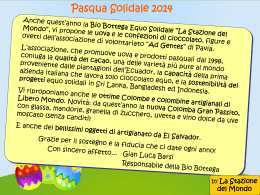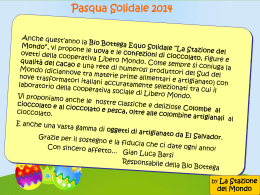METRO 2033 CAPITOLO 1 : LA FINE DELLA TERRA “Chi va là? Artyom, va’ a vedere!” Artyom si alzò con riluttanza dal posto che aveva occupato vicino al fuoco e, portando la mitragliatrice dalla schiena al petto, si diresse verso l’oscurità. Se ne stava al limitare della zona illuminata quando tolse la sicura all’arma e cominciò a urlare in modo burbero e minaccioso, con tutto il fiato che aveva in corpo: “Fermi! Parola d’ordine!” Al buio sentiva passi veloci e discontinui nel punto in cui qualche momento prima aveva udito strani sussurri e mormorii sordi: qualcuno stava indietreggiando per tornare nei recessi della galleria, spaventato dal tono brusco di Artyom e dallo sferragliare dell’arma. Il ragazzo ritornò velocemente vicino al fuoco e si rivolse a Pyotr Andreevich. “Non si è fatto avanti nessuno e non ho neppure ricevuto risposta. Se ne sono andati”. “Idiota! Te l’avevo detto chiaro e tondo: se non rispondono, spara immediatamente! Come puoi sapere di chi si trattava? E se i Tetri si stessero avvicinando?” “No... a giudicare dai rumori bizzarri e dalla cadenza del passo, non credo che fossero esseri umani. Pensa che io non riesca a riconoscere il suono dei passi delle persone? E poi, da quando i Tetri se la danno a gambe levate a questo modo? Lo sa anche lei, Pyotr Andreevich: ultimamente hanno cominciato ad attaccare senza esitazione, hanno assalito una pattuglia a mani nude, affrontando a viso aperto le raffiche di mitragliatrice. Ma questa creatura... è fuggita subito, come un animale spaventato”. “D’accordo, Artyom! Ma sappi che facendo il furbo non andrai lontano. Ti sono stati impartiti degli ordini, perciò è tuo dovere eseguirli, non devi stare troppo a pensarci. Poteva anche essere una sentinella: in quel caso, ora tutti saprebbero che siamo qui, non ci metterebbero molto a calcolare di quante munizioni hanno bisogno... si sbarazzerebbero di noi per il puro gusto di farlo... ci taglierebbero la gola con un coltello e massacrerebbero tutta la stazione, come fecero alla Polezhaevskaya e solo perché tu non hai ammazzato quel miserabile... Fai molta attenzione! La prossima volta li dovrai seguire nella galleria!” Ad Artyom vennero i brividi al solo pensiero della galleria oltre il settecentesimo metro: nessuno aveva mai avuto il fegato di superare quel punto a nord. Le pattuglie erano arrivate fino al cinquecentesimo, avevano illuminato il posto di frontiera con il riflettore del carrello e si erano auto-convinte che la feccia non fosse riuscita a superarlo, quindi erano tornate indietro in tutta fretta. Anche le sentinelle, ragazzoni enormi che avevano fatto parte della fanteria di Marina, si fermavano al seicentodiciottesimo metro. Nascondevano il flebile bagliore delle sigarette riparandole col palmo della mano e se ne stavano fermi, immobili, aggrappati agli strumenti per la visione notturna, per poi cominciare lentamente a indietreggiare, senza mai distogliere lo sguardo dalla galleria, senza mai voltarle le spalle. In quel momento erano di pattuglia al quattrocentocinquantesimo metro, a cinquanta dal posto di frontiera; quest’ultimo veniva controllato una volta al giorno e il sopralluogo quotidiano era già stato effettuato diverse ore prima. Il loro posto era il più distante ed era molto probabile che, dall’ultimo controllo, le bestie messe in fuga dalla pattuglia precedente avessero già ricominciato ad aggirarsi nelle vicinanze. Erano attirate dalle fiamme, dalla gente... Artyom tornò a sedersi e chiese: “Cosa successe di preciso alla Polezhaevskaya?” Benché conoscesse a memoria quel racconto raccapricciante (lo aveva sentito dai commercianti della stazione), provava quasi un bisogno fisico di ascoltarlo di nuovo, come un bambino che vuole sentire storie spaventose di mutanti senza testa e di personaggi tetri che rapiscono i più piccoli. “Alla Polezhaevskaya? Come, non lo sai? Un fatto molto strano... terrificante, direi. Prima di tutto le loro sentinelle cominciarono a scomparire: imboccavano la galleria e non facevano più ritorno. Ovviamente, erano dei pivelli, niente a che vedere con le nostre, ma comunque la loro stazione è di dimensioni ridotte, laggiù vivono molte meno persone... beh, per lo meno, ci vivevano. In ogni caso, le sentinelle cominciarono a sparire: una squadra partiva e non faceva ritorno. Inizialmente pensarono che ci fosse qualcosa a trattenerli: lassù la galleria diventa tortuosa, proprio come qui”. A queste parole, Artyom si sentì gelare. “Nessuna delle pattuglie, nemmeno quelle che rimanevano alla stazione, riusciva a vedere nulla, indipendentemente dalla quantità di luce che utilizzavano per illuminare. Non riapparve nessuno, per mezz’ora, poi per un’ora, che in seguito diventarono due; cominciarono a domandarsi dove fossero finiti quegli uomini che avrebbero dovuto addentrarsi solamente per un chilometro. Non avevano il permesso di avanzare oltre e, comunque, non erano degli stupidi... Per farla breve, dovevano scoprire il prima possibile cosa fosse successo. Inviarono dei rinforzi che li cercarono in lungo e in largo; li chiamarono a squarciagola, con tutto il fiato che avevano in corpo, ma invano: la pattuglia era scomparsa. Le sentinelle erano svanite nel nulla. Ma la cosa peggiore non era che nessuno di loro era riuscito a vedere cosa gli fosse accaduto, ma che non avevano sentito nemmeno un rumore, niente di niente. Di loro non c’era più traccia”. Artyom cominciava a pentirsi di aver chiesto a Pyotr Andreevich di raccontare gli avvenimenti della Polezhaevskaya, perché o era meglio informato, oppure aggiungeva dettagli di fantasia alla storia: descriveva particolari che i commercianti non si sognavano nemmeno, sebbene fossero maestri e veri entusiasti dell’arte della narrazione. Proprio questi dettagli fecero venire la pelle d’oca ad Artyom, malgrado fosse seduto vicino al fuoco. Qualunque fruscio proveniente dalla galleria, anche il più insignificante, ormai faceva galoppare la sua immaginazione. “Quindi, dato che non avevano udito alcuno sparo, si convinsero che le sentinelle li avessero semplicemente abbandonati, che fossero in qualche modo insoddisfatte e che avessero deciso di fuggire. Potevano andarsene al diavolo: se desideravano una vita semplice, se preferivano vagabondare con la marmaglia della peggior specie, potevano farlo finché ne avevano voglia. Era più facile credere che fosse così. Molto più facile. Ma una settimana dopo scomparve un’altra squadra di sentinelle, che non avrebbe dovuto allontanarsi più di cinquecento metri dalla stazione. Era andata come la prima volta: non avevano udito alcun rumore, non avevano ritrovato alcuna traccia. Come se gli altri fossero scomparsi nel nulla. Fu così che alla stazione cominciarono a preoccuparsi. La questione si faceva spinosa, nel giro di una settimana si erano dileguate ben due squadre. Dovevano fare qualcosa, o meglio, dovevano prendere dei provvedimenti. Quindi istituirono un posto di blocco al trecentesimo metro. Vi trascinarono dei sacchi di sabbia, piazzarono le mitragliatrici e un riflettore, come prevedono tutte le regole della fortificazione. Mandarono un delegato alla Begovaya, dato che avevano costituito una confederazione con quella stazione e con la Via del 1905. Inizialmente, c’era stato posto anche per la Campo d’ottobre, ma qualcosa era andato storto, nessuno conosce i dettagli, forse ci fu un incidente. Laggiù le condizioni erano diventate invivibili ed erano fuggiti tutti”. “Comunque, mandarono un delegato alla Begovaya, per avvisarli che, come usavano dire tra loro, c’era puzza di guai e per chiedere aiuto se fosse successo qualcosa. Il primo delegato era appena giunto alla Begovaya e non aveva ancora ricevuto risposta, quando ne arrivò un secondo, madido di sudore, raccontando che gli uomini del posto di blocco rinforzato erano morti tutti, senza nemmeno sparare un colpo. Erano stati assassinati e, cosa ancora peggiore, sembrava che fossero stati massacrati nel sonno! Quegli uomini non si sarebbero mai addormentati, erano troppo spaventati e soprattutto seguivano ordini e istruzioni precisi. A quel punto, gli abitanti della Begovaya compresero che, se non avessero fanno nulla, sarebbe capitato lo stesso anche a loro e avrebbero dovuto affrontare gli stessi problemi nella loro zona. Perciò equipaggiarono di mitragliatrici e lanciagranate le forze d’intervento dei veterani, un centinaio di uomini circa. Ovviamente ci volle un po’ di tempo, quasi un giorno e mezzo, ma poi partirono per andare ad assistere i loro compagni. Tuttavia, quando la squadra entrò nella Polezhaevskaya, non c’era più anima viva, neanche un cadavere. Solo sangue ovunque. Proprio così. Chissà che diavolo era successo. Io, però, non credo proprio che degli esseri umani siano capaci di un gesto del genere”. “Cosa accadde agli abitanti della Begovaya?”. La voce di Artyom suonò diversa, quasi estranea. “A loro non successe nulla. Non appena si resero conto di come si stavano mettendo le cose, fecero saltare la galleria che conduceva alla Polezhaevskaya. Ho sentito dire che laggiù sono franati quaranta metri di gallerie; non c’è modo di scavare per riaprire il passaggio, a meno di usare dei macchinari speciali, che però scommetto non arriverebbero lontano... Ma soprattutto dove trovare macchine di quel genere? Le nostre sono cadute a pezzi quindici anni fa”. Pyotr Andreevich tacque e continuò a osservare il fuoco. Artyom tossì rumorosamente e disse: “È vero, avrei dovuto sparare a quella creatura... sono stato un idiota”. In quel momento sentirono qualcuno chiamare a gran voce da sud, dalla direzione della stazione. “Ehi, laggiù! Al quattrocentesimo metro! Va tutto bene?” Pyotr Andreevich si portò le mani alla bocca come se fossero un megafono e urlò: “Avvicinatevi! Siamo accampati qui!” Tre sagome percorrevano la galleria dalla stazione verso di loro, le torce brillavano al buio; forse erano membri della pattuglia del trecentesimo metro. Quando entrarono nel cerchio di luce emanata dal fuoco, spensero le torce e si sedettero. “Ciao, Pyotr! Allora sei tu! Proprio oggi pensavo: chissà chi hanno mandato ai confini della Terra?”, scherzò la sentinella più anziana, sorridendo e scuotendo il pacchetto di sigarette per farne uscire una. “Ascolta un po’, Andryukha! Uno dei miei ha visto qualcuno quaggiù, ma non è riuscito a sparargli... Si è nascosto nella galleria e non sembrava umano”. “Non sembrava umano? E allora cosa poteva essere?”. Andrey si rivolse ad Artyom. “Non sono nemmeno riuscito a vederlo... Ho richiesto la parola d’ordine, ma la creatura è fuggita, dirigendosi a nord. Tuttavia, i passi non erano umani, erano leggeri e molto veloci, come se avesse quattro zampe invece che due gambe”. “Oppure anche tre!”. Andrey fece l’occhiolino, con una smorfia spaventosa. Artyom rimase senza fiato, mentre ripensava alle storie delle persone a tre gambe della linea Filevskaya: alcune delle stazioni arrivavano fino in superficie e le gallerie non si trovavano in profondità, perciò non avevano potuto beneficiare della protezione dalle radiazioni. Da quelle parti vagavano creature a tre gambe, con due teste e altre terribili mostruosità. Andrey fece un tiro, quindi si rivolse ai suoi uomini: “Ragazzi, già che siamo qui, perché non ci sediamo per qualche minuto? E se una delle creature a tre gambe torna a infastidire i nostri amici, potremo dar loro una mano. Ehi, Artyom! Hai un bollitore?” Pyotr Andreevich si alzò e versò un po’ d’acqua da una tanica in un bollitore ammaccato e ricoperto di fuliggine, poi lo appese sopra la fiamma. Dopo qualche minuto, non appena l’acqua cominciò a bollire, prese a fischiare. Udendo questo suono così familiare e rassicurante, Artyom venne avvolto da un’ondata di calore e di calma. Scrutò gli uomini seduti attorno al fuoco: erano persone forti, affidabili e temprate dalla vita disagevole che conducevano in quel luogo. Ci si poteva fidare di uomini del genere, si poteva contare su di loro: la loro stazione aveva sempre avuto un’ottima reputazione e si era affermata, più delle altre sulla stessa linea, proprio grazie a coloro che sedevano attorno a quel fuoco e a uomini altrettanto valorosi. Il loro era un legame affettuoso, quasi fraterno. Artyom era poco più che ventenne ed era venuto al mondo quando ancora si viveva in superficie. Non era magro e pallido come coloro che erano nati nella Metro, che non osavano uscirne perché temevano le radiazioni e i raggi incandescenti del sole, estremamente dannosi per gli abitanti del sottosuolo. Certo, Artyom riusciva a ricordare di essere stato in superficie una volta sola e solo per un breve istante, giacché le radiazioni di fondo erano talmente forti che se qualcuno fosse stato troppo curioso, ci avrebbe rimesso le penne nel giro di un paio d’ore, prima ancora di riuscire a godersi la passeggiata e di capire cosa fosse successo in quel bizzarro mondo all’aperto. Non aveva alcun ricordo del padre, mentre la madre era stata con lui fino a cinque anni. Vivevano alla Timiryazevskaya. Tutto andava per il verso giusto, la vita scorreva tranquilla e pacifica, ma poi la stazione venne infestata dai ratti. Un giorno, senza il minimo preavviso, enormi ratti grigi, fradici fino al midollo, arrivarono in massa da una delle gallerie nella parte oscura della stazione. Era una diramazione dimenticata della tratta principale proveniente da nord, che svoltava lateralmente, piombava fino a profondità inconcepibili e si perdeva nella complessità della rete composta da centinaia di corridoi gelati, di puzzolenti labirinti d’orrore. La galleria si addentrava nel regno dei ratti, in cui nemmeno il più disperato degli avventurieri si sarebbe mai spinto. Neppure un vagabondo, non riuscendo più a trovare la strada con l’ausilio delle mappe e dei sentieri sotterranei, avrebbe imboccato quella galleria, percependo d’istinto il pericolo oscuro e sinistro che ne emergeva; si sarebbe allontanato in fretta dall’entrata, come se conducesse a una città di appestati. Nessuno infastidiva i ratti, nessuno scendeva nei loro territori, né tantomeno osava oltrepassarne il confine. Furono loro a raggiungere la gente. Quel giorno le vittime furono numerosissime: un fiume vivente di ratti giganti, più grandi di quanto fossero mai stati visti nelle stazioni o nelle gallerie, aveva distrutto gli sbarramenti e invaso le stazioni, sommergendo tutti i difensori e la popolazione, ammutolendo le urla di morte con le masse dei loro corpi. Annientavano tutto ciò che trovavano sul loro cammino, sia i vivi che i morti e persino i loro simili già periti. Continuavano la loro infinita corsa letale, avanzando inesorabilmente, alla cieca, come spinti da una forza al di là dell’umana comprensione. Solo pochi uomini sopravvissero; nessuna donna, nessun anziano o bambino, nessuna delle persone che normalmente sarebbero state salvate per prime. Solo cinque omaccioni erano riusciti a stare al passo del fiume distruttivo. Riuscirono a fuggire solo grazie al carrello parcheggiato lì vicino, mentre stavano di guardia nella parte meridionale della galleria. Udendo le grida provenienti dalla stazione, uno di loro si mosse velocemente in quella direzione per accertarsi di ciò che era successo. Nella Timiryazevskaya erano già quasi tutti morti quando vi fece il suo ingresso. Comprese immediatamente la situazione, scorgendo i primi rigagnoli di ratti che risalivano le piattaforme. Stava per tornare indietro, ben sapendo che non sarebbe mai riuscito ad aiutare coloro che difendevano la stazione, quando improvvisamente qualcuno gli afferrò la mano da dietro. Si voltò e distinse una donna dal volto contratto per la paura, che gli tirava insistentemente la manica e urlava, cercando di sovrastare le innumerevoli grida disperate: “Di me non importa, ma lui deve vivere! Lo salvi, soldato! Abbia pietà!” Si accorse che gli stava porgendo la manina paffuta di un bambino, che lui afferrò senza nemmeno pensare che con quel gesto avrebbe salvato una vita: tirò il bambino a sé, lo sollevò e se lo mise sotto il braccio, quindi cominciò la sua corsa contro la morte e i ratti delle prime file, nel tentativo di superare la galleria e di giungere nel luogo in cui il carrello lo attendeva insieme agli altri pattugliatori. Iniziò a urlare da lontano, da una distanza di cinquanta metri circa, chiedendo loro di avviare il carrello, l’unico motorizzato nel raggio di dieci stazioni. Fu così che riuscirono a seminare i ratti. I pattugliatori procedevano ad altissima velocità, superarono la stazione abbandonata della Dmitrovskaya, dove avevano trovato rifugio alcuni eremiti, ai quali riuscirono a urlare: “Correte via! Ratti!”, senza rendersi conto che quelli non si sarebbero mai salvati. Mentre si avvicinavano allo sbarramento della Savyolovskaya, con la quale fortunatamente avevano accordi pacifici, rallentarono per non cadere vittime del fuoco amico, poiché alla velocità a cui avanzavano sarebbero stati senz’altro scambiati per dei razziatori. Cominciarono a urlare a squarciagola alle guardie: “Ratti! Stanno arrivando!”. Erano pronti per proseguire la loro corsa frenetica attraverso la Savyolovskaya e ancora più avanti, si preparavano a implorare perché li lasciassero procedere oltre, sempre che la lava grigia non avesse inghiottito tutta la Metro. Ma fortunatamente alla Savyolovskaya c’era qualcosa che avrebbe salvato loro, la stazione e persino l’intera diramazione Serpukhovsko-Timiryazevskaya. Erano quasi in stazione, madidi di sudore, urlavano alle guardie della Savyolovskaya di come fossero scampati per un pelo a una morte certa, quando quelle stesse sentinelle cominciarono, con movimenti veloci, a rimuovere la copertura di un’apparecchiatura impressionante. Si trattava di un lanciafiamme, costruito dagli artigiani del luogo usando pezzi di ricambio: era un’arma improvvisata ma incredibilmente potente. Non appena le prime file di ratti furono visibili, mentre diventavano più numerose e nell’oscurità si cominciava a sentire il rumore frusciante e graffiante di migliaia di zampe, le guardie azionarono il lanciafiamme, per spegnerlo solo una volta esaurito il carburante. Un’ululante fiamma arancione riempì la galleria per decine di metri e bruciò i ratti, dal primo all’ultimo, senza sosta, per dieci, quindici, venti minuti. La galleria venne invasa dall’odore rivoltante della carne bruciata e dallo squittio incontrollato degli animali. Dietro gli uomini di guardia alla Savyolovskaya, che erano già diventati degli eroi, conosciuti in tutta la linea della Metropolitana, il carrello finalmente si fermò. A bordo vi erano i cinque uomini fuggiti dalla stazione Timiryazevskaya, ma vi era anche un altro passeggero: il bambino che avevano salvato. Un ragazzino. Artyom. I ratti cominciarono la ritirata. La loro cieca volontà era stata spezzata da una delle ultime invenzioni del genio militare umano. Quando si trattava di uccidere, gli esseri umani erano sempre stati di gran lunga i migliori, rispetto alle altre specie. I ratti defluirono e tornarono nel loro enorme regno, le cui reali dimensioni rimanevano sconosciute. Tutti quei labirinti, che si intrecciavano a profondità inimmaginabili, erano ancora un mistero e comunque totalmente inutili per il funzionamento della Metropolitana. Era difficile credere che quel bandolo fosse stato edificato da dei semplici costruttori di metropolitane, sebbene diversi esponenti alle autorità avessero giurato che era andata proprio così. In passato, uno di questi personaggi aveva lavorato come assistente del capotreno su un convoglio elettrico. Erano rimaste pochissime persone come lui, ed erano tenute in altissima considerazione perché all’inizio erano le sole a riuscire a orientarsi laggiù. Inoltre, non si lasciavano sopraffare dalla paura nei momenti in cui si trovano fuori dalla sicurezza e dalla comodità del vagone, nelle tetre gallerie della Metro di Mosca, nelle viscere di pietra della grande metropoli. Alla stazione, tutti trattavano l’assistente del capotreno con riverenza e insegnavano ai loro figli a fare lo stesso. Molto probabilmente fu per questo motivo che Artyom si ricordava ancora di lui, un uomo magro, allampanato e smagrito dagli anni di lavoro. Indossava un’uniforme da addetto alla Metropolitana ormai sbiadita e consunta, che già da tempo aveva perduto la sua eleganza, ma che lui portava con il medesimo orgoglio con cui un ammiraglio in pensione sfoggiava l’alta uniforme. Persino Artyom, che al tempo era ancora un bambino, aveva notato una sorta di dignità e di potere nella figura cagionevole dell’assistente del capotreno. Era ovvio che fosse così, perché tra tutti i sopravvissuti, gli addetti della Metropolitana venivano considerati come delle guide esperte in spedizioni scientifiche nella giungla impenetrabile. La gente gli credeva senza mai mettere in dubbio la loro autorità, si fidava totalmente di loro e affidava la sopravvivenza di tutti i superstiti alle loro conoscenze e abilità. Molti addetti diventarono capi stazione quando il sistema di governo unificato si sciolse e la Metro venne trasformata in un complesso oggetto di difesa civile, un enorme rifugio contro la pioggia radioattiva, una moltitudine di stazioni autonome senza alcun legame tra loro, e sprofondò nel caos e nell’anarchia. Le stazioni divennero così indipendenti e autosufficienti, degli staterelli separati, con le loro ideologie e i loro regimi, i loro esponenti e i relativi eserciti. Erano in guerra le une contro le altre, si alleavano, formavano federazioni e confederazioni. Un giorno diventavano centri metropolitani di un fiorente impero, mentre quello successivo venivano soggiogate e colonizzate da quelli che erano stati loro amici, oppure loro schiavi. Si creavano alleanze a breve termine per affrontare una minaccia comune, salvo poi assalirsi nuovamente l’un l’altra non appena la minaccia fosse passata e le forze non si fossero ristabilite completamente. Si scontravano tra loro al minimo pretesto, sia per i luoghi in cui vivere, che per il cibo. Ad esempio, si contendevano le coltivazioni di lieviti proteici, le piantagioni di funghi che non necessitavano di luce per crescere, i pollai e i porcili, con galline scheletriche e maiali sotterranei che venivano cresciuti a base di funghi sotterranei e incolore. Ovviamente combattevano anche per l’acqua, o meglio, per i filtri. I barbari, che non sapevano come riparare i sistemi di filtri ormai vetusti nelle loro stazioni, morivano a causa dell’acqua avvelenata dalle radiazioni e si scagliavano con rabbia animalesca contro i bastioni civilizzati, nelle stazioni in cui le dinamo e le piccole, semplicissime centrali idroelettriche funzionavano alla perfezione, dove i filtri erano stati riparati e venivano regolarmente puliti. Qui, grazie alle amorevoli mani delle donne, il suolo umido era costellato di piccoli funghi bianchi e i maiali ben nutriti grufolavano nei loro recinti. Questa infinita e disperata offensiva era generata dal loro istinto di conservazione, che andava oltre l’eterno principio rivoluzionario del divide et impera. Coloro che difendevano le stazioni più ambite si organizzavano in divisioni pronte alla battaglia, composte da ex militari professionisti, affrontavano gli assalti dei vandali, finché l’ultima goccia del loro sangue era stata versata. Si lanciavano in contrattacchi e riconquistavano, con una sola battaglia, ogni metro delle gallerie tra una stazione e l’altra. Le diverse stazioni radunavano i poteri militari per rispondere alle incursioni con spedizioni punitive, o per allontanare i vicini civilizzati da territori cruciali per il sostentamento, nel caso non fossero riusciti a raggiungere degli accordi pacifici, o ancora per resistere a tutte le nefandezze che fuoriuscivano dai buchi e dalle gallerie. Queste ultime erano creature strane, singolari ed estremamente pericolose, del tipo che avrebbe sconfortato Darwin in persona, giacché non soggiacevano ad alcuna delle leggi sullo sviluppo evolutivo. Tuttavia, era chiaro che queste bestie erano diverse dagli animali a cui gli umani erano abituati: che fossero rinati sotto i raggi invisibili e pericolosissimi della luce del sole, che si fossero trasformati da rappresentanti inoffensivi della fauna urbana in tizzoni infernali, o che avessero sempre dimorato a queste profondità e che l’uomo li avesse disturbati solo in seguito, erano comunque parte inconfutabile della vita sulla terra. Sfigurati e perversi, erano cionondimeno degli esseri viventi. Per questo, provavano lo stesso impulso violento di tutti gli altri organismi di questo pianeta: sopravvivere, a qualsiasi costo. E per sopravvivere, riprodursi. E per sopravvivere, combattere. Anche uccidere, per sopravvivere. Artyom accettò una tazza bianca smaltata, in cui era stato versato un po’ del tè prodotto nella stazione. Certo, non si trattava propriamente di tè, ma di un infuso di funghi essiccati e di altri additivi. Il vero tè era rarissimo, veniva razionato e servito solo nelle festività più importanti; inoltre, poteva raggiungere un prezzo decine di volte superiore a quello del tè di funghi. Tuttavia, erano molto orgogliosi dell’infuso che producevano alla loro stazione, tanto da chiamarlo proprio “tè”. Gli stranieri lo sputavano dopo il primo sorso, perché non erano abituati al gusto, ma ben presto vi si abituavano. Il loro tè divenne famoso anche oltre i confini della stazione; persino i commercianti arrivavano alla spicciolata per acquistarlo, rischiando la vita. Così divenne conosciuto su tutta la linea della Metropolitana, tanto che persino la Lega Hanseatica aveva cominciato a interessarsene e grandi carovane piene di infuso magico avevano iniziato a partire dalla VDNKh. Cominciò a girare moltissimo denaro e, dove c’erano quattrini, c’erano anche armi, legna da ardere e vitamine. C’era vita. Da quando alla VDNKh avevano cominciato a produrre quel tè, la stazione era diventata sempre più forte, mentre gli abitanti di quelle limitrofe si erano avvicinati, anche perché erano stati posati nuovi binari. Era arrivata la prosperità. Alla VDNKh erano anche molto soddisfatti dei loro maiali, poiché la leggenda voleva che questi animali fossero entrati nella Metropolitana proprio da questa stazione. Quando tutto cominciò, dei temerari si erano introdotti nel padiglione della fiera in cui venivano allevati i maiali e avevano fatto scendere il bestiame nella stazione. “Artyom, come vanno le cose con Sukhoi?”, gli domandò Andrey, bevendo il suo tè a piccoli sorsi cauti, soffiandoci sopra con attenzione. “Con lo zio Sasha? Va tutto bene. È tornato poco tempo fa da un’escursione lungo la linea, con alcuni dei nostri. Una spedizione, come forse saprà”. Andrey aveva circa quindici anni in più di Artyom. In realtà era una sentinella, ma raramente se ne stava di guardia nei pressi del quattrocentocinquantesimo metro e comunque lo faceva in qualità di comandante dello sbarramento. Laggiù lo assegnavano al trecentesimo metro, sempre con un’ottima copertura; tuttavia sentiva il bisogno di addentrarsi più in profondità, dunque ogni pretesto e ogni falso allarme erano buoni per avvicinarsi all’oscurità e al segreto. Adorava la galleria e conosceva molto bene tutte le diramazioni. Alla stazione non si sentiva a proprio agio tra i fattori, gli artigiani, i commercianti e gli amministratori; molto probabilmente si sentiva inutile. Non riusciva a costringersi a zappare la terra per coltivare i funghi oppure, ancora peggio, a far abbuffare, sempre di funghi, i maiali delle stazioni, immerso nel letame fino alle ginocchia. Ma non sarebbe potuto essere nemmeno un commerciante, poiché non sopportava questa categoria, sin da quando era bambino. Era sempre stato un soldato, un guerriero, e credeva con tutto se stesso che questo fosse l’unico lavoro degno di un uomo. Era orgoglioso di non aver fatto altro nella vita che difendere fattori puzzolenti, commercianti pignoli, amministratori sempre efficienti, oltre naturalmente a bambini e donne. Queste ultime erano attratte dalla sua forza arrogante, dalla sicurezza che ostentava, dalla serenità con cui si proponeva e si relazionava con gli altri, perché era sempre in grado di difenderli. Quando le donne gli promettevano di amarlo, gli offrivano anche il benessere, ma lui si sentiva bene solo oltre il cinquantesimo metro, oltre il punto di svolta, dove le luci della stazione venivano nascoste. Per questo le donne non lo seguivano. Ma perché no? Dopo essersi scaldato per bene grazie al tè, si levò il vecchio berretto nero e con la manica si asciugò i baffi umidi di vapore. Quindi prese a fare una domanda dopo l’altra ad Artyom, ansioso di conoscere le novità e i pettegolezzi provenienti dal sud e scoperti durante l’ultima spedizione dal patrigno, cioè lo stesso uomo che diciannove anni prima era riuscito a strapparlo ai ratti alla Timiryazevskaya e che, non essendo stato capace di abbandonarlo, lo aveva cresciuto. “Anche io so un paio di cose, ma ascolterò con piacere, dovesse anche trattarsi di fatti già noti. Cosa... Ti dispiace?”, insistette Andrey. Non dovette faticare a convincerlo, poiché Artyom si divertiva molto a ricordare e a raccontare le storie del patrigno. Dopotutto, chiunque le avrebbe ascoltate a bocca aperta. “Beh, forse sa dove sono andati”, cominciò Artyom. “Ho saputo che si sono diretti a sud. Compiono missioni top secret, i tuoi amici ‘escursionisti’”, lo canzonò Andrey. “Si tratta di missioni speciali per conto dell’amministrazione!”, fece l’occhiolino a uno dei suoi. “Non c’era proprio nulla di segreto”, Artyom gesticolò in maniera sprezzante. “Era un spedizione di ricognizione, per raccogliere delle informazioni... che potessero essere attendibili. Non ci si può fidare degli stranieri, dei commercianti che ci ammaliano con le loro parole alla stazione, perché potrebbero persino essere degli agenti segreti che tentano di diffondere informazioni errate”. “Non ci si può mai fidare dei commercianti”, rincarò la dose Andrey. “Pensano solo al loro bene. Impossibile fidarsi. Il giorno prima vendono il tuo tè all’Hansa, e il giorno dopo decidono di vendere sia te che i tuoi reni a qualcun altro. Potrebbero essere persino tra noi, a raccogliere informazioni. Ad essere onesto, io non mi fido nemmeno dei nostri”. “Beh, secondo me si sbaglia, Andrey Arkadych. I nostri sono dei bravi ragazzi. Li conosco quasi tutti di persona e sono delle persone normali, come ce ne sono dappertutto, solo che a loro piacciono molto i quattrini e desiderano vivere meglio degli altri, quindi si sforzano di ottenere qualcosa in più”, controbatté Artyom, cercando di difendere i commercianti della zona. “Hai proprio centrato il bersaglio, è quello che intendevo dire io: adorano il denaro e vogliono vivere meglio di tutti gli altri. Chi mi sa dire che fanno quando imboccano la galleria? Riuscite ad assicurarmi che alla prossima stazione non verranno reclutati dagli agenti?” “Quali agenti? A quale fazione apparterrebbero gli agenti ai quali i nostri commercianti si sarebbero sottomessi?” “Ascolta bene ciò che dico ora, Artyom: sei ancora giovane e molte sono le cose che non sai. Dovresti ascoltare gli anziani e, se presterai la dovuta attenzione, riuscirai a vivere più a lungo”. “Ma qualcuno dovrà pur fare il loro lavoro! Se non fosse per i commercianti, ce ne staremmo qui senza equipaggiamento militare, a bere il nostro tè con i fucili Berdan, a sperare che i Tetri se ne stiano alla larga”, replicò Artyom, ribadendo la sua opinione. “Ottimo, c’è un economista in mezzo a noi... Datti una calmata. Piuttosto raccontaci cosa ha visto Sukhoi laggiù. Che sta accadendo ai vicini? All’Alekseevskaya? E alla Rizhskaya?” “All’Alekseevskaya? Nulla di nuovo, coltivano funghi. Dopotutto, cos’è l’Alekseevskaya se non una semplice fattoria... Per lo meno, così ho sentito dire”. A quel punto Artyom abbassò la voce per creare la suspense necessaria all’informazione che stava per rivelare: “Vogliono unirsi a noi. Alla Rizhskaya sono d’accordo. Subiscono crescenti pressioni da sud e il loro morale continua a peggiorare, infatti si è cominciato a parlare di una sorta di minaccia, gli abitanti hanno paura, anche se nessuno sa di cosa. Potrebbe esserci una specie di nuovo impero all’estremità più lontana della linea; o magari la popolazione ha cominciato a temere l’Hansa, perché crede che si voglia espandere; oppure il motivo è ancora diverso. Quei miserabili hanno cominciato ad avvicinarsi a noi, sia la Rizhskaya che l’Alekseevskaya”. “Ma cosa vogliono da noi? Cosa ci offrono?”, sollecitò Andrey. “Vorrebbero creare una federazione e istituire un sistema di difesa comune, per rafforzare i confini di entrambe le estremità, fare in modo che vi sia un sistema di illuminazione costante nelle gallerie tra le stazioni, organizzare una forza di polizia per pattugliare le gallerie laterali e i corridoi, oltre a predisporre carrelli per il trasporto, posare un cavo del telefono, delimitare tutti gli spazi disponibili per la coltivazione dei funghi... Insomma, auspicano un’economia comune: lavorare e aiutarsi l’un l’altro, se ciò si rendesse necessario”. “Ma dov’erano quando noi avevamo bisogno di loro? Quando venivamo infestati dai parassiti che venivano dall’Orto botanico e da Medvedkov? Quando i Tetri ci attaccarono? Loro dov’erano?”, ringhiò Andrey. “Non fare l’uccello del malaugurio, Andrey! Fa’ molta attenzione!”, si intromise Pyotr Andreevich. “Al momento i Tetri non sono qui e tutto va come dovrebbe. Non siamo stati noi a sconfiggerli: gli è successo qualcosa e si sono acquietati; la loro potrebbe anche essere una tattica per risparmiare energia, quindi una federazione non causerà alcun danno, a maggior ragione se ci alleiamo con i nostri vicini. E se ciò andrà a loro vantaggio, porterà benefici anche a noi”. “Così avremo libertà, uguaglianza e fratellanza!”, precisò ironicamente Andrey, usando le dita della mano per sottolineare la sua affermazione. “Beh, non vuole ascoltare il resto?”, reclamò Artyom, offeso. “Certo, Artyom, continua pure”, gli rispose Andrey. “Terminerò la discussione con Pyotr più tardi, l’abbiamo già posticipata troppo a lungo”. “Va bene: quindi, il loro capo parrebbe concordare, non ha alcuna obiezione particolare. Devono solo valutare i dettagli, ben presto ci sarà un’assemblea. Quindi, un referendum”. “In che senso, un referendum? Se il popolo dice sì, allora, tutti d’accordo; se invece dice no, significa che la gente non pensa abbastanza e bisogna darle più tempo per decidere”, lo punzecchiò Andrey. “Secondo te, Artyom, che succede oltre la Rizhskaya?”, sollecitò Pyotr Andreevich, non prestando attenzione ad Andrey. “Cioè, quale sarà il prossimo passo? La Prospekt Mira. Mi sembra la scelta più naturale, dal momento che è il confine della Lega Hanseatica. Il mio patrigno sostiene che la situazione tra l’Hansa e i Rossi sia sempre la medesima e che hanno mantenuto la pace. Nessuno laggiù pensa più alla guerra”, affermò Artyom. La “Lega Hanseatica” era il nome dell’”Accordo tra le stazioni della linea dell’Anello”. Tali stazioni si trovavano alle intersezioni tra le diverse linee e, di conseguenza, anche sulle rotte dei commercianti. Le linee erano interconnesse da gallerie che diventarono il luogo d’incontro per gli uomini d’affari di tutta la Metropolitana. Questi ultimi si arricchirono a una velocità incredibile e ben presto, sapendo che il loro benessere stava suscitando sentimenti di invidia in troppe persone, decisero di unire le forze. Tuttavia, il nome ufficiale era fin troppo scomodo e, tra coloro che non vi appartenevano, l’Accordo veniva soprannominato “Hansa”, poiché una volta qualcuno lo aveva accuratamente paragonato all’alleanza delle città commerciali della Germania medievale; questo nomignolo era accattivante e rimaneva impresso. Al principio, facevano parte dell’Hansa solo poche stazioni e l’Accordo prese piede soltanto gradualmente. La parte dell’Anello che andava dalla Kievskaya alla Prospekt Mira veniva chiamata Arco settentrionale e includeva la Kurskaya, la Taganskaya e la Oktyabrskaya, alle quali si aggiunsero poi la Paveletskaya e la Dobrynskaya, formando un secondo Arco, il meridionale. Ma il problema maggiore, che intralciava l’unione tra i due Archi, era rappresentato dalla linea Sokol. “Questo perché”, gli aveva rivelato una volta il suo patrigno, “la linea Sokol è speciale, sotto un certo punto di vista. Quando si osserva una mappa, è lei ad attirare subito l’attenzione. Prima di tutto, è una linea diritta, come fosse una freccia. In secondo luogo, sulle mappe della Metropolitana è segnalata con un rosso acceso; inoltre, anche i nomi delle sue stazioni fanno la loro parte: Krasnoselskaya, Krasnye Vorota, Komsomolskaya, Biblioteca Lenin e Leninskie Gory...”. Non si sa se fossero i nomi o altro, ma quella linea aveva attirato a sé tutti coloro che si sentivano particolarmente nostalgici del glorioso passato russo. Laggiù, l’idea di fare rinascere lo stato sovietico dalle proprie ceneri trovò terreno fertile. Inizialmente, solo una stazione ritornò ad affermare gli ideali comunisti e una forma di governo socialista, poi fu il turno della vicina e, quando la gente delle gallerie cominciò ad avere il sentore di quest’ottimismo rivoluzionario, si liberò degli amministratori e poi di tutti gli altri. I veterani ancora in vita, ex membri del Komsomol e funzionari di partito, oltre ai membri permanenti del proletariato, si riunirono tutti alle stazioni rivoluzionarie. Fondarono un comitato responsabile della divulgazione, all’interno dell’intera Metropolitana, di questa nuova rivoluzione e delle sue idee comuniste, che venne chiamato “Interstazionale”, nome dall’eco alquanto leniniana. Assemblarono divisioni di rivoluzionari professionisti e di propagandisti per inviarli alle stazioni nemiche. Di norma, non veniva mai versato del sangue, poiché gli abitanti della linea Sokol morivano di fame e aspiravano a ristabilire la giustizia, per la quale, secondo loro, a parte l’egualitarismo non giustificato, non vi era altra opzione. Perciò ben presto l’intera diramazione, dopo essersi infiammata solo da un lato, venne pervasa completamente dal fuoco rosso della rivoluzione. Le stazioni adottarono nuovamente i loro precedenti nomi sovietici: Chistye Prudy ritornò Kirovskaya, Lubianka tornò ad essere Dzerzhinskaya, Okhotnyi Ryad ridiventò Prospekt Marksa. Le stazioni dai nomi più neutrali vennero ribattezzate con appellativi più ideologici: Sportivnaya si trasformò in Kommunisticheskaya, Sokolniki cambiò nome in Stalinskaya, mentre Preobrazhenskaya Ploshchad, dove tutto era cominciato, divenne Znamya Revolutsya. Anche la linea stessa, un tempo Sokol, ora veniva comunemente chiamata la “linea Rossa”. In passato i moscoviti non avevano mai avuto l’abitudine di riferirsi alle linee della Metropolitana con il colore riportato sulla mappa, ma ora questa veniva chiamata ufficialmente “linea Rossa”. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Nel momento in cui fu istituita la linea Rossa, prese a circolare anche il progetto di estenderla nel resto della Metropolitana, ma a quel punto la pazienza delle altre stazioni venne velocemente a mancare: troppe persone ricordavano l’era sovietica, così come erano in molti coloro che consideravano gli agitatori in missione per l’Interstazionale nella Metropolitana come un cancro che si stava espandendo e che minacciava di uccidere l’intero organismo. Ma finché gli agitatori e i propagandisti promettevano alle persone l’elettricità in tutta la Metropolitana, li informavano che se si fossero uniti ai poteri sovietici avrebbero vissuto il vero comunismo, sebbene fosse poco probabile che questa trovata venisse dallo slogan di Lenin, poiché la prima era decisamente intesa allo sfruttamento degli individui, la gente che si trovava al di là dei confini non era per nulla tentata. I divulgatori dell’Interstazionale venivano acciuffati e rimandati nel loro territorio sovietico. A quel punto l’autorità Rossa decise che era venuto il momento di agire in maniera più incisiva: se il resto della Metropolitana non avesse accettato le fiamme divampanti della rivoluzione, allora avrebbero dovuto provare ad accenderle con le loro stesse mani. Inoltre, le stazioni vicine erano preoccupate dalla propaganda comunista che si stava facendo sempre più violenta, la quale nel frattempo era giunta alla stessa conclusione: la storia dimostra che non esiste metodo migliore per inoculare il virus del comunismo che con una baionetta. Così si scatenò una fragorosa tempesta. La coalizione di stazioni anti comuniste, gestita dall’Hansa, fece irruzione sulla linea Rossa per cercare di chiudere l’Anello. Naturalmente l’Hansa non si aspettava di dover affrontare una resistenza organizzata e aveva sopravvalutato i propri poteri. Si era figurata una vittoria senza sforzi, che in realtà non sarebbe mai stata possibile, nemmeno nel futuro più remoto. Il conflitto si trasformò in una guerra lunga e sanguinosa, che continuò senza tregua. Inoltre, la popolazione della Metropolitana non era poi così numerosa... Le ostilità proseguirono per un anno e mezzo e consistettero per lo più in battaglie di posizionamento che comportavano scorribande e diversivi da parte dei guerriglieri, barricate nelle gallerie, esecuzioni di prigionieri, oltre a numerose altre atrocità commesse da entrambe le fazioni. Accadde di tutto: operazioni dell’esercito, accerchiamenti, sfondamenti degli accerchiamenti, oltre a diverse altre imprese, a cui parteciparono comandanti, eroi e traditori. Ma la caratteristica principale di questa guerra era che nessuna delle due fazioni belligeranti riusciva a spostare la propria linea del fronte di una distanza considerevole. Alle volte sembrava che una delle due stesse guadagnando terreno, che avrebbe conquistato la stazione vicina, ma gli avversari resistevano, mobilitavano forze aggiuntive e il piatto della bilancia cominciava a pendere dalla parte del nemico. Tuttavia, la guerra esaurì le risorse ed eliminò le persone migliori; la guerra era sempre estenuante. Coloro che riuscirono a sopravvivere cominciarono a stancarsi. Il governo rivoluzionario, scaltro, sostituì gli enormi obiettivi iniziali con altri più modesti. All’inizio auspicavano la distribuzione del potere socialista e delle idee comuniste all’interno della Metropolitana, ma in seguito i Rossi presero a sperare solo di ottenere il controllo su ciò che consideravano il loro più alto baluardo, cioè la stazione chiamata Piazza della Rivoluzione: prima di tutto per il nome che portava, e in secondo luogo perché era la più vicina alla Piazza Rossa e al Cremlino, le cui torri erano ancora adorne di rubini a forma di stella, stando alle testimonianze di alcuni coraggiosi, così motivati da ciò in cui credevano da risalire solo per ammirarle. In superficie, vicino al Cremlino, al centro della Piazza Rossa, si ergeva il Mausoleo; nessuno sapeva se il corpo di Lenin fosse ancora conservato al suo interno, ma ciò non importava granché. Per i lunghi decenni dell’era sovietica, il Mausoleo non era più stato una tomba, ma si era trasformato in un santuario, simbolo sacro della continuità del potere. Le parate dei grandi capi militari del passato cominciavano proprio da lì, mentre quelle dei leader del presente aspiravano ad arrivarci. Inoltre, si diceva che dagli uffici della stazione della Piazza della Rivoluzione si diramassero passaggi segreti che conducevano ai laboratori segreti del Mausoleo, i quali portavano direttamente alla bara stessa. I Rossi avevano ancora la Prospekt Marksa, prima chiamata Okhotnyi Ryad. Fortificata, divenne una base da cui venivano lanciati gli attacchi sulla Piazza della Rivoluzione. Più di una crociata venne benedetta dall’autorità rivoluzionaria e inviata a liberare la stazione e il sepolcro. Tuttavia, coloro che la difesero comprendevano quale significato avesse per i Rossi e proprio per questo motivo cercarono di resistere fino all’ultimo. La Piazza della Rivoluzione diventò una fortezza inavvicinabile. La battaglia peggiore e più sanguinosa fu combattuta nelle vicinanze della stazione, dove perse la vita un numero incalcolabile di persone; in moltissimi si comportarono da eroi e affrontarono i proiettili a viso aperto, i più coraggiosi si fecero saltare in aria insieme alle granate che si legavano al corpo, nel momento in cui giungevano nei pressi di punti di artiglieria nemica; per di più vi furono coloro che azionarono i lanciafiamme, proibiti contro la gente. Ma fu tutto invano. Riuscivano a riconquistare la stazione per un giorno, ma non erano in grado di fortificarla, perciò venivano sconfitti e si ritiravano il giorno successivo, quando la coalizione si rifaceva avanti con un contrattacco. Lo stesso stava accadendo alla Biblioteca Lenin: era una fortezza dei Rossi e le forze di coalizione avevano ripetutamente provato a conquistarla. La stazione aveva un enorme valore strategico, poiché se fossero riusciti a ottenerla, la linea Rossa si sarebbe divisa in due, assicurando un passaggio diretto ad altre tre linee, con le quali la Rossa non si interseca in nessun altro punto. Era un nodo cruciale, paragonabile a una ghiandola linfatica infettata dalla peste, che di conseguenza avrebbe ammorbato anche il resto dell’organismo. Quindi, per impedire che ciò accadesse, la Biblioteca Lenin andava conquistata ad ogni costo. I tentativi dei Rossi di impadronirsi della Piazza della Rivoluzione si erano rivelati un buco nell’acqua e lo stesso era stato per gli sforzi della coalizione con la Biblioteca Lenin. Nel frattempo la gente era stremata dai combattimenti. La diserzione era molto diffusa: spesso accadde che, durante una battaglia, i soldati dei due fronti decidessero di gettare le armi e di fraternizzare... Al contrario della Prima guerra mondiale, però, i Rossi non ne trassero alcun vantaggio. La miccia rivoluzionaria si stava spegnendo lentamente, mentre la coalizione non si trovava in acque migliori: delusi dal fatto che dovessero costantemente mettere a repentaglio le loro vite, gli alleati decidevano di lasciare e, famiglia dopo famiglia, si spostavano dalle stazioni più centrali a quelle periferiche. Questo esodo lasciò l’Hansa semideserta e indebolita. La guerra aveva avuto un effetto estremamente negativo sul commercio, tanto che i commercianti trovarono altri modi di condurre i loro affari e le più importanti rotte del mercato si svuotarono e pian piano si caddero in disuso... I politici, spalleggiati da sempre meno soldati, sentirono l’urgenza di trovare una maniera di porre fine alla guerra, prima che le armi gli si rivoltassero contro. Per questa ragione, in circostanze che rimasero segrete, i leader delle fazioni nemiche, cioè il presidente dell’Hansa, Loginov e il capo della Confederazione dell’Arbat, Kolpakov, si incontrarono in una delle stazioni neutrali. Firmarono un accordo di pace in tutta fretta; le parti si scambiarono le stazioni: la linea Rossa ricevette una semidistrutta Piazza della Rivoluzione, ma rinunciò alla Biblioteca Lenin. Non era un passo semplice da compiere, per nessuno dei due movimenti; inoltre, la confederazione perse una delle sue parti a causa delle sua influenza sul settore nordoccidentale, mentre la linea Rossa si frammentò, giacché non vi era più alcuna sua stazione che non fosse stata divisa in due. Malgrado entrambe le parti avessero garantito l’un l’altra il diritto di libero transito attraverso i loro ex territori, una situazione del genere non poteva che turbare i Rossi... Purtroppo, ciò che la coalizione aveva proposto loro era troppo allettante. E la linea Rossa non riuscì a resistere. In seguito alla stipulazione dell’Accordo, l’Hansa ebbe la meglio, proprio perché si trovava più vicina all’Anello: l’ultimo ostacolo verso la loro prosperità era stato rimosso. Concordarono di osservare lo status quo e il divieto di condurre propaganda e attività sovversive nei territori dell’ex nemico. Furono tutti soddisfatti e nel momento in cui le voci dei cannoni e dei politici tacquero, toccò ai propagandisti spiegare alle masse che il loro gruppo era riuscito in un’incredibile impresa diplomatica, vincendo la guerra. Trascorsero molti anni da quel giorno memorabile in cui venne firmato il trattato di pace, che in seguito fu sempre rispettato da entrambe le parti. L’Hansa trovò nella linea Rossa un partner economico vantaggioso, mentre quest’ultima rinunciò a tutti i propositi aggressivi: il compagno Moskvin, segretario generale del partito comunista della Metropolitana di Mosca nel nome di Vladimir Lenin, provò, con un’acrobazia dialettica, che esisteva la possibilità di ricostituire il comunismo su una linea della Metro separata e che le antiche ostilità erano state dimenticate. Artyom ricordava bene questa lezione di storia recente, nello stesso modo in cui cercava di ricordare tutto ciò che il patrigno gli aveva raccontato. “Per fortuna quel massacro si è concluso”, affermò quindi Pyotr Andreevich. “Per un anno e mezzo è stato impossibile avvicinarsi all’Anello: c’erano sbarramenti ovunque, controllavano i documenti di tutti anche un centinaio di volte, se ne era necessario. In quel periodo conducevo degli affari da quelle parti e non c’era modo di superare gli sbarramenti se non attraverso l’Hansa. Mi fermarono proprio alla Prospekt Mira, mi misero praticamente al muro”. “E poi cosa successe? Non ce lo hai mai raccontato, Pyotr... Com’è andata?”, chiese Andrey interessato. Artyom si mise più comodo, dato che la staffetta del narratore era stata passata a qualcun altro. Ma la storia si preannunciava interessante, di conseguenza decise di non intromettersi. “Beh, è molto semplice: ritenevano che fossi una spia rossa. Uscii dalla galleria alla Prospekt Mira, sulla nostra linea, che oltretutto era controllata dall’Hansa. È, per così dire, adiacente; laggiù la situazione non era poi così controllata, c’era un mercato, un’area adibita al commercio. Come sapete, la situazione era simile ovunque vi fosse l’Hansa, le stazioni sull’Anello formavano una sorta di territorio base, mentre i passaggi di trasferimento dalle stazioni dell’Anello avevano la funzione di radiali, dove erano stati istituiti dazi doganali e controllo dei passaporti...” “Sappiamo tutti come funzionava laggiù, ce lo vuoi insegnare tu? Dicci piuttosto cosa ti è accaduto!”, lo interruppe Andrey. “Controllo dei passaporti”, ripeté Pyotr Andreevich, corrucciando le sopracciglia, determinato ad arrivare al punto della questione. “Nelle stazioni radiali vi erano mercati ed empori... a cui gli stranieri avevano la possibilità di accedere. Ma non si potevano superare i confini, non c’era alcun modo per farlo. Quel giorno andai alla Prospekt Mira, avevo con me mezzo chilo di tè e avevo bisogno di munizioni per il fucile. Pensavo di riuscire a barattare. Beh, pare che laggiù vigesse la legge marziale, perciò non permettevano di vendere equipaggiamento militare. Chiesi a una persona, poi a un’altra. Trovavano tutte una scusa e si allontanavano di fretta. Solo una mi sussurrò: ‘Ma quali munizioni, idiota che non sei altro. Vattene subito da qui e in fretta. Probabilmente sono già stati informati di ciò che cerchi’. Lo ringraziai e me ne ritornai cautamente nella galleria. All’uscita, una pattuglia mi fermò e sentii fischiare dalla stazione, dopodiché vidi un distaccamento che si avvicinava di corsa. Mi chiesero i documenti e diedi loro il mio passaporto, con il timbro della nostra stazione. Lo controllarono con attenzione e chiesero: ‘Dov’è il tuo lasciapassare?’. Io risposi, sorpreso: ‘Lasciapassare?’. Così scoprii che per avere accesso a quella stazione si era obbligati ad avere un lasciapassare: vicino all’uscita della galleria c’era un tavolinetto, un ufficio, dove controllavano i documenti di identificazione e, nel caso fosse necessario, rilasciavano un lasciapassare. Quanta burocrazia, quei topi di fogna!” “Come riuscii a superare quel tavolinetto, ancora non so dirlo... Perché quei buoni a nulla non mi fermarono? Vallo a spiegare alla pattuglia... Arrivò una montagna di muscoli con il cranio completamente rasato e la tuta mimetica, che cominciò a urlare: ‘È sgattaiolato qui! Si è intrufolato! Si è insinuato furtivamente!’. Cominciò a fare avanti e indietro tra le pagine del mio passaporto e, quando vide il timbro della Sokol, dove avevo vissuto tempo prima, i suoi occhi si iniettarono di sangue, come quelli di un toro che vede un drappo rosso. Di scatto, sfoderò la pistola e ruggì: ‘Mani in alto, delinquente!’. Il suo livello di addestramento mi fu subito ovvio. Mi prese per il bavero e mi trascinò per tutta la stazione, finché non passammo dal punto di trasferimento, dove stava il suo superiore. Qui, mi minacciò: ‘Aspetta qui, devo solo ricevere il permesso dal comando, così posso metterti al muro, sporca spia’. In quel momento stavo per sentirmi male, così cercai di giustificarmi: ‘Che tipo di spia dovrei essere? Io sono un commerciante! Ho portato del tè dalla VDNKh!’. Per tutta risposta mi disse che mi avrebbe riempito la bocca di tè e me l’avrebbe fatto ingoiare con la canna della pistola. Capii quindi che non ero stato molto convincente e che, se il suo superiore gli avesse concesso l’approvazione, mi avrebbe condotto al duecentesimo metro e, con il visto rivolto verso i tubi, mi avrebbe riempito di piombo, come voleva la legge marziale. Pensai che le cose si stavano mettendo male... Giungemmo al punto di passaggio e la mia montagna di muscoli andò a concordare quale fosse il luogo migliore in cui uccidermi. Guardai il suo capo e sentii tutto il peso che portavo sulle spalle dissolversi in un batter d’occhio: si trattava di Pashka Fedotov, un mio ex compagno di classe, con il quale ero rimasto amico anche dopo aver terminato gli studi, ma che poi avevo perso di vista...” “Dannazione! Mi hai spaventato a morte! E io che già pensavo che eri fritto, che ti avrebbero ucciso”, si intromise Andrey, in tono ostile. Tutti gli uomini riuniti attorno al fuoco dell’accampamento del quattrocentocinquantesimo metro scoppiarono in una risata. Persino Pyotr Andreevich, che un momento prima aveva dato un’occhiataccia ad Andrey, non riuscì a trattenersi e sorrise. Le risate risuonarono lungo la galleria, dando vita, da qualche parte nelle sue profondità, a un’eco distorta, uno stridore sinistro che non somigliava a niente che avessero mai udito... sentendolo, uno dopo l’altro, tutti si ammutolirono. Proprio dal fondo della galleria, proveniente da nord, i rumori sospetti diventavano più distinti: si trattava di fruscii e di passi leggeri e ritmici. Ovviamente Andrey fu il primo a udirli. Tacque all’istante e con la mano accennò anche agli altri di fare silenzio, quindi prese la mitragliatrice da terra e si alzò in piedi. Fece scattare lentamente la sicura e caricò una cartuccia; prese a camminare con la schiena rivolta al muro, muovendosi silenziosamente dal fuoco fino all’interno della galleria. Anche Artyom si alzò, era troppo curioso di vedere cosa si era fatto scappare poco prima, ma Andrey tornò indietro e lo guardò stizzito. Si fermò nel punto più lontano che la luce riuscisse a raggiungere, posizionò la mitragliatrice sulla spalla e si sdraiò a terra, gridando: “Illuminate quaggiù!” Uno dei ragazzi aveva con sé una potente torcia ad accumulatore, costruita con vecchi fanali di automobili, l’accese e il fascio luminoso lacerò l’oscurità. Dal luogo che pochi istanti prima era avvolto nelle tenebre, apparve al suolo una sagoma sfuocata, ma solo per un secondo. Era qualcosa di minuto, dall’aspetto non esattamente allarmante, che corse nuovamente verso nord. Artyom non riuscì a trattenersi e urlò: “Spara! Sta fuggendo!” Ma per una qualche ragione Andrey non sparò. Anche Pyotr Andreevich si alzò in piedi, con la mitragliatrice pronta, quindi urlò: “Andryukha! Sei ancora vivo?” Gli uomini seduti attorno al fuoco sussurrarono qualcosa, agitati, e sentirono la sicura di Andrey tornare in posizione. Fu allora che Andrey riapparve alla luce della torcia, togliendosi la polvere dalla giacca. “Sì, sono vivo, sono vivo!”, li informò ridendo. “Che c’è di tanto divertente?”, gli chiese Pyotr Andreevich con sospetto. “Aveva tre zampe. E due teste. Mutanti! I Tetri sono qui! Ci sgozzeranno tutti. Spara o fuggiranno via! Dovevano essere in molti! Proprio così!”. Andrey continuò a ridacchiare. “Perché non hai sparato? È vero, il mio ragazzo non ce l’ha fatta, ma lui è giovane, non sa come vanno queste cose. Ma tu... perché non l’hai finito? Non sarebbe stata la prima volta! Sai cosa è successo alla Polezhaevskaya?”, lo ammonì Pyotr Andreevich stizzito, nel momento in cui Andrey tornò al fuoco da campo. “Sì, so esattamente cosa è successo alla Polezhaevskaya, l’ho sentito decine di volte!”. Andrey agitò la mano nella sua direzione. “Era una cane! Un cucciolo, per giunta... È già la seconda volta che cerca di avvicinarsi al fuoco, al calore e alla luce. Voi l’avete quasi ammazzato e ora chiedete a me perché ho usato tanta cautela. Siete solo dei macellai!” “Come facevo a sapere che era un cane?”, asserì Artyom offeso. “Faceva un rumore tanto strano... Inoltre, la settimana scorsa si diceva che vi fossero ratti grandi quanto maiali”. “Credi ancora alle storielle. Aspetta un momento, porto qui il tuo bel ratto!”, rispose Andrey, spostando la mitragliatrice dietro la schiena e ritornando nell’oscurità. Un minuto dopo sentirono un fischiettio provenire dalle tenebre, quindi una voce che chiamava affettuosa, persuasiva: “Vieni qui piccolino, non avere paura!” Ci mise un po’ a convincerlo, circa dieci minuti, chiamandolo e fischiando. Alla fine la sua sagoma riapparve nella penombra. Tornò al fuoco, sogghignò trionfante e aprì la giacca. Un cagnolino cadde al suolo, tremante, patetico, bagnato e sporchissimo, il pelo arruffato di un colore indistinto, gli occhi neri pieni di paura e le orecchie abbassate. Quando toccò il terreno, cercò immediatamente di fuggire, ma la mano pronta di Andrey lo riacciuffò e lo rimise dove si trovava. Gli accarezzò testa e si tolse la giacca, con la quale coprì l’animale. “Dobbiamo scaldare questo cucciolo”, spiegò. “Dai, Andrey, è un sacco di pulci!”. Pyotr Andreevich cercò di far tornare la ragione in Andrey. “E potrebbe anche avere i vermi. Così prenderai un’infezione e la trasmetterai al resto della stazione...” “Basta, Pyotr, ne ho abbastanza. Smettila di piagnucolare. Guardalo!”, così dicendo ritrasse i lembi della giacca e mostrò a Pyotr il muso del cagnolino che continuava a tremare, probabilmente sia per il freddo che per la paura. “Guarda i suoi occhi, non mentirebbero mai!” Pyotr Andreevich osservò scettico il cucciolo: erano occhi spaventati e senza alcun dubbio onesti. L’uomo si lasciò un po’ andare. “D’accordo, animalista che non sei altro... Aspetta, gli cerco qualcosa da mettere sotto i denti”, mormorò e cominciò a cercare nel suo zaino. “Guarda, guarda. Non si sa mai, potrebbe tornarci utile. Magari quando cresce diventa un bel pastore tedesco”, continuò Andrey, spostando la giacca con il cucciolo più vicino al fuoco. “Ma da dove è venuto un cucciolo del genere e soprattutto com’è arrivato fin qui? In quella direzione non vive nessuno. Ci sono solamente Tetri... Forse allevano i cani?”, chiese uno degli uomini di Andrey, un ragazzo con i capelli arruffati che fino a quel momento non aveva proferito parola e che osservava con sospetto il cagnolino che si era assopito al caldo. “Hai ragione, Kirill”, rispose serio Andrey. “Per quanto ne so, i Tetri non hanno animali domestici”. “Allora come vivono? E cosa mangiano?”, chiese un altro uomo, sfregandosi la mascella non sbarbata, emettendo così il rumore di uno strofinio leggero. Era molto alto e indurito dalle battaglie, aveva spalle larghe ed era tozzo, con la testa completamente rasata. Indossava un lungo mantello di pelle di ottima fattura, che a quei tempi era una vera rarità. “Cosa mangiano? Si dice che si nutrano di qualsiasi tipo di schifezza: carne putrefatta, ratti, umani... Non credo siano schizzinosi”, rispose Andrey, contorcendo il viso con disgusto. “Cannibali?”, chiese l’uomo con la testa rasata, senza far trasparire sorpresa; sembrava che si fosse già imbattuto in cannibali prima. “Beh, cannibali... non sono nemmeno umani. Sono non morti. Chissà che diavolo sono! Per fortuna non sono armati, così ci possiamo difendere, almeno per il momento. Pyotr! Ricordi sei mesi fa, quando siamo riusciti a catturarne uno?” “Certo che mi ricordo”, reagì Pyotr Andreevich, a voce alta. “Rimase nella guardina per due settimane, non beveva acqua, non toccava cibo. Poi ha tirato le cuoia”. “Non l’avete interrogato?”, volle sapere l’uomo. “Non comprendeva ciò che gli dicevamo nella nostra lingua. Gli parlavano un russo semplice, ma lui se n’è stato zitto, per tutto il tempo. Come se avesse la bocca piena d’acqua. Lo hanno anche picchiato, ma non ha comunque parlato. Gli hanno dato da mangiare e non ha parlato. Si limitava a ringhiare, di tanto in tanto. E, poco prima che morisse, ha ululato talmente forte che tutta la stazione si è svegliata...” “Beh, ma il cane come ha fatto ad arrivare fin qui?”, ricordò loro Kirill, riprendendo il filo del discorso. “E chi diavolo lo sa... Forse è fuggito dai Tetri, che volevano mangiarselo. Saranno un paio di chilometri da qui. Non potrebbe essere fuggito da laggiù? Forse appartiene a qualcuno che veniva da nord ed è rimasto vittima di quelle creature. Il cucciolo è riuscito a fuggire. Beh, non importa come sia arrivato fin qui. Guardalo: ti sembra un mostro? Un mutante? No, è solo una cagnetta, nulla di più. È stata attirata dagli umani e ciò significa che è abituata alla nostra presenza. Altrimenti perché avrebbe cercato per tre volte di avvicinarsi al fuoco?” Kirill rimase in silenzio, pensando a quello che era stato detto. Pyotr Andreevich riempì il bollitore d’acqua presa dalla tanica e chiese: “Qualcuno vuole dell’altro tè? Beviamo un’ultima tazza, ben presto ci daranno il cambio”. “Tè, questo sì che è parlare! Beviamo”, ripeté Andrey. Anche gli altri si rianimarono all’idea. Il bollitore cominciò a fare il suo lavoro, Pyotr Andreevich versò un’altra tazza di tè a coloro che lo desideravano, poi fece una richiesta a sua volta: “Ragazzi... non c’è ragione di parlare dei Tetri. L’ultima volta che eravamo qui a discuterne, si sono presentati. Altre persone mi hanno riferito che lo stesso è capitato anche a loro. Forse è solo una coincidenza, io non sono superstizioso, ma... se non lo fosse? Se potessero percepirlo? Il nostro turno è quasi finito, non abbiamo bisogno di affrontare quegli scherzi della natura proprio all’ultimo minuto”. “Sì, ha ragione... non ne vale la pena”, asserì Artyom. “Ragazzo mio, non vorrai tirarti indietro proprio adesso?! Alla fine vinceremo noi!”. Andrey cercò di risollevare Artyom, ma non riuscì propriamente a convincerlo. Il solo pensiero dei Tetri causò un brivido lungo la schiena di tutti, compreso Andrey, malgrado questi cercò di nasconderlo; non temeva gli umani, di nessun tipo: i banditi, gli anarchici più spietati, i soldati dell’Armata Rossa. Ma i non morti gli causavano un senso di disgusto e non perché ne avesse paura, ma perché quando pensava a loro, o a qualsiasi altro tipo di pericolo, non riusciva a stare calmo. Attorno al loro fuoco rimasero tutti in un silenzio pesante, oppressivo, che sentivano schiacciante. I ceppi di legno nodoso crepitavano, mentre di tanto in tanto si sentiva in lontananza provenire da nord un rumore gracchiante, ma attutito e profondo, come se la Metropolitana di Mosca fosse l’intestino gigante di un mostro sconosciuto. Era un rumore terrificante, che lasciava senza fiato. CAPITOLO 2 : IL CACCIATORE La testa di Artyom cominciò di nuovo a riempirsi di assurdità: i Tetri... si era imbattuto in quei dannati non umani una sola volta, durante il suo turno da sentinella, e si era spaventato a morte. Beh, come poteva essere altrimenti? Si stava di guardia, a scaldarsi vicino al fuoco. All’improvviso, lo si sentiva: da qualche parte nei recessi della galleria, risuonava come un colpo sordo, dapprima distante e quindi un po’ meno udibile, poi sempre più vicino e più intenso... Inaspettatamente le orecchie si riempivano di un orribile ululato fatale che si avvicinava... e a quel punto era il caos più completo! Si alzavano tutti in piedi, sollevando i sacchi di sabbia e le casse su cui erano seduti per costruire, il più velocemente possibile, una barriera dietro la quale nascondersi. Il più vecchio tra i presenti urlava a squarciagola: “All’erta!” I rinforzi giungevano di fretta dalla stazione; al trecentesimo metro, dove in effetti si sarebbe svolta la battaglia, cominciavano a togliere la copertura dalla mitragliatrice e la gente si sdraiava a terra, dietro i sacchi di sabbia, rivolgendo le armi verso la galleria e mirando al suo ingresso... Infine, dopo aver aspettato che i Tetri si avvicinassero, giravano il riflettore: all’interno del cono di luce erano visibili sagome strane, inconcepibili. Erano completamente nudi, la pelle nera e lucida, gli occhi enormi e la bocca come uno squarcio... Procedevano a lunghi passi verso le fortificazioni, verso la morte; temerari, senza esitare un momento, si avvicinavano sempre più... Erano tre... cinque... otto bestie... poi, la prima gettava la testa all’indietro ed emetteva un ululato che pareva un requiem. Tutti sentivano un brivido lungo la schiena e solo a stento riuscivano a resistere all’impulso di rimettersi in piedi e di correre, lanciando lontano la pistola, abbandonando i compagni, mandando al diavolo tutto per fuggire... Il riflettore era puntato in direzione degli occhi di quelle creature da incubo, per confonderli con la sua luce accecante; ma il bagliore non aveva effetto sulle loro pupille, infatti i Tetri non cercavano nemmeno di ripararsi il viso con le mani, al contrario erano sempre più vicini... Forse non avevano nemmeno le pupille. Ma finalmente sopraggiungevano quelli del trecentesimo metro con qualche mitragliatrice in più; si stendevano di fianco agli altri, mentre i comandi sfrecciavano sopra le loro teste... Era tutto pronto. A quel punto rimbombava il tanto agognato ordine: “Fuoco!”. In quell’istante, le pistole cominciavano a emettere il loro rumore meccanico, mentre le mitragliatrici rombavano. Ma i Tetri non si fermavano, non si accovacciavano, procedevano sempre ritti, senza rallentare il ritmo della loro avanzata, sempre regolare, senza fretta, come all’inizio. Alla luce del riflettore, si intravvedevano i proiettili lacerare la carne lucida, mentre loro indietreggiavano, cadevano, ma poi si rialzavano subito per continuare la loro marcia. E di nuovo, si udiva quell’ululato, che nel frattempo era divenuto più rauco perché la gola dell’essere che lo emetteva era stata perforata. Passavano diversi minuti prima che la tempesta di pallottole riuscisse a piegare la loro disumana e sventata ostinazione. I demoni erano ormai a terra; ma dato che i ragazzi, senza fiato e con i muscoli indolenziti dalla paura, volevano essere sicuri al cento per cento, li finivano sparandogli alla testa da cinque metri. E quando tutto era finito, quando i cadaveri erano stati gettati nel pozzo, quelle stesse immagini terribili si riproponevano a lungo davanti agli occhi di tutti: i proiettili che affondavano nei corpi neri, il riflettore che bruciava i loro occhi spalancati e loro che continuavano comunque a marciare insistenti... Al solo pensiero, Artyom rimase turbato. Sì, era meglio non parlarne, pensò, nel caso quella storia fosse vera. “Ehi, Andreevich! Preparati! Stiamo arrivando!”, gridarono da sud, dall’oscurità. “Il vostro turno è finito!” Gli uomini attorno al fuoco cominciarono a spostarsi e, cercando di scrollarsi il torpore di dosso, si alzarono e allungarono i muscoli. Si rimisero in spalla zaino e armi, mentre Andrey raccolse la cagnolina. Pyotr Andreevich e Artyom sarebbero ritornati alla stazione, al contrario Andrey e i suoi uomini si dirigevano al trecentesimo metro, poiché il loro turno non era ancora terminato. I loro sostituti li raggiunsero, gli strinsero la mano e si accertarono che non fosse accaduto nulla di inconsueto, quindi gli augurarono il meritato riposo, si sedettero vicino al fuoco e ripresero la conversazione dal punto in cui l’avevano interrotta alla fine del turno precedente. Quando tutti avevano ormai imboccato la galleria verso sud, in direzione della stazione, Pyotr Andreevich ricominciò a discorrere animatamente con Andrey, come se i due riprendessero le fila di una delle loro eterne dispute; a quel punto, il tizio robusto dalla testa rasata, che si era interessato delle abitudini alimentari dei Tetri, si allontanò da loro e si affiancò ad Artyom, tenendo il suo stesso passo. “Quindi conosci Sukhoi?”, chiese ad Artyom a voce bassa, soffocata, senza incontrare il suo sguardo. “Zio Sasha? Beh, certo! È il mio patrigno. Vivo con lui”, gli rispose Artyom, senza nascondere la verità. “Che vuoi dire... il tuo patrigno? Non ho mai sentito una tale...”, borbottò l’uomo. “E tu come ti chiami?”, si decise a domandargli Artyom, dopo aver ragionato per qualche istante: se qualcuno chiede informazioni sulla tua famiglia, anche tu hai il diritto di porre a tua volta una domanda. “Io?”, ribatté l’uomo sorpreso. “Perché lo vuoi sapere?” “Perché così posso dire a zio Sasha, a Sukhoi, che mi hai chiesto di lui”. “Digli che è stato ‘il cacciatore’, che Hunter lo saluta”. “Hunter? Che strano. È il tuo cognome? Il tuo soprannome?”, si informò Artyom. “Cognome? Mmm...”, sorrise compiaciuto Hunter. “Che vuoi dire? È... no, figliolo, non è il mio cognome. Si tratta... come posso descriverlo... di una professione, ecco. E tu come ti chiami?” “Artyom”. “Bene, allora piacere di conoscerti. Sono sicuro che ci rincontreremo molto presto. Ciao!” Fece l’occhiolino ad Artyom prima di allontanarsi, poi rimase indietro al trecentesimo metro, insieme ad Andrey. Non rimaneva molta strada da percorrere, da quella distanza si potevano già udire i rumori vivaci della stazione. Pyotr Andreevich, che ora camminava a fianco di Artyom, lo sollecitò preoccupato: “Senti un po’, Artyom, chi era quello? Che ti ha raccontato quando siete rimasti indietro?” “È... un tipo strambo... Ha voluto sapere di zio Sasha, dal quel che ho capito dev’essere un suo conoscente. Lei lo aveva mai visto?” “Non mi sembra... È appena arrivato, starà alla nostra stazione per un paio di giorni perché pare che stia svolgendo degli affari. Sembra che Andrey lo abbia già incontrato, per questo ha insistito per averlo nel suo stesso turno di guardia. Chissà perché diamine riteneva fosse tanto necessario! Comunque, ha un viso familiare...” “Sì, non è facile scordare una presenza come la sua”, affermò Artyom. “Esatto. Dove l’ho già visto...? Come si chiama, per caso lo sai?”, lo interrogò Pyotr Andreevich. “Mi ha detto Hunter... ‘il cacciatore’. Chissà cosa significa”. “Hunter? Non è di certo un nome russo...”. Pyotr Andreevich si accigliò. Laggiù, in lontananza, era già apparso un bagliore rosso. La VDNKh, come la maggior parte delle altre stazioni, non aveva un normale sistema di illuminazione e, da quasi trent’anni, la gente viveva al chiarore scarlatto delle luci di emergenza e, in qualche caso, gli “appartamenti”, cioè le tende e le stanze, erano illuminati da lampadine normali. Solo alcune delle stazioni più abbienti erano rischiarate da vere e proprie lampade a mercurio, attorno alle quali erano nate leggende: i rozzi abitanti delle province, nelle stazioni dimenticate da Dio, le avrebbero sognate per anni, sperando, un giorno, di riuscire ad ammirare quel miracolo. All’uscita della galleria porsero le armi alle altre guardie e firmarono il registro. Pyotr Andreevich strinse la mano ad Artyom e prima di andarsene aggiunse: “Era ora! Muoio dalla voglia di fare una bella dormita! Le gambe mi reggono a malapena e vedo che anche tu stai dormendo in piedi! Porta i miei saluti a Sukhoi e digli che deve venire a trovarmi”. Nel momento in cui Artyom si congedò, cominciò subito a sentire la fatica e si trascinò fino al suo “appartamento”. Alla VDNKh vivevano duecento persone, alcune nei quartieri di servizio, mentre la maggioranza abitava nelle tende sulla piattaforma. Questi alloggi di fortuna provenivano dall’esercito, ed erano ormai logori e rattoppati, ma comunque intatti. Sottoterra non avevano più dovuto affrontare il vento o la pioggia, perciò erano in buone condizioni; la gente ci stava abbastanza comodamente, anche perché non lasciavano trapelare né calore né luce ed erano persino insonorizzate. Cosa si poteva desiderare di più da una casa? Le tende erano allineate ai muri sui lati dei binari e nell’androne centrale. La piattaforma era stata trasformata affinché somigliasse a una strada, infatti nel mezzo c’era uno spazio abbastanza ampio da permettere il passaggio; alcune tende erano più grandi e ospitavano le famiglie più numerose, occupando i posti sotto le volte. Tra queste arcate, erano diverse quelle che rimanevano libere per permettere il passaggio ai due capi dell’androne e al centro. Vi erano anche altre sistemazioni, sotto le piattaforme, ma lì il soffitto era piuttosto basso e non erano molto adatte per viverci, perciò alla VDNKh venivano usate per immagazzinare le provviste. Le due gallerie a nord si riunivano diverse decine di metri oltre la stazione grazie a un tunnel laterale, che in precedenza permetteva ai treni di fare manovra e tornare indietro. Una delle due gallerie era bloccata e l’altra conduceva a nord, verso l’Orto botanico, quasi fino a Mytischi, ed era tenuta come via di fuga in casi estremi. Era proprio qui che Artyom era stato di guardia. Il segmento rimanente della seconda galleria, quello che le collegava l’una all’altra, era destinato alle coltivazioni di funghi. I binari erano stati smontati e il terreno veniva arato e fertilizzato con i prodotti di scarto ripescati dal pozzo nero. File ordinate di funghetti risplendevano in tutta la galleria. Anche uno dei due tunnel meridionali era crollato, al trecentesimo metro, e questo veniva utilizzato per i pollai e i porcili. La casa di Artyom era sulla via principale, viveva in una delle tende più piccole insieme al patrigno, un uomo molto importante che aveva a che fare con l’amministrazione, poiché manteneva i contatti con le altre stazioni; per questo motivo gli era stata riservata una tenda personale e di primissima qualità. Spesso il patrigno spariva per due o tre settimane di fila e non portava mai Artyom con sé, sostenendo che era occupato in questioni troppo pericolose e che non voleva far correre rischi inutili al ragazzo. Quando tornava era sempre più magro, con i capelli arruffati e talvolta persino ferito. Tuttavia, la prima sera del suo ritorno, stavano insieme e lui gli raccontava storie difficili da credere per un abitante di questo piccolo mondo grottesco, già abituato a racconti incredibili. Anche Artyom sentiva il bisogno di viaggiare, ma era troppo pericoloso vagabondare per la Metro senza una buona ragione. Le guardie delle pattuglie alle stazioni indipendenti erano molto sospettose e non lasciavano passare nessuno che portasse con sé un’arma; di contro, addentrarsi in una galleria del tutto disarmato avrebbe significato un’unica cosa: la morte. Per cui, da quando, insieme al patrigno era arrivato dalla Savyolovskaya, Artyom non aveva mai avuto la possibilità di prendere parte a nessuna escursione degna di questo nome. Di tanto in tanto veniva mandato all’Alekseevskaya per sbrigare degli affari, ma ovviamente non ci andava mai da solo; vi si recavano in gruppo e talvolta raggiungevano persino la Rizhskaya. Ma, oltre a questi, aveva affrontato anche un altro viaggio, del quale non poteva parlare con nessuno, malgrado ne avesse un disperato bisogno... Era accaduto molto tempo prima, quando l’Orto botanico era semplicemente una stazione oscura e abbandonata, e non c’era ancora la minima traccia dei Tetri; quando le pattuglie della VDNKh si appostavano molto più a nord. Al tempo Artyom era ancora un bambino. Lui e i suoi amici avevano deciso di correre il rischio più grande della loro vita: durante un cambio della guardia avevano superato furtivamente lo sbarramento più esterno, avevano portato delle torce e rubato un fucile a canna doppia a uno dei genitori e si erano aggirati a lungo per la stazione dell’Orto botanico. Era stata un’esperienza inquietante, ma comunque interessante. Alla luce delle torce si intravvedevano ovunque resti di insediamenti umani: cenere, libri bruciati, giocattoli rotti, abiti strappati... I ratti sfrecciavano tutto attorno e, di tanto in tanto, insoliti rumori gorgoglianti arrivavano fino a loro dalla galleria settentrionale. Uno degli amici di Artyom, non si ricordava nemmeno quale, ma probabilmente era stato Zhenya, il più vivace e curioso dei tre, suggerì: “Che ne dite se apriamo la barriera e saliamo fino in superficie, su per la scala mobile... giusto per vedere com’è? Così potremmo finalmente scoprire cosa c’è!” Artyom aveva risposto subito che non era d’accordo: nella sua mente bruciavano ancora gli ultimi racconti del patrigno, popolati di gente che aveva trascorso del tempo in superficie, che aveva assistito a qualsiasi genere di orrore e che in seguito era stata a lungo ammalata. Ma gli altri controbatterono che questa era un’opportunità più unica che rara e che non sarebbero mai più riusciti ad arrivare fino a una stazione abbandonata, per giunta senza adulti: in quel momento avevano la possibilità di salire in superficie e di vedere, con i loro stessi occhi, cosa significasse non avere niente sopra la testa. Dopo essersi rassegnato al fatto che non li avrebbe mai convinti, gli altri due proclamarono che, se Artyom avesse voluto fare il codardo, li avrebbe dovuti aspettare di sotto, fino al loro ritorno. Il solo pensiero di rimanere da solo in una stazione abbandonata e, quel che era peggio, di rovinare la propria reputazione di fronte ai suoi due migliori amici, era semplicemente insopportabile, quindi, richiamando a sé tutto il coraggio che aveva in corpo, acconsentì. Furono sorpresi quando videro che il meccanismo che faceva spostare la barriera posta tra la piattaforma e la scala mobile funzionava ancora. Fu Artyom stesso a metterlo in movimento, dopo mezz’ora di disperati tentativi. La parete di ferro arrugginita si spostò emettendo un orribile rumore metallico; a quel punto, davanti ai loro occhi, rimanevano i pochi scalini che li avrebbero condotti di sopra; alcuni erano crollati e, puntando le torce nelle aperture rimaste, si riuscivano a scorgere gli enormi meccanismi che si erano fermati molti anni prima, ormai corrosi dalla ruggine e infestati da un materiale brunastro, che si muoveva quasi impercettibilmente... Non era facile, per loro, sforzarsi di salire. In diversi casi, lo scalino dove mettevano il piede cedeva, emettendo uno stridio, e poi cadeva giù; dovevano superare il divario, aggrappandosi alle decrepite coperture sulle lampade della Metro. Il percorso fino in superficie non era lungo, ma la loro iniziale determinazione li stava pian piano abbandonando già da quando il primo gradino era ceduto; tuttavia, per tirarsi su di morale, si immaginavano di essere dei veri stalker. Stalker... L’uso di questa parola, strana e straniera per la lingua russa, aveva comunque attecchito molto rapidamente. All’inizio, era il nome che veniva dato a quelle persone talmente povere da essere obbligate a recarsi nei poligoni di tiro militari abbandonati, smontare i missili e le bombe non esplose per recuperare i rivestimenti di ottone da rivendere a coloro che acquistavano metalli non ferrosi. Così venivano chiamati anche quei personaggi bizzarri che, in tempo di pace, si aggiravano per le fogne. Ma tutti questi significati avevano qualcosa in comune: si trattava sempre di una professione assai pericolosa, in cui ci si doveva costantemente confrontare con l’ignoto, il mistero, il nefasto... Chissà cos’era accaduto a quei luoghi ormai disabitati, dove la terra radioattiva, sfigurata da migliaia di esplosioni, solcata da trincee e perforata da catacombe, generava una prole mostruosa? Si poteva solamente supporre quali creature vivessero nelle fogne di un’affollata metropoli, quando gli operai avevano chiuso le botole, abbandonando per sempre quei corridoi oscuri, angusti e puzzolenti. Nella Metro, i pochi temerari che avevano il fegato di avventurarsi fino in superficie, erano chiamati stalker. Con le tute protettive e le maschere antigas dalle lenti oscurate, erano armati fino ai denti e andavano in esplorazione della superficie in cerca degli oggetti necessari alla popolazione: forniture militari, equipaggiamento, pezzi di ricambio, carburante... Esistevano centinaia di uomini che osavano svolgere un compito del genere. Tuttavia, coloro che riuscivano a tornare vivi si potevano contare sulle dita di una mano; questi uomini erano utilissimi ed erano anche molto rispettati, ancor più degli ex impiegati della Metropolitana. Coloro che osavano andare lassù dovevano affrontare qualsiasi tipo di pericolo, dalle radiazioni alle creature demoniache che queste avevano generato, poiché anche in superficie c’erano forme di vita, che però non corrispondevano più alla normale concezione che ne avevano gli umani. Tutti gli stalker diventavano leggende viventi, paragonabili a dèi in terra, a cui tutti, dal più giovane al più anziano, guardavano con stupore rapito. In un mondo in cui non erano rimasti più luoghi dove poter andare in barca o volare e in cui le parole “pilota” e “marinaio” stavano perdendo il loro significato, i bambini sognavano di fare gli stalker, di organizzare assalti, con indosso armature splendenti, accompagnati da centinaia di sguardi pieni d’adorazione e di gratitudine; salire fino in superficie, nel regno degli dèi, per combattere i mostri e poi tornare nel sottosuolo per potare alla gente carburante, forniture militari, luce e fuoco. Per portare la vita. Artyom, il suo amico Zhenya e Vitalik la Scheggia, volevano tutti essere degli stalker. Si erano obbligati a salire su, lungo la terrificante scala mobile che emetteva rumori sinistri con i suoi scalini cadenti e si immaginavano con indosso tute protettive, rilevatori di radiazioni, con enormi mitragliatrici sempre pronte, proprio come ci si sarebbe aspettato dai veri stalker. Ma loro non avevano né rilevatori di radiazioni, né protezioni e, invece di imporsi con mitragliatrici dell’esercito, avevano solo un antiquato fucile a canna doppia che, forse, non funzionava nemmeno... Ben presto, terminarono la risalita e si trovarono quasi in superficie. Fortunatamente era notte, perché se così non fosse stato, sarebbero rimasti accecati: i loro occhi, dopo i molti anni trascorsi sottoterra, erano ormai abituati all’oscurità e alla luce rosso porpora dei falò e delle lampade d’emergenza, perciò non avrebbero mai sopportato l’abbagliante luce del sole; accecati e impotenti, non sarebbero mai riusciti a tornare a casa. L’ingresso della stazione dell’Orto botanico era quasi del tutto distrutta, metà del tetto era crollato e attraverso si scorgeva la polvere radioattiva che invadeva il cielo estivo blu scuro, terso e puntellato da una miriade di stelle. Ma cosa significava un cielo stellato per un bambino che non riusciva nemmeno a immaginare di non avere un soffitto sopra la testa? Alzare lo sguardo e non vedere il cemento armato con una serie di fili e di tubi marciti, al contrario, perdersi in un abisso color cobalto, esteso a perdita d’occhio... che effetto faceva! E le stelle! Coloro che non avevano mai visto le stelle non potevano lontanamente immaginare cosa fosse l’infinito, dato che, molto probabilmente, gli uomini erano stati ispirati a quello stesso concetto osservando l’immensa volta celeste in una notte stellata. Milioni di luci brillanti, piccole capocchie argentate incastonate in una cupola di velluto blu... I ragazzi stettero lì per tre, cinque, dieci minuti, incapaci di proferire parola. Non si sarebbero nemmeno mossi e, di certo, entro il mattino successivo sarebbero bruciati vivi, se nelle vicinanze non avessero udito un ululato che gli fece gelare il sangue nelle vene. Tornando alla realtà, erano scesi di corsa verso la scala mobile, percorrendola il più velocemente possibile, senza prestare alcuna attenzione ai gradini, che alle volte cedevano e li facevano sprofondare, quasi fin sui meccanismi. Aiutandosi e tirandosi fuori l’un l’altro, il viaggio di ritorno durò solo qualche secondo. Scesero come dei fulmini gli ultimi dieci scalini, persero il fucile nella corsa e si diressero immediatamente al pannello di controllo della barriera. Ma purtroppo il ferro arrugginito si era inceppato e non gli permetteva di rimetterla al suo posto. Erano spaventati a morte e temevano che i mostri li avrebbero inseguiti. Si precipitarono verso casa, in direzione dello sbarramento settentrionale. Tuttavia, capirono subito di aver fatto qualcosa di sbagliato, perché avevano lasciato aperta la porta ermetica e di conseguenza dato libero accesso ai mutanti, che ora potevano arrivare alla Metropolitana e alle persone. Comunque, trovarono il tempo di decidere di tenere la bocca chiusa e di non spifferare a nessuno degli adulti ciò che avevano fatto. A quelli dello sbarramento riferirono che erano stati a caccia di ratti in una delle gallerie laterali, avevano perso il fucile e si erano spaventati, quindi erano tornati indietro. Ovviamente Artyom dovette subire la furia del patrigno e il suo didietro bruciò a lungo a causa della cinghia dell’ufficiale, ma il ragazzo resistette come un partigiano prigioniero e non rivelò mai il suo segreto militare, proprio come i suoi compagni. Tutti gli credettero. Ma oggi, quando ripensava a questa bravata, sempre più spesso Artyom cominciava a riflettere... Il loro viaggio in superficie e soprattutto la barriera lasciata aperta avevano qualcosa a che vedere con tutta quella feccia che, ormai da diversi anni, assaliva i loro sbarramenti? Salutò i passanti, fermandosi di tanto in tanto per ascoltare qualche novità, stringere la mano a un amico, sfiorare con un bacio la guancia di una ragazza che conosceva, parlare con i più anziani degli impegni del suo patrigno, quando finalmente raggiunse casa. Non c’era nessuno e decise di non aspettare il patrigno e di andare subito a dormire; infatti, un turno di guardia da otto ore era sufficiente per mettere al tappeto chiunque. Si tolse gli stivali e la giacca, quindi affondò il viso nel cuscino. Il sonno non si fece attendere. I lembi della tenda si alzarono e una sagoma enorme, di cui non si poteva scorgere la faccia, sgattaiolò all’interno senza fare rumore; l’unico dettaglio visibile era il minaccioso riflesso rosso della luce d’emergenza sul cranio rasato. Ed ecco una voce ovattata: “Ci incontriamo di nuovo. Vedo che il tuo patrigno non è qui. Beh, non importa. Ben presto troveremo anche lui, non ci sfuggirà. Ora, tu verrai con me. Dobbiamo parlare di una questione importante: che mi sai dire della barriera all’Orto botanico?”. Artyom si irrigidì e riconobbe subito il tizio che aveva incontrato quel giorno allo sbarramento e che si era presentato come Hunter. L’uomo si avvicinò lentamente e senza fare rumore, il suo viso non era ancora visibile. Per qualche strano motivo, la luce cadeva obliqua e non lo rischiarava del tutto. Artyom voleva chiedere aiuto, ma una mano forte, fredda come la morte, gli serrò la bocca. Finalmente riuscì ad afferrare una lanterna, accenderla e dirigere la luce verso il viso di quella persona. Ciò che vide lo svigorì per un momento e lo riempì d’orrore: quella che incombeva sopra di lui non era una faccia umana, ma un terribile muso nero, con due enormi occhi vacui, privi della sclera, e con le fauci spalancate. Artyom sfrecciò via e si lanciò fuori dalla tenda. Improvvisamente le luci si spensero e sulla stazione calarono le tenebre. Rimaneva solo un flebile bagliore riflesso da un piccolo fuoco acceso in lontananza. Senza fermarsi a pensare, Artyom corse in quella direzione, verso la luce. Il demone fece un balzò verso di lui, ringhiando: “Fermati! Non puoi sfuggirmi!”, poi esplose in una risata terribile, che lentamente diventò l’ululato fatale a lui ben noto. Artyom corse via, senza voltarsi; dietro di lui sentiva i passi degli scarponi pesanti, che lo seguivano uniformi e senza fretta, come se il suo inseguitore sapesse davvero che Artyom non poteva sfuggirgli e che presto o tardi sarebbe riuscito a catturarlo. Finalmente Artyom riuscì ad arrivare al fuoco e vide che c’era una persona seduta, di schiena. La raggiunse, stava per toccarle una spalla per chiedere aiuto, ma questa improvvisamente cadde all’indietro e gli fu subito chiaro che era già morta da molto tempo; per una ragione che in quel momento non si seppe spiegare, aveva il viso ricoperto di brina. Guardando il volto della persona congelata, Artyom riconobbe zio Sasha, il suo patrigno. “Ehi, Artyom! Hai fatto una bella dormita, eh?! Ora alzati, hai fatto un sonnellino di sette ore di fila... forza, dormiglione! Abbiamo ospiti!”, lo svegliò la voce di Sukhoi. Artyom si sedette sul letto e lo fissò, sbalordito: “Oh, zio Sash... tu... stai bene?”, chiese infine, dopo aver sbattuto a lungo le palpebre. Era difficile non seguire l’istinto e chiedergli se fosse vivo oppure no, ci riuscì solo perché lo vedeva muoversi davanti a lui. “Certo, non vedi? Forza, ora alzati, non ha senso rimanere lì a poltrire. Poi, voglio presentarti un mio amico”, annunciò Sukhoi. Da qualche parte proveniva una voce ovattata e la fronte di Artyom si imperlò di sudore, ricordando l’incubo di poco prima. “Allora vi siete già incontrati?”, si sorprese Sukhoi. “Beh, Artyom, ne sai una più del diavolo!” Alla fine, il visitatore entrò nella tenda. Artyom ebbe un fremito e appoggiò la schiena al lato della tenda: si trattava di Hunter. L’incubo si fece di nuovo vivido: occhi tetri e vacui, il rimbombo degli stivali pesanti dietro di lui, il corpo rigido vicino al fuoco... “Sì, ci siamo già incontrati”, Artyom riuscì a balbettare e, riluttante, gli porse la mano; quella di Hunter era calda e secca, così il ragazzo pian piano si convinse che il mostro del sogno fosse solo frutto della sua immaginazione risvegliata dalla paura provata durante le otto ore di guardia allo sbarramento, e che questa persona non avesse nulla di sinistro. “Artyom! Facci un favore: vai a fare bollire l’acqua per il tè! Hai già provato il nostro tè?”. Sukhoi fece l’occhiolino al suo ospite. “È una miscela intensa!” “La conosco”, annuì Hunter. “È un ottimo tè, lo fanno anche alla Pechatniki, ma lì è broda per maiali a confronto. Il vostro è tutta un’altra cosa”. Artyom andò a prendere l’acqua, poi si diresse al fuoco comune per farla scaldare. Era severamente vietato accendere il fuoco dentro le tende, poiché in passato un paio di stazioni erano state rase al suolo dagli incendi divampati all’interno delle tende. Nel frattempo pensava alla Pechatniki: si trovava all’altro capo della Metropolitana; chissà quanto ci si impiegava per raggiungerla; quanti cambi, incroci e stazioni bisognava attraversare per arrivarci... quante volte si doveva mentire, combattere, o passare oltre grazie alle conoscenze... Ma questo tizio aveva detto come se niente fosse: “Lo fanno anche alla Pechatniki...”. Doveva ammetterlo, era un personaggio interessante, anche se un po’ lo spaventava; la sua presa sembrava una morsa, ma Artyom non era uno smidollato, anzi... era sempre ansioso di misurare la forza di coloro che aveva di fronte con una bella stretta di mano. Quando l’acqua fu pronta, tornò alla tenda; Hunter si era già levato l’impermeabile, sotto il quale indossava un maglione a dolcevita nero, attillato, che evidenziava il collo potente e il fisico forte e muscoloso. Portava un paio di pantaloni militari, stretti in vita da una cintura da ufficiale. Sopra il maglione aveva un gilet multitasche, mentre sotto il braccio teneva una fondina contenente una pistola lucida, di dimensioni incredibili. Guardandola con più attenzione, Artyom vide che si trattava di una “Stechkin” con un lungo silenziatore, insieme a quello che sembrava un mirino laser. Un mostro del genere costava di sicuro una vita intera di risparmi. Artyom notò subito che non era una pistola semplice, sicuramente non un’arma da difesa; ma poi si ricordò che quando Hunter si era presentato si era autodefinito ‘il cacciatore’. “Dai, Artyom, versa il tè al nostro ospite! E tu, Hunter, accomodati! Dicci come stai!”. Sukhoi era entusiasta: “È una vita che non ci si vede!” “Ti risponderò più tardi. Non ho molto da raccontare. Tuttavia, ho sentito che da queste parti accadono cose strane. Gli spiriti maligni del nord vi attaccano. Oggi, mentre ero di pattuglia, ho sentito delle storie stravaganti. Che succede?”, chiese Hunter sbrigativo, esprimendosi con frasi brevi ma dirette. “È la morte, Hunter”, ribatté Sukhoi, rabbuiandosi improvvisamente. “È la nostra morte che si affaccia alla finestra del futuro. Il destino incombe su di noi. Ecco di cosa si tratta”. “La morte? Mi hanno raccontato che siete riusciti a sconfiggerli facilmente, che non sono armati. Beh...? Da dove vengono e chi sono? Non ho mai sentito niente del genere in nessuna delle altre stazioni. Mai. Ciò significa che sta accadendo solo qui. E io voglio sapere che sta succedendo. Percepisco un enorme pericolo. Ma ho bisogno di sapere di cosa si tratta, di che natura è. Per questo sono qui”. “Il pericolo deve essere eliminato, vero? Sei sempre stato un cowboy, Hunter. Ma la vera domanda che dobbiamo porci è: ‘Il pericolo può essere davvero eliminato?’”. Sul viso di Sukhoi comparve un sorriso triste, poi continuò: “Questo è il problema. Qui è tutto più complicato di quanto possa sembrarti. Non sono solo degli zombie o dei cadaveri che se ne vanno in giro per gli schermi cinematografici, sarebbe troppo semplice! Così potresti caricare la tua rivoltella con proiettili d’argento...”. Sukhoi illustrò ciò che diceva avvicinando i palmi delle mani e fingendo di puntare una pistola, poi continuò: “Bum bum! Fine. E le forze del male sono annientate. In questo caso, però, la situazione è diversa. Fa paura. E, come ben sai, è difficile spaventarmi”. “Te la stai facendo sotto?”, lo incalzò Hunter, sorpreso. “La loro arma principale è il terrore. Gli uomini riescono a malapena a mantenere le posizioni. La gente dorme con le mitragliatrici, o addirittura con gli uzi, sotto il cuscino, mentre loro sono disarmati! Tutti sanno che ne arriveranno ancora, probabilmente più equipaggiati e più numerosi, e hanno voglia di fuggire, ma nel frattempo impazziscono perché hanno paura... Detto tra noi, alcuni sono già diventati pazzi. Questa non è solo paura, Hunter!”. Sukhoi abbassò la voce. “Questa... non so come spiegartelo con parole semplici... È una sensazione che si fa sempre più forte. Non so come, ma stanno entrando nelle nostre menti, e sembra lo stiano facendo di proposito. Li puoi percepire da lontano e il brivido si fa sempre più forte, l’agitazione prende il sopravvento e cominciano a tremarti le gambe. Non riesci ancora a sentire né a vedere niente, ma sai già che sono sempre più vicini... Poi arriva l’ululato e vuoi solo correre via... ma loro si stanno avvicinando, e tu tremi... Poco dopo li vedi arrivare, con gli occhi spalancati, nonostante il riflettore...” Artyom ebbe un fremito. Capì che non era il solo a essere tormentato dagli incubi. Aveva sempre cercato di non parlarne con nessuno, poiché temeva che lo avrebbero considerato un codardo o un pazzo. “Stanno distruggendo le nostre menti, quei mostri!”, continuò Sukhoi. “È come se si mettessero sulla tua stessa lunghezza d’onda, così la volta successiva che ti vedono, riescono a farti provare una paura maggiore. Come ti ho detto, non è solo paura...” Non disse nient’altro. Hunter se ne stava seduto senza muovere un muscolo, lo studiava e sembrava che stesse riflettendo su ciò che aveva ascoltato. Poi prese una sorsata dell’infuso bollente e parlò, calmo: “È una minaccia per tutti, Sukhoi; non solo per la tua stazione, ma per tutta la nostra dannata Metropolitana”. Sukhoi era ancora in silenzio, come se non avesse intenzione di rispondere, ma improvvisamente tuonò: “Per tutta la Metropolitana, dici? No. Non solo per la Metro! È una minaccia per il progresso dell’umanità, che già si era messa nei guai con il progresso. È giunto il momento di pagarla! È una battaglia tra specie, Hunter! Una battaglia tra specie. E questi Tetri non sono né spiriti maligni e nemmeno dei demoni. Questo è l’Homo novus, la creatura successiva sulla scala evolutiva, che è riuscita ad adattarsi meglio di noi all’ambiente. Loro sono il futuro, Hunter! Forse l’Homo sapiens riuscirà a cavarsela per un altro paio di decenni, o addirittura per altri cinquant’anni, in queste maledette buche che ci siamo scavati quando ancora avevamo qualunque cosa, ma non tutti potevano permettersi di stare all’aria aperta, quindi i più poveri tra noi durante il giorno se ne dovevano stare sottoterra. Diventeremo pallidi e malandati come i Morlock di Wells, te li ricordi? Ne La macchina del tempo erano le bestie che, nel futuro, vivevano sottoterra. Anche loro un tempo erano degli Homo sapiens. Sì, siamo ottimisti! Non vogliamo morire! Coltiveremo funghi e li concimeremo con i nostri escrementi, i maiali diventeranno i nostri migliori amici, ma anche i nostri compagni di sventura. Ci ingozzeremo di multivitamine grazie alle appetitose barrette preparate a tonnellate dai nostri scrupolosi antenati. Poi torneremo timidamente in superficie, il più in fretta possibile, per rubare una tanica di carburante, qualche straccio oppure, con un po’ di fortuna, anche una manciata di cartucce, per poi tornare, altrettanto in fretta, nelle nostre cripte soffocanti, guardandoci attorno furtivi, come dei ladri, per controllare che nessuno ci abbia notati. Perché la superficie non è più nostra, il mondo non ci appartiene più, Hunter... Il mondo non ci appartiene più”. Sukhoi ammutolì di nuovo, si mise a guardare il vapore che si alzava lento dalla sua tazza di tè e che si condensava nella penombra della tenda. Anche Hunter rimase in silenzio, mentre d’improvviso Artyom si rese conto che non aveva mai udito il patrigno parlare a quel modo. Dov’era finita la sua sicurezza nel fatto che tutto sarebbe andato comunque per il meglio? Dov’erano i suoi: “Niente panico, ce la faremo!”? Dove aveva lasciato le sue strizzatine d’occhio d’incoraggiamento? Oppure era tutta una messa in scena? “Non hai niente da dire, Hunter? Niente? Forza, contraddicimi! Mostrami le tue argomentazioni e il tuo ottimismo! L’ultima volta che ci siamo parlati, eri sicuro che i livelli delle radiazioni si sarebbero abbassati, che la gente sarebbe ritornata in superficie. Eh, Hunter... ‘Il sole sorgerà sopra la foresta, ma non per me...’” lo canzonò Sukhoi. “Afferreremo la vita con i denti, la tratterremo con tutte le nostre forze. Ma cosa direbbero i filosofi, cosa confermerebbero i membri delle sette, se improvvisamente non avessimo più nulla a cui aggrapparci? Non vuoi crederci, ancora non puoi, ma da qualche parte nel profondo della tua anima, già sai che è così... Però a noi piace tutta questa storia, vero, Hunter? A me e a te piace vivere! Continueremo a scorrazzare nelle profondità più sudice, dormiremo abbracciati ai maiali, mangeremo ratti, ma sopravvivremo! Giusto? Svegliati, Hunter! Nessuno scriverà un libro su di te intitolato La storia di una persona veramente esistita, nessuno canterà la tua voglia d’amare, il tuo istinto smisurato di autoconservazione... Per quanto tempo potremo sopravvivere mangiando funghi, vitamine e maiale? Arrenditi, Homo sapiens! Non sei più il re del creato! Sei stato spodestato! No, non devi morire subito, nessuno insiste. Devi solo agonizzare un po’ più a lungo, soffocare nei tuoi escrementi... Ma sappi, Homo sapiens, che sei antiquato! L’evoluzione, le cui leggi ti sono chiare, ha già prodotto una nuova creatura, tu non sei più l’essere perfetto, il più importante del creato. Sei un dinosauro. Devi farti da parte e cedere il passo a una specie nuova, più perfetta. Non essere egocentrico, la tua partita è terminata, ora fai giocare gli altri. Il tempo è scaduto. Ormai sei defunto. Lascia che le generazioni future si scervellino, cercando di capire perché l’Homo sapiens si sia estinto. Anche se... dubito che vi sia qualcuno a cui interesserà...” Hunter, che per tutto questo monologo aveva continuato a guardarsi le unghie, alzò lo sguardo su Sukhoi e lo ammonì, severo: “Dall’ultima volta che ti ho visto hai perso davvero tutte le speranze. Ricordo che eri proprio tu quello che mi ripeteva che se conserviamo la cultura, se non ci inacidiamo, se non smettiamo di parlare correttamente, se insegniamo ai nostri figli a leggere e a scrivere, allora andrà tutto bene e riusciremo a sopravvivere anche qui, sottoterra... Non eri tu a dirlo? Oppure mi sbaglio? Ora guardati! ‘Arrenditi, Homo sapiens’... Che diavolo significa?” “Beh, sai... ci ho pensato un po’ su, Hunter. Sono arrivato a una conclusione alla quale tu devi ancora giungere, e che forse non comprenderai mai: siamo dinosauri e stiamo vivendo gli ultimi giorni della nostra vita... Ci vorranno dieci o forse anche cento anni, ma la sostanza non cambia...” “Allora la resistenza non serve a nulla, vero?”, lo istigò Hunter con voce cattiva. “Da che parte stai remando, Sukhoi?” L’uomo non risposte, lo sguardo rivolto verso il pavimento. Era ovvio che questa discussione gli era costata moltissimo, perché non aveva mai ammesso le sue debolezze a nessun altro o detto frasi del genere di fronte a un vecchio amico. Inoltre, anche Artyom era presente, e ciò peggiorava le cose. Era doloroso issare bandiera bianca. “No! Tu non aspetterai!”. Hunter pronunciò le parole lentamente, alzandosi in piedi. “E non lo faranno neanche loro! Credi che sia una nuova specie? Evoluzione? Estinzione inevitabile? Escrementi? Maiali? Vitamine? Io non ci sto. E non mi fa nemmeno paura! Hai capito? Non mi offro volontario. Istinto di autoconservazione? Chiamalo come vuoi. Io preferisco azzannare la vita. Al diavolo l’evoluzione. E che le altre specie aspettino il loro turno. Non sono un agnello condotto al macello. Arrenditi e alleati agli esseri più perfetti e più adattati, lasciagli il loro posto nella storia! Se pensi di aver combattuto finché potevi, puoi disertare, io non ti giudicherò. Ma non provare a spaventarmi e non cercare di trascinare anche me al patibolo. Perché mi stai facendo la predica? Hai bisogno di allearti a loro insieme a qualcun altro, in modo da non sentirti in colpa? O il nemico ti ha promesso un piatto di minestra calda per tutte le persone che riuscirai a portargli? La mia lotta è impossibile? Pensi che ci troviamo sull’orlo dell’abisso? Ma io ci sputo sopra, al tuo abisso! Se tu pensi che il tuo posto sia proprio là, sul fondo di quel baratro, allora fai un bel respiro e salta, io non vengo con te. Se l’uomo razionale, un Homo sapiens colto e civilizzato, decide di capitolare, allora io mi rifiuto di essere annoverato tra gli uomini. Piuttosto divento una bestia. E, come tale, azzannerò la vita e, se necessario, mi batterò per sopravvivere. Ce la farò. Hai capito? Io sopravvivrò!” Si risedette e, imperturbabile, chiese ad Artyom un altro po’ di tè. Sukhoi si alzò a sua volta e andò a riempire il bollitore in silenzio, con aria cupa. Artyom rimase da solo nella tenda insieme ad Hunter. Nelle sue ultime parole risuonava il disprezzo, mentre l’ostentata sicurezza di riuscire a sopravvivere accese una scintilla in Artyom. Era già da un po’ che stava pensando se intervenire, quando Hunter si rivolse a lui: “Tu cosa ne pensi, amico mio? Forza, non essere timido... anche tu vuoi diventare un vegetale? Un dinosauro? Rimanere qui, inerme, ad aspettare che ti vengano a prendere? Conosci la parabola della rana nel latte? Due rane caddero in un secchio di latte. Una, la più razionale, comprese subito che non sarebbe potuta resistere e non sarebbe riuscita a ingannare il destino. Soprattutto, se davvero esisteva un aldilà, perché intestardirsi e alimentare false speranze invano? Fu così che incrociò le zampe e andò a fondo. La seconda rana, la stolta, molto probabilmente era atea. Cominciò ad agitare le zampe, apparentemente senza ragione, dato che tutto è già predestinato. Ma lei continuò comunque ad agitare le sue zampette... Però, quando il latte diventò burro, lei riuscì a uscire. Oggi noi onoriamo la memoria della prima rana, eternamente dannata per amore del progresso e del pensiero razionale”. “Chi sei tu?”, azzardò infine Artyom. “Chi sono? Lo sai già. Sono il cacciatore”. “Ma che significa ‘il cacciatore’? Che fai? Vai a caccia?” “Come posso spiegartelo... Sai com’è fatto il corpo umano? È composto da milioni di cellule minuscole, alcune delle quali emettono segnali elettrici, altre immagazzinano informazioni, altre ancora assorbono sostanze nutritive o trasferiscono ossigeno. Ma tutte loro, anche le più importanti, morirebbero in meno di un giorno, anzi, tutto l’organismo morirebbe, se non fosse per le cellule adibite al controllo immunitario, che si chiamano macrofagi e che lavorano, metodiche e regolari, come un metronomo. Quando un’infezione colpisce un organismo, loro la trovano, la raggiungono nel luogo in cui si nasconde e, presto o tardi, riescono ad assalirla e...”, fece il gesto di torcere il collo a qualcuno, seguito da uno sgradevole ‘crack’. “La eliminano”. “Ma questo cos’avrebbe a che fare con il tuo lavoro?”, insistette Artyom. “Immagina l’intera Metropolitana come un organismo umano, molto complesso, composto da circa quarantamila cellule. Io sono il macrofago. Il cacciatore. Questo è il mio lavoro. Qualsiasi pericolo la minacci, deve essere eliminato; e sono io a farlo”. Sukhoi tornò con il bollitore e versò l’infuso bollente nelle tazze. Era ovvio che nel frattempo avesse radunato i suoi pensieri, quindi apostrofò Hunter: “Quindi partirai per eliminare la fonte del pericolo, cowboy? Andrai a caccia e abbatterai tutti i Tetri? Farai un buco nell’acqua, ne sono sicuro. Non si può fare nulla, Hunter. Nulla”. “Esiste sempre un’ultima opzione, l’ultima spiaggia. Far saltare la galleria settentrionale. Farla crollare completamente e isolare la tua nuova specie. Così potranno procreare lassù e lasceranno in pace noi talpe nel sottosuolo, che è diventato il nostro habitat naturale”. “C’è un dettaglio interessante, che sono in pochi a conoscere in questa stazione: hanno già fatto saltare una galleria. Ma sopra di noi, al di sopra della galleria settentrionale, c’è una falda acquifera. Quindi, se facciamo esplodere anche il secondo tunnel, verremo praticamente inondati. Se la prima detonazione fosse stata un po’ più forte, addio, mia cara VDNKh. Per cui, se ora facciamo saltare l’altra galleria a nord, ci sarà un’inondazione e verremo invasi da una brodaglia radioattiva; sarebbe la fine, e non solo per noi. Questo è il reale pericolo per la Metro. Se ingaggiamo una battaglia tra specie in questo momento e in questi termini, saremo noi a perderla. E come si dice negli scacchi: scacco al re”. “Che ne è stato della porta ermetica? Possiamo sicuramente chiuderla in quella galleria”, affermò Hunter. “La porta ermetica è stata rimossa, insieme a tutte le altre di questa linea, quindici anni fa, da qualche intelligentone che le ha poi mandate a un’altra stazione, perché quella potesse essere fortificata. Nessuno si ricorda più quale fosse. Ma ero sicuro che tu lo sapessi. Ecco fatto, di nuovo scacco al re”. “Raccontami una cosa... Negli ultimi tempi vi stanno attaccando più di frequente?”, sembrava che volesse lasciare perdere e portare la conversazione in un’altra direzione. “Attaccando? E come? È impossibile credere che solo poco tempo fa non sapevamo nemmeno che esistessero! E ora sono la nostra minaccia più grande. Credimi, è molto vicino il giorno in cui ci spazzeranno via tutti, con le nostre fortificazioni, i riflettori e le mitragliatrici. Non è possibile allertare tutta la Metropolitana per difendere una sola stazione, che non serve a niente... È vero, il nostro tè è buono, ma è assurdo che altri decidano di rischiare la propria vita solo per il nostro ottimo tè. Alla fine, siamo sempre in competizione con la Pechatniki.... Scacco al re, di nuovo!”. Sukhoi mostrò ancora il suo sorriso triste: “Nessuno ha bisogno di noi. Ben presto non saremo in condizione di gestire l’offensiva. Non possiamo far saltare la galleria e isolarli. E, per ovvie ragioni, non abbiamo i mezzi per andare in superficie e annientarli... Scacco matto. Scacco matto a te, Hunter! E anche a me. Scacco matto a tutti noi, che vogliamo vivere il futuro, capisci quello che ti sto dicendo?”, questa volta il sorriso di Sukhoi si fece amaro. “Lo vedremo”, fece seccato Hunter. “Lo vedremo”. Rimasero insieme ancora un po’, discussero del più e del meno. Artyom non conosceva la maggior parte delle persone di cui parlavano, anche perché facevano riferimento ad avvenimenti particolari. Di tanto in tanto, cominciavano a litigare, ma il ragazzo non ne capiva molto, poiché probabilmente quelle discussioni andavano avanti da anni, si quietavano se i due uomini non si vedevano, per poi riaccendersi quando si rincontravano. Alla fine, Hunter si alzò e annunciò che per lui era arrivata l’ora di andare a letto, dato che, al contrario di Artyom, non aveva dormito dalla sua ultima guardia. Salutò Sukhoi, ma prima di andarsene, si voltò di scatto verso Artyom e gli sussurrò: “Esci con me un momento”. Artyom saltò in piedi e lo seguì, non prestando attenzione all’espressione sorpresa del suo patrigno. Hunter lo aspettava fuori, mentre si allacciava in silenzio l’impermeabile e alzava il chiavistello della porta. “Facciamo due passi?”, suggerì e si mise a camminare veloce sulla piattaforma, verso le tende degli ospiti in cui alloggiava. Artyom si mosse esitante e lo seguì, cercando di indovinare cosa avesse da comunicargli quell’uomo, a lui che era soltanto un ragazzo e che fino a quel momento non aveva fatto nulla di particolare o di utile per gli altri. “Che ne pensi del mio lavoro?”, chiese Hunter. “È molto interessante... voglio dire, se non fosse per te... beh, e per gli altri come te, se ne esistono... noi saremmo già scomparsi...”, riuscì a bofonchiare Artyom, imbarazzato. Si morse la lingua e avvampò. Hunter aveva voluto parlare con lui, per comunicargli qualcosa, gli aveva chiesto di uscire per un momento, per stare da solo con lui, senza il patrigno; il ragazzo, di tutta risposta, era arrossito come un novellino, si era angosciato e aveva blaterato qualcosa di incomprensibile... “Ritieni sia un lavoro rispettabile? Beh, se la gente la pensa così”, sorrise Hunter, “allora non ha senso ascoltare le parole dei disfattisti che vivono tra noi. Il tuo patrigno sta agendo da codardo, proprio così. Ma è un uomo molto coraggioso o, per lo meno, un tempo lo è stato. Qui sta accadendo qualcosa di orribile. Non possiamo permettere che continui. Il tuo patrigno ha ragione: non sono semplici spiriti maligni che abbiamo già visto nelle altre stazioni, non sono vandali, non sono solo dei degenerati. È qualcosa che non abbiamo mai visto prima, più crudele. L’aria è un fremito, sa di morte. Sono qui da soli due giorni e la paura sta già penetrando in me. Da quel che ho capito, più informazioni hai su questi esseri, più li studi, più li vedi, e maggiore è la paura. Ad esempio, tu li hai visti molte volte?” “Solo una. Però ho appena cominciato a fare la guardia a nord”, confessò Artyom. “A dire la verità, è già passato un bel po’ di tempo, ma da allora sono perseguitato dagli incubi. Persino oggi, anche se, come ho detto, ne è passato di tempo!” “Incubi, hai detto? Anche tu?”. Hunter si rabbuiò. “Sì, non sembra una coincidenza... e se vivo qui ancora per un po’, un altro paio di mesi, andando in pattuglia regolarmente, allora di sicuro verrò colpito dallo stesso morbo anche io... No, amico mio. Il tuo patrigno si sbaglia. Non è lui che parla. Non è ciò che pensa davvero. Sono loro che pensano e parlano al posto suo. ‘Arrendetevi’, gli intimano, ‘la resistenza è inutile’. E lui è diventato il loro portavoce. Probabilmente non se ne rende nemmeno conto... Penso che sia vero che questi Tetri riescano a entrarti nella testa e a fare leva sulla tua psiche. Demoni! Ma dimmi, Artyom”, Hunter si girò in modo che stessero faccia a faccia; a quel punto il ragazzo capì che stava per rivelargli qualcosa di molto importante. “Tu hai un segreto? Qualcosa che non confideresti a nessuno qui alla stazione, ma che forse potresti confessare a uno straniero?” “Beh...”. Artyom esitò; questo sarebbe stato sufficiente a qualsiasi persona perspicace per capire che un segreto del genere esisteva eccome. “Anche io ne ho uno. Perché non ce li scambiamo? Ho bisogno di condividerlo con qualcuno, ma voglio essere certo che non lo vada a spifferare in giro. Allo stesso modo, tu mi affidi il tuo. Ma bada: non devono essere stupidaggini su una ragazza o simili, voglio qualcosa di serio, che nessun altro ascolterà mai. Poi io ti svelerò una cosa importante per me. Di cruciale importanza. Hai capito?” Artyom esitò nuovamente. Certo, la curiosità stava per avere la meglio, ma temeva di raccontare il suo segreto a un uomo che non era solo interessato a fare quattro chiacchiere, ma aveva vissuto mille avventure e che, da ciò che poteva vedere, era anche uno spietato assassino; quello non avrebbe esitato nemmeno un secondo per eliminare qualsiasi ostacolo davanti a sé. E se Artyom fosse diventato un accessorio all’incursione dei Tetri...? Hunter lo guardò dritto negli occhi, rassicurandolo: “Non devi avere paura di me. Ti do la mia parola!”. E gli fece l’occhiolino, come lo si fa a un fratello. Camminarono fino alla tenda assegnata a Hunter per quella notte, ma rimasero fuori. Artyom pensò ancora per un attimo, poi decise cosa fare. Ispirò profondamente, poi raccontò la storia della spedizione all’Orto botanico tutta d’un fiato. Quando terminò, Hunter rimase in silenzio per un momento, metabolizzando ciò che aveva udito. Poi, con voce greve, annunciò: “Beh, da un punto di vista strettamente disciplinare, tu e i tuoi amici dovreste essere uccisi per il reato che avete commesso. Tuttavia, ti ho dato la mia parola. Anche se non vale lo stesso per i tuoi amici...” Ad Artyom balzò il cuore in gola e sentì che il corpo si raggelava dalla paura, mentre le gambe cedevano. Non riuscì a proferire parola e attese in silenzio il verdetto. “Alla luce della vostra età e dell’impudenza generale del gesto, oltre al fatto che è accaduto molto tempo fa, sei perdonato. Rilassati”. Per fare in modo che Artyom potesse riprendersi più velocemente, Hunter gli fece di nuovo l’occhiolino, che questa volta era più rassicurante di prima. “Ma sappi che gli altri abitanti della stazione non avranno pietà di te. Quindi, mi hai donato di tua spontanea volontà un’arma potentissima da usare contro di te. Ora, ecco il mio segreto...” Mentre Artyom malediceva la sua lingua lunga, Hunter continuò: “Non ho attraversato tutta la Metropolitana per venire fin qui senza una ragione particolare. Io non rinuncio al mio lavoro. Il pericolo deve essere eliminato, come probabilmente ti sei sentito ripetere un milione di volte, oggi. Deve essere eliminato e verrà eliminato. Ci penserò io. Il tuo patrigno ha paura. Per quanto ne so, si sta lentamente trasformando in un loro strumento. Li combatte ogni giorno con maggiore riluttanza e vuole fare in modo che io mi unisca a lui. Se ciò che mi ha raccontato sulla falda acquifera è vero, allora la possibilità di fare esplodere la galleria è ovviamente fuori discussione. Ma la tua storia mi ha chiarito un paio di punti: se i Tetri si sono intrufolati nella Metro dopo la vostra spedizione, allora vengono dall’Orto botanico. Laggiù c’è qualcosa di malvagio che cresce e che li ha generati, se davvero vengono da lì... Ciò significa che possono essere bloccati in quel punto, vicino alla superficie, senza correre il rischio della falda acquifera. Ma chissà che diavolo è successo al settecentesimo metro della galleria settentrionale. Lì terminano i nostri poteri e cominciano quelli dell’oscurità, cioè la forma di governo più diffusa in tutta la Metropolitana di Mosca. Io là non ci vado. E nessuno lo deve sapere. Riferisci a Sukhoi che ti ho fatto un sacco di domande sulle condizioni della stazione. Quella sarà la nostra verità. Non devi spiegargli tutto, no? E se le cose vanno come dovrebbero, sarò io a dare spiegazioni a chi di dovere. Ma potrebbe anche essere che...”, si interruppe per un istante e osservò Artyom più da vicino. “Che io non torni indietro. Che ci sia un’esplosione o no, se non sono di ritorno per il mattino successivo, qualcuno dovrà raccontare ciò che mi è successo e parlare con i miei colleghi dei demoni nelle vostre gallerie settentrionali. Oggi, qui alla stazione, ho incontrato tutti coloro che conoscevo, incluso il tuo patrigno. Sento, anzi, vedo che tutti coloro che sono stati esposti alla loro influenza sono sopraffatti dal dubbio e dall’orrore. E io non mi posso fidare di persone del genere, ho bisogno di una persona integra, la cui capacità di ragionare non sia ancora stata intaccata da questi spiriti. Ho bisogno di te”. “Di me? Ma come posso aiutarti?”. Artyom era esterrefatto. “Ascoltami. Se non torno, tu dovrai a qualsiasi costo, ripeto: a qualsiasi costo, recarti alla Polis. Alla Città... lì dovrai cercare un uomo soprannominato Melnik e raccontargli tutta la storia. Un’altra cosa: ti darò un oggetto che potrai mostrargli a riprova che sono stato io a mandarti. Entra un minuto”. Hunter aprì il lucchetto della porta d’entrata, sollevò l’estremità della tenda e fece entrare Artyom. All’interno non c’era molto spazio, perché sul pavimento vi erano un enorme zaino mimetico e un baule di dimensioni impensabili. Alla luce della lanterna, sul fondo della sacca, Artyom intravvide la canna scintillante di un’arma, che dall’aspetto sembrava una mitragliatrice manuale dell’esercito. Prima che Hunter riuscisse a chiudere lo zaino e fare in modo che Artyom non sbirciasse, quest’ultimo vide di sfuggita una scatola di metallo, nera e opaca, che conteneva riviste sulle mitragliatrici impilate ordinatamente vicino all’arma e, sull’altro lato, a una piccola granata antiuomo verde. Senza commentare il suo arsenale, Hunter aprì la tasca laterale dello zaino e ne estrasse una piccola capsula di metallo, ricavata da un bossolo da mitra. Il lato su cui ci sarebbe dovuta essere la punta della pallottola era leggermente ripiegato. “Ecco, prendi questa. Non mi aspettare se manco già da due giorni. Non avere paura. Incontrerai persone che ti aiuteranno. Ce la devi fare! Sai bene che dipende tutto da te. Non te lo devo spiegare io, vero? È tutto. Augurati che io ce la faccia e vattene. Devo recuperare un po’ di sonno”. Artyom riuscì a balbettare un arrivederci, strinse la mano di Hunter e vacillando tornò verso la sua tenda, ricurvo, sotto il peso della missione che incombeva sulle sue spalle. CAPITOLO 3 : SE NON RITORNO Artyom era certo che, non appena fosse tornato a casa, il patrigno lo avrebbe subito interrogato e scosso dalla testa ai piedi pur di scoprire di cosa avessero discusso lui e Hunter. Al contrario, l’uomo non lo stava aspettando sulla porta di casa, armato dei più terribili strumenti di tortura, ma stava già russando pacifico, anche perché non dormiva da ormai ventiquattr’ore. Artyom, invece, era stato di pattuglia la sera precedente e aveva riposato durante il giorno; poi sarebbe stato di nuovo impegnato con il turno di notte, questa volta per lavorare alla fabbrica del tè. In seguito a decenni di vita sotterranea nell’oscurità interrotta qua e là dalle macchie di una debole luce rossa, gli uomini avevano perduto la percezione dell’alternanza tra il giorno e la notte. Durante le ore notturne, l’illuminazione della stazione era leggermente più debole, come in passato succedeva sui treni per permettere ai passeggeri di riposare. Tuttavia le luci non si spegnevano mai completamente, eccetto in caso di guasti. Vivendo al buio per così tanto tempo, la vista degli umani si era acutizzata, sebbene non fosse assolutamente paragonabile a quella delle altre creature che popolavano le gallerie e gli anfratti abbandonati. Distinguevano tra “giorno” e “notte” per abitudine, più che per necessità. La maggior parte degli abitanti della stazione preferiva che vi fosse una parte della giornata denominata “notte” in cui tutti dormivano, il bestiame si riposava, le luci si abbassavano e venivano limitati i rumori. Alla stazione vi erano anche due orologi, posti all’entrata delle gallerie: erano considerati oggetti strategici quanto il negozio di armi, i filtri dell’acqua e il generatore dell’elettricità. Veniva eseguita una manutenzione costante e anche i problemi meno importanti venivano immediatamente risolti; inoltre, se un delinquente cercava di sabotarli, veniva punito severamente e poteva essere addirittura esiliato. Vi era anche un codice penale, con il quale la VDNKh giudicava i criminali in processi per direttissima; era utilizzato anche in situazioni straordinarie, alla risoluzione delle quali potevano essere stabilite delle nuove regole. La manomissione di oggetti strategici era punita con le pene più severe; se si fumava o si accendeva un fuoco sulle piattaforme, oppure se si maneggiavano armi o esplosivi in modo irresponsabile si veniva immediatamente espulsi dalla stazione, mentre tutti gli oggetti di proprietà venivano confiscati. Questi severissimi provvedimenti avevano un’unica spiegazione: diverse stazioni erano già state distrutte dagli incendi, poiché le tende prendevano fuoco molto facilmente, le fiamme si diffondevano divorando qualsiasi cosa, mentre le brutali urla di dolore delle persone riecheggiavano per mesi nelle orecchie degli abitanti nelle stazioni vicine. In seguito, alla luce delle lanterne dei timorosi commercianti che si imbattevano per caso in quell’inferno si presentava una scena raccapricciante: corpi carbonizzati a cui erano rimaste incollate plastica sciolta insieme a tela e intere dentature umane spezzate dal calore inaudito delle fiamme. Onde evitare che un simile destino toccasse anche ad altre stazioni, accendere fuochi in maniera avventata diventò un crimine molto grave. Anche rubare, sabotare ed evitare deliberatamente di lavorare erano puniti con l’esilio. Ma, dato che alla stazione vi erano solamente duecento persone, si era sempre ben in vista, quindi era molto raro che venissero commessi questi crimini, che di solito erano perpetrati da forestieri. Il lavoro era obbligatorio. Tutti, sia giovani che anziani, dovevano offrire quotidianamente il loro contributo. Alla porcilaia, alla piantagione di funghi, alla fabbrica di tè, a quella per il confezionamento della carne, al controllo del fuoco e dei servizi ingegneristici, al negozio di armi: tutti gli abitanti lavoravano in almeno due di questi luoghi. Inoltre, ogni quarantotto ore, gli uomini svolgevano il servizio di guardia in una delle gallerie. In caso di conflitto o di un nuovo pericolo dalle profondità della Metropolitana, le pattuglie venivano moltiplicate e le forze della riserva allertate, pronte per entrare in azione. La vita alla VDNKh era organizzata in modo talmente meticoloso che si era guadagnata una reputazione invidiabile; erano molti quelli che desideravano trasferirvisi, anche se era assai difficile che venissero accolti degli stranieri. Mancava ancora qualche ora al suo turno di notte alla fabbrica del tè e Artyom, non sapendo cosa fare, arrancò fino a casa del suo amico Zhenya, lo stesso con cui aveva vissuto l’incredibile avventura in superficie. Zhenya aveva la sua stessa età ma, al contrario di Artyom, viveva con la sua vera famiglia: il padre, la madre e una sorellina. Non accadeva spesso che intere famiglie si salvassero e, nel profondo, Artyom invidiava l’amico. Voleva molto bene al suo patrigno e lo rispettava, persino ora che i suoi nervi stavano cedendo. Ciononostante, sapeva bene che Sukhoi non era il suo vero padre e nemmeno un suo parente stretto, tanto è vero che non lo aveva mai chiamato “papà”. All’inizio Sukhoi gli aveva chiesto di essere chiamato “zio Sasha”, ma in seguito se n’era pentito. Erano passati molti anni e il vecchio orso non era ancora riuscito a farsi una famiglia sua, non aveva nemmeno una donna che lo aspettasse quando faceva ritorno dalle sue spedizioni. Gli doleva il cuore quando vedeva una madre con il suo bambino e sperava che un giorno non dovesse più tornare nell’oscurità e che non gli toccasse più stare lontano dalla vita della stazione per giorni, o settimane, o forse anche per sempre. Inoltre, sperava di trovare una donna pronta a essere sua moglie, che volesse dare alla luce i suoi figli i quali, una volta imparato a parlare, non lo avrebbero chiamato “zio Sasha” ma “papà”. La vecchiaia e la debolezza si facevano prossime, rimaneva sempre meno tempo, si doveva sbrigare. Malgrado ciò, trovava difficile lasciare il suo lavoro. A un incarico ne seguiva subito un altro e non riusciva a trovare nessuno a cui far svolgere i suoi compiti, a cui affidare le conoscenze e i segreti professionali, così da poter eseguire un lavoro un po’ meno manuale alla stazione. Già da tempo rifletteva sul fatto che avrebbe voluto fare qualcosa di più pacifico: sapeva perfettamente che, grazie alla sua autorità, alla sua condotta ineccepibile e alle sue relazioni amichevoli con l’amministrazione avrebbe potuto ricoprire un ruolo da supervisore alla stazione. Ma per il momento, non c’era nessuno in grado di sostituirlo. Quindi si svagava pensando a un futuro più felice e viveva la quotidianità; rimandava il suo ritorno definitivo alla stazione e continuava a versare lacrime e sangue per il bene delle altre stazioni e delle gallerie più lontane. Artyom sapeva che il patrigno, sebbene gli dimostrasse un amore paterno, non lo considerava il suo successore nella vita professionale, poiché lo vedeva come un buono a nulla, immeritevole di una tale responsabilità. Non lo portava con sé durante le spedizioni più lunghe, ignorando il fatto che il ragazzo stava diventato un uomo e non poteva più essere indotto a credere che fosse troppo giovane, che lo avrebbero rapito gli zombie o che i ratti lo avrebbero divorato. Non aveva intuito che questa sua mancanza di sicurezza nei confronti di Artyom aveva spinto il ragazzo a fughe disperate per le quali veniva puntualmente punito dal patrigno. Ma forse non aveva voluto che Artyom rimanesse vittima dell’insensato pericolo mortale che implicava il suo lavoro nella Metropolitana; al contrario, voleva che il ragazzo potesse condurre la vita che Sukhoi tanto sospirava: in pace e sicurezza, lavorando e crescendo i figli, senza sprecare la sua giovinezza inutilmente. Ma così facendo, si stava dimenticando che egli stesso poteva aspirare a una vita del genere; aveva attraversato l’acqua e il fuoco, era sopravvissuto a centinaia di avventure e ne era pienamente soddisfatto. Ma la saggezza conquistata con anni di duro lavoro non gli parlava più, ormai riusciva solo a sentire il peso degli anni e la conseguente stanchezza. Di contro, nelle vene di Artyom ribolliva energia allo stato puro. Aveva appena cominciato a vivere e la prospettiva di svolgere un lavoro ingrato, di condurre un’esistenza da vegetale sbriciolando e facendo seccare funghi, cambiando pannolini, senza mai superare il cinquecentesimo metro, gli sembrava totalmente inconcepibile. Con il passare dei giorni, il desiderio di scappare dalla stazione si faceva più forte, mentre comprendeva sempre più chiaramente quale tipo di vita il patrigno stesse progettando per lui: una carriera come operaio alla fabbrica del tè e come padre di una schiera di marmocchi. Tutto ciò era meno esaltante di qualsiasi altra cosa su questa terra. Era attirato dall’avventura, voleva volare via, libero, come le salsole portate in giro per le gallerie dai flussi d’aria e seguire queste correnti fino all’ignoto, per incontrare il suo destino. Forse era proprio questo che Hunter aveva scorto in lui, chiedendogli di prendere parte a un’impresa tanto rischiosa. Hunter aveva un intuito naturale quando si trattava di capire le gente, infatti dopo una sola ora di conversazione, aveva già compreso che il ragazzo era la persona giusta a cui proporre il suo piano. E anche se non fosse mai arrivato a destinazione, per lo meno Artyom sapeva che, nel caso in cui all’Orto botanico fosse accaduto qualcosa ad Hunter, per attenersi ai suoi ordini avrebbe avuto la possibilità di lasciare la stazione. Naturalmente, il cacciatore aveva fatto la scelta giusta. Per fortuna, Zhenya era in casa perciò Artyom avrebbe passato la serata a chiacchierare sulle ultime indiscrezioni e a ragionare sul futuro sopra una tazza di tè forte. “Fantastico!”, esclamò l’amico rispondendo al saluto di Artyom. “Sei nel turno di notte alla fabbrica?! Ci hanno messo anche me... ero talmente stufo che stavo per chiedere al capo di cambiarmi posto. Ma se ci fanno lavorare insieme allora va bene, credo di riuscire a sopportarlo. Sei appena rientrato dalla pattuglia, vero? Dai, racconta! Ho sentito dire che c’è stata un’emergenza. Che è successo?”. Artyom lanciò un’occhiataccia alla sorella minore di Zhenya, che dall’angolo della tenda stava dimostrando fin troppo interesse nella loro conversazione: aveva smesso di riempire con gli scarti dei funghi la bambola di pezza che la madre le aveva cucito e stava osservando i due ragazzi con il fiato sospeso e gli occhi spalancati. “Ragazzina!”, la richiamò severo Zhenya, che aveva subito compreso la smorfia di Artyom. “Tu e il tuo giocattolo potete andarvene dai vicini. Penso che Katya ti abbia invitato... Sai che dobbiamo essere gentili con i nostri dirimpettai... quindi, va’ e porta con te le bambole”. La bambina squittì indignata e cominciò a raccogliere le sue cose con uno sguardo torvo, mugugnando alla sua bambola, che con occhi consunti osservava inespressiva il soffitto: “Pensate di essere importanti?! Io tanto so già tutto! Parlerete solo di funghi!”, borbottò sprezzante mentre se ne andava. “Lenka, sei troppo piccola per parlare di funghi. Hai la bocca ancora sporca di latte!”, la redarguì Artyom. “Cos’è il latte?”, domandò la bambina perplessa, toccandosi le labbra. Ma nessuno dei due si curò di darle una spiegazione e la domanda rimase sospesa nell’aria. Quando se ne andò, Zhenya fissò i lembi della tenda e richiese: “Beh? Allora, cos’è successo? Forza, sputa il rospo! Ho già sentito troppe versioni discordanti: un tizio ha riferito di aver visto un enorme ratto sbucare dalla galleria; un altro ritiene che tu abbia fatto fuggire una spia dei Tetri e che sia rimasto persino ferito. A chi devo credere?” “A nessuno!”, gli consigliò Artyom. “Mentono tutti. Era un cane, anzi, una cagnolina. L’ha presa Andrey, sostiene che sia un pastore tedesco”, sorrise Artyom. “Sì, ma io ho saputo proprio da Andrey che si trattava di un ratto!”. Zhenya era scettico. “Secondo te mi ha mentito di proposito?” “Non lo sai? È la sua risposta preferita: ‘C’erano ratti grandi quanto maiali’. È un comico nato”, scherzò Artyom. “E tu che mi racconti? Novità? Hai parlato con i ragazzi?” Gli amici di Zhenya erano commercianti, consegnavano il tè e la carne di maiale al mercato della Prospekt Mira e riportavano multivitamine, tela e chincaglierie di qualsiasi tipo; alle volte riuscivano anche a mettere le mani su un po’ di petrolio. In altre occasioni riuscivano a raccattare libri sporchi, spesso con pagine mancanti, che misteriosamente erano finiti alla Prospekt Mira dopo aver viaggiato per quasi tutta la Metro, passando da un baule all’altro, da una tasca a quella successiva, dalle mani di un mercante a quelle di un altro, per trovare, infine, il loro proprietario di diritto. Alla VDNKh erano molto fieri del fatto che, nonostante la distanza dal centro e dalle rotte principali del commercio, gli abitanti riuscivano a sopravvivere decorosamente a condizioni che peggioravano di giorno in giorno e anche a mantenere, per lo meno all’interno dei confini della loro stazione, un buon livello di cultura, che purtroppo sottoterra stava velocemente sparendo. L’amministrazione della stazione aveva fatto del proprio meglio per dare a questo problema il massimo dell’importanza; era infatti obbligatorio insegnare a leggere ai bambini. La stazione aveva anche una piccola biblioteca in cui venivano man mano aggiunti tutti i libri che si riuscivano a trovare nei mercati. In realtà, i commercianti non sceglievano i libri, portavano semplicemente ciò che gli veniva consegnato e li trattavano come se fossero carta straccia. Al contrario, gli abitanti della stazione provavano una certa riverenza nei confronti della carta stampata, tanto che non avrebbero mai strappato una pagina, nemmeno del più stupido romanzo di terza categoria; li consideravano delle reliquie, l’ultimo ricordo di un fantastico mondo ormai sprofondato nell’oblio. Gli adulti che quasi ricordavano a memoria tutte le parole dei romanzi letti, tramandavano questo amore per i libri ai loro figli, i quali, purtroppo, non potevano rammentarsi le storie del vecchio mondo poiché conoscevano solo questo, fatto di gallerie, intersezioni, corridoi, passaggi infiniti e cupi. Nella Metro vi erano pochissimi altri luoghi in cui il testo scritto era idolatrato come qui e gli abitanti della VDNKh si consideravano uno degli ultimi capisaldi della cultura, una roccaforte della civiltà, la più settentrionale sulla linea Kaluzhsko-Rizhskoi. Anche Artyom e Zhenya leggevano molto. Quest’ultimo attendeva scalpitante il ritorno dei suoi amici dal mercato e, al loro arrivo, correva a incontrarli per domandare loro se fossero riusciti a portare qualcosa di nuovo. Perciò, nella maggior parte dei casi, i libri finivano prima nelle mani di Zhenya e solo in seguito venivano catalogati nella biblioteca. Il patrigno di Artyom gli portava dei libri dalle sue spedizioni: nella loro tenda ne avevano uno scaffale quasi pieno. Stavano lassù, su quel ripiano, ingiallivano e diventavano consunti, a causa della muffa e dei morsi dei topi, sebbene spesso arrivassero già sporchi di macchie brune di sangue secco. Possedevano titoli che nessun altro aveva sia nella loro stazione che, molto probabilmente, in tutta la Metropolitana: Marquez, Kafka, Borges, Vian e alcuni classici russi. “I ragazzi non sono riusciti a portare nulla questa volta”, cominciò Zhenya. “Lekha mi ha riferito che presto riceverà una tonnellata di libri da un tizio della Polis e mi ha promesso che ne porterà un paio qui”. “Non mi riferivo ai libri!”. Artyom agitò la mano in direzione di Zhenya. “Cosa ti hanno detto? Com’è la situazione?” “La situazione? Niente di insolito. Naturalmente girano voci di qualsiasi tipo, ma non è una novità. Sai benissimo che i commercianti non riescono a sopravvivere senza i loro pettegolezzi e le loro storie, altrimenti che commercianti sarebbero? Bisogna soppesare bene tutte le sciocchezze che raccontano e poi decidere se crederci o no. Per il momento sembra tutto tranquillo. O per lo meno, se pensiamo al periodo in cui l’Hansa era in guerra con i Rossi... aspetta un attimo!”, d’improvviso si ricordò qualcosa: “Sai che ora alla Prospekt Mira proibiscono di usare la droga? Se trovano un commerciante che la vende, gliela confiscano, lui viene schedato ed espulso dalla stazione; se lo trovano una seconda volta, Lekha sostiene che non gli permettono di accedere all’Hansa per diversi anni, il che significa la morte per un commerciante!” “Davvero?! Ma... l’hanno deciso di punto in bianco? Cosa gli è saltato in mente?” “Sembra che sia allucinogena, dato che influisce sul tuo modo di vedere le cose, e che se assunta troppo frequentemente, può causare danni permanenti al cervello. Quindi, per ragioni di salute”. “Perché tutto d’un tratto si preoccupano del nostro benessere? Che pensino al loro e lascino in pace noi!” “Sai una cosa?”, Zhenya abbassò la voce. “Secondo Lekha stanno mettendo in circolazione un sacco di stupidaggini su cosa sia dannoso per la salute”. “Quali stupidaggini?”. Artyom era sorpreso. “Fanno disinformazione. Ad esempio, una volta Lekha ha percorso la linea oltre la Prospekt Mira ed è riuscito ad arrivare alla Sukharevskaya. Stava conducendo degli affari loschi, di cui però ha mantenuto il più totale riserbo anche con me. Laggiù ha incontrato un uomo anziano, un tipo interessante. Era un mago”. “Chi?”. Artyom non riuscì a trattenersi e scoppiò in una fragorosa risata. “Un mago? Alla Sukharevskaya? Ma dai, il tuo amico Lekha ti ha preso in giro! Poi che ti ha raccontato, che il mago gli ha regalato una bacchetta magica? Oppure un bastone che si trasforma in un fiore?” “Sei un idiota”. Zhenya si era offeso. “Pensi di sapere tutto tu? Solo perché non hai mai incontrato un mago, non significa che non ne esistano. Credi nei mutanti sulla Filevskaya?” “Non c’è bisogno di crederci, quelli ci sono davvero. Non c’è paragone. A me l’ha raccontato il mio patrigno. Ma non ho mai sentito parlare di maghi”. “Sebbene io rispetti Sukhoi, nemmeno lui è onnisciente. E comunque, forse voleva solo spaventarti. Insomma, se non vuoi ascoltare la storia, puoi andartene a quel paese”. “D’accordo, Zhenya, continua. È comunque un racconto interessante, anche se sembra un po’...”, Artyom sorrise. “Ok. Dovevano passare la notte attorno al fuoco. Come sai, nessuno vive in pianta stabile alla Sukharevskaya. I commercianti che giungono dalle altre stazioni vi fanno tappa perché le autorità dell’Hansa alla Prospekt Mira gli hanno imposto un coprifuoco: quando le luci si abbassano, tutti fuori. Ebbene, il gruppo si era accampato laggiù, c’erano diversi ciarlatani e qualche ladro; se ne stavano tutti insieme ai commercianti. C’era anche qualche viandante, che si riposava prima di dirigersi verso sud. Ma nelle gallerie oltre la Sukharevskaya stava cominciando un putiferio: nessuno vive laggiù, né ratti, né mutanti; la maggior parte di coloro che passa da quelle gallerie scompare, senza lasciare alcuna traccia. Dopo la Sukharevskaya, la stazione successiva è la Turgenevskaya, nei pressi della linea Rossa. In quella zona c’era un passaggio verso Chistye Prudy che i Rossi hanno rinominato Kirov, dicono fosse un rivoluzionario comunista... gli abitanti avevano troppa paura, non volevano vivere nei pressi di quella stazione e così lo bloccarono. Quindi ora la Turgenevskaya è rimasta vuota, abbandonata. Perciò la galleria che dalla Sukharevskaya porta al più vicino insediamento umano sembra infinita. Ed è proprio lì che la gente scompare: se percorrono la galleria uno alla volta, quasi sicuramente non arrivano dall’altra parte, ma se riescono a radunare una carovana di una decina di persone, allora ce la fanno. Quando giungono a destinazione riferiscono che in quella galleria non vi sia niente di particolare: è normale, tranquilla, vuota, non vi è nemmeno un passaggio laterale o un luogo in cui sparire. Dicono di non aver incontrato nessuno, nemmeno un bestia e di non aver udito neanche un rumore... Ma poi il giorno dopo, quando la voce si sparge, si viene a sapere che la galleria è pulita e che è semplice attraversarla, qualcuno manda al diavolo la superstizione, ritenta l’impresa da solo e... tombola! Non riesce ad arrivare dall’altra parte”. “Mi sembrava stessi parlando di un mago...”, ricordò tranquillamente Artyom. “Ci arrivo, al mago. Aspetta un attimo”, rispose Zhenya. “Beh, gli uomini sono terrorizzati, non vogliono percorrere da soli quella galleria verso sud e alla Sukharevskaya cercano compagni con cui affrontare il viaggio. Se non è un giorno di mercato non vi sono molte persone, per cui alle volte devono aspettare giorni interi, o addirittura settimane affinché raggiungano un numero sufficiente di persone per partire; più sono, meglio è. Lekha mi ha raccontato che alle volte si incontrano personaggi davvero stravaganti, tra i quali vi sono anche numerosi mascalzoni... bisogna solo saperli individuare. Altre volte, però, si è più fortunati. Appunto, Lekha ha incontrato il mago. Non era come te lo immagini, non di quelli che escono dalla lampada...” “Quello della lampada era un genio, non un mago”, lo corresse attento Artyom, ma Zhenya ignorò il suo commento e continuò: “È un occultista e ha passato metà della sua vita a studiare letteratura mistica di qualsiasi genere. Più che altro hanno discusso delle teorie di Castaneda... Legge nel pensiero e riesce a vedere nel futuro, a scoprire i collegamenti mancanti, ad anticipare pericoli futuri. Sostiene di vedere gli spiriti. E c’è dell’altro...”. Zhenya fece una pausa, per creare un po’ di suspense, “Se ne va in giro per la Metro senz’armi! Completamente disarmato! Ha solo un coltellino, che usa per tagliare il cibo, e un bastone di plastica. Capisci? Afferma che tutti coloro che assumono droga, anche quelli che la bevono, sono dei folli, perché non è come ce la immaginiamo, non è droga vera; e quei funghi... anche quelli non sono ciò che sembrano, soprattutto perché, in passato, non sono mai cresciuti nella regione centrale. In effetti, un giorno ho dato un’occhiata a un libro di micologia e non ho trovato alcuna informazione sui funghi che abbiamo qui. Non c’è nulla che gli somigli, nemmeno lontanamente... Quelli che li mangiano pensando che siano allucinogeni e che si possano avere delle visioni, beh, si sbagliano. Per lo meno, è ciò che sostiene il mago. Ma se li cucini in maniera leggermente diversa, puoi entrare in uno stato in cui riesci a controllare gli eventi nel mondo reale.” “Che mago sbalorditivo! Anche se, per la verità, a me sembra più un drogato...”, dichiarò Artyom con convinzione. “Moltissima della gente che vive qui prende la droga per rilassarsi, ma come ben sai, nessuno ne ha mai abusato. Quel tizio è un tossicodipendente, te lo dico io. E secondo me era in crisi d’astinenza. Senti questa: zio Sasha mi ha raccontato che in una stazione, non ricordo precisamente quale, gli si rivolse un uomo anziano, che cominciò a dirgli di avere un potente sesto senso e che stava combattendo un conflitto contro sensitivi e alieni potenti quanto lui, però malvagi. Riteneva che lo stessero quasi sconfiggendo, che non sarebbe stato in grado di combattere ancora a lungo, poiché stava consumando tutte le sue forze per quelle battaglie. Mi pare che la stazione fosse la Sukharevskaya, o una mezza stazione del genere, in cui la gente si siede attorno ai fuochi da campo al centro della piattaforma, lontani dall’imboccatura della galleria, per dormire un po’ prima di riprendere il cammino. In quel momento videro tre uomini passargli vicino e l’anziano gli riferì, terrorizzato: ‘Vedi? Quello nel mezzo è il sensitivo malvagio, il discepolo dell’oscurità, mentre gli altri due sono alieni che lo stanno aiutando. Il loro capo vive nel punto più profondo della Metropolitana. Stanno pensando che non verranno qui ad affrontarmi perché ci sei tu con me, e non vogliono che le persone normali sappiano di questa guerra. Ora mi stanno attaccando con la loro energia e io mi difendo con uno scudo’. Poi urlò: ‘Continuerò a battermi!’. So che ti viene da ridere, ma per il mio patrigno tutta quella situazione non era per nulla divertente. Immaginati di essere in un punto dimenticato della Metro: ti può succedere qualsiasi cosa! Sembrano idiozie, è vero. Infatti, a quel punto zio Sasha si era convinto che il vecchio fosse solo un pazzo, ma poi il tizio che camminava con i due alieni lo guardò storto e lui vide un bagliore nei suoi occhi...” “Che stupidaggini”, ribatté Zhenya, scettico. “Saranno anche delle stupidaggini, ma sai bene che nelle stazioni più remote devi essere pronto a tutto. Da ultimo, l’anziano gli disse che ben presto avrebbe affrontato la battaglia finale con i sensitivi malvagi, che erano molto più potenti di lui. Nel caso avesse perso, sarebbe stata la fine per tutti. Aggiunse che in passato vi era un numero maggiore di sensitivi buoni, che si trattava di una guerra alla pari. Ma in tempi recenti i cattivi sono riusciti a mettere a segno delle conquiste. Questo vecchio era uno degli ultimi buoni, forse proprio l’ultimo. Se fosse stato ucciso, i malvagi avrebbero vinto e sarebbe stata la fine!” “Secondo me abbiamo già raggiunto la fine” osservò Zhenya. “Beh, non esattamente. Esistono ancora delle possibilità”, ribadì Artyom. “Poi, quando si salutarono, il vecchio lo pregò: ‘Figliolo, dammi qualcosa da mangiare! Le forze mi stanno abbandonando, la battaglia finale si avvicina e da questa dipende il futuro di tutti, anche il tuo!’. Capito? Quel tizio voleva solo qualcosa da mangiare. Proprio come il tuo mago, che però aveva anche qualche rotella fuori posto, ma per un’altra ragione”. “Sei un ingenuo! Non sai nemmeno come va a finire, la mia storia... E comunque, chi ti dice che il vecchio stesse mentendo? A proposito, come si chiamava? Sukhoi ti ha detto il suo nome?” “Sì, me l’ha detto, ma non me lo ricordo con esattezza... aveva un nome strano, che cominciava con ‘Chu’... poteva essere ‘Chum’ o ‘Chump’... Molto spesso i vagabondi usano soprannomi stravaganti al posto dei loro veri nomi. Come si chiamava il tuo mago?” “Riferì a Lekha che in quel momento veniva chiamato Carlos, per la somiglianza. Non so a cosa si riferisse, ma lui lo ha spiegato così. In ogni caso, dovresti ascoltare la fine della storia: al termine della loro conversazione, ammonì Lekha che sarebbe stato meglio non attraversare la galleria settentrionale, sebbene Lekha si stesse preparando per partire proprio il giorno successivo. Però quest’ultimo gli diede retta e non andò. Il mago aveva ragione, perché quel giorno dei delinquenti attaccarono la carovana nella galleria tra la Sukharevskaya e la Prospekt Mira, anche se era considerata una rotta sicura. Metà dei commercianti vennero uccisi e quelli che sopravvissero riuscirono a malapena a difendersi... Beh, che ne pensi?” Artyom non rispose subito e sprofondò nei suoi pensieri. “Non si può mai sapere, può succedere di tutto. Fatti del genere accadevano molto frequentemente, me li raccontava anche il mio patrigno, che ha visto come vivevano nelle stazioni più remote; laggiù gli umani sono diventati dei selvaggi, dei primitivi, e si sono scordati che l’uomo incarna l’essere razionale per eccellenza. Perciò si susseguono gli avvenimenti più strani, ai quali le nostre menti logiche non sono in grado di dare una spiegazione. Non è mai sceso nel dettaglio e... per la verità non me lo ha raccontato direttamente, l’ho sentito per caso”. “Ah ah! Te lo dico io, certe volte descrivono vicende alle quali le persone normali non crederebbero mai. L’ultima volta, Lekha mi ha parlato di un’altra storia... la vuoi ascoltare? Sicuramente questa non l’hai mai sentita dal tuo patrigno. Lekha ne è venuto a conoscenza da un commerciante della linea Serpukhovskaya... Tu credi nei fantasmi?” “Beh, ogni volta che sto con te comincio a chiedermi se ci credo oppure no, ma poi quando sono da solo, o con altra gente, ritorno in me...”, replicò Artyom, riuscendo a malapena a nascondere l’ombra di un sorriso. “Dici sul serio?” “Ovviamente ho letto molte storie e zio Sasha me ne ha raccontate delle altre. Ma, se devo essere onesto, non ci credo davvero. Io non riesco a capirti, Zhenya: qui alla stazione stiamo vivendo un incubo interminabile con tutti questi Tetri, che scommetto non si trovano in nessun’altra parte della Metropolitana. E da qualche parte ci saranno dei ragazzi che parlano di ciò che ci sta succedendo, a cui vengono raccontate storie spaventose sulla nostra stazione e che si chiedono: ‘Credi che questi Tetri esistano davvero?’. Sembra che per te non significhi niente... Hai bisogno di avere più paura di così?” “Non dirmi che a te interessa solo quello che riesci effettivamente a vedere e a sentire... Non pensi che il mondo sia organizzato anche in ciò che non vedi e non senti? Prendi una talpa: non vede niente, è completamente cieca dalla nascita. Ma questo non significa che tutto ciò che la talpa non riesce a vedere non esista... Tu mi stai dicendo questo?” “D’accordo... Quale storia volevi raccontarmi? Del commerciante alla Serpukhovskaya?” “Il commerciante? Sì certo! Beh, non so come, ma Lekha ha incontrato questo tizio al mercato. Non era sicuramente della Serpukhovskaya, ma dell’Anello; un cittadino dell’Hansa che vive alla Dobryninskaya. Laggiù c’è un passaggio che conduce alla Serpukhovskaya. Non so se Sukhoi te l’ha mai riferito, ma su quella linea non c’è anima viva oltre l’Anello, almeno fino alla stazione successiva, cioè la Tulskaya, dove ci sono le pattuglie dell’Hansa. L’organizzazione ha deciso di prendere provvedimenti per difenderla, visto che a loro parere la linea è disabitata... Non si sa mai di cosa possa essere infestata, perciò l’hanno trasformata in una zona cuscinetto. Nessuno prosegue mai oltre la Tulskaya, dicono che non vi sia nulla, le stazioni siano tutte vuote e l’equipaggiamento ridotto a pezzi, quindi vivere laggiù sarebbe praticamente impossibile. È una zona tagliata fuori dal resto del mondo: niente animali, niente parassiti e nemmeno ratti. Totalmente vuota. Tuttavia, quel commerciante aveva un conoscente, un tipo a cui piaceva vagabondare, che una volta era stato oltre la Tulskaya. Non so cosa stesse cercando, comunque raccontò al commerciante che sulla linea Serphukhvskaya le cose non sono poi così semplici e che è vuota per una ragione ben precisa. Gli disse che ciò che accade laggiù è inimmaginabile. Non è un caso che l’Hansa non abbia mai colonizzato la zona, anche se potrebbe diventare una piantagione o una porcilaia perfetta”. Zhenya si interruppe. Si era accorto che finalmente Artyom aveva messo da parte il suo cinismo e lo stava ascoltando a bocca aperta. Si accomodò sul pavimento, sentiva che ce l’aveva fatta: “Sì, beh... so che a te non interessano queste vecchie fandonie. Beviamo ancora un po’ di tè?” “Il tè può attendere! Sputa il rospo, perché l’Hansa non aveva colonizzato la zona? Hai ragione, è molto strano. Il mio patrigno sostiene vi sia un problema generalizzato di sovrappopolazione; in parole povere, non c’è più spazio per tutti. Quindi perché rinunciare alla possibilità di allargarsi un po’? Non è da loro!” “Ah, ma allora ti interessa!? D’accordo... Beh, questo straniero si era addentrato nei recessi dalla galleria, aveva camminato e camminato, ma non aveva mai incontrato anima viva. Niente e nessuno, proprio come nella galleria oltre la Sukharevskaya. Riesci a immaginare la situazione? Nemmeno un ratto! Solo il rumore delle gocce d’acqua. Le stazioni abbandonate rimangono lì, nell’oscurità, disabitate da sempre; si prova un costante senso di pericolo, è oppressivo... Camminando velocemente, riuscì a superare quattro stazioni nel giro di mezza giornata. Era di sicuro un tipo disperato... Vivere un’esperienza del genere completamente solo! Arrivò alla Sevastopolskaya, nel punto in cui c’è il passaggio che conduce alla linea Kakhovskaya. Sai quella su cui vi sono solo tre stazioni, che sembra incompleta, una sorta di appendice... Decise di passare la notte alla Sevastopolskaya. Era stanco morto, sia nel corpo che nella mente... Trovò qualche legnetto e accese un fuoco, in modo che l’oscurità attorno a lui non sembrasse troppo insopportabile, quindi entrò nel suo sacco a pelo e si addormentò sulla piattaforma. Tuttavia, durante la notte...” A quel punto, Zhenya si alzò in piedi, allungò i muscoli e, con un sorriso sadico dichiarò: “Beh, non so tu, ma io ora ho bisogno di una bella tazza di tè!”, e senza attendere la risposta dell’amico uscì dalla tenda con il bollitore in mano e lo lasciò lì a pensare a quello che gli aveva raccontato fino a quel momento. Chiaramente Artyom se l’era presa con Zhenya, ma decise di aspettare paziente il suo ritorno; allora gliene avrebbe dette quattro. Improvvisamente si ritrovò a pensare ad Hunter e alla sua richiesta, che in realtà era sembrata quasi un ordine. Subito dopo tornò a concentrarsi sulla storia di Zhenya. Il ragazzo era tornato con il tè, ne versò un po’ in un bicchiere, ornato da un rarissimo rivestimento in metallo, simili a quelli che un tempo si usavano sui treni per servire proprio il tè. Continuò subito la sua storia: “Si addormentò vicino al fuoco, era circondato da un silenzio assordante, come se avesse le orecchie tappate con del cotone. Nel bel mezzo della notte udì uno strano rumore... di quelli impossibili, che avrebbero messo a dura prova la sanità mentale di chiunque. Cominciò subito a sudare freddo e saltò in piedi. Udì la risata di un bambino, che veniva dalla galleria: si trovava a quattro stazioni dall’insediamento più vicino! Laggiù non ci vivono nemmeno i ratti! Te lo immagini? Era spaventatissimo... Dopo essersi alzato in piedi, corse sotto uno degli archi rivolti verso la galleria e... sai cosa vide? Un treno che entrava in stazione. Un treno vero, con le luci accese, che avrebbero potuto accecarlo! Per fortuna fece in tempo a coprirsi gli occhi con la mano. I finestrini risplendevano di una luce gialla, all’interno c’erano delle persone, ma tutta la scena si svolgeva davanti ai suoi occhi nel silenzio più totale, senza il benché minimo rumore! Non si udiva il ronzio del motore e nemmeno il fracasso delle ruote, il treno scivolava attraverso la stazione in un innaturale silenzio. Capisci? Il tizio si sedette, sentì che il suo cuore stava per cedere... Vedeva della gente ai finestrini del treno, come se stessero chiacchierando senza emettere alcun suono. Il treno, vagone dopo vagone, gli passava davanti agli occhi. Nell’ultimo convoglio riuscì a scorgere un bambino di sette anni che lo fissava, lo indicava con il dito... e rideva. La risata, quella sì che riusciva a sentirla! Il silenzio era tale che riusciva a sentire anche il suo cuore, oltre al bimbo... Il treno sprofondò nella galleria e la risata si fece sempre meno udibile, per poi svanire del tutto. Quindi tornò di nuovo il silenzio più assoluto, il più terribile che avesse mai udito”. “A quel punto si svegliò?”, lo assalì Artyom malevolo, ma con un filo di speranza nella voce. “Ti piacerebbe, eh! Tornò a tutta velocità verso il fuoco ormai spento, raccolse in fretta le sue cose e corse indietro verso la Tulskaya, senza mai fermarsi. Ci mise una sola ora. Era troppo spaventato. Immagina...” Artyom era ammutolito, sconvolto da ciò che aveva sentito. Così, anche nella tenda scese il silenzio. Alla fine, dopo aver raccolto i pensieri, tossì e si assicurò che la voce non lo tradisse. Quindi chiese a Zhenya con il tono più indifferente che gli riuscì: “E tu ci credi?” “Beh, non è la prima volta che mi raccontano una storia del genere sulla Serpukhovskaya”, ribatté Zhenya, “solo che non te le racconto sempre, perché non mi riesce di parlartene normalmente... tu mi interrompi subito! Va bene, per stasera siamo rimasti qui anche troppo, è quasi ora di andare al lavoro. Forza, prepariamoci. Possiamo parlare ancora un po’ durante il turno”. Artyom si alzò restio e si trascinò verso casa. Aveva bisogno di fare uno spuntino prima di cominciare a lavorare. Il suo patrigno stava ancora dormendo, così come il resto della stazione: molto probabilmente la maggior parte delle persone aveva già terminato il proprio turno di lavoro, mentre mancava poco all’inizio di quello notturno. Doveva sbrigarsi. Superò la tenda degli ospiti in cui alloggiava Hunter e vide che i lembi erano aperti: era rimasta vuota. Il suo cuore sussultò. Fu allora che comprese che la sua conversazione con Hunter non era stata un sogno, era avvenuta davvero. Lo sviluppo degli eventi avrebbe potuto avere un impatto diretto su di lui; sapeva benissimo che ben presto avrebbe dovuto affrontare il suo destino. La fabbrica del tè si trovava in un vicolo cieco, in prossimità di una delle uscite bloccate della Metropolitana. Dall’altro lato vi erano le scale mobili che conducevano in superficie. Tutto il lavoro veniva svolto a mano, sarebbe stata una pazzia sprecare la preziosa energia elettrica per la produzione. Al di là dei muri di metallo che separavano la fabbrica dal resto della stazione, da una parete all’altra scorrevano dei fili di metallo sui quali venivano fatti essiccare i funghi puliti. Quando l’ambiente era particolarmente umido, venivano accesi dei fuocherelli per fare in modo che i funghi essiccassero più velocemente e non si ricoprissero di muffa. Sotto i fili erano posti dei tavoli sui quali gli operai tagliavano e sminuzzavano i funghi secchi. Il tè così preparato veniva confezionato in pacchetti di carta o di plastica, a seconda del materiale disponibile alla stazione. Prima del confezionamento venivano aggiunti estratti e polveri: la ricetta era nota solo al responsabile della fabbrica. Era un processo semplice e ripetitivo, per cui, se gli operai non avessero potuto conversare tra loro durante le otto ore in cui tagliavano e facevano a pezzettini i funghi, sarebbe stato davvero estenuante. Artyom lavorò insieme a Zhenya e a un nuovo ragazzo dai capelli arruffati, Kirill, con il quale era già stato di pattuglia. Quest’ultimo si animò quando vide Zhenya, forse perché si erano già visti e avevano avuto modo di chiacchierare. Perciò prese a raccontargli una storia che sembrava fosse stata interrotta in precedenza. Artyom sedeva nel mezzo e non si sentiva abbastanza coinvolto nella conversazione da ascoltare, quindi sprofondò nei suoi pensieri: il racconto di Zhenya sulla linea Serpukhovskaya stava abbandonando la sua memoria, mentre riaffiorava la conversazione con Hunter. Cosa poteva fare? Gli ordini di Hunter erano stati fin troppo categorici, doveva rifletterci sopra. Se il cacciatore non fosse riuscito a portare a termine la sua missione? Aveva deciso di affrontare un’impresa totalmente insensata, osando avventurarsi nel covo del nemico, dove era iniziato tutto. Il pericolo a cui si esponeva era enorme, nemmeno lui ne conosceva la reale portata. Poteva solamente immaginare ciò che lo attendeva al cinquecentesimo metro, in cui la luce del fuoco da campo dello sbarramento di confine si faceva sempre più flebile... le ultime fiamme accese dall’uomo, a nord della VDNKh. Le informazioni che aveva raccolto sui Tetri erano le stesse che tutti conoscevano, solo che gli altri non avevano la minima intenzione di andare a cercarli. In verità, non si sapeva con certezza se all’Orto botanico vi fosse un passaggio da cui quelle bestie potevano intrufolarsi dalla superficie all’interno della Metropolitana. Le probabilità che Hunter non sarebbe riuscito a tornare erano altissime e Artyom cominciò a preoccuparsi. Il pericolo da nord incombeva ed era sempre maggiore, quindi la possibilità di attendere oltre non era contemplabile. Era molto probabile che Hunter sapesse qualcosa sulla natura di questa minaccia, che però non aveva rivelato durante l’incontro con Sukhoi e nemmeno nel corso della sua conversazione con Artyom. Perciò, era cosciente del rischio e sapeva di non essere all’altezza dell’incarico, altrimenti non avrebbe mai preallertato Artyom, dicendogli di prepararsi nel caso in cui la situazione fosse volta al peggio. Hunter non sembrava nemmeno una persona troppo prudente; ciò significava che le possibilità di vederlo tornare alla VDNKh erano meno che scarse. Ma come avrebbe fatto Artyom ad abbandonare la stazione senza dire niente a nessuno? Hunter stesso aveva evitato di avvisare qualcun altro, scoraggiato dal fatto che vi fossero persone di cui non si poteva fidare, il cui cervello veniva, giorno dopo giorno, divorato dai vermi... Come gli sarebbe stato possibile raggiungere la leggendaria Polis tutto da solo, superando i pericoli, sia i più visibili, sia quelli più misteriosi, che attendevano i viaggiatori nelle gallerie oscure e silenziose? D’improvviso, si pentì di avere ceduto di fronte all’incredibile ascendente che Hunter aveva esercitato su di lui e al suo sguardo ipnotico; si rammaricò di avergli rivelato il suo segreto e di avergli promesso di affrontare una missione tanto pericolosa. “Ehi, Artyom! Artyom! Stai dormendo? Perché non ci dici la tua?”. Zhenya gli scosse una spalla. “Hai ascoltato quello che raccontava Kirill? Hanno organizzato una carovana per la Rizhskaya per domani sera: la nostra amministrazione ha deciso di firmare un accordo con loro e sembra che vogliano anche inviare degli aiuti umanitari, dato che potremmo allearci. Pare che abbiano trovato un magazzino pieno di cavi. I capi li vorrebbero piazzare per costruire un sistema telefonico tra le due stazioni, o almeno una linea del telegrafo. Kirill sostiene che chiunque domani non lavori possa andare. Ci stai?” Artyom ci pensò per un momento: il destino gli stava dando l’opportunità di compiere la sua missione... Annuì in silenzio. “Fantastico!”. Zhenya era sollevato. “Allora è deciso. Kirill! Puoi iscrivere anche noi? A che ora si parte, alle nove?” Da quel momento e fino alla fine del turno Artyom non aprì bocca, non era in vena e soprattutto aveva bisogno di pensare. A Zhenya rimase l’ingrato compito di fare compagnia allo scapigliato Kirill e, ovviamente, se ne risentì. Artyom continuò a tagliare i funghi con movimenti meccanici e a ridurli in polvere; prendeva quelli secchi dal filo, li tagliava e così via.... Il viso di Hunter compariva davanti ai suoi occhi, aveva lo stesso atteggiamento di quando gli aveva detto che sarebbe potuto non tornare dalla sua missione, cioè l’espressione calma di colui che è abituato a rischiare la vita. Il suo cuore cominciò a pesare. Aveva uno strano presentimento. Dopo il lavoro Artyom tornò alla sua tenda. Il patrigno si era alzato ed era uscito a sbrigare degli affari. Il ragazzo si lasciò cadere sul letto e sprofondò il viso nel cuscino. Si addormentò all’istante, sebbene avesse deciso di dedicare un po’ di tempo a considerare tutta la situazione in pace. Dopo tutti i pensieri, le preoccupazioni e le conversazioni che aveva intrattenuto il giorno precedente, il suo sonno fu estremamente disturbato. Morfeo lo avvolse e lo trascinò in un abisso: Artyom si vide seduto vicino al fuoco alla stazione Sukharevskaya, di fianco a lui Zhenya e il mago vagabondo dall’insolito nome spagnolo, Carlos. Quest’ultimo stava insegnato a Zhenya a produrre la droga con i funghi, spiegandogli che doveva usarla proprio come facevano alla VDNKh, anche se si trattava di un crimine in piena regola, perché i funghi erano in realtà una nuova forma di vita pensante, che con il tempo avrebbero potuto sostituire gli umani; tuttavia, non erano degli esseri indipendenti, ma elementi collegati da neuroni a un’unità centrale, un fungo gigante, sparso per tutta la Metropolitana. Quindi, coloro che usavano la droga non assumevano una sostanza psicotropa, ma entravano in contatto con questa nuova forma di vita razionale. Se si eseguiva l’operazione in modo corretto, si poteva stringere amicizia con le creature, che poi avrebbero aiutato gli esseri umani collegandosi a loro attraverso la sostanza stupefacente. A quel punto comparve Sukhoi, che minacciava Artyom con il dito indice: non avrebbe mai dovuto assumere la droga, perché se ne avesse abusato il suo cervello sarebbe stato divorato dai vermi. Malgrado ciò, Artyom decise di provare, per vedere se fosse veramente così. Quindi riferì agli altri che doveva uscire a prendere una boccata d’aria e, senza farsi vedere, riuscì a intrufolarsi dietro le spalle del mago dal nome spagnolo. Proprio in quel momento, notò che la parte posteriore del cranio dell’uomo non era più visibile, mentre l’encefalo era pieno di buchi scavati dai vermi. Lunghi parassiti biancastri, attorcigliati su loro stessi, banchettavano con il cervello del mago e scavavano nuovi pertugi, mentre lui continuava a conversare come niente fosse... Artyom si spaventò a morte e decise di fuggire. Cominciò a tirare la manica di Zhenya, perché l’amico lo seguisse, ma quest’ultimo lo ignorò, dicendo a Carlos di continuare. A quel punto notò che alcuni dei vermi si stavano allontanando dal mago e cercavano di raggiungere Zhenya, arrampicandosi sulla sua schiena per raggiungere le orecchie... Così Artyom decise di scappare dalla stazione il più velocemente possibile, ma si ricordò di trovarsi nella galleria che non bisognava attraversare da soli... Si voltò e cominciò a correre nella direzione opposta, di nuovo verso la stazione. Non sapeva perché, ma non riusciva più a uscire. Improvvisamente, dietro di lui apparve una luce. Con una chiarezza e una logica del tutto inusuali per un sogno, Artyom vide la sua ombra riflessa sul suolo della galleria. Si girò e notò che dalle viscere della Metro arrivava un treno, che sfrecciava nella sua direzione, senza fermarsi. Le ruote sferragliavano ed emettevano un rumore assordante, mentre la luce lo accecava... Fu così che le sue gambe smisero di collaborare e persero tutta la loro potenza. Non erano più nemmeno delle gambe: i suoi pantaloni erano pieni di stracci. Il treno stava per raggiungerlo, quando la visione sfumò e svanì. Al suo posto apparve una nuova immagine, totalmente diversa: Artyom vide Hunter, che indossava abiti bianchi e si trovava in una stanza spoglia, dai muri chiarissimi, quasi abbaglianti. Era lì, in piedi, la testa a penzoloni, lo sguardo fisso sul pavimento. Quando alzò gli occhi, prese a fissare Artyom: era una sensazione molto strana perché in questo sogno il ragazzo non riusciva a sentire il proprio corpo, ma gli pareva di riuscire a osservare la scena simultaneamente da tutte le angolazioni. Quando Artyom cominciò a fissare Hunter a sua volta, venne pervaso da un’incomprensibile sensazione di inquietudine, l’attesa di un dettaglio importantissimo, qualcosa che poteva succedere da un momento all’altro... Hunter gli parlò e ad Artyom parve succedesse davvero. Di solito, quando aveva gli incubi, si ripeteva che stava semplicemente dormendo e che le visioni erano solo frutto della sua fervida immaginazione. Durante questo sogno, invece, la sicurezza di potersi svegliare in qualunque momento lo aveva abbandonato. L’uomo cercava di incontrare lo sguardo di Artyom; tuttavia, sembrava che Hunter non riuscisse a vederlo e che stesse andando alla cieca. Tutto d’un tratto, lento e solenne, parlò: “È giunto il momento. Devi portare a termine ciò che mi hai promesso. Devi farlo. Ma ricorda, questo non è un sogno! Non è un sogno!” Artyom spalancò gli occhi, mentre nella sua testa si riproponeva, con terrificante chiarezza, la voce burbera che pronunciava le parole: “Non è un sogno!” “Non è un sogno”, si ripeté Artyom. I vermi e il treno della prima parte dell’incubo svanirono quasi subito dalla sua memoria, mentre ricordava alla perfezione la seconda visione, in tutti i suoi particolari: lo strano abbigliamento del cacciatore, la misteriosa stanza, bianca e vuota. Poi, le sue parole: “Devi portare a termine ciò che mi hai promesso!”. Non riusciva a levarsele dalla testa. Il suo patrigno entrò nella tenda e gli chiese preoccupato: “Artyom, per caso hai visto Hunter dopo che ci siamo incontrati qui da noi? Si sta già facendo sera e lui non è ancora tornato. La sua tenda è vuota. Pensi che se ne sia andato? Ieri ti aveva parlato di quello che aveva in mente di fare?” “No, zio Sasha. Mi ha solo fatto un sacco di domande sulle condizioni della stazione e su ciò che sta accadendo”, mentì Artyom, diligente. “Sono in pensiero per lui, temo che abbia deciso di fare qualcosa di stupido e che potrebbe mettere nei guai sia lui che noi”. Sukhoi era chiaramente turbato. “Non sa con chi ha a che fare... Ehi! Tu non lavori oggi?” “Io e Zhenya ci siamo offerti di recarci alla Rizhskaya con la carovana. Questa sera li aiuteremo ad attraversare la galleria e a svolgere il cavo da laggiù”, spiegò Artyom e improvvisamente comprese che aveva appena preso la sua decisione. In quell’istante, sentì che dentro di lui era cambiato qualcosa, si sentiva più leggero, quasi vuoto, come se fosse riuscito a rimuovere il macigno che aveva nel petto e che gli impediva di respirare. “La carovana? Faresti meglio a startene a casa, piuttosto che vagabondare per le gallerie. Ci dovrei andare anche io, alla Rizhskaya, ma oggi non mi sento per niente bene. Forse un’altra volta... Tu esci ora? Partite alle nove? Beh, ci salutiamo più tardi. Nel frattempo prepara la tua roba!”, e lasciò il ragazzo da solo. Artyom cominciò a riempire lo zaino alla rinfusa, infilandoci dentro tutto ciò che gli sarebbe potuto tornare utile durante il viaggio: una piccola lampada, batterie, funghi, un pacchetto di tè, salsicce di fegato e maiale, un caricatore da mitragliatrice che aveva sottratto a qualcuno, una mappa della Metropolitana e qualche altra batteria... Inoltre, doveva ricordarsi di prendere il passaporto, che ovviamente non sarebbe stato necessario alla Rizhskaya, ma che oltre quella stazione sarebbe stato fondamentale, se non voleva essere messo in prigione o addirittura al muro dalla prima pattuglia della successiva stazione sovrana. Poi c’era la capsula che gli aveva affidato Hunter. Aveva tutto. Si mise lo zaino in spalla e diede un’occhiata alla sua casa per l’ultima volta, quindi uscì determinato. Il gruppo che avrebbe affrontato il viaggio con la carovana si era radunato sulla piattaforma all’entrata della galleria meridionale. Sui binari era già posizionato il carrello, carico di scatoloni di carne, funghi e pacchetti di tè. Sopra di essi era stato sistemato un dispositivo molto ingegnoso, assemblato dagli esperti della zona, che molto probabilmente era il telegrafo. Tra i partecipanti, a parte Kirill, c’erano due uomini: un volontario e un comandante dell’amministrazione, che avrebbe stabilito i rapporti e cercato di giungere a un accordo con gli amministratori della Rizhskaya. Era già tutto pronto e, mentre attendevano il segnale di via libera, giocavano a domino. Le mitragliatrici che gli erano state assegnate per il viaggio erano impilate di fianco a loro, a formare una piramide, le canne rivolte verso l’alto e i caricatori di scorta fissati alle basi con del nastro isolante blu. Finalmente arrivò anche Zhenya, che prima di uscire aveva dovuto dare da mangiare alla sorellina e mandarla dai vicini, poiché i suoi genitori erano ancora al lavoro. All’ultimo secondo, Artyom si ricordò di non aver salutato il patrigno. Si scusò con gli altri e promise di essere subito di ritorno; abbandonò a terra lo zaino e corse a casa. La tenda era deserta, quindi decise di recarsi nella zona in cui un tempo si ritrovava il personale di servizio, dove oggi si riunivano gli amministratori della stazione. Sukhoi era lì, seduto di fronte all’ufficiale capo della VDNKh. Stavano avendo una discussione animata. Artyom bussò sullo stipite della porta e tossì quasi impercettibilmente. “Salve, Alexander Nikolaevich. Potrei parlare un momento con zio Sasha?” “Ma certo, Artyom, entra pure. Un po’ di tè?”, l’ufficiale capo fu ospitale. “Stai già partendo? Quando torni?”, chiese Sukhoi, allontanando la sua sedia dal tavolo. “Non saprei con esattezza...”, borbottò il ragazzo. “Vedremo come va...” Così comprese che quella poteva essere l’ultima volta che vedeva l’adorato patrigno. Non voleva mentire a colui che ricambiava il suo affetto in maniera del tutto disinteressata, non voleva promettergli che sarebbe tornato il giorno successivo o quello dopo ancora, e che tutto sarebbe stato come prima. All’improvviso Artyom sentì bruciare gli occhi e, imbarazzato, notò che erano umidi. Fece un passo avanti e abbracciò il suo patrigno. “Forza... forza, Artyom... Che succede? Dopotutto sarai di ritorno già domani. Beh...?”, sorpreso, il patrigno cercò di rassicurarlo. “Domani sera, se tutto va come dovrebbe”, confermò Alexander Nikolaevich. “Abbi cura di te, zio Sasha! Buona fortuna!”, gli augurò Artyom con voce rauca, dandogli la mano. In un attimo, uscì dalla stanza, mentre Sukhoi lo osservava, attonito. “Che gli è successo? Non è la sua prima volta alla Rizhskaya...” “Non è niente, Sasha, il tuo ragazzo ben presto crescerà. E tu rimpiangerai momenti come questo, in cui ti saluta in lacrime, anche se sta andando solo a due stazioni di distanza! Che stavi dicendo dell’opinione dell’Alekseevskaya riguardo le pattuglie nelle gallerie? Ci sarebbero molto utili...” Quando Artyom raggiunse nuovamente il gruppo, il comandante assegnò una mitragliatrice a ciascuno dei componenti e si informò: “Uomini, siete pronti? Ci sediamo un momento prima di partire?”, e così dicendo si accomodò su una delle vecchie panchine di legno. Gli altri seguirono il suo esempio in silenzio. “Che Dio sia con noi!” Il comandante si alzò e saltò giù, sui binari, prendendo il suo posto in testa alla spedizione. Artyom e Zhenya, i due più giovani del gruppo, si arrampicarono sul carrello e si prepararono per il lavoro più duro. Kirill e il secondo volontario presero posto dietro di loro, completando la catena. “Andiamo!”, urlò il comandante. Artyom e Zhenya cominciarono a fare forza sulle leve, mentre Kirill spingeva da dietro il carrello, che dapprima cigolò, scattò in avanti e poi pian piano scivolò sulle rotaie; gli ultimi due uomini gli camminavano dietro. Fu così che il gruppo scomparve nella bocca della galleria meridionale. CAPITOLO 4 : LA VOCE NELLE GALLERIE La luce inattendibile della lanterna nelle mani del comandante vagava sui muri della galleria, sfiorando il terreno umido e scomparendo completamente quando veniva puntata lontano. Davanti a loro l’oscurità era totale e, già a una decina di passi dagli uomini, divorava avida i deboli raggi delle minuscole torce. Le ruote del carrello cigolavano, emettendo un rumore lamentoso e malinconico; scivolavano verso il nulla, mentre il respiro e i passi ritmici degli scarponi di coloro che camminavano nelle retrovie inframmezzavano il silenzio. Ormai avevano superato gli sbarramenti meridionali, la luce tremolante dei loro fuochi da campo era già svanita da tempo. Avevano oltrepassato il confine del territorio della VDNKh. Il viaggio fino alla Rizhskaya era considerato sicuro, dati i buoni rapporti tra le stazioni e il considerevole scambio di merci e persone tra le due, tuttavia la carovana doveva stare all’erta. Il pericolo non giungeva semplicemente da nord o da sud, cioè dalle due direzioni della galleria, ma poteva anche nascondersi sopra, nei condotti di ventilazione, oppure di lato, nelle molteplici diramazioni al di là delle porte sigillate di quelle che erano state stanze di servizio o uscite segrete; o ancora poteva brulicare sotto le suole degli uomini, nelle botole misteriose, lasciate da coloro che costruirono la Metro, dimenticate e trascurate dagli operai che effettuavano la manutenzione quando la Metropolitana era ancora un semplice mezzo di trasporto. Laggiù, nelle profondità, si nascondevano creature terribili, che avrebbero potuto stringere in una morsa di orrore irrazionale la mente del più sconsiderato temerario che osasse addentrarvisi. Era proprio per questo motivo che la lanterna del comandante scandagliava i muri della galleria, mentre gli uomini tenevano il dito pronto a sbloccare la sicura della loro mitragliatrice, per premere subito il grilletto. Perciò erano poco loquaci; se avessero chiacchierato durante la camminata, avrebbero potuto sentire molto meno distintamente tutti i rumori prodotti dalla galleria. Artyom si sentiva già esausto. Alzava e abbassava la leva che, spostandosi, produceva uno stridio monotono e trasmetteva sempre lo stesso movimento alle ruote. Guardava davanti a sé, ma non vedeva nulla; gli girava la testa, in maniera greve, quasi isterica, a causa del moto del carrello e allo stesso tempo gli si riproponevano le ultime frasi pronunciate da Hunter prima di partire, quelle sul potere dell’oscurità, la forma di governo più diffusa in tutta la Metropolitana di Mosca. Cercò di pensare a come sarebbe riuscito a raggiungere la Polis, progettava un piano, ma il dolore bruciante e la fatica gli avvampavano i muscoli, salivano dalle gambe leggermente piegate, fino al centro della schiena e nelle braccia. Così, tutti pensieri più complicati venivano direttamente estromessi dal suo cervello. Il sudore, caldo e salato, gli gocciolava dalla fronte, dapprima lento, in piccole perle che poi diventarono più pesanti e cominciarono a scendergli sul viso, a finirgli negli occhi... Non poteva nemmeno asciugarsi perché Zhenya si trovava dall’altra parte del meccanismo e se Artyom avesse mollato la leva, l’amico avrebbe dovuto fare il doppio della fatica. Sentiva il sangue pulsare forte nelle orecchie; questo particolare gli ricordò la sua infanzia: quando era bambino adorava mettersi in una posizione poco confortevole proprio per sentire il battito forte e chiaro che gli ricordava i passi dei soldati in parata. Se chiudeva gli occhi, riusciva a immaginare di essere un maresciallo che conduceva la marcia; le fedeli divisioni lo superavano, misuravano il suo passo e lo salutavano. Per lo meno, questa era la scena descritta nei libri sull’esercito. Alla fine, senza girarsi il comandante urlò: “Ok, ragazzi, scendete e fate cambio. Siamo a metà strada”. Artyom scambiò uno sguardo d’intesa con Zhenya, saltò giù dal carrello ed entrambi, senza aprire bocca, si sedettero sui binari, anche se sarebbero dovuti rimanere dietro al carrello. Il comandante li guardò e li rimbrottò comprensivo: “Femminucce...” “È vero...”, ammise pronto Zhenya. “Alzatevi, forza. Non possiamo stare qui a girarci i pollici. È ora di andare. Vi racconterò una storia interessante”. “Anche noi possiamo raccontarle qualche storiella!”, ribatté Zhenya sicuro di sé; non ne voleva sapere di alzarsi. “Conosco a memoria le vostre fandonie: i Tetri, i mutanti e, naturalmente, i vostri amati funghetti. Ma io ne conosco alcune che voi non avete mai sentito. Avete capito bene! È molto probabile che non siano delle storielle, solo che non c’è nessuno in grado di confermarle, cioè qualcuno ha cercato di attestare la loro veridicità, ma non ci è riuscito”. Ad Artyom queste poche parole erano state sufficienti per trovare nuovo slancio. Ora, qualsiasi nuova informazione su ciò che accadeva al di là della Prospekt Mira poteva essere di vitale importanza. Si rialzò in piedi e, spostando la mitragliatrice dalla schiena al petto, prese il suo posto dietro al carrello. Con una spinta, le ruote ripresero a cantare la loro nenia, mentre il gruppo continuava la sua marcia. Il comandante scrutava lo spazio davanti a sé, tendendo al massimo l’orecchio in direzione dell’oscurità. “Ma ditemi, la vostra generazione cosa ne pensa della Metro? È una domanda che mi sono sempre posto...”, si informò il comandante. “Vi raccontate delle storie balzane: conosco uno che è andato laggiù, un altro che si è inventato un’avventura... Uno racconta un fatto in maniera errata e chi lo ascolta lo racconta a una terza persona che, a sua volta, infarcisce la storia di qualche dettaglio. Poi quest’ultima la racconta a una quarta, davanti a una tazza di tè fumante, e questa poi finge che le sia capitata personalmente. Questo è il problema principale della Metropolitana: non ci sono mezzi di comunicazione affidabili; inoltre, non ci è possibile arrivare velocemente da un punto a un altro. In alcuni luoghi non si può passare, altri sono suddivisi a causa dei tumulti... insomma, le condizioni mutano quotidianamente. Pensate che la Metropolitana sia enorme? Beh, sappiate che in treno si potrebbe percorrere l’intera rete da una parte all’altra in una sola ora. Adesso, invece, ci vogliono settimane, sempre che ci si riesca, perché non si sa mai cosa vi sia dietro la curva successiva... Siamo partiti per la Rizhskaya con degli aiuti umanitari... ma il problema maggiore è che nessuno, né io e nemmeno l’ufficiale capo, può mettere la mano sul fuoco e garantire che quando arriveremo laggiù non verremo accolti da una scarica di mitra, o che non troveremo la stazione distrutta da un incendio, senza più anima viva. O che improvvisamente la Rizhskaya abbia deciso di non allearsi all’Hansa, il che significherebbe rimanere isolati per sempre dal resto della Metropolitana. Non abbiamo informazioni esatte... Se riceviamo delle notizie oggi, sappiamo che entro sera saranno già superate e il giorno successivo non saranno più affidabili. È come attraversare le sabbie mobili con una mappa di cent’anni fa. I messi impiegano troppo tempo a recapitare i messaggi e alle volte, quando l’informazione giunge a destinazione, non è più necessaria o è ormai obsoleta, pertanto la verità viene distorta. La gente non ha mai vissuto in condizioni del genere e fa paura pensare a cosa succederà quando non ci sarà più carburante per i generatori o quando rimarremo senza elettricità. Avete letto La macchina del tempo di Wells? Beh, in quel romanzo c’erano i Morlock...” Negli ultimi due giorni era già la seconda volta che Artyom li sentiva nominare: conosceva già i Morlock di Herbert Wells e non voleva riascoltare la storia daccapo. Perciò, ignorando le proteste di Zhenya, fece in modo che la conversazione riprendesse la piega originaria. “Beh, e invece la sua generazione cosa pensa della Metropolitana?” “Fammi pensare... Se vi racconto dei demoni nelle gallerie potrebbe portarci sfortuna, così come della Metro-2 e degli Osservatori invisibili... Io sinceramente non me la sento. Ma posso rivelarvi qualcosa di interessante sul luogo in cui risiedono taluni individui... Ad esempio, dove una volta c’era la stazione Pushkinskaya, proprio nel punto in cui ci sono altri due passaggi pedonali verso la Chekhovskaya e la Tverskaya... Beh, ora quel posto è in mano ai fascisti”. “Fascisti...?”, esitò Zhenya. “Fascisti veri e propri. Molto tempo fa, quando ancora vivevamo lassù”, il comandante puntò il dito verso il soffitto, “c’erano i fascisti. Ma c’erano anche gli skinhead, che appartenevano a un’organizzazione da loro denominata RNE, e altri che si dichiaravano contro l’immigrazione. Ce n’erano di tutti i tipi, sembrava che andasse di moda. Chissà che diamine significava quell’acronimo, nessuno se lo ricorda e secondo me anche gli ex affiliati se ne sono dimenticati. Sembrava fossero scomparsi, non si sentì più parlare di loro, finché all’improvviso qualche tempo fa sono ricomparsi: ‘La Metro è per i soli russi!’, ne avete mai sentito parlare? Oppure: ‘Una buona azione? Pulizia razziale nella Metropolitana!’. Espulsero tutti gli stranieri dalla Pushkinskaya, dalla Chekhovskaya e anche dalla Tverskaya. Qualche tempo dopo si fecero ancora più violenti e cominciarono a punire la gente. Ora la loro forma di governo è il Reich, il quarto, o il quinto... non ricordo con precisione. Non si sono ancora espansi oltre, ma la nostra generazione ricorda ancora il ventesimo secolo e i fascisti... I mutanti della linea Filevskaya esistono davvero; anche i nostri Tetri sono una presenza tangibile. Poi ci sono quelli che appartengono alle sette, i satanisti, i comunisti... Insomma, è come un circo. Ecco cos’è la Metropolitana.” Superarono la porta divelta che conduceva a un ufficio amministrativo abbandonato, o forse era stata una toilette o ancor prima un rifugio... Probabilmente era stato pieno di mobili, ma rimanevano solo dei letti a castello in ferro e un impianto idraulico grezzo. Tutto il resto era stato rubato da tempo e oggi nessuno cercava di entrare in quelle oscure stanze vuote, sparse per tutta la Metro. Tanto non c’era niente da trovare, o meglio... non si poteva mai sapere! Davanti a loro, ecco una debole luce traballante: stavano giungendo in prossimità dell’Alekseevskaya. La stazione non era molto popolata e le pattuglie erano formate da una sola persona, che stava di guardia al cinquantesimo metro, perché non poteva permettersi di appostarsi oltre. Il comandante impartì agli uomini l’ordine di fermarsi a quaranta metri dal fuoco della pattuglia dell’Alekseevskaya; accese e spense la sua torcia diverse volte, secondo una precisa sequenza, dando così il segnale alla sentinella. Una sagoma nera si delineò alla luce delle fiamme: il pattugliatore si era incamminato nella loro direzione e, da lontano, intimò: “Fermi! Non avvicinatevi!” Artyom si domandò se fosse possibile che da un giorno all’altro non si venisse riconosciuti all’arrivo in una stazione con la quale si credeva di intrattenere rapporti amichevoli... Anche loro avrebbero potuto essere accolti con ostilità? La guardia si avvicinava lentamente; indossava un paio di pantaloni militari consunti e una giacca imbottita, sulla quale si riconosceva chiaramente una lettera “A”, sicuramente il simbolo della stazione, dall’iniziale del suo nome. L’uomo aveva le guance scavate e il viso non rasato; dagli occhi trapelava il sospetto, mentre le mani nervose si muovevano sulla mitragliatrice automatica, che teneva appesa al collo. Guardò i visi dei componenti della carovana e sorrise: li aveva riconosciuti. Con un cenno gli fece capire che si fidava, poi spostò l’arma sulla schiena. “Ragazzi! Come state? Siete diretti alla Rizhskaya? Lo sappiamo, ci hanno avvisati. Forza, andiamo!” Il comandante cominciò a interrogare il pattugliatore con voce bassa, quasi impercettibile, quindi Artyom, sperando di non essere sentito a sua volta, si mise a parlare con Zhenya: “Ha un aspetto stanco, come se lavorasse troppo, ed è malnutrito. Penso che vogliano allearsi a noi solo perché le loro condizioni di vita sono pessime”. “E allora?”, rispose l’amico. “Anche noi abbiamo il nostro tornaconto. Se la nostra amministrazione ha deciso che dobbiamo unire le forze, ha le proprie motivazioni. Non lo facciamo perché siamo caritatevoli e vogliamo dar loro di che nutrirsi”. Superarono il fuoco da campo del cinquantesimo metro, dove trovarono la seconda sentinella, che portava abiti identici a quelli dell’uomo precedente. Il carrello continuava il suo viaggio verso la stazione. L’Alekseevskaya era mal illuminata: la gente che ci viveva aveva un aspetto triste e pareva che non avesse nulla di importante da comunicare. Alla VDNKh, invece, gli ospiti venivano sempre trattati con la massima cordialità. Il gruppo si fermò nel mezzo della piattaforma; a quel punto il comandante annunciò che era venuto il momento di una pausa sigaretta. Artyom e Zhenya dovevano rimanere seduti sul carrello per proteggerlo, mentre gli altri si ritrovarono attorno al fuoco. “Non avevo mai sentito parlare dei fascisti e del Reich”, Artyom intavolò la conversazione. “Io invece sapevo che erano da qualche parte”, ribatté Zhenya. “A me però era stato riferito che si trovavano alla Novokuznetskaya”. “Chi te ne aveva parlato?” “Lekha”, ammise Zhenya restio. “Beh, ti ha raccontato anche moltissime altre cose interessanti”, gli ricordò ironico Artyom. “Ma i fascisti ci sono davvero! Solo che Lekha ha sbagliato il nome della stazione. Non stava mentendo, capito?!”. Zhenya era sulla difensiva. Artyom non aggiunse altro e rimase assorto nei suoi pensieri. La pausa sigaretta all’Alekseevskaya non sarebbe durata meno di mezz’ora; il comandante stava discorrendo con il capo della zona, molto probabilmente riguardo la futura collaborazione. Dopodiché avrebbero proseguito il viaggio e cercato di arrivare a destinazione, alla Rizhkaya, entro fine giornata. Avrebbero passato la notte laggiù, discusso di ciò che si doveva decidere e dato un’occhiata al cavo scoperto di recente. Quindi, avrebbero inviato un messaggero per ricevere istruzioni. Se avessero potuto usare davvero questo cavo per istituire un sistema di comunicazione tra le tre stazioni, avrebbero cominciato a posarlo e a utilizzarlo per le connessioni telefoniche. Ma se fosse stato inservibile sarebbero dovuti tornare dritti alla loro stazione. Pertanto Artyom aveva a disposizione un massimo di due giorni. In questo periodo di tempo avrebbe dovuto trovare un pretesto per riuscire a superare gli sbarramenti esterni della Rizhskaya, dove le sentinelle erano ancora più sospettose e pedanti delle pattuglie esterne della VDNKh. Questa mancanza di fiducia nel prossimo era comprensibile: la loro stazione si trovava a sud, dove cominciava la parte più estesa della Metropolitana, perciò lo sbarramento meridionale della Rizhskaya rimaneva spesso vittima di attacchi. Sebbene i pericoli che incombevano sulla popolazione della Rizhskaya non fossero misteriosi e terrificanti quanto quelli che minacciavano la VDNKh, i primi erano costantemente diversi. I combattenti che difendevano la zona d’accesso alla Rizhskaya non potevano mai sapere cosa aspettarsi, quindi dovevano essere pronti a tutto. Due gallerie conducono dalla Rizhskaya alla Prospekt Mira. Per qualche motivo non era stato possibile farne crollare una, quindi gli abitanti della Rizhskaya avevano dovuto collocare posti di blocco in entrambi i tunnel. Questa strategia costò molto cara ai loro uomini; per questo motivo avevano deciso di trovare a tutti i costi una soluzione di stabilità, almeno per la galleria settentrionale. Così avevano pensato di allearsi con l’Alekseevskaya e soprattutto con la VDNKh, affidandogli l’onere di difendere quella zona. In questo modo la galleria viveva un periodo estremamente pacifico, mentre gli uomini si potevano concentrare sulle faccende interne alla loro stazione. Inoltre, alla VDNKh, la consideravano una possibilità per ampliare la loro sfera d’influenza. Alla luce dell’imminente accordo, agli avamposti della Rizhskaya avevano aumentato il numero dei pattugliatori: era necessario dare prova ai futuri alleati che potevano contare su di loro per difendere i confini meridionali. Perciò ad Artyom sembrava estremamente difficoltoso superare gli sbarramenti in entrambe le direzioni. Aveva ancora due giorni per capire come fare. Nonostante le difficoltà, non gli sembrava impossibile. Forse, era quasi più importante capire cosa avrebbe dovuto fare dopo. Anche se fosse riuscito ad attraversare gli avamposti meridionali, in seguito avrebbe dovuto scoprire un itinerario abbastanza sicuro per arrivare alla Polis. Visto che, quando ancora si trovava alla VDNKh, aveva dovuto decidere velocemente, non aveva avuto tempo di pianificare come sarebbe effettivamente giunto a destinazione. Se fosse stato a casa, avrebbe potuto chiedere consiglio ai commercianti di sua conoscenza, senza destare in loro particolari sospetti. Al contrario, sapeva che se avesse chiesto a Zhenya o a qualsiasi altro membro della carovana di indicargli la strada per raggiungere la Polis, avrebbero capito che stava progettando qualcosa di losco. In particolar modo Zhenya ci sarebbe subito arrivato. Non aveva amici all’Alekseevskaya o alla Rizhskaya e non poteva fidarsi di semplici conoscenze. Zhenya stava chiacchierando con una ragazza seduta sulla piattaforma poco lontano e Artyom ne approfittò per controllare furtivamente la minuscola cartina della Metropolitana che aveva nascosto nello zaino. La mappa era stampata sul retro di un bigliettino dagli angoli bruciacchiati che pubblicizzava una fiera, terminata ormai molto tempo prima. Evidenziò la Polis cerchiandola più volte con una matita. La strada per raggiungere la Polis sembrava semplice e breve. Il passato, quel periodo mitico di cui aveva raccontato il comandante... Quando la gente non doveva girare armata e viaggiava da una stazione all’altra anche se doveva cambiare treno e prendere un’altra linea; quando per andare da una parte all’altra della Metropolitana ci si impiegava circa un’ora; quando nelle gallerie vivevano solamente i treni sferraglianti e frettolosi... Allora il percorso dalla VDNKh alla Polis sarebbe stato facile e veloce. Si trovava sulla linea verso la Turgenevskaya e da quel punto c’era una galleria pedonale fino alla Chistye Prudy, come veniva chiamata sull’antica mappa che Artyom stava esaminando con attenzione. Oppure avrebbe potuto prendere la linea Kirovskaya, poi la linea Rossa, la Sokolnicheskaya, e arrivare direttamente alla Polis... Nell’era dei treni e delle luci fluorescenti ci avrebbe impiegato circa mezz’ora. Ma da quando quella linea era stata denominata “Rossa”, con la lettera maiuscola, e il cartello di cotone stampato in rosso era stato appeso all’entrata della galleria pedonale che portava alla Chistye Prudy, prendere la scorciatoia per arrivare alla Polis era fuori discussione. L’amministrazione della linea Rossa aveva desistito: non tentava più di imporre il potere sovietico su tutta la popolazione della Metropolitana; al contrario stava attuando la nuova teoria secondo la quale il comunismo poteva essere istituito su una linea separata. Sebbene l’iniziale sogno non si fosse avverato, avevano continuato a chiamarla “Metropolitana Vladimir Lenin” e per molto tempo non erano riusciti a fare alcun passo in avanti verso la realizzazione del loro grande progetto. Anche se il regime aveva assunto una condotta apparentemente pacifica, la sua fissazione intrinseca non era mutata. Proprio come nel passato, centinaia di zelanti agenti del servizio di sicurezza interno, che provavano di sicuro una certa nostalgia per il KGB, controllavano costantemente gli abitanti della linea Rossa. Allo stesso modo, il loro interesse per gli ospiti provenienti dalle altre linee era perenne. Senza il permesso speciale della direzione dei “Rossi” nessuno poteva recarsi in una delle altre stazioni. Inoltre, sia i malcapitati viaggiatori che le spie dovevano subire il continuo monitoraggio dei passaporti, i controlli e il generalizzato sospetto cronico. Sia i primi che i secondi venivano trattati nella medesima maniera e il destino di entrambi era ugualmente triste. Artyom non poteva nemmeno permettersi di pensare di giungere alla Polis attraversando le tre stazioni di proprietà delle linea Rossa. In generale, al centro della Metro, non esisteva un percorso semplice. Soprattutto se si doveva raggiungere la Polis... Se questo nome veniva menzionato durante una conversazione, sia Artyom che la maggior parte delle altre persone rispettavano un silenzio riverente. Persino in quel momento ricordava con chiarezza la prima volta che l’aveva udito nel contesto di una storia raccontata da uno degli amici del patrigno. Quando il loro ospite se n’era andato, il ragazzo aveva domandato timidamente a Sukhoi cosa significasse quella parola. Il patrigno lo aveva guardato dritto negli occhi e con un vago senso di tristezza nella voce aveva risposto: “Artyom, quello è probabilmente l’ultimo luogo sulla terra in cui gli uomini vivono come tali, dove non hanno dimenticato il significato della parola ‘persona’ e soprattutto il suono che essa deve avere”; quindi aveva sorriso malinconico e aveva aggiunto: “Quella è una vera città”. Polis si trovava in prossimità dell’incrocio di quattro linee della Metro ed occupava, da sola, quattro stazioni: Giardini di Alessandro, Arbatskaya, Borovitskaya e Biblioteca Lenin . Su quella zona tanto estesa si era insediata l’ultimo vero baluardo della civiltà, l’ultimo luogo in cui si trovava una popolazione così vasta che quando gli abitanti delle provincie vi capitavano non potevano fare a meno di chiamarla città. In più, anche il suo nome aveva lo stesso significato: Polis. Questa parola aveva un suono poco familiare, in essa riecheggiavano il potere e la meraviglia di una cultura antica, che sembrava proteggere l’intero insediamento. Forse era proprio per questo che il nome aveva un particolare ascendente su tutti. Il fenomeno della Polis non venne mai imitato nel resto della Metro. Laggiù ci si poteva ancora imbattere nei detentori di una conoscenza antica e bizzarra, che in questo nuovo mondo tanto violento, dove le leggi stavano scomparendo, non poteva essere trovata in nessun altro luogo. Per gli abitanti di quasi tutte le altre stazioni e praticamente per tutto il resto della Metro, il sapere e i suoi fautori stavano affondando con lentezza in un abisso di caos e ignoranza, stavano diventando inutili. Gli intellettuali arrivavano da ogni dove e potevano trovare rifugio solo alla Polis, dove venivano accolti a braccia aperte, perché laggiù governavano ancora persone identiche a loro. Per questo motivo alla Polis, e in nessun altro luogo, si potevano incontrare professori decrepiti che in un particolare momento della loro vita avevano lavorato nei dipartimenti delle università più famose, ormai vuote, ridotte in macerie e popolate solo dai ratti e dalla muffa. Laggiù vivevano anche gli ultimi artisti: attori, poeti, fisici, chimici, biologi... coloro che conservavano nelle loro menti le più grandi scoperte dell’uomo e migliaia di anni di storia. Ma purtroppo, alla loro morte, tutta questa ricchezza sarebbe andata perduta. La Polis si trovava in corrispondenza di quello che era il centro della città in superficie. Sopra di essa si ergeva la Biblioteca Lenin, cioè la più grande fonte di informazioni su tutte le ere storiche. Vi venivano custoditi centinaia di migliaia di libri in decine di lingue diverse, che trattavano tutte le aree dello scibile umano: centinaia di tonnellate di carta su cui erano stati stampati simboli, lettere e caratteri di ogni genere, alcuni dei quali non venivano più compresi perché la lingua che comunicavano era morta assieme alle ultime persone che la parlavano. Ma quell’immensa collezione di libri avrebbe potuto essere letta e compresa, poiché gli scrittori morti centinaia di anni prima avevano ancora moltissime cose da insegnare ai vivi. Di tutte le confederazioni, gli imperi e le stazioni più potenti che avevano i mezzi per organizzare delle spedizioni in superficie, solo la Polis inviava i propri stalker per trovare dei libri. Era l’unico luogo in cui si attribuiva alla conoscenza un valore talmente importante che gli abitanti erano pronti a rischiare le vite dei loro volontari solo per i libri; pagavano ingenti somme di denaro a coloro che venivano assunti per queste imprese. In poche parole, davano maggiore importanza alla ricchezza spirituale piuttosto che a quella materiale. E, sebbene l’amministrazione dimostrasse di scarseggiare di pragmatismo per eccedere con l’idealismo, la Polis continuava ad essere molto forte e, anno dopo anno, nessun problema era riuscito a intaccarla. Se un pericolo la minacciava, l’intera Metropolitana era pronta a concorrere alla sua protezione. L’eco della ben nota ultima battaglia, che si svolse in quei luoghi tra la linea Rossa e l’Hansa, si era spenta, lasciando solo una prodigiosa aura di invulnerabilità e di benessere, che avvolgeva completamente la Polis. Il pensiero di Artyom si soffermò su questa magnifica città e in quel momento non gli sembrò per nulla strano che il viaggio per raggiungere un luogo del genere sarebbe stato complicato. Si sarebbe sicuramente perso, avrebbe dovuto affrontare pericoli e prove di forza, altrimenti lo scopo stesso di questa spedizione avrebbe perso tutto il suo fascino. Se il percorso che attraversava la Kirovskaya lungo la linea Rossa e verso la Biblioteca Lenin pareva impenetrabile e fin troppo rischioso, avrebbe dovuto provare a superare le pattuglie dell’Hansa, seguendo l’Anello. Artyom osservò meglio la mappa bruciacchiata: se fosse riuscito a passare attraverso il territorio dell’Hansa, creando una sorta di diversivo, parlando con le guardie dello sbarramento, combattendo o infiltrandosi con altri mezzi, allora avrebbe raggiunto la Polis abbastanza velocemente. Artyom seguì con il dito le linee sulla mappa: se fosse partito dalla Prospekt Mira in direzione dell’Anello e avesse attraversato le due stazioni dell’Hansa, sarebbe sbucato alla Kurskaya. A quel punto avrebbe potuto prendere la linea Arbatsko-Pokrovsky e da lì sarebbe potuto giungere alla Arbatskaya. Sarebbe arrivato quasi alla Polis. A intralciare il cammino c’era la Piazza della Rivoluzione, che dopo la guerra era passata alla linea Rossa in cambio della Biblioteca Lenin. Tuttavia, i Rossi garantivano il permesso di passaggio a tutti i viaggiatori, poiché questa era stata una delle condizioni basilari per la firma dell’accordo di pace. Dato che Artyom non aveva intenzione di rimanere in quella stazione ma voleva semplicemente attraversarla, in teoria non avrebbe avuto grossi problemi. Ci rifletté per un po’, quindi decise di attenersi a quel piano e di definire i dettagli man mano che si avvicinava alle diverse stazioni. Inoltre, valutò che se qualcosa non avesse funzionato, avrebbe sempre potuto trovare una via alternativa. Osservando le linee che si intrecciavano tra i numerosissimi passaggi, Artyom considerò che il comandante avesse un po’ esagerato nel descrivere le difficoltà in cui si poteva incorrere durante i viaggi nella Metropolitana, anche quelli più brevi. In effetti, si poteva giungere alla Prospekt Mira non solo dalla destra, ma anche dalla sinistra. Artyom toccò la mappa in corrispondenza dell’Anello: arrivati alla Kievskaya, esisteva la possibilità di percorrere il passaggio pedonale fino alla linea Filevskaya o alla Arbatsko-Pokrovsky e da lì sarebbe stato solo a due stazioni di distanza dalla Polis. Non gli sembrava più impossibile. Dalla mappa era riuscito ad attingere un po’ di sicurezza, ora sapeva come agire. Era sicuro che, quando la carovana fosse giunta alla Rizhskaya, lui non sarebbe tornato alla VDNKh insieme al gruppo, ma avrebbe continuato il suo viaggio fino alla Polis. “Stai studiando?”, era arrivato Zhenya senza che Artyom se ne accorgesse. Quest’ultimo quasi si spaventò e, confuso, cercò di nascondere la mappa. “Sì, no... io... volevo individuare sulla mappa la stazione del Reich, quella di cui ha parlato prima il comandante”. “E l’hai trovata? No? Forza, lascia che te la mostri io”, si vantò Zhenya con un vago senso di superiorità; riusciva a orientarsi nella Metropolitana meglio di Artyom e di molti altri loro contemporanei, e ne andava fiero. Con il dito, indicò subito il triangolo disegnato dalla Chekhovskaya, dalla Pushkinskaya e della Tverskaya, senza confondersi. Artyom fece un sospiro di sollievo, ma l’amico credette che fosse verde d’invidia, perciò decise di consolarlo: “Non ti preoccupare, un giorno diventerai anche tu bravo come me”. Artyom simulò un’espressione grata e cambiò velocemente discorso. “Per quanto ancora ci fermeremo qui?”, domandò. “Ragazzi! Ce ne andiamo!”, risuonò la voce da basso del comandante e Artyom comprese che, per il resto del viaggio, non avrebbe più potuto riposarsi. Non era ancora riuscito a mangiare niente. Al carrello, era di nuovo il turno di Artyom e Zhenya. Le leve cominciarono a gracidare, mentre gli scarponi degli altri uomini contro il cemento emettevano un fragore assordante. La galleria si estendeva di nuovo di fronte a loro. Questa volta il gruppo si spostava in silenzio; parlava solo il comandante. Aveva chiamato Kirill vicino a lui e stavano discutendo di qualcosa a bassa voce. Artyom non aveva né la forza né il desiderio di sapere cosa si stavano dicendo; tutte le sue energie erano assorbite da quel dannato carrello. Era palese che l’uomo dietro di loro, rimasto solo, si sentisse a disagio: continuava a guadarsi timidamente alle spalle. Artyom, dal carrello, riusciva a guardarlo in faccia e vedeva anche che dietro l’uomo non c’era proprio nulla di cui essere spaventati. Tuttavia, anche lui si sentiva rassicurato quando si guardava alle spalle. Questa paura mista a sfiducia lo seguiva ovunque andasse, ma sapeva che non era il solo a esserne perseguitato. Qualsiasi viaggiatore che avesse percorso da solo una galleria sapeva cosa significava; gli avevano persino dato un nome: “tunnel-fobia” che si verificava nel momento in cui ci si trovava in una galleria, specialmente nel caso in cui non si fosse forniti di un’illuminazione adeguata. Pareva che il pericolo fosse sempre alle spalle. Di tanto in tanto, questa sensazione si acutizzava al punto che ci si sentiva addirittura lo sguardo di qualcuno sulla nuca, non proprio uno sguardo... chissà chi o cosa diavolo fosse e soprattutto come riusciva a percepire il mondo. Delle volte questa impressione era talmente oppressiva che non si riusciva a sopportarla, ci si voltava come delle schegge, puntando la torcia verso l’oscurità, per scoprire che non c’era proprio nulla... Il silenzio... il vuoto... era tutto tranquillo. Ma nel momento in cui ci si guardava le spalle e ci si sforzava di vedere nell’oscurità finché gli occhi non dolevano, quella stessa oscurità attaccava dall’altra parte e ci si voleva lanciare nella direzione opposta, illuminando la galleria di fronte a sé. C’era qualcuno laggiù? Qualcuno era riuscito a sottrarci qualcosa mentre guardavamo nell’altra direzione? E via così, all’infinito... L’importante era non perdere il controllo, non lasciarsi sopraffare dalla paura, convincersi che fossero tutte fandonie e che non vi fosse nulla da temere, che il rumore che si era sentito era soltanto frutto della nostra immaginazione. Ma era difficile controllarsi, specialmente quando si era da soli. In molti erano impazziti: non riuscivano più a calmarsi, nemmeno quando raggiungevano le stazioni abitate. Ovviamente, dopo un po’, riuscivano a tornare in loro, ma a quel punto non potevano più camminare nella galleria o sarebbero stati sorpresi di nuovo da quella sensazione d’allarme che tutti gli abitanti della Metro ben conoscevano e che si poteva trasformare in una dannosa illusione. “Non preoccuparti, guardo io!”. Artyom rassicurò l’uomo e lui annuì, ma dopo un paio di minuti si voltò di nuovo... proprio non riusciva a farne a meno! Com’era difficile... “Un tizio che conosco ha perso qualche rotella per lo stesso motivo”, Zhenya pronunciò le parole a voce bassa; sapeva perfettamente perché Artyom aveva urlato quella frase all’uomo. “A dire la verità, aveva le sue buone ragioni. Aveva deciso di percorrere da solo la galleria alla Sukharevskaya, ricordi quella di cui ti parlavo? In cui non devi mai essere da solo, ma con una carovana. Ebbene, quel tizio è riuscito a sopravvivere. E sai perché?”, Zhenya sorrise con aria compiaciuta. “Non è mai riuscito a superare il centoottantanovesimo metro, non ne aveva il coraggio. All’imbocco della galleria aveva un’aria risoluta... Ah! Dopo venti minuti ritornò indietro, gli occhi sgranati, i capelli ritti sulla testa, non riusciva più a pronunciare una parola comprensibile. Gli altri non riuscirono a scoprire cosa gli successe e da allora lui ha continuato a blaterare parole senza senso, che per lo più sembrano dei muggiti. Inoltre, non ha mai più messo piede in una galleria, se ne sta alla Sukharevskaya a mendicare. È diventato lo scemo del villaggio. Hai capito la morale della storia?” “Sì...”, rispose Artyom incerto. Il gruppo avanzava nel silenzio più totale. Artyom si perse nuovamente nei suoi pensieri e vi rimase per un po’, cercando di escogitare qualcosa di plausibile da dire allo sbarramento in uscita dalla Rizhskaya. Procedettero tranquillamente finché, dopo poco, Artyom udì un rumore strano che si faceva sempre più forte: proveniva dalla galleria davanti a loro. All’inizio era quasi inudibile, poteva essere simile a un ultrasuono, ma poi gradualmente e senza che il ragazzo se ne accorgesse, era diventato più intenso, sebbene non si riuscisse a ricordare con precisione il momento in cui lo si era sentito per la prima volta. Più che altro si ricordava un fischio, indecifrabile e disumano. Artyom scrutò velocemente i visi degli altri: si muovevano tutti ritmicamente, in silenzio. Il comandante aveva terminato il suo discorso con Kirill, Zhenya era assorto nei suoi pensieri e l’uomo dietro il carrello guardava tranquillo davanti a sé, non era più nervoso come prima. Non sentivano niente... proprio nulla! Artyom si spaventò. La calma e il silenzio del gruppo si fecero ancor più evidenti quando il fischio divenne fortissimo, più incomprensibile e spaventoso. Artyom smise di spingere sulla leva e si rizzò in piedi; Zhenya lo osservava sorpreso. I suoi occhi erano limpidi, non vi era alcuna traccia della droga che Artyom temeva di intravvedere. “Che ti salta in mente?”, il ragazzo era visibilmente infastidito. “Sei stanco? Avresti dovuto dirmelo, senza fermarti a questo modo”. “Non senti nulla?”. Artyom era esterrefatto e il tono della sua voce fece mutare anche l’espressione sul volto di Zhenya. Quest’ultimo si mise in ascolto con maggiore attenzione, senza però smettere di spingere la leva su e giù. Tuttavia, l’andatura del carrello era diminuita, poiché Artyom se ne stava ancora lì, confuso, a cercare di capire da dove giungesse il misterioso rumore. Il comandante notò quello che stava succedendo e si voltò: “Che ti succede? Ti si sono scaricate le batterie?” “Non sente nulla?”, chiese di rimando Artyom. In quel momento una sensazione terribile prese il sopravvento: forse non c’era alcun rumore, proprio per questo nessuno riusciva a sentirlo; forse stava impazzendo ed era la paura che glielo faceva immaginare... Il comandante impartì l’ordine di fermarsi, in modo che il cigolio del carrello e il fracasso degli stivali non interferissero. Le sue mani afferrarono salde la mitragliatrice, mentre lui se ne stava immobile ad ascoltare, tendendo l’orecchio verso la galleria. Ora lo strano rumore era proprio nelle vicinanze, Artyom lo sentiva distintamente, stava diventando sempre più chiaro; il ragazzo osservava il viso del comandante, cercando di capire se anche lui riuscisse a sentire ciò che colmava la sua coscienza di un’agitazione sconvolgente. Al contrario, i lineamenti del comandante si distesero e Artyom venne pervaso da un senso di vergogna. Ma il peggio era che aveva fatto fermare il gruppo senza una buona ragione e aveva allarmato i suoi compagni. Ovviamente Zhenya non riusciva a sentire nulla, sebbene ci stesse provando; anch’egli aveva smesso di fare forza sulla leva, ma alla fine guardò l’amico negli occhi con scherno e lo sfidò: “Allucinazioni?” “Allucinazioni, un corno!”, inaspettatamente Artyom si sentì urlare con irritazione: “Ma siete tutti sordi?” “Sì, proprio allucinazioni”, concluse Zhenya. “Calmi, ragazzi. Non è successo niente. È probabile che ti sia solo sembrato di sentire un rumore. Non preoccuparti, succede. Non ti devi innervosire, Artyom. Forza, rimettetevi al lavoro, così possiamo continuare”, il comandante cercò di calmarlo e nel frattempo riprese la marcia. Artyom non aveva altra scelta che ritornare alla leva del carrello. Stava seriamente cercando di convincersi che quel rumore fosse frutto della sua immaginazione, causato dalla tensione. Cercò di rilassarsi e di non pensare ad altro; sperava di riuscire a escludere quel suono dalla sua testa insieme ai timori più inquietanti. Per un po’ riuscì a isolare i pensieri, ma la mente era così vuota che rendeva il rumore più sonoro, più fragoroso, più chiaro. Trovò un po’ di forza nel fatto che si stavano spostando sempre più a sud, ma il rumore era diventato così assordante che sembrava riempisse tutta la Metropolitana. Improvvisamente Artyom notò che Zhenya stava usando una sola mano e che, senza accorgersi, si stava strofinando le orecchie con l’altra. “Che stai facendo?”, gli mormorò Artyom. “Non so... sono bloccate... mi prudono...”, brontolò. “Non riesci a sentire nulla?”, si informò Artyom. “No, niente di niente, solo una forte pressione”, rispose Zhenya in un sussurro: aveva abbandonato completamente il sarcasmo. Il rumore aveva raggiunto il suo apice, e in quel momento Artyom comprese da dove veniva: usciva da uno dei tubi lungo il muro della galleria, che in passato era stato usato per le linee di comunicazione e chissà per cos’altro. Era rotto. La parte divelta, color nero pece, emetteva quello strano rumore, che proveniva dalle sue profondità. Mentre Artyom cercava di capire perché al suo interno non vi fossero i fili, perché il tubo fosse nero e completamente vuoto, il comandante si fermò all’improvviso e riuscì a esprimersi lentamente e con estrema fatica: “Ragazzi, facciamo... beh... fermiamoci. Non mi sento troppo bene... La testa...” Con movimenti incerti, cercò di avvicinarsi al carrello per sedersi sul bordo, ma non aveva ancora fatto un passo che era già rovinato a terra. Zhenya lo osservava confuso, sfregandosi le orecchie con entrambe le mani, senza spostarsi dal luogo in cui si trovava. Per qualche strana ragione, Kirill aveva continuato a camminare da solo, come se non fosse accaduto nulla, e non reagiva ai loro richiami. L’uomo dietro al carrello si era seduto sui binari e stava piangendo incontrollato, come un bambino. La luce della torcia illuminava il soffitto della galleria e, dal basso, questa scena pareva ancora più sinistra. Artyom venne colto dal panico: era chiaro che la sua era l’unica mente non annebbiata dal suono, che però stava diventando sempre più intollerabile e gli impediva di pensare. Disperato, si coprì le orecchie con le mani e provò un po’ di sollievo. Con tutta la forza che riuscì a richiamare, diede una sberla a Zhenya che si stava strofinando le orecchie con un’espressione inebetita, quindi urlò, cercando di sovrastare il rumore e dimenticandosi che in realtà era l’unico che lo sentiva: “Prendi il comandante! Mettilo sul carrello! Non possiamo stare qui! Dobbiamo andarcene!”, poi raccolse la torcia caduta a terra e si mise a inseguire Kirill che marciava verso l’oscurità come un sonnambulo. Fortunatamente, l’uomo camminava abbastanza lentamente. In pochi balzi Artyom lo raggiunse e gli toccò ripetutamente la spalla. Ma Kirill non voleva saperne di fermarsi e, insieme, si stavano allontanando sempre più dagli altri. Artyom corse davanti a lui e, non sapendo cos’altro fare, gli puntò il fascio di luce negli occhi, che erano chiusi. Kirill aggottò le sopracciglia e interruppe la sua marcia. Mentre Artyom lo teneva con una mano, con l’altra gli aprì le palpebre e fece reagire le pupille alla luce della torcia. Kirill gridò, sbatté le palpebre, scrollò la testa e una frazione di secondo dopo era già ritornato in sé. Riaprì gli occhi e guardò Artyom sconvolto. Accecato dalla torcia non riusciva quasi a vedere nulla e il ragazzo lo dovette condurre per mano finché non arrivarono al carrello. Il corpo svenuto del comandante era adagiato sul piccolo mezzo di trasporto; Zhenya gli sedeva accanto con la stessa espressione stordita di poco prima. Dopo aver lasciato Kirill insieme agli altri, Artyom si diresse verso l’ultimo uomo seduto sui binari, ancora in lacrime. Gli scrutò gli occhi e si accorse che aveva uno sguardo sofferente. Doveva provare una pena intensa, tanto che il ragazzo fece qualche passo indietro perché temeva che alla vista di un tale tormento si sarebbe messo a piangere anche lui. “Sono stati tutti uccisi... ed è stato dolorosissimo!”. Artyom riuscì a distinguere queste parole tra i singhiozzi. Cercò di fare alzare l’uomo, ma lui si scansò e urlò furioso: “Luridi maiali! Delinquenti! Non andrò da nessuna parte insieme a voi, io voglio rimanere qui! Si sentono soli, stanno soffrendo e tu mi vuoi condurre lontano da loro? È tutta colpa tua! Io non mi muovo da qui! Non mi muovo! Lasciami stare, capito?!” All’inizio, Artyom voleva schiaffeggiarlo, per cercare di farlo tornare in sé, ma aveva paura: dato che l’uomo era tanto adirato con lui, si sarebbe potuto facilmente vendicare. Per cui, gli si inginocchiò davanti e, sebbene gli risultasse molto difficile a causa del frastuono sempre più assordante, si rivolse a lui con voce sommessa: “Li vuoi aiutare, vero? Vuoi che non soffrano più?” Tra le lacrime, Kirill guardò Artyom e, con un sorriso sgomento sussurrò: “Certo... certo che li voglio aiutare”. “Allora tu devi aiutare prima me; loro vogliono che tu mi dia una mano: vai al carrello e mettiti alla leva. Dobbiamo arrivare alla stazione il prima possibile”. “Te lo hanno detto loro?”, l’uomo guardava Artyom sbalordito. “Sì”, rispose con sicurezza il ragazzo. “Poi mi lascerai tornare da loro?” “Ti do la mia parola che se poi vorrai tornare da loro, ti lascerò andare”, confermò Artyom e, senza dargli il tempo di pensare, lo strattonò e lo fece salire sul carrello. Lasciò Kirill perché obbedisse ai movimenti meccanici che Zhenya impartiva alla leva, mentre il comandante, ancora privo di sensi, era sdraiato nel mezzo. Artyom assunse la posizione di comando, puntando la mitragliatrice verso l’oscurità, camminando a passo veloce. Era sorpreso nel sentire che il carrello lo stesse seguendo. Sapeva di fare una cosa inaccettabile, non si procedeva mai senza tenere un uomo dietro al convoglio, ma in quel momento era più importante allontanarsi da lì il più in fretta possibile. Ora erano in tre ad azionare la leva, perciò il gruppo si muoveva molto più velocemente di prima. Artyom provò un po’ di sollievo quando il tremendo rumore cominciò a diminuire, insieme alla sensazione di essere in pericolo. Urlò agli altri di mantenere il ritmo e, all’improvviso udì la voce di Zhenya, seria e sorpresa: “Hai spodestato il comandante?” Artyom fece segno di fermarsi, aveva capito di aver superato la zona più pericolosa; quindi tornò dagli altri e si lasciò andare a terra, distrutto, poggiando la schiena al carrello. Lentamente, gli altri uomini si stavano riprendendo. La sentinella della retroguardia aveva smesso di singhiozzare e si stava asciugando le lacrime con le mani, guardandosi attorno perplesso. Il comandante si mosse, poi si alzò emettendo un gemito sordo e lamentandosi delle fitte di mal di testa. Mezz’ora dopo riuscirono a rimettersi in viaggio. A parte Artyom, sembrava che gli altri non ricordassero nulla. “Io mi sono sentito improvvisamente pesante e la testa mi si è annebbiata. Un attimo dopo sono svenuto. Mi era già successo un’altra volta, ma a causa del gas sprigionato in una galleria, lontana da qui. In ogni caso, se fosse stato gas, avrebbe avuto un effetto diverso, istantaneo, su tutti quanti... Hai sentito davvero quel rumore? Sì, è molto strano...”, il comandante pensava a voce alta. “E Nikita piangeva a dirotto... perché, Nikita?”, domandò all’uomo della retroguardia. “Che diavolo ne so... non mi ricordo. Cioè, lo ricordavo un minuto fa, ma ora mi è già uscito di testa... È stato come un sogno, come quando ti svegli, ricordi tutto nei particolari, tutte le immagini sono nitide nella tua testa. Ma dopo qualche minuto ti risvegli per bene e hai già dimenticato tutto. Rimangono solo frammenti di ricordi... È stata la stessa cosa. So che ero molto dispiaciuto per qualcuno... ma chi e perché... non ne ho la più pallida idea”. “Volevi rimanere nella galleria per sempre, insieme a loro. Per convincerti a venire con me ti ho promesso che poi, se tu lo avessi voluto, ti avrei permesso di tornare indietro”, spiegò Artyom, guardando di sottecchi Nikita. “Beh, se ora vuoi tornare, va’ pure”, aggiunse ridacchiando. “No, grazie”, rispose Nikita cupo. “Ho cambiato idea...” “Ok, ragazzi. Siamo stati fermi abbastanza. In questa galleria non c’è niente per cui valga la pena rimanere. Dirigiamoci verso la stazione e quando arriveremo potremo discuterne meglio. A un certo punto dovremo persino ritornare verso casa...” Ma perché fare programmi in un momento del genere? Dovevano già ringraziare il cielo di essere giunti alla prima destinazione! “Andiamo!”, concluse il comandante. “Artyom, stai di fianco a me. Oggi sei il nostro eroe”, aggiunse inaspettatamente. Kirill prese il suo posto dietro al carrello; Zhenya, nonostante le proteste, rimase alla leva con Nikita e insieme ricominciarono la loro avanzata. “Mi hai detto che c’era un tubo rotto? E quel rumore veniva proprio da lì? Sai, Artyom, è probabile che noi zucconi siamo davvero sordi, non riusciamo a sentire... forse tu hai un sesto senso per questo ciarpame. Sei stato molto fortunato, ragazzo mio!”, si congratulò il comandante. “È molto strano che provenisse da un tubo... lo hai visto vuoto? Chissà che diamine ci scorre all’interno, adesso”, continuò, controllando attentamente i tubi intrecciati che pendevano dai muri della galleria. Non mancava molto alla Rizhskaya. Un quarto d’ora dopo intravvidero in lontananza il fuoco della pattuglia, il comandante rallentò il passo e, usando la torcia, comunicò alle sentinelle il segnale luminoso corretto. Li lasciarono attraversare lo sbarramento senza problemi e, poco dopo, il carrello già scivolava sui binari della stazione. Le condizioni della Rizhskaya erano vagamente migliori di quelle dell’Alekseevskaya. Molto tempo prima, sopra questa stazione c’era un grande mercato, perciò tra coloro che riuscirono a correre nella Metropolitana, verso la salvezza, c’erano moltissimi commercianti. Gli abitanti di questa stazione avevano sempre avuto una certa inclinazione per il commercio e la sua vicinanza alla Prospekt Mira, all’Hansa e alle sue principali rotte mercantili gli aveva dato una certa prosperità. Avevano l’elettricità, quella delle stesse luci di emergenza della VDNKh. I loro pattugliatori indossavano vecchie tute mimetiche che però avevano un aspetto decisamente migliore rispetto alle giacche imbottite e decorate delle sentinelle dell’Alekseevskaya. Gli abitanti condussero i forestieri alle loro tende. Il ritorno a casa non era imminente, dato che nessuno era riuscito a capire cosa fosse quel nuovo pericolo nella galleria e non si sapeva come affrontarlo. L’amministrazione della stazione e il comandante della carovana proveniente della VDNKh si riunirono, mentre gli altri ebbero un po’ di tempo libero. Artyom, sfinito e agitato, si mise in branda e si addormentò subito a faccia in giù. Non voleva dormire, ma le forze lo avevano completamente abbandonato. Gli abitanti della stazione avevano promesso che un paio d’ore dopo avrebbero organizzato una festa in onore dei nuovi arrivati e, a giudicare dagli ammiccamenti e dai sussurri dei padroni di casa, sembrava che ci sarebbe stata della carne per cena. Ma prima bisognava riposarsi un po’, senza pensare a niente. Oltre il muro di tela della tenda cominciarono a farsi sentire dei rumori. La festa era stata allestita al centro della piattaforma, dove si trovava anche il fuoco da campo principale. Artyom non riuscì a resistere e sbirciò fuori: diverse persone stavano pulendo il pavimento per stendere a terra un telone impermeabile, mentre qualche metro più in là, altri tagliavano un maiale in pezzi, che poi venivano infilati in un fil di ferro e appesi sopra al fuoco. Le mura della stazione erano molto particolari, non di marmo come quelle della VDNKh e dell’Alekseevskaya, ma ricoperte di piastrelle gialle e rosse. A suo tempo, questa combinazione di colore doveva essere apparsa molto allegra. Ora, sulle mattonelle vitree e sull’intonaco poggiava uno strato di fuliggine e grasso, che però non ne aveva rovinato l’aspetto vivace. Ma la cosa più importante era che dall’altra parte della stazione, praticamente sepolto nella galleria, era rimasto un vero treno, sebbene i finestrini fossero scoppiati e le porte fossero spalancate. Non si trovavano treni in tutti i passaggi o in tutte le stazioni. Negli ultimi vent’anni, la maggior parte di essi, in particolar modo quelli che erano rimasti bloccati all’interno delle gallerie e nei quali non si poteva vivere, erano stati man mano smontati. La gente aveva utilizzato le ruote, i vetri e il materiale di rivestimento del treno per ricostruire la vita nelle stazioni. Il patrigno di Artyom gli aveva raccontato che all’interno dell’Hansa i treni nei passaggi erano stati smantellati per permettere ai carrelli di spostarsi più facilmente da un punto a un altro. Inoltre, stando a ciò che si diceva in giro, erano stati spinti verso la linea Rossa. Nella galleria che portava dalla VDNKh alla Prospekt Mira, non era rimasto alcun convoglio, ma molto probabilmente era un semplice caso. Gli abitanti si stavano pian piano riunendo e Zhenya, con il viso ancora impastato dal sonno, uscì dalla sua tenda. Mezz’ora dopo il capo della stazione arrivò insieme al comandante della spedizione e vennero messi a cuocere i primi pezzi di carne. Il comandante e il governatore sorridevano, scherzavano e sembravano soddisfatti dell’esito del loro incontro. Venne portata una bottiglia di liquore fatto in casa, si brindò e tutti sembravano felici. Artyom mordicchiava la sua carne, leccando il grasso caldo che gli colava sulle mani; osservava i carboni ardenti e il calore che gli suggeriva sempre un’inspiegabile sensazione di intimità e pace. “Sei stato tu a tirarli fuori dalla trappola?”, chiese una voce sconosciuta, che apparteneva a un uomo seduto vicino ad Artyom; lo stava osservando già da qualche minuto. “Chi glielo ha detto?”, il ragazzo rispose alla domanda con un altro interrogativo, scrutando attentamente l’uomo: aveva i capelli cortissimi, la barba incolta e sotto il pesante giaccone di pelle si intravvedeva un gilè che sembrava morbidissimo. Secondo Artyom, il suo interlocutore non aveva nulla di sospetto; sembrava un normale commerciante, di quelli che si incontravano tutti i giorni alla Rizhskaya. “Chi? Uno dei tuoi compagni mi ha raccontato qualcosa”, indicò con un cenno del capo qualcuno che sedeva poco lontano e che stava chiacchierando animatamente con i nuovi amici del comandante. “Beh, sì... sono stato io”, ammise Artyom restio. Sebbene avesse il proposito di fare qualche conoscenza utile alla Rizhskaya, ora che gli si presentava un’ottima possibilità, non ne aveva più voglia. “Mi chiamo Bourbon e tu?” “Bourbon?”. Artyom era sorpreso. “Che razza di nome è? Non c’era un re che si chiamava così?” “No, ragazzo mio. Era il nome di una bevanda, o meglio di un ardente liquore. Si dice che ti mettesse di buon umore. Ma tu come ti chiami?”, insistette l’uomo. “Artyom”. “Ascoltami, Artyom... quando hai intenzione di tornare a casa...”. Bourbon continuava ad insistere e questo insospettì Artyom. “Non saprei. Nessuno ci ha ancora detto niente di preciso. Sa cosa ci è appena successo, signore, quindi capisce bene il perché”, rispose Artyom gelido. “Non sono tanto più vecchio di te, quindi puoi darmi anche del tu... In realtà, quello che ti sto chiedendo... ho una proposta da farti, ragazzo. Non per tutto il tuo gruppo, solo per te: avrei bisogno del tuo aiuto, capito? Non ci vorrà molto...” Artyom non aveva capito granché. L’uomo esitava e c’era qualcosa nel suo modo di parlare che faceva rabbrividire Artyom, il quale avrebbe dato tutto l’oro del mondo per terminare quell’astrusa conversazione il prima possibile. “Non ti devi spaventare, ragazzo”, Bourbon aveva intuito che il suo interlocutore non si fidava di lui e stava cercando di rassicurarlo. “Non c’è nulla di losco, io faccio tutto alla luce del sole, per così dire... o per lo meno, quasi tutto... In pratica, l’altro ieri alcuni dei nostri si stavano recando alla Sukharevskaya, stavano seguendo la nostra rotta, ma non ci sono mai arrivati. Ne è tornato soltanto uno e non si ricorda nulla. Quando è ricomparso, era ricoperto di moccio e ululava proprio come ci ha raccontato il tuo compagno. Gli altri non li abbiamo mai più visti. Forse sono effettivamente arrivati alla Sukharevskaya... o forse no, perché sono ormai tre giorni che non arriva più nessuno dalla Prospekt, e per di più nessuno ci vuole più andare. Io stavo pensando che potrebbe essere stata la stessa schifezza in cui vi siete imbattuti voi. Ho ascoltato un po’ il tuo comandante e... ho supposto che potesse trattarsi della stessa cosa. La linea è la stessa, così come i tubi”. A quel punto Bourbon voltò velocemente la testa, forse per controllare che nessuno lo stesse ascoltando. “Se quella porcheria non ha avuto alcun effetto su di te...”, continuò tranquillo “Mi capisci...?” “Sto cominciando...”. Artyom era dubbioso. “Praticamente... io dovrei recarmi laggiù, ne ho davvero bisogno, capisci? È molto probabile che io reagirò come i nostri ragazzi e i tuoi compagni. Ma sappiamo che tu ne sei immune”. “Tu...”, borbottò Artyom, “tu vorresti che io ti facessi attraversare la galleria? Vuoi che ti aiuti a raggiungere la Sukharevskaya?” “Sì, qualcosa del genere”, Bourbon annuì sollevato. “Non so se lo hai sentito dire, ma oltre la Sukharevskaya c’è un’altra galleria peggiore di questa, è piena di schifezze e... dovrò attraversare anche quella. Laggiù sono accadute cose terribili agli altri commercianti. A noi andrà tutto bene, te lo assicuro. Se decidi di accompagnarmi, ti ricompenserò a dovere. Ovviamente io dovrò procedere verso sud, ma alla Sukharevskaya conosco delle persone che ti troveranno una sistemazione e ti ricondurranno a casa”. Artyom, che per un pelo non aveva mandato al diavolo Bourbon e la sua proposta, comprese immediatamente che questa era la sua possibilità per oltrepassare le porte meridionali della Rizhskaya senza problemi e soprattutto senza ingaggiare un combattimento. Poi avrebbe potuto proseguire... Bourbon non si era sbottonato granché riguardo la sua mossa successiva, ma gli aveva comunque riferito che avrebbe dovuto attraversare la galleria maledetta tra la Sukharevskaya e la Turgenevskaya. Anche Artyom doveva arrivarci: Turgenevskaya - Trubnaya - Tsvetnoy Bulvar - Chekhovskaya... Poi sarebbe stato a un tiro di schioppo dall’Arbatskaya... e quindi dalla Polis... dalla Polis. “Quale sarebbe la ricompensa?”, si decise ad aggiungere Artyom, per cercare di comportarsi il più normalmente possibile. “Qualunque cosa tu voglia. Ma più che altro posso offrirti della valuta”. Bourbon osservava dubbioso Artyom, cercando di fargli capire cosa intendesse. “Cioè cartucce per Kalashnikov. Però se lo desideri posso anche procurarti cibo, liquore o droga”, gli fece l’occhiolino: “Sì, posso trovarti anche quella”. “No, le cartucce vanno bene. Due caricatori pieni. E ovviamente abbastanza cibo per arrivare fin laggiù e tornare indietro. Le mie condizioni non sono negoziabili”, Artyom cercò di sembrare sicuro di sé e di guardare negli occhi Bourbon, che a sua volta lo osservava con uno sguardo di sfida. “Affare fatto”, fece Bourbon per tutta risposta. “Siamo d’accordo: due caricatori per Kalashnikov e qualcosa da mangiare. Ok. Va bene”, borbottò, probabilmente tra sé. “Perfetto, ragazzo. A proposito, come stai? Dovresti dormire. Ti verrò a recuperare tra un po’, quando tutto questo putiferio sarà terminato. Fai i bagagli e, se sai scrivere, lascia un messaggio, così non ti verranno a cercare... Cerca di farti trovare pronto, capito?” CAPITOLO 5 : IN CAMBIO DI CARTUCCE Non riuscì a dormire molto. In realtà Artyom non aveva bisogno di fare i bagagli perché non li aveva mai disfatti, non aveva avuto ragione di farlo. L’unico dettaglio che non riusciva a definire era il modo in cui avrebbe portato la mitragliatrice fuori dalla stazione senza che venisse notata o che attirasse l’attenzione. Gli avevano assegnato un pesante mitra calibro 7.62 con il calcio in legno. Le carovane della VDNKh venivano sempre mandate alle stazioni più vicine con queste armi ingombranti. Artyom era sdraiato con la testa nascosta nella coperta e non rispondeva alle domande scettiche di Zhenya: “Perché te ne stai lì a dormire? Ci hanno dedicato una così bella festa... per caso non ti senti bene?”. L’interno della tenda era caldo e umido e stare sotto le coperte era un supplizio. Il sonno non arrivava e, quando finalmente riuscì a chiudere occhio, sogni inquietanti e confusi lo disturbarono, come se vi assistesse attraverso un vetro opaco. Stava correndo da qualche parte, parlando con una persona senza volto, poi stava correndo di nuovo... Fu Zhenya a svegliarlo, gli scuoteva la spalla e gli sussurrava: “Artyom... È arrivato un tizio per te... Sei nei guai?”, gli chiese cauto. “Vuoi che svegli gli altri e...?” “No, va tutto bene. Chiacchiereremo un po’. Continua a dormire, Zhenya. Torno tra un attimo”. Artyom sembrava calmo mentre indossava gli stivali e aspettava che l’amico tornasse a letto. Fece attenzione a non fare troppo rumore mentre trascinava all’esterno il suo zaino e prendeva la mitragliatrice. In quel momento Zhenya, avendo udito il metallo muoversi, lo apostrofò nuovamente: “E ora che succede? Sei sicuro che sia tutto a posto?” Per toglierselo di torno, Artyom gli dovette mentire: aveva avuto una discussione con quel tizio e doveva dirgliene quattro, ma tutto sarebbe andato per il verso giusto. “Bugiardo”, lo contraddisse Zhenya. “Ok, quando devo cominciare a preoccuparmi?” “Tra un anno”, borbottò Artyom sperando che l’amico non lo sentisse. Poi spostò il lembo della tenda e uscì sulla piattaforma. “Ragazzo, facciamo tardi!”, ringhiò Bourbon. Indossava gli stessi abiti di qualche ora prima, solo che adesso portava in spalla un grande zaino. “Dannazione! Hai intenzione di portarti in giro un peso del genere, attraversare gli sbarramenti con quel coso?”, chiese l’uomo quasi disgustato, indicando la mitragliatrice di Artyom, anche se, per quanto il ragazzo aveva visto, Bourbon non era nemmeno armato. Le luci della stazione si stavano affievolendo. Sulla piattaforma non c’era anima viva, erano tutti andati a dormire esausti, dopo la festa. Artyom cercò di procedere il più velocemente possibile, perché temeva di imbattersi in qualcuno del suo gruppo, ma in prossimità dell’entrata della galleria, Bourbon lo bloccò e gli ordinò di rallentare il passo. I pattugliatori li notarono e, da lontano, gli chiesero dove avessero intenzione di andare nel bel mezzo della notte. Bourbon si rivolse a loro chiamandoli per nome e gli spiegò che avevano degli affari da sbrigare. Quindi l’uomo accese la torcia: “Ascoltami bene”, lo avvisò. “Ci saranno guardie al centesimo e al duecentesimo metro. Tu devi sono startene zitto. Me la caverò io con loro. Peccato che tu abbia un Kalashnikov che sembra quello di mia nonna... non riuscirai a nasconderlo... Dove lo hai recuperato, un affare del genere?” Al centesimo metro procedette tutto senza intoppi. C’era un piccolo fuoco che si stava ormai spegnendo, attorno al quale sedevano due sentinelle in abiti mimetici. Uno dei due stava dormendo, mentre l’altro strinse la mano a Bourbon in modo amichevole. “Affari? Capisco...”, sorrise malizioso. Bourbon non proferì parola finché non raggiunsero il duecentocinquantesimo metro. Marciava svogliato, sembrava quasi infuriato e aveva un’espressione antipatica. Artyom stava cominciando a pentirsi di averlo seguito. Camminava qualche passo indietro rispetto a Bourbon e intanto controllava che la mitragliatrice fosse in ordine e teneva il dito sul grilletto. All’ultimo posto di guardia si stavano verificando dei ritardi: forse Bourbon non conosceva bene i pattugliatori oppure erano loro a sapere fin troppo bene chi avevano di fronte. Il responsabile lo prese da parte e gli fece mettere lo zaino vicino al fuoco mentre lo interrogava. Anche Artyom, che si sentiva uno sciocco, se ne stava vicino al fuoco a rispondere alle domande dell’ufficiale capo. Era chiaro che fossero annoiati e che non avessero niente di meglio da fare. Artyom stesso sapeva che se l’ufficiale capo si metteva a chiacchierare volentieri, allora significava che allo sbarramento tutto procedeva come previsto. Altrimenti, se di recente era accaduto qualcosa di strano, se qualcosa li aveva assaliti dai recessi della galleria, oppure se qualcuno aveva cercato di irrompere da sud, o se ancora avevano udito un rumore sospetto, allora le guardie sarebbero rimaste silenziose attorno al fuoco, senza spiccicare parola, con gli occhi fissi sulla galleria. Sembrava che non fosse accaduto nulla di particolare e che quindi potessero raggiungere almeno la Prospekt Mira senza grossi problemi. “Non sembri di queste parti. Vieni dall’Alekseevskaya?” L’ufficiale capo stava cercando di estorcere informazioni da Artyom, mentre lo guardava fisso in faccia. Ma, dato che Bourbon gli aveva imposto di starsene quieto e di non rivolgere la parola a nessuno, Artyom balbettò qualcosa che poteva essere interpretato in diversi modi, lasciando libera interpretazione all’uomo che aveva di fronte. Quest’ultimo aveva compreso che non sarebbe riuscito a ottenere risposte utili, perciò si voltò verso il suo compagno e, con lui, cominciarono a scambiarsi opinioni su una storia raccontata da un certo Mikhail, che qualche giorno prima stava cercando di concludere degli affari alla Prospekt Mira, ma aveva avuto qualche difficoltà con l’amministrazione della stazione. Sollevato che si fossero stancati di interrogarlo, Artyom rimase accanto al fuoco e prese a fissare la galleria meridionale attraverso le fiamme: pareva la stessa enorme galleria infinita che c’era alla VDNKh e che procedeva verso nord, nella quale poco tempo prima era stato seduto di pattuglia vicino al fuoco del quattrocentocinquantesimo metro. Non sembrava particolarmente diversa. Però aveva una sua tipicità: un odore peculiare che si diffondeva dalle ventole, oppure aveva un’anima tutta sua, un’aura, che le conferiva una certa individualità e la rendeva diversa da tutte le altre. Ad Artyom tornarono alla mente le parole del patrigno: “Nella Metro non esistono due gallerie identiche...”. Sukhoi aveva una sensibilità molto speciale, era uno dei pochi a possederla ed era riuscito a svilupparla negli anni grazie ai numerosissimi viaggi intrapresi. Il patrigno sosteneva si trattasse di “ascoltare la galleria”; lui andava molto orgoglioso di una simile capacità e spesso, nei suoi discorsi, rivelava ad Artyom di essere riuscito a sopravvivere grazie a questo “sesto” senso. Molti altri uomini, sebbene avessero percorso la Metro in lungo e in largo, non potevano avvalersi di un dono del genere. Taluni avevano sviluppato una paura inesplicabile, mentre altri avvertivano voci, rumori e pian piano scivolavano verso la pazzia. Malgrado ciò, tutti concordavano che anche quando in una galleria non c’era anima viva, non era mai completamente vuota: vi era qualcosa di invisibile e quasi intangibile che gocciolava viscido al suo interno, la riempiva, come se fosse il sangue freddo e pesante all’interno delle vene di un leviatano di pietra. Il discorso dell’ufficiale capo stava sfumando mentre Artyom cercava invano di vedere qualcosa nell’oscurità che si ammassava velocemente a qualche metro dal fuoco. Cominciò a comprendere il significato delle parole del patrigno quando gli diceva di “ascoltare la galleria”. Il ragazzo sapeva che al di là di quel confine indistinto, segnato dalle fiamme del fuoco, in cui la luce color porpora si mescolava alle ombre tremanti, vi erano altre persone, anche se in quel momento quasi non riusciva a crederci. Sembrava che la vita si interrompesse a qualche metro dalla luce emessa dal fuoco, che di fronte a loro non ci fosse nulla, tranne un vuoto oscuro e mortale, che rispondeva a un urlo con l’illusione di un’eco sorda. Ma se si stava lì seduti per un po’, coprendosi le orecchie con le mani, se non si cercava di arrivare con la vista fino ai recessi della galleria come per cercare qualcosa; se invece si tentava di dissolvere il proprio sguardo nell’oscurità, di fondersi con la galleria e diventare parte del leviatano, una cellula del suo organismo... attraverso le dita che escludevano i suoni del mondo esterno, una flebile melodia fluiva dal condotto uditivo direttamente verso il cervello: era un suono soprannaturale che arrivava diretto dalle profondità, indistinto e incomprensibile. Non era come quel rumore inquietante e incalzante che fuoriusciva dal tubo rotto della galleria tra l’Alekseevskaya e la Rizhskaya. No, era diverso, chiaro e profondo... Gli sembrava di potersi immergere per un po’ nella tranquillità di questa melodia, in modo da comprendere l’essenza del fenomeno, non grazie alla ragione, ma all’intuito che molto probabilmente era stato risvegliato dal rumore del tubo rotto. Proprio quel suono gli sembrava avesse la stessa consistenza dell’etere e che avanza lentamente lungo la galleria. Ma ritrovandosi all’interno del tubo era marcito, era stato infettato da qualcosa che lo faceva ribollire nervosamente... e quando la pressione si era fatta insopportabile, la tubatura era esplosa. Così il materiale in decomposizione fuoriusciva dal tubo verso il mondo, portando con sé la sua tristezza e causando negli esseri viventi dapprima un senso di nausea, poi la follia più completa. Fu così che Artyom si sentì sul punto di ricevere un’importantissima rivelazione, come se nell’ultima ora passata a vagabondare per la più buia oscurità delle galleria, la sua coscienza si fosse risvegliata e gli permettesse di intravvedere la soluzione a questo grande mistero, che ancora imbrigliava tutti gli esseri razionali e impediva loro di comprendere la vera natura del mondo sotterraneo, scavato nelle viscere della terra dalle generazioni precedenti. Constatando ciò, Artyom si spaventò: era riuscito a dare solo un’occhiata attraverso la serratura della porta dietro la quale quella spiegazione veniva tenuta al sicuro, aveva sperato di scoprire cosa ci fosse al di là, ma aveva visto solo una luce insopportabile che lo accecava. Se avesse aperto la porta, quella stessa luce sarebbe sgorgata fuori, irrefrenabile, e avrebbe incenerito l’audace che aveva varcato l’uscio proibito. Tuttavia, la luce era la conoscenza. Il turbinio di questi pensieri, delle sensazioni e delle preoccupazioni colpì il ragazzo in maniera inaspettata: non era ancora pronto a una scoperta del genere e così ebbe paura. No, era tutto frutto della sua fantasia, non aveva sentito niente, non c’era alcuna verità rivelata: era tutto uno scherzo della sua immaginazione. Si sentiva sollevato e deluso, cercava di capire in che modo, per un istante, gli si fosse manifestata un’incredibile e indescrivibile visione, che però aveva subito perso vigore, sciogliendosi nella sua mente, già tornata la solita foschia fangosa. Temeva la conoscenza e arretrava, ma la porta era stata chiusa, forse per sempre. L’uragano nella sua testa si era disperso così come era arrivato, e lo aveva lasciato devastato, esausto. Artyom era scosso mentre cercava di comprendere dove terminava la fantasia e cominciava la realtà. Si ritrovò anche a pensare se aveva provato realmente tutte quelle sensazioni. Lenta, la sua anima si era riempita di amarezza: si trovava a un passo dall’illuminazione, ma non era stato abbastanza risoluto, non aveva osato diventare tutt’uno con l’etere della galleria, e ora avrebbe dovuto continuare a vagabondare nell’oscurità per il resto della sua vita perché quella volta aveva avuto troppa paura di osservare l’autentica luce della conoscenza. Si continuava a chiedere: “Cos’è la conoscenza?”, cercando di valorizzare ciò che, come un avventato codardo, si era appena rifiutato di vedere. Preso dal vortice dei suoi pensieri, non aveva notato di pronunciare, per diverse volte, le parole ad alta voce. “La conoscenza, amico mio, è la luce. Al contrario, l’ignoranza è l’oscurità più assoluta!”, gli spiegò con entusiasmo uno degli ufficiali capo. “Giusto?”, e allegro, fece l’occhiolino ai suoi amici. Artyom era scioccato, continuava a fissare l’uomo; rimase in quella posizione per un po’, fino al ritorno di Bourbon che gli ordinò di alzarsi e salutò gli ufficiali, aggiungendo che erano ormai in ritardo. “Fai attenzione!”, lo minacciò il comandante dello sbarramento. “Ti lascio proseguire con la tua arma”, e indicò la mitragliatrice di Artyom. “Ma, con quella, non potrai tornare indietro. Ho istruzioni particolari a riguardo”. “Te l’avevo detto, zuccone...”, sibilò Bourbon irritato, mentre si allontanavano velocemente dal fuoco. “Potrai fare tutto ciò che vuoi sulla via del ritorno, ma ti ritroverai ad affrontarli in battaglia. A me non importa, io lo sapevo, sapevo che sarebbe andata così, dannazione!” Artyom non rispose, quasi non sentiva i rimproveri di Bourbon, poiché si era improvvisamente ricordato quello che aveva aggiunto il patrigno quella volta che gli stava spiegando il perché ciascuna galleria è unica: in ognuna di esse scorre una melodia che non ha uguali, ma si può sempre imparare ad ascoltarla. Forse Sukhoi intendeva solo abbellire il suo discorso ma, ricordando ciò che Artyom aveva provato mentre era seduto vicino al fuoco qualche momento prima, capì di aver ascoltato proprio quella melodia. L’aveva sentita davvero, l’aveva ascoltata! Era la melodia di quella galleria. Ciononostante, il ricordo dell’accaduto stava velocemente sfumando e, mezz’ora più tardi, Artyom non era nemmeno sicuro che fosse davvero successo, che non lo avesse solo immaginato e che non si fosse trattato dell’aria che giocava con le fiamme del fuoco da campo. “Ok, è probabile che tu non lo abbia fatto di proposito, ma dimmi, che diavolo hai al posto del cervello?”, gli chiese Bourbon in segno di riappacificazione. “Se non sono gentile con te... beh, mi devi scusare. Ma questo è un lavoro molto stressante. Stavolta non ci è accaduto nulla, quindi va bene così. Ora dobbiamo cercare di arrivare fino alla Prospekt Mira senza essere fermati da nessuno. Poi laggiù potremo rilassarci per un po’. Se tutto va bene non ci vorrà molto. Dopodiché potremmo avere dei problemi”. “Va bene se procediamo così? Quando organizziamo le carovane dalla VDNKh, se si offrono meno di tre persone non partiamo, perché è necessario avere una retroguardia...”, mentre Artyom pronunciava queste parole, si guardava alle spalle. “Beh, ovviamente la carovana ha i suoi pro, con la retroguardia e il resto...”, spiegò Bourbon. “Ma c’è anche un importante contro. Io una volta avevo molta paura e non mi muovevo in gruppi in cui c’erano meno di cinque uomini, altro che tre! Pensi che ci fosse d’aiuto? Non serve proprio a niente. Ci è capitato di trasportare un carico, quindi necessitavamo di protezione: due davanti, tre al centro e una retroguardia, tutto come da manuale. Stavamo andando dalla Tretyakovskaya a... come si chiama... quella che era denominata Marxistskaya. In quella galleria non c’erano problemi. Ma c’era un particolare che non avevo colto subito, un certo deperimento... e poi c’era la nebbia. Non si vedeva un accidenti, nemmeno a un palmo dal naso e le torce quasi non servivano a niente. Quindi decidemmo di legare una corda alla cintura della retroguardia, farla passare in quella di uno degli uomini che stava al centro e infine in quella del comandante in testa al gruppo, in modo che nessuno si perdesse nella nebbia. Procedevamo a passo normale e tutto stava andando per il verso giusto, non c’era bisogno di affrettarsi. Toccando ferro, non avevamo ancora incontrato nessuno e mancavano circa quaranta minuti per arrivare a destinazione... anche se alla fine impiegammo molto meno tempo...”, affermò con una punta d’ironia, poi non aggiunse niente per un po’. “Circa a metà strada, un tizio chiamato Tolyan pose una domanda alla retroguardia. Ma l’uomo in ultima posizione non rispose. Tolyan attese e ripeté la domanda. Il nulla più assoluto. A quel punto, Tolyan si decise a tirare la corda che portava al compagno, finché non ne apparve la fine: era stata tranciata da un morso. Sul serio! Dalla corda gocciolava una sostanza umida e viscida ... La sentinella non c’era e noi non avevamo sentito niente, io ero proprio lì, con Tolyan, che mi mostrò il capo della fune. Mi sentii gelare il sangue. Ovviamente provammo a urlare il suo nome, giusto per sicurezza, ma non ci fu reazione, perché non c’era più nessuno che ci poteva rispondere. Fu così che ci guardammo dritti in faccia e cominciammo ad avanzare veloci. Arrivammo alla Marxistskaya in un batter d’occhio”. “Forse quel tizio vi ha fatto uno scherzo?”, lo rimbrottò Artyom, con un filo di speranza nella voce. “Uno scherzo? Da allora nessuno lo ha più visto. Dopo questo avvenimento, ho capito che se è arrivato il tuo momento, è il tuo momento e basta e una sentinella in più non ti può salvare la vita, ma solo condurti più lentamente alla morte. Viaggio sempre in compagnia di un altro uomo, eccetto in una galleria, dalla Sukharevskaya alla Turgenevskaya, ma lì è diverso. Se succede qualcosa ti trascinano fuori, il più velocemente possibile. Capito?” “Sì, ho capito. Credi che ci permetteranno di entrare alla Prospekt Mira? Ho ancora questo affare...”. Artyom indicò la sua mitragliatrice. “Ci ammetteranno alla radiale, ma non credo proprio che ci faranno passare dall’Anello. Armato di quel cannone, non hai speranza di accedere. Ma a noi non interessa, non dobbiamo stare da quelle parti per troppo tempo. Ci fermeremo per un po’ e poi continueremo il viaggio. Tu sei mai stato alla Prospekt Mira?” “Una volta sola, quando ero molto piccolo. Poi non ci sono più tornato”, ammise Artyom. “Allora conviene che ti racconti un po’ come funzionano le cose, laggiù. Non ci sono posti di guardia, non ne hanno bisogno, perché c’è il mercato e nessuno ci vive in pianta stabile, quindi va bene così. Ma c’è un passaggio che conduce all’Anello, quindi all’Hansa... È una stazione radiale che non appartiene a nessuno, ma vi sono dei pattugliatori dell’Hansa che mantengono il controllo. Per cui bisogna comportarsi bene, capito? Altrimenti ti mandano al diavolo e ti negano l’accesso a tutte le altre loro stazioni. Quando arriveremo laggiù, tu salirai sulla piattaforma e te ne starai lì tranquillo. E quel tuo catafalco...”, indicò con un cenno del capo la mitragliatrice di Artyom, “non andare a sbandierarlo in giro. Io... ho un affare da sbrigare con un tizio, quindi tu dovrai startene seduto e aspettarmi. Quando saremo alla Prospekt, dovremo capire come attraversare quel maledetto passaggio fino alla Sukharevskaya”. Bourbon ammutolì nuovamente e Artyom ricominciò a meditare. In quel tratto, la galleria non era poi così male: il terreno era un po’ umido e lungo i binari correva, nella loro stessa direzione, un fiumiciattolo scuro. Qualche minuto dopo udirono dei fruscii e degli squittii, come se qualcuno stesse graffiando un vetro con un chiodo. Artyom fece una smorfia di disgusto. Gli animali non erano ancora visibili, ma lui percepiva già la loro presenza. “Ratti!”. Artyom pronunciò quella orribile parola, mentre un brivido gli correva lungo la spina dorsale. Li vedeva ancora nei suoi incubi, sebbene i ricordi di quei terribili momenti oscuri, quando la madre e l’intera stazione annegarono nella fiumana di ratti, fossero quasi totalmente scomparsi dalla sua memoria. Ma erano spariti davvero? No, erano solo affondati, come un ago che non era stato estratto dalla carne e che continuava a penetrare più a fondo. Percorreva tutto l’organismo, perché il medico, non abbastanza esperto, lo aveva fatto sprofondare. All’inizio si sarebbe nascosto e sarebbe rimasto dov’era, ma poi una forza sconosciuta lo avrebbe rimesso in moto. Avrebbe danneggiato le arterie, i gangli nervosi, avrebbe lacerato gli organi vitali e condannato il suo ospite a un supplizio intollerabile. Quel ricordo, la furia cieca e la crudeltà insaziabile delle bestie, le dolorose e profonde cicatrici che quell’ago d’acciaio aveva lasciato nel subconscio di Artyom lo disturbavano solo di notte. Ma se li vedeva, oppure se ne sentiva l’odore, provava una specie di scarica elettrica, che lo faceva fremere di riflesso. Per Artyom, per il suo patrigno e forse anche per gli altri quattro che quel giorno riuscirono a fuggire sul carrello, i ratti erano molto più che creature disgustose e spaventose. Alla VDNKh non c’era quasi più l’ombra di un ratto: le trappole erano ovunque ed era stato anche sparso in giro del veleno. Così Artyom si era disabituato alla vista dei topi. Ma brulicavano in tutto il resto della Metropolitana e lui se n’era quasi dimenticato o forse, nel momento in cui aveva deciso di intraprendere questo viaggio, aveva cercato di non pensarci. “Che succede, ragazzo? Hai paura dei ratti?”, si informò Bourbon con malignità. “Non ti piacciono? Ah! Come sei viziato! Ti ci abituerai. Sono ovunque... il che non è male, almeno sei sicuro di non morire di fame”, aggiunse facendogli l’occhiolino, mentre ad Artyom saliva un senso di nausea dalla bocca dello stomaco. “Seriamente”, continuò Bourbon “È meglio cominciare a preoccuparsi quando non se ne vedono in giro: se non ci sono ratti significa che in quel luogo ci sono stati guai seri. Se poi non incontri nemmeno una persona, allora devi cominciare ad allarmarti sul serio. Ma sei i ratti corrono di qua e di là, allora è tutto normale. Ordinaria amministrazione, capito?” Esistono diversi tipi di persone, ma Artyom sapeva benissimo di non voler condividere le proprie sofferenze con questo tipo, quindi annuì e non aggiunse altro. Gli animali non erano poi così numerosi, si allontanavano velocemente dalla luce delle torce e a malapena si riusciva a distinguerli nell’oscurità. Malgrado ciò, una delle bestie riuscì a finire sotto il piede di Artyom, il quale si accorse di avere pestato qualcosa di morbido e scivoloso, poi udì uno strillo acutissimo e penetrante. Perse l’equilibrio e quasi rovinò a faccia avanti insieme a tutto il suo equipaggiamento. “Non temere, ragazzo. Non avere paura”, Bourbon cercò di tirarlo su di morale. “Potrebbe andarci peggio: in questo postaccio ci sono un paio di passaggi in cui sono dappertutto, tanto che bisogna camminare sui binari e più si cammina, più li si schiaccia”; sottolineò ciò che diceva con un grugnito meschino. Ad Artyom venne la pelle d’oca. Non aveva più detto niente, ma le sue mani si erano serrate a pugno. Quel Bourbon... lo avrebbe colpito volentieri! Improvvisamente, cominciarono a udire un baccano indecifrabile che proveniva da lontano: Artyom si scordò subito dell’insulto, afferrò il calcio della sua arma automatica e rivolse a Bourbon uno sguardo inquisitorio. “Non ti preoccupare, va tutto bene. Siamo quasi arrivati alla Prospekt”, lo rassicurò Bourbon dandogli dei colpetti condiscendenti sulla spalla. Sebbene l’uomo avesse avvertito Artyom che non ci sarebbero stati posti di blocco alla Prospekt Mira, tutta questa situazione era molto strana per lui. Avrebbero raggiunto una nuova stazione senza prima vedere da lontano la debole fiamma di un fuoco che ne avrebbe indicato il confine, senza dover affrontare alcun ostacolo. Quando giunsero all’uscita della galleria, il frastuono si fece ancora più assordante e cominciò a intravvedersi il bagliore di una luce. Infine, a sinistra, scorsero una scaletta di ferro e un ponticello che conduceva a livello della piattaforma. Gli scarponi di Bourbon fecero cigolare gli scalini di ferro; dopo qualche metro la galleria cominciò a girare a sinistra e ad ampliarsi: erano arrivati in stazione. Vennero accolti da un raggio di luce bianca; dalla galleria non era visibile, ma di lato c’era un tavolinetto al quale sedeva un uomo che indossava una vecchia uniforme grigia, che Artyom non seppe riconoscere. Portava anche un berretto con visiera. “Benvenuti”, li accolse, distogliendo la torcia dai loro visi. “Siete qui per commerciare o dovete solo transitare?” Mentre Bourbon dichiarava il motivo della loro visita, Artyom diede un’occhiata alla stazione della Prospekt Mira davanti ai lui. Sulla piattaforma, lungo i passaggi, regnava la penombra, ma vi erano anche degli archi illuminati dall’interno da una fioca luce giallognola. Vedendola, Artyom provò un’inaspettata stretta al cuore. Voleva sbrigare le formalità il prima possibile e curiosare per tutta la stazione, tra gli archi, nel punto da cui proveniva quella luce così familiare e confortante che quasi lo faceva star male. Artyom sapeva di non aver mai visto niente di tutto ciò, tuttavia, la vista di quel bagliore fece riaffiorare il suo passato più lontano. D’improvviso gli apparve una strana immagine: una casetta inondata da una luce calda e giallognola, una donna semi sdraiata su un’ampia ottomana che leggeva un libro. Non si riusciva a scorgere il suo viso contro la carta da parati color pastello e il rettangolo blu della finestra. La visione gli si stagliò davanti agli occhi, ma si dissolse un secondo dopo, lasciandolo confuso e allo stesso tempo emozionato. Cosa aveva appena visto? Forse la luce della stazione aveva rischiarato un’immagine della sua infanzia che si era nascosta nei recessi del suo subconscio? Forse la giovane donna che leggeva tranquillamente il libro sul divano spazioso e confortevole era sua madre? Impaziente, Artyom porse il passaporto all’ufficiale dello sbarramento, dopo aver acconsentito a lasciare la sua mitragliatrice nel magazzino della stazione per tutta la durata della loro visita, malgrado l’opinione contraria di Bourbon. A quel punto, Artyom percorse la piattaforma di fretta, attirato come una falena dalla luce visibile dietro una colonna, che preannunciava il frastuono di un bazar. La Prospekt Mira era diversa dalla VDNKh, dall’Alekseevskaya e dalla Rizhskaya. Godere della ricchezza dell’Hansa aveva significato avere un’illuminazione migliore rispetto alle luci di emergenza che rischiaravano le altre stazioni che Artyom aveva visitato fino a quel momento. Non si trattava nemmeno delle stesse lampade che illuminavano la Metro in passato, al contrario la luce che emettevano era debole e soffusa. Ogni sei metri circa, una di queste lampadine pendeva dal soffitto e veniva collegata a quella precedente e a quella successiva da un cavo, che percorreva l’intera stazione. Ma Artyom, che era abituato al torbido chiarore rosso delle luci di emergenza, a quello inattendibile dei fuochi e al fievole bagliore delle piccole torce usate all’interno delle tende, era totalmente estraneo alla luce di questa stazione. Questo stesso splendore aveva rischiarato anche la sua infanzia, quando la vita veniva ancora condotta in superficie, per questo motivo il ragazzo era affascinato dall’intravvedere nella sua mente un’immagine che per lui aveva smesso di esistere moltissimo tempo prima. Quindi, quando giunse nella parte illuminata della stazione, Artyom non si diresse verso le file di commercianti, come facevano tutti gli altri, ma poggiò la schiena a una colonna e, coprendosi in parte gli occhi con la mano, si mise a osservare le lampade, una dopo l’altra, finché gli occhi non cominciarono a dolergli. “Sei completamente impazzito? Perché te ne stai qui a fissarle così? Vuoi perdere la vista? Così diventerai cieco come una talpa e non mi servirai più a niente!”. La voce di Bourbon risuono nelle orecchie di Artyom. “Sei totalmente pazzo: hai dato loro quel tuo marchingegno! Puoi anche andare a farti un giro... e parlare con le lampade, magari hanno storie interessanti da raccontarti!” Artyom gli lanciò un’occhiataccia ostile, ma gli obbedì. La stazione non era sovraffollata, ma le poche persone che c’erano commerciavano, chiamavano, chiedevano, cercavano di urlare più forte dei loro vicini e parlavano a voce talmente alta che Artyom comprese perché, ancora prima di entrare in stazione, si sentisse tutto quel fracasso. Su entrambi i binari poggiavano i resti dei treni, mentre alcuni vagoni erano stati trasformati in alloggi. Lungo la piattaforma erano state sistemate due file di vassoi sui quali erano in bella vista diversi utensili, alcuni in file ordinate, altri alla rinfusa. Da un lato della stazione c’era uno sbarramento di metallo in prossimità di quella che era stata l’uscita verso la superficie, mentre dall’altro c’erano dei sacchi grigi, tutti in fila, che indicavano chiaramente le posizioni della linea di fuoco. Sul soffitto era appeso uno stendardo stranamente bianchissimo, sul quale era stato dipinto un cerchio marrone, il simbolo dell’Anello. Oltre la linea di fuoco vi erano quattro scale mobili che conducevano proprio all’Anello ed era in quel punto che cominciava il territorio della potente Hansa, proibito agli stranieri. Le guardie di frontiera al di là della recinzione, insieme alla solita tuta mimetica, indossavano un soprabito impermeabile, entrambi insolitamente grigi. “Per quale motivo portano una mimetica grigia?”, domandò Artyom a Bourbon. “Semplicemente perché sono dei maiali”, rispose quello sprezzante. “Ora va’ avanti a dare un’occhiata, io devo sbrigare i miei affari proprio qui”. Non c’era nulla che interessasse particolarmente Artyom, solo tè, salsicce, batterie per le lampade, giacche e soprabiti fatti di pelle di maiale, alcuni libri malconci, la maggior parte dei quali pornografici, oltre a bottiglie da mezzo litro il cui contenuto era sospetto, mentre sulle etichette storte stato scritto “vodka fatta in casa”. Era vero: nessuno dei commercianti vendeva droga, che in passato si poteva trovare praticamente ovunque. Persino il modesto ometto scarno dagli occhi umidi che vendeva quel dubbio liquore, quando Artyom gli domandò se avesse un po’ di “roba”, gli intimò di andare al diavolo. Tra gli altri, c’era anche un commerciante che vendeva legna da ardere: piccoli tronchi nodosi e rami che qualche stalker aveva recuperato dalla superficie. Si diceva che bruciassero molto a lungo e che facessero poco fumo. Le poco sonanti cartucce per i Kalashnikov erano la valuta corrente per gli acquisti. Cento grammi di tè venivano cinque cartucce, un pacco di salsicce ne costava quindici, mentre chiedevano venti cartucce per una bottiglia di quel liquore fatto in casa. Le chiamavano affettuosamente “pallottoline”: “Amico, guarda che bella giacca... costa anche pochissimo, solo trenta pallottoline ed è tua. Ok, d’accordo, se te la lascio a venticinque la compri?” Osservando le file ordinate di “pallottoline” sui banconi, Artyom ricordò le parole del patrigno: “Una volta ho letto da qualche parte che Kalashnikov andava molto fiero della sua invenzione, per il fatto che la sua arma automatica era diventata la più famosa in tutto il mondo. Sosteneva di essere molto felice perché, grazie a questo dispositivo, i confini della sua terra natia venivano costantemente tenuti al sicuro. Però, io credo che se avessi inventato un aggeggio del genere sarei impazzito: il solo pensiero che la maggior parte degli omicidi sarebbero stati perpetrarti proprio grazie a ciò che avevo inventato mi fa rabbrividire! È anche peggio che essere l’inventore della ghigliottina”. Una cartuccia, un’uccisione. La vita di qualcuno... spezzata. Cento grammi di tè costavano cinque vite umane. Un pacchetto di salsicce? A buon mercato! Solo quindici vite. Una giacca di pelle di ottima qualità, scontata solo per oggi, costa venticinque vite, così ne risparmiamo cinque. Lo scambio giornaliero a questo mercato era calcolabile nelle vite umane degli abitanti della Metropolitana. “Hai trovato qualcosa?”, si informò Bourbon raggiungendolo. “No, niente di interessante”, ribatté Artyom, quasi senza ascoltarlo. “Sì, hai ragione! È pieno di cianfrusaglie. Ma... ragazzo mio! Una volta questa stazione era l’unico posto in tutta la dannatissima Metropolitana dove si poteva trovare qualunque cosa si desiderasse. Si faceva a gara per aggiudicarsi di tutto: armi, narcotici, donne, documenti falsi...”, sospirò sognante Bourbon. “Ma questi imbecilli”, fece un cenno diretto alla bandiera dell’Hansa, “lo hanno trasformato in un asilo: non puoi fare questo né quello... Va bene, ora andiamo a recuperare la tua palla al piede, dobbiamo continuare il nostro viaggio”. Così dicendo, andarono a riprendere la mitragliatrice di Artyom, poi si sedettero per un momento su una panchina di pietra, prima di accedere alla galleria meridionale. Bourbon aveva scelto quel punto un oscuro proprio per fare in modo che i loro occhi si abituassero alla luce più flebile. “Ok, questo è quanto: io non garantisco niente. Non ho mai provato ad attraversare questa galleria e, in caso di guai, non so come reagirò. Ovviamente tocchiamo ferro, ma se ci troviamo a dover affrontare qualcosa... Beh, se comincio a piagnucolare o divento improvvisamente sordo non dovrebbero esserci problemi. Per quanto ne so, è sempre diverso. I nostri ragazzi non sono riusciti a ritornare alla Prospekt. Penso che non siano arrivati lontano, quindi oggi potremmo anche trovarli da qualche parte. Preparati, perché mi sembra che tu sia un po’ debole di stomaco... e se io comincio a non vederci più dalla rabbia, ti farò tacere con la forza. È proprio questo il problema, capisci? Non so cosa farci... Beh, d’accordo...”. Dopo tutte queste esitazioni, finalmente Bourbon si decise: “Mi sembri un tipo a posto, non sei di quelli che se ne vanno in giro a sparare agli altri nella schiena. Perciò, durante questa traversata ti affido la mia pistola. Fai molta attenzione”, avvertì Artyom guardandolo fisso negli occhi: “Non fare scherzi. Io non ho un gran senso dell’umorismo”. Fece cadere qualche straccio dallo zaino, dai quali estrasse una mitragliatrice avvolta in un involucro di plastica. Anche questo era un Kalashnikov, ma era più piccolo, come quelli in dotazione alle guardie di confine dell’Hansa; il calcio era articolato e corto, al contrario di quello dell’arma di Artyom. Bourbon estrasse il caricatore al suo interno e lo rimise nello zaino, posandoci sopra gli stracci. “Prendi questo”, diede l’arma ad Artyom. “Non riporla per nessun motivo, potrebbe esserti utile. Anche se il passaggio ha un aspetto tranquillo...”. Bourbon non terminò la frase e saltò giù, sul sentiero. “Ok, andiamo: prima partiamo, prima arriviamo”. Fu terribile. Artyom era consapevole che durante il viaggio dalla VDNKh alla Rizhskaya sarebbe potuta succedere qualsiasi cosa, ma per lo meno la gente percorreva quella galleria avanti e indietro tutti i giorni e lui sapeva che verso sud vi erano stazioni abitate, dove erano attesi. Quel tragitto era stato poco piacevole come tutte le volte in cui si doveva lasciare un luogo illuminato e tranquillo. Persino durante la traversata della galleria dalla Rizhskaya alla Prospekt Mira, nonostante i suoi dubbi, si era svagato pensando che davanti a lui vi era una stazione dell’Hansa, cioè un luogo dove si sarebbe potuto riposare in tutta sicurezza. Ma qui la situazione era terrificante. La galleria davanti ai loro occhi era completamente buia: vi regnava un’oscurità assoluta, totale; era talmente fitta che si poteva persino toccare. Porosa come una spugna, assorbiva avidamente i raggi delle loro torce che erano a malapena sufficienti per illuminare lo spazio mezzo metro davanti a loro. Tendendo le orecchie fino al limite, Artyom cercò di distinguere anche il più piccolo germe di quel rumore strano e doloroso, ma invano. Proprio come la luce, anche i suoni faticavano a penetrare quell’oscurità. Persino il tonfo netto degli scarponi di Bourbon risuonava fiacco e sordo. Sulla parete di destra apparve un varco: il raggio della torcia venne inghiottito da quel punto oscuro e Artyom non comprese subito che si trattava di un semplice passaggio laterale della galleria principale. Guardò Bourbon con fare interrogatorio. “Non ti preoccupare, qui una volta c’era un passaggio di trasferimento”, gli spiegò “Per fare in modo che i treni passassero direttamente sull’Anello senza dover transitare dalle altre stazioni. Ma quelli dell’Hansa lo hanno riempito, non sono degli stupidi. Non lascerebbero mai aperta una galleria di questo tipo, soprattutto se arriva dritta nel loro territorio...” Dopo quelle parole, proseguirono taciturni per un tratto piuttosto lungo, ma il silenzio si stava facendo talmente oppressivo che Artyom non riusciva più a sopportarlo. “Senti un po’, Bourbon”, si rivolse all’uomo, per cercare di dissipare le allucinazioni. “È vero che, non molto tempo fa, dei brutali assassini hanno attacco una carovana proprio da queste parti?” Bourbon non rispose subito e Artyom suppose che non avesse sentito bene la domanda. Stava per ripetergliela, quando Bourbon rispose: “Ne ho sentito parlare. Ma io non c’ero, quindi non posso esserne sicuro”. Le sue parole causarono uno strano rumore, quasi soffocato. Artyom riuscì appena a coglierne il senso, poiché faceva molta fatica a distinguere la frase che aveva appena sentito da un pensiero martellante: in questa galleria si faticava a sentire i rumori. “Cosa? Nessuno ha visto niente? C’è una stazione a nord e una a sud, come può essere? Dove possono essere finiti?”, continuò, non perché fosse particolarmente interessato alla conversazione, ma solo per sentire la sua voce. Passarono diversi minuti prima che Bourbon rispondesse; questa volta Artyom non volle mettergli fretta, perché l’eco delle parole appena pronunciate risuonava ancora nella sua testa ed era troppo impegnato ad ascoltarle. “Si dice che vi sia una sorta di botola, che però è nascosta. Non è propriamente visibile. Non so quante possibilità ci siano che si riesca a vedere un passaggio del genere nell’oscurità...”, aggiunse Bourbon con quella che pareva una voce innaturalmente irritata. Ci volle qualche minuto prima che Artyom ricordasse cosa stessero dicendo. Cercò con tutte le sue forze di riprendere il filo del discorso e di porre a Bourbon un’altra domanda, solo perché voleva continuare la conversazione, che per quanto impacciata e difficile fosse, gli stava risparmiando il silenzio totale. “È sempre così buio qui dentro?”, fece Artyom, che si sentì ancora più spaventato, perché quelle ultime parole avevano prodotto un rumore tanto lieve che gli sembrava di avere qualcosa nelle orecchie che gli impedisse di sentire. “Buio? Sì, sempre. È buio dappertutto. Sta giungendo... la grande oscurità... avvolge il mondo e... dominerà per sempre”, rispose Bourbon, intercalando strane pause. “Dove l’hai letta? In un libro o...?”. Artyom notò che doveva fare un sforzo ancora maggiore per percepire il suono delle sue parole; nel frattempo comprese che il linguaggio di Bourbon era diverso, spaventoso... Tuttavia, Artyom non aveva abbastanza forza per sorprendersi. “Un libro... Dobbiamo temere... le verità celate negli antichi... volumi in cui... le parole sono stampate in oro, su pagine... nero ardesia... dove rimarranno per sempre”. Bourbon pronunciò questa frase lentamente e Artyom rimase colpito dal fatto che l’uomo non si voltava più a parlargli, come aveva fatto fino a quel momento. “Bellissima”, Artyom quasi urlò. “E questa da dove viene?” “La bellezza... verrà deposta e distrutta, i... profeti soffocheranno, nel tentativo di formulare le loro premonizioni... per un giorno... il futuro sarà... più oscuro dei loro più tetri... timori e ciò a cui assisteranno... avvelenerà le loro menti...”, proseguì Bourbon tranquillo. Improvvisamente si fermò e voltò il capo a sinistra, in maniera così netta che Artyom udì perfettamente il rumore delle sue vertebre; quindi guardò Artyom dritto negli occhi. Artyom fece qualche passo indietro, cercando a tastoni la sua mitragliatrice, nel caso potesse servirgli. Bourbon lo guardava con gli occhi spalancati, le pupille contratte come capocchie di spillo, anche se nell’oscurità nero-pece della galleria sarebbero dovute essere dilatate al massimo, per cercare di cogliere più luce possibile. Il suo viso aveva un’espressione tranquilla ma innaturale, i muscoli non erano tesi, mentre il sorriso sdegnoso era scomparso dalle sue labbra. “Sono morto”, affermò Bourbon. “Io non ho più tempo”. E rigido come uno stoccafisso, cadde a faccia in giù. A quel punto, le orecchie di Artyom percepirono il solito rumore terribile, solo che questa volta non si accresceva e non si amplificava gradualmente come nell’altra galleria. Lo udì all’improvviso, ad altissimo volume, tanto che lo stordì e lo fece cadere a terra. Qui il rumore era più forte e Artyom, sdraiato sul terreno, non riusciva a radunare le forze per rimettersi in piedi. Quando però riuscì a coprirsi le orecchie, come aveva fatto in precedenza, e a urlare con quanto fiato aveva in gola, si riprese e si alzò. Quindi raccolse la torcia caduta dalle mani di Bourbon e la fece passare sui muri, controllandoli febbrilmente, cercando il punto da cui provenisse il rumore, il tubo rotto. Ma le tubature erano intatte, mentre il rumore proveniva dall’alto. Bourbon giaceva immobile, a faccia in giù, quando Artyom lo girò e notò che i suoi occhi erano ancora aperti. Si concentrò per ricordasi cosa bisognava fare in situazioni del genere, gli mise una mano sul polso e cercò di individuare il battito del cuore. Anche se fosse stato debole o incostante, doveva sentirlo... ma fu tutto inutile. Afferrò Bourbon per le mani e, grondando di sudore, trascinò il suo corpo, sempre più pesante: voleva portarlo lontano da quel luogo. Era terribilmente difficile, anche perché il ragazzo si era dimenticato di togliergli lo zaino dalle spalle. Dopo una ventina di passi, Artyom inciampò in qualcosa di morbido, mentre il suo naso veniva colpito da un odore rivoltante, leggermente dolciastro. Così si ricordò delle parole di Bourbon: “Potremmo anche trovarli da qualche parte...”, e raddoppiò i suoi sforzi, cercando di non guardare dove metteva i piedi, superando i cadaveri sui binari. Trascinò il suo compagno a lungo; la testa di Bourbon assumeva posizioni innaturali, senza vita, mentre le sue mani diventavano sempre più fredde e scivolavano da quelle sudate di Artyom. Non voleva accettarlo, non poteva. Doveva riuscire a portarlo fuori dalla galleria perché glielo aveva promesso, avevano un accordo! Il rumore si stava gradualmente affievolendo e d’improvviso scomparve. Ritornò il silenzio letale di prima e, con enorme sollievo, il ragazzo si concesse una pausa e si sedette sui binari per riprendere fiato. Bourbon giaceva immobile di fianco a lui, mentre Artyom, disperato e con il fiato grosso, osservava la sua faccia pallida. Dopo cinque minuti circa si decise ad alzarsi, afferrò Bourbon per i polsi e riprese a camminare. Non pensava più a niente, era animato solo da una feroce determinazione: doveva trascinarlo fino alla stazione successiva. Ma le sue gambe cedettero, non riuscì a stare in piedi e rimase sdraiato a terra per qualche minuto. Quando si riprese, afferrò Bourbon per il bavero: “Ci arriverò, ci arriverò, ci arriverò, ci arriverò, ciarriveròciarriveròciarriveròciarriverò...”, si rassicurava, sebbene non ci credesse nemmeno lui. Aveva perso tutte le forze, perciò afferrò la sua mitragliatrice, spostò la sicura perché l’arma sparasse colpi singoli; la puntò verso sud, ne esplose uno e urlò: “Gente!” Tuttavia, l’ultimo rumore che sentì non era quello di una voce umana, ma il fruscio delle zampe di un ratto. Chissà per quanto tempo era rimasto sdraiato lì, trattenendo Bourbon per il bavero, stringendo il manico della mitragliatrice, quando i suoi occhi intravvidero una luce. In piedi sopra di lui, un uomo piuttosto anziano, con una torcia in una mano e una strana pistola nell’altra, lo stava guardando. “Mio giovane amico”, scandiva le parole con una voce piacevole e sonora. “Credo tu possa dimenticarti del tuo compagno. È morto stecchito. Vuoi startene qui e raggiungerlo nell’aldilà, oppure pensi che ti possa aspettare ancora per un po’?” “Aiutami a portarlo fino in stazione”, lo pregò Artyom, debolissimo, coprendosi gli occhi per proteggersi dalla luce. “Temo che non ci sarà possibile”, ribatté l’uomo acido. “Non desidero trasformare la stazione della Sukharevskaya in un cimitero, già è scomoda così com’è. Inoltre, se portiamo il cadavere fin laggiù, è improbabile che gli abitanti della stazione gli diano degna sepoltura. Che differenza corre tra lasciare che il corpo si decomponga qui oppure alla stazione, se l’anima immortale è già tornata al suo creatore? O se si reincarnerà? Non so quale religione professi, ma a mio parere, nessuna di esse ha completamente ragione”. “Ma glielo avevo promesso...”, sospirò Artyom. “Avevamo un accordo...” “Amico mio!”, lo sconosciuto aggrottò le sopracciglia. “Sto cominciando a perdere la pazienza. Le regole che mi sono imposto mi impediscono di aiutare i morti quando ci sono abbastanza vivi da salvare. Io sto tornando alla Sukharevskaya, ho vissuto troppo a lungo in questa galleria e ormai i reumatismi si fanno sentire. Se vuoi rincontrare il tuo compagno il prima possibile ti consiglio di rimanere qui: i ratti e le altre creature gentili ti aiuteranno. Ma se ciò che ti frena dal prendere una decisione è l’aspetto legale della questione, allora stai sicuro che il contratto viene rescisso se uno dei cofirmatari non si oppone”. “Ma non posso abbandonarlo qui!”. Artyom cercava di convincere il suo soccorritore. “Era un essere vivente! Dobbiamo lasciarlo in pasto ai ratti?” “Hai detto bene, era un essere vivente”, l’uomo ispezionò il corpo, scettico. “Ma ora è indubbio che sia un cadavere; le cose cambiano. Facciamo così: se vuoi possiamo tornare qui e accendere un falò per cremare il corpo, o qualsiasi altra cosa sei solito fare in queste circostanze. Ora alzati!”, gli ordinò e Artyom, riluttante, si rimise in piedi. Nonostante le sue proteste, lo straniero quasi strappò lo zaino di Bourbon dalla sua schiena e se lo mise sulla spalla. Aiutando Artyom a procedere, si incamminò velocemente. All’inizio, il ragazzo faceva molta fatica a camminare, ma passo dopo passo sembrava che l’uomo, molto più anziano di lui, gli infondesse forza, grazie alla sua energia esuberante. Il dolore ai piedi si placò e pian piano riprese a pensare in maniera razionale. Osservava il viso del suo soccorritore: sembrava che avesse più di cinquant’anni, ma aveva un aspetto raggiante e robusto. Le braccia, che conducevano Artyom, erano salde e non esitarono per la fatica nemmeno un attimo. I capelli erano corti e si stavano ingrigendo, inoltre aveva una barbetta ben tenuta che sorprese Artyom: quell’uomo era troppo curato per vivere nella Metro e specialmente per il posto dimenticato nel quale sembrava abitasse. “Cosa ti è successo, amico mio?”, gli chiese lo straniero. “Non mi sembra abbiate subito un attacco, ma piuttosto che lui sia stato avvelenato... Io voglio davvero sperare che non si tratti di quello che penso”, aggiunse, senza entrare nei dettagli di ciò che temeva. “No... è morto da solo”. Artyom non aveva la forza di aggiungere altro o di spiegare le circostanze della morte di Bourbon, della quale ancora non riusciva a rendersi conto. “È una lunga storia, te la racconterò più tardi”. La galleria si ampliò, sembrava fossero giunti alla stazione. Ma ad Artyom pareva ci fosse qualcosa di strano, insolito. Qualche secondo dopo capì di cosa si trattava. “Ma... è tutto buio!”, guardava il soccorritore sgomento. “Qui non ci sono autorità, quindi non c’è bisogno di dare luce alla gente”, chiarì l’uomo. “È per questo che, chiunque abbia bisogno della luce, se la deve procurare da solo. Alcuni ci riescono, altri no. Ma non preoccuparti, per fortuna io conosco personaggi di rango elevato”, si inerpicò velocemente sulla piattaforma e tese la mano al ragazzo. Girarono al primo arco ed entrarono in un androne; c’era solo un passaggio lungo, un colonnato ad archi su entrambi i lati, poi i soliti muri di ferro e le scale mobili ferme. Vagamente illuminata da piccoli fuochi, la maggior parte della stazione era avvolta nell’oscurità: la vista della Sukharevskaya era oppressiva e molto triste. Una moltitudine di persone sciamava attorno ai fuochi, alcuni dormivano sul pavimento, mentre altre sagome di stracci, praticamente ripiegate su loro stesse, vagavano da un fuoco all’altro. Erano tutti ammassati al centro dell’androne, il più lontano possibile dalla galleria. Il fuoco a cui lo straniero aveva condotto Artyom sembrava più luminoso degli altri e si trovava al centro della piattaforma. “Un giorno questa stazione verrà distrutta da un incendio”, Artyom pensò ad alta voce, osservando scoraggiato l’androne. “Tra quattrocentoventi giorni”, aggiunse il suo compagno, calmo. “Perciò è meglio che te ne vada prima; in ogni caso, è quello che farò io”. “Come fai a saperlo?”. Artyom era raggelato. Ripensò a tutto ciò che gli era stato detto sui maghi e i sensitivi, poi cominciò a scrutare il viso del compagno, alla ricerca dei segni di una conoscenza ultraterrena. “Pitone, figlio della nostra madre terra è turbato”, rispose sorridendo. “Ok, devi dormire un po’, così poi potremo presentarci e fare quattro chiacchiere”. Dopo queste parole, Artyom sentì il sopravvento di una fatica mostruosa, accumulata nella galleria che precedeva la Rizhskaya, nei suoi incubi e negli ultimi avvenimenti, che avevano messo alla prova la sua volontà. Non aveva più forze, nemmeno per stare sveglio, quindi si sdraiò sulla falda di telone impermeabile vicino al fuoco, mise lo zaino sotto la testa e si abbandonò a un lungo sonno profondo e senza sogni. CAPITOLO 6 : I DIRITTI DEL PIU' FORTE Il soffitto era così fuligginoso che non vi era più traccia dell’intonaco che era stato applicato a suo tempo. Artyom lo fissava, cercando di capire dove si trovasse. “Ti sei svegliato?”, riconobbe una voce familiare, mentre si sforzava di ricomporre il puzzle dei suoi pensieri, per ricordare l’accaduto del giorno prima (era stato il giorno precedente?). Ora gli sembrava tutto surreale, indistinto, come la nebbia. Le mura erte dal sonno avevano separato la realtà dai ricordi. “Buona sera”, sentì dire Artyom all’uomo che lo aveva trovato. Era seduto dall’altra parte del fuoco, perciò lo vedeva attraverso le fiamme. Il viso del vecchio aveva qualcosa di misterioso, quasi mistico. “Ora possiamo presentarci: anche io ho un nome normale, come tutte le persone che conosci. Ma è troppo lungo e non mi descrive adeguatamente: sono l’ultima incarnazione di Genghis Khan, ma tu puoi chiamarmi solo Khan, è più corto”. “Genghis Khan?”. Artyom lo guardò sconcertato, anche perché non credeva nella reincarnazione. “Amico mio!”, obiettò Khan come se fosse stato insultato. “Non devi osservare i miei occhi e il mio comportamento con un tanto sospetto, è così ovvio! Sono stato reincarnato in altre forme, anche più facilmente accettabili. Tuttavia, Genghis Khan rimarrà la parte più significativa del mio cammino; sfortunatamente, però, non ricordo nulla di quella vita”. “Perché Khan e non Genghis?”, osò domandargli Artyom. “Dopotutto, Khan non era il cognome, ma solo la professione, se ricordo bene”. “Perché rievoca riferimenti inutili, per non parlare poi di Genghis Aitmatov”, affermò l’uomo riluttante, mentre Artyom non riusciva a comprendere a cosa alludesse. “E comunque, non ritengo sia necessario dover spiegare le origini del mio nome. Tu come ti chiami?” “Io sono Artyom e non so chi ero nella vita precedente, ma forse a quel tempo il mio nome aveva un significato preciso”, approfondì Artyom. “Piacere di conoscerti”, gli rispose Khan, che dava l’idea di essere rimasto completamente soddisfatto dalla sua risposta. “Spero che condividerai con me questo pasto frugale”, aggiunse, poi sollevò e appese sopra il fuoco un malconcio bollitore in metallo, identico a quello che il ragazzo aveva usato durante le pattuglie nella galleria settentrionale della VDNKh. Artyom si alzò, frugò nello zaino e ne estrasse una salsiccia, che aveva portato con sé dalla VDNKh. Con il suo coltellino ne tagliò qualche pezzo e li mise su un cencio pulito, fino a qualche minuto prima anch’esso riposto nel suo piccolo bagaglio. “Ecco qui”, e lo porse al nuovo amico “La possiamo mangiare bevendo il tè”. Il tè di Khan era quello della VDNKh, Artyom lo riconobbe subito. Sorseggiando la bevanda calda da una tazza di metallo smaltato, ripensò agli eventi del giorno prima. Ovviamente, anche l’uomo era assorto nei suoi pensieri e non infastidì il giovane. La pazzia riversatasi nel mondo dal tubo rotto sembrava avere un effetto sempre diverso sulle persone: Artyom la percepiva come un rumore assordante che non gli permetteva di concentrarsi e distruggeva i suoi pensieri, ma per il resto lo aveva risparmiato. Al contrario Bourbon non era riuscito a sopportare quell’attacco potentissimo ed era morto. Artyom non si aspettava che il rumore potesse uccidere qualcuno, altrimenti non avrebbe fatto nemmeno un passo nella galleria oscura tra la Prospekt Mira e la Sukharevskaya. Questa volta il rumore era arrivato di soppiatto e, all’inizio, gli aveva offuscato i sensi. Artyom era sicuro che tutti i soliti rumori della galleria fossero attutiti e, nei primi momenti, non gli era stato possibile sentire nemmeno quel suono acuto, che poi gli aveva improvvisamente bloccato i pensieri, come se si fossero ricoperti di una patina di debolezza; infine gli aveva inflitto un colpo brutale. Per quale ragione non si era accorto subito che, da un momento all’altro, Bourbon aveva cominciato a blaterare in una lingua che non avrebbe mai saputo riprodurre, nemmeno se avesse letto centinaia di libri sulle profezie apocalittiche? Il rumore gli era entrato nel profondo, come se lo avesse stregato e una strana ebbrezza avesse preso il sopravvento. Artyom stesso si era ritrovato a pensare a una serie di sciocchezze, al fatto che non doveva rimanere in silenzio, che dovevano continuare a parlare... ma non gli era venuto in mente di provare a capire cosa stesse succedendo. Qualcosa aveva interferito. Voleva estromettere l’accaduto dalla sua coscienza, non ci voleva più pensare, tanto non sarebbe riuscito a venire a capo di niente. In tutti gli anni passati alla VDNKh aveva solo sentito parlare di fatti del genere. In passato era stato più facile credere che tutte le storie che gli erano state raccontate non fossero semplicemente plausibili. Artyom scosse la testa e guardò di nuovo da una parte all’altra. La stessa penombra soffocante riempiva lo spazio: Artyom pensò che molto probabilmente laggiù non fosse mai arrivata la luce e che sarebbe solo potuto essere più buio, quando le riserve di carburante fossero terminate. L’orologio sopra l’entrata della galleria aveva smesso di funzionare molto tempo prima, poiché non c’era nessuno che si prendesse cura di dettagli del genere. Artyom si domandò perché Khan si fosse rivolto a lui con un “buona sera” dato che secondo i suoi calcoli sarebbe dovuta essere mattina, o addirittura mezzogiorno. “È davvero sera?”, domandò a Khan, perplesso. “È sera per me”, rispose Khan pensieroso. “In che senso?”, Artyom non riusciva a capire. “Vedi, Artyom, è chiaro che tu vieni da una stazione in cui l’orologio funziona; tutti lo osservate con riverenza e controllate l’ora prima sul vostro orologio da polso e poi la paragonate a quella indicata dai numeri rossi sopra l’entrata della galleria. Secondo la tua concezione, il tempo è lo stesso per tutti, proprio come la luce. Beh, qui è il contrario, perché nessuno si fa i fatti degli altri. Nessuno è obbligato ad assicurarsi che vi sia luce per tutti. Vai a parlare con chiunque abiti qui e vedrai che la tua idea gli sembrerà assurda. Chi ha bisogno della luce, la deve portare con sé. Ed è lo stesso anche con il tempo: chi ha bisogno di sapere che ore sono, chi teme il caos, deve portare con sé il tempo. Qui tutti ne tengono traccia, ma secondo le loro stime personali, che sono sempre diverse; ovviamente hanno tutti ragione, ognuno crede che il proprio calcolo sia quello corretto e fa dipendere la propria vita da quei ritmi. Per me adesso è sera, per te è mattino... e allora? La gente come te fa moltissima attenzione a tenere il conto delle ore passate a girovagare, proprio come gli antichi tenevano i carboni ardenti all’interno dei crogioli fumanti, sperando di riuscire a risvegliare il fuoco. Ci sono anche persone, però, che hanno perduto i loro pezzetti di carbone, altre li hanno addirittura gettati via. Come vedi nella Metro è quasi sempre notte e non ha senso cronometrare il tempo in maniera tanto meticolosa. Libera le ore e vedrai che il tempo si trasformerà, è molto interessante. Muterà al tal punto che non lo riconoscerai nemmeno. Smetterà di essere frammentato, diviso in sezioni composte da ore, minuti e secondi. Il tempo è come il mercurio: se lo spargi, si riunisce di nuovo, ritrova la sua integrità e la sua indeterminatezza. L’uomo è riuscito a domarlo, a rinchiuderlo in orologi da taschino e cronometri e, per coloro che tengono il tempo alla catena, questo scorre senza intoppi. Ma se lo liberi, vedrai: scorre in maniera diversa a seconda della persone. Per alcuni è lento e viscoso, lo contano con i respiri attraverso i quali inalano ed espirano il fumo delle sigarette, per altri invece fugge via e riescono a misurarlo solo grazie alle vite che gli passano davanti. Pensi che ora sia mattina? Beh, c’è un’ottima possibilità che tu abbia ragione, circa il venticinque per cento. Tuttavia, il fatto che sia mattina non ha molto senso, dato che il sole sorge là sopra, dove non c’è più vita, o per lo meno non ci sono più persone. Ciò che accade lassù ha valore per coloro che non ci vanno mai? No. Quando io ti dico ‘buona sera’, puoi anche rispondermi ‘buon giorno’, se lo desideri. In questa stazione non viene conteggiato il tempo, eccetto uno, molto particolare: questo è il quattrocentodiciannovesimo giorno, sto facendo il conto alla rovescia”. Ciò detto non parlò più, si limitò a sorseggiare il suo tè caldo, mentre Artyom ragionava sul fatto che alla VDNKh gli orologi della stazione venivano trattati come se fossero delle reliquie e, quando avevano qualche problema, tutti si allarmavano. Le autorità sarebbero rimaste a bocca aperta se avessero ascoltato un discorso del genere... Il tempo non esiste, il concetto stesso del tempo è obsoleto! Ciò che Khan aveva appena descritto ricordò ad Artyom un buffo particolare, che lo aveva sempre fatto riflettere: “Si dice che in passato, quando c’erano ancora i treni, all’interno dei vagoni si sentiva l’annuncio: ‘Attenzione: chiusura porte. La prossima stazione è x,y,z, e la piattaforma successiva sarà alla vostra sinistra o alla vostra destra’”, ricordò. “È vero?” “Ti pare strano?”, Khan inarcò le sopracciglia. “Come potevano annunciare su quale lato si sarebbe trovata la piattaforma? Se percorro i binari da sud a nord, allora la piattaforma è a destra. Se invece vado in senso contrario, si troverà sulla sinistra. Inoltre, se ben ricordo, i sedili erano appoggiati alle pareti del treno, perciò, dal punto di vista dei passeggeri, le piattaforme sarebbero state davanti o dietro, metà da una parte e l’altra metà dall’altra, a seconda della prospettiva”. “Hai ragione”, rispose Khan rispettoso. “In realtà coloro che guidavano i treni parlavano solo secondo il loro punto di vista. Viaggiavano nel primo compartimento, dove la destra era a destra e la sinistra era a sinistra. Perciò molto probabilmente parlavano solo per loro stessi. Avrebbero potuto anche non dire nulla. Ho sempre sentito queste parole, sin da quando ero bambino, e vi ero talmente abituato che non mi sono mai soffermato a rifletterci”. Passò qualche momento, poi continuò: “Mi avevi promesso di raccontarmi cosa è successo al tuo amico”. Artyom fece una pausa e rifletté se raccontare a quest’uomo le circostanze misteriose che avvolgevano la morte di Bourbon, se parlargli del rumore che aveva già sentito due volte nelle ultime ventiquattro ore e della sua influenza distruttiva sulla ragione umana, se raccontargli la sua sofferenza e i suoi pensieri mentre sentiva la melodia della galleria. Decise che, se esisteva qualcuno a cui valeva la pena raccontare tutto, sarebbe stata la persona che credeva di essere l’ultima incarnazione di Genghis Khan, per la quale il tempo non esisteva. Quindi, cominciò a narrare la sua disavventura, in maniera confusa, ansiosa, senza osservare la sequenza degli eventi, cercando di trasmettere le diverse sensazioni che aveva provato, piuttosto che i fatti. “Erano le voci dei morti”, disse calmo Khan, non appena Artyom ebbe terminato il suo racconto. “Cosa?”, il ragazzo si sorprese. “Hai sentito le voci dei morti. All’inizio sembravano un sussurro o un fruscio? Sì, erano loro”. “Quali morti?”, Artyom non riusciva a comprendere. “Tutte le persone che sono state uccise nella Metro sin dall’inizio. Infatti, questo spiega perché sono l’ultima incarnazione di Genghis Khan e non mi reincarnerò mai più. Amico mio, si arriva tutti al capolinea. Non so come è potuto succedere, ma questa volta l’umanità ha superato il limite. Non esistono più né il paradiso né l’inferno. Ma non c’è nemmeno il purgatorio. Nel momento in cui l’anima abbandona il corpo... spero almeno che tu creda nell’immortalità dell’anima? Beh, in quel momento non riesce più a trovare rifugio. Quanti megatoni e bevatroni ci vogliono per disperdere la noosfera? Quest’ultima era reale quanto questo bollitore. Ma checché tu ne dica, non ci siamo mai risparmiati, abbiamo distrutto sia il paradiso che l’inferno. Ora viviamo in questo mondo strano, in cui l’anima deve rimanere dopo la morte del corpo. Comprendi cosa intendo dire? Morirai, ma la tua anima tormentata non si reincarnerà più e, quando essa capirà che il paradiso non esiste, non avrà pace né serenità. È condannata a rimanere nel luogo in cui hai vissuto tutta la tua vita, qui, nella Metro. Io non riesco a darti l’esatta spiegazione teosofica del perché sono a conoscenza di tutto ciò, ma una cosa la so: nel nostro mondo, le anime rimangono nella Metro dopo la morte. Continueranno a percorrere le volte di queste gallerie fino alla fine del mondo, perché non hanno più dove andare. Nella Metro si riuniscono la vita materiale e l’ipostasi dell’altro mondo. Sia l’Eden che l’inferno si trovano qui, nello stesso posto. Viviamo tra le anime dei morti, ci circondano da tutte le parti: coloro che sono stati investiti dai treni, uccisi a colpi di pistola, strangolati, bruciati vivi, divorati dai mostri, quelli a cui il fato ha riservato una morte misteriosa, della quale nessun essere vivente sa nulla e non potrà mai nemmeno immaginare. Per molto tempo mi sono impegnato a capire dove fossero dirette, perché la loro presenza non viene percepita costantemente, perché non si sentono gli sguardi leggeri e freddi provenire dall’oscurità... Ti hanno mai parlato della “tunnel-fobia”? Un tempo credevo che i morti ci seguissero nella galleria, passo passo, e si nascondessero nell’oscurità non appena ci girassimo per controllare. Ora so che gli occhi non servono, perché non riescono a mostrarci i morti. Ma i brividi che ci corrono lungo la spina dorsale, la pelle d’oca, il gelo che paralizza le nostre membra, sono tutti segni del loro invisibile inseguimento. Prima la pensavo così, ma la tua storia mi ha spiegato molte cose. Non so come facciano, ma riescono a intrufolarsi nei tubi, nelle linee di comunicazione. In passato, prima ancora che mio padre e persino mio nonno nascessero, nella città senza vita sopra di noi scorreva un fiumiciattolo. Quelli che vivevano lassù impararono a fermare il corso d’acqua e a reindirizzarlo nei tubi sotterranei in cui molto probabilmente scorre ancora oggi. Questa volta sembra che qualcuno abbia confinato in queste tubature il fiume Stige. Quando il tuo amico parlava, non era lui, quelle erano le voci dei morti. Lui le sentiva nella sua testa e le ripeteva, finché non lo hanno assorbito”. Artyom fissava Khan. Per tutta la durata del monologo non era riuscito a distogliere lo sguardo dal viso dell’uomo, che veniva sfiorato da ombre indistinte mentre i suoi occhi ardevano di un fuoco infernale... non quello rossastro dei falò, erano le fiamme arancioni del lanciafiamme che distrugge tutto... Verso la fine della storia, Artyom era praticamente certo che Khan fosse pazzo, che le voci nei tubi avessero sussurrato qualcosa anche a lui. Sebbene Khan lo avesse salvato da morte sicura e gli avesse dimostrato una tale ospitalità, il pensiero di rimanere con lui era imbarazzante e sgradevole. Doveva pensare a come continuare il suo viaggio attraverso le gallerie peggiori di tutta la Metropolitana, delle quali aveva solamente sentito parlare. Sarebbe dovuto passare dalla Sukharevskaya fino alla Turgenevskaya, per poi proseguire. “Spero che tu mi possa perdonare, se ti ho mentito”, aggiunse Khan dopo una breve pausa. “L’anima del tuo amico non ha raggiunto il creatore, non si reincarnerà e non tornerà in una nuova forma. Si è riunita agli altri infelici, quelli che stanno nelle tubature”. Queste parole ricordarono ad Artyom che aveva deciso di tornare a prendere il corpo di Bourbon per portarlo alla stazione. Bourbon gli aveva riferito di avere degli amici laggiù, che avrebbero riportato indietro Artyom se fossero giunti a destinazione. Così si ricordò anche dello zaino dell’uomo, che non aveva ancora aperto; al suo interno, a parte la mitragliatrice del ragazzo, ci sarebbe potuto essere qualcosa di utile. Ma provava una paura strisciante e tutte le superstizioni di questo mondo gli si insinuarono in testa. Perciò decise di dare solamente un’occhiata, senza toccare o spostare nulla. “Non devi avere paura”, Khan si rivolse inaspettatamente ad Artyom, come se potesse percepire la sua trepidazione. “Adesso ti appartiene”. “Secondo me, invece, sarebbe un furto”, Artyom rispose tranquillo. “Non ti preoccupare, non ti punirà, proprio perché non si reincarnerà”, affermò Khan, non in risposta a ciò che il ragazzo aveva appena detto, ma a ciò che Artyom stava pensando. “Ritengo che quando vengono catturati dai tubi, i morti perdano la loro individualità e divengano parte di un tutto. La loro volontà si dissolve nel volere degli altri e la ragione si prosciuga. Le personalità non esistono più. Ma se temi i vivi e non i morti... beh, allora ti consiglio di trascinare la borsa fino in mezzo alla stazione e rovesciarne il contenuto sul pavimento. Così nessuno ti accuserà di furto e avrai la coscienza pulita. Tuttavia, tu avevi cercato di salvare quell’uomo e lui te ne sarà grato. Potresti considerare lo zaino come ricompensa per ciò che hai fatto per lui”. Parlava in maniera autoritaria, con una convinzione tale che Artyom trovò il coraggio per mettere le mani del borsone ed estrarne il contenuto. Posò gli oggetti sulla tela catramata a terra per guardarli alla luce del fuoco. Vi trovò altre quattro cartucce per la mitragliatrice di Bourbon, oltre alle due che aveva estratto nel momento in cui l’uomo aveva porto l’arma ad Artyom. Era incredibile che il commerciante possedesse un arsenale del genere. Artyom avvolse con cura cinque delle cartucce nel tessuto in cui erano contenute in precedenza e le ripose nello zaino, mentre con l’ultima caricò il Kalashnikov. L’arma era in condizioni eccellenti, oliata e ben curata. Il blocco si spostava senza problemi, e quando lo si premeva, scattava emettendo un rumore sordo, mentre la sicura era un po’ rigida. Erano tutti dettagli che indicavano come l’arma fosse praticamente nuova. L’impugnatura si adattava alla perfezione alla mano di Artyom ed era ben lucidata. Quest’arma gli dava un senso di affidabilità, coraggio, calma e sicurezza di sé. Il giovane decise immediatamente che se c’era una cosa che avrebbe preso a Bourbon, sarebbe stata di sicuro la sua mitragliatrice. Le cartucce 7.62 che Bourbon gli aveva promesso come “pegno” non c’erano. Non gli era chiaro come l’uomo intendeva pagarlo. Artyom ci pensò un po’ su e giunse alla conclusione che molto probabilmente Bourbon non aveva avuto la benché minima intenzione di ripagarlo e, una volta superata la parte più pericolosa, gli avrebbe sparato un colpo alle spalle, l’avrebbe gettato in un pozzo e non ci avrebbe più pensato. Se poi qualcuno gli avesse chiesto dove si trovava Artyom, avrebbe potuto avere una serie di risposte pronte: nella Metro può succedere qualunque cosa e il ragazzo aveva deciso di aggregarsi alla spedizione di sua spontanea volontà. A parte i vari stracci, una mappa della Metropolitana piena di annotazioni che solo lo scomparso proprietario avrebbe potuto comprendere e un centinaio di grammi di droga, trovò anche qualche pezzo di carne affumicata contenuta in sacchetti di plastica, oltre a un taccuino, sul fondo dello zaino. Artyom non si mise a leggere il quaderno e rimase alquanto deluso dal resto del contenuto dello zaino. Nel profondo del suo cuore aveva sperato di trovare qualcosa di misterioso o di prezioso, la ragione per cui Bourbon era tanto intenzionato ad attraversare quella galleria fino alla Sukharevskaya. Credeva che Bourbon fosse un messaggero, o un contrabbandiere o qualcosa di quel genere. Ciò, per lo meno, avrebbe spiegato la sua determinazione di percorrere quella maledetta galleria a qualunque costo e la sua disponibilità a essere generoso. Ma dato che, dopo aver trovato gli ultimi pezzetti di stoffa, nello zaino non era rimasto molto altro, Artyom decise che il motivo della sua insistenza avrebbe dovuto essere un altro. Si era scervellato a lungo sulla ragione per cui Bourbon necessitava di arrivare fino alla Sukharevskaya ma non era riuscito a trovarne una plausibile. All’improvviso si ricordò di aver lasciato quel poveretto nel bel mezzo della galleria, in balia dei ratti, sebbene avesse deciso di tornare là dentro per sistemare il corpo. Tuttavia, non aveva nemmeno una vaga idea di come dare degna sepoltura al commerciante o di cosa fare del cadavere... Bruciarlo, forse? Per farlo, avrebbe dovuto avere nervi ben saldi; inoltre, il fumo soffocante, l’odore di carne e di capelli bruciati sarebbe giunto fino alla stazione, dove avrebbe di sicuro passato dei guai. Trascinare il corpo fino in stazione sarebbe stata un’impresa terribile e faticosa: un conto è trascinare un uomo per i polsi credendo che sia vivo, cercando di allontanare tutti i pensieri negativi sul fatto che non stia respirando e non si senta il battito del cuore. Un altro è trascinare un cadavere. Perciò cosa doveva fare? Proprio come Bourbon gli aveva mentito sul suo pagamento, si sarebbe potuto inventare gli amici alla stazione. Per cui, se Artyom avesse trascinato il corpo fin laggiù, si sarebbe potuto mettere in una situazione peggiore. “Cosa ne fate di quelli che muoiono?”, Artyom domandò a Khan dopo averci pensato per un po’. “Che vuoi dire, amico mio?”, Khan rispose alla domanda con un’altra domanda.”Ti riferisci alle anime dei deceduti oppure ai loro corpi senza vita?” “I cadaveri...”, grugnì Artyom. Si stava stancando di tutte quelle chiacchiere sull’aldilà. “Ci sono due gallerie che conducono dalla Prospekt Mira alla Sukharevskaya”, spiegò Khan e Artyom pensò tra sé che in effetti i treni viaggiavano in due direzioni, per questo vi erano sempre due gallerie. Quindi perché, se Bourbon era a conoscenza della seconda galleria, aveva voluto andare incontro al proprio destino? In quel secondo tunnel si annidava un pericolo ancora più grande? “Ma non la si può attraversare che da soli”, continuò l’uomo “perché nella seconda galleria, vicina alla nostra stazione, il terreno è ceduto e il pavimento è crollato. Si è formato una sorta di burrone molto profondo, in cui, secondo la leggenda che si racconta da queste parti, è caduto un treno intero. Se stai sul ciglio del burrone, non importa da che parte, non riesci a vedere l’altra e la luce della torcia più potente non riuscirà mai a illuminarne le profondità. I più stupidi da queste parti sostengono sia un abisso senza fondo. Ma in realtà è il nostro cimitero; è lì che vanno tutti quelli che tu sprezzantemente chiami cadaveri”. Artyom sentì lo stomaco sottosopra quando capì che sarebbe dovuto tornare nel luogo in cui Khan lo aveva trovato, avrebbe dovuto trascinare il corpo di Bourbon, ormai già rosicchiato dai ratti, fino alla stazione per poi condurlo nella seconda galleria e al burrone. Cercò di convincersi che, in effetti, lanciare il corpo là dentro sarebbe stato come lasciarlo all’interno della galleria perché nessuna delle due poteva essere considerata una degna sepoltura. Ma, proprio nel momento in cui si era preparato a credere che lasciare tutto così com’era fosse la soluzione migliore, gli apparve il viso di Bourbon, chiaro come non mai, che diceva: “Sono morto”. La fronte di Artyom si imperlò immediatamente di sudore. Si alzò con difficoltà, mise in spalla la sua nuova mitragliatrice e si decise: “Ok, io vado. Glielo avevo promesso, avevamo un accordo. Devo farlo”. Così dicendo, cominciò a camminare lungo l’atrio a gambe rigide, poi scese dalla scaletta di ferro che conduceva dalla piattaforma alla galleria. Dovette accendere la torcia ancor prima di scendere le scale. Percorse veloce gli scalini, poi si fermò per un momento perché non aveva più la forza di continuare. L’aria stantia gli soffiava in volto un odore di marcio e per un istante i suoi muscoli si rifiutarono di obbedire. Cercò di obbligarsi a fare un altro passo; nel momento in cui riuscì a superare la paura e la repulsione e cominciò a camminare, il palmo pesante di una mano si poggiò sulla sua spalla. Emise un urlo di sorpresa e si voltò di scatto, il petto irrigidito, poiché comprese subito che non avrebbe avuto tempo di prendere la mitragliatrice dalla spalla o di fare altro... Ma era Khan. “Non avere paura”, si rivolse calmo ad Artyom. “Ti ho messo alla prova. Non devi tornare nella galleria. Il corpo del tuo compagno non è più laggiù”. Artyom lo fissava, interdetto. “Ho eseguito io il rito funebre mentre tu dormivi, perciò non hai motivo di ritornarci: la galleria è vuota”. Così dicendo, Khan diede le spalle ad Artyom e si diresse nuovamente verso gli archi. Sentendosi estremamente sollevato, il giovane si sbrigò per raggiungerlo. Arrivò al suo fianco con poche falcate, poi gli chiese, con voce densa di emozione: “Ma perché lo hai fatto e non me lo hai raccontato prima? Sei stato proprio tu ad assicurarmi che se fosse rimasto nella galleria o se lo avessi riportato alla stazione non avrebbe fatto differenza”. “A me non importa”, Khan scrollò le spalle. “Ma sapevo che per te era molto importante. So che il tuo viaggio ha uno scopo ben preciso e che il tuo cammino sarà lungo e difficoltoso. Non ho idea di quale sia la tua missione, ma capisco che questo fardello sarà troppo gravoso perché tu riesca a portarlo da solo, perciò ho deciso di darti una mano”. Guardò Artyom di sottecchi e gli sorrise. Ritornati al fuoco, si sedettero sulla tela catramata e Artyom non riuscì a fare a meno di domandare: “Cosa volevi dire quando hai menzionato la mia missione? Ho parlato nel sonno?” “No, amico mio. Mentre dormivi non hai aperto bocca. Ma io ho avuto una visione, durante la quale una persona che ha in comune con me una parte del nome mi chiesto di aiutarti. Mi ha avvisato che stavi arrivando ed è proprio per questo che sono venuto a prenderti, mentre cercavi di avvicinarti alla stazione con il corpo del tuo amico”. “È stato per questo?”. Artyom lo guardava incredulo. “Credevo fossi venuto perché avevi udito degli spari...” “Ho sentito degli spari, l’eco è arrivata fin qui. Ma non crederai davvero che ogni volta che sento dei colpi io corra nel tunnel a vedere cos’è successo? Se così fosse, la mia vita sarebbe terminata molto tempo fa e in maniera del tutto ignobile. Questa è stata un’eccezione”. “Cosa mi dici della persona che ha in comune con te una parte del nome?” “Non saprei dirti chi fosse, perché non l’avevo mai visto prima e non gli avevo mai parlato. Tuttavia, so che tu lo conosci. Dovresti arrivarci da solo. Io l’ho visto solo una volta e non dal vivo, ma ho immediatamente percepito la sua colossale forza. Mi ha ordinato di aiutare un giovane che sarebbe arrivato dalla galleria settentrionale e in quel momento è apparsa la tua immagine davanti ai miei occhi. Ovviamente stavo sognando, ma a me è parso tutto talmente vero che quando mi sono svegliato non riuscivo più a distinguere tra sogno e realtà. Era un uomo potentissimo, con la testa rasata, lucente, vestito completamente di bianco... lo conosci?” Artyom venne colto da un senso di nausea come se tutto avesse cominciato a ondeggiare: l’immagine descritta da Khan era chiara nella sua mente. L’uomo che aveva in comune una parte del nome con il suo soccorritore era... Hunter! Khan, Hun... Artyom aveva avuto una visione molto simile, solo che nella sua lui doveva decidere se avventurarsi in questo viaggio. Non aveva visto Hunter avvolto nel lungo impermeabile nero che aveva indossato alla VDNKh in quel giorno memorabile, al contrario indossava abiti morbidi, bianchi come la neve. “Sì, lo conosco”, assentì Artyom, osservando Khan in maniera totalmente diversa da prima. “Ha invaso i miei sogni e, di solito, è una cosa che non tollero. Con lui, però, è stato tutto diverso”, Khan sembrava distratto. “Aveva bisogno del mio aiuto, proprio come te. Non mi ha ordinato di venire a prenderti, non mi ha chiesto di sottomettermi al suo volere; più che altro sembrava che me lo chiedesse con insistenza. Non era in grado di introdursi nella mente di qualcun altro, era solo in grandissima difficoltà. Era disperato e pensava a te di continuo; aveva bisogno di una mano, di una spalla su cui poggiarsi. Io gli ho teso la mano e gli ho offerto la mia spalla. Così, sono venuto a prenderti”. Artyom era sepolto sotto tutti i suoi pensieri, che ribollivano e risalivano nella sua coscienza uno dopo l’altro, si dissolvevano, non riuscivano mai a trasformarsi in parole e tornavano a sprofondare nella sua mente. La sua lingua era secca e il ragazzo ci mise del tempo prima di riuscire ad articolare una parola. Era possibile che quest’uomo fosse già a conoscenza del suo arrivo? Poteva essere che Hunter lo avesse avvisato in qualche modo? Il cacciatore era vivo oppure si era trasformato in un’ombra? Sarebbe mai riuscito a credere a quella storia spaventosa e delirante sull’aldilà che Khan gli aveva raccontato? Sarebbe stato più facile convincersi del fatto che l’uomo fosse un pazzo. Tuttavia, il punto era che quest’uomo conosceva il compito che gli era stato affidato, che lui stesso aveva chiamato “missione” e, sebbene non riuscisse a capire di cosa si trattava, ne aveva compreso sia l’importanza che la gravità. “Dove ti devi recare?”. Khan era calmo e lo guardava negli occhi come se gli stesse leggendo i pensieri. “Parlami del cammino che dovrai intraprendere e io ti aiuterò a compiere il prossimo passo, se ne avrò le possibilità. Me lo ha chiesto lui”. “Polis”, Artyom pronunciò la parola espirando. “Devo arrivare fino alla Polis”. “Come intendi arrivarci da questa stazione dimenticata da Dio?”, si informò Khan. “Amico mio, avresti dovuto percorrere l’Anello dalla Prospekt Mira fino alla Kurskaya o alla Kievskaya”. “Ma lassù c’è l’Hansa e io non conosco nessuno, non sarei mai riuscito a passare! In ogni caso, ora non posso più tornare alla Prospekt Mira. Temo che non riuscirei a sopportare di attraversare un’altra volta quella galleria. Speravo di arrivarci dalla Turgenevskaya. Ho controllato una vecchia mappa in cui viene indicato che laggiù c’è un passaggio fino alla Sretensky Bulvar. Dovrebbe esserci una galleria costruita per metà, attraverso la quale si può giungere fino alla Trubnaya”. Artyom estrasse la mappa bruciacchiata dalla tasca. “Dalla Trubnaya c’è un passaggio fino alla Tsvetnoy Bulvar, l’ho visto sulla mappa. Da lì, se tutto va bene, si può arrivare direttamente alla Polis”. “No”, negò tristemente Khan, scuotendo la testa. “Così non riuscirai mai ad arrivare alla Polis. La mappa non è corretta, è stata stampata prima che tutto accadesse. Vi sono linee della Metro che non furono mai completate, stazioni crollate sotterrando centinaia di innocenti. Inoltre, non sono riportati gli spaventosi pericoli nascosti, che rendono la maggior parte degli itinerari impossibili da percorrere. Potrebbe usarla solo uno sprovveduto o un ingenuo, un bambino di tre anni. Dalla a me”. E così dicendo protese la mano. Obbediente, Artyom gli offrì il pezzo di carta. Khan la fece in mille pezzi e la gettò nel fuoco. Artyom rifletté che il gesto dell’uomo era stato un po’ avventato, ma decise di non contraddirlo. In quel momento, Khan gli chiese: “Ora mostrami la mappa che hai trovato nello zaino del tuo amico”. Rovistando tra le sue cose, Artyom trovò la mappa, ma non si affrettò a porgerla a Khan, dato che lo stesso destino di quella precedente sarebbe potuto toccare anche questo pezzo di carta. Soprattutto, non voleva restare senza una mappa. Khan notò la trepidazione del ragazzo e cercò di riassicurarlo: “Non farò niente del genere, non preoccuparti. Fidati, non faccio mai nulla che non abbia un motivo particolare. Potresti avere l’impressione che alcune delle mie azioni siano irragionevoli e persino un po’ folli. Ma io ne conosco sempre il motivo. Tu non le capisci perché la tua percezione e la tua comprensione del mondo sono limitate; ti trovi solo all’inizio del tuo cammino e sei troppo giovane per conoscere davvero certe cose”. Artyom diede a Khan la mappa di Bourbon. Non aveva la forza di opporsi alle parole dell’uomo. Era un pezzo di cartoncino ingiallito delle dimensioni di una cartolina sul quale vi erano stampate delle palline luccicanti e le parole Buon anno nuovo! Buon 2007! “È molto pesante”, la voce di Khan era rauca e l’attenzione di Artyom si fissò sul palmo dell’uomo, dove era posato il cartoncino; improvvisamente cadde a terra, come se la cartolina pesasse più di un chilo. Un secondo prima, quando Artyom la teneva nella sua mano, non aveva notato nulla di pesante: la carta è carta. “Questa mappa è molto più intelligente della tua”, affermò Khan. “Racchiude una conoscenza tale che non credo appartenesse alla persona che viaggiava con te. Non è per il fatto che è piena di annotazioni e di simboli, per quanto potrebbero essere molto utili. No, è qualcos’altro...”, e si interruppe bruscamente. Artyom alzò lo sguardo e sbirciò il viso di Khan: la sua fronte era solcata da rughe profonde, mentre il fuoco che ormai si stava spegnendo sembrava far ardere i suoi occhi. Il viso era talmente mutato che Artyom si spaventò e desiderò correre via da quella stazione il prima possibile, per recarsi da qualsiasi altra parte, persino nella terribile galleria che era riuscito a superare con così tanta difficoltà. “Lascia che sia io a custodirla”, quella di Khan non era una richiesta ma piuttosto un ordine. “Te ne darò un’altra e tu non ti accorgerai nemmeno della differenza. In cambio ti regalerò qualsiasi altro oggetto”, continuò. “Prendila, è tua”, Artyom la sollevò con facilità, mentre quasi impercettibilmente sputava le parole di assenso. Khan si spostò subito dal fuoco, in modo che il suo viso venisse celato dalle ombre. Artyom immaginò che stesse cercando di riprendere il controllo di sé e non voleva che il ragazzo assistesse alla sua battaglia interiore. “Vedi, amico mio”, la sua voce risuonava nell’oscurità, come se fosse debole e indecisa, spogliata del potere che solo un momento prima Artyom vi aveva udito. “Questa non è una mappa. O meglio, non è solo una mappa, ma una Guida della Metropolitana. Sì, non c’è dubbio alcuno. La persona che la possiede è in grado di attraversare la Metro in due giorni perché è come se questa mappa fosse... viva. Indica il cammino da seguire e come percorrerlo, avvisa in caso di pericolo. Praticamente, conduce lungo il percorso da seguire. È per questo che viene chiamata Guida, con la lettera maiuscola. Ne avevo già sentito parlare. So che ve ne sono pochissime nella Metropolitana e questa potrebbe essere l’ultima. È l’eredità di uno dei maghi più potenti dell’era passata”, spiegò Khan, ritornando vicino al fuoco. “Di colui che risiede nel punto più profondo della Metro?”. Artyom decise di sfoggiare le sue conoscenze, ma Khan lo interruppe subito e la sua espressione si fece torva. “Non citare mai a cuore leggero ciò che nemmeno conosci! Tu non sai che succede nel punto più profondo della Metro! Persino io non ne so quasi nulla e spero che Dio non ce lo renda mai noto. Tuttavia, posso giurarti che qualunque cosa succeda laggiù, è completamente diversa da ciò che hai sentito raccontare dai tuoi amici. Perciò, non ripetere a pappagallo le parole degli altri, perché un giorno potresti pentirtene. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con la Guida”. “In ogni caso”, Artyom non si lasciò sfuggire l’occasione di cambiare discorso e di riportarlo in territorio meno pericoloso, cercando di rassicurare l’uomo come poteva, “Puoi tenere la Guida. Dopotutto, io non so nemmeno come si usa. Inoltre, ti devo la vita. Anche regalandoti questa mappa mi sembra di non riuscire a ripagarti il favore”. “Questo è vero”, le rughe sul viso di Khan si distesero e la voce ritornò quella di qualche istante prima. “Ti ci vorrà molto tempo prima di imparare a usarla. Se me la donerai saremo pari. Io ho una normale mappa della Metropolitana e se vuoi posso copiare le annotazioni della Guida, così le potrai avere anche tu. Inoltre...”, scartabellò nelle sue borse. “Posso offrirti questa”, ed estrasse una torcia dalla forma strana. “Non necessita di batterie. Funziona in modo tale che per caricarla devi eseguire questo movimento. Vedi questi due pomelli? Devi premerli con le dita, così si creerà l’energia necessaria per metterla in funzione. Non è molto luminosa, ma potresti trovarti in situazioni in cui questo raggio di luce ti sembrerà più brillante delle lampade a mercurio della Polis... Mi ha salvato la vita in moltissime occasioni e spero che anche tu la troverai utile. Prendila, è tua. Prendila, su. Lo scambio non è comunque equo: sono io che devo qualcosa a te, non il contrario”. In realtà, per Artyom era incredibilmente vantaggioso. Che se ne faceva di una mappa dalle proprietà mistiche, se non riusciva a percepirle? L’avrebbe comunque gettata via dopo averla girata e rigirata, cercando invano di decifrare i ghirigori che vi erano stati disegnati. “Beh, la strada che ti sei annotato non ti porterà da nessuna parte, se non nell’abisso”. Khan continuò la loro conversazione frammentaria, tenendo in mano la Guida con estrema cura. “Ecco a te, prendi la mia e seguila”, e gli porse una mappa minuscola, stampata dietro a un calendario da taschino. “Stavamo parlando del passaggio dalla Turgenevskaya alla Sretensky Bulvar? Non dirmi che non conosci la terribile reputazione di quella stazione e della lunga galleria che va da qui a Kitay-Gorod?!” “Mi hanno detto che non la si deve percorrere da soli e che è sicura solo se la si attraversa in gruppo. Io pensavo di unirmi a una carovana e di arrivare fino alla Turgenevskaya, per poi staccarmi e prendere il passaggio, dopotutto non credo proprio che si metteranno a inseguirmi...” rispose Artyom, mentre pensieri vaghi si facevano largo nella sua testa. “Laggiù, il passaggio non c’è più. Hanno murato gli archi. Non lo sapevi?” Ma certo! Come aveva fatto a dimenticarselo? Qualcuno glielo aveva detto, ma poi gli era uscito di mente... I Rossi temevano i demoni che popolavano quella galleria, perciò avevano bloccato l’unica altra strada per raggiungere la Turgenevskaya. “Non c’è nessun altro passaggio?”, domandò cauto. “No, la mappa non ne indica nessuno. Il passaggio tra le linee che sono state davvero costruite non comincia alla Turgenevskaya. In ogni caso, anche se esistesse un passaggio, non so se avresti abbastanza coraggio per separarti dal resto del gruppo e avventurarti là dentro, specialmente se, mentre aspetti la carovana, ti vengono raccontate le ultime novità su ciò che succede là dentro”. “Allora che dovrei fare?”. Artyom, scoraggiato, consultava la minuscola mappa. “Puoi arrivare alla Kitay-Gorod, che è davvero una stazione curiosa: lì i principi morali sono, per così dire, opinabili. Ma per lo meno non scomparirai senza lasciar alcuna traccia e i tuoi amici più cari non si dovranno chiedere se tu sia mai esistito davvero, il che alla Turgenevskaya può accadere molto facilmente. Dalla Kitay-Gorod... seguimi con attenzione”, stava tracciando con il dito un itinerario sulla mappa, “devi attraversare due stazioni e poi sei alla Pushkinskaya, dove c’è un passaggio per la Chekhovskaya; laggiù ne troverai un altro che ti condurrà direttamente alla Polis. In questo modo, il cammino dovrebbe essere anche più breve di quello che avevi pianificato tu”. Artyom muoveva le labbra, contando le stazioni e i passaggi di ognuno dei due itinerari. Per quanto contasse, quello suggerito da Khan era davvero più breve e molto meno pericoloso. Artyom non si capacitava del perché non ci avesse pensato prima. Non aveva nessun’altra scelta. “Hai ragione”, articolò infine. “Ci sono spesso delle carovane che arrivano fin laggiù?” “Temo di no. Inoltre, c’è un altro piccolo, fastidioso particolare: per arrivare alla galleria meridionale della Kitay-Gorod devi entrare nella nostra stazione dalla parte settentrionale”, e così puntò il dito sulla dannata galleria alla quale Artyom era appena riuscito a malapena a sopravvivere. “L’ultima carovana diretta verso sud è partita qualche tempo fa. Speriamo che presto si formi un nuovo gruppo di persone intenzionate a mettersi in viaggio. Vai a parlare con quelli che incontri qui intorno, chiedi informazioni, ma non sbottonarti troppo. Ci sono diversi personaggi pericolosi in giro, di cui è meglio non fidarsi. Posso venire con te, così non ti cacci nei pasticci”, aggiunse dopo averci pensato su per un momento. Artyom stava per raccogliere lo zaino quando Khan lo fermò con un gesto: “Non preoccuparti delle tue cose. La gente ha paura di me, quindi gli attaccabrighe non oserebbero mai venire a sbirciare nella mia tana. Mentre tu sei qui, sei sotto la mia protezione”. Artyom lasciò lo zaino vicino al fuoco, ma prese la mitragliatrice perché non si voleva separare dal suo nuovo tesoro. Seguì velocemente Khan, che camminava tranquillo verso i fuochi accesi dall’altro lato dell’atrio. Notò con sorpresa che i barboni denutriti e avvolti negli stracci puzzolenti si ritraevano al loro passaggio. Khan doveva essere davvero una personalità molto temuta. Chissà come mai... Superarono il primo fuoco, ma Khan non rallentò il passo. Si trattava di un fuocherello che faticava a rimanere acceso, al quale erano sedute due persone, un uomo e una donna, stretti l’una all’altro. Stavano sussurrando qualcosa in una lingua sconosciuta e, prima ancora che le parole riuscissero ad arrivare all’orecchio di Artyom, si dispersero. Il ragazzo era talmente affascinato da quei due che quasi si voltò per continuare a guardarli, non riusciva a fare a meno di osservarli. Di fronte a loro ardeva un altro fuoco, questa volta più luminoso, attorno al quale era appostato un intero campo di persone. Si scorgevano i visi di uomini che parevano paesani fieri e coraggiosi, seduti lì per scaldarsi le mani. Si sentì una risata rumorosa, l’aria era satura di voci litigiose, tanto che Artyom si spaventò un po’ e rallentò il passo. Al contrario Khan era tranquillo e sicuro di sé. Raggiunse uno degli uomini seduti, lo salutò e si sedette attorno al fuoco. Il ragazzo non poté fare altro che seguire il suo esempio e accomodarsi di fianco a lui. “... Si guardò e vide che aveva lo stesso sfogo anche sulle mani, mentre sotto l’ascella la pelle si era gonfiata, il bubbone era duro e dolorosissimo. Immaginate quanto fosse spaventato, povero diavolo... Le persone si comportano tutte in modi diversi. Alcune si sparano subito un colpo in testa, altre impazziscono e si lanciano contro le altre, cercano di abbracciarle, perché non vogliono morire da sole. Altre ancora percorrono di corsa la galleria al di là dell’Anello e si lanciano nelle acque stagnanti per non infettare altra gente... Le persone sono diverse. Questo tizio, invece, non appena si vide così, chiese al medico: ‘Ci sono possibilità che io migliori?’ e questo gli rispose diretto: ‘No, nessuna. Quando appare lo sfogo ti rimangono due settimane di vita’. Il comandante del battaglione iniziò con cautela a tirare fuori la Makarov dalla fondina, nel caso il tizio diventasse violento...” Quello che stava parlando era un ometto già avanti con gli anni, aveva il mento ispido e una giacca imbottita. La voce esitava, ansiosa, mentre scrutava con occhi grigi e lucidi ciò che gli accadeva attorno. Artyom non era riuscito a capire cosa stesse raccontando, tuttavia lo spirito della narrazione e il significativo silenzio calato su quel gruppo che fino a un minuto prima stava litigando, lo fecero fremere. Si decise a chiedere informazioni a Khan, ma lo fece sottovoce, per non attirare attenzione su di sé. “Di cosa sta parlando?” “Della peste”, la risposta di Khan fu greve. “È arrivata”. Queste parole emisero il tanfo dei corpi in decomposizione e del fumo denso dei falò accesi per le cremazioni, oltre agli echi delle campanelle d’allarme e agli ululati delle sirene. Alla VDNKh e nei dintorni non si era mai scatenata un’epidemia. I ratti, che portavano malattie, erano stati distrutti e alla stazione vivevano anche diversi medici molto bravi. Il ragazzo sapeva ben poco di malattie infettive mortali e aveva letto solo qualche libro a riguardo. Inoltre, quando era molto piccolo, aveva dovuto affrontare alcune epidemie, che però avevano lasciato una traccia profonda nella sua memoria e avevano popolato a lungo i suoi sogni e le sue paure di bambino. Pertanto, quando aveva udito la parola “peste”, aveva cominciato a sudare freddo e si era sentito mancare. Non domandò altro a Khan, ma ascoltò con sofferente attenzione il racconto dell’ometto con la giacca imbottita. “Ma Rizhy non era il tipo, non era un pazzo. Se ne stette lì in piedi per un minuto, poi disse: ‘Datemi qualche cartuccia e me ne andrò. Non posso più stare qui con voi’. Ho sentito con le mie orecchie il comandante del battaglione che tirava un sospiro di sollievo. Era chiaro che non gli avrebbe fatto piacere sparare a uno dei suoi, anche se era malato. Perciò gli diedero due caricatori e lui partì in direzione nord-est, proseguendo oltre l’Aviamotornaya. Non lo rivedemmo mai più. Il comandante chiese al medico quale fosse il periodo di incubazione della malattia e la risposta fu una settimana. Se a una settimana dal contatto non succede nulla, allora non si è infettati. Perciò, il comandante prese una decisione: saremmo stati tutti lontani dalla stazione per una settimana e poi avremmo agito di conseguenza. Non potevamo rimanere nell’Anello perché, se l’infezione fosse penetrata al suo interno, allora tutta la Metropolitana sarebbe morta. Così ci allontanammo per una settimana intera. Non ci rivolgevamo a coloro che ci stavano intorno perché non potevamo sapere chi fosse infettato. Tra noi c’era un tizio che chiamavamo Bicchiere perché gli piaceva bere. Tutti gli stavano lontano perché aveva passato moltissimo tempo con Rizhy. Quando si avvicinava a qualcuno, gli uomini scappavano dall’altra parte. Uno gli puntò contro la pistola, ordinandogli di allontanarsi. Quando Bicchiere terminò la sua scorta d’acqua, ovviamente gli altri gliene offrirono un po’ della loro, ma gliela lasciavano sul pavimento e fuggivano via, nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi. Dopo una settimana non si seppe più nulla di lui e giravano diverse voci. Si diceva persino che delle bestie lo avessero trascinato via, ma quelle gallerie sono tranquille e pulite. Io personalmente penso che avesse notato il famoso sfogo, le ascelle gli facevano male, quindi è fuggito via. Nessun altro del nostro battaglione è stato infettato; abbiamo atteso ancora qualche giorno, poi il comandante ci ha controllati uno ad uno. Eravamo tutti sani”. Artyom notò che, sebbene cercasse di rassicurarli, la zona vicina all’ometto era rimasta libera, anche se attorno al fuoco non c’era molto spazio ed erano tutti stipati gli uni contro gli altri. “Ti ci è voluto molto per arrivare fin qui, amico?”, gli chiese tranquillo ma deciso un uomo robusto con la barba, che indossava un panciotto di pelle. “Sono passati già trenta giorni da quando siamo usciti dall’Aviamotornaya”, gli rispose l’ometto a disagio. “Ho una notizia per te: la peste è arrivata anche all’Aviamotornaya. Laggiù c’è la peste! Hai capito?! L’Hansa l’ha chiusa, insieme alla Taganskaya e alla Kurskaya. Hanno indetto una quarantena. Lì ho delle conoscenze, cittadini dell’Hansa. Ci sono lanciafiamme appostati ai passaggi tra la Taganskaya e la Kurskaya: tutti coloro che si avvicinano vengono colpiti. La chiamano disinfezione. Sembra infatti che per alcuni il periodo di incubazione sia di una settimana, mentre per altri ci voglia di più, perciò è ovvio che avete riportato indietro l’infezione”, concluse brutalmente, abbassando la voce. “Cosa? Dai, ragazzi... Io sto bene, sono sano! Lo vedete da voi!”. L’ometto saltò in piedi e cominciò a togliersi la giacca imbottita, con movimenti convulsi. Scopriva il corpo sporco, di fretta, e temeva di non riuscire a convincerli. La tensione crebbe: non era rimasto nessuno nelle vicinanze dell’ometto, si erano tutti raggruppati dall’altra parte del fuoco. La gente parlava nervosa e Artyom sentì che qualcuno aveva fatto scattare piano la sicura della propria arma. Rivolse a Khan una sguardo interrogativo e si portò la mitragliatrice al petto, pronto per sparare davanti a sé. Khan rimase in silenzio, ma lo fermò con un gesto. A quel punto si alzò veloce e si allontanò silenzioso dal fuoco, portando Artyom con sé. Dopo una decina di passi si fermò e si mise a osservare la scena. Gesti veloci erano visibili alla luce del fuoco, parevano una sorta di temeraria danza primitiva. Il chiacchierio della folla si era placato e l’azione continuava in un silenzio minaccioso. Infine, l’uomo riuscì a togliersi la maglietta ed esclamò trionfante: “Ecco! Visto? Sono pulito! Sono sano! Non ho niente! Sono sano!” L’uomo con la barba e il panciotto estrasse un asse dal fuoco e lo usò come fiaccola, avvicinandosi con attenzione all’ometto. Lo osservò con disgusto: la pelle era sporca e unta, ma per quanto riuscisse a vedere, non c’era traccia dello sfogo. Perciò, dopo un’ispezione scrupolosa, intimò: “Alza le braccia!” Lo sfortunato alzò velocemente le braccia e mostrò le ascelle fitte di una fine peluria a coloro che si trovavano dall’altra parte del fuoco. L’uomo con la barba finse di tapparsi il naso e lo esaminò meticolosamente alla ricerca dei bubboni. Non riuscì a trovare alcun sintomo della peste. “Sono sanissimo! Siete convinti adesso?”, urlò l’ometto, ormai preso dall’isteria. Si udì un bisbiglio ostile tra la gente. Dando voce al pensiero della folla, cercando di non soccombere a essa, l’uomo più robusto dichiarò: “Beh, poniamo il caso che tu sia sano. Non significa comunque nulla!” “Perché non significa nulla?”, l’ometto venne preso alla sprovvista e venne subito sopraffatto dallo sconforto. “Perché, anche se non sei ammalato, è possibile che tu sia immune: potresti essere un portatore sano dell’infezione. Hai avuto contatti con quel Rizhy? Eravate nello stesso battaglione? Hai parlato con lui, gli hai dato la tua acqua? Gli hai stretto la mano? Sono sicuro che tu gliel’abbia stretta, non mentirmi, amico”. “Che significa se gli ho stretto la mano? Io non mi sono ammalato...”, rispose l’ometto, senza sapere più cos’altro dire. Era immobile, si sentiva impotente e perseguitato dagli sguardi della folla. “È possibile che tu sia ancora infetto, amico. Mi dispiace, ma non possiamo rischiare. È la profilassi, capisci?”, l’uomo con la barba slacciò i bottoni del panciotto e mostrò una fondina di pelle marrone. A quel punto vi fu una reazione di incoraggiamento, mentre tra la folla scattavano altre sicure delle armi. “Ragazzi! Ma io sono sano! Non mi sono ammalato! Guardate voi stessi!”. L’ometto alzò di nuovo le braccia, ma questa volta tutti fecero una smorfia sdegnosa, evidentemente disgustata. L’uomo più robusto prese la pistola dalla fondina e la puntò verso l’ometto che ancora sembrava non comprendere cosa gli stesse succedendo e continuava a borbottare di essere sano. Stringeva la sua giacca imbottita al petto, faceva molto freddo e lui si voleva rivestire. Artyom non riusciva più a sopportare la situazione. Anche lui fece scattare la sicura della sua mitragliatrice e fece un passo verso la folla, anche se esattamente non sapeva cosa avrebbe fatto. Si sentiva un nodo in gola e uno alla bocca dello stomaco, per questo non era in grado di dire una parola. Ma c’era qualcosa in quell’ometto, nei suoi occhi vuoti e disperati, nei suoi borbottii meccanici e senza senso che fece scattare una molla in Artyom e lo fece spostare di un passo in avanti. Non gli era chiaro quale sarebbe stata la mossa successiva, quando sentì una mano sulla spalla... ed era una mano pesantissima! “Fermo”, ordinò Khan impassibile e Artyom rimase sul posto come una statua, mentre la sua fragile determinazione andava in mille pezzi, scontrandosi con la volontà granitica dell’uomo. “Non puoi aiutarlo. Le possibilità sono due: potreste essere uccisi entrambi, oppure tu potresti scatenare la loro furia contro di te. In entrambi i casi, la tua missione non verrebbe mai completata. Devi ricordartelo”. In quel momento, l’ometto si contrasse, urlò, strinse ancor di più la giacca imbottita e in un attimo era già sul sentiero. A velocità sovraumana, scattò verso l’oscurità della galleria meridionale, strillando come un animale impazzito. L’uomo con la barba balzò e si mise a inseguirlo, cercando di mirare alla schiena, ma poi si fermò e fece un cenno con la mano. Si stavano addentrando troppo nella galleria e quelli rimasti sulla piattaforma lo sapevano bene. Non gli era chiaro se l’uomo che stavano inseguendo si ricordasse a cosa stava correndo incontro, forse sperava in un miracolo, oppure la paura aveva cancellato ogni consapevolezza dalla sua mente. Dopo qualche minuto sentirono solo un ululato che lacerò il silenzio sordo della terribile galleria, mentre l’eco dei suoi passi si interruppe all’improvviso, come se qualcuno ne avesse spento l’audio. Non si udì più nessun altro rumore e il silenzio cominciò nuovamente a regnare. Era tutto così bizzarro, estraneo all’udito e alla ragione umana. L’immaginazione cercava di sopperire alle loro mancanze, tanto che ai presenti sembrò di udire un urlo lontano. Ma tutti compresero che era un’illusione. “Amico mio, gli sciacalli sanno sempre quando uno del loro branco è malato”, commentò Khan e quasi Artyom perse l’equilibrio quando notò il fuoco da predatore che ardeva negli occhi dell’uomo. “L’elemento malato è un peso per il gruppo e una minaccia alla sua salute. È per questo che viene ucciso, fatto a pezzi, in mille pezzettini”, sottolineò, come se stesse gustando le parole che pronunciava. “Ma questi non sono sciacalli”, Artyom trovò il coraggio di contraddire Khan, che improvvisamente gli sembrava davvero la reincarnazione di Genghis Khan. “Queste sono persone!” “Secondo te cosa stavano facendo?”, lo sfidò Khan. “Questa è degradazione. La nostra medicina consiste anche in comportamenti da sciacallo. È rimasta poca umanità in noi.” Artyom sapeva come controbattere anche a questa affermazione, ma decise di non contestare l’unico protettore che aveva in questa selvaggia stazione. Khan si aspettava una sua risposta e infine decise che Artyom si fosse arreso e portò la conversazione su un argomento diverso. “Ora, mentre i nostri amici saranno impegnati a discutere sui metodi usati per combattere le malattie infettive, noi dobbiamo battere il ferro finché è caldo. Altrimenti potrebbero decidere di non proseguire per settimane, anche se qui il tempo vola via senza che ce ne rendiamo conto”. La gente attorno al fuoco discuteva animatamente su ciò che era appena accaduto, erano tutti molto tesi, perché l’ombra spettrale di un pericolo terribile li aveva appena avvolti. Stavano cercando di decidere quale sarebbe stata la prossima mossa, ma i loro pensieri, come topi in un labirinto, proseguivano in cerchio, entravano in vicoli ciechi, andavano velocemente avanti e indietro senza riuscire a trovare l’uscita. “I nostri amici si stanno facendo prendere dal panico”, commentò Khan con aria compiaciuta, osservando allegramente Artyom. “Inoltre, sospettano di avere appena linciato un innocente e ciò non incentiva il pensiero razionale. Non ci troviamo più di fronte a un collettivo, ma a un branco: lo stato mentale perfetto per la manipolazione della loro psiche! Le condizioni non potrebbero esserci più favorevoli di così!” Artyom si sentì nuovamente a disagio vedendo l’espressione trionfante sul viso di Khan. Per rispondergli cercò di sorridergli. Dopotutto Khan lo voleva aiutare... ma gli riuscì un sorriso striminzito, poco convinto. “Ora l’importante è l’autorità, la forza. Il branco rispetta il potere, non le argomentazioni logiche”, aggiunse Khan annuendo. “Stai a vedere. Partiremo in meno di un giorno e tu potrai proseguire il tuo cammino”. Detto ciò, percorse qualche metro ed era già in mezzo alla folla. “Non possiamo stare qui!”, la sua voce rombava e i discorsi degli altri si bloccarono all’istante. Gli uomini lo ascoltavano con attenzione: Khan stava usando il suo dono della persuasione, potente, quasi ipnotico. Dopo aver udito queste poche parole, tutti percepirono un acuto senso di pericolo, che pendeva sopra le loro teste. Artyom dubitò che quelle persone avrebbero avuto abbastanza coraggio da rimanere lì. “Ha infettato l’aria! Se continuiamo a respirarla, per noi sarà la fine. I bacilli sono ovunque e, se rimaniamo qui ancora a lungo, ce li beccheremo tutti noi. Moriremo come ratti e marciremo sul pavimento, nel bel mezzo dell’atrio. Nessuno ci verrà ad aiutare... non abbiamo speranza! Possiamo contare solo su noi stessi. Dobbiamo andarcene il prima possibile da questa stazione maledetta, che pullula di microbi. Se partiamo subito, in gruppo, non sarà difficile attraversare la galleria, ma dobbiamo agire velocemente!” La gente assentì. La maggior parte di loro, proprio come Artyom, non riusciva a contrastare il colossale potere di persuasione di Khan. Seguendo le parole dell’uomo, il ragazzo passò in rassegna tutte le circostanze e le sensazioni che gli venivano proposte: minaccia, timore, panico e una flebile speranza di riuscire a fuggire, che aumentava mentre Khan teneva il suo discorso. “In quanti siete?” Diverse persone si misero a contare gli appartenenti al gruppo. Vi erano otto uomini, senza contare Artyom e Khan. “Ciò significa che non possiamo permetterci di aspettare! Siamo già in dieci. Riusciremo ad attraversare la galleria!”, affermò subito Khan, senza dare il tempo ai suoi uditori di tornare in loro. Quindi continuò: “Raccogliete le vostre cose, dobbiamo partire al massimo entro un’ora! Forza, torniamo al fuoco. Anche tu devi prendere la tua roba”, sussurrò quest’ultima frase ad Artyom, strattonandolo verso il loro piccolo accampamento. “L’importante è che non capiscano cosa sta succedendo. Se attendiamo oltre, si cominceranno a chiedere se valga la pena recarsi alla Chistye Prudy. Alcuni di loro erano diretti in direzione opposta, mentre altri vivono qui e non hanno nessun altro posto dove andare. Pare che io ti debba accompagnare fino alla Kitay-Gorod, altrimenti temo che si perderanno o si dimenticheranno dove stavano andando e perché”. Artyom infilò velocemente ciò che era appartenuto a Bourbon nel suo zaino mentre Khan riavvolgeva il telone impermeabile e spegneva il fuoco. Nel frattempo, il ragazzo si mise a osservare ciò che succedeva dall’altro lato dell’androne: gli uomini, che all’inizio raccoglievano frettolosi e animati i loro oggetti, ora si muovevano più lentamente, con meno sicurezza. Qualcuno era accovacciato vicino al fuoco, mentre un altro vagava verso il centro della piattaforma, alla ricerca di qualcosa; un’altra coppia discuteva animatamente. Artyom capì subito cosa stava succedendo e tirò la manica di Khan: “Stanno discutendo”, lo avvertì il giovane. “Ahimè, discutere è una particolarità intrinseca all’essere umano”, rispose Khan. “Sebbene la loro volontà sia stata repressa e loro siano ipnotizzati a tutti gli effetti, gravitano ancora gli uni attorno agli altri e parlano. L’uomo è un animale sociale, non c’è niente da fare. In un’altra situazione accetterei qualsiasi attività umana, considerandola divina o comunque risultato inevitabile dell’evoluzione, a seconda della persona. Ma in questo caso, il fatto che stiano pensando non è un buon segno. Dobbiamo interferire, mio giovane amico, e incanalare i loro pensieri in modo che ci tornino utili”, concluse, issando l’enorme zaino sulla schiena. Il fuoco venne spento e l’oscurità, densa e tangibile, li avvolse, giungendo da ogni parte. Artyom frugò in tasca e ne estrasse la torcia, poi premette il pulsante. All’interno del dispositivo, qualcosa emise un ronzio, poi la luce si accese e illuminò lo spazio davanti a lui in maniera irregolare, vacillante. “Forza, premilo di nuovo, non avere paura”, lo incoraggiò Khan, “Funziona molto meglio di così”. Quando raggiunsero gli altri, le folate di aria viziata provenienti dalla galleria avevano avuto il tempo di schiarire le idee degli uomini, che sembravano meno convinti della proposta di Khan. L’uomo con la barba fece un passo avanti: “Ascolta, fratello”, si rivolse imprudente al compagno di Artyom. Senza nemmeno guardarlo, il ragazzo sentì che l’aria attorno a Khan si era caricata d’energia; era come se, rivolgendosi a Khan con tutta quella familiarità, l’uomo con la barba lo avesse fatto irritare. Di tutte le persone che Artyom conosceva, Khan era sicuramente quello che non avrebbe mai voluto fare infuriare. C’era anche il cacciatore, ma in lui il giovane aveva visto solamente una persona spietata e gli era impossibile immaginarlo arrabbiato; sarebbe stato in grado di uccidere qualcuno con la stessa espressione che avevano coloro che lavavano i funghi o producevano il tè. “Ne abbiamo parlato e pensiamo che tu stia facendo di tutta l’erba un fascio. Ad esempio, per me non vale la pena andare fino alla Kitay-Gorod. Anche quei ragazzi non hanno intenzione di venire. Giusto, Semenych?”. L’uomo con la barba si voltò verso gli altri per trovare il supporto di cui aveva spasmodicamente bisogno. Qualcuno, tra la folla, annuì molto timidamente. “La maggior parte di noi era diretta alla Prospekt Mira, verso l’Hansa, finché non si è verificato quel fatto all’interno della galleria. Avevamo deciso di aspettare qui per poi continuare. Tanto non è rimasto niente, abbiamo bruciato le sue cose. E non cercare di ingannarci parlando dell’aria, non si tratta di peste polmonare. Se siamo stati infettati, lo siamo già, e non c’è più nulla da fare. È ancora più probabile che non vi sia stata proprio alcuna infezione, quindi tu e le tue proposte potete andarvene a quel paese e lasciarci in pace!”. L’uomo con la barba stava prendendo fin troppa confidenza. Artyom rimase un po’ spiazzato da questo attacco; diede un’occhiata al suo compagno e comprese subito che l’uomo si era messo nei guai. Riusciva a percepire quella fiamma ardente negli occhi di Khan, mentre il suo potere e la sua malignità selvaggia gli provocarono un brivido; Artyom sentì che i capelli gli si rizzarono sulla testa, mentre provava il bisogno inumano di mostrare i denti e ringhiare. “E allora perché lo avete ucciso se, dopotutto, non vi era alcuna infezione?”, insinuò Khan, con voce volutamente sommessa. “È la profilassi!”, ribatté l’uomo con uno sguardo insolente. “No, amico mio. Questa non è medicina, è stato un crimine. Ma mi domando: cosa vi ha dato il diritto di fare una cosa del genere?” “Non chiamarmi amico! Non sono il tuo cagnolino, capito?”, grugnì l’uomo con la barba. “Cosa mi ha dato il diritto di fare una cosa del genere? Il diritto del più forte! Non ne hai mai sentito parlare? E dire che non sei nemmeno... Potremmo fare lo stesso anche con il tuo trovatello! Sarebbe la profilassi, capito?”. Con un gesto che Artyom già conosceva, aprì il panciotto e mise una mano sulla fondina. Questa volta Khan non riuscì a trattenere Artyom e l’uomo con la barba si ritrovò direttamente nel mirino della mitragliatrice del ragazzo, prima ancora di riuscire ad aprire la fondina. Artyom ansimava e riusciva a sentire il cuore e il sangue che gli pulsavano nelle tempie. Nella sua testa non trovava un solo pensiero ragionevole, però sapeva una cosa: se l’uomo con la barba avesse aggiunto una parola, oppure se fosse riuscito a impugnare la pistola, lui avrebbe immediatamente premuto il grilletto. Artyom non aveva intenzione di morire come quel poveretto, non avrebbe permesso al branco di ridurre a brandelli anche lui. Il tizio con la barba rimase di stucco, la cattiveria permeava i suoi occhi scuri. A quel punto accadde qualcosa di incomprensibile. Khan fece un gran passo in avanti, guardò l’uomo dritto negli occhi e disse, tranquillamente: “Smettila. Ora obbedirai a me, oppure morirai”. Lo sguardo minaccioso dell’uomo con la barba scomparve all’istante; le braccia gli ciondolavano ai lati del corpo, impotenti. Tutta questa scena era talmente innaturale che Artyom fu subito sicuro che non era stata la sua mitragliatrice, ma le parole di Khan ad avere quell’effetto sull’uomo. “Non mettere mai in discussione i diritti del più forte, sei troppo debole per farlo”, aggiunse Khan, che poi tornò al fianco di Artyom, senza nemmeno disarmare l’uomo. Quest’ultimo se ne stava ancora impietrito e si guardava intorno. Gli altri aspettavano di sentire cos’altro avrebbe detto Khan, che era riuscito a riprendere il controllo della situazione. “La questione è chiusa. Vedo che abbiamo raggiunto l’unanimità. Partiremo tra quindici minuti”. Si voltò verso Artyom e aggiunse: “Avevi detto persone? No, amico mio. Queste sono bestie. Sono un branco di sciacalli e si stavano preparando a distruggere anche noi. Però si sono dimenticati un piccolo particolare: loro sono sciacalli, ma io sono un lupo. Vi sono stazioni in cui mi conoscono solo con questo nome”, aggiunse prima di celare nuovamente il viso nell’ombra. Artyom non parlò, esterrefatto da ciò che aveva visto. Finalmente capì a cosa somigliava tanto Khan. “Tu, però, sei un lupacchiotto”, aggiunse il suo protettore dopo un momento, senza voltarsi, anche se il ragazzo riuscì a sentire un’inflessione affettuosa nella sua voce. CAPITOLO 7 : IL KHANATO DELL'OSCURITA' La galleria era vuota e pulita. Il terreno era asciutto e una piacevole brezza soffiava sui loro visi. Non c’era nemmeno un ratto o passaggi laterali sospetti, che sprofondavano nell’oscurità più assoluta; c’era soltanto qualche porta chiusa. Quella galleria sarebbe potuta essere abitata, proprio come qualsiasi delle stazioni della Metro. Oltretutto, con questa calma così innaturale, gli uomini non se la sentivano di mettersi in guardia, anche perché la paura di morire o di sparire si era dissipata all’istante. Tutte le leggende sulla sparizione della gente sembravano stupide storielle e Artyom si ritrovò a pensare se l’episodio dello sfortunato ometto che si pensava avesse la peste fosse accaduto realmente oppure no. Forse, mentre dormiva sul telone accanto al fuoco del filosofo viandante, aveva semplicemente avuto un incubo. Lui e Khan se ne stavano nella retroguardia, poiché quest’ultimo temeva che gli uomini avrebbero potuto staccarsi dal gruppo uno dopo l’altro e nessuno di loro sarebbe arrivato fino alla Kitay-Gorod. Khan procedeva tranquillo al fianco di Artyom, come se non fosse successo nulla. Le rughe profonde che gli avevano solcato il viso durante la schermaglia alla Sukharevskaya erano praticamente scomparse. La tempesta era passata: vicino ad Artyom ora c’era solo un uomo saggio e controllato, non un lupo adulto e furioso. Ma il ragazzo era sicuro che ci avrebbe impiegato un minuto a trasformarsi. In quel momento capì di avere un’opportunità per farsi svelare alcuni dei segreti della Metropolitana, perciò non poté trattenersi: “Tu riesci a comprendere ciò che succede all’interno di questa galleria?” “Nessuno ci riesce, me compreso”, rispose Khan con riluttanza. “Esistono cose che nemmeno io capisco. Ti posso solo dire che si tratta di un abisso. Un luogo del genere, io lo chiamo buco nero. Non hai mai visto una stella, vero? No, mi hai detto di averne vista una, in passato. Sai nulla del cosmo? Beh, una stella che sta morendo ha l’aspetto di un buco e, se si spegne completamente, la sua energia straordinariamente potente le si rivolta contro e comincia a divorare se stessa, a prendere la materia che si trova all’esterno, per attirarla verso l’interno del buco, al centro, che diventa sempre più piccolo, ma più denso e più pesante, così che la sua forza di gravità aumenta. Questo processo è irreversibile, è come una valanga: con la gravità che continua ad aumentare, la crescente quantità di materia viene attirata sempre più velocemente verso il cuore del mostro. Ad un certo punto, la sua potenza raggiunge una magnitudine tale che risucchia al suo interno anche i suoi vicini e tutta la materia che si trova nella sua sfera d’influenza, persino i raggi di luce. Questa enorme forza permette al buco di divorare i raggi degli altri soli, mentre lo spazio attorno a lui diviene nero e vuoto. E ormai tutto ciò che si trova al suo interno non ha più la forza di uscire. È una stella oscura, un sole nero, attorno al quale regnano solo freddo e oscurità”. Non aggiunse altro e si mise ad ascoltare le conversazioni degli uomini davanti a loro. “Ma tutto ciò cos’avrebbe a che fare con la galleria?”, dovette chiedergli Artyom dopo cinque minuti. “Io ho il dono della preveggenza. Spesso riesco a osservare il futuro, il passato, oppure riesco a trasportare la mia mente in luoghi diversi. Alle volte ciò che vedo non è chiaro e mi viene nascosto; ad esempio, non so come terminerà il tuo viaggio, il tuo futuro è un mistero per me. È come se guardassi in una pozza di acqua sporca e non riuscissi a distinguere nulla. Ma quando cerco di osservare quello che è accaduto qui oppure di comprendere la natura di questo luogo, davanti a me si staglia l’oscurità più assoluta. I raggi del mio pensiero non riescono a tornare indietro da questa galleria. È proprio per questo che la chiamo buco nero. Non posso dirti altro”. Ammutolì ancora per qualche minuto, ma poi aggiunse: “Ed è proprio per questo che mi trovo qui”. “Quindi non sai perché alle volte questa galleria è sicura, mentre certe altre risucchia le persone? Ma soprattutto perché prende a sé solo coloro che viaggiano da soli?” “Non so niente che tu non sappia già, anche se sono tre anni che cerco di svelare questo mistero; finora è stato tutto invano”. I loro passi generavano un’eco distante. L’aria era cristallina, respirare era estremamente facile e l’oscurità non faceva paura. Le parole di Khan non lo misero in guardia, non lo preoccuparono. Artyom sapeva che la tristezza del suo compagno non derivava dai segreti e dai pericoli della galleria, ma dalla futilità delle sue indagini, sebbene per il ragazzo queste sue preoccupazioni fossero ridicole. Il passaggio era proprio di fronte a loro, dritto, vuoto, non vi era alcuna minaccia. Nella sua mente riusciva a udire persino una melodia vivace, che poi cominciò a provenire dall’esterno, senza che lui se ne accorgesse. Infatti, in quel momento Khan lo guardò beffardo e chiese: “Non è divertente? Non c’è niente di cui preoccuparsi, vero? La galleria è tranquilla, pulita”. “Ma certo!”, Artyom convenne allegro. Si sentiva leggero perché Khan era riuscito a capire il suo stato d’animo, il tunnel aveva avuto lo stesso effetto su di lui. Anch’egli camminava e sorrideva, senza sentire il peso dei pensieri più oscuri; credeva che la galleria fosse... “Ora copriti gli occhi, ti prenderò per mano, così non inciamperai. Riesci a vedere qualcosa?”, gli domandò Khan interessato, afferrando piano il polso di Artyom. “No, non vedo nulla. Solo la luce flebile della torcia attraverso le palpebre”, affermò Artyom deluso, serrando ancora di più gli occhi. All’improvviso, sussultò. “Bravo, ce l’hai fatta”, notò Khan soddisfatto. “È bellissimo, vero?” “Incredibile... È come se... non ci fosse il soffitto. Tutto è blu. Mio Dio, che bellezza. E com’è facile respirare!” “Questo, amico mio, è il cielo. È curioso, vero? Riesci a vederlo quando sei dell’umore giusto, ti rilassi e chiudi gli occhi. Lo riescono a vedere in molti. È strano, non trovi? Lo visualizzano persino coloro che non sono mai stati lassù e ci si sente proprio come se si fosse in superficie, prima che accadesse tutto questo”. “Tu riesci a vederlo?”, domandò Artyom pieno di felicità. Non voleva più aprire gli occhi. “No”, risposte mesto Khan. “Riescono a vederlo quasi tutti, tranne me. Io trovo solo un’oscurità fitta, che circonda l’intera galleria. Non so se riesci a comprendere. Sopra, sotto, da tutte le parti. C’è solo un filo sottile di luce, che percorre tutta la galleria e che io seguo come fossi in un labirinto. Forse sono cieco. Oppure lo sono gli altri. Ok, ora apri gli occhi, non sono un cane guida e non ho intenzione di condurti per mano fino alla Kitay-Gorod”. Così dicendo lasciò il polso di Artyom. Il ragazzo cercò di camminare a occhi chiusi, ma inciampò su un traversina e per un pelo non cadde a terra, insieme allo zaino che trasportava. Così, restio, riaprì gli occhi e rimase in silenzio a lungo, sorridendo stupidamente tra sé. “Cos’è stato?”, domandò infine. “Fantasie, sogni, il buon umore... tutto insieme”, rispose Khan. “Tuttavia, è mutevole. Non sono il tuo stato d’animo o i tuoi sogni. Ci sono molti uomini in questa galleria e finora non è accaduto nulla, ma il nostro stato d’animo potrebbe cambiare da un momento all’altro, e tu lo percepiresti. Guarda, siamo già arrivati alla Turgenevskaya! Abbiamo fatto presto. Ma non possiamo fermarci qui, nemmeno per fare una pausa. È molto probabile che ci chiederanno di riposarci un po’, ma non tutti avvertono la galleria allo stesso modo. La maggior parte di loro non prova ciò che è accessibile a te. Dobbiamo proseguire e d’ora in avanti sarà più difficile”. Entrarono in stazione. Il marmo chiaro che ricopriva le pareti era identico in tutto e per tutto a quello della Prospekt Mira e della Sukharevskaya, ma laggiù le pareti e il soffitto erano talmente fuligginosi e sporchi di grasso che la pietra era praticamente invisibile. Qui, invece, era così immacolato che era impossibile non fermarsi ad ammirarlo. Gli uomini avevano lasciato questo luogo molto tempo prima e non era rimasta alcuna traccia della loro presenza. Sorpresi, notarono che la stazione era in buone condizioni, come se non fosse mai stata inondata e non avesse mai visto un fuoco. Se non fosse stato per la profonda oscurità e lo strato di polvere sul pavimento, sulle panchine e sulle pareti, ci si poteva aspettare che da un momento all’altro sulla piattaforma arrivasse una fiumana di passeggeri e che, dopo aver emesso il suo segnale melodioso, il treno entrasse in stazione. In tutti quegli anni, il luogo sembrava rimasto immutato. Il patrigno di Artyom gli aveva descritto tutto con stupore e ammirazione. Alla Turgenevskaya non c’erano colonne. Si intervallavano archi bassi, scolpiti nel marmo pesante. Le torce della carovana non erano abbastanza potenti per dissipare l’oscurità dell’androne e illuminare la parete opposta: sembrava che oltre gli archi non vi fosse nulla, come se cominciasse la fine dell’universo. Attraversarono la stazione abbastanza in fretta e, contrariamente a ciò che temeva Khan, nessuno espresse il desiderio di fermarsi per fare una pausa. Gli uomini sembravano turbati e cominciarono a parlare del fatto che dovevano procedere più veloci per arrivare il prima possibile in un luogo abitato. “Lo senti? Il loro umore sta cambiando...”, osservò Khan tranquillo, puntando un dito verso il soffitto, come se stesse cercando di capire in che direzione soffiava il vento. “È vero, dobbiamo procedere più velocemente; se lo sentono dentro, proprio come io riesco a sentirlo con il mio potere mistico. Ma c’è qualcosa che mi impedisce di continuare su questa strada. Aspettami un attimo qui”. Con attenzione, estrasse dalla tasca la mappa che chiamava Guida. Ordinò a tutti di stare fermi, spense la torcia e a grandi passi cauti scomparve nel buio. Non appena Khan si allontanò, un tizio uscì dal gruppo e lentamente, come se stesse facendo uno sforzo enorme, si avvicinò ad Artyom. La sua voce era talmente impacciata che Artyom non capì subito che si trattava dell’uomo con la barba che lo aveva minacciato alla Sukharevskaya. “Ascolta, abbiamo sbagliato a fermarci qui. Digli che abbiamo paura. Siamo in tanti, ma può succederci qualsiasi cosa. Al diavolo questa galleria e questa stazione! Digli che dobbiamo andarcene. Hai capito? Diglielo, ti prego”. Si guardò intorno, poi tornò di tutta fretta dagli altri. Il ti prego dell’uomo fece rabbrividire Artyom, che ne fu sgradevolmente sorpreso. Azzardò qualche passo in avanti, in modo da essere più vicino al gruppo e ascoltare quello di cui stavano discutendo. Comprese subito che non era rimasta traccia del buonumore di qualche minuto prima. Anche nella sua testa, dove poco prima aveva udito una marcia virtuosa, ora sentiva il vuoto più assoluto, solo l’eco del vento che, sconfortato, soffiava nella galleria di fronte a loro. Artyom ammutolì. Tutto il suo essere si era irrigidito, era teso e si aspettava qualcosa, come un inevitabile cambio di programma. E aveva ragione. Dopo una frazione di secondo, un’ombra invisibile piombò sopra di loro: tutto diventò gelido e spazzò via la sensazione di pace e di fiducia che li aveva accompagnati lungo la galleria. Così Artyom si ricordò delle parole di Khan: non era il suo umore, non era la sua gioia, e il cambiamento di stato d’animo non dipendeva da lui. Nervoso, descrisse un cerchio attorno a sé con la luce della torcia, perché lo aveva pervaso l’oppressiva sensazione di una presenza indefinibile. Il marmo bianco e polveroso si illuminò debolmente, mentre le pesanti tende d’oscurità che avvolgevano gli archi non si mossero, nonostante il movimento allarmato della luce emessa dalla sua torcia. Ciò alimentò l’illusione che il mondo terminasse proprio al di là degli archi. Incapace di riacquistare il controllo, Artyom si mise quasi a correre per raggiungere gli altri. “Vieni qui da noi, amico”, gli si rivolse qualcuno, il cui viso gli era sconosciuto. Sembrava che anche loro stessero cercando di risparmiare le batterie delle loro torce. “Non avere paura. Sei una persona, anche noi siamo persone. Quando si verificano fatti del genere, le persone devono stare insieme. Non credi?” Artyom si accorse con piacere che così andava un po’ meglio. Era spaventato, perciò si sentiva insolitamente amichevole e si mise a parlare con i compagni delle sue paure, sebbene continuasse a domandarsi dove fosse finito Khan: era scomparso da dieci minuti buoni e non era rimasta alcuna traccia di lui. Sapeva benissimo che non si sarebbe dovuto avventurare nella galleria da solo, bisognava andarci in gruppo! Perché si era allontanato così, perché aveva deciso di sfidare la tacita legge di quel luogo? Non poteva essersene dimenticato! Non poteva aver deciso di fidarsi del suo fiuto da lupo! Artyom non riusciva a crederci... Dopotutto, Khan aveva passato tre anni della sua vita a studiare quella galleria e bastava poco per imparare la regola di base e cioè che non bisognava mai percorrerla da soli. Ma il ragazzo non ebbe tempo di valutare ciò che sarebbe potuto succedere al suo protettore, che l’uomo comparve al suo fianco, senza fare rumore. Gli altri si rianimarono. “Non vogliono rimanere qui. Sono spaventati. Dobbiamo proseguire, e in fretta”, propose Artyom. “Sento anch’io che qui c’è qualcosa...” “Non sono ancora spaventati”, lo rassicurò Khan, guardandosi alle spalle. Improvvisamente Artyom notò che la voce dell’uomo, di solito dura e rauca, tremava. Khan continuò: “Anche tu non sai ancora cosa sia la paura, perciò non sprecare il fiato. Sono io ad avere paura. E ricorda di non usare parole a sproposito. Ho paura perché mi sono tuffato nell’oscurità della stazione. La Guida non mi ha fatto proseguire oltre, altrimenti sarei scomparso, senza dubbio alcuno. Non possiamo continuare da questa parte, c’è qualcosa lì davanti a noi... Ma qui è molto buio e il mio occhio non riesce a penetrare l’oscurità, quindi non so con esattezza cosa ci aspetta laggiù. Guarda!”, e con un gesto veloce avvicinò la mappa al viso “Vedi anche tu? Illumina con la torcia! Osserva il passaggio che conduce alla Kitay-Gorod! Non dirmi che non noti nulla di strano”. Artyom scrutò la minuscola sezione del diagramma con talmente tanta concentrazione che sentì male agli occhi. Non riusciva a capire cosa non andasse, ma non aveva il coraggio di ammetterlo con Khan. “Sei cieco? Davvero non riesci a vedere niente? È tutto nero! È la morte!”, sussurrò Khan e, con uno scatto, rimise la mappa in tasca. Artyom lo fissava, cauto. Gli sembrava che Khan fosse impazzito. Si ricordò ciò che gli aveva riferito l’amico Zhenya sulle persone che attraversavano la galleria da sole. Se riescono a sopravvivere, impazziscono dalla paura. Poteva essere accaduto lo stesso anche a Khan? “E non possiamo nemmeno tornare indietro!”, bisbigliò ancora Khan. “Siamo riusciti ad attraversare quella parte di galleria mentre era di buon umore. Ora è rimasta solo oscurità. C’è aria di tempesta, là dentro. L’unica possibilità che ci rimane è proseguire, ma non lungo questa galleria. Dobbiamo prendere quella parallela; forse là dentro non c’è nulla. Ehi!”, si rivolse agli altri, gridando. “Avete ragione! Dobbiamo procedere, ma non in questa direzione. Davanti a noi ci sono solo morte e distruzione”. “Come facciamo a proseguire, allora?”, chiese uno degli uomini, perplesso. “Attraverseremo la stazione e procederemo lungo la galleria parallela, non abbiamo altra scelta. Dobbiamo sbrigarci!” “Oh no!”, tuonò qualcuno. “Tutti sanno che non si percorre mai la galleria nella direzione sbagliata se quella che bisognerebbe prendere è libera. Porta sfortuna. Significa morte certa! Non possiamo addentrarci nella galleria di sinistra”. Diverse voci furono d’accordo. Il gruppo si mise a parlottare tra sé. “A cosa si riferisce?”, chiese Artyom a Khan. “Sono solo credenze del posto”, rispose e aggrottò le sopracciglia. “Al diavolo! Non c’è tempo per stare qui a convincerli e io non ne ho nemmeno la forza... Ascoltate!”, si rivolse al gruppo: “Io mi dirigerò verso la galleria parallela. Chi si fida di me può seguirmi. Per gli altri... addio! A mai più rivederci! Andiamo!”, e fece un segno con il capo in direzione di Artyom, sollevò il pesante zaino che teneva in mano e salì sulla piattaforma. Artyom rimase dov’era, indeciso. Da una parte, Khan conosceva questi tunnel e la Metro molto meglio di qualsiasi altro uomo. Perciò ci si poteva fidare di lui. Dall’altra, però, incombeva su di loro la legge immutabile di quelle maledette gallerie: se si voleva superarle, bisognava attraversarle con un gruppo numeroso. “Che ti succede? Non ce la fai? Dammi la mano!”. Khan si inginocchiò sulla piattaforma e si sporse verso il ragazzo, per aiutarlo. In quel momento, Artyom non se la sentiva di guardarlo negli occhi, perché temeva di rivedere le fiamme di pazzia che aveva già scorto in precedenza e che tanto lo avevano spaventato. Forse Khan non aveva capito che non stava solo ignorando gli avvertimenti degli altri uomini, ma anche quelli della galleria stessa. Era davvero riuscito a percepire la natura del tunnel? Quel punto che l’uomo aveva indicato sulla Guida non era nero, Artyom era pronto a giurare che fosse di un arancione sbiadito, come il resto della mappa. La domanda che si doveva porre era: “Chi, tra loro due, era il cieco?” “Beh? Che stai aspettando? Non capisci che anche il minimo ritardo potrebbe ucciderci? Per tutti i diavoli, dammi la mano!”, Khan urlava. Ma Artyom, sempre fissando il pavimento, si stava allontanando a piccoli passi e si avvicinava al gruppo rumoroso. “Forza, amico! Vieni con noi! Non hai bisogno di intrattenerti con quello stupido. Con noi sarai più al sicuro!”, sentì qualcuno che lo chiamava. “Stupidi sarete voi! Morirai insieme a tutti loro! Se non ti importa un fico secco della tua vita, almeno pensa alla tua missione!” Artyom richiamò tutto il coraggio che aveva in sé e infine riuscì a sollevare la testa e a fissare le pupille dilatate di Khan, nelle quali non trovò il fuoco della pazzia, ma solo disperazione e fatica. Cominciò a dubitare, quindi si fermò per un momento, quando la mano di qualcuno gli si posò piano sulla spalla e lo tirò con gentilezza. “Andiamo. Lascialo morire da solo. Voleva trascinare anche te nella tomba!”, si sentì rassicurare. Il significato di queste parole pesava come un macigno, ma non appena le comprese, si lasciò andare e permise all’uomo di condurlo verso il gruppo. Gli uomini si incamminarono verso l’oscurità della galleria meridionale. Si spostavano molto lentamente, come se il loro movimento fosse intralciato da un liquido denso: sembrava che stessero procedendo nell’acqua. A quel punto Khan, con un’agilità inaspettata, saltò dalla piattaforma fin sul sentiero e raggiunse il giovane con due balzi veloci. Piombandogli addosso, fece rovinare a terra l’uomo che scortava Artyom; poi afferrò quest’ultimo e lo strattonò, portandolo indietro. Ad Artyom sembrava che tutta la scena si stesse svolgendo al rallentatore. Guardandosi alle spalle sorpreso, senza riuscire a dire nulla, aveva visto Khan saltare. Gli era sembrato che quel balzo fosse durato diversi secondi; allo stesso modo, vide che l’uomo con i baffi che indossava la giacca di tela cerata e lo teneva per la spalla era caduto a terra rovinosamente. Ma nel momento in cui Khan lo aveva fermato, il tempo aveva ripreso a scorrere normalmente e, quando gli altri uomini sentirono il rumore dell’impatto, le loro reazioni parvero essere veloci come dei fulmini: procedevano verso Khan con le pistole pronte, mentre lui si spostava di lato, stringeva Artyom a sé con un braccio, lo tratteneva e si faceva scudo con il suo corpo. L’altra mano era protesa in avanti: Khan impugnava la nuova mitragliatrice di Artyom. “Proseguite”, disse Khan con voce rauca. “Non vedo perché dovrei uccidervi, tanto morirete tutti nel giro di un’ora. Lasciateci in pace e andate per la vostra strada”. Mentre parlava, si spostava verso il centro della stazione, mentre le sagome immobili degli indecisi diventavano confuse e si fondevano con l’oscurità. Sentirono un po’ di baccano, molto probabilmente gli altri stavano aiutando l’uomo con i baffi a rialzarsi, dopodiché il gruppo cominciò a dirigersi verso l’entrata della galleria meridionale. Decisero di non unirsi a Khan. Solo allora quest’ultimo abbassò la guardia e, in tono brusco, ordinò ad Artyom di salire sulla piattaforma. “Se ti comporti così, ben presto mi stuferò di salvarti la vita, mio giovane amico”, lo ammonì, senza nascondere lo sdegno. Obbediente, Artyom si arrampicò sulla piattaforma. Khan fece altrettanto e, raccolte le sue cose, si diresse verso l’apertura oscura, mentre il ragazzo lo seguiva da vicino. L’atrio della Turgenevskaya era piccolo: a sinistra c’era un vicolo cieco, chiuso da una parete di marmo; di fronte, invece, c’era una crepa nel muro, coperta da una lamiera di ferro ondulato. Era tutto ciò che si vedeva alla luce della torcia. Il marmo, ingiallito dal passare del tempo, ricopriva l’intera stazione, nella quale vi erano solo tre archi. Questi conducevano a una scala che la collegava alla Chistye Prudy, che i Rossi avevano ribattezzato Kirovskaya; tuttavia il passaggio era stato murato con blocchi di cemento grigio. La stazione era completamente vuota. Non erano rimasti oggetti sul pavimento e non vi erano tracce di attività umana. Non c’era l’ombra di un ratto e nemmeno di uno scarafaggio. Mentre Artyom si guardava intorno, si ricordò di ciò che gli aveva rivelato Bourbon, il quale gli aveva confermato che i ratti non avevano paura di niente, ma se in un luogo non vi era traccia di quegli animali, allora c’era qualcosa che non andava. Afferrandolo per la spalla, Khan attraversò l’androne a passi veloci. Malgrado la giacca pesante, Artyom sentì che l’uomo tremava, come se fosse scosso da brividi di freddo. Quando appoggiarono gli zaini sul bordo della piattaforma, pronti per saltare, una luce flebile li colpì alle spalle e il ragazzo rimase di nuovo sorpreso dalla velocità con cui il compagno reagì al pericolo: in un attimo, Khan si era sdraiato a terra e teneva sotto controllo il punto da cui proveniva il bagliore. La luce non era molto forte, ma era puntata verso i loro occhi, perciò gli fu difficile comprendere chi li stesse seguendo. Un momento dopo anche Artyom si gettò a terra, raggiunse il suo zaino ed estrasse la vecchia arma che portava con sé. Era ingombrante e scomoda, ma causava perfetti fori calibro 7.62; chiunque fosse stato colpito avrebbe faticato a rimanere in piedi. “Che vuoi?”, ringhiò Khan. Nel frattempo Artyom si ritrovò a pensare che, se quella persona avesse voluto ucciderli, molto probabilmente l’avrebbe già fatto. Riusciva a figurarsi la scena dal di fuori: due uomini accovacciati a terra, impotenti, accecati dalla luce della torcia del nemico, minacciati dal suo mirino. Sì, se li avesse voluti uccidere, si sarebbero già ritrovati in una pozza di sangue. “Non sparate!”, implorò una voce. “Non ce n’è bisogno...” “Spegni la torcia!”, intimò Khan, che si spostò verso la colonna per prendere la sua. Finalmente Artyom riuscì ad afferrare la sua arma e, tenendola stretta, rotolò di lato per scansarsi dalla linea di fuoco del nemico e si nascose sotto uno degli archi. Era pronto a spuntare dall’altra parte, nel caso l’avversario avesse deciso di sparare. Ma lo straniero seguì immediatamente gli ordini di Khan. “Ottimo! Ora posa la tua arma a terra!”, la voce di Khan era meno tesa. Il metallo tintinnò sul pavimento di granito e Artyom, puntando la mitragliatrice davanti a sé, strisciò di lato e ricomparve nell’androne. I suoi calcoli erano corretti: quindici passi di fronte a lui, illuminato dai riflessi della torcia sugli archi, con le mani alzate, c’era lo stesso uomo con la barba che aveva dato inizio alla schermaglia alla Sukharevskaya. “Non sparate”, ripeté l’uomo, con voce tremante. “Non intendevo attaccarvi. Ho deciso di venire con voi. Avevi detto che chiunque volesse venire, poteva farlo. Io... io mi fido di te”, si rivolse a Khan. “Ho sentito anche io che laggiù, nella galleria destra, c’è qualcosa. Se ne sono già andati, tutti. Ma io sono rimasto indietro, voglio venire con voi”. “Beh, se non altro hai buon senso”, Khan stava esaminando attentamente l’uomo. “Purtroppo però tu non ispiri fiducia in me, amico mio. Chissà perché”, aggiunse in tono di scherno. “Valuteremo la tua proposta, a condizione che ci consegni tutto il tuo arsenale. Inoltre, nella galleria, camminerai davanti a noi. Se stai cercando di ingannarci, finirai male”. L’uomo con la barba spinse con il piede la sua pistola in direzione di Khan, poi fece lo stesso anche con le cartucce di scorta. Artyom le raccolse e gli si avvicinò, senza mai abbassare l’arma. “Ce l’ho!”, gridò. “Tieni le mani in alto!”, tuonò Khan. “Veloce, salta giù sui binari. Stai fermo, con la schiena rivolta verso di noi!” Assunsero una posizione a triangolo, l’uomo con la barba, che si chiamava Asso, camminava cinque passi più avanti di Khan e Artyom. Dopo un paio di minuti, nella galleria udirono un ululato sordo, che terminò subito dopo essere cominciato. Asso si voltò e li guardò spaventato, dimenticandosi di puntare la torcia di lato. Le mani gli tremavano e il viso, illuminato da sotto, veniva distorto in una terribile smorfia d’orrore. Ciò impressionò Artyom quanto l’ululato di poco prima. “Sì”, annuì Khan, rispondendo alla domanda che Asso non era riuscito a elaborare. “Hanno commesso un errore. Solo il tempo ci dirà se anche noi abbiamo fatto lo stesso”. Procedevano veloci. Di tanto in tanto, Artyom lanciava uno sguardo al suo protettore, che gli sembrava sempre più affaticato: le mani gli tremavano, la camminata era irregolare e il sudore gli colava copioso dalla fronte. Tuttavia, non stavano camminando da molto tempo. Questo percorso era sicuramente più stancante per lui di quanto lo fosse per Artyom. Pensando che le forze del compagno si stavano sempre più affievolendo, il ragazzo non riusciva a fare a meno di riflettere che Khan aveva avuto i riflessi pronti, gli aveva salvato di nuovo la vita. Se Artyom avesse seguito la carovana nella galleria di destra, sarebbe già morto, sarebbe scomparso senza lasciare traccia. Erano in molti, almeno sei. La regola d’oro non aveva funzionato? Khan lo aveva saputo, eccome! Era stata una premonizione oppure era stata la Guida magica a comunicarglielo? Era così strano che un pezzetto di carta con qualche goccia d’inchiostro potesse fare una cosa del genere. Quel brandello di carta straccia li aveva davvero aiutati? Il passaggio tra la Turgenevskaya e la Kitay-Gorod era senza dubbio arancione. O era davvero di colore nero? “Cosa è stato?”, domandò Asso, fermandosi all’improvviso e rivolgendosi ansioso verso Khan. “L’hai sentito? Arriva da dietro...” Artyom lo guardò confuso, avrebbe voluto fare un commento sarcastico sugli scherzi che possono giocare i nervi poco saldi, perché lui non aveva udito il benché minimo rumore. Gli sembrava persino che quella morsa di depressione e pericolo si stesse allentando da quando avevano lasciato la Turgenevskaya. Ma, con sua enorme sorpresa, Khan rimase immobile e gli fece segno di rimanere in silenzio. Si voltò verso la parte della galleria che avevano appena percorso. “Che intuito!”, esclamò dopo qualche istante. “Straordinario. Ti faccio i miei complimenti”, aggiunse, per un motivo che il ragazzo non riuscì immediatamente a spiegarsi. “Se usciamo vivi da qui, dobbiamo riparlarne. Tu non senti niente?”, volle sapere da Artyom. “No, mi sembra tutto tranquillo”, rispose il ragazzo, dopo aver ascoltato per un attimo. All’improvviso, si sentì pervadere da un sentimento... di gelosia? Di offesa? D’irritazione, perché il suo protettore si era complimentato con quello sporco uomo barbuto che solo un paio d’ore prima aveva minacciato di ucciderli. Non gli sembrava il caso. “È molto strano. Ritengo che tu possegga tutti i rudimenti delle abilità che ti permettono di sentire le gallerie. Ma forse non si sono ancora sviluppate completamente. Più tardi, ne riparleremo più tardi”, Khan scosse la testa. “Hai ragione”, si rivolse ad Asso, confermando i sospetti dell’uomo. “C’è qualcosa che viene verso di noi. Dobbiamo sbrigarci”. Si mise di nuovo in ascolto e annusò l’aria, come fosse un vero lupo. “Arriva dalle nostre spalle, come un’onda. Dobbiamo correre! Se ci raggiunge siamo spacciati!”, concluse, cominciando a muoversi in fretta. Artyom dovette sbrigarsi per raggiungerlo e cominciò a correre per non rimanere indietro. L’uomo con la barba stava al passo, nonostante avesse due gambette corte e gli fosse venuto il fiatone. Proseguirono per una decina di minuti e per tutto il tempo Artyom continuava a chiedersi perché stessero correndo a perdifiato e inciampando nelle traversine del binari se la galleria dietro di loro era vuota e tranquilla e non vi fosse alcuna prova che qualcuno li stesse inseguendo. Passarono altri dieci minuti prima che lo sentissero: li stava rincorrendo, gli era già alle calcagna, era qualcosa di nero. Non un’onda, ma piuttosto un vortice oscuro che attraversava il buio. Se li avesse raggiunti, sarebbero andati incontro allo stesso destino che era toccato agli altri sei o a tutti i temerari e gli stupidi che avevano percorso la galleria da soli o nel momento sbagliato, quando infuriava quell’uragano diabolico, spazzando via tutti gli esseri viventi che trovava davanti a sé. Queste supposizioni, insieme a una vaga idea di quello che stava succedendo, si accalcarono nella mente di Artyom, mentre guardava Khan ansioso. Quest’ultimo gli restituì lo sguardo preoccupato e tutto gli fu chiaro. “Beh, ora hai capito?”, aveva il fiato grosso. “Molto male. Ciò significa che è fin troppo vicino”. “Dobbiamo andare più veloci!”. Artyom ansimò, mentre correva. “Prima che sia troppo tardi!” Khan si mise a correre più veloce, ora percorreva la galleria a grandi falcate, senza dire più una parola, senza rispondere alle domande di Artyom. Le tracce di stanchezza che aveva intravisto nell’uomo fino a poco prima sembravano completamente scomparse, lasciando posto a un istinto più selvaggio, quello dell’animale dentro di lui. Artyom faticava a stargli dietro, ma nel momento in cui sembrava fossero riusciti a seminare quell’entità che li inseguiva in modo tanto inesorabile, Asso inciampò su una traversina e stramazzò a gambe all’aria. Aveva il viso e le mani ricoperte di sangue. Per inerzia, Artyom e Khan proseguirono ancora per qualche passo prima di accorgersi che Asso era caduto. Il giovane meditò che non se la sentiva di fermarsi e di tornare indietro per aiutare quel tizio. Voleva lasciarlo lì a morire, quel tozzo leccapiedi dall’intuito straordinario. Voleva avanzare velocemente, prima che il vortice li raggiungesse. Era un pensiero orribile. Artyom venne sopraffatto da un desiderio irrefrenabile di fuggire e di lasciare a terra quel poveretto, tanto che la sua coscienza si mise a tacere. Rimase un po’ deluso quando vide che Khan era tornato indietro e, con un potente scatto, era riuscito a fare rialzare l’uomo con la barba. Il giovane aveva segretamente sperato che il protettore, dato il suo atteggiamento sdegnoso nei confronti della vita degli altri e soprattutto della loro morte, si sarebbe facilmente dimenticato di quel tizio, lo avrebbe lasciato nella galleria e si sarebbe sbrigato a proseguire. Invece, ordinò ad Artyom di prendere Asso per una delle braccia ferite, mentre lui afferrava l’altra. Così cominciarono a trascinarlo. Correre in questo modo era molto più complicato. Asso si lamentava e digrignava i denti per il dolore; tuttavia, Artyom non provava alcun sentimento particolare nei suoi confronti, se non un senso d’irritazione crescente. La mitragliatrice lunga e pesante gli sbatteva dolorosamente sulle gambe, ma aveva le mani occupate e non riusciva a sistemarla. La fine era sempre più vicina. Se si fossero fermati e avessero atteso per altri trenta secondi, il sinistro vortice li avrebbe risucchiati e ridotti in particelle minuscole. Un secondo dopo non avrebbero più fatto parte di questo universo e le loro bocche avrebbero emesso grida di morte ad una velocità sovrannaturale. Questi pensieri non paralizzarono Artyom ma, insieme alla malignità e all’irritazione, gli diedero una forza che aumentava passo dopo passo. Poi, all’improvviso, scomparve. Svanì completamente. La morsa della sensazione di pericolo si aprì così di colpo, tanto che nelle loro coscienze rimase un senso di vuoto, come lo spazio che resta quando viene estratto un dente. La punta della lingua di Artyom andava a battere proprio in quel punto, rimasto libero. Dietro di loro non c’era più nulla, solo la galleria pulita, asciutta e sicura. In quel momento Artyom pensò alla loro fuga dalla paura e dalle fantasie paranoiche, all’inutile fiducia in sensazioni e intuizioni speciali. Sembrava tutto così buffo, stupido e assurdo che scoppiò a ridere. Asso, che si era fermato di fianco a lui, inizialmente lo osservò sorpreso, poi eruppe anche lui in una fragorosa risata. Khan li guardava irritato e alla fine li apostrofò: “Che c’è di tanto divertente? Si sta bene qui, vero? Ora è tutto tranquillo e pulito, non è così?”, e prese a camminare da solo. Fu allora che Artyom si accorse che mancavano una cinquantina di passi per raggiungere la stazione, la cui luce era visibile alla fine della galleria. Khan li attendeva all’entrata, in piedi sulle scale di ferro. Aveva avuto il tempo di fumare una specie di sigaretta fatta a mano, mentre gli altri due ridevano rilassati e percorrevano la breve distanza che li separava. Artyom venne pervaso da un sentimento di compassione per il povero, zoppicante Asso che continuava a lamentarsi tra una risata e l’altra. Si vergognava dei pensieri che avevano attraversato la sua mente quando Asso era rovinato a terra. Malgrado ciò, il suo morale era nettamente migliorato; perciò, quando vide Khan stanco, emaciato, che li osservava con un’espressione sospettosa, gli fece uno strano effetto, poco piacevole. “Grazie!”, il rumore degli stivali di Asso rombava sulle scale, mentre l’uomo saliva sulla piattaforma per raggiungere Khan. “Se non fosse stato per te... Tu... Beh, sarei già morto. Ma tu... non mi hai lasciato a terra. Grazie! Non dimentico facilmente un gesto del genere”. “Non preoccuparti”, ribatté Khan senza alcun entusiasmo. “Perché sei tornato indietro?” “Ti ritengo una persona interessante, con cui poter parlare”. Khan fece volare il mozzicone della sigaretta a terra e scrollò le spalle. “Tutto qui”. Salirono ancora un po’, quando Artyom comprese perché Khan aveva salito le scale fino alla piattaforma, ma non aveva proseguito. Davanti alla vera e propria entrata della Kitay-Gorod vi era una montagna di sacchi di sabbia alta quanto un uomo. Al di là si trovava un gruppo di persone sedute su sgabelli di legno; avevano tutti un’espressione molto seria. Capelli tagliati cortissimi, spalle enormi sotto malconce giacche in pelle e logori pantaloni sportivi: la scena poteva sembrare quasi comica, ma per una ragione inspiegabile, non aveva suscitato in loro alcuna ilarità. Tre uomini sedevano sui rispettivi sgabelli, mentre su un quarto seggiolino c’era un mazzo di carte sparpagliato. Usavano un linguaggio particolarmente colorito, tanto che ascoltandoli Artyom non riconobbe una sola parola normale. Per entrare in stazione c’era una sola possibilità: percorrere uno stretto passaggio e salire una scaletta, alla fine della quale si trovava un cancello. Ma la strada era bloccata da altre quattro guardie, ancora più imponenti, con teste rasate, acquosi occhi grigi, nasi leggermente adunchi, orecchie a cavolfiore e pantaloni da ginnastica con grandi “TT” stampate sulle righe. Inoltre, c’era anche un insopportabile odore di gas di scarico, che rendeva impossibile pensare. “Bene bene, cosa abbiamo qui?”, dalle loro spalle li raggiunse la voce rauca della quarta guardia, che squadrava Khan e Artyom dalla testa ai piedi. “Siete turisti? Commercianti?” “Non siamo commercianti, solo dei viaggiatori. Non abbiamo merce con noi”, spiegò Khan. “Viaggiatori, truffatori!”, rimò la canaglia e sghignazzò rumorosamente. “Hai sentito, Kolya? Viaggiatori, truffatori!”, ripeté, rivolgendosi ai giocatori di carte, che risposero infervorati. Khan sorrise paziente. Un uomo enorme dal collo taurino appoggiò una mano al muro e bloccò loro la strada. “Abbiamo delle operazioni doganali da sbrigare, capite che intendo?”, si spiegò. “Si paga in valuta. Se volete passare, dovete pagare. Altrimenti potete tornarvene da dove siete venuti!” “Di chi sarebbe la prerogativa?”, protestò Artyom indignato. Fu un errore. Molto probabilmente l’omone non capì nemmeno il significato della domanda, ma aveva inteso l’intonazione e non gli era piaciuta. Spingendo Khan, fece un passo in avanti e fu subito di fronte ad Artyom. Gli abbassò il mento e guardò serio il ragazzo: i suoi occhi erano vuoti e sembravano quasi trasparenti; trasmettevano solo stupidità e cattiveria: si capiva che non aveva intenzione di ragionare. Sebbene fosse quasi impossibile sostenere quello sguardo e Artyom continuasse a sbattere le palpebre per la tensione, capì che, negli occhi dell’uomo che se ne stava all’entrata della galleria a guardare la gente che passava, crescevano solo paura e odio. “Vattene al diavolo!”, urlò minacciosa la guardia. Era più alto di Artyom di una ventina centimetri e tre volte più grosso. Il giovane ricordò la leggenda di Davide e Golia e malgrado non si ricordasse chi fosse uno e chi l’altro, sapeva che era il più piccolo e debole ad avere la meglio e ciò gli trasmise un certo ottimismo. “Chi se ne importa!”, trovò l’inaspettato coraggio di ribattere. Chissà perché, questa risposta fece arrabbiare l’uomo ancora di più, perciò alzò le dita corte e grassocce e, con un movimento sicuro, le mise tutte e cinque sulla fronte di Artyom. La pelle dei palmi delle sue mani era giallastra, callosa, puzzava di tabacco e di grasso di automobile. Artyom non ebbe il tempo di riconoscere tutti gli odori, che la canaglia lo spinse indietro. Probabilmente non aveva usato molta forza, ma il giovane indietreggiò di diversi metri e andò a colpire Asso, dietro di lui. Caddero entrambi sul ponticello, mentre il malfattore tornava al suo posto, dove però lo aspettava una sorpresa: Khan aveva gettato la sua borsa a terra e se ne stava impassibile con la mitragliatrice di Artyom tra le mani. In modo dimostrativo, fece scattare la sicura. Poi parlò con voce calma, a indicare che tutto sarebbe potuto finire male, tanto che ad Artyom venne la pelle d’oca. “Perché fate i maleducati?”. Non aveva ancora detto nulla di che ma ad Artyom, pieno di vergogna, che si stava ancora dimenando sul pavimento per cercare di alzarsi, queste parole sembrarono un ringhio d’avviso, al quale probabilmente sarebbe seguito un attacco veloce e violentissimo. Alla fine riuscì ad alzarsi, prese la sua vecchia mitragliatrice dalla spalla e, con la sicura sbloccata, la puntò verso colui che l’aveva offeso. Ora era pronto a premere il grilletto in qualunque momento. Il cuore gli batteva veloce e, tra i sentimenti che provava, l’odio superava di gran lunga la paura. Così si rivolse a Khan: “Lascia che me ne occupi io”. Era sorpreso: sarebbe stato pronto ad ucciderlo, senza alcuna esitazione, solo perché lui l’aveva spinto. La testa rasata dell’uomo, imperlata di sudore, era perfettamente visibile nel suo mirino e la tentazione di usare l’arma era quasi impossibile da tenere a bada. Non gli importava cosa sarebbe successo dopo, l’importante era liberarsi il prima possibile di quel bastardo, vedere scorrere il suo sangue. “All’erta!”, urlò l’omone. Khan, con un gesto fulmineo, gli prese la pistola dalla cintura, si spostò di lato e mirò ai “doganieri” che si erano alzati dal loro posto. “Non sparare!”, riuscì a urlare ad Artyom. La scena si interruppe nuovamente: l’omone era immobile sul ponticello, con le mani alzate, mentre Khan, anch’egli fermo, mirava alle altre tre canaglie che non erano nemmeno riuscite a prendere le mitragliatrici dalla catasta di fianco a loro. “Non abbiamo bisogno di spargimenti di sangue”, Khan era rimasto tranquillo. La sua non era una richiesta, ma un ordine. Poi continuò: “Qui ci sono delle regole, Artyom”, senza togliere gli occhi dai giocatori di carte, che fermandosi erano rimasti in posizioni assurde. Molto probabilmente, quegli uomini con la testa rasata erano a conoscenza della forza letale di un Kalashnikov da quella distanza, per cui non volevano risvegliare sospetti inutili nell’uomo che li controllava a vista. “Qui la regola vuole che, per entrare in stazione, si paghi un dazio. Quanto volete?” domandò Khan. “Tre cartucce ciascuno”, rispose l’omone sul ponte. “E se contrattassimo?”, propose Artyom beffardo, puntando la canna della sua arma alla vita dell’uomo. “Due”, fu l’offerta dell’uomo, che diede un’occhiataccia ad Artyom, anche se non era sicuro di come il ragazzo avrebbe reagito. “Dagliele!”, Khan ordinò ad Asso. “Paga anche per me, così ti sdebiterai”. Asso mise prontamente le mani nella sua sacca da viaggio, mentre si avvicinava alla guardia. Contò sei cartucce brillanti e aguzze. La guardia le afferrò con un gesto veloce, chiudendoci attorno la mano a pugno, che poi si mise in una delle tasche sporgenti della giacca. Quindi guardò di nuovo Khan, in attesa. “Così siamo a posto?”, gli domandò Khan alzando le sopracciglia in tono inquisitorio. L’omone annuì svogliato, senza togliere gli occhi dall’arma di Khan. “La faccenda è conclusa?”, chiese di nuovo Khan. La canaglia non rispose. Khan prese il secondo bagaglio ed estrasse altre cinque cartucce, poi le mise nella mano della guardia. Emisero un tintinnio nel momento in cui caddero nella tasca e scomparvero insieme alla smorfia tesa sul viso dell’omone, che aveva riassunto la solita espressione pigra e sospettosa. “Consideralo un risarcimento per i danni morali”, spiegò Khan, ma le sue parole non sortirono alcun effetto. Era probabile che l’uomo non le avesse nemmeno comprese, così come non era riuscito a capire la domanda precedente. Aveva semplicemente cercato di intuire il significato della frase di Khan dalla sua prontezza nell’usare il denaro e la forza. Comprendeva alla perfezione quest’ultima lingua e probabilmente era anche l’unica che fosse in grado di parlare. “Puoi abbassare le mani”, proferì Khan e alzò l’arma verso il soffitto, lontano dai tre giocatori d’azzardo. Anche Artyom fece lo stesso, ma gli tremavano le mani perché era stato pronto a fare saltare le cervella del tizio con la testa rapata. Non si fidava di questa gente. Tuttavia, la sua agitazione non era fondata. La canaglia si era rilassata e aveva abbassato le mani. Ruggì agli altri suoi compagni che era tutto a posto, appoggiò la schiena alla parete e assunse un atteggiamento indifferente, così permise ai viaggiatori di entrare in stazione. Mentre lo superava, Artyom gli diede un’occhiataccia, ma l’omone lo ignorò e si mise a guardare dall’altra parte. Tuttavia, il giovane riuscì a sentire un disgustato “P-pivello...”, oltre a uno sputo che andò a spiaccicarsi sul pavimento. Si sarebbe voluto voltare, ma Khan, che camminava poco avanti a lui, lo afferrò per la mano e lo trascinò. Artyom rimase in bilico tra l’impulso di girarsi e dare un lezione a quel tipo e il suo lato più codardo che desiderava andarsene da quel luogo il prima possibile. All’improvviso, non appena misero piede sul granito scuro del pavimento della stazione, udirono un urlo, dalle sillabe ben scandite: “Ehi, tu! Ri-dam-me-li!” Khan si fermò, prese la pistola con il caricatore di proiettili arrotondati, contrassegnati con la sigla “TT”, e li lanciò all’omone, che li prese al volo e li rimise alla cintura, osservando irritato Khan che aveva lasciato cadere qualche altra cartuccia sul pavimento. “Scusa”, fece segno Khan. “È la profilassi. Non si chiama così?”, e fece l’occhiolino ad Asso. La Kitay-Gorod era diversa dalle altre stazioni che Artyom aveva visto: non aveva tre archi come la VDNKh, ma c’era un solo atrio enorme con un’ampia piattaforma; i binari correvano su entrambi i lati della stessa, il che conferiva allo spazio un’allarmante impressione di insolita ampiezza. Gli alloggi erano illuminati in maniera disorganizzata, cioè tramite fioche lampade a forma di pera che penzolavano qua e là. Non vi era alcun fuoco acceso, apparentemente non era permesso. Al centro dell’androne era stata sistemata una lampada bianca a vapori di mercurio che irradiava generosamente la zona attorno a sé; per Artyom era un vero miracolo. C’era moltissima gente lì attorno, perciò l’attenzione veniva distratta dalla baraonda e non si riusciva a tenere gli occhi incollati su quella meraviglia per più di un secondo. “Che stazione enorme!”, sospirò sorpreso. “Questa è solo una parte”, spiegò Khan. “La Kitay-Gorod è grande circa il doppio. Ah! È uno dei luoghi più strani del mondo. Credo che tu sappia che tutte le linee si incontrano qui. Osserva quei binari: alla nostra destra c’è la diramazione Tagansko-Krasnopresnenskaya. È difficile descrivere la follia e il disordine di quel luogo. Inoltre, qui alla Kitay-Gorod arriva anche la linea arancione, la Kaluzhsko-Rizhskaya; coloro che vivono sulle altre linee non riescono a credere a ciò che accade laggiù. A parte tutto, questa stazione non appartiene ad alcuna federazione, i suoi abitanti si rappresentano da soli. È un luogo molto curioso. Io la chiamo Babilonia. Con affetto, naturalmente”, aggiunse Khan, guardandosi attorno sulla piattaforma, osservando la gente che si affrettava qua e là. La vita alla stazione non si fermava mai. Era simile a quella della Prospekt Mira, sebbene quest’ultima fosse più modesta e organizzata. Artyom ricordò le parole di Bourbon sul fatto che esistevano luoghi migliori di quell’orribile mercato che avevano attraversato alla Prospekt. Lungo i binari infiniti c’erano file di vassoi e tutta la piattaforma era piena di tende; diverse erano state trasformate in bancarelle, mentre altre venivano usate come alloggio. Su alcune di esse, erano state dipinte le lettere SDAYu[NR1] che stavano a indicare quelle in cui i viaggiatori potevano passare la notte. Si fecero largo tra la folla e, guardando lateralmente, Artyom notò che sui binari alla sua sinistra c’era l’enorme carcassa grigio-blu di un treno. Non era completo, ma composto da tre vagoni in tutto. La stazione era invasa da un fracasso indescrivibile, sembrava che i suoi abitanti non tacessero mai, nemmeno per un istante e continuassero a parlare, urlare, cantare, discutere animatamente, piangere o ridere. In diversi luoghi, al chiasso si mescolava anche la musica e ciò ricreava un’atmosfera festosa, inconsueta per la vita sotterranea. Anche alla VDNKh vi erano persone che cantavano entusiaste, ma laggiù la situazione era diversa; c’erano solo un paio di chitarre e poteva capitare che ci si riunisse nella tenda di qualcuno per rilassarsi un po’ dopo il lavoro. Si poteva trovare musica anche al confine del trecentesimo metro, dove non si doveva tendere troppo l’orecchio per sentire quella che proveniva dalla galleria settentrionale. Attorno al piccolo fuoco da campo, i pattugliatori intonavano, accompagnati dalle chitarre, canzoni su argomenti che Artyom non capiva: raccontavano una guerra a cui lui non aveva preso parte e che era stata condotta seguendo strane regole sconosciute; quei testi spiegavano come si viveva là sopra, prima che tutto cambiasse il mondo. In particolare, ricordava le ballate che descrivevano un luogo chiamato Afghanistan, che Andrey adorava eseguire: non vi era molto da capire, poiché trattavano temi come la tristezza per gli amici perduti e l’odio nei confronti del nemico. Ma Andrey sapeva cantare così bene che tutti quelli che rimanevano ad ascoltarlo si commuovevano, la voce tremava e gli veniva la pelle d’oca. Andrey spiegava ai più giovani che l’Afghanistan era un paese bellissimo, descriveva loro le sue montagne, i passi, i ruscelli gorgoglianti, i villaggi, gli elicotteri e le bare. Artyom ben sapeva cosa fosse un paese, dato che Sukhoi aveva passato moltissimo tempo a spiegargli concetti del genere. Ma, sebbene al ragazzo fossero state impartite nozioni sui diversi governi e la loro storia, le montagne, i fiumi e le valli rimanevano sempre idee astratte, erano solo parole che trovavano definizione nelle fotografie scolorite di un libro di geografia che il patrigno gli aveva mostrato. Nemmeno Andrey era mai stato in quel paese chiamato Afghanistan, era troppo giovane. Aveva semplicemente imparato le canzoni dai suoi vecchi amici dell’esercito. Ma alla VDNKh si poteva trovare musica così? No, i canti erano introspettivi e malinconici. Laggiù non c’era altro e, quando si ricordò di Andrey e delle sue ballate melanconiche, le paragonò alle melodie gaie e giocose che arrivavano da ogni angolo della stazione: il giovane era sorpreso da quanto la musica potesse essere diversa e da come potesse influire sullo stato d’animo delle persone. Si avvicinò ai musicisti che stavano a pochi passi da lui e si fermò ad ascoltarli, senza nemmeno pensarci. Si unì al piccolo gruppo di persone non solo per prestare attenzione alle parole, che narravano le avventure nelle gallerie sotto l’influenza della droga, ma per ascoltare anche solo la musica e osservare, incuriosito, coloro che la interpretavano. Erano in due: uno aveva i capelli lunghi e unti, tenuti a posto da un laccio di pelle annodato attorno alla fronte; indossava strani cenci multicolori e strimpellava la chitarra. L’altro era più anziano, quasi calvo e con un paio di occhiali che erano già stati riparati diverse volte; indossava una vecchia giacca scolorita e incantava i presenti con uno strano strumento a fiato, che Khan chiamò sassofono. Artyom non aveva mai visto nulla del genere: l’unico strumento a fiato che conosceva era la fistola. Aveva incontrato persone che la sapevano suonare bene. Le costruivano tagliando tubi isolanti di diversi diametri, ma lo facevano solo per venderle, perché la fistola non piaceva a nessuno alla VDNKh. Poi c’era la tromba, che somigliava a un piccolo sassofono e che, molto di rado, veniva usata per dare l’allarme se vi era qualcosa che ostruiva la sirena, strumento che veniva utilizzato normalmente. Sul pavimento, a fianco del musicista, era posizionata una custodia per chitarra aperta e contenente una decina di cartucce. Quando il tizio dai capelli lunghi ebbe terminato di cantare a squarciagola, disse qualcosa di particolarmente divertente, l’accompagnò con una smorfia buffa e il pubblico rise di gusto, applaudì e un’altra cartuccia volò dentro la custodia. La canzone sul vagabondare del povero diavolo era terminata e l’uomo con i capelli lunghi si poggiò contro il muro per rilassarsi. Quindi fu il turno del sassofonista con la giacca, che cominciò a eseguire un motivo che Artyom non conosceva, ma che evidentemente era molto popolare da quelle parti poiché la gente prese subito ad applaudire e diverse cartucce guizzarono in aria e atterrarono sul velluto rosso della custodia. Khan e Asso stavano discutendo qualcosa, se ne stavano vicini a un vassoio. Non chiesero ad Artyom di sbrigarsi e lui sarebbe potuto rimanere un’altra ora ad ascoltare quelle semplici melodie, se improvvisamente non fossero state interrotte. Due sagome possenti si avvicinarono ai musicisti barcollando; ricordavano le canaglie che avevano incontrato all’entrata della stazione. Una delle due si accovacciò e, senza troppe cerimonie, afferrò le cartucce dalla custodia e se le fece scivolare nella tasca della giacca di pelle. Il chitarrista dai capelli lunghi si affrettò per raggiungerlo e fermarlo, ma venne subito atterrato da un colpo sulla spalla. Nel frattempo, gli veniva confiscata la chitarra, che veniva alzata verso l’alto: avrebbe potuto essere sbattuta a terra o ridotta in mille pezzi contro la colonna. Il secondo malfattore spinse il vecchio sassofonista contro la parete senza alcuno sforzo particolare, mentre l’uomo cercava di divincolarsi per aiutare l’amico. Nessuno degli spettatori si fece avanti per aiutare i due musicisti. La folla si era ridotta notevolmente e quelli che erano rimasti si coprivano gli occhi oppure fingevano di esaminare la merce in vendita lì vicino. Artyom venne sopraffatto dal senso di vergogna che provava sia per sé che per gli altri, ma decise comunque di non intervenire. “Siete già stati qui oggi!”, si lamentò il musicista con i capelli lunghi, quasi piangendo, tendendosi la spalla con la mano. “Stammi a sentire: se la giornata ti va bene, significa che deve andare bene anche a noi, capito? E non metterti contro di me, siamo intesi? Vuoi finire nel vagone, capellone?”, gli urlò la canaglia, lanciando a terra la chitarra. Era chiaro che averla agitata in aria fino a quel momento era stato più che altro un avvertimento. Quando udì la parola vagone, l’uomo con i capelli lunghi si fermò subito, scosse il capo velocemente e non disse altro. “Hai capito... capellone?!”, terminò il criminale, soffermandosi sulla prima sillaba e sputando, sprezzante, ai piedi del musicista, che non proferì parola. Convinti che la rivolta fosse sedata, i due bulli se ne andarono lentamente, alla ricerca della vittima successiva. Artyom si guardò intorno sgomento e vide che nelle vicinanze c’era anche Asso, che aveva assistito attento alla scena. “Chi erano?”, domandò il ragazzo confuso. “Beh, a te cosa sembravano?”, ribatté Asso. “I soliti banditi. Alla Kitay-Gorod non c’è un governo, perciò vi sono due gruppi che la controllando. Questa parte risponde al comando dei Fratelli Slavi. Qui si raduna tutta la gentaglia della linea Kaluzhsko-Rizhskaya, tutti gli assassini. Vengono chiamati per lo più Kaluzhsky, altri sono denominati Rizhsky, del tipo che non si vedono né a Kaluga e nemmeno a Riga. Vedi laggiù, all’altezza di quel ponticello”, e indicò la scala a destra, in mezzo alla piattaforma, che proseguiva verso l’alto. “Lì c’è un altro androne, identico a questo. L’organizzazione che lo tiene in pugno è diversa da questa, ci sono i musulmani caucasici, cioè gli Azerbaigiani e i Ceceni. Un tempo le due fazioni si facevano guerra e cercavano di conquistare la zona più vasta possibile. Alla fine decisero di dividersi la stazione in due”. Artyom non si curò di domandare cosa fosse un “caucasico” poiché decise che questo nome, così come Ceceni e Azerbaigiani, incomprensibili e impossibili da pronunciare, si riferissero a stazioni di cui non conosceva l’esistenza, da cui provenivano i banditi. “Ora i due gruppi sono in pace”, proseguì Asso. “Vivono alle spalle di coloro che decidono di fermarsi alla Kitay-Gorod facendogli pagare i dazi doganali, che sono identici, in entrambi gli androni: tre cartucce, così non fa differenza da quale parte della stazione si decida di entrare. Ovviamente, qui non esiste un ordine preciso, non ne hanno bisogno. L’unica regola vigente è quella che impedisce di accendere fuochi. Vuoi acquistare della droga? Fai pure. Vuoi dell’alcool? Qui ce n’è in quantità. Potresti persino trovare armi che ti permetterebbero di radere al suolo metà della Metropolitana, nessun problema. La prostituzione è fiorente, ma non te la consiglio”, aggiunse e, imbarazzato, borbottò qualcosa sul fatto che si trattava di una sua opinione personale. “A cosa si riferiva quando ha menzionato il vagone?” “Il vagone? È il loro quartier generale. Se qualcuno si comporta male con loro, se si rifiuta di pagare, se gli deve del denaro o cose simili, lo trascinano laggiù, dove c’è una prigione e anche una stanza per le torture. È un luogo del peccato. Meglio non finirci. Hai fame?”, cambiò discorso Asso. Artyom annuì. Non si ricordava quanto tempo era passato da quando lui e Khan avevano bevuto il tè alla Sukharevskaya. Senza l’aiuto dell’orologio aveva perso la cognizione del tempo. Il suo viaggio nelle gallerie, che gli aveva fatto affrontare esperienze stranissime, poteva essere durato molte ore, ma per quanto ne sapesse, poteva essere anche cominciato solo da qualche minuto. Lo scorrere del tempo all’interno dei tunnel era totalmente diverso rispetto agli altri luoghi da lui conosciuti. In ogni caso, aveva bisogno di mangiare. Si guardò intorno. “Kebab! Kebab caldi!”, vicino a lui c’era un commerciante dalla carnagione scura, con sopracciglia nere e folte e il naso adunco. Pronunciava la parola in maniera strana: il suono della K non era duro e, invece della solita a, aveva usato una vocale che somigliava più a una o. Artyom aveva già incontrato persone che parlavano con accenti insoliti, ma non ci aveva mai badato più di tanto. Il ragazzo conosceva quella parola, anche alla VDNKh cucinavano kebab di maiale e a lui piacevano molto. Ma ciò che il commerciante stava vendendo non assomigliava nemmeno lontanamente a carne di maiale. Artyom, concentrato, l’osservò a lungo e infine riuscì a capire che si trattava di carcasse bruciacchiate di ratti, con le zampe ritorte. Ebbe un conato di vomito. “Tu non mangi i ratti?”, domandò Asso comprensivo. “Loro”, disse indicando con un cenno del capo il commerciante dalla pelle scura, “non ti venderanno mai del maiale. Glielo vieta il Corano. I ratti non sono poi così male”, aggiunse esaminando con l’acquolina in bocca la griglia fumante. “All’inizio disgustavano anche me, ma ormai mi sono abituato. È crudele, lo so... Quando li mangi, poi ti ritrovi sotto i denti un sacco di ossa. Inoltre, hanno un cattivo odore. Ma questi abrek”, diede un’altra occhiata al commerciante, “sanno come cucinarli, non c’è che dire. Li conservano in un intruglio particolare, così la carne diventa morbida come quella di un maialino. Poi usano certe spezie! E soprattutto è molto più economica”. Artyom si mise le mani davanti alla bocca, ispirò profondamente e cercò di pensare a qualcosa di piacevole, che lo distraesse. Ma le carcasse annerite dei ratti, trafitte dagli spiedi, continuavano a corrergli davanti agli occhi: i bastoncini erano infilati dalla parte posteriore del corpo e gli uscivano dalla bocca, che rimaneva aperta. “Tu fai come vuoi, ma io me li mangio. Vieni con me! Uno spiedino costa tre cartucce!”. Asso pronunciò queste ultime parole mentre si dirigeva verso la griglia. Avvisò Khan che sarebbe andato in perlustrazione, alla ricerca di qualcosa di più normale da mettere sotto i denti. Da qualsiasi parte guardava gli veniva offerto liquore fatto in casa in fiaschette di qualunque tipo; scrutò avidamente, ma con estrema cautela, le seducenti ragazze mezze nude vicine alle tende con i lembi sollevati, che lanciavano occhiate invitanti a tutti i passanti. Sebbene fossero volgari, erano rilassate e disinibite, non tese e abbattute dalla vita difficile che conducevano le donne come loro alla VDNKh. Fece un giro tra i commercianti di libri, ma non trovò nulla di interessante. Qui tutto era a buon mercato: c’erano libri tascabili che cadevano a pezzi, alcuni narravano le vicende del grande amore ed erano destinati al pubblico femminile, poi ce n’erano degli altri che raccontavano di omicidi e denaro, più adatti agli uomini. La piattaforma era lunga circa duecento passi, un po’ più del normale. I muri e le buffe colonne, che ricordavano una fisarmonica, erano ricoperti da marmi colorati, per lo più gialli e grigi, che in alcuni punti avevano persino sfumature rosa. Tutta la stazione era decorata da pesanti lastre di un metallo giallo, che con il tempo si era scurito. Su di esse, praticamente irriconoscibili, troneggiavano i simboli di un’epoca passata. I soffitti si erano scuriti a causa dei fuochi e le pareti erano macchiate da una moltitudine di iscrizioni in vernice e fuliggine, che rappresentavano immagini primitive e spesso oscene. In alcuni punti il marmo era scheggiato, mentre le lamiere di metallo erano ammaccate o graffiate. Nel bel mezzo dell’atrio a destra, al di là di una piccola rampa di scale e del ponticello, si intravvedeva la seconda parte della stazione. Artyom avrebbe voluto dare un’occhiata anche laggiù, ma si fermò alla recinzione in ferro, costituita da sezioni di due metri, proprio come alla Prospekt Mira. All’interno dello stretto passaggio vi erano diverse persone, appoggiate al muro di cinta. Dal lato di Artyom c’erano i soliti bulli in pantaloni da ginnastica; dall’altro, invece, gli uomini avevano la pelle scura e i baffi, ma anche loro incutevano un certo timore. Uno di essi teneva tra le gambe una mitragliatrice, mentre un altro aveva un pistola che sporgeva dalla tasca. I banditi conversavano tranquilli tra loro e a malapena si riusciva a credere che un tempo fossero stati in guerra. Abbastanza educatamente, comunicarono ad Artyom che passare dalla parte opposta della stazione gli sarebbe costato due cartucce, che avrebbe dovuto pagare di nuovo per ritornare da dove era venuto. Ma il ragazzo aveva imparato la lezione, non osò discutere l’equità delle tariffe e se ne andò. Camminò in circolo, esaminando le bancarelle e i bazar, quindi ritornò dalla parte della piattaforma da cui erano arrivati. L’androne non terminava laggiù, c’era un’altra scala che conduceva verso l’alto. La percorse e trovò un’altra piccola sala, divisa a metà da una recinzione. Apparentemente questa era un’altra zona di confine tra le due aree. Con sua enorme sorpresa, alla sua destra vide un vero monumento, uno di quelli ritratti nelle fotografie delle città. Questo, però, non era a figura intera, ma era rimasta solo la testa di un uomo. Che testa enorme! Era alta forse due metri... La parte superiore era sporca e il naso era lucido, a causa dei frequenti sfregamenti delle mani degli uomini; ciononostante esigeva rispetto e incuteva anche un po’ di timore. La sua mente si abbandonò a fantasie popolate da giganti. Una di quelle enormi creature aveva perso la testa in battaglia, che poi era stata immersa nel bronzo, perché ornasse l’androne di questa minuscola Sodoma, seppellita nelle profondità della crosta terrestre, nascosta dagli occhi ubiqui di Dio. L’espressione della testa danneggiata era triste e Artyom sospettò che fosse appartenuta a Giovanni Battista, personaggio del Nuovo Testamento, che una volta aveva avuto la possibilità di sfogliare. Infine decise che, date le dimensioni, doveva essere stato il capo di un eroe forte, un vero gigante, che aveva perduto la testa. Nessuno degli abitanti che vi ronzavano attorno fu in grado di dirgli con precisione a chi fosse appartenuta quella testa e lui ne rimase deluso. Vicino alla statua gli si rivelò un luogo meraviglioso, un vero ristorante, allestito in una tenda pulita di un bel verde scuro, proprio come alla sua stazione. All’interno, negli angoli, vi erano vasi di plastica con piante dalle foglie in tessuto; su un paio di tavoli vi erano delle lampade a petrolio, che diffondevano una luce leggera e famigliare in tutta la tenda. Che dire del cibo? Era lo stesso che veniva servito agli dèi: il maiale più tenero con funghi caldi che si scioglievano in bocca. Alla VDNKh i ristoranti offrivano piatti del genere solo durante le feste, ma non erano mai stati così deliziosi. La gente seduta ai tavoli era rispettabile e indossava abiti raffinati. Apparentemente si trattava di commercianti molto importanti. Tagliavano con attenzione pezzi di cotenna fritta, dai quali colava grasso bollente, poi li mangiavano senza fretta. Allo stesso tempo conversavano tra loro in maniera pacata, parlavano di affari e di tanto in tanto gettavano un’occhiata educata ma curiosa in direzione di Artyom. Ovviamente il pasto fu carissimo: dovette prendere quindici cartucce dalla sua riserva per metterle nella mano enorme dell’obeso taverniere. Si pentì di non aver resistito alla tentazione, ma il suo stomaco era soddisfatto e avvolto da un tranquillo torpore, così la voce della ragione fu subito zittita. Inoltre, la tazza di miscela fermentata era dolce e gli diede un piacevole capogiro; non era forte ed era completamente diversa da quel velenoso e torbido liquore fatto in casa che veniva venduto in bottiglie e caraffe sporche, che avrebbe fatto ubriacare solo annusandolo. Costava solo tre cartucce in più. Ma cos’erano tre cartucce, se ti veniva data una fiala di elisir spumeggiante, che ti avrebbe aiutato a scendere a patti con le imperfezioni di questo mondo, ripristinando con esso una certa armonia? Bevve l’intruglio fermentato a piccoli sorsi, seduto da solo, in pace, per la prima volta dopo qualche giorno. Artyom cercò di recuperare i recenti avvenimenti dalla sua memoria per capire fin dove era arrivato e fino a dove sarebbe dovuto ancora andare. Doveva percorrere ancora una parte del suo viaggio e si trovava di nuovo a un crocevia. Si sentiva come l’eroe di quelle storie d’infanzia ormai dimenticate. Il ricordo era così vago che non riusciva nemmeno a rammentarsi chi gliele avesse raccontate: era stato Sukhoi, o i genitori di Zhenya... oppure sua madre? A lui piaceva pensare che fosse stata davvero sua mamma. Gli sarebbe piaciuto rivedere quel viso risorgere dalla nebbia, anche solo per un momento, così da poter riascoltare la sua voce, che narrava con intonazione dolce: C’era una volta... Proprio come nelle fiabe, davanti all’eroe si diramavano tre strade: una verso la Kuznetsky Most, una che conduceva alla Tretyakovskaya, e un’altra verso la Taganskaya. Assaporava la bevanda inebriante, mentre il suo corpo veniva pervaso da un languore beato. Non aveva voglia di pensare, ma tutto ciò che turbinava nella sua mente gli ricordava: “Vai diritto e perderai la vita. Vai a sinistra e perderai il cavallo”. Avrebbe potuto continuare per sempre: aveva bisogno di riposarsi dopo tutte le avventure che aveva vissuto fino a quel momento. Sarebbe valsa la pena attendere alla Kitay-Gorod, dare un’occhiata in giro e chiedere informazioni sulle gallerie agli abitanti. Doveva ritrovare Khan, scoprire se aveva intenzione di proseguire con lui oppure se le loro strade si sarebbero divise in questa bizzarra stazione. Nulla era andato secondo gli assurdi piani di Artyom. Esausto, contemplava la piccola lingua di fuoco che danzava dentro la lampada sul tavolo. CAPITOLO 8 : IL QUARTO REICH All’improvviso si udirono dei colpi di pistola che interruppero il baccano allegro della folla. Poi vi fu l’urlo di una donna e il rumore di una mitragliatrice. Il taverniere paffuto agguantò una pistola da sotto il bancone e corse verso l’entrata della tenda. Artyom lasciò ciò che stava bevendo e lo inseguì, gettandosi lo zaino in spalla e cercando di far scattare la sicura della sua arma. Si dispiacque di aver dovuto pagare in anticipo, perché in questo modo avrebbe potuto fuggire senza saldare il suo debito; le diciotto cartucce che aveva speso ben presto gli sarebbero potute tornare utili. Dalla scala in cui si trovava, vide che stava accadendo qualcosa di terribile. Per scendere avrebbe dovuto farsi strada tra la gente che aveva perso i sensi per la paura e che cercava disperatamente di risalire verso l’alto. La ressa era così opprimente che il ragazzo si domandò se doveva davvero scendere laggiù oppure no... Ma la curiosità era troppa. Sui passaggi si trovavano diverse sagome affrante, con indosso delle giacche di pelle; sulla piattaforma, proprio sotto ai suoi piedi, giaceva una donna morta, a faccia in giù, in una pozza di sangue rosso carminio. La superò velocemente, cercando di non guardarla, ma scivolò e per poco non cadde. Regnava il panico: persone seminude fuggivano dalle loro tende, guardandosi attorno con fare isterico. Uno di loro rimase indietro, con il piede incastrato in uno dei gambali dei pantaloni; si chinò di scatto, si strinse lo stomaco e si accasciò di lato. Tuttavia Artyom non riusciva a capire da dove provenivano gli spari, che continuavano, mentre uomini tarchiati con indosso giacche di pelle correvano da una parte all’altra dell’atrio, togliendosi di torno donne urlanti e commercianti spaventati: non erano questi ultimi a essere stati attaccati, ma i banditi stessi che controllavano questa parte della KitayGorod. Sulla piattaforma non era chiaro chi fosse il vero autore di quella carneficina. A quel punto Artyom comprese perché non vedesse nessuno: gli aggressori erano nella galleria e da lì avevano aperto il fuoco, forse perché temevano di mostrarsi a viso aperto. Questo cambiava di molto la situazione. Non c’era più tempo da perdere, perché non appena avessero capito che la resistenza era caduta, avrebbero invaso la piattaforma, perciò doveva fuggire da quell’entrata il prima possibile. Corse in avanti, tenendo stretta la sua mitragliatrice e guardandosi alle spalle. L’eco degli spari, che risuonava attraverso gli archi, rendeva impossibile comprendere da che parte arrivassero, se da destra o da sinistra. Infine notò delle sagome in mimetica all’imboccatura della galleria di sinistra. Non gli si vedeva il viso, ma solo una macchia nera e Artyom si sentì raggelare. Solo dopo qualche istante ricordò che i Tetri che avevano invaso la VDNKh non erano armati e soprattutto non indossavano abiti di alcun tipo. Gli aggressori avevano il viso coperto da maschere, passamontagna di quelli che si potevano acquistare in qualsiasi mercato d’armi (addirittura, ne regalavano uno quando si comprava un AK-47). Erano giunti sul posto anche i rinforzi Kaluga; si nascondevano a terra tra i cadaveri e rispondevano al fuoco. Sfracellavano i pannelli di compensato montati sui finestrini del vagone, creando posizioni da cui sparare nascosti. I colpi rimbombavano sempre più. Sopra la sua testa, Artyom riuscì a intravvedere la targa di plastica che mostrava l’intricato dedalo delle stazioni, appeso nel mezzo dell’androne. Stavano subendo l’attacco dalla direzione della Tretyakovskaya, quindi fuggire da quella parte era fuori discussione. Per arrivare alla Taganskaya avrebbe dovuto attraversare la parte della stazione che in quel momento era sotto assedio. L’unica via rimasta era attraverso la Kuznetsky Most. Saltando sui binari, Artyom si diresse verso l’oscura entrata della galleria a cui doveva accedere. Non riusciva a vedere né Khan né Asso. Scorse una sagoma che gli ricordava il filosofo viandante, ma quando questo si fermò per un momento, Artyom comprese che si era sbagliato. Non era stato l’unico a prendere quella decisione: metà della gente fuggita dalla stazione stava scappando nella sua stessa direzione. Il passaggio risuonava di grida impaurite, c’era persino una persona che singhiozzava isterica. Le luci delle lampade portatili brillavano qua e là e si vedeva persino il tremolio irregolare di alcune fiaccole. Tutti cercavano di illuminare la strada da percorrere come potevano. Artyom estrasse il regalo di Khan dalla tasca e premette i pulsanti. Diresse il debole raggio ai suoi piedi per cercare di non inciampare e corse avanti, raggiungendo piccoli gruppi di fuggitivi, alcune famiglie al completo, donne sole, anziani e giovani, uomini in forze che trascinavano pacchi che con tutta probabilità non gli appartenevano. Si fermò in un paio di occasioni per aiutare persone cadute a terra. Si trattenne con uno di loro per un momento. Appoggiato contro la parete di mattoni della galleria era seduto un uomo anziano, dai capelli completamente grigi e con una smorfia di dolore stampata sul viso: teneva le mani strette all’altezza del cuore. Di fianco a lui c’era un ragazzo adolescente, che lo osservava sereno, con un’espressione pigra. Dall’aspetto selvaggio e dallo sguardo confuso, si notava subito che il ragazzino era disabile. Nell’anima di Artyom scattò una molla e, quando vide quella strana coppia, anche se si stava sforzando di proseguire e si malediva ogniqualvolta trovava degli ostacoli, si fermò. L’anziano, vedendo che qualcuno si era accorto di lui e del ragazzino, abbozzò un sorriso ad Artyom e cercò di dire qualcosa, ma gli mancava il fiato. Aggrottò le sopracciglia e chiuse gli occhi, provando a radunare le forze. Artyom si piegò su di lui per sentire meglio cosa avesse da dirgli. Ma il ragazzino cominciò a urlare minaccioso e Artyom notò che aveva la bava alla bocca e che scopriva una fila di denti ingialliti. Non volendo affrontare il suo attacco, Artyom si spostò di lato; il ragazzino indietreggiò e, lamentandosi, si sedette goffamente sui binari. “Giovanotto...”, si sforzò l’anziano. “Non... lui... è Vanechka... non... capisce”. Artyom si limitò a scrollare le spalle. “Ti prego... la nitro... glicerina... nella sacca... sul fondo... una pastiglia... Dammela... io non riesco... da solo...”. L’anziano ansava in maniera terribile e Artyom si mise a frugare nella borsa. Trovò subito un pacchetto che sembrava nuovo e ruppe la stagnola con l’unghia. La pillola uscì immediatamente e lui la porse al vecchio, che allargò le labbra in un sorriso colpevole e aggiunse: “Non riesco... le mani... non mi obbediscono... Sotto la lingua...”, poi chiuse di nuovo gli occhi. Artyom osservò dubbioso le sue mani sporche, ma obbedì e mise la pallina scivolosa nella bocca dell’uomo. Lo straniero annuì flebilmente e non disse altro. Sempre più fuggitivi li superavano a grandi passi, ma Artyom riusciva a scorgere solo una fila interminabile di stivali e scarpe sporche, che spesso inciampavano sul legno scuro delle traversine, dopodiché si udivano degli spergiuri. Nessuno badò a loro tre. L’adolescente si trovava ancora nel luogo in cui si era seduto e borbottava tranquillamente tra sé. Artyom, vagamente compiaciuto, notò con indifferenza che uno dei passanti diede un calcio al ragazzo, il quale cominciò a ululare ancora più forte di prima, imbrattandosi i pugni di lacrime, oscillando da una parte all’altra. Nel frattempo l’anziano aprì gli occhi, sospirò rumorosamente e bofonchiò: “Grazie mille... Mi sento già meglio... Mi aiuteresti ad alzarmi?” Artyom lo tenne per il braccio mentre l’uomo si rimetteva in piedi, facendo uno sforzo incredibile. Il ragazzo raccolse la borsa dell’anziano, perciò dovette mettersi la mitragliatrice in spalla. Il vecchio zoppicò, si diresse verso il ragazzino e lo incoraggiò ad alzarsi. Per tutta risposta l’adolescente si mise a gridare e, quando notò che Artyom si dirigeva nella loro direzione, emise un fischio malevolo, mentre la saliva cominciò a gocciolare dal labbro inferiore sporgente. “Sai, ho appena acquistato la medicina”, spiegò l’anziano. “Per la verità, sono venuto appositamente fin qui, in questo luogo tanto lontano. Dove viviamo noi non si riesce a trovare e nessuno me la può procurare, non ho nessuno a cui chiederla. Avevo finito la mia scorta, ho preso l’ultima pastiglia mentre venivamo qui. Poi non volevano farci passare dalla Pushkinskaya... Laggiù ci sono i fascisti adesso! È una vera disgrazia! Ho sentito che vogliono ribattezzare la stazione Hitlerskaya o Schillerovskaya... sebbene non sappiano nemmeno chi fosse Schiller. Pensa un po’, ci volevano impedire di attraversarla. Quegli spacconi ricoperti di svastiche si sono messi a tormentare Vanechka. E lui cosa poteva rispondergli nelle sue condizioni, poverino? Io ero molto preoccupato, il cuore ha cominciato a farsi sentire e solo allora ci hanno lasciati passare. Cosa stavo dicendo? Ma certo! Vedi, le metto apposta sul fondo della borsa, se qualcuno ci perquisisse e ci riempisse di domande, nel caso si facesse un’idea sbagliata. Non tutti sanno di che tipo di medicina si tratti. Poi, all’improvviso, tutti quegli spari! Sono fuggito il prima possibile, ho dovuto persino trascinare Vanechka perché aveva adocchiato dei polli allo spiedo e non si voleva più allontanare. All’inizio non mi dava troppo fastidio, perciò ho pensato che si placasse e che non avrei dovuto usare la medicina, che ovviamente costa un occhio della testa. Poi ho capito che non ci sarei riuscito. Tutte le volte che cercavo di prendere la pillola si faceva sempre più forte. Vanechka non capisce, è da moltissimo tempo che provo a insegnargli a darmi le pastiglie se non mi sento bene, ma non ci arriva: le inghiotte lui oppure estrae dalla borsa un altro oggetto e me lo porge. Io lo ringrazio, gli sorrido e lui ricambia con una tale gioia che ulula per la contentezza. Prego Dio che non mi capiti mai nulla, perché altrimenti non rimarrebbe nessuno a prendersi cura di lui; e chissà che fine farebbe!” L’anziano continuava a parlare in una maniera che incantava, e fissava Artyom dritto negli occhi. Il ragazzo, per una ragione che non si seppe spiegare, provò una strana sensazione. Sebbene l’uomo zoppicasse con tutte le sue forze, Artyom sapeva che stavano procedendo troppo lenti, li stavano superando tutti. Sembrava che ben presto sarebbero stati gli ultimi fuggitivi. Vanechka camminava impacciato alla destra dell’uomo, tenendogli la mano. Gli era tornata un’espressione serena. Di tanto in tanto protendeva la sua mano destra e gorgogliava eccitato, indicando qualcosa che era stato abbandonato o perso da quelli che erano passati prima di loro; alle volte puntava il dito verso l’oscurità, che si faceva sempre più fitta davanti a loro. “Perdonami giovanotto, come ti chiami? Stiamo parlando ma non ci siamo nemmeno presentati... Artyom? Piacere di conoscerti, io sono Mikhail Porfirevich. Porfirevich, esatto. Mio padre si chiamava Porfiry, un nome insolito in epoca sovietica. Era stato persino interrogato da diverse organizzazioni, perché al tempo i nomi in voga erano altri, Vladilen o Stalin... Tu di dove sei? Della VDNKh? Beh, io e Vanechka veniamo dalla Barrikadnaya, dove vivevo io prima”, spiegò l’uomo imbarazzato. “Sai, un tempo laggiù c’era un edificio immenso, altissimo, proprio a fianco della Metropolitana. Ma tu forse non ricordi com’erano gli edifici, vero? Quanti anni hai, se posso? Beh, non è importante. In quell’edificio possedevo un piccolo appartamento, un bilocale, a uno dei piani più alti, da cui si godeva una stupenda vista del centro cittadino. L’appartamento non era grande, ma aveva tutte le comodità, i pavimenti erano in legno di quercia e, come in tutte le altre case, c’era una stufa a gas. Mamma mia, che lusso! Una stufa a gas! Al tempo nessuno ci badava, volevano tutti l’elettricità, ma non potevano averla. All’entrata avevo appeso la riproduzione di un quadro del Tintoretto, in una bella cornice placcata oro, che meraviglia! Il letto era vero, con i cuscini e le lenzuola sempre pulite. Poi avevo una scrivania con un lampada che illuminava tutto per bene. Ma la cosa più importante era che possedevo scaffali di libri che arrivavano fino al soffitto. Mio padre mi aveva lasciato una raccolta di volumi molto fornita e anche io li collezionavo. Argh, ma perché ti sto raccontando tutto ciò? Molto probabilmente non ti interessano queste sciocchezze da vecchio... Tuttavia, ancora oggi, quando mi metto a ricordare, sento la mancanza degli oggetti, in particolare della scrivania e dei libri. Di recente anche del letto. Qui non si trovano lussi come quelli... noi invece avevamo letti in legno intagliati a mano e solo a volte dormivamo a terra, sulle coperte. Ma non ha importanza, ciò che conta è quello che abbiamo qui”, e così dicendo indicò il suo petto. “È più importante ciò che accade all’interno che all’esterno. Quello che abbiamo nella testa deve rimanere sempre lo stesso. E chi se ne frega delle condizioni in cui viviamo, perdona il francesismo! Ma sai, quel letto era speciale”. Non taceva un attimo e Artyom ascoltava rapito, anche se non riusciva a immaginarsi cosa significasse vivere in un edificio alto, come sarebbe stata la vista e cosa si provasse a salire in un ascensore. Quando Mikhail Porfirevich si fermò per un attimo a riprendere fiato, Artyom decise di cambiare discorso, in modo che la conversazione prendesse una piega a lui più utile. Doveva in qualche modo attraversare la Pushkinskaya e da lì usare il passaggio, arrivare alla Chekhovskaya, per poi giungere alla Polis. “Alla Pushkinskaya ci sono davvero i fascisti?”, gli domandò. “Cos’hai detto? Fascisti? Sì, certo...”, l’anziano sospirò confuso. “Sì, sì... gli skinhead con le fasce al braccio... sono terribili. Quei simboli sono appesi all’entrata e in tutta la stazione. Una volta significava che era vietato l’accesso: è una sagoma nera all’interno di un cerchio rosso sbarrato. Pensavo che avessero commesso un errore, perciò gli ho chiesto che ci facevano da quelle parti. Significa che quelli con la pelle scura non possono entrare. In realtà è solo un’idiozia”. Quando udì le parole pelle scura, Artyom guardò Mikhail Porfirevich spaventato e chiese cauto: “Quelli con la pelle scura sono arrivati anche laggiù? Non mi dica che hanno raggiunto anche quella stazione...”, mentre in testa gli turbinavano frenetiche immagini paurose. Come poteva essere? Era nelle gallerie da una sola settimana e i Tetri avevano già attaccato la Pushkinskaya. La sua missione era già fallita? Non era servita a nulla? Era arrivato fin lì invano? No, non poteva essere, gli sarebbero giunte delle voci. Se così fosse, era già tutto finito. Mikhail Porfirevich gli restituì lo sguardo circospetto e, facendo un passo di lato, gli chiese: “E tu, a quale ideologia credi?” “Io? Beh, in realtà... a nessuna”, esitò Artyom. “Perché?” “Che ne pensi delle altre nazionalità, dei caucasici ad esempio?” “Cosa c’entrano i caucasici?”. Artyom era perplesso. “Per la verità, di nazionalità ne so poco. Dove vivevo c’era qualche francese, i tedeschi e gli americani. Ma credo non sia sopravvissuto nessuno... Caucasici, invece... se devo essere onesto, non ne conosco”, ammise goffo. “I caucasici sono quelli con la pelle scura”, spiegò Mikhail Porfirevich, che cercava ancora di capire se Artyom stava mentendo, se lo stava prendendo in giro. “Ma... se ricordo bene, i caucasici sono persone normali. Ne ho visto qualcuno alla stazione, oggi...”, affermò Artyom. “Certo, persone totalmente normali!”, assicurò Mikhail Porfirevich. “Quegli assassini, però, hanno deciso che sono diversi e perciò li perseguitano. Ma è una cosa disumana! Immagina: in quella stazione, proprio sopra i binari, il soffitto è pieno di ganci. Da uno di quelli penzolava un uomo. In carne e ossa! Vanechka era elettrizzato, lo indicava con il dito, urlava e quei mostri lo hanno notato”. Udendo il suo nome, il ragazzino si girò e fissò l’uomo a lungo. Artyom ebbe l’impressione che riuscisse a sentire e che di tanto in tanto potesse persino comprendere di cosa stessero parlando. Ma quando nessuno ripeté il suo nome, perse subito interesse in Mikhail Porfirevich e si concentrò sulle traversine. “Parlando di nazioni, sembra che loro idolatrino la Germania. Dopotutto, sono stati proprio i tedeschi a creare la loro ideologia. Tu sai di che parlo”, Mikhail Porfirovich aggiunse e Artyom annuì incerto, sebbene non avesse la minima idea di ciò a cui si riferisse, ma non voleva passare per un ignorante. “Ci sono aquile tedesche appese ovunque, insieme alle svastiche, il cui significato è abbastanza ovvio. Poi ci sono diverse frasi in tedesco, citazioni di Hitler sul valore, l’onore e altre cose di questo tipo. Organizzano parate e marce. Mentre eravamo laggiù ho cercato di convincerli a non infastidire Vanechka. Loro marciavano lungo la piattaforma e intonavano canzoni sulla grandezza dello spirito e sul disprezzo della morte. Io ritengo che il tedesco sia stato scelto alla perfezione, è stato creato per esprimere concetti del genere. Conosco un po’ di tedesco... Ho una frase qui...”. Si fermò all’improvviso ed estrasse un taccuino sporco dalla tasca interna. “Aspetta un secondo. Punta la torcia qui, per favore... Dov’è finita? Ah, eccola!” Nel cerchio giallo luminoso, Artyom intravvide le lettere gotiche, tracciate con cura su una pagina del blocco, che erano persino incorniciate da foglie di vite disegnate: Du stirbst. Besitz stirbt. Die Sippen sterben. Der einzig lebt - wir wissen es Der Toten Tatenruhm. Artyom sapeva leggere i caratteri latini, li aveva studiati su un libro di testo per bambini che aveva trovato alla biblioteca della stazione. Si guardò alle spalle, poi puntò nuovamente la torcia al taccuino. Non ci aveva capito nulla. “Di cosa si tratta?”, domandò, aiutando ancora Mikhail Porfirovich, infilando il blocchetto nella tasca dell’uomo e cercando di acciuffare Vanechka, che si era fermato in un punto e borbottava infelice. “È una poesia”, spiegò l’anziano, un po’ offeso. “Celebra i caduti in guerra. Non ho intenzione di tradurla parola per parola, ma più o meno significa: Morirai. Quelli che ti sono vicini moriranno. Le tue proprietà scompariranno. Solo la morte gloriosa in combattimento sopravvivrà ai secoli. Ma nella nostra lingua ha un suono patetico, non credi? Mentre in tedesco... sembra che tuoni! Der Toten Tatenruhm! Ti fa sentire i brividi lungo la schiena. Mmm... sì”, si fermò di scatto e sembrò vergognarsi di ciò che aveva appena detto. Procedettero in silenzio per un po’. Ad Artyom pareva buffo che fossero gli ultimi rimasti nella galleria e ciò lo mandava anche su tutte le furie; inoltre, non era chiaro cosa stesse succedendo dietro di loro. Quel tizio si era persino fermato a leggere una poesia! Contro la sua volontà, ripeteva gli ultimi versi del componimento e, all’improvviso, senza una ragione particolare, si ricordò di Vitalik, il ragazzo che era stato con lui all’Orto botanico. Vitalik la Scheggia, che i ladri avevano ucciso con un colpo di pistola mentre cercavano di infiltrarsi nella stazione dalla galleria meridionale. Quel tunnel era sempre stato considerato pericoloso, proprio per questo misero Vitalik a fare la guardia laggiù. Aveva diciotto anni e Artyom stava per compierne sedici. Quella sera erano d’accordo di andare tutti da Zhenya, perché c’era un commerciante di droga che era riuscito a portare un nuovo tipo di sostanza, qualcosa di speciale... Se la prese diritto in testa. Il foro nero era proprio al centro della sua fronte, mentre la parte posteriore del cranio era stata spazzata via. Fine. “Morirai...”. Chissà perché, gli ritornò alla mente, vivida come non mai, anche la conversazione tra il suo patrigno e Hunter, in particolare quando Sukhoi aveva affermato: “E se non ci fosse nulla nell’aldilà? Si muore e dopo non c’è niente. Non rimane nulla. Qualcuno ti ricorderà per un certo periodo di tempo, ma non a lungo”. Anche coloro che ti stanno vicino moriranno, com’era quel verso della poesia? Artyom rabbrividì. Infine, quando Mikhail Porfirevich ruppe il silenzio, Artyom gliene fu grato. “Per caso tu sei diretto nella nostra stessa direzione? Oppure hai intenzione di arrivare solo fino alla Pushkinskaya? Vuoi entrare lì? Intendo dire, entrare nella stazione. Io ti suggerisco di non farlo, Artyom. Non puoi nemmeno immaginare cosa succede laggiù. O forse vuoi venire con noi fino alla Barrikadnaya? Mi farebbe molto piacere fare quattro chiacchiere con te durante il viaggio!” Artyom annuì di nuovo indistintamente e borbottò qualcosa di vago: non poteva spiegare lo scopo del suo viaggio alla prima persona che incontrava, anche se si trattava di un anziano inoffensivo. Mikhail Porfirevich non disse altro, dato che non aveva ricevuto risposta alla sua domanda. Proseguirono, sempre in silenzio, per un tratto più lungo. Dietro di loro non si sentiva alcun rumore e alla fine Artyom riuscì a rilassarsi. In lontananza intravvidero delle luci, inizialmente molto flebili, poi più luminose. Si stavano avvicinano alla Kuznetsky Most. Artyom non conosceva le regole del luogo e perciò decise di nascondere la sua arma. Dopo averla avvolta nel gilet, la mise sul fondo dello zaino. La Kuznetsky Most era una stazione abitata, perciò a cinquanta metri dall’entrata c’era un posto di blocco ben attrezzato: era l’unico, ma aveva un riflettore, che in quel momento era spento ed era equipaggiato di una posizione per mitragliatrice. L’arma era coperta, ma al suo fianco era seduto un uomo in carne con indosso un’uniforme verde malconcia. Stava mangiando qualcosa che somigliava a un purè, da una ciotola da soldato malandata. Vicino a lui c’erano un altro paio di persone con la stessa divisa e con in spalla mitragliatrici che parevano mal assemblate. Controllavano pedanti i documenti di coloro che arrivavano dalla galleria. Davanti a loro c’era una breve coda: tutti i fuggitivi della Kitay-Gorod, che avevano superato Artyom mentre lui procedeva a rilento con Mikhail Porfirevich e Vanechka. Con estrema lentezza, la gente veniva fatta entrare, quasi in maniera riluttante. Un tizio era stato respinto e ora sedeva in disparte, sgomento, senza sapere cosa fare. Di tanto in tanto si riavvicinava al posto di blocco, ma la guardie si rifiutavano puntualmente di farlo entrare e chiamavano la persona successiva. Venivano tutti perquisiti scrupolosamente; infatti, videro come un uomo che non aveva dichiarato la sua Makarov venne espulso dalla fila e, quando lui si mise a discutere, lo legarono e lo condussero via. Artyom sentì lo stomaco sobbalzare, presagio che lo aspettavano dei guai. Mikhail Porfirevich lo guardò sorpreso e, quando Artyom gli sussurrò a bassa voce che era armato, l’uomo annuì in maniera rassicurante e gli promise che tutto sarebbe andato per il meglio. Non era che Artyom non si fidasse di lui, ma sarebbe stato molto interessante vedere come intendeva gestire la situazione. L’anziano si limitò a sorridere misterioso. Il loro turno si stava pian piano avvicinando. Le guardie di confine stavano rovistando nel cappotto di una cinquantenne, mentre lei li accusava di essere dei tiranni ed esprimeva la sua sorpresa per il fatto che potessero esistere degli individui del genere. Artyom era dello stesso avviso, ma decise di non dar voce al suo pensiero, almeno non in modo udibile. Durante la ricerca, una delle guardie trovò diverse granate e le estrasse con un fischio soddisfatto dal reggiseno sporco della donna, chiedendole una spiegazione. Il ragazzo era sicuro che la signora avrebbe raccontato una storia toccante, su come il nipote avesse bisogno di quegli aggeggi per lavorare. Sa, è un saldatore e queste fanno parte del suo equipaggiamento. Oppure gli avrebbe riferito di averle trovate lungo la strada e, come di solito succede, sarebbe corsa a consegnarle alle autorità competenti. Al contrario, la donna fece un paio di passi indietro, imprecò e tornò in velocità nella galleria per nascondersi nell’oscurità. L’uomo addetto alla mitragliatrice posò la ciotola dalla quale stava mangiando e afferrò la sua arma; tuttavia, una delle due guardie, probabilmente il più anziano, lo fermò con un gesto. Il grassone sospirò deluso e tornò alla sua sbobba, mentre Mikhail Porfirevich faceva un passo in avanti, con il passaporto in mano. Fu incredibile come la guardia più anziana, dopo aver rivoltato come un calzino la sacca della donna dall’aspetto inoffensivo senza il benché minimo rimorso di coscienza, fece scorrere velocemente le pagine del taccuino dell’anziano e non fece nemmeno caso a Vanechka, come se il ragazzino non esistesse. Toccava ad Artyom. Porse svelto i suoi documenti alla guardia con i baffi, che controllò scrupolosamente tutte le pagine, illuminando a lungo con la sua torcia i diversi timbri. Poi passò alla fotografia, che guardò e riguardò almeno cinque volte, esprimendo apertamente i suoi dubbi, mentre Artyom sorrideva, cercando di assumere un’espressione innocente. “Perché il tuo passaporto è un modello sovietico?”, domandò infine la guardia con voce austera, non sapendo a cos’altro appigliarsi. “Beh, vede, ero molto piccolo; esistevano ancora i passaporti veri. Poi la nostra amministrazione decise di tamponare con il primo formato che riuscì a trovare”. “Ciò è inammissibile”, l’uomo aggrottò le sopracciglia. “Apri lo zaino”. Artyom si mise ad analizzare la situazione: se l’uomo avesse scoperto la mitragliatrice, lui avrebbe potuto scappare, altrimenti gliela avrebbero confiscata. Si asciugò il sudore dalla fronte. Mikhail Porfirevich raggiunse la guardia, si avvicinò e sussurrò veloce: “Konstantin Alexeyevich, la prego di comprendere, questo giovanotto è mio amico. È una persona rispettabile, posso garantirglielo personalmente”. La guardia di confine aprì il bagaglio e vi infilò dentro la mano. Il ragazzo rimase di stucco. Quindi disse con freddezza: “Cinque”. Artyom stava ancora cercando di capire cosa volesse dire, quando l’anziano prese dalla tasca una manciata di cartucce, ne contò cinque e le mise nella sacca mezza aperta che penzolava dalla cinta del doganiere. Ma la mano di Konstantin Alexeyevich continuò la sua perlustrazione all’interno dello zaino finché non accadde il peggio, perché il suo viso assunse un’espressione interessata. Artyom sentì il cuore fermarsi e chiuse gli occhi. “Quindici”, affermò la guardia, impassibile. Artyom annuì, contò altre dieci cartucce e le infilò nella stessa sacca. Sul viso della guardia non si mosse nemmeno un muscolo. Si limitò a spostarsi di lato per lasciare passare i tre verso la Kuznetsky Most. Artyom, ancora ammirato dalla determinazione dimostrata dall’uomo, marciava verso la stazione. Passò i successivi quindici minuti a discutere con Mikhail Porfirevich, che testardo si rifiutava di accettare le cinque cartucce che aveva pagato per Artyom, insistendo che il suo debito nei confronti del ragazzo era decisamente superiore. La Kuznetsky Most non era molto diversa dalle altre stazioni che Artyom aveva visitato durante il suo viaggio. Aveva gli stessi muri ricoperti di marmo e i pavimenti in granito, ma gli archi erano eccezionalmente alti e ampi, il che le conferiva un’inaspettata sensazione di vastità. Tuttavia, ciò che sorprese Artyom fu che su entrambi i binari si trovavano due treni completi, lunghissimi ed enormi, tanto che occupavano gran parte dello spazio. Dai finestrini veniva una luce calda, che filtrava attraverso le tendine di diversi colori e le porte erano aperte, invitanti... Artyom non aveva mai visto nulla del genere. Dalla sua memoria riaffioravano treni in corsa, che emettevano il caratteristico fischio, con le finestre quadrate illuminate. Erano ricordi della sua infanzia, ma erano sparpagliati, effimeri, proprio come i ricordi di ciò che c’era prima: non appena cercava di farsi tornare alla mente i dettagli, di concentrarsi su un particolare, l’immagine elusiva si dissolveva subito, scorreva via come acqua tra le dita e non rimaneva nulla... Ultimamente, invece, aveva visto solo il treno che era rimasto bloccato all’entrata della galleria della Rizhskaya, oltre a qualche vagone alla Kitay-Gorod e alla Prospekt Mira. Artyom non riuscì a proseguire oltre, rapito dal treno contava le carrozze che si confondevano con la foschia sull’altra estremità della piattaforma, vicino all’entrata della linea Rossa. Laggiù, appesa al soffitto, c’era una tela in cotone rischiarata da un netto cerchio di luce elettrica, mentre sotto di essa si trovavano due uomini armati di mitragliatrice, che indossavano uniformi verdi identiche e berretti con visiera. Da lontano sembravano fin troppo piccoli e parevano dei buffi soldatini di piombo. Quando viveva con la madre, Artyom aveva posseduto tre soldatini giocattolo: uno era un comandante, con una minuscola pistola sfoderata. Urlava qualcosa ed era voltato all’indietro, perché forse stava ordinando alla sua squadra di seguirlo in battaglia. Al contrario, gli altri due erano in piedi, dritti, con le mitragliatrici in mano. Molto probabilmente le tre statuine provenivano da collezioni diverse, perciò era impossibile usarle per giocare: il comandante si lanciava in battaglia e, malgrado le sue urla valorose, gli altri due se ne stavano composti, proprio come le guardie di confine della linea Rossa, non interessati ai combattimenti. Era strano: rammentava così bene i soldatini, ma non ricordava il viso della madre... La Kuznetsky Most era relativamente tranquilla. Le luci, come alla VDNKh, derivavano dall’illuminazione d’emergenza ed erano appese su tutta la lunghezza del soffitto a una misteriosa struttura in metallo, che probabilmente in passato aveva rischiarato la stazione. A parte i treni, non vi era nulla degno di nota. “Spesso ho sentito dire che nella Metropolitana vi sono luoghi di assoluta bellezza, ma da quello che ho visto finora sono quasi tutti identici”, Artyom condivise il suo disappunto con Mikhail Porfirevich. “Non dire così, giovanotto! Esistono posti talmente belli da rimanere senza fiato! Ad esempio la Komsomolskaya, sull’Anello, è un vero e proprio palazzo!”. L’anziano, con fare appassionato, cercò di persuadere Artyom. “Sul soffitto c’è un pannello enorme che ritrae Lenin e, ovviamente, c’è anche tanta altra robaccia... Oh, ma cosa dico!”, si interruppe improvvisamente e continuò la frase in un sussurro: “Questa stazione è piena di agenti segreti provenienti dalla linea Sokolnicheskaya, cioè la linea Rossa, scusa ma io continuo a chiamarla con il vecchio nome... quindi bisogna cercare di non parlare troppo. Il governo locale sembra indipendente, ma in realtà non vuole entrare in disaccordo con i Rossi; se questi ultimi richiedono la testa di qualcuno, loro gliela danno. Ti lascio solo immaginare gli omicidi”, aggiunse, ancora più a bassa voce, guardandosi intorno timoroso. “Forza, andiamo a cercare un posto dove riposare. Io sono stanchissimo anche tu hai l’aria di uno che deve farsi una bella dormita. Passiamo la notte qui, proseguiremo domattina”. Artyom assentì. Quella giornata gli era sembrata infinita e stressante. Aveva un assoluto bisogno di riposo. Mentre il ragazzo seguiva Mikhail Porfirevich, osservava con una punta d’invidia il treno e non riusciva a distogliere lo sguardo dalle carrozze, da dove provenivano risate e conversazioni allegre. Davanti a una delle porte del treno c’era un uomo, che sembrava stanco a causa della giornata di lavoro e stava fumando una sigaretta insieme al vicino; i due discutevano degli avvenimenti della giornata. Alcune donne anziane, riunite attorno a un tavolo illuminato da una lampada che penzolava dal soffitto, bevevano il tè; i bambini correvano attorno a loro. Una situazione del genere era totalmente estranea ad Artyom: alla VDNKh la gente era sempre all’erta perché poteva accadere qualsiasi cosa, da un momento all’altro. Ci si ritrovava la sera nella tenda di qualcuno per fare quattro chiacchiere con gli amici, ma era diverso, non c’erano porte aperte, niente rimaneva in vista, le persone non si riunivano così facilmente, i bambini non correvano dappertutto... Questa stazione era fin troppo felice. “Di cosa vivono qui?”, quando raggiunse l’anziano, Artyom non riuscì a trattenersi. “Come? Non lo sai?”, rispose sorpreso ma educato Mikhail Porfirevich. “Questa è la Kuznetsky Most! Qui ci sono i migliori tecnici di tutta la Metropolitana! Sono maestri importanti, perciò qui portano qualsiasi tipo di aggeggio da sistemare, dalla linea Sokolnicheskaya e persino dall’Anello. L’economia è fiorente! Sarebbe bello poter vivere qui”, sospirò sognante. “Ma in tal senso hanno regole molto rigorose”. Artyom sperò invano di poter dormire in una delle carrozze del treno, in un letto vero. Nel mezzo dell’androne si trovava una fila di grandi tende, simili a quelle in cui viveva alla VDNKh e sulla prima che trovarono era stata stampata la parola HOTEL. Al fianco c’era un lunga fila di fuggitivi, ma Mikhail Porfirevich chiamò in disparte uno degli organizzatori, fece tintinnare un po’ di denaro, sussurrò le parole magiche che cominciavano con Konstantin Alexeyevich e la questione venne subito risolta. “Staremo qui”, fece un gesto d’invito e Vanechka gorgogliò allegro. Gli diedero persino del tè, che non dovettero pagare perché era compreso nel prezzo; i materassi sul pavimento erano talmente morbidi che non appena ci si accomodava non ci si voleva più alzare. Mezzo sdraiato, Artyom soffiava sulla tazza di tè e ascoltava attento l’anziano che gli stava raccontando qualcosa con uno sguardo grave e si era dimenticato del suo tè: “Comandano tutta la diramazione. Non lo ammette nessuno, nemmeno i Rossi, ma né l’Università e nemmeno le stazioni successive sono sotto il loro controllo! Proprio così! La linea Rossa continua fino alla Sportivnaya, dove c’è un passaggio che un tempo era la stazione della Leninskie Gory, a cui poi è stato cambiato il nome, ma io riesco a ricordarmi solo quello vecchio... Ebbene, la Leninskie Gory si trovava sotto un ponte. Proprio lì vi fu un’esplosione, il ponte crollò nel fiume e la stazione venne inondata, perciò non vi è stata alcuna comunicazione con l’Università sin dall’inizio”. Artyom ingurgitò un piccolo sorso di tè e sentì che le sue interiora si fermavano improvvisamente, come se stessero attendendo la rivelazione di qualcosa di misterioso, insolito, che era cominciato quando i binari divelti erano sospesi sopra un precipizio sulla linea Rossa in direzione sud-ovest. Vanechka si mordicchiava le unghie e si fermava di tanto in tanto solo per controllare, con fare soddisfatto, il frutto delle sue fatiche, per poi cominciare di nuovo. Artyom lo osservava con compassione e si sentì riconoscente del fatto che il ragazzino fosse tranquillo. “Alla Barrikadnaya teniamo un piccolo circolo”, Mikhail Porfirevich sorrise imbarazzato. “Ci riuniamo alla sera e spesso ci raggiungono anche gli abitanti della Via del 1905, e ora stanno cercando di individuare tutti i diversi pensatori nella Metro. Persino Anton Petrovich si è trasferito nella nostra stazione... Ma sono tutte sciocchezze, dei semplici raduni letterari. Tuttavia, a volte discorriamo di politica... In realtà alla Barrikadnaya le persone di cultura non sono viste di buon occhio, per cui cerchiamo di non farci notare. Dicevo, Yakov Iosifovich sostiene che molto probabilmente l’Università non sia andata distrutta, perché sono riusciti a bloccare la galleria. Ci dovrebbero essere ancora delle persone laggiù. Non semplici persone, ma... Quello è il luogo in cui si trovava l’Università Statale di Mosca ed è per questo motivo che la stazione si chiama così. È probabile che alcuni dei professori siano riusciti a trovare riparo nella stazione, insieme agli studenti. Sotto gli edifici dell’Università si trovava una sorta di bunker antiatomico, fatto costruire da Stalin, che ritengo fosse interconnesso con delle gallerie speciali a quelle della Metro. E ora, laggiù, si trova un altro tipo di centro intellettuale. Ma forse sono tutte leggende. Là, al potere, ci sono persone colte: le tre stazioni e il bunker sono governati da un rettore e ciascuna stazione è controllata da un preside, che rimane in carica per un certo periodo di tempo. Gli studi non si sono fermati: ci sono studenti, ricercatori, insegnanti! La cultura non è scomparsa come qui. Redigono dei saggi e non si sono scordati di come si conducono le ricerche... Anton Petrovich ci ha riferito che uno dei suoi amici, un ingegnere, gli ha rivelato che hanno scoperto come tornare in superficie! Hanno creato una tuta protettiva e alle volte le loro sentinelle vengono inviate nella Metropolitana... A te non sembra improbabile?”, aggiunse Mikhail Porfirevich guardando Artyom negli occhi. Il ragazzo notò una sfumatura di tristezza nello sguardo del vecchio, una speranza timida e stanca, che lo fece tossire e gli fece rispondere, in maniera sicura: “Perché? Io credo sia possibilissimo! Prenda la Polis, ad esempio. Ho sentito dire la stessa cosa...” “Sì, la Polis è un luogo meraviglioso. Ma come si fa ad arrivarci, di questi tempi? Ho sentito che il consiglio è stato riconquistato dai militari”. “Quale consiglio?”. Artyom alzò le sopracciglia. “Come? La Polis è governata da un consiglio di persone importanti, che laggiù sono bibliotecari o militari. Non so con esattezza cosa succede alla Biblioteca Lenin, perciò non ha senso parlarne ma, da quello che ricordo, l’altra entrata della Polis si trova dietro il Ministero della Difesa, o comunque lì vicino, che alcuni generali erano riusciti a far evacuare. All’inizio, questi militari presero il potere e la loro giunta governò la Polis per un lungo periodo di tempo. Ma alla gente non andava a genio questo tipo di governo, vi furono dei disordini, sangue che scorreva a fiotti... ma è stato molto tempo fa, ancor prima della guerra con i Rossi. Giunsero a un compromesso e venne fondato il consiglio. Al suo interno si scontravano due fazioni, i bibliotecari e i militari, una strana combinazione... Molto probabilmente i soldati non avevano conosciuto molti bibliotecari in carne e ossa, in vita loro. Ma qui convivevano, anche se tra loro vi era un’eterna battaglia, perché prendevano il potere a turno: quando cominciò la guerra con i Rossi, la difesa era molto più importante della cultura, perciò il piatto della bilancia pendeva dalla parte dei generali. Al contrario, in tempi di pace, erano gli uomini di cultura ad avere una maggiore influenza. È come un pendolo. Ho sentito dire che di recente le milizie hanno riguadagnato una posizione di prominenza, impongono la disciplina, il coprifuoco e altre gioie della vita di questo tipo”. Mikhail Porfirevich sorrise appena. “Attraversarla non sarà più facile che arrivare alla Città di Smeraldo... è il nome affettuoso con cui, nel nostro circolo, chiamiamo l’Università e le stazioni che la circondano. Ci sono la linea Rossa oppure l’Hansa, che come tu ben sai non puoi attraversare. Un tempo, prima che arrivassero i fascisti, potevi recarti dalla Pushkinskaya alla Chekhovskaya e tramite un solo passaggio alla Borovitskaya, anche se non è un tratto facile; quando ero più giovane lo percorrevo spesso”. Artyom gli domandò quale fosse il problema di quel passaggio e l’anziano rispose restio: “Nel bel mezzo di quella galleria c’è un treno completamente bruciato. Non ci vado da moltissimo tempo, quindi non so in che condizioni si trovi ora, ma prima si vedevano i resti carbonizzati di coloro che nel momento dell’incendio sedevano ai loro posti... era terribile. Non so come possa essere accaduto, ho chiesto informazioni a degli amici, ma nessuno è stato in grado di raccontarmi con esattezza la vicenda. Inoltre, è molto complicato superare la parte in cui si trova il treno, perché la galleria sta crollando e i detriti hanno riempito gli spazi attorno ai convogli. All’interno, nelle carrozze, succedono cose tremende, che sarebbe difficile spiegare. In generale io sono ateo, non credo in tutte quelle stupidaggini mistiche. Soprattutto ora, non credo più a niente”. Queste parole richiamarono alla mente di Artyom i ricordi lugubri del rumore nella galleria della sua linea e non poté fare a meno di raccontare all’anziano uomo ciò che era capitato a lui e al suo gruppo, poi gli disse di Bourbon e, dopo un momento di esitazione, cercò di ripetere la spiegazione che gli aveva fornito Khan. “Cosa? Che stai dicendo?!? Quelle sono sciocchezze belle e buone!”, lo contraddisse Mikhail Porfirevich, aggrottando austero le sopracciglia. “Ne avevo già sentito parlare. Ricordi che ti raccontavo di Yakov Iosifovich? Beh, lui è un fisico e mi ha spiegato che questo tipo di alterazioni della psiche si susseguono quando le persone sono soggette alle frequenze sonore più basse, che sono fondamentalmente impercettibili. Se non mi sbaglio si aggirano attorno ai sette hertz, ma ormai la mia memoria fa cilecca così spesso! Tali rumori possono verificarsi da soli, ad esempio in seguito a processi naturali come i movimenti tettonici e simili. Devo ammettere che quando me lo ha spiegato non ero molto attento... Ma che abbia a che fare con le anime dei morti? Nei tubi? Ma per piacere...” Questo vecchio era un tipo molto interessante. Era la prima volta che Artyom si confrontava con punti di vista del genere. L’uomo vedeva la Metropolitana da un’angolatura diversa, all’antica, divertente; sembrava che tutto riportasse la sua anima verso la superficie della Terra. Era chiaro che non fosse a suo agio in questo luogo, come se stesse ancora vivendo i suoi primi giorni sottoterra. Artyom, pensando alla discussione tra Sukhoi e Hunter, osò domandargli: “Lei cosa ne pensa...? Noi... gli esseri umani... torneremo mai in superficie? Riusciremo a sopravvivere e a tornare?” Si pentì subito di avergliela posta: era come se Artyom avesse messo il dito in una piaga purulenta dell’uomo, il cui umore mutò all’improvviso; quindi rispose con un filo di voce, quasi fosse esanime: “Non credo, non credo proprio”. “Dopotutto, esistevano anche altre Metropolitane, a San Pietroburgo, a Minsk, a Novgorod”, Artyom elencò i nomi che aveva imparato a memoria e che gli erano sempre parsi senza significato. “Ah! Che magnifica città! San Pietroburgo!”. Mikhail Porfirevich non ribatté, ma sospirò triste. “La cattedrale di Sant’Isacco... O l’Ammiragliato, con la sua guglia... Che grazia infinita! E le serate sulla Prospettiva Nevskij: la gente, il rumore, la folla, le risate, i bambini con i loro gelati, le belle ragazze, la musica che risuonava, specialmente in estate. È molto raro che nei mesi estivi ci sia bel tempo, ma quando succede... il sole, il cielo è terso, azzurro... e respirare è semplicissimo”. I suoi occhi erano fissi su Artyom, ma il suo sguardo lo superava e si dissolveva nella distanza eterea, dove le sagome luminose e maestose degli edifici opachi si ergevano dal fumo scuro. Le descrizioni erano talmente vivide che il giovane ebbe l’impressione che, girandosi, avrebbe potuto vedere ciò che l’uomo gli stava raccontando. L’anziano non disse altro, emise un sospiro profondo e Artyom decise di non interrompere i suoi ricordi. “Sì, esistevano altre Metropolitane, oltre a quella di Mosca. È probabile che la gente si sia rifugiata laggiù e che si sia salvata... Ma pensaci, giovanotto!”. Mikhail Porfirevich sollevò un dito nodoso. “Quanti anni sono passati? Non abbiamo ancora ricevuto notizie... Se ci stessero cercando, non ci avrebbero già trovati, dopo tutto questo tempo? No, non credo proprio”, e chinò il capo. Dopo cinque minuti di silenzio, senza quasi farsi sentire, l’anziano sospirò di nuovo e disse, più a se stesso che ad Artyom: “Abbiamo distrutto un mondo meraviglioso...” Un silenzio cupo pesava sulla tenda. Vanechka, cullato dalla loro conversazione tranquilla, stava dormendo. Aveva la bocca semiaperta e respirava rumorosamente, di tanto in tanto uggiolava, come fosse un cagnolino. Mikhail Porfirevich non parlò più e, malgrado Artyom fosse sicuro che non stava ancora dormendo, non lo voleva disturbare, quindi chiuse gli occhi e cercò di addormentarsi. Sperava che, dopo tutto ciò che gli era accaduto in quella giornata infinita, il sonno lo pervadesse all’istante, ma il tempo passava sempre più lento. Lo stesso materasso che poco prima era sembrato soffice, ora pareva bitorzoluto e, prima di riuscire a trovare una posizione comoda, Artyom dovette girarsi diverse volte. Le meste parole dell’anziano gli vorticavano nelle orecchie. No. Non credo proprio. Non potremo tornare sui viali illuminati, nelle grandiose costruzioni architettoniche, alle luci, alla fresca brezza di una tiepida serata estiva, che scompiglia i capelli e accarezza il viso. Non potremo più vedere il cielo, non sarà mai più come nelle descrizioni dell’anziano uomo. Il cielo si era abbassato ed era rimasto intrappolato tra i fili marci sui soffitti delle gallerie. Sarebbe rimasto per sempre così. Ma prima com’era? Come lo aveva definito? Azzurro? Terso? Ora il cielo era strano, come quello che Artyom aveva scorto all’Orto botanico, ricoperto di stelle. Ma invece di essere blu cobalto, era azzurro chiaro, scintillante, allegro... Gli edifici erano davvero enormi, ma la loro massa non opprimeva; al contrario erano leggeri, come intessuti di un’aria mite. Si libravano, distaccati da terra, i loro contorni si confondevano con l’altezza infinita della volta celeste. Si vedevano moltissime persone! Artyom non ne aveva mai viste così tante insieme, forse solo alla Kitay-Gorod, ma queste erano più numerose; lo spazio tra questi edifici imponenti era pieno di persone. Si affrettavano qua e là e tra loro vi erano anche molti bambini, che mangiavano qualcosa, probabilmente del gelato. Artyom desiderava chiedere a uno di loro se poteva provarne un po’, perché non lo aveva mai assaggiato. Quando era piccolo, aveva sempre sognato di poterlo assaporare. Ma non si poteva trovare da nessuna parte, poiché ormai l’azienda di dolciumi produceva solamente muffa e ratti, ratti e muffa. I bambinetti leccavano questa ghiottoneria e scappavano lontano, ridevano, lo evitavano abilmente e lui non riusciva nemmeno a guardarli in faccia. Artyom non sapeva più cosa stava cercando di fare, se assaggiare il gelato o guardare il viso dei bambini, capire se avevano davvero una faccia oppure no... Si spaventò. I contorni leggeri degli edifici cominciarono lenti a scurirsi e, dopo poco, incombevano già sopra di lui in maniera minacciosa, facendosi sempre più vicini. Artyom stava ancora rincorrendo i bambini e gli sembrava che non stessero più ridendo gioiosi, ma crudeli. Così radunò tutte le sue forze e ne acchiappò uno per la manica. Il ragazzino cercava di liberarsi dalla presa, lo graffiava come un indiavolato, ma stringendolo forte per la gola, Artyom riuscì a vederlo in faccia: era Vanechka, che ruggiva e mostrava i denti; scosse la testa e cercò di afferrare la mano di Artyom. Preso dal panico, quest’ultimo fuggì via e il ragazzino, in piedi, alzò la testa all’improvviso ed emise quello stesso terribile ululato che fece tornare Artyom alla VDNKh... I bambini che gli correvano attorno cominciarono a rallentare e a circondarlo, sempre più vicini, mentre gli enormi edifici scuri si imponevano sopra di loro, avvicinandosi... I bambini riempivano gli spazi sempre più piccoli tra le costruzioni e raccolsero la sfida lanciata da Vanechka, pieni di una malignità selvaggia e di una tristezza gelida; infine si rivolsero verso Artyom. Non avevano il viso, solo maschere nere di pelle con la bocca disegnata e gli occhi che non avevano né sclera, né pupille. All’improvviso si udì una voce che Artyom non riuscì subito a identificare. Era dimessa e la battaglia che imperversava la attutiva. Ma la voce si ripeteva insistente e, ascoltando con più attenzione, ignorando i bambini che si avvicinavano, Artyom riuscì a capire: “Devi andare”. Continuava a ripetersi. Il ragazzo la riconobbe: era la voce di Hunter. Aprì gli occhi e lanciò lontano le coperte. La tenda era buia e afosa e lui aveva la testa pesante: i pensieri non volevano abbandonarlo. Sembrava non riuscire a ritornare in sé, a capire per quanto avesse dormito, se fosse già ora di alzarsi e di riprendere il cammino, oppure se si poteva girare dall’altra parte per cercare di fare un sogno migliore. I lembi della tenda erano aperti e il ragazzo scorse la testa della guardia di confine che li aveva lasciati entrare alla Kuznetsky Most. Konstantin... com’era il patronimico? “Mikhail Porfirevich! Mikhail Porfirevich! Si alzi subito! Mikhail Porfirevich! Ma è morto?”, e senza fare caso ad Artyom, che lo fissava impaurito, piombò nella tenda e si mise a scuotere l’anziano che dormiva. Prima di lui si svegliò Vanechka e cominciò a urlare infuriato. La guardia non badò a lui e quando il ragazzino lo tirò per il braccio, lui gli diede un ceffone. L’anziano si svegliò. “Mikhail Porfirevich! Si deve svegliare subito!”, gli sussurrò insistente il doganiere. “Deve andarsene immediatamente! I Rossi hanno richiesto che lei venga consegnato, la ritengono un diffamatore e un propagandista nemico. Ho continuato a ripeterglielo: quando è qui, in questa sporca stazione, non deve tenere le sue lezioni sull’Università! Mi ha capito?” “La prego, Konstantin Alexeyevich, può dirmi cosa sta succedendo?”. L’anziano voltò il capo confuso, alzandosi dal suo giaciglio. “Io non ho detto nulla, nessuna propaganda. Neanche a pensarci! Ne stavo solo discutendo con il giovanotto qui presente, ma a bassa voce, non c’erano testimoni”. “Beh, allora porti con sé anche il ragazzo! Sa bene che tipo di stazione è questa! La scuoierebbero e poi l’appenderebbero per i piedi alla Lubianka, mentre il suo amico verrebbe messo direttamente al muro, in modo che non apra più la bocca! Forza, si sbrighi! Non indugi oltre! Stanno venendo a prenderla! Al momento stanno conferendo per decidere cosa chiedere in cambio ai Rossi, deve fare in fretta!” Artyom si era già alzato in piedi e aveva lo zaino in spalla. Non sapeva se prendere l’arma dal bagaglio. Anche l’anziano si affaccendava, ma un minuto più tardi erano già in strada e camminavano di buona lena, mentre Konstantin Alexeyevich teneva la mano premuta sulla bocca di Vanechka, che aveva assunto un’espressione da martire. Il vecchio li osservava ansioso, poiché temeva che la guardia potesse decidere di spezzare l’osso del collo al ragazzino. La galleria che conduceva fino alla Pushkinskaya era difesa meglio delle altre. Dovettero superare due sbarramenti, al centesimo e al duecentesimo metro dall’entrata; al primo vi era un rinforzo di cemento armato, un parapetto che ostruiva il passaggio e che obbligava la gente a proseguire sullo stretto sentiero vicino al muro. A sinistra c’era un telefono, i cui fili conducevano al centro della stazione, probabilmente al quartier generale. Al secondo posto di blocco c’erano i soliti sacchi di sabbia, una mitragliatrice e i riflettori, come dall’altro lato. Entrambi gli appostamenti erano sorvegliati dalle guardie e Konstantin Alexeyevich li accompagnò oltre il secondo, finché non raggiunsero il confine. “Forza, starò con voi ancora per cinque minuti. Temo che non potrà mai più tornare da queste parti, Mikhail Porfirevich”, si rivolse all’anziano mentre si dirigevano lenti verso la Pushkinskaya. “Non le hanno ancora perdonato i suoi vecchi peccati e ora l’ha fatto di nuovo. Ho sentito dire che il compagno Moskvin è personalmente interessato a lei, ha capito? Beh, d’accordo, cercherò di pensare a qualcosa. Fate attenzione alla Pushkinskaya!”, lo ammonì procedendo nell’oscurità. “Attraversatela velocemente! Noi li temiamo, quindi cercate di sbrigarvi e non avrete problemi!” Non avevano fretta di raggiungere il luogo in cui erano diretti, perciò i fuggitivi rallentarono il passo. “Perché ce l’hanno così tanto con lei?”. Artyom era curioso e osservava sottecchi l’anziano. “Beh, vedi, il fatto è che quella gente non mi piace. Quando c’era la guerra... io e il mio circolo avevamo redatto dei testi... Anton Petrovich, che al tempo viveva alla Pushkinskaya, aveva accesso a un ciclostile. Alla Pushkinskaya c’era un giornale, dei pazzi prendevano le notizie dall’ Izvestiya… e lui le stampava”. “Ma il confine dei Rossi ha un aspetto innocuo: ci sono solo due persone, una bandiera e nessun rinforzo. Niente, a confronto dell’Hansa”, ricordò Artyom. “Ma certo! Da questa parte sembra tutto innocuo perché la loro forza maggiore sta all’interno, non all’esterno”, sul viso di Mikhail Porfirevich fece capolino un sorriso nefasto. “È lì che si trovano i veri rinforzi. Al confine... sono solo decorazioni”. Continuarono in silenzio, ciascuno con i propri pensieri. Artyom era all’ascolto della sua sensazione per quella galleria. Era molto strano, ma sia questo tunnel che quello tra la Kitay-Gorod e la Kuznetsky Most erano vuoti: al loro interno non si sentiva nulla. Nessuna strana percezione, erano semplici costruzioni senz’anima. Fu allora che si ricordò l’incubo che aveva avuto: i dettagli erano già scomparsi dalla memoria ed era rimasto solo un vago, spaventoso ricordo dei bambini senza volto e delle masse nere che si stagliavano contro il cielo. Tuttavia, aveva udito una voce... Non riuscì a seguire i suoi pensieri fino alla fine. Davanti a lui sentì il familiare e terribile squittio, insieme al fruscio delle zampe, seguito subito dal puzzo soffocante e dolciastro della carne putrefatta. Quando il debole raggio delle loro torce raggiunse il luogo da cui provenivano i rumori, videro davanti ai loro occhi una scena tale che Artyom pensò subito che sarebbe stato meglio consegnarsi nelle mani dei Rossi. Contro il muro, in fila e a faccia in giù, giacevano tre corpi tumefatti; avevano le mani legate dietro la schiena con dei fili elettrici ed erano già stati tormentati dai ratti. Premendosi la manica della giacca contro il naso per non sentire il puzzo putrescente e per non respirare l’aria impestata, Artyom si piegò sopra i corpi e li illuminò. Erano stati svestiti, gli avevano lasciato solo la biancheria intima, e i loro corpi non mostravano segni evidenti di lesioni. Ma i capelli dei tre erano impiastricciati di sangue, in particolare attorno al foro d’entrata della pallottola. “Dietro la testa”, sottolineò Artyom, cercando di mantenere un certo contegno nella voce, sebbene sentisse di dover vomitare da un momento all’altro. Mikhail Porfirevich rimase a bocca aperta e i suoi occhi cominciarono a luccicare. “Cosa fanno, Dio mio, cosa fanno!”, sospirò. “Vanechka, non guardare, non guardare, vieni qui!” Ma Vanechka, che non dimostrava il benché minimo disagio, si acquattò nei pressi del corpo più vicino a lui e si mise a indicarlo con il dito, urlando animatamente. Il raggio della torcia venne diretto verso il muro e illuminò un pezzo di carta sporca, appeso sopra i cadaveri, ad altezza d’uomo; portava la scritta “Vierter Reich”, accompagnata dalla rappresentazione di un’aquila. Poi continuava in russo: “Nessun animale nero ha il permesso di superare il trecentesimo metro dal Grande Reich!” oltre al cartello “Vietato l’accesso” accompagnato dalla sagoma sbarrata di un uomo dalla pelle scura. “Vigliacchi!”, imprecò Artyom a denti stretti. “Solo perché hanno i capelli di un colore diverso?” L’anziano scosse il capo e, tristemente, tirò Vanechka per il bavero, che era ancora accovacciato, occupato ad analizzare i corpi e non voleva essere disturbato. “Vedo che il nostro ciclostile funziona ancora”, disse tristemente Mikhail Porfirevich e proseguì. I viaggiatori si spostavano più lentamente. Dopo due minuti videro le parole “300 metri”, scritte sui muri con la vernice rossa. “Mancano trecento metri”, fece ansioso Artyom, sentendo in lontananza l’eco di un cane che abbaiava. A circa cento metri dalla stazione vennero colpiti da un raggio di luce accecante e si fermarono. “Mani in alto! Fermi dove siete!”, una voce rombò attraverso un altoparlante. Obbediente, Artyom mise le sue dietro la testa, mentre Mikhail Porfirevich si bloccò con le mani alzate verso il soffitto. “Ho detto mani in alto, tutti! Procedente lentamente! Nessun movimento improvviso”, continuò la voce tesa. Artyom non riusciva a vedere chi stava parlando perché la luce che li colpiva negli occhi era troppo forte, gli causava dolore e non poteva fare altro che guardare a terra. Camminarono ancora un po’ a piccoli passi, poi si fermarono quando gli venne ordinato, finché finalmente il riflettore non venne puntato di lato. Era stata eretta un’enorme barricata, due uomini erano in posizione con le loro mitragliatrici, oltre a un altro uomo, con un fondina alla cintura; indossavano tutti uniformi mimetiche e un berretto nero, portato di lato sui crani rasati. Indossavano anche una fascia bianca al braccio, con quella che sembrava una svastica tedesca, sebbene avesse tre punte e non quattro. In lontananza si intravvedevano sagome scure, mentre un cane si agitava nervoso ai loro piedi. Sui muri attorno erano state dipinte croci, aquile, slogan e imprecazioni dirette ai non russi. Artyom rimase stupito perché le frasi erano quasi tutte in tedesco. In un luogo ben visibile, sotto un pannello con la sagoma di un’aquila e una svastica a tre punte, si ripeteva il solito cartello, illuminato dal basso, con la sfortunata sagoma nera: secondo Artyom veniva messo in mostra come una sorta d’icona religiosa. Una delle guardie fece un passo in avanti e accese una torcia, tenendola ad altezza della testa. Camminò attorno ai tre, guardandoli fissi in faccia, forse cercando segni di fattezze non slave. Tuttavia, sembravano russi, per cui spense la torcia e scosse le spalle con disappunto. “Documenti!”, urlò. Artyom porse subito il suo passaporto. Mikhail Porfirevich si frugò nelle tasche e alla fine riuscì a trovare il suo. “Dove sono i documenti per questo?”, domandò disgustata la guardia più anziana, indicando Vanechka con un cenno del capo. “Vede, il fatto è che... il ragazzino...”, si mise a spiegare l’anziano. “Siiiilenzio! Devi rivolgerti a me chiamandomi Signor ufficiale! Rispondi alla mia domanda!”, abbaiò l’ufficiale di dogana, mentre la torcia gli stava per cadere dalle mani. “Signor ufficiale, vede, il ragazzino è malato. Non ha un passaporto, è piccolo... però come può vedere è affidato a me, qui, glielo mostro...”, cominciò a balbettare Mikhail Porfirevich, guadando l’ufficiale in maniera suadente, cercando di trovare una scintilla di compassione nei suoi occhi. Ma l’uomo rimaneva immobile, dritto e austero. Il viso era freddo come la pietra. Fu in quel momento che Artyom sentì nuovamente l’impulso di uccidere qualcuno. “Dov’è la fotografia?”, sputò l’ufficiale, dopo aver fatto scorrere le pagine. Vanechka, che fino ad allora era rimasto tranquillo a osservare la sagoma del cane, di tanto in tanto gorgogliando entusiasta, rivolse la sua attenzione all’ufficiale di dogana, digrignò i denti e gli urlò contro. Artyom rimase di sasso; era talmente spaventato per il ragazzino che dimenticò tutta l’ostilità che provava nei confronti dell’uomo e il desiderio di colpirlo con il bel calcio che si meritava. L’ufficiale di dogana fece involontariamente un passo indietro, fissando Vanechka in malo modo: “Sbarazzatevi subito di questo obbrobrio o lo dovrò fare con le mie mani”. “La prego, lo perdoni, signor ufficiale. Lui non capisce quello che fa”, Artyom fu sorpreso si sentire la sua voce pronunciare quelle parole. Mikhail Porfirevich lo guardò pieno di gratitudine; l’ufficiale controllò velocemente il passaporto di Artyom e glielo restituì, aggiungendo: “Nessuna domanda per te, puoi passare”. Artyom fece qualche passo in avanti e si bloccò: sapeva che le sue gambe non avrebbero obbedito alla testa. L’ufficiale gli voltò le spalle e ripeté la domanda sulla fotografia agli altri due. “Vede, il problema è...”, cominciò Mikhail Porfirevich, poi si interruppe e aggiunse: “Signor ufficiale, il problema è che dove viviamo non ci sono macchine fotografiche. Fare una fotografia in un’altra stazione costa molto e io non ho abbastanza denaro...” “Svestiti!”, lo interruppe l’uomo. “Mi scusi?”, la voce di Mikhail Porfirevich si incrinò e le gambe cominciarono a tremargli. Artyom si tolse lo zaino dalle spalle e lo mise a terra, senza pensare a quello che stava facendo. Ci sono alcune cose che si desidererebbe non fare, ci si impegna in modo che non avvengano, ma tutto d’un tratto accadono da sole. Non si ha nemmeno il tempo di pensarci, perché non giungono fino al centro cognitivo del cervello. Succedono e basta. Poi ci si ritrova a guardarsi dall’esterno, sorpresi, cercando di convincersi che non vi sia colpa, che sia accaduto così, senza interferenze esterne. Se li avessero fatti svestire per condurli insieme agli altri al trecentesimo metro, Artyom avrebbe estratto la mitragliatrice dallo zaino, avrebbe spostato la levetta su automatico e avrebbe cercato di abbattere il maggior numero di non-umani in mimetica, finché non avrebbero ucciso anche lui. Il resto non aveva più senso. Il fatto che conoscesse Mikhail e Vanechka da un giorno appena non significava nulla. Non gli importava che avrebbero ucciso anche lui. Cosa sarebbe successo alla VDNKh? Perché pensare a ciò che sarebbe accaduto dopo? È più semplice non farsi certe domande. “Svestiti!”, articolò l’uomo, ripetendosi. “Perquisizione!” “Ma... mi scusi...”, Mikhail Porfirevich pronunciò indistintamente. “Siiilenzio!”, abbaiò di nuovo l’altro. “Veloce!”, e sottolineò le sue parole con un gesto, prendendo la pistola dalla fondina. L’anziano si mise a sbottonare la giacca il più velocemente possibile, mentre la guardia spostava la pistola e lo osservava in silenzio mentre si levava la maglia, saltellando goffo su un piede per togliersi gli scarponi, traballando, mentre si slacciava la fibbia della cintura. “Più veloce!”, sibilò furente l’ufficiale. “Vede, sono un po’ maldestro...”,cominciò Mikhail Porfirevich, ma l’ufficiale ne aveva avuto abbastanza e colpì l’anziano sui denti. Artyom corse in avanti ma due braccia potenti lo afferrarono stretto da dietro e, per quanto cercasse di liberarsi, era tutto inutile. Fu allora che accadde l’imprevedibile. Vanechka, che era la metà della canaglia con il berretto nero, all’improvviso scoprì i denti e con un ruggito animale gli si avventò contro. L’uomo non si aspettava una velocità tale dal miserabile ragazzino e Vanechka riuscì a prendergli la mano sinistra e a colpirlo al petto. Tuttavia, un secondo dopo, l’ufficiale si riprese e si liberò del ragazzino, fece un passo indietro, protese la mano che impugnava la pistola e premette il grilletto. Il colpo, amplificato dall’eco della galleria, risuonò nelle loro orecchie. Malgrado ciò, ad Artyom sembrò di sentire che Vanechka singhiozzava silenzioso, seduto a terra. Era piegato in avanti, con le mani strette attorno allo stomaco, quando l’ufficiale, con un’espressione disgustata, lo colpì con un calcio e premette di nuovo il grilletto, stavolta puntando alla testa. “Ti avevo avvisato”, lanciò un’occhiata gelida a Mikhail Porfirevich, che era rimasto bloccato lì dove si trovava, atterrito, e guardava Vanechka con la bocca spalancata, mentre dei rumori sordi provenivano dal suo petto. In quel momento, la vista di Artyom si oscurò e sentì una tale forza provenire dall’interno che, quando scattò in avanti, per poco i soldati che lo trattenevano non caddero al suolo. Il tempo rallentò e Artyom riuscì ad afferrare la mitragliatrice, far scattare la sicura e, attraverso lo zaino, a colpire l’ufficiale al petto con una scarica di colpi. Soddisfatto, notò la linea scura di buchi sul verde dell’uniforme mimetica. CAPITOLO 9 : DU STRIBST “Condannato all’impiccagione”, concluse il comandante. Vi fu uno scroscio di applausi che tormentò senza pietà le orecchie del giovane. Artyom alzò la testa con difficoltà e si guardò di lato. Riusciva ad aprire un solo occhio, perché l’altro era tumefatto: era stato brutalmente torturato dalle guardie che lo avevano interrogato. Inoltre, le percosse avevano avuto qualche conseguenza sul suo udito, poiché i rumori gli giungevano come se fossero attutiti da uno spesso strato di ovatta. Sembrava che i denti fossero ancora tutti al loro posto. Ma tanto a cosa gli sarebbero serviti? Attorno, aveva il consueto marmo chiaro, le solite cose... Quella pietra bianca cominciava a dargli sui nervi. Appesi, sopra di lui, enormi candelabri di ferro che forse un tempo erano stati lampadari elettrici. Ora vi erano poggiate due candele e il soffitto era completamente nero. In tutta la stazione c’erano solo due candelabri, uno in corrispondenza con la grande scalinata in fondo e l’altro nel punto in cui si trovava Artyom, nel bel mezzo dell’atrio, sui gradini di un ponticello che si collegava a un passaggio laterale e conduceva a un’altra linea della Metro. Vi erano diversi archi semicircolari e colonne pressoché invisibili e ciò dava l’impressione che vi fosse moltissimo spazio. Che razza di stazione era questa? “Il colpevole verrà giustiziato alle cinque di domani mattina alla stazione Tverskaya”, specificò il grassone di fianco al comandante. Come il suo superiore, non indossava la mimetica verde, ma un’uniforme nera, con bottoni dorati. Entrambi portavano berretti neri, ma non grezzi come quelli dei soldati nella galleria. Numerosissime erano le rappresentazioni di aquile e di svastiche a tre punte, insieme a slogan e a motti in lettere gotiche, tracciate con grande attenzione. Concentrandosi sulle parole sfocate, Artyom riuscì a leggere: “La Metro è per i russi!”, “Neri in superficie!”, “A morte i mangiatori di ratti”. Ve n’erano delle altre, dai contenuti più astratti: “Marciamo verso l’ultima battaglia per innalzare lo spirito russo!”, “Con il fuoco e le armi fonderemo il vero ordine russo!”. Poi c’era una citazione di Hitler in tedesco e un relativamente neutro: “Mente sana in corpo sano!”. Inoltre, c’era un’iscrizione che lo impressionò particolarmente: si trovava sotto al ritratto perfetto di un soldato valoroso dalla mascella e dal mento pronunciati, insieme a una donna dall’aspetto risoluto. Erano rappresentati di profilo, in modo che l’uomo facesse da scudo alla donna. “Ogni uomo è un soldato e ogni donna è madre di un soldato!”, recitava lo slogan. Tutte queste epigrafi e immagini avevano assorbito l’attenzione di Artyom molto più delle parole del comandante. Proprio davanti a lui, al di là di una recinzione, la folla era in fermento. Tuttavia, si era radunato un numero esiguo di persone, che indossavano tutte abiti alquanto insignificanti, giacche imbottite e tute da lavoro sporche. In giro non si vedevano molte donne e, se ciò rifletteva la realtà, in futuro non sarebbero nati molti soldati. La testa di Artyom cadde a penzoloni: non aveva più la forza di tenerla dritta e, se non fosse stato per i due energumeni in berretto che lo scortavano e lo sorreggevano da sotto le braccia, sarebbe già rovinato a terra. Si sentì nuovamente svenire, la testa gli girava e non riusciva a venirgli in mente niente di ironico da dire. Il ragazzo aveva l’impressione che, da un momento all’altro, sarebbe stato fatto a pezzi di fronte a tutta quella gente. Ciononostante, in Artyom si accumulava una sciocca indifferenza rispetto a ciò che gli sarebbe accaduto. Il suo era un interesse puramente astratto e concentrato su quello che lo circondava, come se le parole che aveva udito non fossero rivolte a lui, ma le stesse leggendo in un libro: il destino del protagonista lo appassionava, tuttavia se questo rimaneva ucciso, avrebbe potuto scegliere un altro libro tra quelli sullo scaffale, uno con un lieto fine. Era stato picchiato a lungo e con estrema accuratezza da persone pazienti e forti, mentre altre gli ponevano domande intelligenti e assennate. Come da manuale, la stanza era stata ricoperta da piastrelle di un giallo irritante, così il sangue poteva essere lavato con più facilità. Malgrado ciò, era impossibile eliminare l’odore. All’inizio, gli avevano insegnato a chiamare “Signor comandante” l’uomo smunto dai capelli chiari e lisci e i lineamenti delicati che conduceva l’interrogatorio. In seguito gli avevano ordinato di non porre alcuna domanda, perché lui avrebbe dovuto esclusivamente rispondere. Poi gli intimarono di dare risposte accurate e precise. Artyom non riusciva a comprendere come mai avesse ancora tutti i denti, anche se in effetti alcuni dondolavano e aveva in bocca un pungente sapore di sangue. Dapprima aveva provato a giustificarsi, ma poi gli spiegarono che tanto non ne sarebbe valsa la pena. Quindi era rimasto in silenzio, ma ben presto lo convinsero che anche questa era una reazione sbagliata. Fu dolorosissimo. Quando un uomo forte ti colpisce la testa... beh, si prova una sensazione particolare, non si tratta di un semplice dolore, ma di una sorta di uragano che cancella tutti i pensieri dalla mente e riduce a pezzi i sentimenti. Ma la vera tortura viene dopo. Dopo un po’, Artyom riuscì a comprendere cosa fare. Era molto semplice: doveva gestire le aspettative del comandante nel miglior modo possibile. Quando gli veniva domandato se era stato inviato dalla Kuznetsky Most, doveva fare un cenno con il capo, in segno di assenso. Così il dispendio di forze da parte del ragazzo veniva dimezzato, il comandante non doveva corrugare il naso tipicamente slavo e i suoi assistenti non lo dovevano percuotere. Il capo presunse che Artyom fosse stato incaricato di raccogliere informazioni militari e di portare a termine una sorta di sabotaggio. Il giovane assentì con un nuovo movimento della testa, mentre i torturatori si fregavano le mani soddisfatti. Ma così era riuscito a salvarsi un occhio. Malgrado ciò, non si doveva limitare ad annuire, doveva anche ascoltare ciò che il comandante gli domandava, perché in caso contrario l’umore degli uomini sarebbe peggiorato e uno degli aiutanti avrebbe cercato di rompergli una costola. La conversazione durò un’ora e mezza e proseguì senza fretta.. Artyom non si sentiva più il corpo, non vedeva bene e non udiva quasi nulla. Perse conoscenza diverse volte, ma lo fecero rinvenire usando acqua gelata e ammoniaca. Doveva essere una persona molto interessante con cui fare conversazione. Alla fine, erano arrivati a farsi un’idea totalmente errata di chi fosse in realtà: lo credevano una spia nemica e un sabotatore, giunto fin lì per pugnalare il Quarto Reich alle spalle, decapitarne il comando, gettare al vento i semi del caos e preparare un’invasione. Il suo scopo finale? La diffusione, in tutta la Metropolitana, di un regime caucasico-zionista e antinazionalista. In generale, Artyom ne capiva ben poco di politica, ma un obiettivo così globale non poteva essere altro che molto nobile, perciò confermò: era tutto vero. E meno male! Infatti, aveva ancora tutti i denti. Qualche dettaglio ancora e il complotto era stato svelato; a quel punto permisero ad Artyom di svenire in santa pace. Quando aveva aperto l’occhio l’ultima volta, il comandante stava già leggendo la sentenza. Poi, dopo che la data della sua dipartita da questo mondo venne annunciata al pubblico ed ebbero terminato di sbrigare le ultime formalità, gli infilarono un cappuccio nero sul viso e la vista peggiorò in maniera drastica. Non riusciva a vedere nulla e la testa gli girava ancora di più. Era a malapena riuscito a rimanere in piedi per un minuto, quando smise di lottare, uno spasmo prese il sopravvento sul suo corpo e si vomitò sugli stivali. La guardia fece un passo indietro con cautela e il pubblico mormorò indignato. Artyom venne pervaso da un senso di vergogna, ma solo per un momento; poi fu colto nuovamente da un senso di nausea, mentre le ginocchia gli si mettevano a tremare. Un uomo forte gli teneva alto il mento, quando udì una voce famigliare, che sembrava provenire da un mondo lontano, solo sognato: “Andiamo, vieni con me, Artyom! È tutto finito. Alzati!”, ma il ragazzo non riusciva a trovare la forza necessaria né per alzarsi né per sollevare la testa. Era molto buio, probabilmente a causa del cappuccio. Ma come poteva levarselo se aveva le mani legate dietro la schiena? Doveva toglierselo a tutti i costi, solo così avrebbe potuto controllare se la persona che aveva sentito parlare era davvero lì oppure era stata frutto della sua immaginazione. “Il cappuccio...”, riuscì ad articolare, sperando che l’uomo avrebbe compreso. Il velo nero davanti ai suoi occhi scomparve e Artyom vide Hunter davanti a lui. Non era cambiato di una virgola dall’ultima volta in cui avevano parlato alla VDNKh, qualche tempo prima. Sembrava passata un’eternità. Com’era arrivato sin qui? Artyom, stanco, spostò il capo e si guardò intorno: si trovava sulla piattaforma della stessa stazione in cui avevano letto la sua sentenza di morte. Solo che c’erano cadaveri dappertutto; alcune delle candele di un candelabro bruciavano ancora, mentre le altre erano spente. Nella sua mano destra, Hunter impugnava la stessa pistola che l’ultima volta aveva tanto meravigliato Artyom perché gli era sembrata enorme, con un lungo silenziatore avvitato sulla canna e un incredibile mirino laser. Era una “Stechkin”. Il cacciatore osservava Artyom, ansioso e attento: “Stai bene? Riesci a camminare?” “Sì. Almeno credo”. Artyom richiamò a sé tutto il coraggio che aveva in corpo. In quel momento c’era un altro particolare che attirava la sua attenzione: “Sei vivo? La tua missione è riuscita?” “Come vedi...”, Hunter sorrise, distrutto. “Grazie per l’aiuto”. “Ma io non sono riuscito a portare a termine l’incarico che mi avevi assegnato”, Artyom scosse la testa. Si sentì avvampare per l’imbarazzo. “Hai fatto tutto quello che potevi”, Hunter gli diede un colpetto sulla spalla, come per consolarlo. “Che succede a casa, alla VDNKh?” “Va tutto bene, Artyom. È passato tutto. Sono riuscito a far crollare l’entrata e ora i Tetri non potranno più entrare nella Metro. Siamo salvi. Andiamo”. “Qui cosa è successo?”. Artyom si guardò attorno e notò con orrore che l’atrio era zeppo di uomini e donne morti e, oltre alla sua voce e a quella di Hunter, non si sentiva altro. “Non importa”, Hunter lo guardò deciso negli occhi. “Non te ne devi preoccupare”. Si piegò e sollevò la sua sacca da terra. All’interno c’era una mitragliatrice dell’esercito fumante, il cui caricatore era praticamente vuoto. Il cacciatore si allontanò e Artyom cercò di stare al passo. Guardandosi attorno, notò un particolare a cui non aveva fatto caso in precedenza: diverse sagome nere penzolavano dal ponticello sul quale era stata letta la condanna a morte di Artyom. Mentre procedeva a grandi passi, Hunter non parlava, come se si fosse scordato che il ragazzo riusciva a malapena a muoversi. Per quanto Artyom provasse, la distanza tra lui e l’uomo aumentava e temeva che Hunter potesse andarsene, lasciandolo in quella orribile stazione, col pavimento coperto di sangue scivoloso e ancora caldo e dei cadaveri come unici abitanti. “Me lo merito davvero?”, meditò Artyom. “La mia vita è più importante delle loro?”. Era felice che qualcuno fosse giunto in suo soccorso, ma tutte quelle persone erano sparpagliate qua e là come dei vecchi stracci sul granito della piattaforma, un corpo di fianco all’altro, sui binari, lasciati per sempre nella posizione in cui i proiettili di Hunter le avevano colpite. Erano tutti morti perché lui potesse vivere? Hunter aveva deciso a cuor leggero, come se durante una partita a scacchi avesse dovuto scarificare dei pedoni per salvare uno dei pezzi più importanti... Lui era solo un giocatore, la Metro era la scacchiera e tutte le pedine erano sue perché aveva cominciato una partita contro se stesso. Ma la domanda più importante che si poneva era un’altra: Artyom era talmente importante che tutte questa gente aveva dovuto morire perché lui si salvasse? Il sangue che scorreva sul freddo granito avrebbe pulsato anche nelle sue vene. Era come se l’avesse bevuto, spremuto dagli altri per risparmiare la sua esistenza. D’ora in avanti il suo sangue non sarebbe mai più stato caldo... Facendo uno sforzo enorme, Artyom accelerò il passo per raggiungere Hunter e chiedergli cosa ne sarebbe stato del suo sangue, se almeno stando vicino al fuoco si sarebbe scaldato di nuovo oppure sarebbe rimasto freddo, melanconico, come una gelida notte d’inverno in una remota mezza stazione. Hunter era ormai lontano. Forse, proprio perché Artyom non riusciva a stargli dietro, il cacciatore era sceso sui binari e si era infilato nella galleria con l’agilità di un animale. Sembrava si muovesse come... un cane, forse? No, un ratto... Dio mio! “Tu sei un ratto?”. Artyom riuscì a malapena a pronunciare quelle parole, che lo spaventavano. “No”, fu la risposta. “Sei tu il ratto. Sei un ratto! Un ratto codardo!”, gli ripeté qualcuno all’orecchio, sputando copiosamente. Artyom scosse la testa ma se ne pentì subito dopo. Ora, a causa dei movimenti improvvisi, il dolore gli era esploso in corpo. Perse il controllo degli arti e cominciò a inciampare. Così rimase con la fronte appoggiata a qualcosa di freddo e metallico: la superficie era ondulata e per nulla comoda, ma per lo meno dava un po’ di sollievo alle sue carni in fiamme. Perciò rimase in quella posizione, senza avere le forze per fare la mossa successiva. Riprese il fiato e poi, con attenzione, cercò di aprire leggermente l’occhio sinistro. Era seduto sul pavimento, con la fronte poggiata contro una specie di reticolo, che saliva fino al soffitto e riempiva lo spazio da entrambi i lati dell’arco basso e spazioso. Lui aveva il viso rivolto verso l’atrio, ma sapeva che alle sue spalle correvano i binari. Per quanto riuscisse a vedere, anche tutti gli archi vicini erano stati trasformati in celle e in ognuna di esse erano rinchiuse diverse persone. Questa stazione era l’esatto opposto di quella in cui era stato condannato a morte: la precedente era elegante, illuminata, spaziosa, con colonne traslucide, archi ampi e molto alti, malgrado le iscrizioni e i disegni che ricoprivano i muri. Paragonata a questa, sembrava la sala di un banchetto. Qui tutto era opprimente e spaventoso: il soffitto era basso e arrotondato, come nelle gallerie, e a malapena raggiungeva il doppio dell’altezza di un uomo. Inoltre, c’erano colonne enormi, grezze, ciascuna delle quali era molto più ampia degli archi che supportava, il cui soffitto era talmente vicino al pavimento che Artyom avrebbe potuto toccarlo se non avesse avuto le mani legate dietro la schiena. Oltre a lui, nella cella c’erano altri due uomini: uno era disteso a terra con il viso nascosto da una pila di stracci e gemeva, fiacco; l’altro aveva occhi scuri e capelli castani e non si radeva da un po’; era accucciato con la schiena appoggiata al muro di marmo e osservava Artyom pieno di curiosità. Due uomini corpulenti, in mimetica e berretto, facevano la guardia alle gabbie. Uno dei due teneva al guinzaglio un grosso cane, che di tanto in tanto richiamava a sé. Erano stati loro a svegliare Artyom. Era stato tutto un sogno. Si era immaginato tutto. Lo avrebbero impiccato. “Che ore sono?”, borbottò muovendo un poco la lingua in fiamme e guardando di lato, verso l’uomo con gli occhi scuri. “Le nove e mezza”, rispose l’altro di buon grado, con lo stesso accento che Artyom aveva udito alla Kitay-Gorod: anche lui pronunciava una o al posto della a. Poi aggiunse: “Di sera”. Erano le nove e mezza. Ancora due ore e trenta minuti prima della mezzanotte, cinque ore prima... della fine. Sette ore e trenta minuti. Mentre pensava e contava, il tempo stava già volando via. Una volta Artyom aveva provato a immaginare: cosa avrebbe pensato e provato una persona al cospetto della morte, la notte prima della sua esecuzione? Paura? Odio per i suoi carnefici? Rimpianto? Lui si sentiva svuotato. Il cuore gli batteva forte nel petto, le tempie pulsavano, il sangue gli si accumulava in bocca, finché non era costretto a inghiottirlo: aveva lo stesso sapore del ferro arrugginito. Oppure era il ferro bagnato che aveva il sapore del sangue fresco? Lo avrebbero impiccato. Lo avrebbero ucciso. Non sarebbe più esistito. Non riusciva a immaginarlo, non se ne faceva una ragione. Tutti sanno che la morte è inevitabile. All’interno della Metro, la morte faceva parte della vita quotidiana. Tuttavia, sembrava che capitasse solo agli altri: lui era sempre riuscito a schivare le pallottole, a superare indenne le malattie. La morte di vecchiaia era comunque un processo molto lento, perciò non c’era bisogno di pensarci. Non si può vivere continuando a meditare sulla propria mortalità. Bisogna dimenticarsela. Sebbene prima o poi il pensiero ritornerà, si deve sempre cercare di scacciarlo via, soffocarlo, altrimenti potrebbe radicarsi nella coscienza e rendere la vita una miseria. Non si può pensare al fatto che si deve morire, altrimenti si impazzisce. C’è solo una cosa che può salvare l’uomo dalla pazzia, ed è l’incertezza. La vita del condannato a morte è diversa da quella di una persona normale solo perché il primo sa con esattezza quando morirà, mentre il secondo ne è totalmente all’oscuro e perciò ha la percezione di poter vivere per sempre, anche se esiste sempre una piccola possibilità che potrebbe finire ucciso il giorno successivo, per una disgrazia. La morte non fa paura di per sé, ciò che si teme è l’attesa. Tra sette ore. Come avrebbero eseguito la sentenza? Artyom non riusciva a immaginare come le persone venivano impiccate. Una volta, alla loro stazione, era stato giustiziato un traditore, ma Artyom era ancora molto piccolo e non aveva compreso con esattezza cosa fosse accaduto. Inoltre, alla VDNKh, le esecuzioni non si svolgevano in pubblico. Molto probabilmente gli avrebbero cinto il collo con una corda, poi lo avrebbero attaccato al soffitto oppure avrebbero usato una sorta di sgabello... No, non poteva sopportare il pensiero. Aveva sete. Con uno sforzo immane si mise a pensare; così ritornò sui binari, nel momento in cui aveva sparato all’ufficiale, la prima persona che avesse mai ucciso. La scena gli si ripresentò davanti agli occhi, proiettili invisibili si infilavano nel petto robusto dell’uomo, lasciando segni neri di sangue coagulato. Non provava rammarico per il gesto compiuto e questo lo sorprese. Un tempo riteneva che quando si uccide una persona, questa rimane come un peso sulla coscienza dell’assassino: appare nei suoi sogni, lo disturba finché non invecchia. Tuttavia, lui non aveva provato pietà o pentimento, solo un cupo compiacimento. Artyom sapeva che se la guardia uccisa fosse venuta a turbare i suoi sogni, lui si sarebbe voltato dall’altra parte e il fantasma sarebbe scomparso, senza lasciare alcuna traccia. Ma la vecchiaia... Non sarebbe più invecchiato. Il tempo a sua disposizione stava per scadere. Probabilmente avrebbero usato uno sgabello. Quando si ha così poco tempo, bisogna pensare a qualcosa di importante, al particolare più significativo, quello che si era tenuto da parte per occuparsene in un secondo momento... Al fatto che la vita non era stata vissuta nel modo corretto e, con una seconda possibilità, ci si sarebbe comportati in maniera diversa... No. In questo mondo avrebbe avuto solo questa vita e non avrebbe potuto fare nulla per migliorarla. Quando quella guardia aveva sparato in testa a Vanechka non avrebbe dovuto agguantare la mitragliatrice automatica? Sarebbe dovuto rimanere dov’era? Non avrebbe mai funzionato, anche perché non sarebbe mai riuscito a scacciare Vanechka e Mikhail Porfirevich dai suoi sogni. Cos’era successo al vecchio? Dannazione, quanto avrebbe desiderato una sorsata d’acqua! Prima di tutto lo avrebbero condotto fuori dalla sua cella... poi, se fosse stato fortunato, lo avrebbero portato fino al passaggio. Ma ormai c’era poco tempo. Se non gli avessero infilato quel maledetto cappuccio avrebbe potuto vedere qualcosa di più, oltre alle sbarre dell’inferriata e la fila interminabile di celle. “Da quale stazione vieni?”, chiese Artyom con le labbra secche, allontanandosi dalla rete e cercando di guardare il vicino negli occhi. “Dalla Tverskaya”, rispose l’uomo, che poi domandò a sua volta: “Fratello, perché sei finito qui dentro?” “Ho ucciso un ufficiale”, replicò lento Artyom; faceva molta fatica a parlare. “Oh-oh...”, fece l’uomo con compassione. “Allora verrai impiccato?” Artyom si strinse nelle spalle e si voltò di nuovo, poggiandosi contro il reticolato. “Certo che sì!”, assicurò l’altro. Certo, lo avrebbero impiccato. Tra poche ore. Proprio in questa stazione. Non lo avrebbero trasferito da nessun’altra parte. Se solo avesse potuto bere un po’ d’acqua... per lavare via il sapore metallico che aveva in bocca e per placare la sete causata dalla gola secca; così avrebbe potuto discorrere con il suo vicino per più di un minuto. Non c’era acqua all’interno della cella; dall’altro lato intravvedeva solo un secchio di liquido fetido. Avrebbe potuto chiedere ai suoi carcerieri? Forse si sarebbero dimostrati indulgenti nei confronti dei condannati. Se solo avesse potuto spingere la mani al di là della recinzione e fare un cenno... Ma le mani erano legate dietro la schiena e il cavo era talmente stretto attorno ai suoi polsi che aveva perso la sensibilità nelle mani. Cercò di urlare, ma emise solo un rantolo, che si trasformò in una tosse proveniente dal fondo dei polmoni. Quando notarono che stava cercando di attirare la loro attenzione, entrambe le guardie si avvicinarono alla cella. “Il ratto si è svegliato”, grugnì l’uomo con il cane. Artyom tirò indietro la testa per vedere il viso dell’uomo e sussurrò con estrema difficoltà: “Bere... Acqua”. “Vuoi dell’acqua da bere?”, la guardia con il cane si finse sorpresa. “E a cosa ti serve? Tanto tra un po’ ti appenderanno! No, non te la diamo. Forse in questo modo morirai prima”. La questione venne chiusa così e Artyom chiuse gli occhi, sfinito. Tuttavia, pareva che i due uomini volessero fare conversazione con lui. “Sei riuscito a capire contro chi ti sei messo, lurida canaglia?”, gli domandò l’altra guardia. “E sei russo, per giunta! È solo per gli idioti come quelli, che cercano di colpirti alle spalle...”, e indicò con un cenno del capo il compagno di cella di Artyom. “Ben presto la Metro sarà piena di gente come loro e i russi non riusciranno più nemmeno a respirare”. Il prigioniero con la barba incolta abbassò lo sguardo. Artyom riuscì solo a trovare la forza di scuotere le spalle. “Hanno sistemato per le feste quel bastardello che stava con te”, aggiunse la prima guardia. “Sidorov mi ha riferito che la galleria era un bagno di sangue. Meno male! Bestie! Devono essere distrutti! Non fanno parte del nostro genoma!”, riuscì a ricordare la parola specifica. “Rovinano il nostro mondo. Ah, poi è morto anche il vecchio”, concluse. “Cosa?”, singhiozzò Artyom. Aveva temuto che accadesse, ma sperava che l’anziano si fosse salvato, che lo avessero rinchiuso in una cella poco più in là. “Proprio così. È morto. Lo hanno riempito di piombo e ha tirato le cuoia”, affermò la guardia con il cane, con un tono soddisfatto, perché il ragazzo aveva cominciato a reagire alle loro provocazioni. “Morirai. Tutti i tuoi parenti moriranno...”, vedeva ancora la sagoma di Mikhail Porfirevich che con assoluta disinvoltura si fermava nel bel mezzo della galleria, sfogliava il taccuino e ripeteva l’ultimo verso della poesia, pieno d’emozione. Cosa diceva? “Der Toten Tatenruhm?”. No, il poeta si sbagliava, non potevano più esistere atti di gloria. Ormai non esisteva più nulla. Poi gli venne in mente che a Mikhail Porfirevich mancava il suo appartamento, specialmente il suo letto. I pensieri del giovane cominciarono a infittirsi, fluivano con maggiore difficoltà, finché non scomparvero del tutto. Per riposarsi, poggiò di nuovo la fronte contro la rete e con la mente annebbiata si mise a osservare la manica del suo carceriere. Un svastica a tre punte. Che strano simbolo. Sembrava una stella o un ragno zoppo. “Perché solo tre?”, gli domandò. “Perché tre?”, dovette inclinare la testa verso la fascia che l’uomo portava al braccio per fargli comprendere cosa intendesse. “A te quante ne servono?”, rispose indignato l’uomo con il cane. “Le stazioni sono tre, stupido! È un simbolo di unità. E quando conquisteremo la Polis, aggiungeremo anche la quarta...” “Ma di che parli?”, lo interruppe l’altra guardia. “È un simbolo slavo antichissimo, primordiale! Si chiama solstizio ed è stato usato per la prima volta dai tedeschi; noi lo abbiamo acquisito da loro. Stazioni... deficiente!” “Ma il sole non c’è più...”. Artyom si sforzò a pronunciare le parole. Gli pareva di avere un velo sugli occhi, mentre il senso dell’udito si affievoliva sempre più. “Ci siamo. È ufficialmente impazzito”, annunciò soddisfatta la guardia con il cane. “Vieni, Senya, cerchiamoci qualcun altro con cui scambiare quattro chiacchiere”. Artyom non sapeva quanto tempo fosse trascorso da quando lo avevano messo a sedere in quel luogo, in cui non riusciva né a pensare né a vedere. Di tanto in tanto riacquistava conoscenza e intravvedeva immagini vaghe. Ma tutto era saturo del sapore e dell’odore del sangue. Tuttavia, era sollevato dal fatto che il corpo avesse avuto pietà della mente e avesse distrutto i pensieri: aveva liberato la ragione dal senso di malinconia. “Ehi, fratello!”, il vicino gli scosse la spalla. “Non dormire. Sei rimasto assopito troppo a lungo! Sono quasi le quattro!” Artyom cercò di riemergere dall’abisso dell’inconsapevolezza, ma era complicato: gli pareva di avere dei pesi legati alle caviglie. La realtà riaffiorò lenta, come le sagome indistinte che appaiono su una pellicola appena immersa nella soluzione chimica che le permette di svilupparsi. “Che ore sono?”, gracchiò. “Le quattro meno dieci”, lo informò l’uomo dagli occhi scuri. Dieci minuti alle quattro... Con tutta probabilità sarebbero venuti a prenderlo tra quaranta minuti e tra un’ora e dieci... un’ora e nove... un’ora e otto minuti. Sette minuti. “Come ti chiami?”, volle sapere il suo vicino. “Artyom”. “Io sono Ruslan. Mio fratello si chiamava Ahmed, perciò lo hanno ucciso subito. Ma non sanno cosa farsene di me. Ho un nome russo e probabilmente non si vogliono sbagliare”, l’uomo era felice di essere riuscito a intavolare una conversazione. “Di dove sei?” Ad Artyom non interessava, ma le poche parole scambiate con il vicino barbuto, in qualche modo, gli riempivano la testa. Non voleva pensare alla VDNKh o alla missione che gli era stata assegnata. Non voleva riflettere su ciò che stava accadendo nella Metro. Non ne aveva le forze. Non voleva! “Io vengo dalla Kievskaya. La conosci? Per noi è il sole di Kiev...”. Ruslan sorrise, mostrando una fila di denti bianchi. “Molti di noi vivono laggiù. Sono sposato e ho dei bambini... tre. Il più grande ha sei dita in entrambe le mani!”, aggiunse fiero. Qualcosa da bere. Solo una sorsata, anche se d’acqua tiepida. Non gli sarebbe dispiaciuta comunque. Acqua non filtrata. Qualsiasi tipo di acqua. Ne bastava una sorsata. Poi si sarebbe acquietato, finché le sentinelle non fossero venute a prelevarlo. Desiderava che la sua mente si svuotasse di nuovo. Non voleva più essere disturbato. Aveva bisogno che la testa smettesse di girargli, di prudergli, di indicargli che aveva commesso un errore. Non aveva alcun diritto sul gesto che aveva fatto. Avrebbe dovuto andarsene. Girare le spalle. Coprirsi le orecchie. Marciare in avanti. Procedere dalla Pushkinskaya alla Chekhovskaya. Da lì mancava un solo passaggio. Sarebbe stato così facile. Un solo passaggio e ce l’avrebbe fatta, avrebbe portato a termine il suo compito. Sarebbe stato vivo. Qualcosa da bere. Le mani erano talmente intorpidite che non le sentiva più. Morire è così semplice per quelli che credono in qualcosa, per coloro che sostengono che la morte non sia la fine di tutto. Quelli per cui esiste solo il bianco e il nero, che sanno esattamente cosa devono fare e perché, che sventolano lo stendardo di un’idea, o di ciò in cui credono; lo trattengono nelle loro mani e tutto ciò che vedono ne è illuminato. Coloro che non hanno dubbi o rimpianti. Per loro morire deve essere facile. Se ne vanno con il sorriso sulle labbra. “Prima c’erano frutti talmente grossi! E fiori meravigliosi! Li regalavo a una ragazza e lei mi sorrideva...”, le parole raggiunsero Artyom ma non riuscivano più a distrarlo. Si udirono dei passi provenienti dall’androne. Si stava avvicinando un gruppo di persone, mentre il cuore di Artyom si strinse e si trasformò in un piccolo ammasso di nervi. Stavano venendo a prenderlo? Così presto? Pensava che quaranta minuti sarebbero trascorsi più lentamente. Oppure il suo diabolico vicino gli aveva riferito che mancava più tempo, solo perché voleva dargli una falsa speranza? No, non poteva essere... Tre paia di scarponi si fermarono davanti alla sua cella. Due degli uomini indossavano pantaloni militari, mentre quelli del terzo erano neri. Il lucchetto emise un rumore stridulo e Artyom riuscì a non cadere quando la porta contro cui era poggiato si aprì. “Prendetelo”, ordinò uno degli uomini. Venne afferrato da sotto le braccia e fatto alzare in piedi. “In bocca al lupo!”, gli augurò Ruslan in segno d’addio. Vi erano anche altre due guardie con le mitragliatrici, ma non erano le stesse con cui aveva parlato in precedenza, sebbene avessero lo stesso aspetto anonimo. Un terzo uomo con un paio di baffi ispidi e vacui occhi azzurri indossava un’uniforme nera e un piccolo berretto. “Seguitemi!”, ordinò e Artyom venne trascinato verso la parte opposta della piattaforma. Cercò di camminare da solo. Non voleva farsi condurre a forza, come fosse un fantoccio indifeso... Voleva vivere la sua vita fino in fondo e lo voleva fare con orgoglio. Ma le gambe non gli obbedivano, si piegavano... Riuscì goffamente a poggiarle sul pavimento, ma in quel modo ostacolava il movimento dell’uomo con l’uniforme nera, che gli lanciò un’occhiata severa. Le celle non continuavano fino alla fine dell’atrio: la fila era interrotta al centro dove si trovavano le scale mobili che conducevano al piano inferiore. Laggiù, in profondità, bruciavano delle fiaccole e la sinistra luce color porpora si rifletteva sul soffitto. Si udivano urla di dolore provenire da là sotto. Artyom immaginò gli inferi e provò un certo sollievo quando superarono quella zona. Qualcuno, dall’ultima gabbia, gli urlò: “Addio, amico mio!”, ma Artyom non gli prestò alcuna attenzione. L’unica immagine che vagava davanti ai suoi occhi era quella di un bicchiere d’acqua. Sul muro opposto si trovavano un posto di guardia e un tavolo mal assemblato con due sedie, sopra il quale era appeso il cartello con il simbolo che vietava l’accesso alle persone di colore. Non riuscì a scorgere la forca in nessun luogo, perciò, per un momento, provò un impeto di speranza: lo volevano solo spaventare, non stavano per impiccarlo, ma lo avrebbero semplicemente condotto dall’altro lato della stazione, in modo che potesse fuggire senza che gli altri lo vedessero. L’uomo con i baffi in prima posizione svoltò all’ultimo arco, verso il sentiero, e Artyom si ritrovò a credere alla sua fantasia con ancora più convinzione. Sui binari si trovava una piccola piattaforma su ruote; era sistemata in modo che il pianale fosse allo stesso livello del pavimento della stazione, sul quale si trovava un uomo tarchiato, in uniforme mimetica: stava controllando il nodo di una corda che pendeva da un uncino avvitato nel soffitto. L’unica differenza tra quest’uomo e gli altri era che lui aveva le maniche arrotolate, che lasciavano in bella vista i possenti avambracci. In testa aveva un passamontagna fatto a maglia, sul quale erano stati lasciati due fori, in corrispondenza degli occhi. “È tutto pronto?”, domandò l’uomo in uniforme nera e il boia annuì. “Questo marchingegno non mi piace”, lo informò. “Perché non possiamo tornare al caro, vecchio sgabello? Un attimo e... bum!”. Colpì con il pugno il palmo dell’altra mano. “Il collo si rompe! Ma con questo... mentre si strozza, si contorce come un verme sull’amo. Poi, quando si è soffocato, bisogna ripulire tutto intorno, c’è schifezza ovunque!” “Basta!”, gli ordinò l’uomo in uniforme nera. Poi prese da parte il boia e lo redarguì in tono furioso. Non appena il loro superiore si era allontanato, i soldati avevano ripreso la conversazione interrotta: “Quindi?”, chiese impaziente il militare di destra a quello di sinistra. “Beh, quindi”, sussurrò quello a destra “l’ho spinta contro la colonna, le ho ficcato la mano sotto la gonna, quella si è sciolta e mi ha detto...”, ma non riuscì a terminare la frase che il superiore tornò. “Non ci importa che sia russo! Ha trasgredito la legge! È un traditore! I voltagabbana, i pervertiti e i traditori devono essere puniti nel modo più doloroso possibile!”, incoraggiò il boia. Gli slegarono le mani, gli tolsero la giacca e il maglione. Artyom rimase solo con la canottiera sporca. Poi spezzarono lo spago con il quale aveva legato al collo il bossolo che gli aveva consegnato Hunter. “Un talismano?”, si domandò il boia. “Te lo metterò in tasca, potrebbe sempre tornarti utile”. La sua voce non era per nulla malevola, anzi, era curiosamente confortante. Poi gli presero le mani, gliele misero di nuovo dietro la schiena e lo spinsero sul patibolo. I soldati rimasero sulla piattaforma perché il loro compito era terminato; il ragazzo non avrebbe comunque potuto fuggire perché gli ci voleva tutta la forza che gli era rimasta solo per stare in piedi mentre il boia gli sistemava la corda attorno al collo. Stare in piedi. Non cadere. Non fare rumore. Qualcosa da bere. Pensava solo a questo. Acqua. Acqua! “Acqua...”, gracchiò. “Acqua?”, il boia alzò le mani con disappunto. “E ora dove vado a trovarti dell’acqua? Non è possibile, mio caro, siamo già indietro sulla tabella di marcia. Devi solo essere paziente per un momento, non ci vorrà molto...” Saltò sui binari con un tonfo e si sputò sulle mani prima di afferrare la corda attaccata al patibolo. I soldati erano in fila e il loro comandante aveva assunto un’espressione grave, quasi solenne. “Sei una spia nemica, che ha tradito brutalmente il suo popolo”, cominciò. Nella testa di Artyom danzavano frammenti di pensieri e immagini che imploravano: “Aspetta, è troppo presto! Non sono riuscito ancora a portare a termine la mia missione!”. Inoltre, all’improvviso gli apparve il viso severo di Hunter che scomparve subito dopo nella penombra color porpora della stazione. Poi vide lo sguardo amorevole di Sukhoi e anch’esso sparì dopo poco. Mikhail Porfirevich... “Morirai”... i Tetri... non possono... Aspettate! Sopra tutto ciò, i suoi ricordi intermittenti, le parole, i desideri ricoperti da una foschia densa e soffocante, pesava una sete incolmabile. Qualcosa da bere... “... pervertiti, che screditano la loro nazione...”, continuava a brontolare la voce. Ma all’improvviso nella galleria si udirono delle urla e la scarica di una mitragliatrice, seguita da un fragore assordante; poi la stazione ripiombò nel silenzio. Il superiore in nero si voltò nervoso e pronunciò velocemente le parole: “Condannato a morte. Procedi!”, e diede il segnale. Il boia grugnì e tirò la corta, facendo forza con i piedi sulle traversine. Le tavole scivolavano da sotto le suole di Artyom, sebbene lui si sforzasse di toccarle per riuscire a rimanere sul patibolo; ma queste si spostavano sempre di più. Riuscire a rimanere in piedi era difficilissimo. La corda lo trascinava indietro, verso la morte e lui non voleva, non voleva morire... A quel punto, il terreno slittò via da sotto i piedi e il cappio gli si strinse attorno, a causa del peso del suo corpo. Il collo era costretto dentro la corda, che impediva all’aria di entrare nella trachea. La sua gola emise un rantolo. Non vedeva quasi più nulla, mentre dentro di lui tutto si contorceva. Il suo corpo implorava un po’ d’aria, ma non riusciva a inspirare, per quanto ci provasse. Quindi il corpo del ragazzo cominciò a contorcersi in maniera convulsa, mentre lo stomaco pungeva in modo terribile. La stazione si annuvolò e venne pervasa da un fumo tossico giallo, mentre colpi di pistola esplodevano di fianco a lui. Poi perse conoscenza. “Ehi, impiccato! Forza, dai! Ora non fingere. Ti abbiamo sentito il battito, perciò non puoi fare finta di essere morto!”, qualcuno lo colpì sulle guance, facendolo rinvenire. “Mi rifiuto di fargli di nuovo la respirazione bocca a bocca!”, annunciò un’altra persona. Questa volta Artyom era sicurissimo che si trattasse di un sogno, i suoi ultimi secondi di incoscienza prima della fine, così vicina. Il momento in cui il pugno d’acciaio della morte si era serrato attorno al suo collo era indiscutibile quanto il carrello che si era spostato da sotto i suoi piedi: era stato impiccato sopra i binari. “Smettila di sbattere le palpebre, andrà tutto bene!”, insistette la prima voce. “Ti abbiamo liberato dal cappio in modo che tu possa tornare a goderti la vita e invece te ne stai li a rotolarti per terra!” Qualcuno lo scosse forte. Artyom aprì timido un occhio, poi lo richiuse: era convinto di essersi spento prima del previsto, mentre la vita nell’aldilà era già cominciata. Un essere, che sembrava umano, era chino sopra di lui, ma aveva un aspetto talmente insolito che ad Artyom tornarono alla mente i calcoli di Khan sul luogo in cui si recassero le anime che venivano separate dai loro corpi transitori. La pelle della creatura era giallognola, lo si vedeva anche alla luce della lanterna vicina, mentre al posto degli occhi aveva due strette fessure, come se lo scultore che stava lavorando sulla statua di una persona avesse ne quasi terminato il viso, ma avesse solo abbozzato gli occhi e si fosse dimenticato di terminarli per far sì che la persona potesse vedere il mondo con chiarezza. Il viso era tondo, gli zigomi altissimi. Artyom non aveva mai visto niente del genere. “No, così non funziona”, dichiarò qualcuno con risolutezza; a quel punto gli spruzzarono dell’acqua in viso. Artyom la inghiottì in maniera convulsa e allungò le mani per afferrare la bottiglia. All’inizio si limitò a tenerne in mano il collo, ma poi si alzò e si guardò intorno. Si stava muovendo alla velocità della luce in una galleria oscura. Si trovava su un carrello lungo all’incirca due metri. Nell’aria si sentiva un vago odore di bruciato e Artyom si meravigliò quando capì che il mezzo era alimentato a benzina. Su quella parte del carrello, oltre a lui, c’erano altre quattro persone insieme a un enorme cane dal manto marrone con sfumature nere. Uno degli uomini era quello che aveva colpito Artyom sulle guance. Poi c’era un tizio con la barba, che indossava una giacca imbottita e un cappello con paraorecchie, sul quale era applicata una stella rossa. Dalla schiena gli penzolava un lungo mitra, del tutto simile all’aggeggio che era appartenuto ad Artyom, solo che aveva una baionetta avvitata sulla canna. La terza persona era un uomo enorme, il cui viso Artyom non riuscì a distinguere subito, ma quando ci riuscì fece quasi per saltare giù dal carrello. Aveva la pelle nera. Il giovane lo osservò con più attenzione, poi si calmò. Non era un Tetro, il colore della sua pelle non era come quella dei mostri. Inoltre, aveva un normale viso umano, le labbra leggermente pronunciate e il naso schiacciato, come quello di un pugile. L’ultimo aveva un aspetto ordinario, un bel viso forte con il mento pronunciato, che ricordò al ragazzo un poster che aveva intravisto alla Pushkinskaya. Indossava un giaccone di pelle di ottima fattura, sul quale portava un cinturone con due file di buchi, oltre a una cintura da spada, alla quale era appesa una fondina di enormi dimensioni. Nella parte posteriore del carrello si trovava una mitragliatrice Degtyaryov e sventolava una bandiera rossa. Quando il raggio della lanterna illuminò per caso lo stendardo, il ragazzo non riuscì a capire subito di cosa si trattasse: sembrava solo un cencio rosso con la stampa nera di un uomo barbuto. Tutta questa scena gli pareva ancora più delirante di quella che aveva visto quando Hunter lo aveva salvato miracolosamente facendosi terra bruciata attorno, all’interno della Pushkinskaya. “Ha ripresto conoscenza!”, disse con gioia l’uomo dagli occhi a mandorla. “Impiccato, per quale crimine ti avevano condannato?”, parlava senza alcun tipo di accento, la sua pronuncia era identica a quella di Artyom o di Sukhoi. Era molto strano sentire parlare un russo tanto perfetto da un essere così particolare. Il ragazzo non riusciva a scacciare la convinzione che si trattasse di una farsa e che l’uomo dagli occhi a mandorla muoveva le labbra mentre quello con la barba o quello con la giacca di pelle parlavano per lui. “Ho ucciso uno dei loro ufficiali”, ammise restio. “Beh, buon per te! Sei proprio il tipo di persona di cui abbiamo bisogno! Gli hai dato ciò che si meritano!”. L’uomo dagli zigomi alti era entusiasta, mentre il tizio con la pelle scura seduto davanti si voltò verso Artyom e abbassò il capo in segno di rispetto. Artyom considerò la possibilità che avessero frainteso le sue parole. “Ciò significa che non abbiamo messo in piedi tutta questa scenata per niente”, e sfoggiò un enorme sorriso. Anche lui parlava con un accento impeccabile. Artyom era talmente confuso che non sapeva più cosa pensare. “Come ti chiami, eroe?”, gli domandò il bell’uomo con il giaccone in pelle e il ragazzo si presentò. “Io sono il compagno Rusakov, questo è il compagno Banzai”, e indicò l’uomo con gli occhi a mandorla. “Lui è il compagno Maxim”, l’uomo dalla pelle scura sogghignò di nuovo “mentre questo è il compagno Fyodor”. Per ultimo, fece anche la conoscenza del cane. Artyom non sarebbe rimasto sorpreso di sentire che chiamavano compagno anche l’animale, il nome del quale, invece, era soltanto Karatsyupa. Artyom strinse la mano a tutti, uno per uno: quella secca del compagno Rusakov, quella piccola ma forte del compagno Banzai, quella di Maxim, che sembrava un badile nero e quella carnosa del compagno Fyodor. Cercò seriamente di ricordare tutti i nomi, in particolar modo “Karatsyupa”, così difficile da pronunciare. Tuttavia, sembrava che tra di loro usassero appellativi diversi. L’uomo al comando era il “compagno commissario”, quello dalla pelle scura era “Maximka” o “Lumumba”, quello dagli occhi a mandorla era solo “Banzai” mentre quello con la barba e il cappello era lo “Zio Fyodor”. “Benvenuto alla Prima Brigata Rossa Internazionale Combattente della Metropolitana di Mosca, nel nome di Ernesto Che Guevara!”, annunciò trionfante il compagno Rusakov. Artyom lo ringraziò e non disse più nulla, guardandosi attorno. Il nome era lunghissimo e la sua parte iniziale aveva risvegliato nel ragazzo un sentimento controverso: per un periodo, il colore rosso aveva avuto su di lui lo stesso effetto che fa su un toro; al contrario, aveva sempre associato il termine brigata alle storie sulla malavita illegale della Shabolovskaya che gli raccontava Zhenya. Ma più che altro era incuriosito dal viso che svolazzava sulla bandiera, perciò chiese schivo: “Chi è quello sulla vostra bandiera?”, all’ultimo secondo aveva deciso di utilizzare il termine bandiera, sebbene stesse per dire straccio. “Quello, amico mio, è Che Guevara”, gli spiegò Banzai. “Ceghe... che?”. Artyom non aveva compreso, ma vedendo la rabbia riempire gli occhi di Rusakov e il sorriso beffardo stampato sul viso di Maximka, si rese subito conto di aver detto una stupidaggine. “Il compagno. Ernesto. Che. Guevara”, il commissario scandì le parole. “Il grande. Rivoluzionario. Cubano”. I rumori erano divenuti più udibili, sebbene fossero ancora quasi del tutto intelligibili per Artyom. Tuttavia, il giovane decise di mostrare entusiasmo con lo sguardo e non disse altro. Dopotutto, questa gente gli aveva salvato la vita e sarebbe stato molto scortese irritarli con la sua ignoranza. Superavano le sezioni saldate della galleria a tutta velocità e, durante la loro conversazione, erano riusciti a passare una stazione semivuota, poi si erano fermati nella penombra della galleria successiva. Qui, su un lato, si trovava una breve diramazione con un binario morto sul quale potevano sostare. “Vediamo se quegli sporchi fascisti osano inseguirci”, annunciò il compagno Rusakov. Si dovevano limitare a sussurrare perché il compagno Rusakov e Karatsyupa dovevano stare all’erta per percepire tutti i rumori provenienti dall’oscurità. “Perché lo avete fatto? Salvarmi, intendo”, domandò loro Artyom, scegliendo le parole che gli parevano più appropriate. “Avevamo già pianificato l’incursione, abbiamo ricevuto una soffiata”, spiegò Banzai, sorridendo misterioso. “Una soffiata... su di me?”, chiese Artyom, con la speranza di poter credere alle parole di Khan riguardo la sua missione speciale. “No, in generale”, Banzai fece un gesto indistinto. “Siamo venuti a sapere che avevano in programma di compiere delle atrocità. Perciò il compagno commissario ha deciso che era nostro compito fermarli. Inoltre, questa è la nostra missione: li importuniamo di continuo”. “Da questa parte non hanno piazzato posti di blocco sui sentieri, nemmeno una fiaccola, solo qualche avamposto con semplici fuochi da campo”, aggiunse Maximka. “Li abbiamo superati in un batter d’occhio. Peccato che abbiamo dovuto usare le mitragliatrici. Abbiamo lanciato un fumogeno, avevamo le maschere antigas e siamo riusciti a prendere te, il nostro eroe nazionale, poi ce la siamo svignata”. Zio Fyodor era zitto e fumava una sorta di droga da una pipa, il cui fumo cominciò a fargli lacrimare gli occhi. All’improvviso parlò: “Sì, mio giovane amico, per fortuna eri l’uomo giusto. Vuoi un goccetto?” Da una scatola di ferro, estrasse una bottiglia mezza vuota di un intruglio torbido, lo scosse e lo offrì ad Artyom. Ci voleva molto coraggio per fare un sorso di quella roba: gli fece lo stesso effetto della carta vetrata, ma permise a quella morsa che gli stritolava le interiora già da ventiquattro ore di dissolversi. “Voi siete... Rossi?”, domandò cauto. “Amico mio, noi siamo comunisti! Rivoluzionari!”, rispose fiero Banzai. “Venite dalla linea Rossa?”, volle sapere Artyom. “No, siamo semplici comunisti”, l’uomo era esitante e aggiunse subito: “Il compagno commissario ti spiegherà tutto, è lui il responsabile dell’ideologia, qui”. Il compagno Rusakov, tornato dopo qualche minuto d’assenza, li informò: “È tutto tranquillo”. Il suo bel viso emanava un senso di calma. “Possiamo fare una pausa”. Non avevano nulla con cui accendere il fuoco, perciò appesero un bollitore su un piccolo fornello da campeggio e tagliarono del salame di maiale. Il fatto che dei rivoluzionari mangiassero cibi così prelibati lo insospettì un poco. “No, compagno Artyom, non veniamo dalla linea Rossa”, dichiarò deciso Rusakov quando Banzai gli riferì la domanda del ragazzo. “Il compagno Moskvin ha assunto la posizione di Stalin, ma si è rifiutato di continuare la rivoluzione organizzata in tutta la Metro, denunciando ufficialmente l’Interstazionale e tagliando tutti i fondi preposti alle azioni rivoluzionarie. È un rinnegato e il tipo di persona che scende a compromessi. Noi compagni siamo fedeli al pensiero di Trotsky. Sarebbe come fare un parallelismo tra Castro ed Ernesto Guevara: è per questo motivo che il Che è sul nostro stendardo di guerra”, e indicò il triste straccio con un gesto trionfale. “Siamo rimasti fedeli al vero ideale rivoluzionario, al contrario dei collaborazionisti come il compagno Moskvin. Noi compagni condanniamo loro e la loro linea”. “Ah ah! E chi vi fornisce il carburante?”, aggiunse lo Zio Fyodor, facendo un tiro della sigaretta che aveva preparato poco prima. Il compagno Rusakov avvampò e lanciò un’occhiata brutale allo Zio Fyodor, che assunse una beffarda smorfia di disgusto e ispirò profondamente dalla sua sigaretta. Artyom capì poco della spiegazione del commissario, eccezion fatta per il dettaglio più importante: questa gente aveva poco a che fare con i Rossi che avevano intenzione di trafiggere le membra di Mikhail Porfirevich e di sparargli allo stesso tempo. Ciò lo rincuorò e, cercando di fare buona impressione, ammiccò: “Stalin, è colui che sta nel Mausoleo, vero?” Ma questa volta l’aveva detta grossa. Uno spasmo di rabbia deformò il bel viso coraggioso del compagno Rusakov, Banzai si voltò e persino lo Zio Fyodor si accigliò. “No, no! È vero! C’è Lenin nel Mausoleo!”, Artyom si corresse frettoloso. Le rughe arcigne sulla fronte del compagno Rusakov si rilassarono e poi affermò severo: “Hai ancora molto da imparare, compagno Artyom!” Artyom non desiderava che il compagno Rusakov gli insegnasse qualcosa, ma si trattenne e non rispose altro. Ne capiva veramente poco di politica, ma la materia stava cominciando a interessarlo, così attese che la tempesta si placasse e poi azzardò: “Allora perché combattete contro i fascisti? Intendo dire, anche io sono contro di loro, ma dopotutto voi siete dei rivoluzionari...” “Quei cani! A causa della Spagna, di Ernst Thälmann e della Seconda Guerra Mondiale!”, il compagno Rusakov sputò tra i denti serrati e, malgrado Artyom non avesse capito una parola, non aveva intenzione di dare una nuova dimostrazione della sua ignoranza. Quando versarono l’acqua bollente nelle tazze si ravvivarono un po’. Banzai continuò a porre domande stupide allo Zio Fyodor, fino a portarlo all’esasperazione, ovviamente solo per punzecchiarlo, mentre Maximka, che si era seduto vicino al compagno Rusakov, chiese a bassa voce: “Dimmi, compagno commissario, che ne pensano il marxismo e il leninismo dei mutanti senza testa? È una domanda che mi pongo da un po’. Voglio essere ideologicamente forte, ma su questo punto non ho trovato alcun appiglio”. I suoi denti splendenti brillarono quando sorrise, con uno sguardo colpevole. “Beh, compagno Maxim”, rispose il commissario dopo un momento di pausa. “Questa è una questione spinosa, amico mio”, e si mise a riflettere. Anche ad Artyom interessava sapere come venivano considerati i mutanti da un punto di vista politico, ma soprattutto gli sarebbe piaciuto sapere se esistevano davvero. Tuttavia, il compagno Rusakov rimase in silenzio e i pensieri di Artyom ripresero ad arrabattarsi per trovare una soluzione a ciò che aveva lasciato in sospeso ormai da diversi giorni: doveva arrivare alla Polis. Era stato salvato per miracolo, gli era stata offerta una seconda possibilità, forse l’ultima. Tutto il corpo gli doleva, faticava a respirare, mentre i sospiri più profondi lo facevano tossire; inoltre, non riusciva ad aprire un occhio. Ma desiderava così tanto rimanere con queste persone! Si sentiva molto più tranquillo e sicuro con loro, l’oscurità della galleria sconosciuta non si condensava attorno a lui, opprimendolo. I fruscii e gli scricchiolii che provenivano dalle viscere dei tunnel più neri non lo spaventavano, non lo mettevano in guardia: sperava che questa tregua potesse durare per sempre. Era così bello rivivere il momento del suo salvataggio. Malgrado la morte avesse già serrato la sua morsa di ferro sopra la sua testa, lo aveva solamente sfiorato e la paura appiccicosa, che gli aveva paralizzato le membra, era già del tutto evaporata. Le ultime tracce, nascoste sotto il suo cuore e il suo stomaco, erano state cancellate dal velenoso liquore fatto in casa del compagno Fyodor. Sì... Fyodor, l’amichevole Banzai e il serio commissario vestito di pelle, poi l’enorme Maxim-Lumumba... era così facile stare con loro, non si sentiva più così da quando era partito dalla VDNKh, cent’anni prima. Ormai non possedeva più nulla: la meravigliosa mitragliatrice, cinque caricatori, il passaporto, il cibo, il tè, due torce. Era tutto andato perduto. Lasciato ai fascisti. Gli erano rimasti solo una giacca, un paio di pantaloni e, in tasca, un bossolo ripiegato. Il boia gli aveva sussurrato: “Potrebbe sempre tornarti utile”. E adesso? Sarebbe potuto rimanere con i combattenti dell’Interstazionale, i brigadieri della... beh, non era importante. Vivere la loro vita e dimenticare la sua. No, mai. Non doveva fermarsi nemmeno per un minuto, non aveva tempo di riposare. Non ne aveva il diritto. Questa non era più la sua vita: dal momento in cui aveva accettato la proposta di Hunter aveva messo il suo destino nelle mani di altre persone. Ora era troppo tardi. Doveva andare. Non aveva altra scelta. Rimase seduto in silenzio per diversi minuti, senza pensare a niente di particolare. Ma, secondo dopo secondo, una cupa determinazione maturava in lui, nei suoi muscoli provati, nelle sue vene gonfie e doloranti. Era come un pupazzo a cui fosse stata estratta l’imbottitura: era divenuto un pezzo di stoffa informe che un’entità crudele aveva appeso a uno scheletro di metallo. Non era più lui, perché era stato sparpagliato in giro dalla corrente d’aria che soffiava in una galleria, insieme all’imbottitura del giocattolo; era stato diviso in particelle e ora qualcuno si era insediato sotto la sua pelle, una creatura che non voleva ascoltare la disperata supplica del suo corpo, sanguinante ed esausto; qualcuno che aveva schiacciato sotto i piedi il suo desiderio di resa, di rimanere dove si trovava, di riposarsi, di lasciare, di rinunciare prima che questo sforzo avesse la possibilità di assumere una forma completa e realizzata. Quest’altra persona aveva preso la decisione a livello del suo istinto, oltrepassando a piè pari la coscienza di Artyom, nella quale ora regnavano solo il silenzio e il vuoto più totale. Il solito dialogo interno si era interrotto. Era come se dentro Artyom fosse scattata un molla. Si alzò in piedi, con un movimento goffo e impacciato. Il commissario lo guardò sorpreso, mentre Maxim abbassò la mano sulla mitragliatrice. “Compagno commissario, posso... parlarti per un secondo?”, gli domandò Artyom con voce monotona. Anche Banzai si voltò, ansioso, lasciando in pace lo Zio Fyodor. “Sputa il rospo, compagno Artyom. Io e i miei combattenti non abbiamo segreti”, lo informò cauto il commissario. “Vedi, vi sono estremamente grato per avermi salvato. Ma non ho nulla con cui potervi ripagare. Mi piacerebbe moltissimo restare con voi, ma non posso. Devo proseguire. Io... devo farlo”. Il commissario non rispose. “Beh, e dove saresti diretto?”, si intromise inaspettatamente lo Zio Fyodor. Artyom serrò le labbra e abbassò lo sguardo. Nell’aria aleggiava uno strano silenzio. Aveva l’impressione che gli uomini lo stessero osservando; erano tesi e sospettosi e cercavano di indovinare quali fossero le sue intenzioni. Era un spia? Un traditore? Per quale motivo voleva mantenere il segreto? “Se non vuoi dircelo, non farlo”, lo Zio Fyodor fu conciliante. “Alla Polis”, Artyom non riuscì a fare a meno di comunicarglielo. Non voleva rischiare di perdere la loro fiducia nel solo interesse di una sciocca teoria cospiratoria. “Hai qualcosa da sbrigare laggiù?”, lo Zio Fyodor aveva uno sguardo innocente, ma si capiva che era curioso. Artyom assentì in silenzio. “Ed è urgente?”, l’uomo continuò a sondare il terreno. “Stai sicuro: noi non ti tratterremo. Se non ci vuoi raccontare quello che hai da fare, non ti preoccupare. In ogni caso, non possiamo lasciarti qui, nel bel mezzo della galleria! Vero ragazzi?”, e si voltò verso gli altri. Banzai annuì risoluto, Maximka allontanò le mani dalla canna della sua arma e anch’egli confermò. Poi fu il turno del compagno Rusakov. “Compagno Artyom, sei disposto a giurare sulla testa dei combattenti di questa brigata che ti hanno salvato la vita di non voler intralciare la causa rivoluzionaria?”, domandò in tono severo. “Lo giuro”, Artyom rispose prontamente. Non aveva alcuna intenzione di intralciare la rivoluzione. Aveva cose ben più importanti a cui pensare. Il compagno Rusakov lo osservò a lungo e infine pronunciò il suo verdetto: “Compagni combattenti! Personalmente, io credo al compagno Artyom. Vi chiedo di votare: desiderate aiutarlo a raggiungere la Polis?” Lo Zio Fyodor fu il primo ad alzare la mano e in quel momento Artyom sospettò che fosse stato lui a togliergli il cappio dal collo. Poi votò Maxim, mentre Banzai si limitò ad annuire. “Compagno Artyom, non lontano da qui c’è un passaggio sconosciuto ai più: congiunge la diramazione Zamoskvoretskaya alla linea Rossa”, spiegò il comandante. “Se ti portassimo laggiù, saresti già...” Non riuscì a terminare la frase perché Karatsyupa, che fino a quel momento era rimasto sdraiato tranquillo ai suoi piedi, si alzò sulle zampe e cominciò ad abbaiare in maniera assordante. Con un movimento fulmineo, il compagno Rusakov estrasse la pistola dalla fondina. Artyom non ebbe il tempo di vedere ciò che fecero gli altri: Banzai aveva già tirato il cavo per avviare il motore; Maxim aveva assunto nuovamente la sua posizione nella parte posteriore, mentre lo Zio Fyodor aveva estratto dalla scatola in cui teneva il suo liquore fatto in casa una bottiglia con un cerino che fuoriusciva dal collo. A quel punto la galleria scendeva, perciò la visibilità era pessima, il cane continuava a tirare il guinzaglio e Artyom si sentiva inquieto. “Date una mitragliatrice anche a me”, sussurrò. Non lontano da loro, una potente torcia si illuminava e si spegneva, poi udirono qualcuno che dava ordini a voce altissima. Scarponi pesanti rimbombavano faticosi sulle traversine, qualcuno inciampò e tutto tornò silenzioso. Il commissario teneva con le mani serrate il muso di Karatsyupa, ma il cane riuscì a liberarsi dalla presa e si mise di nuovo ad abbaiare. “Non si avvia!”, borbottò Banzai abbattuto. “Dobbiamo spingerlo!” Artyom fu il primo a scendere dal carrello, seguito a ruota dallo Zio Fyodor e da Maxim. Appoggiarono i piedi contro le traversine per spingere con maggiore forza, così riuscirono a far muovere in avanti quell’enorme mezzo. Tuttavia, si spostava troppo lentamente e quando riuscirono a risvegliare completamente il motore, che ripartì emettendo un rumore simile a dei colpi di tosse, gli scarponi dei nemici erano già fin troppo vicini. “Fuoco!”, l’ordine arrivò dall’oscurità e lo spazio limitato all’interno del tunnel si riempì di un frastuono incredibile. Vennero sfiorati da almeno quattro cartucce, che colpivano casualmente lo spazio attorno a loro, rimbalzando, emettendo scintille, colpendo i tubi e facendoli risuonare. Artyom pensava che ormai non avessero più via d’uscita, ma Maxim si alzò in piedi, tenne la mitragliatrice tra le mani e continuò a sparare a lungo. Le armi automatiche non si sentivano più. Ormai il carrello motorizzato si muoveva con maggiore facilità e dovettero correre per raggiungerlo e saltarci sopra. “Si stanno ritirando! Proseguiamo a tutta velocità!”, l’urlo proveniva da dietro, mentre le mitragliatrici nemiche avevano ripreso a rombare, ancora più forti di prima, ma la maggior parte dei proiettili andava a colpire le pareti o il soffitto della galleria. Lo Zio Fyodor accese velocemente il moccolo della bottiglia, lo avvolse con degli stracci e lo lanciò sul sentiero. Un minuto più tardi scorsero un bagliore e udirono lo stesso scoppio che Artyom aveva sentito quando si trovava sulla piattaforma con il cappio al collo. “Un’altra! Più fumo!”, ordinò il compagno Rusakov. Un carrello motorizzato è un vero miracolo, rifletté Artyom mentre gli inseguitori perdevano terreno cercando di farsi strada in una cortina di fumo. Il veicolo si spostava con facilità e spaventava, scacciandoli via, i passanti che lo fissavano. Entrò repentino alla Novukuznetskay, nella quale il compagno Rusakov si rifiutò categoricamente di fermarsi. Superarono la stazione tanto veloci che il ragazzo non ebbe nemmeno il tempo di capire che aspetto avesse. Tuttavia, non aveva nulla di particolare, a parte la scarsa illuminazione. Vi erano anche diverse persone, ma Banzai gli sussurrò che quello era un luogo insolito e che anche gli abitanti erano alquanto strambi: l’ultima volta che avevano provato a fermarsi se n’erano seriamente pentiti ed erano riusciti a malapena a uscirne vivi. “Scusaci, compagno, non saremo in grado di aiutarti come speravamo”, il compagno Rusakov si rivolse ad Artyom con un tono più confidenziale rispetto a prima. “Non riusciremo a tornare qui per un po’, perciò dobbiamo recarci alla nostra base, alla Avtozavodskaya. Se lo desideri, puoi unirti alla brigata”. Di nuovo, Artyom dovette farsi coraggio e rifiutare l’offerta, ma questa volta fu più semplice. Venne pervaso da una sorta di animata disperazione: tutto il mondo era contro di lui, gli stava andando tutto storto. Malgrado ciò, gli ostacoli che le gallerie avevano posto sul cammino di Artyom avevano risvegliato in lui una rabbia tale da rianimare la sua debole vista di un fuoco ribelle, il quale pareva divorare le paure, il senso del pericolo, la ragione e la forza. “No”, affermò calmo e convinto. “Devo andare”. “In tal caso, proseguiremo insieme fino alla Paveletskaya poi le nostre strade si divideranno”, gli spiegò il commissario, che fino a quel momento non aveva proferito parola. “È un peccato, compagno Artyom. Abbiamo bisogno di combattenti come te”. Vicino alla Novokuznetskaya, la galleria si biforcava e il carrello prese il sentiero di sinistra. Quando Artyom domandò cosa si trovasse in quello di destra, gli spiegarono di non poterlo imboccare, perché gli era vietato: un centinaio di metri più avanti si trovava un posto di blocco dell’Hansa, una vera e propria fortezza. Quella galleria che aveva un aspetto del tutto ordinario, in realtà conduceva direttamente a tre stazioni dell’Anello: l’Oktyabrskaya, la Dobryninskaya e la Paveletskaya. L’Hansa non aveva alcuna intenzione di distruggere quel minuscolo passaggio, poiché i collegamenti di trasporto al suo interno venivano usati esclusivamente dagli agenti segreti dell’organizzazione. Ma se qualcuno cercava di avvicinarsi a quel posto di blocco, sarebbe stato immediatamente ucciso, senza nemmeno avere la possibilità di spiegarsi. Dopo aver percorso il passaggio di sinistra arrivarono alla Paveletskaya. Artyom rifletté che i suoi amici della VDNKh avevano ragione quando gli raccontavano che in passato si poteva percorrere l’intera Metro in una sola ora. Lui non ci aveva mai creduto. Ah! Se solo avesse avuto un carrello motorizzato come questo... Comunque a lui non sarebbe servito a molto, poiché nella Metro c’erano moltissimi luoghi che non potevano essere superati così, come se niente fosse. Non era il caso di mettersi a sognare di possedere un marchingegno del genere: nel suo nuovo mondo non avrebbe più avuto comodità come questa e ogni passo gli avrebbe richiesto sforzi incredibili e dolori lancinanti. I vecchi tempi erano andati; il mondo magico e meraviglioso era scomparso, non esisteva più. Non aveva senso stare a lamentarsi per il resto dei suoi giorni, al contrario, doveva sputare sulla tomba della sua vecchia vita senza mai voltarsi indietro. CAPITOLO 10 : NO PASARÀN! Non c’erano pattuglie visibili all’entrata della Paveletskaya, solo un gruppo disordinato di persone, sedute a trenta metri dall’uscita della stazione, che si spostarono di lato per lasciare passare il carrello dei rivoluzionari, osservandolo con rispetto. “Questa stazione è disabitata?”, si sorprese Artyom, cercando di rimanere calmo: non voleva essere lasciato da solo in una stazione deserta, senza armi, cibo e documenti. “La Paveletskaya?”, il compagno Rusakov lo guardò meravigliato. “Certo che no!” “Allora perché non ci sono guardie di confine?”, insistette il ragazzo. “Perché questa è la Pa-ve-lets-ka-ya!”, li interruppe Banzai, scandendo la parola in sillabe per dare maggiore importanza alla frase. “Chi oserebbe?” In quel momento Artyom ripensò a quanto fosse vero ciò che affermava il saggio e cioè che sapeva di non sapere. Parlavano tutti dell’inviolabilità della Paveletskaya come se non ci fosse bisogno di ulteriori spiegazioni, come se fosse qualcosa che tutti conoscevano. “Beh, vuoi dire che non ne sai niente?”, Banzai era incredulo. “Aspetta e vedrai!” Alla vista della Paveletskaya l’immaginazione di Artyom cominciò a galoppare: i soffitti erano talmente alti che le luci traballanti delle fiaccole che sporgevano dagli anelli al muro non raggiungevano il soffitto e ciò creava un’atmosfera spaventosa ma affascinante: sopra le loro teste si stagliava l’infinito. Enormi archi tondi erano supportati da colonne sottili che stranamente riuscivano a sostenerne il peso. Lo spazio tra un arco e l’altro era abbellito da ornamenti in bronzo, ormai ossidati, ma sempre evocatori di un grande passato. Sebbene si trattasse del tradizionale simbolo di un impero distrutto e pressoché dimenticato, la falce e il martello incorniciati dalle volte sembravano fieri e spavaldi, così come lo erano quando erano stati forgiati. Una fila immensa di colonne disseminate di torce tremolanti e color del sangue si disperdeva nella foschia lontana e, anche laggiù, pareva interminabile. Le fiamme che lambivano le eleganti colonne in marmo a un centinaio o a un migliaio di passi dal luogo in cui si trovava il ragazzo non sembravano in grado di penetrare le tenebre dense, quasi palpabili. Sicuramente questa stazione era stata un castello per ciclopi, per questo tutto era così enorme... Nessuno osava invaderla solo perché era così bella? Banzai mise il motore in folle e il carrello rallentò sempre più, fino quasi a fermarsi, mentre Artyom teneva lo sguardo fisso su quella stazione fuori dal comune. Cosa aveva di strano? Perché nessuno attaccava mai la Paveletskaya? Cosa aveva di tanto sacro? Di sicuro non era perché pareva un posto uscito dalle favole piuttosto che un edificio costruito dall’industria del trasporto... Una folla di ragazzi di tutte le età, sporchi e vestiti di stracci, si riunirono attorno al mezzo ormai fermo; lo osservavano con invidia e un bambino cercò persino di saltare sui binari e di toccare il motore. Fece tutto in un rispettoso silenzio, finché Fyodor non lo scacciò. “Ci siamo, compagno Artyom. Qui le nostre strade si dividono”, il comandante interruppe i pensieri del ragazzo. “Ne ho già discusso con gli altri compagni e abbiamo deciso di farti un piccolo presente. Ecco a te!”, e porse ad Artyom una mitraglietta, che con tutta probabilità era appartenuta a una delle guardie di sicurezza rimaste uccise. “C’è dell’altro”, mise nelle mani del giovane una lampada, la stessa che aveva utilizzato il fascista con l’uniforme nera e i baffi. “Questi sono tutti trofei, quindi cerca di trarre da essi la giusta dose di coraggio. Ti appartengono di diritto. Vorremmo rimanere più a lungo, ma non possiamo attardarci. Chissà fino a dove ci seguiranno quei bastardi fascisti! Di sicuro non oseranno mettere piede alla Paveletskaya”. Nonostante la risolutezza acquisita nella sua nuova vita, Artyom sentì che il cuore gli pesava più del normale quando Banzai gli strinse la mano, augurandogli di portare la termine la sua missione. Maxim gli diede un’amichevole pacca sulla spalla, mentre lo Zio Fyodor gli lanciò la mezza bottiglia della sua pozione, non sapendo cos’altro potergli regalare: “Prendila, amico mio. Ci incontreremo di nuovo e saremo vivi... non periremo!” Il compagno Rusakov gli diede di nuovo la mano e il suo bel viso mascolino si fece serio: “Compagno Artyom! Ci stiamo per separare, ma ho due cose da dirti: prima di tutto, credi nella tua stella. Come disse il compagno Ernesto Che Guevara, Hasta la victoria siempre! E poi... NO PASARÁN!” Tutti gli altri soldati alzarono il pugno destro e ripeterono lo slogan: “No pasarán!” Artyom non poté far altro che alzare il pugno a sua volta e ripetere le stesse parole, con altrettanta decisione e fervore rivoluzionario: “No pasarán!”, malgrado questo rituale fosse per lui pura e semplice pomposità. Ma non voleva rovinare il momento solenne della loro separazione con domande stupide. Apparentemente eseguì la cerimonia secondo i canoni, perché il compagno Rusakov lo guardò con orgoglio e soddisfazione, poi si accomiatò con fare solenne. Il motore si avviò ancor più rumorosamente di prima e, avvolto da una nuvola di fumo grigio-azzurro e accompagnato da una scorta di bambini divertiti, il carrello svanì nell’oscurità. Artyom rimase di nuovo solo e più lontano da casa di quanto fosse mai stato. Mentre vagava sulla piattaforma, il primo dettaglio che notò furono gli orologi: Artyom ne contò subito quattro. Alla VDNKh il tempo era un simbolo speciale, come i libri e i tentativi di costituire scuole per i bambini, cioè la dimostrazione che gli abitanti della stazione non volevano degenerare, che erano ancora degli esseri umani. Tuttavia, sembrava che qui gli orologi avessero un altro tipo di ruolo, più cruciale. Si guardò attorno ancora per un po’ e notò altri particolari fuori dall’ordinario: prima di tutto non c’erano quartieri in cui viveva la gente, come nelle altre stazioni, eccetto qualche convoglio sul secondo binario e nel tunnel: all’interno dell’atrio era visibile solo una piccola parte del treno, per questo Artyom non se ne accorse subito. C’erano ovunque commercianti di qualsiasi tipo, oltre a molti laboratori, ma non c’era una sola tenda in cui vivere, non un semplice riparo dentro il quale passare la notte. Alcuni mendicanti e barboni riposavano in giacigli fatti di cartone. Di tanto in tanto, la gente che girovagava per la stazione si avvicinava agli orologi; coloro che li portavano anche al polso li controllavano ansiosi, paragonando l’orario ai numeri rossi visualizzati sul pannello per poi andarsene in tutta fretta. Artyom meditò che se Khan fosse stato lì con lui, sarebbe stato interessante sentire che ne avrebbe pensato. Al contrario della Kitay-Gorod, stazione in cui la gente dimostrava un vivo interesse nei confronti dei viaggiatori, cercava di rifilargli qualcosa da mangiare, di vendergli qualcosa, di fargli visitare qualche luogo, qui tutti parevano occuparsi dei loro affari. Non si avvicinarono nemmeno ad Artyom e il suo senso di solitudine, inizialmente nascosto dalla curiosità, si fece sentire sempre di più. Il ragazzo cercò di scacciare la crescente depressione e continuò a guardarsi intorno; si sarebbe aspettato di vedere gente diversa, con una fisionomia particolare, poiché la vita in una stazione del genere non poteva far altro che lasciare un segno evidente. A prima vista, le persone erano affaccendate, urlavano, lavoravano, litigavano, come in qualsiasi altro luogo. Ma osservandole con maggiore attenzione, sentì i brividi corrergli lungo la spina dorsale... Il numero dei giovani storpi e anormali era allarmante: uno non aveva le dita, un altro era ricoperto da piaghe disgustose, con un moncherino al posto di una terza mano amputata. Spesso gli adulti erano calvi e malaticci. Non si vedevano persone forti e sane. Il loro aspetto rachitico e deformato offriva un contrasto doloroso con l’enorme stazione oscura in cui vivevano. Nel bel mezzo della vasta piattaforma si trovavano due aperture rettangolari che conducevano nelle profondità, verso i passaggi che portavano all’Anello e quindi all’Hansa. Tuttavia, non c’erano né guardie di confine dell’organizzazione e nemmeno posti di blocco, così come ve n’erano alla Prospekt Mira; infatti una volta qualcuno aveva riferito ad Artyom che l’Hansa teneva tutte le stazioni adiacenti in un pugno di ferro. No, questo luogo aveva qualcosa di strano. Non si avventurò dalla parte opposta dell’androne. Prima di tutto, usò cinque cartucce per acquistare una scodella di funghi tagliati e grigliati e un bicchiere di acqua putrida, dal sapore amaro. Ingurgitò la brodaglia disgustato, seduto su una scatola di plastica rovesciata che in passato aveva contenuto bottiglie vuote. Poi si diresse verso il treno, sperando di poter riposare un po’ al suo interno, dato che le forze lo stavano abbandonando e, più si guardava attorno, peggio si sentiva. I convogli erano molto diversi da quelli della KitayGorod: erano distrutti e completamente vuoti, i sedili bruciati e fusi insieme, i divanetti di pelle soffice scardinati e lanciati da qualche parte, c’erano macchie di sangue dappertutto e bossoli che baluginavano oscure a terra. Questo luogo non era un rifugio, ma una fortezza che aveva dovuto resistere a più di un assalto. Artyom non si attardò attorno al treno, ma quando tornò sulla piattaforma, riconobbe a stento la stazione. Le bancarelle erano vuote e il chiasso si era del tutto calmato; c’era solo qualche vagabondo sulla piattaforma, non lontano dal passaggio centrale. Insomma, non c’era più anima viva. Inoltre, la luce si era notevolmente affievolita, le torce sul lato da cui era entrato in stazione erano state spente e ne rimanevano accese solo alcune nella parte centrale dell’atrio. In lontananza, dalla parte opposta, le braci di un fuoco stavano ancora scoppiettando. L’orologio indicava che erano da poco passate le otto di sera. Cos’era accaduto? Artyom cercò di sbrigarsi, per quanto il dolore fisico glielo permettesse. Il passaggio era chiuso da entrambe le parti e non con le solite porte di metallo, bensì con cancelli di ferro resistente. Lo stesso valeva per la seconda scala, solo che una delle inferriate era aperta per metà. Al di là si distingueva una massiccia rete metallica saldata, come quelle che componevano le celle della Tverskaya, ma con rinforzi più solidi. Inoltre c’era un tavolo, illuminato da una piccola lampada, al quale sedeva una guardia con un’uniforme sbiadita color grigio-azzurro. “Dopo le venti l’accesso è vietato”, disse seccamente, quando il ragazzo chiese il permesso di entrare. “Il cancello riapre alle sei del mattino”, poi voltò il viso a indicare che la conversazione era terminata. Artyom era incredulo: perché la vita di questa stazione si concludeva dopo le otto di sera? Cosa poteva fare adesso? I barboni che si erano infilati nei loro cartoni avevano un aspetto ripugnante, non gli si voleva avvicinare; perciò decise di fare un tentativo al fuoco da campo che brillava all’altro capo dell’atrio. Anche da lontano era evidente che il fuoco non fosse attorniato da un gruppo di mendicanti, ma piuttosto da guardie di confine o da personaggi di quel tipo: dalle ombre disegnate dal fuoco sembravano uomini forti, nelle mani dei quali si distinguevano i contorni marcati delle armi automatiche. Ma cosa dovevano controllare sulla piattaforma? I posti di guardia dovevano essere piazzati all’interno delle gallerie e all’entrata delle stazioni, il più lontano possibile. Qui invece... se una qualche creatura si fosse insinuata nel tunnel o se i banditi l’avessero attaccato, gli uomini in servizio non avrebbero potuto farci niente. Avvicinandosi, Artyom notò un altro particolare: al di là del fuoco, brillava un enorme raggio di luce che a intermittenza illuminava verso l’alto. Sembrava che venisse spento nello stesso momento in cui era stato acceso; inoltre, contrariamente a tutte le leggi della fisica, non colpiva il soffitto, ma spariva dopo un paio di metri. Il riflettore era illuminato solo di tanto in tanto, a intervalli precisi, forse per questo Artyom non l’aveva notato prima. Cosa diamine poteva essere? Si appropinquò al fuoco, salutò tutti in maniera educata, spiegò che era un viaggiatore e che non era a conoscenza dell’orario di chiusura dei cancelli, perciò non era riuscito a uscire dalla stazione. Poi chiese se si poteva riposare lì per un po’, insieme ai pattugliatori. “Riposarti?”, sogghignò la sentinella più vicina a lui. Era arruffato, aveva i capelli scuri e un grosso naso; non era alto ma sembrava molto forte. “Questo non è il posto adatto dove riposare, ragazzo. Ti va bene se riesci a sopravvivere fino al mattino”. Così gli domandò cosa ci fosse di tanto pericoloso nel sedersi davanti a un fuoco nel bel mezzo della piattaforma, ma l’uomo non rispose, fece solo un cenno con il capo guardando alle spalle del ragazzo, dove era acceso il riflettore . Gli altri erano impegnati nelle loro conversazioni e non prestarono la benché minima attenzione ad Artyom. Quindi decise che avrebbe scoperto da solo cosa succedeva laggiù e si incamminò in direzione della luce. Ciò che vide lo sorprese e tutto gli fu improvvisamente più chiaro. Alla fine dell’atrio c’era una minuscola cabina, come quelle che di tanto in tanto si trovano nei pressi delle scale mobili per ottenere il permesso di passare sulle altre linee. Tutt’intorno erano ammassati dei sacchi, spesso rinforzati con enormi lamiere di ferro; uno dei pattugliatori impugnava un tipo d’arma dall’aspetto formidabile, mentre l’altro era seduto nella cabina, sulla quale era stato montato il riflettore, che era puntato verso l’alto. Verso l’alto! Senza protezioni, né barriere, i gradini della scala mobile cominciavano dietro la cabina e arrivavano fin su, in superficie. Il raggio del riflettore era diretto proprio lassù, controllava ansioso tutte le pareti, come se cercasse di trovare qualcuno al buio. Al contrario, riusciva solo a illuminare una sorta di lanterne marroni, il soffitto umido, da cui si staccavano enormi pezzi di intonaco, ma oltre... nessuno riusciva a vedere. All’improvviso il puzzle si ricompose. Per una qualche ragione, la protezione di metallo che solitamente separava la stazione dalla superficie non esisteva più, mancava sia dalla parte della piattaforma che sopra di essa. La Paveletskaya era in contatto diretto con il mondo esterno ed era come se i suoi abitanti vivessero nella paura costante di poter essere attaccati. Respiravano aria contaminata e bevevano acqua contaminata, per questo aveva un sapore tanto strano. Perciò qui si erano verificate numerosissime mutazioni tra i giovani, molte più che alla VDNKh, per esempio. Per la stessa ragione gli adulti sembravano malati: i loro crani erano canuti e lucidi, i loro corpi si consumavano e invecchiavano precocemente. Erano divorati dalle radiazioni, giorno dopo giorno. Tuttavia, il quadro non era completo: ciò non spiegava il fatto che l’intera stazione “moriva” dopo le otto di sera e che l’ufficiale di servizio gli avesse augurato di riuscire a sopravvivere fino al mattino. Tremante, Artyom rivolse all’uomo seduto alla vedetta. “Buona sera”, l’uomo rispose al suo saluto. Era sulla cinquantina, ma aveva perso gran parte dei capelli; quelli che gli rimanevano erano grigi, aggrovigliati sulle tempie e sulla nuca. I suoi occhi scuri scrutarono curiosi Artyom, mentre il modesto giubbotto antiproiettile, anche se completamente abbottonato, non nascondeva la pancia rotonda. Al collo portava un binocolo e un fischietto. “Siediti con me”, e indicò ad Artyom il sacco di sabbia più vicino. “Quei ragazzi laggiù si stanno divertendo alla grande e mi hanno lasciato qui da solo. Io mi sto annoiando a morte. Facciamo due chiacchiere. Ehi, hai preso a pugni qualcuno...?” Così cominciò la loro conversazione. “Come vedi, qui non siamo stati in grado di sistemare la stazione in maniera decente”, spiegò tristemente l’ufficiale, puntando il dito verso l’apertura che portava alla scala mobile. “Ci vorrebbe il cemento armato, non il ferro. Ci abbiamo provato, con il ferro, ma non ha funzionato. In autunno viene spazzato via tutto dall’acqua. Noi costruiamo la protezione e lei la distrugge... è successo già diverse volte, sono morti in tantissimi. Da allora, viviamo così. La vita in questa stazione non è tranquilla come nelle altre. Siamo sempre all’erta, perché quella feccia potrebbe attaccarci da un momento all’altro, basta che sia sera. Durante il giorno le creature non ci infastidiscono, credo che vadano a dormire oppure in perlustrazione della superficie. Ma quando scende la notte, la situazione si fa disperata. Ci siamo dovuti adattare e dopo le otto di sera si rifugiano tutti nel passaggio, dove si trovano le tende. Sulla piattaforma restano solo coloro che rimangono di pattuglia. Aspetta un attimo...”, si interruppe, spostò un interruttore sul quadro di comando e il riflettore prese vita, luminoso come non mai. La conversazione riprese solo quando il raggio bianco si spense, dopo aver perlustrato tutte le tre scale mobili, il soffitto e i muri. “Là sopra”, l’ufficiale di servizio indicò il soffitto con un dito “c’è la Stazione ferroviaria Paveletskaya. Per lo meno, si trovava lassù. Ora è un posto dimenticato da Dio. Non ho idea di dove siano finiti i binari, so solo che vi accadono cose orribili. Ogni tanto si sentono rumori che ti fanno gelare il sangue nelle vene. E quando si intrufolano fin quaggiù...”, si interruppe, poi continuò dopo un minuto: “Noi, quelle creature che scendono dalla stazione ferroviaria, li chiamiamo i Nuovi. Vivere qui non è poi così terribile. Beh, a dire la verità, alcuni dei Nuovi più forti sono riusciti ad abbattere questo sbarramento. Hai avuto modo di dare un’occhiata al treno laggiù, quello uscito dai binari? Ecco, sono arrivati fin là. Siamo riusciti a non farli procedere oltre, più sotto, dove si trovano le donne e i bambini, perché se i Nuovi vi arrivassero sarebbe la fine. I nostri uomini lo avevano capito, perciò si sono ritirati all’interno del treno, dove sono riusciti a far fuori alcune creature. Ma loro... ne sono sopravvissuti solo due su dieci. Uno dei Nuovi è riuscito a svignarsela, in direzione della Novokuznetskaya. Alcuni uomini avevano deciso di inseguirlo il giorno successivo, anche perché si era lasciato dietro una visibile scia di bava; poi però aveva deviato in una galleria laterale e non abbiamo osato andargli dietro. Avevamo già subito abbastanza perdite”. “Ho sentito dire che nessuno attacca mai la Paveletskaya”, ricordò Artyom. “È vero?” “Ma certo”, l’ufficiale annuì serio. “Chi oserebbe infastidirci? Se non ci fossimo noi a difendere la stazione, quelle creature si intrufolerebbero all’interno e invaderebbero la linea. No, nessuno alzerà mai un dito contro di noi. L’Hansa ci ha ceduto la maggior parte di quel passaggio, fino alla fine del loro fortino. Ci hanno fornito le armi, cosicché li potessimo proteggere. Te lo dico io, adorano rifilare agli altri il lavoro sporco! A proposito, come ti chiami? Io sono Mark”. Artyom gli comunicò il suo nome. “Aspetta un attimo, Artyom, c’è qualcosa che si muove là in fondo”, continuò Mark e riaccese veloce il riflettore. “No, forse è solo la mia fantasia”, disse incerto dopo qualche istante. Gradualmente, Artyom veniva pervaso da un’oppressiva sensazione di pericolo. Come Mark, anche lui osservava con attenzione la zona sopra le loro teste, ma dove la sentinella scorgeva l’ombra di una lampada rotta, ad Artyom pareva di intravvedere sagome sinistre e fantastiche, immobili nell’abbagliante raggio di luce. All’inizio credette che la sua immaginazione gli stesse giocando brutti scherzi, ma uno degli strani contorni si spostò quasi impercettibilmente quando la luce lo colpì per un momento. “Aspetta...”, sussurrò. “Prova in quell’angolo, vicino a quella crepa. Svelto!” Come raggelato dalla luminosità del riflettore, in lontananza, a circa metà della scala mobile, qualcosa di grosso ma ossuto si fermò per un momento, poi si mise a scendere la scala, repentino. Mark afferrò il fischietto, che per poco non gli cadde di mano, e ci soffiò dentro con tutta la forza di cui fu capace. Un secondo dopo, gli uomini seduti attorno al fuoco si alzarono e si misero veloci in posizione. Allora Artyom notò un secondo riflettore, che emetteva una luce più fioca, ma che era assemblato in maniera intelligente con una mitragliatrice insolitamente pesante. Il ragazzo non aveva mai visto nulla di simile: l’arma aveva una lunga canna con un’avancarica a capsula; il carrello era in rete, mentre i proiettili scorrevano con facilità nella cartucciera splendente e ben oliata. “Laggiù! A dieci metri!”. Il tizio magro dalla voce rauca seduto vicino a Mark cercò il Nuovo con il riflettore. “Dammi il binocolo... Lekha! A dieci metri, a destra!” “Eccolo! Veniamo a prenderti, dolcezza... stai un po’ fermo”, borbottò il mitragliere, puntando la sua arma alla scura ombra nascosta. “Ci sono!” Il frastuono assordante della mitragliatrice rimbombò attorno a loro; al decimo metro una lampada venne ridotta in mille pezzi, mentre più sopra qualcosa emetteva un grido straziante. “Sembra che ci siamo riusciti”, dichiarò il tizio con la voce roca. “Ok, datemi ancora un po’ di luce... Eccolo lì, è a terra. È finito, quel parassita”. Ma sopra di loro si udirono gemiti intensi, quasi umani, che durarono a lungo. Artyom aveva i nervi a fior di pelle. Quando propose di finire il Nuovo perché non soffrisse più, loro gli risposero: “Se lo desideri, vai, uccidilo. Qui non siamo al poligono di tiro, ragazzo. Abbiamo bisogno del maggior numero di cartucce possibili!” A Mark venne dato il cambio e lui e Artyom raggiunsero il fuoco, da cui l’uomo accese una sigaretta, mentre il ragazzo si mise ad ascoltare le conversazioni. “Sentite questa: ieri Lekha ci stava raccontando degli Hare Krishna”, un uomo enorme con la fronte bassa e il collo potente parlava con una voce da baritono: “Stanno alla Campo d’ottobre e hanno intenzione di recarsi all’Istituto Kurchatov per far scattare il reattore nucleare e portare la luce in tutta la Metro, ma non sono ancora riusciti a organizzarsi. Questo mi fa pensare a quello che mi è successo quattro anni fa, quando vivevo ancora alla Savelovskaya: un giorno mi stavo preparando per andare alla Belorusskaya. Sarei passato dalla Novoslobodskaya, perciò percorsi la zona dell’Hansa. Arrivai alla Belorusskaya, cercai subito l’uomo che dovevo incontrare, sbrigammo i nostri affari e decisi che avremmo dovuto festeggiare bevendo qualcosa. Ma lui mi disse: ‘Ti conviene fare attenzione, da queste parti gli ubriachi scompaiono spesso’ e io gli risposi: “Ma piantala! Non puoi dire di no!’ così ci scolammo una bottiglia insieme. L’ultima cosa che ricordo è che il mio amico si era messo a quattro zampe e urlava: ‘Sono il Lunokhod-1, il rover lunare!’ Poi mi svegliai e... Signore santissimo! Ero legato, imbavagliato, la zucca rapata, rinchiuso in una specie di stanzino, che forse in passato serviva alla polizia per appostarsi. ‘Che disastro!’ dissi tra me. Dopo mezz’ora dei mostri mi vennero a prelevare e mi trascinarono per il bavero fino nell’atrio. Non avevo idea di dove mi trovassi; tutti i cartelli con i nomi erano stati distrutti, le pareti erano imbrattate di uno strano materiale, mentre il pavimento era pieno di sangue. C’erano fuochi accesi ovunque. Avevano scavato buche in tutta la stazione e c’era un buco più profondo degli altri, di almeno venti metri, se non trenta. A terra e sul soffitto erano state disegnate delle stelle, tutte su un’unica fila, proprio come fanno i bambini. A quel punto mi domandai: ‘Mi hanno catturato i Rossi?’ ma poi girai la testa e capii che non era così. Mi condussero sul bordo della fossa, calarono una fune e mi ordinarono di scendere, incitandomi con un fucile d’assalto. Diedi un’occhiata giù: sul fondo c’erano moltissime persone, che scavavano la buca aiutandosi con pezzi di metallo e badili. La terra veniva issata per mezzo di un verricello, caricata su vagoni e spostata in qualche altro luogo. Non riuscivo a reagire finché quei tizi mi minacciavano con i loro fucili d’assalto. Erano dei pazzi, tutti tatuati dalla testa ai piedi, come se fossero una sorta di banda criminale. Mi chiesi se fossi finito nella Zona e se le autorità stessero cercando di tagliare la corda; quei fanatici erano soltanto il loro mezzo per aprirsi la strada. Ma poi ho capito, erano tutte sciocchezze. In quale zona della Metropolitana non c’è polizia? Gli riferii di soffrire di vertigini: sarei caduto e mi sarei spaccato la testa e a quel punto non gli sarei più servito a niente. Si consultarono e mi misero al lavoro ai carrelli, a caricare la terra che veniva estratta dal baratro. Quella ciurmaglia mi aveva ammanettato, legato a una catena e ora si aspettava che sarei stato disposto a caricare i carrelli? Nemmeno per sogno! Però non riuscivo ancora a comprendere cosa stessero facendo. Non esagero: non fu per niente facile”, così dicendo scrollò le spalle gigantesche. “Insieme a me c’erano anche dei tizi più magrolini, che di tanto in tanto svenivano di faccia nella terra. Quelle teste rasate li raccoglievano e li portavano fino alla scala. Una volta sono passato da quelle parti e ho dato un’occhiata: c’era un tizio, un vero balordo, di quelli che si vedevano sulla Piazza Rossa. Stava nel luogo in cui si liberavano di coloro che non gli servivano più. Il tizio aveva un’ascia smisurata, c’era sangue dappertutto e le teste tagliate erano infilzate su dei pali. Per poco non vomitavo. E allora pensai: ‘No, meglio darsela a gambe prima che mi uccidano e impalino anche me’”. “Va bene, ma di chi si trattava?”, lo interruppe impaziente l’uomo dalla voce rauca, che poco prima aveva maneggiato il riflettore. “Lo chiesi all’uomo che lavorava al carrello con me. E sai chi erano? I satanisti! Hai capito? Avevano deciso che la fine del mondo fosse già arrivata, che la Metropolitana fosse la porta che conduceva all’inferno. Mi riferì anche qualcosa a proposito di un cerchio, ma non ricordo”. “Beh, più che una porta è un cancello”, precisò il mitragliere. “Sì, è vero. Quindi, la Metropolitana è il cancello che conduce all’inferno, il quale si trova solo qualche metro più in sotto. Il Diavolo in persona li sta aspettando e loro lo devono raggiungere. Per questo scavano. Da allora sono trascorsi quattro anni. Forse ci sono già arrivati”. “Dove si trova questo luogo?”, domandò il mitragliere. “E che ne so! Dio solo lo sa! Beh, io per lo meno sono riuscito a uscirne. Mi lanciai in un vagone mentre la guardia era girata di spalle e mi coprii con del terriccio. Viaggiai a lungo all’interno del carrello, poi scaricarono il contenuto in una fossa. Io svenni e quando mi ripresi sgattaiolai via, seguii dei binari e continuai a camminare, sempre dritto. Ma poi quei binari ne incrociarono degli altri e persi il senso dell’orientamento. A quel punto qualcuno mi raccolse e quando mi svegliai mi trovavo alla Dubrovka! Il mio salvatore, quel brav’uomo, se n’era già andato. Pensai: ‘Ma dove diavolo mi trovo?’...” Gli uomini si misero a parlare del fatto che girava la voce che alla Rimskaya, nei pressi di piazza Ilich, fosse scoppiata un’epidemia, causando la morte di moltissima gente, ma Artyom non prestò loro attenzione. L’idea che la Metro fosse il passaggio per arrivare all’inferno, oppure ne fosse addirittura il suo primo girone, lo ipnotizzò, mentre un’immagine bislacca prendeva forma davanti ai suoi occhi: centinaia di persone che si muovono operose come delle formiche e che scavano a mani nude una buca infinita, un pozzo che non conduce da nessuna parte, fino al giorno in cui uno dei pezzi di metallo che stanno utilizzando per scavare non si infila nel suolo, al contrario ne fuoriesce in modo allarmante, finché l’inferno e la Metropolitana si uniscono, diventando una cosa sola. A quel punto realizzò che in questa stazione la gente viveva quasi come alla VDNKh: creature mostruose attaccavano di continuo, arrivavano dalla superficie e loro dovevano affrontare da soli questa offensiva. Ma se la Paveletskaya avesse fallito, quei mostri si sarebbero addentrati in tutta la loro linea. Questo significava che, contrariamente a quanto aveva ritenuto in precedenza, la VDNKh non era la sola ad avere un ruolo tanto importante. Chissà quante altre stazioni come quelle c’erano nella Metro: ciascuna di esse doveva prendersi cura di se stessa e combattere, non per la tranquillità generale ma per la propria salvezza. Si poteva arretrare, ritirarsi verso il centro, far saltare in aria la galleria lasciata alle spalle, ma poi si sarebbe rimasti in uno spazio vitale inferiore, finché tutti quelli che erano riusciti a sopravvivere dovevano stiparsi in un minuscolo quadrato di terra, attaccando alla gola il loro vicino. Ma se la VDNKh non era niente di speciale, se c’erano altre aperture verso la superficie che era impossibile celare... ciò significava che... Artyom decise di non pensarci. Quella che udiva era la voce della debolezza, delle ragioni sediziose, melliflue e seducenti che volevano convincerlo a interrompere il suo viaggio, a smettere di tendere verso il suo obiettivo. Ma lui non doveva mollare. Quella sarebbe stata una strada senza uscita. Per distrarsi, si rimise ad ascoltare le conversazioni degli altri. Inizialmente stavano discutendo di un certo Cannone e delle sue possibilità di vincere qualcosa. Il tizio con la voce roca riferì che degli idioti avevano attaccato la Kitay-Gorod e ucciso una moltitudine di persone, ma l’arrivo tempestivo della fratellanza Kaluga aveva sventato l’attacco e gli assassini erano tornati alla Taganskaya. Artyom desiderava precisare che non si trattava della Taganskaya ma della Tretyakovskaya; tuttavia, un tizio pelle e ossa con il viso nascosto contraddisse l’uomo che aveva appena parlato, affermando che i Kaluga erano stati scacciati dalla Kitay-Gorod e che ora la stazione era controllata da un nuovo gruppo, del quale nessuno aveva mai sentito parlare. L’uomo con la voce roca lo contestò a sua volta, così i due cominciarono un’accesa discussione. Nel frattempo Artyom si appisolò. Questa volta non sognò nulla di particolare e dormì sodo finché il fischio di allarme non risuonò e tutti si alzarono in piedi. Lui, però, non riuscì proprio a svegliarsi. Molto probabilmente era stato un falso allarme, perché non venne esploso alcun colpo. Infine, quando Mark lo svegliò, erano già le sei meno un quarto. “Sveglia, è ora di tornare in servizio!”, e scrollò allegramente la spalla di Artyom. “Andiamo, ti mostrerò il passaggio nel quale non ti hanno fatto entrare ieri sera. Hai il passaporto?” Artyom scosse la testa. “Non ti preoccupare, in qualche modo troveremo una soluzione”, promise Mark e infatti dopo qualche minuto si trovavano già nel passaggio, l’ufficiale di sicurezza soffiò servizievole nel suo fischietto il suono del lasciapassare e richiese il pagamento di due cartucce. Il passaggio era molto esteso, anche più della stazione stessa. Lungo un muro si trovavano le tende di stoffa e tutto era illuminato da lampade brillanti (“L’Hansa si prende cura di noi”, fu la spiegazione compiaciuta di Mark), mentre su tutta la lunghezza della parete di fronte c’era un tramezzo alto non più di un metro. “A proposito, questo è uno dei passaggi più lunghi di tutta la Metropolitana!”, puntualizzò fiero Mark. “Cosa? Vuoi sapere che c’è dietro quel tramezzo? Come? Non lo sai? Qualcosa di meraviglioso! Ci investiamo metà di quello che guadagniamo! Ma aspetta, è ancora presto. Comincerà tutto più tardi. La sera, quando la stazione chiude, la gente non ha di meglio da fare, perciò passa sempre qualche ora qui, anche se possono svolgersi dei round di qualificazione persino durante il giorno. Davvero non ne hai mai sentito parlare? Qui c’è un Totalizzatore per le corse dei ratti! Noi lo chiamiamo Ippodromo. Credevo che tutti lo conoscessero...”. Si sorprese quando alla fine comprese che Artyom non stava scherzando. “Ti piacciono la scommesse? Io sono un giocatore d’azzardo”. Ad Artyom interessava assistere alle gare, ma non ne era mai stato un grande appassionato. Inoltre, dato che aveva dormito a lungo, su di lui incombeva un senso di colpa, che con il passare dei minuti aumentava e si faceva sempre più opprimente. Non poteva starsene con le mani in mano fino a sera, non poteva attendere oltre. Doveva mettersi in marcia, aveva già perso troppo tempo. Tuttavia, per arrivare alla Polis avrebbe dovuto attraversare l’Hansa e, al momento, non ne aveva la possibilità. “Con tutta probabilità non potrò trattenermi fino a sera”, ribatté Artyom. “Devo recarmi alla... Polyanka”. “Ma così dovrai attraversare l’Hansa”, ricordò Mark aggrottando le sopracciglia. “Come hai intenzione di attraversare il confine se non hai né visto, né passaporto? Così non posso aiutarti, amico mio. Ma aspetta, ti faccio una proposta: il capo della Paveletskaya, non la nostra, ma quella sull’Anello, è un fanatico di corse dei ratti. Il suo animale, Pirata, è uno dei favoriti. Partecipa tutte le sere, con le guardie del corpo e l’illuminazione al seguito. Che ne pensi di scommettere contro di lui? Potresti farlo tu personalmente!” “Ma io non posseggo nulla con cui scommettere!”, obiettò Artyom. “Puoi usare te stesso, cioè se perdi gli farai da servo. Ma se preferisci, posso farlo io per te”, gli occhi di Mark brillarono per l’eccitazione. “Se vinciamo, otterrai il tuo visto e se perdiamo riuscirai a entrare in quella parte della stazione, solo che poi dovrai capire come uscirne. Hai alternative?” Ad Artyom questa idea non piaceva per niente; gli sembrava disonorevole vendersi come schiavo e soprattutto come Totalizzatore di ratti. Per questo, decise di provare ad accedere all’Hansa in un altro modo. Per un paio d’ore si aggirò intorno a delle guardie di confine dallo sguardo arcigno in uniformi mimetiche grigie, identiche a quelle delle sentinelle alla Prospekt Mira; cercò di attaccare bottone, ma quelli rimasero muti come pesci. Uno di loro, sprezzante, lo chiamò Monocolo e il ragazzo trovò il nomignolo alquanto ingiusto, perché il suo occhio sinistro aveva già cominciato a riaprirsi, anche se continuava a fargli un male del diavolo; poi gli ordinò di togliersi dai piedi, perciò alla fine Artyom abbandonò l’impresa infruttuosa e si mise a cercare i personaggi più sinistri e sospettosi della stazione, cioè gli spacciatori, i trafficanti di armi o un contrabbandiere qualunque. Ma nessuno aveva intenzione di trasportare Artyom fino all’Hansa in cambio della sua arma automatica e della sua lampada. Si fece sera e Artyom si trovò ad affrontarla con una tranquilla disperazione: se ne stava seduto sul pavimento del passaggio e si crogiolava nello sconforto. Proprio attorno a quell’ora, il luogo di transito si rianimava: gli adulti tornavano dal lavoro per cenare con le loro famiglie, mentre i bambini facevano baccano finché non era ora di andare a dormire. Infine, il cancello venne chiuso a chiave e tutti quanti si allontanarono dalle bancarelle o dalle tende per recarsi alle gare dei topi. C’erano moltissime persone, almeno trecento, e trovare Mark tra quella folla non sarebbe stato per nulla semplice. La gente scommetteva su Pirata e se, per una volta, Cannone sarebbe stato in grado di batterlo; citavano anche altri soprannomi e altri corridori, ma era chiaro che questi due non avevano rivali. I padroni dei ratti più rispettati si avvicinarono alla linea di partenza, trasportando in piccole gabbie i loro animali ben curati. Il capo della Paveletskaya sull’Anello non si vedeva da nessuna parte e pareva che anche Mark fosse scomparso dalla faccia della Terra. Artyom temeva che l’uomo sarebbe stato di pattuglia anche quella sera e non si sarebbe presentato. A quel punto cosa avrebbe potuto fare? Ma alla fine, dall’altro lato del passaggio, cominciò una piccola processione. Un uomo anziano con la testa rasata, baffi floridi e lisciati, un paio d’occhiali e un sobrio completo nero procedeva verso di loro scortato da due guardie del corpo imbronciate e trasportava con dignità il peso della sua massa corpulenta, senza alcuna fretta. Uno dei gorilla teneva in mano una scatola imbottita e rivestita di velluto rosso, con una graticcia da cui si intravvedeva qualcosa di grigio. Con tutta probabilità si trattava del famoso Pirata. Le guardie portarono la scatola con il ratto sulla linea di partenza e l’anziano con i baffi si avvicinò all’arbitro seduto dietro una piccola scrivania, scacciò l’aiutante dalla sedia, si accomodò pesantemente sulla seggiola lasciata libera e cominciò a conversare tranquillo con il direttore di gara. Il secondo uomo della sicurezza gli rimaneva vicino, con la schiena rivolta al muro, le gambe aperte e le mani sull’automatica nera appesa al collo. Una persona tanto imponente non gli pareva il tipo giusto con cui discutere di una scommessa... Artyom tremava solo al pensiero di dover fare qualche passo nella sua direzione. Artyom scorse Mark, che con i suoi abiti trasandati si grattava la testa sporca e si avvicinava a quelle persone rispettabili; poi si mise a spiegare qualcosa all’arbitro. Da lontano, il ragazzo riuscì solo a percepire l’intonazione del discorso; ciononostante, notò che all’inizio l’anziano con i baffi avvampò d’indignazione, poi sogghignò arrogante e infine assentì con disapprovazione, si tolse gli occhiali e cominciò a pulirli. Artyom si fece spazio tra la folla, finché non giunse nella zona da cui partiva la gara, dove si trovava anche Mark. “Abbiamo concordato la cosa in via del tutto confidenziale!”, annunciò Mark sfregandosi le mani con gioia. Quando Artyom gli domandò cosa avesse in mente di preciso, l’uomo gli spiegò che aveva appena scommesso personalmente contro il vecchio capo che il suo nuovo ratto avrebbe sconfitto il favorito già durante il primo round. Gli riferì inoltre che aveva dovuto coinvolgere anche il giovane, ma che in cambio aveva richiesto un visto per entrambi, che gli permettesse di recarsi in tutto il territorio dell’Hansa. Per sicurezza, il capo rifiutò la proposta dichiarando di non voler avere niente a che fare con la tratta degli schiavi. Artyom tirò un sospiro di sollievo, ma Mark proseguì con la spiegazione e gli raccontò come il capo ritenesse che una tale insolenza sarebbe dovuta essere punita a dovere. Se il loro ratto avesse perso, Mark e Artyom avrebbero dovuto pulire le latrine della Paveletskaya-Anello per un anno. Al contrario, se avesse vinto, avrebbero ottenuto il visto. Dato che l’anziano capo era sicuro che la seconda ipotesi non si sarebbe mai verificata, acconsentì alla scommessa. E decise che avrebbe punito i presuntuosi nuovi arrivati che avevano osato sfidare il suo animale. “Ma tu ce l’hai, un ratto?”, gli domandò Artyom cauto. “Ma certo!”, lo rassicurò Mark. “Ed è un vero osso duro! Farà a pezzi quel Pirata! Sai com’è riuscito a sfuggirmi, oggi? Quasi non riuscivo a prenderlo! L’ho inseguito praticamente fino alla Novokuznetskaya”. “E qual è il suo nome?” “Il suo nome?” “Sì, come si chiama?” “Beh, diciamo che si chiama Razzo”, propose Mark. “Razzo? Ti sembra un nome minaccioso?” Artyom non era sicuro che la gara consistesse nel fare a pezzi l’avversario, ma non discusse. Quando Mark gli spiegò che aveva catturato il suo ratto solo quella mattina, Artyom non ci vide più: “Allora come sai che vincerà?!” “Credo in lui”, proclamò Mark solenne. “In ogni caso, era moltissimo tempo che desideravo un ratto tutto mio. Ho sempre scommesso su quelli degli altri e quando perdevano pensavo tra me: ‘Beh, non importa. Verrà il giorno in cui anche io avrò un ratto tutto mio e mi porterà fortuna’. Ma non mi ero mai deciso, anche perché non è tanto semplice acciuffarne uno. Inoltre, bisogna avere il permesso dell’arbitro per partecipare... è una tale seccatura! Io sto diventando vecchio, un giorno o l’altro potrei essere divorato da uno di quei Nuovi, oppure potrei morire tutto solo senza aver mai avuto un ratto tutto mio. Ma poi sei arrivato tu e io ho pensato: ‘Ci siamo! Ora o mai più! Se non corro il rischio adesso...’ ho riflettuto tra me ‘... continuerò a scommettere sui ratti degli altri’. Perciò ho deciso: ‘Se devo giocare, lo faccio bene’. Naturalmente voglio anche aiutare te, ma ti prego di scusarmi: tu non sei il motivo principale. E in più desideravo da tempo andare da quel vecchio bacucco e...”, Mark abbassò la voce, “...sfidarlo dicendogli: ‘Scommetto che il tuo Pirata perderà!’. Dovevi vederlo, si è arrabbiato talmente tanto che stava obbligando l’arbitro a squalificare il mio ratto. Sai...”, aggiunse a voce ancora più bassa e a malapena udibile, “tra poco avremo davanti a noi... un anno intero in cui dovremo semplicemente pulire latrine”. “Perché il nostro ratto perderà, senza alcun dubbio!”, Artyom cercò disperatamente di ragionare con lui per l’ultima volta. Mark lo osservava attentamente, poi sorrise e concluse: “E se invece vincesse...?” Con uno sguardo inflessibile, il direttore di gara guardò il pubblico, poi si lisciò i capelli ingrigiti, si schiarì la gola pieno di boria e si mise a leggere i nomi dei ratti che avrebbero gareggiato. Razzo era l’ultimo, ma Mark non notò nemmeno questo dettaglio. Pirata ricevette più applausi di qualsiasi altra bestia e solo Artyom applaudì per Razzo, perché Mark aveva le mani impegnate a tenere la gabbia. Il ragazzo sperava ancora che un miracolo lo avrebbe risparmiato da un abisso infamante e puzzolente. L’arbitro sparò un colpo dalla sua Makarov e i padroni aprirono le gabbie: Razzo fu il primo a uscire e il cuore di Artyom ebbe un sussulto di gioia. Poi però, mentre gli altri proseguivano lungo il percorso, alcuni più veloci e altri più lenti, Razzo non fu all’altezza del suo fiero soprannome: rimase bloccato in un angolo a cinque metri dalla linea di partenza, dove restò per tutta la gara. Incitare gli animali era contro le regole. Artyom lanciò un’occhiata apprensiva in direzione di Mark perché si aspettava che l’uomo sarebbe diventato violento o che, al contrario, avrebbe cominciato a struggersi, sopraffatto dal dolore. Tuttavia l’espressione greve e fiera dell’uomo gli ricordava piuttosto quella del capitano di un incrociatore mentre dà l’ordine di fare affondare la nave per impedire che il nemico la conquisti, una storia di guerra tra i russi e un altro popolo che aveva letto in un libro malconcio alla biblioteca della VDNKh. Dopo un paio di minuti il primo ratto tagliò il traguardo; ovviamente si trattava di Pirata. Arrivò seconda una creatura dal nome incomprensibile, mentre Cannone arrivò terzo. Artyom guardò di sfuggita il tavolo dell’arbitro: l’anziano con i baffi, sudato fradicio a causa dell’agitazione, si asciugava la pelata con lo stesso fazzoletto con cui poco prima aveva pulito gli occhiali e discuteva i risultati con il giudice di gara. Il ragazzo si aspettava che si fossero dimenticati di loro, ma all’improvviso il vecchio si diede una pacca in fronte, sorrise amabile e chiamò Mark con un cenno. Artyom provava la stessa sensazione di quando lo stavano conducendo al patibolo, anche se non altrettanto intensa. Seguì Mark fino al tavolo dell’arbitro e si consolò pensando che, in un modo o nell’altro, sarebbe riuscito a entrare nel territorio dell’ Hansa. Doveva solo capire come fuggire. Ma la disgrazia lo attendeva. Invitandoli con un’abile mossa a salire sulla pedana, il Baffo si voltò in direzione del pubblico e spiegò in poche parole che genere di scommessa avevano discusso, poi proclamò ad alta voce che, come d’accordo, i due mascalzoni sarebbero stati mandati a pulire i bagni per un anno intero, a partire da quello stesso giorno. Due guardie di confine dell’Hansa apparvero dal nulla, confiscarono l’arma ad Artyom e gli assicurarono che, per l’anno a venire, il suo più acerrimo nemico non sarebbe stato molto pericoloso e che gli avrebbero restituito la mitragliatrice al termine della sua condanna. A quel punto, accompagnati dai fischi e dalle urla della folla, vennero condotti all’Anello. Il passaggio continuava sotto al centro dell’atrio, proprio come all’intero dell’altra stazione che portava lo stesso nome; tuttavia, questa era l’unica somiglianza tra le due Paveletskaya. Quella sull’Anello era molto particolare, perché da una parte aveva un soffitto basso, quasi non vi erano colonne, gli archi si intervallavano regolari, uno dopo l’altro lungo la parete, mentre la loro ampiezza era identica a quella dell’area sottostante. Pareva che, per coloro che costruirono la Metro, la prima Paveletskaya fosse stata un gioco da ragazzi, poiché in superficie la terra era più soffice, bisognava solo farsi strada; al contrario, nel terreno in cui costruirono la seconda stazione avevano trovato una roccia durevole e rigida, molto difficile da scavare. Ciononostante, questo luogo non dava adito a pensieri melanconici e deprimenti, come la Tverskaya, forse perché qui l’illuminazione era ottima, le pareti erano decorate con disegni semplici e imitazioni delle colonna antiche, simili alle immagini dei “Miti dell’Antica Grecia”. In breve, questo non poteva essere il luogo peggiore in cui essere messi ai lavori forzati. Fu subito chiaro che si trovavano nel territorio dell’Hansa: prima di tutto era incredibilmente pulito, confortevole e ampio; sul soffitto brillavano lampade vere, contenute in paralumi di vetro; inoltre, nell’atrio, che non era ampio come il suo gemello al piano superiore, non si trovava nemmeno un chiosco, sebbene vi fossero molti tavoli da laboratorio a cui erano sedute persone in tute da lavoro, sui quali vi erano pile intricate di congegni. Nell’aria aleggiava l’odore leggero e piacevole dell’olio delle macchine. Era chiaro che qui la giornata lavorativa terminasse più tardi rispetto all’altra Paveletskaya. Tutti gli oggetti più rappresentativi dell’Hansa erano appesi alle pareti: un’insegna con un cerchio marrone su sfondo bianco, poster, appelli per accrescere la produttività lavorativa e citazioni di un certo A. Smith. Sotto la bandiera più grande, tra due soldati impettiti in uniforme da guardia d’onore, si trovava una teca. Mentre passavano, Artyom si soffermò a controllare di cosa si trattasse, giusto per soddisfare la sua sete di curiosità e per vedere quale oggetto sacro fosse conservato sotto vetro. Lì, sul velluto rosso, accuratamente illuminato da minuscole lampade, erano poggiati due libri: il primo era un volume grandioso, conservato in uno stato impeccabile, con la copertina nera e un’iscrizione dorata in rilievo che riportava la scritta Adam Smith. La ricchezza delle nazioni, mentre il secondo era una copia di un tascabile, con le pagine accuratamente distinte da innumerevoli segni; era in pessime condizioni, tanto che la copertina praticamente distrutta era stata già più volte rincollata. Su di essa troneggiavano le parole: Dale Carnegie. Come vincere lo stress e cominciare a vivere. Artyom non aveva mai sentito nominare questi due autori, ma più che altro si domandò se il capo della stazione avesse utilizzato i pezzi rimasti di quel velluto rosso per imbottire la gabbia del tanto amato ratto. Una delle due linee non era bloccata e di tanto in tanto si scorgevano carrelli in movimento, che per lo più erano azionati a mano e carichi di scatole. Passò anche un carrello motorizzato, avvolto da una nuvola di fumo, che si fermò per un minuto alla stazione prima di proseguire la sua corsa. Per un momento, riuscì a vedere che a bordo si trovavano dei soldati vigorosi, nelle loro uniformi nere, sotto le quali indossavano gilet a righe bianche e nere. Erano tutti equipaggiati di dispositivi per la visione notturna, mentre tenevano sul petto una strana e cortissima arma automatica ed erano protetti da pesanti giubbotti antiproiettile. Il comandante passò la mano su un enorme elmetto con visiera color verde scuro che aveva poggiato sulle ginocchia e scambiò quattro chiacchiere con gli ufficiali di sicurezza della stazione, i quali indossavano le solite mimetiche verdi... a quel punto il carrello svanì nella galleria. Sulla seconda linea si trovava un treno completo, in condizioni persino migliori rispetto a quello che Artyom aveva visto alla Kuznetsky Most. Molto probabilmente, dietro le tendine tirate abitava qualcuno, sebbene dai finestrini disadorni si scorgevano scrivanie su cui erano posizionate stampanti, alle quali sedeva un normale uomo d’affari: sulla porta era appeso un cartello, sul quale erano incise le parole “UFFICIO CENTRALE”. Questa stazione impressionò incredibilmente Artyom, ma mai come la prima Paveletskaya, perché qui non vi era alcuna traccia di quello splendore misterioso e oscuro che faceva tornare alla mente la progenie degenerata della passata grandezza superumana e il potere di coloro che avevano costruito la Metro. Tuttavia, in questo luogo la gente viveva ancora come se non fosse parte dell’esistenza sotterranea, brulicante, decadente e insensata che si conduceva oltre l’Anello. Qui la vita continuava normalmente e in maniera organizzata. Dopo una giornata di lavoro ci si poteva godere il meritato riposo; i giovani non vagavano in uno sciocco mondo fatto solo di storie fantastiche, ma venivano cresciuti con una mentalità volta agli affari: prima cominciavano a fare carriera, più in alto riuscivano a salire sulla scala sociale. Gli adulti non temevano il fatto che, una volta che le loro forze li avessero abbandonati, qualcuno li avrebbe lasciati in una galleria perché venissero divorati dai ratti. Era perfettamente comprensibile la ragione per cui l’Hansa permettesse solo a pochi stranieri di accedere alle proprie stazioni e lo facesse con molta riluttanza. Il numero di posti in Paradiso è limitato, mentre l’inferno è aperto a tutti. “Beh, finalmente sono riuscito a emigrare!”, esclamò Mark guardandosi intorno allegro. Dall’altro capo della piattaforma, una guardia di confine sedeva in una guardiola di vetro, sulla quale era posto il cartello “In servizio”, di fianco a una piccola barra su cui erano state dipinte righe bianche e rosse. Nel caso in cui qualcuno si avvicinasse all’ufficiale in servizio, questo rispettava il segnale di stop, la guardia usciva dalla cabina con un’espressione tronfia, controllava i documenti e alle volte anche la merce e infine alzava la sbarra. Artyom notò che tutte le guardie di confine e gli ufficiali di dogana erano molto orgogliosi dei posti che occupavano: si notava immediatamente che adoravano il loro lavoro. In realtà, come potevano odiarlo? Vennero condotti a una recinzione oltre la quale la strada continuava nella galleria e girava di lato verso un corridoio che portava al quartiere dei funzionari. Tutto era ricoperto da tristi piastrelle gialle, nelle quali erano scavate delle buche, superbamente incoronate da veri e propri water. Artyom e il compagno avrebbero dovuto usare tute da lavoro sudice, badili quadrati su cui cresceva una sostanza strana e una carriola con un’unica ruota, con la quale dovevano descrivere ingarbugliati movimenti a otto, per poi arrivare ai carrelli dove caricare il lerciume che poi sarebbe stato gettato nel più vicino pozzo. Tutte queste azioni erano avvolte da una puzza mostruosa, inimmaginabile, che saturava i vestiti e si avviluppava attorno ai capelli, dalla radice fino alle punte, penetrava sottopelle, tanto che chiunque lavorasse lì dentro cominciava a pensare che quell’odore fosse divenuto parte della sua natura e sarebbe rimasto per sempre, facendo allontanare da sé gli altri uomini, prima ancora che lo vedessero. Il primo giorno di questo lavoro monotono passò talmente lento che Artyom credette gli avessero affibbiato un turno infinito: scavava, scaricava e spingeva, scavava, scaricava e spingeva, faceva defluire, poi tornava indietro dall’altra parte. E ripeteva questo dannato ciclo di tre azioni. Il termine della giornata lavorativa non appariva nemmeno all’orizzonte, poiché i visitatori erano continui e numerosi. Né loro e nemmeno le guardie di sicurezza che stavano all’entrata del locale e alla fine del percorso, presso il pozzo, nascondevano la propria repulsione nei confronti dei poveri lavoratori. Schizzinosi, se ne stavano in disparte e si chiudevano il naso tra pollice e indice, oppure i più educati facevano un respiro profondo prima di entrare per evitare di respirare di fianco ad Artyom e Mark. Sui loro visi si leggeva il ribrezzo e il giovane si ritrovava a riflettere che, dopotutto, quello schifo veniva dalle loro pance! Alla fine della giornata, quando le sue mani si erano consumate fino all’osso, nonostante indossasse degli enormi guanti di tela, ad Artyom parve di avere scoperto la reale natura dell’uomo, oltre al vero significato della vita. L’uomo era una macchina intelligente atta alla decomposizione del cibo e alla produzione degli escrementi, che funzionava senza sosta per tutta la vita, senza un significato, se con il termine “significato” si intende un obiettivo ben preciso. Esso risiedeva nel processo: decomporre la maggior quantità di cibo possibile, convertirlo ancora più velocemente ed eliminare gli scarti. Ciò che rimaneva delle fumanti braciole di maiale, dei succulenti funghi brasati, delle torte più soffici era ora putrefatto e contaminato. I tratti personali cominciavano a svanire e diventavano meccanismi banali per la distruzione del bello e dell’utile, al loro posto creavano solo qualcosa di putrido e senza valore. Artyom era disgustato dalla gente e provava nei loro confronti la stessa avversione che loro dimostravano nei suoi. Mark era stoico, paziente e di tanto in tanto provava a rallegrarlo con frasi del genere: “Non ti preoccupare, mi avevano raccontato che all’inizio l’emigrazione sarebbe stata un’esperienza difficile”. Ma il peggio fu che né il primo giorno e nemmeno il secondo gli si presentò la possibilità di fuggire: le guardie di sicurezza erano sempre molto attente. Per andarsene da lì, Artyom e Mark avrebbero dovuto entrare nella galleria oltre il pozzo per dirigersi verso la Dobryninskaya. Era praticamente impossibile. Passarono la notte in uno stanzino attiguo, la cui porta veniva chiusa a chiave durante le ore notturne, mentre durante il giorno una sentinella li sorvegliava dalla guardiola all’entrata della stazione. Così giunse il loro terzo giorno di lavoro. Le giornate non erano più scandite dalle solite ventiquattro ore, perché il tempo scorreva lento, secondo dopo secondo, dando forma a un incubo senza fine. Artyom si era già abituato all’idea che nessuno gli si sarebbe più avvicinato e non gli avrebbe più rivolto la parola, cioè che lo attendeva un destino da reietto. Gli sembrava di non essere più un umano, di essersi trasformato in un’entità mostruosa al di là di ogni logica, perché coloro che lo guardavano, non solo vedevano qualcosa di orribile e ripugnante, ma vi si relazionavano e ciò li spaventava ancor di più e gli provocava una forte repulsione, come se il ragazzo potesse inoculargli il virus della mostruosità, come se fosse un lebbroso. Prima di tutto, cercò di progettare un piano di fuga. Poi cominciò a ronzargli in testa la sorda voce della disperazione, dopodiché venne pervaso dal torpore, che gli disconnetteva l’intelletto dalla vita. Si richiuse in se stesso, si privò di tutti i sentimenti e delle sensazioni, che protesse con un bozzolo e ritirò in un angolo remoto della coscienza. Artyom lavorava con movimenti meccanici e precisi, come quelli di un automa: scavava, scaricava e spingeva, scavava, scaricava e spingeva, faceva defluire, poi tornava indietro dall’altra parte, più veloce, per cominciare di nuovo a scavare. I suoi sogni persero ogni significato. Durante la notte, proprio come nelle ore di veglia, si vedeva correre all’infinito, scavare, spingere e ancora spingere, poi scavare e correre ancora. La sera del quinto giorno, spingendo la carriola, Artyom inciampò in un badile abbandonato al suolo. Il trabiccolo si ribaltò, il contenuto si rovesciò e lui ci cadde dentro. Quando, lentamente, si alzò da terra, gli balenò in mente un’idea e, invece di affrettarsi a prendere un secchio e un telo, si diresse lento e cauto verso l’entrata della galleria. Si sentiva disgustoso e ripugnante come non mai e sapeva che il suo tanfo avrebbe fatto allontanare chiunque. Proprio in quel momento, forse grazie a un’improbabile confluenza di circostanze, la guardia di sicurezza che di solito se ne stava alla fine del loro percorso non si trovava al suo posto. Senza considerare il fatto che qualcuno avrebbe potuto inseguirlo, il ragazzo imboccò il tunnel. Non vedeva quasi niente, ma malgrado ciò riuscì a non inciampare; camminava sempre più velocemente finché non si mise a correre. Tuttavia, il senso della ragione non era ancora riemerso, non dirigeva il suo corpo, si trovava ancora in uno stato di letargia, acquattato nel suo angolo. Dietro di lui non udì richiami né passi degli inseguitori; c’era solo un carrello carico di merce che gli sferragliava vicino e che gli illuminava la strada con una lanterna dalla luce fioca. Il ragazzo si limitò ad appoggiarsi al muro e lo lasciò passare. Le persone a bordo non lo notarono oppure non considerarono necessario prestargli attenzione, infatti i loro sguardi lo superarono senza soffermarsi su di lui e non gli rivolsero la parola. Comprese che la caduta gli aveva donato un’inaspettata invulnerabilità. La melma puzzolente lo aveva reso invisibile: ciò gli restituiva la forza e la sua coscienza, che cominciò a riaffiorare gradualmente. Ce l’aveva fatta e non sapeva nemmeno come! Contro il buon senso e nonostante tutto era riuscito a fuggire da quella dannata stazione e nessuno lo stava inseguendo! Era bizzarro, incredibile. Se avesse cercato di capire cosa fosse successo, se avesse provato a sezionare questo miracolo con il freddo bisturi della razionalità, la magia sarebbe scomparsa all’istante e il riflettore del carrello dei pattugliatori lo avrebbe raggiunto e riportato indietro. La luce brillava alla fine della galleria. Rallentò il passo e un minuto dopo si trovava già alla Dobryninskaya. La guardia di confine gli pose una semplice domanda e fu subito soddisfatta: “Hanno chiamato un tecnico sanitario?”, e lo lasciò passare senza problemi, sventolandosi il viso con una mano, mentre con l’altra si copriva la bocca. Artyom si doveva sbrigare, doveva uscire in fretta dal territorio dell’Hansa, prima che le guardie si accorgessero della sua assenza, prima di sentirsi addosso il passo pesante dei loro scarponi ferrati, prima che venissero esplosi in aria dei colpi di avvertimento... Più veloce. Non guardava in faccia nessuno, teneva solo gli occhi incollati a terra. Rabbrividiva a vedere con quale disgusto lo guardavano i passanti; aveva fatto terra bruciata attorno a sé, non dovette nemmeno farsi strada a gomitate tra la folla, finché non giunse al successivo sbarramento di confine. E ora cosa poteva raccontare? Gli avrebbero posto altre domande e richiesto di presentare il passaporto. Cosa poteva rispondere? Artyom teneva la testa talmente a penzoloni che il mento toccava il petto. Non vedeva nulla di quello che aveva attorno, infatti quando ripensò a quella stazione si ricordò solo le ordinate lastre di granito scuro del pavimento. Non sostò nemmeno un attimo, raggelato dall’idea che pochi minuti dopo avrebbe udito l’ordine perentorio di fermarsi. Il confine dell’Hansa era sempre più vicino. Ora... Proprio adesso... “Che schifezza è questa?”, una voce boccheggiante gli risuonò nell’orecchio. Era giunto il momento. “Io... beh... io mi sono perso. Non sono di queste parti...”, borbottò Artyom con la lingua secca a causa della tensione, oppure perché si era riuscito a calare totalmente nella parte. “Beh, vattene subito di qui! Hai capito, brutto babbeo?!”, la voce era persuasiva, quasi ipnotica; volle obbedirgli subito. “Sì, certo... io...”, mormorò Artyom, pieno di paura, non sapendo come rispondere. “Nel territorio dell’Hansa è severamente vietato mendicare!”, disse la voce categorica, questa volta da una distanza maggiore. “Ma certo, subito... ho bambini piccoli...”, infine Artyom comprese la strategia da utilizzare e si rianimò un poco. “Quali bambini?! Ma sei impazzito?!”, la guardia di confine avvampò dalla rabbia. “Popov, Lomako, venite subito qui! Scacciate immediatamente questo spregevole individuo!” Né Popov né Lomako avevano intenzione di insudiciarsi le mani toccando Artyom, perciò si limitarono a puntargli alla schiena le loro pistole automatiche. Le imprecazioni adirate del loro superiore li raggiungevano da dietro, anche se al ragazzo sembrava di udire una musica paradisiaca. Ecco davanti a lui la stazione della Serpukhovskaya! Si era lasciato alle spalle il confine dell’Hansa! Finalmente alzò lo sguardo, ma ciò che scorse negli occhi di coloro che gli stavano intorno gli fece venire voglia di guardare nuovamente verso il terreno. Ovviamente, non si trovava nell’ordinato territorio dell’Hansa, era di nuovo nel bel mezzo della bolgia sporca e povera che regnava nel resto della Metropolitana. Ma anche qui Artyom era troppo ributtante. La miracolosa armatura che l’aveva salvato rendendolo invisibile, obbligando le persone a voltarsi dall’altra parte e a ignorarlo, permettendogli di fuggire attraverso gli avamposti e i posti di blocco, lo aveva trasformato nuovamente in un essere puzzolente e disgustoso. Evidentemente era già passato mezzogiorno. Ora che l’iniziale senso di esultazione era svanito, ora che era scomparsa quella strana forza che l’aveva obbligato a percorrere la galleria tra la Paveletskaya e la Dobryninskaya, come se l’avesse chiesta in prestito a qualcuno, il ragazzo era rimasto solo, affamato, stanco morto e senza nemmeno il becco di un quattrino; oltretutto emetteva un fetore inimmaginabile e portava ancora sul corpo i segni dei colpi ricevuti la settimana precedente. Si sedette contro il muro, vicino ad alcuni poveracci, i quali decisero di non poter sopportare la sua compagnia e, imprecando, si allontanarono in diverse direzioni. Artyom era completamente solo. Stringendosi nelle spalle per non sentire freddo, chiuse gli occhi e rimase seduto a lungo, senza pensare a nulla, finché il sonno non prese il sopravvento. Artyom percorreva una galleria non terminata. Era più lunga di tutte quelle che aveva attraversato nella sua vita. Il tunnel si faceva tortuoso, di tanto in tanto scendeva per poi risalire nuovamente, non era mai dritto per più di dieci passi. Il ragazzo continuò a camminare finché muoversi non diventò complicatissimo; i suoi piedi erano insanguinati e pieni di piaghe, gli dolevano, così come la schiena. Passo dopo passo sentiva delle intense fitte di dolore in tutto il corpo, ma finché sperava che l’uscita si trovasse poco lontano, forse già oltre l’angolo successivo, Artyom riusciva a trovare la forza di procedere. A un certo punto, una consapevolezza semplice ma terribile lo pervase: se la galleria fosse stata senza uscita? Se sia l’entrata che l’uscita fossero state bloccate, se un’entità invisibile e onnipotente le avesse chiuse, lasciandolo all’interno, come un ratto che cerca di raggiungere il tunnel preposto dallo scienziato, senza mai riuscirci? Se fosse stato abbandonato in un labirinto senza uscita, nel quale si sarebbe dovuto trascinare fino allo svenimento, senza una ragione particolare, ma solo per divertimento? Un ratto in un labirinto. Un criceto su una ruota. Poi gli fu chiaro: se la sua era una strada che non conduceva all’uscita, allora tanto valeva rifiutarsi di proseguire. Così facendo la liberazione sarebbe arrivata da sé. Perciò si sedette sulla traversina, non perché fosse stanco, ma perché era giunto al capolinea. Le pareti attorno a lui scomparvero e in questo modo comprese che se voleva raggiungere il suo scopo, terminare il suo viaggio, doveva smettere di camminare. Poi l’immagine si dissolse e scomparve. Quando si svegliò, venne colto da un’ansia schiacciante e inizialmente non riuscì a comprendere da cosa fosse stata causata. Solo dopo un po’ cominciò a ricordare brevi dettagli del sogno, a ricomporli come un mosaico. Malgrado ciò, i frammenti non si univano, si sbriciolavano, il collante non era sufficiente per tenerli insieme. Quel collante era un’idea sopraggiunta durante il sogno ed era cruciale, una visione che aveva ricevuto dalla sua anima, di un’importanza estrema. Senza il collante, sarebbe rimasto solo con una manciata di stracci, ma se l’avesse trovato, avrebbe potuto vedere un’immagine incredibile, prodigiosa, che gli apriva orizzonti illimitati. Ma non riusciva a ricordare di quale idea si trattasse. Artyom si scervellò, si prese la testa sporca tra le mani sudice, le labbra sussurravano frasi inintelligibili, mentre i passanti lo osservavano impauriti e schifati. Ma quell’idea non voleva ritornare. Allora, lento e cauto, come se stesse usando una sottilissima fune per recuperare qualcosa che era rimasto incastrato in una palude, cominciò a ricostruirla dai frammenti della sua memoria. E... miracolo! Svelto, afferrò l’immagine e la riconobbe subito, nella stessa forma primordiale in cui si era preannunciata la prima volta nel suo sogno. Per terminare il viaggio, doveva smettere di camminare. Ma ora, alla luce vivace della sua coscienza, l’idea gli parve banale, penosa e immeritevole di tanta attenzione. Per terminare il viaggio doveva smettere di camminare. Beh, certo, se ci si ferma, il viaggio termina. Più semplice di così! Ma era davvero questa la soluzione? Poteva davvero essere la fine del suo percorso? Spesso accade che in sogno ci si presenti un’idea che pare un colpo di genio, ma che alla luce della realtà si rivela essere solo un’insignificante accozzaglia di parole... “Oh, mio amato fratello! Il tuo corpo è insudiciato, ma lo è anche la tua anima”. La voce proveniva da lì vicino, di fianco a lui. La sorpresa fu inaspettata quanto ricordarsi dell’idea avuta in sogno, ma il sapore amaro della disillusione scomparve all’istante. Non gli venne nemmeno in mente che la voce si stesse rivolgendo a lui, perché si era talmente abituato alla gente che lo rifuggiva, prima ancora che lui aprisse bocca. “Tra noi c’è posto per gli orfani e gli sventurati”, proseguì la voce, melliflua, rassicurante e affettuosa. Il ragazzo, senza più trattenersi, si guardò a sinistra e poi, mesto, a destra, temendo di scoprire che la persona che gli aveva rivolto la parola in realtà stesse parlando con qualcun altro. Ma nelle vicinanze non c’era nessuno. Quell’uomo parlava con lui. Così, lentamente alzò la testa e il suo sguardo incrociò quello di un uomo sorridente, non molto alto, che indossava una tunica larga; aveva i capelli color biondo scuro e guance rosee e gli porgeva la mano, in segno d’amicizia. Artyom sentiva un enorme bisogno di contraccambiare, ma non osò sorridergli, perciò gli tese solo la mano. “Perché non fugge da me come fanno tutti gli altri?”, meditò Artyom. “Desidera persino stringermi la mano... Perché si è avvicinato di sua spontanea volontà, quando tutti gli altri mi stanno il più lontano possibile?” “Ti aiuterò, fratello mio!”, continuò l’uomo dalle guance rosee. “Io e i miei fratelli ti offriremo un riparo e ristoreremo la tua forza spirituale”. Artyom si limitò ad annuire, ma per il suo nuovo compagno ciò fu sufficiente. “Permettimi di condurti alla Torre di guardia, mio amato fratello”, intonò; deciso prese per mano il ragazzo e lo portò con sé. Artyom non riuscì a ricordarsi la strada che avevano percorso; comprese solo che l’uomo lo stava conducendo fuori dalla stazione e all’interno di una galleria, quale delle quattro era impossibile saperlo. Il nuovo conoscente si presentò come fratello Timothy. Lungo la strada, sia all’interno della grigia e ordinaria stazione della Serpukhovskaya, che nell’oscurità della galleria, non smise mai di parlare: “Gioisci, caro fratello, perché le nostre strade si sono incrociate e la tua vita sta per subire un cambiamento di enorme importanza. Le squallide tenebre che circondavano il tuo vagabondare senza scopo ben presto vedranno la luce, perché raggiungerai ciò che stai tanto cercando”. Artyom non comprese con precisione cosa avesse in mente l’uomo, poiché per lui la meta era ancora fin troppo lontana; tuttavia, il gentile Timothy dalle guance rosee si esprimeva con calma e dolcezza: il ragazzo avrebbe desiderato ascoltarlo per ore, comunicare con lui nella sua stessa lingua. Artyom gli era grato perché lui non lo aveva allontanato quando il resto del mondo lo aveva ripudiato. “Credi in un solo Dio onnipotente, fratello Artyom?”, gli domandò come per caso Timothy, che lo guardava attentamente negli occhi. Artyom riuscì solo a scuotere il capo in maniera indefinibile e a mormorare qualcosa di altrettanto impossibile da comprendere, che poteva essere interpretato, a seconda dei casi, come un sì o come un no. “Molto bene! Meraviglioso, fratello Artyom”, esclamò Timothy. “Solo se crediamo nella verità ci salveremo dai tormenti dell’inferno eterno e otterremo il perdono dei peccati. Perché...”, a questo punto assunse un’espressione grave e trionfale: “... il regno di nostro Signore Geova è prossimo e la sacre profezie della Bibbia si stanno avverando. Tu studi la Bibbia, fratello mio?” Artyom borbottò di nuovo, ma questa volta l’uomo dalle guance rosee lo guardò con apprensione. “Quando giungeremo alla Torre di guardia, i tuoi occhi si convinceranno che hai bisogno di studiare il Libro Sacro, che ci è stato consegnato dalle mani dell’Altissimo. La benedizione troverà tutti coloro che hanno intrapreso il cammino della Verità. La Bibbia, prezioso dono del nostro Dio, Geova, può essere solo paragonata a una lettera che un padre amorevole redige per il suo figlio più giovane”, aggiunse fratello Timothy per sicurezza. “Sai chi ha scritto la Bibbia?”, domandò ad Artyom in tono severo. CAPITOLO 11 : NON CI CREDO Artyom decise che non aveva più senso fingere e, onesto, scosse la testa. “Te lo riveleranno alla Torre di guardia, insieme a molto altro. I tuoi occhi si apriranno e finalmente potrai vedere anche i dettagli più incredibili”, proclamò fratello Timothy. “Sai cosa disse Gesù Cristo, figlio di Dio, ai suoi discepoli di Laodicea?”. Vedendo Artyom che distoglieva lo sguardo, l’uomo, paziente, scosse il capo in segno di rimprovero. “Gesù disse: ‘Vi chiedo di comprarmi del balsamo, con il quale potrò ungere i vostri occhi, così potrete vedere’. Ma Gesù non parlava di una malattia fisica”, sottolineò fratello Timothy, alzando il dito indice; la sua voce assunse un tono esaltato, un’intonazione stimolante che prometteva alle menti avide di sapere un seguito strabiliante. Artyom espresse subito un vivace interesse. “Gesù si riferisce alla cecità spirituale, che deve essere curata”, affermò Timothy, per svelargli l’enigma. “Proprio come te, migliaia sono le anime perdute che vagano cieche nell’oscurità. Ma la fede nel nostro vero Dio, Geova, è quel balsamo che apre gli occhi e permette di vedere il mondo per quello che è realmente. I tuoi occhi riescono a vedere, ma gli occhi dello spirito sono ciechi”. Artyom meditò che una buona pomata avrebbe fatto miracoli con il suo occhio, quattro giorni prima. Dato che non rispose, fratello Timothy decise che questa idea complessa richiedeva un’interpretazione più profonda e per qualche istante non parlò, per permettere ad Artyom di comprendere meglio ciò che aveva udito. Ma dopo cinque minuti, scorsero una luce tremolante davanti a loro e fratello Timothy interruppe le sue riflessioni e gli riferì l’esaltante notizia: “Vedi quella luce laggiù? È la Torre di guardia. Ci siamo!” In realtà non c’era alcuna torre e Artyom ne rimase deluso. All’interno della galleria c’era soltanto un normale treno, le cui flebili luci rischiaravano l’oscurità fino a quindici metri più avanti. Quando fratello Timothy e Artyom ci arrivarono, dalla carrozza della manutenzione scese un uomo cicciotto, con indosso una veste uguale a quella di fratello Timothy e li andò a salutare; abbracciò l’uomo dalle guance rosee e lo chiamò “mio amato fratello”, da cui Artyom dedusse che si trattava di un modo di dire più che di una vera e propria dichiarazione d’affetto. “Chi è questo giovane?”, domandò l’uomo cicciottello, a bassa voce, mentre sorrideva dolcemente ad Artyom. “È Artyom, un nostro nuovo fratello. Desidera camminare con noi sul sentiero della Verità, per studiare la Sacra Bibbia e rinunciare al Diavolo”, spiegò Timothy dalle guance rosse. “Allora permetti alla Torre di guardia di darti il benvenuto, mio amato fratello Artyom!”, recitò con voce monotona il ciccione. Il ragazzo si sorprese di nuovo del fatto che nemmeno lui sembrava notare il puzzo insopportabile che aveva ormai pervaso tutta la sua persona. “E ora”, disse in tono sommesso fratello Timothy, mentre avanzavano tranquilli verso il primo convoglio “prima che tu possa incontrare gli altri fratelli nella Sala del regno, dovrai ripulire il tuo corpo, poiché Geova è puro e sacro e si aspetta che i suoi discepoli si curino della loro purezza spirituale, morale e fisica, oltre a quella del pensiero. Viviamo in un mondo impuro”, sostenne, dando un’occhiata agli abiti di Artyom, in pessime condizioni, “e ci dobbiamo sforzare il più possibile per rimanere senza macchia agli occhi di Dio, fratello mio”, concluse e condusse in tutta fretta il ragazzo verso un angolo ricoperto da teloni di plastica, non lontano dall’entrata della carrozza. Timothy gli chiese di spogliarsi e gli porse una saponetta dall’odore nauseante. Cinque minuti dopo cominciò a fare scorrere l’acqua da un tubo di gomma. Artyom cercò di non pensare da cosa fosse ricavato il sapone; in ogni caso, non solo si liberò della sporcizia sulla sua pelle, ma riassorbì il puzzo disgustoso che emanava il suo corpo. Quando la procedura fu completata, fratello Timothy porse ad Artyom una tunica relativamente pulita, proprio come la sua, e guardò in tono riprovatorio il bossolo che aveva legato al collo, immaginando che si trattasse di un talismano pagano; tuttavia si limitò a un semplice sguardo di rimprovero. Artyom era sorpreso anche dal fatto che questo strano treno si fosse fermato, chissà quando, nel bel mezzo della galleria e ora serviva da rifugio ai confratelli, che chissà come erano riusciti a fare arrivare l’acqua, fresca e copiosa, fino a quel luogo. Ma quando Artyom gli chiese informazioni sull’acqua proveniente dal tubo di gomma e su come fosse possibile costruire una tale struttura, fratello Timothy si limitò a sorridere misteriosamente e a dichiarare che la sola aspirazione di compiacere Geova spingeva le persone ad atti eroici e gloriosi. La spiegazione fu molto vaga, ma gli sarebbe dovuta bastare. Quindi entrarono nel secondo vagone, in cui erano stati costruiti lunghi tavoli tra rigide panchine, che al momento erano vuote. Fratello Timothy si accostò a un uomo che sembrava stesse facendo un incantesimo davanti a un grande calderone, da cui fuoriusciva un vapore profumatissimo; poi tornò con un grande piatto di una sorta di minestra acquosa, che però si rivelò abbastanza mangiabile, sebbene Artyom non fu in grado di comprendere con cosa fosse stata preparata. Mentre mangiava avidamente la zuppa calda con un vecchio cucchiaio d’alluminio, fratello Timothy lo osservava con un’espressione affettuosa, senza perdere l’occasione di persuaderlo con i suoi discorsi: “Non pensare che io non mi fidi di te, fratello, ma la tua risposta alla mia domanda sulla fede in Dio non mi è parsa convinta. Riesci davvero a immaginare un mondo in cui Lui non esista? Il nostro mondo non può essersi creato da sé, ma solo in seguito a un atto della Sua saggia volontà. L’infinita varietà di forme di vita, la bellezza della Terra...”, con un cenno del capo, muovendo anche la barba, indicò la sala da pranzo. “È stato tutto generato dal caso?” Artyom esaminò attentamente lo spazio attorno a sé, ma non vide altre forme di vita, a parte loro due e il cuoco. Si incurvò di nuovo sopra la sua ciotola e emise degli scettici brontolii. Contrariamente a quanto si aspettava, il suo disaccordo non amareggiò fratello Timothy: l’uomo si era visibilmente rianimato, le sue gote rosee erano avvampate, sembravano quasi infuocate. “Se tutto ciò ancora non ti convince della Sua esistenza”, continuò fratello Timothy energico, “allora prova a pensarla in maniera diversa: se questo mondo non è la dimostrazione del Suo volere divino, significa che...”, la sua voce si interruppe, come dalla paura. Solo dopo diversi istanti, durante i quali Artyom perse completamente l’appetito, terminò la frase: “Significa che l’uomo è lasciato solo insieme alle sue macchine. La nostra esistenza non ha significato e non ha nemmeno senso prolungarla. Ciò indica che siamo soli, nel vero senso della parola; nessuno si prende cura di noi. Sprofondiamo nel caos e non abbiamo la benché minima speranza che alla fine della galleria vi sia la luce. Vivere in un mondo del genere è spaventoso. È impossibile”. Artyom non rispose nulla, ma le parole dell’uomo lo fecero riflettere. Fino a quel momento aveva vissuto una vita invasa dal caos più totale, composta da una serie di vicende senza senso, non interconnesse tra loro. Sebbene questo pensiero lo opprimesse e fosse forte la tentazione di affidare la sua vita a una semplice verità, lo considerava un atto di viltà, poiché grazie al dolore e al dubbio era riuscito a trovare la forza di andare avanti, consapevole che la sua esistenza fosse inutile e che tutti gli esseri viventi avrebbero dovuto resistere all’assurdità e al caos della vita. Ma in quel momento non se la sentiva di contraddire Timothy, che era stato tanto gentile con lui. Si sentiva soddisfatto e ristorato, provava una sincera gratitudine nei confronti di questa persona che lo aveva trovato stanco, affamato e puzzolente, che gli si era rivolto con una parola di conforto, che gli aveva offerto un pasto caldo e gli aveva persino dato degli abiti puliti. Si sentiva in dovere di ringraziarlo in qualche modo, perciò quando l’uomo lo invitò a partecipare a un incontro con gli altri fratelli, Artyom si alzò subito, dimostrando che sarebbe andato volentieri all’incontro o in qualsiasi altro luogo in cui lo avessero condotto. Il ritrovo si sarebbe svolto nella carrozza successiva, cioè nella terza, che era stipata di persone di tutti i generi, la maggior parte delle quali indossava una tunica identica alla sua. Al centro era stato posto un piccolo palco; la persona che lo calcava sovrastava tutti gli altri e quasi toccava il soffitto con la testa. “È cruciale che tu faccia attenzione a tutto ciò che viene detto oggi”, fratello Timothy si preoccupò di dare istruzioni ad Artyom, mentre si faceva strada tra la gente con delle spinte leggere e accompagnava il ragazzo al centro della stanza. L’oratore era anziano, il viso incorniciato da una bella barba grigia che gli scendeva fin sul petto; aveva gli occhi infossati di un colore indistinguibile e guardava la folla calmo, come un saggio. Il viso non era né snello né tondo, ma solcato da rughe profonde che non lo facevano sembrare debole o indifeso, anzi sottolineavano la sua saggezza: sprigionava una forza inspiegabile. “Quello è l’Anziano John”, sussurrò fratello Timothy in tono reverenziale. “Sei molto fortunato, fratello Artyom: non appena comincerà il sermone, i suoi insegnamenti ti pervaderanno all’istante”. L’anziano alzò la mano e il vociare e i mormorii si interruppero subito. Quindi cominciò a parlare, con voce profonda e sonora: “Con la mia prima lezione, miei amati fratelli, capirete ciò che Dio vi sta chiedendo. Per farlo, dovete rispondere a tre domande. Quali informazioni importanti sono contenute nella Bibbia? Chi è l’autore del Libro Sacro? Perché dobbiamo studiarlo?”. Il suo modo di parlare era molto diverso da quello di fratello Timothy, sempre molto intricato. L’anziano infatti parlava in maniera semplice, con proposizioni corte e di facile comprensione. Inizialmente Artyom ne fu sorpreso, ma poi si guardò attorno e notò che la maggior parte delle persone all’interno della sala sarebbe stata in grado di capire solo un discorso lineare e se l’uomo dalle guance rosee si fosse rivolto a loro sarebbe stato come parlare al muro. Nel frattempo, il predicatore dai capelli grigi li informò che la verità di Dio si trovava nella Bibbia, che spiega chi è Lui e quali siano le Sue leggi. Dopodiché prese in analisi la seconda domanda e affermò che la Bibbia fosse stata scritta in più di 1600 anni da una quarantina di persone diverse, tutte ispirate da Dio. “Proprio per questo”, concluse l’anziano “l’autore della Bibbia non è un uomo, ma è Dio in persona, che vive nei cieli. Ora rispondente, fratelli: perché dobbiamo studiare la Bibbia?” Senza aspettare che i fratelli rispondessero, spiegò: “Perché conoscere Dio e compiere la Sua volontà sono promesse di vita eterna. Non tutti concorderanno con la vostra scelta di studiare la Bibbia”, li ammonì, “ma non permettete agli altri di impedirvelo!”. Così dicendo gettò un’occhiata severa su tutta la congregazione. Ci fu un minuto di silenzio e, dopo aver bevuto un sorso d’acqua, l’anziano continuò: “Con la mia seconda lezione, fratelli, voglio rivelarvi chi è Dio. Rispondete a queste tre domande: chi è il vero Dio e qual è il Suo nome? Quali sono i Suoi tratti più importanti? Qual è il modo giusto per rivolgersi a Lui?” Qualcuno tra il pubblico voleva intervenire e rispondere a una delle domande, ma in cambio ricevette sguardi severi e John, indifferente, continuò: “La gente prega diversi dèi. Ma nella Bibbia troviamo scritto che esiste un unico Dio. Lui ha creato tutto ciò che si trova in cielo e in Terra. Dal momento che è stato Lui a donarci la vita, noi dobbiamo pregare solo Lui. Qual è il nome del vero Dio?”, urlò l’uomo dopo una lunga pausa. “Geova!”, a gran voce, la folla rispose all’unisono. Artyom si guardò attorno stranito. “Il vero nome di Dio è Geova!”, confermò il predicatore. “Ha molti titoli, ma un unico nome. Ricordate il nome del nostro Dio e non rivolgetevi a Lui come dei codardi, usando i Suoi titoli. Chiamatelo per nome! Ora chi mi dice qual è il tratto più importante del nostro Dio?” Artyom credeva che qualcuno, tra la folla, fosse vagamente più istruito e rispondesse a quella domanda. Infatti, di fianco a lui, un giovane dall’aspetto serio alzò la mano, ma l’anziano lo batté sul tempo. “La natura di Geova è rivelata nella Bibbia! E i Suoi tratti più importanti sono l’amore, la giustizia, la saggezza e la forza. La Bibbia ci dice che Dio è misericordioso, giusto, pronto a perdonare, magnanimo e paziente. Noi siamo i suoi figli obbedienti e dobbiamo cercare in tutti i modi di essere come Lui”. La congregazione non obiettò e l’anziano, toccandosi la bellissima barba, domandò: “Dite: come possiamo rivolgerci al nostro Dio Geova? Egli ci dice che dobbiamo pregare solo Lui. Non dobbiamo venerare effigi, icone e simboli. Non dobbiamo rivolgerci a loro! Il nostro Dio non divide la Sua gloria con altre entità! Le immagini sono impotenti, non ci possono aiutare!”, tuonò la voce, con fare quasi minaccioso. La folla mormorò in segno d’approvazione. Fratello Timothy rivolse il suo viso gioioso e raggiante verso Artyom: “L’anziano John è un grande oratore, grazie a lui le fila della nostra confraternita accrescono ogni giorno di più e la comunità dei discepoli della vera fede si sta allargando!” Artyom sorrise amaramente. Su di lui, il discorso entusiastico dell’Anziano John non stava avendo lo stesso effetto appassionante che sugli altri appartenenti alla congregazione. Ma forse avrebbe dovuto solo ascoltarlo ancora per un po’? “Con la mia terza lezione vi insegnerò chi è Gesù Cristo”, affermò l’anziano. “Le mie tre domande sono: perché Gesù Cristo viene chiamato l’unigenito figlio di Dio? Perché si è fatto uomo ed è sceso sulla Terra? Cosa farà Gesù nel prossimo futuro?” Fu subito chiaro che Gesù veniva chiamato l’unigenito figlio di Dio perché era stato la prima creazione di Geova, era l’incarnazione terrena dello Spirito Santo e viveva nei cieli. Artyom rimase molto sorpreso: aveva veduto il cielo una volta sola, quel fatidico giorno all’Orto botanico. Qualcuno, una volta, gli aveva raccontato che era possibile che sulle stelle vi fossero altre forme di vita. Il predicatore si riferiva a quelle? L’Anziano John si spiegò: “Chi, tra voi, vuole dirmi perché Gesù Cristo, figlio di Dio, è sceso sulla Terra?”, e fece una pausa teatrale. A quel punto Artyom comprese ciò che stava accadendo attorno a lui: i presenti appartenevano al gruppo dei convertiti che seguivano le lezioni da poco. I veterani non provarono mai a rispondere alle domande dell’anziano mentre gli iniziati cercavano di dimostrare le loro conoscenze e il loro entusiasmo, urlando le risposte e agitando le mani, finché l’uomo non forniva la sua spiegazione. “Quando Adamo non obbedì a Dio, diventò la prima persona a commettere ciò che la Bibbia definisce peccato”, l’anziano affrontò la questione dall’inizio. “Perciò Dio condannò Adamo a morire. Adamo invecchiò e morì, ma trasmise il suo peccato ai figli, i quali invecchiarono, si ammalarono e morirono. Quindi Geova mandò il suo primogenito sulla terra, affinché rivelasse all’uomo la verità di Dio e con i suoi comportamenti puri fungesse da esempio. Poi sacrificò la Sua vita per liberare l’umanità dal peccato e dalla morte”. Ad Artyom questo concetto sembrava molto bizzarro. Perché era necessario punire gli uomini con la morte per poi sacrificare il proprio unico figlio in modo che tutto potesse tornare al suo stato originario? Come poteva accadere se Lui era onnipotente? “Gesù tornò nei cieli, risorse. Fu così che Dio lo chiamò il Re. Presto Gesù cancellerà tutto il male e le sofferenze dalla faccia della Terra!”, promise l’anziano. “Ma riparleremo di ciò dopo la preghiera, fratelli miei!” Chinando obbedienti il capo, si riunirono nella preghiera. Artyom nuotava nel ronzio polifonico da cui non distingueva le singole parole, sebbene il senso fosse chiaro. Dopo cinque minuti, i fratelli cominciarono a scambiarsi parole vivaci, sembrava fossero preoccupati dell’arrivo dello Spirito Santo. Secondo Artyom c’era qualcosa che non quadrava. Era vagamente irritato, ma decise di rimanere ancora per un po’ perché era probabile che la parte più convincente della lezione dovesse ancora arrivare. “Con la mia quarta lezione voglio parlarvi del Diavolo”, guardò la folla con un uno sguardo lugubre e incriminante, quindi li avvertì: “Siete pronti? Fratelli! Il vostro spirito è abbastanza forte per sapere ciò che vi sto per rivelare?” A questa domanda tutti dovettero rispondere, ma il ragazzo non riuscì ad aprire bocca. Come poteva sapere se il suo spirito era abbastanza forte se, in realtà, tutta questa situazione non gli era ancora chiara? “Le mie tre domande sono le seguenti: da dove viene Satana? In che modo Satana tradisce le persone? Perché dobbiamo resistere al Diavolo?” Artyom sentì la risposta senza veramente ascoltarla, perché si era distratto a pensare al luogo in cui si trovava e a come sarebbe potuto uscirne. Riuscì solo a capire che il peccato maggiore del Diavolo era volere che l’uomo lo venerasse, privilegio che spettava solo a Dio. Quindi il giovane si domandò se il vero Dio si preoccupasse realmente di ciascuno dei suoi fedeli e se esisteva davvero una persona completamente devota a Dio... Il linguaggio dell’anziano ora suonava estremamente ufficiale e le domande che poneva al suo pubblico non davano adito ad alcuna discussione. Di tanto in tanto, fratello Timothy volgeva il suo sguardo attento in direzione del ragazzo, andando alla ricerca dell’imminente illuminazione; al contrario, Artyom si stava facendo sempre più cupo. “Satana inganna l’uomo in modo che lui lo veneri”, diceva nel frattempo l’anziano. “Esistono tre modi in cui arriva al suo obiettivo: le false religioni, lo spiritismo e il nazionalismo. Se una religione insegna menzogne su Dio, è al servizio dei propositi di Satana. È probabile che coloro che professano le false religioni pensino di rivolgersi al vero Dio, ma in realtà venerano Satana. Con lo spiritismo gli uomini credono di richiamare gli spiriti perché li proteggano, danneggino gli altri, predicano il futuro ed eseguano miracoli. Dietro ognuna di queste azioni si nasconde la forza malvagia del Diavolo!”. La voce dell’anziano tremava d’odio e ripugnanza. “Oltre a ciò, Satana inganna gli uomini incentivando il loro orgoglio nazionalistico e inducendoli a supportare le organizzazioni politiche”, li ammonì l’anziano con un dito alzato. “L’uomo crede che la sua razza o la sua nazione siano superiori alle altre, ma ciò non corrisponde a verità”. Artyom si massaggiò la parte posteriore del collo, ancora deturpata da un livido rosso e tossì. Non era d’accordo con quest’ultima asserzione. “Alcuni sono convinti che le organizzazioni politiche possano risolvere i problemi dell’umanità. Coloro che credono in questo negano il Regno di Dio. Ma solo Geova riuscirà a trovare una soluzione ai problemi degli uomini. E ora vi rivelerò, fratelli miei, perché dovete resistere al Diavolo. Per farvi ripudiare Geova, Satana potrebbe ricorrere a persecuzioni e ad altre azioni contro di voi. I vostri cari e i vostri vicini potrebbero adirarsi vedendovi studiare la Bibbia; altri potrebbero deridervi. Ma a chi dovete la vita?!”, domandò l’anziano alla platea, con una nota spietata nella voce. “Satana vi vuole spaventare! In modo che smettiate di ricercare Geova! Non permetteteglielo! Rivoltatevi! Contro! Satana!”, le parole di John rombarono come un tuono. “Resistendo al Diavolo darete prova a Geova che volete che sia lui a prendere il sopravvento sulle vostre vite!”. La folla era in estasi. Con un cenno della mano, l’Anziano John acquietò l’isteria generale, per terminare l’adunanza con la sua ultima, quinta lezione. “Qual era il progetto di Geova per la nostra Terra?”, si rivolse al suo pubblico aprendo le braccia. “Geova creò la Terra in modo che l’uomo l’abitasse in pace, per sempre. Desiderava che vi risiedesse un’umanità giusta e felice. La Terra non verrà mai distrutta. Esisterà per l’eternità!” A questa affermazione, Artyom non riuscì a contenersi e sbuffò. In molti lo guardarono adirati e fratello Timothy alzò un dito minaccioso in direzione del ragazzo. “I primi esseri umani, Adamo ed Eva, peccarono e violarono deliberatamente la legge di Dio”, continuò l’oratore. “Perciò Geova li scacciò dal Paradiso, che venne perduto. Ma Geova non dimenticò mai per quale ragione avesse creato la Terra. Promise di trasformarla in un Paradiso, in cui gli uomini potessero vivere per sempre. In che modo Dio sta portando a termine il suo progetto?”, domandò l’anziano. Una lunga pausa indicò che stava per arrivare il momento chiave del sermone. Artyom era tutto orecchi. “Prima che la Terra potesse divenire un Paradiso, gli uomini ingiusti dovevano essere eliminati”, John pronunciò le parole a mo’ di presagio di sventura. “Ai nostri avi è stato promesso che la Terra sarebbe stata purificata attraverso l’Apocalisse, una guerra divina per annientare il male. In questo modo Satana sarebbe rimasto incatenato per mille anni. Non ci sarebbe stato più nessuno che potesse arrecare danno alla Terra. Sarebbe sopravvissuto solo il popolo di Dio! E Gesù Cristo avrebbe regnato sulla Terra per mille anni!”. Così dicendo, l’anziano rivolse il suo sguardo grave alle prime file di spettatori, che stavano cercando di digerire le sue parole. “Comprendete il significato di quello che vi ho appena detto? La guerra divina per l’eliminazione del male è già terminata! Ciò che è accaduto alla Terra peccatrice è stata l’Apocalisse! Il male è stato distrutto! Come secondo la profezia, solo gli uomini di Dio sarebbero sopravvissuti! Noi siamo sopravvissuti all’Apocalisse! Il Regno di Dio è alle porte! Ben presto non ci sarà né vecchiaia, né malattia, né morte! I malati verranno liberati dalle loro medicine e i vecchi ritorneranno giovani! Nel regno di Cristo che durerà mille anni, coloro che sono fedeli a Dio trasformeranno la Terra in un Paradiso e Dio farà risorgere milioni di morti!” Artyom richiamò alla mente la conversazione tra Sukhoi e Hunter riguardo il livello di radiazioni in superficie, che non sarebbe diminuito per almeno altri cinquanta anni; riguardo il fatto che l’umanità era condannata e che altre specie biologiche stavano prendendo il sopravvento... L’anziano non spiegò con esattezza come la Terra si sarebbe trasformata in un giardino fiorito. Artyom desiderava domandargli quali bizzarri tipi di piante sarebbero potute sbocciare in quel paradiso bruciato fino nel midollo, quali uomini avrebbero osato salire in superficie per stabilirsi lassù; se i suoi genitori erano stati figli di Satana e per questo avevano dovuto soccombere durante la guerra per distruggere il male. Ma non disse nulla. Era pervaso da una tale amarezza e da un senso di sfiducia che gli bruciavano gli occhi; si vergognò quando sentì che una lacrima gli scendeva sul viso. Radunando tutte le sue forze, pronunciò un’unica frase: “Mi dica, cosa ne pensa Geova, il nostro vero Dio, dei mutanti senza testa?”. Non arrivò alcuna risposta. L’Anziano John non si degnò neppure di guardare Artyom, ma coloro che stavano vicini al ragazzo lo guardarono spaventati e disgustati, quindi si allontanarono, come se emettesse un odore ripugnante. Fratello Timothy cercò di prenderlo per la mano, Artyom riuscì a liberarsene e, facendosi strada tra i confratelli, arrivò all’uscita. Riuscì finalmente ad andarsene dalla Sala del regno ed entrò nella carrozza che fungeva da refettorio. Sedute ai tavoli c’erano molte persone con ciotole d’alluminio vuote davanti a loro. Nel mezzo della stanza stava accadendo qualcosa di interessante e tutti guardavano in quella direzione. “Confratelli, prima di condividere questo pasto”, parlava un tizio magro, bruttino, con il naso adunco. “Ascoltiamo la storia che ci racconterà il piccolo David e che completerà ciò che abbiamo ascoltato oggi durante il sermone sulla violenza”. Si spostò di lato e il suo posto venne occupato da un bambino cicciotto con il naso all’insù e i capelli talmente biondi da sembrare bianchi, perfettamente pettinati. “Era arrabbiato con me e mi voleva picchiare”, cominciò David, con l’intonazione usata dai bambini quando recitano versi imparati a memoria. “Forse solo perché sono basso... Io sono indietreggiato e ho urlato: ‘Fermo! Aspetta! Non mi toccare! Io non ti ho fatto niente. Cosa può averti offeso? Dimmi che è successo!’” il viso di David assunse un’espressione d’esaltazione per la quale, di sicuro, si era esercitato a lungo. “Cosa ti ha risposto quel terribile bullo?”, si intromise il tizio magro, eccitato. “Alla fine mi spiegò che qualcuno gli aveva rubato la colazione e che perciò stava sfogando la sua rabbia sulla prima persona in cui si era imbattuto”, spiegò David, ma c’era qualcosa nella sua voce che faceva dubitare che comprendesse appieno le parole che aveva appena pronunciato. “Tu come hai reagito?”, domandò l’uomo magro, per accrescere la tensione. “Gli ho semplicemente detto: ‘Se mi picchi, non riavrai la tua colazione’, poi gli ho suggerito di recarsi dal fratello Chef e di spiegargli l’accaduto. Così abbiamo chiesto un’altra porzione di colazione, tutta per lui. Dopodiché mi ha stretto la mano e dopo questo episodio è sempre stato gentile con me”. “L’uomo che ha offeso il piccolo David è presente in questa stanza?”, chiese il tizio magro, con il tono di un pubblico accusatore. Si alzò una mano e un robusto ragazzo sulla ventina con un’espressione ottusa e malevola si incamminò verso il palco improvvisato per descrivere ai presenti l’effetto che le parole del piccolo David avevano avuto su di lui. Non fu un compito semplice. Il ragazzino aveva memorizzato con maggiore facilità anche le parole che non comprendeva. Quando si concluse la presentazione e il piccolo David insieme al penitente colpevole lasciarono il palco accompagnati da un applauso d’approvazione, l’uomo pelle e ossa occupò il loro posto e si rivolse al pubblico con voce appassionata: “È vero! Le parole del mite hanno un potere immenso! Come troviamo scritto nei Proverbi, le parole dell’umile possono rompere persino le ossa. La dolcezza e l’umiltà non sono debolezze, miei amati confratelli, perché la dolcezza nasconde un’enorme forza di volontà! Ce ne dà esempio anche la Bibbia...” Facendo scorrere le pagine del libro ormai usurato finché non trovò la pagina cercata, il fratello si mise a leggere una storia ad alta voce, con tono rapito. Artyom proseguì, seguito da sguardi sorpresi, infine raggiunse la carrozza principale. Non c’era nessuno a fermarlo, stava per scendere sui binari quando la guardia più anziana della Torre, un omaccione garbato ma impassibile, lo salutò cordialmente sulla soglia della porta, bloccandola con il suo corpo e corrugando le sopracciglia folte. Quindi domandò severo ad Artyom se avesse il permesso di uscire. Non sarebbe riuscito a superarlo. Per trenta secondi attese una spiegazione, poi la guardia fece crocchiare le mani, le serrò a pugno e si diresse verso Artyom. Il ragazzo guardò in tutte le direzioni, si sentiva in trappola, ma poi ricordò la storia del piccolo David. Forse, invece di scagliarsi contro la guardia taurina, avrebbe fatto meglio a chiedergli se qualcuno gli aveva rubato la colazione. Per fortuna, proprio in quel momento, fratello Timothy lo raggiunse. Scrutò la guardia di sicurezza e disse: “Questo giovane può passare. Qui non tratteniamo nessuno contro la propria volontà”. La guardia, sorpresa ma obbediente, si scansò. “Permettimi di accompagnarti per un po’, mio amato fratello Artyom”, intonò fratello Timothy e il ragazzo non riuscì a resistere alla magia nella sua voce, così annuì. “Forse non sei abituato al nostro stile di vita, dopotutto questa era la tua prima volta”, Timothy, con voce confortante, cercò di dargli una spiegazione. “Ma ora il seme divino è stato piantato in te. È chiaro ai miei occhi che è caduto su un suolo fertile. Voglio solo ricordarti come non devi agire, ora che il Regno di Dio è più vicino che mai, affinché anche tu possa trovarvi posto. Devi imparare a odiare il male e a evitare ciò che Dio aborre: la fornicazione, che significa infedeltà, la sodomia, l’incesto e l’omosessualità, il gioco d’azzardo, le menzogne, il furto, gli accessi d’ira, la violenza, la stregoneria, lo spiritualismo e l’ubriachezza”. Fratello Timothy snocciolò le parole velocemente, guardando con ansia Artyom negli occhi. “Se ami Dio e se desideri compiacerlo, liberati da quei peccati! I tuoi amici più esperti ti potranno aiutare”, aggiunse, con tutta probabilità alludendo a se stesso. “Onora il nome di Dio, annunciane il Regno, stai lontano dagli affari del male e abiura la gente che ti suggerisce il contrario, perché è Satana che ti parla attraverso le loro parole”, mormorò, ma Artyom non lo stava ascoltando: camminava sempre più veloce e fratello Timothy non riusciva a stargli dietro. “Dimmi, dove potrò trovarti la prossima volta?”, gridò da lontano, respirando affannoso e avvolto nella quasi totale oscurità. Artyom rimase in silenzio e si mise a correre. Dalle sue spalle, nelle tenebre, l’uomo urlò disperato: “La tonaca...!” Artyom corse a perdifiato, inciampò poiché non riusciva a vedere nulla davanti a sé. Cadde diverse volte, spellandosi i palmi della mani sul cemento e scorticandosi le ginocchia, ma non poteva fermarsi. L’immagine della mitragliatrice nera montata sul piedistallo era troppo chiara nella sua mente e in quel momento non riusciva a pensare che, se i confratelli lo avessero raggiunto, avrebbero preferito davvero le semplici parole alla violenza. Era sempre più vicino al suo obiettivo, a un passo dalla Polis, che si trovava sulla stessa linea ed era solo a due stazioni di distanza. Ora doveva solo procedere, senza sgarrare, doveva seguire la sua strada, poi... Artyom entrò nella Serphukhovskaya. Non si fermò nemmeno per un secondo, si limitò a controllare in che direzione procedere, poi si rituffò nell’oscurità della galleria davanti a sé. Ma a quel punto gli accadde qualcosa di inaspettato. La paura della galleria, che aveva da tempo dimenticato, tornò ad assalirlo, pressante sopra di lui, impedendogli di camminare, di pensare o persino di respirare. Ormai credeva di esserci abituato e che, dopo tutto il suo vagabondare, quella paura lo avrebbe lasciato in pace e non avrebbe più osato importunarlo. Non aveva provato timore né preoccupazione mentre si dirigeva dalla Kitay-Gorod alla Pushkinskaya o sul carrello, dalla Tverskaya alla Paveletskaya, e nemmeno durante la faticosa camminata in solitaria, tra la Paveletskaya e la Dobryninskaya. Ma ora era ritornata. Ogni passo in avanti, la sensazione lo assaliva sempre più. Aveva quasi intenzione di tornare indietro e di risalire alla stazione, dove c’erano luce e altre persone, dove la sua schiena non avrebbe percepito di costanti brividi causati da uno sguardo fisso e malevolo. Aveva interagito troppo con la gente e non riusciva più ad avvertire quell’illuminazione che l’aveva pervaso la prima volta che aveva lasciato l’Alekseevskaya. Di nuovo venne inghiottito dalla consapevolezza che la Metro non era un mero mezzo di trasporto costruito in un passato lontano, non era un semplice rifugio antiatomico o il luogo in cui vivevano diverse decine di migliaia di persone... Sembrava piuttosto che qualcuno le avesse donato una vita misteriosa e ineguagliabile e che possedesse un proprio, straordinario senso della ragione, che gli esseri umani non potevano penetrare, perché aveva una coscienza del tutto sconosciuta. Questa sensazione era chiara e precisa, infatti ad Artyom parve che la “tunnel-fobia”, che la gente considerava il proprio rifugio definitivo, fosse una semplice traduzione dell’ostilità di questo enorme essere nei confronti delle creature insignificanti che si erano rintanate tra le sue membra. Ora, questo essere impediva ad Artyom di proseguire. Si metteva in mezzo tra lui e la fine del suo cammino, il momento in cui avrebbe raggiunto il suo scopo: si stava dibattendo, usando il suo antico e potentissimo volere. La resistenza della bestia aumentava, man mano che il ragazzo procedeva. Ora Artyom andava tastoni nell’oscurità più impenetrabile. Gli era impossibile vedersi le mani, anche se le alzava davanti agli occhi. Gli sembrava di essere precipitato al di fuori dello spazio e del tempo e che la sua persona avesse cessato di vivere. Era come se il suo corpo non stesse avanzando, passo dopo passo, all’interno del tunnel, ma si stesse librando, come sostanza di pura ragione in una dimensione sconosciuta. Artyom non riusciva a intravvedere le pareti che si muovevano di fianco a lui, perciò gli sembrava di stare fermo, di non fare nemmeno un passo cosicché il fine ultimo del suo viaggio fosse tanto irraggiungibile quanto lo era stato cinque o dieci minuti prima. I suoi piedi si spostavano sulle traversine, quindi sapeva che la sua posizione spaziale cambiava. Tuttavia, il segnale che indicava al cervello dove si trovavano le nuove traversine su cui poggiare i piedi era completamente uniforme. Registrato una volta per tutte, si ripeteva all’infinito. Anche questo lo faceva dubitare della veridicità del suo movimento. Stava camminando? Si stava avvicinando alla meta? All’improvviso, ricordò la sua visione, che diede risposta al quesito che lo stava tormentando. A quel punto, a causa del terrore dell’ignoto, del male e di quell’ostile entità che gravava su di lui, oppure per dimostrare a se stesso di essere ancora in movimento, Artyom corse in avanti con il triplo della forza. Riuscì a malapena a fermarsi, prevedendo grazie a una sorta di sesto senso che davanti a lui vi fosse un ostacolo. Così riuscì miracolosamente a evitarlo. Attento, sondò con le mani il metallo freddo e arrugginito, poi i frammenti di vetro rimasti incastrati nelle guarnizioni di gomma, i cerchi d’acciaio delle ruote: riuscì a riconoscere che l’ostacolo misterioso era un treno, in apparenza abbandonato. In ogni caso, era circondato solo da silenzio. Gli tornò alla mente la terribile storia di Mikhail Porfirevich, pertanto Artyom non cercò di entrare all’interno dei convogli, ma costeggiò le diverse carrozze rimanendo il più vicino possibile alle pareti della galleria. Riuscì a superare il treno, tirò un sospiro di sollievo e si affrettò a continuare, ricominciando a correre. Tra le tenebre era ancora più difficile, ma le sue gambe lo assecondavano e lui corse finché davanti a lui, su un lato, apparve il bagliore rossastro di un fuoco da campo. La sensazione di conforto fu indescrivibile: era nel mondo reale e stava per raggiungere persone reali. Non gli importava sapere come si sarebbero relazionate con lui, sarebbero potuti essere assassini o ladri, membri di una setta o rivoluzionari. L’importante era che si trattava di creature in carne e ossa, proprio come lui. Non dubitò nemmeno per un istante di poter trovare rifugio presso quelle persone, per nascondersi dall’enorme creatura invisibile che lo voleva soffocare. Oppure stava cercando rifugio dalla sua mente squilibrata? La scena che si ritrovò dinanzi era talmente bizzarra che per un momento dubitò davvero di essere ritornato al mondo reale. Oppure stava ancora vagando tra gli anfratti e i recessi del suo subconscio? Alla Polyanka bruciava un unico, piccolo fuoco, ma dato che si trattava della sola fonte di luce, ciò lo aveva fatto sembrare persino più luminoso delle luci elettriche della Paveletskaya. Due persone vi erano sedute attorno, una voltava le spalle ad Artyom, mentre l’altra lo poteva vedere in faccia, ma nessuno dei due si accorse di lui né lo sentì. Era come se fossero separati da una parete invisibile che li estrometteva dal resto del mondo. In tutta la stazione, per quanto il ragazzo riusciva a scorgere dalla luce del fuoco, erano state impilate cianfrusaglie di qualsiasi tipo; tra gli altri si distinguevano telai di biciclette rotte, pneumatici di automobili, mobili e apparecchi di vario tipo. Inoltre, c’era una montagna di spazzatura dalla quale, di tanto in tanto, i due seduti attorno al fuoco recuperavano cataste di giornali o di libri e li gettavano tra le fiamme. Proprio di fronte al fuoco c’era anche un busto di gesso, di fianco al quale era comodamente acciambellata una gatta. Non si intravvedeva altra anima viva. Uno dei due uomini seduti attorno al fuoco raccontava qualcosa all’altro, senza alcuna fretta. Avvicinandosi, Artyom riuscì a comprendere cosa dicevano: “Le voci sull’Università... secondo me sono tutte false. Si tratta dell’eco di un antico mito riguardante una Città sotterranea nel distretto Ramenki, che faceva parte della Metro-2. Ma naturalmente non possiamo confutare alcuna teoria al cento percento. In generale, qui, niente è sicuro. Viviamo in un impero di miti e leggende. La Metro-2 sarebbe stato quello principale, se ne fosse stato a conoscenza un numero maggiore di persone. Prendi ad esempio la convinzione che esistano gli Osservatori invisibili!” Artyom era sempre più vicino, quando l’uomo che gli voltava le spalle disse: “C’è qualcuno”. “Certo che sì”, confermò l’altro. “Puoi unirti a noi”, fu di nuovo il primo uomo a parlare, rivolgendosi ad Artyom, ma senza voltare il capo. “In ogni caso, non puoi proseguire”. “E perché no?”, obiettò Artyom con agitazione. “C’è qualcuno in quella galleria?” “Ovviamente non c’è nessuno”, spiegò paziente l’uomo. “Chi oserebbe mai entrarci? Non puoi proseguire comunque, te lo dico io. Quindi, siediti con noi”. “Grazie”, Artyom fece un piccolo passo in avanti e si accomodò di fronte al busto. I due uomini erano sulla quarantina. Uno aveva i capelli grigi e gli occhiali squadrati, mentre l’altro era magro, aveva i capelli chiari e la barbetta. Entrambi indossavano giacche imbottite consunte. Fumavano qualcosa da un tubo sottile collegato a quella che sembrava una calabassa, il cui fumo emanava una fragranza inebriante. “Come ti chiami?”, domandò l’uomo dai capelli chiari. “Artyom”, rispose il giovane meccanicamente, poiché era impegnato a studiare i due strani personaggi che aveva di fronte. “Si chiama Artyom”, ripeté l’uomo dai capelli chiari all’altro. “Beh, lo abbiamo capito”, rispose. “Io sono Yevgeny Dmitrievich e questo è Sergei Andreyevich”, continuò l’uomo con i capelli chiari. “Cerchiamo di non essere così formali...”, puntualizzò Sergei Andreyevich. “Sergei, noi due siamo arrivati a una certa età. Potremmo approfittarne. È una questione di status, non trovi?” “Giusto. E poi?”, chiese quindi Sergei Andreyevich ad Artyom. La domanda gli parve abbastanza bizzarra, come se fosse la continuazione di qualcosa che non era nemmeno cominciato. Artyom era alquanto perplesso. “Tu sei Artyom, e cos’altro? Dove vivi, dove stai andando, in cosa credi e in cosa non credi, di chi è la colpa e cosa bisogna fare?”, spiegò Sergei Andreyevich. “Proprio come ai vecchi tempi, ricordi?”, aggiunse all’improvviso Sergei Andreyevich, senza una ragione apparente. “Ma certo!”, rise Yevgeny Dmitrievich. “Vivo alla VDNKh... almeno, una volta vivevo laggiù”, il ragazzo cominciò a raccontare, restio. “Ad esempio... Chi ha piazzato lo scarpone sul pannello di controllo?”, sogghignò l’uomo con i capelli chiari. “Sì! Non è rimasto niente dell’America!”. Sergei Andreyevich fece un sorriso furbo, si tolse gli occhiali e li esaminò alla luce. Artyom li guardò di nuovo, stranito. Forse avrebbe fatto meglio ad andarsene, mentre questi due erano ancora di buon umore. Ma il ragazzo si domandò di cosa stessero parlando prima di notarlo e di farlo avvicinare al fuoco. “Cosa dicevate a proposito della Metro-2? Dovete scusarmi, ho udito per caso una parte del vostro discorso”, ammise. “Vuoi conoscere la leggenda più importante della Metropolitana?”, Sergei Andreyevich sorrise altezzoso. “E cosa vorresti sapere di preciso?” “Stavate parlando di una città sotterranea e di osservatori...” “Beh, la Metro-2 serviva da rifugio per gli dèi del pantheon sovietico, ai tempi del Ragnarök, nel caso in cui le forze del male avessero avuto la meglio”, cominciò Yevgeny Dmitrievich, contemplando il soffitto ed emettendo cerchi di fumo. “Secondo le leggende, sotto la città il cui cadavere giace lassù, sopra di noi, fu costruita un’altra Metropolitana, quella per l’élite. Al contrario, quella che vedi qui è la Metro per il gregge. L’altra, stando al mito, è per i pastori e i loro cani. All’inizio, quando i pastori non avevano ancora perso i loro poteri sul gregge, dominavano da quel luogo, ma in seguito la loro forza si esaurì e le pecore fuggirono. Tra i due mondi vi erano delle semplici porte e, se credi alle leggende, queste si trovano nel punto in cui la mappa è divisa in due da una cicatrice rosso sangue, sulla diramazione Sokolinskaya, probabilmente al di là della Sportivnaya. In seguito si verificò un evento che fece chiudere per sempre l’entrata alla Metro-2. La gente che vive qui perse la consapevolezza di ciò che si era verificato e l’esistenza stessa della Metro-2 diventò mitica, irreale. Ma...”, così dicendo puntò il dito verso l’alto, “... sebbene l’entrata della Metro-2 non ci sia più, ciò non significa che anch’essa abbia smesso di esistere. Al contrario, io ritengo sia tutt’attorno a noi. Le sue gallerie si snodano attorno alle nostre stazioni e le loro stazioni potrebbero trovarsi qualche passo oltre le pareti delle nostre. Le due strutture sono inseparabili, potrebbero essere paragonate al sistema circolatorio e ai vasi linfatici di un organismo. Coloro che ritengono che i pastori non possono aver abbandonato il loro gregge nelle mani del destino, sostengono che essi siano presenti, in maniera impercettibile, nelle nostre vite, ci dirigano, seguano tutti i nostri movimenti, ma non si rivelano e non ci permettono di sapere che esistono. È il mito degli Osservatori invisibili”. La gatta, acciambellata di fianco al busto ricoperto di fuliggine, alzò la testa e aprì gli enormi occhi verdi e brillanti, guardando Artyom con un’espressione sorprendentemente lucida e intelligente. Il suo sguardo non era quello di un animale e il ragazzo non poteva mettere la mano sul fuoco che dietro quegli occhi non ci fosse qualcuno che lo studiava attentamente. La gatta sbadigliò, mostrò la sottile lingua rosa, sprofondò il muso nel suo giaciglio e tornò a dormire, come un’illusione scomparsa. “Ma perché non vogliono metterci al corrente della loro esistenza?”, Artyom ricordò la sua domanda. “Ci sono due ragioni principali: prima di tutto le pecore sono colpevoli di aver rifiutato l’aiuto dei loro pastori in un momento di debolezza. In secondo luogo, dato che la Metro-2 venne estromessa dal mondo, i pastori si svilupparono in maniera diversa da noi: non sono più umani, ma esseri appartenenti a un ordine superiore, la cui logica ci è incomprensibile e i cui pensieri ci sono inaccessibili. Nessuno sa cosa pensano della nostra Metropolitana, ma loro potrebbero cambiare ogni cosa, persino permetterci di ritornare nel nostro meraviglioso mondo perduto perché sono stati in grado di rimpossessarsi dei poteri precedenti. Dato che ci siamo ribellati contro di loro già una volta e li abbiamo traditi, non hanno più niente a che fare con il nostro destino. Tuttavia, i pastori sono ovunque, sanno tutto di noi: ogni respiro, ogni passo, ogni colpo, tutto ciò che accade all’interno della Metropolitana. Osservano il nostro presente e solo quando espieremo il nostro terribile peccato ci rivolgeranno uno sguardo benevolo e ci tenderanno una mano. Allora comincerà una rinascita. Questo è ciò che sostengono coloro che credono negli Osservatori invisibili”. Non disse altro e inspirò il fumo aromatico. “Ma la gente come può pagare per il proprio peccato?”, domandò Artyom. “Nessuno lo sa, eccetto gli Osservatori invisibili. Gli umani non riescono a comprenderlo poiché non sono a conoscenza della dispensa da parte degli Osservatori”. “Perciò la gente potrebbe non essere mai in grado di espiare il proprio peccato?”. Artyom non ci capiva più niente. “La cosa ti infastidisce?”. Yevgeny Dmitrievich fece spallucce e produsse due spettacolari anelli di fumo, il primo infilato nel secondo. Nessuno parlò per diversi minuti, all’inizio il silenzio era leggero e diafano, poi divenne più palpabile, quasi assordante. Artyom provava la necessità di interromperlo il prima possibile, anche con un’affermazione o un rumore senza senso. Chiese: “E voi da dove venite?” “Prima, vivevo a Smolenskaya, non lontano dalla Metro, a circa cinque minuti a piedi”, Yevgeny Dmitrievich rispose al ragazzo, che lo osservava sorpreso: come poteva vivere non lontano dalla Metropolitana? Probabilmente voleva dire che viveva poco distante dalla stazione della Metropolitana, in una galleria, vero? “Si dovevano superare bancarelle che vendevano da mangiare e alle volte compravamo anche la birra; c’erano sempre delle prostitute vicino ai banchetti e la polizia... ehm... aveva il proprio quartier generale in quella zona”, continuò Yevgeny Dmitrievich e Artyom capì che in effetti si riferiva ai vecchi tempi, a ciò che accadeva prima. “Sì, anche io vivevo poco distante da qui, sulla Kalininskiy, in un edificio altissimo”, spiegò Sergei Andreyevich. “Cinque anni fa mi è stato raccontato che qualcuno ha parlato con uno stalker, il quale gli ha riferito che quell’edificio è ridotto in polvere... La Casa del libro è ancora al suo posto, in vetrina ci sono ancora i tascabili in edizione economica, nessuno li ha toccati, ci potete credere? Ma tutto ciò che è rimasto dell’edificio in cui vivevo è un mucchio di polvere e blocchi di cemento. Che strano”. “Com’era la vita prima?”, Artyom era curioso. Adorava porre domande del genere ai più anziani, perché interrompevano qualsiasi azione stessero compiendo e, ben disposti, si mettevano a descrivere i vecchi tempi. I loro occhi assumevano una velatura sognante, distante. Le loro voci avevano un suono completamente diverso e, dai loro visi, pareva che avessero dieci anni in meno. Le immagini del passato che ricomparivano eteree davanti ai loro occhi non erano per nulla simili a quelle che Artyom evocava durante i loro racconti, ma erano comunque molto piacevoli. Era come una dolce tortura, che faceva male al cuore... “Beh, era meraviglioso. A quel tempo, noi... sì! Eravamo indemoniati!”, rispose Yevgeny Dmitrievich cercando le parole giuste. Artyom non riusciva a capire ciò che intendesse l’uomo dai capelli grigi e quando il suo compagno lo capì, spiegò: “Eravamo vivaci e ci divertivamo molto”. “È esattamente quello che volevo dire io: eravamo indemoniati”, confermò Yevgeny Dmitrievich. “Possedevo una Moskvich-2141 verde e per acquistarla, per metterla a punto e cambiarne l’olio avevo speso un’intera busta paga. Una volta, come uno stupido, feci anche sostituire il carburatore con quello di un’auto sportiva e poi usai il protossido d’azoto”. Era ovvio che fosse ritornato indietro nel tempo, quando recuperare il carburatore di una vecchia macchina sportiva per montarlo sulla propria era facile come bere un bicchiere d’acqua. Il suo viso assunse la solita espressione sognante che Artyom tanto amava. Era un peccato che il ragazzo potesse comprendere così poco di ciò che stava raccontando. “È probabile che Artyom non sappia nemmeno cosa sia una Moskvich, figuriamoci un carburatore!”, Sergei Andreyevich interruppe i ricordi dell’amico. “Che significa che non lo sa?”, l’uomo più magro lanciò al giovane un’occhiata seccata. Artyom si mise a studiare il soffitto, riflettendo. “Perché bruciate questi libri?”, cambiò discorso. “Li abbiamo già letti”, lo apostrofò Yevgeny Dmitrievich. “I libri non contengono alcuna verità!”, aggiunse Sergei Andreyevich. “E comunque, potresti spiegarci perché sei vestito così? Sei membro di una setta, forse?”. Yevgeny Dmitrievich mise a segno il colpo decisivo. “No, naturalmente no”, si affrettò a spiegare Artyom. “Ma mi hanno aiutato quando ero in difficoltà”. Con poche parole chiarì in quale cattivo stato si trovasse fino a poco prima, ma non si soffermò sui particolari. “Sì, certo. Fanno sempre così. Riconosco la tattica. Orfani e miserabili... o qualcosa del genere”, annuì Yevgeny Dmitrievich. “Ho partecipato a uno dei loro incontri. Raccontano storie molto stravaganti”, aggiunse Artyom. “Ho ascoltato per un po’, ma non sono riuscito a rimanere a lungo. Ad esempio, sostengono che l’immoralità di Satana consista principalmente nel volere l’adorazione e la gloria dell’uomo anche per sé... Prima credevo fosse un peccato molto più grave, il suo. Ma pare che si tratti di gelosia. Il mondo è davvero tanto semplice? Tutto ruota attorno al fatto che qualcuno non ha intenzione di condividere la propria gloria e i propri fedeli?” “Il mondo non è per nulla semplice”, assicurò Sergei Andreyevich prendendo il narghilè dalle mani dell’amico con i capelli biondi e inspirando profondamente. “Inoltre asseriscono che le principali qualità di Dio siano la sua benevolenza, la gentilezza e la prontezza al perdono. Dio è amore ed è onnipotente. Tuttavia, la prima volta che l’uomo gli disobbedì, Lui decise di scacciarlo dal Paradiso e di renderlo mortale e così perirono molte altre persone. Ma alla fine Dio decide di inviare Suo figlio per salvare il mondo. Quando poi Cristo viene condannato a una morte orribile, si rivolse al Padre, domandandogli perché Lui lo avesse abbandonato. E qual è la spiegazione di questo gesto? Dio voleva epurare, con il sangue del figlio, il peccato del primo umano, che Dio stesso aveva provocato e punito, affinché l’uomo potesse ritornare in Paradiso e scoprire di nuovo l’immortalità. A me sembra una sciocchezza in piena regola, perché Lui avrebbe potuto punire l’uomo meno severamente per il peccato che in realtà non aveva commesso. O comunque avrebbe potuto perdonarlo prima, perché il reato era stato perpetrato nel passato più remoto. Sacrifichi il tuo unico figlio e lo tradisci? Ma che razza di amore è questo? Dio è pronto a perdonare? Dov’è la sua onnipotenza?” “Credo che tu abbia centrato la questione, anche se sei stato un po’ troppo brutale”, approvò Sergei Andreyevich passando la pipa al compagno. “Su questo argomento posso solo dirti che...”, cominciò Yevgeny Dmitrievich, riempiendosi i polmoni di fumo e sorridendo spensierato. Si interruppe per un minuto, poi continuò: “Se Dio possiede davvero qualità particolari o caratteristiche distintive, queste non includono l’amore, la giustizia e il perdono. Osservando ciò che è accaduto sulla Terra dal momento che è stata, ehm, creata, si nota subito che Dio ama solo una cosa e cioè le storie interessanti: prima getta le basi perché si sviluppi una situazione interessante, poi si mette da parte per assistere allo spettacolo. Se il risultato è noioso, aggiunge un po’ di pepe. Il vecchio Shakespeare aveva ragione: il mondo è un palcoscenico. Solo che non si trattava di quello a cui alludeva lui”, concluse. “Solo questa mattina ti hanno descritto secoli di inferno”, rifletté Sergei Andreyevich. “Ciò significa che quando ci arriverai, avrai qualcuno con cui discorrere”, Yevgeny Dmitrievich si rivolse all’amico. “D’altra parte, laggiù si possono incontrare personaggi molto interessanti”, aggiunse Sergei Andreyevich. “Ad esempio quelli dei ranghi più alti della gerarchia della Chiesa cattolica”. “Sì, loro ci sono di sicuro. Ma, a dire la verità, anche i nostri...” Era chiaro che i due uomini non credevano nel fatto che sarebbe giunto il momento in cui sarebbero stati giudicati per ciò che avevano detto fino a quel giorno. Ma il racconto di Yevgeny Dmitrievich su ciò che era accaduto all’umanità era un storia interessante e Artyom si mise di nuovo a riflettere. “Ho letto moltissimi libri”, affermò “ma mi sorprendo sempre quando noto che non hanno nulla a che vedere con la vita reale. Gli eventi, in un libro, sono sempre lineari, ognuno è collegato all’altro, le cause hanno i propri effetti, non c’è nulla che succede e basta. Ma la realtà è completamente diversa! La vita è piena di eventi senza senso che ci accadono a caso, nulla ha una sua sequenza logica. Inoltre, i libri terminano quando si interrompe la catena logica: c’è un inizio, un intreccio, un picco e una fine”. “Un climax, non un picco”, lo corresse Sergei Andreyevich ascoltando le osservazioni di Artyom come se fosse annoiato. Anche Yevgeny Dmitrievich non sembrava particolarmente interessato. Avvicinò a sé l’aggeggio che avevano costruito per fumare, inspirò un po’ di fumo inebriante e trattenne il respiro. “D’accordo, un climax”, continuò Artyom, vagamente scoraggiato. “Nella vita, è tutto diverso. Per prima cosa, una catena logica potrebbe non avere una fine. Inoltre, anche se dovesse concludersi, nessun avvenimento termina solo per questo motivo”. “Con ciò, vuoi dire che la vita non segue alcuna trama?”, gli chiese Sergei Andreyevich, aiutando Artyom a formulare meglio il suo pensiero. Artyom ci pensò un attimo, poi annuì. “Non credi nel destino?”, lo sollecitò Sergei Andreyevich, inclinando il capo da un lato, studiando il ragazzo, mentre Yevgeny Dmitrievich perse interesse nel narghilè e si mise ad ascoltare. “No”, rispose deciso Artyom. “Il destino non esiste, all’uomo accadono solo avvenimenti causali, poi siamo noi a trarne le nostre conclusioni”. “Peccato... peccato davvero”, sospirò Sergei Andreyevich con disappunto, osservando il ragazzo con uno sguardo austero, da sopra i suoi occhiali. “Voglio descriverti la mia teoria, poi capirai da te se corrisponde alla tua vita oppure no. A me sembra che la vita sia una barzelletta senza avvenimenti, senza alcuno scopo, nella quale non esiste il destino, cioè quella molla esplicita e definita che quando nasci ti comunica se diventerai un astronauta, una ballerina o se morirai da piccolo... No, niente di tutto ciò. Quando vivi il periodo di tempo che hai a disposizione... come posso spiegartelo... potrebbe verificarsi qualcosa che ti obblighi a eseguire azioni specifiche, a prendere decisioni particolari e, sempre con il libero arbitrio, tu possa decidere di dedicarti a un’attività o a un’altra. Ma se prendi la decisione giusta, allora tutto accade di conseguenza, non si tratta di eventi casuali, come li hai chiamati tu. Vengono causati dalle tue scelte. Non voglio dire che se avessi deciso di vivere sulla linea Rossa prima che diventasse comunista, allora ci saresti rimasto per sempre e che gli eventi a te riservati non ti sarebbero accaduti. Parlo di una questione molto più sottile. Tuttavia, se in seguito ti dovessi trovare di nuovo a un incrocio e decidessi di percorrere la via giusta, ti ritroveresti a prendere una decisione che non ti sembra più casuale perché la puoi comprendere. La tua vita non sarà più solo un insieme di eventi, ma si trasformerà in una... trama, in cui tutto è collegato da un filo rosso, non necessariamente diritto. Questo è il tuo destino. A un certo punto, se hai percorso la tua strada e la tua vita è diventata una trama, vivrai vicende che sembrano inspiegabili dal punto di vista strettamente razionale o della tua teoria degli eventi casuali. Però, se guardi la vita come una trama, allora ti accorgi che questi stessi fatti si susseguono secondo una certa logica. Il destino non accade e basta, ci devi arrivare tu. Quando gli eventi nella tua vita cominciano a prendere il loro posto all’interno della trama, allora puoi fare passi da gigante. Ancor più interessante è il momento in cui una persona non sospetta nemmeno che gli accada qualcosa, oppure concepisce ciò che gli succede sulla base di false premesse, cercando di sistematizzare gli eventi per farli corrispondere alla propria visione del mondo. Ma il destino ha la sua logica”. Questa teoria balzana, che inizialmente pareva ad Artyom solo una serie di paroloni giustapposti, lo obbligò a guardare con occhi diversi tutto ciò che gli era accaduto dall’inizio del viaggio, da quando aveva acconsentito alla proposta di Hunter di raggiungere la Polis. Tutte le avventure, i viaggi, che in precedenza gli erano sembrati dei tentativi inutili e disperati di raggiungere l’obiettivo della sua missione, che avrebbe inseguito ovunque, gli apparvero in una luce diversa: un sistema elaborato ma organizzato che formava una struttura complicata ma ben concepita. Infatti, se si considerava come primo passo il fatto che Artyom avesse accettato la proposta di Hunter, proprio come aveva teorizzato Sergei Andreyevich, tutti gli eventi successivi, tra cui la spedizione alla Rizhskaya, l’incontro con Bourbon in quella stessa stazione e il momento in cui il ragazzo aveva acconsentito di andare con lui, erano tutti passi in avanti... come il momento in cui Khan lo aveva trovato, anche se sarebbe potuto rimanere alla Sukharevskaya, sebbene il filosofo avrebbe potuto spiegare l’avvenimento in maniera diversa, anche perché Khan stesso aveva fornito una ragione differente alle sue azioni. Quando Artyom era stato preso prigioniero dai fascisti, avrebbe potuto essere impiccato alla Tverskaya, ma le circostanze avevano voluto che la Brigata Internazionale avesse deciso di attaccare la stazione proprio quel giorno. Se i rivoluzionari si fossero presentati un giorno prima o uno dopo, la morte di Artyom sarebbe stata inevitabile e la sua missione sarebbe stata interrotta. Era veramente possibile che la perseveranza con cui proseguiva il suo cammino avesse influenzato gli eventi futuri? Poteva essere che la determinazione, la rabbia e la disperazione che lo avevano condotto a fare passi in avanti avessero dato adito, in maniera inspiegabile, a una realtà che intrecciava tra loro una serie di eventi caotici, che il pensiero e le azioni di qualcuno le avessero ordinate in un sistema, trasformando la vita in una trama, proprio come gli aveva spiegato Sergei Andreyevich? A un primo sguardo, sembrava che non fosse possibile. Ma se ci si soffermava a pensarci un secondo... come altro poteva spiegare l’incontro con Mark, che aveva offerto ad Artyom l’unica possibilità di uscire dal territorio dell’Hansa? Ma soprattutto, quando era stato condannato a pulire le latrine, sembrava proprio che il destino gli avesse voltato le spalle. Tuttavia aveva lottato con le unghie e con i denti, senza nemmeno comprendere le sue azioni ed era accaduto l’impossibile: la guardia che doveva essere al posto di blocco era scomparsa e nessuno lo aveva inseguito. Perciò, dal sentiero che lo aveva portato fuori strada, era riuscito a tornare in carreggiata. Per quanto ne sapeva, la realtà sarebbe potuta essere già seriamente distorta e si sarebbe potuto limitare a sperare che il suo futuro si sviluppasse senza ulteriori intralci. Ma allora ciò significava che, se avesse fatto un passo nella direzione sbagliata, se si fosse allontanato dall’obiettivo, il destino lo avrebbe abbandonato e lo scudo invisibile che evitava che Artyom rimanesse ucciso si sarebbe sbriciolato in mille pezzi? Il filo di Arianna che stava seguendo con tanta attenzione si sarebbe rotto e lo avrebbe costretto ad affrontare faccia a faccia una realtà turbolenta, che si era infuriata in seguito alle sue impudenti intrusioni nella sua sostanza caotica? Era possibile che chiunque provasse a ingannare il fato, e fosse abbastanza irriverente da perseverare nonostante sopra la sua testa si fossero formati nuvoloni oscuri, non potesse lasciare il sentiero a lui predestinato? Da allora la sua vita si sarebbe trasformata in un grigio luogo comune, non sarebbe accaduto nient’altro di particolare, magico o inspiegabile perché la trama era stata interrotta e lui aveva scritto la parola fine alla sua missione da eroe... Ciò significava che Artyom non aveva il diritto, non poteva allontanarsi dal sentiero a lui riservato, cioè dal suo destino? Lo stesso destino nel quale non credeva? Non ci credeva solo perché non sapeva come interpretare ciò che gli era accaduto, non sapeva come leggere i segni che aveva trovato lungo la strada. Al contrario, aveva continuato a credere ingenuamente che la strada che conduceva all’orizzonte, costruita solo per lui, fosse un intricato sentiero abbandonato che portava in direzioni diverse? In realtà sembrava che stesse procedendo dalla parte giusta: gli eventi della sua vita formavano una trama armoniosa che influenzava la volontà e la ragione umana, tanto che i suoi nemici ne erano abbagliati e i suoi amici vedevano la luce ed erano in grado di aiutarlo in tempo. Era una trama che controllava la realtà; le leggi immutabili della probabilità ne cambiavano obbedienti la forma, come con uno stucco, in risposta al potere crescente di una mano invisibile che lo spostava sulla scacchiera della vita. E se fosse stato davvero così, allora la domanda: “Che significato ha tutto ciò?”, che in precedenza avrebbe trovato una risposta solo nel silenzio cupo e rabbioso, ora sarebbe scomparsa. Il coraggio con cui professava a se stesso e la testardaggine con cui proclamava agli altri che non esisteva alcuna Provvidenza o piano divino, che non c’erano né leggi né giustizia a questo mondo, si rivelavano completamente inutili, perché il progetto poteva essere previsto. Non riusciva a resistere a questo pensiero. Era troppo seducente: la stessa risolutezza con cui aveva rifiutato le spiegazioni offerte dalle religioni e dalle ideologie non riusciva a distruggere questa idea. Nel complesso ciò significava una sola cosa. “Non posso rimanere oltre”, disse deciso Artyom e si alzò, sentendo i muscoli che si riempivano di una nuova forza. “Non posso rimanere oltre”, ripeté, ascoltando attento la sua stessa voce. “Devo andare. Devo farlo”. Non si guardò più attorno. Si era dimenticato di tutte le paure che lo avevano condotto sino al fuoco. Saltò sui binari e cominciò a camminare nell’oscurità. I dubbi lo abbandonarono, lasciando spazio a un senso di pace e di sicurezza che collocava ogni tessera del puzzle al suo posto. Era come se, nel momento in cui aveva cominciato a percorrere la strada sbagliata, fosse riuscito a tornare sui suoi passi, a ritrovare il sentiero a lui destinato. Sembrava che le traversine su cui poggiava i piedi si spostassero da sole, senza che lui facesse alcuno sforzo. In un istante, scomparve completamente nelle tenebre. “È una bellissima teoria, vero?”, domandò Sergei Andreyevich, inspirando. “Sembrerebbe quasi che tu ci creda davvero”, rispose Yevgeny Dmitrievich stizzito, grattando la gatta dietro l’orecchio. CAPITOLO 12 : LA POLIS Rimaneva solo una galleria. Solo una, e l’obiettivo assegnatogli da Hunter, che Artyom testardo e incosciente stava cercando di portare a termine, sarebbe stato completato. Mancavano due, forse tre chilometri in una parte di tunnel asciutta e tranquilla, e poi sarebbe giunto alla meta. La testa di Artyom era pervasa da un’eco silenziosa, molto simile a quella della galleria, ma lui cercava di non farsi troppe domande. Ancora quaranta minuti e sarebbe arrivato. Non si era reso conto di camminare in un’oscurità impenetrabile. I suoi piedi continuavano la solita, ritmica marcia sulle traversine. Sembrava che si fosse dimenticato dei pericoli che lo minacciavano e di non avere una mitragliatrice, di non possedere dei documenti identificativi, di non avere una torcia e nessun’altra arma; inoltre indossava ancora quella larga tunica e soprattutto non sapeva nulla su questa galleria o sui rischi che attendevano i viaggiatori che l’attraversavano. Gli era sufficiente la convinzione che nulla lo avrebbe minacciato finché seguiva il suo sentiero. Dov’era finita l’ineluttabile “tunnel-fobia”? Cos’era accaduto alla fatica e alla mancanza di fede? L’eco rovinò ogni cosa. Dato che la galleria pareva essere completamente vuota, il rumore dei suoi passi rimbombava sia davanti che dietro di lui. Il riverbero rimbalzava sui muri, rombava, gradualmente diminuiva fino a diventare un fruscio e dopo poco riecheggiava, dando l’impressione che Artyom non fosse l’unica persona a camminare all’interno di quella galleria. In seguito, questa percezione diventò talmente acuta che il ragazzo sentì il bisogno di fermarsi per ascoltare con maggiore attenzione e scoprire se l’eco dei suoi passi avesse vita propria. Si dibatté nella tentazione per diversi minuti. Si mise a camminare in maniera più lenta e silenziosa. Tese l’orecchio per sentire se questo cambiamento influisse sull’eco. Alla fine Artyom si fermò completamente. Rimase fermo, in piedi, in quelle tenebre impenetrabili e attese: non voleva inspirare profondamente per timore che il rumore dell’aria che gli entrava nei polmoni interferisse con i mormorii più lievi che si udivano in lontananza. Silenzio. Ora che non si spostava più, la sua percezione dello spazio svanì nuovamente. Mentre camminava, gli pareva di aggrapparsi alla realtà con le suole degli scarponi. Quando si fermava nel bel mezzo dell’oscurità nero pece della galleria, non capiva più dove si trovava. Inoltre, aveva la sensazione che quando ricominciava a muoversi, l’eco appena percettibile dei suoi passi raggiungesse il suo udito prima ancora che i piedi posassero sul cemento. Il battito del suo cuore si velocizzò, ma un istante dopo si convinse che prestare attenzione a tutti i fruscii del tunnel fosse una stupidaggine. Per un po’ Artyom cercò di non fare caso a quella eco. Poi gli parve che gli ultimi rimbombi si stessero avvicinando, si coprì le orecchie e procedette. Persino questa soluzione non funzionò a lungo. Dopo un paio di minuti allontanò i palmi delle mani dal viso e riprese a camminare, ma si terrorizzò nuovamente perché l’eco dei passi davanti a lui rimbombava più di prima, come se una persona si stesse avvicinando. Doveva solo fermarsi, così si sarebbero interrotti anche quei rumori, con un ritardo di una frazione di secondo. Questa galleria stava mettendo alla prova Artyom e la sua capacità di sopportare la paura. Ma lui non aveva intenzione di mollare. Era riuscito a sopravvivere in circostanze peggiori, non poteva temere un po’ di oscurità e un’eco. Ma... si trattava davvero di un’eco? Si avvicinava, non c’era alcun dubbio. Artyom si fermò un’ultima volta, quando i passi del fantasma erano udibili appena venti metri davanti a lui. La situazione era talmente inspiegabile e bizzarra che non riusciva a sopportarla. Si asciugò il sudore freddo dalle sopracciglia e con voce rotta urlò in mezzo al vuoto: “C’è qualcuno?” L’eco riverberò vicinissima e Artyom, impaurito, non riuscì nemmeno a riconoscere la propria voce. Le eco si susseguivano, si rincorrevano l’un l’altra nei recessi delle gallerie, man mano perdendo delle sillabe: “C’è qualcuno... qualcuno... uno...” Ma nessuno rispose. Improvvisamente accadde qualcosa di incredibile: le eco cominciarono a tornare indietro, a ripetere la sua domanda: le sillabe perse si ricomponevano nell’ordine inverso e ritornavano a essere sonore, come se qualcuno, a una distanza di trenta passi, avesse ripetuto la domanda del ragazzo con voce sgomenta. Artyom non ce la faceva più. Si voltò per tornare indietro. All’inizio cercò di non procedere troppo velocemente, ma poi si mise a correre. Si era dimenticato di non incoraggiare le sue paure e così rovinò a terra. Ciononostante, dopo un minuto, comprese che l’eco dei passi era sempre a venti metri da lui: il suo inseguitore invisibile non voleva lasciarlo andare. Ansimando, Artyom corse senza capire in quale direzione e infine andò a sbattere contro una parete. La galleria si biforcava. L’eco si affievolì all’istante. Passarono diversi minuti prima che potesse riacquistare le forze, alzarsi e fare un passo in avanti. Era la direzione giusta. Metro dopo metro, il rumore dei passi che strascicavano contro il cemento si faceva più vicino, si avvicinava a lui. Solo il sangue che gli pulsava nelle orecchie riusciva a coprire il minaccioso fruscio. Ogni volta che Artyom interrompeva la sua marcia, anche il suo inseguitore si fermava nell’oscurità. Ormai era sicurissimo che non si trattasse di un’eco. Continuò in questo modo finché i passi non parvero essere un metro davanti a lui. A quel punto Artyom si mise a urlare e lanciò pugni alla cieca, saltando verso il punto da cui riteneva provenisse il rumore. Tuttavia, i pugni colpirono solo l’aria, il vuoto davanti a lui. Nessuno cercò di difendersi dai colpi. Era inutile, le percosse rimanevano sospese nell’aria, mentre lui urlava, saltava indietro e muoveva le braccia ai lati del corpo come se volesse afferrare il nemico che, nell’oscurità, non riusciva a intravvedere. Vuoto. Non c’era nessuno. Ma, nel momento in cui recuperò il fiato e fece un passo avanti verso la Polis, sentì un rumore sordo davanti a sé. Di nuovo menò le mani, di nuovo trovò il vuoto. Gli pareva di perdere la testa. Sforzò gli occhi finché non gli fecero male per cercare di vedere qualcosa, mentre le sue orecchie cercavano di percepire il respiro di una creatura nelle vicinanze. Ma non c’era proprio nessuno. Rimase fermo immobile per diversi, lunghissimi secondi. A quel punto, Artyom rifletté che qualunque fosse la spiegazione di questo strano fenomeno, esso non era pericoloso. Probabilmente era solo l’acustica della galleria. “Quando tornerò a casa chiederò al mio patrigno”, pensò tra sé, ma nel momento in cui stava alzando la gamba per fare un ulteriore passo verso la sua meta, qualcuno gli sussurrò all’orecchio: “Aspetta, non puoi andarci adesso”. “Chi è stato? Chi va là?”, urlò Artyom ansimando. Ma nessuno rispose. Era nuovamente circondato da un vuoto profondo. Si terse il sudore dalla fronte con il dorso della mano e si mise a correre a perdifiato in direzione della Borovitskaya. I passi del fantasma corrispondevano ai suoi, solo che quest’ultimo procedeva nella direzione opposta; il rumore cominciò ad affievolirsi finché non si interruppe del tutto. Solo allora il ragazzo si fermò. Non sapeva cosa fosse stato. Non aveva mai sentito niente del genere dai suoi amici e nemmeno il patrigno gliene aveva parlato quando gli raccontava le storie la sera, davanti al fuoco. Tuttavia, chiunque fosse stato a sussurrargli all’orecchio, gli aveva ordinato di fermarsi e attendere. Ora che Artyom non temeva più quella presenza, poiché aveva avuto tempo di comprendere cosa fosse accaduto e di meditare per bene sul fatto, comprese che la voce era sembrata alquanto convincente. Passò i successivi venti minuti seduto sui binari; si dondolava da una parte all’altra, come un ubriaco, mentre cercava di smettere di tremare e nel frattempo ricordava la voce, che non apparteneva a una creatura umana e che gli aveva ordinato di aspettare. Si mosse solo quando i brividi si affievolirono e il terribile sussurro nei suoi ricordi si mescolò al tranquillo sibilo della corrente d’aria nella galleria. Da quel momento in avanti camminò e basta, cercando di non pensare a nulla, inciampando di tanto in tanto sui cavi che giacevano sul pavimento. Non gli accadde più nulla di spaventoso. Gli sembrava che non fosse trascorso molto tempo, sebbene non sapesse dire quanti minuti erano passati, dato che nell’oscurità gli istanti si susseguono in maniera totalmente diversa. Poi vide una luce alla fine della galleria. La Borovitskaya. La Polis. Quando arrivò, udì un urlo rozzo provenire dalla stazione, seguito dal rumore di spari. Artyom fece un salto all’indietro e si nascose nella nicchia di un muro. Da lontano, sentì le grida prolungate della persona che era stata ferita, seguite da imprecazioni. Poi l’arma automatica risuonò di nuovo, amplificata dalla galleria. Aspetta... Artyom riemerse dal suo nascondiglio più di quindici minuti dopo che la situazione si era calmata. Alzò le mani e camminò lento verso la luce. In effetti, giunse direttamente sulla piattaforma. Non c’era la guardia di turno alla Borovitskaya, sembrava che si affidassero semplicemente alla mitica inviolabilità della Polis. Un punto d’accesso costruito con blocchi di cemento armato era posizionato a cinque metri dal punto in cui terminavano gli archi circolari della galleria. Di fianco ad esso, sdraiato a terra prono e in un lago di sangue, si trovava un corpo senza vita. Quando Artyom apparve nel campo visivo delle guardie di confine che indossavano uniformi verdi e berretti militari, gli venne ordinato di avvicinarsi e di rimanere in piedi con il viso rivolto al muro. Vedendo il cadavere a terra, il ragazzo obbedì immediatamente. Venne subito perquisito, gli fu richiesto il passaporto e, mentre gli tenevano le braccia bloccate dietro la schiena, fu condotto all’interno della stazione. Luce. Proprio quella. Erano vere. Erano sempre vere. Le leggende non mentivano mai. La luce era così brillante che Artyom dovette strizzare gli occhi per non esserne accecato. Ma la luce gli entrava nelle pupille persino attraverso le palpebre, facendogli male, e solo nel momento in cui le guardie di confine lo bendarono, i suoi occhi furono al riparo. Tornare alla vita delle generazioni precedenti era più doloroso di quanto Artyom potesse immaginare. La benda gli venne levata dagli occhi solo all’interno del posto di comando delle guardie, che aveva un aspetto del tutto ordinario, cioè un piccolo ufficio con pareti ricoperte da piastrelle crepate. Qui non c’era quella luce accecante, ma sul tavolo di legno color ocra era stata posizionata una candela, la cui fiammella tremolava all’interno di una scodella d’alluminio. Il comandante delle guardie era un uomo tarchiato, con la barba incolta e una camicia militare verde dalle maniche arrotolate. Inoltre, indossava la cravatta con un elastico. Raccolse poca cera liquida con il dito e l’osservò mentre si raffreddava, poi guardò a lungo Artyom prima di domandargli: “Da dove vieni? Dov’è il tuo passaporto? Che è successo al tuo occhio?” Il ragazzo decise che non aveva senso mentire, così raccontò la verità, riferì che il passaporto se l’erano tenuto i fascisti e c’era mancato poco che anche il suo occhio facesse la stessa fine. Il comandante accolse l’informazione con un’indulgenza inaspettata. “Sì, ne siamo al corrente. Quella galleria di fronte arriva precisamente alla Checkhovskaya. Laggiù abbiamo dovuto costruire una vera e propria fortezza. Al momento non stiamo combattendo, ma ci sono delle brave persone che ci riferiscono quando tenere le orecchie aperte. Dicono qualcosa del tipo: ‘Si vis pacem, para bellum’”, e strizzò l’occhio ad Artyom. Il giovane non comprese quest’ultima frase, ma preferì non informarsi sul suo significato. La sua attenzione venne attratta dal tatuaggio nell’incavo del gomito del comandante: rappresentava un uccello deformato dalle radiazioni, con due teste, le ali spiegate e artigli uncinati. Gli ricordava vagamente qualcosa, ma cosa di preciso, non ne aveva idea. Più tardi, quando il comandante si rivolse a uno dei suoi soldati, Artyom scorse la stessa immagine, ma in miniatura, tatuata sulla tempia sinistra del comandante. “Perché sei venuto fin qui?”, continuò il comandante. “Sto cercando una persona... si chiama Melnik. Probabilmente si tratta di un soprannome. Ho un messaggio importante per lui”. L’espressione sul viso del comandante cambiò all’istante. Il monotono sorriso benevolo sparì dalle sue labbra e i suoi occhi, alla luce della candela, si illuminarono di sorpresa. “Puoi comunicarlo a me”. Artyom scosse la testa e, scusandosi, spiegò che non avrebbe potuto farlo, perché era un’informazione confidenziale e gli era stato ordinato di non parlarne con nessuno, eccetto che con Melnik. Il comandante lo studiò di nuovo e fece segno a uno dei soldati che gli passò un apparecchio telefonico in plastica nera insieme a un cavo ricoperto di gomma, accuratamente arrotolato e della lunghezza giusta. Dopo aver digitato il numero, la guardia di confine parlò nel ricevitore: “Posto Bor-sud. Ivashov. Passami il Colonnello Melnik”. Mentre attendeva risposta, Artyom notò che gli altri due soldati nella stanza avevano lo stesso tatuaggio dell’uccello sulla tempia. “Chi lo desidera?”, domandò il comandante ad Artyom, premendosi il lato del ricevitore contro il petto. “Dica pure che il messaggio viene da Hunter e che è molto urgente”. Il comandante annuì e scambiò un altro paio di frasi con chiunque vi fosse all’altro capo del filo, poi terminò la chiamata. “Vi troverete domani mattina alle nove all’Arbatskaya, presso l’ufficio del responsabile della stazione. Fino ad allora sei libero di circolare”. Fece un cenno al soldato che bloccava la porta, il quale si spostò subito di lato, poi si girò verso Artyom e aggiunse: “Aspetta un attimo... Sembra che tu sia un ospite ragguardevole e che questa sia la tua prima visita qui da noi. Perciò usa questi, ma non dimenticare di restituirli!”. Così dicendo offrì al ragazzo un paio di occhiali scuri con una montatura in metallo malandata. Domani? Artyom venne sopraffatto da un senso di disappunto e di risentimento che gli bruciava dentro. Era giunto fin lì solo per questo motivo, rischiando la sua vita e quella degli altri! Aveva continuato il viaggio, obbligandosi a procedere anche quando le forze lo stavano abbandonando! Era una questione urgente, doveva discutere con questo Melnik, il quale non era riuscito a trovare nemmeno un minuto per riceverlo? Oppure Artyom era in ritardo e Melnik sapeva già tutto? O ancora, Melnik sapeva già qualcosa di cui Artyom stesso non ne aveva la più pallida idea? Forse era talmente in ritardo che tutta la sua missione non aveva più alcuna importanza? “Non fino a domani?”, sbottò il ragazzo. “Il Colonnello è in missione, oggi. Tornerà domani mattina presto”, spiegò Ivashov. “Vai, così avrai anche l’occasione di riposarti un po’”, propose e condusse Artyom fuori dal gabbiotto delle guardie. Il giovane si era dato una calmata, ma sentiva ancora il peso del torto subito; poi indossò gli occhiali da sole e pensò che fossero perfetti, anche perché nascondevano il suo occhio nero. Le lenti erano graffiate e gli oggetti più lontani apparivano distorti, ma quando uscì sulla piattaforma dopo aver ringraziato le guardie di confine, comprese che non sarebbe riuscito a farne a meno. Per lui, la luce delle lampade al mercurio era troppo brillante. Artyom notò di non essere il solo a non riuscire ad aprire gli occhi: alla stazione erano in molti coloro che si coprivano gli occhi con delle lenti scure; forse anche loro erano stranieri. Vedere una stazione della Metropolitana completamente illuminata era alquanto bizzarro, perché non c’erano ombre; alla VDNKh, così come alle altre stazioni, piccole o grandi che fossero, si trovava un numero limitato di fonti luminose, che non riuscivano mai a rischiarare l’intero spazio. Vi erano sempre luoghi in cui non penetrava nemmeno un raggio di luce. Tutto aveva diverse ombre: una, avvizzita ed emaciata, riflessa dalla fiammella della candela, un’altra creata dalle luci di emergenza e una terza, nera e ben definita, che derivava dalla lanterna elettrica. Si mescolavano e si coprivano tra loro e con le ombre delle altre cose o delle altre persone, spesso si allungavano sul pavimento per diversi metri: ti facevano trasalire, ti ingannavano, ti obbligavano a presumere e a indovinare. Alla Polis, invece, tutte le ombre erano eliminate dal bagliore spietato delle lampade a giorno. Artyom rimase di stucco mentre, con gioia, osservava la Borovitskaya. Si era conservata in ottime condizioni. Sulle pareti di marmo o sul soffitto bianco non era visibile nemmeno una traccia di sporco e la stazione era ordinata. Dall’altro capo dell’atrio, una donna con una tuta da lavoro blu si adoperava per lucidare un pannello di bronzo scurito dal tempo, raschiando industriosa il bassorilievo con una spugna e del detersivo. Gli alloggi erano allestiti sotto gli archi; solo due erano stati lasciati aperti da una parte e dall’altra, in modo da avere accesso ai binari, mentre i restanti erano stati murati su entrambi i lati: erano stati trasformati in veri e propri appartamenti. Ognuno di essi aveva un ingresso e alcuni avevano persino un porta di legno e i vetri alle finestre. Da uno di questi proveniva una musica. Davanti a diverse entrate erano stati posizionati degli zerbini, in modo che coloro che entravano in casa potessero pulirsi i piedi. Era la prima volta che Artyom vedeva una stazione così. Questi quartieri sembravano talmente comodi e calmi che sentì il cuore stringersi nel petto e un’immagine della sua infanzia gli si presentò davanti agli occhi. Ma il dettaglio che lo sorprese di più erano le file di scaffali di libri su entrambe le pareti, per tutta la lunghezza della stazione. Occupavano anche lo spazio tra gli “appartamenti” e ciò conferiva al luogo un aspetto meraviglioso, strano, che ricordò ad Artyom la descrizione delle biblioteche medievali che aveva trovato in un libro di Borges. Le scale mobili si trovavano nel punto più lontano dell’androne, in concomitanza con il passaggio per l’Arbatskaya. Le porte a spinta rimanevano aperte e al passaggio c’era un piccolo posto di blocco. Ciononostante, le guardie lasciavano passare chiunque lo desiderasse e in entrambe le direzioni, senza nemmeno controllare i documenti. Dal lato opposto della piattaforma, di fianco al bassorilievo in bronzo, era collocato un vero e proprio accampamento militare. Erano state allestite diverse tende verdi, sulle quali erano riportati gli stessi disegni tatuati sulle tempie delle guardie di confine. C’era anche un carrello, sul quale era stata montata un’arma sconosciuta al ragazzo: una copertura lasciava intravvedere una lunga canna con un caricatore svasato. Nelle vicinanze erano di turno due soldati con uniformi verde scuro, elmetti e giubbotti antiproiettile. L’accampamento circondava una scala di passaggio che saliva fin sopra i binari. Frecce luminose indicavano che si trattava di un’”Uscita verso la città”, era chiaro che quelle precauzioni erano state adottate proprio per questo motivo. Una seconda scala conduceva nello stesso luogo ed era completamente bloccata da una parete di enormi blocchi di cemento. Persone con indosso lunghe tuniche grigie di panno pesante sedevano ai tavoli di legno nel mezzo della stazione. Avvicinandosi, Artyom si sorprese nel notare che anche le loro tempie erano tatuate, non con l’immagine dell’uccello, ma con quella di un libro aperto con uno sfondo di linee verticali, che somigliavano a un colonnato. Scorgendo lo guardo assorto di Artyom, uno degli uomini seduti al tavolo sorrise amabilmente e domandò: “Sei nuovo? È la tua prima volta qui?” Alla parola “nuovo” il ragazzo sussultò, ma si ricompose e annuì. L’uomo che gli aveva rivolto la parola non era molto più vecchio di lui e, quando si alzò per stringere la mano di Artyom, cercando la sua tra le pieghe dell’ampia manica della tunica, notò che erano quasi alti uguali, solo che il fisico dell’uomo era più delicato. Il nuovo amico di Artyom si chiamava Daniel. Non aveva alcuna fretta di parlare di sé e fu subito ovvio che avesse deciso di attaccare bottone con Artyom perché era curioso di ciò che accadeva oltre i confini della Polis, di quali fossero le novità sull’Anello, sui fascisti e sui Rossi... Mezz’ora più tardi erano già seduti nella piccola casetta di Daniel, uno degli appartamenti ricavati dagli archi, e bevevano tè caldo, che sicuramente era stato portato fin qui dalla VDNKh, percorrendo rotte tortuose. La stanza era arredata con un tavolo, sul quale troneggiava una pila di libri, altissimi scaffali in ferro che arrivavano fino al soffitto, anch’essi carichi di grossi volumi, e un letto. Una lampadina elettrica, che emetteva una luce flebile, dondolava da un filo e illuminava un disegno ben fatto di un enorme tempio antico che il ragazzo non riconobbe subito, ma che di sicuro era la Biblioteca eretta da qualche parte sopra la Polis. Quando il padrone di casa terminò le domande, fu il turno di Artyom. “Perché qui tutti hanno tatuaggi in testa?”, domandò. “Non sai nulla delle caste?”, rispose Daniel attonito. “E non hai mai sentito nominare il Consiglio della Polis?” All’improvviso Artyom si ricordò che qualcuno, o meglio Mikhail Porfirevich, quell’anziano che era stato ucciso dai fascisti, gli aveva raccontato che alla Polis il potere era diviso tra soldati e bibliotecari perché in passato gli edifici della Biblioteca si trovavano nei pressi di quelli in cui stavano delle organizzazioni militari. “Sì, ne ho sentito parlare”, annuì. “I combattenti e i bibliotecari. Perciò tu sei un bibliotecario?” Daniel gli lanciò un’occhiataccia spaventata, impallidì e si mise a tossire. Dopo un po’ si ricompose e affermò calmo: “Cosa intendi per ‘bibliotecario’? Ne hai mai visto uno in carne e ossa? Io non te lo consiglio! I bibliotecari stanno su, in alto... Hai notato le fortificazioni laggiù? Spero che non scendano mai tra noi... Non confondere le cose: io non sono un bibliotecario, ma un guardiano. Ci chiamano anche Bramini”. “Che nome strano!”, dichiarò Artyom alzando un sopracciglio. “Vedi, qui abbiamo un sistema di caste, come nell’antica India. Una casta... beh, è come una classe sociale. I Rossi non te lo hanno spiegato? Lascia perdere. C’è la casta dei sacerdoti, detti anche guardiani della conoscenza, che raccolgono i libri e lavorano con essi”, spiegò, mentre Artyom si meravigliò da quanto meticolosamente cercasse di evitare il termine bibliotecario. “Poi c’è la casta dei guerrieri, di coloro che proteggono e difendono. È molto simile a quella che avevano in India, dove c’era anche una casta di mercanti e una di servitori. Ci sono anche qui, e tra di noi le chiamiamo tutte con i nomi in indù: i sacerdoti sono i Bramini, i soldati i Kshatrya, i mercanti sono Vaishya, mentre i servitori si chiamano Shudra. Quando si diventa membro di una casta, rimane quella per la vita. Vi sono speciali riti di passaggio, in particolare per i Kshatrya e i Bramini. In India era una questione ancestrale, di tribù; noi, invece lo scegliamo quando compiamo diciotto anni. Qui alla Borovitskaya, i Bramini sono i più numerosi, quasi tutti apparteniamo a questa casta. La nostra scuola è qui, insieme alle biblioteche e alle celle. Alla Biblioteca si vive in condizioni particolari, perché è attraversata dalla linea Rossa e deve essere protetta. Infatti, prima della guerra, molti di noi vivevano laggiù. Ora si sono spostati alla Giardini di Alessandro. Al contrario, all’Arbatskaya sono quasi tutti Kshatrya, per lo Stato maggiore”. Sentendo un’altra parola di indiano antico Artyom sospirò rumorosamente. Era molto improbabile che avrebbe ricordato tutti i nomi delle caste. Tuttavia, Daniel non se ne curò e continuò il racconto: “Naturalmente, vi sono solo due caste che hanno accesso al Consiglio, la nostra e quella dei Kshatrya... anche se in realtà noi li chiamiamo solo ‘guerrafondai’”, e così dicendo fece l’occhiolino ad Artyom. “Perché si tatuano uccelli a due teste?”, volle sapere Artyom. “Almeno voi avete i libri, che hanno un significato particolare. Ma gli uccelli?” “Si tratta del loro totem”, chiarificò il Bramino Daniel e si strinse nelle spalle. “Penso che fosse il guardiano dello spirito della forze radiologiche di difesa. Suppongo sia un’aquila. Dopotutto, loro hanno credenze particolari. In generale, le caste qui non vanno molto d’accordo. Un tempo c’era anche una faida in corso”. Attraverso le persiane, scorsero le luci della stazione: erano state abbassate perché si stava facendo notte. Artyom si mise a radunare le sue cose. “C’è un hotel dove posso andare a dormire? Domani mattina alle nove devo incontrare una persona all’Arbatskaya e non ho un posto dove stare”. “Se vuoi puoi rimanere qui”, gli propose Daniel facendo spallucce. Io dormirò sul pavimento, tanto ci sono abituato. Stavo per preparare la cena. Resta pure, così potrai raccontarmi qualche altra tua avventura. Sai, io non vado mai da nessuna parte. I guardiani si impegnano a non viaggiare più in là di una stazione”. Dopo averci pensato per un minuto, Artyom annuì. La stanza era comoda e calda, inoltre il ragazzo aveva preso in simpatia il padrone di casa sin dall’inizio. Avevano qualcosa in comune. Dopo quindici minuti, lui stava già pulendo i funghi, mentre Daniel tagliava il lardo in piccole fette. “Hai mai visto la Biblioteca con i tuoi occhi?”, domandò Artyom a bocca piena. La cena era composta da maiale stufato con funghi e i due ragazzi mangiavano da piatti di alluminio da campeggio. “Intendi la Grande Biblioteca?”, chiese di rimando il Bramino, con un’espressione arcigna. “Intendo quella lassù... è ancora al suo posto, vero?”. Artyom puntò la forchetta verso il soffitto. “Solo gli anziani hanno il permesso di recarsi nella Grande Biblioteca. Oltre agli stalker, ovviamente, che lavorano per i Bramini”, rispose Daniel. “Sono loro che portano i libri qui sotto dalla superficie? Dalla Biblioteca... cioè, dalla Grande Biblioteca?”, si corresse velocemente Artyom, quando vide che l’amico si accigliava di nuovo. “Sì, ma solo su ordine degli anziani della casta. Non abbiamo il permesso di farlo da soli, perciò dobbiamo usare dei mercenari”, spiegò a malincuore il Bramino. “Secondo il Testamento, avremmo dovuto farlo noi, proteggendo la conoscenza e impartendola ai cercatori. Ma perché la conoscenza possa essere trasmessa, prima deve essere ottenuta. Tuttavia, chi tra noi oserebbe andare fin lassù?”, chiese tra sé, alzando gli occhi verso il soffitto con un sospiro. “A causa delle radiazioni?”, disse Artyom comprensivo. “Anche per quello, ma per lo più a causa dei bibliotecari”, ribatté Daniel con voce pacata. “Ma tu non fai parte dei bibliotecari? O per lo meno non sei uno dei loro discendenti? Io credevo che fosse così”. “Senti, non parliamone a tavola. Anzi, preferirei che te lo spiegasse qualcun altro. A me non piace parlare di questo argomento”. Daniel si mise a sparecchiare, poi dopo averci riflettuto per un momento, spostò di lato alcuni libri su uno scaffale, rivelando uno spazio vuoto tra i volumi della fila posteriore, dove luccicava una bottiglia panciuta di liquore fatto in casa. I bicchierini erano tra le stoviglie. Per qualche minuto Artyom si era divertito a esaminare le diverse scaffalature, ma dopo un po’ decise di spezzare il silenzio. “Wow, hai davvero moltissimi libri”, esclamò. “Dove vivo io, alla VDNKh, non credo che ce ne siano tanti nemmeno alla biblioteca. Li ho già letti tutti molto tempo fa. Raramente arriva qualcosa di interessante. Solo il mio patrigno mi porta opere interessanti, mentre le valigie dei mercanti non contengono altro che stupidaggini, come romanzi gialli, in cui la metà delle volte non si riesce nemmeno a capire cosa succede. Questa è l’altra ragione per la quale sognavo di avere accesso alla Polis, per la Grande Biblioteca. Non riesco nemmeno a immaginare quanti libri devono esserci al suo interno, se hanno dovuto costruire un luogo tanto immenso per conservarli”, e fece un cenno con la testa in direzione del disegno sopra il tavolo. Gli occhi di entrambi baluginavano a causa dell’alcool. Daniel, lusingato dalle parole di Artyom, si piegò in avanti dichiarò con voce grave: “Tutti quei volumi non hanno senso. La Grande Biblioteca non è stata costruita per loro. Al suo interno non sono conservati i libri”. Artyom lo guardò con estrema sorpresa. Il Bramino aprì la bocca per continuare, ma si alzò improvvisamente dalla sedia, andò alla porta, la spalancò e si mise all’ascolto. Quindi la richiuse, si sedette e sussurrò la fine di ciò che stava dicendo: “La Grande Biblioteca è stata costruita per un unico Libro. Al suo interno vi è nascosto solo quello. Gli altri servono solo a celarlo. A dire la verità, noi lo stiamo cercando”, aggiunse, visibilmente in imbarazzo. “Di che libro si tratta?”, domandò Artyom, anch’egli abbassando la voce. “Un antico volume: le pagine sono nero ardesia e al suo interno è descritta, a lettere d’oro, la Storia, fino alla fine”. “Perché lo state cercando?”, gli chiese Artyom con un filo di voce. “Non capisci davvero?”, domandò il Bramino, scuotendo il capo. “‘Fino alla fine’ significa davvero fino alla fine. Manca ancora del tempo prima di arrivarci... perciò chiunque ne sia a conoscenza...” Un’ombra traslucida si illuminò al di là delle tendine e Artyom, sebbene stesse guardando Daniel negli occhi, la notò e gli fece un cenno. Interrompendo il racconto a metà della frase, Daniel saltò in piedi e si fiondò alla porta. Artyom lo seguì a ruota. Sulla piattaforma non c’era nessuno, ma in direzione del passaggio si udivano dei passi che si allontanavano. Le sentinelle erano assopite sulle loro sedie da entrambi i lati della scala mobile. Quando ritornarono all’interno della stanza, Artyom attese affinché il Bramino continuasse la sua storia, ma quest’ultimo era tornato sobrio e scosse la testa con cipiglio. “Abbiamo il divieto assoluto di raccontare questa storia”, disse seccamente. “La parte sul Testamento è solo per gli iniziati. L’alcool mi ha sciolto la lingua”, fece una smorfia irritata. “E non pensare nemmeno lontanamente di riferire a qualcuno la storia che hai ascoltato! Se vengono a sapere che sei a conoscenza dell’esistenza del Libro, tu avrai guai a non finire, e anche io”. A quel punto Artyom comprese perché le mani avevano cominciato a sudargli quando il Bramino gli aveva raccontato del Libro. Si ricordò. “Di questi libri, ce ne sono diversi, non è così?”, domandò e il suo cuore quasi si fermò per un istante. Daniel lo guardò cauto negli occhi. “Che vuoi dire?” “‘Dobbiamo temere le verità celate negli antichi volumi in cui le parole sono stampate in oro, su pagine nero ardesia dove rimarranno per sempre’”, recitò, mentre il viso senza espressione di Bourbon gli si ripresentava davanti agli occhi, avvolto da una nebbia, mentre in modo meccanico ripeteva parole strane, incomprensibili. Il Bramino lo fissava sbalordito. “Come fai a saperlo?” “Ho avuto una rivelazione. Non esiste un solo Libro... Cosa contengono gli altri?”, domandò Artyom, osservando il disegno della Biblioteca come se fosse vittima di un incantesimo. “Ne è rimasto uno solo. I volumi erano tre”, spiegò Daniel in segno di resa. “Il Passato, il Presente e il Futuro. Il Passato e il Presente sono scomparsi secoli fa. È rimasto solo l’ultimo volume, il più importante”. “E dove si trova?” “Non si sa con esattezza, deve trovarsi negli Archivi principali. Ci sono più di quaranta milioni di volumi ed Esso è tra questi, sia il suo aspetto che la rilegatura sono normali; per riconoscerlo, bisogna aprirlo e sfogliarlo. Secondo la leggenda, le pagine del volume sono nere. Ma ci vorrebbero settant’anni, senza mai dormire o riposarsi, per controllare tutti i libri che si trovano negli Archivi principali. Ma prima di tutto, non si può stare lassù per più di un giorno e in secondo luogo nessuno ti permetterebbe di guardare ogni singolo libro che si trova in quel posto. Questo è tutto”. Mise delle coperte sul pavimento, accese una candela sul tavolo e spense la luce. Artyom si distese controvoglia. Non aveva sonno, sebbene non si ricordasse quale fosse l’ultima volta che era riuscito a riposarsi un po’. “Mi domando: si riesce a scorgere il Cremlino quando si va alla Biblioteca?”, chiese all’aria, perché Daniel si stava già addormentando. “Ma certo. Solo che non lo si può guardare, perché ti risucchia”, mormorò. “Che significa ‘ti risucchia’?” Daniel si alzò sul gomito mentre il suo viso incorniciato da una smorfia d’irritazione veniva illuminato da una macchia di luce gialla. “Gli stalker sostengono che, quando si va in superficie, non si può osservare il Cremlino e in particolare non le stelle sulle torri. Non appena lo guardi non riesci più a distogliere lo sguardo. Se lo fissi troppo a lungo, le stelle del Cremlino ti risucchiano. C’è un motivo per cui i cancelli rimangono spalancati e perché gli stalker non salgono mai nella Grande Biblioteca da soli: se uno rivolge lo sguardo al Cremlino, l’altro cerca di distrarlo subito”. “Che c’è dentro al Cremlino?”, sussurrò Artyom deglutendo. “Nessuno lo sa, perché tra coloro che sono riusciti a entrare, nessuno è mai tornato indietro. Se vuoi, là su quello scaffale, c’è un libro con una storia interessante sulle stelle e sulle svastiche, tra cui quelle sulle torri del Cremlino”. Si alzò, cercò a tastoni il libro sullo scaffale, lo aprì sulla pagina giusta e tornò sotto la sua coperta. Daniel si addormentò in un paio di minuti, ma Artyom avvicinò la candela e si mise a leggere. “... dal momento che erano il gruppo politico meno numeroso e meno influente che intendesse raggiungere il potere in Russia dopo la prima rivoluzione, i Bolscevichi non venivano considerati avversari pericolosi da nessuna delle fazioni opposte. Non godevano del supporto della classe contadina e si affidavano ai pochi sostenitori della classe operaia e nella marina. Lenin, che aveva studiato alchimia e invocazione degli spiriti presso delle scuole svizzere segrete, riuscì a trovare i suoi alleati principali dall’altra parte della barriera tra i mondi. È proprio in questo periodo che il pentagramma apparve per la prima volta come simbolo del movimento comunista all’interno dell’Armata Rossa”. “Come è noto, il pentagramma è il portale tra i mondi più diffuso e accessibile ai novizi, che permette ai demoni di avere accesso alla nostra realtà. Allo stesso tempo, se il creatore di un pentagramma lo usa nella maniera corretta, può controllare i demoni evocati nel nostro mondo e loro gli devono obbedire. Di solito, per controllare al meglio una creatura evocata, viene disegnato un cerchio di protezione attorno al simbolo, per impedire ai demoni di fuggire al di là dell’anello”. “Non è noto come il leader del movimento comunista fosse stato in grado di ottenere ciò che avevano cercato i più potenti maghi oscuri di tutte le ere: stabilire delle connessioni tra i signori dei demoni che controllavano orde di loro simili. Gli esperti sono convinti che i signori stessi, avendo percepito che la guerra era stata annunciata e che il più orribile spargimento di sangue di tutta la storia dell’umanità si stava avvicinando al confine tra i due mondi, evocarono coloro che sarebbero stati in grado di raccogliere delle vite umane per loro conto. In cambio, gli promisero supporto e protezione”. “La storia del modo in cui la leadership bolscevica venne fondata dall’intelligence tedesca è vera, ma sarebbe sciocco e superficiale credere che fu solamente grazie ai suoi compagni stranieri che Lenin e i suoi furono in grado di guadagnarsi il loro favore. Persino allora, il futuro leader comunista aveva dei protettori molto più potenti e saggi degli ufficiali appartenenti all’intelligence militare della Germania del Kaiser”. “Ovviamente, i dettagli del patto con i poteri dell’oscurità non sono accessibili ai ricercatori moderni. Tuttavia, il risultato è chiaro: dopo un breve periodo di tempo, i pentagrammi apparvero sugli stendardi e sui copricapi dei soldati dell’Armata Rossa, ma anche sul loro equipaggiamento militare, allora decisamente scarso. Ognuno di essi apriva una porta a un demone protettore che aveva accesso al nostro mondo e che proteggeva dalle violenze esterne colui che indossava il pentagramma. Come sempre, in cambio, i demoni venivano ripagati con del sangue. Solo nel ventunesimo secolo, secondo le stime più ottimistiche, furono sacrificati circa trenta milioni di abitanti del paese”. “Il patto con i signori dei poteri evocati si giustificò all’istante: i Bolscevichi salirono al potere e lo consolidarono. Lo stesso Lenin, che era servito da intermediario tra i due mondi, non riuscì a sopportare tutto ciò e morì a soli cinquantaquattro anni, consumato dall’interno dalle fiamme dell’inferno; tuttavia, i suoi seguaci continuarono la sua opera senza alcuna esitazione. Subito dopo il paese venne demonizzato. I bambini si appuntarono i loro primi pentagrammi al petto. Pochi sanno che, sin dal primo momento, il rituale dell’iniziazione dei Piccoli ottobristi richiedeva che la spilla bucasse la pelle del bambino. In questo modo, il demone della ‘stella’ del Piccolo ottobrista avrebbe assaggiato il sapore del sangue del proprio ospite futuro, instaurando con lui un rapporto sacro, una volta e per sempre. Crescendo e diventando un Pioniere, il bambino avrebbe ricevuto un nuovo pentagramma e una parte dell’essenza del patto sarebbe stata rivelata a coloro che avessero avuto un’intuizione: un ritratto del leader stampato sull’oro, avvolto tra le fiamme nelle quali scompariva. In questo modo la generazione in ascesa ricordava il suo eroico atto di abnegazione. Dopodiché veniva il Komsomol e infine si poteva arrivare tranquillamente alla casta dei sacerdoti, il Partito comunista”. “Miriadi di spiriti evocati proteggevano tutto e tutti all’interno dei confini dello stato sovietico: bambini e adulti, edifici ed equipaggiamenti, mentre i signori dei demoni si stabilivano nei giganteschi pentagrammi di rubino delle torri del Cremlino, confinandosi di propria spontanea volontà solo per riuscire ad aumentare il loro potere. Da questo particolare punto, linee invisibili di forza si diffondevano in tutto il paese, prevenendo il caos e il tracollo, assoggettando gli abitanti al volere di coloro che occupavano il Cremlino. In un certo senso, l’intera Unione Sovietica si trasformò in un enorme pentagramma, il cui perimetro divenne il confine della nazione stessa”. Artyom alzò la testa dalla pagina del libro e si guardò intorno. La candela si era quasi del tutto consumata e la cera aveva cominciato a emettere fumo. Daniel dormiva della grossa, con la faccia rivolta verso il muro. Artyom si stiracchiò e tornò al libro. “La prova suprema per il potere sovietico fu lo scontro con la Germania nazionalsocialista. Protetta da poteri non meno antichi e potenti di quelli che si trovavano nell’Unione Sovietica, la corazzata della nazione teutonica avrebbe potuto penetrare nelle profondità del nostro paese per la seconda volta in mille anni. Ma in questa occasione sui loro stendardi troneggiava il simbolo rovesciato del sole, della luce e della prosperità. Da quel giorno, cinquant’anni dopo la Vittoria, i carri armati con i pentagrammi sulle torrette si scontravano in battaglia perpetua contro i cingolati con le svastiche: nei musei, sugli schermi televisivi, sui fogli di carta millimetrata staccati dai blocchi usati a scuola...” La candela tremolò un’ultima volta e si spense. Era ora di dormire. Dando le spalle al monumento, si riusciva a intravvedere una piccola sezione del muro altissimo e delle sagome delle torri appuntite che si stagliavano contro il cielo nello spazio tra le case mezze distrutte. Ma, come gli era stato spiegato, non avrebbe potuto girarsi a osservarle. Inoltre, era obbligatorio sorvegliare porte e scalini, perché nel caso fosse accaduto qualcosa, si sarebbe dovuto suonare l’allarme; tuttavia, anche se si osava solo dare un’occhiata, era finita, si era spacciati e anche altri avrebbero sofferto per quel gesto. Di conseguenza, Artyom se ne stava fermo immobile, malgrado il desiderio di girarsi e di guardare lo stesse divorando. Nel frattempo, esaminò il monumento, sulla cui base cresceva copioso del muschio. La statua rappresentava un anziano dall’espressione cupa, seduto su una poltrona capace e appoggiato su un gomito. Qualcosa gocciolava lento e denso dai buchi delle sue pupille bronzee fino al petto, dando l’impressione che il monumento stesse piangendo. Era insopportabile guardarlo troppo a lungo. Perciò, Artyom girò intorno alla statua e controllò attento le porte. Era tutto tranquillo, il silenzio era totale e si udiva solamente una brezza leggera che sfiorava le varie carcasse degli edifici. Il distaccamento si era allontanato diverso tempo prima, ma i superiori non avevano permesso al ragazzo di proseguire con il gruppo. Gli avevano ordinato di stare di guardia e, se fosse accaduto qualcosa, di scendere nella stazione per dare l’allarme e informare gli altri su cos’era successo. Il tempo passava lento, il ragazzo lo misurava con i suoi passi che ritmava tutt’attorno al monumento: uno, due, tre... Successe quando arrivò al cinquecentesimo: udì un frastuono e un ringhio alle sue spalle, dove non poteva guardare. C’era qualcosa lì vicino a lui, che avrebbe potuto aggredirlo da un momento all’altro. Si fermò, tese le orecchie, poi si gettò a terra, a filo della base della statua, con l’arma pronta. Ora era ancora più vicino, lo sentiva dall’altra parte del monumento, distingueva il rauco respiro animalesco. Muovendosi lungo il blocco alla base della statua, si avvicinò pian piano alla fonte del rumore. Voleva fare in modo che le mani non gli tremassero e che il suo sguardo rimanesse fisso sul luogo in cui la creatura sarebbe apparsa. All’improvviso, il respiro e il rumore dei passi cominciarono a battere la ritirata. Ma quando Artyom guardò oltre la statua per approfittare dell’opportunità di sparare alle spalle del nemico sconosciuto, si scordò immediatamente sia del suo oppositore che di tutto il resto. La stella sulla torre del Cremlino era chiaramente visibile da quel punto. La torre stessa rimaneva solo una vaga sagoma alla luce instabile di una luna semi coperta dalle nuvole; al contrario la stella spiccava contro il cielo, attirando l’attenzione di chiunque la osservasse, per una ragione comprensibilissima: luccicava. Artyom non credeva ai suoi occhi, perciò afferrò il cannocchiale. La stella bruciava di un potente rosso acceso, illuminando per diversi metri lo spazio attorno a sé e quando il ragazzo la guardò più da vicino, notò che il fuoco che emetteva era irregolare, come se dentro al rubino gigante fosse confinata una tempesta; brillava a intermittenza, come se al suo interno ci fosse qualcosa che scorreva, ribolliva, che stava per esplodere... Era uno spettacolo di una bellezza incredibile, impossibile da osservare a questo mondo; tuttavia, non era granché visibile da una tale distanza. Doveva avvicinarsi. Spostandosi l’arma sulla spalla, Artyom corse giù dalle scale, saltò sull’asfalto crepato della strada e si fermò nell’unico angolo da cui potesse vedere tutti i muri del Cremlino... oltre naturalmente alle torri. Ciascuna di essere irradiava quella luce dalla sua stella rossa. Artyom quasi non riusciva a riprendere fiato, ma provò di nuovo a guardare attraverso il cannocchiale. Le stelle ardevano, ribollivano con lo stesso splendore irregolare. Avrebbe desiderato osservarle per sempre. Concentrandosi su quella più vicina, il giovane si mise ad ammirare i flussi fantastici, finché all’improvviso non gli parve di poter individuare anche la forma di ciò che si muoveva all’interno, sotto la superficie cristallina. Per meglio distinguere gli strani contorni, doveva avvicinarsi di più. Si era totalmente scordato di tutti i pericoli e si era fermato nel bel mezzo di uno spazio aperto, tenendo il binocolo incollato agli occhi per cercare di capire cosa era riuscito a intravvedere. Infine si ricordò: i signori dei demoni. I marescialli di un esercito di spiriti impuri che erano stati evocati per difendere lo stato sovietico. Il paese e il mondo intero erano ridotti in pezzi, ma i pentagrammi sulle torri del Cremlino erano rimasti intatti: i governatori che avevano stretto il patto con i demoni erano deceduti molto tempo prima e non c’era più nessuno che poteva liberarli... Nessuno? Magari avrebbe potuto provarci lui... Però prima devo trovare i cancelli, pensò. Devo trovare un modo per entrare... “Svegliati! Tra poco devi andare!”, era Daniel che lo scuoteva. Artyom sbadigliò e si sfregò gli occhi. Aveva fatto un sogno interessantissimo, ma non appena si era svegliato era svanito all’instante e non riusciva a ricordare cosa avesse visto. Tutte le luci della stazione erano già accese e sentiva anche il vociare allegro delle donne delle pulizie che spazzavano le piattaforme. Inforcò gli occhiali scuri e si avviò verso i bagni per darsi una ripulita con l’asciugamano, non esattamente pulito, che il padrone di casa gli aveva prestato. Le toilette si trovavano dalla stessa parte del pannello di bronzo e la fila di persone in attesa non era propriamente breve. Si mise in attesa, continuando a sbadigliare e cercando di ricordare almeno qualcuna delle immagini del suo sogno. Per qualche strana ragione la fila si fermò e le persone in attesa si misero a parlottare a voce alta. Cercando di capire quale fosse il problema, Artyom si guardò attorno. Tutti gli sguardi erano fissati su una porta di ferro che fino a un momento prima era sprangata: si era aperta e ne era apparso un uomo altissimo. Quando lo vide, anche il ragazzo dimenticò dove si trovasse. Era uno stalker. Li aveva immaginati esattamente così, sia dalle storie del patrigno che dalle voci che aveva raccolto qua e là dai mercanti girovaghi. Lo stalker indossava una tuta protettiva macchiata e in alcuni punti bruciacchiata, oltre a un lungo e pesante giubbotto antiproiettile. Le spalle erano ampie e da quella destra pendeva, come se niente fosse, una mitraglietta, mentre una cintura di proiettili splendente e ben oliata era appoggiata sull’altra come una bandoliera. Portava un paio di scarponi stringati ma grossolani, nei quali erano infilati i pantaloni. Sulle spalle aveva un grosso zaino di tela. Lo stalker si levò l’elmetto rotondo delle forze speciali insieme alla maschera antigas in gomma e rimase lì fermo, rosso in viso e bagnato, a discorrere di qualcosa con il comandante del luogo. Non era più molto giovane: Artyom notò una barba ispida e grigia sulle guance e sul mento, oltre a qualche filo argenteo tra i corti capelli neri. Tuttavia l’uomo emanava un senso di potenza e di sicurezza in sé, era totalmente a suo agio e, persino qui, in una stazione calma e serena come questa, sarebbe stato pronto ad affrontare il pericolo; non si sarebbe fatto cogliere alla sprovvista. Ormai Artyom era l’unico che continuava a fissare, senza troppe cerimonie, il nuovo arrivato. La gente dietro di lui cercava di incitarlo ad avanzare, poi cominciò a superarlo. “Artyom! Perché sei tanto in ritardo? Se non fai attenzione arriverai tardi!”. Daniel era venuto a cercarlo. Sentendo il suo nome, lo stalker si voltò verso Artyom, lo guardò attentamente, poi fece un lungo passo verso di lui. “Vieni dalla VDNKh?”, gli domandò con una profonda voce sonora. Artyom annuì in silenzio e sentì che le ginocchia cominciavano a tremargli. “Sei tu che stai cercando Melnik?”, continuò lo stalker. Artyom annuì di nuovo. “Io sono Melnik. Hai qualcosa per me?”, lo stalker guardò Artyom negli occhi. Il ragazzo agguantò in tutta fretta lo spago che aveva legato al collo, con il bossolo cilindrico. Gli sembrava strano doversene separare, era diventato un talismano, ma comunque lo porse allo stalker. Quest’ultimo si tolse i guanti di pelle, aprì il coperchio ed estrasse con attenzione qualcosa dalla piccola capsula. Era un pezzo di carta. Un biglietto. “Vieni con me. Non ce l’ho fatta ad arrivare ieri. Mi dispiace. La telefonata è giunta quando ci stavamo già dirigendo in superficie”. Artyom salutò, ringraziò velocemente Daniel e si mise a inseguire Melnik su per le scale mobili che conducevano al passaggio con l’Arbatskaya. “Ha notizie da Hunter?”, domandò con imbarazzo, quasi non riusciva a stare dietro alle lunghe falcate dello stalker. “Mai più sentito. Temo che tu debba chiederlo ai tuoi amici Tetri”, rispose Melnik, voltandosi e guardando Artyom da sopra le spalle. “D’altro canto, si potrebbe dire che ci sono fin troppe novità dalla VDNKh”. Artyom sentì il cuore battere con maggiore forza. “Quali novità?”, chiese cercando di non far notare il tono preoccupato nella sua voce. “Niente di buono”, rispose lo stalker, freddo. “I Tetri sono tornati all’attacco. Una settimana fa c’è stata una dura battaglia e sono rimaste uccise cinque persone. Sembra che il numero dei Tetri sia salito ancora. La gente sta cominciando a fuggire dalla stazione, perché dicono di non riuscire a sopportare l’orrore. Hunter aveva ragione quando mi ha riferito che laggiù si nascondeva qualcosa di sinistro. Riusciva a sentirlo”. “Chi è morto, lo sa?”. Artyom era spaventato, cercava di ricordarsi chi sarebbe dovuto essere di pattuglia quel giorno, una settimana prima... Che giorno era oggi? Era Zhenka? Andrey? Ti prego, fai che non fosse Zhenka... “Non saprei. Non basta che quei non morti si insinuino nelle gallerie, c’è anche qualcosa di sinistro nei tunnel attorno alla Prospekt Mira. Le persone che li percorrono perdono la memoria e in molti sono morti sui binari.” “Cosa possiamo fare?” “Oggi c’è la riunione del Consiglio. Gli anziani Bramini e i generali discuteranno, anche se dubito che potranno aiutare la tua stazione. Riescono a malapena a difendere la Polis, e comunque perché non c’è ancora stato nessuno che abbia fatto un tentativo serio in quella direzione”. Uscirono sulla piattaforma dell’Arbatskaya. Anche qui bruciavano le lampade al mercurio e, proprio come alla Borovitskaya, gli “appartamenti” si trovavano tra gli archi murati. Le sentinelle stavano di guardia ad alcuni di essi e, in generale, c’era un numero di soldati stranamente superiore rispetto al solito. Le pareti erano bianche e in alcuni punti erano appesi stendardi da parata dell’esercito, con ricami dorati rappresentanti aquile, che sembravano quasi insensibili al passare del tempo. C’era molto movimento: i Bramini camminavano senza fretta con le loro tuniche lunghe, mentre le donne delle pulizie lavavano il pavimento e rimproveravano coloro che cercavano di passare sulle zone ancora bagnate. Anche qui c’erano diverse persone provenienti da altre stazioni. Le si poteva identificare dagli occhiali scuri o dal modo in cui usavano le mani per proteggersi mentre strizzavano gli occhi. Gli unici quartieri residenziali e amministrativi si trovavano sulla piattaforma, mentre la zona dei commercianti e di coloro che vendevano cibo si trovava sui passaggi. Melnik condusse Artyom alla fine della piattaforma, dove cominciavano gli uffici, lo fece sedere su una panchina di marmo dai profili in legno, lucidata dal contatto con migliaia di passeggeri e gli chiese di attendere, quindi se ne andò. Osservando gli stucchi intricati che decoravano il soffitto, Artyom rifletté che la Polis era stata all’altezza delle sue aspettative. Qui la vita era organizzata in maniera completamente diversa, la gente non era accanita, esasperata o intimidita come nelle altre stazioni. La conoscenza, i libri e la cultura avevano un ruolo fondamentale. Nel passaggio tra la Borovitskaya e l’Arbatskaya avevano superato almeno cinque bancarelle di libri. C’erano persino dei poster che annunciavano la messa in scena di opere di Shakespeare la sera successiva e, proprio come alla Borovitskaya, si sentiva della musica provenire da tutte le direzioni. Il passaggio ed entrambe le stazioni erano mantenuti in condizioni eccellenti. Nonostante le macchie e le infiltrazioni fossero evidenti sulle pareti, tutti i danni venivano immediatamente riparati dalle squadre di manutenzione, che si ritrovavano dappertutto, sempre frettolose. Per curiosità, Artyom diede un’occhiata alla galleria, dove notò che tutto era in perfetto ordine, era pulito e asciutto; a intervalli di cento metri e fin dove l’occhio riusciva ad arrivare, era accesa una lampadina elettrica. Di tanto in tanto passavano dei carrelli a mano pieni di casse, si fermavano per scaricare qualche passeggero o per caricare una scatola di libri che la Polis mandava nel resto della Metro. “Ben presto tutto ciò finirà”, meditò Artyom dal nulla. “La VDNKh non potrà più sopportare la pressione di quei mostri... E ciò non mi meraviglia”, disse tra sé, ricordando una sera passata al posto di guardia, quando avevano dovuto contenere un attacco dei Tetri, oltre a tutti gli incubi che lo avevano tormentato dopo quello scontro. Era vero che la VDNKh stava cedendo? Questo significava che non aveva più una casa. Chissà se i suoi amici e il suo patrigno erano riusciti a fuggire e, in quel caso, se sarebbe mai riuscito a rincontrarli un giorno, nella Metropolitana. Se Melnik gli avesse detto che aveva completato la sua missione e che non avrebbe dovuto fare altro, allora si promise che sarebbe tornato a casa. Se la sua stazione era destinata a fare la parte di una forza di copertura solitaria contro i Tetri e se i suoi amici e i suoi parenti erano destinati a morire per difenderla, avrebbe preferito essere con loro piuttosto che rifugiarsi in questo paradiso. All’improvviso, sentì il bisogno impellente di tornare a casa, intravvedere le due file di tende dell’esercito, la fabbrica di tè... e di starsene a parlare del più e del meno con Zhenka, raccontargli tutte le sue avventure. Di sicuro non avrebbe creduto alla metà di quello che gli era accaduto... sempre che fosse ancora vivo. “Forza, Artyom”, lo chiamò Melnik. “Ti vogliono parlare”. Si era liberato della tuta di protezione e indossava un maglione a collo alto, un cappello nero della marina senza alcuno stemma particolare e pantaloni multitasche, gli stessi che portava anche Hunter. In qualche modo, lo stalker gli ricordava il cacciatore, non per il suo aspetto ma per il comportamento: era controllato e forte, parlava nello stessa maniera, usando frasi brevi, telegrafiche. Le pareti degli uffici erano ricoperte di legno di quercia macchiato, su cui erano appesi due grandi dipinti a olio, uno di fronte all’altro. Artyom riconobbe subito la Biblioteca del primo quadro, mentre l’altro rappresentava un gigantesco edificio in pietra bianca. La didascalia sotto di esso riportava la scritta: “Stato maggiore, Ministero della difesa della Federazione russa”. Nel mezzo della stanza spaziosa si trovava un enorme tavolo in legno, al quale erano seduti dieci uomini, che osservavano attenti Artyom. Metà di loro indossava le tuniche grigie dei Bramini, mentre gli altri portavano uniformi militari da ufficiali. Come notò in seguito, gli ufficiali sedevano sotto il quadro dello Stato maggiore, mentre i Bramini stavano sotto quello della Biblioteca. Un uomo, basso di statura ma dai modi autorevoli, sedeva solenne a capotavola. Portava un paio di occhiali austeri ed era pressoché calvo. Indossava un abito giacca e cravatta e non aveva alcun tatuaggio a designare l’appartenenza a una delle caste. “Cominciamo”, disse senza nemmeno presentarsi. “Comunicaci tutto quello che sai, compreso ciò che sta succedendo nelle gallerie tra la tua stazione e la Prospekt Mira”. Artyom cominciò a descrivere nel dettaglio la storia delle battaglie sostenute dalla VDNKh contro i Tetri, poi della missione di Hunter e infine del suo viaggio per giungere fino alla Polis. Quando riferì gli eventi accaduti nelle gallerie tra l’Alekseevskaya, la Rizhskaya e la Prospekt Mira, i soldati e i Bramini cominciarono a sussurrare qualcosa tra loro, alcuni erano increduli, altri animati, mentre un ufficiale che sedeva nell’angolo e registrava tutto il suo racconto, di tanto in tanto gli domandava di ripetere ciò che aveva appena detto. Quando alla fine la discussione terminò, ad Artyom venne accordato il permesso di continuare la sua storia, che però suscitò poco interesse nel suo pubblico, finché non giunse alla parte relativa alla Polyanka e ai suoi abitanti. “Se posso!”, lo interruppe uno degli ufficiali, indignato. Aveva cinquant’anni circa, una corporatura massiccia, i capelli tirati indietro e indossava un paio di occhiali dalla montatura in metallo che tagliavano a metà il suo grosso setto nasale. “Tutti sanno, senza alcun dubbio, che la Polyanka è disabitata. La stazione è stata abbandonata molto tempo fa. È vero che ogni giorno vi passano almeno una decina di persone, ma nessuno può vivere laggiù: di tanto in tanto vi sono fuoriuscite di gas, ci sono cartelli di pericolo dappertutto. E anche i gatti e i rifiuti cartacei sono stati portati via da tempo. La piattaforma è completamente vuota. Noi non accettiamo questo tipo di insinuazioni”. Gli altri ufficiali annuirono concordi e Artyom rimase in silenzio, perplesso. Quando si era fermato alla Polyanka, gli era balenato il pensiero che le condizioni tranquille della stazione fossero surreali per la Metropolitana, ma era stato subito distratto dai suoi abitanti, che erano molto più che reali. Tuttavia, i Bramini non ebbero la stessa reazione furiosa dei militari. Al contrario, il più anziano, l’uomo stempiato con la lunga barba grigia, osservò Artyom con estremo interesse e, in una lingua inintelligibile, scambiò qualche parola con coloro che gli sedevano vicini. “Ragazzo, quel gas ha proprietà allucinogene se si mescola in proporzioni particolari con l’aria”, spiegò il Bramino che stava alla destra dell’anziano, in tono conciliante. “Il punto è: ora possiamo credere al resto della sua storia?”, ribatté l’ufficiale, aggrottando le sopracciglia e guardando verso Artyom. “Grazie per il tuo resoconto”, l’uomo con il completo elegante interruppe la discussione. “Il Consiglio ne discuterà e ti informerà del risultato. Puoi andare”. Artyom si diresse verso l’uscita. Tutta la conversazione con i due abitanti della Polyanka che fumavano il calumet era stata davvero solo un’allucinazione? Ciò avrebbe significato che l’idea di essere stato selezionato, di poter piegare la realtà per realizzare il proprio destino era un prodotto della sua immaginazione, un tentativo di auto consolazione? Ora persino il misterioso incontro nella galleria tra la Borovitskaya e la Polyanka non gli sembrava più un miracolo. Gas? Gas. Si sedette sulla panchina di fianco alla porta e non prestò attenzione al vociare distante dei membri del Consiglio che litigavano. La gente gli passava davanti, i carrelli a mano e a motore attraversavano la stazione, i minuti scorrevano e lui rimaneva seduto a pensare. Aveva davvero una missione da compiere o si era immaginato tutto? Cosa avrebbe fatto ora? Dove sarebbe andato? Qualcuno attirò la sua attenzione toccandogli la spalla: era l’ufficiale che durante il suo racconto aveva preso appunti. “I membri del Consiglio hanno deciso che la Polis non può aiutare in alcun modo la tua stazione. Ti ringraziano per il tuo rapporto tanto dettagliato sulla situazione attuale nella Metropolitana. Ora puoi andare”. Era finita. La Polis non li poteva aiutare. I suoi sforzi non erano serviti a nulla. Aveva fatto tutto ciò che aveva potuto, ma non sarebbe cambiato nulla. Ora sarebbe dovuto ritornare alla VDNKh per assistere spalla a spalla gli uomini rimasti a difenderla. Artyom si alzò dalla panchina e si mise a camminare piano, senza una meta precisa. Aveva quasi raggiunto il passaggio verso la Borovitskaya, quando udì un leggero colpo di tosse alle sue spalle. Il ragazzo si girò e vide il Bramino del Consiglio, lo stesso che sedeva alla destra dell’anziano. “Aspetta un attimo, giovanotto. Ritengo che tu e io abbiamo qualcosa di cui discutere... in privato”, aggiunse, sorridendo educatamente. “Se il Consiglio non è in grado di fare qualcosa per te, forse il tuo servo obbediente può darti un aiuto maggiore”. Afferrò Artyom per il gomito e lo condusse verso uno degli appartamenti in mattoni tra gli archi. Qui non c’erano finestre né luci elettriche, solo la fiammella di una candela, che illuminava i visi delle persone radunate nella stanza. Artyom non riuscì a osservarli bene perché il Bramino che lo aveva scortato fin lì spense la fiamma e la stanza sprofondò nell’oscurità. “È vero ciò che hai riferito sulla Polyanka?”, domandò una voce indistinta. “Sì”, rispose Artyom, deciso. “Sai come la chiamiamo noi Bramini? Quella è la stazione del destino. Lasciamo che i Kshatrya pensino che sia il gas a causare cupe suggestioni, noi non li contraddiciamo. Non ridoneremo la vista al nostro nemico più recente. Noi crediamo che, in quella stazione, le persone possano incontrare dei messaggeri della Provvidenza. Quest’ultima non significa nulla per la maggior parte di loro, perciò si ritrovano ad attraversare una stazione vuota, abbandonata. Ma coloro che hanno incontrato qualcuno alla Polyanka dovrebbero considerare molto attentamente ciò che gli è accaduto e ricordarsi ciò che gli è stato detto per il resto della vita. Tu lo ricordi?” “L’ho dimenticato”, mentì Artyom, poiché queste persone non gli ispiravano troppa fiducia e gli ricordavano i membri di una setta. “I nostri anziani sono convinti che tu non sia arrivato qui per caso. Non sei una persona qualunque e le tue abilità speciali, che ti hanno salvato diverse volte, ci possono aiutare. In cambio vogliamo dare una mano a te e alla tua stazione. Siamo i guardiani della conoscenza e abbiamo informazioni che potrebbero salvare la VDNKh”. “Cosa c’entra la VDNKh?”, si agitò Artyom. “Parlate esclusivamente della VDNKh! Non capite che non sono venuto qui solo per salvare la mia stazione e non per una serie di eventi sfortunati! Tutti, tutti voi, siete in pericolo! La VDNKh sarà la prima a cadere, poi il resto della linea e in seguito tutta la Metropolitana...” Nessuno rispose. Il silenzio si fece più fitto. Si udivano solo i respiri ritmici dei presenti. Artyom attese ancora un po’, poi, incapace di starsene zitto, domandò: “Che devo fare?” “Sali, recati agli Archivi principali. Trova ciò che ci appartiene di diritto e riportacelo qui. Se riuscirai a trovare ciò che stiamo cercando, ti conferiremo la conoscenza che ti aiuterà a distruggere la minaccia. E che la Grande Biblioteca possa bruciare se mento”. CAPITOLO 13 : LA GRANDE BIBLIOTECA Artyom uscì dalla stanza direttamente nella stazione, guardandosi attorno con un’espressione furibonda: aveva appena stretto uno degli accordi più bizzarri della sua vita. I suoi committenti si erano rifiutati di spiegargli con esattezza cosa avrebbe dovuto trovare negli Archivi principali, promettendogli di fornirgli maggiori informazioni in un secondo tempo, quando si sarebbe trovato già in superficie. Sebbene gli fosse sovvenuto, per un momento, che stessero parlando del Libro a cui aveva accennato Daniel la notte precedente, non osò domandare ai Bramini delucidazioni in proposito. C’era da tenere in considerazione il fatto che, nel momento in cui il suo ospite gli aveva spifferato il suo segreto, entrambi i ragazzi era piuttosto ubriachi, perciò Artyom avrebbe potuto dubitare della veridicità della storia. Non sarebbe salito in superficie da solo; i Bramini intendevano organizzare una vera e propria squadra. Artyom sarebbe stato accompagnato da almeno due stalker e da un appartenente alla casta, al quale avrebbe dovuto immediatamente consegnare ciò che avrebbe trovato, se la spedizione avesse avuto successo. In seguito, quella stessa persona avrebbe mostrato ad Artyom qualcosa che gli avrebbe permesso di liberarsi della minaccia che incombeva sulla VDNKh. Nel momento in cui era uscito dall’oscurità più impenetrabile della stanza ed era riemerso sulla piattaforma, i termini dell’accordo gli erano parsi assurdi. Come in un antico racconto, Artyom si sarebbe recato dove non sapeva, per prendere ciò che non conosceva, e in cambio avrebbe ottenuto una specie di salvezza miracolosa. Ma cos’altro poteva fare? Ritornare a mani vuote? Era questo che il cacciatore si aspettava da lui? Quando Artyom aveva chiesto ai suoi misteriosi committenti come avrebbe potuto trovare ciò che stavano cercando all’interno degli immensi Archivi della Biblioteca, gli era stato riferito che avrebbe capito ogni cosa a suo tempo. Lo avrebbe sentito. Non fece ulteriori domande, temendo che i Bramini perdessero la loro fiducia nelle sue capacità straordinarie, nelle quali lui stesso ancora non credeva. Infine, era stato avvertito che i soldati non avrebbero dovuto sapere nemmeno una parola del loro accordo, che altrimenti sarebbe decaduto. Artyom si sedette su una panchina al centro dell’atrio e si mise a pensare. Questa era un’ottima possibilità di salire in superficie, cosa che era riuscito a fare una sola volta in precedenza; in questa occasione però, ci sarebbe andato senza temere alcuna conseguenza o terribili punizioni. Salire in superficie, non da solo, ma con veri stalker. Compiere una missione segreta per la casta dei guardiani... Non gli aveva nemmeno domandato perché detestavano tanto la parola “bibliotecari”. Melnik si sedette pesantemente sulla panchina, di fianco a lui. Ora aveva un aspetto stanco e agitato. “Perché hai accettato?”, domandò senza alcuna inflessione nella voce, continuando guardare di fronte a sé. “Come lo ha scoperto?”. Artyom era sorpreso. Era passato meno di un quarto d’ora dalla sua conversazione con i Bramini. “Dovrò venire con te”, continuò Melnik in tono scoraggiato, ignorando la domanda del ragazzo. “Adesso sono io che rispondo di te a Hunter, qualsiasi cosa gli sia successa. Quando si stipula un accordo con i Bramini, non si torna indietro. Non l’ha mai fatto nessuno. Soprattutto, non pensare di andare a spifferare tutto ai militari”. Si alzò, scosse il capo e aggiunse: “Se solo sapessi in che guaio ti sei cacciato... Io vado a riposare. Partiremo stasera”. “Ma lei non è un militare?”, chiese Artyom, raggiungendolo. “Li ho sentiti chiamarla ‘Colonnello’”. “Sì, sono un Colonnello, ma non della loro linea di comando”, rispose Melnik a malincuore e così dicendo se ne andò. Artyom passò il resto della giornata a prendere confidenza con la Polis, camminando senza meta tra gli spazi infiniti delle scale e dei passaggi, esaminando i colonnati maestosi e meravigliandosi del numero di persone che questa città sotterranea potesse ospitare. Studiò con attenzione il gazzettino intitolato “Notizie dalla Metro”, che veniva stampato su carta da pacchi marrone; ascoltò musicisti vagabondi; sfogliò libri alle bancarelle; giocò con i cuccioli in vendita; ascoltò i pettegolezzi più recenti, ma in tutto ciò non riuscì mai a togliersi di dosso la sensazione di essere costantemente seguito e osservato. In diverse occasioni si voltò all’improvviso, sperando di scorgere qualcuno che lo teneva sotto controllo, ma fu tutto inutile. Era circondato da una folla affaccendata e nessuno si accorse di lui. Trovò un hotel in uno dei passaggi e dormì per qualche ora. Alle dieci di sera, come d’accordo con gli altri, si recò alla Borovitskaya, esattamente al cancello che conduceva all’uscita verso la città. Melnik era in ritardo, ma furono proprio le sentinelle a informare il ragazzo e gli offrirono una tazza di tè per ingannare l’attesa. La guardia più anziana interruppe il suo racconto per un minuto, mentre versava l’acqua bollente in una tazza smaltata, poi continuò: “Mi era stato assegnato il compito di ascoltare la radio. Tutti speravano di riuscire a intercettare la frequenza su cui trasmettevano dai bunker del governo, al di là degli Urali. Ma fu tutto inutile, perché i primi obiettivi che colpirono furono proprio quelli strategici. È così che venne raso al suolo il distretto Ramenki, oltre a tutte le residenze estive fuori città, con le loro cantine a trenta metri di profondità... anche quelle annientate. Avrebbero potuto risparmiare il Ramenki, perché in realtà cercarono di non colpire la popolazione pacifica... Al tempo nessuno sapeva che quella guerra ci avrebbe condotto alla fine. Perciò, avrebbero potuto evitare di colpirlo, ma nelle vicinanze si trovava un punto di comando, così buttarono giù anche quello. Per quanto riguarda la vittime civili, dissero che erano tutti dei danni collaterali, così come li chiamarono loro, perdonate l’espressione. Ma a quel tempo nessuno ci credeva ancora, così i pezzi grossi mi misero ad ascoltare le onde radio in un bunker di fianco all’Arbatskaya. All’inizio udii le cose più strane... Niente dalla Siberia, sebbene diverse parti del paese trasmettessero ancora. Anche i sottomarini, strategici e nucleari, erano in onda. Chiedevano se colpire oppure no... La gente non credeva che Mosca non esistesse più. Alla radio, persino i capitani più decorati singhiozzavano come dei neonati. Sapete, è singolare sentire i più esperti ufficiali della marina, che non si erano mai scomposti in tutta la loro esistenza, piangere e implorare che qualcuno andasse a controllare se le loro mogli o le loro figlie fossero tra i sopravvissuti... ‘Andate a cercarle laggiù!’ dicevano. Poi, in seguito, cominciarono a reagire in maniera diversa. C’erano quelli che dicevano: ‘Ci siamo! Siamo all’inferno! Ora vige la legge del taglione...’, si avvicinavano alle loro coste e assaltavano le città. Altri, al contrario, decisero che, dato che la situazione peggiorava di minuto in minuto, combattere non aveva più senso. Perché uccidere altra gente? Ma nessuno gli diede retta. Erano già abbastanza coloro che desideravano vendicare le proprie famiglie. Quelle navi risposero per un periodo relativamente lungo: da ferme sarebbero potute stare sott’acqua per almeno sei mesi. Ovviamente ne trovarono solo alcune, ma non tutte. Beh, questa è la storia che ci si rivolta contro. Ancora oggi, quando ci penso mi vengono i brividi. Ma comunque non era questo il punto. Una volta sono riuscito a collegarmi con un carro armato che era miracolosamente scampato all’attacco. La squadra stava trasportando il cingolato dall’unità o qualcosa del genere... Si trattava di un mezzo costruito con una nuova tecnologia, che lo proteggeva dalle radiazioni. All’interno c’erano quattro uomini. Se ne andarono da Mosca a tutta velocità, diretti a est. Attraversarono villaggi in fiamme, imboccarono strade secondarie, proseguirono e si fermarono per recuperare una sorta di carburante biologico, poi si rimisero in viaggio. Quando la benzina finì si trovavano in un luogo totalmente isolato, dove non era rimasto più nulla da bombardare. Ovviamente anche qui le radiazioni di fondo erano piuttosto alte ma non erano per nulla paragonabili a quelle nelle zone vicine alle città. Perciò si accamparono e scavarono un fossato sotto il carro armato, così da mimetizzarsi. Insomma, eressero una fortificazione. Montarono anche delle tende nelle vicinanze e in seguito costruirono delle capanne di fango, un generatore manuale d’elettricità e vissero per un periodo abbastanza lungo attorno al mezzo. Due anni. Ho parlato con loro quasi ogni notte. Sapevo tutto quello che gli succedeva. All’inizio andava bene, avevano edificato anche una cascina e due di loro avevano avuto figli che erano... quasi normali. Avevano un numero sufficiente di munizioni. Gli succedevano cose strane e, inoltre, le creature che uscivano dalla foresta... Beh, il tenente con cui parlavo non riusciva nemmeno a descrivermele con esattezza. Poi smisero di trasmettere. Passai altri sei mesi a cercarli, ma là fuori era successo qualcosa. Il generatore o il trasmettitore si era rotto oppure avevano terminato le munizioni...” “Stavi parlando del distretto Ramenki”, gli ricordò un’altra sentinella. “Come è stato bombardato? Ma soprattutto, da quando lavoro qui, nessuno è stato in grado di raccontarmi cosa sia successo al Cremlino. Come ha fatto a rimanere in piedi? Perché non è stato colpito? Perché, secondo me, è proprio lì che si trovavano i veri bunker”. “Chi ti ha detto che non è stato attaccato? Certo che è stato colpito!”, assicurò la guardia. “Solo che non volevano demolirlo, perché è un monumento e anche per il fatto che vi stavano testando delle nuove armi. E questo è quello che abbiamo ricevuto in cambio... Sarebbe stato meglio che l’avessero cancellato dalla faccia della Terra già dall’inizio”. Sputò e non parlò più. Artyom sedeva in silenzio, cercando di non distrarre il veterano dalle sue reminescenze. Era molto raro ascoltare qualcuno in grado di scendere tanto nel dettaglio. Ma la sentinella più anziana non disse altro e rimase immersa nei suoi pensieri. Infine Artyom colse il momento buono e decise di porre una domanda che da un po’ gli ronzava in testa: “Però ci sono metropolitane anche in altre città, non è così? Per lo meno, io ho sentito dire che ve ne fossero. È vero che non è rimasto più nessuno, da nessuna parte? Quando lei era un operatore radio non ha percepito alcun segnale da loro?” “No, nessuno. Ma hai ragione. La gente di altre città, di San Pietroburgo ad esempio, si sarebbe dovuta salvare. Le loro stazioni sono state costruite in profondità, alcune sono persino più profonde delle nostre; inoltre, anche il resto della Metro è più o meno simile. Ci sono stato quando ero più giovane, me lo ricordo. Su una linea non c’erano uscite sui binari. Al contrario, avevano costruito delle massicce porte di ferro. Quando il treno arrivava, le porte si aprivano insieme a quelle del treno. Lo ricordo come se l’avessi visto ieri, anche perché allora mi sorprese. Chiesi a chiunque il perché della cosa, ma nessuno fu in grado di spiegarmi la ragione. Un uomo mi disse che le porte servivano per fare in modo che la stazione non venisse inondata, un altro che in questo modo avevano risparmiato un mucchio di denaro quando avevano eseguito i lavori. In seguito, feci amicizia con un operaio della metropolitana, il quale mi raccontò che all’interno della galleria viveva una creatura che aveva divorato metà della squadra di costruzione e che lo stesso stava accadendo anche alle altre squadre. Venivano ritrovati solo ossa rosicchiate e utensili da lavoro. Ovviamente, ciò non venne mai resto noto al pubblico, ma sta di fatto che installarono queste porte su tutta la linea, per stare più sicuri. Ciò successe, lasciami pensare, quando... Beh, quello che le radiazioni possano aver generato laggiù è difficile da immaginare”. La conversazione si interruppe quando Melnik e un altro uomo, basso e tarchiato, con occhi infossati e una mascella gigantesca sulla quale cresceva una corta barba, arrivarono al cancello. Entrambi indossavano già le loro tute protettive e sulle spalle portavano degli enormi zaini. Melnik esaminò Artyom in silenzio, gli piazzò di fianco ai piedi un’enorme sacca nera e proseguì verso la tenda dell’esercito. Artyom vi entrò e aprì la cerniera della borsa, che conteneva una tuta identica a quella di Melnik e del suo collaboratore, con un’insolita maschera antigas: il vetro era grande come tutto il viso e aveva due filtri sui lati; inoltre, c’erano scarponi alti fin sopra la caviglia, ma soprattutto, un nuovo fucile d’assalto, un Kalashnikov con un mirino laser e il calcio pieghevole in metallo. Era un’arma eccezionale. Artyom l’aveva vista solo nelle mani delle unità élitarie dell’Hansa che pattugliavano la linea su carrelli motorizzati. Sul fondo del bagaglio si trovavano una lunga torcia e un elmetto rotondo con una copertura in tessuto. Non aveva ancora terminato di vestirsi quando la tenda si aprì ed entrò Daniel, il Bramino. In mano aveva una sacca con la zip, identica alla sua. Si osservarono meravigliati. Artyom fu il primo a comprendere cosa stava succedendo. “Sali anche tu? Sarai il nostro cicerone? Ci aiuterai a trovare quello che... io non so cosa sia?”, gli domandò in tono beffardo. “Io so cos’è”, ringhiò il Bramino “Ma non ho la più pallida idea di come tu abbia intenzione di cercarlo”. “Nemmeno io”, ammise Artyom. “Mi è stato riferito che me lo avrebbero spiegato in seguito. Perciò, eccomi qui. Sputa il rospo”. “A me invece è stato assicurato che avrebbero inviato un chiaroveggente, che avrebbe compreso da solo dove andare”. “E io sarei il chiaroveggente?”, grugnì Artyom. “Gli anziani ritengono che tu abbia un dono e che il tuo destino sia segnato. Nel Testamento è contenuta una profezia che predice l’arrivo di un giovane, condotto dal fato, che scoprirà i segreti nascosti della Grande Biblioteca e troverà ciò che negli ultimi decenni la nostra casta ha cercato, senza mai riuscire a trovare. Loro sono convinti che quella persona sei tu”. “Si tratta di quel libro di cui mi hai parlato?”, chiese Artyom. Daniel non rispose, poi dopo qualche minuto annuì. “Dovresti riuscire a sentirlo. Non è nascosto a tutti. Se tu sei davvero quel ‘giovane condotto dal fato’ allora non dovrai setacciare gli Archivi principali. Il Libro troverà te”, chiarificò facendo scorrere il suo sguardo inquisitorio su Artyom. Poi aggiunse: “Tu cosa gli hai chiesto in cambio?” Non aveva senso mentire. Solo che Artyom rimase spiacevolmente sorpreso dal fatto che Daniel, cioè la persona che avrebbe dovuto fornirgli le informazioni che avrebbero aiutato il ragazzo a salvare la VDNKh dall’invasione dei demoni, non fosse a conoscenza di questo pericolo o delle condizioni dell’accordo con i membri del Consiglio. Gli riassunse brevemente ciò che avevano concordato e gli spiegò quale fosse la catastrofe che cercava di evitare. Daniel lo ascoltò attento ed era ancora fermo immobile a pensare quando Artyom uscì dalla tenda. Melnik e lo stalker con la barba li stavano già aspettando vestiti di tutto punto con l’equipaggiamento da combattimento, tenevano in mano le maschere antigas e gli elmetti. Il collega era armato di una mitraglietta, mentre Melnik impugnava una copia esatta del fucile d’assalto che avevano fornito ad Artyom. Al collo aveva appeso un dispositivo per la visione notturna. Quando Daniel uscì dalla tenda, lui e Artyom si guardarono con aria spavalda, poi il Bramino ammiccò ed entrambi scoppiarono a ridere. Sembravano dei veri e propri stalker. “Siamo stati fortunati... Prima che i novellini affrontino una missione importante, devono sottoporsi a due anni di addestramento con gli stalker, a prendere legna da ardere in superficie. Io e te, invece, siamo decisamente avvantaggiati!”, sussurrò Daniel ad Artyom. Melnik li guardò con aria di disapprovazione, ma non disse nulla; gli fece solo segno di seguirlo. Giunsero all’arco del passaggio e, dopo aver salito le scale, si fermarono al successivo muro di blocchi di cemento, in prossimità di una porta blindata, controllata da sentinelle. Lo stalker li salutò e gli fece segno di aprire. Uno dei soldati si alzò, si diresse verso l’uscita e spostò con forza il chiavistello. La spessa porta d’acciaio scorse di lato, senza alcuna fatica. Melnik lasciò passare gli altri tre, si congedò delle guardie e uscì per ultimo. Al di là della porta vi era una piccola zona cuscinetto di tre metri alla fine della quale vi erano delle porte a pressione. Anche queste venivano sorvegliate da due soldati armati fino ai denti e da un ufficiale. Prima di impartire l’ordine di alzare la sbarra di ferro, Melnik decise di dare istruzioni ai due novellini. “Ascoltatemi bene: mentre si cammina non si parla. Siete mai stati in superficie? Beh, lasciamo perdere... Dammi la mappa”, si rivolse all’ufficiale. “Finché non arriviamo al vestibolo dovete seguirmi come se foste le mie ombre. Non mettetevi a vagare in giro. Non guardatevi attorno, non dite una parola. Quando usciamo dal vestibolo, non pensate nemmeno di attraversare il cancello girevole o perderete le gambe. Voi dovete seguire me e non fare di testa vostra. A quel punto usciremo. Dieci”, indicò lo stalker con la barba “starà nella retroguardia e coprirà l’ingresso della stazione. Se non ci sono problemi, non appena saremo in strada gireremo immediatamente a sinistra. Non è troppo buio, in questo momento, perciò non useremo le torce. Non vogliamo attirare l’attenzione. Sapete del Cremlino? Sarà alla vostra destra, ma una delle torri si scorge non appena si esce dalla Metro. Non guardate il Cremlino, per nessun motivo! Schiaffeggerò personalmente chiunque ci provi”. “Allora è vero quello che si dice sul Cremlino e sulla regola che vige tra gli stalker di non guardarlo per nessun motivo”, pensò Artyom stupito. All’improvviso, dentro di lui si risvegliò qualcosa, delle immagini frammentarie... Si mossero, poi si placarono di nuovo. “Dobbiamo arrivare alla Biblioteca. Entreremo dal portone, poi saliremo le scale. Io andrò per primo. Se la via è libera, Dieci ci coprirà e noi saliremo, poi saremo noi a coprire lui, mentre procede. Sulle scale non si parla. Se notate un pericolo, date l’allarme con le torce. Non sparate, a meno che non sia strettamente necessario. I colpi li attraggono”. “Attraggono... chi?”, Artyom non riuscì a trattenersi. “In che senso ‘chi’?”, ripeté Melnik. “Chi ti aspetti di incontrare in una Biblioteca? È ovvio, i bibliotecari”. Daniel deglutì rumorosamente e impallidì. Artyom guardò lui, poi fissò Melnik e decise che questo non era il momento adatto per fare il saccente. “E chi sarebbero?” Melnik alzò un sopracciglio, sorpreso. Il suo collega barbuto si mise una mano davanti agli occhi, mentre Daniel abbassò lo sguardo. Lo stalker osservò a lungo il ragazzo con il sopracciglio alzato e, quando comprese che Artyom non stava scherzando, rispose freddo: “Li vedrai da te. La cosa più importante da ricordare è: se li guardi dritto negli occhi non ti attaccano. Capito? Dritto negli occhi. Non lasciare che ti prendano alle spalle. È tutto. Muoviamoci!”. Indossò la maschera antigas e l’elmetto, poi diede il via libera alle sentinelle. L’ufficiale fece un passo verso l’interruttore generale e aprì le porte a pressione. La barriera di acciaio salì lenta: stavano per salire in superficie. Melnik fece un cenno con la mano a indicare che la strada era libera. Artyom spinse la porta trasparente, alzò il fucile e saltò sulla strada. Sebbene lo stalker gli avesse ordinato di seguirlo come un’ombra, di non andarsene in giro a zonzo, era impossibile obbedirgli... Il cielo era totalmente diverso dalla volta in cui l’aveva visto Artyom, quando era un bambino. Invece di esserci uno spazio blu trasparente e infinito, sopra le loro teste ora incombevano densi nuvoloni grigi e, dal cielo che sembrava cotone, cominciavano a cadere le prime gocce di una pioggerellina autunnale. Soffiavano raffiche di vento freddo, che Artyom sentiva anche attraverso il tessuto della tuta protettiva. Qui lo spazio lasciava a bocca aperta, era enorme, a destra, a sinistra, davanti. Era illimitato e ciò lo rendeva affascinante e stranamente deprimente allo stesso tempo. Per una frazione di secondo, Artyom ebbe l’impulso di tornare all’entrata della Borovitskaya, sottoterra, per sentirsi protetto dalle mura ed essere immerso nella sicurezza di uno spazio chiuso, limitato. Riuscì a tenere sotto controllo questa sensazione opprimente solo distraendosi, osservando gli edifici circostanti. Il sole era già tramontato e sulla città stava pian piano scendendo il crepuscolo. Gli scheletri dei caseggiati bassi, dilapidati e scavati da decenni di piogge acide, fissavano i viaggiatori con le orbite vuote delle loro finestre rotte. La città... aveva un aspetto scoraggiante, ma comunque magnifico. Non sentendosi chiamare, Artyom rimase fermo, guardandosi attorno come fosse ipnotizzato. Finalmente poteva paragonare la realtà con i suoi sogni e con i suoi ricordi di bambino, altrettanto offuscati. Daniel, che molto probabilmente non era mai stato in superficie, rimase di sasso, di fianco a lui. L’ultimo a uscire dal vestibolo fu Dieci. Lo stalker colpì Artyom sulla spalla per attirare la sua attenzione e indicò il punto in cui, in lontananza, la sagoma della cattedrale, con tutte le sue cupole, si stagliava contro il cielo. “Guarda la croce”, la voce di Dieci ronzò attraverso il filtro della maschera antigas. All’inizio, Artyom non era riuscito a scorgere nulla di particolare, nemmeno la croce. Solo quando un’enorme ombra alata spiccò il volo dalle travi incrociate, emettendo un urlo prolungato che faceva raggelare il sangue, il ragazzo comprese ciò che Dieci gli stava mostrando. Dopo aver sbattuto le ali, il mostro si alzò in volo e cominciò a planare descrivendo ampi cerchi, alla ricerca di una preda. “Fanno il nido lassù”, Dieci fece un gesto con la mano. Procedendo di fianco al muro, si spostarono verso l’entrata della Biblioteca. Melnik conduceva il gruppo diversi metri avanti, mentre Dieci camminava indietro, con il busto girato, per coprire il retro. Proprio perché entrambi gli stalker erano distratti, Artyom riuscì a lanciare un’occhiata al Cremlino, ancor prima che giungessero alla statua dell’anziano seduto in poltrona. Artyom non voleva farlo, ma nel momento in cui vide il monumento, si sentì scuotere dalla testa ai piedi e nella sua mente qualcosa fu subito chiaro. Un’intera parte del sogno del giorno precedente era ritornata in superficie. Tuttavia, ora non sembrava più soltanto un sogno, perché il panorama e il colonnato della Biblioteca che aveva già visto rassomigliavano a ciò che vedeva di fronte a sé in quel momento. Questo significava che anche il Cremlino era uguale a come se l’era immaginato nelle sue visioni? Nessuno stava guardando il ragazzo, nemmeno Daniel che si trovava lì vicino, perché si era trattenuto con Dieci. “Ora o mai più”, pensò tra sé Artyom. La sua bocca si seccò e il sangue gli cominciò a pulsare nelle tempie. La stella sulla torre brillava davvero. “Ehi, Artyom! Artyom!”, qualcuno lo scosse dalla spalla. Con difficoltà, riemerse dal torpore e tornò a essere consapevole. Il luminoso fascio di luce di una torcia assaltò i suoi occhi. Artyom sbatté le palpebre e si coprì gli occhi con la mano. Era seduto a terra con la schiena poggiata alla base di granito del monumento. Daniel e Melnik erano piegati sopra di lui ed entrambi gli osservavano gli occhi, preoccupati. “Ha le pupille contratte”, affermò Melnik. “Come hai fatto a perderlo?”, domandò a Dieci visibilmente seccato. Quest’ultimo stava a qualche passo da loro e teneva gli occhi fissi sulla strada. “Ho sentito un rumore là dietro e non sono riuscito a ignorarlo”, spiegò lo stalker. “Chi sapeva che sarebbe stato così veloce... guarda, in un minuto era quasi riuscito ad arrivare alla Manezh... E avrebbe proseguito. Per fortuna il nostro Bramino ha la testa sulle spalle”, si congratulò con Daniel dandogli una pacca sulle spalle. “Brilla”, disse Artyom a Melnik con voce flebile. “Brilla”, ripeté guardando Daniel. “Sì, è vero, brilla”, Daniel cercò di essere rassicurante. “Non ti avevo detto di non guardare laggiù, idiota che non sei altro?”, Melnik rimproverò Artyom, ora che il pericolo era passato. “Vuoi obbedire ai tuoi superiori?”, gli domandò e gli diede una sberla sulla nuca. L’elmo attutì il valore educativo del colpo, ma Artyom rimase seduto a terra, sbattendo gli occhi. Quando finalmente ebbe terminato le imprecazioni, lo stalker gli afferrò la spalla e lo scosse, rimettendolo in piedi. Pian piano Artyom si riprese. Si vergognò di non essere riuscito a resistere alla tentazione. Teneva lo sguardo basso, sulle punte dei suoi scarponi, ed esitava a guardare Melnik. Fortunatamente, quest’ultimo non ebbe il tempo di fargli la paternale, perché venne distratto da Dieci, che era rimasto all’intersezione: chiedeva al collega di raggiungerlo, mentre teneva premuto un dito sul filtro della maschera antigas a indicare di fare silenzio. Artyom decise di non mettersi nei guai, di seguire sempre Melnik e di non voltare mai lo sguardo in direzione delle torri enigmatiche. Avvicinandosi a Dieci, a un certo punto anche Melnik rimase immobile. L’uomo con la barba indicava un punto in lontananza, distante dal Cremlino, in cui gli edifici altissimi, ormai ridotti in polvere, che percorrevano tutta la Prospettiva Kalininskiy, ora sembravano solo un sorriso di denti marci. Avvicinandosi cauto, Artyom guardò cosa stava succedendo da dietro le enormi spalle dello stalker e comprese immediatamente la situazione. Nel bel mezzo della Prospettiva, a circa sessanta metri da loro, c’erano le sagome di tre umani immobili, scure contro il crepuscolo. Umani? A una tale distanza Artyom non avrebbe potuto mettere la mano sul fuoco che si trattasse proprio di persone. In ogni caso, erano di altezza media e stavano eretti, su due gambe. Ciò era incoraggiante. “Chi sono?”, sussurrò Artyom con voce rauca, mentre cercava di identificare le sagome distanti attraverso il vetro appannato della sua maschera antigas. Erano delle persone oppure si trattava dei mutanti, di cui aveva tanto sentito parlare? Melnik scosse silenziosamente la testa, facendogli capire di non saperne più di lui a riguardo. Puntò il raggio della torcia verso gli esseri immobili e descrisse tre cerchi, poi la spense. Di tutta risposta, una macchia luminosa brillò da lontano, si mosse in cerchio per tre volte e poi si scomparve. La tensione si allentò all’istante e l’atmosfera scossa tornò alla normalità. Artyom lo percepì ancora prima che Melnik desse il via libera. “Stalker”, spiegò loro la guida. “Ricordate, se dovesse succedervi: i tre cerchi luminosi sono il nostro segnale di riconoscimento. Se ricevete la stessa risposta, potete procedere senza alcun timore, nessuno vi farà del male. Al contrario, se non vi rispondono, allora scappate senza indugio”. “Ma se hanno una torcia, significa che sono umani e non uno di quei mostri della superficie”, obiettò Artyom. “Non so quale dei due sia peggio”, ribatté a sua volta Melnik. Senza ulteriori spiegazioni, proseguì e salì le scale verso l’entrata della Biblioteca. La pesante porta di quercia, alta all’incirca quanto due persone, si spostò lenta, quasi con riluttanza. I cardini arrugginiti emisero un suono acuto, isterico. Melnik scivolò all’interno, sistemandosi il dispositivo per la visione notturna sugli occhi e impugnando il fucile con una mano. Dopo un secondo, riferì agli altri che potevano seguirlo. Davanti a loro si trovava un lungo corridoio; sui muri erano ancora sistemate le strutture in ferro degli appendiabiti, sebbene fossero piegate in posizioni strane: un tempo era stato il guardaroba. Da lontano, alla flebile luce del giorno che pian piano si spegneva e che giungeva fin lì dalla strada, si vedevano i gradini di marmo bianco di una scala che conduceva verso l’alto. Il soffitto era alto circa quindici metri, mentre la ringhiera di ferro battuto del secondo piano era distinguibile a circa metà della parete. Nell’atrio regnava un silenzio fragile, che rispondeva a tutti i passi dei presenti. Le pareti del vestibolo erano ricoperte di muschio che si muoveva quasi impercettibilmente, come se stesse respirando, mentre delle bizzarre piante simili a viti, ma con i tralci grandi quanto il braccio di un uomo, pendevano dal soffitto e arrivavano quasi fino al suolo. Alla luce della torcia, questi brillavano come fossero ricoperti da un grasso lucido, inoltre qua e là vi erano enormi fiori informi che emettevano un odore soffocante che faceva girare la testa. Anch’essi oscillavano leggermente; Artyom non volle avventurarsi per scoprire se a farle muovere fosse il vento che soffiava all’interno dalla finestra rotta del secondo piano, oppure se si muovevano da soli. “Cos’è?”, chiese Artyom rivolto a Dieci, toccando una delle piante. “Vegetazione”, arrivò la risposta attutita dal filtro. “Arbusti domestici che hanno subito radiazioni, ecco cosa. Belle di giorno. Quei botanici hanno fatto un ottimo lavoro...” Seguirono Melnik, raggiunsero le scale e cominciarono a percorrerle, rimanendo alla sinistra del muro, mentre Dieci li copriva. Lo stalker in testa non staccava gli occhi dal rettangolo scuro che era l’entrata verso le altre stanze, proprio davanti a loro. Gli altri scandagliavano con i raggi delle loro torce le pareti di marmo e il soffitto ricoperto di muschio. La vastissima scala in marmo su cui si trovavano conduceva al primo piano dell’ingresso, sopra il quale non c’era soffitto perciò i due piani insieme costituivano un enorme, unico spazio. Il primo piano poteva essere paragonato ai tre lati di un rettangolo: al centro si trovava l’area della scala, mentre gli altri spazi erano tutti occupati da armadietti in legno, la maggior parte dei quali erano bruciati o marciti, tuttavia sembrava che qualcuno li avesse usati fino al giorno precedente. In ciascuna sezione c’erano centinaia di piccoli cassetti. “Lo schedario”, spiegò Daniel a bassa voce, guardandosi attorno con riverenza. “Grazie a questi cassetti si può prevedere il futuro. Gli iniziati sanno come fare. Dopo un rituale, si sceglie un armadietto, poi si apre a caso uno dei cassetti e si pesca una scheda. Se il rituale viene eseguito con esattezza, il nome del libro riportato sulla scheda predirà il futuro, ti avvertirà di un pericolo oppure pronosticherà un successo”. Per un momento, Artyom sentì l’impulso di arrivare fino al mobile più vicino e scoprire quale sezione del catalogo delle schede gli avrebbe riservato il destino. Ma la sua attenzione venne distratta da una ragnatela gigante che si estendeva per diversi metri su una finestra rotta, che si trovava in un angolo lontano della stanza. Nei suoi sottili filamenti alquanto resistenti era rimasto impigliato un uccello di medie dimensioni. Era ancora vivo e si contorceva con le poche forze che gli rimanevano. Con grande sollievo, Artyom non vide quale animale era stato in grado di tessere quell’innaturale tela. Oltre a loro, non c’era anima viva nell’immenso vestibolo. Melnik fece segno di fermarsi. “Ora ascolta”, ordinò ad Artyom. “Non fare caso ai rumori all’esterno... Cerca di ascoltare quelli che senti dentro di te, nella tua testa. Secondo loro il Libro dovrebbe chiamarti. Gli anziani Bramini ritengono che molto probabilmente sia a uno dei piani dell’Archivio principale. Ma il volume che ci interessa potrebbe essere dappertutto, in una delle sale da lettura, su un carrello dimenticato, in un atrio, su uno dei tavolo dei direttori... Perciò, prima di farci strada verso i depositi, prova a rimanere in ascolto da qui. Chiudi gli occhi e rilassati”. Artyom strizzò gli occhi e si mise ad ascoltare attentamente. Nell’oscurità più completa, il silenzio si divise in decine di rumori minuscoli: lo scricchiolio dei ripiani in legno, il fruscio dell’aria che passava nei corridoi, mormorii vaghi, ululati che provenivano dalla strada e un rumore simile a dei colpi di tosse geriatrici, che provenivano dalle sale da lettura... Ciononostante, Artyom non riusciva a udire nulla che rassomigliasse a una chiamata o a una voce. Rimase immobile per cinque minuti, poi per altri cinque; inutilmente trattenne anche il respiro, perché pensò che avrebbe potuto ostacolare i suoi sforzi nel distinguere le voci dei libri vivi dal groviglio di quelli morti. “No”, scosse il capo con aria colpevole, aprendo gli occhi. “Non sento nulla”. Melnik non proferì parola e nemmeno Daniel aprì bocca, ma Artyom comprese la loro espressione di disappunto, che si spiegava da sé. “Forse non si trova qui. Perciò ci dobbiamo recare nei depositi principali, o per lo meno cercheremo di arrivarci”. Dopo un minuto, lo stalker si decise e indicò agli altri di seguirlo. Fece un passo avanti e attraversò l’ampia soglia in cui solo uno delle due ante era rimasta sui cardini. Aveva i bordi bruciacchiati ed era ricoperta di strani simboli. Conduceva su una piccola stanza rotonda, il cui soffitto era alto sei metri e aveva quattro entrate. Dieci seguì Melnik, mentre Daniel, approfittando del fatto che i due uomini non potessero vederlo, fece un passo verso uno degli armadietti, aprì un cassetto e ne estrasse una scheda; la lesse velocemente, il suo viso assunse un’espressione perplessa, quindi infilò il pezzo di carta nella tasca della tuta. Quando comprese che Artyom aveva assistito alla scena, si premette un dito contro le labbra coperte dalla maschera e si mise a correre per raggiungere gli stalker. Anche le pareti della stanza rotonda erano ricoperte da disegni e simboli, mentre in un angolo si trovava un divano in similpelle tagliata, dalla quale uscivano diverse molle rotte. In uno dei quattro passaggi, vicino ad alcuni opuscoli sparpagliati a terra, c’era un libro capovolto. “Non toccate niente!”, li avvertì Melnik. Dieci si sedette sul divano e le molle scricchiolarono. Daniel seguì il suo esempio, mentre Artyom, come se fosse vittima di un incantesimo, fissava insistentemente i libri sparsi a terra. “Sono integri...”, bisbigliò. “Alla biblioteca della nostra stazione dobbiamo mettere il veleno per topi, altrimenti quelle bestiacce si mangiano tutto... Allora, che significa? Non ci sono ratti, qui?”, domandò, ricordandosi di nuovo ciò che gli aveva spiegato Bourbon, ovvero che non si doveva preoccupare se si trovava in un luogo pieno di ratti, al contrario avrebbe dovuto avere paura dove non ce n’era nemmeno l’ombra. “Quali ratti? Ma stai scherzando?”, la faccia di Melnik si fece delusa. “Come fai a trovare ratti qui attorno? Li hanno già mangiati tutti molto tempo fa...” “Chi?”, chiese perplesso Artyom. “In che senso ‘chi’? I bibliotecari, ovviamente”, spiegò Dieci. “Ma allora sono animali o persone?”, volle sapere Artyom. “Di sicuro non sono animali”, rispose lo stalker, scuotendo il capo pensieroso; poi non disse altro. Alla fine di uno dei passaggi si trovava una gigantesca porta di legno, che improvvisamente scricchiolò. Immediatamente, i due stalker si precipitarono in direzioni diverse, riparandosi dietro le due colonne che supportavano l’arco. Daniel scivolò dal divano a terra, poi rotolò di lato; Artyom seguì il suo esempio. “Più sopra c’è la Sala di lettura principale”, sussurrò il Bramino ad Artyom. “Di tanto in tanto si fanno vedere da queste parti...” “Chiudete il becco!”, l’interruppe Melnik con voce crudele. “Non sapete che i bibliotecari non sopportano i rumori? Per loro, sono come un drappo rosso sventolato davanti agli occhi di un toro!”. Così dicendo, imprecò e indicò a Dieci la porta che conduceva alla sala di lettura. L’altro stalker annuì. Rimanendo sempre vicini al muro, i due si mossero lentamente verso le immense ante di quercia della porta. Sia Artyom che Daniel si trovavano a meno di un passo di distanza. Melnik fu il primo a entrare. Con la schiena poggiata a una delle ante, alzò il fucile, così che puntasse verso l’alto, inspirò profondamente ed espirò; quindi aprì con forza il pannello usando la spalla e nello stesso momento puntò la canna del fucile all’oscura imboccatura dell’Atrio principale. Lo seguirono tutti in un istante. L’atrio era una stanza dalle dimensioni impensabili, il cui soffitto si nascondeva a venti metri dal pavimento. Proprio come nell’entrata, dall’alto pendevano le pesanti e spesse viti ricoperte di fiori, mentre sulle pareti sbocciavano le stesse innaturali belle di giorno. Su ciascun lato si trovavano sei enormi finestre, diversi vetri delle quali rimanevano intatti. Tuttavia, la luce che giungeva all’interno era molto fioca, quella della luna penetrava a fatica l’intricato bandolo di tralicci unti e luccicanti. Tempo prima, file di tavoli erano state sistemate a sinistra e a destra, per accogliere i lettori. La maggior parte di quell’arredamento era stata distrutta, alcuni tavoli erano stati bruciati o rotti, ma una decina circa erano ancora intatti. Questi ultimi si trovavano nei pressi un pannello decorato e crepato, al cui centro si trovava una scultura, confusa dalla semioscurità. Dei cartelli in plastica che riportavano la parola “Silenzio!” erano avvitati su tutte le superfici. In effetti, il silenzio di questo luogo era completamente diverso da quello del vestibolo, poiché qui era fitto, quasi si riusciva a toccarlo. Sembrava che riempisse totalmente questo antico atrio bistrattato e si aveva quasi il timore di interromperlo. Se ne stavano in quella stanza, perlustrando lo spazio davanti a loro con le torce, finché Melnik non concluse: “Forse è stato il vento...” Ma in quello stesso istante, Artyom notò un’ombra grigia che passava davanti a loro, tra due tavoli rotti, per poi scomparire in uno spazio oscuro tra gli scaffali. Anche Melnik la scorse. Indossando il dispositivo per la visione notturna, sollevò il fucile, fece un passo cauto sul pavimento ricoperto di muschio e cominciò ad avvicinarsi al misterioso punto d’accesso. Dieci lo seguì e, sebbene ad Artyom e Daniel fosse stato ordinato di rimanere dove si trovavano, seguirono gli stalker: la soglia della stanza aveva un aspetto troppo sinistro e i due non volevano rimanere da soli. Allo stesso tempo, Artyom non riuscì a resistere e scrutò estasiato l’androne, che conservava le vestigia della sua precedente grandiosità. Ciò non salvò solo la sua vita, ma anche quella degli altri. Delle gallerie circondavano l’intero perimetro della sala a diversi metri d’altezza: erano dei passaggi alquanto stretti, chiusi da parapetti in legno. Da quelle gallerie si riusciva a guardare fuori dalle finestre; inoltre, vi erano delle porte che conducevano agli uffici, sia sulle pareti a fianco degli uomini, sia su quelle a entrambi i lati dell’antico pannello. Si aveva accesso alla galleria tramite una coppia di scale che si trovavano su entrambi i lati della scultura oppure attraverso un’altra serie identica di scale che salivano dall’entrata. Proprio da quelle, vide scendere sagome grigie con grosse gobbe, che procedevano caute e silenziose. Le creature che non si confondevano del tutto con l’oscurità ed erano oltre una decina. Sarebbero stati più o meno alti come Artyom se non fossero stati ricurvi, tanto che le loro lunghe zampe anteriori, che somigliavano vagamente a delle braccia, quasi toccavano il pavimento. Le creature si spostavano sulle zampe posteriori, con passi ondeggianti, ma comunque agili e silenziosi. Da lontano parevano più che altro dei gorilla, che Artyom da bambino aveva visto su un libro di biologia con il quale il patrigno gli aveva dato qualche lezione. Artyom ebbe poco più di un secondo per rilevare tutti questi dettagli perché, non appena la sua torcia rischiarò le sagome ingobbite che proiettavano ombre nere e ben marcate sul muro dietro di loro, un rumore diabolico e molto acuto risuonò tutt’intorno. A quel punto le creature si precipitarono giù dalle scale. “Bibliotecari!”, urlò Daniel con tutta la sua forza. “Giù!”, ordinò Melnik. Artyom e Daniel si gettarono a terra. Decisero di non sparare, ricordandosi di ciò che gli aveva spiegato lo stalker e cioè che gli spari o qualsiasi altro rumore forte avrebbe attratto e irritato i bibliotecari. La loro esitazione venne subito dissipata da Melnik, che si buttò al suolo di fianco a loro e fu il primo ad aprire il fuoco. Diverse creature caddero emettendo un grugnito, altre si lanciarono a capofitto nell’oscurità, ma solo per avvicinarsi ulteriormente senza essere notati. Dopo diversi istanti, all’improvviso uno dei mostri apparve a due metri di distanza e cercò di attaccare Dieci alla gola. Quest’ultimo cadde a terra, ma riuscì a liberarsi dalla creatura con uno scatto veloce. “Correte! Tornate nella sala rotonda e cercate di raggiungere gli Archivi! Il Bramino dovrebbe essere in grado di arrivarci, glielo hanno insegnato! Noi rimarremo qui, vi copriremo e cercheremo di scacciarli!”, disse Melnik ad Artyom. Senza dire altro si mise a strisciare per raggiungere il collega. Artyom si spostò in direzione di Daniel e insieme si diressero a tutta velocità verso l’uscita, sempre rasentando il suolo. Uno dei bibliotecari saltò fuori dall’oscurità per cercare di raggiungerli, ma venne abbattuto da una pioggia di proiettili. Gli stalker tenevano d’occhio i due ragazzi. Uscirono dalla Sala di lettura principale e Daniel si lanciò a tutta velocità verso il vestibolo da cui erano arrivati. Per un istante, Artyom immaginò che il Bramino fosse rimasto talmente turbato da quelle creature che stesse cercando di fuggire via. Ma Daniel non correva in direzione delle scale che conducevano all’uscita, al contrario le superò e passò davanti anche agli armadietti contenenti le schede catalogate, fino alla parte opposta dell’entrata. Laggiù, la stanza si rimpiccioliva. Si trovarono davanti tre coppie di porte, sia di fronte che su entrambi i lati: quelle a destra conducevano verso una scala completamente buia. Qui il Bramino si fermò per un istante a riprendere fiato. Ad Artyom ci volle qualche secondo per raggiungerlo, non si sarebbe mai aspettato una tale agilità da quel ragazzo. Immobili, si misero all’ascolto. Udirono dei colpi di pistola e delle grida provenienti dall’Atrio principale, il che significava che la battaglia era ancora in corso. Non era chiaro chi stesse avendo la meglio, tuttavia non potevano perdere tempo e attendere di vedere chi sarebbe riuscito a trionfare. “Perché stiamo tornando indietro? Perché abbiamo cominciato dall’altra parte?”, domandò Artyom ancora affannato. “Non ho idea di dove ci stessero conducendo”, Daniel scrollò le spalle. “Forse avevano intenzione di arrivarci seguendo una via alternativa. Gli anziani ce ne insegnano una sola e conduce direttamente agli Archivi da questo lato del vestibolo. Ora dobbiamo salire le scale per un piano, proseguire per un corridoio e poi per un’altra rampa di scale, quindi dobbiamo attraversare una stanza in cui si trova un secondo schedario, infine saremo negli Archivi”. Puntò il suo fucile nell’oscurità e fece un passo sulla scala. Artyom lo seguì, illuminando la strada con la sua torcia. In mezzo alle scale si trovava il pozzo dell’ascensore che scendeva di tre piani e saliva di altri tre. Sembrava che un tempo fosse ricoperto da pannelli in vetro, dato che in alcuni punti della struttura in ferro fuoriuscivano delle schegge appuntite, ormai ricoperte da decenni di polvere. Attorno al pozzo quadrato c’era una serie di scalini di legno marcio cosparsi da pezzi di vetro, bossoli e cumuli di escrementi secchi. Non c’era alcuna traccia della ringhiera, perciò Artyom dovette rimanere il più vicino possibile alla parete e fare attenzione a dove metteva i piedi perché altrimenti sarebbe scivolato e caduto in quel baratro. Salirono di un piano e si ritrovarono in una piccola sala quadrata, all’interno della quale c’erano tre uscite. A questo punto Artyom comprese che, senza la sua guida, non sarebbe mai riuscito a orientarsi in questo labirinto. La porta di sinistra era aperta su un enorme corridoio oscuro, la cui fine non si scorgeva nemmeno alla luce della torcia. La porta di destra era chiusa ed era stata sbarrata con delle assi, chissà per quale ragione. Il muro vicino riportava la frase, scritta con la fuliggine: “Non aprire! Pericolo mortale!” Daniel scelse il passaggio davanti a loro, che poi curvava e si apriva su un altro corridoio, più stretto e con una serie di nuove porte. Lungo questa galleria il Bramino non camminava più alla velocità di prima e si fermava spesso per mettersi in ascolto. Qui il pavimento era in parquet e alle pareti erano appesi cartelli minacciosi che intimavano al silenzio, per i quali era stata usata la vernice gialla, la stessa dei muri della Biblioteca. Dietro le porte rimaste aperte si scorgevano sale e uffici distrutti. Di tanto in tanto si udivano dei fruscii provenienti da dietro le porte chiuse e in un’occasione ad Artyom parve di sentire anche dei passi. A giudicare dalla faccia dell’altro ragazzo, questo non era per nulla un buon segno ed entrambi si sbrigarono per cercare di andarsene da quel luogo il più velocemente possibile. A quel punto, proprio come si aspettava Daniel, alla loro destra apparve una porta che conduceva a un’altra scala. Qui la visibilità era migliore rispetto all’oscurità degli atri, perché c’erano finestre su tutte le rampe di scale. Dal quinto piano si aveva una visuale completa sul cortile, su alcune costruzioni annesse e sugli scheletri bruciati di diversi pezzi d’equipaggiamento. Tuttavia, Artyom non riuscì a osservare a lungo il cortile, poiché due sagome grigie ingobbite emersero da dietro l’angolo dell’edificio in cui si trovavano i due ragazzi. Stavano attraversando lentamente lo spiazzo, come se stessero cercando qualcosa. All’improvviso, una delle due creature si fermò, alzò la testa e ad Artyom parve proprio che stesse osservando in direzione della finestra a cui si trovava lui. Indietreggiando, Artyom si abbassò. Non dovette fornire alcuna delucidazione al Bramino, che comprese subito. “Bibliotecari?”, sussurrò allarmato, anch’egli inginocchiandosi per non essere visibile dalla strada. Artyom annuì in silenzio. A quel punto Daniel passò la mano sul vetro della sua maschera antigas, come se il gesto lo aiutasse ad asciugarsi il sudore che gli imperlava la fronte a causa della preoccupazione. Radunò i pensieri e si diresse verso le scale, trascinando Artyom dietro sé. Un altro piano e un’altra serie di corridoi... Infine, il Bramino si fermò incerto davanti ad alcune porte. “Non ricordo questo posto”, era perplesso. “Dovrebbe esserci l’entrata al secondo schedario. Nessuno ci ha segnalato che ci sarebbero state diverse porte”. Rifletté per un momento e, quasi scoraggiato, cercò di fare scattare una maniglia. Era chiusa a chiave. Anche le altre porte erano chiuse. Come se stentasse a crederci, Daniel scosse il capo e provò nuovamente a spingere le maniglie. Poi provò anche Artyom, ma senza alcun risultato. “Sono chiuse a chiave”, affermò. Nella sua voce si distingueva una vena di disperazione. All’improvviso, Daniel fece spallucce e Artyom lo osservò, spaventato, poi si allontanò di un passo dal Bramino. Ma Daniel si mise solo a ridere. “Perché non bussi?”, suggerì al ragazzo e aggiunse, con una risata che ormai non riusciva più a controllare: “Scusami, deve essere un attacco d’isteria”. Artyom percepì che la strana risata stava contagiando anche lui. La tensione accumulata nell’ultima ora stava cominciando a farsi sentire e, sebbene cercassero di controllarsi, i loro sciocchi risolini scoppiarono in una fragorosa risata. Per un minuto stettero entrambi con la schiena appoggiata al muro e risero di gusto. “Busso!”, ripeté Artyom tenendosi la pancia e rammaricandosi di non poter togliere la maschera antigas per asciugarsi le lacrime. Si avvicinò alla porta più vicina e bussò per tre volte usando le nocche. Dopo un secondo, si udirono tre rumori identici, provenienti dall’altra parte della porta. La gola di Artyom si prosciugò all’istante e il suo cuore si mise a battere frenetico nel petto. Dietro la porta chiusa c’era qualcuno, che li aveva sentiti esitare e poi ridere. Che diamine era?! Daniel gli lanciò un’occhiata piena di paura e si allontanò dalla porta. Dall’altra parte, qualcuno bussò di nuovo, con più insistenza. A quel punto Artyom fece ciò che Sukhoi gli aveva insegnato: con un calcio fece saltare la serratura della porta di fianco. Non avrebbe mai pensato che funzionasse, ma la porta si aprì con fragore. Il meccanismo d’acciaio della serratura si era staccato dal legno marcio, insieme ad alcune schegge. La stanza che si trovarono davanti era diversa da tutte quelle che avevano visto percorrendo i corridoi della Biblioteca: questa era molto più umida e dava una sensazione opprimente. Inoltre, alla luce delle loro torce, notarono che il piccolo atrio era infestato da strane piante. Tralci spessi, pesanti foglie grasse e un insieme di odori talmente intensi che penetravano persino nella maschera antigas; il pavimento era ricoperto da radici intricate, insieme a tronchi, spine e fiori... Alcune delle radici sparivano in vasi, sia intatti che ridotti a pezzi. Le viti ormai familiari si intrecciavano e sostenevano file di armadietti di legno, il cui aspetto era identico a quelli che avevano trovato nel vestibolo, sebbene questi fossero quasi interamente marciti a causa dell’alto tasso di umidità, il che fu chiaro non appena Daniel cercò di aprire uno dei cassetti. “È il secondo schedario”, esclamò con un sospiro di sollievo. “Non ci manca molto, ormai”. Qualcuno bussò ancora sul legno della porta dietro di loro, poi fece girare la maniglia, come se stesse facendo una prova. Spostando le viti con i fucili e cercando di non inciampare sulle radici che impestavano il pavimento, si affrettarono a superare il sinistro giardino segreto, nascosto nelle profondità della Biblioteca. Alla fine dell’atrio c’era un’altra porta e questa non era chiusa a chiave. Superarono un ultimo corridoio e si fermarono. Erano nei depositi principali. Lo capirono immediatamente. Nell’aria aleggiava la polvere dei libri. La Biblioteca respirava calma, si udivano a malapena i mormorii dei miliardi di pagine. Artyom si guardò attorno e gli sembrò di poter percepire l’odore dei libri antichi, uno dei suoi preferiti, sin da quando era bambino. Guardò Daniel con aria interrogativa. “Ci siamo”, confermò Daniel, poi aggiunse, con una flebile speranza nella voce: “Beh?” “Beh... fa paura”, ammise Artyom, non capendo subito ciò che il Bramino sottintendeva. “Riesci a sentire il Libro?”, aggiunse. “Da qui la sua voce dovrebbe giungerti più chiara”. Artyom chiuse gli occhi per concentrarsi. Sentiva la testa completamente svuotata; sembrava rimbombasse, come l’interno di una galleria abbandonata. Rimase così per un po’, poi ricominciò a sentire i più indistinti rumori della Biblioteca. Tuttavia, non riusciva a udire nulla che potesse somigliare a una voce o a una chiamata. Peggio ancora, non sentiva proprio niente e anche se la voce di cui gli avevano parlato Daniel e gli altri Bramini sarebbe giunta a lui come una sensazione completamente diversa, ciò non avrebbe cambiato la situazione. “No, non sento niente”, e allargò le braccia. “Non importa”, sospirò Daniel dopo un momento di silenzio. “Passiamo a un altro piano. Ce ne sono diciannove. Continueremo finché non lo troviamo. Faremmo meglio a non tornare a mani vuote”. Proseguendo per le scale, passarono diversi piani finché non decisero di fermarsi di nuovo e di sfidare la fortuna. Su questo piano, tutto aveva l’aspetto del luogo in cui si erano trovati all’inizio: una stanza di medie dimensioni con i vetri alle finestre, diverse scrivanie e l’ormai familiare vegetazione sul soffitto e negli angoli; inoltre, c’erano due corridoi stretti che conducevano in direzioni diverse, sulle cui pareti si trovavano file interminabili di scaffali. Il soffitto della sala e del passaggio era basso, arrivava a poco più di due metri e dopo l’incredibile vastità dell’entrata e della Sala di lettura principale, sembrava impossibile riuscire a percorrere lo spazio tra il pavimento e il soffitto, ma soprattutto lì dentro pareva estremamente faticoso riuscire a respirare. Gli scaffali erano pieni di migliaia di libri, molti dei quali sembravano intatti e meravigliosamente conservati; ciò dimostrava che la Biblioteca era stata costruita in modo tale che, persino quando gli uomini l’avevano abbandonata, al suo interno si era preservato un microclima speciale. Vedendo una simile ricchezza, Artyom si scordò per un momento perché si trovava in quel luogo e si tuffò in una delle file, osservò i dorsi dei libri e li toccò rispettoso con la mano. Inizialmente Daniel non intervenne, poiché credeva che il ragazzo avesse finalmente sentito la voce per cui erano stati mandati fin lì; poi capì cosa stava succedendo. Afferrò bruscamente la spalla di Artyom e lo tirò verso di sé. Davanti a loro avevano tre, quattro, sei corridoi; cento, duecento scaffali; migliaia e migliaia di libri. Quando, nell’oscurità più totale, venivano illuminati dal cerchio giallo di luce, facevano intuire l’immensità dei depositi principali. Poi c’era il piano successivo e quello dopo ancora... era tutto inutile. Artyom non percepì nulla che rassomigliasse a una voce o una chiamata. Niente di insolito. Richiamò alla mente i Bramini, durante la riunione del Consiglio della Polis: lo consideravano il prescelto, dotato di un dono speciale e condotto dal fato. Malgrado ciò, i militari avevano subito addotto un’altra spiegazione alle sue visioni: allucinazioni. Aveva cominciato a sentire qualcosa agli ultimi piani, ma non si trattava esattamente di ciò che si aspettava o che desiderava percepire, anzi era la vaga sensazione che qualcuno li stesse seguendo, che gli ricordava la tanto famigerata “tunnel-fobia”. Tutti gli altri piani in cui erano stati gli erano parsi completamente abbandonati, non vi erano segni né di bibliotecari né di altre creature. Ciononostante, aveva il desiderio di continuare a voltarsi, perché sentiva che qualcuno li stava osservando con attenzione dagli scaffali. Daniel lo toccò sulla spalla e diresse la torcia verso il suo scarpone: una stringa, che il Bramino non aveva allacciato a dovere, giaceva lunga sul pavimento. “Mentre la riallaccio, vai avanti e dai un’occhiata. Potremmo avere ancora qualche speranza che tu senta qualcosa”, sussurrò e si accovacciò. Artyom annuì e procedette lento, passo dopo passo: ad ogni secondo si voltava per gettare uno sguardo a Daniel, che non riusciva proprio ad allacciarsi lo scarpone, perché era molto difficile legare una stringa scivolosa con indosso un paio di guanti pesanti. Continuando a camminare in avanti, Artyom puntava la torcia lungo la fila smisurata di scaffali alla sua destra, poi all’improvviso spostava il raggio luminoso a sinistra, cercando di individuare nell’oscurità le sagome grigie e ricurve dei bibliotecari tra i diversi libri polverosi e intaccati dal tempo. Si era allontanato una trentina di metri dal Bramino, quando Artyom udì distintamente un fruscio, due file davanti a lui: il suo fucile era pronto, quindi puntò la torcia nella zona in cui aveva preso la mira con l’arma e con un solo balzo si ritrovò nel corridoio in cui riteneva si fosse nascosto qualcuno. Vide due file di scaffali, piene di volumi fino al soffitto, che arrivavano fin sul fondo alla sala. Non c’era nient’altro. Puntò il fascio di luce a sinistra, perché il nemico poteva essere nascosto nella direzione opposta, ma niente. Artyom trattenne il respiro cercando di distinguere anche il più flebile rumore, ma non c’era nulla. Solo l’illusorio mormorio delle pagine. Si diresse nuovamente verso il passaggio da cui era venuto e indirizzò la luce nel luogo in cui Daniel stava litigando con la sua stringa. Non c’era niente. Niente? Senza guardare dove stava andando, Artyom tornò indietro in tutta fretta. Il fascio di luce della sua torcia saltava frenetico da una parte all’altra, illuminando file e file di scaffali identici, nascosti nell’oscurità. Dove si era fermato? A trenta metri... Trenta metri circa, dovrebbe trovarsi qui... non c’era nessuno. Dove poteva essere andato senza aver prima detto qualcosa ad Artyom? Se era stato attaccato, perché non aveva resistito? Cos’era accaduto? Cosa poteva essergli successo? No, era già andato fin troppo lontano. Daniel sarebbe dovuto essere in un punto più vicino... Ma non era da nessuna parte! Artyom sentì che stava perdendo il controllo delle sue azioni e che si stava facendo prendere dal panico. Si fermò nello stesso luogo in cui aveva lasciato Daniel quando il Bramino si stava allacciando lo scarpone e si abbandonò con la schiena contro uno scaffale, dalle profondità del quale udì una fievole voce disumana, che si trasformò in un lamento inquietante: “Artyom...” Soffocato dalla paura, Artyom quasi non riusciva a vedere più nulla attraverso il vetro appannato della maschera antigas. Si voltò di scatto verso la voce e, cercando di tenere di mira il corridoio con il fucile che gli tremava tra le mani, procedette in avanti. “Artyom...” La voce era ormai dietro l’angolo. All’improvviso, un filo di luce filtrò attraverso uno scaffale, passando tra alcuni libri, a livello del pavimento. Il raggio si muoveva avanti e indietro, come se qualcuno stesse agitando la torcia a destra e a sinistra. Artyom udì lo stridio del metallo. “Artyom...”. Era a malapena percepibile, ma questa volta il sussurro era familiare e non vi fu alcun dubbio che si trattasse della voce di Daniel. Allegro, Artyom fece un lungo passo davanti a sé, sperando di vedere l’amico, quando lo stesso lamento gutturale di prima irruppe nell’aria a due passi dal luogo in cui si trovava. Il fascio di luce continuava a vagabondare sul pavimento, avanti e indietro. “Artyom...”, ripeté la strana voce. Artyom fece un altro passo, voltò il capo a destra e gli venne la pelle d’oca. La fila di scaffali terminava proprio lì, formando una nicchia, nella quale era seduto Daniel, in una pozza di sangue. Il suo elmetto e la maschera antigas erano stati strappati via e giacevano a terra a qualche metro di distanza. Sebbene il suo viso fosse pallido come quello di un cadavere, gli occhi erano coscienti e le labbra si muovevano, nel tentativo di articolare qualche parola sensata. Dietro di lui, semi nascosta nell’oscurità, si nascondeva una sagoma grigia, ricurva su se stessa. Ricoperta da una pelliccia ispida e argentea, una lunga mano scheletrica, non una zampa, ma una mano vera e propria, armata di artigli ricurvi, faceva ruotare distrattamente la torcia caduta a terra, che ora si trovava a mezzo metro dal corpo di Daniel. L’altra mano, invece, scavava nel ventre squartato del Bramino. “Sei qui”, bisbigliò Daniel. “Sei qui...”, gracchiò la voce alle spalle di Daniel, con la stessa identica intonazione. “C’è un bibliotecario... dietro di me. Sono morto comunque. Sparagli. Uccidilo”, intimò Daniel con voce sempre più debole. “Sparagli. Uccidilo”, ripeté l’ombra. La torcia rotolò ancora sul pavimento, verso sinistra, per poi tornare al punto di partenza e ripetere nuovamente il movimento. Artyom sapeva che stava impazzendo. Nella sua mente vorticavano le parole di Melnik, sul fatto che il rumore dei colpi di pistola potesse attrarre quei mostri raccapriccianti. “Vattene”, ordinò Artyom al bibliotecario, non aspettandosi che la creatura comprendesse. “Vattene”, fu la risposta, quasi affettuosa. Tuttavia, gli artigli della mano continuavano a cercare qualcosa nella pancia di Daniel: il Bramino gemette piano, mentre una goccia di sangue tracciava una spessa linea e gli scendeva dalla bocca al mento. “Spara!”, implorò Daniel a voce più alta dopo aver radunato un po’ le forze. “Spara!”, chiese il bibliotecario da dietro il Bramino. Avrebbe dovuto sparare al suo nuovo amico e, così facendo, attrarre altre creature, oppure avrebbe dovuto abbandonare Daniel, lasciarlo morire in questo luogo, mentre era ancora in tempo? Ormai era molto improbabile che il ragazzo potesse essere salvato, aveva l’addome smembrato e l’intestino eviscerato: aveva meno di un’ora di vita. Un orecchio grigio e puntuto apparve da dietro la testa inclinata di Daniel, seguito da un enorme occhio verde che brillò alla luce della torcia. Il bibliotecario sbirciò piano da dietro il giovane morente e, timido, cercò lo sguardo di Artyom. Non voltarti. Guardalo dritto negli occhi... Aveva le pupille verticali, come quelle di un animale. Malgrado ciò, era strano intravvedere delle tracce di intelligenza in quegli occhi sinistri! Ora, più da vicino, il bibliotecario non assomigliava nemmeno lontanamente a un gorilla, né a una scimmia. Il suo viso da predatore era ricoperto di pelliccia; in bocca aveva una moltitudine di zanne lunghissime, che andavano quasi da un orecchio all’altro, mentre gli occhi erano talmente grossi che rendevano il mostro diverso da qualsiasi altro animale che Artyom avesse mai visto, sia dal vivo che in fotografia. Gli sembrò che questa scena durasse delle ore: era sprofondato nello sguardo della creatura e non riusciva più a staccarsi da quelle pupille. Solo quando Daniel emise un lamento profondo e prolungato, Artyom riuscì a liberarsene. Puntò il piccolo cerchio rosso del suo mirino laser direttamente sulla pelliccia arruffata della fronte bassa del bibliotecario e con il pollice fece scattare la levetta del fuoco semi automatico. Udendo il breve scatto metallico, il mostro rabbioso farfugliò qualcosa e si nascose di nuovo dietro la schiena di Daniel. “Vattene...”, disse all’improvviso da dietro Daniel, mimando perfettamente l’intonazione di Artyom. Il ragazzo rimase di stucco: questa volta il bibliotecario non aveva semplicemente ripetuto le sue parole, se le era ricordate, come se ne avesse compreso il significato. Come poteva essere? “Artyom... Mentre riesco ancora a parlare...”, cominciò Daniel dopo aver recuperato le forze e avere concentrato lo sguardo, che si annebbiava sempre più, di minuto in minuto. “Nella mia tasca interna... una busta... mi è stato riferito di consegnartela nel caso avessi trovato il Libro...” “Ma io non ho trovato nulla”, Artyom scosse la testa. “Non ho trovato nulla”, gli fece eco la voce inquietante alle spalle di Daniel. “Non importa... So perché hai accettato l’incarico. Non è per te... Forse ti aiuterà. A me non interessa se ho obbedito agli ordini oppure no... Ricorda solo che non puoi tornare alla Polis... Se scoprono che sei tornato a mani vuote e se lo scoprono i militari... Ritorna nella Metro dalle altre stazioni. Ora spara, ti prego, perché fa molto male... Non voglio...” “Non voglio... male...”, mischiò le parole il bibliotecario, poi emise un sibilo e il suo braccio fece un movimento improvviso all’interno della pancia di Daniel; quest’ultimo sobbalzò in maniera convulsa e urlò con tutta la forza che aveva in corpo. Artyom non riusciva più a sopportare la scena. Gettando al vento qualsiasi tipo di cautela, riposizionò la levetta dell’arma sui colpi automatici e, increspando le labbra, premette il grilletto, riempiendo di proiettili il corpo del suo amico e quello della bestia che si nascondeva dietro di lui. Il rumore fu inaspettatamente fragoroso e fece a pezzi il silenzio della Biblioteca. Ne seguirono insistenti rumori acuti, che si interruppero immediatamente, tutti nello stesso momento. I libri polverosi assorbirono l’eco come delle spugne. Quando Artyom riaprì gli occhi, era tutto finito. Si avvicinò al bibliotecario, che aveva poggiato la testa piena di piombo sulla spalla della sua vittima e, persino da morto, si nascondeva timidamente dietro di lui. Artyom illuminò la scena inquietante e il sangue gli si raggelò nelle vene, mentre le mani gli sudavano dalla tensione. Quindi spinse il corpo del bibliotecario con la punta dello stivale e questo cadde pesantemente indietro. Era morto, non c’erano dubbi. Cercando di non guardare la maschera di sangue che era stato il viso di Daniel, Artyom aprì la cerniera della tuta protettiva dell’amico. Il tessuto si era velocemente inzuppato di sangue denso e scuro e un vapore trasparente si alzava nell’aria fresca degli Archivi principali. Artyom cominciò a provare un forte senso di nausea. La tasca interna... Le dita, all’interno dei guanti protettivi, cercavano goffamente di slacciare il bottone. Gli venne in mente che quegli stessi guanti avevano fatto in modo che Daniel eseguisse i movimenti con quel minuto di ritardo che gli era costato la vita. Un fruscio si udiva distintamente da lontano, seguito dai passi dei piedi nudi lungo il corridoio. Artyom si girò nervosamente e scrutò i passaggi con la torcia. Si rassicurò per un momento: era ancora solo. Continuò a lottare con il bottone, il quale infine cedette e il ragazzo, con le dita rigide, riuscì a estrarre una sottile busta grigia dal fondo della tasca. La busta si trovava all’interno di una busta di plastica, perforata da un colpo di pistola. Inoltre, nella stessa tasca, Artyom trovò una scheda rettangolare macchiata di sangue, che di sicuro era quella che Daniel aveva estratto dal cassetto del catalogo quando si trovavano nel vestibolo. La scheda riportava la seguente scritta: “Shnurkov, N. E., L’irrigazione e la prospettiva agricola nella SSR del Tagikistan. Dushanbe, 1965”. Nelle vicinanze si udivano passi e brontolii indistinti. Non rimaneva altro tempo. Artyom raccolse l’arma di Daniel e la sua torcia, che era caduta dagli artigli del bibliotecario, poi corse il più velocemente possibile dalla stessa strada che aveva percorso in precedenza e, senza guardare dove fosse diretto, superò file interminabili di scaffali. Non sapeva per certo se qualcuno lo stesse seguendo, poiché il rumore dei suoi scarponi, insieme al sangue che gli pulsava nelle orecchie, gli impedivano di sentire qualsiasi tipo di rumore dietro di lui. Non appena saltò sulla scala e cominciò a scendere i gradini, comprese che non sapeva nemmeno su quale piano si trovava l’entrata da cui avevano avuto accesso agli Archivi. Naturalmente avrebbe potuto scendere fino al primo piano, rompere il vetro delle finestre e uscire. Si fermò per un secondo e guardò fuori: al centro del cortile, con le facce rivolte verso l’alto, stavano immobili diverse creature grigie, osservavano le finestre e pareva che stessero fissando proprio lui. Pietrificato, Artyom si avvicinò a una parete laterale e riprese a scendere, cercando di fare meno rumore possibile. Ora riusciva a sentire i passi dei piedi nudi che si facevano sempre più udibili. Poi, quando ormai aveva perso completamente il controllo di sé, riprese a scendere le scale a perdifiato. Uscì al piano successivo per guardarsi attorno, in cerca di una porta conosciuta; quando però non la trovò proseguì fermandosi e nascondendosi negli angoli più bui quando gli pareva che i passi si facessero troppo vicini. Cercava disperatamente tra corridoi senza uscita e cunicoli, ritornava sulle scale, scendeva di un piano o saliva di altri due... forse gli era sfuggito qualcosa? Comprendeva che i rumori infernali che emetteva mentre cercava disperatamente un’uscita da quel labirinto avrebbero attirato gli abitanti più mostruosi della Biblioteca, perciò non riusciva a calmarsi. Tuttavia, continuava a cercare una via d’uscita, senza mai trovarla. Finché, mentre stava risalendo nuovamente le scale, scorse la famigerata sagoma ricurva, sullo sfondo di una finestra rotta. Artyom indietreggiò, si tuffò nel primo corridoio che vide, poggiò la schiena alla parete e puntò il fucile all’apertura da cui si aspettava che potesse arrivare il bibliotecario. Trattenne il respiro... Silenzio. Quel mostro aveva deciso di non seguire Artyom da solo, oppure stava aspettando che il ragazzo commettesse un errore e uscisse dal suo nascondiglio... Malgrado ciò, non era obbligato a tornare indietro dalla stessa parte, perché il passaggio proseguiva. Ci pensò un secondo, poi si allontanò dall’imboccatura del corridoio, tenendo il mirino puntato su di essa. Questo girava di lato, ma nello stesso punto in cui cominciava la curva, nel muro c’era un’apertura nera. La zona era cosparsa di pezzi di mattone e di calce. Obbedendo a un impulso, Artyom entrò nel buco, che conduceva in una stanza piena di mobili rotti. Sul pavimento erano sparsi pezzi di pellicole fotografiche e cinematografiche. Davanti a sé riusciva a scorgere una porta semi aperta, oltre la quale intravvedeva una fetta di luna pallida che irradiava il pavimento. Camminò cauto sul parquet pericolosamente cigolante, quindi raggiunse la porta e sbirciò oltre. Riconobbe la stanza, anche se ora si trovava dalla parte opposta. L’imponente statua della persona che leggeva, l’altezza incredibile del soffitto, le finestre giganti, la grottesca porta di legno che conduceva verso l’uscita, le file disordinate di tavoli da lettura a sinistra e a destra: si trattava, senza alcun dubbio, della Sala di lettura principale. Si trovava su una delle balaustre di legno della stretta galleria che circondava l’atrio a quattro metri d’altezza. Proprio da questa galleria erano stati attaccati dai bibliotecari. Non aveva idea di come fosse riuscito ad arrivare fin qui, dall’altra parte della stanza, dagli Archivi principali, senza ripercorrere la strada che avevano seguito lui e Daniel. Ma non c’era tempo per riflettere. I bibliotecari potevano essergli alle calcagna. Artyom corse giù da una delle due scale simmetriche che conducevano al piedistallo del monumento e saltò, fino a raggiungere le porte. Non lontano dall’arco in legno intarsiato dell’uscita si trovavano diversi corpi deformati di bibliotecari, con le braccia e le gambe aperte: stava passando sul luogo in cui era avvenuta la battaglia e per poco non cadde quando mise il piede in una pozza di sangue denso. La pesante porta era leggermente aperta e una luce bianca lo accecò all’istante. Ricordando le istruzioni di Melnik, Artyom afferrò la torcia con la mano destra e descrisse tre cerchi luminosi, per dare il segnale che si stava avvicinando con intenzioni pacifiche. Il raggio luminoso si spostò immediatamente, Artyom si mise l’arma dietro la schiena e procedette lento verso la stanza rotonda con le colonne e il divano, anche se ancora non sapeva chi vi avrebbe incontrato. Su un treppiedi era stata sistemata una mitraglietta, mentre Melnik era piegato sul suo collega. Dieci era sdraiato sul divano con gli occhi chiusi e di tanto in tanto emetteva brevi gemiti. La gamba destra era piegata in maniera innaturale e, quando Artyom lo vide, capì subito che era rotta all’altezza del ginocchio, che non era piegato indietro ma in avanti. Non riusciva a immaginare come gli fosse potuto succedere e soprattutto quanta forza possedesse la creatura che era stata in grado di mutilare a quel modo il robusto stalker. “Dov’è il Bramino?”. Melnik rivolse la domanda ad Artyom, distogliendo l’attenzione da Dieci per un secondo. “I bibliotecari.... negli Archivi. Hanno attaccato”, Artyom cercò di spiegarsi. Per qualche ragione non voleva rivelargli che, per pietà, l’amico era morto per mano sua. “Hai trovato il Libro?”, domandò bruscamente lo stalker. “No”, Artyom scosse la testa. “Non ho visto né sentito nulla”. “Dammi una mano ad alzarlo... No, meglio che tu prenda il suo zaino e anche il mio. Vedi la sua gamba? Per poco non gliela staccavano. Ora posso solo trasportarlo sulle spalle”, Melnik indicò Dieci con un cenno del capo. Artyom raccolse tutto l’equipaggiamento, i tre zaini, le due mitragliatrici e la mitraglietta, circa trenta chili di peso in tutto, che non erano per nulla facili da sollevare. A Melnik era andata peggio: con difficoltà si caricò sulle spalle il corpo fiacco del collega e ci mise diversi minuti a percorrere i pochi passi che conducevano alla scala e quindi all’uscita. Nel tragitto fino alle porte non incontrarono più bibliotecari, ma nel momento in cui Artyom spalancò il pesante portone di legno per permettere ai due stalker di passare, udirono un ululato lamentoso, pieno di odio e di angoscia, provenire dai recessi più oscuri dell’edificio. Artyom sentì i brividi percorrergli la spina dorsale e si affrettò a richiuderle. L’importante era raggiungere la Metro il prima possibile. “Abbassa lo sguardo!”, ordinò Melnik quando furono in strada. “La stella sarà di fronte a te. Non pensare nemmeno di dare un’occhiata sopra i tetti...” Muovendo a malapena le gambe irrigidite, Artyom fissò obbediente il terreno, sognando di superare con un passo quegli interminabili duecento metri che separavano la Biblioteca dalla Borovitskaya. Tuttavia, lo stalker impedì ad Artyom di scendere nella Metropolitana. “Ora è impossibile andare dalla polizia. Non hai recuperato il Libro e la loro guida è stata uccisa”, spiegò Melnik respirando affannoso, mettendo il collega a terra, con gentilezza. “Ai Bramini questa storia non piacerebbe per nulla. Inoltre, ciò significherebbe che tu non sei il loro prescelto. Ma ti hanno rivelato i loro segreti! Se ti recassi dalla polizia, spariresti senza lasciare traccia. Laggiù hanno degli specialisti, non gli importa se agiscono in maniera intelligente oppure no. Nemmeno io sarei in grado di proteggerti. Ora devi andartene. È meglio se ti rechi alla Smolenskaya. Vai sempre dritto, troverai diverse case, non c’è bisogno di addentrarsi nei vicoli più bui. Potresti riuscire ad arrivarci, se ti sbrighi, prima che sorga il sole.” “Sorga il sole?”, domandò Artyom sorpreso. La notizia che avrebbe dovuto raggiungere da solo un’altra stazione della Metro passando dalla superficie, che giudicando dalla mappa si trovava a circa due chilometri di distanza, lo colpì come un pugno nello stomaco. “Il sole. Gli uomini sono animali notturni ed è meglio che non si facciano vedere in superficie di giorno. Ci sono delle creature che escono dalle rovine per scaldarsi al sole e, se li interrompi, potresti pentirtene per tutta la vita. Per non parlare della luce: diventeresti cieco in due secondi netti e nemmeno gli occhiali scuri ti salverebbero”. “Ma perché devo andare da solo?”, chiese Artyom, che ancora non credeva alle sue orecchie. “Non avere mai paura. Dovrai camminare sempre dritto. Uscirai sulla Kalininskiy e proseguirai su quella via, non devi girare da nessun’altra parte. Cerca di non farti vedere e rimani il più vicino possibile alle case, loro sono dappertutto. Prosegui finché giungi a un incrocio con un secondo grande viale, cioè l’Anello dei Giardini. A quel punto dovrai girare a sinistra e continuare sempre dritto fino a un edificio in pietra bianca, che una volta era la Casa della moda... La troverai subito, proprio di fronte. Dall’altra parte del viale dei Giardini si trova un fabbricato altissimo, distrutto per metà, che era il centro commerciale. Dietro la Casa della moda c’è una sorta di arco giallo sul quale noterai la scritta ‘Stazione della Metropolitana Smolenskaya’. Passa sotto l’arco e giungerai in una piccola piazzetta, una sorta di cortile interno: lì c’è la stazione. Se va tutto bene cerca di scendere. L’entrata è chiusa, vi sono delle guardie, la tengono per i loro stalker. Dovrai bussare al cancello in questo modo: tre colpi veloci, due lenti, poi altri tre veloci. Dovrebbero aprirti. Dì loro che ti ha mandato Melnik e aspettami laggiù. Io porto Dieci all’infermeria e parto subito. Sarò lì prima di mezzogiorno. Ti troverò io. Portati le mitragliatrici, non possiamo sapere come andranno le cose”. “Sulla mappa, però, c’è un’altra stazione più vicina, la... Arbatskaya”, Artyom riuscì a richiamare alla mente il nome. “È vero, ma non devi nemmeno avvicinarti a quel luogo. Non ci provare. Ci passerai di fianco, ma stai dall’altra parte della strada. Cammina velocemente ma non correre. È tutto. Non perdere tempo!”, concluse, poi spinse Artyom verso l’uscita del vestibolo. Il ragazzo non aveva più le forze per controbattere. Si mise una delle mitragliatrici in spalla, tenne la seconda in mano, scese in strada e tornò verso il monumento, coprendosi gli occhi con la mano destra, in modo da non scorgere, nemmeno per errore, i raggi dell’invitante radiosità delle stelle del Cremlino. CAPITOLO 14 : IN SUPERFICE Prima di raggiungere l’anziano di pietra in poltrona, Artyom girò a sinistra per oltrepassare l’angolo della strada lungo i gradini della Biblioteca. Superandolo, lanciò uno sguardo al maestoso edificio ed ebbe di nuovo i brividi: per un momento ricordò i terribili abitanti di quel luogo. Ora la Biblioteca era nuovamente pervasa da un silenzio tetro; con tutta probabilità i suoi custodi si erano già dileguati e nascosti negli anfratti più bui, a leccarsi le ferite dopo l’impudente incursione, per essere in grado di preparare la successiva non appena fosse tornato il prossimo gruppo di avventurieri. Davanti ai suoi occhi apparve il viso pallido e senza vita di Daniel. Il ragazzo capì perché l’amico Bramino fosse tanto intimorito da queste creature e si rifiutasse di parlarne. Aveva visto la sua morte nei suoi incubi? Il suo corpo sarebbe giaciuto per sempre negli Archivi, abbracciato a quello del bibliotecario che l’aveva ucciso. Sempre che queste creature non si nutrissero anche di cadaveri... Artyom trasalì. Sarebbe mai riuscito a dimenticare com’era morto il Bramino, che era divenuto suo amico in soli due giorni? Temeva che Daniel avrebbe tormentato i suoi sogni per molto tempo, continuando a cercare di parlare con lui la notte, articolando parole indistinte con le labbra macchiate di sangue. Uscendo sull’enorme viale, Artyom ripassò velocemente le istruzioni fornitegli da Melnik. Vai dritto finché la Kalininskiy non si incrocia con l’Anello dei Giardini, non girare da nessuna parte... cerca di capire quale sia il viale. Non stare al centro della strada e nemmeno contro i muri delle case, ma soprattutto cerca di raggiungere la Smolenskaya prima che sorga il sole. I famosi edifici imponenti della Kalininskiy, che il ragazzo conosceva dalle cartoline ingiallite delle panoramiche di Mosca, cominciavano a cinquecento metri da lui. Nei pressi del luogo in cui si trovava c’erano invece case più piccole, che continuavano a sinistra sul Noviy Arbat. I contorni dei fabbricati erano ben delineati da vicino e confusi quando ci si allontanava, per poi sparire quasi del tutto nella penombra. La luna era nascosta dietro le nuvole basse, dalle quali filtrava una scarsa luce biancastra, e solo quando il sipario brumoso si dissolse le sagome spettrali delle case ripresero forma per un attimo. Anche con quella luce, con i vicoli che sezionavano la strada ogni cento metri, a sinistra si intravvedeva l’imponente profilo dell’antica cattedrale. Un’enorme ombra alata planò nuovamente sulla cupola sovrastata da una croce. Forse fu proprio per questo motivo che Artyom si fermò, per rivolgere lo sguardo alla bestia che fendeva l’aria, la quale lo notò. Nella semi oscurità era quasi impossibile comprendere se fosse stata solo la sua immaginazione a tracciare la strana figura che, ferma immobile in fondo al vicolo, si era fusa con le pareti praticamente distrutte della casa. Solo quando esaminò quel punto con maggiore attenzione notò che l’area buia si era mossa leggermente e possedeva una volontà propria. Da quella distanza non era facile determinare con esattezza la forma e le dimensioni della creatura, ma era chiaro che stava in piedi su due gambe; perciò Artyom decise di agire come suggerito dallo stalker. Accese la torcia, puntò il raggio nel vicolo e descrisse tre cerchi luminosi. Non ricevette alcuna risposta. Artyom l’attese invano per un minuto, finché non comprese che stare fermo nello stesso luogo poteva essere molto pericoloso. Ma, prima di proseguire, illuminò nuovamente la figura immobile in fondo alla viuzza. Ciò che scorse gli fece decidere di spegnere immediatamente la torcia e di andarsene il più in fretta possibile. Chiaramente non si trattava di un uomo. La sagoma rischiarata dal fascio luminoso era più distinta: era alta circa due metri e mezzo, non aveva né spalle né collo e una grossa testa rotonda fuoriusciva direttamente dal corpo possente. La creatura si era nascosta e stava aspettando il momento buono. Nonostante la sua apparente indecisione, Artyom sentì nelle ossa che rappresentava una minaccia. Percorse centocinquanta metri in meno di un minuto, fino all’ultimo vicolo. Osservò attentamente e capì che non si trattava di una viuzza, bensì di un’apertura scavata in un quartiere residenziale da una sorta di arma. Molto probabilmente gli edifici erano stati bombardati oppure demoliti con armamenti pesanti. Artyom osservò incuriosito le case semi distrutte che si lasciava alle spalle, sebbene la sua attenzione fosse concentrata su un’ombra incerta, immobile. Fu sufficiente puntare la torcia sulla creatura per un solo istante per capire che era lo stesso, oppure un secondo esemplare di mostro. Se ne stava nel mezzo del vicolo, non cercava nemmeno di nascondersi. Se si trattava della stessa creatura che aveva scorto all’isolato precedente, ciò significava che essa era riuscita a muoversi furtivamente lungo la strada parallela fino a quella in cui si trovava Artyom. Invece comprese che aveva coperto quella distanza due volte più velocemente di lui, perché nello stesso momento in cui raggiunse l’incrocio successivo, lo stava già aspettando lì. Per sua immensa sfortuna, scorse un’altra sagoma simile nel vicolo alla destra della via principale. Come la prima, anche questa stava ferma immobile, come una statua. Per un attimo Artyom pensò che forse non si trattava di esseri viventi, ma di segnali piazzati in quei luoghi da qualcuno che desiderava intimidire o avvertire gli altri... Stava per giungere alla terza intersezione, fermandosi all’ultima villetta per controllare dietro l’angolo, quando notò che i suoi misteriosi inseguitori lo avevano superato di nuovo. Il numero delle enormi sagome era aumentato ancora, era molto più semplice vederle, anche perché il velo di nuvole che aveva coperto la luna si era ulteriormente assottigliato. Come in precedenza, le creature se ne stavano in piedi, senza muoversi di un passo, e aspettavano che apparisse dalle aperture delle case. Ma in tutto ciò, era sicuro di non aver confuso degli esseri viventi con pietre e blocchi di cemento appartenenti a strutture crollate? I suoi sensi acuti gli tornavano sicuramente utili sottoterra, nella Metro. Ma in superficie aveva trovato un mondo ingannevole, a lui completamente sconosciuto, in cui tutto era diverso e la vita rispondeva a regole differenti. Non poteva più affidarsi alle impressioni e all’intuizione. Quindi Artyom cercò di superare i vicoli il più velocemente possibile, senza farsi notare; procedette vicino ai muri delle case, attese un secondo e poi ricontrollò dietro l’angolo. Rimase senza fiato: le sagome si spostavano e in maniera sorprendente; allungavano i muscoli verso l’alto e, alzando la testa, annusavano l’aria. Uno di essi si mise persino a quattro zampe e scomparve dietro l’angolo in un solo balzo. Gli altri lo seguirono qualche secondo più tardi. Artyom indietreggiò, si nascose e si sedette a terra, dove riuscì a riprendere un po’ fiato. Ormai non c’erano più dubbi: lo stavano inseguendo. Era come se le creature lo stessero accompagnando, percorrendo le strade parallele. Avrebbero cercato il momento più adatto, finché il ragazzo non fosse arrivato alla nuova apertura. Sarebbero apparsi in un vicolo per assicurarsi che non avesse preso un’altra strada, poi avrebbero continuato a seguirlo, silenziosi come delle ombre. Ma perché? Stavano decidendo quando attaccare? Solo per curiosità? Per quale ragione non si erano decisi a uscire sul viale e avevano preferito nascondersi nelle ombre più oscure? Ricordò di nuovo le parole con cui Melnik gli aveva proibito di abbandonare la strada davanti a lui: era perché quelle creature sarebbero state lì ad aspettarlo e Melnik sapeva che avrebbe corso questo pericolo? Per calmarsi, Artyom cambiò il caricatore della sua mitragliatrice, fece scattare la sicura, poi accese e spense il laser del mirino. Era armato fino ai denti e qui poteva sparare senza causare ulteriori danni, non come all’interno della Biblioteca. Perciò difendersi sarebbe stato più semplice. Inspirò profondamente e si alzò in piedi. Lo stalker gli aveva vietato di fermarsi e perdere tempo. Doveva sbrigarsi. Pareva che qui, in superficie, bisognasse sempre fare presto. Passò un altro isolato e rallentò il passo per controllarsi le spalle. Qui la strada si era fatta ancora più ampia, sembrava quasi che formasse una piazza, parte della quale era isolata dal viale da uno steccato ed era stata trasformata in un parco. Per lo meno pareva che in passato fosse stato un parco: in alcuni punti vi erano degli alberi, sebbene non si trattasse propriamente degli stessi che Artyom aveva avuto occasione di vedere sulle cartoline e nelle immagini. Spessi tronchi nodosi con enormi chiome si stagliavano contro il cielo ad altezze del tutto simili a quelle degli edifici di cinque piani che stavano nella parte posteriore dello spiazzo. Quasi sicuramente, gli stalker si recavano in questi parchi per raccogliere la legna da ardere che riscaldava e illuminava tutta la Metropolitana. Strane ombre tremolarono negli spazi tra i tronchi e in lontananza era stato acceso un piccolo fuoco. Artyom l’avrebbe scambiato per la fiamma di un fuoco da campo se non fosse stata giallastra. Il fabbricato stesso aveva un aspetto sinistro: dava l’impressione che fosse stato per più di una volta teatro di scontri brutali e sanguinari. I piani superiori erano crollati in diversi punti e molti erano stati bucherellati da pallottole. In alcune parti erano rimaste intatte solo due pareti e il cielo notturno era visibile attraverso le finestre vuote. Gli edifici si separavano al di là della piazza e un altro viale enorme si incrociava con la strada. Sopra di lui apparvero dall’oscurità, come delle torrette di guardia, i primi grattacieli del Noviy Arbat. Stando a ciò che indicava la mappa, l’entrata dell’Arbatskaya sarebbe dovuta essere nelle vicinanze, alla sua sinistra. Artyom scrutò di nuovo il parco, così cupo. Melnik aveva ragione: nessuno avrebbe avuto il coraggio di intrufolarsi nelle profondità di questo labirinto per cercare di scendere nella Metro. Più osservava gli arbusti scuri sparsi nei pressi delle strutture in rovina, più gli pareva di intravvedere quelle sagome misteriose che lo avevano inseguito e che si spostavano tra le radici dei giganteschi alberi. Un repentino refolo di vento scosse i pesanti rami degli alberi e le chiome scricchiolarono per il movimento. Con quella folata arrivarono da lontano anche prolungati lamenti. La boscaglia era tranquilla, ma non perché non vi fosse nessuno. Il suo silenzio era simile a quello dei misteriosi inseguitori di Artyom e anch’esso sembrava stesse attendendo qualcosa. Artyom venne sopraffatto dalla sensazione che, se si fosse fermato in quel punto, a esaminare le profondità più recondite del parco, sarebbe stato sicuramente punito. Quindi impugnò meglio la mitragliatrice, guardò indietro per controllare se le creature si fossero avvicinate e proseguì. Qualche secondo dopo si fermò di nuovo perché si trovava all’incrocio dei viali, all’inizio della Prospettiva Kalininskiy. Qui la vista era tale che Artyom non riuscì davvero a sforzarsi di avanzare. Si trovava nel centro di un’intersezione a forma di X tra due vastissime strade, che un tempo erano state percorse da veicoli a motore. Questo snodo stradale era stato costruito in una maniera del tutto particolare: parte della strada asfaltata scendeva in una galleria, per poi riemergere in superficie, mentre sulla destra i viali continuavano a perdita d’occhio. Li si poteva distinguere dalla lunga fila nera di alberi, che erano alti quanto quelli che aveva appena superato. A sinistra si trovava un’altra vasta piazza asfaltata, un complesso groviglio di diversi sentieri, oltre i quali cominciavano nuovamente gli arbusti. Ora si poteva vedere persino oltre e Artyom si chiese se il sorgere del tanto temuto sole si stesse già avvicinando. Sulle strade erano sparpagliate carcasse di automobili bruciate e deformate. Non era rimasto nient’altro, giacché in due decenni di viaggi in superficie, gli stalker erano riusciti a prendere di tutto: la benzina dai serbatoi, le batterie e i generatori, i fanali e i segnali stradali, i sedili strappati sui quali c’erano ancora tracce di carne umana. Si potevano trovare tutti questi oggetti anche alla VDNKh e in qualsiasi altro grande mercato della Metropolitana. L’asfalto era scavato e dappertutto si vedevano crateri e ampie crepe, attraverso le quali spuntavano erba e piccoli steli, che si piegavano sotto il peso di corolle a forma di palla, nelle quali, con tutta probabilità, vi erano nascosti dei semi. La gola fangosa del Noviy Arbat fu subito ben visibile davanti agli occhi di Artyom. Da una parte vi era una fila di case, chissà per quale ragione, per nulla danneggiate. Sembravano libri aperti in vetrina. Mentre dall’altra gli edifici più alti, circa venti piani ciascuno, erano tutti crollati. Il ragazzo si stava lasciando alle spalle la strada che conduceva alla Biblioteca e al Cremlino. Era nel bel mezzo del più maestoso cimitero della civiltà e si sentiva un archeologo, alla scoperta di un’antichissima città, dei resti di un potere passato e di una bellezza sfiorita: anche in coloro che li visitavano a secoli di distanza provocavano soggezione. Cercò di immaginare come vivevano le persone che popolavano questi edifici giganti, che si spostavano su questi veicoli, quando ancora erano nuovi fiammanti e scivolavano sul liscio manto stradale scaldato dalla gomma degli pneumatici e che scendevano nella Metropolitana solo per viaggiare da un punto all’altro di questa città sconfinata. Era impossibile. A cosa pensavano? Cosa li turbava? Cosa può impaurire un uomo che non deve costantemente essere preoccupato della propria vita e non deve combattere ogni secondo per sopravvivere almeno un giorno in più? Per fortuna in quel momento le nuvole scomparvero e divenne visibile una parte del giallognolo disco lunare arricchito di strane striature. La luce intensa che filtrava attraverso quell’apertura tra le nuvole inondava la città morta, intensificandone al massimo la tenebrosa magnificenza. Le case e gli alberi, che finora erano sembrati sagome piatte ed evanescenti, erano ritornati alla vita e avevano acquisito una dimensione. Incapace di spostarsi da quel luogo, Artyom si guardava attorno rapito, cercando di reprimere quel brivido che lo aveva sopraffatto. Solo in quel momento cominciò a comprendere l’angoscia che aveva udito nelle voci degli anziani che raccontavano il passato, che con la loro immaginazione tornavano alla città nella quale avevano vissuto. Solo ora percepì la distanza tra l’uomo di oggi e i risultati e le conquiste del passato: come un fiero uccello che plana e che, quando viene ferito mortalmente, cade a terra per nascondersi in un crepaccio e, dopo essersi rintanato in quel buco, spira da solo. Gli ritornò alla mente un discorso tra il suo patrigno e Hunter, che era riuscito a origliare: l’uomo riuscirà a sopravvivere? Nel caso dovesse riuscirci, sarà lo stesso uomo che aveva conquistato il mondo e che, sicuro di sé, lo governava? Ora anche Artyom era in grado di valutare quanto in basso l’umanità fosse riuscita a cadere e la sua fede in un futuro migliore si dissolse una volta per tutte. La dritta e ampia Prospettiva Kalininskiy si allontanava da lui, si assottigliava gradualmente finché scomparve nell’oscurità, in lontananza. Artyom era in strada, completamente solo, circondato dai fantasmi e dalle ombre del passato; cercava di immaginare quante persone avessero popolato i marciapiedi di giorno e di notte, quante auto avessero sfrecciato a tutta velocità nello stesso punto in cui lui si trovava in quel momento, con quale luce calda e confortevole avessero brillato le ormai vuote e oscure finestre delle case. Dov’era finito tutto? Il mondo sembrava ancora più deserto e desolato, ma Artyom comprese subito che si trattava di un’illusione: la Terra non era affatto esanime o abbandonata, aveva semplicemente cambiato proprietari. Dopo aver riflettuto per un istante, Artyom si voltò verso la Biblioteca: loro se ne stavano immobili a un centinaio di metri e lui si trovava nel bel mezzo della strada. Le creature erano cinque e non avevano più intenzione di nascondersi nei vicoli, sebbene non avessero nemmeno cercato di attirare la sua attenzione. Il ragazzo non riusciva a figurarsi come fossero riusciti a raggiungerlo tanto velocemente e in maniera così silenziosa. I loro corpi si distinguevano senza problemi alla luce della luna: erano potenti, con gli arti posteriori molto sviluppati e forse persino più alti di quanto gli fossero parsi all’inizio. Da quella distanza non riusciva a scorgere i loro occhi, tuttavia sapeva che lo scrutavano attentamente, aspettavano il momento adatto e annusavano l’aria umida per riconoscere il suo odore. Probabilmente conoscevano anche l’odore della polvere da sparo che si era attaccata addosso alla tuta del ragazzo e forse era per questo motivo che non avevano ancora deciso di attaccarlo. Pertanto, si limitavano a osservare Artyom da lontano, per attendere un segno di incertezza o di debolezza nel suo comportamento. Poteva anche darsi che lo stessero accompagnando al confine del loro territorio e che non avessero alcuna intenzione di fargli del male... Come poteva sapere quale sarebbe stata la reazione di quelle creature apparse sulla faccia della Terra, che non rispondevano ad alcuna legge dell’evoluzione? Cercando di mantenere l’autocontrollo, Artyom si voltò con finta disinvoltura e proseguì, guardandosi alle spalle ogni dieci passi. All’inizio i mostri non si muovevano, ma in seguito le sue paure peggiori cominciarono a prendere forma: si misero a quattro zampe e presero a camminare con passo pesante verso di lui. Ma non appena si trovavano a un centinaio di metri dal ragazzo, si fermavano di nuovo. Dopo un po’ Artyom si abituò a questa strana scorta, ma era comunque preoccupato, li teneva d’occhio e la mitragliatrice era sempre pronta. Procedettero così, insieme, lungo l’ampio viale, inondato dalla luce della luna: un uomo, vigile, teso come una corda di violino, che si fermava e si guardava alle spalle ogni trenta secondi dove si trovavano cinque o sei sagome bizzarre, che seguivano il suo passo, senza alcuna fretta. Ciononostante, ben presto gli parve che la distanza che li separava diminuisse sempre più. Inoltre, le bestie erano rimaste in gruppo, ma a un certo punto si erano schierate a ventaglio, come se volessero circondarlo. Artyom non aveva mai affrontato un branco di predatori in vita sua, ma per qualche ragione, gli era chiarissimo che le creature si stavano preparando ad attaccare. Era tempo di agire. Si voltò di scatto e, con la mitragliatrice pronta, mirò a una delle sagome oscure. Il loro comportamento era decisamente cambiato: questa volta non si fermarono e non aspettarono che proseguisse, ma continuarono ad avvicinarsi senza farsi notare, mentre pian piano costituivano un semicerchio. Doveva cercare di spaventarli prima che riuscissero ad accorciare la distanza che li separava, altrimenti sarebbe di sicuro rimasto vittima del loro attacco. Artyom alzò la canna dell’arma e sparò in aria. Il fracasso riverberò sui muri dei grattacieli e riecheggiò fino alla fine dell’altro viale. Il bossolo cadde sull’asfalto con un rumore metallico. Quindi le bestie ruggirono in modo assordante e rabbioso e si precipitarono verso il ragazzo. Riuscirono a coprire le poche decine di metri che li separavano da Artyom in qualche secondo, ma anche lui era pronto: non appena la bestia più vicina fu all’interno del suo mirino, sparò e si mise a correre verso le case. A giudicare dalle urla della creatura, era riuscito a colpirla. Non poteva sapere se questo suo gesto avesse fermato per un attimo le bestie oppure, al contrario, le avesse fatte infuriare ancora di più. Ma subito dopo udì un altro grido: non il ruggito minaccioso delle bestie che gli davano la caccia, ma un gracchiare assordante e continuo, che gli gelò il sangue nelle vene. Arrivava dall’alto e Artyom comprese che un nuovo concorrente si era unito al gioco. Naturalmente, il rumore degli spari aveva attirato l’attenzione di uno dei mostri volanti che nidificavano sulle cupole della cattedrale. Un’enorme ombra sfiorò la sua testa come un proiettile. Voltandosi per un secondo, Artyom notò che le bestie si erano dileguate e che solo una di esse, quella ferita, era rimasta in mezzo alla strada. Continuando a urlare, si trascinava maldestra verso gli edifici, sperando di riuscire a nascondersi al loro interno. Ma non aveva più alcuna speranza di salvarsi: descrivendo un altro cerchio a diverse decine di metri di altezza, il mostro spiegò le enormi ali coriacee e si gettò sulla sua vittima. Si tuffò tanto velocemente che Artyom non fu nemmeno in grado di capire cosa successe in seguito. Dopo aver afferrato la bestia in agonia, l’enorme mostro del cielo sollevò con sé la sua preda senza sforzo visibile e la portò su uno dei tetti dei grattacieli. I suoi inseguitori non uscirono subito dai loro nascondigli, per paura che il mostro potesse tornare. Artyom non aveva tempo da perdere. Rimanendo il più vicino possibile ai muri delle case, corse in avanti dove, secondo i suoi calcoli, sarebbe dovuto esserci l’Anello dei Giardini. Prima di perdere il fiato riuscì a correre per cinquecento metri, quindi si voltò e controllò che le bestie che lo stavano inseguendo si fossero calmate e avessero deciso il da farsi. Il viale era vuoto. Tuttavia, dopo aver percorso qualche decina di metri, controllò in uno degli ultimi vicoli del Noviy Arbat e, impaurito, notò le familiari ombre immobili. Ora cominciava a comprendere perché queste creature non avevano fretta di uscire allo scoperto e preferivano seguire le loro vittime dalle più buie strade secondarie. Lo volevano catturare, ma temevano di attirare l’attenzione dei mostri più grandi e di diventare le loro prede. Ora Artyom si doveva voltare a controllare ogni minuto. Sapeva che le bestie erano in grado di muoversi molto veloci e silenziose e temeva che potessero coglierlo alla sprovvista. La fine del viale era già ben visibile quando uscirono dai vicoli e cominciarono di nuovo a circondarlo. Ormai sapeva come comportarsi: il ragazzo sparò un colpo in aria sperando, come prima, di attirare l’attenzione del mostro alato, di spaventare e quindi far fuggire le bestie. In realtà si fermarono per qualche istante sulle zampe posteriori; poi allungarono il collo. Il cielo rimase vuoto. Forse il mostro era ancora impegnato con la prima vittima. Artyom lo comprese prima dei suoi inseguitori e girò a destra, costeggiò una delle case e si tuffò nell’entrata più vicina. Sebbene Melnik lo avesse avvertito di non fare nulla del genere, adducendo la spiegazione che le case erano abitate, era da pazzi affrontare un nemico tanto potente e mobile come quelle bestie. Lo avrebbero fatto a pezzi prima ancora che fosse riuscito a far scattare la sicura della sua mitragliatrice. L’entrata era avvolta dall’oscurità e dovette accendere la torcia. Il cerchio di luce rendeva visibili pareti logore, ricoperte di oscenità scarabocchiate diversi decenni prima, una scala malandata e le porte rotte di appartamenti distrutti e rasi al suolo dal fuoco. Ratti coraggiosi scorrazzavano in giro come se quel luogo gli appartenesse, aggiungendo un tocco di desolazione alla totalità dell’immagine. Aveva scelto bene l’entrata di quel condominio, in quanto le finestre della scala si affacciavano sul viale e salendo al piano superiore sarebbe stato in grado di accertarsi che le bestie non avessero deciso di seguirlo. Si avvicinarono furtive alla porta d’entrata, ma invece di entrarvi, la circondarono e, accovacciandosi, rimasero nuovamente immobili come delle statue. Artyom non riusciva a credere che si sarebbero ritirate e che avrebbero permesso alla loro preda di sfuggirgli. Presto o tardi avrebbero cercato di raggiungerlo dall’esterno, sempre che non vi fosse nascosto qualcosa nell’entrata; quindi Artyom sarebbe stato costretto comunque a scappare. Salì ancora di qualche piano, illuminò le porte e scoprì che una di esse era chiusa. La spinse con la spalla e si accorse che era bloccata. Senza pensarci due volte, avvicinò la bocca della mitragliatrice alla serratura, sparò un colpo e spalancò la porta con un calcio. A pensarci bene, non aveva importanza in quale degli appartamenti avrebbe innalzato la propria difesa, ma non poté lasciarsi sfuggire la possibilità di osservare in prima persona un’abitazione ancora intatta di un’epoca passata. Prima di tutto chiuse la porta e la bloccò con un piccolo armadio che si trovava nel corridoio. Questa barricata non avrebbe resistito a un attacco serio, ma per lo meno i nemici non sarebbero riusciti a entrare tanto facilmente. Dopodiché, Artyom si avvicinò alla finestra e guardò fuori con attenzione: era un perfetto posto di fuoco, poiché dal quarto piano riusciva a controllare alla perfezione se le bestie si avvicinavano all’entrata. Ce n’erano una decina, tutte sedute a semicerchio davanti alla porta. Ora era in vantaggio e non sprecò altro tempo per dimostrarlo anche ai suoi avversari. Accese il mirino laser, puntò il pallino rosso alla testa della bestia più grande, fece un bel respiro e premette il grilletto. Risuonò un breve colpo e la creatura si accasciò di lato, senza fare alcun rumore. Le altre fuggirono in direzioni diverse alla velocità della luce e un momento più tardi la strada fu di nuovo sgombra. Senza dubbio, non avevano intenzione di allontanarsi troppo. Artyom decise di aspettare per essere sicuro che la morte del loro simile avesse spaventato anche le altre bestie. Nel frattempo, gli rimaneva qualche minuto per esaminare l’appartamento. Sebbene i vetri si fossero rotti molto tempo prima, sia nell’appartamento che nel resto del palazzo, l’arredamento e gli accessori si erano tutti conservati quasi alla perfezione. Piccole pastiglie, che sembravano il veleno per topi usato alla VDNKh, erano state sparse sul pavimento. Forse era proprio per questo motivo che in quel punto non se ne vedeva nemmeno uno. Più si aggirava per l’appartamento, più si convinceva che i proprietari non lo avevano abbandonato di fretta, ma avevano cercato in qualche modo di proteggerlo, sperando, un giorno o l’altro, di poterci ritornare. In cucina non avevano lasciato cibo che potesse attirare roditori o insetti e la maggior parte dei mobili era stata accuratamente avvolta nel cellophane. Spostandosi da una stanza all’altra, Artyom cercò di immaginare come coloro che vi avevano vissuto conducessero la loro vita quotidiana. Quante persone abitavano qui? A che ora si svegliavano, tornavano a casa dal lavoro, cenavano? Chi sedeva a capotavola? Lui conosceva gran parte degli impieghi, dei rituali e di tutto il resto solo grazie ai libri che aveva letto e ora, vedendo una vera e propria abitazione, si convinse che tutto ciò che aveva immaginato fino a quel momento fosse completamente sbagliato. Facendo molta attenzione, Artyom sollevò la pellicola semi trasparente di polietilene ed esaminò lo scaffale dei libri. Tra i vari romanzi gialli che aveva già visto anche alle bancarelle all’interno della Metro, si trovavano anche diversi coloratissimi libri per bambini. Ne afferrò uno per il dorso e lo estrasse con delicatezza. Mentre sfogliava le pagine sulle quali erano raffigurate immagini di animali felici, dal libro cadde un foglio di carta più pesante. Artyom si abbassò a raccoglierlo dal pavimento e si accorse che si trattava di una foto scolorita di una donna sorridente con un bambino piccolo. Rimase di sasso. Il suo cuore si mise a palpitare. Dopo aver portato il sangue in tutto il corpo per mezzo di battiti misurati, questi si velocizzarono in maniera impropria. Artyom sentiva il bisogno di togliersi quella stretta maschera antigas per prendere una boccata d’aria fresca, se quest’ultima non fosse stata avvelenata... Prestando sempre moltissima attenzione, come se la fotografia potesse ridursi in cenere al suo tocco, l’avvicinò agli occhi. La donna rappresentata era sulla trentina e il piccolo che teneva in braccio aveva suppergiù due anni, perciò a giudicare dal buffo copricapo che aveva in testa era difficile determinare se si trattasse di un maschietto o di una femminuccia. Il bambino guardava verso la macchina fotografica e la sua espressione era sorprendentemente adulta e seria. Artyom girò la fotografia e il vetro della sua maschera antigas si appannò: sul retro era stato scritto, con una penna a sfera blu: “Il piccolo Artyom a 2 anni e 5 mesi”. Fu come se qualcuno lo colpisse con una spranga: le gambe gli cedettero e lui scivolò al suolo, avvicinando l’immagine alla luce lunare che filtrava dalla finestra. Perché il sorriso della donna gli sembrava tanto familiare, così simile al suo? Perché aveva cominciato a sentirsi soffocare non appena aveva scorto il suo viso? In questa città, prima che venisse rasa al suolo, vivevano più di dieci milioni di persone. Artyom non era un nome molto usato ma, di sicuro, esistevano decine di migliaia di bambini che si chiamavano così in una megalopoli di diversi milioni di abitanti... come se coloro che vivevano nella Metropolitana portassero tutti lo stesso nome. Le possibilità erano talmente minime che non valeva nemmeno la pena considerarle. Tuttavia, perché il sorriso della donna gli sembrava conosciuto? Provò a frugare tra i suoi ricordi di bambino che alle volte gli si ripresentavano: una piccola stanza confortevole, luci soffuse, una donna che legge un libro... su un ampio divano. Si alzò e si mise a passare da una stanza all’altra come un vortice, per trovare uno dei mobili che rassomigliasse a quelli che aveva visto nei suoi ricordi. Si accorse subito che l’arredamento di una delle camere era sistemato nello stesso modo che rammentava. Il divano era leggermente diverso e la finestra non c’era, ma l’ambiente poteva essere rimasto impresso in maniera distorta nella mente di un bambino di tre anni... Tre anni? L’età sulla fotografia era diversa, ma anche questo non aveva alcun significato. Sulla scritta non vi era una data precisa. Avrebbero potuto scattarla in qualsiasi momento, non per forza qualche giorno prima che coloro che vivevano nell’appartamento dovessero decidere di lasciarlo per sempre. Si convinse: la fotografia poteva risalire a sei mesi, forse anche a un anno prima. A quel punto l’età del bambino con il cappellino strambo sarebbe coincisa con la sua... Allora la probabilità che quello nella fotografia fosse lui... con sua madre... sarebbe stata maggiore. “Ma la foto potrebbe essere stata scattata tre o persino cinque anni prima”, affermò freddamente una voce estranea, dentro di lui. Poteva essere. All’improvviso venne sopraffatto da un altro pensiero. Spalancò la porta del bagno, si guardò attorno e quasi non distinse ciò che stava cercando: lo specchio era ricoperto di uno spesso strato di polvere che non riusciva nemmeno a riflettere la luce della sua torcia. Artyom prese da un gancio un asciugamano lasciato dai proprietari di casa e pulì lo specchio. La zona che aveva strofinato rivelò il suo riflesso con indosso maschera antigas ed elmetto. Illuminò la sua immagine con la torcia e si specchiò. Il suo viso stanco ed emaciato non era del tutto visibile oltre la visiera della maschera antigas, ma lo sguardo degli occhi scuri profondamente incavati gli pareva simile a quello del bambino. Artyom avvicinò la fotografia al suo viso, osservò attentamente quello del piccolo e poi guardò di nuovo il suo riflesso nello specchio. Illuminò ancora l’immagine e poi riguardò la sua faccia nascosta dalla maschera antigas, cercando di immaginare che aspetto avesse l’ultima volta che l’aveva vista. Quando era stato? Poco prima di lasciare la VDNKh, ma non gli riusciva di ricordare quanto tempo fosse passato da allora. A giudicare dall’uomo che scorgeva nello specchio, sembravano passati degli anni... Se solo si fosse potuto togliere quella dannata maschera antigas per confrontare il suo viso con quello del bambino! Molte persone diventavano irriconoscibili quando crescevano, ma nei loro visi rimaneva sempre un tratto che ricordava la loro infanzia. Avrebbe fatto così: non appena fosse tornato alla VDNKh, avrebbe domandato a Sukhoi se la donna che gli sorrideva da quel pezzo di carta poteva rassomigliare a quella condannata a essere divorata dai ratti, che gli aveva affidato la vita del suo bambino. Se poteva sembrare sua madre. Sebbene il suo viso fosse distorto da una smorfia di disperazione e di supplica, Sukhoi sarebbe stato in grado di riconoscerla. Aveva una memoria da elefante e sarebbe riuscito a ricordare con precisione se aveva già incontrato la donna nella foto. Era lei oppure no? Artyom esaminò nuovamente la fotografia e, con una tenerezza di cui non sapeva di essere capace, sfiorò l’immagine della donna. Poi ripose con cura la foto nel libro da cui era caduta e li richiuse entrambi all’interno del suo zaino. Era strano, rifletté, che solo qualche ora prima si trovava nel più enorme magazzino di sapere di tutto il continente, da cui avrebbe potuto scegliere un libro per sé tra uno dei milioni di volumi diversi, molti dei quali avevano un valore inestimabile. Malgrado ciò, li aveva lasciati dov’erano, sugli scaffali a prendere la polvere, e non gli era mai balenato il pensiero che avrebbe potuto trarre profitto dalle ricchezze della Biblioteca. Al contrario, si stava appropriando di questo semplice libro per bambini, dalle immagini modeste, ma gli sembrava di essere entrato in possesso di uno dei tesori più preziosi del mondo. Artyom tornò in salotto per sfogliare anche i libri rimasti sullo scaffale e dare un’occhiata negli armadi, alla ricerca di album fotografici. Ma, alzando gli occhi verso la finestra, percepì che qualcosa era cambiato. Un senso di disagio prese il sopravvento, c’era qualcosa che non andava. Avvicinandosi sempre più, comprese: il colore della notte stava mutando e stavano facendo capolino toni rosa e giallognoli. Stava facendo giorno. Le bestie erano sedute vicino all’entrata ed esitavano ad accedere all’edificio. Il corpo senza vita era scomparso, ma non poteva sapere se l’avesse portato via il gigante alato oppure se fosse stato ridotto a pezzi dai suoi simili. Artyom non riusciva a comprendere cosa impedisse loro di prendere d’assalto l’appartamento, ma per il momento andava bene così. Sarebbe riuscito a raggiungere la Smolenskaya prima del sorgere del sole? Ma soprattutto, sarebbe riuscito a fuggire dai suoi inseguitori? Avrebbe potuto rimanere barricato nell’appartamento, nascosto nel bagno per non essere raggiunto dai raggi solari, in attesa che questi ultimi scacciassero i suoi predatori, per poi tornare nella Metro non appena fosse calata nuovamente la notte. Ma quanto sarebbe durata la tuta protettiva? I filtri della maschera antigas sarebbero riusciti a resistere? Che avrebbe fatto Melnik non trovandolo nel luogo e all’orario pattuiti? Artyom si avvicinò alla porta che conduceva alle scale e si mise in ascolto. Silenzio. Spostò piano l’armadietto e, molto lentamente, aprì poco la porta e sbirciò dallo spiraglio. Non c’era nessuno, ma quando il ragazzo fece scorrere il raggio della sua torcia sulle scale, notò un particolare che non aveva considerato in precedenza. I gradini erano ricoperti di una melma spessa e trasparente, come se qualcuno vi avesse appena strisciato sopra, lasciandosi una traccia alle spalle. Quest’ultima non si avvicinava alla porta dell’appartamento in cui aveva passato tutto questo tempo, ma ciò non consolò Artyom. Significava che le case abbandonate non erano affatto vuote come sembravano? Ora non desiderava più rimanere lì dentro, né tanto meno dormirci. Gli si presentava un’unica soluzione: creare un diversivo per quelle bestie e provare a raggiungere la Smolenskaya prima del sorgere del sole che gli avrebbe bruciato gli occhi e prima del risveglio dei mostri invisibili. Questa volta non prese la mira accuratamente come prima, ma cercò di causare il maggior numero di danni possibile ai predatori. Due di loro ruggirono e caddero al suolo, mentre gli altri si trovarono un nascondiglio nei vicoli. Così sembrava che la strada fosse sgombra. Artyom la percorse correndo, prestando la massima attenzione, preoccupato di un’imboscata. Cercava con tutte le sue forze l’entrata della stazione mentre percorreva a perdifiato l’Anello dei Giardini. “Che spaventosa boscaglia doveva esserci in quei giardini”, rifletté mentre correva. Dopo tutti quegli anni, persino i filari di alberi sui viali si erano trasformati in labirinti senza uscita... E chissà com’era diventato l’Orto botanico e cosa ci era cresciuto. I suoi inseguitori gli permisero di avere un po’ di vantaggio e, mentre loro ricostituivano il branco, lui riuscì a raggiungere quasi la fine del viale. Il cielo si faceva sempre più chiaro, ma pareva proprio che i raggi del sole non scoraggiassero minimamente le bestie, che si divisero in due gruppi, si precipitarono in avanti, accorciando sempre più la distanza che li separava da Artyom. Qui, nello spazio aperto, loro erano avvantaggiati, mentre Artyom non riusciva nemmeno a fermarsi per sparare. Al contempo, si misero a quattro zampe, tanto che le loro sagome non erano più alte di un metro e quasi si confondevano con la strada. Più Artyom cercava di sbrigarsi, più la tuta protettiva, lo zaino, le due mitragliatrici e la fatica accumulata durante quella notte che pareva infinita, si facevano sentire. Ben presto questi demoni lo avrebbero superato e gliel’avrebbero fatta pagare; era disperato. Gli ritornarono alla mente i corpi deformati ma potenti dei mostri che giacevano in pozze di sangue, all’entrata dell’edificio dove avevano avuto la sfortuna di incontrare la sua mitragliatrice. Artyom non aveva avuto il tempo di esaminarli con attenzione, ma un minimo sguardo era stato sufficiente per incidere quell’immagine nella sua memoria: pelo marrone lucido, enormi teste rotonde, bocche nelle quali scintillavano decine di piccoli denti affilati, che sembravano crescere su diverse file. Facendo scorrere mentalmente la serie di immagini degli animali da lui conosciuti, Artyom non riusciva a ricordarne nessuno che potesse essere in grado di diventare un mostro del genere, nemmeno sotto l’effetto delle radiazioni. Fortunatamente, sull’Anello dei Giardini non vi erano alberi: era solamente una strada molto vasta, dalla quale si estendevano diramazioni sia a destra che a sinistra. Prima di mettersi nuovamente a correre, Artyom sparò alle bestie senza nemmeno guardare. Si trovavano ancora a meno di cinquanta metri da lui e si erano divise in un semicerchio, tanto che alcune avanzavano a pochi centimetri da lui. Nei pressi del Sadovoye dovette cercare la strada tra i diversi crateri di cinque o sei metri di profondità ed effettuare una deviazione per costeggiare l’immensa crepa che divideva in due il manto stradale. Le strutture nelle vicinanze avevano un aspetto bizzarro: non erano bruciate, piuttosto parevano sciolte e davano l’impressione che in quel luogo fosse accaduto qualcosa di decisamente particolare, che questa zona avesse dovuto sopportare un attacco più efferato rispetto a quella della Prospettiva Kalininskiy. A qualche centinaio di metri di distanza sorgeva un edificio di dimensioni inconcepibili: pareva un castello medievale, rimasto incolume al passaggio del tempo e degli incendi, che faceva da sfondo cupo e maestoso a quell’ambiente mutilato. Artyom lo osservò per una frazione di secondo, poi fece un sospiro di sollievo, perché una spaventosa ombra alata volò sopra di esso: poteva essere la sua salvezza. Avrebbe solo dovuto attirare la sua attenzione, così che si occupasse dei suoi inseguitori. Alzò la mitragliatrice che teneva in una mano e puntò verso l’alto, al mostro volante, poi premette il grilletto. Non accadde nulla. Aveva terminato le munizioni. Mentre correva, non riusciva a recuperare la mitragliatrice di riserva, che teneva sulla schiena. Perciò, si tuffò nel primo vicolo, si appoggiò al muro e cambiò arma. Ora doveva impedire alle bestie di avvicinarsi: avrebbe svuotato il caricatore del secondo mitra. La prima bestia era già apparsa da dietro l’angolo e si era seduta sulle zampe posteriori con il solito movimento, allungandosi e mostrandosi in tutta la sua incredibile altezza. Si era fatta più audace e si era avvicinata talmente tanto che, per la prima volta, Artyom fu in grado di vederle gli occhi, che erano piccoli, nascosti sotto enormi sopracciglia e che bruciavano di un fuoco verdognolo intriso di malvagità, del tutto simile al bagliore misterioso di quella fiamma che era riuscito a scorgere al parco. Sul Kalashnikov di Daniel non c’era il mirino laser, ma da quella distanza non avrebbe potuto sbagliare per nulla al mondo. Incorniciò la sagoma immobile della bestia con quel mirino, tenne incollata la mitragliatrice alla spalla e premette il grilletto. L’otturatore si mosse lentamente verso il centro, poi si fermò. Cos’era successo? Aveva potuto confondere le due armi, nella fretta? Impossibile, perché la sua arma aveva il mirino laser! Artyom tirò con forza l’otturatore. Era bloccato. Un vortice di pensieri turbinò nella sua testa: Daniel, i bibliotecari... era per questo motivo che il suo amico non era riuscito a ribellarsi quando il mostro grigio lo aveva attaccato in quel bandolo di libri! La sua mitragliatrice non aveva funzionato. Molto probabilmente vi aveva fatto forza in maniera convulsa, mentre il bibliotecario lo trascinava nei recessi dei corridoi... Tutto rimase in silenzio mentre, come degli spettri, apparvero altre due bestie. Attente, studiavano Artyom, che disperato fissava l’arma di Daniel. Sembrava che i mostri stessero tirando le somme della situazione. La creatura più vicina, molto probabilmente il capobranco, saltò e si ritrovò a cinque metri da Artyom. In quel momento, una gigantesca ombra sorvolò le loro teste. Le bestie si sdraiarono a terra e alzarono la testa. Approfittando del momento di confusione, il ragazzo corse verso uno degli archi, senza più alcuna speranza di uscire vivo da questo disastro, ma cercando istintivamente di posticipare la sua morte. Nei vicoli non aveva la minima possibilità contro di loro, ma in ogni caso, tornare sull’Anello dei Giardini era ormai fuori discussione. Si ritrovò al centro di una piazzetta vuota, circondata dai muri delle case, in cui si intravvedevano altri archi e dei passaggi. Lo stesso castello oscuro che l’aveva sorpreso lungo il viale dei Giardini si stagliava contro il cielo, dietro l’edificio verso cui era rivolto. Quando finalmente riuscì a distoglierne lo sguardo, Artyom vide la scritta sull’edificio opposto: “Metropolitana di Mosca - Vladimir Lenin”, e nella parte inferiore “Stazione Smolenskaya”. Le enormi porte di quercia erano socchiuse. Non riusciva a capire come fosse riuscito a schivarli. Ebbe una premonizione di pericolo e la leggera brezza che sentì era quella del predatore che attacca la sua preda. La bestia finì a mezzo metro da lui. Artyom si spostò di lato, cauto, e poi si mise a correre con tutta la forza che aveva nelle gambe verso l’entrata della Metropolitana. Laggiù c’era la sua casa, il suo mondo e sottoterra avrebbe recuperato il controllo della situazione. Il vestibolo della Smolenskaya era esattamente come Artyom se l’aspettava: buio, grigio e vuoto. Fu subito chiaro che gli abitanti di questa stazione salivano sovente in superficie: sia le cabine, un tempo preposte alla vendita dei biglietti, che gli uffici erano stati aperti e saccheggiati e tutto ciò che poteva servire era stato portato via molti anni prima. Non rimanevano né i tornelli né le guardiole degli impiegati della Metro, le fondamenta di cemento erano il solo riflesso della loro passata presenza. L’arco che conduceva alle gallerie era già visibile, mentre diverse scale mobili raggiungevano profondità incredibili. La luce emessa dalla torcia si perdeva durante la discesa e Artyom non era in grado di constatare se l’entrata della Metro fosse davvero in quel luogo oppure no. Tuttavia, non poteva rimanere dove si trovava, perché le bestie si erano già introdotte nel vestibolo, lo sapeva perché aveva udito lo scricchiolio della porta. In pochi secondi avrebbero raggiunto le scale mobili e non avrebbe più potuto approfittare di quel minimo vantaggio che ancora manteneva. Impacciato, percorrendo i traballanti gradini di ferro, Artyom cominciò la sua discesa. Cercò di superare diversi scalini con un unico salto, ma il suo piede scivolò su qualcosa di umido, lui cadde verso il basso e batté la nuca contro un angolo. Riuscì a fermarsi solo dopo aver sbattuto la testa e la nuca sui gradini, ma per fortuna indossava ancora l’elmetto. Scrutando lo spazio dietro di lui con la torcia, Artyom notò subito quello che stava cercando e che temeva di trovare: le immobili sagome scure. Come d’abitudine, prima di attaccare, se ne stavano ferme a studiare la situazione o a decidere impercettibilmente il da farsi. Artyom si voltò e cercò di nuovo di saltare due gradini. Questa volta ci riuscì, aiutandosi con il corrimano in gomma, mentre nella mano sinistra teneva la torcia. Corse per quasi venti secondi, finché non cadde ancora. Dietro di lui udì dei passi pesanti, le creature erano determinate. Artyom sperava con tutto se stesso che le vecchie scale, che cigolavano sotto il suo peso più leggero, sarebbero crollate poiché non erano in grado di sostenere quello superiore dei suoi inseguitori. Ma il fracasso che si avvicinava nell’ombra era indice che le scale stavano sopportando bene il peso. Un muro in mattoni con una grande porta nel mezzo apparve alla luce della sua torcia. Rimanevano solo venti metri prima di raggiungerlo, non di più. Alzandosi in piedi con difficoltà, Artyom coprì il tratto finale in quindici secondi, che gli parvero un’eternità. La porta era costruita con dei pannelli d’acciaio e, sotto i colpi dei suoi pugni, risuonava come una campana. Artyom batté la porta con tutta la sua forza. Nel frattempo le ombre si avvicinavano, le scorgeva indistinte nella semi oscurità, si preparavano all’attacco. Solo dopo qualche secondo comprese, e un brivido improvviso gli percorse la spina dorsale: aveva appena commesso un errore imperdonabile e invece di bussare alla porta seguendo il codice predisposto, aveva solo allarmato le guardie, le quali non avrebbero mai più aperto le porte, non importava chi stesse cercando di entrare. Inoltre, il fatto che il sole stesse sorgendo rendeva la cosa ancora più improbabile. Com’era il codice? Tre veloci, tre lenti, tre veloci? No di sicuro, quello sarebbe stato un SOS. Era certo fossero tre all’inizio e tre alla fine ma non riusciva più a ricordare se dovessero essere colpi lenti o veloci. Se si fosse messo a provare le diverse combinazioni, non avrebbe più avuto alcuna speranza di entrare. Meglio l’SOS... per lo meno in questo modo le guardie avrebbero compreso che dall’altra parte della porta si trovava un uomo. Bussò di nuovo sull’acciaio, poi Artyom prese la sua mitragliatrice dalla spalla e, con le mani che gli tremavano, cambiò il caricatore. Poi mise la luce sulla canna dell’arma e con essa seguì nervosamente i contorni degli archi che si trovavano sopra di lui. Le lunghe ombre delle lampade della stazione si sovrapponevano una all’altra al raggio teso della torcia e non riusciva ad essere sicuro che dietro una di esse non si fosse appostata una delle sagome oscure... Come in precedenza, dall’altra parte della porta non si udiva alcun rumore. “Santo cielo, non è la Smolenskaya”, pensò Artyom. Forse questa entrata era stata bloccata decenni prima e nessuno l’aveva più utilizzata? Era riuscito ad arrivarci per caso, senza seguire le istruzioni dello stalker e forse si era sbagliato! Le scale scricchiolarono poco lontano da lui, a circa quindici metri. Non riusciva più a sopportare la situazione, perciò Artyom aprì il fuoco nella direzione in cui aveva udito il rumore. L’eco causò un impeto di dolore alle orecchie di Artyom. Tuttavia, non si trattava dell’ululato di una bestia ferita. I colpi erano andati sprecati. Non aveva più il coraggio di distogliere lo sguardo, pertanto Artyom poggiò la schiena contro la porta e batté il metallo con il pugno: tre colpi veloci, tre lenti, tre veloci. Gli pareva di aver sentito un pesante stridio metallico provenire dalla porta, ma proprio in quel momento vide arrivare dall’oscurità la sagoma di un predatore, che saltava a tutta velocità. Artyom teneva la mitraglietta nella mano destra e premette il grilletto quasi per caso, perciò il rinculo lo spedì all’indietro. I proiettili squarciarono il corpo della creatura, che invece di azzannare Artyom alla gola cadde sugli ultimi gradini della scala mobile, dato che non si era spostato di più di due metri dal luogo da cui aveva spiccato il salto. Un istante dopo il mostro si alzò e, ignorando il sangue che sgorgava copioso dalle sue ferite, procedette verso il ragazzo. A quel punto, barcollando, saltò di nuovo e spinse Artyom contro il freddo acciaio della porta. Non riusciva più ad attaccare il giovane, perché le ultime pallottole lo avevano colpito alla testa e quindi morì prima ancora di terminare il suo balzo. Tuttavia, l’inerzia del suo corpo sarebbe stata sufficiente per fracassare il cranio di Artyom, se lui non avesse avuto l’elmetto. La porta si aprì e una luce bianca e accesa lo inondò. Dalle scale provenne un terribile ruggito e a giudicare dal baccano c’erano almeno cinque bestie. Le mani forti di qualcuno lo agguantarono per il bavero e lo tirarono verso l’interno, poi il metallo risuonò di nuovo. Serrarono la porta e la sbarrarono. “Sei ferito?”, domandò la voce di fianco a lui. “Dannazione a lui!”, rispose un altro. “Hai visto chi ha portato fin qui? L’ultima volta siamo riusciti a malapena a spaventarli e lo abbiamo fatto usando il gas”. “Lasciatelo in pace. È con me. Artyom! Ehi, Artyom! Torna in te!”, udì una voce familiare e Artyom aprì gli occhi con difficoltà. Sopra di lui c’erano tre uomini; con tutta probabilità due di loro erano le sentinelle e indossavano giacche color grigio scuro e berretti fatti a maglia, oltre a giubbotti antiproiettile. Con un sospiro di sollievo, Artyom riconobbe il terzo uomo: era Melnik. “Beh, è lui o cosa?”, chiese una delle guardie con un tono di disappunto. “Allora prenditelo, ma non dimenticatevi della quarantena e della decontaminazione”. “Avete qualcos’altro da insegnarmi?”, rispose ironico lo stalker. “Rimettiti in piedi, Artyom. È passato molto tempo”, aggiunse, porgendogli la mano. Artyom cercò di alzarsi, ma le sue gambe si rifiutavano di funzionare. Barcollò, non si sentiva bene e soprattutto era stordito. “Dobbiamo andare in infermeria. Tu, aiutami. E tu, chiudi le porte a pressione”, Melnik ordinò agli altri due uomini. Mentre il medico lo visitava, Artyom studiava le piastrelle bianche della sala operatoria. Erano immacolate. Nell’aria della stanza si sentiva anche un forte odore di candeggina e diverse lampade fluorescenti erano agganciate appena al di sotto del soffitto. C’erano anche diversi tavoli operatori e una scatola con gli strumenti pronti all’uso, appesi uno di fianco all’altro. Le condizioni del piccolo nosocomio erano sorprendenti, ma Artyom non riusciva a comprendere perché la pacifica stazione della Smolenskaya avesse bisogno di un ospedale del genere. “Non ci sono fratture, solo qualche livido e diversi graffi. Dobbiamo disinfettarli”, affermò il medico, strofinandosi le mani con un asciugamano pulito. “Può lasciarci soli per un istante?”, domandò Melnik al dottore. “Avremmo bisogno di parlare un po’ in privato”. Annuendo con aria d’intesa, il medico se ne andò. Lo stalker si sedette sul bordo del divano su cui giaceva Artyom e gli chiese di raccontargli nel dettaglio ciò che era accaduto. Secondo i suoi calcoli, il ragazzo sarebbe dovuto arrivare alla Smolenskaya due ore prima e Melnik aveva già programmato di tornare in superficie per andare a cercarlo. Ascoltò la storia dell’inseguimento fino alla fine, senza particolare interesse, chiamò i mostri volanti con un termine preciso, cioè “pterodattili”, ma solo la storia di come Artyom si era nascosto nell’edificio lo sorprese davvero. Quando seppe che, mentre lui se ne stava comodamente all’interno dell’appartamento, qualcuno aveva percorso furtivo le scale, lo stalker si accigliò. “Sei sicuro che non hai messo i piedi nella melma sulle scale?”, scosse il capo. “Ci manca solo che quella schifezza arrivi anche qui in stazione. Ti avevo detto di non avvicinarti alle case. Considerati fortunato che lui non abbia deciso di farti visita durante la tua incursione nell’appartamento...” Melnik si alzò, raggiunse l’entrata, dove erano stati posti gli stivali di Artyom, e controllò meticolosamente le suole di entrambi. Non avendo trovato nulla di sospetto, li rimise al loro posto. “Come ti ho già spiegato, per il momento non potrai tornare alla Polis. Non sono riuscito a raccontare la verità ai Bramini, credono che siate scomparsi entrambi mentre ci trovavamo all’interno della Biblioteca e io sono stato inviato a cercarvi. Ma allora, cos’è successo al tuo amico?” Artyom gli raccontò tutta la storia dall’inizio alla fine, spiegandogli sinceramente com’era morto Daniel. Lo stalker trasalì. “È meglio che tu lo tenga per te. A essere onesti, preferivo di gran lunga la prima versione. Se rivelassi la seconda, i Bramini ti sommergerebbero di domande. Tu hai ucciso il loro uomo e non hai trovato il Libro, ma la ricompensa è rimasta a te. A proposito...”, aggiunse guardando Artyom corrucciato “Cosa c’era nella busta?” Alzandosi sui gomiti, il ragazzo estrasse dalla tasca il sacchetto ricoperto di sangue coagulato, guardò Melnik negli occhi e lo aprì. CAPITOLO 15 : LA MAPPA C’era un foglio di carta, preso da un vecchio blocco scolastico e ripiegato in quattro, oltre a un altro foglio, questa volta di una spessa carta da disegno, sul quale era stato tracciato a matita lo schema delle gallerie. Era esattamente ciò che Artyom si era aspettato di trovare all’interno della busta: una mappa e le spiegazioni per utilizzarla. Mentre percorreva di corsa la Prospettiva Kalininskiy per arrivare alla Smolenskaya non aveva avuto tempo per pensare a cosa potesse contenere la piccola busta che Daniel gli aveva affidato. La soluzione miracolosa a un problema all’apparenza irrimediabile, qualcosa che potesse liberare la VDNKh e l’intera Metropolitana da una minaccia incomprensibile e intollerabile. Nel mezzo del foglio con le spiegazioni c’era una macchia rossiccia. La carta ripiegata si era incollata a causa del sangue del Bramino e, perché rivelasse il suo messaggio, bisognava inumidirla leggermente e prestare attenzione, affinché le istruzioni scritte tanto accuratamente non si danneggiassero. “Numero di serie... galleria... D6... impianti intatti... circa 400.000 metri quadrati... una sorgente d’acqua... non totalmente funzionanti... imprevisti...”, le parole saltarono subito all’occhio di Artyom e, da una riga all’altra, si univano in un’unica frase. Tuttavia, il loro senso rimaneva oscuro. Non sarebbe mai riuscito a riordinarle in maniera sensata, perciò passò il messaggio a Melnik. Quest’ultimo prese il foglio tra le mani e, con moltissima cura, scrutò avidamente ciò che vi era scritto. Per un po’ non disse nulla, poi Artyom notò che le sue sopracciglia assumevano un piega sospettosa. “Non può essere”, sussurrò lo stalker. “Sono tutte sciocchezze! Non possono essersi lasciati sfuggire qualcosa del genere...” Girò il foglio, lo guardò dall’altro lato, poi ricominciò a leggerlo dall’inizio. “Se lo sono tenuti per loro... non l’hanno riferito ai militari. In realtà non mi sorprende... Se glielo avessero comunicato li avrebbero subito accusati di vivere nel passato”, Melnik borbottò frasi indistinte, mentre Artyom attendeva paziente delle spiegazioni. “Me se lo saranno davvero lasciati sfuggire? È danneggiata... Beh, partiamo dal presupposto che funzioni... Ciò significa che sono andati a controllarla!” “Può essere davvero una soluzione?”, domandò infine Artyom, che non riusciva più ad aspettare. “Se tutto ciò che è scritto qui sopra è vero, allora esiste una speranza”, annuì lo stalker. “Di che si tratta? Io non ci ho capito nulla”. Melnik non rispose subito. Rilesse ancora un volta il messaggio, dall’inizio alla fine, poi rifletté ancora per qualche secondo e solo in seguito cominciò il suo racconto: “Ne avevo già sentito parlare. Erano sempre circolate molte leggende a riguardo, ma nella Metro ce ne sono a migliaia, tu lo sai bene. Viviamo tutti di leggende, non solo di pane: quelle sull’Università, quelle sul Cremlino e sulla Polis, tanto che si giunge a un punto che non si riesce più a distinguere la verità dalle storie inventate attorno a un fuoco della Ploshchad Ilicha. Devi sapere che un tempo si sentiva spesso raccontare che da qualche parte all’interno o all’esterno della città di Mosca era rimasta intatta un’unità missilistica. Ovviamente, è impossibile che ciò possa essere accaduto, poiché le attrezzature militari sono sempre gli obiettivi primari. Ma le voci sostenevano che l’attacco non fosse andato a buon fine, che non l’avessero centrata oppure che se ne fossero dimenticati. Perciò, una delle unità non era stata per nulla danneggiata. Ritenevano che qualcuno ci fosse stato veramente, che avesse visto qualcosa e che presumibilmente le attrezzature fossero ancora nuove, coperte da un telone impermeabile, all’interno di un hangar... Naturalmente, non servirebbero a nulla dentro la Metro, perché non riescono a raggiungere in nemici a tali profondità. Sono ancora lì? Beh, lasciamocele”. “Ma cosa c’entrano le attrezzature missilistiche con tutto questo?”. Artyom osservava lo stalker meravigliato; quindi si mise seduto sul divano. “I Tetri sono arrivati alla VDNKh dall’Orto botanico. Hunter sospettava che fossero scesi all’interno della Metro dalla superficie, proprio in quella zona. È logico immaginare che vivano lì sopra. Per la verità, abbiamo due teorie: i fautori della prima ritengono che quelle creature vengano da un luogo che potremmo paragonare a una sorta di alveare, non lontano dall’entrata della Metro. Il secondo gruppo, invece, sostiene che non vi sia alcun alveare e che i Tetri arrivino da fuori città. In effetti, io mi sono sempre chiesto perché non li abbiamo mai notati da nessun’altra parte... Non mi pare logico!” “Ciononostante, forse è solo questione di tempo. Parliamoci chiaro: se giungono qui da un luogo lontano, non possiamo farci niente comunque. Dobbiamo far saltare in aria le gallerie al di là della VDNKh oppure persino oltre la Prospekt Mira, ma presto o tardi troveranno altre entrate”. “Barricarci all’interno della Metropolitana sarebbe la nostra unica possibilità. Dovremmo chiuderci qui dentro, scordarci di salire in superficie e vivere per sempre nutrendoci di maiali e funghi. Io sono uno stalker e posso dirti con certezza che in questo modo non dureremmo a lungo. Ma se questo alveare esistesse davvero e si trovasse nelle vicinanze della Metro, come pensava Hunter...” “Missili?”, suggerì infine Artyom. “Una salva di dodici razzi, con testate a frammentazione ad altissima carica esplosiva, coprirebbe una zona di circa 400.000 metri quadrati”, lesse Melnik, individuando subito il frammento di messaggio corretto. “Se diverse salve di questo tipo colpissero la zona dell’Orto botanico, li ridurrebbero in cenere”. “Ma ha appena detto che sono solo leggende”, obiettò Artyom. “Beh, i Bramini non la pensano allo stesso modo”. Lo stalker agitò il foglio. “Qui spiegano persino come giungere al luogo in cui si trova questa unità militare. Cionondimeno, affermano anche che parte di queste attrezzature sono inutilizzabili”. “E come facciamo ad arrivarci?” “D-6. Qui indica D-6. Cioè la Metro-2. Viene citata anche una delle entrate. Ritengono che la galleria conduca direttamente a quell’unità. Tuttavia, prevedono che per superare la Metro-2 potrebbero sorgere ostacoli inaspettati”. “Osservatori invisibili?”. Artyom ricordò una conversazione che aveva intrattenuto in passato. “Osservatori? Quelle sono solo sciocchezze!”. Melnik fece una smorfia. “Anche l’unità missilistica era solo una leggenda”, aggiunse Artyom. “E rimarrà tale finché non la vedrò con i miei occhi”, tagliò corto lo stalker. “Dove si trova l’uscita per la Metro-2?” “È scritto proprio qui: la Mayakovskaya. È molto strano... ho visitato quella stazione un’infinità di volte e non ne avevo mai sentito parlare”. “Allora che facciamo ora?”. Artyom non stava più nella pelle. “Vieni con me”, rispose lo stalker. “Mangerai un boccone, ti potrai rilassare un po’. Ne discuteremo domani”. Solo nel momento in cui Melnik pronunciò la parola boccone, Artyom si rese conto di avere una fame da lupi. Si alzò, mise i piedi sulle piastrelle fredde del pavimento e prese a barcollare verso gli scarponi, quando lo stalker lo fermò con un gesto. “Lascia le scarpe e tutti i tuoi vestiti qui, mettili in quello scatolone. Te li laveranno e li disinfetteranno. Controlleranno anche il tuo zaino. Là su quel tavolo ci sono un paio di pantaloni e una giacca, indossa quelli per il momento”. La Smolenskaya aveva un aspetto cupo, a causa del soffitto basso e semi circolare, dei piccoli archi e degli enormi muri ricoperti di marmo che un tempo era stato bianco. Sebbene le volte fossero sorrette da fittizie colonne decorative e un intonaco ben conservato adornasse la parte superiore delle pareti, tutto ciò non faceva altro che nutrire la sua prima impressione: la stazione sembrava una cittadella assediata da tempo, che i difensori avevano abbellito alla loro maniera, conferendole un aspetto ancor più severo. Le pareti di cemento armato sulle quali erano state montate immense porte d’acciaio da entrambi i lati della porta a pressione, i punti di fuoco in calcestruzzo all’entrata delle gallerie, tutto indicava che qui gli abitanti avessero motivo di temere per la loro incolumità. Alla Smolenskaya quasi non vi erano donne e tutti gli uomini erano armati. Quando Artyom domandò a Melnik cosa fosse accaduto alla stazione, lui scosse il capo in maniera vaga e sostenne di non notare nulla di insolito. Tuttavia, Artyom riusciva a percepire una strana sensazione di tensione che vorticava nell’aria, come se gli abitanti stessero aspettando che succedesse qualcosa. Le bancarelle erano sistemate in fila al centro dell’atrio, mentre gli archi erano tutti sgombri, come se temessero di bloccarli e di intralciare una possibile evacuazione d’emergenza. Gli alloggi, invece, erano situati esclusivamente negli spazi tra gli archi. A metà delle piattaforme, dove queste scendevano fin sui binari, stava il personale di guardia, che teneva le gallerie costantemente monitorate da entrambi i lati. L’assenza quasi totale di rumori rendeva l’immagine ancora più grottesca. Qui le persone parlottavano tra loro, talvolta sussurravano perfino, come se temessero che le loro voci potessero attirare dei rumori molesti provenienti dalle gallerie. Artyom cercò di ricordare cosa sapeva della Smolenskaya. Aveva forse dei vicini pericolosi? No: i binari, da una parte, conducevano alla sicurissima Polis, il cuore della Metro, mentre l’altra galleria portava alla Kievskaya, della quale Artyom ricordava solo che fosse popolata per lo più da quegli stessi “caucasici” che aveva incontrato per la prima volta alla KitayGorod e nelle celle dei fascisti, alla Pushkinskaya. Ma si trattava comunque di persone normali, perciò non c’era motivo di preoccuparsi tanto. Il refettorio si trovava nella tenda centrale. A giudicare da ciò che gli accadeva intorno, l’ora della cena era passata da un pezzo, perché ai tavoli grezzi, costruiti a mano, rimaneva solo qualche uomo. Artyom si sedette e dopo qualche minuto Melnik tornò con una ciotola piena di una pappetta liquida, grigia e fumante, di certo non invitante. Grazie allo sguardo rassicurante dello stalker, Artyom osò assaggiarla e non si fermò finché non ebbe ripulito la scodella. Il piatto locale si rivelò davvero notevole, sebbene fosse abbastanza difficile capire con quali ingredienti fosse stato preparato. Una cosa era certa: il cuoco non si era risparmiato nell’usare la carne. Una volta terminato di mangiare, Artyom ripose la ciotola in terracotta e si guardò attorno con più calma: due uomini erano ancora seduti al tavolo vicino al loro e parlavano a voce bassa. Indossavano delle normali giacche imbottite, ma c’era qualcosa nel loro aspetto che glieli faceva immaginare in tute protettive, armati di fucili automatici. Artyom notò che uno di essi scambiò uno sguardo con Melnik. Non dissero una sola parola. L’uomo con la giacca imbottita esaminò Artyom quasi con indifferenza, poi ritornò alla sua tranquilla conversazione. Passarono diversi minuti in silenzio. Artyom provò a parlare ancora una volta con lo stalker della stazione, ma Melnik rispose secco e con estrema riluttanza. Quindi l’uomo con la giacca imbottita si alzò dalla sedia, si diresse al loro tavolo e, piegandosi su Melnik, domandò: “Allora, cosa ne facciamo della Kievskaya? Siamo giunti al punto critico...” “Ok, Artyom, va’ a riposarti”, gli ordinò lo stalker. “La terza tenda che troverai è quella per gli ospiti. Il tuo letto è già stato preparato. Ho fatto sistemare tutto. Io starò qui ancora per un po’, devo discutere con questi ragazzi”. Artyom ebbe la sensazione, a lui ben nota, di essere mandato da qualche altra parte perché non ascoltasse le conversazioni degli adulti; tuttavia, il ragazzo obbedì, si alzò e si diresse verso l’uscita. Si consolò pensando che in questo modo avrebbe avuto tempo di dare un’occhiata da solo alla stazione. Guardò più da vicino e con maggiore attenzione: fu così che scoprì diverse piccole particolarità. L’atrio era stato ripulito alla perfezione, tutta la spazzatura che inevitabilmente si trovava nella maggior parte delle stazioni, qui era assente. La Smolenskaya era molto grande, ma non dava per nulla l’idea di essere abitata. All’improvviso si ricordò di un’immagine di un libro di storia, in cui era raffigurato un accampamento miliare di legionari romani. Nello spazio organizzato in maniera perfettamente simmetrica, dal quale si potevano controllare tutte le direzioni, non vi era nulla di superfluo; le guardie erano ovunque e rinforzavano sia le entrate che le uscite... Non riuscì a vagare per la stazione a lungo: dopo aver notato gli sguardi apertamente sospetti dei suoi abitanti, diversi minuti dopo Artyom comprese che lo stavano controllando e preferì ritirarsi nella tenda degli ospiti. Lo aspettava davvero un giaciglio pronto, mentre in un angolo trovò un sacchetto di plastica sul quale era stato scritto il suo nome. Artyom affondò nelle molle cigolanti della branda e lo aprì: all’interno c’erano le cose che aveva lasciato nel suo zaino. Infilò dentro la mano ed estrasse il libro per bambini che aveva portato con sé dalla superficie. Si domandò se avessero controllato questo piccolo tesoro con il contatore Geiger. Di sicuro, vicino a quel libro, il dosimetro avrebbe cominciato a emettere dei clic nervosi, ma Artyom preferiva non pensarci. Sfogliò diverse pagine, decifrando i disegni scoloriti sulla carta ingiallita, attardandosi su alcuni di essi per posticipare il momento in cui avrebbe trovato la sua fotografia tra le pagine successive. Era davvero la sua? Qualsiasi cosa sarebbe successa, sia a lui, che alla VDNKh e all’intera Metropolitana, prima sarebbe dovuto tornare alla sua stazione per chiedere a Sukhoi “Chi è la donna in questa foto? È davvero mia madre?”. Artyom poggiò le labbra sulla foto, poi la ripose di nuovo tra le pagine del libro, che nascose sul fondo del suo zaino. Per un secondo gli parve che tutta la sua vita assumesse un senso compiuto. Un momento più tardi si addormentò. Quando Artyom aprì gli occhi e uscì dalla tenda non si accorse nemmeno di quanto fosse cambiata la stazione. Erano rimasti solo una decina di alloggi intatti, mentre gli altri erano stati distrutti o bruciati. Le pareti erano ricoperte di fuliggine e piene di fori causati da proiettili, mentre l’intonaco si staccava dal soffitto a grossi pezzi che cadevano al suolo. Sui bordi delle piattaforme scorrevano minacciosi rigagnoli neri, che annunciavano l’imminente inondazione. L’atrio era praticamente deserto, a eccezione di una bambina che si trovava di fianco a una tenda ed era impegnata con i suoi giocattoli. Provenienti dall’altra piattaforma, dove si trovava una scala che conduceva a un’uscita, si udivano urla soffocate. All’interno dell’atrio erano rimaste accese solo due lampade d’emergenza che ne dissipavano l’oscurità. La mitraglietta che Artyom aveva lasciato vicino alla branda era scomparsa. La cercò dappertutto, ma invano. Alla fine si rassegnò al fatto di dover andare in perlustrazione disarmato. Cos’era accaduto? Il ragazzo avrebbe voluto domandarlo alla bambina che giocava, ma quando lei lo vide scoppiò in lacrime disperata: cercare di estorcerle delle informazioni era impossibile. Lasciò la bambina singhiozzante, passò sotto un arco e diede un’occhiata al sentiero. Il primo dettaglio che attirò la sua attenzione furono le tre lettere in bronzo avvitate al marmo: “V... NKh”. Dove sarebbe dovuta essere la “D” era visibile solo un alone scuro e una crepa profonda percorreva l’iscrizione marmorea. Doveva controllare cosa stava accadendo nelle gallerie. Se qualcuno aveva conquistato le stazioni, prima di tornare a chiedere aiuto, doveva comprendere la situazione e spiegare con esattezza ai suoi alleati meridionali quale fosse il pericolo che li minacciava. Subito dopo essere sceso sui binari, Artyom notò che l’oscurità era talmente impenetrabile che non riusciva a vedere più in là del suo naso. C’era qualcosa di insolito: rumori singolari provenivano dai recessi della galleria. Entrarci disarmati sarebbe stata una pazzia. Quando quel fracasso si interruppe per un momento, cominciò a udire quello dell’acqua che scorreva a terra, attorno ai suoi scarponi e si dirigeva verso la sua stazione, verso la VDNKh. Gli tremavano le gambe, che si rifiutavano di fare un passo in avanti. La voce nella sua testa non faceva altro che avvertirlo che era pericoloso entrare nel tunnel, che il rischio era troppo alto e che non sarebbe comunque stato in grado di comprendere cosa stava accadendo al buio. Ma un’altra parte del suo cervello, che non voleva prestare ascolto a tutti quelle argomentazioni sensate, lo spingeva sempre più all’interno della galleria, nell’oscurità. Si arrese e, come un giocattolo a molla, fece un passo in avanti. Le tenebre che lo circondavano divennero totali: non riusciva più a vedere nulla. Venne pervaso da una strana sensazione, come se il suo corpo fosse scomparso del tutto. Rimaneva solo la voce del suo io, che dipendeva in tutto e per tutto dalla sua mente. Artyom avanzò per diversi minuti, ma il rumore che proveniva dal luogo in cui cercava di dirigersi non si avvicinava. Poi ne udì degli altri: il fruscio di passi, identici a quelli che aveva sentito in precedenza, in un’oscurità molto simile, sebbene non si ricordasse dove e in quali circostanze. Più quei passi si avvicinavano dalle profondità ignote della galleria, più il ragazzo sentiva che un orrore freddo e oscuro gli penetrava nel cuore, goccia dopo goccia. Non riusciva a sopportare la sensazione, perciò qualche momento dopo si voltò e si mise a correre a perdifiato verso la stazione. Non potendo vedere le traversine nell’oscurità, inciampò su una di esse e cadde. Era consapevole che ormai fosse giunta la sua inevitabile fine. Si svegliò in un bagno di sudore e non si accorse subito di essere caduto dalla brandina durante il sogno. Si sentiva la testa insolitamente pesante, mentre un dolore sordo gli pulsava nelle tempie. Artyom rimase ancora per qualche minuto a terra, finché non si riprese del tutto, sebbene non fosse ancora in grado di reggersi in piedi. In quel momento riuscì a schiarirsi un po’ le idee: i resti dell’incubo erano completamente svaniti e non era più in grado di ricordare nemmeno una parte di ciò che aveva sognato. Alzò il lembo della tenda e sbirciò fuori. Oltre a qualche sentinella, sulla piattaforma non c’era nessun altro. Era già notte. Inspirò ed espirò profondamente la consueta aria umida per diverse volte, poi tornò all’interno della tenda, si stiracchiò sul suo giaciglio e si riaddormentò, sprofondando in un sonno senza sogni. Fu Melnik a svegliarlo. Indossava una giacca impermeabile scura, con il colletto alzato e pantaloni militari multitasche; sembrava fosse pronto a partire di lì a qualche minuto. In testa aveva lo stesso vecchio berretto nero, mentre vicino ai suoi piedi si trovavano due grandi sacche, che Artyom sapeva di aver già visto. Melnik ne avvicinò una ad Artyom, usando la punta del suo scarpone, poi disse: “Ecco. Scarpe, tuta, zaino e armi. Cambiati gli stivali e preparati. Non devi indossare alcuna protezione, perché per il momento non abbiamo intenzione di salire in superficie. Però portala con te. Ce ne andiamo tra mezz’ora”. “Dove siamo diretti?”, domandò Artyom con gli occhi ancora assonnati, mentre cercava di trattenere uno sbadiglio. “Kievskaya. Poi, se riuscirai, proseguiremo sull’Anello fino alla Belorusskaya e alla Mayakovskaya. Poi vedremo. Forza, preparati”. Lo stalker si sedette su uno sgabello nell’angolo e, dopo aver preso un pezzo di un foglio di giornale dalla tasca, cominciò a prepararsi una sigaretta. Di tanto in tanto lanciava un’occhiata ad Artyom e il suo sguardo vigile rendeva il ragazzo nervoso e maldestro. Tuttavia, dopo circa venti minuti, Artyom fu pronto. Senza dire una parola, Melnik si alzò dal suo sgabello, afferrò la borsa e uscì sulla piattaforma. Artyom guardò un’ultima volta la stanza e lo seguì. Passarono sotto un arco e uscirono dalla parte che conduceva ai sentieri. Percorsero le scale di legno utilizzate per scendere sui binari, Melnik fece un cenno con il capo alla sentinella e si mise a camminare in direzione della galleria. Solo in quel momento Artyom notò che le entrate sulle linee erano organizzate in maniera insolita: dalla parte della piattaforma che conduceva alla Kievskaya, metà del sentiero era bloccato da una postazione di cemento armato sulla quale troneggiava un’arma con piccoli spazi riservati ai fucili. Inoltre, c’era anche una grata metallica che ostruiva il passaggio e vi erano due pattugliatori di guardia. Melnik scambiò con loro frasi brevi e incomprensibili, in seguito alle quali una delle guardie aprì il blocco articolato e spinse la grata. Un lato della galleria era percorso da un cavo isolante nero, dal quale ogni dieci o quindici metri penzolavano deboli lampadine. Nonostante l’illuminazione fosse del tutto improvvisata, ad Artyom parve un vero e proprio lusso. Dopo circa trecento passi, il cavo si staccava e altre guardie li attendevano. I membri delle pattuglie non indossavano uniformi, ma avevano un aspetto molto più serio di quelli dell’esercito alla Polis. Riconobbero subito Melnik e uno di loro gli fece segno con la testa e li lasciò passare immediatamente. Quindi lo stalker si fermò al limitare della zona illuminata, prese una torcia dal suo zaino e la accese. Percorsero ancora qualche centinaio di metri, quindi udirono delle nuove voci e scorsero il bagliore di altre torce. Melnik si fece passare la mitraglietta dalla spalla alle mani, con un movimento pressoché impercettibile. Artyom seguì il suo esempio. Molto probabilmente si trattava di un’altra pattuglia della Smolenskaya, posizionata nelle profondità della galleria. Due grossi uomini armati, con giacche avvolgenti dal collo in pelliccia, stavano discutendo con tre venditori ambulanti. I pattugliatori indossavano cappelli fatti a maglia, mentre al collo avevano appesi degli strumenti per la visione notturna grazie a dei lacci in pelle. Anche due dei venditori erano armati, ma Artyom era pronto a scommettere che fossero davvero dei semplici commercianti. In mano tenevano enormi sacchi fatti di stracci e una mappa delle gallerie, mentre negli occhi avevano uno sguardo scaltro, che baluginava ai raggi delle torce; di uomini del genere ne aveva visti a centinaia. Di solito permettevano agli ambulanti di entrare in tutte le stazioni senza particolari problemi, ma sembrava che nessuno volesse accoglierli alla Smolenskaya. “Va tutto bene amico mio, vogliamo solo continuare su questa rotta”, uno dei commercianti cercava di convincere un membro della pattuglia, un uomo allampanato con i baffi, che indossava una giacca imbottita troppo stretta per lui. “Qui ci sono i nostri effetti personali, potete dare un’occhiata da voi. Vorremmo andare a vendere alla Polis”, gli fece eco l’altro ambulante, un tipo massiccio con i capelli che gli coprivano gli occhi. “Che male possiamo farvi? Qui dentro c’è solo della merce. Forza, date un’occhiata, ci sono dei jeans, che sembrano nuovi. Sono sicuro che ci sia anche la vostra taglia, sono di marca, ve ne posso regalare un paio”, il terzo prese l’iniziativa. La sentinella scosse il capo senza parlare, bloccando loro il passaggio. Non rispose, ma non appena uno degli ambulanti fece un passo in avanti, interpretando il suo silenzio come un assenso, entrambe le guardie fecero scattare le sicure delle loro mitragliatrici, quasi in simultanea. Melnik e Artyom stavano a circa cinque metri dietro di loro e, sebbene lo stalker avesse abbassato la sua arma, nel suo comportamento si notava una certa tensione. “Fermi! Vi do cinque secondi per girare i tacchi e andarvene. Questa è una stazione di sicurezza, qui non consentono a nessuno di entrare. Cinque... quattro...”, una delle sentinelle cominciò il conto alla rovescia. “Beh, ma allora come facciamo ad arrivarci? Dobbiamo passare di nuovo sull’Anello?”, era chiaro che uno degli ambulanti fosse pronto alla rissa, ma un altro scosse la testa rassegnato e lo prese per una manica. Pertanto i commercianti raccolsero i loro enormi sacchi da terra e fecero dietro front. Lo stalker e Artyom attesero per circa un minuto, dopodiché il primo fece segno al ragazzo e insieme ripresero il loro cammino verso la Kievskaya, alle spalle degli ambulanti. Mentre superavano i pattugliatori, uno di loro annuì silenzioso guardando Melnik e si portò due dita al lato della fronte, in segno di saluto. “Una stazione di sicurezza?”, Artyom chiese allo stalker non appena superarono lo sbarramento. Il ragazzo non ne poteva più dalla curiosità. “Che significa?” “Torna indietro e chiediglielo”, lo apostrofò l’uomo, e ciò gli fece capire che non doveva più porgli alcuna domanda. Sebbene Artyom e Melnik cercassero di stare qualche passo indietro dai commercianti, il suono delle loro voci si faceva sempre più vicino, finché non si interruppe all’improvviso. Non avevano percorso nemmeno venti metri, quando un fascio di luce li colpì direttamente negli occhi. “Ehi! Chi va là? Di cosa avete bisogno?”, urlò qualcuno nervoso e Artyom riconobbe la voce di uno degli ambulanti. “Calmatevi. Lasciateci passare e non vi infastidiremo. Siamo diretti alla Kievskaya”, rispose lo stalker tranquillo, ma con voce decisa. “Passate, vi lasceremo andare avanti. Non c’è bisogno che ci teniate il fiato sul collo”, annunciarono dall’oscurità, dopo aver conferito per qualche istante. Melnik scosse le spalle con disprezzo e si rimise in cammino senza alcuna fretta; i tre li attendevano a circa trenta metri. Quando Artyom e Melnik si avvicinarono, gli ambulanti poggiarono educatamente la merce a terra, li salutarono e permisero loro di passare. Lo stalker, come se nulla fosse, camminava davanti, ma Artyom aveva notato che la sua andatura era mutata: ora procedeva in silenzio, come se sperasse di smorzare il rumore dei suoi passi. I commercianti li seguivano a ruota, ma Melnik non gli prestò più attenzione. Artyom stesso aveva fatto del suo meglio per sopraffare il desiderio di voltarsi, ma dopo circa tre minuti si girò indietro. “Ehi!”, udirono una voce tesa provenire dalle loro spalle. “Aspettate!”, lo stalker si fermò. Artyom era perplesso: perché Melnik obbediva tanto prontamente a dei semplici venditori ambulanti? “Le regole sono così severe a causa della Kievskaya o perché devono proteggere la Polis?”, domandò uno dei commercianti dopo averli raggiunti. “Ovviamente a causa della Kievskaya”, rispose Melnik e Artyom percepì una fitta di gelosia perché lo stalker non aveva voluto rivelargli niente. “Sì, posso capirlo. La situazione sta diventando insostenibile, alla Kievskaya. Per ora va bene così, ma ben presto quei bacchettoni dovranno essere un po’ più elastici: la gente sta fuggendo in massa dalla Kievskaya. Chi rimarrà alla stazione? Meglio essere uccisi”, borbottò il venditore allampanato. “Tu avresti già imbracciato le armi?”, disse l’altro schiarendosi la voce con tono perfido. “Smettila, non fare l’eroe!” “Beh, se è per questo nemmeno tu”, rispose l’allampanato. “Ma cosa succede laggiù?”. Artyom non riuscì a trattenersi. I due commercianti lo guardarono come se gli avesse posto una domanda alla quale persino un bambino sarebbe stato in grado di rispondere. Lo stalker non aprì bocca e i venditori non risposero, al contrario rimasero in silenzio per diversi minuti. Per questo, o forse perché il silenzio si stava facendo alquanto sinistro, Artyom decise di non voler più alcuna spiegazione. Ma proprio nel momento in cui credeva di non avere più alcuna speranza di ricevere una risposta, l’uomo allampanato disse riluttante: “Le gallerie che conducono alla Parco della Vittoria sono laggiù, davanti a noi...” Udendo il nome della stazione, i suoi due colleghi si avvicinarono l’uno all’altro e Artyom immaginò per un istante che vi fosse una corrente di aria umida e fredda e che la galleria stesse crollando. Persino Melnik si strinse nelle spalle, come se cercasse di scaldarsi un po’. Artyom non aveva mai scoperto nulla di strano sulla Parco della Vittoria e non riusciva a ricordare di avere già sentito racconti riguardanti questa stazione. Allora perché si era sentito a disagio quando aveva udito quel nome? “Cosa? Sta peggiorando?”, domandò lo stalker in tono grave. “Noi che ne sappiamo? Siamo persone normali. Ci passiamo di tanto in tanto. Se ci andrete, lo capirete da voi”, borbottò vago l’uomo con la barba. “La gente scompare”, disse a bassa voce l’ambulante più tarchiato. “Sono molti quelli che hanno paura, perciò fuggono. Però non si riesce a capire chi scompare e chi se ne va di sua spontanea iniziativa, il che è peggio per coloro che rimangono”. “Queste gallerie sono dannate”, disse l’uomo allampanato e sputò a terra. “Ma sono bloccate”, affermò Melnik. “Sono bloccate da sempre e allora? Se non sei di queste parti, faresti meglio ad ascoltarci! Tutti sanno che queste gallerie fanno paura, anche se sono state fatte saltare in aria e sono state bloccate per tre volte. Tutti se lo sentono addosso, non appena arrivano qui, persino Sergeich, laggiù...”, l’allampanato indicò l’amico con la barba. “Proprio così”, confermò l’arruffato Sergeich e si fece il segno della croce, senza un motivo in particolare. “Ma quelle gallerie sono controllate, non è così?”, domandò Melnik. “I pattugliatori le percorrono tutti i giorni”, confermò l’uomo barbuto. “E hanno mai catturato qualcuno o visto qualcosa?”, incitò lo stalker. “Come facciamo a saperlo?”, il commerciante fece un gesto rassegnato. “Non ne ho idea, ma so che hanno cercato di prendere qualcuno”. “Cosa ne pensano coloro che vivono qui attorno?”, Melnik non aveva intenzione di mollare la presa. Il commerciante allampanato non rispose, gesticolò qualcosa di vago, ma si guardò indietro e disse con un sussurro ben udibile: “È la città dei morti”, e si fece di nuovo il segno della croce. Artyom sentiva il bisogno di scoppiare in una grassa risata, perché aveva già udito abbastanza storie, favole, leggende e teorie su dove si trovavano i morti all’interno della Metro: oltre alle anime nei tubi lungo le pareti delle gallerie e al cancello dell’inferno, a cui cercavano di arrivare scavando in una delle stazioni... ora c’era anche una città dei morti alla stazione Parco della Vittoria. Tuttavia, la spettrale corrente d’aria gli aveva stroncato la risata sul nascere e, nonostante gli abiti caldi che indossava, provò un brivido. Però, il peggio era che Melnik non disse più nulla e non pose più domande. Artyom sperava che l’uomo, sprezzante, avesse semplicemente scartato un’idea tanto assurda. Percorsero il resto della strada in silenzio, ciascuno immerso nei propri pensieri. La galleria era tranquilla, vuota, asciutta e sgombra, ma nonostante tutto, la sensazione di una disgrazia incombente pesava come un macigno su di loro e si intensificava passo dopo passo. Non appena entrarono in stazione, quel presentimento li investì, come un fiume sotterraneo, incontrollabile, torbido e agghiacciante. Qui la paura la faceva da padrona e lo si capiva dal primo istante in cui si metteva piede in stazione. Questo era il “sole di Kiev” di cui gli aveva parlato l’uomo con la pelle scura che stava con lui nella cella in cui lo avevano imprigionato i fascisti? Oppure si riferiva alla stazione dallo stesso nome sulla diramazione Filevskaya? Non si poteva dire che la stazione fosse del tutto dimenticata e che i suoi abitanti fossero fuggiti. In realtà qui vivevano molte persone, sebbene si avesse l’impressione che la Kievskaya non appartenesse ai suoi residenti. Cercavano tutti di stare gli uni vicini agli altri, le tende erano adiacenti ai muri, oppure attaccate l’una all’altra se si trovavano al centro dell’atrio. Qui la distanza di sicurezza prevista dalle regole antincendio non era rispettata in alcun modo: era chiaro che questa gente temesse qualcosa di più pericoloso del fuoco. I passanti distoglievano subito lo sguardo stanco non appena Artyom li guardava negli occhi e per evitare gli stranieri si dileguavano in direzioni diverse, come scarafaggi che si insinuano tra le crepe. La piattaforma era stretta all’interno di due file di archi bassi e rotondi, scendeva da una parte con diverse scale mobili, mentre dall’altra si rialzava; vi era infatti una piccola scala dove era stato riaperto il passaggio verso l’altra stazione. Carboni ardenti fumavano dappertutto e nell’aria aleggiava un invitante aroma di carne arrostita. Un bambino piangeva da qualche parte. Nonostante la Kievskaya si trovasse al limitare della città dei morti di cui avevano parlato i commercianti spaventati, la stazione era piena di vita. Salutarono velocemente gli ambulanti che scomparvero nel passaggio verso l’altra linea. Melnik diede un’occhiata prudente attorno e si mise a camminare risoluto lungo uno dei passaggi. Era chiaro che conosceva bene questa stazione, perciò Artyom non riusciva davvero a comprendere perché lo stalker avesse sommerso i commercianti di domande tanto dettagliate su quel luogo. Sperava che, inavvertitamente, potessero rivelare il vero stato in cui si trovava? Stava cercando di smascherare delle spie? Si fermarono per qualche istante all’entrata di un ufficio. La porta era stata scardinata, ma era comunque vigilata da una guardia. Artyom suppose si trattasse della sede delle autorità della zona. Lo stalker venne accolto da un uomo anziano, con la barba rasata e i capelli ben pettinati. Indossava una vecchia uniforme blu da operaio della Metropolitana, scolorita ma sorprendentemente pulita. Era ovvio che, in questa stazione, riusciva a prendersi cura di sé senza troppi problemi. L’uomo accolse Melnik, anch’egli usando le due dita a fianco della fronte, ma non era sincero come il pattugliatore all’interno della galleria, al contrario pareva un gesto eccessivo. Poi fece una smorfia ironica. “Buongiorno”, disse con una piacevole voce profonda. “Buongiorno signore”, rispose lo stalker e gli sorrise. Dieci minuti dopo erano seduti in una stanza riscaldata e bevevano il miglior tè di funghi che Artyom avesse mai assaggiato. Questa volta al ragazzo non venne ordinato di allontanarsi, così come si era aspettato, al contrario gli permisero di prendere parte alla discussione. Sfortunatamente non comprese nulla della conversazione tra lo stalker e il capo della stazione, che Melnik chiamava Arkadiy Semyonovich. Inizialmente Melnik gli chiese notizie di un certo Tretyak, poi domandò se vi erano dei cambiamenti nelle gallerie. Il capo riferì che Tretyak era partito per un viaggio personale, ma sarebbe dovuto tornare presto, perciò gli propose di attenderlo. Poi entrarono nel dettaglio di alcuni accordi e ben presto Artyom perse completamente il filo del discorso. Era seduto lì a guardarsi intorno e a sorseggiare del tè caldo, il cui aroma di funghi gli ricordava la stazione da cui proveniva. La Kievskaya aveva visto tempi migliori: alle pareti della stanza erano appesi arazzi rosicchiati dalle tarme, sebbene il disegno fosse completamente conservato. In alcuni punti, appena sopra le decorazioni, erano attaccate delle bozze disegnate a matita degli snodi delle gallerie, contornate da grosse cornici dorate. Il tavolo a cui erano seduti sembrava antico e Artyom non riusciva a immaginare quanti stalker ci erano voluti per portarlo dall’appartamento vuoto di qualcuno fino sottoterra e quanto denaro era stato disposto a pagare il responsabile della stazione. Su una delle pareti vi era anche una sciabola che si era scurita a causa del tempo, insieme a una pistola antichissima, che pareva essere inutilizzabile. Dall’altro capo della stanza, sopra un guardaroba, era posizionato un enorme teschio bianco di un essere sconosciuto. “Non c’è assolutamente niente in queste gallerie”, scosse il capo Arkadiy Semyonovich. “Continuiamo a controllarle, così la gente può stare tranquilla. Ci sei stato anche tu e sai bene che entrambe le linee sono state bloccate a circa trecento metri dalla stazione. È impossibile che ci sia qualcuno. Sono solo superstizioni”. “Ma le persone continuano a sparire?”, Melnik aggrottò le sopracciglia. “Sì, scompaiono”, concordò il capo. “Ma non si sa dove vadano. Io ritengo che fuggano. Non abbiamo sbarramenti ai passaggi e laggiù...”, indicò le scale con la mano. “Comincia un’intera città. Possono andare dove vogliono, sia sull’Anello che sulla Filevskaya. Alcuni sostengono che ora l’Hansa faccia uscire la gente dalla nostra stazione”. “Ma di cosa hanno paura?”, domandò lo stalker. “Di cosa? Della gente che scompare! È un circolo vizioso!”, affermò Arkadiy Semyonovich come se non potesse farci nulla. “È strano”, Melnik era sospettoso. “Mentre aspettiamo Tretyak, vorrei andare di nuovo con le guardie, giusto per conoscerle meglio. Spero che non gli dispiaccia”. “D’accordo”, annuì il capo. “Anton vive nella terza tenda. È il comandante del prossimo turno. Riferiscigli che ti mando io”. La tenda su cui era stato dipinto il numero “3” era molto rumorosa. Due bambini di dieci anni circa giocavano a terra con bossoli di armi automatiche. Insieme a loro c’era anche una bambina che osservava i suoi fratelli con enorme curiosità, ma che aveva deciso di non partecipare al gioco. Una bella signora di mezza età con indosso un grembiule stava affettando del cibo per la cena. L’ambiente era confortevole e nell’aria c’era un delizioso profumo di casa. “Anton è uscito un attimo. Sedetevi pure mentre aspettate”, offrì la donna, sorridendo cordiale. I bambini osservavano i due uomini molto attentamente, quindi uno si avvicinò ad Artyom. “Ha dei bossoli?”, domandò, guardandolo serio. “Oleg, smettila subito!”, lo riprese la donna, continuando a preparare la cena. Artyom rimase sorpreso dal fatto che Melnik si mise una mano in tasca, rovistò un po’ e ne estrasse diverse cartucce usate, insolitamente oblunghe, che di sicuro non erano stati usate per un Kalashnikov. Prima le strinse nel pugno, poi le fece risuonare, quindi lo stalker porse il tesoro al bambino. I suoi occhi si illuminarono immediatamente, ma non aveva il coraggio di accettare il regalo. “Prendili, forza!”, lo stalker gli fece un occhiolino e passò i bossoli nel palmo disteso del bambino. “Ora vincerò io! Guarda quando sono grossi! Saranno di uno Spetsnaz!”, il bambino gridò felice. Artyom aveva notato che i bossoli con cui i bambini stavano giocando erano stati posizionati su file identiche e a quanto pareva rappresentavano piccoli soldatini di piombo. Anche lui aveva giocato a quel modo un tempo, solo che era stato più fortunato perché aveva posseduto dei veri e propri soldatini, nonostante provenissero da collezioni diverse. A terra si stava svolgendo una battaglia, quando il padre dei bambini entrò nella tenda. Era un uomo basso, magro e con i capelli bagnati, di un color biondo scuro. Vedendo i due estranei, annuì in silenzio e, senza dire una parola, fissò Melnik. “Papà, papà, ci hai portato altri bossoli? Ora Oleg ne ha di più, gliene hanno dati alcuni lunghi!”, il secondo bambino, insistente, tirava i pantaloni del padre. “Siamo stati mandati dalle autorità della stazione”, spiegò lo stalker. “Verremo con voi nella galleria, di guardia. Come dei rinforzi”. “Altri rinforzi sono fuori discussione”, borbottò il capofamiglia, ma le rughe sul suo viso si rilassarono. “Io mi chiamo Anton. Mangeremo un boccone e andremo. Sedetevi pure”, e indicò dei sacchi riempiti che nella sua casa fungevano da sedie. Sebbene i due ospiti si rifiutarono più volte, alla fine dovettero cedere e accettare una ciotola fumante contenente dei tuberi che Artyom non aveva mai visto. Guardò lo stalker con aria interrogativa, ma quest’ultimo ne infilzò uno senza farsi troppi problemi, lo mise in bocca e cominciò a masticare. Il suo viso, solitamente così enigmatico, rifletteva una sensazione simile alla soddisfazione e ciò infuse coraggio nel ragazzo. Il sapore dei tuberi era completamente diverso da quello dei funghi: erano dolci e un po’ grassi. Artyom terminò la sua porzione in pochi minuti. Inizialmente, avrebbe voluto chiedere con cosa fosse stata cucinata la cena, ma poi rifletté che forse sarebbe stato meglio non saperlo. Erano buoni, e ciò era sufficiente. In alcuni luoghi il cervello di ratto veniva considerato una prelibatezza... “Papino, posso venire di guardia con te?”, domandò il bambino al quale lo stalker aveva dato i bossoli, dopo aver mangiato metà della sua porzione e aver spalmato il resto sui bordi della ciotola. “No, Oleg”, rispose il padrone di casa, corrucciando le sopracciglia. “Olezhenka! Cos’è questa storia della guardia? Cosa ti viene in mente? I bambini non ci possono andare!”, lo rimproverò la donna, prendendo per mano il figlio. “Mamma, perché parli di bambini?”, ribatté Oleg, osservando imbarazzato i due ospiti e cercando di pronunciare le parole con una voce più profonda. “Non pensarci nemmeno! Vuoi farmi venire un esaurimento nervoso?”, la madre aveva alzato ulteriormente il tono di voce. “Va bene, va bene”, borbottò il bambino. Tuttavia, non appena la donna si recò dall’altro lato della tenda per prendere qualcosa da mettere in tavola, il piccolo tirò la manica del padre e sussurrò: “Ma l’ultima volta mi hai portato con te...” “Il discorso è chiuso”, fece il padrone di casa severo. “Non importa...”. Oleg borbottò le sue ultime parole tra sé, in modo che gli altri non potessero sentirlo distintamente. Quando finirono di cenare, Anton si alzò dal tavolo, aprì la scatola in metallo che stava sul pavimento, ne estrasse un vecchio AK-47 dell’esercito e propose: “Andiamo? Oggi il turno è più breve, sarò di ritorno tra sei ore”, riferì alla moglie. Sia Melnik che Artyom si alzarono immediatamente. Il piccolo Oleg rivolse uno sguardo disperato al padre, si agitò sulla sua sedia, ma decise di non dire nulla. All’entrata oscura della galleria c’erano due guardie sedute sul bordo della piattaforma con le gambe penzoloni, mentre un terzo uomo bloccava il passaggio e osservava l’oscurità. Sulle pareti comparivano delle scritte: “Confederazione dell’Arbat. Benvenuti!”, le cui lettere erano quasi del tutto cancellate perché non venivano ritracciate da molto tempo. Le sentinelle conversavano a sussurri e si zittivano l’un l’altra se una alzava un po’ troppo la voce. Oltre allo stalker e ad Artyom, insieme ad Anton c’erano altri due uomini della zona. Entrambi erano molto seri e non propensi a fare conversazione; osservavano gli ospiti in modo malevolo e Artyom non riuscì mai a capire come si chiamavano. Scambiarono qualche frase con le persone di guardia all’entrata della galleria e si misero lentamente in cammino. Gli archi rotondi del tunnel erano convenzionali e le pareti sembravano essere rimaste intatte nel tempo. Tuttavia, la sensazione sgradevole di cui avevano parlato gli ambulanti aveva cominciato ad avvilupparsi attorno ad Artyom non appena aveva mosso i primi passi in quella galleria. Una tenebrosa e inspiegabile paura si rivelò dai recessi della galleria e gli diede il benvenuto. Al fronte, però, era tutto tranquillo. Da lontano si udivano voci umane, perché con tutta probabilità era stato posto uno sbarramento anche in quel luogo. Era uno degli appostamenti più strani che Artyom avesse mai visto. Diversi uomini sedevano in cerchio su sacchi pieni di sabbia; nel mezzo si trovava una stufa in ghisa, mentre a qualche metro di distanza c’era un secchio di nafta. I visi dei pattugliatori erano illuminati esclusivamente dalle fiamme che penetravano dalle fessure della stufa e dalla flebile e tremolante luce emessa dallo stoppino di una lampada a olio appesa al soffitto. Quest’ultima oscillava leggermente a causa delle stantie correnti d’aria della galleria e in questo modo sembrava che le ombre delle persone avessero vita propria. I membri della guardia sedevano con la schiena rivolta al tunnel, come se l’aria proveniente da quella direzione gli irritasse gli occhi. Proteggendosi con le mani dai raggi accecanti delle torce dei loro sostituti, le sentinelle si preparavano a tornare a casa. “Beh, com’è andata?”, domandò Anton a uno di loro, versando un po’ di combustibile nella stufa. “Come vuoi che sia andata?”, il membro più anziano della pattuglia sogghignò amaramente. “Come sempre. È vuota, tranquilla. Troppo tranquilla...”. Tirò su con il naso, si alzò e si mise a camminare in direzione della stazione. Mentre gli uomini rimasti avvicinavano i sacchi alla stufa e si sistemavano sopra di essi, Melnik si rivolse ad Anton: “Possiamo proseguire e andare a dare un’occhiata a quello che c’è là in fondo?” “Non c’è nulla da vedere, la galleria è bloccata. L’ho vista centinaia di volte. Va’ a controllare, se lo desideri, si trova a una quindicina di metri da qui”, Anton indicò alle sue spalle, in direzione della Parco della Vittoria. Prima del vero e proprio blocco, la galleria era praticamente crollata. Il terreno era ricoperto di frammenti di roccia e terriccio, mentre in alcuni punti il soffitto era imbarcato, le pareti si sbriciolavano, anche perché si erano avvicinate le une alle altre. Su un lato si trovava un’entrata di uffici non altrimenti identificati, dalla quale era stata scardinata la porta: qui l’oscurità era imperante e alla fine di questa appendice le rotaie arrugginite erano state ammonticchiate su un lato, in una pila ricoperta da blocchi di cemento mischiati a ciottoli e terra. Anche i tubi di metallo che percorrevano le pareti erano immersi in quello stesso strato di terriccio. Illuminando la galleria crollata con la torcia, senza trovare alcuna botola segreta, Melnik scrollò le spalle e rivolse la sua attenzione alla porta sbilenca. Puntò il fascio di luce e guardò all’interno, ma non superò la soglia. “Nemmeno sulla seconda linea ci sono stati cambiamenti?”, domandò ad Anton, non appena ritornò nei pressi della stufa. “Tutto è ancora com’era dieci anni fa”, rispose l’uomo. Rimasero in silenzio per diverso tempo. Le torce erano state spente, perciò la luce proveniva esclusivamente dalla stufa bucherellata e dalla piccola fiamma che danzava oltre il vetro fuligginoso della lampada a olio; l’oscurità che li circondava era densa. Tutte le sentinelle si erano avvicinate il più possibile alla stufa perché i suoi raggi gialli riuscivano a scacciare il buio e il freddo e si respirava con molta meno difficoltà. Artyom aveva cercato di resistere il più possibile, ma il desiderio di sentire un qualsiasi tipo di rumore lo aveva spinto a superare la timidezza: “Non ero mai stato alla vostra stazione prima d’ora”, disse ad Anton tossendo. “Tuttavia, non riesco a capire perché siete di guardia qui, se non c’è niente... Inoltre, non controllate nemmeno nella direzione giusta!” “Così vanno le cose...”, spiegò Anton. “Sembra che qui non vi sia nulla proprio perché siamo di pattuglia”. “Cosa c’è laggiù, oltre quel blocco?” “Vogliamo pensare che vi sia la galleria che arriva...”, si interruppe per un istante e si voltò a osservare la strada senza uscita “fino alla Parco della Vittoria”. “Laggiù ci vive qualcuno?” Anton non rispose e scosse solo vagamente il capo. Rimase in silenzio per un altro po’, quindi domandò interessato: “Non sai nulla della Parco della Vittoria?”, e senza nemmeno attendere una risposta da parte di Artyom continuò: “Chissà cosa diavolo c’è laggiù... In passato era un’enorme stazione, che aveva anche una gemella, fu una delle ultime a essere edificata. I più anziani l’avranno visitata a quel tempo... beh... finché... In ogni caso, si racconta fosse lussuosissima, ma anche molto profonda, non come le altre stazioni più recenti. Si deve pensare che la gente laggiù vivesse nell’abbondanza. Malgrado ciò, non durò a lungo. Ben presto la galleria franò”. “Come successe?”, domandò Artyom. “Si ritiene”, Anton diede un’occhiata furtiva agli altri, “che crollò da sola. Era stata progettata male oppure i materiali che la sostenevano erano stati rubati o un’altra ragione di questo tipo. È accaduto così tanto tempo fa che nessuno lo ricorda con esattezza”. “Beh, io ho sentito dire”, cominciò una delle sentinelle “che le autorità della stazione fecero esplodere entrambe le gallerie. Pareva fossero in competizione con quelle della Parco della Vittoria o qualcosa del genere... Forse temevano che, con l’andar del tempo, la stazione rivale le avrebbe sottomesse. Si sa chi era a capo della Kievskaya allora... chi gestiva gli affari. I personaggi più in vista, che sono abituati a fare sparire le prove. Una scatola di dinamite in questa galleria, un’altra nella successiva, ancora un po’ vicino alla stazione e... bum! Il problema venne risolto senza spargimento di sangue”. “Ma cosa può essere accaduto agli abitanti?”. Artyom si era incuriosito. “Non lo sappiamo con certezza, quando siamo arrivati qui...”. Anton era in procinto di cominciare a raccontare, ma la sentinella che aveva parlato in precedenza lo interruppe: “Cosa può essere successo? Sono morti tutti! Devi capire che quando una stazione viene isolata dal resto della Metropolitana, non può sopravvivere a lungo. I filtri si bloccano, oppure si inceppano i generatori o si allaga. Non possiamo permetterci di vivere in superficie, nemmeno adesso. Ho sentito dire che inizialmente avevano provato a scavare, ma poi ci avevano rinunciato. Coloro che stavano di guardia qui riferivano di udire urla che giungevano attraverso le tubature... Ma ben presto smisero anche di gridare”. Tossì e allungò le mani verso la stufa e non appena si furono scaldate, il pattugliatore osservò Artyom e aggiunse: “Non c’era nemmeno una guerra in corso. Chi combatte così? Al di là c’erano donne e bambini, persino anziani... un’intera città. E perché lo hanno fatto? Semplice: non avevano intenzione di spartire il denaro. Loro avevano la coscienza a posto, non avevano ucciso nessuno. Però... Qual era la tua domanda? ‘Cosa c’è laggiù, oltre quel blocco?’ C’è la morte”. Anton scosse il capo ma non proferì parola. Melnik osservava Artyom con estrema attenzione e per poco non aprì la bocca per aggiungere un dettaglio alla storia appena ascoltata, ma ci ripensò. Il ragazzo ora aveva molto freddo e anch’egli si avvicinò un po’ di più alla stufa. Cercò di immaginare cosa significasse vivere in quella stazione, i cui abitanti credevano che i binari che passavano sotto le loro tende conducessero direttamente al regno dei morti. Pian piano Artyom comprese che il bizzarro posto di guardia all’interno del tunnel bloccato non era davvero necessario, ma era più che altro un rituale. Chi cercavano di spaventare standosene seduti lì? A chi impedivano di giungere alla stazione e nel resto della Metropolitana? Si fece sempre più freddo: né la stufa di ghisa né la calda giacca che gli aveva dato Melnik gli impedivano di rabbrividire. All’improvviso, lo stalker si voltò verso la galleria che conduceva alla Kievskaya, si alzò, controllò attentamente lo spazio attorno a sé e si mise in ascolto. Persino Artyom comprese in pochi secondi la ragione della sua inquietudine: si stavano avvicinando passi veloci e leggeri, mentre in lontananza si intravvedeva il tenue bagliore di una torcia che ballonzolava qua e là, come se colui che la teneva in mano stesse andando di fretta e saltasse da una traversina all’altra per raggiungere il gruppo di guardia il più velocemente possibile. Lo stalker si avvicinò al muro e puntò la mitraglietta verso la fonte luminosa. Anton si alzò piano, scrutò le tenebre e, dalla sua espressione, si riusciva a comprendere che non fosse per nulla preoccupato, perché da quella parte della galleria non sarebbe mai potuto arrivare alcun pericolo serio. Melnik accese la sua torcia e l’oscurità si dissolse quasi a fatica. A una decina di metri da loro, in mezzo ai binari, c’era una piccola sagoma delicata che se ne stava immobile con le braccia alzate. “Papino, sono io! Non sparate!”, era la voce di un bambino. Lo stalker spostò il raggio della torcia in quella direzione e, spolverandosi, si alzò da terra. Il piccolo raggiunse la stufa in meno di un minuto e, imbarazzato, si fissava la punta delle scarpe. Era il figlio di Anton, quello che gli aveva chiesto di montare di guardia insieme a lui. “È successo qualcosa?”, domandò il padre preoccupato. “No... volevo solo stare con te. Non sono più un bambino che deve stare nella tenda con la mamma”. “Come sei riuscito ad arrivare fin qui? C’è una guardia laggiù!” “Ho mentito. Ho detto che la mamma mi aveva chiesto di venire a chiamarti. C’era lo zio Petya, che mi conosce. Mi ha solo ordinato di non guardare in nessuno dei sentieri laterali e di sbrigarmi, così mi ha permesso di passare”. “Più tardi farò un’altra chiacchierata con lo zio Petya”, promise solennemente Anton. “Tu intanto pensa a come lo spiegherai a tua madre. Non ti lascio tornare indietro da solo”. “Posso rimanere con te?”, il bambino quasi non riusciva a contenere la gioia e si mise a saltellare in giro. Anton si spostò di lato, facendo sedere il figlio su uno dei sacchi presso la stufa. Si tolse la giacca per avvolgerlo, ma il bambino scivolò sul pavimento e, estraendo dalla tasca ciò che aveva portato con sé, sistemò il tutto su un fazzoletto: si trattava di una manciata di bossoli e di diversi altri oggetti. Si sedette di fianco ad Artyom, che ebbe il tempo di controllare di che cosa si trattava. Una scatoletta in metallo con una piccola manovella attirò subito la sua attenzione. Oleg la teneva con una mano e con l’altra girava la levetta. In questo modo la scatoletta emetteva un suono metallico, una semplice melodia malinconica. Era ancor più divertente perché, se la si poggiava su un altro oggetto, quest’ultimo risuonava, amplificandone il rumore. Il risultato migliore si aveva con la stufa in ghisa, ma non si poteva lasciarla appoggiata troppo a lungo, perché si scaldava in fretta. Il gioco era talmente intrigante che Artyom decise di provare da sé. “Fa’ attenzione!”, disse il bambino, dandogli la scatoletta bollente e soffiandosi sulle dita bruciate. “Più tardi ti mostrerò un altro trucchetto”, assicurò misterioso. La mezz’ora successiva trascorse lentamente. Artyom, non notando gli sguardi infastiditi delle sentinelle, continuava a girare la piccola manovella all’infinito e ascoltava la musica, mentre Melnik sussurrava qualcosa ad Anton e il bambino giocava a terra con i bossoli. La melodia del piccolo carillon era alquanto monotona, ma aveva un suo fascino. Gli risultava impossibile fermarsi. “No, non capisco”, disse lo stalker e si alzò. “Se entrambe le gallerie sono crollate e vengono protette, secondo te dove vanno a finire le persone che scompaiono?” “Chi l’ha detto che succede tutto in quelle gallerie?”. Anton lo scrutò dal basso in alto. “Ci sono anche dei passaggi che conducono su altre linee, due in tutto, oltre ai binari che portano verso la Smolenskaya... Dico solo che qualcuno si sta prendendo gioco di noi facendo leva sulle nostre superstizioni”. “Ma quali superstizioni!”, interruppe il pattugliatore che aveva raccontato la storia dei tunnel fatti saltare in aria e della gente rimasta dall’altra parte. “La maledizione della nostra stazione è la Parco della Vittoria. Siamo stati condannati a conviverci per sempre...” “Tu, Sanych, rendi le cose più difficili”, lo interruppe Anton disgustato. “Qui c’è gente che pone domande serie e tu vai in giro a raccontare le tue storielle!” “Facciamo quattro passi. Ho visto delle porte e un’uscita laterale mentre venivamo qui. Voglio dare un’occhiata”, gli riferì Melnik. “Anche alla Smolenskaya hanno paura. Kolpakov è personalmente interessato alla questione”. “Adesso gli interessa, eh?”. Anton abbozzò un sorriso triste. “Persino alla Polis si stanno già facendo qualche domanda”, lo stalker estrasse dalla tasca un foglio di carta piegato. Artyom lo aveva già visto alla Polis. In uno dei passaggi erano in vendita su un vassoio, ma costavano dieci cartucce e non valeva la pena pagare così tanto per un pezzo di carta da imballaggio sul quale era stata stampata qualche notizia. Al contrario, sembrava che per Melnik quelle dieci cartucce non facessero la differenza. Diversi articoletti erano ammassati sotto l’orgoglioso nome di “Notizie dalla Metro”; la carta era giallognola e tagliata in maniera imprecisa. Uno degli articoli era persino corredato da una fotografia in bianco e nero. Il titolo richiamava l’attenzione dei lettori: “Continuano le misteriose sparizioni alla Kievskaya”. “Sostengono che i fumatori siano ancora vivi”, Anton prese il pezzo di giornale con cautela e lo appianò. “Ok, andiamo. Ti mostrerò le biforcazioni laterali, sempre che tu la smetta di leggere...” Lo stalker annuì, Anton si alzò, guardò suo figlio e gli disse, perentorio: “Io torno subito. Non fare il cattivo mentre io non ci sono”. Poi, rivolgendosi ad Artyom, domandò: “Puoi tenerlo d’occhio, per favore?” Il ragazzo non poté fare altro che annuire. Non appena il padre si fu allontanato insieme allo stalker, Oleg saltò in piedi e con uno sguardo da monello rubò il carillon dalle mani di Artyom, poi gli urlò: “Prendimi!”, e si mise a correre verso la strada senza uscita. Il bambino era sotto la sua responsabilità, perciò Artyom lanciò un’occhiata colpevole alle altre guardie, accese la torcia e si mise a inseguire Oleg. Il bambino non si fermò a indagare all’interno dell’ufficio semi distrutto, come il ragazzo aveva temuto, al contrario lo aspettava di fianco all’ostruzione. “Senti cosa succede ora!”, esclamò il piccolo. Oleg si inerpicò sulle rocce, raggiunse il livello delle tubature e scomparve tra le macerie. Poi prese il suo piccolo carillon, lo appoggiò sul tubo e girò la manovella. “Ascolta!” Il tubo si mise a ronzare, poi a risuonare, come se quella semplice e triste melodia lo riempisse dall’interno. Quindi, il bambino poggiò l’orecchio al tubo e, come stregato, continuò a girare la manovella per fare in modo che il carillon non smettesse di suonare. Si fermò per un istante, ascoltò e sorrise felice, poi saltò giù dall’ammasso di detriti e porse la scatoletta di metallo ad Artyom: “Forza, prova anche tu!” Artyom già immaginava come sarebbe cambiata la melodia attraverso il tubo cavo di metallo, ma gli occhi del bambino erano talmente vivi che decise di non fare il guastafeste e di provare anche lui. Appoggiò il carillon al tubo, premette l’orecchio contro il metallo freddo e girò la manovella. La musica prese a risuonare talmente forte che quasi spostò di scatto la testa. Artyom non era pratico delle leggi dell’acustica, ma in ogni caso non riusciva a capire come quel pezzo di metallo potesse miracolosamente amplificare la melodia emessa da un carillon tanto piccolo. Girò la manovella ancora per qualche secondo e risentì il motivetto per ben tre volte, poi concordò con Oleg: “È magnifico”. “Ascolta di nuovo”, il bambino si mise a ridere. “Non farlo suonare, ascolta e basta!” Artyom fece spallucce e lanciò un occhiata al posto di guardia per controllare che Melnik e Anton non fossero ritornati, quindi avvicinò di nuovo l’orecchio al tubo. Cosa si sarebbe sentito ora? Il vento? L’eco dello spaventoso rumore che riempiva le gallerie tra l’Alekseevskaya e la Prospekt Mira? Da una distanza inconcepibile, facendosi strada con difficoltà verso la crosta terrestre, giungevano rumori soffocati. Non c’era alcun dubbio: provenivano dalla direzione della Parco della Vittoria, nella quale in realtà sarebbero dovuti essere tutti morti. Artyom, scioccato, rimase immobile ad ascoltare; quando si calmò, cominciò a comprendere: stava udendo qualcosa di impossibile. Udiva della musica. Qualcuno o qualcosa, a diversi chilometri dal punto in cui si trovava, stava riproducendo, nota dopo nota, la musica malinconica del carillon. Tuttavia, era chiaro che non si trattasse di un’eco: il musicista sconosciuto aveva sbagliato in diversi punti, aveva accorciato una nota, ma il motivo rimaneva riconoscibile. Soprattutto, non si trattava di un fischio acuto, ma il rumore somigliava più a quello emesso da una persona che canticchia tra sé... o era un vero e proprio canto? Il coro indefinito di una moltitudine di voci? No, stavano più altro canticchiando... “Allora, lo senti?”, domandò Oleg sorridendo. “Zitto, sto ancora ascoltando! Che cos’è?”, borbottò Artyom con voce rauca, muovendo a malapena le labbra. “È musica! Il tubo suona!”, spiegò semplicemente il bambino. L’impressione mesta e opprimente che questo canto inquietante aveva risvegliato in Artyom sembrava non aver avuto alcun effetto sul ragazzino, per il quale tutto ciò era solo un bel gioco: non si sarebbe mai chiesto come riusciva a sentire una melodia proveniente da una stazione tagliata fuori dal resto del mondo, da cui i vivi erano scomparsi più di dieci anni prima. Oleg salì di nuovo sulla montagna di detriti e si preparava a riavviare il piccolo carillon. Artyom, però, percepì un’improvvisa sensazione di timore inspiegabile, sia per il bambino che per sé, perciò lo afferrò per la mano e, senza prestare attenzione alle sue proteste, lo trascinò di nuovo vicino alla stufa. “Codardo che non sei altro!”, si dimenò Oleg. “Solo i bambini credono a queste favole!” “Quali favole?”, Artyom si fermò per un istante e lo osservò negli occhi. “Che prendono i bambini che entrano nelle gallerie ad ascoltare i tubi!” “Chi li prende?”, Artyom lo fece avvicinare ancora di più alla stufa. “I morti!” La conversazione si interruppe così, anche perché una sentinella che esponeva le sue idee sulla dannazione gli lanciò un’occhiataccia tale che non dissero una parola di più. La loro avventura era terminata giusto in tempo: Anton e lo stalker stavano tornando al posto di guardia, accompagnati da una terza persona. Artyom mise subito a sedere il bambino: il padre gli aveva chiesto di tenere d’occhio Oleg e di non assecondare i suoi capricci. Inoltre, chissà in quali superstizioni credeva Anton... “Scusate, siamo stati trattenuti”, Anton si lasciò cadere sul sacco di fianco ad Artyom. “Ha fatto il bravo, vero?” Artyom annuì, sperando che il bambino avesse il buonsenso di non andare a spifferare la loro avventura al padre. Tuttavia, sembrava proprio che il ragazzino sapesse il fatto suo. Oleg, con sguardo rapito, si dedicò nuovamente ai suoi bossoli. Artyom non conosceva il terzo uomo che era arrivato con Anton e con lo stalker, che era pressoché calvo, magro, con le guance infossate e le borse sotto gli occhi. Si avvicinò alla stufa solo per un istante e fece un cenno agli altri pattugliatori, così il ragazzo ebbe il tempo di guardarlo più da vicino, ma non gli rivolse la parola; fu Melnik a presentarli. “Questo è Tretyak”, disse rivolgendosi ad Artyom. “Proseguirà con noi. È uno specialista: lui è un esperto di missili”. CAPITOLO 16 : LA MELODIA DEI MORTI “Qui non ci sono entrate segrete e non ce ne sono mai state. Lo sai anche tu, vero?”. Tretyak aveva alzato la voce con disprezzo e le sue parole giunsero fino ad Artyom. Stavano ritornando dalla guardia verso la stazione della Kievskaya. Lo stalker e Tretyak camminavano qualche metro indietro rispetto agli altri e discutevano animatamente. Quando Artyom gli si avvicinò per partecipare alla conversazione, i due uomini si misero a sussurrare e perciò non gli rimase altro che tornare dagli altri. Il giovane Oleg, che saltellava qua e là, cercando di non farsi superare dagli adulti, si era rifiutato categoricamente di salire sulle spalle del padre. Ma quando Artyom gli fu a fianco lo prese immediatamente per mano. “Anche io sono un esperto di missili!”, annunciò. Artyom, sorpreso, osservò il bambino: quando Melnik gli aveva presentato Tretyak, Oleg era nelle vicinanze e di sicuro aveva udito le parole pronunciate dallo stalker. Ma sapeva cosa significavano? “Però non devi dirlo a nessuno!”, aggiunse Oleg di tutta fretta. “Gli altri non possono saperlo: è un segreto!” “Ok, non ne parlerò con nessuno”, Artyom stette al suo gioco. “Non c’è nulla di cui vergognarsi, anzi, il contrario! Bisogna andarne fieri, anche se le altre persone potrebbero dirti delle cattiverie, perché sono invidiose!”, spiegò il bambino, sebbene Artyom non intendesse domandargli alcuna delucidazione. Anton procedeva a una decina di metri da loro e illuminava il sentiero. Il bambino fece un cenno in direzione del padre e sussurrò rumorosamente: “Papà dice di non mostrarlo a nessuno, ma tu sai come si mantengono i segreti. Guarda!”, da una tasca interna estrasse un piccolo frammento di tessuto. Artyom lo illuminò con la torcia: si trattava di uno stemma logoro, un cerchio di una spessa sostanza gommata, di sette centimetri di diametro. Su un lato era tutto nero, mentre sull’altro vi era rappresentato un disegno incomprensibile sul quale, su uno sfondo scuro, si incrociavano tre oggetti oblunghi del tutto simili ai fiocchi di neve a sei punte fatti di carta che usavano per decorare la VDNKh quando si festeggiava il nuovo anno. Uno degli oggetti era posizionato in verticale e Artyom riconobbe subito una cartuccia di una mitragliatrice o quella di un fucile da cecchino, sebbene sul fondo vi fossero applicate un paio di ali; al contrario, non riconobbe gli altri due oggetti identici, gialli, con anelli su entrambi i lati. Il misterioso fiocco di neve era circondato da una sorta di corona stilizzata, come una vecchia coccarda, e tutt’attorno c’erano delle lettere. Il colore era sbiadito, quindi Artyom riuscì solo a leggere “... truppe ed es...”, oltre alla parola “... ussia” nella parte inferiore, sotto la figura. Se avesse avuto un po’ più di tempo, sarebbe stato in grado di comprendere ciò che gli aveva appena mostrato il bambino, ma non ci riuscì. “Ehi, Olezhek! Vieni, c’è qualcosa per te!”, Anton chiamò il figlio. “Cos’è?”, gli domandò Artyom, prima che il bambino gli prendesse lo stemma di mano e se lo nascondesse di nuovo in tasca. “RVA!”, scandì Oleg, raggiante d’orgoglio. Gli fece l’occhiolino, poi raggiunse il padre. I membri della pattuglia salirono sulla piattaforma tramite una scala a libretto, poi cominciarono a disperdersi e a tornare verso le loro tende. La moglie di Anton lo aspettava all’uscita della galleria. Con le lacrime agli occhi, si lanciò verso il piccolo Oleg, lo prese per un braccio, poi strillò al marito: “Vuoi che muoia dal dispiacere? Che cosa avrei dovuto pensare? Il bambino era uscito di casa da ore! Devo addossarmi io tutta la responsabilità? Anche tu sei un bambino: non potevi riportamelo indietro?”, urlava. “Len, ti prego, non di fronte a tutta questa gente”, borbottò Anton guardandosi attorno imbarazzato. “Non potevo abbandonare il posto di guardia. Rifletti su quello che stai dicendo: il comandante di avamposto che lo abbandona all’improvviso...” “Ah! Un comandante! Allora va’ e comanda! Come se non sapessi cosa succede laggiù! Il bambino dei vicini è scomparso una settimana fa...” Melnik e Tretyak accelerarono il passo e non si fermarono nemmeno a salutare Anton, lo lasciarono discutere in pace con la moglie. Artyom li seguì in fretta. Anche se ormai non riuscivano più a distinguere le parole, le urla e i pianti della moglie di Anton li raggiungevano anche da lontano. I tre erano diretti verso gli uffici, dove si trovava anche il capo della stazione. Dopo qualche minuto, erano già seduti all’interno della stanza con gli arazzi logori. Il capo stesso, dopo aver annuito con aria d’intesa, se ne andò quando lo stalker gli chiese di lasciarli soli. “È vero che non hai il passaporto?”, si informò Melnik, rivolgendosi ad Artyom. Il ragazzo scosse il capo: gli era stato confiscato dai fascisti e senza il suo documento di riconoscimento si era trasformato in un emarginato sociale. L’Hansa, la linea Rossa e la Polis non l’avrebbero mai accettato. Da quando era con lo stalker, nessuno gli aveva mai posto alcuna domanda personale, ma se si fosse ritrovato da solo, avrebbe dovuto vagare tra le stazioni minori e quelle non civilizzate, quelle come la Kievskaya. Inoltre, non si sarebbe nemmeno potuto sognare di ritornare alla VDNKh. “Non riuscirò a farti ammettere all’interno dell’Hansa senza passaporto. Prima dovrò contattare chi di dovere”, affermò Melnik a conferma delle riflessioni di Artyom. “Potremmo riuscire a ottenerne uno nuovo, ma ci vorrà del tempo. La strada più corta per arrivare alla Mayakovskaya è sull’Anello, che ci piaccia o no. Perciò che facciamo?” Artyom scrollò le spalle. Lo stalker aveva ragione: non poteva aspettare e a lui non sarebbe stato concesso di entrare nel territorio dell’Hansa per giungere alla Mayakovskaya. La galleria che ci arrivava dalla direzione opposta passava dalla Tverskaya, ma sarebbe stata una follia tornare nel covo dei fascisti e nella stazione trasformata in una prigione sotterranea. Non c’era altra scelta. “Sarebbe meglio che io e Tretyak ci recassimo subito alla Mayakovskaya”, Melnik si mise a spiegare il suo piano. “Cercheremo l’entrata della D-6. Non appena la troveremo, torneremo a prenderti e forse nel frattempo avremo anche trovato una soluzione per il passaporto. Ci metterò io una buona parola. Al contrario, se non troviamo questa entrata, torneremo comunque qui. Non ci dovrai aspettare a lungo. Ci arriveremo abbastanza velocemente. Dovremmo riuscire a fare tutto in un giorno. Starai qui ad aspettarci?”, osservò Artyom con un’espressione interrogativa. Artyom scrollò di nuovo le spalle. Gli pareva che lo stessero trattando come un bambino. Lui aveva portato a termine la sua insignificante missione, gli aveva raccontato del pericolo e ora loro non lo volevano tra i piedi. “Eccellente”, commentò lo stalker. “Torneremo in mattinata. Ci metteremo in cammino subito, per non perdere altro tempo. Per quanto riguarda il vitto e l’alloggio, ne discuteremo con Arkadiy Semyonovich. Sarà molto gentile con te, non preoccuparti! Mi sembra tutto... No, aspetta”, si toccò una tasca ed estrasse dei fogli di carta macchiati di sangue: la mappa e le spiegazioni. “Prendila. Io l’ho ricopiata. Non si può mai sapere come andranno le cose. Però ti prego di non mostrarla a nessuno...” Melnik e Tretyak partirono meno di un’ora più tardi, non prima di aver parlato con il capo della stazione. Arkadiy Semyonovich fu di parola e accolse subito Artyom nella sua tenda, lo invitò a cenare con lui quella stessa sera, poi andò a riposarsi. L’alloggio per gli ospiti era isolato rispetto agli altri ed era mantenuto in ottime condizioni. Ciononostante, al suo interno, Artyom si sentì a disagio sin dall’inizio. Diede un’occhiata fuori e notò di nuovo che le altre tende erano ammassate le une accanto alle altre, posizionate il più lontano possibile dalle entrate delle gallerie. Ora che lo stalker era partito, Artyom era solo in una stazione sconosciuta e così gli ritornò quella sensazione di disagio che aveva già provato in precedenza. In ogni caso, la Kievskaya lo spaventava, sebbene non vi fosse una ragione evidente. Si stava già facendo tardi. Le voci dei bambini sparivano pian piano e gli adulti uscivano di rado dalle loro tende. Artyom non aveva intenzione di vagare per la piattaforma, perciò si mise a rileggere per la terza volta i fogli che gli aveva affidato Daniel in punto di morte, ma dopo un po’ non ce la fece più e si incamminò per andare a cena da Arkadiy Semyonovich, con mezz’ora di anticipo. L’anticamera dell’ufficio era stata trasformata in una cucina, dove lavorava una ragazza attraente, che aveva qualche anno in più di Artyom, la quale aveva messo a stufare in una grande padella della carne insieme a delle radici tuberose, mentre in una pentola a fianco faceva bollire gli stessi ortaggi bianchi che aveva assaggiato a casa di Anton. Il capo della stazione era seduto su uno sgabello e sfogliava un libretto malandato, sulla cui copertina erano rappresentati un revolver insieme alle gambe di una donna, che indossava una paio di collant neri. Quando scorse Artyom, Arkadiy Semyonovich mise da parte il libro con evidente imbarazzo. “Qui ci annoiamo molto”, e così dicendo rivolse al giovane un sorriso d’intesa. “Vieni, entriamo in ufficio. Katerina ci apparecchierà la tavola e noi potremo bere qualche bicchiere”, e gli fece l’occhiolino. La stanza con gli arazzi e il teschio aveva un aspetto completamente diverso: era illuminata da un’abat-jour coperta da un tessuto verde che fungeva da paralume, perciò sembrava un po’ più confortevole. La tensione che aveva perseguitato Artyom sulla piattaforma era completamente scomparsa ai raggi di questa lampada, senza lasciare alcuna traccia. Arkadiy Semyonovich prese una piccola bottiglia dalla credenza e versò un liquido bruno dall’aroma inebriante in insoliti bicchieri panciuti. Ne uscì pochissimo, solo un dito, e Artyom rifletté che probabilmente quel liquore costava come un’intera scatola di quello fatto in casa che aveva assaggiato alla Kitay-Gorod. “Un sorso di cognac”, Arkadiy Semyonovich rispose al suo sguardo curioso. “Ovviamente proviene dall’Armenia, ma ha quasi trent’anni. Viene da là sopra”, il capo si mise a osservare il soffitto, sognante. “Non preoccuparti, non è contaminato, l’ho controllato io stesso con il dosimetro”. La bevanda sconosciuta era molto forte, ma il sapore piacevole e l’aroma intenso lo rendevano ottimo. Artyom non lo bevve tutto d’un sorso, ma cercò di assaporarlo poco a poco, seguendo l’esempio del padrone di casa. Gli pareva che dentro di lui stesse pian piano scoppiando un incendio, che però si acquietò e si trasformò in un piacevole calore. L’atmosfera nella stanza era diventata ancor più gradevole e Arkadiy Semyonovich anche più simpatico. “È sorprendente”, commentò Artyom, serrando gli occhi soddisfatto. “È buono, vero? Circa sei mesi fa uno stalker ha trovato delle scorte totalmente integre alla Krasnopresnenskaya...”, spiegò il capo della stazione. “In una cantina, come spesso era successo in passato. Il cartello era caduto e nessuno l’aveva notato. Ma uno di noi si ricordava che fosse lì, prima che quello si staccasse; lui sapeva che un giorno sarebbe andato a controllarla e quindi decise di farlo. Era rimasto lì così tanto tempo che era persino migliorato. Dato che ci conoscevamo, me ne diede due bottiglie per cento proiettili. Alla Kitay-Gorod ne vogliono duecento ciascuna”. Fece un altro piccolo sorso, poi, pensieroso, si mise a guardare la luce della lampada attraverso il bicchiere del cognac. “Si chiamava Vasya, questo stalker”, lo informò il capo. “Era un brav’uomo. Non uno di quei ragazzini che insegue il vento, un tipo serio. Riusciva a trovare solo le cose migliori. Non appena tornava dalla superficie, veniva subito da me. Mi diceva: ‘Beh, Semyonovich, ecco a te qualche rifornimento’”, Arkadiy Semyonovich sorrise debolmente. “Gli è successo qualcosa?”, domandò Artyom. “Adorava la Krasnopresnenskaya. Continuava a ripetere che era la vera El Dorado”, Arkadiy Semyonovich assunse un’espressione triste. “Un grattacielo stalinista era rimasto intatto... ecco perché al suo interno tutto era rimasto come era stato lasciato... Lo zoo si trovava dall’altra parte della strada. Chi sarebbe andato a curiosare là dentro, alla Krasnopresnenskaya? Una paura tremenda... Era un disperato, Vasyatka, correva sempre troppi rischi. E alla fine andò a cacciarsi in un pasticcio. Lo trascinarono dentro lo zoo e il suo collega riuscì a malapena a svignarsela. Perciò, brindiamo a lui”. Il capo respirava a fatica e versò un altro bicchiere a entrambi. Ricordandosi del prezzo improponibile del cognac, Artyom stava per protestare, ma Arkadiy Semyonovich gli mise in mano il bicchiere panciuto con decisione, spiegandogli che un suo rifiuto avrebbe insultato la memoria dello sprezzante stalker che era riuscito a trovare questa bevanda divina. Nel frattempo la ragazza aveva preparato il tavolo, mentre Artyom e Arkadiy Semyonovich passarono a un più ordinario, ma comunque bevibile, liquore fatto in casa. La carne era stata cucinata a regola d’arte. “La situazione in questa stazione è terribile”, dopo un’ora e mezza Artyom non aveva più peli sulla lingua. “C’è qualcosa che fa paura, che fa vivere costantemente con una sensazione d’oppressione”. “Ci siamo abituati”, Arkadiy Semyonovich scosse il capo, vago. “Ci sono persone che vivono qui. Non è peggio che...” “No, non mi fraintenda”, credendo che il capo della Kievskaya si fosse offeso, Artyom si affrettò a calmarlo. “Sono sicuro che lei stia facendo tutto il possibile... ma qui c’è qualcosa che non quadra. Tutti parlano solo di una cosa: della gente che scompare”. “Mentono!”, lo interruppe Arkadiy Semyonovich. Ma poi aggiunse: “Non scompaiono tutte le persone. Solo i bambini”. “Sono i morti che li prendono?” “Chi lo sa! Io personalmente non credo nei morti. Ne ho visti fin troppi nella mia vita, non credere. Ma non portano nessuno da nessuna parte. Se ne stanno lì tranquilli. Ma laggiù, al di là del blocco”, Arkadiy Semyonovich fece segno in direzione della Parco della Vittoria e quasi perse l’equilibrio, “Laggiù c’è qualcuno. Questo è certo. Ma noi non possiamo andarci”. “Perché?”. Artyom cercò di concentrarsi sul suo bicchiere, ma lo vedeva sempre più sfuocato e sembrava che si stesse spostando da solo sul tavolo. “Se aspetti un secondo, te lo mostrerò...” Il capo della stazione si allontanò dal tavolo, vi rimase impigliato, poi si alzò con difficoltà e tornò alla credenza. Da uno dei ripiani sollevò con cura un lungo ago di metallo leggero, che su una delle estremità aveva una piuma. “Che cosa sarebbe questo?”. Artyom si accigliò. “Mi piacerebbe saperlo...” “Dove l’ha trovato?” “Infilzato nel collo di una sentinella che era di guardia nella galleria di destra. Sanguinò pochissimo, ma giaceva a terra, completamente blu, con la bava alla bocca”. “Sono venuti dalla Parco della Vittoria?”, cercò di indovinare Artyom. “E chi lo sa”, borbottò Arkadiy Semyonovich e nello stesso tempo prese i due bicchieri. “Ti prego”, aggiunse, riponendo l’ago nella credenza “non raccontarlo a nessuno”. “Ma nemmeno lei lo ha detto a qualcuno? La aiuterebbero e la gente si sentirebbe più al sicuro”. “No, nessuno si sentirebbe al sicuro, fuggirebbero tutti come dei ratti! Se ne stanno già andando ora... Non c’è un’entità da cui difendersi, non c’è un nemico. Non è visibile, è proprio questo che fa paura. Se gli mostrassi quell’ago che succederebbe? Pensi che si sentirebbero al sicuro? È ridicolo! Sparirebbero tutti, quei bastardi, mi lascerebbero qui da solo! E allora che razza di capo sarei senza di loro? Un capitano senza nave!”. Alzò la voce, ma poi emise un rantolo e ammutolì. “Arkasha, Arkasha, non fare così, va tutto bene...”, la ragazza, allarmata, si sedette accanto a lui e si mise ad accarezzargli la testa. Con suo disappunto, Artyom comprese attraverso i fumi dell’alcool che la ragazza non era la figlia del capo della stazione. “Tutti! Siano tutti maledetti! Come i ratti, su una nave! Rimarrò da solo! Ma non mi arrenderò!”, era chiaro che non riusciva a darsi una calmata. Artyom si alzò con difficoltà e barcollò verso l’uscita. La guardia che sorvegliava la porta lo guardò con aria interrogativa e gli fece schioccare le dita davanti al viso, indicando con il capo l’ufficio di Arkadiy Semyonovich. “È ubriaco fradicio”, borbottò Artyom. “Sarebbe meglio lasciarlo stare, almeno fino a domani”, e continuando a ondeggiare si diresse verso la sua tenda. Doveva trovare la strada. Cercò diverse volte di entrare nell’alloggio di qualcun altro, ma volgari imprecazioni di uomini e strilli acuti di donne gli indicarono che aveva scelto quello sbagliato. Il secondo liquore che avevano bevuto si era rivelato molto più forte degli intrugli a buon mercato, lo notava solo ora. Gli archi e le colonne fluttuavano davanti ai suoi occhi e, come se non bastasse, cominciava a sentirsi male. In un altro momento della giornata qualcuno avrebbe aiutato il ragazzo a raggiungere la tenda degli ospiti, ma ora la stazione sembrava completamente deserta. Persino i posti di guardia alle uscite delle gallerie erano abbandonati. Rimanevano accese solo tre o quattro lampade che emettevano una luce molto fioca e, a parte quelle, l’intera piattaforma era immersa nell’oscurità. Quando Artyom si fermò e si guardò attorno con maggiore attenzione, gli parve che nelle tenebre vi fosse qualcosa che si agitava piano. Non credeva ai suoi occhi, perciò arrancò in direzione di uno dei punti che gli erano sembrati più sospetti, con tutta la curiosità e il coraggio di un ubriaco. Non lontano dal passaggio che conduceva sulla linea della Filevskaya, in prossimità di uno degli archi, i movimenti della massa oscura non erano graduali, come in altri angoli, ma improvvisi, come se fossero calcolati. “Ehi! Chi è là?”, urlò il ragazzo, che nel frattempo si era avvicinato ma manteneva comunque una distanza di sicurezza di una quindicina di metri. Non rispose nessuno, però gli sembrò che un’ombra allungata trapelasse da un punto particolarmente oscuro, tanto che sembrava quasi fosse un tutt’uno con le tenebre. Tuttavia, Artyom era certo che qualcuno lo stesse osservando. Il ragazzo tremava, ma riuscì a mantenere l’equilibrio e fece un altro passo in avanti. L’ombra si rimpicciolì bruscamente, come se si fosse ritirata, poi scivolò via. Un improvviso odore nauseabondo pervase le narici di Artyom, a cui venne il voltastomaco. Di che odore si trattava? In quel momento, gli si ripresentò davanti agli occhi una delle immagini che aveva visto nelle gallerie mentre si stava avvicinando al Quarto Reich: corpi ammucchiati l’uno sull’altro, con le mani legate dietro la schiena. Il puzzo della carne in decomposizione? In quello stesso istante, a una velocità impensabile, come una freccia scagliata da un arco, l’ombra si buttò sopra di lui. Un viso pallido con strane macchie e occhi profondamente infossati apparve per qualche secondo. “Un morto!”, sibilò Artyom. Quindi sentì un dolore lancinante, come se la testa gli si rompesse in migliaia di piccoli pezzi, il soffitto si mise a danzare mentre tutto il resto girava, per poi offuscarsi. Riemergendo e risprofondando dallo stato di debolezza in cui si trovava, riusciva a udire delle voci, poi ebbe una sorta di visione che scomparve subito dopo. “La mamma non me lo permetterebbe. Si arrabbierebbe molto”, disse il bambino, non lontano da lui. “Proprio come oggi, ha urlato per tutta la sera. No, non ho paura, tu non mi spaventi e canti davvero molto bene. Solo che non voglio far piangere di nuovo la mamma. Non rimanerci male! Beh, se è solo per un po’, allora va bene... Torneremo prima di colazione?” “... Non c’è più tempo. Non c’è più tempo”, ripeteva una voce baritonale. “Non abbiamo tutto il giorno. Sono già fin troppo vicini. Alzati. Non stare lì. Alzati! Se perdi le speranze, se ti tiri indietro, altri prenderanno subito il tuo posto. Io continuo la battaglia. Dovresti farlo anche tu. Alzati! Non capisci...” “Chi sarebbe? Dal capo? È un ospite? Sì, certo, ne porterò uno! Va’, aiuterai anche tu... Per lo meno sbrigati. Pesante... Non ti deve interessare se ha qualcosa che tintinna nelle tasche. Beh, d’accordo, sto scherzando. È tutto. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. Ma io non posso, non posso... me ne vado!” I lembi della tenda si aprirono all’improvviso e il fascio di luce di una torcia lo colpì diritto negli occhi. “Sei tu Artyom?” Il ragazzo riusciva a malapena a distinguere il viso, ma la voce sembrava quella di un giovane. Artyom si alzò dalla brandina, ma la sua testa cominciò inesorabilmente a girare e gli venne la nausea. Un dolore sordo gli faceva pulsare la nuca e ogni volta che la toccava gli pareva fosse sempre più infuocata; in quel punto aveva i capelli appiccicati, molto probabilmente a causa del sangue coagulato. Ma cosa gli era accaduto? “Posso entrare?”, gli domandò il nuovo arrivato e, senza attendere che Artyom gli accordasse il permesso, entrò nella tenda, chiudendo il lembo dietro di sé. Poi piazzò in mano al ragazzo un piccolo oggetto metallico. Non appena Artyom accese la sua torcia, la vide: era un bossolo, trasformato in una capsula avvitata, la stessa che gli aveva affidato Hunter a suo tempo. Non credeva ai suoi occhi: Artyom cercò di svitarla ma gli sfuggì, perché aveva le mani sudate dall’emozione. Finalmente scorse un piccolo pezzo di carta. Era davvero un messaggio di Hunter? “Complicazioni inaspettate. L’uscita verso la D-6 è bloccata. Tretyak è stato ucciso. Aspettami, non andare da nessuna parte. Abbiamo bisogno di tempo per organizzarci. Cercherò di tornare il prima possibile. Melnik”. Artyom lesse nuovamente il biglietto, per analizzarne il contenuto. Tretyak era stato ucciso? L’uscita verso la Metro-2 era bloccata? Ciò significava che tutte le loro speranze e i loro piani erano stati vani! Confuso, osservò il messo. “Melnik ti ha ordinato di rimanere qui e di aspettarlo”, confermò il visitatore. “Inoltre, mi ha riferito che Tretyak è morto. Lo hanno ucciso con una freccia avvelenata. Non sappiamo chi possa aver fatto una cosa del genere, ma ora Melnik dovrà organizzare una forza di mobilitazione. È tutto. Devo scappare. Vuoi rispondergli qualcosa?” Artyom rifletté per un attimo sulla risposta da inviare allo stalker: “Che posso fare? Abbiamo qualche speranza? Forse dovrei lasciare perdere tutto e tornare alla VDNKh per rimanere al fianco delle persone a cui tengo, almeno negli ultimi istanti?”, quindi scosse il capo. Il messo si voltò in silenzio e uscì. Artyom si lasciò cadere sulla branda e cominciò a meditare: non aveva nessun luogo in cui andare. Non poteva avere accesso all’Anello e non poteva tornare alla Smolenskaya, dato che non aveva un passaporto e nemmeno un accompagnatore. La sua unica speranza era che, nei giorni a venire, Arkadiy Semyonovich sarebbe stato tanto ospitale quanto la sera prima. Alla Kievskaya ormai si era fatto “giorno”. Le lampade erano molto più luminose e, di fianco all’ufficio dove si trovava l’appartamento del capo, c’era anche una lampada a mercurio che emetteva una luce che rischiarava parte della stazione. Trasalendo per il dolore alla testa, Artyom si trascinò fino all’ufficio del capo. All’entrata c’era una guardia che lo fermò con un gesto. Dall’interno provenivano dei rumori, diversi uomini stavano discutendo ad alta voce. “È occupato”, spiegò la guardia. “Se vuoi puoi attendere”. Qualche minuto più tardi, Anton uscì dall’ufficio come un razzo. Il capo lo seguì a ruota; i suoi capelli erano ancora pettinati alla perfezione, solo che ora aveva le borse sotto gli occhi, la faccia visibilmente gonfia e ricoperta da una corta barbetta argentata. “Cosa ci posso fare io? Cosa?”, urlò il capo inseguendo Anton, poi sputò e con la mano si diede una pacca sulla fronte. “Ti sei svegliato?”, quando notò Artyom, sorrise beffardo. “Devo rimanere qui fino al ritorno di Melnik”, dichiarò Artyom in tono di scusa. “Lo so, lo so. Me l’hanno riferito. Vieni, entriamo. Ho ordini ben precisi che ti riguardano”. Arkadiy Semyonovich lo invitò con un gesto. “Nel frattempo, mi hanno chiesto di farti la fotografia per il passaporto. Ho ancora tutto l’equipaggiamento risalente al tempo in cui la Kievskaya era una stazione normale... Forse Melnik riuscirà a recuperare un passaporto vuoto e così potrai riavere il tuo documento”. Fece sedere Artyom su uno sgabello e lo inquadrò con l’obiettivo di una piccola macchina fotografica di plastica. La luce del flash fu accecante: per i cinque minuti seguenti Artyom non riuscì a vedere più nulla e si guardava attorno inutilmente. “Scusa, mi ero scordato di avvisarti... Starai morendo di fame. Vieni, Katya ti darà qualcosa da mettere sotto i denti. Purtroppo io oggi non ho tempo da dedicarti. La situazione sta peggiorando: durante la notte è scomparso il figlio maggiore di Anton e ora quell’uomo ci sta dando del filo da torcere... ma a che scopo? Inoltre, loro mi hanno informato che stamattina ti hanno trovato sulla piattaforma! Con la testa insanguinata! Cosa è successo?” Artyom non rispose immediatamente, ma poi articolò: “Non ricordo... probabilmente sono caduto... ero ubriaco”. “Sì, è stata una bella serata”, ridacchiò il capo. “Ok, Artyom, io devo mettermi al lavoro. Torna più tardi”. Artyom scese dallo sgabello. Davanti a lui gli si ripresentò il viso del piccolo Oleg. Il figlio maggiore di Anton... Era davvero lui? Ricordava che la sera prima il bambino aveva girato la manovella del suo piccolo carillon, l’aveva poggiato sul tubo di ferro e gli aveva rivelato che solo i bambini più piccoli temevano che i morti li avrebbero rapiti se si fossero recati nelle gallerie e avessero ascoltato le voci dei tubi. Un brivido percorse la schiena di Artyom. Era vero? Era accaduto per causa sua? Impotente, guardò di nuovo Arkadiy Semyonovich, aprì la bocca, ma se ne andò senza dire una parola. Il ragazzo tornò alla sua tenda, si sedette a terra e rimase in silenzio per un po’ a guardare nel vuoto. Si mise a riflettere: lo sconosciuto che l’aveva scelto per quella missione, allo stesso tempo lo aveva condannato, perché praticamente tutti coloro che avevano deciso di condividere parte del loro viaggio con lui erano morti. Bourbon, Mikhail Porfirevich e il nipote, Daniel... Hunter era scomparso senza lasciare traccia e persino i combattenti della brigata rivoluzionaria che lo avevano salvato avrebbero potuto essere uccisi all’interscambio successivo. Ora Tretyak. Ma il piccolo Oleg? Artyom aveva portato la morte tra i suoi amici? Non riuscendo a comprendere cosa stava accadendo, si alzò, si mise in spalla lo zaino e la mitragliatrice, afferrò la torcia e uscì sulla piattaforma. Con movimenti meccanici procedette verso il punto in cui era stato assalito la notte precedente. Fece un passo avanti e rimase di sasso: il morto gli riapparve tra i ricordi annebbiati dell’ebbrezza. Rammentava tutto, non era stato un sogno. Doveva trovare Oleg o per lo meno aiutare Anton a cercare il figlio. Era stata tutta colpa sua. Non aveva controllato il bambino a dovere. Aveva permesso a Oleg di fare quello strano giochetto con i tubi e ora lui era lì sano e salvo, ma il piccolo era scomparso. Artyom era convinto che non fosse fuggito, ma che durante la notte gli fosse accaduto qualcosa di terribile e inesplicabile, perciò il ragazzo si sentiva doppiamente colpevole perché avrebbe potuto impedire che succedesse, ma qualcosa lo aveva fermato. Si mise a osservare il punto in cui la terrificante creatura si era nascosta. Al suo posto ora c’era solo una montagna di spazzatura e, passandola al setaccio, Artyom riuscì solo a spaventare un gatto randagio. Dopo aver controllato la piattaforma senza ottenere alcun risultato, si avvicinò al sentiero e saltò sui binari. I pattugliatori all’entrata della galleria lo guardarono straniti, poi lo avvertirono che se fosse entrato nel tunnel lo avrebbe fatto a suo rischio e pericolo e nessuno si sarebbe assunto la responsabilità per ciò che gli sarebbe potuto accadere. Questa volta Artyom non percorse la stessa galleria del giorno precedente, ma imboccò la seconda, quella parallela. Come aveva riferito il comandante delle guardie, anche questa era bloccata e l’avamposto si trovava proprio nel punto in cui c’era il blocco: un barile di ferro faceva da stufa, mentre i sacchi erano stati posizionati tutti intorno. Sui binari c’era un carrello a mano, carico di sacchi di carbone. Le sentinelle sedute sui sacchi discorrevano tra loro a voce bassissima e, non appena lui si avvicinò, saltarono in piedi e si misero a fissare il ragazzo. Ma poi uno di loro diede l’OK, le guardie si calmarono e ripresero i loro posti. Dando un’occhiata più da vicino, Artyom riconobbe il comandante: era proprio Anton. Il ragazzo borbottò parole incomprensibili, si voltò e tornò indietro. Aveva il viso in fiamme perché non era riuscito a guardare negli occhi l’uomo il cui figlio era scomparso a causa sua. Artyom si trascinò in direzione della stazione, a testa bassa, continuando a brontolare: “Non è stata colpa mia... Non sono riuscito... Cos’altro avrei potuto fare?” Il fascio di luce della torcia illuminava il sentiero davanti a lui. All’improvviso, notò un piccolo oggetto che giaceva desolato nell’ombra, tra due traversine. Anche da lontano, gli pareva di averlo già visto e il suo cuore si mise a battere veloce. Artyom si abbassò e raccolse la scatoletta da terra. Girò la manovella e risuonò la melodia malinconica. Era il carillon di Oleg. Forse lo aveva perso, oppure lo aveva lasciato lì di proposito. Artyom poggiò a terra il suo zaino e si mise a scandagliare a fondo le pareti della galleria. Non lontano c’era una porta che sembrava conducesse a degli uffici, ma in seguito Artyom scoprì che al di là c’erano solo bagni pubblici. Proseguì per altri venti minuti, ma non riuscì a cavarne un ragno dal buco. Tornò al suo zaino e si sedette a terra, appoggiando la schiena alla parete. Piegò la testa all’indietro e si mise a osservare il soffitto, esausto. Un istante dopo si rialzò e vi puntò la sua torcia che, vibrando, rivelò la presenza di un’apertura oscura, appena visibile sul cemento annerito. Sopra il punto in cui Artyom aveva raccolto il carillon di Oleg c’era una botola richiusa male. Tuttavia, non c’era modo di raggiungerla, dato che il soffitto era alto più di tre metri. La soluzione gli si presentò in un lampo: afferrò il carillon che aveva trovato, lanciò lo zaino sui binari e corse in direzione delle sentinelle. Non temeva più di guardare Anton negli occhi. Rallentando il passo verso l’avamposto, in modo che i pattugliatori non si allarmassero, Artyom si avvicinò ad Anton e, in un sussurro, gli raccontò della scoperta. Due minuti dopo abbandonarono il posto di guardia tra gli sguardi interrogativi degli altri uomini e azionarono il carrello a mano, con movimenti alternati. Si fermarono sotto la botola: il carrello era abbastanza alto e così Artyom, salendo sulle spalle di Anton, riuscì a raggiungerla e ad aprirla, si issò al suo interno e poi fece salire anche l’uomo. Sebbene lo stesso corridoio si diramasse sia a destra che a sinistra, Anton non ci pensò due volte e si diresse in direzione della Parco della Vittoria. Qualche secondo più tardi fu chiaro che aveva avuto ragione, perché trovarono un bossolo oblungo che brillava alla luce flebile delle loro torce: era uno di quelli che Melnik aveva regalato al bambino il giorno precedente. Sollevato dalla scoperta, Anton si mise a correre. Proseguì per altri venti metri, fino al punto in cui il corridoio era bloccato da una parte e sul pavimento si trovava un’altra botola annerita, anch’essa semi aperta. Anton, fiducioso, si calò al suo interno. Ancor prima che Artyom potesse aprire bocca per obiettare, era già scomparso. Sì udirono un tonfo, qualche imprecazione e poi una voce strozzata che diceva: “Fai attenzione quando salti, è alto quasi tre metri. Forza, punterò la torcia, così potrai vedere dove atterri”. Artyom mise le mani sul bordo, poi si calò a penzoloni e, dopo qualche oscillazione, mollò la presa cercando di atterrare con i piedi tra le traversine. “Come faremo a tornare lassù?”, domandò il ragazzo raddrizzandosi. “Ci verrà in mente qualcosa”, Anton raggirò il problema con un gesto della mano. “Sei certo che non pensavano fossi morto?” Artyom scrollò le spalle. Nonostante il dolore alla nuca, ora che era sobrio, il pensiero che qualcuno lo avesse attaccato la notte precedente alla Kievskaya gli sembrava assurdo. “Andremo alla Parco della Vittoria”, decise Anton. “I problemi vengono di sicuro da lì. Lo avrai percepito anche tu, dato che sei stato alla nostra stazione”. “Ma perché ieri non ci ha raccontato niente?”, domandò Artyom, raggiungendo Anton e cercando di stare al passo con lui. “Il capo non ce lo permette”, rispose l’uomo corrucciato. “Semyonovich teme il panico e sostiene che non si debbano alimentare i pettegolezzi. Ha paura che gli soffino il posto, ma ognuno ha i suoi limiti. Io glielo avevo già detto secoli fa che non sarebbe riuscito a mantenere il segreto per sempre... Negli ultimi due mesi sono scomparsi tre bambini e quattro famiglie sono fuggite dalla stazione. Poi abbiamo trovato quella guardia con l’ago conficcato nel collo. No, lui ritiene che si diffonderebbe il panico e che tutti perderemmo il controllo. Ma è solo un codardo”, e in preda a un impeto di rabbia, Anton sputò a terra. “Chi può aver costruito quell’ago...?” Artyom soffocò la domanda e Anton si fermò nel bel mezzo dei binari. “Cosa? Tu l’hai visto?”, chiese il pattugliatore, preso alla sprovvista. Artyom non rispose. Anche lui si era fermato e si mise a osservare il pavimento; spostava la torcia da un lato della galleria all’altro per vedere meglio ciò che l’uomo gli stava indicando. Una sagoma gigantesca era stata rozzamente disegnata a terra: aveva una forma serpeggiante, era larga circa quaranta centimetri e lunga quasi due metri, sembrava proprio un serpente, oppure un verme. Su un’estremità era stata tracciata una protuberanza che somigliava a una testa, che rendeva l’immagine ancora più simile a un enorme rettile. “Un serpente”, disse Artyom. “Forse a qualcuno è caduta della vernice?”, ribatté ironico Anton. “No, qui il colore non è stato versato. Questa è la testa... che è rivolta in quella direzione. Sta strisciando verso la Parco della Vittoria...” “E noi lo seguiremo...” Qualche centinaio di metri più avanti trovarono altri tre bossoli, nel bel mezzo del sentiero, così cominciarono entrambi a camminare più velocemente. “Bravo ragazzo!”, disse Anton orgoglioso. “Chi avrebbe mai pensato che potesse ricordarsi di lasciare delle tracce!” Artyom annuì. Era sempre più certo che, sebbene l’ignota creatura l’avesse attaccato senza emettere alcun rumore, il bambino era ancora vivo. Ma Oleg aveva deciso di sua spontanea volontà di andare con il misterioso rapitore? Allora perché aveva deciso di lasciare delle tracce? Il ragazzo rimase in silenzio per qualche minuto e lo stesso fece anche Anton. L’intensa oscurità aveva cancellato la recente sensazione di gioia e di speranza e il giovane venne pervaso dalla paura. Sperando che, con il suo gesto, l’uomo l’avrebbe perdonato, si era scordato di tutti gli avvertimenti e dei terribili racconti sussurrati. Si era dimenticato che lo stalker gli aveva ordinato di non allontanarsi dalla Kievskaya. Anton era stato spinto fin lì dalla voglia di riabbracciare il figlioletto, ma perché anche Artyom si stava recando alla terribile Parco della Vittoria? Perché stava trascurando se stesso e la sua missione principale? Ma poi si ricordò degli strani personaggi che aveva incontrato alla Polyanka, del discorso sul destino e si sentì sollevato, anche se questa sensazione durò solo una decina di minuti, finché non trovarono un altro simbolo che rappresentava il serpente. Questa sagoma era grande circa il doppio della precedente e sembrava stesse cercando di convincere i viaggiatori che si trovavano sulla strada giusta. Ciononostante, Artyom non era tranquillo. La galleria sembrava infinita: camminarono a lungo, per più di due ore, secondo i calcoli del ragazzo. La terza rappresentazione del serpente gigante era lunga più di dieci metri e quando la raggiunsero udirono qualcosa. Anton si fermò di colpo, volse l’orecchio alla galleria e anche Artyom si mise in ascolto. Dalle profondità del passaggio provenivano strani rumori intermittenti; inizialmente non riuscirono a comprendere di cosa si trattasse mai poi realizzarono: era una cantilena molto simile a quella che Artyom aveva udito nel tubo della Kievskaya dopo che vi aveva appoggiato sopra il carillon, solo che questa volta era accompagnata dal suono dei tamburi. “Ci siamo”, annuì Anton. Il tempo, che nelle ultime ore era scivolato via lento, rimase pressoché immobile. Osservando l’uomo, Artyom capì immediatamente che la sua testa aveva assunto un movimento strano, troppo veloce, come se fosse in preda a convulsioni. Quando Anton cominciò a cadere di lato, ridicolo come un animale di pezza, il ragazzo era certo di avere abbastanza tempo per riuscire ad afferrarlo prima che toccasse terra. Ma all’improvviso sentì qualcosa pungergli leggermente la spalla, impedendogli di soccorrere l’amico. Disorientato, guardò il punto in cui era stato colpito e scoprì un ago d’acciaio con una piuma che gli perforava la giacca. Non riuscì nemmeno a pensare di levarlo perché tutto il suo corpo era pietrificato, gli sembrava che fosse scomparso. Le gambe deboli cedettero alla forza di gravità e Artyom finì a terra. Tuttavia, rimase sempre cosciente, anche se la respirazione stava diventando un’azione fin troppo complicata. Non riusciva a muovere gli arti. Udì dei passi leggeri che si avvicinavano. Non potevano essere dei passi umani. Artyom aveva imparato a riconoscerli molto tempo prima, durante i turni di guardia alla VDNKh. Un improvviso odore acre raggiunse le sue narici. “Uno, due. Stranieri, presi”, constatò qualcuno sopra di loro. “Colpo ottimo, erano lontani”. “Il collo, la spalla”, rispose un altro. Le voci erano insolite: prive di intonazione, piatte, ricordavano vagamente il ronzio monotono del vento nelle gallerie. Ma non c’era alcun dubbio, erano voci umane. “Per mangiare, ottima mira. È ciò che desidera il Grande verme”, continuò la prima voce. “Per mangiare. Uno, tu. Due, io. Portiamo gli stranieri a casa”, aggiunse il secondo. L’immagine che gli si presentò davanti agli occhi fece sussultare Artyom, che venne sollevato da terra senza alcuna cautela. Per una frazione di secondo, intravvide un viso smagrito, con occhi scuri e infossati. Poi le creature spensero la torcia e tutto venne avvolto dall’oscurità. Il ragazzo capì che lo stavano trascinando come un sacco perché la testa gli stava sanguinando copiosamente. La strana conversazione tra i due non si era interrotta, sebbene le frasi fossero intervallate da forti gemiti. “Un ago paralizzante, non avvelenato. Perché?” “L’ha ordinato il comandante. L’ha ordinato il sacerdote. È ciò che desidera il Grande verme. Così possiamo usare la carne”. “Sei intelligente. Tu e il sacerdote siete amici. Il sacerdote ti insegna tante cose”. “Per mangiare”. “Uno, due, i nemici arrivano. C’è odore di polvere da sparo nell’aria, di fuoco. Nemici cattivi. Come sono arrivati qui?” “Non so. Il comandante e Vartan li interrogano. Tu e io siamo i cacciatori. Così il Grande verme è felice. Tu e io riceveremo una ricompensa”. “Molto da mangiare? Scarponi? Una giacca?” “Molto da mangiare. Niente giacca. Niente scarponi”. “Io sono giovane. Caccio i nemici. È bello. Molto? Una ricompensa... io sono felice”. “Oggi bene. Vartan porta un nuovo giovane. Tu, io, noi cacciamo i nemici. Il Grande verme è felice. La gente canta. Festa”. “Festa! Sono felice! Balli? Vodka? Io ballo con Natasha”. “Natasha e il comandante ballano. Non tu”. “Io sono giovane, forte, il comandante è molto vecchio. Natasha è giovane. Io caccio i nemici, coraggioso, giusto. Io e Natasha, noi balliamo”. Poco lontano si udivano nuove voci. Inoltre, si capiva che era appena cominciata una discussione. Artyom suppose che fossero giunti in stazione. Qui l’ambiente era quasi buio come le gallerie e c’era un unico fuoco da campo, vicino al quale lanciarono il ragazzo senza prestare alcuna attenzione. Le dita d’acciaio di qualcuno lo presero per la barba e gli girarono il viso, mentre attorno a lui si era radunato un gruppo di diverse persone dall’aspetto bizzarro, inimmaginabile. Erano quasi del tutto nude e avevano le teste rasate, ma sembrava che non avessero per niente freddo. Sulla fronte di ognuno di loro era stata tracciata una linea ondulata, simile al serpente rappresentato nel tunnel. La loro statura minuta gli conferiva un aspetto malsano poiché avevano le guance infossate e un incarnato pallido; tuttavia, emanavano una sorta di forza sovraumana. Artyom ricordò con quale estrema difficoltà Melnik avesse trasportato il tenente ferito dalla Biblioteca e paragonò la situazione a quella che stava vivendo: le strane creature li avevano trasportati alla stazione molto velocemente. Quasi tutti tenevano in mano una lunga freccia. Il ragazzo capì con sua sorpresa che quegli arnesi erano costruiti con materiale plastico di rivestimento, lo stesso usato per distanziare e isolare fasci di fili elettrici. Dalle loro cinture penzolavano delle enormi baionette, come fossero vecchi Kalashnikov. Avevano tutti più o meno tutte le stessa età e nessuno dimostrava più di trent’anni. Per qualche minuto li scrutarono in silenzio, poi l’unico che aveva la barba e una linea rossa in fronte annunciò: “Ok, sono felice. Questi sono i nemici del Grande verme, il popolo delle macchine. Popolo malvagio, carne tenera. Il Grande verme è soddisfatto. Sharap, Vovan sono coraggiosi. Io porterò in prigione questi appartenenti al popolo delle macchine e li interrogherò. Domani è festa, tutti i buoni mangeranno i cattivi. Vovan! Quale ago? Paralizzante?” “Sì, paralizzante”, rispose un uomo tarchiato con una linea blu in fronte. “Paralizzante è buono. La carne non si rovina”, spiegò la creatura con la barba. “Vovan, Sharap! Portate i nemici in prigione, seguitemi!” La luce cominciò a sparire. Nelle vicinanze si udivano nuove voci, qualcuno espresse la sua gioia in maniera disarticolata, qualcun altro si lamentò mesto. Poi si udì un canto basso, appena percepibile e per nulla piacevole. Sembrava che i morti stessero davvero cantando e Artyom ricordò i racconti sulla Parco della Vittoria. Quindi lo rimisero a terra, di fianco a lui vide che veniva gettato anche Anton e in breve tempo perse conoscenza. Sembrava che qualcuno lo avesse spinto e che gli suggerisse di rialzarsi subito. Lui si stiracchiò, accese una lanterna, la coprì con la mano in modo che i suoi occhi sensibili e ancora intrisi di sonno non gli dolessero; controllò la tenda... dove aveva lasciato la mitragliatrice?! Quindi si diresse verso la stazione. Aveva avuto così tanta nostalgia di casa, ma ora che era tornato alla VDNKh non era per nulla felice. Il soffitto color fumo, le tende vuote crivellate di proiettili e la cenere pesante nell’aria... Pareva che fosse accaduto qualcosa di tremendo, la stazione era assai diversa da come se la ricordava. Da lontano, molto probabilmente dall’altra parte della piattaforma, udiva degli ululati selvaggi, come se stessero scuoiando una persona. L’intera stazione era illuminata da solo due lampade di emergenza, i cui deboli raggi penetravano con difficoltà le indolenti nuvole di fumo. Sulla piattaforma non c’era nessun altro, eccetto una bambina che giocava seduta a terra, di fianco a una delle tende vicine. Artyom stava per chiederle cosa fosse successo e dove erano scomparsi tutti gli altri, ma quando incrociò lo sguardo della piccola, quest’ultima si mise a piangere a dirotto, perciò cambiò idea. Le gallerie. Le gallerie che conducevano dalla VDNKh all’Orto botanico. Se gli abitanti della sua stazione fossero fuggiti da qualche parte, sarebbero andati in quella direzione. Al contrario, se avessero deciso di scappare verso il centro, verso l’Hansa, non avrebbero lasciato lui e la bambina da soli. Il ragazzo saltò sui binari e si diresse verso il vuoto oscuro dell’entrata della galleria. “È pericoloso senza armi”, rifletté, ma in ogni caso non aveva nient’altro da perdere. Doveva andare in avanscoperta. I Tetri erano riusciti a superare lo sbarramento? Se così fosse stato, lui era l’unica speranza rimasta. Doveva scoprire la verità, per fare rapporto agli alleati a sud. Non appena varcò l’entrata, l’oscurità lo avvolse, insieme alla paura. Davanti a sé non vedeva assolutamente nulla, ma riusciva a sentire dei disgustosi rumori di morsi. Ancora una volta si rammaricò di non avere una mitragliatrice, ma ormai era troppo tardi per tornare indietro. In lontananza cominciarono a sentirsi dei passi, che si avvicinavano sempre più: pareva si facessero più vicini quando Artyom camminava e che si fermassero quando anche lui interrompeva la sua marcia. Gli era già accaduto qualcosa del genere, ma non si riusciva a rammentare quando e come. Era tremendo doversi muovere nell’invisibile, nell’ignoto... si sarebbe dovuto scontrare con un nemico? Gli tremavano le ginocchia, non riusciva a spostarsi velocemente e, più il tempo passava, più il terrore cresceva. Le tempie gli si imperlarono di sudore freddo. Secondo dopo secondo si sentiva sempre più a disagio. Infine, quando i passi erano a circa tre metri da lui, Artyom non riuscì più a trattenersi, inciampò, cadde, si rialzò e scattò indietro, verso la stazione. Cadde ancora, però questa volta le gambe si rifiutarono di sorreggerlo e comprese che la sua morte era ormai imminente. “... Tutto, su questa Terra, deriva dal Grande verme. Una volta il mondo intero era solamente di pietra, non c’era nient’altro, solo pietra. Niente aria, niente acqua, niente luce, né fuoco. Non esistevano né l’uomo né le bestie. Il mondo era di pietra fredda. Fu così che il Grande verme costruì la sua casa”. “Ma come è arrivato fin qui, il Grande verme? Da dove viene? Chi lo ha generato?” “Il Grande verme è sempre esistito. Non mi interrompere. Edificò la sua casa nel centro preciso del mondo e poi dichiarò: ‘Questo mondo sarà mio. È costituito dalla pietra più dura, ma io lo rosicchierò e vi costruirò dei passaggi. È freddo, ma io lo scalderò con il calore del mio corpo. È buio, ma io lo illuminerò con la luce dei miei occhi. È morto, ma io lo popolerò con le mie creazioni’”. “Chi sono le sue creazioni?” “Le creazioni sono le creature del Grande verme, generate dal suo grembo. Sia tu che io, siamo tutti sue creazioni. E così fu. Quindi il Grande verme parlò di nuovo: ‘Tutto sarà come ho deciso, perché d’ora in avanti questo mondo sarà mio’. Così cominciò a rosicchiare i passaggi nella roccia più resistente, che passando all’interno del suo ventre si ammorbidì, grazie alla sua saliva e alla sua linfa vitale. In seguito la roccia prese vita e generò i funghi: il Grande verme rosicchiava la pietra e la faceva passare attraverso sé. Questo processo durò migliaia di anni, finché i passaggi non percorsero tutta la Terra”. “Migliaia? Quanti sono? Uno, due, tre...? Quanti? Un migliaio?” “Le tue due mani hanno dieci dita, Sharap ha dieci dita... No, Sharap ne ha dodici... Così non funziona. Allora... Dron ha dieci dita. Se prendiamo te, Dron e altre persone tutte insieme, se ce ne fossero tante quante sono le vostre dita, tutti voi insieme ne avreste dieci ciascuno moltiplicato per dieci. In questo modo ne risultano cento. Un migliaio sono dieci volte cento”. “Sono moltissime dita. Non riesco a contarle”. “Non importa. Quando i sentieri del Grande verme apparvero sulla Terra, venne completata la sua prima opera. Quindi proclamò: ‘Ho creato migliaia di sentieri rosicchiando la pietra più resistente, che si è sgretolata. Questa ghiaia è passata attraverso il mio ventre, si è inzuppata della mia linfa ed è venuta alla vita. In precedenza, la pietra occupava tutto lo spazio di questo mondo, ma ora sono apparsi degli spazi vuoti. D’ora in poi, quando genererò i miei figli, loro popoleranno questi spazi’. Le sue prime creazioni, il cui nome è stato ormai dimenticato, si fecero strada attraverso il suo ventre; erano grandi e forti, proprio come il Grande verme. E Lui le amava. Ma le creature non avevano nulla da bere, poiché nel mondo non esisteva l’acqua, così morirono di sete. Il Grande verme ne fu addolorato. Prima di allora non aveva mai provato nulla di simile, perché nessuno lo aveva amato. Inoltre, non sapeva nemmeno cosa fosse la solitudine. Tuttavia, aveva creato una nuova forma di vita, l’aveva amata e ora era difficile separarsene. Il Grande verme cominciò a piangere e le sue lacrime riempirono il mondo e così apparve anche l’acqua. Quindi affermò: ‘Ora esiste sia un luogo in cui vivere, sia l’acqua per dissetarsi. La Terra, saziata dalla linfa del mio ventre, è viva e genera i funghi. Ora plasmerò delle nuove creature. Genererò i miei figli. Vivranno nei sentieri che ho rosicchiato, berranno le mie lacrime e si nutriranno dei funghi cresciuti dalla linfa del mio grembo’. Temeva di dare alla luce altre creazioni grandi quanto lui, perché era preoccupato che non ci sarebbe stato abbastanza spazio, acqua e funghi. Inizialmente creò le pulci, poi i ratti e quindi i gatti; poi i polli, i cani i maiali e quindi l’uomo. Ma le cose non andarono come se le era immaginate: le pulci cominciarono a nutrirsi di sangue, i gatti a mangiare i ratti, i cani a infastidire i gatti; l’uomo invece uccideva tutti gli altri e li usava per sostentarsi. Quando poi, per la prima volta, un uomo uccise un altro uomo e con lui si sfamò, il Grande verme comprese che i suoi figli non erano più degni di lui, quindi versò lacrime di dolore. Ogni volta che un uomo si alimenta di un altro uomo, il Grande verme si dispera, le sue lacrime scorrono nei passaggi e li inondano. L’uomo è buono. La carne è appetitosa. Dolce. Ma ci si può nutrire solo dei propri nemici. Io lo so”. Artyom aprì e richiuse le dita delle mani, che erano legate dietro la schiena con un cavo e si erano intorpidite, ma per lo meno rispondevano ancora agli impulsi nervosi. Persino il fatto che aveva dolori in tutto il corpo era un buon segno. La paralisi causata dall’ago era temporanea. In testa gli vorticò la stupida idea che, al contrario dello sconosciuto narratore, lui non ricordava come i polli fossero entrati nella Metro. Sicuramente alcuni mercanti erano riusciti a portarli sottoterra da qualche mercato. Sapeva che avevano trovato i maiali in uno dei padiglioni della VDNKh, ma chissà com’era andata con le galline... Cercò di dare un’occhiata a ciò che aveva intorno, ma riusciva a vedere solo l’oscurità più nera. Tuttavia, percepiva la presenza di qualcuno, poco lontano da lui. Era già passata più di mezz’ora da quando Artyom aveva ripreso i sensi. Pian piano si rendeva conto di dove si trovava. “Si sta risvegliando, lo sento”, pronunciò una voce rauca. “Chiamo il comandante. Il comandante li interrogherà”. Si era mosso qualcosa, poi si era fermato. Artyom cercò di stiracchiare le gambe, ma si accorse che anche queste erano state legate con il cavo; quindi provò a rotolare di lato, ma andò a colpire qualcosa di morbido. Poi udì un lamento prolungato, pieno di dolore. “Anton! Sei tu?”, sussurrò Artyom. Nessuno rispose. “Ah ah! I nemici del Grande verme si sono risvegliati...”, disse qualcuno nell’oscurità, in tono derisorio. “Sarebbe stato meglio se non aveste ripreso conoscenza”, era la stessa voce saggia e rozza che, nell’ultima mezz’ora, aveva narrato la storia del Grande verme e della creazione della vita. Fu subito chiaro che questo guardiano era diverso dagli altri abitanti della stazione: invece di esprimersi con un linguaggio primitivo, fatto di frasi sconnesse, lui parlava correttamente, quasi in maniera pomposa e persino il timbro della sua voce era del tutto umano, al contrario di quello degli altri. “Chi sei? Liberaci!”, sibilò Artyom muovendo la lingua con difficoltà. “Sì, sì. È quello che dicono tutti. No, sfortunatamente, a prescindere da dove foste diretti, il vostro viaggio è giunto al termine. Vi tortureranno e poi vi cucineranno. E voi cosa farete?”, rispose la voce dall’oscurità, piena di indifferenza. “Anche tu sei... imprigionato?”, chiese Artyom. “Beh, siamo tutti in prigione. Ma voi verrete liberati oggi stesso”, ridacchiò il suo compagno invisibile. Anton si lamentò di nuovo e cominciò a muoversi. Borbottò qualcosa di incomprensibile ma non aveva ancora ripreso conoscenza. “Perché siamo tutti seduti qui, nell’oscurità, come abitanti delle caverne?” Venne acceso un accendino e la fiamma illuminò il volto dell’uomo che aveva parlato: aveva una lunga barba grigia e sporca, capelli imbrattati e opachi, occhi beffardi, che si perdevano in una ragnatela di rughe. Di sicuro era sulla sessantina. Sedeva su una sedia, dall’altra parte delle sbarre di ferro che dividevano in due la stanza. Anche alla VDNKh avevano un luogo del genere, che aveva un nome strano, “la gabbia delle scimmie”. Artyom aveva visto le scimmie solo nei libri di testo di biologia e in quelli dei bambini. In ogni caso, quella struttura veniva usata come prigione. “Non riuscirò mai ad abituarmi a questa dannata oscurità, devo usare questa robaccia”, si lamentò il vecchio, coprendosi gli occhi. “Beh, perché siete venuti fin qui? Non c’è abbastanza posto dall’altra parte?” “Ascolta”, Artyom non gli permise di finire di parlare. “Tu sei libero... puoi farci uscire, prima che tornino quei cannibali! Tu sei un uomo normale...” “Certo che potrei”, rispose. “Ma ovviamente non lo farò. Non scendiamo a patti con i nemici del Grande verme”. “Che diavolo è il Grande verme? Di cosa stai parlando? Io non l’ho mai sentito nominare, perciò non posso essere suo nemico...” “Non importa che tu lo abbia sentito nominare oppure no. Tu vieni da quella parte, dove vivono i suoi nemici e questo significa che voi siete delle spie”, l’inflessione derisoria nella voce del vecchio si fece all’improvviso inflessibile. “Voi avete le armi e le torce! Dannati giocattoli meccanici! Macchine per uccidere! Di quale altra prova hai bisogno per comprendere che voi, gli infedeli, siete i nemici della vita, i nemici del Grande verme?”, saltò in piedi dalla sua sedia e si avvicinò alle sbarre. “Tutto ciò che è accaduto è colpa vostra e di quelli come voi!”, il vecchio spense l’accendino surriscaldato e, nell’oscurità che invadeva la stanza, lo si sentì soffiarsi sulle dita. A quel punto si udì una nuova voce, che sibilava e faceva raggelare il sangue. Artyom si spaventò ancor di più e si ricordò di Tretyak, ucciso da un ago avvelenato. “Ti prego”, si mise a implorare con veemenza: “Prima che sia troppo tardi! Perché ti comporti così?” Il vecchio non rispose e, un minuto più tardi, la stanza venne riempita da rumori diversi tra loro: passi di piedi nudi sul cemento, respiri affannosi, il fischio dell’aria attraverso le narici. Nonostante Artyom non vide nessuno di coloro che entrarono, comprese subito che lo stavano studiando molto attentamente, lo guardavano, lo annusavano e ascoltavano il rumore assordante del cuore nel petto del ragazzo. “Il popolo del fuoco. Odora di fumo, odora di paura. Uno è l’odore della stazione dall’altra parte. L’altro è straniero. Uno, l’altro, sono nemici”, sibilò qualcuno. “Lascia che lo faccia Vartan”, ordinò un’altra voce. “Accendi il fuoco”, intimò qualcuno. L’accendino venne acceso nuovamente e, nella stanza, oltre all’uomo anziano nelle cui mani vacillava la fiamma, c’erano tre selvaggi con la testa rasata, che si proteggevano gli occhi con le mani. Artyom aveva già avuto modo di vederne uno, quello più tarchiato e con la barba. Anche gli altri gli sembravano visi già conosciuti. Osservando Artyom negli occhi, fece un passo avanti e si fermò alle sbarre. Il suo odore non era come quello degli altri: il ragazzo vi percepì un vago puzzo di carne decomposta. Non riuscivano a smettere di osservarlo. Artyom trasalì, perché comprese dove aveva visto quel viso in precedenza: era la creatura che lo aveva attaccato nella notte alla Kievskaya. Una strana sensazione si impadronì di lui: era simile a una paralisi, solo che questa volta era la sua mente a essere colpita. I suoi pensieri si fermarono e, obbediente, mostrò la sua coscienza al silenzioso inquisitore. “Attraverso una botola... rimasta aperta... Sono venuti per il bambino, il figlio di Anton. Lo hanno rapito durante la notte. È tutta colpa mia, gli ho permesso di ascoltare la vostra musica nel tubo... Sono salito sul carrello. Non l’ho raccontato a nessun altro. Siamo arrivati insieme. Non l’abbiamo chiusa...”. Artyom rispose alle domande che sembrava sorgessero spontanee nella sua testa. Era impossibile resistervi o nascondere qualcosa alla voce silenziosa che esigeva delle risposte. Colui che interrogò Artyom venne a sapere tutto ciò che gli interessava in meno di un minuto. Poi annuì e fece un passo indietro. L’accendino venne spento. Lentamente, come quando ritorna la forza in una mano intorpidita, Artyom riacquistò il controllo di sé. “Vovan, Kulak! Tornate nella galleria, al passaggio. Chiudete la porta!”, diede istruzioni una delle voci, con tutta probabilità si trattava del comandante con la barba. “I nemici rimarranno qui. Dron controllerà. Domani sarà festa, il popolo mangerà i nemici, onorerà il Grande verme”. “Che avete fatto a Oleg? Cosa gli avete fatto?”. Artyom inveì contro di loro, ma la porta si richiuse emettendo un rumore sordo. CAPITOLO 17 : I FIGLI DEL VERME Passarono diversi minuti nella più totale oscurità e Artyom, credendo di essere rimasto solo, cercò di alzarsi, almeno per mettersi seduto. I cavi che gli cingevano gambe e mani erano stati annodati stretti e le estremità erano intorpidite e doloranti. Il ragazzo si ricordò le parole del patrigno che gli spiegava in che modo sulla pelle potesse formarsi una necrosi, se una fasciatura o un laccio emostatico rimanevano legati troppo a lungo. Ciononostante, gli pareva che ormai non avesse più alcuna rilevanza. “Nemico, stai fermo!”, lo intimidì la voce. “Dron sparerà l’ago paralizzante!” “Non è necessario”, Artyom si bloccò subito, obbediente. “Non devi sparare”. Aveva una flebile speranza. Forse sarebbe riuscito a convincere il suo carceriere ad aiutarli a fuggire. Ma come fare a parlare con un selvaggio che a malapena ti comprende? “Chi è questo Grande verme?”, pose la prima domanda che gli venne in mente. “Il Grande verme crea la Terra. Crea il mondo, crea l’uomo. Il Grande verme è tutto. Il Grande verme è la vita. I nemici del Grande verme, il popolo delle macchine, sono la morte”. “Non ne ho mai sentito parlare”, ribatté Artyom, scegliendo con attenzione le parole. “Dove vive?” “Il Grande verme vive qui. Vicino a noi. Attorno a noi. Il Grande verme scava tutti i passaggi. L’uomo dice che è lui. No. Il Grande verme. Dà la vita, prende la vita. Scava nuovi passaggi, il popolo li abita. I buoni onorano il Grande verme. I nemici del Grande verme vogliono ucciderlo. Lo dicono i sacerdoti”. “Chi sono questi sacerdoti?” “Uomini anziani, con capelli in testa. Solo loro possono. Loro sanno, ascoltano i desideri del Grande verme, poi li comunicano al popolo. I buoni fanno come dicono. I cattivi non obbediscono. I cattivi sono il nemico, noi li mangiamo”. Richiamando alla mente la conversazione che aveva udito per caso, pian piano Artyom cominciò a capire: con tutta probabilità, il vecchio che aveva raccontato la leggenda del verme era uno di quei sacerdoti. “Il sacerdote dice: è vietato mangiare la gente. Dice che il Grande verme piange quando un uomo ne mangia un altro”, gli rammentò Artyom, cercando di esprimersi allo stesso modo del selvaggio. “È contro il volere del Grande verme mangiare le persone. Se restiamo qui, ci mangeranno. Il Grande verme si dispererà e piangerà”, aggiunse, misurando le parole. “Certo! Il Grande verme piangerà”, si udì una voce derisoria provenire dall’oscurità. “Ma le emozioni sono emozioni e le proteine non possono essere sostituite con nessuno di quegli alimenti confezionati”, ora era l’uomo anziano a parlare, Artyom riconobbe il timbro e l’intonazione. Non sapeva se fosse rimasto nella stanza per tutto il tempo oppure se si fosse appena intrufolato, passando inosservato. Ma ciò non era importante, perché lui non l’avrebbe mai liberato da quella cella. A quel punto, un altro pensiero si insinuò nella testa di Artyom e lo fece rabbrividire. Per fortuna Anton non aveva ancora ripreso conoscenza e non poteva sentire. “E il bambino? I bambini che rapite? Mangiate anche loro? Il bambino? Oleg?”, domandò senza fare rumore, fissando l’oscurità con gli occhi spalancati dalla paura. “Non mangiamo i piccoli”, rispose il selvaggio, anche se Artyom credette che fosse ancora il vecchio a parlare. “I piccoli non possono essere malvagi. Non possono essere nemici. Prendiamo i piccoli per spiegargli come vivere. Gli spieghiamo del Grande verme. Gli insegniamo a onorarlo”. “Bravo, Dron”, si complimentò il sacerdote. “Studente modello”, aggiunse. “Cos’è accaduto al bambino che avete rapito la notte scorsa? Dov’è? È stato il vostro mostro a trascinarlo via, lo so”, li accusò Artyom. “Mostro? Chi ha dato vita a questi mostri?!”, esplose l’uomo. “Chi ha generato queste creature mute, con tre occhi, senza braccia e con sei dita, che sono morte mentre nascevano e non si possono riprodurre? Chi le ha private di un aspetto umano, gli ha promesso il paradiso e le ha mandate a morire nelle viscere senza uscita di questa città maledetta? Di chi è la colpa e chi è il vero mostro?” Artyom non rispose. Anche il vecchio non disse più nulla, respirava rumorosamente per cercare di calmarsi. Infine Anton riprese i sensi. “Dov’è?”, la sua voce era rauca. “Dov’è mio figlio? Dov’è mio figlio? Ridatemi mio figlio!”, si mise a urlare e, cercando di liberarsi, si rotolò sul pavimento andando a colpire prima le sbarre della gabbia, poi la parete. “Violento”, osservò il vecchio con lo stesso tono derisorio che aveva utilizzato fino a quel momento. “Dron, fallo calmare”. Si udì un rumore strano, come se qualcuno avesse tossito, quindi qualcosa sibilò nell’aria e, dopo qualche secondo, Anton tornò a essere calmo. “Molto educativo”, sottolineò il sacerdote. “Andrò a prendere il bambino, gli mostrerò il suo papà. Gli dovrà dire addio. A proposito, è molto bravo, il padre deve essere fiero di lui, resiste molto bene all’ipnosi...” Si udirono dei passi strascicati, poi la porta stridette. “Niente paura”, il carceriere pronunciò le parole in maniera sommessa. “I buoni non uccidono e non mangiano i bambini dei nemici. I piccoli non hanno peccato. Gli possiamo insegnare a vivere bene. Il Grande verme perdona i nemici giovani”. “Mio Dio, ma che diamine è questo Grande verme? È totalmente assurdo! Peggio dei miscredenti e dei satanisti! Come puoi credere in lui? Qualcuno lo ha mai visto, questo tuo verme? Lo hai visto oppure no?”. Artyom provò la via del sarcasmo, ma stare sdraiato a terra con le braccia e le gambe legate rendeva le cose più difficili. Come quando era rimasto ad aspettare nella prigione dei fascisti, prima che lo impiccassero, dentro di lui crebbe l’indifferenza nei confronti del suo stesso destino. Poggiò la testa sul pavimento freddo e chiuse gli occhi, attendendo una risposta. “È vietato guardare il Grande verme. Proibito!”, replicò seccamente il selvaggio. “È impossibile”, ribatté Artyom riluttante. “Non esiste nessun verme... Le persone hanno costruito le gallerie, sono tutte annotate sulle mappe... Ce n’è anche una rotonda, dove si trova l’Hansa. Solo l’uomo può costruirne di rotonde. Non so nemmeno se hai idea di cosa sia una mappa...” “Lo so”, rispose tranquillo Dron. “La studio con i sacerdoti, ce la mostrano. Sulla mappa non ci sono molti passaggi. Il Grande verme ne ha costruiti di nuovi e non sono ancora segnati. Anche qui, a casa nostra, ci sono nuovi passaggi, quelli sacri che non sono sulla mappa. Gli uomini delle macchine creano le mappe e pensano di poter scavare i passaggi. Sono stupidi, orgogliosi. Non sanno niente. Il Grande verme li punisce per questo”. “Perché li punisce?”, Artyom non comprendeva. “Per la loro arr... arr-o-ganza”, articolò attentamente il selvaggio. “Per l’arroganza”, confermò la voce del sacerdote. “Il Grande verme creò l’uomo per ultimo. Era la sua progenie preferita. Non aveva dotato nessun’altra creatura d’intelletto, solo l’uomo. Sapeva che l’intelligenza era una giocattolo pericoloso, perciò ordinò: ‘Vivete nel mondo con la terra, con la vita e tutte le creature. Onoratemi’. Dopodiché il Grande verme scese nelle profondità della Terra, ma prima disse ancora: ‘Verrà il giorno in cui io ritornerò. Comportatevi come se fossi qui con voi’. L’uomo obbedì al suo creatore e visse nel mondo che aveva creato, insieme ai suoi simili e alle altre creature. Tutti rispettavano il Grande verme. Generò dei figli e i suoi figli diedero la vita altri figli. Di padre in figlio, di madre in figlia tramandavano le parole del Grande verme. Ma coloro che avevano udito i suoi ordini con le loro stesse orecchie ben presto morirono e se ne andarono anche i loro figli, diverse generazioni si susseguirono e il Grande verme non era ancora tornato. Poi, uno dopo l’altro, gli uomini smisero di rispettare la sua volontà e si comportarono come più gli aggradava. Vi erano coloro che dichiaravano: ‘Non è mai esistito nessun Grande verme, men che meno adesso’. Altri si aspettavano che il Grande verme tornasse e li punisse. Li avrebbe ridotti in cenere con la luce dei suoi occhi, avrebbe divorato i loro corpi e fatto crollare i passaggi in cui vivevano. Ma il Grande verme non è tornato. Si è solo disperato per quelle persone. Le sue lacrime sono salite dalle profondità della terra e hanno inondato i passaggi inferiori. Ma coloro che hanno voltato le spalle al loro creatore hanno dichiarato: ‘Nessuno ci ha creati, noi siamo sempre esistiti. L’uomo è bellissimo e potente, non può essere stato creato da un verme qualunque!”. Dissero inoltre: ‘Tutta la Terra è nostra, è sempre stata nostra e lo sarà per l’eternità. Non è stato il Grande verme a rosicchiare i passaggi, ma li hanno costruiti i nostri antenati’. Così accesero un fuoco e cominciarono a uccidere le creazioni del Grande verme sostenendo un solo credo: ‘Tutta la vita che ci circonda è nostra e tutto esiste solo per soddisfare la nostra fame’. Crearono le macchine per uccidere più velocemente, per seminare morte e distruzione sulle vite create dal Grande verme e per soggiogare il suo mondo. Ma nemmeno allora Lui risalì dalle profondità più estreme in cui si era rifugiato. Loro risero e cominciarono a comportarsi ancora peggio, a contravvenire alle regole che Lui aveva dettato. Lo fecero per disonorarlo e costruirono macchine che potessero imitare le sue qualità. Crearono macchinari, vi entrarono e risero di nuovo: ‘Ecco! Ora possiamo governare come il Grande verme; ma noi non siamo un’unica creatura, bensì decine. I nostri occhi sparano fulmini e quando arriviamo noi risuona il tuono e le creature abbandonano i loro rifugi. Abbiamo generato il verme, non è stato Lui a partorire noi’. Tuttavia, nemmeno questo fu sufficiente. Il loro cuore si alimentava d’odio, così decisero di distruggere la terra su cui vivevano. Crearono migliaia di macchine diverse: che emettevano fuoco, che sputavano ferro, che affettavano la terra in piccole parti. Quindi presero a distruggere la Terra e tutti gli esseri viventi che la abitavano. Ma il Grande verme non riusciva a sopportare tutto ciò e li condannò. Gli confiscò il loro dono più importante, l’intelletto. La follia li pervase, rivolsero le macchine contro la loro stessa specie e cominciarono a uccidersi l’un l’altro. Non ricordavano più perché stessero facendo una cosa simile, ma non riuscivano a fermarsi. Fu così che il Grande verme punì l’uomo per la sua arroganza”. “Ma non tutti gli uomini?”, domandò la voce di un bambino. “No, vi erano anche coloro che ancora ricordavano il Grande verme e lo avevano sempre onorato. Avevano rinunciato alle macchine e alla luce per vivere in questo mondo, all’interno della Terra. Essi vennero salvati e il Grande verme non dimenticò mai la loro lealtà. Non li privò del loro intelletto e gli promise il mondo intero, non appena i nemici si fossero arresi. E così sarà”. “Così sarà”, ripeterono insieme il selvaggio e il bambino. “Oleg?”, lo richiamò Artyom, udendo una cadenza familiare nella voce del piccolo. Il bambino non rispose. “Ancora oggi, i nemici del Grande verme vivono nei passaggi che hanno scavato perché non possono rifugiarsi da nessun’altra parte. Lì non venerano Lui, ma continuano a idolatrare le loro macchine. La pazienza del Grande verme è enorme, è stata sufficiente per diversi secoli di oltraggi umani. Però non sarà così in eterno: è stato predetto che quando Lui assesterà il colpo finale al cuore oscuro del paese del nemico, quest’ultimo verrà annientato e il mondo cadrà in mano al popolo dei buoni. È stato predetto che verrà il momento in cui il Grande verme invocherà l’aiuto dei fiumi, della terra e dell’acqua. La crosta terrestre affonderà, le correnti ribolliranno e scorreranno veloci, finché il cuore oscuro del nemico sprofonderà nell’oblio. Infine, Lui riuscirà a trionfare e i buoni saranno felici, non esisteranno più malattie e ci saranno funghi in abbondanza per tutti”. Una fiamma si accese: Artyom era riuscito ad appoggiare la schiena contro la parete e ora non doveva più piegarsi in maniera dolorosa perché le persone al di là delle sbarre rimanessero all’interno del suo campo visivo. Nel bel mezzo della stanza, un bambino sedeva a terra a gambe incrociate e gli dava le spalle. Sopra di lui incombeva la sagoma avvizzita del sacerdote, illuminata dalla fiammella dell’accendino acceso che teneva in mano. Il selvaggio con la cerbottana in mano era di fianco a loro, appoggiato allo stipite della porta. I loro occhi erano fissi sul vecchio che aveva appena terminato il suo racconto. Artyom girò la testa con difficoltà e si mise a guardare Anton, che era rimasto immobile nella stessa posizione convulsa in cui lo aveva paralizzato l’ago. Fissava il soffitto e non riusciva a vedere il figlio, ma sicuramente era riuscito a sentire tutto. “Alzati, ragazzo mio, e osserva questa gente”, ordinò il sacerdote. Il bambino si levò in piedi e si voltò verso Artyom. Era Oleg. “Avvicinati. Li riconosci?”, domandò il vecchio. “Sì”, il bambino annuì, osservando Artyom corrucciato. “Lui è mio papà, mentre con lui ho ascoltato le vostre canzoni nei tubi”. “Il tuo papà e il suo amico sono persone cattive. Usano le macchine e disprezzano il Grande verme. Ricordi quando hai detto a me e a zio Vartan cos’ha fatto tuo papà quando i cattivi hanno deciso di distruggere il mondo?” “Sì”, Oleg annuì di nuovo. “Ce lo vuoi raccontare di nuovo?”, il vecchio afferrò l’accendino con l’altra mano. “Mio papà lavorava per le RVA, le forze missilistiche. Era un esperto di missili. Una volta, anche io sarei voluto diventare come lui”. La gola di Artyom si inaridì. Come aveva fatto a non capire l’enigma, quando il bambino glielo aveva rivelato? Ecco dove aveva trovato quello strano stemma e perché aveva dichiarato di essere un esperto di missili, proprio come il povero Tretyak! Si trattava di una coincidenza incredibile. Nella Metro erano rimaste anche persone che servivano nelle forze missilistiche e due di loro si trovavano alla Kievskaya. Poteva essere un caso? “Un esperto di missili... Persone come lui crearono il peggior male del mondo, ancor più di tutti gli altri messi insieme. Azionavano macchine ed equipaggiamenti che bruciarono e distrussero la Terra e tutte le forme di vita. Il Grande verme perdona coloro che si allontanano da lui, ma non quelli che distruggono il mondo e seminano la morte, non quelli che hanno attuato un tale progetto. Tuo padre ha causato un dolore intollerabile al Grande verme. Tuo padre ha distrutto il nostro mondo con le sue stesse mani. Sai che cosa merita?”, la voce del vecchio si era fatta severa. “La morte?”, domandò il bambino esitante, osservando prima il sacerdote, poi suo padre, ripiegato su se stesso sul pavimento della gabbia. “La morte”, confermò il sacerdote. “Deve morire. Prima moriranno quelli che hanno inflitto sofferenze al Grande verme, prima verrà esaudita la sua promessa; il mondo rinascerà e verrà riconsegnato nelle mani dei buoni”. “Allora il papà deve morire”, convenne Oleg. “Bravo, ragazzo!”, il vecchio diede qualche colpetto affettuoso sulla testa del bambino. “Ora va’, torna a giocare con lo zio Vartan e gli altri bambini! Fa’ attenzione a non cadere nell’oscurità! Dron, accompagnalo. Io rimarrò ancora un po’ qui con gli uomini. Torna tra mezz’ora con gli altri e porta i sacchi. Noi saremo pronti”. Venne spenta la luce. Il fruscio veloce dei passi del selvaggio, insieme a quelli leggeri del bambino, svanirono in lontananza. Il sacerdote tossì e si rivolse ad Artyom: “Vorrei fare quattro chiacchiere con voi, se non vi dispiace. Di solito non catturiamo nessuno, a meno che non si tratti di bambini, che sono sempre minuti e malaticci... Ma gli adulti che arrivano fin qui... Beh, mi piacerebbe poter parlare con loro, solo che... se li mangiano troppo velocemente...” “Perché insegnate loro che è male mangiare le altre persone?”, domandò Artyom. “Mi stai chiedendo il perché del verme che si dispera e tutto il resto? Beh, come posso spiegartelo? È per il loro futuro. Ovviamente, tu non li vedrai crescere e forse nemmeno io, ma ora stiamo gettando le basi per il futuro di una civiltà: una cultura che vivrà in armonia con la natura del mondo. Il cannibalismo è un male necessario per loro. Nulla sopravvive se non si sostenta di proteine animali. Ma le leggende rimarranno vive e quando il bisogno diretto di uccidere e di abbuffarsi della carne dei propri simili svanirà, loro non lo faranno più. Solo allora il Grande verme si ricorderà. Per voi è stata una sfortuna vivere in questo periodo tanto affascinante...”, il vecchio si mise a ridere in maniera sgradevole. “Ho visto moltissime cose diverse nella Metropolitana”, ribatté Artyom. “In una stazione credevano che, se avessero scavato a sufficienza, sarebbero giunti all’inferno. In un’altra, sostenevano che fossimo già sulla soglia del Paradiso, perché la battaglia finale tra il bene e il male si era già svolta e coloro che erano riusciti a sopravvivere erano stati scelti per entrare nel Regno del Paradiso. Dopo tutto ciò la storia del tuo Grande verme non mi pare per nulla convincente. Almeno tu ci credi?” “Che differenza fa? Cosa c’entra ciò che io o gli altri sacerdoti crediamo?”, ghignò il vecchio. “Tu non sopravvivrai molto a lungo, ti rimangono poche ore, perciò ti racconterò una cosa. Si può essere così onesti solo con quelli che si porteranno tutte le rivelazioni nella tomba. Ciò in cui io credo non è rilevante. L’importante è che la gente creda. È difficile credere in un dio che ho creato io stesso”, il sacerdote si interruppe per un istante, rifletté e continuò: “Come posso spiegartelo? Quando ero uno studente all’Università, seguii corsi di filosofia e di psicologia, anche se dubito che tu sappia di cosa si tratta. Avevo un professore che insegnava psicologia cognitiva; era un uomo estremamente colto, che strutturava i processi intellettuali in maniera sistematica. Era un vero piacere ascoltarlo. Un giorno gli posi una domanda, la stessa che, a quel tempo, ronzava in testa a tutti i ragazzi della mia età: ‘Dio esiste?’ Avevo letto diversi libri, ne avevo discusso con altri, come si è soliti fare in quell’ambiente; mi ero persuaso che Lui non esistesse. Non so perché, ma avevo deciso che quel professore in particolare, grande esperto dell’animo umano, potesse rispondere in modo dettagliato alla domanda che tanto mi affliggeva. Mi recai nel suo ufficio, con il pretesto di discutere di un componimento, quindi gli domandai: ‘Secondo lei, Ivan Mikhalych, Dio esiste davvero?’ La sua risposta mi sorprese alquanto. Mi disse: ‘Secondo la mia opinione non vale la pena rispondere a una domanda del genere. Io provengo da una famiglia di credenti, abituata all’idea che Lui esista. Dal punto di vista psicologico, non ho nemmeno provato ad analizzare la verità perché non ne trovavo l’utilità. In generale, non si tratta di una domanda cognitiva basata su un principio, come un comportamento quotidiano. La mia fede non mi dà la convinzione di un potere supremo, ma la spinta ad adempiere a dei comandamenti prestabiliti, a pregare prima di coricarmi e a recarmi in chiesa. Per me è meglio così, mi sento più in pace’. Questo è quanto”, così dicendo il vecchio ammutolì. “E con ciò?”, Artyom non riuscì a trattenersi. “Che io creda o meno nel Grande verme non è così importante. Ma i comandamenti pronunciati dalle labbra divine sopravvivono per secoli. Un’ultima cosa: crea un dio e insegna la sua parola. Credimi, il Grande verme non è peggiore di altri dèi, ed è riuscito a sopravvivere a molti di loro”. Artyom chiuse gli occhi. Né Dron né il capo di questa sorprendente tribù e neppure strane creature come Vartan mettevano in dubbio l’esistenza del Grande verme. Per loro era qualcosa di prestabilito, l’unica spiegazione per ciò che vedevano attorno a loro, l’unica autorità per agire e il solo termine di paragone con cui giudicare il bene e il male. In cos’altro poteva credere un uomo che non aveva mai visto nient’altro che la Metro? Ma, tra le leggende riguardanti il verme, c’era ancora qualcosa che Artyom non riusciva a comprendere. “Perché li istighi tanto contro le macchine? Cosa c’è di male nei nostri meccanismi? L’elettricità, la luce, le armi e il resto... Dai tuoi insegnamenti si evince che la gente deve vivere senza queste comodità”, fece notare al vecchio. “Cosa c’è di male nelle macchine?!”, il tono dell’anziano cambiò in maniera drammatica: la gentilezza e la pazienza con cui aveva esposto i suoi pensieri fino ad allora si erano dissolte nel nulla. “Un’ora prima della tua morte vuoi insegnare a me i benefici delle macchine?! Beh, guardati attorno! Solo un cieco non noterebbe che, se l’umanità avesse avuto un po’ più di senno, non si sarebbe affidata alle macchine! Come osi propinarmi le tue chiacchiere sul ruolo degli equipaggiamenti, proprio qui alla mia stazione? Tu non sei nessuno!” Artyom non si aspettava che la sua domanda, molto meno sediziosa della precedente riguardante la fede nel Grande verme, provocasse una tale reazione nel vecchio. Non sapendo cosa rispondere, rimase in silenzio. Il respiro affannato dell’anziano si sentiva nell’oscurità; sussurrava imprecazioni e cercava di calmarsi. Riprese a parlare solo dopo diversi minuti. “Non sono abituato a parlare con i miscredenti”. A giudicare dalla voce, il vecchio era riuscito a ricomporsi. “Mi sono fatto prendere dall’impeto della conversazione. C’è qualcosa che sta trattenendo i piccoli. Non ci hanno ancora portato i sacchi”. Fece un’altra pausa significativa. “Quali sacchi?”, il ragazzo rispose alla domanda strategica. “Vi prepareranno: quando ho parlato di tortura, non sono stato preciso. L’inutile crudeltà va contro gli insegnamenti del Grande verme. Quando io e miei colleghi ci rendemmo conto che qui il cannibalismo aveva attecchito e non potevamo più fare nulla per impedirlo, decidemmo di occuparci del lato culinario della questione. Qualcuno si ricordò dei coreani che, quando mangiavano i cani, li catturavano vivi, li infilavano in sacchi e li uccidevano a bastonate. La carne ne trae un enorme beneficio. Diventa più morbida, più tenera. I molteplici ematomi di un uomo sono una leccornia per un altro. Perciò, ti chiedo di non giudicarci con severità. Anche io preferirei prima morire e poi essere preso a bastonate. Inevitabilmente vi saranno delle emorragie interne, ma una ricetta è una ricetta”. Il vecchio illuminò la stanzetta con l’accendino per vedere l’effetto che aveva prodotto la sua rivelazione. “Tuttavia, c’è qualcosa che li trattiene, non sarebbe dovuto accadere...”, aggiunse. Un fischio lo interruppe. Artyom udì delle urla, delle corse, dei pianti di bambini, poi di nuovo quel fischio sinistro. Alla stazione era accaduto qualcosa. Anche il sacerdote ascoltava i rumori con apprensione, quindi spense l’accendino e non disse altro. Diversi minuti più tardi, si udì il frastuono di scarponi sulla soglia della porta e una voce profonda mormorò: “Qualcuno è ancora vivo?” “Sì, siamo qui! Artyom e Anton!”, urlò il ragazzo con tutta l’aria che aveva nei polmoni, sperando che il vecchio non fosse armato di cerbottana e aghi avvelenati. “Eccoli qui! Coprite sia me che il bambino!”, gridò qualcun altro. La stanza venne rischiarata da una luce abbagliante, il vecchio si lanciò verso l’uscita, ma l’uomo che bloccava il passaggio lo colpì sul collo e il sacerdote cominciò ad ansimare e quindi cadde a terra. “La porta, tenete la porta!”, qualcosa stava crollando; dell’intonaco si staccò dal soffitto e la polvere infastidì Artyom, che chiuse gli occhi. Quando li riaprì, c’erano due uomini nella stanza. Non si trattava di soldati ordinari, in effetti Artyom non aveva mai visto niente del genere in vita sua. Indossavano lunghi e pesanti giubbotti antiproiettile sopra uniformi nere fatte su misura, erano entrambi armati di insolite mitragliatrici corte, con mirini laser e silenziatori. Inoltre, avevano enormi elmetti in titanio con copertura per il viso, come quelli degli Spetsnaz dell’Hansa, e grossi scudi, anch’essi in titanio con fori per gli occhi. Avevano un aspetto straordinario. Alle spalle di uno degli uomini era visibile un lanciafiamme. Ispezionarono velocemente la stanza, illuminandola con lunghe torce incredibilmente potenti, a forma di manganelli. “Sono questi?”, chiese uno degli uomini. “Sono loro”, confermò l’altro. Il primo soldato esaminò subito il lucchetto della gabbia, fece qualche passo indietro e saltò, colpendo le sbarre della cella con i suoi scarponi. I cardini arrugginiti si ruppero e la porta cadde a pochi centimetri da Artyom. L’uomo si abbassò su un ginocchio davanti al ragazzo e sollevò la maschera di protezione. A quel punto Artyom comprese: era Melnik, che lo guardava di traverso. Con il suo enorme coltello a serramanico spezzò i cavi che gli tenevano legate le gambe e le mani, quindi passò ad Anton. “Sei vivo”, sottolineò Melnik soddisfatto. “Riesci a camminare?” Artyom annuì, ma non riuscì a rialzarsi: il suo corpo era troppo intorpidito e non riusciva ancora a controllarlo del tutto. Altri uomini entrarono nella stanza e due di loro si misero alla porta e assunsero subito una posizione di difesa. In totale c’erano otto combattenti. Erano tutti vestiti ed equipaggiati come quello che aveva assaltato la stanza, ma molti di loro indossavano anche dei lunghi impermeabili di pelle, proprio come quello di Hunter. Uno di loro fece scendere a terra il bambino che teneva tra le braccia e lo coprì con lo scudo che portava al braccio. Il piccolo entrò immediatamente nella cella e si mise al capezzale di Anton. “Papà! Papà! Ho mentito perché pensassero che fossi dalla loro parte! Ho mostrato ai soldati dove vi trovavate! Perdonami, papà! Papà, di’ qualcosa!”, il bambino non riuscì a trattenere le lacrime. Anton osservava il soffitto con occhi inespressivi. Artyom temeva che due aghi paralizzanti in un solo giorno potessero essere troppi per il comandante della guardia. Melnik toccò il collo di Anton con due dita. “Sta bene”, concluse dopo qualche secondo. “È vivo. Portate una barella!” Mentre Artyom spiegava allo stalker l’effetto degli aghi paralizzanti, due altri combattenti aprirono una barella di tela, la poggiarono a terra e vi sistemarono sopra Anton. A terra, il vecchio si agitava e si mise a borbottare qualcosa. “Chi è questo?”, domandò Melnik e, dopo aver ascoltato la descrizione del ragazzo, ordinò agli altri: “Lo porteremo con noi e lo useremo come copertura. Com’è la situazione?” “Tutto tranquillo”, riportò uno dei soldati alla guardia della porta. “Torniamo nella galleria”, disse allora lo stalker. “Dobbiamo portare il ferito alla base, insieme all’ostaggio, così lo potremo interrogare. Forza, andiamo”. Così dicendo, lanciò ad Artyom una mitragliatrice e aggiunse: “Se tutto va come pianificato, non dovrai usarla. Non hai alcuna protezione, perciò faresti meglio a stare dietro di noi. Tieni d’occhio il piccolo”. Artyom annuì e prese per mano Oleg, trascinando via il bambino dalla barella del padre. “Posizioniamoci a tartaruga”, ordinò Melnik. Un attimo dopo i combattenti formarono un ovale, mettendo in avanti gli scudi in maniera tale che sembravano tutti collegati l’uno all’altro; oltre agli scudi, erano visibili solo gli elmetti. Quattro di loro portavano la barella con le mani libere. Il bambino e Artyom erano all’interno della formazione, completamente protetti dagli scudi. Imbavagliarono il vecchio, gli legarono le mani dietro la schiena e lo misero nella posizione di testa. Dopo diversi colpi ben assestati smise di cercare di liberarsi, si calmò e prese a fissare scontroso il pavimento. I primi due soldati, quelli che erano dotati di speciali strumenti per la visione notturna, erano gli occhi della tartaruga. I dispositivi erano fissati direttamente ai loro elmetti, perché avessero le mani libere. Al comando, la compagnia si chinò un poco, per fare in modo che anche le gambe venissero coperte dagli scudi, e si mise a procedere velocemente. Stretto tra i combattenti, Artyom teneva la mano di Oleg e lo trascinava in avanti. Non riusciva a vedere nulla e capiva ciò che succedeva al di fuori solo dalle frasi asciutte che carpiva. “Tre a destra... Donne e un bambino”. “A sinistra! Sotto l’arco, sotto l’arco! Stanno sparando!”, gli aghi cominciarono ad attaccare il metallo degli scudi. “Abbatteteli!”, per tutta risposta si udì il rombo delle mitragliatrici. “Eccone uno... Due... Continuate a muovervi, muovetevi!” “Da dietro! Lomov!” “Altri spari!” “Dove, dove? Non andate laggiù!” “Avanti, ho detto! Tenete l’ostaggio!” “Dannazione, mi è volato davanti agli occhi...” “Fermi! Fermi! Stop!” “Che c’è lì davanti?” “È tutto bloccato! Ci saranno almeno quaranta persone! Una barricata!” “È lontana?” “Venti metri. Non sparano”. “Si stanno avvicinando dai lati!” “Sono riusciti a costruire una barricata in così poco tempo?” Una pioggia di aghi colpì gli scudi. Al segnale si abbassarono tutti su un ginocchio in modo che fossero completamente protetti. Anche Artyom si chinò per mettere al riparo il bambino. Misero a terra la barella con Anton, mentre la cascata di aghi si intensificava. “Non rispondete! Non rispondete! Aspetteremo...” “Uno mi ha colpito lo scarpone...” “Preparate le torce... Al tre, luce e fuoco. Chiunque sia equipaggiato di visione notturna, scelga subito il suo obiettivo... Uno...” “Come sparano...” “Due! Tre!”. Diverse torce potentissime si accesero simultaneamente e le mitragliatrici presero a rombare. Provenienti da davanti a sé, Artyom udiva le urla e i lamenti dei morenti. Poi il fuoco cessò inaspettatamente e Artyom si mise in ascolto. “Laggiù! Là! Con la bandiera bianca... si stanno arrendendo?” “Cessate il fuoco! Negozieremo. Mettete davanti l’ostaggio!” “Smettila, bastardo, stai fermo! Ce l’ho! Ce l’ho! Vecchio intelligentone...” “Abbiamo il vostro sacerdote! Lasciateci uscire da qui!”, Melnik pronunciò le parole a gran voce. “Fateci tornare nella galleria! Ripeto: lasciateci uscire da qui!” “Beh, che succede? Che succede?” “Nessuna reazione. Non parlano”. “Forse non ci comprendono?” “Illuminatelo un po’ meglio...” “Date un’occhiata”. Le negoziazioni si interruppero all’improvviso. Sembrava che i combattenti fossero assorti nei loro pensieri. Cominciarono quelli nella prima fila, poi anche quelli nella retroguardia si acquietarono. Il silenzio era teso, non preannunciava nulla di buono. “Che succede?”, domandò Artyom con apprensione. Nessuno gli rispose. I soldati avevano persino smesso di proseguire. Artyom sentì che il palmo della mano che teneva quella del bambino aveva cominciato a sudare. Il piccolo la scosse. “Sento... che ci sta fissando...”, disse a bassa voce. “Liberate l’ostaggio!”, ordinò Melnik all’improvviso. “Liberate l’ostaggio!”, ripeté un altro combattente. Artyom non riuscì più a trattenersi e si raddrizzò per sbirciare al di là degli scudi e degli elmetti: davanti a loro, a una decina di metri, dove si incontravano tre accecanti raggi luminosi, si trovava un uomo alto che reggeva con la mano nodosa uno straccio bianco. I suoi occhi non erano infastiditi dalla luce e non cercava nemmeno di ripararli con le mani, il suo viso si riusciva a distinguere con chiarezza: era simile a Vartan, quello che lo aveva interrogato qualche ora prima. Artyom si rituffò dietro gli scudi e fece scattare la sicura della sua mitragliatrice, dopo aver preparato il caricatore. La scena a cui aveva appena assistito era rimasta tale: sia inquietante che affascinante, gli fece ricordare per un momento un vecchio libro, “Racconti e miti dell’Antica Grecia” che adorava guardare quando era bambino. Una delle leggende raccontava di una creatura mostruosa, semi umana, il cui sguardo aveva trasformato diversi valorosi guerrieri in pietra. Fece un sospiro, radunò tutta la sua forza di volontà per evitare di guardare il viso dell’ipnotizzatore, superò gli scudi come una scheggia e premette il grilletto. Dopo la strana, muta battaglia tra mitragliatrici con silenziatori e cerbottane, il rumore del Kalashnikov sembrò distruggere le volte della stazione. Sebbene Artyom fosse convinto che sarebbe stato impossibile mancarli da una tale distanza, accadde ciò che più temeva: la creatura aveva compreso le sue intenzioni e non appena la testa di Artyom apparve da sopra gli scudi, il suo sguardo si serrò su quegli occhi senza vita. Riuscì a mettere in azione la mitragliatrice, ma una mano invisibile riuscì abilmente a spostare di lato la canna dell’arma. Sparò praticamente a vuoto, solo un proiettile andò a segno e colpì alla spalla la creatura, che emise un assordante suono gutturale e poi, con un movimento elusivo, scomparve nell’oscurità. “Abbiamo pochi secondi”, pensò Artyom. Solo qualche secondo. Quando la squadra di Melnik aveva fatto irruzione nella Parco della Vittoria, dalla loro avevano avuto l’elemento sorpresa. Ma ora i selvaggi erano riusciti a organizzare una forza di difesa e sembrava non vi fosse alcuna possibilità di superare quella barricata. L’unica soluzione che rimaneva era dirigersi dalla parte opposta. Le parole del suo carceriere gli risuonarono nella mente: le gallerie che non sono sulla mappa della Metro permettono di uscire dalla stazione. “Ci sono altre gallerie qui?”, domandò a Oleg. “C’è un’altra stazione, oltre il passaggio. È proprio come questa, come fosse riflessa in uno specchio”, il bambino indicò con la mano. “Siamo andati a giocare laggiù, ci sono gallerie come queste, ma ci hanno detto che era proibito andarci”. “Torniamo indietro! Verso il passaggio!”, urlò Artyom a squarciagola, cercando di imitare la voce profonda e autoritaria di Melnik. “Ma che diavolo...?”, lo stalker ringhiò con disprezzo. Era ritornato in sé. Artyom lo prese per una spalla. “Presto, hanno un ipnotizzatore”, farfugliò. “Non possiamo superare quello sbarramento! C’è un’altra uscita laggiù, oltre quel passaggio!” “È vero, questa stazione ha una gemella... Andiamo!”, lo stalker accettò la decisione. “Mantenete la formazione! Indietro, piano!” Gli altri cominciarono a spostarsi lentamente, come controvoglia. Impartendo nuovi ordini, Melnik riuscì a fare in modo che la squadra si ricomponesse e battesse la ritirata prima che altri aghi potessero raggiungerli dall’oscurità. Quando si rimisero in piedi si trovavano sui gradini del passaggio, poi il combattente che si trovava all’estremità posteriore della formazione strillò e si afferrò lo stinco. Continuò a salire gli scalini, ma era palese che le gambe gli si stessero irrigidendo; infatti, dopo pochi secondi ebbe un crampo che lo atterrò e lo fece contorcere come un panno strizzato. Quindi rimase immobile a terra. Il gruppo si fermò. Dietro la copertura di scudi, due soldati si adoperarono per fare alzare il loro compagno, ma ormai era tutto finito. Il suo corpo stava diventando completamente blu davanti ai loro occhi, mentre dalla bocca fuoriusciva una spessa schiuma. Sia Artyom che Melnik sapevano cosa significava. “Prendi il suo scudo, l’elmetto e la mitragliatrice. Veloce!”, ordinò ad Artyom. “Andiamo, forza!”, urlò agli altri. L’elmetto in titanio che avrebbe dovuto sfilare dalla testa dell’uomo era ricoperto di quella terribile schiuma e Artyom non riuscì proprio a eseguire l’ordine dello stalker. Si limitò a raccogliere la mitragliatrice e lo scudo, prese posizione nella retroguardia della formazione, si protesse con lo scudo e cominciò a procedere dietro agli altri. Ormai stavano quasi correndo. A quel punto qualcuno lanciò un fumogeno e, approfittando della confusione, la squadra scese sui binari. Un altro combattente lanciò un urlo e cadde a terra. Erano rimasti in tre a trasportare la barella con Anton. Artyom cercò di non mostrarsi da dietro lo scudo e, diverse volte, sparò dietro di sé senza nemmeno guardare cosa colpisse. Quindi la situazione divenne improvvisamente calma: non veniva più sparato alcun ago sebbene, a giudicare dal rumore dei passi e dalle voci attorno, l’inseguimento non fosse ancora terminato. Con tutto il coraggio che aveva in corpo, Artyom decise di guardare oltre lo scudo: il gruppo si trovava a dieci metri dall’entrata della galleria. I primi soldati ci erano già entrati. Altri due, girandosi, illuminarono la strada e coprirono gli altri. Ma non ve ne fu alcun bisogno: sembrava che i selvaggi non avessero intenzione di inseguirli dentro quel tunnel, al contrario si radunarono a semicerchio, abbassarono le cerbottane e si coprirono gli occhi per proteggerli dalla luce accecante delle torce, poi si misero in attesa di qualcosa, in silenzio. “Nemici del Grande verme, ascoltate!”, il capo con la barba apparve tra la folla. “Nemici: state mettendo piede nei passaggi sacri al Grande verme. I buoni non vi inseguiranno. Oggi è vietato percorrerli. Enorme pericolo. Morte e dannazione. Nemici: riconsegnateci il vecchio sacerdote e andatevene”. “Non lasciatelo andare, non ascoltateli”, intimò lentamente Melnik. “Andiamocene”. Proseguirono con cautela. Artyom e diversi altri combattenti si spostavano all’indietro e non distoglievano lo sguardo dalla stazione che stavano abbandonando. All’inizio nessuno li seguì, ma poi si udì qualcuno: stava discutendo, dapprima non ad alta voce, ma poi con un tono sempre più concitato. “Dron non può! Dron deve andare! Per il maestro!” “Vietato andare! Stop! Stop!”, una sagoma oscura si rivelò dall’oscurità ai raggi delle torce a una tale velocità che fu impossibile colpirla. Dietro di lei ne apparvero altre in lontananza. Non riuscendo a colpire il primo selvaggio, uno dei combattenti lanciò qualcosa davanti a sé. “Giù! Granata!”. Artyom si lanciò sulle traversine con il viso rivolto verso il terreno, si coprì la testa con le mani e aprì la bocca, proprio come il patrigno gli aveva insegnato. L’incredibile rumore e la forza assordante dell’onda d’urto colpirono le sue orecchie e lo schiacciarono a terra. Rimase fermo per diversi minuti, ad aprire e chiudere gli occhi, cercando di ritornare in sé. Il frastuono gli martellava ancora in testa e vedeva cerchi colorati davanti agli occhi. Dopo aver ripreso il controllo, la prima cosa che udì furono parole disarticolate, ripetute all’infinito: “No, no, non sparare, non sparare, non sparare, Dron non è armato, non sparare!”, voltò il capo e si guardò attorno. Nel punto in cui si intersecavano i raggi delle torce, con le mani alzate, si trovava il selvaggio che gli aveva fatto la guardia mentre era imprigionato. Due soldati lo tenevano sotto fuoco, attendendo ulteriori ordini; nel frattempo gli altri si alzavano e si ripulivano, scuotendosi di dosso la densa polvere sospesa nell’aria, mentre il fumo giungeva fin lì dalla stazione. “Cosa? È crollato?”, domandò qualcuno. “Con un’unica granata... Tutta la Metro rimane in piedi per un pelo...” “Beh, per lo meno non cercheranno più di raggiungerci. Almeno finché non liberano la strada...” “Così dovrebbero essere sistemati per un po’. Andiamo, non c’è tempo, non sappiamo quanto ci metteranno a rimettersi in piedi”, ordinò Melnik. Fecero una pausa solo un’ora dopo. Durante la loro marcia, la galleria si era divisa in due e lo stalker, che conduceva il gruppo, scelse da che parte andare. In un punto videro degli enormi cerchi in ferro battuto, che con tutta probabilità erano serviti ad azionare dei portelloni. A fianco si intravvedevano i detriti di una porta a pressione. Oltre a questo, non trovarono nulla di interessante: la galleria era completamente vuota, buia e senza vita. Camminavano lenti, il vecchio inciampava a ogni passo e cadde diverse volte. Dron procedeva controvoglia e borbottava tra sé frasi riguardo i divieti e la dannazione, finché non lo imbavagliarono. Quando finalmente lo stalker gli permise di fermarsi e schierò le sentinelle dotate di dispositivi per la visione notturna a cinquanta metri in entrambe le direzioni, il sacerdote, ormai esausto, crollò al suolo. Il selvaggio continuava a implorare qualcosa di indistinto attraverso il bavaglio, fino a che le guardie non gli permisero di avvicinarsi al vecchio. A quel punto si mise in ginocchio e carezzò la testa del sacerdote con entrambe le mani legate. Il piccolo Oleg si precipitò vicino alla barella dove si trovava il padre e prese a singhiozzare. La paralisi era passata, ma Anton era ancora privo di sensi, come quando lo aveva colpito il primo ago. Nel frattempo, lo stalker richiamò Artyom al suo fianco. Il ragazzo non riusciva più a contenere la curiosità. “Come ci avete trovato? Ormai ero convinto che ci avrebbero mangiato”, ammise. “Pensi fosse difficile? Avete lasciato il carrello sotto alla botola. Le guardie lo hanno notato quando Anton non è tornato per il tè. Non si sono voluti avventurare all’interno da soli, perciò hanno lasciato una sentinella di guardia e hanno fatto rapporto al capo. Tu non mi hai aspettato nemmeno per un istante! Io sono ripartito per tornare alla Smolenskaya, alla base, per radunare dei rinforzi. Ho trovato subito degli uomini, ma avevamo bisogno di tempo per equipaggiarci. Nel frattempo mi sono messo a riflettere su quello che era accaduto alla Mayakovskaya. Laggiù la situazione è simile a qui: una galleria crollata, dove io e Tretyak ci siamo separati. Stavamo cercando l’entrata della D-6 dalla mappa. Ci trovavamo a cinquanta metri l’uno dall’altro. Molto probabilmente lui si era avvicinato di più. Sono passati tre minuti, l’ho chiamato a gran voce, ma non ha risposto. Sono corso da lui e l’ho trovato a terra, completamente blu, gonfio, con la bocca piena di quella schifezza. L’ho preso per le gambe e l’ho trascinato fino in stazione. Poi mi sono ricordato del racconto di Semyonovich sulla sentinella avvelenata; ho illuminato il corpo di Tretyak e gli ho trovato un ago piantato nella gamba. A quel punto ho cominciato a comprendere. Ti ho mandato un messo per comunicarti di rimanere alla stazione, che avrei sistemato un paio di cose e poi sarei tornato da te. Ma non ci sono riuscito”. “Allora sono anche alla Mayakovskaya?”, Artyom era sorpreso. “Ma come sono riusciti a giungere fin lì dalla Parco della Vittoria?” “Ecco come ci sono arrivati”, lo stalker si tolse il pesante elmetto e lo mise a terra. “Spero che mi perdonerai se non sono venuto fin qui solo per salvarti ma anche per portare avanti una ricognizione. Ritengo vi sia un’altra uscita che conduce alla Metro-2. Questi cannibali sono riusciti anche ad arrivare alla Mayakovskaya. A proposito, laggiù la situazione è la medesima: anche lì di notte scompaiono i bambini. Chissà dove diavolo li portano, perché non ne rimane più traccia”. “Significa che... vuole dire...”, il pensiero era sembrato talmente incredibile che Artyom stesso non osava pronunciare le parole ad alta voce: “Secondo lei, l’entrata che conduce alla Metro-2 è qui da qualche parte?” La porta della D-6, il misterioso fantasma della Metropolitana, era davvero nelle immediate vicinanze. Tutte le voci, le storie, le leggende e le teorie sulla Metro-2 che aveva sentito raccontare durante la sua vita cominciarono a vorticargli nella testa. “Lascia che ti dica anche un’altra cosa”, lo stalker gli fece l’occhiolino. “Io credo che siamo già entrati. Solo che per il momento mi è stato impossibile verificarlo”. Chiedendo una torcia a uno dei soldati, Artyom si mise a controllare le pareti della galleria. Notò lo sguardo sorpreso degli altri: di sicuro doveva sembrare uno stupido, ma non riuscì a farne a meno. Inoltre, riusciva solo in parte a comprendere cosa aspettarsi una volta raggiunta la Metro-2. Binari d’oro, forse? Gente che viveva come nel passato, in un’abbondanza fiabesca e che non conosceva gli orrori della loro vita quotidiana? Dèi? Passò da una sentinella all’altra e, non trovando niente, si rivolse di nuovo a Melnik, il quale discuteva con il combattente che sorvegliava i selvaggi. “Che ne dobbiamo fare degli ostaggi? Li finiamo?”, domandò il soldato con naturalezza. “Prima di tutto, voglio fare una chiacchierata con loro”, rispose lo stalker. Piegandosi in avanti, rimosse il bavaglio dalla bocca del vecchio, poi fece lo stesso anche con il secondo prigioniero. “Maestro! Maestro! Dron viene con te. Vengo con te, Maestro!”, si lamentò il selvaggio oscillando da una parte all’altra sopra il sacerdote gemente. “Dron sta violando il divieto di entrare nei passaggi sacri, Dron è pronto a morire per mano dei nemici del Grande verme, ma Dron viene con te, fino alla fine!” “Cos’altro c’è? Cos’è questo Grande verme? Cosa sono i passaggi sacri?”, domandò Melnik. Il vecchio non rispose. Osservando con timore i soldati, Dron spiegò in tutta fretta: “I passaggi sacri del Grande verme sono proibiti ai buoni. Il Grande verme potrebbe rivelarsi lì dentro. L’uomo può vedere. È vietato guardare! Solo i sacerdoti possono. Dron ha paura, ma viene lo stesso. Dron viene con il maestro”. “Quale verme?”, lo stalker arricciò il naso. “Il Grande verme... il creatore della vita”, spiegò Dron. “I passaggi sacri sono più avanti. Non ci si può andare tutti i giorni, ci sono giorni vietati. Oggi è un giorno vietato. Se vedi il Grande verme, diventi cenere. Se lo senti, verrai maledetto e morirai in fretta. Tutti lo sanno. Gli anziani ce lo insegnano”. “Laggiù sono tutti deficienti come questo?”, lo stalker guardò Artyom. “No”, il ragazzo scosse la testa. “Parli con il sacerdote”. “Sua Eminenza”, Melnik si rivolse al vecchio in tono ironico. “Spero che mi perdonerà, ma io sono solo un vecchio soldato... Come posso esprimermi al meglio... Io non conosco parole forbite. Ma c’è un luogo che vi appartiene, che noi stiamo cercando. Supponiamo ci si possa arrivare... Vi sono custoditi degli oggetti... Frecce lucenti? Lance distruttive?”, e guardò il viso del vecchio, sperando che reagisse a una delle sue metafore, ma il sacerdote testardo non diceva una parola e lo osservava corrucciato. “Le bollenti lacrime degli dèi?”, provò nuovamente lo stalker, sebbene sia Artyom che gli altri fossero rimasti a bocca aperta. “I fulmini di Zeus?” “Smettila di prendermi in giro”, lo interruppe il vecchio, sprezzante. “I tuoi sporchi scarponi da soldato non calpesteranno nulla di divino”. “Missili”, Melnik si fece subito risoluto. “L’unità missilistica appena fuori Mosca. C’è un’uscita in una galleria della Mayakovskaya. Deve ricordarsi di cosa sto parlando. Dobbiamo arrivarci subito e lei farebbe meglio ad aiutarci”. “Missili...”, il vecchio ripeté lentamente, come se stesse assaporando la parola sulla lingua. “Missili... Quanti anni ha, una cinquantina, vero? Allora se lo deve ricordare per forza. Nel mondo occidentale li chiamavano SS-18 ‘Satan’. Fu l’unica illuminazione di una civiltà ormai cieca dalla nascita”. “Sei sicuro di essere invincibile come credi?! Avete distrutto il mondo intero! Siete davvero invincibili?” “Ascolti, Sua Eminenza, non abbiamo molto tempo”, lo interruppe Melnik. “Le do cinque minuti”, mentre gli mostrava le cinque dita della mano, le fece scrocchiare. Il vecchio fece una smorfia: sembrava che né l’abbigliamento da combattente dello stalker e dei suoi soldati né la minaccia così poco velata nella voce di Melnik avessero avuto il benché minimo impatto su di lui. “Voi cosa potreste farmi?”, sorrise. “Torturarmi? Uccidermi? Forza, tanto sono già vecchio e nella nostra religione non ci sono abbastanza martiri. Fatevi avanti, uccidetemi! Così come avete ucciso centinaia di milioni di altre persone! Come avete sterminato il mondo intero! Il nostro mondo! Premete il grilletto delle vostre dannate mitragliatrici, allo stesso modo in cui avete premuto i grilletti e i pulsanti di decine di migliaia di dispositivi letali!”, la voce del vecchio, dapprima debole e rauca, si fece subito dura. Nonostante i capelli grigi impiastricciati, le mani legate e la bassa statura, non aveva più un aspetto patetico, al contrario emanava una forza incredibile, ogni nuova parole sembrava più convincente e minacciosa della precedente. “Non c’è bisogno che mi strangoliate con le vostre mani, non vedrete la mia agonia... Voi e tutte le vostre macchine sarete dannati! Avete sminuito sia la vita che la morte... Mi considerate un pazzo? Ma i veri folli siete voi, i vostri padri e i vostri figli! Non è stata una rischiosissima pazzia cercare di soggiogare tutta la Terra sotto il vostro dominio, imbrigliare la natura fino a causarle crampi e convulsioni? Dove eravate quando il mondo è stato distrutto? Avete assistito alla sua fine? Avete visto tutto quello che ho visto io? Il cielo, che dapprima pareva si sarebbe sciolto, è stato inghiottito da nuvole inanimate! I fiumi e i mari ribollivano, riportando a riva creature senza vita, e in seguito si sono trasformati in materia congelata! Il sole, che era scomparso dal cielo, non è riapparso per anni interi! Case ridotte a brandelli in un secondo, mentre le persone che le abitavano venivano incenerite! Avete udito le loro grida d’aiuto?! E coloro che morirono a causa delle epidemie e delle radiazioni? Avete udito i loro spergiuri pieni di dolore?! Guardate lui!”, disse, indicando Dron. “Guardate tutti coloro che non hanno braccia, non hanno occhi, hanno sei dita! Persino coloro che sono riusciti a sviluppare nuove abilità!” Il selvaggio si inginocchiò vicino al vecchio e accolse tutte le sue parole con riverenza. Tuttavia, anche Artyom provava una sensazione molto simile e persino i soldati fecero un riluttante passo indietro. Solo Melnik continuò intento a fissare gli occhi del sacerdote. “Avete assistito alla morte di questo mondo?”, seguitò il vecchio. “Sapete di chi è la colpa? Chi ha trasformato immense distese di foreste vergini in deserti bruciati? Che avete fatto al mondo? Al mio mondo? La Terra non aveva mai vissuto niente di più malvagio della vostra dannata civiltà meccanica, che è un cancro, un’enorme ameba che risucchia avidamente tutte le sostanze nutritive e utili, per liberarsi di quelle di scarto, fetide e avvelenate. E ora mi dite che avete ancora bisogno di missili?! Necessitate delle armi più tremende create da una civiltà di criminali! Perché? Per completare ciò che avete iniziato? Assassini! Vi odio, vi odio tutti!”, urlò rabbioso, poi si mise a tossire e ammutolì. Nessun altro osò proferire parola finché il vecchio non smise di tossire e poi riprese il suo sermone: “Ma il vostro tempo è giunto alla fine... e, anche se non riuscirò a sopravvivere fino ad allora, altri mi sostituiranno. Verranno coloro che comprenderanno la perniciosità della tecnologia, coloro che riusciranno a farne a meno! Le vostre fila si stanno riducendo e non riuscirete a sopravvivere molto a lungo. Mi dispiace non poter essere presente alla vostra completa distruzione! Tuttavia, i figli che abbiamo allevato ci saranno! L’uomo si pentirà di aver raso al suolo tutto ciò a cui teneva, in nome della sua arroganza! Dopo secoli di morte e illusione, finalmente imparerà a distinguere il bene dal male, la verità dalle menzogne! Noi stiamo educando coloro che popoleranno la Terra dopo di voi e, per fare in modo che la vostra agonia non venga protratta troppo a lungo, ben presto trafiggeremo il vostro cuore con il pugnale della nostra misericordia! Il fiacco cuore della vostra civiltà corrotta... Quel giorno è vicino!”, e così dicendo sputò ai piedi di Melnik. Passò qualche minuto prima che lo stalker si decidesse a rispondergli. Lanciò un’occhiataccia al vecchio ancora tremante di rabbia, poi si mise a braccia conserte e domandò, interessato: “E allora lei che ha fatto? Ha concepito una sorte di verme e inventato una storia che ispirasse i suoi cannibali a odiare la tecnologia e il progresso?” “Zitto! Che ne sai tu del mio odio per la vostra dannata, diabolica tecnologia?! Che ne capisci tu della gente, delle loro speranze, dei loro obiettivi e delle loro necessità? Se gli antichi dèi hanno permesso che l’uomo andasse all’inferno e lo hanno voluto seguire insieme al resto del mondo, non ha senso richiamarli alla vita... Nelle tue parole sento la più terribile arroganza, il disprezzo, l’orgoglio che hanno condotto l’umanità sull’orlo del disastro. Perciò, anche se non esiste nessun Grande verme, anche se l’ho creato io, ben presto vi convincerete che questo dio sotterraneo totalmente inventato è molto più potente dei vostri esseri celestiali, quegli idoli che sono caduti dai loro troni e si sono ridotti in mille pezzi! Vi prendete gioco del Grande verme! Continuate pure! Ma ride bene chi ride ultimo!” “Ne ho abbastanza. Il bavaglio!”, ordinò lo stalker. “Per ora non toccatelo, potrebbe tornarci utile”. Imbavagliarono di nuovo il vecchio ostinato, mentre lui cercava di urlare altre oscenità. Al contrario, il selvaggio non disse nulla, sembrava disperato, se ne stava con le spalle penzoloni e non distoglieva lo sguardo spento dal sacerdote. “Maestro! Che significa che non esiste il Grande verme?”, si decise infine, e pronunciò le parole con tono grave. Il vecchio non si degnò nemmeno di guardarlo. “Che significa? Il maestro ha inventato il Grande verme?”. Dron parlava con voce monotona, scuotendo il capo. Il sacerdote non rispose. Ad Artyom parve che l’anziano uomo avesse consumato tutta la sua energia vitale durante il discorso precedente e che ora fosse esausto. “Maestro! Maestro... Il Grande verme esiste... Li sta ingannando! Perché? Sta mentendo per confondere i nemici? Lui esiste... esiste!”. Dron cominciò inaspettatamente a ululare: la sua voce, metà lamento e metà pianto, era talmente disperata che Artyom fu sul punto di avvicinarsi a lui per consolarlo. Al contrario, pareva che il vecchio si fosse già accomiatato dalla vita e avesse perso interesse nel suo discepolo, il quale era tormentato da nuovi dilemmi. “Esiste! Esiste! Esiste! Noi siamo i suoi figli! Siamo tutti suoi figli! Lui esiste, è sempre esistito e sempre esisterà! Esiste! Se il Grande verme non esiste... significa che... siamo completamente soli...” Al selvaggio, che ormai si sentiva abbandonato, stava accadendo qualcosa di terribile: Dron andò in trance; continuava a scuotere la testa, come se sperasse di dimenticarsi ciò che aveva appena udito, ed emetteva lo stesso suono costante. Le lacrime che gli scendevano dagli occhi si mischiavano con la bava che gli usciva dalla bocca. Non cercò nemmeno si asciugarsi il viso e con le mani si teneva il cranio rasato. I soldati lo liberarono, lui cadde a terra, si coprì le orecchie e poi si colpì ripetutamente il capo. Iniziò a rotolarsi a terra, in maniera selvaggia e incontrollata, mentre le sue grida riempivano l’intera galleria. I combattenti cercarono di calmarlo, ma nemmeno i calci e i pugni riuscivano a farlo smettere di ululare. Melnik guardò il cannibale con disapprovazione, quindi sbottonò la fondina che teneva al fianco, estrasse la sua Stechkin con il silenziatore, mirò a Dron e premette il grilletto. Il silenziatore risuonò piano e il selvaggio si afflosciò all’istante. Le sue urla disarticolate si fermarono subito, ma per diversi secondi l’eco ripeté le ultime sillabe che aveva pronunciato, tanto che parve allungare di un momento la vita di Dron: “ooooooooooolooooo...” Dopo averci pensato un po’ su, Artyom comprese che l’ultima parola urlata dal selvaggio prima della sua morte era stata: “Solo!” Lo stalker fece scivolare la pistola al suo posto. Artyom non riusciva a sollevare lo sguardo verso di lui perché continuava a fissare Dron che era stato ammutolito con la forza e il sacerdote, seduto poco lontano da lui, che non aveva reagito in alcun modo alla morte del suo discepolo. Quando il cane della pistola era scattato, il viso del vecchio si era a malapena contratto, si era girato di sfuggita per guardare il corpo del selvaggio e si era di nuovo voltato, nella più totale indifferenza. “Andiamo”, ordinò Melnik. “Altrimenti, con tutto questo rumore, potrebbe raggiungerci metà della popolazione della Metropolitana”. La squadra si rimise in posizione. Misero Artyom nella retroguardia, con la potente torcia e il giubbotto antiproiettile di uno dei combattenti che trasportava Anton. Un minuto più tardi, entrarono nelle profondità della galleria. Artyom non era la persona più adatta per stare dietro al gruppo, poiché le sue gambe si muovevano ancora con difficoltà, inciampava sulle traversine e rivolgeva uno sguardo impotente al combattente davanti a lui. I rantoli morenti di Dron rimbombavano ancora nelle sue orecchie: aveva assorbito la sua disperazione, la disillusione e la riluttanza a credere che l’uomo fosse rimasto completamente solo in questo terribile mondo oscuro. Era una sensazione bizzarra, ma solo dopo aver udito gli ululati del selvaggio e la sua nostalgia disperata per un essere divino inventato, comprese appieno il sentimento universale di solitudine che nutriva la fede dell’intera umanità. Se lo stalker avesse avuto ragione e se, già da un’ora, avessero imboccato le gallerie della Metro-2, allora la misteriosa struttura si sarebbe rivelata solo un progetto ingegneristico, fatto costruire molto tempo prima dai suoi proprietari, sul quale aveva preso il sopravvento un gruppo di cannibali semi pensanti e di sacerdoti fanatici. I combattenti si misero a parlare a voce bassissima: la squadra entrò in una stazione vuota, dall’aspetto inusuale. La piattaforma era corta, il soffitto basso, le colonne enormi erano in cemento armato, mentre le pareti erano ricoperte da piastrelle invece che dal solito marmo. Tutto ciò indicava che la stazione non dovesse fare nessuna buona impressione, al contrario doveva semplicemente proteggere al meglio tutti coloro che la utilizzavano. Lettere di bronzo avvitate al muro e ossidate con il passare del tempo formavano una parola incomprensibile: “Sovmin”, mentre in un altro luogo componevano i termini: “Casa del Governo della Federazione Russa”. Artyom sapeva che non esistevano stazioni con quel nome all’interno Metropolitana. Pareva che Melnik non avesse alcuna intenzione di rimanere lì; si guardò attorno velocemente, scambiò qualche battuta rapida con i suoi combattenti e la squadra proseguì. Artyom era pervaso da una strana sensazione che non fu in grado di esprimere in alcun modo. Nella sua testa, gli Osservatori invisibili non erano più una forza minacciosa, saggia e incomprensibile, ma antiche sculture fantasmagoriche che illustravano antichi miti e che sarebbero crollati a causa dell’umidità e dell’aria che percorreva le gallerie. Le altre credenze che gli erano state rivelate durante il suo viaggio si perdevano come sciocchezze nella sua coscienza. Uno dei segreti mai svelati di tutta la Metropolitana si stava rivelando davanti a lui: stava percorrendo la D-6, già denominata la leggenda più importante della Metropolitana da una delle persone che aveva incontrato nella sua missione. Tuttavia, anziché essere felice, Artyom si ritrovò stranamente amareggiato. Stava cominciando a comprendere che alcuni segreti dovrebbero rimanere tali perché non hanno spiegazioni; inoltre, esistono delle domande le cui risposte sarebbe sempre meglio non conoscere. Artyom sentiva l’alito gelido della galleria tagliargli le guance, proprio nei punti in cui erano state bagnate dalle lacrime. Scosse il capo proprio come Dron e cominciò a tremare a causa della corrente umida e fredda, che portava con sé l’odore del marcio e della desolazione, causa della solitudine e della vacuità. Per un secondo gli parve che nulla al mondo avesse più senso. La sua missione e i tentativi umani di sopravvivere in un mondo tanto diverso erano inutili. Non c’era nulla: solo una galleria vuota e oscura nella quale avrebbe dovuto arrancare per percorrerla dalla stazione della “Nascita” a quella della “Morte”. Coloro che ricercavano la fede dovevano andare a perlustrare le ramificazioni della linea. Ciononostante, le stazioni erano sempre due e la galleria che le collegava rimaneva una sola. Quando Artyom raccolse i suoi pensieri e tornò in sé, si accorse di essere rimasto indietro diverse decine di metri dal resto del gruppo. All’inizio non comprese cosa lo aveva fatto risvegliare, ma poi controllando le pareti e ascoltando con più attenzione, capì: su uno dei muri c’era una porta semi chiusa, attraverso la quale si udiva un rumore che stava aumentando di intensità. Si trattava di un mormorio monotono, di un brontolio insoddisfatto. Probabilmente, quando gli altri erano passati nelle vicinanze della porta non era ancora del tutto udibile, ma ora era difficile non notarlo. La squadra aveva superato il punto già di un centinaio di metri. Artyom riuscì a resistere al desiderio di mettersi a correre e di raggiungerli, trattenne il respiro, si avvicinò alla porta e la spalancò. Davanti a lui si rivelò un lungo e ampio corridoio, che terminava con un quadrato nero, un’uscita. Il mormorio giungeva proprio da lì e stava diventando sempre più insistente, proprio come il ruggito di un enorme animale. Il ragazzo non osò entrarci. Rimase, come stregato, a fissare la vuota oscurità e ad ascoltare, finché il rumore non diventò fragoroso e, al bagliore della sua torcia, intravvide qualcosa di enorme che si precipitava verso di lui. Indietreggiò, sbatté con forza la porta e corse a perdifiato, finché non raggiunse gli altri. CAPITOLO 18 : L'AUTORITA' Avevano già notato la sua assenza e si erano fermati. Un raggio bianco percorse la galleria e quando venne puntato su di lui Artyom alzò le braccia e urlò: “Sono io! Non sparate!” La torcia si spense. Il ragazzo corse verso gli altri aspettandosi una lavata di capo, ma quando li raggiunse, Melnik si limitò a domandargli a voce bassa: “Non hai sentito nulla?” Artyom annuì, ma non gli raccontò quello che aveva appena visto, perché pensò si trattasse della sua immaginazione. Sapeva che nella Metro doveva considerare con estrema attenzione tutto ciò che gli pareva di vedere. Cos’era stato? Sembrava un treno in corsa, ma non poteva esserlo: erano trascorse decine d’anni dall’ultima volta in cui nella Metro c’era stata elettricità a sufficienza per fare muovere i treni. La seconda possibilità era persino più improbabile: Artyom ricordò gli avvertimenti dei selvaggi riguardo i passaggi sacri al Grande verme. “Non esistono più treni funzionanti, vero?”, chiese allo stalker. Melnik lo guardò con disprezzo. “Quali treni? Quando si sono fermati non si sono mai più mossi, finché non sono stati smontati per usare le diverse parti. Secondo te cosa sono questi rumori? Io ritengo siano i corsi d’acqua sotterranei. Ce n’è uno nelle vicinanze, lo abbiamo superato da poco. Dannazione! Ci sono problemi molto più importanti. Ancora non sappiamo come uscire da qui”. Artyom non voleva che l’uomo pensasse di avere a che fare con un folle, perciò non disse nient’altro e lasciò cadere l’argomento. Sicuramente si trattava del fiume, e non era lontano: i rumori sgradevoli dell’acqua corrente e il gorgoglio del ruscelletto oscuro che correva lungo i binari disturbavano il silenzio tenebroso della galleria. Le pareti e gli archi baluginavano a causa dell’umidità ed erano ricoperti da uno strato sottile e biancastro di muffa, mentre qua e là vi erano delle pozzanghere. Artyom aveva cominciato a temere l’acqua nelle gallerie e questo luogo lo rendeva particolarmente inquieto. Il suo patrigno gli aveva raccontato delle gallerie e delle stazioni inondate, che per fortuna erano quelle più profonde oppure si trovavano a molti chilometri di distanza, per cui era improbabile che un disastro di quel genere sommergesse un’intera diramazione. Ma più proseguivano, più la galleria diveniva asciutta: i piccoli rivoli scomparivano gradualmente, la muffa sulle pareti si faceva più rara e l’aria più leggera. Il tunnel scendeva ed era sempre più vuoto. Per l’ennesima volta, Artyom si rammentò di ciò che gli aveva rivelato Bourbon e cioè che le gallerie vuote sono quelle che dovrebbero incutere più timore. Pareva che anche gli altri lo avessero compreso e spesso si voltavano indietro per dare un’occhiata ad Artyom che procedeva in ultima posizione, inciampando sulle traversine; ma dopo averlo guardato negli occhi, tornavano a rivolgere lo sguardo davanti a loro. Proseguirono sempre diritto, senza indugiare sulle grate tagliate dei passaggi laterali e sulle spesse porte in ferro chiuse con lucchetti che si intravvedevano alle pareti. Solo ora Artyom si rendeva veramente conto dell’immensità del labirinto che era stato scavato nella terra, sotto la città, da decine di generazioni di abitanti. Nella Metro si trovavano numerosi passaggi e corridoi che si diramavano nelle profondità di una gigantesca ragnatela. Alcune delle porte che superarono erano aperte: il raggio di una torcia che vi si infiltrava riportava alla luce per qualche secondo stanze abbandonate e letti a castello arrugginiti. La desolazione regnava ovunque e Artyom si mise alla ricerca delle più piccole tracce di presenza umana, anche se invano. La grandiosa struttura della Metro-2 era morta e abbandonata da tempo e, se anche il ragazzo avesse trovato dei resti umani, non si sarebbe spaventato più di quanto lo fosse già. La marcia sembrava essere interminabile. Il vecchio camminava sempre più lentamente, era esausto e ormai né i colpi sulla schiena né le esortazioni più scurrili dei combattenti potevano fargli riprendere il passo del gruppo, che non si era mai fermato per più di trenta secondi, se non quando i soldati che trasportavano la barella con Anton dovevano scambiarsi di posto. Oleg, invece, stringeva i denti, tenace; anche lui era stanco, ma non si lamentò nemmeno una volta. Si limitava a tirare su con il naso, caparbio, e cercava di stare al passo con gli altri. All’improvviso scoppiò un’accesa discussione tra gli uomini che conducevano il gruppo: sbirciando da dietro le enormi spalle dei combattenti, Artyom riuscì a intuire cosa stesse succedendo. Erano entrati in una nuova stazione, che aveva un aspetto molto simile a quello della precedente, cioè archi bassi, colonne grandi quanto zampe d’elefante, pareti di cemento armato imbiancate con vernice a olio. La piattaforma era talmente vasta che era impossibile vedere con chiarezza cosa ci fosse dall’altro lato: a occhio, ci sarebbero potute stare almeno duemila pers
Scaricare