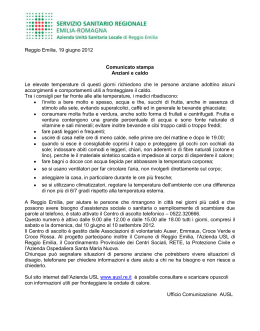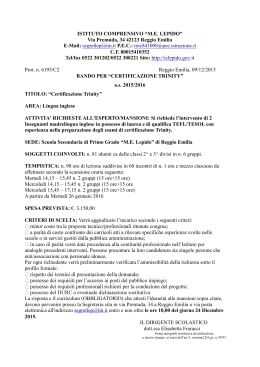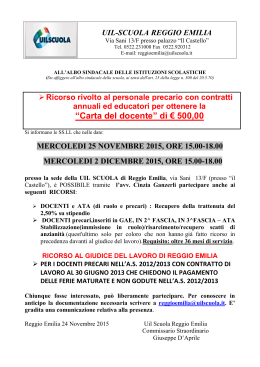RS RS Anno XLV RICERCHE STORICHE Direttore Ettore Borghi N. 112 ottobre 2011 Rivista semestrale di Istoreco (Istituto per la storia della Resisistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia) Direttore Responsabile Carlo Pellacani Coordinatore di redazione ed editing Glauco Bertani Comitato di Redazione: Michele Bellelli, Lorenzo Capitani, Mirco Carrattieri, Alberto Ferraboschi, Alessandra Fontanesi, Benedetta Guerzoni, Marzia Maccaferri, Fabrizio Montanari, Francesco Paolella, Ugo Pellini, Massimo Storchi, Antonio Zambonelli Direzione, Redazione, Amministrazione Via Dante, 11 - Reggio Emilia Telefono (0522) 437.327 FAX 442.668 http://www.istoreco.re.it e.mail: [email protected] Cod. Fisc. 80011330356 Prezzo del fascicolo numeri arretrati il doppio € 13,00 Abbonamento annuale € 20,00 Abbonamento sostenitore € 73,00 Abbonamento benemerito € 365,00 Abbonamento estero € 50,00 I soci dell'Istituto ricevono gratuitamente la rivista Foto di copertina: I cent’anni dell’Unità d’Italia a Reggio Emilia, Teatro municipale, 14 giugno 1959. (Fonte: Fototeca Biblioteca Panizzi) Foto sfondo sezioni: Primavera 1945. Locomotiva precipitata il 7 novembre 1944 nel torrente Tresinaro, presso Scandiano, per la distruzione di due arcate del ponte in seguito ad attentato (Fonte: Archivio storico della Provincia di Reggio Emilia) I versamenti vanno intestati a ISTORECO, specificando il tipo di Abbonamento, utilizzando il Conto Corrente bancario BIPOP-CARIRE n. IT05J 02008 12834 000100280157 oppure il c.c.p. N. 14832422 La collaborazione alla rivista è fatta solo per invito o previo accordo con la redazione. Ogni scritto pubblicato impegna politicamente e scientificamente l’esclusiva responsabilità dell’autore. I manoscritti e le fotografie non si restituiscono. Stampa GRAFITALIA – Via Raffaello, 9 Reggio Emilia Tel. 0522 511.251 Fotocomposizione ANTEPRIMA – via Gramsci, 104/f Reggio Emilia Tel. 0522 271.185 Editore proprietario ISTORECO (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia) Registrazone presso il tribunale di Reggio Emilia n. 220 in data 18 marzo 1967 e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia cod. fisc. 80011330356 Registrazione presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 220 in data 18 marzo 1967 Con il contributo della Fondazione Pietro Manodori Indice Ettore Borghi, Ugo Benassi, un ricordo 5 Ricerche Marco Marzi, Andrea Montanari, I «giubilei della patria». Il centenario dell’Unità nella roccaforte del pci (1959-1961) 9 Elena Mantelli, L’Episcopato emiliano e la guerra d’Etiopia 25 Cleonice Pignedoli, Quando passava «Pippo». Bombardamenti alleati su Castelnovo ne’ Monti e dintorni 57 150° dell’Unità d’Italia. Letture Con gli occhi di oggi. Introduzione di Ettore Borghi Ippolito Nievo di Alessandra Fontanesi Carlo Cattaneo di Fabrizio Solieri Giuseppe Mazzini di Marco Marzi Silvio Pellico di Michele Bellelli 77 78 81 85 88 Memorie/Testimonianze Gianfranco Romani, Sassi Angelo detto Maramôt (1877-1947). Ricordo di un sovversivo 93 Didattica Simona Anceschi, Valeria Benevelli, Irene Bonfrisco, «Come potevamo noi cantare». Testi, musiche e immagini della Resistenza 123 Fabrizio Solieri, La Didattica della storia. Il 150° dell’Unità d’Italia e i percorsi di Istoreco sul Risorgimento 137 Lorena Mussini, Simone Procida, 150° dell’Unità d’Italia. Una classe del liceo «Canossa» ripercorre… I cento passi di Peppino Impastato. Appunti di un viaggio 140 Materiale d’archivio Alberto Ferraboschi, L’Archivio storico della Provincia di Reggio Emilia. Una risorsa per la memoria locale 147 Note e rassegne Alberto Ferraboschi, Dall’aquila estense al tricolore sabaudo. L’unificazione nazionale a Reggio Emilia (1859-1861) 163 Recensioni 182 3 Ugo Benassi, un ricordo Ettore Borghi La presente nota vuole mantenersi circoscritta all’esperienza diretta del suo estensore, consigliere comunale e poi assessore in quelli che, a Reggio, rimarranno i «tempi di Benassi». L’intento sarebbe il tentativo di rispondere alla domanda su quale tipo di sindaco fu Ugo Benassi, in quegli anni Ottanta del secolo scorso, le cui insidie, già all’opera, si vedranno più tardi, e comunque potevano essere piuttosto materia di studiosi o cassandre, ma non costituivano certo il pensiero dominante per chi vedeva chiaramente che c’era ancora molto da fare, e da fare bene (non a caso era del tutto assente allora la falsa contrapposizione fra il politico e il cosiddetto «uomo del fare», essendo ben fissato che il fare che contava era, anche a livello locale, un fare politico e collettivo). Non sarà inutile ricordare che sindaco e giunta erano eletti in consiglio e dal consiglio. Che i consiglieri erano passati al vaglio delle preferenze. Che il «consigliere anziano» presiedeva la seduta inaugurale, per poi passare la mano al sindaco fresco di elezione. In astratto può darsi che la situazione contenesse elementi di contrasto (essere a capo della parte «esecutiva» e allo stesso tempo presiedere quella «legislativa»). In concreto, questo metodo era in grado di garantire un’assidua presenza – non solo fisica, intendo – del sindaco ai lavori del Consiglio e alla loro valorizzazione. E Benassi metteva in questo ruolo molta passione, ma altrettanto rispetto. Non c’era mai questione tanto di dettaglio, se sollevata dai consiglieri d’opposizione, da poter essere guardata come trascurabile (come oggi appare, purtroppo, in consessi istituzionali anche più alti) sulla base della propria sicura maggioranza numerica. Gli assessori, si sa, si vedono «delegare» determinate competenze, ma, a differenza di quello che potrebbe avvenire in un contesto «aziendale» (la metafora dell’istituzione politica e dello stesso Stato come azienda non aveva ancora la sua equivoca fortuna), delegare nel caso di Benassi non equivaleva a sbarazzarsi del fastidio. Il suo essere sindaco era garanzia non solo formale dell’unità dell’amministrazione. Raramente, o piuttosto mai, l’ho visto disattento quando la replica o la proposta in sala del Tricolore era affidata ad uno dei suoi assessori. Data la passione calcistica di 5 Ugo non sarà irriverente, allora, paragonare il suo atteggiamento a quello di un allenatore molto presente in campo. Le riunioni della giunta comunale esaltavano questa qualità. I temi all’ordine del giorno erano per lo più preceduti da un preambolo estemporaneo, in cui Benassi riferiva di cose viste e persone ascoltate (i suoi legami con la città, l’esplorazione dei suoi umori). Nelle discussioni era ascoltatore attento, con una particolare abilità nella sintesi conclusiva, da autentico primus inter pares. Era un modo di stare in gruppo per più aspetti diverso da quello dell’équipe pedagogica di Loris Malaguzzi (altra mia grande fortuna vissuta), eppure simile nella politicità degli atteggiamenti di entrambi i leader: il senso alto della responsabilità, che vuol dire ricerca infaticabile – e non sempre facile da soddisfare – della qualità come diritto di tutti (i cittadini, i bambini). Chiedendo venia per il riferimento personale (o, per meglio dire, privato), dirò infine che presi parte a questa esperienza ormai non più giovanissimo e all’inizio con riluttanza, considerandola comunque una parentesi nell’insegnamento, ma che alla fine espressi a Ugo la mia riconoscenza per avermi consentito di maturare l’equivalente di una seconda laurea, grazie alle cose apprese e ancor più alle tante, competenti, degne persone conosciute e viste all’opera. 6 1983. Ugo Benassi alla tribuna durante lo svolgimento del XVI Congresso provinciale pci Ricerche I «giubilei della patria» a Reggio Emilia Il centenario dell’Unità nella roccaforte del pci (1959-1961) Marco Marzi Andrea Montanari 1961: il secondo giubileo della patria Se il Risorgimento fosse un fatto storico retrospettivo, sganciato da ogni interesse attuale, se esso coinvolgesse soltanto le opinioni degli storici di professione, sarebbe certo per noi motivo di sorpresa riscontrare tanta animosità polemica … ma poiché così non è, poiché la vicenda del Risorgimento nelle forme e nei modi in cui essa si svolse, coinvolge tutta una serie di problemi politici attuali, poiché celebrare il Risorgimento significa oggi esprimere un giudizio storico, un giudizio politico sulla classe dirigente italiana, sulla sua capacità di direzione, di costruzione di uno stato liberale moderno, questa animosità politica non ci sorprende1. Il tenore di simili affermazioni – pronunciate dall’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Reggio Emilia Sergio Morini durante una seduta del Consiglio comunale nel maggio del 1959 – rappresenta un limpido esempio di come, nel contesto di acceso scontro ideologico che caratterizza gli anni della Guerra Fredda, anche la memoria di eventi storici ormai lontani sia oggetto di contesa. Il triennio 1959-61, durante il quale si festeggia il centenario delle vicende che portarono alla nascita dello Stato italiano, offre un punto d’osservazione privilegiato per approfondire tale questione; nonostante sia trascorso un secolo e il paese abbia nel frattempo mutato radicalmente volto, le forze politiche della Repubblica continuano infatti a riservare un particolare 1 Archivio generale del Comune di Reggio Emilia (d’ora in poi agcre), titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1949-60, Estratto di verbale di deliberazione del consiglio comunale, 26 giugno 1959. 9 A sinistra, Sergio Morini, e, con gli occhiali, il maestro Fedele Valent interesse per quei miti e quei valori che avevano animato il dibattito politico e culturale dell’Italia liberale prima e di quella fascista poi2. Certo, il clima dei festeggiamenti di «Italia ’61», sigla burocraticamente scelta per battezzare il complesso di cerimonie del centenario dell’Unità, non è il medesimo respirato durante il maestoso giubileo del 1911, l’«anno santo della patria»3 secondo la definizione datane da Pascoli. L’aggressivo e fastoso patriottismo nazionalista del primo Novecento esce completamente screditato da vent’anni di dittatura fascista e dall’immane catastrofe del secondo conflitto mondiale al punto che, nell’immediato dopoguerra, autorevoli voci si levano per invocare l’avvento di un’era post-nazionale. Ciononostante, secondo Giorgio Vecchio, «nell’Italia repubblicana degli esordi, nella sua gente, nei suoi governanti non è morta l’idea di patria, e il sentimento nazionale non è venuto 2 Sull’evoluzione del patriottismo negli anni dell’Italia repubblicana si vedano: E. Gentile, La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 250-373; G. Vecchio, Tricolore, feste e simboli dello stato nel primo decennio repubblicano, in F. Tarozzi, G. Vecchio (a cura di), Gli italiani e il Tricolore. Patriottismo, identità nazionale e fratture sociali lungo due secoli di storia, Il Mulino, Bologna 1999; A. Parisella, Tricolore, rappresentazioni e simboli della nazione nelle culture popolari e nella cultura di massa dell’Italia repubblicana, ivi. 3 G. Pascoli, Patria e Umanità, Zanichelli, Bologna 1914, p. 17. 10 meno, piuttosto esso si è trasformato dopo le tragiche giornate da poco trascorse»4. Il mantenimento, negli anni successivi al 1945, di una configurazione istituzionale europea basata sugli stati nazionali unitamente alla ricerca di valori identificativi in grado di conservare l’unità di un paese dilaniato dalla guerra conducono, infatti, al confinamento delle aspirazioni antinazionali, in favore di un patriottismo riscoperto ma accuratamente depurato dei suoi aspetti più perversi. Fatto salvo il rifiuto del bellicismo, dell’imperialismo e dell’esasperata retorica di potenza, tutte le fazioni che hanno contribuito alla lotta di Liberazione – compresi quei partiti la cui cultura politica è tradizionalmente legata a istanze internazionaliste, come cattolici e social-comunisti – si orientano così rapidamente verso l’adozione di uno spirito patriottico. Lo sviluppo di un acceso conflitto politico-ideologico dopo la calata della «cortina di ferro», tuttavia, rende improrogabile quell’orizzonte nazionale unitario tracciato durante la Resistenza. Come giustamente osserva Emilio Gentile, nei primi decenni dell’Italia repubblicana la fedeltà alla nazione tende a identificarsi con quella «verso altre entità ideali, storiche, politiche – dalla religione all’ideologia, dall’umanità al partito – considerate eticamente superiori allo stato nazionale», con la conseguenza che «il primato della fedeltà alla patria ideale rispetto alla patria statale favorì la dissociazione dell’idea di patria dalla realtà dello stato nazionale, e soprattutto incoraggiò una più accentuata ideologizzazione del mito nazionale, avviata dal fascismo, e proseguita, in tutt’altro contesto, dai partiti»5 della Repubblica. Dagli anni Cinquanta in poi, il patriottismo italiano si presenta, dunque, sotto molteplici vesti, ognuna delle quali funzionale alla legittimazione del partito che l’ha elaborata. Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di interpretazioni dettate esclusivamente da ragioni di convenienza, ma sinceramente filtrate da un approccio ideologico; un approccio che, come si è osservato nelle dichiarazioni di Morini, influenza anche la lettura degli eventi assurti a mito fondativo della nazione6. Di conseguenza, nel 1961, l’impronta data alle celebrazioni risente inevitabilmente dell’egemonia della Democrazia cristiana sulle istituzioni e sul comitato organizzatore dei festeggiamenti. La commemorazione del centenario si innesta, infatti, su una ricostruzione storica strumentale, volta a raffigurare le vicende italiane dei cent’anni precedenti come un disegno provvidenziale teso alla riconciliazione fra Stato e Chiesa. Si può quindi affermare, citando ancora una volta Emilio Gentile, che il centenario sia stato «una rappresentazione che, simbolicamente, fu molto più l’autoglorificazione del partito dominante, Vecchio, Tricolore, feste e simboli dello stato nel primo decennio repubblicano, cit., p. 352. Gentile, La grande Italia, cit., p. 290. 6 Sul mito del Risorgimento nell’Italia repubblicana si vedano, oltre ai saggi già citati nella nota 1: M. Baioni, Risorgimento conteso. Memorie e usi pubblici nell’Italia contemporanea, Diabasis, Reggio Emilia 2009; M. Ridolfi, Risorgimento, in M. Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 1998. 4 5 11 quale guida illuminante del “feudo di Maria”, che la celebrazione della “patria degli italiani” unificati nello Stato nazionale»7. Anche i cattolici, dunque, dopo essere stati tra i più critici detrattori dell’Unità negli anni dell’Italia liberale, si sono convertiti alla causa nazionale, con il duplice obiettivo di ricattolicizzare il paese e giustificare la propria posizione all’interno degli organi dello Stato. Oltre a consacrare la permanenza al potere della dc, il secondo giubileo della patria svolge poi un’evidente funzione legittimante rispetto al sistema economico nazionale. La designazione di Torino come sede del comitato organizzatore e della quasi totalità degli eventi ufficiali8 dimostra la volontà della classe dirigente di farne una vetrina del recente decollo industriale. Se i fasti imperiali di Roma erano stati la coreografia perfetta nel 1911 per celebrare un’Italia pronta a sfidare le altre potenze europee nell’edificazione di un impero, la Torino della fiat si rivela indubbiamente più indicata a rappresentare la grandezza del paese in un contesto internazionale segnato dalla sfida tra modelli contrapposti. È in termini di crescita produttiva dunque, e non più di espansione territoriale, che il governo intende dar prova del prestigio dell’Italia e, contemporaneamente, giustificare il percorso economico adottato. Contro tale rappresentazione si scagliano comunisti e socialisti, oltre ad alcuni rappresentanti dei partiti laici, i quali non intendono tuttavia negare il valore della celebrazione, ma solamente opporsi alla raffigurazione faziosa offerta dallo Stato. Specularmente a ciò che avviene nell’universo cattolico, anche pci e psi, infatti, tradizionalmente legati a una visione internazionalista, hanno ridefinito la propria identità in chiave nazionale negli anni tra il 1943 e il 1945, consapevoli che legittimazione e incremento del consenso richiedessero un rapporto più stretto con la tradizione patriottica. Se però il psi, salvo una formale adesione, mantiene una sostanziale indifferenza verso il mito della patria, ben diverso è l’atteggiamento assunto dal pci. Fin dal 1944 – anno in cui Togliatti lancia, in piena sintonia con le direttive dell’Unione Sovietica, la parola d’ordine del «partito nuovo»9 – i comunisti perseguono una sistematica opera di nazionalizzazione del partito, accompagnandola a un attento utilizzo di retorica e simbologia tricolore. In tale opera di riconversione si inserisce inoltre, sempre su iniziativa di Togliatti, una rivalutazione delle potenzialità Gentile, La grande Italia, cit., p. 358. Oltre a essere sede delle celebrazioni più importanti, Torino ospita le tre principali esposizioni: la mostra storica dell’Unità d’Italia, la mostra delle regioni italiane e l’esposizione internazionale del lavoro, tutte dedicate all’illustrazione e all’esaltazione dei progressi economici e sociali dell’Italia repubblicana. Per una descrizione dettagliata degli eventi e iniziative ufficiali realizzate per il centenario dell’Unità italiana si vedano: Italia ‘61. La celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia, Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell’unità d’Italia, Torino 1961; M. Merolla, Italia 1961. I media celebrano il Centenario della nazione, Franco Angeli, Milano 2004. 9 P. Togliatti, Opere, a cura di L. Gruppi, vol. V, Editori riuniti, Roma 1984, p. 79. 7 8 12 del mito del Risorgimento democratico, posto su una linea di continuità ideale con la Resistenza – definita «secondo Risorgimento»10 – e con le battaglie per la democratizzazione dell’Italia nel dopoguerra. Una simile lettura consente al pci, in prima linea sia nella lotta di Liberazione sia nell’impegno per la completa attuazione dei principi costituzionali, di rivendicare per sé il ruolo di unico erede del movimento risorgimentale e mostrare la propria causa politica sotto una veste patriottica. Il maggior partito della sinistra acquisisce così uno strumento con cui contestare la legittimità del governo, accusato di eccessiva sudditanza verso l’imperialismo americano e di muoversi in direzione contraria agli interessi della nazione italiana. Tale strategia propagandistica non è tuttavia un’esclusiva del pci, additato a sua volta di asservimento alla volontà dell’Unione Sovietica. Il patriottismo dei partiti della prima repubblica non rappresenta, dunque, un fattore integrante ma, al contrario, funge da arma di delegittimazione degli avversari politici. È in questo clima arroventato, nonostante l’inizio della distensione internazionale, che si festeggia il secondo giubileo della patria. Anche a Reggio Emilia, come si vedrà, la commemorazione dell’Unità si trasforma in un episodio che divide le forze politiche piuttosto che unirle nella ricerca di un terreno comune. I festeggiamenti a Reggio. Il centenario della liberazione dal dominio estense Come già nel 191111, anche nel 1961 il territorio della provincia di Reggio Emilia è amministrato da forze politiche che in Parlamento siedono tra i banchi dell’opposizione12. Il partito di maggioranza è infatti, nella gran parte dei coSul mito della Resistenza come secondo Risorgimento si vedano: F. Traniello, Sulla definizione della Resistenza come «secondo Risorgimento», in C. Franceschini, S. Guerrieri, G. Monina (a cura di), Le idee costituzionali della Resistenza, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1997, pp. 17-25; C. Pavone, Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato, Bollati Boringhieri, Torino 1995, pp. 3-69; Id., Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 209-224. 11 Sul primo giubileo della Patria a Reggio Emilia ci permettiamo di rinviare, in mancanza di altri studi sull’argomento, ai nostri: M. Marzi, A. Montanari, I «giubilei della patria» a Reggio Emilia. Il cinquantenario dell’Unità nella Reggio socialista (1909-1911), in «RS-Ricerche Storiche», 111/2011; Id., «L’essere socialisti non ci fa dimenticare di essere italiani». Contromemoria e patriottismo socialista a Reggio Emilia nel cinquantenario dell’Unità d’Italia (1909-11), in «L’Almanacco», 57/2011. 12 Per un quadro della realtà provinciale di Reggio Emilia in questi anni si vedano: Una stagione appassionata. Gli anni Sessanta a Reggio Emilia, Elettra, Modena 2006; Un territorio e la grande storia del ’900. Il conflitto, il sindacato e Reggio Emilia, vol. II; L. Baldissara (a cura di), Dal secondo dopoguerra ai primi anni ‘70, Ediesse, Roma 2002. Per un una storia del pci reggiano si veda G. Zaccaria, La destalinizzazione a Reggio Emilia. Dal dissenso di Valdo Magnani alla via italiana al socialismo, Il Voltone, Reggio Emilia 1984. 10 13 L’apertura delle celebrazioni del centenario della liberazione dal dominio estense muni, il pci, alleato a un psi qui egemonizzato dalla corrente contraria a ipotesi di partecipazione a governi di centro-sinistra, mentre la dc riceve elevati consensi soltanto nelle zone di montagna. Data una simile composizione politica, la celebrazione reggiana assume inevitabilmente una configurazione differente nei contenuti da quella organizzata a livello nazionale, ma altrettanto partigiana e funzionale alla legittimazione del partito dominante. Tale dato si registra già a partire dal giugno 1959, in occasione del centesimo anniversario della liberazione dal dominio estense. Dovendosi commemorare un episodio storico di interesse locale, sono le amministrazioni comunale e provinciale a farsi carico dell’organizzazione delle celebrazioni, nominando un apposito comitato. Conseguentemente, le iniziative realizzate risentono di un’impostazione politicamente favorevole alle sinistre; ciò emerge già dal contenuto del manifesto ufficiale diffuso dal Comune: «celebrando, domenica 14 giugno 1959, il glorioso centenario della sua libertà, il popolo reggiano rinnovi l’impegno che la fece protagonista di tante vittorie dal Primo Risorgimento alla Resistenza antifascista, nel proposito comune di tutta la nazione di far progredire la giovane Repubblica italiana nello spirito della carta costituzionale»13. Le 13 14 Cento anni fa il popolo reggiano portò in piazza il “Tricolore”, in «L’Unità», 12 giugno 1959. scelte del comitato organizzatore, sebbene composto da personalità di provenienza politica eterogenea14, sono indubbiamente in linea con tale indirizzo. Esso dichiara come propria intenzione, infatti, quella di tenere in costante considerazione il nesso dialettico fra il passato e il presente, fra i problemi (risolti od elusi) del movimento di unificazione nazionale e i compiti attuali di una lotta pratica ed ideale che propone, come esigenza di progresso per tutta la società italiana, l’ulteriore allargamento delle basi democratiche e popolari dello stato; e questo nella consapevolezza dell’unità e continuità di un processo storico in atto, in fase di pieno svolgimento, pur attraverso contrasti e gravi contraddizioni15. Il comitato decide di impegnarsi «in due direzioni, non contrastanti, ma complementari»16: contribuire, in primo luogo, al dibattito ideale e all’elaborazione storiografica sul tema del Risorgimento e, in secondo luogo, realizzare iniziative in grado di instillare una coscienza democratica in ampi strati di popolazione; tutto ciò rifuggendo, nel primo caso, la freddezza del dibattito accademico e, nel secondo, qualsiasi formula retorica e apologetica17. Coerentemente a questa impostazione, esso organizza sia iniziative storico-culturali sia eventi per il grande pubblico18. Tanto nel tentativo di recupero della tradizione risorgimentale, quanto nel rifiuto delle formule altisonanti degli anni dell’Italia liberale e fascista, è possibile cogliere la piena adesione delle amministrazioni locali alla linea lanciata dai vertici nazionali di pci e psi dal dopoguerra in poi. Presieduto dal comunista Sergio Morini, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Reggio, il comitato organizzatore conta al suo interno esponenti del pci come Lando Landini, assessore anziano all’amministrazione provinciale, del psi come Franco Boiardi e Renzo Barazzoni, e da uomini di cultura vicini alla sinistra come Guerrino Franzini e Giuseppe Armani; lontani dall’aerea social comunista sono invece i restanti membri: Giuseppe Coppini, presidente provinciale delle acli e preside dell’Istituto magistrale; Corrado Costa, poeta e artista; Mario Degani, archeologo e direttore dei musei; Rodolfo Macchioni Jodi, storico dell’arte e della letteratura. Cfr. Centenario dell’Unità d’Italia (celebrazioni reggiane), in «Il 1859 a Reggio Emilia», 12 giugno 1959. 15 S. Morini, Nel centenario dell’Unità d’Italia, in «Il 1859 a Reggio Emilia», 12 giugno 1959. 16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 Tra le iniziative per il grande pubblico vi sono alcune cerimonie, quali un corteo preceduto da gonfaloni per il centro cittadino, una seduta pubblica dei consigli comunale e provinciale durante la mattina e la premiazione dei vincitori di un concorso per studenti per la realizzazione di un tema sul Risorgimento, ma anche momenti di intrattenimento, come i tornei di pallacanestro e judo in piazza della Libertà nel pomeriggio e un concerto di musiche risorgimentali alla sera in piazza Prampolini. Tra le iniziative a carattere culturale vanno ricordate la conferenza di Renato Zangheri al teatro municipale e due pubblicazioni: lo studio dello storico locale Odoardo Rombaldi dal titolo Gli Estensi al governo di Reggio dal 1523 al 1859 (Age, Reggio Emilia 1959); l’opuscolo «Il 1859 a Reggio Emilia», raccolta di articoli realizzati da studiosi reggiani sulla storia del 1859 e distribuita durante le cerimonie istituzionali del mattino. Cfr. Domenica si celebrerà il centenario della insurrezione, in «L’Unità», 12 giugno 1959. 14 15 Inevitabilmente, l’impostazione filocomunista assegnata alle celebrazioni conduce a una violenta disputa tra le forze politiche cittadine. Si deve tuttavia registrare il carattere talvolta esageratamente pregiudiziale delle contestazioni sollevate dalle opposizioni; lampante, in tal senso, il caso della federazione reggiana del partito socialdemocratico, che già alcuni mesi prima aveva negato «ai carnefici della Polonia dell’Ungheria e del Tibet il diritto morale di poter celebrare in purezza di spirito quel mirabile evento che fu il Risorgimento nazionale»19 e i cui esponenti si rifiutano, per una presa di posizione ideologica, di partecipare alle cerimonie ufficiali. È in particolare l’evento centrale della giornata, una conferenza al teatro municipale del professor Renato Zangheri dell’Università di Bologna sul tema «Libertà e Unità d’Italia nelle lotte del ‘59», a dare adito alle proteste. La raffigurazione della storia italiana e reggiana dipinta dal futuro sindaco di Bologna è, in effetti, difficilmente accettabile per gli avversari del pci; il suo discorso ripropone in sostanza le tesi di Antonio Gramsci20, secondo cui il Risorgimento sarebbe stato una rivoluzione passiva, manovrata dal partito moderato e quindi incapace di dare seguito alle aspirazioni sociali di quella parte di popolo che ne aveva combattuto le battaglie21. Inoltre, Zangheri riconosce nelle successive lotte del movimento operaio e socialista – per aver progressivamente esteso alle classi proletarie i diritti conquistati dalla borghesia nel 1861 – la necessaria continuazione delle lotte per l’unificazione: Una patria, una dignità di cittadini, i diritti civili elementari. I lavoratori reggiani e italiani li conquistarono da soli: col loro sacrificio, con la paziente, oscura opera di redenzione, nei campi, nelle fabbriche, nell’aspra quotidiana ricerca del lavoro e del pane. E in quest’opera da quando Prampolini, figlio di patrioti conservatori, si getta all’apostolato fra l’umile gente lavoratrice, in quest’opera la vostra città riprende il posto che ebbe alle origini: rialza il tricolore e lo restituisce alla Patria ricco di nuova vita, perché nuovo sangue è affluito nel sangue della nazione. Il vostro tricolore, padre Cervi, uomo di “nude opere di braccia”, dei vostri figli, che se son morti non “ignoranti di scienze, di arte, di lettere” lo debbono ad altri ideali, più grandi perché più umani”22. Cornuti e mazziati, in «La Giustizia», 16 giugno 1959. Sullo stesso argomento si veda anche Improntitudine comunista, in «La Giustizia», 3 aprile 1959. 20 Per una sintesi dell’interpretazione gramsciana del Risorgimento si veda W. Maturi, Interpretazioni del Risorgimento. Lezioni di storia della storiografia, Einaudi, Torino 1962, pp. 617-641. Gli scritti di Gramsci su questo periodo storico sono raccolti nel volume A. Gramsci, Il Risorgimento e l’Unità d’Italia, Donzelli, Roma 2010. 21 «Scossero il giogo della tirannia i coraggiosi abitanti di Reggio», in «Il Comune», 24 giugno 1959. 22 Solennemente celebrato il centenario della Liberazione di Reggio dagli Estensi, in «L’Unità», 16 giugno 1959. 19 16 L’epopea risorgimentale è dunque posta su una linea di continuità storica che va dalla fondazione della Repubblica reggiana nel 1796 alla guerra di Liberazione, passando attraverso l’affermazione del socialismo prampoliniano. L’appello finale è un invito alla prosecuzione di tale ciclo di battaglie per il progresso: Non parrà forzatura retorica o polemica se io, qui, a Reggio, città medaglia d’oro del II Risorgimento, sento il dovere di concludere una celebrazione del I Risorgimento con questo richiamo. Non è solo per il legame ideale che unisce i martiri di allora con quelli di ieri: non è solo per il comune e sacro patrimonio di sofferenza. È perché la continuità della storia non può spezzarsi. Coloro che rinchiudono le memorie Il provveditore agli studi di Reggio Emilia Ettore risorgimentali in una nicchia e Lindner insieme a Sergio Morini le affidano alla venerazione come in uno stanco rituale, respingono, che lo vogliano o non, l’eredità che ci viene da quelle memorie: una eredità di valori da difendere e di limiti da superare23. Principale animatore del dissenso all’orazione è l’onorevole Alberto Ferioli, personalità di spicco della sezione locale del pli; sostenitore di un’interpretazione del Risorgimento nei termini di una rivoluzione nazionale che coinvolse tutte le componenti sociali del popolo italiano, il deputato liberale definisce in una nota ufficiale il discorso di Zangheri «classista e dogmatico di pretta marca marxista»24. Alla sua, si aggiungono le voci di alcuni membri del comitato d’onore delle celebrazioni e dei consiglieri democristiani, rispettivamente comunale e provinciale, Giuseppe Mazzoli ed Ettore Lindner, insieme ai quali Ferioli chiede un’interpellanza al sindaco e una al presidente della giunta Ibidem. Agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1949-60, Interpellanza di Alberto Ferioli, 14 giugno 1959. 23 24 17 provinciale. Nel mirino delle opposizioni finiscono anche il comitato organizzatore, accusato di non aver rispettato il carattere unitario e al di sopra delle parti che la cerimonia avrebbe dovuto assumere25, e una pubblicazione sulla storia del 1859 a Reggio, distribuita nel corso della giornata26, alla cui stesura sarebbero stati chiamati a collaborare – stando all’accusa – soltanto elementi di fede social-comunista27. La risposta delle amministrazioni locali, ferme nel respingere le interpellanze, rivela un’incompatibilità radicale tra i due schieramenti nell’intendere la funzione delle celebrazioni. Non è solo sulla ricerca di una presunta correttezza scientifica del discorso di Zangheri, infatti, che si attesta la difesa, quanto su una differente concezione di «unitarietà» nelle commemorazioni. Per i socialcomunisti tale termine si traduce sì nell’esaltazione di quel comune «patrimonio di valori civili e morali che stanno alla base del Risorgimento», quali «la conquista dell’unità e gli ideali nazionali di libertà e indipendenza», ma non è tuttavia estensibile agli studi storici, pena la costruzione di un fasullo «quadro idilliaco, secondo il quale cattolici e moderati, federalisti e partito d’azione, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele II, Stato pontificio e Piemonte, avrebbero camminato a braccetto»28. Contrari all’adozione di una simile impostazione conciliatorista – che, da un lato, condurrebbe allo «svuotamento delle celebrazioni su un piano di formalità evocative» e, dall’altro, è riconosciuta come funzionale alla propaganda del Governo – gli esponenti di pci e psi ritengono maggiormente opportuno muoversi sul «terreno del dibattito, nel rispetto delle opinioni altrui, con quella correttezza scientifica di impostazione che l’avversario ha il diritto di chiederci», dato che il patrimonio unitario di valori patriottici derivati dal Risorgimento «non può annullare la diversa accentuazione dei giudizi e delle posizioni»29. Preso atto dell’inconciliabilità di vedute tra maggioranza e opposizione, i gruppi consiliari di dc, pli e psdi decidono di inoltrare un comunicato congiunto al sindaco, in cui si dichiara: I sottoscritti, mentre respingono e condannano l’impostazione partigiana data dall’Amministrazione comunale a una celebrazione che doveva trovare concordi Suscita interpellanze e deplorazioni l’orazione ufficiale del prof. Zangheri, in «Gazzetta di Reggio», 16 giugno 1959. 26 Si tratta del numero unico «Il 1859 a Reggio Emilia», 12 giugno 1959. 27 Si vedano: Agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1949-60, Estratto di verbale di deliberazione del consiglio comunale, 26 giugno 1959; Archivio storico della Provincia di Reggio Emilia (d’ora in poi ASPRE), Registri delle deliberazioni del consiglio provinciale, 20 giugno 1959. 28 Agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1949-60, Estratto di verbale di deliberazione del consiglio comunale, 26 giugno 1959. 29 S. Morini, Unità e lotta ideale nelle celebrazioni del Risorgimento, in «L’Unità», 18 giugno 1959. 25 18 tutti i cittadini, dichiarano di non riconoscere nell’attuale Amministrazione comunale l’organo idoneo ad effettuare la celebrazione di così importante avvenimento, onde informano la S.V. che voteranno contro ogni proposta che venisse fatta in avvenire dall’Amministrazione comunale su questo argomento e, conseguentemente, si asterranno dal prendere parte alle manifestazioni celebrative, essendo chiaro che queste altro non sono che espressioni dei due partiti che costituiscono la maggioranza consiliare30. A questo annuncio seguono, lungo il mese successivo, le dimissioni della totalità degli esponenti del Comitato d’onore politicamente vicini alla minoranza. A fare da apripista è ovviamente Ferioli, annunciando il proprio ritiro immediatamente dopo lo scontro in aula31; lo seguono l’onorevole democristiano Pasquale Marconi32, lo storico e presidente dell’Associazione provinciale stampa reggiana Ugo Bellocchi33, il prefetto Salvatore Camera, il questore Edoardo Greco, il provveditore agli studi e consigliere comunale democristiano Lindner, il presidente dell’Ente provinciale del turismo e consigliere comunale socialdemocratico Renato Marmiroli34 e, infine, i suoi compagni parlamentari Guido Franzini e Alberto Simonini35. Il centenario dell’unificazione Se paragonate alla battaglia cittadina scatenata dal discorso di Zangheri del 1959, le celebrazioni del 27 marzo 1961, centenario dell’unificazione nazionale, possono apparire, a una lettura superficiale, come il trionfo del politically correct. Ciò si deve al fatto che, in questa occasione, il Governo vigili sulle modalità di festeggiamento a livello locale, imponendovi un taglio politicamente più equilibrato. Pur concedendo alle amministrazioni la possibilità di organizzare iniziative corollarie, il prefetto viene infatti incaricato di supervisionare il funzionamento dell’intera macchina celebrativa36. Il comitato organizzatore Energica protesta delle minoranze per gli atteggiamenti faziosi della Giunta, in «Il Resto del Carlino», 4 luglio 1959. 31 Aspre, deposito 1510, Festività, centenari, celebrazioni varie, categoria centenari e celebrazioni varie, monumenti, Lettera di dimissioni di Alberto Ferioli, 27 giugno 1959. 32 Netta presa di posizione degli on. Ferioli e Marconi, in «Il Resto del Carlino», 28 giugno 1959. 33 Aspre, deposito 1510, Festività, centenari, celebrazioni varie, categoria centenari e celebrazioni varie, monumenti, Lettera di dimissioni di Ugo Bellocchi, 4 luglio 1959. 34 Si vedano gli articoli: Prefetto ed altre autorità dimettono dal Comitato d’onore, in «Gazzetta di Reggio», 10 luglio 1959; Il Prefetto ed altre autorità si dimettono dal Comitato d’onore, in «Il Resto del Carlino», 10 luglio 1959. 35 Simonini e Franzini si dimettono dal Comitato provinciale d’onore, in «Il Resto del Carlino», 23 luglio 1959. 36 Agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1961-64, Comunicazione del Prefetto agli amministratori locali, 5 gennaio 1961. 30 19 che questo nomina è, di conseguenza, composto da una rappresentanza più vasta del precedente e meno vicina alla maggioranza social-comunista: ne fanno parte, oltre all’Amministrazione comunale, il presidio militare reggiano, le associazioni d’arma, il provveditorato agli studi guidato dal democristiano Lindner e l’Ente provinciale del turismo, alla cui testa vi è il socialdemocratico Marmiroli37. Il presidente dell’anpi Gismondo Veroni, escluso dal comitato, denuncia il deliberato tentativo di realizzare «celebrazioni improntate a fredda ufficialità e prive di qualsiasi legame tra i motivi ideali del 1° Risorgimento e quelli della lotta di Liberazione»38. La scelta dell’oratore per il discorso al teatro municipale, apparentemente cauta e super partes, cade sull’onorevole repubblicano Randolfo Pacciardi, la cui aura di imparzialità è rafforzata dal fatto che a Reggio Emilia il pri raccolga in questi anni esigui consensi. La rievocazione dell’epopea risorgimentale esposta dall’ex ministro degli Esteri39 è improntata al superamento di qualsiasi appropriazione esclusiva di tale tradizione da parte dei singoli partiti; nonostante la sua fede repubblicana, egli attribuisce persino ai monarchici un ruolo nel processo di costruzione nazionale, dimostrando la volontà di fare del patriottismo un fattore unificante per gli italiani di qualsiasi credo politico. In realtà Pacciardi è fiero avversario dell’ideologia comunista e, impersonando l’anima del pri più ostinatamente contraria allo slittamento verso sinistra del governo40, non rappresenta una scelta del tutto imparziale. Più o meno esplicitamente, infatti, contraddice in alcuni passaggi il proprio intento di conciliazione, lasciandosi sfuggire diverse dichiarazioni anticomuniste, dalla stigmatizzazione della «moda italiana di negligere i pensatori nostri e affidarsi a falsi apostoli stranieri»41 all’affermazione che, in ossequio al pensiero mazziniano, una rivoluzione sociale in Italia «sarebbe una rivoluzione a ritroso … se ci facesse schiavi e non più compiutamente liberi, se restringesse la sfera delle libertà invece di allargarla a tutte le classi. La proprietà è giusta se è il frutto di un lavoro compiuto e non serve allo sfruttamento dell’uomo»42. Al di là di tali insinuazioni, il ragionamento di Pacciardi, volto a raffigurare il movimento risorgimentale come politicamente e socialmente eterogeneo, risulta poi del tutto funzionale ai partiti di orientamento interclassista. Di conseguenza, il di- Domani si celebra ufficialmente il Centenario dell’unità d’Italia, in «L’Unità», 26 marzo 1961. Una protesta dell’A.N.P.I. per la sua esclusione dal Comitato delle celebrazioni, in «L’Unità», 31 marzo 1961. 39 Il discorso di Pacciardi è integralmente riportato in La celebrazione del primo centenario dell’Unità d’Italia a Reggio Emilia. Discorsi di Renato Marmiroli e Randolfo Pacciardi. 27 marzo 1961, Nuova poligrafica reggiana, Reggio Emilia 1961. 40 Per una biografia di Randolfo Pacciardi di vedano: Grande dizionario enciclopedio Utet, Vol. XV, Tipografia sociale torinese, Torino 1989, p. 209; R. Traquandi, Randolfo Pacciardi, Albatros, Roma 2011. 41 La celebrazione del primo centenario dell’Unità d’Italia, cit., p. 18. 42 Ivi, p. 16. 37 38 20 scorso incassa il plauso di tutti i giornali vicini alle forze di Governo, ma non quello dell’«Unità», che in primo luogo gli rimprovera il mancato allacciamento tra Risorgimento e guerra di Liberazione – in realtà presente anche se effettivamente lasciato in secondo piano43 – e, in secondo luogo, rispedisce al mittente l’accusa di asservimento allo straniero44. È nel secondo evento organizzato per la giornata, una seduta pubblica dei consigli comunale e provinciale, che le varie anime politiche e le divergenti ricostruzioni storiche si scontrano, sebbene tutto si svolga in uno scenario di pacificazione e comunione d’intenti. In seguito alle introduzioni solenni degli assessori alla Pubblica istruzione, rispettivamente comunale e provinciale, Franco Boiardi e Davide Valeriani, i rappresentanti dei gruppi consiliari prendono, infatti, a turno la parola per esprimere la posizione del proprio partito in merito all’unificazione italiana45. I consiglieri di pci e psi non cessano di insistere sul filo rosso che collega Risorgimento e Resistenza, definendo il fascismo «anti-risorgimento»46 e soffermandosi sul ruolo svolto dal movimento operaio e contadino nelle battaglie per la liberazione dal giogo straniero. In risposta, i missini pretendono «rispetto ed onore anche per altri ideali del tutto validi in coloro che per essi giunsero fino al supremo olocausto»47; i consiglieri del pli ricordano che la nascita dell’Italia «è il frutto di un movimento liberale, di idee e uomini liberali»48; i democristiani, infine, oltre a rivalutare la figura di Pio IX49, sottolineano che «il contributo dei cattolici, nonostante la sofferenza di Al termine del proprio discorso Pacciardi afferma «Anche nel deserto più triste delle rovine desolate, come quello dell’ultima guerra, che pure conobbe, nella insurrezione popolare, alte e vibranti pagine di epopea che l’accostarono appunto alla grande epopea dei nostri padri»; cfr. La celebrazione del primo centenario, cit., p. 19. 44 Riuniti in seduta solenne i civici connessi per la celebrazione del Centenario dell’unità d’Italia, in «L’Unità», 28 marzo 1961. 45 Celebrato il centenario dell’Unità, in «Il Resto del Carlino», 28 marzo 1961. 46 Agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1961-64, Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Reggio Emilia, 27 marzo 1961. 47 Ibidem. 48 Aspre, Registri delle deliberazioni del consiglio provinciale, 27 marzo 1961. 49 Per quanto riguarda la posizione della curia reggiana in merito al dibattito sul Risorgimento si vedano gli articoli: Il Risorgimento senza retorica, in «La Libertà», 29 agosto 1959; Grato a Pio IX Mazzini andò in processione, in «La Libertà», 25 marzo 1961; Vittorio Emanuele II non voleva «andare all’inferno», in «La Libertà», 20 febbraio 1960; Osanna e «crucifige» al Papa del Risorgimento, in «La Libertà», 7 marzo 1959; L’ultimo Concilio, in «La Libertà», 31 gennaio 1959. Nel 1959 il vescovo di Reggio Beniamino Socche arriva a proporre la costituzione di un centro studi per indagini e ricerche storiche sull’apporto del clero italiano nel processo risorgimentale (cfr. Auspicato un Centro italiano di studi sull’apporto del Clero al Risorgimento, in «L’Avvenire d’Italia», 2 luglio 1959). Sempre «L’Avvenire d’Italia» riporta puntualmente le proteste portate in Consiglio comunale da esponenti della minoranza, cattolica e non, dirette verso le scelte dell’Amministrazione: si vedano a proposito gli articoli La minoranza protesta vivacemente per l’atteggiamento fazioso dei socialcomunisti, in «L’Avvenire d’Italia», 4 luglio 1959; Celebrati gli eventi del 1859 dalla Deputazione di Storia Patria, in «L’Avvenire d’Italia», 16 giugno 1959 e Una interpellanza del Dr. Mazzoli sulle celebrazioni del Centenario, in «L’Avvenire d’Italia», 25 giugno 1959. 43 21 molti per l’acuirsi del dilemma fra Stato e Chiesa, fu costantemente generoso e all’opera degli uomini singoli si aggiunse l’opera di movimenti organizzati»50. La cornice interpretativa unitaria auspicata da Pacciardi si trova dunque a fare i conti con una realtà politica estremamente sfaccettata, sia a livello nazionale che locale, dove l’abbozzo di una linea di memoria comune appare irrealizzabile. Lo stesso leader repubblicano, d’altra parte, non si è dimostrato completamente immune dalla tentazione di sfruttare il sentimento patriottico per criticare i propri avversari. Il convegno sul Risorgimento a Reggio Così come si erano aperte nel giugno del 1959, le celebrazioni reggiane del centenario terminano con un’accesa polemica. A rinfocolare gli animi e dividere nuovamente gli schieramenti politici è l’evento conclusivo realizzato dal Comune: un convegno di studi sul Risorgimento a Reggio nel dicembre del 196151. In questa occasione le critiche precedono addirittura l’inizio dei lavori organizzativi, generando una rapida frattura tra gli ambienti culturali vicini alla sinistra e quelli guidati da personalità legate alle forze di Governo52. Il comitato reggiano dell’Istituto nazionale del Risorgimento, l’Ente provinciale per il turismo, la Deputazione di storia patria e il provveditorato agli Studi si rifiutano infatti di collaborare al convegno diversi mesi prima della data stabilita, nonostante l’invito della giunta53. Già nelle celebrazioni pubbliche precedenti, d’altra parte, il contributo offerto da tali enti era stato impalpabile, se non concorrenziale, avendo essi optato per la realizzazione di un autonomo programma di conferenze54. Agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1961-64, Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Reggio Emilia, 27 marzo 1961. 51 Per il programma completo del convegno si veda agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1961-64, Biglietto di invito al convegno di studi sul Risorgimento a Reggio Emilia, dicembre 1961. Gli atti del convegno sono stati successivamente pubblicati in Il Risorgimento a Reggio. Atti del convegno di studi (28-29 dicembre 1961), La nazionale, Parma 1964. 52 Si veda l’articolo Il convegno sul Risorgimento: dibattito o monologo?, in «Gazzetta di Reggio», 21 settembre 1961. 53 Agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1961-64, Comunicato stampa in risposta alla «Gazzetta di Reggio», 22 settembre 1961. 54 Tra gli eventi organizzati dagli istituti culturali reggiani autonomamente dall’Amministrazione occorre ricordare: la conferenza di Giovanni Spadolini del 16 giugno 1959 alla Deputazione di Storia Patria sul tema «Risorgimento emiliano e unificazione italiana», cfr. Spadolini ha celebrato il centenario del 1859, in «Il Resto del Carlino», 17 giugno 1959; il ciclo di conferenze di approfondimento sul Risorgimento al palazzo del Capitano del popolo organizzato dall’Istituto per la Storia del Risorgimento e dall’Ente provinciale per il turismo di Reggio Emilia. Cfr. Centenario dell’Unità d’Italia. Programma di conferenze. Reggio Emilia, Palazzo del Capitano del Popolo. 24 aprile – 5 giugno 1960, Nuova poligrafica reggiana, Reggio Emilia 1960. 50 22 Il diniego è ancora una volta giustificato dalla presunta monopolizzazione del dibattito culturale da parte di intellettuali di orientamento social-comunista. Non si può negare la vicinanza alle sinistre delle tre principali personalità chiamati a relazionare – Franco Boiardi, Sergio Morini e Odoardo Rombaldi – né il tardivo coinvolgimento degli altri istituti culturali nei lavori organizzativi. Secondo Marmiroli, infatti, l’invito del Comune sarebbe giunto «a organizzazione già fatta e precisata in ogni suo particolare»55. Ciononostante, occorre notare come fra i relatori compaiano anche studiosi – valgano per tutti il sacerdote Carlo Cipolli e il democristiano Salvatore Fangareggi – la cui fede politica non può essere assolutamente tacciata di faziosità a favore del partito comunista. Al di là del fatto che l’Amministrazione abbia realmente tentato di escludere una parte del mondo culturale reggiano dal convegno, ciò che qui interessa è ancora una volta l’emergere di una radicale e radicata contrapposizione ideologica. Rispetto agli eventi precedenti essa risulta, se possibile, ancora più accentuata, determinando un vero e proprio boicottaggio da parte degli istituti che non vi hanno preso parte, della stampa vicina ai partiti di Governo e delle scuole, evidentemente condizionate dalla posizione del provveditore agli studi56. Si chiude così, com’era iniziato, il secondo giubileo della patria a Reggio Emilia. Paradossalmente, la festa che avrebbe dovuto celebrare il valore dell’unità nazionale, non fa che rivelare, qui come nel resto del Paese, l’esistenza di un’insanabile frattura politica e ideologica. Agcre, titolo 23, rubrica 9 Feste e celebrazioni, filza 2, fascicolo 1961-64, Lettera di Renato Marmiroli all’assessore alla P. I. del Comune di Reggio Emilia, 22 dicembre 1961. 56 Provincialismo e anticultura negli ambienti borghesi reggiani, in «L’Unità», 2 gennaio 1962. 55 23 L’Episcopato emiliano e la guerra d’Etiopia Elena Mantelli A metà degli anni Trenta del secolo scorso l’episcopato emiliano, come il resto del mondo cattolico e del clero italiano1, aderendo in modo pressoché corale alla campagna d’Etiopia, fu indotto a rapportarsi con gli ostici temi del nazionalismo, del colonialismo, della guerra, nonché con il concetto di «missione» applicato a tale impresa. La sintonia con il fascismo fu tutt’altro che scontata e logica, dato il trascorso dissidio con lo Stato e la recente riflessione pontificia al riguardo, riflessione che i vescovi emiliani dimostrarono di avere scarsamente recepito e rielaborato. Essi, infatti, spinti dal desiderio di dimostrare il patriottismo del clero e ancora legati a concezioni tradizionali, salvo poche e sporadiche eccezioni non fecero propri né il timore per le derive di un nazionalismo estremo, né la condanna della guerra in quanto tale. Inoltre, non avendo ancora assimilato il nuovo concetto di missione, intesa come opera slegata dal potere coloniale e attenta alle culture dei paesi da evangelizzare, finirono con il subire il fascino delle prospettive missionarie e civilizzatrici che l’impresa apriva. Chiesa, nazionalismo, colonialismo e guerra Riguardo ai temi implicati nel conflitto in questione Pio XI ricevette in eredità dal suo predecessore un lascito importante e innovativo. Infatti la prima guerra mondiale, una guerra che sconvolse l’Europa intera e le sue colonie, rese Benedetto XV consapevole della necessità per il papato di allargare gli orizzonti oltre la ristretta prospettiva europea per occuparsi delle sorti inter- 1 M. Rosa, Clero e società nell’Italia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1992; M. Guasco, Storia del clero in Italia dall’Ottocento a oggi, Laterza, Roma-Bari 1997; G. De Rosa (a cura di), Storia dell’Italia religiosa, vol. III. L’età contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1995. 25 nazionali al fine di difendere la pace contro qualunque minaccia, prima fra tutte quella di un certo nazionalismo che nella sua forma «estrema» andava indubbiamente respinto; così come andava rivista, a suo avviso, la tradizionale teoria della «guerra giusta», perché divenuta quanto mai inadatta e non più proponibile in un contesto di spaventoso perfezionamento delle armi di distruzione di massa2. Allo stesso modo la Grande Guerra aveva anche minato la credibilità dell’uomo bianco nelle colonie, motivo per cui il papa era sta indotto a ripensare il pensiero missiologico della Chiesa, promuovendo quel grande aggiornamento auspicato già da Leone XIII sul finire del secolo XIX3. A tal fine, il 30 novembre 1919, aveva emanato l’enciclica missionaria Maximum illud per prendere le distanze dal colonialismo politico, vietando quello religioso e spirituale4. Dato Benedetto XV rielaborò e attualizzò la tradizionale dottrina della «guerra giusta», derivata da sant’Agostino e poi sviluppata da san Tommaso, che ammetteva la guerra solo se lecita, cioè se intrapresa per un giusto titolo, una giusta causa e secondo un’intenzione retta. Nell’enciclica Ad beatissimi del novembre del 1914, deplorò la guerra, in quanto foriera di rovine e stragi tra fratelli della stessa famiglia umana; inoltre nella famosa Nota ai capi dei popoli belligeranti, dell’agosto 1917, condannò «l’inutile strage» in corso e individuò alcuni strumenti di promozione della pace. Nel dopoguerra alcuni teologi domenicani francesi e tedeschi cominciarono una revisione della teoria della «guerra giusta» con cui si era affrontato il conflitto appena concluso. Si chiesero se, di fronte ai progressi dei mezzi di distruzione di massa e alla conseguente impossibilità di combattere secondo princìpi cristiani, non si dovesse considerare ingiusta ogni guerra in quanto tale. L’unica scelta lecita al cristiano non doveva forse essere il pacifismo e l’azione a favore di un’organizzazione internazionale che riducesse i motivi di conflitto? Alcune di queste idee innovative furono accolte in Italia da una minoranza di intellettuali cattolici (Olgiati, Vercesi, Pucci), ma non fecero breccia nel sentire comune. Nel maggio 1922 Benedetto XV, con l’enciclica Pacem Dei munus pulcherrimum, tornò sul tema della pace, auspicando la nascita di una lega tra le nazioni al fine di garantire l’ordine internazionale. Tuttavia la neonata Società delle Nazioni, a dispetto di quanto il pontefice sperava, non pose come suo fondamento la legge cristiana e non coinvolse neppure le potenze sconfitte. Diversi cattolici nutrirono le medesime speranze del papa, ma poi, delusi dalla realizzazione ginevrina, aderirono, per contrapposizione, al nazionalismo, ormai fuso con il fascismo. Tuttavia, ancora per tutti gli anni Venti, il nazionalismo cattolico si tenne a distanza dagli orientamenti più imperialisti. Cfr. A. Canavero, I papi e la pace nel XX secolo, in A. Giovagnoli (a cura di), Pacem in terris. Tra azione diplomatica e guerra globale, Guerini e Associati, Milano 2003, p. 42. 3 Nelle colonie, da sempre, la Chiesa aveva dovuto fare i conti con ragioni di natura politica. Già con la creazione della Congregazione di Propaganda fide, nel 1622, aveva cercato di svincolare le missioni dal potere degli Stati cattolici, abolendo il sistema del patronato. Eppure l’incalzare dell’imperialismo europeo a fine XIX secolo e il frequente utilizzo del cristianesimo per legittimare il dominio coloniale indussero a un ulteriore ripensamento, fino a prospettare la creazione di un clero autoctono in terra di missione. Già Leone XIII, pur non apportando decisivi cambiamenti all’impostazione missionaria tradizionale, sostenne «l’inadeguatezza dei vecchi apparati di Chiesa alle realtà in mutamento al tramonto dell’Ottocento», preannunciando il grande aggiornamento iniziato da Benedetto XV. Cfr. S. Trinchese, Sviluppi missionari e orientamenti sociali. Chiesa e Stato nel magistero di Leone XIII, in De Rosa (a cura di), op. cit., p. 85. 4 J. Metzler, La Santa Sede e le missioni. La politica missionaria della Chiesa nei secoli XIX e XX, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, p. 87. 2 26 che la Chiesa era ritenuta uno dei maggiori strumenti di dominio degli Stati colonizzatori, egli aveva voluto separare nettamente la causa della missione da quella del colonialismo, richiamandosi all’universalismo cattolico e affermando la necessità della formazione di un clero indigeno. Aveva, perciò, proibito il sostegno a ideali nazionalisti e attribuito valore di civiltà ai paesi «pagani». Pio XI proseguì nel solco tracciato dal predecessore, dando ulteriori contributi. Continuò a occuparsi della pace, puntando a un riconoscimento internazionale del ruolo chiave della Santa Sede. In pratica cercò di ripristinare il tradizionale internazionalismo della Chiesa cattolica: se con la Ubi arcano Dei sostenne l’impotenza del solo laicato nel ricostruire e preservare la pace dopo la Grande Guerra, tre anni dopo, con l’enciclica Quas primas, affermò la necessità, per il bene del mondo intero, della sottomissione dell’umanità all’autorità della Chiesa. Sempre nell’enciclica Ubi arcano Dei del 1922 deplorò il nazionalismo estremo, in quanto distante e contrario alla visione cristiana, e ridusse il campo d’applicazione del tradizionale principio di guerra giusta, considerando ogni conflitto un flagello. Infine, per quanto attiene al campo della missione, proseguì nella presa di distanza dagli interessi coloniali e nella promozione delle chiese locali. A tale scopo, tra le sue prime decisioni appena divenuto papa, mandò in Cina monsignor Celso Costantini con il preciso compito di creare un clero autoctono. Poi promosse con forza l’evangelizzazione dell’Africa, dell’India e della Cina, guadagnandosi il titolo di «papa delle missioni». Infine accentrò a Roma tutti gli organi preposti alle missioni, allo scopo di svincolarli dalle pressioni politiche e quindi per dare loro una effettiva dimensione sovranazionale. Certamente il suo approccio fu ancora eurocentrico, eppure egli dimostrò una singolare coscienza della complessità e della dignità delle altre culture. Allo stesso modo, verso le Chiese separate da Roma, pur rimanendo in un’ottica di ritorno degli erranti (o all’obbedienza), sostenne comunque i primi esperimenti «ecumenici». Il suo pensiero faticò tuttavia ad attecchire, perché altri fattori ed eventi influirono maggiormente sulla cultura dell’epoca, determinando quell’ondata patriottica che esplose con la guerra d’Etiopia. In particolare nel 1929, salutata con i massimi clamori da ambo le parti, sopraggiunse la «conciliazione», che pose fine all’antico dissidio tra Stato e Chiesa e avvicinò il mondo cattolico alla politica estera del regime. Si diffuse così il culto dei martiri cattolici della guerra e proliferarono manifestazioni patriottico-religiose da parte delle associazioni cattoliche5. G. Vecchio, Patriottismo e universalismo nelle associazioni laicali cattoliche, in A. Acerbi (a cura di), La Chiesa e l’Italia. Per una storia dei loro rapporti negli ultimi due secoli, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 256-260. 5 27 La guerra d’Etiopia segnò l’apice di questo incontro tra cattolici e fascisti, oltre che il culmine del consenso del popolo italiano al regime. La scarsa ricezione del pensiero papale riguardo ai temi implicati fece prevalere, tra i cattolici e il clero, concezioni tradizionali e valori condivisi con l’ideologia mussoliniana6, tanto che aderirono alla causa persino figure cattoliche fino ad allora in aperto dissenso con il regime, mentre le poche voci controcorrente, come quella di Luigi Sturzo, non ebbero alcuna presa. Emblematici furono i discorsi dell’arcivescovo di Milano, monsignor Ildefonso Schuster, il quale, sperando in una «cattolicizzazione» del fascismo, vide nell’impresa una grande occasione in tale direzione7. Nella famosa predica del 28 ottobre 1935 egli esaltò il ritorno dell’Italia alla fede cattolica e si espresse in questo modo: «Cooperiamo pertanto con Dio in questa missione nazionale e cattolica di bene; soprattutto in questo momento in cui sui campi d’Etiopia il vessillo d’Italia reca in trionfo la Croce di Cristo, spezza le catene degli schiavi, spiana la strada ai missionari del Vangelo»8. La Chiesa subì il fascino dell’idea di una civiltà «romana cattolica» da portare a popolazioni barbare e nella vittoria in Africa intravide «grandezza e missione di civiltà per una nazione riconciliata con il cattolicesimo»9. La guerra suscitò la speranza di una «definitiva trasformazione del regime in senso nazionalcattolico»10, speranza che andrà scemando verso la fine degli anni Trenta11. Prevalsero temi tradizionali, tra cui la giustificazione della guerra in termini di catarsi, e valori condivisi da cattolici e fascisti, come la disciplina verso la F. Traniello, L’Italia cattolica nell’era fascista, in De Rosa (a cura di), op. cit., p. 292. E. Nobili, La parabola di un’illusione. Il cardinal Schuster dalla guerra d’Etiopia alle leggi razziali, NED, Milano 2005; A. Giovagnoli, Il Vaticano di fronte al colonialismo fascista, in A. Del Boca (a cura di), Le guerre coloniali del fascismo, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 126; V. Marchi, L’«Italia» e la missione civilizzatrice di Roma, «Studi Storici», 36/1995, p. 492. 8 P. Beltrame Quattrocchi, Al di sopra dei gagliardetti. L’arcivescovo Schuster: un asceta benedettino della Milano dell’«era fascista», Marietti, Casale Monferrato 1985, p. 191. 9 R. Moro, L’opinione cattolica su pace e guerra durante il fascismo, in M. Franzinelli, R. Bottoni (a cura di), Chiesa e guerra. Dalla benedizione delle armi alla Pacem in terris, Il Mulino, Bologna 2005, p. 276. 10 Traniello, L’Italia cattolica nell’era fascista, cit., p. 293. 11 Per lungo tempo la storiografia ha visto nelle leggi razziali del ’38 un elemento di rottura tra cattolici e regime, fino a sostenere che la linea di Pio XI fu più anti-nazionalista che anticomunista. Cfr. D. Veneruso, Il seme della pace. La cultura cattolica e il nazional-imperialismo tra le due guerre, Studium, Roma 1987. Oggi si ritiene, piuttosto, che da questo fatto abbia avuto inizio un processo di presa di distanza, a causa della convergenza italo-tedesca, che fece crollare le speranze di molti clerico-fascisti in una restaurazione confessionale dello Stato. Cfr. C.A. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia dall’unificazione agli anni Settanta, Einaudi, Torino 1998, p. 669; P. Scoppola, La Chiesa ed il fascismo. Documenti e interpretazioni, Laterza, Bari 1971, p. 316; R.A. Webster, La croce e i fasci. Cattolici e Fascismo in Italia, Feltrinelli, Milano 1964; A. Riccardi, Roma «città sacra»? Dalla conciliazione all’operazione Sturzo, Vita e Pensiero, Milano 1979. 6 7 28 patria o il mito dell’impero12. La sintonia su quest’ultimo punto fu una novità di quegli anni. Nella prima metà degli anni Trenta, l’imperialismo fascista si connotò come un movimento universale, volto non soltanto a un’espansione territoriale, ma anche alla diffusione di una nuova civiltà13. In tale prospettiva il tema dell’impero fu accolto anche dal mondo cattolico che, con la nascita dell’impero coloniale, abbandonò ogni reticenza. Durante il corso della guerra alcune voci continuarono a distinguere la prospettiva cattolica da quella fascista, ma la maggior parte vide una provvidenziale coincidenza tra missione imperiale italiana e crociata cristiana. Si evitarono i temi centrali dell’imperialismo fascista, quali la mistica dello Stato-nazione, la volontà di potenza imperialistica, la rivoluzione universale14, ma non mancò chi affiancò il tema cattolico della missione spirituale a quello fascista del mito di Roma. Eppure in territorio coloniale non si verificò questa sintonia tra Chiesa cattolica e fascismo. Certo, il regime si servì della religione cattolica per legittimare e consolidare il proprio dominio e agevolò l’ingresso di nuove congregazioni missionarie nel paese. Sul piano diplomatico la Santa Sede, spesso, assecondò i desideri del fascismo e in molti casi missionari e autorità ecclesiastiche si dimostrarono entusiasti del dominio italiano. Tuttavia vi furono anche motivi di tensione e non si verificò un appoggio unanime da parte dei missionari. Alcuni di essi non tacquero di fronte alla crescente violenza a cui Graziani, nei primi anni della dominazione, sottopose la popolazione cristiana e il clero etiope. Non solo, essi ebbero il coraggio di promuovere opere a difesa dei meticci, attività quanto mai invisa al regime. Per la Chiesa, l’Etiopia costituiva una terra di missione sui generis, perché non si trattava semplicemente di evangelizzarla, ma anche di ricondurre l’antica Chiesa cristiana etiope, qui presente, all’obbedienza romana, interrotta nel 451, quando i cristiani etiopi, influenzati dai vicini egiziani, non avevano accettato i dogmi stabiliti dal concilio di Calcedonia. A questo scopo nel 1924 Pio XI aveva ricevuto ras Tafari Makonnen. La conquista italiana fu vista come un aiuto anche in questa direzione, ma il tentativo di riunificare le due Chiese era malvisto dal governo fascista che puntava a indebolire il potere e l’influenza del clero etiope, profondamente legato all’impero negussita. Infatti, se Hailé Selassié aveva cercato di modernizzare l’Etiopia perseguendo l’idea di un impero cristiano che assimilasse le popolazioni musulmane di Moro, L’opinione cattolica su pace e guerra, cit., p. 285. Idem, Il mito dell’impero in Italia fra universalismo cristiano e totalitarismo, in D. Menozzi, R. Moro (a cura di), Cattolicesimo e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra le due guerre mondiali (Italia, Spagna, Francia), Morcelliana, Brescia 2004, pp. 311-371. 14 E. Gentile, La Grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo, A. Mondadori, Milano 1999, p. 185. 12 13 29 recente ingresso nello Stato, ma che, al contempo, assicurasse la supremazia delle antiche genti cristiane e il ruolo della Chiesa copta quale fonte di legittimazione, il regime volle, invece, fare piazza pulita di tale sistema di potere, sostituendolo del tutto con il nuovo apparato coloniale. Per questo il governo coloniale perseguì una politica filo-islamica a danno dei cristiani15. La regione ecclesiastica emiliana negli anni Trenta Negli anni Trenta la regione ecclesiastica Emilia, sotto la direzione dell’arcivescovo di Modena, era ancora distinta dalla Flaminia16 e comprendeva le diocesi di Carpi, Fidenza, Guastalla, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Durante la campagna d’Etiopia i vescovi emiliani, a livello collegiale, non affrontarono mai il tema della guerra né in sede ufficiale né su un piano informale, segno che essi non nutrirono dubbi sulla bontà dell’impresa e sull’atteggiamento da tenere al riguardo. Nella loro corrispondenza e nei loro incontri annuali17 non ne fecero alcun cenno, mentre si dimostrarono preoccupati di altre questioni, quali la minaccia del protestantesimo, del neopaganesimo, dei balli pubblici, nonché la denatalità e la tutela dell’Azione cattolica18. L’episcopato emiliano comprendeva presuli di generazioni diverse. Il vescovo di Reggio Emilia, monsignor Eduardo Brettoni19, era il più anziano. 15 P. Borruso, Chiesa e Stato nell’Impero d’Etiopia e nell’Africa orientale italiana, in R. Bottoni (a cura di), L’Impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941), Il Mulino, Bologna 2008, pp. 519-542. 16 Nel 1889 una circolare della Congregazione per i vescovi istituì, in Italia, diciassette regioni ecclesiastiche, tra cui l’Emilia, che comprese tutte le attuali diocesi dell’Emilia Romagna. Un decreto del 27 giugno 1908 della stessa Congregazione divise, poi, la zona in due regioni autonome: l’Emilia e la Romagna (detta anche Flaminia). Tuttavia l’affinità di problemi pastorali spinse le due conferenze a tenere spesso riunioni congiunte. Nel 1930 tennero un concilio plenario, i cui atti furono pubblicati in occasione della quaresima del 1935. Cfr. Lettera Pastorale dei Vescovi Emiliani per la Quaresima 1935: il Concilio Plenario, «L’Eco. Foglio Ufficiale della Curia Vescovile di Parma», 1-2 (1935), pp. 17-25. 17 Conferenze e concili regionali furono attivati con il pontificato di Pio XI al fine di favorire un maggiore collegamento tra l’episcopato. Cfr. Traniello, L’Italia cattolica nell’era fascista, cit., p. 273. 18 Atti e disposizioni dei Vescovi della Regione Emiliana. Le conferenze dei Venn. Presuli, «L’Eco. Foglio Ufficiale della Curia Vescovile di Parma», 5-6 (1935) pp. 66-67. 19 Su monsignor Eduardo Brettoni, oltre a testi celebrativi, esistono contributi scientifici, come l’ampia opera di S. Spreafico, I cattolici reggiani dallo Stato totalitario alla democrazia. La Resistenza come problema, 5 voll., Tecnograf, Reggio Emilia 1986-2001, o il più recente saggio di G. Giovanelli, L’episcopato di Eduardo Brettoni e il sofferto esordio ai tempi nuovi, in corso di stampa. Il primo ha tratteggiato la figura del vescovo all’interno di una ingente antologia di documenti sul mondo cattolico e il fascismo a Reggio Emilia. Il saggio di Giovanelli è destinato a far parte di un volume sulla storia della diocesi e mi è stato gentilmente dato in consultazione: esso allarga la visuale all’intero episcopato di Brettoni nella sua complessità, senza limitarsi ai risvolti politici. 30 Originario della provincia di Firenze, dopo gli studi a Roma e alcuni incarichi nella diocesi d’origine, divenne vescovo di Reggio Emilia nel 1911. Da subito si trovò di fronte alla guerra, fenomeno che divenne oggetto centrale anche della sua riflessione. Inizialmente fu attratto dal programma antisovversivo del fascismo, ma non tardò a coglierne la distanza ideologica dalla visione cristiana. Nonostante ciò, continuò a lungo a sperare di poterlo «cattolicizzare»20. Il suo rapporto con il regime fu, perciò, tormentato, fatto di alti e bassi, di dure proteste per alcuni episodi e di esaltazione per altri21. La guerra d’Etiopia rientrò tra questi ultimi. Egli lodò l’azione italiana, animato da un forte amor patrio, sentimento maturato durante la prima guerra mondiale, e dalla convinzione del valore civile e morale dell’impresa. Fece propri i motivi della propaganda fascista, che lasciava ben pochi spazi all’esercizio di un pensiero critico al riguardo. Tuttavia non fu del tutto sordo alla critica al nazionalismo «immoderato» portata avanti da Pio XI, tanto che sentì la necessità di precisare che la guerra d’Etiopia era lecita in quanto il colonialismo fascista non era «ingiusto e oppressore» come altri. Di simili vedute furono anche Menzani e Bussolari, i quali furono nominati negli anni Venti, prima della conciliazione, mentre si spegneva la generazione segnata dal pensiero di Leone XIII e dalla prima guerra mondiale. Allora molti dei nuovi vescovi furono scelti tra coloro che accolsero pienamente gli ideali Giovanelli, op. cit. I preti che lo conobbero negarono che egli avesse avuto sentimenti filofascisti. Secondo una testimonianza di don Carlo Lindner «Brettoni non fu mai fascista, come non lo fu il suo amico Evasio Colli vescovo di Parma, a differenza del fascistissimo loro confratello Domenico Menna, presule di Mantova». Cfr. C. Lindner, L’antifascismo del vescovo Brettoni, in Spreafico, op. cit., vol. III. Dal collateralismo conflittuale al riscattto cruento: quale sacerdozio?, p. 872. Diversamente, Spreafico, pur negando un presunto filofascismo di Brettoni, ha parlato di un «collateralismo conflittuale», sostenendo che «gli avvenimenti del 1935-36 offrono l’immagine di una Chiesa agganciata e trascinata lungo un piano inclinato, anche se la documentazione raccolta dà ragione a don Cocconcelli che ha sostenuto come all’epoca non tutti i sacerdoti fossero divenuti tutti fascisti, perché accanto a simpatizzanti, molto preoccupati del pericolo comunista, vi sarebbero stati diversi preti con molte riserve verso il regime». Giovanelli ritiene invece che il diario del presule smentisca questo presunto affiancarsi del mondo cattolico al fascismo e provi, piuttosto, il contrario: fu cioè il fascismo a tentare di ottenere il consenso della Chiesa con promesse di protezione e valorizzazione. A suo parere, occorre considerare alcuni punti fondamentali del pensiero di Brettoni, quali il forte patriottismo, la concezione laica dello Stato, il rispetto per l’autorità costituita, la centralità della persona, l’assenza di pregiudizi nei rapporti umani e, infine, il risvolto unicamente pastorale del suo antifascismo. Il vescovo attribuì sempre un grande valore alla patria, anche quando essa si identificò con il fascismo. Tuttavia il suo patriottismo si differenziò da quello fascista, come dimostrano i suoi appunti a commento del fallito attentato anarchico al re del 12 aprile 1928. In quell’occasione Brettoni decise di celebrare una messa per lo scampato pericolo. L’iniziativa, al principio sostenuta dalle autorità locali, fu poi boicottata per ordine del governo, perché non si volle divulgare il fatto. Il vescovo, nel suo diario, constatò con rammarico il completo allineamento del comune e della prefettura al regime mussoliniano. 20 21 31 patriottici, allo scopo di superare l’antico dissidio con lo Stato. Essi si fecero perciò promotori «dell’accordo di fatto tra doveri civili e doveri cristiani in vista di una società permeata dalla fede»22. Monsignor Ersilio Menzani23, di origine bolognese, si formò nel capoluogo emiliano e fu nominato vescovo di Piacenza nel 1920 dal concittadino Benedetto XV, il quale, prima di divenire papa, era stato suo vescovo. Menzani si insediò in piena affermazione del fascismo, vivendo tutta la parabola del regime e assumendo atteggiamenti diversi a seconda delle circostanze storiche. Cercò sempre un’armonia con le autorità, ma non si sottrasse, talvolta, dalla dura critica24. Inizialmente, come il resto del mondo cattolico, fu sospettoso e temette per la violenza anticlericale e antipopolare del movimento. Ma una volta superate le tensioni del 1924, sopraggiunto il concordato e sedati i dissapori del 1931, entrò in buoni rapporti con l’autorità locale. La concordia fu disturbata solo da pochi incidenti episodici, che non gli impedirono di salutare benevolmente la guerra d’Etiopia, la campagna di Spagna e la battaglia del grano. La guerra d’Abissinia gli parve giusta e altamente civile. Menzani è l’unico presule emiliano di cui è testimoniata una qualche corrispondenza con soldati Monticone, L’episcopato italiano dall’Unità al Concilio Vaticano II, in M. ROSA (a cura di), op. cit., p. 301. 23 La personalità di monsignor Menzani, vescovo di Piacenza dal 1920 al 1961, è stata a lungo oggetto solo di commemorazione. Una più attenta trattazione scientifica ha avuto inizio con il lavoro di Lorenzo Bedeschi sul carteggio del presule con papa Della Chiesa. Cfr. L. Bedeschi, La questione romana in alcune lettere di Benedetto XV, «Rassegna di Politica e Storia», 10/1964, pp. 21-25. Franco Molinari, analizzando dapprima il suddetto carteggio, poi l’ostico tema dei rapporti tra Menzani e il fascismo, ha posto in rilievo la prospettiva religiosa e si è basato su fonti diverse rispetto a quelle usate dagli storici della resistenza, quali la stampa locale, il bollettino della curia e la corrispondenza inedita, conservata presso l’archivio diocesano. Cfr. F. Molinari, Il carteggio di Benedetto XV con mons. Ersilio Menzani, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 20/1966, pp. 410-449; Id., Mons. Ersilio Menzani ed il fascismo, «Bollettino Storico Piacentino», 1976, p. 40. Molinari ha analizzato il contesto entro cui il vescovo si trovò a operare, con particolare riferimento alla vicenda del giornale cattolico «Il Nuovo Giornale», mentre Luigi Mezzadri e Roberto Tagliaferri si sono soffermati sulla concezione dei rapporti tra Chiesa e mondo espressa da Menzani nelle sue lettere pastorali. Cfr. F. Molinari, «Il Nuovo Giornale» di Piacenza e il fascismo, in P. Pecorari (a cura di), Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI, 1922-1939. Atti del quinto Convegno di storia della Chiesa, Torreggia 25-27 marzo 1977, Vita e Pensiero, Milano 1979, pp. 997-1026; L. Mezzadri, R. Tagliaferri, Chiesa e mondo nelle lettere pastorali di mons. Ersilio Menzani vescovo di Piacenza, in Pecorari (a cura di), cit., pp. 984-996. 24 Molinari sostiene che «sarebbe errato addebitare il peccato di fascismo al Menzani per il fatto che egli abbia ricercato l’armonia delle autorità». Non si trattò cioè di fascismo o di antifascismo, bensì di un mutevole rapporto di collaborazione, in cui si alternarono momenti diversi e si mescolarono riconoscimenti per le benemerenze del regime con deprecazioni per i suoi atteggiamenti «ghibellini». La formula più giusta da usare sarebbe quella di «afascismo». Cfr. F. Molinari, Mons. Ersilio Menzani ed il fascismo, cit., p. 68. 22 32 al fronte, anche se ridotta a una sola lettera. I giovani dell’Azione cattolica, mandati in Africa, nel gennaio del 1936 gli fecero recapitare la fotografia della chiesetta che avevano costruito nella colonia, affermando di aver voluto così esaudire i paterni consigli del presule stesso, che in quel periodo stava terminando la chiesa del Corpus Domini25. Menzani rispose dicendosi lieto per le notizie ricevute e per l’opera compiuta dai suoi giovani, animati da viva fede. Invocava, perciò, la benedizione ed esprimeva i più fervidi auguri affinché essi, «compiuto tutto il loro dovere con santo entusiasmo», rientrassero «nell’antica loro terra, per riprendere il ritmo normale alla vita, godendo dei vantaggi che il vittorioso santo esercito ha procurato alla nostra cara Patria»26. Nel 1935 lo spionaggio fascista lo definì «molto proclive al Regime». Infatti l’unica relazione della polizia politica sul presule, del settembre del 1935, recita così: S. E. Mons. Ersilio Menzani è il vescovo di Piacenza. A tale importante diocesi fu nominato da Benedetto XV, di cui era molto amico. Mons. Menzani è nato in Mongardino, presso Bologna, nel dicembre del 1872. Nel clero bolognese seppe subito eccellere, tanto che della diocesi di Bologna divenne vicario generale. Poco prima che ad essa diocesi venisse nominato il Card. Nasalli Rocca, Benedetto XV, pensava promuovere, il Menzani, affidandogli la sede di Piacenza. Effettivamente si dice che tale nomina fosse voluta dal famigerato Faggiani, aiutante di camera di Benedetto XV, che con il Menzani andava molto d’accordo. E fu così che la nomina avvenne ad insaputa del Card. De Lai, Segretario della Concistoriale, al quale il Pontefice disse di aver nominato da sé il vescovo di Bologna. Mons. Menzani è tutto pervaso da idee... moderne, e molto proclive al Regime. Sembra che per tale motivo sia poco ben visto in Vaticano; tanto che gli si ostacola qualunque promozione, ch’egli desidererebbe ardentemente, e per la quale sta facendo forti pressioni all’amico Card. Nasalli Rocca, nativo di Piacenza. Ma in Vaticano, e specialmente in Segreteria di Stato, non vogliono sentirne parlare. Si dice che Mons. Menzani, col suo fare troppo liberale, abbia più d’una volta creato degli imbarazzi alle superiori autorità ecclesiastiche27. Tuttavia la sua buona disposizione iniziò a scemare con il sopraggiungere dell’alleanza di Mussolini con Hitler e tutto ciò che ne derivò28. Archivio storico diocesano di Piacenza, Menzani Acta-Corrispondenza, 1935-1937. Ibidem. 27 Archivio Centrale dello Stato, ministero degli Interni, Divisione affari riservati, Polizia politica, fascicoli personali, busta 826, fascicolo Menzani Ersilio. 28 Per Mezzadri e Tagliaferri, Menzani guardò con favore al fascismo, non per adesione verso un sistema capitalistico, bensì perché, conformemente alle prime posizioni di Pio XI, ritenne che uno Stato autoritario fosse, in quel momento, del tutto preferibile a un altro. In un clima di forte scristianizzazione, giudicò i sistemi politici in base al loro rapportarsi con la Chiesa e, per questo, preferì il fascismo al comunismo e al liberalismo. Mussolini, infatti, cercò opportunisticamente il favore della gerarchia e non si oppose in modo manifesto alla religione. Menzani, perciò, appoggiò il regime, ma fintanto che questo non oltrepassò il limite. Quando iniziò a invadere ambiti fondamentali per la Chiesa, come l’educazione, allora non lesinò critiche. Cfr. L. Mezzadri, R. Tagliaferri, op. cit., pp. 993-995. 25 26 33 Anche il vescovo di Modena, monsignor Giuseppe Antonio Bussolari29, aveva origini bolognesi, ma ebbe una formazione diversa rispetto a Menzani, dato che era entrato nell’ordine dei cappuccini. Il suo episcopato a Modena durò solo tredici anni, ma fu intenso e non privo di difficoltà. Le sue esperienze precedenti la nomina episcopale, interne all’ordine, furono di studio e di formazione e lo tennero piuttosto distante da problemi sociali e politici, tanto che anche durante il suo episcopato evitò sempre di esprimersi al riguardo, salvo alcuni riferimenti rapidi e circoscritti30. Non si dimostrò filofascista in senso stretto, come sottolinea Luigi Paganelli, anche se accettò il regime e, in parte, stimò Mussolini. Dopo il fallito attentato al duce del novembre 1926, celebrò un solenne Te Deum per lo scampato pericolo, ringraziando Dio per aver sottratto la patria a un tale danno, condannando l’attentatore e invitando la popolazione al rispetto dell’autorità che viene da Dio31. Nonostante ciò, nel 1934 lo spionaggio fascista non vide in lui un sostenitore del regime e si espresse in questi termini: «Mons. Bussolari è di indole piuttosto dura, e d’idee intransigenti poco proclivi al Fascismo. Egli poco viene in Roma, e preferisce incaricarsi personalmente di tutti gli affari della sua archidiocesi, alla quale è unita l’Abbazia di Nonantola. Mons. Bussolari è Consultore della S. Congregazione dei Sacramenti, ed è reputato uno dei più dotti presuli della chiesa latina»32. Allo scoppio della guerra d’Etiopia, pur appoggiando senza riserve l’impresa, egli entrò di rado nel merito della questione. A differenza di quanto fecero altri cattolici in diocesi, uscì difficilmente dall’ambito religioso: invitò a pregare, a compiere il proprio dovere e a ringraziare il Signore, ma raramente trattò temi politici. Si dimostrò rigorosamente lealista, raccomandando in ogni occasione il rispetto delle autorità, ma non intervenne con frequenza e spontaneità, Volendo approfondire l’episcopato di Giuseppe Antonio Ferdinando Bussolari, ci si scontra con una grande scarsità di studi al riguardo. Infatti non solo le commemorazioni, ma anche i saggi usciti più di recente o mantengono un taglio celebrativo o analizzano aspetti molto specifici. Cfr. G. Pistoni, S. Ecc. Mons. Giuseppe Antonio Ferdinando Bussolari O.F.M. Cap. Arcivescovo di Modena e Abbate di Nonantola - 12 dicembre 1964 nel XXV dalla morte, Scuola Tipografica Sordomuti, Bologna 1966; D. Cotti, Nelle funebri solenni onoranze che le autorità religiose, civili e il popolo di S. Giovanni in Persiceto celebrano in memoria e in suffragio dell’illustre concittadino l’ecc.mo arcivescovo Giuseppe Antonio Ferdinando Bussolari, Tip. L. Parma, Bologna 1940; F.A. Samoggia, Elogio funebre di mons. Giuseppe Antonio Ferdinando Bussolari, arcivescovo di Modena, abate di Nonantola, O.F.M., «La Provincia dei Cappuccini di Bologna», 1940, pp. 6-12; A. Leonelli, L’arcivescovo cappuccino, in A. Barbieri, A. Leonelli, G. Montanari, Storia dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, vol. II. Dal secolo XVIII all’anno 1977, Tipolitografia Paltrinieri, Modena 1997, pp. 313-327; L. Paganelli, I cattolici e l’Azione Cattolica a Modena durante il fascismo dal 1926 al 1945, Mucchi e SIAS, Modena 2005. 30 L. Paganelli, op. cit., p. 60. 31 «Bollettino del Clero della Diocesi di Modena e di Nonantola», 10 (1926), pp. 116-117. 32 Archivio Centrale dello Stato, Ministero degli Interni, Divisione affari riservati, Polizia politica, fascicoli personali, busta 207, fascicolo Bussolari Giuseppe. 29 34 limitandosi ad eventi particolari, forse ineludibili senza lo scoppio di tensioni. Aderì quindi alla guerra, ma sempre con una certa distanza dalla politica. Di altra tempra furono i rimanenti tre vescovi emiliani, che vennero nominati negli anni Trenta, quando, attenuandosi l’euforia concordataria, la scelta dei nuovi presuli dipendeva meno da «motivazioni ad extra», come era avvenuto nel decennio precedente. Si privilegiarono piuttosto figure di robusta formazione teologica, di ferma obbedienza al papa e di «provato interesse per l’apostolato dei laici»33. La nomina fu comunque regolata dalle nuove norme sancite dai Patti lateranensi, che garantivano giuridicamente che l’episcopato assumesse atteggiamenti patriottici, così da favorire «un clima di stretta collaborazione tra Chiesa e Stato»34. Monsignor Evasio Colli35 rappresentò la figura di spicco della Conferenza episcopale emiliana, tanto che il papa gli chiese più volte di prendere servizio presso la sua segreteria, ma egli rifiutò sempre per sincero attaccamento alla diocesi di Parma. Originario del Monferrato, si formò a Roma. Dopo le prime esperienze sacerdotali nella diocesi d’origine, nel 1927 fu nominato vescovo di Acireale, in Sicilia, ma dopo pochi anni passò a Parma, dove rimase fino alla morte. Qui, all’epoca del suo arrivo, nel 1932, regnava una certa armonia tra Stato e Chiesa. Erano ormai lontani i sussulti degli anni Venti, che avevano visto le squadre del sansepolcrista Italo Balbo assediare i rivoltosi dell’oltre- A. Monticone, op. cit., p. 309. E. Nobili, Vescovi lombardi e consenso alla guerra. Il cardinale Schuster, in R. Bottoni (a cura di), op. cit., p. 268. 35 Malgrado la rilevanza del suo lungo episcopato, la figura di Evasio Colli, che tenne la cattedra episcopale parmense dal 1932 al 1971, resta inadeguatamente esplorata. Cfr. E. Colli, Lettere pastorali (1932-1956) raccolte in occasione del Suo Giubileo Sacerdotale, a cura di P. Triani, SEI, Torino 1956; Idem, Altre lettere pastorali. Scritti, documenti, discorsi raccolti nel decimo anniversario della morte, a cura di P. Triani, Tipolitografia Benedettina Editrice, Parma 1981; Idem, Semina Flammae. Documenti di vita pastorale, a cura di P. Triani, OVE, Parma 1960; P. Bonardi, Mons. Evasio Colli mediatore di pace. Autorità ecclesiastica e occupanti tedeschi (agosto 1943-aprile 1945), Tecnografica, Parma 1996; A. Bianchi, Colli, in F. Traniello, G. Campanini (a cura di), Dizionario storico del Movimento cattolico in Italia 1860-1980, vol. III/1, Marietti, Torino 1984, pp. 242-243. Più abbondanti sono le commemorazioni e i cenni in opere generali o in studi sull’Azione Cattolica: A. Marocchi, Mons. Colli negli scritti del suo segretario Mons. Arnaldo Marocchi, Tipolitografia Benedettina Editrice, Parma 1987; S. E. l’Arcivescovo E. Colli, vescovo di Parma, Azione Cattolica parmense, Parma 1955; La Chiesa di S. Evasio. Vita di mons. E. Colli, arcivescovo di Parma, s.n., Parma 1971; P. Bonardi, La Chiesa di Parma e la guerra 1940-1945, Tipolitografia benedettina Editrice, Parma 1987; F. Morini, Parma nella Repubblica Sociale, Edizioni La Sfinge, Parma 1989; A. Fappani, F. Molinari, Chiesa e Repubblica di Salò, Marietti, Torino 1981; P. Trionfini, Esperienze e aspettative dei cattolici emiliani tra guerra e Resistenza (1940-1945), in B. Gariglio (a cura di), Cattolici e Resistenza nell’Italia settentrionale, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 199-276; G. Pisanò, Storia della Guerra Civile in Italia, FPE, Milano 1965; R. Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1927-1937), Il Mulino, Bologna 1979, pp. 343-344; Franzinelli, Il clero italiano e la «grande mobilitazione», in Bottoni (a cura di), op. cit., p. 258. 33 34 35 torrente, cattolici e socialisti insieme36, i popolari perseguitati dal nascente movimento fascista e lo stesso vescovo, monsignor Guido Maria Conforti, vietare a più parroci di benedire i gagliardetti degli squadristi, come protesta per le continue aggressioni e in ottemperanza alle disposizioni pontificie circa la neutralità politica del clero37. Al principio degli anni Trenta la situazione era diversa. Il regime si era definitivamente attestato, facendo tacere ogni opposizione con le leggi liberticide del 1926. I cattolici avevano rinunciato alla protesta, scendendo sul campo della collaborazione. Monsignor Colli, che non aveva vissuto le tensioni precedenti, non fu maldisposto verso le autorità locali e cercò sempre di collaborare. Aderì quindi alla campagna d’Etiopia non in quanto guerra fascista, ma perché ritenne che il colonialismo italiano fosse diverso da quello di altri paesi europei. A suo avviso l’Italia dava alle sue imprese un contenuto religioso, missionario e civile che altre potenze trascuravano del tutto. Si espresse spesso sulla guerra in corso, più di quanto fosse necessario per consolidare i rapporti con il fascismo. Sembrò spinto dalla volontà di dimostrare il patriottismo dei cattolici, a lungo accusati di non essere per nulla legati alla patria, ma, allo stesso tempo, fu l’unico presule emiliano a rielaborare il tema del patriottismo e a prendere le distanze da alcuni aspetti del nazionalismo fascista, come emerge dalla pastorale che scrisse in piena guerra d’Etiopia, nella primavera del 1936, e che intitolò per l’appunto I Cattolici e la Patria38. Monsignor Giacomo Zaffrani, profondo conoscitore di teologia, filosofia dogmatica e storia ecclesiastica, si formò e iniziò il ministero nella diocesi di Como39. Qui si guadagnò cattiva fama presso le autorità, perché si adoperò per sostenere l’Azione cattolica e il partito di don Sturzo, difendendoli dagli attacchi del nascente movimento fascista. Di conseguenza, il 22 luglio 1932, quando il ministro dell’interno, informato dalla Santa Sede dell’intenzione del papa di nominarlo vescovo di Guastalla, chiese il nulla osta del governo, mentre i prefetti di Como e di Reggio Emilia non espressero dubbi40, l’ambasciatore 36 Canali, La Gioventù Cattolica a Parma negli anni del pontificato di Pio XI, in P. Pecorari (a cura di), op. cit., p. 959. 37 A. Manfredi, Guido Maria Conforti, EMI, Bologna 2010, p. 397. 38 E. Colli, I Cattolici e la Patria, «L’Eco. Foglio Ufficiale della Curia Vescovile di Parma», 1 (1936), pp. 1-4. 39 Anche l’episcopato di monsignor Zaffrani (1932-1960) risente di una scarsa attenzione storiografica. Si ricordano, qui, solo uno scritto commemorativo, La sua memoria resterà in benedizione, «La Libertà», numero speciale, 1960, e qualche riferimento in alcune opere generali, come quella già citata di Spreafico. Giacomo Zaffrani (Casalzuigno 1878-¬1960) compì gli studi e si formò nella diocesi di Como, dove venne ordinato sacerdote nel 1910. Il 30 ottobre 1932 venne consacrato vescovo a Como e l’8 dicembre fece il suo ingresso a Guastalla, quale undicesimo vescovo della giovane diocesi. Durante il suo lungo episcopato si occupò della ricostruzione del seminario diocesano e della formazione del clero, valorizzò l’ingegno dell’Azione Cattolica, rivolse l’attenzione ai braccianti della zona, sostenendone lo sciopero del ’49. 40 M. Casella, Per una storia dei rapporti tra fascismo e i vescovi italiani (1929-1943), «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», 36/2007, p. 192. 36 De Vecchi oppose forti riserve: «Politicamente non è sicuro perché ha troppo vissuto partecipando alla resistenza che il popolarismo ha opposto in Como al Fascismo. Esprimo ogni riserva per questo uomo anche se a Guastalla il nuovo Vescovo non troverà più l’ambiente di Como». In un altro appunto – anonimo, ma attribuibile con buona probabilità allo stesso ambasciatore –ribadì tale giudizio, scrivendo: nell’immediato dopo guerra – al Partito Popolare Italiano che nella provincia di Como era predominante, Mons. Zaffrani, ha dato non poca attività. Con l’avvento del fascismo, e soprattutto con il nuovo e importante ufficio affidatogli di Vicario Generale della Diocesi, i suoi legami con i vecchi esponenti popolari del comasco e della Valtellina si sono molto attenuati, e – nonostante le difficoltà e resistenze locali – egli ha cercato di adattarsi alle nuove condizioni; e risulta anzi che in molte circostanze – specialmente nel periodo del governo episcopale di Mons. Pagani, sotto il quale si verificarono non pochi e non lievi incidenti, che ebbero una certa ripercussione anche nei rapporti tra Chiesa e Stato – Mons. Zaffrani, fece opera equilibratrice, sforzandosi di attenuare gli atteggiamenti troppo aspri e intransigenti del Vescovo e di parte del Clero. Attualmente Mons. Zaffrani ha molta ostilità nella Valtellina, essendo egli tra i più fermi oppositori della creazione della nuova diocesi di Sondrio. Ad ogni modo egli gode la stima universale della sua città e del clero, per la vita esemplare, per la sua cultura, per il suo carattere affabile e per la sua carità41. Solo il 13 settembre il ministero dell’Interno, dopo aver ottenuto il parere positivo di Mussolini, diede il via libera al nunzio apostolico42. Nella cittadina emiliana i rapporti del presule con il fascismo non furono né facili né lineari43. Anch’egli evitò di esporsi apertamente e si concentrò soprattutto sul potenziamento dell’Azione cattolica. Al momento del suo arrivo nel 1932 l’atmosfera favorì la collaborazione, perché il clima post conciliationem non era stato compromesso dagli scontri del 1931 e le successive campagne d’Etiopia e di Spagna confermarono tale armonia. Tuttavia questa iniziale convergenza non gli impedì, qualche anno più tardi, di scorgere il pericolo delle leggi razziali, da cui prenderà le distanze44. All’epoca della guerra d’Etiopia lodò l’impresa del regime. Nei suoi discorsi si soffermò spesso sulla questione: l’affrontò non solo perché costretto a inter- Archivio Centrale dello Stato, ministero degli Interni, Affari Politici, 1931-45, Ambasciata, busta 9. 42 Casella, op. cit., p. 193. 43 Uno studio di Antenore Benatti ha dimostrato che né l’Azione cattolica né il presule aderirono all’ideologia fascista, che anzi, sotto l’influenza del vicino don Primo Mazzolari, guardarono con sospetto per la matrice anticlericale e antireligiosa. Cfr. A. Benatti, Cattolici e violenze fasciste a Guastalla, in Pecorari (a cura di), op. cit., p. 1034. 44 L. Bisi, T. Soresina, Guastalla: venti secoli di storia, Comune di Guastalla, Luzzara (Reggio Emilia) 1990, p. 268. 41 37 venire alle cerimonie del regime, bensì la trattò direttamente e con puntualità, passandone in rassegna tutte le implicazioni. Chiara fu la sua assunzione di tutti i temi della propaganda. Probabilmente i suoi interventi ebbero anche un sottile intento riabilitativo agli occhi del fascismo, data la difficoltà con cui aveva ottenuto l’exequatur governativo. Tuttavia, il motivo che maggiormente lo animò fu un sentimento patriottico: di rado si riferì o nominò Mussolini e il fascismo, mentre richiamò puntualmente il popolo alla disciplina, valore tradizionale che accomunò cattolici e fascisti45. Quanto detto fin qui riguardo agli altri presuli non può essere affermato con altrettanta fondatezza per l’allora vescovo di Carpi, monsignor Carlo De Ferrari46. Allo scoppio delle ostilità, infatti, la piccola diocesi emiliana si trovò priva del suo pastore: monsignor Giovanni Pranzini era morto da pochi mesi e si attendeva la nuova nomina, che giunse solo a dicembre. La Santa Sede designò De Ferrari, uno stimmatino originario della provincia di Bolzano e ben visto dal regime, come dimostrano le pratiche per l’exequatur. Infatti, verso la fine del 1936, quando il ministro dell’Interno Buffarini chiese il parere dei prefetti di Modena e Udine, il primo diede semplicemente il nulla osta politico, mentre il secondo precisò che Carlo De Ferrari dimostrava il suo attaccamento al regime. Scrisse: Padre Carlo De Ferrari fu Carlo et fu Panzina Prautner, nato a Lichtenberg 2 ottobre 1885 est direttore locale Collegio Arcivescovile Bertoni dal 29 marzo 1932. Precedentemente dimorava at Roma, ma ignorasi quale carica ricopriva. Qui conduce vita ritirata, dedita studio astraendosi vita pubblica et non partecipando manifestazioni, ma esplicazione proprio ufficio nei contatti con insegnanti et discepoli dimostra maniera non dubbia attaccamento istituzioni Regime. Inchiesta rigorosa mia nulla in contrasto per eventuale di lui nomina at Vescovo Diocesi Carpi47. Se ne deduce che era un personaggio non troppo scomodo per il regime. Fece il suo ingresso in Carpi l’11 febbraio del 1936. La documentazione conservata presso l’Archivio della curia vescovile non testimonia alcuna presa di posizione esplicita del vescovo nei confronti della guerra d’Abissinia. Alla cerimonia di ingresso in diocesi, visitò la Casa del fascio, dove tornò in altre occasioni48, e al termine del discorso alla diocesi non mancò di rivolgersi benevolmente alle autorità con queste parole: Moro, L’opinione cattolica su pace e guerra, op. cit., p. 285. La figura di Carlo De Ferrari (1885-1962), vescovo di Carpi dal 1935 al 1941, non è stata ancora esaminata in modo completo. Si vedano alcuni riferimenti in opere generali: P. Trionfini, Dalla fine dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale, in A. Beltrami, A. Mori (a cura di), Storia della Chiesa di Carpi, vol. I. Profili cronologici, Mucchi, Modena 2006, pp. 193-210; Paganelli, op. cit., pp. 68-70; A. Bellini, Chiesa carpigiana, Azione Cattolica e fascismo durante il pontificato di Pio XI, in Pecorari (a cura di), op. cit., pp. 1027-1031. 47 Archivio Centrale dello Stato, ministero dell’Interno, Direzione Generale Affari di Culto, Vescovi, busta 72, fascicolo Diocesi di Carpi. 48 Le festose accoglienze al novello vescovo, «Bollettino Ufficiale della Diocesi di Carpi», 3 (1936), p. 4. 45 46 38 Da ultimo, non ultimo certo, è alle Autorità civili e politiche che si rivolge devoto il pensiero del Vescovo, per offrire e chiedere, con cristiana e italiana lealtà, quella mutua intesa e collaborazione di cui l’Italia sta oggi dando al mondo insuperato ed insuperabile spettacolo. Nella mia ormai non breve carriera di educatore, già molto prima che la Conciliazione avesse i suoi auspicati protocolli, io ho sempre insegnato colla parola e coll’esempio ai miei giovani che i due supremi amori della Religione e della Patria non sono scindibili in un cuore sinceramente cristiano. Oggi che un solenne giuramento mi lega, oltre che alla Chiesa Santa, all’Augusta Maestà del Re sono fiero di aver raggiunto un posto di responsabilità, in un’ora decisiva per le maggiori fortune della Patria diletta; né sarò, spero, l’ultimo a compiere tutto il mio dovere e più del dovere, ove occorra, nei limiti del possibile49. La guerra d’Etiopia vi compariva per allusioni, parlando di «ora decisiva». Vi fece riferimento anche un anno dopo, il 31 ottobre 1937, quando partecipò al Congresso eucaristico nazionale a Tripoli, motivato dalla volontà di dare un contributo «al prestigio d’Italia di fronte alle altre nazioni»50. In quest’occasione ringraziò Dio per aver permesso che l’Italia ottenesse l’impero, nonostante le circostanze «quanto mai contrastanti e gloriose»51. I vescovi emiliani durante il conflitto Il 5 dicembre 1934 truppe irregolari abissine attaccarono i soldati italiani presso il villaggio Ual Ual, che apparteneva alla Somalia italiana. In passato, il confine tra territori italiani ed etiopi era stato superato più volte anche dai militari italiani, eppure tale incidente divenne subito per il regime fascista un casus belli per giustificare la futura aggressione dell’Etiopia. Da quel momento iniziò un’opera di legittimazione del prossimo intervento, attraverso stampa e diplomazia. Inizialmente la propaganda fascista puntò sul motivo dei confini minacciati; poi, quando nel giugno 1935 la Gran Bretagna misconobbe ufficialmente le mire italiane e si schierò con la Società delle Nazioni, vennero sottolineati altri temi, quali la necessità d’espansione di un popolo in esubero, il diritto a un impero coloniale, la rivolta dell’Italia proletaria contro le potenze plutocratiche, la missione civilizzatrice in un paese selvaggio. Pio XI si mostrò da subito prudente: da una parte intese difendere le legittime esigenze demografiche italiane di fronte alla Società delle Nazioni, dall’altra cercò di scongiurare lo scoppio di un conflitto armato che rischiava di minare il precario equilibrio europeo; perciò, già venti giorni dopo l’incidente sopra ricordato, egli, in un discorso al Sacro collegio, pur non nominando esplicita- C. De Ferrari, Al venerabile clero e diletto popolo della diocesi di Carpi salute e benedizione nel Signore!, «Bollettino Ufficiale della Diocesi di Carpi», 2 (1936), p. 2. 50 Notificazione, «Bollettino Ufficiale della Diocesi di Carpi», 10 (1937), p. 4. 51 Ibidem. 49 39 mente l’Italia, alluse alla vertenza italo-etiopica, esprimendo la speranza che la corsa agli armamenti in atto fosse volta a garantire la pace e non a preparare la guerra, perché, in caso contrario, sarebbe stato necessario invocare Dio con le parole del salmo 67: «Dissipa gentes quae bella volunt»52. Il pontefice ripropose tale preghiera anche nell’aprile del 1935, durante il Concistoro segreto per la canonizzazione di John Fisher e Thomas More, ma sempre senza dichiarati riferimenti all’Etiopia, di cui parlò esplicitamente solo il 28 luglio, in occasione dell’avvio della beatificazione del missionario Giustino De Jacobis. Infatti in quegli ultimi mesi prima dell’aggressione, in piene trattative diplomatiche, il papa aveva deciso di riprendere la canonizzazione di missionari che avevano operato in terra etiope a fine Ottocento e aveva espresso un’idea di missione come «assunzione degli interessi profondi del paese d’adozione che non riguardava solo i cattolici, ma si estendeva anche agli eretici e agli infedeli». Tra il vincenziano De Jacobis, la cui figura era pressoché priva di connotazioni politiche, e il cappuccino Guglielmo Massaia, da poco insignito dal regime di una medaglia d’oro alla memoria, Pio XI aveva scelto il primo, perché meno suscettibile di politicizzazione. Ciò nonostante, le agenzie di stampa straniere e fasciste che commentarono la cerimonia interpretarono comunque il gesto come un appoggio alla politica coloniale fascista54. Tuttavia, quando il 27 agosto il papa ruppe gli indugi e biasimò gli intenti bellicosi italiani, il regime reagì in modo del tutto opposto. In occasione di un convegno internazionale di infermiere cattoliche, organizzato a Castelgandolfo, a cui parteciparono circa duemila persone, Pio XI, al termine del discorso ufficiale, criticò una possibile invasione dell’Abissinia, sostenendo che i giusti bisogni di un popolo ad espandersi non potessero giustificare l’uso della forza, che anche una guerra di portata locale fosse foriera di gravi conseguenze e che gli orrori della guerra fossero sempre condannabili55. La notizia che il papa si era espresso contro la guerra, resa subito nota dalle agenzie di stampa internazionali, suscitò il disappunto delle gerarchie fasciste e provocò un vero incidente diplomatico. Fu la prima grande crisi dopo i Patti lateranensi. Il governo italiano, attraverso l’ambasciatore Giuseppe Talamo, reagì violentemente, prospettando la compromissione dei rapporti tra Stato e L. Ceci, Il papa non deve parlare. Chiesa, fascismo e guerra d’Etiopia, Laterza, Bari 2010, p. 27. A. Giovagnoli, L’Africa nella “geopolitica” di Pio XI, in Bottoni (a cura di), L’impero fascista, cit., pp. 243-244. 54 Ceci, Il papa non deve parlare, cit., pp. 29-30. 55 Il discorso di Pio XI, pronunciato il 27 agosto 1935 a Castelgandolfo al termine del Congresso internazionale delle infermiere cattoliche, è uno dei documenti più importanti per studiare l’atteggiamento del papa. Cfr. Giovagnoli, Il Vaticano di fronte al colonialismo fascista, cit., p. 125; C.F. Casula, Domenico Tardini (1888-1961). L’azione della Santa Sede nella crisi fra le due guerre, Studium, Roma 1988; L. Ceci, Santa Sede e guerra d’Etiopia: a proposito di un discorso di Pio XI, «Studi Storici», 44/2003, pp. 511-525. 52 53 40 Chiesa nel caso di altri interventi simili, tanto che il papa e la curia finirono con il cedere al ricatto. In Segreteria di Stato vaticana, monsignor Pizzardo, responsabile degli affari ecclesiastici straordinari, e il suo collaboratore monsignor Tardini corsero subito ai ripari e, insieme al redattore dell’«Osservatore Romano», corressero il discorso. Il papa ebbe qualche perplessità, ma alla fine lo approvò e lo fece pubblicare, così epurato, il 1° settembre56. Il nuovo testo risultò, però, oscuro e ambiguo, tanto da suscitare interpretazioni diverse e reazioni opposte anche a livello internazionale, per cui la curia, subito dopo, dovette pubblicarne un’interpretazione ufficiale in cui precisò che il papa aveva inteso sostenere che la necessità d’espansione di un popolo, pur essendo un bisogno e non un diritto, doveva comunque essere tenuta in considerazione; così come il diritto alla difesa poteva giustificare una guerra solo a patto di non superare i limiti consentiti. Ma questa lettura ufficiale produsse ulteriore ambiguità come dimostrano le più svariate definizioni date al gesto pontificio: per i comunisti si trattava di una presa di distanza dal regime; per Salvemini, di un intervento volutamente oscuro e sibillino; per la stampa cattolica, con poche eccezioni, di un’adesione alla guerra57. Non solo, l’interpretazione della stampa antifascista estera preoccupò il regime che, per questa ragione, lanciò un diktat al pontefice in vista del suo imminente intervento in occasione del convegno degli ex-combattenti, auspicando un esito ben diverso rispetto al precedente e facendo preventivamente togliere gli altoparlanti58. Ma l’8 settembre Pio XI, rivolgendosi a 15.000 reduci di guerra cattolici nella basilica di San Paolo, si dimostrò molto più cauto: parlò solo del significato metaforico della guerra, senza definirla d’aggressione, e sostenne la necessità di una pace accompagnata dalla giustizia, cioè di un riconoscimento dei giusti bisogni dei popoli. La stampa fascista non tardò a strumentalizzare tali parole, interpretandole come una rinuncia di Pio XI ad esprimersi contro la guerra d’Etiopia59. 56 Giovagnoli individua le cause di questo ritrarsi del papa studiando i documenti dell’ambasciata italiana presso la Santa Sede, sfuggiti a molti storici di Pio XI. Tali fonti, a suo avviso, confermano la «perplessità e contrarietà di Pio XI verso la guerra fascista all’Etiopia, ma anche la sua complessiva prudenza nell’evitare una condanna troppo esplicita». Cfr. Giovagnoli, Il Vaticano di fronte al colonialismo fascista, cit., pp. 124-125. 57 Il diario di monsignor Tardini, all’epoca impiegato nella Segreteria di Stato, dimostra la fondatezza storica della revisione operata da monsignor Pizzardo. Alla luce di tali fatti, Casula ha definito Pio XI prudente nel condannare, ma distante dall’allineamento della sua Segreteria e di «Civiltà Cattolica». La stessa tesi è sostenuta anche da Lucia Ceci, secondo la quale, dopo gli avvenimenti sopraddetti, Pio XI avrebbe rinunciato a sostenere una posizione in aperto contrasto con la politica espansionistica fascista. 58 Ceci, Il papa non deve parlare, cit., p. 51. 59 Per questo, Lucia Ceci sostiene che i documenti testimoniano con netta evidenza una diversità di posizioni tra la curia romana, preoccupata di non entrare in contrasto con il regime, e il pontefice, intimamente avverso al colonialismo italiano e a questa guerra nello specifico. Tuttavia, a suo avviso, è altrettanto innegabile storicamente che Pio XI, dando il suo assenso alla revisione delle sue parole e all’interpretazione ufficiale del suo pensiero, redatte dalla curia, di fatto si rese responsabile del suo indietreggiare rispetto alle prime posizioni critiche. Cfr. ivi, p. 52. 41 Tutto ciò non ebbe vasta eco in Emilia, dove i presuli, al massimo, pubblicarono i testi dei discorsi nei bollettini diocesani, senza dare risalto ai contenuti. A Reggio Emilia, Brettoni li riportò entrambi, sia quello alle infermiere60 sia il successivo rivolto agli ex-combattenti61, ma dimostrò di non aver recepito i dubbi che Pio XI aveva avanzato in quelle occasioni. Il 3 ottobre 1935 le truppe italiane, senza alcuna dichiarazione ufficiale di guerra, passarono il confine invadendo il territorio etiopico. La Santa Sede, informata dal 1° ottobre di tale intenzione, fece un estremo tentativo presso i governi inglese e francese, allo scopo di convincerli ad acconsentire ad alcune richieste italiane, ma fu tutto inutile. Da quel momento Pio XI rinunciò ad esprimere i propri dubbi pubblicamente, optando per la via diplomatica, formale e informale, per dissuadere Mussolini dai suoi intenti, ma sia il progetto di scrivere una lettera al duce sia quello di contattarlo direttamente attraverso padre Tacchi Venturi non ebbero i risultati sperati. I cattolici, che nella fase delle trattative avevano assunto posizioni diverse, oscillanti tra il desiderio di missione e il pacifismo propagandato a quell’epoca dal pontefice, risposero compatti alla dichiarazione di guerra62. Anche l’episcopato emiliano partecipò a questa corale ed entusiastica adesione. Bussolari dispose che ogni venerdì si offrisse l’adorazione eucaristica alla patria e ai soldati al fronte, pregando con le sue parole: Preghiamo per il nostro Re, il nostro Capo del Governo e i loro collaboratori, che il Signore li illumini, li conforti e li guidi a conoscere, a deliberare ed attuare quanto può condurre al miglior bene della nostra cara Patria, secondo i suoi disegni provvidenziali, col minor sacrificio possibile di sangue e di vite umane. Preghiamo in modo particolare per i nostri cari soldati perché Dio li difenda dai pericoli del corpo e dell’anima, li sostenga nel compimento del loro dovere; per tutto il nostro caro popolo; per le famiglie dei richiamati63. Brettoni intervenne a una manifestazione propiziatoria, organizzata dalla giunta degli uomini di Azione cattolica il 27 ottobre nel tempio della Ghiara, in cui si riunì «tutta Reggio religiosa e patriottica»64. Il presule iniziò il suo lungo discorso constatando la gravità del momento. Per la «Nazione», sostenne, era una grande ora, perché, tra spine e sacrifici, essa stava cercando, per il suo L’ansia, il voto e la preghiera di Pio XI per la pace nella giustizia, «Bollettino della Diocesi di Reggio Emilia», 9 (1935), pp. 145-149. 61 La parola di amore di Pio XI ai 15000 ex combattenti di tutte le nazioni, «Bollettino della Diocesi di Reggio Emilia», 10 (1935), pp. 161-164. 62 Ceci, Il papa non deve parlare, cit., pp. 53-70. 63 Un nobilissimo invito del nostro arcivescovo, «La Settimana Modenese», 26 ottobre 1935, p. 2. 64 Circa l’atteggiamento del vescovo, il questore di Reggio non spese molte parole, limitandosi a notificare il suo intervento durante tale manifestazione. Cfr. Archivio di Stato di Reggio Emilia, Gabinetto della Prefettura. Clero. Attività del clero e dell’Azione Cattolica. Relazioni mensili, 1935, ottobre. 60 42 popolo, una via di sussistenza che non allontanasse i suoi figli da lei. Brettoni dichiarò di non voler parlare in veste di statista, senza tuttavia esimersi dal difendere le aspirazioni dell’Italia, la quale stava agendo non come un ingiusto aggressore, bensì come un popolo civile che intende riversare la sua popolazione in esubero su una terra per la maggior parte incolta e arretrata. Così facendo, essa arrecava vantaggio agli stessi indigeni, offrendo loro l’industria e l’elevata civiltà cristiana, tanto che l’alto consesso della Società delle Nazioni, idealmente perfetto, ma in pratica settario, ingiustamente la puniva applicandole pesi iniqui. Lo dimostrava la benevola accoglienza delle popolazioni conquistate. Evidente era la necessità che una potenza civile abolisse il mostruoso schiavismo ancora vigente in quelle terre. A tale scopo, per il presule, non vi era potenza più adatta dell’Italia, che vantava grandi pionieri di civiltà e cristianesimo in quei luoghi. Detto questo, Brettoni si scusò per aver esulato dal campo religioso più del dovuto, giustificandosi con la necessità di spiegare il motivo di quella corale preghiera a Dio affinché proteggesse i soldati, conducesse alla vittoria, difendesse contro le sanzioni e donasse la pace. Infine il presule invocò san Frumenzio, primo vescovo di Axum in Etiopia, commemorato in quel giorno per una felice coincidenza, perché si affrettasse la realizzazione di questi voti e «su quelle terre, desolate dalla barbarie e dallo schiavismo, si estenda dominatrice e feconda la luce della civiltà che viene da Roma e dalla Chiesa Cattolica»65. Evidentemente Brettoni, pur affermando di non parlare in veste di statista, non mancò di snocciolare tutti i temi politici della questione: la legittimità dell’espansione italiana per far fronte a una popolazione in esubero, la critica della prassi societaria, la buona accoglienza delle genti etiopi, il destino del popolo italiano di essere missionario e civilizzatore in una terra tenebrosa attanagliata dallo schiavismo, l’auspicio della vittoria della civiltà sulla barbarie. In tutta l’Italia i presuli si prestarono a benedire i soldati partenti, tanto da suscitare grande interesse da parte della stampa. La curia romana dovette presto intervenire per fare chiarezza circa l’ambiguità del gesto. Molti si chiedevano se la benedizione fosse rivolta ai singoli soldati, spesso fedeli, oppure alla guerra e alla politica fascista. Il 23 ottobre «L’Osservatore Romano» precisò che le cerimonie intendevano benedire le truppe, non la guerra e la sua ratio66. In Emilia la documentazione non ha lasciato grande memoria di tali cerimonie vescovili. Solo di Menzani sappiamo con certezza che in ottobre donò ai soldati partenti per l’Africa una medaglia di sant’Antonio, protettore di Piacenza, in memoria della sua esperienza di «soldato romano della legione Tebea»: si trattò di un richiamo forzatamente personalizzato per indicare la «Te- La solenne manifestazione religiosa al tempio della Ghiara per i nostri soldati e per la vittoria, «Bollettino della Diocesi di Reggio Emilia», 11 (1935), pp. 175-177. 66 Ceci, Il papa non deve parlare, cit., p. 73. 65 43 baide», confinante con l’Abissinia, come simbolo della nuova meta in cui i soldati piacentini, a imitazione del santo patrono, erano chiamati a portare la civiltà tra i barbari67. L’11 ottobre 1935 la Società delle Nazioni condannò, quasi all’unanimità, l’aggressione dell’Italia e dispose sanzioni di carattere economico a suo danno. L’opinione pubblica internazionale fu mobilitata contro il fascismo da una violenta campagna di stampa denigratoria, mentre il regime si difese appellandosi al patriottismo degli italiani, tanto che l’intera nazione reagì indignata, appoggiando ancora di più la causa68. Le sanzioni non furono mai applicate rigorosamente e non influirono più di tanto sull’economia italiana, ma furono sfruttate al massimo dalla macchina propagandistica del regime. L’episcopato sostenne con forza l’iniquità delle sanzioni. Colli scrisse: In quest’ora carica di eventi, mentre col pretesto della pace in Africa si semina la guerra in Europa; mentre si tenta di soffocare colla violenza le giuste aspirazioni che, a parole, si riconoscono al nostro paese, l’iniqua unione di tutti gli Stati contro l’Italia ha rinsaldato e deve sempre più rinsaldare l’incrollabile unione di tutti gli Italiani col loro governo69. Anche Zaffrani approfondì l’argomento nel suo primo intervento sulla guerra in corso, quando, rivolgendosi direttamente ai fedeli, assunse la situazione politica che l’Italia stava vivendo a principale argomento del suo messaggio. Esordì fornendo un quadro della situazione, a suo parere, grave: mentre l’Italia aveva iniziato la conquista dell’Etiopia per dare uno sfogo sicuro alla sua popolazione in esubero, il resto degli stati si era coalizzato contro di lei, stabilendo sanzioni economiche. E non nascondeva presagi e timori per lo scoppio di una guerra mondiale. Raccomandò, perciò, di mantenere una forte e salda disciplina: disciplina della parola, lasciando ai governanti il compito di giudicare; disciplina dei costumi, evitando di sciupare; disciplina del costume, vivendo in raccoglimento. In particolare sollecitò i parroci e ogni buon cristiano alla preghiera per la pace, quella pace annunciata da Cristo risorto, la pace nella giustizia, nella verità e nella carità, augurandosi che le sanzioni non venissero realmente applicate70. Brettoni intervenne sul bollettino diocesano il 5 dicembre, quando le sanzioni divennero effettive, invitando a pregare per la pace, a sacrificarsi per la patria e a collaborare con le autorità. Tuttavia fornì solo istruzioni pratiPio ricordo ai soldati diretti all’Africa Orientale, «Il Nuovo Giornale», 4 ottobre 1935, p. 2; Molinari, «Il Nuovo Giornale» di Piacenza e il fascismo, cit., p. 1021 68 G. Rochat, Guerre italiane in Libia e in Etiopia. Studi militari 1921-1939, Pagus, Treviso 1991, p. 100. 69 E. Colli, Il dovere dell’ora attuale, «L’Eco. Foglio Ufficiale della Curia Vescovile di Parma», 11 (1935), p. 131. 70 G. Zaffrani, Al Ven. Clero ed ai Fedeli dilettissimi della mia Diocesi, «Bollettino della Diocesi di Guastalla», 11 (1935), pp. 147-148. 67 44 che, riducendo al minimo le considerazioni politiche. Data l’eccezionalità del momento, raccomandò a ciascuno di dare un contributo secondo le proprie possibilità e di cooperare con il governo, perché si superassero le difficoltà. Occorreva ascoltare «la voce esortatrice della Fede». Ogni buon cittadino e buon cristiano, sapendo che ogni cosa veniva da Dio, doveva chiedere la sua protezione e la sua assistenza attraverso la preghiera, privata e pubblica, i sacramenti e la santificazione delle feste; doveva poi attenersi alla più seria disciplina nel rispettare le disposizioni del governo, poiché opporsi all’autorità significava resistere a Dio: «E del resto la sobrietà, la parsimonia e rinuncia ai piaceri, anche leciti, corrisponde perfettamente all’austerità del costume cristiano e allo spirito di mortificazione che è specialmente proprio di questo tempo di Avvento e che rende anche la preghiera più accetta a Dio»71. Di fronte alle sanzioni il regime lanciò la campagna di raccolta di oro, argento e metalli preziosi, e in tale iniziativa trovò largo appoggio presso il clero e i vescovi emiliani. Menzani, come notificarono la stampa locale e il bollettino della curia, inviò al segretario federale una catena che gli ricordava uno dei momenti più importanti della sua vita, motivando il gesto con la necessità, in quell’ora, di sentire «imperioso il dovere di dare generosamente e di sostenere serenamente ogni sacrificio per la dilettissima Italia»72. Al termine del sinodo diocesano, rinnovò quest’invito e si compiacque del fatto che il clero e i cattolici fossero tutti animati da un ardente amore per l’Italia, cui era affidata la missione di portare la vera civiltà in un mondo ancora tanto barbaro73. I richiami non cessarono per tutto il corso del conflitto; infatti, anche all’inizio del 1936, egli lanciò un «paterno richiamo al pericolo dei turbamenti politici che gravano sul mondo», concludendo in questo modo: «saggiamente l’Autorità esige delle astinenze, delle privazioni. Ebbene facciamole volentieri e santifichiamole, offrendole a Dio con spirito di penitenza e di espiazione del nobile scopo suggerito dall’amor patrio, e così esse torneranno tanto più accette al Dio degli eserciti»74. Tanto che, sempre nel gennaio, quando la rivista fascista «Italia e Fede» promosse una raccolta dei discorsi di alcuni vescovi contro le sanzioni, fu contattato pure Menzani. 71 Il vescovo di Reggio Emilia e principe al clero e al popolo della diocesi, «Bollettino della Diocesi di Reggio Emilia», 12 (1935), pp. 198-199. 72 «Bollettino Ufficiale della Curia Vescovile di Piacenza», 11 (1935), p. 158; La raccolta dell’oro per la Patria e il significativo esempio di mons. Vescovo, «Il Nuovo Giornale», 29 novembre 1935, p. 2. 73 Mons. Vescovo si compiace dell’esito del Sinodo Diocesano ed invita i fedeli a dare il più efficace aiuto alla Patria, «Il Nuovo Giornale», 29 novembre 1935, p. 2. 74 Di fronte ai pericoli che sovrastano l’umanità S. E. il Vescovo invoca la pace nella verità e nella giustizia ed invita i suoi diletti figli alla preghiera e alla penitenza, «Il Nuovo Giornale», 3 gennaio 1936, p. 2. 45 Sulla stessa linea si collocò Bussolari che, oltre a offrire qualcosa egli stesso, si rallegrò per il contributo dato dalla cittadinanza alla campagna autarchica ed esortò i ritardatari ad aderire a tale iniziativa, in quanto dovere di ogni buon cittadino e buon cristiano era aiutare economicamente il governo nelle difficoltà e adattarsi a una vita austera come l’ora richiedeva75. Per il 18 dicembre 1935 Mussolini indisse la cosiddetta «Giornata della Fede», sicuro del successo e dell’appoggio di tutta la Chiesa italiana, ma non altrettanto certo del sostegno del papa. In novembre l’adesione alla causa si era intensificata coinvolgendo la maggior parte dei cattolici e tutti gli alti prelati, come dimostravano lettere pastorali, prediche, fogli diocesani. Invece Pio XI, nel silenzio ufficiale, non aveva rinunciato al tentativo di convincere Mussolini ad accettare il piano Laval-Hoare, attraverso l’azione diplomatica informale di padre Tacchi Venturi, tanto che l’11 dicembre un articolo dell’«Osservatore Romano» aveva parlato di una fiduciosa attesa nelle annunciate trattative. Il duce, inoltre, sapeva che il papa disapprovava la guerra e che molti dall’estero chiedevano che si esprimesse contro di essa. Per questo si era attivato diplomaticamente per impedirgli di parlare di pace sia il 16 dicembre, in occasione della nomina di alcuni nuovi cardinali, sia in vista del Natale, pena la rottura delle buone relazioni tra Stato e Chiesa76. Tuttavia, alla fine, i fondati timori del duce vennero scongiurati e la «Giornata della Fede» fu un grande successo propagandistico per il regime. Pio XI non parlò della guerra e il piano LavalHoare naufragò. La partecipazione della Chiesa all’iniziativa fu massiccia. Il clero si sentì in armonia con il papa, perché il suo silenzio produsse la convinzione che anche il Vaticano fosse del tutto favorevole. Infatti l’episcopato, pur mancando di una riflessione chiara e completa sul tema del nazionalismo e colonialismo in rapporto alla morale cattolica e quindi essendo privo dei mezzi per contrastare la propaganda fascista, non avrebbe mai assunto posizioni che fossero apparse in chiaro contrasto con il pontefice. I presuli ripresero molti dei motivi della propaganda fascista, tra cui l’invettiva contro gli alleati della prima guerra mondiale, l’analogia con la storia della Roma antica (le antiche donne romane avevano consegnato i loro gioielli per le necessità della guerra), l’uguaglianza di tutti i donatori nell’offerta come davanti a Dio, la superiorità dei colonizzatori rispetto a colonizzati di un infimo livello civile, morale e religioso, la lotta sobria e proletaria dell’Italia contro le potenze plutocratiche sanzioniste. In aggiunta essi affermarono che contribuire alla «campagna dell’oro» significava compiere la volontà di Dio, perché la guerra era combattuta non solo per la causa del popolo italiano, ma anche per quella della religione cattolica romana. Per questo espressero una condanna morale verso gli evasori della 75 76 46 Alte esortazioni, «Il Popolo», 7 dicembre 1935, p. 3. Ceci, Il papa non deve parlare, cit., p. 5. donazione dell’oro. A loro avviso il colonialismo italiano faceva coincidere il mito della romanità con la cultura missionaria cattolica, perché si dimostrava molto diverso dal «bieco» imperialismo economico di matrice protestante. Salvo pochissime eccezioni, accettarono di benedire le fedi di acciaio sostitutive di quelle d’oro. Il vescovo castrense di Roma, Angelo Bartolomasi78, si distinse per il suo appoggio entusiasta all’impresa, ma anche i vescovi emiliani non furono da meno. Significativamente solo Menzani ingiunse ai suoi parroci di benedire le fedi in chiesa79, in quanto luogo più adatto, mentre gli altri vescovi non diedero alcuna indicazione al riguardo, probabilmente perché non scorsero il pericolo che una tale iniziativa potesse sminuire il valore religioso della benedizione. Anzi, solo Brettoni e Zaffrani celebrarono il rito in duomo, mentre gli altri lo fecero in luoghi civili e simbolici per i fascisti: Colli presso il palazzo del Fascio, Bussolari al Tempio dei Caduti, Menzani nella chiesa di San Francesco, da sempre prescelta per celebrazioni e manifestazioni civili. Gli stessi prelati donarono anelli o gioielli di famiglia. A Parma, in una grande manifestazione ampiamente celebrata dai giornali cittadini80, Colli donò la fede nuziale della defunta madre81, accompagnando il gesto con un discorso sul valore di quel dono. Sostenne che donare l’anello nuziale, il simbolo più prezioso del vincolo familiare, significava vedere nella patria una seconda famiglia cui riservare lo stesso amore, la stessa fedeltà e lo stesso spirito di sacrificio serbati per le proprie famiglie. La sostituzione con rudi anelli di ferro non doveva rattristare, perché anche la più antica e gloriosa corona d’Italia era di ferro, sicché le donne italiane con la fede di ferro al dito potevano ben dire, come fece Napoleone per la corona ferrea: «Dio me l’ha data, guai a chi la tocca!»82. G. Dalla Torre, Azione Cattolica e fascismo: il conflitto del 1931, AVE, Roma 1945; Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nel 1931. Atti dell’incontro tenuto a Roma il 12-13 dicembre 1981, AVE, Roma 1983. 78 P. Terhoeven, Oro alla patria. Donne, guerra e propaganda nella giornata della fede fascista, Il Mulino, Bologna 2006, p. 106. 79 Il comunicato del vescovo, apparso su «Il Nuovo Giornale» il 13 dicembre, recitava così: «Rendo noto ai RR. Parroci della diocesi che – se verranno richiesti di benedire gli anelli nuziali da sostituirsi a quelli d’oro offerti per la Patria – gradisco che vi si prestino, recitando l’Oremus che per tale benedizione è inserito nel “Rito per la celebrazione del matrimonio”. Trattandosi di funzione sacra e collettiva, si fa presente che il suo luogo proprio è la Chiesa, dove questa solenne ed altamente significativa benedizione venne la prima volta impartita. Per la Città, gli anelli nuziali saranno da me personalmente benedetti nella Cappella del Vescovado». 80 Le donne parmensi deporranno domani le fedi nuziali, che offrono alla Patria fascista, nell’elmo di battaglia di Alessandro Farnese duca di Parma, «Corriere Emiliano», 17 dicembre 1935, p. 3; S. E. il vescovo benedirà stamane nel sacrario dei caduti fascisti le fedi che sostituiranno quelle d’oro donate alla Patria, «Corriere Emiliano», 18 dicembre 1935, p. 5. 81 Venticinquemila anelli nuziali offerti alla Patria, «Corriere Emiliano», 19 dicembre 1935, p. 3; 18 dicembre. Il discorso di Mons. Vescovo, «L’Osservatore Romano della Domenica», 29 dicembre 1935, p. 11. 82 Ibidem. Vedi anche: L’offerta delle “Fedi”, «L’Osservatore Romano della Domenica», 22 dicembre 1935, p. 11. 77 47 Ai parroci, cui fosse richiesta la benedizione delle fedi sostitutive, Menzani diede le seguenti disposizioni: recita dell’Oremus e svolgimento della funzione in chiesa. Egli stesso officiò la cerimonia nella cappella del vescovado83 e donò il proprio anello episcopale84. Stando a quanto riportato e rielaborato dal quotidiano fascista locale, accompagnò il gesto con queste parole: Oggi questa parola fa pensare ad un piccolo anello, ad una verghetta d’oro che secondo il rito della Chiesa viene benedetta ogni volta che due cristiani si giurano eterno amore. Questa benedizione è discesa sopra le nuove famiglie che voi costituiste e giustamente gli sposi serbano il più profondo rispetto per quella “fede” che nessuno permise mai che venisse toccata o profanata. Oggi però una voce, la voce della patria, si alza e risuona, e domanda agli sposi la “fede”. E tutti con lo stesso sentimento, con lo stesso entusiasmo, rispondono all’appello. È giusto, continua S. E. Menzani, che sia offerto anche il mio anello, che ricevetti per le mie mistiche nozze dalle mani di Benedetto XV85. A Modena la raccolta degli anelli avvenne in tutte le sezioni fasciste della provincia e presso il Tempio dei caduti della città. Il settimanale cattolico locale, «Il Popolo», fornì un resoconto della manifestazione, notificando che «al Tempio dei Caduti è stato un continuo pellegrinaggio per tutta la giornata e l’offerta delle fedi veniva fatta con tale consapevolezza e un tale spirito patriottico da rimanere commossi»86. Brettoni, a Reggio Emilia, preparò per tempo la comunità all’evento e vi partecipò in prima persona, esprimendosi pubblicamente. «Il Solco Fascista» pubblicò interamente il suo discorso. Egli esaltò le spose italiane che avevano reso quel giorno, da nefasto qual era a causa delle sanzioni, fausto per la straordinaria iniziativa. Il penoso distacco da un simbolo così caro era divenuto una bella vittoria, che aveva accomunato l’augusta regina e la più umile popolana, testimoniando un’inaudita unità nazionale87. Anche Zaffrani si rivolse alla comunità. Constatò innanzitutto un peggioramento delle condizioni politiche del paese rispetto all’epoca del suo primo intervento sul tema. Infatti, contrariamente alle sue speranze, erano sopraggiunte le sanzioni. Ribadì perciò la raccomandazione alla disciplina della parola, dei costumi e del costume. Invitò alla preghiera, «affinché soddisfatte le giuste aspirazioni della Patria nostra, tutto si ricomponga nella tranquillità dell’ordine e possano i nostri uomini e i nostri giovani tornare presto incolumi a riprendere le feconde opere della pace». Incoraggiò i parroci a promuovere la raccolta dell’oro e diede loro istruzioni al riguardo. Occorreva spiegare che le nuove 83 84 85 86 87 48 Comunicato di S. E. Mons. Vescovo, «Il Nuovo Giornale», 13 dicembre 1935, p. 2. La giornata della “Fede”, «Il Nuovo Giornale», 20 dicembre 1935, p. 2. Il Vescovo di Piacenza offre l’anello episcopale, «La Scure», 19 dicembre 1935, p. 2. L’offerta della fede, «Il Popolo», 21 dicembre 1935, p. 3. Il discorso di S. E. mons. Brettoni, «Il Solco Fascista», 19 dicembre 1935, p. 2. fedi, così benedette, equivalevano spiritualmente a quelle offerte per la patria, anzi esse risultavano «impreziosite dal sacrificio compiuto»88. Questo grande entusiasmo si esaurì un poco nei mesi successivi, tanto che sia la morte di padre Reginaldo Giuliani89 che la consacrazione al Sacro Cuore, promossa da padre Gemelli90, ebbero scarsa risonanza in Emilia. A Modena «Il Popolo» diede notizia della morte del domenicano91, ma non fece alcun cenno al progetto di padre Gemelli; a Piacenza il settimanale cattolico si occupò di entrambe le notizie, ma in modo piuttosto sintetico92. Solo Zaffrani, a Guastalla, sostenne con un certo entusiasmo la consacrazione dei soldati, pubblicando la lettera di padre Gemelli sul bollettino diocesano93. Intanto la guerra in poco tempo giunse al termine. L’8 marzo 1936 Badoglio ordinò di preparare la marcia finale su Addis Abeba, senza calcolare i rischi a 88 G. Zaffrani, Ai venerandi Sacerdoti e al popolo dilettissimo, «Bollettino della Diocesi di Guastalla», 12 (1935), p. 160. 89 Al principio del febbraio 1936 giunse in Italia la notizia della morte del padre domenicano Reginaldo Giuliani, cappellano al seguito delle truppe italiane. Questi aveva aderito alla guerra con entusiasmo, spinto da diverse motivazioni, quali la ricerca di gloria, l’adesione al fascismo, una cattiva fama nel suo ambiente ecclesiastico, una concezione profondamente religiosa della guerra coloniale. Visse la sua partecipazione all’impresa come una missione, promuovendo la costruzione della prima chiesa cattolica di Adua e facendo erigere una cattedrale in Addis Abeba. Disprezzava la Chiesa etiope, che giudicava eretica, ignorante, oziosa, opportunista, spalleggiatrice del Negus. Morendo in battaglia divenne subito «emblema dell’immolazione missionaria e dell’ardore patriottico». La sua memoria fu celebrata dai legionari, dai confratelli, dalle filodrammatiche parrocchiali e dalle alte sfere del regime. Divenne il simbolo allegorico della vittoria dell’Italia e del cattolicesimo, tanto che sulla sua vicenda nacque una copiosa produzione agiografica. Tuttavia, con il crollo del fascismo, questa figura così celebrata cadde nel più completo oblio. Non mancarono scritti apologetici e riferimenti in opere generali, ma uno specifico studio scientifico comparve solo nel 2008 ad opera di Giovanni Cavagnini. Cfr. M. Franzinelli, Il clero e le colonie. I cappellani militari in Africa Orientale, «Rivista di Storia Contemporanea», 4/1992, pp. 592-598; G. Cavagnini, Nazione e provvidenza. Padre Reginaldo Giuliani tra Fiume ed Etiopia (1919-36), «Passato e Presente. Rivista di Storia Contemporanea», 81/2010, pp. 43-67. 90 Padre Agostino Gemelli, come durante la Grande Guerra, promosse la consacrazione delle truppe al Sacro Cuore di Gesù, ma questa volta l’iniziativa riscosse meno consensi e fu guardata con sospetto sia dai comandi militari che dall’ordinariato militare. Quando Gemelli, a fatica, riuscì a strappare i necessari permessi, non vide realizzata la sua opera, perché il ministro della Guerra ridusse il rito alla sola distribuzione del Vangelo durante la messa della domenica. Cfr. D. Menozzi, Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana della società, Viella, Roma 2001; F. De Giorgi, Forme spirituali, forme simboliche, forme politiche. La devozione al S. Cuore, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 2/1994, pp. 365-459; A. Zambarbieri, Per la storia della devozione al Sacro Cuore in Italia tra ’800 e ’900, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 41/1987, pp. 361-432. 91 L’eroica morte di padre Reginaldo Giuliani sul campo di battaglia, «Il Popolo», 8 febbraio 1936, p. 2. 92 Il vangelo a tutti i soldati, «Il Nuovo Giornale», 17 aprile 1936, p. 1; Consacrazione dei soldati al Sacro Cuore, «Il Nuovo Giornale», 24 aprile 1936, p. 1. 93 L’Opera della Regalità di N. S. Gesù Cristo, «Bollettino della Diocesi di Guastalla», 5 (1936), p. 101. 49 cui andava incontro, ma aderendo alle esigenze di prestigio interno di Mussolini, il quale il 9 maggio, leggendo il famoso telegramma del generale, annunciò il successo e proclamò la nascita dell’impero tra l’esultanza generale94. A Parma, mentre tutta la cittadinanza si dava a «grandiose manifestazioni popolari»95, anche Colli espresse il suo compiacimento, come notificò la stampa locale96. Il «Corriere Emiliano» diede ampio spazio alla cerimonia di ringraziamento presieduta dal presule e commentò in questo modo: «La religione cattolica, che dal più alto al più umile sacerdote, ha sorretto con la sua alta e nobile autorità morale, l’aspro compito che il regime ha affrontato, ha riunito, ancora una volta, tutto il popolo di Parma, in tutte le sue gerarchie, le sue classi, per innalzare a Dio le preci del ringraziamento e per implorarne l’aiuto e benedizione per l’avvenire»97. Colli, in quell’occasione, pronunciò un lungo discorso in cui, stando alle fonti fasciste, richiamò al dovere della riconoscenza verso il re, il duce, il popolo, i soldati e Dio che aveva assistito l’Italia in un terribile momento. Sebbene tutto il mondo avesse congiurato contro il paese, Dio aveva «scritto diritto», permettendo che giungesse la vittoria, «dovuta alla venerazione sacra di tutti gli animi, di tutte le menti, di tutti i cuori, che si sono fusi come l’oro». Occorreva, perciò, promettere venerazione al Signore per le battaglie future, in particolare per quella che si stava combattendo in Europa contro il bolscevismo. Infine Colli invitò i parmigiani ad assumere i motti che furono propri di Alessandro Farnese, il quale sul suo stendardo aveva fatto scrivere In Te honor et gloria sotto la figura di Cristo, da un lato, e Sub tuo patrocinio sull’altro, accanto all’immagine della Madonna98. A Piacenza la vittoria scatenò un entusiasmo generale. Tutti i giornali diedero la notizia con articoli di prima pagina99. Menzani, in occasione dell’inizio delle missioni paoline, ringraziò il Signore per aver esaudito il suo desiderio di poter intonare, nel prossimo congresso, il canticum novum di riconoscenza per il passaggio dalle ansie della guerra ai gaudi della pace. Quindi annunciò la celebrazione del Te Deum e ribadì: La nostra dilettissima Patria è stata oggetto ancora una volta delle predilezioni di Dio. La ferma e chiaroveggente volontà di Chi ci regge e di Chi ci governa, la grande abilità dei nostri Condottieri, e l’ammirabile spirito di sacrificio dei nostri soldati Rochat, op. cit., p. 118. Oltre sessantamila persone ascoltano la fiera, altissima parola del capo, «Corriere Emiliano», 6 maggio 1936, p. 3. 96 Te Deum di ringraziamento per la vittoria, «Corriere Emiliano», 9 maggio 1936, p. 5; Per la vittoria, «L’Osservatore Romano della Domenica», 17 maggio 1936, p. 14. 97 Il Te Deum di ringraziamento in Duomo, «Corriere Emiliano», 10 maggio 1936, p. 5. 98 Ibidem. 99 La guerra italo-abissina è terminata con una completa vittoria delle nostre armi, «Il Nuovo Giornale», 8 maggio 1936, p. 1. 94 95 50 hanno aperto all’Italia un nuovo vasto e fecondo campo ove essa potrà avere la sua necessaria espansione, e dove potrà portare la sua benefica opera di civiltà cristiana. Per tutto questo dobbiamo sentire profondamente nel cuore la riconoscenza al Signore che segna al nostro popolo i suoi gloriosi destini...100. La domenica, quindi, «benché avesse precedentemente assunto altri impegni»101, non mancò di celebrare il ringraziamento in cattedrale, alla presenza delle autorità e di tutte le associazioni patriottiche. Il quotidiano fascista abbondò nei toni celebrativi, definendo il discorso di Menzani come «tutto ispirato alla più profonda fede cristiana e al più alto patriottismo»102. Anche Bussolari attese al solenne rito, ritenendo doveroso ricordare «cristianamente» chi era caduto, ringraziare Dio e invocare una pace feconda103. Sul bollettino diocesano rivolse al clero e all’intera diocesi una lettera, perché in ogni parrocchia non si tralasciasse di celebrare l’evento. In quei giorni, in cui si era udita la voce del capo del governo che annunciava la fine della guerra e il sopraggiungere della pace romana, era necessario rivolgersi riconoscenti all’Altissimo. Infatti con la vittoria si esaudiva la secolare preghiera della cattolicità e il sacrificio dei missionari veniva ripagato, perché l’eresia copta, causa della rovina morale, poteva finalmente essere estirpata. L’Italia si era fatta strumento della Provvidenza, prospettando per la colonia un futuro di «libertà, pace e grandezza»104. Di pari enfasi patriottica fu il discorso di monsignor Brettoni, tanto che «Il Solco Fascista» lo definì «ispirato ai più alti sentimenti di Fede e di Patria». Il vescovo, stando al resoconto del quotidiano fascista, ricordò la cerimonia propiziatoria celebrata in ottobre e ringraziò Dio per aver esaudito la sua preghiera, illuminando il re, il duce, i soldati, e permettendo la realizzazione di una grande impresa in poco tempo e nonostante gli ostacoli. Non tralasciò di riconoscere il merito degli uomini, degni del ricordo delle generazioni a venire. Infine concluse invocando dal Signore la pace e la vittoria morale della civiltà cristiana e romana, affinché anche la popolazione abissina conoscesse la redenzione in Cristo105. 31 maggio: inizio delle Missioni Paoline, «Il Nuovo Giornale», 8 maggio 1936, p. 2. Il solenne “Te Deum” di ringraziamento per la Vittoria italiana, «Il Nuovo Giornale», 15 maggio 1936, p. 3. 102 Il solenne “Te Deum” di ringraziamento per la vittoria delle nostre armi, «La Scure», 12 maggio 1936, p. 2. 103 Solenne Te Deum in duomo per la grande vittoria, «La Gazzetta dell’Emilia», 8 maggio 1936, p. 3. 104 Lettera di S. Eccellenza Rev.ma ai parroci delle due diocesi, «Bollettino del Clero della Diocesi di Modena e di Nonantola», 5 (1936), p. 63; Ai MM. RR. parroci di Modena e Nonantola, «Il Popolo», 9 maggio 1936, p. 3. 105 Il discorso di S. E. Mons. Brettoni, «Il Solco Fascista», 7 maggio 1936, p. 2. 100 101 51 Lo stesso giornale fascista della zona, nella pagina riservata a Guastalla, diede notizia della commemorazione officiata da Zaffrani con queste parole: Sabato sera alle 18,30 S. E. il Vescovo Mons. Zaffrani, ha celebrato solennemente in Duomo il Te Deum di ringraziamento a Dio per la grande vittoria delle nostre armi che segna una tappa luminosa della marcia della civiltà latina in Africa Orientale. ... S. E. il Vescovo, sceso dalla balaustra dell’Altare Maggiore, ha pronunciato una vibrante allocuzione che è stata tutto un inno di esaltazione del valore delle nostre truppe e degli illuminati Capi che hanno loro tracciato la via della gloria e di quelli che ve le hanno condotte con sicura coscienza di compiere alta opera di civiltà, oltre che una necessaria azione di difesa del nostro prestigio e una affermazione non meno necessaria del diritto del nostro popolo di espandersi per vivere onestamente del proprio lavoro in terre abbandonate prima all’arbitrio della barbarie e oggi redente dal tricolore106. Il 30 giugno Hailé Selassié, dal suo esilio, denunciò presso la Società delle Nazioni l’uso di gas tossici proibiti da parte delle truppe italiane in Abissinia. L’opinione pubblica internazionale rimase molto impressionata da tale notizia, ma il regime negò categoricamente, sicché il consenso interno non ne fu scalfito. Osservazioni finali L’atteggiamento dell’episcopato emiliano nei confronti della guerra d’Etiopia fu di pieno consenso. Tuttavia questa convergenza non significò, né implicò, anche un allineamento tout court con l’intera politica fascista. In nessuno dei casi analizzati, infatti, si trattò di presuli filofascisti in senso stretto, come comprova il fatto che in altre circostanze, soprattutto all’inizio del ventennio e, più tardi, con l’avvicinarsi del regime al nazismo, essi presero talvolta ferme posizioni contro atti giudicati ingiusti e inconciliabili con il loro credo. Ciò dimostra che i motivi di adesione alla guerra non furono di natura prettamente politica, ma sono piuttosto individuabili in talune concezioni ben radicate nel contesto culturale, sociale ed ecclesiale in cui i presuli si trovarono a operare, nonché in valori, tra cui il culto dell’autorità e la disciplina, condivisi con il fascismo ed enfatizzati dalla particolare contingenza storica, che vide Chiesa e regime accomunati anche dalla presenza di nemici comuni. È interessante notare come in questa occasione quasi tutti i vescovi emiliani, nei loro discorsi, abbiano sostenuto il valore della disciplina. Colli vide in essa una virtù fondamentale per la coesione e la concordia del popolo. Zaffrani esortò i fedeli del- Corriere di Guastalla. Il Te Deum in duomo per la vittoria italiana, «Il Solco Fascista», 13 maggio 1936, p. 3. 106 52 la sua diocesi a mantenersi disciplinati in tutti gli ambiti della vita. Allo stesso modo anche gli altri presuli insistettero molto su tale valore. Essi videro nella guerra una possibilità per l’evangelizzazione dell’Etiopia, ancora lontana dalla «vera fede». La presenza nel paese di un’antichissima chiesa cristiana, la chiesa copta per l’appunto, non esimeva affatto dalla necessità di un’azione missionaria cattolica. Ai loro occhi la missione civilizzatrice del regime e quella evangelizzatrice della chiesa cattolica venivano a coincidere perfettamente, tanto che la guerra parve loro giustificata anche dal contributo che dava all’espansione del cattolicesimo107. Menzani sostenne che all’Italia fosse stata affidata «la sacra missione di allargare la vera civiltà»108. Brettoni, nel suo discorso al tempio della Ghiara, sottolineò come tale impresa portasse, insieme ai vantaggi materiali, anche «la luce e la elevatezza della civiltà cristiana»109; inoltre, durante la celebrazione del Te Deum dopo la vittoria, si espresse in questo modo: «Conceda dunque Iddio la vittoria morale della civiltà cristiana e romana e conceda, infine, di portare fra le popolazioni nella nuova Africa italiana i benefici di quella redenzione per cui tutte le cose e tutte le genti vengono restaurate in Cristo»110. Eppure la riflessione pontificia su temi missiologici da tempo andava in un’altra direzione. L’incalzare dell’imperialismo europeo a fine XIX secolo e il frequente utilizzo del cristianesimo per legittimare il dominio coloniale avevano già indotto Leone XIII a riconoscere l’inadeguatezza delle strutture ecclesiali tradizionali e ad auspicarne un aggiornamento di cui si erano fatti poi carico Benedetto XV e Pio XI: essi erano giunti a prendere le distanze dal colonialismo politico, vietando quello religioso e spirituale e auspicando la nascita di un clero indigeno. In particolare, papa Ratti aveva inteso in maniera nuova anche il rapporto con le Chiese orientali, separate da Roma, tra cui quella copta, e alla tradizionale prospettiva proselitista di una nuova evangelizzazione aveva sostituito quella di un ritorno alla Chiesa cattolica. Come ha sottolineato Agostino Giovagnoli, tale impostazione «ignorava certo la dimensione del rispetto ecumenico, ma implicava almeno il riconoscimento di una qualche validità della fede copta»111. La stessa discrepanza tra papa e vescovi emerge se si analizza il tema della guerra. Infatti il fatto che per giungere a tale evangelizzazione bisognasse ricorrere a un conflitto armato non creò problemi, poiché rientrava a tutti gli effetti nel concetto tradizionale di guerra giusta, concetto ancora profondamente radicato, anche se a partire da Benedetto XV i papi avevano già iniziato 107 108 109 110 111 Colli, Il dovere dell’ora attuale, cit., p. 131. Mons. Vescovo si compiace dell’esito del Sinodo Diocesano, cit., p. 2. La solenne manifestazione religiosa al tempio della Ghiara, cit., pp. 175-177. Il discorso di S. E. Mons. Brettoni, cit., p. 2. Giovagnoli, Il Vaticano di fronte al colonialismo fascista, cit., p. 120. 53 a ripensare tale teoria, incamminandosi verso una condanna della guerra in quanto tale. Per Colli, invece, la guerra non doveva mai essere intrapresa con facilità, ma vi erano situazioni in cui si rendeva necessaria per ristabilire il diritto. Inoltre ogni buon cittadino, una volta che essa veniva dichiarata, era tenuto a prendervi parte con disciplina per il bene comune. Certamente tutti i vescovi emiliani si premurarono di pregare e far pregare per la pace, augurandosi che giungesse presto. Tuttavia nessuno di loro mise in dubbio la legittimità dell’impresa in virtù di un rifiuto del conflitto armato in sé. Anzi, le ragioni dell’Italia furono approvate senza riserve. Risulta perciò evidente che, allo scoppio delle ostilità, i presuli non avevano recepito e rielaborato le più recenti riflessioni del papa sui temi del nazionalismo, della guerra e delle missioni cattoliche. Essi ne subivano l’insinuarsi, ma faticavano ad accoglierle e a conciliarle con il contesto culturale che li circondava, dando vita a significative contraddizioni teoriche e pratiche. È quanto accadde anche per il tema del nazionalismo. I vescovi furono animati da un forte desiderio di dimostrare il patriottismo del clero italiano e la sua volontà di collaborare con lo Stato italiano. Fu più del tradizionale lealismo nei confronti delle autorità: fu un vero e proprio fervore patriottico per nulla scontato e usuale nel clero italiano112. Infatti, in passato, il dissidio tra Stato e Chiesa, scaturito dall’unità d’Italia, aveva spinto i cattolici su posizioni «antistatali»113 e aveva indotto il clero a guardare alla politica come luogo di secolarizzazione in senso ideologico e a tenersi a di- Esemplificative di tale atteggiamento diffuso tra il clero furono le parole di Bussolari a conclusione di un intervento sul bollettino, volto a raccomandare la recita della colletta Pro pace e un ossequiente rispetto delle autorità: «La preghiera sia accompagnata dall’animo nostro calmo e tranquillo, ossequiente sempre alle Autorità. Mostriamoci pronti all’obbedienza e al sacrificio e colla nostra vita ordinata di perfetti cittadini cooperiamo all’avvento della pace nella verità, nella giustizia e nella carità. Vi benediciamo paternamente». Colletta “Pro pace”, «Bollettino del Clero della Diocesi di Modena e di Nonantola», 12 (1936), pp. 166-167; Notificazione di S.E. Rev. ma mons. arcivescovo, «Il Popolo», 30 novembre 1935, p. 3. 113 Quando il nuovo stato italiano diede prova lampante della sua avversione all’istituzione ecclesiastica, la corrente intransigente prevalse su quella neoguelfa, sancendo il tramonto di una prospettiva «romana» per l’Italia. Le vicende del 1848 indussero Pio IX, poco prima acclamato come il papa liberale, a fare un passo indietro. Tutte le illusioni di una convergenza di vedute tra la cultura risorgimentale, d’origine laica, e la cultura cattolica si infransero. I cattolici, per la maggior parte, si arroccarono su una posizione intransigente che cercava di veicolare una diversa concezione di italianità. Non contrastarono l’idea di una patria italiana in sé, ma solo la storica realizzazione compiuta dallo stato sabaudo. A lungo furono accusati di essere antipatriottici, ma la storiografia ha ormai appurato che non si trattò di anti-italianità, bensì di un’avversione alla specifica idea di nazione proposta e attuata dal movimento risorgimentale. I cattolici furono antistatali, non antipatriottici. Cfr. Giovagnoli, La Chiesa in Italia tra nazione e Stato, in Acerbi (a cura di), op. cit., p. 371; G. Formigoni, L’Italia dei cattolici, Il Mulino, Bologna 1998, pp. 29-32; A. Riccardi, Il caso religioso in Italia, in M. Impagliazzo (a cura di), La nazione cattolica. Chiesa e società in Italia dal 1958 a oggi, Guerini e Associati, Milano 2004, pp. 21-38; R. Traniello, Cultura politica del clero e coscienza civile degli italiani, in Acerbi (a cura di), op. cit., p. 23. 112 54 stanza dalla politica ufficiale. La situazione aveva iniziato a cambiare a fine ’800, quando vari fattori avevano favorito un graduale approccio alla politica del paese, tanto che già durante la guerra di Libia e la prima guerra mondiale parte del clero aveva aderito alla causa italiana, lasciandosi andare ad espressioni patriottiche114. Ma soltanto con la «conciliazione» i cattolici si erano sentiti pienamente pacificati con lo stato italiano e la guerra d’Etiopia fu la prima occasione di dimostrare il loro patriottismo senza riserve. Tuttavia il patriottismo in quegli anni veniva spesso confuso o fatto coincidere con il nazionalismo; perciò Pio XI, fin dai primi anni del suo pontificato, aveva messo in guardia su tale rischio. L’episcopato, anche su questo fronte, si dimostrò scarsamente ricettivo e assai contraddittorio, come troviamo documentato nei diversi interventi. L’atteggiamento di Colli, su questo punto, è paradigmatico. Egli, infatti, nella primavera del ’36, in piena guerra d’Etiopia, mentre appoggiava di fatto l’impresa fascista, scrisse una lettera pastorale dal titolo significativo I Cattolici e la Patria, in cui, pur intenzionato a difendere il patriottismo cattolico, volle prendere le distanze dalle derive totalitarie, attraverso il richiamo al tradizionale tema neoguelfo dell’universalismo cattolico, in sintonia con la visione di Pio XI. Nella lettera chiarì il concetto di patriottismo per i cattolici, smentendo chi li accusava di dimostrarsi patriottici per riconoscenza verso la politica religiosa del regime o per paura dell’avvento di comunismo, massoneria e protestantesimo, ma, allo stesso tempo, sancì una forte distinzione tra il patriottismo dei cattolici e il nazionalismo, sostenendo come l’obbedienza alla patria avesse un limite: la legge di Dio. Mise inoltre in guardia contro il pericolo delle ideologie totalizzanti e «statolatriche», diffuse in nazioni come la Germania, che innalzavano lo Stato a divinità somma e ad esso subordinavano ogni cosa: l’individuo, la famiglia, la religione. A tale visione egli oppose la concezione cristiana, che non vede il suddito in funzione dello Stato, ma piuttosto lo Stato al servizio degli uomini e del bene comune. Il rimedio al nazionalismo estremo era, a suo avviso, quello prospettato già da Benedetto XV: la collaborazione economica, militare e intellettuale tra diverse nazioni. Appare evidente che nella visione di Colli il concetto di nazione non coincide con quello di fascismo. Questo dimostra che la sua non fu una totale adesione, perché il suo rapporto con il regime fu più articolato di quanto la storiografia abbia spesso mostrato anche per altri vescovi italiani. Inoltre la discrepanza che abbiamo rilevato tra Pio XI e i presuli emiliani non significò G. Vecchio, op. cit., p. 234; G. De Rosa, Il movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Laterza, Bari 1976, pp. 327-335; Moro, L’opinione cattolica su pace e guerra, cit., p. 224. 114 55 contrasto: di sicuri sentimenti «papalini», essi non si sarebbero mai opposti al pontefice; semplicemente ripresero, dagli interventi pontifici, gli argomenti più in sintonia con la politica italiana, mentre ignorarono le questioni internazionali, finendo con il subire il fascino dell’ebbrezza patriottica e della prospettiva missionaria. 56 Quando passava «Pippo» Bombardamenti alleati su Castelnovo ne’ Monti e dintorni1 Cleonice Pignedoli I bombardamenti alleati sulla città e la provincia di Reggio Emilia sono stati ben documentati dal monumentale lavoro di Amos Conti e Michele Becchi, 22000 bombe su Reggio Emilia, e ben poco può essere aggiunto. Resta da raccogliere l'invito dei due autori a ricostruire in sede locale, con le documentazioni contenute negli archivi comunali, le incursioni alleate nei vari comuni. In Appennino fu ripetutamente colpito Castelnovo ne' Monti e la ss 63, che i tedeschi ritenevano di importanza strategica e snodo da cui partivano le azioni di rastrellamento verso i comuni limitrofi, controllati a tratti dalle forze partigiane. Infatti, alle forze tedesche già presenti in paese, si aggiungeranno, dal maggio 1944, altre truppe, tanto che il capo della Provincia ordinerà di predisporre cinquecento accantonamenti con paglia a terra e alloggi per trenta ufficiali. I soldati erano stanziati a Palazzo ducale, mentre le gerarchie di comando alloggiavano all'albergo Tre Re. Tuttavia le prime vittime degli Alleati furono in una borgata assai poco strategica. Il 14 maggio due aerei, nel corso di un'operazione di bombardamento su Reggio Emilia e Parma, nella traiettoria di ritorno dall'obiettivo principale, a causa del malfunzionamento della rastrelliera di sgancio, gettarono fuori bordo almeno sei bombe da venti libbre. Su Montecavolo, Leguigno, Paullo e Giandeto causarono solo un grande Le testimonianze di Fracassi Dino, Rivi Bruno, Agostini Raffaella, Montipò Miranda, Viappiani Anna Franca, Cappellini Anna, Pignedoli Giulio, sono state raccolte da Cleonice Pignedoli a luglio 2011. La testimonianza di Giliana Battistessa è stata raccolta da Cleonice Pignedoli nel 2004. 1 57 spavento. Altri spezzoni furono lanciati su una colonna di fedeli che in quel momento usciva dall'oratorio di Beleo. Dino Fracassi, classe 1937, racconta: Ricordo molto bene il momento in cui siamo usciti dall'oratorio di Beleo, era la sagra di San Michele, ci siamo incamminati lungo la strada che portava verso il rio Beleo perché io dovevo andare a Costa Medolana alla sagra, dove mi aspettavano mia nonna e mia zia. In quel momento sentiamo una squadriglia; un aereo o due si sono abbassati e hanno lanciato degli spezzoni, delle piccole bombe, che sono esplose a cinquanta metri da dove eravamo noi. La strada era in mezzo al bosco, circondata da una siepe e si sentiva quando le schegge tranciavano le foglie e i rami. La gente ha cominciato a urlare e poi qualche adulto ha cominciato a dire “buttatevi per terra, buttatevi per terra”. Mi son buttato per terra e mi ricordo che mia cugina ha preso un bambino e lo ha riparato dentro una piccola fessura in una roccia e si è messa sopra per proteggerlo. Poi il bombardamento finì, ci siamo rialzati e io sono andato a Costa Medolana, da dove mia nonna urlava, mi chiamava ad alta voce ed io da sotto dicevo “state zitta che ci bombardano ancora..” avevo solo sette anni. Arrivati su, nessuno aveva più voglia di mangiare anche se era il giorno della sagra. Vediamo passare gente che va a Casina a cercare dei medici e del materiale per feriti perchè a Case di Sopra uno spezzone aveva centrato le case. Qualcuno ha fatto delle interpretrazioni miracolistiche “Ecco San Michele ci ha salvato” perché nessuno di quelli che uscivano da Messa si era ferito. Nel pomeriggio noi ragazzini andavamo a cercare le schegge e facevamo a gara a chi trovava la scheggia più grossa e anche io ne avevo raccolto e le avevo portate a casa. La manovra fu dettata da un guasto, come affermano i rapporti alleati, e non era certo contemplato che i piloti si preoccupassero della vita dei civili. A Case di Sopra, cinque saranno i morti e molti i feriti gravi. Un'intera famiglia sterminata, con una bambina di quattro mesi ad aprire l'elenco delle vittime di Castelnovo ne' Monti. Bruno Rivi aveva sei anni quando la sua famiglia fu decimata. Ero piccolo, ma me lo ricordo. Era una domenica mattina, sentiamo che sta arrivando uno stormo di aerei, dicono che siano stati americani. I tedeschi erano in ritirata, venivano dal mare lungo la ss 63 e passando facevano dei bei disastri, incendiavano le stalle, prendevano il bestiame e poi cercavano i partigiani... Nel 1944 veder passare degli aereoplani era una cosa eccezionale, io, mio fratello e mia sorella stavamo correndo su un'altura per vederli meglio. Mio padre, mia madre con mia sorella Franca in braccio, mio bisnonno Fulgenzio, mio nonno Paolo erano sui gradini di casa. Uno spezzone incendiario è caduto nel cortile e li ha presi in pieno. Mia madre, mia sorella, mio nonno Fulgenzio sono morti sul colpo, mio padre e l'altro mio nonno Paolo all'ospedale. Noi siamo rimasti feriti, io al collo, mio fratello Domenico alla pancia, mia sorella Lillia è stata ferita a una gamba, che poi fu portata a Milano per essere operata. 58 Però ci siamo salvati. C'era un asinello legato alla siepe... la bomba l'ha centrato in pieno. Dei tre piccoli orfani si occuperà una zia, informata dal Commissario prefettizio di Castelnovo ne' Monti. «Arrivò mia zia Rachele, la sorella di mia mamma, da Milano che poi ci adottò. Abbiamo vissuto qui ancora due anni, poi dopo la guerra ci siamo trasferiti a Milano e siamo sempre vissuti là. Ora sono tornato a Reggio Emilia, vivo in città, ma per tre mesi abito a Case di Sopra», conclude Bruno Rivi. Oltre ai bambini, rimasero ferite cinque persone, tra cui uno zio, Quinzio Attolini, la nonna Maria Vasirani e Fernando Cagnoli, che chiederà più tardi il riconoscimento del suo stato di invalido. La ss 63 continuò ad essere presa di mira dagli Alleati e divenne pericoloso transitare con i carri agricoli: il 3 luglio venne mitragliato un carro agricolo a Casina, con due feriti e la morte dei bovini del traino. Castelnuovo Monti vivrà la sua giornata più terribile il 5 luglio 1944. Alle 6 del mattino gli abitanti vennero svegliati dal rombo degli aerei che sganciarono, in tornate successive, ben 25 ordigni. L'obiettivo era Palazzo ducale, sede della gendarmeria tedesca, dei carabinieri, ma anche di appartamenti civili e della scuola media «Italo Balbo». L'edificio si affaccia su via Roma, ha davanti anche ora un parco, allora circondato da una rete metallica e da pilastri sormontati dai simboli del fascio. Di fianco la scuola elementare, l'ospedale Principe Umberto, di fronte case civili, un forno, l'albergo e i negozi della ditta Zurli. Via Roma era ed è l'arteria principale, l'ingresso al paese. La mira degli aerei non fu molto precisa: le bombe caddero sulla strada, sulla casa di Aniceto Agostini; distrussero la scuola elementare, l'ospedale, il podere di Montedello all'incrocio con l'attuale via Bismantova, alcune case a Villa Rosa, ma Palazzo ducale restò in piedi. Per l'onda d'urto o colpiti da schegge morirono quattro militi tedeschi, un milite della gnr, ma il maggior numero di vittime sarà tra i civili. La guerra aveva ormai cambiato natura, diventava ogni giorno di più guerra che portava la morte tra la popolazione: mieteva le vite di bambini, anziani, inermi pazienti di un ospedale, mentre i militari venivano meno colpiti. I morti totali saranno 18, i feriti cinquanta. Molti di loro rimarranno segnati per tutta la vita. Secondo una stima del Commissario prefettizio, i danni furono notevoli: venti milioni di lire. Giuseppe Battistessa allora abitava con la famiglia, a Palazzo ducale in un appartamento sopra la gendarmeria tedesca e proprio per questo ritenuto un rifugio sicuro per lui, renitente alla leva. Quella mattina si trovava in casa con lo zio. Nella testimonianza, resa ad Amos Conti, spiega anche le circostanze che portarono gli Alleati a decidere il bombardamento su Castelnovo ne' Monti. Ai primi di luglio 1944 mio fratello maggiore, che già faceva parte di una formazio- 59 ne partigiana, ci informò, tramite una staffetta, che era stato deciso con il Comando inglese un bombardamento proprio su Palazzo ducaleove la gendarmeria tedesca era stata molto rafforzata per il contrasto dell’attività partigiana e la difesa della ss 63. Se ben ricordo il bombardamento sarebbe dovuto avvenire la domenica, ma vi fu un ritardo di tre giorni. Frattanto i miei familiari erano tutti sfollati ed ero rimasto nella casa… Fui colto dalla prima esplosione ancora all’interno del palazzo, ove alcune pareti interne crollarono. Affacciatomi ad una finestra vidi distintamente due caccia in picchiata sganciare altre bombe. Riparatomi sotto un davanzale, mi sembrò che il palazzo crollasse. Le due case antistanti, aldilà della strada erano praticamente sparite…2. Da Villaberza, Giliana Battistessa, sorella di Giuseppe (Geppe), con grande apprensione osserva lo sgancio di bombe su Castelnovo. Mia mamma aveva un po' di terra a Villaberza con una casetta. Ci avevano detto: abbandonate la caserma perché presto verrà bombardata. Aspetta aspetta … abbiamo pensato sono storie. Quando ci prendeva la paura andavamo a Villaberza e poi si tornava su perché a Castelnovo avevamo le nostre comodità… Quando hanno bombardato, per fortuna eravamo a Villaberza. Io ero uscita presto di casa per venire alla scuola commerciale, dove ero segretaria e ho assistito ai lanci delle bombe sia della prima che della seconda volta. Vedo questi aerei che girano su Castelnovo e lanciano le bombe. In caserma c'era mio fratello Geppe insieme a mio zio… Ho saputo poi che tra il primo e il secondo lancio erano riusciti a scappare. Quando sono arrivata alla Croce le donne mi dicevano… sei matta dove vuoi andare? Hanno colpito le case di fronte, l'ospedale, ma la caserma non l'hanno centrata. Quando sono arrivata c'era un tedesco morto sul cancello, morto il povero Picciati, che era nella Milizia. Giliana racconta anche lo strazio dei sopravvissuti. Arrivo a Castelnovo e mi si presenta uno spettacolo pauroso! Il preside Amodio, della scuola media, era in pigiama con i piedi insanguinati, era sceso in strada, sceso... sceso con tutto il palazzo si può dire e camminava sulla strada lastricata dai vetri, e il suo bambino di appena un anno era morto. Una cosa orribile. I coniugi Arlotti erano morti, la Raffaella, loro figlia, aveva gli occhi pieni di calcinacci. E tutti dicevano... perderà la vista. Raffaella Agostini, 11 anni, si salverà benché raggiunta da una fiammata. Oggi ricorda bene quella terribile giornata: Il brano della testimonianza di Giuseppe Battistessa in A. Conti, M. Becchi, 22.000 bombe su Reggio Emilia. Bombardamenti alleati e vita (e morte) quotidiana 1940-1945, Diabasis-Istoreco, Reggio Emilia 2008. 2 60 Eravamo saliti a Castelnovo per paura dei bombardamenti a Reggio. In città ogni giorno suonava l'allarme e bisognava scappare nei rifugi. Allora mio padre disse andiamo a Castelnovo, lui diceva – là non bombardano... val più una bomba che tutto Castelnovo – Invece... La mamma ha sentito degli apparecchi. La prima bomba è caduta sulla strada qui davanti. Allora siamo scappati, ma la bomba ci ha preso in pieno. Io una fiammata al viso, mio fratello Franco ha perso un occhio. La mia mamma, poverina, è morta sul colpo, mentre mio papà è rimasto ferito. Lo hanno portato all'ospedale, ma era bombardato anche quello. Allora lo hanno portato all'ospedale di Montecchio, ma poverino è morto durante il viaggio, non ce l'ha fatta ad arrivare. I nostri contadini della Fornace ci sono venuti a prendere, mi hanno portato via con una scala, altro che barella! E siamo stati da loro per un po'. In quei giorni ero ferita e tutti venivano a guardare. Io non ci vedevo e loro dicevano – poverina perderà la vista – pensavano forse che fossi anche sorda, mentre io sentivo tutto. Poi siamo dovuti andare noi a prendere la salma di mio padre. Giù abbiamo trovato una brava persona, una signora che noi non conoscevamo, che si è presa la briga di mettere lei una cassa di zinco, Franco è andato, ha restituito i soldi. Ma è stato un gesto di buona gente verso degli sconosciuti. Venne ucciso anche lo zio Luigi che dormiva nella camera sul davanti. Quando vedo gente che oggi fa la guerra, penso “non sapete quello che fate...” Speriamo non ne tornino più. Al piano di sopra era in affitto il direttore della scuola media, nel crollo lui e la moglie si salvarono, ma morì il loro figlioletto di un anno. Per ricostruire la casa ci volle molto tempo e se ne occuparono l'amministratore e il nostro tutore. Finalmente la casa era pronta, ma io non ero maggiorenne, avevo 19 anni e il tutore non mi voleva lasciare da sola ad abitarci. Io però ero stanca di stare in giro in collegio, in casa di parenti. Volevo casa mia. Allora il tutore acconsentì, ma mi disse bada di comportarti bene perché se vengo a sapere qualcosa torni via. Allora per la paura, non uscivo nemmeno con le mie amiche. Ma non mi importava, finalmente ero a casa… Una bomba cadde sul podere di Montedello e venne sterminata un'altra famiglia. Il nonno Adamo Viappiani con le nipotine Anna Teggi di tre anni, Franca Viappiani di sei mesi. I genitori, già al lavoro nella stalla, si salvarono. Anna Franca Viappiani, nata nel 1945 e chiamata con il nome delle sorelle che non ha mai conosciuto, ci racconta quello che ha sempre sentito dai genitori. La mamma era nella stalla, corre in casa per mettere in salvo le figlie e la casa è venuta giù. Un armadio le ha salvato la vita, mentre le bambine sono morte per lo spostamento d'aria. Il nonno è rimasto nel letto. Erano senza più niente, solo con i vestiti che avevano addosso. Poi sono andati ad abitare in due stanze che gli aveva dato Ghidoni Alfeo, vicino all'ospedale. Mio padre, Carlo Viappiani, non è più stato quello. Gli è venuto il mal di cuore; non essendo più in grado di lavorare la terra, aveva perso il lavoro perché il proprietario del fondo aveva dato i campi da coltivare agli altri suoi mezzadri. Faceva l'operaio quando lo chiamavano. Mi ricordo che aspettava la neve così guadagnava qualcosa con la spalata. E' morto che aveva 56 anni. 61 La mira degli Alleati fu veramente pessima, verrà colpita anche la borgata di Villa Rosa, pochi metri a nord di Palazzo ducale. Miranda Montipò aveva allora sei anni, ma il ricordo di quella mattina è rimasto indelebile. «Allora abitavamo in Villa Rosa, in affitto, dove mio padre aveva una piccola attività di falegname. Io ero a letto con la febbre. Arriva mia nonna e dice “scappate che bombardano”. Da Monte Forco arrivano degli aerei. Tutti sono scappati ma io sono rimasta lì». La mamma, che ha in braccio il figlio Carlo di tre mesi, si accorge che la figlia non c'è. Mio padre allora torna in casa mi prende in braccio e scappiamo. Appena in tempo. Un boato tremendo e la mia casa non c'è più. Siamo sbalzati lontano in mezzo al prato. Guardo mio padre: ha una ferita sulla fronte. Ci siamo riparati dietro una siepe. E tutti i malati dell'ospedale che venivano giù in camicia, pigiama... C'erano buchi enormi nei campi, sembravano vulcani. Io ho avuto odore di polvere nel naso fino a vent'anni. Mio fratello, in braccio a mia mamma era tutto coperto di terra e mia madre che continuava a pulirgli gli occhi... Dopo ci ha ospitato una famiglia, i Viappiani dei Boschi, ci hanno dato la loro camera, mio nonno lo ricordava sempre con riconoscenza. E nella stalla c'era pieno di feriti. Siamo stati lì qualche giorno e poi siamo sfollati dal prete di Campolungo. Abitavamo in canonica. Là, ho avuto ancora più paura. Quasi ogni giorno passavano o i tedeschi per i rastrellamenti o i partigiani. Nella mia vita non ho potuto mai guardare un film di guerra senza tremare come una foglia. Il bombardamento di luglio rappresentò il realizzarsi di una realtà fino allora soltanto paventata, vista come remota, conosciuta dai racconti dei tanti sfollati dalle città che si erano rifugiati nel capoluogo e nelle frazioni vicine, dove la vita sembrava più sicura. Dopo il bombardamento ognuno si arrangiò alla meglio con la carità di parenti o amici. L'archivio comunale conserva numerose richieste di risarcimento danni o di alloggio. Ma i problemi non furono di facile soluzione poiché Castelnovo ospitava sfollati, truppe tedesche e non vi erano più stanze libere. Nel bombardamento molti persero tutto, ma per fortuna non la vita e nemmeno i propri cari. Carlo Montipò, nonno di Miranda, fece presente che si trovava sprovvisto di casa e di mezzi di sostentamento a dover provvedere a moglie, figlio, nuora e due nipoti e che il suo figlio maggiore non aveva dato più notizie dopo la partenza per la campagna d'Africa. La nipote Miranda ancora racconta: «Dopo ci hanno data una casa popolare, dietro il vecchio Comune, a me sembrava una reggia. Aprivamo il rubinetto e scendeva l'acqua. Mi sembrava una cosa incredibile! Prima si andava con il secchio alla fontana». Nell'immediato ci fu da risolvere il problema degli ordigni inesplosi. Fino ad autunno inoltrato furono al lavoro gli uomini dell'unpa per disinnescare bombe inesplose. 62 Le segnalazioni si susseguirono: una, di quintali 2,5, si trovava nella casa Largader e precisamente presso l'ufficio di distribuzione Edison; ancora ad ottobre si ritrovò un ordigno fra le macerie dell'ospedale, ma il Comitato provinciale protezione antiaerea aveva cessato l'attività di recupero delle bombe inesplose e ogni azione dovrà essere a spese del Comune. Mario Fabbiani, Commissario prefettizio, si trovò a gestire il dopo bombardamento: non solo la distruzione, i problemi degli alloggi, la mancanza di materiali, ma anche i comportamenti delle truppe tedesche che si appropriarono di ciò che rimase. Il 1° agosto Fabbiani denunciò il prelevamento illegittimo di 98 coperte militari, da parte di un tenente tedesco. Le coperte erano state inviate dalla Prefettura e destinate ai senza tetto dell'incursione nemica del 5 luglio. In una lettera, senza risposta, troviamo il suo invito alla gendarmeria tedesca ad indagare e possibilmente a restituire le coperte. La Direzione provinciale dell'alimentazione ordinò un controllo sulla ditta Zurli che aveva denunciato un danno ai fabbricati e alle merci alimentari. Il Commissario fece notare che le merci, solo in minima parte distrutte dal bombardamento, furono invece asportate da truppe tedesche in transito, mentre sui fabbricati i danni erano notevoli. Castelnovo si trovò isolato: interrotto il collegamento telefonico e da settembre anche l'autoservizio sarsa, verrà sospeso. Il Commissario prefettizio si appellò ai parroci affinché raccomandassero ai loro fedeli la scrupolosa osservanza delle norme antioscuramento, ignorate soprattutto nelle borgate sparse. Fu necessario richiamare al rispetto degli orari anche le suore della Croce; infatti il 29 novembre alle 5:10, mentre aerei nemici sorvolavano il territorio comunale, una finestra del loro edificio, era interamente illuminata con grave pericolo per tutto il fabbricato. Da qualche mese era stata costituita la 12ª Legione milizia artiglieria contraerea con centro raccolta notizie a Castelnovo ne' Monti . Dietro il nome altisonante c'era un gruppo di avvistamento formato da militari in congedo e anziani che si alternava sul Monte Castello, senza mezzi per lanciare l'allarme alla popolazione. Il 6 agosto verrano convocati i muratori disponibili; dovranno presentarsi con i ferri del mestiere per la riparazione del tetto della casa comunale. Ma i materiali da costruzione, calce, gesso, fil di ferro, scarseggiavano ovunque; risultava quasi impossibile avere i vetri per riparare le finestre, che ancora mancheranno nell'agosto successivo, a guerra terminata. Dalle macerie della scuola elementare verranno recuperati banchi, sedie, cattedre e lavagne, ma la scuola a settembre non riaprirà. Sarà compito della nuova Amministrazione del dopoguerra, con il sindaco Umberto Sozzi, far sì che le scuole riprendano a funzionare, ma non sarà impresa facile. Alla richiesta di locali ai privati, possidenti del luogo, tutti risponderanno di utilizzare i locali dell'ex Casa del fascio in cui avevano trovato 63 posto i partiti antifascisti, la dc, il pci, il psi e anche l'udi. Il 10 agosto 1944 un'ulteriore incursione alleata su Palazzo ducale non provocò vittime. Sull'episodio non si trovano documenti e anche le memorie si confondono con l'attacco del mese precedente. Le truppe tedesche si difendevano in vari modi dagli attacchi aerei, ad esempio ordinando lo scavo di fossati ai lati della ss 63, oppure facendosi scudo con i civili. Spesso i tedeschi formavano dei convogli di bestie rastrellate, con carri condotti da civili; in caso di attacco aereo, i soldati si riparavano nei fossati e intimavano ai civili di non muoversi dalla strada, tenendoli sotto la minaccia dei fucili. Per i bombardamenti, l'autunno e l'inverno passeranno abbastanza tranquilli fino a marzo del 1945 quando un mitragliamento sulla ss 63 seminò ancora cinque vittime. In località La Croce morì un bambino di due anni, Mario Beggi e un uomo di cinquant’anni, Luciano Tagliati. Qualche minuto dopo l'aereo, sorvolando a bassa quota, mitragliò un carro agricolo sulla ss 63 all'altezza di Felina Amata. Falciato un ragazzo di 14 anni, Grizzi Aronne e lo zio Luigi 52 anni. Racconta Giulio Pignedoli, cugino delle vittime: Li abbiamo portati su con una scala a pioli, Aronne era stato colpito da una pallottola esplosiva e aveva un osso fuori dalla gamba, suo zio Luigi respirava ancora. Sono arrivati a casa vivi, ma sono spirati quasi subito. Anche il funerale era un pericolo. Abbiamo costruito casse di legno grezzo e li abbiamo portati via attraverso i campi, eravamo in pochi. Nessuno si fidava a venire ai funerali. L'ospedale e le sue vittime Nel 1931 Pasquale Marconi aveva fondato l'ospedale «Principe Umberto». Il nucleo originario era costituito da un piccolo edificio, che si era via via ingrandito. Nel 1944 svolgeva le funzioni di cura per gli abitanti della montagna, di sanatorio per l'intera regione ed ospitava anche un Piccolo Cottolengo. Come ricordano molti testimoni, l'edificio dell'ospedale venne colpito in pieno, fu distrutta la Villetta, sede amministrativa, fortemente danneggiata l'ala ovest. Gli ammalati, tra la prima e la seconda ondata di lanci, fuggirono nei campi e si ripararono alla meglio. Non tutti però riuscirono a mettersi in salvo: le vittime saranno quattro. La documentazione è stata ricostituita dai registri di morte del Comune di Castelnovo ne' Monti. Molti feriti furono trasferiti negli altri ospedali della provincia, al Santa Maria di Reggio, al nosocomio di Montecchio. Morirono in ospedale Remo Frigeri da Fiorano, 41 anni; Ugo Manfredi, 65 anni da Felina; Adelia Masini, 54 anni da Bologna e ancora un bambino, Achil- 64 le Cappellini, 11 anni da Carpineti. Ugo Manfredi era ricoverato in ospedale per una ferita di arma da fuoco. Soldati tedeschi durante un rastrellamento, lo avevano colpito ad un gamba mentre tentavano di aprire uno stipite chiuso a chiave. Triste anche la sorte di Achille, raccontata dalla sorella Anna. A casa, in un angolo c’era il tavolinetto da calzolaio di mio zio. Sopra una luce di quelle che usavano una volta, di metallo. Achille ha trovato in giro un bossolo di fucile che non era ben esploso. È venuto in casa, ha preso il martello l’ha pestato e quello è esploso. Ha perso tre dita e aveva una grave ferita al ginocchio. Non so come l’abbiano portato all’ospedale, non me lo ricordo. Venne qualcuno da Reggio Emilia che gli fece una protesi a un ginocchio. Fu ricoverato per tanto tempo, ma ormai era guarito. Quando è stato bombardato l'ospedale stava benino e dopo tre giorni lo avrebbero mandato a casa. Lui non riuscì a scappare. Ci dissero che lo colpirono nella finestra centrale dell’ospedale. Una signora poi ci raccontò che era rimasto sotto il crollo di una porta. A mia madre lo fecero vedere, solo dopo che lo avevano ricomposto… era tutto fasciato. Era un bellissimo bambino con gli occhi azzurri. Il funerale me lo ricordo… su un carro, con una cassa grezza, con i fiori di campo, delle rose, delle margherite che avevamo noi. Quando siamo stati là alla fontana sono arrivati degli aerei e noi siamo scappati dietro le siepi e abbiamo lasciato lì nella strada il carretto con i buoi e la cassa… Una famiglia duramente colpita: uno zio, Carlo Pignedoli, il partigiano Mitra, fucilato il 26 gennaio 1945 a Ciano d'Enza, il papà di Achille, catturato in fabbrica a Milano e deportato in Germania. «Mio papà – continua la sorella – non lo sapeva che il figlio era morto. Quando è tornato dalla prigionia gli siamo andati incontro alla corriera e glielo abbiamo detto. Il giorno dopo aveva l’itterizia dal dolore». Adelia Masini era ricoverata con la figlia Adriana; venivano da Bologna. Adelia morì sul colpo, mentre Adriana, forse ferita, verrà trasportata a Reggio Emilia, dove guarirà. Si sposerà a Reggio Emilia e lì vivrà fino al 2003. Il suo trasferimento a Reggio la farà ritenere morta; infatti il suo nome compare nella lapide delle vittime civili della guerra, inaugurata nel 2002 a Reggio Emilia. L’archivio comunale di Castelnovo ne' Monti conserva un lungo carteggio tra il figlio di Adelia e le autorità. Ci furono problemi sulla sepoltura, una bicicletta da restituire, gli abiti prestati da un ignoto castelnovese, la richiesta di riavere gli effetti personali della madre defunta. Arnaldo Algeri elenca minuziosamente gli effetti che la madre aveva con sé in ospedale e conclude la sua lunga lettera con una viva preghiera: la restituzione di una catenella d’oro con una croce d’argento che la mamma aveva al collo al momento della morte. Poche cose, ma non la catenella, verranno consegnate solo il 14 ottobre 1944 a testimonianza delle difficoltà a rimuovere le macerie per la mancanza di manodopera. 65 Giuseppe Panciroli, di Reggio Emilia, perse in ospedale un apparecchio Radio Marelli cinque valvole e, passato lo spavento, chiese al commissario straordinario della città, Celio Rabotti, un congruo indennizzo, che non sappiamo se abbia avuto. L'ospedale e il sanatorio dovranno essere chiusi. Gli ospiti del Piccolo Cottolengo furono ospitati a Fontanaluccia da don Mario Prandi. Alcune suore e alcuni malati troveranno ricovero nella parrocchia di Santo Stefano, nella vicina borgata di Rosano. La memoria La memoria dei bombardamenti è strettamente legata al nome di «Pippo», che ricorre spesso nelle narrazioni dei testimoni. Secondo alcuni, un aereo da ricognizione, secondo altri un aereo alleato o tedesco che sparava su ogni piccola luce e portava la morte a chi non rispettava l'oscuramento. Un aviatore solitario che viaggiava di notte, ma anche di giorno non lesinava mitragliamenti a bassa quota. Magari non era uno solo, ma in ogni caso era pericoloso. Secondo Cesare Bermani, che ha scovato racconti su Pippo in ogni parte d'Italia, si legge il tentativo di attenuare una drammatica realtà rappresentata dal fatto che gli alleati angloamericani bombardassero e mitragliassero non solo i fascisti e i tedeschi, ma anche i nostri paesi e le città, provocando quelli che, con una terribile espressione militare, vengono oggi chiamati danni collaterali. La stampa clandestina antifascista contrastava le notizie ufficiali che parlavano di attacchi terroristici nemici. Il Comitato di difesa dei contadini diffuse un volantino in cui si affermava: I bombardamenti e i mitragliamenti quotidiani, che subiamo, sono i primi effetti di un ben più grave pericolo che minaccia le nostre campagne. I tedeschi e i fascisti in ritirata, fedeli ai loro metodi briganteschi compiono ogni sorta di delitti, razzie e ladrocini ai danni delle delle popolazioni; ci depredano del bestiame, dei foraggi, dei cereali, incendiano tutto ciò che non possono rubarci, più la deportazione di massa degli uomini in terre nemiche, senza speranza di ritorno, minacciano l'esistenza presente e futura delle nostre famiglie… La popolazione montana attuò dagli inizi dell'occupazione nazista una precisa scelta, aiutando e nascondendo gli aviatori alleati. Tuttavia i luoghi pubblici di memoria dedicati esclusivamente alle vittime dei bombardamenti sono inesistenti, nonostante il giudizio netto sulla responsabilità primaria del fascismo nell'aver trascinato l'Italia in un conflitto tanto devastante non debba far temere operazioni di revisionismo o strumentalizzazione politica. 66 Il numero complessivo di 22 vittime civili solo nel comune di Castelnovo ne' Monti tra cui sette neonati e bambini (la proporzione è impressionante) e solo sei militari, testimonia un mutamento nella guerra che purtroppo permane anche nei conflitti contemporanei. Ogni operazione di memoria su questi avvenimenti non sarà quindi retorica, ma occasione di riflessione sulle guerre e sull'agire umano. Elenco delle vittime dei bombardamenti dell'Appennino reggiano3 Casina-borgata di Montale di Pianzo – 2 maggio 1944, h. 12:45 Sono sganciate sette od otto bombe, muoino: Cleonice Fontana, anni 50; Erminia Gherardi, anni 72. Castelnovo ne’ Monti-borgata di Case di Sopra – 14 maggio 1944 Spezzonamento. Muoiono: ATTOLINI Paolo, anni 55; RIVI Franca, mesi 4; RIVI Giacomino, anni 34; VASIRANI Fulgenzio, anni 74; VASIRANI Maria Irina, anni 33. Castelnovo ne’ Monti – 5 luglio 1944 Bombardamento. Muiono: AGOSTINI Aniceto, anni 67; ARLOTTI Irene, anni 47; ARLOTTI Luigi, anni 59; BENEVELLI Virgilio, anni 59; BOTTAZZI Marino, anni 35 (milite); CAPPELLINI Achille, anni 11; FRIGERI Remo, anni 41; FUSCO Ludovico Maria, anni 1; MANFREDI Ugo, anni 65; MASINI Adelia in Algeri, anni 54; PICCIATI Giovanni, anni 38 (milite); TEGGI Anna, anni 3; VIAPPIANI Adamo, anni 69; VIAPPIANI Franca, mesi 6. Militari tedeschi deceduti: HEIN Helmut, anni 43; KZAUDAZUM Gustav, anni 40; BLOS Hans, anni 40; CZINK Martin, anni 36. Casina, località Canala – 19 agosto 1944 Mitragliamento alla corriera della SARSA. Diversi feriti e invalidi. Il mezzo viene mitragliato finché non va a fuoco. Muore: VINCENTI Iride, anni 27, di Ligonchio. Secchio e Costabona – 12 ottobre 1944 Mitragliamento. Muoiono: CORSINI Luigi, anni (?); GOVERNARI Eraldo, anni 12. Casina-località San Giacomo – 14 ottobre 1944 Sganciate cinque bombe. Mancato l'obiettivo del ponte viene colpita in pieno una casa. Muoiono: CROCI Maria Luisa, anni 5; LANZI Bruna, anni 18; LANZI Zaide, anni 21. Carpineti – 3 dicembre 1944 Colpita la casa cantoniera sulla SS 63. Muoiono i coniugi: CASTIGLIONI Teodora, anni 50; FIORINI Natale, anni 53. Tratto da A. Conti, M. Becchi, op. cit., aggiornamento con ricerche negli archivi storici dei Comuni interessati. 3 67 Carpineti-strada di Villaprara – 8 marzo 1945 Mitragliamento. Muore: VALESTRI Adolfo, anni 35. Castelnovo ne' Monti-SS 63, località Croce – 8 marzo 1945 Mitragliamento. Muoiono: BEGGI Mario, anni 1; TAGLIATI Luciano, anni 50. E poi all'altezza di Felina Amata: GRIZZI Aronne, anni 14; GRIZZI Luigi, anni 52. Ramiseto – 18 marzo 1945 Muore: COSTI Agostino, anni 14. Cerrè Sologno-località Bragolo –14 aprile 1945 Bombardamento. Viene colpita in pieno una casa e muoiono i componenti di un'intera famiglia: BERTINI Giuseppe, anni (?); BERTINI Ulderico, anni (?); GIORGINI Ida in Bertini, anni (?); MARIANI Luigia in Bertini, anni (?); BATTAINI Carlo, anni 9. Collagna –23 aprile 1945 Bombardamento. Muore: COMPARONI Antonio, anni 87, invalido. Castelnovo ne' Monti deve annoverare tra le vittime dei bombardamenti anche FARINELLi Bianca, anni 17, deceduta a Pietra Ligure. Fonti bibliografiche e archivistiche • Conti A., Becchi M., 22.000 bombe su Reggio Emilia. Bombardamenti alleati e vita (e morte) quotidiana 1940-1945, Diabasis-Istoreco, Reggio Emilia 2008. • Bermani C., Spegni la luce che passa Pippo. Voci, leggende e miti della storia contemporanea, Odradek edizioni, Roma 1996. • Archivio Storico Comunale di Castelnovo ne' Monti, Cartelle 1944, 1945. • Archivio Parrocchiale Castelnovo ne' Monti, Registro dei morti. • Milani F., Il Dr. Pasquale Marconi autobiografo (... quasi), Tipografia Casoli, Castelnovo ne' Monti 1973. • Franzini G., Storia della Resistenza Reggiana, Tecnostampa, Reggio Emilia, 19663. • Elenco sepolture cimitero tedesco della Futa, Istoreco, Reggio Emilia. 68 Documenti La famiglia Rivi al completo poco prima del 14 maggio 1944 La signora Rina Teggi con la figlia Anna, morta nel bombardamento del 5 luglio 1944. Sullo sfondo il podere di Montedello Comunicazione delle vittime e dei danni del Commissario prefettizio di Castelnovo ne’ Monti alla Prefettura di Reggio causati dai bombardamenti del 1944 Richiesta aiuto di Carlo Montipò Achille Cappellini, al centro, con la sua famiglia a Busanella di Carpineti Comunicazione del direttore dottor Bertoldi dei ritrovamenti degli effetti personali della signora Adelia Masini Algeri Ultima parte del lungo elenco di effetti personali smarriti in seguito al bombardamento del luglio 1944 che Adriano Algeri, figlio della defunta Adelia Masini, invia all’ospedale Umberto I (oggi Sant’Anna) 150° dell’Unità d’Italia Letture 150° dell’Unità d’Italia. Letture Con gli occhi di oggi: Ippolito Nievo, Carlo Cattaneo, Giuseppe Mazzini, Silvio Pellico Introduzione Ettore Borghi Con gli scritti che presentiamo – e con altri che potranno seguirli – non intendiamo certamente inseguire la velleitaria ambizione di un impossibile canone dei «libri del Risorgimento». Si tratta di un intento più semplice e «sperimentale»: dare in lettura a giovani ricercatori un certo numero di opere di gestazione remota e di diversa fortuna, il cui tratto comune è di appartenere all’età risorgimentale, per tentare così, entro precisi limiti, di rendere la voce a significative figure di protagonisti e scrittori. Alcuni di questi testi non hanno fatto parte, lungo la storia successiva, delle letture «obbligate» nel sistema scolastico. Altri, invece, costituirono ingredienti indispensabili nella formazione borghese dell’Italia liberale, per essere poi rimossi o antologizzati e manipolati in età fascista. Invero non pochi ricomparvero (ma quanto furono letti?) in fortunate ed economiche collane nel secondo dopoguerra. Memorabile, fra l’altro, la utilissima bur dalla grigia copertina, che offrì nel suo folto catalogo molta materia «risorgimentale», dai mazziniani Doveri dell’uomo alle traduzioni di Giovanni Ruffini, per fare solo qualche esempio. In molti casi, fenomeno non certo raro, quelli che intendiamo rispolverare sono titoli più citati che letti, indipendentemente dai tempi e dalle generazioni. E poi, a tanti decenni di distanza, resta oggi più che mai da fare i conti con il sapore difficile di una lingua letteraria moderna ancora in formazione (l’ottocentesca «questione della lingua» che si studia – si studiava? – a scuola). Per tutte queste ragioni ci si poteva attendere da lettori non pregiudizialmente condizionati o una lettura, per così dire, estraniante, volta a sottolineare le diverse forme di distanza, oppure un approccio attualizzante, che è, infine, un modo per render conto (qualcuno lo dichiara esplicitamente) di tratti persistenti e di lunga durata (il «carattere degli italiani», il lascito della loro storia municipalistica e divisa). E questo ci pare sia stato l’atteggiamento prevalente, e probabilmente il più costruttivo. 77 I Mille in Sicilia Le lettere di Ippolito Nievo1 Alessandra Fontanesi Queste lettere scritte dall’autore delle più celebri Confessioni di un italiano, dal 5 maggio 1860 fino al 23 febbraio 1861, hanno il merito – come parte degli epistolari celebri – di restituirci la freschezza dell’attimo in cui l’azione dell’impresa dei 1070 in Sicilia si svolse. L’epistolario si rivela essere un’importante cronistoria dei fatti a cui l’intendente Nievo assiste e che però non può fare a meno di rendere con la sua arte e humour: Palermo, 28 maggio 1860 Bice carissima – Scrivo questa data con piacere e con orgoglio. Ma tu prima di tutto amerai sapere l’itinerario preciso della nostra gita di piacere. Partiti il 5 maggio all’alba da Genova, il 6 si approdò a Telamone in Toscana donde devi aver ricevuto il mio biglietto. L’undici (il mio giorno benaugurato) fummo in vista della Sicilia. Ancorammo nel porto di Marsalla ove un quarto d’ora dopo giunsero due fregate e una corvetta Napoletana. Lo sbarco dei nostri fu pronto e felice; ma mentre io attendeva a scaricare le munizioni del secondo nostro vapore Il Lombardo cominciò il cannoneggiamento. Rimasimo colle polveri e colle granate sulla spiaggia, sotto una gragnola di palle, finché le carrette si risolsero a scendere dalla città. Le nostre schiere assicurate dietro gli argini del molo rispondevano alle bordate con grido – Viva l’Italia! – Il battesimo del fuoco fu per esse santo e grandioso ... 2. Le lettere che Ippolito scambia con i familiari e l’amata cugina Bice (e di cui spesso compare la risposta così da rendere l’epistolario dialogato) ripropongono la realtà della vita di Nievo e dei suoi sentimenti: dall’entusiasmo dell’inizio della spedizione si passa al tedio e alla noia per il luogo e per «il caldo africano», per la vita palermitana in cui sarà costretto, per il lavoro di Intendente che deve svolgere perché Garibaldi stesso glielo impone. Tuttavia dalle lettere, soprattutto quelle più intime e fresche che Nievo indirizza alla cugina (e amata ma sposata con il caro cugino Carlo) Bice Melzi Gobio, cogliamo degli affreschi inediti e affascinanti della vita in una nuova parte del nascente Regno d’Italia. Palermo viene descritta come una città in evoluzione e che accoglie «gli eroi di Calatafimi» con grande generosità: I. Nievo, Lettere garibaldine, Einaudi, Torino 1961. Testo con in Appendice Giornale della Spedizione in Sicilia e Resoconto amministrativo della prima spedizione in Sicilia, dalla partenza da Genova, il cinque maggio, all’ultimo armistizio coll’armata napolitana in Palermo li 3 giugno1860. Una copia del libro si trova presso la sezione conservazione della Biblioteca civica «A. Panizzi». 2 Nievo, Lettere garibaldine, cit., lettera IV, p. 7 1 78 Chi lo avrebbe detto quando eravamo stanchi, cenciosi e mezzo morti di fame e di sete sulle montagne di Parco, che quella bella e vasta città distesa sulla marina e veduta da lungi come un sogno incredibile, avrebbe baciato collo sventolio della sua aria, dilettato colle sue musiche e scarrozzato nei suoi mille legni che non la cedono in nulla a quelli del Bastione di Porta Orientale [a Milano, N.d.R.]? Chi lo avrebbe detto che le nostre mani sarebbero rientrate nella morbida schiavitù dei guanti, che ci saremmo fatti uomini, ufficiali, semidei, dopo di essere stati briganti, filibustieri e semibestie? Sai che è il sogno di Arlecchino finto Principe! Ma qui starà poco che diventeremo Principi sul serio, perché di Eccellenze e Mezze Altezze ve n’ha di tale abbondanza, che per non scomparire noi siamo obbligati a trinciarla almeno da Duchi …3. Si descrive il cambiamento ma non la rivoluzione garibaldina che Nievo e gli altri speravano, anzi dalle parole del vice intendente generale si deduce delusione per la svolta politica più moderata che sta prendendo tutta l’impresa e per l’oscuramento che l’epopea dei Mille sta subendo. Dopo la battaglia del Volturno infatti anche il «miracolo garibaldino» sarà ricondotto nell’epopea che ha fatto di Vittorio Emanuele II il liberatore che ha unificato l’Italia. Immergiamoci ancora, tramite le parole del Nievo, nell’atmosfera della «nuova» Palermo, tuttavia ancora dotata di parecchie vestigia feudali: Signori e signore non ne mancano, e per di più vi sono anche le monache, che mettono nel mondo la punta di un piedino ed amano almeno di fiutare qualche filo d’aria peccaminosa. Vedi che gli avanzi di Calatafimi, come ci chiama il Generale, hanno trovato modo di ristorare al meglio. Per altro, a parlarti sul serio, non si cessa di lavorare, anzi il mio dispetto è che non si lavori abbastanza e come io vorrei. Abbiamo un ministero della guerra che avrà anche la coda ma un capo non certo: è una fabbrica così fertile di ufficiali e colonnelli che finirà col gallonare tutti i siciliani, bene inteso che noi della prima spedizione siamo considerati sempre come una specie di esseri superiori, ai quali Generali e Marescialli di fattura posteriore levano tanto di cappello. Si sta lavorando per la medaglia per i 1070 argonauti: la città ci scrisse come cittadini ed altre due medaglie ci vuol dare il Generale per Calatafimi e Palermo. Vedi che è un buon principio per un Museo Numismatico. […] Il sarcasmo poi lascia spazio all’entusiasmo quando Nievo scrive più avanti nella stessa lettera del futuro della campagna: La spedizione di Napoli torna sul tappeto, ora che è certa la promulgazione della Costituzione, ma temo che il Generale voglia aspettare per assaggiare il terreno. Io per me ho tanta fede in S. Gennaro come ne ebbi in S. Rosalia [protettrice di Palermo, N.d.R.] e mi getterei addirittura nelle fauci del Vesuvio. Ne uscirebbe un’eruzione che porterebbe le sue lave fino alle porte di Ancona e spazzerebbe l’Italia dalle lordure di Lamorcière. Intanto si perde tempo e i partiti rialzano le corna. Guai se 3 Ivi, lettera XXII, alla cugina Bice Melzi Gobio, p. 24 79 venisse qui chi non deve venirci! A Napoli, a Napoli! È il nostro grido – il mio in particolare, perché quella è la strada di riavvicinarmi a voi …4! Ardore e ardimento ancora vivi sono nell’animo romantico del trentenne Nievo, devoto da sempre alla causa dell’Italia unita: sono queste le caratteristiche che avvicinano e possono coinvolgere un giovane lettore contemporaneo. Benché il piacere delle lettura preveda una buona edizione critica delle Lettere, come quella che ho potuto sfogliare, e una selezione anche degli scritti; altrimenti la noia, per un «nativo digitale», sarebbe assicurata. Noia che sarebbe alquanto immeritata perché il personaggio Ippolito Nievo, insieme alla sua famiglia, sprizza fiducia e devozione alla causa in modo entusiasmante5. Dal punto di vista degli eventi storici tutti i punti salienti della campagna di Sicilia, dell’avvento dell’amministrazione sabauda, della liberazione infine del Regno delle Due Sicilie sono ben tratteggiati e ovviamente descritti con un punto di vista totalmente soggettivo: Nievo preciso e minuzioso nello svolgere le sue mansioni da intendente, nel «mettere a posto i conti e passare in rassegna» sente, e scrive, il fiato sul collo delle critiche che da più parti inizieranno a piovere sulla gestione Garibaldi dell’impresa, sul sospetto che quei conti non siano stati così precisi6. Nievo che viene fatto colonnello durante la sua visita a Napoli e che di lì a poco scrive della sua amarezza, confessata al solito per Bice, per aver ricevuto il decreto di scioglimento dell’Esercito meridionale: «Tuttavia non ti nascondo il mio dispetto. Una si bella epopea eroica finire così con un Decreto di S. M.! Ne serberò eterno rancore al Conte di Cavour, … il qual rancore non porterà certo pregiudizio alla rotondità del suo addome … »7. Insomma dalle lettere, che possono essere ulteriormente intrecciate con il Giornale della Spedizione di Sicilia (presente in questa edizione) agile e dettagliato, abbiamo il quadro e il polso degli avvenimenti che hanno fatto Nievo, Lettere garibaldine, cit., lettera XXII, alla cugina Bice Melzi Gobio, pp. 25 - 26 «Il suo volontarismo, che mostra già i segni del suo destino nelle prime irrequietudini quarantottesche, lo spinge poi, nella campagna del 1859, a militare con le Guide a cavallo dei Cacciatori delle Alpi, piuttosto che, come i suoi fratelli, nell’esercito regolare e lo fa infine partecipe della più romantica e romanzesca azione del volontarismo italiano, dell’impresa dei Mille», ivi, introduzione della curatrice Andreina Ciceri, p. XVI. 6 «Se sono sempre questioni delicate le questioni di denaro figurati poi per me che ho ereditato tutta la gestione rivoluzionaria da maggio (1860, N.d.R) in poi! È un caos inestricabile, nel quale è un uomo di coraggio chi non si perde e chi mette la propria responsabilità nel dovere di regolarlo. Furono troppe le accuse che bersagliarono un partito cui ci si vuole ascrivere perché io possa abbandonare il timone della barca, ora che, dopo qualche furioso colpo di vento, siamo in vista del porto … Mi rassegno rabbiosamente come sempre, ma son deciso a finire come ho cominciato e a rimettere a Garibaldi puro ed onorato come me lo diede il difficile incarico …», ivi, lettera LII, Alla cugina Bice Melzi Gobio, p. 90. Si veda anche sullo stesso tema la lettera LXIII indirizzata sempre alla cugina. 7 Nievo, Lettere garibaldine, cit., lettera LX, p. 105. 4 5 80 una parte della storia dell’Italia unita. E se sono pagine ricche di entusiasmo patriottico sono anche parole prive di retorica altisonante. È tutta vita quella che trasuda dall’epistolario di Nievo. Vita spezzata, giovane e all’inizio di una carriera, se non politica, letteraria e giornalistica di sicuro successo. Ippolito Nievo morirà tragicamente e misteriosamente trasportando proprio le carte dell’amministrazione garibaldina dalla Sicilia a Napoli, durante il naufragio del vapore Ercole, dando vita a varie ipotesi e congetture che hanno prodotto letteratura anche recentissima8. Nell’ultima lettera che si conosca, sempre indirizzata alla cugina Bice scrive della sua voglia di ritornare finalmente al nord, desiderio che si inabisserà tristemente nel Golfo di Napoli: Ti assicuro che questa volta Palermo mi ha fatto un tristissimo effetto; … Su e giù per colline, per boschi per giardini tutto il giorno con tanto di musone a Mamma Natura la quale me ne rimerita facendomi sembrar brutto tutto ciò che dovrebbe essere allegro. Meno male che giovedì o alla lunga domenica questa vitaccia sarà finita e rivedrò Napoli e Genova e Milano. Prima della metà di marzo conterei di tentare per due o tre giorni la cura dei tortelli … . Cattaneo e le considerazioni sul 1848 Fabrizio Solieri Il famoso testo di Carlo Cattaneo (1801-1869) Considerazioni sul 18489 accompagna l’imponente raccolta di documenti inerenti i tre anni che vanno dalla salita al soglio pontificio di Pio IX fino alla caduta della repubblica veneziana di Daniele Manin, ultimo atto dell’infelice esperienza delle ondate di rivolte popolari nella penisola e della seguente prima guerra d’indipendenza10. Nel romanzo Il prato in fondo al mare del 1974, autore il pronipote Stanislao Nievo, il drammatico evento è rappresentato come «una sospetta strage di Stato italiana, maturata dalla Destra e decisa dal potere piemontese per liquidare la Sinistra garibaldina: «strage» con la quale si sarebbe aperta la storia dell’Italia unita». Se ne occupa anche Umberto Eco nel suo ultimo lavoro Il cimitero di Praga. 9 In mancanza di una edizione recente e di facile reperimento, si farà riferimento alla versione digitale pubblicata sul sito del Progetto Manuzio con la collaborazione dell’Associazione mazziniana all’indirizzo: http://www.liberliber.it/mediateca/ebook/c/cattaneo/considerazioni_ sul_1848/pdf/consid_p.pdf Tale versione fa riferimento al volume C. Cattaneo, Scritti Storici e Geografici, a cura di Gaetano Salvemini ed Ernesto Sestan, Le Monnier, Firenze 1957. Il titolo originale dell’opera, che in seguito ha avuto fortuna indipendentemente dalla sua concezione originaria era Considerazioni al primo volume dell’Archivio Triennale delle cose d’Italia. 10 Un’introduzione e una ricognizione generale dell’opera si trova nell’articolo Manifesto alle “Considerazioni sulle cose d’Italia del 1848” ora antologizzato in C. Cattaneo, Scritti Politici, Le Monnier, Firenze 1965, pp 455-471. 8 81 Questo testo ha preso però una valenza tutta particolare perché contiene in nuce gran parte degli elementi che hanno reso Cattaneo una voce unica nel variegato panorama politico del Risorgimento italiano le cui riflessioni, profonde ed estremamente complesse, meriterebbero oggi un’analisi attenta e competente, ben lontana dalla trivializzazione a scopi elettorali che le coinvolge. Cattaneo, in pieno Ottocento, quindi nel bel mezzo del recupero più o meno pretestuoso e posticcio delle tradizioni culturali nazionali, ha la lucidità di cogliere che «la coscienza esplicita e solenne d’una vita comune e nazionale è un fatto nuovo e proprio del secolo»11 che deriva dallo stato di sottomissione via via più forte cui i vari popoli sono sottoposti dai sovrani restaurati. La rivelazione della natura, diciamo così, oppositiva, del concetto di nazionalità è confermata per esempio dalla nascita dello spirito germanico sotto il dominio napoleonico. In Italia è il dispotismo austriaco, dimentico del riformismo settecentesco, ad aver aizzato lo spirito nazionale. A queste considerazioni va premesso che Cattaneo non è sempre stato un fautore del distacco del Lombardo-Veneto dalla sfera austriaca. Questa evoluzione del suo pensiero avviene soltanto dopo la delusione culminata nel 1848, quando l’atteggiamento asburgico nei propri domini italiani rende palese che non ci potrà essere nessun progresso verso la libertà finché questi territori saranno sottoposti all’Austria (senza che questo, peraltro, significhi necessariamente la creazione di uno stato unitario nazionale). Gli errori della potenza egemone in Italia finiscono quindi per provocare il risveglio di un popolo, quello lombardo-veneto, assai pacifico; ne consegue il crescente odio austriaco contro la nazionalità italiana e, per reazione, l’ulteriore incremento del sentimento nazionale a partire proprio dalle categorie più umili della popolazione urbana. In questo contesto il passaggio che l’autore dedica a Mazzini è indicativo della sua visione autenticamente filo-popolare degli avvenimenti del 1848. Cattaneo, infatti, accusa Mazzini di non parlare veramente la lingua del popolo di «non penetrare addentro nella carne del popolo, come la coscrizione, e il bastone tedesco e la legge del bollo e l’esattore...»12. Inoltre, fatto ancora più grave, viene rimproverato a Mazzini di aver tradito in almeno due occasioni l’ortodossia repubblicana essendosi rivolto nel 1831 a Carlo Alberto e, nel 1847, a Pio IX. Quest’ultimo è il vero nume tutelare dei movimenti della primavera del 1848: Pio IX è stato adottato dal popolo come simbolo della libertà italiana, si tratta di un fenomeno altamente coinvolgente per le masse popolari e, certamente, in massima parte estraneo alle intenzioni del pontefice (come si è 11 12 82 C. Cattaneo, Considerazioni sul 1848, Ami Books, 2003, p. 6. Ivi, p. 12. poi visto alla prova dei fatti). Chiunque abbia modo di leggere i resoconti del breve periodo tra la salita di Giovanni Maria Mastai Ferretti al soglio pontificio ed il suo «tradimento» della causa unitaria può concordare, infatti, con le affermazioni di Cattaneo: «Pio IX fu fatto da altri: e si disfece da sé. Pio IX era una favola immaginata per insegnare al popolo una verità»13. È universalmente noto il durissimo giudizio di Cattaneo su Carlo Alberto, un giudizio che risulta interessante ancora oggi perché contiene alcune delle ragioni profonde del suo pensiero. Carlo Alberto viene accusato di essere sempre indeciso tra le opinioni opposte, di non avere apertamente sposato la causa italiana ma di «vivere in concubinato con la rivoluzione»14. Ancora più dannose sono le conseguenze della propaganda dei partigiani di Carlo Alberto all’interno del movimento unitario: Cattaneo ritiene che il popolo avesse già dimostrato durante i fatti di Milano di essere in grado di prendere in mano la situazione, l’intervento di un sovrano (le cui intenzioni liberatrici erano assai dubbie) aveva invece contribuito ad allontanare di nuovo dalla nazione le classi più numerose e a portare tra i ceti più elevati «un animo per molti aspetti simile a quello degli antichi ghibellini; i quali nascevano e morivano nella perenne aspettazione d’un esercito che scendesse a render loro sugli eguali un predominio che di per sé non valevano a conservare»15. Vero protagonista delle Considerazioni di Cattaneo è, come abbiamo visto, il popolo, fatto nazione dall’incapacità austriaca di governare rispettando le autonomie e capace di vincere senza eccessi e senza vendette, sconfitto alla fine non per la propria magnanimità nei confronti del nemico ma per l’eccessiva fiducia nel falso amico. Quale significato occorre dare a questa affermazione di Cattaneo? Si tratta di un punto cruciale della sua, per certi versi discutibile, lettura degli avvenimenti del 1848. Cattaneo, infatti, sostiene che, a un certo punto, l’Austria si trovasse in tale difficoltà, unitamente agli altri stati da essa dipendenti, che la libertà italiana poteva essere colta senza troppe difficoltà e senza spargimenti di sangue. È stato appunto l’intervento di un sovrano come Carlo Alberto a far sì che si mettesse la libertà italiana in subordine rispetto all’unità. Questo perché sono i regnanti a puntare ad ingrandire il proprio Stato per fronteggiare alla pari i propri avversari. Tuttavia, dice Cattaneo, non è nella grandezza territoriale che sta la forza di uno Stato: la prima forza nelle cose umane è la volontà e non è necessariamente il numero di uomini a dare la volontà. La volontà sta nel popolo e nella coincidenza tra i bisogni del popolo e quelli di chi lo comanda: è ovvio che gli interessi dei regnanti d’Italia sono assai diversi da quelli del popolo. 13 14 15 Ivi, p. 66. Ivi, p. 15. Ivi, p. 17. 83 Infatti: «Qui fu l’errore dell’unità da conseguirsi con persuadere un principe “di codarda e fiacca natura” a divenire magnanimo e deliberato»16. Il popolo aveva in realtà vinto la sua guerra e avrebbe potuto portare in fondo la sua vittoria se i suoi nemici, tra cui molti pubblicisti, non avessero quanto meno minimizzato, se non cancellato, la sua vittoria magnificando la potenza degli eserciti pronti alla guerra del re. L’Austria alla fine ha avuto gioco facile perché ha ritorto contro l’unità italiana la volontà di conquista di un regnante italiano sugli altri. Se la causa dell’unità italiana avesse inalberato il vessillo dell’eguaglianza, della giustizia, della libertà e dell’umanità, le sue forze non sarebbero state disperse. All’idea universale di libertà, che avrebbe reso tutti i popoli concordi in quest’opera, venne purtroppo posta innanzi la più angusta idea dell’unità e dell’indipendenza. Una volta compianta la triste fine degli eventi bellici Cattaneo passa ad analizzare l’importanza delle giurisdizioni municipali. Egli sostiene che basterebbe avere delle realtà municipali libere e rispettose ognuna della libertà del proprio vicino per realizzare quello stato di felicità e di «unione» non statuale ma effettiva di cui l’Italia necessita. «Le varietà quasi familiari delli Stati nulla toglie alla coscienza nazionale»17 sostiene Cattaneo e aggiunge che il tempo, le idee, il commercio le innovazioni decise in comune finirebbero poi per ridurre le varie tradizioni municipalistiche. Se il Piemonte non avesse voluto in qualche maniera appropriarsi della riconquistata libertà della Lombardia e delle altre città italiane, avrebbe colto una vittoria molto più grande: il libero commercio con tutti i popoli italiani, la possibilità di vedere sviluppare le migliori forze delle varie parti d’Italia, l’assenza di nemici alle porte. Per Cattaneo, paradossalmente, il rispetto delle divisioni municipali avrebbe realizzato la vera unità nazionale portando al massimo livello la concordia e lo sviluppo delle potenzialità della penisola. La lettura di questa e di altre opere di Cattaneo risente oggi delle aspettative legate all’utilizzo parziale e pretestuoso di singoli brani del suo pensiero per scopi di mera speculazione politica. Certamente, nel merito, le argomentazioni portate dall’autore riguardo le possibilità di vittoria «autonome» del popolo italiano sono discutibili e risentono di una lettura non sufficientemente distaccata della situazione militare e diplomatica italiana ed europea. Tuttavia, una lettura disinteressata e attenta permette di cogliere aspetti originali ed interessanti per quanto riguarda l’analisi sulla natura del dominio austriaco in Italia, le origini dei movimenti popolari del 1848 ed i rapporti tra i regnanti dei vari Stati italiani. Se nelle Considerazioni l’idea federale è ancora 16 17 84 Ivi, p. 21. Ivi, p. 78. abbozzata, vi sono in realtà già presenti i tratti più originali cioè la preminenza della libertà delle comunità municipali sull’unità, la fiducia nella forza della nazionalità a prescindere dalla struttura unitaria dello Stato nonché la natura essenzialmente «progressista» di un’idea di società basata sulla permanenza di comunità locali autonome. Nel pensiero di Cattaneo queste comunità, garantendo un maggiore benessere degli abitanti, favoriscono un atteggiamento sereno, positivo e aperto verso l’esterno: è l’esatto contrario dell’idea, tanto in voga oggi, di comunità locali ciecamente schierate in un atteggiamento di timorosa chiusura nei confronti di un mondo che non sanno più interpretare. Giuseppe Mazzini, «Dei doveri dell’uomo» Marco Marzi A oltre centocinquant’anni dalla pubblicazione, sovviene naturale chiedersi se Dei doveri dell’uomo sia un testo ormai superato, da relegare agli studi storici, o la proposta politica contenuta al suo interno conservi ancora un valore nella società contemporanea. Innegabilmente, l’opera è figlia di un contesto politico-culturale, quello del Risorgimento, che si è oggi radicalmente modificato. Valori come l’indipendenza e l’unificazione nazionale, largamente presenti tra le sue pagine, non appartengono più al sentire comune di noi uomini occidentali del XXI secolo, abituati a vivere in un mondo che tende, da un lato, alla globalizzazione economica e culturale e, dall’altro, a un sempre più forte decentramento politico degli stati. Ma anche il lessico e i contenuti, così intrisi di fede patriottica da far sì che Mazzini venga ricordato come l’«apostolo dell’idea nazionale», rinviano a una società ancora caratterizzata da una forte presa sulle masse da parte di religioni e ideologie, difficilmente paragonabile all’attuale. Eppure, gli studiosi che si sono occupati di storia dell’influenza del pensiero mazziniano sono concordi nel sostenere che lo scritto in questione non abbia esaurito il proprio messaggio con il raggiungimento dell’Unità italiana, ma, al contrario, abbia goduto di una larga risonanza nel dibattito politicointellettuale dei secoli XIX e XX. La ragione di una simile longevità, raramente riscontrabile in altri classici del Risorgimento, emerge con chiarezza nel testo: i Doveri trattano una serie di argomenti che hanno continuato a destare interesse ben oltre il 1861; non si concentrano infatti esclusivamente sulla questione nazionale, pur dedicandovi un’elevata attenzione, ma toccano diversi temi – quali diritto, politica, economia, religione e questione sociale – nel tentativo di costruire un vero e proprio sistema filosofico. Negli ultimi anni dell’Italia liberale, in quelli del fascismo e del secondo dopoguerra si assiste quindi a un diffuso recupero del pensiero del patriota ge- 85 novese da parte di uomini, partiti e istituzioni politicamente eterogenei. Oltre che negli esponenti del partito repubblicano, richiami a Mazzini sono riscontrabili in socialisti come Geoge Sorel e Gaetano Salvemini, nazionalisti come Enrico Corradini, cattolici come Romolo Murri, fascisti come Giovanni Gentile e antifascisti come Carlo Rosselli. Le dottrine contenute nei Doveri hanno addirittura oltrepassato i confini dell’Europa, influenzando personalità di rilievo come Lev Tolstoj, Woodrow Wilson e Gandhi. Ma come emerge dai recenti studi di Simon Levis Sullam, che si è occupato di tale questione nell’opera L’apostolo a brandelli, il numero di coloro che hanno rivendicato un’eredità mazziniana è estremamente esteso e non si limita a questi nomi altisonanti. Questa circolazione tanto ampia e variegata si deve all’elevata complessità che contraddistingue l’ideologia mazziniana, caratterizzata da un continuo accostamento tra concetti apparentemente antitetici. Ciò emerge ripetutamente nei Doveri, al cui interno è possibile rinvenire, per fare qualche esempio: un nazionalismo che non nega né l’internazionalismo né forme di decentramento comunale; una fede religiosa che si accompagna a forti critiche in direzione delle istituzioni ecclesiastiche; un pensiero socioeconomico indiscutibilmente liberale ma allo stesso tempo anti-individualista; una concezione della libertà che ha la propria base nei doveri piuttosto che nei diritti. È dunque comprensibile come quest’opera, in seguito a una selezione arbitraria di alcune sue parti, si sia potuta conciliare a correnti di pensiero tanto diverse. Se una riproposizione integrale dei Doveri risulta assolutamente poco realistica all’alba del terzo millennio, nemmeno l’isolamento di alcuni concetti dal discorso complessivo può tuttavia rappresentare una strategia accettabile per rilanciare il pensiero di Mazzini. Adottando un simile approccio si rischia, infatti, di travisarne completamente il messaggio. L’unica via a mio parere percorribile consiste invece in una preliminare estrapolazione della sua filosofia di fondo, separandola dalla relativa concretizzazione pratica proposta dall’autore per il XIX secolo, e nella successiva applicazione della stessa all’attuale contesto politico-economico. Tale filosofia di fondo si può, con il rischio di incorrere in un’eccessiva semplificazione, così sintetizzare: all’umanità è stata assegnata una missione da Dio che consiste nel perseguimento del progresso; per raggiungere questo fine, essa deve rispettare una serie di doveri, riconducibili ai principi dell’educazione, della libertà e dell’associazione. È interessante osservare come, una volta individuata tale chiave di lettura, le apparenti contraddizioni incontrate acquistino immediatamente coerenza: considerando l’associazione in comunità ampie come uno strumento indispensabile per perseguire il progresso, la costruzione di uno Stato nazionale rappresenta evidentemente un traguardo nell’Italia frazionata della prima metà dell’Ottocento, ma allo stesso tempo non contrasta con forme di affratellamento più ampie; la sua fondazione non può inoltre andare a discapito di forme comunitarie minori, come il comune o la famiglia, perché esse hanno un ruolo fondamentale nell’educazione dell’uo- 86 mo; se si riconosce l’importanza di un impegno di tutto il popolo nella crescita morale e intellettuale collettiva, il miglioramento delle condizioni materiali della sua parte più povera è una battaglia indispensabile, ma questa non si può realizzare cancellando la proprietà privata, la quale agisce secondo l’autore da stimolo fondamentale per il progresso; se si individua nella fede religiosa uno strumento per spingere gli uomini a raggiungere importanti conquiste, questa non può tuttavia porsi gli stessi obiettivi predicati dalla Chiesa del XIX secolo; la priorità riservata ai doveri, infine, è imprescindibile perché l’umanità si impegni attivamente nei compiti che le sono stati affidati. L’ipotesi da dimostrare è quindi se, accettando il progresso della civiltà umana come tensione ideale che deve guidare l’azione degli uomini e delle loro istituzioni, gli strumenti e le regole individuate da Mazzini per perseguire tale finalità si possano considerare ancora utili nella realtà attuale. Personalmente, penso di sì. L’associazionismo, in primo luogo, è un valore che andrebbe riscoperto. Sul piano politico, Mazzini intese con questo termine l’aggregazione degli uomini in comunità più ampie possibili e, se si concentrò particolarmente sull’unificazione nazionale, fu perché questa rappresentava la prima tappa verso l’affratellamento dell’umanità intera. Rispetto al XIX secolo si sono fatti innegabilmente dei passi avanti in questa direzione con la costituzione di istituzioni sovranazionali, ma tali organismi presentano alcuni difetti non indifferenti: guidati da uomini non sempre direttamente eletti, tendono innanzitutto a non essere reale espressione della volontà popolare delle nazioni che vi aderiscono; troppo deboli rispetto ai singoli Stati, sono poi raramente in grado di imporre la propria supervisione sui rapporti internazionali. Occorre dunque impegnarsi ulteriormente perché queste realtà divengano più democratiche e ottengano una capacità d’intervento maggiormente incisiva sulle scelte di politica estera dei governi nazionali. Altrettanto auspicabile è la diffusione del principio dell’associazionismo in economia, il quale ha nei Doveri il significato dell’unità tra capitale e lavoro. In un mondo sempre più asservito a un mercato senza regole, in cui l’eccessivo livello raggiunto dalla finanza ha condotto a una crisi che è ancora lontana dal terminare i suoi effetti negativi, riportare il lavoro al centro della produzione della ricchezza avrebbe sicuramente il merito di condurre la nostra economia ipercompetitiva verso forme più solidaristiche e meno dannose per la collettività. Ancora valido è, in secondo luogo, l’accento posto sui doveri verso le comunità di appartenenza, la cui osservanza è innegabilmente un requisito del quale tutta la società contemporanea, e in particolare quella italiana, continua a essere carente. In un paese dove si parla spesso di legalità e si lamenta la scarsa diffusione di coscienza civica, la battaglia per il rispetto di un codice etico pubblico ha sicuramente ancora un senso. A questo principio è direttamente legato quello dell’educazione, strumento fondamentale per instillare 87 tali valori. Un’educazione che si differenzia dall’insegnamento professionale, definito da Mazzini con il termine «istruzione», e che necessita di un sistema gratuito e accessibile a tutti. Non è tuttavia difficile scorgere nell’Italia contemporanea un processo che si muove in direzione contraria alla realizzazione di un buon sistema educativo, originato dai pesanti tagli alla spesa pubblica nel settore della scuola e dal ruolo deleterio che vanno assumendo i mass media nella formazione dei giovani. Che tali principi siano condivi o no, è indubbio che i Doveri dell’uomo abbiano ancora qualcosa da dire ai giorni nostri, purché si accetti di scinderne l’afflato ideale dalla concretizzazione storica operata nel testo. Questa interpretazione, se non pretende di essere esente da critiche, è a mio parere l’unica in grado di strappare questo scritto dal confinamento negli studi di storia del pensiero politico a cui sembra destinato. Le mie prigioni di Silvio Pellico, oggi Michele Bellelli Uno degli eventi chiave del Risorgimento italiano fu la pubblicazione di un libro, Le mie prigioni, scritto da Silvio Pellico, un ex detenuto politico e carbonaro. Il volume vide la luce nel 1832 ed ebbe un immediato e inatteso successo di pubblico, sia in Italia che all’estero. Come è noto Le mie prigioni racconta l’esperienza dell’autore come detenuto nel carcere dello Spielberg. Situato nella città di Brno, nell’odierna Repubblica Ceca, era all’epoca la più importante prigione politica dell’impero austriaco. Ricordiamo brevemente alcuni fatti. Dopo la fine dell’era napoleonica il congresso di Vienna aveva imposto la restaurazione degli antichi regimi e l’abbattimento degli Stati e delle istituzioni nate con la rivoluzione francese. In Europa la Santa alleanza garantiva le principali nazioni contro eventuali ritorni di fiamma rivoluzionari e in Italia poterono ritornare sui loro troni i vecchi sovrani spodestati. Al fine di combattere la restaurazione nacque la Carboneria, una società segreta suddivisa in varie sezioni, note come vendite, che agiva in nome dell’ideale dell’unità italiana. La Carboneria è ricordata soprattutto per la sua partecipazione ai falliti moti del 1820-21 e del 1830-31, esattamente il decennio che raccoglie l’esperienza della detenzione dell’autore. Come si apprende dalla sua biografia, Silvio Pellico aderì ad una vendita carbonara (nota come Federati) su iniziativa di Pietro Maroncelli il 20 agosto 1820, per venire arrestato il 13 ottobre dello stesso anno. Il giudizio del tribunale austriaco è rapido e spietato: condanna a morte (applicabile per il solo fatto di essere iscritti alla Carboneria), commutata in 15 anni di carcere duro 88 da scontare nella fortezza morava dello Spielberg. Pellico e Maroncelli trascorreranno circa otto anni nel «peggior ergastolo» della monarchia asburgica, per poi ottenere, improvvisa, la grazia imperiale che consentì loro di ritornare in libertà, con la sola imposizione di non entrare mai più in territorio austriaco. Dopo la sua liberazione Pellico non partecipò più alla vita politica né pubblicamente, né in altre società segrete; nel 1832 diede alle stampe Le mie prigioni, il cui successo editoriale in tutta Europa fu di estrema importanza per la causa del Risorgimento, tanto da far dire, probabilmente allo stesso Metternich, che i ricordi di Pellico sono stati per l’Austria più dannosi di una battaglia perduta. Il successo dell’opera è riconducibile ad alcuni caratteri del quadro storico culturale dell’epoca: il momento politico con ancora viva l’eco dei moti del 1830-31, l’interesse per la materia religiosa tanto importante per l’autore, la diffusione della memorialistica. La qualità più evidente fu la pacata e lucida verità delle sue pagine, senza le amplificazioni letterarie, senza l’utilizzo di un tono eroico, tanto nel libro Le mie prigioni quanto nella vita privata del suo autore. Vale la pena ricordare il comportamento tenuto da Silvio Pellico nei confronti della politica e del processo negli anni successivi alla sua liberazione. Lontanissimo da quella che oggi si definisce giustizia-spettacolo, non parla mai del procedimento penale nei suoi confronti o degli interrogatori subiti se non per le sentenze che lo riguardano: la condanna a morte, la deportazione allo Spielberg e infine la grazia. Non c’è quasi traccia delle questioni politiche che hanno deciso il destino politico di Pellico e di altri. Della sua adesione ai Federati sappiamo grazie alla sua biografia e non c’è traccia di risentimento nei confronti di Pietro Maroncelli che pure fu il colpevole del loro arresto grazie ad un’ingenuità. Di lui anzi rimane una delle immagini più significative e commoventi del Risorgimento: la drammatica amputazione della gamba subita in prigione. Leggere le memorie di prigionia di un uomo incarcerato per le sue idee filoitaliane, condannato a morte, poi commutato in ergastolo, senza che avesse mai compiuto atti di violenza contro alcuno, semplicemente perché si opponeva alla dominazione di un impero al quale non sentiva di appartenere è stata un’esperienza significativa. Per affrontare questo impegno, oltre a Le mie prigioni ho riletto anche alcuni altri saggi, noti e meno noti, sulla storia del Risorgimento, una cosa necessaria per rinfrescare la memoria su quegli anni così lontani. Ne ho ricavato un piccolo compendio di vizi e virtù degli italiani, uguali allora come oggi, quasi. L’esperienza di Pellico rappresenta quelle virtù, anche civiche, di dedizione alla causa e di disobbedienza civile nei confronti di un sistema riconosciuto iniquo: non tradisce i compagni incarcerati per ottenere la libertà, come altri hanno fatto, accetta la condanna a morte con mansuetudine (è solo la grazia imperiale che gli evita l’esecuzione e poi lo rimette in libertà). 89 Il cancelliere Metternich, durante due suoi viaggi nella penisola fra il 1817 e il 1819, mise ben in rilievo invece i vizi degli abitanti della penisola che evidentemente confermavano ampiamente la sua fedeltà all’impero e alla restaurazione e a quella famosa definizione di espressione geografica data all’Italia. «L’italien crie beaucoup, mais il n’agit pas. On en trouve la preuve dans l’histoire des trente dernières années pendant lesquelles, malgrés toutes sortes de menées, il n’y a jamais eu en Italie de mouvemente révolutionaire dans le sens propre du mot… ». La ragione fondamentale di una simile rassicurante constatazione consisteva nell’estrema divisione, nello spezzettamento molecolare degli italiani, tanto al Nord quanto al Sud. «En Italie on se déteste de province à province, de ville à ville, de famille à famille, d’individu à individu»18. La rilettura non solo della principale opera di Silvio Pellico, ma anche di altri scritti sul e del Risorgimento, può servire a ri-conoscere, nel senso di conoscere di nuovo, uomini e fatti che spesse volte non abbiamo più affrontato dopo l’epoca degli studi obbligatori, dandoli forse per scontati e remoti. E forse è proprio questo il motivo principale per rinverdire queste letture, non tanto rinfocolare un nuovo spirito nazionalistico, nel senso novecentesco del termine, quindi di superiorità della propria nazione rispetto alle altre, quanto nel senso risorgimentale, inteso perciò come libertà e sovranità dei popoli affrancati dai tiranni. In un periodo della storia nazionale denso di crisi, di problemi e di egoismi personali e ideologici, ricordare che ci sono stati italiani di ogni regione che 150 anni fa hanno combattuto, hanno ucciso e sono morti per l’unificazione del nostro paese è di estrema importanza. Ogni città italiana, fino al più piccolo borgo, ha vie, piazze e scuole intitolate agli eroi del Risorgimento che lottarono contro la tirannia asburgica e contro i vari ducati e principati preunitari, veri e propri dinosauri sopravvissuti alla nascita delle moderne nazioni non già in virtù della loro forza e libertà, ma solo con la sottomissione alle baionette straniere. È importante ricordare a eventuali nostalgici di questi staterelli quanto essi siano stati economicamente e politicamente inutili grazie alla loro divisione e sottomissione all’Austria di Metternich e Radetzky (del quale oggi ricordiamo, e neanche tutti, solo la bella marcia di Strauss, composta per celebrare la vittoria militare austriaca nella prima guerra d’indipendenza) che servivano un potere per certi versi illuminato ed efficiente, ma che non esitava a sopprimere con la morte o la deportazione ogni minimo dissenso. Uno dei primi atti del governo provvisorio dell’Emilia e del comune di Reggio Emilia è stato quello di abolire le pene corporali ai detenuti che il duca d’Este aveva mantenuto in vigore insieme alla pena di morte eseguita anche a carico di sacerdoti (don Andreoli nel 1822)19. Storia d’Italia, volume 3, Dal primo settecento all’unità, Einaudi, Torino 1973, 1218-1222. Archivio storico del comune di Reggio Emilia, atti del Governo provvisorio dell’Emilia e verbali del consiglio comunale, anni 1860-1861. 18 19 90 I martiri di Belfiore, i fratelli Bandiera, i volontari del battaglione Toscano – studenti e docenti universitari – caduti a Curtatone e Montanara, la spedizione in Aspromonte, la presa di Roma, Custoza e Lissa, Solferino e San Martino, Marsala e Calatafimi, Cesare Battisti e Nazario Sauro, e la lista potrebbe continuare ancora a lungo. Uomini e donne di ogni estrazione sociale e provenienza geografica che scelsero di abbandonare le loro case per seguire l’ideale dell’unità italiana assumendosene i rischi in prima persona, compiendo un atto di profondo amore e altruismo verso il nostro popolo. E l’insegnamento finale di Silvio Pellico e degli altri eroi del Risorgimento può essere proprio questo: spiegare agli italiani di oggi una virtù che Metternich proprio non ci ascriverebbe: l’obbedienza civile, il rispetto per la più ampia comunità nazionale e internazionale e non solo per il proprio borgo, ottenuto cominciando a ricordare chi con le armi o con la penna lottò per fare l’Italia e gli italiani, agendo e non gridando. 91 Memorie Testimonianze Sassi Angelo detto Maramôt (1877-1947) Ricordo di un sovversivo Gianfranco Romani Mio nonno Angelo1 Angelo Sassi2 era considerato un pericoloso, un socialista sovversivo, aggettivo quest’ultimo molto in voga nel primo periodo fascista. E con il termine «pericoloso» era altrettanto considerato dal locale parroco don Nemesio Dazzi. Figuriamoci! Una modestissima persona, calzolaio di campagna, forse iscritto al circolo socialista. A Cavazzoli3 tutti conoscevano l’operosità, l’onest’uomo Maramôt (Maramotti) al calsulêr (calzolaio). Se qualcuno lo chiamava Sassi, quasi non si voltava! Il cognome aggiuntivo Maramotti lo seguì dalla natia San Pro- Angelo Sassi Maramotti Debbo riconoscenza a Vittorina Manghi Fontanesi, mia prima cugina, figlia unica di Evelina (cl. 1906), primogenita di Angelo. Solamente attraverso i suoi ricordi diretti e le preziose testimonianze rilasciategli dalla madre, ho potuto risalire a situazioni specifiche del periodo dei primi decenni del 1900. 2 Nel raccontare la vita di Angelo Sassi detto Maramotti è da evidenziare la difficoltà di rievocare episodi degli inizi del 1900 non riportando la parlata dialettale, il lessico genuino del nostro vernacolo, poiché all’epoca fra la gente semplice, è noto, si parlava unicamente in dialetto. Si rischierebbe di travisare il carattere, la natura dei nostri progenitori, una mancanza rispetto alla quale non mi sento di rinunciare: così alcune affermazioni, in seguito, le riporterò in dialetto contando di essere condiviso. Con l’occasione nomino qui con vero piacere, una citazione del prof. Luciano Serra, che mi onora della sua amicizia, nota persona di elevata cultura, saggista e poeta. «Il dialetto è realtà e storia, sacralità e scurrilità, bene e male, tradizione e adeguamento a ciò che muta. È un concreto vivaio di memorie, esplorarlo è specchiarsi nel tempo». Viaggi nel dialetto in «Reggio Storia» n. 123, p.16. 3 La zona suburbana di Cavazzoli (Reggio Emilia), prevalentemente agricola, contava ai primi del ’900, diversi proprietari terrieri e molti affittuari e\o mezzadri che lavoravano duramente la terra, ai limiti della sopravvivenza dati gli insufficienti utili che il «padrone» loro riservava e considerati i numerosi figli che le famiglie procreavano all’epoca. C’erano anche i casânt, a pigione, non molto numerosi, che stavano dando inizio ai mestieri artigiani e in seguito alla classe operaia. 1 93 spero, dato che il papà Luigi (cl. 1846) già lo portava; tale secondo cognome, ha avuto origini ignote nonostante mie ricerche. E a proposito di Luigi per una circostanza fortuita sono venuto in possesso di copia di un documento dei «Reggiani benemeriti del Risorgimento nazionale, campagna del 1866». Nello stralcio dell’elenco che pubblichiamo, al n. progressivo 1189, pagina 84, appare il padre di Angelo, Sassi Luigi di Francesco, già nominato Maramotti, all’epoca abitante a Coviolo. Adattando due facciate del documento in una, ho ritenuto utile riportare nella pagina seguente l’attestato, a testimonianza di un avvenimento storico che riporta eventi di soli cinque anni dopo l’avvenuta Unità d’Italia del 1861. Vi fu, infatti, il 24 giugno 1866, a Custoza, la seconda battaglia contro le forze austriache alla quale presero parte diverse centinaia di volontari reggiani alcuni dei quali compresi nell’elenco riportato (assolutamente parziale per brevità di spazio). Il documento scritto da Ettore Morini, inoltre riporta un godibile sonetto su Reggio, in terzina, di Vincenzo Monti. Altresì si possono godere la configurazione, i caratteri grafici, compreso un semplice, felice cartiglio, della scrittura dei primi del ’900. I primi elenchi dei volontari citati, furono anche diffusi il 14 maggio 1866 dal sindaco Pietro Manodori attraverso il giornale «L’Italia Centrale». Della prima spedizione fece parte, come detto, Sassi Luigi che compare nell’elenco al n. 874. Il nonno Angelo era nato nel 1877 a San Prospero, in un’isolata casa rurale nella profonda campagna ai confini con Sesso; il papà Luigi, classe 1846, era stato soldato per 11 anni, poi probabile bracciante. Della madre di Angelo nulla è conosciuto. Attorno al 1895, il nonno apprende il mestiere di scarparo attraverso un duro apprendistato presso un bravo calzolaio anziano, buon conoscente del padre Luigi, molto severo. Nel 1903 trasloca, assieme al padre, da San Prospero a Cavazzoli. Un anno dopo si sposa con la ventitrenne Giuseppina Levrini del luogo, che gli darà cinque figli fra gli anni 1906 e 1915. Dopo il secondo figlio, nel 1908, la Nina – diminutivo di Giuseppina come veniva da tutti chiamata – la’sera fâta mêl (si era fatta male), come si diceva allora, per tentare di nascondere un aborto. Il nonno, quando non era chiamato a giornata dai contadini, all’inizio della buona stagione, portava fuori di casa il banchetto da lavoro, posizionandolo vicino al muro della medesima. Di buon’ora s’infilava la tagliuzzata pettorina di cuoio e mentre martellava il cuoio, messo preventivamente a bagno, su una larga piciôrla (ciotolo piatto di fiume), al calsulêr, rispondeva al saluto con un cenno del capo, con giovialità, mentre canticchiava appena delle nenie incomprensibili, dando a esse il 4 «Reggio Storia» n. 129, p. 49. 95 Foto di famiglia di fine aprile 1915, Angelo, il papà Luigi, volontario nella campagna del Risorgimento del 1866, la moglie Giuseppina e i cinque figli ritmo dei colpi del martello, dato che non di rado teneva fra le labbra, se non in bocca, d’là smintèina (piccoli chiodi molto appuntiti), idonei per il tipo di lavoro che stava eseguendo, per atavica abitudine e praticità. 96 La guerra Il ritorno Angelo Sassi abitava con la famiglia in un lungo vecchio caseggiato chiamato via Galo (da un ameno caso avvenuto molto tempo addietro riguardante la proprietà di un gallo...), nel quale abitavano altre 14 famiglie. Il fabbricato, demolito circa 15 anni fa, è visibile nella fotografia a piè pagina ed era stato costruito con scarsi mezzi in due riprese alla fine del 1800 a neanche cento metri dalla chiesa di Cavazzoli. Era l’inizio dell’estate del ’18 quando tornò dalla guerra, dimagrito, con capelli cortissimi dato che al fronte pressoché tutti erano colpiti dai pidocchi. Fu quindi congedato diversi mesi prima della fine del conflitto. Si può ritenere che la ragione dell’anticipata fine ferma, possa essere dovuta ad una fortuita presa in esame dei documenti personali del fante Sassi. S’immagini la incontenibile emozione, la gioia della moglie Nina che per poco non svenne nel vedere, incredula, dopo oltre due anni di forti ansie, angosce, priva di notizie sulla sorte del proprio caro, la sua figura avanzare con passo esausto nel cortile, improvvisamente: per un attimo le parve un fantasma! Nel disorientamento della commossa circostanza, papà Angelo, divisa Il caseggiato dove abitava Angelo e chi scrive fino al 1955 (foto in inverno ripresa dal fondo) detta via «Galo» 97 indosso, riuscì ad abbracciare e baciare goffamente, stranito e concitato, oltre alla Nina, solamente i primi due figli di 11 e 12 anni, mentre l’ultimo figlio Giacomo di tre anni, spaventato, corse in braccio alla madre. Le altre due sorelline, Carola e Virginia, ritrose all’abbraccio del padre, uomo per loro sconosciuto, smarrite, corsero anch’esse verso la madre. Invano la Nina, con voce singhiozzante, quasi gridava, stridula: «è vostro padre, è vostro padre!». Rientrarono tutti in casa: Angelo si guardò attorno col batticuore e alzò la testa dato che il soffitto gli appariva più basso. Chiese alla moglie del mastello grande e dov’erano i suoi attrezzi da calzolaio. Subentrò lentamente un’aria gioiosa, anche i bambini, che non toglievano gli occhi di dosso all’uomo nuovo giunto nella loro casa, tendevano pian piano ad avvicinarsi. Alla sera, in un momento successivo, moglie e marito soli, ritrovarono la loro intimità dopo il lungo tempo trascorso. Nella commovente circostanza Angelo pianse sommessamente quando chiese alla Nina delle ultime ore del proprio padre Luigi, deceduto nell’agosto di due anni prima: annuiva al racconto, spesso ingoiando, per il nodo in gola che lo aveva preso; a bassa voce Nina disse: «Gli ultimi giorni non parlava quasi più, poverino, ma aveva un’espressione serena e negli ultimi momenti sentìi appena un farfugliare, avvicinai la lucerna e vidi un piccolo movimento delle labbra, poi si spense». Dopo qualche giorno si sparse la voce del ritorno di Maramôt al calsulèr e iniziarono le richieste della sua opera da parte delle famiglie contadine. Al mattino presto, come d’abitudine, metteva fuori nel cortile davanti a casa il banchetto di lavoro. La benedizione pasquale Era il periodo prossimo alla Pasqua e il nuovo parroco don Augusto Pagliarini, come consuetudine, visitava le case per impartire la benedizione pasquale5. Quel mattino avanzava nel cortile del caseggiato dove abitava Angelo, accompagnato da un chierichetto, salutando con un cenno del capo chi era presente. Il nonno era intento al suo lavoro, ma vedendo le altre persone che guardavano in direzione della strada, alzò la testa. Appena vide la tonaca nera gli si coprirono gli occhi! Scattò in piedi, si tolse la pettorina di cuoio e in un baleno, brandendo un affilato trincetto, si diresse rapido in direzione dello sbalordito parroco e gridò: «Bròta panarasa, scapa via set’vo mìa che’t’còra!»6 (brutto Il precedente, don Nemesio Battista Dazzi morì il 17 aprile 1918 a soli 43 anni con cristiana rassegnazione. 6 Il termine che’t’cora veniva usato in occasione dell’uccisione del maiale. Frase forte, ma si sa in quei tempi non si andava tanto per il sottile. 5 98 scarafaggio, vattene via se non vuoi che ti trapassi il cuore!). L’ignaro parroco sbalordito, si arrestò spaventato: indietreggiò, poi girandosi si mise a correre verso la strada tenendo alzato l’abito talare. Don Nemesio Dazzi e la sua annotazione. «Maramotti» al fronte La ragione del forte intervento del nonno era maturata nei quasi tre anni di sofferenze, di rischio della vita al fronte e dalle tragiche condizioni che la famiglia subì. Angelo aveva la convinzione, poi rivelatasi esatta comprovata nei fatti, che il defunto don Dazzi fosse stato il diretto responsabile della situazione citata. Era stata celebrata una crudele ingiustizia! Le non comuni circostanze sopracitate avevano avuto il determinante incisivo antefatto che segue. Dobbiamo risalire a circa tre anni prima, quando nella primavera del 1915, giunse a Angelo Sassi la cartolina di presentazione al Distretto militare. Con sgomento e rabbia, considerato che oltretutto aveva 38 anni, si presentò per capire, dato che da qualcuno gli fu detto che la sua condizione famigliare gli poteva di certo evitare l’arruolamento. Il carabiniere graduato lo ascoltò senza batter ciglio, rigidissimo, ignorò le ragioni dell’arruolando, timbrò e firmò un foglio e allungandolo disse con tono perentorio: «con questo, entro tre giorni devi presentarti al comando di reggimento di Verona; vale anche per treno». Angelo voleva ribattere le sue ragioni; iniziò a dire qualcosa ma si rese conto di avere davanti un sordo. Costernato, girò i tacchi mentre sentiva crescere dentro di sé il gelo nel sangue. Giunto a casa, cercando di nascondere lo sconforto, non disse niente alla moglie: gli diede la busta sforzandosi ad un gesto normale. La Nina capì ma non parlò. S’intendeva il dolore che l’attanagliava, l’espressione del viso, il camminare, i gesti diversi. Il fante Sassi Angelo doveva partire per il fronte! Al comando di reggimento a Verona, venne condotto, dopo avere percorso vari corridoi, nell’ufficio di un maresciallo dei carabinieri. Il sottufficiale addetto lesse due volte i documenti del Sassi; poi alzando la testa disse con un certo tono: «Ma tu non dovresti essere qui!». E chiamò un incaricato. Angelo chiese sbigottito delle spiegazioni. Il maresciallo riaprì la cartella e fu in quel momento che Angelo si sentì dire: «Qui c’è una annotazione del parroco del tuo paese, vistata dai colleghi di Reggio Emilia. Ora come ora non si può fare niente!». Sull’improprio reclutamento del Sassi si può ritenere che il rigoroso legale disciplinare militare, nel caso Angelo Sassi militare 99 in esame, non venne applicato! Credo si possa constatare che il potente, organizzato ordinamento clericale, ebbe il sopravvento sulle leggi e regolamenti militari. Era evidentemente importante colpire l’uomo di idee socialiste e anticlericali. L’unico avvenimento ricordato dal nonno dei tanti mesi pericolosamente trascorsi al fronte, raccontatomi dalla figlia Evelina, fu la tragica circostanza avvenuta nel corso della ritirata di Caporetto. Era la fine di ottobre del ’17 e le truppe in rotta stavano riattraversando l’Isonzo in quel periodo in forte piena. Occasione fortunosa volle che, alla maggioranza della fanteria, si unirono sciolti reparti di cavalleria. Angelo, come i tanti commilitoni che, in preda a forte agitazione si assiepavano per l’attraversamento del fiume, era già in serie difficoltà per l’orgasmo collettivo procurato dalla paura del nemico alle spalle, dalla fame e dalla stanchezza delle marce dei giorni addietro. La corrente del fiume aumentava man mano che ci si avvicinava al centro del letto, quando, al limite delle forze, con l’acqua al petto, le passò radente sul fianco destro un collega della cavalleria che incitava a gran voce un robusto cavallo. Angelo, con l’energia rimastagli, riuscì ad afferrarne seppure con difficoltà la coda; l’animale lo trainò, sferzato energicamente dal collega della cavalleria. Fu la salvezza! Primavera del ’15. La moglie a casa, Maramotti in guerra Dopo la partenza del marito la nonna Nina (Giuseppina) si trovò ad affrontare una situazione preoccupante, pesantissima, come è facile immaginare. L’aiutava Lavinia, una vicina di casa mossa da bontà e compassione. In grande difficoltà la Nina si rivolse al fratello Adelmo che abitava fortunatamente vicino. Questi già all’arrivo della cartolina precetto al cognato Angelo pensò ad un errore; era certo dell’esonero data la famiglia a carico. Quando la sorella gli disse che il marito era stato arruolato, ebbe come un forte colpo allo stomaco. Da persona responsabile qual era, sentì il peso di una grande preoccupazione. All’incontro i due fratelli si abbracciarono piangendo; il nodo in gola rendeva difficili le parole. Dopo un penoso silenzio Adelmo disse: «Stai su Nina! vedrai che qualcosa faremo». Nei giorni seguenti andò spesso a trovarla incoraggiandola, intrattenendosi coi bambini e facendo compagnia al bisnonno Luigi: poveretto, faceva una gran pena, seduto immobile in un angolo della cucina, agli acciacchi dell’età univa la preoccupazione del figlio in guerra; con in mano il bastone d’appoggio, lo rigirava battendolo a terra ogni tanto, guardando fisso il pavimento poi alzando lo sguardo diceva qualche parola di lieve rimprovero ai pronipoti, allorché si accendeva fra loro una scaramuccia. I giorni passavano fra le difficoltà, con i figli che spesso bisticciavano non obbedendo alla sorella maggiore Evelina, già molto matura per i suoi dieci 100 anni, incaricata dalla mamma di accudire i fratelli. Era ancora estate quando Adelmo parlò alla sorella di una cosa alla quale da un po’ di tempo pensava: fare una domanda in Comune per un posto di bidella anche approfittando del fatto che le scuole, costitute da due modeste stanze adattate in aule, erano parte del caseggiato dove la Nina abitava. Essa acconsentì ma poco credendo al buon risultato, oppressa com’era. Il fratello, infermiere professionale e fra i primi volontari della Croce Verde, era uomo conosciuto e benvoluto da molti, anche per il forte positivo carattere. Andò in Comune facendo presente all’impiegato, lo stato di estrema indigenza della famiglia della sorella, dopo la incredibile partenza per la guerra del marito, unico sostentamento. Parlò accoratamente al sorpreso funzionario che tutto scrisse su un modulo promettendo un fattivo interessamento e dicendo: «Ripassi fra dieci giorni». Puntuale Adelmo si presentò e capì subito dall’espressione dell’uomo la risposta positiva! Disse: «La Levrini Sassi Giuseppina è stata accettata e può iniziare il lavoro subito, all’inizio delle lezioni ai primi di settembre» e allungò un foglio dell’ufficio del Personale del Comune. Adelmo raggiante, si precipitò a casa della sorella con la busta in mano: la Nina capì, abbracciò il fratello e pianse mentre il nodo in gola gli impediva di ringraziare come avrebbe voluto. Si seppe, poi, che il Comune si rivolse al Distretto militare per informazioni e avere conferma delle condizioni disagiate della famiglia. Il ruolo comprendeva anche la refezione a mezzogiorno consistente in una scodella di minestra agli scolari, una lista di massima per l’approvvigionamento settimanale delle derrate e fornitura delle stoviglie. La nonna iniziò così il nuovo lavoro con impegno ma non poteva certo togliersi la preoccupazione del marito in guerra, priva di notizie com’era. Chiedeva alle maestre come andava il conflitto e al fratello che riportava quanto pubblicavano i giornali. Alla preparazione della minestra l’aiutava la figlia maggiore lavando le stoviglie e pulendo le verdure assieme alla vicina di casa, anima buona religiosa praticante. La Nina era attenta ad aggiungere qualche mestolo in più per i propri figli e nei mesi invernali qualche pezzo di legna della scuola, finiva nella cucina di casa. Le pur piccole trasgressioni non erano compiute a cuor leggero, procuravano un disagio all’onesta Nina: ma la spinta veniva dalla fame, dal bisogno. Fu per lei un periodo di grandi sacrifici, sottoposta a giornate di durissimo lavoro fra la scuola, la casa, i cinque figli e lo suocero anziano. Loro crescevano ed erano sempre più preoccupazioni, ansie, ristrettezze. Ogni momento era buono per una baruffa. Una disperazione! I poveri indumenti dei più grandicelli, «passavano» ai fratelli più piccoli; esisteva allora una specie di tunichetta senza maniche, di panno recuperato e cucito in casa che almeno permetteva una certa facilitazione alla preoccupata madre; magra, occhi fondi, fazzoletto scuro sempre in testa, portava avanti con tenacia, lottando, la sua lunga 101 giornata. Alla sera, sfinita dalla fatica e dal sonno, non vedeva il momento di coricarsi! Nei mesi invernali occorreva, per tempo, accendere le stufe nelle due aule. Pensare, oggi, ad una donna, già provata, che al freddo si doveva alzare attorno alle 6, facendo piano per non svegliare i figli piccoli, prendere al buio i fulminant (fiammiferi di legno), accendere la lucerna e stringere in vita il grembiule nel quale metteva un carico di legna per avviare il fuoco nelle stufe; la sera precedente, poco prima di coricarsi, predisponeva nei due focolai, una misurata quantità di stlèin (legnetti) preparati dal nonno Luigi con una piccola accetta, adatti ad avviare il fuoco. Le maestre, comprensive, chiudevano un occhio se i banchi non erano sempre spolverati e qualche calamaio non era pieno d’inchiostro. Un momento di piccola gioia, la Nina lo provava quando il fratello, a fine mese, le consegnava la busta del modesto stipendio, ritirata con delega all’Esattoria del Comune. La cena, molto spesso, era costituita da zuppe di latte e mele cotte: i due figli piccoli e il nonno Luigi erano accomunati dai pochi denti. Al momento di andare a letto, occorreva una specie di adunata per lavare i figli: il solito mastello grande in mezzo alla cucina. Poi tutti al piano superiore. Le tre femminucce erano state poste in un letto unico. Carola, mia madre, nel ’16 aveva sette anni. Gli altri due figli maschi, Gino e Giacomo avevano una camera accanto. In un tristissimo giorno dell’agosto del ’16, venne a mancare il padre di Angelo, Luigi, all’età di 68 anni. Fu di grande aiuto il fratello della Nina, occupandosi delle esequie avendo esperienza specifica delle circostanze e partecipando a spese senza nulla dire; sollevò così la poveretta dalle incombenze del funerale che l’avrebbe ulteriormente afflitta. In quei giorni Nina aveva sempre in testa Angelo! Si chiedeva: come stava? Era ferito? Era vivo? Chiese ad Adelmo se c’era modo di trasmettergli la ferale notizia; esso subito si recò al Distretto militare – unico modo di contatto – con il certificato di morte di Sassi Luigi chiedendo che fosse trasmesso al figlio, attraverso idonei organi di comando. Venne promesso interessamento, ma aggiunsero anche che, proprio nel periodo in essere, al fronte si stavano per compiere grandi offensive sul Carso triestino. Infatti, non pervenne alla moglie del fante Sassi Angelo risposta alcuna, anche nei lunghi mesi a seguire. A giurnêda (una giornata di lavoro dal contadino). Angelo al scarpulèin Com’era in uso in quegli anni, le famiglie contadine accumulavano le scarpe da riparare all’incirca nel corso di una annata, in attesa del convenuto arrivo del calzolaio (al scarpulèin). Allo scopo esisteva quasi sempre, nella posta 102 vuota in fondo alla stalla, un banchetto a gambe corte idoneo all’uso, costruito dal più abile dei figli a manovrare arnesi per i più modesti lavori da falegname. Angelo arrivava al mattino presto con il grosso fagotto legato al manubrio della bicicletta che conteneva i’usvej, (gli arnesi del mestiere) esclusi gli affilati trincetti riposti in una custodia di spesso cuoio realizzata dal medesimo, legata al collo e pendente sotto un’ascella. Ben accolto dal padre anziano – al’resdòr (reggitore) – dopo un buon bicchiere di lambrusco, accompagnato nella stalla dove al centro già c’era il banchett; veniva quasi circondato da ogni genere di scarpe, scarponi per i campi e sandali. Con occhio e mani esperte, il nonno metteva da parte le calzature irriparabili (dato che gli veniva portato di tutto), non senza qualche scuotimento di testa di disapprovazione del padrone di casa, seduto un po’ distante. Le mucche giravano la testa verso il nuovo venuto sgranando ancor di più gli occhi e menando la coda. Per i bambini era un po’ una festa, un diversivo e attorniavano il banchetto incuriositi non senza ricevere qualche velato rimbrotto dal calzolaio, avvicinandosi troppo; a volte era necessaria una leggera gomitata al più vicino, quando, chi lavorava arrotolava lo spago con la pece e nel tenderlo gli sfuggiva la presa, ad arte, per delicatamente colpire. Le donne della famiglia erano attente al tempo nel quale gli uomini erano nei campi: provavano una sorta di atavica vergogna nel dare le loro scarpe «della festa» per riparazioni; solitamente chiedevano almeno i sovertâch (sopratacchi). E se il calzolaio diceva loro con garbo che certe scarpe erano mìa piò bòuni (non riparabili) il viso della donna si incupiva, pensando che poi doveva chiedere il permesso al marito per comprarne delle nuove. Prima di ritornare a casa e quando si poteva, con la benevolenza della resdòra come altre volte aveva fatto, il nonno veniva garbatamente chiamato in cucina, ricevendo dalla indulgente donna parti di cibo rimasti dal pranzo, messi nella madia allo scopo. Non senza un certo imbarazzo, Angelo si presentava, con il sacchetto di tela bianca con cordicella di chiusura, sempre ben lavato; sacchetto che la moglie Nina riponeva sempre in fondo al fagotto degli arnesi in un angolo protetto, sperando di trovarlo gonfio al ritorno del marito. Essa, accorta, all’arrivo del marito, apriva il fagotto prelevando il sacchetto in modo da non farsi vedere ed era sollevata quando, tastandolo ne captava il contenuto. Alla cena, univa il cibo donato al proprio, cercando di confonderlo nella preparazione dei piatti. I figli non dovevano sapere che parte del mangiare era forestiero, anche se la più grande, a tavola, guardava la madre in un certo modo, mentre rigirava inusuali pezzi di carne nel piatto. La quotidiana preoccupazione di sfamare tante bocche: la carestia assillava la Nina che si trovava a sostenere la dura condizione con sacrifici, ma sempre con dignità. Solamente dall’inizio del ’22, arrivò in casa un modesto aiuto finanziario dalla figlia Evelina, riuscendo essa a trovare un lavoro presso il calzificio in 103 Gardenia7 che poi divenne il più noto Bloch. Percorreva a piedi, con i suoi 16 anni, la strada da casa al posto di lavoro e ritorno. 1924. L’agguato dei fascisti Un giorno di inizio primavera del ’24, Angelo venne chiamato a giurnêda dalle sorelle Montanari. La loro bella casa era ubicata appena all’inizio della strada per Roncocesi. Un confinante, tale Gambini, saputo dell’arrivo del calsulêr, portò diverse scarpe da riparare alle vicine. Le due sorelle, nubili e benestanti, a Cavazzoli venivano chiamate al putèli ed Fréra (le bambine del fabbro) da un predecessore di famiglia fabbroferraio. Abitò nella casa per molti anni, anche il fratello ingegnere Dante, che divenne presidente della Provincia di Reggio Emilia dal 1951 al ’64. Il nonno all’opera dal mattino presto, verso sera era stanco ma con volontà si impegnò per finire i lavori; giunta l’ora di cena, la sorella maggiore Artemisia insistette con Angelo affinché restasse. Non avendo preavvisato la moglie, esso sapeva che si preoccupava se non lo vedeva tornare all’ora consueta; ma accettò per non essere scortese. Finita in modo rapido la cena, Maramôt – così era quasi sempre chiamato – ringraziò, mise gli arnesi nel solito robusto fagotto alla svelta e salutò con cordialità. Dopo avere annodato l’involto al manubrio della bicicletta, la inforcò dirigendosi con decise pedalate verso casa. Non aveva percorso neanche trecento metri quando, nel buio, al poco riflesso procurato dalla strada bianca intravide una persona, appena al di là del ciglio, in atteggiamento strano come se stesse facendo i suoi bisogni. Angelo rallentò, poi si fermò pensando che l’uomo potesse avere necessità di aiuto; dette una voce, ma non avendo ricevuta risposta scese dalla bicicletta e si avvicinò per capire la curiosa situazione e fu in quel momento che avvertì alle spalle la presenza di persone. Era un’esca! Fu un attimo. L’uomo chinato si alzò di scatto avendo il viso mezzo coperto, si avvicinò brandendo la mani in avanti mentre da dietro il nonno sentì delle braccia che lo bloccavano. Cadde la bicicletta, anche per il peso degli arnesi e andò a terra anche il nonno per il forte spintone ricevuto. Preso alla sprovvista, sbalordito, udì una voce concitata che diceva: «Dai, dai, clèe lò» (dai, dai che è lui). Nel tumulto, ricevette un calcio alla pancia, due pugni in testa mentre cercava di difendersi, sbraitando e bestemmiando: piovvero botte da tutte le parti mentre uno degli aguzzini continuava a ripetere: «dai, dai!». Angelo trattenuto a terra oramai mezza stordito, fu poi colpito da un più brutale colpo che si abbattè violentemente sul viso. Gli aggressori finirono 7 Quartiere nord di Reggio Emilia. 104 tirandogli un calcio allo stomaco. Dopo diversi minuti a terra, sanguinante, mio nonno, impolverato e disorientato, allungando faticosamente un braccio, tastò nel ghiaietto della strada, al buio, con la vista annebbiata, per cercare la bicicletta e i preziosi arnesi sparsi tutt’attorno. Respirava con grande affanno. Si drizzò lentamente su un fianco. Sentiva male alla bocca e a un orecchio. Con le mani impolverate si toccò le labbra insanguinate e, con la testa che gli girava, si guardò attorno nel totale silenzio dei campi che attorniavano la strada. Cercò in tasca il fazzoletto per tamponarsi il labbro che continuava a sanguinare. Nella testa confusa, però, chiaro era il tono dell’unica voce distintamente udita all’inizio dell’agguato, era la medesima voce sentita alcune settimane prima alla sede del fascio. Già aveva pensato che gli assalitori non potevano che essere dei fascisti. Raccolti gli arnesi, legato il fagotto al manubrio della bicicletta si accorse che la ruota era contorta e così, imprecando, si avviò a piedi per tornare a casa, distante oltre un chilometro, con una mano sul manubrio mentre con l’altra teneva premuto il fazzoletto sulla ferita. Sotto casa, confuso e sofferente, chiamò la moglie a bassa voce. La Nina, già preoccupata per l’inconsueto ritardo, uscì rapida nel cortile intuendo che qualcosa di serio era accaduto, giacché il marito non era aduso chiamarla. E allarmata, lo vide: giacca rotta, sporco e imbiancato dalla polvere e col fazzoletto in mano intriso di sangue. Si impressionò mentre gli si avvicinava; con voce flebile, anche per non farsi udire dai figli, lo fissava incredula alla incerta luce del cortile: «Pover Nìin, s’tani fât ?» (Povero Angelo, cosa ti hanno fatto?). Con tono forzato per rassicurarla, rispose: «Gnìnto, gnìnto, stêr mìa mêl; manda Gino a ciamêr to fradèll, gò al làber cal’sângua» (Niente, niente, non stare male; manda Gino a chiamare tuo fratello, ho il labbro che sanguina). Il figlio diciassettenne si precipitò dallo zio Adelmo che fortunatamente non era di turno in ospedale. Subito giunto, l’infermiere, ad una luce, guardò il labbro e vedendo un taglio profondo con gonfiore alla gengiva, praticò una sommaria medicazione; poi indusse il cognato, recalcitrante, a salire sulla canna della propria bicicletta per andare al Pronto soccorso, dato che il labbro superiore era proprio spaccato, ma non lo disse ad Angelo per non impressionarlo. Il medico di turno, che conosceva bene il Levrini il quale collaborò all’intervento, dovette praticare diversi punti di sutura al labbro, medicare l’orecchio contuso e un livido che aveva allo stomaco. Tornarono oltre mezzanotte, trovando la Nina8 seduta, con la testa chinata sulle braccia, appoggiata al tavolo di cucina, pressoché addormentata. E così l’antifascista «sovversivo» Sassi Angelo detto Maramôt, aveva ricevuto un’altra «lezione» dai solerti picchiatori fascisti. A «ricordo», portò fino alla fine dei suoi giorni la cicatrice sul labbro, in parte coperta dai baffi9. 8 9 Nel ambito famigliare il nonno veniva chiamato Nììn e la nonna Nina. Testimonianza della figlia primogenita Evelina. 105 La cooperativa di Cavazzoli La «Giustizia» del 4 luglio 1909 racconta dell’inaugurazione della cooperativa a Cavazzoli10. Era così divenuta realtà il tanto atteso luogo aperto ad incontri, oggetto da tempo di accorata speranza sui posti di lavoro e nei campi. Finalmente ci si poteva trovare in compagnia, in un luogo amico, bere un bicchiere, fare una partita a carte. Il nonno Angelo ne divenne un assiduo frequentatore. Dopo una settimana di intenso lavoro, fatiche e preoccupazioni, alla domenica, nel primo pomeriggio, ci si incontrava: era diventato un appuntamento tacito, unico svago atteso dalla classe operaia e contadina. Nell’unico stanzone, con il banco di mescita sul fondo, arrivavano gli avventori e dopo i primi saluti, le sedie attorno ai tavoli venivano occupate. L’ambiente si apprestava a riempirsi di odori e di fumo, mentre cominciavano ad arrivare bottiglie di lambrusco, le carte e la lavagnetta col gessetto per segnare i raggi delle partite a briscola; alla fine di ogni gioco, un calloso dito di un giocatore appena intinto nel fondo di un bicchiere, avrebbe cancellato i segni. Verso la metà del pomeriggio, giungevano vassoi colmi di buon erbazzone. All’approssimarsi dell’ora di cena le discussioni si alzavano di tono, gli animi si scaldavano con la complicità dei bicchieri vuotati: usciva, inevitabile, l’allusione che rivelava, con tono smorzato ma grave, lo sfogo represso, le privazioni che il regime fascista pesantemente imponeva. Si liberava la coscienza, spinta da una lieve esaltazione liberatoria e le parole fluivano alle labbra, mescolandosi, ma udendosi, nel pur rumoroso ambiente. Le finestre del locale, prive di tende, al piano terreno, davano su un fianco del fabbricato e così era agevole l’avvicinarsi alle medesime, col favore dell’imminente scuro della sera. Un piccolo gerarca fascista capo settore, sguinzagliava un suo galoppino del posto che conosceva le persone, all’orario opportuno, il quale approssimandosi di soppiatto, vedeva e udiva. Nel giro di poco più di un’ora, arrivava una grossa auto nera dalla quale uscivano alcune camicie nere che facevano irruzione nell’esercizio. Nel silenzio che sul momento si era creato, si udì una voce arrogante: «che nessuno si muova!». Due uomini, scostando i tavoli, si diressero verso le persone segnalate, «colpevoli» di avere pronunciato frasi antifasciste. Il capo della squadra, che pareva armato da come teneva le mani all’altezza del cinturone, era fermo a gambe aperte davanti alla porta. Dal fondo si potevano udire mugugni repressi. Gli «invitati» ad uscire, di norma non più di due o tre, presi con forza sottobraccio, erano poi spinti nell’auto con destinazione la sede del fascio di via Trattasi del fabbricato ancora oggi esistente, il secondo dopo casa Campioli in direzione nord, prospiciente il centro del borgo, attualmente di proprietà Tirelli. 10 106 Dalmazia; diverse volte, dei «sovversivi» prelevati, faceva parte il nonno Angelo, ben conosciuto dai fascisti. La cerimonia era nota: il renitente, fatto sedere al cospetto del gerarca, avendo esso alla spalle due «collaboratori», veniva investito da una dura reprimenda, seguita dalla richiesta di iscrizione al partito e seguente elogio della politica del regime, con un finale «saluto al Duce!». Chi come Angelo, non rispondeva al saluto e non accettava l’iscrizione, subiva la consueta «cerimonia» del manganello e dell’olio di ricino, accompagnata da pesanti improperi. Il nonno era coriaceo, duro: la sua dignità, in quelle drammatiche circostanze, lo faceva soffrire ben di più delle botte e dei ripetuti insulti ricevuti. Ma tornando alla cooperativa, cito l’episodio di un aderente al circolo socialista, in possesso di una piccola effige di Prampolini. L’uomo convinse il banconiere ad infilare, in mezzo ad un ritaglio di giornale, fra il muro ed il pesante bancone, la piccola riproduzione, come presenza di fede politica, beneaugurante, del locale. Quando il promotore della nascosta iniziativa, tarchiato, di bassa statura, di mestiere carrettiere, si portava al banco per un bicchiere, attento, schizzava appena l’occhio dalla parte del muro, dicendo piano: «Dài, dòm da bèver a Camèl!» (Dai, diamo da bere a Camillo!). Ammiccando una intesa col banconiere, se ne andava con aria appagata11. Dopo molti anni, un giorno, durante una visita alla cugina Vittorina, ottenni di poter curiosare (volevo scrivere snasuplér, – bello! – mettere il naso) in una vecchia scatola da sempre riposta in un cassetto del buffet, (così veniva chiamato il modesto mobile il cui nome evidenzia radici francesi), posto nella «sala» e tramandatagli dalla madre: una specie di cofanetto di lamierino con coperchio, ornato con gioiose figure di fanciulle danzanti, in gran parte scolorite, conservato negli anni gelosamente. Aprendolo mi sembrò di sentire l’odore del passato fuoriuscire: vecchi bottoni, un ditale per cucire, una busta sgualcita contenente vecchie foto, carabattole varie e alcuni ritagli disordinati di giornali; fra uno di questi, vidi, con mia grande stupore un cartoncino piegato in due che, apertolo, mostrò una ingiallita immagine di Prampolini con cappello, impressa in evidenti caratteri di stampa dei primi del ’900. Subito, mentalmente, collegai l’immagine con il nonno Angelo: Prampolini ha sempre rappresentato per lui, come per tanti, un forte ideale, un orientamento preciso di fede politica. Tornando alla circostanza dell’effige dietro al bancone della cooperativa, noto a pochissimi12, si deduce che evidentemente anche il nonno era in possesso di una copia della stessa immagine, che negli anni finì nel vecchio cofanetto di famiglia e lì conservato nel tempo. 11 12 Testimonianza della zia Evelina. Testimonianza di Angelo alla figlia Evelina. 107 Certo nel primo decennio del secolo non potevano esserci riproduzioni diverse, dato anche il rischio che la detenzione del cartoncino poteva comportare. Una ulteriore prova della identicità della figura, la ebbi circa un anno fa allorché fra le mie carte, mentre cercavo altro, spuntò una copia simile, con aggiunta una particolare scritta, vergata con mano decisa. Felicemente sorpreso, nel rigirare il cartoncino fra le dita, pensavo alla sua provenienza e vagliando mentalmente alcune possibilità, penso di essere giunto alla esatta conclusione. L’inciso è di mano di Ondina, sorella di Paolo Davoli, come rilevabile dalla riproduzione sotto riportata13. «questa foto la trovai nascosta nella biancheria di mio padre Diego Davoli, Ondina sorella del martire Paolo Davoli» La figlia di Angelo, Evelina, si sposò nel ’28 con Manghi Arnaldo ed ebbero unica figlia Vittorina. Lo zio Arnaldo di professione falegname, lavorò per molti anni presso l’autocarrozzeria A. Gallingani; il titolare sposò Ondina Davoli; lo zio mantenne con la medesima amichevoli rapporti: i due si conoscevano bene fin da bambini, a Cavazzoli, da dove proveniva anche Artemio Gallingani. In virtù di tale legame, sicuramente Ondina diede copia dell’immagine con la propria scritta, allo zio Arnaldo, deceduto nel 1998; il medesimo la trasmise a chi scrive, sapendo del mio interesse per la storia, ahimè, meno vivo di oggi negli anni addietro. La versione, come detto, è arricchita da una testimonianza resa con la calligrafia peculiare della scrittura elementare femminile del primo decennio del 1900. Trovo opportuno ricordare qui, con memoria riconoscente, l’antifascista Diego Davoli nato attorno al 1870, padre di Paolo, Ondina e Giuseppe (chiamato Peppo) considerati gli anni travagliati in cui visse. Uomo di poche parole, di mestiere perforatore di pozzi, lavoro all’epoca molto faticoso data la totale manualità del medesimo e deceduto a soli 14 giorni dopo la morte di Paolo, fucilato assieme ad altri nove compagni il 28 febbraio ’45. L’eroe della fede antifascista Paolo Davoli, nato a Cavazzoli nel 1900, amico fraterno del futuro sindaco Cesare Campioli, è figura ben nota della storiografia locale del periodo della Resistenza. 13 108 Le due sorelle Delle sere inoltrate della domenica nelle quali Angelo non faceva ritorno a casa all’orario più o meno consueto, la moglie Nina già conosceva il triste motivo. Le due figlie maggiori Evelina e Carola lo intuivano e dopo un breve cenno d’intesa con la madre, con determinazione e tanto coraggio, si avviavano a: «andòm a tôr al papà» (andiamo a prendere il papà). Uscire di sera nel buio della strada, camminare guardinghe e tese nel totale silenzio, attente ad ogni rumore che non fosse quello prodotto dai propri passi, dava indubbiamente alle due giovanissime ragazze una profonda ansia e timore. L’età, 18 anni l’una e 15 l’altra; erano, nel camminare, quasi sempre abbracciate per un senso reciproco di maggiore sicurezza, anche perché nel lungo tratto di strada dopo la ferrovia, da un lato c’era il Crostolo con alte erbacce e la riva che scompariva verso l’alveo, mentre dall’altro si ergeva un’alta e fitta siepe scura che incuteva apprensione. A volte mia madre canticchiava per esorcizzare la critica situazione: come ad ingannare se stessa, per darsi coraggio. Tuttavia si doveva portare a termine il tragitto fino alla sede del fascio di via Dalmazia, quindi oltre la via Emilia; ma lì almeno la strada aveva un po’ d’illuminazione. Il «recupero» del proprio padre avvenne nell’arco di circa due anni, dal ’22 al ’24, sempre di domenica; più raramente nel ’25. Di certo non contavano le stagioni. Una sera d’inverno rimasta indimenticabile, con tanto di neve, le sorelle dovettero calzare i pulachîn14. Quella sera Carola non stava bene, aveva al flòss15 (il flusso) e dovette penare nel percorrere il tragitto. Arrivarono finalmente alla «sede» e come le altre volte, al cospetto della porta sempre chiusa, iniziarono prima a chiamare ad alta voce, poi bussarono sempre più forte col pugno. Dopo un po’, un milite aprì e dietro lui apparve Angelo che si stava avvolgendo nel tabarro con difficoltà: per i fascisti era una circostanza conosciuta che si ripeteva. Senza parlare, i tre si avviarono circospetti mentre il nonno nel mettersi il vecchio cappello, ebbe un movimento di sofferenza. Evelina se ne accorse e chiese a suo padre cosa avesse. «Mân mìa picê fôrt, ma un còlp la ciapée anch n’urècia» (Non mi hanno picchiato forte, ma un colpo ha preso anche un’orecchio), rispose Angelo e portandosi una mano all’orecchio destro, la ritrasse sporca di sangue. Imprecò Così erano chiamati una sorta di bassi stivaletti che il loro padre aveva eseguito per tutti i figli, anche per la premura della madre; poi se li «passavano» dall’uno all’altro man mano che i piccoli piedi crescevano. 15 Come si diceva allora, per indicare un disturbo intestinale che dava diarrea. 14 109 e bestemmiò dalla rabbia. Si tolse il cappello e si tastò la testa dove aveva un gonfiore e la spalla destra dove aveva male, disse. La Carola infilò un braccio sotto il tabarro stringendosi al padre, mentre l’Evelina, giunti in una zona di luce, guardò l’orecchio ferito. Riattraversarono la via Emilia col padre che camminava poco bene anche sostenendolo; le due facevano anche fatica per la neve che aveva ripreso a scendere. Arrivati finalmente alla ferrovia dove la strada un po’ saliva, si fermarono per prendere fiato. Angelo dolorante e confuso si chinò a fatica sotto le sbarre del passaggio a livello sempre abbassate, ma nel chinarsi non seppe trattenere una scoreggia. Ripresero il cammino con disagio, oramai erano vicini a casa; le due sorelle erano stanche e infreddolite mentre il loro padre procedeva, ora piegato in avanti tenendosi la pancia, avvertendo il forte inizio del premere dell’intestino procuratogli dall’olio di ricino, prima fattogli ingerire. La Nina, poveretta, in attesa, in forte apprensione, diede un altro sguardo alla sveglia di cucina, tendendo l’orecchio per sentire ogni piccolo rumore, anche se la neve tutto ovattava. Poi un calpestìo, un rumore di scarpe battute come per togliere la neve, la fece sussultare. Erano loro! Udì la voce arrabbiata e roca del marito oramai sulla soglia: «chi bròtt câncher lè!» (quei brutti cancheri lì!). Ed era ben intuibile a chi si riferiva! La Nina con gli occhi lucidi baciò le due figlie e aiutò tutti a togliersi i vistî mòj (i vestiti bagnati) appendendoli, meglio che poteva, alle «bacchette» del tubo della stufa, mantenuta accesa; voleva medicare l’orecchio del marito, visto insanguinato, ma non c’era il tempo! Angelo, sofferente, al limite dei forti stimoli intestinali, chinato e con le mani sull’addome, chiese immediatamente alla moglie di accompagnarlo in fondo al corridoio dove c’era al cèso del mèistri (la latrina delle maestre)16 che fortunatamente risparmiava di uscire all’aperto. Le due figlie, stanchissime, andarono di sopra, rapide a letto, cercando di fare piano; appena sotto le fredde coperte, accostarono piano piano i loro piedi a quelli della sorella dodicenne Virginia, per «rubargli» un poco di tepore: meno male che la bambina si mosse appena, ma non si svegliò17. La parte della casa dove abitavano i nonni, comprendeva le due aule scolastiche e fu eseguito allo scopo un «servizio» personale per le due maestre (nient’altro che un rialzo in cemento col buco, ma le pareti del piccolo locale erano almeno rivestite con piastrelle pur di seconda mano). Tutte le altre famiglie del caseggiato si dovevano servire di una misera costruzione, senza sottotetto, distaccata dal fabbricato, che accoglieva alla buona, due servizi igienici; al precario muro che li divideva, erano stati praticati ad una certa altezza, dei fori passanti allo scopo malandrino di spiare furtivamente parti intime di chi stava dall’altra parte (!). Nel periodo invernale, date le basse temperature, immaginiamo il forte disagio subìto, considerato le parti del corpo scoperte. Alla sera le donne vi andavano portandosi fiammiferi e candela, non senza una certa apprensione. 17 Testimonianza diretta della zia Evelina di tutto l’episodio. 16 110 Un cocomeraio antifascista Ballabeni Maino, nato a Roncocesi ai primi del ’900, frequentava spesso Cavazzoli dove viveva un fratello e conosceva Maramôt al calsulêr – così era chiamato il nonno, così da tutti conosciuto – anche perché lì univa un forte ideale antifascista: si erano parlati spesso nelle domeniche pomeriggio alla Cooperativa. Maino era un soggetto particolare, dal forte carattere, si atteggiava spesso ad atteggiamenti spavaldi che provenivano anche da un turbolento passato famigliare. La moglie lo aveva lasciato e allorché capitava l’occasione, ma raramente, di citarla, la bollava con disprezzo con un: «cla s’centrêda lè!» (quella scentrata lì!) e si poteva capire a cosa si riferiva. Viveva solo e chi scrive ebbe modo di conoscerlo anche se avanti negli anni; manteneva forte forza fisica e uno spirito baldanzoso. E su Maino voglio ricordare un gustoso fatto narratomi da lui stesso. Attorno agli anni ’38, nella stagione calda, teneva aperta alla sera, una specie di baracca per la vendita di cocomeri, nel centro di Cavazzoli, accanto alla Cooperativa e ai due frequentati giochi da bocce. Un rustico tavolo e una panca davano modo agli avventori di gustare fette del ghiotto frutto. Per richiamare i clienti Maino declamava: «Taglio rosso! Taglio rosso!»; ma nel detto si poteva notare un certo particolare tono, una (consapevole) maliziosa provocazione. Da alcuni fascisti che giravano nella strada, si staccò un piccolo gerarca avvicinandosi al casotto e: «Te ed’dèv smèter de’stusighêr! Et’faròm sarêr al casôt!». (Tu devi smettere di stuzzicare! Ti faremo chiudere la baracca!). Maino che era di carattere deciso, come detto, tenendo sul banco una tagliente roncola bene in vista, (che non c’entrava niente col taglio dei cocomeri) replicò con tono energico: «mé, e’ghò da vènder agli ingòri!» (io devo vendere i cocomeri!). All’allontanamento dell’intruso, fra sé sogghignava maligno e contento: mentre addentava una sottile fetta sputando rumorosamente le midolle per terra, seguiva con gli occhi fessurati il gruppetto nella strada che si allontanava. Sfollamento a Vezzano s/C e la morte della nonna Nina Era circa fine luglio del ’43, quando assieme alla nonna andammo sfollati a Sedrio di Vezzano s\C presso la famiglia contadina Morini. Fu il nonno Angelo ad organizzare il nostro provvisorio alloggio, dati i bombardamenti in corso in quel periodo, avendo avuto tramite un amico, la possibilità di contattare il Morini. Infatti, un ulteriore pericoloso episodio accaduto, contribuì al nostro allontanamento. Nel pieno della notte fra il 16 e il 17 luglio si ebbe l’incursione di una squadriglia di bombardieri inglesi Lancaster, 111 aventi l’obbiettivo di «spegnere» le importanti centrali elettriche di Via Gorizia, assieme alle reti di distribuzione ad alta tensione che da lì si diramavano. L’attacco però registrò un clamoroso insuccesso. Le bombe di grosso calibro sganciate, unite a spezzoni incendiari, colpirono fabbricati civili nelle zone adiacenti comprese fra Via Bainsizza, Emilia all’Angelo, Dalmazia e l’attuale Via Costituzione. Si registrarono sette vittime e diversi feriti18. In quei cupi momenti veniva spesso citato il ponte sul Crostolo della ferrovia Milano-Bologna come probabile prossimo obbiettivo, distante dalla nostra abitazione non più di duecento-duecentocinquanta metri in linea d’aria. Accingendoci al viaggio, caricammo su un carretto alcuni indumenti e le poche cose personali; partimmo da casa con malcelati tristi saluti di tutti. Imbaldanzito dal nuovo accadimento, seduto davanti accanto al carrettiere, un buon conoscente del nonno, ignaro della seria situazione bellica, mi sentivo tutto eccitato e ancor di più, allorché il conduttore, intendendo i miei sguardi, mi mise in mano le redini del cavallo. Solo allora, girandomi indietro, vidi la nonna, sempre in silenzio e con gli occhi lucidi, malamente appoggiata ad una sponda con frapposta una borsa. Arrivammo a Sedrio, una frazione di Vezzano, che era quasi mezzogiorno, con il sole che picchiava forte, data la sosta dopo la salita delle Forche di Puianello per fare riposare il cavallo, dandogli da bere. Trovammo gentile ospitalità dai Morini. Anche se sono trascorsi 67 anni, ricordo ancora alcuni momenti vissuti in quegli anni spensierati d’infanzia: il profumo e il gusto del pane casareccio, (definito «bianco»); la discesa gioiosa da un’altura al comando di due mucche sciolte che mi illudevo di comandare ma poi compresi, deluso, che sarebbero scese tranquillamente anche sole; il timore che mi incutevano le salamandre nero-giallastre, dall’aspetto inquietante, mai viste prima dall’ora, che si muovevano lente, con la lunga coda, sul fondo del grande pozzo cisterna completamente aperto. Poi i ricordi si fanno confusi. La nonna non stava bene, si lamentava ed era sempre sdraiata; fu ricondotta a casa dove poverina, si spense il 17 agosto all’età di 62 anni. Angelo ne fu duramente colpito, cadde in depressione, non parlava quasi mai e gli si accentuarono gli attacchi d’asma. Ritorno dalla guerra di Gino Mi fu riferito che la Nina, durante l’agonia, chiamava il secondogenito Gino (cl. 1907) che sapeva in guerra, ignorandone la sorte. Poi dagli accadimenti che seguirono la tragica circostanza: quasi un sortilegio si avverrò. Il decesso A. Conti, M. Becchi, 22.000 bombe su Reggio Emilia. Bombardamenti alleati e vita (e morte) quotidiana 1940-1945, Diabasis-Istoreco, Reggio Emilia 2008, pp. 57-58. 18 112 della madre salvò il figlio dalla deportazione in Germania; si concretizzò nella sua tragica morte, l’amore per il figlio portato suo tramite alla salvezza, come di seguito vedremo. Nella prima decade di agosto l’artigliere Sassi Gino, nello sbandamento caotico delle truppe provocato dal 25 luglio, fu trasferito da Vibo Valentia (CZ) a Mantova, da dove scrisse subito a casa. Già accusava, senza dirlo ai superiori, sintomi di malessere, disturbi digestivi e minzioni irregolari. Come detto, il 17 dello stesso mese morì sua madre; per una coincidenza, il giorno stesso arrivò a casa la lettera di Gino che rendeva noto il suo trasferimento. Dopo un concitato consulto con Angelo, il mattino presto del giorno dopo, partirono in bicicletta alla volta di Mantova, il genero Arnaldo Manghi, avendo in tasca il certificato di morte della povera Nina, accompagnato da un volonteroso amico. I tempi non erano dei più sicuri, regnava il caos nelle nostre truppe: al ponte di barche che attraversava il Po, ai due vennero chiesti i documenti e furono perquisiti. Giunti alla caserma, furono accompagnati al comando dove consegnarono il certificato. Ebbero poi un rapido, quanto emozionante incontro con Gino: molto abbattuto, debole per i malanni, pianse alla notizia; l’ufficiale addetto in seguito all’attestato medico, gli firmò un permesso speciale di tre giorni. Il 18 agosto ‘43 il genero di Angelo, Manghi Arnaldo, nel fare ritorno in bicicletta da Mantova come prima scritto, fu molto stupito dalla moltitudine di soldati e mezzi corazzati tedeschi che percorrevano la ss 63 in direzione sud. Tanto lo zio Arnaldo mi raccontava anni fa, rievocando quei giorni carichi di emozionanti eventi, eccitato nel ricordare lo sferragliamento dei mezzi corazzati che lo rasentavano in modo poco rassicurante. Riprendendo quella testimonianza rimastami in testa negli anni, dal momento che la data del 18 agosto non mi tornava in ordine ai movimenti tedeschi citati e desiderando meglio capire, ho consultato testi di storia del periodo19. Il giorno seguente 19 agosto, Gino era a casa. Fu grande l’emozione del padre e dei fratelli nel riabbracciarlo: era dimagrito dopo i tanti mesi senza vederlo, trascorsi in guerra, dove la malattia iniziò ad attaccarlo a causa delle dure condizioni alle quali dovette L’armistizio fu firmato a Cassibile il 3 settembre e reso noto l’8. Come mai già il 18 del mese precedente c’erano truppe tedesche in movimento? Evidentemente i comandi erano già stati informati del prossimo accordo italo-alleato. Infatti, addirittura già il 6 agosto vi fu un incontro fra i generali V. Ambrosio e Keitel; il primo pretese chiarimenti che il tedesco non diede, circa il massiccio afflusso di forze tedesche. Ancora il 15 dello stesso mese a Bologna, ci fu un altro scambio di vedute tra il generale Roatta assieme ad altri alti ufficiali per l’Italia e Jodl (sottocapo di stato Maggiore Generale), Rommel e von Rintelen. Roatta dovette accettare che Rommel e Kesserling, nei rispettivi settori, avessero giurisdizione anche sulle truppe italiane agli ordini del Re. 19 113 sottostare. Nel cuore di tutti, il forte dolore per la dolorosissima perdita subita due giorni prima da tutta la famiglia. Gino chiese al padre di andare al cimitero assieme all’altro figlio Giacomo. Giunto sul luogo della sepoltura della madre, stravolto, si inginocchiò scavando la terra ancora molle, piangendo e chiamando la madre: una penosissima circostanza oltremodo straziante. Il padre Angelo si girò, non potendo trattenere le lacrime, poi tornò sul figlio col cuore che gli pareva scoppiare e con l’aiuto di Giacomo lo alzarono. Angelo e i due figli rimasero ancora diversi minuti in silenzio, immobili, davanti al cumulo di terra inesorabilmente nera20. Tornarono a casa trovando un vuoto senza parole: lo sgomento più crudele era intorno. Lo zio Gino, pallido, depresso, non sapeva capacitarsi, ritrovare le trascorse abitudini di vita. Non parlava quasi mai del tanto tempo trascorso in guerra sparando con un cannone grosso calibro che ad ogni colpo diffondeva in lui e ai compagni addetti al pezzo, per la immane detonazione, come un nevrotico svuotamento d’animo che dopo ore e ore di fuoco, ti lasciava sconvolto e stremato. Le privazioni e i disagi fisici patiti, gli procurarono una infiammazione renale, con alterazione alle vie urinarie, sfociata in seguito in nefrite. Dopo due giorni si dovette mettere a letto accusando febbre alta e pesante spossatezza. Venne chiamato il medico d’urgenza – erano già in scadenza i giorni di permesso – il quale rilasciò un certificato di malattia che fu immediatamente portato ai carabinieri. La mattina seguente vennero a casa due militi dell’arma, uno dei quali maresciallo a verificare le condizioni dell’ammalato, rivolgendogli parecchie domande e compilando un modulo. Poi venne l’8 settembre e tutto cambiò. Lo zio, sempre allettato, incaricò il fratello Giacomo di accordarsi con un confinante contadino, amico fidato, per nascondere, seppellendoli sotto la concimaia, l’uniforme d’ordinanza che avvolgeva moschetto e munizioni. Gli anglo-americani, che avevano bollato di doppiezza Badoglio, erano al Sud mentre nelle nostre zone i tedeschi comandavano sottomettendo i fascisti; gli ex militari che non si erano presentati alle caserme erano considerati disertori, come è noto. L’artigliere Sassi Gino, malattia a parte, rientrava in questa schiera. Il nonno Angelo, aveva rapporti di lavoro e di buona conoscenza con una onesta famiglia contadina abitante nella valle San Giulio21. Testimonianza della zia Evelina, deceduta nel ’65. Il nome «valle» – così da tutti chiamata nella zona – attribuito alla località, pare improprio, visto che siamo in piena pianura immersa in campi coltivati. Probabile atavica derivazione per indicare luogo a sè, isolato (dal centro di Cavazzoli). Negli anni ’40, ma anche precedentemente, gli abitanti, dieci-undici famiglie tutte contadine proprietarie, a riprova, venivano chiamati i valèin (i vallini) cioè quelli della valle San Giulio. 20 21 114 Essa portava il medesimo cognome, Sassi, ed erano suoi lontani cugini. Facendosi coraggio, Angelo si recò a casa di Domenico (Mèngo) per chiedergli se poteva ospitare il proprio figlio ammalato, illustrandogli le critiche condizioni. Mèngo si consultò con il figlio maggiore Renzo, dati i possibili rischi; si era in pieno periodo bellico e la persona poteva essere considerato un fuggiasco. Dopo comprensibili titubanze, il capo famiglia, con grande cuore, accettò anche perché i costumi dell’epoca consideravano il rifiuto come un pesante sgarbo, un’offesa. Anche il fatto che Sassi Domenico avesse tre figli maschi, in malaugurato caso di controllo, si sarebbe potuto «giocare» sull’identico cognome. Altresì venne considerata la situazione generale bellico-politica, in quel periodo abbastanza tranquilla e la località isolata. Essendo anch’io presente nella casa, ricordo confusamente – avevo sette anni – le saltuarie visite serali di un medico: la presenza dell’ospite doveva essere mantenuta logicamente riservata. Pertanto chi scrive, considerato un cuginetto innocente, era preposto per tenere i collegamenti dalla stanzetta ricavata nel sottotetto, al resto della casa e con i miei famigliari. Lo zio Gino, sempre allettato, mi chiedeva del padre Angelo e dei fratelli. Di tanto in tanto, a sera inoltrata riceveva una visita con tutta probabilità, dal fratello o dal padre, ma qui i miei ricordi, anche di come vivevo nella casa, svaniscono. Unica cosa rimastami nella mente, si riferisce al sacchetto bianco del pane; lo zio, accortosi degli ammanchi, procurati di nascosto da chi scrive – avevo sempre fame – appese il sacchetto ad un chiodo già infisso nel muro, sopra al letto, in alto dove non potevo arrivare. I mesi trascorrevano; perdurava l’occupazione tedesca e l’oppressione fascista. Le famiglie dovevano fare i conti con la tessera annonaria, il cibo pesantemente insufficiente; le patate scarseggiavano perché ricercatissime sostitute del pane. Se la cavano meglio i contadini usufruendo direttamente dei prodotti della terra, della preziosa frutta e verdura, nonché di burro e formaggio – se pur razionato – per quelli che portavano il latte al caseificio. Comparve il mercato nero. Il nonno Angelo aveva ancora dentro di sé la scomparsa della moglie, era spesso taciturno, la solitudine lo incupì e gli attacchi d’asma si fecero più frequenti. All’inizio dell’inverno la salute dello zio Gino migliorò. Fui fatto rientrare a casa e messo a dormire assieme al nonno nel vecchio letto matrimoniale, ritengo, per essergli di conforto e aiutarlo di notte nei momenti più critici della sua malattia: gli parlavo e aggiungevo sotto la sua testa un cuscino per migliorale il respiro. Mi intristiva il vederlo soffrire, respirare frequentemente a bocca aperta, la testa chinata sul petto. Lo guardavo con apprensione ed egli avvertendolo, si girava appena verso di me, dicendomi amorevolmente: «Adèsa am’pâsa, stâgh ed’mèi. Dòrom Franchìn22, dòrom!». (Adesso mi passa, sto meglio. Dormi Franchino, dormi). 22 Franchino, così mi chiamava il nonno, come diminutivo di Franco. 115 Quell’anno venne un inverno crudo e ricordo bene il freddo intenso, le coperte un po’ sgualcite aggiunte sul letto. La camera era posta a nord, dove dalla finestra senza tende ne imposte, si poteva vedere il vicino campanile della chiesa e udire i rintocchi delle campane che mi procuravano un piacere distensivo: mi abbandonavo al suono che entrava in me, alla sua profonda vastità. Al mattino i vetri della finestra li trovavo coperti di cristalli ghiacciati che davano forma a magnifiche composizioni poliedriche. Dicembre 1944. I Manfredi di Villa Sesso23 Il nonno andava molto volentieri da Vergéni (Virginio) per fargli visita data l’amicizia che li univa. Raggiungeva comodamente casa Manfredi attraversando il Crostolo servendosi della passerella che permetteva di attraversare il torrente; l’accesso era abbastanza vicino alla nostra casa. Cerano le scarpate in corrispondenza, nei due argini: una in discesa, l’altra in salita che consentiva di raggiungere Sesso. Nelle amichevoli confidenze, si sentivano convintamente uniti dagli ideali antifascisti, assieme ad una venerazione per Camillo Prampolini. Negli incontri si avvertiva una motivazione di coscienza politica, seppure agli inizi; i contatti vennero sempre mantenuti dato anche che i due erano pressoché coetanei essendo Virginio più giovane di un anno rispetto al nonno. E quando lo chiamavano a lavorare a giurnèda, per il calzolaio Maramôt era una vera festa: trovava una accoglienza cordiale anche dalla moglie Maria e dai figli, specialmente da parte di Gino. Alla fine del buon pranzo un brindisi, con uno speciale lambrusco, era indirizzato a tempi migliori «nuovi e diversi» e si poteva bene immaginare a quali tempi si alludesse. Anche chi scrive venne portato dal nonno Angelo dai Manfredi sulla canna della bicicletta (marca Tre Fucili molto apprezzata negli anni ’30). Quella mattina mi chiamò, dicendomi contento: «et’pôrt mègh dal me amîgh Vergéni» (ti porto con me dal mio amico Virginio). E pedalando fischiettava appena arie strane. Il ricordo pur lontano, è rimasto in me. Avevo poco più di sette anni e avevo l’incarico di tenere stretto, sul manubrio della bicicletta, l’allaccio del fagotto degli arnesi, non infilare le dita fra le bacchette dei freni e stare attento a non mettere i piedi fra i raggi della ruota anteriore. Ero tutto eccitato e vivace com’ero, davo dei piccoli colpetti al fanale a carburo che mi trovavo proprio lì davanti, che essendo montato su molle andava su e giù e per me era divertente. Al secondo-terzo colpo il nonno mi diceva di smettere anche perché mi muovevo, compromettendo il precario equilibrio della bici. Per l’episodio, la testimonianza proviene, come per altri casi citati, dalla cugina Vittorina che la ricevette dalla madre Evelina, primogenita di Angelo. 23 116 Quando poi da sopra l’argine del Crostolo ci infilavamo verso la stretta passerella che permetteva di attraversare il torrente, il nonno frenava per la troppa velocità accompagnando allegro, un: «Oh, oh, oh!». Che bel rievocare! Sento ancora la sua voce gioiosa. Risalendo sull’argine di Sesso, aiutavo a spingere la bicicletta. Della grande casa colonica dei Manfredi, ho lontana memoria di persone gentili, della resdora che mi chiamò con un dolce cenno della mano dall’uscio di cucina, per poi darmi un pezzo di pane fatto da poco tempo, fragrante, buonissimo, «Un grugnîn ed’pân bianc» (Un cornetto di pane bianco fatto in casa)24, di un alto mucchio di erba fresca sotto il portico da poco raccolta che emanava uno strano odore. Entrato nella stalla, ricordo di molte mucche che mi parevano più grosse del solito e due di esse, girando la testa, mi guardavano con grandi occhi muntlând (muggivano). Poi venne il ’44, il tragico 20 dicembre, il nefasto crudele giorno dell’eccidio! Sesso e Cavazzoli sono limitrofi, divisi solamente dal Crostolo: la notizia si sparse rapidamente. Angelo venne informato da un vicino di casa attivo in politica, tale Ezio Ghisi, che era al corrente dei rapporti del nonno con Virginio Manfredi; non volle credere alla notizia! Se la fece ripetere. Si isolò Angelo, entrando in un sofferto mutismo per poi piangere sommessamente con il capo fra le mani. Gli uscirono alla mente i quattro figli: Gino, Guglielmo, Aldino e Alfeo – già fucilato tre giorni prima – e il loro padre Virginio. Apprendendo sconvolto che esso, resosi conto che i figli erano portati a morte, con slancio fatale, liberandosi a forza dagli sghignazzanti sgherri fascisti che lo stavano trattenendo per le braccia, volle unirsi a loro. Alcuni giorni dopo l’infausto evento, ignorando gli ordini fascisti, il nonno facendosi forza, sebbene col cuore a pezzi, volle andare a casa Manfredi nonostante la figlia Evelina cercasse di dissuaderlo, temendo per la sua salute, con i suoi 67 anni. Angelo sentiva forte l’impulso di portare di persona la sua vicinanza, il suo solidale affetto alla vedova di Virginio, Maria Giglioli. Consapevole che l’incontro con una madre e moglie di cari appena trucidati sarebbe stata una circostanza difficile, lo fece pensando a Vergéni. Col cuore in tumulto, inforcata la bicicletta, arrivò alla casa vedendo comparire dopo alcuni istanti da sotto il portico Maria, pallida, vestita di nero con un fazzoletto stretto in testa dello stesso colore. Alzando appena la testa, disse: «Sìv’vò Maramôt?» (Siete voi Maramotti?)25 e scoppiò in un debole pianto. Povera donna: non aveva più lacrime. Colpì Angelo il totale silenzio intorno: sia dai vicini campi, sia dalla casa, non si percepiva un fiato, Maria si avvicinò lentamente, si abbracciarono e 24 Il pane di casa nostra, di casànt, non era bianco di schietta farina di solo grano, come quello fatto dai contadini. 25 All’epoca le persone nate nel 1800, per loro costume, davano del «voi» anche ai buoni conoscenti, specialmente se di sesso diverso. 117 piansero insieme e la disperazione del momento bloccava a entrambi la parola. Angelo fece un passo indietro, ingoiò, anche perché l’emozione e i primi sintomi dell’asma gli rendevano affannoso il respiro. Maria lo invitò ad entrare in casa, ma l’amico rifiutò garbatamente: proprio non se la sentiva! Troppi i bei ricordi vissuti. Prima di salutarla, con vera grande fatica, riuscì a dirle: «Vergéni le’stée un grân òm! Em’ricurdarò sèimper ed’lò! I vôster in’mìa môrt per gninto! Maria fèv curâg! Turnarò a catàrov» (Virginio è stato un grande uomo. Mi ricorderò per sempre di lui! I vostri cari, non sono morti invano! Maria fatevi coraggio! Tornerò a trovarvi). Riporto, a conclusione, un breve passaggio significativo dal finale del libro Sesso ai suoi caduti per la libertà a firma di Guerrino Franzini: «Con l’angoscia nel cuore e negli orecchi i rumori degli spari, Maria vagò fra la casa e i campi silenziosi, per due giorni senza mangiare, senza incontrare anima viva. I fascisti avevano minacciato la gente del vicinato, ordinando che nessuno si avvicinasse alla casa o portasse aiuti in qualsiasi modo ai sopravissuti»26. Appendice Cavazzoli dalla fine dell’Ottocento all’alba del XX secolo Da carte, appunti e copie di documenti ad indirizzo storico raccolti da chi scrive in diverse cartelle purtroppo non in ordine cronologico, ho reperito una interessante raccolta di articoli tratti dal giornale «La Giustizia» che vanno dal 1891 al 1922. Nell’aprile del ’22, è noto, la sede del giornale fu data alle fiamme dalla barbarie fascista; dopo alcuni mesi però, l’«Organo dei socialisti reggiani» riprese le pubblicazioni anche se in edizioni ridotta, inizialmente. Ho rilevato altresì sulla rivista di Istoreco «Ricerche Storiche», n. 15 del 1971, altre citazioni di vicende simili alle sopracitate, sempre dovute ad «imprese» fasciste, relative agli anni dal 1923 al ’25. Trattasi di accadimenti di modesta entità, tutti avvenuti a Cavazzoli, ma a mio parere significativi, considerati gli anni nei quali avvennero; riporterò di seguito alcuni stralci nella forma di scrittura originaria. Credo di potere senz’altro affermare, che nelle incursioni e bastonature fasciste che hanno avuto luogo negli anni citati, tra gli avventori della Cooperativa, poteva essere presente Sassi Angelo. L’intenzione è di fare conoscere il difficile ambiente politico-sociale fra la fine del 1800 e i primi decenni del ’900, nel quale si muovevano i primi circoli Sesso ai suoi caduti per la libertà, a cura del Comitato Promotore per l’erezione del monumento ai Martiri di Villa Sesso Comune di Reggio Emilia, Reggio Emilia 19653, p. 25. 26 118 agli albori del socialismo di fede prampoliniana. Fare rivivere le difficoltà, anche in una modesta frazione ai margini della città, che però era giunta a contare, alla fine del 1920, n. 131 iscritti al circolo socialista; e ciò nonostante le «pressioni» che conosciamo messe in atto dal nascente movimento fascista e dal comportamento del parroco don Lodovico Caroli, che non lesinava anche nelle prediche domenicali dal pulpito, di avversare duramente la condotta dei «senza religione» socialisti. Nella non facile realtà di vite duramente vissute, fatte anche di delazioni, ingiuriosi pettegolezzi e piccinerie in uso nell’epoca in specie nei piccoli borghi, viveva e operava il sovversivo Maramôt. Riferiamo di seguito, come sopra accennato, quanto scritto sui numeri della «La Giustizia»: 27 sett. 1891. Si è svolto nei giorni scorsi il funerale della figlia di Fornaciari Luigi al quale il prete non ha voluto partecipare. Alla cerimonia ha presenziato il campanaro di Villa Cavazzoli. 6 febb. 1898. Venerdì scorso, venne trasportata civilmente al cimitero la salma della compianta nostra compagna Maria Iemmi Fornaciari. Il funerale riuscì imponente. Il corteo, preceduto dal concerto di Cavriago, era composto di circa 300 persone, fra cui una trentina di donne, i rappresentanti di parecchi circoli Socialisti e moltissimi altri nostri compagni. Sulla bara stava una corona dei Socialisti di Villa Cavazzoli. Al cimitero parlò, commosso e commovendo, il bravo nostro compagno Arturo Bellelli, falegname, che esortò calorosamente tutti i presenti a combattere per preparare alla classe lavoratrice un avvenire migliore. 13 febb. 1898. Narrammo domenica scorsa che era stata trasportata civilmente la salma della nostra compagna Maria Iemmi Fornaciari. Ora sentano i lettori cosa avvenne poi. Il giorno dopo quei funerali che avevano suscitato l’ira del prete e dei bigotti, si sparse nel villaggio la voce che la cassa contenente il cadavere della povera Iemmi era stata levata dal luogo ove l’avevano deposta alla presenza del marito e degli amici, per essere seppellita in un angolo a parte, in modo da tenerla ben distinta dai cadaveri cattolici. “È morta come una bestia, si osava dire, e deve essere seppellita come un cane!!”. E questa voce di odio feroce e infintamente stupido usciva dalla chiesa di quel Cristo che proclamò fratelli gli uomini di tutti i paesi di tutte le razze, di tutte le religioni! Il fatto però era talmente grave che da principio non si volle crederlo. Poiché assicuravasi che era stata compiuta per volontà del prete, immediatamente pochi minuti dopo i funerali. Lo stesso capo-becchino, signor Fratti l’ha confessato ed ha anzi diretto egli stesso la “civile ed altissima impresa”!! Intanto, a protesta gentile contro l’infame rappresaglia, i Socialisti di Cavazzoli hanno deliberato di portare fiori ogni domenica sulla tomba della povera Iemmi che fu onesta e buona come certamente non lo è nessuno di coloro che vollerlo offenderla morta. 6 mar. 1898. Domenica scorsa, coi compagni di Coviolo, San Pellegrino e Rivalta, in numero di oltre 400, ci recammo in mesto pellegrinaggio al cimitero di Cavazzoli per deporre fiori sulla tomba della compagna Maria. 11 mar. 1900. Arturo Bellelli e due altri nostri compagni di Roncocesi: Melli Angelo e Guidetti Arcangelo sono stati condannati ciascuno a £ 100 di multa per avere 119 indetto una conferenza privata, divenuta poi, secondo l’accusa, una conferenza pubblica. 7 febb. 1904. Il circolo Socialista di Cavazzoli invita i compagni a fare opera di propaganda perché i lavoratori si allontanino dal prete. Delibera inoltre di prendere misure severe contro quei compagni che non frequentano le scuole serali. 19 febb. 1905. A Villa Roncocesi Guidetti Arcangelo e Paglia Angela si sono sposati senza incomodare il prete. “Bravissimi e 1000 auguri”. 4 lug. 1909. Domenica nel pomeriggio, favorita dal tempo splendido, ebbe luogo la inaugurazione della Coop. Succursale in Villa Cavazzoli, anzi per dir meglio, nel capoluogo della villa dov’è la chiesa, non nel borgo di Cavazzoli lungo il Crostolo. Molta gente, a piedi, in bicicletta, in carrozza convenne dalle ville d’intorno e dalla città. In un bellissimo gioco da bocce, parlarono il compagno Zibordi che scusò l’impreveduta assenza dell’onorevole Borciani, e il compagno Bonini: il primo toccando della cooperazione animata di finalità e d’idealità socialiste; il secondo più particolarmente svolgendo i principi del nostro partito.....Gli oratori furono applauditi, e la simpatica festa, che segna una nuova conquista della nostra organizzazione, continuò nella serata in letizia e buona armonia. 16 ago. 1917. Dal fronte mandano saluti ai compagni del circolo Socialista di Roncocesi e Cavazzoli, Campioli Casimiro e Lusetti Ortensio. 2 set. 1917. Da Cavazzoli: domenica scorsa 26 Agosto 1917 qui fu festa di San Giulio, e il prete, come al solito, volle farlo portare in procissione. Scelse per tale facchinaggio, giovani del 900 e del 901, i quali per non mettersi in urto con le loro famiglie cattoliche, o forse per paura di persecuzioni in questi tempi eccezionali si sobbarcarono al non lieve peso di San Giulio. Ma con manifesto scandalo, mentre stavano sotto ... il giogo, si fecero sentire a stramaledire il prete, S.Giulio, la procissione e la barella ch’era gravosa troppo alle loro spalle. Coerenza cari giovani, coerenza!! Se avete accettato di portare “S. Juli” perché farsi sentire a maledirlo? O ribelli del tutto o servi animali da soma del tutto!!! 23 mag. 1920. È da parecchio tempo che il prete di Cavazzoli, aiutato da qualche suo beniamino, lavora per formare anche in questa villa la famosa Lega gialla, senza potervi riuscire, tantoché alla prima chiamata s’accorse che tra i pochi convenuti mancava proprio la presenza del vero lavoratore autentico della terra, e così a malincuore ha dovuto rinunciare all’esposizione del suo grandioso programma, e rimandare l’adunata ad altra occasione migliore... 2 gen. 1921. A Cavazzoli continua ad esserci molto fermento all’interno del circolo socialista: ci sono altre espulsioni alla vigilia del congresso di Livorno. 20 feb. 1921. Nell’ultima assemblea della sezione socialista di villa Cavazzoli udita la relazione del congresso di Livorno, si deplorò la condotta dei comunisti che preferirono la loro opinione assai discutibile alla disciplina di partito. Dai numeri di feb., mar., apr., mag., 1921. Comincia ad infuriare in tutta la nostra provincia la violenza fascista. Una delle prime vittime di tali barbarie è proprio la «Giustizia» il giornale dal quale abbiamo preso tutte queste notizie, che nell’aprile 1921 viene dato alle fiamme. 8 gen. 1922. Da Cavazzoli: il nostro buon parroco don Caroli ha rivolto, pubblicamente in chiesa, acerbi rimproveri a 2 ragazzine per avere esse commesso la grave 120 colpa di partecipare ad una modesta festicciola tenutasi nella nostra cooperativa nella notte di capodanno. Né sono mancati severi ammonimenti ai genitori, che non sanno più comandare ai loro figli, che li lasciano crescere senza religione. Sarebbe, a questo proposito, molto meglio che il prete moralista badasse ai fatti suoi, perché questi delicati argomenti potrebbero ritorcersi contro di lui, perché si potrebbe citargli il contegno morale, noto a tutti, di certe sue devote matildine… Ma lo zelo del reverendo non si limita a questo; egli è anche uno strenuo organizzatore del pìpì (partito popolare) ed è riuscito a costruire un gruppo cattolico femminile racimolando qualche giovinetta specialmente tra i contadini più incolti. Perché le tessere di iscrizione possano essere accettate più facilmente egli le fa distribuire gratis, sicché molte le hanno senza neanche sapere cosa rappresentino. Molte altre lo confessano loro stesse, sono iscritte nel circolo per imposizione dei genitori e contrariamente alla loro volontà. Ma naturalmente basta far numero per poter dire che il pìpì è il partito più forte. Unisco alcuni stralci riguardanti unicamente Cavazzoli, tratti da «Ricerche Storiche» n. 15 del 1971. Febbraio 1923. Ambrogi Egidio è costretto ad ingerire olio di ricino ed è bastonato. 2 ottobre 1924. L’operaio Arturo Cherubini è bastonato dai fascisti perché visto il giorno prima con una bandiera rossa sulla bicicletta. 15 novembre 1924. Vengono bastonate una decina di persone fra le quali: Poli, Speroni, Anceschi. 18 novembre 1924. Nella borgata ha avuto luogo una incursione di squadre fasciste con una decina di operai feriti. 9 febbraio 1925. Viene colpito con bastonate Riccò Medoro e successivamente fermati, percossi e bastonati tutti coloro che rincasavano. 27 marzo 1925. Gli avventori della Cooperativa vengono schiaffeggiati ed intimati di andare alla propria abitazione. 121 Didattica «Come potevamo noi cantare» Testi, musiche e immagini della Resistenza1 Simona Anceschi Valeria Benevelli Irene Bonfrisco «…in questi cento anni di storia italiana c’è stata anche una guerra “giusta” (se guerra giusta esiste). L’unica che non fosse offesa delle altrui patrie, ma difesa della nostra: la guerra partigiana». Don Lorenzo Milani2 Presentazione Il progetto ha avuto come primo risultato l’allestimento della mostra fotografica Una cornice per ricordare e come prodotto finale la rappresentazione dello spettacolo teatrale Come potevamo noi cantare. Gli anni della Resistenza sono stati raccontati attraverso i canti, le testimonianze della «grande storia», quella che si studia sui libri, e della «piccola storia», quella delle donne e degli uomini che hanno vissuto questi difficili anni proprio sul nostro territorio. Attraverso la documentazione d’epoca si è voluto ricostruire con i ragazzi una sorta di quadri viventi da immortalare con lo scatto fotografico. Queste immagini sono divenute oggetto della mostra e sono state proiettate durante lo spettacolo. Il punto di partenza del nostro lavoro è stato l’intervento in classe della dottoressa Alessandra Fontanesi, esperta di Istoreco, che ci ha presentato, all’interno di un laboratorio dal titolo Avevamo vent’anni, il periodo della Resistenza attraverso le canzoni più rappresentative. 1 2 Progetto a cura delle docenti della Scuola secondaria di I grado di Casalgrande. Don L. Milani, Lettera ai cappellani militari, Barbiana, 1965. 123 L’ impegno di noi docenti è stato quello di contribuire a conservare i valori di questi eventi storici che, come ha affermato il nostro presidente della repubblica Giorgio Napolitano, «trovarono la loro magistrale e duratura espressione nella Costituzione repubblicana»3 e trasmetterli alle giovani generazioni, affinché la conoscenza e il ricordo possano aiutarli a divenire cittadini consapevoli. Fasi fondamentali di lavoro TEMPI DI REALIZZAZIONE: novembre 2010-giugno 2011 INSEGNANTI COINVOLTI: Simona Anceschi, docente di Italiano; Antonella Armani, docente di Sostegno; Valeria Benevelli, docente di Storia; Irene Bonfrisco, docente di Musica CLASSI COINVOLTE: 3ª E, 6 alunni di 3ª A e 5 alunni di 3ª C Fasi di lavoro: Laboratorio Avevamo vent’anni a cura di Istoreco Attività curricolari in classe: •Storia: studio del periodo storico; visione del video Partigiani a cura del Comune di Correggio; analisi e commento delle testimonianze contenute nel video; studio dei costumi e degli usi quotidiani attraverso l’analisi di materiale fotografico; •Italiano: lettura, analisi e commento dei testi utilizzati nello spettacolo; produzione di testi (lettere, pagine di diario, racconti) in cui i ragazzi hanno dovuto vestire i panni di uomini e donne della Resistenza; •Musica: ascolto e analisi dei brani più rappresentativi della Resistenza; fonti storiche di questi repertori; esecuzione strumentale e vocale delle trascrizioni di questi brani. Attività laboratoriale: •gennaio-febbraio: realizzazione delle fotografie ambientate nel territorio di Casalgrande e dintorni; •marzo-aprile: allestimento della mostra fotografica presso la Sala espositiva «Incontro» di Casalgrande e prove musicali d’insieme; •maggio-giugno allestimento dello spettacolo e rappresentazioni presso il teatro «Fabrizio De André» di Casalgrande il 30 aprile 2011 e «Casa Cervi» il 1° giugno 2011. G. Napolitano, Intervento in occasione del 64° anniversario della Liberazione, Mignano Monte Lungo, 25 aprile 2009. 3 124 Attività integrativa: – viaggio di istruzione a Monaco e visita al campo di concentramento di Dachau. Mostra fotografica «Una cornice per ricordare» Casalgrande, sala espositiva «Incontro», 12 aprile-1° maggio 2011 Il manifesto della mostra (le fotografie sono di Simona Anceschi) 125 Ricordare significa non dimenticare. Conservare e trasmettere agli altri la memoria di esperienze, anche negative, è fondamentale, perché solo analizzando eventi passati è possibile evitare che gli errori si ripetano in futuro, ma soprattutto è importante cercare nel passato esempi di solidarietà e collaborazione tra gli uomini. Il titolo della mostra Una cornice per ricordare è stato scelto dai ragazzi che, con il loro impegno e il loro lavoro, si sono resi testimoni del valore fondamentale della memoria. Essi sono i protagonisti delle foto: rappresentano i loro nonni, i partigiani e le staffette che hanno combattuto nella nostra terra per liberare l’Italia dal nazifascismo. La mostra ha avuto come filo conduttore la canzone scritta da Italo Calvino nel 1959 Oltre il ponte, il cui testo, suddiviso in strofe, ha introdotto quattro delle cinque sezioni in cui la mostra è stata articolata. La canzone ha come fine principale quello di trasmettere alle generazioni future i valori che stavano alla base della Resistenza. Un ex partigiano racconta ad una ragazza le esperienze sue e dei suoi compagni di lotta, ma soprattutto racconta il perché della loro scelta. Per quei ventenni pieni di ideali era insopportabile il male che si trovavano di fronte, ma «oltre il ponte» in mano al nemico, vedevano l’altra riva in cui c’era tutto il bene che desideravano. La conquista di quella riva era l’obiettivo comune. Di seguito vengono illustrate le cinque sezioni della mostra, ognuna delle quali è stata corredata dai testi prodotti in classe dai ragazzi. La scelta Tutti coloro che hanno partecipato alla Resistenza hanno dovuto effettuare una scelta: per alcuni è stata facile, quasi immediata, facevano già parte di gruppi antifascisti; per altri è stata più difficile e tormentata. Molti hanno deciso, perché disgustati dal comportamento incoerente del re e del governo Badoglio dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943. Tutti, però, sentivano l’esigenza di fare qualcosa per il proprio Paese. Così Alessandro, vestendo i panni del partigiano Sirio, si è presentato ed ha raccontato le ragioni della propria scelta: Sono un partigiano della Brigata Reggio-Tricolore, nome di battaglia: Sirio. Sono appassionato di astronomia e Sirio è la stella più luminosa del cielo, l’unica che mi tiene compagnia nelle fredde notti su in montagna, dove mi sono rifugiato dopo l’8 Settembre. Prima di diventare partigiano ero uno studente, frequentavo la facoltà di medicina all’università di Bologna, dove sono entrato in contatto con altri ragazzi critici, come me, del regime fascista. Uno, in particolare, mi ha colpito per la profonda intelligenza ed il modo semplice e diretto di esprimersi. Il suo sogno è diventare giornalista e penso proprio che ci riuscirà: si chiama Enzo Biagi. 126 Non sono un uomo d’azione, un combattente istintivo, preferisco pianificare bene le azioni di guerriglia. Talvolta devo scontrarmi con alcuni miei compagni che hanno la frenesia del fare, che vogliono combattere, attaccare il nemico. Penso che questo atteggiamento consenta loro di esorcizzare la paura, in particolare quella della morte. È troppo presto morire a vent’anni! La morte è un pensiero che si fa strada anche nella mia mente, soprattutto nelle notti buie in cui sono di guardia al nostro accampamento. Allora alzo gli occhi e cerco Sirio che brilla in cielo… La lotta La lotta condotta dai partigiani, le azioni di guerriglia, i sabotaggi, gli attacchi improvvisi, la vita in montagna in luoghi impervi ed inospitali ha appassionato e coinvolto emotivamente i ragazzi che hanno elaborato riflessioni e testimonianze di vita. Matteo, il partigiano Snake, scrive ai familiari: In questo casolare i giorni passano e non succede nulla, intanto fuori piove e sembra non abbia intenzione di smettere. Dormiamo su letti improvvisati, con le gocce che cadono dal soffitto. Molti sono ammalati. Io ho freddo, di notte non dormo e mi chiedo quando finirà questo inferno; sono preoccupato per voi: ho sentito alla radio che hanno bombardato Modena. Mi man- 127 cate, è da vari giorni che non ci sentiamo, qui è sempre più pericoloso; certe volte mi viene da piangere quando penso che non vi vedrò per molto tempo, poi però, quando mi immagino la fine della guerra, mi rassereno. Il ruolo della donna La funzione delle donne è stata meno appariscente, ma non meno essenziale di quella degli uomini. Le staffette erano insegnanti, studentesse, ma soprattutto donne del popolo: operaie, contadine, e infermiere. Il loro compito consisteva nel portare viveri, indumenti, ed in particolare informazioni da un gruppo partigiano all’altro. Facevano chilometri a piedi, in bicicletta, sui carri bestiame dei treni, rischiando la vita sotto i bombardamenti o la cattura. Ciò è stato rivissuto dai ragazzi nelle immagini e nelle produzioni scritte. Elisa, nome di battaglia Gina, ricorda ormai anziana: Ormai quegli anni sono passati e io sono vecchia, ma il ricordo dei momenti trascorsi con i miei compagni è ancora vivido. La paura di essere scoperti, l’agitazione, la finzione dell’indifferenza, e in certi momenti anche la felicità. I giorni non passavano mai e lo stesso i mesi e gli inverni. Proprio come quel pomeriggio, istanti di terrore. Dovevo andare a Bologna. Io non ero mai andata più lontano di Reggio. Solo il pensiero mi inquietava. Anche questa volta dovevo consegnare un pacco del quale non conoscevo il contenuto... La condivisione degli ideali Come hanno affermato Sergio Romagnoli e Giorgio Luti: «La Resistenza non avrebbe potuto essere quel grande movimento di popolo e di massa che fu durante la guerra di Liberazione se non avesse permesso e quindi favorito la convivenza fraterna nelle sue fila di uomini tanto diversi …»4. I partigiani che combattevano fianco a fianco erano persone appartenenti a ceti sociali completamente differenti: alcuni erano studenti, altri insegnanti, altri ancora operai e contadini. Spesso possedevano idee politiche molto diverse, ma tutti avevano un ideale comune: liberare l’Italia dal nazifascismo, combattendo in prima persona, senza dipendere completamente dall’aiuto degli Alleati. Uomini e donne hanno condiviso questo ideale. Dopo la guerra la «condivisione» ha riguardato anche il desiderio, l’esigenza di tramandare tali esperienze alle generazioni future, di raccontare quello che si era vissuto, perché nessuno mai più fosse coinvolto in vicende analoghe. Il film documentario Partigiani, in- 4 S. Romagnoli, G. Luti, L’Italia partigiana, introduzione, Longanesi, Milano 1975. 129 teramente realizzato nel comune di Correggio e proiettato in un spazio apposito all’interno della mostra fotografica, attraverso la voce dei protagonisti, ha raccontato ai visitatori l’esperienza della condivisione prima e dopo la guerra. Grande era il desiderio di condividere e di raccontare, lo stesso Calvino descrive questo clima di fervore: «L’essere usciti da un’esperienza – guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca»5. La Liberazione «Giulia! Giulia! Ma non passeranno più gli aerei?». «Sì che passeranno, ma non ci bombarderanno più!». Non c’era cosa più bella che vedere una bambina di otto anni felice, felice perché era finalmente finita la guerra! Mi affacciai alla finestra e intravidi un’ombra scendere dalla collinettta dietro casa 5 I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione, Einaudi, Torino 1947. 130 mia. Allora uscii fuori dalla casa e lo vidi di nuovo: era vivo! Gli corsi incontro e lo abbracciai. Un abbraccio interminabile, che racchiudeva tante emozioni, belle e brutte, che avrei conservato per sempre nel mio cuore. Non ci potevo credere, era riuscito a sopravvivere alla fame, al freddo, ma soprattutto alla guerra. Finalmente potevamo stare insieme, senza preoccuparci del domani. Potevamo dormire senza fare più incubi. Potevamo vivere, vivere davvero! È veramente toccante il modo in cui Giulia, vestendo i panni della partigiana Lena, ha rivissuto la gioia della fine della guerra e l’emozione del ritorno alla vita. 131 Spettacolo teatrale «Come potevamo noi cantare» Casalgrande, Teatro «Fabrizio De André», 30 aprile 2011 Gattatico, «Casa Cervi», 1° giugno 2011 Casalgrande, Teatro «Fabrizio De André», 30 aprile 2011. Irene Bonfrisco dirige i ragazzi Gattatico, «Casa Cervi», 1° giugno 2011 132 Come potevamo noi cantare. Questo è il titolo che abbiamo scelto per il nostro spettacolo, tratto dalla poesia Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo. La lirica, testo tra i più significativi dell’immediato dopoguerra, evoca il periodo tragico della dominazione tedesca, della guerra civile dopo l’8 settembre 1943, punto di partenza degli eventi ricordati nello spettacolo. Nella lirica, di fronte alla presenza della violenza e della crudeltà della guerra, la poesia è costretta a tacere. Ma, come afferma Quasimodo, «la posizione del poeta non può essere passiva nella società ... Un poeta è tale quando non rinuncia alla sua presenza in una data terra, in un tempo esatto, definito politicamente»6. Da qui la scelta «di cantare». La scelta di fare «cantare» i nostri ragazzi, per conoscere ciò che è stato, per conservarne la memoria e per contribuire a creare una coscienza civile. Lo spettacolo ha ripercorso le tappe fondamentali del periodo che va dalla caduta del fascismo del 25 luglio del 1943 fino alla Liberazione con l’aiuto di alcuni video documentari storici proiettati sullo sfondo. Il sipario si è aperto sui versi di John Donne Nessun uomo è un’isola7. La lirica invita ogni uomo a sentirsi parte vivente del genere umano. Noi abbiamo raccolto il monito contenuto nei versi finali E così non mandare / mai a chiedere per chi suona la campana: / essa suona per te. Il suono di una campana ha dato inizio allo spettacolo e ha scandito i diversi momenti in cui è stata strutturata la rappresentazione. Anche sul palcoscenico, i ragazzi hanno vestito i panni degli uomini e delle donne della Resistenza: ognuno di loro si è presentato al pubblico con il nome di battaglia scelto, ha letto testi letterari, testimonianze di partigiani del nostro territorio e passi estrapolati dagli elaborati scritti, ha cantato e suonato brani tratti dal canzoniere della Resistenza, mentre sullo sfondo scorrevano le fotografie della mostra. Le musiche sono state tratte prevalentemente dai canti partigiani diffusi nel territorio reggiano. Anche in questa guerra il canto ha avuto un significato importante. Attraverso esso si veicolavano emozioni, sentimenti, ideali ed orientamenti politici. Secondo la testimonianza di Cino Moscatelli, comandante partigiano in Valsesia, il canto partigiano è stato «un efficace strumento di propaganda e di organizzazione, di disciplina e di educazione collettiva. Per mezzo di rime e ritmi semplici si orientavano politicamente i partigiani, si impartivano direttive di lotta, si faceva appello ai loro sentimenti più nobili»8. S. Quasimodo, Il falso e vero verde, Appendice alla raccolta, Schwarz, Milano 1954. J. Donne, Nessun uomo è un’isola, Meditation XVII, Henry Alford, London 1839. 8 C. Bermani, Gli studi sul canto partigiano, in Canzoni e Resistenza, Atti del Convegno nazionale di studi Biella, 16-17 ottobre 1998, a cura di Alberto Lovatto, Consiglio regionale del Piemonte; Borgosesia, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli, Torino 2001. 6 7 133 Altre fonti che ci testimoniano l’importanza del canto nella vita dei partigiani le possiamo trovare nella letteratura di scrittori italiani del dopoguerra. Possiamo citare Italo Calvino, nel Sentiero dei nidi di ragno9, Vasco Pratolini nelle Ragazze di Sanfrediano10 e Beppe Fenoglio che, nel Partigiano Johnny, definisce il canto Fischia il vento una canzone «travolgente», e inoltre afferma «Quella loro canzone è tremenda. È una vera e propria arma contro i fascisti …». Come spesso accade in questi repertori le canzoni nascono più o meno spontaneamente a partire da melodie conosciute sulle quali si innestano nuovi testi. Nella scelta dei canti abbiamo privilegiato quelli più conosciuti e diffusi nel nostro territorio. Tali repertori, dopo la Liberazione, hanno continuato a vivere in occasione di raduni, feste di partito e celebrazioni civili. Chi continuava ad interpretarli erano cori vocali, piccoli complessi strumentali e bande di paese. Queste sonorità hanno conferito alle musiche un carattere genuino e popolare che nella nostra esecuzione abbiamo cercato di rievocare. I brani sono stati quindi reinterpretati così come ci sono stati trasmessi dalla tradizione: talvolta suonati con arrangiamenti che ricordano la scrittura bandistica, talvolta cantati, talvolta eseguiti in modo più originale. Ai canti partigiani abbiamo affiancato anche altre musiche. Tra queste la canzone Maramao perché sei morto, composta nel 1939 e diffusa dalla radio negli anni della guerra nell’interpretazione del famoso Trio Lescano, ci ha aiutato a ricreare l’atmosfera tipica degli anni Quaranta, in cui la radio costituiva il principale mezzo di informazione. Gli strumenti utilizzati sono stati quelli che quotidianamente i ragazzi suonano in classe: il flauto dolce nelle sue diverse estensioni (soprano, contralto, tenore), la chitarra e gli strumenti a percussione. L’intero ensemble è stato accompagnato dal pianoforte. Come già sottolineato, per noi e per i nostri ragazzi «cantare» significa ricordare. Pertanto, abbiamo voluto dedicare uno spazio particolare al tema della memoria proponendo agli spettatori la poesia di Primo Levi Se questo è un uomo. Di seguito, l’esecuzione di un brano musicale della tradizione ebraica I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 1947 « – Cantano! – esclama Pin. Difatti dal fondovalle arriva l’eco di un canto indistinto. – Cantano in tedesco… – mormora il cuoco. – Scemo! – grida la donna. – Non senti che è Bandiera rossa? – Bandiera rossa? – l’omino fa una piroetta per aria battendo le mani e il falchetto azzarda un volo con le ali tarpate sopra la sua testa. – Sì: è Bandiera rossa! Prende la corsa, giù per i dirupi, cantando “Bandiera rossa la trionferà…” fino a un ciglione da cui porge l’orecchio. Sì. È Bandiera rossa! Torna di corsa con grida di gioia, col falchetto che plana legato alla catenella come un aquilone. Bacia la moglie, dà uno scappellotto a Pin e tutti e tre si tengono per mano cantando». 10 V. Pratolini, Le ragazze di Sanfrediano, Mondadori, Milano 1961 «poi si udì una voce nel gruppo dei partigiani, al centro della piazza, che cominciò una canzone, e si levò il coro. Scarpe rotte, eppur bisogna andar. A conquistare la rossa primavera, dove splende il sol dell’avvenir». 9 134 ha fatto da sottofondo alle immagini scattate durante la visita effettuata presso il campo di concentramento di Dachau. Nell’appendice all’edizione scolastica del 1976 di Se questo è un uomo11 Primo Levi scrisse «Conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre. Per questo, meditare su quanto è avvenuto è un dovere di tutti». Desideriamo concludere questo articolo riportando le parole che il sindaco di Casalgrande, Andrea Rossi, ci ha gentilmente inviato alcuni giorni dopo la rappresentazione a Casa Cervi. Ringraziandolo per avere contribuito alla realizzazione del progetto, facciamo nostra la speranza espressa nelle ultime righe. In una sede che è insieme casa della memoria e simbolo della Resistenza della nostra provincia e simbolo della lotta di Liberazione, e al tempo stesso un vivace luogo di socializzazione e confronto, si è svolta una serata piacevole e importante. Importante perché dei giovani studenti, futuri cittadini di domani, sono riusciti a fare propria una storia, quella del movimento partigiano, che ha segnato il riaffermarsi dei valori di libertà, di cittadinanza e di uguaglianza, e a renderla spettacolo teatrale. Si è trattato di un evento che mi ha regalato emozioni e mi ha dato la speranza di un dialogo intergenerazionale che è alla base della nostra vita democratica, anche futura, e del senso collettivo di comunità. Casalgrande, 3 giugno 2011 Materiali utilizzati nello spettacolo: Brani musicali: •Compagni fratelli Cervi (1944). Composta dai partigiani del Distaccamento Fratelli Cervi nel Reggiano comandato da Sintoni (Fausto Pattacini), sull’aria di una vecchia canzone irredentista Dalmazia. •Maramao perché sei morto (1939). M. C. Consiglio e M. Panzeri. •Fischia il vento (1943/44). Parole di Felice Cascione sulla musica della canzone russa Katjusha (composta da Michail Isakovskij e Matvei Isakovic Blanter nel 1938) portata in Italia dai reduci della tragica campagna di Russia. •Bella ciao. Canto partigiano dell’Italia Centrale (Lazio, Abruzzo, Emilia), è la trasformazione del canto epico-lirico Fior di tomba, di cui si conoscono versioni già sulla medesima aria. •La Brigata Garibaldi (marzo-aprile 1944). Parole dei partigiani Mario Bisi e Rino Pellicciara sull’aria di un motivo militare. È considerato l’inno ufficiale delle brigate garibaldine della provincia di Reggio Emilia. I due 11 P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1976. 135 autori del testo, appartenenti alla Divisione Aristide, lo scrissero a Castagneto di Ramiseto, nelle montagne reggiane. •Oltre il ponte (1959). Italo Calvino e Sergio Liberovici. •Un as der Rebbe lacht. Canzone Yiddish appartenente al repertorio Klezmer. •Il canto degli italiani (1847). Goffredo Mameli e Michele Novaro. Eseguito in coda allo spettacolo per rendere omaggio ai 150 anni dell’Unità d’Italia. Testi letterari Passi tratti da: •Alcide Cervi, I miei sette figli •Nuto Revelli, La guerra dei poveri •Ignazio Silone, Vino e pane •Appunti e immagini della resistenza a Casalgrande (testimonianza di Sergio Bedeschi e Nello Codeluppi) •Rossana Rossanda, La ragazza del secolo scorso •Giaime Pintor, Il sangue d’Europa •Federico del Boca, Il freddo, la paura e la fame •Margherita Iannelli, Coi partigiani in casa •Elio Vittorini, Uomini e no •Renata Viganò, L’Agnese va a morire •Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici •Vittorio Foa, Il cavallo e la torre •Primo Levi, Se questo è un uomo 136 La Didattica della storia Il 150° dell’Unità d’Italia e i percorsi di Istoreco sul Risorgimento Fabrizio Solieri I festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, che hanno in buona parte coinciso con l’anno scolastico 2010-2011, ci offrono l’occasione per alcune riflessioni sulla didattica della Storia in generale e, più nello specifico, sulla Didattica della storia del Risorgimento. In realtà bisogna considerare che l’attenzione verso le tematiche riguardanti il processo di unificazione italiana da parte delle scuole non è necessariamente legata ai limiti temporali dei festeggiamenti ufficiali: da quando, all’interno del vasto panorama delle proposte didattiche di Istoreco (raccolte nella pubblicazione Prendi il Tempo), sono stati istituiti dei percorsi specifici sul Risorgimento questi hanno sempre riscosso una notevole attenzione. Ritengo giusto isolare tra le tante, almeno due motivazioni: la prima è che questi temi sono stati a lungo trascurati anche nell’insegnamento universitario ed i docenti si trovano quindi in difficoltà nel trattarli in classe; la seconda è che, finalmente, si è persa la patina «eroico-istituzionale» della storia del Risorgimento e si è passati a considerare tale periodo nella sua vera forma cioè come snodo fondamentale dell’ingresso del nostro Paese nel mondo contemporaneo, uno snodo quindi meritevole di approfondimenti specifici e interdisciplinari. A questo non soccorrono i manuali scolastici di Storia così preoccupati di dare «un colpo al cerchio ed uno alla botte», in ragione delle cangianti maggioranze parlamentari, e affermare tutto ed il contrario di tutto su ogni specifico argomento meritevole di dibattito (si tratti di lotta al brigantaggio, struttura istituzionale dell’Italia unita, Resistenza o altro). La Didattica della storia del Risorgimento non è però un caso isolato: mi pare di poter notare una generale richiesta di «didattica» all’interno della scuola italiana. La questione è solo apparentemente un paradosso: la progressiva burocratizzazione del ruolo dell’insegnante (cui vengono demandate funzioni di assistenza sociale, segretariato, ragioneria generale, interpretariato ecc.) fa sì che molto spesso le competenze specifiche del docente non possano emer- 137 gere e che si debbano cercare altrove quelle risorse umane che sarebbe sufficiente formare adeguatamente e liberare da incombenze improprie. Uno dei percorsi che ha raccolto le maggiori adesioni da parte delle scuole è stato «L’Italia chiamò: il Risorgimento italiano e i suoi oppositori a 150 anni dall’unità». Tale percorso si divide in due parti: la prima, istituzionale, riassume le principali tappe, gli avvenimenti, i processi economici, politici e sociali del Risorgimento italiano. La seconda parte invece tenta di fare chiarezza nel mare magnum delle interpretazioni e delle molteplici versioni sul processo di unificazione italiano. Quest’ultimo aspetto risulta di importanza fondamentale per la formazione degli studenti e dei cittadini in generale. Soprattutto negli anni caratterizzati dalle celebrazioni si assiste a una valanga di storie e controstorie che sembrano affermare punti di vista agli antipodi. Ovviamente è molto difficile orientarsi tra tante voci contrastanti e il pericolo è quello di lasciarsi affascinare dalle «teorie del complotto» che hanno il pregio di essere esaustive, cioè di spiegare tutto, anche a costo di forzature e contraddizioni. Ciò che realmente importa, quindi, non è soltanto approfondire gli argomenti specifici di un dato periodo storico ma prima di tutto cercare di chiarire quale sia lo statuto specifico della disciplina storica, vale a dire dotare gli studenti degli strumenti adatti per discernere, tra tante pubblicazioni, quelle degne di attenzione e quelle invece da scartare perché prive dei necessari requisiti di scientificità. Per fare questo ritengo che siano fondamentali due aspetti: il primo è il contatto con le fonti documentarie e soprattutto il rapporto tra l’interpretazione (onesta, disinteressata e consapevole) della fonte e la pubblicazione degli studi; detto in maniera più semplice, chiarire finalmente agli studenti l’importanza e il significato della note a piè di pagina (in vista, magari, di un loro corretto utilizzo nella famosa «tesina» per l’esame di maturità). Il secondo aspetto riguarda la «lentezza» del lavoro storico, cioè instillare la diffidenza per tutto quello che sembra clamorosamente e improvvisamente smentire decenni di studi e fare finalmente chiarezza completa sui «misteri» di questo o quest’altro argomento. Chiunque pratichi il lavoro storico sa bene che difficilmente ci sono clamorosi rivolgimenti e scoperte: nei casi fortunati gli studiosi migliori introducono un nuovo punto di vista che apre sentieri di ricerca nuovi che si vanno ad aggiungere ai precedenti, magari contribuendo a definirli meglio ma raramente cancellandoli completamente. Comunque, in ogni caso, chi si accinge a studiare un determinato argomento deve necessariamente portare su di sé gli studi precedenti e, nel caso, spiegare dove sbagliavano, piuttosto che ignorarli completamente. Alla fine non soltanto i risultati della ricerca storica sono spesso lenti ma sono sempre incompleti: non esiste cioè nessun quadro storico tanto dettagliato da essere completamente esaustivo, gli studenti devono imparare che soltanto nei romanzi gialli o nelle ricostruzioni dei «complottisti» tutti i fatti e le circostanze trovano una loro collocazione precisa. Un ruolo particolare e fortemente innovativo hanno rivestito negli ultimi 138 anni nella didattica di Istoreco le visite guidate ai luoghi di interesse storico nella città e nella provincia. Per quanto riguarda la storia del Risorgimento il percorso didattico è denominato Reggio s’è desta: strade e monumenti del periodo giacobino e risorgimentale e comprende una lezione introduttiva in classe seguita da una passeggiata nel centro cittadino alla ricerca dei luoghi simbolo del periodo giacobino e risorgimentale che si conclude con la visita guidata alla Sala e al Museo del Tricolore. In Italia gli studenti, spesso inconsapevolmente, vivono una situazione privilegiata: la storia è materialmente intorno a loro. Attraverso la visita guidata-laboratorio en plein air, che usufruisce del beneficio della lentezza, i ragazzi (e anche gli adulti) possono trovare numerose testimonianze del nostro passato solo parzialmente cancellate dalla trasformazione della città. È senza dubbio importante il fatto che in questo modo possono appropriarsi di nozioni che sarebbe molto più difficile far passare attraverso una lezione frontale in classe. Tuttavia dal punto di vista didattico ci sono almeno due altri aspetti ancora più formativi: il primo è la stimolazione della curiosità per ciò che li circonda: non esiste alcun tipo di conoscenza senza curiosità. Il secondo aspetto riguarda la capacità di «alzare lo sguardo da terra» (non soltanto in senso metaforico) cioè il saper cogliere autonomamente degli aspetti notevoli della realtà e delle sue trasformazioni; si tratta di combattere contro la tendenza contemporanea che vede i giovani letteralmente bombardati da migliaia di notizie, messaggi e stimoli di cui tuttavia non riescono a trattenere nulla o quasi. L’anno delle celebrazioni che si avvia alla conclusione ha segnato il positivo ritorno al centro dell’attenzione locale e nazionale delle tematiche riguardanti il processo di unificazione italiana. Tuttavia da parte delle istituzioni sono stati privilegiati gli ambiti celebrativi ed espositivi a scapito della ricerca. Manca, anche nel campo delle discipline storiche, una precisa volontà di investimento in questa direzione. Si tratta di una scelta estremamente pericolosa e poco lungimirante. Nel momento in cui viene meno la ricerca anche la migliore esposizione e il museo più ricco sono condannati a ricoprirsi di polvere ed il medesimo discorso vale per la didattica. La didattica vive della ricerca: i docenti, infatti, devono temere la sciatteria non la complessità delle questioni per specialisti della materia. È ovvio che per essere fruibili dagli studenti i risultati della storiografia più aggiornata necessiteranno di riduzioni ed adattamenti ma i ragazzi colgono, senza esitazioni e con grande partecipazione, il rinnovarsi degli studi. Per questo motivo è necessario che la didattica funzioni da stimolo per la ricerca e non esaurisca il suo ruolo nella ripetizione di un sapere storico che per la sua stessa natura è destinato a un precoce invecchiamento. 139 150° Unità d’Italia Una classe del liceo «Canossa» ripercorre… I cento passi di Peppino Impastato* Appunti di un viaggio Lorena Mussini Simone Procida Che senso assume oggi far dialogare le giovani generazioni con una realtà così peculiare del nostro paese come la Sicilia? E se, ragionevolmente, i sensi possono essere molteplici e si possono declinare in altrettanti percorsi di notevole interesse sul piano culturale e di un’educazione alla cittadinanza attiva, in che modo è possibile condurre insieme ai giovani questo dialogo e quali strategie formative attuare perché davvero gli argomenti studiati e le problematiche trattate si traducano in consapevolezza e in un impegno civile non scontato né estemporaneo? * Progetto pluridisciplinare – Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva «La legalità non è un’isola. Reggio Emilia-Palermo: andata e ritorno». Istituto superiore liceale «Matilde di Canossa» di Reggio Emilia, a.s 2010/2011-classe 3 I spp, docenti: Lorena Mussini, Simone Procida. In collaborazione con: ANPI, Istoreco, Museo Cervi, Cooperativa Oscar Romero, Libera sezione Palermo-Casa Memoria «Peppino Impastato», Istituto magistrale di Palermo «Regina Margherita». Ringraziamenti. I ragazzi della classe 3ª I spp e i docenti referenti del progetto vogliono ringraziare con profonda gratitudine per la collaborazione e il sostegno costante: anpi, in particolare Fiorella Ferrarini e Gemma Bigi; Istoreco; Museo Cervi, nella persona di Gabriella Bonini; i ragazzi e gli operatori di Libera di Palermo; gli studenti, i docenti e in particolare il Preside dell’Istituto Magistrale Regina Margherita di Palermo, prof. Guido Gambino, per l’accoglienza calorosa e l’ospitalità squisita che ci hanno riservato. Infine, un sincero, commosso grazie alla famiglia Impastato e alla operatrice che ha curato a Cinisi la nostra visita alla Casa-Memoria, rendendo il nostro incontro un’esperienza indimenticabile. 140 È a partire da queste domande che si sono definiti gli obiettivi fondamentali del nostro progetto pluridisciplinare sulla Sicilia, cogliendo anche l’occasione della ricorrenza dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia che volevamo trasformare in un’opportunità ed uno stimolo per i ragazzi ad approfondire il contributo culturale, artistico e letterario di una terra centrale per la storia del nostro paese come la Sicilia, evidenziandone però anche le contraddizioni esistenti e i problemi ancora irrisolti. Ma proprio per istituire una sorta di dialogo nel tempo e nello spazio, il progetto è stato pensato come ricerca-azione che si poteva concludere anche con un viaggio in terra siciliana, cosa che si è realizzata al termine dei percorsi di studio e delle attività di preparazione previste dal progetto. Il viaggio compiuto per incontrare luoghi e testimoni significativi della ricchezza storica e della civiltà di quella terra ci ha fatto incontrare anche tanti siciliani che si impegnano perché i valori della legalità, della giustizia, delle opportunità di lavoro e di emancipazione per tutti non restino solo belle utopie o sogni mancati. Per questo, alle lezioni di studio ed approfondimento tenute in classe dagli insegnanti delle discipline coinvolte nel progetto (italiano, storia, filosofia, storia dell’arte, scienze dell’educazione) si sono intrecciati momenti più interattivi di partecipazione a convegni per incontrare ed ascoltare esperti, giornalisti e magistrati impegnati nella lotta contro la mafia ed altre organizzazioni criminali e quanti nella società civile o nella realtà educativa si battono a favore della giustizia e della legalità. La classe ha così avuto l’opportunità di ascoltare e incontrare il magistrato Nicola Gratteri, il giorno 27 gennaio 2011 nell’ambito del convegno studi dedicato alla memoria e all’impegno contro le altre ingiustizie del nostro tempo. E il giorno 26 febbraio 2011 la classe ha partecipato all’incontro con il giornalista Giovanni Abbagnato, che ha presentato al liceo Canossa il libro da lui curato Strozzateci tutti, libro che raccoglie contributi vari e significativi di 23 scrittori del Sud, uniti dall’impegno antimafia. Il convegno, promosso ed organizzato dall’associazione Oscar Romero e dalla referente per la Regione Emilia Romagna Rosa Frammartino, è stato un’occasione importante per affrontare la complessità del fenomeno mafioso e le varie modalità che la mafia ha di radicarsi nella realtà socio-economica e nella società civile di un territorio, ma soprattutto nel tessuto produttivo del nostro Paese, con tentacolare ramificazione in tutte le zone dove ci siano ricchezze appetibili. L’argomento è stato ripreso ed approfondito anche in classe con letture di testimonianze relative ai giudici Falcone e Borsellino e di Peppino Impastato, completato dalla visone del film I cento passi. Queste attività sono state coronate dalla visita a Cinisi della Casa-Memoria degli Impastato, nel corso del viaggio in Sicilia; visita che ha visto un’intera mattinata dedicata a Cinisi e ai luoghi più significativi che fanno da sfondo alla vicenda umana ed esistenziale di Peppino Impastato (il palazzotto di Tano Badalamenti, la ferrovia, la via centrale del paese, ecc.). Senza dubbio per i ragazzi è stato uno dei momenti più toccanti e commoventi del percorso, non solo perché hanno ripercorso i Cento Passi che separavano 141 la casa degli Impastato da quella del boss mafioso della zona, Badalamenti; ma anche perché le domande di oggi e dei nostri ragazzi si sono intrecciate alle domande dei ragazzi di allora che, come Peppino prima di tutti, avevano cercato di trovare delle risposte col giovanile coraggio di quell’impegno e di quelle azioni di denuncia. Anche l’attività pomeridiana presso l’associazione regionale di Libera a Palermo ha toccato diversi aspetti importanti e difficili che incontrano quanti si impegnano e lottano concretamente perché i valori della giustizia e della legalità si traducano in lavoro e prospettive per i giovani, prospettive di studio e di impegno reale per tutti, in opportunità di poter realizzare onestamente traguardi importanti e normali quanto una casa, un lavoro, una famiglia. Anche in questa occasione abbiamo voluto che fossero i ragazzi a porre domande e interrogativi sui tanti problemi e sui rischi che questo impegno comporta ed una delle cose più belle che ci siamo sentiti chiedere è stata: che cosa possiamo fare tutti noi, nel nostro quotidiano per contrastare la mafia? Una delle risposte più belle fra le tante ascoltate: anche essere qui insieme a noi, tutti quanti da Reggio Emilia, è una testimonianza alla città, ai palermitani che c’è attenzione, coscienza, sensibilità e solidarietà e si sa, finché c’è l’attenzione della società civile e della collettività, c’è una sorta di protezione e difesa per coloro che sono impegnati in prima persona nelle tante attività antimafia. Ma proprio perché volevamo che il percorso di studio e di educazione alla cittadinanza attiva si traducesse anche in una sorta di riconoscimento degli apporti culturali della Sicilia, perché si destrutturasse lo stereotipo «siciliano, uguale mafioso», abbiamo approfondito e studiato diversi periodi storici in cui la Sicilia è stata la culla di civiltà fiorenti e ricche e di processi storici che in qualche modo anticipavano o sintetizzavano le sorti dell’intero paese. Così, a partire dalla Magna Grecia siamo giunti, attraverso la civiltà arabo-normanna e la splendida corte di Federico II di Svevia, al regno delle Due Sicilie e ai Borbone fino alla proclamazione del Regno d’Italia e al risorgimento mancato per le regioni del Sud nella dura realtà dell’Italia post-unitaria. Ed è in questa prospettiva che si iscrive il gemellaggio con l’Istituto magistrale di Palermo «Regina Margherita», che non solo ci accolto con squisita ospitalità nella persona del preside, professor Gambino, e dei docenti che hanno accompagnato la nostra visita compiuta alla scuola, affascinante gioiello sul piano architettonico incastonato nel centro storico di Palermo, ma si è tradotto in attività di scambio culturale ed educativo fra la nostra classe e la classe dell’Istituto che ci accolto. I ragazzi di Palermo ci hanno raccontato i tanti progetti europei, e non, che realizzano nel corso dei loro studi al Regina Margherita; ci hanno parlato della loro vita scolastica e della loro bella città, ci hanno trasmesso il loro entusiasmo a cambiare le cose e il loro sentirsi partecipi ed interpreti di una terra ricca di civiltà, di umanità gentile ed ospitale. I ragazzi palermitani ci hanno ringraziato per essere andati in Sicilia ed averli voluti incontrare per aver voluto conoscere, capire, ascoltare ed apprezzare 142 Lorena Mussini (al centro in seconda fila), Simone Procida (riconoscibile a fianco della targa) e gli studenti del Canossa davanti alla Casa Memoria «Peppino Impastato» un patrimonio millenario di cultura, passione e progresso che va ben oltre l’equazione Sicilia-mafia. L’incontro molto vivace ed emozionante si è concluso con… un assaggio delle deliziose golosità siciliane e con la promessa che il prossimo anno scolastico saranno loro a salire su nella nostra terra, per un tour di… storia, cultura, memoria e delizie gastronomiche! L’abbraccio finale dei nostri ragazzi con quelli palermitani sulla splendida terrazza della loro scuola, da cui si dominava con un unico sguardo tutta Palermo, ha suggellato un viaggio davvero straordinario per suggestioni ed emozioni. Questo lo abbiamo scritto noi… Le parole dei ragazzi Valerio Franceschini: «Dopo questa esperienza ho capito come la mafia non sia semplicemente quel gruppo organizzato di criminali che fanno leva sulla massa e sul senso di insoddisfazione comune, ma sia un vero e proprio modo di agire radicato in quasi ogni persona, in quantità variabile. Mafia è volere qualcosa ottenendolo ingiustamente, mentre qualcun altro ha sudato per ottenerlo; fare qualcosa di ingiusto ed influenzare così gli altri ad agire 143 malignamente; infrangere continuamente regole rispettate dagli altri e portare sofferenza a coloro che agiscono giustamente, facendoli sentire “diversi”. Per sconfiggere l’organizzazione vera e propria denominata mafia bisogna sradicare da noi questo modo di comportarsi ed acquisire un forte senso di comunanza e fratellanza, agendo in modo giusto e comune». Laura Prestìa: «Quando siamo atterrati all’aereoporto «Falcone Borsellino» di Palermo si sentiva già un’aria diversa, non solo per l’aria del mare, ma proprio per la disponibilità, la felicità, l’allegria che trasmettevano i siciliani… abbiamo fatto visita all’associazione Libera che, con la sua costante presenza sul territorio, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul complesso e articolato mondo che il termine mafia racchiude; sono tante le attività che vedono Libera presente nel tessuto socio-culturale siciliano e nazionale e tutte le associazioni e i volontari che ne fanno parte comunicano un’intensa positività nell’agire insieme». Quando siamo atterrati all’aereoporto «Falcone Borsellino»… Elisabetta Carapezzi: «Troppo spesso si dà per scontato che qui, al “Nord”, non vi sia alcuna forma di criminalità organizzata, o in ogni caso si fa finta che non ci sia. Una cosa che ho notato personalmente è il differente approccio che le persone hanno nei confronti di questo delicato argomento. Infatti, mentre nella nostra realtà regionale spesso sembra che il problema non sussista, non abbia né peso né sostanza e che sia delimitato a una circoscritta condizione; al “Sud” sembra che le persone sviino il discorso, a meno che non siano direttamente coinvolte nella sua prevenzione o nel diretto contrasto. Nel contesto di una reticenza nel parlare di questo tema abbiamo potuto notare la stupenda solarità elargita dalle persone del posto. Siamo rimasti meravigliati da questa caratteristica e subito ci siamo sentiti accolti come se fossimo a casa nostra: non solo dalle persone che abbiamo conosciuto direttamente, ma anche dai semplici passanti che, indossando un sorriso, chiacchieravano con noi, persone che non avevano mai incontrato e conosciuto. Questa calorosità rispecchia pienamente la bellezza dei luoghi». Mariantonia D’Amico: «Sapendo dell’incontro con questa associazione, mi ero preparata a sentire parlare sempre allo stesso modo di mafia e di come combatterla. Ed invece mi sono dovuta ricredere. La passione con cui si parla dei progressi che si sono fatti e dei progetti che si hanno intenzione di svolgere ti fa venire voglia di tornare a casa e renderti utile. Andare subito in una delle varie affiliate di Libera o di qualsiasi altra organizzazione, iscriverti e partecipare attivamente a far scomparire la mafia da tutto il paese». 144 Sabrina Fontana: «Strano arrivare a Cinisi, il paese di Peppino, strano entrare nella sua casa, strano contare cento passi e giungere di fronte alla casa di Badalamenti; tutto ciò di cui abbiamo parlato per mesi ora è dinnanzi a te. Un paese come tanti altri, come quelli del nord, eppure è successo tutto li. Ciò dimostra che una realtà che può sembrare normale può nascondere attività illegali che Peppino ha avuto il coraggio di denunciare, prima con il circolo di musica e cultura e poi con Radio aut. Il suo coraggio è forte, anche la sua incoscienza di giovane gli ha permesso di essere un eroe e di andare contro ad un sistema in cui era coinvolta la sua famiglia in primis. Quindi, Peppino ti ringraziamo perché sei stato uno dei promotori della lotta contro la mafia, rimettendoci la vita. Non ti scorderemo mai, e sarai una delle motivazioni, come tante altre vittime della mafia, a scegliere di non rimanere indifferenti ma di dire di no». Silvia Iotti: «Con la visita all’associazione Libera di Palermo ho avuto conferma del fatto che la mafia non è un fenomeno che opera solo nella parte meridionale della nostra penisola ma è un’organizzazione che ha esteso i suoi traffici anche nella parte settentrionale della nazione. Per questo motivo è necessario che ognuno di noi, anche se solo nel suo piccolo, si impegni al fine di contrastare queste organizzazioni malavitose compiendo una scelta che si basa sul dover intraprendere la “strada più comoda” o al contrario quella “più giusta”». Mariachiara Torrelli: «I volontari di Libera possono essere un esempio per tutti noi; non sono degli eroi, semplicemente persone che hanno scelto da che parte schierarsi, persone che a differenza di noi sono uscite dall’oblio dell’indifferenza, persone che credono in qualcosa portandolo avanti. Allora possiamo combattere la corruzione con una scelta, con una scelta che pian piano può cambiare le sorti del mondo, nel mondo in cui tu vivi e ne fai parte». 145 Materiali d’ a r c h i v i o L’Archivio storico della Provincia di Reggio Emilia Una risorsa per la memoria locale Alberto Ferraboschi* Gli archivi storici delle Province Il recente conferimento al Polo archivistico dell’archivio storico della Provincia di Reggio Emilia, oltre a consolidare un originale modello di conservazione della memoria locale1, offre l’occasione per scoprire l’importante patrimonio storico-documentario rappresentato dagli archivi storici delle Province. In effetti, all’interno del panorama archivistico le risorse documentarie delle Province costituiscono ancora oggi per lo più una «fonte dimenticata»2. Del resto, il disinteresse nei confronti degli archivi delle istituzioni provinciali rappresenta un dato di lungo periodo nel contesto archivistico e storiografico italiano3. Questo basso livello d’attenzione è imputabile a diverse ragioni. Un * Responsabile Archivio storico della Provincia di Reggio Emilia. 1 L’esperienza del Polo archivistico di Reggio Emilia rappresenta a tutti gli effetti un modello all’interno del panorama archivistico regionale e si pone in coerenza con quanto approvato il 21 novembre 2009 dalla 2ª Conferenza nazionale degli archivi che ha individuato nei poli archivistici i luoghi e gli strumenti idonei della cooperazione interistituzionale per la conservazione, gestione e valorizzazione coordinata del patrimonio documentale. 2 G. Nicolosi, Per una storia delle amministrazioni provinciali, in «Le Carte e la Storia», 1/2000, p. 165; F. Valacchi, Elementi per la definizione di un censimento sistematico delle fonti conservate negli archivi storici delle amministrazioni provinciali in C. Cavallaro (a cura di), Una mente colorata. Studi in onore di Attilio Mauro Caproni per i suoi 65 anni, Vecchiarelli editore, Roma 2007, pp. 751-772. 3 Sebbene negli ultimi anni si debba registrare un crescente interesse storiografico sul tema delle amministrazioni provinciali in Italia – testimoniato anche dai convegni nazionali di studi del 2002 (Le Province in Italia. Fonti, storie e prospettive, Lecce, 12-13 dicembre 2002) e del 2009 (Le amministrazioni provinciali in Italia nell’età contemporanea. Aspetti storici e giuridici, Padova, 19-20 novembre 2009) – lo stato degli studi riguardanti la Provincia in età contemporanea risulta ancora piuttosto deficitario, soprattutto se confrontato con la solida e qualificata tradizione di studi sviluppatosi negli ultimi decenni intorno alla storia delle città. Per un bilancio storiografico e archivistico si può fare riferimento a Nicolosi, Per una storia delle amministrazioni provinciali, cit., pp. 158-172; Valacchi, Elementi per la definizione di un censimento sistematico delle fonti conservate negli archivi storici delle amministrazioni provinciali, cit.; F. Agostini (a cura di), Le amministrazioni provinciali in Italia. Prospettive 147 primo elemento, in larga misura oggi superato, riguarda il retaggio della politica conservativa nazionale incentrata principalmente sulle fonti archivistiche di produzione statale che ha generato una notevole sottovalutazione dei complessi documentari non statali4. Una seconda ragione è più propriamente di carattere storico-politico. Infatti, il tradizionale disinteresse verso gli archivi storici provinciali è la conseguenza di quel pregiudizio istituzionale gravante sulla Provincia5 quale ente «fragile», «artificioso» e dal carattere «ibrido»6 destinato a riemergere anche nel lungo dibattito sull’abolizione dell’ente Provincia7. Ciò generali e vicende venete in età contemporanea, Franco Angeli, Milano 2011. Tra le monografie devono almeno essere segnalati i seguenti lavori: A. Amorth, Le Province, in A. Amorth (a cura di), Le Province, Neri Pozza, Vicenza 1968; V.G. Pacifici, La Provincia nel Regno d’Italia, Gruppo Editoriale Internazionale, Roma 1995; A. Polsi, Per una storia delle amministrazioni provinciali in Italia, Il Campano, Pisa 2003. Occorre inoltre ricordare che i contributi storiografici sulle singole e specifiche realtà provinciali appaiono ancora piuttosto limitati, sebbene tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, sulla scia della ricca stagione storiografica dedicata alle forme del potere locale, si sia intensificato il lavoro di ricerca sul ruolo esercitato dalle amministrazioni provinciali nei diversi contesti territoriali. Oltre al classico lavoro di Mola su Cuneo (A.A. Mola, Storia dell’Amministrazione provinciale di Cuneo dall’Unità al Fascismo, 1971), tra i lavori più recenti, senza alcuna pretesa di completezza, si possono menzionare gli studi sulla Terra d’Otranto (M. De Giorgi, La Provincia di Terra d’Otranto, 1861-1923). Ricomposizione delle fonti e costruzione di una banca dati, Manduria, Lacaita 1995), Torino (A. Castagnoli, Torino. Dalla ricostruzione agli anni Settanta. L’evoluzione della città e la politica dell’Amministrazione provinciale, 1995), Firenze (S. Merendoni, G. Mugnanini, La Provincia di Firenze e i suoi amministratori, 1996), Asti (A. Gamba, La Provincia di Asti tra cronaca e storia, 2002), Siena (Nicolosi, La provincia di Siena in età liberale. Repertorio prosopografico dei consiglieri provinciali 1866-1923, 2003), Ferrara (D. Tromboni, Terra di Provincia. Uomini donne memorie figure, 2003), Pesaro-Urbino (A. Varni, La Provincia di Pesaro e Urbino nel Novecento. Caratteri, trasformazioni, identità, 2003), Pisa (E. Fasano, Storia della Provincia di Pisa, 2004) e Modena (E. Guaraldi, Breve storia della Provincia di Modena 1859-2009, 2009). 4 Sul tema delle politiche conservative legate al controllo sulla trasmissione della memoria dello stato-nazione, all’interno della vasta letteratura sono fondamentali gli studi di I. Zanni Rosiello. Ad esempio, cfr. I. Zanni Rosiello, Archivi e memoria storica, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 36-42. 5 Sul rapporto tra la problematica identitaria dell’ente Provincia e il modesto appeal storicoarchivistico delle amministrazioni provinciali hanno insistito numerosi studiosi. Tra i tanti, cfr. G. Nicolosi, Per una storia dell’amministrazione provinciale di Siena. Il personale elettivo (1865-1936). Fonti, metodologia della ricerca e costruzione della banca dati, Siena, Di. Gips., Working Paper n. 30, 1997, p. 1 e p. 11; L. Baldissara, Una «sfida al buon senso»?. Dell’ente provinciale nella storia, in F. Guarini (a cura di), La Provincia di Pisa, cit., pp. 43-45; P. Aimo, Un’istituzione «debole». L’Ente provincia nella seconda metà dell’Ottocento, in Agostini (a cura di), Le amministrazioni provinciali in Italia, cit., pp. 38-39. 6 Nonostante la più recente stagione di studi abbia evidenziato lo specifico ruolo esercitato dalla Provincia nell’ambito del funzionamento del sistema politico locale e nazionale (specie dell’età liberale), permane ancora diffuso anche in ambito storiografico il giudizio circa la debolezza e lo scarso rilievo dell’ente Provincia nell’ordinamento amministrativo, specialmente a causa di alcuni vizi di origine generati dalla prima legislazione unitaria cfr. Nicolosi, Per una storia delle amministrazioni provinciali, cit., p. 159. 7 Per una ricostruzione del dibattito abolizionistico della Provincia lungo l’intera vicenda dell’Italia repubblicana cfr. F. Bonini, Le Province della Repubblica: l’abolizione mancata, in Agostini (a cura di), Le amministrazioni provinciali in Italia, cit., p. 161-187. 148 ha comportato inevitabilmente una debolezza nella definizione di una specifica e riconosciuta fisionomia di questa tipologia di archivio. Infine, vi è una terza ragione connessa alla «cultura archivistica» e derivante dall’atteggiamento della comunità scientifica nei confronti della documentazione contemporanea. Il patrimonio documentario delle Province, in quanto costituito prevalentemente da materiale otto-novecentesco, è stato ritenuto troppo recente per essere meritevole di una particolare attenzione (specialmente rispetto a quella dei Comuni, enti territoriali di origine più remota, depositari non di rado anche di documentazione molto antica). In effetti a lungo l’attività e la mentalità degli archivisti erano state caratterizzate dall’idea che le carte d’archivio erano tanto meno importanti quanto più ci si avvicinava al tempo presente. Una secolare tradizione dottrinaria e pratica, peraltro connessa ai coevi studi storici non troppo interessati a scavare nel terreno della contemporaneità, ha dunque e per lungo tempo pesato sulla conservazione/non conservazione delle carte più recenti8. In realtà, in considerazione dello specifico ruolo svolto storicamente dalla Provincia nell’ordinamento amministrativo quale ente intermedio tra Comuni, Stato e Regioni (di più recente istituzione)9, gli archivi provinciali possono fornire preziosi contributi alla ricerca storica: da quella delle classi dirigenti (si pensi al tema cruciale della Provincia quale luogo d’insediamento privilegiato del notabilato in età liberale)10 passando per quella socio-sanitaria (specialmente nel campo della beneficenza pubblica e assistenza psichiatrica per la tradizionale competenza sui «poveri mentecatti»)11, quella scolastica (con particolare riguardo all’ambito dell’istruzione scientifica e tecnica)12, quella della I. Zanni Rosiello, Archivi, archivisti, storici, in L. Giuva, S. Vitali, I. Zanni Rosiello, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea, Mondadori, Milano 2007, p. 13. 9 «Una volta inserite nell’assetto amministrativo statale, soprattutto in età liberale, quando costituivano ancora l’unico anello di congiunzione tra lo Stato e le singole municipalità, le province hanno finito per svolgere un ruolo ben definito che è andato consolidandosi nel tempo» (Nicolosi, Per una storia dell’amministrazione provinciale di Siena. Il personale elettivo, 1865-1936, cit., p. 2). 10 Nicolosi, La Provincia come «luogo» del notabilato in età liberale. Considerazioni storiche e storiografiche, in Agostini (a cura di), Le amministrazioni provinciali in Italia, cit., pp. 93-101. 11 Sull’importanza della documentazione archivistica provinciale quale «fonte imprescindibile per lo studio del disagio mentale» cfr. P. Romagnoli, Gli atti dell’assistenza psichiatrica della provincia di Modena: tipologie documentarie e loro organizzazione in A. Giuntini (a cura di), Povere menti. La cura della malattia mentale nella provincia di Modena fra Ottocento e Novecento, Tipografia TEM, Modena 2009, pp. 87-95. 12 Come è stato osservato, «la storiografia ha tematizzato il rapporto tra le scuole e i Comuni ma quasi per niente quello scuole-Province, se non per gli aspetti finanziari» nonostante gli archivi provinciali offrano ampio e ricco materiale per indagare tale questione cfr. A. Gaudio, La Provincia e la scuola. Appunti, in Fasano Guarini (a cura di), La Provincia di Pisa, cit., p. 649. 8 149 gestione del territorio (con riferimento alle infrastrutture viarie e ferroviarie)13, fino alla storia istituzionale (anche in relazione al tema della finanza locale)14 e all’emergente filone della storia ambientale15. Più in generale, gli archivi delle Province rappresentano una risorsa preziosa sia in quanto espressione di un ente titolare di composite competenze16 (alcune delle quali di particolare rilevanza nel processo di costruzione dello stato nazionale)17, sia in quanto riflesso di un soggetto amministrativo operante su scala sovralocale, promotore e gestore anche di un ricco patrimonio informativo nell’ambito provinciale (si pensi alle sistematiche indagini conoscitive che furono realizzate lungo l’età liberale in diverse materie)18. Occorre poi ricordare che in caso di dispersioni o distruzioni (parziali o totali) di documentazione degli archivi comunali19, il materiale delle Province può svolgere una fondamentale funzione surrogativa20. Da ultimo, si deve Per uno studio di caso nel contesto emiliano cfr. A. Manicardi (a cura di), La Provincia si fa strada. Centocinquant’anni di viabilità nel territorio modenese, Nuovagrafica, Carpi 2008. 14 Ad esempio tra gli studi più recenti si segnala la ricerca dedicata alla Varese ottocentesca di Ivana Pederzani che ben evidenzia le implicazioni politico-amministrative connesse al fondamentale ruolo di controllo tutorio svolto dalla Deputazione provinciale sui bilanci comunali (I. Pederzani, «Il carro del progresso». Spesa pubblica, politica e società a Varese in età liberale (1859-1898), Unicopli, Milano 2009, in particolare, pp. 330-341). 15 A mero titolo esemplificativo si può fare riferimento agli studi dedicati al ruolo della Provincia in materia ambientale nel contesto pisano, C. Torti, La politica ambientale, in Fasano Guarini (a cura di), La Provincia di Pisa, cit., pp. 605- 648, e in quello veneto P. Santinello, Provincia, ambiente e territorio dal secondo Novecento ad oggi nel Veneto, in Agostini (a cura di), Le amministrazioni provinciali in Italia, cit., pp. 408-421. 16 Vale la pena di ricordare che, ai sensi della legge 20 marzo 1865 n. 2248 (ripresa in modo sostanziale dalla legge crispina del 1888 e dai testi unici emanati nel 1898, nel 1908 e nel 1915), la Provincia aveva una serie di competenze specifiche elencate dalla legge, un potere regolamentare e un potere di nomina di rappresentanti in altri organismi rappresentativi; tra i principali campi su cui la Provincia poteva esercitare la propria iniziativa vi era la «creazione di stabilimenti pubblici provinciali» come le scuole agrarie e professionali, musei, ricoveri e istituti di pubblica beneficenza, il «mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia», la manutenzione delle «strade provinciali e i lavori relativi a fiumi e terreni posti dalle leggi a carico della Provincia». 17 Si pensi, ad esempio, al tema delle infrastrutture viarie e ferroviarie o alla questione dell’istruzione tecnica e scientifica, aventi forti implicazioni con il processo del nation building. A ciò si aggiunga il ruolo svolto dalle amministrazioni provinciali italiane durante la fase postunitaria nella definizione di un sistema simbolico-rituale e di elaborazione della memoria di stampo nazional-patriottico anche in relazione alle competenze sulla conservazione dei beni monumentali e artistici. 18 Sul ruolo di snodo della Provincia nel processo di sviluppo degli apparati informativi dello Stato nazionale ottocentesco attraverso la sistematica raccolta e classificazione delle informazioni cfr. G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana 1861-1993, Il Mulino, Bologna 1996, p. 109. 19 Emblematico da questo punto di vista nel contesto reggiano è il caso dell’archivio storico del Comune di Toano che fu completamente bruciato nel corso della seconda guerra mondiale, l’8 luglio 1944 ed il 31 agosto dello stesso anno. Cfr. G. Rabotti (a cura di), Archivi storici in EmiliaRomagna, Analisi, Bologna 1991, p. 846. 20 G. Plessi, Compendio di archivistica, CLUEB, Bologna 1990, pp. 98-99. 13 150 segnalare la tendenza degli archivi delle amministrazioni provinciali ad aggregare importanti e molteplici complessi documentari, talora lasciati in eredità dagli stati preunitari21. In particolare, tra i fondi aggregati agli archivi delle Province che presentano maggiore interesse storiografico si segnalano quelli degli organismi creati a livello provinciale dal fascismo nella costruzione di un sistema di salvaguardia sociale (dall’Opera nazionale maternità ed infanzia22 al consorzio provinciale antitubercolare) o quelli degli uffici periferici delle organizzazioni internazionali, l’unrra (United nations relief and rehabilitation administration) e l’aai (Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali), che si occuparono di gestire a livello locale gli aiuti internazionali nella delicata fase della ricostruzione del secondo dopoguerra23. La storia conservativa dell’archivio della Provincia di Reggio Emilia La storia dell’archivio della Provincia di Reggio Emilia riflette la complessità della vicenda storica dell’ente Provincia, evidenziando una conseguente incertezza della pratica conservativa24. Infatti, come ha osservato Federico Valacchi, «in assenza di strumenti assimilabili alla circolare Astengo per i Comuni, ogni provincia ha gestito in maniera autonoma e non sempre lineare propri titolari di classificazione, col risultato di sedimentazioni piuttosto eterogenee e comunque difficilmente riconducibili ad un quadro complessivo che ne rendesse Ad esempio, nell’ambito emiliano l’Archivio storico della Provincia di Modena è depositario del Gridario Estense (1527-1854) e degli Atti dell’Ufficio Esposti della Congregazione di Carità (1828-1937) mentre l’Archivio storico della Provincia di Bologna conserva diversi fondi preunitari come gli archivi dell’Ospedale degli esposti (sec. XV-1937), dell’Opera pia dei carcerati (16011798), della Congregazione di Carità (1798-1814), la Casa Provinciale di Lavoro (1818-1861) e la Casa provinciale di correzione (1826-1882). Cfr. C. Ghelfi (a cura di), Provincia di Modena. Guida all’archivio, Tipolitografia Jolly, Modena 1994, pp. 50-51; M.L. Bongiovanni, F. Delneri (a cura di), Guida archivio storico provinciale di Bologna, Provincia di Bologna, 2007, pp. 140-149. 22 L’importanza degli archivi provinciali per le storie locali dell’onmi è stata evidenziata anche da Michela Minesso nell’introduzione allo studio dedicato alla vicenda storica dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia cfr. M. Minesso (a cura di), Stato e infanzia nell’Italia contemporanea. Origini, sviluppo e fine dell’Onmi 1925-1975, Il Mulino, Bologna 2007, p. 26. 23 Ad esempio l’Archivio storico della Provincia di Reggio Emilia conserva una consistente documentazione relativa all’attività dell’unrra nel contesto locale. Tale materiale riveste un rilevante interesse storico in quanto allo stato attuale non risultano ancora disponibili specifici studi di caso in ambito locale sull’attività dell’Amministrazione per gli aiuti internazionali. Per un inquadramento della complessa vicenda dell’aai, snodo di notevole importanza nel processo di «ricostruzione sociale» della nazione e operante tra il 1945 e il 1962 cfr. A. Ciampani (a cura di), L’Amministrazione per gli Aiuti Internazionali. La ricostruzione dell’Italia tra dinamiche internazionali e attività assistenziali, Franco Angeli, Milano 2002. 24 Sulla vicenda conservativa dell’archivio storico della Provincia di Reggio Emilia sia consentito rinviare a A. Ferraboschi (a cura di), Memoria e identità. Catalogo mostra documentaria, Reggio Emilia 2008. 21 151 agevole la lettura e l’utilizzazione»25. Nel caso della Provincia di Reggio fin dal 1888, a vent’anni dalla costituzione della Provincia, fu necessario elaborare un nuovo titolario più idoneo ai compiti dell’amministrazione. Dunque, nel corso del tempo si susseguirono diversi titolari: il primo copre il periodo dal 1860 al 1888; il secondo dal 1889 al 1903 (composto da 11 titoli suddivisi in rubriche e filze); il terzo dal 1904 al 1962 (composto da venti titoli suddivisi in categorie, rubriche e filze). Nel 1962 fu istituito un nuovo titolario con venti titoli suddivisi in categorie e filze. A questa «instabilità» classificatoria occorre aggiungere che l’archivio della Provincia depositato oggi presso il Polo archivistico presenta alcune lacune relative alla documentazione ottocentesca; queste carenze sono riconducibili in parte a un furto avvenuto nel 1938, quando vennero trafugate 165 filze, di cui 15 anteriori al 1863. Inoltre nel 1888, in occasione della conversione dell’allora Archivio consorziale (o di deposito) in Archivio di Stato, fu versato presso l’Archivio di Stato di Reggio Emilia diverso materiale documentario. Il nucleo documentario della Provincia attualmente conservato presso l’Archivio di Stato di Reggio Emilia riguarda il periodo 1860-1865, è suddiviso in titoli e rubriche ed è formato da 54 volumi e mazzi, corredato da sei registri di protocollo26. Come la maggior parte degli archivi storici degli enti locali, anche l’archivio della Provincia ha avuto una difficile vita conservativa fino ai tardi anni Ottanta del Novecento, anche in ragione della qualità della cultura archivistica presente all’interno del contesto di riferimento. In base ad un’indagine sulla gestione degli archivi degli enti locali della provincia di Reggio Emilia27 risalente al 1988 l’archivio della Provincia di Reggio Emilia versava ancora in una situazione piuttosto critica. Infatti, la scheda dedicata all’archivio della Provincia curata da Silvia Pastorini denunciava una condizione di degrado con «materiale non ordinato, consultazione assai difficoltosa, condizioni generali cattive»28. Il problematico stato conservativo ha contribuito così a rendere l’archivio della Provincia praticamente inaccessibile alla ricerca storica ed esclusa dalla circolazione e produzione culturale per lungo tempo29. Valacchi, Elementi per la definizione di un censimento sistematico delle fonti conservate negli archivi storici delle amministrazioni provinciali, cit. Cfr. Badini, Gli archivi e la storia in W. Baricchi (a cura di), Il Palazzo ducale, Reggio Emilia, Tecnograf, 1989, pp. 90-98; N. Campanini, Relazione intorno all’archivio generale provinciale di Reggio nell’Emilia per l’anno 1889, Reggio Emilia 1890. 27 Cfr. M. Storchi, M.N. Casali (a cura di), Archivi e autonomie dal cln alla Ricostruzione, Edizioni delle Autonomie, Reggio Emilia 1988. Ringrazio Massimo Storchi per la segnalazione bibliografica. 28 Ivi, p. 49. 29 In effetti, fino agli ultimi decenni del novecento all’interno della storiografia locale sono praticamente assenti i riferimenti alla documentazione relativa all’archivio della Provincia. Solamente alla fine degli anni Ottanta, grazie in particolare ai due studi dedicati alla storia dell’amministrazione provinciale reggiana, Baricchi (a cura di), Il Palazzo ducale, cit.; G. Badini (a cura di), La Provincia di Reggio Emilia 140 anni di storia, La nuova Tipolito, Felina 2000, l’archivio della Provincia cominciò ad essere effettivamente frequentato per finalità di ricerca storica; inoltre risalgono a quella stessa congiuntura i primi studi sugli amministratori provinciali come il lavoro dedicato a Velia Vallini che attinge largamente al patrimonio documentario dell’ente cfr. A. Appari (a cura di), Velia Vallini. Istituzione e cultura dei servizi a Reggio Emilia 1951-1974, Linotipia Emiliana, 1992. 25 26 152 Solamente alla fine degli anni Ottanta del Novecento, nel quadro della «fioritura di iniziative volte al recupero e alla valorizzazione di archivi non statali»30 e sulla scia della campagna archivistica che interessò gli archivi degli enti locali della regione Emilia-Romagna31, emerse all’interno dell’ente una consapevolezza dell’importanza delle fonti d’archivio della Provincia per la memoria locale32. Si crearono così le condizioni per la costituzione di una sezione separata d’archivio storico con il trasferimento in locali di deposito situati in località San Maurizio a Reggio Emilia. Il materiale vi fu trasferito nel 1989, quando fu avviata l’organizzazione del materiale archivistico pre-1945 e fu istituita la sezione storica dell’archivio della Provincia. In tale circostanza fu effettuato un primo parziale intervento di riordino del materiale documentario e fu anche redatto uno strumento inventariale33. Esaurita questa prima fase di attenzione, è principalmente nell’ambito delle politiche di valorizzazione dell’identità e della memoria locale promosse dalla Provincia negli ultimi anni che si sono create le condizioni per l’avvio di un vero e proprio progetto di recupero e valorizzazione delle risorse documentarie34. In particolare, nel 2008 è stato effettuato un intervento di recupero e riordino parziale di un secondo nucleo documentario dell’archivio storico35 e, grazie anche al recente trasferimento presso il Polo archivistico36. sono maturate le condizioni per un organico lavoro di riordino della documentazione e di valorizzazione del patrimonio archivistico. I. Zanni Rosiello, Gli archivi nella società contemporanea, Il Mulino, Bologna 2009, p. 86. Gli interventi archivistici si collocavano nel quadro della normativa regionale in materia archivistica, la legge regionale 27 dicembre 1983, n. 42 «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale». 32 La deliberazione n. 1399/5000 approvata dal Consiglio provinciale il 22/4/1988 con cui fu approvato il progetto di riorganizzazione del materiale archivistico ricordava che «la documentazione contenuta negli archivi della Provincia riguarda un arco di tempo di circa un secolo e in parte testimonia le trasformazioni politico-amministrative conseguenti ai mutamenti economici e sociali avvenuti fra il sec. XIX e XX in un’ottica intermedia tra lo Stato ed i Comuni» così come «risulta essere di notevole importanza sia la conoscenza sia la conservazione di quegli atti che sono la testimonianza di un importante momento della storia della comunità». 33 Cfr. W. Baricchi (Studio Arteas), Archivio storico della Provincia di Reggio Emilia. Inventario, 1990. 34 Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 201 del 24/7/2007 è stata istituita l’U.O. Valorizzazione archivio storico e protocollo preposta alle funzioni di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio documentario dell’archivio della Provincia ed afferente alla storia del territorio reggiano. 35 In tale circostanza è stato redatto anche uno strumento di corredo: A. Casotto (a cura di), Provincia di Reggio Emilia. Archivio storico elenco di consistenza con indicazioni topografiche (1895-1968). 36 In data 6 dicembre 2010 è stato sottoscritto tra la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Reggio Emilia il contratto per il deposito dell’archivio storico della Provincia di Reggio Emilia presso il Polo archivistico di Reggio Emilia. 30 31 153 L’archivio storico della Provincia di Reggio Emilia La documentazione dell’archivio storico della Provincia comprende oltre 650 metri lineari ed è relativa all’arco cronologico 1860-1969. La tipologia documentaria è piuttosto variegata (verbali di sedute di organi collegiali, lettere, progetti, mappe, ecc.) e riflette in misura significativa le diverse competenze che la Provincia ha assunto fin dalla sua istituzione. Tra le serie più importanti conservate vi sono gli Atti del Consiglio Provinciale che costituiscono il punto di partenza per ogni tipo di ricerca storica. Degli atti del Consiglio provinciale è disponibile anche un indice-sommario delle delibere adottate dal Consiglio provinciale dal 1860 al 1907, corredato dall’elenco dei consiglieri provinciali dal 1860 al 190737, grazie al quale è possibile orientarsi agevolmente nelle ricerche. Inoltre, in virtù delle tradizionali competenze rivestite dalla Provincia, risulta particolarmente interessante il materiale archivistico concernente la gestione del territorio (viabilità, regime delle acque, ferrovie, ecc.), quello relativo all’assistenza e beneficenza (dall’infanzia abbandonata all’assistenza psichiatrica e alle varie forme di povertà) e quello inerente l’istruzione. L’archivio della Provincia è costituito dalle principali sezioni: • • • • • • • Atti deliberativi Assistenza Economato e tesoreria Personale Sanità Patrimonio Ufficio tecnico Gli archivi aggregati Come si è ricordato in precedenza, una delle peculiarità degli archivi delle Province è la tendenza ad aggregare archivi di altri enti e istituzioni. Questo vale anche per la Provincia di Reggio Emilia. Infatti, il patrimonio documentario si è arricchito nel corso del tempo anche di numerosi archivi acquisiti per vari motivi. In alcuni casi si tratta di documentazione prodotta da altre istituzioni o uffici divenuti via via di competenza della Provincia, in altri casi di testimonianze di consorzi e commissioni ai quali l’ente ha partecipato. Tra i numerosi archivi aggregati si segnalano: Provincia di Reggio Emilia, Indice-sommario delle deliberazioni prese dal Consiglio Provinciale di Reggio Emilia dal 1860 a tutto l’anno amministrativo 1906-1907, Artigianelli, Reggio Emilia 1909. 37 154 • Comitato di Assistenza Civile (1915-1920) • Opera nazionale maternità ed infanzia (1950-1976) • Consorzio per la sistemazione della montagna reggiana (1930-1967) • Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (1945-1969) • Consorzio provinciale antitubercolare (1928-1961) • Azienda promozione turistica già Ente provinciale per il turismo (19511995) Il fondo fotografico storico Il fondo fotografico storico della Provincia di Reggio Emilia è costituito da circa diecimila positivi su carta e 2700 negativi. Il patrimonio fotografico documenta principalmente l’attività della Provincia dai primi anni del Novecento (la fotografia con datazione certa più antica è una veduta del Bacino Grisanti del 1901) fino agli anni Novanta del XX secolo. Si tratta in prevalenza di immagini che testimoniano l’attività istituzionale dell’ente come la realizzazione di opere pubbliche (costruzione di strade, ponti, scuole), l’operato degli organi amministrativi, lo svolgimento di iniziative pubbliche (convegni, celebrazioni ecc.) e di rappresentanza (delegazioni, gemellaggi, ecc.). Non mancano tuttavia serie fotografiche realizzate per ricerche specifiche della Provincia o come apparato per pubblicazioni capaci di aprire ampi e suggestivi scorci sul territorio provinciale. Le tecniche fotografiche presenti nella collezione sono diverse e di rilevante interesse per la tipologia dei montaggi e per il buono stato di conservazione. Il 25 percento circa della collezione è, infatti, databile entro il 1940. Un’altra parte rilevante, circa il 30 percento, risale ai decenni 1950-1960. Il resto della documentazione è degli anni 1970-1990. Nella collezione sono presenti fotografie dei maggiori studi fotografici di Reggio Emilia e provincia attivi fin dagli ultimi anni dell’Ottocento: Vaiani, Fantuzzi, Sevardi, Farri, Ars, Artioli. Le fotografie che seguono fanno parte del Fondo fotografico storico della Provincia di Reggio Emilia 155 Documenti 1900 ca. Operai alla costruzione di un ponte sul tratto della strada Ciano-Vetto (Foto Giuseppe Fantuzzi) 1890 ca. Fabbrica calce, cemento e gesso della Società anonima scandianese 1935 ca. Cerimonia ai giardini pubblici a Reggio Emilia 1950 ca. Ponte di chiatte sul Po 1959. Inaugurazione della strada Pratissolo-Carpineti 1959. Lavori sulla strada Felina-Carpineti 1960. Strada Passo delle Forbici 1963-64. Strada provinciale del passo di Pradarena, con vista sul Cavalbianco 1968. Inaugurazione dell’Istituto tecnico agrario «Zanelli» Senza data. Inaugurazione iti di Castelnovo ne’ Monti Note e Rassegne Dall’aquila estense al tricolore sabaudo L’unificazione nazionale a Reggio Emilia (1959-1861) Alberto Ferraboschi Le premesse dell’unificazione nel reggiano Fin dall’età moderna il territorio reggiano faceva parte dell’antico ducato estense che, a seguito degli equilibri geopolitici scaturiti dal congresso di Vienna del 1815, costituiva uno degli stati «satelliti» dell’impero d’Austria nella penisola italiana. La tutela austriaca sul ducato era esercitata in forma mediata attraverso linee laterali della dinastia Asburgo (Maria Beatrice d’Este, madre del duca Francesco IV, aveva sposato l’arciduca Ferdinando d’Asburgo mentre il duca Francesco V si era unito in matrimonio con la principessa Adelgonda di Baviera) ma soprattutto grazie alla «forza di persuasione» rappresentata dall’imponente apparato militare austriaco dispiegato nei vicini territori del Veneto dove era operativo il sistema fortificato del «quadrilatero» compreso tra Mincio, Po e Adige (i cui capisaldi erano le fortezze di Peschiera, Mantova, Legnago e Verona). Anche per questa ragione, la funzione dell’esercito estense, così come quello degli altri stati «minori» italiani, in pratica era di mantenimento dell’ordine interno e di primo intervento. In particolare, all’esercito ducale in caso di conflitto era affidato essenzialmente il compito di rafforzare le guarnigioni delle cosiddette province transpennine (Garfagnana, Lunigiana estense, Massa e Carrara) per impedire sommosse e rafforzare il tratto di confine che confinava con il Regno sabaudo (Aulla-Fosdinovo-Carrara). Le truppe estensi dunque dovevano agire principalmente come forza di sicurezza interna e, in caso di necessità, resistere fino all’arrivo degli austriaci (ovvero poco più di una settimana) poiché tra l’impero austriaco e il ducato di Modena operava fin dal 1847 una convenzione militare che, se da un lato garantiva al duca l’assistenza austriaca, dall’altro lato obbligava lo Stato estense a concertare l’intervento dell’esercito con le strategie militari austriache (analoga convenzione interessava anche il granducato di Toscana mentre contingenti militari austriaci presidiavano permanentemente Bologna e Ferrara). L’esercito estense risultava quindi pienamente integrato nel sistema diplomatico-militare volto a conservare alla Casa d’Asburgo una posizione di predominio nella penisola; anche per tale ragione il modesto esercito dei duchi d’Este ammontava complessivamente a meno di quattromila uomini, con una minima struttura logistica e un carattere prettamente difensivo al punto che era sprov- 163 visto di un corpo di cavalleria, la classica arma d’attacco degli eserciti ottocenteschi. La stretta dipendenza dall’Austria e la posizione strategica dei domini austroestensi, compresi tra il cuore della pianura padana e l’area appenninica, coinvolsero dunque il territorio reggiano nelle vicende militari e politiche che attraversarono la penisola italiana nel biennio unitario 1859-1860. Infatti, il progetto della Torino liberale di Cavour per la creazione di un regno dell’Alta Italia da realizzare attraverso il ridimensionamento dell’egemonia austriaca sul nord della penisola italiana finì per ripercuotersi direttamente sulla sopravvivenza del regime estense. L’area della bassa pianura emiliana compresa tra i ducati padani di Parma, Modena e il Lombardo-Veneto dell’Impero d’Austria nel 1859 costituì uno dei principali teatri della seconda guerra d’indipendenza. Questo evento, se da un lato incise sull’economia locale, dall’altro lato fu un importante fattore di mobilitazione sociale e politica coinvolgendo profondamente la società locale reggiana. Ne conseguì un’attiva ed estesa partecipazione alle vicende belliche, anche con fenomeni di diserzione dall’esercito estense e austriaco, ma soprattutto mediante consistenti arruolamenti volontari nelle file sabaude. In particolare, dopo la sfortunata campagna del 1848-49 che vide il coinvolgimento di ben 692 reggiani, nella primavera del 1859 si registrò un notevole flusso di giovani volontari che, spesso con mezzi di fortuna e attraverso peripezie, si recavano in Piemonte per arruolarsi nell’esercito sabaudo. Tra i circa ventimila volontari che giunsero nel regno sabaudo dai vari lembi della penisola italiana per combattere contro l’Austria si contarono infatti oltre novecento reggiani; in genere erano ragazzi giovanissimi appartenenti prevalentemente al ceto medio o ambienti popolari ma anche a «primarie famiglie per ricchezza e per cariche» come Giovanni Balletti (fratello dello storico Andrea Balletti), ferito mortalmente a 18 anni sul campo di battaglia di San Martino nel giugno del 1859. In effetti, non di rado si trattava di giovani appartenenti a famiglie borghesi che diedero vita a vere e proprie dinastie risorgimentali, spesso destinate a perpetuarsi attraverso diverse generazioni; si pensi, ad esempio, ai sette fratelli Ferrari (i «Cairoli di Reggio» che parteciparono a tutte le vicende belliche risorgimentali: Antonio, volontario nel 1848-49, Giulio, caduto a Novara nel 1849, Prospero, Filippo, Vincenzo e Battista, volontari nel 1859 e Ludovico, morto a Bergamo nel 1866), ai cinque fratelli Ruffini (caduti tra il 1821 e il 1870), ai tre Calderini (Stefano, il «Vieusseux di Reggio», animò uno dei principali circoli del liberalismo reggiano sotto gli Estensi; Italo fu volontario a Bazzecca nel 1866; Mario fu garibaldino a Bligny nel 1917 e morì in Africa nel 1936), ai quattro Fiastri (Giacomo, caduto a Palermo nel 1866; Giulio, maggiore dei bersaglieri volontario nelle campagne risorgimentali; Giorgio e Giulio, ufficiali decorati nella Grande Guerra) o ai tre Giusti (Antonio militò nei Cacciatori della Magra nella campagna del 1859; Filippo fu garibaldino e partecipò alla battaglia dei Vosgi nel 1870; Enrico, tra gli animatori del locale movimento irredentista, partecipò come volontario alla prima guerra mondiale). Piuttosto numerosi furono anche i volontari garibaldini reggiani che seguirono l’«Eroe dei due mondi» fin dal 1859, quando si pose alla guida del corpo volontario dei Cacciatori delle Alpi. Tra le oltre cinquecento «camicie rosse» reggiane che seguirono Garibaldi nelle sue molteplici avventure militari (compresi sei volontari che partecipa- 164 rono alla spedizione di Mille) si annoverano personalità in grado di testimoniare le diverse vie d’accesso al garibaldinismo e il suo stretto rapporto con l’internazionalismo: dall’avventurosa personalità di Gaetano Davoli, postiglione delle diligenze che dopo aver combattuto con l’esercito sabaudo nel 1859 e con Garibaldi in Sicilia, a Bezzecca e Mentana, abbracciò le cause libertarie di vari movimenti europei partecipando all’insurrezione in Grecia contro il dominio ottomano e alla Comune parigina del 1870; passando per Antonio Ruini (padre del costituente Meuccio Ruini) che traghettò verso il garibaldinismo dall’esperienza studentesca e partecipò alla campagna del 1866 a Bezzecca per poi assumere l’insegnamento in alcune scuole della città; fino a due figure che dopo l’Unità aprirono longeve attività imprenditoriali della Reggio contemporanea: Leopoldo Trabucchi, arruolatosi nei garibaldini dopo aver combattuto nelle battaglie di Montebello, Palestro, Magenta e fondatore nel 1872 dell’omonima vetreria, mentre il bresciano Annibale Franzini, dopo aver raggiunto come volontario Garibaldi a Napoli al suo ritorno nel 1873 creò la Società anonima Franzini Annibale. La massiccia e diversificata adesione giovanile alla causa nazionale era certamente il risultato della forte capacità d’attrazione presso diversi strati sociali della «scelta della patria» emersa durante il cosiddetto «decennio di preparazione»; tuttavia il fenomeno dei giovani volontari che andavano a battersi per l’Italia unita assumeva anche nel reggiano diversi significati in quanto, da un lato, esprimeva forme d’integrazione alla collettività civica attraverso la lotta per l’Unità e dall’altro lato, specialmente per quanto riguarda il garibaldinismo, rappresentava un nuovo elemento di militantismo rivoluzionario destinato – come si vedrà più innanzi – ad alimentare nel corso del tempo una vera e propria cultura «sovversiva». In ogni caso, a prescindere dalle forti implicazioni sociali e politiche, l’arruolamento dei volontari e la preparazione dell’esercito piemontese furono proprio le ragioni che spinsero l’Austria a notificare al Piemonte il 24 aprile 1859 l’ultimatum che ingiungeva di smobilitare le proprie truppe aprendo così le ostilità tra il regno del Piemonte (con il suo alleato francese) e l’Austria. Dopo pochi giorni le sorti del ducato estense seguirono quelle dell’Austria ed il 2 maggio, con la dichiarazione di guerra del Piemonte al duca di Modena, anche lo Stato estense veniva formalmente coinvolto nel conflitto. In concomitanza con il precipitare degli sviluppi bellici, il regime estense rafforzò a Reggio le misure militari, anche per la tradizionale diffidenza nei confronti della municipalità reggiana, mentre s’inasprirono le relazioni tra la guarnigione militare di stanza in città e la comunità locale con ripetuti episodi di prepotenze e violenze ai danni della cittadinanza. In particolare il duca inviò da Modena una compagnia di linea di ottocento soldati per rafforzare il presidio della città con la conseguenza di provocare ulteriori disordini. Per ritorsione fu proibita l’annuale fiera della Ghiara del mese di maggio durante la quale la corte estense abitualmente si trasferiva a Reggio per un mese; inoltre fu imposta la chiusura di due noti luoghi della socialità borghese ubicati in via del teatro (oggi via Crispi): la libreria di Calderini e Menozzi, storico ritrovo dell’intellettualità liberale, e il caffè della Traviata, frequentato dai liberali più giovani. Nel frattempo il movimento patriottico – che nella fase della Restaurazione era riuscito a penetrare in modo significativo nella società locale, reclutando esponenti della nobiltà e della borghesia, ma anche 165 sacerdoti – viveva una situazione di attesa di eventi più grandi in grado di ribaltare la debolezza e le divisioni interne. Dal governo provvisorio all’annessione al regno sabaudo Verso la metà di maggio si fece sempre più consistente la possibilità di un attacco ai domini estensi da parte delle truppe francesi sbarcate a Livorno le quali, a seguito della caduta del governo granducale, assieme alle milizie toscane iniziarono a muoversi verso l’Abetone. Il dispositivo militare austro-estense sotto il comando operativo del generale Jablonsky aveva la funzione di fronteggiare le truppe franco-toscane nonché i corpi franco-piemontesi che scendevano dall’Appennino. Nello scenario del progressivo riposizionamento dell’esercito estense sul versante emiliano del territorio appenninico, a Reggio la montante tensione indusse il locale presidio estense comandato dal maggiore Giuseppe Casoni a sfilare per il corso della Ghiara ostentando i pezzi d’artiglieria. L’agitazione patriottica cresceva con l’arrivo delle notizie degli eventi bellici e del rapido sviluppo delle operazioni militari tra le truppe franco-piemontesi e quelle dell’impero austriaco. A seguito delle vittorie franco-piemontesi a Montebello (20 maggio) e soprattutto a Magenta (4 giugno) che aprì all’esercito sabaudo la strada dell’invasione della Lombardia, cominciarono a susseguirsi in tutta l’Italia centrale le sollevazioni che avrebbero portato in breve tempo alla cacciata del granduca di Toscana, della duchessa di Parma, del duca di Modena e delle autorità pontificie da Bologna e dalle legazioni romagnole. In particolare, con la definitiva caduta a Parma del governo borbonico (9 giugno) l’intera frontiera occidentale estense divenne per il regime ducale ormai indifendibile. L’11 giugno il duca Francesco V, appresa la notizia della disfatta austriaca di Magenta e del conseguente ripiegamento delle armate imperiali dietro il fiume Mincio, decise di abbandonare lo Stato e, dopo aver desistito dal proposito di attestarsi nella piazzaforte di Brescello, nominata una reggenza ripiegò verso il Po. L’evacuazione della capitale estense da parte del duca e il ritiro delle truppe estensi a Mantova era l’epilogo del regime austro-estense, concludendo nel reggiano la lunga dominazione estense durata oltre quattrocento anni. In effetti, la situazione a Reggio era precipitata fin dall’11 giugno quando il podestà, conte Carlo Ritorni, aveva telegrafato al ministero dell’Interno per ricevere istruzioni mentre strade e piazze vibravano d’entusiasmo patriottico: nella situazione di sbandamento dovuta all’assenza di precise direttive da Modena, il rappresentante estense e il suo entourage non avevano avuto altra scelta che darsi alla fuga. Il 12 giugno, all’avvicinarsi delle truppe franco-piemontesi che avanzavano, la città insorse cogliendo l’occasione per liberarsi dal dominio austro-estense e una folla guidata dai capi liberali inneggiò all’annessione in una città sgomberata poche ore prima dalla guarnigione estense. La formazione del governo provvisorio a Reggio coincise quindi con la breve stagione d’autonomia causata dal vuoto di potere seguito al crollo del regime estense e colmato dall’iniziativa di esponenti del liberalismo locale. Si trattava di un movimento di notabili «patriottici», espressione del ceto aristocratico-borghese da tempo in collegamento 166 con la sabauda «Società Nazionale», che aveva l’obiettivo di realizzare l’annessione allo Stato sabaudo. Non a caso nel pomeriggio dello stesso 12 giugno dal davanzale della loggia comunale fu esposto il busto di Vittorio Emanuele II fra le sventolanti bandiere dei Savoia e della Francia. Il Comitato governativo provvisorio composto da quattro membri (Enrico Terrachini, Pietro Ferrari, Carlo Baroni e Gherardo Strucchi) raccoglieva il fior fiore del movimento patriottico locale transitato in gran parte nel corso degli anni cinquanta alle istanze liberal-cavouriane. Il più rappresentativo di questi esponenti era indubbiamente l’avvocato Enrico Terrachini, autentico notabile con un ruolo di primo piano nella fase di preparazione dell’insurrezione che guardava al Piemonte moderato di Cavour. Il comitato, presieduto dallo stesso Terrachini, agì dunque in attesa di confrontarsi con i rappresentanti di Torino e nel frattempo adottò alcuni importanti provvedimenti (come l’imposizione ai gesuiti di lasciare i posti di comando, i beni e le istituzioni assegnati dal duca nonché la parificazione degli ebrei) mentre per la preservazione dell’ordine pubblico decise l’istituzione di una Guardia civica guidata da Domenico Sidoli, una personalità che poteva vantare un excursus di tutto rispetto all’interno del movimento patriottico reggiano. Il comitato governativo provvisorio inviò poi al sovrano sabaudo una delegazione – composta da Luigi Chiesi, Prospero Viani e Pietro Bolognini – per annunciare, come già nel 1848, la volontà di annessione al Piemonte, assumendo anche un chiaro carattere secessionista rispetto alla realtà modenese. In realtà la fase del governo provvisorio avrebbe avuto vita breve; infatti già nella serata del 14 giugno 1859 l’avanguardia piemontese costituita da una colonna di 180 soldati piemontesi del reggimento Real Navi giunta da La Spezia attraverso il passo del Cerreto fece il suo arrivo a Reggio tra il giubilo della popolazione. Ebbe così inizio una complessa fase di transizione destinata a portare anche a Reggio, come nelle altre città emiliane, il potere politico-amministrativo nella mani del re Vittorio Emanuele II tramite l’istituzione di commissari straordinari piemontesi nelle diverse province (Adeodato Pallieri a Parma, Luigi Carlo Farini a Modena e Massimo D’Azeglio a Bologna). Dopo l’arrivo il 15 giugno del commissario regio per Modena e Reggio Luigi Zini (che tentò senza riuscirvi d’imporsi al comitato governativo reggiano), il governo piemontese inviò Luigi Carlo Farini nell’ex ducato estense allo scopo di sostituirsi ai governi provvisori che si erano autonomamente costituiti. Giunto a Modena il 19 giugno, fece il suo ingresso a Reggio il pomeriggio del 25 giugno e, dopo aver raccolto «la rinnovazione di dedizione al Piemonte» espressa dall’avvocato Pier Donnino Dongiovanni, poté constatare in prima persona l’entusiasmo popolare suscitato dall’annessione: mentre la banda cittadina eseguiva davanti all’ex palazzo ducale brani musicali intervallati da «grandi applausi della moltitudine di popolo», il governatore dovette «per ben tre volte mostrarsi alla ringhiera del balcone del palazzo» per salutare i reggiani accorsi per festeggiare il rappresentante sabaudo. L’arrivo dell’esercito piemontese comportò dunque un rapido quanto indolore passaggio di regime, privo sostanzialmente di quel complesso di vendette, agitazioni e ripercussioni, spesso di natura personale, che aveva caratterizzato l’ultimo cambiamento di governo nel 1848. Si segnalarono solo alcuni episodi d’intolleranza nei confronti di ex militi ducali come lo schiaffeggiamento in piazza del capitano Giuseppe Valen- 167 tini senza tuttavia comportare spargimento di sangue come invece accadde a Parma dove fu ucciso dal furore popolare il colonnello Anviti. Non mancarono in questa delicata fase di transizione cerimonie ed episodi particolarmente significativi come la messa solenne e il Te Deum di ringraziamento in San Prospero promosso dal Comitato governativo il 26 giugno per la sanguinosa vittoria delle armate franco-piemontesi a Solferino e San Martino. Un fattore importante che caratterizzò la vita cittadina nella fase di transizione dopo la liberazione dal regime austro-estense fu l’intensa attività giornalistica che prese avvio in città. Infatti, i giornali dell’epoca finirono per diventare autorevoli rappresentanti delle diverse voci reggiane. Il primo giornale che apparve a Reggio dopo l’arrivo dei piemontesi fu «Il Crostolo» che, anche nel nome della testata, rifletteva quello spirito municipalista che caratterizzò la fase di transizione allo Stato nazionale. Infatti, fin dal luglio del 1859 uscì il nuovo quotidiano la cui nascita, dopo l’esperienza pionieristica de «Il Giornale di Reggio» del 1848, rappresentò un evento particolarmente significativo sia sul piano giornalistico che su quello politico. Il giornale, diretto inizialmente da Gherardo Strucchi e quindi da Paolo Ottavi, contribuì a orientare la popolazione verso una sollecita annessione e sferrò una dura campagna di stampa contro l’ormai decaduto regime estense. Dunque, mentre si stavano completando le vicende belliche della seconda guerra d’indipendenza, Farini s’insediò con pieni poteri al governo dell’Emilia (il 28 giugno il Comitato governativo di Reggio passò definitivamente l’esercizio dei poteri municipali all’intendente generale Campi), cominciando a importare anche nel reggiano, attraverso un’«infornata» di decreti, le leggi e gli istituti del Regno di Sardegna. In un contesto soggetto al plurisecolare dominio estense, Farini impose in nome e per delega di Vittorio Emanuele II, gli ideali e il governo dello Stato piemontese attraverso un’energica opera di modernizzazione legislativa. Tuttavia solamente un mese dopo il suo insediamento Farini ricevette un telegramma del governo sardo che lo invitava a rientrare a Torino. Infatti, a seguito delle vicende della seconda guerra d’indipendenza, l’8 luglio i capi di Stato maggiore dell’esercito piemontese, francese ed austriaco avevano firmato l’armistizio di Villafranca che sembrava lasciare uno spiraglio per una restaurazione ducale. Nella situazione di vuoto di potere creatasi con la sconfitta dell’Austria le potenze europee discussero la possibilità di restaurare gli ex governanti nei ducati (la Brigata estense stanziata in Veneto e forte di 3600 uomini pareva sul punto di avviare un’iniziativa militare ducale) ovvero d’istituire uno Stato separato nell’Italia centrale (eventualmente sotto il principe Girolamo Napoleone, cugino dell’imperatore francese, o di qualche altro sovrano). È in tale situazione d’incertezza che Farini, rivelando un temperamento intraprendente e una buona dose di spregiudicatezza, deposte le vesti di governatore piemontese attraverso un piano ben orchestrato riuscì a farsi acclamare il 28 luglio dai modenesi e reggiani «dittatore» (ovvero capo del governo provvisorio) dell’Emilia. In effetti, anche a Reggio dopo l’armistizio di Villafranca la popolazione reagì con manifestazioni di piazza alla situazione di incertezza e fin dal 15 luglio si susseguirono iniziative popolari a favore dell’annessione al Piemonte culminate con un «pronunciamento» a favore della dittatura Farini proposto dall’avvocato 168 Giovanni Fiastri. La mossa spregiudicata di Farini compiuta con il sostegno dei liberali modenesi e reggiani, analogamente a quanto avvenne in Toscana per opera del barone Ricasoli, volta a «forzare» la situazione internazionale e gli equilibri diplomatici in corso di definizione dopo il luglio 1859 fu un passaggio cruciale nel processo di unificazione italiana sotto le insegne sabaude. Infatti, le «rivoluzioni liberali» emiliane e toscane impressero un’accelerazione all’unità rendendo di fatto impraticabile il ritorno degli antichi regimi; inoltre dimostrarono che l’annessione al Piemonte era la linea da preferire nell’Italia centrale, rendendo in tal modo quasi obbligata l’adozione della stessa strategia nell’Italia meridionale, una volta acquisita l’opportunità di attuarla. Infine, la via dell’annessione al Piemonte sbarrò definitivamente la strada a ulteriori progetti di tipo repubblicano, facendo perdere di credibilità le alternative alla soluzione sabauda promossa da Cavour. Dunque, nel Reggiano come nel resto dell’Emilia e in Toscana, il passaggio dalla realtà preunitaria allo Stato nazionale vide come protagonisti i gruppi di notabili moderati che seppero orientare decisamente le popolazioni locali verso l’annessione sabauda; pertanto, diversamente da quanto sarebbe avvenuto in seguito, ad esempio, nelle Marche e in Umbria dove l’annessione non fu preceduta dalla nascita di governi provvisori, i piemontesi non dovettero imporre l’unificazione ma al contrario si trovarono a prendere atto della scelta unitaria assunta dai governi provvisori locali di cui Farini nel reggiano era l’espressione riconosciuta. Chiamato a gestire il periodo immediatamente successivo alle sollevazioni delle popolazioni emiliane, Farini agì con estrema determinazione, dotandosi di collaboratori in grado di corresponsabilizzare nella gestione del potere anche i gruppi liberali emiliani, compreso quello reggiano che poteva vantare un notevole curriculum organizzativo e operativo risalente al periodo preunitario. La scelta di una gestione partecipata del potere, utilizzando anche la dirigenza liberale locale, fu dunque la via seguita da Farini sicché tra i più stretti collaboratori del «dittatore» troviamo il reggiano Luigi Chiesi, nominato fin dal 29 luglio a capo del ministero di Grazia e Giustizia. Dopo aver assunto il 18 agosto il titolo di «dittatore delle provincie modenesi e parmensi», Farini seppe frenare le tendenze autonomistiche manifestate da Reggio e l’8 dicembre 1859 completò l’unificazione politica dei tre complessi emiliani (di fatto attuando un vero e proprio processo di regionalizzazione) riunendo sotto un’unica realtà politica e amministrativa denominata «Regie Province dell’Emilia» territori un tempo appartenenti a tre diverse realtà statali (il ducato di Parma, il ducato di Modena e Reggio e la Romagna pontificia). Il potere assunto da Farini fu ratificato da una «assemblea nazionale» cui spettò anche il compito di proclamare formalmente la decadenza del precedente regime. A Modena si raccolse così l’«assemblea nazionale emiliana» nella quale sedettero anche 25 deputati per Reggio e sette per Guastalla eletti nelle elezioni del 14 agosto. Tra i reggiani con ruoli di primo piano nel consesso modenese troviamo il vice-presidente Carlo Baroni, il segretario Prospero Viani, il segretario al ministero della Pubblica istruzione Bernardino Catellani e Benedetto Maramotti che il 16 agosto propose la dichiarazione di decadenza di Francesco V e l’annessione al Piemonte, proprio negli stessi giorni in cui Garibaldi giunse a sorpresa a Reggio infiammando 169 ulteriormente l’entusiasmo patriottico in città. L’assemblea nazionale modenese (come quella eletta a Parma e Bologna) ebbe un’importante funzione costituente in quanto decise intorno al futuro assetto istituzionale e sui poteri da conferire a Farini, sebbene si trattasse di fatto di una ratifica di poteri già assunti. A Modena, così come a Parma e in Toscana, le «assemblee costituenti» nate sotto il controllo dei moderati nonostante gli evidenti limiti politici ebbero comunque un importante valore simbolico; si compì infatti un rito di passaggio dalla disgregazione fra diversi stati ad una nuova entità unitaria, in attesa della definizione della situazione internazionale e del plebiscito dell’11 e 12 marzo 1860. Destinato a divenire uno degli elementi fondativi del nuovo Stato, il plebiscito del marzo 1860 venne organizzato con cura anche nel reggiano in un acceso clima unitario in cui il condizionamento esercitato dalle élites liberali si sovrapponeva agli aspetti spontaneistici della grande festa popolare. Infatti, la consultazione, disposta per legittimare l’esito dei rivolgimenti politici-istituzionali del 1859, fu presentata e gestita sotto forma di grande festa popolare, con case e vie imbandierate di tricolori e manifestazioni patriottiche. Già il 4 marzo cominciarono a circolare per le strade cittadini di diversa estrazione sociale con una fettuccia tricolore al petto o sul cappello sulla quale era stampata la parola «annessione» mentre il giorno successivo il commendatore Buoncompagni e Luigi Chiesi, dopo aver attraversato le vie principali della città con addobbi e bandiere, furono accolti dall’entusiasmo patriottico degli studenti del ginnasio. Il decreto di convocazione di Farini stabiliva che potevano votare tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni e godessero dei diritti civili. Le votazioni si tennero nel capoluogo l’11 e 12 marzo 1860 in un clima di mobilitazione promosso dalle forze moderate, preoccupate dall’astensionismo, le quali tuttavia riuscirono a far valere le tradizionali capacità di condizionamento del notabilato proprietario sulle popolazioni rurali. Deferenza nei confronti delle élites e controllo sociale vennero così esplicitamente utilizzati a favore dell’annessione; nei giorni immediatamente precedenti la consultazione l’intendente generale di Reggio diede incarico alle «persone più influenti» della città di recarsi nelle ville e nei comuni della provincia dove permanevano le antiche fedeltà fondate sul paternalismo tradizionale dei ceti proprietari per favorire la partecipazione alla votazione. In effetti, il prete liberale Angelo Camurani nella sua cronaca registrò «il gran concorso di contadini a dare il voto» nella mattina dell’11 marzo, mentre il giorno successivo rilevava che «continua anche oggi l’accorrere delle persone a deporre nelle urne il proprio voto. È stato veramente uno spettacolo imponente, e l’allegrezza brillava, e traspariva negli atti, nei canti e suoni coi quali quasi tutte le ville del comune si presentavano in masse ordinate». Inoltre, nonostante i timori della vigilia, anche il clero reggiano non assunse un orientamento ostile, astenendosi da tentativi di sabotaggio del voto; benché solo 84 dei 230 preti residenti in città votarono, non mancarono parroci che condussero alle urne le loro «pecorelle» favorendo e non osteggiando il movimento nazionale. Interessanti poi alcuni risvolti della consultazione tenutasi a Reggio; ad esempio, lo storico Andrea Balletti ricorda che, pur bambino di nove anni, ebbe modo di partecipare al voto per l’annessione; inoltre, sempre secondo la testimonianza di Angelo 170 Camurani, dopo il ricevimento delle urne, alla sera del 12 marzo «con le solennità di legge si diede principio allo spoglio che fu fatto pubblicamente. I vari risultati parziali sono stati accolti con applausi delle non poche persone assistenti, e l’operazione durò sino a giorno grande». Con un’opposizione all’annessione fortemente screditata e in assenza di una vera e propria alternativa (la formula «regno separato» sulla quale gli elettori furono chiamati a pronunciarsi in alternativa all’annessione era piuttosto vaga alludendo sia alla costituzione di un regno separato dell’Italia centrale quanto alla possibile restaurazione dei vecchi regimi), i voti per l’annessione al Piemonte furono in città 12.226 contro 27 mentre in provincia di Reggio furono 50.012 contro i 77 per un regno separato. Le astensioni rimasero al di sotto della percentuale complessiva dell’Emilia (19 percento degli iscritti al voto) e dunque anche nel Reggiano la mobilitazione delle forze moderate e l’azione del condizionamento dei proprietari terrieri ebbero la meglio sulla contropropaganda legittimista estense. In ogni caso, nonostante i limiti, il plebiscito anche nel Reggiano rappresentò un passaggio fondamentale in quanto consentì un inedito pronunciamento popolare sull’assetto politico-istituzionale, aprendo alle masse la partecipazione al processo politico unitario. Il 15 marzo 1860 il ministro di Grazia e Giustizia pubblicava i risultati definitivi del plebiscito tenutosi in tutte le province dell’Emilia. A fronte di 526.218 iscritti, i votanti furono 427.512, i voti favorevoli all’annessione 426.006, quelli favorevoli a un regno separato 756, i voti nulli 750. Il 18 marzo Farini si recò a Torino per consegnare al re i risultati del plebiscito e l’Emilia, ormai unita anche dal punto di vista territoriale, entrava così a far parte del Regno di Sardegna. Pertanto, nelle settimane successive il primo re d’Italia coglieva i frutti del successo con una visita trionfale nei nuovi territori entrati a far parte del regno. Alla fine di aprile del 1860 Vittorio Emanuele II dopo aver visitato la Toscana si trasferì a Bologna dove rimase fino al 4 maggio per poi partire alla volta di Modena dove soggiornò due giorni. Quindi il 6 maggio 1860, il giorno della partenza da Quarto di Garibaldi e dei Mille, Vittorio Emanuele II si recò a Reggio premiando anche la fedeltà dei reggiani con un’elargizione alla città di 6000 lire da destinare ai poveri, ai feriti, agli infermi e all’asilo infantile. Nonostante la brevità della visita (il sovrano rimase in città dalle 10 alle 17), l’incontro con il re fu un momento di grande festa preparato con cura e solennità. In particolare, per offrire un degno omaggio al sovrano, il Consiglio comunale stabilì l’abbattimento del bastione di porta San Pietro e l’intitolazione a Vittorio Emanuele della barriera che sarebbe stata edificata nel 1873. Inoltre, la visita del re fu l’occasione per un primo riordino della toponomastica all’insegna della nazionalizzazione e della causa unitaria. Infatti il Consiglio comunale il 26 aprile 1860 cambiò i nomi delle principali piazze e strade cittadine: piazza Cavour al posto di piazza d’Armi, contrada Farini invece di via degli spadai e di San Giorgio, via Emilia a San Pietro invece di strada maestra a San Pietro, via Emilia a Santo Stefano invece di strada maestra a Santo Stefano, via del teatro invece di via alla cittadella. Preceduto da questi imponenti preparativi, il re fu accolto alla stazione da un colpo di cannone e dal suono delle campane in festa; dopo aver ricevuto dal sindaco Luigi Ancini le chiavi simboliche della città (così come nel 1805 furono consegnate a 171 Napoleone e nel 1814 a Francesco IV) il sovrano giunse tra la folla alla basilica della Ghiara dove assistette ad un solenne Te Deum. Passò quindi all’ex Palazzo ducale dove ricevette le autorità e dal balcone del palazzo presenziò alla sfilata della Guardia nazionale e della guarnigione. La solenne visita del sovrano chiuse simbolicamente la fase d’ingresso della realtà reggiana nello stato nazionale, contrassegnata per Reggio dalla fine del potere estense, dall’instaurazione dell’amministrazione provvisoria piemontese sotto la guida di Luigi Farini e dalla successiva annessione allo Stato sabaudo. Terminò così anche il processo di insediamento del regime liberale destinato a radicarsi agevolmente in città mentre nel territorio provinciale si sarebbe scontrato con una certa chiusura dei ceti rurali anche per la radicata influenza del clero legittimista (in particolare nell’area appenninica dove nei decenni postunitari si registrarono diversi episodi di insorgenze antisabaude e filoestensi). L’unificazione politica e amministrativa Dopo la conclusione dei plebisciti nell’Italia centrale, l’iniziativa per l’unificazione nazionale passò dalla monarchia sabauda ai democratici i quali, attraverso la personalità di Garibaldi, puntarono a smantellare le ultime roccaforti dell’Ancien régime: il Regno delle Due Sicilie e lo stato pontificio. La notizia della preparazione di una nuova spedizione garibaldina in partenza per il mezzogiorno si diffuse rapidamente tra maggio e giugno del 1860 anche in Emilia. Infatti, tra i volontari accorsi a Genova da ogni parte d’Italia figurava anche un gruppo di sei giovani garibaldini reggiani: Rainero Taddei, Antonio Ottavi, Eugenio Ravà, Massimiliano Costetti, Giuseppe Capellini e Filippo Riccioni. Fra le «camicie rosse» reggiane che sbarcarono a Marsala si distinse Rainero Taddei che nella cruenta battaglia di Maddaloni del 1° ottobre 1860 guidò i compagni all’assalto «agitando il berretto rosso sulla punta della spada»; la militanza garibaldina dell’ebreo Eugenio Ravà era invece un’ulteriore testimonianza dell’ampia adesione dell’ebraismo reggiano al movimento risorgimentale. In seguito fu organizzata dal luogotenente di Garibaldi, Nino Bixio, una seconda spedizione di volontari che ingrossarono le file garibaldine con la partecipazione di circa trecento reggiani. Mentre nella penisola si svolgevano gli eventi decisivi che avrebbero portato al compimento dell’unificazione nazionale, nel reggiano si avviava il progressivo adattamento politico-amministrativo al nuovo contesto istituzionale. Infatti, il traghettamento all’interno del regno sabaudo comportò per Reggio l’inserimento in un quadro istituzionale uniformato dallo Statuto albertino del 1848 e dalla legislazione piemontese. In particolare, dopo il regime provvisorio del 1859, i reggiani avevano visto sacrificate le loro istanze autonomistiche con l’estensione della legge del 23 ottobre 1859, conosciuta come legge Rattazzi, sull’ordinamento comunale e provinciale. Introdotta da Farini con decreto del 27 dicembre 1859, la legge introduceva importanti novità che erano già state parzialmente sperimentate nel corso delle elezioni del settembre 1859 quando fu eletto il primo consiglio comunale e venne nominato come sindaco Luigi 172 Ancini, eletto con soli 375 voti. In particolare per Reggio un’importante novità era costituita dal principio dell’elettività dei consigli comunali, previsto dalla nuova legge al posto del precedente sistema di cooptazione nonché dal meccanismo del doppio accesso censitario e capacitario (principio che invece lo Stato sabaudo sperimentava già dal 1848). In effetti con la legge Rattazzi i requisiti per essere elettori erano assai restrittivi: avevano diritto al voto i cittadini che avevano compiuto 21 anni che pagavano annualmente nel comune una imposta annua proporzionale al numero degli abitanti, secondo una scala che andava dalle cinque lire annue (nei comuni inferiori a tremila abitanti) alle 25 lire annue in quelli superiori ai sessantamila abitanti. I limiti di censo non si applicavano poi a una serie di categorie professionali (laureati e professori, membri delle regie accademie, funzionari e impiegati civili e militari dello stato, ecc.). Rimanevano esclusi dal diritto di voto gli analfabeti e le donne. Sul piano della rappresentanza politico-amministrativa, con la realizzazione dell’unificazione nazionale la tradizionale concezione corporato-territoriale che individuava in notabilati aristocratico-borghesi il soggetto sociale della rappresentanza locale, veniva dunque formalmente superata, almeno sotto il profilo giuridico, dalla conquista di una costituzione rappresentativa censitaria destinata a formalizzarsi in seguito nel cosiddetto codice del «diritto amministrativo comune» del 1865. Infatti, con la legge 20 marzo 1865 n. 2248, la quale riprendeva sostanzialmente la legge Rattazzi del 1859, il sistema elettorale amministrativo del Regno d’Italia fondato sul duplice binario censitario e capacitario di accesso al voto, sulla durata in carica quinquennale dei consiglieri comunali, sul rinnovo annuale di un quinto degli stessi consiglieri e di metà dei membri della giunta municipale e infine sulla nomina regia del sindaco per un triennio assumeva la sua fisionomia definitiva. In questo modo, con il carattere elitario e ristretto del nuovo sistema elettorale si sanciva formalmente il principio di stampo liberal-borghese secondo il quale i diritti di partecipazione politica non andavano riconosciuti a tutti ma solo a chi poteva esercitarli in modo responsabile in base a requisiti di indipendenza personale, economica e culturale. A ciò, come si diceva, si aggiungeva che il capo dell’amministrazione comunale – il sindaco – pur dovendo essere uno degli eletti, era però nominato dal Re e quindi di fatto scelto dal prefetto. Dunque, in realtà l’assetto amministrativo postunitario modificava solo in parte gli organi amministrativi comunali preunitari confermando in sostanza l’impianto centralistico del regime austro-estense e facendo permanere un’impronta notabilare su base censitaria. Pertanto, gli equilibri sociali in seno al Consiglio comunale mutarono solo parzialmente con le elezioni amministrative del febbraio 1860, le prime compiute ai sensi della legge Rattazzi del 23 ottobre 1859. Indubbiamente la normativa introduceva un certo dinamismo grazie a una base elettorale più fluida nonché alla più larga autonomia riconosciuta all’ente locale; tuttavia anche nel Reggiano l’elettorato definito essenzialmente su base censitaria restò fino alle riforme crispine del 1888 assai ristretto (ancora nel 1876 gli elettori politici erano 1711 pari al 3,4 percento degli abitanti) e finì quasi per coincidere con le vecchie liste degli eleggibili alle cariche comunali, riconfermando ai seggi comunali una classe politica socialmente omogenea di matrice aristocratico-borghese. 173 Il carattere elitario della rappresentanza politico-amministrativa era poi aggravato anche dalla scarsa partecipazione al voto se si considera che a Reggio l’affluenza media alle elezioni amministrative tra il 1860 e il 1889 si attestò intorno al 34 percento. Per tali motivi i protagonisti di questo primo momento furono una ristretta cerchia di notabili moderati che basavano principalmente la loro legittimazione politica sulla partecipazione all’esperienza risorgimentale. Infatti, si trattava di uomini appartenenti in gran parte alla generazione che aveva partecipato alla rivoluzione del 1848, usciti per la maggior parte da famiglie della borghesia risorgimentale reggiana (Sidoli, Bolognini, Manzotti, Ferrari, Rasori, ecc.) e accomunati dall’avversione al regime austro-estense e dalla condivisione della lotta per l’indipendenza: si andava dai leaders storici della «consorteria» moderata reggiana (Enrico Terrachini, Domenico Sidoli, Carlo Baroni, Gioacchino Paglia, Luigi Ancini e Domenico Nobili) passando per gli esuli scampati alle condanne della polizia estense (Luigi Chiesi, Prospero Pirondi) e i reduci delle battaglie risorgimentali (Fortunato Modena e Romualdo Caselli) fino a personalità che, nel rivendicare una «libertà d’azione» in alcuni decisivi frangenti, avevano testimoniato il loro dissenso al passato regime, attuando una sorta di «resistenza passiva» (come l’avvocato Giulio Cesare Vedriani che rifiutò di far parte del tribunale di Rubiera in occasione del processo ai congiurati del 1821). L’unificazione nazionale sancì per la comunità reggiana anche il riconoscimento di un autonomo spazio istituzionale all’interno del nuovo contesto nazionale coronando l’antica aspirazione di autonomia da Modena. Infatti, se già nel settembre del 1859 era stato eletto il primo consiglio comunale con il nuovo anno si costituirono gli organi della neocostituita Provincia di Reggio Emilia (prima dell’unità in base alla ripartizione amministrativa estense del 1848 il territorio provinciale era diviso tra i compartimenti di Reggio Emilia e Guastalla). Il 21 marzo 1860 si insediò nell’ex palazzo ducale del corso della Ghiara, ribattezzato «Palazzo Nazionale», sotto la presidenza dell’intendente generale Domenico Marco il primo Consiglio provinciale composto da quaranta consiglieri rappresentanti 18 mandamenti (circondari) del territorio provinciale. Anche il Consiglio provinciale era stato eletto a suffragio ristretto e esprimeva in larga misura la classe dirigente liberale uscita dalle vicende risorgimentali; il primo presidente del Consiglio fu Giulio Cesare Vedriani a cui sarebbe seguito dopo pochi mesi Luigi Chiesi. Il Consiglio sceglieva una Deputazione, presieduta dal governatore (dal 1861 denominato prefetto), alla quale era demandato il controllo di merito sugli atti degli enti locali concernenti prestiti, beni comunali, mutui, spese. In ragione di tale competenza la Deputazione provinciale svolgeva anche un importante ruolo tutorio sui Comuni. Tra i primi atti della nuova amministrazione vi fu la realizzazione nel settembre 1860 di una Raccolta di dati statistici a corredo della relazione sullo stato economico e morale della Provincia, promossa da Pietro Manodori che documenta l’impegno delle élites locali a prendere piena conoscenza del territorio provinciale. Inoltre, i nuovi consiglieri provinciali dovettero subito misurarsi con l’assetto delle circoscrizioni comunali e dei relativi problemi connessi alla riorganizzazione amministrativa che non sempre aveva tenuto in debita considerazione le esigenze delle comunità locali. 174 La classe politica risorgimentale Con l’istituzione del Consiglio comunale e provinciale e delle relative giunte si completava così l’architettura istituzionale che risultava egemonizzata da una classe politica locale dotata di un profilo socio-professionale ben definito. Infatti, come nel resto del paese all’indomani dell’Unità la provincia di Reggio presentava una struttura socio-economica imperniata sull’agricoltura, a cui si affiancava una modesta presenza manifatturiera (circoscritta principalmente all’ambito della piccola unità artigianale a conduzione familiare). La struttura fondiaria era caratterizzata dal predominio della piccola e media proprietà contadina mentre assai ridotta era la quota della grande possidenza la quale, peraltro, aveva dimensioni piuttosto modeste se confrontate con gli sterminati latifondi delle grandi famiglie dell’aristocrazia romana e del mezzogiorno d’Italia. All’interno del mondo agricolo i rapporti tra proprietà e lavoro erano segnati dal sistema mezzadrile, fondato sull’appoderamento, sulla coltura promiscua, sul lavoro della famiglia colonica e sulla residenzialità diffusa nelle campagne. Elemento peculiare della mezzadria consisteva nel definire un «modello di controllo sociale globale», essendo interpretato dal notabilato della possidenza come un baluardo fondamentale per perpetuare nelle campagne reggiane i rapporti sociali tradizionali. Si trattava di un orientamento assai diffuso all’interno del mondo proprietario che rifletteva la mentalità paternalistica e la concezione organicistica dei rapporti sociali, pienamente coerente con la matrice terriera dei suoi fautori. Questa concezione era alimentata anche della tradizione umanistica e letteraria della classe dirigente liberale che tendeva a idealizzare la vita rurale e la natura agreste, facendone il luogo privilegiato per la realizzazione della «pace sociale». Il rapporto tra la città e la campagna era mediato dal ruolo dei proprietari residenti nel capoluogo che limitavano il loro soggiorno nei loro poderi durante le stagioni estive ed autunnali, amministrando dalla città negli altri periodi dell’anno l’andamento delle aziende rurali tramite fattori di fiducia. In un paese ancora prevalentemente agricolo, dalla persistente egemonia dei proprietari terrieri, l’élite fondiaria costituiva dunque il nucleo centrale dei ceti dirigenti dei primi decenni postunitari comprendente un composito universo sociale che andava dall’area della possidenza a quella delle professioni per passare attraverso l’aristocrazia fino all’influente comunità ebraica. Nel loro insieme costituivano quel ristretto universo borghese d’orientamento liberalmoderato, preminente sul piano della ricchezza, del potere locale, del prestigio sociale e della forza attrattiva sui gruppi emergenti, destinato a mantenere il controllo della vita politico-amministrativa locale nella seconda metà dell’Ottocento. Si trattava dunque di élites composte da elementi sociali che avevano tratto occasione di crescita e di valorizzazione nel corso dei decenni precedenti, a partire da una classe d’impronta aristocratico-terriera che avrebbe continuato a mantenere un ruolo importante anche dopo l’Unità; infatti, l’affermazione dei nuovi gruppi sociali di tipo borghese non comportò una rapida emarginazione dei nuclei nobiliari locali dai luoghi del potere. Certamente i privilegi legati al ceto nobiliare e istituzionalmente garantiti dal regime austro-estense cessarono sul piano legale al momento dell’ingresso di Reggio nello 175 Stato unitario. Tuttavia, il ruolo svolto da diverse famiglie del patriziato locale a favore della causa unitaria così come la tradizionale influenza nobiliare esercitata sui ceti borghesi e popolari consentì agli ambienti aristocratici di continuare a condizionare la vita politica-amministrativa locale anche dopo la fine del regime estense. Infatti, tra i protagonisti delle vicende politiche locali troviamo diversi esponenti dell’aristocrazia come i Cassoli, i Gherardini, i Fiastri, i Fossa e gli Ancini; inoltre i primi sindaci che si succedettero al governo della città dall’Unità fino agli anni Ottanta dell’Ottocento (Luigi Ancini, Pietro Manodori e Gian Francesco Gherardini) appartenevano a illustri casate dell’aristocrazia locale. All’interno della classe dirigente locale assunsero un ruolo centrale anche i professionisti possidenti; avvocati, notai, medici, ingegneri che, emersi per la prima volta alla ribalta della vita pubblica durante la fase napoleonica, parteciparono agli acquisti delle proprietà, comprese quelle ex ecclesiastiche, coronando con immobili e ville un crescente potere sia al vertice del Comune sia nelle altre istituzioni cittadine (opere pie, istituti di credito, ecc.). Buona parte dei professionisti (in particolare appartenenti al mondo delle professioni legali come avvocati e notai), in virtù dell’influenza connessa all’esercizio della professione, assunsero così un ruolo importante nella vita politicaamministrativa locale. Non è dunque un caso che dagli ordini delle professioni forensi uscirono i maggiori protagonisti della vita cittadina dei primi decenni postunitari, da Luigi Chiesi a Giovanni Fiastri, da Antonio Gorisi a Pierdonnino Bongiovanni. A seguito dell’emanazione del decreto del Comitato governativo del 15 giugno 1859, confermato nel settembre successivo da Farini, con il quale si poneva fine alle discriminazioni religiose si aprirono spazi d’affermazione sociale e politica anche per diversi esponenti dell’antica comunità ebraica reggiana che fin dall’inizio del Quattrocento si era insediata a Reggio rimanendo a lungo confinata in una condizione di emarginazione da parte del regime estense. Con l’ingresso di Reggio nello Stato unitario gli ebrei, dopo aver partecipato attivamente all’esperienza risorgimentale, si inserirono a pieno titolo nella vita sociale, culturale e politica locale, divenendo parte integrante di quella ristretta élite destinata a reggere le sorti cittadine fino ai tardi anni Ottanta dell’Ottocento. Per quanto la nutrita minoranza ebraica (ammontante a 832 unità nel 1861) non costituì dal punto di vista politico un blocco omogeneo – se non altro per l’antagonismo esistente tra i due principali esponenti della comunità, il liberale monarchico Ulderico Levi e il repubblicano Raimondo Franchetti – la matrice borghese di gran parte dell’ebraismo reggiano contribuì a mantenere un tratto socialmente conservatore della maggioranza della comunità israelita. Del resto, la connotazione moderata di gran parte degli ebrei reggiani trovò un riscontro non solo nella candidatura a sindaco dell’avvocato Alessandro Liuzzi (avanzata nella primavera del 1873 dal prefetto e declinata dall’interessato) e nella presenza di diverse figure del notabilato ebraico nella direzione dello «storico» organo del liberalismo locale, «L’Italia Centrale», ma soprattutto nel ruolo politico e amministrativo assunto dal principale esponente del moderatismo reggiano del secondo Ottocento: Ulderico Levi (deputato e senatore del Regno, fu l’ultimo presidente liberale del Consiglio provinciale dal 1889 al 1901). In effetti, il ben definito profilo socio-professionale della classe politica risorgi- 176 mentale reggiana si rifletteva chiaramente nell’ambito politico. Il 27 gennaio 1861 si tennero anche nel reggiano le consultazioni generali per l’elezione del Parlamento del nuovo regno, proclamato, in base a una legge approvata per acclamazione dal Parlamento, il 17 marzo dello stesso anno. Anche a Reggio il risultato elettorale evidenziò l’ampia legittimazione di cui godeva la classe politica moderata che, sotto la guida di Cavour, aveva saputo portare a compimento l’unificazione nazionale; nel capoluogo venne eletto con 515 voti (contro i novanta del mazziniano Giovanni Grillenzoni) il generale Enrico Cialdini, ufficiale originario di Castelvetro di Modena, noto per i suoi trascorsi militari, personaggio di rilievo nazionale che cessò dalla carica di deputato per la nomina a senatore nel 1864. Gli sarebbe succeduto un altro autorevole esponente del moderatismo emiliano e uomo di Minghetti, il reggiano Giovanni Fiastri, che avrebbe contribuito a connotare il collegio cittadino come un feudo moderato, gestito dai principali esponenti dal notabilato locale. In effetti, i liberali moderati reggiani guidarono la vita politico-amministrativa locale per il trentennio postunitario, occupando i principali centri del potere politico, economico e culturale locale. Come si è detto, il notabilato moderato sul piano politico basava la propria legittimazione al governo dalla partecipazione alle vicende risorgimentali esprimendo a livello locale gli orientamenti filosabaudi dello schieramento liberale e creando nel 1874 un primo embrione di partito politico, l’Associazione costituzionale (la prima fondata in Italia insieme a quella milanese), destinata a divenire una delle più importanti e potenti associazioni costituzionali del moderatismo italiano. In questo modo Reggio Emilia nel periodo postunitario si caratterizzò come una delle principali roccaforti del moderatismo italiano, esprimendo a livello politico-parlamentare uomini della destra storica appartenenti alla cosiddetta «consorteria emiliana» che facevano riferimento al bolognese Marco Minghetti. Gli esclusi dalla legittimazione risorgimentale: democratici e cattolici Al di fuori delle istituzioni locali e nazionali rimanevano senza un’effettiva rappresentanza politico-istituzionale ampi settori della società locale riconducibili alle nascenti organizzazioni del movimento operaio e alla Chiesa cattolica. Erano i cosiddetti esclusi dalla «legittimazione» dello Stato liberale che anche nel Reggiano lasciavano aperta la questione della contestazione del sistema politico uscito dai rivolgimenti risorgimentali. A raccogliere il grosso degli esuli e dei combattenti che avevano militato nelle file mazziniane e garibaldine era il campo democratico dove stavano coloro che avevano concepito il processo di unificazione come il risultato di un riscatto nazionale e sociale finalizzato alla creazione di uno Stato repubblicano. Del raggruppamento facevano parte per lo più professionisti, intellettuali, possidenti e componenti della borghesia reggiana più avanzata, ma anche esponenti di estrazione piccolo borghese come artigiani, esercenti e impiegati. Fin da subito l’area democratica risultò distinta in tre anime principali in cui spesso si confondevano istanze del mazzinianesimo, del 177 radicalismo e del democraticismo garibaldino; al suo interno troviamo notabili liberalprogressisti di matrice borghese sostenitori della sinistra parlamentare e legalitaria con tinte radicaleggianti e anticlericali come Carlo Borsiglia, Igino Bacchi Andreoli e il conte Corrado Palazzi Trivelli; i repubblicani in gran parte ex garibaldini come Angelo Camparini, Carlo Flori, Giovanni Rasori legati in buona misura alla breve ma intensa esperienza del giornale «La Rivoluzione» e accesi sostenitori del completamento dell’unificazione nazionale con la conquista di Roma e Venezia; infine, il primo nucleo del movimento internazionalista e anarchico reggiano che si ispirava alle prospettive di emancipazione sociale aperte nel 1864 dalla fondazione a Londra dell’Associazione internazionale dei lavoratori, comprendente alcuni attivisti di spicco come l’oste Pietro Artioli, fondatore e direttore tra il 1873 e il 1874 del periodico «L’Iride», il liquorista Angelo Canovi e il conciapelli Giovanni Ferrarini che, per certi aspetti, possono essere considerati come i precursori del movimento socialista nel Reggiano. Le variegate forze democratiche progressiste avevano importanti punti di riferimento in alcune associazioni come le società di mutuo soccorso ispirate a principi repubblicani-socialisti; in particolare la «Società di mutuo soccorso tra gli operai», sorta nell’agosto 1860 su basi ideologiche-politiche mazziniane, dopo essere stata sciolta nel 1862 per la sua caratterizzazione politica divenne gradualmente uno degli epicentri delle forze progressiste. La composita area della democrazia aveva stretti rapporti anche con la loggia massonica reggiana di cui costituiva uno dei principali punti di incontro e di aggregazione. La loggia Uno per tutti, tutti per uno era stata fondata nel 1873 nella fase del fervore organizzativo che caratterizzò l’immediato periodo postunitario e di fatto recuperava la tradizione risorgimentale ed unitaria delle società segrete del periodo risorgimentale. Il sodalizio liberomuratorio tendeva ad aggregare le diverse componenti che non si riconoscevano nel blocco d’ordine uscito dai rivolgimenti risorgimentali e, nonostante una fisionomia medio-borghese, esprimeva un certo interclassismo riunendo aristocratici (il conte Corrado Palazzi Trivelli), professionisti (gli avvocati Aronne Rabbeno, Carlo Borsiglia e Igino Bacchi Andreoli) ma anche impiegati (il segretario comunale Pietro Casali, l’assicuratore Giovanni Rasori, l’impiegato Cesare Guardasoni e l’insegnante Contardo Vinsani), artigiani ed esercenti (il ramaio Angelo Manini e l’oste Giovanni Ferrarini). I massoni reggiani si riunivano in un locale lungo la via Emilia e avevano come portavoce ufficioso il giornale «La Minoranza» (fondato nel 1874 e divenuto in seguito «La Minoranza intransigente»), un foglio fortemente caratterizzato da un’ideologia positivista e anticlericale. L’attività della loggia reggiana si caratterizzò soprattutto per la realizzazione di un associazionismo laico che intendeva contrapporsi alla tradizionale presenza in campo sociale ed assistenziale delle istituzioni ecclesiastiche: da iniziative di stampo filantropico e mutualistico (premi per gli allievi dell’orfanotrofio cittadino, comitato per i feriti dell’Erzegovina e della Bosnia, Società di mutuo soccorso fra camerieri, cuochi e arti affini, Società operaia, ecc.) a molteplici forme associative rivolte a diffondere i principi dell’anticlericalismo, della fede nella scienza e nel progresso (Circolo anticlericale, Società razionalista e Circolo studi sociali) fino alla promozione delle prime 178 esperienze cooperative (nei primi anni Ottanta l’ex garibaldino e dirigente della locale loggia massonica, Contardo Vinsani, avrebbe inaugurato la prima società cooperativa reggiana di consumo, sorta dalla convergenza con gli ambienti politici e intellettuali del socialismo prampoliniano). Sempre nel corso degli anni Settanta si costituì un altro importante punto di riferimento organizzativo delle forze democratiche: la «Società dei reduci delle patrie battaglie» intitolata a Giuseppe Garibaldi. Sorta nel 1877 su iniziativa repubblicana, la società che raccoglieva i numerosi veterani reggiani delle campagne garibaldine (circa cinquecento) si sarebbe caratterizzata per la capacità di mobilitare il locale schieramento democratico e progressista in occasione delle richieste d’allargamento del suffragio e delle numerose ritualità pubbliche legate alla tradizione garibaldina. Più in generale, la società «Garibaldi» divenne l’antagonista della «consorteria» moderata, diventando un centro propulsivo dell’associazionismo radicale e «sovversivo» ma anche un importante veicolo di patriottismo risorgimentale nella Reggio del secondo Ottocento. L’altra componente socio-politica destinata a rimanere esclusa dagli esiti dell’unificazione nazionale era quella riconducibile al mondo cattolico. In effetti, la conflittualità che caratterizzò i rapporti tra Stato nazionale e Chiesa cattolica intorno alla cosiddetta «questione romana» (ovvero la prospettiva dell’annessione di Roma allo Stato nazionale con il superamento del potere temporale del pontefice) non mancò di esercitare i suoi condizionamenti anche nel Reggiano. Il fallimento della posizione cattolico liberale che si era fatta strada faticosamente anche nella realtà locale durante la fase risorgimentale cedette il passo alla lunga stagione del conflitto tra Stato e Chiesa destinato a tradursi sul piano formale con la promulgazione del Sillabo (l’elenco delle ottanta proposizioni erronee) del 1864 e la proclamazione dell’infallibilità pontificia del 1870. Inoltre, con la pronunzia vaticana del 1868 sul divieto per i cattolici di partecipare alle elezioni (non expedit) furono creati i presupposti anche nel Reggiano per l’astensionismo di massa dei cattolici e il loro allontanamento dalla vita pubblica. Nel periodo di transizione allo Stato nazionale e nel primo periodo postunitario la Chiesa reggiana fu guidata da due vescovi: dal 1849 al 1866 vescovo di Reggio fu Pietro Raffaelli che traghettò la Chiesa locale nello stato nazionale impegnandosi nella battaglia contro l’anticlericalismo liberale. La guida passò poi nelle mani di Carlo Macchi, vescovo dal 1867 al 1873, uomo di preghiera e notevole organizzatore destinato a reggere la Chiesa reggiana durante il Concilio vaticano I e nella fase critica della polemica tra temporalisti e antitemporalisti che si sviluppò intorno alle premesse della questione romana. Gli «intransigenti temporalisti» erano i nostalgici del vecchio regime che esortavano i cattolici alla disobbedienza verso il nuovo ordine costituito e avevano nel vescovo di Guastalla monsignor Pietro Rota uno degli esponenti maggiori. Il nucleo dei cattolici intransigenti della prima generazione era costituito in prevalenza da sacerdoti (come il vicario vescovile Iacopo Casoli) ma anche da nobili e proprietari terrieri (come il conte Prospero Liberati Tagliaferri e Giuseppe Turri). Questi ultimi furono anche autorevoli eruditi e animatori della stampa cattolica locale: «Il Genio Cattolico» e «Il Consigliere 179 del Popolo». In particolare il quindicinale «Il Genio Cattolico» uscì dal 1868 al 1877 e rappresentò nel Reggiano la cultura dell’intransigentismo cattolico in linea con l’atteggiamento ostile della Santa Sede verso la rivoluzione liberale. Infatti, il giornale diretto da uomini formatisi durante il regime estense sostenne con tenacia la causa della restaurazione ducale disconoscendo l’esito liberal-nazionale uscito dai rivolgimenti del 1859-1860. Tali personalità continuarono a sperare in un ritorno dell’autorità estense seguitando a sentirsi partecipi del precedente regime; in particolare il conte Prospero Liberati Tagliaferri fu uno dei principali esponenti emiliani del «legittimismo» cattolico, partecipando anche al primo congresso veneziano del 1874 dell’Opera dei congressi (l’organizzazione che fungeva da centro di coordinamento delle varie associazioni cattoliche presenti sul territorio italiano mantenendosi su posizioni di rigida opposizione verso il liberalismo laico). Diversamente da Modena dove la componente intransigente fece sentire in modo rilevante e duraturo il proprio peso, nel Reggiano il legittimismo cattolico non fu in grado di esercitare un ruolo politico significativo, anche per gli specifici tratti del clero locale emersi già durante il travagliato passaggio tra antichi e nuovi regimi. In effetti, fin dal periodo francese una parte consistente del clero reggiano prese posizione a favore delle nuove istituzioni sorte dalle ceneri dell’Ancien régime, schierandosi poi nella stagione risorgimentale a favore della causa unitaria. I sacerdoti reggiani di sentimenti liberali trovavano i propri richiami ideali nel filone culturale del cattolicesimo liberale egemonizzato dal neoguelfismo e svolsero anche un importante ruolo pubblico nella fase di transizione allo Stato nazionale. La messa celebrata in San Prospero per la causa italiana all’indomani dell’apertura delle ostilità tra il Piemonte e l’Austria nell’aprile 1859, le liturgie in suffragio dei caduti nelle guerre risorgimentali, il Te Deum di ringraziamento per l’unità, le omelie a sostegno dell’annessione di numerosi sacerdoti e l’appello a Farini del clero reggiano nel marzo del 1860 a favore dell’unificazione furono importanti testimonianze, dalla forte valenza simbolica, dello spirito nazionale di una parte consistente del clero reggiano. Dunque, grazie anche all’impegno di alcune figure di spicco del clero come il paletnologo Gaetano Chierici, il canonico di San Prospero Angelo Camurani o il professore di liceo Angelo Volpe, fin dalla fase unitaria la componente cattolica dei «transigenti e conciliatoristi» si schierò a favore di una conciliazione tra lo Stato italiano e la Chiesa, sostenendo l’impegno dei cattolici nel nuovo Stato e la causa del superamento del potere pontificio su Roma (nel 1862 furono numerosi i sacerdoti reggiani che aderirono all’iniziativa di padre Passaglia per una rinuncia spontanea del pontefice al potere temporale). In tal modo, nella cruciale fase dell’unificazione nazionale il ruolo svolto da una parte consistente del clero reggiano confermò una specifica attitudine «reattiva» della Chiesa locale nel lungo e travagliato confronto tra Chiesa e contemporaneità. Fonti e bibliografia •Il 1859 a Reggio, numero unico edito a cura del Comitato reggiano per le celebrazioni del Centenario dell’Unità d’Italia, Tecnostampa, Reggio Emilia 1959. 180 •Il 1859 a Reggio. Stato, comune e società, numero monografico «Bollettino Storico Reggiano», 140/2009. •Badini G., Pietro Manodori, benefattore, sindaco, presidente, Tecnostampa, Reggio Emilia 2000. •Balletti A., Storia di Reggio nell’Emilia, Multigrafica, Roma 1968. •Balletti A., Storia di Reggio nell’Emilia. Seconda parte 1859/1922, Diabasis, Reggio Emilia 1996. •Balzani R., Il tricolore e il risorgimento, in Montanari M., Ridolfi M., Zangheri R., Storia dell’Emilia Romagna, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 47- 61. •Bellelli M., «An vin piô». I reggiani in alcuni eventi per l’Unità d’Italia, in «RS-Ricerche Storiche», 111/2011, pp. 28-31. •G. Boccolari G., Fontanesi T., Le origini del movimento operaio e contadino, in Festanti M., Gherpelli G. (a cura di), Storia illustrata di Reggio Emilia, AIEP, San Marino 1987, vol. II, pp. 417-432. •Bonaccioli M., La visita di Garibaldi alla Città del Tricolore, copia anastatica a cura di O. Montanari, Comune di Reggio Emilia, Reggio Emilia 2009. •Cammarano F., Consorteria moderata e propaganda socialista. Reggio Emilia dall’immobilismo sociale alla cultura politica, in Pombeni P. (a cura di), All’origine della «forma partito» contemporanea. Emilia-Romagna 1876-1892: un caso di studio, il Mulino, Bologna 1986, pp. 115-180. •Camurani A., Cronichetta giornaliera 1859-1870, La Nuova Tipolito, Felina 1996. •Corradini C., Organizzazione e strategia dell’esercito estense, in «Reggio Storia», 28/1985, pp. 48-54. •Corradini C., La difesa del Ducato nel 1859, in «Reggio Storia», 30/1986, pp. 4-15. •Chierici G., La visita di Vittorio Emanuele II a Reggio Emilia, 6 maggio 1860, in «Bollettino Storico Reggiano», 83/1994, pp. 51- 63. •Dallari U., Il 1859 in due ducati dell’Emilia (Reggio e Guastalla), Primo Borghi editore, Reggio Emilia 1911. •Del Bue M., Storia del socialismo reggiano. Dalle origini alla prima guerra mondiale, Grafic Studio, Montecchio 2009. •Ferraboschi A., Borghesia e potere civico a Reggio Emilia nella seconda metà dell’Ottocento (1859-1889), Rubbettino, Soveria Mannelli 2003. •Festanti M. e Panizzi C., I giorni dell’Unità. Politica e società a Reggio dal 1859 al 1861, Comune di Reggio Emilia, Reggio Emilia 2011. •Fincardi M., Campagne emiliane in transizione, CLUEB, Bologna 2008. •Gianferrari A., Reggio Emilia e il Risorgimento, AGE, Reggio Emilia 1961. •Menziani A., La caduta del ducato di Modena: dalla battaglia di Magenta ai trattati di Villafranca e Zurigo, in «Atti e Memorie Deputazione di Storia Patria per le antiche province modenesi», serie XI, vol. XXXIII, Aedes Muratoriana, Modena 2011, pp. 231-260. •Morini E., I reggiani benemeriti del Risorgimento nazionale, Tipografia Calderini, Reggio Emilia 1910. •Municipio di Reggio Emilia, Reggio dopo l’Unità, Tecnostampa, Reggio Emilia 1964. •Rombaldi O., Reggio nella «nuova Italia» in Festanti M., Gherpelli G. (a cura di), Storia illustrata di Reggio Emilia, AIEP, San Marino 1987, vol. II, pp. 369-384. •Ruini A., Memorie garibaldine la campagna del ’66, a cura di Camurani E., Mattioli, Fidenza 2010. •Spaggiari W., Il Risorgimento, in Festanti M., Gherpelli G. (a cura di), Storia illustrata di Reggio Emilia, AIEP, San Marino 1987, vol. II, pp. 353-368. •Spreafico S., La chiesa di Reggio Emilia tra antichi e nuovi regimi, Cappelli, Bologna 1979. •Tadolini G., I Giusti. Tre generazioni di irredentisti a Reggio Emilia dal 1859 al 1924, in Carrettieri M., Ferraboschi A. (a cura di), Piccola patria, grande guerra. La prima guerra mondiale a Reggio Emilia, CLUEB, Bologna 2008. •Varini G., Storia di Reggio Emilia, Tecnostampa, Reggio Emilia 1968. •Zanni Rosiello I., L’unificazione politica e amministrativa nelle «province dell’Emilia» (185960), Giuffrè, Milano 1965. 181 Recensioni M. INCERTI, V. RUOZI, Il bracciale di sterline per la libertà. Cento bastardi senza gloria. Una storia di guerra e di passioni, Aliberti, Reggio Emilia 2011, pp. 349, 18 euro «È una storia meravigliosa. È la mia storia, e la storia della mia gente». Sono parole di Scott Fitzgerald che possono essere fedeli compagne nella lettura di Il bracciale di sterline, ovvero, come precisa il sottotitolo, Una storia di guerra e di passioni con Cento bastardi senza gloria protagonisti di una delle imprese più spericolate e determinanti per le sorti del conflitto a nord della Linea Gotica. Questa meravigliosa «nostra» storia inizia con l’Operazione Tombola, nome in codice dell’attacco condotto, nel marzo del 1945, da formazioni partigiane (i Gufi Neri in particolare) e Alleate contro uno dei principali comandi tedeschi dell’Italia settentrionale, situato nei pressi di Reggio Emilia, a Botteghe di Albinea, in due edifici limitrofi, Villa Rossi e Villa Calvi. A Matteo Incerti e Valentina Ruozi, giovani giornalisti reggiani «cacciatori di ricordi» e artefici di una lunga, accurata ricerca storica ampiamente documentata alla fine del volume, va il merito di aver legato all’invisibile filo della narrazione quell’azione di guerra e altre vicende successive, con un fitto intreccio di eventi, luoghi, personaggi e tempi. Nasce così un racconto affascinante, coinvolgente, un lungo ma agevole viaggio di trecento pagine che inseguendo un bracciale di sterline, un suono di cornamusa e un telo di paracadute trasformato in abito da sposa conduce quei cento «eroi per caso», partiti in una lontana primavera, sino ai nostri giorni. E prende corpo allo stesso modo un romanzo corale, un libro-verità in cui la memoria è per gli autori volontà di ricordare, impegno di essere, sebbene di una generazione successiva a quella della Resistenza, interpreti sinceri e commossi di un momento decisivo nel quale le coscienze migliori si sono ritrovate. Il senso e il valore della guerra di liberazione, che per Franco Fortini ha rappresentato un «corso accelerato di storia del secolo, di etica, di estetica», vengono salvati nel Bracciale di sterline dallo «scialo ontologico» del tempo e ricondotti al presente, senza strumentalizzazioni politiche, arricchiti dalla carica umana dei protagonisti di quegli avvenimenti; dal partigiano Bruno, ad esempio, indignato dall’attuale sfacelo morale dell’Italia, a David E. Jones e «Rocky» Riojas, militari statunitensi ancora segnati nell’intimo dalla violenza del conflitto. Il primo elemento di originalità del libro consiste nella capacità di affrontare con semplicità una materia vasta e complessa: nell’arco degli anni le innumerevoli tessere di eventi e di esperienze individuali si affiancano nella composizione di un mosaico, storico e morale, spinto oltre i confini temporali della guerra, quasi a rispondere a una domanda tanto frequente quanto ignorata: «ma cos’è accaduto dopo?». Ed è una tale nota distintiva a rendere difficile la collocazione dell’opera in un ambito di «genere», quale il «romanzo storico», o nelle correnti tradizionali della letteratura «resistenziale», racchiusa entro i limiti di un periodo, di una memoria e di una connotazione ideale fortemente connessa alla militanza partigiana. Il secondo elemento è di carattere divulgativo: lo sviluppo del racconto, la chiarezza di esposizione, la ricchezza di fonti e di dettagli aprono la prospettiva di un nuovo orizzonte di scrittura, dove la verità storica assume la forma di un romanzo proiettato nel presente, rivolto alle giovani generazio- 182 ni e di forte tensione pedagogica. A questo punto ci si potrebbe interrogare sul motivo per cui la ricchezza reggiana di storia e «storie», di azioni ed emozioni legate alla Resistenza non abbia offerto figure quali Fenoglio, Fortini, Revelli, Vittorini, Meneghello o Viganò. Il più vicino a noi, Ubaldo Bertoli, ha scritto della quarantasettesima brigata Garibaldi sull’Appennino parmense. La causa primaria è forse individuabile nella situazione di Reggio e dintorni, dove il contrasto politico e ideologico si è fortemente, talvolta tragicamente radicato durante il conflitto e nel dopoguerra ostacolando sia il confronto tra le diverse posizioni sul fronte antifascista, sia un’interpretazione degli eventi in chiave narrativa. Paradossalmente un attento critico e docente di letteratura, Gabriele Pedullà, ha visto proprio nel reggiano Silvio D’Arzo l’opportunità mancata: «l’unico scrittore che avrebbe potuto raccontare il collasso dei più elementari punti di riferimento dopo l’8 settembre, rispetto al quale la Resistenza rappresentò il primo segno di riscossa». Non è certo questa l’occasione per affrontare un tema così complesso, che sarebbe però interessante approfondire; resta il fatto che Il bracciale di sterline giunge ora non solo a colmare un vuoto, ma anche a offrire un nuovo e originale contributo letterario alla storia e ai valori della lotta contro il nazifascismo. Dal punto di vista formale una minore enfasi avrebbe probabilmente giovato al testo, che in diversi «passaggi» assume un tono lievemente forzato. Si tratta però di un problema presente in molte narrazioni legate alla Resistenza (ad esempio in L’Agnese va a morire della Viganò) ed affrontato in alcune elaborazioni critiche, nella ricerca dei mezzi stilistici, come ricordava Meneghello, per «tenere a bada la commozione». Una commozione che potrà anche apparire retorica, ma che affiora spontanea dal messaggio racchiuso nell’ultima riga del libro: «Per non smettere mai di sognare, di lottare, per non smettere mai di sperare». Giovanni Guidotti A. CANOVI, Pianure Migranti. Un’inchiesta geostorica tra Emilia e Argentina, Diabasis, Reggio Emilia 2009, pp. 400, CD allegato, 22 euro Nel 2009, lavorando a una ricerca su due famiglie castelnovesi emigrate tra Pergamino e Buenos Aires («RS-Ricerche Storiche» 108/2009 e 109/2010), ho conosciuto Antonio Canovi impegnato in un’indagine per una pubblicazione imminente: Pianure Migranti, un’importante ricerca sui reggiani dei comuni del Po partiti alla volta del vasto territorio argentino. Lo scenario dà il titolo al progetto: Pianure perché le inchieste si snodano tra pianura Padana e Pampa Umeda, Migranti perché entrambe le suddette aree geografiche sono state interessate da fenomeni rispettivamente di emigrazione l’una e immigrazione l’altra, in un arco temporale che copre dalla fine del XIX alla seconda metà del XX secolo. Questa ricerca-azione e uno studio geostorico d’interazione diretta con i suoi protagonisti: gli emigranti e i discendenti che hanno ricostruito la propria identità argentina su radici italiane. Già dal primo approccio il lettore si deve preparare a un punto di vista «diverso»: tutto si snoda dal basso per descrivere dall’interno uno dei più rilevanti 183 fenomeni sociali del Novecento italiano. Dalle interviste ai racconti, la fonte orale passa sulla pagina scritta senza artifici, con il suo linguaggio diretto e spesso dialettale. La microstoria dei migranti emiliani qui riceve la giusta attenzione, sono proprio le voci provinciali e spesso dimenticate che hanno permesso lo sviluppo economico argentino. Scrive Blengino: «i nostri emigranti furono imprenditori di se stessi ...» (Venezia, Università Ca’ Foscari, 2003) ma lo furono anche per il paese che li accolse, pur con l’Italia nel cuore. S’intrecciano tra i paragrafi le storie di contadini, operai, mercanti, passando dagli strati sociali più semplici a quelli più abbienti. Una storia onesta, senza sviste o censure. Ci sono i successi individuali e collettivi, le crisi economiche e la memoria dolorosa dei desaparecidos. Tante parti di un puzzle che danno forma alle similitudini tra la nostra cultura regionale e quella esportata in terra argentina. Da un lato il potenziale attrattivo del libro è forte, sostenuto dalla curiosità e dall’interesse suscitati da queste storie di vita, dall’altro non si nasconde una lettura faticosa. La scelta di proporre un archivio di fonti prevalentemente orali ostacola la fluidità testuale, sia stilistica che sintattica. La proposta del materiale di ricerca conservato con attenzione filologica è un metodo ormai ampiamente collaudato dagli storici che, tuttavia, mantiene vivo un eterno dilemma ben definito nelle parole di Brecht: «Chi costruì Tebe dalle sette porte?» (C. Ginzburg, 1999). All’interno di questo pur prezioso archivio di memorie, la materia grezza dell’indagine storica si sostituisce al corpus centrale demandando al lettore il compito dello storico. L’ordine dei capitoli, che segue le tappe effettuate per la raccolta delle testimonianze, appare confuso, così come la trasposizione scritta delle interviste resta abbandonata all’emotività dei ricordi in un contesto che diviene surreale. Il lettore si proietta in uno sconfinato Nuovo Mondo con curiosità e disagio, esattamente come nelle testimonianze dei nostri migranti. La mancanza di strumenti utili all’orientamento geostorico soprattutto per chi inizia una lettura digiuno d’Argentina, insieme ad una traduzione non perfetta di alcune terminologie spagnole, affaticano la comprensione del testo. Ci si pone una domanda: quali sono le intenzioni dell’autore? Si tratta forse di una proposta del materiale ancora acerbo di uno storico che vorrebbe passare il testimone di un lavoro incompiuto? Non si sarebbe posta l’esigenza di una pubblicazione divulgativa. Il lettore accorto ha il diritto di conoscere la tracciabilità delle fonti, poterle verificare e attingervi ma lo storico non può permettersi di abbandonarlo al vociare confuso della microstoria (dei «costruttori di Tebe»). Completa l’edizione un cd che racchiude le registrazioni delle interviste documentate nel libro. Concordo con questa scelta in quanto l’impostazione metodologica rende la ricerca molto più adatta ad una diffusione orale e interattiva. Il supporto multimediale è una giusta risposta alle necessità espressive dell’intero lavoro porta il lettore a seguire, con rinnovato interesse, il diario di un viaggio nella nostra memoria storica, un po’ troppo «costretta» a una versione nero su bianco. Serena Cantoni 184 C.M. LANZAFAME, Battaglieri. Storie di liscio emiliano, Prefazione di Gianpaolo Borghi, CLUEB, Bologna 2011, pp. 372, 18 euro Con questo libro, voluto dalle Amministrazioni comunali di Bibbiano, Cavriago e Montecchio, Carmelo Mario Lanzafame, sulla falsariga dell’altro suo lavoro Socialismo a passo di valzer, uscito nel 2006, sviluppa una complessa e approfondita ricerca sul ballo liscio nella Val d’Enza con riflessi sulle città di Reggio e Parma. I promotori hanno favorito la ricerca per «dare dignità ad una storia, erroneamente considerata minore, che è parte integrante del percorso di emancipazione del territorio della val d’Enza». Lanzafame parte dalle danze saltellate che precedettero il liscio, eseguite prevalentemente col violino da suonatori orecchianti, per arrivare a descrivere un fenomeno professionale tipicamente emiliano come quello dei concerti di fiato. Il complesso d’archi, che eseguiva principalmente i balli della furlana e della piva, proveniva da una secolare tradizione che sopravvisse in quasi tutta la montagna reggiana fino agli anni Sessanta del Novecento. Questa musica fu fonte di sostentamento e di integrazione dei miseri redditi dei suoi praticanti. Con l’epoca napoleonica, poi in quella asburgica e per tutto l’Ottocento, cominciò una nuova pratica in cui le bande militari dapprima per funzioni politiche quindi religiose, civili e ludiche, determinarono con forza l’introduzione degli strumenti a fiato. In particolare sul Ghiardo si svolsero per decenni manovre militari ed i reggimenti che le eseguivano periodicamente organizzavano feste da ballo con le loro bande. La presenza di militari musicisti portò un arricchimento delle conoscenze musicali dei civili e, mediato da tali bande, il passaggio a quelle civiche fu quasi naturale. Esse divennero la base musicale anche nelle feste danzanti pubbliche. Nel tessuto della ricerca, che entra profondamente nel sociale, si mescolano episodi di liti e ubriacature, di cioccone e di amori, di passione per la musica da ballo che ci fanno rivivere il passato di un mondo colorato che ha incubato il liscio reggiano; vi appaiono lunghe liste di cognomi tipicamente locali. Largo spazio è dedicato alla natura ed allo svolgimento di concerti e feste da ballo nei veglioni, nelle sagre, nelle feste private rompendo giustamente col preconcetto della rigidità calendariale. Si tratta di un mondo sia rurale, sia cittadino, sia di periferia urbana dove stavano le osterie storiche del «fuori porta» e dove gruppetti di suonatori isolati o le nascenti orchestrine allietavano col ballo le classi popolari. Il repertorio era già stato adattato all’intrattenimento danzante di coppia e da tempo erano comparsi valzer, mazurca e polca. Il passaggio alle orchestrine di liscio avviene già nel primo Novecento e lo sforzo di Lanzafame si manifesta nel documentarne l’attività ed i comportamenti secondo un processo di progressivo «tradimento della tradizione» che porta la musica etnica alla «popular music» del secondo dopoguerra. In val d’Enza, già dalla fine dell’Ottocento al primo Novecento il rapporto con la politica si fece sentire. Un fenomeno importante fu la costruzione della ferrovia Reggio-Ciano che portò in zona masse di lavoratori ed i luoghi e gli ambienti socialisti (l’osteria, la cooperativa, la casa del popolo) divennero centri di aggregazione anche per il ballo. La musica passò in mano alle organizzazioni proletarie con riflessi diretti sui repertori ed il nascente socialismo fu la culla di un nuovo modo di «stare insieme». 185 Mario Lanzafame analizza anche il mondo cattolico e le sue organizzazioni che, specie nella parrocchia di Calerno, furono molto attive. Il retroterra strumentistico, la istruzione musicale diffusa, il clima generale favorirono la formazione di una categoria di musicisti compositori che daranno vita a quello che sarà il cosiddetto liscio popolare, ma non folclorico, basato sui fiati, che passerà attraverso famiglie di suonatori e trionferà nel famosissimo Battagliero composto negli anni Trenta da Tienno Pattacini. Quel valzer, che potrebbe assurgere ad inno della provincia di Reggio, ricalca il carattere «battagliero» dei kwariaghini e dei barcaroli. Lanzafame analizza questi passaggi con peculiarità indagando meticolosamente negli archivi comunali, parrocchiali e in altre fonti disponibili e la profondità della ricerca archivistica non comprime l’aspetto umano. È tutto un lavoro di scavo alla ricerca di ogni notizia che possa risultare utile, dai permessi rilasciati ai suonatori alle sanzioni loro comminate, dai verbali delle riunioni agli atti riguardanti le bande civiche, ai loro bilanci, agli statuti e quindi al ruolo dei comuni ed all’intreccio con le vicende socio-politiche dell’epoca. Notevole l’apparato bibliografico consultato, e commentato in ricche note a piè di pagina, dal quale emerge il quadro politico, sociale ed economico che fa da sfondo alla nascita ed allo sviluppo spontaneo dei concerti di fiato. Il lavoro di ricerca ricostruisce storie collettive come ad esempio quella della plurisecolare «Martlàsa» di Montecchio e individuali dei personaggi che hanno ruotato attorno a questo mondo. Questi personaggi fanno ancora capolino nella memoria collettiva oppure sono ormai relegati alla memoria storica o archivistica. L’autore, nell’ultimo capitolo dedicato ai tempi recenti che vanno dalla regressiva fase fascista alle cronache degli ultimi successi fino alle soglie del 2000, fa anche largo uso di testimonianze orali. Il libro non è di facile lettura in quanto l’intento storiografico dell’autore prevale su quello divulgativo e vengono riportate una quantità di informazioni, non sempre lineari sul piano temporale, che rendono difficoltoso il seguire la traccia principale della ricerca condotta. Il volume si chiude con una ricchissima appendice contenente gli elenchi dei complessi e delle orchestre coi nomi dei loro componenti in attività, tra il 1822 ed il 2010, a Barco, Bibbiano, Calerno, Cavriago, Montecchio, Sant’Ilario. Bruno Grulli A. GUARNIERI, E. LAGUARDIA, 1975. Un delitto emiliano, Odoya, Bologna 2011, pp. 113, 15 euro Sarebbe proprio da abbandonare la formula «anni di piombo» quando si parla di anni Settanta, perché parziale, falsante, ideologica. Non c’è poi tanto bisogno di «memoria condivisa» su quel periodo, anche perché una memoria condivisibile sarebbe impossibile da avere (o a che prezzo?) – su questo ha ragione Luca Telese nella postfazione a questo volume. Gli anni Settanta, anche a Reggio, sono stati ben altro che «anni di piombo». Ed è altra l’eredità che potremmo ricavarne. Non si dovrebbe ridurre tutto e tutti a una 186 specie di guerra (guerra civile, guerra «non dichiarata»), una guerra un po’ scema, a una specie di delirio collettivo, al dominio del terrore che si diffondeva dall’alto (soprattutto) come dal basso. Davvero qualcuno s’incazzava a sentir parlare di compromesso storico o a vedere come si viveva nelle carceri italiane, e aveva buone ragioni per farlo. Per questo non dovremmo nemmeno rileggere tutta la galassia dei movimenti, dei gruppi e dei sottogruppi, da Lotta continua all’autonomia (e le magnifiche riviste che producevano: basterebbe solo riavere oggi «Rosso»), e poi le Brigate rosse e tutti gli altri (ma senza dimenticarsi mai del pci e della dc) come una macchina infernale, come l’omicida della creatura di Berlinguer e di Moro (oltre che di Moro stesso) – quel Moro «grande politicante» che sarebbe diventato «grande statista» solo a maggio del ’78, per dirla con Sciascia... A un certo punto del Divo di Paolo Sorrentino, Andreotti confessa: altro che «strategia della tensione», quella (la nostra) era «strategia della sopravvivenza»! Ecco, la categoria della sopravvivenza, certo in un senso molto diverso da quello dei governi dc, potrebbe esserci molto utile per capire lo Stato e alcune leggi, i partiti e i gruppi, gli «opposti estremismi», ma anche la violenza e la creatività, il bene comune e la vitalità coltivati negli anni Settanta. Questa graphic novel è dedicata alla storia di Alceste Campanile, meno al suo delitto (nonostante il titolo) che al suo mondo reggiano ed emiliano, mondo politico (non c’era solo il potere del pci!) e culturale, una cultura come vero work in progress, che oggi ci manca terribilmente: Dalla, Roversi, Guccini (e poi Tondelli) e tanti altri, sono solo alcuni nomi di una «emilianità» ormai solo nella memoria. Dopo aver letto questa storia a fumetti – i suoi autori sono stati molto bravi a riempirla di riferimenti alla musica e ai libri di quegli anni – non viene tanto da riflettere su quel «delitto emiliano»; è molto meglio provare a immaginarsi quanto fossero vive (più vive) e contraddittorie, ma anche pericolose in certi momenti, città come Reggio e Bologna. Questo libro non può essere troppo facilmente catalogato assieme ai tanti altri, usciti negli ultimi anni, che si riferiscono a una specie di «vittimologia» degli anni Settanta – e che dominano la memorialistica sul periodo. Non che non sia importante la memoria delle vittime, ma non è molto utile fare soltanto memoria attraverso lo sguardo proprio delle vittime (e, peggio ancora, dei loro eredi); e tanto meno rimanendo in eterno dentro i tribunali o davanti alle lapidi. Fin che si è in tempo, sarebbe proprio il caso di far riemergere, sollecitare le memorie diverse (anche sgradevoli, a volte); e ciò per evitare, da un lato, l’odioso revisionismo che fa dire: «Rossi e neri (e dc, pci, polizia...), tutti uguali»; dall’altro, per evitare semplificazioni manichee (buoni contro cattivi, democratici contro violenti, costituzionali contro eversivi, ecc. Anche qui, viva la complessità. Francesco Paolella 187 A. RAPINI, Lo stato sociale, Archetipolibri, Bologna 2011, pp. 234, 19 euro Giunge al momento opportuno questo studio sulla genesi e sullo sviluppo della stato sociale, quell’invenzione europea che è stata giustamente riconosciuta come un «tassello rilevante dell’identità culturale e politica del Vecchio continente»: l’attuale congiuntura economica e finanziaria che attanaglia soprattutto gli stati europei (reduci da un’incompiuta unificazione) sembra costituire l’estremo approdo di una stagione di conquiste nella gestione della cosa pubblica e nel rapporto dello Stato con la povertà e con i bisogni sociali dei cittadini. La condizione attuale, comunque, può costituire materia per altri studi in quanto il lavoro di Rapini si concentra (si fa per dire) sulla nascita delle prime esperienze di assistenza sociale (le assicurazioni) alla fine dell’Ottocento, giungendo fino agli anni Ottanta del Novecento, quando si palesa un ridimensionamento dei programmi del welfare state. Di materia da analizzare, entro queste due date, ce n’è abbastanza per impensierire qualsiasi ricercatore. Rapini affronta l’analisi di questo periodo storico con grande determinazione e utilizzando un metodo di lavoro che pone a confronto casi e contesti paradigmatici, favorendo approfondimenti mirati su talune esperienze e l’approccio ad un panorama d’insieme dinamico che permette valutazioni di sintesi. Considerando lo stato sociale come una rivoluzione di lunga durata, l’autore ne periodizza l’evoluzione identificando al suo interno quattro fasi distinte che possono trovare ragioni di connessione al mutare dei rapporti tra l’economia, la società, lo Stato e gli attori collettivi. La prima fase corrisponde alla nascita e all’affermarsi delle assicurazioni sociali, «quale dispositivo per assistere i cittadini di fronte ai principali rischi connessi al lavoro». Tale fase nasce nel 1883 e si conclude con la Grande Guerra. Essa trova la sua origine in Germania, ove nel 1883 viene varata l’assicurazione obbligatoria contro le malattie dei lavoratori, nel 1884 quella contro gli infortuni e nel 1889 quella contro l’invalidità e la vecchiaia. La povertà, nella logica bismarckiana, è vista come un male sociale e la politica assistenziale che s’intende modificare – in larga parte affidata a enti religiosi ed a società di mutuo soccorso – ne individuavano esclusivamente aspetti di ordine pubblico. Con l’assicurazione obbligatoria si instaura il riconoscimento di un diritto legale a una prestazione che prescinde da discriminazioni sociali o politiche. Non è avventato intravedere in questo balzo epocale l’influsso, seppur non dichiarato, della consapevolezza dei giacobini francesi che vararono la Costituzione del 1793 che le istituzioni pubbliche dovessero garantire il diritto dei singoli al lavoro, all’istruzione, all’assistenza, alla felicità. Tale consapevolezza si sfalda tra i marosi della lotta civile che affonda le acquisizioni della Rivoluzione francese, fornendo nuova linfa agli ospizi di mendicità. Così è avvenuto anche altrove, in Inghilterra ad esempio. Alla Germania spetta, dunque, il primato di aver introdotto la concezione dello stato sociale. La seconda fase è caratterizzata da incertezza e transizione: essa coincide con il periodo che va dalla Grande Guerra alla depressione del 1929. Più che con i problemi economici e finanziari che si scatenano in quegli anni, lo stato sociale deve fare i conti con la difficoltà, da parte delle istituzioni politiche, di accettare la definitiva consunzione dei modelli ottocenteschi e di comprendere le esigenze e i problemi della moderna società di massa. Mercé la particolare situazione di quegli anni, gli stati non adottano 188 interventi necessari (oggi si direbbe «strutturali») per includere quelle masse nello Stato, sollevandole da miseria e disoccupazione. Oltreché poveri, milioni di persone restano sudditi e non acquisiscono lo status di cittadini. È nella terza fase, che corre dagli anni Trenta agli anni Settanta del Novecento, che si afferma lo stato sociale. Si afferma il ruolo dello Stato che «dosando strumenti e interventi mutevoli da contesto a contesto» diventa il centro nevralgico di regolazione degli squilibri economici e sociali. Sono anni in cui si manifesta una critica feroce al mercato e al laissez-faire. Il periodo bellico, pur con gli effetti che può ingenerare una situazione drammatica e lacerante di quel tipo, favorisce l’affermarsi di una concezione pragmatica dell’esercizio democratico del diritto di cittadinanza, di cui il concetto di welfare state (stato del benessere) è una derivazione diretta. Dall’idea di stato sociale che matura negli anni della lotta antifascista è quella su cui si basa la successiva costruzione dello Stato assistenziale e dell’affermazione di concreti doveri nei confronti dei cittadini per salvaguardarne diritti sanciti costituzionalmente. Tale stato sociale persiste tuttora, anche se già nella terza fase dell’indagine, cioè dagli anni Settanta agli anni Ottanta del Novecento, con un’accentuazione negli anni successivi che non sono oggetto d’indagine per ragioni di scientificità delle fonti, si manifestano i primi cedimenti della concezione maturata in epoca bellica. L’analisi di Rapini, svolta con una persistente attenzione alla interdisciplinarietà dell’indagine, centra dunque un aspetto di rilievo della società d’oggi, e offre sostegno ad una comprensione dell’evoluzione dello stato sociale, in Italia e in Europa, per esaminare con compiutezza di riferimenti possibili o volute modifiche al sistema vigente. Essa non tiene conto del cosiddetto welfare aziendale, né dell’attività benefica di istituti religiosi, e neppure delle iniziative di soggetti che si riconoscono nel Terzo settore: questa limitazione non risulta limitativa, ma rafforza piuttosto la definizione dell’oggetto di analisi e permette all’autore di effettuare un’analisi precisa e documentata del fenomeno. Cui forniscono ulteriore spessore la calibrata cronologia degli eventi relativi all’affermarsi, al consolidarsi e al ripensarsi dello stato sociale, nonché l’antologia di documenti, di ricostruzioni e interpretazioni storiografiche, ma anche di documenti ufficiali di non facile consultazione ed essenziali per comprendere talune scelte politiche e le difficoltà attuative di un’idea ugualitaria e solidaristica che affonda le sue origini nella rivoluzione francese. Il lavoro, forse pensato per gli studenti dei corsi universitari, è un buon vademecum per politici, sociologi e mediatori culturali affinché i valori e le conquiste dello stato sociale non abbiano a disperdersi come fragili miraggi. Carlo Pellacani 189 E.FRANZINA, Dal fascio alla fiamma. Fascisti a Verona dalle origini al MSI, Cierre Edizioni, Sommacampagna 2011, pp. 288, 16 euro Indifferenza e conflittualità. Queste le prime parole che mi vengono alla mente per indicare, semplicisticamente, la storia del fascismo a Verona. L’indifferenza della popolazione rispetto alla politica, rimarcata dagli autori per spiegare come la maggioranza della gente, in queste terre, abbia troppo spesso subito senza opporsi. Conflittualità interna al partito, per tutta la durata del ventennio: uno scontro a differente intensità tra le varie correnti sia per il potere che per la linea politica. Questa lucida e dettagliata ricerca ci mostra quarant’anni di storia del fascismo e del neofascismo, dal ’19 al ’60 circa, a Verona, raccontandola con i documenti, gli articoli di giornale, i carteggi e talvolta le voci di chi ha vissuto quella stagione politica nelle fila fasciste. Il testo, suddiviso in cinque saggi ognuno dei quali affronta un differente lasso di tempo, non manca di ricchi riferimenti bibliografici che aiutano il lettore a creare un esauriente quadro del contesto socio-politico. L’opera, come è spiegato nell’introduzione redatta dal curatore Emilio Franzina, ha come obiettivo quello di trovare un rapporto tra l’attuale situazione politica di Verona e il suo passato per mezzo della ricerca storica: capire insomma, se e come è possibile tracciare un filo conduttore tra il fascismo di ieri e di oggi. «Romana, bersaglieresca, fascista nell’animo fin dalla vigilia!» Così Mussolini descrisse Verona nel ’38 in un discorso e così Maurizio Zangarini intitola il proprio saggio che tratta del periodo 1918-1943. Fin dall’inizio l’autore mostra come già prima dell’avvento del fascismo la «rossa» Verona, poi tanto rossa non era. Il saggio mette in luce come, sin dalla nascita, fu in larga parte l’alta borghesia ad occupare i posti di potere nel partito e nell’amministrazione; questo ci porta al saggio di Federico Melotto. Questo secondo saggio racconta in primo luogo i contrasti interni al partito, dei quali però la società non sembra accorgersi; l’autore mostra anzi come il consenso al partito crebbe in modo esponenziale, non per l’entusiasmo dei più ma per l’impegno di pochi e «l’accontentarsi» di tanti. Il saggio di Olinto Domenichini affronta invece gli anni dal 1943 al 1945, gli anni della Resistenza e della repressione; Resistenza che a Verona fu debole: con scarso appoggio della popolazione e dilaniata dai delatori. Non vi fu, d’altro canto, un’adesione in massa alla Repubblica sociale italiana, ciò a dimostrare il relativo interesse della maggioranza alle tormentate e cruente vicissitudini di quegli anni. Roberto Bonente, infine ripercorre la nascita del msi: dalla galassia di piccole organizzazioni neofasciste la cui maggioranza trova un punto d’incontro in un partito. L’immagine che ci viene data di Verona, è di una città che non ha avuto particolari sussulti, una città che non ha mai fatto pienamente i conti col proprio passato o forse non ne ha mai sentito l’esigenza. Uno sguardo particolare va dato al saggio di Silvia Pasquetto, Donne della destra. In poche pagine, grazie alle testimonianze di alcune militanti missine, l’autrice riesce a descrivere il ruolo delle donne nel msi: troppo spesso osteggiate «esse si trovano a rivestire ruoli ed assolvere compiti prestabiliti, … meriti e capacità sembrano non bastare, visto che devono attendere il momento opportuno per essere valorizzate». Due generazioni di donne sono descritte in questo saggio: ex saf missine della «prima 190 ora», lige alle regole imposte dal partito che accettarono in definitiva, il predominio maschile quasi assoluto e donne che, per ovvi motivi anagrafici, iniziarono l’attività politica negli anni Settanta, più critiche rispetto al ruolo impostogli. Traspare tuttavia che queste donne cercarono nella politica, ed a loro modo la trovarono, «un’opportunità emancipatrice» . In conclusione possiamo trovare in questo libro un’approfondita ricerca che aggiunge un tassello alle altre esperienze di studi territoriali, andando ad arricchire la conoscenza particolare dell’esperienza fascista e neofascista. Riccardo Berni A. MARCHI, L’ostinazione laica. L’esperienza giornalistica di Arrigo Benedetti, Prospettiva editrice, Siena 2010, pp. 106, 14 euro Alberto Marchi copre, con questo risarcimento della figura e dell’impegno civile, di Arrigo Benedetti il grande vuoto che ha circondato, in ambito reggiano, il centenario della sua nascita. Se si esclude una rievocazione commemorativa tenutasi a Vetto d’Enza, il comune ove è situato Gazzano, che accoglie le spoglie mortali del giornalista-scrittore e che è al centro di un’opera di grande respiro come Tempo di guerra, nella nostra provincia non si sono avute altre significative manifestazioni di ricordo e di valorizzazione. Diverso, fortunatamente, è stato l’atteggiamento di Lucca, sua città natale, ove un convegno di studi ha esplorato aspetti noti e sconosciuti della sua feconda attività di giornalista e di protagonista delle principali battaglie civili e politiche italiane. Alberto Marchi esplora, con questo agile e circostanziato studio, un periodo limitato della vita di Arrigo Benedetti, cioè la sua collaborazione con «Panorama» negli anni dal 1967 al 1969. L’analisi riguarda oltre cento articoli apparsi nella rubrica settimanale «I Tempi», un pulpito dal quale giunsero in quegli anni difficili della vita italiana considerazioni e indicazioni di alto valore culturale, politico e umano. In questa esperienza giornalistica, derivante dalla conclusione della fruttuosa e innovativa collaborazione con Eugenio Scalfari e con «L’Espresso», dopo la propositiva parentesi dell’«Europeo», Benedetti fece emergere in tutta la sua portata un patrimonio di idee e un metodo di indagine e di analisi giornalistica e culturale di stampo ostinatamente laici. Si tratta di una scelta di campo che Benedetti aveva fatto propria fin dai tempi del «Mondo» e dello straordinario sodalizio intellettuale che era animato da Mario Pannunzio, e che avrà attuazione in ogni fase della sua troppo breve esperienza terrena. La sorte postuma di Arrigo Benedetti mostra quanto fosse appropriata la definizione di «giornalista famoso e sconosciuto» con cui Ottavio Cecchi, appena tre anni dopo la sua morte, sintetizzò la prevedibile dimenticanza che sarebbe stata riservata ad una figura tanto importante del giornalismo italiano del trentennio successivo alla fine della seconda guerra mondiale. Il lavoro di Alberto Marchi è dunque prezioso, sia per la riproposizione di un periodo così significativo della storia italiana di cui sono depositari non pochi testimoniprotagonisti tuttora viventi, sia per l’ostinata lezione di laicità che deriva da una scelta 191 politica e culturale di tipo liberale che ha concorso a plasmare conquiste importanti dell’Italia del dopoguerra. Alberto Marchi sottolinea inoltre, e appropriatamente, la desolazione mortificante in cui si trovano studi sulla figura e sull’opera di Arrigo Benedetti. «Manca tuttora un biografia, così come mancano contributi in grado di dar conto e di approfondire la complessità del suo autentico approccio culturale», scrive Marchi. Ed in effetti, se si eccettua un saggio di Adolfo Scoto di Luzio del 2003, il panorama è davvero sconfortante anche sotto il profilo dell’interesse per la sua attività letteraria (tra cui Paura all’alba e Tempo di guerra). A trentacinque anni dalla morte di Arrigo Benedetti, superando mere intenzioni celebrative, c’è da augurarsi che si possa assistere ad un’attenzione adeguata all’opera propositiva e innovatrice di questo grande giornalista e scrittore. Carlo Pellacani 192
Scarica