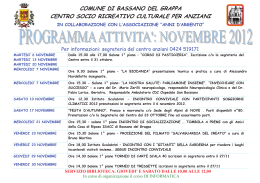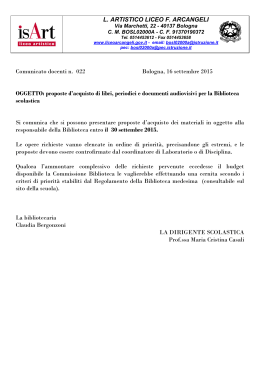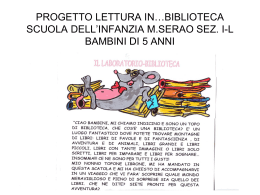CAPITOLO 3 La biblioteca comunale La biblioteca comunale di Soriano nel Cimino si inserisce in una realtà regionale debole: per motivi storici, legati all’influenza che sulla cultura ha avuto lo Stato della Chiesa, e morfologici (è altissimo nel Lazio il numero dei paesi al di sotto dei mille abitanti), solo il 35% dei comuni ha una biblioteca locale; la prima provincia, per numero di biblioteche, è quella di Latina, segue Viterbo, Roma, Frosinone e in ultimo, con solo 15 biblioteche su 73 comuni, la provincia di Rieti1. Questo quadro poco rassicurante, però, è rasserenato dall’esistenza di alcune splendide realtà, come appunto quella di Soriano nel Cimino, che, come vedremo nei capitoli seguenti, ha tutti i numeri per essere considerata una biblioteca all’avanguardia non solo rispetto alla situazione regionale, ma anche rispetto ad un quadro nazionale. La biblioteca comunale di Soriano nel Cimino è stata istituita nel Maggio 1977. 1 Questi dati sono stati forniti durante il Primo Convegno regionale dedicato alla promozione della lettura per bambini e ragazzi, svoltosi ad Anagni il 29 e 30 maggio 2003. 81 La sua istituzione si inserisce in un contesto politico molto interessante per la storia delle biblioteche nel nostro paese. Viene istituita nel fervore che segue la legge regionale n. 30 del 1975 - “Sviluppo delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati”- , inserita nel progetto di programmazione della regione Lazio e voluta dall’allora assessore regionale alla cultura Tullio De Mauro. Un primo esperimento, nel Lazio, di istituire una biblioteca pubblica in ogni comune, fu effettuato nella Provincia di Rieti nel 1962, ma il fallimento di questo tentativo, che portò le biblioteche create a chiudere entro un triennio, condizionò la nascita e lo sviluppo di esperienze analoghe, ritardando, anche, la formazione del Sistema bibliotecario della Provincia di Viterbo, inizialmente previsto per il 1965. Si è dovuto attendere la creazione delle regioni a statuto ordinario, nel 1970, e la separazione della Soprintendenza bibliografica del Lazio da quella dell’Umbria, per vedere la nascita di questo sistema bibliotecario. Nella Provincia di Viterbo si sviluppa il Piano L, dove “L” stava per libro: prevedeva l’istituzione di una biblioteca pubblica in ogni comune che ne avesse fatto richiesta e la creazione di un centro rete affidato alla Biblioteca provinciale “Anselmo Anselmi.” I comuni dovevano occuparsi di individuare e reperire i locali idonei e il personale; la Soprintendenza regionale si preoccupava di assicurare un primo arredo (tavoli, scaffali, sedie e schedari), di destinare un iniziale fondo librario di circa trecento libri (già inventariati, timbrati e catalogati) e di assicurare un contributo 82 mensile di lire 40.000. La biblioteca provinciale fungeva anche da Centro di alimentazione del Sistema, acquistando i volumi secondo i suggerimenti che provenivano dalle singole biblioteche e consegnandoli loro già catalogati e pronti per essere inseriti negli scaffali. Questa impostazione iniziale, nella quale la biblioteca di Soriano va subito ad inserirsi, rimase pressoché invariata per circa dieci anni; poi, decisioni di carattere amministrativo finirono per modificare e incrinare i rapporti tra il centro e le singole biblioteche. La storia dei primi anni di vita della biblioteca di Soriano, è una storia fatta di difficoltà, problemi economici e carenza di personale. In quegli anni, non esisteva in tutta la provincia un solo comune che prevedesse nella propria pianta organica la figura del bibliotecario. Per i primi sei mesi, della biblioteca si sono occupati due impiegati comunali, i quali cercavano di garantire l’apertura due o tre pomeriggi a settimana, prendendo il finanziamento regionale di lire 40.000 mensili come straordinario. Dopo questo breve periodo, la biblioteca viene gestita da Gabriella Evangelistella, che ottiene il posto di ruolo solo nel 1980 e che da allora è l’anima e l’asse portante della biblioteca stessa. Precedentemente al 1977 non era esistita a Soriano nessun tipo di biblioteca o centro lettura. Così, la nuova istituzione ha dovuto costruire la sua raccolta partendo esclusivamente dal fondo iniziale garantito dai finanziamenti regionali. Come è facilmente intuibile, la “fame di libri” ha 83 caratterizzato i primi anni dell’attività bibliotecaria. Il primo passo è stato quello di rendere circolanti le biblioteche scolastiche tramite la biblioteca comunale; questo speciale collegamento (esperimento unico nella provincia) ha permesso di aumentare l’offerta della comunale di 1610 libri e, nello stesso tempo, ha permesso che il patrimonio librario scolastico venisse finalmente catalogato per materia e per autore (fino ad allora gli era stata garantita la sola registrazione). Viene mantenuto uno stretto legame anche con il Sistema Bibliotecario Provinciale che garantisce, nel 1979, 1081 libri circolanti. Per incrementare il patrimonio, da subito si inizia, anche, una ricerca di poesie in dialetto edite ed inedite, tesi di laurea e pubblicazioni di vario tipo su Soriano che vadano a costituire un embrione di sezione locale (partita da una situazione di totale assenza di materiale sulla storia locale, già nel 1981 la biblioteca affermava di essere in grado di potere offrire qualcosa in più della bibliografia ufficiale riportata dagli storici locali). Importante scoperta è stata quella dell’esistenza di un ex centro di lettura nella frazione di Chia, dal quale si sono recuperati 815 libri. Le difficoltà relative al patrimonio non sono le uniche che una biblioteca di prima istituzione, come quella di Soriano, ha dovuto affrontare. Dai timbri alle scaffalature, tutto mancava alla nuova biblioteca, e ricostruendo la sua storia, ci si trova davanti alla testimonianza di numerosi appelli alle varie amministrazioni comunali, quasi sempre poco disponibili, per l’acquisto delle attrezzature più indispensabili e perfino per 84 l’installazione della linea telefonica, “poiché le esigenze cui deve rispondere una piccola biblioteca sono esattamente le stesse di una biblioteca di grandi dimensioni” (relazione tecnica 1979); ”anche per la richiesta di mezzi essenziali come scaffali e schedari, la bibliotecaria viene considerata quasi come una questuante e ogni cosa che serve alla biblioteca è relegata, ancora, alla fine del bilancio e considerata come bene voluttuario” (relazione tecnica 1981). Fin dall’inizio, la biblioteca ebbe chiaro quale avrebbe dovuto essere il suo ruolo nell’ambito della realtà comunale nella quale operava. La biblioteca istituita a Soriano nel Cimino non è mai stata una biblioteca a carattere storico e di conservazione, come la maggior parte delle biblioteche del Lazio, ma da subito si è identificata come una biblioteca per il pubblico, con l’intento di divenire punto di riferimento per tutti i cittadini; nel regolamento per la biblioteca comunale approvato dal consiglio comunale il 30 ottobre 1978 all’art.1 si dice: “La biblioteca del Comune di Soriano nel Cimino è istituita come servizio pubblico e sociale da rendere alla cittadinanza e come centro vivo e attivo di cultura.” Nello stesso atto all’art. 2 si esplicitano gli scopi di questa istituzione, che, per la loro lungimiranza e rilevanza per l’argomento da me trattato, ritengo sia utile riportare: 85 “a) offrire ai cittadini, con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni, i mezzi per l’informazione, la formazione e l’aggiornamento professionale e culturale e l’utilizzazione del tempo libero; b) conservare e tutelare l’integrità del patrimonio librario antico e di pregio; c) promuovere una migliore conoscenza della storia locale, delle tradizioni, del costume, dell’ambiente attraverso la creazione e la valorizzazione di una Sezione locale.” Nel corso del tempo, le attività svolte dalla biblioteca o in collaborazione con essa (di cui di seguito si parlerà ampiamente), hanno dimostrato la fedeltà a questi principi, che, anzi, sono andati ancor più maturando e dei quali ci si è resi ancor più consapevoli. Nel nuovo regolamento, approvato il 10 dicembre 1998, la biblioteca si definisce “servizio informativo e culturale di base da rendere alla comunità.” E nell’articolo dedicato agli scopi si dice: “La biblioteca svolge funzioni di documentazione, organizzazione ed uso pubblico dell’informazione sul territorio o in ambiti tematici, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, promovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civica e democratica dei cittadini e la consapevole partecipazione alla vita associata. 86 A questo scopo, incrementa e valorizza le proprie raccolte, sulla base di specifiche indagini sulle esigenze dell’utenza (…)” È qui evidente il modo in cui il dibattito sulla promozione della lettura, di cui si è parlato nella prima parte della trattazione, è stato recepito da questa istituzione: la biblioteca di Soriano nel Cimino, nella persona della sua bibliotecaria, condivide l’importanza dell’abitudine alla lettura nella formazione del ragazzo per la sua crescita personale, intellettuale e per una sua partecipazione attiva nella società, tanto da inserire l’obiettivo della diffusione della lettura nel suo regolamento ufficiale, ritenendolo uno tra i principali obblighi da lei perseguiti. Principio e filo conduttore delle scelte fatte dalla biblioteca è quindi questo offrirsi cittadinanza. come Nelle lo strumento dichiarazioni per della l’esercizio effettivo bibliotecaria della Gabriella Evangelistella, la biblioteca è il mezzo attraverso il quale ogni cittadino riesce ad acquisire le informazioni e la documentazione necessarie tanto al soddisfacimento dei più semplici e banali bisogni della vita quotidiana (dal costo di un certo tipo di auto, alle informazioni sulla surgelazione domestica), quanto alla costruzione del proprio ruolo individuale nella comunità a cui appartiene. Anche l’installazione nei locali della biblioteca di postazioni telematiche segue questa linea: questo è il solo luogo 87 pubblico dove l’accesso alle reti è offerto non solo come una disponibilità di computer, ma come momento di integrazione tra le diverse fonti e tipologie informative e, soprattutto, con l’assistenza di specifiche professionalità, esperte nella consulenza all’utente nel processo della ricerca e della documentazione. E’ una struttura al servizio di tutta la comunità: - dei cittadini portatori di esigenze informative di base - di coloro che devono operare sulla comunità locale, come un amministratore chiamato a governarla - di qualsiasi professionista, operatore economico, imprenditore che vi svolge una attività - di quella fascia di utenti che chiede alla biblioteca di essere una finestra aperta sul mondo Parlare della storia della biblioteca di Soriano nel Cimino, per prima cosa, ci porta a parlare della storia della sua sede. La sede di una biblioteca è uno degli elementi che, con maggior, peso influiscono sull’efficacia dei servizi, vuoi per l’impatto esterno e di immagine che una bella biblioteca ha su tutta la collettività, vuoi perché una sede idonea è di per sé l’indicatore della considerazione nella quale viene tenuto il servizio di informazione e lettura da cittadini e amministratori pubblici, e questo 88 vale sia per i servizi inseriti in grosse realtà metropolitane, sia per quelli inseriti in piccoli centri abitativi, come Soriano.2 Inizialmente, la sede della neo-istituzione fu individuata nei locali comunali di Piazza Marconi: si tratta di un locale di circa 60 mq suddiviso in tre vani, con all’entrata un grosso camino che nei primi tempi veniva utilizzato per riscaldare gli ambienti; oggi è sede dell’ufficio anagrafe del comune. Ci si è presto accorti dell’inadeguatezza di questi spazi. Nella premessa al testo curato da Gabriella Evangelistella3 nel 1984 sulla biblioteca, il sindaco di allora, Marcello Giovannini, ammette che “la struttura attuale, in seguito all’incremento del patrimonio librario e all’afflusso sempre maggiore di frequentatori, ha evidenziato tutti i suoi limiti. Di qui l’idea di destinare i locali di Palazzo Catalani, in via Roma, a sede della Biblioteca Comunale, del Museo di Storia Civica e dell’Archivio Storico.” In realtà, nei fatti, l’amministrazione comunale ha dimostrato di non essere, poi, così vicina ai problemi strutturali, e non solo, della sua biblioteca comunale, come invece sembrava far trasparire dalle sue dichiarazioni; e il desiderato trasferimento nella nuova sede non ha potuto avere luogo fino al 1990, nonostante nel 1984 i lavori di ristrutturazione fossero già iniziati e che per essi il Comune aveva già ricevuto quello che il sindaco stesso definiva un 2 Nel rapporto sull’analisi della struttura e dei servizi delle biblioteche di base in Italia, svolta dall’AIB nel 2002, è indicato che laddove viene aperta una nuova sede della biblioteca si verificano nell’arco di pochi anni incrementi molto significativi di utenza e di prestito, addirittura del 50%, testimoniando la tendenza della popolazione di apprezzare ambienti confortevoli e servizi ben organizzati. 3 La biblioteca comunale, a cura di Gabriella Evangelistella, Viterbo, Agnesotti, 1984, p. 5. 89 “cospicuo contributo erogato dalla regione Lazio che ha accolto il progetto.” Il trasferimento ha dato alla biblioteca una nuova dignità e soprattutto gli spazi adeguati per portare avanti con successo tutte le attività di cui da sempre si era fatta carico, tanto che la storia stessa dell’istituzione, nell’idea di chi ci lavora e anche di chi ne usufruisce, è divisa in due: prima e dopo il trasferimento. Il Palazzo Catalani, in via Roma, dove nell’aprile del 1990 è stata trasferita la biblioteca, è stato donato al comune negli anni ’50 dal sorianese Tito Catalani; è costituito da quattro piani (compresi il seminterrato,4 che dal 1991 è sede dell’archivio storico e il piano mansardato), per un’estensione complessiva di 626 mq. Appena trasferiti nei nuovi ampi spazi, che poi sono stati più volte modificati e adattati, via via, alle nuove esigenze, si sono ricavati un’ampia e luminosa sala lettura, una emeroteca, una sala per ragazzi e una saletta per la fruizione di audiovisivi. Il timore che la diversa ubicazione della sede, meno centrale, provocasse una disaffezione alla frequenza della biblioteca, si è rivelato 4 L’area del seminterrato è articolata in cinque vani, di cui quattro destinati all’archivio storico e uno al deposito per la biblioteca. Il trasferimento dei documenti dell’archivio (tranne le pergamene, il libro delle copie, il catasto 1427 e lo statuto membranaceo, conservati in una cassetta metallica entro un armadio posto nell’anticamera attigua alla stanza del Sindaco) nella sede attuale è avvenuto in modo discontinuo e senza adeguata supervisione, cosicché la documentazione è stata accatastata a terra in maniera disordinata e confusa rendendo assai difficoltosa la successiva riordinazione per gruppi omogenei. I lavori di riordinamento si sono svolti in tre fasi e sono stati terminati il 31 agosto 1997. 90 infondato: gli utenti hanno conservato l’abitudine al servizio. Oggi, però, la bibliotecaria parla del prezzo che purtroppo si è dovuto pagare: la piccola biblioteca in piazza Marconi, al centro di una zona allora popolosa e centrale, sembrava un piccolo bazar dove bastava allungare una mano per trovare tutto quello che serviva; i bambini di allora, forse, anche, per l’ubicazione stessa della biblioteca entro le mura, erano più autonomi, venivano da soli, giocavano in strada, oggi, invece, devono essere accompagnati e, per andare in biblioteca, devono organizzare la propria giornata, cadenzata da corsi di nuoto, musica, lezioni private e partite a calcetto, e quella dei propri genitori. La struttura più grande mette più soggezione e rende l’utente meno autonomo; inoltre lei, personalmente, come bibliotecaria, lamenta un contatto col pubblico meno diretto, per il quale ammette di aver sofferto. Tra l’aprile 2002 e il febbraio 2003, la sede della biblioteca ha dovuto subire nuovi disagi. Si è resa necessaria la ristrutturazione di una parte del solaio e parte dell’edificio è stata chiusa al pubblico. La sezione ragazzi, la cui ubicazione coincideva con la parte da ristrutturare, è stata perciò trasferita nel vicino chiostro di S. Agostino. Il trasferimento ha coinciso con due fatti molto importanti per la vita stessa della biblioteca: l’allontanamento della ludoteca comunale e il rientro di un addetto alla distribuzione che, dopo aver lavorato molti anni nell’istituzione bibliotecaria, ne era stato allontanato nel 1999; dopo aver 91 fatto causa all’amministrazione comunale, è potuto rientrare in servizio proprio nell’anno del trasferimento. L’aumento del personale è stato molto importante per il lavoro della biblioteca: nella situazione eccezionale del distaccamento dalla sede della sezione ragazzi, il nuovo addetto alla distribuzione è stato affidato a questa delicata utenza, limitando i disagi, di organizzazione e di gestione, che comunque si sono dovuti affrontare; quando la situazione, nel febbraio del 2003, con molto ritardo rispetto ai tempi che si erano previsti, è tornata alla normalità, la biblioteca ha potuto finalmente sfruttare con maggior profitto il vantaggio di un personale più numeroso (l’indice di dotazione di personale a tempo pieno è di 0,97 ogni duemila abitanti) ed ha potuto aumentare l’orario d’apertura. L’orario d’apertura è un’indicazione primaria del grado di amichevolezza di una biblioteca pubblica; la biblioteca di Soriano ha sempre cercato di ampliare il più possibile la fascia di orario di apertura, così da rendersi accessibile alle diverse esigenze di un utenza differenziata. Dal 2000 ha potuto garantire 32 ore di apertura; ora, nel 2003, la biblioteca è aperta tutte le mattine dal lunedì al sabato e tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, per un totale di 44 ore settimanali, rientrando perfettamente negli standard dell’IFLA, che considera un indice di apertura degno di un buon servizio quello compreso tra le 40 e le 60 ore di apertura5. 5 http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/guide-it.htm (15/10/2003) 92 L’allontanamento della ludoteca è stato, invece, motivo di grande rincrescimento per la bibliotecaria, che aveva duramente lavorato per la sua istituzione e gestione. La sua presenza all’interno della biblioteca favoriva l’avvicinamento di mamme e bambini al mondo del libro: gli spazi e i percorsi erano stati pensati in modo tale che i bambini che si recavano in ludoteca si trovavano a camminare in mezzo a copertine colorate e inciampavano in bacheche tematiche rinnovate periodicamente; anche le mamme, i papà e i nonni si trovavano a dover passare nel “settore d’ingresso” della biblioteca, ricco di servizi di orientamento e offerte di lettura. La presenza di altri servizi, che attirano dentro l’edificio l’utenza infantile, può essere molto utile; presenta qualche vantaggio, anche, il catechismo nella vicina chiesa o la scuola comunale di musica a cinquanta metri dalla biblioteca. Attualmente, l’articolazione funzionale degli spazi e dei percorsi individuati nella biblioteca di Soriano nel Cimino, si ispira al modello della biblioteca a tre livelli, ideato dal tedesco Heinz Emunds alla fine degli anni ’70, “un modello funzionale di riorganizzazione della biblioteca da cui deriva una riorganizzazione degli spazi. L’obiettivo è la soddisfazione dell’utente.”6 6 LAURA RICCHINA, Progettare la multimedialità nella biblioteca a tre livelli: un modello orientato all’utente, in La biblioteca amichevole, a cura di Ornella Foglieni, Milano, Ed. Bibliografica, 2000, p. 272. 93 Il primo livello di servizio consta in un “settore d’ingresso”, che precede, fisicamente e funzionalmente, la sala lettura e il magazzino. È uno spazio non molto grande, ma vi si trovano ubicati tutti i servizi di accoglienza: c’è un bancone unico per il ricevimento del pubblico, per la distribuzione e per il prestito, dove è posizionato anche il registro delle presenze, che i visitatori firmano entrando; sulla sinistra, vicino l’entrata, è disponibile un computer con una stampante, dove è possibile accedere al catalogo o navigare in Internet. In questo piccolo spazio iniziale ci sono espositori di forma e capienza diverse, che danno, già, un assaggio di ciò che possiede la biblioteca: uno è dedicato alle ultime novità editoriali, esposte di piatto per essere più facilmente individuabili da un occhio poco abituato alla disposizione classica dei libri in biblioteca e, ancora non perfettamente consapevole di cosa sta cercando, gli altri contengono libri esposti secondo criteri tematici, che vengono periodicamente modificati a seconda di quelli che si intuisce siano gli interessi del momento, o a seconda di ciò che gli addetti ritengono sia doveroso pubblicizzare, perché non adeguatamente utilizzato. In questa zona iniziale c’è anche uno spazio dedicato ai volantini delle attività culturali promosse dalla biblioteca stessa o fruibili dalla cittadinanza indipendentemente da essa; vi si trovano qui opuscoli informativi sui servizi erogati dalla biblioteca, bibliografie da essa autonomamente redatte sul suo patrimonio bibliografico, gadget della biblioteca come buste informative o colorati 94 segnalibri e altro materiale analogo. Si trova qui anche una macchina del caffè destinata al ristoro dell’utenza. Prima ancora dell’entrata è disposta una piccola scaffalatura, l’angolo del bibliobaratto dove sono inseriti alcuni libri che la biblioteca ha ritenuto di dover scartare, o che, provenienti da donazioni, non sono stati fatti entrare a far parte della raccolta per la presenza in catalogo di opere equivalenti, meglio aggiornate o in miglior stato di conservazione. Gli utenti hanno la possibilità di appropriarsi di questi testi barattandoli con altri o pagando alla biblioteca la simbolica somma di 50 centesimi. Da questo settore d’ingresso è subito facilmente visibile e accessibile l’ufficio del personale e la sezione ragazzi. Quello che, in una targa affissa alla parete è definito ufficio della bibliotecaria, è in realtà una zona di passaggio dove è collocato materiale documentario di diverso supporto (cd audio, videocassette); vi sono tre terminali collegati alla rete e accessibili al pubblico, due stampanti e una macchina fotocopiatrice a colori. Qui si fermano tutti quelli a cui è necessario un aiuto nella ricerca di informazioni bibliografiche, o informazioni generiche, chi vuole soddisfare curiosità o fermarsi a fare due chiacchiere. È qui che è il cuore del vero servizio di reference. Di seguito si entra nelle sale lettura dove la gran parte del materiale librario è esposto a scaffali aperti, proprio come previsto dal modello di Emunds; lo scopo è quello di rendere direttamente accessibile all’utenza, senza la necessaria presenza del bibliotecario, che potrebbe inibire le 95 scelte o gli assaggi di lettura, il posseduto della biblioteca. La collocazione dei libri è disposta secondo le classi Dewey, alle quali è fatta precedere la numerosa sezione della narrativa adulti (N.A.), un angolo destinato alla sezione locale (S.L.) e uno spazio in cui è disposto uno dei due fondi speciali posseduti dalla biblioteca: si tratta del fondo Onofri-Guerrieri, fornito alla biblioteca come donazione in continuazione e ricco di novità editoriali, del quale è fornita in versione sia cartacea che telematica la bibliografia speciale. Nell’idea originale della biblioteca a tre livelli, la collocazione dovrebbe seguire criteri tematici e non per sistemi di classificazione, e dovrebbe unire insieme diverse tipologie di materiale accomunate dall’appartenenza del loro contenuto alla stessa area tematica. Una simile disposizione del patrimonio, pur condivisa dalla bibliotecaria di Soriano nel Cimino, richiederebbe alla biblioteca stessa dei sacrifici e degli sforzi non sostenibili dall’istituzione. In fondo alle sale lettura vi è un angolo dedicato all’emeroteca: è un angolo molto luminoso, circondato per due lati da vetrate, una delle quali dà sul giardino della biblioteca; è arredato con un tavolo rotondo e divani sui quali sedersi per leggere le numerose riviste e quotidiani ai quali la biblioteca è abbonata. Nella vetrata che si affaccia sulla strada è allestita una vetrina delle novità visibile dall’esterno. Anche il giardinetto è attrezzato con tavolini e sedie e utilizzato nei mesi più caldi per leggere o studiare. 96 In tutto questo piano terra i disabili possono muoversi attraverso degli scivoli nelle sale e ad essi è garantito l’accesso al banco prestiti e ai computer; tra il personale stesso della biblioteca c’è un ragazzo disabile che lavora come tirocinante guidato di lavoro in convenzione con la ASL. Al piano superiore è ubicato il materiale librario facente parte della classe 800, la letteratura, e in un’altra sala il secondo dei fondi speciali: il fondo Carleo, ereditato dalla biblioteca come volontà testamentale e corredato, anch’esso di bibliografia. Qui c’è anche uno spazio in cui è possibile leggere ai bambini con l’ausilio di un videoproiettore, e un’ampia sala destinabile a diversi usi (letture sceniche, riunioni, studio). La zona mansardata, utilizzata negli anni passati da Il gruppo giovani, è ora momentaneamente disattivata. In grande considerazione è tenuta la SEZIONE RAGAZZI. Nel dibattito che la vede ubicata in un edificio esterno e indipendente, o in una sezione della biblioteca per gli adulti, o estesa nei diversi angoli tra i documenti che sono destinati ai più grandi, la biblioteca di Soriano prende una posizione definita, optando per la seconda soluzione. “Pensare veramente lo spazio dei bambini in biblioteca è un’idea recente: purtroppo, a un’utenza che costituisce spesso il 40%, a volte anche il 50%, degli utenti delle biblioteche di pubblica lettura, raramente corrispondono superfici, arredi, patrimoni e finanziamenti adeguati. […] Molte nuove strutture bibliotecarie all’estero hanno deciso, invece, di 97 collocare in posizione privilegiata, proprio i servizi ai ragazzi, con l’idea che la loro visibilità sia positiva per la biblioteca nel suo insieme.”7 Questa è la linea seguita nella biblioteca pubblica di Soriano, dove un terzo delle risorse finanziarie sono destinate ad accrescere il patrimonio della sezione ragazzi. Come è già stato visto, la sezione ragazzi è ubicata vicino l’entrata immediatamente visibile e facilmente accessibile. Al suo interno è allestito uno scaffale pedagogico, un settore dedicato a genitori a insegnanti ed educatori con riviste, saggi, cataloghi, documentazione prodotta da altre biblioteche, percorsi bibliografici tematici e altri materiali inerenti la lettura, il libro e la letteratura per ragazzi. La sala è circondata da libri collocati a scaffale aperto seguendo il criterio alfabetico per autore; una segnaletica colorata aiuta a individuare le lettere dell’alfabeto. Ci sono anche delle nicchie e degli scaffali messi in evidenza dove sono posizionati libri suddivisi per collane o per case editrici, elementi discriminanti che i bambini che frequentano la biblioteca di Soriano e partecipano agli incontri scolastici in biblioteca con le loro classi, dimostrano di saper conoscere bene. Si trovano poi sparse nella sala delle ceste e dei contenitori in cui i libri o gli albi colorati sono posizionati periodicamente secondo criteri tematici, o anche mettendo in evidenza l’autore o la collana del mese. 7 ANTONELLA AGNOLI, Biblioteca per ragazzi, Roma, AIB, 1999, p. 21. 98 Una costruzione a castello separa questa parte della sala con un angolo morbido destinato ai bambini da zero a cinque anni dove sono giochi, album colorati, libri gioco e diverse edizioni dedicate ai più piccini. La sala immediatamente attigua a questa, fa ancora parte della sezione ragazzi ed è destinata alla zona divulgazione: qui ci sono le enciclopedie, i vocabolari, i libri di scienze, di storia e di geografia ordinati per classi Dewey. Questa zona si vorrebbe ripensata per aree di interesse, suddivisione sicuramente più vicina all’utenza a cui è destinata e che metterebbe i bambini in condizione di avere accesso ai documenti con più facilità e con il minimo di assistenza da parte dei bibliotecari. L’organizzazione degli spazi di questa sezione ragazzi consente sia la possibilità di svolgere attività individuali (lettura e scelta dei libri, ricerche, uso del computer – è presente un computer, anche se i bambini hanno tranquillamente accesso anche agli altri terminali), sia la possibilità di svolgere attività di gruppo (racconti ad alta voce, lavori con le classi). 99
Scarica