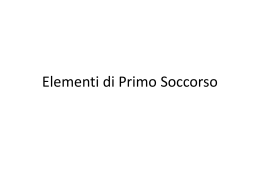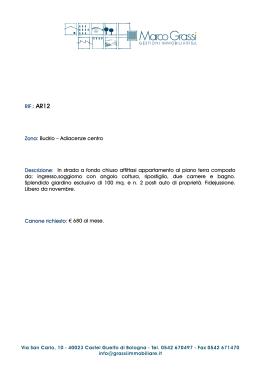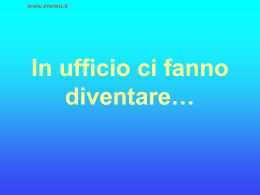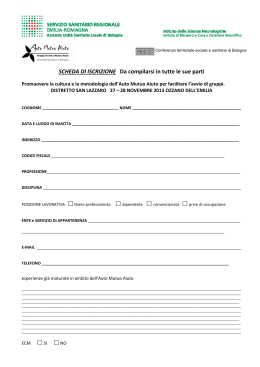Lorenza Servetti Corinna Testi Pescatori e la società budriese Una parola ben più autorevole ed efficace della mia doveva risuonare in questo momento ed inneggiare al lavoro, alla previdenza, al risparmio, al mutuo soccorso, all’istruzione, a questi vincoli che fraternamente riunendovi costituiscono lo scopo della vostra società. [...] Non fu un vano scopo che mi decise a parlarvi, ma il pensiero che non sarebbe tornato sgradito a voi, operaie, la parola di un’operaia, perché tale non deve chiamarsi solo chi incallisce la mano nel quotidiano e aspro lavoro quotidiano, ma ancora chi dà alla società il lavoro della propria mente e del lavoro sente le fatiche e insieme le soddisfazioni. [...]Ricordate che ognuna di voi, per quanto modesto, umile sia l’ufficio che compie nel mondo, può fare e molto per il bene comune. Allora soltanto, impegnandoci, potremo dire di non avere vissuto inutilmente e di avere lasciata qualche parte di noi che non andrà dispersa nel mondo. [...] Incitate dunque, socie operaie, le vostre compagne ad entrare nel nostro sodalizio. Dite loro che la donna non perde nulla della sua femminilità associandosi in nome del lavoro, della previdenza, del mutuo soccorso, dell’istruzione. Ella mostra invece di volere degnamente occupare il posto al quale la moderna società l’ha innalzata per amore di giustizia. Dite loro che nei giorni dolorosi quando il male viene tristemente a visitarvi e con esso entrano i timori angosciosi di un domani forse senza pane perché senza lavoro, la vostra associazione accorre pronta ad allontanarli co’ suoi sussidi, che non sono un’elemosina umiliante, ma il frutto del vostro lavoro stesso, dei modesti vostri risparmi che la cooperazione ha fatto il miracolo di moltiplicare. […] Mostratevi sempre unite e ferme nei propositi. Dalla comunanza e dallo scambio di idee non potranno uscirne che cose vantaggiose per la nostra Società (operaia) e fate sì che essa possa diventare il modello delle presenti e future associazioni femminili, decoro nostro e del nostro paese. Queste “Parole della signorina Corinna Testi”, tratte dal discorso commemorativo dei vent’anni della Società operaia femminile di Budrio a lei affidato il 27 giugno 1897, ben presentano la loro autrice e, insieme, mettono in luce anche aspetti importanti della società budriese in cui ella operava e per il cui miglioramento si prodigò tutta la vita1. Corinna Testi, di famiglia benestante, avrebbe potuto godere individualmente della sua posizione sociale, del “privilegio” dell’istruzione - il padre Guglielmo, veterinario, aveva avuto ampie possibilità di far studiare i suoi figli, lei da maestra, il fratello da medico. Volle invece impegnarsi perché tale privilegio fosse esteso a tutti, diventasse un “diritto”. C’è un filo rosso che attraversa la sua opera: la convinzione che l’istruzione per tutti e la solidarietà, il mutuo soccorso, l’“agire per il bene comune”, siano fondamentali per il benessere e il progresso di una comunità. E che il valore di una comunità si manifesti proprio nella capacità di mettere in atto questi principi. Idee e principi che le derivavano anche dall’ambiente famigliare: la madre Enrica Boari – che fu nel primo consiglio direttivo dell’Asilo infantile, ma soprattutto il padre Guglielmo Testi, mazziniano, repubblicano, fortemente impegnato nella politica budriese, nel momento in cui Budrio, dopo l’attiva partecipazione al Risorgimento, iniziava la sua vita di Comune di Prima classe del nuovo regno unitario. Fu proprio Guglielmo che nel 1863 svolse un ruolo molto importante nel tentativo di “riorganizzazione” della “Società Operaia di Mutuo soccorso e Miglioramento” di Budrio, fra le prime del territorio bolognese, sorta nel settembre 1861 sotto l’impulso di quella di Bologna, di cui era uno dei principali dirigenti il concittadino Quirico Filopanti2. La Società operaia budriese, di cui era stato proclamato presidente onorario Giuseppe Garibaldi e socio onorario Giuseppe Mazzini, nel proprio statuto contemplava come proprio scopo la “reciproca solidarietà, il mutuo soccorso, la promozione dell’istruzione, dell’educazione, del benessere degli operai”. Interclassista, aveva un direttivo composto da mazziniani, garibaldini, democratici del partito d’azione ed era guardata con sospetto dalle autorità prefettizie. Nel 1863 era stata “sospesa” dal prefetto per aver partecipato, a Genova, al “Congresso delle Associazioni democratiche”, da cui era sorta quella “Società emancipatrice italiana” che il governo sciolse per i suoi fini considerati “sovversivi”. Anche la Società budriese venne guardata con sospetto e, per dare il permesso di riaprirla, il prefetto chiedeva l’assicurazione di eliminare “ogni fine politico”, di dedicarsi solo al mutuo soccorso, e, di fatto, la costituzione di una nuova Società. I membri dell’associazione però non vollero rinunciare ai principi fondatori e non accettarono questa delibera, appellandosi al fatto che la società budriese non era stata sciolta, ma solo sospesa. Tra questi scontri mai risolti si arriverà al 1871, quando, pur 1 La Società Operaia Femminile di Mutuo Soccorso di Budrio nel XX Anniversario della sua fondazione. Parole della Signorina CORINNA TESTI e del Dott. ETTORE ZANARDI- Il giorno 27 giugno 1897 Budrio, Budrio, 1897. Opuscolo conservato da un privato, che mi ha gentilmente concesso di consultarlo. 2 Filopanti ne fu presidente nel 1863, 1864,1866 e1868. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bologna era stata fondata il 9 aprile 1860. di far rivivere l’associazione, cedettero e acconsentirono ad una “rifondazione”, riprendendo tuttavia il nome, lo statuto e le finalità della prima società. Intanto nel 1864 era stata fondata da Raffaele Belluzzi, importante figura del mondo politico e culturale bolognese e a Budrio professore della Scuola tecnica da lui creata, la “Società Liberale Budriese”, liberal progressista, che accolse molti membri della sospesa Società Operaia, fra cui Guglielmo Pescatori, che per molti anni ne fu presidente. La presenza a Budrio di un associazionismo così vario - nel 1862 si era aggiunta anche la “Società del Tiro a segno”, garibaldina - ispirato a favorire “il progresso sociale e culturale”, è un segno della vivacità della vita politica locale nei primi anni postunitari: centri propulsori di valide iniziative, le associazioni divennero anche un bacino da cui attingere i nuovi amministratori. Nel 1877 nella Società operaia alla sezione maschile, se ne era aggiunta anche una femminile, rispondendo ad una richiesta avanzata nel corso degli anni Settanta da tutte le Società operaie del Bolognese. Si inizia con 39 socie effettive ed 8 onorarie, numero che non variò molto negli anni, mantenendo una media di 45-50 iscritte (ma nel 1889 ve ne furono 128 e nel 1897, 150). Già l’anno dopo la fondazione, la Società femminile ha una propria bandiera ed una sua rappresentante nel Consiglio Direttivo maschile. Dal 1889 avrà anche un proprio Direttivo, eletto annualmente dall’Assemblea delle socie ed una propria sede. Prospetto del “Movimento dei soci e delle socie” 1878-1879 (Archivio storico Comunale; da: Fedora Servetti Donati, Movimenti e associazioni popolari a Budrio dopo l'Unità) Lo statuto della sezione femminile, basato sui principi fondanti della maschile, si arricchisce di nuovi temi, legati specificatamente alla condizione femminile: Art. 3 La società ha per principio la fratellanza e per fine il Mutuo Soccorso, col miglioramento morale, intellettuale ed economico delle operaie. Quindi essa fornisce alle socie un sussidio in caso di malattia e per il parto e un sussidio mensile dopo i 65 anni di età. Consentendolo i suoi mezzi, favorisce ed aiuta le istituzioni pubbliche educative, come: scuola popolare, conferenze, biblioteca; ne fonda delle proprie, stanzia premi a favore di socie o di figlie di socie per profitto e frequenza nelle scuole. La sezione fu presieduta a lungo da Gismunda Redditi Menarini, personalità di spicco della società budriese del periodo, attivamente impegnata in opere benefiche e nella valorizzazione del ruolo della donna. E’ a lei che si devono importanti iniziative, come, fra le prime dell’associazione, la fondazione di una “Scuola di Ricamo per giovinette”, specializzata in lavori in étamine e in seta: i proventi delle vendite dei ricami servivano per l'acquisto di libri, per gite d’istruzione e aiuti alle socie bisognose. O l’istituzione di una dote annua di £.25 per le socie nubili senza mezzi, alla cui realizzazione la Menarini contribuì con denaro proprio, per non gravare troppo sul bilancio della Società, come fece in più di una occasione, come, fra le altre, per la realizzazione della bandiera. Ultimo decennio dell'Ottocento: esposizione dei lavori della “Scuola di ricamo” (Da: Fedora Servetti Donati, Immagine di un paese nei suoi antichi soprannomi- Budrio 1750-1950) Non è un caso che a commemorare il XX anniversario della Società operaia femminile sia chiamata Corinna Testi, già da tempo impegnata nella Società e dirigente. E insieme a lei Ettore Zanardi, medico, dirigente socialista, attivo nella vita politica e sociale del paese, in prima linea nella lotta per la difesa della salute pubblica, della scuola e dell’istruzione, temi che porterà all’attenzione pubblica anche attraverso un giornale “militante” da lui fondato “Il Lavoratore” Organo socialista(1901-1907). Zanardi sarà poi, agli inizi del 1900, l’ideatore del primo sanatorio “popolare” per malati di tubercolosi. Li lega, oltre ad un’amicizia fraterna, la condivisione di ideali e lo stesso forte senso della comunità. Corinna ha solo 25 anni, ma ha già alle spalle un’esperienza grande di messa in pratica di quell’“operare per il bene comune”, valore fondante della Società operaia. Dal 1892 è direttrice dell’“Asilo Infantile per i figli dei lavoratori”, alla cui fondazione aveva collaborato. Opera importante per la comunità, fortemente voluta dalla prima Giunta socialista, insediatasi nel novembre 1889, con sindaco Silvio Monari, primo sindaco elettivo (fino ad allora il sindaco era di nomina regia) e un consiglio comunale in cui anche la classe operaia era rappresentata: su 25 consiglieri vi erano 8 operai e un colono3. Grande fu l’investimento della giunta sulla scuola, con anche i primi progetti di edilizia scolastica - realizzati poi solo nella seconda esperienza socialista del 19044. Alle spese di gestione dell’Asilo, che forniva anche la refezione a mezzogiorno, partecipano, insieme al Comune, la Partecipanza e la Congregazione di carità, mentre per le spese di impianto i soldi erano già stati raccolti da un “Comitato” presieduto da Gismunda Redditi, il cui marito, l’ingegnere Luigi Menarini sistemò gratis i locali in cui sarebbero stati accolti i bambini. Luigi Menarini e il fratello Enrico, amici di Filopanti, e di Carducci, facevano parte di quella schiera di personaggi budriesi, che avevano partecipato attivamente al processo risorgimentale e alla riorganizzazione postunitaria del comune: membro della Società operaia e più volte presidente della Società liberale, consigliere comunale e presidente a più riprese della Congregazione di carità, aveva anche messo a disposizione della comunità, gratuitamente, le proprie competenze professionali. Nel 1880 aveva attuato gratis i lavori per la trasformazione del Palazzo comunale e nel 1891 segue tutti i lavori per rendere possibile l'avvio dell’asilo. Alla morte, nel 1898, Luigi lasciò tutto il suo patrimonio all’Asilo, compresa la villa in Via Benni, che, secondo la sua volontà, dopo la morte della moglie Gismunda, ne sarebbe diventata la sede definitiva. 3 4 Effetto della legge elettorale del 1882, in cui al requisito del censo per essere elettori fu sostituito quello delle capacità: («saper leggere e scrivere») e dell’ ulteriore allargamento del corpo elettorale nel 1889: a Budrio da 685 iscritti alle liste elettorali amministrative nel 1888 si passa a 1.517 del 1889, dal 4,2% al 9,3% della popolazione complessiva (16.305 abitanti). Ad ottenere ciò contribuì fortemente la Società Operaia con l’istituzione di scuole serali. Archivio storico Budrio, Consiglio Comunale 14-4-1890. E così fu: dal 1914, infatti, un anno dopo il decesso di Gismunda, nella bella villa Menarini adattata al nuovo uso, si trasferì l'Asilo, intitolato alla memoria della piccola Argentina Menarini, figlia dei donatori, e arricchito con nuovi lasciti della stessa Gismunda e della sorella dell’ingegnere, Costanza. L'Asilo cominciò a funzionare nel 1892, sotto la direzione di Corinna Pescatori, che nel testo sopracitato, proprio nel ventesimo della Società operaia ricorda “l’entusiasmo, l’alacrità con cui le socie si adoperarono perché questo stesso luogo, che ogni giorno s’allieta della gioconda spensieratezza di molti dei vostri figlioletti che qui accoglie, sorgesse presto per il bene loro, per la vostra tranquillità”. Villa Menarini in via Benni nel 1897. Al centro del gruppo presso il cancello, Gismunda Redditi Menarini (Archivio fotografico Cocchi; da: Fedora Servetti Donati, Movimenti e associazioni popolari a Budrio dopo l'Unità) Fedora Servetti Donati nel primo studio sulla Pescatori parla di un suo resoconto sul primo anno di funzionamento dell'Asilo, L’Asilo infantile di Budrio. Parole della Direttrice. Saggio annuale, 1893, in cui appariva “quali modernissimi intendimenti pedagogici la guidassero”5. Saggio oggi purtroppo non più rintracciabile. Abbiamo però la testimonianza delle sue moderne concezioni didattiche nell’istituzione di una piccola “Accademia” teatrale per i bambini che, giocando, imparavano a recitare. A questo scopo scrisse l’operetta per parole e musica Gino e Mimì , che nell’ottobre del 1897 i bambini, istruiti dalla Direttrice, rappresentarono nel Teatro Consorziale e, visto il successo, anche in altri teatri in giro per l’Italia. Nel 1901 compose e diede alle stampe anche un’altra “favola in prosa e musica per ragazzi”, Fata Regina, e continuò negli anni a organizzare e seguire le “filodrammatiche” scolastiche. Album con le foto della recita di “Gino e Mimì regalato dai bambini alla loro direttrice (Proprietà privata) 5 Fedora Servetti Donati, Movimenti e associazioni popolari a Budrio, Tamari,1974,pp. L’opuscolo si trovava nell’archivio privato della figlia Graziella. Cartolina postale con la foto di una recita della “filodrammatica” diretta da Corinna. Budrio 1916-1917 (Archvio fotografico Fedora Servetti Donati) L’impegno per l’istruzione - considerata un bene primario per il progresso di una comunità - continuerà negli anni, con la consapevolezza della necessità di agire per renderla accessibile e gratuita anche per chi tradizionalmente ne era escluso, come le donne, in piena condivisione con le idee del pedagogista Antonio Gabelli: “il risorgimento di un popolo comincia dall’educazione della donna”6. Nella sua opera all’interno della Società operaia, Corinna insiste proprio su questo, sul valore dell'istruzione, “che deve aggiungersi al sentimento di fratellanza”, come sottolineava lo statuto della società. Diverse sono le iniziative da lei promosse in questo senso: l’istituzione di premi ai figli delle socie che si distinguono a scuola; le “gite d’istruzione” per le socie stesse, a visitare le seterie di Portomaggiore, ad esempio, ma anche semplicemente a vedere il mare a Rimini, nella convinzione che non è istruzione solo il sapere che si acquista lungo assiduo studio sui libri, ma tutto ciò che, presentandosi nuovo alla nostra mente, accresce il patrimonio delle idee, e scopre innanzi al pensiero un più vasto orizzonte. [...] Migliorare la nostra mente e il nostro cuore, snebbiare la mente dall’ignoranza, se è un diritto che la società riconosce nella donna, è nel tempo stesso un dovere a cui la donna deve ubbidire. 6 A.Gabelli, L’Italia e l’istruzione femminile, in “Nuova antologia”, vol. XV, Roma, 1870. Sempre nell’ottica del contribuire alla diffusione del sapere fra le classi popolari e del mettere in pratica i principi statutari della Società operaia, lavorò alla catalogazione dei libri della Biblioteca Comunale per ripristinare la Biblioteca Circolante, già in funzione nel 1871 sotto il patrocinio della Società. A lei fu affidato il compito di organizzare un’Università Popolare, promuovendo incontri culturali, conferenze, studi, concerti. Oggi, con la dispersione dell’archivio privato della famiglia Pescatori e di gran parte delle carte relative alla Società operaia, non ne è rimasta documentazione scritta7; tuttavia si può supporre con sufficiente certezza che l’Università budriese sorgesse su impulso della Università popolare “G.Garibaldi” di Bologna, istituzione legata alla Società operaia, nata col fine di “diffondere la scienza e la cultura... per la redenzione dall’ignoranza”. Vi si tenevano corsi di storia, arte, geografia, legislazione, fisica, chimica, cicli di conferenze sull’attualità anche con proiezione di diapositive e gite di istruzione8. Pure fuori dall’ambito della Società operaia, fu sempre disponibile a impegnarsi in prima persona in progetti per il bene della collettività, come la grande avventura del Sanatorio popolare di Zanardi: nel 1902 la troviamo segretaria di quel “Comitato di signore e signorine pro sanatorio”, costituito ad hoc, per contribuire alla difficile impresa della raccolta fondi. Il Comitato contribuì con lotterie, mercatini, sottoscrizioni popolari di pochi centesimi che, “anche se le somme raccolte non erano granché - dice Zanardi - avevano l’ottimo effetto di far capire agli operai come il loro contributo benché modesto fosse necessario un’opera di difesa collettiva”. E accompagnò l'impresa del sanatorio fino alla sua realizzazione, organizzando anche, poco prima dell’inaugurazione, una festa nel parco del sanatorio ( Domenica 4 giugno 1905)9. Corinna aveva continuato il suo impegno sociale anche dopo il matrimonio, nel 1898, con Giuseppe Garibaldo Pescatori, figlio di quell’Erminio, seguace e amico di Garibaldi, dapprima repubblicano mazziniano, poi vicino alle posizioni internazionaliste della Comune parigina, che introdusse a Bologna le idee dell’Internazionale dei lavoratori, fondando nel 1871 una nuova società operaia, internazionalista: “Il Fascio Operaio”. Allontanatasi dal paese per seguire in Friuli il marito, professore di lettere classiche che là aveva avuto la cattedra (anche lei ottenne un insegnamento di canto e musica nella Scuola Normale - per maestre - di San Pietro al Natisone), rimasta vedova pochi anni dopo, nel 1907 fece ritorno a Budrio con i due figli, e riprese subito la sua attività nella Società operaia femminile. 7 8 9 Rimane però la documentazione di una fonte orale: i ricordi della figlia Graziella trasmessi a Fedora Servetti Donati. Cfr. L. Arbizzani, Sguardi sull’ultimo secolo, p.104. Bologna nel 1903 diventerà la sede della Federazione nazionale delle Università Popolari. Si veda qui oltre il saggio di Cinzia Venturoli. La festa, come le altre iniziative pro sanatorio del Comitato, viene pubblicizzata sul giornale fondato da Zanardi, “Il Lavoratore” (28 maggio 1905). Sua é la proposta di attivare nei locali della Società un laboratorio di maglieria a macchina, i cui guadagni, uniti alle modeste quote associative, si aggiunsero ai fondi per una pensione, anche se modesta, per le socie anziane. Con tali iniziative mise in pratica le sue modernissime idee sul lavoro femminile, ribadendone l’importanza e affermando la necessità di preparare la donna al suo inserimento lavorativo, per tutelarla. Lei stessa aveva sempre lavorato fuori dalle mura domestiche: cosa non frequente all’epoca. Il tema del lavoro è centrale anche nell’articolato progetto che nel febbraio 1918, con la guerra ancora in corso, presentò al Municipio: Fondiamo scuole elementari di agricoltura e di educazione domestica. Osservazioni e proposte al Municipio di Budrio. “Osservazioni” in cui si dimostra come in una moderna concezione della società, istruzione e preparazione al lavoro debbano procedere di pari passo e debbano essere applicate a un campo troppo a lungo trascurato, quello dell’agricoltura, tanto più importante - nota Corinna - dopo le distruzioni della guerra. Senza soffermarmi sull’analisi interessantissima che la Pescatori fa del momento storico e della ripresa che deve seguire alla guerra, vorrei indicare solo alcuni punti cruciali: le scuole elementari di agricoltura, gratuite, “fondate e mantenute dai Comuni o da Comitati privati col concorso di Enti o Comuni, sussidiate dai Ministri dell’agricoltura e dell’Istruzione” rispondono alla necessità di “formare un nuovo lavoratore dei campi, dalla mentalità più larga e comprensiva, sradicare dannosi pregiudizi, imparare l’uso delle macchine, cambiare l’opinione che il mestiere del contadino valga assai meno degli altri mestieri”. E tanto più importanti saranno per le donne “dei campi”, alla cui cooperazione è dovuta gran parte del lavoro rurale: esse dovranno diventare un mezzo per farle uscire dalla condizione di inferiorità in cui sono tenute, “considerate talvolta poco più di uno strumento da lavoro o poco meno di una bestia da soma.[...] Solo la scuola potrà compiere questa opera di rinnovamento con efficacia e sollecitudine perché la scuola resterà il faro da cui si irradia la luce continua, che vince e fuga l’ignoranza”. Il progetto, pur avendo ottenuto l’approvazione del Ministro per l’agricoltura, non venne messo in opera, forse per mancanza di mezzi. Ma Corinna non si diede per vinta e qualche anno dopo (1922), sempre sotto il patrocinio della Società Operaia femminile budriese, fondò la Scuola Serale di Disegno Applicato alle Arti e ai Mestieri, che funzionò almeno fino al 1927. Anche tale iniziativa si inseriva in quel programma di educazione-istruzione accessibile a tutti che costituisce, come abbiamo visto, il filo rosso dell’opera della Pescatori: gratuita, aperta a tutti, uomini e donne, si svolgeva in ore serali proprio perché rivolta a lavoratori; vi si insegnava, oltre al disegno applicato, anche cultura generale. La presidenza della scuola era stata affidata ad Augusto Majani (Nasìca) e vi tennero lezione validissimi insegnanti bolognesi, artisti affermati dell’entourage di Alfonso Rubbiani, come i professori Aldrovandi e Simoncini, e il budriese Giovanni Venturoli, che aveva già partecipato ai lavori di decorazione del Municipio. Vi insegnava anche la figlia di Corinna, Graziella Pescatori, futura importante pittrice, allora poco più che sedicenne e già appassionata di pittura. La scuola ebbe grande successo, come ci dimostra la lunga lista degli studenti documentati (108) e dovette essere anche di gran giovamento: fra gli alunni ritroviamo molti, allora giovani lavoranti, che diventarono poi fra i più apprezzati artigiani del paese. Forte anche la partecipazione delle donne, di poco inferiore a quella maschile. Il suo carattere innovativo ed i suoi pregevoli risultati ebbero un riconoscimento nazionale alla Mostra nazionale didattica di Firenze del 1925, dove la Scuola venne premiata con una medaglia di bronzo, oggi conservata presso la Biblioteca comunale. I disegni esposti nella mostra che accompagna il convegno, fortunosamente recuperati da un privato e donati con generosità al Comune, sono una piccola parte dell’intero fondo (458 disegni), ma bastano a dimostrare la vivacità culturale di quella che abbiamo chiamato “un’avventura collettiva” e l’importanza di una “educazione al lavoro”. Nel 1925 troviamo la Pescatori impegnata ad organizzare un ginnasio inferiore (Ginnasio Filopanti) privato, gestito dai genitori, dove, per suo espresso interessamento, furono gratuitamente accolti alcuni ragazzi che, pur avendo dimostrato attitudine agli studi, non avrebbero potuto continuarli per le loro condizioni familiari. Gli alunni avrebbero sostenuto l’esame da privatisti al Liceo Galvani di Bologna, dove da tempo Corinna lavorava come segretaria. Alla fine degli anni Trenta, in accordo col Comune, commissionò, completamente a sue spese, un censimento delle opere d’arte esistenti nel Budriese a Heinrich Bodmer, studioso e critico d’arte, noto in Italia e all’estero per le sue pubblicazioni e già direttore dell’Istituto Germanico di Storia dell’Arte in Firenze. Questi, tra il 1938 e il 1940, compì accurati sopralluoghi e studi, ma lo scoppio della guerra e il ritorno, pochi anni dopo, in Svizzera interruppero l’opera. Il Bodmer morì prima che si fosse potuto pubblicare il suo lavoro, che, ancora manoscritta e senza la revisione generale che l'autore avrebbe voluto, fu inviata dalla vedova al Comune di Budrio, nel cui archivio è conservata: fonte preziosissima per gli studi del patrimonio artistico budriese futuri. Ancora dunque Corinna Testi Pescatori si rivela “instancabile animatrice di ogni opera culturale e sociale a Budrio”, come l’aveva definita Fedora Servetti Donati nel primo studio su di lei. E anche questo ultimo atto di amore per il proprio paese risponde a quel senso della comunità che ha caratterizzato tutta la sua opera: un bene comune da difendere e far progredire con impegno individuale e collettivo, condividendo i valori della solidarietà, del lavoro e dell’istruzione per tutti, considerati motori di ogni progresso sociale. UN’AVVENTURA COLLETTIVA Mostra dei lavori degli allievi della “Scuola serale di Disegno applicato alle Arti e Mestieri” di Corinna Testi Pescatori (1922-1927) a cura di Susan Williams e Lorenza Servetti Gli allievi della “Scuola serale di Disegno applicato alle Arti e Mestieri”. Al centro, in prima fila, la fondatrice Corinna Testi Pescatori (Archivio fotografico Montanari-Pazzaglia) Lorenza Servetti Scheda introduttiva I disegni esposti nella mostra fanno parte di un ricco corpus (432 disegni di almeno 108 diversi autori) fortunosamente salvato dalla dispersione e donato, nel 2005, dalla famiglia che li ha ricuperati al Comune di Budrio. Oggi sono conservati nella Biblioteca Comunale “Augusto Majani”. Essi sono il frutto di una delle più significative esperienze realizzate in paese nei primi decenni del ‘900: la “Scuola serale di Disegno applicato alle Arti e Mestieri”, fondata da Corinna Testi Pescatori (1872-1953), instancabile animatrice di ogni opera culturale e sociale a Budrio fra Otto e Novecento. Donna dalle idee avanzate, Corinna considerava l’istruzione un bene primario per tutti e dedicò la sua vita a mettere in atto questo principio. La Scuola serale aveva come scopo appunto quello di offrire un’istruzione professionale e rendere accessibile il sapere anche a chi era avviato al lavoro, comprese le donne, le più escluse dall’istruzione. E per rendere più completa la formazione degli alunni, accanto al disegno applicato vi si insegnava anche cultura generale. Fu una vera “avventura collettiva”, come abbiamo voluto chiamarla, cui parteciparono tra i 1922 e il 1927, gli autori dei disegni: ragazze e ragazzi che la sera, dopo il lavoro, la frequentavano con passione, consapevoli di godere di un privilegio – l’insegnamento gratuito – e di una grande opportunità: imparare ad eseguire disegni precisi e armoniosi per intagli su legno, ricami, circuiti elettrici, mobili, inferriate e cancelli, utili per il loro futuro lavorativo, sotto la guida di validi insegnanti bolognesi, artisti affermati dell’entourage di Alfonso Rubbiani, come Armando Aldrovandi e Luigi Simoncini, il budriese Giovanni Venturoli, ed anche Augusto Majani (Nasica), che ne fu presidente. La scuola fu patrocinata dalla “Società operaia femminile di Mutuo Soccorso” di Budrio, fondata nel 1877, della quale Corinna era da lungo tempo una dirigente e ai cui principi di “reciproca solidarietà, mutuo soccorso e promozione dell’istruzione, dell’educazione e al benessere degli operai”, anche questa iniziativa si ispirò. Nei fogli di molti disegni se ne può vedere il timbro, accanto al “visto” di Luigi Simoncini, che ne fu direttore e maestro. Il successo dell’iniziativa fu grande, come testimonia la lunga lista delle allieve e degli allievi, e notevoli furono i risultati concreti: furono messi in luce abilità e talenti degli studenti, giovani lavoranti che diventarono poi apprezzati artigiani: falegnami, fabbri, meccanici, sarte, ricamatrici, e che mantennero vivo il ricordo della scuola e lagratitudine per quello che era stato loro offerto, come appare dalle testimonianze che abbiamo raccolto. Come quella del figlio di Valter Starni - di cui sono in mostra i disegni di cancelli e inferriate, e che realizzò poi con suo padre la cancellata del cimitero di Budrio - che ricordava sempre con affetto la fondatrice Corinna, presente a tutte le lezioni e che loro studenti in gruppo accompagnavano a casa, fuori Budrio, per non farle fare il tragitto da sola. O quella di una allieva, divenuta provetta ricamatrice di corredi, che quando la guerra le distrusse la casa piangeva disperata non solo per non aver più un tetto, ma per la perdita dei preziosi disegni fatti a scuola, a cui si ispirava per i suoi ricami. Il carattere innovativo della scuola ed i suoi pregevoli risultati ebbero anche un riconoscimento alla “Mostra nazionale didattica” di Firenze del 1925, dove la Scuola venne premiata con una medaglia di bronzo finemente lavorata. Nel poderoso corpus delle opere - che comprende disegni decorativi, i più numerosi, con motivi geometrici o floreali, di chiara influenza liberty; lavori che rappresentano scene di fantasia, animali, nature morte; disegni architettonici, tecnici o raffiguranti elementi di arredamento, fino a progettazioni edilizie - risalta una vivacità e una passione che ci fa pensare ad una scuola seguita con dedizione e con gioia, vissuta come grande opportunità di apprendimento e possibilità di esprimere le proprie capacità. L’esposizione di una parte notevole di questo materiale, organizzato secondo i soggetti raffigurati, in modo da dare il senso complessivo del corpus - al quale si aggiungono alcune opere conservate da privati e gentilmente concesse - vuole essere un contributo offerto ai concittadini per una conoscenza più approfondita del patrimonio storico e culturale di Budrio e, al contempo, un omaggio a Corinna Testi Pescatori, e alle donne e agli uomini che con tanto fervore parteciparono alla sua innovativa iniziativa. La mostra è stata ripresentata a Bologna, da maggio a luglio 2012, presso la galleria Freak Andò di Maurizio Marzadori, nell’elegante allestimento di Raffaele Battaglia e Maurizio Marzadori: ai disegni si è aggiunta l’esposizione di pezzi di artigianato (mobili, inferriate, pizzi e decori) che ne richiamano i motivi e lo stile. Per l’occasione è stato pubblicato anche un opuscolo con i disegni. (Si veda il Pdf “Un'avventura collettiva”) Gli autori dei disegni del Fondo “Corinna Testi Pescatori” COMELLINI Rinaldo ALBERONI Giuseppe ALBERONI Salva ARMAROLI Guerrino BACCA Anna CURTI Angiolino DALL’AGLIO Luigi DE LUCCA Stefano FAVALINI Arvedo FAVALINI Walter BACCA Onorato BALOTTA Domenica BETTINI Ernesto FEDERICI Amilcare BIAVATI Armando FEDERICI Armando BONAGA Adolfo BONDIOLI Francesco BONORA Edgardo BONORA Giulio BONORA Pietro BONORA Rino BORGHINI Laura BORTOLOTTI Assunta FEDERICI Derna GALVANI Antonio GARAVINI Costante GHELLI Lisetta GIULIANI Marcella GORIA Elena GRASSI Romano BOTTAZZI Francesco GNUDI Raffaella BUSI Bianca LODI Giorgio BUTTAZZI Paolina MAGAGNOLI Gualtiero CACCIARI ……… MAGLI Giovanni CANTELLI Giovanni MARANI Francesco CAPRINI Angelo MARCHESINI Ostilio CARPANI Adolfo MARCHESINI Pacifico CASARI Isotta MASETTI Gianna CHIODINI Edmondo MASSARENTI Ada CHIODINI Leone MASSARENTI Nino CODICE’ Albertina MESSEDAGLIA Clara MINARELLI Elio SARTI G. MINGARDI Renato SAVIGNI Evaristo MINGHETTI Mercede SCANABISSI Enotrio MONARI Clara SCANABISSI Salva MONARI Nives SCANABISSI Valentina MONTANARI Alfonsina SGARZI Angelo MONTANARI Giulia SGARZI Francesco MONTANARI Teresa SPISNI Dino MONTANARI Lina STARNI Walter MONTI Angelo TESTI Maria MORARA Ariodante TESTONI Clara (Ormea?) NASCETTI Bruno TRIPPA Angelo NASCETTI Giacomo (Mino) TOMESANI Renato NASCETTI Lina VEROLI Lina OPPI Fidenzio VILLA Amedeo (fu Aldo) ORSONI Enzo VILLA Amedeo (di Domenico) ORSONI Oliviero VILLA Marino PARENTI Aldo ZAGA Loredana PARENTI Luigi ZAGA Maria PATELLI Paolo ZAMBONI Cesare PAVANI Lorenzo ZAMBONI Guido POGGI Lidia ZAMBONI Maria RAMBALDI Adolfo ZANOTTI Giorgio REGGIANI Aldo ZANOTTI Lina RONCHI Gianni ZECCHINI Olga RUBINI Aldo ZUCCHERI Amedeo RUGGERI Renata ZUCCHERI Leonida SAMOGGIA Maria Cinzia Venturoli Un percorso su istruzione e welfare tra XIX e XX secolo. L’esperienza bolognese In queste mie brevi note vorrei provare ad allargare il nostro sguardo in un dialogo fra nazionale e locale che ci permetta di mettere in luce l'importanza dell'attività che coinvolgeva, e coinvolge, la comunità locale sia come associazioni di lavoratori e cittadini, sia come amministrazione; attività che, soprattutto nella nostra regione e nella nostra provincia ha assunto un importante ruolo nello sviluppo del welfare state, dello stato sociale. Partendo dall'Unità d'Italia, dalla fine dell'800, le tappe che dobbiamo brevemente toccare sono il fascismo e gli anni cinquanta. Frutto della necessità di offrire risposta ai gravi problemi sollevati dalla nascita dell'economia di mercato, lo Stato sociale, la lotta alla povertà e all'emarginazione, hanno assunto apetti differenti a seconda dei tempi storici. Gli studiosi sono d’accordo sul fatto che le origini delle moderne politiche sociali, e quindi del Welfare state, vadano rintracciate nella grande intuizione di Bismarck sulle «assicurazioni sociali obbligatorie » e a partire dal 1898 tali forme di protezione sociale sono state introdotte anche nel nostro paese proprio per integrare le classi operaie dell’industria nel sistema politico e istituzionale italiano con interventi mirati verso determinati gruppi sociali. Bisogna però fare un passo indietro e tornare all'indomani della nascita del Regno d'Italia quando il settore della beneficenza pubblica era basato sulle Opere pie e sulle associazioni volontaristiche: era la cosiddetta carità legale, cioè l'azione di tutela dei ceti più deboli svolta dallo Stato a livello locale era demandata alle Province e in ambito comunale alle Congregazioni di carità. La politica del laissez faire caratteristica dell'orientamento dei gruppi dirigenti del nuovo stato italiano fece sì che l'intervento nel campo dell'assistenza e della previdenza fosse realmente molto limitato e l'esperienza mutualistica nacque proprio per fare fronte alle carenze dello Stato nei confronti delle esigenze dei lavoratori e di larghissimi strati della popolazione. Interessante è l’analisi dell’esperienza del mutuo soccorso, ovvero delle associazioni nel mondo del lavoro che è alla base di una cultura e di una pratica sociale fondate sull'idea di solidarietà tra eguali al fine di soddisfare bisogni (assistenza, prevenzione, organizzazione del tempo libero, servizi alla persona, istruzione …) di fronte al consolidarsi della società industriale. Si svilupparono, in Europa e in Italia, forme mutualistiche, di tipo sindacale ed organizzative come le cooperative Case del popolo, che non solo fornivano modi e luoghi di aggregazione e di mutuo soccorso, ma fungevano da pungolo all'amministrazione statale affinché prendesse in considerazione le esigenze dei proletari, dei lavoratori. Pungolo che, seppur lentamente, porterà fino ai governi Giolitti ad una prima strutturazione del sistema previdenziale. Nel 1864 il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicò la prima statistica post-unitaria delle società di mutuo soccorso aggiornata al 31 dicembre 1862 ; da questa indagine si rilevò che le associazioni di mutuo soccorso in Italia erano 443, concentrate in Piemonte, Liguria, Emilia, Lombardia, Toscana e Umbria, con 111.608 soci. Di esse solo il 15% erano nate prima del 1848; il 38% fra il 1848 e il 1860 (di cui il 70% in Piemonte) e il 47% nei soli due anni fra l’unificazione e la redazione dalla statistica. Su queste origini così rapide e tumultuose, e strettamente legate alle vicende politiche risorgimentali, si innestò un processo di sviluppo più graduale, ma estremamente importante per estensione e continuità. Secondo le statistiche pubblicate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, le società di mutuo soccorso delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, il cui territorio oggi grosso modo corrisponde a quello della Regione Emilia Romagna, aumentarono dalle 66 del 1862 alle 520 del 1904. Sono cifre che collocano il territorio delle otto province «emiliane» fra quelli in cui l’associazionismo mutualistico italiano conobbe una maggiore diffusione. Le società operaie potevano, e dovevano, invece assolvere compiti di assistenza essenziale per le classi disagiate e, secondo il giudizio Gioacchino Pepoli, esponete della destra e Sindaco di Bologna negli anni immediatamente successivi al 1861, queste organizzazioni si dedicavano all’assistenza in modo diverso rispetto a quello della carità privata (umiliante per il lavoratore diceva nel 1865), lo facevano stimolando l’operosità dei propri aderenti e, soprattutto, il coinvolgimento delle società operaie era un mezzo per evitava il conflitto sociale 10. Questo era un punto fondamentale visto che le uniche società operaie ritenute legittime erano quelle non politicizzate. «L’operaio soffre: la sua vita è torturata dai bisogni: egli cerca nei disordini sovente il rimedio dei suoi mali, odia invece di amare, cospira invece di lavorare. Sta al Comune, provvido tutore di tutti, di aprire in questa notte oscurissima allo intelletto del popolo uno splendido orizzonte», affermava il Pepoli nel 186711. In quegli anni il Comune, quindi si operava per favorire e sviluppare le società di mutuo soccorso, a patto che si astenessero da qualsiasi tipo di iniziativa politica. La netta prevalenza delle società maschili restò indiscussa lungo l’arco di tempo qui considerato, con un numero assai basso di società femminili e una percentuale di società miste (in cui cioè erano ammesse le donne) che si aggirava attorno ad un quarto del totale. Furono soprattutto donne intellettuali, dell'alta borghesia che crearono strutture di sostegno, assistenza, ed educazione dirette a donne di classi sociali meno agiate. A Bologna era attivo già nel 1890 un comitato per il miglioramento della donna. Nel maggio 1898 le leghe femminili furono considerate sovversive e vennero sciolte12. In seguito vennero fondate la società di mutuo soccorso femminili, laiche o religiose, caratterizzate da finalità di mutuo sostegno: a 10 11 12 Gioacchino Pepoli e le società di mutuo soccorso, Bologna, regia tipografia, 1878, p. 11 (discorso tenuto alla società artigiana di Bologna il 22 gennaio 1865). M. Maragi, Storia della Società operaia di Bologna, Imola, Galeani, 1970, p. 94. R. Ropa, Dall’unità d’Italia alla prima guerra mondiale, in R. Ropa, C. Venturoli, Donne e lavoro una identità difficile, Bologna, Compositori, 2010, p.68. quella bolognese, all'inizio del 1878, erano iscritte 864 lavoratrici e in Emilia l'adesione più alta era per le leghe agricole: 47%. In seguito all'enciclica Rerum novarum, si diffusero fra fine ottocento ed inizio ‘900 le organizzazioni cattoliche. Temi che occupavano le organizzazioni femminili erano, oltre alla mutua assistenza fra le socie, l'istruzione e la creazione, diremo noi, di servizi quali gli asili. Temi questi che trovavano una sensibilità anche nelle amministrazioni comunali tanto che, ad esempio, in Consiglio comunale di Bologna, Ceneri nel 1878 affermava che la beneficenza doveva mutare in assistenza e il municipio non doveva risparmiare su questo tipo di interventi (gratuità dei libri scolastici, aumento dei salari, servizio medico a domicilio) per poi largheggiare per la costruzione del monumento al re13. Molte le iniziative che guardavano verso l'istruzione delle classi sociali allora sistematicamente escluse da quello che donne e uomini legati all'associazionismo ritenevano un bene essenziale. Ad esempio, le Università Popolari che spesso erano allocate, soprattutto nei paesi di provincia, nelle Case del popolo. Questa esperienza iniziò in Italia nei primi anni del Novecento, ad esempio a Bologna l’inaugurazione dell’Università Popolare «Giuseppe Garibaldi» avvenne nel 1901 e, fino l'avvento del fascismo, si sviluppò sul territorio nazionale soprattutto nei luoghi in cui più presenti erano le forze socialiste e democratiche una rete di queste organizzazioni che avevano lo scopo di diffondere l'istruzione e la cultura a livello popolare. Fu l’Emilia-Romagna la regione in cui si mostrò più interessante il movimento delle Università Popolari, anche perché in questa regione si tentò di adeguare la struttura delle Università e dei corsi alle esigenze locali 14. Nel 1912 esistevano in provincia di Bologna 9 succursali di questa organizzazione le Università Popolare di Bologna, secondo il giudizio degli studiosi, furono centri di irraggiamento e di azione molteplice ed unitaria a favore della cultura popolare in tutta la regione, e divennero un elemento così solido della vita democratica cittadina, che solo il fascismo poté porre fine alla loro opera15. In molte altre realtà, invece, le Università andarono in crisi fin dal 1902 e lo stesso Antonio Gramsci nel 1916 esprimeva alcune critiche sulla struttura di queste 13 14 15 A. Preti, F. Tarozzi, L’attività di consigliere comunale, in A. Varni (a cura di), Giuseppe Ceneri l’avvocato, lo studioso, il politico, Bologna, il mulino, 2002, pag. 85 . Ambrosoli, Iniziative di educazione popolare in Italia tra ottocento e novecento, in Il sapere per la società civile: le università popolari nella storia d’Italia, Varese, Università popolare di Varese, 1994, p. 99. M. G. Rosada, Le università popolari in Italia: 1900-1918, Roma, Editori Riuniti, 1975, p. 93. istituzioni che, in molti casi non erano riuscite a catturare l’attenzione delle persone che ne seguivano i corsi, visto che questi erano giudicati, a volte, solo nozionistiche. Nel 1904 si cercò di rilanciare queste organizzazione e venne dapprima fondata la Federazione e poi, nel 190616, l’Unione italiana dell’Educazione popolare che legava, in una sorte di rete educativo-culturale, le Università popolari ad altre istituzioni quali l’Unione magistrale e la Lega delle cooperative. Istruzione e scuola erano uno dei punti caratterizzanti anche il programma della giunta popolare di Bologna nei primi anni del novecento, in questo continuo rimando fra associazionismo e amministrazione. Nel programma della giunta si trovavano temi quali: istruzione laica, refezione comunale, abolizione o trasformazione della Scuola Superiore femminile, sviluppo dell’edilizia scolastica e riordinamento del regolamento riguardante gli insegnanti 17. Della refezione a lungo il Consiglio comunale aveva discusso anche durante la precedente amministrazione Dallolio e, per la maggioranza popolare era «non un atto di carità e di beneficenza, ma come integrazione dell’insegnamento elementare, perché, se si pretende che i bambini poveri vadano a scuola, si deve anche fornir loro il modo di poterne profittare al pari di tutti gli altri» 18. Nonostante le difficoltà e le limitazioni legate al bilancio comunale questo servizio venne istituito e, secondo le relazioni di Giuseppe Sgarzi direttore della Refezione, influì positivamente «sul benessere morale e materiale, sulla disciplina, sull’interessamento allo studio e sulla frequenza alla scuola», dei bambini ammessi ad usufruire di questo servizio19. L’esistente istituto professionale femminile pareva agli amministratori non in grado di soddisfare le nuove richieste e le nuove esigenze di Bologna perché «se è vero (e non è da dubitarsi) che anche l’educazione e l’istruzione della donna debbono informarsi ai sentimenti ed ai bisogni del tempo e del popolo, è innegabile che l’età moderna, richiede eziandio nel campo femminile la massima diffusione dello insegnamento a base professionale» Il nuovo Istituto doveva formare «abili operaie e brave massaie» attraverso laboratori e corsi di durata compresa fra i tre e i quattro anni in cui sarebbero stati insegnati, fra l’altro, sartoria e taglio, cucina, ricamo e merletti nei laboratori, mentre 16 17 18 19 F. Cambi, Le università popolari nella storia dell’educazione (1900-1914). Cultura popolare, educazione scientifica e immagini della scienza, in Il sapere per la società civile: le università popolari nella storia d’Italia, Varese, Università popolare di Varese, 1994, p. 117 e segg. M. D’Ascenzo, La scuola elementare nell’età liberale Il caso Bologna 1859-1911, Bologna, Clueb, 1997, pp. 234-245. ASCBo, Atti del consiglio comunale, tornata del 23 dicembre 1903. Comune di Bologna, Servizio della refezione scolastica, anno 1904-1905, Bologna, regia tipografia, 1905, pp. 18-19. i corsi potevano essere di telegrafia, commerciale e di lingua francese. Per le alunne che avessero deciso di frequentare solo i laboratori erano previste lezioni di italiano, aritmetica, disegno e di storia del Risorgimento. L’attenzione alla storia, a quella contemporanea soprattutto, e al suo insegnamento era un atteggiamento da sempre vivo nelle istituzioni comunali fin dai primi momenti dopo l’Unità indipendentemente dall’appartenenza politica degli amministratori. La trasformazione della Scuola superiore portava con sé l’abolizione del corso elementare a pagamento, preparatorio alla Scuola, abolizione motivata anche dalla convinzione che la scuola dovesse essere una occasione in cui tutte le classi sociali convivessero, si conoscessero, potessero imparare gli uni dagli altri e che quindi il «Comune democratico» dovesse agire per eliminare, anche in questo campo, le differenze di classe20. «Pane e alfabeto» era stato lo slogan elettorale della lista socialista che resse l’amministrazione di Bologna dal 1914; per la realizzazione della sua prima parte, la giunta aveva messo grande impegno, ma anche per quello che riguarda lo sviluppo dell’istruzione, ancora e soprattutto verso le classi sociali più povere, e per il miglioramento delle sedi scolastiche intensa fu l’attività dell’Amministrazione e in particolar modo dell’assessore Mario Longhena. «Promettemmo ai nostri elettori pane ed alfabeto: il pane l’abbiamo dato e vogliamo dare anche l’alfabeto» affermava nel 1918 il sindaco Zanardi rivendicando l’attività della sua amministrazione nei confronti dei bambini ai quali, veniva offerta una completa assistenza scolastica. In primo luogo gli asili che non dovevano essere «case di custodia» come veniva esplicitamente richiesto anche dal Ministro della pubblica istruzione, ma luoghi igienicamente adeguati in cui poter insegnare ai bambini a «amare le cose belle e disimparare a trastullarsi tra il fango e le immondizie», seguendo quindi una concezione pedagogica moderna21. In particolar modo, però, l’Amministrazione cercò di intervenire sull’istruzione elementare, popolare e professionale, giudicate fondamentali per permettere ai giovani della classe operaia di avere una adeguata istruzione. Secondo il giudizio dei socialisti non vi era ancora una scuola adatta alle esigenze di questa parte della popolazione, non vi era cioè ancora nessuna istituzione in grado di «creare l’operaio», di formare operai specializzati. A questo scopo vennero stanziati fondi per i corsi popolari di avviamento, anche se secondo i socialisti erano le scuole professionali e quella industriale in specifico da sviluppare. Anche le scuole serali 20 21 E. Jacchia e A. Nigrisoli, Relazione sul progetto di soppressione della Scuola Tecnica Femminile e di istituzione d’una Scuola Comunale Professionale Femminile di arti e mestieri, Bologna, 1903, p. 8 ASCB, Atti del Consiglio comunale, tornata del 24 febbraio 1918. potevano essere utili in questa complessa organizzazione volta a fornire il maggior numero di strumenti per l’istruzione delle classi meno abbienti, così come le biblioteche popolari che potevano «sottrarre i giovani operai alle osterie», ma la Giunta si lamentava di poter fare molto poco in questo campo, dove pure sarebbe stato necessario intervenire a fondo, vista la ristrettezza dei bilanci. La scuola avrebbe dovuto fornire non solo le prime nozioni culturali ma anche «quell’insieme di cognizioni e di sentimenti, pei quali i giovani potranno, fatti adulti, essere migliori, più forti, più temperati alle future lotte del lavoro»i. Nell’intenzione degli amministratori socialisti si doveva organizzare una scuola che potesse formare operai specializzati, esperti nel proprio lavoro e consapevoli dell’organizzazione delle strutture in cui si trovavano a lavorare, ma anche, e forse soprattutto, operai coscienti della propria condizione e della possibilità e della necessità di rivendicare i propri diritti. Persone che, grazie alla scolarizzazione e «formati col beneficio dell'istruzione da noi loro procurata», avrebbero infine potuto occuparsi di politica ed essere anche eletti al parlamento e nelle istituzioni locali22. Per poter assolvere a questo compito la scuola elementare doveva essere preceduta dagli asili, così come accennato, ed affiancata da altre istituzioni quali patronati, refezioni, dopo scuola, scuole speciali e colonie. Nell’ambito dei bilanci comunali elevate furono sempre le spese previste per l’istruzione, tanto che di sovente dalla minoranza si sollevarono proteste sia per la quantità di questi stanziamenti, sia per la diversa concezione che i consiglieri avevano dell’educazione. Per l’assessore Longhena gli educatori, diventati una necessità a causa della guerra e del conseguente impegno delle donne nei lavori extradomestici, dovevano diventare una istituzione importante per l’educazione popolare, soprattutto per i bambini delle periferie o dei quartieri poveri del centro cittadino, così che anche questi potessero avere la possibilità di essere adeguatamente educati e seguiti, senza dover ricorrere ad opere di beneficenza o a scuole private non in grado di fornire la necessaria qualità dell’attività pedagogica né delle strutture cosa che invece il Comune era in grado di fare23. Il Comune diventava così, anche nel campo dell’istruzione, un soggetto fondamentale ed estremamente attivo e presente, mentre secondo la minoranza il Comune doveva solo essere un elemento di integrazione dell’educazione «privata e paterna» 22 23 ASCB, Atti del Consiglio comunale, tornata del 16 febbraio 1916. G. Balduzzi, La politica per la scuola elementare nella Bologna “Rossa” (1914-1919), in L. Rossi (a cura di), Cultura, istruzione e socialismo nell’età giolittiana, Milano, Franco Angeli, 1991., p. 211. Le donne, ancora escluse dal diritto principale di cittadinanza, ovvero dal voto, usavano le loro associazioni per seguire, incitare spingere le amministrazioni locali a impegnarsi per i temi che ritenevano essenziali, ancora una volta la creazione della previdenza, i miglioramenti sul lavoro, la tutela della maternità e dell'infanzia, l'istruzione e la creazione dei servizi. Un esempio, fra i tanti, di questa volontà del fare, del creare, aggregandosi, i servizi di cui si necessitava per poter migliorare non solo la propria vita, ma anche la vita della comunità è la creazione degli asili delle mondine nella vicina Molinella. Fra la prima guerra mondiale e il 1919, la politica previdenziale dei governi, da Salandra a Nitti, si caratterizza essenzialmente per l'estensione ai lavoratori agricoli dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a completamento di un ciclo avviato nel 1898, e per l'introduzione di altre due assicurazioni obbligatorie che valsero a colmare un ritardo accumulato nei confronti dei Paesi europei, vale a dire l'assicurazione sull'invalidità e vecchiaia per gli operai dell'industria e quella contro la disoccupazione. Durante il fascismo Quando il fascismo va al potere - e prima ancora dell'edificazione della dittatura, negli anni delle politiche liberiste - si è già manifestata l'esigenza di unificare, semplificare e generalizzare i trattamenti previdenziali da cui è sorta la Cassa nazionale infortuni, poi la Cassa nazionale assicurazioni sociali. Su questo terreno vi sono dunque, elementi di continuità che non devono però fare perdere di vista ciò che attiene in maniera specifica alla politica del regime La necessità di mantenere il consenso (o di non acuire il dissenso) dei lavoratori i cui salari erano sensibilmente ridotti negli anni della crisi economica, di utilizzare le risorse degli enti e di attuare politiche sociali volte a premiare gruppi e individui schierati a favore del fascismo portano da un lato, a costruire i “grandi enti”, e , dall’altro, a frammentare le gestioni e i benefici degli enti assicurativi-assistenziali e, in ultima analisi, a un uso distorto dello stesso principio assicurativo. La torsione in senso centralistico e autoritario della politica sociale del fascismo, solo in parte mascherata dal moltiplicarsi degli enti e degli operatori ad essa deputati, è strettamente connessa alla centralità che tale politica viene assumendo nel “nuovo ordinamento”, come stanno a testimoniare la propaganda e l'autorappresentazione del regime. Il fascismo si presentava, all’interno e all’estero, come la più moderna soluzione dei problemi di assistenza e previdenza per gli strati più deboli della popolazione, nella prospettiva di costruire una società armonica in cui tutti sarebbero stati soddisfatti, educati, integrati. Quello che è certo è che, a fronte delle innovazioni legislative e delle concrete realizzazioni, la soddisfazione dei bisogni elementari divenne ardua per gli strati popolari dopo il 1926 e negli anni Trenta. D'altro canto, il fascismo tende a non riconoscere (e neppure ad utilizzare) la categoria dei “poveri”, estranea all'apparato teorico che doveva sostenere la costruzione di una società fascista: una delle parole d'ordine della politica sociale fascista era stato proprio il superamento del “vecchio concetto di carità e di beneficenza”, in nome di un'attività previdenziale e assistenziale improntata alla “solidarietà umana, nazionale e fascista, attività che non umiliano, ma educano le masse lavoratrici al risparmio”24. A fianco dei maggiori istituti costituiti per grandi fasce di lavoratori (enti locali, privati, stato, parastato), videro la luce molti altri nel campo della beneficenza, dell’assistenza e della previdenza. La loro gestione assunse i tratti comuni ad altri ambiti dell’organizzazione fascista: accentramento e doppioni burocratici, autoritarismo, ma anche corruzione e degenerazioni corporativa. Il moltiplicarsi degli istituti, ma anche la loro parcellizzazione, la mancanza di controlli e di regole rispettate fu all'origine di un sistema clientelare i cui esiti si sarebbero protratti ben oltre la fine del fascism. Non va poi dimenticato che, a fianco dei nuovi enti, rimasero attivi quelli tradizionali di beneficenza, legati all'associazionismo caritativo borghese e alle istituzioni ecclesiastiche. In questo settore, lo Stato fascista conservò praticamente immutata l’organizzazione della pubblica carità preesistente. Si affermò allora un’inedita “ideologia dell’assistenza pubblica” fondata sull'inefficienza dell'intervento - un giudizio diffuso tra gli stessi assistiti - compensata dalla sua gratuità, e con un ampio potere discrezionale, anche in materia di ricoveri, nelle mani di primari e podestà. Anche in questo caso, il proliferare delle mutue lasciò ai margini i lavoratori agricoli, a ribadire l’attenzione del regime fascista nei confronti di agrari e affittuari e il pieno rispetto da essi esercitato sul sistema delle relazioni agrarie. Anche se non ne conosciamo l'entità, i poveri, gli indigenti esistevano ed avevano bisogno di assistenza e di beneficenza. Fra gli strumenti di una politica assistenziale, legata anche in questo caso strettamente alla creazione del consenso e alla costruzione del “mito di Mussolini”, va annoverata la segreteria particolare del Duce, a cui gli italiani rivolgevano lettere, suppliche, richieste di vario genere; fra queste, naturalmente, anche domande di aiuti ed elargizioni in denaro. Le richiesta riguardavano, solitamente, le condizioni abitative – e quindi l’accesso alle case popolari - sussidi per famiglie numerose e per disoccupati, premi di fecondità e di 24 Cfr. A. Preti, C. Venturoli, Fascismo e stato sociale in V. Zamagni (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia Dal Medioevo ad oggi, Bologna, il Mulino, 2000. nuzialità. La segreteria particolare disponeva anche di fondi che provenivano da Enti o donazioni private e che venivano erogati in forme assai varie, dalla beneficenza al finanziamento di lavori pubblici. Le elargizioni venivano di solito effettuate attraverso il Partito fascista e le sue organizzazioni periferiche, oppure erano fatte pervenire direttamente a coloro che ne avevano fatto richiesta; anche le istituzioni di beneficenza si rivolgevano a questa struttura per ottenere finanziamenti di vario genere. Le domande erano numerose: ad esempio, nel periodo ottobre 1936- ottobre 1937 giunsero a Mussolini 123.047 istanze di sussidio e 77.578 richieste di lavoro, a dimostrazione del disagio economico del paese e del carisma di Mussolini, dalla cui diretta volontà, nell'immaginario di tanti italiani, discendevano gli aiuti, la beneficenza, le opere pubbliche. Nell’organizzazione dell’assistenza e nella politica sociale fascista, le donne assunsero così un ruolo particolare: da un lato erano investite del ruolo di madri, e poste ai margini, anche per ragioni congiunturali, del mondo del lavoro; dall’altro acquistarono una visibilità pubblica assumendo compiti nell'organizzazione della assistenza. Durante il regime fascista, nei fasci femminili e nelle organizzazioni giovanili del partito, le donne vedevano consacrato un ruolo pubblico che ricalcava quello privato di cura e istruzione; paradigmatico è in questo senso il ruolo di visitatrice. Le Visitatrici fasciste, istituzione creata nel 1930, ispezionavano gli Istituti di cura e si recavano presso le famiglie considerate bisognose per portare aiuti e per controllare al contempo la fedeltà al regime, requisito necessario per ricevere i sussidi. Il modello femminile più propagandato dal regime era quello delle Massaia rurali: donne legate alla campagna, lontane dai vezzi e dai vizi delle città, impegnate ad accudire una famiglia numerosa25. Le donne che portavano sostegni economici a domicilio, le massaie rurali che curavano l’assistenza nelle campagne si facevano quindi carico del doppio ruolo benefico e propagandistico attribuito loro dal regime. Nelle iniziative rivolte all’infanzia, la befana del Duce fu una tipica istituzione del regime, estesa a tutto il territorio nazionale con norme ben definite e con la consueta doppia finalità di beneficenza e propaganda . L’ultima riforma degli enti di assistenza fu quella che portò, nel 1937, alla creazione dell’Eca, Gli esiti furono modesti, visto che le funzioni dell’Eca non si discostavano, in realtà, da quelle della Congregazione di carità: La galassia previdenziale mostrò un intreccio fra gestioni autonome privilegiate, frutto di riconoscimento politico, di pegno di fedeltà al regime, e controllo o uso politico centralizzato degli istituti previdenziali e delle loro risorse. L'ulteriore 25 C. Venturoli, Dal regime fascista agli anni Sessanta, R. Ropa, C, Venturoli, Donne e lavoro, cit., intreccio fra assicurazione sociale (o “previdenza sociale”) e politiche socioassistenziali del regime sta a testimoniare l'insufficienza degli esiti delle prime e l'uso compensativo delle seconde in una duplice accezione: quella propriamente “fascista” (dalla politica demografica a quella della razza) e quella anticiclica. La previdenza non rende dunque superflua l'assistenza, anche se questa cerca di qualificarsi in forme “moderne” e “fasciste” (dalle integrazioni salariali all'assistenza alla maternità e all'infanzia) che producono effetti concreti e costituiscono modelli d'intervento non effimeri. Dopo la guerra Nell’immediato dopoguerra si doveva affrontare l’emergenza, e si doveva pensare, e ripensare, l’amministrazione e la democrazia. Dapprima bisognava fare fronte alle distruzioni, alle precarie condizioni materiali, in altre parole, bisognava assistere chi era rimasto colpito dagli eventi bellici, infatti uno dei primi interventi che videro l’impegno, anche e soprattutto, femminile fu quello rivolto ai reduci: vennero organizzati i rimpatri e l’assistenza agli uomini ricoverati negli ospedali. Un altro versante in un cui si concentrò immediatamente l’attività delle donne fu quello dell’assistenza ai bambini. Le donne, organizzate in associazioni femminili e nei partiti, nonché nei sindacati. Anche in questo caso come primo intervento si tentò di rispondere alle emergenze portando aiuto ai bambini residenti in zone nelle quali la guerra aveva causato disagi ancor più rilevanti rispetto a quello che era successo nella pianura bolognese, ecco quindi l’accoglienza dei bambini del sud (Napoli, Cassino, Frosinone) e di bambini dell’Appennino. Dal 1947, dopo una decisione del Comitato centrale del Pci, si iniziò a preparare l’organizzazione per ospitare i bambini, vi si impegnano donne dell’Udi e dei partiti della sinistra ed anche rappresentanti degli enti amministrativi. Secondo alcuni dati, all’inizio di questa attività 6.000 famiglie si dichiararono disposte a offrire ospitalità a bambini di Napoli e Cassino e alla fine del gennaio 1947 cominciarono ad arrivare i piccoli ospiti. Sempre rivolti all’infanzia vi furono altri momenti di organizzazione, infatti, convinte che non bastasse dare cibo e riparo, le donne cominciarono ad impegnarsi nell’organizzazione delle colonie e degli asili in cui alla cura si cercò di affiancare un progetto educativo. Questo impegno, queste lotte, molto spesso furono difficili ed ebbero prezzi alti per le donne che vi parteciparono. A titolo di esempio si può ricordare come Vittorina Tarozzi, nel 1954, venne arrestata e condannata ad un anno senza condizionale in quanto accusata di aver offeso il prefetto quando, in qualità di consigliere comunale, si era recata in prefettura per chiedere che non vi fossero veti o tagli nel bilancio comunale sui fondi stanziati per le colonie come poteva invece accadere. Le donne dell’Udi chiedevano alla Prefettura, alla Provincia e ai Comuni, di stanziare i fondi necessari (nella misura dei 2/4 la Prefettura e del ¼ rispettivamente il Comune e la Provincia) per assicurare durante i mesi invernali a tutti i bimbi figli di disoccupati e alluvionati ospitati nella nostra provincia: una tazza di latte tutti i giorni; una maglietta di lana per i mesi invernali; la refezione scolastica a tutti i bimbi bisognosi. Chiedevano inoltre alle Prefetture, al Comune, all’Onmi, di costituire mense gratuite per mamme e bimbi bisognosi dai 0 ai 6 anni; al Patronato scolastico, al Comune, alla Prefettura grembiulini, libri e materiale didattico per i bimbi bisognosi26. La preoccupazione che il prefetto, e più precisamente la Giunta provinciale amministrativa, potesse annullare gli stanziamenti, respingendo le delibere del consiglio comunale, era molto presente, visto che non così rari erano le situazione in cui ciò avvenne in tutti i comuni della provincia bolognese. Ad esempio, proprio in seguito alle richiesti dell’Udi il comune di Medicina stanziò nel 1952 «un contributo straordinario alla refezione scolastica di 150.000 £» che fu annullato dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna perché «la spesa facoltativa in parola non è ammissibile date le condizioni deficitarie del bilancio e la posizione del comune agli effetti della sovrimposta». Per i primi momenti del dopo 1945 le donne avevano cercato di lavorare assieme in questo campo dell’assistenza, poi, dal 1948 in poi questo divenne impossibile, a causa della guerra fredda e quindi, pur cercando nelle amministrazioni di collaborare per quanto possibile. Si formarono però due associazioni il Cif, Udi, che in quei primi anni del dopoguerra si impegnarono moltissimo per organizzare una rete di servizi dedicata ai bambini e quindi alle donne. Sola a Bologna l’Udi nel 1947 organizzò 28 colonie che ospitavano 5.200 bambini e 21 doposcuola con 270 bambini. Il Cif nel 1948 organizzò 40 colonie temporanee e 32 diurne ospitando 10.130 bambini. Le donne, per diversi motivi, sono protagoniste e a loro sono affidati i temi dell’assistenza, anche in virtù di vecchi stereotipi. Immediatamente dopo la Liberazione, nel 1946 Anselmo Marabini, esponente del partito comunista, scriveva su «La lotta»: 26 Carta rivendicativa, Udi, Comitato provinciale. gennaio 1952. Chi meglio della donna può concorrere nella buona amministrazione delle Opere Pie, dove ci sono i nostri ammalati, i nostri vecchi, i nostri bambini orfani da assistere con amore? La donna in questa grande opera di assistenza sociale vi metterà senza dubbio l’ardore di madre […]. Innanzi tutto la donna più dell’uomo è dotata di uno squisito senso pratico e umano […] la partecipazione della donna alla vita del paese è anche preziosa per l’elaborazione di leggi democratiche sull’assistenza sociale, sulla protezione della famiglia, sull’organizzazione dei servizi annonari. Anche in questo secondo dopoguerra venivano individuati due campi ritenuti molto importanti: l’acculturazione e la qualificazione professionale da un lato e l’allestimento di servizi in grado di affiancare le donne nei loro compiti dall’altro. Erano, in questo senso, ritenuti di grande importanza i servizi che si rivolgevano ai bambini e all’organizzazione dell’assistenza in generale; venivano, poi, rivendicati anche tutti quegli strumenti che siano volti a sollevare dagli oneri e dagli obblighi del lavoro domestico le donne ad esempio l’istallazione delle lavatrici elettriche pubbliche per sollevare le donne del peso esclusivo delle faccende famigliari. Gli asili nido avrebbero dovuto essere un servizio rivolto a tutte le donne, non solo per quelle che lavorarono; i nidi, cioè, non erano una sorta di luogo in cui lasciare i bambini in assenza della madre, ma un luogo utile alla crescita fisica, psicologica e sociale dei bambini. La soddisfazione di queste esigenze doveva venire dagli enti locali, gli unici in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini in questo campo in cui il decentramento era indispensabile. Nella seconda metà degli anni sessanta i servizi alla prima infanzia diventano una priorità, ricorda Adriana Lodi: Una cosa di cui vado molto orgogliosa è quella di avere condotto una grande battaglia contro l’istituzionalizzazione dei vecchi e dei bambini. Ma una cosa è parlarne nei convegni, ed un'altra è avere la possibilità di fare delle scelte concrete contro l’istituzionalizzazione, e noi le abbiamo fatte. Dicevano: “i primi anni di vita è bene che il bambino stia con la madre”, ma dopo i primi anni di vita, se la madre è rimasta a casa, chi la prende più a lavorare? Quindi, abbiamo cominciato a pensare agli asili nido comunali, ma il riferimento non poteva essere quello dell’Omni. Chiedemmo alla scuola comunale “Elisabetta Sirani” di istituire corsi serali rapidi per dirigenti di comunità ed assistenti d'infanzia, perché l'asilo potesse aprire con un personale adeguato. All'inaugurazione del primo asilo nido nel 1969 presentammo i conti insieme ad una delibera che prevedeva tre mesi di attività per i tre asili nido per cento bambini per una spesa complessiva di diciotto milioni. Ci furono polemiche in giunta: “Come si fa a sostenere dei servizi di questo genere, è molto meglio dare i soldi alle madri perché stiano a casa, altrimenti ci costa troppo”. Fu una grande battaglia politica condotta all’interno, ma se Bologna non avesse messo in piedi allora tutti questi servizi, oggi il livello della città sarebbe ben diverso! Se qui a Bologna c'è il maggior numero di donne che lavorano in tutta Italia, è proprio perché ricevono dei sostegni, degli aiuti attraverso servizi qualificati ed innovativi. Queste sono le cose che dibattevamo allora al nostro interno e che oggi sono nuovamente in discussione. Per esempio, per gli anziani c'era solo un vecchio ricovero. Pino Beltrame, che era stato assessore dall’immediato dopoguerra, aveva progettato una nuova casa di riposo, rivoluzionaria per quell'epoca. Una volta nel vecchio ricovero c’erano i cameroni con trenta quaranta posti letto, mentre lì c’erano camerette da due-tre letti, quindi un modo nuovo di pensare all’assistenza per gli anziani. Ci sono voluti molti anni per passare dal progetto alla realizzazione, poi ad un certo punto, dopo aver preparato questa bella casa di riposo, venduta in seguito al Giovanni XXIII che la gestiva, non abbiamo pensato ad aumentare i posti per le case di riposo, anzi ci siamo opposti ed abbiamo intrapreso un'altra strada., se una persona era vecchia, era senza pensione e viveva da sola, dove finiva? Doveva andare al ricovero. Noi abbiamo deciso di cambiare quest'impostazione offrendo delle alternative. Per gli anziani che non avevano mezzi, molti allora non avevano la pensione, ci siamo inventati il sussidio in luogo di ricovero che invece di supplire le spese dei costi di mantenimento all’interno della struttura sanitaria andavano direttamente all’assistito. Ci siamo detti che era meglio spendere un tot per ogni ricovero, dare cioè i soldi direttamente agli anziani perché potessero restare nella loro casa. In seguito, abbiamo istituito dei centri di assistenza domiciliare. Nel percorso di costruzione di un Welfare efficiente e giudicato indispensabile un filo rosso lega e collega i diversi nodi e si dipana nel secolo scorso acquisendo di volta in volta diverse sfumature, ma rimanendo sempre al centro dell’interesse degli amministratori. L’entrata delle donne sulla scena politica e amministrativa dà a questo percorso una, direi inevitabile, accelerazione.
Scarica