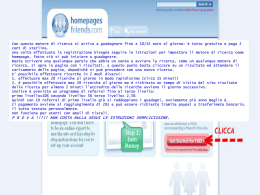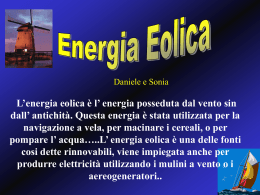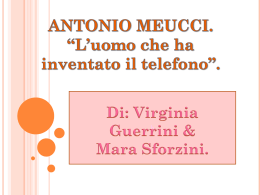Invenzioni e inventori italiani Note a cura del Prof. Leonardo Masotti 1 (El. En. SpA) Illuminazione Alessandro Cruto e la lampadina elettrica a incandescenza Come molte invenzioni, è talvolta limitativo attribuirne il merito ad una sola persona. Spesso l’inventore è giunto al suo risultato attraverso i tentativi, le idee e i successi solo parziali di altri che lo hanno preceduto. Nel caso della lampadina elettrica il merito e la fama (ma non bisogna trascurare le favorevoli condizioni commerciali…) spettano certamente a Edison, ma anch’egli ha conosciuto i suoi precursori, più o meno brillanti, più o meno utili. La lampada elettrica ad incandescenza è nata a poco a poco, in una serie di tentativi e perfezionamenti successivi. Per rendersene conto ripercorriamo brevemente le vicende che portarono alla sua realizzazione. Punto di partenza il noto fenomeno per il quale i corpi solidi portati all’incandescenza diventano luminosi e l’emissione di luce aumenta rapidamente col salire della temperatura. I ricercatori, appena constatarono che il passaggio di una forte corrente elettrica attraverso un sottilissimo filo era capace di portarlo a temperature altissime, pensarono di applicare questo nuovo mezzo all’illuminazione. Fin dall’inizio il platino, il cui punto di fusione supera i 2000°, attirò su di se l’attenzione. Il primo tentativo fu compiuto nel 1843 dall’inglese de Moylens, costruendo una lampadina costituita da una spirale di platino su cui cadeva, grano a grano, della polvere di carbone. Nel 1845 l’americano William Starr sostituì al platino una sottilissima bacchetta di carbone. Ambedue le lampade davano per pochi minuti una luce rossastra e poi si disgregavano. Nel 1852 vediamo apparire un primo perfezionamento importante, per opera del piemontese De Changhy. La desinenza francese del nome, non rara nelle famiglie piemontesi, e la circostanza che le sue esperienze furono compiute in Belgio, diedero ai più l’uso di attribuirgli una nazionalità franco-belga. Egli diede alla lampadina ad incandescenza tutte le caratteristiche moderne e per ritardare la rapida alterazione del filamento incandescente, lo racchiuse in un’ampolla in cui veniva fatto il vuoto. Facendo uso di una stretta spirale di platino, riuscì a ottenere una luce abbagliante e bianchissima della durata di parecchi minuti. Un risultato notevole che adeguati perfezionamenti avrebbero certamente condotto ad una soluzione pratica. Erano però indispensabili i mezzi finanziari necessari a continuare le esperienze. Invano De Changhy si rivolse ad enti e privati; nessuno lo ascoltò. Dopo un paio d’anni di tentativi inutili, ridotto in miseria, dovette rinunciarvi. Seguì un lungo periodo in cui i tentativi furono abbandonati e quasi dimenticati finché, nel 1877, li riprese il russo Lodiguine, ottenendo alcuni miglioramenti e risultati che ebbero larga eco nei giornali tecnici. Queste pubblicazioni attirarono l’attenzione di Edison, già noto per una serie di invenzioni fra cui quella del fonografo, punto di partenza della sua fama mondiale. Edison, partendo da quella preparazione precisa che ha caratterizzato la sua straordinaria carriera di inventore moderno, cominciò con l’assicurarsi i mezzi necessari all’impresa. Erano molte le personalità che riponevano nel suo genio inventivo la più assoluta fiducia: in pochi giorni riuscì a mettere assieme un comitato di ricerche pronto ad assumerne le spese. La sottoscrizione, fissata a 300000 dollari, fu subito coperta: fu creato un apposito laboratorio dove tutti gli sforzi furono concentrati fin dall’inizio alla ricerca di un filamento capace di sottostare a lungo, senza alterarsi, ad altissime temperature. 2 Provati i corpi più diversi, Edison si convinse che nessuno dei filamenti di platino o di carbone, fino allora usati, era capace di fornire i risultati richiesti. Si racconta che sia stato il caso ad instradarlo sulla giusta strada: trovandosi privo di fiammiferi, accese un sigaro con un pezzetto di carta. La sua attenzione fu colpita dal fatto che la carta carbonizzando, pur diventando fragilissima, conservava la sua forma. Ciò lo spinse a bruciare varie qualità di fibre sottoponendole ad altissima pressione: un operazione delicatissima che riuscì solo dopo molteplici tentativi, adottando un filo di cotone. Giorgio Bryan, allora primo assistente di Edison, così ha narrato le circostanze che accompagnarono questa storica esperienza: «Per carbonizzare il piccolo pezzo di filo, curvato a forma di forcina di capelli, esso fu posto in una forma di nickel, portata poi, per cinque ore, in un forno coperto. Rimossa la forma, e fattala raffreddare, fu aperta, e ci accingemmo a togliere il sottilissimo filo carbonizzato e ad immetterlo nel bulbo di vetro. Fu un’impresa di somma delicatezza e pazienza, che costò un’intera notte ed un giorno. Da un intero rocchetto di filo, non riuscimmo ad ottenere che un solo pezzo, il quale si ruppe poi nel trasporto. Ben due volte dovemmo ricominciare l’operazione. Finalmente potemmo ottenere il tanto sospirato filamento ed immetterlo nella lampada. Il bulbo fu vuotato d’aria, la corrente posta in funzione, e la tanto agognata luce splendè ai nostri occhi. Era il 21 ottobre 1879. La lampada continuò a bruciare per quaranta ore consecutive, poi si spense». Se scientificamente il problema era risolto, l’invenzione si presentava ancora imperfetta. Il filamento era troppo fragile: una piccola scossa era sufficiente ad infrangerlo, quindi ricominciarono ricerche affannose. Oltre 10000 fibre furono provate prima di poter trovare, nel bambù, un elemento superiore a tutti gli altri. Contattati esploratori in tutti i paesi del mondo, per trovare la specie più adatta, questa fu finalmente rinvenuta in un bambù gigante tipico dell’isola di Ceylon, capace di fornire un carbone molto denso, elastico, resistente alle scosse. Con questo nuovo materiale, anche se non perfetto, sul finire del 1880, fu iniziata la produzione delle lampadine e nacquero le prime installazioni. Le ricerche del solo filamento avevano comportato l’enorme spesa di oltre 200000 dollari. Eppure, il problema che aveva posto a così dura prova la perseveranza di Edison, aveva già avuto una soluzione pratica ad opera di un modesto italiano. Una soluzione anche piuttosto raffinata e definitiva poiché, scartando le delicate carbonizzazioni di fibre vegetali, aveva portato alla produzione di un filamento artificiale elastico e resistente dello spessore desiderato. Un risultato, questo, al quale l’inventore americano giunse solo nel 1888, cioè ben otto anni dopo. L’inventore è Alessandro Cruto, piemontese nato a Piossasco presso Torino il 18 maggio 1847. Figlio di un capomastro, non seguì un corso regolare di studi; il padre, dopo che il giovinetto ebbe concluso le scuole elementari, si limitò a inviarlo a Torino ad una scuola di architettura. In quel periodo, il giovane Alessandro lesse alcuni libri di fisica e di chimica e vi si appassionò, cominciando a sognare di nuove invenzioni. Tornato al paese natio, pur aiutando il padre, continuò i suoi studi. Dopo aver oscillato fra argomenti vari, si soffermò sulla possibile cristallizzazione del carbonio avente, come fine principale, la produzione artificiale del diamante. Le condizioni familiari non erano però così floride da permettergli d’impiegare denaro in esperimenti. A forza di risparmi riuscì ad acquistare un piccolo compressore di gas ed alcuni altri modesti macchinari. Nel 1874 riscaldando ad alta temperatura l’etilene, gas ricco di carbonio, ottenne del carbonio puro che, se era ancora lontanissimo dall’assumere la forma del diamante, presentava già caratteristiche oltremodo interessanti. Durissimo, con esso si poteva tagliare il vetro. Il procedimento per ottenerlo era molto semplice. In un forno era posto un tubo di ferro all’interno del quale si trovava un tubetto di porcellana, in cui scorreva un flusso di etilene ad alta pressione. Dopo qualche ora il tubo di porcellana si ricopriva di un sottile rivestimento di carbonio che, facile a distaccarsi, si presentava sotto l’aspetto di una lamina lucente perfettamente omogenea. Perfezionando le sue esperienze, Cruto riusciva inoltre ad ottenere gli stessi depositi con gas alla pressione normale, regolandone a volontà lo spessore. Nel 1879 una circostanza fortuita apriva a Cruto una nuova via. In quell’anno Galileo Ferraris teneva a Torino una serie di conferenze di volgarizzazione sui progressi dell’elettricità. Il 24 maggio fu la volta dei tentativi d’illuminazione elettrica. Lo scienziato piemontese, dopo averli passati in rivista e facendo cenno ai 3 risultati ancora incerti ottenuti da Edison, dimostrò come questi si trovasse ostacolato dall’impossibilità di ottenere industrialmente un filamento capace di resistere a lungo ad altissime temperature. Per Cruto queste parole suonarono come una rivelazione. Nelle sue laminette di carbonio non vi era forse la soluzione del problema? Tornato a casa, alcune esperienze preliminari gli assicurarono che non si era sbagliato nelle sue previsioni. Per compiere però un’esperienza definitiva erano necessari mezzi finanziari di cui non disponeva. Si diede da fare per cercarli, ma raccolse solo qualche buona parola e poco denaro. Riuscì ad ottenere dal professore di fisica Naccari di poter compiere le sue ricerche nel laboratorio dell’Università. Dopo appena un mese di tentativi, il 5 maggio 1880, la prima lampada rispondente ai principali requisiti di praticità era funzionante. Ne costruì subito una decina e cominciò per il nostro inventore il duro calvario per trovare chi s’interessasse alla sua invenzione. Non ottenne nulla dai privati e nemmeno dalle sovvenzioni governative. Eppure, a dimostrazione della notevole resistenza delle sue lampadine, basterebbe ricordare che, senza esser mai sostituite, furono impiegate per più di un anno in molteplici esperienze e maneggiate senza tregua e senza riguardi. Tutto questo avveniva mentre ancora Edison era impegnato nella ricerca del materiale idoneo. Inoltre col sistema Cruto tutto era ridotto alla massima semplicità e si producevano in breve tempo centinaia di filamenti. Questi erano ottenuti prendendo dei sottilissimi fili di platino (del diametro di un centesimo di millimetro); dopo averli piegati nella forma voluta, venivano rinchiusi in un recipiente di vetro pieno di etilene. Resi incandescenti dal passaggio di una corrente elettrica, al contatto del platino, l’etilene si scomponeva e deponeva sul filamento una durissima incrostazione di carbonio. Intanto i mesi passavano e nemmeno le sempre più frequenti notizie che giungevano dall’America sui successi di Edison bastavano a scuotere l’indifferenza generale. Dovevano giungere le prime lampadine in Italia per convincere gli scettici che non si trattava di esagerazioni giornalistiche! Tre lampadine arrivarono nel dicembre 1881 su ordine di un ottico torinese di nome Barduzzi. Ricevuta la notizia, Cruto si recò ad esaminarle e così poté convincersi che il suo lavoro non era inferiore. Propose al Barduzzi di fare una prova comparativa che si risolse a suo vantaggio. Ciò convinse quattro delle persone presenti a gettare le basi di una società di sfruttamento del sistema italiano. Tuttavia la società era alquanto modesta: i soci si impegnavano a fare un versamento di 5000 lire subito ed altre 5000 a produzione iniziata. Solo allora si sarebbe sottoscritto il capitale necessario allo sviluppo della nuova industria. Non si può fare a meno di sottolineare la differenza con i 300000 dollari messi a disposizione di Edison per le sole ricerche preliminari! Fig. 1. Prime lampadine elettriche Cruto a filamento artificiale, costruite a Torino nel 1880 4 Nonostante tutto, nel 1882, la piccola fabbrica cominciò a funzionare. Nel 1884 le lampade Cruto conobbero all’Esposizione di Torino un vero trionfo, dimostrandosi superiori a quelle di Edison. Fu allora costituita una società anonima con sede ad Alpignano, di cui per alcuni anni Cruto restò il direttore tecnico. La concorrenza straniera fu però troppo forte: nell’immediato dopoguerra la fabbrica, nata con tante difficoltà, chiuse e il nome di Cruto, creatore di una delle prime lampadine elettriche a filamento artificiale, scomparve dal mercato. Alessandro Cruto era morto a Torino nel 15 dicembre 1908 quasi nell’indifferenza. Arturo Malignani e il vuoto industriale Il nome di Arturo Malignani si lega in parte a quello di Alessandro Cruto e all’avventura della lampadina a incandescenza italiana. Egli fu padre di un ritrovato impiegato per lunghi anni in molte fabbriche sparse in tutto il mondo. Tutto nacque dalla seconda esigenza fondamentale nella fabbricazione della lampadina (la prima era quella del filamento), ovvero quella di poter facilmente ottenere il vuoto nell’ampolla di vetro. All’inizio dell’industria delle lampadine, la soluzione del problema era ottenuta dall’impiego della così detta pompa Sprenghel, apparecchio fino allora usato solo nei laboratori. Il suo principio era basato sull’impiego di un tubo barometrico, lungo circa un metro e del diametro approssimativo di tre millimetri, in cui veniva iniettato uno spruzzo di mercurio che, sminuzzandosi in tante minutissime goccioline, discendeva rapidamente ed aspirava l’aria contenuta nel palloncino. Un sistema decisamente poco pratico che, all’inizio della sua applicazione, necessitava di una pompa per ogni lampadina, con quale ingombro è facile comprendere… L’operazione inoltre richiedeva alcune ore e le esalazioni del mercurio rendevano pericolosissima questa industria per gli operai che vi erano adibiti. Finché l’illuminazione elettrica fu ai suoi inizi e il consumo delle lampadine limitato, questi inconvenienti, pur gravi, furono sopportabili, ma, in seguito, quando la richiesta delle lampadine crebbe vertiginosamente, con il diffondersi del nuovo sistema in tutto il mondo, la produzione del vuoto, affidata a congegni così delicati e lenti si trasformò in vera calamità. Questo stato di cose durò fino al 1895, in cui venne reso noto il sistema Malignani. Nato ad Udine nel 1865, Arturo Malignani iniziò a lavorare nella sua città facendo il fotografo, ma di pari passo si appassionò a svariati problemi di chimica, fisica e meccanica. Per suo merito, Udine fu una delle prime città d’Europa a conoscere l’illuminazione elettrica. A soli 23 anni nel 1888, aiutato da alcuni investitori locali, installò una prima centrale termoelettrica con la relativa distribuzione per l’illuminazione, aggiungendovi un laboratorio per la produzione delle lampadine elettriche necessarie all’azienda. Da allora dedicò tutti i suoi studi al perfezionamento di quest’ultime, specialmente ad ottenerne l’aumento della durata. Si convinse che la lunghissima durata dello svuotamento delle ampolle non fosse tanto dovuta all’eliminazione dell’aria, quanto alla necessità di espellere i gas prodotti durante l’operazione dall’accensione del filamento. Senza l’eliminazione di questi gas, che producevano attorno al filamento un’aureola azzurrognola, il vuoto non tardava a diventare insufficiente, determinando una rapida diminuzione di luce e, dopo breve durata, la rottura del filamento. Malignani, dopo infinite prove, trovò che lanciando nelle ampolle dei vapori di fosforo, questi si combinavano con il gas blu dando luogo ad un precipitato il quale lasciava un vuoto perfetto e permanente. Trovato il modo di perfezionare il vuoto con l’intervento chimico, il geniale friulano pensò pure di creare un tipo di pompa che funzionasse più rapidamente di quella a mercurio e permettesse lo svuotamente contemporaneo di un gran numero di lampadine. Il primo successo lo ottenne con una pompa ad olio, il cui cilindro era lungo ben quattro metri, ed era manovrata da due uomini che camminavano avanti ed indietro. Non era ancora un metodo pratico e, subito 5 dopo, Malignani costruì una pompa azionata meccanicamente composta di diversi grossi cilindri posti in serie di cui il primo faceva il vuoto nel secondo, il secondo nel terzo e così via. Con questo sistema, completato dal metodo chimico, bastava un tavolino largo quanto un’ordinaria scrivania per ottenere una produzione sufficiente (allora) all’impiego in un salone di molte centinaia di metri quadrati. L’abolizione dell’uso del mercurio toglieva ogni pericolo per la salute degli operai. Queste radicali innovazioni funzionarono a Udine per alcuni anni, senza che Malignani pensasse a brevettarle. Avendo creato tutto da sé, senza ricorrere ad insegnamenti altrui, era persuaso che altrove si facesse altrettanto, se non di meglio. Nel 1892 un tecnico tedesco di passaggio casualmente ad Udine gli dimostrò e lo convinse del contrario, spingendolo a brevettare le sue trovate ed a farle conoscere. Il successo fu immediato. All’inventore friulano piovvero richieste da tutte le parti del mondo. Lo stesso Edison mandò a Udine alcuni tecnici per verificare i risultati ottenuti e in seguito alle prove lo chiamò a New York, per stabilire un contratto di cessione dei brevetti. Malignani partì per gli Stati Uniti portando un modello di pompa perfezionato, con cui si poteva produrre il vuoto in meno di un minuto per lampadina. A proposito di questo viaggio si narra un curioso episodio. Sbarcando sul suolo americano la dogana voleva imporre a Malignani un dazio di ingresso di molto superiore al valore della pompa. L’inventore dichiarò che, piuttosto che pagare, avrebbe gettato la pompa in mare costruendone poi un’altra in America. «La butti pure in mare - risposero imperturbabili i doganieri - però purché paghi lo stesso il dazio, giacché questo è mare americano. Se non vuol pagare, la deve portare, scortato da noi, a parecchie miglia dalla costa, fuori dalle acque territoriali». Naturalmente Malignani rise e pagò. Galileo Ferraris e il trasporto dell’energia a distanza «Raccogliere il lavoro di un motore e mandarlo, in varie guise distribuito, a distanza di centinaia e migliaia di metri, senza che la trasmissione assorba tanta parte, da ledere le convenienze economiche: ecco il seducente problema che mi sta innanzi, la complessa soluzione del quale potrà promuovere innovazioni manifatturiere, invertire la relativa ricchezza dei paesi, cambiare la faccia del mondo industriale. I numerosi motori idraulici, possibili sopra ogni corrente, con la trasmissione della forza a distanza, potranno contendere alla macchina a vapore, il prezioso privilegio, di portare lavoro ovunque lo richiegga il facile commercio ed i bisogni della vita». Con queste profetiche parole, era il giugno 1869, uno studente ventiduenne iniziava la sua tesi di laurea, presentata alla Commissione esaminatrice della Scuola di applicazione per gl’ingegneri di Torino. La tesi si concludeva con queste parole ancor più visionarie: «L’energia oggi localizzata domani sarà mobilitata». Essa veniva a toccare uno dei punti più assillanti dell’industria di allora, il cui sviluppo in tutti i paesi del mondo era localizzato e incatenato dalla necessità di svolgersi nell’immediata vicinanza di una sorgente di moto o energia. Il giovanissimo autore, dopo aver esaminato i vari mezzi fino allora utilizzati per trasmettere a distanza l’energia, con molto intuito affermava che solo i progressi delle scoperte elettriche avrebbero potuto risolvere in modo definitivo il problema. La tesi di laurea fu accolta con grande interesse. L’autore era il giovane Galileo Ferraris. Galileo Ferraris nacque il 31 ottobre 1847 a Livorno Vercellese, ora ribattezzata in suo onore Livorno Ferraris, in una semplice famiglia piemontese. Si distinse subito per la sua familiarità con le scienze esatte, con spiccato amore per la fisica. Conquistata la laurea, non volendo abbandonare i suoi studi, preferì alla carriera di libero professionista quella scientifica pura. Nel 1871, grazie anche a una sua importante memoria sull’elettricità, veniva nominato assistente alla cattedra di fisica tecnologica di Torino. Morto nel 1878 il professor Codazza, che ne era titolare, ne prendeva il posto ricevendo allo stesso tempo l’incarico d’insegnare fisica alla Scuola di Guerra. 6 Ferraris, pur proseguendo nei suoi studi preferiti sull’elettricità, si era contemporaneamente occupato di problemi di ottica, pubblicando fra l’altro un trattato sui cannocchiali che, tradotto in varie lingue, aveva fatto conoscere il suo nome anche all’estero. Risultato di questi studi la convinzione della stretta analogia fra i fenomeni ottici e quelli elettrici, convinzione destinata ad avviarlo alla sua grande scoperta. Nel 1881, inviato come delegato italiano a Parigi all’Esposizione mondiale e al Congresso dell’elettricità che, per la prima volta, riuniva i principali elettrotecnici del mondo, di ritorno pubblicava un rapporto che può esser considerato il primo trattato italiano di elettrotecnica. Vi era in particolare esaminata e discussa la possibilità della trasmissione e della distribuzione a distanza dell’energia elettrica. La dinamo e il motore a corrente continua avevano fatto compiere al problema un primo passo, ma non si era ancora capaci di superare le grandi distanze, senza andare incontro a perdite enormi. Il problema era stato infatti prospettato a Parigi sotto un nuovo aspetto, per opera del geniale inventore francese Marcel Deprez. Deprez, noncurante dello scetticismo dei più, aveva proposto, per vincere la resistenza prodotta dalle condutture elettriche, di elevare la tensione della corrente impiegata proponendo dinamo e motori ad alta tensione. Galileo Ferraris, con grande intuito, si era immediatamente schierato, pressoché da solo, a difendere queste nuove idee. Queste ebbero una conferma quasi immediata l’anno dopo: all’Esposizione di Monaco fu effettuata una prima trasmissione di energia a 40 chilometri con una perdita di appena il 48%, cifra enorme oggi, ma miracolosa allora. L’Esposizione internazionale di Torino, la cui parte elettrica fu personalmente curata dal Ferraris, fece compiere un altro passo in avanti. In essa facevano infatti la loro comparsa i primi trasformatori, dovuti al francese Gaulard (in collaborazione con l’inglese Gibbs). Con questi dispositivi che permettevano, secondo il bisogno, d’innalzare o abbassare la tensione elettrica, gli inventori speravano di poter generalizzare i principi enunciati da Deprez. Ma i trasformatori funzionavano solo con correnti alternate: questo appariva come un grave difetto poiché questa forma di corrente aveva, rispetto a quella continua, un numero limitatissimo di applicazioni. Lo scoglio principale era la mancanza di un motore che potesse utilizzarle praticamente. Ferraris concentrò la sua attenzione sul superamento di questo problema che ottenne grazie al campo rotante. In questo modo egli stesso narra della sua invenzione: «Alla sera del 17 agosto 1885, come al solito ero uscito a passeggio. Camminavo fantasticando, e la naturale successione dei miei pensieri mi riportò verso l’analogia dei fenomeni elettromagnetici con quelli ottici, di cui alcuni punti oscuri avevano in quei ultimi mesi eccitato la mia indagine. Ad un tratto un lampo attraversò la mia mente, facendomi balenare una possibilità, che mi abbagliò per le sue conseguenze. Avevo pensato all’origine della luce polarizzata ellitticamente e circolarmente, la quale si basa sopra la combinazione di due semplici movimenti oscillatori. Quale ragione impediva di ottenere lo stesso fenomeno elettromagneticamente, sostituendo alle oscillazioni luminose le variazioni di due campi magnetici debitamente incrociati? In apparenza nessuna. Ciò essendo, da due campi magnetici alternativi, di eguale frequenza, perpendicolari l’uno all’altro e presentanti una differenza di fase, si sarebbe dovuto ottenere nello spazio compreso, un campo magnetico risultante che non si annullasse in alcun momento e la direzione del quale ruotasse, compiendo un giro in ogni periodo dei campi componenti». La scoperta teorica del campo rotante poteva dirsi compiuta: mancava, per completarla, solo la conferma dell’esperienza. Il grande scienziato nell’aspettativa passò una notte quasi insonne e i suoi assistenti furono molto sorpresi al mattino seguente, 18 agosto, di trovarlo già in laboratorio che li aspettava. Fece subito preparare due spirali piatte di filo di rame e le dispose in modo che i loro piani facessero fra di loro un angolo di 90°. Sospese nello spazio da esse racchiuso un cilindretto cavo di rame, con l’asse coincidente con i loro piani mediani. Il sistema era alimentato da un piccolo alternatore Siemens e un trasformatore Gaulard. Quando fu immessa corrente nel circuito primario, dopo un attimo, il cilindretto prese a ruotare e appena Galileo Ferraris invertì una delle correnti il cilindretto, che stava girando in un senso, rallentò la sua rotazione fino a riprenderla in senso inverso. Il primo passo fondamentale verso la trasmissione dell’energia elettrica poteva dirsi concluso. La scoperta venne resa pubblica solo il 18 marzo 1888, in una comunicazione all’Accademia delle Scienze di Torino; comunicazione immediatamente riprodotta dalle principali riviste scientifiche del mondo. 7 Ferraris venne a trovarsi nelle condizioni più favorevoli possibili anche per trarre immensi profitti dalla sua scoperta, ma non volle. A chi affannosamente lo consigliava di prendere, senza perder tempo, i brevetti che gliene garantissero i frutti, rispose: «La scienza ha ideali più alti dell’utile materiale diretto. Prima dell’importanza industriale vi è quella scientifica, prima dell’utile materiale quello intellettuale. Vi sono scoperte che non possono essere proprietà di uno solo, poiché appartengono al progresso dell’umanità». Ebbe, comunque, alti riconoscimenti morali. Delegato nel 1893 dal governo a rappresentare l’Italia al Congresso internazionale degli elettrotecnici di Chicago, fu accolto in modo trionfale. Quando entrò nell’aula delle assemblee, con leggero ritardo, fu riconosciuto da Edison, da Lord Kelvin e da altri massimi scienziati: in un attimo il suo nome volò fra i presenti e l’intera assemblea scattò in piedi prorompendo in un prolungato applauso. Ristabilito il silenzio, Edison pregava Ferraris di venirsi a sedere al banco della presidenza, definendolo: il più grande fra gli elettrotecnici viventi. Rimase modesto nonostante i trionfi d’America: ad un amministratore delegato di una grande società americana, che grazie alla sua scoperta aveva avuto un immenso sviluppo, che gli offriva a titolo di riconoscenza un congruo assegno, rispose: «Faccio il professore, non l’industriale». Accettò solo, come ricordo, un modello di campo rotante che lo stesso amministratore aveva fatto riprodurre in oro. Tornato in patria riprese le sue lezioni. Il 1° febbraio 1897, mentre dettava la sua solita lezione, fu colpito da malore e si narra che, a quanti lo circondavano, abbia detto: «La macchina è guasta». Il 7 dello stesso mese il grande scienziato e inventore si spegneva; quattro mesi prima, il 21 ottobre 1896, era stato chiamato a fare parte del Senato del Regno e ne era rimasto commosso. Il 29 giugno 1854 il conte Camillo di Cavour, presentando alla Camera Piemontese il progetto del traforo del Moncenisio, aveva detto: «Poter trasformare l’acqua che cade in forza portatile, farebbe per il nostro paese quello che hanno fatto le macchine a vapore per l’Inghilterra. Noi abbiamo in cadute d’acqua più forza motrice che ne abbia l’Inghilterra con tutte le macchine a vapore che ha in attività». Il grande statista, con cognizione di causa o meno, non aveva torto. Sarà proprio grazie alla produzione di energia idroelettrica e all’invenzione di Galileo Ferraris che l’industria italiana riuscirà anni dopo a svilupparsi nel nord e a ripartire nel secondo dopoguerra, nonostante la carenza di petrolio e carbone, sostituiti da quello che venne chiamato l’oro bianco (ovvero l’energia fornita dalle dighe). 8 Automobile Il motore a scoppio In uno scritto in data 4 agosto 1678, l’abate francese de Hautefeuille proponeva due sistemi di sollevamento d’acqua per mezzo dell’esplosione di una piccola quantità di polvere da cannone. Nel 1693 una proposta simile era avanzata dal celebre fisico olandese Huygens. Il sistema ha un’importanza storica, poiché da esso il francese Denis Papin trasse nel 1880 l’idea della sua macchina a vapore. Nel 1801 Filippo Lebon, in aggiunta ad un suo brevetto sulla produzione del gas illuminante, faceva cenno al potere esplosivo di una miscela di aria e di gas e prevedeva la possibilità di una sua applicazione alla produzione di forza motrice. Nel 1810 Henry costruì un battipalo in cui la forza esplosiva della polvere era direttamente impiegata per lanciare il maglio. Nel 1823 Samuel Brown tentò di applicare al prosciugamento di un canale una macchina che operava per mezzo del vuoto prodotto da esplosioni e un apparecchio analogo fu proposto nel 1826 da Herskins-Hazard. Seguirono nel 1833 Samuel Welman-Wright e nel 1838 Ador: tutti senza ottenere risultati migliori dei precedenti. Nel 1841 appare un primo nome italiano, quello del nobile milanese Luigi De Cristoforis, segretario del Reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti. Egli presentò un apparecchio, da lui chiamato igneo-pneumatico, costituito da un corpo di tromba in cui, per mezzo dell’esplosione di aria e di vapori di nafta, si produceva una rarefazione sufficiente a sollevare una notevole quantità di acqua. L’inventore riuscì a ripetere l’esplosione ad intervalli regolari. La macchina, oltre ad essere premiata, fu descritta negli Atti del Regio Istituto. Erano però tentativi slegati, senza reale applicazione pratica. Ben diversa ed armonica si presentò l’opera di un altro italiano: Eugenio Barsanti. Eugenio Barsanti, inventore del motore a scoppio, nacque a Pietrasanta (cittadina della Versilia) il 12 ottobre 1821. Compiuti i primi studi nell’Istituto delle Scuole Pie tenute dai Padri Scolopi, a diciassett’anni comunicò ai suoi familiari l’intenzione di seguire la vocazione religiosa; si trasferì così (compiuto il noviziato) nel Collegio di S. Michele a Volterra. La sua straordinaria intelligenza lo fece notare ai suoi superiori: appena ventenne, fu promosso in quell’Istituto professore di filosofia, fisica e matematiche. Il gabinetto di fisica a sua disposizione era ben povero di strumenti, ma il giovane studioso seppe farne buon uso, creando con ingegnosità manuale più di un apparecchio che mancava. Ripetendo la nota esperienza voltiana dell’esplosione che si produce quando in un adeguato miscuglio di ossigeno ed idrogeno si fa scoccare una scintilla elettrica, gli nacque la prima idea dell’utilizzo pratico di questa grande energia così liberata. Costruì un piccolo apparecchio col quale compì numerose esperienze. Trasferitosi nel 1849 a Firenze per occupare il posto di professore di fisica al Collegio S. Giovannino, l’idea nata a Volterra si avviò a forma concreta. Il suo ingegno e la sua modestia gli erano valsi l’amicizia e la simpatia di molti scienziati toscani dell’epoca. Tra questi il fisico e idraulico lucchese Felice Matteucci, che divenne in seguito suo inseparabile collaboratore. Matteucci veniva spesso a trovare il Barsanti, intrattenendosi in lunghe discussioni sopra i temi scientifici più diversi. Al finire di una di queste riunioni, in data che non è possibile precisare ma che presumibilmente si aggira nei primi mesi del 1852, Barsanti confidò all’amico la speranza di realizzare un motore azionato dalle esplosioni di aria mista ad un gas, o impregnata di vapori di un combustibile liquido. 9 Il progetto suscitò l’entusiasmo di Matteucci e lo trovò disponibile alle prove necessarie. Era infatti dotato di una predisposizione non comune ad ideare dispositivi meccanici e si rivelò un ottimo complemento al Barsanti, che aveva già tracciato disegni di massima e pensato a varie possibili soluzioni. Con la nuova collaborazione presero corpo i dettagli indispensabili alla realizzazione pratica. La creazione del motore Barsanti-Matteucci non fu il risultato di successivi dispositivi meccanici, modificati a tentativi durante la costruzione e dopo le prime prove, ma la conseguenza logica di una lunga serie di ricerche preliminari, condotte con rigido spirito scientifico e destinate ad approfondire le conoscenze dei fenomeni che accompagnano e regolano l’esplosione di miscugli gassosi in recipienti chiusi. Al principio del 1853 le ricerche preliminari potevano considerarsi concluse. Gli inventori decisero di stabilire con un documento ufficiale, anche se segreto, la priorità delle loro idee. Il 5 giugno 1853 depositarono presso la fiorentina Accademia dei Georgofili una memoria in plico sigillato, da aprirsi solo a richiesta degli inventori. Il fondamentale documento storico, conservato a Firenze nell’Archivio dell’Osservatorio Ximeniano, fu reso pubblico il 20 settembre 1863 quando Barsanti e Matteucci vollero stabilire la loro assoluta precedenza rispetto a un motore da poco costruito dal belga Lenoir. Sul finire del 1853 era iniziata la costruzione del primo motore, affidando la fusione e la lavorazione delle parti alla Fonderia di ferro di seconda fusione fuori di Porta San Frediano presso il Pignone, stimata fonderia fiorentina di cui era proprietario Pietro Benini, grande amico dei due inventori. Fu terminata sul finire del 1854. Nel frattempo Barsanti e Matteucci erano entrati in contatto con Guglielmo Haehner, console a Livorno di Sassonia e Wurtemberg e capo di un’importante azienda commerciale. Interessatosi vivamente al nuovo motore, propose di associarsi agli inventori offrendo loro il modo di ottenere all’estero, e principalmente in Inghilterra, i brevetti indispensabili ad assicurare i frutti della nuova invenzione. L’entusiasmo dell’Haenher fu però di breve durata: recatosi a Londra, nel marzo 1854, incontrò le prime difficoltà. Gli fu detto che sull’argomento esistevano precedenti brevetti; si trattava in realtà di primordiali motopompe, come quelle proposte nel 1823 da Brown, e non di un motore propriamente detto capace di sostituire la macchina a vapore. Ciò non tolse che Haenher, il quale era un commerciante e non un tecnico, ne restasse impressionato. Gli inventori insistettero e l’Haenher, benché a malincuore, continuò le pratiche. Il 26 giugno 1854, scriveva in una lettera: «Il loro brevetto è pubblicato a Londra come lo prova il Mining Journal che ho ricevuto». L’atto ufficiale di nascita del motore a scoppio era firmato. L’Haenher poco dopo si ritirava dalla Società assumendosi parte delle spese, ammontanti a 121 sterline. I due inventori proseguirono a loro esclusive spese, studiando e modificando le parti meccaniche della prima macchina. Le difficoltà incontrate in Inghilterra e la sfiducia dimostrata da tecnici di gran fama, spinsero Barsanti e Matteucci alla ricerca di migliori soluzioni costruttive, onde fornire ai diffidenti una smentita e togliere qualsiasi appiglio all’assoluta originalità della loro invenzione. Un nuovo e definitivo brevetto inglese fu concesso, senza discussioni, il 12 giugno 1857, al quale seguirono altri brevetti. In Piemonte il 31 dicembre 1857 e 26 luglio 1858, in Belgio il 10 febbraio 1858 e 4 febbraio 1859, in Francia il 9 gennaio 1858. Nel 1857 gl’inventori avevano ormai ottenuto la conferma pratica: il loro motore funzionava! In una memoria stampata a Milano, il cui testo autografo di pugno di Barsanti è conservato all’Osservatorio Ximeniano, si legge: «Al principio del 1856, fu esposta nell’Officina della Ferrovia Maria Antonia, una macchina che agiva con sufficiente regolarità e costanza comunicando il movimento ad una forbice ed a un trapano, e così per la prima volta fu veduta una serie ininterrotta di esplosioni, rese quasi impercettibili all’udito, convertirsi in una forza d’indole affatto opposta e produrre un movimento. Questa macchina bastava ad annunciare che fra non molto la forza del vapore sarebbe sostituita da un’altra forza economica perfetta». Non tardarono a presentarsi persone disposte a mettere a disposizione mezzi economici per trovare e sviluppare applicazioni alla nuova scoperta. Nacque così il 19 ottobre 1860, con l’intervento di alcune personalità fiorentine, la Società Anonima del nuovo motore Barsanti-Matteucci. Nel frattempo erano stati realizzati numerosi perfezionamenti, che figurarono in un motore, costruito dalla ditta Escher e Wys di 10 Zurigo, della potenza di circa 20 cavalli e che venne esposto in funzione alla Prima Esposizione del Regno d’Italia (Firenze, 1861). Malgrado gli inizi incoraggianti non erano mancate le difficoltà. Nel 1860 Louis Figuier scriveva un articolo entusiastico che annunciava come novità straordinaria la realizzazione di un motore a gas, autore un francobelga di nome Jean Joseph Étienne Lenoir. Giunta notizia in Italia, Barsanti e Matteucci protestarono vivacemente, facendo risaltare la loro assoluta priorità poiché, mentre il loro brevetto datava dal 1854, quello di Lenoir era del 1859 e ottenuto solo pochi mesi dopo la descrizione del motore italiano sulla rivista inglese Engineer. Le proteste italiane non trovarono ospitalità in nessun giornale francese e i due inventori riuscirono solo ad ottenere che, a Milano, l’Istituto lombardo di Scienze ne riconoscesse ufficialmente la priorità, premiandola con una modesta medaglia d’argento. In quest’occasione era stato presentato un nuovo motore, della forza di 4-5 cavalli costruito a Milano dall’Elvetica (oggi Breda). Le richieste cominciarono ad arrivare. La maggioranza di esse verteva però su motori di piccola potenza, tre o quattro cavalli al massimo, capaci di impiego nella piccola industria. Per soddisfare la domanda era necessario iniziare la produzione in grande, cosa difficile a realizzare allora in Italia. Allo scopo Barsanti pensò quindi di rivolgersi a costruttori esteri. Fu prescelta la Società Cockerill di Seraing, presso Liegi nel Belgio, anche perché questa si dichiarò disposta (a prove riuscite) alla produzione anche per altri paesi. Tutto sembrava quindi assicurare alla nuova invenzione un roseo avvenire. Invece accadde che Matteucci, recatosi in Francia per rinnovare i brevetti che stavano per scadere, si ammalò gravemente. Ciò costrinse Barsanti, malgrado fosse affetto da incipiente cecità, a recarsi da solo a Liegi. Nelle grandi officine Cockerill ricevette una cordiale accoglienza che si trasformò in sincera ammirazione quando il motore, che aveva portato con se, cominciò a funzionare. Anche questa fu una breve gioia: si ammaalò di lì a pochi giorni di tifo e, il 18 aprile 1864, morì. F Fig. 2. Motore Barsanti e Matteucci – Costruito a Firenze nel 1854 dalle Officine Benini Il giorno del funerale, cosa eccezionale, le officine Cockerill chiusero e capi e operai accompagnarono la salma prima in chiesa e poi alla stazione, da dove partì per Firenze. 11 Scomparso Barsanti e sempre ammalato gravemente Matteucci, gli affari della società fiorentina precipitarono. Fu posta in liquidazione: brevetti, modelli, disegni e motori valutati per un complesso di 270000 lire, dopo due aste andate deserte, trovarono un acquirente per 17600 lire. In pratica i motori finirono nella ferraglia e sul nome di Barsanti cominciò a scendere l’oblio. Sgombrato il terreno da possibili opposizioni, non fu difficile per altri strappare la ribalta. Dopo il belga Lenoir, saltarono fuori i due fortunatissimi tedeschi Otto e Langen che presentarono all’Esposizione Universale di Parigi del 1867 un motore a gas, accolto con immenso successo e premiato con un’onorificenza. Il tecnico Giuseppe Colombo protestò vivamente e venne pure Matteucci, portando con se disegni e brevetti originali. La Presidenza dell’Esposizione dette questa curiosa risposta: «La Francia guarda all’invenzione, non agli inventori». Invece, nel 1878, l’Accademia delle Scienze di Parigi attribuì a Lenoir il Gran Premio Montyon e lo proclamò, ingiustamente, “primo ideatore del motore a scoppio”. Enrico Bernardi e gli inizi dell’automobilismo in Italia Complemento per antonomasia del motore a scoppio (invenzione italiana) è sicuramente l’automobile. Pioniere italiano in questo campo è il veronese Enrico Bernardi, con due date fondamentali: 1880, costruzione di un motore a benzina a rotazione rapida; 1894, realizzazione di una vetturetta automobile che presentava per la prima volta numerosi perfezionamenti, in seguito universalmente adottati. Nello stesso periodo ci sono rapidi sviluppi in tutta Europa. Sul finire del 1863 il belga Jean Joseph Étienne Lenoir (contrapposto in Francia all’italiano Barsanti nell’invenzione del motore a scoppio) costruiva una vettura munita di motore a petrolio, della potenza di un cavallo e mezzo, che girava al regime del tutto insufficiente di 100 giri al minuto. Il veicolo, pesantissimo, compì alcuni brevi percorsi ad una velocità irrisoria. Nel 1877, l’austriaco Siegfried Marcus realizzava un veicolo munito di motore a gas, con risultati di poco dissimili. Per giungere ai primi risultati pratici, bisogna aspettare il tedesco Gottlieb Daimler. Nato a Schòndorf nel Wurtemberg, il 17 marzo 1834, iniziò giovanissimo la sua carriera di geniale meccanico, prima in Inghilterra, poi in patria dove, conosciuti Otto e Langen, divenne direttore della famosa ditta costruttrice di motori a gas. Durante lo svolgimento delle sue mansioni si persuase che nel motore a scoppio ci poteva essere la soluzione di forza ideale per la trazione poiché leggero e trasportabile, a patto che lo si rendesse del tutto indipendente dagli ingombranti generatori di gas. Il 16 settembre 1884 otteneva un brevetto dal titolo: Perfezionamento dei motori a gas ed a olio, completato l’anno dopo con un’aggiunta in cui il carburante usato è unicamente il petrolio o la benzina. Il 15 aprile 1885 provava un suo motorino applicato ad un bicicletta: ottenne la velocità di 15 chilometri all’ora. Il primo passo poteva dirsi compiuto. Il 27 dicembre 1887 seguiva lo storico brevetto: Veicoli mossi da un motore a gas od a petrolio, omnibus sopra rotaie, con un motore ad un cilindro posto nel mezzo del veicolo. L’anno dopo, all’Esposizione di Brema, una piccola linea tranviaria con vetture munite di motore a scoppio aveva pieno successo. La notizia delle esperienze giunse in Francia, dove ancora cercavano invano di risolvere il problema della locomozione stradale alleggerendo e perfezionando la macchina a vapore, e vi suscitò vivo interesse, non privo però di incredulità. Prima a intuirne tutta l’importanza fu la signora Sarazin, proprietaria di una officinetta ereditata alla morte del marito. Con lungimiranza acquistò i brevetti Daimler, associandosi a Emile Levassor ed a Panhard, e diede vita alla casa omonima (Panhard et Levassor), famosa nei primi fasti dell’automobilismo. La prima vettura automobile francese giungeva sulle strade nel 1891. 12 Per completezza va ricordato che un altro tedesco insidia Daimler per l’invenzione del motore per automobile. Questi è Karl Benz di Mannheim, che ottenne nel marzo 1884 un brevetto per un motore a scoppio a due tempi e, nel 1886, costruì un triciclo a ruote motrici posteriori, unite da un differenziale. La prima corsa automobilistica ebbe luogo a Parigi il 21 giugno 1894: vinse una macchina a vapore! L’anno dopo vi fu la rivincita del motore a scoppio sulla Parigi-Bordeaux, 1200 chilometri compiuti alla media oraria di 25 chilometri: un risultato che parve quasi miracoloso! Ritorniamo ad Enrico Bernardi: nacque a Verona nel 29 maggio 1841 e fin da ragazzetto mostrò una grande predilezione per la meccanica. A quindici anni costruiva un modellino di locomotiva, con inversione di moto, e all’Esposizione industriale di Verona del 1856 fu premiato con una menzione, per la sua gioia. Compiuti gli studi a Padova, nel 1863 si laureava ottenendo subito dopo il posto di assistente alle cattedre di idrometria, geodesia e fisica sperimentale. Lo stipendio era piuttosto misero e fu così che accettò ben volentieri, nel 1867, la nomina a professore di fisica all’Istituto tecnico di Vicenza. Vi restò fino al 1879. In quel periodo incominciò a interessarsi ai motori a gas che, da poco, avevano fatto la loro comparsa. Lo prova una memoria presentata nel 1876 all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dal titolo: Studi sopra i motori a gas. La convenienza di usare un carburante liquido, che abolisse ingombranti gazometri, gli venne alla mente. Prescelse la benzina e in ciò fu il primo. Dopo molti tentativi, nel 1880, costruiva con le sue mani un motorino. La data del 1880 è di grande importanza poiché i primi perfezionamenti di Daimler sono del 1882, cioè di due anni dopo, e il relativo brevetto è del 1884. All’inizio del 1883 aveva già presentato all’Istituto Veneto una memoria: Sopra un nuovo motore specialmente applicabile alle macchine da cucire. Motorino che funzionò in pubblico all’Esposizione di Torino del 1884. Lo stesso anno adattava uno di questi motorini, della potenza di 1/8 di cavallo, a una bicicletta destinata al figlio Lauro. Forse lo si può definire solo un giocattolo, ma il motore era comunque completo in tutte le sue parti e la prima bicicletta a motore di Daimler data 1885, cioè un anno dopo. Bernardi, in questo primo periodo, non si preoccupò di proteggere con brevetti le sue invenzioni. Questa noncuranza è tipica di molti inventori italiani (e non solo) e si deve attribuire alle condizioni sociali ed economiche in cui molti di loro si venivano a trovare. Per fare un paragone, il tedesco Daimler era un industriale installato sulle più solide basi e agguerrito da una profonda preparazione tecnica sull’argomento che aveva maturato alla direzione delle grandi officine Otto e Langen. In Germania, come in Inghilterra e in Francia, si poteva contare su di una società già avviata verso la produzione industriale di massa, dove quindi la ricerca del profitto e l’investimento di capitali avevano raggiunto una prima completa maturazione. Al contrario l’italiano Bernardi si poteva considerare un isolato che viveva in un ambiente di provincia decisamente a vocazione contadina o al massimo artigianale, quindi costretto a fare affidamento unicamente sulle sue forze. Erano ancora troppo rari, isolati e di dimensioni limitate gli insediamenti industriali in Italia: di conseguenza anche la crescita e lo scambio tecnologico ne venivano ostacolati. Non deve quindi stupire che poche geniali menti abbiano magari proposto invenzioni o scoperte degne di ammirazione, ma che a queste non sia seguita applicazione pratica o diffusione di massa. Enrico Bernardi può forse rappresentare uno di questi esempi perché, per quanto geniale, non si può fare a meno di riconoscere al Daimler l’immenso merito pratico poiché, dalla prima motocicletta del 1885, passiamo nel 1889 al veicolo meccanico a quattro ruote. Il Bernardi, nominato nel 1879 professore dell’Università di Padova, continuò le sue ricerche. Nel 1894 veniva costituita a Padova la Società Miari Giusti & C. per la costruzione di vetture Bernardi di cui l’inventore aveva studiato un primo tipo, prendendo questa volta i relativi brevetti. Vediamo quali elementi presentasse questa vettura. Le caratteristica più degna di nota era il motore a valvole in testa comandate: ricordiamo che queste entrarono in uso solo nelle macchine da corsa nel 1903 e in quelle da turismo nel dopoguerra. Inoltre carburatore a galleggiante, regolatore per l’immissione automatica e polverizzatore elicoidale, filtro di benzina e di aria (dispositivi in seguito universalmente adottati). Oliatore automatico per tutte le parti in movimento, silenziatore allo scappamento. Accensione a rete o a spugna di platino. Refrigerazione a circolazione d’acqua. La vettura possedeva tre cambi di velocità, oltre la retromarcia. Due freni, uno a pedale, l’altro a mano. La velocità massima era di 35 chilometri all’ora. 13 In una parola l’insieme non solo rivaleggiava, ma superava, specialmente nei dettagli, quanto di meglio fosse mai stato realizzato. Purtroppo l’ambiente ristretto, l’indifferenza di pubblico e il disaccordo fra i soci della prima società (costituita più da sportivi che da industriali, quindi mancanti di senso commerciale) furono le cause del mediocre ritorno di vendita. Le cose non migliorarono quando la primitiva società si trasformò, con l’aggiunta di altri elementi, in Società Bernardi. Dopo alcuni anni di vita, sempre più stentata, fu posta in liquidazione. Pochi mesi prima, l’11 luglio 1899, a Torino in casa del conte Bricherasio era stata decisa la creazione di una società anonima nazionale per la fabbricazione di autoveicoli. Cesare Gatti-Goria ne aveva trovato la sigla che poi diventerà famosa: FIAT. Ne seguirono altre subito celebri in tutto il mondo, come la Lancia, soprattutto grazie ai loro successi sportivi che avevano grande eco. Oltre alla velocità si migliorò anche l’affidabilità, anche qui rimarcata da imprese di grande impatto mediatico, come il famoso raid compiuto nel 1907 dal Principe Scipione Borghese da Pechino a Parigi. Dopo la parentesi della grande guerra (in cui tra l’altro fecero la loro comparsa le prime armi autotrasportate), l’automobilismo fa la sua irruzione definitiva nelle società industrializzate. Nascono le leggende di piloti come Sivocci, Bordino, Ascari, Campari, Brilli-Peri e Nuvolari, i quali diventano i nuovi eroi dell’era moderna celebrati non solo dai giornali, ma anche da artisti, scrittori e poeti. Tornando un attimo ad Enrico Bernardi, che fu il capostipite italiano, questi morì a Torino il 12 febbraio 1919. Fig. 3. Motore a benzina costruito nel 1880 da Enrico Bernardi Antonio Pacinotti: la dinamo e il motore a corrente continua L’invenzione della pila aprì la via alla più duttile tra le forme dell’energia. Gli effetti fisici e chimici di essa si dimostrarono fin dall’inizio così importanti da far in sperare innumerevoli e immediate applicazioni. In pratica però queste speranze urtarono contro l’ostacolo di un generatore ingombrante, costoso e non abbastanza potente per renderne adatto l’uso industriale. Le limitazioni scomparvero solo a partire dal giorno in cui la scoperta dei reciproci rapporti fra magnetismo ed elettricità fornì il mezzo per trasformare la forza meccanica in elettricità e viceversa. 14 Il merito di aver tracciato la strada è universalmente attribuito a Oersted. Il 15 febbraio 1820, durante una sua lezione all’Università di Copenaghen, mentre dimostrava ai suoi allievi i fenomeni calorifici prodotti da una corrente elettrica, Oersted vide l’ago calamitato di una bussola posta sul tavolo oscillare ad ogni passaggio di corrente. Sorpreso dall’inaspettato fenomeno, ripetè l’esperienza nel suo laboratorio verificando che ogni qualvolta un ago calamitato, mobile su di un leggero perno, era avvicinato ad un conduttore percorso da corrente, esso deviava tanto più ampiamente quanto questa era più intensa. La scoperta, appena conosciuta, ebbe un’eco enorme fra gli scienziati di tutti i paesi. Solo otto giorni dopo, il francese Ampère formulava la sua celebre legge, cardine dei rapporti che esistono fra i fenomeni elettrici e magnetici. In questo, come in molti altri casi, vi sono stati dei precursori che, magari, non compresero appieno le potenzialità e la portata delle loro invenzioni o scoperte. È l’esempio di Giandomenico Romagnosi (nacque a Salsomaggiore presso Parma l’11 dicembre 1761, morì a Milano l’8 giugno 1835) che, strano a dirsi non era un fisico, ma un filosofo e giureconsulto. Giunto a Trento nel 1801, in qualità di segretario del Consiglio generale della città, aveva installato in casa un piccolo laboratorio, facendo numerose esperienze a cui spesso assistevano amici e conoscenti. Il Giornale di Trento, l’8 agosto 1802, pubblicava questa interessante notizia: «Il consigliere Giandomenico Romagnosi, abitante in questa città, ben noto alla repubblica delle lettere, si affretta a comunicare ai fisici di Europa un esperimento relativo al fluido elettrico applicato al magnetismo». Dopo aver dato una descrizione della disposizione usata, il giornale aggiungeva: «Prese un ago calamitato, fatto a modo di una bussola nautica, incastrato in mezzo ad un pezzo di legno quadrato, e levatone il vetro che lo copriva lo pose sopra un isolatore di vetro, in vicinanza della pila. Dato di piglio alla catena d’argento (che comunicava con essa) ne avvicinò l’estremità all’ago magnetico e così lo fece divergere di alcuni gradi dalla sua direzione polare...». Vi si possono effettivamente leggere parecchie similitudini con l’esperimento di Oersted anche se bisogna aggiungere che Romagnosi, probabilmente, non comprese appieno le implicazioni del suo esperimento. Nel 1802 il piemontese conte Carlo Marozzo riusciva a magnetizzare, per mezzo del passaggio della corrente elettrica, alcuni aghi di acciaio, precorrendo così il francese François Dominique Arago nell’invenzione dell’elettrocalamita (avvenuta nel 1820). L’abate Francesco Zantedeschi, professore dell’Università di Pavia, in una memoria pubblicata il 27 marzo 1829 prospettava con grande chiarezza la possibilità dell’impiego di campi magnetici per la produzione di correnti elettriche. Precedeva quindi di oltre due anni la famosa memoria del fisico inglese Faraday sulle correnti indotte, destinata a fissare le possibilità di trasformare il magnetismo in elettricità. Egli dimostrò infatti che, avvicinando o allontanando un circuito percorso da una corrente elettrica a un altro privo di essa, si forma in quest’ultimo una corrente, oppure, interrompendo a tratti la corrente nel primo, ad ogni apertura e chiusura di corrente si genera sempre nel secondo circuito una corrente indotta: e, finalmente, avvicinando o allontanando il polo di una calamita a un circuito chiuso, oppure tenendo ferma la calamita e spostando il circuito si ottiene lo stesso risultato. In altre parole, col dispendio di movimento (energia meccanica) si può ottenere una sorgente di elettricità identica a quella fornita dalla pila. Numerosi inventori si sforzarono di creare un così promettente tipo di generatore: di questi apparecchi furono costruiti centinaia di modelli, ma ben pochi uscirono dall’ambito dei laboratori, poiché richiedevano un eccessivo consumo di energia e producevano quasi esclusivamente correnti alternate, allora industrialmente inutilizzabili. Il problema fu risolto da Antonio Pacinotti. Antonio Pacinotti nacque a Pisa il 17 giugno 1841. Suo padre Luigi era professore di fisica tecnologica nell’Ateneo pisano. È naturale quindi che il futuro inventore si dilettasse fin da ragazzo con gli apparecchi usati dal padre. Finiti gli studi secondari s’inscrisse al corso di matematica nell’università locale. Di sera, e spesso di notte, si divertiva a compiere esperienze. L’elettricità, in particolar modo, lo appassionava. Non aveva però ancora nessuna idea precisa su quello che desiderava ottenere. Aveva però già nella mente il desiderio di una macchina capace di trasformare la forza meccanica in corrente elettrica continua, per sostituire le costose ed ingombranti batterie di pile. Il problema era però considerato insolubile, poiché tentato invano dai più noti fisici di Europa. 15 Sul finire del 1858, Pacinotti ebbe l’idea di quel geniale dispositivo, noto sotto il nome di anello di Pacinotti, che, sorpassando d’un balzo le difficoltà, diventò il punto di partenza della prima generatrice elettromagnetica di corrente continua. Il primo modello, costruito nel 1859, funzionò subito benissimo. Si trattava però di un dispositivo di dimensioni minuscole, quasi di un giocattolo. Per dimostrare l’importanza pratica dell’invenzione era indispensabile costruire una macchina capace di applicazione industriale. Pacinotti vi pensò, ma un po’ per la paura della spesa necessaria, un po’ per le preoccupazioni dovute all’inizio della carriera (si era da poco laureato a Pisa), la cosa fu rimandata di mese in mese... Né l’inventore pensò ad assicurarsi la priorità della sua invenzione con richieste di brevetti. Raggiunta finalmente la carica di professore di fisica all’Istituto tecnico di Bologna, si decise a rendere pubblica la sua applicazione, inviandone la descrizione alla rivista Il Nuovo Cimento di Firenze dove, dopo lunghi mesi di attesa, fu pubblicata il 3 maggio 1865 sotto il titolo: Elettrocalamita transversale: un’applicazione di questo sistema di calamita ad una macchina magneto-elettrica ed elettromagnetica. In questo storico documento Pacinotti indicava pure chiaramente, punto fondamentale, la reversibilità del suo apparecchio, il quale poteva funzionare sia da generatore, sia da motore, a seconda gli fosse fornita forza meccanica od elettrica. La memoria, a cui Pacinotti affidava le sue speranze, passò del tutto inosservata; né più fortunati furono i tentativi per trovare chi fosse disposto ad anticipare i capitali necessari a mettere in produzione l’invenzione. Era viva però in Pacinotti la speranza di trovare all’estero quello che gli era negato in patria. Sopravvenne un’occasione favorevole: il Ministro dell’Istruzione Pubblica, nell’agosto dello stesso anno, aveva deciso d’inviarlo a Parigi ad acquistare alcuni strumenti di fisica. Partì munito di numerosi estratti dell’articolo del Nuovo Cimento. Appoggiato da larghe raccomandazioni, poté conoscere più di uno scienziato di fama e fra questi il professor Jamin il quale promise che, alla prima occasione opportuna, si sarebbe occupato della cosa. Vedremo poi in seguito in quale curioso modo mantenne la promessa. Inoltre, si recò alla nota officina Froment per l’acquisto di un micrometro e colse l’occasione per interessare alla sua invenzione Demoulins, che ne era allora il proprietario. Questi gentilmente gli rispose che, trattandosi di argomento particolare, era meglio ne parlasse col capo officina, più compete in macchine elettriche. Appena chiamato il capo officina, Pacinotti ricominciò a spiegare, rispondendo alle varie obiezioni che gli erano mosse. Finita l’intervista lasciò naturalmente il solito opuscolo anche al capo officina. Il nome del capo era Zenobio Gramme, nato presso Liegi in Belgio il 4 aprile 1826 da poverissima famiglia, morto milionario a Parigi nel 1901 e da molti testi di oltr’Alpe ostinatamente dichiarato inventore della dinamo. Pacinotti, reduce da Parigi, aspettò invano che le promesse avute nella capitale francese si avverassero: nessuno diede segno di vita. Solo un brutto giorno il nostro inventore, sfogliando i resoconti dell’Accademia delle Scienze di Parigi, stupefatto lesse che sotto l’egida del professor Jamin un certo... Zenobio Gramme aveva presentato alla massima società scientifica francese un modello di apparecchio, copia fedele del suo. Pacinotti scrisse immediatamente a Jamin, ricordandogli i colloqui avuti e scrisse pure al Gramme. Nessuna risposta. Solo i Resoconti dell’Accademia di Scienze, con la loro abituale imparzialità, si limitarono a pubblicare la lettera di protesta inviata da Pacinotti al presidente. Inutile dire che anche questa unica voce lasciò il tempo che trovò. Gramme si racchiuse nel silenzio, sicuro che il tempo avrebbe fatto il resto, e aveva ragione. Oltre ai molti soldi che l’invenzione di Pacinotti gli fruttò, nel 1881 ricevette anche il Gran premio Volta di 50000 franchi. Ironia della sorte: un gran nome italiano servì a coprire una grande ingiustizia commessa contro un altro italiano. Però, più fortunato di tanti altri dimenticati, Pacinotti ottenne in seguito il riconoscimento, se non materiale, almeno morale dei suoi meriti. Questo era già stato invocato da uno dei più grandi scienziati tedeschi già nel 1875, Werner Siemens, ma giunse in forma ufficiale solo nel 1886. In quell’anno infatti, per opera di un altro grande elettrotecnico e inventore italiano, Galileo Ferraris, il congresso mondiale di elettricità di Washington proclamava Antonio Pacinotti primo inventore della dinamo e del motore elettrico a corrente continua, lasciando tuttavia a Gramme il merito della sua applicazione industriale. Nel 1906 il re nominava Antonio Pacinotti senatore del Regno; gli onori poco cambiarono alla sua vita modesta e laboriosa. Morì il 25 marzo 1911 e fu sepolto nel Camposanto di Pisa. 16 Fig. 4. Schema della dinamo e motore a corrente continua creati nel 1859 da Antonio Pacinotti (disegno pubblicato il 3 maggio 1863 nel Nuovo Cimento) La galvanoplastica La galvanoplastica, che permette di depositare elettricamente sopra un oggetto metallico, o metallizzato, uno strato di metallo scomponendo un suo sale disciolto in un liquido appropriato, marcò la nascita dell’elettrochimica. Tradizionalmente è attribuita da molti testi al russo-tedesco Moritz Hermann Jacobi che la realizzò nel 1832, o al francese De la Rive, o anche agli inglesi Henry e George Richards Elkington, le cui esperienze si aggirano attorno al 1840-42. In realtà invece essi si limitarono a completare, applicandole a scopi industriali, le esperienze iniziate trent’anni prima dal pavese Brugnatelli, amico carissimo di Alessandro Volta e suo collega nell’Università di Pavia. Luigi Valentino Brugnatelli, medico, fisico e chimico, nacque a Pavia nel 1761. Laureato in medicina nel 1784, fu nominato ripetitore al Collegio Ghisleri in Pavia, poi col medesimo incarico all’Università, diventando professore titolare nel 1796. 17 Mente versatile, si occupò dei più svariati argomenti. Ebbe il merito di aver dato all’Italia, con il suo Trattato di chimica, un primo corso italiano di questa scienza, fino allora insegnata facendo uso unicamente di traduzioni e di raffazzonature di testi stranieri. Grande amico di Volta, tanto da essergli compagno nel 1801 nello storico viaggio a Parigi in cui il grande comasco presentò la pila a Napoleone, fu tra i primi a ricercare le possibili applicazioni della nuova scoperta. Brugnatelli era anzitutto un chimico ed è logico che in questa direzione si concentrassero le sue ricerche. Avendo constatato assieme a Volta, sul finire del 1800, che una soluzione di sale metallico veniva scomposta nei suoi elementi dalla corrente della pila e il metallo rigenerato allo stato puro si depositava in uno strato regolare e fortemente aderente sul polo negativo, gli sorse la speranza di poter ricoprire elettricamente con uno strato metallico un oggetto debitamente preparato. Era questo un ritrovato di grandissima importanza, fino allora cercato invano, specialmente per la doratura che costituiva una pericolosa industria per quanti vi lavoravano. Il processo in uso consisteva di solito nello spalmare l’oggetto da dorarsi di amalgama, soluzione di oro nel mercurio. L’oggetto così preparato veniva poi esposto al fuoco. Sotto l’influenza del calore, il mercurio evaporava e restava aderente l’oro. La lucentezza si otteneva poi per mezzo di uno dei soliti brunitoi. I vapori di mercurio, prodotti durante l’operazione, per le loro proprietà tossiche non tardavano a produrre negli operai effetti micidiali. Erano stati bensì proposti vistosi premi per la creazione di apparecchi di protezione, ma questi, poiché difettosi, o inutili o per l’incuria degli operai nel farne uso, avevano lasciato le cose allo stato di prima. La maggior difficoltà incontrata dal Brugnatelli nell’iniziare le sue ricerche, fu trovare il liquido adatto a formare il bagno. Dopo molti tentativi scelse gli ammoniuri, prodotti però poco maneggevoli essendo esplosivi. Con essi ottenne però i primi risultati. Al principio del 1802 ne dava pubblicazione negli Annali di fisica e di chimica di Pavia da lui diretti, in una memoria che non lascia dubbi circa i suoi diritti di priorità. Eccone il brano più saliente: «Facendo partire da due poli positivo e negativo della pila, due fili di platino, le cui estremità peschino nell’ammoniuro di mercurio, dopo alcuni minuti si vedrà il polo negativo coperto di goccioline di mercurio: di uno strato di rame se è ammoniuro di rame : di oro se è ammoniuro d’oro e così via». Poco dopo questa pubblicazione, lo scienziato pavese inviava sulla sua scoperta un’interessante lettera allo scienziato belga Van Mons, in cui si dilungava in dettagli sopra i risultati ottenuti. Infatti scriveva: «Recentemente ho dorato in modo perfetto due grandi medaglie di argento, facendole comunicare per mezzo di un filo di acciaio, col polo negativo di una pila di Volta, e tenendole una dopo l’altra nell’ammoniuro d’oro di recente preparato e saturo». Si conservano tuttora a Pavia alcuni preziosi cimeli di primi depositi galvanici, costituiti da insetti, piccoli crostacei, piante e fiori, ramati e dorati con quel processo. Che il metodo del Brugnatelli non si sia limitato ad alcune esperienze da laboratorio, ma sia stato applicato praticamente da qualche artista intelligente, lo dimostra un altro documento di cinque anni posteriore al primo annuncio. Giovanni Battista Gagliardo nella sua Biblioteca di Campagna, largamente letta e diffusa anche fra gente di modesta condizione, nel 1807 indica il nuovo metodo consigliandone l’uso. Ad esso dedicava uno speciale capitolo, ricco di consigli pratici, sotto il titolo: Metodo per indorare le medaglie e fini pezzi di argento con il galvanismo, del signor Brugnatelli, professore della R. Università di Pavia. Sta di fatto però, per oggettività storica, che il Brugnatelli dopo aver ottenuto gli ottimi primi risultati non si preoccupò di perfezionare la sua scoperta. Egli non era uomo d’industria, ma uno scienziato. Dopo aver lanciato l’idea, altri ne trassero un profitto ben maggiore. Lo dimostrano le circostanze che permisero allo scienziato tedesco-russo Pritz Hermann Jacobi di raggiungere l’apogeo della notorietà. Nato a Potsdam il 21 settembre 1801, acquisì presto fama anche all’estero e fu chiamato nel 1837 in Russia dallo Zar Nicola I a coprire una cattedra a Pietroburgo. L’anno dopo annunciava la scoperta della galvanoplastica a cui era giunto, come confessò lui stesso, in modo del tutto causale. Jacobi si occupava allora di perfezionare un piccolo battello, la cui propulsione si effettuava per mezzo di un curioso motore elettromagnetico di sua invenzione. La corrente elettrica necessaria era fornita da una grossa batteria di pile Daniel, costituite da un vaso di vetro contenente dell’acido solforico diluito in cui pesca un 18 cilindro di zinco il quale a sua volta abbraccia un vaso poroso contenente una soluzione di solfato di rame in cui è immerso un cilindro di rame. Jacobi, nello scegliere i vasi porosi, per distinguerli li segnava con la lettera G di materiale a base di piombo (iniziale della parola tedesca gut, buono). Compiute varie esperienze di propulsione, smontando la batteria di pile per ripulirla dalle incrostazioni, si accorse con grande sorpresa che il segno fatto dal piombo era sostituito da un identico segno costituito da un sottile strato di rame. Da qui a creare speciali stampi in cui il metallo potesse essere depositato elettricamente il passo era breve. Bastava infatti preparare gli stampi con una materia plastica qualsiasi, cera, gesso, ecc., spalmarne l’interno di piombo, per ottenere la riproduzione dell’oggetto voluto, distaccandolo poi senza difficoltà dalla sua matrice. Le prime prove vennero coronate da pieno successo. L’imperatore di Russia, interessatosi personalmente alla cosa, ordinò l’acquisto dei brevetti del Jacobi, pagandoli la cospicua somma di 25000 rubli. Dispose per l’immediata creazione di un primo stabilimento galvanoplastico, ponendolo sotto la direzione ed il controllo del suo genero, il Duca di Leuchtemberg. La fabbrica, che solo due anni dopo occupava già 2000 operai, fu quasi esclusivamente adibita alla riproduzione di oggetti d’arte destinati a doni imperiali. 19 Telefono cellulare La nascita della radiotelegrafia Guglielmo Marconi nasce a Bologna il 28 aprile 1874. La madre, l’irlandese Annie Jameson, era la seconda moglie di Giuseppe Marconi, donna molto intelligente e amante dell’Italia dove aveva stabilito il suo domicilio. Il piccolo Guglielmo trascorse la sua prima giovinezza in parte a Firenze e in parte a Livorno, poiché la madre temeva, per la costituzione gracile del figlio, il clima di Bologna, troppo umido nella cattiva stagione. Frequentò la scuola tecnica e dimostrò fin dall’inizio un particolare interesse per la fisica, tanto da frequentare lezioni supplementari di scienza, impartitegli a Livorno dal professor Vincenzo Rosa, da cui imparò le prime nozioni di elettricità. Nei soggiorni bolognesi, approfittando dell’amicizia che legava il padre con Augusto Righi, ebbe l’occasione di parlare con lo scienziato dei suoi sogni e progetti e venne iniziato da questi alle allora misteriose onde elettriche che si propagano nello spazio senza bisogno di conduttori. Il tedesco Enrico Hertz le aveva scoperte per la prima volta nel 1888 e Righi ne aveva sviscerato, in una serie di classiche ricerche, le proprietà dimostrandole identiche a quelle della luce. Il mistero di questo nuovo e quasi sconosciuto mondo appassionò il giovane Marconi. Acquistò libri, imparò come si producessero queste onde e seppe che esistevano dispositivi capaci di rivelarne la presenza. Un’idea cominciò a germogliare nella sua mente: inviare dei segnali elettrici senza bisogno di conduttori. Nelle vacanze estive del 1894 cominciò a costruire e le prime prove furono incoraggianti: riuscì a comunicare alla distanza di qualche metro. Proseguì nei perfezionamenti e giunse il giorno della prova decisiva. Nella villa paterna di Pontecchio, presso Bologna, sistemò il trasmettitore vicino alla finestra del granaio e il ricevitore alla distanza di poche centinaia di metri, sulla sommità di una collinetta prospiciente alla villa. Con l’assistenza di un contadino, preso come aiutante, il quale agitava un fazzoletto, ebbe la dimostrazione che il ricevitore funzionava ogni qual volta egli trasmetteva la lettera S, rappresentata nell’alfabeto Morse con tre punti corrispondenti all’emissione di tre brevi gruppi di onde elettromagnetiche. Marconi, nonostante la sua prima euforia, comprese che la sua invenzione avrebbe potuto presentare un vantaggio sulle segnalazioni ottiche solo se fosse riuscita a sorpassare anche gli ostacoli naturali. Portò il ricevitore a ridosso della collina, in modo che questa s’interponesse fra il ricevitore e il trasmettitore. Per essere avvisato immediatamente, in caso di riuscita, disse al suo collaboratore: «Prendi il fucile e se vedi questo martelletto, simile a quello del campanello elettrico, vibrare e cantare tre volte di seguito come un grillo: spara». Tornato al granaio, premette tre volte il tasto rudimentale che comandava l’emissione delle onde elettriche e subito dopo un colpo di fucile rintronò nella valle. Per generare le onde aveva adoperato un oscillatore di Righi, per riceverle il coherer, sottile tubetto ripieno di polvere metallica. Lo aveva creato, fin dal 1884, Temistocle Calzecchi Onesti, professore di fisica al Liceo Beccaria di Milano, dimostrandone la conduttività sotto l’influenza delle onde. Dopo il primo successo il giovane inventore continuò le esperienze con diverse modifiche e suscitava la curiosità di quanti venivano a visitare la famiglia Marconi. La maggior parte di questi curiosi considerava però il lavoro del giovane Marconi alla stregua di un banale passatempo, senza intuirne le potenzialità. In famiglia il padre, pur facendosi un po’ pregare, finiva sempre con lo sborsare il denaro necessario ad acquistare apparecchi spesso costosi; al contrario, la madre nutriva grande fiducia e non fece mancare mai il 20 suo appoggio: infatti, quando Guglielmo espresse il desiderio di ottenere un brevetto che lo rendesse legalmente proprietario della prima scoperta, la madre si occupò della cosa, scrivendo in Inghilterra ad un congiunto. Il 2 luglio 1897 il brevetto inglese era concesso. Il giovanissimo inventore, fin dal 1896, si era affrettato a proporre al nostro Ministero delle Poste e Telegrafi alcune prove, assumendone tutte le spese. In risposta arrivò una breve lettera d’ufficio in cui la proposta veniva ricusata, perché… priva di qualsiasi interesse!!! La disillusione era dura, ma il giovane inventore non si fece scoraggiare e, sempre con l’appoggio della madre, decise di partire per l’Inghilterra per cercare l’aiuto che, per il momento, gli era impossibile ottenere in patria. Giunto a destinazione si trovò in circostanze piuttosto favorevoli. La possibilità di trasmettere segnali elettrici, senza l’intervento di conduttori, non era più considerata un’utopia in Inghilterra. Alcune esperienze, eseguite con sistema del tutto diverso da quello italiano, erano in corso proprio quei giorni e suscitavano l’interesse anche del pubblico inglese. A compierle era sir William Preece, direttore dei telegrafi britannici, al quale Marconi ebbe la fortuna di essere presentato pochi giorni dopo il suo arrivo. Il vecchio scienziato inglese intravide subito l’avvenire riservato alle idee del giovanissimo concorrente. Con rara oggettività, ne divenne un fervente fautore, subito dopo aver assistito a una prova eseguita nella pianura di Salisbury, sul finire del 1896. Benché la distanza superata fosse di appena 3 chilometri, il risultato sembrò sbalorditivo. L’11 e 14 maggio del 1897 le esperienze venivano ripetute attraverso il canale di Bristol, fra Lavenok Point e l’isoletta di Fiat Holm, a una distanza di 13 chilometri. Le comunicazioni risultarono ottime, nonostante il maltempo e l’interposizione di alcune colline. Pochi giorni dopo sir William Preece, in una seduta della Royal Istitution appositamente convocata, descriveva a un folto pubblico di tecnici e di scienziati l’invenzione di Marconi, ponendo l’accento sulla potenziale futura immensa importanza. La conferenza, per la notorietà dell’autore, ebbe un’eco enorme. I giornali inglesi ne riportarono ampi riassunti e la notizia venne telegrafata in tutti i paesi del mondo. Una prima società, destinata a sfruttare i brevetti, fu immediatamente costituita sotto il titolo di Wireless Telegraph Trading Signal Company. Le sfere ufficiali italiane si svegliarono: il ministro della Marina, Benedetto Brin, fece contattare l’inventore avvisandolo che il suo dicastero era disposto a compiere a La Spezia una serie di esperienze ufficiali fra la costa e le navi incrocianti nel golfo. Marconi accettò. Prima vi fu una dimostrazione preliminare, eseguita a Roma fra due sale del Ministero della Marina, poi furono iniziate le prove a La Spezia, il 10 luglio 1897 e proseguite per alcuni giorni, con esito perfetto a distanze progressive che raggiunsero i 10 chilometri. Durante queste esperienze dovette però prender atto che nelle alte sfere istituzionali prevaleva lo scetticismo e si convinse che non sarebbe riuscito ad ottenere alcun appoggio o sostegno finanziario governativo per continuare le sue ricerche in Italia. Pare che ne fosse rimasto profondamente deluso poiché, quando aveva ceduto i suoi brevetti alla società inglese, si era riservato la proprietà personale di quelli italiani che avrebbe voluto cedere gratuitamente all’esercito ed alla marina … ma nessuno gli chiese nulla! Marconi tacque e se ne tornò amareggiato in Inghilterra. Il 3 giugno 1898 veniva inaugurato un primo servizio regolare radiotelegrafico fra l’isola di Wright e Bournemount, ad una distanza di 23 chilometri. Lord Kelvin, famoso nella storia per essere stato padre della telegrafia transoceanica per mezzo di cavi, volle essere il primo a inviare un radiotelegramma, pagando la tariffa telegrafica. I primi incassi equivalevano a poche miglia di lire, dopo neanche 30 anni il giro d’affari era di centinaia di milioni. 21 Dai radiofasci alla rete telefonica mondiale Il dopo guerra marca, per l’opera marconiana, un nuovo ancor più completo trionfo. Questo è rappresentato dalla nascita della «rete radiotelegrafica e radiofonica mondiale». A segnarne le basi, l’applicazione dei radiofasci. Mentre le onde irradiate con i vecchi sistemi si propagano circolarmente e raggiungono non solo la stazione a cui sono destinate, ma tutte quelle che si trovano nel suo raggio di portata, con il sistema a fascio, invece, la loro quasi totalità è concentrata verso il punto desiderato. Punto di partenza l’impiego delle onde corte e cardine l’opportuna disposizione dell’antenna, per il cui tramite le onde elettromagnetiche sono lanciate nello spazio e ricevute. Marconi, fin dalle sue prime esperienze, aveva cercato di concentrare le onde alla trasmissione e alla ricezione. Ne fanno fede i suoi primi brevetti, fra cui quello americano del 1897. Aveva ricorso a riflettori parabolici di metallo. Inoltre il 3 marzo 1899, il grande inventore leggeva all’Associazione degli elettricisti di Londra una memoria nella quale dimostrava la possibilità di proiettare un fascio di onde elettromagnetiche, anziché irradiarle circolarmente, e preconizzava l’uso di questi radiofasci per le segnalazioni alle navi in caso di nebbia. L’impiego dei riflettori costituiti da superfici metalliche era legato all’uso di onde cortissime, di cui ignorava ancora un metodo di produzione sufficientemente intenso, quindi i riflettori vennero abbandonati. Nel 1902, durante la famosa campagna radiotelegrafica della Carlo Alberto, Marconi credette di poter affermare: «Bisognerà aumentare la lunghezza d’onda per aumentare la portata delle trasmissioni». Quattordici anni dopo, nonostante tutti i trionfi riportati, si ricredeva e dichiarava, fra la stupefazione e lo scetticismo dei più: «o mi sono ingannato, e tutti mi hanno seguito; sono il primo a ritornare sui miei passi ed a riprendere l’impiego delle onde corte sulle quali si baserà l’avvenire della radiotelegrafia». Fulcro del nuovo orientamento, un fatto d’importanza capitale: la scoperta compiuta dall’inglese Fleming, poi perfezionata dall’americano De Forest, della valvola termoionica. Il reimpiego delle onde corte per le trasmissioni a grande distanza riportò sul terreno l’utilità dei riflettori. Permaneva il problema della loro costruzione. Se l’impiego delle onde lunghe aveva scartato i riflettori (si avrebbe dovuto dare ad essi l’irrealizzabile larghezza di decine di chilometri), non per questo gli sperimentatori avevano rinunciato alla speranza di una soluzione con mezzi più pratici delle pareti metalliche. Furono compiute numerose ricerche, spesso complicate e difficili. L’inglese Brown aveva verificato che, prendendo due antenne parallele, separate l’una dall’altra da una distanza corrispondente ad una mezza lunghezza dell’onda usata, e alimentandole con identica corrente oscillatoria, le onde non si propagano più circolarmente nello spazio, ma secondo le intensità variabili raggiungendo un massimo perpendicolarmente al piano formato dalle due antenne. Marconi dimostrava poi che i due fasci opposti, così prodotti, possiedono un angolo tanto più acuto quanto più numerosi sono gli elementi usati, e l’intensità è massima quando l’antenna ha ogni suo elemento di una lunghezza uguale a quella dell’onda usata. Avviene però che il concentramento si effettui non solo nella direzione voluta, ma anche in quella diametralmente opposta, e da questo lato in pura perdita; quindi necessità di trovare il mezzo di proiettare le onde in un’unica direzione. La soluzione si ottenne ricorrendo al potere riflettente di un filo isolato, di pari lunghezza dell’antenna vibrante, posto parallelamente dietro di essa. Il fenomeno permise la costruzione di grandi riflettori sostituendo, alle pareti metalliche irrealizzabili, cortine di fili. Prima fu dato a queste la forma parabolica, usata nei riflettori luminosi, per poi passare a quella piana, l’unica che si adatti alle antenne a cortina. Con questo metodo Marconi riuscì ad ottenere un radiofascio di grande intensità, orientabile nella direzione voluta. Quanto si è detto per la trasmissione, può ripetersi per la recezione. L’antenna, posta sulla strada seguita dal radiofascio, ha il potere di ricezione raddoppiato dal riflettore, il quale rimanda su di essa le onde che non l’hanno influenzata direttamente. Mentre con il sistema a trasmissione circolare l’energia ricevuta è minima, con i radiofasci essa si trova centuplicata, permettendo grandi economie di impianti. L’adozione dei radiofasci permette inoltre l’installazione di un numero grandissimo di radiolinee stabili senza pericolo di reciproci disturbi. 22 Durante l’infuriare della grande guerra ebbe inizio la realizzazione della nuova invenzione. Nel 1916 Marconi, spinto dall’impellente necessità di guerra, riprese l’intenso studio della radiotelegrafia direttiva, compiendo in segreto a Genova e a Livorno numerose esperienze, con nuovi apparecchi creati allo scopo. Fece uso di onde cortissime, da 3 a 4 metri. I riflettori erano costituiti da un numero relativamente piccolo di fili disposti secondo una superficie parabolica. Il generatore d’onde era lungi dall’essere perfetto, essendo ancora costituito da un oscillatore a scintilla. Le esperienze iniziate in Italia furono continuate in Inghilterra. Nel 1920 e 1921 s’intensificarono, adoperando come generatore un nuovo dispositivo a valvole termoioniche. I risultati furono notevoli e oltre al perfetto funzionamento dei riflettori, si rivelò l’enorme portata delle onde corte. L’energia raccolta dal ricevitore si dimostrò 250 volte maggiore di quella afferrabile con un sistema circolare. Con la primavera del 1923 s’inizia l’era dei tentativi a grande distanza, fra la vecchia e gloriosa stazione di Poldhu in Cornovaglia (la stessa che, sul finire del 1901 aveva lanciato le prime comunicazioni radiotelegrafiche transoceaniche fra l’Europa e l’America) e l’Elettra, lo yacht-laboratorio di Marconi. A Poldhu era stata stabilita un’antenna a riflettore parabolico, in connessione con uno speciale apparecchio trasmettitore ad onda corta (97 metri). La potenza impiegata, circa 16 cavalli, cioè minima in confronto di quella fino allora usata in una qualsiasi altra stazione di portata superiore ai 1000 chilometri. Per attuare la ricezione delle trasmissioni a radiofascio vennero prestabilite speciali fermate: a Funchal nell’isola di Madera (km. 2340 da Poldhu) e a San Vincenzo di Capo Verde (km. 4300). In ambedue i porti l’Elettra veniva a trovarsi sempre in condizioni sfavorevoli, ancorata a ridosso di alte montagne. Le esperienze furono iniziate, senza che a Poldhu agissero i riflettori, allo scopo di risolvere la prima parte del problema: la verifica della portata delle onde corte. I segnali, sia a Siviglia, sia a Casablanca, furono uditi perfettamente. Entrato in azione il sistema a fascio, i vantaggi di esso si rivelarono in tutta la loro straordinaria importanza. Giunta la nave alle Isole di Capo Verde, i segnali continuarono ad essere uditi con perfetta intensità. Marconi diede ordine affinché Poldhu diminuisse progressivamente l’energia impiegata. Anche ridotta a poco più di un cavallo, le comunicazioni si mantennero più chiare di quelle che si potevano ricevere da stazioni potentissime a onda lunga, come ad esempio da quella di Leafield, impiegante oltre 400 cavalli. Era un grandioso successo, ma non sufficiente ancora ad appagare i desideri. Se si erano raggiunte le possibilità di un molto più rapido ed economico servizio notturno, quello diurno era ancora difficile. Nonostante i grandi progressi conseguiti dalla radiotecnica, risorgeva l’ostacolo che, all’inizio della radiotelegrafia, aveva orientato gli studi verso le onde sempre più lunghe con conseguente costruzione di stazioni sempre più potenti e costose. Ora, prima condizione di un servizio è di poter effettuare la comunicazione in ogni momento desiderato. Allo scopo di studiare a fondo la questione, l’impianto di Poldhu venne notevolmente migliorato, al riflettore parabolico fu sostituito il riflettore piano o a cortina di cui, nel frattempo, si erano verificati i vantaggi. Contemporaneamente venivano presi accordi affinché alcune stazioni Marconi, situate nell’America del Nord, in quella del Sud e perfino in Australia, cercassero di captare le emissioni circolari a onde corte emesse da Poldhu. La lunghezza d’onda venne diminuita a 92 metri. Il 30 maggio la stazione australiana di Sidney, posta a km. 16000 da quella inglese, annunciava di udire chiaramente i segnali e lo stesso confermavano New York, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montreal. Dal 12 al 14 con l’Argentina venne posto in azione il radiosfascio e si ottennero di notte comunicazioni perfette, alla velocità fino allora sconosciuta di 100 parole al minuto. Ogni comunicazione diventava però impossibile quando il percorso delle onde doveva effettuarsi in piena luce. Si rivelò un particolare del tutto inaspettato. Sidney annunciava di ricevere perfettamente durante due periodi, dalle 5 alle 9 del mattino (ora di Greenwich) e dalle 6,30 alle 8,30 della sera. Confrontando questi orari, e riferendoli alla tendenza delle onde corte a seguire zone non illuminate, ne veniva la straordinaria conseguenza che le comunicazioni fra l’Inghilterra e l’Australia si propagavano alla mattina verso ovest, cioè attraverso l’Atlantico, l’America ed il Pacifico, compiendo 24000 chilometri, mentre la sera prendevano la via opposta attraverso l’Europa e l’Asia, percorrendo solo 16000 chilometri. Nonostante il grave ostacolo prodotto dalla luce, l’era delle onde corte era nata e con essa una schiera di innumerevoli sperimentatori dilettanti! 23 Parallelamente alla «Marconi», parecchie altre società radiotelegrafiche si posero a studiare i vari aspetti del problema. Sul finire del 1923 l’invenzione poteva considerarsi definitivamente compiuta. Restava l’ultimo ostacolo da superare, il più ostico di tutti: la trasmissione diurna. Marconi nell’agosto 1924 iniziava una nuova serie di esperienze a radiofascio fra la stazione di Poldhu e l’Elettra. La nave si recò in Spagna, toccò Madera, indi si fermò a Napoli, dopo aver sostato al Pireo. In ogni punto furono compiute osservazioni. A Madera si poté constatare che, facendo uso di onde di lunghezza inferiore ai 92 metri, si otteneva il miglioramento nella trasmissione diurna, miglioramento di gran lunga rinforzato con uso di riflettore trasmittente. L’opacità presentata dalla luce solare si attenuava rapidamente con il decrescere della lunghezza d’onda. Furono successivamente provate lunghezze di 60, di 47 e finalmente di 32 metri. Con queste ultime si riceveva perfettamente in pieno giorno, a Beirut (km. 3890 da Poldhu), mentre con 92 metri i segnali si percepivano imperfettamente a Madera, posta a metà distanza. Nell’ottobre erano eseguite esperienze di controllo diurno, con onde di 32 metri, fra Poldhu, Buenos Aires, New York, Montreal e Sidney. Con quest’ultima stazione la comunicazione si poteva mantenere per 23 ore sulle 24 con una potenza di appena 16 cavalli. Per la prima volta la parola umana superava i km. 20000, massima distanza terrestre. Al Governo inglese, forte del suo primato nel possesso dei più rapidi mezzi di comunicazione intercontinentale, non poteva sfuggire l’immensa portata pratica ed economica del nuovo sistema a radiofascio. Malgrado fosse orgoglioso di possedere la più perfetta organizzazione radiotelegrafica del mondo, per realizzare la quale aveva speso somme enormi, non esitò a slanciarsi nella nuova via, iniziando una vera rivoluzione nelle sue comunicazioni a grandissime distanze. Dopo aver seguito con la massima attenzione i risultati ottenuti dalle progressive esperienze marconiane, nel giugno 1924 firmava con l’inventore un contratto per la costruzione di un gruppo di stazioni, destinate a collegare direttamente per radiofascio l’Inghilterra con i punti estremi del suo vasto impero. Le condizioni di collaudo erano durissime, tali da essere di gran lunga inadempibili da qualsiasi altro sistema radiotelegrafico. Esse consistevano nel collegare l’Inghilterra con il Canada, il Sud Africa, l’India e l’Australia, alla velocità minima di 100 parole al minuto in ricezione e trasmissione contemporanea, per la durata di 18 ore al giorno. L’irradiazione dell’energia doveva effettuarsi entro un angolo di 15°, in modo che quella diffusa fuori di questo angolo non fosse superiore al 5% di quella irradiata lungo l’asse del fascio congiungente le due stazioni. L’energia impiegata doveva essere almeno dieci volte minore a quella richiesta da qualsiasi vecchio sistema. La velocità si dimostrò adeguata. Furono infatti sorpassate le 400 parole al minuto, raggiungendo una potenzialità media di 300000 parole al giorno, molto maggiore di quella realizzabile da qualsiasi cavo sottomarino. Per impedire una concorrenza disastrosa non priva di possibili inconvenienti, per pressione del Governo inglese all’inizio del 1928 il Sindacato dei grandi cavi inglesi, che sfruttava buona parte delle comunicazioni telegrafiche fra continenti, si fondeva nella Società Marconi. La guerra accanita, durata un trentennio, aveva il suo epilogo. All’organizzazione inglese si aggiungevano i collegamenti Londra-New York e Londra-Argentina. Entrò in servizio poco dopo quello Spagna-Argentina, importante poiché non si limitava alla grande repubblica sudamericana ma, con collegamento a cavo, assicura le comunicazioni del Cile e dell’Uruguay con l’Europa. Con l’avvento dei radiofasci si realizzò il primo sistema misto radio-cavo che non si limitava a scavalcare gli oceani, congiungendo due stazioni, ma permetteva l’incanalamento diretto di qualsiasi trasmissione fino a giungere, attraverso opportune diramazioni, al punto desiderato. Il sistema fu poi esteso anche alle navi in navigazione. Il 30 marzo 1930, da bordo dell’Elettra ancorata a Genova, alla presenza dei rappresentanti della stampa mondiale, Marconi dimostrava che anche una nave della modesta stazza di 800 tonnellate era capace, con i nuovi apparecchi da lui perfezionati, di porsi in comunicazione con le più lontane stazioni radiotelegrafiche e per il loro tramite di scambiare, senza bisogno di preavviso, conversazioni con qualsiasi abbonato telefonico della rete a loro collegata. Contemporaneamente in occasione dell’inaugurazione dell’Esposizione di Elettricità di Sidney in Australia con una breve emissione d’onde Marconi comandava da Genova l’accensione delle lampade illuminanti il municipio della città posta agli antipodi. 24 Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la Stazione radiotelegrafica ad onde corte della Città del Vaticano. Le parole lette da Pio XI potevano, per la prima volta, essere udite contemporaneamente dall’Asia alle Americhe, dall’Africa all’Australia, all’Oceania. L’invenzione della pila A metà tra storia e leggenda la pila nasce dalla disputa di due grandi scienziati attorno … ad una rana! Luigi Galvani, illustre medico e anatomico dell’Università di Bologna, fra le molte ricerche aveva intrapreso di determinare l’azione dell’elettricità sulla sensibilità nervosa e sulla contrazione muscolare. Le sue esperienze si erano concentrate specialmente sulle rane, dimostratesi simili a sensibilissimi elettroscopi. Come sorgenti di elettricità erano solo conosciute le cosiddette macchine elettrostatiche a dischi di vetro. Il canonico Von Kleist Canaens vi aveva aggiunto, nel 1745, la bottiglia di Leida, capace di trattenere e accumulare una forte carica di elettricità in piccolo spazio. Inoltre Benjamin Franklin, nel 1752, aveva dimostrato l’origine elettrica del fulmine e creato il parafulmine. Il 20 settembre 1786 Galvani cercava appunto di verificare l’influenza dell’elettricità atmosferica a cielo sereno sopra i muscoli di una rana. Come nelle precedenti esperienze, l’aveva spellata e privata del capo, delle zampe anteriori e di metà del tronco, appendendola poi, con un uncino di rame, alla ringhiera di ferro del balconcino di casa. Quel giorno le contrazioni, tante volte verificate avvicinando l’animaletto ad una macchina elettrica o anche ottenute durante temporali, non si verificavano. Arrivata sera, Galvani decise di rimandare il seguito all’indomani. Nel togliere l’uncino di rame, infitto nel midollo spinale della rana, volle il caso che lo sfregasse contro il ferro della ringhiera. Fu molto sorpreso nel vedere contrarsi violentemente gli arti inferiori dell’animaletto. Il fenomeno risultò ripetibile ed egli cercò una spiegazione e una conferma definitiva. Ripeté l’esperienza in laboratorio. Collocò la rana sopra una lastra di ferro pulita, ponendo sotto i nervi lombari un uncino di rame. Constatò così il ripetersi delle contrazioni ogni volta che l’uncino di rame toccava il ferro. Il fenomeno pareva inesplicabile, poiché nel laboratorio nessuna macchina elettrica era in azione e gli elettroscopi non segnalavano presenza di elettricità. Di più, essendo il cielo sereno, si doveva pure scartare qualsiasi influenza d’origine atmosferica. Verificò pure che non si ottenevano variazioni nell’andamento delle esperienze quando s’interponevano fra i due metalli corpi conduttori. Ogni contrazione cessava invece quando era interposto un isolante. Esclusa ogni possibile influenza elettrica esterna, si affacciava spontanea l’ipotesi che il fenomeno avesse la sua sorgente nell’animaletto stesso. Spiegazione che sorrise subito allo scienziato bolognese, data la sua qualità di medico e lo spinse a considerare l’eventualità dell’esistenza di un’elettricità animale, propria della rana. La convinzione in breve si trasformò in certezza. Studiò pure la composizione dell’arco bimetallico e scoprì che alcune combinazioni davano migliori risultati di altre. Dopo molte esitazioni, Galvani si decise a rendere pubbliche le sue scoperte. Il resoconto apparve in uno storico opuscolo dal titolo: Sull’azione dell’elettricità nel moto muscolare, pubblicato a Bologna nel 1791. In esso, così spiegava la sua ipotesi: «Tutti gli animali possiedono una elettricità loro propria (elettricità animale) la quale si raccoglie nel cervello, secernata dal sangue che affluisce a questo viscere. L’elettricità viene condotta per mezzo dei nervi ai muscoli, che riescono così caricati al modo di altrettante bottiglie di Leida: di elettricità positiva all’interno delle loro fibre, di elettricità negativa nella parte esterna. I nervi sono poi a paragonarsi al conduttore che trasporta l’elettricità dell’armatura interna della bottiglia di Leida all’armatura esterna. L’arco metallico completa il circuito attraverso il quale si compie la scarica produttrice della contrazione muscolare». La memoria di Galvani, appena conosciuta, ebbe un’immensa eco fra gli scienziati d’Europa, i quali si affrettarono a ripetere le inaspettate esperienze. Fra i primi Alessandro Volta, già noto per la creazione di numerosi nuovi strumenti, fra cui l’elettroforo, la pistola a gas, l’elettroscopio a condensatore, ecc. 25 Alessandro Volta aveva allora 47 anni. Era nato a Como il 18 febbraio 1745 e proveniva da famiglia nobile, benché ridotta a condizioni finanziarie modeste. Compì i primi studi nella scuola pubblica locale, dimostrando fin dall’inizio straordinarie doti. Inseparabile suo compagno di allora, benché di qualche anno più anziano, un certo Giulio Cesare Gattoni, morto poi in veste di canonico. Questi, appassionato di fisica e di ricca famiglia, aveva potuto ancora giovinetto crearsi un piccolo laboratorio. Qui il giovane Alessandro attinse i primi elementi di quell’amore alle ricerche che segneranno poi tutta la sua vita. A 18 anni riuscì ad allacciare una seguita corrispondenza coll’abate francese Nollet, fisico allora molto noto. A questo si aggiunsero altri scienziati ed ebbe così inizio quella copiosa attività epistolare che gli fu sempre cara. Nel 1769 dava alle stampe la sua prima memoria, alla quale, a breve distanza, ne seguirono altre. Questi scritti, che egli si affrettava ad inviare ai fisici più noti, lo fecero rapidamente conoscere ed apprezzare procurandogli nel 1774 il posto di rettore del Ginnasio di Como. L’anno dopo l’invenzione dell’elettroforo poneva le prime basi della sua fama. Era questo un apparecchio semplicissimo che permetteva di ottenere inesauribilmente cariche di elettricità. Doveva aggiungervi la scoperta del metano, o gas di palude. L’idrogeno, o aria infiammabile come si diceva allora, fu da lui studiato a lungo. Riconobbe il potere esplosivo di questo gas, quando è misto a una adeguata proporzione d’aria, grazie ad un curioso archibugio con cui compì numerose esperienze. Questo piccolo apparecchio, che rimase noto in molti trattati di fisica sotto il nome di «pistola di Volta», inspirò settant’anni dopo a un altro italiano, padre Eugenio Barsanti, la prima idea del motore a scoppio. Creò pure una lucernetta ad idrogeno, da lui chiamata «lampada perpetua», acquistandosi così il titolo di precursore dell’illuminazione a gas. Lo studio dei conduttori elettrici lo spinse inoltre a prevedere la nascita del telegrafo, proponendo di lanciare un segnale fra Como e Milano per mezzo di fili sostenuti da pali. Nel 1778, di ritorno da un suo primo viaggio all’estero, venne nominato professore di fisica all’Università di Pavia, carica mantenuta per molti anni. Le sue nuove e migliorate condizioni finanziarie gli permisero di approfittare delle vacanze per compiere nuovi viaggi d’istruzione. Visitò la Francia, il Belgio, l’Olanda, l’Inghilterra e la Germania. Nel frattempo, aumentando il numero delle sue scoperte, creava nel 1782 il condensatore e un nuovo elettroscopio di maggiore sensibilità. Gettò le basi dei rapporti fra la dilatazione dell’aria e la temperatura, precorrendo di un decennio il francese Gay Lussac. Avido di nuove conoscenze e sperimentatore formidabile, si comprende con quale interesse Volta abbia letto la descrizione delle esperienze di Galvani. Da prima approvò le idee dello scienziato bolognese sull’esistenza di un’elettricità animale, tanto da definire questa ipotesi: «una delle più grandi e luminose scoperte che meritano di far epoca negli annali della fisica e chimica». Poi, progressivamente, se ne distaccò. Bisogna ricordare che Volta era, per estrazione, un fisico e che quindi fosse interessato a ricercare se, invece di un’origine animale, non ve ne fosse una puramente fisica. Dopo tre anni di esperienze, la sua convinzione era maturata e, nel dicembre del 1793, scriveva all’abate Anton Maria Vassalli, professore dell’Università di Torino: «Che pensa ella della pretesa elettricità animale? Per me sono convinto da un pezzo che tutta l’azione procede originariamente dai metalli combaciatiti con un corpo umido qualunque». Questa affermazione, appena nota, sollevò fra gli scienziati un immenso scalpore. Mentre moltissimi restarono fedeli alle idee di Galvani, altri si volsero verso Volta, dando così origine alla storica controversia la quale, per lunghi mesi, divise la scienza europea in due accaniti campi avversari. Per risolverla s’imponeva un’esperienza decisiva la quale o dimostrasse l’esistenza di un’elettricità unicamente prodotta da un corpo vivente senza intervento di metalli, o viceversa la possibilità di generare elettricità unicamente dal contatto di metalli eterogenei. In realtà il problema era molto più complesso poiché, nel loro esclusivismo, ambedue i contendenti avevano torto e ragione. 26 L’esistenza di un’elettricità animale, affermata da Galvani, era tutt’altro che un assurdo. Trenta anni dopo un altro grande italiano, Leopoldo Nobili, creando sofisticati strumenti d’indagine, riusciva a misurare correnti elettriche proprie ad esseri viventi, dando origine ad una fondamentale scienza: l’elettrofisiologia. Aveva pure ragione Volta fissando nell’arco metallico una sorgente elettrica, benché cadesse in errore nell’ostinarsi ad attribuirne l’origine unicamente al contatto dei metalli, scartando ostinatamente la causa reale costituita dal processo chimico di ossidazione. Anche se le incalcolabili conseguenze pratiche che derivarono dalla pila hanno posto in leggera penombra il nome di Galvani rispetto a quello di Volta, la figura dello scienziato bolognese non può essere posta su di un gradino inferiore a quello occupato dal grande comasco. In Galvani non solo è da ammirarsi lo scienziato, ma anche la sua fierezza morale. Nel 1797, avendo rifiutato d’inchinarsi ai francesi e di prestare giuramento alla Repubblica Cisalpina, fu radiato dal posto di professore e dovette rifugiarsi presso un fratello. Ridotto in condizioni non lontane dalla miseria, scoraggiato e sfibrato dalla lotta, fu colpito da una malattia che lo portò alla tomba, il 14 dicembre 1798. Pochi giorni prima, il Ministero degli Studi gli aveva restituito, con tardiva giustizia, la sua cattedra universitaria: aveva 61 anni, essendo nato a Bologna nel 1737. Volta, invece, continuava nella sua ascesa trionfale. Persuaso, come abbiamo detto, che l’elettricità si producesse dal contatto ad umido di due metalli diversi, cercò anzitutto i più adatti, sforzandosi a moltiplicare i dispositivi di contatto al fine di creare un generatore di elettricità il più possibile intensa. È ormai accertato che la prima pila fu costruita e provata nel 1799 a Como, dove Volta si era rifugiato allorché la seconda Coalizzazione Europea aveva avuto ragione delle truppe francesi in Italia; l’Università di Pavia era stata provvisoriamente chiusa e i professori esonerati. La grande scoperta fu annunciata in una lunga lettera, datata il 20 marzo 1800 da Como, diretta a sir Joseph Banks, presidente della Royal Society. Fu letta ai soci della grande società scientifica inglese, riuniti in seduta solenne il 26 giugno. Però già da qualche giorno Banks ne aveva reso noto il contenuto ad alcuni amici e corrispondenti di Volta, fra cui i noti fisici inglesi Carlisle, Nicholson e l’italiano Tiberio Cavallo. Questi si erano affrettati a costruire, secondo le indicazioni ricevute, una pila composta di 17 scudi di argento e altrettanti dischi di zinco, separando le coppie così formate con cartone bagnato. Così verificarono l’esattezza delle affermazioni voltiane. Queste esperienze furono ripetute il 26 giugno alla presenza dell’assemblea sollevando un vero stupore. Lo stupore divenne entusiasmo quando, quasi immediate, si verificarono le prime applicazioni fra cui la decomposizione dell’acqua, ottenuta il 2 maggio da Nicholson e Carlisle. Pochi mesi dopo il tedesco Tromsdor aggiungeva la fusione di sottili fili di metallo e la scomposizione di ossidi mentre l’italiano Brugnatelli realizzava i primi esperimenti di galvanoplastica. Dalla disposizione usata nei primi apparecchi, costituiti da colonne di dischi sovrapposti, nacque il nome popolare di pila che rimpiazzò quasi subito quello di organo elettrico artificiale, con cui Volta aveva battezzato la sua creazione (quasi a ribadire quello che considerava l’elemento definitivo di vittoria nella sua lotta contro le teorie galvaniane). Il 2 giugno 1800 Napoleone, dopo la vittoria di Marengo, richiamò Volta a continuare le sue lezioni all’Università di Pavia, invitandolo a recarsi a Parigi per ripetere le sue esperienze sulla pila alla presenza dei membri di quell’Accademia delle Scienze. Dopo alcune titubanze, nel settembre del 1801, Volta si mise in viaggio, accompagnato dal fido amico Brugnatelli. Giunsero nella capitale francese il 26 dello stesso mese. Qui l’arrivo di Volta costituì l’avvenimento del giorno e i più noti scienziati si prodigarono a rendergli onore. Il 6 ottobre i due italiani furono ricevuti da Napoleone, allora Primo Console, il quale il giorno dopo assistette alla seduta dell’Accademia dove Volta lesse la sua memoria sulla pila ed eseguì con essa alcune esperienze. Napoleone, allo scopo di dare maggior risalto al suo vivo interessamento, vi giunse in uniforme di accademico. Si narra che, rivolgendosi al suo medico Corvisart, esclamasse: «Dottore, ecco l’imagine della vita. La colonna vertebrale è la pila, il fegato il polo negativo, il rene il polo positivo». Propose che allo scienziato italiano fosse decretata una speciale medaglia d’oro, onore fino allora mai tributato ad uno straniero. Vi aggiunse un dono di 6000 franchi e un assegno annuo. In seguito, divenuto 27 imperatore, gli decretò la Corona Ferrea e la Legion d’onore, aggiungendovi la nomina a senatore e il titolo di conte. La sua ammirazione per il grande comasco si mantenne sempre inalterata. A provarlo si possono riportare due episodi. Nel 1803 Napoleone, mentre stava visitando a Parigi la biblioteca dell’Istituto di Scienze, si fermò davanti ad una corona di alloro che portava sui nastri di bronzo la dedica Au grand Voltaire. Cancellò le ultime tre lettere, in modo che si potesse leggere invece: Au grand Volta. L’anno dopo, Volta, ormai sessagenario, aveva chiesto di essere posto a riposo e sostituito nell’insegnamento di Pavia; l’imperatore fece rispondere: «Io non potrei acconsentire al ritiro di Volta. Se le sue funzioni di professore sono troppo gravose bisogna ridurle. Tenga pure una sola lezione all’anno, se vuole. L’Università di Pavia sarebbe colpita al cuore se un nome così illustre sparisse dagli elenchi dei suoi professori. D’altra parte un buon generale deve morire sul campo dell’onore». Caduto l’impero napoleonico, Volta, opinando la sua tarda età, si ritirò da ogni carica politica e si stabilì nella sua amata Como ove trascorse gli ultimi anni. Agli ultimi di febbraio del 1827, assalito da febbre reumatica si pose a letto; si aggravò rapidamente e si spense il 6 marzo. Fig. 5. Pile di Volta a tazza e a colonna (da incisioni dell’epoca) La vicenda di Meucci, inventore del telefono Antonio Meucci nacque a Firenze, il 13 aprile 1808, in una casetta di via dei Serragli. Giovanissimo entrò al servizio del Granduca Leopoldo in qualità di custode delle porte della città: il suo compito era la verifica dei passaporti. Tale mansione, per il suo carattere burocratico, poco si adattava alla sua indole; lasciò l’ufficio per lavorare presso un certo Alessandro Linari, impresario teatrale. 28 Grazie alla sua mente ingegnosa, Meucci ben presto seppe distinguersi nell’immaginare nuovi dispositivi scenici. Frequentando la sartoria teatrale, di cui era pure proprietario Linari, conobbe Ester Mocchi, un’operaia toscana, e la sposò. Nel 1833 il Tacon Opera House dell’Avana offrì ai due coniugi una buona scrittura: a lui come attrezzista teatrale, a lei come sarta. La prospettiva del lungo viaggio fu accolta con entusiasmo dal Meucci. In questo soggiorno il giovane fiorentino ebbe la prima idea della sua invenzione. A conferma, molti anni dopo, Ester Meucci scriveva in una sua lettera: «Fu alla Avana che, dopo molte prove, mio marito riuscì, benché ancora debolmente, a parlare con persone che si trovavano poste al di là della strada». Nel 1841 l’incendio del teatro in cui lavorava privo Meucci della sua occupazione e lo convinse a trasferirsi negli Stati Uniti per trovare appoggi per la sua invenzione: si trasferisce così a New York. Nel 1845 si stabilisce a Olifton, nell’isola di Long Island, dove acquista una modesta casetta. Spinto dalle necessità economiche, impianta col tenore Salvi una piccola fabbrica di candele, destinata a diventare storica malgrado il suo modesto sviluppo. Qui Meucci, fervente patriota, nonostante i suoi modesti mezzi aiuta gli emigrati politici italiani e accoglie il profugo Garibaldi che fu per tre anni, dal 1850 al 1853, il suo collaboratore. Seppur dedito alla sua attività, in questo periodo non abbandona l’idea della trasmissione della voce. Qualche persona, invitata alle prove, considera i suoi apparecchi giocattoli, anziché gli elementi di quella che diverrà una delle più straordinarie scoperte moderne. A settimane d’intense ricerche succedono lunghi periodi di scoraggiamento: i finanziamenti si rivelano indispensabili e necessari e allo scopo. All’inizio del 1857 incarica un amico, il disegnatore italiano Nestore Corradi residente a New York, di eseguire alcuni schizzi dei suoi apparecchi. Questi disegni (che furono poi allegati ad una prima domanda di brevetto) sono senza dubbio eloquenti: uno di essi rappresenta due persone che telefonano e, se ciò non bastasse, sotto di esso il Meucci scrive: «L’invenzione consiste in un diaframma vibrante e in un magnete elettrizzato da un filo a spirale, che lo avvolge. Il diaframma vibrando al suono della parola, ad ogni vibrazione altera la corrente del magnete, producendo una serie di interruzioni elettriche rapidissime quanto i movimenti vibratori del diaframma. Queste alterazioni di corrente trasmettendosi all’altro capo del filo imprimono analoghe vibrazioni al diaframma ricevente, riproducendo la parola». Nel 1860 Meucci incarica un amico, Enrico Bandelari, di cercare gli investitori necessari a costituire una società di sfruttamento, a cui dà il nome di Teletrophone Company: i risultati sono disastrosi… la sottoscrizione riesce a raccogliere appena 20 dollari! Passano ancora degli anni, durante i quali la situazione economica di Meucci peggiora ulteriormente: ceduta la fabbrica di candele, tenta altre attività con risultati sempre più infelici. Eppure in questa situazione precaria si aggrappa sempre più alla sua invenzione come ancora di salvezza dal naufragio. Racimolata una modesta somma, costruisce nuovi apparecchi e si decide finalmente a chiedere un brevetto che ne salvaguardi i diritti. Questo gli viene concesso dall’Ufficio Brevetti di Washington il 28 dicembre 1871. Ottenuto il titolo ufficiale di proprietà, si guarda intorno per cercare di nuovo chi sia disposto a fornirgli la possibilità di eseguire una prova in grande stile, atta a persuadere gli increduli. Si rivolge così a Grant, direttore della società telegrafica Western Telegraph Company. L’accoglienza ricevuta gli fa sperare di aver finalmente trovata la strada giusta. Grant s’interessa vivamente alla cosa: chiede chiarimenti, disegni, promettendo esperimenti a breve scadenza. Però, quando si giunge al momento di passare dalle parole ai fatti, tutto cade nel silenzio. Con varie scuse l’inventore è tenuto in sospeso e le prove rimandate di mese in mese, quando, stanco e disilluso, Meucci chiede la restituzione del suo incartamento che gli viene detto esser stato smarrito. Solo in seguito si saprà quanto questa strana e poco credibile scomparsa nascondesse in realtà. Intanto le condizioni finanziarie del povero inventore si fanno sempre più disastrose: ferito dallo scoppio di una caldaia è costretto, per lungo tempo, ad astenersi da qualsiasi lavoro. Meucci arriva alla soglia della miseria assoluta e, per mangiare, la moglie deve alienare gli oggetti più indispensabili. Infine anche i modelli degli apparecchi sono costretti a seguire la stessa sorte: vengono ceduti al prezzo di 6 dollari a un mercante di oggetti usati. Inoltre, per mancanza della somma indispensabile a pagare le relative tasse, anche il brevetto del 1871 non rinnovato, è scaduto. 29 Una delle maggiori invenzioni del XIX secolo sembra ormai destinata all’oblio, ma improvvisamente sorge un fatto nuovo. Il 6 febbraio 1876, alle due del pomeriggio, si presenta al direttore dell’Ufficio Brevetti di Washington un certo professor Graham Bell di Boston, con una richiesta di brevetto per un sistema atto a trasmettere elettricamente a distanza la parola. Un’ora dopo, identica domanda del signor Elisha Grey di Chicago. Il direttore è perplesso: nella sua lunga carriera non gli è mai capitato un fatto simile. La legge americana è severissima per tutto ciò che riguarda brevetti e richiede il giuramento, con relative sanzioni penali, quando una priorità può lasciare dubbi. Bell, giura, è giunto primo: quindi gli spetta il diritto di precedenza. Grey intenta contro di lui un processo, ma lo perde ed è condannato a risarcire danni e spese. Le prime esperienze di trasmissione telefonica sono intanto compiute pubblicamente a Boston e sul finire dello stesso 1876, ripetute a Filadelfia, approfittando di una esposizione. Il successo sorpassa ogni aspettativa. Lord Kelvin, che vi assiste, proclama la nuova invenzione: «Meraviglia delle meraviglie». Viene costituita una grande società per lo sfruttamento dell’invenzione e si installano i primi impianti che si moltiplicano con una rapidità vertiginosa. Le azioni della nuova società vanno alle stelle, tanto più che essa, con ogni mezzo, riesce a creare un vero monopolio. Un gruppo di italiani, che conosce i diritti di Meucci, si riunisce e tenta di ottenere per il reale inventore un adeguato compenso. La lotta fin dall’inizio si dimostra impari e la società Bell, con capitalizzazione ormai milionaria, crea una così fitta rete d’intrighi da far naufragare ogni tentativo e nel 1884 la pratica è abbandonata. Le diatribe legali non finiscono però qui. L’anno dopo, il 17 agosto, due americani, Benthiysen di New York e Huntington di Mississipi, in risposta ad un’azione giudiziaria iniziata contro di loro dal monopolio Bell, rispondono con una denuncia per falso e frode in cui è affermano: «Graham Bell ha coscientemente giurato il falso dichiarandosi primo inventore del telefono». La vertenza, restata fino allora nell’ambito d’interesse privato, diventa di dominio pubblico, tanto più che il maggior danneggiato è lo stesso governo federale degli Stati Uniti, costretto fino ad allora a pagare grosse somme per fare uso dei brevetti Bell. Viene quindi ordinata una rigorosa inchiesta i cui i risultati non tardano a spingere l’autorità ad iniziare una procedura penale. La società Bell corre ai ripari appoggiandosi a una furiosa campagna di stampa contro gli avversari. Gli interessi economici in gioco e la disputa diventano così grandi da spingere il presidente degli Stati Uniti, Cleveland, all’intervento: ordinò la sospensione di ogni azione. Questa intromissione, giudicata anticostituzionale, provoca una reazione ancora più violenta; gli avversari del governo ne fanno una piattaforma politica. Vi è intanto chi pronuncia il nome di Meucci e sopra questo nome s’ingaggia una furiosa battaglia. Sotto la crescente pressione dell’opinione pubblica la procedura è riaperta e i giornali non tardano a rivelare circostanze gravi e sospette: si viene a sapere così che i disegni di Meucci sono misteriosamente scomparsi dall’Ufficio Brevetti di Washington. Si apprende che la società Bell, fin dall’inizio, si era impegnata a versare alla Western Telegraph il 20% dei suoi utili, cifra che per il periodo 1881-85, ammontava all’enorme somma di oltre due milioni di dollari. Viene allora fuori la storia dei disegni e descrizioni dell’invenzioni consegnati da Meucci a uno dei direttori della Western e che erano andati misteriosamente perduti e mai restituiti. A questo punto la causa procede serrata; sono chiamati a deporre i più noti scienziati degli Stati Uniti finché, dopo alterne vicende, nel dicembre del 1886 la Suprema Corte Federale degli Stati Uniti emana la sentenza definitiva che dichiara accertata la priorità dell’italiano Antonio Meucci nell’invenzione del telefono, invenzione di cui Graham Bell si è fraudolentemente appropriato. Una vittoria unicamente morale perché i difensori dell’inventore italiano, logorati dalle lunghe cause, si erano da tempo ritirati. D’altra parte nessun diritto spettava al Meucci: il suo brevetto, non rinnovato, era scaduto fin dal 1873. Il processo, che per più di un lustro aveva appassionato gli Stati Uniti, cadde un po’ alla volta nell’oblio e Graham Bell poté continuare, indisturbato, ad accumulare milioni su milioni. 30 L’11 giugno 1882, nove giorni dopo la morte di Giuseppe Garibaldi, un grande corteo di italiani si era recato in pellegrinaggio alla casetta di Long Island, passata di proprietà al tedesco Bachmann, noto fabbricante di birra. In quell’occasione il Bachmann dichiarò di donare agli italiani la casa che aveva ospitato Garibaldi, ponendo come condizione che Antonio Meucci la potesse occupare vita natural durante. L’inventore vi passò gli ultimi anni, assistito dalla famiglia Nissini alla quale era legato da cara amicizia. La morte lo colse il 18 ottobre 1889. Alcuni anni dopo la storica casetta venne minacciata da necessità edilizie e, per iniziativa della Società Garibaldi di State Island, fu trasportata in un terreno acquistato con la generosità degli emigrati italiani ivi residenti. Il primo monumento all’inventore fu inaugurato il 16 settembre 1923, grazie alla sottoscrizione lanciata dall’Ordine dei Figli d’Italia in America. In Italia l’eco della vicenda di Meucci non aveva ricevuto grandi attenzioni. Il primo riconoscimento arrivò solo nel 1924 con una targa marmorea nel palazzo delle poste e telegrafi di Firenze. L’opera del grande inventore fiorentino venne celebrata per la prima volta dal mondo scientifico ed accademico nel 1930, a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche presieduto da Guglielmo Marconi: fu pubblicato un opuscolo, grazie all’ingegner Luigi Respighi, in cui erano riuniti i principali documenti della priorità Meucci. Fig. 6. Telefono di Meucci. Questo disegno fu tracciato nel gennaio del 1857 dal pittore Nestore Corradi di New York. Servì poi a documentare il brevetto rilasciato dall’Ufficio Brevetti di Washington il 28 dicembre 1871 L’algoritmo di Viterbi e la telefonia mobile Viterbi è nato a Bergamo il 9 marzo 1935. Nel 1939 la sua famiglia si trasferì a Boston a causa delle leggi razziali approvate in Italia. I genitori, all’età di 6 anni, cambiarono il suo nome in Andrew. A Boston Viterbi compì il suo percorso scolastico fino al conseguimento del Master presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Proprio al MIT i suoi interessi si indirizzarono verso le problematiche innovative della comunicazione per mezzo di segnali digitali, ossia segnali che rappresentano le informazioni in forma numerica. Nel 1957 Viterbi si trasferì in California, dove iniziò a lavorare presso il Jet Propulsion Lab del California Institute of Technology. In quel periodo i suoi interessi si concentrarono su una tecnica di trasmissione innovativa chiamata “spread spectrum” (a spettro distribuito), che consiste nell’impiegare per la trasmissione una gamma di frequenze più ampia rispetto a quella strettamente necessaria per l’invio dell’informazione 31 desiderata. In questo campo Viterbi ottenne importanti risultati teorici nell’ambito della comunicazione digitale, occupandosi in particolar modo di metodi di codifica e decodifica. Questi temi costituirono l’argomento della sua tesi di dottorato, conseguito nel 1962 presso la University of Southern California, e alimentarono le conoscenze del suo gruppo di lavoro al Jet Propulsion Lab che progettò l’impianto di telemetria per il primo satellite americano, Explorer 1. Le idee di Viterbi diedero un contributo determinante alla soluzione di due importanti problemi che dovettero essere risolti per mantenere i contatti con il satellite: la debolezza dei segnali ricevuti, dovuta alla distanza, e il continuo cambiamento della frequenza dei segnali stessi, causato dal movimento orbitale. Nel 1963 iniziò la propria carriera accademica come professore presso la School of Engineering and Applied Sciences della University of California, Los Angeles (UCLA), posizione che mantenne fino al 1973. Nel 1967 pubblicò sulla rivista IEEE Transactions on Information Theory un articolo dal titolo Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum Decoding Algorithm. Si trattava di un algoritmo profondamente innovativo, noto oggi universalmente come “Algoritmo di Viterbi” e destinato a contribuire in modo determinante allo sviluppo successivo della teoria dell’informazione e delle telecomunicazioni. L’algoritmo fu originariamente concepito per la trasmissione dati nello spazio, ove bisogna tener conto di condizioni avverse che possono produrre variazioni casuali del segnale trasmesso. Questo problema viene normalmente affrontato utilizzando codici che introducono un’opportuna ridondanza per proteggere i segnali da confusione al lato del ricevitore. Una classe importante è costituita dai cosiddetti codici convoluzionali, in cui si prevede che i dati originali vengano trasformati e ripetuti tramite un’opportuna operazione matematica. Infatti, mentre nei codici cosiddetti a blocco si applica la stessa codifica ai singoli blocchi in cui il flusso di dati viene suddiviso, nei codici convoluzionali la codifica intreccia porzioni di blocchi del flusso originario di dati e ogni simbolo partecipa alla determinazione di simboli di codice un elevato numero di volte. Poiché la codifica convoluzionale rende il flusso di dati particolarmente interdipendente, la decodifica richiede calcoli molto più complessi di quanto sia necessario in una codifica a blocchi disgiunti. L’algoritmo di Viterbi interviene proprio in fase di decodifica per determinare quale sequenza di dati trasmessi sia la più probabile causa del flusso osservato in uscita. L’algoritmo calcola la probabilità dei diversi flussi in ingresso in modo ricorsivo, eliminando in blocco, ad ogni passo, quelli di probabilità minore. Tale eliminazione permette una notevole riduzione della complessità delle operazioni di calcolo necessarie. Il modello stocastico cui si applica l’algoritmo di Viterbi è sufficientemente generale da adeguarsi alla descrizione di fenomeni di diversissimo genere. Di conseguenza, man mano che lo sviluppo scientificotecnologico lo permetteva, l’uso dell’algoritmo si è esteso a molti altri campi in cui il fenomeno studiato è modellabile tramite una cosiddetta catena di Markov nascosta. In particolare, i campi di applicazione dell’algoritmo comprendono attualmente la biologia computazionale, la linguistica computazionale ed il riconoscimento vocale. Durante il periodo in cui era professore a UCLA, Viterbi sviluppò un interesse crescente per l’attività di tipo imprenditoriale, che lo portò a fondare nel 1968 la società Linkabit, assieme ai due colleghi Irwin Jacobs (UCSD) e Leonard Kleinrock (UCLA), uno dei “padri” della rete Internet. La Linkabit inizialmente sviluppava studi e simulazioni riguardanti l’algoritmo di Viterbi per conto di agenzie governative e col tempo si procurò importanti commesse. Nella metà degli anni 70, la Linkabit vinse un contratto per la realizzazione delle apparecchiature per le comunicazioni radio tra le stazioni di terra e l’intera flotta dello U.S. Air Force’s Strategic Air Command. La tecnologia sviluppata dalla Linkabit fece da precursore alle attuali “Wireless Wide Area Networks” nonché ai modem WiFi attualmente implementati nei computer portatili. Nel 1985 Viterbi e Jacobs fondarono una nuova società, la Qualcomm, destinata a divenire un gigante dell’industria e leader nel settore delle telecomunicazioni. Qualcomm è oggi nota al grande pubblico soprattutto per aver sviluppato il diffusissimo software Eudora per la posta elettronica. Qualcomm contribuì inizialmente alla progettazione di un innovativo sistema di satelliti in orbita bassa (precursore dei successivi Iridium e Globalstar), nonché del sistema satellitare Omnitracs per la localizzazione dei mezzi di trasporto e la comunicazione fra questi e le centrali operative. Nello sviluppo di tali sistemi, Viterbi affrontò il problema di permettere la “multiplazione”, ossia la trasmissione contemporanea di informazioni da parte del più elevato numero possibile di mezzi di trasporto, senza che a causa di tale contemporaneità le trasmissioni interferissero l’una con l’altra. 32 Viterbi, sfruttando la propria grande esperienza accumulata nel campo della teoria dell’informazione e delle telecomunicazioni, contribuì ancora una volta all’avanzamento delle conoscenze del settore, lavorando allo studio ed al raffinamento di una forma di multiplazione innovativa, il CDMA (Code Division Multiple Access), che prometteva prestazioni nettamente superiori rispetto a quelle delle tecniche tradizionali. Usando il CDMA, tutte le trasmissioni avvengono contemporaneamente ed utilizzano la stessa banda di frequenze. La caratteristica innovativa ed unica del CDMA è che ad ogni trasmissione dati si assegna uno specifico codice, diverso da tutti gli altri. La struttura matematica dei codici CDMA garantisce che comunicazioni simultanee non si disturbino a vicenda: decodificando tutti i segnali presenti nell’etere con uno specifico codice si ottengono esclusivamente i dati originariamente codificati con quello stesso codice, mentre le comunicazioni degli altri utenti, che usano codici diversi, appaiono come rumore che la decodifica è in grado di scartare. L’esperienza accumulata durante lo sviluppo di Omnitracs permise alla Qualcomm di entrare come protagonista di primo piano nel campo della telefonia cellulare. In quegli anni la telefonia cellulare di prima generazione, basata sull’uso di segnali analogici, era in fase di rapidissima espansione. Contemporaneamente era in corso la fase di standardizzazione riguardante la seconda generazione (digitale), nella quale Qualcomm irruppe proponendo l’adozione del CDMA quale alternativa alle tecniche concorrenti allora in gara, ovvero FDMA (Frequency Division Multiple Access) e TDMA (Time Division Multiple Access). Viterbi si prodigò per far conoscere e diffondere il CDMA, tanto nella comunità scientifica quanto nell’ambito di commissioni federali e internazionali e presso altre aziende, fino a riuscire nell’intento di far riconoscere nel 1993 il CDMA come standard per la telefonia cellulare di seconda generazione, a fianco del TDMA. Nell’anno 2000 erano in funzione nel mondo circa 50 milioni di telefoni cellulari basati sul CDMA, di cui circa 20 in America e 30 in Asia. L’Europa, invece, scelse il solo TDMA per la rete GSM, sviluppata negli stessi anni. Grazie alla sua superiorità concettuale, il CDMA è rientrato prepotentemente in scena nella telefonia cellulare cosiddetta di terza generazione, ossia digitale e a larga banda, tanto che il sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) prevede l’impiego del W-CDMA, un’evoluzione a larga banda del CDMA originale. Oggi oltre un miliardo di telefoni cellulari in tutto il mondo, tanto di seconda che di terza generazione, hanno come fattore comune l’utilizzo dell’algoritmo di Viterbi in fase di correzione degli errori. Viterbi ha ottenuto importanti e numerosi riconoscimenti ed è stato eletto membro di prestigiose accademie. Tra i principali riconoscimenti: il Premio Cristoforo Colombo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1975), l’ IEEE Alexander Graham Bell Medal (1984), il titolo di Grande ufficiale della Repubblica Italiana (2001), l’IEEE Claude Shannon Award. Ritiratosi dall’industria, Viterbi si è dedicato in particolar modo alla filantropia, attraverso la Viterbi Family Foundation. Natta e il polipropilene Giulio Natta nacque a Porto Maurizio (ora Imperia) il 26 febbraio del 1903 da una famiglia di giudici e avvocati. Dopo gli studi liceali si iscrisse alla facoltà di ingegneria del capoluogo ligure e terminò gli studi al Politecnico di Milano. Entrò, come allievo interno, nel laboratorio di Giorgio Renato Levi: al Politecnico era appena giunta un’apparecchiatura tedesca (in conto riparazioni belliche!) adatta per lo studio dei cristalli con i raggi X e il giovane Natta si appassionò a questa nuova area di ricerca. La sua principale scoperta scientifica ebbe un’applicazione quasi immediata sul piano pratico e questo è un evento che avviene di rado. Poco importa che il suo lavoro sia stato più applicativo che di ricerca pura. Il nome di Giulio Natta è legato allo sviluppo impetuoso della chimica macromolecolare che risale agli anni cinquanta e si fonda sul processo detto di polimerizzazione. Esso consiste nel passaggio da un componente chimico a basso peso molecolare a un composto ad alto peso molecolare, ad esempio nel passaggio da un gas ad una materia plastica. Appena dopo la laurea Natta ha il suo primo incarico nel 1925 e diventa libero 33 docente nel 1927, a ventiquattro anni. Nel 1932, alla vigilia della cattedra, fruisce di una borsa e va a Friburgo nel laboratorio del fisico Seemann per imparare le tecniche di diffrazione elettronica. A Friburgo lavorava anche Staudinger e Natta ebbe qui un incontro precoce con gli alti polimeri. Durante la guerra i chimici italiani, tra cui Natta, furono spinti a cercare di migliorare la produzione industriale italiana e infrangere così il monopolio che la Germania deteneva nella chimica europea. A partire dal 1938, Natta contribuì alla costruzione dell’impianto per la produzione della gomma sintetica a Ferrara. Nel dopoguerra avvenne l’incontro fondamentale con l’imprenditore Pietro Giustiniani. I due intrapresero un viaggio negli Stati Uniti per constatare da vicino sia il livello tecnico dell’industria chimica americana, sia gli orientamenti del management. Entrambi furono colpiti da due fatti che non avevano riscontro in Europa: le strutture di ricerca industriale impiegavano migliaia di ricercatori e la produzione aveva in gran parte abbandonato il carbone, come materia prima, per orientarsi verso la petrolchimica. Al ritorno dal viaggio Giustiniani strinse con Natta un accordo di collaborazione strategica, con cui metteva a disposizione del grande chimico industriale uomini e mezzi adeguati per stabilire al Politecnico di Milano un centro di ricerca avanzata. Il programma di collaborazione ebbe un’impennata imprevista nel 1952. Durante un Convegno a Francoforte Natta ascoltò una conferenza di Karl Ziegler sulla reazione di Aufbau, da lui recentemente scoperta. Questa reazione permetteva di ottenere dei bassi polimeri dell’etilene ‘lineari’. Ziegler aveva già pubblicato e parlato su questo, ma nessuno, apparentemente, ne era stato scosso. Giulio Natta, invece, lo fu e convinse Giustiniani ad invitare Ziegler a Milano, dove si firmò un accordo con il quale la Montecatini acquistava i diritti per lo sviluppo industriale in Italia delle scoperte di Ziegler e Natta otteneva l’accesso agli studi del chimico tedesco. II tedesco Karl Ziegler, professore presso l’Istituto Max Planck di Mülheim, operando su di un gas, l’etilene, e passando a una sostanza plastica, il polietilene, riuscì a mettere a punto un sistema che già facilitava notevolmente la trasformazione dall’uno all’altra. Prima delle ricerche di Ziegler tale processo richiedeva una temperatura di 200 gradi e una pressione di ben 1000 atmosfere. Lo scienziato tedesco trovò il modo di operare a temperatura ambiente e con pressione di una atmosfera. Eliminate le complicatissime apparecchiature prima indispensabili, eliminato il grave pericolo di esplosione dovuto all’alta temperatura e all’alta pressione, era finalmente possibile la produzione su scala industriale della sostanza plastica ricavata dal gas. Natta, utilizzando il metodo elaborato da Ziegler per la trasformazione del gas in sostanze plastiche, lo applicò ad un gas diverso dall’etilene, sul quale aveva operato lo scienziato tedesco. Il ricercatore italiano impiegò il propilene, da cui ottenne una nuova sostanza plastica: il polipropilene. La sua migliore qualità sta nel fatto che essa fonde a 180 gradi; essa può inoltre prendere sia la forma di materia plastica (il moplen), sia quella di filato sintetico (il meraklon), ambedue di facile lavorazione e di elevata resistenza. Un alto punto di fusione in una materia plastica significa soprattutto che la si puo usare senza danno per contenere liquidi bollenti o la si può stirare se è in forma di fibra. Le applicazioni industriali della scoperta di Natta sono dunque vastissime e di uso molto comune. Sotto la guida di Natta furono pubblicati oltre 1200 articoli; egli stesso ne firmò 540, oltre a circa 500 brevetti. La Montecatini cominciò la produzione commerciale del polipropilene nel 1957. Nel 1962 la produzione mondiale del polietilene ad alta densità di Ziegler e del polipropilene di Natta raggiungeva le 250000 tonnellate; l’anno successivo i due scienziati ricevettero congiuntamente il premio Nobel per la chimica. Giulio Natta morì a Bergamo il 2 maggio 1979. 34
Scaricare