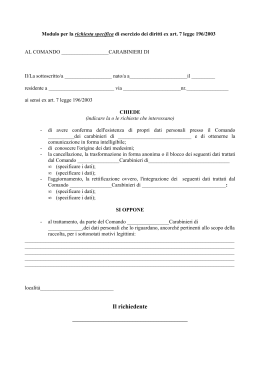Terrorismo Brigate Rosse Via Fracchia VIA FRACCHIA 12, INTERNO 1: LA STRAGE DI GENOVA Se non si trattasse di uno dei capitoli più tragici e per molti versi tra i più cupi della stagione del terrore, si potrebbe cominciare con lo scrivere nella migliore tradizione dei romanzi d'appendice - che a Genova era "una notte buia e tempestosa". Già, perché quella notte del 28 marzo 1980 su Genova pioveva a dirotto. Pioveva e tuonava. Ma il dato meteorologico, in quelle ore tenacemente ostinate a non voler lasciare spazio ad un'alba uggiosa e bagnata, non ha molto peso in questa storia di morti ammazzati, di giovani carabinieri feriti, di terroristi "pentiti", di generali decisi a tutto e di uomini politici intenti a barcamenarsi fra ragion di Stato, figlioli prodighi (di sangue?) e interventi legislativi. Quello che si solleva a Genova, in quella orribile notte che dà sull'alba, in via Fracchia 12, interno 1, è un sipario che mostra più ambiguità che certezze, che lascia intravedere più che vedere. Un sipario che nessuno ancora oggi, a distanza di anni ed anni, ha avuto il coraggio di sollevare del tutto. Poteva essere una data importante, forse fondamentale, nella lotta che si combatte da otto anni contro il terrorismo e che lo Stato ha mostrato di voler intensificare dopo la morte di Moro. Si rivelerà invece un giorno debole. Un giorno colmo di vergogna. Forse uno dei giorni più brutti e odiosi degli anni di piombo. L'operazione scatta alle 4.10. Gli uomini che circondano la palazzina al 12 di via Fracchia, una costruzione un po' trasandata, affacciata su una curva a gomito che in discesa porta dal quartiere Oregina, verso la parte bassa della città, sono in gran parte in borghese. Ma la loro presenza, nonostante l'ora prossima alle prime luci, non sfugge ai pochi occhi indiscreti che da dietro le persiane socchiuse osservano intimoriti i movimenti silenziosi e percepiscono, alla lontana, gli ordini impartiti sottovoce. Che quelle figure che si muovono furtivamente siano poliziotti o carabinieri non ne dubita nessuno. Sono carabinieri. Carabinieri un po' particolari, quelli che fanno parte, da quasi un anno, dello speciale nucleo creato dal gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa per combattere l'eversione armata di sinistra in modo deciso e frontale. Quegli occhi indiscreti scompaiono all'improvviso dall'ombra delle persiane socchiuse, quando una gragnuola incessante di spari travolge il silenzio del quartiere. Come è spesso accaduto in questi terribili anni è un flash dell'Ansa a diffondere le prime notizie che subito i giornali radio trasmettono. Alle 6.53, quando ancora le redazioni dei quotidiani sono deserte, le telescriventi battono queste poche righe: "Secondo le prime notizie giunte a Roma, quattro presunti terroristi sono stati uccisi in un conflitto a fuoco con i carabinieri avvenuto all'alba a Genova. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un sottufficiale dell'Arma. Le persone morte sono tre uomini ed una donna". La segnalazione, stringata ma esatta nei pochi particolari, è giunta ad un giornalista dell'agenzia svegliato a casa dal Comando generale dei carabinieri. Anche le successive notizie che l'Ansa trasmette alle 6.59 e alle 7.42 sono essenziali e precise. Contengono dapprima l'indicazione del quartiere e l'ora in cui il "conflitto a fuoco" è avvenuto e poi anche l'esatta indicazione della via e del numero civico. La terza notizia dell'agenzia sottolinea un particolare importante: "È trapelato che nell'appartamento di via Fracchia sono stati trovati numerosi documenti che potrebbero essere di notevole interesse". Attorno alle 9.00 il comando generale dell'Arma diffonde sull'operazione un comunicato che per ben 11 giorni sarà l'unica notizia ufficiale per chi vuole conoscere la verità dei fatti: "L'operazione antiterrorismo condotta stamane in Italia settentrionale e coordinata dal Comando generale dei carabinieri, dopo laboriose indagini che avevano consentito la localizzazione di covi e basi logistiche di formazioni eversive a Genova, Torino e Biella - afferma il comunicato - è scattata simultaneamente poco dopo le quattro di stamane con largo spiegamento di mezzi e militari dell'Arma dei gruppi di Genova, Torino e Vercelli e delle sezioni anticrimine, che nella circostanza indossavano giubbotti e caschi protettivi. A Genova i carabinieri, fatti segno a colpi di arma da fuoco, hanno reagito prontamente, sostenendo un violento conflitto nel corso del quale i quattro occupanti dell'appartamento, tre uomini e una donna, sono rimasti uccisi, mentre un sottufficiale dell'arma è rimasto ferito. A Torino e Biella sono state localizzate due basi logistiche ed arrestati sei presunti brigatisti e fiancheggiatori. Sono stati rinvenuti esplosivi, armi, materiale e documenti che sono tuttora al vaglio dei carabinieri. Il comandante generale dell'Arma, gen. Umberto Cappuzzo, ha fatto pervenire ai militari operandi il suo vivissimo elogio. L'operazione è tuttora in corso". E "in corso" lo resterà, se è vero che mai come in questa occasione le notizie fluiranno con il contagocce, per giorni e giorni. Ma cosa è successo in via Fracchia? Chi sono i quattro brigatisti uccisi? Perché il sottufficiale Rinaldo Benà è rimasto gravemente ferito (si saprà quasi subito ad un occhio, che perderà dopo un intervento chirurgico)? Non indossava, come il comunicato del comando si è affrettato a sottolineare, il casco protettivo? Al di là del comunicato ufficiale, i carabinieri - sempre così prodighi di informazioni quando una loro operazione riesce - questa volta tacciono oppure forniscono a mezza bocca ai giornalisti versioni smozzicate, confuse e contraddittorie. Non solo: il cordone che dalle 4 si è stretto attorno a via Fracchia è quanto mai impenetrabile. Tempi tecnici per vuotare il covo brigatista degli "importanti documenti" trovati? La necessità di non "bruciare" un'"operazione tuttora in corso"? Oppure un certo malcelato imbarazzo per la carneficina avvenuta all'interno dell'appartamento? 1. Via Fracchia: la verità sequestrata I giornalisti che nella prima mattinata arrivano a Genova si trovano di fronte ad uno strano ed insolito muro di silenzio. Fanno appena in tempo a vedere da lontano quattro bare, fatte con legno grezzo, trasportate fuori dall'androne dello stabile di via Fracchia e due pulmini dei carabinieri sui quali vengono caricati pacchi e grossi sacchi neri di quelli usati per le immondizie con dentro, si ritiene, il materiale trovato nell'appartamento. I carabinieri - questa l'impressione dei giornali - hanno "sequestrato" l'operazione. Letteralmente. Scrive Antonio Ferrari, inviato del Corriere della Sera: "Fuori dal condominio di via Fracchia giungono le auto della Digos. Ma sono costrette a rientrare in questura. A dieci metri dalla casa c'è un cordone insuperabile. Non si passa. Compongo il numero di telefono di Annamaria Ludmann. Risponde un carabiniere 'Sono un giornalista, quando possiamo entrare?' 'Né ora, né dopo. Si 1 rivolga al comando'. Al comando dell'Arma dicono che gli "ufficiali sono fuori" . Un nome comunque è spuntato: è quello di Annamaria Ludmann. È figlia dell'intestatario dell'interno 1 di via Fracchia 12, il capitano di lungo corso Corrado. Lei è un'insegnante di francese di 33 anni, separata, una ragazza modesta, bruttina, strabica, militante delle Brigate rosse, nome di battaglia "Cecilia". Una semplice militante che, lo si apprenderà subito, non era ricercata, né all'interno dell'organizzazione svolgeva un ruolo importante. Non aveva partecipato ad alcuna azione. Aveva un solo e semplice compito, quello di mettere a disposizione delle BR l'appartamento di via Fracchia, lasciatole in eredità dal padre, morto nel '77. Insomma Annamaria Ludmann è sì una brigatista, ma un pesce davvero piccolo. La proprietaria di un "covo", la vivandiera di un gruppo di terroristi della 1 Cfr. Il Corriere della Sera (30-3-1980). colonna genovese che si riuniva a casa sua. Chissà, forse lavava e stirava loro la biancheria. Quello della Ludmann è il primo nome che salta fuori. Ma non sono i carabinieri a fornire l'informazione. Loro continuano a dire di non sapere nulla. E non stanno mentendo. Di quel massacro sanno davvero poco. Praticamente solo di averlo fatto. Chi sono gli altri tre brigatisti? Nessuno lo sa. Sono pesci piccoli come la Ludmann o clandestini? Brigatisti di supporto come Annamaria o regolari? Fornitori di vitto e alloggio come l'insegnante di francese o membri della direzione strategica? E ancora: se i carabinieri hanno colpito a colpo sicuro in via Fracchia cosa aspettavano di trovarvi e soprattutto chi? Uomini o materiale? Quest'ultimo interrogativo è quanto mai lecito se si tiene conto di quanto confiderà quasi due anni dopo a Massimo Caprara, giornalista di punta, ex segretario di Palmiro Togliatti, il procuratore capo di Genova Squadrito: "La verità è che abbiamo trovato un tesoro. Un arsenale di armi... Soprattutto una 2 trentina di cartelle scritte meticolosamente da Aldo Moro alla DC, al Paese" . Allora Dalla Chiesa e i suoi uomini cercavano terroristi o documenti? E che terroristi e quali documenti? Ancora Massimo Caprara scrive: "Qualcosa in particolare impegna il generale Dalla Chiesa nell'inverno del 1980. La lunga serie delle lettere del presidente incarcerato non è completa. Nella lettera del 25 aprile (1978. NDA) Moro minaccia testualmente: 'Io sarò ancora come punto irrinunciabile di contestazioni e di alternativa'. La dichiarazione ha avuto un seguito materiale scritto di suo pugno... In via Montenevoso (a Milano. NDA) è conservato un testo manoscritto del presidente della DC mai fatto circolare. Il 28 marzo in via 3 Fracchia... perché uccidere visto che si erano arresi?" . L'allusiva prosa di Caprara non è delle più chiare, ma sta di fatto che certamente gli uomini di Dalla Chiesa non sanno chi troveranno in via Fracchia, se è vero che ancora il giorno successivo al massacro brancolano nel buio circa l'identità degli altri tre terroristi. Il 29 marzo sono le BR a farsi vive con un volantino in cui indicano in "Pasquale, operaio della Lancia di Chivasso", "Roberto, operaio marittimo" e "Antonio, operaio Fiat" i nomi di battaglia dei tre brigatisti 2 3 Cfr. Pagina (25-2-1982). Ibidem. Da notare che Caprara, riferendosi al covo brigatista milanese di via Montenevoso, parla di un “manoscritto del presidente della DC mai fatto circolare”, particolare questo che emergerà solo otto anni dopo, quando questo documento salterà fuori quasi per caso, nascosto dietro ad un tramezzo. Questo particolare riferito da un giornalista significa che quel documento, in realtà, era già noto, certamente al gen. Dalla Chiesa e ad ai suoi uomini. E che non fu trovato casualmente, otto anni dopo, ma fu fatto trovare per chissà quale gioco politico. sconosciuti. Due di essi, aggiungono, "Roberto" e "Antonio" fanno parte della direzione strategica dell'organizzazione, il vertice massimo delle Brigate Rosse. Due pezzi da novanta dell'eversione, quindi. Ma Dalla Chiesa e i suoi carabinieri lo sapevano? Nel maggio 1980, a neppure due mesi dalla strage di via Fracchia, davanti ai parlamentari della commissione Moro, lo stesso Dalla Chiesa dirà: "Non potevamo pensare di trovare la Ludmann, che poteva essere e restare solo colei che dava l'appartamento (...). Noi non potevamo sapere che fossero quattro. Sapevamo 4 che potevano essere rintracciati due latitanti e due 'regolari'" . Quindi un'operazione al buio? Un'irruzione alla cieca? Non era forse proprio il gen. Dalla Chiesa il teorico dei lunghi appostamenti, delle investigazioni laboriose e meticolose, dell'uso delle macchine fotografiche? E allora perché tanta fretta nell'irrompere in via Fracchia dove tutto lascia pensare che il superaddestrato nucleo del generale non sapesse né cosa, né tantomeno chi avrebbe trovato? Chi aveva accelerato tanto i tempi dell'operazione? E, soprattutto, chi aveva indicato loro quell'appartamento di via Fracchia? 2. L'imprendibile colonna genovese Ma facciamo un passo indietro. L'operazione di via Fracchia, che segna una sconfitta di portata eccezionale per le BR, anche perché con essa crolla il mito dell'imprendibilità della colonna genovese, ha un antefatto ed un contesto politico, entrambi di particolare rilevanza. L'antefatto è l'arresto di Patrizio Peci, capo della colonna torinese delle BR, primo "pentito" del progetto armato di sinistra. La cattura di Peci e di Rocco Micaletto, quest'ultimo della direzione strategica brigatista, viene resa nota il 21 febbraio 1980 e sarebbe avvenuta due giorni prima, il 19, in una piazza di Torino, Ma c'è chi dice che Peci, in realtà, sia stato catturato due volte, la prima addirittura il 13 dicembre 1979, più di due mesi avanti e che sia stato utilizzato da Dalla Chiesa come infiltrato. Sarà quanto sosterranno le BR un anno dopo, durante il sequestro di Roberto Peci, fratello di Patrizio. E sarà anche quanto "confesserà" alle Br - con dovizia di particolari - lo stesso loro "prigioniero" Roberto. Sta di fatto che la cattura di Peci resterà per sempre un mistero. 4 Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia - Doc. XXIII n 5 - vol. quarto - Roma 1984, pag. 256. Dubbi ne solleverà anche l'allora deputato radicale, lo scrittore Leonardo Sciascia quando, come facente parte della commissione Moro, rivolto al generale Dalla Chiesa gli dirà: "Ho troppa considerazione per lei per credere che i carabinieri non sapessero e lo 5 lasciassero fuggire così" . Era infatti emerso che i carabinieri controllavano già da diversi mesi Peci e Micaletto che poi diranno di aver arrestato il 21 febbraio 1980. "I terroristi sono stati pedinati, fotografati con il teleobiettivo e la foto appare sui giornali (...). Sono braccati e identificati da tempo ma non si conoscono - non li conoscono neppure i giudici - le modalità e il luogo dove i carabinieri hanno stabilito il contatto e quando e come l'hanno perso e quando l'hanno ristabilito. Si parla di 6 infiltrati all'interno delle BR, si dice che vi operino già da un anno" . Si sa anche che la base di corso Lecce a Torino, abitata da Peci e Maria Giovanna Massa, era già stata individuata da tempo e che in essa erano stati trovati i contenitori degli ordigni anticarro utilizzati per gli attentati, falliti, del 15 e il 24 novembre 1979 contro i blindati dei carabinieri e la caserma Lamarmora. Si sa ancora, per certo, che Peci era già controllato dalla polizia e che in corso Lecce i carabinieri precedettero gli agenti - con i quali avevano peraltro stretto il patto di agire insieme - ottenendo però il risultato di trovare la base vuota. "Si viene a conoscenza di un'altra notizia: una volta Peci, pedinato dai carabinieri (...) Si rifugia in una base bR. La luce dell'alloggio è accesa, i carabinieri attendono... Peci 7 scompare da un'altra porta" . Insomma i dubbi sulle modalità dell'arresto di Peci sono molte e del tutto irrisolti8. 5 6 7 8 Ibidem. Cfr. C. Stajano - Op. cit. - pag. 184. Ibidem. Dubbi sul modo e sulla data dell'arresto di Patrizio Peci vengono avanzati anche dalla commissione d'inchiesta sul caso Moro, non soltanto attraverso le domande rivolte al gen. Dalla Chiesa dal deputato radicale Sciascia. Infatti, dopo l'audizione dell'alto ufficiale dei carabinieri dell'8 luglio 1980, la commissione decide di rivolgergli dei precisi quesiti, inviandogli una lettera il 23 luglio. Dalla Chiesa risponde, sempre per lettera, quasi un anno e mezzo dopo, esattamente il 13 dicembre 1981, fornendo una "ricostruzione cronologica della vicenda Peci" che, nella sostanza, ribadisce la versione ufficiale dei carabinieri. In tale "ricostruzione" è detto che: I) "Due uomini le cui caratteristiche fisico somatiche appaiono molto vicine a quelle dei noti latitanti br Peci Patrizio e Micaletto Rocco" vengono intercettati a distanza nel novembre 1979; II) I1 26 novembre 1979 Peci e "l'infermiera Massa Maria Giovanna" vengono pedinati dai carabinieri mentre compiono il tragitto tra la loro abitazione in corso Lecce 25, a Torino, e una cartoleria e viceversa; Si sa soltanto che una volta arrestato e portato in carcere Peci chiede di incontrare Dalla Chiesa. La molla del "pentimento" è scattata. È lo stesso generale a raccontare, nei dettagli, questa seconda fase che porterà il capo della colonna torinese, un altro BR dopo Moretti che viene dalle Marche, a dare il via al fenomeno del "pentitismo": ossia alla trattativa che lo Stato decide di aprire - non sempre alla luce del sole - con vasti settori del partito armato. E che di una trattativa vera e propria si tratti starebbe a dimostrarlo il contesto in cui la strage di via Fracchia si inserisce. Sta infatti per nascere il secondo governo presieduto da Francesco Cossiga, già ministro dell'Interno all'epoca del caso Moro. Un governo che segna il rientro effettivo del PSI nell'esecutivo. I carabinieri arrivano in via Fracchia venerdì 28 marzo: manca una settimana esatta al varo del nuovo governo. Per lunedì 31 è già stato convocato il vertice di maggioranza sul tema "lotta al terrorismo e tutela dell'ordine pubblico". A Montecitorio c'è clima di ottimismo e sui giornali è cominciato il "totoministri". Il presidente della Repubblica Pertini quel giorno è a Pozzuoli al giuramento degli allievi piloti. Da Parigi, per la seconda volta in pochi giorni, il leader comunista George Marchais attacca Berlinguer per il suo incontro con Mitterrand che starebbe a simboleggiare, per i comunisti francesi, una politica di eurosinistra, contrapposta all'ormai morente strategia eurocomunista. Il dollaro sfiora le 900 lire. Il blitz di Genova assume i connotati di un'operazione concertata in grande stile. Non a caso il 22 marzo, sei giorni prima dell'assalto in via Fracchia, il gen. Dalla Chiesa ha chiesto ed ottenuto di incontrare proprio Cossiga che III) IV) V) Subito dopo i due spariscono, nonostante l'appartamento di corso Lecce 25 sia sempre sotto osservazione dei carabinieri; Il 14 dicembre i carabinieri, stanchi di attendere, irrompono nell'appartamento brigatista dove la luce è accesa da giorni. Non vi trovano persone, ma solo armi e documenti; Dopo diversi arresti di brigatisti della colonna torinese (lo stesso 14 dicembre 1979 viene catturato Giuseppe Di Cecco che transitava in corso Lecce; il 15 la sorella gemella Mari Carmela, assieme ad Angela Vai e Giuseppe Mattioli; poche ore dopo Mario Volgarino e Antonio Delfino), il giorno 19 febbraio 1980 "finalmente Peci e Micaletto - è scritto nella 'cronologia' firmata di pugno da Dalla Chiesa - sono arrestati in piazza Vittorio Veneto di Torino". C'è da notare che la "cronologia" del generale dei carabinieri aggiunge due particolari inquietanti. Scrive lo stesso Dalla Chiesa: "I1 16 marzo (1980, 12 giorni prima della strage di via Fracchia a Genova, quando Peci ha già avuto due colloqui con il generale nel carcere di Cuneo ed è già avviato al 'pentimento'. NDA), intanto, si avverte la sensazione che si tenda ad estraniare l'Arma dall"affare Peci, tant'è che l'ufficiale generale è costretto ad intervenire per affermare l'esclusiva competenza dei Reparti Speciali Anticrimine dei Carabinieri, in funzione della precedente complessa operazione (...). Avendo avuto la sensazione di manovre diversive di origine non potuta precisare, la magistratura torinese nella nottata del 21 marzo dispone il trasferimento del Peci da Cuneo a Torino per lo stesso giorno 21". Di “persone qualificatesi come appartenenti alla Digos" che avrebbero parlato con Patrizio Peci nel carcere di Cuneo, promettendogli 500 milioni e la fuga se avesse "confessato" a loro le cose che sapeva sulle BR, parla anche il fratello di Patrizio, Roberto nelle "dichiarazioni" rese alle Brigate Rosse di cui era prigioniero Cfr. nota (21) di questo stesso capitolo. Per la "ricostruzione cronologica della vicenda Peci" fornita dal generale Dalla Chiesa alla commissione Moro si veda: Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia - Doc. XXIII n. 5 - vol. ventisettesimo - Roma 1988, pag. 89. da lì a poco sarà colui che formulerà la famosa legge sui "pentiti" che entrerà, però, in vigore due anni dopo. Quali ipotesi è possibili formulare? a) che Peci, catturato molto prima del 2 febbraio e rimesso in circolazione per ridisegnare la mappa delle postazioni brigatiste a Torino, abbia contrattato con Dalla Chiesa un "trattamento di favore" che poi avrà in cambio di alcune rivelazioni; b) che per poter dare garanzie a Peci, Dalla Chiesa abbia bisogno a sua volta di garanzie politiche che Cossiga gli promette; c) che a Peci, Dalla Chiesa chieda a sua volta informazioni per un'operazione di ampia portata che servirebbe a dimostrare al "palazzo" che i "pentiti" servono; d) che per questo Peci racconti a Dalla Chiesa di un appartamento a Genova in via Fracchia dove... 3. Gli "angoli bui" di via Fracchia Via Fracchia, come abbiamo visto, si trova nella parte alta della città. Oregina è un quartiere abitato da piccola borghesia impiegatizia e da una certa "aristocrazia operaia". Ad un centinaio di metri c'è l'abitazione di Guido Rossa, l'operaio-sindacalista dell'Italsider ucciso l'anno prima dalle BR. Per accedere all'interno 1, del n. 12 di via Fracchia, 17 appartamenti in tutto, si salgono sette scalini che conducono al portone dello stabile. Si entra in un androne, poi si scende una scala ripida e stretta di 12 scalini e ci si trova in un seminterrato di cinque metri quadrati sul quale si affacciano due porte: quella di destra immette in cinque cantine, quella di sinistra ha sul campanello il nome: "Corrado Ludmann". L'appartamento è composto di sette vani: la porta dà su un piccolo ingresso che conduce, sulla destra, ad un corridoio lungo e stretto sul quale si affacciano nell'ordine la cucina, la sala da pranzo, il bagno. Poi il corridoio gira a destra e sulla sinistra c'è il salone. Un piccolo ripostiglio sta di fronte alla cucina dalla quale, così come dalla sala da pranzo, attraverso un balconcino, si accede ad un giardinetto che con una serie di piccole scale porta sul retro della palazzina. Data questa descrizione c'è quindi da chiedersi perché i carabinieri decidano di fare un'irruzione nell'appartamento, pur sapendo che, considerata la posizione angusta in cui l'appartamento è situato, i rischi di un massacro sono altissimi. Chiunque abbia visto l'ubicazione dello stabile di via Fracchia e il luogo quasi sotterraneo dove è situato l'appartamento può capire, infatti, che l'irruzione aveva solo due possibilità: la strage dei brigatisti o quella dei carabinieri. Ma per il momento nessuno può entrare nell'appartamento, neppure i giornalisti. Il 29 marzo, il giorno successivo al blitz, i carabinieri diffondono in un comunicato l'elenco del materiale trovato nell'appartamento9. Si diffonde anche la voce, ripresa da qualche giornale, che i carabinieri, dopo aver catalogato tutto il materiale trovato nell'appartamento, stiano scavando in giardino. Avrebbero infatti trovato una cartellina con l'appunto: "materiale da decentrare sotto terra"10. È evidentemente grande, per i carabinieri, l'interesse per qualcosa che resterà misterioso e che doveva trovarsi in via Fracchia. Forse, chissà, magari proprio seppellito in giardino. 4. Perché tanti silenzi? Grande comincia anche ad essere lo sconcerto di una parte dell'opinione pubblica. Il Secolo XIX, in un corsivo non firmato, pubblicato in prima pagina il 1° aprile, scrive tra l'altro: "comprendiamo le esigenze collegate al difficile lavoro degli inquirenti. Ma a distanza di quattro giorni il silenzio imposto sulla sparatoria li via Fracchia e il riserbo categorico su una tragedia che ha il peso li quattro morti e di un ferito grave appaiono inaccettabili. L'immagine di una magistratura disinformata, di giornalisti seccamente respinti, di un governo che non riferisce, di forze politiche che non chiedono, di polizie che si contrastano rappresentano un prezzo che non figura nei patti di una democrazia che combatte, ma che deve farlo su due fronti, contro il terrorismo e contro le conseguenze del terrorismo". L'immagine di una lotta contro l'eversione che va imbarbarendosi comincia a farsi strada. E non è un'immagine fumosa. Nel frattempo sono stati identificati altri due brigatisti crivellati di proiettili. Sono Lorenzo Betassa e Piero Panciarelli. Il primo è un dirigente di primo piano delle BR, operaio della Fiat. Un altro brigatista insospettabile. Così come sconosciuto era Panciarelli. Fino al 3 aprile dei quattro cadaveri di via Fracchia tre risultano essere brigatisti che nessuna polizia ricercava e il quarto è ancora un corpo senza nome. Sarà necessaria una telefonata anonima delle stesse Brigate Rosse 9 Ecco l'elenco del materiale trovato cosi come è stato fornito dai carabinieri: "5 pistole di fabbricazione estera; 2 pistole automatiche 'sterling', 1 fucile; 2 000 cartucce; 2 bombe 'energa'; 2 mine anticarro; quantità imprecisata di esplosivo plastico; un riproduttore fotografico; macchine da scrivere e registratori; drappi rossi con la stella BR: materiale per falsificare documenti; carte d'identità; patenti e passaporti in parte di provenienza furtiva, in parte falsificati alcuni dei quali interamente compilati; targhe rubate e opuscoli BR; vario materiale documentario dell'organizzazione terrorista; un elenco con 3.000 nominativi, probabili obiettivi di attentati". 10 Vedi, ad esempio, Il Corriere della Sera (2-4-1980). all'ANSA per sciogliere il mistero: il quarto uomo di via Fracchia è Riccardo Dura, 30 anni, uscito da Lotta Continua nel 1973, ritenuto un vero capo, anzi un "duro" dell'organizzazione, colui che autonomamente decise di uccidere Guido Rossa e che - come riferisce il quotidiano dell'organizzazione in cui aveva militato, prima di scegliere la lotta armata - era solito minacciare di morte, con una pistola puntata alla nuca, coloro che avevano intenzione di lasciare la guerriglia. Quattro brigatisti venuti dal nulla, quindi. Ecco il colpo grosso del gen. Dalla Chiesa che, se anche riesce ad eliminare due capi brigatisti, certamente ignorava chi avrebbe trovato nell'appartamento, ma sicuramente sapeva che cosa. C'è chi dice che sia un qualcosa cercato, ma non trovato, meno di due anni prima a Milano nell'appartamento-archivio di via Montenevoso. Forse le due borse sottratte dall'auto di Moro il 6 marzo 1978? Mistero. Soltanto il 5 aprile, ossia addirittura otto giorni dopo il blitz, la magistratura riceve il rapporto dei carabinieri su quanto accaduto quella notte. È un rapporto scarno, contraddittorio, che comincia ad alimentare dubbi anche nella stampa che nel suo insieme si è mostrata fino a quel momento assai "poco curiosa". Il rapporto dei carabinieri - secondo quanto la magistratura genovese renderà noto - così spiega il blitz del 28 marzo: i carabinieri circondano via Fracchia e un gruppo di uomini si presenta davanti all'int.1 dello stabile, armati e protetti da giubbotti e caschi con visiera antiproiettile. Intimano di aprire la porta. Qualcuno da dentro, di certo una voce femminile, quindi quella della Ludmann, risponde: "Va bene, ora apro" e invece dà tre mandate di serratura. I carabinieri allora sfondano la porta e, al di là di una tenda, intravedono un corridoio buio. Ordinata la resa si sentono rispondere: "Va bene, siamo disarmati", proprio mentre viene sparato un colpo di pistola che colpisce all'occhio il maresciallo Rinaldo Benà. Costui, tranquillizzato dall'annuncio di resa, si era imprudentemente alzato la visiera del casco. A questo punto sempre stando alla ricostruzione ufficiale - i carabinieri aprono a loro volta il fuoco e sentono il tonfo di un corpo che cade, mentre notano due uomini e una donna avanzare carponi nel corridoio. Viene accesa una fotoelettrica che permette loro di vedere uno dei due uomini con in pugno una pistola e la donna con in mano una bomba a mano. Infine i carabinieri aprono nuovamente il fuoco. La carneficina è terminata11. 11 Ecco il testo integrale del comunicalo emesso dalla magistratura genovese il 5 aprile 1980, dopo aver ricevuto il rapporto dei carabinieri: "Dalla ricostruzione riferita dai carabinieri sul conflitto a fuoco avvenuto venerdì scorso, 28 marzo, nel corso del quale hanno perso la vita Ludmann Anna Maria, Betassa Lorenzo, Panciarelli Piero e Dura Riccardo è emerso che i medesimi, portatisi all'esterno dell'appartamento int.1 di via Fracchia n.12, dopo ripetute intimidazioni ad aprire, rimaste, nonostante la dichiarata accettazione, senza effetto, colpivano la porta di accesso, che cedeva spalancandosi. Potevano cosi intravedere, al di là di una Dal comunicato della magistratura emerge anche un particolare: la pistola da cui è partito il colpo che ha ferito Benà subito dopo si era inceppata. Nulla viene invece detto sul numero di colpi d'arma da fuoco sparati dai brigatisti e dai carabinieri. Soltanto una visita dei giornalisti nel "covo" potrebbe chiarire alcuni particolari, ma l'autorizzazione tarda ad arrivare. Perché? La stampa comincia ad innervosirsi. Il 6 aprile, giorno di Pasqua, in un fondo in prima pagina sulla Repubblica dal titolo "Non si poteva prenderli vivi?", Gianni Rocca scrive: "l'impressione generale che si trae dalla lettura del documento (il comunicato della magistratura. NDA) non induce certo ad una positiva valutazione (...). La dinamica del blitz genovese in via Fracchia lascia ritenere che l'azione avrebbe dovuto essere concepita con un coefficiente di sicurezza maggiore. (...) Abbattere la porta di un appartamento, sia pure dopo aver ricevuto assicurazioni collaborative da parte dei suoi abitanti, è atto estremamente rischioso, soprattutto se in partenza si sa che quegli abitanti sono pericolosi terroristi armati fino ai denti. Irrompere al buio in un alloggio può portare il poliziotto o il carabiniere a non avere chiara la percezione del pericolo e a mettere in forse lo scopo dell'operazione, che è quella della cattura e non dell'uccisione del brigatista ricercato. In Italia, le azioni di guerra e la ricerca del morto a tutti i costi sono patrimonio dei soli terroristi: ed è proprio per questo che essi sono fuori dalla legalità. Dall'altra parte stanno le forze dell'ordine che agiscono in virtù di un mandato che promana dalla legge e che a questa devono rendere atto. L'irruzione, così com'è avvenuta, e il suo successivo svolgersi dimostrano che i carabinieri sono stati esposti a gravi pericoli. La domanda che sorge spontanea è dunque: una volta circondata la casa dalle scale, dai vari accessi esterni, non si poteva ordinare la resa? E se necessario non si potevano usare i candelotti lacrimogeni per snidare e comunque fare uscire allo scoperto i terroristi? Se il blocco era totale, le possibilità di fuga dovevano essere minime. Si obietterà che i brigatisti erano forniti di bombe a mano e addirittura di esplosivo e che la soluzione dell'accerchiamento avrebbe presentato anch'essa pericoli. Ma si pone allora un'altra domanda: perché non ricorrere alla tecnica dell'agguato al gruppo terrorista quando cioè fosse uscito di casa? Avrebbe agito qui il fattore sorpresa, quello decisivo in ogni azione militare, lo stesso del resto, che tanto spesso rende imprevedibili i terroristi che lo usano nei confronti delle loro vittime predestinate (...). Non dovremmo mai stancarci di ripetere che la pena di morte in Italia viene applicata solo dai terroristi. Ma è proprio per questo che il paese li condanna e isola". tenda, un corridoio buio, dal quale non proveniva alcun rumore. Intimavano allora agli occupanti la resa, ed una voce maschile rispondeva: 'va bene, siamo disarmati'. Subito dopo però dal fondo del corridoio veniva esploso un colpo di pistola che colpiva al capo il m.llo Benà. I carabinieri aprivano il fuoco e udivano il tonfo di un corpo che cadeva a terra. Intimata nuovamente la resa, essi potevano notare due uomini e una donna avanzare carponi nel corridoio provenendo da una stanza laterale. A questo punto era possibile far luce con un faro in dotazione. Seguiva immediatamente da parte dei tre una brusca reazione, ed i carabinieri, notato che uno dei due uomini impugnava una pistola e la donna una bomba a mano. riaprivano 1l fuoco con tutte le armi. Cessato il fuoco si constatava che i tre erano stati colpiti a morte. Per incarico della Procura della Repubblica i periti stanno svolgendo sul fatto accertamenti di carattere medico-legale e balistico. La pistola dalla quale è partito il colpo che ha colpito il m.llo Benà è stata trovata con un proiettile in canna percosso ma non esploso. Nell'appartamento, oltre a vario materiale documentale e a strumenti per la falsificazione di carte d'identità e patenti, sono stati rinvenuti fucili mitragliatori, bombe da fucile antiuomo e controcarro, pani di esplosivo plastico e numerose munizioni". 5. Finalmente nel ''covo della strage''. Il comunicato della magistratura è del 5 aprile, però soltanto tre giorni dopo, l'8, i magistrati entrano nell'appartamento di via Fracchia, rimasto in pieno possesso dei carabinieri per ben 11 giorni. Perché tanto ritardo? Perché tanta fideistica certezza in ciò che i carabinieri hanno scritto nel loro rapporto? Lo stesso 8 aprile anche i giornalisti sono finalmente ammessi nell'appartamento. E possono così constatare di persona che molte cose riferite in forma ufficiale dai carabinieri non combaciano con ciò che con i loro occhi possono vedere. La "visita" al "covo della strage" è permessa per soli tre minuti e i giornalisti entrano uno alla volta, accompagnati da un ufficiale dell'arma. Così Piero Valentino, corrispondente della Repubblica da Genova, racconta la visita: "Sul pianerottolo di ingresso, di fianco alla porta, quattro fori allineati a quaranta centimetri da terra sono il primo mistero non risolto (...). La porta che si apre al cronista è stretta, non ha alcun segno di forzatura e neppure un colpo. 'La porta cadeva spalancandosi', dice la versione ufficiale, ma in che modo sia stata aperta nessuno lo sa ancora (...). Lo spazio dell'ingresso è di 4 metri quadrati: un citofono, un portabiti, un lampadario abbastanza lussuoso. Tutto, secondo la versione ufficiale, si è svolto da qui al corridoio di fronte, sul quale si affacciano tutti i vani dell'alloggio, tranne la cucina che è subito a sinistra (...) tra il corridoio e l'ingresso c'è però una porta laccata di bianco che appare chiaramente forzata: si vede dagli infissi. In più, ad altezza d'uomo, ci sono i segni di sei proiettili che l'hanno trapassata. Anche questo è un altro mistero che la ricostruzione ufficiale non risolve (...). In fondo, all'incrocio dei traghettoni degli ingressi sulle altre stanze e più su fin quasi al soffitto, altri buchi di proiettili, otto in tutto, molto vistosi. È qui che i carabinieri, 'dopo aver intimato nuovamente la resa', dicono di essere riusciti a notare, nel buio, 'due uomini e una donna avanzare carponi provenendo da una stanza laterale', ed è qui che accendono il faro potente che fa scattare la 'brusca reazione' dei tre brigatisti. Da quale stanza laterale stavano 'sbucando'? E perché i colpi sono arrivati così in alto 12 se i tre 'strisciavano', uno con pistola e l'altro con bomba a mano?" . Anche il cronista del Secolo XIX ha molti dubbi e scrive: "La porta dell'abitazione non presenta alcun segno di forzatura. Come hanno fatto i carabinieri ad entrare? C'è un'altra domanda: come hanno potuto i carabinieri accedere all'interno dell'edificio, se il portone esterno infatti era dotato di una 12 Cfr. La Repubblica (9-4-1980). serratura molto particolare? Probabilmente i militari ne possedevano la chiave, e forse, 13 qualcuno fa notare, si erano procurati persino quella dell'appartamento" . Si diffonde, in corrispondenza a questa ipotesi, "una voce", fatta filtrare proprio dalla caserma di via Valfrè a Torino, dove hanno la loro sede gli uomini della brigata antiterrorismo di Dalla Chiesa: si sarebbe arrivati a via Facchia grazie a un mazzo di chiavi (tre piccole e una grossa) trovato in tasca al brigatista Rocco Micaletto, catturato - secondo la versione ufficiale - assieme a Patrizio Peci il 19 febbraio 198014. È un modo come un altro per coprire il "pentimento" di Peci e la mancanza di segni di sfondamento sulla porta dell’appartamento di via Fracchia? Anche il giornalista del Corriere della Sera non crede alla veridicità della versione fornita dai carabinieri e scrive: "Prima di entrare si notano, accanto alla porta d'ingresso in basso, ad una decina di centimetri da terra, alcuni buchi: hanno tutta l'aria di una sventagliata di mitra. Ma, dalla ricostruzione fornita dai carabinieri, non si parla di sparatorie sul ballatoio: oggi nessuno ha dato spiegazioni, (...) ma in quell'alba del 28 marzo può essere successo di 15 tutto, anche che qualcuno abbia sparato dove non ce n'era bisogno" . 6. A via Fracchia muore anche Dalla Chiesa? Al di là dei silenzi dei carabinieri e del comportamento della magistratura genovese - che sembra completamente tagliata fuori da questa operazione e per nulla interessata ad accertare quale sia stata l'esatta dinamica dell'assalto in via Fracchia - ci sono alcune considerazioni da fare. La prima è che mai, prima d'ora, nonostante le decine e decine di "covi" scoperti e brigatisti arrestati, si era verificata una simile carneficina. Il quotidiano Lotta continua, ad esempio, fa notare che "a Parma, lo scorso febbraio, in via Santa Caterina 33, la Digos 'prese' un covo di Prima linea che conteneva un grosso arsenale (3 mitra, 10 pistole, 4 bombe a mano, 5 ordigni diversi, migliaia di pallottole, un giubbotto antiproiettile) e catturato quattro terroristi con una tattica completamente diversa: circondarono l'edificio, invitarono la gente ad allontanarsi dal portone, attesero che quelli di Prima linea - del tutto ignari 16 scendessero in strada" . 13 Cfr. Il Secolo XIX (9-4-1980). 14 La “voce” è riportata dalla Repubblica (29-3-1980). 15 Cfr. Il Corriere della Sera (9-4-1980). 16 Cfr. Lotta continua (5-4-1980). La seconda considerazione è, come già accennato, che non è mai stato chiarito se gli uomini di Dalla Chiesa - giunti in via Fracchia su indicazione di Patrizio Peci - cercassero uomini o documenti. Se cercavano uomini, certamente non sapevano né che uomini, né di che "statura" nell'organizzazione, altrimenti non sarebbero occorsi sei giorni per aver tutti i nominativi dei quattro terroristi uccisi. Forse Peci, che operava a Torino ed in precedenza era stato a Milano, ma mai a Genova, aveva sentore soltanto di un indirizzo e di un appartamento frequentato da brigatisti, alcuni "di rilievo"? Oppure i carabinieri cercavano a Genova una vendetta e insieme un'azione esemplare? La vendetta, cioè, per i quattro carabinieri uccisi dai brigatisti nel capoluogo ligure tra il 21 novembre 1979 (il maresciallo Vittorio Battaglin e il carabiniere Mario Tosa) e il 25 gennaio 1980 (il col. Emanuele Tuttobene, definito dalle BR "uomo di punta di Dalla Chiesa", e l'appuntato Antonio Casu)? E allo stesso tempo un'azione esemplare e di ampia risonanza per mostrare la capacità d'attacco dell'Arma, un'azione che, aumentandone il prestigio agli occhi dei politici, accelerasse la messa in opera, cosa che regolarmente avvenne, della "legge sui pentiti", preparata da Cossiga, votata dal Parlamento, ma voluta e caldeggiata proprio da Dalla Chiesa? Oppure in via Fracchia il nucleo di Dalla Chiesa cercava qualche documento particolare sul quale non dovevano restare in vita testimoni? Ad esempio documenti sul caso Moro, forse gli originali del suo "memoriale", forse le bobine dei suoi "interrogatori", magari un filmato, oppure lettere dello stesso leader democristiano di cui ancora oggi non conosciamo il contenuto? Quello delle lettere è, come abbiamo già visto (vedi cap. IX), uno dei tanti "misteri" del caso Moro. Non si è mai saputo con esattezza quante Moro ne abbia scritte e se quelle rese note siano tutte quelle redatte nel "carcere del popolo" delle Br. Sorprende, ad esempio, che ancora il 12 maggio 1988, cioè dieci anni dopo il caso Moro, il SISDE (il servizio segreto del ministero dell'Interno) - su richiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta di poter pubblicare lettere e comunicati relativi alla vicenda di quei 55 giorni - abbia risposto dicendosi "contrario"17. 17 Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sull'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia - Doc. XXIII n. 5 - vol. ventottesimo, Roma 1988, pag. 13. Tra gli altri documenti su cui il SISDE si è detto "contrario" alla pubblicazione da parte della commissione Moro figurano: un appunto su "visita delegazione SISDE al Servizio Israeliano"; "attività svolta all'estero da Giovanni Senzani"; "collegamenti internazionali terrorismo e campi addestramento Sud Yemen"; "caso Hyperion (la scuola di lingue di Parigi diretta da alcuni personaggi delle primissime BR. NDA)"; "rapporti terrorismo italiano con centrali straniere"; "Appunti su fotocopiatrice e stampatrice sequestrate nella tipografia di via Pio Foà a Roma". Non sapremo mai la verità su via Fracchia. Non conosceremo mai il perché di quell'eccidio che certo non esalta la correttezza democratica dello Stato nella lotta all'eversione. Non sapremo mai neanche cosa c'era di tanto importante in via Fracchia, oltre a due capi brigatisti e a due semplici militanti. E forse resterà per sempre il dubbio che il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in un agguato mafioso il 3 settembre 1982, abbia cominciato a morire proprio in quella piovosa alba del 28 marzo 1980. A ben vedere, infatti, il suo "declino" per così dire politico, e di certo quello della sua carriera militare, cominciano proprio con il "colpo" assestato alle BR a Genova. Di lì a poco, pur continuando nella sua lotta vincente al terrorismo, Dalla Chiesa si troverà improvvisamente sbarrate molte porte. E soprattutto sarà costretto a dire il suo "obbedisco", accettando la carica di prefetto di Palermo. Non avrà mai i "superpoteri" per la lotta alla mafia ampiamente concessi, poi, dopo la sua morte, ai suoi successori (a De Francesco prima e quindi in misura ancora maggiore a Sica). E finirà crivellato di proiettili in una via del capoluogo siciliano18. Di lui ha detto Beppe Niccolai, che fu anche commissario dell'antimafia: "Quando Dalla Chiesa viene ucciso sono in molti a tirare un sospiro di sollievo: i mafiosi ed i politici, quelli di Palermo e di Roma. Perché Dalla Chiesa era anche il 19 custode di tanti segreti raccolti nella lunga stagione del terrorismo" . Ma al di là delle ipotesi e dei dubbi, restano le ombre che quel 28 marzo 1980 si sono proiettate su via Fracchia. Tre studiosi del fenomeno terrorista ne tracciano i contorni. Scrive Giorgio Bocca: "Si procede secondo la legge del taglione: quattro carabinieri uccisi a Genova, quattro brigatisti giustiziati (...). La stessa stampa lascia cadere un'indagine che sarebbe facilissima, non chiede perché mai si sia arrivati a uno scontro a fuoco quando la casa 20 era circondata e i brigatisti senza via di scampo" . E lo scrittore Leonardo Sciascia aggiunge: 18 Per una ricostruzione della personalità di Carlo Alberto Dalla Chiesa, specie in relazione alla sua scelta di accettare l'incarico di prefetto di Palermo, si veda il libro scritto dal figlio: Nando Dalla Chiesa Delitto imperfetto - Mondadori, Milano 1984. 19 Da un colloquio con gli autori. 20 Cfr. G. Bocca - Op. cit. - pag. 171. "Molti sono i punti della vicenda Peci che non mi convincono; e non ultimo quello dell'uccisione dei brigatisti in via Fracchia a Genova. Non sono per nulla convinto, voglio dire, che quelle persone non potessero essere catturate vive e senza rischi per 21 quei carabinieri che partecipavano all'azione" . Infine Corrado Stajano: "Quale è stato il 'pacchetto della trattativa' tra Peci e il gen. Dalla Chiesa, perché la magistratura non è stata informata, perché i brigatisti sono stati ammazzati in quel modo? L'operazione coinvolge misteriosi 'livelli superiori'? Che cosa avrebbero potuto dire quei quattro brigatisti sul delitto Moro e sulla catena di rivelazioni che Peci stava facendo proprio in quei giorni al generale? Si sono volute forse far sparire tracce di complicità imbarazzanti e puntellare le verità più fragili della confessione di Patrizio Peci? Oppure è necessario ancora una volta rifiutare l'uso di ragione chiamato 'dietrologia' e cercare le cause di quanto è accaduto in via Fracchia 12 soltanto nell'incompetenza e nella precipitazione dilettantesca del nucleo dei 22 carabinieri addestrato ad operare senza uccidere?" . 7. Ancora coni d'ombra, ancora misteri. Ma le macchie oscure che il 1980 porta con sé non sono finite. L'operazione di via Fracchia deve avere avuto un certo effetto a livello politico e alcune garanzie a favore dei "pentiti" devono essere state date da quegli ambienti a Dalla Chiesa, e più in là ancora, alle forze di polizia, se non solo il fenomeno non si arresta con Peci, ma da quel momento andrà generalizzandosi all'interno del partito armato delle BR, e ancor maggiormente tra gli altri partitini armati, con progressione quasi geometrica. Ma torniamo per un momento a Peci e alla valanga delle sue confessioni. Intanto chi è costui? Proviene dai gruppi della sinistra extraparlamentare (Lotta continua per l'esattezza). A metà degli anni '70 lascia la nativa San Benedetto del Tronto, nelle Marche, per aggregarsi alle BR milanesi e poi passare a Torino a guidarne la colonna. Peci ha scarsi rapporti politici con il vertice dell'organizzazione, ma sa quel tanto che basta per accreditarsi agli occhi dei carabinieri con le sue informazioni. Che in verità sono molte. Egli sa tutto della struttura combattente che agisce nel torinese, conosce luoghi ed indirizzi dei depositi di armi, sa dove vivono gli altri militanti, i loro collegamenti e conosce molto anche Prima Linea che a Torino ha una 21 Cfr. L 'Espresso (20-2-1983). 22 Cfr. C. Stajano - Op. cit. - pag. 191. sua presenza attiva. Se decide di collaborare con quelli che sono stati per anni i suoi "nemici", le forze dello Stato, lo fa con estrema consapevolezza. Prima tratta, poi, per avere contropartite, dà a Dalla Chiesa la segnalazione di via Fracchia, quindi, ottenute le necessarie promesse, apre il rubinetto delle confessioni. Tutto calcolato. Peci è un pentito? "No. Io credo sia soltanto un generale fellone - afferma Emilio Vesce - un capo che sa che la guerra sta per essere persa e allora si consegna al nemico, apre con esso una trattativa e poi contribuisce a sconfiggere l'esercito che fino a poco prima guidava. Una 23 scelta lucida la sua, calcolata nei minimi particolari" . Tanto calcolata che proprio contro di lui le BR si accaniranno, sequestrando ed uccidendo suo fratello Roberto l'anno successivo, durante la loro campagna contro il "pentitismo"24. 23 24 Da un colloquio con gli autori. Durante il suo sequestro Roberto Peci racconterà ai carcerieri delle BR la storia del "vero arresto" di suo fratello Patrizio. La "dichiarazione" di Roberto Peci sarà diffusa in forma autografa e inviata dalle BR ad alcuni giornali. Soltanto Vita, Il Quotidiano dei Lavoratori e Lotta Continua ne pubblicheranno il testo integrale. La "dichiarazione" di Roberto Peci alle BR, con tutti i limiti che può avere, data la sua situazione di costrizione, sarà oggetto di un'interrogazione parlamentare rivolta al governo dal gruppo radicale e di un esposto alla magistratura dell'on. Marco Boato. Per documentazione ecco una sintesi, per punti, di quanto da lui affermato: 1) Patrizio Peci sarebbe stato arrestato, con il suo consenso e quello dei suoi familiari, il 13 dicembre 1979, alle 9, vicino alla stazione di Torino, dopo una serie di contatti avuti con la famiglia a partire dal maggio dello stesso anno. Nel corso del primo contatto, Patrizio disse che "era stanco e non ce la faceva più e che si sentiva sbandato; dicendo queste cose - aggiunge Roberto Peci - pianse ripetutamente. I carabinieri intercettarono la telefonata e la passarono ad uno psicologo che la analizzò, concludendo che Patrizio stava perdendo colpi ed era in piena crisi". 2) Patrizio Peci sarebbe stato sottratto ai giudici e interrogato in un appartamento privato di Torino. 3) I1 gen. Dalla Chiesa, dopo aver ottenuto informazioni sulla colonna torinese delle BR, avrebbe "rilasciato" Peci perché fornisse maggiori informazioni sull'organizzazione armata e per consentire ai carabinieri, attraverso il pedinamento, di acquisire prove sull'attività delle BR. 4) Dalla Chiesa avrebbe autorizzato Peci a partecipare alle azioni terroristiche delle BR. 5) I1 giudice Giancarlo Caselli, di Torino (futuro procuratore capo di Palermo), informato solo successivamente dell'arresto di Peci da parte dei familiari, avrebbe poi collaborato all'operazione gestita dai carabinieri. 6) I1 19 febbraio 1980 Peci sarebbe stato arrestato una seconda volta, in questa occasione assieme a Rocco Micaletto, dopo essere stato preventivamente informato dai carabinieri sulla necessità di interrompere l'operazione in seguito alle preoccupazioni e sollecitazioni provenienti da non definite autorità romane. La notizia dell'arresto suo e di Micaletto viene data alla stampa il 21 febbraio. 7) Dalla Chiesa avrebbe convinto Peci a fornire ulteriori informazioni ed in particolare quelle relative al covo di via Fracchia, sostenendo che per ottenere dai "politici" "garanzie" per provvedimenti di clemenza, sarebbero stati necessari successi clamorosi nelle operazioni antiterroristiche. 8) L'uccisione di tutti i BR presenti nell'abitazione di via Fracchia, quindi, sarebbe stata premeditata per precise finalità politiche e di propaganda. 9) Una volta conclusa l'operazione di via Fracchia, Dalla Chiesa si sarebbe recato a Roma dove avrebbe incontrato Cossiga, all'epoca presidente del Consiglio e Pertini, capo dello Stato, "i quali si impegnarono a fare una legge in breve tempo sui pentiti. Cossiga e Pertini - sostiene Roberto Peci dissero anche di essere d'accordo di fare avere a Patrizio un lavoro all'estero con dei soldi per sistemarsi". 8. Dai verbali manca "un foglio"... o "un figlio''? Intanto, proprio grazie a Peci, un altro cono d'ombra si proietta sulla vita politica italiana, portando a galla, ancora una volta, il ruolo dei servizi segreti. È la storia dei verbali degli interrogatori di Peci che il vice-capo del SISDE, Silvano Russomanno, "passa" al giornalista del Messaggero, Fabio Isman (finiranno entrambi incriminati ed arrestati). A parte il danno che la pubblicazione dei verbali, con nomi e indirizzi, provoca alle operazioni imbastite da Dalla Chiesa, c'è da registrare un fatto: proprio da quelle carte emerge uno "scandalo" che assume subito dimensioni politiche. Peci ha infatti parlato, anche se non in maniera esplicita, durante le sue confessioni, del ruolo importante svolto in Prima Linea da Marco Donat Cattin, il "comandante Alberto", figlio del senatore e vice-segretario della Dc, Carlo. Peci ha fatto riferimento ad "un piellino" (Roberto Sandalo) con cui si sarebbe incontrato, molto amico del figlio di un ex ministro. Nei verbali passati alla stampa del fatto non si fa cenno, ma pubblicandoli a sua volta Lotta continua aggiunge - in una parentesi inserita nel testo - la dizione maliziosa "manca un figlio", anziché "un foglio". Ai primi di aprile la notizia che il figlio di Carlo Donat Cattin sia un pericoloso terrorista di Prima linea, fuggito in Francia, si diffonde. Il "piellino" di cui parla Peci, cioè Roberto Sandalo, viene arrestato a Torino il 29 aprile. Ha da poco abbandonato PL, ormai allo sbando, e ha cercato qualche protezione dal padre del suo amico Marco che a suo dire sarebbe stato informato dal presidente del consiglio Cossiga dell'imminente disarticolazione di Prima Linea. Lo stesso Cossiga - secondo Sandalo avrebbe suggerito a Donat Cattin padre di far espatriare suo figlio25. Ne nasce una bagarre politica di enormi dimensioni. Carlo Donat Cattin si dimette dal suo incarico in seno alla DC e Francesco Cossiga rischia di essere rinviato davanti all'Alta Corte. Lo salverà prima, il 31 maggio, la commissione inquirente che con 11 voti (DC, PSI, PSDI) contro 9 (PCI, PR, MSI-DN e indipendenti di sinistra) decide per l'archiviazione del caso e poi, il 23 luglio, l'assemblea del Parlamento, a Camere riunite, che con 10) entre Peci, convinto delle promesse di Dalla Chiesa, comincia con le sue confessioni fiume, "si presentarono tre persone, qualificatesi come appartenenti alla Digos, le quali dissero a Patrizio afferma Roberto - che se avesse detto le cose che sapeva a loro, lo avrebbero fatto scappare il giorno dopo con 500 milioni; mio fratello rifiutò perché era convinto che gli avrebbero sparato mentre scappava". 25 Davanti ai magistrati torinesi Roberto Sandalo riferisce queste parole del sen. Carlo Donat Cattin: "Cossiga mi ha anche detto: 'Noi cercheremo di tenere la notizia il più coperta possibile, tu vedi, se riesci, di mandare tuo figlio all'estero. Un conto è che lo prendano, un conto è che sia all'estero". M 507 voti contrari e 406 favorevoli respingerà una richiesta avanzata dal PCI per un supplemento di indagini. Eugenio Scalfari sulla Repubblica scrive: "Il senatore Carlo Donat Cattin ha provocato con il suo comportamento la crisi forse più grave che la Repubblica abbia attraversato nei trentacinque anni della sua pur tormentata esistenza (...). Credevamo di aver toccato il fondo con l'assassinio di Moro. 26 Invece lo tocchiamo ora" . 9. Un criminologo rallenta la frana brigatista. L'arresto di Peci per le Brigate rosse è una vera frana. Non c'è solo il massacro di via Fracchia, che nei fatti taglia la testa alla colonna genovese e colpisce duramente la direzione strategica dell'organizzazione. Non ci sono solo gli arresti di militanti indicati dallo stesso Peci. Non c'è soltanto l'abbandono precipitoso di basi logistiche che Peci potrebbe conoscere. C'è un dato ben più importante: il referente politico che, nonostante l'esasperato militarismo di Mario Moretti, resta al primo posto nella strategia brigatista, ossia gli operai delle grandi fabbriche, è in crisi. Alla Fiat sono partiti i licenziamenti e le casse integrazioni. È cominciata la grande ristrutturazione aziendale accettata senza troppa combattività dai sindacati. La mitica classe operaia italiana appare in ginocchio. È il dato di fatto che farà dire ad un fondatore delle Brigate Rosse come Alberto Franceschini: "Mi dispiace dirlo, ma le BR sono state sconfitte da Agnelli. La grande ristrutturazione della Fiat, portata avanti da Romiti nel 1980, ha rappresentato per noi anche un dato simbolico: i licenziamenti, i 20.000 cassintegrati. Per noi fu uno shock che tutto questo passasse senza alcun tipo di risposta da parte degli operai. Anzi il corteo dei 40.000 capetti della fabbrica fu per noi il segnale che il movimento rivoluzionario aveva registrato una grande sconfitta. Una sconfitta strategica che per le Brigate Rosse significa l'inizio dell'isolamento più totale. Come abbiamo reagito a questi mutamenti radicali? In primo luogo nascondendoci il fatto che, a quel punto, non avevamo più alcuna capacità progettuale. Poi accelerando al massimo gli elementi di violenza. È un paradosso: ma quando le BR hanno cominciato davvero il terrorismo, allora sono 27 scomparse" . E il "vero terrorismo", come lo definisee Franceschini, ossia il terrorismo gratuito, senza più alcuna finalità, le BR lo cominciano dopo le “confessioni” di Patrizio Peci anche per un altro motivo: all'interno 26 Cfr. La Repubblica (1-6-1980). 27 Da un'intervista di Alberto Franceschini a "Speciale GRI" (15-3-1988). dell'organizzazione - anche, ma non solo - a causa delle difficoltà della mitizzata classe operaia, va tacitamente accendendosi un dibattito serrato sulle reali prospettive della lotta armata. Un "chi siamo e dove andiamo?" ancora timido che si era però già proposto nel 1979 con l'uscita di Valerio Morucci e di Adriana Faranda con soldi e armi dalla colonna romana (formeranno il MPRO, Movimento Proletario di Resistenza Offensiva che avrà brevissima vita), poi con l'insubordinazione dimostrata da Riccardo Dura (ucciso in via Fracchia) nell'esecuzione del tutto personale dell'omicidio Rossa all'inizio dell'80. Episodi emblematici di una situazione divenuta insostenibile perché le BR stanno scoprendo di non aver più un vero ''cervello". Mario Moretti, infatti, dopo il caso Moro, pur restando il capo dell'organizzazione, non ha più il carisma di prima. Il nucleo di fedelissimi raccolti attorno a lui appare quanto mai artificioso. Il suo carattere incerto trova riflessi nella mancanza di una strategia politica reale per le BR che stanno lentamente, ma inesorabilmente, diventando una banda di assassini che uccide senza più avere alcun collegamento né nelle fabbriche, né a livello di settori dell'autonomia, ormai del tutto ripiegati su se stessi. Una banda armata che fa sempre più fatica a reclutare nuove leve; che ha talmente ideologizzato il simbolo che spesso colpisce alla rinfusa, senza programma, né coordinamento tra un'azione e l'altra. Una banda che oltretutto ha tagliato i ponti con i brigatisti in carcere i quali criticano sia l'atteggiamento che Moretti ha nei loro confronti (li usa di fatto solo per fare i documenti), sia la mancanza di un vero "programma rivoluzionario". Ma c'è di più. Dopo che è stato reso noto l'arresto di Peci, ogni colonna ha preso ad andare per proprio conto. I genovesi, dopo via Fracchia, sono letteralmente scomparsi dalla scena28 e quelli rimasti - come Gregorio Scarfò o Livio Baistrocchi - o sono "emigrati" a Roma oppure direttamente all'estero. La colonna veneta è ancora in formazione e il 12 maggio ha scelto come obiettivo l'attacco diretto contro le forze dell'ordine, uccidendo a Mestre Alfredo Albanese, funzionario della Digos, un "alziamo il tiro", anche questo, del tutto simbolico, venato da un certo isterismo azionista. In formazione è anche la colonna napoletana che ha fatto il suo esordio il 16 marzo a Salerno, colpendo a morte il procuratore capo Girolamo Minervini. La colonna milanese, che dispone di pochissimi militanti, si è invece rifondata da poco, dopo i colpi ricevuti nel '78 con la scoperta del "prezioso" covo di via Montenevoso. Si chiama "colonna Walter Alasia", ma ormai con le Brigate Rosse ha poco a che spartire. È in aperta polemica con la direzione strategica ed ha scelto, sotto la guida di un ex militante 28 L'ultima azione delle Brigate rosse a Genova risale al 24 marzo 1980, esattamente quattro giorni prima della scoperta dell'appartamento di via Fracchia. Si tratta del ferimento del consigliere comunale DC, Giancarlo Moretti. dell'autonomia con esperienze sindacali e una visione molto operaista, come Vittorio Alfieri, di accentuare la linea "fabbrichista", da tempo abbandonata dalle BR morettiane. Tiene nel suo mirino dirigenti di aziende, come Pietro Dellera dell'Alfa Romeo (ferito il 21 febbraio), ma sta preparandosi al “salto” verso l'omicidio (cadranno in novembre il capo del personale della Marelli, Renato Briano e il direttore di uno stabilimento della Falk, Manfredo Mazzanti). A Moretti quelli dell'"Alasia" rimproverano tutto: la mancanza di strategia in generale, l'isolamento politico in cui ha cacciato le BR in particolare, il tradimento dei legami con la classe operaia. Verranno espulsi sul finire dell'80. Il "cuore" delle Br è quindi a Roma, dove l'organizzazione dispone del maggior numero di basi e militanti e dove soprattutto sta mettendosi in luce un nuovo "cervello": Giovanni Senzani. Chi è Senzani? "Per me - risponde Franceschini, che ammette però di non averlo mai conosciuto, anche se la sua linea politica per un po' lo ha convinto - potrebbe essere chiunque. Un pazzo. Un estremista della peggior specie. Qualcuno ha parlato anche di servizi segreti. Non so davvero come definire Senzani. Sicuramente in una certa fase, direi dalla fine dell'80 al suo arresto, ha dimostrato di essere uno dei pochi cervelli delle Brigate 29 rosse" . A distanza di anni, se c'è nel panorama eversivo italiano una figura che non ha mostrato per intero la sua faccia costui è proprio Giovanni Senzani. Cognato di Enrico Fenzi (ritenuto da alcuni un ideologo sottile, fedelissimo di Moretti), Senzani è un professore di criminologia che non si sa con esattezza né come, né quando approdi alla lotta armata. È infatti, ad oltre vent’anni dalla sua cattura (gennaio 1982), proprio Senzani l'unico brigatista di rilievo che non abbia accettato interviste e che si è sempre sottratto a qualsiasi dichiarazione. Le biografie ufficiali lo vogliono in contatto con l'estremismo armato fin dal 1974-75 quando, impiegato alla biblioteca comunale di Torre del Greco, vicino Napoli, fa da “consulente” ai NAP per il sequestro del magistrato Giuseppe Di Gennaro. C'è però chi lo vuole in contatto con ambienti del ministero della Giustizia nel 1977-78 e lo indica come "la talpa" delle uccisioni avvenute, entrambe nel '78, dei magistrati Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione, ambedue funzionari del settore carceri presso il ministero. C'è perfino un "pentito" che lo indica in contatto con settori dei servizi segreti militari30. 29 Da un colloquio con gli autori. Le notizie certe parlano invece di Senzani, arrestato nella primavera del 1979 in quanto componente del comitato toscano delle Brigate rosse dal giudice fiorentino Pierluigi Vigna e rimesso in libertà poco dopo. Sarebbe in questo periodo che comincia la sua scalata all'interno dell'organizzazione dove prende in breve tempo il posto di Prospero Gallinari, arrestato nel settembre 1979, all'interno della direzione strategica delle BR. Ritenuto da Moretti uno dei pochi "veri intellettuali", assieme a Fenzi, da lui conosciuti nelle Brigate Rosse, Senzani assume nell'estate 1980 il compito di ricostruire la colonna napoletana, dopo le perdite subite (arresto di Luca Nicolotti e Bruno Seghetti) con l'azione che ha portato all'uccisione del consigliere regionale democristiano della Campania, Pino Amato (Napoli, 19 maggio). Ma Senzani si muove molto, sul finire dell'80, tra Napoli e Roma. Il suo scopo è quello di assumere il comando di tutta l’organizzazione armata e suo è il progetto e la messa a segno di un'azione vincente sotto diversi profili che rilanci in modo deciso il ruolo finora confuso e inutilmente sanguinario dell'organizzazione: il sequestro del giudice romano Giovanni D'Urso, un alto funzionario delle carceri presso il ministero di Grazia e Giustizia. Nell'ottica delle BR, per i risultati che darà, si tratta di un'azione esemplare: D'Urso non verrà ucciso, ma liberato dopo una trattativa fruttuosa per i terroristi; l'operazione aprirà gravi contrasti nel mondo della stampa sul "pubblicare-non pubblicare" i comunicati delle BR; un filo verrà riallacciato con i brigatisti detenuti perché a loro viene affidata l'ultima parola sulla sorte del magistrato. Spetterà infatti al "comitato unitario" del carcere di Palmi e al "comitato di lotta" di quello di Trani decidere se D'Urso debba essere ucciso o meno. Sequestrato il 12 dicembre 1980 (ancora una data simbolica, trattandosi dell'undicesimo anniversario della strage di piazza Fontana), D'Urso viene rilasciato dopo 24 giorni di prigionia, il 5 gennaio 1981, legato e 30 I1 "pentito" è Roberto Buzzati - condannato nel 1988, con sentenza definitiva, per il sequestro di Roberto Peci - secondo il quale Senzani avrebbe mantenuto rapporti con i servizi proprio durante quel sequestro. Ad indicare Senzani come legato al SISMI è anche Luciano Bellucci, in rapporti con Alvaro Guardili, intimo del faccendiere Francesco Pazienza (costui agente dichiarato del SISMI). Bellucci, nel periodo 1968-72, aveva coabitato con Senzani. C'è inoltre da segnalare che il deputato radicale Massimo Teodori, che ha fatto parte della commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2, nel citare un documento agli atti della stessa commissione, sostiene: "non si può affermare che Senzani era un infiltrato, ma appare sempre più chiaro che all'interno delle BR abbia fatto strani giochi. Ed è certo che tra parte delle BR e parte dei servizi segreti il discorso era aperto, da tempo" (Cfr. Panorama 13-8-1984). Si tratta, quindi, non di prove, ma di supposizioni in qualche modo avallate soprattutto dal ruolo avuto da Senzani nel sequestro dell'assessore democristiano della Campania, Ciro Cirillo, liberato grazie all'intervento, oltre che della camorra, dello stesso SISMI. Altri dubbi sui reali legami di Senzani con apparati statali sono nati quando si è diffusa la notizia che, pur essendo un detenuto in isolamento, era stato affidato proprio a lui il compito di insegnare l'italiano al turco Ali Agca, l'attentatore del Papa. imbavagliato nel bagagliaio di un'auto (un altro simbolo che ci riporta al bagaglio della Renault 4 che conteneva il cadavere di Moro, come a voler sottolineare la diversa conclusione dei due sequestri, il primo gestito da Moretti, il secondo da lui, Senzani). In cambio le BR - che il 31 dicembre 1980, a sequestro ancora in corso, hanno ucciso, sempre a Roma, il generale dei carabinieri Enrico Galvaligi ottengono la chiusura del carcere dell'Asinara, la "cayenna italiana". Galvaligi è stato ucciso come se nella sua rinnovata strategia Senzani abbia voluto mettere "una ciliegina di morte" sulla "torta del caso D'Urso". Il 29 dicembre sono stati, infatti, proprio i carabinieri dei reparti specializzati del GIS a soffocare la rivolta brigatista nel carcere di Trani e Galvaligi era il vice responsabile dell'ufficio che sovrintende ai carabinieri di guardia all'esterno delle carceri. Il comunicato finale delle BR sfugge ai soliti toni paleorivoluzionari e sposa in pieno un cinismo che ben si addice alla figura di Senzani: "La borghesia ha, adesso, un altro problemino: che fare di un aguzzino pentito? Perché D'Urso è proprio un aguzzino pentito. Ha collaborato con la giustizia proletaria, ci ha rivelato nei minimi dettagli i progetti, le strutture e gli uomini che, a partire dal ministero di Grazia e Giustizia fino ai nodi periferici, sovrintendono alla strategia dell'annientamento. In questo comportamento non ravvisiamo un ravvedimento morale di cui è incapace, ma una scelta politica di cui sappiamo tenere conto. Per anni la stampa di regime si è affannata a trovare una talpa del ministero di grazia e giustizia. Adesso gliene forniamo una noi, con nome e cognome: Giovanni D'Urso. Avevamo detto che l'opportunità di eseguire o di sospendere la condanna a morte di Giovanni D'Urso doveva essere valutata politicamente dalle Brigate Rosse e dagli organismi di massa rivoluzionari dentro le carceri. Gli obiettivi politici e militari sono stati ampiamente raggiunti. Il movimento dei proletari prigionieri, il movimento rivoluzionario, le Brigate Rosse hanno conseguito una grande vittoria In considerazione di tutto ciò la giustizia proletaria acconsente ad un atto di magnanimità. La sentenza viene sospesa e il prigioniero D'Urso rimesso in libertà". Il magistrato Giovanni d’Urso - contrariamente a quanto affermato nel comunicato brigatista – ha sempre smentito qualsiasi sua forma di “collaborazione” con i suoi rapitori. 10. Prima linea: verso l'ultima spiaggia Se Giovanni Senzani e le sue "nuove" BR rilanciano con il caso D'Urso l'immagine di un'organizzazione ancora capace di tenere in scacco lo Stato, ben diversa è la sorte che spetta a Prima Linea. In eterna competizione con le stesse Brigate Rosse, PL - dopo la conclusione del sequestro Moro - ha scelto una collocazione più movimentista, ma non per questo meno militarista, proprio per continuare affannosamente a distinguersi. E per farlo meglio colpisce quasi a casaccio, ferendo dirigenti d'azienda, medici, assessori di piccoli comuni della cintura torinese, architetti che progettano carceri, magistrati che curano l'esecuzione degli sfratti. Uccidono anche un criminologo napoletano, Alfredo Paolella, reo di collaborare con i funzionari degli istituti carcerari. Poi, dopo l'assurdo omicidio del giudice Alessandrini - e siamo agli inizi del '79 - Prima Linea va completamente in tilt. I suoi ragionamenti, solo all'apparenza tanto sofisticati (abbiamo visto le giustificazioni proprio per il delitto di Alessandrini), diventano incomprensibili persino per la zona politica più attigua, quella dell'autonomia operaia. Una strana forma di esistenzialismo paranoico sembra assalire il gruppo. Ma non è una malattia. È solo la continuità, portata al parossismo, della loro premessa politica. Quel sentirsi paladini di un mondo di sfruttati che vedono contrapposto a quello degli sfruttatori. Il loro progetto non sta nell'abbattere questo tipo di Stato, ma nell'essere la "prima linea", appunto, di un immaginario anti-Stato. E quando se ne accorgono, lo "spontaneismo" prende il sopravvento. Nel '79 hanno ucciso un barista, Carmine Civitate, per vendicare due loro compagni, Barbara Azzaroni e Matteo Cageggi, morti ammazzati dalla polizia, pare chiamata proprio da quel barista. Poi, nel dicembre dello stesso anno, hanno assaltato una scuola di formazione aziendale a Torino, mettendo cinque docenti e altrettanti studenti contro un muro e sparando loro alle gambe. Convinti cosi di attaccare un "laboratorio" della ristrutturazione capitalista. Il 1980 è invece l'anno della follia pura: punire un presunto "pentito", che ha soltanto sfiorato l'organizzazione (William Waccher); uccidere un magistrato che ha preso il posto di Alessandrini e continua le indagini su PL (Guido Galli); sparare alla testa di un architetto romano incaricato di ristrutturare il carcere di Rebibbia (Sergio Lenci). Poi il tracollo. La slavina dei "pentiti". 11. Pentirsi è bello? L'organizzazione armata, la clandestinità, le prospettive di una vita in gioco e per sempre sono diventate sempre più un fardello enorme per coscienze inquiete, ma al fondo mosse da una ideologia fragile, che dietro le sbarre frana con lo stesso rigore con cui si è sedimentata. Da Peci in poi, fino al 31 agosto 1982, saranno 357 i terroristi "pentiti"31. Checché ne dicano ancor oggi diversi brigatisti del nucleo storico, il "pentitismo", se ha distrutto completamente organizzazioni come Prima Linea, ha rappresentato anche per le BR un rospo duro da digerire. In fondo 31 L'elenco completo dei terrorisiti "pentiti" al 31 agosto 1982 è stato pubblicato in: Comnissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l'uccisione di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia - Doc. XXIII, n. 5 - vol. ventottesimo - Roma 1988, pagg. 159-531. il "progetto pentiti", studiato a tavolino da Cossiga e Dalla Chiesa, ed avallato in tutte le sue forme dall'intero arco politico, con esclusione dei radicali, dei missini e di una parte esigua dell'ex "nuova sinistra", era la chiave di volta, la mossa vincente dello Stato. Si trattava di battere il terrorismo sul suo stesso terreno: respinto il rischio della trattativa globale, veniva imboccata la via della trattativa con il singolo. Una strategia vincente proprio grazie all'indebolimento ideologico e politico che il fenomeno eversivo, con l'andare del tempo, stava subendo. È il "pentitismo" che ha sconfitto politicamente l'ipotesi della lotta armata in Italia oppure è stata la sconfitta politica che, attraverso il "pentitismo", ha ridotto quantitativamente – e in modo progressivo - l'area eversiva presente nel paese? Per chi è convinto che i progetti di ribellismo armato in Italia siano esauriti la domanda non può che sembrare retorica. Ma così non è. Come ogni fenomeno che riesca ad assumere dimensione nazionale, anche il terrorismo ha in Italia un suo “zoccolo duro". È lo "zoccolo duro" dell'ideologia, della convinzione personale ed interpersonale del diritto - per quanto sbagliato esso possa essere giudicato - alla opposizione armata. Ed è per questo che, all’inizio del terzo millennio, la parola terrorismo anche in Italia non è un’espressione desueta e che uomini armati facciano ancora la loro comparsa sulla scena della vita quotidiana. In pochi si sono chiesti chi sono davvero i "pentiti" del terrorismo italiano. Nessuno ha mai analizzato, ed è una ricerca tutta da fare, quali personalità individuali, che tipo di militanti, quali scelte politiche si nascondano realmente dietro le scelte dei "pentiti". Nessuno si è mai chiesto perché non esista un solo terrorista del "nucleo storico" che, pur avendo davanti a sé anni e anni di galera, abbia imboccato questa via. La risposta è semplice e sta nell'ordine delle cose: il "pentitismo" è la scelta di chi non ha alcun "background" politico. Di chi è giunto alla scelta armata sulla spinta della sola "ideologia dell'azione" senza alcuna "ideologia del pensiero". Non si tratta, come qualcuno ha lasciato intendere, soltanto di pure scelte di comodo del tipo: "mi pento così evito di stare in galera per troppo tempo". Oppure: “mi pento perché non credo più in quello che ho fatto". Il discorso è più complesso: il "pentitismo", pur restando una scelta nella sfera del personale, rappresenta un atteggiamento politico complessivo. Il "pentito" non è "un miserabile" tout court, come ha osservato Oreste Scalzone. Non è "un miserabile" perché fa arrestare decine e decine di persone con cui fino ad un attimo prima ha condiviso scelte sbagliate. È "un miserabile" perché impregnate della miseria del suo pensiero erano le sue scelte politiche precedenti. Perché ha scelto di diventare un terrorista, ignorando che prima di mettere la vita degli altri in gioco, stava ponendo la sua esistenza a disposizione di qualcosa che un gioco non era. Ed è facile "pentirsi" di ciò in cui non si crede. O in cui si crede solo con il velleitarismo parolaio. E non è un caso che la maggiore percentuale di "pentiti" si sia registrata, ancor più che in Prima Linea e nei gruppetti del "terrorismo diffuso", nelle fila delle organizzazioni armate nere32. Dice, a questo proposito, un "non pentito" come il leader di estrema destra Paolo Signorelli: “Io ritenevo che la peculiarità della nostra Weltanschauung non avrebbe consentito il manifestarsi del fenomeno del 'pentitismo' tra le nostre file; ma evidentemente per molti era stato più importante sembrare che essere. Tant'è che numerosi giovani, e meno giovani, che si atteggiavano a 'guerrieri senza sonno', posti dinanzi alla prospettiva del carcere duro hanno scelto la via della resa, della delazione, dell'impostura, dell'infamità (...). Aleandri, che su Costruiamo l'azione aveva scritto nel 1978 'vogliamo la morte degli infami... E fosse per un giorno, fosse per un'ora, ritorneremo ad alzare il grido di guerra... Che trionfi la Rivoluzione!', diverrà 'infame' subito dopo o e verrà ritenuto uno 'studioso sereno e distaccato'. Calore aveva scritto sempre su Costruiamo l'azione nel 1983 un articolo estremamente virulento contro i magistrati, minacciandoli di fargli fare la fine di Occorsio, diverrà amico e collaboratore stimatissimo dei giudici di tutta Italia. Ebbene, con Aleandri e Calore sostenni una serie di scontri perche io venivo accusato da loro di rimanere troppo ancorato a posizioni di 'destra', mentre io esternavo a loro la preoccupazione che i colpi di acceleratore verso 'sinistra' avrebbero condotto a snaturare l'iniziativa sorta con l'obiettivo di creare un'area nuova per idee nuove"33. Un velleitarismo parolaio quindi che arriva all'azione sull'onda emotiva, senza alcun retroterra politico. Lo stesso vuoto che avvolge anche una formazione di "ragazzini" come quella della Brigata XXVIII marzo, stroncata, pur essendo infiltrata dai carabinieri34, solo dopo l'omicidio del giornalista Walter Tobagi (Milano, 28 maggio 1980). 32 Secondo l'avv. Stefano Menicacci (colloquio con gli autori) difensore di numerosi imputati per reati di terrorismo dell'estrema destra, fra cui anche Stefano Delle Chiaie, nell'analizzare la validità delle confessioni di un pentito, la magistratura dovrebbe tenere conto di tre punti: "In primo luogo andrebbe condotta un'indagine sulla personalità dei pentiti per valutare l'attendibilità delle loro dichiarazioni; secondo: bisognerebbe accertare di volta in volta se le informazioni rese dai pentiti siano state acquisite al processo in maniera legale; terzo: che le loro informazioni legalmente acquisite siano verificate con i criteri da sempre adottati della prova penale, escludendo che premesse costruite su criteri astratti e massime giurisprudenziali, valide solo nel processo in cui furono rese, possano automaticamente servire come chiavi atte ad aprire anche in certi processi la difficile porta della verità". 33 34 Da lettere scritte dal carcere agli autori da Paolo Signorelli. Cit. L'infiltrato è Rocco Ricciardi, confidente dei carabinieri per quasi un anno e mezzo (dal marzo 1979 all'ottobre 1980) il cui ruolo emergerà, con molto clamore, soltanto nel 1985, durante il processo di primo grado per il delitto Tobagi. Secondo quanto lo stesso Ricciardi riferirà durante il dibattimento, i carabinieri sarebbero stati da lui avvertiti che un attentato era in preparazione contro "qualcuno della stampa". Ai carabinieri - stando alle sue dichiarazioni - Ricciardi avrebbe fatto anche il nome di Walter Tobagi: "fu una mia ipotesi personale e in questi termini la riferii ai carabinieri" (Cfr. brani della deposizione di Rocco Ricciardi in L 'Unità 14-6- 1985) . È proprio per l'assassinio di Tobagi che Marco Barbone, 22 anni, una volta arrestato, non esiterà a fare i nomi di decine e decine di giovani militanti di movimento (è stato detto addirittura centinaia), alcuni dei quali per nulla passati alla lotta armata o in essa con ruoli del tutto marginali. Tant'è che la logica del "pentimento" (che resta pur sempre un modo facile per uscire di galera e cancellare il proprio passato) - come abbiamo già detto - non ha coinvolto chi, come i brigatisti del "nucleo storico", un retroterra politico lo aveva e - per quanto dannatamente sbagliato sia stato lo difende oggi come ieri quando sparava o si organizzava in banda armata contro lo Stato. La storia dei "pentiti" è storia tremenda. Storia di coscienze, di opportunismi, di madri in lacrime che convincono i figli. Di drammi personali. Ma e anche una storia di intrighi, di vendette personali. Di strane morti. Come quella del "superpentito nero" Stefano Tisei, trentunenne, ex parà, ex militante di Ordine Nuovo, protagonista discusso e ambiguo di quasi tutte le inchieste sull'eversione di estrema destra, trovato morto in uno squallido alberghetto di Milano con una siringa infilata nel braccio. Causa della morte: overdose di eroina. Una morte davvero strana la sua, come strana era la sua figura, a metà tra l'informatore dei Servizi (gli inquirenti lo chiamavano scherzosamente "il maresciallo") e il provocatore vecchio stile. Un uomo d'ordine, ma al tempo stesso uno sbandato, eroinomane, millantatore e ricattabile che con le sue accuse ha spedito in galera più di 150 persone. Lo trovano la mattina del 26 novembre 1988 sdraiato sul letto di una stanza d'albergo nei pressi della stazione centrale, sul prezzo della quale aveva ottenuto uno sconto, mostrando il tesserino da poliziotto. Tisei, condannato a sette anni di reclusione per i suoi trascorsi neofascisti, aveva scontato solo qualche giorno di carcere, poi, misteriosamente, era uscito di galera. E misteriosamente era morto, qualcuno dice "suicidato" perché forse, anche lui, sapeva troppo. Ma, si dirà, la storia dei "pentiti" resta una storia efficace perché ha permesso di disarticolare militarmente un fenomeno endogeno alla società italiana. Ma un fenomeno che è politico Si può sconfiggere solo sul piano militare? Oppure basta dire che "il terrorismo" è stato sconfitto politicamente perché non ha trovato il retroterra necessario? Che cosa ha fatto lo Stato per battere sul terreno dell'ipotesi politica futura l'eversione? Oppure l'importante è relegare il pensiero armato nell'ambito del solo pensiero perché le armi non sparino più? Interrogativi a cui nessuno, ancora oggi, può dare una risposta netta ed inequivocabile. La risposta è affidata alla storia di questo paese. Come le è affidata un'altra risposta. Lo Stato ha davvero fatto tutto per porre fine all'ipotesi armata? Fonte: Adalberto Baldoni e Sandro Provvisionato – La notte più lunga della Repubblica. Ideologie, estremismi, lotta armata – Serarcangeli, Roma 1989. Ripubblicato in: A che punto è la notte? – Vallecchi, Firenze 2003.
Scarica