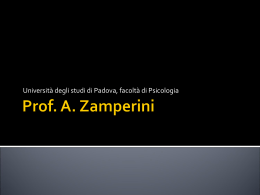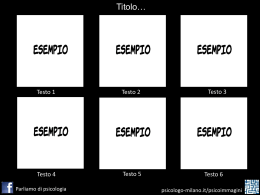51 /
Alfred North Whitehead (1)
Alfred North Whitehead ebbe un ruolo di rilievo nella fervida riflessione logica ed
epistemologica che lo affiancò, a Cambridge, nei primi decenni del Novecento, a
George Edward Moore e a Bertrand Arthur William Russell. Condivise con quest’
ultimo – che ne era stato allievo – il progetto di una logicizzazione della matematica.
Dalla valorizzazione del “logicismo” di Friedrich Ludwig Gottlob Frege – che
intendeva ricavare la matematica sino ad allora conosciuta dai concetti fondamentali
della logica, in virtù di un rigoroso apparato formale – scaturirono i monumentali
“Principia matematica” in tre volumi (1910-1913), scritti in collaborazione dai due.
Solitamente, però, chi ripropone le direttrici essenziali dell’ opera appiattisce e
risolve le posizioni di Whitehead nella filosofia della matematica di Russell. Ma il
contributo specifico sulla geometria e sulla logica delle relazioni di Whitehead ai
“Principia”, merita una maggior attenzione. Altrimenti non se ne comprenderebbe lo
specifico percorso successivo. Whitehead trasse, infatti, dalla collaborazione ai
“Principia”, la sollecitazione a sviluppare una acuta riflessione epistemologica che
ridiscutesse quella dominante concezione meccanicistica di mondo e di natura che il
pensiero contemporaneo aveva ereditato dalla fisica newtoniana e dalla filosofia
moderna. Intraprese, dunque, un cammino la cui traiettoria lo avrebbe portato lontano
dall’ atomismo logico dei “Principia” (che intendeva generare le proposizioni
“molecolari” da quelle “atomiche”, semplici, aderenti ai fatti), sul quale invece
Russell insistette, condizionato da quel “tremendo” suo allievo che era stato
Ludwig Wittgenstein. Russell avrebbe riconosciuto che costui, ancor giovane, gli
poneva questioni alle quali frequentemente lui stesso non sapeva dare risposta.
Eppure il maestro intuiva che l’ allievo possedesse già le risposte ai propri quesiti.
Ma – a parte l’ influenza di Wittgenstein su Russell – è bene sottolineare che l’
epistemologia di Whitehead non si fermò all’ analisi critica della conoscenza e del
linguaggio (comune) come accadde a George Edward Moore. La cui difesa del senso
comune (al quale già nel Settecento aveva conferito dignità gnoseologica Thomas
Reid) contro il neoidealismo di Francis Herbert Bradley, fu un vero e proprio
“toccasana” per gli stessi Russell e Wittgenstein. “Il tempo non è reale?” si chiedeva
Moore. E allora come potremmo aver fatto colazione “prima” di pranzare? E, del
resto, mentre io nego l’ esistenza di oggetti materiali, guardo le mie mani … E ne ho
una conoscenza intuitiva ed immediata. Il realismo di Moore insegnava a Russell e a
Whitehead che il mondo esiste effettivamente. Esso è costituito di fatti e di linguaggi
che mirano a descriverli. E proprio mentre Moore pubblicava la sua “Confutazione
dell’ idealismo”, Whitehead e Russell davano alle stampe i “Principi di matematica”.
Nella cui introduzione lo stesso Russell ammetteva che i caposaldi delle sue
concezioni filosofiche provenivano essenzialmente da Moore. “… devo a lui –
scriveva – il pluralismo che interpreta il mondo … Prima di apprendere < le sue >
teorie > mi sentivo del tutto incapace di costruire una qualsiasi filosofia dell’
aritmetica, mentre accettandole mi trovai immediatamente liberato da un gran numero
di difficoltà che ritengo siano altrimenti insuperabili”. Così nella traduzione italiana
di Ludovico Geymonat. Whitehead, comunque, come ha ben sottolineato Lluìs
Oviedo del Pontificio Ateneo Antonianum di Roma, con altri autori, deve aver
“sofferto la crisi legata alla percezione dell’ impossibile autofondazione della
matematica”. I prodromi della crisi del logicismo, che sarebbe giunta al suo apice con
Kurt Gödel, si eran già manifestati con gli insolubili paradossi che Russell s’ era
trovato di fronte. E nell’ ultima fase del suo intenso lavoro, dopo che la matematica,
le scienze e l’ epistemologia erano stati i suoi interessi dominanti, Whitehead volle
costruire, infatti, sulle fondamenta della scienza contemporanea (la teoria della
relatività e la quantistica), una organica cosmologia metafisica realista. Essa
mostrava risonanze delle filosofie di Platone, Georg Wilhelm Friedrich Hegel e
Gottfried Wilhelm Leibniz. Ed era il frutto del superamento tanto del meccanicismo
della fisica moderna quanto del materialismo meccanicistico e del sostanzialismo
dualistico della filosofia moderna. Si prefigurarono, così, nell’ intero percorso di
Whitehead, ben tre fasi: “una caratterizzata – come ha ben appuntato Ornella Bellini
– dalle riflessioni sulla logica e sulla matematica, un’ altra da quelle sulla fisica e
sulla filosofia della scienza, una terza indirizzata soprattutto alla costruzione di un
sistema metafisico fondato sulla cosmologia”. Le radici di ciascuna fase affondano
nella precedente ed il pensiero di Whitehead si sviluppa con armonia e coerenza,
senza soluzioni di continuità, e trae costante alimento da una arteria realistica. Nel
primo Whitehead predominava l’ interesse logico-matematico, che non sarebbe mai
venuto meno in lui, giacchè “La scienza della matematica pura potrebbe rivendicare
di essere la creazione più originale dello spirito umano” e “La logica è l’ igiene che il
matematico usa per far sì che le sue idee restino sane e robuste”. Il secondo
Whitehead meditò attentamente sulla teoria della relatività e approfondì lo studio
delle scienze naturali. E, visto che “I progressi fondamentali hanno a che fare con la
reinterpretazione delle idee di base”, l’ ultimo Whitehead approdò ad un “realismo
organico” (o “filosofia dell’ organismo”) che gli fece opporre un universale
panpsichismo – per cui tutto è vivo e tutto sente, e nulla vi è di inorganico nella
natura – al moderno meccanicismo di stampo cartesiano e newtoniano. Partendo, in
sostanza, dalle acquisizioni più recenti della fisica, costruiva una cosmologia
sistematica cui ricondurre unitariamente i processi del mondo organico, della cultura
e della società umana, nelle loro continue interrelazioni. Come ha scritto Annalisa
Usai nell’ introduzione all’ edizione italiana di “Il concetto di natura” (tradotto da
Mauro Leonardi), Whitehead ritenne che “Alle nozioni meccaniciste della sostanza e
delle sue particelle materiali inerti < fosse > necessario sostituire i concetti di energia
e di processo”. ”L’ universo intero” deve pertanto essere concepito, secondo
Whitehead, come “organismo e non macchina. Non accade tuttavia che nella
processualità universale la realtà vada perduta, anzi, Whitehead accentua sia l’
aspetto del divenire che l’ aspetto formale e metafisico del reale. Non a caso egli si
rifà a Platone e alla sua dottrina del mondo sensibile che, essendo sempre in un
processo di generazione, non perviene mai all’ essere, anche se questo si realizza nel
suo stesso non-essere”. Se ne trae che “Il processo … non si può capire se non in
relazione a forme immutabili, anche se queste non vanno considerate in sé, ma come
caratteristiche del processo”. L’ angolazione realistica di Whitehead distingue tra la
natura come oggetto della percezione e il pensiero, ma non in modo dualistico.
Ornella Bellini ha ricordato come il “meccanicismo organico” o “realismo organico”
di Whitehead andasse ponendo le proprie premesse “tra gli ultimi anni londinesi e i
primi ad Harvard con le nuove concezioni di natura, esperienza, tempo, spazio, dato
sensoriale, evento < che egli andava maturando >”. L’ intenso lavorìo epistemologico
produsse, dunque, “Nuove concezioni – precisa la Bellini – che, ancor prima di
presentare la “filosofia dell’ organismo” come sistema, si confrontano, criticandola,
con l’ immagine della natura della fisica classica newtoniana e con quelle filosofie
sostanzialiste, meccaniciste, idealiste (e quindi con Spinoza, Cartesio, Berkeley,
Kant) che in vario modo ne subiscono l’ ispirazione”. La critica del meccanismo
materialista gli dovette certamente rendere grata la prospettiva di Leibniz. Proprio
opponendosi a Cartesio, Leibniz aveva colto nella stessa spiegazione meccanicistica
l’ esigenza di attingere ad un piano più profondo, metafisico e finalistico. Leibniz non
aborriva i “philosophi novi”. Egli stesso elaborò il calcolo infinitesimale, la cui
notazione lo avrebbe fatto preferire ai matematici nel confronto con il metodo delle
flussioni di Isaac Newton. Leibniz non condivideva, però, la rimozione della filosofia
antica e medioevale che la scienza moderna esigeva. Sostenne che tra la filosofia e la
scienza moderna, da una parte, e la metafisica tradizionale, dall’ altra, non vi è
contraddizione. Colse la distinzione fra il piano delle cause finali e delle forme
sostanziali, e quello delle cause meccaniche. Ma la distinzione non escludeva, tra i
due ordini causali, l’ integrazione, la mediazione, la sintesi, in vista di una
comprensione e di una spiegazione completa della natura. Certamente non credeva
che la fisica moderna avrebbe potuto giovarsi delle forme sostanziali e delle cause
finali, pena il ritorno alla sterile fisica aristotelica. Ma contestò il concetto cartesiano
di “res extensa”: sostenere che i corpi sono essenzialmente estesi, così come le
menti-anime razionali sono essenzialmente sostanze pensanti, era errato. La semplice
estensione – che a Cartesio parve ciò che di essenziale vi è in un corpo, al di là delle
qualità sensibili – non giustifica l’ inerzia che ogni corpo oppone al moto. Il
mutamento di stato di un corpo esigerebbe una forza. Ma la forza non si spiega in
termini semplicemente meccanici, come è possibile, invece, per l’ estensione ed il
movimento: essa ci proietta immediatamente in una dimensione metafisica. Cartesio
credeva che Dio avesse impresso al mondo-macchina una quantità di moto costante,
il cui valore sarebbe costituito dal prodotto della massa per la velocità. Leibniz
propose, invece, come costante la “forza viva”, il cui valore corrisponderebbe al
prodotto della massa per la velocità al quadrato. La “forza viva” era sostanzialmente
l’ energia cinetica, ma, al di là dell’ anticipazione, è rilevante notare come la
dimensione meccanicistica lo rinviasse, immediatamente, ad un ordine causale
metafisico. Il finalismo non subentrava al meccanicismo; ne era, piuttosto, la
giustificazione e il fondamento. La correzione dell’ “errore” di Cartesio svelava la
natura metafisica dei fondamenti del mondo fisico. Tali fondamenti trascendono lo
spazio, il tempo, l’ estensione e il moto. La superficie meccanicistica della natura
rinvia ad una sottostante pluralità infinita di “centri di forza” attivi: quelle “monadi”
che sono sostanze semplici e spirituali, “atomi metafisici” o punti spirituali. Sulla
scia di Leibniz, Whitehead riflettè sulla percezione sensoriale. Egli la definì come
“prensione”, ad indicare l’ appropriazione e la presa di coscienza di dati provenienti
da una realtà “altra” dal pensiero e che sono eterogenei al pensiero stesso. Essi non
sono certo riducibili al soggetto conoscente. Ma non per questo sono passivi. Se ciò
di cui acquisiamo coscienza è altro dal pensiero, non ne è però meno attivo. Nel
mondo vi sono, dunque, due dimensioni, non meno reale l’ una rispetto all’ altra.
“Ogni attualità è bipolare: fisica e mentale”: enunciava Whitehead. La percezione, l’
attività, la vita, sono in tutto, e nulla vi è di inorganico, passivo, inanimato, nel
mondo. E un universo vivo non poteva da lui esser rappresentato che alla maniera di
Leibniz. Evocando il pluralismo dei “reali” di Johann Friedrich Herbart (1776-1841),
Whitehead avrebbe valorizzato la “monadologia” di Leibniz: l’ universo è costituito
da una infinita pluralità di monadi. Al concetto di monade, Leibniz era giunto proprio
attraverso la sua critica all’ “errore” di Cartesio. La stessa dimensione meccanicistica
esige la “forza viva”, il cui principio non può che essere una sostanza originaria e
spirituale, una forza primigenia metafisica che egli chiamò “monade”, a significarne
l’ assoluta semplicità ed unità, che soltanto una sostanza spirituale, appunto, può
avere. La monade non può esser confusa con l’ atomo di Leucippo e Democrito,
Epicuro e Lucrezio, riproposto in chiave moderna da Gassendi. L’ atomo è un “corpo
primo”. Ma non vi è corpo che possa dirsi assolutamente semplice, giacchè ciò che è
corporeo è comunque esteso e quindi composto di parti. La monade è un atomo
metafisico e spirituale. Se si vuole, è un punto, purchè non si faccia confusione con il
punto – astratto e non reale – dello spazio cartesiano. Ciascuna delle infinite monadi
vive dentro di sé la vita di un’ anima. Percepisce e trae dal suo fondo le
rappresentazioni, che scaturiscono l’ una dall’ altra. Ciascuna monade rappresenta e
percepisce, dentro di sé, il mondo, che altro non è che la rappresentazione svolta da
infinite monadi, ognuna delle quali non è che un particolare punto di vista su di esso.
Leibniz paragona le infinite monadi ad altrettanti osservatori che si dispongano a
cerchio attorno ad una città. Ciascuno di essi ne coglie, dalla propria particolare
prospettiva, un aspetto. Mette a fuoco alcune cose, e tutto il resto gli resta confuso.
Quel che gli appare indistinto sarà variamente chiaro a tutti gli altri, secondo una
gradazione infinita. E viceversa. L’ ultimo Whitehead, da parte sua, sostenne che
nell’ universo vi è un processo continuo di “concrescenza”, che è il frutto del
progressivo sviluppo delle monadi ed a cui concorrono e partecipano tanto la
dimensione fisica quanto quella psichica, entrambe reali. Ogni fase dello sviluppo
dell’ universo si mostra nuova rispetto alle precedenti. La sua inesauribile
potenzialità, che si esprime in una “evoluzione creatrice ed emergente”, è certamente
divina.
52 /
Alfred North Whitehead (2)
Alfred North Whitehead – “l’ ultimo platonico di Cambridge” – articolò la sua
filosofia attraverso tre stadi, come hanno evidenziato Rudolf Metz e Victor Lowe.
Nel “first period”, l’ ancor giovane Whitehead sviluppò l’ interesse, del resto mai
sopito, per la logica e la matematica. Ma lo studente Whitehead, in effetti, spaziava
con versatilità dalla matematica alla storia, dalla filosofia alle scienze, dalle lettere
classiche alla poesia. Ormai anziano, nel periodo di Cambridge, avrebbe coltivato,
accanto alla dominante cosmologia, la filosofia della storia, l’ etica e l’ estetica. Non
gli mancava, del resto, una forte attitudine alla sintesi interdisciplinare. E, per quanto
Bertrand Russell si sia mostrato un impietoso allievo quando ha scritto che, almeno
sino al 1918, il Maestro era sostanzialmente privo di un preciso orientamento
filosofico, non vi è dubbio che Whitehead sia stato un matematico incline alle
questioni filosofiche sin dagli esordi. L’ esitazione ad assumere nette e ben definite
posizioni filosofiche può esser dovuta – come notava, del resto, lo stesso Russell – ad
una circostanziata preoccupazione per il rigore e la puntualità delle premesse, così da
evitare conclusioni affrettate e grossolane, cui la fallace razionalità umana facilmente
espone. Un’ avvertenza decisamente cartesiana. Il secondo Whitehead, comunque,
approfondì la fisica e le scienze naturali in una prospettiva critica ed epistemologica.
L’ ultimo Whitehead sarebbe poi approdato ad una concezione cosmologicometafisica che assumeva le conclusioni più recenti della scienza tra Ottocento e
Novecento e superava il materialismo, il meccanicismo e il sostanzialismo della fisica
e della filosofia moderne. Fra i tre stadi del suo percorso non vi è, però, alcuna
soluzione di continuità. Vi è chi ha notato, nell’ evoluzione del pensiero di
Whitehead, un movimento che procede per “ampie approssimazioni sintetiche
successive” (Massimo Bonfantini). Già il primo Whitehead metteva in discussione,
ad esempio, il concetto moderno e newtoniano di “mondo materiale”. Era la premessa
del rifiuto successivo di una dottrina gnoseologica consolidata: quella della
distinzione tra qualità primarie o oggettive e qualità secondarie o soggettive dei corpi.
Una tale dottrina aveva lontane ed antiche origini atomistiche (Leucippo e
Democrito), ed era stata riscoperta da Cartesio, Locke e lo stesso Newton. Ma il
primo Whitehead preparava anche il rifiuto della “concretezza mal posta” (“fallacy of
misplaced concretedness”) che ritiene reali non i concreti oggetti ordinariamente
percepiti, bensì le astratte entità fisico-matematiche. Su queste e altre coordinate si
sarebbe mosso il secondo Whitehead nel predisporre – con una serrata disamina
epistemologica – la sua conclusiva cosmologia metafisica, proprio in alternativa all’
immagine del mondo proposta dalla scienza e dalla filosofia moderne.
Alfred North Whitehead nacque a Ramsgate (Kent) nel 1861 e sarebbe morto a
Cambridge (Massachusetts) nel 1947. Il padre, dapprima insegnante, sarebbe
divenuto pastore della Chiesa anglicana. Dopo gli studi classici a a Sherborne
(Dorsetshire) seguì i corsi di matematica pura e applicata al Trinity College di
Cambridge, dal 1880 al 1885. Dal 1885 al 1910 sarebbe stato, successivamente,
“yellow”, “lecturer” e “senior lecturer”. Trasferitosi nel 1910 a Londra, insegnò all’
University College e all’ Imperial College of Science and Technology di Kensington.
Dei suoi incarichi direttivo-educativi restano “I fini dell’ educazione e altri saggi”
(1924). Gli anni londinesi videro prevalere in lui, accanto agli irrinunciabili interessi
matematici e logici, quelli per la fisica e l’ epistemologia, mentre andava
delineandosi la preoccupazione cosmologico-metafisica che avrebbe dominato la sua
produzione più matura. Ebbe la cattedra di filosofia all’ Università di Harvard
(Cambridge) nel 1924. Proprio negli anni dell’ insegnamento statunitense (protrattosi
sino al 1937), elaborò quel realismo organico con cui si proponeva di dar
integrazione e sistemazione unitaria alle nuove prospettive delle scienze del suo
tempo. La filosofia non doveva esser soltanto epistemologia e non doveva limitarsi a
soppesare e ridiscutere criticamente le categorie delle scienze naturali. Il suo compito
più impegnativo doveva esser quello di costruire una “aggiornata” cosmologia
metafisica. Aveva sviluppato il programma logicista (che voleva dar integrale
fondamento logico alla matematica) con Bertrand Russell. I due pubblicarono i
“Principia Mathematica” (1910-1913), di cui il “Trattato di algebra universale” (“A
treatise of universal algebra”, 1898), “On Mathematical Concepts of the Material
World” (1906) e “The Axioms of Projective Geometry” (1907) di Whitehead
costituiscono una sorta di lavoro preliminare e, per certi aspetti, una anticipazione,
giacchè vi si ritrova l’ ideale leibniziano di una “caratteristica universale” come
insieme di tutti i concetti primitivi necessari alla elaborazione-risistemazione di tutta
la conoscenza umana. La “characteristica universalis” di Gottfried Wilhelm Leibniz
intendeva costituire un ben preciso linguaggio simbolico, privo delle approssimazioni
e delle ambiguità dei linguaggi naturali. Esso doveva assumere come paradigma il
calcolo matematico, per ridurre i processi inferenziali ad un altrettanto rigoroso
calcolo logico. Il “calculus ratiocinator” avrebbe ricondotto le inferenze ad una
precisa manipolazione di simboli.Al contrario di molti filosofi del suo tempo, Leibniz
non disprezzava la logica formale aristotelica e scolastica. Si stupiva, anzi, che non se
ne comprendesse la potenziale utilità per la razionalità e per una rigorosa edificazione
della scienza. Ma avvertiva anche l’ esigenza di farne un uso accorto. Ammirava il
sillogismo (ad esempio: “Tutti gli uomini sono mortali”; “Socrate è un uomo”; ergo
“Socrate è mortale”) e lodava Aristotele per averlo acquisito. Vi scorgeva una sorta di
“matematica universale la cui importanza” non era ancora stata rilevata. Vi scopriva
“un’ arte di infallibilità” che doveva esser valorizzata e bene impiegata. E intendeva
fondare una “logica più sublime”. Come ha sottolineato Luigi Lentini (“Lo statuto
della conoscenza scientifica nella epistemologia contemporanea”, Logica e filosofia
della scienza, Università Ca’ Foscari di Venezia), “L’ idea fondamentale che sta alla
base di questa “logica più sublime” consiste nella generalizzazione della nozione di
“calcolo””. Il calcolo, secondo Leibniz, era un’ operazione che si avvale di caratteri e
che non deve riguardare soltanto le quantità ma qualsiasi ragionamento. La “mathesis
universalis” di Leibniz intendeva costituire una vera e propria aritmetizzazione della
logica. E gli originali precorrimenti del filosofo-scienziato di Lipsia (“De arte
combinatoria”, 1666; “Opuscoli e frammenti inediti di Leibniz”, pubblicati soltanto ai
primi del Novecento) avrebbero mostrato tutto il loro valore, proprio negli sviluppi
novecenteschi della filosofia della matematica e della logica matematica.
Frequentemente, le introduzioni ai “Principia matematica” riducono l’ apporto di
Whitehead alle tesi di Russell. Si sostiene che Russell e, quasi “al traino”, Whitehead
tentarono di realizzare in modo compiuto il programma della fondazione logica della
matematica, svelando l’ antinomia del quinto postulato del sistema di Friedrich
Ludwig Gottlob Frege e risolvendo brillantemente il problema delle antinomie con la
“teoria dei tipi”. Si aggiunge, non meno avvedutamente, che, poi, il programma
logicista sarebbe incappato nelle stroncature del “Tractatus logico-philosophicus” di
Ludwig Wittgenstein, per uscirne distrutto. Di recente, da noi, Luca Gaeta (“Segni
del Cosmo. Logica e Geometria in Whitehead”) ha voluto sottolineare la validità
intrinseca della “pratica matematica”, della geometria e della logica del primo
Whitehead, solitamente sacrificate all’ ultimo Whitehead, filosofo e assertore di una
nuova cosmologia. Gaeta invita ad intendere il primo periodo di Whitehead come “il
nucleo di tutte le sintesi posteriori che non si succedono però teleologicamente,
rappresentando ciascuna un momento compiuto e un centro definito di attenzione all’
interno del quale Whitehead si muove e dal quale muove a nuovi sviluppi”. Ma Gaeta
non si è occupato soltanto delle “potenzialità filosofiche” del primo Whitehead; ha
voluto valorizzare anche “l’ interesse intrinseco del discorso fondazionale di
Whitehead sulla geometria”. “Benché estremamente aggiornato e consapevole sia
della obsolescenza di una esclusiva interpretazione quantitativa della matematica, sia
della crisi in cui versa la tradizionale fondazione intuitiva, Whitehead – scrive Gaeta
– assume la fertilità del metodo ipotetico-deduttivo senza per questo abbandonare l’
idea che gli enunciati matematici vertano, in ultima analisi, su proprietà generali del
mondo di esperienza. Le modalità effettive con cui egli dà voce a un orientamento
ontologico della matematica si rivelano di grande interesse e originalità. Sin dagli
esordi è chiaro che l’ abbandono dell’ interpretazione quantitativa investe
direttamente per lui la concezione delle oggettività, tramutandosi in un coerente
antimaterialismo. Lo spazio stesso, in quanto tradizionale oggetto di studio della
geometria, è indagato matematicamente da Whitehead e risolto nel costrutto
relazionale di rinnovate entità fisiche basilari. Lo studio delle proprietà geometriche
non guarda più soltanto alla garanzia della loro validità, ma anche alla
concettualizzazione della loro scaturigine”. Su una cosa, del resto, Gaeta non ha
dubbi: “l’ impostazione filosofica logicista di Russell < sottesa ai “Principia
Mathematica” > è troppo eterogenea rispetto alla continuità di atteggiamento che
accomuna le altre opere whiteheadiane del “first period””. In sostanza, bastano “On
mathematical concepts of the material world” (1906) di Whitehead, “per cogliere il
formalismo dei “Principia” e la logica delle relazioni adoperati da Whitehead come
strumenti linguistici di una indagine cosmologica, laddove per Russell la logica è
indifferente all’ esistenza del mondo”. Dall’ originale contributo dato ai “Principia
Mathematica”, Whitehead fu indotto, comunque, ad una riflessione filosofica che gli
fece prendere le distanze da Russell. Cominciò a interrogarsi sull’ interpretazione
newtoniana del mondo materiale e sviluppò una originale epistemologia le cui
risultanze sono contenute ne “L’ organizzazione del pensiero” (1917), nella “Ricerca
sui principi della conoscenza naturale” (“An Enquiry Concerning the Principles of
Natural Knowledge”, 1919), ne “Il concetto di natura” (“The Concept of Nature”,
1920). “Il principio della relatività” (“The Principle of Relatività with Applications to
Physical Science”, 1922) sondava le implicanze filosofiche della teoria della relatività
di Einstein. L’ ultimo Whitehead impresse una svolta decisamente metafisica alla sua
produzione, che si distingue però, nettamente, dalla metafisica classica e, in
particolare, da quella razionalistica di stampo cartesiano. “La scienza e il mondo
moderno” (“The Science and the Modern World”, 1925), “Il divenire della religione”
(“Religion in the Making”, 1926), “Simbolismo” (“Symbolism, Its Meaning and
Effect”, 1927), “Processo e realtà” (“Process and Reality”, 1929), “Avventure di
idee” (“Adventures of Ideas”, 1933), “Modi del pensiero” (“Modes of Thought”,
1938), “Scienza e filosofia” (“Science and Philosophy”, 1947) sono saggi che
attestano la fecondità del suo radicale ripensamento di alcuni caposaldi della
gnoseologia tradizionale e contemporanea.
53 /
Alfred North Whitehead (3)
Fra il 1919 e il 1922 il “secondo” Alfred North Whitehead sviluppò una riflessione
epistemologica fondata sulla ferma convinzione che i postulati della scienza sono
metafisici. L’ empirismo classico, le sue riformulazioni contemporanee, la posizione
empiristica e naturalistica secondo la quale non vi è altra realtà che quella sensibile,
scaturiscono, comunque, da un’ intuizione metafisica riguardo all’ essere, al mondo,
all’ uomo. Docente di matematica al Trinity College di Cambridge e poi all’
University College londinese e all’ Imperial College of Science and Technology di
Kensington, in questi anni Whitehead condivise con la moglie il dolore per la perdita
del figlio Eric, pilota dell’ aeronautica inglese morto in guerra nel 1917. Non sono
mancati coloro che hanno visto nella perdita del figlio uno dei fattori che
determinarono la transizione dal “secondo” al “terzo Whitehead”, che dalla filosofia
della scienza traeva una esigenza metafisica. L’ istanza metafisica-cosmologica
sembra però esser, più che biografica, internamente costitutiva dell’ intera riflessione
di Whitehead. Come ha ben notato Annalisa Usai introducendo l’ edizione italiana di
“The Concept of Nature” (1920, “Il concetto di natura”, traduzione di Mauro
Leonardi, 1974), “come lo studio della matematica e della logica aveva condotto
Whitehead a occuparsi del valore della scienza e delle sue astrazioni, cioè dell’
epistemologia, ora proprio la stessa epistemologia conduce Whitehead ad allargare l’
orizzonte delle sue speculazioni e ad abbracciare una problematica schiettamente
filosofica”. L’ ultimo Whitehead si sarebbe volto, infatti, ad una concezione organica
della realtà, aprendosi ad una “teologia filosofica” o “filosofia della religione” che, da
una concezione organica della realtà (filosofia dell’ organismo), vuol risalire a Dio,
integrando le acquisizioni scientifiche, religiose, morali ed estetiche . Già mentre
stava lavorando con Bertrand Russell ai “Principia Mathematica”, il “primo
Whitehead” si mostrava scettico sulla nozione classica e newtoniana di un mondo
materiale le cui coordinate sono i punti dello spazio, gli istanti del tempo e i
corpuscoli di materia. Da quell’ atteggiamento critico prese le mosse l’ indagine
epistemologica che avrebbe caratterizzato il “secondo Whitehead”. Di fronte a lui,
problematicamente, stava la relazione tra la dimensione dei puri concetti logicoscientifici e il piano della concreta percezione. Ed era certo che una filosofia della
scienza dovesse acquisire la consapevolezza che quello dell’ esperienza attuale, da
cui si muove la scienza, è un mondo “radicalmente disordinato e disorganico”. La
scienza fatica a rendersene conto poiché il suo “linguaggio modellato”, formale,
ordinato, composto, immette nelle nostre menti “concetti esatti come se essi
rappresentassero i dati immediati dell’ esperienza”. Cadiamo nella fallace illusione di
“avere esperienza immediata di un mondo di oggetti perfettamente definiti, i quali,
come li conosciamo attraverso i dati dell’ esperienza sensibile, accadono in esatti
istanti di tempo, in uno spazio formato da punti esatti, senza parti e senza grandezza:
il puro, esatto, preciso mondo che è la meta del pensiero scientifico”. L’
epistemologia di Whitehead si scontrava con la “duplicazione della natura in due
sistemi di realtà”. Egli era costretto a rilevare la contrapposizione di due mondi, l’
uno logico, ordinato, esatto, e l’ altro percepito, confuso, disordinato. Ma solo quest’
ultimo è reale. E questo nonostante la scienza classica e la metafisica tradizionale
sostenessero il contrario. Il sapere che veniva dal passato era carico di dualismi, il
primo dei quali opponeva la natura, così come l’ aveva costruita la fisica classica, alla
natura trasmessa dalla percezione. La convergenza della scienza classica e del
sostanzialismo ribaltava la reale funzione che “mondo della scienza” e “mondo della
percezione” hanno nella conoscenza. Il mondo esperito e percepito è stato ridotto a
fenomeno della coscienza, alla dimensione delle qualità soggettive e secondarie,
prive di un’ oggettiva realtà. Viceversa, il mondo delle leggi logiche, matematiche e
scientifiche, è divenuto un mondo vero, oggettivo, primario: una sorta di celata cosa
in sé da cui scaturiscono le percezioni. L’ epistemologo Whitehead rifiutava la
contrapposizione tra le qualità primarie (oggettive) e le qualità secondarie
(soggettive) dei corpi, sostenuta da molti filosofi (dapprima Leucippo e Democrito,
gli antichi atomisti, poi Cartesio e Locke tra i moderni). E non accettava la
contrapposizione tra l’ esperienza “scientifica” e quella “soggettiva”-individuale
comune. Riteneva inadeguata l’ idea di sostanza costruita dal moderno naturalismomeccanicismo. Si chiedeva, insomma, perché non si riconoscessero come reali gli
oggetti percepiti e si attribuisse, invece, erroneamente, concretezza agli enti (astratti)
fisici, matematici, scientifici. Come possiamo trascendere gli enti che la percezione ci
mostra? Non dobbiamo andar oltre! Questo non vuol dire che si debba rinunciare ai
costrutti e alle operazioni della scienza. E’ però necessario non ribaltare l’ ordine
della realtà ed evitare la “concretezza mal posta”. La concretezza viene dalla
percezione. Le categorie concettuali con le quali descriviamo il mondo della
percezione sono, invece, astratte. E non viceversa. Whitehead era certo che la
razionalità filosofica e scientifica non possa avere, all’ orizzonte del suo luminoso e
lineare percorso, “idee di chiarezza e generalità”. La filosofia non muove, come
vorrebbe Cartesio, da postulati chiari, distinti, evidenti. Sua unica ambizione non può
esser che quella di una generalizzazione teorica della complessità e della multiformità
dei processi della vita, nelle sue numerose forme ed espressioni. Le teorie scientifiche
non possono pretendere la veridicità: esse non sono altro che generalizzazioni e
semplificazioni destinate ad una continua revisione e adeguazione a ciò che tentano –
inadeguatamente – di esplicare. La filosofia e la scienza gli apparivano – ricordando
uno dei suoi titoli - nient’ altro che “avventure di idee”. Tali debbono essere, se poste
di fronte alla complessità della realtà. Una cosmologia autenticamente realista non
riduce – come faceva la metafisica tradizionale – la realtà alle relazioni tra la sostanza
e le sue qualità. Oltre l’ illusorio dualismo di soggetto e oggetto, la realtà dev’ essere
colta nella sua complessa processualità. Essa è un processo nel quale non si danno
sostanze separate, ma “eventi”, strutture e forme in reciproca connessione, che si
possono definire tanto soggettivi quanto oggettivi. Le premesse dell’ ultimo
Whitehead, quello di una cosmologia metafisica che si può definire come “filosofia
dell’ organismo” o “meccanicismo organico”, risiedono dunque in un approccio
critico al meccanicismo materialista. Ornella Bellini (“Alfred North Whitehead”) ha
rilevato come già nel giovane Whitehead allignasse un atteggiamento critico tanto nei
confronti dei “reali oggettivi”, vale a dire dei punti dello spazio e dei corpuscoli
materiali primi, quanto delle particelle di materia e degli istanti di tempo affermatisi
con Isaac Newton. L’ essere umano conosce il mondo percependolo come oggetto
della propria sensazione. La conoscenza umana viene dalle sensazioni. Conosco una
mela in quanto la gusto, la odoro, la tocco e la vedo. Avverto il mio mal di denti in
modo diverso da altri, anche se poi il dente e la sua patologia costituiscono un
identico oggetto di scienza per tutti. Non c’ è conoscenza degli “eventi” del mondo
che possa prescindere dalla datità fisica della cosa reale e che possa prescindere dalla
sensibilità. “Le cose che troviamo nello spazio – scriveva Whitehead ne “Il concetto
di natura” – sono il rosso della rosa, il profumo del gelsomino ed il rombo del
cannone. Noi tutti abbiamo detto ai nostri dentisti dove è il nostro mal di denti. Così
lo spazio non è una relazione tra sostanze, ma tra attributi”. L’ errore della teoria
della materia sta nella sua premessa: “l’ accettazione dogmatica dello spazio e del
tempo come condizioni esterne per l’ esistenza della natura”. Ma è un pregiudizio la
convinzione che spazio e tempo siano ciò al cui interno è collocata la natura. “… la
filosofia – sosteneva – ha trasformato illegittimamente la pura entità, che è
semplicemente un’ astrazione necessaria al processo del pensiero, nel sostrato
metafisico di quei fattori della natura che in diversi sensi sono riferiti alle entità
come loro attributi”. Filosofi e scienziati hanno “presupposto questo sostrato in
quanto sostrato degli attributi, situato nello spazio e nel tempo”. Ma “L’ intero essere
della sostanza consiste nell’ essere un sostrato degli attributi”. Il sostanzialismo
moderno ha ritenuto che “la materia fosse … sostanza della natura” e che “la sostanza
fosse nello spazio”. Non la sostanza, bensì gli attributi sono nello spazio. “Lo spazio
non ha nulla a che fare con le sostanze, ma solamente con i loro attributi” e “… se la
materia viene concepita come una sostanza nello spazio, lo spazio nel quale essa si
trova non ha nulla a che fare con lo spazio della nostra esperienza”. Dal “Timeo” di
Platone in poi, attraverso Aristotele, la filosofia della natura ha imboccato una strada
sbagliata. Da allora in poi si è considerata “la materia come elemento fondamentale
per la formazione dello spazio”. Whitehead propone un esempio: “ … in un museo,
un esemplare è chiuso in una vetrina. Esso sta lì per anni. Ma è sempre lo stesso
esemplare; gli stessi elementi chimici e le stesse quantità di tali elementi sono
presenti dopo come erano presenti prima. Così l’ ingegnere e l’ astronomo si
occupano di movimenti di cose che permangono effettivamente nella natura. Ogni
teoria della natura che perdesse di vista per un solo momemtjo questi fatti basilari
dell’ esperienza sarebbe semplicemente ridicola”. Senonchè, “ … il significato
scientifico di questi fatti è finito soffocato in un groviglio metafisico di dubbio
valore”. Occorre perciò eliminare la metafisica e riprendere da “ … uno
spregiudicato esame della natura … < per > gettare nuova luce su molti concetti
fondamentali che dominano la scienza e guidano il progresso della ricerca”. A
Whitehead appare chiaro – come nota Ornella Bellini – che le scienze matematiche e
le scienze fisico-matematiche “stabiliscono relazioni tra cose che non sono evidenti e
possiedono un livello di astrazione tale che la loro validità prescinde dall’ evidenza
acquisita con la percezione guidata dai sensi (quindi dai casi particolari e dalle entità
particolari). Così i numeri 3 o 5 sono tali non perché derivati da o riferiti a 3 o 5
entità materiali particolari (sassi, grani ecc: ). Analogamente la descrizione scientifica
del corso degli eventi si è identificata in quella tendenza vittoriosa “deduttivoquantitativa” che, insistendo sulla quantificazione della materia come unico mezzo
per una comprensione oggettiva, ha finito per astrarre sia dal soggetto percipiente che
dal tipo di percezione conseguita e ha incoraggiato a considerare soltanto quelle
entità (molecole, atomi, protoni, neutroni ecc.) che si muovono nello spazio e che s’
influenzano reciprocamente”. Per cui, concludeva Whitehead nell’ “Introduzione alla
matematica”, quella mela che io assaporo, odoro, tocco, viene descritta “in termini di
posizione e moto di molecole, una descrizione che … ignora … la vista, il tatto, il
gusto e l’ odorato”. Da qui l’ esigenza di colmare il solco scavato tra l’ oggettività
scientifica e la concreta e comune esperienza percettiva, ridiscutendo le categorie e il
metodo della fisica classica newtoniana e delle metafisiche moderne,
sostanzialistiche, meccanicistiche e idealistiche. La soluzione sarebbe consistita in
una cosmologia (“meccanicismo organico”) che avrebbe ripensato in modo originale
tanto l’ esperienza quanto la scienza.
54 /
Alfred North Whitehead (4)
Alfred North Whitehead articolò la sua filosofia attraverso tre fasi, che non debbono
esser considerate come altrettanti compartimenti stagni. Ciascuna di esse, infatti,
prelude alla successiva. La quale ne costituisce la naturale evoluzione e ne scaturisce
con coerenza dialettica. Il giovane Whitehead, dominato dall’ attenzione per la logica
e la matematica, aveva scritto con Bertrand Russell, i “Principia Mathematica”. Già
nel primo Whitehead, quello del periodo londinese, cresceva però un’ attitudine
epistemologica, fortemente critica nei confronti della filosofia moderna e della fisica
newtoniana, nelle loro pretese meccanicistiche, sostanzialistiche, idealistiche. E il
secondo Whitehead, del resto, predisponeva la terza fase di una riflessione che
sarebbe sfociata in una cosmologia metafisica che si può definire meccanicismo
organico o filosofia dell’ organismo. Ne “Il concetto di natura”, l’ epistemologia di
Whitehead criticava l’ avvento di una inaccettabile teoria nella filosofia della scienza
moderna: quella della “duplicazione della natura in due sistemi di realtà, reali
ambedue ma in senso diverso”. Secondo la scienza e la filosofia moderne “Una <
delle due > realtà sarebbe costituita da enti del tipo degli elettroni, materia di studio
per la fisica speculativa”. “Questa – aggiungeva – sarebbe la realtà a disposizione
della conoscenza; sebbene secondo questa concezione essa non venga mai
conosciuta, poiché ciò che si conosce è l’ altra specie di realtà, l’ azione sussidiaria
dello spirito. Così vi sarebbero due nature: la prima delle quali sarebbe un’ ipotesi e
la seconda un sogno”. La teoria della duplicazione “consiste nel duplicare la natura in
due sezioni, ossia nella natura appresa nella sensazione e nella natura che è causa
della sensazione. La natura che costituisce il fatto della sensazione contiene in sé il
verde degli alberi, il canto degli uccelli, il calore del sole, la durezza della sedia, l’
impressione del velluto. L’ altra natura invece, che è la causa della sensazione, viene
immaginata come un sistema di molecole e di elettroni che agiscono sullo spirito in
modo da provocare la sensazione della natura apparente. Il punto d’ incontro delle
due nature sarebbe lo spirito, su cui la natura causale eserciterebbe il suo influsso e di
cui la natura apparente sarebbe l’ influsso …”. Una tale deformazione della
comprensione della natura era nata, secondo lui, dalla “teoria degli accrescimenti
psichici < che > vorrebbe trattare la qualità del verde come un’ aggiunta psichica
fornita dallo spirito percipiente; e vorrebbe lasciare alla natura soltanto le molecole e
l’ energia raggiante che influenza lo spirito attraverso la percezione”. All’ origine
della duplicazione della natura sta il modo in cui la materia è stata concepita in età
moderna: essa sarebbe una sostanza della quale noi dovremmo percepire gli attributi.
Ma proprio nel Seicento la “semplicità idillica” della tesi che “le cose di cui
percepiamo gli attributi ci appaiono come frammenti di materia”, entrò in crisi di
fronte alle teorie della luce e del suono. La teoria della sostanza e dei suoi attributi fu
incrinata dalle “teorie consideranti la luce e il suono come qualcosa di proveniente
dai corpi emittenti; e in particolare Newton stabilì chiaramente la connessione della
luce coi colori”. La semplicistica teoria percettiva di “sostanza e attributo” fu
destituita di fondamento: “Quanto vediamo dipende dalla luce che penetra nell’
occhio. Inoltre non percepiamo neppure ciò che penetra nell’ occhio. Le cose
trasmesse sono onde o – come pensava Newton – particelle; mentre le cose viste sono
colori”. Era una incongruenza che John Locke, empirista classico, affrontò
distinguendo tra qualità primarie e qualità secondarie dei corpi. Qualità secondarie
come i colori, dice Whitehead, ricordando la tesi di Locke, “non < sarebbero >
attributi < propri e originari > della materia, sebbene vengano percepite come se lo
fossero”. Ma per quale motivo dovremmo percepire qualità secondarie, se esse sono
del tutto soggettive? Sostenere che si percepiscano “una quantità di cose che non
esistono”, diceva Whitehead, è proprio una “trovata infelice”. E aggiungeva che “Per
noi i bagliori rossi del tramonto fan parte della natura quanto le molecole e le onde
elettriche, con cui gli uomini di scienza pretendono spiegare il fenomeno”.
Conosciamo una mela in quanto la odoriamo, la gustiamo, la tocchiamo. Ciascuno
percepisce il suo mal di denti diversamente da ogni altro. Eppure le scienze fisicomatematiche intendono la mela come moto di molecole e considerano identici i denti
di tutti. Ma come si può prescindere dall’ oggetto o dal fatto reale quando si voglia
conoscere il mondo? Vi sono proprio soltanto molecole e atomi che si muovono nello
spazio, e nient’ altro? L’ asimmetria esistente tra la conoscenza scientifica, oggettiva
e distaccata, e quella sensoriale, vissuta e concreta, esige un ripensamento dell’
esperienza e della stessa scienza. Whitehead, da un lato, mette in discussione le
categorie della fisica classica. Dall’ altro elabora una cosmologia. In “The
Organisation of Trought Educational and Scientific” (1917, “La scienza moderna”,
nella traduzione italiana di Antonio Banfi, 1959) Whitehead intende la scienza come
“organizzazione mentale dell’ esperienza”. Ove l’ esperienza non è che “quel flusso
di percezioni, sensazioni ed emozioni che formano la nostra esperienza di vita”, delle
quali la scienza ricerca relazioni, dando ordine a quel che sarebbe caotico e
disorganico. In sostanza, la scienza riposa, realisticamente, sulla concretezza dell’
“effettuale e vissuto reale percepito”, come ha scritto Ornella Bellini. La scienza non
può confondere, come ha fatto sinora, concetti esatti e dati immediati dell’
esperienza, in nome dell’ oggettività. Non può astrarre dalla concretezza della
particolarità per inseguire relazioni tra idee. L’ epistemologia deve comprendere il
rapporto fra concreti dati percettivi e costruzione scientifica del mondo. La scienza
non può rinunciare all’ esperienza e alla percezione. E’ errato distinguere tra la
sostanza, che avrebbe il carattere della permanenza, e l’ accidentalità degli attributi
della sostanza stessa. E non è meno ingannevole credere che la scienza debba
occuparsi solo di presunte qualità primarie dei corpi, oggettive ed essenziali,
ignorando quelle secondarie, in quanto meramente soggettive. “Concretizzazione mal
posta” definisce Whitehead un tale errore. Le astrazioni logiche son diventate sostrati
metafisici degli attributi degli enti: attributi intesi come fatti naturali. Le intrusioni
della metafisica razionalistica nella scienza hanno prodotto una visione dell’
universo nella quale i nostri contenuti mentali vengono scambiati per effettive e
concrete realtà. Dello stesso errore – la sostituzione del concreto con le mere
astrazioni – s’ è resa responsabile la scienza newtoniana. La “teoria della
localizzazione semplice”, sostiene Whitehead, è scaturita dal postulato newtoniano
che il tempo e lo spazio sono assoluti. Essi costituirebbero lo “sfondo” sul quale si
verificano gli “eventi” fisici, ed avrebbero una realtà oggettiva indipendente da
quegli stessi eventi. La “localizzazione semplice” degli atomi o corpuscoli materiali
vuole che i corpi o le sostanze si situino semplicemente nello spazio-tempo. Non vi
sarebbe altra collocazione, per gli atomi di materia, che il “qui” nello spazio-tempo.
Il tempo scorre e la materia persiste nella propria indifferenza ad esso. Il tempo, nel
suo scorrere uniforme come le lancette di un orologio, è, a sua volta, indifferente alla
materia-sostrato. Ma il tempo non è una semplice successione, come credeva David
Hume, e lo spazio non è la semplice localizzazione della materia-sostanza. In effetti,
scrive Whitehead in “The Science and the Modern World” (1925, “La scienza e il
mondo moderno”, 1959, nella traduzione di Antonio Banfi), “l’ entità … che è il
risultato finale del nostro atto di percezione … è l’ oggetto sensibile”. E per oggetto
sensibile, egli intende, ad esempio, “il verde di una data sfumatura … un suono di
qualità e tono definito … un determinato odore … una qualità definita di sensazione
tattile”. E aggiunge che “I rapporti tra una simile entità e lo spazio, durante un certo
periodo di tempo, sono complessi … l’ oggetto sensibile è l’ oggetto di un’ inserzione
nello spazio-tempo”. Lo spazio non è l’ astratto “luogo della materia”. Esso è,
concretamente, il “volume”. E il volume non è una molteplicità di punti, i quali non
hanno volume. Realisticamente, il “volume” prende corpo in una stanza. E una stanza
non è che un insieme di parti, ciascuna delle quali ha realtà solo se ricondotta alle
altre. Per capire la sua concezione dello spazio, Whitehead invita a considerare un
semplice esempio: “Non c’ è che da guardare in uno specchio e vedere l’ immagine
riflessa di qualche foglia verde dietro la vostra schiena. Per voi in A ci sarà del verde,
ma non solamente in quel A dove vi trovate. Il verde in A sarà un verde localizzato
nell’ immagine della foglia dentro allo specchio. Ora volgetevi e guardate la foglia
stessa. Voi percepite ora il verde nello stesso modo di prima, salvo che è posto nella
vera foglia. Io non faccio che descrivere ciò che percepiamo; noi abbiamo coscienza
del verde quale elemento nell’ unificazione prensiva di oggetti sensibili; ogni oggetto
sensibile, tra gli altri il verde, ha il suo proprio modo, che può esprimersi come posto
altrove”. I volumi costituiscono delle “entità all’ interno della totalità; non si possono
astrarre da ciò che li circonda senza distruggere la loro stessa natura”. E il tempo?
Contro la concezione di David Hume del tempo come di una pura successione,
Whitehead sostiene in “Symbolism, Its Meaning and Effect” (1927, “Il simbolismo,
suo significato e sue conseguenze, traduzione italiana di F. Cafaro, 1963), che “Il
tempo … come successione dei nostri atti di esperienza … non è pura successione …
ma derivazione da stato a stato, dello stato posteriore che mostra conformità con il
precedente; e la pura successione è un’ astrazione dell’ irreversibile relazionalità del
passato concluso con il presente che ne deriva”. Come ha scritto Ornella Bellini, il
“tempo in concreto” di Whitehead, “il solo di cui il soggetto ha esperienza e può
parlare, è sempre un tempo vissuto; non è il tempo dell’ orologio, una “pura
successione” di dati senza nesso causale tra il precedente e il successivo … è
anzitutto “durata”, “conformazione” del presente al passato e del presente con il
futuro”. E, aggiunge la Bellini, “Il principio di “conformazione” come criterio di
lettura del tempo … e degli eventi che in esso si succedono, non suggerisce un’
estrinseca e mera conformazione dei dati esteriori degli eventi, ma sottende che il
divenire è divenire dal passato al presente e anticipa il futuro; sottende un accadere
come concrescere degli eventi, come concorrenza reciproca tra il prima e il dopo …
gli eventi sono inseriti in un processo relazionale al cui interno è iscritta la loro storia,
il loro “curriculum vitae”, la loro “memoria””.
55/
Alfred North Whitehead (5)
Alfred North Whitehead ha concluso il suo fecondo percorso epistemologico
approdando ad una “filosofia dell’ organismo”, un “meccanicismo organico”, che
intendeva essere una sistematica cosmologia metafisica. La “filosofia dell’
organismo” era il frutto di un lungo travaglio che era iniziato con il giovane
Whitehead, logico e filosofo della matematica, il quale aveva scritto, con Bertrand
Russell, i “Principia Mathematica”. L’ epistemologia del secondo Whitehead avrebbe
poi inferto fieri colpi al “concetto di natura” elaborato dalla fisica classica e dalla
filosofia moderna. Attaccando a fondo il materialismo meccanicista e il
sostanzialismo razionalista, che avevano dominato nel Seicento e nel Settecento, sino
a buona parte dell’ Ottocento, Whitehead ridiscuteva le categorie della fisica
newtoniana e proponeva una cosmologia metafisica fondata su di un modo nuovo di
pensare la concreta esperienza sensoriale e percettiva. Whitehead migrò negli Stati
Uniti nel 1924, quando ebbe una cattedra di filosofia alla Harvard University. Allora
emerse quel vero Whitehead i cui presupposti eran già latenti nelle giovanili indagini
logico-matematiche. E mostrò un afflato che comprendeva le prospettive,
apparentemente eterogenee, della scienza, della morale, dell’ estetica e della
religione. Lluìs Oviedo (Pontificio Ateneo Antonianum, Roma) ha scritto che il suo
“tentativo di “ordinare” o di stendere una mappa del reale, dove la scienza e gli altri
saperi – la morale, l’ estetica e la religione – possano trovare il loro posto”, potrebbe
esser definito come una “teoria unificata della realtà”, “se questa espressione non
possedesse oggi delle connotazioni più fisico-cosmologiche che non filosofiche”.
Whitehead intese – come sostenne lui stesso in “Process and Reality. An Essay in
Cosmology” (1929, “Processo e realtà”, traduzione italiana di N. Bosco, 1975) –
proporre il “tentativo di formulare un sistema coerente, logico e necessario di idee
generali nei termini in cui ogni elemento della nostra esperienza possa essere
interpretato”. Era un progetto che si apriva alla fisica dei “quanta”, alla teoria della
relatività, alla biologia evoluzionistica e alle acquisizioni più recenti della scienza.
Whitehead diede udienza, come ha sottolineato Ornella Bellini, alla “forza
disgregatrice di quelle idee-guida delle scienze che compromettono seriamente il
primato della scienza meccanica”. Tra quelle idee-guida sono da enumerare “l’
evoluzionismo in biologia”; la grande ascesa delle scienze biologiche che, facendo
dell’ organismo il loro oggetto, spostano l’ attenzione dalla materia inorganica alla
materia organizzata e agli organismi; la nuova concezione di “atomicità” della
materia formulata dalla fisica dei “quanta”; quella di un campo fisico di forze che
invade lo spazio, compreso il vuoto apparente, e che sconfessa l’ immagine del
mondo come pieno e vuoto e difende “l’ idea della continuità””. Nel progetto di
Whitehead emergeva anche la circolarità dialettica tra due dimensioni della realtà
che, ambiguamente, la filosofia e la scienza moderne avevano voluto rigidamente
contrapporre: quella oggettiva e quella soggettiva. Whitehead, ha scritto Oviedo, era
consapevole che “nella nuova fisica i fenomeni reali non possono essere del tutto
separati dai processi di osservazione che vogliono oggettivarli” e affrontò, quindi, “le
sottigliezze della percezione e della conoscenza … < il > difficile rapporto che si
stabilisce tra il soggetto che conosce e la realtà conosciuta, un rapporto che nelle
nuove formulazioni, di cui Whitehead è interprete, ne sovverte la distinzione
classica”. Il perno dell’ ultimo Whitehead fu la “togetherness”, l’ idea di una
complessa struttura di interdipendenze e di correlazioni, fuori della quale non vi è
esistenza. Isolare un fatto od una idea dalla struttura cui appartengono significa
stroncare la comprensione del sistema nel quale hanno senso. Non si intende l’
esperienza opponendo, semplicisticamente, l’ oggetto al soggetto, l’ effetto alla
causa, l’ istante susseguente all’ istante precedente. Occorrono categorie come quelle
della sincronicità, dell’ isotopia e dell’ analogia per comprendere il dinamismo di una
realtà che non è statica e che non può esser costituita da corpuscoli stabili o da forze
costanti e determinabili. La realtà è processuale. Quel che in essa appare stabile non è
che una attualizzazione, del tutto transitoria e passeggera, di un qualche momento del
processo continuo che sfugge ad ogni tentativo di stabilizzarne ed immobilizzarne le
singole frazioni. Whitehead propone, alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche, l’
universale e incessante fluire delle cose che già aveva sollecitato Eraclito e che
avrebbe interrogato numerosi filosofi moderni e contemporanei, ponendo l’ accento
sulla relazionalità anziché sulla singolarità, sulla struttura anziché sull’ elemento,
sulla comunicazione sociale anziché sulle singole unità sociali … In “Processo e
realtà” Whitehead ha esposto con una intelligibilità che non sempre caratterizza i suoi
scritti (la cui complessità è peraltro dovuta alla novità delle tematiche esposte), le
“nozioni primarie” della sua “filosofia dell’ organismo”: “entità reale”, “prensione”,
“nesso”, “principio ontologico”. Ne emerge la totalità dell’ universo come un
incessante e inarrestabile processo nel quale si verificano eventi, l’ un l’ altro
correlati. Si tratta di “eventi connessi nelle loro relazioni spazio-temporali”. Non
sostanze ma eventi, non materia inerte e assolutezza di spazio e tempo ma vivente
organicità: tale è il cosmo di Whitehead. Gli eventi sono connessi tra di loro in un
processo relazionale e organico tra parti e intero. La materia è, essa stessa, processo e
rientra in un sistema organico (un organismo) che è coinvolto nella reciproca
relazione delle parti e dell’ intero. L’ universo non può più esser pensato come una
macchina (così come voleva il meccanicismo moderno) bensì come un organismo che
“concresce”. L’ “evento” di Whitehead non è che l’ essere nella sua processualità
continua, còlto in un istante unico e irripetibile, determinato nello spazio e nel
tempo. La sussistenza di ciascun evento dev’ essere ricondotta alla connessione che
lo lega agli altri eventi. Nel divenire complessivo della natura, vi è un
condizionamento continuo e reciproco tra gli eventi: ciascuno rinvia agli altri. La
natura è vita, processo organizzativo. L’ universo dinamico e vivo si esplica come un
processo di crescita continuo, nel quale convergono una molteplicità di fattori. Esso
è, appunto, “concrescenza” da un modo di essere all’ altro. E’ un processo
teleologicamente orientato nella direzione di “essenze” che gli sono immanenti. Il
passato non scompare ed è anzi presente nella “creazione” di sintesi sempre nuove
che hanno in se stesse le “essenze”. Whitehead pensa, riguardo a quest’ ultime, alle
“forme” eterne di Platone. Gli “oggetti eterni” sono potenzialità che si realizzano nel
processo della realtà. E, secondo Whitehead, come scrive Ornella Bellini, “Il primo
che “intuì il problema dell’ organicismo … fu < proprio > Platone; per lui le cose
del mondo materiale e temporale partecipano delle “forme” del mondo eterno”. La
“forma” platonica diventa, con Whitehead, “oggetto eterno”. E la Bellini precisa che
“Un “oggetto eterno” esprime una “potenzialità di entità reali” sebbene in sé e
prescindendo dall’ estrinsecazione della propria potenzialità non sia affatto reale”.
Eppoi, l’ oggetto eterno “manifesta un carattere “neutro” quanto al suo “accesso
fisico” in una qualsiasi entità reale del mondo temporale, giacchè sono le entità che
trascelgono (“decidono”) di attuarsi e di divenire attraverso un “sentimento
complesso che implica un legame completamente determinato con ogni elemento
dell’ universo, dove il legame è una prensione o positiva o negativa””. Del resto “Il
sentimento di prensione … sottolinea l’ attingimento dell’ entità reale all’ oggetto
eterno, la “concrescenza” di ogni entità reale e il suo nesso indistruggibile con la
totalità della realtà. Ogni entità reale è processo e concrescenza di prensione,
partecipa dei caratteri dell’ entità da cui prende …, ma né essa esaurisce la
potenzialità autocreativa dell’ universo espressa dagli oggetti eterni, né la forma
soggettiva dell’ entità reale … s’ identifica con i dati da cui è determinata”. La Bellini
conclude che “In questo senso, allora, il passaggio dalla potenzialità degli oggetti
eterni alla realtà attuale non è mai un processo definitivo e compiuto, ma attesta un’
inesauribile circolarità tra la totalità dei primi e l’ effettualità della seconda”. E
Whitehead scrive che “Ogni fatto è più che le sue forme, e ogni forma “partecipa” a
tutto quanto il mondo dei fatti. La definitezza del fatto è dovuta alle sue forme, ma il
fatto individuale è una creatura, e la creatività è il fatto ultimo al di là di tutte le
forme, inspiegabile attraverso le forme, e condizionato dalle sue creature …”
(“Processo e realtà”). Emergere e permanere sono le caratteristiche di quel processo
che è l’ universo. Il processo della realtà seleziona ed attua gli “oggetti eterni”, le
“essenze”. “Il confronto con le altre visioni dinamiche dell’ epoca moderna – ha
scritto Lluìs Oviedo – rappresenta una buona chiave di lettura dell’ opera di
Whitehead. Il processo, così come viene concepito, non è per nulla caotico, come
invece avviene nel caso del modello evolutivo dominante. Pensare Dio, afferma il
nostro Autore, implica pensare l’ impossibilità del “puro chaos””. E Whitehead
concepisce Dio come la totalità degli “oggetti eterni”. Nell’ idea che del processo ha
Whitehead, continua Oviedo, “c’ è meno spazio per la contingenza, per la cieca legge
delle variazioni spontanee e delle selezioni fortuite. Ma non c’ è neanche spazio per
concepire una “finalità della storia”, né di stampo hegeliano né secondo altre versioni
che cercano di descrivere un punto di arrivo dell’ umanità, come le escatologie
secolarizzate dei tempi moderni. Il processo è ordinato e conosce una sua teleologia,
che esprime l’ idea di Dio …”. Conclude Oviedo sostenendo che “Dopo Whitehead,
il tentativo di codificare in modo dinamico la realtà e la nostra esperienza verrà
riproposto anche in altri ambiti del pensiero … si potrebbe pensare a un certo
capovolgimento dell’ ontologia classica operato dalla fenomenologia che ha
sottolineato in modo radicale la relazionalità; non più le sostanze, ma le relazioni
avrebbero la priorità; non il soggetto, ma il rapporto di dipendenza verso l’ altro
dovrebbe considerarsi come istanza fondativa”. L’ universo dinamico di Whitehead
consiste di un processo di continua e ininterrotta crescita: concrescenza da un modo
d’ esistere ad un altro, processo orientato finalisticamente all’ attuazione di essenzeforme che gli sono immanenti e che divengono reali solo quanto siano collocate nel
divenire spazio-temporale. Tra gli enti possibili alcuni addivengono a costituire l’
universo realmente esistente. “La natura è un edificio di processi che si sviluppano –
scrive Whitehead in “La scienza e il mondo moderno” - . La realtà è il processo …
Un avvenimento ha dei fatti contemporanei. Ciò vuol dire che un avvenimento riflette
in se stesso i modi di questi suoi contemporanei, come uno spettacolo di realizzazioni
immediate. Un avvenimento ha un passato. Ciò vuol dire che riflette in sé i modi dei
suoi predecessori: in quanto ricordi fusi nel suo proprio contenuto. Un avvenimento
ha un avvenire. Ciò vuol dire che un avvenimento riflette in se stesso gli aspetti che l’
avvenire proietta sul presente, o, in altri termini, gli aspetti che contengono il presente
e che riguardano l’ avvenire. Così un avvenimento porta in sé un’ anticipazione del
futuro”.
56 /
Enrico Morselli
Enrico Morselli ebbe risonanza internazionale per la scuola antropologica e
psichiatrica da lui fondata. Lo psichiatra italiano mostrò versatili interessi,
riconducibili comunque unitariamente alla centralità della condizione umana, che egli
indagò con analitico e sperimentale sguardo positivista-evoluzionista. L’ antropologia
era, secondo lui, “la storia naturale del genere umano” ed egli la concepiva come
quella scienza che indaga l’ essere umano con lo stesso rigore, nel metodo e nell’
osservazione, con cui la scienza fisica studia i fatti naturali. Quella di Morselli fu un’
antropologia che si dispiegò secondo un’ ampia ed organica pluralità di prospettive,
muovendosi tra l’ indagine sociologica, quella psicopatologica e quella delle
discipline carcerarie. Di originaria formazione psichiatrica, si mosse tra la psicologia
sperimentale, la neuropatologia, la psichiatria forense, la medicina legale e la terapia
delle “malattie mentali”. Pur non incrinando il custodialismo (una questione che in
Italia sarebbe stata affrontata soltanto nella seconda metà del Novecento da Franco
Basaglia) si impegnò per un rinnovamento dell’ ospedale psichiatrico. Articolò una
approfondita riflessione epistemologica nella filosofia delle scienze criminali e
introdusse innovative tecniche nell’ assistenza ai cosiddetti malati mentali. Mario
Portigliatti Barbos, nel ricostruire la storia della psichiatria in Piemonte ed un secolo
di insegnamento psichiatrico universitario a Torino, definisce Enrico Morselli come
“il più “evoluzionista” degli alienisti italiani e insieme il più “filosofo” tra i
positivisti”, ma, soprattutto, evidenzia le resistenze e le opposizioni che egli incontrò
in seguito alla sua decisione di abolire “i vecchi mezzi di coercizione (catene del peso
anche di 5-6 kg) ancora usati < nell’ Ospedale psichiatrico di Torino > e per aver
installato un laboratorio di psicologia sperimentale”. I contributi di Morselli nella
ricerca psicopatologica vertono sulla genesi corticale dell’ epilessia e sulle nevrosi
traumatiche. Alla specificità delle ricerche unì un forte interesse teorico, fermamente
convinto com’ era della bontà e della validità del metodo positivo. Fu l’ animatore e
il direttore di quella “Rivista di filosofia scientifica” che uscì a Torino dal 1881 al
1891 e che svolse una feconda “opera di divulgazione … delle idee del positivismo”,
come ricorda Eugenio Garin nella sua “Storia della filosofia italiana” (1966).
Nonostante vi collaborassero “anche uomini d’ origine e d’ ispirazione diversa …
predominante – scrive Garin – rimase il tono positivistico, che non di rado anzi venne
precisandosi in manifestazioni di naturalismo o di materialismo”. L’ obiettivo della
Rivista era quello di far trionfare il metodo sperimentale e di congiungere
definitivamente filosofia e scienza “anche in Italia”. L’ esigenza di diffondere una
mentalità positiva e di promuovere un dibattito ed un rinnovamento nelle scienze
umane, lo spinse a fondare, del resto, numerose riviste d’ argomento psichiatrico.
Sono da ricordare la “Rivista sperimentale di Freniatria” (1875), la “Gazzetta del
manicomio” (1881), la “Rivista di Patologia Nervosa e Mentale” (1897), “Psiche”
(1911), e i “Quaderni di Psichiatria” fondati nel 1914, anno in cui assunse la
direzione della Società Freniatrica Italiana. Morselli fu tra coloro che si nutrirono con
maggior vigore delle sollecitazioni della “scuola positiva” italiana, dirigendo la
propria concreta ricerca nelle coordinate che essa aveva tracciato. La “scuola
positiva” aveva in Roberto Ardigò la sua maggior espressione filosofica, e nei
discepoli di costui, da Marchesini a Tarozzi, una robusta ed originale prosecuzione
che si sarebbe protratta ben oltre l’ Ottocento, pur scivolando talvolta nell’
arrendevolezza all’ idealismo. E, al riguardo, non pare però ormai condivisibile il
giudizio negativo di Garin su Giuseppe Tarozzi, il quale avrebbe condiviso la
“distruzione della ragione” emersa a fine secolo, collocandosi “sulla linea del Mach,
del Boutroux e specialmente del Bergson”. In effetti, erano le stesse nuove
acquisizioni e teorie scientifiche che esigevano un ripensamento dello scientismo
classico ottocentesco. E il positivismo fu indotto ad una critica “interna” alla filosofia
della scienza ed alla stessa scienza, che, all’ epoca, si volle confondere con l’
irrazionalismo decadentista e misticheggiante. In ogni caso, a parte la “crisi del
positivismo”, vera o presunta, seguita, all’ alba del nuovo secolo, alla ripresa
idealistica, la “scuola positiva” italiana non può esser ridotta ad una semplice
reazione alla filosofia idealistica che era stata rappresentata da Terenzio Mamiani. La
propensione ad emancipare il pensiero scientifico dal dominante spiritualismo
tradizionale e le forti sollecitazioni laiche e illuministiche dell’ età risorgimentale,
avevano conferito interna e solida coesione interna alla comunità scientifica. La
“scuola positiva” operò nella direzione di una sprovincializzazione della cultura
italiana e mirò a sottrarla al ghetto della metafisica, restituendola alle direttrici
continentali, prime il materialismo e l’ evoluzionismo. Ne venne una feconda cultura
positiva, un efficace paradigma dal quale scaturì un intenso lavoro multidisciplinare,
che trovava la sua unità nell’ idea originaria di Herbert Spencer e August Comte della
filosofia come sintesi metodologica e unitaria del sapere scientifico. Essa propose,
soprattutto, un solido metodo d’ indagine a chi indagava nella società e nelle relazioni
umane. La sua carica antimetafisica indusse la storiografia come la sociologia, la
pedagogia come la psicologia, alla ricerca sperimentale, all’ attenzione per i dati dell’
esperienza, all’ aderenza ai fatti. “Il metodo positivo – ha scritto acutamente Garin –
fu erudizione nel campo delle scienze storiche, e soverchia erudizione talora, ma utile
e salutare esempio di ricerca severa, e preziosa disciplina d’ indagine; fu nel campo
della filosofia richiamo alla concretezza dell’ esperienza, al limite fisico che
accompagna ogni atto spirituale; fu esigenza di studi e di problemi umani, appello
alla corposità del mondo degli uomini, ove l’ idea è vuota parola se non s’ incarna nel
veicolo terreno”. Della cultura positiva di Enrico Morselli, articolata fra concreta
indagine antropologica ed epistemologia teorica, non disancorata dai problemi dell’
essere umano, ha scritto diffusamente M. Di Giandomenico (“S, Tommasi medico e
filosofo”, 1965). Morselli era nato a Modena nel 1852 e sarebbe morto a Genova nel
1929. Conseguì la laurea in medicina nel 1874 e nello stesso anno entrò a far pratica,
con Augusto Tamburini, nell’ ospedale psichiatrico di San Lazzaro (Reggio Emilia),
sotto la guida di Carlo Livi. Conseguì la libera docenza in psichiatria nel 1877. Nel
1880, ebbe la docenza straordinaria della Clinica psichiatrica a Torino e poi, nel
1886, essendovi sostituito da Cesare Lombroso, docente di malattie nervose e mentali
a Genova (ove successe a Dario Maragliano), insediandosi anche nella cattedra di
psicologia sperimentale. A Genova promosse ed avviò corsi di antropologia generale
e criminale, neuropatologia ed elettroterapia. Diresse, dal 1877 al 1899, gli Ospedali
psichiatrici di Macerata e di Torino, ove incontrò la collaborazione di Gabriele
Buccola ed Eugenio Tanzi. La sua opera di maggior rilievo secondo la prospettiva
della filosofia della scienza, (quella nella quale si saldano l’ attitudine clinica, l’
abilità a formulare nuove prospettive e ipotesi per la ricerca, e la critica
epistemologica), fu il “Manuale di semeiotica delle malattie mentali” (1885). Fra le
sue opere di filosofia scientifica sono da ricordare “L’ anima funzione biologica del
corpo” (1886) e “Le ultime fasi dell’ evoluzionismo in Italia” (1889). La “Critica e
Riforma del metodo in Antropologia” (1880) e l’ “Antropologia sperimentale” (18881891) sono palesemente ispirate all’ evoluzionismo di Herbert Spencer. Morselli
rifiuta il tradizionale antropocentrismo. L’ essere umano si colloca in una più ampia
vicenda evolutiva, nella quale si succedono fasi come quella cosmica, biologica,
psicologica, sociologica. Senza voler riconoscere all’ uomo una collocazione
privilegiata e centrale nell’ universo, Morselli ritiene che costui non sia altro che “un’
animale della famiglia dei Primari, del sottordine dei Eopiteci, dell’ ordine dei
Primati”: non si tratta che di un organismo il cui sviluppo è l’ “effetto naturale o …
logico dell’ evoluzione cosmica”. L’ “Antropologia generale”, che ribadisce una
comprensione dell’ uomo secondo la teoria dell’ evoluzione, è del 1911. “Biografia di
un bandito”, l’ analisi psichiatrica e sociologica di Giuseppe Musolino, è del 1903.
“La nevrastenia degli adolescenti” è del 1911. “Le neurosi traumatiche”, prese in
considerazione soprattutto nelle forme suscettibili di risarcimento, furono date alle
stampe nel 1913. Al 1879 risale la relazione medico-legale e processuale de “L’
uccisore dei bambini Carlino Grandi”; del 1899 è la relazione “Sullo stato mentale
del conte Cesare Mattei”, una esemplare indagine clinico-biografica. Rilievi critici
sui fenomeni medianici si ritrovano in “Psicologia e spiritismo” del 1908. “Il
magnetismo animale e l’ ipnotismo” risale al 1886. “L’ uccisione pietosa” è del 1925.
Era inevitabile che Morselli, da psichiatra e psicopatologo, si misurasse con la
psicoanalisi di Sigmund Freud. Pubblicò un ampio saggio in due volumi su “La
psicoanalisi”, nel 1926, esprimendo, in modo emblematico, l’ atteggiamento mentale
tipico della cultura positivista e della psichiatria italiana nei confronti della psicologia
del profondo. Le principali categorie della metapsicologia freudiana furono da lui
drasticamente rifiutate. Ne recuperava alcune in chiave evoluzionistica,
riconducendole al tradizionale quadro della psichiatria organicistica. Giancarlo
Gramaglia ha trattato la cosa nelle “Notes sur la psychanalyse italienne entre les deux
guerres (1915-1945)” («Revue internazionale d’ histoire de la psychanalyse”, 1992) e
nella voce “Enrico Morselli” del “Dictionnaire international de la psychanalyse,
notions biographies, oeuvres, événements, institutions” (2002). La diffusione della
psicoanalisi avrebbe comunque incontrato, in Italia, tenaci e molteplici barriere.
Ostile le fu, tra l’ altro, la stessa psicologia sperimentale torinese (Friedrich Kiesow).
Cesare Lombroso la ignorò in modo sprezzante, pur conoscendola. Meritevole sarà,
pertanto, l’ impegno di Cesare Luigi Musatti (1897-1989), fondatore, nel 1955, della
“Rivista di psicoanalisi”, che riprendeva l’ impegno della “Rivista italiana di
psicoanalisi” voluta da Edoardo Weiss (1889-1970) e costretta a cessare le
pubblicazioni nel 1936. Di Musatti resta, tra l’ altro, il poderoso ed organico “Trattato
di psicoanalisi” (1949). Formatosi in matematica e in filosofia nell’ Università di
Padova, Musatti fu poi assistente dello psicologo triestino Vittorio Benussi,
succedendogli nel 1927 alla guida dell’ Istituto di psicologia. A Milano ebbe la
cattedra di psicologia dal 1945 al 1967. Era approdato alla psicoanalisi muovendo
dalle ricerche sulla suggestione ipnotica che aveva avviato con lo stesso Benussi.
57/
Pasquale Villari (1)
Pasquale Villari introdusse il metodo positivo nelle scienze storiche e l’ Ottocento
italiano lo vide propugnatore di quella storiografia positivistica che intendeva
liberarsi da ogni ingerenza metafisica senza rinunciare alla considerazione delle idee
e degli ideali che guidano gli uomini nel loro concreto operare. In tal modo, se la
storiografia di Villari si liberava dalle astrattezze della filosofia della storia, evitava di
ridurre la comprensione del mondo storico ad una dimensione naturalistica e
materialistica. Uno scadimento cui non s’ erano sottratti alcuni seguaci francesi di
Auguste Comte. Ludovico Geymonat (“Immagini dell’ uomo. Filosofia, scienza e
scienze umane nella civiltà occidentale”, 1989) ha scritto, impietosamente, a
proposito della diffusione della cultura positivista in Italia, che “il positivismo dei
filosofi non scaturì da una seria riflessione sulle nuove scoperte scientifiche e sui
metodi in esse applicati – come accadde, per esempio, per Comte e per Mach – onde
i positivisti italiani non seppero far sentire né agli scienziati né ai filosofi l’ interesse
dei problemi filosofici emersi dalla scienza moderna. Così, in molti casi, invece di
combattere la metafisica per sostituirle uno spirito filosofico concreto, si limitarono a
opporre alla metafisica spiritualistica una “filosofia della natura” altrettanto
dogmatica”. Non è il caso di Villari che, con Giustino Fortunato (1848-1932),
Leopoldo Franchetti (1847-1917), Enrico Ferri (1856-1929) e altri, avviò concrete e
attente indagini sulle condizioni sociali ed economiche del Paese, denunciando alla
classe politica liberale le arretratezze, le incongruenze, le povertà di un’ Italia da poco
unita. Pasquale Villari era nato da una facoltosa famiglia borghese a Napoli nel 1827
e sarebbe morto a Firenze nel 1917. Rimase orfano, ancor adolescente, del padre,
avvocato. La formazione purista che ricevette da Puoti non gli impedì di vivere con
trasporto i moti napoletani del Quarantotto. Esule a Firenze, nonostante le materiali
difficoltà, approfondì la biografia di Fra’ Savonarola. Gli interessi storici gli
fruttarono la cattedra di Filosofia della storia nell’ Università di Pisa sino al 1861,
quando divenne docente di storia all’ Istituto fiorentino di Studi superiori. Il lavoro
storico che lo vedeva aggirarsi fra la storia medioevale e quella moderna, non gli
precluse un concreto impegno civile (al quale non fu certo estraneo l’ incitamento del
maestro Francesco De Sanctis), che lo vide banditore di un proclama contro la
monarchia borbonica nel Napoletano e poi segretario dell’ ambasciata garibaldina
presso i Savoia. Decisivo per la sua carriera politica nell’ Italia unita, sarebbe stato il
libello politico nel quale si interrogava sulle responsabilità della duplice sconfitta che
l’ Italia aveva subito, a Lissa e a Custoza, contro gli austriaci. Non se la prese con
qualche sfortunato ammiraglio, come fece l’ opinione pubblica borghese, ma si
interrogò sulla fragilità burocratica e amministrativa dello Stato unitario e sulla
precarietà dell’ identità e della coscienza nazionale. Divenne deputato nel 1873 e fu
senatore del Regno nel 1897 sino al 1904. Fu Ministro della pubblica istruzione con il
marchese di Rudinì nel biennio 1891-1892. Negli anni dell’ esperienza parlamentare
si occupava della Questione meridionale, ma la passione civica non era in lui
disgiunta dall’ indagine storica, attenta con acribia ed erudizione ma anche con spirito
fortemente positivistico, alla cultura politica italiana. Fra i suoi contributi
storiografici sono certamente da ricordare, “L’ Italia, la civiltà latina e la civiltà
germanica” (1861), “Le invasioni barbariche in Italia” (1901, 1905), “Lettere
meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia” (1878, 1885), “La
questione sociale in Italia” (1902), “La storia di Gerolamo Savonarola e de’ suoi
tempi narrata con l’ aiuto di nuovi documenti” (1859-1861, 1887), “Niccolò
Machiavelli e i suoi tempi illustrati con nuovi documenti” (1877-1882, 1895-1897),
“I primi due secoli della storia di Firenze” (1893-1894, 1905), “Scelta di prediche e
scritti di fra’ Gerolamo Savonarola con nuovi documenti intorno alla sua vita”
(1898), “Le invasioni barbariche in Italia” (1900) e “L’ Italia da Carlo Magno alla
morte di Arrigo VII” (1910). Di Pasquale Villari hanno scritto F. Baldasseroni
(“Pasquale Villari. Profilo biografico e bibliografia degli scritti”, 1907), l’ allievo
Gaetano Salvemini (“Pasquale Villari” negli “Scritti vari”, 1900-1957) e,
recentemente, Mauro Moretti (“Pasquale Villari storico e politico”, 2005). Eugenio
Garin assegna a Pasquale Villari un ruolo di rilievo nel generale rinnovamento
prodotto dal positivismo italiano, pur fra varie contraddizioni e suggestioni
contrastanti, nella cultura nazionale. E’ certo che, come scrive lo stesso Geymonat, i
positivisti italiani “compresero che lo svecchiamento dell’ Italia era legato al
diffondersi della mentalità positivistica, anche in relazione al fatto che l’ unificazione
politica dell’ Italia poteva diventare effettiva se si fossero trasformate a fondo le
strutture della società”. Le classi dirigenti non furono molto sollecite nell’ accogliere
le indicazioni dei positivisti, ma, grazie alla generale visione del mondo positivista
che si diffondeva negli ambienti scientifici, la comunità scientifica nazionale si
consolidava e si integrava. Mentre nel pensiero scientifico urgeva l’ esigenza di una
emancipazione da categorie tradizionali vetuste che già la cultura laica ed illuminista
aveva scosso, con la storiografia positiva crescevano una nuova sensibilità
antropologica ed un nuovo metodo di indagine sociale. E se non se ne può certo
ignorare una certa miopia sociale ed una scarsa attenzione per le miserie del “Paese
reale” escluso dal “Paese legale” dei notabili liberali e del blocco borghese agrario
conservatore, rappresentato in Parlamento dai Governi della Destra storica, della
storiografia positiva resta il valore innovativo nell’ indagine. Francesco Barbagallo
(“Questione meridionale: i meridionalisti”, in “Storia d’ Italia”, a cura di Fabio Levi,
Umberto Levra e Nicola Tranfaglia) accomuna Villari a Sidney Sonnino, Leopoldo
Franchetti e Giustino Fortunato in un “riformismo conservatore” che esprime il
“primo meridionalismo”. Proprio le “Lettere meridionali” (1878) di Villari avrebbero
avviato la “riflessione critica sulla condizione del mezzogiorno all’ interno dello stato
italiano”. Non vi è dubbio, come scrive Barbagallo che “La disperata situazione delle
masse contadine, oscillanti tra la più dura miseria e la più violenta rivolta, < rendesse
> precario nel Sud l’ equilibrio sociale e debole la base del consenso allo stato. Ciò
era apparso con evidenza già negli anni del “grande brigantaggio”, che i governi della
Destra avevano ritenuto sufficiente stroncare con la repressione militare”. Ora,
secondo Barbagallo, le indagini e le attenzioni dei “primi meridionalisti” scaturivano
dai timori che i fatti della Comune parigina e il ritorno di fiamma del socialismo
suscitavano nelle classi dominanti, per cui “i più consapevoli esponenti della
borghesia < si misero a cercare > soluzioni più durature per la “questione sociale””.
Indubbiamente la classe dirigente maturò, pur fra varie incertezze, un diverso
atteggiamento. Nella Sinistra liberale si consolidava la consapevolezza che “L’
autorità dello stato non poteva sempre fondarsi sulla repressione ma doveva allargare
le basi del consenso nella società, operando le necessarie riforme, secondo il modello
dei governi conservatori inglesi o anche dell’ autoritario stato tedesco”. Le
preoccupazioni per le sorti dello Stato liberale avrebbero spinto “alcuni acuti
intellettuali” tra i quali Pasquale Villari, ad avviare una importante attività di ricerca e
di analisi della realtà meridionale che, pur nei diversi settori d’ indagine, si
caratterizzò in modo uniforme per una comune aspirazione ad un’ approfondita
conoscenza della situazione reale, indagata coraggiosamente, senza timore di rivelare
le gravi responsabilità della politica governativa e i pesanti arbitrii delle classi
dominanti”. Barbagallo lo riconosce senza esitazioni e sottolinea che “la precisa
denuncia del Villari si svolgeva soprattutto sul piano delle istituzioni, a livello
politico, amministrativo, culturale”. Ed è certo che “il soggetto attivo, responsabile
della direzione di questa nuova politica di trasformazione sociale ed economica era
indicato < non nel governo e nello stato > ma nella borghesia terriera meridionale,
finalmente convinta della necessità, ben nota ai conservatori inglesi, di “riformare per
conservare””. Un’ interpretazione condivisibile, quella di Barbagallo, soprattutto
laddove conclude che Villari e gli altri ignoravano il “carattere specifico del
fondamento, economico e sociale, del potere … esercitato dagli agrari nel Sud … e
… del ruolo complessivamente secondario che si andava preparando per l’ agricoltura
meridionale nell’ ambito dell’ unitario meccanismo di sviluppo capitalistico”. L’
impraticabilità politica delle conclusioni che derivavano dall’ indagine meridionalista
di Villari non può, comunque, far trascurare le sue novità metodiche e il suo nuovo
atteggiamento nella ricerca. Ne “La filosofia positiva e il metodo storico” (1865),
egli dichiarava che “La filosofia positiva … studia solo fatti e leggi sociali e morali,
riscontrando pazientemente le induzioni della psicologia con la storia e ritrovando
nelle leggi storiche le leggi dello spirito umano”. La filosofia positiva non si occupa
di “un uomo astratto, fuori dello spazio e del tempo, composto solo di categorie e
vuote forme”. Il suo oggetto è “un uomo vivente e reale, mutabile per mille guise,
agitato da mille passioni, limitato per ogni dove …”. In un tale programma vi era il
rifiuto dell’ impossibile “conoscenza assoluta dell’ uomo” e il rigetto della pretesa
metafisica di cogliere “la prima ed eterna ragione di tutto”. Una più adeguata
conoscenza dell’ uomo passa attraverso lo “studio del contingente e del mutabile”,
muovendo dalla consapevolezza che l’ essere umano “muta continuamente”. L’ uomo
è “forma transitoria nell’ eterno circolo della natura … molecola nell’ immensità del
mondo”. E perciò l’ uomo, come ha notato Eugenio Garin (“Storia della filosofia
italiana”, 1966) “rinuncia all’ assoluto, a uno spirito infinito di cui sia collaboratore
efficace. Alla certezza di una collaborazione divina, si sostituisce la malinconica
serietà di una carriera terrestre”. Proprio per questo è importante conoscere i moventi
interni, gli ideali e le convinzioni che lo spingono ad agire ed a superare “senza sosta
la realtà naturale”. Certamente non si può “costruire la scienza “a priori” … < è
necessaria > una ricerca a posteriori”, sosteneva il maggior positivista italiano,
Roberto Ardigò, ne “Sull’ origine e sul progresso della filosofia della storia” (1854),
come ricorda Garin. E criticando le aprioristiche e triadiche leggi storiche di
Giambattista Vico (le età degli dei, degli eroi e degli uomini), di August Comte (gli
stadi teologico o fittizio, metafisico o astratto, scientifico o positivo) o di Wilhelm
Hegel (la dialettica), Ardigò citava Villari come proprio precursore. Poi, alla storia
come scienza e alla storiografia positiva di Pasquale Villari, Benedetto Croce avrebbe
opposto la storia come arte; all’ universale e all’ astratto, il concreto e l’ individuale.
Giacchè la storia non sarebbe che narrazione di quel che è accaduto. Così ne “La
storia ridotta sotto il concetto generale dell’ arte” (1893). Ma la storia della
storiografia doveva ancora rivelarsi molto feconda e si sarebbe prolungata nell’ intero
Novecento, ridiscutendo il proprio statuto epistemologico-metodologico e la propria
scientificità. Paolo Corsini, ad esempio, (“Storiografia. Saggio critico, testimonianze,
documenti”, 1978) ha ricostruito il multivoco dibattito che ha accompagnato il lavoro
degli storici nel corso dell’ intero Novecento, mostrandone la complessità e la
molteplicità nelle prospettive.
58 /
Pasquale Villari (2)
Pasquale Villari non ha certamente avuto un ruolo secondario nella vita culturale e
politica dell’ Italia liberale fra Otto e Novecento. Storico di solida impronta
positivistica, si occupò di Machiavelli e Savonarola, oltre che della Firenze
medioevale. Unì al lavoro storiografico l’ impegno politico e civile. Proprio per la
concezione positivistica di una storiografia che è attenta all’ “effettuale”, e, dunque,
alla condizione sociale ed economica dell’ Italia appena unificata. Delio Cantimori
(“Storici e storia. Metodo, caratteristiche e significato del lavoro storiografico”, 1971)
ricordava come l’ idea di “vita pubblica”, di “vita italiana” venisse a Villari dal
maestro Francesco De Sanctis, “creatore e suscitatore di energie”. La “Storia della
letteratura italiana” di De Sanctis si concludeva con l’ esigenza imperativa di
ritrovare la “vita italiana”, liberandola “da ogni velo e da ogni involucro” e
“guardando alla cosa effettuale con lo spirito di Galileo, di Machiavelli”. Villari fu
deputato e senatore del Regno, sino a guidare il Ministero della pubblica istruzione.
Tra l’ altro, nel 1869, fu lui ad ottenere dal Ministro Bargoni l’ istituzione della
cattedra di antropologia nella Facoltà fiorentina di filosofia e lettere, che Paolo
Mantegazza avrebbe ricoperta per primo. La motivazione di Villari sulla nuova
disciplina era in piena sintonia con le sue convinzioni: “l’ antropologia è la prima
pagina della storia”. Villari fu particolarmente attento alla “questione sociale” ed alla
“questione meridionale” che andavano emergendo drammaticamente nelle vicende
dell’ Italia unita. Non fu certo indifferente alla crescente emigrazione delle masse
contadine italiane. Guardava con preoccupazione all’ involuzione “morale” e civile
della vita politica italiana, tra scandali finanziari e durissima risposta repressiva da
parte del Governo crispino ai diffusi moti popolari contro il caro-vita. Nel 1893
Villari interveniva alla Camera: “Dove andiamo?” chiedeva alla classe politica
liberale. E la invitava a riflettere sul fatto che “presso di noi le moltitudini, massime
quelle delle campagne, parteciparono assai poco alla rivoluzione < il Risorgimento >,
e punto alla vita politica. Tutto fu opera della borghesia, che divenne quindi padrona
d’ ogni cosa. E la storia di altri popoli c’ insegna quali sono i pericoli, cui si va
incontro ogni volta che la società intera è abbandonata in balìa di un solo ordine
sociale, massime se questo è la borghesia”. E ricordando il regime orlèanista
sottolineava che, in Francia, dopo il 1830, la borghesia e l’ affarismo la fecero da
padroni: “il Governo < francese > prese allora il carattere e la forma di una
compagnia industriale, nella quale gli affari si fanno solo in vista dei vantaggi che i
soci possono cavarne”. Villari sferzava la Destra storica per non aver saputo attuare
un’ efficace politica di alfabetizzazione popolare: “L’ Italia, si disse, è un paese
democratico e civile, deve avere la istruzione obbligatoria. Ma per ciò fare
occorrevano nuovi edifizi scolastici, maestri, scuole in gran numero, il che voleva
dire parecchi nuovi milioni, che i Comuni non avevano, e non li aveva il Governo.
Pure si voleva la legge. Ma quando il Ministero la presentava, e si vedeva la spesa, la
legge veniva respinta, senza perciò smettere di chiederla. Finalmente ne fu presentata
una, che rendeva obbligatoria la istruzione elementare, riducendola quasi a due anni,
il che era in fondo una illusione, per non dire una derisione. Non occorrevano però i
molti milioni, e la legge fu votata. Avemmo così la legge, non la istruzione. Chi
avevamo voluto ingannare? Un giorno che io m’ affaticavo a dimostrare tutto ciò ad
uno di coloro che l’ avevano chiesta e l’ avevano votata, egli esclamò impazientito: E
chiudetele queste vostre scuole, le quali fanno più male che bene!”. Di fronte ad un
apparato burocratico dello Stato che cresceva e che costava, Villari auspicava “quelle
riforme organiche, veramente serie, che pur sono tanto necessarie … Né si vuol
capire che l’ avere istituzioni più modeste e più vitali, sarebbe un’ economia d’ altra
natura, ma non meno efficace. Non avremmo un così grande sciupìo di forze, di
uomini e di danaro”. Villari chiedeva alla classe politica liberale una nuova politica e
sosteneva che “Se la nostra classe governante, che è in sostanza la borghesia, avesse
fin dal principio voluto riconoscere le condizioni infelici delle nostre plebi, e
migliorarle, facendo volontariamente i sacrifici necessari, essa le avrebbe avvicinate a
sé, rialzandole moralmente ed economicamente, ne avrebbe fatto una forza nuova di
progresso industriale e morale, le avrebbe condotte a partecipare più largamente alla
civiltà, alla vita nazionale, ed avrebbe in un medesimo tempo aumentato il suo
ascendente sopra di esse, migliorato, nobilitato il proprio carattere morale. Ma pur
troppo, in un tempo nel quale tutti i popoli civili hanno promosso una serie di grandi
riforme sociali, le quali grandemente migliorarono le condizioni dei lavoratori nelle
città e nelle campagne, noi non abbiamo fatto nulla addirittura, salvo a gettar qualche
volta polvere negli occhi. La prova ne è che … va sempre crescendo la emigrazione
di coloro che la fame caccia dal proprio paese, in cerca di pane e di lavoro, spesso
invece ricevendo insulti … I coltivatori della terra, che son pure in Italia quelli che
producono la ricchezza nazionale, in molte delle nostre province, dopo una giornata
di lavoro più lunga o più dura assai di quella d’ ogni altro operaio nel mondo civile,
non hanno ancora tanto da sfamarsi”. Passione civica nazionale, impegno civile,
attenzione alle questioni della storia contemporanea emergono dalle riflessioni di
Villari. Dovette esser certamente una lezione valida ed uno sprone per intellettuali
come Gaetano Salvemini. Dopo aver pubblicato “La psicologia come scienza
positiva”, nel 1870, Roberto Ardigò aveva notato il contesto asfittico nel quale
faticosamente si muoveva il positivismo italiano: “… del positivismo in Italia non si
può dire che ci sia se non qualche piccolo ed isolato e affatto recente tentativo, che si
può dire principiare da un articolo del Villari”. E in una lettera del 1873 (“Lettere
edite e inedite, 1850-1894”, a cura di Wilhelm Büttemeyer, 1990) Ardigò citava
alcuni altri isolati propugnatori del positivismo nella Penisola: i pedagogisti Angiulli
e Gabelli … Ma aveva ragione Benedetto Croce quando definiva il positivismo
italiano una “negazione della filosofia”, un deteriore tentativo di sostituire al
momento speculativo-filosofico-idealistico, una “filosofia naturalistica e agnostica” e
il momento “estraneo < alla filosofia > della fisica e delle scienze naturali” ??? Nella
sua “Storia della filosofia italiana” (1966) Eugenio Garin si oppose alla stroncatura di
Croce, e sostenne che, in Italia, “il metodo positivo fu erudizione nel campo delle
scienze storiche … utile e salutare esempio di ricerca severa, e preziosa disciplina d’
indagine, < generale > richiamo alla concretezza dell’ esperienza … esigenza di studi
e di problemi umani, appello alla corposità del mondo degli uomini, ove l’ idea è
vuota parola se non s’ incarna nel veicolo terrestre”. Ardigò coglieva l’ isolamento di
chi, come lui, voleva diffondere in Italia una psicologia positiva che espungesse le
tradizionali dottrine metafisiche dell’ anima e desse priorità al metodo scientifico,
senza per questo cadere nel materialismo (dal quale aveva preso le distanze). Non
aveva un’ ampia letteratura italiana dalla quale ripartire: soltanto “La filosofia e la
ricerca positiva, quistioni di filosofia contemporanea” (1868) di Andrea Angiulli, e
“La filosofia positiva e il metodo storico” (1866) di Pasquale Villari. Non molto, per
la verità, ma è certo che la “frattura” antitradizionalista di Ardigò risvegliava latenti
istanze innovatrici. Eugenio Garin ricordava “il motivo positivistico che venne
imponendosi ai più seri fra i neokantiani e gli hegeliani < in Italia >, da Fiorentino a
Spaventa, per non insistere poi su tipici rappresentanti di una “sinistra” italiana, quali
il Tommasi o, su altro piano, il Labriola”. Garin ricorda proprio la parabola evolutiva
che condusse Salvatore Tommasi da un finalismo teistico a “Le dottrine mediche e la
clinica”, un saggio del 1865 in cui rivendicava “per le scienze “obbiettive e naturali”
una piena indipendenza da qualunque speculazione metafisica, da qualunque
presupposto che non sia integralmente spiegabile con l’ esperienza”. E rimarca che
“All’ affermazione del Tommasi fatta nel campo medico corrisponde quella del
Villari … nel campo degli studi storici”. Della predominante esigenza metodica in
costoro s’ è detto certo anche Alfredo Saloni (“Il positivismo e Roberto Ardigò”,
1969). Saloni ha sostenuto, senza mezzi termini, che “… per il Gabelli, come anche
per il Villari, altro positivista di nessuna scuola, il positivismo è un metodo piuttosto
che una dottrina, un metodo di interpretazione, che serve a liberarci dai sogni della
metafisica e ad orientarci nella realtà della vita”. Ed ha aggiunto che “Il sistema
sarebbe stato per il Gabelli nient’ altro che un impaccio alla sua aspirazione a
guardare nella loro varietà e molteplicità i processi dell’ educazione, a conferir loro
un senso veramente concreto, ad utilizzarli in conformità dei suoi piani di politico e
di educatore, ché tale era veramente il Gabelli, non filosofo, a interpretarli e
svilupparli in armonia con le più urgenti, pratiche necessità”. E quel che vale per
Gabelli nella pedagogia, è da trasporre per Villari nella storiografia: vi è in costoro,
direbbe Saloni, “… tutto il positivismo essenziale, il richiamo dall’ astrattezza alla
realtà, dalla semplice teoria ai fatti che soli possono determinarla, il rifiuto di ogni
dogmatismo, la fede nell’ esperienza, nell’ esercizio della ragione da questa non
disgiunto …”. Il rifiuto di una rigida sistematicità, non impedì, peraltro, una
riflessione squisitamente filosofica a Villari, come emerge dagli scritti di “Arte, storia
e filosofia” (1884) e dagli “Scritti vari” (1894). Una meditazione mai, comunque,
disgiunta dalla consapevolezza delle problematiche contemporanee. Nelle “Lettere
meridionali”, criticando implicitamente la Destra storica, sosteneva che “… la vita di
una nazione non può restringersi tutta ai soli computi del pareggio. Noi potremmo
essere uniti, liberi, indipendenti, colle finanze in equilibrio, e pure formare una
nazione senza significato … Occorre che un nuovo spirito ci animi, che un nuovo
ideale baleni dinanzi a noi. E questo ideale è la giustizia sociale, che dobbiamo
compiere prima che ci sia domandata. E’ necessario ridestare in noi quella vita
morale, senza cui una nazione non ha scopo, non esiste. Ed è necessario al nostro
bene materiale e morale. Senza liberare gli oppressi, non aumenterà fra noi il lavoro,
non crescerà la produzione, non avremo la forza e la ricchezza necessarie ad una
grande nazione. L’ uomo che vive in mezzo agli schiavi, accanto agli oppressi e
corrotti, senza resistere, senza reagire, senza combattere, è un uomo immorale che
ogni giorno decade”.
59 /
Giuseppe e Sergio Sergi
Sergio Sergi è stato un “antropologo fisico”, erede e continuatore del padre Giuseppe
il quale, in Italia, dell’ antropologia fisica, oltre che della psicologia, fu vero e proprio
precursore. Il figlio ha saputo essere un autorevole protagonista di quell’ “epoca
antropometrica” che ha dato notevoli contributi alla storia dell’ antropologia, tra i
quali l’ indagine sui reperti fossili di ominidi che via via venivano acquisiti. Sergio
Sergi dev’ essere situato nell’ alveo fecondo della paleoantropologia che nacque a
metà dell’ Ottocento con J. C. Fuhlrott. Costui avviò l’ indagine scientifica sui fossili,
scoprendo la calotta dell’ “uomo di Neanderthal” presso Düsseldorf. Poi, alla
disciplina avrebbero dato sistematicità il francese Marcellin Boule (1861-1942), il
tedesco Gustav Schwalbe (1844-1916) e altri. Una buona introduzione, sintetica,
organica ed efficace, alla disciplina, si trova nelle voci dedicate all’ antropologia e
all’ etnologia, da Alessandro Lupo, Claudio Cavatrunci, Egidio Cossa, Alba Rosa
Leone, nell’ “Enciclopedia Italiana” fondata da Giovanni Treccani (nell’ edizione del
1995). L’ antropologia viene, definita, nella “Treccani”, come “il ramo delle scienze
biologiche che studia l’ umanità dal punto di vista naturalistico, cioè in quanto
costituente un particolare gruppo zoologico, sulla scorta di caratteri morfologici,
fisiologici e psicologici”. Per un approfondimento delle questioni dell’ antropologia
fisica, sono pur sempre validi gli studi dello stesso Sergio Sergi come “Antropologia
dell’ Italia” (“Terra e Nazioni, L’ Italia, caratteri generali”, 1936), “Terminologia e
divisione delle scienze dell’ uomo. I risultati di un’ inchiesta internazionale”, in
“Rivista di antropologia”, 1947) e “Gli uomini nel Pleistocene, Epoche glaciali”,
1950). Il termine “antropologia” è, comunque, polivoco e, pur rinviando alla
centralità dell’ essere umano come oggetto di indagine ed alla sua comprensione nella
molteplicità delle sue manifestazioni, ha prodotto saperi e ambiti disciplinari diversi.
Nel Novecento, con “Il posto dell’ uomo nel cosmo” (1927) di Max Scheler, è nata l’
antropologia filosofica. Una vera e propria “dottrina dell’ uomo”, che aveva
antecedenti nell’ “Antropologia pragmatica” (1798) di Immanuel Kant e ne “L’
essenza del cristianesimo” (1841) di Ludwig Feuerbach. Con Scheler la filosofia si
riappropriava di un problema, quello dell’ essere umano, che era sempre stato suo. E
che s’ era visto sfuggire di mano, con l’ avvento, nella seconda metà dell’ Ottocento,
dell’ antropologia fisica, cresciuta nell’ alveo dell’ etnologia e della zoologia. L’
antropologia filosofica ha voluto ritrovare, tra l’ altro, un ruolo di organizzazione e di
sintesi dei dati acquisiti dalle scienze positive nell’ Ottocento. L’ antropologia fisica
si affermò, infatti, come scienza fisico-organica dell’ uomo, dei gruppi e dei tipi
umani. Essa acquisì la sua autonomia separandosi dall’ etnologia, che continuò ad
occuparsi soprattutto delle società primitive. Nel frattempo andava consolidandosi
anche l’ antropologia culturale, che si sarebbe occupata, appunto, delle culture umane
e che avrebbe prodotto un’ ampia messe di studi, scuole e indirizzi. Per la verità, nell’
area anglosassone, l’ antropologia fisica s’ è riferita alla storia naturale degli ominidi,
mentre l’ etnologia e l’ etnografia si sono occupate della dimensione sociale e della
storia delle civiltà. Gerhard Heberer, curatore, con Gottfried Kurth e Ilse Schwidetzy,
di “Antropologie” (1959, “Antropologia” nella traduzione italiana di Libero Sosio,
1966), ha richiamato l’ esigenza di una antropobiologia (E. Fischer) e di una biologia
umana generale (E. Eickstedt) di cui l’ antropologia fisica non sarebbe che una
importante branca. D’ altra parte, Heberer è convinto che l’ antropologia, nella
misura in cui è “scienza dell’ uomo”, non possa ridursi all’ esclusivo ambito
biologico, e che debba riversarsi in una “scienza generale dell’ uomo”, ove anche le
“discipline umanistiche” abbiano la loro giusta collocazione. Una cosa, per lui, è
certa: ribadendo la convinzione di Eugen Fischer (1952), egli sottolinea che l’
antropologia (fisica) “non … pretende né di comprendere l’ uomo intero, ossia anche
il suo aspetto spirituale non indagabile con i metodi delle scienze naturali, né di
negare quest’ ultimo”. Per quanto riguarda l’ antropologia come scienza naturale e
disciplina biologica, Heberer è convinto che “Le nostre conoscenze sono spesso
ipotetiche, provvisorie, prive di basi sicure”, anche se è certo che, per l’ antropologia
come per ogni altra scienza, “l’ ipotesi è il “primum movens””. La sua
preoccupazione è, comunque, quella di distinguere l’ “elemento puramente ipotetico”
dal “complesso di teorie e di dati di fatto sicuramente stabiliti” e acquisiti. E non ha
dubbi che vi sia “un saldo patrimonio di conoscenze su cui si può costruire e che …
costituirà in futuro la base per un ulteriore sviluppo” dell’ antropologia fisica. Eugen
Fischer, da parte sua, ha tracciato le diramazioni ed i settori di indagine in cui si
articola l’ antropologia; tra i più rilevanti vi sono: la morfologia umana, che si occupa
del corpo e degli organi degli ominidi; la paleoantropologia o morfologia degli
ominidi fossili; l’ antropogenetica o scienza dell’ ereditarietà dell’ essere umano; e la
antropologia sociale o sociologia dei gruppi umani. La nascita dell’ antropologia
come scienza ”naturale”, nel secondo Ottocento, era stata accompagnata da un lungo
travaglio. Laceranti controversie opposero, ad esempio, i sostenitori del
monogenismo e quelli del poligenismo. I criteri per la classificazione dei gruppi
umani e la questione delle indagini sui reperti osteologico-craniometrici, divisero a
lungo gli antropologi fisici. Le polemiche non impoverirono ed anzi promossero le
ricerche e gli studi antropologici. Il fisiologo, medico ed etnologo William Frédéric
Edwards – membro della Royal Society di Londra – aveva fondato, nel 1839, la
“Società di etnologia” a Parigi, e, nel 1855, De Quadrefages ricoperse la prima
cattedra di antropologia, che venne istituita nel 1832, presso il “Museum d’ Histoire
naturelle” parigino. Società antropologiche sorsero nelle maggiori città europee: a
Parigi, per iniziativa di Paul Broca, nel 1859, la “Société d’ Antropologie”; a Londra,
nel 1863, l’ “Anthropological Society”; a Berlino, nel 1869, la “Berliner Gesellschaft
für Antropologie, Etnologie und Urgeschichte”; a Vienna, nel 1870, l’
“Anthropologische Gesellschaft in Wien”. La “Società fiorentina di antropologia” fu
fondata da Paolo Mantegazza nel 1868. Un anno dopo, nel 1869, nasceva la “Società
italiana di antropologia, etnologia e psicologia comparata”. Già attorno alla metà del
secolo, Charles Darwin poneva le basi di quella teoria dell’ evoluzione che, con la
teoria genetica di Gregor Mendel, avrebbe tracciato la linea direttrice dell’
antropologia in senso biologico. Oggi le cattedre di antropologia, dalla primatologia
(lo studio delle grandi scimmie) alla genetica delle popolazioni nella prospettiva
evoluzionistica, alla paleoantropologia o paleontologia umana e così via, sono
numerose e qualificate anche nelle Università italiane. E un indubbio merito spetta a
precursori come i Sergi padre e figlio. Il padre, Giuseppe, era nato a Messina nel
1841 e sarebbe morto a Roma nel 1836. Versatile ed eclettico negli interessi (aveva
studiato con grande precocità, da autodidatta, il greco e il sanscrito, per poi dedicarsi
alla filologia comparata), ebbe a Milano la cattedra universitaria di filosofia. Fu poi
docente di antropologia nell’ Università di Bologna dal 1880 al 1884 e poi a Roma
dal 1884 sino al 1916. Avrebbe acquisito notorietà nell’ ambito degli studi di
psicologia. I “Principi di psicologia sulla base delle scienze sperimentali” sono del
1873-74. “Gli elementi di Psicologia” risalgono al 1879: furono subito tradotti in
francese, suscitando un interesse internazionale. I suoi saggi di antropologia e
psicologia sperimentale sarebbero stati prolifici e numerosi. Ne pubblicò a centinaia.
Attento visitatore delle Case dei bambini di Maria Montessori, ne diede una
valutazione ampiamente positiva. Giuseppe Sergi è stato, tra l’ altro, il fondatore del
Museo romano di antropologia e del Laboratorio di psicologia sperimentale della
cattedra di antropologia dell’ Università di Roma. Giuseppe Montesano, direttore
della Scuola ortofrenica di Roma, ove lavorò con la Montessori, avrebbe sottolineato
il peso della psicologia fisiologica e biologica di Giuseppe Sergi nello sviluppo della
psicopatologia e dell’ ortofrenia. Su di lui si può vedere: “Giuseppe Sergi nella storia
della psicologia e dell’ antropologia in Italia” (1987), un volume a più voci curato da
V. Lazzeroni. Continuò il lavoro di Giuseppe Sergi il figlio Sergio, che nacque a
Messina nel 1878 e sarebbe morto a Roma nel 1972. Ricoprì la cattedra di
antropologia all’ università di Roma, dopo il padre. Lì diresse la “Rivista di
antropologia” dal 1926. Tra i suoi numerosi contributi scientifici sono da ricordare
almeno “Craniografia e craniometria del primo paleantropo di Saccopastore” (1944) e
“Il cranio del secondo paleantropo di Saccopastore” (1948).
I due crani
neanderthaliani sono tuttora esposti nel Museo di antropologia dedicato al fondatore
Giuseppe Sergi, e che è collegato al Dipartimento di Biologia Animale e dell’ Uomo
dell’ Università di Roma “La Sapienza”. Il primo dei due crani fu riportato alla luce
nel 1929. Il secondo fu rinvenuto sei anni dopo, anch’ esso in una cava di ghiaia
presso la via Nomentana di Roma. Oggetto di studio da parte di Giuseppe Sergi, che
aveva elaborato un originale metodo di craniometria (la scienza che si occupa delle
forme del cranio attraverso la misurazione e il calcolo matematico dei punti
craniometrici), i due crani fanno parte di una collezione di oltre seimila reperti
scheletrici umani. Emiliano Bruner, ricercatore presso il Dipartimento, ha illustrato
(“Modelli per l’ evoluzione”, in “Sapere”, 2003) le più recenti acquisizioni
tecnologiche e metodologiche della ricerca nell’ ambito paleoantropologico. Le
indagini sull’ anatomia e sulla morfologia del cranio dei primati umani e non umani,
esistenti ma anche estinti, l’ attenzione per il popolamento del Continente europeo e
del Nord Africa, oltre che per le forme neanderthaliane, gli studi sulla variabilità
endocranica e dello scheletro facciale delle popolazioni attuali, hanno – tra l’ altro –
costituito, a partire dalla seconda metà del Novecento, ambiti privilegiati dell’
antropologia. E si pongono in feconda continuità con il lavoro dei precursori come
Giuseppe e Sergio Sergi.
60/
Giuseppe Sergi
Giuseppe Sergi rientra certamente nella schiera di quei precursori che contribuirono,
in Italia, a cavallo di Otto e Novecento, all’ autonomia della scienza psicologica ed al
suo progressivo distacco dalla filosofia tradizionale. Guido Cimino (“Origine e
sviluppi della psicologia italiana”) ha collocato la nascita della psicologia italiana
come scienza, tra gli ultimi decenni dell’ Ottocento e la seconda Guerra mondiale, in
un contesto fortemente positivistico-evoluzionistico. I tratti salienti che ne emergono
sono la radicale antimetafisica, lo scientismo, il riduzionismo materialistico e
naturalistico. Una tale connotazione, scrive Cimino, restituisce quella “immagine del
mondo … sorta in concomitanza con lo straordinario sviluppo delle scienze … con la
cieca fiducia nel progresso e con la radicata convinzione che la ricerca scientifica
avrebbe potuto risolvere tutti i problemi dell’ umanità”. In un rinnovato e ancor più
solido clima “illuministico”, che rivalutava con maggiori certezze le aspettative
settecentesche nel progresso e nell’ efficacia della scienza, la psicologia costruiva la
sua nicchia tra le “scienze umane”. Nonostante il positivista August Comte, nella sua
classificazione delle scienze, la smembrasse tra la biologia e la sociologia, numerosi
altri, da Darwin a Spencer a Haeckel, contribuirono a rifondarla come scienza
empirica e naturalistica. Fu certamente tale il contesto culturale positivista che
sollecitò psichiatria, fisiologia e biologia a conferire un taglio solidamente scientifico
alla psicologia. Il fecondo e intenso lavorìo sarebbe proseguito per tutto l’ Ottocento,
innescando, alla fine del secolo, produttive sperimentazioni e attività di laboratorio.
Alle quali, d’ altra parte, fornirono un robusto sostegno teorico le teorie dell’
evoluzione e dell’ ereditarietà. Cimino ha colto nel segno quando ha rilevato il
contributo decisivo dell’ evoluzionismo al superamento dell’ insanabile dualismo tra
anima e corpo, “res cogitans” e “res extensa”, con cui Renato Cartesio aveva
inaugurato la filosofia moderna. “Nel considerare l’ attività psichica come l’ ultimo
stadio di un processo evolutivo – scrive Cimino - … la teoria darwiniana aveva finito
per sanare la frattura …. fra i fenomeni psichici studiati dai filosofi e gli eventi fisicochimici indagati dagli scienziati, e per integrare l’ uomo nella natura in maniera
molto più radicale di quanto non avesse fatto la rivoluzione scientifica del Seicento”.
Del resto, i Lumi settecenteschi erano gli eredi della scienza galileiano-newtoniana,
portatrice di rosee aspettative per il destino dell’ umanità. E i positivisti ottocenteschi
non avevan fatto altro che introdurre le scienze umane nella classificazione delle
scienze, attribuendo loro lo stesso rigore metodologico di quelle naturali. Essi erano
al di qua di quel dibattito sulla specificità di metodo ed oggetto che le scienze storico
sociali posseggono rispetto alle scienze della natura, che avrebbe caratterizzato lo
storicismo tedesco contemporaneo, da Wilhelm Windelband a Max Weber. L’
intenso impegno che contraddistinse la crescita di una psicologia scientifica italiana
sul finire dell’ Ottocento, vide distinguersi, accanto ad antropologi come Giuseppe
Sergi e Paolo Mantegazza, psichiatri come Gabriele Buccola, Enrico Morselli e
Augusto Tamburini, oltre a neurofisiologi come Mario Panizza e Luigi Luciani.
Secondo la tesi di S. Marhaba (“Lineamenti della psicologia italiana: 1870-1845”,
1981), gli psicologi scienziati come Kiesov, De Sanctis, Ferrari, Benussi e Gemelli,
andavano nettamente distinguendosi dagli psicologi filosofi. G. P. Lombardo e R.
Foschi (“La psicologia italiana e i principali orientamenti filosofici e scientifici nell’
Italia della prima metà del Novecento”, introduzione a “La psicologia italiana e il
Novecento”, 1997) affiancano Sergi a Gabriele Buccola e Roberto Ardigò in quello
che giudicano l’ esordio della psicologia positivistica italiana. Ne distinguono, perciò,
una seconda fase – che si distingue per l’ abbandono delle basi positiviste e il ricorso
ad altri impianti filosofici, come il pragmatismo americano di Peirce e la
fenomenologia di Brentano – ed una terza fase, conclusiva, che vede crescere la
psicotecnica. Giuseppe Sergi, con Gabriele Buccola e Roberto Ardigò, nel porre le
basi di una psicologia scientifica in Italia, risentì fortemente del positivismo
evoluzionistico. E non vi è dubbio che i “Principi di psicologia” (1873-1874) di
Sergi, con “La psicologia come scienza positiva” (1870) di Ardigò, abbiano segnato
l’ inizio di un’ epoca nuova. Sergi, in effetti, si muoveva lungo la coordinata del
positivismo con rigorosa ortodossia e intendeva ridurre la filosofia ad antropologia, in
vista di una piena comprensione scientifica dell’ essere umano, sotto il profilo
etnologico-pedagogico-sociale e psicologico. In una simile prospettiva
interdisciplinare, l’ antropologia avrebbe assunto una funzione coordinatrice nei
confronti delle altre scienze. E Sergi assumeva una prospettiva decisamente
materialistica quando intendeva ridurre i fatti psicologici alla dimensione meramente
fisiologica, studiandoli da antropologo fisico e da fisiologo. Ma il suo materialismo
assumeva anche una connotazione decisamente evoluzionistica quando collocava i
fenomeni psichici in un progressivo adattamento filogenetico all’ ambiente. Egli
evocava la legge biogenetica fondamentale di Ernst Heinrich Haeckel, cara ai
positivisti. Secondo il biologo tedesco, la teoria dell’ evoluzione di Darwin, di cui fu
fervente sostenitore, doveva essere integrata con la corrispondenza della filogenesi e
dell’ ontogenesi, per cui l’ evoluzione di un singolo organismo non è che la
ricapitolazione dell’ intera evoluzione della specie. L’ evoluzione individuale
(ontogenesi) ripercorrerebbe, sia pur sinteticamente, l’ evoluzione dell’ intera specie
(filogenesi). In sintonia con Ardigò, Sergi credeva fermamente in una nuova scienza
psicologica, anche se nessuno dei due ne tracciò le precise coordinate
epistemologico-metodologiche ed evitò concrete indagini sperimentali. L’ afflato
positivistico spingeva comunque Sergi a intravvedere nella nuova scienza psicologica
uno strumento di “civilizzazione”. L’ elevazione morale di cui si sarebbe fatta
portatrice, avrebbe giovato tanto all’ educazione delle nuove generazioni quanto al
recupero dei “devianti”, criminali o ebefrenici che fossero. Egli si inseriva in quel
rinnovamento pedagogico della scuola di base italiana che aveva, tra i maggiori
fautori, Andrea Angiulli, Saverio De Dominicis, Aristide Gabelli, Francesco
Orestano, Luigi Credano e Roberto Ardigò. Francesco Bettini (“I programmi di
studio per le scuole elementari dal 1860 al 1945”, 1961) ha evidenziato l’ apporto
della “corrente positivistica” all’ innovazione della scuola italiana, soprattutto nei
gradi inferiori, rivolti al popolo. Ad una “scuola vecchia”, dominata dall’ Arcadia e
dalla retorica, per dirla con Francesco de Sanctis, i positivisti opponevano, scriveva
Bettini, “il reale … Il positivismo nell’ ordine intellettuale è … il ridestarsi dello
spirito critico, è il senso del reale che riprende il sopravvento. E il positivismo
pedagogico … dominerà la scuola italiana per circa mezzo secolo”. In particolare,
nelle istruzioni date ai maestri da Aristide Gabelli e firmate dal ministro liberale
Boselli, spiccava il primato del metodo. “L’ istruzione intellettuale – avvertiva
Gabelli - < dev’ essere > sviluppata con cura perché le cognizioni sono
indispensabili; però più di loro importa l’ abitudine che il pensiero acquista dal modo
con cui esse vengono somministrate: modo di pensare, che dura tutta la vita e che
deve essere ben radicato, chiaro, proficuo, per potersi poi alimentare di per se stesso.
Quindi, non idee generali, che sono sintesi premature, estranee al pensiero dei
fanciulli ed imposte dogmaticamente, e che, non essendo comprese, riescono fatte di
sole parole; ma osservazioni, e cioè istruzione data dai sensi, e, perché data con
metodo più chiara, compiuta, consapevole, coerente di quella che per mezzo dei sensi
stessi si riceve prima di metter piede nella scuola. Cose, non parole; curiosità ben
desta e attenzione; contatto continuo col mondo reale o dei fatti naturali e sociali …”.
Proprio nel contesto di una pedagogia scientifica e sperimentale – che rientra nel più
ampio quadro dell’ attivismo – crebbe ed acquisì originalità il metodo di Maria
Montessori. Alessandro Leonarduzzi (“Maria Montessori. Il pensiero e l’ opera”,
1967) collocava la ‘dottoressa’ “fra quegli autori i quali, muovendosi dalle ricerche
e dai risultati propri della scienza da loro coltivata, si proposero di trarne illazioni o
applicazioni d’ ordine pedagogico”. Leonarduzzi non ha dubbi nel sottolineare che,
proprio nel caso della Montessori, “l’ antropologia, la biologia, la neurologia infantile
sarebbero, appunto, le scienze costituenti la stazione di partenza per il successivo
cammino nel territorio dell’ educazione, per quanto vada segnalato che ella insisterà
… sul valore della psicologia, pretendendo anzi di porsi sulla linea della ‘pedagogia
sperimentale’, ricavando … per via induttiva e rigorosamente scientifica, nell’ ambito
della scuola o dell’ istituzione educativa, i principi e le regole del suo < nuovo >
metodo”. Giuseppe Sergi contribuì, dunque, in maniera rilevante, a precostituire quel
sostrato dal quale Maria Montessori sarebbe cresciuta con le sue innovative proposte
pedagogiche per l’ infanzia. Le opere di Giuseppe Sergi (per le quali si può leggere il
“Volume Giubilare” in suo onore, nella “Rivista di Antropologia”, 1915-16 e 1937,
in cui è contenuto anche il saggio di Erminio Troilo, “Dalla scienza dell’ essenza alla
scienza dell’ uomo”) attestano la sua aderenza all’ elementarismo e all’
evoluzionismo e la sua particolare attenzione alle questioni educative (“Per l’
educazione del carattere”, 1893; “Educazione ed istruzione”, 1892). Fu, tra l’ altro, l’
autore del primo testo di psicologia fondato sulle ricerche sperimentali da poco
avviate: i “Principi di psicologia sulla base delle scienze sperimentali ad uso delle
scuole” (1873). Lo stretto legame tra intelligenza ed affettività e l’ esigenza di una
partecipazione attiva e democratica alla vita sociale e civile, lo inducevano, poi, a
privilegiare, nell’ educazione, “attitudini che servano ai bisogni della vita reale”, il
rafforzamento della volontà e il controllo dei sentimenti. Di fronte al froebelismo,
che si era tradotto, anche in Italia, nei “Giardini d’ infanzia”, Giuseppe Sergi riteneva
che l’ educatore dovesse incoraggiare le manifestazioni spontanee del bambino. L’
adulto, d’ altra parte, deve guardarsi dai pericoli del misticismo e del simbolismo, che
rischiano di deviare la mente infantile da un normale sviluppo, come certe
incongruenze del sistema di Fröbel lasciano temere. Una pedagogia psicoantropologica esigeva l’ attenzione alla concretezza psico-fisica del bambino evitando
di indurre automatismi nelle sue manifestazioni psico-motorie. Recentemente,
Giacomo Cives (“L’ antropologo Giuseppe Sergi e il suo giudizio sulla Montessori”)
ha ribadito l’ attenzione favorevole e l’ apprezzamento positivo di Giuseppe Sergi per
il metodo delle Case dei Bambini, a conferma della continuità e della sintonia della
sperimentazione di una pedagogista, la Montessori, cresciuta proprio nel contesto
positivista italiano.
61 /
Gabriele Buccola
Gabriele Buccola è certamente uno dei più significativi precursori della psicologia
sperimentale delle sensazioni e dei processi mnemonici in Italia. Il primo tra gli
italiani ad essere veramente psicologo,anche a livello internazionale (S. Marhaba).
“L’ attività psichica – scrisse – è una proprietà generale la quale s’ inizia nei protozoi
e poco a poco e lentamente attinge il più alto grado di sviluppo nei corpuscoli dei
centri cerebrali dell’ uomo che si possono dire vere cellule intellettive”. Il suo nome è
associato a F. Donders negli studi pionieristici della cronometria mentale, la scienza
che misura i tempi (di reazione) delle operazioni mentali con adeguati test. Vi è chi
ha proposto il cronoscopio di Hipp, illustrato nel Catalogo di Zimmermann, come
strumento simbolico ed emblematico delle ricerche di cui Buccola fornì relazioni in
vari suoi articoli, tra cui “Sulle modificazioni sperimentali della sensibilità e sulle
teorie relative. Nota preventiva” (1880, in collaborazione con G. Seppilli), “Sulla
relazione del tempo fisiologico col senso locale cutaneo” (1881), “Sulla misura del
tempo negli atti psichici elementari. Studi ed esperienze” (1881), “La durata del
discernimento e della determinazione volitiva” (1881-82), “Sul tempo di reazione in
un caso di demenza paralitica” (1881), “La durata delle percezioni complesse” (1882,
in collaborazione con E. Morselli), “La riproduzione delle percezioni di movimento
nello spazio visivo. Ricerche sperimentali” (1881), “La riproduzione delle percezioni
di movimento nello spazio tattile. Ricerche sperimentali” (1881-82), “Le recenti
esperienze sul tempo delle sensazioni olfattive” (1883), “La legge del tempo nei
fenomeni del pensiero. Saggio di psicologia sperimentale” (1883-84), “Il tempo del
processo psichico nella estesiometria tattile. Nuove ricerche sul senso locale cutaneo”
(1883) e “Sul tempo di percezione dei colori. Ricerche sperimentali” (1883-84, in
collaborazione con G. Bordoni-Uffreduzzi). L’ impiego del cronoscopio di Hipp per
misurare la durata del processo di discriminazione nella percezione di suoni e colori,
costituì un contributo di tutto rispetto nella fisiologia dell’ attenzione nell’ uomo sano
o alienato. Nella “Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione
con l’ antropologia e le scienze giuridiche e sociali” (fondata da Carlo Livi nel 1875 e
diretta da Augusto Tamburini dal 1877), a rappresentare per varii decenni la
psichiatria italiana anche all’ estero, apparvero proprio gli studi di Buccola sulla
psicometria, accanto a quelli, non meno rilevanti, di Golgi sull’ istologia del sistema
nervoso e di Luciani sulle funzioni del cervello. Dell’ importanza dell’ apporto di
Buccola hanno trattato G. Sprini, C. Inguglia e S. Untorella ne “Il contributo di
Gabriele Buccola alla nascita della psicologia scientifica in Italia” (“Gabriele
Buccola’s contribution in the rise of scientific psychology in Italy, 2003, nella Rivista
“Teorie & Modelli”). Già Riccardo Luccio e Caterina Primi si erano occupati del
“Positivismo ed evoluzionismo nel pensiero di Gabriele Buccola e Francesco De
Sarlo”, nel volume dedicato a “La psicologia in Italia: una storia in corso” (1999). La
“biografia intellettuale” di Buccola è proposta da Riccardo Luccio in un saggio a più
voci su “La Psicologia in Italia. I protagonisti e i problemi scientifici, filosofici e
istituzionali (1870-1945)” a cura di Guido Cimino e Nino Dazzi (Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”), ove proprio le vicende della psicologia italiana, dalle
origini, marcate dal positivismo evoluzionistico, alla “querelle” tra psicologiscienziati e psicologi-filosofi, sino al clima asfittico del neo-idealismo, vengono
ricostruite attraverso le “biografie intellettuali”, i percorsi personali, le sfide
problematiche dei Sergi, Vignoli, Sighele, Ferrari, De Sanctis, Colucci, Kiesow, De
Sarlo, Aliotta, Bonaventura … e dei numerosi altri protagonisti della storia della
psicologia scientifica in Italia.
Gabriele Buccola era nato a Mezzojuso (Palermo) nel 1854, e sarebbe morto a Torino
nel 1885, un anno dopo che, in Italia, era stato tradotto il “Trattato di psichiatria di
Emil Kraepelin”, con una introduzione di Augusto Tamburini, ed Enrico Morselli
stava diffondendo il “Manuale di semiotica delle malattie mentali”. Laureatosi in
Medicina a Palermo, nel 1879, Buccola approfondì la sua formazione psichiatrica
con lo stesso Tamburini, nell’ Istituto freniatrico di Reggio Emilia. Le ricerche da lui
avviate nella psicologia sperimentale sarebbero confluite nel saggio “La legge del
tempo nei fenomeni del pensiero”, pubblicata nel 1883 a Torino. Lì, si sottolineava l’
autonomia metodologica della psicologia. L’ anno prima aveva dato alle stampe “La
dottrina dell’ eredità e i fenomeni psicologici” (1882). Nel 1881 era divenuto
assistente di Enrico Morselli nell’ Università di Torino. Ottenne, poi, la libera
docenza e decise di trasferirsi a Monaco, ma la morte lo colse improvvisamente e
prematuramente. Nel 1880 (proprio mentre Cesare Lombroso fondava l’ “Archivio di
psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell’ uomo
alienato e delinquente”) Buccola aveva prodotto il saggio “Sulle idee fisse e sulle loro
condizioni fisiopatologiche”, nel quale adottava la dottrina herbartiana del conflitto
tra le idee per imporsi nella coscienza. Herbart, ai primi dell’ Ottocento, aveva
elaborato il concetto di “quantità di appercezione”, per intendere il complesso delle
impressioni passate che contribuiscono all’ elaborazione della nuova esperienza.
Herbart fu tra coloro – come Locke, Hartley, Hume, Priestley, i due Mill, Brown,
Ebbinghaus, Müller, Ziehen – che delinearono una sistematica psicologia dell’
associazione. In essa avrebbero trovato le loro radici la psicologia dell’
apprendimento e della memoria. D’ altra parte, proprio Herbart, analizzando
quantitativamente le condizioni in cui si dà la totale rimozione di una
rappresentazione – alla quale subentrerebbe, perciò, uno “stato affettivo” autonomo aveva tracciato la pista della psicologia del profondo. E se formulò, per primo, con
Locke, la dottrina dell’ autocoscienza – ovvero dell’ attitudine del singolo a
considerarsi, comunque e sempre, uno e identico nei confronti delle proprie
molteplici condizioni - non ignorò che parti del “se stesso” possano essere, anche
temporaneamente, escluse dalla memoria cosciente, e perciò “rimosse”. Con Leibniz,
aveva, per primo, concepito quella “soglia assoluta” al di sotto della quale l’
organismo non reagisce a stimoli di minima intensità. Costruendo una teoria della
personalità secondo la quale nel formare l’ individuo concorrono tanto l’ ereditarietà
quanto la memoria come acquisizione progressiva di nozioni e criteri di valutazione,
Wellek, Heiss, Thomae e altri, avrebbero pensato proprio alla “massa d’
appercezione” coniata da Herbart. Costui, aveva elaborato, tra Sette e Ottocento, un
realismo pluralistico secondo il quale – al di là dell’ esperienza – vi è una molteplicità
di “reali”, ciascuno semplice e immutabile nella propria essenza. Nell’ “Introduzione
alla filosofia” (1813) scriveva che “gli enti < i reali > conservano se stessi, ognuno
nel suo proprio interno, e secondo la loro propria qualità contro il perturbamento che
avverrebbe quando si potesse superare l’ opposizione dei più”. I “reali herbartiani”
permangono identici a se stessi e sono affatto privi di determinazioni. Invece non
sono privi di attività o passività nei confronti degli altri, al contrario delle monadi di
Leibniz. Lo esige la realtà quotidianamente esperita dagli organi di senso: essa mostra
continui mutamenti e molteplici stati. Ogni reale è, dunque, in relazione con gli altri.
Purtuttavia non subisce alcuna modificazione essenziale. Anche l’ anima è un reale
ed è soggetta all’ azione di altri reali. La sua risposta consiste in atti di
autoconservazione: tale è la natura e l’ origine delle percezioni-rappresentazioni.
Queste ultime si eliminano o si rafforzano reciprocamente, a seconda che si
oppongano o si unifichino. Ne nascono gli stati emotivi, gli atti volitivi e le altre
facoltà mentali. E le facoltà non sono innate. Esse derivano, invece, dal meccanico
gioco delle rappresentazioni. Un gioco che può esser espresso secondo leggi
matematiche. Le rappresentazioni si organizzano secondo “masse”. Se le “masse”
sono coese, ne scaturiscono intelletto e ragione. Il dominio di una massa
rappresentativa sulle altre, è all’ origine del carattere di ciascuno. E l’ io non è altro
che una “appercezione” nella quale una “massa” di rappresentazioni attrae quelle
affini.
Guido Cimino (nel recente saggio su “Origine e sviluppi della psicologia italiana”) d’
intesa con G. P. Lombardo e R. Foschi (“La psicologia italiana e i principali
orientamenti filosofici e scientifici nell’ Italia della prima metà del Novecento”,
1997) restituisce Buccola alla prima fase della psicologia italiana, cui sarebbe seguita
una seconda, contraddistinta dal superamento del positivismo ortodosso. R. Luccio
(“Gabriele Buccola e il positivismo evoluzionista in Italia”) ha ricondotto a
Mantegazza, Haeckel e Spencer, la consapevolezza di Buccola che i fatti psichici
sono il risultato di una complessa evoluzione materiale dall’ omogeneo all’
eterogeneo. Scrive Cimino che, in lui, “La convinzione “ontologica” di una riduzione
dello psichico al biologico e la teoria dell’ ereditarietà delle caratteristiche psichiche
(dall’ istinto all’ intelligenza) si accompagnano, sul piano “metodologico” al tema
positivistico del primato del “fatto”, della sacralità del “fenomeno”. L’ esperienza ci
pone di fronte i fenomeni, siano essi fisici o psichici, e, al di là del loro statuto
ontologico, compito dello scienziato è quello di osservare e sperimentare per arrivare
a scoprire tramite induzione le regolarità o leggi che li governano”. E a conferma di
tali affermazioni, Cimino ricorda quanto sostiene Buccola ne “La legge del tempo nei
fenomeni del pensiero”: “La vecchia metafisica va in traccia di “noumeni” senz’
avvedersi che l’ universo è una pura fenomenalità che il pensiero non può sorvolare
sulle apparenze concrete se non col rischio di cadere nell’ astratto, che i limiti infine
della conoscenza sono i limiti della induzione, e questa non può darci nulla al di là
della vita fenomenica … Ciò che costituisce un dato sicuro di cognizione, con diritto
scientifico indipendente da qualunque principio o idea, è il fenomeno. Il fenomeno,
che sembra qualcosa di fluttuante nella realtà, può fornirci delle nozioni e delle leggi
stabilmente fisse: anzi, come osserva un eminente pensatore {Ardigò}, non si dà altra
natura di dati conoscitivi, altra stabilità di princìpi scientifici, fuori dell’ empiria …
La scienza non si dimezza … riducendola al mero fatto”.
Scarica