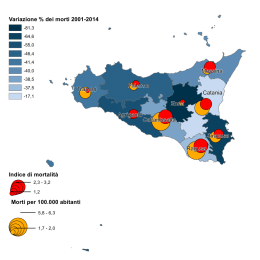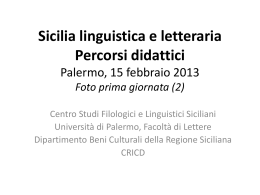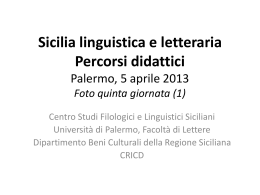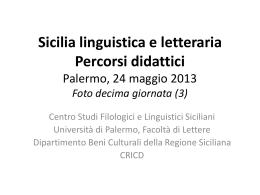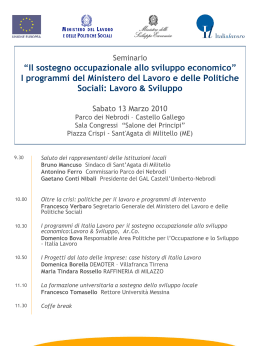Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica numero 3 - 20 maggio 2011 Direttore responsabile: Giovanni La Barbera Direttore scientifico: Simonetta La Barbera Comitato Scientifico: Claire Barbillon, Franco Bernabei, Silvia Bordini, Claudia Cieri Via, Rosanna Cioffi, Maria Concetta Di Natale, Antonio Iacobini, César García Álvarez, Simonetta La Barbera, Donata Levi, François-René Martin, Emilio J. Morais Vallejo, Massimiliano Rossi, Gianni Carlo Sciolla, Philippe Sénéchal. Redazione: Carmelo Bajamonte, Francesco Paolo Campione, Roberta Cinà, Nicoletta Di Bella, Roberta Priori, Roberta Santoro. Progetto graf i c o , e d i t i n g e d e l a b o r a z i o n e d e l l e i m m a g i n i : Nicoletta Di B e l l a e R o b e r t a P r i o r i . Università degli Studi di Palermo Facoltà di Lettere e Filosofia Dipartimento di Studi culturali Società Italiana di Storia della Critica d’Arte ISSN: 2038-6133 - DOI: 10.4413/RIVISTA Copyright © 2010 teCLa – Tribunale di Palermo – Autorizzazione n. 23 del 06-10-2010 http://www.unipa.it/tecla __________________________________________________________ © 2010 Università degli Studi di Palermo Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica numero 3 - 31 maggio 2011 Proprietà artistica e letteraria riservata all’Editore a norma della Legge 22 aprile 1941, n. 663. Gli articoli pubblicati impegnano unicamente la responsabilità degli autori. La proprietà letteraria è riservata alla rivista. I testi pubblicati non possono essere riprodotti senza l’autorizzazione scritta dell’Editore. Gli autori debbono ottenere l’autorizzazione scritta per la riproduzione di qualsiasi materiale protetto da copyright. In riferimento al materiale iconografico fornito dagli autori a corredo dei testi, la Redazione si riserva il diritto di modificare, omettere o pubblicare le illustrazioni inviate. I lavori sono pubblicati gratuitamente. È possibile scaricare gli articoli in formato pdf dal sito web di “teCLa”. È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale anche a mezzo di fotoriproduzione, Legge 22 maggio 1993, n. 159. 4 Simonetta La Barbera Presentazione 12 Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin-Louis Millin tra Francia, Germania e Italia 46 Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 84 Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 106 Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica allo studio della storia dell’arte siciliana dal tardo antico al barocco 144 Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte. Erwin Panofsky e l’educazione estetica in presenza di disabilità visiva 168 Marcella Marrocco Il museo negli scritti di Giulio Carlo Argan Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica A nche questo terzo numero di teCLa offre ai lettori alcuni interessanti contributi che prendono in esame aspetti particolari della cultura artistica sia europea che nazionale, ma anche siciliana, in un arco di tempo compreso tra gli albori dell’Ottocento e la prima metà del secolo successivo. I l primo articolo, Un grande corrispondente europeo. Aubin-Louis Millin tra Francia, Germania e Italia, proposto in due parti distinte da Monica PretiHamard e da Bénédicte Savoy, prende in esame la figura di Aubin-Louis Millin, uno dei principali attori della vita intellettuale e delle istituzioni culturali nella Francia post- rivoluzionaria. Oltre ai ruoli ufficiali che lo impegnarono soprattutto nella riorganizzazione degli istituti di istruzione pubblica – il Louvre e la Biblioteca nazionale di Francia – che erano stati arricchiti dalle campagne di confisca delle opere d’arte e di libri praticate da Napoleone in Italia (1796), fu raffinato intellettuale in contatto con numerosi studiosi. Le due autrici ricordano l’importanza del viaggio in Italia compiuto dal settembre 1811 al novembre 1813, durante il quale Millin visitò diverse città della Penisola e le cui Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica tappe sono solo parzialmente descritte nel Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à Génes, edito a Parigi nel 1816, sulla scia dei viaggi di studio e di ricerca quali quelli di Lanzi, di Cicognara, di Seroux d’Agincourt e sui quali Gianni Carlo Sciolla ha fornito illuminanti disamine. Soprattutto, dalle autrici sono analizzati i rapporti che il francese ebbe con intellettuali in particolare tedeschi ed italiani, individuando all’interno della sua corrispondenza due importanti carteggi che contengono gli scambi epistolari con l’archeologo tedesco Karl August Böttiger e con l’erudito romano Francesco Cancellieri e dalla lettura dei quali le informazioni fornite consentono di evidenziare i forti rapporti culturali che caratterizzavano lo spazio europeo del sapere nei primissimi anni del secolo XIX. Da questa corrispondenza risaltano sia le scelte di gusto dei corrispondenti sia gli aspetti del collezionismo del periodo, anche “il fissarsi di una storia della disciplina archeologica e dei suoi metodi, con interessanti riflessioni teoriche che palesano sia i modelli di erudizione e di circolazione ereditati dal XVIII secolo sia la creazione di strumenti moderni, democratici, rapidi e istituzionalizzati di diffusione del sapere”. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica N icoletta Di Bella, analizzando gli Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852), affronta gli stessi temi in un ambito più ristretto, ma non per questo meno interessante, quale è spesso quello della letteratura artistica siciliana, in questo caso messinese dell’Ottocento. L’articolo prende in esame la figura di Carmelo La Farina, intelligente conoscitore della cultura locale, indagandone alcune pubblicazioni, in particolare le ΄lettere artistiche΄ destinate ai più autorevoli membri della intellighenzia isolana e raccolte, nel 1835, in un volume intitolato Intorno le Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina – Ricerche ordinate in più lettere. Egli privilegia in modo innovativo per i suoi tempi, l’aspetto filologico piuttosto che quello descrittivo, spesso riscrivendo le vicende più salienti della storia artistica della città del Faro, ritornando nelle Lettere sulle tradizionali attribuzioni della precedente storiografia locale, correggendone diverse, facendo anche più volte nuova luce intorno alle notizie biografiche che riguardavano gli artisti messinesi. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica A nche l’articolo di Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo è dedicato ad un conoscitore siciliano, l’erudito palermitano Agostino Gallo, il cui breve saggio, pubblicato nel 1863, ha come argomento precipuo le arti decorative siciliane (argenteria e oreficeria, marmi mischi, maiolica ecc.) e le attività dei più importanti artisti attivi fra la fine del XVIII e il XIX secolo ai quali più volte, come attestano le varie Notizie intorno agli artisti siciliani raccolte e consultabili nei manoscritti da lui redatti e oggi conservati presso la Biblioteca Regionale di Palermo, dedica particolare attenzione analizzando anche le cause che avevano favorito il fiorire di questa particolare produzione. L’intento dichiarato dall’autore, che lo accomuna ai quasi coevi esiti di Giuseppe Meli e di Gioacchino Di Marzo con i quali la storiografia artistica siciliana inizierà ad approdare al rango di critica d’arte, è quello “di riabilitare la fortuna critica della scuola artistica siciliana in un più ampio contesto storiografico e di creare un momento unificante, all’insegna di un’arte italiana, proprio all’indomani dell’Unità”. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica L I o scritto di Iolanda Di Natale, Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica allo studio della storia dell’arte siciliana dal tardo antico al barocco, prende appunto in esame l‘attività di questo storico dell’archeologia e dell’arte siciliane. Agnello, i cui lavori sulla produzione artistica paleocristiana e medievale isolana sono stati fondamentale punto di riferimento per le successive generazioni di studiosi, ha fornito con le sue numerose e pluritematiche ricerche un interessante proseguo e approfondimento degli studi di Gioacchino Di Marzo, Paolo Orsi ed Enrico Mauceri, soprattutto, un significativo contributo alla conoscenza del sistema artistico sia siracusano sia della Sicilia tutta, con riferimento anche alle arti decorative e alla produzione artistica del Barocco isolano. n Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte. Erwin Panofsky e l’educazione estetica in presenza di disabilità visiva, Roberta Priori analizza una particolare applicazione che il metodo iconologico teorizzato da Erwin Panofsky trova nell’ambito dell’educazione estetica nei casi di disabilità visiva. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica La studiosa si sofferma sulle fasi che caratterizzano il metodo didattico sviluppatosi alla fine degli anni Novanta presso il Museo tattile di Pittura antica e moderna Anteros dell’Istituto per ciechi Francesco Cavazza di Bologna. La percezione sensoriale (che corrisponde alla panofskiana lettura preiconografica), la cognizione (che corrisponde alla lettura iconografica) e l’interpretazione (che corrisponde alla lettura iconologica) dell’opera d’arte, nella lettura della Priori si evidenziano come i tre momenti che possono aiutare i non vedenti e gli ipovedenti per una più profonda comprensione dei manufatti. L’autrice parte dall’analisi di alcune opere giovanili e del periodo amburghese di Erwin Panofsky, in cui lo studioso si confronta con la tradizione critico-metodologica fornitagli dagli studi di Heinrich Wölfflin e di Alois Riegl ma anche dalle teorie di Aby Warburg e di Ernst Cassirer, evidenziando come nel percorso che lo porta alla sistematizzazione teorica del metodo tripartito, sia possibile rintracciare quelle possibilità, che prendendo spunto dal pensiero panofskiano, si possono indirizzare non soltanto all’educazione estetica dei non vedenti e anche “all’applicabilità degli aspetti educativo - pedagogici all’interno del complesso dibattito su percezione e significazione delle forme dotate di valore estetico”. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica I nfine, Marcella Marrocco, nello scritto Il museo negli scritti di Giulio Carlo Argan, pone degli interrogativi sull’attualità delle posizioni arganiane osservando che il critico durante tutta la sua attività, di studioso prima e di politico poi, ha considerato i musei, analizzati sia in riferimento alla loro struttura, soprattutto alla loro funzione sociale, quali oggetto di studio e di quella riflessione critica che lo ha quindi portato ad occuparsi della città intesa quale Gesammtkunstwerk, come oggetto estetico e come soggetto politico. La Marrocco ripercorre il percorso critico di Argan che partendo dalla lettura di Read e Dewey ed avendo i fondamenti metodologici nel pensiero dei suoi maestri, Venturi e Panofsky, nel definire la sua imago urbis assegna un ruolo centrale proprio ai musei che come luogo di incontro tra istanze storiche e istanze estetiche si pongono come spazio didattico privilegiato per l’educazione del cittadino. Con quella che la studiosa definisce ‘lucida previsione’, Argan anticipa i concetti di museiscuola e anche di una nuova scena urbana, di una nuova piazza che non è solamente luogo di incontro Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica e di scambio culturale, ma anche metafora dei valori della società. In questa lucida previsione di quelli che sono oggi i nuovi modelli museali, “dalla critica del museo-logo, del museo-archiscultura all’apprezzamento di quei musei capaci di porsi come nuova «direttrice urbana», la Marrocco individua nelle posizioni arganiane spunti di riflessione ancora validi per il dibattito contemporaneo. Ancora una volta concludo questo breve editoriale con un ringraziamento ai colleghi che in qualità di componenti del comitato scientifico e di attenti e generosi revisori hanno contribuito con le loro osservazioni e suggerimenti, alla possibilità di offrire ai lettori un materiale che spero risulti di interessante ed utile lettura. Simonetta La Barbera Un grande corrispondente europeo. Aubin-Louis Millin tra Francia, Germania e Italia di Monica Preti-Hamard e Bénédicte Savoy Nell’ambito di un convegno dedicato alle dinamiche degli scambi artistici in Europa e ai loro attori, ci è parso interessante interessarci alla sua attività di corrispondente tra la Francia, l’Italia e il mondo tedesco. Una ricerca ovviamente parziale, che acquista senso solo se viene messa in rapporto con altre ricerche, in particolare coi lavori pionieristici realizzati da Cecilia Hurley durante gli scorsi anni2. C hiunque si interessi alle scienze e alle arti nella Parigi del periodo rivoluzionario e napoleonico ha incontrato il suo nome. Aubin-Louis Millin (1759-1818) è uno dei principali attori della vita intellettuale e delle istituzioni culturali francesi intorno al 1800. Contemporaneamente soprintendente del Gabinetto delle Medaglie e Antichità a Parigi, tessitore di reti di contatti, perno di un vasto sistema di informazioni letterarie, redattore del famoso “Magasin encyclopédique”, uno dei più efficaci strumenti di diffusione delle novità scientifiche europee in Francia, Millin è senz’altro una delle personalità che meglio incarnano i tre imperativi della République des lettres: propagazione, emulazione, scambio1. Per analizzare il ruolo d’intermediario di Millin, la sua corrispondenza offre un ricco campo di ricerca. Essa permette di seguirlo da vicino: dinamiche transfrontaliere un po’ evanescenti; canali di diffusione internazionali; la costruzione di un sapere e di un discorso omogeneo su obiettivi scientifici comuni (monumenti antichi, monete e medaglie, testimonianze architettoniche, ecc.). Nelle pagine seguenti ci proponiamo di delineare una cartografia teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 12 numero 3 - maggio 2011 sommaria della rete epistolare di Millin nello spazio germanico e in Italia, insistendo soprattutto sul carattere complementare della sua attività di corrispondente e quella di viaggiatore. Tenteremo poi di individuare, alla luce di due precisi scambi epistolari, le funzioni della corrispondenza, la natura delle informazioni e degli oggetti scambiati, l’impatto di questi scambi sull’elaborazione di un sapere comune. Cercheremo infine di valutare, in termini di transferts culturali, quali effetti triangolari abbia comportato il doppio dialogo tra Millin e le comunità dotte italiane e tedesche. In ultima analisi, si tratta di contribuire ad una migliore conoscenza delle interrelazioni forti che caratterizzavano lo spazio europeo del sapere sotto l’Impero. Millin descrive così le sue attività in una lettera del 9 gennaio 1812 scritta da Roma. Attività certo diverse da quelle che svolge di solito a Parigi, ma tuttavia caratterizzate, come quelle, dalla preoccupazione costante di accumulare conoscenze e documenti sul patrimonio artistico messo alla sua portata; di curare le sue reti sociali e le amicizie professionali; ma anche, e soprattutto, di alimentare la sua vasta corrispondenza. Una corrispondenza di cui i ventotto volumi che la racchiudono al dipartimento dei manoscritti della Bibliothèque nationale de France ci suggeriscono l’ampiezza (tanto più che questi volumi presentano non poche lacune). Questi ventotto volumi contengono soprattutto le lettere ricevute da Millin. Gli autori sono dotti francesi, ma anche più di trecento eruditi europei rappresentati da almeno una lettera. In generale tuttavia essi sono presenti con diverse lettere, il cui insieme conta talvolta diverse centinaia di pagine. Tra i corrispondenti europei si annoverano almeno novantacinque autori germanofoni, distribuiti in tutta l’Europa centrale, da Amburgo a Trieste e da Strasburgo a San Pietroburgo. Ma vi figurano anche tedeschi di Parigi o di Roma. Sono presenti inoltre quasi centocinquanta italiani, alcuni inglesi, degli scandinavi, degli olandesi e qualche spagnolo. La maggior parte delle lettere ricevute di Millin è in francese, anche se l’erudito parigino insiste molto sulla propria capacità di leggere il tedesco e l’italiano. La rete di corrispondenti europei di Millin. Millin e lo spazio germanofono Bénédicte Savoy J’ai bien peu de momens libres, il faut voir le monde et le recevoir, courir les monumens quand il fait beau, visiter les cabinets et les artistes lorsque le tems est – comme depuis 8 jours – detestable, rediger mes notes et entretenir ma correspondance avec le ministre, mon administration, mes parens, mes amis, et les redacteurs subrogés du magasin3. Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 13 numero 3 - maggio 2011 Il suo plurilinguismo ha talvolta un tono militante. Esso gli conferisce una fama internazionale di poliglotta, come testimoniano queste parole, scritte nel 1813 dallo spagnolo Juan Andrés, napoletano d’adozione: di strumenti moderni, democratici, rapidi e istituzionalizzati di diffusione del sapere. In effetti, tra i corrispondenti tedeschi di Millin si annoverano tanto dei rappresentanti della pura tradizione filologica universitaria tedesca quanto dei conservatori di biblioteche più o meno pubbliche, dei pedagoghi, ma anche e soprattutto dei librai e degli esponenti del giornalismo. Anche se Millin non ha mai viaggiato in Germania, era considerato dalla comunità scientifica d’oltre Reno come un alleato estremamente importante. È spesso lui che si sforzava di contattare per ottenere informazioni affidabili sulla vita culturale parigina. È a lui che venivano spesso raccomandati i giovani da introdurre in società. Questo status privilegiato, questa visibilità particolare di Millin non è un fenomeno esclusivamente franco-tedesco. Ne si ritrovano le forme, forse un po’ attenuate, nel contesto franco-italiano. Millin, che non era mai andato in Germania, viaggiò a lungo in Italia. La sua corrispondenza italiana, intensa e diversificata, ci testimonia l’importanza che rivestirono i suoi viaggi. Vi scrivo in italiano […]. Potrei scrivervi anche in ispagnolo, tutte due lingue a voi egualmente note che la francese, come pure il tedesco e l’inglese, […] che formano la vostra poliglottia4. Un poliglottismo limitato certo a conoscenze soprattutto passive, ma che è una delle armi principali di Millin nel paesaggio intellettuale francese. Ama infatti sottolineare sistematicamente, nelle lettere ad alcuni corrispondenti tedeschi: Votre langue ne m’est point etrangere et comment sans sa connaissance suivre les travaux philologiques, malheureusement la plupart de nos litterateurs et de nos savants l’ignorent, c’est ce qui fait que nous sommes si peu au courant de ce qui se passe hors de notre republique5. Millin e l’Italia, Millin in Italia Monica Preti-Hamard Essere al corrente e mettere al corrente, ecco cosa interessa Millin. La specificità (e l’interesse particolare) del suo modus operandi va senz’altro ricercata nella sintesi che egli propone tra modelli di erudizione e di circolazione ereditati dal XVIII secolo e la creazione «J’avois toujours désiré de faire le voyage d’Italie. Mes regards se tournoient sans cesse vers cette terre classique […]» scrive teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 14 numero 3 - maggio 2011 Aubin-Louis Millin in aprtura del suo Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à Gênes6. È in Italia che Aubin-Louis Millin, all’età di cinquantadue anni, compì il suo unico viaggio fuori di Francia. Vi consacrò due anni, dal settembre 1811 al novembre 1813, durante i quali egli visitò una gran parte della Penisola. Questo viaggio, tanto desiderato e lungamente preparato, rappresentava il coronamento della sua carriera di savant e di responsabile di istituzioni culturali: «J’aurai un plaisir infini à vous voir en Italie assurer par la vue des objets et des lieux les connaissances que vous avez déjà su acquérir si loin de ce beau Pays […]», gli scriveva Seroux d’Agincourt che, sin dal 1809, lo aspettava a Roma7. Gli obiettivi di Millin erano, da una parte, quello di verificare ed approfondire le sue conoscenze, dall’altra, quello di riunire un materiale documentario (soprattutto Gioacchino Camilli, Tombeau du cardinal Roverella à Saint Clément (Giovanni Dalmata e aiuti, Monumento funebre del cardinale Bartolomeo Roverella, 1477), Paris, BnF . Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy libri e stampe) destinato ad arricchire le collezioni della Bibliothèque nationale ed anche le proprie. In Italia egli fece inoltre realizzare, da artisti impiegati sul posto, diverse migliaia di disegni principalmente di «monuments inédits», ma anche di siti, paesaggi e costumi locali. Questo ricco materiale doveva servirgli da base per future pubblicazioni e per l’insegnamento dell’archeologia che da numerosi anni impartiva al Cabinet des Médailles e la cui principale novità era proprio l’analisi diretta delle opere (originali o riproduzioni)8. Millin avrebbe voluto pubblicare il resoconto completo del suo viaggio d’Italia, accompagnato da illustrazioni. Un progetto ambizioso che occupò gli ultimi anni della sua vita: «C’est pour moi un sujet de recherches et d’études, et de correspondance continuelle» – scriveva al collega ed amico Karl August Böttiger da Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 15 numero 3 - maggio 2011 F Parigi il 26 aprile 18149; progetto che tuttavia rimase incompiuto. Furono pubblicati solo alcuni libri su argomenti specifici, qualche articolo nel “Magasin encyclopédique” e i quattro primi volumi del Voyage, riguardanti il Nord dell’Italia e senza illustrazioni10. Nonostante l’importanza di questo viaggio, non esiste ancora alcuno studio approfondito sull’argomento. Disponiamo peraltro di fonti eccezionali che sono tuttavia sparse e difficilmente utilizzabili separatamente: esse si trovano per la maggior parte alla Bibliothèque nationale de France, ma sono disseminate nei suoi diversi dipartimenti11. L’analisi incrociata delle diverse fonti, che ho intrapreso, consente di studiare questo importante viaggio che, come si intuisce, offre innumerevoli possibilità e assi di ricerca: storia del viaggio, “transferts culturels”, storia del collezionismo, storia della disciplina archeologica e dei suoi metodi, ecc. Inoltre la ricostruzione del corpus di disegni fatti eseguire da Millin in Italia e la loro identificazione potrà offrire una testimonianza straordinaria di monumenti e siti alcuni dei quali hanno subito modificazioni o sono oggi scomparsi. Mi limiterò qui ad evidenziare due aspetti: le motivazioni e gli interessi che mossero Millin ad intraprendere il viaggio in Italia; l’organizzazione di quello che definirei un “bureau de correspondance itinérant”. in dall’inizio Millin giustifica il suo viaggio come un’iniziativa di interesse generale in una lettera inviata, appena partito, ad un collega membro dell’Istituto e subito pubblicata nel “Magasin encyclopédique”12. Egli vi afferma che l’Italia, ambita meta di tutti i viaggiatori del passato, non è più la stessa – «Tout a été changé» –; si propone dunque di essere l’“osservatore” di tali mutamenti e ne vuole rendere conto al pubblico con una nuova descrizione13. Il campo di interessi e la rete di persone incontrate durante il suo viaggio sono vastissimi. Nello spirito dell’universalismo enciclopedico, le sue ‘curiosità’ spaziano dall’arte antica e moderna ai fenomeni naturali, dalla lingua alla religione, dalle istituzioni agli usi e costumi. Ma soprattutto Millin va alla ricerca di «monuments inédits», ossia di reperti antichi che ancora non erano stati studiati né resi pubblici attraverso l’incisione o, qualora lo fossero stati, erano copiati male e quindi conosciuti in maniera parziale o erronea. Attraverso nuove riproduzioni e descrizioni, basate sull’esperienza diretta, egli desidera diffonderne la conoscenza ‘esatta’. Gli orizzonti cronologici dell’antico sono per Millin vasti, coprendo, oltre all’antichità greca e romana, anche le antichità cristiane e il Medioevo. Egli si interessa inoltre alle testimonianze teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 16 numero 3 - maggio 2011 della storia francese in Italia come per esempio, nel Sud, i monumenti normanni e angioni. La stessa larghezza di vedute riguarda il tipo di opere studiate: Millin non si interessa solo ai “capolavori” dell’arte monumentale, ma a tutte le espressioni artistiche (codici, iscrizioni, medaglie, vasi o suppellettili) che possa aiutare alla comprensione della “cultura figurativa” di un’epoca. Egli rivela in questo modo una concezione etno-antropologica dell’Antichità e del Medioevo come scoperta globale di una civiltà, di cui occorre ricostruire tutti i tasselli con ogni testimonianza possibile. Questo approccio dell’Antichità e del Medioevo era del resto in sintonia con le ricerche più avanzate della Roma della fine del XVIII secolo, di quel circolo cosmopolita di collezionisti e studiosi quali Seroux d’Agincourt, Lanzi, Borgia, Zelada e Zoega, al quale Millin apparteneva idealmente. Gli obiettivi di Millin in Italia trovano anche consonanze profonde con il programma “antropologico” della Société des Observateurs de l’homme di cui fu membro. Animata dall’“idéologue” di Louis-François Jauffret, questa Société, benché effimera (1799-1804), ebbe un ruolo importante nella transizione dei saperi che caratterizza il passaggio tra Sette e Ottocento. Essa è legata alla nascita di una moderna pratica epistemologica sulle questioni riguardanti l’uomo, considerato nei suoi aspetti fisici, morali e intellettuali all’interno delle varie civiltà. Una pratica basata sull’osservazione empirica e sperimentale, sui viaggi, sullo scambio interdisciplinare nonché sulla divulgazione attraverso l’insegnamento e la pubblicazione14. S ono questi le motivazioni e gli interessi che mossero Millin in Italia e che determinarono il suo itinerario15. Millin seguì un percorso quanto più completo possibile percorrendo la Penisola dal Nord al Sud. Arrivato in Italia attraverso il Moncenisio, egli visita Torino e il Piemonte e si dirige poi direttamente a Roma. Nella capitale pontificia si trattiene per due lunghi soggiorni (dal 30 novembre 1811 a metà marzo dell’anno successivo, poi dal 29 aprile al 14 giugno 1814). Nel frattempo, trascorre più di un anno nel Regno di Napoli che visita sistematicamente. Non si limita a Napoli, ma percorre anche la Calabria, il Molise, gli Abruzzi e le Puglie. La disfatta dell’esercito francese in Russia lo induce a prendere la via del ritorno, visitando di passaggio la Toscana, Venezia e la Lombardia con un breve soggiorno a Milano. In tutto, egli visitò oltre duecento tra città e località minori. Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 17 numero 3 - maggio 2011 Si tratta di un viaggio minuziosamente preparato ed organizzato. Millin, che parte accompagnato da un segretario, l’alsaziano Jacques Ostermann, ha accumulato un bagaglio di conoscenze, di libri e di documenti; dispone inoltre dell’appoggio politico ed istituzionale nonché di una vasta rete di relazioni: Un viaggio di studio e di ricerca, dunque, ed in questo si avvicina più ai viaggi di un Lanzi17, di un Cicognara o di un Seroux d’Agincourt che ai viaggi pittoreschi di tradizione settecentesca: tuttavia egli non ha l’ambizione di tracciare una storia dell’arte panoramica ed esaustiva. Uomo di comunicazione e grande divulgatore, desiderava rendere pubbliche le sue scoperte, comunicarle alla comunità internazionale dei conoscitori per permettere lo scambio di idee e di informazioni e, in questo modo, di far progredire la conoscenza. La velocità e la vastità di trasmissione erano inoltre per lui essenziali al fine di evitare che gli studiosi avanzassero su false piste, ritardando così il progresso comune. Dal regesto della posta inviata che teneva regolarmente aggiornato, si constata che, nonostante gli incessanti spostamenti, egli inviava in media fino a cinquanta lettere per settimana. Bisogna pensare che percorreva territori allora tutti sotto il controllo diretto o indiretto della Francia e che poteva quindi beneficiare di una rete postale centralizzata. Gli italiani e gli stranieri residenti in Italia indirizzavano le loro lettere nelle città sedi delle direzioni delle poste più vicine al luogo dove egli si trovava; Millin pertanto comunicava regolarmente a tutti i suoi spostamenti: il suo viaggio è pubblico. La posta in provenienza dai diversi paesi d’Europa, invece, […] je vais donc voir ce beau pays et y passer un assez longtems car je ne veux pas le parcourir rapidement, j’y ai une foule de relations de nationaux de françois et d’etrangers, un coffre rempli de tous les voyages un peu interessant derrière ma voiture16. Grazie ai suoi contatti internazionali e alla sua conoscenza delle lingue, egli può infatti procurarsi e leggere un grandissimo numero di libri di viaggiatori che siano francesi, inglesi, tedeschi o danesi. Ricorre anche alle diverse guide locali e alla letteratura specializzata. Durante il viaggio, egli continua inoltre a tenersi informato dell’attualità della ricerca facendosi inviare da tutta Europa gli articoli di giornali riguardanti l’Italia. Il suo fine è di verificare e di completare le informazioni a sua disposizione, ciò che spiega le metodicità del suo viaggio e il fatto che scelga di perlustrare le regioni d’Italia meno note, come la Calabria, il Molise, gli Abruzzi o le Puglie, visitando anche territori quasi sconosciuti. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 18 numero 3 - maggio 2011 Forme continuava ad essere inviata a Parigi da dove gli era spedita, senza spesa, ovunque si trovasse. Un’organizzazione che egli stesso aveva perfettamente messa a punto prima di partire. Così scriveva all’amico e collega Karl August Böttiger a Dresda, dieci giorni prima della partenza: e funzioni della corrispondenza di Millin: due esempi Le lettere di Aubin-Louis Millin a Karl August Böttiger Bénédicte Savoy Come abbiamo detto, la corrispondenza tra Millin e Böttiger costituisce solo un sott’insieme in seno all’ampia serie di lettere “tedesche” ricevute o spedite dall’erudito parigino; ed acquisisce un pieno senso solo in rapporto ad altri tipi di fonti (le pubblicazioni scientifiche degli autori, i cataloghi delle loro biblioteche, i rendiconto delle loro opere, i resoconti di viaggio che li menzionano). Essa permette tuttavia di studiare la natura dei rapporti che univano Millin ai rappresentanti tedeschi della sua disciplina, intesa in senso largo. Da questo punto di vista, questa corrispondenza illumina in particolare il modo in cui venne creato e si fece oggetto di cure un asse transnazionale, strategico, del sapere e della sua diffusione pubblica (in particolare nel campo dell’archeologia), asse che le successive costruzioni storiografiche hanno spesso sminuito o affatto dimenticato. Infine, in un’epoca in cui le diverse specializzazioni universitarie e scientifiche si stanno differenziando, questa corrispondenza permette di cogliere la percezione rispettiva che i suoi autori avevano del loro ambiente scientifico che lo circondava19. Il faut mon cher ami m’ecrire comme si j’etois a Paris, et m’adresser de meme ce que vous auriez a m’envoyer. On gardera les livres, gravures & jusqu’a mon retour et les lettres me seront expediées sans frais partout ou je serai […] je voulois emporter votre livre sur l’acheologie de la peinture mais il n’est pas encore arrivé ; j’ai dit de me l’adresser sous bande, car je desire bien le lire et en faire l’application aux monumens que je pourrai observer dans mon voyage. On m’adressera de meme dans mon absence les ouvrages qu’on aura mis chez moi et dont j’aurai trouve le titre interessant afin que je puisse me tenir au courant j’ai pour cela le timbre de la direction des postes, ainsi il ne m’en coutera rien. Vous voyez que nous pouvons entretenir nos liaisons comme a Paris18. L’attività di corrispondente è per Millin essenziale e non può tollerare alcuna interruzione. Due importanti carteggi, quello con l’archeologo tedesco Böttiger e quello con l’erudito romano Francesco Cancellieri sono rappresentativi delle diverse funzioni di questa forma di scambio. Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 19 numero 3 - maggio 2011 Il “Magasin encyclopédique” è al centro dello scambio epistolare che ci interessa; il “Neuer Teutscher Merkur”, il “Journal des Luxus und der Moden”, la rivista “London und Paris” e, più tardi, il “Morgenblatt für gebildete Stände”, queste gazzette nelle quali Böttiger è a diverso titolo coinvolto, vi sono costantemente evocate. Ultimo punto comune: due secoli dopo la loro morte, Millin e Böttiger appaiono oggi come attori secondari, schiacciati retrospettivamente dal peso di personalità che hanno potuto frequentare, come Dominique-Vivant Denon o Ennio Quirino Visconti per l’uno, Goethe, Wieland o Herder per l’altro. Millin è già conosciuto e riconosciuto in Germania quando Böttiger lo accosta nel febbraio 1797. Fatto significativo, egli viene individuato in primo luogo come professionista della diffusione, e il suo nome si trova associato subito a quello del suo giornale. Chi era Böttiger? In un articolo pubblicato nel 2001, Claude Rétat ricorda che Millin fu considerato dai suoi contemporanei come il “Monsieur Archéologie” del momento, «operaio, rappresentante e quasi apostolo dell’archeologia»20. Con una piccola forzatura potremmo utilizzare le stesse qualifiche per l’archeologo tedesco Böttiger – archeologo, ma anche uomo di stampa e di rapporti come Millin –. La simmetria dei loro percorsi, del resto, non si limita a questo: Millin nasce nel luglio 1759, Böttiger nel giugno 1760. Studi di filologia moderna per il primo, classica per il secondo. Seguace l’uno di una filantropia educativa (Millin), professionista della pedagogia l’altro (fu direttore del collegio di Weimar), essi insegnano entrambi la loro scienza ad un pubblico di cultori non specialisti – Millin d’estate (per mancanza di riscaldamento), Böttiger d’inverno –. Tutti e due sono attivi massoni21. L’uno e l’altro riuniscono vaste biblioteche private, che aprono generosamente al pubblico interessato nelle loro rispettive città. E tutti e due occupano, l’uno in Francia, l’altro in Germania, una posizione chiave nel paesaggio del giornalismo dotto. Propagazione, emulazione, scambio: consci della necessità che hanno le scienze, le lettere e le arti, di mantenere i «mezzi di corrispondenza e comunicazione che son loro tanto necessari»22, Millin e Böttiger utilizzano i giornali come gli strumenti privilegiati della loro azione scientifica. C’est surtout le nouveau Magasin encyclopédique rédigé par vous, lui écrit Böttiger, qui m’a fait admirer l’étendue de vos connaissances et le rare talent de les rendre publiques en différentes voies23. Ampiezza delle conoscenze e talento nel renderle pubbliche: in termini di strategia editoriale, legarsi a Millin, alle sue connessioni e al suo giornale avrebbe offerto a Böttiger una pubblicità inedita sulla scena europea, e gli avrebbe allo stesso tempo permesso di teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 20 numero 3 - maggio 2011 ottenere informazioni di prima mano sulla vita scientifica francese e, più in generale, sugli argomenti alla moda che, in un contesto non adeguatamente rappresentate nel “Magasin encyclopédique”: «Pardonnez, Monsieur, la franchise avec laquelle je vous parle, c’est justement la littérature allemande qui me paraît être bien défectueuse dans le journal. Elle n’y entre presque pas»25. Al di là di questo incipit, tutto sommato classico, anche se costituisce un’eccezione nel campo franco-tedesco, si rimane colpiti dal fatto che Millin prenda l’iniziativa di dare subito allo scambio un carattere di autentico dialogo scientifico: tra il 1797 e il 1817, la corrispondenza presenta il tessuto di un sapere condiviso che, in questi primi anni del XIX secolo, è all’origine di pubblicazioni quasi simultanee, in Francia e in Germania, su argomenti molto vicini. Si è discusso in altra sede della forte compenetrazione scientifica e metodologica dei procedimenti di Millin e Böttiger26. È importante sottolineare come al centro delle preoccupazioni del tedesco e del francese ci sia l’Italia. L’Italia e le sue ricchezze archeologiche; l’Italia e le sue collezioni di opere d’arte; l’Italia e il progresso scientifico di cui essa è ancora capace. In questo modo, dietro Millin e Böttiger, due comunità scientifiche si sforzano, sotto l’Impero, di elaborare un sapere e un linguaggio comune su oggetti che fanno parte di ciò che l’epoca considera come il patrimonio dell’umanità. In modo significativo, è in genere nel campo tedesco che il francese Millin va a procurarsi le informazioni e gli strumenti concettuali di estrema concorrenza editoriale, permettono ai giornali tedeschi di vender bene. In effetti, in quegli anni, in cui la geografia culturale dell’Europa si riorganizza a vantaggio di Parigi, una delle preoccupazioni dei circoli illuminati tedeschi è quella di accedere ad un’informazione affidabile di provenienza francese. Böttiger è dunque alla ricerca d’informazioni sicure sull’effervescente vita letteraria e teatrale parigina, ma anche e soprattutto sulla riorganizzazione degli istituti di istruzione pubblica – Louvre e Bibliothèque nationale de France – che erano stati da poco arricchiti dalle campagne di confisca delle opere d’arte e di libri praticate in Italia (1796). Böttiger lo scrive in modo palese a Millin: «J’ai beaucoup de questions à vous faire sur le Muséum dont vous êtes le conservateur», prima di suggerire che questo rapporto potrebbe essere anche l’occasione di ottimizzare a distanza, imitando o mutuando le pratiche di Millin, alcune delle proprie competenze pedagogico-scientifiche: «[J’ai beaucoup de questions à vous faire] sur le plan de vos cours en archéologie, sur laquelle je vais publier moi-même»24. Come controparte, Böttiger offre al suo corrispondente di mandargli traduzioni, informazioni regolari sulle novità archeologiche, filologiche e letterarie tedesche, che considera Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 21 numero 3 - maggio 2011 che gli permettono di cogliere le novità archeologiche o bibliografiche Per diversi mesi, e in modo regolare, Millin informa il suo dell’Italia. Valga a testimonianza, tra numerosissimi altri esempi, corrispondente dell’arrivo e della ripartizione degli oggetti confiscati, questa annotazione sulla scoperta dei «manoscritti di Ercolano»: ma anche delle grandi collezioni private inglesi e francesi formatesi in Italia, quella dei vasi etruschi di Thomas Hope (1796-1831), Nous possedons a l’institut six manuscrits d’Herculanum dont nous quella di Edmé-Antoine Durand (1768-1835) o quella di Joséphine sommes tres embarrassés ce seroit le cas d’y appliquer la méthode du Bonaparte, per esempio. La maggior parte di queste informazioni cher Sickler, il faudroit la connoitre27. vengono pubblicate da Böttiger, ed alimentano tanto i suoi lavori scientifici che i suoi giornali. Intorno al 1800, il polo germanofilo e In senso inverso, Millin propone molto concretamente il suo aiuto germanofono della Bibliothèque nationale, intorno a Millin, svolge per l’elaborazione di opere tedesche su alcune questioni italiane, come quindi un ruolo importantissimo nella diffusione internazionale di lo suggeriscono queste frasi, tratte da una lettera a Böttiger: informazioni sul patrimonio archeologico europeo. J’ai reçu l’ouvrage de M. Reichard, dites Lui que je pourrai Lui fournir des notes pour son Itinéraire d’Italie28. Je Lui conseille beaucoup de reduire ainsi son grand ouvrage29 en différentes parties parce qu’il pourra toujours perfectionner successivement l’une ou l’autre à mésure que l’édition s’épuisera, et il pourrait aussi mettre à part ses conseil généraux sous le titre Guide des voyageurs30. La corrispondenza di Aubin-Louis Millin e Francesco Cancellieri Monica Preti-Hamard Francesco Cancellieri32 – considerato al suo tempo da Giulio È vero che, visto dalla Germania, e nel contesto del trasferimento Perticari «principe dei viventi eruditi nelle cose italiane»33 – non è a Parigi di migliaia di opere d’arte confiscate in Italia, Millin occupa tra i più illustri corrispondenti di Millin, ma l’importante carteggio una posizione privilegiata. Quando Böttiger lo sollecita nel febbraio conservato, che si estende per oltre un decennio, offre numerosi 1797, il trasferimento massiccio di questo patrimonio artistico spunti per lo studio della vita culturale ed artistica a Parigi e a Roma italiano domina l’attenzione degli ambienti illuminati tedeschi31. nei primi decenni dell’Ottocento; esso fornisce inoltre importanti teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 22 numero 3 - maggio 2011 Giovanni Antonio Baruffaldi (dis.), Filippo Cenci, Francesco Cancellieri romano, 1819, in Catalogo di tutte le produzioni letterarie edite ed inedite della Ch. Me. dell’abate Francesco Girolamo Cancellieri, coll’elenco dei manoscritti lasciati ai suoi eredi, Roma, Dalla Tipografia Ferretti, 1846. informazioni sul viaggio in Italia del Francese e sulla sua attività di corrispondente e d’intermediario. Conviene prima soffermarci brevemente sulla personalità di Cancellieri. Nato a Roma nel 1751 e formatosi presso le scuole gesuitiche del Collegio Romano, anche dopo la soppressione della Compagnia di Gesù (1773), continuò ad essere sostenuto dall’influente “partito gesuitico” che ne facilitò la carriera e ne determinò orientamenti ed interessi culturali. Il lungo pontificato di Pio VI, segnato da numerose iniziative intese alla celebrazione trionfalistica della Roma archeologica e di quella pontificia, fornì a Cancellieri le occasioni e le grandi linee della sua abbondante attività letteraria. I suoi interessi principali – la storia della liturgia cattolica e dei riti romani, e la topografia sacra della città di Roma – si manifestano nelle sue opere maggiori, quali il trattato De secretariis basilicae Vaticanae (1786) o la Storia de’ solenni possessi de’ Sommi Pontefici (1802), vere summae di sapere antiquario, ed in un gran numero di scritti minori dedicati ad aspetti particolari della liturgia sacra o a singoli monumenti; questi ultimi destinati, nell’intenzione dello stesso autore, non soltanto agli studiosi, ma anche ad un pubblico più largo di turisti italiani e stranieri. Si intravedono già qui le qualità che dovettero fare di Cancellieri un interlocutore privilegiato per Millin: la sua conoscenza approfondita delle fonti per la storia della Roma classica e cristiana, la sua rigorosa tecnica di raccolta e di pubblicazione dei documenti, nonché la sua vocazione di colto divulgatore. Proprio grazie alle sue pubblicazioni Cancellieri si affermò come figura di prestigio nella Roma del tempo. Nominato soprintendente della Stamperia vaticana nel 1802, mantenne la carica anche dopo l’occupazione francese e sotto la Restaurazione fino alla morte nel 1826, ma il suo ruolo fu Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 23 numero 3 - maggio 2011 gli estratti tradotti in francese e i resoconti dei suoi libri, che in molti casi redige egli stesso35. Così nella prima lettera conservata a Cancellieri, scritta da Parigi il 16 agosto 1806, egli argomenta: sempre più marginale, rimanendo sostanzialmente legato ad una cultura attardata, erudita e classificatoria. È all’apice della sua carriera e nel fasto della Parigi imperiale al momento dell’incoronazione di Napoleone, che Cancellieri, giunto nel 1804 al seguito della spedizione pontificia, incontra Millin. Un incontro che, sostenuto da interessi ed amicizie comuni, evolverà in una relazione duratura, documentata da un’ampia corrispondenza inedita, oggi conservata in parte alla Bibliothèque nationale de France ed in parte alla British Library di Londra34. Benché lacunoso, questo carteggio, composto di oltre duecentocinquanta lettere, copre gli anni dal 1806 al 1818. La corrispondenza più abbondante riguarda gli anni dal 1812 al 1818 per ragioni che vedremo. Due funzioni principali motivano questa epistolario bilingue (Millin scrive in francese, Cancellieri in italiano): lo scambio di informazioni e di materiale bibliografico; l’organizzazione e la raccolta di documenti iconografici sull’Italia. Ce sera par ces extraits successifs que je ferai connaître parmi nous vos utiles travaux qui n’ont encore obtenu en France toute la celebrité qu’ils meritent car c’est en repetant plusieurs fois a nos francois les noms des savans etrangers qu’on les leur fait connaître. M. Visconti avant son arrivée n’etait gueres connu chez nous que par les frequentes notices que j’ai données de ses ouvrages et dans mon journal et dans mes cours sur les antiquités, il en est de même du celebre Bottiger qui est sans contredit un des plus habiles philologues. Comme il n’a ecrit qu’en allemand son nom ne serait pas connu si je n’avais pas donné souvent des notices sur ses ecrits. C’est le seul merite que j’aie aupres des gens de lettres et *** qui m’a valu la bienveillance de plusieurs. Je serai tres heureux de pouvoir obtenir toujours la votre et la continuation de votre amitié36. Come appare chiaro, il “Magasin encyclopédique” fu per Millin lo strumento principale per consolidare ed estendere la sua rete di relazioni internazionali. In questa lettera egli afferma inoltre il suo ruolo di promotore delle culture italiana e tedesca in Francia e sollecita nello stesso tempo una circolazione triangolare di informazioni. I n primo luogo Millin e Cancellieri scambiano le proprie pubblicazioni. Fin dall’inizio, Millin apre inoltre al corrispondente italiano le colonne del “Magasin encyclopédique” e vi inserisce teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 24 numero 3 - maggio 2011 «M. Visconti», citato nella lettera, è Ennio Quirino Visconti37, archeologo illustre e direttore del Museo Capitolino, prima del suo esilio politico a Parigi (1799) dove fu nominato conservatore delle Antichità del musée central des Arts. Professore e membro dell’Institut (dal 1803) e come tale collega di Millin, intrattenne con quest’ultimo strette relazioni. Dopo la sua morte, il francese ebbe il progetto di consacrargli una vasta opera biografica che, tuttavia, non fu realizzato. Ne reca testimonianza una lettera all’amico e collega tedesco Böttiger: Attraverso la biografia di Ennio Quirino Visconti, un italiano stabilitosi a Parigi, Millin voleva rendere conto di una stagione feconda di scambi tra eruditi e studiosi in tutta Europa che, in questi anni tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX, lavoravano per fondare un nuovo approccio alle opere d’arte. Nello stesso spirito, in un’altra lettera a Cancellieri, egli suggeriva al suo corrispondente l’opportunità di stabilire un sistema regolare che consentisse di inviare a Roma il “Magasin encyclopédique” in cambio di altri giornali romani come le “Memorie Enciclopediche” di Giuseppe Antonio Guattani e le “Efemeridi di Roma” che, da Parigi, sarebbero [stati] più facilmente comunicabili alle nazioni dell’Europa settentrionale: Si me charge de cette tache ce n’est pas en speculation car il ne m’en reviendra rien certainement, et peut etre sera-ce le contraire. je ferai un ou deux volumes contenant tout ce que je pourrai recueillir sur la vie de Visconti et sur ses ouvrages dont je donnerai une analyse, j’examinerai l’influence qu’ils ont eu selon les epoques, les pays, les genres sur l’acheologie et l’erudition. J’y joindrai ou plutot j’y melerai une histoire litteraire du dernier siecle dans sa fin et des dix sept annees de celui-ci depuis Winckelmann, en faisant connaître les savants, antiquaires, ***des arts avec qui il a ete en rapport et enfin les etablissemens, les musées a tout les monumens qu’il a decrits, je mettrai dans une Appendix ce qu’on pourra recueillir de sa correspondance, et des lettres qui lui ont été adressées, enfin je recueillerai les petites notes inedites que je pourrai rassembler. Le tout sera accompagne de son portrait; l’ouvrage splendidement imprimé chez Didot. Voilà mon plan, j’ecrirai a toutes mes relations en Europe […]38. Cela ne peut que tourner à l’avantage des artistes et des gens de lettres de Rome, puisque ce sera un moyen de faire connaître leurs succès et leurs productions, non seulement aux français, mais encore aux nations du Nord qui obtiennent plus facilement les journaux de France que ceux d’Italie39. Millin fu per Cancellieri, il quale non conosceva il tedesco, il principale intermediario per gli scambi con la Germania che rimasero tuttavia assai limitati: è al francese che chiede l’opportunità di spedire alcuni libri a Gottinga per un’eventuale traduzione in tedesco ed è ancora Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 25 numero 3 - maggio 2011 M a Millin che invia gli esemplari delle sue opere destinati a Böttiger affinché ne parli nei suoi giornali d’oltre Reno, chiedendo in cambio opere di bibliografia. Cosciente del pericolo di emarginazione della cultura romana, Cancellieri continuò a sollecitare la pubblicazione di articoli ed estratti dei suoi lavori nel “Magasin encyclopédique”40. a soprattutto Cancellieri fu per Millin un contatto essenziale durante il suo viaggio in Italia, diventando il suo «directeur des arts à Rome» come lo definisce ad un altro suo corrispondente, Giuseppe Capecelatro, arcivescovo di Taranto ed erudito insigne42. Infatti, dopo aver lasciato Roma nel marzo 1812 per recarsi nel Sud dell’Italia, Millin lo incarica di sorvegliare il lavoro dei disegnatori e dei copisti romani al suo servizio43. Un lavoro sul quale si tiene peraltro regolarmente informato e che continua a dirigere da lontano tramite uno scambio intenso di lettere. Nello stesso tempo, egli informa il corrispondente romano dell’itinerario del suo viaggio, delle sue scoperte e degli altri disegni che fa eseguire in diversi luoghi. Queste lettere forniscono quindi dettagli essenziali sul viaggio di Millin, sui disegnatori, sul tipo di lavoro a loro richiesto, sui monumenti disegnati, sull’organizzazione e le modalità di raccolta di questa ricchissima collezione di copie. Ancora più interessante, in molti casi ho potuto mettere in relazione le numerose informazioni contenute nelle lettere con i disegni conservati alla Bibliothèque nationale de France. Nel corso del suo viaggio, Millin sceglie personalmente i disegnatori e i monumenti da disegnare. Tra gli artisti che ho già potuto identificare figurano il torinese Angelo Boucheron44, il veneziano Lavori che del resto devono molto a Millin. Egli prodiga infatti all’amico, in lunghe lettere, le sue osservazioni, correzioni ed aggiunte in uno spirito di collaborazione, per favorire il progresso della scienza comune41. Da parte sua, Cancellieri fu un informatore prezioso per il francese, tenendolo aggiornato sulle scoperte archeologiche, sulle novità bibliografiche e sul variegato mondo culturale ed artistico romano. Tramite il suo corrispondente, Millin poteva disporre velocemente anche di tutta la produzione di opuscoli e di scritti minori, estremamente prolifica a Roma, di cui Cancellieri si teneva minutamente informato anche grazie al suo impiego di direttore della Stamperia di Propaganda Fide. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 26 numero 3 - maggio 2011 V Luigi Zandomeneghi45, i romani Bartolomeo Pinelli46 e Gioacchino Camilli47, il tedesco Franz-Ludwig Catel48 che lo seguì nel viaggio in Calabria eseguendo, oltre che copie di monumenti, disegni di paesaggi e di vedute, infine Michele Steurnal, Carlo Pecorari e Filippo Marsigli49 attivi a Napoli. Lo stesso Millin informava i suoi orrei adesso soffermarmi più particolarmente sui disegni che il francese fece eseguire a Roma. Tra i copisti romani al suo servizio, oltre ai già citati Gioacchino Camilli e Bartolomeo Pinelli, andrà aggiunto l’abate Giuseppe Guerigi53, archivista della basilica vaticana, esperto in paleografia, al quale egli affidò la copia delle iscrizioni di monumenti e lapidi. Riguardo poi alla scelta dei soggetti da copiare, Millin procedette in due maniere: attraverso ampie campagne sistematiche o per singoli monumenti. Nel primo caso rientrano i disegni di monumenti inediti dei musei Vaticani commissionati a Bartolomeo Pinelli, il quale fu incaricato di eseguire anche le incisioni destinate ad illustrare un complemento ai volumi dei musei Pio-Clementino e Chiaromonti54; tale complemento non fu tuttavia poi pubblicato per mancanza di tempo e di mezzi nella situazione politica mutata55. La campagna di copie affidate a Pinelli si estendeva inoltre a numerosi altri monumenti antichi di diversi luoghi pubblici e collezioni private56. Un’altra ampia campagna di copie riguardava le iscrizioni inedite antiche e medievali di cui Millin riunì un’importante raccolta («véritable trésor lapidaire» secondo le sue stesse parole)57, oggi conservata nel dipartimento dei manoscritti della Bibliothèque nationale de France in ben diciannove volumi58. Le copie delle iscrizioni furono corrispondenti dei progressi della sua raccolta documentaria senza poter celare la gioia quasi frenetica che gli procurava: «on diroit que je veut emporter Rome dans des feuilles de papier»50, scriveva a Böttiger o ancora, a Capecelatro, «Le nombre des monumens inedits que j’y ai recuellis est si considerable que je n’ose le dire. Le vrai peut quelques fois n’être pas vraisemblable, et cela aura l’air d’une charlatanerie»51. Questo tipo di appropriazione “virtuale” è tuttavia ben diverso da quella, “reale”, che altri francesi imponevano nello stesso periodo al patrimonio italiano52. Quello che Millin ricerca in primo luogo è la fedeltà e l’esattezza delle copie: non vuole integrazioni di alcun tipo, né alcun abbellimento; inoltre esige che i disegni siano interamente eseguiti davanti alle opere originali. Il suo obiettivo è riunire una documentazione che abbia valore “scientifico”, suscettibile di essere resa pubblica ed accessibile a tutti. Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 27 numero 3 - maggio 2011 verosimilmente realizzate tutte dall’abate Guerigi59. I primi undici volumi contengono le iscrizioni antiche (greche, romane e cristiane) suddivise, nei primi quattro, secondo la loro provenienza (essenzialmente la Biblioteca Vaticana e i Musei Vaticani) e negli altri sette per temi60. Gioacchino Camilli, Tombeau d’un religieux en mosaïque dans l’église de Sainte Sabine (lastra tombale di Munio de Zamora, padre generale dei Domenicani, 1300), 1813, firmato in basso a destra “Camilli fece”, iscrizioni lungo il lato destro: “Palmi romani 19 on(ce) 9” e in basso a sinistra: “61”, BnF . sua firma). Per alcune di esse, lo stesso Camilli eseguì delle copie colorate all’acquarello. Questo materiale era destinato ad una pubblicazione, anch’essa rimasta inedita, sulle iscrizioni sepolcrali di Roma dal V secolo al 1450. Grazie ai proficui scambi che questo convegno ha consentito, ho potuto individuare le origini e le motivazioni di questo importante progetto concepito da Millin in piena epoca di riscoperta dei “primitivi” e ancora tutta da studiare. L’idea gli fu suggerita da Cancellieri che conosceva i materiali (appunti Gioacchino Camilli, Fragment d’un pavé en mosaïque trouvé dans la villa de Mattei en 1814, manoscritti e xilografie) iscrizioni in basso a sinistra: raccolti dall’antiquario e “Trovato nel viale di mezzo della collezionista seicentesco villa Mattei nel marzo 1814”; in basso al centro: “Scala di Palmi Perfetto Francesco Gualdi per Romano”; in basso a sinistra: “115”, la pubblicazione di un BnF. I successivi otto volumi contengono le iscrizioni medievali classificate nell’ordine alfabetico delle chiese di provenienza: più di ottanta edifici vi si trovano recensiti; oltre alle trascrizioni epigrafiche, essi contengono numerose lapidi figurate: in questi casi vi interviene il disegnatore Gioacchino Camilli (che spesso appone la teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 28 numero 3 - maggio 2011 disegnatori) non segue in questo caso un piano sistematico di raccolta, ma è determinata dall’interesse storico-artistico dei reperti o dall’attualità di una scoperta, come per esempio il mosaico trovato nel 1814 nella villa Mattei. A Roma Millin s’interessò soprattutto alle antichità cristiane allora neglette e quindi maggiormente esposte al rischio di distruzione, come rende conto nelle lettere ai suoi colleghi dell’Institut a Parigi, poi pubblicate nel “Magasin encyclopédique”: Je ne suis pas contenté d’épuiser, autant que je l’ai pu, les monumens antiques grecs ou romains qui enrichissent les Musées et qui décorent les palais et les ville, j’ai aussi porté mon attention sur les monumens chrétiens qui sont plus imminement menacés de la destruction. Je n’ai point fait dessiner ceux qu’on trouve dans les ouvrages de Ciampini, de Boldetti, de Bottari, et dans quelques écrits particuliers, quoique Ciampini surtout les ait très-mal représentés; mais j’ai reproduit quelques-uns de ceux qui sont gravés dans l’ouvrage du respectable M. Dagincourt. Il les a donnés d’après une échelle qui convient à son plan; mon but a été d’attirer l’attention du gouvernement sur les monumens qu’ils représentent. Ces dessins sont faits avec la plus grande fidélité; la couleur des marbres et des émaux y est imitée, ainsi que celle de l’or; je ne regretterai point mes soins et ce que ces dessins m’ont coûté, s’ils produisent l’effet que j’en espère. Cette recherche m’a fait trouver encore, dans des sacristies, des monumens et des ustensiles chrétiens très-curieux, tels que la chape de Léon III, qu’on prétend que ce Pape portait quand il a sacré Charlemagne, le piviale de Silvestre II, etc.62 Gioacchino Camilli, Eglise Sant’Andrea Catabarbara Patricia – Rome, Paris, BnF. trattato sulle lapidi sepolcrali figurate delle chiese di Roma, rimasto anch’esso inedito61. L’analisi comparata di questi progetti condotti a due secoli di distanza potrà fornire spunti interessanti per la comprensione della complessa vicenda della fortuna dei “primitivi” nonché per lo studio dei “transferts culturels” tra Francia e Italia. Sempre grazie all’appoggio e al sollecito aiuto di Cancellieri, Millin poté dirigere da lontano, durante il suo viaggio, l’esecuzione delle copie di numerosi altri “monumenti inediti”, affidate per la maggior parte a Gioacchino Camilli. La scelta dei monumenti da copiare (di cui il Francese aveva lasciato precise liste a Cancellieri e a suoi Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 29 numero 3 - maggio 2011 conte Montalivet tra il gennaio e il febbraio 1812 per sensibilizzarlo alla valorizzazione di quei monumenti64. Alcuni disegni fatti eseguire da Millin, oggi conservati alla Bibliothèque nationale de France, recano testimonianza della sua curiosità e della sua particolare attenzione per diverse antichità cristiane: Gioacchino Camilli, Dalmatique dite la chapel de Saint Léon tirée de l’église de Saint Pierre dalle decorazione mu- (dalmatica detta di Carlo Magno, oggi al museo sive, alla scultura, del Tesoro di San Pietro, Città del Vaticano), firmato e datato in basso a destra alla suppellettile e ai “Camilli Fece 1812”, iscrizioni in basso a paramenti ecclesiastici. sinistra: “103”, “Cappa di S. Leone III”; al Alcune lettere scambiate centro: “Dalmatique du Vatican”, BnF. tra Millin e Cancellieri riguardano le copie eseguite da Gioacchino Camilli dei due preziosi paramenti pontifici sopra menzionati, «la chape de Léon III» (dalmatica detta di Carlo Magno, oggi Gioacchino Camilli, Mosaïque de l’Apside dans l’Eglise de S. Théodore Temple de forme ronde, anciennement consacré à Rome (Il Redentore tra i SS. Pietro, Paolo, Teodoro e un altro santo, VI sec.), 1812, firmato e datato in basso al centro: “G. Camilli disegnò 1812”, iscrizione in basso a sinistra: “1002”, BnF. In linea con Seroux d’Agincourt63, rianimando la tradizione dell’erudizione sacra sei-settecentesca, Millin ebbe un ruolo non secondario nella rivalutazione dell’arte medievale all’inizio del XIX secolo: oltre a promuoverne lo studio e divulgarne la conoscenza, egli dimostrò inoltre una moderna coscienza patrimoniale, sensibilizzando i poteri pubblici alla salvaguardia e alla conservazione. Proprio «les monuments écclesiastiques» e «les églises des premiers temps du christianisme» sono al centro delle sue preoccupazioni in altre lettere che egli scrisse da Roma al ministro degli Interni teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 30 numero 3 - maggio 2011 al museo del Tesoro di San Pietro, Città del Vaticano)65 e «le piviale de Silvestre II» (piviale detto “di San Silvestro”, oggi Museo della Basilica di San Giovanni in Laterano)66; copie che ho entrambe ritrovate alla Bibliothèque nationale de France. Anche in questo Gioacchino Camilli, Dalmatique dite la chape de caso Cancellieri agiSaint Léon tirée de l’église de Saint Pierre (dalmatica detta di Carlo Magno, oggi al museo del Tesoro di sce, oltre che come San Pietro, Città del Vaticano), 1812, firmato in intermediario, come basso a destra “G. Camilli fe.”, iscrizione in informatore. Così, a basso a destra: “Cappa di S. Leone III nella Sagrestia di S. Pietro”; in basso a sinistra: proposito della “cappa “104”, BnF. di Leone III”, in una lettera del 4 maggio 1812 informa Millin dell’esistenza di un disegno appartenuto al Cardinale Stefano Borgia e allora in possesso di Monsignor Valenti: Gioacchino Camilli, Une grande chape à fond d’or avec un grand nombre de figures (piviale detto “di San Silvestro”, oggi al Museo della Basilica di San Giovanni in Laterano), disegno colorato all’acquarello su fondo oro, BnF. Ora [Camilli] penserà a fare il disegno della cappa di Leone III. Io sapevo che il Cardinale Borgia l’avea fatto eseguire, ma non mi era noto in quali mani fosse ora passato. Avendo fatte molte ricerche, mi è stato supposto, che possa essere presso Monsignor Valenti. Io vi sono andato due volte, ma non l’ho potuto trovare in casa. Domani vi tornerò, e se mi riuscirà di averlo, glielo farò copiare con tanta minor fatica, e con maggior sollecitudine, con non poco di lei risparmio67. Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 31 numero 3 - maggio 2011 Millin risponde da Castrovillari, in Calabria, il 23 maggio seguente, convenendo sull’opportunità di cercare il disegno Borgia, ma insistendo sulla sua volontà di avere la copia richiesta, preferibilmente dall’originale68. Nel frattempo Cancellieri aveva scritto al suo corrispondente per informarlo che Camilli, essendo andato a vedere il disegno in quattro fogli di Monsignor Valenti, «non l’ha trovato esatto, né nelle figure, né nei colori. Onde lo ha cominciato sull’originale con somma diligenza, e son certo, che verrà una bella cosa» (Parigi, 15 maggio 1812)69. Il disegno era già finito all’inizio dell’agosto seguente e i lavori proseguivano alacremente, come possiamo constatare dalle lettere dei mesi seguenti. Vale la pena riportarne alcuni passaggi per rendere conto dell’efficacia del sistema di corrispondenza epistolare instaurato da Millin durante il suo viaggio: dans le premier volume ou le second du Museo Pio-Clementino en frontispice, je n’en ai pas besoin. Ces figures n’offrent aucune difficulté ainsi j’espere qu’il sera discret pour le prix si il veut surtout que je le puisse occuper jusqu’à mon second retour en octobre 1813, ce qui sera facile. […] (Naples, 6 août 1812). […] Il Sigr Camilli ha già terminato tutti i mosaici del Pavimento della Stanza delle Muse, avendo tralasciato soltanto il mascherone di mezzo, che suppone, che a lei non serva. Ora si accinge a fare il Piviale di S. Silvestro, il Musaico di S. Teodoro, la Gemma di S. M. in Campitelli, l’avorio della Barberina, e la Porta di S. Prudenziana, col Deposito che era a S. Clemente […] (Roma, 6 novembre 1812). […] M. Camilli a tres bien fait de ne pas dessiner le masque du milieu de la mosaique du musée. Il y a un trait leger de l’ensemble de cette mosaique dans un des frontispices du grand ouvrage de votre celebre Visconti, mais je desirois les petits cadres colories parce que c’est le seul monument ou on voye des comediens avec leur costume theatral en couleur. Le Terence n’a pas le meme avantage. Je vois que ce brave jeune homme a encore de l’ouvrage pour quelques jours, puisqu’il travaille bien et qu’il est interessant et honnete j’aime mieux n’employer que lui afin de l’employer plus longtemps dans ces tems difficiles […] (Naples, 9 novembre 1812). […] Si monsieur Camilli a terminé la cappa il peut s’occuper d’un dessin que je veux faire executer. C’est celui de la mosaïque de la Salle des Muses, qui represente differentes scenes de theatre. Je desire que chaque exagone ou il y a une scene ou une figure soit separé parce que mon objet est d’en faire le sujet d’une dissertation sur le costume theatral70. Il faut donc que les couleurs soient fidelement imitées il faut aussi faire dans le dessin des petits cubes irregulier qui fassent juger que c’est une mosaïque et non une peinture. Quand a la vue generale de la mosaïque elle doit etre […] Il Sigr Camilli sta lavorando il disegno del Piviale di S. Silvestro, che sarà più laborioso di quello di Leone III, formandolo tutto in un foglio, che rassomiglierà a un gran ventaglio, ed il monumento teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 32 numero 3 - maggio 2011 del card. Roverella a S. Clemente. Io l’ho diretto a Monr Callisto Marini, canonico di S. Giovanni, con un mio biglietto di raccomandazione, con un altro del marchese Longhi, pel musaico di S. Teodoro, e con uno del P. Burini per licenza di disegnare l’immagine di S. M. in Campitelli. È andato alla Barberina dove gli hanno fatto vedere un Dittico e tre miniature in carta pecora. Non ha saputo capire quale di queste tre Ella desidera. Onde la prego a significarmelo più chiaramente, per non errare. Egli suppone che sia la più grande, con varj busti di diverse figure assai belle. Se fosse questa, subito vi porrà mano. Le trasmetto la nota di tutte le sue opere, con un foglio a parte di quelle, che mi sembra, che vi si debbano aggiungere […] (Roma, 13 novembre 1812). Gioacchino Camilli, Dalmatique dite la chape de Saint Léon tirée de l’église de Saint Pierre(dalmatica detta di Carlo Magno, oggi al museo del Tesoro di San Pietro, Città del Vaticano), 1812, firmato in basso a destra “Camilli fece”, iscrizione in basso in basso a sinistra: “105”, BnF. […] Je ne connois pas le piviale [il Piviale di San Silvestro] c’est M. Pouyard qui me l’a indiqué. […] Je ne me rappelle pas d’un diptyque a la Barberini mais tres bien du guerrier a cheval tableau d’ivoire du bas empire. Je vous ai prié de voir si il etoit dans le Thesaurus diptycorum de Gori. Il faut pour les peintures que je reprenne les notes de Pinelli […] (Naples, 15 novembre 1812). […] Il Piviale di S. Sivestro è ormai finito, ed è pienissimo di figure. Il Dittico Barberino è già stato disegnato da Pinelli, col Guerriero a Cavallo, e con altre Pitture onde non occorre pensarvi […] Gioacchino Camilli, Dalmatique dite la chape de Saint Léon tirée de l’église de Saint Pierre (dalmatica detta di Carlo Magno, oggi al museo del Tesoro di San Pietro, Città del Vaticano), 1812, firmato in basso a destra “Camilli fe.”, iscrizione in basso a sinistra: “106”, BnF. (Roma, 24 novembre 1812). Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 33 numero 3 - maggio 2011 Gli ultimi due lavori affidati a Gioacchino Camilli, che egli terminò dopo il rientro di Millin in Francia, sono le copie del Rotulo di Giosué e del Mosaico di Palestrina. Il ben noto Rotulo di Giosué71, rotulo bizantino del X secolo ed una delle prime vestige d’iconografia biblica, fu copiato da Gioacchino Camilli in 33 tavole oggi incollate in un volume in folio della Bibliothèque nationale de France72. Per guidare la realizzazione di questo prezioso documento che Millin, seguendo Seroux d’Agincourt, riteneva più antico e risalente all’epoca paleocristiana73, egli prodigò numerosi consigli e redasse apposite note all’attenzione del disegnatore raccomandando soprattutto la più grande fedeltà all’originale: «Je demande surtout que rien ne soit embelli. J’ai bien peur que quelques figures ne l’aient été alors j’aurois une image et non une copie. Faite grande attention a l’exactitude pour le style. Je Gioacchino Camilli, Histoire de Josué d’après un manuscrit grec de la Bibliothèque du Vatican (Rotulo di Giosué, X sec., Codice vaticano palatino greco 431), iscrizione in alto a destra : “Tava 1a”, BnF. teCLa - Rivista recommande surtout les inscriptions. Cela est tres essentiel car il faut que la forme des caracteres soit exacte»74. Millin desiderava inoltre vedere le tavole via via che erano ultimate, facendosele inviare nelle diverse tappe del suo viaggio di ritorno per apportare eventuali modifiche. Così, dopo averla esaminata, chiese che la tavola n. 9 fosse rifatta in quanto i colori «des figures se raccordent mal»75; egli reiterava inoltre le raccomandazioni affinché anche le proporzioni fossero rispettate per poter ricostituire esattamente il rotulo. Solo a lavoro ultimato Camilli poté iniziare un’altra impegnativa impresa per il committente francese: la copia a grandezza naturale del mosaico nilotico di Palestrina. Questo celebre mosaico era stato al centro dell’attenzione di collezionisti ed eruditi sin dalla sua scoperta nel XVI secolo per il suo temi di Critica e Letteratura artistica 34 numero 3 - maggio 2011 interesse antiquario e naturalistico76. Lo stesso Millin nel 1799 aveva pensato di scrivere una memoria sugli animali e i vegetali che vi sono rappresentati per la Societé d’histoire naturelle alla quale apparteneva; un progetto caldeggiato dal suo amico Böttiger e al quale Millin dovette allora rinunciare in quanto la realizzazione delle tavole illustrative sarebbe stato un impegno troppo difficile ed oneroso77. Non è quindi sorprendente che il Francese, avutane la possibilità, avesse chiesto al suo disegnatore romano una copia del mosaico, che egli volle realizzata e colorata davanti all’originale. Camilli vi si applicò soggiornando numerosi mesi a Palestrina nel 1815; infine, il 25 aprile 1816, inviò a Parigi la copia in 44 fogli78. A Millin mancò il tempo di realizzare la pubblicazione progettata, ma presentò subito la copia all’appena ricostituita Académie des inscriptions et belles-lettres. Per renderla accessibile ad un più largo pubblico propose inoltre a Auguste de Forbin, direttore dei Musées Royaux, di esporla al Louvre: Je suis obligé de la garder en porte feuilles a cause de ses dimensions, elle perd ainsi de son interet. Peu de personnes peuvent la voir et en avoir connaissance, et si elle etoit au musée […] je serai charmé qu’un pareil monument soit exposé aux regards du public79. Gioacchino Camilli, Histoire de Josué d’après un manuscrit grec de la Bibliothèque du Vatican, (Rotulo di Giosué, X sec., Codice vaticano palatino greco 431), iscrizione in alto a destra: “Tava 32a”, firmato e datato in basso a destra: “Camilli a Roma 1814”, 1814, BnF. Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 35 numero 3 - maggio 2011 elitaria del collezionismo da “cabinet” o alla sociabilità di un ristretto circolo di conoscitori e “antiquaires”. Egli favorì dunque in ogni modo un ampio scambio di informazioni. Lo dimostrano gli epistolari che abbiamo qui analizzato, i quali forniscono inoltre spunti inediti per studiare gli incroci di interessi e di relazioni tra Francia, Germania e Italia attivi nella costituzione europea di una scienza archeologica, troppo spesso ricondotta a definiti ambiti nazionali. A questo riguardo, non sembra quindi esagerato considerare l’insieme della corrispondenza di Millin come l’opera principale della sua carriera di studioso. Gioacchino Camilli, “Mosaïque de Palestrina”, firmato e datato in basso a destra: “Gioacchino Camilli fece a Palestrina 1815”, BnF L’attività del collezionista era per Millin indissociabile da quella del divulgatore. Inoltre, l’esperienza visiva era per lui una condizione necessaria per la conoscenza («voir» et «avoir connaissance»)80: la pratica del viaggio assume qui tutta la sua importanza in quanto consente l’osservazione diretta dei “monumenti” e la loro riproduzione esatta, permettendone una classificazione metodica e trasmissibile. Allontanandosi dalla tradizione erudita, basata essenzialmente sullo studio dei testi, Millin è tra i fondatori di una nuova scienza archeologica, che non corrispondeva più alla pratica Appendice 1. Aubin-Louis Millin a Francesco Cancellieri [Londra, BL, Add 22891 - Vol. VII] J’avois pensé que ces dessins avoient ete faits sur des papiers uniformes et s’ajustant ensemble par les extremités des figures, comme les planches des colonnes Trajane et Antonina. Comment un homme qui a ces ouvrages sous les yeux a t’il pu prendre du papier de differentes tailles, ne pas regler la hauteur des champs des peintures, et ne pas le faire de maniere a pouvoir s’ajuster? teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 36 numero 3 - maggio 2011 Des que le rouleau sera termine nous songerons a la mosaïque et ensuite au reste. Il faut toujours finir une chose avant de songer aux autres. Je repete a M. Camilli qu’a ces observations pres je suis tres content de son dessin. Je l’engage a y mettre son nom qu’il a omis parce que il ne peut que lui faire honneur. Je l’assure de mon amitié. pour sa reputation ni pour son existence a venir. Il faut refaire la feuille qui n’est pas conforme aux autres. Quand je serai a Paris et qu’il sera question de publier le Josue, je pourrai manager avec lui pour le graver et le colorier. 3. Aubin-Louis Millin a Auguste comte de Forbin [Parigi, Bnf, Mss. fr. 24686, foll. 182-184] Aubin Louis Millin De grace que M. Camilli ne fasse plus mes dessins sur du papier de rebut et casse, il est impossible de les conserver quand ils ont des coupures. Lettera non datata (ma 1817) Monsieur le Comte Vous avez vu la belle imitation que j’ai fait faire a Rome de la mosaïque de Palestrine. Il n’existe aucune autre copie fidele de ce precieux monument qui, outre l’interet qu’il presente pour l’histoire de l’art, a encore le merite d’offrir aux yeux les scenes, les mœurs, les images, les sites, les plantes et les animaux de la haute ægypte relativement aux tems ou il a ete fait. Tout a ete calque avec le plus grand soin. La couleur a ete imitee sur le lieu même ou j’ai entretenu pendant plus de trois mois un artiste, dirigé par un chanoine qui depuis trente ans s’occupe de l’histoire de son pays. J’ai fait faire cet ouvrage il y a cinq ans uniquement par cet attrait qui me porte a recueillir tout ce que je puis trouver de nouveau sur les connaissances qui ont ete l’objet constant de mes etudes et il est de mon devoir de m’en occuper. Je l’ai mis il y a environ six mois sous les yeux des membres de l’academie des belles lettres, tous mes confreres qui sont aussi les votres se 2. Aubin-Louis Millin a Francesco Cancellieri [Parigi, Bnf, Mss. fr. 24680, fol. 179] Florence, 18 août 1813 Note sur M. Camilli Josue Il y a au n° 9 des figures qui se raccordent mal, c’est un leger inconvenient. Je ne vous en parle que pour lui recommander ce genre d’exactitude si nous faisons la mosaïque [de Palestrina]. J’ai rassemblé mon Josue. Il manque encore le nos 5. 14. 25. 26. pour qu’il soit terminé. Je brule de les recevoir. Cet ouvrage lui fera honneur quand je le ferai voir a l’Institut et ne sera perdu ni Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 37 numero 3 - maggio 2011 sont ecries qu’un pareil ouvrage etoit perdu chez un particulier, qu’il devroit etre dans un etablissement public puisque l’artiste, le naturaliste, l’antiquaire y pouvoient trouver, chacun selon leurs yeux, des sujets d’observations et qu’enfin sa place etait au musee royal. J’ai repondu que mon intention avait ete de faire peindre cette mosaïque pour moi, que je ne pretendais pas vouloir cacher et enfouir une chose qu’on croyait utile, que je la cederais volontiers, mais que ne le faisant pas pour argent ni pour besoin, je ne pouvois pas entamer sur ce point des sollicitations vives. Depuis j’ai eu l’honneur de vous voir, vous avez examiné cette peinture, elle vous a paru ainsi qu’a vos confreres interessante. Je suis obligé de la garder en porte feuilles a cause de ses dimensions, elle perd ainsi de son interet. Peu de personnes peuvent la voir et en avoir connaissance, et si elle etoit au musée je pourrais la consulter comme tout le monde et je n’en aurais pas moins le merite de l’avoir fait executer. Si vous jugez Monsieur le Comte que l’affaire puisse s’arranger, j’y suis tout disposé et je serai charmé qu’un pareil monument soit exposé aux regards du public. Il me serait toujours agreable de traiter avec un homme tel que vous et si la proposition vous plait, les conditions seraient bientôt reglées. Agréez l’assurance de la haute consideration et du sincere attachement avec les quels j’ai l’honneur d’etre Monsieur le Comte Votre devoué confrere A. L. Millin Tutte le immagini sono gentilmente concesse dalla Bibliothèque nationale de France di Parigi, ad eccezione dell’immagine di p. 23, del Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut di Firenze. 1 Questo articolo è il testo di una conferenza presentata in occasione del convegno internazionale Roma e la creazione di un patrimonio culturale europeo nella prima età moderna. L’impatto degli agenti e corrispondenti d’arte e d’architettura, sotto la direzione di Christoph Frank, Roma, Villa Medici, 13-16 ottobre 2005. La conferenza è stata presentata a due voci: Bénédicte Savoy si è occupata delle relazioni di Millin con la Germania, Monica Preti-Hamard di Millin e l’Italia. Sull’argomento sono inoltre in preparazione gli atti del convegno Voyages et conscience patrimoniale. AubinLouis Millin (1759-1818) entre France et Italie (Parigi, Institut national du patrimoine, 27-28 novembre 2008, Roma, Sapienza Università di Roma, 12-13 décembre 2008), a cura di Anna Maria D’Achille, Antonio Iacobini, Monica Preti-Hamard e Gennaro Toscano (in corso di stampa presso Campisano Editore, Roma). Le trascrizioni dei documenti sono conservative. I tre asterischi *** indicano una parola o una porzione di testo illeggibili. Abbreviazioni Bnf : Parigi, Bibliothèque nationale de France BL : Londra, British Library Ringraziamenti Teniamo a ringraziare Chistophe Frank per aver creato l’occasione di presentare a Roma questo contributo a due voci nonché Philippe Sénéchal per la rilettura dell’articolo e i suoi sagaci commenti. 2 C. Hurley, Le non-dit comme principe d’écriture sous la Révolution: les Antiquités nationales (1790-1798) d’Aubin-Louis Millin, in “Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte”, 53, 1996, pp. 275-284; Ead., Aubin-Louis Millin: programme du cours d‘histoire des arts chez les anciens, Paris 1805 with manuscript notes by Antoine Maire Chenavard, in “Scholion”, 0.2001, pp. 57-66; Ead., Building on ruins: Aubin-Louis Millin’s Antiquités nationales (1790-1798), tesi sotto la direzione di Jean-Daniel Morerod e Georg Germann, Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Institut d’histoire, 2004; Ead., Un cosmopolitisme journalistique: les généalogies du “Magasin encyclopédique”, in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne. Le Magasin encyclopédique - Les lettres à Karl August Böttiger, teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 38 numero 3 - maggio 2011 peints qui y ont été découverts en 1813, C. Wassermann, Paris 1816; Description d’une mosaïque antique du musée pio-clémentin à Rome, représentant des scènes de tragédies, impr. de P. Didot l’aîné, Paris 1819. 11 Il dipartimento dei Manoscritti conserva, oltre ai ventotto volumi della “correspondance littéraire” di Millin (preziosi anche per studiare il viaggio in Italia e la rete di corrispondenti italiani), 19 volumi contenti le copie di iscrizioni antiche e medievali fatte eseguire da Millin durante il suo soggiorno italiano, principalmente a Roma. Il Département des Estampes et de la Photographie conserva inoltre più di 1000 disegni del viaggio d’Italia. Questo importante fondo segnalato una ventina di anni fa da Françoise Arquié Bruley (Au Cabinet des Estampes, dessins executés en Italie de 1811 à 1813 pour Aubin-Louis Millin, in “Revue de la Bibliothèque nationale de France”, 15, 1985, pp. 25-43) non è poi stato studiato, anche per le difficoltà di identificarlo nel suo insieme. Infatti, acquistato dalla biblioteca a due riprese, nel 1819 e nel 1822, in seguito alle nuove classificazioni ottocentesche, esso è stato diviso in diverse ripartizioni tematiche, topografiche o per artisti: è soltanto grazie ad un inventario manoscritto compilato al momento dell’acquisizione, che oggi possiamo tentare la ricostruzione di questo corpus smembrato. Alla Bibliothèque de l’Arsenal esistono inoltre sette cartoni di note ed appunti di Millin durante il suo soggiorno in Italia. 12 Lettre de M. Millin à M.*** par M. Millin.... 13 Millin ribadisce queste idee, quasi negli stessi termini, in apertura del primo volume del suo Voyage, pubblicato nel 1816, in un contesto politico ancora mutato: «L’Italie a été plusieurs fois décrite; ainsi ce n’étoit pas l’espoir d’y faire quelque heureuse découverte qui m’inspiroit le désir de voir ce pays si vanté. Je voulois examiner moi-même les grands monumens dont il s’enorgueillit, et que les meilleurs dessins et les gravures les plus fidèles ne peuvent qu’imparfaitement représenter. D’ailleurs quoiqu’on ait publié tant de descriptions de l’Italie, il n’existe aucun ouvrage qui en donne une idée conforme à celle qu’on doit s’en faire aujourd’hui. Richard, Lalande, Wolkmann, Bernouilli, et ceux qui leur ont succédé, ont enrichi leurs ouvrages de détails importans, et seroit de meilleurs guides, mais leurs écrits manquent d’ordre; ils ont tout recueilli sans goût et sans choix, et la marche des événements a tellement vieilli ces ouvrages, qu’il reste peu d’observations dont on puisse profiter. Des souverainetés ont été détruites, les lois et l’administration ont été changés; et, quoique les derniers événemens aient Atti del convegno, (Amiens 2003), a cura di G. Espagne e B. Savoy, HildesheimZurich-New York 2005, pp. 107-119. 3 Millin a Böttiger, Rome, 9 janvier 1812, in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne…, lettera n. 102, pp. 513-515: p. 514. 4 Bnf, Mss. fr. 24697. 5 Millin a Böttiger, Paris, 3 mars 1797, Aubin-Louis Millin et l’Allemagne…, lettera n. 2, pp. 296-300: p. 297. 6 A.-L. Millin, Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à Gênes, 2 voll., C. Wassermann, Paris 1816. 7 Lettera di Seroux d’Agincourt a Millin, Rome, 13 novembre 1809, Bnf, Mss. fr. 24697. 8 L. Therrien, L’histoire de l’art en France: genèse d’une discipline universitaire, Paris 1998, pp. 37- 44; C. Hurley, Aubin-Louis Millin: programme du cours d’histoire des arts chez les anciens.... 9 Aubin-Louis Millin et l’Allemagne..., lettera n. 105, pp. 519-520. 10 A.-L. Millin, Voyage en Savoie...; Id., Voyage dans le Milanais, à Plaisance, Parme, Modène, Mantoue, Crémone, et dans plusieurs autres villes de l’ancienne Lombardie, 2 voll., C. Wassermann, Paris 1816. Articoli: Lettre de M. Millin à M.*** par M. Millin, membre de l’Institut impérial, contenant quelques additions à son voyage de Paris à Lyon (Grenoble, le 25 septembre 1811), in “Magasin encyclopédique”, ottobre 1811, V, pp. 347-387 (estratto: Paris, J. B. Sajou, 1811); Lettre de M. Millin, membre de l’Institut impérial de France, et de la Légion d’honneur, à M. Boulard, ancien notaire, et membre de plusieurs académies, contenant quelques détails de son voyage de Lyon à Chambéry, in “Magasin encyclopédique”, novembre 1811, VI, pp. 93-134 (estratto: Paris, J. B. Sajou, 1811); Lettre de M. Millin,... à M. Langlès, membre de l’Institut, sur le carnaval de Rome (Rome, 12 février 1812), in “Magasin encyclopédique”, aprile 1812, II, pp. 241-312 (estratto: Paris, J.-B. Sajou, 1812) ; Royaume de Naples, in “Magasin encyclopédique”, gennaio 1814, I, pp. 155-157; Extrait de quelques lettres adressées à la classe de la littérature ancienne de l’Institut impérial par A.-L. Millin, pendant son voyage d’Italie, in “Magasin encyclopédique”, marzo 1814, II, pp. 5-75 (estratto: Paris, J. B. Sajou, 1814). Libri: Description des tombeaux qui ont été découverts à Pompeï dans l’année 1812, Impr. royale, Naples 1813; Description d’une médaille de Siris, dans la Lucanie, C. Wassermann, Paris 1814; Description d’un vase trouvé à Tarente, C. Wasermann, Paris 1814; Description des tombeaux de Canosa, ainsi que des bas-reliefs, des armures et des vases Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 39 numero 3 - maggio 2011 sondaggi e ricerche capaci di fare emergere la base comune franco-tedesca della storia dell’archeologia in Europa. Storia all’interno della quale il “Magasin encyclopédique” – come in molti altri campi – svolge un ruolo importante. Essa, del resto, per essere completa, dovrebbe tener conto sistematicamente di altri assi transnazionali (ed includere certamente l’Italia e la Germania, ma anche, per esempio, la Danimarca), come pure di campi di studio vicini all’archeologia così come era intesa all’inizio del XIX secolo, quali la filologia o le scienze naturali. 20 C. Rétat, Revers de la science..., p. 99. 21 Riguardo all’appartenza di Millin alla Mère-Loge du Rite écossais philosophique, si veda C. Rétat, Revers de la science…, p. 107. Su Böttiger e la massoneria, si veda E. F. Sondermann, Karl August Böttiger, Literarischer Journalist der Goethezeit in Weimar, Bonn 1983, in particolare pp. 34-35. 22 Prospectus del 1805, citato da C. Rétat, Revers de la science…, p. 101. 23 Millin a Böttiger, Paris, 12 février 1797, Aubin-Louis Millin et l’Allemagne..., lettera n. 1, pp. 293-295. 24 Ibid. 25 Ibid. 26 B. Savoy, Des musées nationaux aux vases antiques du comte de Paroy. Regards allemands sur les collections parisiennes autour de 1800, in Collections et marché de l´art en France, 1789-1848, Atti del convegno, (Parigi 4-6 dicembre 2004), a cura di M. Preti-Hamard e Ph. Sénéchal, inha/Presses Universitaires de Rennes, ParisRennes 2005, pp. 387-405. 27 Millin a Böttiger, Paris, 22 janvier 1816, in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne..., lettera n. 114, pp. 533-536: p. 534. 28 Probabilmente: H. A. O. Reichard, Guide des voyageurs en Italie et en Suisse; faisant partie de la 6e éd. originale du Guide des voyageurs en Europe, Weimar 1810, annunciato nel “Magasin encyclopédique”, 1811, II, pp. 222-223 e ibid., III, p. 194. 29 Cfr. H.A.O. Reichard, Guide des voyageurs en Europe, 6a ed., 4 tomi, Weimar, 1812. 30 Millin a Böttiger, Paris, 24 avril 1811, in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne.., lettera n. 97, pp. 501-506: 503-504. 31 B. Savoy, Patrimoine annexé. Les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800, 2 voll., Maison des Sciences de l’Homme, Paris 2003, I, capitolo VI. 32 A. Petrucci, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XVII, ad vocem, Roma rétabli plusieurs Etats, et renouvelé plusieurs institutions, ces révolutions ont amené de grandes variations dans les mœurs et les usages. J’ai donc cru qu’il étoit encore possible de donner une nouvelle description de l’Italie, et de lui imprimer quelque intérêt, en visitant cette riche contrée, et en profitant de tous les ouvrages dont elle a été le sujet». A.-L. Millin, Voyage en Savoie…, I. 14 Lo studio più recente e stimolante su questa Société è: J.-L. Chappey, La Société des Observateurs de l’homme (1799-1804), Société des études robespierristes, Paris 2002. Si veda anche A. Castorina, Un observateur de l’homme e lo studio dell’archeologia: note su Millin, in “Prospettiva”, 69, 1993, pp. 88-93. 15 Itinerario che ho potuto ricostruire precisamente completando le fonti edite con le informazioni contenute nella corrispondenza. 16 Millin a Böttiger, Paris, 31 août 1811, in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne..., lettera n. 100, p. 511. 17 L. Lanzi, Viaggio del 1793 Pel Genovesato e il Piemontese, a cura di G. C. Sciolla, Libreria Editrice Canova, Treviso 1984. 18 Ibid. 19 Ad oggi, non esiste ancora una sintesi sullo spazio del sapere archeologico in Europa nel XIX secolo né, più semplicemente, alcuno studio approfondito sull’opera archeologica di Böttiger o di Millin. Vanno tuttavia segnalati, tra i lavori più recenti, le ricerche che René Sternke sta conducendo per la sua tesi sulla corrispondenza di Böttiger e Désiré Raoul Rochette (su Raoul-Rochette vi veda anche la voce a lui consacrata da È. Gran-Aymerich e N. Lubtchansky, in Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, a cura di Philippe Sénéchal e Claire Barbillon, inha, Paris 2009: http://www.inha.fr/spip.php?article2506); la tesi di Cecilia Hurley sulle Antiquités nationales di Millin (cfr. nota 1); l’articolo di C. Rétat, Revers de la science. Aubin-Louis Millin, Alexandre Lenoir, in Rêver l’archéologie au XIXe siècle: de la science à l’imaginaire, a cura di E. Perrin-Saminadayar, Publications de l’Université de Saint-Étienne, Saint-Etienne 2001, pp. 97-119; e, più generalmente, È. Gran-Aymerich, Naissance de l’archéologie moderne, 1798-1945, cnrs éditions, Paris 1998. Considerando inoltre che ci si trova di fronte, nella corrispondenza di Millin, ad una straordinaria abbondanza di informazioni spesso allusive (titoli di libri, nomi di persone, allusioni a dibattiti eruditi ecc.), non è questione qui di avanzare risultati definitivi. La presentazione che segue è piuttosto concepita come un invito a proseguire teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 40 numero 3 - maggio 2011 Millin. Roma, 4 dicembre e 22 dicembre 1812, ibid., foll. 94r. e 105r.). 42 «Je reçois toujours les lettres de votre brave abbé Cancellieri, mon directeur des arts à Rome, c’est à dire qu’il a bien voulu se charger de conduire et de payer, avec mon argent, les artistes qui travaillent pour moi». Lettera di Millin a Capecelatro, Reggio [Calabria], 22 juin, 1812, Bnf, Mss. fr. 24681, fol. 4r. Su Capecelatro, si veda P. Stella, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 18, ad vocem, Roma 1975, pp. 445-452 nonché il recente artcolo di M. Toscano, The figure of the naturalist-antiquary in the Kingdom of Naples: Giuseppe Giovene. and his contemporaries, in “Journal of History of Collections”, 2007, 19, pp. 225-237. 43 F. Cancellieri, Le Sette cose fatali di Roma antica, Luigi Perego Salvioni, Roma 1812, «Dedica al Ch. Sig. Cav. Albino Luigi Millin», pp. 3-4: «[…] dopo la vostra partenza, seguita ai 9 dello scorso marzo, io vi ho accompagnato col cuore a Napoli, nell’Abruzzo, nella Puglia, e fin nel fondo della Calabria, dove vi ha spinto, ad onta di ogni difficoltà e pericolo, l’ardente desiderio di visitare la Magna Grecia, madre feconda di tante insigni scuole filosofiche, la patria invidiabile di tanti eroi, in cui le belle arti hanno fiorito fin dai tempi più remoti, e dove la natura presenta anche adesso il vago spettacolo de’ più rari fenomeni, e la stessa sua popolazione un luminoso teatro di oggetti degni di osservazione. // Di più vi ho scritto in ogni ordinario e non contento di essermi impiegato nell’adempimento delle vostre molteplici commissioni, per fare eseguire le copie fedeli ed esatte delle iscrizioni di tutte le nostre chiese, e del Museo Vaticano, e i disegni coloriti a contorno de’ più belli monumenti sacri e profani di questa città, che fin nelle rovine spirano ancora la prisca e nativa lor maestà, mi sono occupato nella vostra assenza di questo lavoro, per dedicarlo all’illustre vostro nome». 44 Angelo Boucheron (Torino, ca. 1776-1859), plasmatore, disegnatore ed incisore, figlio del famoso argentiere del Regno Sardo Giovan Battista Boucheron (Torino, 1742-1815). 45 Luigi Zandomeneghi (Colognola, 1778-Venezia, 1850), scultore allievo di Canova. 46 Bartolomeo Pinelli (Roma, 1781-1835), disegnatore, incisore e pittore, celebre soprattutto per le sue vedute della città e dei costumi romani. Non citiamo qui l’abbondante bibliografia sull’artista, la cui attività per Aubin-Louis Millin tuttavia, a mia conoscenza, non è stata studiata. 1974 (con indicazione di fonti e bibliografia). 33 F. Seni, Vita di Francesco Cancellieri, Roma 1893, p. 52. 34 Bnf, Mss. fr. 24680 e Londra, BL, Add 22891-Vol. VII. A Parigi sono conservate le lettere di Cancellieri e numerose copie delle lettere di Millin (tuttavia in gran parte illeggibili). Il volume della British Library contiene gli originali delle lettere di Millin: esso fa parte di 12 volumi di lettere e altro materiale manoscritto che lo stesso Cancellieri vendette nel 1824 al collezionista inglese Dawson Turner (1775-1858); la biblioteca li acquistò alla vendita della collezione di quest’ultimo, cfr. Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 18541860, London 1875, pp. 757-765. 35 Le opere di Francesco Cancellieri iniziano ad essere regolarmente recensite nel “Magasin encyclopédique” dal giugno 1806 fino al gennaio 1816. 36 BL, Add 22891-Vol. VII. 37 Su Ennio Quirino Visconti (Roma, 1751 - Parigi, 1818), si veda l’esaustiva voce bio-bibliografia redatta da Daniela Gallo, in Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, a cura di P. Sénéchal, C. Barbillon, inha, Paris 2009: http://www.inha.fr/spip.php?article2565. 38 Lettera datata: Paris, 25 février 1817 (ma piuttosto 1818), in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne.., lettera n. 121, p. 548. 39 Paris, 9 mars 1809. BL, Add 22891-Vol. VII. 40 «Ecco il primo libro che comincia a trattare delle lodi del P. abate di Costanzo.[…] Io pongo questo nuovo mio figlio fra le sue braccia amorose, e lo raccomando alla sua bontà, affinché egli gli faccia avere un posto onorevole nel suo magazzino [il “Magasin encyclopédique”]. Dal valutabilissimo di Lei suffragio dipende la sua riputazione onde sono sollecito di sentire qual ne sarà il suo pregiatissimo giudizio» (Lettera di Cancellieri a Millin, Roma, 24 ottobre 1814, Bnf, Mss. fr. 24680, fol. 317r.). 41 Cancellieri riceve ammirato le precise osservazione e correzioni di Millin che integra regolarmente in fase di stampa o in edizioni aggiornate: «Ma chi può mai paragonarsi a Lei, Biblioteca ambulante, Archivio animato, e vero Emporio di ogni sapere?»; «Tutte le sue Lettere sono vere Lezioni le più istruttive, ed io le leggo col maggior interesse e sempre più la ringrazio de’ suoi Lumi, che con tanta pazienza ha trovato il tempo di somministrarmi per la mia Biblioteca Pompejana che più non si riconoscerebbe con tante belle giunte» (Lettere di Cancellieri a Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 41 numero 3 - maggio 2011 carres qui forment a eux seules 8 planches. C’est une speculation de capitaliste certainement les auteurs auroient dirigé l’ouvrage autrement s’ils avoient ete les maitres. J’ai fait dessiner tout ce qui n’est pas publié dans cet ouvrage je n’ai pris cependant que les morceaux qui sont utile pour l’instruction en laissant les statues indeterminables et j’ai de quoi faire deux volumes si on vouloit vendre du papier comme on l’a fait pour le Musée Chiaramonti, mais le tout rendu au trait pourra tenir en un volume 4°. […]/ J’ai aussi fait dessiner tout ce qui restoit dans le musée du Vatican, j’ai parcouru tous ses magazins et j’y ai trouvé et fait dessiner une trentaine de pieces interessantes, c’est cette dernière partie que j’ai laissée a faire a mon dessinateur en partant de Rome» (Millin a Böttiger, Naples, 24 avril 1812, in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne.., lettera n. 104, p. 517). «Monsieur Pilat est ici avec l’empereur d’Autriche. Il m’a dit que Hartmann était employé à Vienne, ce qui me fait beaucoup de plaisir. Je ne sais s’il a publié, comme il le voulait, sa traduction du Museo-Chiaromonti si les observations que Vous proposez de lui donner n’ont pas encore été employées, je pourrais Vous fournir de bons renseignemens. Les auteurs ont mis peu de critique dans le choix qu’ils ont fait des pièces. Ils n’ont presque publié que des statues & ont tenu peu de compte des restaurations. Enfin ils ont donné dans des groupes comme antiques des figures connues pour modernes. J’ai les dessins, & même les gravures de tout ce qu’ils ont négligé, & il y a des morceaux bien plus curieux pour l’érudition que ceux qu’ils ont publiés» (Millin a Böttiger, Paris, 26 avril 1814, in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne..., lettera n. 105, p. 520). Il mese seguente, Millin aspettava altre incisioni per la pubblicazione progettata: «J’attends les gravures que Pinelli me doit remettre pour publier la suite des monumens des musées de Rome dont j’ai, comme vous le savez, à-peu-près cent planches» (Millin a Cancellieri, Paris, 23 mai 1814, BL, Add 22891 - Vol. VII). 56 Nella corrispondenza Millin-Cancellieri si trovano alcune di queste liste di opere da copiare, comunicate da Millin a Pinelli: Bnf, Mss. fr. 24680, foll. 3235, 126 e BL, Add 22891-Vol. VII. I luoghi di provenienza dei «monumenti» da disegnare sono, oltre ai Musei Vaticani (compresi i «Magazzini»), numerose chiese (Santa Prudenziana, Santa Maria dei Monti, San Giovanni in Laterano, Santa Maria in Trastevere, Santi Cosma e Damiano, Santa Maria sopra Minerva), la Biblioteca Barberini nonché diverse collezioni private (Villa Albani, Villa Madama, «casa Ruffini», «chez Mr Maximilien», «Prince Poniatowski», «chez Mr 47 Gioacchino Camilli, disegnatore e calcografo attivo a Roma nella prima metà dell’Ottocento. 48 Franz-Ludwig Catel (Berlino, 1778-Roma, 1856), disegnatore e pittore. Nel 1812 accompagnò Millin per parte del suo itinerario nel Sud dell’Italia. 49 Cfr. G. Toscano, Le Moyen Âge retrouvé: Millin et Ingres à la découverte de Naples ‘angevine’, in Ingres, un homme à part?: entre carrière et mythe, la fabrique du personnage, a cura di C. Barbillon, P. Durey, U. Fleckner, La Documentation Française, Paris 2009, pp. 275-310. 50 Millin a Böttiger, Rome 9 janvier 1812, in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne..., lettera n. 102, p. 514. 51 Millin a Capecelatro, Reggio [Calabria], 22 juin, 1812. Bnf, Mss. fr. 24681, fol. 4 v. 52 Proprio negli stessi mesi (dal settembre al dicembre 1811) era in Italia Dominique-Vivant Denon con la missione di prelevare una scelta di quadri “primitivi” destinati al Musée Napoléon: cfr. M. Preti-Hamard, L’exposition des ‘écoles primitives’ au Louvre: ‘la partie historique qui manquait au Musée’, in DominiqueVivant Denon: l’œil de Napoléon, catalogo della mostra (Parigi, 20 ottobre 1999 - 17 gennaio 2000) a cura di P. Rosenberg, M.-A. Dupuy, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris 1999, pp. 226-253. 53 Le notizie di questo personaggio si ricavano dalla corrispondenza di Millin. 54 E.Q. Visconti, Il museo Pio-Clementino descritto da Ennio Quirino Visconti, 7 voll., Roma 1782-1807 (il primo volume redatto da Giovanni Battista Antonio Visconti); F.A. Visconti, G.A. Guattani, Il museo Chiaramonti aggiunto al PioClementino da n. S. Pio VII con l’esplicazione de Filippo Aurelio Visconti e Giuseppe Antonio Guattani. Pubbl. da Antonio d’Este e Gaspare Capparone, 2 voll., Roma 1808. 55 Non mi è stato per ora possibile rinvenire i disegni e le incisioni di Bartolomeo Pinelli, spesso menzionati nella corrispondenza Millin - Cancellieri. Millin parla di questo progetto di pubblicazione anche nella sua corrispondenza con Böttiger: «Hartmann a tort de publier le Musée Chiaramonti, cet ouvrage est indispensable pour ceux qui ont un gout decidé pour l’antiquité et qui possedent le Musée Pio Clementin mais il lui est bien inferieur je ne dis pas seulement pour le texte mais aussi pour les planches elles ne representent guere que des statues et des bustes, dans lesquels on n’a guere tenu compte des restaurations, les bas reliefs y sont peu nombreux, il y en a je crois deux ce sont des autels teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 42 numero 3 - maggio 2011 con le opportune illustrazioni tutti questi monumenti, come attesta il ch. Charles Guillaume Krafft nella Notice sur Aubin Louis Millin […] Parigi 1818 […] dice M. Millin rapporta un recueil précieux et unique d’inscriptions depuis le cinquième siècle jusqu’à l’année 1450. Avec les desseins des figures, qui ornent ces monuments». Devo la segnalazione e la trascrizione di questo documento a Fabrizio Federici il quale ha condotto importanti ricerche su Francesco Gualdi. Si veda: F. Federici, Il trattato Delle memorie sepolcrali del cavalier Francesco Gualdi: un collezionista del Seicento e le testimonianze figurative medievali, in “Prospettiva”, 110111, aprile-luglio 2003 (2004), pp. 149-159. Lo stesso studioso sta attualmente preparando un’edizione critica del trattato per le Edizioni della Scuola Normale Superiore di Pisa. 62 Extrait de quelques lettres adressées à la classe de la littérature ancienne de l’Institut impérial…, pp. 67-68. 63 Su Seroux d’Agincourt, si vedano i recenti studi: I. Miarelli Mariani, Seroux d’Agincourt e l’histoire de l’art par les monuments. Riscoperta del medioevo, dibattito storiografico e riproduzione artistica tra fine XVIII e inizi XIX secolo, Bonsignori, Roma 2005; Eadem, Les «Monuments parlants»: Seroux d’Agincourt et la naissance de l’histoire de l’art illustrée, in Histoire de l’art par les monumens depuis sa décadence au IVe siècle jusqu’à son renouvellement au XVIe: ouvrage enrichi de 325 planches par J. B. L. G. Seroux d’Agincourt, introduzione al vol. VII, Aragno, Torino 2005; D. Mondini, Mittelalter im Bild. Seroux d’Agincourt und die Kunsthistoriographie um 1800, Zurich InterPublishers, Zürich 2005. 64 Per la trascrizione di queste lettere, cfr. M. Preti-Hamard, “Je me suis trouvé bien neuf en arrivant dans cette ville”. Millin à Rome et ses lettres au ministre de l’Intérieur comte de Montalivet (janvier-février 1812), in “Les Cahiers d’Histoire de l’Art”, 7, 2009, pp. 82-98. 65 Seta blu decorata in seta, argento e argento dorato. Numerose ipotesi sono state formulate su questo paramento che oggi si ritiene essere un sakkos bizantino del XIV secolo. Si veda: Byzantium: Faith and Power (1261–1557), catalogo della mostra (New York, 23 marzo - 4 luglio, 2004), a cura di H. C. Evans, New Haven and London 2004, cat. n. 177, pp. 300-301 (con bibliografia precedente). 66 Lino decorato in seta, oro, argento e perle, indossato da Bonifacio VIII nel primo Giubileo celebrato nel 1300 (fine XIII-inizi XIV secolo). Si veda: Tesori d’arte sacra di Roma e del Lazio dal Medioevo all’Ottocento, catalogo della mostra Venuti», «madame la princesse de Dietrischtein», «l’atelier de Canova»). 57 Extrait de quelques lettres adressées à la classe de la littérature ancienne de l’Institut impérial…, p. 69. 58 BnF, Mss. fr. 24656-24674. 59 Riguardo alla copia delle iscrizioni dei Musei Vaticani, Cancellieri scriveva: «Le Iscrizioni di Guerigi vengono a venti per volta ogni sabato. Onde puo immaginarsi a qual numero siano giunte. Le profane de’ Magazzeni del Museo del Vaticano sono scritte a due, e a tre per foglio, quando son corte, per non abusare della sua generosità, benché la fatica di andare fino al museo, di muoverle, di alzarle per poterle copiare, sia maggiore di quella fatta per copiare nel suo gabinetto le Cristiane» (Lettera di Cancellieri a Millin, Roma, 28 giugno 1812, Bnf, Mss. fr. 24680, fol. 31 r.). 60 I titoli manoscritti descrivono il contenuto dei diversi volumi (BnF, Mss. fr. 24656-24666): «Vigna Carpegna; chiostro di S. Paolo; biblioteca Vaticana» – «Cippi posti nel corridore del Museo Vaticano» – «Nelle rimesse dietro il Museo Vaticano; corridore del Museo vicino alla porta della biblioteca; campana della chiesa S. Balbina» – «Nelle rimesse dietro il Museo Vaticano; stanza dietro il Museo Vaticano; inscriptiones solo Ostiensi, jussu Pii VII erutæ; iscriptiones græcæ» – «Inscriptiones antiques de Rome: Dei, deæ, sacrorum ministri … artifices, officinatores, negotiatores» – «Inscriptiones antiques de Rome: Duces exercitus … epitaphia patronorum, liberorum et servitorum» – «Inscriptiones antiques de Rome: Epitaphia maritorum et uxorum» – «Inscriptiones antiques: Epitaphia parentum et liberorum, fratrum et sororum, item alumnorum» – «Monumenta græca et monumenta romana veterum Christianorum» – «Monumenta veterum Christianorum» – «Epitaphia defuntorum nomine vel ab incertis posita». 61 F. Cancellieri, Notizie sulla storia dell’Accademia dei Lincei, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Lat. 9683, fol. 469 r.: «Avendo io fatto conoscere nel 1813 al mio incomparabile amico cavalier Millin l’importanza, e l’utilità di questo lavoro [l’opera di Gualdi sulle «memorie sepolcrali»], che perciò era assai da dolersi, che non si fosse ultimato, io l’indussi a intraprenderlo. Egli dunque incaricò varj esperti giovani di andare a disegnare esattamente i depositi ne’ pavimenti, e ne’ muri di tutte le chiese, e di tutti i chiostri di questa città, per farne ben rilevare i diversi vestiarj, e di ricopiarne con fedeltà tutte le iscrizioni. Onde partì carico di questo tesoro, con animo di far incidere, e di pubblicare Monica Preti-Hamard - Bénédicte Savoy Un grande corrispondente europeo. Aubin--louis millin... 43 numero 3 - maggio 2011 405. Le 44 tavole sono conservate sciolte entro un volume gran folio della Bibliothèque nationale de France: Gb-61-Ft 6 (113 cm.) 79 Lettera non datata (ma 1817) di Millin a Auguste comte de Forbin, BnF, Mss. fr. 24686, foll. 182-184. Se ne veda la trascrizione in appendice. 80 Sull’affermarsi dell’importanza dell’esperienza visiva negli studi antiquari, si veda l’ormai classico: A. Momigliano, Ancient History and the Antiquarian, in “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, 13, 1950, pp. 285-315; anche in Contributo alla storia degli studi classici, I, Roma 1955, pp. 67-106. Si veda inoltre: A. Schnapp, La conquête du passé. Aux origines de l’archéologie, Carré, Paris 1998 (trad. italiana: La conquista del passato: alle origini dell’archeologia, a cura di G.P. Tabone, Leonardo, Milano1994. (Roma, 1 novembre 1975 - 11 gennaio1976) a cura di M. Andaloro, A. Costamagna, L. Cardilli Alloisi, Roma 1975. 67 Bnf, Mss. fr. 24680, fol. 22r. 68 BL, Add 22891-Vol. VII: «Il sera mieux sans doute de calquer le dessin de la chape: cela sera moins long et moins couteux mais si on ne peut le trouver il faudra le faire d’après l’original». 69 Bnf, Mss. fr. 24680, fol. 24 r. 70 Questa “dissertazione” fu pubblicata postuma (Description d’une mosaïque antique du Musée Pio-Clémentin à Rome, représentant des scènes de tragédies; par A. L. Millin …, P. Didot, Paris 1819). Tuttavia, un «Avertissement» in apertura del volume indica che l’autore ne aveva completato interamente la preparazione: Millin, non solo aveva scritto il testo, ma aveva anche diretto l’esecuzione delle incisioni per le tavole illustrative, tratte dai disegni eseguiti da Gioacchino Camilli a Roma; aveva inoltre letto la Description all’Académie des belles-lettres, nella seduta del 10 aprile 1818. 71 Esso si compone ora di 15 membrane sciolte di varia grandezza, ma fino al 1902 questo era lungo circa 10 metri e mezzo. Si veda: P. Franchi de’ Cavalieri, Il Rotulo di Giosuè: codice Vaticano Palatino Greco 431; riprodotto in fototipia e fotocromografia, Milano 1905. 72 BnF Est., Ad-131-Fol. 73 Cfr. J.B.L.G. Seroux d’Agincourt, Histoire de l’art par les Monuments, depuis sa décadence au IVe siècle jusqu’à son renouveau au XVIe, 6 voll., Paris 1823, III, Planches XXVIII-XXX. 74 Florence, 13 juillet, 1813, BL, Add 22891 - Vol. VII. Se ne veda la trascrizione in appendice. 75 Florence, 18 août 1813, Bnf, Mss. fr. 24680, fol. 179. Se ne veda la trascrizione in appendice. 76 C. Forni Montagna, Nuovi contributi per la storia del mosaico di Palestrina, in “Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche”, serie 9, vol. 2 1991, pp. 227-293. 77 Si vedano le lettere di Millin a Böttiger (Paris, 28 juin e Paris, 3 octobre 1799) e di Böttiger a Millin (Weimer, 3 octobre 1799), in Aubin-Louis Millin et l’Allemagne..., lettere nn. 30, 33, 34, pp. 367-371, 376-380 e 380-383, qui pp. 370, 377-378 e 381. 78 Lettera di Camilli a Millin, Roma, 25 aprile 1816, BnF, Mss. fr. 24679, fol. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 44 S critti d’arte di C armelo L a F arina (1786 - 1852) di Nicoletta Di Bella Davvero lungo l’elenco delle società scientifiche2 delle quali il Nostro fu membro; socio promotore dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti3, vi fu accolto come socio ordinario col nome di “Accertato”, a soli sedici anni, il 20 marzo 1802 e dal 1830 ricoprì il ruolo di Segretario Generale. Il primo discorso4 letto nella prestigiosa istituzione nel luglio 1806, a soli vent’anni, in cui si proponeva di «descrivere le Antichità della nostra Messina, mostrarne le reliquie, ed additarne i mezzi per conservarle»5, fu proprio a sostegno della necessità dell’istituzione a Messina di una Cattedra di Belle Arti e di un Museo Civico6, inteso con una impostazione e uno spessore culturale ben diversi rispetto a quelli delle più famose quadrerie di Ruffo, Arenaprimo o Brunaccini7, delle ricche wunderkammern e delle raccolte di mirabilia, anche se frutto della stessa molteplicità di interessi. In Sicilia infatti, C armelo La Farina, una delle figure più interessanti nel panorama della cultura messinese dei primi decenni del secolo XIX, fu uomo politico, archeologo, erudito e conoscitore, di grande apertura mentale e dotato di una propensione all’indagine filologica di notevole modernità. Nato a Messina nel 1786, studiò Lettere classiche all’Accademia Carolina. Nel 1815 sostituì Andrea Gallo in qualità di professore di Matematica nella stessa istituzione (divenuta poi Università di Messina), all’età di soli diciassette anni. In seguitò si laureò a Catania in Giurisprudenza e dal 1839 insegnò Geometria Trigonometria e Sezioni Coniche nella neonata Regia Università degli Studi1. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 46 numero 3 - maggio 2011 i primi esiti degli orientamenti più attuali rivolgono la propria attenzione agli ‘strati medi’ della popolazione, un pubblico di dotti, scrittori, eruditi e anche artisti, fino a quel momento non ammessi alle grandi collezioni, che con la diffusione dell’istruzione richiedono e ottengono l’accesso agli oggetti e alle fonti8. Le raccolte, le biblioteche, insieme alle accademie, diventano i principali strumenti di formazione intellettuale dei nuovi ceti borghesi9. Non mancano a diverso livello locale dimostrazioni concrete di organi di propulsione culturale e didattica quali il ‘museo’, con annessa biblioteca e sede dell’Accademia degli Etnei, del principe di Biscari Ignazio Paternò di Castello, «inaugurato a Catania nel 1758 per “l’utilità degli studiosi e il decoro della patria” ammirato dal Riedesel e da Goethe»10. Il discorso di Carmelo La Farina può intendersi un vero e proprio manifesto ideologico della sua attività futura: «descrivere le antichità di Messina»11 – sia quelle ritrovate casualmente tra le macerie scampate ai terremoti sia i manufatti archeologici esito delle campagne di scavo –, recuperandole, mostrando e conservando gli originali nei musei, valutando i danni dell’incuria del tempo e degli uomini e i rischi ancora incombenti, eventualmente sostituendo gli originali con delle copie esposte alle intemperie, come confermerà anche in anni più maturi12, agganciandosi alla tradizione storiografica precedente, che, già con figure di eruditi quali Francesco Susinno13, Antonino Mongitore14, Gaetano Grano15 e Jakob Philipp Hackert16, Fedele da San Biagio17, aveva sottolineato l’importanza del recupero delle fisionomie cittadine attraverso la ricostruzione del panorama artistico locale18. Il proposito di realizzare un Museo Civico entro le mura del Palazzo Senatorio aveva riscosso Ignoto, Ritratto di Tommaso Alojsio Juvara, notevole successo tra Palermo, Biblioteca Comunale. Foto Enzo Brai. gli Accademici19 che, spronati dall’abate Cassinese D. Gregorio Cianciolo20 – strenuo sostenitore insieme a La Farina e in quegli anni alla loro guida – collaborarono fattivamente mediante la donazione di pregiate opere d’arte21. Queste prime collezioni, in seguito, furono ulteriormente implementate grazie alla partecipazione del Senato messinese che intervenne sia assegnando alcuni locali, sia tramite finanziamenti, Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 47 numero 3 - maggio 2011 scambi e acquisti, tra i quali i cinque pezzi superstiti del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina22. Intanto La Farina, cui era stata conferita da parte del Senato cittadino la nomina a Prefetto onorario23 del neonato Museo Civico sito presso i locali dell’ex Archivio degli Atti Notarili, veniva inviato in vari posti dell’Isola per acquistarvi monete24, ceramiche, marmi ed altri oggetti che andavano ad ampliare le collezioni25, ulteriormente accresciute a seguito della soppressione delle Corporazioni religiose nel 1866 e al trasferimento nei locali dell’antico monastero di San Gregorio26. L’interesse per l’istituzione di borse di studio e la grande attenzione per le arti figurative compaiono spesso quali tematiche ricorrenti in molti dei dibattimenti cui egli prese parte all’Accademia Peloritana27. Il supporto ai giovani artisti è difatti una delle costanti che traspaiono negli scritti dell’erudito messinese28, sebbene l’apprezzamento per l’arte contemporanea, nel momento in cui vengono meno la committenza religiosa e quella laica tradizionale, sia subordinato alle capacità di emulare l’antico e di esaltare le patrie glorie29. Strenuo sostenitore di giovani promesse locali30, La Farina propugnava presso il Municipio lo stanziamento di borse di studio31 al fine di consentire alle nuove leve di completare la propria formazione all’estero, perfezionandosi in contesti culturalmente più aggiornati32. L’attenzione alla formazione degli artisti è pari all’apprezzamento senza riserve nei confronti dei grandi nomi del momento: tra tutti Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen, Pietro Tenerani33, esponenti di quella cultura neoclassica che ebbe in La Farina uno degli animatori nel contesto messinese e di cui ennesimo riflesso è la passione per l’archeologia. Ancora nell’Ottocento il pensiero predominante in Sicilia è caratterizzato da riflessioni di impronta winckelmanniana, che avevano consolidato nella coscienza intellettuale locale – grazie anche alla pratica, ancora in voga, da parte di visitatori stranieri, di compiere il viaggio in Sicilia allo scopo di indagare i reperti dell’antichità – l’idea di un retaggio da riscattare, in un contesto di rifiorita attenzione nei confronti dell’archeologia sostenuta anche da molteplici iniziative, quale ad esempio, l’istituzione della “Commissione di Antichità e Belle Arti” ad opera del governo Borbonico nel 182734. Non è semplice delineare brevemente le idee sull’arte dominanti a Messina nella prima metà dell’Ottocento. Sin da un primo sguardo, infatti, risulta evidente come le correnti culturali della città peloritana siano frutto di contraddizioni e integrazioni derivate da un’estrema varietà di situazioni che si concretizzano nell’opera degli artisti e negli scritti degli esponenti della letteratura critica. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 48 numero 3 - maggio 2011 Il più disaminato dei dibattiti del periodo, la polemica tra Neoclassici e Romantici, vede il Nostro tra i suoi interpreti messinesi35. Sebbene la posizione provinciale dei protagonisti della vicenda culturale non consenta di definire quale vera e propria querelle l’atteggiamento conflittuale e le vistose contraddizioni tra le Pietro Tenerani, Monumento a Ferdinando II di Borbone, Messina, giardino di via Garibaldi. due tendenze di gusto36, l’attenzione ad estenuati modelli di cultura neoclassica, e l’attrazione verso suggestioni romantiche ancora accademizzanti, mancò di forti tensioni, nonostante il moltiplicarsi di periodici tematici37, il contributo apportato da studi di stampo europeo38 e i molteplici saggi di eruditi di cultura illuministico-borghese. L’aspetto più evidente si ebbe in un’accezione classicistica di derivazione accademica sulla scorta della coeva trattatistica francese39 che ribadiva i seicenteschi principi di “nobiltà” e “decoro”40 e gli ormai abusati assunti di supremazia del disegno sul colore e di “Bello” connaturato all’arte classica già ampiamente permeati in ambito locale41, ma che sfociò in un rinato amore per le arti, esplicitato da molteplici iniziative. L’apporto di alcuni spunti prettamente romantici, maggiormente evidenti dopo gli anni ’30, non venne disdegnato, ma incontrò difficoltà ancor maggiori a causa della poderosa matrice culturale borbonica saldamente ancorata in Sicilia42 e che all’indomani dell’Unità tornerà a farsi sentire, seppur in senso più eclettico e con diverse implicazioni ideologiche43. Nel primo quarantennio del secolo, si affacciavano in Sicilia i primi tentativi di affermare le nuove istanze romantiche, fortemente osteggiate dagli spiriti più conservatori, in una sorta di istinto di protezione del clima intellettuale locale. Soprattutto tra i membri più giovani dell’Accademia Peloritana emerge qualche tentativo di approccio a posizioni che in ambito extra-isolano appaiono già consolidate, per quanto timidamente difese. Tra i dibattiti discussi in quegli anni all’Accademia, quello del 1832 intitolato Del Romanticismo44 di Felice Bisazza45, autore appena Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 49 numero 3 - maggio 2011 ventitreenne, che esponeva la sua testimonianza Questa volontà di ricostruzione si orientò in senso estremamente eclettico, in un mix di neomanierismo, revival gotico, riesumazioni rococò e espedienti neopalladiani sulla scia della presenza inglese nella Sicilia di quegli anni51, in un momento in cui era fortemente sentita l’esigenza di ricostituire un senso di continuità con i fasti del passato seppur adeguandosi nella forma alle richieste della committenza, mentre le nuove spinte romantiche si mantenevano a livello epidermico, insufficienti per modificare in modo profondo la ‘formazione intellettuale’ nel suo complesso, ogni aspetto dell’arte, ma anche la moda, il costume e le arti decorative. Il tentativo di superamento della percezione di decadenza causata della perdita di modelli culturali per la generazione degli artisti di quegli anni52, in bilico tra la memoria di una produzione artistica classicheggiante e i nuovi contenuti ‘spirituali’, riscattava appieno, nella portata degli interessi, la qualità non sempre eccelsa53, innestandosi perfettamente con la nascita di iniziative quali l’istituzione del Museo Civico e la promozione dei giovani artisti da parte dell’Accademia Peloritana54. con un sostanziale fraintendimento dello spirito romantico. La posizione di “equilibrista” che molta critica gli imputò, il tentare una conciliazione tra due schieramenti che nell’Isola vedevano i classici in netta preponderanza sullo sparuto gruppo romantico, rivela non solo la difficoltà (o forse meglio, la paura dettata anche da un abito spirituale irresoluto) di assumere atteggiamenti netti, ma anche la fatica a comprendere fino in fondo la portata della sua stessa proposta46. I l pungolo liberale portato dai moti del ’48 caldeggerà il pensiero romantico tra i teorici siciliani e i custodi del patrimonio artistico isolano, talvolta incarnati in figure di spicco del movimento risorgimentale47. Fino ad allora era mancata in Sicilia una vera e propria speculazione teorica – ad esclusione di generiche indicazioni sui manufatti architettonici48 – benché una prima manifestazione delle nuove tendenze si fosse palesata sulla stampa periodica49 – soprattutto in dispute ancora lontane dalla ricerca di vere e proprie nuove articolazioni formali – per progetti e restauri della città, sull’impeto dello slancio architettonico nato successivamente al sisma del 178350. Tra la fine degli anni ’20 e i primi anni ’30 alcune memorie archeologiche55 – ma anche un studio di natura scientifica56 – a firma di La Farina appaiono anche tra le pagine del palermitano “Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la Sicilia”, di cui è collaboratore teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 50 numero 3 - maggio 2011 ordinario57, già dal 1823, per esplicita richiesta del Marchese delle Favare, Direttore Generale di Polizia e Luogotenente Generale di Sicilia. La partecipazione al “Giornale”, diretto da Giuseppe Bertini, si conclude nel ’33 con la pubblicazione delle prime notizie su un giovane incisore messinese, nell’articolo intitolato Messina. Biografia Tommaso Alojsio Juvara, Ritratto di Carmelo La Farina, Messina, Biblioteca di Tommaso Aloisio58. Universitaria Regionale. Il Nostro affronta questioni connesse all’archeologia in diversi saggi. Del 1822 è il volume Su di un antico sarcofago nella chiesa de’ PP. Conventuali di Messina59, corredato da un’incisione in rame. Ancora nel ’32 ribadisce il suo interesse verso temi di natura archeologica pubblicando nella città dello Stretto un interessante contributo relativo al rinvenimento di un sepolcreto romano60 a seguito degli scavi della piazza S. Giovanni Gerosolimitano, da lui diretti su incarico del marchese della Cerda. Nel 1844 pubblica per i tipi di Giuseppe Fiumara una memoria intitolata Sopra un anello segnatorio. Considerazioni61. Fu anche recensore per la “Sentinella del Peloro”62, un periodico di idee liberali e progressiste che ebbe però breve vita63. P er quanto gli scritti di La Farina risentano della sua formazione classicistica, l’attenzione alle opere dell’antichità si palesa anche nell’interesse per il recupero, la conservazione e la tutela di prodotti medievali64 e l’esposizione nei musei di «opere vetustissime, […] monumenti rimasti dell’età di mezzo e de’ secoli bassi», oltre che di reperti di storia naturale e di “macchine” moderne65. Un’attenzione che, va sottolineato, è un’esigenza di tutela che sebbene arrivi a sfiorare tendenze di gusto romantico66, è in realtà una necessità di natura conservativa connessa alla volontà di incrementare continuativamente le collezioni museali67. Anche in questo caso si tratta di un fenomeno tutt’altro che provinciale, prodotto della cultura illuministica e delle manifestazioni più floride dell’erudizione locale, non legato esclusivamente a rivendicazioni campaniliste nemmeno in quei casi in cui l’apertura critica ed estetica furono meno accentuate68, bensì diffuso a livello europeo: opere d’arte Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 51 numero 3 - maggio 2011 e vestigia dell’antichità acquistano nuovi significati alla luce dello studio delle fonti e si trasformano a loro volta in «semiofori»69. I manufatti di epoca medievale, considerati emblemi di un periodo di magnificenza e autonomia politica dell’Isola, ben si prestavano al ruolo di portavoce del messaggio di «memoria di antiche glorie italiane»70 e pertanto divennero oggetto delle «cure pressoché esclusive di quanti operavano nel campo della tutela degli edifici storici»71, dando le mosse ad un’azione di salvaguardia metodologicamente fondata alla ricerca delle origini, promuovendo massicce campagne di interventi, e soprattutto nella seconda metà del secolo, ad operazioni di liberazione dalle Carmelo La Farina, Intorno le belle arti, superfetazioni settecenMessina 1835. tesche arrivando talvolta a sconcertanti restauri di ripristino e ad integrazioni, sebbene a Messina in modo meno invasivo che a Palermo72. La ricchezza e la varietà delle problematiche affrontate dal poliedrico studioso raggiunge il suo apice nelle lettere pubblicate sui più prestigiosi periodici isolani, in cui rettifica molte notizie errate73, Carmelo La Farina, Intorno le belle arti, Messina 1835, frontespizio. dà notizia di acquisti effettuati per la «pubblica galleria, in cui come bello sacrario si sono ricolti i dipinti della scuola messinese»74, oltre che a segnalare la presenza di opere credute perdute – sia a Messina che nelle zone limitrofe – e a suggerire attribuzioni, sempre fornendo un’accurata documentazione in proposito75. E ancora ricorda acquisizioni di manoscritti e documenti da parte dell’Accademia Peloritana dei teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 52 numero 3 - maggio 2011 Pericolanti76, a dimostrazione della modernità del suo atteggiamento di grande apertura verso l’indagine filologica che lo porta al voler sempre trascrivere personalmente le notizie d’archivio, riportando con estrema accuratezza date, firme, iscrizioni di fondamentale importanza per la ricostruzione documentaria, iconografica e iconologica di opere ormai perdute e ad una costante verifica delle fonti (Giuseppe Buonfiglio77, Placido Samperi78, Caio Domenico Gallo79) e non solo locali, ma anche Vasari80 e Lanzi81 cui corregge non poche sviste, dimostrando un atteggiamento estremamente aggiornato, che trovava illustri riscontri nell’ambito della critica filologica internazionale82. È il caso della biografia di Onofrio Gabrieli83 della quale emenda alcuni errori84, pubblicando tra le altre notizie, il documento di Battesimo che consente di anticipare di tre anni, al 1619, la data di nascita fino a quel momento tramandata dalle fonti85. Anticipa anche al 165086 il ritorno in patria dell’artista dal soggiorno tra Napoli, Roma e Venezia, grazie ad un documento ritrovato nella Sagrestia della chiesa di S. Paolo delle Monache, che fissa a quella data anche l’esecuzione del Martirio di S. Placido del Marolì87, suo concittadino e compagno durante i nove anni del periodo veneziano, di cui Lanzi dà un giudizio molto poco lusinghiero88. T Antonio Catalano “il Vecchio”, Sacra Famiglia con S. Anna, Cefalù (PA), Chiesa dei Cappuccini. Foto Enzo Brai. Nicoletta Di Bella ra le comunicazioni più interessanti fornite da La Farina, le notizie relative ad Antonio Catalano89 nella quarta lettera, indirizzata a Giuseppe Grosso Cacopardo90, in cui espunge dal catalogo dell’artista la Madonna del Rosario per la chiesa dell’Annunziata “alla Ciaera”, firmata «minchello cardili fec», recuperata dopo il terremoto del 1908 e oggi in deposito al Museo regionale di Messina91 aggiungendo un altro nome alla famiglia dei pittori Cardillo e la S. Anna nella chiesa di S. Giovanni nel villaggio Castanea92, chiaramente Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 53 numero 3 - maggio 2011 firmata e datata «gaspar camarda pingebat 1612», estendendo l’arco temporale entro cui collocare l’attività dell’artista93, cui assegna anche la Madonna del Rosario di Venetico, firmata e datata 160694. Le Lettere Artistiche, dedicate ai più autorevoli membri della cultura isolana – in ordine di successione a Agostino Gallo95, Pietro Lanza96, Lazzaro Di Giovanni97, Giuseppe Grosso Cacopardo98, Placido Vasta99, Nicolò Americo Fasani100, Giuseppe Alessi101, Gaetano Grano102, Francesco Arrosto103, Tommaso Aloysio Juvara104– vennero raccolte da La Farina nel 1835 in un volume intitolato Intorno Le Belle Arti, e gli Artisti fioriti in varie epoche in Messina – Ricerche di Carmelo La Farina ordinate in più lettere105. Edito a Messina dalla Stamperia Fiumara, la stessa dello “Spettatore Zancleo”, consta di 94 pagine comprendenti l’indice delle lettere e le errata corrige. Ricevette lusinghiere recensioni in ambito locale106, ma anche su Giuseppe Arifò109, Carlo Gemmellaro110, Salvatore Betti111, Lorenzo Majsano112, Carmelo Allegra113, tratte da periodici quali “Lo Spettatore Zancleo”, “il Faro”, “Scilla e Cariddi”114. La Corte non seguì l’elenco115 redatto originariamente da La Farina, ma ne ricopiò le note autografe e fornì copie dattiloscritte degli originali116, nelle quali, in una chiosa, fornisce la spiegazione del metodo seguito per la redazione di postille e annotazioni117. La Corte Cailler precisa anche l’intenzione di La Farina di ripubblicare un volume comprensivo di tutte le lettere, probabilmente ventiquattro118 e fornisce un lungo elenco degli artisti e degli argomenti che il Nostro aveva trattato o aveva intenzione di trattare119. Le lettere impostate secondo una formula stilistica convenzionale, un preambolo dedicato al destinatario, il vero e proprio articolo denso di notizie storiche e documentarie già accennate nel titolo e la conclusione con un breve commiato, come già osservato, furono, inizialmente in gran parte pubblicate sullo “Spettatore Zancleo”120 e si ponevano in modo speculare agli scritti di Giuseppe Grosso Cacopardo apparsi sul periodico “Maurolico”121 – della cui riviste non isolane, ad esempio il “Giornale Arcadico” di Roma, la “Gazzetta Privilegiata” di Bologna. U na Seconda Parte delle lettere, raccolta da Gaetano La Corte Cailler107 e da lui intitolata Intorno le Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina - Ricerche ordinate in più lettere, Parte II, Messina 1835-1845, consta di sette lettere indirizzate ad Anastasio Cocco108, Commissione deputata alla compilazione egli fece parte – negli stessi anni. Anche nei saggi più brevi La Farina mostra la sua obbiettività e competenza nel ricostruire cronologie di artisti ignorati, nel teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 54 numero 3 - maggio 2011 rinnovare il catalogo di quelli già parzialmente noti e nel documentare personalità fino a quel momento sconosciute, sempre con precisa analisi filologica e riscontro dei documenti d’archivio, manifestando lo sguardo attento dell’esperto conoscitore122. Nella quinta lettera123, la figura di Francesco Laganà, artista pressoché ignoto, viene arricchita da interessanti attribuzioni dell’erudito messinese che gli riconferma la paternità della Madonna del Rosario della chiesa dei PP. Basiliani di Mili Superiore (Me)124 irridendo l’ignoranza dell’artista che si firma francesco. laganà. § pingebat. 1B38, scambiando la B col il 6. Riconducendo i modi del pittore a quelli di Andrea Quagliata, passa a segnalare due dipinti non ricordati dalle fonti, il San Liberale Vescovo, nella chiesa di S. Liberale a Messina, firmato Giovan Paolo Fonduli, Andata al Calvario, Castelvetrano (TP), chiesa di S. Domenico. Foto Enzo Brai. Nicoletta Di Bella e datato 1625 e l’Angelo Custode, per il convento di S. Agostino a Taormina, firmato e datato 1627, che considera opere giovanili125. È la competenza dettata dall’esperienza e dall’uso di un occhio attento ed allenato che lo spinge a confutare, nella terza lettera, datata 20 gennaio 1834 126 e diretta a Lazzaro Di Giovanni, la permanenza a Messina dell’artista cremonese Giovan Paolo Fonduli127, affermando che la tavola firmata io. paulus funduli cremonen. pingebat 1593 e rappresentante San Diego, realizzata per il convento degli osservanti di S. Maria di Gesù inferiore e successivamente passata al Museo Nazionale, non fosse stata eseguita nella città del Peloro, come affermato da Grosso Cacopardo128, ma che si trattasse di una copia di quella dipinta per la chiesa degli Osservanti di Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 55 numero 3 - maggio 2011 Palermo nel 1589 e passata successivamente in casa del Principe di Palagonia. Polidoro da Caravaggio, S. Giordano, Adorazione dei Pastori, Messina, Museo Regionale (già Messina, chiesa di S. Maria dell’Altobasso). Foto Enzo Brai. L’acume nella ricerca d’archivio e l’attenzione nello studio delle fonti, si palesano ancora una volta nella seconda lettera, indirizzata a Pietro Lanza, intitolata Sull’anno di morte di Polidoro Caldara da Caravaggio129, artista che ebbe grande fortuna nelle pagine della letteratura artistica isolana, nella quale il Nostro, inizia con una lunga annotazione biografica tratta dalle pagine di Vasari130 e precisa subito: «benché [questo racconto] paja sottile e minuto, m’induce ad alcune osservazioni, da che può torsi argomento di varie inesattezze»131, dimostrando con acuti ragionamenti come la data del 1543, indicata come anno di morte dell’artista lombardo, fosse errata, anche se sino a quel momento accettata anche dalla trattatistica locale132 che aveva contestato quanto sostenuto in merito al luogo di sepoltura. Il brano di Vasari viene criticato punto per punto da La Farina che ne demolisce le ipotesi di fondatezza dimostrando la superficialità con cui nelle pagine dell’aretino erano esposti numerosi avvenimenti, quali la realizzazione degli apparati trionfali133 in occasione della venuta di Carlo V nel 1535, e collocati cronologicamente dal toscano prima dell’esecuzione della celebre Andata al Calvario di Polidoro, oggi al Museo di Capodimonte, di cui si hanno notizie certe134. Uno degli argomenti che La Farina porta a sostegno della propria tesi è la data di consegna del dipinto dell’Adorazione dei Pastori, commissionato al Caldara dai confrati di S. Maria dell’Alto (Me), portato a termine, secondo le fonti, dal Guinaccia135. Il dipinto, ipotizza La Farina citando Samperi, rimase incompiuto a causa della morte improvvisa dell’artista, da fissarsi dunque poco oltre il 1534136; in realtà la data di consegna dell’agosto del ’34 è nota solo dal documento di commissione stipulato il 5 febbraio 1533137. Il Nostro teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 56 numero 3 - maggio 2011 sottolinea ancora che dal 1535 cessa ogni notizia sul pittore lombardo; inoltre, nessuna menzione ai fatti criminosi che portarono alla morte di Polidoro è accennata nei registri della Confraternita degli Azzurri, fondata nel 1541 con la funzione di assistere i condannati a morte, né si trovano memorie di eventuali spese processuali nell’archivio della Corte Stratigozionale o nei libri della Tavola Pecuniaria138. Questi elementi, lo portarono dunque a sostenere la tesi di un possibile scambio di cifre nella datazione proposta da Vasari139. Ancora una volta, sono le puntuali indagini documentarie che consentono a La Farina di rilevare, nella lettera indirizzata a Francesco Arrosto140, notevoli incongruenze nella cronologia Polidoro da Caravaggio, Andata al Calvario, Napoli, Museo e relativa a Giovanni Simone Comandè Gallerie Nazionali di Capodimonte (già Messina, chiesa dell’Annunziata dei Catalani). Foto Enzo Brai. tramandate dalla storiografia artistica, Nicoletta Di Bella consentendo di anticipare la tradizionale data di nascita del 1580 al 1558141. Lo stesso dicasi per le correzioni apportate alla biografia di Filippo Tancredi142, figura di spicco nella produzione pittorica non solamente isolana del secolo XVII, di cui anticipa la data di morte dal 1725143 al 13 ottobre 1722, nella sesta lettera rivolta a Felice Bisazza, nelle quali, ricostruendo il profilo del pittore puntualizza la genealogia materna dell’artista, concludendo con parole taglienti: «[…] quali cose, mio caro Felice, ho voluto sporti, perché tu ti facessi accorto della poca o nissuna diligenza di alcuni scrittori che a furia lanciata ti dicono le più curiose novelle di questo mondo»144. Rettifiche a datazioni proposte dalle fonti sono presenti anche nella dodicesima lettera intitolata Si fissa l’anno del ritorno in patria Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 57 numero 3 - maggio 2011 del famoso dipintore Antonino Barbalonga da Messina145, dedicata a Tommaso Aloisio Juvara, possessore di un bozzetto del Barbalonga per il dipinto raffigurante San Filippo Neri146. Le riflessioni dello studioso messinese avevano fornito un ricco apporto alla critica a lui più prossima e a quella sucFrancesco Cardillo, Madonna col Bambino, cessiva, ad esempio S. Anna e S. Venera, Novara di Sicilia (ME), nella ricostruzione chiesa Madre. Foto Enzo Brai. della figura di artisti poco conosciuti, quali Francesco Laganà, o Andrea Quagliata, o dei pittori Francesco e Stefano Cardillo. Questi ultimi, padre e figlio, furono oggetto della prima lettera indirizzata ad Agostino Gallo147, in cui La Farina esordisce evidenziando subito la vaghezza di informazioni sicure relative alla figura dei due artisti, ribadendo ancora una volta la necessità di valutare senza leggere «a spento lume le altrui opinioni intorno alla cronologia degli artisti, elemento necessariissimo per la storia critica delle belle arti» attingendo «a buone sorgive, dopo non poche operose ricerche, e disamine»148. Nella piena applicazione del “metodo” proposto, Francesco Cardillo, Pietà, Castroreale lo studioso prosegue (ME), chiesa Madre. Foto Enzo Brai. con una breve analisi delle notizie sui due artisti messinesi pervenute fino alla redazione della Memorie di Hackert-Grano149 che include il pittore “Cardillo” nella scuola di Polidoro, citando Samperi150, Buonfiglio151 – che prendeva in esame esclusivamente la figura di Francesco – ma anche Caio Domenico Gallo152, che a sua volta citava il manoscritto di Francesco Susinno153. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 58 numero 3 - maggio 2011 dei Mercanti, citando il brano in cui l’autore delle Memorie messinesi descrive il dipinto quale opera di «Francesco Cardillo messinese di tanta perfezione che i nostri lo rapportano come opera di Rubens»163. Contesta a Grosso Cacopardo di aver anche affermato, riferendo l’opinione di Caio Domenico Gallo, che Cardillo dipingeva con “grazia” e “tenerezza” tali da farlo confondere col Correggio164 e sottolinea come la sua opinione fosse condivisa da autorevoli firme, quale ad esempio Giuseppe Bertini, che già alla precoce data del ’23 scriveva: Nella lettera è presente solo un breve accenno154 all’attività di ritrattista per cui l’artista era celebre, ma fornisce notizie più attuali citando Grosso Cacopardo155 che, rifacendosi a sua volta a quanto affermato da Gallo, aveva confutato l’attribuzione a Francesco dei due quadri del Monastero dell’Alto raffiguranti S. Benedetto e S. Bernardo, perduto, e la Visitazione156, gravemente danneggiata durante il terremoto del 1908 e oggi al Museo Regionale di Messina, mentre gli riferisce la tela firmata «Cardillus me fecit» in un piccolo cartiglio retto nel becco da un cardellino157, raffigurante la Madonna del Soccorso col Bambino incoronata da angeli tra San Michele e San Francesco della chiesa Madre del comune di Soccorso158, riportando erroneamente il titolo di Natività. Anche la Strage degli Innocenti nel chiostro del Carmine, perduta durante il terremoto del 1783159, è citata da La Farina come opera di Francesco sulla scorta di quanto scritto dal Grosso Cacopardo160, mentre Susinno la dice opera di Stefano e Gallo la legge inizialmente quale frutto di una collaborazione tra i due, ipotesi che La Farina smentisce decisamente affermando che i pittori non lavorarono mai insieme dato che il padre morì quando Stefano era appena dodicenne161. Segnala, ancora, la Madonna di Monserrato per la cappella del castello di “Consaga” (Gonzaga), commissionata da Francesco Beltrandes e datata 1600162 e il San Francesco per l’Oratorio chi non darebbe, per figura, in grandi scrosci di risa all’udire lo storico Gallo che credè di Rubens il quadro di S. Francesco fra le spine di Stefano Cardillo? Né ha maggior peso quanto dello stesso scrive il N. A. Questa pittura a chi non conosce il Cardillo, sembra un’opera del Coreggio: tale e tanta è la grazia e la tenerezza colla quale è dipinta165. È interessante notare come La Farina avesse infatti superato il topos della storiografia siciliana del XIX secolo che tendeva a ricordare acriticamente la produzione artistica isolana del ‘600 nell’ambito del classicismo di derivazione raffaellesca. Il Nostro prosegue l’aspra critica al suo conterraneo osservando come questi perseverava nell’errore, scambiando volutamente padre e figlio «senza quel fior di critica, di cui è usato far tesoro nelle sue filologiche ed artistiche Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 59 numero 3 - maggio 2011 disamine»166, pur di non ricusare l’attribuzione della Madonna di Monserrato167 a Stefano, alla luce delle evidenti affinità stilistiche con la Pietà rinvenuta a Castroreale168, datata 1603 e firmata Francesco169. La Farina espunge dunque dal catalogo di Stefano tutte le opere note, perdute e non, seppur lasciando una possibilità per la distrutta Strage degli Innocenti, ipotesi con la quale concorda la critica più recente170. Si limita a segnalare Il fa per tutti, o sia calendario e notizie per alcuni dati biografici reperiti nel l’anno 1814, copertina, 1814. corso delle sue ricerche: l’anno di nascita, 1585, il matrimonio con Flavia Cuttuni appena diciottenne, il 27 gennaio 1613, e la data di morte, l’1 febbraio 1635171. il 1812 e il 1822. Già alla precoce data del 1812, infatti, Carmelo La Farina fornisce alcune brevi notazioni di carattere artistico, non mancando di apportare alcuni importanti e preziosi contributi, segno di un’attenzione che gli consentirà di effettuare in anni più maturi attribuzioni inedite, supportate Deodato Guinaccia, Annunciazione, Messina, Museo dalle sempre più Regionale (già Messina, chiesa di S. Maria delle Grazie). Foto Enzo Brai. puntuali ricerche in archivio e dalla minuziosa analisi delle opere. È il caso, solo per citare un esempio, della perduta Annunciazione per la chiesa degli Agostiniani “alla Ciaera” del 1585174, che per primo La Farina assegna a Deodato Guinaccia175 sulla scorta del confronto stilistico col dipinto di medesimo soggetto realizzato dall’artista per i Carmelitani A lcuni dei temi affrontati nelle lettere erano stati oggetto della rubrica Notizie sui pittori messinesi172 pubblicata nella “Strenna (o Calendario Astronomico) Il fa per tutti”173 edita per dieci anni, tra teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 60 numero 3 - maggio 2011 di S. Teresa a Portareale nel 1551 e oggi al Museo di Messina, già ricordato anzitempo in un piccolo cameo176. di intellettuale con aperture e interessi che sembrano presagire la figura del moderno storico dell’arte – con un orizzonte quasi pre-venturiano – che ha di certo avuto un ruolo rilevante nello studio delle vicende artistiche isolane, autore di acute osservazioni e scopritore di utilissime notizie documentarie fondamentali per l’avvio di molte moderne ricerche su artisti siciliani. O ltre ai numerosi scritti per gli atti delle varie istituzioni di cui era membro, gli articoli di tema artistico e le monografie177, decisamente corposo è anche il numero delle riviste alle quali La Farina apportò contributi di stampo scientifico e letterario. Per lo “Spettatore Zancleo” e per “Il Faro”, scrisse altri interessanti Saro Zagari, Carmelo La Farina, contributi, quali Congettura sul sito Messina, Museo Regionale. dell’antico Nauloco178 e la Biografia dell’astronomo messinese Antonio Maria Jaci179, oltre che alcuni prospetti statistici sulla cittadina dello Stretto180, che vennero poi continuati sul “Giornale degli Atti dell’Intendenza del Valle di Messina” 181. Appare dunque evidente la versatilità e l’eclettismo di una figura ________________________ L’autore ringrazia Enzo Brai per la ricerca iconografica e la selezione delle immagini. 1 Carmelo La Farina fu titolare del prestigioso titolo di Cancelliere Archiviario del Comune. Nel 1811, fu nominato membro e geometra esaminatore della Deputazione metrica di Messina, dove propugnò l’adozione del sistema metrico decimale, sebbene fortemente osteggiato dai più. Nel 1828 venne incarcerato ingiustamente, e tradotto nelle Prigioni Centrali di Palermo, con le accuse di “falsità in pubblica scrittura” riscontrate su alcuni atti durante le ispezioni delle Imperiali Reali Truppe Austriache. La sua innocenza fu accertata dopo un anno di carcere nel forte di Castellammare, a seguito di un ricorso richiesto dal La Farina stesso. Dopo il reintegro alle mansioni, e ripresa la propria attività di erudito, Carmelo La Farina ebbe modo di mostrare la molteplicità dei suoi interessi con una notevole e diversificata mole di pubblicazioni. Fu anche effettivo al Congresso degli Scienziati nel 1846 e membro della Società Economica della Provincia di Messina e di quella della Calabria Ulteriore seconda. Nel 1845-46 ricoprì il ruolo di Giudice di Gran Corte Criminale a Catanzaro. In merito all’attività politica del La Farina – padre del patriota Giuseppe – egli va menzionato anche quale membro del Parlamento siciliano durante la rivoluzione Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 61 numero 3 - maggio 2011 1971, M. Guttilla, Orientamenti estetici e ambiti culturali del restauro tra Settecento e Ottocento nella storiografia artistica: i Dialoghi palermitani di Fedele Tirrito, in Padre Fedele da San Biagio fra letteratura artistica e pittura, catalogo della mostra a cura di G. Costantino, S. Sciascia, Caltanissetta 2002, pp. 73-96; per ulteriore bibliografia si veda Ead., Pittura e incisione del Settecento, in Storia della Sicilia, vol. x, Editalia Domenico Sanfilippo Editore Roma 2000, pp. 287-364. 3 Fondata nel 1728, l’Accademia rivestiva un ruolo di enorme importanza nella vita culturale della Messina del tempo. Basti ricordare che l’Università fu nel 1679 abolita, per essere riaperta solo nel 1838 e che dal luglio 1829 all’Accademia fu concessa la facoltà di conferire lauree. Cfr. G. Oliva, Memorie storiche e letterarie della Reale Accademia Peloritana di Messina, in “Atti della R. Accademia Peloritana”, a. V-VI (1884-1888), pp. 1-254. 4 C. La Farina, Discorso Accademico di D. Carmelo La Farina recitato a 2. Luglio dell’anno 1806, in Discorsi Accademici inediti, ms. sec. XIX della Biblioteca del Museo regionale di Messina ai segni MS 32. 2, pp. 431-449, ripubblicato in M.P. Pavone, Aggiunte alla storiografia artistica messinese del primo Ottocento. I “Discorsi” di due soci dell’Accademia Peloritana: Domenico Bottaro e Carmelo La Farina, in Miscellanea di studi e ricerche, a cura di G. Barbera, “Quaderni dell’attività didattica del Museo Regionale di Messina”, 12, La Grafica Editoriale-Edizioni Di Nicolò, Messina 2002, pp. 77101 e in part. 92-101. Cfr. G. Oliva, Memorie storiche e letterarie…, a. CLXXXVIIXLXXXVIII, vol. XXVII, Messina 1916, pp. 168-169. 5 C. La Farina, Discorso Accademico di D. Carmelo La Farina…, sec. XIX, p. 431 [2002, p 92]. 6 Ibid., p. 447 [2002, pp. 99-100]. 7 G. Grosso Cacopardo, Saggio storico delli varij Musei che in diversi tempi ànno esistito a Messina, Messina 1853, in Opere, vol. I, scritti minori (1832-1857), a cura di G. Molonia, Società messinese di storia patria, Messina 1994, pp. 434-475; G. La Corte Cailler, Pitture già in casa Arenaprimo, in “Archivio Storico Messinese” (da qui in poi abbreviato in “ASM”), a. III, 1903, pp. 203-207; V. Ruffo, Galleria Ruffo nel secolo XVII in Messina, in “Archivio Storico Siciliano”, n.s., a. XXXIX, 1914, ff. 3-4, pp. 329-349; Id., Galleria Ruffo nel secolo XVII in Messina (con lettere di pittori ed altri documenti inediti), in “Bollettino d’Arte”, a. X, 1916, ff. 1-2, pp. 21-64; ff. 3-4, pp. 95-128; ff. 5-6, pp. 165-192; ff. 7-8, pp. 237-256; ff. 9-10, pp. 284-320; ff. 11-12, pp. 369-388; O. Moschella, Il collezionismo a Messina nel secolo del ’48 in quanto rappresentante dell’Università di Messina. A seguito della restaurazione borbonica fu rimosso dai numerosi incarichi civili e scientifici che ricopriva, compresi quelli universitari, quando il suo nome risultò tra quelli dei professori implicati nelle vicende legate ai moti. Morì a Messina il 28 ottobre 1852. Cfr. G. Molonia, Premessa, in C. La Farina, Intorno alle Belle Arti…, 2004, pp. 11-39; per il ruolo di esaminatore della Deputazione metrica di Messina e gli scritti in proposito, cfr. C. La Farina, Relazione del rapporto tra i pesi e le misure usate in Messina pria di gennaio 1811, ed i pesi e le misure della nuova Legge, in cui vi sono inserite la Tavola di riduzione delle due corde abolite alla generale di Canne 16 per uso de’ Notaj; e le cinque Tavole del nuovo sistema metrico della Sicilia, Letterio Fiumara e Giuseppe Nobolo socj, Messina 1811, pubblicata anche in “Il fa per tutti o sia Calendario, e notizie per l’anno 1813”, 1812, p. 98. Cfr. anche A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica o apparato metodico alla storia letteraria della Sicilia, vol. III, G. Pedone, Palermo 1854, p. 30; G. Oliva, Annali della città di Messina continuazione all’opera storica di C. D. Gallo, con cenni biografici dei cittadini illustri della seconda metà del secolo 19, vol. VIII, Società messinese di storia patria, Messina 1954, p. 264. 2 La Farina era membro delle siciliane Accademia delle Scienze Lettere ed Arti (Palermo), Zelanti (Acireale), Civetta (Trapani), Lilibetana (Marsala), Floriomontana (Monteleone), e fuori dai confini isolani la Società libera di emulazione (Rouen), l’Istituto di Corrispondenza Archeologica (Roma), l’Etrusca Accademia (Cortona), l’Istituto e Reale Accademia (Firenze, Arezzo), la Valdarnese (Montevarchi), gli Incamminati (Modigliana), e infine gli Eutoliti (San Miniato), Cosentina (Cosenza). Già dal XVII secolo nell’Isola le Accademie assolvono, insieme alle Biblioteche pubbliche e ai Circoli e alle adunanze letterarie, al ruolo di cassa di risonanza della cultura erudita locale. Vi si discettava dei temi più svariati, dando ampio spazio anche a tematiche di respiro europeo, quali il progresso delle Scienze e delle Arti. Cfr. A. Mongitore, Le Accademie di Sicilia, ms. del secolo xviii ai segni QqE32, Biblioteca Comunale di Palermo; D. Schiavo, Saggio sopra la storia letteraria e le antiche Accademie della città di Palermo, E spezialmente dell’Origine, Istituto e Progresso dell’Accademia del Buon Gusto del Sac. Dott. Domenico Schiavo direttore di essa Accademia, Socio Colombario di Firenze, ed Accademico Augusto di Perugia, in Saggi di dissertazione dell’accademia palermitana del Buon Gusto, Stamperia de’ SS. Appostoli in Piazza Vigliena, Presso Pietro Bentivegna, Palermo 1755, vol. I, pp. III-LI; G. Palermo, Sull’utilità delle pubbliche Accademie, S. Sciascia, Palermo teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 62 numero 3 - maggio 2011 XVII, EDAS, Messina 1977; Ead., Il depauperamento del patrimonio artistico messinese dopo la rivolta, in La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento, atti del convegno (Messina, 10-12 ottobre 1975), a cura di S. Di Bella, L. Pellegrini, Cosenza 1979, pp. 595-604; S. Di Bella, Collezioni messinesi del ‘600: quadri dispersi di pittori siciliani e non, A. Sfameni Editore, Messina 1984; Id., Collezioni messinesi della prima metà del ‘700, A. Sfameni, Messina 1985; Id., Mercato antiquario messinese del ‘700: una vendita di quadri e monete, in Moant IIa Mostra di Antiquariato, catalogo della mostra (Messina, 6-21 maggio 1989), Messina 1989, s.p.; Id. Il collezionismo a Messina nei secoli XVII e XVIII, in “ASM” 74, 1997, pp. 5-90; T. Pugliatti, Antiquariato e collezionismo. Fonti di recupero di un patrimonio disperso, in Moant IIa Mostra…, 1989, s.p.; Ead., Collezionismo e antiquariato a Messina dal Cinquecento al Novecento, in Aspetti del collezionismo in Italia da Federico II al primo Novecento, in “Quaderni del Museo Regionale Pepoli”, Trapani 1993, pp. 95-124; Wunderkammer siciliana, alle origini del museo perduto, catalogo della mostra (Palermo, 4 novembre 2001 - 31 marzo 2002), a cura di V. Abbate, Electa Napoli, Palermo 2001; D. Ligresti, Sicilia aperta (secoli XCV-XVII). Mobilità di uomini e idee, in “Quaderni - Mediterranea. Ricerche storiche”, 2006, 3, pp. 300-302. K. Pomian, Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi - Venezia xvi-xviii secolo, Il 8 Saggiatore, Milano 2007, pp. 54-55. 9 C. De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano, Ponte alle Grazie, Firenze 1991, p. 135. 10 Ibid., p. 124. In ambito palermitano si ricordano alcune donazioni che portarono all’istituzione di una pubblica galleria accorpata alla Regia Università degli Studi, quale quelle del principe di Belmonte ma anche il legato testamentario autografo di Enrico Pirajno barone di Mandralisca, datato 26 ottobre 1853, in cui annunciava la volontà di costituire un «Liceo coi suoi Gabinetti e Biblioteca» nei locali del proprio palazzo. V. Abbate, Per Mandralisca collezionista e studioso, in Giovanni Antonio Sogliani (1492-1544), a cura di V. Abbate, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2009, pp. 15-16. 11 C. La Farina, Intorno le Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina. Ricerche di C. La Farina ordinate in più lettere, parte I, Stamperia Fiumara, Messina 1835, p. 84: «…descrivere le antichità della nostra Messina, mostrare le reliquie ed additare i mezzi come conservarle […] molto si è perduto per incuria del tempo e degli uomini […] e quei pochi [monumenti] che ci rimangono forse anche essi si perderanno coll’andare degli anni, se una giusta provvidenza non darà riparo a questo sconcerto». Cfr. M.P. Pavone, Aggiunte alla storiografia artistica…, p. 100. 12 Cfr. C. La Farina, Su di un antico sarcofago nella chiesa de’ PP. Conventuali di Messina. Pochi cenni del Dottore in ambe le leggi Carmelo La Farina, Professore di Matematica nella R. Accademia Carolina de’ Pubblici Studj, Prefetto del pub. Museo Peloritano ec. Socio corrispondente dell’Accademia del buon gusto, ed attual Promotore in quella de’ Pericolanti, ov’è detto l’Accertato, Antonino d’Amico Arena, Messina 1822, p. 26: «…le antiche iscrizioni, e le medaglie, [...] sono i principali, ed i più irrefrenabili documenti da tramandare alla posterità la storia civile, e religiosa dei popoli». 13 Storiografo e sacerdote, Francesco Susinno (1660/1670 - 1739 circa) fu anche pittore. I molti viaggi di studio, prima a Napoli e poi nel 1700 a Roma, dove conobbe Carlo Maratta, sono evidenti nei frequenti richiami ad opere viste a Messina e provincia, a Catania, a Palermo, a Siracusa e nella vicina Calabria. La sua opera manoscritta Le Vite dei Pittori Messinesi, completata nel 1724, è stata edita nel 1960, a cura di Valentino Martinelli; in essa Susinno dimostra capacità critica e attributiva davvero inusuali per la sua epoca, e grande attenzione alle nuove istanze storiografiche. Cfr. F. Susinno, Le Vite de’ Pittori Messinesi, (Messina 1724), a cura di V. Martinelli, Le Monnier, Firenze 1960. 14 Antonino Mongitore (Palermo, 1663 - 1743), canonico del capitolo della Cattedrale di Palermo, consultore e qualificatore del Sant’Uffizio, ebbe una prolifica produzione letteraria principalmente orientata ad argomenti riguardanti l’ambito siciliano in genere, con un’attenzione particolare alle attività delle numerose accademie dell’epoca. La sua opera Memorie dei pittori, scultori, architetti e artefici in cera siciliani (1740 ca., ed. a cura di E. Natoli, Palermo 1977) fu la principale fonte per il Villabianca (G.M. Emmanuele e Gaetani di Villabianca, Le divine arti della pittura e della scultura, a cura di D. Malignaggi, Giada, Palermo 1988) e per Gaspare Palermo (G. Palermo, Guida istruttiva per potersi conoscere con facilità tanto dal siciliano, che dal forestiere tutte le magnificenze e gli oggetti degni di osservazione della città di Palermo capitale di questa parte dei R. Dominj, Reale Stamperia, Palermo 1816). Alla morte venne sepolto nella chiesa di San Domenico a Palermo. 15 Gaetano Grano (Messina, 21 novembre 1754 - Messina, 13 marzo 1828), laureato in medicina, fu precettore di retorica nella Reale Accademia Carolina, presso cui esercitò la carica di bibliotecario dal 1780 al 1828, anno della morte. Nel 1806 figura tra i fondatori del Museo Civico Peloritano. Membro di numerose Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 63 numero 3 - maggio 2011 dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, Palermo 2002) in cui affronta, con evidente intento didascalico ma non senza una moderna apertura, la ricostruzione del percorso artistico degli artefici, siciliani e non, che maggiormente contribuirono alla formazione della cultura figurativa della Sicilia, tentando una sintesi di concetti generali e nozioni particolari della coeva teoria sull’arte. R. Cinà, Conoscitori nella Sicilia del Settecento. Padre Fedele da San Biagio, in La critica d’arte in Sicilia nell’Ottocento, a cura di S. La Barbera, Flaccovio, Palermo 2003, pp. 84-86. 18 S. La Barbera, Giuseppe Maria Di Ferro teorico e storico dell’arte, in Miscellanea Pepoli. Ricerche sulla cultura artistica a Trapani e nel suo territorio, a cura di V. Abbate, Museo regionale Pepoli, Trapani 1997, pp. 147-166. 19 I dibattiti in merito alla sistemazione del neonato museo impegnarono i nomi più illustri dell’élite culturale messinese anche in anni successivi. Si veda ad esempio: G. La Corte Cailler, Sistemazione della Pinacoteca, in “ASM”, a. II, ff. 1-2, 1901-1902, p. 134; Id., Museo Civico, ivi, a. II, ff. 3-4, 1901-1902, pp. 153-155; G. Oliva, Museo Civico, ivi, a. IV, ff. 1-2, 1903, pp. 230-232; Id., Pel riordinamento del Museo, ivi, a. VIII, ff. 1-2, 1907, pp. 147-148; S.A., Per Istituzione di un Museo Nazionale e di un Ufficio dei Monumenti a Messina, ivi, a. XVIII, f. unico, 1917, pp. 135-137. 20 Per la figura di Gregorio Cianciolo, il cui nome è ricordato sull’iscrizione marmorea apposta sulla porta del neonato museo Civico, si vedano: G. Grosso Cacopardo, Biografia del P. D. Gregorio Cianciolo, in “Il Maurolico, Giornale di Scienze, Lettere e Arti”, a. II, vol. 3, n. 7, settembre 1838; G. Coglitore, Storia monumentale-artistica di Messina, Tipografia del Commercio, Messina 1864. 21 Tra le prime eterogenee collezioni che andarono a costituire il nucleo iniziale delle raccolte del Museo Civico Peloritano ci si avvalse di quelle di Tommaso Alojsio Juvara, Giuseppe Arenaprimo, Gregorio Cianciolo, Giuseppe Grosso-Cacopardo e Giuseppe Carmisino. Facevano parte delle collezioni molti dipinti di scuola messinese, «marmi delle epoche greche, romane e saracene» ma anche oggetti di storia naturale, armi e armature da guerra risalenti alle epoche più svariate. G. Oliva, Memorie storiche e letterarie…, a.a. CLXXXVII-XLXXXVIII, vol. XXVII, Messina 1916, p. 169; cfr. G. La Farina, Messina e i suoi monumenti, Stamperia di G. Fiumara, Messina 1840: «[nel Museo Civico] si trovava una ragguardevole galleria di quadri […] il ricco Presepe di Polidoro di Caravaggio, accademie, tra le quali quella degli Zelanti ad Acireale, fu ripetutamente eletto Presidente dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Tra le numerose cariche che ricoprì, quella di Priore di S. Maria della Latina nel 1786, quella di Giudice ecclesiastico della Regia Udienza nel 1789 e quella di Giudice delegato della Regia Monarchia in Messina nel 1791. Nel 1814 venne accettato quale membro della commissione per la compilazione dei codici del Regno delle Due Sicilie. Fu infine Giudice Interno del Regio Tribunale di Monarchia in Sicilia nel 1817 e, nello stesso anno, Abate-Regio Priore di S. Andrea di Piazza. Infine, fu Vescovo in Partibus della Santissima Basilica di Terra Santa, Consigliere del Re delle Due Sicilie Ferdinando IV di Borbone. Nel 1821 rifiutò la carica di Luogotenente Generale in Sicilia. Quale corrispondente di Scinà, Landolina e Gregorio, collaborò con J.P. Hackert alla redazione delle Memorie de’ Pittori Messinesi edito a Messina nel 1792. Nel 1797 contribuì alla realizzazione dei Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino dell’abate Spallanzani e nel 1841 pubblicò la Guida alla Città di Messina. 16 Jakob Philipp Hackert (Prenzlau, 15 settembre 1737 - San Pietro di Careggi, 28 aprile 1807), artista tedesco, lavorò molto in Italia. Si stabilì a Roma nel 1768 e fu pittore di corte per il re di Napoli. Nel 1792 pubblicò le Memorie de’ Pittori Messinesi, redatto con il notevole apporto di Gaetano Grano che non aveva voluto comparire come autore. Si veda: Memorie de’ Pittori Messinesi di J.F. Hackert e G. Grano, con introduzione note e appendice bibliografica di S. Bottari, in “ASM”, XXVIII-XXXV, n.s., 1934, pp. 1-53. 17 Matteo Sebastiano Palermo Tirrito (San Biagio Platani, 18 gennaio 1717 - Palermo, 9 agosto 1801) fu frate cappuccino, pittore di buon livello e letterato; nell’ambiente agrigentino e palermitano ebbe la sua prima formazione, che completò con diversi viaggi a Roma dove fu anche alle dirette dipendenze del papa, che gli commissionò alcuni affreschi. Membro dell’Accademia dell’Arcadia in Roma, dell’Accademia del Buon Gusto a Palermo e dell’Accademia degli Ereini pure a Palermo, frequentò quella rinomatissima di S. Luca presso la cui Scuola del Nudo ebbe occasione di studiare con Sebastiano Conca e Marco Benefial. Fu autore di molteplici componimenti, sebbene in questa sede prema ricordare principalmente i Dialoghi familiari sopra la pittura difesa ed esaltata dal P. Fedele da S. Biagio pittore cappuccino col Sig. Avvocato D. Pio Onorato palermitano alla presenza de’ suoi Allievi nella Bell’Arte, disposti in quindici giornate (Palermo 1788, ed. cons. a cura e con introduzione di D. Malignaggi, Regione siciliana, Assessorato teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 64 numero 3 - maggio 2011 e Faustina “minore” moglie di Marco Aurelio, La Farina scrive: «Non poche di queste medaglie furono da me acquistate, ed altre vennero in potere al culto e diligente Grosso Cacopardo». 25 In merito al dipinto raffigurante la Madonna in trono col Bambino tra due Santi di Battista Dalliotta, La Farina scrive: «[…] la quale pittura esistea (nell’anno 1821) nella chiesa di S. Giorgio, nel villaggio di Briga. Al qual villaggio che sta a undeci miglia dalla città io mi recai nel 1832; e chiesi di presente ivi giunto di quel quadro: che vidi in miseranda condizione e tramestato colla polvere e quasi vile oggetto calcato. Me ne venne dolore: che veder così volti in bassi gli egregi dipinti, o quei che servono a fermare, o rischiarare le nostre memorie, non può che con generoso fremito patirsi. E quindi curai, come meglio potei, farne acquisto. E nella quadreria diedi non indecoroso loco a quella pittura». Cfr. C. La Farina, Lettera VII. Si adducono…, 1835, pp. 101-102. Gioacchino Di Marzo è tra i primi studiosi ad accogliere questa attribuzione, cfr. Delle Belle arti in Sicilia dal sorgere del secolo XV alla fine del XVI, vol. iii, libro vii, Palermo 1862, p. 301. 26 Cfr. G. La Corte Cailler, Museo Civico, in “ASM”, 1902, II, 3-4, pp. 153155; Id., Per riordinamento del Museo, in “ASM”, 1907, VIII, 1-2, pp. 147-148; Id., Per l’istituzione di un Museo Nazionale e di un Ufficio dei Monumenti a Messina, in “ASM”, 1917, XVIII, , pp. 153-155; F. Campagna Cicala, Dal collezionismo…, p. 13. Per la costituzione di Musei Pubblici e Gallerie e l’acquisizione di opere e strutture sia tramite donazioni volontarie sulla base di modelli «evergetici» che tramite sequestri da parte delle istituzioni, si veda K. Pomian, Collezionisti, amatori…, pp. 352-354. Sui problemi e le scelte effettuate dal nuovo stato nazionale in relazione al patrimonio artistico acquisito con la soppressione delle Corporazioni religiose cfr. P. Picardi, Il patrimonio artistico romano delle corporazioni religiose soppresse, protagonisti e comprimari (1870-1885), De Luca Editori D’Arte, Roma 2008. 27 Miscellanea in due volumi di manoscritti relativi a trattazioni e discorsi declamati dai soci dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, raccolte tra il 1737 e il 1803 e il 1803 e il 1808, ai segni Ms. 32. 2 della Biblioteca Regionale del Museo di Messina. 28 C. La Farina, Messina. Biografia di Tommaso Aloisio, in “Giornale di Scienze, Lettere ed Arti”, t. 42, n. 53, f. 125,1833, pp. 197-200. 29 M.P. Pavone, Aggiunte alla storiografia…, pp. 77-101. 30 Tra i molti artisti, lo scultore Giuseppe Arifò, l’incisore Tommaso Alojsio quadro ricco di figure, e di stupenda composizione; la strage degli Innocenti, ardito lavoro del Rodriguez; la vedova di Naim, sterminato quadro del Menniti; un S. Diego di Gio. Paolo Funduli cremonese; la trasfigurazione di Gesù Cristo di Antonio Catalano; il martirio di S. Placido del Vanoubracken; Giacobbe al pozzo, Saulle e Davidde, Ester, Giacobbe e i suoi figliuoli, Assalonne, Davidde e l’Amalechita, composizioni a mezza figura dello Scilla, ed altri non pochi, per lo più della rinomata scuola messinese»; S. La Farina, Sul Museo Peloritano, Tip. del Commercio, Messina 1860; G. La Corte Cailler, Il Museo Civico di Messina, ms. 1901, ed. a cura di N. Falcone, Pungitopo, Marina di Patti 1981. 22 F. Campagna Cicala, Dal collezionismo privato alle pubbliche raccolte. Recenti acquisizioni del Museo regionale di Messina, in Acquisizioni e documenti sul patrimonio storicoartistico del Museo regionale di Messina, a cura di G. Barbera, “Quaderni dell’attività didattica del Museo Regionale di Messina”, 9, La Grafica Editoriale - Edizioni Di Nicolò, Messina 1999, p.13. 23 La Farina ottenne la carica di Prefetto del Museo dal 1813 e per questo incarico gli venne anche attribuito un vitalizio, come sappiamo dalla lettera che scrisse al suo corrispondente Agostino Gallo per essere agevolato in alcune lungaggini burocratiche, legate ai mancati pagamenti. Nella lettera datata 8 maggio 1823 Carmelo La Farina lamenta al suo corrispondente palermitano la lentezza del procedimento di nomina a Prefetto e i molti impedimenti per la consegna delle iniziali 24 onze – poi aumentate a 30 nel 1821 – che avrebbe dovuto ricevere come corrispettivo. Preme perché Gallo si adoperi in suo favore riguardo al ricorso avanzato al Luogotenente Generale di Napoli. Cfr. ms. sec. XIX ai segni Qq 10 110, della Biblioteca Comunale di Palermo; Stato discusso per l’esercizio dell’anno 1822 (Da aver vigore anche pel 1823), opera a stampa conservata presso la Biblioteca del Museo Regionale di Messina. Cfr. anche G. Molonia, Premessa, in C. La Farina, Intorno alle Belle Arti…, 2004, pp. 11-12. 24 Nell’articolo intitolato Congettura del prof. C. La Farina sul sito dell’antico Nauloco (estratto dal “Il Faro che siegue lo Spettatore Zancleo. Giornale di Scienze Lettere e Arti”, a. IV, vol. I, f. 3, Marzo 1836, p. 165-168, nota 2) riguardo al ritrovamento in contrada Bagni, nei pressi dell’attuale Spadafora (Me) di antichi resti murari, di vasche, e di un «vaso di grossa argilla» contenente 200 monete di bronzo coniate dalla zecca di Roma in un arco di tempo che va dall’81 d.C. al 175 d.C. per gli imperatori Domiziano, Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 65 numero 3 - maggio 2011 letteratura siciliana nel 1835 tra le pagine del palermitano “Il Vapore. Giornale istruttivo e dilettevole accompagnato dal figurino di moda” (1836, a. III, t. III, n. 19, pp. 249-251), diretto dagli stessi Linares. Lo scritto non dava sufficiente risalto al ruolo dei letterati messinesi nella vicenda culturale del tempo; riferendosi all’attività giornalistica dello “Spettatore Zancleo”, il compilatore asseriva che «se la passava a far riviste, a dare e soffrire ingiurie», che il “Maurolico” «appariva come il sole di febbraio»; riguardo a “L’amico delle donne”: «un nuovo giornale usciva con l’anno 1835 in Messina tutto croci, tutto sepolcri, tutto romantico, e moriva in sul nascere»; per “L’Innominato”: «un secondo ne appariva e con qual nome? Voi chiederete, non so io, non sa lui, non ebbe battesimo». La polemica, iniziata dai compilatori dello “Spettatore Zancleo” (1836, a. V, nn. 4, 5, 17) e fomentata successivamente sulla “Trinacria” (1836, n. 17) con accuse di parzialità che nascondevano in un malcelato campanilismo, ragioni politiche, raggiunse il suo apice con attacchi personali ai redattori del “Vapore” – che ribatterono (1836, vol. III, n. 24, pp. 193-194) a loro volta sostenuti dai redattori palermitani de “Il Telegrafo” (1836, n. 48), della “Cerere, giornale officiale di Sicilia” (1836, nn. 19, 148, 184 e 189), dell’“Imparziale” (1836, nn. 39, 42 e 47) – causando la sospensione da parte delle autorità dello “Spettatore Zancleo”. Le offensive si acuirono ulteriormente tra le pagine de “Il Faro” (1836, n. 7), al punto da giungere ad una sfida a duello tra due redattori delle testate, impedita in extremis dal duca di Cumia, direttore generale della polizia siciliana. Alcune firme messinesi comparse in questa controversia andarono a formare il nucleo costitutivo della seconda edizione del “Maurolico”, col sostegno del “Gabinetto Letterario”, stampata, ancora una volta, dai torchi di Tommaso Capra nel 1841. Cfr. G. Arenaprimo, La stampa periodica in Messina dal 1675 al 1860. Saggio storico e bibliografico, in “Atti della R. Accademia Peloritana”, VIII, 1892-1893, p. 89; G. Oliva, Annali della città di Messina…, 1893, pp. 271-272, 290-291; Una lezione ai Signori fratelli Linares, compilatori del «Vapore», Malta, Nuova tip. Italiana, 1836, 4° (irreperibile già ai tempi di Oliva che lo precisa in Annali…, pp. 271-272); A. e V. Linares, Alla gioventù messinese i fratelli Linares sulla lezione pubblicata colla data apocrifa di Malta in risposta all’articolo di polemica del «Vapore», diretto ai compilatori del «Faro», Palermo, Lao, 1836, 4°; G. Pitrè, ad vocem Felice Bisazza, in Nuovi profili biografici contemporanei italiani, Palermo 1868, p. 191; N.D. Evola, Polemiche giornalistiche e albori di italianità in Sicilia, estratto da “La Sicilia nel risorgimento italiano”, a. III, f. Juvara, il pittore Michele Panebianco, ma anche gli scienziati Carmelo Pugliatti e Natale Catanoso. 31 C. La Farina, Belle arti, in “Lo Spettatore Zancleo”, III, n. 32, 1835, pp. 254-255; Id., Belle Arti, in “Lo Spettatore Zancleo”, III, n. 33, 7 ottobre 1835, pp. 263-264. 32 Si veda ad esempio, su Giuseppe Arifò, pensionato messinese a Roma per studiare scultura presso lo studio di Pietro Tenerani: ibid. 33 Fu dietro pressioni di Carmelo La Farina che il Senato messinese assegnò al Tenerani la commissione per il monumento bronzeo a Ferdinando II di Borbone che fu eseguito a Monaco di Baviera nel 1839 e che venne fuso durante i moti insurrezionali del 1848. Per Tenerani (Torano (Rt), 1789 - Roma 1869) e le vicende relative alla realizzazione del monumento a Ferdinando di Borbone si veda O. Raggi, della vita e delle opere di Pietro Tenerani, del suo tempo e della sua scuola nella scuola, Firenze 1880; S. Susinno, Premesse romane alla scultura purista dell’Ottocento messinese, in La scultura a Messina nell’Ottocento, catalogo della mostra a cura di L. Paladino, (21 agosto - 31 ottobre 1997), Assessorato regionale dei Beni Culturali, ambientali e della Pubblica Istruzione, Messina 1997, p. 51; S. Grandesso, Pietro Tenerani (1789-1869), Silvana, Cinisello Balsamo 2003. 34 F.P. Campione, La nascita dell’estetica in Sicilia, in “Aestethica Preprint”, 76, aprile 2006, pp. 27-48. 35 Per la figura di La Farina e un utile spaccato sull’entourage culturale in cui gravitava, si veda F. Bisazza, Della presente civiltà messinese. Lettera di Felice Bisazza al suo degno amico Gaetano Grano, in “Lo Spettatore Zancleo”, II, n. 44, 31 dicembre 1834, pp. 340-350. La Farina è citato insieme a Giuseppe Grosso Cacopardo «per l’amore per le patrie cose». Cfr. G. Molonia, Premessa, in C. La Farina, Intorno alle Belle Arti…, 2004, p. 17. 36 Per l’apertura italiana verso la cultura europea e tedesca sulla stampa periodica sulla scorta degli scritti di Madame Amia Luisa de Staël-Holstein, che, come è ben noto, diede l’avvio della discussione fra classicisti e romantici con la pubblicazione nel gennaio 1816 dell’articolo intitolato Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni sul periodico «La Biblioteca italiana», cfr. C. Carmassi, La letteratura tedesca nei periodici italiani del primo Ottocento (1800-1847), Jacques e i suoi quaderni editore, Pisa 1984. A Messina un acceso dibattito si ebbe a seguito della pubblicazione dell’articolo dei fratelli Antonino e Vincenzo Linares Un colpo d’occhio sulla teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 66 numero 3 - maggio 2011 I, pp. 3-18; M.I. Palazzolo, Intellettuali e giornalismo nella Sicilia preunitaria, Società di Storia patria per la Sicilia Orientale, Catania 1975; S. La Barbera, Linee e temi della stampa periodica palermitana dell’Ottocento, in Percorsi di critica. Un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, a cura di R. Cioffi, A. Rovetta, Vita e Pensiero, Milano 2007, pp. 87-121. 37 Tra i primi periodici che diffusero le idee romantiche, il già citato la “Biblioteca italiana. Giornale di Letteratura Scienze ed Arti” (Milano 1816-1859), l’“Antologia. Giornale di Scienze, Lettere e Arti” (Firenze 1821-1832), quasi a continuazione del “Conciliatore”, del “Giornale Euganeo” e del “Gondoliere” in Veneto, il “Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti” (1832-1834) e “Il Vesuvio” (1835) a Napoli. Cfr. Storia letteraria d’Italia, a cura di A. Balduino, L’Ottocento, a cura di A. Balduino, tomo 2, ed. cons. Piccin nuova libraria, Padova 1990, p. 879. F. Bernabei, C. Marin, Critica d’arte nelle riviste lombardo-venete. 18201860, Canova Edizioni, Treviso 2007; D. Levi, Cavalcaselle. Il pioniere della conservazione dell’arte italiana, Giulio Einaudi Editore, Torino 1988, Ead., Storiografia artistica e politica di tutela: due memorie di G.B. Cavalcaselle sulla conservazione dei monumenti (1862), in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte nell’Ottocento in Italia, atti del convegno (Palermo 15-17 aprile 2003), a cura di S. La Barbera, Officine Tipografiche Ajello e Provenzano, Bagheria 2004, pp. 53-76 ; A.C. Tomasi, Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore, Marsilio Editore, Venezia 1998. In ambito isolano va evidenziata la fitta rete di rapporti con gli intellettuali del continente, che avveniva tramite una serrata corrispondenza, con lo scambio e la collaborazione tra testate, ove non mancarono vivaci dibattiti e polemiche e la circolazione della produzione letteraria. Tra i periodici siciliani, il “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia”, pubblicato a Palermo da 1823, diretto dall’abate Giuseppe Bertini fino al 1833 quando vi subentrò Vincenzo Mortillaro di Villarena. Fu a causa delle tendenze indipendentiste del Mortillaro che la pubblicazione fu soppressa nel ’42 per poi riprendere nel ’48 col titolo di “Giornale di Scienze Lettere ed Arti per la Sicilia. Nuova Serie”, di cui furono editi solo quattro fascicoli; “Il Mercurio siculo” (1818; 1823-1831); “La Cerere, giornale officiale di Sicilia” (1823-1847); “Lo Stesicoro, Giornale catanese” che comincia le sue pubblicazioni il primo aprile del 1835 durante la provvisoria sospensione del “Giornale del gabinetto letterario dell’Accademia Gioenia” (1834, 1839-43, 1850-51) e prosegue la stampa fino al luglio del 1836; “La Specola”, che cessa la sua attività, dopo un solo anno di pubblicazioni, iniziate il primo febbraio del 1840 e terminate il 15 giugno del 1841; i messinesi il “Maurolico”, pubblicato dal 5 ottobre 1833 all’aprile del 1840, lo “Spettatore Zancleo” (Messina 1831-1836, 1839-1847) e il “Faro” (Messina 1836-1839). Cfr. N. D. Evola, Polemiche giornalistiche e albori di italianità in Sicilia, estratto da “La Sicilia nel risorgimento italiano”, a. III, f. I, gennaio-giugno 1933, pp. 3-18; M.I. Palazzolo, Intellettuali e giornalismo nella Sicilia preunitaria, Società di Storia patria per la Sicilia Orientale, Catania 1975; Percorsi di critica…, 2007, e in part. i saggi di C. Bajamonte, F.P. Campione, S. La Barbera. Per la figura di G. Bertini si veda ad vocem Bertini Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani (da questo momento D.B.I.), vol. IX, Roma 1967, pp. 546-547; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia, a cura di C. Napoleone, Ricci, Parma 2006, p. 162. 38 K.F. von Rumohr, Italienische Forschumgen, 3 voll., Berlin-Stettin 18271831, Schlosser, Frankfurt am Main 1920; A. Thiers, Salon de 1822 et collection des artiche insérés an Constitutionnel, sur L’Exposition de cette année, Maradan, Paris 1833; Id., Salon de 1824, in “Le Constitutionell”, 30 agosto 1824, pp. 3-4; J.D. Passavant, Rafael von Urbino und sein Vater Giovanni Santi, Brockhaus, Leipzig 1839-1858; E.J. Delécluze, Louis David, son école et son temps, Didier Libraire-editeur, Paris, 1855; G.B. Cavalcaselle – J.A. Crowe, The early flemish painters. Notices of their lives and works, J. Murray, London 1857 (ed. it. Storia dell’antica pittura fiamminga, Le Monnier, Firenze 1899); Id., A history of Painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia, from the fourtheenth to sixteenth century, 2 voll, J. Murray, London 1871; Id., Storia della pittura in Italia dal secolo ii al secolo xvi, Le Monnier, Firenze 1886-1908 (ed. it. A cura di A. Mazza, voll xi, Le Monnier, Firenze 1908); G. Morelli (I. Liermolieff), Kunstkritische Studien uber italienische Malerei: Die Galerien Borghese und Doria Pamphli in Rom, F. A. Brockhaus, Leipzig 1890, (ed. it. Della pittura italiana: le gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma, studii storico critici, Treves, Milano 1897); Id., Die Galerien zu München und Dresden, F. A. Brockhaus, Leipzig 1891; Id., Die Galerie zu Berlin, F. A. Brockhaus, Leipzig 1893; Giovanni Morelli e la cultura dei conoscitori, Atti del Convegno Internazionale (Bergamo 4-7 giugno 1987) a cura di G. Agosti, M. E. Manca, M. Panzeri, con il coordinamento scientifico di M. Dalai Emiliani, 3 voll. Pierluigi Lubrina Editore, Bergamo 1993. 39 A.C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux arts. Par m. Quatremère de Quincy, Jules Didot, Paris 1823, motiva l’arte proprio in quanto apparenza, l’imitazione in quanto atto creativo ‘altro’, Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 67 numero 3 - maggio 2011 preparando la giustificazione del Romanticismo. Cfr. R. Schneider, L’esthétique classique chez Quatremére de Quincy, Hachette, Paris 1910; P.H. Valenciennes, Eléments de perspective pratique à l’usage des artistes suives de réflexion et de conseils à un élève sur la peinture et particulièrment sûr le genre de paysage, Desenne, Duprat, Paris 1800; L. Venturi, Storia della critica d’arte, Einaudi, Torino 1964, p. 251; L. Gallo, “Sentimento del colore” e “Colore del sentimento”: la riscoperta di Pierre-Henri de Valenciennes nell’opera di Lionello Venturi, in Lionello Venturi e i nuovi orizzonti di ricerca della storia dell’arte, Atti del convegno internazionale di studi (Roma 10-11-12 marzo 1999, Accademia Nazionale dei Lincei, Università “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Storia dell’arte Università “La Sapienza”, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea), a cura di S. Valeri, in “Storia dell’Arte” n. 101 (n.s. 1) Nuova Serie - Gennaio-Aprile 2002, Anno XXXIII, diretta da M. Calvesi e O. Ferrari, CAM Editrice, Roma 2002, pp. 118-129. 40 M.P. Pavone, Storiografia artistica, in Mostra sulla cultura e le ipotesi di ricostruzione della Messina del terremoto. La trama culturale, a cura di F. Campagna Cicala, G. Campo, (Messina 18 febbraio - 18 marzo 1989), Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della p.i. (Palermo), Amministrazione provinciale, Amministrazione comunale, Facoltà di scienze politiche, Messina 1989, pp. 40-43. 41 P. Fedele da San Biagio, Dialoghi sopra la pittura…. 42 M.P. Pavone, Storiografia artistica a Messina nell’Ottocento: Carmelo La Farina, Giuseppe Grosso Cacopardo, Carlo Falconieri e Giuseppe La Farina, in “ASM”, 52, 1988, pp. 23-60 e in part. 23- 24; G. Molonia, Arte cultura e società a Messina nell’Ottocento, in La scultura a Messina…, 1998. 43 M.P. Pavone, Aggiunte alla storiografia…, 2002, p. 78. 44 F. Bisazza, Del Romanticismo, Memoria letta da Felice Bisazza nella ordinaria ragunata del 27 settembre 1832 della Classe di Belle Arti della Regia Accademia Peloritana, Pappalardo, Messina 1833 (poi in F. Bisazza, Opere…, vol. III). Cfr. anche G. Oliva, Memorie storiche e letterarie…, a.a. CLXXXVII-XLXXXVIII, vol. XXVII, Messina 1916, pp. 208-210. 45 Felice Bisazza (Messina, 1809-1867), poeta, traduttore e teorico della poesia romantica, collabora a molti periodici, specie messinesi: “L’Osservatore Peloritano”, “Il Maurolico”, “Lo Spettatore Zancleo”, “L’Innominato”, “Il Faro”, “La Sentinella del Peloro”, “Il Nuovo Faro”, “La Rivista Periodica”, “L’Amico delle Donne”, “La Trinacria”, “Aristocle”, “Il Giornale del Gabinetto Letterario”, “La Farfalletta”, “Scilla e Cariddi”, “La Lanterna”, “Empedocle”, “La Lucciola”, “Il Tremacoldo”, “Il Caduceo”, “L’Eco Peloritano”, “L’Estro”, “L’Interprete”, “Gazzetta di Messina”, “La Parola Cattolica”, “Il Dicearco”, “Il Veridico”. Per Bisazza cfr. ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 167; S. Ribera, Biografia di Felice Bisazza, in F. Bisazza, Opere di Felice Bisazza da Messina pubblicate per cura del Municipio, 3 voll., Tipografia Ribera, Messina 1874; M. Tosti, Felice Bisazza e il movimento intellettuale in Messina nella prima metà del XIX secolo, Prem. Off. Graf. La Sicilia, Messina 1921; I. Stellino, Felice Bisazza, in La cultura estetica in Sicilia fra Ottocento e Novecento, a cura di L. Russo, “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo – Studi e Ricerche”, 18, 1990, pp. 13-29; S. Correnti, La cultura siciliana agli albori del XIX secolo, in “Studi e ricerche di Sicilia”, CEDAM, Padova 1963, pp. 65-110. 46 F.P. Campione, La nascita dell’estetica…, p. 60. 47 Tra i protagonisti dei moti risorgimentali che si occuparono di Belle Arti, risaltano i nomi, oltre che di Carmelo La Farina, anche dei più accesi difensori del pensiero romantico in Sicilia, quali il figlio di quest’ultimo, Giuseppe, di Felice Bisazza, Francesco Paolo Perez, Lionardo Vigo, Domenico Ventimiglia e Gaetano Daita. 48 Va notato, a tale proposito, la varietà di argomentazioni relative alla rivalutazione dell’architettura medievale, evidenziando come il fenomeno sia strettamente connesso al recupero delle tradizioni nazionali e in particolare alle istanze patriottico-risorgimentali. Cfr. F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni – Protagonisti ed interpreti del restauro dei monumenti a Palermo nella seconda metà dell’Ottocento, Officina, Roma 1994, p. 44; P. Palazzotto, Teoria e prassi dell’architettura neogotica a Palermo nella prima metà del XIX secolo, in Gioacchino Di Marzo…, pp. 225-237. 49 A tale proposito Pavone menziona l’articolo di Enrico De Sangro ne “Il Tremacoldo”, a. I, n. 28, 1856. Cfr. M.P. Pavone, Storiografia artistica a Messina nell’Ottocento: Carmelo La Farina, Giuseppe Grosso Cacopardo, Carlo Falconieri e Giuseppe La Farina, in “ASM”, 52, 1988, p. 28. 50 Per la bibliografia relativa si veda G. Molonia, La stampa periodica a Messina (1808-1863) – Dalla «Gazzetta Britannica» alla «Gazzetta di Messina», Di Nicolò, Messina 2004; cfr. anche La produzione bibliografica. Premessa all’esposizione bibliografica in Mostra sulla cultura…, pp. 44-53. 51 Per la bibliografia relativa cfr. M. Accascina, Profilo dell’architettura a teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 68 numero 3 - maggio 2011 Messina dal 1600 al 1800, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1964, cap. VI e relative note, pp. 228-229; F. Basile, Lineamenti della storia artistica di Messina. La città dell’Ottocento, Edizioni Leonardo, Roma 1960, con esauriente bibliografia in nota. 52 V. Saccà, La Cattedra di Belle Arti nella Università di Messina, Tipografia D’Amico, Messina 1900, p. 96. 53 M.P. Pavone, Storiografia artistica in Mostra sulla cultura…, pp. 40-43. 54 Ibid. 55 Del 1829 una memoria archeologica in una lettera indirizzata a Giuseppe Bertini, Direttore del “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia” intitolata Su una antica iscrizione scoperta in Messina e che oggidì si conserva nel Museo Peloritano. Lettera del Dott. Carmelo La Farina Prefetto dello stesso all’Ab. Giuseppe Bertini, in “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia”, 1829, t. 25, f. 73, pp. 76-78 (estratto dal “Giornale Letterario di Sicilia”, n. LXXIII, Palermo MDCCCXXIX, ristampato con aggiunte nel 1832). Cfr. E. Braun, Archeologia. Scavi taorminesi, in “Il Faro che siegue lo Spettatore Zancleo. Giornale di Scienze Lettere e Arti”, a. IV, vol. I, 1836, pp. 251-253; G. La Farina, Messina e i suoi…, 1840, p. 75; G. Rizzo, Iscrizioni tauromenitane, in “ASM”, IV, 1903, ff. 1-2, p. 108. 56 C. La Farina, Sopra una scaturigine di acqua sulfurea in Messina ed analisi di essa acqua, in “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia”, 1823, tomo 2, n. 53, fasc. 4, pp. 82-83. 57 I periodici siciliani dell’Ottocento. Periodici di Palermo, vol. I, a cura di P. Travagliante, C.u.e.c.m., Catania 1995, p. 24. 58 C. La Farina, Messina. Biografia di Tommaso…, pp. 197-200. 59 Id., Su di un antico sarcofago…, 1822. 60 Id., Sposizione di alcune lapidi sepolcrali rinvenute in Messina nel largo di S. Giovanni Gerosoliminitano di Carmelo La Farina, Segretario Generale della Reale Accademia de’ Pericolanti, Prefetto del Museo Peloritano e Corrispondente della Commissione di Antichità e Belle Arti, per A. D’Amico Arena, Messina 1832. Cfr. I. Bitto, Le iscrizioni greche e latine di Messina, vol. I, Di.Sc.A.M, Messina 2001, pp. 87-94, nn. 29-32. 61 Id., Sopra un anello segnatorio. Considerazioni, Stamperia G. Fiumara, Messina 1844. 62 Id., Rassegna critica. Antichità termitane. Esposte da Baldassarre Romano, Palermo un vol. in 8° di pag. 175 con 2 tavole, in “Sentinella del Peloro. Foglio Periodico”, a. I, 2° sem., n. 29, Messina 15 Aprile 1841, pp. 229-231. 63 Edita per i tipi di Michelangelo Nobolo, la “Sentinella del Peloro. Foglio Periodico” con il motto “Avanti”, dal 1 ottobre 1839 al n. 30 del 30 aprile 1841. Sebbene fossero previste 36 uscite annue la pubblicazione fu molto irregolare: tra gennaio e luglio 1840 furono pubblicati solo 10 numeri. Tra il 1839 e il 1841 ospitò numerosi saggi di storia dell’arte di Giuseppe La Farina, tra i quali Messina e i suoi…, (1840) che fu gravemente censurato. Cfr. G. Molonia, La stampa periodica…, p. 116-117. 64 I «monumenti di antichità del medioevo» per cui la Commissione di Antichità e Belle Arti «promuoverà e regolerà i ristauri; imprenderà e regolerà gli scavamenti di antichità di pubblica appartenenza», ponendoli per la prima volta sullo stesso piano di quelli «di archeologia», solo dopo il maggio 1863, quando l’allora Ministro per la pubblica Istruzione Michele Amari emanò un rivoluzionario regolamento specifico per la Sicilia per la tutela del patrimonio culturale che comprendeva anche l’introduzione di un moderno sistema di catalogazione degli oggetti d’arte. La Commissione provinciale di Messina fu istituita col Regio Decreto n. 2885 del 23 dicembre 1875. Si veda anche Regio decreto 3 maggio 1863 n. 772 che approva il regolamento della Commissione di Antichità e Belle Arti della Sicilia, Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale di Antichità e Belle Arti, Roma, I vers., b. 501; cfr. F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni…, pp. 57-58. 65 C. La Farina, Discorso Accademico…, sec. XIX, p. 449 [2002, pp. 100-101]. 66 Tra le pagine dello “Spettatore Zancleo” Giuseppe La Farina esplicita in un articolo intitolato Il romanticismo dello spettatore, ciò che «intendiamo noi per romanticismo […] quel sistema che pone il bene per fine di ogni scienza ed arte, il bello per mezzo, l’inspirazione per principio […]. Il nostro romanticismo è quello che si addice ad un uomo che non degrada se stesso, è quel sistema che mira a perfezionamento, che tende a progresso, che (come li appella il compagno Silvio Pellico)[Silvio Pellico fu prigioniero nel carcere dello Spielberg insieme a Giorgio Guido Pallavicino Trivulzio, che fu presidente della Società nazionale italiana fondata da Giuseppe La Farina insieme a Daniele Manin. L’associazione si poneva come obiettivo l’unificazione e l’azione popolare, ribadendo il principio dell’indipendenza italiana, promuovendo la posizione moderata di Cavour a discapito dei metodi insurrezionali mazziniani; disponeva di un suo organo periodico: “Il Piccolo corriere d’Italia”] dominerà l’Europa, perché nasce dal Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 69 numero 3 - maggio 2011 69 K. Pomian, Collezionisti, amatori…, pp. 47. 70 F. De Stefano, Storia della Sicilia dall’XI al XIX secolo, a cura di F.L. Oddo, Laterza, Bari 1977, p. 263. 71 F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni…, p. 45. 72 Nella seconda metà del secolo si avrà un’intensificazione delle operazioni volte alla tutela, ma anche al ripristino, degli edifici di epoca medioevale, molto trasformati da interventi seguiti al terremoto del 1783. Con Giuseppe Patricolo (Palermo, 1834-1905) alla guida dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti dal 1884 si assistette a Messina al compimento di numerose campagne di restauro «con la stimolante prospettiva di poter finalmente porre a confronto l’architettura normanna palermitana con gli esempi più tardi della città peloritana». Tra gli esempi più pregnanti a Messina, si citano i restauri del Duomo ad opera di G. Patricolo. Cfr. G. La Monica, Giuseppe Patricolo restauratore, ILA Palma, Palermo 1985, di San Francesco, di Santa Maria degli Alemanni, di Santa Maria della Scala, dell’Annunziata dei Catalani. Cfr. M.A. Oteri, La cultura neomedievalista a Messina nell’Ottocento e i restauri della chiesa di S. Francesco d’Assisi, in Francescanesimo e Cultura nella provincia di Messina, atti del Convegno di studio (Messina 6-8 novembre 2008), Biblioteca francescana – Officina di studi medievali, Palermo 2009, p. 219 e pp. 213-224. 73 Cfr. C. La Farina, Intorno le Belle Arti…, 1835 e in part. Lettera VI. Si purga di talune mende la biografia di Filippo Tancredi. Al chiaro e gentile Felice Bisazza, pp. 47-56; Lettera IX. Si stabilisce l’epoca della morte di Antonio Catalano, ed altra pittura si produce di Gaspare Camarda. Al chiarissimo Giuseppe Grosso Cacopardo pp. 72-74; Lettera XI. Si producono alcuni dipinti di G. Simone Comandè, del Van-Houbracken, del Bova, del Menniti. Al Chiarissimo Dr. Francesco Arrosto, pp. 81-83; Lettera XII. Si fissa l’anno del ritorno in patria del famoso dipintore Antonino Barbalonga da Messina. Al Valoroso Artista Tommaso Aloisio, pp. 84-90; Id., Lettera XIV. Si producono per la prima volta talune statue di Gio. Battista Mazzolo, scultore messinese, e si corregge un trascorso del Vasari nella vita del Frate Montorsoli. All’alacre ingegno di Giuseppe Arifò, in “Lo Spettatore Zancleo. Giornale Periodico”, a. III, n. 29, 29 luglio 1835, pp. 228-231; Id., Lettera XV. Si corregge da talune mende la biografia di Onofrio Gabriele, pittore da Messina. Al Chiarissimo Dr. Carlo Gemellaro Professore di Storia Naturale nella R. Università degli Studi in Catania, in “Il Faro che siegue lo Spettatore Zancleo. Giornale di Scienze Lettere ed Arti”, a. IV, vol. I, 1936, pp. 37-49; Id., Lettera XVI. Memorie del dipintor presente stato di civiltà e non vi è forza umana che possa far gire retrogrado un popolo quando una forza morale a perfezionamento lo sospinge». G. La Farina, Il romanticismo dello spettatore, in “Spettatore Zancleo”, 1835, a. III, n. 10, pp. 7576; P. Barocchi, Testimonianze e polemiche figurative in Italia, G. D’Anna, Messina, Firenze 1972, pp. 71 e ss.; Ead., Storia moderna dell’arte in Italia. Manifesti polemiche documenti.Dai neoclassici ai puristi 1780-1861, vol. I, Giulio Einaudi Editore, Torino 1998; S. Bordini, L’Ottocento 1815-1880, Carocci, Roma 2002, pp. 41-47; C. Savettieri, Dal Neoclassicismo al Romanticismo, Carocci, Roma 2006, pp. 132-153. Giuseppe La Farina, patriota, figlio di Carmelo, nacque a Messina nel 1815. Nel 1835 si laureò in giurisprudenza nell’Università di Catania. Partecipò attivamente al dibattito tra classicisti e romantici e curò tra le pagine de “Lo Spettatore Zancleo” le recensioni di opere letterarie, storiche, musicali, teatrali, i resoconti di avvenimenti artistici e culturali ed una rubrica fissa intitolata “Rassegna di giornali siciliani”. Partecipò al movimento insurrezionale antiborbonico del 1837, a seguito del quale fu costretto a lasciare Messina e a stabilirsi a Firenze. Nel marzo 1838 tornò a Messina, ma nel 1841 nuovamente accusato di cospirazione, fu costretto a tornare a Firenze dove rimase fino al febbraio del 1848. Tornato in Sicilia fu chiamato a far parte, come deputato messinese, del nuovo Parlamento di Palermo. Assunse il Ministero della Pubblica Istruzione e fece anche parte della missione diplomatica inviata in alcune capitali della penisola per raccogliere consensi verso il governo siciliano. Fu, per un anno, alla direzione del ministero della Guerra. Per cinque anni fu esule prima a Marsiglia, poi a Parigi e infine a Tours. Nel 1854 si trasferì a Torino. Dopo l’ingresso di Garibaldi a Palermo nel 1860, Cavour gli diede il delicato incarico di rappresentare in Sicilia il governo, dal quale fu cacciato. Nel 1861 fu eletto deputato e poi vice presidente della Camera. Morì a Torino il 5 settembre 1863. Le sue ceneri furono portate a Messina nel 1872 in occasione dell’inaugurazione del Gran Camposanto. Per G. La Farina si veda Giuseppe La Farina, Atti del convegno di Studi (Messina, 21-22 maggio 1987), a cura di P. Crupi, Pungitopo, Marina di Patti 1989. 67 «Mi conforta il riflettere non esser nuovo in Italia il pensiero di raccogliere ogni documento storico o notizia riguardante l’arte del disegno, […] sia di una città o provincia che, dell’intera nazione». Cfr. C. La Farina, Discorso Accademico…, 2002, p. 86, nota 16. 68 C. De Benedictis, Per la storia…, p. 133. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 70 numero 3 - maggio 2011 da Firenze Filippo Paladini. Al chiarissimo professore Salvatore Betti Segretario perpetuo dell’Accademia Pontificia di S. Luca, in “Il Faro. Giornale di Scienze, Lettere ed Arti”, a. IV, t. II, n. VIII,1836, pp. 65-77. 74 C. La Farina, Intorno le Belle Arti…, 1835, p. 64 e in part. Lettera VII. Si adducono…, pp. 57-65. 75 Ibid., e in part. Lettera IV. Di alcuni dipinti di Antonio Catalano finor sconosciuti, e di altri a lui non direttamente attribuiti. Al culto e gentile Giuseppe Grosso Cacopardo, pp. 37-42; Lettera V. Si aggiunge Francesco Laganà al novero dei pittori messinesi, e si annunciano altri dipinti di Andrea Quagliata. All’Onorando Ab. Placido Vasta, pp. 4346; Id., Intorno le Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina. Ricerche di C. La Farina ordinate in più lettere, parte II, Messina 1835-1845 e in part. Lettera XIII. Si tiene parola del messinese dipintore Stefano Giordano, e della Cena del Signore dallo stesso condotta. Al Chiarissimo Dr. Anastasio Cocco, in “Lo Spettatore Zancleo. Giornale Periodico”, a. III, n. 24, 17 giugno 1835, pp. 190-191. 76 Pavone precisa che Carmelo La Farina manifesta una notevole soddisfazione in occasione dell’acquisto del manoscritto degli Annali del Gallo da parte dell’Accademia Peloritana. Cfr. M.P. Pavone, Aggiunte alla storiografia…, p. 86, nota 13. 77 G. Buonfiglio e Costanzo, Messina, Città Nobilissima descritta in viii libri, (Venezia1606), rist. anast., a cura di P. Bruno, G. B. M., Messina 1985. 78 P. Samperi, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio protettrice di Messina, Messina 1644. Cfr. la rist. anast. in 2 voll. con introduzioni di G. Lipari, E. Pispisa, G. Molonia, Intilla, Messina 1990 e Id., Messana S.P.Q.R. Rerumq. Decreto Nobilis Exemplaris et Regni Siciliae Caput Duodecim titulis illustrata. Opus posthumum r. p. Placidi Samperii Messanensis Societatis Jesu in duo volumina distributum…2 voll., typis Rev. Cam. Archiep. Placidi Grillo, Messina 1742. 79 C.D. Gallo, Annali della Città di Messina Capitale del Regno di Sicilia, vol. I, Messina 1756 (contiene l’Apparato agli Annali…), vol. II, 1758; vol. III, 1804; vol. IV 1875. Cfr. Annali della Città di Messina, Tipografia Filomena (poi Reale Accdemia peloritana, poi Società messinese di storia patria), Messina 1877-1882. 80 A differenza di Grosso Cacopardo, nella Lettera XIV. Si producono per la prima volta…, La Farina è critico nei confronti dello storiografo toscano, cui accusa un’imprecisione relativamente alla vita del Montorsoli, quando scrive «avendo trovato [i messinesi] un uomo secondo il gusto loro, diedero, finite le fonti, principio alla facciata del Duomo, tirandola alquanto innanzi». Lo studioso precisa che sull’architrave della porta a sud ovest è riportato l’anno di costruzione, 1518, e che il 1528 è indicato sull’architrave della porta laterale, ricordando che il Montorsoli giunse a Messina solo nel 1547; cfr. G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino illustrate con note di Mons. Giovanni Gaetano Bottari e P. Della Valle. Con la Vita dell’autore scritta da lui medesimo e l’introd. Alle tre arti del disegno, architettura, scultura e pittura, 16 voll., Societa tipografica de’ classici italiani, contrada di s. Margherita, no 1118, Milano 1807-1811, t. 13, p. 580. Dalle ricerche documentarie (Registri senatori del 1534 e 1535, vol. 28, fol. 42, cfr. C. La Farina, Intorno alle Belle Arti…, 2004, pp. 155-156, nota 9) La Farina desume inoltre che nel 1534 il Mazzolo realizzò tre delle quattordici statue marmoree per la porta maggiore del Duomo; in “Lo Spettatore Zancleo”, a. III, n. 29, Messina 29 luglio 1835, pp. 228-231. Cfr. anche F. Caglioti, Due opere di Giovambattista Mazzolo nel Museo regionale di Messina (ed una d’Antonello Freri a Montebello Jonico) in Aspetti della scultura a Messina dal XV al XX secolo, a cura di G. Barbera, “Quaderni dell’attività didattica del Museo Regionale di Messina”, 13, 2003, pp. 37-60; S. Di Bella, Scultori ed opere da alcuni documenti d’archivio, ibid., pp. 155-164; S. La Barbera, La scultura della Maniera a Messina. Note di letteratura artistica, ibid., pp. 135-154; Ead., La scultura della Maniera nella letteratura artistica messinese, in AA.VV., Fontane d’acqua a Messina, Catalogo della mostra a cura di G. Barbera, Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali, Messina 2004, pp. 133-152. Confuta anche le imprecisioni riguardo alle note biografiche di Filippo Paladini, e in particolare Lanzi che riferendo quanto scrive Gregorio (Discorsi intorno alla Sicilia di Rosario di Gregorio abbate di S. Maria di Roccadia e Professore del diritto publico siciliano della R. Università di Palermo. Con discorsi inediti, Pedone e Muratori, Palermo, t. I, p. 210) gli attribuisce il San Giuseppe di Casteltermini, opera del trapanese Andrea Carreca, per il quale chiede un parere ad Agostino Gallo: «Mi occorre pregarvi per una nota delle dipinture così esistenti di F. Paladini, e s’è possibile con la indicazione degli anni della loro esecuzione, dovendomi valere in un articolo che vado a scrivere su quest’artista, di cui la biografia scritta dal Grosso contiene a mio avviso diverse lagune, ed inesattezze». Cfr. Lettera di Carmelo La Farina ad Agostino Gallo, 20 agosto 1835, ms. sec. XIX, QqG 10 110 della Biblioteca Comunale di Palermo. Cfr. Lettera XVI. Su Filippo Paladino, in “Il Faro. Giornale di Scienze, Lettere ed Arti”, a. IV t. II, n. VIIII, 1836, pp. 65-77. Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 71 numero 3 - maggio 2011 84 Lionardo Vigo nelle Lettere di L.V. a Ferdinando Malvica sopra una gita da Catania a Randazzo, in “Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia”, t. X, f. 29 (Palermo maggio 1934, pp. 196-218) scambia il San Michele arcangelo con l’angelo Custode. 85 C. La Farina, Lettera XV. Si corregge da talune mende…, 1836, pp. 37-49. Sulle lettere artistiche di Carmelo La Farina, cfr. infra. 86 Confuta Grosso Cacopardo (Memorie de’ pittori messinesi e degli esteri che in Messina fiorirono dal secolo XII sino al secolo XIX, Messina 1821, p. 134) che data il rientro a Messina al 1662. 87 Domenico Marolì (Messina 1612 - Scaletta Zanclea (Me) 1676). Allievo di Antonello Riccio, studiò anche a Venezia presso il Veronese. Operò a Bologna. Ridotto in schiavitù dai turchi che assalirono la nave che lo riportava in patria, riuscì a tornare a Palermo, dove realizzò numerosi dipinti. Rientrato a Messina fu coinvolto negli avvenimenti politici del 1674 e dovette emigrare. Ritornò prima a Venezia e morì in Spagna durante i moti del 1676. Per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in L. Sarullo, Dizionario artistico dei siciliani. Pittura, a cura di M.A. Spadaro, Novecento, Palermo 1993, pp. 334-335; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 547. 88 L. Lanzi, Storia Pittorica della Italia…, vol. I, p. 468, nota 2. 89 Antonio Catalano detto “l’Antico” (1560 - 1630). Per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in Dizionario artistico..., 2, pp. 87-88; T. Pugliatti, La pittura del Cinquecento in Sicilia. La Sicilia orientale, Electa, Napoli 1993, pp. 256-269, 337, note. 4-5; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 251. 90 C. La Farina, Lettera IX. Si stabilisce l’epoca…, 1835, pp. 72-74. 91 Domenico Cardillo, ad vocem in Dizionario artistico..., 2, p. 74. L’opera è certamente databile alla seconda metà del XVI secolo, data la presenza nel paesaggio di sfondo della lanterna del porto nel braccio di S. Raineri, costruita su disegno del Montorsoli nel 1555. Oggi la firma citata da La Farina è illeggibile, essendo andata distrutta la parte inferiore della tavola. Cfr. Cardillo, ad vocem in D.B.I., 19, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1976, pp. 770-772. 92 Il dipinto, citato in Messina e dintorni. Guida a cura del Municipio, Prem. stab. G. Crupi, Messina 1902, pp. 383, risulta disperso. T. Pugliatti, Arte e storia nella provincia di Messina, Samperi, Messina 1986, pp. 56, 72, precisa che nella chiesa esiste ancora il dipinto attribuito al Camarda raffigurante l’Immacolata e 81 La Farina consultò l’opera di Lanzi nella sesta edizione: L. Lanzi, Storia Pittorica della Italia, 6 voll., Milano, G. Silvestri, 1823. Cfr. C. Gauna, La Storia Pittorica di Luigi Lanzi. Arti Storia e Musei nel Settecento, L.S. Olschki, Firenze 2003. Nella Lettera I. Su i pittori Francesco e Stefano Cardillo da Messina La Farina è estremamente polemico nei confronti del Lanzi. Scrive infatti: «Non è a dirsi quanta diligenza, ed amore ci vogliono in questi benedetti studî, quanto lieto ozio, e sorriso di fortuna; ma quanta più pacatezza, e meno slancio, e meno impeto nel giudicare: nel giudicare quindi in siffatte cose ci vuol fermezza, e non interrotte ricerche, e studio i vecchi archivî, che mal si adattano ad occhi infermi, come quelli ad esempio, che invece di compilare delle opere le copiano, e non le san copiare, e certi altri di cui giova far silenzio.» (Intorno alle Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina Ricerche di Carmelo La Farina ordinate in più lettere, Stamperia Fiumara, Messina 1835, p. 3). Per Lanzi si veda L. Lanzi, Storia Pittorica della Italia dal Risorgimento delle Belle Arti fin presso la fine del XVIII secolo, 6 voll. (Bassano 1795-1809), ed. a cura di M. Capucci, 3 voll. Sansoni editore, Firenze 1968-1974; G. Perini, Luigi Lanzi: questioni di stile, questioni di metodo, in Gli Uffizi: quattro secoli di una galleria. Fonti e documenti, atti del convegno internazionale di studi, (Firenze 20-24 settembre 1982), a cura di P. Barocchi e G. Ragionieri, Bonechi Editoriale, Firenze 1982, pp. 215-265; Sulle diverse edizioni della Storia Pittorica cfr. P. Barocchi, Sulla edizione lanziana della Storia pittorica dell’Italia, 1795-1796, in “Annali della Scuola Normale Superiore. Classe di lettere e filosofia”, s. IV, quaderni nn. 1-2, (Giornate di studi in onore di Giovanni Previtali, a cura di F. Caglioti), 2000, pp. 293-319; Ead., Sulla edizione del 1809 della “Storia pittorica dell’Italia” di Luigi Lanzi, in “Saggi e Memorie di storia dell’arte”, n. 25, 2001, pp. 297-307; M. Rossi, Le fila del tempo. Il sistema storico di Luigi Lanzi, in “Quaderni della Fondazione Carlo Marchi”, n. 31, L.S. Olschki, Città di Castello (PG) 2006, pp. 57-92. 82 Per la critica delle fonti, l’originalità dell’opera d’arte contrapposta alla copia, l’osservazione di opere d’arte tra spiritualità e tecnica nella letteratura critica del tempo si veda, ad esempio, K.F. von Rumohr, Italienische…. 83 Onofrio Gabrieli (Gesso (Me) 1619 - 1706). Si veda Onofrio Gabrieli 16191706, catalogo della mostra a cura di G. Barbera e F. Campagna Cicala (Gesso (Me), 27 Agosto-29 Ottobre 1983), Industria Poligrafica della Sicilia, Messina 1983; ad vocem in D.B.I., 51, Catanzaro 1998, pp. 68-70; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, 2006, p. 429. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 72 numero 3 - maggio 2011 Santi, attribuito con certezza da G. La Farina, Messina e i suoi…, p. 154. 93 Gaspare Camarda (1570 ca. - 1655), allievo di Antonio Catalano, quando scrive La Farina era documentato solo fino al 1606. Per la sua figura e la bibliografia a lui correlata si veda ad vocem in Dizionario artistico…, 2, pp. 65-66; T. Pugliatti, La pittura del Cinquecento…, pp. 264-266. 94 C. La Farina, Lettera IX. Si stabilisce l’epoca…, 1835, pp. 72-74. 95 Agostino Gallo (Palermo 7 febbraio 1790 - 16 maggio 1872) collezionista di quadri, libri, cimeli di ogni tipo relativi alla storia, alla cultura e all’arte siciliana. Raccolse 152 ritratti ad olio di siciliani illustri che donò alla Biblioteca comunale di Palermo. La sua collezione di 103 quadri fu invece donata al Museo nazionale e oggi è conservata presso la Galleria regionale di Palazzo Abatellis. Fra le molte sue opere riguardanti la letteratura, la storia, l’archeologia, l’arte, le poesie, le liriche, le biografie, i saggi di critica d’arte, ricordiamo il Saggio su pittori siciliani vissuti dal 1800 al 1842 del 1842, e la manoscritta Storia delle Belle Arti in Sicilia dall’epoca greca sino al secolo XIX, oggi edita a stampa (a cura di A. Mazzè, Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione, Palermo 2000). Membro di moltissime accademie e associazioni culturali, italiane e straniere, collaborò a numerose pubblicazioni periodiche, fra le quali “L’Ape. Gazzetta letteraria di Sicilia” (1822), il “Giornale di scienze, lettere e arti per la Sicilia (1832-1840) e “L’Indagatore siciliano”. Promosse la realizzazione di un Pantheon di glorie siciliane nella chiesa di S. Domenico, in cui fossero eretti monumenti commemorativi ai siciliani più illustri e oggi è lì sepolto, ricordato da un mezzobusto opera di Benedetto Civiletti. Per la figura di Agostino Gallo e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem Dizionario dei siciliani illustri, F. Ciuni, Palermo 1939, pp. 236-237; ad vocem in D.B.I., 51, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Catanzaro 1998, pp. 697-699; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, pp. 433-434; F.P. Campione, Agostino Gallo: un enciclopedista dell’arte siciliana, in La critica d’arte dell’Ottocento, a cura di S. La Barbera, Flaccovio, Palermo 2003, pp. 107-127. 96 Pietro Lanza Branciforti, Principe di Scordia, di Trabia e di Butera (Palermo 19 agosto 1807 - Parigi 27 giugno 1855). Letterato, politico patriota, fu, giovanissimo, direttore della sezione Lettere ed Arti nell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti e della Commissione Antichità e Belle Arti. Dal 1835 al 1837 fu Pretore di Palermo ed in seguito, dal 1841 al 1848, ministro degli Affari ecclesiastici per il Regno delle due Sicilie. Attivo durante i moti del 1848, durante il governo provvisorio assunse la presidenza del Quarto comitato (amministrazione civile, istruzione pubblica e commercio). Costretto all’esilio dopo la restaurazione borbonica, morì a Parigi. Numerosi i suoi scritti di natura storica e letteraria; si ricordano in particolare Degli Arabi e del loro soggiorno in Sicilia del 1832, apprezzato da Michele Amari, e Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1532 al 1789 da servir d’aggiunte e di chiose al Botta del 1836. Per la figura di Pietro Lanza e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in Dizionario dei siciliani…, p. 287. 97 Lazzaro Di Giovanni (Palermo 1769 - 5 novembre 1856), intellettuale e conoscitore del patrimonio artistico cittadino, fu «custode e intendente di Belle Arti della collezione d’arte dell’Università di Palermo, nucleo iniziale del futuro Museo Nazionale insieme alla raccolta di Giuseppe Ventimiglia e Cottone, principe di Belmonte, di cui il Di Giovanni fu fidecommissario. Redasse l’inventario della collezione e curò l’allestimento nei locali dell’università adibiti a pinacoteca, riordinò la raccolta di disegni. Ufficiale della Regia Segreteria di Stato della Sicilia dal 1815 fino alla morte, sospese l’incarico nel 1820, probabilmente per la partecipazione ai moti rivoluzionari palermitani. Membro della Commissione di Antichità e Belle Arti, curò il restauro del Paradiso di Pietro Novelli. Scrisse un circostanziato inventario delle opere d’arte esitenti nelle chiese di Palermo, che lasciò manoscritto». Per la figura di Lazzaro Di Giovanni e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in D.B.I., XV, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1991, p. 43; L. Di Giovanni, Le opere d’arte nelle chiese di Palermo, trascrizione e commento critico a cura di S. La Barbera, Flaccovio, Palermo 2000. 98 Giuseppe Grosso Cacopardo (Messina 2 settembre 1789 - 18 dicembre 1878), fu storico dell’arte, erudito, archeologo. Continuatore dell’opera del Grano Memorie de’ pittori messinesi (1821), fu anche autore della prima Guida per la città di Messina (1841). Fondatore e redattore del “Maurolico”. Per la figura di Giuseppe Grosso Cacopardo e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in Dizionario dei siciliani…, 1939, pp. 259-260; ad vocem in D.B.I., LX, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2003, pp.11-13. 99 Per la figura di Placido Vasta, si veda G. Oliva, Annali della città di Messina…, vol. VIII, 1954, pp. 351-352. 100 Nicolò Americo Fasani, fu «Uffiziale di carico nella real Segreteria Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 73 numero 3 - maggio 2011 Grano, estratto da “Il Maurolico, Giornale del Gabinetto Letterario di Messina”, n.s., a. I, f. 7, 1842; G. Noto, Elogio del dotto prelato monsignore don Gaetano Grano, Firenze, co’ tipi di G. Marenich, 1828; G. Oliva, Annali della città di Messina…, p. 240-243. 103 Francesco Arrosto (Messina 2 luglio 1798 - marzo 1840), successe al padre Gioacchino alla cattedra di chimica della reale Accademia Carolina che gli fu tolta a seguito della sua partecipazione ai moti del 1837. Fu membro effettivo della Società economica della valle di Messina che gli assegnò il premio “Paolo Cumbo”. Fu membro della Labronica di Livorno e socio benemerito della Reale Accademia peloritana in cui, dal 1829, ricoprì la carica di segretario per la classe di scienze fisiche e matematiche. Per la figura di Francesco Arrosto e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in Dizionario dei siciliani…, pp. 48-49; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 130. 104 Tommaso Alojsio Juvara (Messina 13 gennaio 1809 - 30 maggio 1875), incisore, formatosi alla scuola del Camuccini, fu presidente della Calcografia Camerale. Insegnò calcografia a Messina nel ’46, a Napoli nel ’50 e a Roma nel ’72, condividendo la carica di Direttore con Paolo Mercuri. Tra le sue opere più celebri, la Madonna alla Reggia di Napoli e il San Carlo Borromeo, di fronte alle quali si suicidò nel 1875. Per la figura di Tommaso Alojsio Juvara e per la bibliografia a lui relativa si veda Litografia, in “Passatempo per le Dame”, a. 4, n. 28, 9 luglio 1836, pp. 125-126 [ma 225-226]; A. Gallo, Lettera di Agostino Gallo all’egregio incisore Tommaso Aloisio Messinese professore d’intaglio in Napoli, in “La Lira”, a. I, n. 51, 6 novembre 1852, pp. 203-204; Id., Sull’influenza ch’esercitarono gli artisti italiani in varii regni d’Europa ad introdurvi, diffondervi o migliorar l’arte d’intagliar cammei in pietre dure e tenere, incidere in rame, cesellare e smaltare in argento e in oro, Tipografia Barcellona, Palermo 1863, p. 13; A. Gallo, Notizie degli incisori siciliani, a cura di D. Malignaggi, Università degli studi di Palermo, Palermo 1994, pp. 125-128. T. Aloysio-Juvara, Della storia e dello stato odierno dell’arte dell’incisione, in “Nuove Effemeridi Siciliane di Scienze, Lettere ed Arti”, a. I, dispense IX-X, dicembre 1869 - gennaio 1870, pp. 404-416; ad vocem in Dizionario dei siciliani…, p. 276; ad vocem, in Allgemeines Lexikon der bildender Kunstler, a cura di U. Thieme - F. Becker XIX, F. Ullmann, Leipzig 1926, pp. 357-358; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 511; Neoclassicismo e aspetti accademici. Disegnatori e incisori siciliani, a cura di D. Malignaggi, Università degli studi di Palermo, Palermo 2004. e Ministero di Stato dell’Interno di Napoli». Cfr. G. Molonia, Intorno alle Belle Arti…, p. 101, nota 1. 101 Giuseppe Alessi (Enna 1 febbraio 1774 - Catania 31 agosto 1837), sacerdote e canonista, fu geologo, archeologo e numismatico. Iscritto a numerose accademie italiane e straniere, insegnò Diritto Canonico all’Università di Catania. Lasciò la sua collezione geologica all’Accademia Gioenia di Catania e la biblioteca e la raccolta di reperti archeologici alla Chiesa Madre di Enna. Tra i suoi scritti ricordiamo la Storia Critica della Sicilia dai tempi favolosi alla caduta dell’Impero Romano, 2 voll., dai torchi dei FF. Sciuto, Catania 1834-1843. Per la figura di Giuseppe Alessi e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in Dizionario dei siciliani…, p. 27; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, pp. 101-102. 102 Gaetano Grano, (Messina, 21 novembre 1754 - 13 marzo 1828) medico, ma anche latinista, letterato, storico, antiquario, studioso di numismatica e paleografia, di storia naturale, fisica, filosofia e legge. Fu precettore di retorica nella Reale Accademia Carolina, della quale, nel 1780, gli fu conferita la carica di bibliotecario, che mantenne fino alla morte nel 1828. Fu più volte Presidente dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti e Socio dell’Accademia degli Zelanti di Acireale. Nel 1806 contribuì alla fondazione del Museo Civico Peloritano. Ricoprì numerosi incarichi istituzionali e non: Priore di S. Maria della Latina (1786), Giudice ecclesiastico della Regia Udienza (1789) , Giudice delegato della Regia Monarchia in Messina (1791), Membro della commissione per la compilazione dei codici del Regno delle Due Sicilie e Giudice Interno del Regio Tribunale di Monarchia in Sicilia (1814), Abate-Regio Priore di S. Andrea di Piazza, Vescovo in Partibus della Santissima Basilica di Terra Santa, Consigliere del Re delle Due Sicilie Ferdinando IV di Borbone (1817). Nel 1821 Luogotenente Generale in Sicilia, carica da lui rifiutata. In contatto con numerosi personaggi di rilievo della cultura del tempo come Domenico Scinà, Saverio Landolina ed Rosario Gregorio. Coadiuvò Jakob Philipp Hackert nella stesura delle Memorie De’ Pittori Messinesi (Messina 1792), anche se non volle che il suo nome vi figurasse. Collaborò anche con l’Abate Lazzaro Spallanzani alla redazione dei Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino”. Da segnalare la Guida alla Città di Messina, anche questa pubblicata anonima nel 1826. Possessore di una pregiatissima collezione naturalistica e di una ricca pinacoteca purtroppo dispersa. Cfr. ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 466; V. Scarcella, Cenni biografici di mons. Gaetano teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 74 numero 3 - maggio 2011 105 La prima raccolta riporta in copertina Ricerche di Carmelo La Farina ordinate in più lettere, mentre sul frontespizio appare la dicitura Intorno Le Belle Arti, e gli Artisti fioriti in varie epoche in Messina - Ricerche di Carmelo La Farina ordinate in più lettere. Stampata a Messina nel 1835 dai torchi dei Fiumara, fu annunciata da Felice Bisazza tra le pagine dello “Spettatore Zancleo” nella rubrica Rivista Letteraria (“Lo Spettatore Zancleo”, III, n. 25, 1 luglio 1835, p. 93), e fu recensita da molte riviste dell’epoca. Una Seconda Parte fu raccolta da Gaetano La Corte Cailler che la intitolò Intorno le Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina - Ricerche ordinate in più lettere, Parte II, Messina 1835-1845 che però non fu mai pubblicata. 106 Recensione di S. Betti, Intorno le Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina; ricerche di Carmelo La Farina ordinate in più lettere - Messina 1835 dalla Stamperia Fiumara, in “Il Faro. Giornale di Scienze, Lettere ed Arti”, a. IV, t. II, 1836, pp. 98-99; pubblicato anche in C. La Farina, Intorno alle Belle Arti…, 2004, pp. 229-230; Recensione di G. Di Lorenzo, Intorno le Belle Arti, e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina; ricerche di Carmelo La Farina ordinate in più lettere - Messina 1835 dalla Stamperia Fiumara, in -8° di pag. 93, in “Giornale di scienze, letteratura ed arti per la Sicilia”, a. XIII, vol. 50, t. II, aprile - maggio - giugno 1835, pp. 207-210. 107 Gaetano La Corte Cailler (Messina 1 agosto 1874 - 26 gennaio 1933) inizia giovanissimo a collaborare con alcuni giornali locali, scrivendo di storia ed arte messinese e nel 1898 ottiene un impiego come copista presso la Cancelleria del Tribunale di Messina. Nel 1899 è nominato socio ordinario della Reale Accademia Peloritana ed è socio fondatore e firmatario del primo Statuto sociale della Società Messinese di Storia Patria. Nel 1901 viene immesso in servizio come guardasala al Civico Museo Peloritano, allora ospitato nel soppresso monastero di S. Gregorio, di cui compila una guida. Diviene direttore nel 1904. Nel 1902 il Municipio pubblica la Guida di Messina e dintorni del quale La Corte Cailler è uno dei maggiori estensori. Strenuo ricercatore di documenti d’archivio riguardanti la storia e la cultura artistica di Messina, dopo il terremoto del 1908, la famiglia si trasferisce a Palermo per pochi anni. Ritornato a Messina, il 2 giugno 1910 ricostituisce, con i pochi amici sopravvissuti, la Società Messinese di Storia Patria. Ricopre numerosi ruoli: ispettore onorario comunale di Antichità e Belle Arti, componente della Commissione conservatrice dei monumenti, degli scavi ed oggetti di antichità ed arte della Provincia di Messina, ispettore bibliografico onorario. Per G. La Corte Cailler si veda “ASM”, III serie, XXXII, 41, Messina 1983, volume interamente dedicato alla sua figura, e in particolare: G. Molonia, Gaetano La Corte Cailler: note biografiche, ivi, pp. 17-27; G. La Corte Cailler, Il mio Diario, a cura di G. Molonia, 3 voll., Edizioni g. b. m., Messina 1998-2003; S. La Barbera, Dalla coinnosseurship alla nascita della Storia dell’arte in Sicilia: il ruolo di Adolfo Venturi, in Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi, Atti del Convegno (Sapienza Università di Roma, 25-28 ottobre 2006) a cura di M. D’Onofrio, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2008, pp. 309-328. 108 Anastasio Cocco (Messina 29 agosto 1799 - 26 febbraio 1854) fu farmacologo e naturalista. Nel 1819, a vent’anni, fu ammesso all’Accademia Peloritana dove lesse il suo primo discorso Sull’origine, progressi ed utilità della botanica. Dal 1827 professore di Materia medica alla Reale Accademia Carolina, appena elevata al rango di Università, professò la necessità di basare lo studio e l’applicazione delle scienze mediche sul metodo dell’osservazione, dell’analisi e della sperimentazione. Dal 1851 fu segretario della Reale accademia Peloritana. Per la figura di Anastasio Cocco e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in Dizionario dei siciliani…, p. 127; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 287. 109 Giuseppe Arifò (Messina 1803-1842), scultore. Studiò a Roma presso l’Accademia di S. Luca con il Tenerani insieme ad Antonio Gangeri, Giuseppe Prinzi e Saro Zagari. Le sue opere, menzionate tra gli altri anche da Gaetano La Corte Cailler (Il Museo Civico di Messina…, p. 173), sono ad oggi scomparse. Per la biografia di Giuseppe Arifò e la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in L. Sarullo, Dizionario artistico dei siciliani. Scultura, a cura di B. Patera, Novecento, Palermo 1995, p. 10. 110 Carlo Gemmellaro (Catania 4 novembre 1787 - 21 ottobre 1866) fu medico chirurgo, zoologo, botanico e archeologo. Prese parte alla battaglia di Waterloo. Dal 1831 fu nominato professore di Storia Naturale prima e di Geologia e Mineralogia poi, all’Università di Catania. Noto soprattutto per i suoi studi di vulcanologia, creò una fiorente scuola di geologi tra le fila dei membri della catanese Accademia Gioenia. Per la figura di Carlo Gemmellaro e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in Dizionario dei siciliani…, p. 243; R. Cristofolini, Carlo Gemmellaro, geologo e vulcanologo, in L’Accademia Gioenia. 180 anni di cultura scientifica (1824-2004). Protagonisti, luoghi e vicende di un circolo di dotti, a cura di Mario Alberghina, Giuseppe Maimone Editore, Catania 2005, pp. 131-135. 111 Salvatore Betti (Orciano di Pesaro (An) 1792 - Roma 1882) fu professore Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 75 numero 3 - maggio 2011 Felice e Domenico Bisazza, Luigi Pellegrino, Giovan Battista Calapai, Riccardo Mitchell, Lorenzo Maisano, Francesco Bertolami, Carlo Gemmellaro, Giuseppe De Spuches, il barone Pasquale Galluppi. G. Arenaprimo, La stampa periodica…, 1892-1893, pp. 84-85. 115 La numerazione è fedele da XIII a XVI. La Corte Cailler ipotizza che la lettera XVII, da “Scilla Cariddi”, che non riuscì a reperire, possa non essere mai esistita, o al più che potesse trattare di Giuseppe Camarda o di Letterio Paladino, argomenti annunciati per le lettere XIX e XX, anch’esse mancanti. G. La Corte Cailler, Intorno le Belle Arti…, p. 82 bis. La lettera inizialmente numerata dal La Farina come XVII e intitolata Si riconosce per opera di Luca Villamaci la statua di S. Vittorio Angelica fu pubblicata col numero XVIII tra le pagine del “Il Faro. Giornale di Scienze, Lettere e Arti”, a. VI, t. IV, fasc. 15, 1838. 116 Solo per le lettere XIII, XIV, XV e XVIII. La lettera XVI fu ritagliata dal giornale. 117 La Corte Cailler aggiunge delle integrazioni, e riporta, oltre alle glosse di La Farina, anche gli emendamenti apportati dall’Arenaprimo che aveva posseduto il manoscritto autografo dopo Grosso Cacopardo, cui era pervenuto dopo la morte dell’autore. 118 «In breve anderò a pubblicare la seconda parte delle mie lettere, che non sono meno di altre dodici…», ancora «Io vado nel parere, completando la pubblicazione di circa altre 12 lettere, ristampate tutte in un volume con qualche addizione alle prime…». Cfr. Lettera di Carmelo La Farina ad Agostino Gallo datata 11 giugno 1835 e Lettera di Carmelo La Farina ad Agostino Gallo datata 20 agosto 1835, ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, XIX sec., ai segni 2 Qq G 110. 119 Francesco e Stefano Cardillo, Polidoro Caldara, Deodato Guinaccia, Gio. Paolo Funduli, Antonio Catalano, Francesco Laganà e Franco Bonajuto, Gio. e Nicolino Van Houbracken, Filippo Tancredi, Dalliotta, Giannotto, Giovanni Fulco, Antonello Resaliba, Animali del presepe, Gaspare Camarda, Salvatore Mittica, Ignazio Brugnani, Comandè, Antonino Bova, Mariano Menniti, Antonino Barbalonga, Stefano Giordano, Gio. Battista Mazzolo, Onofrio Gabrieli, Filippo Paladino, Domenico Campolo, Andrea Quagliata, Michele Maffei. 120 Il periodico, di chiara connotazione nazionalistica e taglio antimunicipalistico, di dichiarato intento politico letterario, foggiato sul modello del “Giornale di Scienze Lettere e Arti” di Bertini e vicino ideologicamente alla di Storia dell’arte, Mitologia e Costumi presso l’Accademia Pontificia di San Luca in cui subentrò a Guattani, nel 1830, nel ruolo di segretario perpetuo. Strenuo difensore del classicismo, assunse posizioni palesemente antiromantiche nei suoi scritti tra le pagine del “Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti” che diresse dal 1819. Per la figura di Salvatore Betti e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in D.B.I., vol. IX, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1967, pp. 724-726; A. Cerutti Fusco, Gaspare Salvi (1786 - 1849) Architetto e professore di architettura teorica nell’Accademia di San Luca e il dibattito architettonico del tempo, in La cultura architettonica nell’età della restaurazione, a cura di G. Ricci, G. D’Amia, Mimesis, Milano 2002, p. 281. 112 Lorenzo Maisano (S. Lucia del Mela (Me) 1791 - Messina 1847), medico, insegnò Medicina Pratica all’Università di Messina. Membro fondatore della Società Cuveriana di Parigi, fu anche socio ordinario della Commissione Provinciale di Vaccinazione, socio ordinario prima e vicedirettore poi della Prima Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti e socio corrispondente di quella di Scienze Mediche di Palermo, della Gioenia di Catania e di quella degli Zelanti di Acireale. Per la figura di Lorenzo Majsano si veda R. Lombardo, Biografia del fu Lorenzo Majsano, professore di Clinica Medica scritta da Raffaele Lombardo, professore di Fisiologia, Tip. di Commercio, Messina 1847. 113 Carmelo Allegra (Messina 1810 - 1880), sacerdote, insegnante di francese. Fondatore del giornale “Scilla e Cariddi”, periodico di carattere politico. A causa della sua attività antiborbonica fu diffidato dalla Questura ed incarcerato nel 1847. Durante la rivoluzione del 1848 diresse “L’aquila siciliana”, in seguito rinominata “Trinacria”. Sospeso dall’insegnamento al tempo della restaurazione borbonica, scrisse Prose di vario genere (Messina 1846) e collaborò a numerose testate. Per la figura di Carmelo Allegra e per la bibliografia a lui relativa si veda ad vocem in Dizionario dei siciliani…, pp. 28-29. 114 Diretta da Carmelo Allegra, fu pubblicata bimestralmente dal 1843 al 1846 per i tipi di Michelangelo Nobolo. Tra i collaboratori, oltre Carmelo La Farina, Giovanni Giamboj, Marino Zuccarello Patti, Remigio Bisignani, Leonardo Antonio Forleo, Saverio D’Amico, Nicolò Camarda, Giovanni Minà Morici, Domenico Ragona Scinà, Antonio Fulci, Ercole Tedeschi Amato, Lodovico Fulci Gordone, Andrea Di Gregorio, Silvestro La Farina, Antonio Minà La Grua, teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 76 numero 3 - maggio 2011 sui dubbi precisando la propria appartenenza a quella schiera di «eletti, che non leggono a spento lume le altrui opinioni intorno alla cronologia degli artisti, elemento necessariissimo per la storia critica delle arti belle». Cfr. C. La Farina, Lettera I. Su i pittori Francesco e Stefano Cardillo da Messina, in Intorno alle Belle Arti…, 1835, p. 3. 123 Cfr. C. L a F arina , Lettera V. Si aggiunge Francesco Laganà…, 1835, pp. 43-46. 124 V.M. Amico, Dizionario topografico della Sicilia. Tradotto dal latino ed annotato da Gioacchino Di Marzo, t. I, Tipografia di Pietro Morvillo, Palermo 1855, p. 119. Il dipinto è oggi conservato presso la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo. 125 Per Andrea Quagliata (Messina 1594 - 2 giugno 1660), si veda ad vocem in Dizionario artistico..., 2, p. 431; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 809. Per i dipinti citati cfr. G. La Corte Cailler, Sicilia monumentale. Alcune opere d’arte osservate in Taormina, in “Atti della R. Accademia Peloritana”, a. XVII, 1902-1903, p. 92. 126 C. La Farina, Lettera III. Se il Pittor Gio: Paolo Fondoli Cremonese possa noverarsi tra gli esteri, che in Messina fiorirono, in Intorno alle Belle Arti…, 1835, pp. 31-36. 127 Cfr. G. Biffi, Memorie per servire alla storia degli artisti cremonesi, ed. critica a cura di L. Bandera Gregori, in “Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona”, a. XXXIX, n. 2, 1989. 128 G. Grosso Cacopardo, Memorie de’ pittori messinesi…, pp. 88-89. 129 C. La Farina, Lettera II. Sull’anno di morte di Polidoro Caldara da Caravaggio, in Intorno alle Belle Arti…, 1835, pp. 17-30. 130 G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori…, t. 9, pp. 248 e sgg. 131 C. La Farina, Lettera II. Sull’anno di…, 1835, p. 21. 132 Vasari lo vuole nella chiesa Cattedrale, mentre Buonfiglio e Gallo asseriscono che sia tumulato nella chiesa del Carmine. J.P. Hackert, G. Grano, Memorie de’ Pittori Messinesi, Stamperia reale, Napoli 1792, p. 22; G. Grosso Cacopardo, Memorie de’ pittori messinesi…, p. 47; C.D. Gallo, Annali della Città di Messina…, vol. I, 1756, p. 98. Alle opere citate da Grosso Cacopardo, La Farina aggiunge al catalogo dell’artista lombardo due opere di piccole dimensioni, che curiosamente comprendevano entrambe un piccolo autoritratto del pittore. Si tratta di un Martirio di S. Placido, che ricorda in casa del «fu Presidente Finocchiaro» e poi passato in collezione Geraci, già citato da G. Bertini (Estratti di opere di autori “Antologia” del Gabinetto Vieusseux, fu pubblicato a partire dal 1831 per i tipi d Giuseppe Fiumara. Nel 1836, il giornale sempre guidato dal La Farina, dovette cambiare il suo titolo in “Il Faro” a causa delle polemiche politico-letterarie sostenute contro il palermitano “Il Vapore” dei fratelli Linares, appoggiati dalla polizia. I compilatori, spinti da «l’amore per la bella patria» manifestarono, immediatamente dopo la sospensione, la volontà di riprendere le pubblicazioni con l’intento di «condurre al vero per mezzo del bello […] per svegliare gli spiriti divenuti ormai neghittosi per un sonno troppo lungo per causa del quale troppo à sofferto l’amor nostro nazionale» con l’obbiettivo di «portare nella ognor massa crescente dell’umano sapere quell’unità che manca e senza della quale non avran pace gli animi, né i popoli vera quiete» (“L’Indagatore”, 1834, I, pp. 61-35). “Il Faro” aveva in copertina una epigrafe (Felix quem faciunt alien pericola cautum) e un verso (La verità nulla menzogna frodi). Dal 1839 il giornale riacquistò il nome di “Spettatore Zancleo” e il proprio stampo prettamente politico e continuò le sue pubblicazioni settimanali in modo regolare fino al 1847. Cfr. S. La Barbera, La stampa periodica palermitana…, p. 87-121. Qualche sporadico numero di natura letteraria uscì con scarso successo, con contributi di autori minori. Cfr. G. Arenaprimo, La stampa periodica…, 1892-1893, pp. 158-160, 162-166; G. Oliva, Annali della città di Messina…, estratto da “La Sicilia nel risorgimento italiano”, a. III, f. I, pp. 3-18. 121 Pubblicato dal 5 ottobre 1833 all’aprile del 1840. Tra i principali corrispondenti i nomi dell’intellighenzia siciliana del periodo: oltre al citato Grosso Cacopardo, Francesco Arrosto, Felice Bisazza, Antonio Catara Lettieri, Anastasio Cocco, Agostino Gallo, Carlo Gemelli, Alojsio Juvara, Agatino Longo, Lorenzo Maisano, Raffaello Politi, Carmelo Prestigiovanni, Giovanni Saccano, Antonio Sarao, Domenico Ventimiglia, Lionardo Vigo. Dal maggio 1841 la nuova serie del giornale in cui La Farina figura tra i corrispondenti, fu edita per i tipi di Tommaso Capra col titolo di “Il Maurolico. Giornale del Gabinetto Letterario di Messina”. Intitolato solo “Giornale del Gabinetto Letterario di Messina” dal 1842 al 1 settembre 1874, quando fu chiuso per ordine del Governo. Cfr. G. Arenaprimo, La stampa periodica…, 1892-1893, pp. 166-169; G. Oliva, Annali della città di Messina…, 1893, pp. 263, 270-271. 122 Relativamente alle attribuzioni ai pittori messinesi Francesco e Stefano Cardillo, nella prima lettera indirizzata ad Agostino Gallo, La Farina manifesta i Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 77 numero 3 - maggio 2011 e di studi, sia del gruppo di angeli avvinghiato al tempietto dell’Adorazione dei Pastori, che di apparati per i “Trionfi” per Carlo V. Cfr. Il disegno conservato al Kupferstichkabinett di Berlino, inv. K.d.Z. 26458, 79.D.34; cfr. A. Marabottini, Polidoro…, pp. 176, 215, 333-334. 138 Lo stesso La Farina precisa che i libri del Banco iniziano dal 1837, sebbene Gallo negli Annali li dati a partire dal 1586. Ci informa che molti dei tomi furono rubati e venduti come carta dopo il terremoto del 1783. Cfr. C. La Farina, Lettera II. Sull’anno di morte…, 1835, pp. 28-29, nota “p”. 140 C. La Farina, Lettera XI. Si producono alcuni dipinti…, 1835, pp. 81-83. 141 Gaetano La Corte Cailler è concorde: «Non è possibile che Comandè, nato nel 1580, assistesse alla scuola di Paolo Veronese, morto nel 1588». Cfr. le annotazioni autografe, ripubblicate in C. La Farina, Intorno alle Belle Arti…, 2004, p. 130, n. 4. Già Susinno ne Le Vite de’ pittori messinesi (ms. 1742, ed a cura di V. Martinelli, Pubblicazioni dell’Istituto di storia dell’arte medievale e moderna, Facoltà di lettere e filosofia, Università di Messina, Firenze 1960, pp. 121-125) e Mongitore nelle Memorie dei pittori, scultori, architetti e artefici in cera siciliani (1740 ca., ed. a cura di E. Natoli, S.F. Flaccovio, Palermo 1977, p. 100), datano la nascita dell’artista al 1558. 142 Filippo Tancredi (Messina 1655 - 1722). Per la sua figura e la bibliografia a lui relativa si veda M. Guttilla, Filippo Tancredi, in “Quaderni dell’A.F.R.A.S.”, n. 3, Palermo 1974; ad vocem in Dizionario artistico..., 2, pp. 518-519; M. Guttilla, Pittura e incisione nel Settecento, in Storia della Sicilia, Editalia - Domenico Sanfilippo Editore 2, Roma 1999, pp. 290-297; Ead., Gli studi pioneristici di Maria Accascina sulla pittura del Settecento. Sviluppi, conferme e piccole novità, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Maria Accascina (Palermo Erice 14-17 giugno 2006), a cura di M.C. Di Natale, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2007, pp. 300-315 e in part. 309; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 946; Ead., Cantieri decorativi a Palermo dal tardo Barocco alle soglie del Neoclassicismo, in Il Settecento e il suo doppio, Rococò e Neoclassicismo, stili e tendenze europee nella Sicilia dei viceré, atti del convegno internazionale di studi (Palermo 10-12 novembre 2005), a cura di M. Guttilla, Kalòs, Palermo 2008, pp. 177-207 e in part. 185. 143 J.P. Hackert, G. Grano, Memorie de’…, p. 64; G. Grosso Cacopardo, Memorie de’ pittori messinesi…, p. 207. siciliani. Memorie de’ pittori Messinesi, ecc. Sei Lettere MSS. di Giuseppe Grosso Cacopardi. Continuazione dell’Estratto, in “Giornale di Scienze, letteratura e Arti per la Sicilia”, a. I, t. IV, 1823, pp. 101-102) e una Deposizione dalla croce, nello studio dei fratelli Giuseppe, Letterio e Pietro Subba, passata successivamente in mano al La Farina stesso. Le attribuzioni sono accettate anche dalla critica successiva, cfr. G. Di Marzo, Delle Belle arti…, 1862, p. 231; T. Pugliatti, La pittura del Cinquecento…, p. 132. Infine segnala anche un S. Giacomo apostolo, perduto nel terremoto del 1693, per la chiesa dei Conventuali di Catania nella cappella dei Principi della Torre (F. Cagliola, Almae siciliensis Provincaie Ordinis Minorum Canventualium S. Francisci manifestationes novissimae, sex explorationibus camplexae, Venezia 1644, ed. a cura di F. Rotolo, Palermo, Officina di Studi Medievali, 1984, p. 73). 133 Ci rimangono svariati disegni e schizzi oltre che una testimonianza diretta e particolareggiata in un libretto in versi opera di Colagiacomo d’Alibrando, datato il 1 settembre 1534 e dedicato al nobile Pietro Ansalone committente del dipinto; C. d’Alibrando, Il Triompho il qual fece Messina nella Intrata del Imperator Carlo V e Molte altre cose Degne di notizia…, Messina 1535, pubblicato anche in C.D. Gallo, 1758, t. II, libro VII, pp. 499-516. Cfr. A. Marabottini, Polidoro da Caravaggio, Edizioni dell’Elefante, Roma 1969, pp. 176, 215, 333-334; P. Leone De Castris, Polidoro da Caravaggio fra Napoli e Messina, Roma 1988-1989, pp. 130132. 134 Tutte le notizie relative al dipinto si evincono dal libretto di Colagiacomo d’Alibrando, dedicato a Pietro Ansalone. Cfr. T. Pugliatti, La pittura del Cinquecento…, p. 121; P. Leone de Castris, Polidoro da Caravaggio…, pp. 130-131. 135 Per l’opera, Marabottini (Polidoro…) ipotizza il nome di Stefano Giordano. Teresa Pugliatti considera l’ipotesi attributiva al Guinaccia «improponibile per ragioni cronologiche» (La pittura del Cinquecento…, 1993, p. 124). 136 In ambito isolano solo G. Di Marzo (Delle Belle arti in Sicilia…, 1862, p. 235) concorda con La Farina nel correggere la data di morte proposta da Vasari, anticipandola al ’34. 137 E. Mauceri, Polidoro da Caravaggio a Messina, in “Sicilia”, 1928, gennaio, pp. 3-5. È stato suggerito (T. Pugliatti, La pittura del Cinquecento…, pp. 123125) che dato l’alto numero di richieste, l’esecuzione della pala dell’Alto fosse stata rimandata, ipotesi confortata dalla presenza nello stesso gruppo di schizzi teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 78 numero 3 - maggio 2011 144 C. La Farina, Lettera VI. Si purga di talune…, 1835, pp. 47-56. 145 Id., Si fissa l’anno del ritorno in patria del famoso dipintore Antonino Barbalonga da Messina. Al Valoroso Artista Tommaso Aloisio, in Intorno alle Belle Arti…, 1835, pp. 84-90. 146 Alojsio Juvara rispose a La Farina con una lettera intitolata Intorno a taluni dipinti di Antonino Barbalonga, pubblicata nel 1837 ne “Il Faro. Giornale di Scienze, Lettere ed Arti”, a. V, v. III, n. 13, pp. 69-76; la lettera è ripubblicata in Appendice, II – Belle Arti, in C. La Farina, Intorno alle Belle Arti…, 2004, pp. 221-229. 147 Datata “Messina, 9 dicembre 1833”, cfr. C. La Farina, Lettera I. Su i pittori..., 1835, pp. 3-16. 148 Ibid., p. 3. 149 J.P. Hackert, G. Grano, Memorie de’…, p. 19. 150 P. Samperi, Messana S.P.Q.R.…, p. 614, n. 267; Id., Iconologia della gloriosa…, p. 601. 151 G. Buonfiglio e Costanzo, Messina, Città Nobilissima…, 18r. 152 C. D. Gallo, Annali della Città di Messina…, vol. III, 1804, pp. 107, nota 21, 183. 153 F. Susinno, Le Vite…, p. 168. 154 C. La Farina, Lettera I. Su i pittori..., 1835, p. 4. La Farina aveva già accennato ai dipinti dell’Alto in Notizie di alcuni Pittori Messinesi, in “Il fa per tutti …”, 1812, p. 127 155 G. Grosso Cacopardo, Memorie de’ pittori messinesi…, pp. 26, 64, ascrive a «un Cardillo da Messina» fiorito «verso gli ultimi del 1400» i due dipinti. Anche G. La Farina (Messina e i suoi…, pp. 57-58) concorda con questa ipotesi. Gallo è citato pure da Di Marzo (Delle Belle arti in Sicilia…, 1862, p. 171) che ricorda i due dipinti e in merito alla Visitazione precisa, che «in un angolo si scorge con tutta leggiadria dipinto un cardellino, siccome emblema del cognome del dipintore. Il quale così innanzi si mostra in quell’opera, per singolar progresso dell’arte nel comporre con grande sviluppo le figure, nel disegnare e colorire con somma energia e con profonda scienza, e nel trattar con molta abilità la prospettiva, ch’è degno di appartener veramente alla scuola del cinquecento; e forse fiorì al di là dell’epoca, che il Gallo stabilì per lui nel cadere del decimo quinto secolo». La segnalazione è ripresa successivamente da Brunelli che però non concorda con Di Marzo in merito all’ipotetica datazione. Lo studioso riscontra i modi del Giuffrè nello stile dell’artista che nel dipinto raffigurante la Visitazione «pose e non pose la sua firma. Non scrisse il nome ma in un angolo pose un cardellino…» sulla base del raffronto con un dipinto di analogo soggetto realizzato per la chiesa del Varò a Taormina (E. Brunelli, Note antonelliane, in “L’Arte”, 1908, pp. 300-304 e in part. 300301; cfr. ad vocem Cardillo in Allgemeines Lexikon der bildender Kunstler, a cura di U. Thieme - F. Becker, V. F. Ullmann, Leipzig 1911, p. 585, Id., Antonino Giuffrè, il vecchio Cardillo, Alfonso Franco, in “Giornale di Sicilia”, 21 maggio 1931, p. 3). Per le ipotesi sulla figura di un ‘maestro Cardillo’ si vedano anche G. Columba, Terremoto di Messina. Opere d’arte recuperate dalle R. Soprintendenze dei Monumenti, dei Musei e delle Gallerie di Palermo, Stabilimento tipografico Virzì, Palermo 1915, p. 42, che riferisce l’attribuzione di Carmelo La Farina; E. Mauceri, Dipinti inediti dei sec. XV e XVI nel Museo Nazionale di Messina, in “Bollettino d’Arte”, a. XIII, ff. 5-6-7-8, maggio-agosto 1919, pp. 77-79; Id., Il Museo Nazionale di Messina, La Libreria dello Stato, Roma 1929, p. 39; S. Bottari, Ricerche intorno agli Antonelliani, in “Bollettino d’Arte”, s. II, a. X, f. VII, gennaio 1931 (a. IX), pp. 291-316 e in part. 315-316, nota 24; Id., Introduzione, in J.P. Hackert, G. Grano, Memorie di Pittori Messinesi, Stamperia Reale, Napoli 1792, ed. con introduzione, note e appendice bibliografica a cura di S. Bottari, in “ASM”, n.s., a. XXVIIIXXXV, 1934, p. 19. 156 La critica più recente è concorde nel ritenere che il dipinto non possa essere assegnato a Francesco. Cfr. Cardillo, ad vocem in D.B.I., 19, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1976, pp. 770-772; ad vocem in Dizionario artistico..., 2, pp. 74-75; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, p. 228. 157 G. Rosini, Storia della pittura italiana esposta coi monumenti, presso Niccolo’ Capurro, Pisa 1845, vol. v, p. 43; T. Pugliatti, La pittura del Cinquecento…, pp. 168170. 158 Frazione di Gualtieri Sicaminò (Me). Per i Cardillo si veda, ad vocem in D.B.I., XIX, Roma 1976, pp.780-782. 159 C.D. Gallo, Apparato agli Annali…, p. 183. 160 G. Grosso Cacopardo, Memorie de’ pittori messinesi…, p. 64; F. Susinno, Le Vite…, p. 168; C. D. Gallo, Annali della Città di Messina…, vol. III, 1804, p. 183; C. La Farina, Lettera I. Su i pittori…, 1835, p. 13 161 G. Grosso Cacopardo, Memorie de’ pittori messinesi…, 1821, p. 64; F. Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 79 numero 3 - maggio 2011 Susinno, Le Vite…, p. 168; C. D. Gallo, Annali della Città di Messina…, vol. III, 1804, p. 183; C. La Farina, Lettera I. Su i pittori…, 1835, p. 13. 162 Questo dipinto era citato da Grosso Cacopardo come opera del solo Stefano. La Farina riporta Samperi che la definisce «opera a meraviglia bella» P. Samperi, Iconologia della gloriosa Vergine…, p. 601. Cfr. Memorie de’ pittori messinesi…, pp. 102-103. 163 G. Grosso Cacopardo, Guida per la città di Messina scritta dall’Autore delle Memorie de’ pittori Messinesi, presso Giuseppe Pappalardo, Siracusa (Messina) 1826, rist. anast. Bologna 1989, p. 29. Giuseppe La Farina cita il documento parzialmente pubblicato dal padre (C. La Farina, Lettera I. Su i pittori..., 1835, p. 14) ribadendo che «questa pittura dava il Gallo al Rubens, ed il Grosso a Francesco Cardillo; ma non è d’attribuirsi né all’uno né all’altro. Nel catalogo de’ confrati, che ha cominciamento col 1588, sta scritto “Agostino Massena genovese entrò li 11 marzo 1629; regalò l’egregio quadro, che si conserva nel nostro Oratorio di quando il P. S. Francesco si gettò nudo tra le spine: opera di eccellente pittore fatta venire dal medesimo dalle Fiandre. Il prezzo è costato duecento scudi di nostra moneta.” Or dunque è a dirsi che al Cardillo non partiene, né tantomeno al Rubens, il quale nel 1629 era già da un decennio passato da questa vita», cfr. Messina ed i suoi monumenti, Messina 1840, p. 71; parimenti Salvatore Lanza descrive il dipinto informando che «si attribuisce a Rubens o a Francesco Cardillo, ma pare non possa essere né dell’uno né dell’altro, avuto riguardo all’anno in cui fu eseguito», cfr. Guida del viaggiatore in Sicilia, Palermo 1859, p. 134. In questi anni l’attenzione alla penetrazione della cultura fiamminga in Sicilia si ha anche da parte di Gioacchino Di Marzo che ne La Pittura in Palermo nel Rinascimento, del 1899, segnala alcuni esempi di opere ed artisti provenienti dalle Fiandre evidenziandone il forte impatto in ambito locale. Questi studi saranno approfonditi dallo studioso anche nel saggio intitolato Di Antonello da Messina e dei suoi congiunti (in Documenti per servire alla Storia di Sicilia, pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria, s. IV, v. IX, Palermo 1903 e saranno ulteriormente indagati metodologicamente nello scritto degli ultimi anni dedicato al pittore anversate Guglielmo Borremans (Guglielmo Borremans di Anversa, pittore fiammingo in Sicilia nel secolo XVIII (17151744), Virzì, Palermo 1912). 164 G. Grosso Cacopardo, Guida per la città di Messina…, 1826, rist. anast. Bologna 1989, p. 120. 165 G. Bertini, Saggio sulle Memorie de’ Pittori Messinesi, ed Esteri, che in Messina fiorirono: Messina 1821, n. 8 Fasc. I e II, in “L’Iride. Giornale di Scienze, Lettere ed arti per la Sicilia”, a. I, t. II, Palermo 1822, pp. 100-118 e in part. Parte II. Estratti di autori siciliani…, in “Giornale di Scienze, Letteratura ed Arti per la Sicilia”, a. I, t. IV, 1823, p. 87. 166 C. La Farina, Lettera I. Su i pittori..., 1835, p. 9. 167 Nel volume posseduto da La Corte Cailler, appartenuto a Grosso Cacopardo prima e all’Arenaprimo poi, è presente una postilla apposta nel 1903 ricopiata dagli originali autografi di La Farina, in cui si precisa che «Il quadro della Madonna di Monserrato, nella cappella del forte Gonzaga “venne sotto i nostri occhi, da chi lo aveva in serbo, audacemente trafugato”». Cfr. Premessa, in C. La Farina, Intorno alle Belle Arti…, 2004, p. 50, nota 20. 168 G. Grosso Cacopardo, Belle Arti. Continuazione delle Lettere sulla pittura dell’Autore delle Memorie dei Pittori Messinesi. Lettera III, “Maurolico. Foglio periodico”, s. I, n. 6 (Messina 9 novembre 1833), pp. 42-43; cfr. G. Grosso Cacopardo, Opere…, 1994, pp. 30-31. 169 Queste ultime due opere, insieme alla tela con la Madonna col Bambino, Sant’Anna e Santa Venera della chiesa Madre di Novara di Sicilia, firmata “Ego feci” entro un piccolo cartiglio portato dal solito cardellino, datato 1607 e dunque probabilmente sua ultima opera, sono le uniche sopravvissute. Dal Registro dei Morti della chiesa del convento di S. Girolamo dei Domenicani di Messina, al foglio 194, si evince che Francesco Cardillo morì il 29 ottobre 1607, come lo stesso La Farina informa. Cfr. G. Borghese, Condizioni di Novara sotto l’aspetto della civiltà e dell’arte, in “ASM”, 1905, a. VI, ff. III-IV, pp. 223-262; Id., Novara di Sicilia e le sue opere d’arte (da documenti inediti), in “ASM”, 1906, a. VII, ff. III-IV, pp. 223-262; Cardillo, ad vocem in D.B.I., XIX, Roma 1976, pp.780-782, osserva che sia la Pietà che la Madonna e Santi di Novara rivelano l’adesione a modi manieristico-controriformati e una spiccata attenzione verso effetti naturalistici e cromatici vicini ai modi di Antonio Catalano l’Antico, discordando in modo piuttosto evidente dalle espressioni della Madonna di Soccorso, in cui evidenti caratteri polidoreschi spiccano nel registro inferiore, specie nella figura del demone. Cfr. P. Leone de Castris, Polidoro da Caravaggio…, p. 178, 184; T. Pugliatti, La pittura del Cinquecento…, pp. 169-170. 170 Cfr. Cardillo Francesco, ad vocem in Dizionario artistico..., 2, pp. 74-75; ad vocem in Enciclopedia della Sicilia…, 2006, p. 228. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 80 numero 3 - maggio 2011 L’attribuzione è accettata con qualche riserva da G. La Farina (Messina e i suoi…, 1840, pp. 38-39), e successivamente da G. Di Marzo (Delle Belle arti in Sicilia…, 1862, p. 309), s.a., Messina e dintorni, guida a cura del Municipio, Prem. stab. G. Crupi, Messina 1902) e A. Salinas e G.M. Columba (Terremoto di Messina (28 dicembre 1908). Opere d’arte recuperate dalle RR. Soprintendenze dei Monumenti, dei Musei e delle Gallerie di Palermo, Palermo 1915, p. 25), che lo dicono «recuperato nel museo», sebbene non figuri tra le opere esistenti. Cfr. T. Pugliatti, La pittura del Cinquecento…, p. 332, nota 8. 176 Id., Notizie di alcuni Pittori Messinesi, in “Il fa per tutti…”, 1812, p. 125. 177 Si ricordano tra le altre: C. La Farina, Elogio funebre per Sua maestà Ferdinando I Borbone, Re del Regno delle Due Sicilie, nella straordinaria tornata della reale Accademia de’ Pericolanti del dì 8. Febbraio 1825. Letto dal Socio Carmelo La Farina Dottore in ambe le leggi, professore di matematica nella reale Accademia Carolina, deputato, ed esaminatore geometra per l’equazione de’ pesi, e delle misure, prefetto del pub. Museo, ed Accademico del Buon Gusto, Giuseppe Fiumara, Messina 1825; Id., Inno da cantarsi nel Real Teatro della Munizione della Città di Messina la sera de’ 29 luglio 1828 nella sempre lieta occasione di essere ornato dall’Eccellentissimo Signore Marchese della Favara, brigadiere de’ reali Eserciti, Gentiluomo di Camera con esercizio, Cavaliere degl’insigni Reali Ordini di S. Gennaro, e di S. Ferdinando, e del Merito, cavaliere di 1.ma Classe dell’ordine Imper. Austriaco della Corona di Ferro, Cavaliere di Giustizia del Real Ordine Militare di S. Stefano P. e M. Consigliere di Stato Ministro Luogotenente Generale di S. M. (D. G.) in questa parte de’ Reali Dominj ec. ec. ec. Parole di Carmelo La Farina, Antonino d’Amico Arena, Messina 1828; Id., Pell’assunzione alla Sacra porpora di D. Francesco di Paola Villadicani, Cardinale del titolo di S. Alessio, Arcivescovo di Messina ec.ec., Discorso pronunziato nella Reale Accademia Peloritana il dì 12 ottobre 1843 dal suo Segretario Generale Professore Carmelo La Farina giudice di tribunale civile, Stamperia di G. Fiumara, Messina 1843; Id., Cenni biografici dell’eminentissimo principe D. Francesco di Paola Villadicani, patrizio messinese dei principi di Mola, dei marchesi di Condagusta, dei baroni Lando, Pirago, e Cartolano, Cardinale Presbitero si S. R. C., del titolo di S. Alessio, già Vescovo di Ortosia, Arcivescovo di Messina, Conte di Regalbuto, Barone di Bolo, Signore di Alcara, ec. ec. ec., per Carmelo La Farina, Giudice di Gran Corte Criminale, Professore di Geometria e Trigonometria nell’Università Messinese, prefetto del Pubblico Museo, Membro effettivo del VII Congresso degli Scienziati Italiani, Membro dell’istituto di corrispondenza Archeologica di Roma, della Società libera di emulazione di Roano, e dell’Etrusca della Valdarnese di Montevarchi, degl’Incamminati di 171 Reg. dei Matrimoni, fol. 41, retro, num. 173. Pubblica anche notizie riguardo ai fratelli di Stefano, figli di Francesco, formatosi alla scuola di Antonello Rizzo, del quale sposò la figlia Giovannella da cui ebbe quattro figli: Stefano (21 febbraio 1595), Vincenzio (29 agosto 1596) morto a soli ventotto anni, Flavia (30 novembre 1600), Anna Maria (5 febbraio 1603). Cfr. Reg. dei Morti, fol. 33, num. 910; Reg. dei Matrimoni, della Parrocchiale Chiesa di S. Nicolò dell’Arcivescovado del 1593, fol. 98, retro; Morto il 6 gennaio 1625, Reg. dei Morti, fol. 6, num. 144; Reg. dei Natali, della Parrocchiale Chiesa di S. Nicolò dell’Arcivescovado sotto i giorni indicati. G. Molonia fa notare che C.D. Gallo, erroneamente segnala Stefano come l’ultimo dei figli e non il primo quale è effettivamente (Annali della Città di Messina…, t. III, Messina 1803, p. 107, nota 21). 172 Nel 1812 riporta notizie relative a Pietro Oliva, Polidoro, Guinaccia, Mariano e Antonio Riccio (C. La Farina, Notizie di alcuni Pittori Messinesi, in “Il fa per tutti o sia Calendario, e notizie per l’anno bisestile 1812”, 1812, pp. 121127) e segnala notizie Su un antico sarcofago esistente a Messina (in Ibid., pp. 41-43). In nota menziona anche un breve saggio sulla famiglia degli «Antonii» in riferimento alle Memorie degli artisti messinesi di Grosso Cacopardo, «dottissimo anonimo concittadino», pubblicate l’anno precedente in un articolo intitolato “Strenna Galante dell’Animoso Accademico Peloritano», cfr. C. La Farina, Notizie di alcuni Pittori Messinesi, in Ibid., pp. 121, nota 1. Nel 1813 riferisce di G. S. Comandè, A. Catalano, A. Rodriguez (C. La Farina, Continuazione delle notizie su alcuni Pittori Messinesi, in “Il fa per tutti o sia…”, 1812, pp. 139-144); nel 1814 cita M. Minniti, A. Socino, F. Giannitti, D. Marolì, A. Quagliata (C. La Farina, Continuazione delle notizie su alcuni Pittori Messinesi, “Il fa per tutti o sia …”, 1814, pp. XX-XXIV). 173 “Il fa per tutti o sia Calendario, e notizie per l’anno bisestile 1812” (1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822) fu pubblicato dal 1812 per dieci anni, dai torchi di Giovanni del Nobolo. Cfr. G. Arenaprimo, La stampa periodica…, 1892-1893, p. 147, nota 1; Id., Almanacchi e Strenne di altri tempi, in “Eros. Rivista artistica letteraria”, I, 1900, f. I, pp. 9-12. 174 L’opera era stata riferita in precedenza alla “scuola di Polidoro”, o più genericamente definita “di stile raffaellesco”. Cfr. C.D. Gallo, Apparato agli Annali…, 1755, p. 172; G. Grosso Cacopardo, Guida per la città di Messina…, 1826, p. 2; Id., Guida per la…, 1841, p. 2. 175 C. La Farina, Lettera VII. Si adducono varie notizie..., 1835, pp. 60-61. Nicoletta Di Bella Scritti d’arte di Carmelo La Farina (1786 - 1852) 81 numero 3 - maggio 2011 Modigliana, degli Entoleti di S. Miniato, dell’Accademia di Scienze e Lettere di Palermo, degli Zelanti di Aci-Reale, della Civetta di Trapani, della Lilibetana di Marsala, dell’Accademia Cosentina, della Florimontana di Monteleone, Membro della Società Economica della Provincia di Messina, e di quella della Calabria Ulteriore Seconda, segretario Generale della Reale Accademia Peloritana, Stamperia di Tommaso Capra, Messina 1846. 178 C. La Farina, Congettura del prof. C. La Farina…, Marzo 1836, pp. 165168. Cfr. F. Bisazza, Archeologia. Congettura del professore Carmelo La Farina, sul sito dell’antico Nauloco. Messina (estratto dal Faro, fascicolo III, Marzo 1836) 8. Di pag. 6, in “Il Faro che siegue lo Spettatore Zancleo. Giornale di Scienze Lettere e Arti”, a. IV, vol. II, f. 9, Settembre 1836, pp. 190-191. 179 C. La Farina, Congettura del prof. C. La Farina sul sito dell’antico Nauloco, estratto dal “Il Faro che siegue lo Spettatore Zancleo. Giornale di Scienze Lettere e Arti”, a. IV, vol. I, f. 4, Aprile 1836, pp. 253-260. 180 C. La Farina, Statistica della Città di Messina, in “Lo Spettatore Zancleo”, a. II, n. 22, Messina 28 Maggio 1834, p. 176; ivi, a. II, n. 22, Messina 3 Giugno 1835, p. 173-175; Id., Statistica della Città di Messina in “Il Faro. Giornale di Scienze Lettere e Arti”, a. IV, vol. I, Messina 1836, pp. 311-314; ivi, a. V, vol. III, “da Gennaro a Giugno”, Messina 1837, pp. 81-85. 181 C. La Farina, Statistica della Città di Messina, in “Giornale degli Atti per l’Intendenza del Valle di Messina”, a. 1835, f. III, pp. 62-63. Edito dal 3 maggio 1818, giorno dell’insediamento nel palazzo municipale del Barone di Mandrascate, Intendente del Vallo di Messina, il periodico fu pubblicato con regolarità, inizialmente ogni decade, poi dal 1822 divenne mensile e nel ’37 se ne pubblicò un solo numero di appena 8 pagine, a causa della epidemia di colera che aveva colpito la città. Dal numero 4 del 1838 mutò il suo nome in “Giornale dell’Intendenza della Provincia di Messina e le pubblicazioni durarono fino al 1859. G. Molonia, La stampa periodica…, 2004, p. 68. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 82 Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo di Carmelo Bajamonte del canonico Cesare Pasca, su cui avremo occasione di tornare nell’apparato critico5. Sembra restituire, invece, una sensibilità diversa, e in un’inedita ottica nazionalistica, uno scritto compilato nel giro di anni successivi all’Unità da uno dei maggiori intellettuali siciliani del periodo. È da assegnare infatti ad Agostino Gallo6 il merito di aver posto in congruo rilievo, in un libretto singolare quanto negletto7, un’area distinta di attività artistiche indagata nelle sue vicende e contestualizzata nei livelli più vari. Lo studio, coscienziosamente preparato con la volontà di individuare le caratteristiche distintive della cultura isolana in seno a quella italiana, è rimasto a oggi in una sorta di limbo, escluso sia dalla letteratura del XVIII secolo – che possiamo ritenere di mediocre gittata perché occupatasi di arte in maniera episodica e disaccentata – sia dal sistema storiografico I l panorama della letteratura artistica siciliana dell’Ottocento riguardo alle arti decorative presenta esiti di natura mistilinea. Sull’argomento disponiamo di una nutrita produzione letteraria1, sebbene si tratti per la più parte di studi municipalistici di computisti eruditi, spesso approntati con un armamentario teorico spuntato: nella prima metà del XIX secolo, è facile scorgere tali declinazioni nelle pagine di padre Benigno da Santa Caterina2, di Giuseppe Maria Fogalli3 o di Giuseppe Maria Di Ferro4, le cui notazioni sulle arti sono sparse in testi di varia natura (biografie, guide, panegirici, testi confessionali). Anche nella stampa periodica si trovano affrontati alcuni aspetti della produzione delle arti tecniche come negli articoli teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 84 numero 3 - maggio 2011 del secolo seguente, quando con il fiat di Gioacchino Di Marzo la critica d’arte in Sicilia fu8. Agostino Gallo – è forse il caso di rammentarlo – è un poliedrico esponente della Repubblica delle lettere, organico alle istituzioni culturali (fu socio di accademie italiane, Deputato della R. Università, Segretario Archeologo della Commissione di Antichità e Belle Arti di Palermo), pubblicista e ben provveduto divulgatore con le chiavi di un’ampia comunicazione. ‘Giano bifronte’ fra enciclopedismo settecentesco e nuovi approcci alla storia dell’arte, si darà a più imprese spezzettate lasciando una congerie di appunti, rimasti in gran parte manoscritti per troppa abbondanza di propositi9. In questo articolato apparato bibliografico, quanto andremo a leggere rappresenta una messa in ordine di appunti e interventi Giuseppe Patania, Agostino Gallo, pubblicati su periodici 1826, Biblioteca Comunale, delle Due Sicilie, dedicati Palermo. Foto Enzo Brai. all’intaglio ligneo10 o ad artefici poco noti al grande pubblico quali Michele Laudicina11 o Girolamo Bagnasco12. Apparso prima sul quindicinale “Diogene” di Palermo – un giornale scientifico e letterario diretto dall’amico e biografo Paolo Sansone, che si avvaleva di Gallo in veste di redattore – l’apografo viene poi girato al “GiornaA. Gallo, Sull’influenza ch’esercitarono gli artisti italiani in varii regni d’Europa, le Arcadico” di Roma13, Palermo 1863. diretto dall’archeologo e Commissario alle antichità dello Stato Pontificio Pietro Ercole Visconti14, nipote di Ennio Quirino, al quale erano giunti da Palermo anche altri lavori fra cui la Necrologia di Giuseppe Patania15 e una Vita di Angelo Marini16. Il lavoro sarà infine pubblicato come estratto, sempre nel 1863, con i tipi dello stabilimento Barcellona di Palermo. Dedicata all’«insigne scultore italiano che nelle forme corrette ed eleganti e nella grazia ingenua elevò l’arte a maggior gloria» – cioè Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 85 numero 3 - maggio 2010 a Pietro Tenerani, uno dei segnatari del Manifesto del Purismo (1843), forse l’artista (in Sicilia nel 183817) che più di ogni altro in quel momento incarnava gli ideali estetici dello scrittore – l’operetta riprende il disegno del Saggio su’ pittori del 184218, di di far noto ai siciliani i vanti eccelsi di questa terra […]; mostrare altresì agli stranieri che non è vano lo studio dei nostri monumenti, ed esortarli che prima di scrivere dell’universa Italia vengano qui e veggano, e non ci appartino dalla gran famiglia degli stati italiani21. cui ricalca sia le motivazioni ideologiche – nell’esercizio di una critica militante versata soprattutto negli artisti contemporanei – sia il modo di organizzare la materia, basato con gesto di riepilogo su una rassegna di personalità e indirizzi che ancorché stringata testimonia nel numero la vivacità del caleidoscopio siciliano. Gallo compendia in una ventina di pagine un profilo storicoartistico ideologizzato e mirato a riabilitare la regione nel novero delle scuole artistiche italiane. Nel contesto di un Ottocento nazionalistico19, è dunque messa a punto una strategia tendente a costituire in unità le singole realtà locali secondo precise priorità: fare l’Italia artistica sulla base di una convergente proposta storiografica; compensare il ritardo accumulato nei confronti degli ‘esteri’; e, nel caso specifico della Sicilia, legittimare l’appartenenza a pieno titolo a tale sistema sopraregionale non senza partigianeria e un pervasivo spirito di revanche20. Un’urgenza di cui si farà interprete anche un giovanissimo Gioacchino Di Marzo che nel primo volume Delle Belle Arti esibiva il manifesto Ora l’aspetto da porre in rilievo è la modalità con la quale Gallo tenta di risolvere un complesso d’inferiorità, ingaggiando il confronto su un terreno secondo lui propizio, quello delle arti decorative, riconosciute di pari dignità estetiche e creative rispetto alle maggiori. In un discorso che lo scrittore riteneva suscettibile di approfondimenti22, l’attenzione si appunta in prima battuta su tale ambito, nell’intento di rivendicarne la preminenza nello scenario italiano, poiché nella «sede natia di Cerere» una tradizione artistica che affondava radici in un passato antico aveva visto prosperare la glittica, la ceroplastica, il commesso marmoreo, l’arte dello smalto, i capolavori di argenteria e oreficeria, la maiolica, tutte arti non secondarie per l’incommensurabile estro inventivo e la perfezione tecnica che le significava. Aggiunti al commentario i testi di due autori di solida preparazione – Andrea Pietro Giulianelli23 e Aubin-Louis Millin24 – Agostino Gallo produce in apertura un elenco d’intagliatori dell’antichità, tralasciando ex professo – e rimarca con intonazione sarcastica – i teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 86 numero 3 - maggio 2011 Non credo sia necessario uno sforzo interpretativo per riconoscere la piena continuità con la tradizione filorinascimentale, giocata su un’idea conservatrice del Disegno, padre delle arti e fondamento del bello. Ma Gallo, in maniera ancor più radicale, e quasi ribaltando lo schema evolutivo e le dinamiche cicliche di progresso e decadenza dell’arte, trovava già nella Sicilia Aubin Louis Millin, Introduzione dell’età classica il principio di allo studio delle pietre intagliate, una perfezione, sboccata poi Palermo 1807. nel XII secolo e rifiorita nel Cinquecento. La Sicilia, dove la gliptica era già diffusa nelle colonie greche, produsse «infiniti lavori di tal genere della più bella invenzione, del più elegante disegno, e della più diligente e graziosa esecuzione»29; oggetti piccoli e facilmente trasportabili, «divenuti preda degli avidi viaggiatori» e portati nei loro musei, che «hanno dovuto incitare i loro artisti o a imprenderne simili, o a migliorare il loro bulino, e certo a propagarvi l’amore di quest’arte»30. nomi degli incisori siciliani di gemme e di medaglie, «per annunziarli il primo nella mia storia delle nostre belle arti antiche e moderne, e non esporli innanzi alla rapacità di qualche pirata [scil. Gioacchino Di Marzo] che scrivacchia sullo stesso argomento»25. Lo scrittore dimostra di aver letto anche Angelo Mazzoldi26 dal quale fa discendere uno schema di periodizzazione delle arti, nate etrusche, sul suolo italico, anziché greche, che incontra l’ascendente della sua parabola nel Rinascimento. Che in Italia risorgesse prima che altrove il disegno figurativo dopo il rinascimento delle arti è stato provato da tutti gli scrittori anche stranieri. Ed essendo esso base ed elemento indispensabile dell’intaglio in pietre dure e della incisione o cesellatura in metalli, certo è che l’Italia dovea precedere in questi rami tutte le altre nazioni27. Chiosa poi: l’arte di incidere in pietre dure piccolissime figure ed ornati offre maggiori difficoltà che quella di scolpire in grande nel marmo, ed è per sé stessa oggetto di massimo lusso reale o principesco, e di gran costo per il tempo indispensabile a condurre gli oggetti a perfezione, così non poteva salire al massimo grado di essa che nel secolo del più squisito gusto e più fastoso lusso e di maggior ricchezza in Italia, che fu tutto il corso del XVI secolo28. Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 87 numero 3 - maggio 2011 L’esaltazione del primato italiano, cui si giunge attraverso scorciatoie – i «buoni lavori» delle officine Malvica alla Rocca38 per la raffinata idealistiche e letterariamente retoriche, induce Gallo a confutare eleganza dei motivi ornamentali neoclassici; allunga invece una la «strana opinione» di Cesare Cantù31 fitta ombra sulle cineserie e con accenti sul primato della Francia nell’arte dello energici ne stigmatizza il brutto nei smalto: egli fa così osservare che in Sicilia «vasoni dipinti della Cina e del Giappone, sin dall’epoca normanna e aragonese si pesantissimi per la porcellana […] goffi realizzarono mirabilia di arte suntuaria per le ridicole figure di quegli stupidi quali la Corona di Costanza32, il «calice di cinesi, da stupidi artisti effigiati e dipinti»39. forma greca, fregiato di antiche miniature Qui Gallo spara a zero, malevolo e con e smalti»33 custodito nella chiesa di S. Maria un tono pontificale, espressione di quel di Randazzo34, il Paliotto Carandolet del classicismo che ne aveva irreggimentato Tesoro della Cattedrale di Palermo35. Qui il gusto, orientandone le direttrici della è opportuno rilevare la piena sintonia con ricerca storiografica nonché molte un clima culturale sensibile alla riscoperta scelte collezionistiche fra cui, appunto, i etico-estetica del medioevo normanno“bianchi” Malvica40. svevo, anche in termini di tutela e restauro Preso l’abbrivo dagli elenchi di intagliatori architettonico36, in anni che videro a guida scrutati da Vasari e Baldinucci (i.e. Matteo del dicastero della Istruzione Pubblica del Nassaro, Giovanni Jacopo Caraglio, Michele Amari storico islamista37. Valerio Vicentino, Alessandro Cesari, Vincenzo Riolo, Ritratto di Valerio Villareale, Palermo, Nel paragrafo successivo è toccato il tema Biblioteca Comunale. Foto Enzo Brai. Jacopo da Trezzo, Annibale Fontana della «porcellana ben dipinta con figure ed ornati» e Gallo trova e gli altri), Gallo fa splendere, in un’ideale linea di continuità, la idoneo lodare – dopo Faenza, Ginori e la Real Fabbrica di Napoli pleiade dei comprimari siciliani. Apre un artista di prim’ordine, teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 88 numero 3 - maggio 2011 Il mercato di monete e medaglie celebrative, placchette e bassorilievi su pietre dure – tramite cui si erano incrementate le collezioni archeologiche di musei locali quali il Salnitriano46 o il Martiniano47 – toccò l’apice con la cultura neoclassica e, dalla fine del ’7 all’800, svolse un’importante funzione di educazione al gusto antico48. Queste classi di oggetti concorsero a orientare il fare artistico verso l’imitazione dei classici anche nella didattica accademica; furono argomento d’illustrazioni49 corredate da tavole con effigi gemmali o monetali costituenti l’enorme congegno mnemotecnico di un Valerio Villareale41 scultorerestauratore del Real Museo Borbonico, direttore degli scavi di Pompei, e dal 1815, anno del suo rientro a Palermo, professore di Scultura e direttore dello Stabilimento di Belle Arti della R. Università degli Studj42, il quale più per diletto e per picca di emulare l’antico volle ancora incider cammei e gemme, e vi riuscì egregiamente, come nella scultura in marmo [con opere che] son modello di elegante stile e contestano che ancor vive tra’ siciliani l’antico genio ellenico43. Raffaello Politi, Un cammeo in onice, in “Poliorama Pittoresco”, Napoli 1843. È arcinoto che negli anni dell’apprendistato romano l’artista, introdotto nel circuito antiquario grazie anche alla mezza parentela con lo scultore incisore e medaglista Benedetto Pistrucci44, era molto concentrato nella realizzazione di gemme incise benvolute all’emporio d’arte della capitale in fibrillazione per l’antico45. Melchiorre Di Bella, Giuseppe Garofalo, numismatica, in Opuscoli siciliani, XIII, 1772. Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 89 Tavola numero 3 - maggio 2011 museo cartaceo, che rivela – lo ha notato Pomian50 – l’interesse essenzialmente iconografico verso le immagini incise su tali manufatti (al di là della qualità della pietra). Saremmo dunque in errore se sottovalutassimo il ruolo-guida dell’antiquaria, in Sicilia vicaria della critica d’arte fino ai primi tre decenni del XIX secolo, o il gran fermento della coeva stampa periodica51 di cui i tanti articoli apparsi nel “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia” di Palermo reggono un’esauriente campionatura52. Al di là del redditizio commercio dell’antico – anche a prezzi stracciati stando alla testimonianza di un fine collezionista, l’erudito danese Frederik Münter, che fu tra noi sullo scorcio del XVIII secolo53 – non dovrebbero esser trascurati i buoni esiti di un mercato parallelo di oggetti moderni venduti per autentici. Perché Michele Laudicina (attr.), Cammei, Trapani, Museo regionale Pepoli. «anche falsificare poteva essere un gioco, ma era soprattutto una sfida: nei confronti dell’antico che si imitava, nei confronti degli esperti cui si sottoponeva l’opera»54, come ricorda Gallo in teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 90 numero 3 - maggio 2011 quell’aneddoto55 su un ‘falso antico’ acquistato da un grand-tourist, incisione de’ cammei e gemme che copiava dagli antichi, e per tali li vendeva a gran prezzo agli stranieri»63. Artista prolifico «molto esperto e risoluto nel maneggio del bulino», bravo sì, ma con un talento più imitativo che originale, non riuscendo altrettanto ispirato nei lavori d’invenzione, se una sua agata orientale raffigurante Ferdinando I a cavallo lasciò un tale scontento nell’entourage reale che all’artista non fu corrisposto nemmeno il pattuito64. Laudicina – epigono di Villareale come i fratelli Giuseppe e Raffaele65 – istruì nell’arte di intagliare cammei e incidere conchiglie i due nipoti Michele jr. – scomparso nel 1837 – e Giuseppe, ancora attivo nel 1863 «con riputazione di valoroso artista»66. Salutato da Gallo come uno dei migliori artisti contemporanei, Tommaso Aloysio Juvara, allievo di Vincenzo Camuccini a Roma e di Paolo Toschi a Parma e «fra i primi incisori italiani moderni pel corretto disegno, per la morbidezza delle carni, la grazia e la varietà del bulino, imitativa degli oggetti»67. La storia dell’incisione, oltre Vincenzo Catenacci o Filippo Rega, non può prescindere da altri nomi eccellenti, primi fra tutti i fratelli Bartolomeo e Luca Costanzo da Sambuca68, principali artefici della produzione medaglistica dei Borbone69, «che seppero imitar sì bene le più rare monete grecosicule, fra le quali la Sicheliotan, da illudere i più esperti conoscitori stranieri che le compravano come antiche»70. Laudator temporis acti, realizzato proprio da Villareale, abilissimo nel modellare anche statuette fittili à la grecque56. Objets d’art per amatori facoltosi decisi a procacciarsi cammei – spesso adeguati alle funzioni decorative dell’oreficeria e montati in gioielli e parures – o incisioni su conchiglia, un materiale più economico della pietra dura e anche più facile da scolpire visto che per incidere le valve non era necessario il banco con castelletto57. Opere spesso premiate pubblicamente con medaglie d’oro o d’argento58 nelle mostre periodiche organizzate dal Reale Istituto d’Incoraggiamento di arti e manifatture, da Ferdinando II di Borbone «con tanta sapienza al bene di questo regno stabilito»59. Di più: l’ambiente orafo trova sponda negli interventi sui periodici (si leggano per esempio gli encomi sull’orafo palermitano Giovanni Fecarotta60) e, su scala nazionale, in pubblicazioni come il saggio di “oreficeria archeologica” licenziato a Firenze nel 1862 dall’orafo e antiquario romano Augusto Castellani61. V olevo continuare questo ragionamento e notare come, non a caso, l’altra figura menzionata sia il già ricordato Michele Laudicina, professore di Gliptica a Trapani62, che «diessi di proposito alla Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 91 numero 3 - maggio 2010 Gallo pratica ancora il luogo winckelmanniano della superiorità degli antichi cui i moderni fanno bene a tendere – «il genio eccitato dal clima e da’ grandi modelli»71 – e svela un debole verso oggetti simili, amati anche sotto forma di impronte, che amava mostrare nella casa-museo all’Olivella summa delle sue esperienze e luogo di incontro per artisti, dotti, visitatori72. Non meno interessanti mi sembrano le glosse sul medaglista Giuseppe Barone73, su Ignazio Melazzo – «valente e franco incisor di medaglie» ma scaltro contraffattore di conî, al fresco già dal 182774 –; sull’orafo Marco Di Chiara, allievo di Giuseppe Patania e Valerio Villareale, del quale Gallo aveva scritto nel 1839 su “L’Oreteo” di Palermo75; su Paolo Cataldi, infine, altro «abilissimo orafo, che speculò un metodo e una macchina per riprodurre medaglie antiche»76. In particolare, l’attività di quest’ultimo artista, originario di Buccheri e attivo nel Val di Noto, risulta documentata in alcune carte d’archivio inedite da cui vien fatto di supporre che il problema delle falsificazioni fosse tenuto in un certo conto dalla politica culturale borbonica77. solo l’esistenza di un mercato di copie e contraffazioni nei conî – che automaticamente consentiva alle richieste di un collezionismo competitivo disposto a tutto pur di completare le serie mancanti – ma un largo orizzonte che intriga storia economica e storia del gusto, argomento che rinvio volentieri a una prossima occasione. Del resto già Domenico Sestini, regio antiquario di S.A.R. il Granduca di Toscana, ricorda come nel XVIII secolo a Catania, città in cui prestava servizio come bibliotecario presso Ignazio Paternò Castello V principe di Biscari, godesse largo successo un’officina di falsificatori esperta nell’imitazione degli esemplari più rari78. Detto questo occorre aggiungere che non solo l’anticomania caratterizzava la cultura artistica isolana, ma tutta una produzione di cui Gallo arguisce il pregio intrinseco dai materiali trattati con un raffinamento creativo di straordinaria sottigliezza e vivacità. Ma lasciamolo dire: In Sicilia diverse produzioni naturali, come le agate, i diaspri, e altre pietre a diversi colori, l’ambra, il corallo, le madriperle, le conchiglie, hanno apprestato agli artisti nell’intaglio i materiali più belli e svariati, onde effigiarvi graziose figurine. Talché fu promosso un commercio attivissimo con gli stranieri da più secoli, principalmente sostenuto da Trapani, città addetta a tali incisioni, e feconda di vivaci e industriosi ingegni79. N on è l’unico riferimento all’attività di falsari, su cui sono riuscito a recuperare una casistica eterogenea testimoniante non teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 92 numero 3 - maggio 2011 Maestranze siciliane, Paliotto (part.), II metà XVII sec., chiesa di S. Giuseppe dei Teatini, Palermo. Foto Enzo Brai. Oltre alla silografia impiegata per i libri illustrati nell’editoria sin dal XV secolo80, la Sicilia poteva vantare a parere dello scrittore il primato assoluto nell’uso delle «gemme fittizie», le paste vitree colorate e dorate. Invenzione per consuetudine ascritta al francese Homberg agli inizi del XVIII secolo, ma qui già attestata in epoca fenicio-punica81, ricomparsa con l’arte musiva in età normanna e tornata in voga nell’Ottocento con Angelo e Luigi Gallo82, fratelli di Carmelo Bajamonte Agostino, tramite molteplici impieghi anche nel campo del restauro «per riparare i guasti degli antichi musaici»83. Suscita attenzione anche il passo sul fantasioso artificio dei marmi policromi al quale Gallo affida tutta la sua soddisfazione per il genio siciliano: «Il talento speculativo de’ siciliani si valse di questi marmi per imitar la natura nel comporre con vari pezzetti, secondo le proprie tinte, fiori, piante e ornati che risultano di grande effetto e bellezza»84. Un giudizio molto positivo che potrebbe spendersi sia per l’ornamentazione barocca sia per lavorazioni del XIX secolo, come i pavimenti e i rivestimenti in marmo e mosaico della neogotica casa Forcella, citati a non finire dalla contemporanea letteratura artistica come non plus ultra di bello artificio85. Gallo scandaglia la cattivante peculiarità del mischio siciliano – cui, a differenza del mosaico fiorentino impiegato negli opifici medicei solo per «mobili e tavolini», è tributato «l’onore di anteriorità e d’invenzione […] laonde Palermo può andare fastosa per questo riguardo più che la bella ed elegante Firenze e la magnifica Roma» – con cui dal XVII secolo si approntò il rutilante addobbo permanente per chiese e cappelle. Nell’iperbole di queste righe – più che sottolinearvi la scarsa conoscenza di un’opera quale la Cappella dei Principi, mausoleo di Ferdinando I de’ Medici (1604), e dei relativi studi monografici86, a dimostrazione del fatto che nella città Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 93 numero 3 - maggio 2011 toscana non si producessero soltanto arredi lapidei – può essere applaudita la maturità di giudizio sul valore delle decorazioni a marmo mischio che a quella data non doveva essere così pacifica, se l’autore biasima in una nota la dismissione degli apparati marmorei e la demolizione della parrocchia di S. Giacomo la Marina di Palermo87, avvenute proprio nel 1863 quando il suo scritto A.Fecarotta(Dis.eLit.),Cinquemani odorava ancora di inchiostro. & Marotta (Lit.), Urna di S. Rosalia. Fra le «sotto-specie» della scultura è annoverata l’argenteria depauperata lungo i secoli da alienazioni consumate «con pietosa fraude». È il caso di annotare che l’arte degli argentieri del XVII secolo, fucina di “macchine” barocche come l’Urna di S. Rosalia (1631) della Cattedrale di Palermo88, si ritrova affiliata stilisticamente alla blasonata scuola gaginiana tardo rinascimentale, giacché sono «gli ultimi scolari degli scolari di Antonio Gagini»89, e soprattutto Nibilio90 – che Gallo confonde con Niccolò, figlio di Giacomo, stando alla lezione tràdita da Vincenzo Auria nel Gagino redivivo (1698) –, a essersi distinti per le loro belle fatiche, fra cui ricorda il paliotto di seta ricamata con placche d’argento per i benedettini di S. Martino R. Politi, Giacomo Bongiovanni e Giuseppe delle Scale91. Vaccaro, in “Poliorama Pittoresco”, Non mancano cenni alla Napoli 1843. ceroplastica, «ch’è pure de’ tempi greci e romani in Sicilia, non indietreggiò nell’epoca moderna, particolarmente in Palermo»92, e a un’artista ricca di intuizioni, Anna Fortino, allieva di Rosalia Novelli e Giacomo Serpotta93, alle cui «opere squisite» Agostino Gallo aveva fatto assumere un rilievo di primo piano già nell’articolo uscito su “Passatempo per le Dame”94. Affine all’arte della cera è la teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 94 numero 3 - maggio 2011 coroplastica «madre del di Caltagirone, «addetti cisello e dell’incisione», a modellare in argilla in cui si distinsero i costumi villaneschi in epoca classica delle nostre contrade Demofilo, Gorgaso e con tal verità ed il pittore Zeusi, il cui espressione da recar luogo natale (Eraclea sorpresa e diletto. Minoa) era stato Laonde sono avidaprima reclamato alla mente ricercati e Sicilia95. Sono trascorsi comprati dagli strapochi anni dal 1858, nieri»99. quando Raffaello Politi, Mi occorre spendere corrispondente di Gallo, qualche parola in pubblica i Cenni biografici merito a una certa su’ valentissimi plasticisti da insistenza di Gallo Caltagirone Bongiovanni e sulla commerciabilità Vaccaro96, già passati sul di queste manifatture, Giovanni Antonio Matera (e bottega), Presepe, Palermo, Collezione privata. Foto Enzo Brai. “Poliorama Pittoresco” elemento che è forse di Napoli nel 184397. Il palermitano sembra guardare all’excursus uno dei più significativi nel suo opuscolo, da decifrare come pieno storico della ceramica tratteggiato dall’amico siracusano, con cui convincimento di un alto standard qualitativo e di un possibile scambiava idee, libri, quadri98: è comparabile l’impostazione diacroallargamento imprenditoriale per alcune officine di industria nica culminante proprio nei gruppi di terracotta dei Bongiovanni artistica100, che avevano ottenuto incoraggianti riconoscimenti Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 95 numero 3 - maggio 2011 anche nell’International Exhibition di Londra del 1862101. È facile accorgersene anche quando il palermitano illustra i presepi in legno, tela e colla di «un certo Matera», elogiato per la «insuperabile semplicità, verità ed espressioni ne’ pastori»102. L’occhio da conoscitore ne coglie le specificità del linguaggio con i richiami al naturalismo pittorico seicentesco e alle sculture di Bernini – come era stato già notato da Jacob Burckhardt103 – e l’attitudine per una messa in scena atipica rispetto alla tradizione napoletana, i cui scarabattoli «senza l’artificio d’un paesaggio artistico, non producevano il bell’effetto di quelli di Palermo»104. Prima di finire un’ultima osservazione: con questi brevi accenni Gallo arma la prora verso ulteriori studi che cadono ai primissimi anni del Novecento, in un’ottica riferibile, grosso modo, alla museologia e alla storia del collezionismo – si prenda come esempio il tentativo di approfondimento svolto da Salvatore Romano proprio sulle opere di Giovanni Matera105 – o al problematico aspetto dell’attribuzionismo e alla fortuna critica di artefici di difficile identificazione, come i Nolfo scultori trapanesi, sulle cui tracce doveva muovere, con risultati non sempre illuminanti, il canonico trapanese Fortunato Mondello106. Ho idea, dunque, che la proposta d’interpretazione affacciata da Agostino Gallo – un autore che anche in anni recenti non ha smesso di appassionare la critica – si ponga principalmente come un superamento del divario fra arti alte e applicate in una nuova prospettiva nazionale. Un primo apporto, non senza distorsioni campanilistiche e tratti inconferenti, ma però apprezzabile nell’attesa del riconoscimento che le seconde vivranno presto in Sicilia, solo che si rifletta sulla fondazione del Museo Artistico Industriale diretto dallo scultore Vincenzo Ragusa (1884)107, sulla vivace diffusione di periodici specialistici108, e sull’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-’92, con numerose divisioni dedicate alle arti industriali109. ________________________ L’autore ringrazia Enzo Brai per la ricerca iconografica e la selezione delle immagini. 1 Sul tema cfr. S. La Barbera, Le arti decorative nelle fonti e nella letteratura artistica siciliana, in Splendori di Sicilia. Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Charta, Milano 2001, pp. 260-277. 2 Benigno da Santa Caterina, Trapani nello stato presente, profana e sacra, mss. del 1810-1812, custoditi ai ss. 199-200 presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani. 3 G.M. Fogalli, Memorie biografiche degl’illustri trapanesi per santità, nobiltà, dottrina ed arte, ms. della I metà del XIX secolo, custodito ai ss. 14 C 8 presso la Biblioteca del Museo regionale “A. Pepoli” di Trapani. 4 Per il trapanese Giuseppe Maria Berardo Di Ferro e Ferro cfr. S. La Barbera, Giuseppe Maria Di Ferro teorico e storico d’arte, in Miscellanea Pepoli. Ricerche sulla cultura artistica a Trapani e nel suo territorio, a cura di V. Abbate, Trapani 1997, pp. 147-166. 5 C. Pasca, Cenno di Cesare Pasca beneficiale della real cappella Palatina di Palermo. Delle pietre dure e dell’arte di lavorarle – Dell’uso e commercio dei marmi – Su gli smalti e teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 96 numero 3 - maggio 2011 Visconti (1802-1880), in “Bollettino dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie”, XIX, 1999, pp. 113-127. In anni precedenti il rapporto fra Agostino Gallo e Pietro Ercole Visconti era stato animato dalla polemica letteraria su Angelo Costanzo e Vittoria Colonna, come ricordato da A. Gallo, Risposta alle osservazioni critiche del chiar. cav. Pietro Ercole Visconti sulla vita di Angelo di Costanzo scritta da Agostino Gallo, in Poesie italiane e latine e prose di Angelo di Costanzo or per la prima volta ordinate e illustrate con la giunta di molte rime inedite tratte da un antico codice la versione poetica de’ carmi latini e la vita dell’autore per opera di Agostino Gallo siciliano, Lao, Palermo 1843. 15 A. Gallo, Necrologia di Giuseppe Patania, in “GASLA”, t. CXXIV, gennaiofebbraio-marzo,1852, pp. 344-354 16 Id., Vita di Angelo Marini siciliano insigne scultore ed architetto del secolo XVI per la prima volta messo in luce da Agostino Gallo da Palermo, in “GASLA”, t. CLXXIII, n.s. XXVII, giugno, luglio e agosto 1861, 1862, pp. 327-356. 17 Allo scultore carrarese il Decurionato messinese commissionò la statua in bronzo di Ferdinando II. Cfr. L. Paladino, Situazione della scultura a Messina nell’Ottocento, in La scultura a Messina nell’Ottocento, catalogo della mostra a cura di L. Paladino, Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I., Messina 1997, pp. 19-25. 18 A. Gallo, Saggio di Agostino Gallo su’ pittori siciliani vissuti dal 1800 al 1842, in G. Capozzo, Memorie su la Sicilia tratte dalle più celebri accademie e da distinti libri di società letterarie e di valent’uomini nazionali e stranieri con aggiunte e note per Guglielmo Capozzo socio di varie accademie, vol. III, Virzì, Palermo 1842, pp. 123-147. Per il Saggio cfr. S. La Barbera, Il «Saggio sui pittori siciliani vissuti dal 1800 al 1842» di Agostino Gallo, in Le parole dei giorni. Scritti per Nino Buttitta, vol. I, a cura di M.C. Ruta, Sellerio, Palermo 2005, pp. 358-377. 19 Vedi F. Bologna, La coscienza storica dell’arte d’Italia, Garzanti, Milano 1992, in part. pp. 165 e ss. Per la situazione siciliana cfr. S. La Barbera, Dall’erudizione alla connoisseurship alla critica d’arte in Sicilia. Metodologia degli studi sull’arte dalla fine del secolo XVIII ai primi decenni del XX secolo, in Metodo della ricerca e Ricerca del metodo. Storia, arte, musica a confronto, atti del convegno di studi (Lecce, 21-23 maggio 2007) a cura di B. Vetere con la collaborazione di D. Caracciolo, Congedo, Galatina 2009, pp. 283-310. 20 «Si comprendeva ormai che la migliore aureola glorificante da offrire alla Sicilia consisteva nell’esaltarne il valore, per cosi dire, materno nei confronti della cultura italiana: la Trinacria, erede incorrotta e continuatrice di greci e di latini, l’arte del mosaico – Sulle crete e l’arte di lavorar la terra cotta – Delle terre che si possono usare nella pittura e dell’asfalto, in “La Lira. Giornale artistico-letterario-teatrale” [poi “La Lira”], a. I, n. 26, 27 marzo 1852, pp. 101-102: «Ho voluto qui brevemente parlare dello stato attuale di alcune arti in Sicilia, e delle materie indigene che servono all’esercizio di esse, per essere un soggetto poco trattato dagli altri. Mi sono prefisso in questo un doppio scopo: di promuovere dai privati imprenditori il miglioramento di esse arti, e l’introduzione dei materiali proprî del nostro suolo, e quando l’opera de’ privati non bastasse chiedere la protezione della pubblica autorità». Ivi, p. 101. 6 Per il profilo di Agostino Gallo (1790-1872) cfr. F.P. Campione, Agostino Gallo: un enciclopedista dell’arte siciliana, in La critica d’arte in Sicilia nell’Ottocento. Palermo, a cura di S. La Barbera, Flaccovio, Palermo 2003, pp. 107-127. 7 A. Gallo, Sull’influenza ch’esercitarono gli artisti italiani in varii regni d’Europa ad introdurvi, diffondervi o migliorar l’arte d’intagliar cammei in pietre dure e tenere, incidere in rame, cesellare e smaltare in argento e in oro, Tipografia Barcellona, Palermo 1863. 8 Per la figura e l’opera di Gioacchino Di Marzo cfr. S. La Barbera, Gioacchino Di Marzo critico d’arte dell’Ottocento, in Sul Carro di Tespi. Studi di storia dell’arte per Maurizio Calvesi, a cura di S. Valeri, Bagatto Libri, Roma 2004, pp. 211-228. 9 G.M. Mira, Bibliografia Siciliana ovvero Gran Dizionario Bibliografico delle opere edite e inedite, antiche e moderne di autori siciliani o di argomento siciliano stampate in Sicilia e fuori, vol. I, Gaudiano, Palermo 1875, pp. 387-394; A. Gallo, Autobiografia (ms. XV. H. 20.1.), ed. a cura di A. Mazzè, Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, Palermo 2002, in particolare pp. 100-132. 10 A. Gallo, Notizia intorno all’arte dell’intaglio in legno dell’epoca Sveva in Sicilia, in “Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia” [poi “ESLS”], t. V, a. II, 1833, pp. 94-96. 11 Id., Necrologia, in “ESLS”, t. V, a. II, 1833, pp. 104-105, in cui tra i lavori di «tutto finimento» del Laudicina sono menzionati gli oggetti della collezione del principe di Trabia. 12 Ibid., pp. 105-107. 13 A. Gallo, Sull’arte dell’intaglio in pietre dure o tenere in Italia. Saggio di Agostino Gallo da Palermo, in “Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti” [poi “GASLA”], t. CLXXXI, n.s. XXXVI, gennaio-febbraio 1863, 1864, pp. 50-85. 14 Per il quale cfr. D. Pacchiani, Un archeologo al servizio di Pio IX: Pietro Ercole Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 97 numero 3 - maggio 2011 raccolte con diligenza da Agostino Gallo da Palermo (ms. XV. H. 16, cc. 1r-25r; ms. XV. H. 15, cc. 62r-884r), ed. a cura di A. Anselmo, M.C. Zimmardi, Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, Palermo 2004. Sulle polemiche fra Gallo e Di Marzo cfr. A. Mazzè, L’incompiuta Storia delle Belle Arti: progetti e polemiche, in A. Gallo, Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esteri soggiornanti in Sicilia da’ tempi più antichi fino al corrente anno 1838. Raccolte diligentemente da Agostino Gallo palermitano per formar parte della sua Storia delle belle Arti in Sicilia (ms. XV. H. 14), ed. a cura di A. Mazzè, Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, Palermo 2000, pp. V-XXIII. 26 A. Mazzoldi, Delle origini italiche e della diffusione dell’incivilimento italiano all’Egitto, alla Fenicia, alla Grecia e a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo, Guglielmini e Redaelli, Milano 1840. 27 A. Gallo, Sull’influenza…, pp. 5-6. 28 Ivi, p. 6. 29 Ibid. 30 Ibid. 31 Ibid. Con molta probabilità con riferimento alla lettera Sugli smalti pubblicata dal briviese a Milano nel 1833. 32 Ibid. Sull’opera, custodita nel Tesoro della Cattedrale di Palermo, cfr. C. Guastella, in Federico e la Sicilia dalla terra alla corona, vol. II, arti figurative e suntuarie, catalogo della mostra a cura di M. Andaloro, Ediprint, Siracusa 1995, scheda 6, pp. 63-74; M.C. Di Natale, Ori e argenti del Tesoro della Cattedrale di Palermo, in M.C. Di Natale, M. Vitella, Il Tesoro della Cattedrale di Palermo, Flaccovio, Palermo 2010, pp. 39-52. 33 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 20. 34 E. Mauceri, Monumenti di Randazzo, in “L’Arte”, IX, 1906, pp. 185-192, fig. 3, p. 186; S. Bottari, Le oreficerie di Randazzo, in “Bollettino d’Arte”, a. VII, s. II, n. I – luglio, 1927, pp. 301-309, fig. 1; M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Flaccovio, Palermo 1974, p. 127. 35 A. Gallo, Vita di Angelo Marini…, p. 348, nota 1. Per l’opera cfr. C. Guastella, in Federico e la Sicilia…, vol. II, scheda 21, pp. 123-133; M. Vitella, I manufatti tessili della Cattedrale di Palermo, in M.C. Di Natale, M. Vitella, Il Tesoro…, pp. 112-114. 36 F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni. Protagonisti ed interpreti del restauro dei ponte tra la classicità e i tempi nuovi dell’Italia moderna». G.C. Marino, L’ideologia sicilianista. Dall’età dei «lumi» al Risorgimento, Flaccovio, Palermo 1971, p. 199. 21 G. Di Marzo, Delle Belle Arti in Sicilia dai Normanni sino alla fine del secolo XIV, vol. I, Salvatore Di Marzo, Palermo 1858, pp. 67-68. 22 «[…] in altri miei saggi proverò del pari che ciò avvenne anche per l’architettura, per la scultura in marmo, la pittura e la musica e per molte invenzioni utili al consorzio civile». A. Gallo, Sull’influenza…, p. 19. Un’urgenza evidentemente molto sentita da Agostino Gallo che nel 1863 aveva fondato insieme con alcuni studiosi siciliani anche l’Assemblea di Storia Patria, con lo scopo di far conoscere il contributo dato dalla Sicilia all’Unità italiana e al progresso della civiltà. Cfr. V. Di Giovanni, La prima Società di Storia Patria in Palermo (17771803), in “Archivio Storico Siciliano”, n.s., a. VIII, 1883, pp. 497 e ss. 23 A.P. Giulianelli, Memorie degli Intagliatori moderni in pietre dure, cammei, e gioje, dal Secolo XV fino al Secolo XVIII, Fantechi e Compagni, Livorno 1753. 24 Introduzione allo studio delle pietre intagliate del Sig. A.L. Millin. Conservatore degli antichi monumenti nella Biblioteca di Parigi, e Professore d’istoria e delle antichità nella medesima. Dal francese nell’idioma italiano ridotta, Solli, Palermo 1807. Il nome di Aubin-Louis Millin de Grandmaison circola moltissimo in Sicilia sia attraverso il Dizionario portatile delle favole (Bassano 1804) che con questa Introduzione allo studio delle pietre intagliate, pubblicata in prima edizione a Parigi nel 1796, tradotta a spese di Francesco Abate e stampata nel 1807 per i tipi Solli. L’edizione previde un apparato di «poche note, che riguardano alcuni articoli dell’arte d’intagliare in Sicilia» e su artisti dello scolpire in piccolo, come i fratelli trapanesi Andrea e Alberto Tipa. In aggiunta alla descrizione delle pietre e della «parte meccanica della gliptica», di tipologie e collezioni italiane e europee, una parte dello scritto è dedicata alla «critica delle pietre intagliate» cioè a dire «l’arte di formare un giudizio, sia intorno alla bellezza, ovvero all’antichità delle medesime», nella consapevolezza che «il saper distinguere le pietre antiche da quelle moderne è cosa assai difficile, e si sono da se stessi ingannati i più abili conoscitori», p. 43. Per Aubin-Louis Millin (Parigi 1759-1818) cfr. M. Preti-Hamard-B. Savoy, infra. 25 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 5, nota 2. Le notizie manoscritte sono ora A. Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione delle monete in Sicilia dall’epoca araba sino alla castigliana (ms. XV. H. 15, cc. 1r-45v) Notizie de’ figularj degli scultori e fonditori e cisellatori siciliani ed esteri che son fioriti in Sicilia da più antichi tempi fino al 1846 teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 98 numero 3 - maggio 2011 nota 1, p. 27. Villareale v’insegnò anche Glittica e Osteologia dal 1827 al 1837. 43 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 12. Qui Gallo riprende un topos della letteratura su Villareale come artista neoclassico che «ha più diritto alla nostra gratitudine per aver preso la scultura da mani di Ignazio Marabitti che immegliandola bensì non poté però rialzarla alle vere sue forme di bellezza per le capricciose e sconce maniere invalse verso la metà del secolo XVIIo». E. Amato, La Psiche del sig. Valerio Villareale, in “Il Contemporaneo. Giornale periodico di Scienze e Lettere, di Arti e Mestieri”, a. I, n. 4, 15 febbraio 1846, p. 32. 44 Nel 1802 Villareale sposò Teresa Lucchi cugina del Pistrucci. Cfr. G.A. Guattani, Memorie enciclopediche romane sulle Belle arti, antichità etc., vol. I, Salomoni, Roma 1806, p. 124. Si veda pure Sgadari di Lo Monaco, Pittori e scultori siciliani dal Seicento al primo Ottocento, Agate, Palermo 1940, p. 151. 45 S. Costanzo, Valerio Villareale, in “Passatempo per le Dame” [poi “PpD”], a. 4, n. 38, 17 settembre 1836, pp. 301-305 scrive che l’artista «anche in questo ramo [la gliptica] seppe trarsi l’altrui ammirazione facendo de’ non pochi squisiti lavori che gli procacciaron fama perché di un’attitudine originalissima, e con quei tagli assoluti di che i Greci usavano per dar finimento ad opere di cotal natura» p. 303. Per la situazione romana vedi L. Pirzio Biroli Stefanelli, Glittica, medaglistica, oreficeria. Artisti-artigiani per l’Europa, in Maestà di Roma da Napoleone all’Unità d’Italia. Universale ed Eterna Capitale delle Arti, catalogo della mostra, Electa, Milano 2003, pp. 517-520; A. Pinelli, Il Neoclassicismo nell’arte del Settecento, Carocci, Roma 2005, pp. 69-77. Imprescindibile F. Haskell, N. Penny, L’antico nella storia del gusto. La seduzione della scultura classica 1500-1900, Einaudi, Torino 1984. 46 Per il museo, istituito dal gesuita Ignazio Salnitro nel 1730 nei locali del Collegio Massimo dei Gesuiti di Palermo, cfr. R. Graditi, Il museo ritrovato. Il Salnitriano e le origini della museologia a Palermo, Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I., Palermo 2003. 47 Sul museo dell’antica abbazia benedettina di San Martino delle Scale la cui origine (1744) si deve all’iniziativa del priore Giuseppe Antonio Requesens e di don Salvadore Maria Di Blasi, cfr. V. Abbate, «Ut mei gazophilacii … nova incrementa pernosceres»: Salvadore Maria Di Blasi e il Museo Martiniano, in Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Electa, Napoli 2001, pp. 165-176; R. Equizzi, Palermo San Martino delle Scale. La collezione archeologica: storia delle collezione e catalogo delle ceramiche, «L’Erma» di Bretschneider, monumenti a Palermo nella seconda metà dell’Ottocento, Officina, Roma 1994, pp. 55 e ss. Sul mito del medioevo nel XIX secolo cfr. I. Porciani, Il Medioevo nella costruzione dell’Italia unita: la proposta di un mito, in Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell’Ottocento: il Medioevo, a cura di R. Elze, P. Schiera, Il Mulino - Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 1988, pp. 163-191. 37 Senatore del Regno unitario dal 1861 per volere di Cavour, Michele Amari (1806-1889) resse il dicastero dal dicembre del 1862 al settembre del 1864. 38 R. Daidone, Le officine palermitane di maiolica della seconda metà del Settecento. Testimonianze e documenti, in Terzo fuoco a Palermo 1760-1825. Ceramiche di Sperlinga e Malvica, catalogo della mostra a cura di L. Arbace, R. Daidone, Arnaldo Lombardi, Palermo 1997, pp. 17-29. 39 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 9. Per le cineserie cfr. H. Honour, L’arte della cineseria. Immagine del Catai, Sansoni, Firenze 1963. Per le ricadute locali P. Palazzotto, Riflessi del gusto per la cineseria e gli esotismi a Palermo tra Rococò e Neoclassicismo: collezionismo, apparati decorativi e architetture, in Argenti e cultura Rococò nella Sicilia centro-occidentale 1735-1789, catalogo della mostra a cura di S. Grasso, M.C. Gulisano, Flaccovio, Palermo 2008, pp. 535-561. 40 Gallo ci informa che nella sua collezione erano: «due statuette, una sacerdotessa, ed una Melpomene, che son pregevoli». A. Gallo, Intorno ad un lavoro di maiolica in Palermo, rappresentante la Beata Vergine col Bambino, modellato da Luca della Robbia fiorentino, in “GASLA”, t. CLIX, n.s. XIII, gennaio-febbraio, 1859, pp. 59-73. L’articolo, dedicato a una robbiana con la Madonna col Bambino del convento di S. Domenico di Palermo, anticipa alcuni temi dell’opuscolo sulle arti applicate siciliane di cui noi. Per la robbiana con la Madonna del cuscino cfr. F. Negri Arnoldi, Due esempi di terracotta in Sicilia, in Splendori di Sicilia…, pp. 108-113. 41 Per Valerio Villareale (1773-1854) cfr. D. Malignaggi, Valerio Villareale, catalogo a cura di D. Favatella, “Quaderni dell’A.F.R.A.S. Scultura”, 1, Palermo 1976. Si veda anche I. Bruno, Valerio Villareale un Canova meridionale, allegato a “Kalós – arte in Sicilia”, a. XII, n. 1, Gennaio-Marzo 2000. Per l’attività di restauratore cfr. V. Chiaramonte, Valerio Villareale, scultore e conoscitore, tra cultura antiquaria e restauro, in Gli uomini e le cose. I. Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra XVIII e XX secolo, atti del convegno nazionale di studi (Napoli, 18-20 aprile 2007) a cura di P. D’Alconzo, ClioPress, Napoli 2007, pp. 25-57. 42 F. Meli, La Regia Accademia di Belle Arti di Palermo, Le Monnier, Firenze 1939, Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 99 numero 3 - maggio 2011 Linee e temi della stampa periodica palermitana dell’Ottocento, in Percorsi di Critica…, pp. 87-121. 52 Vedi per esempio N. Maggiore, Ricerche su di alcune medaglie di Camarina antica città della Sicilia, in “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia” [poi “GSLA”], t. 28, fasc. 84, 1829, pp. 269-288; G. Politi, Invito a’ dotti Archeologi per la interpretazione d’un antico Cammeo di Giuseppe Politi siracusano, in “GSLA”, t. 49, fasc. 146, 1835, pp. 127-134; O. Abbate, Lettera al chiarissimo P. Vito Cavallo. Per un cammeo, in “L’Oreteo. Nuovo Giornale”, a. II, n. 23, 1840, pp. 182-183. Per i lineamenti dell’antiquaria in Sicilia cfr. D. Scinà, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, vol. II (Palermo 1825), Edizioni della Regione Siciliana, Palermo 1969, pp. 76-107; vol. III (Palermo 1827), pp. 117-141. Per gli studi di numismatica nel XIX secolo cfr. R. Macaluso, Storia degli studi di numismatica antica in Sicilia: F. Ferrara, G. Alessi, C. Gemmellaro, G. Romano, in “Sicilia Archeologica. Rassegna periodica di studi, notizie e documentazione edita dall’Ente Provinciale per il Turismo di Trapani”, a. XI, n. 38, dicembre 1978, pp. 59-65. 53 «Le dette monete son vendute per un certo discreto prezzo […] in guisachè senza molta spesa se ne può acquistare una mediocre raccolta». F. Münter, Viaggio in Sicilia di Federico Munter tradotto dal tedesco dal tenente d’artiglieria cav. D. Francesco Peranni con note e aggiunte del medesimo. Prima versione italiana, vol. I, Abbate, Palermo 1823, p. 149. Cfr. E. Di Carlo, Dai Diarî di Federico Münter (il suo soggiorno a Palermo), in “Archivio Storico per la Sicilia”, a. IV-V, 1938-1939, pp. 471-481; T. FischerHansen, Frederik Münter in Syracuse and Catania in 1786: antiquarian leglislation and connoisseurship in 18th century Sicily, in Oggetti, uomini, idee. Percorsi multidisciplinari per la storia del collezionismo, atti della tavola rotonda (Catania, 4 dicembre 2006) a cura di G. Giarrizzo, S. Pafumi, Fabrizio Serra, Pisa-Roma 2009, pp. 117-137. 54 C. Savettieri, Dal Neoclassicismo al Romanticismo, Le fonti per la Storia dell’arte, 6, Carocci, Roma 2006, p. 131. 55 «[…] fu presentato da un rivenditore ad un viaggiatore un bel cammeo imitante l’antico, inciso dal nostro artista, e quegli volendosi accertare di esser greco, ne chiese il suo parere. Il Villareale si tolse scaltramente d’imbarazzo con indicargli un antiquario che dicea di aver maggior conoscenza di lui in quel genere; e confermato dal medesimo di essere antico, il viaggiatore lo comprò a gran prezzo». A. Gallo, Sull’influenza…, p. 12. 56 «Lo egregio scultore palermitano Valerio Villareale modellò con questa Roma 2006. 48 Per gli aspetti più generali di questo fenomeno cfr. E. Paul, Falsificazioni di antichità in Italia dal Rinascimento alla fine del XVIII secolo, in Memoria dell’antico nell’arte italiana. I generi e i temi ritrovati, t. II, a cura di S. Settis, Einaudi, Torino 1985, pp. 413-439; K. Pomian, Collezionisti, Amatori e Curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo [1987], il Saggiatore, ed cons. Milano 2007, pp. 306 e ss.; Le gemme incise nel Settecento e Ottocento. Continuità della tradizione classica, atti del convegno di studio (Udine, 26 settembre 1998) a cura di M. Buora, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2006. 49 R. Politi, Un cammeo in onice, in “Poliorama Pittoresco. Opera periodica diretta a diffondere in tutte la classi della società utili conoscenze di ogni genere, e a rendere gradevoli e proficue le letture in famiglia”, a. VII, sem. II (11 Febbrajo – 5 Agosto 1843), n. 51, 29 luglio 1843, pp. 401-403; Id., Due cammei e due intagli in onice descritti dall’artista Raffaello Politi, Stamperia dell’Intendenza, Noto 1847. L’articolo è corredato dalla litografia di G. Riccio del cammeo appartenente alla variegata collezione di Politi; il secondo contributo, dedicato a Nicola Santangelo, ministro segretario di stato di Francesco I, è una succinta descrizione di quattro gemme antiche della medesima collezione. Su Politi cfr. C. Bajamonte, Raffaello Politi (1783-1870). Fra antiquaria e critica d’arte, tesi di Dottorato di Ricerca in Storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea in Sicilia (ciclo XVIII - 2004/2007), Università degli Studi di Palermo, Tutor Prof.ssa Simonetta La Barbera. Per il periodico napoletano cfr. N. Barrella, Il dibattito sui metodi e gli obiettivi dello studio sull’arte a Napoli negli anni quaranta dell’Ottocento e il ruolo di «Poliorama Pittoresco», in Percorsi di Critica. Un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, atti del convegno (Milano, 30 novembre – 1 dicembre 2006) a cura di R. Cioffi, A. Rovetta, Vita e Pensiero, Milano 2007, pp. 21-34. 50 K. Pomian, Dalle sacre reliquie all’arte moderna. Venezia-Chicago dal XIII al XX secolo, il Saggiatore, Milano 2004, in part. pp. 192 e ss. 51 F. Minolfi, Intorno ai giornali e all’odierna cultura siciliana cenno di Filippo Minolfi, Gabinetto Tipografico all’insegna di Meli, Palermo 1837; E. Rocco, Giornali siciliani, in “Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti. Opera periodica compilata per cura di G.R.”, vol. IX, a. III, Napoli 1834, pp. 262-268. Il periodico napoletano, fondato nel 1832 e diretto da Giuseppe Ricciardi, si occupò anche di periodici “al di là del Faro”. Sul ruolo della stampa periodica cfr. S. La Barbera, teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 100 numero 3 - maggio 2011 l’organizzazione delle esposizioni di belle arti, con modalità simili a quelle di altre città italiane, risultò uno dei cardini del sistema dell’arte del XIX secolo. L’istituto fu sottoposto alla Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione e dotato di una sorta di bollettino d’informazione intitolato “Novello Giornale del Reale Istituto d’Incoraggiamento”. Negli anni 1834-1838 le “Effemeridi” di Palermo pubblicheranno i resoconti dei lavori a firma dell’abate Emmanuele Vaccaro segretario del R. Istituto. Gli elenchi di belle arti e dei premi conferiti furono continuati nella forma di opuscoli fino al periodo postunitario. Cfr. R. Busacca, Sullo Istituto d’incoraggiamento e sulla industria siciliana. Ragionamento economico di Raffaele Busacca, Gabinetto Tipografico all’insegna di Meli, Palermo 1835. Sotto l’aspetto artistico, uno dei rarissimi contributi lo offre D. Malignaggi, Accademie e promozioni delle arti nei primi anni dell’Ottocento siciliano, in La formazione professionale dell’artista. Neoclassicismo e aspetti accademici, a cura di D. Malignaggi, Palermo 2002, pp. 7-27. Per il quadro italiano S. Pinto, La promozione delle arti negli Stati Italiani dall’età della riforma all’Unità, in Storia dell’arte italiana. Parte seconda. Dal Medioevo al Novecento, Vol. II, Dal Cinquecento all’Ottocento. II Settecento e Ottocento, Einaudi, Torino 1982, in part. pp. 791-1079; Arti Tecnologia Progetto. Le esposizioni d’industria in Italia prima dell’Unità, a cura di G. Bigatti, S. Onger, Franco Angeli, Milano 2007. 60 Cfr. K., Di un ostensorio, in “Il Buon Gusto. Giornale istruttivo e dilettevole per la Sicilia”, a. I, n. 17, 1 aprile 1852, p. 66-67; Y., Belle Arti. Un grande ostensorio, in “La Lira”, a. I, n. 29, 17 aprile 1852, p. 115. Si veda anche Sul grande ostensorio dei RR. PP. Benedettini di S. Martino lavoro di Giovanni Fecarotta incisore e giojelliere di Palermo. Parole di un amico ed ammiratore di lui, Palermo 1854. Gli scritti trattano della «più bella opera di oreficeria, che ai nostri giorni si fosse mai veduta […] in argento dorato; pezzi d’oro e gemme», realizzata per i pp. Benedettini di San Martino delle Scale da Giovanni Fecarotta. Per l’ostensorio oggi perduto cfr. S. Barraja, Un episodio di conservazione della suppellettile ecclesiastica, in L’eredità di Angelo Sinisio. L’Abbazia di San Martino delle Scale dal XIV al XX secolo, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, F. Messina Cicchetti, Palermo 1997, fig. 3, p. 321. Gli appunti manoscritti di Gallo sull’orafo, risalenti al quarto decennio del XIX secolo, sono ora A. Gallo, Notizie degli incisori siciliani, a cura di D. Malignaggi, Palermo 1994, pp. 123-124. Per gli aspetti tecnico-innovativi dell’oreficeria siciliana cfr. R. Vadalà, Nuove forme dell’oreficeria europea nella Sicilia dell’Ottocento, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito creta [un particolare tipo di argilla proveniente dal feudo Misercannone presso Monreale] come per saggio dei gruppi di figure diverse, e riuscirono così belle da imitare le statuette greche». C. Pasca, Sulle crete e l’arte di lavorare la terra cotta, in “La Lira”, a. I, n. 33, 15 maggio 1852, pp. 129-130. Durante il XIX secolo con questa stessa argilla rossa furono realizzati dalla R. Fabbrica di Napoli anche vasi figurati del tutto simili ai classici. [J.J. Haus], Dei vasi greci comunemente chiamati etruschi delle lor forme e dipinture dei nomi ed usi loro in generale colla giunta di due ragionamenti sui fondamentali principj dei Greci nell’arte del disegno e sulla pittura all’encausto, Reale Stamperia, Palermo 1823, p. 16; cfr. pure G. Galbo Paternò, Sull’arte ceramografica in Sicilia e su gli esperimenti che si sono ai nostri giorni eseguiti. Pochi ricordi di Giovanni Galbo-Paternò Baronello di Montenero, Virzì, Palermo 1847. 57 C. Pasca, Cenno di Cesare Pasca…, p. 102. Nell’articolo oltre a Michele Laudicina e ai Tipa è ricordato il trapanese Giovanni Anselmo, intagliatore di conchiglie attivo intorno alla metà del XVIII secolo. 58 M.S.G. [Stefano Mira e Sirignano Marchesino di San Giacinto], Reale Istituto d’Incoraggiamento, in “PpD”, a. II, n. 23, 7 giugno 1834, pp. 180-181. Nella premiazione del 1834, tenutasi come quella di Napoli il 30 maggio giorno onomastico di Ferdinando II, fra le tante furono conferite medaglie d’argento a Gioachino Bongiovanni di Caltagirone per le manifatture di terracotta, ad Alberto di Giorgio da Trapani per manifatture di coralli, agli argentieri Antonino Pampillonia e Giovanni Ficarrotta (o Fecarotta). Quest’ultimo fu insignito della medaglia d’argento anche nel 1836, «per diversi perfetti lavori in oro e argento a smalto e cesellatura», e nel 1846. Nel 1838 ottenne la medaglia d’oro. Nell’esposizione del 1836 fu premiata con medaglia d’argento anche Teresa Gargotta e Salinas (madre di Antonino) «per lavori di conchiglie indigene maestrevolmente eseguiti». S. Costanzo, Reale Istituto d’Incoraggiamento, in ivi, a. 4, n. 24, 11 giugno 1836, pp. 192-195. Su questi temi cfr. C. Bajamonte, I “musei effimeri” dell’Ottocento. L’origine delle esposizioni d’arte in Sicilia, in c.d.s. 59 Proemio, in “Effemeridi scientifiche e letterarie e lavori del R. Istituto d’Incoraggiamento per la Sicilia”, a. III, t. IX, Gennaio Febbrajo e Marzo, 1834, p. IV. Il Reale Istituto – fondato il 9 novembre 1831 da Ferdinando II su modello del precedente istituito a Napoli che aveva avviato la consuetudine delle premiazioni periodiche per le migliori manifatture del Regno (1826) – mirava a promuovere le attività legate all’agricoltura, al commercio e alle manifatture. Mediante Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 101 numero 3 - maggio 2011 Juvara ad Agostino Gallo, a cura di G. Molonia, in “Messenion d’oro. Trimestrale di cultura e informazione”, n.s., n. 20, aprile-giugno 2009. 68 A. Gallo, Notizie degli incisori…, pp. 116-117; D. Malignaggi, L’Acquaforte. Vincenzo Riolo, Francesco La Farina, Bartolomeo e Luca Costanzo Incisori, Palermo 2008. Si veda pure P. Sgadari di Lo Monaco, Pittori e scultori…, p. 35 che definisce Luca «abilissimo contraffattore di quadri antichi di cui fece poco scrupoloso commercio». 69 Cfr. E. Ricciardi, Medaglie del Regno delle Due Sicilie 1735-1861, I.T.E.A. Edit. Tip., Napoli 1930. 70 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 14, nota 1. Sulla moneta cfr. Esame della celebre del signor medaglia antica battuta in nome di tutti i siciliani coll’epigrafe marchese G. Haus, in “GSLA”, t. 18, fasc. 52, 1827, pp. 71-97. Fra i contributi più segnalo E. recenti al problema delle monete con la leggenda Sjoqvist, Numismatic notes from Morgantina. 1. The Sikeliotan Coinage, in “Museum Notes”, American Numismatic Society, n. 9, 1960. 71 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 18. 72 G. Raymondo Granata, Duecentosessanta giorni in Palermo nel 1861 ovvero biografia e gabinetto scientifico-artistico dell’archeologo signor Agostino Gallo, Stamperia del Commercio, Messina 1863, p. 51 ricorda infatti «dodici grandi e mezzani quadri formante un’accolta di circa 1500 medaglie in gesso, in gran parte cavate da camei e gemme antiche». 73 Un elenco delle sue medaglie è in A. Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione..., pp. 39-40. 74 «Ignazio Milazzo, come imputato di contraffazione di moneta, fu rinchiuso nella casa di correzione di Palermo al 26. Dicembre 1827. A 2. Marzo 1830 fu condannato all’Ergastolo». Archivio di Stato di Palermo [poi A.S. Pa.], Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale in Sicilia. Polizia, filza 222, fasc. 20/2, doc. 908, verbale in data in data 13 agosto 1835. Per le notizie sull’orafo cfr. A. Gallo, Notizie degli incisori…, pp. 129-130. 75 Ibid., Sopra una medaglia di Tiziano incisa in metallo da Marco di Chiara, in “L’Oreteo. Nuovo Giornale”, a. I, n. 1, 1839, pp. 5-6. 76 Id., Sull’influenza…, p. 14, nota 2. 77 A.S. Pa., Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale in Sicilia, Ripartimento Interno, Busta 18, Relazione di Gabriele Judica Regio Custode delle nazionale, atti del convegno internazionale di studi in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice, 14-17 giugno 2006) a cura di M.C. Di Natale, Salvatore Sciascia, Caltanissetta 2007, pp. 466-474. 61 A. Castellani, Dell’oreficeria antica. Discorso di Augusto Castellani, Le Monnier, Firenze 1862. Su Augusto Castellani (1829-1914) cfr. I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana, catalogo della mostra, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2005. Cfr. anche G. Pucci, Antichità e manifatture: un itinerario, in Memoria dell’antico nell’arte italiana. Dalla tradizione all’archeologia, t. III, a cura di S. Settis, Einaudi, Torino 1986, pp. 251-292; P. Giusti, Gioielli e «bisciuttieri» a Napoli nell’Ottocento, in Civiltà dell’Ottocento. Le arti a Napoli dai Borbone ai Savoia. Le arti figurative, catalogo della mostra, Electa Napoli, Napoli 1997, pp. 221-225. 62 F. Mondello, Bozzetti biografici di artisti trapanesi de’ sec. XVII, XVIII e XIX, Tip. Modica-Romano, Trapani 1883, pp. 40-44; F. Pipitone, La graduale trasformazione dalla bottega artigiana all’accademia nella prima metà dell’Ottocento in Sicilia, in La formazione professionale dell’artista. Neoclassicismo e aspetti accademici, a cura di D. Malignaggi, Università degli Studi di Palermo, Palermo 2002, in part. pp. 5574; R. Vadalà, Corallari e scultori attivi a Trapani e nella Sicilia occidentale dal XV al XIX secolo, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e XIX secolo, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I., Palermo 2003, ad vocem, pp. 382-383. 63 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 12. Cfr. pure Id., Notizie degli incisori…, pp. 131-134; M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Flaccovio, Palermo 2000, pp. 255-260. 64 A. Gallo, Necrologia…, p. 105; Id., Notizie de’ figularj degli scultori e fonditori…, pp. 255-256. 65 Id., Sulla scuola di scultura fondata in Palermo dal sig. Valerio Villareale, in “PpD”, a. 5, n. 19, 13 maggio 1837, pp. 145-148. 66 Id., Sull’influenza…, p. 13. 67 Ibid. Si veda inoltre Litografia, in “PpD”, a. 4, n. 28, 9 luglio 1836, pp. 125126 [ma 225-226]; A. Gallo, Lettera di Agostino Gallo all’egregio incisore Tommaso Aloisio Messinese professore d’intaglio in Napoli, in “La Lira”, a. I, n. 51, 6 novembre 1852, pp. 203-204; Id., Notizie degli incisori…, pp. 125-128. T. Aloysio-Juvara, Della storia e dello stato odierno dell’arte dell’incisione, in “Nuove Effemeridi Siciliane di Scienze, Lettere ed Arti”, a. I, dispense IX-X, dicembre 1869 – gennaio 1870, pp. 404-416. Sul rapporto fra Agostino Gallo e l’artista cfr. Lettere di Tommaso Aloysio teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 102 numero 3 - maggio 2011 Marchese Forcella in Palermo. Cenno di Angelo Osnato da Caronia, Messina 1845. Si tratta di Palazzo Forcella-de Seta, riconfigurato dal 1833 per volere del marchese Enrico Carlo Forcella secondo un eclettismo revivalistico che qui trova forme compiute e originali. Cfr. G. Di Benedetto, Palazzo Forcella-de Seta, in “Kalós – arte in Sicilia”, a. 10, n. 2, Marzo-Aprile 1998, pp. 24-31. P. Palazzotto, Teoria e prassi dell’architettura neogotica a Palermo nella prima metà del XIX secolo, in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte…, pp. 228-230. 86 Mi riferisco in particolare a A. Zobi, Notizie storiche riguardanti l’Imperiale e Reale stabilimento dei lavori di commesso in pietre dure di Firenze raccolte e compilate da Antonio Zobi, Le Monnier, Firenze 1841. 87 Sulla chiesa cfr. A. Mazzè (a cura di), Le parrocchie, Flaccovio, Palermo 1979, pp. 73-153. 88 Per l’arca cfr. M.C. Di Natale, S. Rosaliae Patriae Servatrici, Palermo 1994, pp. 11-80. 89 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 18. 90 Le prime precisazioni sull’argentiere Nibilio Gagini, nipote di Antonello, si devono a G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI. Memorie storiche e documenti, 2 voll., Tipografia del Giornale di Sicilia, Palermo 1880 e 1883. Cfr. M.C. Di Natale, Gioacchino Di Marzo e le arti decorative, in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte…, pp. 157-167. 91 Cfr. M.C. Di Natale, Paliotto, scheda II.37, in Ori e Argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Electa, Milano 1989, pp. 211-212. 92 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 19. 93 Cfr. A. Turrisi Colonna, Sopra Anna Fortino. Lettera di Annetta Turrisi Colonna a Nicolò suo fratello, in “ESLS”, a. VI, t. XXIII, 1838, pp. 36-42. Sulla Fortino scriverà anche S. Mira e Sirignano, Biografie e cose varie, Tipografia del Giornale di Sicilia, Palermo 1873, pp. 76-84. 94 A. Gallo, Lavori artistici in cera di Anna Fortino palermitana, in “PpD”, a. 4, n. 33, 13 agosto 1836, pp. 261-264. 95 Id., Sulla vera patria di Zeusi pittore dell’epoca greca e cenni biografici dello stesso per Agostino Gallo, Palermo 1861. Lo studio fu ripubblicato in “GASLA”, t. CLXXV, n.s. XXX, gennaio-febbraio, Roma 1863, pp. 81-148. 96 R. Politi, Cenni biografici su’ valentissimi plasticisti da Caltagirone Bongiovanni e antichità di Noto al ministro Marchese Ferreri, in data 16 novembre 1818, cc. 23-24. 78 D. Sestini, Sopra i moderni falsificatori di medaglie greche antiche nei tre metalli e Descrizione di tutte quelle prodotte dai medesimi nello spazio di pochi anni, Tofani, Firenze 1826, per il quale cfr. S. Pafumi, Museum Biscarianum. Materiali per lo studio delle collezioni di Ignazio Paternò Castello di Biscari (1719-1786), Alma, Catania 2006, p. 113. 79 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 15. Gallo accenna in nota alla collezione del conte Corrado Ventimiglia che contava 400 varietà di pietre dure. Su una raccolta del XVIII cfr. il Catalogo di una raccolta di pietre dure native di Sicilia esistente presso l’abate D. Domenico Tata, Raimondi, Napoli 1772. Su questi temi cfr. soprattutto M.C. Di Natale, I maestri corallari trapanesi dal XVI al XIX secolo, in Materiali preziosi…, pp. 23-56. 80 Cfr. Immagine e testo. Mostra storica dell’editoria siciliana dal Quattrocento agli inizi dell’Ottocento, a cura di D. Malignaggi, Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I., Palermo 1988. 81 «Perocché in alcuni sepolcri greci e cartaginesi, apertisi in diverse città di Sicilia e in quelli di Palermo nella strada di Mezzomonreale [l’area della necropoli punica di corso Calatafimi] de’ tempi Fenici e Cartaginesi, si sono rinvenute fiale, vasettini e gingilli di ragazzi in vetri colorati». A. Gallo, Sull’influenza…, p. 16. Su questi aspetti si veda A. Spanò Giammellaro, I vetri della Sicilia punica, Unione Accademica Nazionale, Corpus delle Antichità Fenicie e Puniche, Bonsignori, Roma 2008. 82 Per le attività dei fratelli Gallo cfr. A. Rotolo, La cultura meccanica siciliana dal XVII al XIX secolo, Fondazione Ignazio Buttitta, Palermo 2009, pp. 118-120. 83 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 16. Si veda anche C. Pasca, Su gli Smalti e l’Arte del Mosaico, in “La Lira”, a. I, n. 31, 1 maggio 1852, pp. 122-123, in cui, oltre a Angelo Gallo, è ricordato Sebastiano Zerbo, che a seguito dell’incendio scoppiato nel 1811 all’interno del Duomo di Monreale nel 1817 ne restaurò i mosaici con l’impiego di paste vitree. Sulle pratiche del restauro musivo cfr. M. Guttilla, Un interprete del restauro musivo dell’Ottocento: Rosario Riolo e il suo ambiente, in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte nell’Ottocento in Italia, atti del convegno di studi nazionali (Palermo, 15-17 aprile 2003) a cura di S. La Barbera, Palermo 2004, pp. 246-262. 84 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 16. 85 Cfr. C. Pasca, Cenno di Cesare Pasca…, p. 102; Sull’interno della casa del Sig.r Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 103 numero 3 - maggio 2011 Vaccaro riprodotti con aggiunte e parte istorica dell’arte di modellare in creta, Tipografia Blandaleone, Girgenti 1858. Si veda inoltre A. Ragona, I figurinai di Caltagirone nell’Ottocento, Sellerio, Palermo 1996. 97 R. Politi, Giacomo Bongiovanni e Giuseppe Vaccaro, in “Poliorama Pittoresco”, a. VII, sem. II (11 Febbrajo – 5 Agosto 1843), n. 32, Napoli 18 Marzo 1843, pp. 249-250. L’articolo è accompagnato da uno «schizzo litografico» raffigurante il gruppo con il Ciabattino. Anche nella stampa periodica locale sono segnalati contributi sui due maestri calatini. Cfr. P. Palazzotto, Cronache d’arte ne «La Cerere» di Palermo, in Percorsi di Critica…, pp. 123-142. 98 Cinquantuno lettere autografe ad Agostino Gallo (7 Maggio 1826 – 12 Settembre 1866), ms. del sec. XIX, custodito ai ss. 2 Qq G 113, n. 36 presso la Biblioteca comunale di Palermo. 99 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 18. Altre notizie su Giacomo e Giuseppe Vaccaro Bongiovanni sono in Id., Notizie de’ figularj degli scultori e fonditori…, pp. 269-272. 100 Anche Francesco di Paola Avolio esprime l’idea di rilanciare economicamente il settore dell’arte dei figulini e di «svegliare l’addormentate braccia ad opere migliori». F. Avolio, Delle antiche fatture di argilla che si ritrovano in Sicilia, Lorenzo Dato, Palermo 1829, pp. xlii-xliii. Gioacchino Di Marzo ricorda, piuttosto, l’importanza delle officine trapanesi: «Da più di un secolo gli artisti trapanesi si rivolsero a cavar profitto dall’abbondanza degli alabastri del patrio territorio, e dalla pesca del corallo e delle conchiglie», nominando fra gli artisti Giovanni Anselmo, Andrea e Alberto Tipa, Michele Laudicina e Pietro Bordino «di cui si sono venduti eccellenti lavori a fondo ed a rilievo sopra agate orientali». Dizionario topografico della Sicilia di Vito Amico. Tradotto dal latino ed annotato da Gioacchino Di Marzo chierico distinto della Real Cappella Palatina, vol. II, Pietro Morvillo, Palermo 1856, p. 624. 101 Nel catalogo dell’Esposizione di Londra – classi 33 (Works in precious Metals and their imitations and Jewellery) e 35 (Pottery) – figurano fra gli altri Giuseppe Laodicini (!) per i cammei su conchiglia, il corallaro trapanese Carlo Guida, Gaetano Armao di Santo Stefano di Camastra per riproduzioni di vasi etruschi, Giuseppe Vaccaro Bongiovanni. Questi artisti parteciparono anche all’Esposizione Nazionale di prodotti agricoli e industriali e di belle arti di Firenze del 1861. 102 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 19. Per Giovanni Matera (1653-1718) cfr. G. Bongiovanni, Giovanni Antonio Matera un grande scultore di figure “in piccolo”, allegato a “Kalós – arte in Sicilia”, a. III, n. 6 Novembre-Dicembre 1991. Si veda pure G. Cocchiara, I pastori del Matera, in “Sicilia”, n. 36, 1962, nn. 103 J. Burckhardt, Il Cicerone. Guida al godimento delle opere d’arte in Italia [1855], vol. I, Sansoni, Firenze 1992, p. 784. 104 A. Gallo, Sull’influenza…, p. 19. Sul presepe napoletano si veda almeno L. Correra, Il Presepe a Napoli, in “L’Arte”, II, 1899, pp. 325-346; F. Mancini, Il Presepe napoletano. Scritti e testimonianze dal secolo XVIII al 1955, SEN, Napoli 1983; M. Piccoli Catello (a cura di), Il Presepe Napoletano. The Neapolitan Crib, Guida, Napoli 2005. 105 S. Romano, Di alcune eccellenti figure in legno scolpite dal trapanese Matera verso il 1700 e che ora trovansi a Monaco nel Museo Nazionale bavarese, in “Archivio Storico Siciliano”, n.s., a. XXVII, 1902, pp. 241-255. Puntualizza quanto scritto da Salvatore Romano F.A. Belgiorno, I presepi di Matera a Monaco tra storia e leggenda, in “Kalós – arte in Sicilia”, a. 14, n. 3, Giugno-Settembre 2002, pp. 6-9. 106 F. Mondello, L’Arte nel Presepio per le piccole figure degli scultori Nolfo di Trapani, con 4 illustrazioni, ms. del 1905, custodito ai ss. 190 presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani. Per il canonico trapanese (1834-1908) cfr. M. Vitella, Fonti del XIX secolo per la Storia dell’arte in Sicilia: il canonico Fortunato Mondello, in Metodo della ricerca…, pp. 407-420. 107 Cfr. V. Crisafulli, 1884 Vincenzo Ragusa e il Museo Artistico industriale Scuole Officine, in 1884 Vincenzo Ragusa e l’Istituto d’Arte di Palermo, a cura di V. Crisafulli, Kalós, Palermo 2004, pp. 13-41. 108 Si veda per esempio R. Cinà, Arte e gusto sulle pagine de “L’Arte Decorativa Illustrata”, in “teCLa-Effemeride”, 2010, www.unipa.it/tecla/effemeride/1_ effemeride.php, DOI 10.4413/EFFEMERIDE. Sulla rivalutazione delle arti decorative rimando a G.C. Sciolla, La riscoperta delle arti decorative in Italia nella prima metà del Novecento. Brevi considerazioni, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento…, pp. 51-58; F. Bologna, Dalle arti minori all’industrial design. Storia di una ideologia, Laterza, Bari 1972. 109 Esposizione Nazionale 1891-92 in Palermo. Catalogo generale, Stabilimento Tipografico Virzì, Palermo s.d. [ma 1891]; “Palermo e l’Esposizione nazionale del 1891-92. Cronaca illustrata”, Treves, Milano 1892; “L’Esposizione Nazionale illustrata di Palermo. 1891-92”, Sonzogno, Milano 1892. Cfr. A.M. Fundarò, teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 104 numero 3 - maggio 2011 Le arti industriali siciliane nell’Esposizione di Palermo, in Dall’artigiano all’industria. L’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892, a cura di M. Ganci, M. Giuffrè, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo 1994, pp. 237-264. Carmelo Bajamonte Appunti su uno scritto poco noto di Agostino Gallo 105 Giuseppe agnello: contributi sulla stampa periodica allo studio della storia dell’arte siciliana dal tardo antico al barocco di Iolanda Di Natale cultura siciliana, qual è quello fra le due guerre, cui seguono i difficili anni della “ricostruzione”. La formazione giovanile di Giuseppe Agnello1 si svolge presso il L’ Seminario di Siracusa, iscrivendosi nel 1910 al corso di laurea in Lettere Moderne presso l’Università di Catania. Guida e modello sarà per lui il Vescovo Luigi Bignami2, che consapevole delle qualità del giovane lo esorta a lasciare la vita ecclesiastica per seguire quella degli studi3. Al prelato Agnello dedicherà una delle sue opere giovanili, Un Vescovo umanista. Luigi Bignami4, pubblicata nel 1925. Abbandonata la vita clericale Agnello si dedica pienamente agli studi, particolarmente attratto dalle letterature neolatine e nel 1913 consegue, a pieni voti, la laurea in Lettere Moderne discutendo una brillante tesi dal titolo La leggenda di S. Oliva5, relatore il Prof. Paolo Savj Lòpez6, filologo formatosi presso la scuola fiorentina7 che si attività di Giuseppe Agnello si inserisce a pieno titolo nel novero delle più significative espressioni di impegno civile e scientifico che il secolo appena trascorso ha generato. La sua è una vicenda senz’altro ammirevole data l’esemplarità di questa figura di studioso e “politico” in grado di offrire un contributo rilevante, pur se ancora di matrice erudita, allo sviluppo del sistema culturale regionale, proprio in funzione della sua partecipazione al più ampio panorama nazionale. Questi aspetti, che saranno illustrati nelle pagine seguenti, rendono articolata e affascinante la sua opera, in un periodo cruciale per la teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 106 numero 3 - maggio 2011 storici dell’arte italiani, i cui precedenti illustri si trovano in primis in area tedesca, ma anche francese e anglosassone. Proprio negli anni in cui Agnello si appresta a pubblicare la sua autobiografia, escono il Diario di un borghese (1948 e 1962) di Ranuccio Bianchi Baldinelli, Riassumendo una vita. Note autobiografiche (1960) di Enrico Mauceri, Tempo di ricordi (1955) di Alfredo Gargiulo; opere che, idealmente, potrebbero tutte farsi risalire al primo illustre esempio di biografia di uno storico dell’arte, rappresentato dal volume di Adolfo Venturi, Memorie autobiografiche (1927)11. Inframmezzati al racconto delle tristi e difficili vicende che vedono il Nostro protagonista negli anni del fascismo e della coraggiosa resistenza al regime, in La mia vita nel ventennio emergono anche episodi legati alle amicizie con importanti archeologi e studiosi del tempo, con intellettuali impegnati nella comune lotta e, ancora, resoconti di viaggi, sempre in Italia (gli viene infatti imposto il divieto di recarsi all’estero). Proprio i legami con i più importanti studiosi del tempo, le loro visite, tra le quali si ricorda quella dello storico Adolf Schulten, di Benko Hovart e ancora quella di Eduard Sthamer, rappresentano per Agnello un momento di distensione e di svago. Assidui sono i soggiorni romani in occasione dei quali frequenta il salotto del principe Ruffo della Scaletta, intrattiene rapporti con Giuseppe Maragotti (direttore del settimanale “L’Idea”, de “L’Illustrazione Vaticana” e ancora di riuniva intorno alla figura di Domenico Comparetti8. Qui il giovane studioso instaura importanti relazioni con la scuola fiorentina. L’influenza su di lui esercitata dai maestri fiorentini è evidente nel suo metodo storiografico improntato a quel positivismo di matrice scientifica che non può non essere ricondotto proprio agli sviluppi raggiunti Giuseppe Agnello 9 in seno a quel cenacolo . Declinata l’offerta del Prof. Savj Lòpez di proseguire l’attività di ricerca in Germania, nel 1913 Giuseppe inizia ad esercitare la professione di insegnante prima, nella scuola media di Adrano e, successivamente, presso il Liceo-Ginnasio “R. Settimo” di Caltanissetta10. La mia vita nel ventennio, opera di natura autobiografica, inserisce Agnello all’interno di quel florido filone della memorialistica degli storici dell’arte particolarmente fiorente tra Ottocento e Novecento, che sembra potersi ricondurre – come nota Gianni Carlo Sciolla – alla tradizione delle autobiografie di artisti e di Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 107 numero 3 - maggio 2011 “Sicilia del Popolo”) e con Mario Recchi, fine intellettuale e critico d’arte, fondatore della rivista “Archivi”; partecipando anche agli incontri serali nella casa del Prof. Giulio Emanuele Rizzo12. pevole volontà di partecipazione: sono questi, infatti, anni di grande impegno, non solo in ambito politico, ma anche in quello degli studi. Proprio a partire dal rientro nella città di Archimede, infatti, iniziano a prender forma i primi e cruciali fondamenti di quelle ricerche che ne caratterizzeranno la ricchissima produzione scientifica. Siracusa viveva allora un clima di interessante fervore culturale e artistico, generatosi intorno alla figura di Paolo Orsi17, archeologo di notissima fama, giunto a A Firenze entra in contatto col Prof. Gaetano Pieraccini13 e frequenta l’editore Attilio Vallecchi per il quale pubblica nel 1925 il saggio Paolo Orsi14; a Genova incontra Giovanni Ansaldo che gli propone di collaborare al “Lavoro”, con scritti di natura letteraria e non politica; a Milano rinsalda il legame con l’amico Francesco Siracusa nel 1890 in qualità di Ispettore degli Scavi e Cianciò, anche lui docente di lettere. Contatti dei Musei. Lo stesso Agnello, ricordando le lunghe e relazioni questi che ci permettono di meglio passeggiate, le lezioni e le campagne di scavo al approfondire la figura dello studioso ed il suo seguito dell’illustre studioso, non mancherà mai di lavoro di ricerca alla luce di quell’ampio clima di riconoscere il debito nei confronti di quell’uomo studi e contatti nazionali ed internazionali che lo che era stato per lui maestro e modello indiscusso vedono spesso protagonista. di cultura e preparazione. Cartina topografica di Ortigia Il volume che, come si ha avuto modo L’interesse sempre più forte per la politica è, (dal sito della Società di Storia di anticipare, ricostruisce i difficili anni invece, alla base dello scritto pubblicato nel 1921, Patria di Siracusa). del ventennio fascista15, prende avvio a seguito del discorso da lui letto in occasione dei dall’anno 1919 quando, dopo nove mesi di permanenza in festeggiamenti per il VI Centenario Dantesco: Passioni politiche e terra francese, a metà gennaio Agnello rientra in Sicilia16. ire di parte nella vita di Dante18. Un comune destino sembra legare La stabilità lavorativa e coniugale segna una nuova e più consa- Agnello al sommo poeta: quello del perseguitato. Disattese le teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 108 numero 3 - maggio 2011 speranze di un ritorno ad una democrazia giusta e forte, anche a Il 1925 è per Giuseppe un anno colmo di dolori, ma è anche il Siracusa nell’estate del 1920 era stata costituita la prima associazione periodo in cui inizia a dedicarsi alacremente agli studi, coltiva con fascista. Il fare politica viene vissuto da Agnello costanza quegli interessi per l’archeologia quale «strettissimo dovere di ogni cittadino che e per l’arte, emersi negli anni universitari e si preoccupi delle sorti della propria patria»19. fiorentini ed ancora progrediti a seguito del Questa la ragione che lo spinge nel 1920 a proficuo contatto con Paolo Orsi. Con lo costituire la sezione siracusana del Partito studioso di chiara formazione positivista, Polare Italiano20, per il quale si presenta nella la cui attività, discostandosi dalla tradizione lista popolare alla elezioni del 1924, in aperto antiquariale, assume caratteri decisamente contrasto al listone fascista, pur consapevole di innovativi, Agnello, ha in comune la medesima andare incontro a un «certo sbaraglio». Il difficile frequentazione dell’Istituto di Studi Superiori clima che precede le elezioni viene ancor più di Firenze24. esasperato dalla pubblicazione del suo libello La lezione in particolar modo del D’Ancona Il Carnevale politico nel siracusano21. I risultati delle e del Comparetti25, testimoni del cruciale elezioni, ben noti, costituiscono una delle pagine passaggio dalla filosofia alla filologia e dalla più tristi della storia della democrazia in Italia22. storiografia filosofica a quella filologica, ma Imboscate, insulti, pedinamenti, intimidazioni anche della crisi dell’idealismo di matrice si susseguono con regolarità quotidiana tedesca e del prorompente imporsi al suo G. Agnello, Siracusa Medievale. Monumenti all’indirizzo dell’autore del Carnevale politico – inediti, Muglia Editore Catania, Catania, posto di tendenze propriamente positiviste, volumetto giunto sin nelle mani di Mussolini23 – 1926. è riscontrabile, altrettanto fortemente, in cercando il regime di dimostrarne con ogni mezzo l’inconciliabilità Orsi quanto in Agnello26. Del resto è stata più volte messa in luce della posizione politica assunta rispetto all’impiego statale. la filiazione dei suoi studi da quelle tematiche che, in tarda età, Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 109 numero 3 - maggio 2011 avevano attirato l’interesse del suo maestro27, sotto la cui spinta e protezione prendono forma quei primi e fondamentali contributi sul Medioevo isolano28. Periodo salda ‘base estetica’, indispensabile a un corretto giudizio sull’arte. Quale risultato di questi primi studi tra il 1923 e il 1926 pubblica sugli annuari del 1923-24 e del 1924-25 del R. Liceo-Ginnasio “T. Gargallo”, da lui personalmente curati, due interventi che riscossero l’apprezzamento di Pietro Toesca e Benedetto Croce, rispettivamente intitolati Paolo Orsi e Siracusa Medievale. Monumenti inediti31. Quest’ultimo, ristampato presso l’editore Muglia di Catania nel 192632, segna l’esordio di Agnello storico dell’arte. Già da questa prima opera, se da un lato è evidente l’iniziale dipendenza nei confronti di quel filone di studi precedentemente avviato dall’Orsi33, dall’altro si può intuire l’orientamento verso cui la ricerca dello studioso siracusano si stava autonomamente indirizzando. Il volume viene preparato e anticipato da una serie di articoli apparsi su importanti testate regionali e, soprattutto, nazionali. A partire dal giugno 1925, infatti, dalle pagine de “Il Giornale d’Italia” e “Il Mondo” si susseguono numerosi e nodali contributi dedicati dallo studioso alla ricostruzione e all’ampliamento delle conoscenze sull’arte bizantina e medievale, sino ad allora quasi del tutto inesplorate34. I diversi lavori monografici compilati dallo studioso durante tutto l’arco della sua vita, sono sempre preparati e anticipati da saggi ed articoli pubblicati sulla stampa periodica e dallo spoglio questo, sino ad allora, poco investigato dagli studiosi locali, ad eccezione del grande storico Gioacchino Di Marzo, iniziatore di questo ricco filone di ricerche e approfondimenti, la cui figura è stata messa in luce anche da G. Agnello, Foglio Roberto Longhi che ne ha posto manoscritto, Biblioteca Comunale di Siracusa. in evidenza l’importanza degli studi sull’arte siciliana e sottolineato la validità delle attribuzioni29. L’approccio di Agnello nei confronti del Medioevo presenta un notevole passo in avanti rispetto agli studiosi siciliani a lui contemporanei, rivelando una particolare consonanza coi coevi studi sull’argomento portati avanti in ambito nazionale, in special modo, da Pietro Toesca30, allievo di Adolfo Venturi, al quale può essere assimilato sia per affinità di temi (il Medioevo in primis) e tipologie di ricerche, sia per il convincimento della necessità di una teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 110 numero 3 - maggio 2011 alla Enciclopedia italiana35. Se il filosofo rifiuta di fare del Professore «un martire o un perseguitato politico», non dello stesso avviso si dimostra Pietro Fedele, succeduto a Gentile alla guida del Ministero della P.I. I primi di giugno del 1926 arriva l’ordine di trasferimento. Non pochi fedeli ed illustri amici, nonostante le sollecitazioni del Professore a desistere rispetto ad ogni tentativo di intervento in sua difesa, si espongono al fine di ottenere un provvedimento di revoca all’ingiusto trasferimento, tra tutti il senatore Paolo Orsi e il Vescovo Carabelli36. Ogni tentativo risulta nullo e solo pochi mesi dopo il trasferimento a Cento, in Emilia Romagna, il 24 agosto, Agnello viene raggiunto da un avviso del Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione con cui gli si comunica che, per essersi posto in posizione di incompatibilità con le direttive generali del Governo, si procedeva alla sua definitiva dispensa dal servizio. La risposta del Professore, esemplare nel rigore del ragionamento e, ancor più, nell’alto valore civile e morale, espressione della grande dignità dell’uomo, segna l’inizio di un lungo periodo da esiliato in patria37. In quegli anni di isolamento Agnello si dedica con ancor più passione e solerzia agli studi d’arte: indaga e riporta alla luce una Sicilia ancora inedita, riscoperta ed illustrata tra molteplici difficoltà, connesse ad uno studio tanto ampio e, sino ad allora, raramente praticato, condotto con sagacia, senza alcun sostegno bibliografico emerge con chiarezza come il rapporto che lega le monografie agli interventi su stampa periodica possa essere considerato inscindibile: un continuo gioco di scambi e rimandi, approfondimenti, aggiornamenti e stralci, che è caratteristica propria di questa amplissima produzione scientifica, il cui alto grado qualitativo si accompagna alla G. Agnello, Guida del Duomo di ricchezza quantitativa e la Siracusa, Officine D’Arte Grafica cui ampiezza di temi viene A. Lucini & C., Milano 1930. piacevolmente supportata da un prosa scorrevole ed incisiva. Nonostante l’impegno profuso da Agnello nell’adempimento della sua professione, le pressioni affinché venga allontanato dall’insegnamento continuano con insistenza, raggiungendo l’allora Ministro dell’Istruzione Giovanni Gentile che, poco più tardi, inviterà però lo studioso a collaborare Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 111 numero 3 - maggio 2011 L’ da parte delle autorità. I risultati di queste impegnative indagini vengono pubblicati con un’intensità quasi frenetica, per lo più sotto forma di saggi e di articoli destinati alla stampa periodica: giornali quotidiani, settimanali e riviste. Per tutta la durata del ventennio fascista, infatti, questa tipologia di interventi rappresenta l’unico modo a disposizione del «pericoloso sovversivo» per far sentire la sua voce di studioso e per diffondere i risultati del suo lavoro scientifico. Raramente, durante gli anni del regime, Agnello riesce ad ottenere l’appoggio di enti pubblici o di case editrici disposti a pubblicare i suoi lavori monografici, considerati, a tutt’oggi, uno dei più fecondi contributi allo studio della storia dell’arte siciliana dal tardo antico sino al Barocco. Il ruolo assunto dalla stampa periodica tra il XIX e XX secolo è stato negli ultimi anni posto in rilievo dalla critica che ne ha evidenziato l’importanza rispetto sia al dibattito, sia alla divulgazione degli studi di storia dell’arte e dell’architettura38. Un fenomeno questo attività di Giuseppe Agnello, relativamente alle “cose di Sicilia”, espressa nei numerosi saggi, negli articoli, ma soprattutto nelle recensioni, lascia trapelare la fitta rete di scambi, di relazioni e di dialogo culturale che questo appartato studioso di Canicattini riesce a mantenere, anche in anni storicamente difficili, con la comunità scientifica italiana ed europea; relazioni e scambi che, proprio dalle pagine della stampa periodica, prendono corpo oltrepassando gli angusti confini dell’Isola. Fondamentale, in questo senso, l’amicizia col già citato Paolo Orsi, ma anche quella con Umberto CanottiBianchi41, suo editore, cui è legato non solo dai comuni interessi culturali e scientifici, ma anche dalla medesima posizione politica che non di rado rende difficili e pericolosi i più semplici contatti fra i due studiosi, entrambi considerati pericolosi attivisti e, per questo, sempre tenuti sotto stretto controllo dalle forze di polizia del regime. Ancora un’altra significativa amicizia, cui si è già in precedenza accennato, è quella che lega Agnello all’Arcivescovo Carabelli, al quale dedicherà nel 1933 un saggio breve: Monsignor Carabelli e l’arte42. È proprio l’Arcivescovo che, incurante dello sdegno generale espresso dalle più alte cariche del regime, in occasione della riapertura del Duomo di Siracusa, invita lo studioso a presenziare diramato e ricco di fecondi apporti di cui Agnello, come molti studiosi, risulta essere pienamente conscio: pubblica, infatti, non solo negli “Archivi Storici” regionali, ma anche in periodici come “L’Osservatore Romano”, “Siculorum Gymnasium”39 e, ancora, “Brutium” di Alfonso Frangipane40. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 112 numero 3 - maggio 2011 alla conferenza di presentazione del lungo e poderoso intervento di restauro. La conferenza, tenuta il 14 gennaio del 1927 presso il Palazzo Arcivescovile, a seguito della revoca della concessione del Teatro Comunale, nonostante l’inquietudine della vigilia e le voci di una possibile invasione del palazzo, è un successo; l’interesse dello studioso per le vicende artistiche inerenti il Duomo siracusano43 è testimoniata dai numerosi articoli apparsi con continuità ininterrotta a partire dal 1926. Questi studi, variegati ed ampi, sia per quantità, che per tematiche, consentono allo studioso di spaziare su argomenti molteplici, G. Agnello, Un monumento millenario. attraversando un arco di Il Duomo di Siracusa già Tempio di tempo che dal mondo greco Athena, in “Italia Nostra”, XXXIV, 1928. classico giunge sin dopo il Settecento e di poter, inoltre, affrontare le più svariate sfaccettature dell’arte, da quella figurativa a quella decorativa, muovendosi liberamente dall’analisi del grande artista a quella del più oscuro artigiano44. Attratto inizialmente dalle vicende architettoniche, assolutamente eccezionali, del tempio cristiano, considerato monumento siracusano per eccellenza, Agnello ben presto allarga i suoi interessi anche ai molti tesori custoditi all’interno del Duomo. Proprio in funzione della particolare attenzione da lui riservata alla storia e agli sviluppi dell’architettura, si è più volte proceduto alla sua identificazione – peraltro riduttiva – quale “storico dell’architettura”. Limitazione questa che non spiegherebbe, ad esempio, il grande interesse I. Marabitti, S. Paolo, 1757, Siracusa, assegnato da Agnello all’apCattedrale profondimento delle vicende legate alla Cappella del SS. Sacramento, detta “Torres” dal nome dell’Arcivescovo committente e fondatore, fonte illimitata di spunti per studi su artisti e artigiani operanti all’interno della Cattedrale Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 113 numero 3 - maggio 2011 siracusana nei secoli XVII e XVIII: Andrea Vermexio, cui si deve il progetto originario, insieme ai figli; i capimastri delle Regie Fabbriche, Antonio Greco, Cosimo Russo e Giuseppe Guido; gli scultori maltesi Michele Casanova e Marcello Gaffar, cui spetta la decorazione scultorea con angeli, sirene, putti e stemmi , solo per citarne alcuni. Un’attenzione tutta particolare viene poi riservata a tre artisti: il pittore messinese Agostino Scilla, il romano Luigi Vanvitelli e lo scultore fiorentino Filippo Della Valle. Il primo, cui si deve la decorazione pittorica della cappella, viene esaltato dallo studioso negli articoli Un ignoto frescante del Seicento: Agostino Scilla e Gli affreschi di Agostino Scilla nella Cappella del SS. Sacramento nella Chiesa Cattedrale di Siracusa. Agli altri due, artefici rispettivamente dello splendido ciborio e del paliotto marmoreo con l’Ultima Cena, Agnello dedica, tra il 1927 e 1967, numerosi articoli Al palermitano Ignazio Marabitti, il «più insigne rappresentante della scultura siciliana del XVIII sec.» e, peraltro, allievo di Filippo Della Valle a Roma dal 1740 ca., Agnello dedica un numero cospicuo di approfondimenti, principalmente connessi all’attività siracusana, con riferimento alla committenza chiesastica e al Duomo; l’attività del rinomato scultore viene puntualmente confermata dalle preziose fonti d’archivio. Del resto, è indubbio che la ricerca e lo spoglio del documento d’archivio, ai fini di un’attenta indagine storico-filologica, rappresentino per Agnello una delle principali linee di impostazione del lavoro dedicato alla ricostruzione e all’analisi delle problematiche concernenti tanto la storia dell’arte, quanto l’archeologia. Ai numerosi saggi ed articoli, lo studioso non manca mai di allegare una ricchissima messe di scritti e documenti rinvenuti presso archivi e biblioteche, frutto di una rigorosa ed attenta ricerca, spesso anche estenuante, da cui, anche in tarda età, non sembra in alcun modo potersi esimere. Da questa passione per il documento d’archivio nascono, ad esempio, importanti interventi sulla stampa periodica cui si devono aggiungere i diciassette saggi pubblicati sulla rivista “Archivi”, diretta da Mario Recchi, alla quale collabora dal ’37 al ’60, scrivendo nella sezione dedicata ai “Documenti d’Archivio per la Storia dell’Arte”. Tornando agli studi dedicati al Duomo, in merito al rifacimento settecentesco del prospetto, Agnello concentra la sua attenzione su un altro artista, l’architetto Pompeo Picherali. Protagonista della ricostruzione di Siracusa, dopo il disastro tellurico del 1693, il nome del Picherali era riemerso solo agli inizi del XX secolo, quando Enrico Mauceri aveva pubblicato un contributo su “L’Arte” di Adolfo Venturi, dedicato alla maggiore chiesa siracusana. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 114 numero 3 - maggio 2011 Ma sarà proprio Agnello a far pienamente luce su questa figura di scientifico o giudizio critico. Da questa convinzione prende forma architetto e pittore locale, vicino alla potente famiglia romana dei quella battaglia che vedrà Agnello impegnato in prima fila nella Colonna, attivo presso la chiesa del Carmine e sensibilizzazione rispetto a tematiche quali la in quella di S. Domenico e citato, in qualità di tutela, la conservazione e la salvaguardia del perito, nei lavori di rifacimento della facciata bene storico-artistico e paesaggistico65. della Cattedrale61. Ancora, al periodo dei primi Larga parte degli studi cui si è accennato studi sul Duomo di Siracusa62 e, soprattutto, (sia in materia propriamente di arte che di del suo restauro, risalgono le prime consapevoli tutela) trova largo spazio su riviste collegate prese di posizione nei confronti del cruciale alla Chiesa: contrariamente all’atteggiamento tema della tutela dei beni storico-artistici63 delle istituzioni statali deputate alla diffusione – secondo grande polo d’interesse dei suoi e promozione della cultura, le istituzioni studi – i cui presupposti teorici risalgono al ecclesiastiche si dimostrano molto più attente al principio del “restauro scientifico” di Gustavo lavoro portato avanti dallo studioso siracusano Giovannoni64. L’analisi storico-critica, anche che più volte è chiamato a collaborare con le per Agnello, deve sempre essere accompagnata principali testate scientifiche ed informative di e verificata da un’attenta ricerca sul campo, arte sacra, quali: “Arte Cristana”, “L’Illustrazione facendo ricorso a sopralluoghi, rilievi, fotografie vaticana”, “L’Osservatorio romano”, “Per G. Agnello, Le argenterie di e ricerche documentarie finalizzate a restituire, Canicattini Bagni, in Πεπραγμένα του l’Arte sacra”, “Presenza cristiana”, “Rivista nella sua interezza, il complessivo sistema storico Θ’Διεθους Βυζαντινολογικου Συνεδρίου, di archeologia cristiana”, “Rivista diocesana 1955. e culturale. La salvaguardia del bene, inteso di Siracusa” e “Rendiconti della Pontificia quale documento primario, da conoscere “in presa diretta”, risulta Accademia Romana di Archeologia”. Lo stretto legame con la allora indispensabile, necessaria e propedeutica a qualunque studio Chiesa è, oltretutto, testimoniato dall’invito mossogli nel 1928 a far Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 115 numero 3 - maggio 2011 parte della Commissione per l’Arte Sacra della Diocesi di Siracusa (successivamente, nel ’46, verrà anche nominato ispettore onorario ai monumenti). La difficile ricostruzione delle origini del cristianesimo e del suo diffondersi nell’isola rappresenta uno dei campi di ricerca favoriti da Agnello. A questo tema egli dedica però numerosi studi G. Agnello, Le argenterie di Canicattini Bagni, monografici incentrati in “Πεπραγμένα του ’Διεθους Βυζαντινολογικου Θ’Συνεδρίου”, 1955. sull’arte bizantina: risale Patena e cucchiaio bizantini. al 1942 Paolo Orsi - Sicilia Bizantina66; al 1951 I Monumenti bizantini della Sicilia67, preludio al più celebre L’architettura bizantina in Sicilia68, edito nel 1952, in cui il campo di indagine viene dallo studioso allargato a tutta la Sicilia Orientale. Il volume sembra idealmente porsi a completamento della mono- grafia di Arduino Colasanti69 che, invece, aveva del tutto trascurato il “capitolo siciliano” nel complesso e articolato quadro italiano. Questi lavori si presentano già per alcuni spunti che Agnello non mancherà di approfondire in tappe successive (soltanto con Palermo bizantina70 edito nel 1969, si potrà considerare completo essendo anche allargato a tutta la Sicilia, il quadro da lui dedicato all’arte bizantina) andando, non solo ad arricchire sempre più la storia dei monumenti d’arte del thema di Sicilia, ma anche a confermare quella convinzione che, da lui in poi, si riscontrerà in maniera ininterrotta in tutta la storiografia artistica, a sostegno della continuità culturale che il mondo bizantino ebbe in Sicilia almeno fino alla metà del XII secolo71. Anche nel caso di questi studi le monografie del Nostro vengono anticipate da importanti contributi destinati alla stampa periodica: a partire dal 1931 vengono pubblicati in puntate su “Arte Sacra” quattro articoli dedicati a Siracusa Bizantina (restituiti, in forma organica nel ’32 nelle pagine dell’“Archivio Storico per la Sicilia Orientale”); nel ’36, sempre in “Arte Sacra”, esce Architettura rupestre bizantina: Il cenobio di S. Marco nel Siracusano (su questo tema Agnello interverrà, tre anni dopo, al V Convegno Internazionale di Studi Bizantini tenutosi a Roma nel settembre del 1936); al 1951, invece, risale il saggio Monumenti bizantini della Sicilia, pubblicato su “La Nuova Italia” e ancora altri numerosi articoli72. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 116 numero 3 - maggio 2011 Si tratta di ricerche su monumenti ancora esistenti nella Sicilia orientale sempre più innanzi, spingendosi i suoi interessi sino al Barocco. che testimoniano, con la loro sopravvivenza, il momento chiave Agnello, infatti, più volte dimostra di considerare la produzione della diffusione del artistica isolana mediecristianesimo nell’isola. vale, come frutto di L’attenzione riservata quella rinascita ellenizdallo studioso a questo zante che, dopo il periodo storico, la tramonto della civiltà volontà di affrontare classica, torna a paletali studi secondo un sarsi nel trionfo della più organico approccio cultura di derivazione metodologico, ha perbizantina73. messo di collocare tali Se all’arte normanna preesistenze non solo Agnello dedica dinel novero della grande versi interventi sulla eredità greca, ma anche stampa periodica74, di quella latina, sino ad pietra miliare dei suoi allora poco celebrata. studi è, fuor di ogni L’indagine sull’arte G. Agnello, Architettura Bizantino-Normanna. La Basilica dei SS. Giovanni e Marziano in Siracusa, dubbio, L’architettura del periodo bizantino in “Bollettino d’Arte del Ministero della P.I., Luglio 1929. Facciata della Chiesa dei sveva in Sicilia75, opera, SS. Giovanni e Marziano di Siracusa. rappresenta solo il ancor oggi attuale capitolo iniziale di uno studio che, ripercorrendo tutta la storia e ineguagliata, alla quale resta strettamente legato il suo nome76. artistica isolana di età medievale, lo porterà progressivamente Il volume, già pronto nel 1931, su consiglio di Orsi, è inviato Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 117 numero 3 - maggio 2011 dall’autore all’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte. Sebbene il manoscritto ottenga, in un primo momento, l’approvazione della Commissione e di Adolfo Venturi, rimane nei cassetti dell’Istituto per ben due anni, costringendo così lo studioso a ritiralo. Le ragioni di una simile indifferenza non sono sicuramente da ricercare nella scarsa qualità del manoscritto che, sempre grazie all’intervento di Orsi, nel 1935, fu pubblicato nella “Collezione Meridionale” diretta da Umberto Zanotti-Bianco, ricevendo, appena un anno dopo, il premio dell’Accademia d’Italia, tra la sorpresa dell’autore e di coloro che malevolmente lo avevano sempre ostacolato e deriso. Nel volume Agnello affronta con spirito decisamente pionieristico, data la povertà degli studi precedenti, l’analisi di una quindicina di edifici praticamente ignoti o dimenticati, spesso destinati ad altri usi impropri fra cui il castello Maniace di Siracusa, l’Ursino di Catania, il castello di Augusta, la Torre di Federico di Enna, monumenti cui, nello stesso anno, sarà dedicata la pubblicazione di Guido Di Stefano77. L’intenzione di Agnello è quella di segnalare e illustrare un primo nucleo di monumenti di architettura militare, realizzati per volere di Federico II, attraverso la sua metodologia rigorosamente analitica che sappiamo basata sull’analisi stilistica e sulla ricerca documentaria al fine di restituirli correttamente al loro ambiente storico-artistico. Onde evitare di incorrere in troppo facili e arbitrarie deduzioni o di generalizzare su influenze e derivazioni, lo studioso si attiene sempre ad un esame il più obbiettivo possibile. Volontà questa che, fin dai primi scritti, caratterizza la sua produzione, rivelandone l’intento di fare più “storia” che “critica”. Pur evitando quindi di formulare un giudizio critico, Agnello, già da L’architettura sveva in Sicilia, richiama l’attenzione su di un periodo storico all’interno del quale individua l’origine di una vera e propria rivoluzione artistica indissolubilmente legata alla figura del suo ideatore, Federico II, e che, proprio nell’isola, raggiunge la sua forma più compiuta. I suoi studi sull’architettura sveva, prendono le mosse da quelli del francese Emile Bertaux il quale, avvalendosi delle ricerche condotte sulla Sicilia dal collega Join-Lambert, aveva espresso l’idea della piena goticità dei castra federiciani e della loro discendenza da una vera e propria scuola, soprattutto in merito all’architettura militare78. È interessante notare come nelle sue analisi comparative Agnello non trascuri di rintracciare affinità e rispondenze con l’architettura militare bizantina e musulmana, ponendo a confronto le espressioni artistiche dell’Africa settentrionale con quelle della Sicilia, rintracciando le relazioni con il gotico e con le architetture mediate dall’azione dei Crociati e quelle di derivazione propriamente cistercense. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 118 numero 3 - maggio 2011 Proprio queste argomentazioni, mai aprioristiche o fideistiche, già in L’architettura sveva era stata anticipata la preparazione e rafforzano l’impianto teorico dello studioso che, come si è già detto, che, nonostante, la differente titolazione, voluta dallo Zanotti risulta sempre scevro da preconcette impostazioni ideologiche79. per ragioni editoriali, è concepito da Agnello come effettiva Alcuni particolari momenti dell’architettura fedecontinuazione del primo. Il volume è incentrato riciana vengono, oltretutto, discussi anche in sull’analisi di castelli minori o non pienamente diversi articoli pubblicati nel corso degli anni riconducibili all’età federiciana o la cui originaria sul “Bollettino Storico catanese” dove compare nel conformazione, altamente compromessa 1940 Il Castello di Catania nel quadro dell’architettura da superfetazioni, interventi ed adattamenti sveva; al 1950 risale Lo stato attuale di monumenti successivi, ne rende parziale la lettura (per svevi in Sicilia; in “Siculorum Gymnasium” sono esempio la Torre di Vindicari e quella di Menfi, il pubblicati Monumenti svevi ignorati e Riflessi svevi nel Catello di Rometta e quello di Agira o ancora S. Castello di Scaletta; in occasione della “Celebrazione Maria degli Alemanni a Messina)84. L’importanza Federiciana”, nel 1951, esce Arte ai tempi di Federico riservata all’analisi dell’arte federiciana, in Sicilia, II. I monumenti svevi nel Siracusano; sulla rivista porta lo studioso a ribadire l’importanza di queste “Palladio”80 pubblica il saggio S. Maria della Valle forme architettoniche, costruttivamente e stilistio la «Badiazza» in Messina, sulla medesima rivista, camente intese che, spingendosi ben al di là dell’età un decennio prima era comparso un analogo federiciana, si propagano in epoca angioina G. Agnello, L’architettura sveva in Sicilia, contributo a firma del messinese Stefano Bottari81; Collezione Meridionale Editrice, Roma ed aragonese, sino alla metà del Quattrocento, e ancora Il Castello svevo di Prato, il Castello svevo di 1935. periodo in cui gli elementi ispani definitivamente Milazzo82. Molti dei lavori sopra citati sono raccolti, con aggiunte e prendono il sopravvento sulle reminiscenze sveve. La riscoperta modifiche, nell’ultimo lavoro dedicato dallo studioso all’architettura della Sicilia medievale e rinascimentale deve sicuramente molto sveva: L’architettura civile e religiosa in Sicilia nell’età sveva83, di cui alla figura di questo studioso, le cui ricerche, pionieristiche nel Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 119 numero 3 - maggio 2011 campo, rappresentano uno dei maggiori contributi allo sviluppo degli approfondimenti sulla storia artistica isolana di questi secoli. Studi che mantengono, ancor oggi, nell’impianto generale, la loro validità e coerenza85. Sebbene alcune posizioni siano state in tempi recenti riviste e spesso corrette, il contributo scientifico dato da Giuseppe Agnello rappresenta un significativo punto di partenza per tutti gli studiosi delle generazioni future, fra cui non si può non ricordare Giuseppe Bellafiore che al tema della Sicilia bizantina, normanna e sveva dedicherà due volumi: Architettura in Sicilia nell’età islamica e normanna (827-1194) e Architettura dell’età sveva in Sicilia (1194-1266)86. Se larga parte degli studi sin ora esaminati si concentrano sull’arte dei cosiddetti “secoli bui”, un consistente nucleo di saggi ed articoli viene riservato dallo studioso a tematiche che dal Rinascimento giungono sino al pieno Settecento. Già nel 1927, compare su “L’Osservatore Romano” un articolo dedicato a L’Annunciata di Antonello da Messina87. Ancora una volta Agnello, allora giovane esordiente, prende le mosse dal suo maestro Paolo Orsi che recatosi nel 1888 a Palazzolo Acreide, aveva personalmente voluto prendere visione dell’Annunciazione di Antonello da Messina, oggi conservata presso la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo a Siracusa, opera ritenuta una delle più importanti fra quelle realizzate dal pittore precedentemente al soggiorno veneziano del 1475. Nel sottolineare la profonda influenza esercitata nella Sicilia quattrocentesca dalle tendenze spagnole e catalane, evidente nella profusione dei broccati, nelle dorature, nei caratteristici sfondi a “estofado” – tendenza decorativa rappresentata da artisti gravitanti Antonello da Messina, Annunciazione, 1474, Siracusa, Galleria regionale di palazzo Bellomo. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 120 numero 3 - maggio 2011 Allo studio, a lui sicuramente più congeniale, dell’architettura del primo Quattrocento, Agnello dedica L’architettura aragonese-catalana in Siracusa93, opera edita nel 1942 nella “Collezione Meridionale” diretta da Umberto Zanotti-Bianco. Il lungo saggio è incentrato particolarmente sulle vicende di due dei più bei palazzi siracusani, sino ad allora praticamente sconosciuti: Palazzo Gargallo sede della storica Camera Regionale (istituita dall’aragonese Federico il Semplice nel 1361 c.a.) e Palazzo Greco (oggi sede dell’Istituto del Dramma Antico), la cui fondazione viene fatta risalire a quel clima di straordinaria floridezza commerciale tradottosi, proprio nella prima metà del XVI secolo, in una eccezionale vivacità edilizia tra influenze esotiche e serena compostezza rinascimentale94. L’insediarsi nella città di un governatore, del personale della Magna Curia, delle magistrature speciali aveva generato – secondo lo studioso – una vera e propria competizione tra nobiltà spagnola e locale, che ebbe nella produzione architettonica le sue più interessanti manifestazioni. Il rinnovamento del volto edilizio di Ortigia andò così in profondità da caratterizzare indelebilmente l’aspetto della città tanto che, insieme al più tardo barocco, il connotato gotico-catalano ne rimane una componente di preminenza95. Agnello tornerà sul tema delle influenze spagnole sull’arte siciliana ancora in alcuni interventi: Influssi e ricordi spagnuoli nel Siracusano, Influssi e ricordi spagnuoli nel intorno alla corte di Alfonso d’Aragona, quali Pietro de Saliba88, Tommaso de Vigilia89 o Riccardo Quartararo90 – Agnello rileva come anche Antonello non rifugga da queste tendenze, pur possedendo la sua arte una forte propensione all’eclettismo, che gli consente, inoltre, di fondere mirabilmente elementi fiammingheggianti con elementi gotici. Lo studioso individua nella prima produzione dell’artista elementi riconducibili alla scuola di Jacomart Baço – il riferimento è al S. Zosimo della Cattedrale di Siracusa – osservando che nella tavola dell’Annunciata iniziano a emergere «i primi germi del rinnovamento. La stilizzazione gotica, l’eccessiva ricerca di ornati, il rigidismo geometrico cedono il posto a una severa nudità ambientale, ad una schietta armonia divisionistica, ad una più diffusa vibrazione di colori […]. Le figure della Madonna e dell’Angelo appaiono ispirate ad una minore severità ascetica e animate quasi da un contatto più diretto colla realtà, da una più sincera osservazione della vita»91. Affiora da queste pagine tutta la forza dello storico dell’arte, informato del dibattito nazionale e regionale, dai conoscitori e storici, quali G.B. Cavalcaselle, G. Di Marzo e G. La Corte, fino ai più recenti aggiornamenti di Adolfo e Lionello Venturi e di Stefano Bottari92, all’interno del quale il Nostro si inserisce a pieno titolo. Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 121 numero 3 - maggio 2011 Siracusa, Palazzo Greco, inizio XIV sec., Siracusa. Ragusano pubblicati anche in lingua spagnola in “Revista Geográfica Española”; mentre approfondirà ulteriormente le caratteristiche dell’architettura catalanoaragonese, allargando l’analisi anche a quella della penisola, ne L’architettura aragonesecatalana nell’Italia insulare e continentale, saggio edito in “Rivista sto- si considera la trascuratezza con cui, per lungo tempo, la letteratura artistica nazionale e, purtroppo anche regionale, aveva affrontato lo studio dell’ arte siciliana dei secoli XV e XVI97. Si devono infatti al Di Marzo98 i primi studi pionieristici e sistematici sulla Sicilia rinascimentale, studi che hanno l’indiscusso merito di aver restituito alla storia nomi ed opere sino ad allora ignorati. Se il contributo dato da Agnello alla rivalutazione dell’arte figurativa in particolare siracusana del Quattrocento99 non è rapportabile a quello del Di Marzo o di altri studiosi quali Mauceri, Bottari o Accascina100, ciò non ne limita la validità e l’accuratezza dell’analisi, attenta, anche a segnalare importanti tavole, degnissime di nota, se pur anonime. Si tratta di una serie di opere di grande interesse, perché punti di riferimento e di comparazione per l’identificazione di un comune centro di elaborazione locale101. Al di là delle attribuzioni avanzate, ciò che l’autore tiene a sottolineare nel volume è l’esistenza di una scuola locale improntata alla forte influenza che sugli artisti locali esercitavano i maestri spagnoli, catalani e barcellonesi – primo fra tutti il Borassà, alla cui influenza Agnello lega la prima produzione antonelliana – iniziatori e promotori di una attività artistica e industriale che in nessun’ altra città, come a Siracusa, seppe penetrare con sì tanta forza, in pittura quanto in architettura. rica del Mezzoggiorno” nell’anno 196796. Esclusi questi sporadici interventi, lo studioso, tratta organicamente il tema del Rinascimento nel 1964, relativamente alla sola Siracusa, in Siracusa nel Medioevo e nel Rinascimento. Nel volume ampio rilievo viene riservato oltre che all’architettura, anche alla locale scuola pittorica, indagando personalità che in molti casi restano ancor oggi celate nel buio. Si tratta di un’operazione di particolare interesse se teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 122 numero 3 - maggio 2011 All’arte figurativa del XVI secolo il Nostro dedica numerose ricerche, ancora una volta pazientemente condotte tra archivi e attraverso sopralluoghi, volte a portare alla luce nomi ed opere a lungo dimenticate. Queste ricerche hanno, per esempio, permesso di fare luce su un pittore vissuto sullo scorcio del XVI secolo, attivo a Siracusa, quale Giuseppe Piccione102. è ancora più motivato per il fatto che la città nella lavorazione del marmo non ha mai posseduto una tradizione locale di rilievo, così i grandi ordini religiosi e le casate patrizie si rivolgevano alle più rinomate botteghe della Sicilia occidentale, osservando anche che la città vantava una lunga e notevole tradizione nella particolare lavorazione della pietra calcarea. Ma i più significativi contributi dedicati dallo studioso all’approfondimento di questo periodo riguardano la fiorente stagione della scultura; numerosi sono quelli che si inseriscono all’interno dei più generali e già ricordati studi dedicati al Duomo di Siracusa, dove sono conservate pregevoli opere riconducibili a una delle più interessanti scuole fra quelle che la storiografia isolana possa annoverare, quella dei Gagini. In particolare lo studioso si occupa della Madonna della Neve e della S. Lucia103; opere del celebre S e, per gli interventi dedicati al Quattrocento e al Cinquecento, Agnello molto deve al suo conterraneo Enrico Mauceri, come dimostra la bibliografia di Siracusa nel Medioevo e nel Rinascimento104, tutt’altro respiro e autonomia possiedono gli studi dedicati al Barocco. L’interesse dello studioso per questo periodo storico – come nota il figlio Santi Luigi che affiancherà il padre in molte delle ricerche e degli approfondimenti sul Barocco – emerge in tempi decisamente precoci, come testimonia la recensione a Rinascimento e Barocco di Heinrich Wölfflin, pubblicata nel 1929 in “Per l’Arte Sacra”. Sicuramente è stata proprio la lettura di questo fondamentale saggio, pienamente inscrivibile all’interno di quella generale rivalutazione italiana (in primis Longhi) ed europea della produzione artistica del secolo XVII, ad avviarlo verso questi studi. Tale processo era allora ancora agli albori e, Antonello di cui si conserva presso il Museo Bellomo di Siracusa anche un pregevole sarcofago realizzato nel 1506 per Giovanni Cardenas, Governatore della Camera Regionale. Agnello non manca di ricordare l’opera di Francesco Laurana (la Lastra tombale di Giovanni Cabastida, Governatore della Camera Regionale) e quella di Giovan Battista Mazzolo (il Monumento funebre di Eleonora Branciforti). Il ricorso, come egli stesso precisa, ad artisti continentali che sappiamo da Di Marzo attivi in numerosi centri dell’isola, a Siracusa Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 123 numero 3 - maggio 2011 certamente, non si può affermare che si diffondesse con facilità negli ambienti intellettuali ed eruditi del tempo, soprattutto se si considera che un simile dibattito si originava in seno ad una cultura fortemente classicista ed ancora tutta incentrata sugli studi del Rinascimento, non solo a livello nazionale, e caso tipico è stato quello di Benedetto Croce, ma ancora più in ambito isolano. Agnello, conscio di questa situazione, riguardo alla dimensione siciliana, afferma che sebbene alcuni approfondimenti, dovuti ad autori quali Salvatore Caronia Roberti105, Filippo Meli106, Alessandro Giuliana Alajmo107, Enrico Mauceri108, Maria Accascina109, avessero già portato a nuove ed importanti acquisizioni, la necessità di fare ancora molto, esigeva un continuo aggiornamento rispetto al contesto nazionale ed internazionale. A tal proposito ricorda come, anche nel quadro del nuovo interesse per il Barocco, promosso da Corrado Ricci intorno al terzo decennio del XX secolo110, la Sicilia fosse rimasta ancora relegata in una dimensione provinciale, a eccezione solo della rilettura critica di alcune emergenze architettoniche barocche come quelle di Palermo, Catania o Noto. Lo storico siracusano in occasione del Congresso Internazionale di Studi sul Barocco (Lecce 1969) nel suo intervento su L’architettura barocca in Sicilia111, non manca, inoltre, di sottolineare il ruolo di apripista svolto dal veloce compendio sull’architettura siciliana che G. Agnello, I Vermexio. Architetti ispanosiculi del secolo XVII, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1959. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 124 numero 3 - maggio 2011 famiglia dei Vermexio, architetti “proto barocchi”115, la cui bottega Enrico Calandra, architetto allievo di Ernesto Basile e Giuseppe si forma intorno alle figure del già ricordato Andrea e del figlio Damiani Almeyda, pubblica con Laterza nel 1938112, dedicando due Giovanni116. Le indagini capitoli al Seicento e al condotte da Agnello, Settecento. L’architettura sempre attraverso l’inbarocca in Sicilia scritto dispensabile ricerca ricco di notevoli spunti d’archivio, verificata e di riflessione, si pone supportata da un’attenta come momento di sintesi analisi stilistica, hanno dei molti studi portati messo in rilievo la avanti da Agnello sul complementarietà tema ampio e variegato tra l’attività di Andrea del Barocco; una serie e di Giovanni, dove di studi in forma di l’abilità del capofamiglia, saggi e articoli apparsi ancora chiaramente su periodici e riviste a incline a moduli tardo partire dal 1928 e sino al rinascimentali, viene 1975, dedicati ad aspetti G. Agnello, I Vermexio. Architetti ispanosiculi del XVII, 1959. perfezionata dal figlio quanto mai vari e spesso Chiesa del Sepolcro di S. Lucia di Siracusa. e discepolo, capace di scarsamente indagati, con destreggiarsi tra il vecchio e il nuovo, muovendosi liberamente tra particolare riferimento all’indagine sull’attività delle maestranze113. castigata sobrietà e tormentosa ricchezza, quest’ultima di impronta Tra questi un importante nucleo – successivamente raccolto in chiaramente barocca. A questa prestigiosa famiglia di architetti, una intelligente monografia apparsa nel 1959114 – è dedicato alla Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 125 numero 3 - maggio 2011 cui lo studioso dedicherà il volume I Vermexio architetti ispano-siculi del secolo XVII edito nel 1959, va attribuita una vera e propria trasformazione della città: il loro nome si può ricondurre a più bei capolavori del XVII e XVIII secolo, simboli di quel ridestato desiderio di rinnovamento: il Palazzo Senatorio117, la Chiesa del Sepolcro di S. Lucia118, la Chiesa di S. Lucia extra moenia, la Chiesa e il Collegio dei Gesuiti119, la Chiesa di S. Filippo Neri, la Chiesa di S. Benedetto, la Chiesa di Monte Vergini120, il Palazzo Arcivescovile121 e la cappella Torres. Con identica acribia, Agnello esamina anche altre figure di architetti dei secoli XVII e XVIII, pressoché ignoti, come per esempio Luigi Caracciolo, cui dedica due articoli dal titolo Un architetto ignorato del sec. XVII. Ma il suo interesse non si limita, certo, alla sola architettura e scultura, argomento su cui torna con uno scritto dedicato allo scultore fiorentino Gregorio Tedeschi, attivo in Sicilia agli inizi del XVII secolo122 e autore di una S. Lucia (1634) collocata presso la Chiesa del Sepolcro123. In due interessanti saggi, Note e documenti inediti su artisti ignorati del secolo XVIII in Sicilia e Pittori siciliani dei sec. XVI‑XVII‑XVIII, pubblicati sulla rivista “Archivi”, rispettivamente nel 1937 e nel 1947, lo studioso si occupa di una serie di artisti locali, sino ad allora poco noti, o addirittura sconosciuti: Luciano Alì, Ermenegildo Martorana, Gregorio Lombardo, Rosario Minniti, Giacomo Ferlito, Antonino Maddiona, Francesco Callia, Mario Cordua, Antonino Calvo, Antonino Bonincontro e Mauro e Giuseppe Troia124. La ricognizione sulla pittura cinque-seicentesca meridionale, non si limita alla riscoperta di figure ignorate e pressoché dimenticate. Agnello, infatti, dedica una serie di contributi molto interessanti a Mario Minniti125, sodale di Caravaggio, e al pittore calabro Mattia Preti126 artisti che colloca nella corretta prospettiva storica (avvalendosi anche di una importante mole di documenti provenienti dagli archivi locali), riconducendone la filiazione stilistica al naturalismo di matrice caravaggesca127. Com’è risaputo, non fu solo il Minniti che, tra i giovani pittori siciliani, subì l’influsso di Michelangelo da Caravaggio. Il passaggio di quest’ultimo da Messina aveva sconvolto, non meno che a Roma, le frigide tradizioni accademiche dei pittori locali che, come i Catalano e i Comandè, tenevano allora incontrastato il campo. Non pochi seguirono la nuova maniera, ma solo due – il nostro pittore [Mario Minniti] e Alonso Rodriquez – riuscirono meglio ad assimilarla esprimendosi con atteggiamenti personali. Sono appunto queste comuni caratteristiche che rendono spesso così difficile l’esame del definitivo giudizio di attribuzione128. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 126 numero 3 - maggio 2011 un ventennio di isolamento civile e culturale, nel 1943 a seguito dello sbarco delle truppe anglo-americane, Agnello si ritrova protagonista della vita cittadina, essendo chiamato a collaborare con le Autorità alleate per il riordinamento e la sistemazione dei servizi più urgenti132. A Siracusa è anche tra i fondatori del Partito Democratico Cristiano, eletto alla Consulta nazionale133 nel 1945 è presentato alle elezioni per la Costituente134. A questo Borgianni. Proprio con Longhi, Agnello periodo risalgono due volumi frutto entrerà in contatto, dopo la pubblicazione dell’impegno politico e letterario: Buona di un articolo su una copia del Seppellimento sera colonnello Stevens135 e Chi farà il processo di S. Lucia di Caravaggio (1608 ca.), allora al fascismo?136. Boicottata la candidatura, il custodita presso la chiesa del Collegio 18 marzo 1947 Agnello viene espulso dal dei Gesuiti129. La tela, realizzata nel 1797 partito. Abbandonata la militanza politica dal pittore-copista siracusano Raffaello lo studioso si dedica completamente Politi130, è stata oggetto di studio da parte alle sue ricerche e all’insegnamento. di Agnello e giudicata positivamente da Longhi che tuttavia la esclude dal Michelangelo Merisi da Caravaggio, Il Seppellimento di Già nel 1943 era stato chiamato dall’Università di Catania a reggere la catalogo del Caravaggio, al quale era Santa Lucia, 1608, Siracusa, Chiesa di S. Lucia. cattedra di Archeologia Cristiana137. stata dubitativamente attribuita131. Dopo Un interesse, quello per i caravaggeschi, perfettamente in linea con alcuni importanti filoni di ricerca della Storia e della Critica d’arte in Italia fra le due guerre, portati avanti da Lionello Venturi e da Roberto Longhi. In particolare, Longhi indirizzerà la grande stagione di studi sul naturalismo e sulla pittura barocca e ricordo solamente i contributi su Caravaggio, Mattia Preti, Orazio Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 127 numero 3 - maggio 2011 A seguito di revisione di concorso Agnello, nel 1948, riprende la docenza, vincendo la cattedra di Archeologia Cristiana sempre presso l’Ateneo catanese, presso cui insegnerà sino al 1959 (anno del pensionamento) per poi nuovamente rientrarvi due anni dopo, usufruendo della legge promulgata nel ’59, che prevedeva l’innalzamento dell’età pensionabile a settantacinque anni per coloro i quali, a causa della persecuzione fascista, avevano subito un ritardo della carriera. Dal 1949 al 1957 gli viene affidato anche l’insegnamento di Storia delle Religioni e nell’anno accademico 1949-50 assume la cattedra di Storia dell’Arte Medievale e Modena, ricoperta da Stefano Bottari138 che si era trasferito a Bologna. Si è lungamente discusso in occasione delle giornate di studio dedicate all’attività scientifica di Agnello139 sulla possibilità di inquadrarne le ricerche all’interno di quello che è l’ambito di pertinenza dell’Archeologia Cristiana. È indubbio che, quando lo studioso assume l’incarico presso l’Ateneo catanese, pur avendo già fornito importanti contributi sull’arte paleocristiana, il nucleo più significativo di studi e di ricerche era nell’ambito della storia dell’Arte Medievale. Agli anni dell’insegnamento universitario risalgono le più sistematiche ricerche inerenti necropoli, cimiteri subdiali e ipogei del siracusano, tuttavia, non si possono trascurare alcuni articoli apparsi già a partire dal ’26140, relativi ad indagini condotte su monumenti paleocristiani e bizantini quali la Chiesa di S. Pietro141 o la Chiesa dei Santi Giovanni e Marziano142. Al di là delle difficili inclusioni dell’attività di Agnello all’interno di una o dell’altra disciplina, risultano particolarmente significative le parole pronunziate da Salvatore Russo143, Presidente della Società Siracusana di Storia Patria, Istituto di Studi Paolo Orsi. 144 Storici . Lo stesso Agnello nel discorso letto in occasione della prolusione dell’anno accademico 1948-49, oltre a fissare l’ambito epistemologico della disciplina, richiamando alla necessità immediata di un programma di ricerche e scavi volti al recupero del documento primario e insostituibile che è il monumento in se stesso, dimostra anche di considerare in una chiave moderna e innovativa la stessa periodizzazione, scavalcando i limiti tradizionali della disciplina e allargando quindi il campo di studi dell’Archeologia cristiana oltre il IV secolo, sino all’età araba. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 128 numero 3 - maggio 2011 A Come già sottolineato, il problema della ricostruzione delle origini del cristianesimo, in primis, per la città di Siracusa e, successivamente, anche per la Sicilia nel suo complesso, costituisce uno dei perni fondamentali attorno al quale si muovono e prendono forma i numerosi studi di Agnello ai quali va riconosciuto il merito di avere riportando alla luce un’età, quella paleocristiana, allora ancora poco indagata e conosciuta149. Indubbiamente, come accennato all’inizio di questo scritto, le prime ricerche dedicate alla Sicilia paleocristiana, nascono certamente da quell’interesse per l’Archeologia, da lui vissuto quale momento di verifica analitica delle notizie provenienti dalle fonti letterarie; due discipline intese come complementari e sussidiarie l’una all’altra. Si deve ribadire che un ruolo fondamentale, nell’ipostazione metodologica e nell’approccio alla disciplina, gli era pervenuto dal contatto con Paolo Orsi, a cui va attribuito il merito di avere, per primo, posto come necessaria un seria campagna di scavo, volta a restituire alla città siracusana, la sua importante storia non solo pagana, ma anche cristiana. Almeno fino alla seconda metà dell’Ottocento, infatti, la cultura archeologica in Sicilia non si era occupata del periodo tardo antico, se non per riferimenti sporadici di carattere informativo. Alle campagne di scavo condotte dal Nostro si deve il riconoscimento dell’importanza della Siracusa lla luce di ciò, si può meglio comprendere l’impostazione riservata a numerosi studi, molti dei quali sono da lui raccolti e poi pubblicati in Le arti figurative nella Sicilia bizantina145. Mi riferisco agli articoli scritti lungo un esteso arco di tempo che va dal 1928 al 1959 e che rivelano la propensione di Agnello verso tutte le forme dell’arte; attenzione che diviene palese anche negli articoli dedicati alle arti applicate, argomento particolarmente caro allo studioso146, come attestano numerosi articoli dedicati a questi particolari manufatti147. Negli approfondimenti sulla Sicilia di età bizantina che compie negli anni della piena maturità, Agnello pone in risalto come ancora nei due decenni a metà dello scorso secolo, fosse ancora poco noto e quindi di difficile analisi critica, l’analisi degli avvenimenti artistici intercorsi in quel periodo che iniziato nel 535 con la riconquista della Sicilia per opera di Belisario, poteva ritenersi concluso nell’827 solo sulla carta politica, dal momento che la dimensione culturale prevalentemente greca continuerà in Sicilia ben oltre e nonostante la parentesi musulmana148. Tale conclusione viene supportata dallo studioso facendo ricorso ad un orizzonte storico quanto mai ampio, in studi che spaziano dall’architettura, sino a temi propri dell’archeologia cristiana (pittura paleocristiana, catacombe o santuari rupestri…). Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 129 numero 3 - maggio 2011 sotterranea di età cristiana, essendo emerso un quadro totalmente nuovo delle catacombe di S. Lucia (la cui superficie venne quadruplicata rispetto a quella rilevata dall’Orsi) e di quella della Vigna Cassia. Sempre a lui si deve anche una attenta ricognizione, fondamentale per sua stessa ammissione, “delle campagne”, “dei monti”, “del suburbio”, del territorio limitrofo alla città. Da docente spinge i suoi allievi a non limitarsi alla sola area del siracusano, spronandoli a cercare ed ad indagare anche i diversi luoghi d’origine, estendendo così le ricerche a quei siti nei quali lui stesso, in prima persona, non sempre era nelle condizioni di recarsi. Molte di queste ricerche sia seguite personalmente da Agnello, sia sotto la sua supervisione, dai suoi allievi sono state pubblicate nella “Rivista di Archeologia Cristiana”, organo ufficiale della Pontificia Commissione di Archeologia Cristiana150, che nel 1951 affida allo studioso l’incarico di Ispettore per le Catacombe di Siracusa e della quale diviene membro nel 1957; dal 1950 al 1960 è anche consultore della Pontificia Commissione centrale per l’Arte Sacra151. Un’intensità eccezionale quella che caratterizza la produzione scientifica di Agnello. Con ritmo insistente si succedono, oltre ad una importate monografia dedicata alla Pittura paleocristiana della Sicilia152, anche numerosissimi saggi apparsi su “Nuovo Didaskaleion”153, su “Presenza Cristiana”, su “Italia Nostra”, su “Palladio”, su “Siculorum Gymnasium”154. Su testate giornalistiche locali e nazionali (“La Voce di Siracusa”, “Settegiorni di Siracusa”, “L’Osservatore romano”, “La Sicilia”) vengono inoltre pubblicati, a partire dal 1960, diversi articoli spesso firmati “SIGMA”155. Nell’ambito degli studi di Archeologia va anche ricordata un’iniziativa di particolare merito, che vede Agnello non solo quale ideatore, ma anche come primo promotore: a lui il merito di aver dato avvio ai Congressi Nazionali di Archeologia Cristiana156 (di cui a partire dal 1952 sarà Presidente del Comitato scientifico157), il primo dei quali si svolge proprio a Siracusa nel 1950. Si tratta di una progetto di particolare rilievo volto, da un lato a stimolare gli scavi e le ricerche a livello sia nazionale che locale, dall’altro a richiamare l’attenzione su una disciplina, sino ad allora, di appannaggio quasi esclusivo della Chiesa e dei suoi funzionari. Con questi Congressi, Agnello rivendica anche per l’Archeologia Cristiana un ruolo di guida all’interno delle ricerca scientifica, tanto nelle Università quanto a livello delle Sovraintendenze. La Bibliografia compilata dal figlio dello studioso, Santi Luigi con la collaborazione di Giuseppe Palermo, conta 619 testi, tra monografie, saggi su periodici e articoli su giornali158. Giuseppe Agnello muore a Siracusa il 28 settembre 1976. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 130 numero 3 - maggio 2011 e indispensabile alle indagini cui verteranno i successivi studi. 6 Sull’eminente filologo Paolo Savj Lòpez, (Torino 1876 - Napoli 1919), si veda: F. Picco, Opere di Paolo Savj-Lòpez, Athenaeum, Pavia 1920; L. Sorrento, Paolo Savj Lòpez: commemorazione letta nell’aula Magna della R. Università di Catania il 16 giugno 1919, Tip. Santo Garufi, Catania 1920; M. Marescalchi, Paolo Savj Lòpez, Direzione della Nuova Antologia, Roma 1921. Sul debito scientifico dell’Agnello nei confronti di colui che fu il suo primo maestro, cfr. A. Prandi, Per Giuseppe…, p. 25 e P. Testini, Giuseppe Agnello, in “Archivio Storico Siracusano”, n. IV, 1975-76, p. 7. 7 Mi riferisco alla Scuola di Studi Filologici e Letterari dell’Istituto di Studi Superiori di Firenze, formatasi a partire dal 1860 intorno alle emblematiche figure del Comparetti e del D’Ancona. Si veda a tal proposito E. Garin, La cultura italiana tra ‘800 e ‘900, Laterza, Bari 1962. 8 Sulla figura di Domenico Comparetti, cfr. G. Pugliese Carratelli, ad vocem “Comparetti Domenico”, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 27, pp. 672-678 e Domenico Comparetti tra antichità e archeologia, individualità di una biblioteca, catalogo della Mostra (Firenze 1998), a cura di M.G. Marzi, Il ponte, Firenze 1999. 9 Il figlio dello studioso Santi Luigi sottolinea l’importanza che l’ambiente dell’Istituto Superiore toscano ebbe nella formazione non solo culturale del Nostro, proponendola, anche in virtù del contatto, avvenuto negli anni fiorentini, con l’emblematica figura di Gaetano Salvemini, quale chiave di lettura della futura presa di posizione civile e morale del genitore nei confronti del diffuso malcostume politico del Mezzogiorno d’Italia e delle vergognose ingerenze del regime fascista. 10 Dopo un breve periodo di insegnamento a Catania, chiamato alle armi, prende parte alle operazioni militari sul fronte francese inquadrato in un reparto delle T.A.I.F. (Truppe Ausiliarie Italia-Francia). A Siracusa, nel 1915, incontra Pia Accardi, giovane professoressa di origini toscane. A questa donna dal temperamento deciso e coraggioso Agnello dedicherà nel 1962 il volume autobiografico La mia vita nel ventennio, Mascali Editore, Siracusa 1962. 11 Si veda a tal riguardo G.C. Sciolla, L’autobiografia di Enrico Mauceri e le memorie degli storici dell’arte tra Ottocento e Novecento, in Enrico Mauceri (1860-1966). Storico dell’arte tra connoisseueship e conservazione, Atti del Convegno internazionale (Palermo 27-29 settembre 2007) a cura di S. La Barbera, Flaccovio, Palermo ______________________ 1 Giuseppe Agnello nasce il 5 febbraio del 1888 a Canicattini Bagni, piccolo centro della provincia di Siracusa. Maggiore di due figli, è da subito destinato al seminario, per volere della madre e dello zio sacerdote, Giuseppe Cultrera. Per la ricostruzione della vita e della produzione dello studioso, oltre che alle informazioni gentilmente fornite dal nipote Prof. Giuseppe Agnello, si è fatto riferimento ai volumi: Per Giuseppe Agnello, Società Siracusana di Storia Patria, Siracusa 1977; Giuseppe Agnello. Atti delle Giornate di studio nel decennale della scomparsa, a cura di S.L. Agnello (Canicattini Bagni-Siracusa, 28-29 novembre 1986), Flaccavento, Siracusa 1993; G. Agnello, La mia vita nel ventennio, Mascali Editore, Siracusa 1962 e S.L. Agnello, G. Palermo, Bibliografia degli scritti di Giuseppe Agnello, Quaderni della Società Siracusana di Storia Patria, III, Siracusa 1978. 2 Su Luigi Bignami, cfr. V. Maraschini, Un Vescovo Milanese-Siciliano. Mons. Luigi Bignami Arcivescovo di Siracusa, (con presentazione di Ettore Baranzini, Gasparini), Tip. Tipez, Milano 1942. 3 La lettera datata 11 luglio 1910 fa parte della corrispondenza tra il Vescovo Bignami e il Prof. Agnello; ne viene riportato un frammento in G. Giarrizzo, Prefazione a Il Carnevale politico nel Siracusano, a cura di G. Agnello, Comitato Nazionale A.N.P.I., Siracusa 1985 (ristampa del volume edito dalla Società Tipografica di Siracusa, Siracusa 1924), p. VIII. 4 G. Agnello, Un Vescovo umanista. Luigi Bignami, Società tipografica, Siracusa 1925. Il volume riporta il discorso tenuto da Agnello in occasione della commemorazione del Vescovo nel terzo anno dalla sua scomparsa, organizzata dal Circolo della Libertà Cattolica. Il discorso è stato pubblicato preceduto da una introduzione e seguito da una postilla. Si vedano anche gli altri scritti dedicati al Vescovo: G. Agnello, Un vescovo umanista, in “Il Popolo”, 22 marzo 1925, p. 3; Id., Mons. Bignami ed il suo sogno di rinascita del duomo, in “Foglio ufficiale dell’Arcidiocesi di Siracusa”, suppl. XV – 6, 1926, p. 3. 5 La tesi, pubblicata sotto forma di saggio nel 1925, è preceduta da numerosi studi, nel corso dei quali il giovane laureando si cimenta con la lingua tedesca, acquisendone ben presto la completa padronanza, supporto questo funzionale Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 131 numero 3 - maggio 2011 non quale poeta, esaltando, piuttosto, rilevandone la civiltà e la nobile umanità con le quali il sommo poeta, seppe conciliare «passioni politiche» e «desiderio di redenzione morale». 19 Id., La mia vita…, p. 79. 20 Il P.P.I. fu fondato nel 1919 da Don Luigi Sturzo al quale Agnello era legato da una profonda stima, testimoniata anche da una affettuosa corrispondenza. Due lettere sono riportate in G. Agnello, La mia vita…, pp. 104-105. A questo periodo risalgono numerosi articoli inviati a “Il Popolo”, in cui lo studioso compie una chiara disamina della convulsa situazione politica di quegli anni. Si vedano a tal proposito: G. Agnello, Fascismo e massoneria, in “Il Popolo”, 24-25 aprile 1923; Id., Il risveglio massonico, ivi, 30 aprile-1maggio 1923; Id., Disordini durante una processione, ivi, 18-19 maggio 1923; Id., Equivoco massonicofascista, ivi, 8-9 giugno 1923; Id., Attendo l’on. Mussolini, ivi, 13-14 giugno 1923; Id., Sindacalismo fascista in tribunale, ivi, 20-21 giugno 1923; Id., Violenze sindacali fasciste condannate, ivi, 30 giugno-1 luglio 1923; Id., Vibrata protesta dell’Ordine dei medici, ivi, 27-28 settembre 1923; Id., Echi della fasta della Vittoria. Commemorazioni e conflitti a Siracusa, ivi, 14-15 novembre 1923; Id., Convegno popolare a Siracusa, ivi, 28-29 dicembre 1923; Id., Gravi provocazioni fasciste contro giovani cattolici siracusani, ivi, 19 febbraio 1924; Id., Spedizione punitiva fascista contro manifesti popolari, ivi, 13 marzo 1924. 21 Id., Il Carnevale politico nel siracusano, Società Tipografica, Siracusa 1924. Il volume verrà ristampato nel 1985 con una prefazione introduttiva curata da G. Giarrizzo. Il volumetto pubblicato dall’autore con la precisa volontà di intervenire in forma pubblica in risposta ai violenti attacchi provenienti dalle fila del fascio, raccoglie parte degli articoli comparsi in forma sfusa sul quotidiano politico “Il Popolo”..Si tratta nello specifico degli articoli: G. Agnello, I partiti politici nel Siracusano. Liberismo – Democrazia – Radicalismo, in “Il Popolo”, 7 dicembre 1923; Id., Dopo il convegno dei Prefetti a Siracusa, ivi, 13-14 dicembre 1923; Id., I partiti politici nel siracusano. Il socialismo, ivi, 28-29 dicembre 1923; Id., I partiti politici nel siracusano. Il Fascismo, ivi, 16 gennaio 1924; Id., I partiti politici nel siracusano. Il Popolarismo, ivi, 7 febbraio 1924. 22 Sulle elezioni del 1924 si veda G. Agnello, La colossale tratta dei bianchi nel siracusano, in “Il Popolo”, 19 aprile 1924. 23 Id., La mia vita…, pp. 54-55. 2009, pp. 59-66. 12 Melilli (Siracusa) 1869 – Roma 1950. Fu Archeologo, studioso di arte e numismatica antica, collaborando a Siracusa con Paolo Orsi e quindi funzionario nell’amministrazione delle Belle Arti presso il Museo Nazionale di Napoli e presso di Roma partecipando alle campagne degli scavi del Foro e del Palatino. Nel 1907 vinse il concorso per la cattedra di Archeologia presso l’Università di Torino, insegnando successivamente anche a Roma e a Napoli. Tra le sue numerose opere ricordo Teatro Greco (1916), La pittura ellenistico-romana (1930), Prassitele (1932), Monete greche della Sicilia (1946). 13 Firenze 1864-1957. Sull’illustre figura, cfr. Gaetano Pieraccini. L’uomo, il medico, il politico (1864-1957), catalogo della mostra (Firenze 19 maggio - 21 giugno 2003) a cura di F. Carnevale, Z. Ciuffoletti, M. Migliorini Mazzini, M. Rolih, Olschki Editore, Firenze 2003. 14 G. Agnello, Paolo Orsi (con bibliografia inedita in appendice), Vallecchi Editore, Firenze 1925. 15 Sul fascismo si veda S. Lupo, Il fascismo: la politica di un regime totalitario, Donzelli editore, Roma 2000. 16 Dopo esser stato assegnato all’Ufficio pensioni di Siracusa, sul volgere dell’anno, torna finalmente all’insegnamento; divenuto professore di ruolo, esercita la professione presso il Liceo-Ginnasio di Reggio Calabria fino al 1920 quando fa rientro a Siracusa, assegnato al Liceo-Ginnasio “T. Gargallo”. 17 Paolo Orsi (Rovereto 1859-1935) compie la sua formazione a Vienna, a Padova e a Roma (presso la Regia Scuola Italiana di Archeologia) e a Firenze, dove approdato nel 1885, in qualità di bibliotecario alla Biblioteca Nazionale Centrale, si accosta all’entourage del Comparetti. Inviato a Siracusa nel 1890 Orsi dà subito avvio ad una serie intensissima di ricerche che gli consentono di tracciare il primo quadro storico, sistematico delle originarie culture dei Siculi della Sicilia preellenica. A tal proposito, cfr. G. Libertini, Centuripe a Paolo Orsi animatore e Maestro degli studi di antichità siciliane, Libreria Tirelli, Catania 1926; U. Zanotti Bianco, Paolo Orsi, Palermo 1921; Bibliografia degli scritti di Paolo Orsi, con prefazione di S. L. Agnello, a cura di A.M. Marchese, Scuola normale superiore, Pisa 2000. 18 G. Agnello, Passioni politiche e ire di parte nella vita di Dante, Società Tipografica, Siracusa, s. d. [ma 1921]. L’intervento esaminava la figura di Dante, teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 132 numero 3 - maggio 2011 (Sicilia), in “Roemische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte”, XV, 1901, p. 345-351. 34 G. Agnello, L’Arte bizantina in Sicilia, in “Il Giornale d’Italia”, (Cronaca siciliana), 26 giugno 1925; Id., Arte bizantina I, in “Il Giornale d’Italia”, (Cronaca di Siracusa), 2 agosto, 1925; Id., L’Arte medievale a Siracusa, in “Il Mondo”, 18 agosto, 1925; Id., Castel Maniace e l’arte imperiale sveva a Siracusa, ivi, 23 agosto 1925; Id., Siracusa bizantina, ivi, 28 agosto 1925; Id., Arte bizantina II, in “Il Giornale d’Italia”, (Cronaca siciliana), 20 ottobre 1925; Id., L’architettura sotto gli aragonesi, in “Il Mondo”, 29 ottobre 1925; Id., Medio-Evo inedito, in “Il Popolo”, 6 novembre 1925. 35 Cfr. G. Agnello, Siracusa (Archeologia e arte: Medioevo ed età moderna), in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, XXXI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1936, pp. 873-874 e le voci Squillace (Medioevo ed età moderna), Ibidem, XXXII, p. 430 e Stilo (Arte: Medioevo ed età moderna), Ibidem, p. 739. 36 Il Vescovo Carabelli, succeduto alla cattedra arcivescovile siracusana, alla morte del Bignami, intrattiene con Agnello un rapporto di affettuosa amicizia. 37 Sulla corrispondenza tra Agnello e i funzionari del Ministero della P.I., cfr. G. Agnello, I documenti di un esonero, Tipografia Santoro, Siracusa, s.d. [ma 1926]. 38 Riviste d’arte tra Ottocento ed Età contemporanea. Forme, modelli e funzioni, a cura di G.C. Sciolla, Skira Editore, Milano 2004. 39 Si veda per esempio G. Agnello, Monumenti svevi ignorati, in “Siculorum Gymnasium. Rassegna semestrale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania”, III, 1-2, 1950. 40 R. Cioffi, Per uno studio delle riviste d’arte del primo Novecento: note su Alfonso Frangipane e la rivista “Brutium”, in L’arte nella storia. Contributi di critica e storia dell’arte per G.C. Sciolla, a cura di V. Terraroli, F. Varallo, L. De Fanti, Skira, GenèveMilano 2000, pp. 85-93. 41 Fondatore con Paolo Orsi della “Società Magna Grecia” e della rivista “Archivio Storico per la Calabria e la Lucania”, svolge un’intensa attività soprattutto in difesa del patrimonio monumentale e ambientale. Sulla figura di Umberto Zanotti-Bianco si veda: V.E. Alfieri, Umberto Zanotti Bianco, la Nuova Italia, Firenze 1956; S. Zoppi, Umberto Zanotti-Bianco: patriota, educatore, meridionalista: il suo progetto e il nostro tempo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. 42 G. Agnello, Monsignor Giacomo Carabelli e l’arte, in Memoria di S. E. Rev. 24 Cfr. Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana tra ‘800 e ‘900. L’area fiorentina, a cura di E. Capannelli, E. Insabato, Olschki, Firenze 1996. 25 Cfr. C. Gambaro, Domenico Comparetti e il suo contributo all’archeologia, Tesi di laurea in Storia dell’archeologia classica, Università degli Studi di Firenze, a.a. 1988-1989, relatrice prof. Maria Grazia Marzi; Domenico Comparetti tra antichità e archeologia. Individualità di una biblioteca, Catalogo della mostra (Firenze, 28 gennaio-28 febbraio 1998) a cura di M. G. Marzi, Il Ponte, Firenze 1999. 26 A tal proposito si veda C. Dionisotti, Ricordi della scuola italiana, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1998. 27 G. Agnello, Paolo Orsi.... 28 Si ricorda a tal proposito il contributo pionieristico fornito a questi studi da Adolfo Venturi; per un approfondimento, cfr. A. Iacobini, Adolfo Venturi pioniere di una disciplina nuova: la storia della miniatura in Adolfo Venturi e la storia dell’arte oggi, Atti del convegno (Roma 25-28 ottobre 2006), a cura di M. d’Onofrio, Edizioni Panini, Modena 2008, pp. 269-286. 29 Sul contributo fornito dal Di Marzo alla rivalutazione degli studi sull’arte siciliana medievale si è fatto riferimento alla registrazione audio, gentilmente messami a disposizione dalla Prof.ssa S. La Barbera, dell’intervento tenuto da M. Andaloro in occasione del Convegno di Studi su Gioacchino di Marzo e la Critica d’arte nell’Ottocento, (Palermo 14-16 aprile 2003) a cura di S. La Barbera. Si veda pure a tal proposito: S. La Barbera, Di Marzo e “La Pittura in Palermo nel Rinascimento”, in Gioacchino di Marzo e la Critica d’arte nell’Ottocento…, pp. 168-180. 30 Sulla figura del Toesca, cfr. R. Longhi, Pietro Toesca, in AA.VV., Letteratura italiana. I critici, vol. V, Marzorati, Milano 1987, pp. 3347-3351. 31 G. Agnello, Paolo Orsi, in “R. Liceo-Ginnasio T. Gargallo” di Siracusa. Annuario per l’anno 1923-24, Società tipografica, Siracusa 1924 e Id., Siracusa medievale. Monumenti inediti, in “R. Liceo-Ginnasio T. Gargallo” di Siracusa. Annuario per l’anno 1924-5, Società tipografica, Siracusa 1925. 32 Id., Siracusa Medievale. Monumenti inediti (Con illustrazioni fuori testo), Muglia Editore, Catania 1926. 33 Si vedano a tal proposito P. Orsi, Incensiere bizantino della Sicilia, in “Byzantinische Zeitschrift”, V, 1896, p. 567-569; Id., Chiese bizantine nel territorio di Siracusa, ivi, VII, 1898, p. 1-28 ; Id., Stauroteca bizantina in bronzo di Ragusa Inferiore Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 133 numero 3 - maggio 2011 ma Monsignor Giacomo Carabelli Arcivescovo di Siracusa, (numero unico), Società Tipografica, Siracusa 1933. 43 Ad Agnello si deve la compilazione di una approfondita guida del Duomo di Siracusa, purtroppo, in un primo momento, poco diffusa a causa delle ingerenze del regime fascista, che ne ostacolò la diffusione. Cfr. G. Agnello, Guida del Duomo di Siracusa, Officina d’Arte Grafica A. Lucini & C., Milano, s. d. [ma 1930]; Id., Guida del Duomo di Siracusa, 2ª edizione aggiornata, Officina d’Arte Grafica A. Lucini & C., Milano, s. d. [ma 1949]; Id., Guida del Duomo di Siracusa, 3ª edizione aggiornata, Mascali Editore, Siracusa 1964. 44 Un cospicuo numero di interventi inerenti il Duomo di Siracusa è stato dedicato dallo studioso alle arti decorative. Cfr. G. Agnello, I tessuti e i ricami d’arte della Cattedrale di Siracusa e i loro recenti restauri, in “Arte sacra”, III, 1933, pp. 211- 216; Id., Splendori di vita artistica. I cancelli in ferro battuto nella Cappella del SS. Sacramento della Cattedrale di Siracusa, in “Vita nostra”, IV,11, 1939, p. 2; Id., Splendori d’arte nel Duomo di Siracusa. I cancelli in ferro battuto nella Cappella del SS. Sacramento, in “L’Avvenire”, (Cronaca siciliana), 14 novembre, 1939, p. 2; Id., Il SS. Sacramento nell’arte. Le argenterie nella Cattedrale di Siracusa, in “Vita nostra”, V, 3, 1940, pp. 2-3; Id., Il SS. Sacramento nell’arte. Le argenterie del Duomo, in “Vita nostra”, V, 4, 1940, pp. 1-2; Id., Il SS. Sacramento nell’arte. Le argenterie del Duomo, in “Vita nostra”, V, 5, 1940; Id., Gli antichi stalli corali del Duomo di Siracusa, in “Arte cristiana”, LIX, 1971, pp. 174-181. Agnello è tra i primi a dare avvio al processo di rivalutazione di questi manufatti artistici e dei loro artefici; si ricordano a tal proposito gli studiosi: Gioacchino Di Marzo, Enrico Mauceri, il cui contributo è stato evidenziato negli atti dei due convegni Gioacchino Di Marzo e la critica d’arte nell’ Ottocento in Italia, Atti del convegno, (Palermo, 15-17 aprile 2003) a cura di S. La Barbera, Officine Tipografiche Aiello e Provenzano, Bagheria (Palermo) 2004; Enrico Mauceri (1869-1966)… e ancora, Maria Accascina il contributo della quale è stato recentemente posto in luce da Maria Concetta Di Natale. Cfr. Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti del convegno Internazionale in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice, 14-17 giugno 2006) a cura di M.C. Di Natale, Salvatore Sciascia Editore, Palermo 2007. 45 G. Agnello, Giovanni Torres e la fondazione della Cappella del SS. Sacramento nella Chiesa Cattedrale di Siracusa, in “Vita nostra”, IV, 6, 1939, pp. 2-3. Il progetto iniziato sotto l’Arcivescovo Torres, verrà ultimato sotto il suo successore l’Arcivescovo Capobianco, intorno alla meta del Seicento. 46 Id., Architetti e scultori ignorati nella Cappella Torres a Siracusa, in “Archivi”, XVIII, 1951, pp. 143-61. 47 Sul pittore rimando a V. Abbate, Quadrerie e collezionisti palermitani del Seicento, in Pittori del Seicento a Palazzo Abatellis, a cura di V. Abbate, Electa, Milano 1990, pp. 58-63; G. Barbera, A. Scilla, Talìa incorona Epicarmo, scheda n. 21, in Pittori del Seicento…, pp. 145-147; V. Abbate, La stagione del grande collezionismo, in Porto di Mare 1570-1670. Pittori e pittura a Palermo tra memoria e recupero, a cura di V. Abbate, Electa, Napoli 1999, pp. 107-131. 48 Per Vanvitelli, cfr. C. De Seta, Luigi Vanvitelli, Electa, Napoli 1998. In particolare per l’attività alla Reggia di Caserta si veda Casa di Re. Un secolo di storia alla Reggia di Caserta. 1752-1860, catalogo della mostra a cura di R. Cioffi, Skira, Milano 2004. 49 G. Agnello, Capolavori ignorati del Vanvitelli e del Valle nella Cattedrale di Siracusa, in “Per l’Arte Sacra”, IV- 5, 1927, pp. 3-15. 50 Id., Un ignoto frescante del Seicento: Agostino Scilla, in “Per l’Arte sacra”, IV, 6, 1927, pp. 3-8; Id., Gli affreschi di Agostino Scilla nella Cappella del SS. Sacramento nella Chiesa Cattedrale di Siracusa, in “Vita nostra”, IV, 7, 1939, pp. 2-3, ripubblicato in Id., Gli affreschi di Agostino Scilla nella Cappella del SS. Sacramento, in “L’Avvenire”, (Cronaca siciliana), 8 luglio 1939, p. 4. 51 Id., Capolavori ignorati...; Id., Ricordi vanvitelliani a Siracusa, in Atti dell’VIII Convegno Nazionale di Storia dell’Architettura (Caserta, 12-15 ottobre 1953), Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, Roma 1956, pp. 99-104; Id., Due cibori di Luigi Vanvitelli, in “Arte cristiana”, LV, 1967, pp. 71-74; Id., Un capolavoro: il ciborio di Luigi Vanvitelli nella Cappella del SS.mo Sacramento nella Cattedrale di Siracusa, (Cronaca siciliana) in “L’Avvenire”, 13 agosto 1939, p. 4; Id., Una nobile opera di scultura: l’«Ultima Cena» di Filippo Valle nella Cappella del Sacramento della Cattedrale di Siracusa, in “L’Avvenire”, (Cronache di Sicilia), 12 novembre 1939, p. 4. 52 Per Ignazio Marabitti (1719-1797), cfr. D. Malignaggi, Ignazio Marabitti, in “Storia dell’Arte”, n. 17, 1974; L. Sarullo, Dizionario degli Artisti Siciliani. Scultura, vol. III, Novecento, Palermo 1993, ad vocem a cura di F. Pipitone, pp. 205-209. 53 Si veda in particolare G. Agnello, L’architettura di Siracusa nel Sei e nel Settecento, in “Palladio”, I-IV, gennaio-dicembre 1968, pp. 111-132. 54 Id., Arte gesuitica, in “ Per l’Arte sacra”, VII, 1930, pp. 78-83. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 134 numero 3 - maggio 2011 63 Agnello concepisce l’opera d’arte tanto nel suo valore estetico, quanto in quello sempre più consapevole di documento del nostro patrimonio storico e culturale. Principio, questo, che ci consente di inquadrarne la sensibilità artistica nel novero delle più moderne posizioni verso le quali progressivamente si andava indirizzando il dibattito di studiosi e critici dell’arte in ambito nazionale ed internazionale, relativamente alla politica di conservazione e tutela di quei beni che ancora a quel tempo, e per molto ancora, la nostra legislazione avrebbe definito come “cose artistiche”. A tal proposito, cfr. W. Cortese, Il patrimonio culturale. Profili normativi, Terza Editrice, Palermo 2007. 64 Per Giovannoni l’intervento di restauro deve necessariamente poggiare su una preliminare ricerca filologica. A sostegno di tale idea, il monumento, inteso sempre come documento, va studiato e tutelato a prescindere dal periodo storico di appartenenza o da una sua presunta maggiore dignità, applicazione questa che troverà poi nella cosiddetta Carta di Atene (1931) i suoi principi fondanti. Cfr. M. Vecco, L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale, Milano 2007, p. 183. 65 Per quanto concerne la rivalutazione del paesaggio, inteso quale patrimonio nazionale, negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, il governo giolittiano si muove verso questa direzione promuovendo una nuova coscienza “geografica”, intesa sia nella sua valenza territoriale che storica, in relazione anche alla formazione di una coscienza nazionale. Un ruolo di rilievo va attribuito a Corrado Ricci, protagonista del dibattito nazionale che precedette la legge 1909, a sostegno di una nuova consapevolezza del valore paesaggistico e della necessità della sua tutela; valore questo successivamente sancito dal provvedimento del 23 giugno 1912 (legge n. 688) nel quale le disposizioni in materia di tutela e salvaguardia vengono estese a ville, parchi e giardini di rilevanza storico-artistica. Si veda a tal proposito: A. Emiliani, Quattro punti di politica istituzionale, in La cura del bello. Musei, storie, paesaggi per Corrado Ricci, catalogo della mostra (Ravenna, 9 marzo 22 giugno 2008), a cura di A. Emiliani, C. Spadoni, Milano 2008, pp. 27-43; R. Balzani, Per le antichità e le belle arti. La legge 364 del 20 giugno 1909 e l’Italia giolittiana, Bologna 2003. Per un maggiore approfondimento si veda anche: D. Levi, I luoghi e l’ombra incerta del tempo. Enrico Mauceri e due suoi mentori, Corrado Ricci e Paolo Orsi, in Enrico Mauceri (1869-1966)..., pp. 77-85. Dal 1950 al 1974 Agnello è Presidente della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siracusa. Cfr. G. Agnello, Il Museo di Siracusa e l’urgenza di un provvedimento riparatore, in “Il 55 Id., Il prospetto della Cattedrale di Siracusa e l’opera dello scultore palermitano Ignazio Marabitti, in “Archivi”, IV, 1937, pp. 63-74 e pp.127-143; Id., L’opera dello scultore Ignazio Marabitti nella Cappella del SS. Sacramento della Cattedrale di Siracusa, in “Vita nostra”, V, I, 1940, p. 2. 56 Id., Opere ignorate dello scultore Ignazio Marabitti, in “Archivi”, XXII, 1955, pp. 228-248. 57 Id., La Biblioteca Alagoniana e il risveglio intellettuale a Siracusa nella seconda metà del ‘700, in “Sicilia”, 11-6, 1927, pp. 5-10, saggio edito nella rivista “Sicilia” nel 1927; Id., La biblioteca Alagoniana nella vita intellettuale del Settecento a Siracusa, in “Archivio storico Siracusano”, II, 1956, pp. 127-135. Il saggio è preceduto dalla notizia che il testo riporta parzialmente il discorso letto l’8 maggio 1954 in occasione della inaugurazione della biblioteca Alagoniana, trasferita dalla vecchia sede nei nuovi locali annessi al palazzo Arcivescovile; Id., Le penose condizioni dell’Archivio di Stato di Siracusa, in “Archivio Storico Siracusano”, X, 1964, pp. 167-169 importante intervento di denuncia in quanto i preziosi volumi in essa conservati rischiavano di andare perduti a causa di infiltrazioni d’acqua; Id., L’Ordine di Malta e la fonte documentaria degli archivi privati, in “Archivio Storico di Malta”, IX, 1937-38, pp. 203-211. 58 Interamente distrutto dal terremoto del 1693 viene ricostruito, tra il 1728 ed il 1753, su disegno dell’architetto trapanese Andrea Palma. Cfr. G. Agnello, Memorie inedite varie sul terremoto siciliano del 1693, in “Archivio Storico per la Sicilia orientale”, VII, 1931, pp. 390-402. 59 A tal proposito, cfr. G. Agnello, Memorie inedite varie sul terremoto siciliano del 1693, ivi, VII, 1931, pp. 390-402. 60 E. Mauceri, La facciata della Cattedrale di Siracusa, in “L’Arte”, X, 5, 1907. 61 Sulla vita e sulle opere del Picherali, cfr. G. Agnello, Pompeo Picherali architetto siracusano del sec. XVIII alla luce di nuovi documenti, in “Archivio Storico della Sicilia”, II-II, 1936-37, pp. 271-47; Id., Su Pompeo Picherali ed il prospetto del Duomo siracusano, in “Brutium”, XVIII, 1939, pp. 12-14; Id., Nuove notizie sull’architetto siracusano Pompeo Picherali, in “Archivio Storico della Sicilia”, VI, 1940, pp. 185-238 e Id., Nuovi documenti sull’architetto Pompeo Picherali, in “Archivio Storico siciliano”, II, 1947, pp. 281-315. 62 I d., Il Duomo di Siracusa e i suoi restauri, in “Per l’Arte sacra”, IV, 1-2, 1927, pp. 2-40. Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 135 numero 3 - maggio 2011 Corriere di Sicilia”, 13 settembre 1925, p. 3; Id., La chiesa della Madonna dei Miracoli in Siracusa e l’opera dei recenti restauri, in “Arte e Restauro”, XIV, 1/2, 1937, pp. 2326; Id., La rinascita di antichi monumenti religiosi. La chiesa della Madonna dei Miracoli a Siracusa, in “L’Illustrazione vaticana”, VIII, 1937, pp. 680-683; Id., Monumenti di Siracusa. Il Castello svevo ritrova l’antico splendore, in “Il Giornale d’Italia”, (Cronaca siciliana), 19 marzo 1947, p. 2; Id., Difficoltà finanziarie per i restauri a Palazzo Abela, in “Il Giornale d’Italia”, (Cronaca siciliana), 18 giugno 1949, p. 2; Id., Risorge il bel chiostro di San Domenico, in “Il Corriere di Sicilia, (Cronaca di Siracusa), 23 giugno 1949, p. 2; Id., Nobili antichi monumenti d’arte destinati agli usi meno adatti, in “La Sicilia”, (Cronaca di Siracusa), 8 novembre 1949, p. 2; Id., Lo stato attuale dei monumenti svevi in Sicilia, in “Itinerario della Cultura e della Scuola siciliana”, 1-3, 1950, pp. 4-6; Id., Castel Maniace sia restituito all’arte, in “Corriere di Sicilia”, (Cronaca di Siracusa), 14 giugno 1950, p. 2; Id., La mutilazione di piazza L. Greco Cassia. Affiora la «responsabilità storica» del sovvertimento edilizio cittadino, in “Giornale dell’Isola”, (Cronaca di Siracusa), 24 agosto 1950, p. 2; Chiuso per noi il «ritorno» polemico sulla costruzione dell’edificio I.N.A.I.L. con una controreplica del prof. Agnel lo, in “Corriere di Sicilia”, (Cronaca di Siracusa), 29 agosto 1950, p. 2; Id., Un importante restauro: la chiesa paleocristiana di S. Pietro a Siracusa, in “Arte cristiana”, XXXVIII,, 1951, pp. 25-30; Id., Le gravi condizioni della Piazza Santa Lucia, in “Corriere di Catania”, (Cronaca di Siracusa), 13 gennaio 1953, p. 4; Id., Minaccia di franare Piazza Santa Lucia a causa degli scavi nella sottostante catacomba, in “La Sicilia”, (Cronaca di Siracusa), 13 gennaio 1953, p. 4; Id., Il colossale a tutti i costi?, in “Presenza cristiana”, V-10, 1957, p. 3 [A proposito dell’erigendo santuario alla Madonna delle lacrime a Siracusa]; Id., Passa alla controffensiva il prof. Agnello stigmatizzando il modernismo di mons. Musumeci, in “La Domenica”, 9 giugno 1957, p. 3; Id., Il concorso per il tempio alla Madonnina delle lacrime, in “Arte cristiana”, XLV, 1957, pp. 79-86; Id., Il tempio delle lacrime, in “Il Mondo”, 9 luglio 1957, p. 13; Id., Squilla il campanello d’allarme per il languente patrimonio artistico, in “La Domenica”, 13 luglio 1958, p. 2; Id., La necessità di valorizzare insigni monumenti sottolineata in una conferenza al Rotary Club, in “La Sicilia”, (Cronaca di Siracusa), 22 luglio 1958, p. 5; Id., Sfumò per un gioco d’intrighi la sistemazione del Castello Maniace, in “La Domenica”, 27 luglio 1958, p. 3; Id., Tutelare i nostri monumenti, in “La Voce di Siracusa”, 25 luglio 1959, p. 1; Id., La questione del costruendo Palazzo di Giustizia e la proposta di «vincolo» della zona di Montedoro, in “La Sicilia”, (Cronaca di Siracusa), 12 novembre 1960, p. 5; Id., Si difende e contrattacca la commissione per le bellezze pa noramiche, in “Siracusa nuova”, 12 novembre 1960, p. 2; Id., La profanazione dei monumenti esige drastici e urgenti rimedi, in “La Voce di Siracusa”, 20 gennaio 1962, p. 1; Avvilito e infranto il fascino della nostra suggestiva città, in “La Voce di Siracusa”, 17 novembre 1962, p. 1; Id., Il problema di Castel Maniace e le responsabilità della so printendenza ai monumenti, in “Settegiorni di Siracusa”, 24‑25 novembre 1962, p. 4; Id., Intervista col Prof. Giuseppe Agnello, Presidente della Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, in “Settegiorni di Siracusa”, 1-2 dicembre 1962, pp. 4 e 11; Id., Per il restauro della basilica di S. Marziano a Siracusa, in “Arte cristiana”, LI, 1963, pp. 25-28; Id., I guasti di Siracusa, in “Le Vie d’Italia”, LXIX, 1963, pp. 920-928; Id., Problemi archeologici ed esigenze industriali, in “Sette giorni di Siracusa”, 12-13 gennaio 1963, pp. 7‑8; Id., Il sacco di Siracusa, in “Il Mondo”, 5 febbraio 1963, p. 15; Id., Le ferite di Siracusa, in “Le Vie d’Italia”, LXX, 1964, pp. 946-956; Id., Vicende poco note della Venere Landolina, in “Siculorum Gymnasium”, XVIII, 1965, pp. 120-143; Id., Siracusa, in “Italia nostra”, 47, 1966, pp. 31-32; Id., I monumenti bizantini della Sicilia e la loro tutela, in Byzantino-Sicula, Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, Palermo, 1966 (“Quaderni, 2”), pp. 7-17; Id., L’ipogeo Politi a Siracusa e la storia della sua scoperta, in “Siculorum Gymnasium”, XIX, 1966, pp. 226-244; Id., Lo scempio edilizio di Siracusa, in “Il Cittadino”, 27 luglio 1967, pp. 1 e 4; Id., Raso al suolo dall’ANAS l’artistico portale settecentesco di viale Scala Greca, in “Siracusa Nuova”, 2 novembre 1968, p. 1; Id., I primi tentativi per il riscatto del Teatro Greco di Siracusa, in “Dioniso”, XLII, 1968, pp. 216-244; Id., Il decreto del vincolo di Ortigia e la storia delle sue vicende, in “Archivio storico si racusano”, XIILXIV, 1967-68, pp. 209-214; Id., Il vincolo di Ortigia: storia delle sue vicende, in “La Domenica”, 25 maggio 1969, pp. 1-2; Id., Siracusa, in “Italia nostra”, 69-70, 1970, p. 43; Id., Dopo anni di abbandono e di distruzioni si intravede un futuro migliore per gli antichi castelli di Sicilia, in “Cronache castellane”, 23, 1970, pp. 715-716; Id., Sculture romaniche tra i ruderi, in “Atti e Memorie dell’Istituto per lo Studio e la Valorizzazione di Noto antica”, 1970, pp. 107-112; Id., Si intravede un futuro migliore per gli antichi castelli di Sicilia, in “La Sicilia”, 3 novembre 1970, p. 3; Id., Disprezzo per la tutela della città e delle sue antiche bellezze naturali, in “Il Gazzettino di Siracusa”, 20 marzo 1971, pp. 1 e 3. 66 P. Orsi, Sicilia bizantina, a cura di G. Agnello con prefazione di U. ZanottiBianco, Vol. I, Arti Grafiche Aldo Chicca Editore, Tivoli 1942 (“Collezione teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 136 numero 3 - maggio 2011 in Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani (Palermo 21-25 aprile 1954), 1, Scuola linotypografica Boccone del Povero, Palermo 1955, pp. 295-301; Id., L’architettura religiosa militare e civile dell’età normanna, in “Archivio storico Pugliese”, XII, 1959, pp. 159-196 e Id., L’architettura monastica nel Trecento, in “Ortigia”, 1-3, 1927, pp. 9-10. 75 Id., L’architettura sveva in Sicilia, (con disegni di R. Carta e G. Di Grazia), Collezione Meridionale Editrice, Roma 1935, (“Collezione Meridionale diretta da U. Zanotti-Bianco, s. III: Il Mezzogiorno Artistico, 10”). 76 Id., L’architettura sveva in Sicilia, Roma 1935, riedizione a cura di W. Krönig, Siracusa 1986. 77 Id., La destinazione militare dei monumenti d’arte, in “Realtà nuova”, XV, 1950, pp. 447-448. È il caso del Castello Maniace di Siracusa, la cui destinazione militare rese necessaria una serie di trasformazioni che alterarono profondamente la facies dell’edificio. È merito di Giuseppe Agnello l’aver restituito graficamente la straordinaria pianta del monumento federiciano. 78 A tal proposito, cfr. E. Bertaux, Castel del Monte et les architectes français de l’empereur Frédéric II, Paris 1897 (Extrait des Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres); Id., L’art dans l’Italie méridionale de la fin de l’empire romain à la conquête de Charles d’Anjou, 3 voll., A. Fontemoing, Paris 1904. Per Bertaux e gli aggiornamenti sulla sua opera, cfr. V. Papa Malatesta, Émile Bertaux tra storia dell’arte e meridionalismo. La genesi de L’art dans l’Italie méridionale, École française de Rome, Roma 2007; L’art dans l’Italie Méridionale, Aggiornamento dell’Opera di Emile Bertaux sotto la Direzione di Adriano Prandi, tomi IV-VI, École Française de Rome & Università di Bari, Rome1978; W. Krönig, Castel del Monte-Frédéric II et l’architecture française…, pp. 929-951; C.A. Willemsen, I castelli di Federico II nell’Italia meridionale, Società Editrice Napoletana, Napoli 1979. 79 Si vedano S. Bottari, Ancora sulle origini dei castelli svevi della Sicilia, in Atti del Convegno Internazionale di Studi Federiciani (Palermo, Catania, Messina, 1018 dicembre 1950), Tip. A. Renna, Palermo 1952, pp. 501-506; Id., La genesi dell’architettura siciliana del periodo normanno, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale, s. 2, VIII, 1932, 28, 1, pp. 320-337; Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Architettura e archeologia, a cura di C.A. Di Stefano, A. Cadei, Ediprint, Siracusa-Palermo 1995; G. Di Stefano, L’architettura gotico-sveva in Sicilia, F. Ciuni, Palermo 1935; Id., L’architettura religiosa in Sicilia nel secolo XIII, in “Archivio Storico Meridionale diretta da U. Zanotti-Bianco-s. III: Il Mezzogiorno Artistico, 15”). 67 G. A gnello, I monumenti bizantini della Sicilia, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1951. 68 Id., L’architettura bizantina in Sicilia, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1952 (“Collezione Meridionale diretta da U. Zanotti-Bianco, s. III: Il Mezzogiorno Artistico, 16”). 69 A. Colasanti, L’arte bizantina in Italia, Bestetti e Tumminelli, Milano 1912. 70 G. Agnello, Palermo bizantina, Verlag Adolf M. Hakkert, Amsterdam 1969. 71 Si vedano a tal proposito: M. Andaloro, L’orizzonte tardoantico e le nuove immagini, Jaca Book, Milano, 2006; Id., La croce dipinta di Siracusa e l’orizzonte bizantino-mediterraneo, in Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Arti figurative e arti suntuarie, a cura di C.A. Di Stefano, A. Cadei, M. Andaloro, I-II, Siracusa-Palermo 1995, pp. 474-480; E. Kitzinger, Alle origini dell’arte bizantina. Correnti stilistiche nel mondo mediterraneo dal III al VII secolo, ed. a cura di M. Andaloro, P. Cesaretti, Jaca Book, Milano 2005; A. Iacobini, Le porte del paradiso: arte e tecnologia bizantina tra Italia e Mediterraneo, Campisano, Roma 2009; La cristianizzazione in Italia tra Tardoantico ed Altomedioevo, Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento 20-25 novembre 2004), a cura di R.M. Bonacasa Carra, E. Vitale, Carlo Saladino Editore, Palermo 2007. 72 G. agnello, Architettura bizantino-normanna. La basilica dei Santi Giovanni e Marziano in Siracusa, in “Bollettino d’arte del Ministero della P.I.”, IX, 1929-1930, pp. 3-24; Id., S. Lorenzo Vecchio presso Pachino, ivi, XXXIII, 1948, pp. 63-68; Id., La basilichetta trichora del Salvatore a Catania, in “Rivista di Archeologia cristiana”, XXIII‑XXIV, 1947-1948, pp. 147-168; Id., La chiesa della Favorita presso Noto, in “Bollettino d’arte del Ministero della P.I.”, XXXIV, 1949, pp. 307-310; Id., Un importante restauro: La chiesa paleocristiana di S. Pietro a Siracusa, in “Arte cristiana”, XXXVIII, 1951, pp. 25 ‑30. 73 Proprio a questa civiltà va ricondotta – secondo lo studioso – la prima arte di matrice propriamente cristiana, punto di partenza indispensabile all’interpretazione dei successivi sviluppi artistici, da quello normanno a quello svevo. 74 Id., Le sculture normanne di Santa Lucia di Mèndola nel Museo di Siracusa, in “Bollettino d’arte del Ministero della P.I.”, VII, 1927-1928, pp. 586-595; Id., Architettura bizantino-normanna. La basilica dei Santi Giovanni e Marziano in Siracusa, ivi, IX, 1929-1930, pp. 3-24; Id., Aspetti della scultura normanna in Sicilia, Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 137 numero 3 - maggio 2011 Siciliano”, 1938, pp. 51-60; Id., Monumenti della Sicilia Normanna, 2ª edizione a cura di W. Kroning, Flaccovio, Palermo 1978; H.W. Kruft, Storia delle teorie architettoniche da Vitruvio al Settecento, Laterza, Roma Bari 2004. 80 G. Agnello, Problemi ed aspetti dell’architettura sveva, in “Palladio. Rivista di storia dell’architettura e restauro”, n. s., X, 1-2, 1960, pp. 37-47. 81 S. Bottari, Intorno alle origini dell’architettura sveva nell’Italia meridionale e in Sicilia, in “Palladio”, n.s., 1, 1951, pp. 21-53. 82 G. Agnello, Il castello di Catania nel quadro dell’architettura sveva, in “Bollettino storico catanese”, V, 3, 1940; Id., Lo stato attuale dei monumenti svevi in Sicilia, in “Itine rario della Cultura e della Scuola siciliana”, 1-3, 1950, pp. 4-6; Id., Monumenti svevi ignorati, in “Siculorum Gymnasium”, III, 1950, pp. 106-121; Id., L’Arte ai tempi di Federico II. I monumenti svevi del Siracusano, in “L’Illustrazione siciliana”, IV - 7 / 10, 1951, pp. 23-30; Riflessi svevi nel castello di Scaletta, in “Siculorum Gymnasium”, V, 1952, pp. 199-209; Id., S. Maria della Valle o la «Badiazza» in Messina, in “Palladio”, 111, 1953, pp. 49-66; Id., Il castello svevo di Prato, in “Rivista dell’Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte”, III, 1954, pp. 147-227; Id., Il Castello svevo di Milazzo, in “Rivista dell’Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte”, IV, 1955, pp. 20-41. 83 Id., L’architettura civile e religiosa in Sicilia nell’età sveva, Collezione Meridionale Editrice, Roma 1961 (“Collezione Meridionale diretta da U. Zanotti-Bianco-s. III: Il Mezzogiorno Artistico, 19”). 84 Per gli aggiornamenti sull’arte federiciana in Sicilia si veda: M. D’Onofrio, Il castello di Federico II a Gaeta, in Arte d’Occidente. Temi e metodi, Studi in onore di A. M. Romanini, vol. I, Edizioni Sintesi Informazione, Roma 1999, pp.151-158; I Normanni popolo d’Europa MXXX-MCC, catalogo della mostra (Roma, 28 gennaio - 30 aprile 1994, Venezia, 20 maggio - 18 settembre 1994) a cura di M. D’Onofrio, Marsilio, Venezia 1994; Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Arti figurative e arti suntuarie, a cura di M. Andaloro, catalogo della mostra (Palermo 1994-1995), Ediprint, Palermo 1995; F. Basile, L’architettura della Sicilia Normanna, V. Cavallotto, Catania - Caltanissetta - Roma 1975; M. Righetti Tosti-Croce, La scultura del castello di Lagopesole, in Federico II e l’arte del Duecento italiano. Atti della settimana di studi, I, a cura di A. M. Romanini, Congedo, Galatina 1980, pp. 237-252. 85 Molti degli studi portati avanti da Agnello sul tema della Sicilia medievale sono stati ripresi, in tempi recenti, da non pochi studiosi. A tal proposito si ricordano, ad esempio, gli approfondimenti sull’architettura federiciana condotti da Henri Bresc e Ferdinando Maurici, I castelli demaniali della Sicilia (secoli XIIIXV), in Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), a cura di Francesco Panero e Giuliano Pinto, Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali, Cherasco 2009, pp. 271-317 o da Antonio Cadei, La forma del castello: l’Imperatore Federico II e la Terrasanta, Zip, Pescara 2006; ancora si ricordano gli studi sia di archeologia, che di architettura medievale condotti da Camillo Filangeri, Monasteri basiliani di Sicilia: mostra dei codici e dei monumenti basiliani siciliani, Atti del convegno (Messina 3-6 dicembre 1979), STASS, Palermo 1980. 86 Cfr. G. Bellafiore, Architettura in Sicilia nell’età islamica e normanna (827-1194), A. Lombardi, Palermo 1990; Id., Architettura dell’età sveva in Sicilia 1194-1266, A. Lombardi, Palermo 1993; Id., Dall’Islam alla Maniera. Profilo dell’architettura siciliana dal IX al XVI secolo, Flaccovio, Palermo 1975. 87 G. Agnello, L’Annunciata di Antonello da Messina, in “L’Osservatore Romano”, 9 ottobre 1926, p. 2. Il medesimo articolo, con qualche variante e col titolo La chiesa dell’Annunziata e la pala di Antonello da Messina, viene pubblicato l’anno successivo anche su “Aχραιων”, numero unico diretto da G. Migliore Leone, Società Tipografica Editrice, Siracusa 1927, pp. 9-12 e in “Per l’Arte sacra”, IV‑4, 1927, pp. 5-11. Si veda a tal proposito S. La Barbera, Enrico Mauceri connoisseur, museologo e storico dell’arte, in Enrico Mauceri..., pp. 31-57. 88 Sull’artista, cfr. E. Brunelli, Pietro de Saliba, Tipografia dell’Unione cooperativa editrice, Roma 1906. 89 Sull’artista, cfr. M.C. Di Natale, Tommaso de Vigilia I, (con introduzione di M. Calvesi), in “Quaderni dell’A.F.R.A.S.”, n. 4, 1974; Ead., Tommaso de Vigilia II, (con introduzione di M. Calvesi), in “Quaderni dell’A.F.R.A.S.”, n. 5, 1977. 90 Sull’artista, cfr. E. Mauceri, Riccardo Quartararo a Napoli, in “L’Arte”, VI, fasc. I-IV, 1903, pp. 128-129; S. Bottari, Da Tuccio di Gioffredo a Riccardo Quartararo, in “Arte Antica e Moderna” (estratto), 1959, pp. 170-171; F. Meli, Documenti su Riccardo Quartararo, in “Arte Antica e Moderna”, 1965, pp. 375-383; T. Pugliatti, Pittura del Cinquecento in Sicilia. La Sicilia occidentale 1484-1557, Electa, Napoli 2008, in part. pp. 119 e ss. 91 G. Agnello, La chiesa dell’Annunziata…, in “Per l’arte sacra”, pp. 8-9. 92 Si vedano a tal proposito i diversi contributi forniti da questi studiosi: G. Di Marzo, Di Antonello da Messina e dei suoi congiunti. Studi e documenti, Palermo teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 138 numero 3 - maggio 2011 cura di S. La Barbera, Flaccovio, Palermo 2003; S. La Barbera, Note sulla letteratura artistica siciliana dei secoli XVII-XX, in L. Di Giovanni, Le opere d’arte nelle chiese di Palermo, trascrizione e commento a cura di S. La Barbera, Flaccovio, Palermo 2000, pp. 7-40; G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, UTET, Torino 1995; M. Accascina, Indagini sul primo Rinascimento a Messina e provincia, in Scritti in onore di Salvatore Caronia, La Cartografica, Palermo 1966, pp. 1-16. 98 Si vedano a tal proposito G. Di Marzo, La pittura in Palermo nel Rinascimento. Storia e Documenti, Reber, Palermo 1899; Id., Delle belle Arti in Sicilia, S. Di Marzo, F. Lao, Palermo, 1858-1866. 99 Sulla pittura figurativa del siracusano si veda Da Antonello a Paladino. Pittori messinesi nel siracusano dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra (Siracusa 14 dicembre 1996 - 28 febbraio 1997) a cura di G. Barbera, Ediprint, Siracusa 1996. 100 Su Maria Accascina, cfr. Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento…. 101 Vengono citati, a tal proposito, un polittico con Madonna in trono col Bambino tra i SS. Lucia e Marziano della chiesa di S. Martino e due opere conservate presso il Museo Bellomo: una Vergine in trono col Bambino e il Polittico di S. Maria. La critica allora riconduceva le opere o al pittore locale Stefano da Zevio o, in funzione dei legami intravisti con il Serra e con il Borassà, a un pittore locale di formazione spagnola legato alla scuola o addirittura ad un autore spiritualmente vicino a Gentile da Fabriano. 102 Si veda a tal proposito G. Agnello, Pittori siciliani dei secoli…., p. 47. 103 Cfr. S.L. Agnello, Attività gaginiane e precisazioni documentarie, in “Bollettino storico catanese”, 1946. 104 Nella bibliografia Agnello cita tra le sue fonti diversi lavori di Enrico Mauceri: La pittura Siracusana nel sec. XV, in “Rassegna d’Arte, X, 1910, pp. 23-27 e Su alcuni pittori vissuti a Siracusa nel Rinascimento, in “L’Arte”, VII, 1904, pp. 161167. 105 S. Caronia Roberti, Il Barocco in Palermo, a cura del Banco di Sicilia, Palermo 1935; Id., L’architettura del Barocco in Sicilia, Tip. De Magistris e V. Bellotti, Palermo 1955. 106 Giuseppe Agnello si serve in particolare di F. Meli, Degli architetti del Senato di Palermo nei secoli XVII e XVIII, Scuola tip. Boccone del povero, Palermo 1938. 107 Si vedano per esempio A. Giuliana Alajmo, Andrea Palma e la sua sconosciuta opera in Sant’Antonio Abate, Antonino Perna, Palermo 1949; Id., Gli architetti del 1902; Id., Di Antonello d’Antonio da Messina. Primi documenti messinesi, in “Archivio Storico Messinese”, II, 1903; Id., Nuovi studi ed appunti su Antonello da Messina con 25 documenti, Libreria Editrice Ant. Trimarchi, Messina 1905; J. A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, The Early Flemish Painters. Notices of their lives and works, J. Murray, London 1857 (ed. it. Firenze); S. Bottari, Antonello da Messina, Principato, Messina - Milano 1939; G. La Corte Cailler, Antonello da Messina. Studi e ricerche di G. La Corte Cailler con documenti inediti, in “Archivio Storico Messinese”, IV, 1903, pp. 332-441. 93 G. Agnello, L’architettura aragonese‑catalana in Siracusa, Arti Grafiche Aldo Chicca Editore, Tivoli 1942 (“Collezione Meridionale diretta da C. ZanottiBianco-s. III: Il Mezzogiorno Artistico, 14”). 94 Si veda a tal proposito E. De Benedictis, Della Camera delle Regine siciliane. Memoria storica, Tip. Di A. Norcia, Siracusa 1890. 95 Anche in questo caso si tratta di studi pioneristici e larga parte del materiale pubblicato da Agnello circa i due palazzi è praticamente inedito. A tal proposito si vedano anche S. Russo, Siracusa medievale e moderna, A. Lombardi, Palermo 1992; A. Conejo da Pena, La arquitectura civil en la Sicilia del siglo XV: influencias del levante de la Corona de Aragón, in “Quaderni del Mediterraneo”, 10, 2003, pp. 119-166; Siracusa città e fortificazioni, catalogo della mostra (Siracusa 19 giugno - 19 luglio 1987) a cura di L. Dufour, Sellerio, Palermo 1987; Id., Siracusa tra due secoli. Le metamorfosi di uno spazio 1600-1695, A. Lombardi, Palermo 1998; Verso un repertorio dell’architettura catalana, Province di Caltanissetta,Catania, Enna, Messina, Palermo, a cura di L. Anderozzi, Aracne, Roma 1996; Verso un repertorio dell’architettura catalana, Province di Agrigento, Ragusa, Siracusa,Trapani, a cura di G. Pagnano, Siracusa 2005; G. Pagano, I paramenti lapidei di età aragonese a Siracusa, in Verso un repertorio..., pp. 41-56. 96 Id., Influencias y recuerdos españoles en la región de Siracusa, in La Huella de España en Sicilia, “Revista Geográfica Española”, Madrid (traduzione italiana Influssi e ricordi spagnuoli nel Siracusano, in Spagna in Sicilia) pp. 88-104; Id., Influencias y recuerdos españoles en Ragusa y su región (Influssi e ricordi spagnuoli nel Ragusano), pp. 125-134; Id., L’architettura aragonese‑catalana nell’Italia insulare e continentale, in “Rivista storica del Mezzogiorno”, 1-1/2, 1966, pp. 243 -259. 97 Si veda per una più dettagliata ed approfondita trattazione degli indirizzi della critica d’arte rispetto alla questione siciliana La critica d’arte in Sicilia nell’Ottocento, a Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 139 numero 3 - maggio 2011 vermexiano di S. Lucia a Siracusa, in “Archivio storico della Sicilia orientale”, VII, 1954, pp. 153-177. 119 Id., Architettura gesuitica. La Chiesa del Collegio di Siracusa, in “Per l’Arte sacra”, V-1, 1928, pp. 7-16. 120 Per una trattazione dell’opera dei Vermexio a Siracusa, si veda G. Agnello, I Vermexio…, pp. 25. 121 Id., Il Palazzo dei Vescovi a Siracusa e l’opera di Andrea Vermexio, in “Palladio”, II, 1952, pp. 65-70; Id., Giovanni Torres Osorio vescovo ed umanista, in “Archivio storico della Sicilia orientale”, IX, 1933, pp. 223-276; Id., Rinascimento e barocco nella Casa dei Vescovi a Siracusa, in “L’Illustrazione vaticana”, V, 1934, pp. 21-22. 122 Per lo scultore, cfr. L. Sarullo, Dizionario degli Artisti Siciliani. Scultura, vol. III, Novecento, Palermo 1993, ad vocem a cura di V. Scavone, C. Vella, p. 325. 123 G. Agnello, Gregorio Tedeschi scultore fiorentino del sec. XVII e la sua attività in Sicilia, in “Archivi”, VII,1940, pp. 180-197. 124 Id., Note e documenti inediti su artisti ignorati del secolo XVIII in Sicilia. Luciano Alì - Ermenegildo Martorana - Gregorio Lombardo - Rosario Minniti - Giacomo Ferlito, in “Archivi”, III, 1936, pp. 286-299; Id., Pittori siciliani dei sec. XVI‑XVII‑XVIII: Mario Minniti - Antonino Maddiona - Giuseppe Piccione - Francesco Callia - Mario Cordua - Antonino Calvo - Antonino Bonincontro - Mauro e Giuseppe Troia, ivi, VI, 1939, pp. 42-54. 125 Id., Un caravaggesco: Mario Minniti, in “Archivi”, VIII, 1941, pp. 60-80. Per gli aggiornamenti sul siracusano Mario Minniti (1577-1640) rimando a Mario Minniti. L’eredità di Caravaggio a Siracusa, catalogo della mostra Siracusa 30 maggio - 19 settembre 2004) a cura di G. Barbera, V. Greco, Electa, Napoli 2004. 126 G. Agnello, Mattia Preti e alcune sue tele sconosciute, in “Per l’Arte sacra”, IX, 1932, pp. 53-57. Su Mattia Preti (Taverna 1613 - La Valletta 1699), cfr. Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta, catalogo della mostra (Napoli, 1999), Electa, Napoli 1999. 127 Id., Il caravaggismo in Sicilia ed Alonso Rodriguez pittore messinese, in “Bollettino d’Arte”, s. II, IV, 1924-1925, pp. 559-571. 128 Id., Un caravaggesco…, p. 71. 129 Id., Una tela ignorata del Caravaggio (?) a Siracusa, in “Per l’Arte Sacra”, V, 1, 1928, pp. 7-16. 130 Su Raffaello o Raffaele Politi (Siracusa 1783 - Agrigento 1870), cfr. G. Senato di Palermo. Mariano Smiriglio. I. La vita. II. Le opere: Porta Felice, Tip. A. Perna, Palermo 1950; Id., L’architetto della Catania settecentesca. G.B. Vaccarini e le sconosciute vicende della sua vita, in “L’Illustrazione siciliana. Periodico d’arte di pensiero e critica”, a. III, n. 1- 2, gennaio-febbraio, 1950, pp. 17-18. 108 Cfr. E. Mauceri, Il Caravaggismo in Sicilia e Alonso Rodriguez, pittore messinese, estratto da “Bollettino d’arte”, XIX, giugno, IV, s. II, 12, pp. 559-571. 109 In particolare M. Accascina, Profilo dell’architettura a Messina dal 1600 al 1800, a cura del Comune di Messina, Ateneo, Messina 1964. 110 Per l’attività di Corrado Ricci si veda La cura del bello…. 111 G. Agnello, L’architettura barocca in Sicilia, in Barocco europeo, barocco italiano, barocco salentino, Atti del Congresso Internazionale sul Barocco (Lecce e T. d’O., 2124 settembre 1969), a cura di P.F. Palumbo, Centro di Studi Salentini, (“Congressi Salentini, I”), Lecce 1970, pp. 157-182. 112 E. Calandra, Breve storia dell’architettura in Sicilia, Laterza, Bari 1938. 113 G. Agnello, Scultori e marmorari catanesi del Settecento a Siracusa, in “Catania”, IV,1932, pp. 163-172; Id., Aspetti artigiani dell’architettura barocca in Siracusa, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, Università di Roma, VI-VIIVIII, fasc. 31-48, 1961, pp. 281- 286. 114 Id., I Vermexio, architetti ispano-siculi del secolo XVII, “La Nuova Italia” Editrice, Firenze 1959, (“Collezione Meridionale diretta da U. Zanotti-Bianco-S. III: Il Mezzogiorno Artistico, 17”). 115 Il volume monografico è stato preceduto dagli articoli: Id., Architettura vermexiana. Il palazzo Corvaia a Siracusa, in “Archivio storico siracusano”, I, 1955, pp. 23-30; Id., Monumenti vermexiani sconosciuti, in Atti del V Convegno Nazionale di Storia dell’Architettura, (Perugia 23 settembre 1948) Noccioli, Firenze 1957, pp. 395-405. 116 Per l’aggiornamento bibliografico rimando a L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. I. Architettura, a cura di M.C. Ruggieri Tricoli, ad voces a cura di M. T. Montesanto, Novecento, Palermo 1993, pp. 434-435. 117 G. Agnello, L’opera di Giovanni Vermexio nel palazzo del Senato a Siracusa, in “Archivi”, XI-XVI, 1949, pp. 46-81. 118 Id., La Chiesa del Sepolcro di S. Lucia e l’opera di Giovanni Vermexio, in Santa Lucia. Terzo Centenario del Patrocinio di Santa Lucia, numero unico a cura della On. Deputazione della Cappella di S. Lucia, Siracusa, 5 maggio 1946; Id., Il tempio teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 140 numero 3 - maggio 2011 138 Per Stefano Bottari (1907-1967), cfr. G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento…, p. 252. 139 Mi riferisco alle “Giornate di studio in onore di Giuseppe Agnello nel decennale della scomparsa” tenutesi a Canicattini Bagni e a Siracusa il 28-29 novembre 1986. Al convegno intervennero il Prof. Vincenzo la Rosa, il Sen. Giuseppe Alessi dell’Istituito dell’Enciclopedia Italiana, Salvatore Pricoco e Anna Maria Marchese docenti dell’Università di Catania, Salvatore Boscarino docente dell’Università di Palermo, Salvatore Russo, allora Presidente della Società Siracusana di Storia Patria, Corrado V. Giuliano della Lega per l’ambiente di Palermo e Gioacchino Gargallo di Castel Lentini, docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 140 In vero molti articoli di questo primo periodo si riferiscono all’attività portata avanti dall’Orsi nel campo dell’Archeologia Cristiana: Paolo Orsi e gli studi cristiano-bizantino della Sicilia e della Calabria, La Sicilia sotterranea cristiana e la Sicilia bizantina nel volume dedicato allo studioso dall’“Archivio Storico per la Calabria e la Lucania”. Si vedano G. Agnello, Paolo Orsi e gli studi cristiano‑bizantini della Sicilia e della Calabria, in “L’Illustrazione vaticana”, VII, 1936, pp. 81-84; Id., La Sicilia sotterranea cristiana e la Sicilia bizantina, in Paolo Orsi 1859-935, volume a cura dell’Archivio storico della Calabria e Lucania, Roma 1935, anche riportato in “Archivio storico per la Calabria e la Lucania”, V – 3/4, 1935, pp. 253-274. 141 Si veda a tal proposito G. Agnello, Siracusa Medievale…, pp. 14-19. 142 Id., Architettura bizantino-normanna…, in “Bollettino d’Arte”, IX, 192930, pp. 72-79; Id., Esplorazioni nella cripta di S. Marziano a Siracusa, in “Arte sacra”, IV, 1934, pp. 67-68. 143 S. Russo, Ricerca storica e memorie patrie, in Giuseppe Agnello. Atti…, p. 139: «…quando ci si chiedeva se Giuseppe Agnello fosse un politico, un archeologo o uno storico dell’arte, o se fosse uno storico dell’arte con delle simpatie per l’archeologia, o un archeologo con delle aperture per la storia dell’arte, sono tutti interrogativi che mi lasciano molto perplesso. In realtà la sua natura, il suo sentimento fondamentale è questo amore inesausto per il passato e per la ricerca del passato». 144 La Società viene istituita il 3 dicembre 1953 nella sala della Giunta Municipale di Siracusa. Tra i fondatori: il Sindaco di Siracusa, Marcello Alagona, Mario Tommaso Gargallo, Santi Luigi Agnello, Paolo Albani, Giorgio Badame, Russo, Cenni su la vita e le opere di Raffaello Politi, Tip. Montes, Girgenti 1870; L. Sarullo, Dizionario degli Artisti Siciliani. Pittura, vol. II, Novecento, Palermo 1993, ad vocem a cura di E. Sessa, pp. 416-418. Cfr. pure C. Bajamonte, Raffaello Politi “bizzarro scrittore, insigne archeologo, artista intelligente”, in “Kalós – arte in Sicilia”, a. 19, n. 2, Aprile-Giugno 2007, pp. 28-33 e A. Palermo, Raffaello Politi uomo e scrittore (Siracusa, 1783-Girgenti, 1870), s.e., Marino 2007. 131 Per la vicenda del quadro si veda S.L. Agnello, Due secoli ad un catalogo, in Centri e periferie del Barocco, vol. III, Barocco mediterraneo. Sicilia, Lecce, Sardegna, Spagna, a cura di M.L. Madonna, L. Trigilia, Officina, Roma 1992, pp. 351. Il dipinto si trova oggi nella chiesa di S. Giuseppe di Siracusa. Cfr. anche Sulle orme di Caravaggio tra Roma e la Sicilia, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, G. Barbera, C. Strinati, R. Vodret, Marsilio, Venezia 2001, scheda 13 a cura di G. Barbera, p. 134. 132 Nel ruolo di Provveditore agli studi, affidatogli dall’A.M.G.O.T. (Allied Military Government of Occupied Territories-Amministrazione militare alleata dei territori occupati), lo studioso ripristina e riorganizza le scuole del siracusano, che grazie al suo intervento già nell’autunno dello stesso anno riprendono con regolarità a funzionare in tutta la provincia. 133 Si vedano a tal proposito i diversi articoli apparsi nel 1946: G. Agnello, Intervento alla Consulta nazionale, 19 febbraio e 4 marzo 1946, in “Atti Parlamentari”, Consulta nazionale, Assemblea della Camera dei Deputati, Roma 1946; Id., A proposito di una polemica, in “La Gazzetta”, 3 marzo 1946 e Id., Candidati alla Costituente e moralità politica, in “L’Idea Popolare”, 30 maggio 1946. 134 Id., Giuseppe Agnello candidato alla D.C., in “L’Idea Popolare”, 30 maggio 1946, p. 1. 135 Id., Buona sera colonnello Stevens, Mascali editore, Siracusa 1946. 136 Id., Chi farà il processo al fascismo?, Mascali editore, Siracusa 1947. 137 In quegli anni l’Ateneo etneo si preparava ad inaugurare un nuovo filone di studi e ricerche che – citando le parole di Salvatore Pricoco, docente presso l’Ateneo catanese e allievo dello stesso Agnello – si possono racchiudere nel termine “cristianistica”. Sino ad allora gli insegnamenti avevano concentrato e indirizzato le migliori risorse verso l’indirizzo classico, di antica e robusta tradizione, tralasciando le indagini sul Medioevo alla sola filologia romanza. Cfr.: S. Pricoco, Il Docente, in Giuseppe Agnello. Atti…, p. 62. Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 141 numero 3 - maggio 2011 a sentire la necessità di avviare nuove ricerche in Sicilia anche per il periodo della cristianizzazione. Lo stesso Giovanni Battista De Rossi, contemporaneo dello Schultze e archeologo cristiano “romano” per eccellenza, ideatore e promotore della Pontificia Commissione di Archeologia Cristiana, pur non avendo conoscenza diretta dei monumenti siculi ne caldeggiava vivamente gli studi. Il voto fu accolto, agli inizi del Novecento, da Joseph Führer e da Paolo Orsi, al quale si deve il quadro più vasto ed organico della Sicilia Paleocristiana e Bizantina fino agli studi di Giuseppe Agnello. Importanti lavori sul patrimonio cimiteriale cristiano ed ebraico si devono anche ad altri due insigni archeologi: Antonino Salinas (per la Sicilia Occidentale) e Francesco Saverio Cavallari (per la Sicilia Orientale), quest’ultimo, primo Sovraintendente alle Antichità di Sicilia il cui operato fu proseguito prima proprio da Orsi e poi, a partire dal 1941, da Luigi Bernabò-Brea. Sui recenti studi inerenti la Sicilia paleocristiana e le prime forme d’arte della civiltà cristiana si veda Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 2004), a cura di R.M. Carra Bonacasa, E. Vitale, Carlo Saladino Editore, Palermo 2007; La Sicilia centro-meridionale tra il II e il VI sec. d. C., catalogo della mostra (Caltanissetta - Gela, aprile-dicembre 1997) a cura di R.M. Bonacasa Carra, R. Panvini, Sciascia, Caltanissetta 2002; R.M. Carra, Insediamenti e spazio cristiano in Sicilia, in Materiali per una topografia urbana. Status quaestionis e nuove acquisizioni, Atti del V convegno sull’’archeologia tardoromana e altomedievale in Sardegna, Oristano, S’Alvure, 1995, p. 241-270. 150 Istituita da Pio IX il 6 gennaio 1852 per iniziativa del gesuita Giuseppe Marchi (1795-1860), già conservatore dei sacri cimiteri, e del “padre fondatore” degli studi di Archeologia Cristiana, Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), con lo scopo di “custodire i sacri cimiteri antichi, per curarne preventivamente la conservazione, le ulteriori esplorazioni, le investigazioni, lo studio, per tutelare inoltre le più vetuste memorie dei primi secoli cristiani”. Con i Patti Lateranensi (art. 33 del Concordato) la sua autorità e sfera d’azione e di studio fu estesa a tutte le catacombe esistenti sul territorio italiano. Sull’ argomento si veda: R. Jacqard, L’Institut pontifical d’Archéologie Chrétienne. Journal de cinquante années (1925-75), Roma 1975. Sull’Ispettorato di Siracusa si veda A. Ferrua, La Sicilia nella mia vita, in L’Accademia selinuntina di Scienze, Lettere, Arti di Mazara del Vallo ed il Premio Sélinon 1987, Mazara del Vallo 1987. 151 Tra i più importanti ricordo: G. Agnello, Sicilia cristiana. Le catacombe Luigi Bernabò Brea, Sebastiano Capodieci, Salvatore Grillo, Vittorio Guardo, Michele Minniti, Rocco Moscato, Corrado Piccione e Raffaele Strano. A reggere la presidenza nei primi anni è Mario Tommaso Gargallo vero ispiratore del sodalizio, alla sua morte lo succederà nel 1958 Giuseppe Agnello. L’impegno fondamentale è costituito dalla pubblicazione dell’Archivio Storico Siracusano che per serietà scientifica e il rigore documentario dei contributi di qualificati collaboratori ha conseguito e mantiene un posto di alta considerazione nel mondo culturale italiano e internazionale. 145 G. Agnello, Le arti figurative nella Sicilia bizantina, Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, Palermo 1962 (“Testi e Monumenti pubblicati da Bruno Lavagnini. Monumenti. 1”). I diversi capitoli sono il frutto di una ristampa, talora con aggiunte e modificazioni, di studi apparsi negli anni 1928-1959. 146 Id., Capitoli e ordinamenti degli orafi e degli argentieri dal XV al XVIII secolo, in “Archivi”, XXIII, 1956, pp. 99-115; Ibidem, Orafi e argentieri dei secoli XVI, XVII, XVIII, pp. 265-294; Ibidem, Orafi e argentieri dei secoli XVI, XVII, XVII, pp. 343361; Id., Un maestro del ferro battuto. Domenico Ruggeri, in “Per l’Arte sacra”, VI, 1929, pp. 72-78; Id., Argentieri e argenterie del Settecento (I), ivi, pp. 12-25; Id., Argentieri e argenterie del Settecento (II), ivi, VI, 1929, pp. 151-165; Id., III Mostra d’arte sacra. Rassegna regionale retrospettiva del paramento e dell’arredo (Caltanissetta, 14-28 aprile 1954), Ente Provinciale per il Turismo, Caltanissetta 1954, pp. 11‑14. 147 Id., Arte bizantina. Il cofanetto eburneo dell’ex Cattedrale di Lentini, in “Per l’Arte sacra”, X, 1933, pp. 44-52; Id., Un nuovo importante contributo alla storia e alla lettura degli antichi codici della melurgia bizantina, in “Rivista musicale italiana”, XLIII, 1939, pp. 109-114; Id., Cimeli bizantini. La stauroteca di Lentini, in “Siculorum Gymnasium”, IV, 1951, pp. 85-89; Id., Sculture bizantine della Sicilia, in “Siculorum Gymnasium”, V, 1952, pp. 76-91 (seguono altre tre puntate, una nel vol. VI del 1953 alle pp. 222-35 una nel vol. VII del 1954 alle pp. 104-117 e, infine, l’ultima nel vol. X del 1957 alle pp. 101-122); Id., Croci bizantine di Sicilia, in “Siculorum Gymnasium”, VI, 1953, pp. 88-98; Id., Il ritrovamento subacqueo di una basilica bizantina prefabbricata, in “Byzantion”, XXXIII, 1963, pp. 1-9. 148 Per tali aspetti, cfr. F. Maurici, Castelli medievali in Sicilia. Dai bizantini ai normanni, Sellerio, Palermo 1992, pp. 13-47; Sicilia romana e bizantina, a cura di C. Quartarone, Grafill, Palermo 2006. 149 Prima di Giuseppe Agnello era stato Victor Schultze, nel 1877, il primo teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 142 numero 3 - maggio 2011 e S. Maria a Siracusa, in Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Matera, Venosa, Menfi…, 25-31 maggio 1969), “L’Erma” di Bretschneider, Roma 1971, pp. 25-43; Id., Discorso inaugurale, ivi, pp. 486-490; Id., Ringraziamento e commiato del Presidente, ivi, pp. 494-497; Id., Gli ultimi scavi nella catacomba di S. Maria a Siracusa, in Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Edizioni Lint, Trieste 1974 (“Antichità alto-adriatiche”, VI), pp. 443-465. Sugli interventi di Agnello ai Congressi Nazionali ed Internazionali di Archeologia Cristiana si veda pure: Rilievi strutturali e sepolcri a baldacchino nelle catacombe di Sicilia, in Actes du Ve Congrès International d’Archéologie Chrétienne (Aix-en‑Provence, 13-19 septembre 1954), Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana - Société d’Edition Les BellesLettres, Città del Vaticano - Paris 1957 (“Studi di Antichità Cristiana”, XXII); Id., The Frescoes in the Crypt of St. Martian at Syracuse, in X. Milletlerarasi Bizans Tetklkleri Kongresi Tebligleri (Actes du Xe Congrès International d’Etudes Byzantines) (Istanbul, 15-21. IX. 1955), Publication du Comité d’Organisation du X. Congrès International d’Etudes Byzantines, Istanbul 1957, p. 109; Id., Recenti scoperte e studi sui cimiteri paleocristiani della Sicilia, in Atti del VI Congresso Internazionale di Archeolo gia Cristiana (Ravenna, 23‑30 settembre 1962), Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1965 (“Studi di Antichità Cristiana”, XXVI), pp. 279-294; Id., Recenti scoperte di monumenti paleocristiani nel Siracusano, in Akten des VII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie (Trier, 5 11 September 1965), Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana - Deutsches Archáologisches Institut, Città del Vaticano - Berlin 1969 (“Studi di Antichità Cristiana”, XXVII), pp. 309326; Id., Le catacombe di Sicilia e di Malta e le loro caratteristiche strutturali, in Atti del XV Congresso di Storia dell’Architettura (Malta, 11-16 settembre 1967), Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, Roma 1970, pp. 213-235. 157 Id., Prefazione, in Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Siracusa, 19-24 settembre 1950), “L’Erma” di Bretschneider, Roma 1952, pp. 5-6. 158 Ancora ne sono stati recentemente aggiunti dal nipote a completamento della già ricchissima enumerazione. dell’altipiano di Ragusa, in “Rivista di Archeologia cristiana”, XXIX, 1953, pp. 6787; Id., Sicilia cristiana. I monumenti dell’agro netino, ivi, XXX, 1954, pp. 169-188; Id., Catacombe inedite di Cava d’Ispica, ivi, XXXV, 1959, pp. 87-104; Id., Necropoli paleocristiane nell’altipiano di Sortino, ivi, XXXX, 1963, pp. 105-129; Id., Nuovi ritrovamenti nella catacomba di S. Maria a Siracusa, ivi, XLIX, 1973, pp. 7-31. 152 Id., La pittura paleocristiana della Sicilia, Società Amici Catacombe, Città del Vaticano 1952, (“Collezione ‘Amici delle Catacombe’, XVII”). 153 La rivista storica dell’Ateneo catanese, fondata nel 1912 da Paolo Ubaldi e rifondata dal Prof. Emanuele Rapisarda, rimane attiva fino al 1934, anno della morte del suo ideatore. Dall’atto della sua rifondazione, in occasione della quale il titolo viene modificato da “Didascaleion” a “Nuovo Didascaleion”, la rivista esce sempre, più o meno con continuità ininterrotta sino al 1970. 154 G. Agnello, L’oratorio ipogeico di Castelluccio, in “Nuovo Didaskaleion”, II, 1948, pp. 36-50; Id., Problemi archeologici della Sicilia paleocristiana, in “Presenza cristiana”, 11-14, 1954, p. 3; Id., Gli affreschi dei santuari rupestri della Sicilia. Le grotte di Lentini, in “Rendiconti della pontificia Accademia romana di Archeologia”, XXX‑XXXI, 1957-59, pp. 189-204; Id., Siracusa, in “Italia nostra”, 17, 1960, pp. 26-27, resoconto dei ritrovamenti archeologici sotto il Palazzo del Senato; Id., Un sacello pagano con affreschi nella catacomba di S. Lucia a Siracusa, in “Palladio”, XIII, 1963, pp. 8-16; Id., L’ipogeo Politi a Siracusa e la storia della sua scoperta, in “Siculorum Gymnasium”, XIX, 1966, pp. 226-244. 155 Id., In Piazza Archimede ritrovamenti archeologici, in “La Voce di Siracusa”, 26 marzo 1960, p. 2; Id., Nel sottosuolo del Palazzo del Senato. Ritrovamenti archeo logici, ivi, 15 aprile 1960, p. 2; Id., Problemi archeologici ed esigenze industriali, in “Sette giorni di Siracusa”, 12‑13 gennaio 1963, pp. 7-8; Id., La scoperta di nuove catacombe a Siracusa, in “L’Osservatore romano”, 17 aprile 1964, p. 5; Id., Nuova rivelazione catacombale della Siracusa paleocristiana, in “La voce di Siracusa”, 6 giugno 1965, p. 2; Id., Sulla catacomba di Manomozza, in “La Sicilia”, (Cronaca di Siracusa), 21 aprile 1970, p. 6; Id., Sensazionale scoperta a Siracusa di un vasto complesso catacombale, in “La Sicilia”, 21 ottobre 1970, p. 3. 156 Id., Prefazione, in Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Siracusa, 19-24 settembre 1950), “L’Erma” di Bretschneider, Roma 1952; Id., La Sicilia cristiana e i suoi illustratori…, ivi, pp. 7-29; Id., La necropoli e la chiesa rupestre di Bibinello…, ivi, pp. 31-47; Id., Recenti esplorazioni nelle catacombe Cassia Iolanda Di Natale Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica... 143 Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte. rwin anofsky e l’educazione estetica in presenza di disabilità visiva di Roberta Priori E p Pittura antica e moderna “Anteros” dell’Istituto per Ciechi “Francesco Cavazza” di Bologna viene svolta un’intensa attività didattica rivolta alle persone non vedenti e ipovedenti. La curatrice e autrice dei contenuti tecnico-scientifici del museo, Loretta Secchi, in sinergia con l’Associazione Scuola di Scultura Applicata, la Cattedra di Ottica fisiopatologica dell’Ospedale Sant’Orsola, l’Unione Italiana Ciechi e l’Istituto per Ciechi “Francesco Cavazza” di Bologna, ha partecipato all’elaborazione di un metodo funzionale al raggiungimento di una più profonda comprensione dell’opera per i non vedenti attraverso l’iconologia2. All’interno del vasto corpus di studi panofskiano3, il S e oggi per uno studioso dell’arte la collocazione del proprio oggetto di studio in un contesto e la contemporanea decifrazione delle concezioni personali culturali che esso ha in sé, è un metodo d’analisi ormai consolidato, si può senza alcun dubbio affermare che questo si deve alle intuizioni del teorico tedesco Erwin Panofsky. Il metodo di ricerca e interpretazione dei fenomeni artistici da lui teorizzato, quello iconologico, domina tuttora il dibattito riguardante gli studi storico-artistici1 e continua a stimolare riflessioni sulle pratiche volte all’apprendimento della storia dell’arte e nell’ambito della didattica sperimentale delle arti. Dal 1999 presso il Museo Tattile di saggio Iconography and Iconology. An introduction to the Study of Reinassance Art, pubblicato nel 1955 in Meaning in the visual art 4, rappresenta un punto di arrivo della riflessione di Panofsky sul metodo di indagine dell’opera d’arte e sancisce la nascita dell’iconologia come disciplina. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 144 numero 3 - Maggio 2011 Quando infatti Erwin Panofsky affidava a questo celebre contributo la definizione di iconologia come «ramo della storia dell’arte che si occupa del soggetto o significato delle opere d’arte contrapposto a quelli che sono i loro valori formali»5, affermava lucidamente del metodo tripartito le potenzialità del pensiero panofskiano rivolte all’educazione estetica in presenza di disabilità visiva e l’applicabilità dei suoi aspetti educativo-pedagogici all’interno del complesso dibattito su percezione e significazione delle forme dotate di valore estetico. che la forma e il contenuto potessero e inevitabilmente dovessero coesistere per una comunicazione unitaria e approfondita del fenomeno artistico. Osserva in proposito Claudia Cieri Via: L’ educazione estetica dei non vedenti è stata negli ultimi anni al centro di numerosi studi che hanno visto la nascita di diversi contributi teoretici volti a sviluppare metodi pedagogici che possano garantire non solo l’accesso ai beni culturali ma favorire la formazione e l’integrazione sociale dei disabili della vista all’interno di un or- L’iconologia, come metodo di studio delle immagini e in particolare delle opere d’arte si caratterizza sostanzialmente per un’implicita finalità conoscitiva volta a cogliere nell’immagine e/o nell’opera d’arte non solo il come o il cosa ma anche il perché dei fenomeni artistici, indagando sulla genesi, sui diversi aspetti del loro manifestarsi, in rapporto alla tradizione artistica e letteraria e al contesto storico-culturale, con un’attenzione infine per i fenomeni di diffusione e di ricezione6. Percezione formale, cognizione e interpretazione – il cosa, il come e il perché – dell’opera d’arte rappresentano quindi i passaggi che conducono alla sintesi interpretativa cui giunse Panofsky attraverso l’elaborazione del metodo iconologico e costituiscono l’anello di congiunzione tra le caratteristiche del suo pensiero e il tema di questo studio: rintracciare nel percorso che conduce alla sistematizzazione Roberta Priori Erwin Panofsky Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 145 numero 3 - maggio 2011 mai acquisito riconoscimento della funzione educativa e psicoriabilitativa dell’esperienza estetica7. La Secchi sintetizza così: Su queste premesse opera l’équipe coinvolta nella sezione didattica del Museo “Anteros” composta da esperti in teoria dell’arte, psicologia della percezione tattile e ottica, storia e pedagogia 1. 2. dell’arte, tiflologia e scultura applicata. 3. La collezione del museo comprende circa quaranta esemplari di Percezione tattile delle forme e delle strutture (anche ottica in caso di uso del residuo visivo) = lettura preiconografica10. Cognizione delle forme e riconoscimento della loro identità = analisi iconografica11. Significazione della rappresentazione e sua estensione di senso = interpretazione iconologica12. capolavori della pittura dei periodi compresi tra l’età classica e quella contemporanea: riproduzioni tridimensionali in bassorilievo Tre livelli interpretativi: livello esterno fenomenico, semantico e documentario13, dunque, che si rivelano teorie essenziali per un corretto approccio all’opera d’arte e che vedono «teoria dell’arte, formalismo, storia degli stili, contenutismo, semiotica e psicologia della percezione confluire nell’applicazione didattica, adattata alle esigenze percettive e cognitive dei disabili della vista, del metodo tripartito panofskiano»14. A questo punto è necessario ripercorrere seppur brevemente alcuni passaggi della produzione teorica di Panofsky, soprattutto giovanile, per comprendere meglio le peculiarità del suo pensiero in merito alla percezione e cognizione delle immagini all’interno del denso dibattito teorico sviluppatosi a partire dalla seconda metà del XIX secolo in Europa e la funzionalità del suo metodo interpretativo rivolta prospettico di celebri dipinti8, rilievi tecnici, copie di rilievi rinascimentali, tavole propedeutiche al concetto di stile storico, tavole funzionali alla comprensione della prospettiva e delle categorie della rappresentazione9. La lettura tattile di un bassorilievo avviene in tre fasi. Queste tre fasi, specifica la Secchi, coincidono con tre livelli di lettura, correlati e inscindibili, che vengono sempre rispettati ma praticati in proporzioni diverse. Dopo aver letto le strutture geometriche nascoste e gli schemi interni della composizione (analisi preiconografica), riconosciuto i contenuti convenzionali dell’immagine (analisi iconografica), ed esplorato il senso dell’opera d’arte (analisi iconologica), il lettore giunge all’esperienza estetica, anche in relazione al suo pregresso culturale e alle sue potenzialità percettive. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 146 numero 3 - maggio 2011 all’educazione estetica dei non vedenti e ipovedenti. L’analisi dello In risposta alle concezioni espresse da Wölfflin, teorico formalista, stile, della forma e del contenuto di un’opera d’arte ha dominato le in una conferenza sul problema dello stile nelle arti figurative, tenuta ricerche teoriche dell’arte e il pensiero panofskiano è stato più volte il 7 dicembre 1911 presso l’accademia Prussiana delle scienze17, al centro di aspre e controverse Panofsky pubblica nel 1915 uno critiche, rimproverandosi allo dei suoi primi contributi teorici: studioso un’interpretazione delDas Problem des Stils in der bildenden l’opera deficitaria della conoscenza Kunst 18, che possiamo considerare dei valori della forma15. il primo manifesto del suo sistema L’esigenza di Panofsky, fin dai interpretativo. In esso affiora suoi primi scritti, è appunto quella una precisa critica all’estetica di di affrontare le questioni cruciali Wölfflin. delle ricerche metodologiche della Le tematiche della conferenza di Scienza dell’arte (Kunstwissenschaft), Wölfflin contenevano già le idee di rintracciare un metodo che che egli svilupperà in una delle permetta un approccio alternativo sue più importanti pubblicazioni: e complementare all’opera d’arte, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. e di codificarlo nell’ambito della Das Problem der Stilentwicklung in tradizione della Kunstgeschichte, der neuren Kunst19. In quest’opeTavola propedeutica alla conoscenza dei concetti prospettici. intesa come disciplina16. ra la forza dell’interpretazione Quando Panofsky, nel secondo decennio del XX secolo, comincia a formalista, già trattata da Wölfflin in Reinassance und Barock del 1888 scrivere i suoi primi saggi, la disciplina della Storia dell’arte è quasi in cui affronta il problema dello stile dal Rinascimento al Barocco20, esclusivamente dominata da parametri di analisi e giudizio formalisti. sembra raggiungere l’apice21. Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 147 numero 3 - Maggio 2011 fissi e immutabili essendo essi il risultato di un’interpretazione attiva e pregni di un profondo significato espressivo. Lo stile, per Panofsky, si forma dunque non sulle impressioni visive fisiologiche, ma sulla loro interpretazione23. Già nel modo in cui si rapporta a Wöllflin, Panofsky manifesta la necessità di non considerare più separata la forma dal contenuto. Inoltre, in Das Problem der Stils in der bildenden Kunst, Panofsky, ancora in opposizione a Wölfflin, traccia una relazione fra il termine visione e le possibili interpretazioni del suo significato. Così i vari vocaboli che rimandano all’idea di visione – sehen (vedere), Auge (occhio), optische (ottico) – se intesi unicamente nel loro senso letterale, rimangono relegati ad un ambito meccanicistico, vuotati di ogni significazione che non faccia riferimento ad una mera funzionalità fisica. Dunque, sostiene Panofsky, Tavola propedeutica alla conoscenza dei concetti prospettici L’approccio critico di Panofsky trova origine nella distinzione wölffliana fra il contenuto espressivo delle opere d’arte e le forme che sono i veicoli di tale espressione. Per Wölfflin le forme dipendono dal modo di vedere e di raffigurare di tutta un’epoca, cioè dall’“occhio” e non dalla disposizione individuale degli artisti. «Per Panofsky invece la visione è un processo fisiologico immutabile nel corso della storia»22: quello che varia è l’interpretazione di ciò che si vede. Così i modi di rappresentazione, differenti e tipici per ogni epoca, non sono colui che ponesse alla base della proprie considerazioni questo concetto fisiologico - obiettivo della visione, dovrebbe effettivamente affermare che la visione rientra in una sfera “inferiore” dell’attività artistica, in una sfera che sta al di qua dell’espressione, e che essa non ha nulla a che fare col sentimento o col temperamento […]; ma egli dovrebbe anche ammettere che la visione in questo senso non svolge ruolo alcuno nella costituzione di uno stile: l’occhio in quanto organo, che agisce soltanto nella teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 148 numero 3 - Maggio 2011 registrazione della forma ma non per la costituzione della forma, non sa nulla del “pittorico”, delle “ superfici”, della forma “chiusa” o della forma “aperta”. La visione nel senso figurato della parola sta al di qua di qualsiasi espressione, ma anche al di qua di ciò che Wölfflin denomina “ottica”24. Panofsky, allora, si domanda: se l’occhio è uno strumento organico e non psicologico, come sottintenderebbe Wölfflin, possiamo separare la relazione dell’“occhio” con il mondo dalla relazione della psiche (Seele) col mondo?25. Fornendo ai termini che rimandano all’idea di visione (occhio, vedere, ottico) una connotazione che superi il semplice riferimento all’attività fisiologica, Panofsky sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla psiche (Seele). Considerata il “luogo” del sentire e del temperamento, infatti, la Seele conferisce un contenuto espressivo a ciò che l’occhio vede, quasi gonfiando ogni lavoro artistico di valori e intenzioni che superano lo stadio immediatamente fruibile delle forme. Di conseguenza, lo stile non sembra avere una doppia origine: «una forma intuitiva priva di significato psicologico» da una parte, e «un contenuto costituito dallo stato d’animo e interpretabile in termini espressivi», dall’altra26. Pertanto, mettendo in correlazione l’intima dimensione fornita dall’“occhio” e l’elaborazione individuale fornita dalla Tavola propedeutica alla conoscenza dei concetti prospettici (figura geometriche) Seele, Panofsky arriva a dimostrare il ruolo combinato della rappresentazione e dell’espressione nell’esperienza percettiva. L’opera d’arte, considerata individualmente o in relazione con altre immagini, è il risultato di un’interazione fra le categorie generali della rappresentazione e la Seele individuale. Gli artisti, Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 149 numero 3 - Maggio 2011 sostiene Panofsky, ognuno dando voce alla propria psiche, determinano comunque categorie stilistiche generali. Insomma: l’esigenza espressiva dell’artista, […] si manifesta sì in forme generali ma anche queste ultime […] derivano da […] una volontà di forma che in certo modo è immanente a tutta un’epoca e che si fonda su un atteggiamento fondamentale identico dello spirito, non dell’occhio27. Al contrario di Wölfflin, dunque, per Panofsky, per usare una terminologia che si pone in linea con la critica kantiana, la singola opera d’arte e l’arte di un periodo sembrano affini come manifestazioni di una volontà aprioristica di forma e di espressione28. È in questo senso quindi che per il non vedente nella prassi di apprendimento dell’opera d’arte la percezione della forma può avvenire, in una prima fase, proprio attraverso la «denominazione dei soggetti primari, [l’]apprezzamento dei valori comunicativi delle forme, l’individuazione di geometrie nascoste e tipologie stilistiche»29. E, come accade per la relazione fra occhio e psiche, le categorie generali di Wölfflin ottengono pieno valore solo quando sono poste in relazione con forme reali e particolari. Per Panofsky questa relazione crea e allo stesso tempo spiega il problema dello stile: se la relazione dell’occhio con la Seele sembra essenziale per Bassorilievo con sottoquadri del Duca Federico da Montefeltro di Piero della Francesca. attivare la categoria dello stile e per fornirla di valore analitico ed euristico, allora questa reale interazione sarebbe anche responsabile della molteplicià e dell’eterogenità della forma individuale. Lungi comunque dall’offrire un completo ragionamento sulle categorie di Wölfflin, Panofsky conclude il suo saggio asserendo che una spiegazione esaustiva non è in ogni caso possibile perché teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 150 numero 3 - Maggio 2011 Studio delle tecniche di esplorazione tattile con uso di sensori la causalità non può essere sempre determinata. Tuttavia, continua, anche «se la conoscenza scientifica non è in grado di rilevare le cause storiche e psicologiche delle forme generali della raffigurazione artistica, a maggior ragione il suo compito Roberta Priori dovrebbe essere quello di indagare il suo senso (Sinn) metastorico e metapsicologico, cioè di chiedersi che cosa significhi il fatto che un’epoca raffigura in modo lineare o pittorico, in superficie o in profondità. Ma la scienza dell’arte si alienerebbe la possibilità stessa di porre queste domande, che sono infinitamente feconde, se, invece di concepire i grandi fenomeni rappresentativi come imponenti manifestazioni dello spirito (Geistes), volesse per così dire determinarli mediante leggi naturali e se volesse vedere in essi modalità della visione che non sarebbero più in alcun modo interpretabili»30. L’individuazione del significato convenzionale e culturale insieme all’individuazione del tema costituisce un ulteriore passaggio della lettura dell’opera. Operare come un teorico della conoscenza, permette inoltre a Panofsky di assumere il ruolo di interprete. Da questo punto di osservazione egli è in grado di considerare (vedere) ciò che sta nell’oggetto e allora «un gesto involontario, privo di qualsiasi proposito espressivo può essere espressivo»31. Convalidando il ruolo dell’interprete contemporaneo delle opere d’arte Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 151 numero 3 - maggio 2011 S di uno stesso artista, o registrando le reazioni estetiche ai vari lavori dei diversi artisti contemporanei, Panofsky si avvia a determinare la sostanza e la funzione dei concetti fondamentali della Storia dell’arte: la determinazione di categorie interpretative; la ricerca dei principi che regolamentano il rapporto tra l’opera e il suo contesto, soltanto per citarne qualcuno32. Procede nell’intento, quindi, di econdo Panofsky: «il più importante rappresentante della vera filosofia dell’arte può essere considerato Alois Riegl»; è stato lui ad essere «andato più lontano nella determinazione e nell’applicazione dei concetti fondamentali […]: se lo stesso concetto di volere artistico (Kunstwollen) è stato coniato da lui, egli ha scoperto alcune categorie che sono in larga misura adatte a definirlo […]. I suoi concetti di “ottico” e di “tattile” […] mirano già […] a chiarire un senso che è immanente ai fenomeni artistici»33. Il concetto di Kunstwollen, allora teorizzato da Riegl nell’opera Stilfragen 34, trova una determinare le basi teoriche e filosofiche per l’analisi dell’opera e per la sua comprensione fenomenica attraverso il confronto con la figura di Alois Riegl. Sandro Botticelli, Nascita di Venere, e bassorilievo teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 152 numero 3 - maggio 2011 probabile definizione nell’«impulso, tendenza formale impersonale che orienta l’insieme della produzione artistica delle differenti epoche storiche»35, una sorta di volere genetico, una necessità intima quest’ultimo con altri fenomeni e non da una fonte di conoscenza di ordine superiore: risalire dal punto di vista iconografico alle fonti di una determinata raffigurazione, far derivare un determinato complesso di forme dalla storia dei tipi oppure da determinati influssi, spiegare la realizzazione artistica di un certo maestro nell’ambito della sua epoca oppure sub specie del suo carattere individuale, tutto ciò significa mettere i fenomeni in relazione l’uno con l’altro, nell’ambito del grande complesso globale dei fenomeni che vanno indagati, e non determinare la loro posizione e il loro significato da un punto d’Archimede fissato al di fuori della loro cerchia d’essere36. che, insieme, genera e condiziona opera e stile. La volontà artistica interiore, quindi, si fa artefice del progredire stilistico attraverso i tempi, racchiudendo in sé non soltanto l’atteggiamento spirituale di un’epoca ma anche gli intenti più profondi dell’artista. Nello scritto del 1920 intitolato Der Begriff der Kunstwollen, Panofsky continua la sua riflessione sulle problematiche metodologiche della scienza dell’arte. Sebbene il saggio sia anteriore al periodo amburghese, possiamo sicuramente allinearlo agli scritti teorici che seguiranno e che costituiranno le basi teoriche del suo pensiero, anche dopo l’emigrazione negli Stati Uniti. L’inizio dell’opera ci introduce subito lungo una delle principali linee di riflessione dei primi saggi teorici di Panofsky: Panofsky ci avverte subito che la Storia dell’arte dovrebbe riferire i propri studi anche ad una «conoscenza di ordine superiore», piuttosto che rifarsi solamente ad una «conoscenza di ordine storico». Determinare la posizione e il significato di un fenomeno d’arte non può prescindere da un’indagine dei fattori esterni ad essa, occorre infatti un’analisi di diversi fenomeni relazionati tra loro, nell’ambito dell’intero complesso dei fenomeni che vanno indagati. Teorizzare di una certezza fondata esclusivamente sull’apporto informativo della fonte, per esempio, sarebbe come generare un postulato privo di conferme oggettive. Nel saggio, Panofsky sottolinea anche come le opere d’arte fossero ancora tradizionalmente analizzate in relazione alla Il fatto che gli oggetti artistici affaccino di necessità la pretesa di venir considerati in modo che non sia semplicemente storico, costituisce la maledizione e insieme la fortuna della scienza dell’arte. Una considerazione puramente storica, sia che proceda rifacendosi esclusivamente al contenuto o alla storia della forma, spiega il fenomeno opera d’arte solo a partire dalla relazione di Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 153 numero 3 - Maggio 2011 loro collocazione (ruolo) all’interno di differenti griglie formali ed iconografiche. Lo studioso è ben consapevole che queste classificazioni analizzavano i fenomeni artistici prescindendo dall’opera d’arte in quanto fenomeno intellegibile in sé, osservando che «non basta spiegare un’opera d’arte [come fa Wölfflin] rifacendosi ad altre opere d’arte, oppure ad altri eventi accaduti nella stessa epoca […]: come filosofi dobbiamo prima di tutto fissare alcuni principi interpretativi che ci mettano in grado di guardare all’opera d’arte nel suo valore intrinseco»37. Tali principi, come osserva la Neher, ci forniranno quello che Panofsky definisce un punto d’Archimede, cioè «uno spunto di spiegazione che fonderà la Storia dell’arte e che darà alle nostre intuizioni un’urgenza che va oltre l’opinione contingente e il fatto raccolto»38 « per indicare, così come scrive Ann Michael Holly, il modo in cui le parole possono essere in grado di esprimere la potenza ontologica di una singola rappresentazione visiva»39. «Si può affermare, che l’attività di Warburg ha mostrato alla storia dell’arte, per parlare alla Dürer, un neu Künigreich (nuovo regno) e l’ha dotata dei mezzi per conquistarlo». Così scrive Panofsky nel necrologio di Aby Warburg, che venne pubblicato in “Hamburger Fremdenblatt”41 il 28 ottobre 1929, due giorni dopo la scomparsa dell’amato maestro. Da qui si può partire per comprendere quanto fondamentale, secondo Panofsky, sia stato il contributo di Warburg alla storia dell’arte, quanto peso abbia avuto l’influenza dello studioso nella sua stessa opera e quanto incisivo sia stato il suo apporto per lo sviluppo di un approccio contestuale all’opera d’arte. L’indagine storico artistica di Warburg, infatti, propende per una conoscenza contenutistica ed iconografica dell’opera d’arte. I suoi scritti, pubblicati per intero nel 1932, possono consi- E. Panofsky, Working on “Ovide moralisé” in verse derarsi tra i massimi in Stockholm. F ino ad ora risulta evidente rileggendo i saggi giovanili di Erwin Panofsky quanto il Nostro ricerchi una conciliazione fra l’approccio formale e quello contenutistico all’opera d’arte soprattutto dal momento in cui si avvicina alla figura di Aby Warburg40. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 154 numero 3 - Maggio 2011 contributi del tempo agli studi sulla pittura rinascimentale 42. Già nei primi saggi43 Warburg lascia trasparire in modo evidente il suo metodo innovatore: l’attenzione all’ermetismo, alla commistione di diverse culture lo conducono a considerare la propria ricerca come un «percorso di ricostruzione organica della creazione artistica»44. L’immagine nell’opera d’arte è per lui principalmente un aiuto per l’espressione di una memoria sociale. L’immagine doveva essere considerata nel suo rapporto con la religione e con i suoi riti, con la poesia, e cioè legata ad un concetto di cultura inteso come un tutto, come un insieme articolato e inscindibile. La frequentazione di Warburg45, durata circa un decennio, influenzerà gli interessi di Panofsky verso nuovi e più ampi campi di ricerca. Nel necrologio, egli sottolinea «l’attenzione assoluta per i dettagli apparentemente meno significanti, nell’indagine dei quali [Warburg] scorse sempre la premessa di ogni conoscenza e la volontà (o meglio necessità) di considerare la storia della cultura umana come una storia delle passioni umane, che nella loro orrida semplicità […] rimangono costantemente uguali in uno strato dell’esistenza solo in apparenza celato dalla civilizzazione e – che proprio per questo – lo spirito, che conferisce la forma, deve contemporaneamente manifestare e domare con creazioni culturali»46. Ancora: gli scritti redatti tra gli anni Venti e Trenta da Panofsky, risentono fortemente delle letture e della frequentazione dell’ambiente che si sviluppa intorno all’istituto Warburg, fondato nel 1922 e costantemente in collaborazione con le attività del Kunstistorisches Seminar47. L’attenzione del pensiero panofskyano trova una nuova direzione: l’analisi non è più soltanto prettamente formale, ma scandaglia i motivi che originano l’opera, i riflessi culturali che la rendono manifestazione di un significato espresso. L’ interpretazione di Warburg rappresenta, quindi, per Panofsky, una chiave di volta utile alla trasformazione della storia dell’arte in una disciplina in cui l’origine dello stile venga considerato come il risultato di un insieme di condizioni che abbracciano ogni aspetto dell’esperienza umana e costituisce la base per la lettura iconologica panofskiana. «Warburg – continua Panofsky – dovette provare a comprendere storicamente non solo la letteratura e la teoria dell’arte, ma anche il culto, la lingua, la filosofia, la matematica e le scienze naturali, in breve, la somma di quello, che Ernst Cassirer tenterà di fondare sistematicamente come mondo della “forma simbolica”»48. Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 155 C numero 3 - maggio 2011 (1923-1929)50. Come già dal titolo si può dedurre, punto centrale della filosofia di Cassirer è il simbolo51. Le forme simboliche – la lingua, il pensiero, l’arte e così via – sono il mezzo attraverso cui si estrinseca la realtà. Egli investiga «ogni tipo di sforzo umano senza distinzione, poichè ognuno di essi include, nella sua struttura, le forme simboliche di cui lo spirito fa uso per comprendere la realtà»52 e, ancora, sviluppa i percorsi e le ramificazioni delle forme, assirer e Panofsky furono colleghi all’università di Amburgo e al Warburg Institute fin dagli inizi degli anni Venti. Per anni Panofsky si recò a seguire le sue lezioni e un vivace e fertile scambio di pensiero caratterizzò la loro amicizia. Cassirer appare come attento interprete neokantiano fin dalle sue prime pubblicazioni49. Ad Amburgo, negli anni Venti, si dedicherà alla sua monumentale opera Die Philosophie der Symbolischen Formen mostrando come uno stesso concetto assuma un diverso significato Tavole propedeutiche alla conoscenza degli stili Romanico e Gotico teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 156 numero 3 - maggio 2011 in base ai differenti sistemi filosofici in cui esso trova applicazione come elemento costruttivo. La teoria di Panofsky sulla Storia dell’arte rispecchia fin da subito ciò che egli aveva imparato da Cassirer. Diverse saranno le tematiche che consolideranno il loro sodalizio intellettuale: i comuni interessi per il neoplatonismo53; l’adesione al programma critico kantiano; l’idea che i contributi culturali umani debbano essere compresi nelle loro strutture di fondo, per poterli confrontare in tutte le loro diverse manifestazioni54. I riflessi della teoria cassireriana costituiranno per Panofsky un fondamento filosofico che caratterizzerà l’interpretazione dell’aspetto tematico - oggettivo55 dell’arte e saranno palesati in uno dei suoi saggi teorici più fortunati e conosciuti: mi riferisco al saggio sulla prospettiva56. La prospettiva come “forma simbolica” è uno dei saggi più famosi e significativi tra quelli riguardanti gli anni amburghesi nel quale la tesi principale esposta da Panofsky è che la prospettiva lineare non è il solo e naturale modo di rappresentare lo spazio tridimensionale pittorico, ma anche una convenzione appropriata all’esperienza occidentale dello spazio. Egli è ben consapevole del fatto che ci siano stati altri metodi di rappresentazione che hanno cercato di catturare aspetti della visione trascurati nella prospettiva lineare, osserva, però, che il modo in cui lo spazio è organizzato nelle opere d’arte corrisponde alla comprensione teorica dello spazio nel periodo preso in considerazione. I fuochi della considerazione di Panofsky sono l’Antichità e il Rinascimento. È ben nota la sua dimostrazione che gli antichi erano consapevoli delle curvature prospettiche cui può essere soggetta l’esperienza visiva basandosi anche su diversi testi filosofici e teoretici, come quello sull’ottica di Euclide57. Periodo dopo periodo, Panofsky mette in rapporto il trattamento artistico delle relazioni spaziali, particolari varianti di prospettive realizzate dagli artisti di una determinata era, con le tendenze filosofiche e scientifiche. Nella forma simbolica si condensano sintomi e problematiche scientifiche, politiche, religiose ed economiche del periodo che ha prodotto l’opera d’arte. Si solleva, quindi la possibilità che culture differenti abbiano inteso il mondo intorno a loro in modi differenti. Ecco perché «diviene essenziale per le varie epoche e province dell’arte chiedersi non soltanto se conoscano la prospettiva, ma di quale prospettiva si tratti»58. La spiegazione di Panofsky dello sviluppo dello spazio pittorico è posto in uno schema di sviluppo che termina con il Rinascimento e che inaugura la moderna concezione matematica dello spazio inteso come luogo infinito e omogeneo59. Si ritiene che si potrebbe Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 157 numero 3 - Maggio 2011 perfino comparare la funzione della prospettiva rinascimentale, continua Panofsky, con quella della filosofia critica60. Nell’ultima parte del saggio, Panofsky tenta una riconciliazione in modi diversi fra i principi interpretativi delle parti precedenti e alcune questioni – quelle relative alla forma e al contenuto – trattate nei suoi primi contributi teorici. Questa parte, poi, trova una sua naturale prosecuzione nel manifesto teoretico del 1925, il saggio intitolato Sul rapporto tra la storia dell’arte e la teoria dell’arte in cui si ritrova un’esposizione più ampia degli schemi neo-kantiani già trattati nei saggi precedenti. Prosegue dunque da parte di Panofsky la teorizzazione di una nuova metodologia critica della Storia dell’arte: ovvero ciò che può essere considerato uno dei principali apporti panofskiani alla tradizione del metodo tedesco. Nei cinque anni che separano questo saggio dal “concetto di Kunstwollen” c’è stato, nella concezione panofskiana, un mutamento del modo di intendere e costruire i fondamenti della Storia dell’arte (Grundbegriffe). L’occasione per il cambiamento è data dal contatto con Edgard Wind, di cui Panofsky e Cassirer all’università di Amburgo avevano esaminato la tesi di dottorato. Gli interessi di Panofsky per il significato intrinseco, per la coerenza e l’antitesi della coppia obiettivismo/soggettivismo, mutuati da Riegl61, una riformulazione, diventando antitesi ontologica fra “plenum” e “forma” (Fülle und Form), antitesi considerata dallo studioso la categoria fondamentale della realizzazione artistica62. Plenum e forma costituiscono i due poli entro cui le singole opere d’arte possono essere situate, «l’incontro tra percezione indiscriminata e capacità di organizzazione dei dati sensibili»63. Tutto ciò che è un’opera d’arte, realizza una risoluzione in plenum e forma64, cercando di fornire le categorie che regolamentano il processo artistico, producendo un ulteriore spunto fondamentale utile al tentativo di analisi sistematica del prodotto dell’arte. Questo breve percorso espositivo su Erwin Panofsky – muovendosi attraverso i suoi scritti, teorico-metodologici – ha voluto evidenziare le linee del pensiero critico di uno dei più esimi studiosi di storia dell’arte che, prima di altri, ha applicato i suoi sforzi nella continua ricerca dei motivi oggettivi dominanti il prodotto artistico e il suo significato, non limitandosi esclusivamente all’esame della forma pura. Panofsky infatti, come abbiamo visto, considera la caratteristica e l’interpretazione della forma tanto necessaria quanto di pari livello per un apprezzamento completo dell’opera d’arte, perché essa è «eine unlöslich verschränkte Einheit seiner Elemente Form, Idee (Motiv und Bedeutung) und Gehalt ist» [un’indissolubile, intrecciata unità dei suoi elementi: forma, idea (Motivo e Significato), e contenuto]65. sono sempre presenti. Quest’ultimo riferimento, però, subisce teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 158 numero 3 - Maggio 2011 Gli scritti sin qui citati vanno intesi allora come i presupposti epistemologici all’approccio panofskyano alla storia dell’arte, la genesi tematica e teoretica di quel metodo iconologico che sarà poi teorizzato nel periodo americano e che offre i presupposti per un lettura dell’opera in cui caratteristiche strutturali, estetiche e stilistiche diventano comprensibili e interpretabili per il vedente e per il non vedente. E se è vero che l’approccio iconologico verrà coerentemente sistematizzato solamente nel 193966, è vero anche che i fondamenti necessari alla sua teorizzazione vanno ricercati proprio nei lavori degli anni amburghesi, primo fra tutti quel Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst pubblicato nel 1932 e ritenuto uno dei più importanti scritti dell’ultimo periodo tedesco67. Q Lettura tattile concernente i principi generali di raffigurazione»68, sfruttando quindi, una conoscenza stilistica che esclusivamente un esame storico può produrre. Allora una descrizione che si limitasse unicamente all’apprezzamento formale descriverebbe il prodotto artistico come elemento di una creazione completamente privo di ogni senso. Ogni descrizione, nota allora Panofsky, deve trasformare gli elementi costitutivi dell’opera uesto testo rappresenta il momento culminante dell’elaborazione critica che sfocierà nella formulazione del metodo tripartito iconologico. Per arrivarci Panofsky prende le mosse dalla questione essenziale che riguarda la pura descrizione di un’opera d’arte. Essa, afferma ancora il teorico, va necessariamente compiuta non soltanto sulla base delle percezioni immediate dell’oggetto ma tenendo presente «il sapere Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 159 numero 3 - Maggio 2011 d’arte in simboli «di qualcosa di raffigurato». Riconoscendo il carico di valori significativi che muove la creazione artistica. Atteso questo, l’oggetto della descrizione non può più essere soltanto la forma ma unitamente ad essa il senso della forma. Senso che appartiene alla regione che il Nostro definisce “anteriore”. Una regione in cui resiste l’immediata esperienza esistenziale, le informazioni immediatamente accessibili perché conosciute, poiché secondo le parole di Panofsky, “culturalmente consaputo”. Se così non fosse, citando ancora un esempio inserito nel saggio, «un uomo che non avesse mai sentito parlare del contenuto dei Vangeli, riterrebbe probabilmente la Cena di Leonardo la rappresentazione di un gruppo di commensali piuttosto agitati che fossero in disaccordo su una faccenda di denaro»69. Esiste allora un primo strato “primario”, che Panofsky definisce “regione del senso fenomenico”, intuibile attraverso l’esperienza esistenziale, e uno strato secondario – la “regione del senso del significato” – cui possiamo pervenire soltanto in base ad un sapere tramandato per “via letteraria”. Pertanto, senza precedenti È chiaro, dunque, come la relazione tra i dati della raffigurazione e le rappresentazioni dell’esperienza sia il risultato di una familiarità con i principi generali della raffigurazione che permettono poi la realizzazione dell’opera. Cioè, come nota il teorico, con la “conoscenza dello stile” raggiungibile soltanto attraverso una penetrazione della situazione “storica”. Per dirla con Panofsky, insomma, «un’opera d’arte estranea, per tempo o per genere, a colui che vuole descriverla, prima di poter essere descritta, deve venire articolata nella storia dello stile»70. Intesa così, dunque, la descrizione di un’opera d’arte si trasforma in un’interpretazione che fa diretto riferimento alla storia della raffigurazione. E all’intuizione descrittiva nel senso del fenomeno si affianca l’intuizione iconografica nel senso del significato. E se per il senso del fenomeno era determinante la conoscenza dello stile, per il senso del significato ciò che risulta essenziale è la “conoscenza dei tipi”. E con quest’ultima espressione, “i tipi”, Panofsky, intende «una raffigurazione in cui un senso fenomenico determinato si è così saldamente fuso con un determinato senso del significato da diventare tradizionalmente il veicolo di quest’ultimo»71. La conoscenza dei tipi, inerisce, allora, a quel bagaglio di fonti che rimanda alle informazioni vive nella “coscienza del tempo”. La storia dei tipi, pertanto, ci permette di selezionare quale, tra due testi probabilmente adatto all’interpretazione dell’opera, sia in realtà conoscenze letterarie non potremmo comprendere ciò che intendesse rappresentare Leonardo nel senso del significato. Potremmo invece soltanto descriverlo limitandoci esclusivamente, e sottolinea Panofsky “grezzamente”, a ciò che salta subito all’occhio. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 160 numero 3 - Maggio 2011 Sarà pertanto la storia di ciò che ci è stato tramandato a delimitare il campo delle possibilità interpretative di un opera d’arte. E se poi la corretta interpretazione arriva a superare lo strato costituito dal senso del significato, ecco allora che essa si eleva fino a raggiungere quella regione alta che Panofsky definisce la «regione del “senso del documento” ovvero la “regione del senso dell’‘essenza’»75. Così, raggiungendo il suo senso più profondo e sublime, ogni manifestazione d’arte, superando il suo senso fenomenico o di significato, raggiunge un contenuto ultimo “essenziale”, «l’involontaria e inconscia», per dirla con le parole del Nostro, «autorivelazione di un’atteggiamento di fondo verso il mondo»76. Da ciò segue, naturalmente, che il compito dell’interpretazione sia quello di affondare nello strato ultimo del «senso essenziale». Solo così essa potrà disvelarne il senso profondo, cogliendo la pienezza della sua emanazione come testimonianza elevata del «senso unitario della concezione del mondo»77. Il senso essenziale, o significato intrinseco o simbolico di un’immagine dotata di valore estetico, come abbiamo visto, è quindi il punto di arrivo di un percorso conoscitivo e permette l’integrazione di persone che attraverso l’arte, intesa come scienza o come storia delle idee, possono così percepire e interpretare ciò che non vedono. quello che meglio realizza il senso del suo significato. In una diversa sezione del saggio, infine, Panofsky, rimandando alle proposizioni di Heidegger e alle sue considerazioni sul pensiero kantiano72, arriva all’espressione di un concetto che egli definisce l’«essenza dell’interpretazione». Muovendosi, infatti, dal concetto generale desunto da Heidegger per cui «di qualsiasi conoscenza filosofica ciò che conta non è ciò che essa dice nella proposizione che enuncia, bensì ciò che di non detto essa propone attraverso ciò che essa dice»73, e adattandolo al campo della descrizione artistica, Panofsky, ricava l’assunto per cui una descrizione deve necessariamente superare lo stadio iniziale della considerazione per valutare quello più complesso dell’interpretazione. Esiste però, nell’ambito “pericoloso” dell’interpretazione il rischio per nulla secondario di incorrere in una descrizione falsata. Ancora citando Heidegger, allora, il Nostro trova, nella limitazione dell’arbitrio, il limite a qualsiasi attività interpretativa. La fonte dell’interpretazione, dunque, deve essere sempre costituita dalla facoltà conoscitiva e dal patrimonio conoscitivo del soggetto che compie l’interpretazione, cioè dalla nostra esperienza esistenziale di vita, quando occorre scoprire semplicemente il senso del fenomeno, dal nostro sapere letterario quando si tratta del senso del significato74. Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 161 numero 3 - Maggio 2011 ________________________ determinata dalla conoscenza sensoriale e intellettuale dell’immagine e permette la condivisione di codici linguistici, semantici e tecnici che hanno il pregio di arricchire la comunicazione e l’integrazione tra persone vedenti e non vedenti». L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, p. 63. Per una esaustiva e completa bibliografia sulla percezione dei non vedenti rimando a L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, pp. 167-173. Per un’introduzione agli aspetti teoretici pedagogici dell’educazione estetica ed un panorama delle iniziative rivolte ai non vedenti nell’ambito dei beni culturali in Italia e in Europa cfr. AA. VV. L’arte a portata di mano. Verso una pedagogia di accesso ai Beni Culturali senza barriere, Atti del convegno, Portonovo di Ancona 21 – 23 ottobre 2004, Armando editore, Roma 2006. 8 Il bassorilievo prospettico ha origini nel Rinascimento fiorentino e la sua particolarità è la presenza del sottosquadro, cioè di «profili staccati dal piano di posa, corrispondenti alle qualità estetiche del disegno, delle linee di contorno e dei volumi dei corpi. Per questa ragione, spiega la Secchi, il bassorilievo tecnico mutua le regole della rappresentazione dalla pittura prospettica quattrocentesca e le traduce in valori tattili. (…) Le ragioni per le quali si è ritenuto opportuno tradurre la pittura in bassorilievo, a uso delle persone disabili della vista, sono le seguenti: la pittura prima d’ora era stata avvicinata dalle persone non vedenti solo mediante descrizioni verbali supportate dall’esplorazione tattile di disegni a rilievo e ciò non facilitava l’acquisizione, percettiva e cognitiva, dei concetti di scorcio, spazio prospettico, relazione spazio-temporale tra elementi, contorno, volume, superficie, valore espressivo ed estetico della forma. Tra disegni a rilievo e bassorilievi vi è però una significativa complementarietà». Ibid. p. 64. Sulla realizzazione del bassorilievo tecnico si veda L. Secchi, P. Gualandi, Logiche di ideazione e realizzazione della pittura tridimensionale per una didattica speciale delle arti, in AA. VV. L’arte a portata di mano. Verso una pedagogia di accesso ai Beni Culturali senza barriere…, 2006, pp. 235-245 e L. Secchi, P. Gualandi, Tecniche di rappresentazione plastica della realtà visiva, in Toccare l’arte. L’educazione estetica di ipovedenti e non vedenti, a cura di A. Bellini, Armando, Roma 2000. Infine sull’uso descrittivo, informativo e colmativo della parola cfr. L. Secchi, Tra sensi e intelletto. Cecità e forza dello sguardo interiore, in “L’integrazione scolastica e sociale”, edizioni Erikson, v. 7, n. 3, giugno 2008. 9 Cfr. L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, 2004, pp. 63-66. Tutte le immagini sono state gentilmente concesse dal Museo Tattile di pittura Antica e Moderna “Anteros” di Bologna, ad eccezione di quelle delle pp. 145 e 154 (Copyright ©2011 Institute for Advanced Study, Princeton). 1 Cfr. C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto. Per una storia del pensiero iconologico, Carocci, Roma 20092. 2 Cfr. L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione, Carocci, Roma 2004. Per un approfondimento sull’istituto e il museo si consiglia la consultazione del sito www.cavazza.it. 3 L’opera completa di Panofsky, che comprende i primi scritti teorici, quella svolta ad Amburgo tra il 1921 e il 1933 e quella successiva del periodo statunitense – quest’ultima redatta quasi esclusivamente in lingua inglese –, comprende diciassette libri e circa centocinquanta articoli. All’interno della monumentale opera panofskiana possiamo distinguere tre grandi linee: gli scritti nei quali prevale la ricerca storico-artistica, quelli dedicati alla teoria dell’arte e quelli riguardanti la metodologia. La principale fonte bibliografica in lingua italiana sulle opere di Panofsky, è reperibile in E. Panofsky, Studi di Iconologia, I temi umanistici nell’arte del Rinascimento, Einaudi, Torino 1975, pp. 349-370, alla quale rimanda anche Gian Carlo Sciolla in G.C. Sciolla, La critica d’arte del novecento, Utet, Torino 1995, p. 145. La fonte bibliografica in lingua tedesca, invece, è quella in E. Panofsky, Sinn und Deutung in der bildenden Kunst, a cura di R. Heidt, DuMont, Köln 1996, pp. 477-491. 4 E. Panofsky, Meaning in the Visual Arts, New York 1955 (trad. it. Il significato nelle arti visive, Torino 1996). Il testo era già apparso come introduzione al saggio Studies in Iconology del 1939. Cfr. E. Panofsky, Studies in Iconology, Oxford University Press, New York 1939 (trad.it. Studi di Iconologia, Einaudi, Torino 1975, pp. 3-38). Cfr. C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto…, pp. 181-199. 5 E. Panofsky, Il significato nelle arti visive…, p. 31. 6 Cfr. C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto…, p. 17. 7 A questo proposito aggiunge la Secchi: « La conoscenza della pittura nelle persone non vedenti rafforza i processi immaginativi e aiuta la comprensione del mondo della rappresentazione grafica e plastica. Inoltre il rapporto con il valore estetico dell’immagine predispone alla pratica dell’interpretazione teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 162 numero 3 - Maggio 2011 für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft”, 10, 1915, pp. 460 – 467, trad. it., Il problema dello stile nelle arti figurative, in La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti, Feltrinelli, Milano 1994, pp. 145-156. Cfr. S. Tedesco, Il metodo e la storia, Aesthetica Preprint, Supplementa, Centro internazionale Studi di Estetica, Palermo 2006, pp. 13-33. 19 H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, München 1915, trad. it., Concetti fondamentali della storia dell’arte, Longanesi, Milano 1953. 20 H. Wölfflin, Renaissance und Barock, München 1888, trad. it. Rinascimento e Barocco. Ricerche intorno all’essenza e all’origine dello stile barocco in Italia, Vallecchi, Firenze 1928. 21 Egli definisce infatti l’opera d’arte come una «storia delle forme che procede da una continuità interiore dell’evoluzione». H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, München 1915, trad. it., Concetti fondamentali della storia dell’arte, Longanesi, Milano 1984, p. 456. Cfr. A. M. Holly, Panofsky and the Foundations of Art History, Cornell University Press, Ithaca, NY 1984, trad it. Panofsky e i fondamenti della storia dell’arte, Jaca Book, Milano 1991, p. 38. 22 G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento…, 1995, p. 127. 23 Cfr. ibid. 24 E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” …, p. 149. 25 Ibid., p. 148. «Ma le cose stanno veramente così? Possiamo veramente dire che sia soltanto il diverso atteggiamento dell’occhio a promuovere ora uno stile pittorico, ora uno lineare, ora uno stile subordinante, ora uno coordinante? E anche se ci decidessimo ad esprimerci in questo modo, a chiamare cioè le possibilità della linearità, ecc. possibilità ottiche, e a definire ciò che determina la scelta di queste possibilità come un particolare atteggiamento dell’occhio, potremmo ancora considerare questo “occhio” come uno strumento organico e per nulla psicologico, e ritenere che sia possible distinguere di principio il suo rapporto col mondo dal rapporto complessivo dello spirito col mondo?». 26 E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” …, p. 146. 27 Ibid., p. 155. 28 Panofsky parla di Ausdruckwillen (volontà espressiva) e Gestaltungswille (volontà di forma). 10 Questo primo livello di analisi individua «soggetti primari e avviene attraverso percezione tattile e ottica (in caso di uso del residuo visivo)». Cfr L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, 2004, p. 63; R. Arnheim, Aspetti percettivi dell’arte per i ciechi, in Per la salvezza dell’arte, Feltrinelli, Milano 1994;. R. L. Gregory, Occhio e cervello. La psicologia del vedere, Il Saggiatore, 1966 Milano; Y. Hatwell, Elaborazione dei dati spaziali e sviluppo cognitivo dei non vedenti, in AA.VV., Vedere con la mente: conoscenza, affettività, adattamento nei non vedenti, a cura di D. Galati, Franco Angeli, Milano 1992. 11 In questo passaggio si arriva all’individuazione del tema e del suo significato convenzionale. Cfr. L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, 2004, p. 74. 12 Ibid., p. 72. In questo terzo livello, conclude la Secchi, «si cerca il significato intrinseco, simbolico ed estensibile, dell’immagine. Nel confronto tra opere di medesimo tema iconografico, appartenenti ad epoche e artisti diversi, si svela la costante risignificazione dei contenuti e delle forme». Ibid., p. 74. 13 Cfr. G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento…, 1995, p. 132. 14 L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, 2004, p. 73. 15 Tra questi basti citare l’ espressione coniata da Otto Pächt, esponente della Nuova Scuola viennese, nel 1964 di “Storia dell’arte per ciechi” per definire gli indirizzi di studio iconologici. 16 In una lettera a Erbert von Einem datata 1 aprile 1962, Panofsky afferma: «Con le mie ricerche mi sono proposto non tanto di produrre qualcosa di “originale”, ma piuttosto, e per quanto hanno potuto le mie forze, di salvare per il XX secolo il più possibile della tradizione del XIX (Vöge, Riegl, Goldschmidt, Warburg, perfino un po’ di Friedländer e di Wölfflin). Difatti, è importante che esistano degli eclettici nella scienza come nell’arte. Sono orgoglioso di aver imparato dagli studiosi di lingua tedesca e di essere considerato, non a torto, un rappresentante del metodo tedesco». H. Von Einem, Erwin Panofsky zum Gedänknis, in “Wallraf-Richartz-Jahrbuch”, XXX, 1968, pp. 362-367. 17 H. Wöllflin, Das Problem des Stils in der bildenden Kunst, in “Sitzungberichte der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften”, XXXI, 1912, p. 572 e sgg; l’intervento contiene già le idee che saranno sviluppate in Kunstgeschichtliche Grundbegriff nel 1915. 18 E. Panofsky, Das Problem des Stils in der bildenden Kunst, in “Zeitschrift Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 163 numero 3 - Maggio 2011 29 L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, 2004, p. 74. 30 E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica”…, p. 155. 31 E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” …, p. 156. 32 In realtà Panofsky, durante tutto il suo percorso formativo e teorico, si confronterà sempre con la figura e la portata delle tesi elaborate da Wölfflin. In non pochi interventi riconosce l’unicità e l’importanza del teorico formalista e sottolinerà sempre il debito che la moderna disciplina della storia dell’arte ha nei suoi confronti. Il lavoro di Wölfflin, per esempio, su Albrecht Dürer: Die Kunst Albrecht Dürer, Bruckmann, Monaco 1905 - trad. it., Albrecht Dürer, Salerno, Roma 1987 – sarà un riferimento fondamentale e imprescindibile per alcuni scritti di Panofsky sull’artista; cfr. E. Panofsky, Dürers Stellung zur Antike, in “Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte”, I, pp. 43-92 (trad. it. Albrecht Dürer e l’antichità classica, in Il significato nelle arti visive, Einaudi Torino1996, pp. 227-76) e E. Panofsky, Dürers Darstellungen des Apollo und ihr Verhältnis zu Barbari, in “Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen”, XLI, 1920, pp. 359-377. Arriverà persino a dedicargli uno scritto: Heinrich Wölfflin. Zu seinem 60. Geburtstage am 21. Juni 1924, in “Hamburger Fremdenblatt”, 21 giugno 1924. Ancora, negli scritti amburghesi, Wölfflin sarà un punto di confronto continuo e imprescindibile e sarà esplicitamente considerato fra i grandi teorici della Storia dell’arte di lingua tedesca, cfr.. E. Panofsky, Das erste Blatt aus dem «Libro» Giorgio Vasaris; eine Studie über die Beurteilung der Gotik in der italienischen Renaissance, mit einem Exkurs über zwei Fassadenprojekte Domenico Beccafumis, in “Städel-Jahrbuch”, VI, pp. 25-72; trad. it. La prima pagina del «Libro» di Giorgio Vasari, in Il significato nelle arti visive, Torino 1962, pp. 171-224. 33 E. Panofsky, Der Begriff des Kunstwollens, in “Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft”, XIV, pp. 321-39; trad. it. Il concetto del «Kunstwollen», in La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti, Milano 1994, pp. 157-177, p. 159 e sgg. Sulla “tattilità dell’occhio” e sulla funzione informativa del tatto Alois Riegl ha lasciato osservazioni molto utili alla riflessione sul ruolo della tattilità nella teoria dell’arte tra XIX e XX secolo: «Nelle sue analisi sulle forme della visione e sul Kunstwollen (volontà artistica) troviamo costanti riferimenti alla visione da lontano e da vicino, oppure alla visione intermedia che permette di bilanciare il bidimensionalismo visivo con la ricostruzione intellettuale del volume attraverso l’evocazione della percezione tattile e la comprensione della plasticità dei corpi», cfr. L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, p. 49. «La vista – afferma Riegl in Grammatica storica delle arti figurative, la raccolta delle lezioni pubblicate dopo la sua morte nel 1966 – non può penetrare le cose: vede sempre e solamente quella superficie delle cose che è rivolta verso chi guarda. Cioè l’occhio non vede una forma tridimensionale, ma una superficie bidimensionale: vede solo l’altezza e la larghezza, non la profondità. Abbiamo bisogno di un altro senso per convincerci dell’esistenza della profondità, cioè il tatto. La vista rivela solo l’esistenza della profondità, ma solamente il tatto può accertarsi della sua forma». Ibidem . Cfr. A. Riegl, Historische Grammatik der bildenden Künste, tr. it. Grammatica storica delle arti figurative, Cappelli, Bologna 1983, pp. 360-61. Cfr. A. Von Hildebrand, Il problema della forma nelle arti figurative, Andrea Pinotti e Fabrizio Scrivano, a cura di, Aesthetica, Palermo 2001. Cfr. M. Mazzocut-Mis, Voyerismo tattile. Un’estetica dei valori tattili e visivi, Il Melangolo, Genova 2002. 34 A. Riegl, Stilfragen, Siemens, Berlin 1893; trad. it. Problemi di stile, Feltrinelli, Milano 1963. 35 D. Arasse, Note sur Alois Riegl et la notion de”volonté d’art”(Kunstwollen), in “Scolies. Cahiers de recherches de l’Ecole Normale Supérieure”, 2, 1972, pp. 123-32, come sottolineato da G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento…, pag 16. 36 E. Panofsky, Der Begriff des Kunstwollens, in “Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft”, XIV, pp. 321-39. trad. it. Il concetto del «Kunstwollen», in La prospettiva come “forma simbolica”…, pp. 157-177, p. 157-158. Per punto di Archimede è generalmente riconosciuto quel principio di certezza che non trae origine dalle proprie percezioni. La definizione si vuole far risalire a Cartesio. «Non ci è noto come il termine “punto di vista archimedeo” sia divenuto un’espressione ricorrente nella teoria della storia dell’arte, ma sappiamo che W. Worringer già lo usò nel saggio del 1907 Abstraktion und Einfühlung. Cfr. A.M. Holly, Erwin Panofsky e i fondamenti della storia dell’arte,… 1984, p. 76. 37 A. M. Holly, Panofsky e I fondamenti della storia dell’arte…, pp. 76-77. 38 Cfr. A. Neher, “The Concept of Kunstwollen”, neo-Kantianism, and Erwin Panofsky’early art theoretical essays, in “Word & Image”, vol. 20, 1, Taylor & Francis Ltd, Essex 2004, pp. 41-51. Panofsky dichiara che la fondazione della Storia dell’arte deve essere intesa in termini kantiani e rifacendosi, dunque, al pensiero del grande filosofo tedesco, indica la sua idea di Kunstwollen: la Storia dell’arte dovrebbe iniziare un’indagine dentro ciò che può essere individuata come la teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 164 numero 3 - Maggio 2011 Trascinatori indiscussi e figure cardine dell’ambiente amburghese - definito uno dei più vivaci centri della Germania prebellica - furono Aby Warburg e Ernst Cassirer, punti di riferimento fondamentali nell’evoluzione del pensiero panofskiano. 41 Riedito in E. Panofsky, A. Warburg, in “Repertorium für Kunstwissenschaft”, LI, 1930, pp. 1 - 4; trad. it. Aby Warburg in E. Panofsky, Imago pietatis e altri scritti del periodo amburghese (1921-1933)…, pp. 183-188. 42 A. Warburg, Gesammelte Schriften, Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur europäischen Renaissance, Teubner, Leipzig- Berlin 1932; trad. it. La rinascita del paganesimo antico. Contributi alla storia della cultura, Nuova Italia, Firenze 1987, p. 248; cfr. nuova edizione: Id., Opere I-II. La rinascita del paganesimo antico e altri scritti, I (1889 – 1914); II (1917-1929), a cura di M. Ghelardi, Aragno, Torino 2004-07. Cfr. C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto…, pp. 31-129. 43 A. Warburg, Sandro Botticellis “Geburt der Venus” und “Frühlig”. Eine Untersuchung über die Vorstellungen von der Antike in der italienischen Frürenaissance, L. Voss, Hamburg-Leipzig 1893, tr. it. La “nascita di Venere” e la “Primavera”di Sandro Botticelli. Ricerche sulle immagini dell’antichità nel primo Rinascimento italiano, in La rinascita del paganesimo antico, 1987, pp. 121 e sgg . 44 L. Secchi, nota introduttiva a E. Panofsky, Imago Pietatis e altri scritti del periodo amburghese (1921-1933)…, 1998, p. 27. 45 L’attività di Warburg del tutto legata alla fondazione ad Amburgo di un’originale biblioteca, fu costantemente rivolta alla ricerca comparata. «L’idea decisiva era che i libri nel loro insieme – ciascuno con la sua maggiore o minore quantità di informazione e ciascuno potenziato da quelli vicini- potessero guidare lo studente, attraverso i loro titoli, alla considerazione delle forze fondamentali dello spirito umano e della sua storia», cfr F. Saxl, The history of Warburg’s Library (1886/1944) redatto nel 1943, rimasto incompiuto, fu integrato da Gombrich: cfr. E. H. Gombrich, Aby Warburg: an Intellectual Biography, The Warburg Institute, London 1978, tr. it. Aby Warburg. Una vita intellettuale, Feltrinelli, Milano 1983. Cfr. A. M. Holly, Panofsky e I fondamenti della storia dell’arte …, p. 107. 46 E. Panofsky, Imago pietatis e altri scritti del periodo amburghese (19211933)…, p. 184. 47 Tra gli scritti sui motivi iconografici religiosi si segnala: Id., Das Braunschweiger Domkruzifix und das «Volto Santo» zu Lucca, in Festschrift für Adolph categoria che equivale all’arte, cercando i “criteri di determinazione”, cogliendoli in base a concetti fondamentali, dedotti a priori, non attribuirli allo stesso fenomeno, ma alle condizioni della sua esistenza e del suo essere “così”. Panofsky crede fermamente che in tal modo si possa pervenire ad una comprensione delle basi dell’arte “parallela” alla conoscenza empirica formulata da Kant. A suo avviso i passi più importanti in questa direzione sono stati fatti da Riegl, che sebbene non riuscì mai a centrare l’argomento direttamente, ha dato la chiave di lettura con la quale cercare “le leggi inerenti che stanno sotto l’attività artistica”. Osserva infatti che Riegl «introdusse un concetto che […] doveva designare la somma o l’unità delle forze creative che in esse si esprimevano, che l’organizzavano sia formalmente sia contenutisticamente dall’interno: il concetto di “volere artistico” [Kunstwollen]»; cfr. E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica”…, 1994, p. 159. Ancora, il concetto di Kunstwollen «definisce le caratteristiche fenomeniche dell’argomento in questione non in senso generale, come il concetto specifico scoperto per via astrattiva, ma mediante un concetto fondamentale, che riveli il senso - significato immanente e che riveli le radici più proprie dell’essenza del fenomeno»; «[…] il volere artistico non può essere altro che ciò che “sta” (non per noi, bensì obiettivamente) come un senso ultimo e definitivo nel fenomeno artistico». Ibid., p. 166. Ciò che abbiamo bisogno di fare nella Storia dell’arte, allora, è iniziare un’analisi critica o trascendentale dei nostri giudizi sull’arte, allo scopo di determinare il loro puro contenuto artistico. Panofsky non stava insinuando che il concetto di Kunstwollen potesse individuare tutte le categorie artistiche, ma credette che forse poteva fornirci quella centrale perché il Kunstwollen spiegava come gli elementi della struttura visiva fossero trasformati da processi interni e specifici all’arte, anche se inizialmente dipendono dalla relazione che la coscienza stabilisce col mondo. 39 A. M. Holly, Panofsky e I fondamenti della storia dell’arte…, pp. 93. 40 Cfr. T. Lancioni, Il senso e la forma. Il linguaggio delle immagini fra teoria dell’arte e semiotica, ed. Leonardo, Bologna 2000. Nel 1921 Panofsky viene nominato Privatdozent e posto alla guida del Kunsthistorisches Seminar di Amburo dove manterrà questa carica fino al 1926, anno in cui diventerà professore ordinario. Panofsky si dedicherà all’insegnamento fino al 1933 circondato dai colleghi Edgar Wind, Charles de Tolnay e manterrà stretti contatti con Fritz Saxl, Rudolf Wittkower e Gertrud Bing della Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 165 numero 3 - Maggio 2011 53 E. Panofsky, Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie, G. B. Teubner, Leipzig - Berlin 1924, trad. it. Idea, Contributo alla storia dell’estetica, La nuova Italia, Firenze 1996. In questo saggio monografico Panofsky esamina l’evoluzione della nozione platonica d’idea dall’antichità a Bellori. Idea sviluppa in termini storici ciò che Cassirer aveva sostenuto durante una conferenza, tenutasi alla biblioteca Warburg, sulla dottrina platonica del bello in arte, pubblicato in E. Cassirer, Die Idee des Schönen in Platos Dialogen, in “Vorträge der Bibliothek Warburg”, II, Hamburg 1924. 54 R. Heidt Heller, Erwin Panofsky (1892- 1968), in Altmeister moderner Kunstgeschichte…, pp. 164-187. 55 R. Heidt Heller, Erwin Panofsky (1892- 1968)…, 1999, p. 168. La Heidt utilizza per indicare il termine «oggettivo» l’aggettivo tedesco «gegeständlich». C’è una ben articolata distinzione nella lingua tedesca: mentre das Objekt, letteralmente, denota un oggetto nel mondo, das Gegenstand, nell’accezione filosofica, invece, implica la comprensione di un oggetto da parte della mente in modo che esso si manifesti come una ri - rappresentazione, o elemento per l’analisi. 56 E. Panofsky, Die Perspektive als «simbolische Form», in “Vorträge der Bibliothek Warburg” 1924-25, Leipzig- Berlin 1927, pp. 258 – 330, trad. it. La prospettiva come “forma simbolica”, in La prospettiva come “forma simbolica”…, pp. 37-141. 57 Ibid., pp. 46-54. 58 Ibid., p. 50. 59 «Così la grande evoluzione che da uno spazio di aggregati conduce a uno spazio sistematico giunge a una provvisoria conclusione; ma a sua volta questa conquista della prospettiva non è altro che una espressione concreta di ciò che contemporaneamente era stato scoperto dalla filosofia teoretica e dalla filosofia della natura. […] L’infinità in atto, che per Aristotele non era neppure concepibile e che per l’alta Scolastica lo era soltanto nella forma dell’onnipotenza divina, […], ha ormai assunto la forma della Natura naturata. […]. Nonostante l’afflato mistico, questa concezione dello spazio è già quella che più tardi verrà razionalizzata da Cartesio e formalizzata nella teoria kantiana». E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica”…, pp. 70-71. 60 La prospettiva può essere concepita in termini kantiani sia perché essa è «come un consolidamento e una sistematizzazione del mondo esterno, sia come un ampliamento della sfera dell’io», ibid., p. 72. Neher sottolinea nel suo Goldschmidt zum 60. Geburtstag, Leipzig, pp. 37-44, trad. it. Il crocifisso del duomo di Braunschweiger e il “volto Santo” di Lucca, in Id., Imago Pietatis e altri scritti del periodo amburghese, Il Segnalibro, Torino, 1998. Cfr. Id., Bemerkungen zu Dagobert Frey’s “Michelangelostudien”.., 1921, pp. 35-45. Cfr. E. Panofsky, F. Saxl, Dürers «Melanconia I»; eine quellen- und typengeschichtliche Untersuchung, Leipzig-Berlin 1923. Cfr. E. Panofsky, Dürers Stellung zur Antike, in “Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte”, I, 1921, pp. 43-92, trad. it. Albrecht Dürer e l’antichità classica…, pp. 227-76. Nel 1922 il saggio è stato pubblicato a Vienna. E. Panofsky, F. Saxl, A Late-Antique Religious Symbol in Works by Holbein and Titian, in “Burlington Magazine”, XLIX, 1926, pp. 177-181; ripubblicato in Meaning in the Visual Arts…; trad. it. L’ «Allegoria della prudenza» di Tiziano: poscritto, in Il significato nelle arti visive…, pp. 149-168. 48 E. Panofsky, Imago pietatis e altri scritti del periodo amburghese (19211933) …, p. 185. 49 E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, I - III, Berlin 1906 - 1920; IV, Stuttgart 1957; trad.it., Storia della filosofia moderna, I: Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza dall’umanesimo alla scuola cartesiana; II: Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza da Bacone a Kant; III: Il problema della conoscenza nei sistemi postkantiani; IV: Il problema della conoscenza nei sistemi posthegeliani, Einaudi, Torino 1952, 53, 55, 58. E. Cassirer, Kants leben und Lehre: Immanuel Kant Werke, Berlin 1918; trad.it. Vita e dottrina di Kant, La Nuova Italia, Firenze 1977). 50 E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, 3 voll., Berlin 1923-1929; trad. it. Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze: vol.I: Il linguaggio, 1961, 1976; vol. II: Il pensiero mitico, 1964, 1977; vol III/ 1, III/ 2: Fenomenologia della conoscenza, 1966. Cfr. M. Van Vliet, a cura di, Ernst Cassirer et l’art comme forme symbolique, PU Rennes, Rennes 2010. 51 Secondo la stessa definizione di Cassirer: «La filosofia delle forme simboliche non solo cerca le categorie della conoscenza dell’oggetto nella sfera teoretico - intellettuale, ma parte dal presupposto che simili categorie si debbano trovare ovunque, così che da un caos di impressioni si formi un cosmo, cioè una caratteristica e tipica “visione del mondo”». Cfr. E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche…, 1923-1929, II, p. 43; cit. in A. M. Holly, Panofsky e i fondamenti della storia dell’arte…, 1991, p. 128. 52 A. M. Holly, Panofsky e i fondamenti della storia dell’arte…, 1991, p. 132. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 166 numero 3 - Maggio 2011 articolo che i saggi panofskiani sulla prospettiva e sulle umane proporzioni presentano un punto di vista autorevole nei confronti del passato ed hanno un carattere espressamente ermeneutica; inoltre, la Neher ricorda che il fine dei due saggi non è normativo, come invece accade nel saggio sul Kunstvollen. Cfr. A. Neher “The Concept of Kunst wollen”…, 2004, p. 47. 61 Cfr. E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” …, pp. 179 e sgg. 62 La prima formulazione dell’antitesi “plenum” “forma” va attribuita a Wind. Cfr. E. Wind, Zur Systematik der künstlerischen Probleme, in “Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft”, 18 (1924/1925), pp. 438-486. 63 L. Secchi, L’educazione estetica per l’Integrazione…, 2004, p. 68. 64 E. Panofsky, Über das Verhältnis der Kunstgeschichte zur Kunsttheorie, in “Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft”, pp. XVIII, pp. 129-61; trad. it. Sul rapporto tra la storia dell’arte e la teoria dell’arte, in La prospettiva come “forma simbolica” …, p. 181. 65 R. Heidt Heller, Erwin Panofsky (1862 – 1968) in H. Dilly (a cura di), Altmeister moderner Kunstgeschichte…, pp. 164-187, p. 164. 66 § n. 4. 67 Precedente a questo testo è Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst, (Ercole al bivio e altre antiche rappresentazioni nell’arte nuova, 1930), uno studio delle trasformazioni e propagazioni di un tema classico (Ercole al bivio) nell’arte medievale rinascimentale. Cfr. G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento…, 1995, pp. 131-132. 68 E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” …, p. 216. 69 E. Panofsky, ibid., p. 216. 70 Ibid., p. 220 71 Ibid., p. 222 72 M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, Longanesi, Milano, 1973. E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” …, p. 224. 73 74 Ibid., p. 226. 75 Ibid, p. 227. 76 Ibid., p. 228. 77 Ibid. In ultima analisi, a conclusione di saggio Panofsky, inserisce in Suna tavola sinottica gli elementi indispensabili per una piena e profonda interpretazione di ogni prodotto artistico. Roberta Priori Vedere attraverso e oltre l’opera d’arte... 167 Il Museo negli scritti di Giulio carlo argan di Marcella Marrocco delle arti fondato sulla prospettiva, e di un valore metaforico dell’immagine urbana, Argan assegnerà un ruolo centrale proprio ai musei, che come luogo di incontro tra istanze storiche e istanze estetiche ma anche dell’autenticità dell’opera, si pongono a suo parere come spazio didattico privilegiato in cui il cittadino ha la possibilità di educarsi all’esercizio del giudizio di valore che, come sottolinea lo studioso, è atto critico, esercizio di libere scelte, in ultima analisi “atto politico”. Musei scuola certo, ma anche nuova scena urbana, nuova piazza, luogo di incontro e di scambio culturale, metafora dei valori della società, nuovo “centro” capace di esercitare sulla città e sulla civitas un forte potere seduttivo, assumendo all’interno dello spazio urbano il ruolo un tempo svolto dal tempio, dalla cattedrale, dal palazzo comunale. I musei, il loro allestimento, la loro funzione sociale sono oggetto di studio e di interesse da parte di Giulio Carlo Argan sin dai primi anni della sua attività di critico e di funzionario delle Belle Arti, impegnato, sotto il ministero Bottai, nella tutela del patrimonio artistico1, ma avranno un ruolo centrale anche negli anni più maturi della sua riflessione critica, quando l’attività di studioso prima, e di politico poi, lo porterà ad occuparsi della città Gesammtkunstwerk come oggetto estetico e come soggetto politico. Nella definizione della sua imago urbis, di un’estetica urbana che ha i suoi assi portanti nell’identificazione tra storia dell’arte e storia della città, nel riconoscimento di un “sistema urbano” teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 168 numero 3 - Maggio 2011 Già nel 1938, in occasione di una recensione sul nuovo ordinamento della Galleria e del Museo della Ceramica di Pesaro, Argan individua che le varie penalizzazioni cui l’opera è sottoposta all’interno dei musei, soprattutto l’allontanamento dal luogo per essa pensato e nella funzione educativa il fine principale del museo, osservando che immaginato dall’artista, con la conseguente perdita della funzione l’allestimento museografico, mai mero intervento tecnico, si configura sociale originaria, sono una sorta di male necessario in nome della come frutto di giudizio di valore, di salvaguardia e della tutela. atto critico. Il museo è il luogo in Sin da questa prima fase della cui l’opera viene ricondotta al suo sua attività di critico e di storico originale valore e torna ad essere dell’arte Argan dunque riconosce testimonianza storica «dei rapporti ai musei il ruolo fondamentale di che possono e devono esserci tra luoghi promotori di cultura, in l’arte del passato e l’odierna»2. quanto «luogo di ricerca scientifica Alla base delle sue considerazioni e di attività didattiche organizzate»6, museografiche espresse tra gli anni luogo di educazione collettiva7 Trenta e Cinquanta3 è dunque la e centro nevralgico della città moderna, terreno di incontro tra ferma convinzione della funzione l’arte e la civitas, luogo di crescita pedagogica del museo, concepito Parigi, Louvre, veduta esterna. culturale e civile, naturalmente non solo come luogo in cui si deputato alla formazione di tutti coloro che, a vari livelli, si occupano conservano le opere, ma nel quale soprattutto lo storico, secondo il della progettazione della città. suo metodo4, mette in atto giudizi critici, opera una selezione, che è atto critico, non di manufatti ma appunto di valori. Alla base di quest’idea del museo come scuola8, certamente derivata Pur riconoscendo validità teorica all’analisi di Benjamin5, Argan dal pensiero di Read9 e da suggestioni che rimandano ad una lettura si discosta dalle conclusioni del filosofo tedesco, evidenziando dell’opera di Dewey, Art as experience, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 169 numero 3 - Maggio 2011 c’è il riconoscimento della validità di un’educazione basata sull’esperienza diretta dell’opera d’arte, ovvero sul ripercorrere in maniera attiva la storia dell’esperienza estetica10. L’arte in tal modo si configura come foriera di un processo educativo di tipo formale ed estetico che, non più passivo ma basato sull’esperienza, è il solo che possa portare l’uomo, e il cittadino, ad una matura consapevolezza del proprio agire nello spazio G.C. Argan, Intervista sulla fabbrica dell’arte, a cura di T. Tini, Bari 1980. e nel tempo, quindi del proprio agire storico11. Da qui la funzione sociale dell’arte e del museo, sottolinea Argan, e la consapevolezza che si possa non solo «educare attraverso l’arte» ma anche – e qui la differenza con Read – «educare all’arte»12. Il museo allora non può più essere concepito come luogo della contemplazione estatica, ma come organismo vivo, vitale, attivo, capace di coinvolgere il visitatore, di farlo diventare attore, non più solo spettatore, di un processo comunicativo; esso diviene lo spazio della presa di coscienza e della memoria dei valori sui quali si riconosce una determinata civiltà e all’interno del quale il cittadino può ancora cercare la propria identità politica e culturale. Spazio essenziale all’interno della città contemporanea, contribuisce al costituirsi della polis, può influenzarne le scelte etiche e le strategie di sviluppo13. Esiste però un divario profondo tra la funzione che i musei sono chiamati ad assolvere e lo stato dei musei italiani. Nell’esercizio del suo ruolo di Ispettore centrale, Argan ne denuncia la crisi, la loro incapacità di portare avanti il compito educativo e la funzione socio-politica cui Roma, Centrale Montemartini. sono chiamati. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 170 numero 3 - Maggio2011 Una delle cause è da rintracciarsi, secondo il critico, nella stessa natura delle istituzioni museali italiane, spesso ospitate in edifici storici all’interno dei quali ragioni conRovereto, MART, ingresso. servative e di salvaguardia finiscono per limitare fortemente la flessibilità dello spazio interno e la sua strutturazione funzionale14. Già alla fine degli anni Quaranta, in un documento dal titolo I Musei d’arte moderna e il loro moderno ordinamento15, rimasto inedito e recentemente pubblicato in un saggio di Valentina Russo, Argan insiste sulla necessità di costruire nuovi musei come atto necessario alla valorizzazione delle opere, non più per la loro salvaguardia e tutela ma come riconoscimento critico della capacità che le opere stesse hanno di farsi foriere di valori ancora attuali e moderni, della loro capacità di collocarsi, anche spazialmente e temporalmente, all’interno di strutture moderne, realizzate secondo codici comunicativi contemporanei. Da qui la necessità, accanto alle sale espositive, di laboratori per la ricerca e il restauro, biblioteche, fototeche, sale di consultazione e di studio, ovvero di Palermo, Galleria Regionale della Sicilia, Palazzo tutte quelle strutture Abatellis, cortile interno, veduta esterna. indispensabili allo studio dell’opera come complesso documento storico. Poiché la ricerca storica è per definizione continuamente in fieri, anche le strutture museali dovranno allora essere pronte ad accogliere, attraverso un’organizzazione funzionale e variabile degli spazi, i risultati dell’attività scientifica, mettere in atto un’esposizione flessibile, da modificare ed aggiornare coerentemente con gli sviluppi della ricerca16. In occasione della II Conferenza generale dell’International Council of Museums, tenutasi a Londra dal 17 al 22 luglio 1950, Argan afferma con forza questo concetto: È certo che il carattere monumentale dell’edificio rappresenta sempre un impedimento allo sviluppo di un museo secondo un razionale programma scientifico e museografico. È perciò Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 171 numero 3 - Maggio 2011 l’ordinamento originario (ma solo laddove esso si è mantenuto perfettamente integro), perché testimonianza storica d el New York, MOMA, interno. «gusto raffinatissimo» del tempo19, pur riconoscendo però la possibilità di migliorare, senza stravolgere, gli allestimenti museografici di grandi musei, come per esempio il Louvre o gli Uffizi, attraverso nuovi sistemi di illuminazione e sempre mirando alla costituzione di un «ambiente neutro»20. La terza tipologia è quella di musei recentemente allocati in edifici storici, senza che vi sia alcuna relazione tra le collezioni e il contesto nel quale sono ambientate, collocazione giustificabile solo se si voglia sottrarre gli edifici al degrado e all’abbandono, e che può risultare comunque un’operazione di grande rilievo scientifico, se eseguita con metodo critico e con rigore filologico. Apprezza, ad esempio, la sistemazione di Palazzo Abatellis, nell’antico quartiere palermitano della Kalsa, necessario stabilire i limiti entro i quali la simbiosi di un monumento e museo deve essere accettata come un’esigenza o un mezzo per la protezione del patrimonio artistico, e al di là dei quali deve essere respinta come un’assurda mortificazione dell’attuale coscienza dei valori artistici. In altri termini si tratta di distinguere i casi in cui l’unità di monumento e museo, nelle sue varie gradazioni, costituisce un vero e proprio documento storico, e i casi in cui è affatto occasionale o ricercata artificiosamente in forza del decaduto e deprecabile criterio museografico dell’ambientamento storico dell’opera d’arte17. Argan ovviamente distingue tra edifici il cui apparato decorativo costituisce già esso stesso un museo (la cui efficacia educativa risulta alquanto limitata, ma per i quali risulta prevalente, nell’interesse dei curatori, la conservazione dell’integrità del documento)18, e quelli le cui collezioni sono ab antiquo legate ad un edificio monumentale, Roma, MAXXI, interno. per i quali va rispettato teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 172 numero 3 - Maggio 2011 alla trentennale direzione di Palma Bucarelli23. La vitalità della Galleria ha avuto per tanti anni un effetto coinvolgente e trainante sulla vita culturale di Roma24. Un impegno, quello della Bucarelli per la GNAM, che in non poche occasioni, denuncia Argan, si è dovuto scontrare però con l’ostruzionismo non solo della politica ma anche di tanti esponenti del mondo della cultura che non hanno compreso come, per realizzare un grande museo d’arte contemporanea, fosse indispensabile una coraggiosa e impegnativa strategia culturale, sostenuta da ingenti investimenti25. sede dell’allora Museo Nazionale, oggi Galleria Regionale della Sicilia, ad opera dell’architetto Carlo Scarpa21. Diverso il discorso per i nuovi musei che dovrebbero essere ospitati invece in architetture appositamente realizzate secondo i più moderni criteri, tenendo presenti le principali funzioni, quella scientifica e quella didattica, che sono chiamati ad assolvere22. Nella maggior parte dei casi i grandi musei italiani, lamenta Argan, sono rimasti fermi nella rigida custodia di determinati valori estetici, non hanno aperto le porte alla cultura Lo stesso ostruzionismo alcuni anni novecentesca, non hanno messo in più tardi avrebbe incontrato Argan, atto una politica mirata all’acquisizione Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, esterno. divenuto sindaco di Roma, nel di opere di artisti contemporanei, promuovere il progetto di ampliamento della GNAM, che avrebbe come è accaduto invece nelle principali istituzioni museali straniere, reso il museo «moderno anche nel disegno e nella funzione»26. sono rimasti volutamente chiusi alle nuove tendenze della cultura Argan fu accusato in quell’occasione di voler realizzare un Beauborg mondiale, e non per mancanza di fondi, ma per «difetto di cultura». romano. Come egli stesso ribadisce, non si trattava di avversione Piccola eccezione per tanti anni, nell’arretrato panorama italiano, la «contro l’arte moderna ma contro l’ipotesi di un museo moderno». Galleria Nazionale d’Arte Moderna, grazie al personale impegno e Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 173 numero 3 - Maggio 2011 In realtà, fin dal primo disegno, l’ingrandimento della Galleria non era pensato come la semplice aggiunta di un certo numero di stanze ma come un organismo strutturalmente nuovo, in cui l’apparato informativo, didattico, sociale di animazione sarebbe stato anche quantitativamente prevalente rispetto alla zona espositiva»27. Come sottolinea nell’intervista rilasciata ad Achille Bonito Oliva, il progetto rimase per tanti anni bloccato e l’attività della Galleria penalizzata. La vicenda della Galleria Nazionale d’Arte Moderna è esemplare per comprendere l’orientamento ideologico - culturale di quegli anni sui musei. Se il museo moderno, ribadisce Argan, deve essere un luogo dove si fa esperienza diretta dell’arte, esso non può essere estraneo ai fermenti culturali della modernità né può trascurare l’importanza metodologica del confronto. Da qui la necessità di una politica museale che incentivi i lasciti, le donazioni di privati, gli investimenti nell’acquisizione di opere d’arte straniere28, nella precisa convinzione che al museo sacrario e al museo forziere non deve succedere il museo-collettore, ma il museo laboratorio che documenterà l’arte come oggetto di ricerca scientifica e la ricerca scientifica stessa, nel comune rigore delle diverse metodologie29. Dunque un museo che non teme di «utilizzare» la cultura e l’arte, che non considera le opere come venerabili reliquie, ma che aspira a diventare esso stesso propulsore di vita30. I n tal senso apprezza anche i musei americani (una particolare menzione va al Museum of Modern Art di New York, definito «esemplare»31 e ad Alfred Barr che ne fu il direttore negli anni precedenti la seconda guerra mondiale32), i quali, pur essendo strutturati su modelli distanti da quelli europei, si rivelano organismi funzionanti, «centri vivi di cultura, scuole di educazione estetica, fortemente legati alla vita della comunità»33. Argan sostiene a gran voce l’idea di aprire i musei alle città, di farli divenire luogo di incontro e di crescita, di studio e di confronto, arricchendoli di strutture adeguate alle nuove funzioni34, privilegiando in particolare un apparato comunicativo non rigido e statico, ma problematizzato e interattivo, strutturato secondo criteri simili a quelli seguiti nelle mostre, che risultano più coinvolgenti nei confronti del pubblico. La validità di una mostra sta, a suo avviso, proprio nel suo essere costantemente supportata da un serio lavoro di ricerca; la sua teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 174 numero 3 - Maggio 2011 funzione è quella di porre dei quesiti, dei problemi, di far parlare allo stesso tempo scientificamente pertinente, lo spazio espositivo l’opera d’arte, di farla dialogare con altre opere d’arte, ma anche museale35. Si comprende facilmente a questo punto perché Argan avversi, con il pubblico e con gli studiosi. La mostra dovrebbe essere il seppure con accenti meno drastici luogo in cui si cerca di dare delle del suo collega ed amico Cesare risposte ai quesiti che le opere Brandi36, o del francese André hanno già posto e ove si pongono altre domande (come avviene in un Chastel37, tutte quelle mostre che sistema comunicativo che funzioni non siano supportate da un serio realmente e che abbia come fine lavoro scientifico e che non abbiano l’accrescimento generale delle cocome fine ultimo il progresso degli noscenze). La sua validità, come studi e l’avanzamento della ricerca38. tale, secondo Argan, sta tutta nella Proprio perché il fine del museo capacità che essa ha di funzionare deve essere quello di promuovere come ulteriore laboratorio di ricerca la crescita culturale della comunità, e di sperimentazione, oltre che come Argan sottolinea l’importanza di spazio educativo. uno stretto collegamento tra museo Londra, Tate Modern, Turbine Hall. Anche a livello espositivo, l’allee università, luogo privilegiato stimento di una mostra può avere della ricerca, da un lato, museo utili ricadute sulla sistemazione stabile del museo, nel momento e tessuto produttivo della città dall’altro. Il riconoscimento del in cui il lavoro preparatorio e le strategie espositive sperimentate museo anche come istituzione capace di determinare importanti per le esposizioni temporanee fungano da laboratorio di ricerca ricadute sulla vita produttiva della città potrà, secondo Argan, non museografica, in modo tale da rendere sempre più coinvolgente, e solo sottrarre alla crisi i musei italiani, ma riconoscere il loro ruolo Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 175 numero 3 - Maggio 2011 attivo nella valorizzazione dell’immagine urbana39, come egli stesso chiarisce nel corso di una celebre intervista rilasciata nel 1980. In questa attribuisce al museo la possibilità di essere, all’interno della città intesa come opera d’arte totale, un centro propulsore di crescita per l’intera comunità, luogo dell’educazione estetica nel quale è possibile ripercorrere criticamente la storia delle forme attraverso le quali l’uomo ha organizzato la sua esistenza civile e storicizzata40. Il museo in tal senso esercita una precisa funzione “politica”, collabora cioè alla costruzione di una polis moderna e funzionale nella quale è ancora possibile l’incontro tra il cittadino e i valori estetici e civici sui quali si fonda il divenire storico di una comunità. Perché questo possa avvenire è però necessario che i musei si adeguino all’altezza del loro compito, rendano possibile al loro pubblico l’esercizio alla comparazione e al confronto, senza i quali non possono esserci né critica né giudizio di valore, che sono i fondamenti di una cultura libera e socialmente consapevole, è inoltre indispensabile che si aprano alla cultura contemporanea e compiano una necessaria trasformazione da «musei patrimoniali» a «musei funzionali»41. Il museo patrimoniale, basato sull’accrescimento delle collezioni, aveva una sua ragion d’essere all’interno di un sistema capitalistico teCLa - Rivista che guardava all’opera d’arte, da un lato come importante e sicura forma d’investimento, dall’altro come strumento di promozione, da parte delle società imprenditoriali, della propria immagine, vera e propria operazione di marketing. Entrato in crisi quel tipo di organizzazione sociale, non avrebbe più senso un museo, specie se d’arte contemporanea, basato su un valore, quello della proprietà dell’oggetto, non più attuale. Inevitabilmente il nuovo museo deve rispecchiare le nuove dinamiche della società, che investono tutti i settori della cultura, e in primo luogo puntare sulla capacità di comunicazione e sull’attivazione di servizi. Ad Argan è perfettamente chiaro come il potere del futuro non stia più nel possesso materiale di beni, ma nella capacità di controllare e guidare l’informazione e la comunicazione. Il museo può ancora educare alle libere scelte, al confronto, all’esercizio della critica come strumento di libertà. Il problema, avverte, non è quello di educare dall’alto le masse ai valori della cultura e dell’arte contro l’impoverimento spirituale dilagante e contro la mercificazione della cultura stessa. Il compito del museo moderno non è quello di fornire delle alternative di gusto ma di educare all’esercizio della critica, di porsi come attivatore di crescita e di sviluppo culturale nei confronti della città. Esso sarà strutturato come una «attrezzatura temi di Critica e Letteratura artistica 176 numero 3 - Maggio2011 scientifica specializzata per la ricerca estetica»42 e come uno spazio esposizione permanente45 e, senza mettere in discussione la proprietà in cui si possa ancora realizzare un incontro reale tra l’artista e il pubblica del patrimonio culturale, tende a svincolare l’istituzione suo pubblico, una nuova scena urbana che consenta di utilizzare le museale da un rigido controllo statale, e a prevedere un sistema di moderne tecnologie per fare esperienza viva della storia, spazio nel musei collegati tra loro e con più avanzati istituti e centri di cultura. quale il visitatore Un luogo di incontro, sperimentazione e ricerca. La nuova scena urbana dell’incontro tra l’artista è costretto a sperimentare, a e il suo pubblico, tra l’opera compiere atti percettivi predisposti e controllati da quel e il suo fruitore, ma anche e tecnico della percezione che è, soprattutto, luogo di incontro oggi l’artista43. della civitas, nuova piazza, centro E ancora: di una polis moderna e funzionale, che recupera all’interno del la metodologia, mettere a museo il suo rapporto con le punto l’attrezzatura della sperimentazione estetica, ma radici storiche e umanistiche deve anche fissare i precedenti della propria cultura. Ciò da storici della ricerca; dimostrare cui il museo moderno non può che non da oggi gli artisti prescindere, tanto più nell’epoca contestano il sistema, anzi hanno Londra, Tate Modern. sviluppato entro il sistema (prima della riproducibilità tecnica che fosse il sistema a metterli dell’opera d’arte, è il rapporto fuori) una critica del sistema44. con gli originali. Il museo deve rimanere il luogo in cui si fa esperienza Da questo punto di vista Argan è certamente un precursore. Giunge dell’originale, dell’autenticità come valore, il luogo in cui l’unicum che è addirittura a preconizzare un museo nel quale non vi sia alcuna l’opera continua a intercettare nel presente la nostra coscienza46. Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 177 numero 3 - Maggio 2011 Perché il museo d’arte contemporanea possa assolvere il suo difficile compito e diventare però realmente un centro propulsore di Roma, MAXXI , interno. vita, cioè non soltanto un contenitore di opere ma un organismo dinamico, capace di attivare spinte culturali forti sul tessuto urbano, e dotato come tale di una sua precisa azione urbanistica, fondamentale è la sua «localizzazione»47. Argan non ha dubbi sul fatto che il museo difficile, la cui riuscita non sempre è proporzionale agli investimenti, sia economici che organizzativi. Anche musei imponenti per il progetto che li sosteneva e per gli investimenti che vi sono stati destinati, hanno spesso fallito questo fondamentale obiettivo. Non a caso egli cita, come esempio significativo, il Beaubourg. Per molti anni il Centre George Pompidou, con la sua natura volutamente irriverente, provocatoria, capace di segnare una cesura profonda con un certo monumentalismo tipico dell’architettura museale48, è stato l’icona del museo contemporaneo, tappa fondamentale, come sottolinea Franco Purini, del passaggio dal museo tradizionale, patrimoniale e conservatore, all’odierno museo dell’iperconsumo49. E, come ogni icona, è divenuto oggetto di un acceso dibattito culturale. Argan considera il Centre Pompidou una grande macchina organizzaParigi, Centre George Poumpidou, esterno. tiva, un luogo in funzionale, contrariamente al museo d’arte antica, tradizionalmente collocato nei centri storici, possa assolvere al meglio la sua funzione se collocato in zone periferiche della città. Il museo può divenire allora non solo luogo di crescita e di formazione, ma una struttura capace di attivare sul territorio un’intensa attività culturale e di contrastare l’isolamento delle periferie. Si tratta di un compito teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 178 numero 3 - Maggio 2011 cui si fa un’importante e meritoria operazione di divulgazione da istituzione culturale, comunque benemerita, a «direttrice culturale, ma dove l’arte viene «consumata», non «prodotta». urbana» 50; è risultato incapace di porsi come «centro» urbano, come «faro che irradia» 51 la città circostante 52. Il museo parigino cioè, secondo il critico, a dispetto della sua struttura polifunAngelo Trimarco ha zionale e della sua sottolineato a tal proimmagine aperta alla posito come Argan sia multiculturalità, non stato poco favorevole è riuscito a proporsi a quei musei definiti come spazio critico in «archisculture» che si cui l’arte «si fa», non è impongono sul tessuto riuscito a trasformarsi in urbano con la forza luogo della creatività in imponente della loro atto. immagine, finendo per A partire dalla sua offuscare, con la loro collocazione urbana, capacità seduttiva, la nel centro storico di percezione delle opere Parigi, assolutamente che vi si conservano 53. dissonante con la sua Negli ultimi venti anni Guggenheim, Bilbao. struttura in acciaio e l’immagine e la funzione cemento, secondo Argan, il Beaubourg non interagisce veramente del museo nel contesto urbano sono radicalmente mutate. con la natura del quartiere parigino, non attivando un dialogo Oggi l’idea di una localizzazione decentrata dei musei costruttivo con lo spazio urbano, non ha compiuto il salto d’arte contemporanea è considerata in parte superata. Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 179 L’ numero 3 - Maggio 2011 architettura dei nuovi musei, o gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli antichi, sono quasi tutti volti al recupero, anche urbanistico, della centralità della funzione museale54. La tendenza più diffusa è quella della costruzione di vere sculture urbane, architetture che si impongono per l’originalità delle loro forme, per la forza comunicativa della loro immagine e talvolta sembrano ingaggiare una sfida con le opere che sono chiamate ad esporre, quasi volessero divenire musei di se stesse55. Proprio il contrario di quella essenzialità, di quella discrezione formale più volte invocata da Argan. Dunque nel momento in cui si celebra il centenario della nascita del grande critico torinese viene spontaneo interrogarsi sull’attualità della concezione arganiana dei musei. In attesa di leggere gli atti dei numerosi convegni che si sono succeduti su questi temi56, ritengo che l’attualità delle tesi arganiane stia tutta proprio nel riconoscimento di una funzione “urbanistica” del museo quale possibile «attivatore» di crescita morale e civile della città, idee forse attuali proprio in quanto allora erano «troppo avanti», utopistiche57. Lo dimostra lo spazio sempre più ampio che alla questione del rapporto museo-città viene riservato nell’ambito del dibattito culturale contemporaneo58. teCLa - Rivista Qualunque sia l’idea di museo che si voglia portare avanti oggi, asettico contenitore architettonico, laboratorio scientifico e di ricerca o archiscultura che si impone come “logo urbano”, è indubbio che il museo rappresenti attualmente una delle poche istituzioni capaci ancora di far valere la propria forza simbolica positiva. Come scrive Angelo Trimarco sulla scia delle tesi arganiane, il museo come luogo d’incontro e di crescita civile ma anche di svago e di divertimento, ha preso il posto un tempo occupato dalle cattedrali o dai palazzi del potere ed è divenuto il luogo a partire dal quale è stata spesso ripensata la forma di una città; agisce così da “catalizzatore”, capace di attivare una ricostruzione dell’identità cittadina59. In alcune circostanze l’intervento, non stravolgendo e non modificando completamente la percezione dell’immagine urbana, è riuscito a porsi come un elemento aggregante e risignificante60. In molti casi poi la nuova architettura museale è divenuta l’occasione per attuare un’opera di risanamento del tessuto urbano, recuperando architetture industriali dismesse e attivando un processo d’interazione con il territorio circostante, creando all’interno delle città nuovi percorsi culturali, alternativi rispetto a quelli storici e tradizionali. Esempio tra i più riusciti di questa nuova tipologia di architettura museale la Tate Modern di Londra61. Oggetto di analogo intervento di riuso, anche se di proporzioni più limitate è stata in temi di Critica e Letteratura artistica 180 numero 3 - Maggio 2011 Italia la Centrale Montemartini, oggi polo decentrato dei Musei che Argan considerava l’unico ruolo possibile per l’Urbs, quello Capitolini, realizzato nei locali della prima centrale termoelettrica di di capitale culturale, con l’apertura di due nuovi grandi musei, il Roma. Scelto nel 1997 come sede per un’esposizione temporanea MAXXI e l’ampliamento del MACRO. dal titolo Le macchine e gli dei, è poi divenuto, a La struttura architettonica del MAXXI, partire dal 2005, sede espositiva permanente aperto al pubblico nel maggio 2010, ma già delle nuove acquisizioni dell’istituzione da anni fruibile come work in progress, primo capitolina e si pone, insieme alla vicina sede museo in Italia destinato all’architettura e universitaria di Roma Tre, come importante alle arti del XXI secolo, va ad innestarsi centro di sviluppo e di rivalutazione del sul preesistente complesso militare dell’ex quartiere Ostiense. caserma Montello e va ad inserirsi in un Dopo anni di stasi, durante i quali l’appello quartiere di Roma, il Flaminio, oggetto di studiosi come Argan era rimasto negli ultimi anni di una forte opera di inascoltato, anche l’Italia ha visto il nascere risemantizzazione62. Non opera isolata di nuovi spazi museali destinati all’arte il MAXXI, ma inserita all’interno di una contemporanea (dal MART di Rovereto riqualificazione dell’area, che coinvolge al MADRE di Napoli, dal Museo d’Arte anche gli importanti impianti sportivi che Contemporanea del Castello di Rivoli vi sorgono, può contare soprattutto sulla Giulio Carlo Argan in un’immagine all’ampliamento della GNAM, più volte forte attrazione esercitata dall’Auditorium degli anni ’50. auspicato, come si è già detto, dallo stesso di Renzo Piano. Il Parco della Musica, Argan, e per il quale si era battuto da storico dell’arte e da sindaco). sede della prestigiosa Orchestra Santa Cecilia, infatti, con le sue tre Negli ultimi mesi Roma, proprio mentre le veniva riconosciuto il sale, vere casse di risonanza che si aprono nel cielo della capitale, nuovo status giuridico di Roma Capitale, è tornata a ricoprire quello affiancate da biblioteche, spazi multimediali, spazi espositivi, ma Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 181 numero 3 - Maggio 2011 anche bar, ristoranti, bookshop, tende a porsi oggi come uno dei principali poli culturali della città, luogo di incontro tra la cultura tradizionale e nuove forme di sperimentazione e di ricerca e sempre più connotato come spazio ove si attua una continua fusione tra le varie forme d’arte. In questo contesto, la realizzazione del MAXXI si inserisce come polo dialettico, capace di dialogare con la prestigiosa istituzione, come spazio fluido, di passaggio e interconnessione, capace di determinare insieme ad essa, una forte concentrazione di funzioni culturali aperte al contemporaneo, in un’area storica della città63. Nell’intento della progettista c’era l’intenzione di creare un luogo di svago e di divertimento, che fosse allo stesso tempo luogo di crescita culturale per i cittadini, offrendo loro un’alternativa concreta e possibile ai “non luoghi” dei centri commerciali. Il museo, che non teme di utilizzare materiali moderni come l’acciaio e il vetro e colori come il rosso, vuole tuttavia dialogare con la città, creare con essa un continuum, a partire dall’uso del basalto per la pavimentazione delle terrazze, lo stesso materiale con cui sono realizzati i marciapiedi di Roma, e dalla presenza sul tetto di fontane a sfioro, con un richiamo evidente ad “altre” fontane che da secoli segnano fortemente l’imago urbis. Ma se musei come la Tate Modern, il British, la nuova sede del MACRO e per certi versi lo stesso MAXXI, hanno mantenuto, nonostante la modernità dell’architettura, un rapporto di dialogo con la storia e il contesto urbano nel quale sono inseriti, diversa è la valutazione che si può fare a proposito delle cosiddette «archisculture», architetture museali che tendono invece a rompere, almeno sul piano architettonico, e quindi visivo, un legame con la struttura dei vecchi centri urbani e a imporsi con la forza dirompente del loro impatto estetico. Certamente il museo che più di tutti ha fatto e fa discutere in tal senso è il Guggenheim di Bilbao. Simbolo del museo-logo, opera A ltro grande evento per Roma l’ampliamento del MACRO, il Museo dell’Arte Contemporanea di Roma, già inaugurato, ma la cui apertura definitiva al pubblico è avvenuta il 4 dicembre 2010. Il nuovo museo progettato da Odile Decq, un parallelepipedo trasparente dal “cuore rosso”, ha il suo punto di forza nelle terrazze, concepite, come ha lei stessa dichiarato, come delle piazze-giardini, come luogo di incontro aperto ai cittadini della capitale. Ho voluto regalare loro un modo di star bene e d’incontrarsi. Una nuova forma di piazza, che ricorda le terrazze romane e che emoziona. Uno spazio che, grazie all’incontro con la cultura, spinge a farsi delle domande. Non un luogo morto64. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 182 numero 3 - Maggio 2011 aveva evidenziato l’incapacità di interazione con il contesto urbano architettonica che certamente è riuscita ad imporsi nell’immaginario e del quale Ciorra sottolinea il carattere autoreferenziale, processo collettivo con una forza dirompente, esso è stato tuttavia oggetto che ha raggiunto il livello massimo con il Guggheneim di Gehry66. di accesissimi dibattiti e di critiche infiammate. Secondo Joseph Non a caso il Beaubourg di Renzo Piano e Richard Rogers, il Nuovo Rykwert, è riuscito a costituirsi non solo come luogo di attrazione Louvre, ripensato da Ieoh Ming turistica ma addirittura ha avuto Pei, e naturalmente il Guggheneim un effetto altamente positivo nel di Bilbao sono considerati da controllo del separatismo basco65. Franco Purini emblemi dei musei Eppure il “caso Bilbao” viene dell’iperconsumo. considerato da molti studiosi Un museo, quello dell’iperconsumo, come punto di arrivo di una nel quale l’arte viene «consumata»67, crisi d’identità della tradizionale al pari di una merce qualunque, in funzione museale, e di conseguenza qualche modo opacizzata dalla stessa della stessa istituzione museo, architettura museale: quest’ultima sempre più avviata da un lato verso tende a porsi come «edificio logo», operazioni di marketing turistico immagine seduttiva ma al tempo e di utilizzazione commerciale, stesso scarnificata della città, dall’altro ormai scollegata dalla incapace di intessere un osmotico realtà urbana e dal contesto di scambio, una vera comunicazione e riferimento logico, sempre più Giulio Carlo Argan in un’immagine degli anni ’80. interazione con il tessuto urbano68. preoccupata di interagire con la Questi contenitori accostano generi artistici assolutamente difdimensione “mondo”. Si tratta di un processo che, come sottolinea ferenti e secondo nessun criterio scientifico o storico. Il rischio Pippo Ciorra, ha avuto inizio proprio con il Beaubourg, di cui Argan Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 183 numero 3 - Maggio 2011 più forte, avverte Purini, per questi musei, che somigliano molto ai grandi centri commerciali, è quello della perdita dell’identità spaziale e temporale; essi non dialogano più con il contesto urbano, non lo caratterizzano ma lo dominano, divengono icone di una città metropolitana ma rimangono incapaci, come del resto sosteneva a gran voce Argan per il Beaubourg, di vivificarlo e di far sì che si attui quella che è una delle prime funzioni del museo, cioè la costituzione di uno spazio critico, luogo in cui si fa esperienza “critica” dell’arte. Viene da chiedersi a questo punto, insieme a Salvatore Settis69, quale possa essere, nel contesto molteplice del contemporaneo, che oscilla tra musei-archisculture, macchine dell’iperconsumo dove la cultura diviene un gadget dal valore aggiunto70 e tendenza ad una musealizzazione diffusa, che si estende al territorio e agli spazi urbani e che in nome di una politica conservativa, sottrae, talvolta con eccessiva facilità l’opera al contesto, de-storicizzandola, quale possa essere la formula che consente di mediare esigenze conservative e di tutela, istanze estetiche e funzione educativa. L’unica risposta possibile sembra essere proprio quel rapporto con la città, che è rapporto storico, ed è rapporto osmotico e dialettico, incontro tra il futuro e il preesistente, sul quale può costituirsi la costruzione di un’identità culturale della civitas moderna71. Rapporto con la città che è cosa diversissima dalla musealizzazione della città. Argan, già negli anni ’70, era contrario a mettere in atto un processo di questo tipo, convinto che l’unico modo per mantenere in vita i centri storici non fosse quello di relegarli a funzioni turistiche ma di riportarvi dentro la vita, di potenziarne le funzioni culturali, di farvi tornare gli abitanti. Nella riflessione di Settis sembrano riecheggiare, aggiornati alla situazione contemporanea, gli interrogativi di Argan non solo sulla funzione, ma addirittura sulla reale capacità di sopravvivenza dei musei, almeno nella loro forma tradizionale. L’intervento di Settis sembra muoversi su una sorta di continuum ideale con il percorso tracciato da Argan. Richiama infatti l’attenzione sul fondamentale rapporto tra il museo e la città, sostenendo con forza la tesi secondo cui il museo, quasi come una nuova piazza urbana, si pone come luogo dell’identità civica, luogo in cui è possibile fare esperienza del senso di appartenenza ad una comunità politica e ai suoi valori storici72. Colpisce, quasi a sottolineare questo senso di continuità con l’idea arganiana di museo e di città, il riferimento ad un «sistema di relazioni» che è uno dei fondamenti su cui Argan costruisce l’intera teoria sulla città ma soprattutto l’insistenza sulla necessità di fare esperienza diretta, attraverso l’arte, dei valori della civitas e sull’importanza del recupero di una coscienza storica dell’essere cittadini, certamente favorita dalla fruizione critica, e ovviamente teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 184 numero 3 - Maggio 2011 libera, del patrimonio artistico, all’interno e fuori dai musei, come possibilità di salvezza dell’arte e della città. Già nel 1968 Argan scriveva: critico militante, sindaco di Roma, Catalogo della Mostra documentaria (Roma, 28 febbraio - 30 aprile 2003), a cura di C. Gamba, Bagatto Libri, Roma, 2003, pp. 31-36; V. Russo, Giulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza, Nardini, Firenze 2009; M. Serio, Al centro delle strutture di tutela: il rapporto con Bottai, in Giulio Carlo Argan. Storia dell’arte e politica dei beni culturali, a cura di G. Chiarante, Graffiti, Roma 2002, pp. 21-27; O. Ferrari, Dalle riforme del ’39 agli anni del dopoguerra, ibid., pp. 28-38. 2 G.C. Argan, L’ordinamento della Galleria e del Museo della Ceramica di Pesaro (1938) ripubblicato in Id., Promozione delle arti, critica delle forme, tutela delle opere. Scritti militanti e rari (1930-1942), a cura di C. Gamba, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2009, pp. 226-230: p. 226. In particolare, del nuovo allestimento della Galleria Argan apprezza la scelta del curatore di esporre solo le opere più significative sul piano artistico, riservando delle sale didattiche a quelle aventi puro carattere documentario; loda poi le tinte neutre delle pareti che esaltano i valori cromatici delle ceramiche esposte, e ancora apprezza l’uso di materiali moderni per la realizzazione delle teche, attraverso cui si realizza l’attualizzazione delle opere. Ibid., pp. 228-230. 3 Id., Progetto di Riordinamento della Real Galleria Estense di Modena, (1935), in “Annali dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli”, 12, 2002, pp. 147-161; Id., Le mostre degli antichi capolavori italiani a Chicago e a New York: la mostra di Chicago, (1940), in V. Russo Promozione delle arti…, pp. 258-261. Si veda su questi argomenti anche V. Russo, Museografia e restauro, in Ead., Giulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza…, pp. 63-70. 4 In merito alla possibilità di applicare all’arte il metodo storico, fondamentale è il saggio La Storia dell’arte che Argan pubblicherà nel 1969 (Cfr. G.C. Argan, La storia dell’arte, in “Storia dell’arte”, I, nn. 1-2, 1969, pp. 5-37, ripubblicato in Id., Storia dell’arte come Storia della città, a cura di B. Contardi, Editori Riuniti, Roma 1984, pp. 19-81), vero e proprio manifesto programmatico del suo pensiero critico, dedicato «alla venerata memoria di Lionello Venturi ed Erwin Panofsky». Da Panofsky Argan trae l’assunto secondo cui lo studio dell’arte si pone come disciplina umanistica, fondata sulle categorie storiche di spazio e tempo (Cfr. La storia dell’arte come disciplina umanistica, in E. Panofsky., Il significato nelle arti visive, Einaudi, Torino 1999, pp. 3-28, e Il problema dello stile nelle arti decorative, in Id., La prospettiva come forma simbolica. E altri scritti, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 151-154: p. 153. Cfr. R. Priori, infra. Per un approfondimento su questo tema si veda S. La sola possibilità che rimane all’arte di non essere assorbita e atomizzata dall’apparato tecnologico è di non perdere, di conservare attraverso il museo il contatto con la propria storia: proprio perché sia più chiara e portante la sua azione politica (nel senso di Baudelaire) nel presente. L’arte non deve porsi come recupero della perduta libertà degli istinti, ma come aspro processo di liberazione, che ha i suoi precedenti storici ed è ancora molto lontano dal suo compimento. Non vogliamo la libertà dalla civiltà-repressione, ma la liberazione della civiltà tecnocratica. Non vogliamo fermare il progresso, vogliamo che il suo ritmo batta con il ritmo storico della civiltà73. ______________________ 1 La carriera di Argan come conservatore inizia nel 1933 con la nomina ad ispettore alle Belle Arti, ruolo svolto in primis presso la Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna di Torino, poi, dall’agosto del 1934, presso la Regia Galleria Estense di Modena; nel 1935 è trasferito alla Soprintendenza alle Gallerie di Roma, presso la Direzione Generale Antichità e Belle Arti e, nominato nel 1936 Soprintendente di II classe, viene comandato al Ministero, dove svolgerà la sua attività fino al 1956, anno della nomina a Professore Straordinario di Storia dell’Arte Medievale e Moderna presso l’Università di Palermo. Cfr. G.C. Argan, Intervista sul Novecento, rilasciata a M. Perelman e A. Jaubert, Graffiti editore, Roma 2005, pp. 11-22; Giulio Carlo Argan. Progetto e destino dell’arte, Atti del Convegno (Roma, 26-28 febbraio 2003) a cura di S. Valeri, in “Storia dell’Arte”, supplemento al n. 112, settembre-dicembre 2005; Giulio Carlo Argan (1909-1992). Storico dell’arte, Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 185 numero 3 - Maggio 2011 Tedesco, Panofsky: la scienza dell’arte e il problema del tempo storico, in Id., Il metodo e la storia, Aesthetica Preprint, Supplementa, Centro internazionale Studi di Estetica, Palermo 2006, p. 15). «La storia dell’arte è la sola possibile scienza dell’arte» scrive Argan nel 1969 (G.C. Argan, La storia dell’arte…, p. 21). Sulla scia di Panofsky, anche per Argan giudicare storicamente un fatto, e l’opera d’arte si pone come il più elevato esito del fare umano, significa in primo luogo analizzarne la capacità di funzionare all’interno di un determinato contesto culturale, cogliere il rapporto tra quel fatto che è l’opera, e innumerevoli altri fatti, evidenziare il rapporto di necessità intercorrente tra l’opera e la dimensione spazio-temporale di cui è espressione, riconoscere l’opera d’arte come una struttura complessa, nella quale interagiscono, con pari efficacia, una parte iconica e una semantica, entrambe inserite in un rapporto relazionale con la storia della cultura (riconoscere quindi a pieno titolo la Kulturgeshichte come componente essenziale della storia dell’arte), accertare se essa è ancora in grado di parlare alle coscienze, di interagire con la società. Significa quindi porre l’opera non come fatto isolato e casuale, opera del genio avulsa dal contesto, ma al contrario valutarla come esito complesso e articolato di un agire finalizzato, che, in quanto tale, si pone come agire storico, l’espressione più elevata di un complesso sistema relazionale. Il valore aggiunto dell’opera d’arte, ciò che la rende un unicum, è proprio il bagaglio di esperienze e conoscenze che è insito nel fare umano, che è un fare storico. «La materia supera così la propria inerzia, il proprio limite fisico originario; entra in rapporto col mondo, diventa portatrice di esperienza storica», scrive Argan in Progetto e destino, Il Saggiatore, Milano 1968, p. 21. Mentre però Panofsky, come sottolinea Salvatore Tedesco, riconosce all’opera d’arte una doppia natura, che è insieme storica, e quindi come tale condizionata dal tempo storico, e al tempo stesso sovrastorica, ovvero proiettata idealmente verso la ricerca di universali e incondizionate condizioni di validità (Cfr. S. Tedesco, Panofsky: la scienza dell’arte…, p. 18), l’analisi metodologica di Argan sembrerebbe restringere il proprio campo e limitarsi a considerare la dimensione storica, spazialmente e temporalmente determinata, dell’opera d’arte. Mentre quindi Panofsky mira alla costruzione di una teoria dell’arte che coincida idealmente con la storia dell’arte, il metodo di analisi proposto da Argan si muove esclusivamente sul piano dell’analisi storica. Scopo del giudizio storico, scrive Argan, non è l’accertamento dell’artisticità dell’arte, ma della sua capacità di funzionare all’interno di un dato sistema culturale, che è un sistema relazionale, della capacità di farsi portatrice di valori che sono valori culturali di un dato luogo e di un dato tempo, e di verificare la validità o meno di quei valori ogni qual volta l’opera si sottopone al giudizio della coscienza, ovvero pretende di costituirsi come ‹‹assoluto presente››. In tal senso, avverte Argan, la storia dell’arte è una storia speciale in quanto a differenza della storia politica essa non si compie in assenza bensì in presenza dell’evento. L’Hic et nunc dell’opera d’arte, il suo esserci e il suo attualizzarsi, il suo divenire sempre presente al presente della coscienza che la giudica, il suo ‹‹flagrante accadere›› costituiscono gli elementi che differenziano la storia dell’arte dalla storia in generale (Cfr. G.C. Argan, La storia dell’arte…, p. 30). 5 Benjamin sosteneva che l’esponibilità cui l’opera era sottoposta nella cultura contemporanea, anche all’interno dei musei, aveva agevolato il processo di allontanamento del pubblico dall’opera reale in cambio di una sempre maggiore diffusione del suo valore iconico. Cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 2000, pp. 27-29. Sulla stessa linea si muove E. Migliorini, L’arte e la città, Fiorino, Firenze 1975, pp. 27-30, per il quale il museo sancisce definitivamente la separazione non più sanabile tra l’opera d’arte e la città. 6 G.C. Argan, L’arte nel quadro della cultura moderna, in Id., Storia dell’arte come storia della città…, p. 96. 7 Sulla funzione educativa dei musei nel pensiero di Argan si veda pure C. De Carli, Argan: L’arte di educare, in Rileggere Argan. L’uomo. Lo storico dell’arte. Il didatta. Il politico, Atti del Convegno (Bergamo, 19-20 Aprile 2002), a cura di M. Lorandi e O. Pinessi, Moretti & Vitale, Bergamo 2003, pp. 94-110. 8 G.C. Argan, Il Museo come scuola, in “Comunità”, n. 3, 1949, pp. 64-66; Id., La funzione educativa dei musei, s.d. [ma 1951-1954], ACS, Min. Pubbl. Istr., Dir. Gen. AA.BB.AA., III Div., 1929-1960, b-307, in V. Russo, Giulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza…. Anche Lionello Venturi era stato un convinto assertore della finalità strettamente didattica del museo e dell’importanza di un’intensa collaborazione scuola-museo. Si veda in proposito L. Venturi, I nostri musei d’arte moderna, in “Ulisse”, anno XI, fasc. XXVII, 1957, p. 1372-1374. 9 Il pensiero di Argan è sostanziato dalla condivisione delle tesi di Herbert Read, oltre che da una neppure troppo velata accettazione dell’impostazione didattica del Bauhaus, al cui interno l’artista, come nel caso di Klee, è esso stesso teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 186 numero 3 - Maggio 2011 ripropone continuamente come un problema che esige una soluzione nel presente della nostra coscienza, l’opera d’arte è veramente assoluta, universale, eterna». 16 Secondo Argan le esposizioni dovranno avere tutte le caratteristiche necessarie alla corretta visione delle opere esposte: dalla neutralità architettonica e tonale dello spazio espositivo alla presenza di pareti divisorie mobili, dalla corretta illuminazione, da adattare caso per caso alle opere, alla realizzazione di intere pareti in vetro, caratteristiche che solo «un’architettura modernissima» e progettata per tale scopo può avere. 17 G.C. Argan, I musei allestiti in edifici storici, (1950), in V. Russo, Giulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza…, pp. 151-157: p. 151. Cfr. sullo stesso tema Id., L’architettura del museo, in “Casabella - Continuità”, XVIII, 202, agosto-settembre 1954, p. V; Id., Problemi di museografia, ivi, XIX, 207, settembre-ottobre 1955, pp. 64-67. 18 Argan ritiene validi questi criteri soprattutto per i musei d’arte decorativa, perché la salvaguardia dell’unità documentaria ed estetica tra suppellettili e struttura architettonica contribuisce a sottolineare la continuità tra arti maggiori e minori; cita come esempio virtuoso il Museo di S. Martino della Certosa di Napoli, dove il mantenimento dell’unità armonica tra arti decorative e struttura del museo non risulta minimamente intaccato dall’applicazione di moderni criteri di allestimento. A tal proposito non manca di sottolineare l’importanza di incentivare la nascita e il potenziamento di musei di arte decorativa e applicata, che potrebbero trovare degno contesto in ville e palazzi di valore artistico sparsi per il territorio italiano, anch’essi esposti ad un altissimo rischio sul piano conservativo, e che costituirebbero tra l’altro, un documento importante delle varie tradizioni artistiche locali. Ibid., p. 153. 19 Ibid., p. 154. 20 Ibid., p. 155. 21 «Per un antico edificio» scrive Argan «non v’è miglior riuso che farne un museo moderno, è giusto che il lascito storico di una città stia nei vecchi centri. Per Scarpa era questione di principio, pensava che il restauro rigorosamente filologico di un monumento e la sistemazione modernissima di un museo potessero benissimo coesistere e collimare, il principio di metodo dell’operazione era il medesimo: si trattava sempre di riportare dei testi antichi alla condizione di perfetta attualità che era anche recupero della loro autenticità. La galleria palermitana, come dello un educatore, proiettato verso la tensione ideale della ricerca, della continua innovazione, e per il quale l’educazione artistica non può disgiungersi dalla continua ricerca di valori, formali ma anche sociali. Cfr. G.C. Argan, Arte, scuola e città, in “Metro”, n. 15, 1968, pp. 4-12; Id., Il museo d’arte moderna, in “Metro”, n. 14 (1968), pp. 5-11. Argan fu traduttore e curatore dell’opera di H. Read, Educare con l’arte, a cura di G.C. Argan, Edizioni di Comunità, Roma 1954. 10 Tanto per Argan quanto per Read l’arte contribuisce a sviluppare e potenziare le capacità espressive dell’uomo, facilitando quel processo di integrazione fra l’individualità del singolo e la comunità che è caratteristica, e al tempo stesso condicio sine qua non, di una società democratica. Sulla relazione tra la concezione educativa del museo e il rapporto con le teorie di Read e Dewey si veda pure E. Bonfanti, M. Porta, Città, museo e architettura. Il gruppo BBPR nella cultura architettonica italiana 1932-1970, Vallecchi, Firenze 1973, pp. 150-151. 11 G.C. Argan, Il Museo come scuola…, p. 65. 12 Id., Prefazione a H. Read, Educare con l’arte…, pp. 9-17. 13 Si confrontino su questo punto le tesi arganiane con gli attuali studi di museologia e si potrà constatare come la posizione del critico torinese sia ancora oggi di grande attualità. Cfr. G. Pinna, Una storia recente dei musei, in A. Lugli, G. Pinna, V. Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 2005, p. 10. Sulla funzione sociale e politica dei musei concorda pure Adalgisa Lugli, che riconosce al museo del Novecento lo status di «simbolo», «punto di riferimento culturale di prima grandezza»; cfr. Ead., Museologia, in A. Lugli, G. Pinna, V. Vercelloni, Tre idee di museo…, p. 48; A. Mottola Molfino, Il libro dei musei, Allemandi, Torino 1991, pp. 147-166. 14 Argan osserva che la monumentalità degli edifici storici che ospitano importanti collezioni, quando non costituisce essa stessa un unicum, sul piano storico-documentario, con le opere che vi si conservano, finisce per essere fortemente limitante nella lettura e nell’interpretazione critica delle opere. Infatti, l’impossibilità di intervenire sulla distribuzione degli spazi, la loro mancata organizzazione in chiave funzionale, l’assenza frequente di laboratori, biblioteche, strumenti didattici, sale destinate a convegni, impedisce ai musei storici italiani di assolvere alla loro funzione educativa. 15 G.C. Argan, I Musei d’arte e il loro moderno ordinamento, in V. Russo, Giulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza…, p. 141, osserva che: «Proprio in quanto si Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 187 numero 3 - Maggio 2011 26 Ibid., p. 41. 27 Ibid. 28 Argan osserva che un museo d’arte contemporanea che non sia in grado di offrire al suo visitatore, occasionale o abituale, un quadro rappresentativo della cultura contemporanea che è, per se stessa internazionale e multiculturale, è un museo che ha fallito la sua primaria funzione, quella educativa e formativa. 29 G.C. Argan, Un Museo non è un deserto, in “L’espresso”, XXI, n. 10, 9 marzo 1975, ripubblicato col titolo Musei Italiani in Id., Occasioni di critica, a cura di B. Contardi, Editori Riuniti, Roma 1981, pp. 48-49. Su questo tema si veda A. Mottola Molfino, Il libro dei musei…, pp. 147-166. La studiosa cita più volte le opinioni di Argan (ibid., p. 157, p. 162) in merito all’indebolimento delle funzioni culturali del museo, determinato dalle sempre più pressanti esigenze turistiche, e alla necessità di potenziarne la «funzione scientifico - culturale - didattica». Non condivide però l’idea arganiana del museo come scuola. Cfr. ibid., p. 129. 30 G.C. Argan., La crisi dei musei italiani, in “Ulisse”, anno XI, fasc. XXVII (1957), pp. 1397-1410, p. 1398. 31 Id., I musei d’arte e il loro moderno ordinamento…, p. 144. 32 Id., Musei d’arte moderna, in Museo perché, museo come…, p. 39. 33 Id., La crisi dei musei italiani…, p. 1399. 34 Argan avanza anche l’ipotesi di dotare i musei di mense, luoghi di ristoro, librerie che possano rendere più confortevole la permanenza degli studiosi all’interno dei musei, precorrendo per certi aspetti la Legge Ronchey sui servizi aggiuntivi. Si veda in proposito G.C. Argan, Il museo come problema architettonico e urbanistico, s.d., in V. Russo, Giulio Carlo Argan. Restauro, critica, scienza…, pp. 158-161. 35 Id., Musei d’arte moderna…, p. 45. Cfr. Id., La crisi dei musei italiani…, pp. 1400-1401: «Ma è certamente possibile avvicinare la struttura interna del museo a quella della mostra: evitare le sistemazioni fisse e monumentali, gli ordinamenti rigidi, le presentazioni solenni e immutabili». 36 C. Brandi, Il problema delle esposizioni, in “Ulisse”, anno XI; fasc. XXVII, (1957), pp. 1383-1391. 37 A. Chastel, L’uso della storia dell’arte, Laterza, Roma - Bari 1982, pp. 94-102. 38 Lo studioso condivide con Brandi la convinzione che, in ogni caso, l’organizzazione di una mostra debba essere subordinata alla messa in stato di sicurezza e alle ragioni di conservazione dell’opera. Cfr. G.C. Argan, La crisi dei stesso Scarpa il museo veronese di Castelvecchio, è un esempio di quella che potrebbe parere, ma non è, una coincidenza di contrari: l’antico e il moderno, Scarpa sapeva fare della puntuale critica dei testi un’invenzione artistica». Cfr. G.C. Argan, Introduzione, in G.C. Argan, V. Abbate, E. Battisti, Palazzo Abatellis, Novecento, Palermo 1991, p. 8. 22 Argan, in qualità di Ispettore Centrale al Ministero della Pubblica istruzione sottolinea la necessità di associare alla struttura conservativa dei musei italiani la funzione didattica, di dotare i musei di un direttore tecnico-scientifico con competenze didattiche, di potenziare le mostre, di collegare l’attività del museo alla produzione industriale e alle scuole d’arte, di dotare i musei italiani, sulla falsa riga di quelli americani, di uno staff tecnico specializzato nell’allestimento delle esposizioni. Cfr. Id., La funzione educativa dei musei (ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. AA.BB.AA., III Div., 1929-1960, b. 307), s.d. [ma 19511954], in V. Russo, Giulio Carlo Argan, Restauro, critica, scienza…, pp. 145-148. 23 Alla direttrice Argan riconosce il merito di avere colto l’importanza della trasformazione del museo in uno spazio funzionale, di aver dato voce, nei limiti del possibile, e pur nel rispetto dell’italianità dell’istituzione, ad una prospettiva internazionale, l’unica possibile per un museo che aspiri a essere espressione di una cultura moderna, mondiale e globalizzata, e ancora di aver aperto le porte alle donazioni di artisti come Burri, Capogrossi, Fontana e di aver esposto Pollock, Rothko, Mondrian, Picasso, Klee e tanti altri. Per l’ attività di Palma Bucarelli cfr. Palma Bucarelli: il museo come avanguardia, catalogo della mostra (Roma, 26 giugno 2009 - 17 gennaio 2010), a cura di M. Margozzi, Electa, Milano 2009. 24 A. Bonito Oliva, Care istituzioni. Intervista a Giulio Carlo Argan, in “Figure”, fasc. 2-3, 1982, pp. 19-25. 25 G.C. Argan, Musei d’arte moderna, in Museo perché, museo come, De Luca, Roma 1980, pp. 39-40, osserva che non era stata compresa l’importante funzione di un museo d’arte contemporanea per la crescita culturale della Capitale. L’Italia era rimasta per decenni indifferente davanti alle opere dei grandi maestri dell’arte contemporanea e si era lasciata spesso sfuggire opere di Manet, di Cézanne, di Matisse, di Picasso, e non solo per colpa dello stato ma per la responsabilità di tanti studiosi che non avevano fatto propria la battaglia per l’arte moderna, che non avevano aperto le porte del museo alle donazioni private dei grandi industriali del Nord. teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 188 numero 3 - Maggio 2011 comproprietà. Sarà un luogo attrezzato per la sperimentazione ad alto livello sui processi della comunicazione; dotato di apparecchiature scientifiche moderne, di un’estrema adattabilità, di una grande disponibilità di spazio e di mezzi. Sarà manovrato da una numerosa equipe di specialisti e di ricercatori. Sarà in rapporto con tutti i rami della ricerca scientifica e tecnologica. Sarà, infine, un centro di ricerca al cui funzionamento (e non gestione, come vorrebbero alcuni artisti ragionieri) dovranno partecipare, come nella scuola, tutte le “componenti”: artisti, critici, tecnici, consumatori. Sarà dunque una struttura capace di rinnovarsi continuamente, col proprio movimento stesso». 44 Ibid. 45 Id., Un’idea di Roma…, pp. 75-76. 46 Id., Musei d’arte moderna…, p. 43. Cfr. Id., La Storia dell’arte…, p. 30. 47 Id., Musei d’arte moderna…, p. 43. 48 Sul valore urbanistico del Beaubourg si veda R. Piano, Giornale di bordo, Passigli Editore, Firenze 2005, p. 28. 49 F. Purini, I musei dell’iperconsumo, in Museums. Next generation. Il futuro dei musei, Catalogo della Mostra (Roma 21 settembre 2006 - 29 ottobre 2007), a cura di P. Ciorra, D. Tchou, Electa, Milano 2006, pp. 51-55: p. 5; un’interpretazione analoga del Beaubourg è quella che si può leggere in S. Suma, Nuovi musei tra iperconsumo e ipertrofia, in Il museo all’opera. Trasformazioni e prospettive del museo d’arte contemporanea, a cura di S. Zuliani, Bruno Mondadori, Milano 2006, pp. 103-109. 50 Diversa è l’opinione di A. Mottola Molfino, Il libro dei musei…, p. 239. 51 G.C. Argan, Musei d’arte moderna…, p. 39. 52 Laddove invece la vocazione urbanistica è fortemente rivendicata da Renzo Piano: l’architetto ne sottolinea la capacità incisiva sul territorio e, al contrario di Argan, considera la collocazione del museo al centro della città indispensabile allo svolgimento della sua funzione urbana. Cfr. R. Piano, Giornale di bordo…, p. 30. 53 «Agli inizi degli anni Ottanta dell’altro secolo – e dunque sul limitare dei due millenni – ad Argan il nesso arte-architettura-città è sembrato ineludibile a condizione appunto che il museo diventi scena urbana, uno spazio vitale della città. Essenziale diviene perciò, nella sua riflessione la scelta del luogo. La sua speranza – è anche utopia – è che il museo della nostra contemporaneità, che distingue da quello d’arte antica, ospitato nei palazzi antichi del centro storico, nato dal farsi del lavoro quotidiano degli artisti, deve abitare una zona residenziale musei italiani…, pp. 1397-1410, in particolare pp. 1400-1401. 39 Ibid., pp. 1406-1407. Sul ruolo riconosciuto da Argan ai musei scrive M. Calvesi, Giulio Carlo Argan, in Giulio Carlo Argan. 1909-1992. Storico dell’arte, critico militante…, p. 14: «Al vertice della visione estetica di Argan si collocava l’idea (utopica se confrontata al presente, ma storicamente incarnata nei grandi modelli del Rinascimento) della città dell’uomo. Non una città-museo, ma una città dove i musei-scuola fossero il documento della pregnanza storica e civile dell’arte, e dell’arte mostrassero l’organico sistema, ovvero un sistema-guida della produzione, dal dipinto o dalla scultura all’oggetto di arredo e delle arti minori, e da queste matrici formali all’organizzazione dello spazio architettonico e urbanistico, e cioè appunto della città». 40 «[I musei] non devono servire a ricoverare opere d’arte sfrattate o costrette a battere il marciapiede del mercato. Non avrebbero spazio bastante e non è questo il loro compito. Dovrebbero essere istituti scientifici o di ricerca, con una funzione didattica aggiunta; ed essere i grandi e i piccoli nodi della rete disciplinare dell’archeologia e della storia dell’arte. Poche opere esposte permanentemente, anche nessuna; molto personale scientifico, ma studiosi aperti e non “conservatori”; molte mostre piccole e grandi, a rotazione, con il materiale dei musei integrato da prestiti. Nessuna dipendenza da ministeri e direzioni generali: gestione diretta da parte di uno scelto personale tecnico-scientifico. Modello per l’uso di quella veramente Gesamtkunstwerk che è la città. In altre parole il museo non dovrebbe essere il ritiro o il collocamento a riposo delle opere d’arte ma il loro passaggio allo stato laicale, cioè allo stato di bene della comunità: il luogo in cui davanti alle opere non si prende una posizione di estasi ammirativa, ma di critica o di attribuzione di valore». G.C. Argan, Intervista sulla fabbrica dell’arte, a cura di T. Trini, Laterza, Roma-Bari 1980, pp. 124-125. 41 Id., Musei d’arte moderna…, p. 43. Cfr. Id., Il museo d’arte moderna, in “Metro”, n. 14 (1968), pp. 5-11; Id., Un’idea di Roma, intervista di Mino Monicelli, Editori Riuniti, Roma 1979, p. 76. 42 Id., Il museo d’arte moderna…, p. 9. 43 Ibid., p. 10: «Il museo di domani, il museo di massa, non sarà più una mostra permanente di oggetti riscattati dal piano della merce a quello di modello di valore, dalla proprietà del privato a quella della comunità; e proposti ad un’amministrazione che, in ultima analisi, sarà soltanto la sublimazione del compiacimento della Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 189 numero 3 - Maggio 2011 nel 2002 dall’Accademia Nazionale di S. Luca in collaborazione con la DARC e la Triennale di Milano e coordinata da Franco Purini (si vedano I musei dell’iperconsumo. Materiali di studio, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 21 marzo 2002), a cura di P. Ciorra, S. Suma, Accademia Nazionale di San Luca, Roma 2003; il convegno Il museo all’opera. Trasformazioni e prospettive del museo d’arte contemporanea, tenutosi a Salerno il 25-26 novembre 2005, promosso dalla Cattedra di Museologia dell’Università degli Studi di Salerno e dalla Fondazione Filiberto Menna; il convegno Il Futuro dei Musei tenutosi a San Pietroburgo il 30 giugno 2006; la mostra tenutasi dal 21 settembre al 29 ottobre 2006 al MAXXI di Roma dal titolo Musei nel XXI secolo. Idee, progetti, edifici (su quest’ultima si veda Museums. Next generation…). 59 Cfr. A. Trimarco, Post-storia…, pp. 64-65. 60 Si pensi alla cupola di vetro e acciaio del British Museum, realizzata nel 2000 da Norman Foster, che mentre realizza all’interno del celebre museo londinese spazi destinati ai cosiddetti servizi aggiuntivi, crea al contempo una forma architettonica che, attraverso la trasparenza del vetro, pone in comunicazione le rovine greche con il cielo della metropoli contemporanea e realizza una sorta di agorà interna al museo, luogo di incontro e di comunicazione. 61 La Tate Modern, a Londra, realizzata nel 2000 da Herzog e de Meuron recuperando la struttura della dismessa centrale elettrica di Bankside, è riuscita ad attivare una ri-segnificazione del territorio – la realizzazione è parte di un più ampio progetto di riqualificazione del Waterfront fluviale della città, ai margini dei Docklands – sottolineata pure dalla contemporanea costruzione del Millennium Bridge, opera di Norman Foster, ponte che collega fisicamente e prospetticamente la Tate alla cattedrale di St. Paul, ma anche il tempio londinese dell’arte contemporanea alla City, cuore produttivo e finanziario di Londra, istituendo così un ponte ideale tra passato e futuro, tradizione e modernità, cultura ed economia. Sulla specificità dell’intervento architettonico si veda K. Powell, Tate Modern, in Id., New London architecture…, pp. 76-77; Id., Millennium Bridge, ibid., pp. 40-41; Millennium Bridge, in N. Foster, Catalogue. Foster and Partners…, pp. 204-205. Anche F. Purini, I musei dell’iperconsumo…, p. 55, riconosce alla Tate Modern la capacità di costituirsi come spazio capace di creare un dialogo significativo tra passato e contemporaneità all’interno del tessuto urbano londinese, un museo attivatore di cultura, «che non consuma la città». di massa, prossima alla città, un’area ampia e disseminata nel sociale. Per Argan è dunque più importante la collocazione urbanistica che l’immagine architettonica del museo, da pensarsi invece come «effimera, labile, volumetrica», in grado di accogliere funzioni e servizi informativi sempre più complessi». Cfr. A. Trimarco, Il museo. Arte e decostruzione, in Id., Post-storia. Il sistema dell’arte, Editori Riuniti, Roma 2004, p. 67. 54 M.C. Taylor, Dalla semplicità alla complessità: come cambia l’architettura museale, in Capolavori del Guggenheim. Il grande collezionismo da Renoir a Warhol, Catalogo della Mostra (Roma, 4 marzo - 5 giugno 2005), a cura di E. Siciliano, L. Dennison, Skira, Milano 2005, pp. 33-41; F. Dal Co, Il Guggenheim Museum: da tempio dell’arte non-oggettiva a museo globale, ibid., pp. 43-51. 55 Si veda in proposito anche A. Trimarco, Post-storia…, p. 64: «Così il Guggenheim Bilbao Museoa, oltre ad essere un’archiscultura, in antagonismo, si è detto riduttivamente, con l’arte – espone in maniera flagrante se stesso piuttosto che rispettosamente, il lavoro dell’arte – si pone anche, al culmine di una parabola inaugurata negli anni Settanta dal Centre Pompidou, come «catalizzatore delle trasformazioni urbane». 56 Si fa riferimento alle iniziative e ai convegni promossi dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Giulio Carlo Argan e in particolare al Convegno in onore di Giulio Carlo Argan, promosso dall’Accademia Nazionale dei Lincei, tenutosi a Roma il 19 novembre 2009 (con interventi di Salvatore Settis e Marisa Dalai Emiliani su Argan, il museo e la conservazione dei Beni Culturali); il Convegno Arte, Città, Politica. La battaglia per la cultura di Giulio Carlo Argan, Roma, 16 giugno 2010, promosso dall’associazione Bianchi Bandinelli; il Convegno internazionale promosso sempre dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario e dalla Fondazione Bruno Zevi sul tema: Progettare per non essere progettati: Giulio Carlo Argan, Bruno Zevi e l’architettura, tenutosi a Roma il 28 settembre 2010 presso l’Auditorium del MAXXI. 57 Cfr. M. Calvesi, Giulio Carlo Argan…, p. 14; E. Bonfanti, M. Porta, Città, museo e architettura…, p. 151 e nota 154; A. Trimarco, Post-storia…, p. 67. 58 Si ricordino, fra le numerose iniziative, registrate negli ultimi anni, la mostra Musei per un nuovo millennio. Idee, progetti edifici (Cfr. Musei per un nuovo millennio, Idee, Progetti Edifici, a cura di V. Magnago Lampugnani, A. Sachsa, Monaco - Londra - New York 2001); la ricerca e il convegno su I musei dell’iperconsumo, promosso teCLa - Rivista temi di Critica e Letteratura artistica 190 numero 3 - Maggio 2011 72 S. Settis, Ma il museo ha un futuro?…, p. 53. 73 G.C. Argan, Il museo d’arte moderna…, p. 10. 62 A. Vittorini, Il contesto urbano, il concorso, l’avvio dei lavori, in MAXXI. Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, a cura di P. Baldi, Electa, Milano 2006; Ead., Una nuova centralità per l’area flaminia, ibid., pp. 66-69. 63 Cfr. S. Settis, Roma al futuro, in MAXXI…, pp. 28-31; P. Baldi, La missione istituzionale, ibid., pp. 33-35. 64 L’incontro-Odile Decq, contro l’archistar system, a cura di F. Giuliani, in “la Repubblica”, 26 ottobre 2010. 65 Cfr. J. Rykwert, La seduzione del luogo. Storia e futuro della città…, pp. 295297. Sulla funzione svolta dal Guggenheim di Bilbao concorda pure M. Carta, Bilbao: rinnovamento urbano ad Abaidoibarra, in Id., Next city: culture city, Meltemi, Roma 2004, pp. 89-91, che considera l’edificazione del Guggenheim di Gehry come «l’azione pilota» di un piano di intervento volto al recupero delle aree urbane dismesse e al potenziamento della cultura urbana come risorsa per lo sviluppo e la crescita economica e sociale della città, a partire dalla riscoperta dell’identità geografica del luogo, in particolare dalla valorizzazione del waterfront. 66 P. Ciorra, No Building no party? La prossima generazione di musei, in Museums. Next generation…, pp. 10-15. 67 Cfr. A. Bonito Oliva, Musei. I supergadget nella città del 2000, in “la Repubblica”, 16 ottobre 2006. 68 F. Purini, I musei dell’iperconsumo, in Museums. Next generation…, pp. 51-55: p. 51. 69 S. Settis, Ma il museo ha un futuro?, estratto dall’intervento al convegno Il futuro dei musei tenutosi a San Pietroburgo il 30 giugno 2006, in “la Repubblica”, 30 giugno 2006, p. 53. 70 Si veda in proposito A. Bonito Oliva, Musei. I supergadget…, pp. 34-35. 71 Esempio interessante in Italia è quello del Museo MADRE di Napoli. La scelta fortemente voluta di concepire uno spazio per l’arte contemporanea come «museo aperto» nel cuore pulsante e vivo di una città storica come Napoli si è tradotta in un intervento dal forte significato urbanistico. Il museo infatti sorge all’interno dell’antico Palazzo Donnaregina, in pieno centro storico, ristrutturato e restaurato per l’occasione da Alvaro Siza, che ha curato un intervento discreto, quasi invisibile, dettato, come sottolinea Gravagnuolo (L’architettura dei musei d’arte…, p. 34) «dalla volontà di cancellare piuttosto che di aggiungere», riuscendo a realizzare uno spazio che dialoga con il centro della città, senza lacerarne il tessuto storico. Marcella Marrocco Il Museo negli scritti di Giulio Carlo Argan 191
Scarica