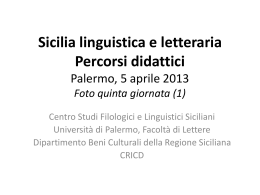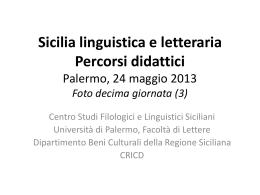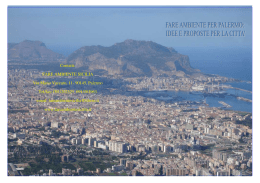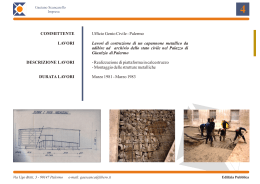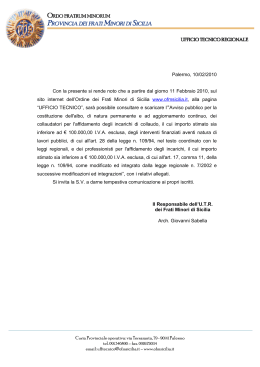Giovanni Evangelista Di Blasi Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia www.liberliber.it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Editoria, Web design, Multimedia http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia AUTORE: Di Blasi, Giovanni Evangelista TRADUTTORE: CURATORE: Insenga, Pompeo NOTE: Contiene un'appendice: Continuazione dei vicerè che governarono la Sicilia sotto i principi Borboni, di Pompeo Insenga DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/ TRATTO DA: Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia / di Giovanni E. Di Blasi ; seguita da un'appendice sino al 1842 / di Pompeo Insenga – Palermo : dalla Stamp. Oretea, 1842. – 876, CXLVIII p., \1! c. di tav. : ritr. ; 26 cm. CODICE ISBN: informazione non disponibile 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 15 dicembre 2008 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO: Ruggero Volpes, [email protected] REVISIONE: Ezio Sposato, [email protected] PUBBLICAZIONE: Catia Righi, [email protected] Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: http://www.liberliber.it/ Aiuta anche tu il "progetto Manuzio" Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. Qui le istruzioni: http://www.liberliber.it/sostieni/ 2 [1] STORIA CRONOLOGICA DEI VICERÈ LUOGOTENENTI E PRESIDENTI DEL REGNO DI SICILIA DI GIOVANNI E. DI-BLASI seguita da un’Appendice sino al 1842. VOLUME UNICO PALERMO DALLA STAMPERIA ORETEA Via dell’Albergaria n. 240. 1842. [2] [3] A VINCENZO MORTILLARO MARCHESE DI VILLARENA SOCIO DI VARIE ACCADEMIE CHE AL REGIME DE’ PUBBLICI AFFARI DALLA SOVRANA MUNIFICENZA A LUI COMMESSI LO STUDIO DELLE SCIENZE E DELLE LETTERE CON MIRABILE SOLERZIA CONGIUNGENDO DELLE PATRIE COSE MOSTRASI TENERISSIMO CULTORE QUESTA EDIZIONE IN ATTESTATO DI OSSEQUIO GLI EDITORI INTITOLANO [4] [5] Avvertimento La Storia de’ Vicerè in Sicilia scritta da G.E. Di-Blasi, e per la prima volta da lui data alla luce nel 1790, abbraccia un lungo tratto di storia delle cose siciliane, imperocchè comincia dall’anno 1409, e tutte va narrando le vicende che succedettero nella Sicilia sino al 1774, sotto il reggimento dei varî signori che la dominarono. Questa storia assai pregevole per la copia de’ fatti, e per l’esattezza del racconto supera di gran lunga quelle che precedentemente aveano impreso il Pirri, l’Amico, e l’Auria, avvegnachè, siccome osserva l’autor del Prospetto della Storia Letteraria di Sicilia nel secolo XVIII, le fatiche di costoro ordinariamente -1- riduconsi a semplici tavole cronologiche, e non son mica scevre di errori, laddove il Di-Blasi, ritraendo non pochi lumi dalle cronache, e da’ giornali esistenti nella libreria di questo Comune, e sopra tutto da’ pubblici archivî, con disegno più nobile, e con maggior criterio venne dettando la sua, e ne formò una parte principale della storia nostra. Sicchè nel suo genere può questa dirsi un’opera interamente compiuta, ed è forse quella che più onora il nome del nostro instancabile storiografo Di-Blasi. Tale è il giudizio che di siffatta istoria pronunciava il chiarissimo ab. Domenico Scinà; e non son perciò da farsi le meraviglie se oggi che lo studio delle patrie cose è in alto onore salito, trovandosi già da più tempo esaurita la prima edizione, sia nato nell’animo di molti il desiderio di averne una seconda. [6] E per appagare appunto coteste brame noi ci siamo determinati a pubblicarla nuovamente colle stampe, comprendendola in un solo volume, ed impiegando ogni attenzione perchè l’eleganza delle forme all’importanza della materia corrispondesse; nè credemmo far opera ingrata a’ leggitori offerendone loro un’Appendice, che servisse di continuazione sino a’ giorni nostri. Ci giova intanto sperare che le nostre cure meritar possano una favorevole accoglienza, e che il gradimento de’ dotti sia per esserci di sprone ad altre somiglievoli imprese. GLI EDITORI. [7] PREFAZIONE Ogni costumato ed onesto cittadino amar deve la sua patria, e la nazione di cui è membro, sagrificarle i suoi talenti e i suoi sudori, e renderla, per quanto da esso si può, più illustre e più conspicua. L’uomo nato in società deve agire a profitto di essa. Colui, che immerso in un ozio vile trascura di adoperarsi ad avvantaggiarla, non sarà che uno insetto nojoso nella vita sociale; e quegli, che invece di cercare i mezzi di renderla migliore, s’occupa ad avvilirla e a distruggerne i pregi, sarà a ragione riconosciuto come snaturato, traditore e misantropo, indegno perciò di vivere fra gli uomini. Come varî sono i bisogni della nazione e della patria, così varî sono gli oggetti, che si presentano all’uomo nazionale e cittadino, e tutti conducenti a farle sussistere e risplendere. La legislazione, l’amministrazione della giustizia, l’agricoltura, la pastorizia, il commercio, la nautica, l’educazione, le altre scienze, le arti sono tanti sostentacoli di questo vasto edifizio. Non è possibile che tutti i singoli componenti una società nazionale si occupino d’un solo di questi oggetti; le inclinazioni degli uomini, anche le virtuose, non sono le medesime, ed a chi piace un’applicazione, e a chi un’altra, a misura che ve li tragge il proprio genio; oltre che se unico fosse l’intrattenimento di tutti, la nazione anderebbe certamente a perire nel modo istesso che una fabrica rovinerebbe, se non fosse sostenuta, che da uno solamente de’ lati. Fingiamo per grazia d’esempio che i nazionali s’applicassero unicamente alla coltura delle terre, o alla guerra, o al commercio, noi avremmo una nazione del tutto agricola, o del tutto guerriera, o del tutto commerciante; ma questa nazione solo agricola, o solo guerriera, o solo commerciante non potrà punto reggere, perchè priva di tutti gli altri mezzi che conducono alla sua sussistenza. Fa perciò di mestieri che i membri tutti di una nazione influiscano a conservarla o colle braccia, o colla mente: applicandosi chi alla coltura delle terre, chi al commercio, chi alla guerra, chi alle arti utili, chi alla giurisprudenza, chi alla educazione, e chi ad illustrare le scienze, e ad indicare le vie più opportune a promuovere il bene, e la felicità della medesima. Io porto ferma opinione, se una vaga lusinga non mi tradisce, che nulla sievi, che abbracci così agevolmente tutti gli obbietti necessarî per conservare la nazione, come la storia degli annali de’ tempi. Il penetrare nelle passate età, e il sapere come la nazione sia stata retta così in pace, come in guerra; l’internarsi nello spirito delle leggi o antiche, o che a misura delle circostanze promulgate si sono, colle quali è stata governata; l’indagare i progressi dell’agricoltura e del commercio, e come accrescendosi l’una, e fiorendo l’altro siesi la nazione arricchita; e decadendo, sia [8] divenuta povera; il cercare i costumi della medesima, e i modi co’ quali siensi corretti, qualora deviavano dal diritto sentiero della ragione; l’andare in traccia degli uomini illustri, che co’ loro talenti politici hanno saputo tenere nel giusto equilibrio lo stato, e coi loro lumi hanno coltivato le scienze e le arti, ed indicate le maniere di renderle utili alla società, sono tante salutari istruzioni al nazionale, per apprendere in qual modo possa vantaggiare la sua patria, e rendersi così degno d’essere numerato fra’ giovevoli membri di essa; sono tanti dolci sproni, che lo invitano a sagrificare le sue vigilie in servigio della medesima. Saranno già trascorsi 12 anni, da che io, dietro d’aver servito il mio ordine, e la chiesa di Palermo nell’istruire la gioventù negli studî de’ sacri fasti della chiesa, e della dommatica teologia, di cui diedi allora alla luce le instituzioni per uso del suo clero di Palermo, per comando del nostro grazioso sovrano, che per sua clemenza mi onorò col titolo di suo regio istoriografo, e per mio particolare genio ancora mi sono applicato alla studio della nostra storia. Quantunque la cognizione degli annali delle altre nazioni sia un ornamento dello spirito, e meriti d’esser commendata; quella nondimeno della propria è un dovere; ed è -2- colpevole colui, che facendone poco, o niun conto, dirige le sue applicazioni a cercare gli avvenimenti delle straniere genti. Bisogna amare la propria nazione, e questo è un dovere d’ogni cittadino, nè questa può amarsi, se noi non ne sappiamo i pregi. Il mio scopo adunque è stato principalmente indiritto alla storia siciliana. A vero dire noi siamo ricchi di scrittori, che hanno sudato ad illustrare la nostra nazione o con darci una generale storia di essa, o con tesserne delle particolari di parecchie più famose città della nostra isola; ma gli uni e gli altri non sembra, che abbiano avuto altro intento, che quello di scrivere gli annali de’ tempi; ma delle leggi, de’ costumi, dell’agricoltura, del commercio, delle arti, e scienze, e della religione o non parlarono punto, o assai superficialmente. Perciò la prima mia occupazione fu appunto quella di tessere la storia di Sicilia, considerandola ancora sotto questi civili rapporti, e la ho recata al suo termine, quantunque non abbia ancora veduta la pubblica luce. Mi sono di poi applicato ad emendare i più grossolani errori presi da certuni degli storici, che hanno scritto della nostra isola, l’opere de’ quali vanno per le mani di tutti, e sono riputate come le migliori da coloro, che non penetrano tanto addentro nella cognizione delle nostre cronache. Così mi è riuscito di fare nell’esame della storia generale del signor Burigny da me pubblicato in Napoli l’anno 1786 sotto il titolo di Lettere di Giovanni Filotete, e nelle correzioni ed aggiunte apposte all’opuscolo di Ferdinando Paternò Sicani Reges, che comunque manoscritto, era nondimeno diffuso per tutta la Sicilia; in guisa che non v’è quasi libreria, nè famiglia catanese, che non ne possegga una copia, cui il Mongitore nella sua biblioteca profuse molte lodi, non so se meritate da questo autore. E finalmente pressato dagli amici, e per difendere l’onesto e dotto uomo abate Giuseppe Vella dalla taccia d’impostore, che un anonimo sotto il nome di L. de Veillant volea affibiargli addosso, dandolo per un ciurmatore, che avesse finto, e da se fabbricato il famoso codice arabo-martiniano, che ha tenuto e tiene tutta l’europea letteratura in espettazione, per sapere appuntino, come accadde l’invasione dei Saraceni nella nostra isola, e ciò ch’eglino vi operarono nel tempo che la governarono, scrissi una lettera apologetica sotto il nome accademico d’Alessio Aganippeo, di cui mi avea molti anni sono onorato una delle Accademie di Siracusa. In essa addimostrai non solo a mio avviso, ma a quello degli altri ancora, assai evidentemente l’autenticità del detto codice giusta le sacre leggi dell’arte diplomatica, la verità del volgarizzamento fattone dal ridetto abate Vella, e l’ignoranza, la debolezza nelle obbiezioni, e la insolenza del suo contradittore le Veillant 1. Terminati i suddetti lavori m’è venuto in mente che sarebbe utile il dare una compiuta [9] storia cronologica de’ vicerè, luogotenenti, e presidenti del regno di Sicilia. Questa, almeno traggendola dai principî del secolo XV fino alla nostra età, mi pare che sia, come in effetto è, una delle parti più importanti degli annali della nostra nazione. Sono i vicerè, i luogotenenti, e i presidenti del regno gli organi, per mezzo de’ quali giungono a noi gli oracoli sovrani; e perciò per la loro bocca ci si comunica tutto ciò, che riguarda la legislazione, e le mire politiche della corte. Per tutto il restante, che una corte lontana non potea provvedere o risolvere, essendo le redini del governo affidate alle loro mani, ne furono eglino interamente gli arbitri, ed in parte ne sono stati ancora, quando i sovrani hanno fatta la loro dimora in Napoli, e perciò non molto lungi da noi. Questa è la storia, che io ora presento al pubblico. Comincerà questa serie cronologica de’ viceregnanti dall’anno 1409. Ma nel darle questo principio, non è mio intendimento il far credere, che prima di questo tempo non vi sieno stati degli altri personaggi, che governato abbiano questa isola, dappoichè se ne impossessarono i serenissimi principi normanni; ma solo di tessere la storia di quelli, che costantemente la ressero, dopo che i nostri re cessarono di fare in Sicilia una permanente dimora; quanto è a dire, da quando non vi fu più corte in questo sfortunato regno. Quantunque i nostri principi, mentre dimoravano permanentemente fra noi, ci avessero da loro stessi per lo più governato, accadea nondimeno allo spesso, che dovessero valersi di altri, i quali esercitassero le loro veci, o perchè furono eglino costretti ad allontanarsi per altre bisogne, o perchè erano da sè incapaci a tenere le redini, essendo ancora fanciulli, o trovandosi privi de’ talenti necessarî ad amministrarne il governo. Così sotto il gran conte Ruggiero il Malaterra 2, ci mentova un certo Pietro Meritone, che dice d’essere restato vicegerente nella Sicilia, allorchè l’anno 1090 questo principe andò in Calabria per gastigare la temerità di Mainerio Gerenzio reo di fellonìa; Petrum Meritonensem, cui vices suas plurimum commiserat, ut per Siciliam exercitum commovens post se acceleret, mittit: quantunque sospettare a ragione si debba, che costui piuttosto fosse stato un generale, che un politico governante, cui solo fosse stata data la 1 Sotto un tal nome ascondeasi, secondo il comune parere, quel potentissimo ingegno del can. Rosario de Gregorio, nè andava egli ne’ suoi giudizî fallito: ché l’impostura del cerretano maltese dopo qualche tempo fu per opera del governo smascherata e confusa; e lo stesso Di-Blasi nella sua storia civile del regno di Sicilia, tom. 5, lib. 6, sez. 1, epoca saracena, ebbe poi a ricredersi della erronea opinione da lui precedentemente sostenuta. Chi fosse vago di conoscere tutte le particolarità di questo curioso aneddoto, legga la descrizione fattane dal chiarissimo ab. Domenico Scinà nel capo IV del terzo volume del suo Prospetto della Storia letteraria di Sicilia nel secolo XVIII. (Nota degli Editori.) 2 Hist. Sic. IV, cap. XVI. -3- commissione di raccogliere l’esercito, e di menarlo in Calabria; come par che additi questo biografo di Ruggiero, quando soggiunge: Qui prudenter injuncta perficiens, infra octo dies ab omni Sicilia copioso exercitu congregato in Majo ad comitem adduxit. Dovette nondimeno nella lontananza di Ruggiero restare alcuno, che governasse la Sicilia. Prima di questo tempo, cioè l’anno 1075 in una breve annotazione manoscritta, che rinviensi nella libreria del senato di questa città, di carattere del canonico Antonino Mongitore, che porta il seguente titolo: Vicerè innanzi che si appartassero dal regno li re, io trovo nominato un certo Ugone Gircè, ch’era genero del conte, e fu anche detto Gozecta; e il Pirri nella sua cronologia de’ re ci nomina inoltre all’anno 1083 e al 1092 Giordano suo figliuolo. Morto il gran conte Ruggiero, siccome Simone suo primogenito, e successore non avea che dieci anni, era d’uopo, che altri lo guidasse nella difficilissima arte di governare; ed Oderico Vitale 3 racconta, che l’anno 1103 fu eletto per balio, e tutore di questo fanciullo Roberto figliuolo del duca di Borgogna, il quale fu dichiarato principe di tutta la Sicilia. Nel regno del re Ruggiero fratello di Simone, quantunque io sappia che questo sovrano mancò spesse volte dal nostro regno, non trovo non ostante mentovato alcuno, che lo abbia retto in suo nome. Ma sotto Guglielmo I l’anno 1115 governò la Sicilia il famoso Majone, e poi Arrigo Aristippo arcidiacono di Catania, Silvestro conte di Marsico, e Riccardo eletto vescovo di Siracusa. Morto questo re, fu l’amministrazione della Sicilia, durante la minore età di suo figliuolo Guglielmo il buono, nelle mani di Romualdo Guarna arcivescovo di Salerno, e della regina Margarita sua madre fin dall’anno 1166. Di poi comandando sola questa principessa, si vede alla testa degli affari Gilberto conte di Gravina suo consanguineo all’anno 1167, ed indi Riccardo conte di Molise. Sotto Tancredi finalmente, che fu l’ultimo de’ re Normanni, ebbe nella di lui lontananza l’amministrazione di questo regno Riccardo conte della Cerra. Nel dominio de’ principi svevi non abbiamo memoria d’alcun viceregnante sotto il regno di Arrigo VI, e di Federico II. Poco durò il regno del primo, e verisimilmente l’imperadrice Costanza, come l’erede, avrà retta la Sicilia; il Pirri non ostante ci rammenta [10] Arrigo Testa maresciallo dell’impero a nome di questo monarca. Del secondo, che poco si trattenne nella nostra isola, ci mancano i monumenti; nè ci resta che il registro degli anni 1239 e 1240, che inedito fino all’età nostra fu poi pubblicato in Napoli dal dotto Gaetano Carcani prefetto della stamperia regia l’anno 1786. Tuttavia dal medesimo registro rileviamo, come questo principe, tenendo l’occhio vigile a quanto riguardava il governo di Sicilia, mantenea un continuo carteggio co’ suoi ministri, e mandava loro le sue cesaree determinazioni, ora da Foggia, ora da Milano, ora da Lodi, ora da Cremona, ora da Pisa, ed ora da diversi altri luoghi, dove dimorava. Combinando le poche lettere di questo registro, abbiamo ragione di giudicare, che non vi fosse allora veruno particolarmente destinato a reggere il regno, ma che le incombenze fossero ripartite fra molti, senza che uno dipendesse dall’altro, a’ quali l’augusto principe direttamente scrivea, dando i suoi sovrani comandi. Era in quel tempo l’isola come divisa in due parti, che venivano separate dal fiume Salso, oggi detto di Termine, e ciascheduna avea il suo maestro giustiziere, il questore, il doganiere, o segreto; ed oltre a questi v’erano i proveditori delle fortezze, i maestri portolani, i correttori, i castellani de’ regî palagi, e delle fortezze, il prefetto delle fabbriche, il maestro delle razze de’ cavalli, ed altri ufficiali, a’ quali erano direttamente spedite le lettere reali, in cui stavano scritte le sovrane deliberazioni. Ciò nonostante noi ritroviamo nella cronologia del Pirri nominati diversi vicegerenti, cioè Corrado Alemando duca di Spoleto, Riccardo di lui figliuolo, Pietro arcivescovo di Palermo, Riccardo conte di Caserta, Guglielmo Bonello conte di Marsico, e Pietro Ruffo conte di Catanzaro, de’ quali non sappiamo, se possa con fondamento dirsi, che governassero a nome di esso principe la nostra isola. Dopo la morte dell’imperadore Federico, e fino che arrivò in Italia il re Corrado, Manfredi suo fratello, come balio tenne le redini del governo. Passato da questa vita Corrado, restò tutore del piccolo Corradino, ed amministratore di Napoli e di Sicilia Bertoldo marchese di Hoemburg, e poi per la renunzia di questo riprese il comando il ridetto Manfredi, finchè per la voce sparsasi, o fattasi spargere, che Corradino fosse morto, si fè egli coronare monarca di questo regno. Avendo però così Bertoldo, come Manfredi, dimorato per lo più in Puglia, dovette certamente esservi in Sicilia chi presedesse agli affari. Nella mentovata annotazioncella del Mongitore vengono rammentati come vicerè sotto Manfredi, già coronato sovrano di Sicilia l’anno 1260, Ruggiero Lentini, e l’anno 1262 Corrado Capece. Ma oltre a questi devono certamente nominarsi prima Federico di Maletta congionto dello stesso re, di cui scrisse Saba Malaspina 4: Rex Manfredus deliberato consilio Fredericum Malecta comitem Bizani consanguineum suum cum quadam quantitate Theutonicorum ad gubernandam Siciliam capitaneum destinavit. Dopo di questo, Federico Lanza conte di Squillaci: Fredericus Lancea, prosiegue lo stesso storico 5, comes Squillacis, qui insolentias regionis ejusdem ab experto calcare praenoverat, de beneplacito regis Manfredi capitaneus in Sicilia subrogatur; ed 3 Hist. Eccl., lib. XIII. Muratori, Rer. Ital. Script., t. VIII, lib. II, cap. 5, pag. 803. 5 Ivi. 4 -4- indi Riccardo Filangeri conte di Marsico: Jam tota Sicilia in pacis reformatione disposita, et Frederico predicto domesticis restituto solatiis, Richardus Filangerius comes Marsici ad ejusdem regimen deliberatione provida destinatur 6; le quali parole trovansi nel continuatore della storia di Niccolò de Jamsilla 7, che vuolsi che sia lo stesso Saba Malaspina, così riguardo a Federico Maletta, e a Federico Lancia, che rispetto a Riccardo Filangeri. A questi aggiunge il Pirri nella citata cronologia Corrado principe di Antiochia, che veramente è quel Corrado Capece, che fu conte di Capizzi, che abbiamo notato, e Corrado Gaetani Pisano, che vuolsi genero dello stesso imperadore Federico. Ne’ diecissette anni, che occupò Carlo di Angiò il nostro regno, non essendovisi egli giammai recato, lo dovette certamente governare per mezzo de’ suoi vicarî. Noi ne vediamo nominati due; il primo fu Filippo di Monforte, ch’era stato spedito dopo la conquista della nostra isola: Mittitur postmodum, racconta lo stesso Malaspina 8, vicarius in Siciliam dominus Philippus de Monteforti homo bellicosus, et statura placibilis. L’altro fu Falcone di Puiricard, ossia di Poggio-Riccardo, [11] che il Maurolico 9 chiama Podiorico, ai quali come vicarî fu affidato il reggimento del nostro regno, prima delle vertigini nate, quando il re Corradino venne in Italia. Ma dopo il tragico fine di questo infelice principe, essendo stata esposta la nostra isola alle crudeltà de’ ministri di Carlo, non più sappiamo precisamente chi ci avesse retto. Otto ce ne rammenta il Pirri, da che Carlo s’impossessò della Sicilia, cioè Blandino d’Urso, i detti Filippo Monforti, e Falcone di Poggio-Riccardo, Giovanni Gerardi, Guglielmo Stendardo, Guglielmo Belmonte, Adamo de Morier, ed Erberto Doria. Il Caruso 10 ci rapporta i nomi del detto Guglielmo Stendardo grande ammiraglio, e primo maresciallo del regno, e di Giovanni di Granmenil arcivescovo di Palermo, e gran cancelliere, de’ quali racconta, che unitamente al vicario Falcone di Poggio-Riccardo governavano dispoticamente il nostro regno. Egli è indubitato, che reciso lo stame di Corradino, ch’era il legittimo re di Sicilia, i Francesi non serbarono più limiti nelle loro operazioni, e facendola d’assoluti padroni, agivano come meglio loro aggradiva. Noi troviamo sul termine del governo angioino un certo Giovanni di s. Remigio, che dimorava in Palermo, quando accadde la strage de’ Francesi; questi però era un maestro giustiziere, non un viceregnante. Per venire ora a’ principi della casa d’Aragona, (lasciando da parte ciò, che raccontasi dopo il Vespro siciliano, cioè che Ruggiero Mastrangelo fu eletto governatore del regno, che fu una provvidenza interina, finochè venissero gli Aragonesi), Pietro che fu il primo di questi re dopo la suddetta famosa epoca, dovendo partire per Bordeaux in occasione del famigerato duello, che dovea farsi fra lui e Carlo d’Angiò, lasciò per reggente la regina Costanza sua moglie, dandole per consiglieri Alaimo di Caltagirone, e Ruggiero Laurìa. Prima di questo tempo, e appunto nell’anno 1282, in cui accadde la giornata fatale ai Francesi, trovo ancora nella più volte riferita annotazioncella del canonico Mongitore notato come vicerè Guglielmo Calcerano, che non saprei dire, se fosse stato eletto da Carlo, o da Pietro. Dopo la morte di questo principe, assunto, giusta la di lui testamentaria disposizione, il suo secondogenito Giacomo al diadema siciliano, rammentasi nella carica di vicerè l’anno 1291 Niccolò Lancia, sebbene ci sia ignoto in quale occasione sia stato costui lasciato per governarci. Chiamato indi Giacomo alla corona d’Aragona nella morte del fratello Alfonso, nè volendo spogliarsi di quella di Sicilia, quantunque il dovesse in forza del testamento paterno, lasciò per vicario Federico suo fratello, il quale, comechè dovesse essere il sovrano della Sicilia, si contentò nondimeno, per compiacere Giacomo, di cedere a’ suoi diritti, e amministrare il regno in nome di esso. Penetratasi dai Siciliani la cessione della Sicilia fatta dal nuovo re di Aragona a Carlo lo Zoppo di Angiò, nè avendo potuto gli ambasciadori spediti dal regno persuadere quel sovrano a ritrarsi da quanto promesso avea, fu Federico, ch’era il vicario, coll’unanime voto della nazione acclamato l’anno 1296, e coronato per sovrano. Questo principe si fermò sempremai presso di noi, nè si allontanò se non quando l’anno seguente 1297, andò per breve tempo in Calabria ad impadronirsi di alcune terre e castella di quella provincia, e quando l’anno 1298 udendo che il fratello Giacomo veniva in Italia a fine di farlo sbalzare dal trono, partì per andare a combatterlo per mare. In questa seconda occasione (giacchè della prima non abbiamo monumenti, che ci additino chi fosse restato a governarci), lasciò per vicario il suo primogenito Pietro II, che poco prima avea fatto coronare e riconoscere per re di Sicilia. Siccome però questo principe non avea che soli anni dodici, nè perciò era in grado di sostenere da sè il peso del governo, fu eletto per di lui direttore Simone Valguarnera esperto cavaliere in guerra, e nell’arte di reggere i popoli. Accaddero poi gl’infelici tempi di Pietro già mentovato, di Ludovico I, e di Federico III detto il Semplice, e alla morte di questo monarca di Maria figliuola di esso restata erede in assai tenera età. Furono questi governi così sconvolti e così inviluppati per le discordie dei primarî baroni, che può ben dirsi, che 6 Ivi, tom. VIII, lib. VI, pag. 804. Ivi, pag. 588 e 589. 8 Hist., lib. IV, cap. 20, pag. 858. 9 Sican. Hist., lib. III, pag. 129. 10 Mem. Stor., par. II, lib. II, vol. I, pag. 330. 7 -5- niuno allora, nè da regnante, nè da viceregnante governasse l’isola. Un’assoluta e costante anarchìa la tribolava; i Chiaramontani, i Palici, i Ventimigli, gli Alagoni, i Peralti, i Rossi, i Moncadi, i Valguarneri, e tanti altri nobili ne turbarono la tranquillità, e comandarono dispoticamente, chi in una parte, chi nell’altra della Sicilia, ed ora immergendola in sanguinosissime guerre, ora rappattumandosi [12] fra di loro, e squarciandola in diverse dinastie, delle quali rendevansi indipendenti padroni, la ridussero al tristo stato di non sapere a qual mai signore ubbidir dovesse. Si durò in questa morbosa crisi, finochè il re Martino il Giovane, assistito da’ consigli del padre, il duca di Monblanco, venne in compagnia della regina Maria sua moglie al governo della Sicilia l’anno 1392. Non è però a credersi, che nel tempo di questa aristocrazia, e stante la pusillanimità e l’insufficienza dei regnanti, fosse restato il regno senza un capo, che almeno in apparenza fosse creduto di avere la ispezione degli affari. I nostri annali sotto il regno di Pietro II, e intorno all’anno 1340 ci rammentano l’infante Giovanni duca di Atene, fratello dello stesso sovrano, qual governatore generale del regno; e prima di esso l’anno 1230 vien nominato nella mentovata annotazione del Mongitore Damiano Palici. Continuò lo stesso duca di Atene nel medesimo posto, durante la minore età di Ludovico, e fino all’anno 1348 in cui morì. Nondimeno il Mongitore nella consaputa notarella ci addita altri governatori sotto il regno di questo piccolo re, cioè Niccolò Lancia l’anno 1341, e Ximenes de Cerda l’anno 1342. Dopo che il principe Giovanni cessò di vivere, restò balio e governatore del regno Blasco di Alagona, fino che visse la regina Margherita madre di Ludovico. Alla morte di questa principessa l’anno 1353 prese il comando col nome di vicaria del regno, per opera dell’anzidetto Blasco, Costanza sorella del re, ch’era badessa di s. Chiara in Messina, donna d’intemerati costumi, e di somma prudenza, pelle quali doti fu con gaudio e piacimento quasi universale ricevuta. Ma la presta morte di costei fe’ poco sentire ai Siciliani lo influsso de’ suoi benefici intenti, onde vivente re Federico venne sostituita nel suo grado dalla sorella Euffemia, la quale, quantunque non vi fosse ben accolta per trovarsi d’un carattere interamente contrario a Costanza, pure per le sue istanze fu forza contentare. Ella pertanto persistè nel dominio, mentre visse Ludovico, e nella minore età di Federico il Semplice altro suo fratello; sebbene il Mongitore nel citato manoscritto nell’anno 1356 avvisi che fu vicerè Matteo Chiaramonte. Finalmente venendo a morte l’ultimo de’ Federici l’anno 1376, e lasciando erede Maria unica sua figliuola, che non avea ancor toccati i quattordici anni, destinò per testamento un solo vicario che fu il conte Artale di Alagona, nelle mani del quale restasse la direzione degli affari. Ma i conti Manfredi di Chiaramonte, Francesco Ventimiglia, e Guglielmo Peralta, ch’erano signori ricchi e potenti, aveano da per loro usurpata l’autorità, e s’erano fatti riconoscere da’ popoli; ciò che il conte Artale non avendo modo di domarli, per amor della pace dovette tollerare, e perfino fu costretto a trattare con essi gli affari più importanti del regno. Gli stessi sovrani Martino e Maria, scrivendo in Sicilia, diressero le loro lettere a quattro vicarî invece di uno, riguardando come legittimi coloro, che non erano che intrusi. Tutti codesti vicariati, baliaggi, e luogotenenze si esercitavano talvolta da’ mentovati personaggi, nulla ostante che i regnanti fossero presenti in Sicilia; e ciò, come si è detto, o per la loro incapacità, o per la minore età: le quali cose esigevano che l’amministrazione degli affari fosse ad altri affidata. Così avvenne ne’ regni di Pietro II, di Ludovico I, e di Federico III, e in quello di Maria, mentre restò in Sicilia. Partita questa principessa, o per meglio dire rapita e trasportata in Aragona da Raimondo Moncada conte di Agosta, i quattro vicarî lasciati dal padre, che abbiamo rammentati, continuarono ad esercitare la vicegerenza nel regno, sebbene ne abusarono con uno intollerabile dispotismo, operando da sè stessi, e senza punto consultare il re Martino conte di Eserica, che per il matrimonio contratto con Maria era il legittimo amministratore dell’isola, che eglino non vollero giammai riconoscere, divenendo così non già governatori, ma veri tiranni della medesima. Non si farà in quest’opera motto veruno dei nominati vicarî, balî, e governatori, che precessero i tempi del re Martino il Giovane, non volendo noi, come abbiamo da principio proposto, parlare di quelli che governarono la nostra isola, se non dal punto, in cui fu la medesima priva della residenza de’ proprî principi; e perciò comincerà questa storia cronologica dalla regina Bianca, che in verità fu la prima che resse questo regno per qualche anno, da che Martino il Giovane andò in Sardegna, dove morì, e da che Martino il Vecchio suo padre, che dimorava in Aragona, ci governò per mezzo di questa principessa. Quale esempio fu poi seguito da’ di lui successori, che non mai più vennero a fissare la loro dimora fra di noi, se n’eccettuino Alfonso il Magnanimo, che vi si trattenne per qualche tempo, l’augusto Carlo V, che vi dimorò pochi [13] giorni, Vittorio Amedeo di Savoja, che non vi si fermò che un anno, e l’amabile re Carlo III Borbone, che vi stiede finochè fu coronato nella cattedrale di Palermo re di Sicilia. Non son io l’unico, o il primo, che abbia intrapreso di dare al pubblico una serie cronologica de’ vicerè, luogotenenti, e presidenti del regno di Sicilia; debbo con candidezza confessare, che assai prima di me molti illustri nostri scrittori hanno corsa la stessa carriera. Il Pirri nella cronologia de’ re, parlando delle varie famiglie normanna, sveva, aragonese, castigliana, ed austriaca, fe’ in ogni regno delle medesime, la serie -6- de’ vicegerenti, che ci comandarono. Di poi lo storiografo canonico Antonino d’Amico scrisse un opuscolo sotto questo titolo: Chronologia de los virreyes, presidentes, y de otras personas, que han governado el regno de Sicilia, di cui se ne fecero in Palermo ben due edizioni, e la seconda per i torchi di Pietro Coppola l’anno 1640, e poi per la terza volta fu ristampato l’anno 1687 co’ torchi di Giacomo Epiro per opera di Giuseppe Scoma, il quale fu presidente del tribunale della gran corte, e ne accrebbe la serie fino all’anno 1687, in cui amministrava il regno come vicerè il duca di Veraguas. Dieci anni dopo, cioè l’anno 1697, comparve nella stessa città colle stampe di Pietro Coppola l’Historia cronologica de’ signori vicerè di Sicilia dal tempo che mancò la personale assistenza de’ serenissimi re di quella, il di cui autore fu il dottor Vincenzo Auria conosciuto per altre sue letterarie produzioni. Questi due ultimi scrittori non dànno principio alla loro cronologia, che dalla regina Bianca, da quel punto cioè, in cui fu il nostro regno con una non interrotta successione governato da coloro che furono da’ sovrani destinati a questo reggimento; e perciò non fanno parola veruna de’ vicarî, de’ balî, e de’ governatori, che prima di questo tempo abbiamo nominati, e che non sono taciuti dal Pirri. Le due cronologie del Pirri, e dell’Amico sono in verità due meri cataloghi, dandoci i soli nomi di coloro ch’eglino pretesero che fossero stati vicerè e presidenti del nostro regno. L’Auria però, quantunque abbia seguita fedelmente la cronologia stampata dal canonico Amico, si diffonde nondimeno, dandoci allo spesso de’ dettagli delle famiglie de’ viceregnanti, e di alcune non sempre interessanti azioni de’ medesimi. Sono le suddette tre cronologie difettose alquanto, e peccano contro le leggi cronologiche, perciocchè ora dànno il titolo di vicerè a coloro che non lo ebbero, ora mettono in questa classe quelli che non furono, che meri consiglieri dati a’ governanti, ora diminuiscono, ed ora accrescono il numero degli anni ne’ quali ressero la Sicilia; e sopratutto o sbagliano nel riferire gli anni ne’ quali destinati furono a questo governo, o per lo meno non accennano nè il giorno in cui furono eletti, nè il tempo in cui arrivarono in Sicilia, nè il dì in cui presero possesso di questa insigne carica. Considerando io questi essenziali difetti, che in una storia cronologica non sono punto da comportarsi, mi era determinato di riprodurre il libro dell’Auria (nome venerato presso quasi tutti i nostri nazionali): opera, che oramai resa si era rara; di farvi delle giunte e delle correzioni, e di continuare la serie de’ vicerè dall’anno 1691, in cui questo scrittore la terminò, fino alla presente età. Lo stesso pensamento par che sia venuto in capo allo infaticabile canonico Antonino Mongitore, il quale, oltre le molte opere che pubblicò colle stampe, lasciò diversi manoscritti, ch’esistono nella biblioteca di questo senato di Palermo. Il benemerito signor canonico Tommaso Angelini custode della medesima libreria mi comunicò non ha guari l’esemplare della cronologia dell’Auria, ch’era fra’ libri del Mongitore, in cui ogni foglio di stampa trovasi intersecato da uno o due fogli di carta bianca, ne’ quali di carattere di esso Mongitore trovansi alcune annotazioni, colle quali avvertiva gli errori, o riempiva i voti dell’Auria. Era certamente suo intendimento ristampare questa cronologia coll’emendazioni e cogli aggiungimenti da lui fatti; imperciocchè io trovo nel frontespizio scritto di suo carattere: con le aggiunte di Antonino Mongitore. Verisimilmente non ebbe tanta vita da poter recare a compimento la meritata ristampa; e infatti le note sono imperfette, nè ritrovasi dopo il viceregnato del duca di Veraguas, con cui termina l’Auria, che un semplice catalogo de’ vicerè, che ressero la Sicilia fino all’anno 1737, nel quale cominciò a governare il principe Bartolomeo Corsini, e la sola descrizione delle azioni di Giovanni Emanuele Fernandez Paceco marchese di Vigliena, prima che fosse destinato l’anno 1701 al viceregnato di Sicilia, e una breve nota di quanto questo vicerè operò in Napoli, dapoichè l’anno 1702 fu spedito a quel governo. Restai molto tempo dubbioso, se compiendo ciò che il Mongitore avea intrapreso, fosse miglior partito fare una ristampa dell’Auria, [14] producendo collo stesso metodo la serie de’ vicerè fino a’ nostri dì, ovvero fosse più espediente il tessere da capo la storia cronologica de’ medesimi; e incerto di ciò che dovessi fare, ne consultai gli amici più illuminati, acciò mi dirigessero nel piano che tener dovessi. Dopo un lungo e diligente esame, valendomi de’ loro suggerimenti, mi sono attenuto al secondo progetto, e mi sono perciò determinato a scrivere una nuova storia cronologica diversa da quante fino ad ora se n’erano prodotte. Molte furono le ragioni che mi ritrassero dal primo pensamento di ristampare l’Auria. Lo stile ampolloso di questo scrittore, che sebbene fosse al gusto del passato secolo, non piace ora al palato di coloro che amano nella storia la chiarezza, la semplicità, e la naturalezza, non potea a questi tempi esser grato a’ leggitori, e il ridurlo alla maniera che ora si preferisce, oltra che mi avrebbe apportato una intollerabile fatica, non avrebbe al certo dato al pubblico l’opera di questo scrittore, com’egli la scrisse, ma al più lo scheletro di essa vestito in una nuova foggia. Inoltre essendovi in esso libro molto da aggiungere e da emendare, e dovendosi le addizioni e le correzioni mettere in tante note a piè di pagina, avrebbe ciò apportato una infinita noja a’ leggitori, i quali ad ogni momento sarebbono stati costretti di saltare dal testo alle note, e da queste ritornare a quello. Finalmente, per intralasciare tanti altri motivi, ognun vede come ristucca all’eccesso quella perpetua monotonìa che rinviensi costantemente nell’Auria, dove ad ogni pagina vi si legge: I medesimi vicerè, il medesimo vicerè, il medesimo presidente ec. -7- Nel formare questa storia cronologica mi sono giovato de’ lumi che mi hanno somministrate le cronache, i giornali, ed i diarî del Paruta, del Rosa, dell’Auria istesso, e del Mongitore, che adornano la biblioteca del senato di Palermo, a’ quali debbo aggiungere quelli del meritevolissimo cavaliere Francesco Maria Emanuele e Gaetani marchese di Villa Bianca, che me li ha generosamente e gentilmente comunicati. Ho anche con infinita fatica svolti i regî archivi della cancelleria, del protonotajo, e della conservatoria, i di cui custodi, i signori Ignazio Majo, Giuseppe Barbici, e Giuseppe Fiore, si sono molto interessati nell’agevolarmi, e ciò a fine di fissare i tempi precisi ne’ quali furono eletti, vennero, e presero possesso del viceregnato, luogotenenza, o presidenza del regno que’ personaggi, de’ quali favello, e per consultare i diplomi, che vo citando. Non ho anche intralasciato di avvalermi delle notizie somministrate dal Pirri, dall’Amico, dall’Auria, e dal mentovato Mongitore nelle note manoscritte a questo ultimo, quando le ho trovate conformi alla verità; lo che voglio che sia avvertito per non defraudare persona delle dovute lodi, e acciocchè niuno fastidioso critico mi accusi di essermi vestito, come la cornacchia di Esopo, delle penne altrui; e a quest’oggetto noterò fedelmente i luoghi, da’ quali ho tratti i monumenti e le notizie. Mi è anche piaciuto nel distendere questa storia d’inserirvi tutto ciò che accadde nel governo de’ viceregnanti così nel nostro regno, come lungi da esso, purchè questi governanti vi avessero avuto qualche parte; e in questo modo io credo di dare una porzione principale della storia siciliana, dal punto in cui perdemmo la residenza de’ nostri monarchi, fino all’età presente. Lo storico deve essere scevro da ogni prevenzione, e dire le cose come accaddero, senza punto alterarle. Io perciò nel riferire il governo di coloro che ressero la Sicilia, nè prenderò il tuono di un affettato encomiatore, nè quello di un austero critico, ma tenendomi fra i limiti della bella ed amabile verità, loderò ciò che merita di essere in essi commendato, e condannerò ciò che merita disapprovazione. Non avvi uomo che sia privo de’ vizî, e colui che ne ha una menoma porzione, è da noverarsi fra gli ottimi. Così cantò Orazio: Nam vitiis nemo sine nascitur: optimus ille est, Qui minimis urgetur. 11 E perchè alcuno de’ viventi non m’incolpi, parlerò solo de’ morti, e chiuderò la serie di questi viceregnanti col rispettabilissimo monsignor Serafino Filangeri mio particolar protettore, la di cui memoria non sarà mai per estinguersi nella mia mente. Lascerò poi, che coloro che scriveranno dopo di me, parlino con liberi sensi di quei personaggi che ci hanno governato, e che o da poco sono morti, o tuttavia vivono. Sarà quest’opera divisa in quattro libri, cioè in tanti, quante sono l’epoche de’ diversi sovrani che hanno avuta la Sicilia in dominio, senza dimorarvi personalmente, e che per conseguenza l’hanno retta per mezzo de’ loro viceregnanti; cioè gli Aragonesi, i Castigliani, gli Austriaci, ed i Borboni. Egli è vero, che nell’ultimo libro si rammenteranno Vittorio Amedeo di Savoja, e Carlo VI d’Austria della Branca di Vienna; [15] ma come il primo non dominò che quattro anni, e il secondo non vi regnò che quattordici, mi è parso di non moltiplicare per questi brevi governi il numero de’ libri, ma d’inserirli nell’epoca borbona. Seguirà per ornamento di questa storia la serie cronologica che riguarderà gli anni, i nomi, l’elezioni, e i possessi dei vicerè, de’ luogotenenti, e de’ presidenti del regno. Ed altri cinque cataloghi ragionati vi si uniranno, cioè 1° de’ maestri giustizieri, 2° de’ presidenti della gran corte, 3° de’ presidenti del patrimonio, 4° di quelli del concistoro, e 5° de’ reggenti siciliani del consiglio d’Italia, e de’ consiglieri della giunta di Sicilia in Napoli: ministri tutti, che hanno molta relazione co’ vicerè, e colla storia di Sicilia. Questi tali indici sono appunto quelli che mi hanno fatto molto sudare sulle carte polverose degli archivî. Il Pirri e l’Auria che ce n’hanno dato conto, non citano per lo più le cedole delle loro elezioni, sono caduti in enormi errori, dandoci una serie imperfetta e mancante de’ medesimi, e sbagliando ancora gli anni nei quali furono promossi, e quelli ne’ quali cessarono di essere nelle magistrature, o per morte, o per renunzia, o perchè furono levati di carica, o perchè furono innalzati a' gradi maggiori. A sanare queste piaghe mi è convenuto di svolgere i registri de’ nostri archivî, a fine di ordinare la serie di questi ministri, e di fissare l’epoche della loro elezione, e della loro dimora nell’impiego, in cui furono adoperati. Nel che non oso dire di avere supplito interamente a’ difetti, mentre mi sono talvolta mancati i materiali per compierne i cataloghi, e ciò senza mia colpa, perchè gli stessi accennati archivî privi ne sono. Avrei bramato per rendere questa storia più nobile di adornarla con tutti i ritratti de’ viceregnanti e presidenti del regno, nè mi sarebbe stato malagevole di darne le vere immagini; avvegnachè nella maggior parte si trovano espressi al vivo nella sala, e nelle anticamere del regio palagio: Ma trovo peso non delle mie braccia, Nè opra da pulir colla mia lima, dirò col Petrarca 12. Le strette finanze di un privato non sostengono la spesa necessaria per disegnare, 11 Sat. lib. IV, sat. 3. -8- incidere, e fare imprimere i busti di centosessantacinque personaggi, che hanno sostenuta questa carica. Voglio lusingarmi di avere adempiuto in tutte le sue parti l’incarico che mi sono addossato, e che questa opera possa incontrare l’approvazione de’ miei connazionali, che avranno una esatta e veridica storia de’ viceregnanti di questo regno. Dal canto mio posso assicurare di non avere intralasciata diligenza, nè risparmiata fatica per soddisfare alla loro curiosità, impiegando i miei, quanti che sieno, talenti per rendere quest’opera meno difettosa che fosse possibile. Spero perciò da’ medesimi cortese indulgenza e compatimento, se alla loro aspettativa esattamente non corrisponde. [16] 12 Par. 1, son. 5. -9- [17] Storia Cronologica dei VICERÈ LUOGOTENENTI E PRESIDENTI DEL REGNO DI SICILIA LIBRO PRIMO DE’ VICERÈ SOTTO I PRINCIPI DELLA SCHIATTA D’ARAGONA CAPO UNICO La regina Bianca Vicaria. Morto l’anno dell’era volgare 1377 Federico III detto il Semplice, l’ultimo de’ maschi discendente da Pietro I di Sicilia, e III dei re di Aragona che regnarono in quest’isola, non restò di lui, che una principessa dell’età di quattordici anni, che gli era nata dalla regina Costanza sua prima moglie figliuola di Pietro IV re di Aragona chiamato il Ceremonioso. Questa principessa fu riconosciuta come l’erede del trono, e cominciò a regnare presso di noi, sotto però la tutela e la reggenza di Artale di Alagona Catalano, ch’era uno de’ più potenti signori dell’isola, ed uno de’ quattro vicarî lasciatile dal padre. Per le scissure nate fra i due terribili partiti dei Catalani, e dei Chiaramontani, questa regina fu l’anno 1379 rapita da Raimondo de Moncada conte di Agosta, e chiusa nel forte castello di detta città, di cui era padrone, mentre stava per darsi in isposa a Giovanni Galeasso conte della Virtù, nipote di Bernabò Visconti, con cui avea il condominio dello stato di Milano. Contradicendo a queste nozze la maggior parte de’ Siciliani, e non volendo il mentovato re di Aragona Pietro IV avo della Regina alienare il regno di Sicilia, sul quale credea di avere de’ certi e legittimi diritti, spedì, saputo il ratto di quella principessa, quattro galee con truppe al Moncada, ordinando che fosse trasportata in Barcellona, affine di essere allevata dalla regina Eleonora sua zia, figliuola di Pietro II re di Sicilia. Così fu eseguito, e la regina Maria ai 4 di giugno 1381 s’imbarcò sulle galee catalane dal castello dell’Alicata, dove era stata trasportata. Stiede Maria presso a nove anni in educazione. Era intanto il suo regno amministrato da quattro vicarî, e dalle guerre intestine giornalmente tribolato. Potea più presto dirsi un regno feudale, in cui ogni magnate si facea lecito di attaccare impunemente il suo nemico. In questo spazio di tempo morì il re Pietro IV, e lasciò due figliuoli maschi natigli dalla sopranominata regina Eleonora sua terza moglie, cioè Giovanni, che gli successe nel regno di Aragona, e Martino duca di Monblanco. Questi in verità aveano diritto alla corona di Sicilia, quando fosse per vacare, come figli di una madre ch’esser potea l’erede di Pietro II, ma come erano avanzati in età, pensarono di dar per marito [18] alla regina Maria Martino il giovane, figliuolo del duca di Monblanco, cui il padre e lo zio cessero sul nostro regno ogni loro pretensione. Furono perciò stabilite le nozze fra la nostra regina e Martino il giovane a’ 29 di novembre 1391, e poichè erano cugini i medesimi, fu presa la dispensa dell’antipapa Clemente VII, che in Aragona era riconosciuto per legittimo pontefice. L’anno seguente partirono i due reali sposi, e arrivarono in Sicilia a’ 25 marzo 1392, dove regnarono. Non appartiene al nostro scopo lo avvertire, quanto stentasse il nuovo re Martino col consiglio del padre, che volle accompagnarlo, a ridurre in tranquillità la nostra isola, e a debellare coloro che negarono di sottomettersi. Quel che fa al proposito egli è, che la regina Maria se ne morì, senza lasciar prole, a’ 25 maggio 1402, e che Martino divenuto vedovo, per farsi un erede, l’anno seguente 1403 sposò Bianca, figliuola di Carlo III re di Navarra: principessa adorabile non meno per la sua bellezza, che per le virtù, che a dovizia l’adornavano. Visse fino all’anno 1404 nella più desiderabile armonia con quest’amabile sposa, da cui scrive il Surita 13, che ottenesse un figliuolo, che poco dopo nato finì di vivere. Fu però costretto ad abbandonarla l’anno suddetto chiamato dal padre Martino il vecchio già re di Aragona dopo la morte del fratello Giovanni I, il quale desiderava di abbracciarlo, e di conferire con esso alcuni rilevantissimi affari. Partì adunque a’ 22 di ottobre dello stesso anno, e prima di lasciare la Sicilia dichiarò la sua novella sposa vicaria, governatrice, amministratrice, e procuratrice del regno, concedendole il mero e misto impero non meno ne’ civili, che ne’ criminali affari, con una plenipotenza illimitata, per cui potesse far uso di tutte le rendite del real patrimonio, come le sembrasse più utile, mutare, levare, o creare nuovi uffiziali, e far tutto ciò che potesse fare lo stesso Monarca, approvando quanto ella fosse per ordinare, e comandando a’ castellani, a’ baroni, alle soldatesche, e a tutti gli altri uffiziali militari, civili, e criminali, che ubbidissero alla regina Bianca come se fosse lo stesso re 14. Durò poco questa luogotenenza, giacchè Martino per le novità che tentavano i fuorusciti contro la Sicilia, fu obbligato di ritornarvi nel mese di agosto 1405. Un caso impensato però divise di nuovo l’anno 1408 questa felice coppia. La Sardegna, regno che appartenea a Martino il vecchio suo padre, si era ribellata. Brancaleone Doria, il marchese di Orestano, e il visconte di Narbona, ch’erano le persone più autorevoli in quell’isola, operavano dispoticamente, e aveano 13 14 Annales de Arag., t. II, lib. X, cap. 84, p. 447. Capit. Regni Sic., t. I in Martino p. 182. - 10 - già scosso il giogo del legittimo loro sovrano. Martino re di Sicilia, ch’era nel fiore della sua gioventù, avendo appena attinti gli anni trentadue, ch’era dotato di una fortezza e costanza indicibile; e che avea un cuor magnanimo e capace di affrontare qualsivoglia pericolo, concepì l’alto disegno di debellare i Sardi, e servendo il padre, di coglier le palme delle sue vittorie. Enunciò al padre il suo desiderio, e lo pregò a fornirlo di truppe, che unite alle sue, che avrebbe recate da Sicilia, sarebbero bastanti a conquidere i sollevati. Se fosse lieto di questo generoso progetto il vecchio Martino, può ciascheduno immaginarlo. Ogni padre è sensibile nel vedere che i figliuoli non tralignano dall’avita virtù. Approvò adunque questa risoluzione, ma mostrò desiderio, che il figliuolo andasse prima in Barcellona per seco conferire sul piano, che dovea osservarsi nella meditata guerra. Volendo il re Martino ubbidire a’ voleri del padre, partì sulla fine di ottobre dell’anno 1408, non già 1409, come per errore scrissero gli autori dell’arte di verificare le date 15, dalla città di Trapani, ma anzi che partisse, tornò a dichiarare la regina Bianca sua moglie vicaria generale del regno colle stesse facoltà che le avea accordate l’anno 1404 16, lasciando le ordinazioni che doveano osservarsi dalla medesima, e da’ consiglieri ch’erano stati da lui eletti per assisterla 17. Non potè il re Martino eseguire il meditato viaggio per Barcellona. Arrivato in Alquer, e vedendo a qual grado era giunta la ribellione de’ Sardi, credè, che fosse più espediente il fermarvisi colle truppe, che avea recate da Sicilia, e perciò spedì Bernardo Caprera conte di Modica al padre per sollecitare l’armata aragonese, che dovea [19] unirsi alla sua, per attaccare in battaglia i rubelli. Intanto la regina Bianca rimasta governatrice del regno reggeva con dolcezza ed umanità i popoli, e intenta sempre ad agevolare le imprese del suo caro sposo, spediva in Sardegna truppe, cavalli, orzi, farine, biscotto, e quanto potea preparare per servizio dell’armata, ed animava i mercadanti, con far loro a nome del marito generose promesse, a portare de’ viveri in quell’isola. Abbiamo preziosi monumenti tratti da’ nostri archivî che promulgheremo, quando la sorte ci permetterà di pubblicare la nostra storia civile di questo regno, da’ quali rilevasi, quanto la Sicilia contribuì al buon esito della guerra di Sardegna, e come la regina Bianca si affaticò per soddisfare le brame del re Martino. Secondò la fortuna le mire di questo prode sovrano, cui riuscì con un oste assai minore di quella de’ rubelli di guadagnare sopra di loro due battaglie, l’una navale al primo di giugno 1409, e l’altra a’ 26 dello stesso mese per terra, per la quale uccise loro sei mila uomini, e ridusse il visconte di Narbona coi suoi a fuggire, e a ricoverarsi nel castello di Morreale 18. Mentre questo invitto principe meditava di compire l’opera, e d’impossessarsi del resto dell’isola, cadde infermo in Cagliari, e fu rapito dalla morte a’ 25 di luglio dello stesso anno 1409, non già 1408, come il Muratori 19 lasciandosi strascinare dall’autore del frammento della storia siciliana 20 erroneamente lasciò registrato. Prima di morire egli ebbe spazio di fare il suo testamento, e in esso dichiarò, come richiedea ogni ragione, erede universale nel regno di Sicilia, e nelle isole adiacenti, e nel ducato di Atene, e di Neopatria Martino suo padre re di Aragona. Per provvedere poi agl’imminenti bisogni del nostro regno, ordinò che continuasse nel vicariato la regina Bianca, con che dovesse governare col consiglio di sei soggetti, che le destinò, e de’ procuratori di sei città principali, cioè Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti, e Trapani. Egli merita di essere osservato, che fra’ consiglieri non furono eletti nè Bernardo Caprera, nè Sancio Ruitz de Lihori suoi favoriti, come quelli che si odiavano a morte, ed avrebbono sempre sconcertate le pacifiche determinazioni del consiglio. L’afflitto re di Aragona dopo di avere sfogato l’interno dolore, da cui era penetrato per l’inaspettata perdita dell’unico suo figliuolo, approvò il di lui testamento, e per togliere ogni dubbio che potesse nascere, che morto il re Martino fosse spirata la giurisdizione della regina Bianca, la confermò nella carica di vicegerente, di luogotenente, e di generale protettrice del regno di Sicilia, come si fa chiaro dalla carta di conferma data in Belisguardo nel territorio di Barcellona, che trovasi registrata ne’ capitoli del regno 21, sebbene vi sieno corsi tre principali errori, come osserva M. Francesco Testa 22, l’uno dell’anno, che deve essere non 1408 ma 1409, l’altro del mese, dovendo essere o settembre, o ottobre, avvegnachè la notizia della morte del figliuolo non gli fu data che a 17 di settembre, ed il terzo del luogo, dovendosi leggere Belsguart, e non Belsiguard, come ivi si osserva. La savia, e prudente disposizione testamentaria del giovane re Martino confermata dal di lui padre il monarca di Aragona, che fu approvata da tutti i buoni, dispiacque all’estremo a Bernardo Caprera conte di Modica, il quale non potè soffrire di vedersi escluso dal consiglio della viceregina dopo di essere stato in 15 Chronologie historique des rois de Sicile et de Naples, p. 901. Amico, Catana Illustrata, t. II, lib. VI, cap. 8, p. 279. – Capit. Regni Sic. in Martino cap. 66, p. 182. 17 Capit. Regni Sic., ibid. cap. 67, p. 184. 18 Surita, Annales de Arag., t. II, lib. X, cap. 87, p. 452. 19 Annali d’Italia, an. 1408, t. IX, p, 48. 20 Muratori, Rer. Ital. Script., t. XXIV, p. 48. 21 Cap. Regni Sic. in Martino t. I, cap. 68, p. 187 e 188. 22 Pag. 188, n. h. 16 - 11 - quello del re, a cui pretendea di aver diritto sopra di ogni altro per la luminosa carica di gran giustiziere che occupava, e per i nuovi considerabili servigî resi alle corone di Aragona e di Sicilia nella guerra di Sardegna. È anche verisimile ciò che scrisse il Caruso 23, ch’ei fosse irritato contro la memoria di Martino I che nel testamento nominando e lasciando de’ legati a’ suoi confidenti, non lo mentovava neppure per ombra. Presso il Surita, che ci ha conservata questa carta 24, rammentansi i generosi legati, che questo principe lasciò a coloro che lo aveano così lodevolmente servito nella spedizione di Sardegna, fra’ quali il più considerabile era quello, con cui fu riguardato il rivale del Caprera D. Sancio Ruitz de Lihori; ma niun motto si fa del suddetto conte di Modica. Pieno dunque di rovella dopo la guerra di Sardegna venne in Sicilia a turbare il [20] governo della regina Bianca, e a suscitare, se gli era possibile, il baronaggio e le città siciliane alla ribellione. Previde il re di Aragona gli sconcerti che costui potea eccitare, e per prevenirli gli ordinò che se ne stesse ne’ suoi feudi, nè osasse di entrare in alcuna città o terra appartenente alla corona 25. L’ardimentoso conte dispregiò i comandi reali, e contro il divieto fattogli venne a mano armata nella capitale, dove dopo di essersi fermato alquanti giorni per farsi un partito, si determinò a portarsi in Catania, per far la guerra alla regina Bianca, e a’ di lei consiglieri, che se ne stavano fortificati nel castello Ursino. Crebbe l’audacia di questo cavaliere, quando arrivò in Sicilia l’infausta notizia della morte del re di Aragona Martino il vecchio, che accadde a 31 di maggio 1410, per cui immaginò, non senza fondamento, che fosse mancata alla regina Bianca ogni autorità, la quale sarebbe tutta secondo le leggi del regno venuta nelle sue mani, come quello ch’era il gran giustiziere della Sicilia. Sembrava invero che fosse questa principessa decaduta da qualsisia potere, essendosi seccata, colla morte del re mentovato, la fonte da cui se le tramandava, e che questo fosse devoluto al Caprera; impercioccbè le consuetudini del regno trasfondevano in tutti gl’interregni l’autorità di governare nel sacro consiglio, di cui era capo il gran giustiziere. Ma quantunque la regina Bianca fosse senza titolo, era nondimeno amata dalla maggior parte della nazione, la quale bramava che la medesima continuasse a dominare; e dall’altra parte, comunque il diritto del Caprera fosse chiaro, era egli nonostante in esecrazione della maggior parte de’ Siciliani, che ricusavano di ubbidirgli. Fu quindi diviso il regno in due fatali fazioni; l’una sostenuta da Sancio Ruitz de Lihori intendea, che Bianca dovesse proseguire nel vicariato, come se Martino non fosse morto, l’altra credendo mancata ogni giurisdizione in quella principessa sostenea il partito del conte di Modica. Fra questi due opposti sentimenti de’ nazionali cominciarono le ostilità; e il Caprera, che avea le maggiori forze in suo potere, tolse dalle mani della regina non solamente le città e le terre demaniali, ma quelle ancora, che diconsi della camera reginale. Cercarono gl’imparziali di estinguere questo incendio che devastava l’intera Sicilia, nè la regina Bianca era restìa a pacificarsi. Noi abbiamo una lettera di questa principessa datata in Castronovo a 30 aprile 1411, che promulgheremo quando si stamperà la storia, con cui promettea di condonare tutte le ingiurie e i danni che l’erano stati fatti, ogni volta che se le fossero restituite come a vicaria del regno tutte le città e castella usurpate dal Caprera; ma questi caparbio nei suoi sentimenti ricusò ogni accomodamento. Durando l’ostinazione delle due fazioni, e considerandosi che qualunque ne fosse l’esito favorevole all’una, e avverso all’altra, sempre la Sicilia sarebbe per restare involta nelle guerre intestine; parve che il migliore espediente fosse per essere quello di spogliare i due contendenti di qualsivoglia autorità, e di affidare il governo del regno a de’ soggetti tratti dai tre ordini dello stato, i quali interinamente lo reggessero. Concepirono questa ardita idea i coraggiosi Messinesi, i quali proposero, che si convocasse un generale parlamento, ed ebbero anche lo spirito d’intimarlo in Taormina, che fu creduto il luogo più salubre e libero dalla crudele epidemia, che allora tribolava la Sicilia. La regina Bianca che amava la pace, e il Lihori, ch’era il capo del suo partito, accettarono l’invito; ma l’altiero Caprera se ne rise, e trattò con dispregio questa proposizione: sostenendo che non era da disputarsi a chi appartenesse nell’interregno il comando della Sicilia, che per le leggi nazionali dovea restare nelle mani del gran giustiziere, e del sacro consiglio. Nonostante il rifiuto del conte di Modica si congregarono in Taormina i baroni, e i procuratori delle terre demaniali, che non erano del di lui partito, e molti prelati, e vi venne ancora la regina Bianca. Fu tenuta quest’assemblea colle consuete solennità, e vi fu risoluto che la regina Bianca deponesse l’esercizio e l’amministrazione del vicariato di Sicilia, e che frattanto, che il regno non avesse il suo re, restasse il comando in potere di un consiglio, che fosse composto da un prelato, da due baroni, da sei deputati di Messina, da due deputati di Palermo, e da un deputato di ogni città, che avea mandato il suo procuratore al parlamento, e che questo consiglio dovesse dispacciare a nome del re di Sicilia, della regina D. Bianca vicaria del regno, e del reggimento del regno di Sicilia stabilito dal pubblico parlamento. Siccome poi le 23 Mem. Stor., part. III, vol. I, p. 2. Annales de Arag., t. II, lib. X, cap. 88, p. 453. 25 Surita, Ann. de Arag., t. III, lib. X, cap. 89, p. 454. 24 - 12 - città di Catania, di Siracusa, [21] di Trapani, e di Gergenti non vi aveano destinati i loro procuratori; così fu risoluto, che in caso, che le dette città aderissero alle risoluzioni del parlamento, si permettea alle medesime, che avessero i loro membri nel consiglio, cioè Catania due, ed uno ciascheduna delle altre tre città. Questa reggenza fu incaricata coll’università di Messina di fare ogni opra, acciò il nuovo re fosse della casa reale di Aragona, di farsi consegnare dalla regina Bianca le fortezze che avea in potere, e di arrollare delle truppe, delle quali fosse capitan generale Antonio Moncada conte di Adernò per la sicurezza del regno 26. Di questo parlamento fa menzione il Mongitore alla pagina 48 delle sue memorie istoriche dei parlamenti 27. Inerì la regina Bianca alle determinazioni del parlamento, come costa da una circolare che questa principessa scrisse a’ 27 di maggio 1411 da Nicosìa ai baroni e alle università, esortandoli a conservarsi ubbidienti alla casa di Aragona, che si pubblicherà a suo tempo nel nostro codice, che sarà annesso alla storia civile. Con qual’animo udisse il Caprera le determinazioni del parlamento è facile il congetturarlo; le dichiarò egli tosto nulle e di niun vigore, e i parlamentarî temerarî e rubelli, perchè aveano avuto l’ardire di pensare a darsi un re, e a separarsi dalla corona di Aragona. Non gli fu difficile il farlo credere a molti baroni, e particolarmente a’ Catalani. Unito a questi, che ritrovavansi potenti, cominciò ad impossessarsi delle città e delle fortezze del regno, e se non in tutto, vi riuscì in parte. Le città nemiche de’ Messinesi, i quali aveano dominato nel parlamento, si distaccarono dalla regina Bianca, e vennero a sottomettersi al gran giustiziere conte di Modica, e fra queste la città di Palermo, la di cui emulazione con Messina è abbastanza nota, la quale mal soffriva il vedere eletti sei deputati messinesi, quando di essa, ch’era la capitale, non se ne disegnavano che due, quanti ne venivano accordati a Catania. Mentre le due fazioni si laceravano, scrive il Fazello 28, che la regina Bianca si era ritirata a Catania nella fortezza Orsina, dove spesso andava a visitare alcune monache vicino alla sua abitazione, che forse erano le benedettine di s. Placido, il monastero delle quali avea questa principessa arricchito di non poche facoltà, come ci lasciò registrato Giov. Battista de Grossis 29, e che il Caprera tentò di sorprenderla inutilmente; giacchè essendo stata avvertita, si ridusse sollecitamente in luogo di sicurezza. Fallito al gran giustiziere questo colpo, e volendo levare ogni suspizione, la fe’ pregare, che si compiacesse di abboccarsi seco per troncare le cagioni delle civili discordie, che turbavano la Sicilia. Non ricusò la regina di udirlo, ma siccome non si fidava di questo suo nemico, fu accordato che l’avrebbe ascoltato dalla poppa di una galea, stando il conte sul ponte, a cui la trireme si sarebbe accostata. Così fu fatto, e il Caprera dopo molti ragionamenti finalmente le palesò il desiderio che avea di prenderla in moglie. Sdegnossi Bianca ad una cotale impertinente dimanda, e senza punto rispondergli, scrive questo storico, ordinò a Raimondo Torella, ch’era il capitano della galea, di allontanarsi dal ponte, e di ricondurla al castello. Il Maurolico 30 però soggiunge una circostanza, cioè che alla proposizione del conte la regina non seppe contenersi dall’ingiuriarlo dicendo: va via vecchio scabioso: Hui senex scabide. Noi non osiamo contraddire due storici di cotal tempra, ma stentiamo a persuaderci che Bianca fosse dopo il parlamento andata a Catania, città che dovea allora esserle sospetta, perchè avea ricusato di mandare i suoi procuratori all’assemblea del regno tenutasi in Taormina. Checchè sia di ciò, da questo avvenimento, e da quanto lasciò scritto Lorenzo Valla 31, forse i nostri scrittori ricavarono, che il Caprera avea in animo di sposare la regina Bianca, e di cingersi la testa della corona di Sicilia, dalla quale infamia il Surita cerca ad ogni modo di difenderlo 32. Ciò ch’è certo egli è, che questa principessa vedendo mancare le città demaniali, e temendo che le città della camera reginale non seguissero il loro esempio, pensò di ridursi a Siracusa, che n’era la principale, [22] e andò a starsene nel castello di Marquetto di essa città: lusingandosi che la sua presenza avesse contenuti nel dovere quei cittadini; e intanto incaricò il grande ammiraglio Lihori, acciò unito ad Antonio Moncada destinato capitan generale dal parlamento, invigilasse alla sua difesa, e tenesse lontano l’odiato conte di Modica. Questi era a giorno de’ movimenti della sua nemica, e de’ timori da’ quali era agitata, sospettando di non essere assalita; e pensò, prima che si fosse meglio fortificata, di mettersi in marcia per Siracusa, e di assediare quel castello. Partì adunque con mille fanti e settecento cavalli, e giunto alla detta città cinse quella fortezza per terra e per mare, e minacciò il Lihori di un severo gastigo, perchè avesse preso le armi contro di lui, ch’essendo il presidente del regno rappresentava la corona 33. Dubitava nondimeno, che non arrivassero al castello di Marquetto frequenti soccorsi, e che perciò l’assedio divenisse lungo ed inutile; Artale di 26 Surita, loc. cit. t. III, lib. XI, cap. 7, p. 6 e seg. Merita questo erudito canonico di essere emendato, poichè isbaglia egli nel credere, che codesto parlamento siesi tenuto in Taormina dopo la morte accaduta in Sardegna del re Martino il giovane, e cita a torto il Surita, e il Pirri, che non ne parlano, che dopo la morte di Martino il vecchio. 28 Deca II, lib. IX, cap. 8, pag. 164. 29 In Decachordo Ecclesiae Catanensis, part. I, p. 174. 30 Sican. Hist., lib. V, p. 188. 31 Istor. di Ferdinando di Castiglia, lib. II. 32 Annales de Aragon., t. III, lib. XI, cap. 7, p. 6. 33 Surita, Annal. de Aragon., t. III, lib. XI, cap. 7, pag. 7. 27 - 13 - Alagona passeggiava per i mari di Siracusa con una squadra di galee genovesi. Per impedire adunque, che questi non v’introducesse de’ viveri, e delle soldatesche, e munizioni da guerra, fe’ fabbricare intorno al castello un ponte di barche, che guarnì di truppe ad oggetto d’impedire ogni approcciamento. Era assai critica la situazione in cui trovavasi la regina Bianca co’ suoi. Non potea sperare veruno umano soccorso, e avendo le milizie del Caprera colle macchine cominciato a battagliare le mura del castello, paventava ogni momento di non divenire la preda di questo terribile nemico. In questo stato di cose Giovanni Moncada, che militava sotto gli stendardi del conte di Modica, non avendo mai potuto indurre il suo comandante a trattare più umanamente quella reale principessa, e compassionandone la vicina rovina, abbandonò co’ suoi il campo, e venne ad unirsi alla regina, per cercare il modo di liberarla dagli artigli di questo nibbio. L’arrivo di costui rallegrò l’animo abbattuto di quella principessa. Fu tosto eletto per capitano, e gli furono affidati trecento cavalli, e molti fanti. Fu concertato, ch’egli con questa truppa comparisse nelle vicinanze di Siracusa, per tentare un combattimento con quelle del Caprera, e per tenerlo così a bada; e che intanto Raimondo Torella si sarebbe accostato al ponte colla sua galea per prendere a bordo la regina Bianca, e trasportarla in un più sicuro luogo. Così fu eseguito; il prode Moncada attaccò le soldatesche ch’erano alla difesa del ponte, e impossessatosi di una punta del medesimo incominciò ad incalzarle, in modo che andavano piegando e fuggendo. Durante questa mischia la principessa scese dal castello, e stava già per mettere il piede sul ponte per imbarcarsi sulla galea, ch’era già pronta, quando inaspettatamente cesse questo al peso de’ combattenti, e Bianca fu costretta a ritornare nella piazza. Questo inopinato caso afflisse il Moncada, il quale persuaso, che nelle guerre tante volte giovano le risoluzioni violente, determinato di liberare quella principessa, o di morire, fe’ aprire la porta del castello, e sortendone come un leone, colla sua gente piombò sulle truppe del Caprera, le sbaragliò, e le costrinse a fuggire, restando il castello libero dall’assedio. Cooperarono a questa impresa i Siracusani, i quali prese le armi obbligarono il conte di Modica ad evacuare la loro città 34. Quantunque la regina Bianca fosse restata signora di Siracusa, nondimeno, scrive il Surita 35, che se ne partì. Ci è ignoto dove mai fosse andata; ma è verisimile che avesse girato per la Sicilia, per conservarsi l’amicizia de’ suoi affezionati servidori, per tirare degli altri al suo partito, e per cercare la maniera di domare l’insolente Caprera. Noi la troviamo a 3 di luglio in Randazzo, dove vennero parecchi baroni ad ossequiarla, che trovansi nominati distintamente in una sua lettera scritta alla città di Palermo, a favore della quale accordò di poi una generale quietanza di tutto ciò che si era speso per conto della corona di Aragona, e di lei medesima. Passò di poi in Nicosia, dove chiamò con una circolare de’ 20 dello stesso mese i baroni per assisterla, e convocò un nuovo parlamento in Messina, invitandovi anche con una lettera de’ 24 la contessa di Gulisano. Da Nicosia venne a Taormina, d’onde a’ 23 di agosto scrisse una lettera di doglianza al comune di Genova per ciò che quei cittadini uniti al Caprera aveano operato contro di essa in Siracusa. Da Taormina tornò a Nicosia ad oggetto di soccorrere il castello di Naro assediato dal conte di Modica, e vi [23] chiamò il servizio militare, sebbene non avesse potuto difenderlo, essendo caduto nelle mani di questo barbaro conte, che trattò crudelmente il fedele castellano. Tutti questi fatti si ricavano da’ monumenti, di cui abbiamo le copie autentiche. Intanto nella valle di Mazara gli affari aveano cambiato di aspetto. In Palermo, dove fin’allora si era sostenuto il partito del Caprera, si cominciò a pensare diversamente. Quei cittadini, o perchè fossero ristucchi e malcontenti dell’alterigia di questo cavaliere, o che si fosse ne’ loro animi eccitato il desiderio comune agli altri Siciliani di avere un proprio re, presero le armi, e tumultuando per la città dichiararono che non voleano più soffrire il giogo della casa reale di Aragona, e ch’era giusto di avere il proprio sovrano, come lo aveano i Catalani. Fu perciò proposto di trattare il matrimonio fra la regina Bianca, e Niccolò Peralta, e di acclamarli per monarchi della Sicilia. Questo cavaliere era nato da Giovanni Peralta, e dalla principessa Eleonora di Aragona figliuola del duca di Atene e di Neopatria, uno de’ figliuoli del re Federico II 36, e perciò per linea femminile discendea dalla real casa di Aragona. Piacque questo progetto, e sulla speranza che potesse agevolmente eseguirsi, fu invitata la regina Bianca, da quando trovavasi assediata in Siracusa, a venirsene in Palermo. Accettò questa principessa l’offerta, e scappata da Siracusa, e fatto il giro per alcuni luoghi della Sicilia, che abbiamo accennato, a’ 9 di ottobre si ritrovò a Castronovo. Ivi seppe che il Caprera stavasene con ottocento cavalli alle porte di Palermo per sorprenderla, e spedì con altrettanta truppa di cavalleria, ma meglio agguerrita, l’ammiraglio de Lihori, il conte Arrigo Rossi, Giovanni Moncada, e Riccardo Filangeri per farnelo sloggiare. Arrivati questi guerrieri alla capitale cominciarono a scaramucciare colla cavalleria del conte di Modica, il quale atterrito dall’arrivo di questa truppa, la notte seguente a marcie sforzate se ne fuggì, avendo perso da cinquanta de’ suoi in parte presi, e in parte uccisi. Udito l’allontanamento del Caprera, la 34 Ivi lib. IX, cap. 18, p. 14. Ivi cap. 18, p. 15. 36 Sbaglia il Caruso (Mem. Stor. part. III, lib. I, vol. I, p. 9) volendo che Eleonora fosse figliuola di Federico II, dovea dirla nipote. 35 - 14 - regina a’ 18 dello stesso mese di ottobre partì da Castronovo e venne a Palermo, dove prese alloggiamento al palagio de’ Chiaramontani detto volgarmente l’Ostiere presso la riva del mare, per essere a portata di scappare, se il suo nemico tornava a inquietarla. Non erano ignote in Aragona le guerre civili della Sicilia, e siccome non erasi ancor deciso fra’ pretensori alla successione di Martino il vecchio, a chi mai si dovesse dare la preferenza, il parlamento dei regni spagnuoli congregato in Catalogna non era in grado di dare delle provvidenze; molto più che gli ambasciadori spediti dall’assemblea tenutasi a Taormina pretendevano di avere un proprio re indipendente dalla corona di Aragona, e voleano che questi fosse Federico conte di Luna bastardo di Martino il giovane. Era cosa facile, se i parlamentarî di Barcellona non provvedevano alla Sicilia, che i Siciliani, i quali aveano le armi alle mani, profittando della rivoluzione, in cui erano i regni di Valenza e di Aragona per le competenze fra’ concorrenti a quella eredità, si determinassero a scegliersi un sovrano; e già noi abbiamo avvertito che in Palermo si era risoluto di acclamare Nicolò Peralta. Stavano quindi incerti di ciò che dovessero fare, e aspettavano dal vantaggio del tempo che si desse sesto, eletto che fosse il nuovo re, alle vertigini della Sicilia. Erano nonostante spinti a dare qualche provvidenza dal re di Navarra padre della regina Bianca, che dimandava che la sua figliuola fosse liberata dalle insidie del Caprera, e dall’antipapa Benedetto XIII, il quale avea spediti tre nunzî a Barcellona, i quali chiedevano che la principessa Bianca fosse soccorsa, e che fosse conservato il regno di Sicilia, che per le dissensioni dei baroni era vicino alla sua rovina 37. Vessati da queste istanze determinarono per una interina provvidenza di spedire ambasciadori in Sicilia, i quali procurassero colle buone che così il conte di Modica, come coloro che erano del partito della regina Bianca, deponessero le armi, e che cessassero le ostilità, finochè si fosse deciso qual esser dovesse il legittimo erede del morto re di Aragona 38. Passò qualche tempo prima che gli ambasciadori catalani si potessero mettere all’ordine per portarsi in Sicilia, e fra questo mentre continuavano le dissensioni. La [24] regina Bianca poi, che venne in Palermo, colle sue amabili maniere sempre più si attirava l’amore dei popoli, e di giorno in giorno molte città che stavano dal partito del Caprera riconoscevano la di lei autorità, e si sottomettevano al suo potere. Fu famosa in questo tempo la confederazione fattasi nella città di Trapani agli 11 di novembre 1411 39 fra’ Trapanesi, i due baroni di Castelvetrano, e di Partanna, e le università di Mazara, di Marsala, di Salemi, e del monte S. Giuliano, per cui si obbligarono di mantenere a proprie spese un’armata a fine di difendere la regina Bianca, e la real casa di Aragona, e di offendere i nemici di essa, i quali guidati dal gran giustiziere intorbidavano la quiete di Sicilia. Questa lega dovea esser partecipata a Federico Ventimiglia capitano di Palermo, e a Calcerando Peralta capitano di Sciacca, restando invitati ad unirsi alla medesima, e pregati di ottenere l’approvazione della regina, e del di lei sacro consiglio 40. Nel seguente mese ebbe questa principessa il piacere di veder ritornare sotto il suo dominio la città di Catania. Signoreggiava in essa, salvo il castello, il conte di Modica, e vi avea posto per governatore Giovanni Filangeri. Sancio Ruitz de Lihori incaricato di levargliela dalle mani, venne con alcuni baroni e truppe vicino la porta nuova, e facendo scalare le muraglie senza strepito a 28 dicembre 1411 41 ne cacciò il governatore, e se ne impossessò a nome della regina 42. Fra coloro che in Catania sostenevano il partito del Caprera, dee nominarsi F. Mauro Calì dell’ordine dei minori, maltese e vescovo di Catania; ma la regina Bianca fin dal mese di giugno di quest’anno l’avea spogliato, come rubello, di quel vescovado, e avea destinato per amministratore di detta chiesa F. Tommaso Asmari nobile catanese dell’ordine di san Benedetto, che poi ne divenne vescovo l’anno 1416 43, dopo che Mauro la rinunciò. Giunse alle orecchie del conte di Modica la notizia che stavano già per arrivare in Sicilia gli ambasciadori spediti dal parlamento di Barcellona, per intimargli di metter giù le armi, e di non più molestare la regina Bianca. Non potea egli disubbidire senza incorrere nello sdegno dei suoi nazionali; pensò dunque di prevenirli, e di tentare, se gli era possibile, di avere nella mani questa principessa, anzichè arrivassero gl’inviati di Barcellona. Essendo egli dunque nella città di Alcamo non distante da Palermo che ventotto, o trenta miglia, radunò tutta la sua gente, e di notte marciò verso la capitale. Per quanto grandi fossero le diligenze che egli adoprò, acciò la sua marcia restasse celata, non isfuggirono la vigilanza di 37 Surita, Annales de Aragon., t. III, lib. XI, cap. 19, pag. 15. Surita, loc. cit. t. III, lib. XXIX, p. 20. 39 Il Caruso (Mem. Stor., part. III, vol. I, p. 8) rammenta questa lega, e la vuol fatta l’anno 1410, ma s’egli avesse riflettuto, che viene additata nell’atto la quinta indiz., che non cominciò che nel settembre del 1411, si sarebbe ricreduto dal suo errore. 40 Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, t. II, p. 178. 41 Rapporta questo fatto l’autore anonimo del Fragmentum Historiae Siculae (presso Muratori Rer. Ital. Script. t. XXIV, pag. 1092), ma lo riferisce all’anno 1412. S’inganna però, poichè la presa di Catania avvenne prima dell’arrivo degli ambasciadori spediti da Catalogna, i quali giunsero, come diremo, nel mese di gennaro 1412. Accadde dunque nel dicembre antecedente. 42 Surita, loc. cit., t. III, lib. XI, cap. 76, p. 58. 43 Pirri, Not. Eccl. Siciliensium, not. I. Eccl. Catan. p. (m.) 53. – De Grossis in Catana Sacra p. 143 e 185: et in Decachordo Eccles. Catan., § 14, p. 127. – Amico, Catan. Illustr., t. II, lib. VII, p. 676. 38 - 15 - coloro, ai quali stava a cuore la salvezza della regina. Fu essa subito avvisata, e sollecitamente uscendo dal suo palagio s’imbarcò colle damigelle sulla galea, che era comandata dal Torella, e indirizzandosi verso il lido, dove oggi è il molo nuovo, e che chiamavasi allora s. Giorgio, si pose in sicuro 44. Restò oltremodo sdegnato il conte di Modica nel vedersi scappata la sua preda. Il Fazello 45 modestamente dice, ch’ei vedendosi fallito il colpo, fe’ cose da pazzo: Plura [25] velut insaniens non dissimulanter egit, e con pari modestia scrisse il Caruso 46, diede, dice egli, nelle smanie, e in debolezze indegne di un suo pari. Ma il Maurolico con sincerità storica 47 non esita punto a propagare le di lui debolezze, e racconta che il Caprera entrato nella camera della regina, e trovato il di lei letto sconvolto, e ancor caldo, abbia detto: se ho perduta la pernice, rimane in mio potere il nido: ubi cernens cubile turbatum, quale solet ad subitum timore relinqui, perdicem, ait, perdidi, sed nidum teneo, e soggiunge che diviato spogliandosi delle sue vesti, si coricò nelle tiepide piume, e voltandosi per esse colle narici aperte, fiutando a guisa di un cane da caccia, andava dietro all’odore della preda; protinusque depositis vestibus, lectum, ut adhuc erat tepidum, subit, ac per totum se volutans, et subinde spiritum per nares traens significabat, obganniens more venatici canis, ad lustrum ferae sese odore delectari 48. Così questo vecchio stolto, lussurioso e rimbambito Pasceva i suoi famelici desiri 49 e mostrava, di quali stravaganze è capace un cuore innamorato, e che le piaghe insanabili del cieco fanciullo nè per età, nè per gravi malattie sanar si possono. Sfogata la malnata passione, e rivestitosi il Caprera, diè sacco al palagio l’Ostiere, e s’impossessò di tutte le gioie, e le mobilie della regina, che furono dopo valutate per dieci mila fiorini, quali fu poi obbligato a pagare al procuratore di questa principessa, quando, fattasene la causa innanti all’infante D. Giovanni successore nel viceregnato alla medesima, si decise a Catania l’anno 1416 che ne fosse rimborsata. Stavasi Bianca in alto mare, incerta qual partito dovesse prendere. Intanto la veloce fama di quel ch’era accaduto in Palermo arrivò a Trapani, dove di fresco nel mese di gennaro istesso erano arrivati da Catalogna gli ambasciadori mentovati. Udendo questi le circostanze, nelle quali era questa principessa, senza più aspettare la galea richiesta, si affrettarono di correre tosto a Palermo, dove giunti andarono a trovare la regina, e dopo di averle dato conto della loro commissione, la consigliarono a sbarcare, e a ricoverarsi nel castello di Solanto, dove avrebbero curato che stesse ben difesa, e custodita. Acconsentì Bianca alle loro insinuazioni, e venne a Solanto, del di cui castello il Torella divenne il custode. Corsero tosto a guardare la sventurata regina alcuni nobili con settecento cavalli, ed ivi si trincerarono. Erano questi Antonio Moncada conte di Adernò, Arrigo Rosso conte di Sclafani, Matteo Moncada conte di Caltanissetta, il conte Matteo Ventimiglia, l’ammiraglio Sancio de Lihori, Calcerando Santapau, Giovanni Moncada, Giovanni Baluzio, ed altri baroni e cavalieri, che si erano tutti congiurati contro l’altiero conte di Modica 50. Assicuratasi Bianca da ogni insulto, che potesse arrivarle dal Caprera, dichiarossi ben contenta che gli ambasciadori Catalani, che ella rispettava per l’onore dovuto alla corona di Aragona, fossero gli arbitri delle differenze che erano insorte fra lei, e il gran giustiziere. Premea a detti ambasciadori il ridurre la Sicilia in quiete, e principalmente per alcune novità accadute di fresco in Messina. I papi hanno sempre preteso, sebbene vanamente, di avere diritto sopra la Sicilia, e che i nostri re, come sovrani di Napoli e di Sicilia, offerissero alla santa sede ogni anno la chinea, e pagassero il censo per ambe le Sicilie, appoggiati o alla falsa donazione di Costantino, o a quelle di Pipino, di Carlo Magno, di Ludovico II, degli Ottoni, e di s. Arrigo, che sono dello stesso calibro, ed insussistenti, specialmente per conto della Sicilia, non potendo questi principi dare ciò che non appartenea loro, nè aveano conquistato, e che era in potere dei Saraceni. Ora il pontefice Giovanni XXIII volendo trar vantaggio dalle vertigini, in cui erano i regni di Aragona, e di Sicilia, avea spedito in Messina con tre galee un legato apostolico, il quale fu incaricato di promulgare che non avendo i re Aragonesi pagato il tributo alla santa sede per la Sicilia, che teneano (dicea egli) in feudo 44 Il Maurolico (Sican. Hist. lib. V, p. 189 e 190), e il Caruso (Mem. Stor. part. III, lib. I, vol. I, pag. 10) rapportano lo stesso fatto, ma discordano in una circostanza; giacchè vogliono che il Caprera prese questa risoluzione, poi che seppe l’arrivo a Trapani degli ambasciadori. Racconta lo storico messinese, da cui il Caruso trasse questa notizia, che gli ambasciadori giunti a Trapani spedirono Pietro Martini a Palermo, acciò chiedesse alla regina la galea che comandava il Torella, con cui intendeano di portarsi a Palermo, e che costui passando per Alcamo fu trattenuto un giorno e mezzo dal conte di Modica, per impedire che la regina Bianca sapesse l’arrivo degl’inviati, e per eseguire il disegno che allora gli venne in capo; e riflette che l’inganno usato da questo nemico della regina, giovò alla medesima, perchè, se la galea fosse andata a Trapani, come il Martini avea commissione di ricercare, la principessa non avrebbe forse avuta la maniera di sottrarsi al suo nemico. 45 Tom. III, dec. II, lib. IX, cap. 8, p. 167. 46 Mem. Stor. part. III, lib. I, vol. 2, p. 2. 47 Sican. Hist. lib. V, p. 190. 48 Ivi. 49 Tasso, canto 18. 50 Surita, Annal. de Aragon., t. III, lib. XI, cap. 76, pag. 59. - 16 - dalla medesima, era perciò questo regno caduto in potere del papa. Fu cosa agevole a questo prelato il persuaderne in quei tempi d’ignoranza i buoni Messinesi, i quali tostamente giurarono ubbidienza al medesimo, come a legato [26] pontificio, e lo stesso giuramento fe’ la città di Melazzo, ch’era allora una delle maggiori fortezze dell’isola, ed appartenea alla giurisdizione di Messina; il solo castello di Mattagrifone ricusò di riconoscere il dominio del papa. La facilità, con cui Messina col suo territorio si sottomise, fe’ sperare al legato che presto tutta la Sicilia avrebbe fatto lo stesso, e con questa lusinga cominciò ad arrolar gente, a pagar soldi, e a fare altri preparamenti di guerra per conquidere la dominante nazione catalana. Paventavano adunque gli ambasciadori, e con essi il Caprera, che mentre continuavano le discordie fra le due fazioni, il legato del papa non attirasse al suo partito le altre città del regno oramai ristucche della guerra civile, e non venisse a capo di cacciare dalla Sicilia la regina Bianca, gli ambasciadori di Barcellona, il gran giustiziere, e tutti i Catalani, e i loro aderenti, e non si verificasse il proverbio che fra due litiganti venisse un terzo al godimento della cosa contrastata. Il Caprera ancora era particolarmente angustiato dalle voci sparse che forse Carlo il nobile re di Navarra, e padre della regina Bianca avrebbe mandati de’ soldati alla insidiata figliuola per sostenerla. Questi timori resero più arrendevole il conte, il quale si contentò che si trattasse la pace. Per parte del gran giustiziero comparvero Arcimbao de Fox fratello del visconte di Castalbo, parente del Caprera, ed Artale de Luna conte di Caltabellotta. Costoro seppero così bene far valere le ragioni del conte di Modica, le quali, come abbiamo divisato, erano assai più fondate che quelle della regina Bianca, che trassero i giudici a suo favore; avvegnachè fu risoluto, che tutte le città e castella del regio demanio, comprese ancora quelle della camera reginale, fossero in avvenire amministrate dal gran giustiziere, il quale le tenesse, a nome di quel principe, che sarebbe stato dichiarato monarca di Sicilia: che la regina Bianca si ritirasse nel castello di Catania coll’assegnamento di venti mila fiorini all’anno, senza punto ingerirsi nel governo: e che fosse tregua fra’ baroni del partito reginale, e il conte di Modica. Non potè la regina Bianca, che avea scelti per arbitri gl’inviati di Aragona, contraddire a quanto eglino aveano determinato, e perciò partita da Solanto andossene a Catania assistita in quel castello da Gabriele di Faulo, ch’era stato, anche vivente Martino il giovane, destinato a servire e difendere in quel castello questa principessa 51. Se fu contento il Caprera della sentenza degli ambasciadori catalani, non lo furono certamente coloro che aveano abbracciato il partito della vicaria, i quali a malincuore soffrivano di vederla spogliata di ogni potere, e che tutta l’autorità si fosse tramandata nelle mani del loro nemico, da cui, nulla ostante la tregua, poteano temere che non cercasse de’ pretesti per vendicarsi. Suggerirono adunque a questa principessa che gli ambasciadori catalani l’aveano tradita, e aveano pregiudicati i di lei interessi; e che trovandosi ora libera e in tutta sicurezza, potea rescindere quanto coloro per una certa condiscendenza verso il loro compatriotta aveano ingiustamente sentenziato. Non fu d’uopo di molta fatica per persuadere la regina assuefatta a comandare, la quale cambiando di sentimento dichiarò di non volere più stare a quanto si era stabilito a Solanto. Il primo ad alzar bandiera contro la suddetta convenzione fu il conte Giovanni Ventimiglia, il quale, vantando di essere stato eletto dalla regina Bianca capitan generale, marciò verso Siracusa, e se ne impossessò 52. Ecco dunque resi inutili i maneggi degl’inviati di Catalogna, ed ecco acceso con nuova forza il fuoco della dissensione, che stava sepolto sotto le ceneri di una finta tregua. Trovossi diviso nelle stesse due fazioni il baronaggio, tenendo gli uni il partito della regina, che riconoscevano, malgrado la sentenza datasi a Solanto, come vicaria del regno, e sostenendo gli altri il Caprera, ch’era il gran giustiziere. Non eravi modo di smorzare questo incendio, avvegnachè erano irreconciliabili nemici il Lihori, e il Caprera, che trovavansi alla testa de’ due partiti. Il teatro di questa nuova guerra divenne la città di Palermo, ch’era in potere del conte di Modica, trattone il castello che dopo la partenza della principessa non volle mai sottomettersi, e soffriva dal medesimo l’assedio. Arrivarono colle loro soldatesche presso questa città l’ammiraglio mentovato de Lihori, e Antonio Moncada conte di Adernò, e intimarono al Caprera che levasse l’assedio, e restituisse alla vicaria i castelli e le soldatesche, che avea sotto il suo comando, e andasse in Catania [27] a farle omaggio. Il superbo conte non rispose a questa intimazione in altro modo, se non con quello di schierare le sue truppe in ordine di battaglia fuori le mura di Palermo, addimostrando così, qual conto ei facesse delle loro bravate. Mentre le due osti erano sopra le armi, il Caprera, non si sa per quale affare, dovè rientrare in città. Ne fu avvisato il Lihori da una spia, il quale vi pose in aguato alcune soldatesche. Ritornando il conte al campo fu da queste sorpreso, che lo circondarono, e malgrado gli sforzi ch’ei fece per liberarsi, lo fecero prigione, e lo condussero all’armata della regina 53. 51 Surita, loc. cit., t. III, lib. IX, cap. 76, pag. 59. Ivi. 53 Surita, loc. cit., t. III, lib. XII, cap. 3, p. 77. 52 - 17 - Qual fu allora la contentezza del Lihori nel vedersi l’arbitro del suo formidabile nemico, e quale quella della regina Bianca nel trovarsi colla prigionia di un solo restituita nella primiera autorità! L’ammiraglio considerando quanto importasse la custodia di questo prigioniero, nè fidandosi di altri, ordinò che fosse trasportato immediatamente nel fortissimo castello della Motta, ch’era di sua pertinenza, e che fosse ivi colla possibile diligenza guardato. Durò in prigione questo infelice cavaliere fino che fu fatto il re di Aragona, come in appresso racconteremo. Il Surita 54 scrive, che s’è vero quanto lasciò registrato Lorenzo Valla 55, il conte di Modica fu in quella fortezza trattato assai villanamente, e non come meritava un così ragguardevole personaggio, che avea così ben servita la corona di Aragona nella conquista del regno di Sicilia. Il racconto del Valla viene additato dal Fazello 56, e da altri nostri più moderni storici. Nondimeno noi non possiamo indurci a crederlo vero, almeno nelle sue circostanze, e abbiamo delle congetture plausibili per riputarlo un romanzo 57. Liberatasi la regina Bianca dal Caprera, continuò nell’esercizio di vicaria del regno. Siccome gli aderenti al conte di Modica, trovandosi privi di capo, doveano pensare a casi loro, e sottomettersi al di lei potere, avrebbono dovuto in Sicilia godersi de’ giorni lieti, e ridursi ogni cosa alla primiera tranquillità; ma costoro, malgrado la prigionia del Caprera, più pertinaci di prima, tennero fermo a non volere riconoscere per vicaria questa principessa, e perciò la Sicilia restò involta nelle stesse dissensioni durante quasi tutto l’anno 1412, fino che il nuovo re di Aragona pensò a darvi riparo. Prima che noi mettiamo il termine a questo primo libro, non sarà discaro a’ nostri leggitori di sapere nell’interregno, che corse fra la morte di Martino il vecchio, e l’elezione di Ferdinando il giusto, a nome di qual principe si fossero stipulati in Sicilia gli atti pubblici. I nostri notari si servirono di due formole ne’ loro rogiti. L’una era la seguente: Regnante Domino nostro Domino rege Aragonum, et Siciliae; senza nominar chi fosse. Io trovo questa maniera in due donazioni fatte per mani di notar Manfredo la Muta al mio monistero di s. Martino delle scale di Palermo, l’una de’ 14 di novembre, e l’altra de’ 19 dello stesso mese, V. indizione 1411, dalla quale forma di scrivere ben rilevasi che riputavano allora [28] inseparabile il regno di Sicilia da quello di Aragona. L’altra era questa: In regno Sicilie rege carente ob sacre memorie inclytorum Dominorum nostrorum. Dominorum regum utriusque Martini, et filii excellentissimorum Aragonum, et Sicilie regum ac Athenarum, et Neopatrie Ducum obitum corporalem, valido, et regimine gubernatione vigente Aragonum dive domus. Così sta scritto in un’altra donazione fatta allo stesso monistero da Manfredo Muta, e stipulata per gli atti dello ignorantissimo notar Paolo de Rubeo. Le une, e l’altra conservansi nell’archivio martiniano, e si promulgheranno nel nostro codice diplomatico della storia civile di questo regno. 54 Ivi. De regno Ferdinandi de Aragonia, lib II. 56 Dec. II, lib. IX, cap. 8. 57 Rapporta questo scrittore, che il Lihori fe’ rinserrare il Caprera in una cisterna, e che ordinò che si aprissero gli aquedotti in guisa che entrando le acque fu vicino a soffocarsi, chiedendo inutilmente soccorso da’ domestici; che finalmente alle tante grida accorse un uomo, il quale mosso da compassione andò tosto ad avvisarne il Lihori, il quale fingendo di esser sorpreso da questo improvviso accidente, comandò che fosse tratto, così bagnato come era, dalla cisterna, e trasportato in un’altra prigione del pari orrenda, perchè oscura e puzzolente; che ivi non potendo reggere agli strapazzi ed ai digiuni che soffriva, cercò di guadagnarsi il carceriere, offrendogli mille scudi d’oro, se lo lasciava scappare; che questi, pascendolo di speranze, palesò l’offerta all’ammiraglio, il quale gli permise di promettergli la fuga, ma a condizione che prima pagasse i mille scudi, e che scappasse dalla finestra. La pattuita somma fu tosto soddisfatta dagli amici del Caprera, e il custode puntualmente la notte l’attaccò con una fune, e lo fe’ scendere. Credea il conte di essere già vicino ad acquistare la sospirata libertà, ma si trovò deluso. Il Lihori avea fatte stendere in aria delle reti, dalle quali mentre calava l’infelice cavaliero si trovò accalappiato, senza potersene disbrigare, e vi restò per la notte, e la seguente giornata fino all’ora di vespro, divenendo così la favola di coloro, che passavano per quella strada. Or quale verisimiglianza troveremo noi in questo racconto? Ci persuaderemo che il Lihori in tempi così critici si fosse ritirato alla Motta, e avesse abbandonata la corte della regina, dove era la molla movente tutti gli affari? Troveremo noi probabile che gli amici del Caprera, da’ quali diconsi sborsati i mille scudi d’oro, se ne stessero alla Motta, cioè in un paese di cui era signore il loro più ridottabile avversario? Immagineremo noi che una carcere di tanta importanza, in cui si custodiva un prigioniero, che tanto premea di conservare, fosse sferrata alla finestra, e per conseguenza così poco sicura? 55 - 18 - LIBRO SECONDO DE’ VICERÈ SOTTO I PRINCIPI DELLA CASA DI CASTIGLIA. Diversi erano i competitori alla successione de’ regni di Aragona, di Valenza, di Catalogna, e di Sicilia, ch’erano vacati per la morte di Martino il vecchio, la maggior parte de’ quali era abbastanza forte per farsi ragione colla spada alla mano. Rincrescea ai rappresentanti de’ tre regni spagnuoli, che questa contesa si dirimesse con ispargimento di sangue, e per evitare questo flagello della umanità, si accordarono a nominare nove giudici dotti, e di retta coscienza, innanzi ai quali ciascheduno de’ pretensori potesse rappresentare le sue ragioni, e da’ quali, senza ammettersi ulteriore appellazione, si eleggesse colui, che avea maggior diritto a questi regni. Non rechi a veruno meraviglia che il nostro regno, il quale nulla avea da cedere a’ tre delle Spagne, non fosse stato punto considerato, quasi che fosse una pertinenza di quelli. Sono codesti gli effetti delle intestine dissensioni. I nostri baroni in vece di concorrere cogli altri regni alla scelta del nuovo monarca, se ne stavano divisi in fazioni, e tutta la loro occupazione era di distruggersi scambievolmente. Gli eletti nove giudici, famosi per dottrina e per santità 58, si chiusero nel castello di Caspe nella provincia di Aragona con proposito di non uscirne, se prima non avessero eletto il successore del re Martino il vecchio, facendosi una legge che fossero necessarî almeno sei voti, perchè fosse legittima l’elezione. Citati i concorrenti, ed udite le ragioni che apportavano, sei de’ giudici di comune consenso si dichiararono a favore dell’infante Ferdinando di Castiglia, a’ quali essendosi uniti gli altri tre, nel dì 28 di luglio 1412 59, per la bocca di s. Vincenzo Ferrer, ch’era uno de’ giudici, dichiararono il detto principe erede, e successore ne’ contrastati regni 60. Questa elezione fu universalmente applaudita da’ popoli. Ferdinando per senno e per virtù era riputato il più gran sovrano di quel secolo, e si era acquistato il nome di Giusto, avendo generosamente ricusata la corona di Castiglia offertagli dagli ordini dello stato alla morte di Arrigo III suo fratello, volendo che fosse coronato il di lui figliuolo, quantunque non avesse che ventidue mesi, di cui fu egli tutore, amministrando a nome del nipote lodevolmente quel regno 61. Dopo di aver dati i dovuti ripari a’ regni di Spagna, rivolse Ferdinando l’animo a quello di Sicilia, dove maggiori erano le turbolenze, alle quali per la distanza de’ luoghi non era agevole il rimediare. Oltre le intestine guerre, che aveano turbata questa isola, dava ombra la pace fattasi fra Ladislao re di Napoli, e il pontefice Giovanni XXIII. Si era sottratto il monarca napolitano dall’ubbidienza di Gregorio XII, che avea fin’allora riconosciuto per pontefice, e si era riconciliato con Giovanni, da cui avea ottenuta l’investitura del regno di Sicilia. Ora siccome questo papa avea, [29] come abbiamo osservato nel libro antecedente, delle aderenze in Messina e ne’ suoi contorni, e Ladislao era assai vicino, potea accadere che i Siciliani angustiati dalle continue guerre non s’inducessero ad abbandonare l’Aragona, e a riconoscere per loro sovrano il ridetto principe. In questo stato di cose deliberò il nuovo re Ferdinando di spedire de’ soggetti abili in Sicilia, i quali in compagnia della regina Bianca dassero sesto a questo sconcertato regno. CAPO I. La regina Bianca vicaria del regno. I due nostri cronologisti de’ vicerè di Sicilia, cioè il canonico Antonino Amico 62 e Vincenzo Auria 63 comunque sieno di accordo con noi, che la regina Bianca fosse stata confermata nel vicariato del regno dal re Ferdinando il Giusto, le assegnano non ostante quattro vicegerenti, che uniti alla medesima regessero l’isola. I nominati da loro sono Romeo de Corbera maestro dell’ordine de’ cavalieri di Montesa nel regno di Valenza, Ferdinando de Vega maestro Portolano del regno, Ferdinando Vasquez Porrado cancelliero del re e maestro segreto del regno, e Martino de Torres. Racconta l’Auria, che il Surita 64 a questi aggiunge altri tre, cioè Pietro di Escalante, Bonanato Pere, e Lorenzo Redon. La verità però è che l’annalista spagnuolo non aggiunge altri tre a’ quattro nominati, quasi che fossero stati sette, come pare che voglia dire l’Auria, ma in vece del Vega, del Vasquez, e del Torres nomina l’Escalante, il Pere, e il Rodon: deliberò, dic’egli, embiar a Sicilia con solemne embaxada a fray Romeu de Corbera maestre de Motesa, y a Messen Pedro Alonso d’Escalante, Messen Bonanat Pere, y a Lorenzo Redon. Per conciliare questa differenza di soggetti spediti dal re di Aragona, fa di mestieri dire, che i primi eletti furono l’Escalante, il Pere, e il Rodon, e che non 58 Surita, Annal. de Arag., t. III, lib. XI, cap. 72, p. 56. Il Rainaldo (in Annal. ad an. 1410, t. VIII, pag 309, n. 11) anticipa due anni questa elezione, fissandola lo stesso anno in cui morì Martino il vecchio, cioè l’anno 1410, ma si sbaglia all’ingrosso. 60 Surita, loc. cit. cap. 87, p. 70. 61 Surita, loc. cit. t. III, lib. XII, cap. I, p. 74. 62 Chronologia de los virreyes, y presidentes del reyno de Sicilia, p. 2. 63 Hist. cronol. delli signori vicerè di Sicilia, p. 4. 64 Annal. de Arag., t. III, lib. XII, cap. 3, p. 77. 59 - 19 - potendo l’Escalante, e il Pere portarsi in Sicilia, o perchè erano più necessarî in Barcellona al real servizio, furono di poi scelti in vece loro il Vasquez, o Velasquez, e il Torres. Che la bisogna sia andata così, lo deteggiamo da’ registri del protonotaro degli anni 1412 e 1413, ne’ quali sono nominati non già l’Escalante e Pere, ma il Vasquez, e il Torres, e da ciò che nello stesso capo il Surita soggiunge che conveniva al real servizio: que guedassen Pero Alonso de Escalante, y Bonanat Pere, y en su lugar fue un famoso doctor en decretos castellano llamado Martin de Torres, y despues fue embiado otro Letrado tambien castellano del Consejo del rey, que fue el licentiado Fernan Velasquez su canceller. Ferdinando Guttieres de Vega, ch’è il quarto nominato da’ nostri cronologi, non partì cogli altri tre, ma fu spedito dopo, come or ora diremo. Prima di mandare costoro in Sicilia, il re Ferdinando avea scritto alla regina Bianca, dandole conto della sua assunzione a’ regni del morto Martino, e sollecitandola ad accordare la libertà al conte di Modica, per cui era stato pregato da’ grandi della sua corte. Dovette questa lettera essere contemporanea alla elezione de’ mentovati soggetti, e perciò de’ primi del mese di ottobre 65. Noi abbiamo fra le nostre carte la risposta fatta dalla medesima principessa al ridetto monarca da Lentini sotto li 20 dello stesso mese di ottobre, la quale è mancante del suo principio, ma contiene ciò che riguarda l’articolo della prigionia del Caprera, intorno al quale dice al re Ferdinando, che ha già provveduto che la persona di questo prigioniero sia sicura da ogni danno, o pericolo, e che non sieno punto molestate le di lui possessioni, ma che il servigio di S.M., e la pace del regno ricercava che ei restasse ben guardato in prigione. Soggiunge che stavasi compilando il processo, essendo pubblici e notorî i delitti di questo temerario, e che si sarebbe, subito che fosse compito, spedito alla corte, sperandosi che S.M. secondo i dettami della giustizia avrebbe fatto gastigare gl’infiniti ed esquisiti delitti di costui per esempio degli altri. In questa occasione rammenta i danni, che il Caprera avea recati alle città, e terre, e vasalli della corona, oltre le infami azioni usate contro se stessa, e i suoi beni, che vendè al pubblico incanto, come se fossero stati una preda fatta a’ nemici della corona. Prega perciò il re ad ordinare che fossero restituiti senza spargimento di sangue i luoghi, che il conte di Modica avea occupati, appartenenti al regio [30] demanio, e conchiude che la libertà di costui potrebbe esser nociva allo stato, poichè non si era nella Sicilia goduta in qualche maniera un’aura di tranquillità, che dal dì in cui il Caprera era stato carcerato. Malgrado questa forte rimostranza non sapea il re Ferdinando persuadersi che il conte di Modica fosse così reo, come era dipinto, e sospettò che quanto scrivea la regina Bianca era opra di Sancio de Lihori nemico giurato del medesimo. Si confermò in questa sospicione dalle relazioni arrivate alla sua corte da’ partigiani del conte di Modica, le quali portavano che il Lihori, non ostante che già si sapesse il legittimo erede del regno di Sicilia, e di quei di Spagna, continuava a tener viva la guerra, e arrecava danno alle città di Palermo, di Marsala, di Salemi, di Mazara, e agli altri luoghi che si erano mostrati propensi per il suo antagonista. Stando in questo errore si determinò di mandare in Sicilia Ferdinando Guttieres de Vega, que, dice il Surita 66, era un cavallero, de cuya prudencia, e industria el rei hizo major confiança en todas las cosas de mayor importancia, cui ordinò che partisse subito per la sua commissione, e che unito agli altri cercasse colla sua destrezza ed attività di ridurre gli aizzati animi alla bramata pace, e di procurare la libertà del Caprera. Di questi personaggi mandati dal re Ferdinando in Sicilia parla ancora l’autore del Frammento sulla storia di Sicilia stampato dal Muratori 67, ma non ne nomina che tre, e li suppone spediti due anni dopo. Eccone le parole: anno 1414, 7 indictionis fù mortalitati in la isola di Sicilia, undi chi vinniro vicerrè, et gubernaturi lu mastru di Montesa, Misseri Ferrandu de Vega, et Misseri Martinu di Turs. Or costoro vennero eglino come viceregnanti e governatori dell’isola, o come semplici consiglieri della regina Bianca? Questo appunto è l’articolo che ci sembra degno di essere esaminato. Se si dà fede all’autore del testè nominato frammento, vinniro vicerrè et gubernaturi, e dall’autorità di costui forse i nostri cronologi Amico, e Auria li collocarono come vicegerenti uniti alla vicaria. Noi però da quanto lasciò scritto il Surita, cui doveano essere note le carte della cancellaria di Aragona, e dagli ordini che costoro seco recarono, opiniamo che non fossero stati destinati, che come consiglieri della vicaria. Unica luogotenente in Sicilia vien nominata ed eletta la regina Bianca: proveyò, dice il cronista aragonese 68 por su lugartienente general a la reyna de Sicilia, e coloro che furono destinati dal re, non hanno altro titolo che quello di ambasciadori del re: sus ambaxadores. E ch’eglino non fossero stati mandati come luogotenenti, o vicerè, ma solamente come consiglieri della vicaria la regina Bianca, ben rilevasi dal diploma reale, che fu loro consegnato. Erano eglino incaricati di far conoscere come vicaria del regno la regina Bianca da tutte le città e castella, che prima ubbidivano al conte di Modica, e se queste difficoltavano a sottomettersi, di convocare in ciascheduno di detti luoghi, per i quali passavano, i governatori e i popoli, e di palesar loro in quelle assemblee, come Ferdinando per sentenza di giudici era stato dichiarato il legittimo successore in tutti i regni della real corona di Aragona, e che per tale 65 Surita, loc. cit. Loc. cit. 67 Rer. Ital. Script., t. XXIV, p. 1092. 68 Loc. cit. 66 - 20 - era stato riconosciuto da tutti i vassalli, che gli aveano giurato fedeltà; che dietro a questa dichiarazione era egli venuto colla regina, l’infante Alfonso, e gli altri suoi figliuoli nella città di Saragoza, dove era stato ricevuto con grandissimo onore, e vi avea convocate le corti generali di quei regni, le quali, oltre di avergli fatto il dovuto omaggio, aveano anche riconosciuto come erede il di lui primogenito; che di poi avea data commissione a diversi letterati di esaminare la successione nel regno di Sicilia, i quali con uniforme parere erano stati di avviso che gli appartenea; che quindi erano stati eglino inviati, come suoi ambasciadori, acciò ricevessero in suo nome il giuramento di fedeltà da’ prelati, baroni, e popoli, della Sicilia, con potere di giurare ancor eglino, e confermare i privilegi, e le libertà della nazione, e coll’incombenza di metter ordine ad ogni cosa, e di ridurre il regno nel buono e pacifico stato. Che se nonostante alcuno ricusasse di ubbidire alla vicaria, erano incaricati di fare ogni opra per farla riconoscere, e di stabilire, per troncare ogni difficoltà, un consiglio, che le stesse a lato nella forma come era stato prima prescritto in Barcellona dal re Martino il vecchio 69. Questa provvidenza data dal monarca di Aragona abbastanza addita che la podestà data agli ambasciadori non era che [31] passaggiera, e unicamente indiritta a ricever gli omaggi, a giurare l’osservanza de’ privilegi, e a procurare la pace; ma che tutta l’autorità era tramandata nell’eletta vicaria generale. Ciò vieppiù si fa palese dalla maniera come vien prescritto il nuovo consiglio. Determinò il re che questo senato fosse composto da persone indifferenti, d’intemerata coscienza, e zelanti dell’onore della corona di Aragona, e del bene della repubblica. Dovea il loro numero essere di diciotto consiglieri, nove dei quali fossero Catalani, e fra questi i quattro ambasciadori, e nove Siciliani. Che se questo numero sembrasse eccedente, permettea S.M. che si minorasse a dodici, sei de’ quali fossero Catalani, compresivi i quattro ambasciadori, e sei Siciliani. Nelle determinazioni dovea esservi il concorde parere di dieci, se il consiglio era composto di diciotto, cinque Catalani, fra quali gli ambasciadori, e cinque Siciliani. Che se il consiglio era composto di dodici, dovea allora esservi il consenso di otto, quattro Catalani, fra quali due degli ambasciadori, e quattro Siciliani 70. Or se gli ambasciadori fossero stati vicegerenti, secondochè piacque a’ nostri cronisti, come erano eglino confusi cogli altri consiglieri, senza altra distinzione che quella di dovere o tutti o parte votare nelle risoluzioni, che far si doveano? Questo privilegio, che a loro soli era concesso, addimostra una maggiore considerazione, ch’eglino avessero sopra gli altri votanti, la quale potea nascere dall’opinione di letteratura, che riconoscea in essi il re Ferdinando, non già ch’eglino fossero correggenti colla regina Bianca. Non sapremmo per l’appunto additare il giorno in cui eglino arrivarono in Sicilia: il loro cammino era indiritto a Trapani, d’onde, come città che allora era contraria al partito del Caprera, doveano cominciare ad eseguire la loro commissione. Abbiamo motivo da credere che vi fossero arrivati nell’entrare del mese di dicembre; avvegnachè noi abbiamo fra le nostre carte una lettera della regina Bianca scritta da Catania a’ 24 di dicembre 1412 agli uffiziali, e all’università di Palermo, da cui si ricava che gli ambasciadori erano già in Sicilia, sebbene questa principessa non li avesse ancora veduti 71. Eseguirono gli ambasciadori, girando per il regno, gli ordini sovrani, e poi si presentarono alla regina Bianca, cui esibirono i loro dispacci, e unitamente ad essa presero a dar sesto al disordinato regno. Ogni cosa andava bene, e solo trovarono degli ostacoli nel grande ammiraglio Sancio Ruitz de Lihori, quando a nome del re Ferdinando richiesero che mettesse in libertà il conte di Modica. Ma perchè egli sempre si negò di consegnarlo, e poichè era pressato a farlo, per esimersi dalla reità di disubbidienza, prese il pretesto di dire, che sarebbe egli stesso andato alla corte a presentare al re questo prigione. Forse l’opera di persuadere il Lihori era riserbata all’efficacia del cavaliere Ferdinando Guttieres de Vega, che fu poi spedito espressamente a quest’oggetto. Dopo l’arrivo adunque di costui riuscì agli ambasciadori di ottenere dal Lihori che fosse consegnato il conte di Modica. Ma siccome ebbero questi nelle mani anche il processo, dal quale rilevavansi gli enormi delitti del medesimo, non istimarono eglino stessi di metterlo in libertà; ma lasciandolo in prigione a nome loro scrissero alla corte, facendo presenti al re le reità di questo cavaliere, e aspettando gli ulteriori ordini. Il conte di Pallas, e parecchi altri de’ principali baroni della Catalogna, ch’erano uniti in parentela col Caprera, non intralasciavano di fare continue premure a quel Monarca, acciò si compiacesse di accordargli la libertà. 69 Loc. cit. Loc. cit. 71 La suddetta lettera è una risposta che fa Bianca alla città di Palermo, che l’avea avvisata dell’ottimo stato de’ monarchi di Aragona, e dell’arrivo degli ambasciadori, che da Trapani si era saputo in quella capitale. Si rallegra la regina dell’una e dell’altra notizia; dice a’ Palermitani di avere certi riscontri di essere confermata vicaria del regno, e di ottenere l’arbitrio di disporre della sorte del Caprera, e di determinare tutto ciò che riguarda il bene del regno, col consiglio però de’ ministri che tiene presso di sè, e di quelli che le saranno mandati dall’Aragona. S’ingannò ella intorno al Caprera, come si è veduto e si osserverà. Duolsi di poi la principessa di questa capitale, perchè avea seguito il partito del conte di Modica, tenendo a nome di esso i castelli, e particolarmente il palagio degli Schiavi, escludendo i fedeli Catalani, e introducendovi i Guasconi nemici della corona di Aragona. Ordina perciò all’università, che rimuova gli uffiziali del Caprera, che chiama occupatore e destruttore del regno, obblighi i castellani a render le fortezze, richiami i cittadini fuorusciti zelanti della corona, e tolga le barriere poste contro il palagio reale, minacciando di gastigare coloro per colpa dei quali i suoi ordini non fossero eseguiti. 70 - 21 - Ferdinando o per condiscendere a’ desiderî de’ congionti del conte, o che avesse in considerazione i singolari servigî che quest’uomo avea resi in Sicilia a’ due Martini, o perchè non volea che per [32] questo affare si accendesse una guerra in tempo, in cui ei non si era ancora bene assodato nel possesso de’ suoi regni, divenne alla fine ad accordare la richiesta grazia, ma sotto le seguenti condizioni: 1° che Bernardo Cruillas procuratore del conte prigioniero facesse omaggio, e giuramento di fedeltà nelle sue mani sotto la pena di centoventi mila fiorini; 2° che il detto conte di Modica, liberato che fosse dalle carceri, dovesse fra il termine di soli otto giorni, imbarcarsi sopra una galea, o qualunque altra nave, e andare direttamente in Ispagna; 3° che dopo che fosse arrivato nel regno di Valenza, e nel principato di Catalogna, dovesse fra quindici altri giorni partirne per presentarsi alla corte; e 4° che il detto di Cruillas come procuratore dovesse consegnare nelle mani del re, o di Ruggiero figliuolo del conte di Pallas, o di Berengario Dolms il castello di Monclus, il castello, e la villa di Hostalric, e i castelli di Argimon, e di Parafolls colle guarnigioni in essi esistenti, restando i medesimi a nome del re. A queste condizioni fu scarcerato Bernardo Caprera conte di Modica, il quale partì nel prescritto termine, e giunse in Catalogna; e indi facendo viaggio verso Barcellona, si presentò al re ai 12 di luglio 1413 72. Così fu liberata da questa spina la Sicilia, e restò la regina Bianca nel pacifico possesso della medesima 73. Fra le commissioni date agli ambasciadori, e consiglieri della regina Bianca l’una delle principali era quella di osservare le forze del regno, e di collocare ne’ castelli gli Alcaidi a loro ben visti, i quali riconoscessero la sovranità della corona di Aragona 74. Fu ciò eseguito tostamente, e fu regolata la quantità delle soldatesche, che dovessero essere stipendiate per conto della camera reale. Ferdinando Vasquez uno de’ quattro ambasciadori spediti in Sicilia, e consigliere della vicaria avea ricevuta la carica di maestro segreto. A costui dunque fu spedito ordine dalla regina Bianca col parere del consiglio di pagare in avvenire dalle rendite delle segrezie i salarî di due mesi a ottantacinque Bacinetti alla ragione di dieci fiorini per Bacinetto, e quaranta due Piccardi, o Pigliardi, contando per ciascheduno di essi sei fiorini 75. L’ordine, che noi abbiamo fra le nostre carte, è dei 24 di aprile 1413, e in esso sono descritti i nomi di coloro, a’ quali dovea pagarsi il detto stipendio. Avvegnachè colla partenza del Caprera fossero cessati i torbidi, nei quali era stata per molto tempo involta la Sicilia, e col dolce governo della regina Bianca, e dei suoi consiglieri vi si godesse la tranquillità, rincrescea nondimeno ai Siciliani avvezzi fin all’anno 1409 ad avere il proprio re, il vedersi ridotti alla trista condizione di provinciali; e desideravano che fosse loro concesso un sovrano proprio, che dimorasse nel regno. Questa loro brama era anche in qualche modo accompagnata dalla necessità. Il re Ladislao di Napoli, che avea ricevuta, come si è detto, da Giovanni XXIII l’investitura del regno di Sicilia, comunque per la guerra che stava sostenendo col suo competitore Luigi di Angiò non fosse in grado di rivolgere per allora i suoi pensieri all’acquisto di questo regno, non perciò l’avea lasciato di mira, e tenea in Messina delle segrete intelligenze. Laonde era da temersi che, se mai questo principe si fosse disbrigato del suo emolo, non piombasse con tutte le sue forze contro la Sicilia, che sotto la condotta di una femmina, e priva di difesa potea agevolmente soccombere. Inoltre sebbene non vi fosse allora frai Siciliani verun dissidio intorno al sovrano che doveano riconoscere, giacchè i Messinesi stessi, che stavano per Ladislao, osservando i disgusti nuovamente nati fra questo re, e il papa ridetto, erano divenuti per accettare per loro monarca Ferdinando il Giusto, furono nondimeno divisi rispetto agli affari di religione, a causa [33] che trovandosi tribolata la chiesa dallo scisma di tre papi, cioè di Giovanni XXIII, di Gregorio XII, e di Benedetto XIII, altri nazionali aderivano ad una Ubbidienza, o sia partito, ed altri ad un’altra. In questo stato di cose lusingavansi eglino, che ottenendo che risedesse nell’isola il proprio re, si sarebbe potuto far fronte a Ladislao, se nulla attentasse contro la Sicilia, e sarebbesi conosciuto da tutta la nazione lo stesso capo della chiesa. In questa intelligenza consigliatisi fra di loro si determinarono di spedire un’ambasceria al re Ferdinando, la quale chiedesse per re di Sicilia Federico di Aragona conte di Luna figliuolo bastardo di Martino il giovane. Siccome però dubitavano di non ottenerlo, essendo stato questo principe escluso per sentenza dalla successione nel congresso di Caspe, pensarono d’incaricare gli ambasciadori, supposto che Ferdinando ricusasse di accordarlo, di chiedere che almeno restasse contento di mandare uno dei suoi figliuoli per re di Sicilia. Gli 72 Surita, loc. cit., t. III, lib. XII, cap. 19, p. 88 e 89. È uno de’ soliti strafalcioni di M. de Burigny (Hist. de Sicil., liv. X, § II, t. II, p. 297), che Ferdinando si astenne dal prendere il titolo di re di Sicilia fino che non restò vinto il Caprera. Oltre che costui era stato imprigionato assai prima che quel monarca fosse dichiarato erede de’ regni di Martino il vecchio, tutte le carte che noi abbiamo del detto re smentiscono questa favola. 74 Surita, loc. cit., t. III, lib. XII, cap. 3, p. 88 e 89. 75 Bacinetto propriamente significa quella celata di acciaio che portavano i soldati. Cassis galea in modum bacini dice Ducange nel Glossario alla voce Bacinetum, ma presso di noi valeva il soldato che portava questa difesa in capo. Oltre varie carte dei nostri, che potrebbono rapportarsi, ciò si fa palese dal capitolo VI del re Martino, dove si legge che questo re ordinò quod ipsa Regia Majestas habeat certos Bacinectos, videlicet trecentos, che sembrano addetti alla guardia della persona reale. Piccardi dicevansi quei soldati che si valevano della picca nella guerra. Picardus, dice lo stesso Ducange all’articolo di questo nome, qui pica, seu clarissa (Gall. Pique) in bello utitur. 73 - 22 - scelti ambasciadori furono Ubertino de Marinis eletto arcivescovo di Palermo, Filippo Ferrera vescovo di Patti, e Giovanni di Moncada 76. Avea penetrato il re Ferdinando la risoluzione dei Siciliani; e poichè non era al caso di dimembrare il regno di Sicilia da quello di Aragona, scrisse pressantissime lettere alla regina Bianca, e a’ di lei consiglieri, affinchè impedissero la partenza degli ambasciadori, e quando mai non trovassero modo di frastornarla, che si maneggiassero, acciò la loro dimanda si restringesse solo a pregarlo di mandare per vicario e governatore del regno uno dei suoi figliuoli. Per quanto la vicaria si fosse affaticata per distogliere i Siciliani dal loro proponimento, nulla potè ottenere; gli ambasciadori partirono sotto il pretesto che vi andavano per altro oggetto, cioè per la discordia che vi era nel regno intorno al vero pontefice. Giunsero eglino in Saragozza nel tempo in cui Ferdinando, conquiso il suo competitore, il conte di Urgel, celebrava la solenne sua coronazione. Rappresentarono eglino le cagioni della lor venuta, e non potendo nulla sperare per il conte di Luna fecero l’altra istanza, chiedendo uno dei figliuoli del monarca per sovrano di Sicilia, così ricercando i voti della nazione, l’eccellenza del regno, e il pericolo, in cui era, di divenir preda del re di Napoli. Ferdinando avrebbe voluto compiacerli, ma non era possibile di indurvi i Catalani, i quali non avrebbero sofferto questa separazione della Sicilia dalla corona di Aragona. Pur nondimeno per non lasciarli affatto dispiaciuti, promise loro che fra breve avrebbe mandato l’infante Giovanni suo secondogenito per governatore dell’isola 77. Ottenuta questa risposta 78 partirono gli ambasciadori lieti di non avere intieramente perduto il tempo, e si restituirono in Sicilia. Affrettò la partenza dell’infante Giovanni la morte del re Ladislao senza prole. Diveniva per questa perdita Giovanna II sua sorella l’erede del regno di Napoli. Era questa principessa vedova di Guglielmo duca di Sterlich figliuolo di Leopoldo III duca d’Austria. Tra i concorrenti ad impalmare questa nuova regina fu dal di lei consiglio preferito il mentovato Giovanni duca di Pegnafiel, e Momblanco, e ne furono celebrati gli sponsali in Valenza ai 4 di gennaro 1415. Dovea perciò questo infante partirsi fra breve con quello accompagnamento, che era conveniente a sì gran principe, che andava a ricevere la corona di Napoli, e con un’armata proporzionata per tenere a freno i baroni rivoltati di quel regno, e resistere al duca di Angiò, che contrastava quella corona alla regina Giovanna. Ma prima che questo principe partisse, quella volubile principessa, senza avere in considerazione i sponsali contratti in Valenza, prese per marito Jacopo conte della Marcia, lasciando indietro l’infante Giovanni. Questi nondimeno si dispose alla partenza per la Sicilia. Intanto alle premurose istanze fatte dal re di Navarra, che desiderava ardentemente di vedere la sua amata figliuola, [34] fu permesso che la regina Bianca potesse liberamente tornarsene in Navarra alla casa paterna; e in fatti ne partì prima che arrivasse il duca di Pegnafiel accompagnata da Pietro Martinez de Peralta, che il di lei genitore le avea a questo effetto spedito dalla sua corte 79. CAPO II. Giovanni infante di Castiglia duca di Pegnafiel e Momblanco. Sebbene sia cosa certa che questo principe fosse arrivato in Sicilia per governarla l’anno 1415, ci è non ostante ignoto in qual mese vi sia venuto, nè alcuno dei nostri storici ce lo addita. L’intrepido M. de Burigny, che scrisse senza monumenti la sua storia, con gran franchezza 80 asserisce che vi arrivò nel mese di gennaro, o al più nei primi di febbraro. Ciò però non ha fondamento veruno; imperciocchè essendosi conchiuso fra la regina Giovanna II di Napoli, e l’infante Giovanni il matrimonio ai 4 di gennaro 1415 81, ed essendosi stabilito per patto che l’infante sarebbe partito nel seguente febbraro con un’armata per andare al soccorso della sua novella sposa, e finalmente essendosi cambiata di sensi la sudetta regina di Napoli, dopo che ritornarono da Valenza i suoi ambasciadori, e prima che l’infante Giovanni si fosse mosso dalla corte del padre, fa di mestieri credere, che assai più tardi fosse egli venuto in Sicilia. Era egli pressato allora a partire per le critiche circostanze, nelle quali si trovava la regina Giovanna. Cambiatasi questa di volontà, ed essendosi data in braccio ad un altro marito, non dovea l’infante avere più sollecitudine di venire in Italia; giacchè per conto della Sicilia gli affari erano così bene amministrati, che non ricercavano ch’ei si affrettasse 76 Surita, loc. cit. t. III, lib. II, cap. 36, p. 102. Ivi. 78 In questa occasione rappresentarono al re gli ambasciadori che il baronaggio restava malcontento nel vedere tuttavia carcerato il conte Antonio Ventimiglia, ch’era stato posto in ceppi nelle passate vertigini, perchè si era mostrato partitario del conte di Modica, e che era agevole, ch’essendo questi già in libertà, si rompessero del pari le ritorte del Ventimiglia; ed appalesarono che se non si dava questa provvidenza, potea accadere che i di lui parenti, che erano possenti e numerosi, non accendessero una nuova guerra civile. Ferdinando dopo di avere esaminato questo affare nel suo consiglio di stato, ordinò che il conte Antonio fosse sprigionato dal castello di Malta, dove stava rinchiuso, e che si presentasse alla corte per esaminarsi la sua causa, durante il quale esame volle che i castelli di Geraci e della Roccella restassero in potere del fisco. (Surita, loc. cit. t. III, lib. XII, cap. 36, p. 102). 79 Surita, loc. cit. t. III, lib, XII, cap. 46, p. 109. 80 Hist. de Sicile, t. II, par. II. liv. X, § II, p. 297. 81 Surita, loc. cit. t. III, lib. XII, cap. 46, p. 109. 77 - 23 - a governarla. Noi dunque opiniamo, che assai più tardi sia egli comparso nella nostra isola, e forse nel mese di settembre, se fossero veri i calcoli dello stesso Burigny. Attesta egli nello stesso luogo che questo real principe non compì neppure un anno del suo viceregnato. Essendo la cosa così, come non è inverisimile, e costando a noi da un autentico monumento, di cui fra poco faremo menzione, che questo principe trovavasi tuttavia in Sicilia ai 20 di agosto 1416, quindi deducesi che egli, per potersi verificare che non vi dimorò un anno, dovè venirvi o in settembre dell’anno antecedente o più tardi. Ma abbiamo delle prove che egli era in Palermo ai 15 di giugno 1415, e che perciò venne in Sicilia forse nella primavera. Pretesero l’Auria 82, e il Caruso 83, che questo principe, oltre la carica di vicerè, e governatore generale di Sicilia, avesse ancora quella di grande ammiraglio; e il primo di questi storici scrive ch’ei fosse solito di soscriversi El Infante admirall de Sicilia; l’altro per dare qualche apparenza a questo titolo attesta ch’egli ebbe questa dignità in vece di Sancio Ruitz de Lihori visconte di Gagliano. Viene smentito il primo da monumenti tratti dalle nostre cancellerie, che rapporteremo in appresso, nei quali questo vicerè costantemente si sottoscrisse El Infante, senza far mai menzione dell’ammiragliato. Viene convinto da falsità l’altro da un monumento, che di poi addurremo, in cui Sancio de Lihori facendo il giuramento di fedeltà al nuovo re Alfonso nelle mani dello stesso infante Giovanni, si sottoscrive: Admiratus regni Siciliae. Si accostò dunque più alla verità il canonico Antonino Amico, che di questo principe semplicemente attesta ch’ei governò la Sicilia con titolo de Virrey 84. Checchessia di questi errori, che ci basta di avere brevemente emendati, egli è certo che i Siciliani restarono ben contenti del nuovo loro governante; e sebbene non vi sieno le memorie delle feste fatte al di lui arrivo, non può dubitarsi che fu ricevuto con onore, e come figliuolo del sovrano, e come un giovane amabile e colmo di virtù. Venne sicuramente sulle prime a Palermo, o che fosse sbarcato a Trapani, come fatto aveano gli ambasciadori del padre, de’ quali si è fatta parola nel capo antecedente, o che avesse approdato direttamente nel porto di questa capitale, e vi dovè venire nel mese di maggio al più tardi. L’ambasceria spedita da’ Messinesi, che trovasi registrata nella nostra regia cancelleria 85, e poi fu resa pubblica [35] nell’edizione de’ capitoli del regno di Sicilia fatta l’anno 1741 86, che si esegui a’ 14 giugno, mostra abbastanza che questo principe era arrivato poco tempo prima, giacchè i Messinesi primieramente si rallegrano de suo fausto, et felicissimo adventu, laonde computando i giorni necessarî, perchè ne giungesse la notizia a Messina, il tempo per eleggere gli ambasciadori, e quello ch’era necessario acciò questi dalla loro città si portassero a Palermo, dovè per sicuro scorrervi da presso un mese, ancorchè si voglia supporre ch’eglino vi fossero venuti colla possibile sollecitudine. Per farsi strada codesti inviati a chiedere delle grazie a favore di Messina, dichiararono in primo luogo, ch’eglino bramavano coi loro concittadini di essere governati dal serenissimo infante, non solo come vicerè e governatore, quale era allora, ma ancora come proprio monarca di Sicilia; intorno alla qual cosa protestarono, che siccome ne aveano istantemente pregato il re Ferdinando suo padre, da che fu elevato al regno di Aragona, così non avrebbono intralasciato di costantemente supplicarnelo con fiducia, che S.M. finalmente li avrebbe compiaciuti. Ciò fa chiaro vedere come i Siciliani tutti, e in ispezie i Messinesi bramarono sempre di avere un proprio sovrano, e di separarsi dalla dipendenza della corona di Aragona. L’amabile principe, rispondendo graziosamente a’ loro complimenti intorno al suo arrivo: per conto poi della brama, ch’eglino mostravano di averlo per re, si dichiarò loro tenuto della buona volontà in cui erano; ma coll’innata sua prudenza e moderazione palesò, che non gli era a grado che si parlasse mai più di questo affare, dovendo eglino restar contenti di aver per sovrano suo padre, ch’era un principe virtuoso, giusto, benigno, e potente, il di cui governo sarebbe stato il più utile e il più vantaggioso alla nazione: Illustris dominus infans, così risponde in di lui nome il protonotajo del regno, rengratiat eis de bona affectione, quam exhibuerunt in demostratione laetitiae, et jucunditatis ejus adventus; et cum habeant regem virtuosum, justum, benignum, et potentem, et a caetero teneat dominus infans, quod per nullam aliam personam sic utiliter, nec commode hoc regnum gubernari possit, sicut per personam domini regis, de cujus regimine debent esse contenti, non expedit de hac materia ultra pertractari 87. Non solamente i Siciliani bramavano di aver l’infante Giovanni per sovrano, ma i Napolitani ancora nudrivano lo stesso desiderio. Appena era egli arrivato in Sicilia, che se gli esibirono parecchi baroni di quel regno, e sopra tutti i Calabresi, ch’erano malcontenti del governo della regina Giovanna, di agevolarlo alla conquista di Napoli, lo che, stanti le turbolenze ch’erano nella corte, era assai agevole di ottenere. Non sapendo questo principe qual fosse per essere la volontà del padre, e se avesse voluto vendicarsi dell’affronto 82 Cronologia de’ signori viceré di Sicilia, p. 4. Mem. Stor., tom. III, p. 25. 84 Chronolog. de los virreyes, y presidentes del reyno de Sicilia, p. 3. 85 Registro dell’anno 1415, f. 30. 86 Tom. I, p. 199. 87 Capitula Regni Sic., t. I. in Ferdinando I, cap. 3, p. 199. 83 - 24 - fattogli della regina Giovanna, che dietro di avere conchiusi gli sponsali coll’infante suddetto, avea senza verun motivo scelto un altro per marito, stimò d’intrattenere con favorevoli risposte i baroni mentovati, e intanto scrisse al padre per udire dal medesimo cosa fosse da farsi in quelle circostanze. Ma il re Ferdinando, che non avea per norma delle sue azioni che la giustizia, conoscendo i diritti che avea la regina Giovanna nel regno di Napoli, ebbe orrore a fomentare la ribellione de’ suddetti baroni, e scrisse al figliuolo, che non volea che si facesse veruna novità 88. Escluso per le determinazioni del re di Aragona il progetto della conquista del regno di Napoli, si applicò interamente l’infante Giovanni a procurare la felicità dei Siciliani. Ci duole all’estremo che ci manchino tutti i monumenti, da’ quali potrebbe agevolmente rilevarsi quali utili provvedimenti abbia egli dati a vantaggio di questo regno. Ce ne restano pochi, che rapporteremo, da’ quali si detegge l’ottimo governo di questo principe. Era molto tempo che i nostri mari trovavansi infettati da’ pirati, i quali turbavano il commercio de’ Siciliani. A farneli sloggiare, non avendo i re di Sicilia forze bastanti, fu permesso agli stessi nazionali di esercitare la piraterìa, ma previa la permissione della corte, e con una certa indipendenza dal grande ammiraglio. Accadea nondimeno che questo supremo comandante di mare facesse delle estorsioni a coloro, ch’erogavano le proprie facoltà nel fabbricare, e mantenere delle navi da corso, ed esponevano le loro vite per tenere netti i mari dalle scorrerìe, ed usare contro i nemici della nazione il diritto di [36] rappresaglia. Pensò il re Martino il giovane di riparare a questo disordine, che scoraggiava i Siciliani dall’impegnarsi a discacciare i nemici, e a render sicuro il traffico che facea per mare il regno, e perciò promulgò alcuni capitoli, ed ordinazioni, colle quali prescrivea, quali diritti appartenessero all’ammiraglio, così ne’ trasporti, come nelle prede che accadevano. L’infante Giovanni adunque, poichè venne al governo della Sicilia, udendo le istanze fatte da’ Messinesi, perchè procurasse di difendere il regno dalle scorrerìe de’ Mori, che danneggiavano i popoli, e li metteano in servitù, procurò di animare gli uomini facoltosi a scorrere per i nostri mari, affine di cacciare questi nemici della nazione, e per togliere ogni ostacolo, confermò con un suo dispaccio dato in Catania a’ 18 di agosto 1415 le leggi prescritte dal re Martino intorno all’uffizio dell’ammiraglio 89. Questo è quel monumento, di cui parlano l’Auria, e il Caruso di sopra additati, e sotto il quale credettero che il duca di Pegnafiel siesi sottoscritto: Nos el infante Almiral de Sicilia; ma oltrechè le parole Almiral de Sicilia mancano nel codice della nostra cancellaria, ed oltre ciò che abbiamo avvertito, cioè a dire, che nel seguente anno Sancio Ruitz de Lihori continuava a sottoscriversi ammiraglio di Sicilia, lo che non avrebbe fatto, se questa carica appartenea all’infante Giovanni, dal contesto del privilegio chiaramente si riconosce, che l’ammiraglio era il ridetto de Lihori: Nos vero attendentes fidem puram, et devotionem sinceram, quam idem SANCHIUS gessit temporibus retrofluxis tam erga regales celebris memoriae olim Aragonum, et Siciliae reges, quam erga serenissimum principem dominum genitorem nostrum regem Aragonum, et Siciliae gloriosum; nec minus accepta, et valde grata servitia, quae eidem principi praestitit, personae, ac bonorum suorum periculis, et dispendiis nullatenus evitatis, quae praestat ad praesens, et praestare Deo annuente confidimus gratiora, eidem SANCHIO, suisque quibuscumqe officialibus, et substitutis, eadem capitula per nos, et nostrum consilium matura, et diligenti indagine provisa, et considerata, ut extant, de verbo ad verbum confirmamus etc. Potea egli parlar così, se il Lihori non era più l’ammiraglio di Sicilia, e se di questa carica n’era egli in possesso? Siccome però in alcuni esemplari ritrovansi le parole El Enfante Almiral de Sicilia, sospetta a ragione monsignor Francesco Testa, che vi possa esser corso errore, e che vi mancasse un articolo, dovendosi leggere: Nos el Enfante al Almiral de Sicilia. Durante il regno del re Ferdinando accadde in Sicilia la morte di Antonio Ventimiglia conte di Golisano, che lasciò erede dei vasti suoi stati Costanza sua figliuola 90. La pingue dote di questa dama, e la di lei illustre prosapia resero questo matrimonio desiderato da molti. Il conte Arrigo Manuele cugino del re Ferdinando chiedea che si desse in isposa al suo figliuolo primogenito; le stesse pratiche facea per il suo figliuolo il grande ammirante di Castiglia Alfonso Enriquez, e anche Gilberto de Centelles procurava per se stesso d’impalmarsi colla medesima. Il re di Aragona, a cui erano state fatte le istanze, ne scrisse all’infante Giovanni, e gli ordinò che facesse ogni opra presso la contessa madre della donzella, e presso Giovanni Ventimiglia conte di Geraci zio della medesima, acciò il matrimonio si contraesse col figliuolo del conte Arrigo; e non potendo ottenersi d’indurli a darla al figlio dell’ammirante di Castiglia, o almeno al detto di Centelles. L’infante trattò l’affare per tutti e tre, e vedendo che i parenti preferivano l’ultimo ai primi due pretensori, appuntò il matrimonio con questo, come fu eseguito 91. 88 Surita, loc. cit., tom. III, lib. XII, cap. 4, p. 113. Capitula Regni Sic., t. I, p. 479 e seg. 90 Scrisse il Caruso che questo cavaliere ebbe un figliuolo per nome Francesco, che fu diseredato per disgusti, ch’egli stesso non sa additarci (Mem. Stor. part. 3, lib. II, tom. III, p. 25). Noi non osiamo di contestarlo, mancandocene i monumenti. 91 Surita, Annales de Aragon., t. III, lib. XII, cap. I, pag. 114. 89 - 25 - Poco campò Ferdinando il giusto, essendo morto ai 2 di aprile 1416. Scrisse l’Auria 92 che l’infante Giovanni fu chiamato dal re, perchè non era al gusto di esso re lo stare in Sicilia il suo figliuolo, per levare occasioni di nocevoli novità, e dietro a questo cronologo raccontò lo stesso il Burigny 93. Assai meglio il canonico d’Amico 94 attestò, che l’Infante Giovanni governò en nombre de su Germano. Forse l’Auria opinò così, intendendo male quanto lasciò registrato il Surita 95. Il racconto di questo storico non porta altro, se non che, trovandosi il re [37] Ferdinando gravemente infermo in Perpignano, e con poca speranza di superare il grave male, da cui era molestato, e avendo udito dai suoi consiglieri che i Siciliani persistevano nella volontà di avere per re uno dei di lui figliuoli, come ne erano stati avvisati da Ferdinando Velasquez, e che era da temersi che eglino tentassero di far ciò che fatto aveano alla morte del re Alfonso e all’assunzione di Giacomo al trono di Aragona, quando elessero per sovrano l’infante don Federico, era disposto, per impedire ogni novità in Sicilia, a richiamare l’infante Giovanni. Ma che ciò non siesi eseguito, lo dinota lo stesso annalista, il quale soggiunge, che essendosi considerate le circostanze nelle quali erano i regni di Napoli, e di Sicilia, per cui era necessaria la presenza di questo principe cotanto amato dai Siciliani, fu determinato di non innovar nulla, e di lasciare all’infante la libertà di restarsi, o di partire, e nel secondo caso di inviargli le istruzioni, se mai si risolvea di abbandonare questo governo. Forse l’infante Alfonso, che temea che non gli mancasse il regno di Sicilia, ordiva questa macchina, e infatti egli sollecitava il fratello, sotto il pretesto della pericolosa infermità del padre, a venire alla corte. Prima che arrivasse in Sicilia la funesta notizia della morte di Ferdinando il giusto, decise l’infante Giovanni una delle pendenze, che erano fra l’ammiraglio Lihori, e il conte di Modica. Dolevasi il primo, che essendo stati presi nei mari di Sardegna, secondo le leggi di buona guerra, a tempi del re Martino, alcuni Genovesi, ed essendo stata loro promessa la libertà per il prezzo di dieci mila fiorini, che lo stesso monarca avea donati al detto Sancio, che li tenea prigioni nel suo castello della Motta, il Caprera promise loro di farli scappare, se aveano modo di dare adito alle sue truppe in quella fortezza. Assediata questa, e presa per i maneggi, che internamente faceano i Genovesi, non solamente costoro furono posti in libertà, ma furono inoltre occupati tutti i beni dell’ammiraglio, e distribuiti dal conte di Modica ai suoi familiari. Richiedea perciò che fosse rindennizato non meno dei dieci mila fiorini dovuti per conto dei Genovesi, che dei beni che gli erano stati allora rubati. L’infante esaminata diligentemente questa causa col consiglio di due giureconsulti, deffinì, che Riccardo di Leofante procuratore del Caprera fosso tenuto di pagare al Lihori dieci mila fiorini per il riscatto dei Genovesi, e cinque mila per prezzo dei beni derubati, e condannò inoltre il conte di Modica alle spese. Il documento che rapporta questa sentenza è presso di noi, ed è dato in Catania ai 10 di aprile 1416. Morto il re Ferdinando, e fattegli le solenni esequie, lasciò scritto il Surita 96 che il primo pensiero, che cadde in mente al re Alfonso, fu quello di richiamare il fratello dalla Sicilia. Ingelosito egli dell’amore, che i Siciliani mostravano verso il medesimo, e sapendo il desiderio ch’eglino aveano che regnasse sopra di loro, dubitava che l’acclamassero per re, udita la morte del di lui padre. Spedì perciò immediatamente nel nostro regno Antonio Cardona, con ordine all’infante Giovanni di ricevere come suo vicario il giuramento di fedeltà dai prelati, dai baroni, e dalle università dell’isola, di deporre nelle mani di Domenico Ram vescovo di Huesca, che era presso di lui, e dello stesso Cardona, la carica di vicerè, e di ritornarsene in Ispagna. Acciò poi il fratello Giovanni non credesse che veniva richiamato per sospetti, che avea sparsi il Velasqez, gli mandò Alfonso l’articolo del testamento del padre, per cui il regno di Sicilia veniva incorporato a quelli della corona di Aragona. E perchè questo amaro sorso fosse inghiottito dal fratello con piacere, furono aspersi gli orli del vaso che lo porgea, del soave liquore di un altro regno; giacchè se gli proponea il matrimonio colla regina Bianca, ch’era l’erede della Navarra. Nondimeno il re Alfonso non era sicuro che l’affare potesse riuscire come desiderava. Gli animi dei Siciliani erano pur troppo dichiarati di voler essere governati dall’infante Giovanni, e di volerlo per re; laonde era a temersi, se questa commissione non era eseguita con una politica la più sopraffina, che eglino inaspriti non si sollevassero, e non si opponessero alla partenza del loro governatore. A questo effetto fu incaricato il Cardona di muover le pedine con destrezza, e a misura delle circostanze; e gli fu anche consegnato un dispaccio, per cui si accordava all’infante sudetto ogni potere, e la libertà di fare tuttociò che stimasse di essere più convenevole. Queste politiche precauzioni produssero il desiato [38] effetto. L’infante Giovanni, che era di un’indole amabile, e lontana da ogni ambizione, punto non esitò a compiacere il fratello, e ad eseguire la volontà del padre, e ordinò che si allestissero alcune navi per ritornarsene in Ispagna 97. 92 Cronologia de’ signori viceré di Sicilia, p. 4 e 5. Hist. de Sicile, t. II, part. II, liv. X, § II, p. 297. 94 Chronologia de los virreyes del reyno de Sic. 95 Loc. cit. lib. XII, cap. 56, p. 116 e 117. 96 Loc. cit., cap. 57, p. 126. 97 Surita, loc. cit. p. 127. 93 - 26 - Non fu però così sollecita la di lui partenza, giacchè accadde, come diremo, nel seguente agosto, e intanto egli proseguì nella carica di vicario, e governatore della Sicilia. Ci restano nei nostri archivii parecchi monumenti, che ci additano ciò che ei fece prima di partire. Cominciò, secondo l’istruzione che avea avuta dal fratello, dal ricevere a nome del medesimo il giuramento di fedeltà. Adunque ai 23 di maggio 1416 furono chiamati i baroni nel castello di Catania, e nella sala detta de’ Paramenti, dove resero il ligio omaggio nelle mani dell’infante. Questo è quel diploma da noi accennato, nel quale è alla testa dei baroni D. Sancio Ruitz de Lihori, che si titola Ammiraglio del regno di Sicilia. Lo stesso giorno l’infante giurò a nome del fratello di osservare, e mantenere i privilegi, le libertà, le costituzioni, e i capitoli accordati dai re di Aragona predecessori ai baroni di Sicilia. In questo stesso atto ritrovansi i giuramenti di fedeltà fatti in diverse giornate da quei baroni, che non furono forse a tempo, quando fu fatta la solenne funzione nella sala de’ Paramenti, e di costoro parte giurò nelle mani dell’infante Giovanni, sino che ei dimorò in Sicilia, e parte nelle mani dei nuovi vicerè. Siccome poi i sindici delle università non poterono essere presenti, quando fu ricevuto l’omaggio dei baroni, perciò lo infante ai 30 dello stesso mese scrisse una lettera circolare a tutte le università, alle quali partecipò di essere stato dal fratello Alfonso confermato vicerè, e governatore della Sicilia, e di essere stato incaricato di ricevere il giuramento di fedeltà dalle medesime, e di promettere la conservazione di tutti i privilegi, libertà, e immunità, che esse per lo passato godeano: ed ordinò alle medesime, che mandassero in Catania i loro sindici a riconoscere il nuovo sovrano. La università di Catania, dove dimorava la corte viceregia, tre giorni prima di questa lettera avea reso il ligio omaggio, e avea dal serenissimo infante ottenuta la conferma dei suoi privilegi, capitoli, libertadi, e consuetudini. Questi diversi atti tratti dai nostri archivî sono appo di noi. Non può mettersi in dubbio che l’infante Giovanni nei mesi nei quali continuò a governarci a nome del fratello non abbia del pari come prima procurati i nostri vantaggi, ma noi non abbiamo potuto acquistare tutte le carte, che potrebbero darcene le distinte notizie. Una ci è capitata a sorte nelle mani, che addimostra il suo zelo per la nazione. È questa una lettera scritta ai 20 di luglio 1416 alla repubblica di Venezia. Si erano in quella città stabilite molte nuove imposizioni e gabelle sulle mercatanzie che vi s’introduceano, e nelle spedizioni che doveano farsi da Venezia, tante erano le angarìe degli uffiziali, e le lungherie dei tribunali, che ne soffrivano i mercadanti scapito, e grave interesse. Era inoltre il console di Sicilia residente in Venezia privo delle giurisdizioni, e delle prerogative che i consoli Veneziani godeano nel nostro regno. A mantenere dunque l’onore dei nostri consoli, e a liberare i nostri trafficanti dai pesi mentovati, scrisse l’infante Giovanni ai rappresentanti di quella repubblica, dolendosi dell’uno, e dell’altro; e ricercò che i mercadanti siciliani, e i consoli della nazione fossero trattati cogli stessi privilegi, di cui quei della repubblica godevano nel nostro regno: dichiarando che altrimenti sarebbono in avvenire i consoli, e mercatanti veneziani soggetti nel regno ai medesimi pesi, ed angarie, che soffrivano i nostri a Venezia. Un’altra carta ci resta di questo principe prima che abbandonasse la Sicilia. Durava da molto tempo la causa fra la regina Bianca e il conte di Modica Bernardo Caprera per la restituzione delle gioie, ed altri mobili, che questi avea trovati nel palagio dell’Osteri, quando questa principessa, all’udire l’arrivo del conte in Palermo, scappò quasi ignuda colle sue damigelle, e s’imbarcò sulla galea del Torella; del qual fatto si è da noi lungamente parlato. La regina Bianca, fin da quando regnava Ferdinando il giusto, avea fatte efficaci istanze, acciò se le rendessero, e non solo volea il prezzo delle medesime, ma il triplo. Era questa causa involuta; dovendo prima costare l’usurpazione; e inoltre, siccome codesti beni più non esistevano, bisognava valutarne il vero prezzo. Poichè dunque si esaminarono tutti gli articoli necessarî per decidere a norma della giustizia questa lite, il principe [39] Giovanni ai 27 di luglio proferì la sentenza, per cui il conte di Modica fu condannato a pagare alla regina dieci mila fiorini, e le spese della lite da arbitrarsi dallo stesso serenissimo infante, e fu imposto silenzio alla regina Bianca rispetto al triplo che pretendea. Partì da Catania l’infante Giovanni, e andò ai 21 di agosto nella città di Agosta, nel di cui porto erano tre navi pronte per riceverlo. Vi si trattenne qualche altro giorno, o almeno fino ai 24, non essendo forse i venti opportuni per quel viaggio. Noi lo ricaviamo da quel monumento, in cui si nominano quei baroni, che dopo la funzione del giuramento di fedeltà fatta in Catania ai 23 di maggio, ad ora ad ora arrivavano alla corte viceregia per far lo stesso; avvegnachè noi leggiamo in esso le seguenti parole: XXIX Augusti in terra Auguste Rogerius de Pollicino Baro Turturichi juravit, et fidem, et homagium prestitit, ut supra manibus et ore commendatum, ut supra in manibus Domini Infantis, presentibus Adelentato Ferrando Guttierez, et protomedico domini infantis, et magistro Bino de Mariscalco, et pluribus aliis. Era egli dunque ai 24 di agosto in Sicilia, e vi esercitava la carica di vicario del fratello, nè partì che dopo 98. 98 Il Caruso (Mem. Stor. part. 3, lib. III, p. 28) racconta, che i Siciliani restarono scorucciati nell’osservare che l’infante Giovanni si mostrasse insensibile alle premure ch’eglino aveano di farlo re, e che piccati di cotale indifferenza verso di loro, dichiararono di non opporsi nemmeno alla di lui partenza. Non trovando noi autore che lo dica, immaginiamo che questo scrittore se lo sia figurato. - 27 - CAPO III. Domenico Ram vescovo di Lerida, e Antonio Cardona. Il primo di questi due vicerè fu una persona molto rispettabile nella corte di Aragona. Era egli stato vescovo di Huesca, ed era stato eletto al parlamento di Alcaniz, per comunicare le determinazioni dei parlamentarî a quelli di Tortosa, e di Saragoza, intorno alla maniera di determinare la causa della successione del regno di Aragona, e scelto per uno dei nove giudici per deciderla. Fu di poi destinato ambasciadore al re Ferdinando il Giusto per dargli il giuramento di fedeltà, ed ebbe l’onore di ungere questo sovrano nella solenne sua coronazione. Questo monarca volendo trattare il matrimonio fra la regina Giovanna di Napoli, e l’infante Giovanni suo figlio, affidò questo delicato affare al suddetto prelato, e il re Alfonso il Magnanimo nella vacanza del viceregnato di Sicilia lo scelse a questa cospicua carica in compagnia del Cardona. Fe’ poi tanto conto di questo personaggio, che lo promosse al vescovado di Lerida 99, gli procurò da Martino V la porpora, che ottenne ai 23 di luglio 1423, ed indi lo fece passare all’arcivescovado di Tarragona, e lo disegnò por suo ambasciadore al concilio di Basilea, come può osservarsi presso il Surita 100. Fu poi eletto da Eugenio IV vescovo di Porto 101. Non meno ragguardevole è da riputarsi l’altro vicerè Antonio Cardona. Era egli figliuolo secondogenito di Ugo Visconte di Cardona, e si accasò con Leonora de Villena, da cui nacque Pietro de Cardona, che fondò in Sicilia la nobile casa Cardona dei conti di Golisano. Fu Antonio uno dei componenti il parlamento generale di Barcellona, e siccome era la sua famiglia affezionata a Giacomo d’Aragona conte di Urgel, si unì col fratello a dare per sospetti monsignor Domenico Ram vescovo di Huesca, Bonifazio Ferrer, Berengario de Bardaxi, e Francesco de Aranda; nello che ebbe per compagni gli ambasciadori del re di Francia, e della regina Violante di Sicilia; e unitisi i giudici a Caspe, egli vi andò, come procuratore del suddetto conte, per [40] rappresentarvi i di lui diritti 102. Acquietate poi le vertigini della Spagna, e superato il conte di Urgel, tornò Antonio Cardona in grazia della corte, e fu adoperato dai monarchi di Aragona nel loro servizio. Costui destinò il re Alfonso al fratello l’infante Giovanni per portagli l’ordine di ricevere in suo nome il giuramento di fedeltà dai Siciliani, e di dimettere di poi il viceregnato dell’isola nelle mani del vescovo di Lerida Domenico Ram, che gli era stato dato per consigliere da Ferdinando il Giusto, e trovavasi perciò in Sicilia, e dello stesso Cardona, cui fu in compagnia del Ram affidata la stessa carica. Il dispaccio, con cui questi due personaggi furono eletti vicerè di Sicilia, fu sottoscritto dal re Alfonso al primo di agosto dell’anno 1416 103. Trovandosi in questo, e nei seguenti tempi più di un vicerè, e delle volte tre, ed ancora quattro, come anderemo di mano in piano divisando, fa di mestieri che noi, prima di proseguire il nostro racconto, esaminiamo come, e con quali limiti eglino governassero il regno. Salta naturalmente agli occhi il dubbio, se mai l’uno fosse indipendente dall’altro; se fosse affidata a ciascheduno la sua particolare incombenza; o se dovessero tutti di accordo risolvere gli affari; o se essendo codesta come una forma di reggenza, questa avesse un capo, che dovesse proporre i bisogni del regno; e quale autorità maggiore avesse questi sopra gli altri, ovvero se fosse pari la giurisdizione in tutti, senza che l’uno precedesse all’altro. Noi confessiamo che lo scioglimento di questo nodo ci è costato molta fatica, nè ci lusinghiamo tuttavia di avere colpito nel segno. La più agevole maniera, per venire a capo della soluzione di questi dubbî, sarebbe stata quella di avere nelle mani le cedole reali, e le istruzioni, che furono date a codesti vicerè, dalle quali si sarebbe di leggieri rilevato quali fossero le incombenze che si davano loro, e quali limiti si fossero prescritti alla loro autorità. Ma per quanto noi ci siamo affaticati nello svolgere i volumi della reale cancelleria, e dell’uffizio del protonotaro, adoprando anche i lumi degli uffiziali di codesti archivî, non ci è venuto fatto di ritrovare alcuna cedola, o istruzione data ai medesimi, che potesse menarci a ciò che ricercavamo. Forse allora non era in costume il farle registrare negli archivi regî. Solo ci è caduto in sorte un monumento nell’uffizio del conservatore del regio patrimonio, di cui favelleremo nel capo seguente, dell’anno 1418 e 1419 col titolo di Restrictio viceregum, che era verisimilmente una istruzione, per cui era limitata l’autorità assoluta, che si 99 La traslazione di questo prelato alla chiesa di Lerida fu poco prima che accadesse la di lui elezione al viceregnato di Sicilia, come ne fa testimonianza lo stesso Surita (tom. III, lib. XII, cap. 62), e perciò noi costantemente osserviamo, in tutti i dispacci da lui firmati mentre fu vicerè, che si sottoscrisse semplicemente Ilerdensis. Durò nel governo di questa chiesa fino alla morte di monsignor Consalvo Ixar arcivescovo di Tarragona, che accadde l’anno 1436. 100 Annales de Arag., t. III, lib. XI, XII, e XIII. 101 Morì questo cardinale in età decrepita in Roma a’ 25 di aprile 1445, e fu sepolto nella Basilica Lateranense, dove si legge il seguente epitafio; Hic jacet Reverendissimus in Christo Pater D. Dominicus Ram Epis. Portuensis S. R. E. Cardinalis Tarracon. nuncupatus Qui obiit Anno Domini MCCCCXLV. mens. Aprilis Aetatis suae centesimae vel circa. 102 Surita, Annales de Arag., t. III, lib. XI, cap. 73, p. 56, e cap. 82, p. 64. 103 Registro della Regia Conservadoria degli anni 1415 e 1416 VIII Ind., fogl. 155. - 28 - dava loro nelle cedole. Ma da questo nulla cavasi intorno alla proposta ricerca, se erano indipendenti l’uno dall’altro, o se dovessero unirsi per decidere gli affari. Perciò nulla di certo possiamo assicurare per soddisfare la giusta curiosità dei nostri leggitori. Pur nondimeno, permettendocisi di opinare per congetture, noi diremo ciò che ci è riuscito di ritrovare nei molti dispacci, che da questi uniti vicerè allora furono emanati. E prima abbiamo osservato che alcuni di questi diplomi sono sottoscritti da tutti, alcuni da un solo, ed essendo eglino tre o quattro, da due o da tre. In secondo si è da noi veduto, che quando tutti sottoscrivono, il luogo più degno, o sia alla destra, è sempre occupato dal più ragguardevole per posto. Così de’ due vicerè, de’ quali favelliamo in questo capo, alla destra sta il vescovo di Lerida, e alla sinistra Antonio di Cardona. Quando poi monsignor Domenico Ram partì, e il re Alfonso destinò due altri vicerè Ferdinando Velasti, o Velasques, e Martino de Torres, dei quali parleremo nel seguente capo, allora prendea il primo luogo il Cardona, il secondo il Velasti, e il terzo il de Torres. Finalmente talvolta si avverte il motivo per cui invece di tre per esempio ne sono sottoscritti due, e vi si dice: sub signo duorum propter absentiam tertii, ovvero propter absentiam alterius. Quindi ciascheduno vi mettea il proprio sigillo, e perciò taluni dei dispacci portano un sigillo, taluni due, e taluni anche tre, e quattro. Da tutte queste minute osservazioni, che si sono da noi fatte, ci pare verisimile che il re Alfonso nel disegnare al viceregnato di Sicilia due, o tre, o quattro soggetti, non abbia voluto dividere le incombenze; giacchè noi veggiamo che indifferentemente in tutte le diverse materie vi si sottoscrivono; ma abbia data loro la stessa autorità sopra ciò che riguardava i suoi reali servigî, e i vantaggi del regno. Questa però non fu da questo [41] sovrano circoscritta in modo che uno non potesse operare senza l’altro; ma se si trovavano insieme, risolveano gli affari di comune consenso, e se alcuno trovavasi lontano, allora provvedea colui che era presente. Solo si dava la preferenza al più antico, e al più degno nelle sottoscrizioni. Ma se eglino erano di dispari sentimenti, qual’era allora la determinazione che si prendea? Noi confessiamo d’ignorarlo, e siamo di avviso che il re Alfonso, prevedendo questo caso, abbia voluto in appresso destinarvi tre vicerè, ad oggetto che il maggior numero dei voti potesse risolvere l’affare. Forse nella elezione dei due Ram, e Cardona non v’era questo bisogno. La sperienza che avea negli affari il vescovo di Lerida, la veneranda sua canizie, e la ecclesiastica dignità di cui era decorato, doveano indurre il Cardona a deferire ai di lui saggi pensamenti. Ma poichè questi fu chiamato dal re per altri più premurosi affari, allora al Cardona non uno, ma due vicerè furono uniti, affinchè nel caso che fossero discordanti i loro pensamenti, si risolvesse ciò che i più arbitravano di doversi fare. In qual mese veramente Domenico Ram vescovo di Lerida fosse stato richiamato dal viceregnato di Sicilia, non può con precisione definirsi, ma è cosa certa che ciò accadde nell’anno 1419; imperciocchè nei dispacci viceregii, che sono nell’uffizio del protonotaro, si osserva sottoscritto insieme col Cardona fino ai 25 di aprile del detto anno, nè comparisce questo vicerè Cardona in compagnia del Velasti, e del Torres che ai 23 del seguente mese di maggio. Durante il governo di questi due vicerè ottenne la Sicilia dal magnanimo Alfonso una singolare grazia, che poi non osservata sotto i regni dei suoi successori, fu in parte riconcessa dall’invitto Carlo III re delle Spagne. Era l’arcivescovo di Messina Fr. Tommaso Grisafi a mal partito di salute l’anno 1418, e siccome allora quella prelazia era un buon boccone, formicavano i pretensori per ottenerla; la pretendevano molti cardinali, alcuni spagnuoli, e diversi cospicui soggetti siciliani. Siccome questa malattia trasse in lungo, così furono in caso i viceregnanti di consultare la volontà del sovrano, che ritrovavasi in Ispagna. Alfonso dunque rispose con lettera data in Fragues ai 16 dicembre dello stesso anno, in cui ordina che niuno straniero di qualunque grado, quantunque fosse cardinale, potesse nel regno ottenere benefizii o pensioni, quando non costi, che vi abbia dimorato per dodici anni continovi, e stabilisce che codesti benefizii o pensioni onninamente sieno conferiti ai regnicoli, e se mai costoro saranno citati da forastieri alla corte romana, si comanda, che non rispondano, nè vi costituiscano dei procuratori 104. Questa graziosa determinazione fu pubblicata dal vicerè Antonio Cardona con suo editto ai 23 di marzo dell’anno seguente 1419. Noi or ora vedremo quanto fosse stato costante questo sovrano nel volere esclusi gli stranieri dai benefizî del regno di Sicilia. CAPO IV. Antonio Cardona, Ferdinando Velasti, e Martino de Turribus. Partito dalla Sicilia il vescovo di Lerida, e restando nell’esercizio della carica di viceregnante Antonio de Cardona, il re Alfonso gli diede per compagni nel governo Ferdinando Velasti, e Martino de Turribus, che amministrarono il viceregnato per lo spazio di due anni. La regia cedola, in cui per la partenza del vescovo di 104 Pirri, Sic. Sacra Not. II. Eccles. Messan. p. 356. - 29 - Lerida furono eletti vicerè i sopramentovati soggetti, è data in Barcellona ai 15 di marzo 1419 105, e in questa elezione è da avvertirsi, che quantunque l’autorità data ai detti vicerè nella cedola reale fosse molto ampia, pur nondimeno fu questa per un’altra carta limitata. Questo è il monumento tratto dalla stessa officina del conservadore 106 che noi abbiamo mentovato nel capo antecedente, che ha questo titolo: Memorial de las cosas, et avisaments observadores por los nobles don Anthon de Cardona, Mosser Ferran Vasquez Porrado e Mizer Martin de Torres Virreys en lo reyno de Sicilia per lo Senior Rey — Paulus secretarius, e che nel registro viene nominato, come si è detto, Restrictio viceregum, di cui ecco il sunto: prescrive Alfonso, che la podestà accordata ai vicerè di far grazie e doni, e di conferire gl’impieghi indifferentemente, resti ristretta, [42] cioè, che senza prima consultare S.M. non possano eleggere alle seguenti cariche, cioè del maestro giustiziere, dell’ammiraglio, del gran siniscalco, del cancelliere, del maestro portulano, del maestro segreto, del protonotaro, dei segretarî, del provveditore dei castelli, del tesoriere, del maestro razionale, e del conservadore. Intorno alla podestà di donare, si vieta loro di dar feudi, o beni feudali, o burgensatici, che oltrepassassero la rendita di due once castigliane, nè danaro che fosse maggiore di due mila fiorini di Firenze. Si proibisce anche ai medesimi di poter fare i castellani di Catania, di Palermo, di Mozia, di Malta, della Pantellaria, di capo di Orlando, d’Inigo, di Milazzo, di Cefalù, di Trapani, di Girgenti, di Sciacca, della Licata, di Mazara, di Marsala, di Marquet, e quando vacassero le dette cariche di castelli per privazione, o resignazione, o morte, o in altra maniera, allora potessero affidarne interinamente la custodia a persone meritevoli, fino che il re non avesse altrimenti disposto. Termina questa carta con dirsi che nei casi di necessità, o di pubblica utilità del regno possano i vicerè, non ostante la detta restrizione, far uso di quel potere, che si è loro dato nella cedola, ed operare come farebbe il re istesso se fosse presente. Il primo di questi due aggiunti vicerè, che il Surita 107 chiama Ferdinando Velasquez, noi Velasti, perchè così lo veggiamo sottoscritto nei dispacci, e qualche volta Vasquez, Velaste, e Velasto, fu un uomo famoso nella storia di Spagna, e di Sicilia. Era egli castigliano, e fu uno dei quattro ambasciadori spediti dal re Ferdinando in Sicilia per metter fine alle vertenze fra il conte di Modica Bernardo Caprera, e la regina Bianca sostenuta da Sancio Ruitz de Lihori 108, della quale ambasciata abbiamo di sopra fatta menzione 109, ed era licenziato in legge, cancelliere del re, ed uno dei membri del suo sacro consiglio. Castigliano del pari era l’altro vicerè Martino de Turribus, come egli si sottoscrive, o de Torres come lo chiamano il Surita, e i nostri scrittori. Questi è detto dal mentovato scrittore degli annali di Spagna un famoso doctor en decretos, ed era stato ancora spedito in Sicilia l’anno 1412 in compagnia del Velasti, e di altri due ragguardevoli soggetti per la causa, che abbiamo additata. Ma fu questi anche adoprato, mentre ritrovavasi vicerè di Sicilia, l’anno 1420 per andare a Napoli con Raimondo de Perellos, e Giovanni Ansalone giudice della gran corte di Sicilia, ad oggetto di soccorrere la regina Giovanna di Napoli assalita da Luigi di Angiò, poichè questa principessa avea adottato per figliuolo il re Alfonso il Magnanimo 110. Ritrovavasi egli ancora nunzio, e collettore apostolico in questo regno. Durante il reggimento di questi tre vicerè molte cose accaddero, che sono degne di osservazione. Il re Alfonso, che malgrado le guerre nelle quali era occupato, non lasciava di procurare i vantaggi de’ suoi fedeli Siciliani, non contento di avere stabilito per legge, come abbiamo divisato nel capo antecedente, che gli esteri fossero esclusi dalle prelazìe, da’ benefizî, e dalle pensioni, eccetto che non fossero dimorati nel regno lo spazio almeno di dodici anni, volle inoltre nell’anno 1420 che fossero sequestrate tutte le chiese, che non fossero possedute da’ Siciliani, e tutti i loro frutti, proventi, ed introiti, ordinando che questi fossero depositati in potere di una persona proba, e fedele. Fu questa seconda legge intorno alle dignità ecclesiastiche stabilita l’anno 1420, e lo stesso anno dal vicerè Antonio de Cardona promulgata in Palermo agli 8 di settembre, il quale destinò il regio tesoriere, acciò girasse per tutta la Sicilia, e per le isole ad essa aggiacenti, affine di sequestrare le chiese ch’erano amministrate dagli stranieri, e ricevesse i frutti delle medesime, lasciandovi de’ procuratori che in avvenire ne esigessero le rendite 111. Ritrovarono i tre mentovati vicerè che le spese, che si faceano ne’ giudizî, erano eccessive, ed aggravavano considerabilmente i litiganti non meno nelle cause civili, che nelle criminali. I giudici esigevano esorbitantissimi diritti, e a proporzione i ministri subalterni cercavano di smungere il più che potessero le borse de’ vassalli del re. Volendo adunque eglino dare un pronto riparo a questi disordini, esaminata ogni cosa secondo i limiti del giusto, pubblicarono in Palermo nel mese di marzo dello stesso anno 1420 i loro [43] regolamenti, che si trovano registrati nel tomo 1° de’ capitoli del regno sotto questo titolo: 105 Registro della Regia Cancelleria all’anno 1418 1419, Ind. XI, f. 216. In libro Mercedum an. 1418, 1419, f. 219. 107 Ann. de Aragon., t. III, lib. XII, cap. 3, p. 77. 108 Surita ivi. 109 Lib. I, capo unico. 110 Surita, loc. cit, lib. XIII, cap. 5 e 6, p. 141 e 142. 111 Pirri, Sicilia Sacra Not. II. Eccl. Messan. p. m. 356 e 357. 106 - 30 - Ordinationes factae per magnificos, et potentes dominos vicereges, regnante serenissimo rege Alphonso rege Aragonum Siciliae etc. supra juribus solvendis curialibus regiis apud urbem Panhormi anno Domini MCCCCXX de mense martii XIII indictione 112. Sono queste comprese in quarantotto capitoli, a’ quali ne fu aggiunto a’ 2 di maggio un altro intorno al premio da darsi a colui, che ne avesse denunziati i contravventori. Riguardano le suddette ordinazioni tutti i diritti, che appartengono a’ giudici nelle cause così civili, che criminali: prescrivendosi ciò che devono esigere, e i casi ne’ quali debbono astenersi dal riscuotere verun pagamento; quelli de’ due maestri notari, cioè della gran corte, e del concistoro; quelli dell’archivario; e finalmente quelli dei commissarî, de’ servienti, e del carceriere. Vi sono anche stabiliti i diritti del protonotaro, e de’ maestri razionali, del regio algozino, e de’ referendarî. Le tariffe fissate in quei tempi muoverebbono le risa, se volessero eseguirsi alla nostra età: giacchè a parte, che in moltissimi casi si ordina, che nulla punto esigano, chi non resterebbe sorpreso nell’udire che il pedaggio di un giudice della gran corte che viaggia nel regno, o per servigio del re, o per l’interesse de’ privati, non dovesse essere più di tarini otto al giorno? 113 Ma egli è d’avvertire, che nel principio del quintodecimo secolo, quando ancora non eransi scoperte l’Indie, e le doviziose miniere di esse, il valore del denaro era di gran lunga maggiore di quel, che al presente si apprezza; e quindi ciò che allora si facea con poca moneta, ora a stento può farsi con molta. Noi abbiamo le mete per le derrate dell’epoca aragonese, nelle quali osserviamo che una così detta salma di grano valea quattro tarini, la carne a tre grana al rotolo, e così di seguito, quando ora non si ha questa che per 32 grani il rotolo, e quella per once due e tarini 20, o più la salma. Egli è vero che talvolta i giudici, e gl’inferiori uffiziali hanno abusato del loro potere, esigendo o diritti, che loro non competono, o in maggior somma, che non si deve; ma il governo ha di mano in mano occorso a cotali abusi, e sono comparse altre ordinazioni, che prescrivono i giusti diritti da esigersi. Mentre governavano il regno di Sicilia i suddetti tre vicerè, era l’isola di Malta molestata da’ corsari, i quali, occupando Comino, ch’è piccola isola fra Malta e il Gozzo, teneano in suggezione i Maltesi, e loro impedivano di potere liberamente trafficare. Fu adunque ricorso al governo, e fu a’ medesimi accordato che potessero fabbricare in quell’isola un forte, e mettervi guarnigione, per impedire ogni approccio di codesti ladri di mare, che ivi agevolmente si ricoveravano 114. Questa piccola isola è oggi in potere de’ cavalieri dell’ordine Gerosolimitano, poichè ebbero concessa da Carlo V quella di Malta. Questo forte fu accresciuto da Adriano de Vignacourt gran maestro dell’ordine sulla fine del secolo XVII, o più verisimilmente fu riedificato, essendosi forse rovinato per il terribile terremoto accaduto in Sicilia, e nelle isole aggiacenti agli 11 di gennaro dell’anno 1693, che fu funestissimo; ed oltre di avere scossi dalle fondamenta innumerabili edifizî, fu micidiale ancora agli abitanti, che vi morirono a migliaja. CAPO V. Giovanni de Podio Nuchi, Arnaldo Ruggiero de Pallas, e Niccolò Castagna. Mancandoci nel reale uffizio del protonotaro gli atti de’ possessi de’ primi nostri vicerè, non possiamo con certezza stabilire, quando si fossero partiti i tre vicerè, de’ quali abbiamo favellato, e quando fossero subentrati gli altri tre, de’ quali ora ragioneremo. Il primo di quelli, che si allontanò prima degli altri, fu certamente Martino de Turribus destinato, come abbiamo riferito, a liberare la regina Giovanna di Napoli dalle armi di Ludovico d’Angiò, e a prender possesso dei castelli, che cedea questa sovrana al re Alfonso già dichiarato suo figliuolo adottivo, sebbene non fosse stato il principale in questa ambascerìa; giacchè colui, che rappresentava le veci di questo re, fu Raimondo de Perellos. Noi non sappiamo s’egli dopo di avere eseguita questa commissione sia ritornato in Sicilia ad esercitare la carica di vicerè: i nostri archivî non ce ne danno lume alcuno. Quel ch’è certo egli è, che nell’anno 1421 e precisamente dopo l’anno 1420 il Cardona, il [44] Velasti, e il de Torres cessarono di governare come vicerè la Sicilia, e che subentrarono in loro vece il Podio, il Ruggiero, e il Castagna, cominciandosi ad osservare sottoscritti da costoro i diplomi viceregî nel mese di settembre 1421. Siccome il de Torres continuò a fermarsi nel regno nell’impiego di nunzio, e collettore apostolico, noi crediamo che l’unico che siesi allontanato dalla Sicilia sia stato Antonio Cardona, giacchè il Velasti opiniamo che sia restato colla carica di maestro segreto, nè guari passò, come vedremo nel seguente capo, ch’ei fu di nuovo eletto vicerè. Ora per dar conto de’ tre nuovi viceregnanti, Podio, Ruggiero, e Castagna, era il primo catalano, e religioso dell’ordine de’ Domenicani. Fu costui chiaro non meno per sangue, che per dottrina, imperciocchè riputavasi per dottissimo maestro in teologia, intervenne nel famoso concilio di Costanza, dove predicò nell’ultima sessione, e poi essendo stato eletto l’anno 1417 Ottone Colonna per pontefice, che prese il nome di Martino V, questi lo scelse per suo confessore, e gli diede la carica di referendario. Era allora la chiesa di 112 Cap. Regni Sicil. in Alphonso, t. I, p. 273. Ivi, pag. 276. 114 Abele, Malta illustrata, lib. IV, not. I, p. 428. 113 - 31 - Catania divisa in due fazioni. Fin da’ tempi della regina Bianca Mauro Calì aderente del conte di Modica era stato deposto dal vescovado, e i monaci che allora erano i canonici di quella chiesa, avevano eletto Tommaso d’Asmari priore della chiesa. Il clero non aderì a questa nuova elezione, e sosteneva il legittimo vescovo Mauro; quindi, mentre la chiesa universale era vessata dallo scisma, la chiesa particolare di Catania provava nel suo seno la divisione, stando i monaci con parte della città per Tommaso, e il clero coll’altra parte per Mauro; e intanto le rendite di essa erano amministrate da Martino de Turribus, come nunzio apostolico. Finalmente, resasi la pace alla chiesa universale, ed elettosi Martino V, i due contendenti vescovi di Catania si dimessero l’uno, e l’altro del governo della chiesa di questa città, e il pontefice al secondo anno del suo ponteficato vi spedì Giovanni Podio 115. Il cognome di questo prelato non è rapportato nello stesso modo; ce lo avverte il Pirri 116, da cui siamo istruiti, che delle volte era detto de Podionucis, delle volte Podomentanus, quando de Podomitis, e quando de Podyomitis. Vuolsi, per quanto scrive Michele Pio 117, che fosse stato eletto vicerè mentre il re Alfonso ritrovavasi, come or ora diremo, in Messina, per cedola data in quella città a’ 15 di giugno 1421. Fu caro non meno a questo sovrano, che al ridetto pontefice, da cui ottenne lettera al vescovo di Siracusa, allora delegato apostolico, affinchè lo agevolasse per riacquistare i beni della sua chiesa, ch’erano stati ingiustamente alienati; e infatti venne a capo di riprenderli, e fra gli altri ebbe il castello di Aci, ch’era in potere di Ferdinando Velasti. Giovanni Battista de Grossis 118 pretende, ch’egli fosse stato generale de’ Domenicani, ed a confermarlo rapporta 119 una lettera di S. Vincenzo Ferreri scritta l’anno 1403 al medesimo, nella quale lo chiama maestro generale. Ma bisogna osservare, come ce ne avvertono il P. Vincenzo Fontana 120, e Gian-Michele Cavalieri 121 , che allora era la chiesa squarciata dallo scisma di Urbano VI, e di Clemente VII. Questi, che fu eletto papa da quindici cardinali a Fondi, era riconosciuto per legittimo pontefice in Francia, nelle Spagne, in Scozia, nell’isola di Cipro, e nella Sicilia: tutto il resto del mondo cattolico stava sotto l’ubbidienza di Urbano. Or siccome le chiese erano divise, così ancora gli ordini monastici, e perciò quelli dell’ubbidienza di Urbano avevano un generale diverso da quelli dell’ubbidienza di Clemente, e perciò S. Vincenzo Ferreri, ch’era spagnuolo, riconoscea per maestro generale dell’ordine F. Giovanni Podio Catalano, a cui scrivea come suo legittimo superiore, sebbene il resto dell’ordine, che riconoscea per vero pontefice Urbano VI, avesse un altro maestro generale. Morì questo prelato l’anno 1431 122, dopo di avere governata la chiesa di Catania intorno a tredici anni. Di Arnaldo Ruggiero de Pallas noi non abbiamo altra notizia, eccetto che fu de’ conti di Pallas, ch’è una cospicua famiglia di Aragona. Noi ritroviamo fin dall’anno 1314 un altro Arnaldo Ruggiero de Pallas, che si accasò con Urraca de Entença rispettabilissima dama, il quale poi l’anno 1328 ottenne dal re Alfonso IV il cingolo militare con altri illustri cavalieri 123. Il nostro, ch’ebbe lo stesso [45] nome, fu l’anno seguente 1422 confermato nel viceregnato di Sicilia. Il terzo Niccolò Castagna, nato Siciliano, fu famoso per la sua destrezza nel maneggiare gli affari. Fu egli consigliere del re Martino I, tesoriere generale del regno, maestro razionale, e strategoto di Messina sua patria. Lo stesso re Martino l’adoprò in molti rilevantissimi negozî, ne’ quali diede saggio della sua attività, e fedeltà nel servigio reale. Morti i due Martini I e II, ed eletto re di Aragona e per conseguenza di Sicilia Ferdinando il Giusto, fu spedito alla corte di questo principe come ambasciadore del regno, e della città di Messina, per rallegrarsi della sua assunzione a quel trono. Fu perciò amato dai principi, e signore potente in Sicilia; giacchè oltre le baronìe di Saponara, e di Rocca, possedè quelle di Biscari, di Bavuso, di S. Andrea, di Monforte, di Calvaruso, di Condrò, ed altri feudi, che sono indicati dallo Inveges 124. Fu anche pio signore; imperocchè per suo testamento l’anno 1424 fondò un ospedale nella strada de’ Fiorentini, che mena all’argenteria in Messina, vicino alla chiesetta di s. Maria di Monserrato, lasciandovi delle ricche rendite per mantenerlo 125. Anzichè questi nuovi vicerè fossero eletti, il re Alfonso era venuto per la prima volta in Sicilia, per prepararsi a portar la guerra al re Ludovico di Angiò, e difendere la regina Giovanna, che lo avea, siccome abbiam detto, adottato per figlio. Giunse egli in Palermo a’ 12 di febbraro 1421 che che ne abbia scritto 115 Amico, Catana Illustrata, lib. VI, cap. 8, e lib. VII, cap. 1. Sic. Sacra Not. I. Eccl. Cat. p. 54. 117 Hist. Domin., part. II, lib. III, fol 5. 118 Catana Sacra, p. 188. 119 In Decac. Cat., t. I, pag. 138. 120 In Thesauro Domin. part. II, f. 236. 121 Nella Galleria Cent. III, p. 223. 122 Amico, Cat. Illust. lib. VII, cap. I, § 20. 123 Surita, Annal. de Aragon., t. II, lib. VI, cap 17, p. 22, e lib. VII, cap. 1, p. 85. 124 Nell’apparato al Palermo Nobile. 125 Samperi, Messana Illustrata, t. II, lib. VI, p. 504. 116 - 32 - l’Auria 126, che lo fa arrivato lo stesso giorno dell’anno antecedente, lo che è un errore manifesto; avvegnachè Alfonso non venne nel nostro regno, se non dopo che la flotta comandata da Perellos arrivò in Napoli, e fu messo in possesso questo luogotenente del ducato di Calabria a nome del suo sovrano, e de’ castelli principali. Ora l’arrivo della flotta sicolo-aragonese accadde a’ 6 di settembre 1420, ed a’ 19 del detto mese fu dato il possesso al Perellos; laonde nel febbraro dell’anno seguente dovette accadere la venuta di Alfonso nella nostra isola. Fu accolto in Palermo, per quanto noi immaginiamo, con trasporti di gioja, siccome costumano i Palermitani all’arrivo de’ loro sovrani. Il Pirri 127, parlando di Alfonso in Palermo, ci racconta che questo principe siasi obbligato con giuramento a mantenere i privilegi, le consuetudini, e le immunità dei Siciliani; che chiamò appresso di se tutti i prelati, e gli ambasciadori delle città, dai quali ricevè il giuramento di fedeltà; che in questa cerimonia fu dato il primo luogo all’arcivescovo di Palermo, di poi a quello di Messina, e il terzo luogo a quello di Morreale; dietro al quale resero il ligio omaggio gli altri vescovi, e prelati; vuole, che nell’entrare gli ambasciadori delle città, ebbe la stessa preferenza quello di Palermo sopra quello di Messina, e che allora fu fatto quel famoso distico: Invida felici semper Messana Panormo Posthac Alphonso judice victa sile. Soggiunge, ch’ei stabilì che i governatori di Palermo fossero in avvenire sei, e che si chiamassero giurati, come si nominavano nei regni di Aragona, di Valenza, e di Catalogna. Tutte queste singolari notizie dice di avere tratte da un repertorio manoscritto del giureconsulto Giovanni Luigi Settimo intorno alle cose feudali, e dalla dissertazione di Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo intorno al primato della chiesa palermitana. L’Auria di poi 128 ci avvisa, che Alfonso accordò alla città di Palermo di poter fabbricare un molo fra il castello a mare, e la compagnia della carità, che oggi chiamasi molo piccolo, o la cala; e che un dì andò a Morreale per osservare quel magnifico tempio. Di tutti questi fatti, che narrano i mentovati scrittori, noi non ritroviamo vestigio alcuno presso gli storici contemporanei, e per quel che appartiene a Palermo, ci fa meraviglia, come il de Vio, che registrò tutti i privilegi di Palermo, non faccia motto di quelli, che questi autori ci additano. Noi intanto, seguendo le pedate dell’autore del frammento della storia siciliana 129, che dee riputarsi contemporaneo, crediamo che Alfonso, il di cui principale obbietto, nel portarsi in Sicilia, fu di assoldar gente, e di prepararsi a soccorrere la regina Giovanna di Napoli, non si trattenne in Palermo che pochissimi giorni, e sollecitamente andossene in Messina, per essere più a portata di [46] compiere il suo disegno. Ivi furono chiamati i baroni, le università, e i prelati siciliani, e vi vennero ancora molti conti, e baroni della Calabria per trattare la maniera, che si dovea tenere a fine di fare sloggiare gli Angioini dagli stati della regina. Dimorò in Messina molti mesi; imperocchè lo stesso anonimo ci lasciò registrato, che questo principe ai 30 del seguente maggio ne partì, ed andò a Taormina, e di là nel dì seguente andò a Catania, dove entrò per la porta di Aci, ed avendo visitata la chiesa di s. Agata, passò al castello, e vi si fermò due giorni, e la sera dei 2 di giugno partì su di una galea scortata da due altre, e si restituì a Messina ai 3 dello stesso mese 130 . Allora noi crediamo che Alfonso, essendo vicino a portarsi in Napoli, abbia destinato i nuovi vicerè che dovessero succedere agli antecedenti, il governo dei quali, essendo presente il re, era cessato. Se la cedola fatta a favore di Mons. Giovanni de Podio, come di sopra abbiamo avvertito, fu sottoscritta a Messina ai 15 di giugno 1421, egli è verisimile che le altre cedole ancora fatte per Arnaldo Ruggiero de Pallas, e per Niccolò Castagna sieno della istessa data. Alfonso non si determinò a questa scelta, se non dopo che venne a Catania, e vi riconobbe il Podio. I talenti, e l’esperienza del Castagna gli erano noti, e vieppiù li conobbe nella dimora fatta a Messina, dove costui esercitava la carica di strategoto; perciò elesse questi due, per affidare ai medesimi il reggimento della Sicilia, e vi unì per terzo il Pallas, che forse stava ai suoi fianchi, e della di cui destrezza era abbastanza convinto. Provveduto il regno di governanti, partì ai 19 di giugno Alfonso per Napoli, ma non essendo prospero il vento, si trattenne al monastero del Salvadore fino ai 25 dello stesso mese. Siamo affatto allo scuro di tutto ciò, che accadde in Sicilia nel breve governo di questi tre vicerè. Il regno fu tranquillo, e malgrado la pestilenza che entrò in Napoli nel mese di aprile dell’anno 1422, e che obbligò quella corte a partirne, e a ridursi a castello a mare, questa per la diligenza dei governanti non mai penetrò nelle nostre contrade, nulla ostante i soccorsi, che dovettero giornalmente somministrarsi al re per mantenimento dell’armata. 126 Cronol. de’ Vicerè di Sic., pag. 5. Chronologia Regum Siciliae, p. 90 e 91. 128 Chronologia de’ Vicerè di Sicilia, p. 5. 129 Muratori, Rer. Ital. Script., t. XXIV, p. 1092. 130 Muratori, Rer. Ital. Script., tom. XXIV, p. 1092. 127 - 33 - CAPO VI. Giovanni de Podio Nuchi, Arnaldo Ruggiero de Pallas, e Ferdinando Velasti. La poca accuratezza dei nostri antichi, che lasciarono nel buio molti fatti interessanti della storia siciliana, è la cagione per cui non sappiamo per qual motivo Niccolò Castagna mancò di essere vicerè di Sicilia, e fu in di lui luogo scelto per la seconda volta Ferdinando Velasti, che ritrovavasi maestro segreto del regno. Era pure il Castagna un personaggio rispettabile per le gravi cariche che avea sostenute, come si è di sopra accennato, alle quali avea aggiunta nell’anno antecedente 1421 la luminosissima di vicerè. Per quale ragione adunque egli lasciò questo anno 1422 di più esercitarla? ne fu discaricato forse da Alfonso? ne chiese egli la sua dimissione, o se ne mori? Questo è ciò che noi sospettiamo, sebbene non abbiamo fondamento di asserirlo. Checchesia di ciò, egli è certo che il Castagna in quest’anno più non comparisce, e si vede in sua vece sottoscritto il Velasti. Durò il viceregnato di questi tre per un altro anno, cioè sino all’anno 1423 nel qual tempo continuava la guerra in Napoli, ed erano già nate delle diffidenze fra la regina Giovanna, e il re Alfonso. Non sappiamo in quest’anno cosa sia accaduto di particolare in Sicilia sotto il loro governo, se forse non se ne eccettua la peste, la quale, malgrado le diligenze che si erano usate per allontanarla, era penetrata nell’isola, dietro di avere già abbandonate le contrade napolitane. Di questa peste non fanno veruna menzione i nostri nazionali, e solo l’accenna l’autore del frammento della storia siciliana, il quale assicura che cominciò ad infettare la nostra Sicilia nel mese di aprile 1423, e che la strage fu particolarmente in Catania, e che morì allora Bernardo Caprera, che era il gran giustiziere 131. Dal che ricaviamo che questo cavaliere, che era stato trasportato in Ispagna e privato dei suoi castelli e della carica di gran giustiziere, nel regno del re Alfonso entrò in di lui grazia, riprese questa insigne carica, ritornò nel possesso dei suoi beni, e morì in Sicilia l’anno 1423. Dal Surita 132 sapevamo, che se gli erano restituiti i beni [47] che possedea in Sicilia, ma che vi fosse ritornato, avesse ripreso l’uffizio di gran giustiziere, e fosse cessato di vivere l’anno 1423 ci sarebbe ignoto, se l’anonimo scrittore del frammento suddetto non ce ne avesse avvertito. CAPO VII. Niccolò Speciale, nel di cui governo venne in Sicilia, e vi esercitò dominio l’infante Pietro. Ecco un solo vicerè, che regola tutta la Sicilia. Fu questi Niccolò Speciale maestro razionale del regno, e signore di Paternò, di Spaccaforno, e di altri luoghi. Era egli nato in Noto, e fu uomo di rari talenti, e molto caro al re Alfonso. Il Pirri 133 parlando di questo suo concittadino, scrisse che egli fu l’autore della storia siciliana fino ai suoi tempi. Nicolaus Specialis prorex Siciliae litteris tradidit historiam siculam ad sua tempora anno 1444. Lo storiografo canonico Antonino d’Amico, quantunque nulla ci rammenti di questa storia, attesta nondimeno che ei fu un uomo dotto, chiamandolo muy famoso letrado 134. L’Auria seguendo il Pirri ci dice 135, che compose una bella historia di Sicilia, come dicono alcuni, in lingua latina, che comincia dall’anno 1282 nell’espulsione dei Francesi fino al 1337, la quale va manoscritta attorno, e ne fanno menzione gli historici, la quale pochi anni sono è uscita stampata a Parigi nel 1688 nel fine del volume intitolato Marca Hispanica. Quest’opera, di cui fa menzione l’Auria, fu stampata da Stefano Baluzio cotanto benemerito della repubblica letteraria, il quale volendo dare alla luce l’opera postuma suddetta intitolata Marca Hispanica, di cui era autore il famigerato arcivescovo di Parigi Pietro de Marca, stimò opportuno di aggiungervi la storia siciliana ancora inedita di Niccolò Speciale, come quella che rapportava parimenti le gesta dei re Aragonesi. Ma Niccolò Speciale, che scrisse la storia siciliana, non è lo stesso che quello, di cui parliamo, e che fu vicerè di Sicilia; e ci fa meraviglia come il Pirri, accurato scrittore, di due diversi uomini che aveano lo stesso nome e lo stesso cognome, e vissero in diversi secoli, ne abbia fatto uno. Se egli avesse riflettuto a ciò che la mentovata storia riferisce 136, cioè che essendo morto l’anno 1334 il pontefice Giovanni XXII, ed essendo stato eletto per di lui successore Benedetto XII, Federico re di Sicilia: Ogerium de Versolo, Nicolaum de Lauria, et scriptorem hujus opusculi nuntios misit, si sarebbe di leggieri persuaso, che l’autore della storia siciliana, che l’anno 1334 era in età da destinarsi ambasciadore al Papa Benedetto XII, non potea esser quello, che l’anno 1423 fu vicerè di Sicilia, e morì l’anno 1444, quando non se gli vogliano dare gli anni di Nestore. 131 Muratori, loc. cit. p. 1093. Ann. de Arag., lib. XII, cap. 62, p. 127. 133 Not. Eccl. Sic. Not. I. Eccl. Syrac. p. 225. 134 Cronol. de los Virreyes, y Presidentes e. c. che han governado el Reyno de Sicilia, p. 4. 135 Cronologia de’ Vicerè di Sicilia, p. 5. 136 Lib. VII, cap. 5. 132 - 34 - Durò solo nel governo della Sicilia Niccolò Speciale fino all’anno 1429, nel qual tempo diede delle utili provvidenze in vantaggio del regno, e per la tranquillità dello stato, delle quali ne accenneremo alcune sulla fine di questo capo; ma mentre governava così provvidamente la Sicilia, vi giunse l’infante Pietro duca di Noto, e fratello del re Alfonso. Era stato lasciato questo principe alla conservazione della città di Napoli, quando il mentovato sovrano erasene andato in Ispagna affine di liberare dalla prigionia Arrigo suo fratello, che tenea preso il re di Castiglia. Or mentre egli conservava gli acquisti fatti dagli Aragonesi nel regno di Napoli, la regina Giovanna, che avea di già disdetta la filiazione adottiva dichiarata prima a favore del re Alfonso, si collegò coi Genovesi, i quali preparata una poderosa flotta, sbarcarono a Gaeta, e posto l’assedio a quella città, dopo alquanti giorni obbligarono Antonio de Luna che vi comandava a rendere quella piazza; presero di poi Procida, Vico, Massa, Sorrento, e tutta la costa di Amalfi, e piombarono sopra Napoli, e per il tradimento di Giacomo Caldora s’impossessarono della città ai 12 di aprile 1424, e ridussero l’infante Pietro a ritirarsi a Castelnuovo, dove si rifuggirono tutti coloro che erano affezionati alla nazione catalana. Sebbene quel castello, che fu tosto assediato dalle vincitrici armi degli Angioini, e dei Genovesi, fosse ben provisto di munizioni da guerra, e potesse sostenere per lungo tempo l’assedio, nondimeno mancavano i viveri per tanta gente che vi si era ricoverata. In questo stato arrivò una porzione della flotta aragonese spedita dal re Alfonso in soccorso del fratello, e [48] comandata da Federico de Luna, la quale non essendo bastante a fare isloggiare i nemici, l’infante amò meglio di lasciare nel castello tante delle migliori truppe, quante fossero bastanti a soffrire l’assedio, senza patire la carestia; ed egli intanto imbarcatosi nei primi di agosto, dopo di avere saccheggiati i lidi di Napoli, prese la via di Sicilia, e alla metà del mese istesso arrivò in Messina 137. All’arrivo di questo principe reale Niccolò Speciale stimò suo dovere il deporre il governo nelle di lui mani; ma l’infante non si trattenne che tre giorni in essa città, ed occupato nell’eseguire i suoi disegni, passò subitamente a Siracusa coll’armata aragonese, dove si fermò, e spedì alcune galee a Catania per provvederla di biscotto, di vino, e di tutto ciò che potesse esserle necessario, ed ai 5 di settembre salpò da quel porto con tutte le navi, e veleggiò verso il suo destino. Qual mai fosse stato l’oggetto di questo viaggio non è del pari asserito dagli scrittori. Se si ode l’autore del frammento della storia siciliana 138, questi racconta che l’infante Pietro volea portare la guerra direttamente in Affrica, e che perciò rivoltò le prore verso l’isola di Malta, dove si fermò qualche giorno, aspettandovi alcune navi da carico; e ai 10 si pose nuovamente alla vela per conquistare le Gerbe; ma sembrandogli malagevole questa impresa, pensò piuttosto di assalire l’isola di Cerchena, dove sbarcò ai 19 del mese; e sebbene avesse trovata una forte resistenza, non di meno diede a quegli abitanti una rotta considerabile, prese l’isola, e messe in ceppi intorno a tre mila e quattrocento di essi. Passò di poi, prosiegue a dirci il mentovato anonimo, agli scafati, che appartenevano al re di Tunisi, il quale paventando alla vista della flotta siciliana, stimò più a proposito il trattarla amichevolmente, che l’impegnarsi alla difesa. Laonde mandò molti doni all’Infante Pietro, e a Federico de Luna, figliuolo bastardo del re Martino I, che era il grande ammiraglio, e restituì i cristiani, che tenea in catena. Ciò ottenuto, ritornò l’armata in Malta, e di là partendo arrivò a Siracusa ai 14 del seguente ottobre. Ma se si dà orecchio a Bartolomeo Fazio, che a nostro conto merita una maggior fede, e perchè fu genovese, e perchè fu uno dei familiari del re Alfonso; questi dà un anteriore destino alla flotta catalana, e vuole, che l’infante Pietro sia prima andato per ordine del fratello a Genova 139, per sostenervi Tommaso Fregoso, che n’era stato discacciato dal duca di Milano. Quindi, secondo questo scrittore, l’infante venne prima a Pisa con ventidue galee, alle quali si unirono due altre dei fiorentini, che erano tampoco in guerra col duca Filippo, e avvicinandosi a Genova cominciò a devastarne i lidi, nè partì se non chiesta la pace dal mentovato duca, e restituito il Fregoso nel dominio di quella repubblica. Dietro a questa impresa fe’ quella dell’isola di Cerchena, che si è accennata. Restituitosi l’infante Pietro a Siracusa, Niccolò Speciale, che alla di lui partenza, o per Malta, o per Pisa, avea riprese le redini del governo, ritornò a deporle fino che questo principe si trattenne nel regno. Noi abbiamo nella regia cancellaria, e nell’uffizio del protonotaro diversi dispacci di questo infante dati da quei paesi, nei quali si ritrovava, e la maggior parte da Trapani, dove si fermò molto tempo, e fino ai primi di febbraro dell’anno seguente 1425, nei quali però egli non s’intitola vicerè di Sicilia, ma Infans Petrus Aragonum, et Sicilie pro serenissimo domino domino Alfonso Dei gratia Aragonum, et Sicilie Rege. Perciò noi non l’abbiamo annoverato, come fecero l’Amico e l’Auria, frai vicerè di Sicilia; giacchè opiniamo ch’egli abbia comandato nel nostro regno, non già per la dignità viceregia che gli avesse conferito il re Alfonso, ma per quella plenipotenza accordatagli dal medesimo in tutti i suoi stati, dove si trovava. Egli non volea fermarvisi, avendo con replicate istanze ricercato al fratello il permesso di ritornare in Ispagna. Alfonso avrebbe desiderato ch’ei vi si fosse trattenuto, così per essere a portata di riacquistare il 137 Surita, loc.cit. t. III, lib. XIII, cap. 41, p. 176. Muratori, loc. cit., t. XXIV, p. 105 e 1096. 139 Rer. suo tempore gest., lib. III, p. 78 e seg. 138 - 35 - regno di Napoli, dove tuttavia era in suo potere il Castelnuovo, se mai alcuna favorevole circostanza si presentasse; come per tenere a freno Federico de Luna, che i Siciliani amavano come figliuolo del re Martino, ch’era stato la delizia della nazione, e co’ suoi talenti e la sua virtù militare era capace d’indurli a proclamarlo per sovrano. Ma finalmente non volendo dispiacere un fratello, che l’avea così [49] ben servito nella guerra di Napoli, di Genova, e dell’Africa, e dal di cui valore potea molto compromettersi, mosso dalle frequenti premure gliene accordò il permesso, ma a condizione che seco conducesse, o facesse prima partire dal regno Federico suddetto. Prima di abbandonare la Sicilia volle l’infante Pietro fare un piccolo giro per le città principali di essa, e venendo prima a Noto, e di poi a Catania, di là passò a Palermo nel mese di novembre, e da questa capitale si ridusse a Trapani, dove aspettava la flotta, con cui dovea partire per andare prima in Sardegna, secondo gli ordini del fratello, e poi in Ispagna. Si trattenne in detta città per lo meno sino a’ 4 di febbraro 1425, essendovi nell’uffizio del protonotaro un suo dispaccio dato in detto giorno da Trapani. Fe’ anche partenza per Catalogna il principe Federico, conducendo seco Tarsia sua madre donna catanese, ed una sorella. Allontanatosi l’infante Pietro dalla Sicilia, ne riprese il governo Niccolò Speciale, e durò solo in questa carica fino all’anno 1429. Molte utili provvidenze si ritrovano date da questo famoso governante. Merita sopra di ogni altra di essere commendata la prammatica che promulgò in Messina a’ 2 di agosto 1425 140. Erano quei tempi calamitosissimi per la chiesa di Dio, e sebbene Martino V la reggesse, non era nondimeno il pastore universale; giacchè persisteva ancora nello scisma Pietro de Luna, che si facea chiamare Benedetto XIII, ed era riconosciuto per pontefice in molti stati, e principalmente in quelli del re Alfonso, che trovandosi in collera con Martino, che sostenea il partito della regina Giovanna, avea fatto riconoscere ne’ suoi regni, e per conseguenza in Sicilia, Pietro de Luna per legittimo papa. I tempi dell’anarchìa sono quelli de’ vizî, facendosi ciascheduno lecito ciò, che gli viene in grado di fare. Gli ecclesiastici Siciliani vestivano a loro modo, poco curandosi di portar l’abito, e la tonsura prescritta al clero, e invece di occuparsi nell’esercizio del loro ministero, s’impacciavano in negozî secolareschi. I vescovi o non voleano, o non poteano ridurli al dovere; la male intesa loro immunità impediva che la podestà laicale li gastigasse, e perciò, senza che alcuno frenasse la loro licenziosa vita, erano divenuti lo scandalo di tutti i buoni. Volendo intanto il vicerè Speciale riparare questi disordini, pensò di privare costoro del vantato privilegio dell’immunità ecclesiastica, acciò potessero i magistrati liberamente punirli, come i loro eccessi ricercavano. Questo fu il fine della mentovata prammatica, con cui fu ordinato che tutti quegli ecclesiastici che non vestivano l’abito, e non portavano la tonsura chericale, o s’intromettevano in affari laicali, non potessero in avvenire godere della immunità personale, dichiarandoli in questi casi soggetti alla podestà secolare. S’egli fosse divenuto a questo passo, perchè già era morto l’antipapa, ed Egidio Mugnone, ch’era stato in sua vece eletto, e avea preso il nome di Clemente VIII abbandonato da tutti era più presto un fantoccio, che un papa, non sappiamo definirlo, essendo incerto l’anno in cui Pietro de Luna morì, volendo il Rainaldo che finisse di vivere l’anno 1424, e sostenendo il Mansi che la di lui morte accadde nell’anno di appresso. Nello stesso anno, e nel giorno 23 del medesimo mese, promulgò nella mentovata città alcune ordinazioni distinte in quarantuno capitoli, colle quali, volendo dar riparo agli eccessi de’ diritti che esigevano gli uffiziali messinesi, per cui frequenti erano le querele dei litiganti, fissò le ragioni, che competessero a’ maestri notari, a’ giudici, agli avvocati e procuratori, a’ castellani, a’ carcerieri, a’ contestabili, a’ birri, e agli altri servienti della curia, prescrivendo gravi pene a coloro, ch’esigevano di più 141. Savissimi sono ancora, ed esatti i capitoli, e gli statuti, che questo vicerè promulgò in Palermo a’ 13 di novembre dell’anno seguente 1426 142 intorno all’amministrazione della dogana di questa capitale, co’ quali provvidde al servigio del sovrano, e al sollecito disbrigo nella introduzione, e nella uscita delle mercatanzie, e alla sicurezza delle medesime, e al vantaggio del commercio. Fu destinata una casa per collocarvisi le mercatanzie vicino al mare, dove allora eravi una porta detta della marina non molto lungi da porta felice, e che diceasi ancora porta del molo vecchio, che oggi è murata, e stava fra la detta porta felice, e quella che poi si aprì della doganella 143, nella qual casa fu ordinato, che dimorasse una persona idonea da eleggersi dalla regia corte, la quale colla sua famiglia stesse alla [50] custodia delle merci, che poi, pagate le gabelle, si rendevano a’ rispettivi padroni, a cui erano affidate le chiavi di essa porta, affine di evitarsi le frodi. Colla stessa prudenza regolò questo vicerè il regno, mentre fu solo negli anni di appresso 1427-1428, fino che gli fu dato un compagno nel viceregnato, come or ora siamo per dire. 140 Tom. III, Prag. p. 2. Cap. Regni Sic., t. I. in Alphonso p. 302 e seg. 142 Capit. ivi, p. 277 e seg. 143 Giardina, Porte di Palermo. 141 - 36 - CAPO VIII. Niccolò Speciale, e Guglielmo Moncada. Per qual ragione il re Alfonso, dopo di aver lasciato per lo spazio di sei anni nelle sole mani di Niccolò Speciale il governo della Sicilia, gli abbia poi dato per compagno il conte di Caltanissetta Guglielmo Moncada, è a noi sconosciuto. Se sia lecito il congetturare, sembra che questo principe amasse di non affidare ad un solo il reggimento di quest’isola, salvo che in certi particolari casi, qualora i soggetti che vi destinava, erano molto esperimentati nell’arte di governare, come si è veduto in Niccolò Speciale, e si vedrà fra non poco in Lopez Ximen de Urrea. Ma se è così, dirà forse taluno, perchè non continuò a reggere solo lo Speciale? perchè, io immagino, Alfonso avea in animo di condur seco nella guerra, che meditava di portare nel regno di Napoli, questo uomo illustre, che potea servirgli di consigliere; e perciò prima di eseguire questo suo pensamento, volle dargli un compagno, e poi due, siccome vedremo, acciò questi istruiti dalla sperienza di questo vecchio ministro potessero da sè soli bene amministrare il regno. Era il Moncada un distinto personaggio in Sicilia; imperocchè oltre l’illustre sua nascita, e i molti feudi che possedeva, era anche insignito delle cospicue cariche di gran cancelliere, e di gran camerlengo di Sicilia: le quali, comunque non fossero nell’aspetto in cui erano sotto i re Normanni, giacchè erano ridotti a puri titoli senza autorità, e senza profitto, non lasciavano nondimeno di essere onorevoli alle famiglie. Il re Alfonso avendolo conosciuto davvicino, qualora si portò in Sicilia, l’ebbe in tanta estimazione, che cambiando di sentimenti, non lo lasciò, siccome avea ideato, al governo del regno, ma volle condurlo seco alla guerra di Napoli, dove ebbe la sventura nella battaglia navale coi Genovesi nell’anno 1435, di correre la stessa sorte del sovrano, restando prigioniero con altri nobili suoi compagni. Scrisse Giovanni Agostino Lingueglia 144, che il nostro Guglielmo si liberò dalla prigionia con un grosso sborzo di denaro, e sulla di lui testimonianza lo asserisce Vincenzo Auria 145. Ma vanno errati l’uno e l’altro; il duca Filippo signore di Milano rilasciò generosamente senza riscatto non solamente il re coi suoi fratelli, ma i nobili prigioni ancora che erano stati presi in quella battaglia. Lo attestano oltre il Surita 146, gli scrittori di quei tempi. Vaglia per tutti Bartolommeo Fazio, che fu contemporaneo, e familiare del re Alfonso. Eccone le parole 147: Nec multi dies intercessere, quum foedus hisce legibus sancitum est, ut scilicet Alphonso, fratribus, regibusque, et coeteris captivis, quos Mediolani, quos Genuae in potestate haberet, sine precio dimissis, societas eo iure staret etc. Cominciò a governare il regno questo conte di Caltanissetta in compagnia di Niccolò Speciale nel mese di settembre 1429. Nell’uffizio del protonotaro, che noi abbiamo particolarmente riscontrato, non lo troviamo sottoscritto insieme con Speciale prima dei 13 dello stesso mese. Durarono ambidue in questa amministrazione per un solo anno, imperocchè nel seguente anno 1430, come diremo nel capo di appresso, fu loro unito un terzo, cioè il conte di Geraci. Noi non abbiamo alcuna fra le determinazioni, che fecero in quest’anno i due vicerè Speciale, e Moncada, che sia degna di commendazione, salvo che l’approvazione da loro data alle costituzioni, e capitoli intorno all’uffizio, e ai diritti del protomedico, che scrisse Antonio di Alessandro protomedico del regno. Queste costituzioni in progresso di tempo furono corrette, e più chiaramente stese da Filippo Ingrassia, che fu ancora egli nello stesso posto, il quale le fe’ poi l’anno 1564 stampare in Palermo con una prefazione, nella quale dà conto delle medesime, come furono distese dal di Alessandro, e confermate dai ridetti vicerè, e di ciò che egli vi avea tolto, o aggiunto. [51] CAPO IX. Giovanni Ventimiglia conte di Geraci, Niccolò Speciale, Guglielmo Moncada vicerè, e poi Pietro Felice, e Adamo de Asmundo presidenti. Uno dei più grandi e per senno, e per virtù illustri uomini, che nel regno di Alfonso furono chiari in Sicilia, egli è senza dubbio alcuno Giovanni Ventimiglia conte di Geraci. Fino dalla primiera sua gioventù fu egli ai servizî del re Martino il Giovane, e non avendo più che ventiquattro anni, fu da questo sovrano prescelto per uno dei suoi capitani nella guerra di Sardegna, che intraprese; e lo servì con tale coraggio, che fu uno di quelli che gli ottennero la strepitosa vittoria, per cui egli sconfisse così gloriosamente, e domò i rubelli. Morto questo sovrano in Cagliari l’anno 1409 ritornò Giovanni in Sicilia, dove, non discostandosi dal lato della regina Bianca vicaria del regno, ne sostenne sempre i diritti contro la fazione del conte di Modica, che volea spogliarla del dominio della Sicilia. Entrato in possesso di quest’isola il re Alfonso il Magnanimo, 144 Storia della casa Moncada, t. I, p. 305. Cronologia de’ signori vicerè di Sicilia, p. 6. 146 Ann. de Aragon., t. III, lib. XIV, cap. 31. 147 Rer. suo tempore gestarum Hist., lib. IV, p. 104. 145 - 37 - e portando questi l’anno 1420 la guerra in Corsica, il nostro Ventimiglia volò in soccorso del suo sovrano, menando seco numerose squadre di soldati, che manteneva a sue spese. Conoscendo perciò questo sovrano i meriti distinti di questo personaggio, e i frequenti servizî resi alla corona, stimò bene di promuoverlo all’insigne carica di vicerè di Sicilia, dandolo per compagno a Speciale, ed a Moncada l’anno 1430. Mentre il Ventimiglia ritrovavasi a governare la Sicilia fu disfidato da Federico conte di Luna bastardo del re Martino il Giovane. Questo cavaliere, che credeasi, come figliuolo di Martino, il legittimo erede del regno di Sicilia, malgrado che fosse stato dal re Ferdinando il Giusto, e da Alfonso trattato onorevolmente, considerando quest’ultimo sovrano, da cui era stato spogliato della carica di grande ammiraglio, per suo nemico, se gli ribellò, e si unì col re di Castiglia, con cui Alfonso era in guerra, e avea tratto al suo partito Ferdinando, e Giovanni Ventimiglia figliuoli del conte di Geraci. Questi dunque irritato dalla fellonìa dei suoi figli, avea scritto piccanti lettere al conte Federico, lagnandosi che li avesse sedotti, e che avesse avuto la temerità di spacciare che la famiglia Ventimiglia fosse del suo partito. Questa contesa per lettere fra il conte de Luna, e Giovanni Ventimiglia durò qualche tempo, e aizzatosi l’animo di Federico, fe’ la braverìa di chiamare a duello questo vicerè, come collo stesso ardire vi avea chiamato prima il re Alfonso. Ma questo savio sovrano, e il prudente conte di Geraci non diedero orecchio, nè risposero all’invito, che questo sconsigliato giovane avea loro fatto. Essendosi convenuta una tregua di cinque anni fra il re di Castiglia, e il nostro re Alfonso, questi, cui stava a cuore l’acquisto del regno di Napoli, pensò di ritornare in Italia, e per non dare ombra, dichiarò di voler portare la guerra contro gli Affricani, che disturbavano il commercio dei cristiani colle frequenti loro piraterìe. Avendo perciò ammanita una flotta di ventisei galee, e di molte navi da trasporto, a’ 23 di maggio dell’anno 1432 partì, e andò in Sardegna, affine di passare all’assedio di Tunisi. Stando in Cagliari ebbe avviso da Sicilia che la città di Tropèa era stata assediata, e presa dagli Angioini, e che la guarnigione si era ritirata nel castello, e si sarebbe anche resa, se non era soccorsa fra venti giorni, come avea pattovito il castellano. Cambiata adunque direzione, partì subito per la Sicilia, e arrivato in Palermo vi si trattenne solo due ore per prendere a bordo il vicerè conte di Geraci, valente e sperimentato capitano, con cui veleggiò verso Tropèa, dove, sebbene fosse giunto l’ultimo giorno dell’accordata tregua, ebbe il dispiacere di vedere sotto i suoi occhi rendersi quella fortezza, qualunque ne fosse stata la cagione, o che egli non avesse tosto potuto sbarcare le truppe, o che il Roda, che era il castellano, siesi affrettato di consegnare il castello, per ricuperare i figliuoli, che dati avea per ostaggi 148. Venne indi Alfonso a Messina, e accresciuta la sua armata, che già consistea nelle mentovate ventitrè galee già dette, in ventitrè navi da trasporto, e in sessanta altri legni, e preparati i viveri, e le macchine da guerra, sul principio di agosto, conducendo lo stesso Giovanni Ventimiglia, levò le ancore, e indirizzò le prore verso l’isola delle Gerbe, dove pervenne ai 15 dello stesso mese 149. [52] L’esito di questa guerra non fu così prospero, come si dovea sperare; non già che le truppe siciliane e aragonesi avessero mancato di coraggio; elleno, alla testa delle quali era il nostro Giovanni Ventimiglia, aveano respinti i Mori dal ponte di pietra, che univa l’isola colla terra ferma, e sconfitto, costretto a fuggire, e obbligato a cercar la pace Boferio re di Tunisi, che con una poderosa armata era venuto in soccorso di quella assediata piazza; ma perchè il magnanimo Alfonso, contro il parere del Ventimiglia, e fidando troppo nel valore dei suoi, cadde in due errori che l’obbligarono a rimbarcarsi, e a ritornare in Sicilia; giacchè dietro alla prima sconfitta data a quei barbari, non fe’ diroccare il ponte come dovea, per togliere ogni comunicazione alla piazza colla terra ferma, e nella seconda battaglia, in cui conquise i Mori, accordò a Boferio una tregua, fino che fosse conchiuso il trattato di pace. Il primo errore l’obbligò ad una seconda azione per conquistare l’isola, che avrebbe potuto di leggieri, rotto che fosso stato il ponte, avere nelle mani senza più sguainare la spada; il secondo diè agio all’astuto re moro di rinforzare con altre truppe il castello, e poi che ebbelo assicurato, di far nascere tante, e così grandi difficoltà al trattato di pace, che mancando di giorno in giorno le provigioni all’esercito, dovette Alfonso, per non farlo perir di fame, partirsene senza far nulla, e ritornarsene in Sicilia. La schiettezza del cuor magnanimo di Alfonso non potea confarsi colla frode africana, e coi raggiri di quel versipelle re moro. Appena arrivato in Messina dopo di essersi trattenuto qualche giorno a Malta, essendo stato ucciso Sergianni Caracciolo l’amasio della regina Giovanna in Napoli, che avea in tutte le maniere frastornati i suoi maneggi per pacificarsi con quella sovrana, si eccitarono nel cuore di questo re le speranze di poter riacquistare l’amore della regina, e già era vicino ad ottenerlo per le opere di Covetta Ruffo duchessa di Sessa, se egli troppo frettoloso non si fosse impegnato a sollevare i baroni principali di Napoli, e fra questi il duca di Sessa marito della mentovata dama, e da lei odiato a morte. Si cambiarono perciò le favorevoli 148 149 Surita, Annal. de Arag., lib. XIV, cap. 3. – Fazio, Rer. suo tempore gest. lib. IV, p. 91 e 92. Ivi. - 38 - circostanze, nelle quali si ritrovava, e a stento potè ottenere una tregua di dieci anni colla medesima Giovanna 150. Deposto adunque per allora ogni pensiero di conquistare il regno di Napoli, rivolse Alfonso l’animo a regolare quello di Sicilia. Noi lo troviamo in Palermo ai 14 di gennaro 1433 nel qual giorno vuolsi dal Mongitore 151, che egli vi abbia celebrato un parlamento nel regio ospizio. Fondasi egli sulle parole del protonotaro Leonardo di Bartolomeo, che stanno annesse ai capitoli, che furono in quella occasione promulgati: Lecta fuerunt praedicta capitula per me Leonardum de Bartholomeo prothonotarium, et logothetam in Sala magna terranea Regii Ospitii felicis urbis Panhormi, praefato Excellentissimo Domino Rege more regio in Solio sedente, praesentibus ibidem Praelatis, Comitibus, Baronibus, Collateralibus, Doctoribus, aliisque quamplurimis in numero copioso die XIV. Januarii XII. Indictione MCCCCXXXIII. Regnique dicti Serenissimi Regis nostri decimo octavo. Ma che questa sia stata quell’adunanza, che noi chiamiamo parlamento, non sappiamo persuadercelo. Noi per parlamento intendiamo la unione dei tre ordini dello stato, cioè degli ecclesiastici, dei baroni, e dei rappresentanti delle città demaniali, i quali radunati esaminano ciò che riguarda o il servizio del sovrano, o il vantaggio del regno. Non entrano in quest’assemblea nè i collaterali, nè i giureperiti, nè altra qualsiasi persona, che non sia dei tre divisati ceti. Non fu dunque questo un parlamento propriamente detto, ma fu una promulgazione di alcuni stabilimenti fatti dal re Alfonso per il vantaggio del regno di Sicilia, ai quali volle egli dare tutta la forza possibile, facendoli pubblicare nel regio palagio, sedendo egli sul trono, e alla presenza dei prelati, dei conti, dei baroni, dei suoi ministri consiglieri, e di chiunque altro che volesse udirne la lettura. Vincenzo Auria 152 parlando della dimora del re Alfonso in Sicilia, dove si trattenne fino all’anno 1435, rapporta due cose che meritano di essere emendate, cioè 1° che questo serenissimo principe in quel tempo: fece comporre, e pubblicare da Jure-Consulti il rito di Sicilia, e 2° che publicò..... una Prammatica detta Catalana intorno ai Prelati di Sicilia, e i Vassalli del Re, benchè oggi non si osserva. La pubblicazione del rito fu assai posteriore; può ben essere, che egli allora ne abbia data l’incombenza ai [53] giureperiti, ma la promulgazione del rito non fu fatta che l’anno 1446, come costa dal privilegio dato apud Maczonum Rosarum prope Hospitaletum (ch’era un luogo vicino a Capua, dove trovavasi egli accampato) die vigesimo tertio mensis octobris decimae indictionis anno Domini millesimo quadrigentesimo quadragesimo sexto 153. Riguardo alla prammatica detta catalana, che non sapremmo dire se fosse stata allora pubblicata, egli è falso che fosse in disuso, giacchè fu sempre osservata, e tuttavia si osserva nel nostro regno; sebbene per amore della verità dobbiamo confessare, che i raccoglitori delle prammatiche lasciarono d’inserirvela o per malizia, o per dimenticanza. Espone poi assai confusamente questo cronologo l’argomento di questa prammatica, dicendoci che sia intorno ai prelati di Sicilia, e i vassalli del re, non ricavandosi dalle di lui parole cosa s’intendea. Questa prammatica adunque per intelligenza di chi legge nacque dall’enorme abuso che faceano i vescovi delle armi spirituali, fulminando per ogni menoma causa la scomunica contro i ministri regî, ed i baroni feudatarî, i quali sotto il nome di vassalli unicamente vengono. Alfonso per metter freno a questo disordine, colla mentovata legge prescrisse ai prelati, che non potessero in avvenire senza il previo consenso del sovrano e del vicerè valersi di questa censura contro di alcun ministro, o barone feudatario, e ciò sotto la pena ai detti prelati, se disubbidivano, di avere confiscati tutti i beni temporali che possedevano, stabilendo che qualora eglino avessero qualche querela contro alcuno dei ministri, o dei baroni suddetti, dovessero rappresentare al real trono, o a chi fa le veci del re, il torto che avessero ricevuto, dai quali avrebbono ottenute le providenze di giustizia. Mentre Alfonso promulgava in Palermo delle costituzioni, vi giunsero ai 28 di luglio 1433 da Spagna Giovanni re di Navarra, l’infante Pietro, e Arrigo gran maestro dell’ordine di s. Jacopo fratelli di esso, o perchè volessero con esso concertare il piano della guerra, che far si dovea contro il re di Castiglia, essendo vicino al suo termine la tregua stabilita; o perchè ve li avesse chiamati il re per la guerra che meditava contro di Napoli, dove gli cresceano le speranze per l’amicizia contratta col principe di Taranto nemico giurato della regina Giovanna. Il fatto fu che i fratelli del re non vennero soli, ma condussero seco un’armata, che si trattenne nel porto di Trapani. Si sparse allora la voce che il re ritornava in Ispagna; ma intanto la flotta, forse perchè non si volea far partire, o perchè i venti fossero contrarii 154, per lo spazio di tre mesi non si mosse. Mentrechè andavano spianandosi al re Alfonso le difficoltà per la conquista del regno di Napoli, il re Luigi d’Angiò, il principale ostacolo che si frapponesse ai suoi disegni, sulla metà di novembre 1434 se ne morì in Calabria nel castello di Cosenza, e in capo a pochi mesi cioè agli 11 di febbraro 1435 finì anche di vivere la regina Giovanna. Queste morti fecero mutar pensiero al detto sovrano, e dopo di essersi assicurato 150 Fazio, Rer. suo temp. gest., lib. IV, p. 100. Mem. Stor. de’ Parlam., t. I, p. 49. 152 Cronologia de’ vicerè di Sic., p. 6. 153 Capit. Regni Sic. t. I, p. 230. 154 Fazio, loc. cit. 151 - 39 - per mezzo del suo confidente Caraffello Caraffa, che avea spedito in Napoli segretamente, essere la maggior parte di quei cittadini disposta a ricercarlo per sovrano, da Catania, dove si ritrovava, venne sollecitamente in Messina col proposito di portare le armi contro il regno di Napoli 155; e prima di ogni altra cosa spedì in Calabria il nostro conte di Geraci Giovanni Ventimiglia con mille cavalli, ed indi a poco Minicuccio Aquilano con un pari numero di soldati da cavallo, con ordine di unirsi al principe di Taranto suo collegato, e di riacquistare quanto si era perduto in quella provincia. Quel che si operasse il prode Ventimiglia, non è quì il luogo di riferirlo; ricuperò egli immediatamente quanto si era occupato dal Caldora in quella provincia, e procurò al suo re l’amicizia di molti baroni del regno di Napoli, oltre al principe di Taranto che abbiamo mentovato, i quali presero Capua, e chiamarono Alfonso, acciò con ogni sollecitudine venisse a continuare la conquista di quel regno. Fu perciò questo sovrano obbligato a partirsi dalla Sicilia, come fe’, con sette galee, lasciandovi l’infante Pietro, acciò allestisse il resto dell’armata, e preparasse le provigioni da bocca, e da guerra, per seguirlo in quella impresa. Non vi ha dubbio che durante la dimora del re Alfonso in Sicilia dovea cessare l’autorità dei tre vicerè, che noi abbiamo mentovati in questo capo. La presenza del sovrano e di un principe, qual era Alfonso, bastava a regolare ogni cosa, nè occorrea [54] che altri s’ingerisse nel reggimento. Pur nondimeno con nostro sorprendimento noi osserviamo nei registri della cancellaria, e del protonotaro, che non ostante la presenza di Alfonso, eglino seguitavano a dispacciare, come se il re ne fosse lontano. Troviamo molte carte reali sottoscritte da Alfonso ora in Messina, ora in Palermo, ora in Trapani, e in altri luoghi del regno; ma troviamo insieme, che gli stessi vicerè, quasi il re non vi fosse, amministravano la giustizia nella stessa forma, e davano gli ordini opportuni per regolare la Sicilia. E cessando questi di esercitare la carica, quantunque Alfonso fosse ancora presso di noi, troviamo altri due che reggevano, col titolo però di presidenti del regno, cioè Pietro Felice, ed Adamo Asmundo. Considerando intanto come ciò avesse potuto accadere, sebbene paia che sia contro tutte le regole, nè potrebbe credersi vero, se non ne restassimo convinti dalle carte autentiche degli archivî, non troviamo altro scampo a conciliare questo promiscuo modo di governare, se non supponendo che il re Alfonso, essendo venuto in Sicilia unicamente per prepararsi per la conquista del regno di Napoli, che era lo scopo suo favorito, abbia voluto serbare, come suol dirsi, l’incognito, e lasciare che i suoi luogotenenti, i quali per altro non avranno nulla fatto, senza il di lui previo consenso, reggessero la Sicilia, come s’egli fosse assente; e che abbia fatti quei soli dispacci, che sogliono dai monarchi sottoscriversi per più rilevanti affari, comunque non sieno nel luogo, dove debbono pubblicarsi, ed eseguirsi. Di Pietro Felice, che fu con Adamo Asmundo, eletto presidente del regno intorno al mese di dicembre 1432, giacchè allora compariscono i loro dispacci, non abbiamo veruna notizia che ci additasse chi fosse, dove nato, e in quale impiego si trovasse, allorchè fu eletto a questa carica; i nostri scrittori non ce ne fanno punto motto, e i due cronologi Amico, ed Auria si contentano di accennarcene il nome solamente 156. Pur nondimeno dovè essere persona d’importanza non solamente per il posto a cui fu destinato, ma inoltre perchè lo veggiamo preferito ad Adamo Asmundo, occupando il luogo più nobile nelle sottoscrizioni dei dispacci. La di lui firma non è mai nè Felice, nè Felix, ma o P. Ffelluz, o P. Ffelitz, come trovo comunemente nei registri delle nostre regie cancellarie. Più presto di Adamo Asmundo, che nei suddetti libri si sottoscrive Addam Asmund 157, può darsi qualche notizia. Egli era di una famiglia nobilissima di Catania, e fiorì sotto Ferdinando il Giusto padre di Alfonso. Questo magnanimo re fe’ molto conto della di lui dottrina in diritto civile, e lo promosse ben tre volte alla carica di giudice della gran corte; e di poi lo elesse per uno dei maestri razionali del suo regio patrimonio. Il P. Abate Amico 158 racconta, ch’egli ebbe il governo di Sicilia, gli anni 1427 e 1428, ma noi di questa dignità allora avuta non troviamo monumento che ce ne parli; e perciò crediamo che siavi errore nell’anno, e che debba dirsi 1432 e 1433, quale onore ebbe altre volte, come in appresso si dirà. Scrisse egli alcuni consigli legali, i quali furono molto apprezzati dai giureperiti, come colla testimonianza di Giuseppe Cumìa ci avvisa il Mongitore 159. Questi due presidenti del regno conservarono la detta carica fino che, partito il re Alfonso, prese il comando di Sicilia l’infante Pietro, di cui ora favelleremo. 155 Fazio, loc. cit. p. 102. Il canonico Mongitore, che fu a parere de’ letterati un diligentissimo investigatore delle più minute cose, neppur egli nelle note manoscritte che fe’ alla cronologia dell’Auria, che oggi possiede la libreria del senato di Palermo, ci dà alcuna notizia di questo presidente del regno; lo che ci porge un argomento certo che nulla se ne sappia. 157 Il p. abate Vito Amico (Catana Illustr. lib. XII, cap. 4) lo chiama ancora Sismondo, Adamus Sismundus, dice egli, sive Asmundus, ma ne’ diplomi non vien detto altrimenti che Asmundo. 158 Catana Illustr. t. IV, lib. XII, cap. 4, p. 157. 159 Bibl. Sic. t. I, append. I, p. 1. 156 - 40 - CAPO X. L’infante Pietro, e poi Ruggiero Paruta. Si è da noi rammentata nel capo antecedente la presa di Capua fatta dagli amici del re Alfonso, e la partenza di questo sovrano con sette galee ad oggetto di prendere ancora la forte piazza di Gaeta, acciò avendo in potere queste due città, e le loro castella, potesse agevolmente marciare allo assedio di Napoli. La partenza del re può fissarsi nel mese di aprile 1435, o a quel torno; giacchè noi dai registri della regia cancellaria rileviamo, che egli nel mese di [55] marzo del detto anno era tuttavia in Messina; nè veggiamo i nuovi dispacci dell’infante Pietro, che sotto i tre del maggio seguente. Questo real principe dunque, da che partì il fratello alla volta di Gaeta, prese le redini del governo, e cessarono allora di comandare coloro, che, presente il re Alfonso, esercitavano la carica di presidenti del regno. Noi non troviamo nel breve tempo che dimorò l’infante in Sicilia altri dispacci, che i suoi, nei quali senza dirsi nè vicerè, nè presidente, adoprò lo stesso titolo che è stato da noi accennato, quando abbiam rammentato il primo suo arrivo in Sicilia, essendo vicerè Niccolò Speciale 160. Dal che si può a ragione dedurre che egli avesse ottenuta dal fratello una generale sopraintendenza su di ambi i regni di Napoli, e di Sicilia, dove senz’altra antecedente commissione comandava come luogotenente di Alfonso, allor quando questi era lontano. Resse Pietro la nostra isola non più che un mese e pochi giorni, nei quali, oltre di dare le provvidenze necessarie al buon regolamento della medesima, facea i preparativi di soldatesche, e di attrezzi militari, e di viveri, per portarsi a Gaeta. Questa fortezza era difesa con coraggio da Francesco Spinola, e da Ottolino lo Zoppo, che vi comandavano, e con pari valore era assediata dal re Alfonso, e dai suoi collegati baroni del regno di Napoli. Sollecitava perciò questo principe, cui stava a cuore d’imposessarsene, il fratello in Messina, affinchè andassevi prestamente, potendo il suo arrivo conferire a farla rendere. Ma per ammanire ogni cosa era d’uopo di qualche tempo, e perciò non potè Pietro così diviato partire. Si proseguiva nondimeno l’assedio violentemente, e crescendo di giorno in giorno la carestia in quella piazza, avvegnachè neppure i Genovesi per i contrarii venti vi recavano viveri, furono costretti gli assediati a promettere di rendersi tre giorni dopo, che si fosse saputo, che era arrivata a Genova la notizia dello stato infelice in cui si ritrovavano 161: condizione, che ricusò di accordare il re Alfonso. Mentre adunque Ottolino venuto al campo del re procurava di ottenere i più onorifici patti per le milizie, e i cittadini, arrivò coll’armata, e le provigioni da guerra, e da bocca l’infante Pietro, la di cui venuta dovea atterrire gli abitanti; ma questi, che non aveano avuta veruna parte nella determinazione presa da Ottolino, nè intendeano di rendersi, fecero una così grande difesa, che assaliti da tutte le parti per mare, e per terra respinsero sempre i nemici, ed obbligarono il re Alfonso, per non sagrificare tanta gente, a far sonare la ritirata, e a cambiare in blocco l’assedio da tanti mesi fatto. Prima di partire da Messina il serenissimo Pietro, sostituì per vicerè di Sicilia Ruggiero Paruta palermitano. La cedola fu spedita a Messina ai 9 di giugno 1435, e fu registrata in Palermo nella regia cancellaria 162 ai 18 dello stesso mese, in cui viene questi eletto vicerè con ampia facoltà di poter sostituire. Devono in questo luogo emendarsi i cronologi Antonino d’Amico, e Vincenzo Auria, che fissano l’elezione di Ruggiero Paruta l’anno 1436, quando costa chiaramente dalla cedola che accadde nell’anno antecedente. Di questo cavaliere, che durò pochissimo tempo per allora nel governo di Sicilia, altro non sappiamo, se non che fu dal re Alfonso eletto per castellano del regio palazzo, e avea anche l’onore di essere maestro razionale del regio patrimonio. CAPO XI. Antonio de Cardona, Adam de Asmundo, Leonardo di Bartolomeo, e Battista Platamone presidenti del regno. Siccome Ruggiero Paruta lasciato vicerè dall’infante Pietro fu costretto a partire per portarsi a Gaeta dal re Alfonso, e per trattar con esso di presenza alcuni rilevanti affari, così in forza dell’autorità conferitagli dalla cedola del serenissimo infante durante la sua lontananza, costituì per suoi luogotenenti, e presidenti del regno i suddetti quattro personaggi. L’elezione di questi dovè essere registrata nella regia cancellaria, o nell’uffizio del protonotaro. Antonino Amico nella sua cronologia cita la pag. 166 del registro di quella dell’anno 1435-1436, ma questo registro oggi manca, come nell’officina del protonotaro mancano quelli del 1433-1434, del [56] 1434-1435, e del 1435 e 1436, lo che ci priva di molte notizie, che potrebbero interessare questa cronologia de’ vicerè di Sicilia. Diremo non ostante di questi quattro presidenti ciò che potremo ricavare da altri fonti. 160 Lib. II, cap. 7. Fazio, loc. cit. lib. IV, p. 120 e 121. 162 All’anno 1434 - 1435, p. 210. 161 - 41 - Non sappiamo se Antonio de Cardona fosse stato quello stesso, che abbiamo appellato vicerè l’anno 1416 con Domenico Ram vescovo di Lerida 163, e di poi l’anno 1419 e 1420 con Ferdinando Velasti, e Martino de Turribus 164. Non sarebbe inverisimile che potesse essere il medesimo; e che colui che fino all’anno 1420 fu nostro vicerè, avesse ripreso dopo sedici anni nuovamente il governo di Sicilia. Ma molte ragioni c’inducono a crederlo diverso. E primieramente essendo egli stato uno del partito del conte di Urgel, quando si trattava l’anno 1412 dell’elezione del nuovo re di Aragona, poichè fu da quel signore spedito a Caspe per suo procuratore, egli è a credersi che fosse già allora un uomo di età matura per trattare un affare di tanta conseguenza; e perciò sarebbe stato molto vecchio all’anno 1436, di cui parliamo 165. Inoltre sarebbe stato un disonore per esso, che dopo di avere governata la Sicilia da vicerè eletto dal re Alfonso l’anno 1416, ora dopo venti anni la reggesse da presidente, che è un grado inferiore a quello di vicerè proprietario, e da sostituito di Ruggiero Paruta privato cavaliere. Queste ragioni ci muovono a persuaderci che questo Antonio Cardona, che per altro era conte di Caltabellotta, e maestro giustiziere del regno, non fosse già quello che l’anno 1416 veduto abbiamo nel cospicuo posto di vicerè. Di Adamo Asmundo, di cui abbiamo favellato al capo IX di questo libro, non occorre che noi facciamo di nuovo parola, e solo riflettiamo, dall’osservare come spesse volte era egli incaricato del governo del regno, in quale estimazione fosse presso il sovrano, e presso coloro che ne faceano le veci. Il terzo di questi presidenti lasciati dal Paruta, cioè Leonardo di Bartolomeo, era un cavaliere palermitano famoso giureconsulto, ed oltre di essere protonotaro del regno, era ancora signore della terra della Trabia, che oggi è eretta in principato. Molto prima, cioè l’anno 1431 era stato egli mandato alla corte del re Alfonso, che trovavasi in Messina, in compagnia di Giovanni Abbatellis, e di Francesco Ventimiglia, per presentare a questo sovrano alcune suppliche a nome della città di Palermo; e ne ottenne la reale approvazione. Riguardavano queste i privilegi, e consuetudini di essa città capitale, la quale dimandava: 1° che i cittadini nelle cause così civili, che criminali, potessero, prima che fosse pronunziata la sentenza, convenire fra di loro, e concordarsi, senza che fosse necessario il permesso di quel tribunale in cui si era introdotta la causa, e senza doversi pagar nulla ai giudici: 2° che salvo i tre casi eccettuati dal re Martino, non potessero i cittadini essere carcerati, subito che dessero una idonea mallevadorìa: 3° che quando il giudice della corte pretoriana conosce che le lettere regie, o viceregie, o di altro uffiziale urtassero contro i privilegi della città, se ne potesse sospendere l’esecuzione, e potesse l’università farne delle rimostranze una, due, e più volte; e 4° finalmente che fosse lecito ai cittadini di camminare armati, purchè non facciano abuso delle armi; nel qual caso sieno vietate solo a colui che ne abusa 166. Era Leonardo di Bartolomeo un uomo popolare, e rispettato dalla plebe, come ne diede le prove l’anno 1450, quando suscitatosi in Palermo un tumulto contro coloro che amministravano negligentemente l’annona, e poi dilatandosi contro le persone ricche, e [57] potenti 167, egli girando per le piazze, acquietando il furibondo popolo, e dando le provvidenze necessarie, perchè non mancasse il pane, sedò quella tempesta, e liberò la città dal saccheggio; sebbene a costo della propria vita; giacchè vi fu ucciso da Tommaso Crispo, che era uno dei sollevati, cui non piacea che cessasse la sollevazione. Ma questa popolarità appunto di Leonardo dispiacea al governo. La ragion di stato non soffriva che la nobiltà dominasse sopra gli animi dei plebei. Fe’ palese il re Alfonso il suo malcontentamento contro di Leonardo, per la troppa familiarità che egli 163 In questo libro cap. 3. In questo libro cap. 4. 165 Pare che il Surita sia inciampato in errore, o almeno colui che fece l’indice di questo annalista spagnuolo; poichè dopo che all’articolo di Antonio de Cardona (tom. 7, p. 141) si nota, che questo cavaliere andò dopo la morte del re Martino al parlamento di Barcellona, e diede per sospetti alcuni giudici per la causa della successione ne’ di lui regni, e che fu procuratore a Caspe per il conte di Urgel, le quali cose accaddero l’anno 1412, dice in fine che nella ribellione de’ Catalani egli si offerì al re Giovanni per andare a reprimerla. Ora la ribellione di Catalogna accadde l’anno 1462, nè pare naturale che colui ch’era già in matura età l’anno 1412 avesse potuto dopo cinquant’anni vestirsi di usbergo, e maneggiar la spada per isconfiggere i rubelli. Noi dunque opiniamo che questo secondo Antonio Cardona, che potè essere nipote del primo, sarà stato colui che esibì al re Giovanni l’opera sua per andare alla guerra contro i Catalani, o che fu qualche altro della stessa famiglia in Ispagna che portava lo stesso nome. 166 Michaelis de Vio, Urbis Panhormitanae Privilegia, p. 197. 167 Il Pirri (lib. IV. de Abbatiis, part. I, not. 1, S. Martini Panormi, p. 198) avvisa che il motivo di questo movimento popolare nacque da che il senato spacciava frumenti vecchi e di cattiva condizione; e rapporta che il furioso popolo, dopo di avere osservato che si chiudevano le orecchie alle sue giuste lagnanze, corse arrabbiato a’ granai della città, e trattine i frumenti li diede a mangiare a’ porci; e siccome vi era in città una grandissima carestia di olio, e Giovanni Castrone, che aveane una grandissima quantità, non volea darlo che a carissimo prezzo, i sollevati andarono alla di lui casa, e rotte le porte, ne cavarono le botti piene di esso, e apertele, fecero scorrere per la via di Toledo tutto l’olio che contenevano, che passando come fiume andò a precipitarsi al mare. Noi immaginiamo che vi sia dell’esagerazione in questa descrizione del Pirri, stentando a persuaderci che i porci avessero potuto consumare i grani della città, e che l’olio del Castrone fosse in tanta quantità, quanto scorrendo per la larga e spaziosa strada del Cassero avesse potuto parere un fiume che scorresse verso la marina. Il Mongitore (Bibl. Sic. t. II) vuole che questo storiografo abbia detto che Leonardo di Bartolomeo fu ucciso dalla plebe palermitana, e perciò ne lo corregge, assicurando che gli apportò la morte Tommaso Crispo, ma s’inganna; il Pirri non addita da chi fu ucciso, e solo accenna che in quel tumulto fu egli ammazzato. Eccone le parole: Inter haec interficitur Leonardus Bartholomaeus Trabiae dominus, et Siciliae Prothonotarius. 164 - 42 - avea colla gente del volgo, allora quando, essendo stato questo barbaramente trucidato in quella occasione, nè il re medesimo, nè il vicerè d’Urrea, che allora governava, vendicarono la morte di questo benemerito cavaliere, come osserva il Fazello 168. Vuolsi, che egli fosse l’autore del rito della gran corte 169, che poi fu approvato, siccome diremo a suo luogo, dal re Alfonso. Di Battista Platamone, che è il quarto dei presidenti, il Toppi 170, che suol rubarci i nostri ragguardevoli personaggi per farli suoi, pretende che ei fosse patrizio salernitano; ma s’inganna, costando dagli archivii di questa famiglia che ei fu cavaliere catanese, e nacque in detta città da Bernardo Platamone; ed ebbe inoltre due fratelli: Pietro, che fu cavaliere dell’ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, e Antonio, che fu vescovo di Malta fin dall’anno 1412, ed era monaco benedettino 171. Battista da ragazzo cadde in mare, e corse risico di sommergersi 172. Fu di poi mandato dal padre a Bologna ad oggetto di apprendervi la giurisprudenza, dove ricevè la laurea dottorale nell’una, e nell’altra legge. Ritornato in Sicilia ricco di legali cognizioni esercitò con molta riputazione il mestiere di avvocato; in guisa che arrivate al re Alfonso le notizie della di lui dottrina in giure, lo promosse l’anno 1420 al rispettabile grado di avvocato fiscale della gran corte, che esercitò per sei anni fino all’anno 1426, in cui rinunciò questa carica per volere del medesimo re, che lo chiamò presso di sè, come consigliere intimo, e segretario. L’elogio che ne fa questo principe, è il più certo argomento del conto in cui lo avea, imperciocchè vien da lui detto consiliarius, et secretarius noster, et nostri cordis interiora sciendo, et conservando. Non fa perciò meraviglia che sia stato da questo sovrano adoprato nelle più scabrose commissioni. Noi sappiamo che fu mandato ambasciadore a varî pontefici, alla regina Giovanna di Napoli, e ad altri principi dell’Europa, e che sempre ottenne quanto il suo re bramava. Questi servigi resi alla corona gli fecero meritare, che fosse fatto giudice perpetuo della gran corte: cosa che finora è stata senza esempio, e inoltre la carica di presidente del regno, e poi quella di vicerè proprietario, come in appresso diremo. Rammentasi con lode di questo cavaliere, che ritrovandosi il re Alfonso esausto in denari per le spese esorbitanti che gli conveniva di fare a cagione della guerra nel regno di Napoli, egli generosamente vendè il castello e [58] il territorio di Aci suoi proprî per la somma di once novemila, che corrispondono a ventiduemila e cinquecento scudi, e soccorse così il suo sovrano. Fissano gli scrittori catanesi la morte di questo cavaliere intorno all’anno 1448 173. La presidenza di costoro non fu di molta durata, nè oltrepassò l’anno 1435, che che con error cronologico ne abbiano scritto Antonino Amico, e Vincenzo Auria, additandola l’anno 1436, imperocchè dietro alla sconfitta ch’ebbe presso Gaeta l’armata aragonese il dì 5 di agosto 1435, nella quale vi restarono prigionieri il re Alfonso, i due suoi fratelli, Giovanni re di Navarra, ed Arrigo, con parecchi altri signori catalani, e siciliani 174, l’infante Pietro, che a sorte con due delle sue galee si era sottratto alla persecuzione dei Genovesi, e si era ricoverato nell’isola d’Ischia, non potendo per allora dar riparo nè alla prigionia de’ suoi fratelli, nè agli affari oramai rovinati di Napoli, amò meglio di ritirarsi in Sicilia, dove stando con maggior sicurezza, potesse con miglior consiglio determinare ciò che fosse uopo di fare, e mantenere i Siciliani nella dovuta ubbidienza al loro sovrano. CAPO XII. L’infante Pietro, e alla di lui partenza Ruggiero Paruta, e Battista Platamone. Continovano i due mentovati cronisti a cadere negli stessi sbagli cronologici, fissando il ritorno del serenissimo infante Pietro nell’anno 1436, e la di lui partenza nell’anno seguente 1437, in cui rapportano 168 Dec. II, lib. IX, cap. 9. Mongit. Bibl. Sic., t. II, art. Leonardus de Bartholomaeo, p. 112. 170 Bibl. Napol. degli Uomini Illustri. 171 Pirri, Not. Eccl. Sic. Not. VII Eccl. Melitensis. 172 Amico, Catana Illust., tom. IV, lib. XII, cap. 4, pag 157. 173 Gio. Battista de Grossis, Decacordo Catanese, t. II, p. 146. — Amico, Catana Illust. t. IV, lib. XII, cap. IX, p. 157 e 158. 174 Mentova il Surita (Annal. de Arag., lib. XIV, cap. 26) i cavalieri siciliani, che in quella battaglia restarono prigionieri. Questi furono Guglielmo Raimondo Moncada conte di Caltanissetta, Antonio, Ferdinando, e Gio. Ventimiglia figliuoli del conte Giovanni marchese di Geraci, due figli di Antonio de Cardona, ch’era restato presidente del regno, un altro figliuolo del conte Gilberto de Centelles, Niccolò Speciale, e Guttiero Nava. Fra questi già due erano stati vicerè di Sicilia, cioè Guglielmo Moncada, e Niccolò Speciale, i quali coll’arte politica unendo il valore militare erano andati a servire Alfonso nella guerra di Napoli. Questi cogli altri prigioni, eccetto il solo re nostro, furono condotti a Genova, dove, prosegue a raccontarci questo annalista aragonese (cap. 31), da’ Genovesi furono umanamente trattati, ma la maggior gentilezza e cortesia fu usata a’ Siciliani, e ciò per il continuo commercio che passava fra quella repubblica, e la nostra nazione. I primi però che ottennero la libertà furono i tre figliuoli di Giovanni marchese di Geraci, essendosi il re Alfonso impegnato presso il duca di Milano a farli tosto liberare, e ciò in considerazione dei replicati servigi fattigli dal loro padre, e segnalatamente nel mantenere sotto il dominio aragonese la città di Capua, nonostante che il re fosse prigione, e nel difenderla contro gli sforzi validissimi de’ nemici. 169 - 43 - l’elezione per vicerè de’ due Paruta, e Platamone 175. Se non ci mancassero i registri degli anni 1435-1436 così della regia cancelleria, come dell’uffizio del protonotaro, ci sarebbe agevole coll’aiuto delle cedole o de’ diplomi il mostrare il loro errore, ma essendone privi, siccome si è di sopra divisato, lo paleseremo in altra guisa, valendoci della testimonianza di Bartolommeo Fazio, e del giornalista di Napoli, che furono autori contemporanei, di Giovanni Stella, e dello stesso Surita accuratissimi scrittori degli annali genovesi, e aragonesi. Seguendo le tracce de’ suddetti storici, il ritorno dell’infante Pietro in Sicilia, la sua nuova partenza per tentare la conquista di Napoli, o per andare a prendere il re Alfonso in Genova, e l’elezione per Vicerè suoi sostituti del Paruta, e del Platamone accaddero prima che spirasse l’anno 1435. Por averne chiare le prove fa di mestieri che noi brevemente accenniamo i fatti allora successi, dalle note cronologiche de’ quali risulterà la verità di quanto abbiamo asserito. La famosa disfatta dell’armata aragonese, nella quale restarono prigioni il re Alfonso, i due suoi fratelli, e il fiore della nobiltà spagnuola, siciliana, e napolitana, accadde a’ 5 di agosto 1435 176. Lo stesso giorno, e sopravenendo la notte l’infante Pietro si salvò ad Ischia 177, d’onde dovè tosto partire per ricoverarsi in Sicilia; imperciocchè raccontando il giornalista napolitano, che di là a doi dì andò l’armata genovese verso Ischia con disegno di pigliarla 178, nè potendovisi egli sostenere, nè avendo seco che due galee, fu [59] certamente costretto, se mai vi si era fermato, il che non sappiamo, ad abbandonare quell’isola, e rifuggirsi in Messina; ma noi sospettiamo che la stessa notte de’ 5 agosto, fatte in Ischia le provigioni da bocca per il viaggio, e dando gli ordini a quel castellano che difendesse alla meglio quel castello, fece vela e si mosse verso la detta città. Ciò posto, come costa da’ mentovati storici, ne segue certamente che questo principe fuggitivo, dandogli anche giorni cinque per questo viaggio, dovette arrivare presso di noi intorno a’ 10 dello stesso mese di agosto 1435. È dunque sbagliato il calcolo cronologico dell’Amico, e dell’Auria, quando fissano il ritorno di questo fratello del re l’anno 1436. Osserviamo ora quand’egli ne fosse partito, e vi avesse lasciati per suoi luogotenenti il Paruta, e il Platamone. Arrivato il re Alfonso in Milano divenne così amico del duca Filippo 179, che non solo ottenne che il re Giovanni suo fratello, ch’era stato trasportato in Genova, venisse a Milano, ma lo ridusse a collegarsi seco, e a facilitargli la conquista del regno di Napoli 180. Fu dunque stabilito per venirne a capo, che intanto andassero in Ispagna i due fratelli Giovanni e Arrigo a fine di prepararvi un’armata, e che i due ragguardevoli baroni napolitani, il principe di Taranto e il duca di Sessa ritornassero in Napoli per far animo agli amici della casa di Aragona, e per impedire che vieppiù si dilatassero gli Angioini, fino che fossero arrivate le armate regie, per accingersi con queste di proposito all’intero acquisto del regno di Napoli. Così fu fatto: i due fratelli del re 181 co’ due cavalieri napolitani giunsero in Genova per partirsi ciascheduno per il suo destino. Il principe di Taranto, che dovea passare in Puglia, venne prima in Sicilia, dove recò all’infante Pietro le lettere del re Alfonso, per le quali lo riscontrava della libertà ottenuta da lui, e da’ comuni fratelli, e della confederazione fatta col duca di Milano, ch’era contento ch’egli fosse preferito a Renato di Angiò nel possesso del regno di Napoli, e lo pregava, come dice il giornalista napolitano 182, a portarsi subito coll’armata all’impresa di quel regno, o, come più verisimilmente scrisse il Fazio 183, a venire con cinque galee a Porto Venere, dove egli sarebbesi trasferito per prenderlo a bordo, e condurlo a Napoli; 175 Gio. Battista de Grossis, Decacordo Catanese, tom. II, p. 146. — Amico, Catana Illus., tom. IV, lib. XII, cap. 4, p. 157 e 158. 176 Stella, Annales Genuenses, presso Murat. tom. XVII, Rer. Ital. Script., p. 1317. Bartolommeo Fazio, Rer. suo temp. gest. lib. IV, p. 155. 178 Giornal. Napol. presso Murat. tom. XVII. Rer. Ital. Script. pag. 1101. 179 Appena possono credersi le finezze che Filippo fe’ al re Alfonso, e ad Arrigo di lui fratello. Oltre averli nobilmente alloggiati nel palagio, in cui stava la duchessa, fece ogni opra per alleggerire la pena dell’avuta disfatta. Alla prima visita che fe’ loro, si astenne dal fare verun motto di questa disgrazia, e i suoi ragionari furono lieti e giocondi, non avendo loro parlato, che di cacce e di piaceri. Di poi mandò loro cani, uccelli, e tutto ciò che potea divertirli, destinò a’ medesimi e cacciatori, e cavalli con ordine di servirli, come se fosse egli stesso, e fe’ dire a questi principi che potevano liberamente cacciare ne’ suoi serragli sotto la fortezza, ne’ quali stavano racchiuse alcune bestie selvaggie, e talvolta volle essere ancora egli della partita. 180 Surita, Annales de Aragon., t. III, lib. XIV, cap. 31, pag. 234. 181 Se fosse piaciuto a’ Genovesi che si dasse così la libertà a’ nemici, e che si rendesse nelle mani di Alfonso quella conquista, che nella battaglia navale de’ 5 di agosto se gli era rapita, può ciascheduno da sè immaginarselo. Non finirono nondimeno con questo i dispiaceri de’ medesimi; n’ebbero eglino a soffrire de’ più mortificanti; avvegnachè, come lo accenna lo Stella (Annales Gen. presso Murat., t. XVII. Rer. ltal. Script. pag. 1318), furono obbligati a ricevere Giovanni re di Navarra, ch’era stato loro prigioniero, con ogni onorificenza, come se fosse il sovrano di Genova, e di condurlo sotto baldacchino sino al palagio della sua residenza. Ma ciò che li umiliò all’estremo, fu l’ordine ricevuto dal duca di Milano di preparare una flotta per accompagnare il re Alfonso a Napoli, e servirlo per la conquista di quel regno: comando che, nonostante le loro replicate rimostranze, dovettero a forza eseguire (Fazio, Rer. suo temp. gest. lib. IV, pag. 141). 182 Giornal. Napol. p. 1103. 183 Rer. suo temp. gest. lib. V. p. 148. 177 - 44 - prescrivendogli ancora che recasse insieme una nave carica di frumenti. Tutto ciò avvenne nel mese di novembre, o nel dicembre seguente dello stesso anno 1435, siccome rilevasi dal giornalista suddetto, che lo racconta dopo di avere riferita la carestia che la città di Capua soffrì in novembre, e i mezzi adoprati dall’accorto conte Giovanni marchese di Geraci, che vi comandava, per allontanare il nemico, ed introdurre viveri in quella città. Prosegue a dirci lo stesso giornalista, che l’infante Pietro rallegratosi grandemente di queste liete notizie partì subito con undici galee, e andò ad Ischia, non sappiamo se a fine di cominciare l’impresa della conquista del regno di Napoli, come a questi piace, o per passare tosto a Porto Venere per unirsi al re Alfonso suo fratello, come abbiamo detto di trovare registrato presso il Fazio. Che che sia di ciò, l’infante Pietro trovandosi in quella isola non tralasciò di fare delle pratiche con alcuni aderenti alla casa di Aragona, e di assicurarli che stando eglino costanti nel [60] partito che preso aveano, fra breve si sarebbono liberati da qualsisia pericolo. Mentre egli faceva queste diligenze, seppe che in Gaeta era entrata la peste, e che gli Angioini per timore di essa aveano abbandonata quella città, dove era anche morto attaccato da questo male Lancellotto Agnese gentiluomo napolitano, che vi governava. Perciò rendendosegli agevole, giacchè i nemici erano scappati, l’acquisto di quella gran fortezza, al quale per altro era invitato da coloro de’ Gaetani, i quali erano rimasti affezionati al re Alfonso, pensò che fosse necessario di dimettere ogni altro pensiero, e di assicurarsene subito; e perciò levate le ancore andossene alla ridetta città, che per mezzo degli amici che vi avea, e senza sfoderare la spada, occupò il dì di Natale 1435 184. Da tutti questi fatti, che sono contestati dagli scrittori sincroni, viene evidentemente provato, siccome avevamo promesso di dimostrare, che il ritorno dell’infante Pietro in Sicilia, e la di lui partenza dalla medesima, dopochè il re Alfonso e i suoi fratelli furono liberati dalle ritorte, non accaddero che nell’anno 1435, e che per conseguenza l’elezione di Ruggiero Paruta, e di Giovan Battista Platamone per suoi luogotenenti nel governo del regno di Sicilia non avvenne che nel mese di dicembre dell’anno medesimo. Siccome questo serenissimo principe dopo la presa di Gaeta non più si distaccò da’ fianchi del fratello, e lo assistè sempre nella guerra di Napoli, in cui morì, non possiamo punto sospettare che egli fosse un’altra volta ritornato in Sicilia, come sarebbe d’uopo per salvare l’errore cronologico dell’Amico, e dell’Auria. Egli è a credere che il Paruta, ch’era andato a Gaeta a trovare il re Alfonso, nella famosa giornata de’ 5 agosto fosse rimasto sopra le galee comandate dall’infante Pietro, e con esso si fosse salvato, e fosse ritornato in Sicilia; giacchè non abbiamo monumento veruno che ci additi ch’ei vi si fosse restituito in altro modo; nè si vede nominato fra i prigionieri fatti da’ Genovesi, che poi furono liberati; ciò che non si sarebbe intralasciato di avvertire dal Surita, che rapporta i nomi dei personaggi siciliani, che non morirono in quella battaglia, e vi restarono presi. Il Paruta, oltre di essere un cavaliere di una distinta famiglia, e ornato delle due insigne cariche di castellano del regio palagio, e di maestro razionale, era abbastanza commendabile, e degno di esser nominato per conto ancora del viceregnato di Sicilia, che gli era stato conferito dall’infante Pietro prima di partire coll’armata verso Gaeta per la guerra, che il re Alfonso facea nel regno di Napoli. Quantunque però fosse cessata ogni podestà ne’ quattro luogotenenti col ritorno di Ruggiero, non perciò egli prese le redini del governo, ma la somma autorità restò nelle mani del serenissimo Pietro, avendo noi più volte osservato, che, quando questo real principe era in quest’isola, dispacciava solo in forza della facoltà accordatagli dal fratello su i regni delle due Sicilie. Quel che si abbia fatto questo infante nel breve spazio che si fermò presso di noi, e fino al mese di novembre o dicembre 1435 prima di partire per Ischia, non è arrivato alla nostra cognizione, mancando, come si è detto, il registro dell’anno 1435-1436 ne’ due archivî reali; ma verisimilmente sarà stato tutto intento a preparare truppe e navi per accingersi a liberare i fratelli dalla prigionia del duca di Milano, per mantenere le intelligenze nel regno di Napoli, e per soccorrere il conte Giovanni Ventimiglia che governava in Capua, l’unica piazza ch’era restata in potere delle armi aragonesi. Sembrava proprio alla partenza per Ischia colle galee del principe Pietro, che dovesse ritornare nelle mani di Ruggiero Paruta l’amministrazione del regno, e ciò parea tanto più naturale, perchè egli l’altra volta, partendo per Gaeta, lo avea sostituito per vicerè nel governo dell’isola. Ma non si sa per qual ragione l’infante non stimò di lasciarvelo solo, e vi accoppiò Battista Platamone, ch’era stato uno de’ quattro luogotenenti eletti nella sua lontananza dallo stesso Paruta. Forse questo accorto principe, trattando più davvicino il Platamone, e trovandolo così illuminato nella politica e nella facoltà legale, stimò che fosse espediente per il servizio del fratello, e per il vantaggio de’ popoli, che questi fosse dato per compagno a Ruggiero, acciò unitamente procurassero la felicità de’ Siciliani, e la tranquillità del regno. Lasciò scritto il p. abate Vito Amico regio storiografo 185, che il Platamone continuò nel governo del regno insieme con Ruggiero Paruta per lo spazio di tre anni ad triennium, e siccome lo fe’ eletto l’anno 1436, secondo il di lui calcolo sarebbe durato questo [61] viceregnato fino all’anno 1439, nel che la sbagliò, come 184 185 Giorn. Napol. p. 1103. Cat. Illust. tom. IV, lib. XII, cap. 4, p. 157. - 45 - noi addimostreremo nel capo seguente; è nondimeno certo, che questi due vicerè restarono unitamente in questa carica fino all’anno 1437, nel quale il re Alfonso, annullando tutte le antecedenti elezioni di vicerè e presidenti del regno, e quelle ancora dell’infante Pietro, volle che il solo Ruggiero Paruta reggesse da vicerè la nostra isola. Molte cose operarono questi due vicerè durante la loro amministrazione, e varî dispacci loro, ora sottoscritti da ambedue, ora da uno di essi, si promulgarono nel regno. Fra questi è degno di ogni considerazione quello dato in Polizzi a’ 18 di luglio dell’anno 1437, e sottoscritto da Battista Platamone, uno de’ due mentovati vicerè. Per intendere quanto sia interessante questo monumento, bisogna avvertire che nel concilio di Basilea, che convocato sin dall’anno 1431 andò poi a terminare nel 1443, fra le molte sante disposizioni che furono date da que’ vescovi che lo componevano, una delle principali fu quella di abolirsi in avvenire tutte le riserve de’ vescovadi, e degli altri beneficî, che i papi costumavano di fare. Perciò nella ventesimaterza sessione, che fu tenuta in dì di sabato a’ 25 di marzo 1436, fu promulgata una costituzione sinodale, per cui i padri annullavano tutte le riserve fatte dal papa nello stato romano, e in tutti gli altri luoghi del cristianesimo, e vietavano che se ne potessero mai più fare in avvenire. Questo era un secondo colpo dato alla corte di Roma dietro al primo, che avea ricevuto nella ventesima prima sessione tenuta a’ 9 di giugno 1435, per cui malgrado gli sforzi de’ legati di Eugenio IV erano abolite le annate. Restava questo papa scorucciato nel vedersi così tarpate le ali dell’usurpata assoluta autorità; ma quando poi seppe che nella sessione ventesimasesta, che fu tenuta a’ 26 di luglio 1437, era egli citato a portarsi a Basilea per render conto della sua condotta, e colla minaccia di esser deposto se non ubbidiva, non seppe raffrenarsi, e con sua bolla sciolse il concilio, e lo trasferì a Ferrara. Non fecero alcun conto i padri del concilio nè della bolla di dissoluzione, nè di quella che intimava un nuovo concilio a Ferrara; ma proseguendo le loro sessioni, nella trentesimaquarta sessione dei 25 di giugno 1439 deposero Eugenio IV dal pontificato, e nella trentesimanona tenuta ai 17 di novembre dello stesso anno elessero il nuovo pontefice, che fu Amedeo duca di Savoja che prese il nome di Felice V. Ora in queste differenze, che erano fra il papa Eugenio IV e i padri del concilio di Basilea, le potenze europee erano anche divise fra di loro, giacchè alcune sostenevano i diritti del mentovato pontefice, ed altre teneano il partito del concilio basileense. Alfonso che trovavasi malcontento di Eugenio IV, perchè nella guerra di Napoli questo papa si era dichiarato a favore di Renato di Angiò, e avea destinato Giovanni Vitelleschi patriarca di Aquileia, cattivo e scandaloso prelato, ma che avea fama di ottimo capitano, acciò con tre mila cavalli, ed altrettanti fanti passasse nel regno di Napoli al soccorso della regina Elisabetta moglie di Renato, proteggette le determinazioni dei padri del concilio di Basilea; e perciò ordinò che in Sicilia fossero osservati i decreti di quella adunanza. Dunque ad istanza del vescovo di Catania vien comunicata dal vicerè Platamone la conciliare costituzione intorno alle riserve all’abate di S. Lucia 186, cui si ordina che sia fedelmente eseguita, e che sia perciò annullata l’esecutoria data ad una bolla pontificia fatta a favore di un certo Riccardo: insinuandoglisi, essere volere del sovrano che in ogni modo fossero osservate nei suoi stati tutte le determinazioni di quel concilio. Come poi Alfonso rappacificatosi con Eugenio IV l’abbia riconosciuto per legittimo pontefice, ed abbia rivocati gli ordini antecedenti, forse avremo luogo di rammentarlo in appresso. Posteriormente a questo tempo il re Alfonso promulgò in Gaeta, l’ultimo giorno di settembre dello stesso anno 1437, una prammatica, con cui comandò che fossero eseguiti i nuovi regolamenti di quel concilio intorno all’elezione dei vescovi. Il costume dell’antica chiesa, per cui i collegi delle chiese nelle vacanze eleggevano i pastori delle anime, era stato abolito, e i papi aveano introdotto l’abuso di riserbarsi il diritto di provvedere. I padri adunque del concilio di Basilea stimarono di dar riparo a questa usurpazione, per cui allo spesso accadea, che le pecorelle di Gesù Cristo erano affidate nelle mani dei rapaci lupi; e con una loro costituzione [62] restituirono gli elettori nell’antico diritto, e prescrissero il modo, come dovessero fare l’elezione secondo le canoniche leggi, non dando luogo alle commendazioni, al favore, o alla orrenda simonìa. E siccome il papa si trovava di aver fatte delle riserve, perciò stabilirono che egli fosse tenuto di avvisare gli elettori, che senza riguardo alle medesime, o alle bolle emanate, o alle regole della cancelleria, passassero liberamente ad una nuova elezione, scegliendo il più degno. Comunicò Giovanni de Piscibus vescovo di Catania ambasciadore di Alfonso nel concilio questa santa costituzione al suo sovrano, il quale trovandola ottima, come quella che conducea al bene della chiesa, ne ordinò colla suddetta prammatica l’esecuzione ai suoi fratelli, ai vicerè dei suoi regni, e a tutti i suoi sudditi così secolari, che ecclesiastici di qualunque grado, e dignità. 186 Questo abate di s. Lucia, che dovè essere Giacomo Porzio, vien nel dispaccio chiamato Orator Regius, titolo che corrisponde all’avvocato della corona, o come noi chiamiamo l’avvocato fiscale del patrimonio, cui perciò appartenea il dare l’esecutoria alle carte straniere, e quindi anche a quelle di Roma. - 46 - CAPO XIII. Ruggiero Paruta solo, Bernardo Requesens, e poi Gilberto Centelles, e Battista Platamone, e indi Raimondo Perellos vicerè. Stabilirono il canonico Amico 187, e dopo lui l’Auria 188, la nuova elezione del Paruta fatta dal re Alfonso per vicerè di Sicilia all’anno 1437, ma s’ingannarono; imperocchè il dispaccio di Alfonso è dato in Capua ai cinque di gennaro dell’anno seguente 1438, datum Capue V. mensis januarii anno Domini 1438, e fu comunicato dallo stesso Paruta ai magistrati ai 4 del seguente maggio, come si fa palese dal registro della regia cancellaria 189. In questo reale diploma il re Alfonso non solo esclude dal viceregnato tutti i vicerè sostituiti dall’infante Pietro, ma inoltre il detto suo fratello; quantunque questo principe, siccome abbiamo osservato, avesse la generale luogotenenza nei regni di Napoli, e di Sicilia. Qual sia stata la cagione, per cui questo sovrano, eleggendo il solo Paruta, che per altro stava governando il nostro regno in compagnia del Platamone, abbia annullate tutte le precedenti elezioni di vicerè, o presidenti, e la luogotenenza ancora generale del fratello, non assegnandosene nella carta reale il motivo, resta a noi occulto. Può ben essere, che egli abbia voluto in qualche modo risarcire il poco conto, che l’infante Pietro mostrò di fare di questo eccellente uomo, quando dopo di averlo l’anno 1435 eletto vicerè con amplissima facoltà di darsi dei sostituiti, e dopo che questi dovendo per i gravi affari portarsi alla corte avea lasciati, durante la sua lontananza, quattro presidenti del regno, nel suo ritorno coll’infante suddetto non fu più lasciato solo a governare la Sicilia, ma gli fu dallo stesso principe dato per compagno Battista Platamone. È dunque verisimile, che Alfonso udendo il dispiacere, che provato avea il Paruta nel vedersi dimezzata la sua autorità, per addimostrargli in quale estimazione lo avea, abbia risoluto di spedirgli l’onorevole dispaccio, con cui lo reintegrava solo nel governo di Sicilia, escludendo tutti gli altri antecedentemente eletti, e persino il fratello Pietro, che era stato fin allora suo perpetuo vicario nell’amministrazione di questi due regni. Questa per altro è una congettura che noi facciamo, potendo essere avvenuto che da altre cause l’animo del re Alfonso sia stato mosso a così operare. Di questo terzo viceregnato del Paruta ottenuto dal medesimo con singolar dispaccio dal magnanimo Alfonso non fa veruna menzione il Pirri, il quale non ci accenna 190 che i due primi; l’uno, in cui fu solo, e l’altro, in cui ebbe per compagno Battista Platamone. Ma ciò non deve recare maraviglia; la cronologia di questo regio storiografo non è punto esatta, e per quel che riguarda i vicerè di Sicilia, è assai più mancante che le due, che ci hanno scritte l’Amico, e l’Auria. Collocato il Paruta con un dispaccio così onorifico nel governo di tutta la Sicilia, si occupò interamente a rendere dei considerabili servigî al suo sovrano, e a procurare la felicità del regno, di cui gli era stata confidata l’amministrazione. Faceasi allora con calore la guerra nel regno di Napoli; il re Renato di Angiò, che era tenuto in ceppi dal duca di Borgogna, coll’esorcismo di ducento mila dobble si era liberato dalle catene, e con molta truppa era venuto a Napoli, dove assicuratosi il suo partito, e avvalorato dalle milizie del Caldora, che segli era unito, trovavasi già in grado di far fronte al re Alfonso. Questi perciò, che in passato avea fatta [63] la guerra lentamente, conobbe allora che era d’uopo di accalorare questa impresa; giacchè se punto si dava tempo al nemico di augumentare le sue forze, rendevasi allora più malagevole la conquista di quel regno. Il Paruta, secondando le premure del suo principe, non intralasciava dalla Sicilia di somministrare uomini, attrezzi militari, e le vettovaglie necessarie per l’esercito, che avrebbe allora indubitatamente presa quella città, se la disgraziata morte dell’infante Pietro, che era il principal movente in quello assedio, non avesse agghiacciato il sangue al re, e alle sue soldatesche. Stava del pari a cuore del Paruta la sicurezza dei Siciliani, i quali sebbene nell’interno del regno godessero una invidiabile tranquillità, erano nondimeno vessati dagl’inquieti Tunisini, che turbavano il commercio per mare, e inoltre, sbarcando nei lidi della Sicilia, predavano i beni degli abitanti, e molti di questi riducevano in ischiavitù. Non era allora il caso di rintuzzare colla forza la temerità di costoro; le truppe e le galee, che avrebbero potuto difendere il regno, si trovavano lontane, ed intente a servire il re nell’assedio di Napoli. Fu dunque creduto miglior partito il cercare la pace al re di Tunisi, per impedir così che i sudditi di questo principe moro molestassero in avvenire la Sicilia. Ne propose il Paruta il progetto al magnanimo Alfonso, il quale creò a questo oggetto per suo ambasciadore a quel Bey il P. Giuliano Majali monaco del monistero di san Martino delle scale di Palermo, dell’ordine di san Benedetto, cui fu spedito un onorifico dispaccio da Gaeta al primo di dicembre 1438, col quale venne egli eletto inviato del re con plenipotenza a quel principe, per stabilire gli articoli di una costante pace fra i Tunisini e i Siciliani. Non è del nostro argomento il rapportare in questo luogo ciò che abbia questo santo e virtuoso monaco fatto in 187 Chronolog. de los virreyes, p. 6. Cronologia de’ Vicerè di Sicilia, p. 12. 189 All’anno 1437 e 1438, p. 231. 190 Chronologia Regum Siciliae, p. 100. 188 - 47 - Tunisi per assicurare la felicità di Sicilia. Basta dire che egli fu accolto con distinzione da quel re, ottenne dal medesimo quanto bramava, si trattenne lo spazio di presso a tre anni in quella corte, nè ne partì, che con rincrescimento di quel moro, che non volea privarsene, e a grandissimi stenti gliene accordò il permesso, accompagnandolo con molti doni, dei quali alcuni tuttavia si conservano in quel monistero 191, e con lettera al re Alfonso in cui faceagli elogî di questo virtuoso religioso. Fanno durare l’Amico, e l’Auria questo terzo governo del Paruta fino all’anno 1440 in cui gli danno poi per successori Gilberto Centelles, e Battista Platamone, il quale per la terza volta veniva impiegato nel governo del regno; ma noi fra questi due, e il Paruta troviamo un altro vicerè, cioè Bernardo Requesens l’anno 1439, come costa dal registro della regia cancellaria 192. Di questo cavaliere che allora esercitò per poco tempo il viceregnato, noi parleremo più diffusamente in appresso, avendo governato altre volte, e più lungamente la nostra isola. Dietro al Paruta colloca il Fazello 193 un certo Pietro Montagna. Bisogna però convenire che questo nostro storico abbia fatto un mazzo di granchi nel descriverci il catalogo dei vicerè, che governarono la Sicilia sotto il re Alfonso. Ecco come egli li numera: l’infante Pietro, Niccolò Speciale, Gilberto Centelles, Battista Platamone, Ruggiero Paruta, Pietro Montagna, Bernardo Rochense, e poi Lupo Simenio Durrea 194. Da quanto si è finora detto, e da ciò che si dirà in appresso, si fa palese quanto questa cronologia del Fazello sia scorretta. Anche l’Inveges 195 mentova fra i vicerè il Montagna, e si meraviglia come il Pirri trascuri di nominarlo nel catalogo dei vicerè di Sicilia, e dice che egli governò il regno col carico di presidente del regno nel 1420. Filadelfo Mugnos antecedentemente a questo 196 scrisse, che il detto cavaliere, che vuole aragonese, [64] occupò molti supremi posti, e fra questi quello di vicerè nell’anno 1447. La differenza fra questi scrittori nello stabilire l’anno, in cui vogliono che il Montagna abbia governato il regno nostro: il volere alcuni che fosse stato vicerè, ed altri che fu eletto presidente: e il non trovarsi nei registri della regia cancellaria, e del protonotaro verun dispaccio di questo signore negli anni in cui dicesi da essi vicerè, o presidente di Sicilia, sono i motivi che ci hanno indotto a non noverarlo in questa nostra cronologia. Furono adunque successori di Bernardo Requesens i due Gilberto Centelles, e Battista Platamone. Di quest’ultimo si è parlato abbastanza nei capi XI e XII di questo libro; diciamo ora un motto del primo. La famiglia Centelles, o come altri la chiamano, Centeglios, fu famiglia catalana antichissima e nobilissima, di cui parlano con molta riputazione gli scrittori spagnuoli. Vuolsi che da Catalogna molti di questa schiatta sieno passati in Sicilia. Il Surita 197 mentova un certo Gilberto Centelles, che era generale della cavalleria in Majorca, il quale l’anno 1394 passò in Sicilia in soccorso del re Martino d’Aragona. Racconta poi all’anno 1415 che un Gilberto de Centelles si casò con donna Costanza Ventimiglia unica figliuola, ed erede di Antonio Ventimiglia conte di Golisano, che era già morto 198. Questi certamente fu quello che piantò la razza Centelles in Sicilia. Non è punto inverisimile, che egli stesso nell’anno 1440, cioè venticinque anni dopo il contratto matrimonio, sia stato promosso col Platamone alla sublime carica di vicerè di Sicilia. Breve fu l’amministrazione, come ora diremo, di questi due viceregi. Nello spazio di tempo in cui governarono, null’altro di singolare noi crediamo che debba rammentarsi, che la loro prammatica intorno ai notari, e al loro salario pubblicata in Palermo ai 23 di novembre 1440. Nasceano alla giornata delle controversie coi notari intorno al pagamento delle scritture, che deve da litiganti ad essi farsi, i quali pretendeano un maggior prezzo per le medesime di quello che si volea lor pagare, e quindi continuamente erano vessati i tribunali per istabilire la tassa degli atti notariali. A togliere adunque questi piati, i mentovati due vicerè stabilirono con trentanove capitoli le tariffe per i testamenti, i contratti, e tutti gli strumenti pubblici necessarî a farsi 199. Queste ordinazioni, che furono da loro promulgate, previo il consenso reale, furono poi confermate, e di nuovo pubblicate ai 16 di giugno 1443 dal vicerè Lopez Ximenes de Urrea. Successe al Centelles ed al Platamone l’anno 1441 Raimondo de Perellos, che latinamente nei dispacci vien detto de Perleonibus, o Perillionibus, il quale venne eletto vicerè in vita dal re Alfonso, come si fa 191 Nella sagrestia del monistero di s. Martino delle Scale conservansi due piviali di chiesa di velluto cremisi, che furono fatti da un manto reale che fu dato in dono da quel re moro al detto Giuliano. I viaggiatori che arrivano ivi, veggono con piacere, come dopo lo spazio di trecento e più anni si conservi quel drappo così bello, e col colore così vivo, come se fosse stato tinto da pochi anni. 192 All’anno II. indiz. 1439-1440, fogl. 204. 193 Dec. II, lib. IX, p. 182. 194 Alphonsus Rex initio sui Principatus anno salutis 1415 Vicarium summum in Siciliam misit Infantem; sed anno deinde 1425 Nicolaum Specialem netinum Proregem Siciliae constituit. Quo defuncto Gilbertus Centellus, Baptista Platamonius, Rogerius Paruta, Petrus Montagna, et Bernardus Rochensis suo ordine Siciliae Regis nomine praefuerunt. Pag. 182, e poi pag. 183: Instituerat eo tempore Alphonsus Lupum Simenium Durream hispanum genere, virum bello praeclarum Siciliae Proregem. 195 Palermo Nobile. Nobiliario Viceregio, p. 160. 196 Teatro Genealogico, part. I, p. 160. 197 Annales de Arag., t. II, lib. X, cap. 52, p. 407. 198 Ivi tom. III, lib. XII, cap. 50, p. 114. 199 Capit. Regni Siciliae, t. I in Alphonso p. 287. - 48 - chiaro dal dispaccio sottoscritto in Capua ai 14 di febbraro 1441, che conservasi nella regia cancellaria 200. Di questo cavaliere abbiamo favellato sul principio di questo libro 201, quando si è accennato che ei fu destinato con Giovanni Ansalone, e Martino de Turribus in soccorso della regina Giovanna, che avea adottato per figlio il re Alfonso. Era egli visconte di Reda, ed era stato adoprato in molte occasioni dai sovrani di Aragona. Il re suddetto l’ebbe in molta estimazione, e lo scelse per capo dell’ambascerìa, e del soccorso mandato alla regina mentovata. Questi, dopo di essere venuto in Sicilia per prendere gli altri due ambasciadori Torres, ed Ansalone, con dodeci galee, e tre galeotte passò in Napoli, dove felicemente giunse ai 6 di settembre 1420, e fu tosto messo in possesso del Castel nuovo 202. Ai sedici poi dello stesso mese, essendo stato dalla regina convocato il parlamento nel medesimo castello, in cui questa principessa diè conto agli ordini dello stato di avere già adottato per figliuolo Alfonso re di Aragona, il Perellos, che fu presente coi suoi colleghi a quella cerimonia, fu posto in possesso, come il principale rappresentante dell’adottato sovrano, del ducato di Calabria, e cavalcò come in trionfo per tutta la città di Napoli vestito di drappo d’oro, e accompagnato da quattro bandiere, nelle quali erano interzate colle armi del re di Aragona, e della regina di Napoli quelle ancora del papa. Furono in questa occasione celebrate delle festività in quella capitale, e fu consegnato anche al Perellos il castello dell’Uovo 203. Dopo alcuni giorni, e positivamente a’ 24 dello stesso mese, [65] furono convocati i cinque seggi nobili, e quello del popolo, i quali alla presenza del Perellos che fu riconosciuto come vicerè, giurarono che avrebbono tenuta per sovrana di tutto il regno la regina Giovanna, eccetto il solo ducato di Calabria, che ella avea rinunziato al re Alfonso, e che dopo la di lei morte avrebbono ubbidito a questo principe già dichiarato suo figliuolo, tenendolo per vero re e per legittimo successore 204. Nati poi dei disgusti fra il re Alfonso e la regina Giovanna, che lo diseredò, e chiamato in soccorso di questa principessa Francesco Sforza Attendolo, fu data battaglia ai 31 di maggio dell’anno 1423 fra le truppe di questo condottiero, e le catalane a S. Maria l’Ogliolo, oggi detta S. Maria a Formello con perdita di queste 205 , dove vi restarono prigionieri i migliori uffiziali del re, fra’ quali il Perellos 206. Alfonso ne restò così dispiaciuto, che quantunque non avesse mai voluto in alcun modo rendere il gran siniscalco Sergianni Caracciolo, prigioniero di grande importanza, come quello per cui spasimava la regina Giovanna, e per cui avrebbe cesso la metà del suo regno affine di ricuperarlo, non dimeno per liberare il Perellos, di cui facea cotanto conto, e Bernardo Centelles, che era altresì un valente capitano, si contentò di rilasciare il Caracciolo, ricambiandolo coi due mentovati illustri personaggi 207. Quanto abbiamo finora riferito di questo cavaliere abbastanza addimostra qual uomo ei fosse, e in qual pregio lo avesse avuto il re Alfonso, il quale oltre di averlo promosso alla carica di suo maresciallo, e di averlo eletto governatore di Rosciglione, e di Cerdagna, si avvalse della di lui attività in varie ambascerie che mandò a molti principi, ed in particolare in quella che spedì all’imperatore Sigismondo l’anno 1434 in occasione che questo augusto dovea cingersi la fronte del serto imperiale, e per trattarvi il grande affare della continuazione del concilio di Basilea, come racconta il Surita 208, il quale parlando di questo ministro assicura, che il re Alfonso gli affidava le incombenze più segrete, e scabrose: en quien el Rey siempre encarcava las cosas de mayor confiança. Non fia perciò meraviglia, se dietro a tanti singolari servigii ricevuti dal Perellos, questo sovrano l’abbia eletto conte di Castellammare della Stabia, e volendogli accordare un riposo l’abbia scelto durante la sua vita per vicerè di Sicilia. Non dovette questo vicerè continuare molto tempo in questa vitalizia carica: era egli vecchio, quando vi fu promosso, giacchè si fa menzione di esso fino dall’anno 1391 qualora dal re di Aragona Giovanni I fu creato visconte de Perellos in Saragoza ai 13 di febbraro 209; sicchè essendo da questa creazione all’elezione di vicerè scorsi cinquant’anni, è assai verisimile che fosse avanzato in età, quando fu destinato per governare questo regno. Noi opiniamo, sebbene ci manchino le notizie che ce lo avvisino, che egli non vi durò che presso a due anni, e che morì in questo impiego; giacchè all’anno 1443 vediamo promosso a questa carica Ximenes de Urrea, di cui favelleremo nel capo che siegue. Mentre il Perellos ebbe l’amministrazione di quest’isola, non si sa cosa sia particolarmente accaduto presso di noi; l’ostinata guerra nel regno di Napoli, che poi terminò così gloriosamente per il re Alfonso l’anno 1442, tenea intenti gli occhi di tutti gli scrittori, nè si rivolgeano agli affari di minor conto, che riguardavano questa provincia. Solo ci sono note alcune grazie accordate da quel sovrano, e per opera di 200 Reg. degli anni 1440 e 1441, 3 lnd., f. 303. Cap. 4. 202 Surita, Annal. de Arag., t. III, lib. XIII, p. 142. 203 Giorn. Napol. t. XXI, presso Murat. Rer. ltal. Script. p. 1084. 204 Surita, Annal. de Aragon., t. III, lib. XIII, cap. 6, p. 142. — Giorn. Napol. p. 1084. 205 Giornali Nap., p. 1088. 206 Fragm. Hist. Sic., p. 1098. 207 Surita, loc. cit. lib. XIII, cap. 18, p. 154. 208 Ivi lib. XIV. cap. 13, p. 219. 209 Surita, loc. cit., t. II, lib. X, cap. 47, p. 400. 201 - 49 - questo vicerè alla città di Palermo. Avea questa università implorata la reale clemenza contro il fisco regio che inquietava i cittadini, ed avealo supplicato di compiacersi di concedere: 1° che si annullassero tutte le accuse fino a quel tempo fatte contro i cittadini, e gli abitanti di Palermo: 2° che il fisco non facesse nuova perquisizione dei delitti già commessi fino allora dai cittadini, e dagli abitanti: 3° che il fisco non potesse procedere contro i cittadini palermitani, eccetto che in certi particolari delitti; e 4° che non potesse procedere contro gli usurarî per via di accusa, di denunzia, o d’inquisizione. Alfonso destinò il vicerè Raimondo Perellos, Antonio Sin suo tesoriero, e Gabriele Cardona maestro razionale, i quali esaminassero le dimande dell’università. Fattasi matura riflessione dai [66] medesimi tre ministri sulle medesime, furono accordate le suddette grazie con alcune riserve, e il re, con dispaccio dato nel Campo presso a Napoli ai 28 di dicembre 1442, confermò i capitoli convenuti con questi ministri 210. CAPO XIV. Ximen de Urrea, Lopes Ximenes de Urrea vicerè, e i presidenti del regno da quest’ultimo sostituiti durante il suo primo governo, cioè Antonio Rosso e Spadafora l’anno 1447, Adamo Asmundo, Pietro Speciale, Calcerano de Corberas, Pietro Gaetano, Giovanni Abatelli, i quattro giudici della Gran Corte l’anno 1449, Simone Bologna arcivescovo di Palermo l’anno 1450, il ridetto Antonio Rosso l’anno 1452, lo stesso arcivescovo di Palermo l’anno 1453, e il medesimo Antonio Rosso l’anno 1456. Due cavalieri della nobilissima famiglia di Urrea dominarono colla carica luminosa di vicerè di Sicilia sotto il governo del re Alfonso il Magnanimo, Ximen de Urrea, e dopo di questo Lopes Ximenes de Urrea, lo che debbe attentamente avvertirsi per iscansare l’errore di taluni, che di questi due non ne hanno fatto che un solo. Così il Pirri 211, enumerando i vicerè che governarono sotto i re aragonesi della schiatta di Castiglia, non nomina che il solo Lopes Ximenes de Urrea successore di Raimondo de Perellos, cui dice che fu sostituito dall’anno 1444 fino all’anno 1459. Ma il canonico Antonino d’Amico 212, e dietro a questo Vincenzo Auria 213 distinguono abbastanza l’uno dall’altro, e in questo impiego fanno durare colla scorta dei pubblici documenti il secondo sino all’anno 1475, come noi in appresso anderemo additando. Che poi sieno stati due distinti l’uno dall’altro, si fa troppo chiaro dalle sottoscritte che si osservano nei dispacci viceregî, giacchè il primo quasi costantemente si soscrive Ximen de Urrea, e l’altro quasi sempre Lop Ximenes de Urrea. Egli è vero, che in taluni dei registri così della cancellaria, che del regio protonotaro si trova talvolta scritto: Ximen de Urrea in quegli anni, in cui dovrebbe scriversi Lop Ximenes de Urrea, e talvolta Lopes Ximenes de Urrea, dove dovrebbe solamente essere scritto Ximenes de Urrea 214; ma questi furono certamente errori dei copisti, i quali, siccome questi due vicerè furono l’uno dietro l’altro, poterono confondere il nome dell’uno col nome dell’altro. Del resto l’atto di elezione, che noi in appresso rapporteremo, di Lopes Ximenes de Urrea fatta l’anno 1445, in cui si dice, che rimosso Ximenes de Urrea per altri affari, viene eletto al vacante viceregnato Lopes Ximenes de Urrea, ci fa chiaramente vedere la verità di quanto asseriamo. Noi dunque seguendo le pedate dei due suddetti cronologi, ed assicurati dalle carte viceregie che sieno stati diversi, li distingueremo, e favelleremo in questo capo dell’uno e dell’altro. Ximen, o, come altri lo chiamano, Scimen de Urrea, successe dunque al Perellos nel governo della Sicilia l’anno 1443, come costa dai registri dei nostri regî archivî 215; ma vi durò poco tempo, giacchè, come in appresso osserveremo, avendolo il re Alfonso richiamato l’anno 1445 per spedirlo altrove per altri rilevanti affari, depose il governo. Sotto questo vicerè furono rivocati tutti gli ordini del re emanati a favore del concilio di Basilea, e contro il pontefice Eugenio IV. Questo papa non così per sostenere Renato di Angiò, cui avea accordata l’investitura del regno di Napoli, che per vendicarsi del re Alfonso per l’approvazione data alle costituzioni del concilio di Basilea, alla deposizione di esso dal pontificato, e all’elezione di Felice V fatta nell’anno 1439, si era fitto in capo di frastornargli l’acquisto del regno di Napoli, e di spogliarlo, s’era possibile, dei regni di Sicilia e di Sardegna. Avea perciò nel mese di aprile 1441 fatta lega con Tommaso Campofregoso Doge di Genova, per cui si obbigava nello spazio di un mese di mettere in piedi un esercito, che fosse almeno di quattro mila soldati da cavallo, e di mille e cinquecento fanti, con cui sarebbe entrato nel regno di Napoli a far la guerra ad Alfonso, e la repubblica dal suo canto si compromettea di allestire una flotta di dodici [67] galee, di quattro navi grosse, e di altri legni piccoli, in cui vi fossero ducento uomini di armi, e tutte le macchine necessarie alle battaglie; e se questa non fosse bastante, di accrescerla, sino che fosse 210 Del Vio, Privilegia Urbis Panorm. p. 280 e seg. Chronol. Reg. Ital., p. 100, n. 14. 212 Chronologia de los virreyes. 213 Cronologia de’ signori vicerè di Sicilia, p. 12. 214 Vedi i registri degli anni 1441 e 1442 IV. Ind. — 1442 e 1443 V. Ind. — 1443 e 1444 VI. Ind. — e 1444 e 1445 VII. Ind. 215 Cancell. e Prot. agli anni 1442 e 1443 V. Ind. — 1143 e 1444 VI. Ind. — 1444 e 1445 VII. Ind. 211 - 50 - creduta atta all’uopo. Così leggesi nell’atto stipolato ai 26 del detto mese, ed anno rapportato dal Rinaldi 216. Così eseguì Eugenio, spedendo alla volta di Napoli l’armata, cui costituì per comandante il cardinal Giovanni Vitelleschi, cui inoltre ordinò che citasse il re Alfonso, acciò in un dato termine si presentasse in Roma a render ragione al papa dell’invasione del regno di Napoli contro i diritti della santa sede, e della sua contumacia nel ricusare di riconoscerlo per legittimo capo della chiesa 217. I felici progressi delle armi aragonesi nel regno suddetto, di cui Alfonso divenne interamente padrone l’anno 1443, fecero cambiare sentimenti ad Eugenio, il quale osservando, quanto questo sovrano fosse divenuto potente, cominciò a ragione a temere, che egli sbrigatosi della guerra di Napoli non pensasse d’invadere lo stato ecclesiastico, e non si accingesse a farlo sbalzare dal soglio pontifizio, collocandovi Felice V, con cui esso re avea fatto un segreto trattato, che accennano il Giannone 218, e il Muratori 219, per cui questo antipapa si obbligava di dargli l’allor creduta necessaria investitura del regno di Napoli, e dugento mila pezze d’oro a condizione che accordasse i decreti del concilio di Basilea, che lo riconoscesse per legittimo pontefice, e che cercasse di trarre al suo partito il re di Castiglia, e il duca di Milano. I medesimi padri del concilio nel mese di ottobre dell’anno 1441 spedirono un’ambasciada allo stesso nostro sovrano, per cui lo supplicavano a sostenere le loro determinazioni, compromettendosi di fargli ottenere dal nuovo papa da loro eletto quanto gli era stato da Eugenio ingiustamente negato. Alfonso non avea trascurato, come di sopra abbiamo divisato, di ordinare in tutti i suoi stati l’esecuzione di quanto i padri di Basilea aveano definito, e di vietare ai suoi sudditi ogni commercio con Eugenio, e colla corte romana. Or tutti questi fatti, che non poteano essere ignoti a questo papa, l’intimidirono per modo, quando osservò i progressi delle armi aragonesi di Alfonso, che pensando a casi suoi abbandonò Renato di Angiò, e cominciò a fare delle pratiche per conciliarsi col nostro sovrano. Non era il grande animo di questi lontano dal far la pace, giacchè non già la religione, ma la politica, e l’interesse della sua corona, l’avea indotto ad approvare i decreti di Basilea, e l’elezione di Felice V, e perciò diede a divedere di essere disposto alla riconciliazione ogni volta che il papa rinunziasse alla protezione della casa d’Angiò, e venisse a ragionevoli patti. Assicurato Eugenio della buona volontà di Alfonso, destinò in Napoli come legato apostolico il cardinal Vitelleschi l’anno 1443 affine di trattare in suo nome la pace col re nostro. Dopo molti dibattimenti finalmente fu stabilita la convenzione, per cui Eugenio si obbligò a riconoscere per sovrano di Napoli Alfonso, concedendo al medesimo, e ai di lui figliuoli la pretesa investitura, e di accordare al principe Ferdinando il diritto di succedere in quel regno, comunque fosse bastardo; e il re si compromettea di riconoscere per legittimo pontefice Eugenio, di aiutarlo contro Francesco Sforza, che occupata avea la Marca d’Ancona, di fornirgli una flotta di galee ogni volta che questo pontefice volesse fare la guerra al turco, o ai re di Affrica, di richiamare da Basilea i prelati mandati al concilio, e di non riputare per cardinali coloro, che erano stati promossi alla porpora dall’antipapa Felice V 220, con altri patti. Fedele Alfonso alle sue promesse non [68] solamente si preparò a far la guerra allo Sforza, ma richiamò subito da Basilea i vescovi dei suoi regni, e nello stesso anno 1443 in Gaeta ai 20 di giugno sottoscrisse una circolare per tutti i suoi stati, nella quale dichiarò che sulle prime avea aderito al concilio di Basilea, perchè credea che fosse un’assemblea la quale rappresentasse la chiesa di Dio destinata a riformare tutti gli abusi che erano in essa nati; ma che poi si era accorto, che molte disposizioni date da quel concilio non tendevano a riformare la chiesa, ma piuttosto a turbarla; e perciò era divenuto neutrale, aspettando l’esito di quell’adunanza, per poi esaminare se i decreti fossero per essere indiritti al bene del cristianesimo. Svanite di poi le tenebre, e comparsa la verità nel suo chiaro lume, dopo un maturo esame rilevato avea che Eugenio IV era l’unico, e legittimo pontefice cui doveano i fedeli ubbidire, come al capo supremo della chiesa. Quindi 216 In Ann. ad an. 1441, t. IX, p. 319, n. 16. Rayn., ivi, num. 17. 218 Storia Civile di Napoli, t. IV, lib. XXVI, cap. 11. 219 Annali d’Italia 1441, t. X. 220 Fra i cardinali eletti da Felice V rammentasi Niccolò Tedeschi, detto volgarmente l’Abate Palermitano, ch’era Arcivescovo di Palermo. S. Antonino (In Chron. part. III, tit. 22, cap. 10) scrisse, che Felice lo aggregò al sacro collegio in mercedem iniquitatis, perchè avea aderito alla deposizione di Eugenio, e alla elezione dell’antipapa; molti scrittori, e fra questi il Mongitore (Bibl. Sic. t. II, art. Nicolaus Tedeschius, p. 100) lo difendono, non essendo egli stato presente nè quando fu detronizzato Eugenio, nè quando fu promosso Felice; e vogliono che questi lo fe’ cardinale in premio della singolare dottrina, e de’ rari meriti, de’ quali era fornito. Non si sa se questo prelato abbia giammai deposta la porpora, malgrado gli sforzi di Eugenio, per non far considerare come cardinali gli eletti di Felice; il Pirri (Sic. Sacra Not. I. Eccl. Panorm. p. 164) dice quam tamen dignitatem ipse non exuit, quamquam suam deposuisset Felix. Quel ch’è certo egli è, che Niccolò V successore di Eugenio non solamente riconobbe i cardinali ch’erano sopravissuti all’antipapa, ma confermò ancora con una bolla dell’anno 1449 tutti gli atti di Felice, e tutte le promozioni ecclesiastiche da lui fatte. Sebbene allora, quando fu promulgata questa bolla, il Tedeschi fosse morto, giacchè finì di vivere l’anno 1445, nondimeno questo diploma pontifizio addimostra essere stata legittima la di lui elezione in cardinale della santa chiesa. Nello che è da emendarsi l’errore cronologico del Pirri nelle or ora riferite parole, le quali par che indichino, che Felice avesse deposto la dignità pontifizia prima che morisse il Tedeschi, che non volle spogliarsi della cardinalizia; quando è certo, che Felice fe’ questo sagrifizio quattro anni dopo che il Tedeschi era morto. 217 - 51 - rivocando tutti gli antecedenti decreti promulgati, affinchè l’adunanza di Basilea fosse riconosciuta come sinodo universale, quasi che non fossero punto emanati, comanda che tutti i suoi sudditi ubbidissero ad Eugenio, e a lui ricorressero in ogni occasione. Questo diploma che noi abbiamo osservato in un codice dell’archivio del venerabile monistero di S. Martino delle Scale intitolato: Registro dei privilegi, fu promulgato dal vicerè Ximenes de Urrea in Palermo sotto i 27 dello stesso mese, ed anno. Ecco come la ragion politica, facendo servire ai suoi fini la sacrosanta religione, fe’ cambiare i sentimenti di quel principe. Nell’anno istesso, e nel medesimo mese sortì in Catania un disordine. Eravi ivi fra Pietro Geremia, che oggi la chiesa onora col titolo di beato, dell’ordine dei frati predicatori, il quale siccome predicava contro il vizio, e il mal costume, non andava al genio di coloro, che non osservavano la legge di Gesù Cristo. Un dì, non si sa per qual particolar ragione, fu questo santo religioso insultato pubblicamente da un prete catanese, che avea nome Giuliano Darqueri. Il vescovo di quella città, che era Monsignor Giovanni de Piscibus, udendo l’insolenza fatta al B. Pietro, stimò suo dovere di far carcerare il mentovato sacerdote, e ne diede subito parte al governo. Ximenes de Urrea con lettera scritta in Palermo ai 25 del detto mese loda lo zelo del prelato, e lo esorta ad usare lo stesso rigore in simili casi; ma perchè il B. Geremia avea supplicato il vicerè, acciò si perdonasse a quel prete, comanda che per rispetto alle istanze di quest’ottimo religioso restasse sospesa la causa, nè si procedesse contro il delinquente. In questa lettera del vicerè merita di essere osservato che a quella età ancora costumavasi di declinare i naturali giudizî, allegandosi qualche privilegio, giacchè questo governante dice: et a lu fattu di quilli, li quali per avadiri judiciu declinanu vostru foru, allegandu privilegiu di familiaritati, et cappellania regali, vi risponnimu, chi ni digiati per vostri littiri particularmenti intimari cui, et quali su per nui, proinde ci provedirimu e scriviremuvi comu sinci avrà a procediri 221. Le umili preghiere del B. Pietro Geremia, e la condiscendenza del vicerè Ximenes de Urrea non servirono che ad accrescere gli insulti. Non guari passò, e appunto nello stesso mese, che si videro affissati per la città dei cartelli ingiuriosi non meno a questo santo religioso, che ai suoi confrati. Gli uffiziali catanesi ne avvertirono subito il governo, e Ximenes de Urrea sotto la data dei 3 di luglio scrisse una seconda lettera allo stesso vescovo 222, avvisandogli di avere incaricati gli stessi uffiziali di adoprare ogni diligenza per iscuoprire gli autori di codesti cartelli, e nel caso che fossero ecclesiastici, di carcerarli, e consegnarli, per essere puniti, alla curia vescovale, e suggerendogli che ancora egli facesse delle pratiche per svelarsi il reo, e per conoscersi se vi avessero avuta parte gli ecclesiastici; nel qual caso vuole che sieno severamente gastigati ad oggetto d’incutere terrore agli altri, e col loro esempio impedirsi che in avvenire si cadesse in simili eccessi. Così questo vicerè andava procurando che vi fosse la tranquillità nel regno, che egli governava, e che si amministrasse in esso la giustizia. Noi sospettiamo che nel [69] viceregnato di questo cavaliere i tunisini abbiano ritornato ad inquietare il commercio nostro marittimo, e che egli abbia spedito al loro re il padre Giuliano Majali monaco di S. Martino, di cui si è altrove fatta menzione, cui fu unito il milite Antonio Dentici. Nasce il nostro sospetto da una lettera scritta da esso vicerè sotto la data di Palermo all’ultimo di maggio 1443, e diretta: Fratri Juliano, et Antonio Dentici militi regiis ambasciatoribus. In essa duolsi l’Urrea, che dopo la loro partenza non abbiano dato alcuno avviso, nè di essere arrivati, nè di ciò che avessero operato, le quali cose desiderava il re Alfonso di sapere, e perciò li prega a non trascurare di scrivere in quale stato fossero le cose, affinchè egli ne potesse riscontrare sua maestà 223. La lettera non accenna nè dove sieno stati mandati, nè per qual cagione sieno stati destinati ambasciadori, ma siccome fu eletto principalmente il padre Giuliano Majali, di cui si è detto in quanta estimazione fosse tenuto presso il re di Tunisi, non sembra inverisimile, che questa sia stata diretta a quel principe. In questo tempo dovettero le chiese di Sicilia assoggettarsi ad un donativo, che richedea Alfonso per sostenere il peso della guerra. Scrive il Pirri 224, che Niccolò Tedeschi arcivescovo di Palermo vi si oppose, assegnando per mottivo, che senza il previo consenso del romano pontefice non poteano le chiese aggravarsi di collette. Perciò il re ricorse ad Eugenio IV, il quale, siccome era restato contentissimo della guerra che facea questo sovrano contro lo Sforza per riconquistare alla santa sede la Marca, gli concesse che potesse tassare gli ecclesiastici dei suoi regni per la somma di ducento mila scudi di oro sotto il pretesto che dovesse armare contro il turco, e inoltre lo quittò delle cinquanta mila marche di argento, che pagava alla chiesa romana per il regno di Napoli 225. Dovette adunque Ximenes de Urrea, inerendo agli ordini reali corroborati dal permesso pontifizio, obbligare le chiese di Sicilia a pagare la rata corrispondente della somma additata. Mentre questo cavaliere ci governava, accadde in Catania un incendio dei più strepitosi del Mongibello, e siccome la lava del fuoco era indiritta verso la città, così restarono quegli abitanti sorpresi da un gran terrore, 221 Mss. della libreria del senato di Palermo Lit. P. 9 dall’anno 1411 fino all’anno 1536. Nello stesso Mss. 223 Nel Ms. della libreria del senato di Pal., p. 9. 224 Sic. Sacra Not. I. Eccl. Panormi, p. 165. 225 Rainaldo negli Annali all’anno 1443, tom. IX, p. 410. 222 - 52 - temendo che le fiamme non divorassero le loro abitazioni. Scrissero il Fazello 226, e Filoteo 227, che trovandosi ivi il B. Pietro Geremia, di cui si è favellato, accompagnato dal clero, e dal popolo, e conducendo il famoso velo, che i Catanesi dicono che fosse stato di S. Agata, alla volta del furibondo monte, Iddio si compiacque di far fermare l’igneo torrente, e di liberare quei cittadini dal timore, da cui erano afflitti. Lo stesso attesta il Pirri 228, il quale ci racconta ancora, che il detto B. Pietro Geremia fu nello stesso anno incaricato da Ximenes de Urrea con lettere dei 17 settembre 1444 di riparare la cattedrale di essa città, che minacciava rovina. Nello stesso anno fu ottenuta ai 22 di aprile la bolla di ergersi nella medesima città l’università degli studî che fu ai 28 del seguente maggio confermata con real dispaccio dal re Alfonso in Napoli. Di questa erezione da quì a poco parleremo più diffusamente. Ma quest’ottimo vicerè ci abbandonò nel mese di giugno 1445. Alfonso, dovendo valersi dei di lui talenti per altri più interessanti affari, lo richiamò dalla Sicilia, e in di lui luogo scelse un altro del pari meritevole personaggio della stessa famiglia d’Urrea, che si chiamava Lop Ximenes. Il dispaccio reale, in cui si rammenta il di lui richiamo, e la elezione del successore, fu dato nel Castel nuovo di Napoli ai 25 del mentovato mese 229, le di cui parole dobbiamo in questo luogo riferire, perchè si conosca, che i Ximenes de Urrea furono due, l’uno dietro all’altro: Cum, vi si dice, Viceregnatus officium vacat ad presens per revocationem ad alia nostri negotia et servitia absque ulla nota infamie ab eodem viceregnatus officio magnifici dopni XIMINI DURREA militis.... Ecco il primo Ximenes de Urrea, che fu richiamato: Tenore itaque presenti confisi ad plenum de fide industria legalitate et animi probitate vestris gratis, et de certa nostra scientia motuque proprio dictum domnum Lupum ipsius regni Sicilie ultra farum et insularum sibi coadjacentium viceregem nostrum ex latere nostro sumptum locumtenentemque solum et unicum in dicto regno Sicilie ultra farum et insulis [70] sibi coadjacentibus facimus statuimus creamus perficimus et ordinamus ac ex ipso nostro latere solleniter delegamus. Ecco l’altro Ximenes de Urrea, che vien sostituito al primo. Era Lopes Ximenes de Urrea de latere del re Alfonso, imperocchè era cameriero maggiore di questo sovrano, ed uno dei suoi più intimi confidenti. Quando Bartolomeo Fazio ambasciadore di Genova fu spedito al re Alfonso dalla sua repubblica, affine di ottenere da questo principe o la pace, o per lo meno una tregua, egli stesso racconta 230, che gli furono assegnate tre persone dalla corte per istabilire le condizioni della tregua, e questi furono: Lupus Ximenes, Baptista Platamonius, ac Joannes Alzina, dal che rilevasi in quale riputazione egli allora fosse, che fu destinato capo della deputazione assegnata dal re. Antonio Panormita 231 ne parla con grandi elogî. Nell’onorifico diploma fattogli all’occasione di inalzarlo al ragguardevole posto di vicerè di Sicilia, oltre gli elogii che si danno alla di lui virtù, come dalle parole da noi trascritte si ricava, segli dà inoltre una facoltà, di cui niun altro prima di lui godette, nè altri dopo di esso giammai ottenne, cioè segli accordò che potesse per sei mesi starsene, ogni volta che più gli piacesse, fuori della Sicilia; nel qual caso potesse eleggere a suo beneplacito un presidente, che gli succedesse durante la sua lontananza. Questo privilegio singolare, di cui egli fe’ spesso uso, ci fa capire la cagione per la quale veggiamo a quando a quando ora un presidente, ora un altro, e tante volte molti, e di poi osserviamo, che ritornava ad esercitare la stessa carica il medesimo Lopes Ximenes. Era cioè egli vicerè proprietario, e gli altri non erano che suoi sostituti, l’autorità dei quali cessava, qualora questo cavaliere, dopo di esserne stato lontano, se ne ritornava nel regno. Lo stesso re Alfonso restò così compiaciuto della saggia condotta di questo cavaliere, che lo investì ancora, per quel che dicesi, l’anno 1458 del viceregnato di Napoli, lasciandogli insieme il governo di Sicilia. Ciò, oltre il Surita 232, lo attesta ancora F. Angelo di Sciacca in una cronaca mss. citata dallo storiografo Antonino Amico 233 , che la possedea, ed il Panormita similmente 234 il conferma, soggiungendo quod antea nulli alii contigerat. Noi nondimeno non sappiamo indurci a persuaderci, che egli avesse esercitata questa carica nel regno di Napoli; almeno gli storici napolitani non fanno alcuna menzione del di lui governo, e neppure lo nominano come vicerè di quel regno. Uno dei principali obbietti, che si propose Lupo Ximenes de Urrea nell’entrare al governo della Sicilia, fu appunto quello di fare tantosto eseguire il reale ordine, che si ergesse in Catania l’università degli studî. Era molto tempo che i Catanesi si affaticavano per procurare questo privilegio alla loro città. Fin dall’anno 226 Dec. I, lib. II, cap. 4 Topogr. p. 34. 228 Not. Eccl. Sicil, Not. I. Eccl. Cat. p.. 55. 229 Nella Reg. Cancel., all’anno 1445 VII. Ind. f. 420 230 Rer. suo temp. gest., lib. VIII, p. 221. 231 Dicta et facta Alphonsi regis, lib. III, n. 13. 232 Ann. de Aragon. t. IV, lib. XVI, cap. 52, p. 58. 233 Chron. de los virreyes del Reyno de Sic., p. 8. 234 Dicta, et facta Alfonsi regis, lib. III, n. 13. 227 - 53 - 1435, mentre questo sovrano era in Palermo, fra le altre grazie richiesero anche questa, e ne ottennero il consenso reale 235. Ma perchè allora si era nel comune errore di credere che l’erezione delle università non dipendesse dai sovrani, ma fosse privativamente riserbata al romano pontefice, ottenuto il permesso regio, cercarono i Catanesi di procurare dalla corte romana la bolla riputata necessaria per istabilirsi la desiderata università, e ne fu incaricato Giovanni de Primo benedettino catanese, ed abate di S. Paolo, che poi fu vescovo di essa città, e cardinale di Santa Chiesa, acciò si cooperasse ad ottenerla dal pontefice. I disgusti fra il papa Eugenio, e il re Alfonso, che noi abbiamo accennati, forse impedirono che questo papa accordasse il desiato diploma, e potè ancora esservi di ostacolo la risoluzione presa da questo sovrano di non più riconoscere per legittimo pontefice il detto Eugenio, ma l’antipapa Felice V. Fattasi dipoi la pace fra il sacerdozio, e l’impero, tornò l’abate di S. Paolo a fare le sue istanze presso il pontefice a nome dei Catanesi, e finalmente ottenne la bramata bolla, come si è detto, ai 22 di aprile 1444, che Alfonso confermò ai 28 di maggio dello stesso anno. Vincenzo Auria 236 parlando dell’elezione di Lupo Ximen d’Urrea fatta l’anno 1445 nota che in questo anno istesso il serenissimo re Alfonso per decreto pontificio di Eugenio IV, e per suo real privilegio concesse a Catania gli studî generali, e cita per testimonî il Pirri, e il Grosso; ma s’ingannò; imperocchè e l’uno e l’altro di questi scrittori fissano così il [71] diploma pontifizio, come il dispaccio reale all’anno antecedente 1444, e nei giorni e mesi che noi abbiamo additati. L’una dunque, e l’altra carta del pontefice, e del re furono emanate, mentre il nostro regno era governato da Ximenes de Urrea, e Lupo Ximenes suo successore non fe’ altro che sollecitarne l’esecuzione. E siccome per piantarsi l’università suddetta era necessario che si assegnasse alla medesima una rendita, colla quale potessero pagarsi i cattedratici, e farsi le necessarie altre spese al mantenimento di essa, perciò il re accordò con sua real carta alla detta città mille e cinquecento scudi annuali da cavarsi dalle così dette tratte reali delle estrazioni dei grani. Questo secondo dispaccio appartiene appunto all’anno 1445, essendo dato nel Castel nuovo di Napoli al primo di giugno dello stesso anno. Dietro a questa real grazia Lupo Ximenes de Urrea con lettera viceregia sottoscritta in Palermo ai 30 di agosto del medesimo anno ordinò al capitano, al patrizio, ai senatori, e ai giudici di Catania, che immediate si mettessero in possesso dell’ottenuto privilegio, aprendo l’università, ed assegna per ragione di questa sua sollecitudine, il pericolo in cui erano, se moriva il papa, di perderlo, perchè dice, che le bolle dei papi per la loro morte restano senza effetto, se prima non se n’è cominciata l’esecuzione. Entrando l’anno 1446 pensò questo governante di convocare in Palermo il generale parlamento, che per quanto a noi costa, non si era più radunato da dodici anni, anzi fin da che il re Alfonso era stato in Palermo l’anno 1433. Non sappiamo precisamente il giorno in cui fu tenuto; il Mongitore 237 non lo accenna 238, e solo racconta, che il vicerè, che ei chiama Gio. Lopez Durrea, propose agli ordini dello stato, che il re, poichè avea ricevuti molti opportuni sovvenimenti da loro per l’acquisto del regno di Napoli, proponea per non più aggravarli la ricuperazione dei beni del suo regio padronato, che in quella guerra avea o venduti, o pignorati, e che ricercava perciò qualche donativo. Soggiunge che il parlamento gli fe’ un dono di cento venticinque mila fiorini, ed elesse per suoi ambasciatori a Napoli Simone di Bologna cittadino, ed arcivescovo di Palermo 239, Federico Abbatellis, Giovanni Antonio Barresi barone di Pietraperzia, e Andrea Castelli, i quali portassero questa offerta al re, e chiedessero alcune grazie al medesimo, che credeansi necessarie al vantaggio del regno. Questo, per quanto a noi costa, è il primo parlamento, in cui siesi introdotto l’uso di fare anche al vicerè un donativo, che fu allora stabilito di cinque mila fiorini. Di questi quattro ambasciadori del parlamento si fa menzione nei capitoli del regno 240, nei quali sono anche rapportati il memoriale che eglino fecero a nome del parlamento a S.M., e le grazie che richiedeano in cinquantuno capitoli, colle risposte di quel sovrano, che benignamente le accorda con piccole riserve, come può ivi diffusamente osservarsi. Fu sottoscritto il real chirografo ai 23 di ottobre del medesimo anno apud 235 V. Coco, Leges latae a Ferd. III ad augendum Gymnasium Catinae, p. 10. Cronol. de’ signori Vicerè di Sic., pag. 12. 237 Mem. Istor. de’ Parl., t. I, p. 60. 238 Dobbiamo in questo luogo avvertire, che il Mongitore nel citato luogo asserisce che il detto parlamento fu tenuto nella cattedrale di Palermo, quando dagli atti di esso parlamento (pag. 93) si rileva, che si radunò in la sala grandi di lu Regiu Hospicio, seu Steri di la dicta chitati, nella piazza detta della Marina, dove fino all’età nostra dimorò l’abolito Tribunale del S. Uffizio. Questi atti furono trovati fra’ manoscritti del detto canonico dal di lui nipote il parroco Francesco Serio, che nella terza edizione de’ parlamenti fatta l’anno 1749 li pubblicò per la prima volta. Forse il di lui zio, quando scrisse le memorie storiche de’ parlamenti, non avea ancora avuti nelle mani quegli atti, e suppose che la radunanza si fosse fatta nel duomo di Palermo. Questo errore è avvertito dal Serio. 239 Il Caruso (Mem. Stor. part. III, lib. III, p. 58) lo chiama monsignor Abbatelli; ma si vede che codesto fu uno sbaglio del copista, chiamando egli dappoi Simone Bologna l’arcivescovo di Palermo. Forse egli avea scritto Beccadelli, che era il vero cognome di questo prelato, e l’amanuense vi pose Abbatelli. 240 Tom. I in Alphonso, p. 333. 236 - 54 - Maczonum Rosarum prope Hospitalettum; che era il campo presso a Capua, dove ritrovavasi il re per marciare coll’esercito contro di Francesco Sforza, per riacquistare la Marca alla santa sede. In questo istesso giorno, e verisimilmente ad istanza dei suddetti ambasciadori, fu dal re approvato, e sottoscritto il rito del regno di Sicilia 241. Noi abbiamo parlato nel capo IX di questo libro dell’errore dell’Auria, che suppone che fosse stato promulgato questo rito mentre il re Alfonso era in Palermo, e abbiamo ivi detto che forse allora sarà stata data l’incombenza di stenderlo. Potremmo [72] in questo luogo additare, quanto sia necessario alla nostra età che questo stesso rito, il quale allora fu creduto il più opportuno, ed oggi vien riputato difettosissimo, o si abolisse, o si correggesse; ma ci rimettiamo a quanto abbiamo scritto nella nostra storia 242, rapportando i sentimenti di un giureconsulto, che ne appalesa per minuto tutti i difetti. Egli è a credersi, che terminato appena il mentovato parlamento il vicerè Lupo Ximenes de Urrea, valendosi della facoltà ottenuta dal re Alfonso di potere a suo piacere abbandonare la Sicilia per lo spazio di sei mesi, sia partito dal regno; imperocchè noi troviamo nell’uffizio del protonotaro 243 un dispaccio viceregio dello stesso, per cui in forza dell’autorità conferitagli da S.M., quando ai 25 di giugno 1445 fu eletto vicerè proprietario, elegge per presidente del regno durante la sua lontananza Antonio Rosso. Questo dispaccio è dato in Palermo ai 15 di giugno 1446. Questo cavaliere, cui si dà ancora l’altro cognome di Spadafora 244, era il conte di Sclafani, e noi lo vedremo ben due altre volte lasciato dal mentovato vicerè per presidente del regno. Per qual motivo ei sia partito, e dove sia andato, non si sa; nè viene da verun monumento additato; ma verisimilmente sarà ito a salutare il re Alfonso in Napoli, da cui era estremamente amato, e forse a conferire con esso intorno agli affari del regno di Sicilia. Ritornò egli presto a riprendere l’esercizio della sua carica, trovandolo noi in Sicilia l’anno seguente 1447, dove si trattenne tutto l’anno di appresso 1448, e parte dell’anno 1449. Era il re Alfonso in guerra coi Veneziani, e col conte Francesco Sforza per sostenere il duca Filippo di Milano, contro di cui costoro aveano prese le armi. Or siccome quelli erano potentissimi per mare, i Milanesi credettero, che facendo loro una guerra marittima, sarebbe stato agevole il distrarli dall’assedio di Milano. Fu pregato perciò il nostro re, perchè preparasse una flotta per tenere occupati i Veneziani a difendere il loro commercio. Alfonso non era in istato di far fronte con una poderosa classe ai medesimi; volendo nondimeno compiacere il duca, da cui riconoscea la sua libertà, e quella dei fratelli, fe’ armare una grossa nave da carico, il di cui comando fu dato ad Innico Davalo riputato per uno dei più sperimentati capitani nelle guerre marittime, con ordine di dare la caccia alle navi veneziane, che venivano da Alessandria. Questo illustre uomo unendo alla nave affidatagli dal re un’altra più piccola, che avea predata verso Tunisi, cominciò ad incrocicchiare nel mare jonio, e a far danno ai trafficanti veneziani. Interessava moltissimo a quella repubblica la libertà del commercio, che era allora la sorgente delle sue ricchezze; e perciò udendo le scorrerie di queste barche comandate dal Davalo, fe’ tosto armare sei navi da carico, cui unì quindici galee con ordine d’inseguire le navi reali, e discacciarle da quei mari. Arrivata la flotta veneziana nel mare jonio, Innico, che conoscendosi di gran lunga inferiore non avea voglia di menar le mani, pensò meglio di mettersi al largo, e prese la via di Sicilia. Le navi veneziane accortesi della sua fuga, cominciarono ad inseguirlo, ed a far forza di vele per raggiungerlo; ma sopravvenuta la notte non furono più al caso di riuscirvi, ed egli ebbe campo di salvarsi a Siracusa. Non perciò si smarrirono i Veneziani, ma coraggiosi entrarono violentemente in quel porto. Fu tosto avvisato Lupo Ximenes de Urrea nostro vicerè del pericolo in cui erano Siracusa, e le navi reali. Laonde diviato si partì da Palermo con una numerosa cavalleria, sforzando la marcia per volare al soccorso. Mentre questi si affrettava di arrivare sollecitamente, il Davalo si era fortificato, avendo fatto costruire innanzi delle sue navi una barriera di legni, e avendo anche gettati dei ponti al lido, affine di essere soccorso dalla città. Purnondimeno i Veneziani essendo assai numerosi, ruppero la barriera, ed attaccarono la zuffa. Molte furono le scaramucce sanguinose fra i Veneziani, e i nostri sostenute dalle milizie, che seco avea condotte il vicerè, nè lasciò l’artiglieria di Siracusa di tuonare contro i nemici, e grande fu la mortalità dall’una, e dall’altra parte. Quantunque le forze dei Veneziani fossero superiori, giacchè la loro flotta fra navi, e galee era di ventun legno, nondimeno non potè giammai riuscir loro d’impossessarsi delle due navi reali. Si era avuta l’avvertenza, come abbiamo osservato, di tenerle come legate al [73] lido per mezzo dei ponti, ed erano sempre soccorse da truppe fresche, che somministrava la città, nè fu perciò possibile di distaccarle. 241 Ivi p. 272. Lib. ultimo, cap. 22. 243 Registro degli anni 1446-1447, VIII Ind., f. 51. 244 Amico, Chronol. de los Virreyes de Sicil., pag. 6. 242 - 55 - Irritati i Veneziani della costante resistenza che trovarono nelle due reali navi, nè più sperando d’impadronirsene, malgrado la superiorità delle loro forze, non potendo altrimenti vincerle, pensarono di disfarsene col fuoco, e fatta avvicinare una barca incendiaria 245 questa le bruciò, senza che, dice il Fazio 246, vi fosse stato modo di salvarle. Vincenzo Auria 247 racconta, che per le diligenze usate dal vicerè d’Urrea fu liberata una delle navi regie dalle fiamme, e lo stesso avvisa il padre Abate Amico 248, citando l’uno, e l’altro il Panormita 249. Sarebbe la testimonianza di questo uomo illustre di gran peso, come di uno scrittore contemporaneo, che stava ai fianchi del re Alfonso, ma noi sospettiamo a ragione, che il fatto rapportato dal Beccadelli sia diverso da quello, di cui ragioniamo. E primieramente il Panormita parla di un incendio di una nave regia, mentre Lupo Ximenes de Urrea era già vicerè di Napoli: Lupus Simoninus Durreae Dominus per id temporis Neapoli proregem agens, onore che gli fu accordato assai posteriormente. In secondo luogo mentova due navi grandissime: navem alteram ex duabus, quas instar montium rex aedificaverat, quando noi sappiamo che delle due navi che comandava Innico Davalo una sola era grande, e l’altra piccola. Di poi pare dal contesto che Lupo fosse allora a Napoli, quando sappiamo che era in Sicilia, e a Siracusa. Inoltre questo incendio descritto dal Panormita viene attribbuito alla negligenza dei marinari: Nautarum negligentia deflagrasse, come se fosse stato un incendio accidentale; e da ultimo il Beccadelli non fa motto veruno nè di Siracusa, nè dell’assalto dato alle navi regie dai Veneziani, nè della nave incendiaria, con cui fu alle medesime appicciato il fuoco: circostanze tutte, che questo diligente scrittore certamente ommesse non avrebbe. Noi perciò staremo al racconto di Bartolomeo Fazio, autore ancor esso contemporaneo, che stava nella corte di Alfonso, il quale ci attesta che ambedue furono divorate dal fuoco, senza che l’umana diligenza le avesse potuto salvare: appulsa navi incensa illas cremaverunt, nec ulla humana ope inhiberi, restinguive incendium potuit 250. È molto verisimile, che Lupo Ximenes de Urrea, dopo la improvvisa partenza che far dovette per marciare al soccorso di Siracusa, e delle navi regie assalite dai Veneziani, volendo portarsi in corte per dar conto al re Alfonso di ciò che era accaduto, abbia lasciata come una reggenza, che regolasse interinamente gli affari del regno. Fu questa composta da quattro maestri razionali, i quali furono Adamo Asmundo, Pietro Speciale, Calcerano de Corbera, e Pietro Gaetano, dal maestro segreto Giovanni Abatelli, da quattro [74] giudici della gran corte, e dal conservatore di quel tempo. L’atto almeno di elezione di costoro, come presidenti del regno, fa menzione della necessità in cui era questo vicerè di andare alla corte per conferire col re affari che riguardavano il suo reale servigio 251, ed è dato dei 23 di luglio XII indizione 1449. Non sappiamo se prima di questo fatto di Siracusa sia accaduto il tumulto di Modica, che vien rammentato dal Caruso 252, e dal padre Abate Amico 253. Scrivono eglino che avendo Giovanni Bernardo Caprera figliuolo del famigerato Bernardo, e signore di Modica con angarie disgustati i suoi sudditi, questi presero le armi, e tumultuando contro il padrone, cui imputavano una intollerabile tirannia, e la usurpazione ancora dei reali diritti, inalzarono le reali insegne. Il vicerè informato di questa sollevazione chiamò presso di se Giovanni Bernardo per discolparsi, e spedì in Modica due ministri non solo per sedare quei moti, ma per esaminare ancora se il conte fosse reo di quei delitti, di cui era incolpato. Fattosi il processo si trovò che ei vessava i Modicani, e insieme rendea sue le ragioni della corona. Laonde conosciutasi la sua reità fu dal 245 Il Fazello (dec. II, lib. IX, cap. 9, pag. 184) lasciò registrato, che i Veneziani per consiglio di uno de’ marinari del re, che era disertato e si era ricoverato presso di loro, aveano riempito la poppa la prora, e l’albero di una nave che aveano seco, di foglie secche di alberi, e aspettato che il vento soffiasse verso le navi regie, dandole fuoco ve la spinsero, e così accadde il mentovato incendio. Lo stesso vien raccontato dall’Auria (Cronol. de’ signori Vicerè di Sicil., p. 13), che verisimilmente copiò il Fazello. Queste particolari circostanze non sono punto additate dal Fazio, da cui abbiamo questo fatto. 246 Rer. suo temp. gest., lib. IX, p. 329 e 330. 247 Cronol. de’ signori Vicerè di Sic., p. 13. 248 Nelle note al Fazello dec. II, lib. IX, cap. 9. not. 9, p. 187. 249 Dicta, et facta Alphonsi regis, lib. III, n. 9. 250 Questa disgrazia, prosegue a raccontarci il Fazio (Rer. suo temp. gest., lib. IX, p. 330) indusse Alfonso ad ordinare che si armassero tosto dieci galee, il comando delle quali fu affidato a Bernardo Villamarino, con ordine di marciare nel mare adriatico, e fare mano bassa sopra i Veneziani. Questi ne aveano altrettante, e avendo udito che si avvicinava la flotta regia, uscirono dal loro porto, e andarono in cerca della medesima per batterla. Una improvvisa tempesta disperse le galee veneziane, cinque delle quali trasportate da’ venti vennero verso Epiro. Forse lo stesso turbine avea obbligata la flotta reale ad andare in quel mare, la quale si era ricoverata nel porto Coturnino. Accortosi il bravo ammiraglio Villamarino dell’avvicinamento delle cinque galee veneziane sortì da quel porto, e andò incontro alle medesime per batterle, le quali alla vista del nemico, essendo in minor numero, presero la fuga. L’inseguì Bernardo, ed ebbe la sorte di averne nelle mani tre, quantunque due fossero vote, giacchè la ciurma, presentendo il pericolo, presa terra erasene scappata. Proseguì il Villamarino il suo viaggio nell’Arcipelago, recando infiniti danni a’ Veneziani, e impossessandosi di molte barche di quella repubblica. Questa guerra marittima durò più di un anno, nel qual tempo le due potenze scambievolmente si offesero, ma i loro stati molto soffrirono, essendo cessato il commercio fra i Veneziani, e i sudditi del re Alfonso, specialmente nella Puglia, nell’Abruzzo, a Bari, e in Sicilia, come attesta l’autore degli annali napolitani (p. 1130). 251 Registro della reale Cancelleria dell’anno 1449-1450, XII Indiz., f. 346. 252 Mem. Stor. part. III, lib. VI, p. 60. 253 Lexicon Siculum Vallis Neti, part. II. art. Motyca, p. 104. - 56 - vicerè condannato all’ammenda di sessanta mila scudi, per cui non avendo denari in cassa fu costretto a vendersi tre grosse terre, cioè il Comiso, Giarratana, e Spaccaforno 254. Di questo tumulto, salvo i due mentovati scrittori Caruso, ed Amico, niun’altro de’ nostri storici ha parlato, e lo stesso Placido Caraffa, che fa la storia di Modica, neppure l’accenna. Alcuno di questi presidenti eletti ai 23 di luglio 1449 dimorò in Girgenti, trovando noi nella regia cancellaria molti dispacci dati in detta città, ne’ quali è sottoscritto Calcerano de Corbera, trai quali l’ultimo dei 28 di agosto dello stesso anno 255. Ritornò però presto in Sicilia il vicerè d’Urrea, osservandosi i suoi nuovi dispacci nel mese di settembre 1449, e vi si fermò pochi mesi; imperocchè entrando l’anno 1450 partì di nuovo, e lasciò per presidente del regno Simone Bologna arcivescovo di Palermo. La elezione fu fatta ai 3 di gennaro 256, ma poco ve lo lasciò, cioè sino ai sette, o otto di maggio, avvegnachè noi ritroviamo che il Bologna dispacciò sino ai sette del detto mese, e al dì 9 dello stesso comparvero i nuovi dispacci di Lupo Ximenes de Urrea, come si può osservare nell’accennato registro. Ma se abbiamo ignorato con certezza il tumulto di Modica dell’anno 1449, non possiamo sicuramente dubitare di quello che accadde in Palermo all’anno di cui ragioniamo 1450, come quello che vien contestato non solamente dai nostri storici, ma da pubblici monumenti ancora. Era l’annona amministrata, come allo spesso succede, trascuratamente da coloro ai quali ne stava affidata la cura; e perciò mancava l’abbondanza dei viveri, che è cosa necessaria nelle città popolose, perchè vi regni la tranquillità. Lupo Ximenes vicerè ritrovavasi in Messina, dove forse da Napoli era venuto, per essere più a portata di custodire il regno nella guerra, che ancor faceano i Veneziani; e la di lui lontananza influiva probabilmente ad accrescere la negligenza dei ministri. La mancanza delle vettovaglie cominciò a rincrescere al popolo: la plebe niente soffre meno, quanto la carestìa; un sordo mormorio cominciò ad udirsi per la città, si faceano delle aspre doglianze, perchè le piazze non erano provvedute, e si stentava ad avere i viveri, e questi per i soliti monopolii si otteneano a prezzi esorbitanti. Non essendo ascoltati dai sordi ministri i lamenti popolari, dalle querele venne la plebe ai fatti, e prese le armi assaltò dapprima le case degli uffiziali dell’annona, e le saccheggiò. Di poi rivolta a quelle dei cittadini ubertosi, ai quali attribuiva la carestia, le spogliò a viva forza. Per quietare questi rumori dei sollevati non vi erano forze bastanti. Il [75] senato, che avrebbe potuto calmare la sedizione, era appunto incolpato, perchè per incuria di esso era la città sprovista, e perciò se vi si fosse provato, lungi dal fermare il corso all’incendio, lo avrebbe maggiormente acceso. Eravi in Palermo Leonardo di Bartolomeo signore della Trabìa, e protonotaro del regno, di cui si è parlato al capo XI di questo libro, cavaliere amato dal popolo, ed autorevole, il quale si rese al luogo dove era la folla dei tumultuanti, e con buone maniere, e dando altronde le provvidenze affinchè il pane non mancasse, venne a capo di tranquillare la città 257. Udita il vicerè in Messina la notizia del fermento che era in Palermo, si affrettò a partire per ridursi a questa capitale. Racconta il Fazello 258, che avvicinatosi il Durrea in Palermo, i cittadini gli serrarono le porte, e negarono di riceverlo, se prima non accordava loro il perdono anche a nome del re. Sembra a noi inverisimile questo fatto, che li avrebbe resi più colpevoli: giacchè avrebbono irritato l’animo del vicerè, laddove doveano renderselo benevolo, per ottenere più agevolmente dal re la desiata venia. Dunque crediamo che fu ricevuto onorevolmente, e supplicato a mediarsi presso il re; perchè rimettesse la colpa dei passati popolareschi movimenti. Il re Alfonso volle che prima subissero la dovuta pena i capipopoli, e poi accordò che la città spedisse i suoi inviati per ottener clemenza a favore degli altri. Si trova registrato presso il Fazello 259, che vi fu mandato il solo padre Giuliano Majali monaco Benedettino 260 del monistero di S. Martino delle Scale, che per la sua pietà e destrezza era in molta riputazione presso il sovrano. Noi però da un monumento, che rinviensi nell’archivio del senato di Palermo, e che fu pubblicato da Michiele del Vio 261, 254 Fu, dicesi, la prima comprata da Periconio Naselli de’ principi di Aragona, la seconda da Simone Settimo cavaliere Pisano, e la terza da Antonio Caruso maestro razionale. Le due prime si possedono ancora dalle ridette famiglie Naselli, e Settimo, ma la terza passò poi per via di femina, cioè d’Isabella figliuola di Antonello Caruso, nella casa Statella dei principi di Mongelini, essendosi maritata a Francesco l’anno 1520. Si osservi per conoscersi quanto allora valesse la moneta, che lo stato di Spaccaforno, che era la maggiore di queste terre, non fu venduto che per undici mila scudi, che oggi rende più di annuale profitto. 255 Registro della regia Cancelleria dell’anno 1448-1449, XI. Ind., fogl. 244. 256 Ivi fogl. 166. 257 Il Fazello (deca II, lib. IX, t. III, p. 183) scrisse che questo cavaliere per quietare il popolo vi sagrificò la vita; imperciocchè mentre girava per la città acciò si sopisse la sollevazione popolare, fu ucciso da Tommaso Crispo. Non è ciò inverisimile, avvegnachè noi veggiamo poco dopo Giovanni Agliata col carattere di protonotaro del regno. 258 Deca II, lib. IX. 259 Ivi. 260 Il Caruso lo chiama abate di s. Martino, ma si sbaglia. Il padre Giuliano non fu mai abate ma semplice monaco, il quale, salvo le occasioni in cui il servizio del re, o il pubblico bene della patria lo chiamavano dalla sua spelonca, menò sempre una vita solitaria nell’antico monistero detto delle Ciambre presso la terra del Borgetto, dove al presente fra le rovine si mostra la piccola celletta, in cui egli abitava. 261 Privilegia felicis, et fidelissimae urbis Panhormi, p. 314. - 57 - ricaviamo che egli ebbe per compagni Antonio de Luna conte di Caltabellotta camerlengo del re, Giovanni Abatelli maestro segreto, e Giovanni Agliata protonotaro del regno. Che questa ambasceria sia stata mandata principalmente dalla città di Palermo per la occasione del tumulto, di leggieri appalesasi dalla prima dimanda che fecero gl’inviati, la quale sta compresa nei seguenti termini: In primis supplica la universitati di la dicta chitati a la dicta maestati, ki actenti li antiqui et grandi servicii, et subventioni moderni facti per la dicta chità a la sua maestati et la fidelitati, la quali ha sempri mustrata a la maestati predicta, ki sia sua merci actentu comu esti ja notoriu, ki li principali homini di la dicta chitati tantu officiali, quantu li gintili homini, et altri multi chitatini et burgisi, li quali solinu fari, et presentari la universitati predicta, secundu la antiqua observantia, non hajanu intervenutu, non cunsentutu a lu tumultu noviter factu in la dicta chitati, declarari regii consilii deliberatione praehabita, et de certa scientia la dicta universitati essiri absenti immuni et inculpabili di lu tumultu predictu, et essiri stata et essiri in la solita fidelitati di sua maestati 262. Quetati i tumulti di Palermo, e spediti gli ambasciadori della città per ottenere dal re il perdono, per comando dello stesso sovrano il vicerè Lupo Ximenes de Urrea convocò in Palermo l’anno 1451 il generale parlamento nella sala del vecchio palagio detto lo Steri. Il preciso giorno, e mese, in cui fu tenuta questa adunanza, non si sa, ma si sa bene che gl’inviati spediti dagli ordini dello stato, per fare ad Alfonso l’offerta del donativo, e supplicarlo di molte grazie a favore del regno, ottennero da questo principe le medesime agli 8 di aprile dello stesso anno, e per conseguenza questo congresso dovette tenersi o in gennaro, o in febbraro, o al più in marzo 1451. Espose nell’apertura del parlamento il vicerè 263, che il re per le ingenti spese fatte per la conservazione dei suoi regni era stato costretto ad impegnare, vendere, o alienare i beni del [76] regio demanio, e che pensando ora di ricuperare ciò di cui avea spogliato il regio erario, bramava a questo effetto di essere colla solita affezione, e liberalità soccorso dai suoi fedeli vassalli di Sicilia. Considerata la dimanda ragionevole fatta a nome di S.M., volendo i tre ordini del regno addimostrare alla medesima la premura che aveano di compiacerlo; assegnarono al medesimo il donativo di cento cinquanta mila fiorini da pagarsi al regio tesoriere fra lo spazio di anni otto d’indizione in indizione, e destinarono gli ambasciadori a nome del parlamento, per fargli in Napoli codesta offerta, e per richiedergli alcune grazie in vantaggio del regno 264. Nel detto parlamento fu anche offerto il donativo di cinquemila fiorini al vicerè introdottosi nell’antecedente. Sebbene gli atti non dicano quali fossero stati gli ambasciadori destinati da questo parlamento, nondimeno il parroco Francesco Serio nelle note che fa ai parlamenti promulgati dal suo zio canonico Mongitore 265 dice, che costoro furono il padre Giuliano Majali, il conte di Caltabellotta, Gio. de Abatellis, e Gerardo Agliata. Gli stessi si vedono nominati nel tomo I dei capitoli del regno stampati da monsignor Francesco Testa 266, nè è inverisimile che il parlamento, per non fare maggiori spese, abbia incaricati di questa offerta, e della dimanda delle grazie quegli stessi ragguardevoli soggetti, che poco prima la città di Palermo avea destinati alla corte per chiedere dal re il perdono per il passato tumulto, ed altri favori a vantaggio dei cittadini, e della sua università. Questi inviati adunque, che furono incaricati a nome della città di Palermo, ebbero modo di far gradire ad Alfonso l’offerta del parlamento, e di ottenere dal medesimo le grazie che sono additate nei capitoli del regno 267, che quel sovrano segnò a Puzzuolo agli otto di aprile dell’anno 1451. In capo a tre giorni, cioè agli 11 dello stesso mese, come ambasciadori della città di Palermo, ottennero dallo stesso monarca un altro dispaccio, in cui sono registrati il perdono, e le grazie, che egli accordò alla medesima 268. Così, contenti di avere felicemente adempiute ambe lo commissioni loro appoggiate, ritornarono gloriosamente in Sicilia. Il genio viaggiante di Lupo Ximenes de Urrea, che correa da Sicilia a Napoli, e da Napoli in Sicilia, e che, quando era in questo regno, ora andava in una città, ed ora in un’altra, che noi abbiamo osservato finora, ed osserveremo in appresso, par che siesi fermato alquanto, quando l’anno 1450 ritornò presso di noi, avvegnachè non veggiamo che si sia più mosso sino al mese di maggio 1452, e per quanto dai viceregî dispacci si ricava, la di lui dimora fu sempre nella capitale. Noi proseguendo la storia cronologica di questo vicerè dobbiamo in questo luogo rammentare un di lui dispaccio sottoscritto in questa città ai 13 di maggio 1451, che ci appalesa un aneddotto curioso, che da alcuno dei nostri storici nazionali non ci è stato additato, e che cavasi dal detto monumento tratto dalla regia cancellaria 269. Eccolo: 262 De Vio, Privilegia Urbis Panhormi, p. 315. Mongit., Parlam. gen. di Sicilia, t. I, p. 97. 264 Mongit., Parl. di Sic., t. I, p. 97. 265 Ivi, pag. 98, nota a. 266 Cap. Regni Sic. in Alphonso, p. 359. 267 Ivi. 268 De Vio, Priv. Urbis Panhormi, p. 314 e seg. 269 Registro dell’anno 1450-1451, XIII Ind., f. 228. 263 - 58 - Il re Alfonso ritiratosi alla Torre del Greco in compagnia della sua cara Lucrezia Alagni, dopo di essersi pacificato coi suoi nemici, stavasene a menare una vita tranquilla; ma inaspettatamente trovò che gli ecclesiastici gli aveano suscitati dei sinistri nelle Spagne, e principalmente nei regni di Valenza, di Majorca, e nei contadi di Rosciglione, e di Ceretana. Pretendea questo monarca sopra i beni ecclesiastici, e quelli dei luoghi pii, che segli pagassero le decime, le primizie, e gli altri diritti che dovevansi sulle possessioni, che i prelati e le chiese godevano, per la plausibilissima ragione, che i pesi reali si dovessero da tutti del pari soffrire, senza che mutassero condizione, perchè dalle mani laiche fossero passati i beni nelle ecclesiastiche. I prelati di allora, che pensavano diversamente da quel che ora mossi dalla ragione o dalla forza pensano, udirono con orrore la pretenzione di questo monarca, e perciò se gli opposero gagliardamente, sostenendo che i beni da loro posseduti erano liberi, nè poteano esser soggetti a peso alcuno. Alfonso dispiaciuto della loro ostinazione fe’ prima esaminare dai suoi giureperiti questo affare, ed essendosi dai medesimi sentenziato che legittimo era il di lui diritto, cominciò ad esigere colla forza ciò che gli ecclesiastici non voleano di buona voglia dargli. L’esecuzione dei reali ordini irritò gli ecclesiastici, i quali vedendo diminuite le loro rendite, cominciarono ad incolparne gli esattori, [77] dichiarandoli incorsi nelle censure fulminate dai canoni contro gl’invasori delle rendite delle chiese. Quindi oltre le quistioni nate fra’ prelati e i ministri, delle quali il popolo rimanea scandalizzato, questi da certuni erano riputati come veramente scomunicati. Era allora nel soglio pontifizio Niccolò V, che era stato il successore di Eugenio IV, il quale udendo i rumori suscitati in Ispagna, riputò esser suo dovere di smorzare in culla questo incendio, e pregò Alfonso, che si contentasse, che questa controversia fosse da lui decisa, come capo della chiesa cattolica. Vi consentì questo re, e in forza di questa compiacenza fu ordinato ai prelati di Valenza, di Majorca, e dei due mentovati contadi, che andassero, o spedissero i loro procuratori in Napoli, dove S.S. avrebbe inviato un cardinale legato, da cui si sarebbe dato fine a questa lite. Fu dunque destinato a quella corte Giovanni Cardinale del titolo di S. Lorenzo in Lucina, il quale arrivato in quella capitale, avendo radunati nella sala arcivescovale i vescovi che vennero da Spagna, e i procuratori di coloro che non vi si portarono, e delle altre chiese, e luoghi pii dei suddetti regni, e contadi, e udite le loro pretensioni, e le ragioni sulle quali si appoggiavano, andò poi più volte a conferire col re, e dopo varî andirivieni, indusse finalmente i prelati, e procuratori delle altre chiese a fare un donativo ad Alfonso, e questi a contentarsene, restando così il re ricompensato in parte di quel che volea, e quelli soddisfatti, che non restasse lesa la loro pretesa immunità reale. Fu stabilito poi che questo donativo fosse di ducentocinquemila e quattrocento fiorini; ma protestando i prelati, e procuratori delle chiese contradicenti, che non poteano portare questo peso, il cardinale determinò che si riparasse in questo modo: cioè che ne avrebbero pagati cento ottantacinquemila, e quattrocento gli ecclesiastici di Aragona, di Valenza, di Catalogna, di Majorca, di Minorca, e dei contadi di Rosciglione, e di Ceritana; quindicimila le chiese di Sicilia, e cinquemila quelle di Sardegna 270. Di tutto questo fatto dà conto il vicerè Lupo Ximenes de Urrea nel mentovato dispaccio dei 13 di maggio 1451, ordinando ai prelati della Sicilia che eseguissero quanto era prescritto nelle ordinazioni fatte dal cardinale legato ai 4 di gennaro 1451. Nell’anno di appresso 1452 fu di ordine del re convocato un nuovo parlamento in Palermo e nella sala del regio palagio dello Steri dal vicerè Lupo Ximenes de Urrea. Non si sa in qual mese, e in qual giorno ne fu fatta l’apertura, non venendoci accennato, ma certamente prima del mese di maggio, avvegnachè dopo li 15 di questo mese partì da Sicilia il detto vicerè, come or ora saremo per dire. L’oggetto di questo straordinario parlamento fu appunto per dimandare un nuovo donativo per ricomprare, o riacquistare i beni del regio erario, che si erano alienati o venduti; giacchè li centocinquanta mila fiorini esibiti nell’antecedente assemblea parlamentaria a questo fine si erano da S.M. erogati per altri più pressanti bisogni. Gli ordini dello stato adunque, conoscendo la giustizia di questa dimanda, dopo varî colloqui determinarono di offerire al re duecentomila fiorini da pagarsi nello spazio di dodici anni, con che veramente s’impiegassero in riscatto delle terre del regio demanio, e delle gabelle regie, e non in altri usi. Furono in questa occasione eletti gli ambasciadori del parlamento, i quali recassero al re questo donativo, e ricercassero alcune grazie vantaggiose al regno 271. Gl’inviati suddetti furono Simone di Bologna arcivescovo di Palermo, Fr. [78] Ambrogio d’Isfar 270 Questa risoluzione fatta dal cardinal legato fu ingiusta, e non potea nascere che da un certo dispotismo, che la corte di Roma usurpava sopra tutte le chiese del cristianesimo. La quistione era fra il re Alfonso, e i prelati, chiese, e luoghi pii di Valenza, di Majorca, di Rosciglione, e della Ceritana. Ch’entravano dunque i prelati, e le chiese, e luoghi pii di Aragona, di Catalogna, di Sicilia, e di Sardegna a portare insieme il peso di quel donativo, che Alfonso ricercava da quelli co’ quali era in contrasto? Ridicola è poi la ragione che apporta il cardinale, da cui dicesi mosso a tassare quelle chiese, che non aveano avuta veruna parte in questo piato: Considerantes, dic’egli, unam solam esse Orbis terrarum Ecclesiam in plures partes, et membra, quae diversas constituunt Ecclesias, divisam. L’unità della chiesa non si riferisce che all’unione della fede, e della comunione col visibile capo della medesima, non mai alle rendite, le quali ciascheduna chiesa possiede da per sè indipendentemente dall’altra. E se vuolsi che la chiesa è una sola rispetto ancora all’entrate, perchè non fe’ il cardinale anche soggiacere a questo donativo la chiesa romana, ch’era la madre di tutte, e dovea darne la prima l’esempio? 271 Mongit., Parl. gen. di Sic., p. 99 e seg. - 59 - abate di S. Martino 272, Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci, e Antonio de Luna Peralta conte di Caltabellotta, i quali furono accolti da Alfonso alla Torre del Greco, dove dimorava, e fecero le loro istanze ai 12 di agosto 1452. Le grazie che furono dimandate al re, e che sono registrate nella raccolta dei capitoli del regno 273, furono o in tutto, o in parte concesse dal re Alfonso, come si può ivi osservare, fra le quali fu molto gradita dai Palermitani quella che accordò loro il diritto per sei anni di poter fabbricare moneta 274. Erano sempre stati i Messinesi gelosissimi del privilegio accordato loro dal re Martino, di coniarsi solamente nella loro città il denaro, e sempre si erano opposti che questo diritto fosse concesso ad altri, e particolarmente ai Palermitani. Come poi abbiano perduto questo gius, e come sia passato privativamente alla capitale, dove solo si battono le monete, lo diremo a suo luogo, quando si parlerà del vicerè conte di S. Stefano. Questa grazia fu tosto dal vicerè fatta eseguire 275. Terminato questo parlamento Lupo Ximenes de Urrea pensò di partirsi da Palermo e di andare a trovare il re in Napoli, e volendo lasciare un presidente, che reggesse la Sicilia, mentre egli ne stava lontano, scelse a questo impiego Antonio Rosso Spadafora conte di Sclafani. Il dispaccio viceregio, che trovasi nell’uffizio del protonotaro 276, è sottoscritto in Palermo ai 15 di maggio 1452, e la ragione che assegna il vicerè, per cui viene mosso a fare questa scelta, è appunto perchè era costretto a passare alla corte per affari che riguardavano il servizio del re. Forse Alfonso avea bisogno dei di lui consigli per la guerra che dovea intraprendere contro i Fiorentini, che malgrado le insinuazioni che egli avea fatto loro fare dai suoi ambasciadori, perchè si separassero della lega col conte Francesco Sforza duca di Milano, divenuto oramai troppo potente in Italia, persistevano costantemente ad aiutarlo colle loro forze 277. Il nostro vicerè era del pari uomo di politica, che di guerra; e perciò non è fuori di proposito, che avesse voluto il re consultarlo, acciò riuscisse questa spedizione; molto più che avea destinato per capo della medesima il principe Ferdinando suo figliuolo naturale, e gli premea che ne uscisse con reputazione. Ritornò in Sicilia il de Urrea nello stesso anno 1452, checchè ne abbiano scritto l’Amico 278, e l’Auria 279, che lo fanno ritornato l’anno seguente. La dimostrazione n’è evidente giacchè abbiamo la prammatica reale confermante la bolla di Niccolò V intorno ai censi sottoscritta da esso in Palermo ai 13 o ai 23, come leggesi nell’esemplare della cancellaria, di dicembre dell’anno suddetto 1452. Erano le usure nel regno di Sicilia montate all’eccesso: ciò che apportava ingenti danni agli abitanti, che aveano bisogno di danaro. Fu perciò implorato il pontefice Niccolò V, acciò mettesse modo all’avidità degli usurarî, il quale con sua bolla data in Roma nel dì ultimo di settembre 1452 prescrisse, che in avvenire non potesse esigersi dal denaro un frutto maggiore del dieci per cento 280. Questa bolla fu confermata con sua prammatica ai 20 di ottobre dello stesso anno dal re Alfonso, e promulgata in Palermo dal vicerè Lupo Ximenes de Urrea al detto giorno di dicembre, e fu poi per tutto il regno pubblicata per ordine viceregio agli 11 di gennaro dell’anno di appresso 1453 281. Non si trattenne in Sicilia questo vicerè, che fino ai 16 del mese di agosto del suddetto anno, nel qual giorno noi troviamo un suo dispaccio viceregio 282, con cui adducendo la solita cagione della necessità di portarsi alla corte per conferire col sovrano alcuni affari d’importanza, sceglie per la seconda [79] volta per presidente del regno l’arcivescovo di Palermo Simone Bologna. È molto probabile che lo stesso Alfonso ve lo avesse chiamato, per affidargli il governo del regno di Napoli durante la sua lontananza. Continuava la guerra contro il duca di Milano, e la repubblica di Firenze, che abbiamo poco fa accennata; e siccome i Veneziani aveano preso a suo carico il portar le armi contro Francesco Sforza Attendolo, così Alfonso si era obbligato di attaccare i Fiorentini, e vi avea mandato con una considerabile armata il suo real figliuolo Ferdinando, che fe’ accompagnare da Federico duca di Urbino, e da Averso Ursino riputati in quella età per 272 Ambrosio Isfar e Cruillas di nobilissima famiglia catalana era abate perpetuo del monistero di s. Martino, secondo la regola benedittina, e il costume di allora, che gli abati governassero, mentre viveano, i monasteri loro destinati. Lasciò scritto Rocco Pirri (Not. Abat. l. IV, not. 1. Sancti Martini Panormi) che questo prelato morì in Napoli nel mese di agosto 1452 dopo fatta l’ambasceria, e fu seppellito nel monistero di Santa Maria di Monte Oliveto, avendo assistito all’esequie lo stesso re Alfonso, e avendovi recitato l’elogio funerale il famoso Antonio Beccadelli detto il Panormita. Per quante diligenze siensi da noi fatte in Napoli l’ultima volta, che andammo in quella città, cioè l’anno 1781, per rinvenire nell’archivio di quel monistero alcuna memoria di questo fatto, non ci potè mai riuscire di ritrovarlo. 273 Tom. I in Alphonso pag. 377 e seg. 274 Ivi, cap. 437, p. 394. 275 Francesco Strada, Aquila trionfante, p. 367. 276 Registro dell’anno 1451-1452, XV. Ind., f. 290. 277 Fazio, loc. cit. lib. X, p. 345. 278 Chronol. de los virreyes de Sicil., p. 7. 279 Cronologia de’ signori vicerè di Sicilia, p. 14. 280 Capit. Regni Sic. t. I, in Alphonso, p. 326. 281 Ivi, pag. 331 e 332. 282 Reg. della regia Cancelleria all’anno 1452-1453, XV Indiz., f. 357. - 60 - valenti capitani, acciò lo agevolassero colle loro truppe, e coi loro consigli 283. La campagna non riuscì molto vantaggiosa nè ai Veneziani contro il duca di Milano, nè alle milizie regie contro i Fiorentini; a tal che scorse la stagione, senza che ne avessero tratto nè Alfonso, nè i Veneziani verun profitto. Siccome poi i Fiorentini aveano chiamato in soccorso Renato d’Angiò, così entrando questi in Italia, e unitosi dapprima con Francesco Sforza, gli affari dei Veneziani andarono di male in peggio, e in breve tempo perdettero quasi tutto il proprio stato 284. Non osando adunque eglino di continuare da sè la guerra, atterriti dalle frequenti disfatte, spedirono ad Alfonso un ambasciadore, per pregarlo affinchè con maggiori forze andasse egli stesso a sconfiggere i Fiorentini; lusingandosi che in codesto modo Renato di Angiò sarebbe tosto corso in di loro aiuto, dai quali era stato principalmente chiamato; il che accadendo, non avrebbono eglino avuto a fronte che il solo Francesco Sforza, con cui solo poteano azzardarsi. Acconsentì questo sovrano alle loro istanze, e promise che al più presto sarebbe andato personalmente contro i Fiorentini 285, e che infatti vi si sarebbe diposto alla seguente primavera. In questo tempo accadde il primo caso di Sciacca, che viene da taluni dei nostri storici tacciuto. Due famiglie cospicue di quella città, Perollo, e de Luna fino dai tempi del re Martino erano sempre state nemiche per dimestici interessi, e conservavano un odio scambievole, restando divisa Sciacca in due fazioni, delle quali erano essi capi, che si trovavano i più ricchi, e i più potenti di quel paese. Una lite vinta contro Pietro Perollo da Antonio de Luna conte di Caltabellotta riaccese lo sdegno di Pietro, che con un infame, e sagrilego attentato assalì con gente armata il conte, mentre ai 6 di aprile 1455 assistea alla solenne processione della sacra Spina, e lo lasciò tramortito in guisa, che fu creduto morto; ma tratto il creduto esangue cadavere in una vicina casetta dagli amici, fu trovato che avesse ancora un residuo di vita, e perciò fasciategli per allora le piaghe, e poi curate, si ristabilì, e andossene al suo feudo per sottrarsi alla persecuzione del nemico. Arrivata la notizia di questo atroce assassinio al vicerè Lupo Ximenes de Urrea, ordinò il processo contro il Perollo, e i di lui complici. Mentre i magistrati raccoglievano le testimonianze, il vicerè fu chiamato, come or ora vedremo, alla corte. Antonio intanto riavutosi dalle sue ferite, e machinando di vendicarsi contro l’assassino, a cui la vista delle recenti cicatrici cotidianamente lo spronavano, non ebbe la pazienza di aspettare l’esito della tarda giustizia, ma radunata una poderosa squadra di uomini armati rientrò in Sciacca cercando il nemico. Questi a sorte non trovavasi nel proprio palagio, e udendo il pericolo era scappato dalla città. Antonio non potendolo avere nelle mani, attaccò gl’innocenti famigliari di esso, che fe’ tutti barbaramente trucidare, e lo stesso macello ordinò contro i parenti e i partitarî di Perollo, apportando la strage, e la desolazione a tutta la città. Nè ancor sazio fe’ incendiare il palagio di Pietro, e le case di tutti i di lui congionti ed aderenti. Questo fatto, per cui Sciacca restò rovinata per ogni riguardo, fu rapportato al re Alfonso, il quale volendo restituire la tranquillità a quello sventurato paese, d’onde colle mani intrise di sangue dei loro cittadini il Perollo, e il de Luna erano partiti, bandì l’uno, e l’altro di questi barbari cavalieri, e fe’ confiscare i loro beni. Dovendo adunque, per ritornare là dove eravamo rimasti, Alfonso disporsi alla nuova campagna, e abbandonare Napoli, non è fuori di proposito, che egli abbia chiamato a sè il nostro Lupo Ximenes de Urrea, così per conferire con esso intorno alla presente guerra, come per affidargli il governo di Napoli. Quel che è certo egli è, che ei fu eletto per vicerè di quel regno, senza toglierglisi il [80] viceregnato di Sicilia, come si fa palese dalla cronaca mss. di frate Angelo di Sciacca 286, e da Antonio Panormita, e Girolamo Surita da noi di sopra citati, quantunque il re per una malattia sopragiuntagli non sia andato poi alla guerra, nè perciò egli abbia esercitato per allora il governo di quel regno. Altri pensieri agitavano la mente di questo sovrano, per cui siesi determinato a trattenere per alcun altro tempo presso di se il nostro Lupo Ximenes de Urrea. La città di Costantinopoli, che era posseduta dai Cristiani, era caduta in potere degli Ottomani ai 29 di maggio dell’anno 1433. Maometto II, malgrado i patti fatti dal suo antecessore con Costantino Paleologo, che n’era il signore, la occupò a gran danno del cristianesimo. Si borbottava contro i principi europei, che guerreggiando fra di loro, aveano trascurato di porgere aiuto all’augusto di Oriente, e sofferto che quella famosa città cadesse nelle mani dei Turchi; e soprattutto n’erano incolpati il re Alfonso, ed i Veneziani, come quelli che erano più a portata di soccorrere Costantino. Vivea ancora il pontefice Niccolò V, che restò dolentissimo di questo caso; e siccome l’impero di quello augusto non era interamente conquistato dai Musulmani, sperando che si potesse tuttavia dare qualche soccorso a quel cadente principe, imprese di pacificare le potenze belligeranti, e d’indurle ad impegnarsi piuttosto in una guerra sacra per isconfiggere il comune nemico. Alfonso non si mostrò lontano dal consentire ai consigli del pontefice, e cominciarono gl’inutili trattati, che non è qui luogo di riferire 287. 283 Fazio, Rer. suo temp. gest., pag. 346 e seg. Macchiavello, Storia Fiorentina, t. II, lib. VI. — Corio, Hist. Milan., part. VI, pag. 946 e 947. 285 Fazio, Rer. suo temp. gest, lib. X, p. 380. 286 Nella libreria del senato di Palermo, p. 409. 287 Fazio, Rer. suo temp. gest., lib. X, p. 393 e seg. 284 - 61 - Per prepararsi però ad attaccare un così potente nemico, qual era Maometto, vi era d’uopo di molto danaro, e perciò Alfonso dopo di essersi giovato dei lumi del nostro Lupo Ximenes de Urrea, lo rimandò in Sicilia, per ottenere dai suoi amorosi vassalli dei sussidî per questa importante guerra. Il ritorno del de Urrea in Sicilia dovette accadere tra’ 27 di ottobre, e i 27 di novembre dell’anno 1455, giacchè noi ritroviamo nei registri della regia cancellaria 288 un dispaccio viceregio sottoscritto ai 27 di ottobre 1455 da Simone Bologna arcivescovo di Palermo, come presidente del regno; e di poi ai 27 del seguente novembre si vede nei medesimi registri 289 di nuovo sottoscritto qual vicerè Lupo Ximenes de Urrea. Noi crediamo che egli siesi nel tempo che dimorò in Napoli, sulle prime occupato ad agevolare il suo re nella guerra, che volea continuare contro i Fiorentini, e contro Francesco Sforza duca di Milano, e per cui avea già preparata un’armata forte di nove mila cavalli, e di quattro mila fanti. Questa guerra nondimeno non fu proseguita; i Veneziani spossati da tante spese segretamente fecero la pace col duca di Milano, e coi Fiorentini in Lodi, senza prima consultarne, come richiedea il dovere, il nostro sovrano, il quale non era entrato in questo ballo, se non per aiutare i suoi collegati vessati da Francesco Sforza. Dolse ad Alfonso la impulitezza di quei repubblicani, e ne fe’ alte lagnanze col di loro ambasciadore; ma siccome era principe magnanimo, e conoscea che il bene del tutto ricercava la pace, vedutine gli articoli, e trovando, che non erano punto a sè pregiudizievoli, vi acconsentì, e richiamò il figliuolo Ferdinando coll’esercito dalla Toscana 290 . Mentre il re guerreggiava coi Fiorentini, era per conseguenza chiuso ogni commercio fra questi, e i Siciliani. Pur nondimeno, come suole spesso accadere, molti dei nostri faceano occultamente traffichi con quella nazione, malgrado il sovrano divieto. L’uomo corre dove crede di trovare dell’utile, e del guadagno, ed arrischia talvolta di perder tutto per trarre un maggior lucro dalle sue derrate, o merci. Molti erano stati scoverti rei di avere trasgrediti gli ordini reali, e contro altri si stava compilando il processo per gastigarneli. La città di Palermo, madre amorosa dei suoi concittadini ed abitanti, spedì alla corte un certo Leonardo (che non potè certamente essere Leonardo di Bartolomeo 291, e perciò non sappiamo chi mai si fosse stato), per ottenere dal magnanimo, e clemente monarca l’indulto per tutti coloro, i quali avessero, non ostante la sovrana proibizione, praticato, contrattato, trafficato coi Fiorentini, e [81] con altre persone, colle quali era vietata ogni comunicazione. Il re benignamente accolse la supplica, purchè intorno a questo delitto prima dell’arrivo dell’inviato dell’università non si fosse transatto intorno alle pene dovute ai rei. Questa grazia fu segnata da Alfonso nella terra di Trajetto ai 5 di marzo 292 1456, e di poi eseguita da Lupo Ximenes de Urrea in Palermo ai 23 di aprile dello stesso anno, come costa dal dispaccio viceregio pubblicato dal de Vio 293. In questo istesso anno convocò il riferito vicerè il parlamento ordinato dal re Alfonso nella solita sala del regio palagio; non sapremmo però dire in qual mese, o giorno, poichè gli atti non lo accennano. Rapportò egli, che il serenissimo re si era deliberato di andare, o di mandare una flotta navale contro il turco nemico della nostra santa religione per debellarlo 294. Era questo, come si è detto, l’obbietto amato dal pontefice Niccolò V, il quale avea fatta ogni opra per rappacificare i sovrani di Europa, affinchè eglino poi, fra di loro collegati, potessero sconfiggere Maometto II, che era divenuto assai potente, e temerario. Ne venne egli a capo prima di morire, essendosi pacificati tutti i principi belligeranti, esclusa la repubblica di Genova, e collegati, come bramava, contro il comune nemico col trattato che è diffusamente riferito dal Fazio 295. Ma non potè avere il piacere di vedere incominciata la guerra contro il sultano di Constantinopoli, essendo stato rapito dalla inesorabil morte ai 24 di marzo dell’anno 1455. Quantunque poi coll’elezione di Callisto III (il quale da suddito, e consigliere intimo di Alfonso, mentre era un privato, diventò suo nemico, qualora fu fatto papa) questo progetto contro il turco non avesse allora avuto effetto, nondimeno il re continuava a nudrire questo pensiero, e perciò richiese nel ridetto parlamento un donativo, con cui potessero armarsi sei galee, e mantenersi per tutto il tempo di questa impresa. I parlamentarii applaudirono concordemente alla sovrana risoluzione, e rincrebbe loro di non potere, come bramavano, agevolarla. Purnondimeno stando loro a cuore 288 All’anno 1455-1456, III Ind., fog. 136. Secondo volume dello stesso anno, pag. 41. 290 Fazio, Rer. suo temp gest., lib. X, p. 383 e seg. 291 Leonardo di Bartolomeo signore di Trabia, e protonotaro del regno era morto, ucciso ne’ tumulti popolari di Palermo, come scrisse il Fazello (dec. II, lib IX, cap. IX), e noi in questo stesso capo abbiamo avvertito alla pag. 75, nota 1. Ciò che comprovasi ancora dal monumento di quell’anno accennato di sopra, e rapportato dal de Vio, in cui rammentasi, come protonotaro del regno, Giovanni Agliata, che dovè essere il di lui immediato successore. 292 Nel monumento prodotto da Michele de Vio leggesi: datum in Civitate nostra Trajecti die quinto mensis Maji quartae Inditionis anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo sexto. Or non è possibile che la grazia del re sia stata sottoscritta a’ 5 di maggio, e l’esecuzione sia de’ 23 di aprile dello stesso anno, laonde abbiamo emendato questo errore, e ci siamo determinati a dire: nel mese di marzo. 293 Privilegia urbis Panhormi, p. 332 e seg. 294 Mongit., Parlam. di Sic., t. I, p. 102. 295 Rer. suo temp. gest., lib. X, p. 408 e seg. 289 - 62 - di compiacere nella forma migliore, che potessero, il loro sovrano, malgrado le angustie nelle quali si ritrovava il regno, esibirono sessanta mila fiorini da pagarsi in due anni, che erano allora bastanti per la fabbrica di quattro galee, destinando per capitani delle medesime il vicerè Lupo Ximenes de Urrea, il famoso Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci, di cui abbiamo più volte favellato in questo libro, il gran contestabile, e il grande ammiraglio del regno 296. Perchè poi il re non restasse defraudato dalla speranza di ottenere dalla Sicilia sei galee, le città di Palermo, e di Messina si offerirono di armarne altre due, una per ciascheduna, ma sotto certe condizioni. Non si fe’ in questo parlamento alcun regalo al vicerè; forse la povertà, in cui era il regno, non lo soffriva. Furono dagli ordini dello stato eletti due ambasciadori, che recassero al real soglio codesta offerta, e dimandassero al re alcune grazie in vantaggio del regno. Il paroco Francesco Serio nelle note della raccolta dei parlamenti 297 scrisse, che gli ambasciadori destinati in questa occasione furono il padre Giuliano Majali, e Federico Abatelli. Lo stesso leggesi nei capitoli del regno 298. Noi nondimeno abbiamo un documento dell’archivio del ven. Monistero di S. Martino, in cui dicesi, che il compagno del Majali fu il vescovo di Girgenti, che era allora F. Domenico Xarth monaco Cisterciense 299. Contiene questo una lettera 300 scritta dai prelati, ed ecclesiastici del regno di Sicilia al padre [82] Giuliano Majali, in cui lo pregano a far presente al re le scarsezze, in cui il regno, ed eglino particolarmente si trovavano, per le quali non erano in grado di offerire un più abbondante donativo. A conciliare questa contradizione non può altro dirsi, se non che l’elezione fu fatta nella persona del vescovo di Girgenti, e che non avendo questi potuto andare alla corte o per malattia, o per altra ragione, sia stato in di lui vece eletto Federico Abatelli. Gradì il re Alfonso l’offerta fatta dal parlamento, e dalle due città di Palermo, e di Messina, per cui veniva compiuto l’armamento, che egli avea ricercato delle sei galee; e per riguardo alle grazie dimandate dai parlamentarî, che furono molte, trattene tre che non credette di dovere accordare, tutte le altre volentieri concesse, comunque ad alcune abbia apposte le necessarie limitazioni. Può ciò riscontrarsi nel tomo I dei capitoli del regno 301, dai quali anche intendiamo, che il reale dispaccio fu segnato in Castelnuovo di Napoli ai 24 di febbraro dell’anno seguente 1457. Il vicerè Lupo Ximenes de Urrea era partito l’anno antecedente 1456 per andare alla corte, dove era stato chiamato dal re Alfonso, forse per conferire intorno alla guerra, che questo sovrano volea fare al turco, e la di lui partenza dovè accadere dopo li 29 di settembre, giacchè in detto giorno noi veggiamo segnato il dispaccio, con cui ci dichiara che essendo stato chiamato dal monarca per affari importanti, in forza del permesso reale, che ha di eligere ogni volta che vuole, un presidente, che reggesse il regno nella sua lontananza, sceglie a questo posto il conte di Sclafani Antonio Ruffo e Spadafora 302, che noi abbiamo più volte rammentato, e veduto nella stessa luminosa carica. Ma la guerra contro il Turco andava di giorno in giorno procrastinandosi, non ostante gli sforzi di Callisto III pontefice romano, che secondando le mire del suo antecessore, procurava ad ogni costo di indurre i principi cristiani a questa impresa. Il re di Francia Carlo VII si era costantemente negato di aderirvi; il Portogallo era imbarazzato in affari più rilevanti; i principi di Germania erano occupati a difendere i loro stati; i Veneziani, che erano in pace con Maometto II, si scusarono di collegarsi; e i Genovesi, che erano in guerra col nostro re Alfonso, quantunque si fossero mostrati pronti a somministrare le loro squadre navali, purnondimeno dimandavano di prima pacificarsi; ciò che non era cosa agevole di ottenere dal nostro re, che era a ragione irritatissimo contro i Campofregosi, che allora comandavano in quella repubblica. Restavano 296 Come si chiamassero il gran contestabile, e l’ammiraglio, resta a noi ascoso; ma sospettiamo che l’ammiraglio fosse stato Antonio Ventimiglia figliuolo del marchese di Geraci Giovanni, che fu un prode conduttore della flotta reale, come a suo tempo avremo luogo di dire, e che naturalmente successe al padre, che occupava questa carica l’anno 1432, come costa dal Surita negli Annali lib. XIV, cap. 4. 297 Parlam. di Sic., t. I, p. 104, nota b. 298 Cap. Reg. Siciliae, t. I, p, 398. 299 Pirri, Not. Eccl. Sic. Not. III. Eccl. Agrig. p. 308. 300 “Venerabilis, et nobis quamplurimum dilecte salutem in Domino. Comu per lo reverendissimo in Christo Patri Episcopu di Girgenti sarriti informatu, congregatu lu Regnu secundu la solita consuetudini supra la peticioni di lo laudabili e santu propositu di lu Signuri Re sopra lu fattu di la Cruchiata, et fattu lu Consiglu per li tri brachi, videlicet Ecclesiasticu, Baruni, et Universitati, tutti una voce laudaru et acceptaru tali proposta. Verum comu vostra Paternità sa, li cosi di quistu Regnu su assai exhausti, et presertim di nui altri Ecclesiastici, chi non potimu offeriri quillu, chi di voluntà haviamu, fichimu una offerta quantu plui possibili fussi, et speramu in Deu adimplirila, e conclusa la cosa, e fatti li Capituli, comu si soli fari, tuttu tu Regnu, zoè tutti li ditti tri brachi havinu elettu la vostra Paternità, chi insembli cum lu predictu Reverendissimu Signuri Episcopu, lo quali fu eletto legatu in quistu, sia a disimpachari quilli cosi, di li quali supplica lu dittu Regnu, comu largamenti per li Capituli, et altri istrucioni vidiriti; cu vui accomandari li facti di quistu Regnu ni pari superchu, non altru. Datum Panormi die X. Februarii IIII. Indict. 1456. Prelati, et Ecclesiastici persuni di lo Regno di Sicilia. Ex Archivio Ven. Monast. S. Martini de Scalis ex originali cum sigillo in charta veteri.” – Forse il Majali era in Napoli ancora, quando fu celebrato questo parlamento. 301 In Alphonso p. 400 o seg. 302 Registro della regia Cancelleria dell’anno 1456-1457, V. Ind., fol. 54. - 63 - perciò impegnati in questa guerra i soli Callisto, ed Alfonso, le di cui forze a paragone di quelle del Sultano erano per così dire una menoma frazione, a tal che era una stravagante presunzione di voler provarsi con così piccolo apparato ad una impresa cotanto strepitosa. Ecco il motivo per cui fu differita la guerra col Turco 303. Allontanatasi per allora ogni idea di apportare le armi contro di Maometto II, Lupo Ximenes de Urrea ritornò l’anno istesso 1457 in Sicilia, e riprese l’esercizio della sua carica. Niente di singolare, che sia a nostra notizia, avea operato nel suo terzo breve governo il conte di Sclafani nella lontananza di Lupo Ximenes de Urrea, se sen’eccettui [83] un dispaccio mandato in Malta, di cui fa menzione l’Abela 304, con cui vietò a quegli abitanti, che potessero armare in corso; e la cagione che si addita di quest’ordine, è appunto il sospetto che vi fosse in mare una poderosa armata di Mori, e che perciò non era conveniente che si lasciasse quell’isola sprovista di gente; avvegnachè mancando eglino, era più agevole ai Mori d’impossessarsene, ciò che sarebbe caduto in grandissimo danno dei due regni di Sicilia, e di Napoli. Sarebbero state le isole di Malta, e del Gozzo un ricovero molto opportuno, e comodo agli Affricani per poter fare più liberamente le loro scorrerìe, ed aveano più volte tentato di averle nelle mani, ma ne erano stati sempre respinti dai coraggiosi Maltesi. Ne conobbe l’importanza, come diremo, l’augusto Carlo V, il quale le concesse poi ai cavalieri dell’ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, dopo che furono discacciati da Rodi, al valore dei quali devono la Sicilia, e il regno di Napoli la loro conservazione. Ritornato, siccome detto abbiamo, Lupo Ximenes de Urrea al suo proprietario governo di Sicilia continuò a reggere colla solita prudenza questo regno sino alla morte del re Alfonso accaduta ai 26 di giugno 1458. Era questo sovrano tutto occupato nella guerra coi Genovesi, che erano anche sostenuti dal re di Francia, il quale avea loro somministrate molte truppe sotto il comando di Giovanni di Angiò figliuolo di Renato. Le cose erano ridotte a tali estremi, che se la morte non avesse reciso lo stame della vita di Alfonso, Genova bloccata per mare e per terra, e ridotta già in fame sarebbe fra pochi dì caduta. Ma Alfonso, mentre si aspettava di giorno in giorno la lieta notizia, che finalmente quella altiera repubblica avea ceduto alle possenti sue armi, s’infermò agli 8 di maggio 1458 nel Castelnuovo, dove abitava, con febbre, che dal suo principio fu creduta dai medici pericolosissima. Purnondimeno, malgrado la gravità del morbo, egli non lasciava di dare le necessarie provvidenze per sconfiggere i Genovesi. Ma sempre più malignando, e imperversando la infermità, passò, forse per cambiar aria, al castello dell’Uovo, dove peggiorò, e finalmente ai 27 del seguente giugno se ne morì nell’età di anni settantaquattro non ancor compiti, lasciando inconsolabili i suoi sudditi, per aver perduto il più grande, e il più magnanimo dei principi di quel secolo, e i Genovesi lieti e contenti per essersi liberati dal più fiero loro nemico, e per avere conservata la libertà, che erano già all’orlo di perdere. Essendo il re Alfonso morto senza figliuoli legittimi, il giorno prima di morire, facendo il suo testamento dichiarò erede di tutti gli stati suoi il re Giovanni sovrano di Navarra, quello stesso che sotto Ferdinando il Giusto col nome di conte di Pegnafiel era nostro vicerè, come fu riferito al libro primo di questa cronologia 305 ; che poi ammogliato colla regina Bianca vedova di Martino il Giovane, ed erede del regno di Navarra divenne ancor egli re. Ne eccettuò il regno di Napoli come regno di conquista, che lasciò al principe Ferdinando suo figliuolo bastardo, che avea fatto prima riconoscere per sovrano dai Napolitani, e per cui avea ottenuta l’investitura da’ due papi Eugenio IV, e Niccolò V. Arrivata la notizia in Navarra della morte di Alfonso, e del suo testamento, il re Giovanni per assicurare gl’interessi del regno di Sicilia, spedì subito al medesimo Lupo Ximenes de Urrea la cedola reale, con cui lo confermava vicerè del nostro regno con quell’istesso potere, che gli era in prima stato accordato dal defunto suo fratello, così nel nostro regno, che in quello di Napoli 306. Era alla corte del re Alfonso il principe di Viano Carlo primogenito del re Giovanni, che per alcuni dimestici disgusti si era allontanato dal padre 307, il quale nonostante che fosse dispiaciuto di Giovanni suo 303 Si emendi perciò il parroco Francesco Serio, il quale nelle note a’ parlamenti t. I, p. 102, nota b, parlando della flotta preparata dal re contro il turco, ci lasciò scritto, che questo preparamento di guerra non ebbe effetto stante la morte seguita del detto re Alfonso a’ 27 giugno del medesimo anno 1457. Alfonso non mori, come si dirà, che nell’anno 1458, e perciò vi era tempo bastante a cominciare almeno questa impresa, se le altre cagioni da noi addotte non l’avessero impedita. 304 Istoria di Malta, lib. IV, nota 1, p. 428. 305 Cap. 2. 306 Surita, Ann. de Arag., lib. XVI, cap. 52, p. 58. 307 A bene intendere ciò che in appresso saremo per dire di questo real principe, fa di mestieri di sapere, che la regina Bianca madre di lui, e sovrana di Navarra morì l’anno 1442, e nel suo testamento lo dichiarò erede del regno suo, e del ducato di Nemours, che le appartenea, come era dovere; ma lo pregò insieme, che, mentre vivea il padre, lasciasse di farsi nominare re, nè se ne valesse senza il permesso paterno. Ubbidiente egli a’ materni avvertimenti si astenne per allora dall’assumere il titolo di re, e dall’amministrare l’eredità che gli cadea, lasciando che il Re Giovanni suo padre fosse riconosciuto qual sovrano della Navarra. Come poi vide che il genitore passò l’anno 1447 a seconde nozze, e pose sul proprio suo soglio Giovanna Enriquez figliuola dell’almirante di Castiglia, femina altera, la quale avendo preso sul vecchio marito un grande ascendente, trattava l’erede del trono di Navarra con dispregio, si pentì della troppa condiscendenza addimostrata alle insinuazioni della madre, e pensò ad occupare la sovranità, che per natura e per testamento segli dovea. Le misure prese per venirne a capo, non furono così ben dirette, che Giovanni - 64 - genitore, fe’ [84] delle pratiche, acciò i Napolitani lo riconoscessero per sovrano, sperando che egli grato a quanto avrebbe operato, o gli avesse ceduto il regno di Napoli, o quello di Navarra. Ma il re Ferdinando, figliuolo di Alfonso, che al salire sul trono trovò tanti emoli che tentavano di rapirglielo, fingendo di nulla sapere dei maneggi del cugino, con somma avvedutezza lo accarezzò in modo, promettendogli la continuazione della pensione assegnatagli da Alfonso, che lo fe’ desistere da ogni ulteriore pretensione, e lo indusse a portarsi in Sicilia coi Catalani del suo partito, dove forse avrebbe potuto migliorare le sue fortune. Giunse questo sfortunato principe in Palermo, e vi fu ricevuto da Lupo Ximenes de Urrea con ogni onorificenza, come vero re di Navarra, ed erede della monarchia di Aragona. Ivi arrivato, o che privo dell’appoggio dello zio Alfonso pensasse seriamente a riconciliarsi col padre, o che ne fosse così consigliato dal nostro vicerè, che era un gran politico, si determinò di spedire ai deputati dei regni di Aragona e di Valenza Giovanni di Morreale suo tesoriere, e Pietro di Ruzza suo consigliero, come inviati, acciocchè quei deputati implorassero dal re Giovanni il perdono. Per via si unì a questi monsignor Giovanni di Aragona arcivescovo di Saragoza, che ritrovavasi in Napoli incaricato ancora egli di procurare la pace fra il padre e il figlio 308. Mentre il principe di Viano dimorava in Palermo, giunse al Ximenes l’ordine di ricevere a nome del nuovo re di Aragona il ligio omaggio dai Siciliani. Il vicerè suddetto a questo effetto convocò un parlamento a Castrogiovanni 309, dove volle anche intervenire Carlo il principe di Viano. Dopo di aver tutti gli ordini dello stato riconosciuto per loro sovrano Giovanni re di Aragona, e di aver fatto nelle mani del vicerè il giuramento di fedeltà, fu discusso quali grazie si dovessero dimandare al nuovo sovrano vantaggiose al regno, e dopo un lungo esame fu risoluto di chiedere le ottantotto, che si trovano registrate nei capitoli del regno 310. Gli atti di questo parlamento si sono perduti, non trovandosi nei nostri archivî; ma ci restano i capitoli delle grazie, dai quali restiamo informati che furono destinati in Ispagna a chiederle, come ambasciadori dei parlamentarî, Simone Bologna arcivescovo di Palermo, Guglielmo Raimondo di Monte Cateno maestro giustiziere del regno, Antonio de Luna 311, altrimenti detto Peralta conte di Caltabellotta gran contestabile del regno, Vassallo Speciali, e il dottore di legge Girolamo Ansalone. La prima, e la seconda delle grazie [85] richieste dal parlamento tenuto in Castrogiovanni riguardavano il principe di Viano primogenito del re. Dimandavano i parlamentarî in primo luogo, che il re Giovanni ricevesse questo suo figliuolo nell’antica grazia, e che lo riguardasse in avvenire colla benevolenza con cui prima l’avea caro. Rappresentarono in secondo luogo 312, che siccome diviene florido un regno colla presenza del proprio sovrano, o di qualche suo figliuolo che lo rappresenti, per la di cui opera resta equilibrata la giustizia, ed impedita ogni cagione che possa apportare la diminuzione, e il crollo dello stato, perciò desideravano i parlamentarî che S.M. in persona venisse per lo meno a visitare la Sicilia per dar riparo agl’inconvenienti nati in essa isola per la lontananza del proprio sovrano; e che intanto che ei si risolvesse a venire, costituisse per suo vicario e luogotenente generale con plenipotenza il di lui figliuolo primogenito Carlo principe di Viano 313, senza permettere che altri in questo frattempo amministrasse il regno colla carica non sapesse renderle inutili. Carlo fu vinto, e imprigionato, nè potè liberarsi dalle ritorte, che alla dura condizione di rinunziare al regno di Navarra, sino che vivesse il padre. Alfonso era stato il mediatore di questa pace, il quale per sottrarlo alle violenze della madrigna lo chiamò in Napoli, e gli assegnò dodici mila ducati di rendita per il suo congruo, e decente mantenimento. Era dunque questo real principe in Napoli, quando Alfonso finì di vivere. 308 Surita, Ann. de Aragon., t. IV, lib. XVI, cap. 48, p. 53. 309 Comunemente gli scrittori nostri nazionali, il Fazello, il Bonfiglio, il Maurolico, l’Auria, il Caruso, l’Aprile, il Mongitore, a’ quali va dietro il francese Burigny, scrivono che questo parlamento fu convocato in Caltagirone, ma sbagliano; giacchè gli ambasciadori spediti in Ispagna da’ tre ordini dello stato attestano nel loro memoriale, che congregatum parlamentum fuit in terra Castri Joannis (Capit. Regni Sic., tom. I in Joanne p. 432), il che anche lasciò registrato il Surita: en el mismo tiempo se tenia parlamento de los estados de quel reyno en Castrojuan. (Annales de Aragon., lib. 16, cap. 53, p. 58). Questo errore dei nostri storici fu avvertito prima di noi da monsignor Francesco Testa nelle note ai capitoli del regno (nota 6), il quale ci avvisa, che i capitoli delle grazie che si domandavano al nuovo re furono sottoscritti a Caltagirone, dove da Castrogiovanni era venuto il principe Carlo primogenito del re Giovanni. Questa per ventura fu la cagione, per cui i riferiti scrittori, vedendo nella sottoscrizione la data di Caltagirone, immaginarono che ivi si fosse anche tenuta la parlamentaria adunanza. Il Mongitore (Mem. Stor. dei Parlam., pag. 52) si fa carico di questa difficoltà, e per conciliare le cose scrive, che il suddetto parlamento: fù convocato in Castrogiovanni, e concluso in Caltagirone. Ma qual prova ne adduce egli? nessuna. 310 Tom. I in Joanne pag. 430 e seg. 311 Questi è quel medesimo Antonio de Luna, che per il riferito primo caso di Sciacca era stato bandito dal regno dal re Alfonso, e si era ricoverato in Roma. Gli uffizii dei congionti, e degli amici gli ottennero finalmente da questo magnanimo principe la grazia di poter ritornare. Il favorevole dispaccio, che fu anche accordato al Perollo, non fu sottoscritto che poco prima che Alfonso morisse. Il re Giovanni appena salito sul trono di Sicilia confermò questa grazia. 312 Capit. Regni Sicil. tom. II in Joanne, cap. 3, pag. 433. 313 Amavano i Siciliani estremamente questo real principe così in memoria della di lui madre la regina Bianca, che vi era stata adorata, come per le sue virtù. Era egli bellissimo di corpo, e trattava tutti con dolci maniere; era protettore delle lettere, e delle scienze, alle quali si applicava assiduamente, e con frutto, avendo tradotto la Morale di Aristotele, e scritta una Storia Cronologica de’ Re di Navarra; si esercitava nella poesia, e componea varie canzonette in lingua spagnuola, che cantava egli stesso colla sua chitarra. Così racconta il Surita (Annales de Aragon., lib. XVII, cap. 25), il quale riferisce ancora, che mentre egli dimorava in - 65 - di vicerè 314. Richiesero inoltre che il re stabilisse per legge 315 che in avvenire i vicerè di Sicilia dovessero essere i figliuoli primogeniti dei sovrani, essendo cosa vantaggiosa ed utile al regno che coloro, che un giorno doveano esser assunti al regio soglio siciliano, conoscessero i loro sudditi, e fossero a portata di sapere le loro leggi, e consuetudini. Le premurose istanze fatte dai Siciliani a favore del principe di Viano, che abbiamo finora appalesate, furono forse la cagione per cui l’esito dell’ambasceria mandata dal parlamento 316 non riuscì molto felice. Arrivarono eglino alla corte nel mese di gennaro del seguente anno 1459. Era incerto l’animo del re Giovanni a qual partito dovesse appigliarsi. Gli piacea da un canto il tener lontano dalla Navarra il principe Carlo, ch’essendo il vero erede di quel regno, potea suscitargli dei sinistri; ma temea dall’altro, che se lasciava questo suo primogenito in Sicilia, i Siciliani non fossero per acclamarlo per loro re. Non gli era ignoto il desiderio di questi isolani di avere un proprio sovrano, ed ei per esperienza lo avea conosciuto, quando come vicario del padre Ferdinando il Giusto fu al governo di quest’isola, dove gli convenne di fare una virtuosa resistenza alle seducenti esibizioni di taluni, che si dichiararono di volerlo mettere sul trono siciliano. Conoscea inoltre i meriti singolarissimi di questo suo primogenito, che si attiravano il rispetto, e l’amore di tutti, i quali in un trasporto potevano impensatamente eleggerlo per sovrano. In questo conflitto di pensieri conobbe che la peggiore delle risoluzioni fosse quella di lasciarlo in Sicilia, e determinatosi a richiamarlo, diede udienza agli ambasciadori, ai quali disse, che era inclinato a perdonare al figliuolo, purchè ritornasse in Ispagna, e destinò in Sicilia Giovanni Moncayo governatore del regno di Aragona, con ordine al figliuolo che tosto partisse accompagnato dal [86] vicerè 317 Lupo Ximenes de Urrea, e venisse nell’isola di Majorca, dove avrebbe saputa la sua volontà. In quanto poi alle grazie richieste dai parlamentarî ne accordò alcune, altre le negò, o ad esse non diede veruna risposta 318. Per toglier poi ai Siciliani ogni lusinga di restar smembrati dall’Aragona, nell’anno appresso 1460 alla dieta, o corte tenuta in Fraga nell’Aragona giurò per sè, e per i suoi successori, che i regni di Sicilia, e di Sardegna colle isole adjacenti non sarebbono mai separati dalla corona di Aragona 319. I mentovati capitoli si trovano sottoscritti dal re Giovanni nel suo palagio di Alcaçar nella città di Saragoza ai 25 di febbraro 1460 320. CAPO XV. Giovanni de Moncayo vicerè di Sicilia. Governo del sacro consiglio, alla testa del quale era Guglielmo Raimondo Moncada conte di Adernò maestro giustiziere. Bernardo Requesens vicerè. Giovanni de Moncayo cavaliere di grande esperienza, ed abilissimo nel trattare i grandi affari, nell’occasione che dovea portarsi in Sicilia per sollecitare la partenza del principe Carlo in compagnia di Lupo Ximenes de Urrea, avea ottenuto dal re Giovanni una cedola reale, con cui era eletto vicerè del regno Messina, solea spesso ritirarsi nel monistero di s. Placido de’ padri Benedittini lontano intorno a dieci miglia dalla città a fine di rivolgere i famosi manoscritti, che Gilforte d’Ursa, che il Pontano chiama Giulio Forte, siciliano regalati avea a quei religiosi. Univa egli a questi doni un costume irreprensibile e raro ne’ principi indipendenti, e giovani. Ecco perchè i Siciliani bramavano di essere retti da questo signore, e per cui nel parlamento gli fu anche fatto un grazioso donativo di venticinque mila fiorini. Ma oltre a’ meriti particolari di Carlo era la loro inchiesta appoggiata al dispiacere di vedersi ridotti in provincia dopo la morte del re Martino il Giovane, condizione assai dura per un regno che avea sempre goduto della presenza dei loro sovrani, da’ quali riconoscea lo stato florido, in cui si era sempre mantenuto. 314 Queste espressioni doveano in qualche maniera ferire l’animo di Lupo Ximenes de Urrea, che da tanti anni amministrava il regno, quasi che i Siciliani ne restassero malcontenti; ma da quanto saremo per dire, sospettiamo ch’egli, che venerava il principe di Viano, acconsentisse a questa dimanda, la quale sembrava ingiuriosa a sè che trovavasi presente nel parlamento. 315 Capit. regni Sic. in Joanne, cap. 5, pag. 434. 316 Michele del Vio (Privil. Urbis Panormitanae, pag. 342, e seg.) rapporta una particolare supplica fatta al re dalla città di Palermo, che dicesi consegnata all’arcivescovo Simone di Bologna, e al giureperito Cristoforo de Benedictis. Deve dunque questo ultimo aggiungersi agli ambasciadori spediti in questa occasione, sebbene non fosse inviato dal parlamento, ma dalla sola capitale. 317 L’allontanamento di Lupo Ximenes de Urrea dal nostro regno, sebbene non fosse stato deposto dalla carica, addita abbastanza che il re Giovanni si fosse insospettito, che il detto vicerè fosse del partito del figliuolo suo primogenito, e che non volle lasciarlo per allora in Sicilia per evitare, che i Siciliani collo appoggio del vicerè non tentassero qualche novità a favore di quel principe. Ma il vederlo ritornare dopo cinque anni allo stesso governo, ci fa opinare o che Lupo si fosse discolpato dai sospetti che erano caduti nell’animo del re, o più verisimilmente che essendo già morto il principe di Viano, cessò ogni ostacolo per rimandare questo vicerè in Sicilia, che per la sua esperienza, ed attività negli affari era molto opportuno a questo governo. 318 Il Caruso (Mem. stor. p. 3, l. 4, t. 3), francamente scrisse, che il re Giovanni accordò quanto nei capitoli di grazia si era richiesto, eccetto il capitolo, in cui si dimandava che in avvenire il governo di Sicilia si dasse sempre ai figliuoli primogeniti del monarca di Aragona. Convien dire che questo storico non abbia mai letto le risposte date alle dimande dei parlamentarii, dove avrebbe osservato che ad alcune dicesi: non placet, ad altre: non procedit, ad altre: Dominus Rex mandabit provisiones suas, a certe: visis privilegiis providebitur, e simili risposte, che non additano approvazione, o concessione, e che a talune non fu data veruna provvidenza (V. Cap. R. Sic. in Joanne p. 432 e seg.). Ed è quì da avvertire il silenzio del re alle prime quattro domande, che riguardavano il principe di Viano, silenzio misterioso, che fa sospettare che la riconciliazione promessa agli ambasciadori non fosse sincera, come non fu. 319 Surita, Annales de Aragon. lib. 17, cap. 2, pag. 75. 320 Cap. regni Sic. tom. I in Joanne pag. 475. - 66 - per la lontananza dell’Urrea, che andava ad accompagnare Carlo principe di Navarra. Il dispaccio è dato ai 9 di ottobre VII indizione 1459 321. Arrivò egli in Sicilia nel mese di novembre dello stesso anno, ma non se ne sa il giorno. Il principe Carlo era stato, mentre trovavasi in Messina, riscontrato ai 15 di questo mese delle buone disposizioni nelle quali era il padre, di rimetterlo in grazia, e credendole sincere, sen’era rallegrato all’estremo, ed avea dato parte di questa sua contentezza, come scrisse il Surita 322, a Catania, e ad altre città del regno. Il Moncayo col suo arrivo lo confermò nel suo errore, a segno che affrettò la sua partenza, per rendersi presso il padre, e colla possibile sollecitudine abbandonò la Sicilia fra le lagrime dei nazionali, e in compagnia di Lupo Ximenes de Urrea veleggiò all’isola di Majorca 323. Il nuovo vicerè Giovanni de Moncayo governò il regno di Sicilia sino alla sua morte, [87] che accadde nell’anno 1462 ai 27 di ottobre. Fra le molte provvidenze che egli diede, mentre fu in questa carica, merita di esser rapportata quella che riformava un abuso introdotto dagli Ebrei in Termini. Aveano eglino il diritto di macellare per conto loro gli animali, ma costumavano di vendere ai Cristiani ciò, che sopravvanzava. Questo commercio delle carni da loro macellate era allora creduto un grave, ed enorme delitto, come quello che era proscritto dalle leggi canoniche. Peronde il vicerè superstizioso cattolico credè suo dovere di dar riparo a questo da lui creduto scandaloso disordine; e con suo decreto dei 25 di novembre 1460 ordinò che restassero separate le carni degli Ebrei da quelle che servivano ad uso dei Cristiani, o che tutto ciò che sopravvanzava a quelli, non potesse vendersi a questi, e dovesse restare per conto loro sotto pena di once venti ai venditori. Prescrisse inoltre, che fossero i Cristiani avvisati dal pubblico banditore di questo decreto, ed anche intimati i macellai tutti, i quali, qualora contravenissero, oltre la multa, sarebbono soggetti ad esser processati, e puniti come infrattori della legge. Mentre questo vicerè ci governava, e precisamente l’anno 1462, in cui morì, accadde in Sicilia la carestia, da cui più che ogni altra città fu afflitta Messina. Si erano i Messinesi, per non far perire dalla fame i loro abitanti, provveduti di grani alla Licata, e a Naro. Ma, come soventi volte suole accadere nella scarsezza dei viveri, ne aveano comprati tanti, quanti soverchiavano al bisogno di Messina, per poter poi farne delle vendite altrove, e trarne profitto; e intanto la città della Licata, e quella di Naro, che erano state per così dire spolpate dai Messinesi, si erano ridotte in cotale penuria, che erano all’orlo di patire elleno stesse la fame da cui liberato aveano gli altri paesi. Laonde pensando ai casi loro, nè volendo restar sproviste, impedirono l’ulteriore estrazione dei grani, quantunque appartenessero ai Messinesi, che li aveano comprati. Fu ricorso perciò da questi al vicerè Gio. Moncayo, il quale non intendendo i sacri diritti della natura, dai quali i Naresi, e i Licatesi erano assistiti, nè conoscendo la cabala che potea appiattarsi nell’eccessiva compra fatta dai Messinesi, senza più riflettere comandò che si lasciassero liberamente sortire da Naro, e dalla Licata tutti quei frumenti, che per compra anteriormente fatta appartenevano ai Messinesi. Il can. Antonino Amico 324, e l’Auria 325, che segue le di lui pedate, assegnarono due governi a Gio. de Moncayo, l’uno l’anno 1459 e l’altro l’anno 1462, e fra questi due tempi vogliono che ci abbia retto l’anno 1461 Bernardo de Requesens. S’eglino avessero riscontrato con diligenza i registri dell’uffizio del protonotaro, che citano in margine, si sarebbono agevolmente accorti del loro sbaglio, ed avrebbono di leggieri conosciuto, che Giovanni de Moncayo, da che l’anno 1459 fu destinato al governo di Sicilia, vi continuò fino alla morte accaduta a’ 27 ottobre 1462, senza che il Requesens fosse ancor venuto a reggere questo regno. Tre dispacci regî adunque di Giovanni sovrano di Aragona rinvengonsi nei riferiti registri, l’uno dei 28 agosto 1461, il secondo dei 4 aprile 1462, e il terzo dei 3 gennaro 1463 326. Nel primo viene 321 Nell’archivio del protonotaro reg. dell’anno 1458-1459, indiz. VII, pag. 160. Annales de Aragon., lib. 16, cap. 53, p. 58. 323 Non appartiene alla storia di Sicilia, e molto meno a quella che riguarda la cronologia dei suoi vicerè, il raccontare le altre sventure di questo disgraziato principe. Nondimeno per soddisfare la curiosità dei nostri leggitori, diremo brevemente, che arrivato Carlo nell’isola di Majorca vi fu trattenuto dal padre, incerto di ciò che dovea fare, fino al mese di marzo dell’anno seguente 1460. Finalmente per le premure di coloro che desideravano questa pace, ai 22 del detto mese fu ammesso in corte sotto certe condizioni, e abbracciato dal re. Gli applausi che i compatriotti fecero al di lui ritorno, ferirono l’animo del geloso vecchio, che cercava una occasione di disfarsene. L’innocente principe, credendo vera la riconciliazione, stavasene tranquillo in una privata vita, e pensò a casarsi, facendo delle segrete pratiche per avere in moglie Isabella di Castiglia. Questo fu il delitto che esaggerò la crudele madrigna al marito, il quale chiamato il figliuolo a Lerida, lo fe’ tosto mettere in ceppi, e lo confinò senza sentire le sue discolpe nel castello di Altona. Questo atto ingiusto del re disgustò i popoli, che fecero vive istanze, perchè il principe fosse liberato. Giovanni aizzato dalla moglie stiede fermo nella sua risoluzione e perfino ordinò, che segli compilasse il processo, accusandolo ancora di fellonia. Ma crescendo le tumultuazioni, e temendo che i popoli stracchi non gli togliessero l’usurpato trono, per consiglio della moglie venne a patti, e fattolo sortire dalla prigione, gli cesse la Catalogna. Poco sopravvisse a questa finta pace il malavventurato principe. Morì egli ai 13 di settembre dell’anno seguente 1461 di anni 40, non senza sospetto di veleno fattogli propinare dalla vendicativa madrigna (vedi il Surita, e il Mariana). Gli strazii fatti a questo amabile signore sono una macchia alla vita del peraltro buono Giovanni re di Aragona, che non potrà mai dileguarsi; e ci istruiscono quanto può sull’animo di un vecchio debole, e innamorato una femina ambiziosa e altiera. 324 Chronol. de los Virreyes, y Presid. del reyno de Sic., p. 8 e 9. 325 Cronologia de’ signori vicerè di Sic., p. 14 e 15. 326 Reg. dell’uffizio del Protonot. all’anno 1458-1459, VII lndiz., p. 162, e all’anno 1462-1463, XI Ind., f. 183 e 184. 322 - 67 - eletto Bernardo Requesens, durante la lontananza di Lupo Ximenes de Urrea, per vicerè di Sicilia. Nel secondo si ordina, che mentre Giovanni de Moncayo dimorava in Sicilia, questi, e non Bernardo de Requesens fosse riconosciuto per vicerè. Nel terzo finalmente, in cui sono registrate le due antecedenti carte reali dei 28 agosto 1461, e dei 3 aprile 1462, si torna a dichiarare vicerè di Sicilia Bernardo de Requesens. Dall’osservazione dei tre mentovati dispacci si fa chiaro che il Requesens, quantunque fosse stato eletto vicerè di Sicilia, mentre ne [88] era lontano il d’Urrea, ai 28 di agosto 1461, nondimeno fu impedito a partire nell’anno seguente 1462 colla carta dei 4 aprile; o che il re Giovanni avesse avuto bisogno dell’opera sua, o che avesse cambiato di sentimenti, nè gli fosse sembrato decente il richiamare, appena compito l’anno del viceregnato, il de Moncayo uomo fornito di tanti meriti, e che lo avea così lodevolmente servito nell’allontanare il principe di Viano, e Lupo Ximenes de Urrea dalla Sicilia. Non partì dunque dalla corte del re Giovanni il Requesens, se non dopo il terzo dispaccio dei 3 di gennaro 1463 quando verisimilmente era arrivata la notizia della morte del Moncayo 327. Confermasi questa verità dal fatto; imperocchè nello spazio di tempo, che corse dall’anno 1461 all’anno 1462, in cui vuolsi che il Requesens sia stato la prima volta vicerè, non trovasi alcun dispaccio viceregio sottoscritto dal medesimo. Proseguì dunque a reggere, finchè visse, Giovanni de Moncayo, cioè fino ai 27 di ottobre 1462. Siccome poi egli nel morire non destinò verun presidente che governasse la Sicilia, così secondo il costume subentrò nell’amministrazione degli affari politici il sacro consiglio, alla testa del quale era allora il maestro giustiziere, carica che occupava Guglielmo Raimondo Moncada conte di Adernò. Nell’officina del protonotaro si comincia a vedere sottoscritto il sacro consiglio ai 15 di novembre del detto anno 328. La prima occupazione del conte di Adernò, e dei suoi compagni fu quella di riparare alla carestia, che tribolava la Sicilia. La determinazione, che abbiamo accennata, fatta dal vicerè de Moncayo a favore dei Messinesi fu creduta dal sacro consiglio irregolare, e fu revocata immediatamente. Questo contrario ordine costernò la città di Messina, o che in effetto non fosse vero, come si era spacciato dai Naresi, e dai Licatesi, che coloro che erano incaricati dell’annona di quella città, avessero provveduta una maggior quantità di grano di quello che le bisognava, o che costoro nella sicurezza, in cui erano di avere i frumenti a Naro, e alla Licata, li avessero altrove trafficati; il fatto è che accadde veramente la carestìa in quella città. I senatori messinesi perciò fecero le loro dimostranze al sacro consiglio sotto i 27 di dicembre dell’anno 1462 329, rappresentandogli che la città per la sospensione delle tratte di Naro, e della Licata non avea modo di sussistere; e perciò pregavano che si dasse aiuto agli afflitti abitanti, protestandosi che eglino non erano mallevadori, se suscitavasi qualche tumulto, o se i cittadini nelle angustie, nelle quali si trovavano, uscissero in corso come pirati, rubando tutti i frumenti che incontravano, e facendo così valere i primitivi diritti, che ha ognuno alla propria sussistenza. Sebbene noi non abbiamo monumenti, che ci additino le provvidenze date dal governo, nondimeno dal non trovare alcuno scrittore che ci accenni, che i Messinesi avessero eseguito quanto minacciavano i senatori, salvo un piccolo tumulto, che or ora racconteremo, abbiamo ragione da sospettare, che si sia dato riparo alle necessità di Messina, o rivocando l’ordine emanato a favore di Naro, e della Licata, o facendola provvedere di grani da Catania, che ne era abbondante. Arrivò finalmente Bernardo Requesens al governo di Sicilia, ed eseguì l’ordine del sovrano di Aragona di non prender possesso, se non scorsi venti giorni dopo il suo arrivo. Vi dovette giungere ai 3 o ai 4 di maggio dell’anno 1463, avvegnachè dal registro del protonotaro 330 ricavasi che fu letta nel palagio dello Steri ai 23 di esso mese la cedola reale 331. Quantunque, come abbiamo opinato, il sacro consiglio abbia dati gli opportuni ripari, acciò Messina non soffrisse la fame, nondimeno la plebe, che nelle carestìe non è mai sazia di pane, e sempre teme che l’annona sia malamente amministrata, si suscitò a rumore. Gli scrittori messinesi 332 confusamente [89] ci additano questa tumultuazione, sebbene non ce ne accennino la sorgente; e raccontano che si sollevò il popolo contro la nobiltà, e ch’erano alla testa dei sollevati Giovanni Mallone, e Niccolò Tabutano. Soggiungono, che i plebei provvedutisi di cannoni si erano radunati intorno al palagio reale, che per la nata sedizione stava chiuso, e cercavano di buttarne a terra le porte, affine di aprire le carceri, e trarne i prigioni, per così 327 Non sappiamo indovinare da qual cagione siesi mosso il re Giovanni ad ordinare nel terzo dispaccio, che Bernardo Requesens non potesse prendere possesso del viceregnato, se non scorsi venti giorni da che arrivava nel regno. E’ questo un mistero, che non ci dà l’animo di dicifrare, e lo abbandoniamo volentieri agl’indovinamenti de’ politici. 328 All’anno 1462-1463, XI Ind. 329 Nell’ufficio del Protonotaro in un volume a parte, in cui sono registrate le consulte dell’anno 1394 in poi, f. 69. 330 Reg. dell’anno 1462-1463, XI Ind., f. 183. 331 Quando fu letta la suddetta cedola mancava il protonotaro, il quale è quello che dà vigore alle carte reali; e perciò il nuovo vicerè, come nello stesso registro (pag. 184) si legge, per togliere ogni ostacolo ordinò che si rileggesse a’ 27 dello stesso mese, presente questo ministro. 332 Maurolico, Sic. Hist., lib. V. p. 293. — Bonfiglio, Hist. Sic., lib. X, p. 377. - 68 - accrescere il loro numero. Rapportano eglino questo fatto all’anno 1462, e quindi dovè accadere, mentre reggea il sacro consiglio, e ci assicurano che fu tosto sopito, e furon presi e carcerati gli autori del tumulto 333. Il vicerè Bernardo Requesens, dapoichè cominciò a governarci, si determinò di usare il rigore della giustizia contro i sollevati, che erano ancora in prigione in Messina, non avendo forse il sacro consiglio voluto condannarli, giacchè a momenti si aspettava il nuovo vicerè. Dunque formatosi, e terminato il processo, ordinò che al Mallone, che forse non era plebeo, si troncasse il capo; al Tabutano, che era uno dei principali, il quale conservava nella propria casa le armi dei sediziosi, con una tenaglia rovente furono strappate a brani le carni; tutti gli altri furono impiccati per la gola presso il real palagio, dove si erano tumultuariamente radunati, e poi squartati. Stavasi la corte viceregia in Palermo, e questa dimora era malamente sofferta in Messina, ed in Catania: nella prima di queste città per la vecchia pretensione in cui sempre furono quegli abitanti, che la loro patria fosse la capitale del regno, dove per conseguenza dovesse risedere il principe governante; e nella seconda per il possesso in cui era stata, mentre regnarono i principi aragonesi, di averli quasi sempre dimoranti dentro le sue mura. Perciò l’una, e l’altra città rinnovarono le antiche loro istanze per ottenere che la curia si allontanasse da Palermo, e fissasse la sua dimora in Messina, e in Catania. Per dar poi un certo colore alle loro mire, rappresentarono, che fosse espediente che il vicerè girasse coi suoi ministri per il regno, affine di osservare coi propri occhi le necessità degli abitanti, e per dar loro le necessarie provvidenze che da lontano di rado riescono opportune, dipendendo dalle relazioni di coloro, che spesso o per interesse, o ad altrui contemplazione ingannano la mente di chi governa. Il Requesens volle udire intorno alle suppliche ricevute da ambedue le città l’avviso dei suoi consiglieri, e a questo oggetto ai 23 di novembre dello stesso anno 1463 convocò il consiglio, cui propose le dimande dei Messinesi, e dei Catanesi, ed ordinò che opinassero, se il vantaggio del regno e il servigio del sovrano ricercavano che la corte abbandonasse la città di Palermo, e andasse girando per l’isola. Diversi furono i pareri dei ministri, giacchè altri furono di sentimento che dovesse partire, e visitare le varie città e terre del regno, per occorrere ai bisogni di ognuno; altri credettero che fosse di mestieri prima disbrigare i grandi affari che erano sul tappeto, e poi partire per quella parte del regno, dove fosse maggiore la necessità: ed altri finalmente furono di parere che non era il caso di abbandonare la capitale, ricercandolo il vantaggio di essa, e il servigio del sovrano. Così leggesi nell’atto registrato in un volume dell’officina del protonotaro 334. Sembra che fu seguita la opinione dei primi, poichè troviamo che in capo a poco tempo il vicerè Requesens andossene a Messina. Intanto da Spagna giunse l’ordine che si convocasse il generale parlamento per esaminarsi tutto ciò che riguardava il servizio del re, e il bene pubblico del regno. Il vicerè Requesens, forse per compiacere in parte i Messinesi, si determinò di tenere nella loro città questa adunanza, e perciò da Messina istessa, dove, come abbiamo accennato, si era portato, spedì le circolari sotto i dieci di gennaro 1464 335, ordinando che per gli 8 del seguente febbraro gli ordini dello stato si portassero in essa città a celebrarvi il parlamento 336. Le suddette lettere parlano [90] generalmente del servizio del re, e del vantaggio del regno, ma nulla in particolare accennano degli affari che trattar doveansi in quella adunanza. O che il tempo prescritto degli 8 di febbraro fosse assai breve, o che i parlamentarî non avessero voglia di andarvi: egli è certo, che arrivato il prescritto giorno pochi di coloro che erano stati invitati al parlamento erano arrivati in Messina. Laonde il Requesens ne sospese il cominciamento, aspettando che venissero gli altri. Come poi vide che nonostante non vi arrivavano, per spingerli a non mancare, scrisse nuove lettere circolari, nelle quali, per mostrare quanto fosse necessaria quest’assemblea, palesò il motivo che avea fin allora tenuto celato, anche al marchese di Geraci, per cui era convocato. Era già morto, come abbiamo osservato 337, Carlo principe di Viano primogenito del re Giovanni, e la regina Giovanna madrigna del medesimo bramava che il suo figliuolo Ferdinando fosse dai regni riconosciuto per il legittimo erede di S.M., ai di cui vezzi cedendo il 333 Il Bonfiglio (ivi) riferisce che i rei furono fatti prendere, e gastigati da Bernardo Requesens, che dice Stratigò di Messina. Ma s’inganna: il Requesens era in Ispagna, nè sappiamo che fosse mai stato stratigoto di Messina. Più accuratamente scrive il Maurolico. 334 Reg. dell’anno 1394 et aliorum annorum f. 66. 335 Reg. del protonot. dell’anno 1463-1464, Ind. XII. fog. 95 e seg. 336 Fra le circolari spedite per questo parlamento merita di essere osservata quella che vien diretta a Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci (Reg. del protonot. dell’anno 1463-1464, Ind. XII. p. 93). Questo rispettabile vecchio, dopo di avere date innumerabili riprove nel regno del re Alfonso della sua destrezza nel maneggiare gli affari, e del suo valore nelle molte guerre che questo sovrano ebbe a sostenere, dopo la di lui morte si era ritirato ne’ suoi stati pieno di onori, e di reputazione, per godervi negli ultimi anni di sua vita gli ozi, e la tranquillità di uno stato privato. Ma tale era l’opinione che si avea dei di lui talenti, e condotta, che il vicerè si compromettea di un felice successo, s’egli venisse al parlamento, e perciò efficacemente ne lo pregò: “Et pirchì ni pari decenti cosa, ultra la generali requisitioni fatta a tutti quilli è solitu, et consuetu, chiamari a tali parlamentu vui comu persuna singulari in lo regno, et solito prestari grandi, et alti servitii a li re, qui pro tempore regnarunt, essiri singularmenti requestu, et non passari per la generalitati di li altri. Vi pregamo, incaricamo, requidimo, et cumandamo per gran servitio di lu signuri re vogliati a lu dictu tempo trovarivi in quista citati, dove speramo con prudentia, bon consiglio, autoritati, et credito vostru fari gran servitiu alla majestati preditta ec.” 337 Nel principio di questo capitolo pag. 86, nota 7. - 69 - vecchio monarca, diede ordine al vicerè che convocasse a questo oggetto il parlamento, e inducesse gli ordini dello stato a giurare fedeltà all’infante principe. Questa cagione appalesa il Requesens nelle seconde circolari, che sono in data dei 20 dello stesso 338 mese di febbraro 339. Ci mancano gli atti di questo parlamento 340, e perciò ci è ignoto che altro vi si sia trattato, e qual esito abbia avuto. Forse saranno rimasti a Messina, senza che si avesse avuta la diligenza di trasportarli nei regî archivî, o si saranno perduti; destino accaduto ad infiniti altri monumenti. Non può però mettersi in dubbio che ogni cosa sia avvenuta a seconda dei desiderî del re Giovanni, e che tutta l’assemblea parlamentaria abbia riconosciuto per primogenito, e successore nel regno di Sicilia l’infante Ferdinando. Rilevasi ciò agevolmente da quanto scrive il Surita 341, il quale ci racconta che monsignor Giovanni Burgio vescovo di Mazara, come ambasciadore del regno di Sicilia, fe’ nella cattedrale di Saragoza il giuramento di fedeltà nelle mani della regina Giovanna, come tutrice del principe Ferdinando, a nome dei prelati, dei baroni, e delle università siciliane, per cui riconobbero quello infante per universale successore, e futuro re di Aragona, e di Sicilia dopo la morte del re Giovanni, e che per questo conto gli giurarono ubbidienza, come vassalli al suo natural signore. Arroggesi, come vedremo nel seguente capo, che ritornando Lupo Ximenes de Urrea al governo di Sicilia, viene spedita la cedola così a nome del re Giovanni, come a nome del principe Ferdinando di lui figliuolo, e amministratore dei regni di Aragona. Terminato il parlamento il vicerè Requesens ritornò alla capitale; almen noi dai monumenti ricaviamo che ai 2 di giugno dello stesso anno egli era in Palermo. Era accaduto in quel tempo un fatto, che richiamò l’attenzione del governo. Arrivò presso la Colombara di Trapani una nave chiamata nei [91] registri Cactana, la quale perseguitata da tre navi genovesi padroneggiate dall’arcivescovo di quella città 342 si era ivi rifuggita. Incalzavano nonostante i Genovesi per danneggiarla, e perciò i Trapanesi stimarono di esser loro dovere per diritto di ospitalità il difendere, e il soccorrere l’invasa barca, come fecero, e tosto ne resero partecipe il vicerè. Siccome poi per la custodia della barca si era speso, e dovea spendersi molto denaro, i rappresentanti di quella città avvedutamente da una parte lo consultarono, se le spese dovessero farsi a conto del regio erario, e dall’altra impedirono che la barca partisse, obbligando con giuramento il padrone a promettere che non si sarebbe allontanato, se prima non giungevano le risposte del governo. Noi troviamo nell’officina del protonotaro registrate tre lettere scritte da Palermo al capitano, ai giudici, ai senatori, e al segreto di Trapani dei 2, dei 3, e dei 7 di giugno 1464 343. Nella prima di esse loda, ed approva quanto eglino fatto aveano per soccorrere l’offesa nave, e insinua ai medesimi che continuassero in tutti i possibili modi ad aiutarla; mostra nella seconda lettera il suo gradimento per ciò che aveano operato, e li conforta a proseguire nell’impresa; ma intorno alle spese dice che gli sembrava più ragionevole che si pagassero dal padrone, essendosi fatte per la salvazione della sua nave: nondimeno permette che quelle che si erano finallora fatte si passassero ai conti della camera. Soggiunge che se mai l’arcivescovo di Genova si contentava di avere la provvisione di quaranta quintali di formaggio, di venticinque teste di bestiame, e di un cantaro di candele di sego, trattone il biscotto, che nella carestìa di allora non potea somministrarglisi, pagando tutto a denaro contante, e promettendo di tosto partire, senza più molestare nè la nave Cactana, nè gli altri vascelli del re; che in questo caso segli diano le suddette cose. E poichè i Trapanesi aveano anche richiesto che si mandassero in Trapani le due galee regie che erano in Palermo, il Requesens nega di poter farlo, servendo le medesime per altri affari più importanti del sovrano. Nell’ultima di queste lettere disapprova il vicerè la risoluzione presa di far giurare il padrone della nave di non partire dal porto di Trapani senza il suo previo permesso, essendo questo contro il diritto delle genti; e perciò ordina, che nonostante il giuramento e la promissione fatta, messer Giacomo, che così chiamavasi, potesse liberamente partire quando più gli piacesse, e prescrive ai medesimi rappresentanti della città di Trapani, che non desistessero dal difenderlo fino che dimorerà nel loro porto. Nel tempo che l’arcivescovo di Genova facea la caccia alla nave Cactana, eravi nel porto di Trapani una nave veneziana comandata da Giorgio Dragone. Costui fe’ scendere in terra un marinaro genovese il quale 338 Reg. dell’ufficio del protonotaro dell’anno 1463-1464, XII Indiz., f. 118 e 119. La città di Palermo avea spedito in Messina la procura al nobil uomo messer Ferrante di Milina uomo dotto, per assistere in suo nome al parlamento; ma come non si sapea il motivo per cui celebravasi questo parlamento, cioè il ligio omaggio che si ricercava da’ Siciliani al principe Ferdinando, nell’atto della procura non v’era bastante facoltà per fare il dimandato giuramento. Fu d’uopo perciò che il vicerè scrivesse all’università di Palermo, esortandola a mandare secondo il costume i proprii procuratori, o assegnare almeno a messer Ferrante un altro compagno colle dovute facoltà, assicurandola che ciò tornava a maggior suo onore. La lettera è de’ 24 di febbraro dello stesso anno. (Reg. del protonot. dell’anno 1463-1464, XII Ind., p. 124). 340 Niuno de’ nostri storici fa motto, per quel che sappiamo, di questo parlamento, e lo stesso canonico Antonino Mongitore, il più accurato raccoglitore dei parlamenti, punto non ne parla, nè nella sua raccolta, nè nelle memorie che la precedono, e però possiamo vantare di essere stati i primi ad annunziarlo fondati sopra i monumenti autentici de’ nostri archivii. 341 Annales de Aragon., t. IV, lib. XVII, cap. 58, p. 133 e 134. 342 Costui dovè essere Paolo Fregoso, che ambizioso, come egli era, più volte si era impadronito della ducale dignità; ma discacciato dalla fazione contraria, e fuggendo, dopo che il duca di Milano si era impossessato di Genova, si compiacea di esercitare lo scandaloso mestiere di corsaro. 343 Reg. dell’anno 1463-1464, XII Indiz., f. 150, 151, e 160. 339 - 70 - cominciò a scandagliare il fondo del mare, in cui era la perseguitata nave di messer Giacomo. Avvedutisi i Trapanesi dell’opra che facea il marinaro genovese, lo fecero carcerare, e cercandolo trovarono, che avea in petto alcuni docati veneziani. Sospettarono dunque che costui fosse stato anche mandato in terra per raccogliere la moneta veneziana, che era in Trapani, e però opinarono, che padron Giorgio Dragone fosse reo di due delitti, cioè di aver fatto scandagliare il fondo del porto, e di avere fatto estrarre moneta dal regno, e quindi lo imprigionarono ancora, e diedero conto di ciò, che si era da loro operato, al vicerè. Era il Dragone sicuramente amico dell’arcivescovo di Genova, il quale osservando la di lui prigionìa, lo raccomandò al vicerè de Requesens, e nella lettera si mostrò inclinato a mettersi al servizio del re di Aragona. Il Requesens fe’ esaminare dai suoi ministri le reità, delle quali veniva incolpato il veneziano Dragone, i quali non reputandole così gravi, nè degne di meritar castigo, furono di avviso che dovesse esser posto in libertà col suo marinaro, e che segli dovessero restituire i denari che avea addosso. Stando a questo parere dei suoi consiglieri il vicerè con dispaccio dei 7 di giugno 344 comandò, che non avendo altri delitti il Dragone fosse subito scarcerato, restituendoglisi [92] tutto ciò che gli era stato sequestrato. Rispondendo di poi all’arcivescovo di Genova, e riscontrandolo di quanto avea ordinato a sua contemplazione a favore del suo raccomandato, in riguardo all’offerta di quel prelato, l’accetta, e gli dice che avrebbe mandato a Trapani con una galea Consalvo di Nava, e Bartolomeo la Torre per condurlo in Palermo; o se non vi volesse venire, per stabilire con esso gli articoli della convenzione. La lettera ha la stessa data dei 7 di giugno 345. Dietro a due giorni, cioè ai 9 del detto mese, poichè dovea partire da Trapani la barca di maestro Bernardo trapanese, che dovea andare in Girgenti per caricare, e poi recare a Palermo quantità di grani, il Requesens scrisse a questo prelato un’altra lettera, con cui lo pregava a proteggere la detta barca, e ad impedire che fosse molestata 346. Quel volpone dell’arcivescovo di Genova o conchiuse il trattato col Nava, e con la Torre in Trapani, che noi non sappiamo, o venne in Palermo, e trattò col vicerè Requesens sotto le seguenti condizioni. Si obbligava egli di servire il re di Aragona colle tre sue navi per lo spazio di tre mesi, e per altrettanto tempo ancora, quando così piacesse a quel sovrano, e di partire subito da Trapani, e portarsi direttamente nei lidi di Barcellona, o di Tarragona per eseguire ciò che sua maestà gli avrebbe ordinato. Fece a quest’oggetto il giuramento, e il ligio omaggio nelle mani del luogotenente del maestro giustiziere di Sicilia, obbligando sè, e tutti i beni suoi all’esecuzione del fatto contratto, e ricevette per soldo dei primi tre mesi quattro mila docati. Assicuratosi il Requesens dal giuramento solenne, che credea che quel perfido ecclesiastico non sarebbe stato mai capace d’infrangere, e deluso dalle di lui espressioni, colle quali dichiarò, che intanto avea ricevuta quella somma, perchè si trovava senza denari, giacchè del resto era desideroso di servire il re di Aragona gratuitamente, e senza ombra d’interesse, immaginò che non potea meglio assicurare una nave messinese di botti cinquecento, che carica di grani, cottoni, cavalli, ed altre mercanzie andava in Aragona per conto del re, che facendola accompagnare dall’arcivescovo di Genova arrollato al servizio di quella corona, e ordinò al padrone di quella nave, che ubbidisse in tutto ai comandi di quel prelato. Partì la nave messinese scortata in apparenza dall’arcivescovo di Genova, il quale prese la via di Sardegna, e quando giunse al capo Pula, calpestando tutti i sacri doveri, ai quali era tenuto, con esecrando tradimento s’impadronì della nave, e di tutto il carico che era in essa per conto del re di Aragona suo padrone. A buona sorte di questo sovrano pervennero in quei mari tre grosse navi genovesi, che andavano in cerca dell’iniquo arcivescovo. Questi accortosene, e temendo di non rimanervi prigione, prese la risoluzione di fuggire, e non volendo abbandonare la sua sacrilega preda, s’imbarcò sulla nave messinese, che per altro era più veliera, e scappò. Vedendosi inseguito dai suoi nemici, andò a rifuggirsi nella terra di Pepoli, di cui era signore Giacomo Appiano suo consanguineo, lusingandosi per la parentela che avrebbe potuto conservare la roba rapita. Era Giacomo di un diverso carattere da quello del Fregoso, giacchè vantava quella onestà, di cui questi era privo. Inorridì egli all’udire il tradimento fatto da questo indegno arcivescovo al re di Aragona, cui si era con giuramento obbligato di servire fedelmente, e non solo ricusò di ricoverarlo nel suo castello, ma inoltre sequestrò i beni rubati, per conservarli a nome del re Giovanni. Informato di tutto questo fatto il vicerè Bernardo Requesens, spedì a Pepoli Niccolò Lucchese, che accompagnò con sua lettera in data degli 11 di ottobre 1464 a Giacomo Appiano, che loda di quanto avea operato, e prega a consegnare al medesimo Lucchese ciò che era stato derubato al re di Aragona. Questo aneddoto, che fu sconosciuto ai nostri storici, rilevasi dalla mentovata lettera, la quale conservasi nell’archivio del Protonotaro 347. Continuò questo vicerè de Requesens nell’amministrazione del regno di Sicilia sino all’anno 1465 quando, come diremo nel seguente capitolo, Lupo Ximenes de Urrea fu rimandato a riprendere nello stesso posto le redini del governo. Era il Requesens stato in grandissima riputazione di uomo di senno e di valore 344 Reg. del protonotaro dell’anno 1463-1464, XII Indiz., f. 160. Reg. del protonotaro dell’anno 1463-1464, XII. Indiz, f. 160. 346 Reg. ivi, f. 163. 347 Reg. ivi, f. 269. 345 - 71 - fino dai tempi di Alfonso il Magnanimo. Il Surita racconta all’anno 1453 348, che essendo questo sovrano in guerra con [93] Rainiero d’Angiò, che era venuto in Italia per soccorrere i Fiorentini, Bernardo fu incaricato che custodisse con parte dell’armata l’isola di Corsica, e per aiutare i baroni delle case d’Istria, e di Cinerca, e tutti coloro che erano fedeli. Dopo la morte di Alfonso fu spedito al re Giovanni dal serenissimo Carlo principe di Viano per procurare i mezzi di riconciliarlo col padre, il quale lo elesse per suo cameriere, come lo chiama nei tre dispacci di sopra accennati, nei quali lo destina al viceregnato di Sicilia. Il Bonfiglio 349, siccome si è avvisato, scrive che fu stratigoto di Messina, ma codesto è certamente un errore, come si è osservato, non essendovi altri frai Messinesi istessi che lo additi. L’Auria 350 racconta, che da alcuni manoscritti ricavasi che egli fosse maestro portolano, ma non accenna punto quali sieno codesti manoscritti, e dove si trovino. Quel che è certo egli è, che questi fu il fondatore della famiglia Requesens, che risiede in Palermo, la quale possiede col titolo di principato l’isola della Pantellerìa, una delle adjacenti al nostro regno; dal che sospettiamo che egli dopo il viceregnato vi si sia fermato, nè ne sia più partito. Il P. Pietro Ansalone nella Storia, che fa di molte famiglie cospicue della Sicilia 351, parlando di questa di Requesens assicura, che ebbe la signoria della terra di Aci, che ora è passata nella famiglia Reggio. CAPO XVI. Ritorno di Lupo Ximenes de Urrea al governo di Sicilia. Giovanni Moncada presidente del regno per la supposta di lui partenza. Morte del de Urrea. Quantunque Lupo Ximenes de Urrea fosse dimorato lungi dalla Sicilia per lo spazio di presso a sei anni, cioè dall’anno 1459, quando andò ad accompagnare il principe di Viano alla corte del re Giovanni, fino all’anno 1465, in cui ritornò a governarci, non fu nondimeno mai spogliato dalla carica di nostro vicerè; e sebbene in questo spazio di tempo fossero stati eletti il Moncayo, e il Requesens colla medesima viceregia dignità, non ostante nelle loro cedole sempre è espresso, che vi erano promossi durante la lontananza dell’Urrea 352. Vi ritornò egli all’anno 1465 non solamente a nome del re Giovanni di Aragona, ma per parte ancora del principe Ferdinando, riconosciuto, come abbiamo osservato, per primogenito, ed erede dei regni del padre 353. La prima delle azioni di Lupo Ximenes de Urrea, dapoichè ritornò a reggere il nostro regno, fu un’ambasceria mandata al re di Tunisi. Ci è ignoto a quale oggetto principalmente vi sia stata spedita; se perchè si fosse disturbata la buona armonia fra quella reggenza, e la nostra Sicilia, o per altra cagione. Nella lettera che il mentovato vicerè scrisse a quel re sotto li 30 di novembre 1465 354, solo si avvisa, che i due inviati, il venerabile religioso maestro Salvo teologo, e dottore delle leggi di Dio 355, e messer Francesco Martino si mandano per alcune facende che occorrono. È però da osservarsi che eglino non furono del pari incaricati delle stesse commissioni, ma che alcune erano affidate ad ambidue, ed altre singolarmente al solo maestro Salvo, del quale si fanno i dovuti elogî, e con cui prega quel Bey, che tratti a solo a solo gli affari segreti, dei quali è incaricato, prestando fede a quanto egli sarà per dirgli, e dando a lui solo le risposte. Un’altra provvidenza assai vantaggiosa diede nello stesso tempo questo vigilantissimo governante. Siccome i nostri sovrani non ebbero una ferma dimora, ma stavano ora in una città ora in un’altra, perciò i registri delle [94] loro ordinazioni rimaneano in quelle città, dove aveano abitato, e poi, trascurandosi di collocarli negli archivî regî, si sperdevano fra le mani dei particolari. Fu il d’Urrea avvisato che in Catania, dove i principi aragonesi si erano molto tempo fermati, eranvi molti registri dei suddetti re, e sopra tutto della regina Bianca; ordinò quindi al capitano di quella città con dispaccio dei 13 di dicembre 1465 356, che promulgasse un pubblico bando, per cui intimasse ad ogni, e ciascheduno di qualunque grado, e condizione che fosse, il quale o tenesse i mentovati registri, o sapesse coloro che li posseggono, di consegnarli al nobile 348 Ann. de Arag., t. IV, lib. XVI, cap. 18, p. 22. Hist. Sic. part. I, lib. X, p. 377. 350 Cronologia de’ signori vicerè di Sic., p. 15. 351 Pag. 365. 352 Reg. del protonot. all’anno 1458-1459 f. 160. 353 Il padre abate Amico (nelle note al Fazello t. III, dec. II, lib. 9, cap. 10, n. 4, pag. 190) commentando il Fazello, che scrisse, di esser piacciuto al re Giovanni l’anno 1473 di scegliere il figliuolo Ferdinando a corregnare seco nel regno di Sicilia, e a farvelo coronare, opinò che ciò non accadde così tardi, ma che più rettamente l’inaugurazione di Ferdinando, come re di Sicilia, si fe’ l’anno 1465. Noi comunque siamo di accordo che il Fazello sia cascato in errore, differendo la coronazione, e l’aggregazione alla signoria del regno di Sicilia fino all’anno 1475, non possiamo nonostante menar buono a questo commentatore che debbano riferirsi all’anno 1465, e guidati dal Surita (Annales de Aragon. tom. 4 lib. XVIII, cap. 16, p. 157), che dovea un poco meglio sapere gli annali di Aragona, siamo di avviso, come in appresso additeremo, che questa inaugurazione avvenne tre anni dopo, cioè l’anno 1468. 354 Registro di Luca Pollastra segretario dell’anno 1465 segnato n. XVI, e conservato nella regia cancellaria fogl. 280. 355 Questo maestro Salvo, di cui fa gli elogii il vicerè d’Urrea, dovette essere il padre Salvo Casetta palermitano dell’ordine dei Domenicani, intorno a cui può leggersi quanto ne scrisse il Mongitore (Bib. Sic. tom. II, pag. 207). 356 Dallo stesso registro di Luca Pollastra dello stesso anno segnato nella regia cancellaria n. XVI, f. 291. 349 - 72 - messer Giovanni dello Medico regio archivario, luogotenente, e maestro notaro dell’ufficio del protonotaro del regno, o di dare avviso presso di cui sieno, e questo sotto la pena di once cento da applicarsi al regio fisco. Nel detto dispaccio avverte poi, che egli ha date le stesse disposizioni per i registri che ritrovavansi a Messina, dove è data la lettera, e in altre città del regno. Quanto sarebbe desiderabile che le cure del governo si rivolgessero nuovamente a questo oggetto! I nostri archivii regii, come altre volte ho avuto occasione di rammentare, sono mancanti di parecchi monumenti, che non tutti si sono perduti, ma restano ancora negli archivî particolari delle chiese, e delle famiglie. Non sarebbe ella una cosa utile, che l’attenzione di chi presiede all’amministrazione di questo regno obbligasse i possessori a consegnare alle regie officine, quelle carte che mancano, affinchè se ne avessero le copie estratte dalle medesime, ed autenticate dai regî ministri, e così gli archivî non ne restassero privi? E giacchè siamo su di questo proposito, mi piace di avvertire, che sarebbe parimente necessaria un’altra provvidenza intorno alle carte, che tuttavia esistono nei regî archivî. Questi preziosi monumenti sono pessimamente conservati. I luoghi, nei quali si custodiscono, sono umidi, e niente ventilati; i volumi, spezialmente gli antichi, si rinvengono nella maggior parte disciolti; alcune pagine di essi volanti, e soggette a smarrirsi; molte carte corrose dalla tignuola, e l’inchiostro in alcune è così dileguato, che a gran fatica, e spesse volte interpetrando vi si leggono le parole. Sarebbe perciò d’uopo, che si scegliessero delle camere asciutte, dove l’aria fosse libera; che i volumi disciolti si rilegassero, e si battessero, perchè la polvere non ne consumasse il resto; e che si facessero le copie di quei che a stento si leggono, e coll’andare del tempo diverranno così consunte, che qualunque uomo pratico non sarà più capace di cavarne le mani. Mi si perdoni questa digressione; il servizio del re, il vantaggio del regno, e l’amore per la storia, che da questi monumenti, come da fiaccole, tragge la verità dei fatti, dettato mel’hanno. Forse un dì i sovrani, o coloro che a nome loro ci reggono, se mai rivolgono gli occhi a questa nostra cronologia, persuasi di quanto scrivo, vi daranno i dovuti ripari. Or per ritornare al nostro Lupo Ximenes de Urrea convocò egli un parlamento generale, e scelse per luogo di quest’assemblea la città di Polizzi, destinando il dì 11 di settembre per l’apertura. Le lettere circolari sono date in Palermo ai 16 di agosto 1466 357. Ma poichè il marchese di Geraci, l’ammiraglio, e il conte di Caltanissetta erano ammalati, nè poteano nel prefisso giorno trovarsi presenti in Polizzi all’adunanza degli ordini dello stato, il vicerè, cui stava a cuore che vi assistessero i mentovati ragguardevoli personaggi, amò meglio di prolungare il tempo del parlamento, e con una lettera circolare dei 4 di settembre XV. Indizione 358 lo differì fino ai 25 dello stesso mese 359. Questo parlamento, non essendo ancora trascorsi i tre anni da che era stato tenuto l’altro dal vicerè Bernardo Requesens fu straordinario, e ne furono la cagione le guerre intestine, nelle quali erano involti gli stati del re di Aragona, e le molestie che recavano i vicini, [95] i quali profittando delle vertigini interne suscitatesi in quegli stati, cercavano d’invaderli. Le circostanze allora della corte erano assai critiche; il re Giovanni era molto vecchio, nè atto a respingere da sè stesso o gli inquieti vassalli, o i molesti vicini; dominava la regina Giovanna, che preso avea un grande ascendente sull’animo del re, nè il principe reale Ferdinando, quantunque dichiarato governatore generale dei regni del padre, era ancora capace di starsene alla testa degli eserciti. Era perciò uopo di avvalersi dei suoi generali, e di preparare diverse armate disperse ora per tenere a freno i sollevati, ed ora per rintuzzare gl’invasori; e questa permanente guerra ricercava che si profondessero giornalmente i regî tesori. Cercava adunque questo principe dei sussidî per sostenersi, e li chiedea dai Siciliani, i quali per il loro attacco alla casa di Castiglia volentieri li avrebbono somministrati, e per la lunga pace che goduto aveano, erano in istato di porgerli. Noi crediamo che questo parlamento 360 non siesi altramente tenuto in Polizzi, e che siesi trasferito in Palermo. Si detegge che la bisogna sia andata così, da un dispaccio viceregio dato ai 9 di gennaro 1467, e indiritto ad Antonio Sin tesoriero del re, con cui segli ordina che del denaro tratto dal donativo offerto dal braccio ecclesiastico nell’ultimo parlamento tenuto a Palermo si consegnassero al nobile Cristoforo di Benedetto maestro segreto once ottocento, prezzo di tre mila salme di grano comprato alla Licata alla ragione di tarini otto la salma 361, ad oggetto di trasmettersi in Ispagna per servizio del sovrano 362. Ora mentovandosi in 357 Reg.. del prot. dell’anno 1465-1466, XIV. lnd., f. 220. Reg. ivi. 359 È in questo luogo da avvertirsi, che nel detto dispaccio viceregio Antonio Ventimiglia, figliuolo di Giovanni, era chiamato per antonomasia lu Marchisi, senza additarsi il feudo, cui era addetto questo titolo; poichè in quel tempo egli solo godea il marchesato in Sicilia; perciò nominandosi il marchese, s’intendea già che fosse quello di Geraci. Il conte di Caltanissetta era allora Guglielmo Raimondo Moncada, che trovavasi maestro giustiziere del regno. L’ammiraglio è a credersi che fosse Arrigo Ventimiglia figliuolo del Marchese Antonio. 360 Di questo parlamento saremmo all’oscuro, se non avessimo le lettere circolari registrate, siccome abbiamo osservato, nell’officina del protonotaro. I nostri storici nazionali, e lo stesso Mongitore non ne fanno alcun cenno. 361 Si osservi quanto fosse allora vile il prezzo dei grani. Noi dobbiamo convenire, che non essendosi ancora scoperte le Indie, l’argento e l’oro aveano un valore assai maggiore di quello che hanno al presente, ma nondimeno calcolandosi la differenza fra questi metalli dai tempi del re Giovanni a quelli nei quali ora siamo, sempre sarà vero che allora i grani vendevansi a buon mercato. 358 - 73 - questo diploma del mese di gennaro 1467 l’ultimo parlamento tenuto a Palermo, questo non potè essere altro, che quello che fu intimato in Polizzi per i 12 di settembre 1446, e poi fu differito sino ai 25 di esso mese, e che forse per altri intoppi, che saranno nati, si sarà trasportato in Palermo; quando non si voglia credere, che nello spazio di poco più di tre mesi siensi celebrati due differenti parlamenti, l’uno in Polizzi, e l’altro in Palermo, il che non sembra punto verisimile. Trovò Lupo Ximenes de Urrea poco dopo il suo ritorno in Palermo, che vi era così nella capitale, come per tutte le altre abitazioni del regno una penuria considerabile di bestiame da macello: male, cui spesso la nostra Sicilia è soggetta, e male intollerabile ai popoli, i quali non solo restano aggravati dall’enorme prezzo, a cui per la scarsezza si vendono le carni, ma talvolta nemmeno possono averle, quantunque pronti a pagarle quanto si voglia. Ricercando l’origine di questa carestìa, conobbe esserne cagione la troppa facilità, per cui si permettea l’estrazione di queste spezie di animali. Laonde volendo dar riparo a cotale disordine, con suo dispaccio dei 5 di dicembre dell’anno 1466 363 vietò sotto la multa di once cento da applicarsi a favore della camera, qualunque vendita di vacche, di giovenchi, porci, pecore, castrati a qualunque straniero, che non fosse abitante colla sua famiglia in Sicilia. Volle inoltre che coloro che comprato avessero cotali animali, essendo già proibita ogni estrazione, potessero restituirli ai venditori, quali fossero obbligati a rendere il denaro che ne aveano percepito. Fu perciò incaricato Pietro Gallina portiero di girare per il regno, ed intimare questo bando viceregio. Crescea già negli anni il principe Ferdinando, ed essendo arrivato al quintodecimo della sua età, il re Giovanni gli assegnò i consiglieri, gli uffiziali, e gli altri familiari necessarî alla sua corte, e lo destinò al comando dell’armata preparata contro i Catalani, che si erano sollevati. Era perciò d’uopo di assegnargli una rendita, con cui potesse mantenere i suoi cortigiani; e siccome il re non potea trarla dalle provincie della Spagna, comunque vastissime, decretò con suo dispaccio sottoscritto in Ampurdam a’ 15 di aprile 1446, che delle gabelle dovutegli nella città di Palermo si pagassero di anno in anno al medesimo principe tredici mila fiorini. Quest’ordine fu comunicato al vicerè Lupo [96] Ximenes de Urrea, il quale ne comandò la esecuzione con una carta viceregia data nella istessa città capitale sotto li 2 di settembre dello stesso anno 364. Stava a cuore de’ Romani pontefici la guerra contro di Maometto II, ma non ne erano secondati dai sovrani di Europa, che distratti da altri affari che premeano loro più davvicino, non poteano somministrare i necessarî soccorsi. Il buon Pio II morì nell’anno 1464 col dispiacere che questo suo progetto non si fosse punto eseguito, e Paolo II, che gli successe nel pontificato, non intralasciò di fare ogni opra per promuovere lo stesso disegno, e spedì dapertutto i suoi apostolici commissarî, non solamente per indurre i principi a mantenere la promessa, ma ancora per esigere le collette dei fedeli per la nuova crociata. Fu per la Sicilia destinato il famoso Pietro Ranzano, che era allora provinciale dei Domenicani 365. Trovò questi degli ostacoli per eseguire i voleri del papa presso il marchese di Geraci, e ne fe’ ricorso al vicerè, il quale per mostrare il suo rispetto verso la santa sede, scrisse al suddetto marchese una lettera in data dei 27 aprile 1467, nella quale lo pregava a permettere, che si esigessero le collette imposte dal pontefice, e che si potessero estrarre dai di lui stati i denari raccolti per la detta crociata, per depositarsi nel banco di Palermo 366. Nuove ripruove diede il vicerè Lupo Ximenes de Urrea della sua venerazione verso la santa sede nello stesso anno, quando lo stato pontifizio trovossi in una gran penuria di bestiame, nè potea trarne dalla Sicilia per il divieto sotto la multa di once cento fattone l’anno antecedente. Trovandosi in queste angustie Paolo II spedì al vicerè Luca de Amodeis suo nunzio, acciò il pregasse, stante la carestìa in cui era Roma, e le città della chiesa, di permettere l’estrazione di tre mila animali da macello. Aderì volentieri questo cavaliere alle premure del pontefice, e non solamente accordò la richiesta estrazione, ma ordinò insieme, che il nunzio pontifizio fosse agevolato nella compra, e liberato da qualunque dazio solito pagarsi nell’estrazione degli animali bovini; e siccome ostava il dispaccio che lo proibiva, e la pena pecuniaria imposta ai trasgressori, perciò egli dispensò per questa volta i venditori dalla multa, che avrebbono incorso, trasgredendo l’ordine viceregio. Accordò inoltre con un altro dispaccio allo stesso nunzio de Amodeis la facoltà di estrarre quindici frai cavalli, e mule per servizio della santa sede franche e libere da ogni dogana. Questi due dispacci, che sono ambidue dei 25 di maggio 1467 sono dati nella città di Morreale, dove era allora il vicerè 367. 362 Reg. della regia cancellaria dell’anno 1466-1467 XV Indiz., f. 296. Reg. del segretario Luca Pollastra conservato nella regia cancellaria dell’anno 1466 segnato num. XX, f. 127. 364 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1466-1467, XV. Indiz., num. 126, fogl. 11. 365 Pietro Ranzano, che fu poi vescovo di Lucera, era palermitano, e di famiglia nobile. Può osservarsi il di lui elogio nella Biblioteca siciliana del canonico Antonino Mongitore t. II. p. 155, e più distesamente nelle Memorie estratte da’ di lui Annali mss. dal p. Antonio lo Presti domenicano sotto nome di Valentino Barlona nel t. VI degli Opuscoli di autori siciliani. 366 Manoscritto della biblioteca del senato di Palermo, lettera P. IX. 367 Registro di Luca Pollastra secretario dell’anno 1466-1467, XV. Indiz., segnato num. 30, e nella regia cancelleria f. 79, e nella istessa cancelleria nel reg. dello stesso anno, segnato num. 126, f. 304. 363 - 74 - Le guerre intestine della Spagna andavano sempre di male in peggio; i rubelli Catalani aveano chiamato in loro ajuto Giovanni di Angiò, il quale per la vecchia nimistà che passava fra la sua, e la famiglia di Aragona, volentieri andò a sostenere il partito de’ rivoltati. Mancando al re Giovanni di giorno in giorno il denaro per sostenere il peso di questa guerra, spedì in Palermo una galera comandata da Consalvo di Nava, a fine di trarne quel denaro che trovavasi depositato nel banco pubblico per suo conto. Il vicerè d’Urrea, cui giunse l’ordine di sbancare questo denaro, s’indirizzò ad uno dei principali deputati del regno, che nel registro della regia cancelleria non è nominato 368, incaricandolo, che ordinasse al banco, che si consegnasse al suddetto di Nava quella quantità di pecunia che vi stava a nome del sovrano per conto dei donativi 369. Oltre i vantaggi del regno a se affidato, [97] cercava questo vicerè di conservare al suo sovrano l’amicizia delle potenze italiane. Erano i Veneziani in guerra coi Fiorentini; i fuorusciti di questa repubblica si erano ricoverati a Venezia, ed aveano ricercato il patrocinio di quel senato. Trovavansi interessati in questa guerra tutti i principi italiani. Alessandro Sforza signore di Pesaro, Ercole d’Este, fratello del duca Borso, Pino degli Ordelassi signore di Forlì, Galeazzo Pico padrone della Mirandola, Marco, e Lionello Pii signori di Carpi, Astorre di Manfredi signor di Faenza, Galeazzo duca di Milano, Ferdinando re di Napoli, e Federico conte di Urbino vi erano intrigati, chi per una parte, chi per l’altra. Il Duca di Ferrara, e il Pontefice Paolo II. si erano cooperati, sebbene indarno, per la pace 370. Il re di Aragona era da molto tempo collegato co’ Veneziani, ma non vi avea presa parte. L’accorto Lupo Ximenes de Urrea spedì a Venezia nel mese di Marzo 1468. Guglielmo Clement, affine che spiasse gli andamenti delle potenze italiane, e lo avvertisse di mano in mano di quanto accadeva; e per dare un motivo apparente a questo viaggio, l’incaricò di far pratica con quel senato, confermandogli la buona amicizia del re di Aragona, e invitandolo a rinovare l’antica lega con quei patti, che a misura delle circostanze di allora avrebbe il Clement creduti i più vantaggiosi. Noi ricaviamo queste notizie dalla istruzione data dal detto vicerè a questo inviato, che conservasi nella officina del protonotaro 371. Finalmente riuscì alle truppe regie nella provincia di Ampurdam di sconfiggere i sollevati sostenuti dalle truppe del duca Giovanni d’Angiò, di mettere in fuga coloro, che restarono vivi, e d’imposessarsi della loro artiglieria. Fu dato avviso di questa insigne vittoria al vicerè, che la comunicò a tutti i baroni, ed alle università, ordinando le pubbliche illuminazioni per il vantaggio avuto dalle armi regie 372. Era già il re Giovanni vicino a sera, e inoltre avea già perduta la vista; pensò perciò di dar moglie all’unico suo figliuolo Ferdinando, e gli destinò l’infanta di Castiglia Isabella, ch’era l’erede di quel regno. Per dare di poi a questo Principe il titolo di re, lo dichiarò correggente nel regno di Sicilia agli 8 giugno 1468, e nella domenica seguente lo fe coronare nella Cattedrale di Saragozza 373. In questo istesso anno 374 fu la città di Messina attaccata dal flagello della peste, non dappertutto, ma in quella contrada, dove abitavano i giudei, ed è detta volgarmente la Giudeca. Vi durò sei mesi, ma per la vigilanza de’ magistrati non si estese fuori di quel recinto, e solo sagrificò quattrocento di quegli infelici 375. La vicina morte, che di giorno in giorno si aspettava del Re di Aragona, avrebbe potuto apportare de’ torbidi, e particolarmente rispetto al regno di Sicilia, ch’era così lontano dagli altri stati di quella Monarchia. Uno di quei principi, che avrebbe potuto invaderlo, era Ferdinando re di Napoli, e figliuolo del re Alfonso. Questo magnanimo sovrano non solamente non ebbe animo di tentare questa ingiusta usurpazione, ma per mostrare il suo disinteresse, e la premura, che avea di conservarlo al suo fratel cugino, spedì in Aragona il vescovo di Sessa, e in Sicilia l’abate Ruggio suo familiare, per assicurare il re Ferdinando, e il vicerè nostro, che nel caso infausto che soccombesse al comune destino Giovanni suo zio, era egli pronto di somministrare tutte le sue forze ad oggetto di mantenere alla corona di Aragona il nostro regno. Questa graziosa offerta fu aggradita non meno dal re Ferdinando, che da Lupo Ximenes de Urrea, il quale stimò suo dovere il 368 Nello stesso registro di Luca Pollastra segnato num. 30 dell’anno 1467, e conservato nella regia cancelleria f. 257 e 259. Da questo monumento si ricava, che la deputazione del regno volea mandare alla corte un ambasciadore, forse per trattare col re Giovanni affari concernenti a’ donativi; poichè in esso il vicerè asserisce che quest’inviato potrà spedirsi in appresso: “et appressu può andari lu ambasciaturi a la majestati sua, et fari quillu li sarrà per vui altri commisso, tanto supra la facenda di quisti danari, quantu di li altri.” 370 Corio, Storia di Milano, P. VI. — Diario Ferrarese presso Muratori Rer. Ital. Script., t. XXVI. pag. 210 ed altri. 371 Reg. dell’anno 1467-1468. I. Ind. f. 148. 372 Reg. di Luca Pollastra dell’anno 1468, segnato num. 33, e conservato nella regia cancel. fog. 66. 373 Così il Surita (Annales di Aragon. tom. IV. lib. XVIII, cap. XVI, pag. 156 157,) seguito dal Pirri, dall’Aprile, e dal Caruso, per lo che debbono emendarsi il Fazello, e il Maurolico, che trasferiscono questa coronazione fino all’anno 1473, e ancora il Padre Abate Amico, che l’anticipa all’anno 1465. 374 Cade in due errori il mentovato P. Abate Amico nelle note al Fazello (Dec. II, lib. IX, cap. X, tom. III, pag. 190), il quale vuole in primo luogo che questa peste accadde nell’anno 1465, in cui egli fissa, siccome abbiamo osservato, la coronazione di Ferdinando in re di Sicilia, e cita il Maurolico senza avvedersi, che questo scrittore messinese (Sic. Hist. lib. V. p. 191) ne fa menzione all’an. 1468, e in secondo luogo racconta che questo flagello fosse stato universale per tutta la Sicilia, quando costa che non oltrepassò un quartiere di Messina. 375 Maurolico, Sic. Hist., lib. V, p. 191. — Bonfiglio, Hist. Sic., part. I, lib. X, p. 375. 369 - 75 - parteciparla a’ principali baroni del [98] nostro regno, e a tutte le università di esso, come si fa palese dalla circolare spedita da Palermo a’ medesimi sotto i 29 di gennaro 1469 376. Il matrimonio fra il re Ferdinando, e la principessa Isabella erede della Castiglia trovò degli ostacoli per parte di Arrigo fratello di essa, non ostante i quali venne a compimento; e se ne celebrarono le nozze in Valladolid nel mese di ottobre 1469. Arrivata questa fausta notizia in Sicilia, Lupo Ximenes de Urrea volle, che fosse solennizzata una festa per tutto il regno. Ci mancano le memorie delle dimostrazioni fatte nelle altre città della Sicilia, ma ci sono restate quelle della capitale scritte da Pietro Ranzano 377, da cui apprendiamo, ch’era pretore della medesima Pietro Speciale, il quale ordinò sei giorni di feste, in cui si fecero delle cavalcate, delle illuminazioni, ed altri segni di gioja. Perchè si conosca quali fossero a quella età le maniere di celebrare, diremo in accorcio: che le principali case erano nelle esteriori mura adornate di drappi; le vie della città erano sparse di verdi frondi, e di alberi recisi con quei frutti, che permettea la stagione; sulle muraglie della città erano collocate a quando a quando delle botti, che la sera s’incendiavano, ad oggetto di accrescere la illuminazione; i balconi de’ palagi erano ornati di torchj di cera; ed oltre la solenne cavalcata della nobiltà, che in un numero di 1400 passeggiò con torcieri accesi per le principali strade, quattrocento giovani vestiti nobilmente giravano per la città ballando, e cantando. Si veda l’accennata descrizione del Ranzano. Ma queste allegrezze nel dì primo di dicembre dello stesso anno, ch’era il sesto de’ giorni festivi, fu funestato da un oragano suscitatosi nel Porto, che fracassò ventitrè grosse navi, che vi stavano ancorate, e fe perire una gran quantità di marinari. Oltre le sollevazioni accadute nella Catalogna, noi opiniamo che in Sardegna ancora vi fossero stati de’ movimenti, e che il vicerè Lupo Ximenes de Urrea sia stato incaricato di portarsi in quella Isola per frenare i sollevati. Nasce la nostra opinione da due dispacci viceregî de’ 4 marzo 1470 mandati al cavaliere F. Pietro Cases dell’ordine di S. Giovanni Gerosolimitano da Siracusa; nel primo de’ quali lo promuove alla carica di capitano d’armi per tutto il regno di Sicilia, e nel secondo, dandogli conto che per comando del re Giovanni dee presto partire dal regno per portarsi in Sardegna, gli ordina che non si muova dalla Sicilia durante la sua lontananza, malgrado qualunque cagione, che ne avesse, o altro comando 378, che ne ricevesse, sotto la pena di perdere il priorato, i beni, che possedea, e la castellanìa, di cui era investito, poichè il di lui allontanamento sarebbe tornato in disservigio del monarca di Aragona 379. Dovendo poi egli lasciare un capo politico al regno nella sua assenza, ne spedì il viglietto a Giovanni Moncada conte di Adernò, ch’era il maestro Giustiziere del regno di Sicilia 380. Ma questa elezione di presidente del Moncada non ebbe effetto; il vicerè non partì per allora, o perchè si fossero quietati i movimenti di Sardegna 381, o che più urgenti cagioni 382 ne lo impedissero. Giunse in questo medesimo anno in [99] Palermo Pietro Antonio di Fuligno, che Ferdinando re di Napoli spediva 383 a Tunisi a fine di far la pace con quel Bey. Fu questo inviato incaricato di conferirsi prima dal vicerè di Sicilia, ad oggetto di sapere, se dovesse ancor trattare per il re di Aragona suo zio, essendo già spirata la tregua, che avea questo monarca stabilita con quel Moro. Lupo Ximenes de Urrea non avea bastante podestà per risolverlo, nè tempo di aspettare le risposte da Spagna per sentire la volontà del suo sovrano. Prese perciò la risoluzione di permettere all’ambasciadore del re di Napoli di trattare la pace ancora a nome del monarca Aragonese; ma a condizione, che fosse a questo re libero l’approvarla, o il ricusarla, 376 Registro di Luca Pollastra dell’anno 1468-1469 segnato num. 37, e conservato nella regia cancelleria fogl. 41. Vedi il tomo IX. degli Opuscoli Siciliani nella prefazione della dissert. del Ranzano: de auctore, et primordiis felicis Urbis Panormi, pag. 6 e seg. 378 Essendo il Cases cavaliere dell’ordine gerosolimitano, potea esser chiamato dal Gran Maestro di Rodi stante la guerra, che minacciava Maometto II., il quale si era dichiarato che non sarebbe restato di farla, se non esterminava tutti i cristiani. Questa chiamata del Gran Maestro preveduta dal vicerè fu la causa, per cui in questo dispaccio gli vietò, per qualunque motivo, o ordine contrario, di partire. 379 Manoscritto della libreria del Senato di Palermo, lett. P. 9. 380 Reg. dell’Uffizio del Protonotaro dell’an. 1469-1470, III. Indiz. fogl. 39. 381 Il Surita (Annales de Aragon. t. IV. lib. XVIII, cap. 68, pag. 190) ci rammenta intorno a questi tempi la ribellione di Leonardo di Aragona, che si facea chiamare il marchese di Orestano, che pretendea di succedere nello stato di suo Avo, e dei suoi Zii, ed era perciò in guerra col vicerè, e coi governatori dell’Isola. Il re di Aragona vi destinò un’armata per domarlo, di cui forse dovea avere il comando il nostro Lupo Ximenes de Urrea. Forse questi fu vinto, o vedendo il turbine, che lo minacciava, venne a sottomettersi. 382 Maometto II, di cui abbiamo favellato nell’antecedente nota 3, tenea pronto un esercito di non meno di ducento mila uomini, col quale, e con una poderosa flotta intendea d’invader Roma, e tutta l’Italia, e per conseguenza le adjacenti isole. Così scrive il cardinal Bessarione con una Enciclica diretta a tutti i principi d’Italia presso il Rainaldo (In Annal. ad ann. 1470. T. X, pag. 488 num. 29 e seg.) Laonde non è inverisimile che Lupo Ximenes de Urrea ricevendo queste notizie dall’Italia, e avvertito particolarmente da Guglielmo Clement da Venezia, dove per la guerra dichiarata da quel Sultano alla repubblica si stava a giorno di quanto si pensava a Costantinopoli, abbia creduto più espediente il conservare la Sicilia minacciata dalle armi ottomane al re di Aragona, che lo andare in Sardegna a sedare i tumulti. 383 Di questa spedizione non parlano punto gli storici napolitani; ci faremo perciò un piacere di rammentarla, e di accrescere con questo aneddoto gli annali napolitani. 377 - 76 - come si sa chiaro dalla memoria consegnata al detto Pietro Antonio di Fuligno di ciò, che dovea trattare per il vicerè di Sicilia col re di Tunisi 384, ch’è segnata in Palermo agli 11 di maggio dell’anno suddetto. Non avea intralasciato intanto il suddetto vicerè al primo arrivo dell’inviato del re di Napoli di avvisarne il re di Aragona, e di proporgli il mezzo termine, ch’ei pensava di prendere. Il re Giovanni approvò il pensamento dell’Urrea, e con dispaccio segnato nella Villa di Mansone sotto il 26 di maggio destinò il nobile Andrea di Navarro 385, come suo ambasciatore a quel Bey, con facoltà di stabilire la pace con esso; e solo ricercò quattro mesi di tempo per cessare le offese; avvegnacchè essendo dispersi gli stati della corona di Aragona, potea accadere che alcun vassallo non inteso ancora della pace recasse danno a’ sudditi del re Tunisino. Per la Sicilia però, ch’è vicinissima all’Affrica, non richiese per mettersi fine alla ostilità, che il breve tempo di quindici giorni 386. Accompagnò lo stesso re quest’ambasceria con sua lettera indiritta allo stesso re di Tunisi, che onorò col titolo di Serenissimo re, in cui gli dà conto, che spediva il nobile Andrea di Navarro, a fine di ottenere da lui la stessa pace, che cercava il re Ferdinando di Napoli 387. Ricevuto il dispaccio reale, e la lettera scritta dal re Giovanni al re di Tunisi, Lupo Ximenes de Urrea sollecitò Andrea di Navarro a partire, e oltre la lettera del Monarca di Aragona, gli consegnò altre tre sue lettere, una per lo stesso re di Tunisi, la seconda per il di lui primogenito, e la terza per il doganiere di quel Principe, che chiamavasi Sidanachyamur, pregando il primo a condiscendere alla proposta pace, e gli altri a cooperarvisi 388. Siamo incerti se il di Navarro l’abbia conchiusa; anzi abbiamo dei ragionevoli sospetti da credere, o che non se ne abbiano potuto stabilire le condizioni, o che il di Navarro, di cui le scritture non più ci parlano, sia morto in questa spedizione, e non abbia potuto portare al suo termine questo affare. Quel, ch’è certo, egli è, che le ostilità, come diremo, continuarono colla Sicilia, e fu d’uopo di far poi una tregua di due anni con quel Re: ciò che mostra che la pace allora non fu fatta. Maometto II avea già posto l’assedio a Negroponte appartenente alla signoria di Venezia, e la stringeva dappertutto. Il vicerè Lupo Ximenes de Urrea volendo per l’amistà, che passava fra il re di Aragona, e quella repubblica, porgerle ogni soccorso, spedì da Palermo un brigantino, padroneggiato da Andrea Magliocco, ad Ughetto di Pan, che comandava due galee di Sicilia spedite per spiare gli andamenti della flotta Ottomana, con ordine di andare a’ servigii di Niccolò Canali ammiraglio de’ Veneziani. [100] Noi abbiamo l’istruzione data da questo vicerè al Magliocco al primo di agosto 1470 di ciò, che dovea fare 389, l’ordine dato al Pan di unirsi alla flotta Veneziana dato lo stesso giorno 390, e la lettera antecedentemente, cioè all’ultimo di luglio scritta al Canali, in cui oltre l’assistenza delle due mentovate galee gli esibisce dalla Sicilia tutti i possibili ajuti per l’armata, ch’ei comandava 391. I soccorsi prestati, ed esibiti non arrivarono in tempo; già Negroponte era caduta in mano de’ turchi, e ne arrivò il tristo annunzio in Sicilia, partito che fu appena il brigantino, che sparse il terrore per tutta l’Isola, ch’era minacciata dalle vittoriose armi di Maometto. Perciò il vicerè spedì una circolare per tutte le città marittime, e terre del regio demanio, ordinando che si riparassero le mura, le torri, e i castelli, e si provvedessero le armi, e tutto ciò ch’era necessario alla difesa; permettendo ancora, quando fosse uopo, che si mettessero per questa necessità delle imposizioni; giacchè trattavasi della conservazione della cristiana religione, del servizio del re, e della preziosa libertà dei vassalli. Questa circolare fu segnata in Palermo ai 5 di agosto dello stesso anno 1470 392. Quantunque però questo vicerè avesse sospesa la sua partenza dal regno per i motivi di sopra addotti, non dimeno non era ancor sicuro, se la corte restasse contenta ch’ei ne’ presenti bisogni non si allontanasse. Ciò si fa palese dalla lettera, ch’ei scrisse sotto li 10 dello stesso mese a’ senatori di Messina, che lo pressavano, affinchè negli urgenti pericoli non si scostasse dalla Sicilia; giacchè in essa assicura che il servizio del Sovrano l’obbliga a partire, e che la sua lontananza sarebbe breve, durante la quale si compromettea dalla fedeltà de’ baroni, e delle Università, che il regno sarebbe ben custodito 393. Presumiamo nonostante, come si è detto, ch’egli non partì, e perchè negli archivii non trovasi alcun dispaccio, che non sia da lui sottoscritto, e perchè osserviamo ch’egli a’ 6 di ottobre era tuttavia in Palermo, come costa dalla lettera, che scrisse al 384 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’anno 1469-1470, III. indiz. fogl. 126. Questo Cavaliere è, e sarà famoso negli annali di Palermo per l’istituzione dell’opera laicale, che tuttavia porta il suo nome, a cui lasciò porzione dei suoi beni, per erogarsene i frutti in tante doti da darsi alle donzelle orfane, e virtuose. Codesta donazione fu dal medesimo fatta, mentre vivea, cioè l’anno 1468. (Vedi Villabianca Istituz. della vener., e pia opera di Andrea di Navarro pag. 6, e seg.), e perciò rendesi assai più commendabile. Il Marchese suddetto di Villabianca sospetta dall’osservare questa donazione nell’anno 1468, che questo donatore fosse morto allora, ma s’inganna, essendo chiaro dal monumento che citeremo, ch’ei vivea l’anno 1470, ed era vegeto, ed atto a servire il Re, e il pubblico in questa ambasceria. 386 Reg. dell’uffizio del protonotaro an. 1470, III. indiz. fogl. 259, e seg. 387 Reg. ivi fogl. 263. 388 Reg. di Luca Pollastra dell’an. 1470, segnato num. 79, e conservato nella Regia cancel. f. 58. 389 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’anno 1470 fog. 277. 390 Ivi fogl. 276. 391 Ivi fogl. 275. 392 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’an. 1469.1470, III. indiz. pag. 279. 393 Ivi pag. 283. 385 - 77 - Doge di Venezia Cristoforo Moro, che lo avea ringraziato delle generose offerte fatte all’ammiraglio Canali . In essa lettera rinnova le stesse esibizioni, che avea prima fatte, protestandosi pronto a somministrare tutti i possibili ajuti all’armata Veneziana, così per mantenere l’amicizia con quella repubblica, come perchè trattavasi del bene comune, e della conservazione della cristiana religione. Era ammirabile in questo vicerè la saggia condotta, con cui cercando il servizio del Sovrano, si guardava dall’angheriare i vassalli. Ne diede egli una manifesta prova nel mese di novembre dello stesso anno 1470. L’abuso introdottosi in Sicilia di moltiplicarsi i muli, avea reso rari i cavalli, ciò, che tornava in disservizio del Sovrano, la di cui cavalleria potea difficilmente montarsi; e però fu costretto fin dall’anno 1469 di promulgare una prammatica, con cui per rendere necessaria la razza dei cavalli vietava ai marchesi, conti, baroni feudatarî, e a’ cittadini onorati di far uso di soli muli; ordinando, che ciascheduno di essi dovesse tenere tanti cavalli, quanti muli; e che se non potesse tenere, che una bestia, questa dovesse esser cavallo, e non mula. Volle inoltre che coloro, che avessero armenti di giumente, fossero costretti almeno a farne coprire due parti da cavalli, ed una sola da somari stalloni. Ne eccettuò da questa legge le mule da basto, e di affitto, e quelle che servivano per macinare il grano. Le pene stabilite ai contraventori di questa prammatica erano di mille fiorini per i conti, e i visconti, di oncie cinquanta per i gentiluomi, e di oncie venticinque per qualunque altra persona 395. Queste multe pecuniarie sembravano gravi, e poteano dar luogo ad accuse fiscali a danno de’ vassalli. Imperò il pretore, e gli uffiziali di Palermo pregarono Lupo Ximenes de Urrea, acciò si fosse compiacciuto di toglierle; ed egli umano, e ragionevole divenne a sospenderle, e a riserbare a sè il gastigo di coloro, che trasgredito avessero la prammatica 396. I progressi delle armi Ottomane, e le perdite fatte dalla repubblica di Venezia patria di Paolo II indussero questo pontefice a [101] pacificarsi col Duca di Urbino, e col re Ferdinando di Napoli suoi nemici; e a conchiudere con essi una lega contro il turco. Si desiderava che vi si collegasse ancora il re di Aragona, e perciò dal re Ferdinando ne furono fatte delle pratiche verso Lupo Ximenes de Urrea, i di cui consigli molto allora valeano alla corte del re Giovanni. Questo vicerè spedì al sovrano di Napoli Niccolò Leofante, cui diede le sue istruzioni 397, per sapere di che trattar dovesse; e intorno a procurare che il re di Aragona entrasse nella confederazione contro il Turco, promette al detto re Ferdinando di fare ogni opra per indurvelo 398. Dall’accennata Istruzione se ne tragge, che l’Urrea si disponea a partire per la Sardegna, giacchè vi si legge; Noi speriamo partire da questo Regno fra otto giorni per essere in Sardegna, dove credimo fra pochi giorni pacare, e tranquillare quello Regno. Pare, che questa risoluzione fosse efficace; perchè oltre di avere egli eletto per Presidente del regno nella sua mancanza il gran giustiziere Tommaso di Moncada conte di Adernò, che trovavasi lontano da Palermo, considerando che nella detta capitale poteano accadere de’ fatti, che non soffrivano dimora, elesse con suo dispaccio de’ 26 di novembre 1470, Pietro Speciale maestro razionale, Antonio Sin tesoriero, e Giacomo Pylaya avvocato fiscale, ai quali diede la facoltà di recare le necessarie provvidenze co’ ministri del sacro consiglio ne’ casi urgenti, ordinando agli uffiziali sotto la pena della vita, e della confiscazione de’ beni di ubbidire a’ loro comandi 399. Ciò non ostante egli è certo, che neppure allora fu eseguito il meditato viaggio per la Sardegna, come costa da una lettera dal medesimo Vicerè scritta al re Ferdinando di Napoli sotto li 22 di aprile dell’anno seguente 1471, e speditagli nella occasione che partiva per Roma monsignor Paolo Visconti 400 Arcivescovo di Palermo chiamatovi dal Pontefice, in cui dice, che tornando la galea, che conducea in Napoli il detto Prelato, intendea di partire per Sardegna, lasciando al governo del regno il maestro giustiziere 401; e lo stesso torna a dire in un’altra istruzione data a Niccolò Leofante per il re di Napoli 402 sotto li 25 dello stesso mese, ed anno, da cui apprendiamo che dopo il viaggio di Sardegna sarebbe questo vicerè andato in Aragona. Faceansi in questo tempo degli armamenti in Napoli, e dei preparativi in Sicilia, e particolarmente in Messina per la difesa del regno. Il re Ferdinando armava per la lega in cui era entrato col Papa, colla 394 394 Reg. del Protonotaro dell’anno 1470.1471. IV. indiz. fogl. 29. Ivi pag. 35, e seg. 396 Nello stesso Reg. fogl. 64. 397 Nello stesso Reg. del Protonotaro ivi fogl. 95. 398 Da questa istruzione ricaviamo una notizia, che i nostri storici ci hanno tacciuta: cioè, che la città di Mazara appartenesse al re di Napoli, e non già al monarca di Aragona, imperciocchè in essa vi si legge quanto segue: “La città di Mazara haviremo raccomandata non altramente, che Palermo, e Messina, perchè essendo di S.M., non manco cura havemo di quilla, che di quelle del Signor Re so Patri, ca cussì havemo in comandamento dal Signor Re, et quando non l’avessimo farriamo lo simile per l’affettione, et voluntà havemo al servitio di sua signoria”. Chiama il re di Aragona Padre del re Ferdinando, perchè questo principe per tale lo riputava. Nello stesso, e in altri monumenti vien detto insieme padre, e zio. 399 Reg. del Protonotaro dell’anno 1470-1471, IV. Indiz. fog. 98. 400 Questo prelato, di cui parlano con reputazione il Tritemio, e il Passevino, fu palermitano, e uomo dottissimo. Ci avvisa il Pirri, ch’egli lasciò al suo convento dei Carmelitani di Palermo la sua scelta libreria, che consistea in 300 volumi (Sic. Sacra Not. 1. Eccl. Panorm. pag. 169). 401 Manoscritto della Bibl. del Senato di Palermo Lett. P. 9. 402 Reg. dell’uffizio del Prot. dell’an.1470-1471 IV. Indiz. f. 170. 395 - 78 - republica di Venezia, e cogli altri principi d’Italia contro il Turco; ed in Sicilia si fortificavano i castelli, e si provvedeano di tutto il bisognevole per una valida difesa per lo stesso obbietto, temendosi che le forze ottomane dopo l’acquisto di Negroponte non si volgessero contro questo regno, e in particolare contro Messina, che è la chiave di oriente. La gente oziosa, che non penetra nei gabinetti dei sovrani, o che crede di saperne i veri interessi, veggendo questi armamenti credette di trovarvi un motivo diverso da quello, che compariva in apparenza; e sparse che il re Ferdinando di Napoli, volendo profittare della vicina morte del re Giovanni, armava per mettersi in istato, quando questo re finisse di vivere, di invadere la nostra isola; e che il vicerè Lupo Ximenes de Urrea, presentendo le mire del re Ferdinando di Napoli, avea creduto suo dovere di prepararsi a difendere questo regno, e a deludere gli sforzi, che il re suddetto avrebbe fatti per conquistarlo. Così si parlava a Lipari, e per tutta la Calabria, e i [102] discorsi istessi faceansi in Messina. Il vicerè spedendo alla Corte di Napoli Niccolò Leofante, si era doluto di queste false voci, che si erano sparse a Lipari, e per la Calabria, e le stesse doglianze il re Ferdinando fece di poi col vicerè, mandandogli Niccolò Tomacelli, contro i messinesi, e ricercò che fossero castigati coloro, che in quella città spargevano codeste favole. Apprendiamo questo aneddoto dalla risposta, che sotto il primo di giugno 1471 diede il suddetto vicerè al Tomacelli inviato di Ferdinando 403, in cui confessa di essersi divulgata questa notizia nell’uno, e nell’altro regno, alla quale, per altro egli non avea data mai fede, sapendo l’amore, che portava il re Ferdinando al Monarca di Aragona suo padre, e zio 404; e si dichiara pronto a punire coloro che ne erano gli autori, ogni volta che gli fossero noti. Avvisa poi a quel re, che egli nondimeno avea rimproverati i messinesi, perchè avessero fatti maggiori preparamenti, che non bisognavano, lo che forse avea dato motivo alle chiacchiere, che si erano divulgate 405. Egli è certo che gli affari della Sardegna non ebbero ulteriore progresso, qualunque ne fosse stata la cagione; o che il marchese di Orestano, che suscitava dei rumori, si fosse ricreduto del suo errore, o che, come scrisse il Surita 406, il re di Aragona avendo sulle spalle una nuova guerra col duca di Lorena, amò meglio di sopire i disturbi nati in quella isola, e di perdonare a Leonardo di Aragona. Perciò restò dismessa interamente la partenza di Lupo Ximenes de Urrea. Noi lo troviamo ancora in Palermo ai tre di settembre 1471, come costa 407 da un dispaccio viceregio indiritto al tesoriere Antonio Sin 408. Allontanatosi ogni sospetto di partenza, se ne restò l’Urrea in Sicilia, e continuò a reggerci colla solita sua prudenza, e destrezza. Era molto tempo, che non si celebrava il parlamento; giacchè l’ultimo si era tenuto, come detto abbiamo sul principio di questo capo, in Palermo, l’anno 1465, e per altro il re di Aragona avea bisogno di sussidii per vincere la ostinatezza della città di Barcellona, che non volea riconoscerlo per sovrano. Il d’Urrea adunque pensò di convocarlo, come ne avea ricevuto l’ordine dalla corte, e stabilì, che per il primo di novembre 1472 gli ordini dello stato fossero pronti nella città di Polizzi. La circolare indirizzata ai prelati, ai baroni, e alle università è data da Palermo ai 30 di settembre dello steso anno 409. Sopravvenne di poi al vicerè una gagliarda febbre, per cui restò così spossato di forze, che non era più in grado di fare questo viaggio;[103] laonde col consiglio del marchese di Geraci, e di altri baroni cambiò il luogo del parlamento, e lo trasportò in Palermo. Così egli scrisse ai senatori di Messina con lettera segnata in 403 Reg. dell’an. 1470-1471 IV. Indiz. nell’officina del Protonotaro fogl. 172. Da questo monumento si rileva l’errore, in cui cadde il per altro diligente Ludovico Antonio Muratori, il quale ne’ suoi Annali (all’ann. 1477, t. IX. pag. 323.) scrisse, che il re Giovanni non avea mai approvato, che fosse pervenuto al bastardo re Ferdinando il regno di Napoli conquistato dal fratello Alfonso coi denari dei suoi popoli, e che perciò sino all’anno 1477 era sempre passata mala intelligenza fra la corte di Napoli, e quella di Aragona, la quale non cessò, che nel detto anno, quando Ferdinando di Napoli, essendo rimasto vedovo, prese in moglie la vedova del principe di Castiglia, che avea nome Giovanna, ed era figlia del re di Aragona. Oltre i diversi altri argomenti, che smentiscono questa pretesa discussione fra i due re, sono una prova bastante dell’amistà che passava fra le due corti, l’accennata risposta data al Tomacelli, e le altre lettere, che di sopra abbiamo rapportate, che mostrano la buona armonia, che sempre si mantenne tra il re di Napoli, e Lupo Ximenes de Urrea, che non avrebbe coltivata l’amicizia del re Ferdinando, se la sua corte gli fosse stata nemica. 405 Si parla in questa risposta data al Tomacelli della vicina partenza del vicerè per l’Aragona, giacchè dicesi, che nel lasciare, che ei farà colui, che deve reggere la Sicilia in suo nome, gli raccomanderà, che in tutti i bisogni ricorresse per aiuto, e per consiglio al re di Napoli, come dilettissimo figlio del monarca di Aragona, ciò che è un’altro argomento contro il Muratori della corrispondenza, che passava fra questi due sovrani. Apprendiamo ancora da questa risposta, che il vicerè avea dimandati al re di Napoli i registri della Sicilia (erano forse questi i dispacci del re Alfonso suo padre intorno al nostro regno), e che quel principe glieli aveva cortesemente accordati; della quale graziosa donazione egli lo ringrazia, promettendo che destinerebbe la persona, cui doveano essere consegnati. Questi crediamo che siano nelle nostre cancellarie, ma si doveano dimandare ancora quelli dei principi Svevi, e di Carlo d’Angiò, che ci mancano a danno grave della nostra storia. 406 Annales de Aragon. tom. IV. l. 16. cap. 67, pag. 190. 407 Reg. della Regia Cancel. dell’anno 1471-1472, V. Ind. fogl. 2. 408 Questo dispaccio ci palesa, quale fosse allora il salario de’ vicerè; giacchè si ordina al tesoriere, che dei primi introiti della camera segli pagassero le oncie 700 assegnategli per il salario dell’anno 1471-1472, V. Indiz., di terzo in terzo, secondo il costume. Si avverta però che 700 oncie di allora valeano considerabilmente più, che ora non vagliono. 409 Reg. del Protonotaro dell’anno 1472-1473. IV. Indiz. fogl. 26, e seg. 404 - 79 - questa città ai 15 di ottobre 1472 410, e nel giorno seguente a quelli di Catania 411, ai quali diede conto per qual motivo, non ostante i regolamenti dati dai sovrani, che cotali adunanze si dovessero convocare nella loro città, egli avesse destinata la città di Polizzi per luogo del parlamento, e perchè poi lo avesse trasferito a Palermo 412. Di questo parlamento non abbiamo veruna memoria presso i nostri scrittori della storia siciliana, e lo stesso canonico Antonino Mongitore, comunque nelle sue memorie 413 mentovi un parlamento all’anno 1472, dice non ostante che siesi tenuto ai venti di febbraro, quando sappiamo, che dovea tenersi nel mese di novembre. Abbiamo nondimeno qualche notizia di esso dai capitoli accordati dal re Giovanni al regno di Sicilia 414, l’anno 1474. Ricaviamo da essi, che i sussidî ricercati furono per i torbidi, che erano tuttavia in Catalogna; che il regno di Sicilia era esausto, ma che nondimeno i parlamentarî, per mostrare il loro ossequio al re, aveano offerto la somma di cinquanta mila fiorini da pagarsi in due anni, e che era stato eletto per ambasciadore del parlamento Pietro de Luna, il quale, oltre di recare l’offerta, apportò la nota delle grazie, che gli ordini dello stato ricercavano da sua maestà al numero di nove, che nella maggior parte furono accordate 415. Non erano appena terminate le sessioni del parlamento, che giunse al vicerè la giuliva notizia, che già la città di Barcellona si era sottomessa all’ubbidienza del re Giovanni. Di questo lieto avviso ne fu dato conto a tutte le università del regno con una lettera circolare, in cui si ordinava, che si rendessero le dovute grazie a Dio, e si facessero dei festeggiamenti, e delle illuminazioni, essendo stata questa vittoria la causa, per cui cessava la guerra, e si tranquillavano i regni di S.M. 416. Non restò conchiusa, come fu avvertito, la pace proposta col re di Tunisi, per cui fu mandato il nobile Andrea di Navarro; seguivano le ostilità dei corsari tunisini, e oltre ai danni, che ne soffriva il commercio, spesso i vassalli del re nostro cadevano in ischiavitudine. Rincrescea al cuore di Lupo Ximenes de Urrea il danno, che recava ai siciliani la non conchiusa pace coi tunisini; ed essendo capitato in Palermo il signor Raffaello Vives ambasciadore del re di [104] Portogallo, che passava in Tunisi per lo stesso oggetto, gli diede incombenza di trattare la pace anche a nome del re di Aragona, e di quel di Napoli; e siccome vi erano in Tunisi cinquecento schiavi siciliani, l’Urrea si compromise di pagare per raccattarli sessantamila doble da trarsi dal danaro, che si sarebbe cavato dalla bolla della Crociata 417, che si aspettava dal sommo pontefice 418. Per animare poi il Vives, e il di lui compagno Emanuele Boa a portare al suo termine questo negozio, con un’altro dispaccio dei 20 di novembre dell’anno 1472 promette loro, che ottenuta che eglino avranno la pace, o per lo meno una tregua, ne avrebbono in premio ottenuta la libera estrazione dai porti di Sicilia, e da qualunque luogo dove sogliono conservarsi i grani, che noi diciamo caricatori, senza fare veruna spesa, di 410 Reg. dell’uffizio del Protonot. ivi pag. 35. Nello stesso Reg. pag. 36. 412 Due ragioni assegna, per cui destinò la città di Polizzi per convocarvisi gli ordini dello Stato: la febbre sopravvenutagli appena ricevuto l’ordine del Re di tenere il parlamento, che inabilitandolo a fare il lungo viaggio di Catania, lo avea indotto a scegliere la città di Polizzi come la più vicina; e la vecchiaja del marchese Geraci, ch’era uno dei primi baroni del regno, che non gli permetteva di andare così lontano. Dice poi di averlo intimato in Palermo per la recidiva della stessa febbre, che solendo sempre essere peggiore, lo avea ridotto in istato di non potersi più muovere. 413 Parlam. di Sicilia pag. 52. 414 Capit. Regni Sic. in Joanne tom. I. pag. 490 e seg. 415 Il grande Ammiraglio Antonio Ventimiglia non potè intervenire a questo parlamento, e scelse per suo procuratore il nobile Giuliano Passaflumine, cui diede le sue istruzioni da presentarsi al vicerè. In esse uniformandosi a quanto fossero per determinare i parlamentarii intorno al donativo da offerirsi al re, propone le grazie, che credea necessarie a chiedersi. È degna di osservarsi l’accusa, che egli fa a tre giurisperiti, dei quali si tacciono i nomi. Essi, dice, che da molto tempo erano intenti ad impoverire il regno per le frodi, dalle quali nasceano alla giornata le discordie, e le nimicizie frai cittadini, e per cui accadevano allo spesso degli omicidii, a segno che non vi era più sicurezza di andare da un luogo ad un’altro, e neppure da una in un’altra casa. Dolevasi della indulgenza del vicerè, che sulla speranza di esser presto richiamato in Spagna, trascurava di apporvi riparo. Era perciò di avviso, che fra le grazie, che domandar doveansi a S.M., la principale dovesse essere: che si compiacesse di promuovere in avvenire soggetti virtuosi, ed incorruttibili per l’amministrazione della giustizia, e per gastigare coloro degli uffiziali, che abusano del loro ministero, trattando con alterigia i sudditi di S.M., e commettendo enormi ingiustizie; e che si degnasse di fare una esatta indagine dell’abilità, e dei costumi di coloro, ai quali, tradito dalle false relazioni, promesso avea nelle vacanze le magistrature. Sono questi i veri obbietti, che aver debbono i parlamentarii, della ispezione dei quali è il benefizio del pubblico, e queste dovrebbono essere le vere grazie da domandarsi al Sovrano. Questo voto conservasi nella regia cancellaria (registro di Antonio Monaco segr. dell’anno 1472 segn. num. 36 pag. 132, e di Stefano Macri segr. dello stesso anno segn. num. 69 pag. 28). 416 Reg. di Stefano Macri segret. dell’an. 1472-1473 VI. Indiz. segnato num. 59 conservato nella Regia cancell. fog. 35. 417 Questa è la prima volta che noi vediamo nominata la bolla della Crociata accordata ai serenissimi re di Sicilia; laonde sospettiamo che non abbia una più antica origine che questa dell’anno 1472. Egli è vero che i pontefici costumarono prima di questo tempo di cercare dai Cristiani dei sussidii, per far la guerra al Turco; ma allora esigevano eglino medesimi per mezzo dei loro legati il denaro, e lo applicavano eglino stessi negli armamenti. Questa però di cui parliamo, era accordata ai sovrani, i quali teneano delle flottiglie, per custodire i nostri mari dall’invasione dei legni barbareschi, e per ricomperare quei disgraziati vassalli, che per isventura erano caduti nelle loro mani. 418 Reg. del Protonotaro dell’anno 1472-1473, VI. Indiz. fogl. 171. 411 - 80 - quei frumenti dei quali aveano di bisogno 419. Siccome però il Vives ed il suo compagno erano prima andati in Roma, spediti dallo stesso vicerè, e in questo viaggio aveano speso di proprio trecento sessanta docati, somma, che il regio erario non potea per allora pagare, il vicerè con un terzo dispaccio del primo di dicembre seguente si scusa di non essere in grado di farli soddisfare; ma in nome suo, e del re di Aragona ancora promette che subitochè saranno ritornati da Tunisi, sarà loro interamente pagato non solo questo denaro, ma quanto ancora saranno per spendere nel futuro viaggio 420. Appena arrivato il Vives a Tunisi venne a capo di stabilire con quel re una tregua di due anni, durante la quale si sarebbono con agio trattati gli articoli della pace. Ne fu tosto avvisato il vicerè, il quale con un pubblico bando ai 19 di dicembre istesso fe promulgare prima in Palermo, e poi per tutto il regno questa sospensione di ostilità; prescrivendo che dal primo di gennaro 1473 in poi cominciava la convenuta tregua, e vietando ai sudditi del re da questo giorno in avvenire di molestare i Tunisini 421. Il re Giovanni volendo ricompensare lo zelo del figliuolo nel sottoporre alla di lui ubbidienza la città di Barcellona, gli assegnò in Sicilia le rendite, che erano chiamate le gabelle riservate del regno, trattenendosi solo sopra di esse per uso suo quei tredici mila fiorini, che erano state al re Ferdinando in prima assegnate, quando fu dichiarato correggente. Questo assegnamento fu fatto secondo il Surita 422 agli 8 di giugno 1473. Perciò questo primogenito del re Giovanni spedì in Palermo Giovanni Madrigale come suo procuratore, ad oggetto di esigersi l’assegnato denaro. I deputati del regno attenti a conservare le leggi costituzionali della nazione, con sua umile risposta scrissero a questo sovrano: che era prima necessario, secondo i capitoli del regno, che ei fosse riconosciuto per re di Sicilia, esigendo dai sudditi il ligio omaggio di fedeltà, e giurando l’osservanza delle nostre leggi, e costituzioni 423. La lettera dei deputati è data in Palermo ai 22 di aprile 1774. Persuaso della ragionevolezza della loro dimanda il re Ferdinando incaricò il vicerè Lupo Ximenes de Urrea, affinchè dasse il giuramento, e ricevesse il ligio omaggio. Questi con circolare dei 7 di maggio dello stesso anno intimò i baroni, gli ecclesiastici, e le università, acciò per i 15 del seguente mese di giugno venissero, o mandassero i loro procuratori per questa solenne funzione 424. Troviamo nell’anno istesso celebrato in Palermo il generale parlamento; ma non si dice nè il mese, nè il giorno, in cui si radunarono gli ordini dello stato; solamente sappiamo che furono in esso offerti al re soli cinquanta mila fiorini da pagarsi in due anni, e che fu destinato come [105] ambasciadore dei parlamentarî Pietro de Luna 425, il quale portatosi alla corte del re Giovanni richiese, ed ottenne molte grazie a favore del regno 426. Nel ridetto anno soffrirono gli Ebrei in Sicilia una gran persecuzione. Il Surita, che ce ne fa menzione 427, non accenna dove nascessero i primi movimenti contro questi infelici. Il Caruso opinò nelle sue memorie storiche 428, senza apportarne veruna prova, che il primo macello ne fu fatto in Palermo; noi però più volentieri abbracciamo il sentimento di Monsignor di Giovanni 429, il quale lasciò scritto, che nel dì 15 di agosto dedicato all’assunzione di Maria Vergine si sollevò in Modica in gran tumulto il popolo, e gridando: Viva Maria, e periscano gli Ebrei, entrò furiosamente nel ghetto, e trucidò quanti ebrei vi trovò. Il Surita adduce per motivo di questa sollevazione la temerità degli stessi, che disputavano contro la nostra santa religione. Quel, che è certo, egli è, che il numero dei forsennati crebbe in quelle parti, e che si comunicò il loro furore ai paesi circonvicini. Il vicerè, tosto che ne fu avvisato, fe’ impiccare per la gola sei dei principali capi; ma questo rigore nulla giovò, giacchè crescea di giorno in giorno la rabbia popolare, e particolarmente in Modica, e nella città di Noto, giunse a tal segno la barbarie, che furono passati a fil di spada non solo gli uomini, e le donne ebree, ma persino i teneri, ed innocenti fanciulli; e contasi, che in uno di questi ghetti ne furono trucidati seicento, e cinquecento in un altro. Questa epidemica crudeltà diramandosi continuamente nella valle di Noto, il vicerè prese l’espediente di avvicinarvisi, acciò fosse più a portata di ripararvi, e andò a fissare la sua dimora nella città di Catania. Stava già per spirare la tregua col re di Tunisi: il re di Aragona distratto dalla guerra con quel di Francia per la contea di Rosciglione, non avea potuto spedirvi il suo ambasciadore per stabilire gli articoli della pace. Considerando il vicerè, che spirando la tregua tornerebbe la Sicilia ad esserne molestata, spedì al Bey suddetto il tesoriero del regno Guglielmo Peralta con una lettera offiziosa a quel principe, in cui lo pregava a nome del suo monarca di prolungare la tregua per altri due anni. Noi abbiamo copia della suddetta lettera, e 419 Dal medesimo Reg. allo stesso foglio. Reg. del Protonotaro dell’anno 1472-1473, IV. Indiz. fogl. 171. 421 Reg. di Antonio Monaco segret. dell’anno 1473 conservato nella regia cancell. fogl. 128. 422 Annales de Aragon. tom. IV, lib. XVIII, cap. 16, fogl. 157. 423 Reg. di Stefano Macri Segr. dell’anno 1473-1474, Indiz. VII, conservato nella regia cancelleria al num. 65 fogl. 159. 424 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’an. 1474, VII. Indiz. fogl. 69. 425 Mongit. Parl. di Sic. tom. I. pag. 105. 426 Capit. Reg. Sic. t. I. in Joanne pag. 498. 427 Annales de Aragon. t. IV, lib. XIX, cap. XIV, pag. 222. 428 P. 3, lib. IV. 429 Ebraismo della Sicilia cap. XXV. part. I, num. 19, pag. 188. 420 - 81 - ancora le istruzioni date al Peralta nella regia cancellaria 430. La lettera è segnata in Catania agli 8 di giugno 1475. Ci è ignoto qual esito abbia avuta la commissione affidata a questo prelato. Questa fu l’ultima provvidenza data da questo vicerè. Ammalatosi egli gravemente in Catania, pieno di anni, e di meriti se ne morì ai 12 di settembre dello stesso anno, compianto dai siciliani tutti da lui così lodevolmente per tanti anni governati. Fu egli uomo valorosissimo nelle azioni militari, e gran politico nel maneggio dei grandi affari; fu amato, e riputato moltissimo non solo dal re di Aragona, e dal di lui figliuolo il re Ferdinando, ma dalle altre potenze europee ancora, come uno sperimentato ministro nell’arte difficilissima di reggere i popoli. CAPO XVII. Giovanni Tommaso di Moncada conte di Adernò maestro giustiziere, e presidente del regno. Guglielmo Pujades, e Guglielmo Peralta vicerè. Più volte nell’antecedente capo si è fatta menzione di Giovanni Tommaso di Moncada che il vicerè Lupo Ximenes de Urrea avea disegnato per presidente del regno, quando dovea partire per la Sardegna. Siccome però questa partenza per i varî intoppi, che si frapposero, non mai ebbe effetto, il Moncada restò in possesso dell’onorevole dispaccio, nè esercitò, vivendo l’Urrea, la carica addossatagli. Morto però in Catania il detto vicerè, o in forza dell’antecedente dispaccio, o per nuova commissione datagli prima che questi finisse di vivere, che noi non sappiamo, (giacchè nell’officina del protonotaro non ci è riuscito di trovarne il monumento, che i cronologi abate Amico, ed Auria ci accennano), o perchè secondo le leggi del regno, quando muore il vicerè, nè disegna il successore, resta il maestro giustiziere col sacro consiglio al governo [106] del regno, egli è certo, che resse interinamente la Sicilia, e per pochi giorni questo cavaliere. Era egli catanese, ed oltre la dignità di maestro giustiziere, ebbe quella di governatore delle armi nella sua patria, e nella città di Agosta, mentre il regno era minacciato dalla invasione dei Turchi. Era stato carissimo al re Alfonso, e creato dal medesimo l’anno 1424 tesoriero del regno. Scrivono i nostri storici, che fu uomo dotto, particolarmente nelle belle lettere, e nella poesia. Le sue pistole latine furono stampate in Militello l’anno 1620 per i torchi di Giovanni Rovo, che poi il Carrera rese volgari, e furono ristampate colla traduzione ai fianchi italiana, e spagnuola in Valenza l’anno 1658. Di questo distinto personaggio parlano, oltre i suddetti cronologi, il Marineo 431, Agostino Lingueglia 432, il P. Abate Amico 433, e il Mongitore 434, il quale ne stroppia il nome chiamandolo in vece di Giovan Tommaso, Giovanni Antonio. Di questo illustre soggetto, di cui tornerà in appresso il discorso, non abbiamo verun monumento interessante in questo suo primo governo, che durò pochi giorni. Afflisse frattanto estremamente l’animo del vecchio Giovanni, e del re Ferdinando la perdita di un così amabile ministro, quale era stato Lupo Ximenes de Urrea, e considerando quanto fosse necessario nei presenti pericoli, in cui era la nostra isola, minacciata non meno dell’Italia dalle forze ottomane, che vi si destinasse un soggetto, che sapesse attirarsi l’affetto dei sudditi, e fosse in estimazione delle potenze d’Italia, che potessero in ogni evento soccorrerlo, fra molti soggetti, che ebbero presenti, rivolsero l’occhio al gran maestro di Montesa, che si era mostrato prode cavaliere nelle armate, ed era dotato di prudenza, di consiglio, di zelo della giustizia, e di ogni altra virtù per reggere gli stati, di costumi irreprensibili, ed amato dai Veneziani, dal duca di Milano, dai Fiorentini, dai Genovesi, dal papa, e dal sacro collegio, e dal re di Napoli, che lo tenea in conto di padre. Questo vecchio venerabile nondimeno, quantunque fosse stato in particolare pregato dai sovrani per accettare la carica di vicerè, se ne scusò, rappresentando, che era oramai per lui il tempo di abbandonare il mondo, e di ritirarsi a menare gli ultimi giorni di sua vita nella solitudine delle dimestiche mura per vivere a Dio; anzi rinunziò la luogotenenza generale del regno di Valenza, che tuttavia esercitava 435. Accettata, come era dovere, la scusa del benemerito gran maestro di Montesa, siccome l’affare non soffriva dimora, si determinò il re Giovanni di scegliere due vicerè: cioè Guglielmo Pujades, che era conservadore in Sicilia, e Guglielmo Peralta, quello stesso, che era stato poco prima spedito per ambasciadore a Tunisi. La real cedola fu spedita da un luogo detto lo Spedalet presso Barcellona ai 2 di ottobre dello stesso anno 1475, e fu registrata nell’uffizio della regia cancellaria 436 ai 23 di dicembre 437. Non 430 Reg. di Luca Pollastra senza coperta dell’anno 1475, VIII. Indiz. fogl. 281. Epist. lib. V. ad Cataldum Parisium. 432 Ritratti della Prosapia, et Heroi Moncadi p. I. Imag. 12, pag. 439, e seg. 433 Catana Illus. t. IV. lib. XII. cap. 4, p. 163. 434 Bibl. Sic., tom. I, p. 366. 435 Surita, Annales de Arag., t. IV, lib. XIX, cap. XXXVIII, p. 249 436 Reg. dell’anno 1475.1476, IX Indiz., f. 104. 437 É d’uopo di emendare in questo luogo lo sbaglio preso dal padre abate Amico, il quale nella sua Catana illustrata (lib. XII, tom. IV, cap. 4, p. 163), scrisse che il conte di Adernò dopo la morte di Ximenes de Urrea fu presidente del regno: integro triennio, quando appena governò tre mesi. 431 - 82 - sappiamo, se ne avesse preso il possesso il solo Pujades, ma è più verisimile, che si fosse aspettato il ritorno da Tunisi del Peralta: qual congettura rendesi assai probabile dall’osservarsi, che siesi differito fino ai 23 di dicembre di registrare le lettere patenti. Avrà certamente il Peralta, udita la sua elezione, risoluto di partirsi da Tunisi, e di lasciare ad alcun altro la commissione di ultimare la proposta tregua. Ci è ignoto il nome della persona destinata; ma ci costa che costui stava già trattando la pace col re di Aragona, e di Sicilia, e prevenne il vicerè, acciò, sebbene terminasse il tempo della tregua, impedissero in Sicilia, che si armassero dei legni contro i Tunisini, come egli ne era convenuto con quel re. Noi abbiamo la risposta dei due vicerè Pujades, e Peralta a questa persona incaricata, scritta da Palermo ai 7 febbraro 1476, nella quale lodano quanto questi ha operato, ed assicurano che daranno le provvidenze, acciò dalla parte dei Siciliani non siano turbati questi primi principî per la pace 438 . Di questi due vicerè nulla abbiamo che meriti di essere registrato, se se ne eccettui il [107] parlamento generale, che fu convocato in Palermo per il primo, o il secondo giorno di maggio per ordine dei sovrani, come si fa palese dalla circolare indiritta ai prelati, ai baroni, ed alle università da Catania sotto i 15 di marzo 1477 439. Mancano gli atti di questo parlamento, e perciò ignoriamo quali affari vi si sieno trattati, e qual donativo sia stato offerto ai sovrani; solo nell’accennata circolare si dice generalmente, che si chiamavano i parlamentarî per bisogni concernenti il servigio del re, e il bene del regno. Il Mongitore nella raccolta dei parlamenti trascura di farne motto 440. CAPO XVIII. Giovanni Cardona conte di Prades vicerè, Giovanni Tommaso Moncada presidente del regno. Mentre i due vicerè Pujades, e Peralta governavano questo regno, inaspettatamente si videro tolti d’impiego. Il re Giovanni con un dispaccio dato in Barcellona ai 3 di agosto 1477, che fu poi registrato in Palermo ai 22 del seguente ottobre 441, li privò della carica affidata loro, ed elesse per vicerè Giovanni Cardona conte di Prades, che trovavasi in Napoli. Il motivo apparente, che si apporta nel dispaccio, della loro rimozione, è che eglino doveano andare in Sardegna per assistere quel vicerè nelle tumultuazioni, che il marchese di Orestano, malgrado il perdono ottenuto, continuava a suscitarvi. Ma il Surita 442 ci addita il vero motivo, per cui furono deposti. Il vicerè d’Urrea negli ultimi anni del suo governo, oppresso dalla vecchiaia, e dalle infermità, che abbiamo mentovate, era divenuto indulgentissimo, e trascurava di apporre i dovuti ripari ai disordini, che alla giornata nascevano in Sicilia. La corte di Barcellona intesa degli abusi introdottisi nel regno, nello scegliere Pujades, e Peralta li avvertì particolarmente di due cose, cioè di metter ordine alle cattive costumanze, che si erano introdotte, e di esigere con esattezza le regali rendite, e tutto quel denaro, che si potesse, per mandarsi alla corte, la quale per le molte guerre, che sostenea, era sempre in necessità di averne. Costoro adunque, per farsi merito coi sovrani, non solo erano rigorosissimi nello estirpare gli abusi, e nella esazione delle rendite della camera, ma cercavano tutte le maniere da far denari, per così impinguare la cassa della corona, senza badare alla massima, che spesso summum jus summa injuria est; e senza riflettere che i monarchi, comunque vogliano essere soccorsi dai loro vassalli, non amano però che questi sieno angariati, e ridotti in povertà. Dolevansi i Siciliani del soverchio rigore dei viceregnanti, e dei modi irregolari, con cui faceansi le esazioni; e siccome ambidue questi moderatori del regno aveano il nome di Guglielmo, colla solita loro acutezza gridavano, che erano tornati i tempi di Guglielmo il Malo, e che il monarca di Aragona in vece di uno ne avea loro mandati due per scorticarli. Queste mormorazioni giunsero a penetrare nei gabinetti reali, e Giovanni per evitare il male, che ne potea nascere, si determinò di allontanarli sotto un altro pretesto. Fra gli altri incarichi, che furono dati al nuovo vicerè, vuolsi che vi sia stato quello di frastornare il matrimonio, che il re di Napoli Ferdinando stava trattando fra uno dei suoi figliuoli, ed Anna Caprera contessa di Modica. Giovanni Caprera figliuolo del famoso Bernardo, di cui si è favellato nel primo, e nel presente libro di questa cronologia, era morto senza eredi, e perciò succedea nei vasti stati l’unica sua sorella Anna, cui i due Guglielmi Pujades, e Peralta aveano accordata l’investitura della contea suddetta. La fresca 438 Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1475.1476, IX Indiz., f. 194. Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1476.1477, X. Indiz., segnato lett. A. f. 253 e seg. 440 Questo scrittore nelle memorie storiche, che precedono gli atti dei parlamenti, fa menzione all’anno 1475 di un parlamento, che dice celebrato immediatamente dopo la morte di Lupo Ximenes de Urrea. Muovesi a crederlo dalle parole del Pirri (Chron. Reg. Sic., p. 101), il quale racconta, che il conte di Adernò fu eletto presidente del regno in regni Comitiis. Ma noi stentiamo a persuaderci, che il nostro storiografo abbia voluto indicare un parlamento generale; e immaginiamo che abbia voluto additarci una radunanza del sacro consiglio, e dei baroni che si ritrovavano a Catania, quando morì l’Urrea, i quali e perchè Giovanni Tommaso Moncada era stato eletto dal defunto vicerè, qualora dovea andare in Sardegna, per suo successore, e perchè trovavasi maestro giustiziere, determinarono che interinamente governasse il regno. 441 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1477.1478, XI. Indiz., fog. 59. 442 Annales de Arag., tom. IV, lib. XX, cap. 14, p. 285. 439 - 83 - [108] età di questa dama, che non avea che diciotto anni, la nobiltà del suo sangue, e la considerabile dote 443 che possedea, le attrassero molti concorrenti, che anelavano per averla in isposa, e fra questi un figliuolo di Ferdinando re di Napoli, a cui forse non dispiacea il metter piede nel nostro regno. I due viceregnanti, che allora reggevano la Sicilia, penetrarono i maneggi segreti, che si faceano dal re Ferdinando, e ne avvisarono immediatamente il re di Aragona, il quale sapendo il genio della nazione siciliana di avere un proprio sovrano, e dubitando, che mettendo il piede in Sicilia un figliuolo del re di Napoli, non tentassero i nostri di scuotere il giogo aragonese, acclamando questo principe per suo signore, s’ingelosì di questo trattato, e cercò di attraversarlo, dandone la commissione al vicerè conte di Prades 444. Ma questo istesso vicerè era uno di coloro, che pretendevano di fare entrare nella sua casa questa ricca, e nobile donzella; ei procurava di ottenerla in isposa di Ferdinando Cardona suo nipote, nato dal suo primogenito il contestabile di Aragona, e credea di avervi un maggior diritto per conto della moglie sua, che era della stessa famiglia Caprera. Giunse alle orecchie del re Giovanni la notizia delle pratiche, che si faceano dal conte di Prades, e diffidando di lui, spedì in Sicilia Antonio Gerardino suo segretario con lettere alla vedova contessa madre di Anna. Recavano queste, che il re istesso volendo passare alle terze nozze, volea questa dama per moglie 445. Il vicerè non mostrò di opporsi ai disegni del sovrano; anzi incaricò il protonotaro del regno Gerardo Agliata, e il maestro razionale Giacomo Bonanno, affinchè si cooperassero col Gerardino per fare eseguire le intenzioni del proprio monarca. Qualunque ne sia stata la cagione, ogni pretensore ne fu escluso, e piacque agli occhi della donzella Federico Enriquez il primogenito del grande ammirante di Castiglia 446, che la sposò 447. Gli affari di Sardegna andavano sempre di male in peggio. L’inquieto Leonardo di Aragona non intralasciava di tenere in continove turbolenze quel regno; a tal che fu d’uopo al re Giovanni, dopo che segli era compilato il processo, di pronunciare contro di esso la sentenza, con cui lo dichiarò rubello, lo condannò a morte, e gli fe confiscare i beni. Costui nondimeno punto non sgomentandosi alla fatale sentenza, e ricusando di ubbidire al giudizio del suo re, alzò pubblicamente la bandiera della ribellione, e facendosi nominare monarca di Sardegna, coi suoi fratelli, e figliuoli, e con gente armata sotto lo stendardo, che avea le armi di Arborea, girava per le città, e terre dell’isola, obbligando gli abitanti dei luoghi, che conquistava, a prestargli il ligio omaggio, e a riconoscerlo per loro sovrano. Il vicerè di quella isola coi senatori, ed uffiziali si erano ricoverati nel forte castello di Cagliari; e trovandosi senza truppe, munizioni da guerra, e viveri, scrissero pressanti lettere al conte di Prades, chiedendo questi soccorsi, senza i quali quel regno agevolmente sarebbe caduto nelle mani dei rubelli 448. L’affare era di molta [109] importanza; e perciò il conte di Prades, considerando quanto tornasse al servizio del re di Aragona la conservazione di quella isola, da una parte spedì tosto in soccorso di essa due vascelli carichi di grano, e fe’ preparare la nave di un certo Oliver, per trasportarvi vettovaglie, ed altro, che prontamente bisognasse; e dall’altra convocò in Palermo per i 15 di febbraro uno straordinario parlamento, invitandovi gli ordini dello stato, acciocchè si dassero le provvidenze per soccorrere, e difendere la Sardegna. Si dà conto di quanto abbiamo riferito nella circolare data in Palermo ai 13 di gennaro 1478 449. Gli atti di questo congresso parlamentario si sono dispersi, come gli antecedenti, e i nostri storici neppure lo menzionano; laonde ci è ignoto cosa siesi ivi trattato, e quali soccorsi siensi poi mandati in Sardegna. Il Surita 450 scrive, che in esso fu inoltre fatto al re un donativo di venticinque mila fiorini per la guerra, che sostenne in Sardegna. Ci resta di questo parlamento nell’uffizio del protonotaro 451 una carta, che contiene un atto di suprema autorità, che esercitarono i tre ordini dello stato radunati in parlamento, e rappresentanti il regno, dei 17 di marzo 1478, con cui confermano per un’altro biennio, cioè 443 Scrisse il Surita (Ann. de Arag. t. IV, lib. XX. cap. 14, pag. 286), che la contea dava un’annua rendita di venti mila fiorini, somma allora considerabile, e che i vassalli di essa erano dieci mila. Il p. Aprile (Cronol. della Sicilia, lib. II, cap. 3, p. 246) nega che vi potesse essere allora una popolazione così poco numerosa negli stati di Modica; e per dimostrare che fosse maggiore, adduce la numerazione degli abitanti fatta per ordine del re Vittorio Amedeo di Savoja a’ suoi tempi, da cui rilevasi che allora nella città di Modica non si calcolava che vi fossero meno di diecinove mila abitanti, e che si ragionava che gli abitanti della contea sorpassavano il numero di cinquantamila ed ottocento. Se codesto argomento provi ciò che pretende questo gesuita lo decidano i politici, i quali sanno che le popolazioni crescono e mancano, e che non può trarsi prova del numero degli abitanti dell’anno 1477 da quelli che furono nel 1714. 444 Eravi anche frai concorrenti l’infante Arrigo di Aragona, su cui cadendo gli stessi sospetti, si fece ogni opra per escluderlo. 445 Non è verisimile che Giovanni già decrepito scrivesse da senno; ed è a credersi ch’egli abbia fatta questa dimanda per fare allontanare tutti i pretensori, e darla poi ad Alfonso di Aragona suo nipote, figliuolo bastardo del re Ferdinando suo figliuolo. 446 Surita, Annales de Arag., t. IV, lib. XX, cap. 18, p. 286. 447 Il Caruso (Mem. Stor. part. III, lib. IV, tom. 3, p. 82) scrisse che questo cavaliere trovavasi a caso in Sicilia, dove era venuto per alcuni suoi affari. L’Aprile poi (nel citato luogo) intende, che questo matrimonio siesi fatto colla volontà del re Giovanni, il quale era contento che questa dama si sposasse con chiunque, purchè fosse un suo vassallo come lo era l’Enriquez. Noi però, da quanto abbiamo tratto dal Surita, non sappiamo persuadercene. 448 Si erano uniti al marchese di Orestano il visconte di Galluri, ed altri signori, in guisa che la ribellione crescea a dismisura di giorno in giorno. 449 Reg. del Protonotaro dell’anno 1477-1478, XI. Indiz. fogl. 49 e seg., e fogl. 74. 450 Annales de Arag., tom. IV, lib. XX, cap. 15, pag. 287. 451 Reg. dell’anno 1477.1478, XI Indiz., segnato colla lettera A, f. 251. - 84 - per gli anni XII, e XIII Indizione, i giudici della gran corte, perchè questo è il servizio del re. Dalla qual carta ne caviamo, che il parlamento fu differito al seguente mese di marzo. Ella però è cosa certissima, che nel suddetto parlamento fu tra le altre cose stabilito, che lo stesso vicerè conte di Prades andasse di persona in Sardegna, ed egli vi si dispose immantinente. Nell’uffizio del protonotaro 452 noi abbiamo l’atto di elezione di presidente del regno, che il detto vicerè di Cardona fa in persona di Giovanni Tommaso di Moncada conte di Adernò, e maestro giustiziere sotto li 9 di aprile 1478, e in esso atto vi si dice espressamente, che essendosi nel parlamento poco prima tenuto in Palermo stabilito, che il vicerè conte di Prades si portasse in Sardegna per sedare i tumulti ivi insorti, lascia egli per presidente del regno il mentovato conte di Adernò 453. Non divennero nonostante i parlamentarî a contentarsi che il vicerè partisse, che a grandissimo stento. Rappresentarono eglino al conte di Prades, che era cosa pericolosa il lasciare il regno di Sicilia sprovisto di truppe, mentre una flotta del Turco d’intorno a mille vele era marciata verso la Vallona, e a Larta nell’Albanìa per conquistare quei castelli, che erano non molto lontani dalla nostra isola. Essendo dunque questa isola assai più rispettabile che non era la Sardegna, minacciata dalle mani ottomanne, non parea ragionevole il metterla a rischio di essere invasa dai Turchi, per domare un rubello, che inquietava la Sardegna. Ma il Cardona, che credea di trarre degli allori da questa impresa, fu costante nella risoluzione di andarvi, sempre sul pretesto, che così ricercava il servigio del sovrano. Bisognò dunque compiacerlo; e intanto supponendosi che non partisse così presto, fu spedito a tutta fretta in Aragona Giovanni Madrigale, per far presenti al monarca i pericoli, ai quali era esposta la Sicilia, che si lasciava priva di soldatesche, e di munizioni. Non volle il conte di Prades aspettare che fosse ritornato da Barcellona il Madrigale, e senza dar retta alle premure de’ deputati del regno, fe imbarcare in Palermo alcune compagnie di soldati, acciò andassero alla difesa di Cagliari, ed egli, affrettandosi di raggiungerle, andò con una galera a Trapani, dove l’ammiraglio di Aragona Giovanni Villamarino ebbe ordine di aspettarlo colla squadra. Appena fu ivi arrivato, che mosse le vele verso la Sardegna, conducendo ancora seco alcune navi cariche di seicento salme di grano, per recar viveri a’ Sardi 454. Giunse in quell’isola nello stesso mese di aprile. L’arrivo del conte di Prades non potè non [110] apportare gelosìa a Niccolò Carroz vicerè di Sardegna, il quale dietro di aver ridotto agli estremi il marchese di Orestano, soffriva a malincuore, che altri venisse a raccogliere le palme delle sue fatiche. Intanto ritornò a’ 30 di aprile Giovanni Madrigale da Barcellona, e sapendo che il conte di Prades era già in Sardegna, andò a sbarcare a Cagliari, ed apportò le lettere del re di Aragona, colle quali lodava la presa risoluzione di andare egli di persona in Sardegna. Gli interessi del marchese Orestano andavano assai male; già era a mal partito prima che arrivassero le truppe da Sicilia, e l’armata regia; laonde aspettandosi l’intera rovina, richiese un’abbocamento col Cardona, dichiarando ch’egli avrebbe svelati alcuni segreti, che molto conducevano al riposo di quell’Isola, e al servigio de’ sovrani di Aragona, esibendo anche di mostrare alcune lettere, ch’egli ricevute avea dal re Ferdinando primogenito del re Giovanni 455. Il conte, e con esso anche Giovanni Madrigale erano di avviso di ascoltare l’Orestano fondati sulla massima politica, che nelle guerre è saggia condotta il dare orecchio al nemico, qualora domanda di essere ascoltato. Ma il vicerè di Sardegna, martellato dal vedersi un rivale, che volea rapirgli la gloria di aver conquiso l’Orestano, fu di contrario parere, dichiarando che questo nemico del re cercava il congresso per prender tempo, e isfuggire la tempesta, che così davvicino gli sovrastava. Il conte di Prades temendo, se l’affare non riusciva in vantaggio della corona di Aragona, che non potesse esserne egli incolpato, non si ostinò nella sua opinione, e ricusò di abboccarsi coll’Orestano. Avvedendosi poi delle gelosie del Carroz, e persuaso per altro che i sovrani non aveano che temere in Sardegna da questo rubello ora mai ridotto alla necessità di sottomettersi, pensò di sagrificare la gloria, che avrebbe potuto acquistare in questa guerra, e lasciando la flotta, e le truppe agli ordini di quel vicerè 456, se ne partì a’ 3 di maggio, e ritornò in Sicilia per accudire alla nostra difesa 457. 452 Reg. dell’anno 1477.1478, XI Indiz. f. 37. Il Caruso (Mem. Stor. part. III, lib. IV, tom. III, p. 83), e il padre abate Amico (nelle note al Fazello tom. III, dec. II, lib. IX, cap. 10, nota 7, p. 190) scrissero, che il conte di Prades lasciò per suo luogotenente Sigismondo de Luna conte di Sclafani; non ebbero eglino presente l’atto di elezione, che noi abbiamo accenato, e conservasi nell’uffizio del protonotaro; e caddero in questo errore, perchè non badarono alle parole del Surita, il quale espressamente dice, che il de Luna fu eletto capitano delle truppe, che si destinavano per la Sardegna. (Annal. de Arag., tom. IV, lib. XX, cap. 15, p. 290). 454 Surita, Annal. de Aragon., tom. IV, lib. XX, cap. 18, p. 291. 455 Il re Ferdinando favoriva il marchese di Orestano, e non avea mai approvata la condotta finallora tenuta contro di questo cavaliere, quantunque per un rispetto riverenziale verso il vecchio padre non si fosse mai opposto. 456 Riuscì al Carroz di terminare gloriosamente questa guerra. Egli a’ 18 di maggio venne a trincerarsi coll’esercito alla distanza di una lega dal castello di Macometto, di cui era signore il Marchese di Orestano. Questi, credendosi abbastanza forte, sortì da quella fortezza, e presentò la battaglia, la quale fu sanguinosa, e a lui funesta, essendo morta una prodigiosa quantità di fanti, e di soldati di cavalleria e molti nobili, ch’erano del partito, e fra questi, ciò che più gli ferì il cuore, il suo primogenito Artale di Alagona. Dopo questa sconfitta, non potendosi più sostenere, s’imbarcò alla marina di Bosa con due suoi figliuoli, e tre fratelli, e col Visconte di S. Luri, e si avviò verso Genova per salvarsi. Come però le disgrazie non vanno mai sole, la barca che lo conducea s’incontrò con una 453 - 85 - Era la nostra Isola malamente guernita, avvegnacchè oltre di essere priva di soldatesche, che si erano spedite nella maggior parte in Sardegna, le stesse piazze trovavansi in cattivo stato, e bisognava molto denaro per renderle capaci di una valida difesa. Conobbe il conte Prades la necessità in cui era il regno, e trovandosi l’Erario regio esausto, non trovò altro mezzo per occorrere a queste stremità, che quello d’imporre una grossa contribuzione del dieci per cento a tutte le rendite, per cui era necessario, che si convocasse un parlamento straordinario. Chiamò adunque in Polizzi gli ordini dello stato, avvisandoli con una circolare data in Trapani a’ 29 di giugno dello stesso anno 1478, che il servigio del re, e il benefizio universale del regno ricercavano che si radunassero in Polizzi per i 25 del seguente mese di luglio 458. Nella circolare suddetta, perchè i parlamentarî non temessero che nel parlamento [111] dovesse trattarsi di qualche altro sussidio ricercato dalla corte, previene il vicerè i loro animi, che in esso non si tratterrà punto di donativo, e che solo l’oggetto di quella convocazione era il bene del regno. Fece egli antecedentemente al tempo dell’assemblea parlamentaria le sue pratiche per tutta la valle di Mazzara, e trovò gli abitanti disposti a secondare le sue mire. Infatti la città di Palermo anticipò le risoluzioni, e con un atto degli 8 di luglio dello stesso anno, precedente la convocazione solita del consiglio nella casa del Senato, stabilì che dal primo di settembre XII. Indizione si dovessero pagare due tarini per ogni salma di frumento, e un tarino per ogni botte di vino; dichiarando, che questo denaro non dovesse impiegarsi in altro uso, che per riparare le fortezze del regno, e della capitale 459. Le stesse diligenze fece egli nella città di Catania, e forse per attirare quei cittadini ai suoi disegni, sapendo la loro pretensione, di cui si è parlato nel capo antecedente, cioè che i parlamenti si celebrassero nella loro città, si determinò di trasportare questa assemblea ivi; come si fa manifesto dall’ordine dato al regio portiere Antonio di Paola, acciò girasse per le città, e terre del regno, intimando, che il parlamento era trasferito in Catania, e per i 20 di agosto 460. Non era il conte di Prades certo del buon esito di questo parlamento; sapea egli benissimo, che i Messinesi si sarebbono opposti alla contribuzione della decima sopra tutti i proventi; e per indurveli pensò prima di portarsi in Catania, di andare a Messina. Facendo la sua dimora nella casa di Antonio Sollima, chiamò a se i nobili della città, ai quali espose il pericolo in cui era la Sicilia, e principalmente la loro patria, d’essere invasa dai Turchi, e perciò la necessità, in cui eglino erano di concorrere coi loro voti al proposto sussidio, che si dimandava per il bene, e per la sicurezza di tutti. La nobiltà non opponendosi direttamente alle mire del vicerè con pulitezza chiese tempo a rispondere; ma diede abbastanza a divedere al medesimo, ch’era di contrario avviso. Accorgendosi egli di ciò, e sperando di ottenere quanto chiedea dal popolo, ch’è sempre nemico de’ nobili, chiamò i principali, e proposto loro il bisogno del regno, per indurli a consentire, promise a’ medesimi la sua protezione contro la nobiltà. Nondimeno ancora questi dimandarono del tempo a deliberare, e in quanto si appartenga a’ nobili dissero, ch’eglino non aveano alcun motivo di dolersene, avendo sempre conosciuto per esperienza ch’erano i loro padri, e che non cercavano che il vantaggio del popolo, e della città. Negli stessi termini si contenne il senato chiamato ancora a quest’oggetto, dichiarando che prima di risolvere era di mestieri di consultare questo affare. Laonde il Cardona osservando, che nulla era da sperarsi da’ Messinesi, propose a’ medesimi, purchè non si fossero opposti nel parlamento, che li avrebbe fatti dichiarare esenti con tutto il loro territorio dalla proposta tassa, ed avrebbe inoltre obbligati i parlamentarî a somministrare alla loro città quindici mila scudi per ristorare le mura della città. Ma cantò a’ sordi; restarono i Messinesi costanti nella loro risoluzione, protestandosi che avrebbono sempre preferito il vantaggio di tutta l’isola ai particolari loro comodi 461. Quindi il vicerè vedendo inutili tutti i suoi sforzi, se ne andò a Catania. Partito appena il conte di Prades, i Messinesi convocarono il consiglio, e scelsero i loro ambasciadori al parlamento. Furono eletti tre soggetti di grandissimo merito, cioè il cavaliere Giovanni Staiti, Ludovico Bonfiglio, e il giureperito Giovanni Antonio Gotto, ai quali furono date le consuete istruzioni. Non vi fu parlamento nè più strepitoso, nè più tumultuoso di questo. Giunto il giorno destinato alla prima sessione, gli ambasciadori di Messina vennero nella sala dell’assemblea, ed occuparono il più nobil luogo delle galee della flotta del re, che l’assaltò, e fe’ prigioni tutti i suddetti personaggi, e con questa preda venne in Palermo, dove dopo la vittoria il resto della flotta comandata dal Villamarino si era restituita. L’ammiraglio suddetto die parte di questo acquisto al vicerè conte di Prades, il quale, volendosene far merito colla corte, gli ordinò che consegnasse i prigionieri. Non ne fu ubbidito, il Villamarino volea egli aver la gloria di presentarsi al Re, e partitosi da Palermo andò a Trapani, dove arrivarono sei galee sottili genovesi, ch’erano venute in Sicilia, per soccorrere il marchese Orestano. L’ammiraglio Aragonese isfuggì il loro incontro, e partì per Barcellona. Vuolsi che il Villamarino avesse in animo di consegnare i prigioni al re Ferdinando, da cui sperava il marchese di Orestano di essere trattato con clemenza, e riconciliato col vecchio re Giovanni. (Surita, Annales de Aragon. lib. XX. cap. XVIII. t. IV. pag. 292). 457 Surita, Annales de Aragon. lib. XX. cap. 18. pag. 291. 458 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’anno 1477-1478, XI. indiz. fog. 52, 54. 459 Reg. del Protonotaro dell’anno 1478, XI. lndiz. segnato lit. B. fogl. 17. 460 Ivi fogl. 28. 461 Maurolico Sic. Hist. lib. V. pag. 195. - 86 - sotto la vecchia pretensione che la loro patria, di cui erano i rappresentanti, era la capitale del regno. Il conte di Prades per togliere ogni etichetta coi Palermitani fe’ un atto, per cui ordinò agli ambasciadori di Messina, che prendessero il solito posto dopo quelli di Palermo: dichiarando che ciò comandava per la quiete del parlamento, ma che non intendea di recare pregiudizio ai diritti dei Messinesi, esibendosi di far loro giustizia, quando producessero delle ragioni efficaci. Minacciò di poi, se non ubbidivano, che li avrebbe riconosciuti issofatto incorsi nelle pene della disubbidienza riserbate al suo arbitrio. Intimato quest’ordine allo Staiti, [112] che per la malattia era restato in casa, rispose a nome di tutti: Questa è facenda di grandissima importantia, et per quisto delibero con maturo consiglio respondiri 462. Questa risposta non piacque al vicerè, il quale tornò a comandar loro che ubbidissero. Replicò allora il Bonfiglio, che era l’altro ambasciadore nobile, che sarebbe stato loro onorevole il soffrire anche la morte per sostenere il decoro della propria patria, nè si mossero dal posto occupato. Eravi fra gli ambasciadori di Palermo Niccolò Leofanti regio tesoriero, il quale udendo queste parole dal Bonfiglio disse al vicerè, che questa resistenza era un manifesto indizio di ribellione. Non tenne fermo il messinese a questo rimprovero, e dando al Leofanti una mentita, snudò la spada, e lo minacciò, se non tacea, che gliel’avrebbe conficcata nella gola. Questo insulto fatto nel parlamento ad un ministro regio, e alla presenza del principe, irritò l’animo del conte di Prades, il quale ordinò, che il Bonfiglio, e il Gotto fossero subito carcerati; e spedì alla casa dello Staiti Antonio Sollima secretario di corte, acciò gl’intimasse, sotto la pena d’incorrere la disgrazia del sovrano, di non sortirne sino a nuovo ordine. Questo disturbo nato nel parlamento ne fe’ sospendere per allora le sessioni 463. Arrivata in Messina la notizia della prigionia dei due ambasciadori, e dell’arresto in casa dello Staiti, ognuno può immaginarsi, come si sieno aizzati quei cittadini. Incolpavano eglino lo Staiti di pusillanimità, gridando che egli per isfuggire ogni incontro cogli ambasciadori di Palermo, si fosse infinto ammalato, quando non era; e sopra ogni credere erano irritati contro il Sollima, che chiamavano traditore della patria, perchè avesse intimato allo Staiti la carcerazione in casa. La smaniosa plebe volendo vendicarsi di costui corse alla di lui casa con fascine, e vi appiccò il fuoco. Sarebbe questa stata incenerita, se le lagrime della moglie, e dei figliuoli, che chiedevano pietà, e il consiglio dei savî cittadini, i quali suggerivano che dovea castigarsi il traditore, non già la moglie, e i figliuoli, che erano innocenti, non ne l’avessero frastornata. Cessato ogni tumulto, e dato luogo alla riflessione, fu risoluto di mandare quattro altri ambasciadori al vicerè per ottenere la liberazione dei tre loro cittadini. Prima che costoro arrivassero, i prigioni erano stati estratti dalle carceri, e lo Staiti era già stato posto in libertà. Il conte di Prades si era lasciato persuadere a far questa grazia pelle preghiere dei parlamentarî; ma per fare ogni cosa ordinatamente avea prima chiamati gli ordini dello stato nella chiesa di S. Agata, col consenso dei quali fe’ sprigionare i due, Bonfiglio, e Gotto. Lo Staiti fu presente a quell’adunanza, malgrado l’arresto in casa, così consigliato dal Sollima, che verisimilmente ne avea ottenuto il segreto permesso dal vicerè 464. Terminate queste vertenze fu cominciata la seconda sessione, e fu proposta dal Cardona la contribuzione del 10 per cento sopra tutte le rendite, per riparare i forti della Sicilia. Non furono uniformi i pareri dei parlamentarî. Coloro, che erano stati guadagnati da esso, si uniformarono al di lui sentimento; altri si opposero; ed altri cercarono tempo a deliberare. Quando toccò a parlare allo Staiti, egli con un’eloquente orazione fe’ rilevare i danni che sarebbono accaduti alla nazione, ed in conseguenza agl’interessi ancora dei sovrani, se per poco si accettava il proposto dazio, per cui il regno si sarebbe ridotto alla estrema povertà, e si correva risico d’inasprire gli animi dei Siciliani in un tempo, in cui era espediente di allettarli coi benefizî. Dichiarò di poi, che egli tanto più volentieri palesava gl’interni sensi del suo animo, quanto la sua patria non avea interesse in questo affare; giacchè il signor vicerè avea promesso di renderla immune da questo dazio, e di somministrare ancora una grossa somma di denaro per riparare le sue fortificazioni, ogni volta che i Messinesi approvassero questo progetto. Il parlar schietto dello Staiti, ed il disinteresse che egli mostrava, nonostante che Messina fosse libera da questa contribuzione, fe’ grandissima impressione sul cuore degli altri parlamentarî, i quali si unirono al di lui parere, trattine gli ambasciadori palermitani, e i pochi seguaci del vicerè. Ma in Palermo stesso, fattasi maggiore riflessione su di questo affare, e conosciutesi le difficoltà, che nascevano alla giornata, la nobiltà, e il popolo di accordo elessero quattro altri ambasciadori, i quali arrivati a Catania annullarono quanto fatto aveano i loro antecessori, [113] e unitisi ai Messinesi si opposero al proposto dazio. Il conte di Prades vedendo che il partito contrario in vece di scemare andava augumentandosi, prese la risoluzione di sospendere per allora la conchiusione del parlamento 465. Noi abbiamo la circolare da esso sottoscritta in Catania ai 23 di settembre 1478 con cui trasferisce il parlamento 462 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’anno 1478. XI. indiz. segn. lit. A fogl. 65. Maurolico, Sic. Hist. lib. V, pag. 196. 464 Ivi. 465 Maurolico, Sic. Hist. lib. V, p. 196. 463 - 87 - in Palermo, e vi chiama gli ordini dello stato per i 25 del seguente ottobre 466. Non essendoci nei regî archivii verun altro atto intorno a questo parlamento, nè facendone alcun motto i nostri storici, e nemmeno i Messinesi, è assai verisimile che non sene sieno continuate in Palermo le sessioni, e che sia restato così irresoluto questo affare. Morì finalmente ai 19 di gennaro 1479 il vecchio re Giovanni nell’età di 82 anni non ancor compiuti, lasciando erede dei vasti suoi stati il re Ferdinando II, eccetto la Navarra, di cui fu erede la principessa Eleonora figliuola della regina Bianca sua prima moglie. Si seppe in Palermo la morte di questo sovrano ai 7 del seguente mese di febbraro. Il conte di Prades all’avviso, che n’ebbe, scrisse a tutti i prelati, ai baroni, e alle università, dando loro conto di questa perdita, e prescrivendo che in avvenire riconoscessero per solo monarca della Sicilia il re Ferdinando; che facessero solenni esequie al morto Giovanni, ed indi celebrassero, come in passato era stato il costume, l’esaltazione del nuovo principe con feste, illuminazioni, e rendimenti di grazie. La lettera è data lo stesso giorno 7 di febbraro 467. La morte del re Giovanni rallegrò i Siciliani tutti, i quali odiavano il conte di Prades per molte cagioni, e particolarmente per il grave dazio del 10 per cento, che volea imporre nel parlamento tenuto a Catania, che poi, come si è avvertito, non ebbe esecuzione; ma soprattutto ne restarono contenti i Messinesi, i quali non poterono mai dimenticare l’affronto fatto ai loro ambasciadori in Catania, quando due di essi furono imprigionati, e il terzo ebbe l’arresto in casa, e l’essere stati da questo vicerè costretti a cedere il luogo agli ambasciadori di Palermo: articolo molto interessante per quei cittadini. Eglino perciò destinarono, appena avuta la notizia della morte del re Giovanni, Ludovico Bonfiglio, e Giovanni Antonio Gotto, che erano stati imprigionati in Catania, ai quali aggiunsero Antonio Urso del ceto plebejo, acciò andassero come ambasciadori alla corte per rallegrarsi col Re della sua esaltazione, e gli offerissero un donativo di tre mila scudi 468. Il conte di Prades avea già convocato in Palermo gli ordini dello stato per gli otto del mese di marzo 1479 con una circolare sottoscritta in Palermo ai 12 di febbraro antecedente 469, affinchè si scegliesse un ambasciadore a nome del regno, per congratularsi col mentovato monarca. Come poi seppe, che i Messinesi aveano già spediti i loro inviati, i quali recavano insieme la detta somma molto allora necessaria ai bisogni della corte 470, e temea a ragione, che costoro non fossero per fare ogni sforzo, per ottenere che egli fosse deposto dal viceregnato, il che potea loro agevolmente accadere colla seducente offerta, che faceano; perciò fece delle pratiche per esser egli stesso eletto a questa ambascerìa. Lusingavasi egli che di presenza gli sarebbe riuscito più facile il discolparsi, e che questa elezione potea anche giovargli per addimostrare che era amato dalla nazione, che non avrebbe certamente affidati i proprî interessi ad un nemico. Ottenne egli l’intento; gli ordini dello stato, o perchè volessero compiacerlo, o perchè amassero di allontanarlo, lo destinarono per ambasciadore della nazione alla corte. Restò a governare il regno lo stesso maestro giustiziere Giovanni Tommaso Moncada conte di Adernò, come presidente del regno. Era la Sicilia sempre minacciata dalle armi del Turco. Divenuto Maometto signore della Vallona, era sempre in grado di molestarla; e perciò il presidente Moncada, da che era [114] partito il conte di Prades, si applicò a difenderla dalle incursioni ottomanne; e dato il regolamento, come dovea occorrersi ad ogni bisogno di qualunque città, o terra marittima, che potesse essere assalita, spedì ai 4 di maggio 1479 le istruzioni a tutti i baroni, ed a tutte le università del regno, ordinando loro, che armassero fanti, e cavalieri nelle loro città, e terre, e ad ogni avviso corressero in difesa dei luoghi assaltati 471. Nella stessa lettera vi si legge un poscritto, in cui sono avvisati, che in punto si era saputo che Scuteri era passato in potere del Turco, e che dalla Vallona erano partiti dieci galee, e sei fuste armate, delle quali non sapeasi il destino, e si rinnovavano gli avvertimenti di starsene all’erta, essendo verisimile che la detta flottiglia fosse destinata a fare delle scorrerìe nei mari di Sicilia 472. Al conte di Adernò non era assegnato salario, e faticando egli cotidianamente per il servigio del regno; spendendo anche del suo, per prevenire i pericoli, dai quali era la Sicilia minacciata, stimò che fosse conveniente e per rimunerazione dovuta alle sue fatiche, e per ristorarsi delle spese fatte, che gli fosse assegnato. Ricorse adunque al sacro consiglio, il quale conoscendo ragionevole la di lui dimanda, gli assegnò mille, e cinquecento fiorini, e per allora mille fiorini, contando dal dì, che partì il Cardona, fino al mese di settembre. Il dispaccio segnato da lui, e dai regî consiglieri ai 30 di agosto 1479 fu indirizzato a Gismondo de 466 Reg. del Protonotaro dell’anno 1477-1478, XI. Indiz. lett. A, fogl. 224, e seg. Reg. del Protonotaro dell’anno 1478.1479, XII. Indiz. segn. lett. G, fogl. 35. 468 Maurolico, Sic. Hist. lib. V, p. 202. 469 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’an. 1478-1479, XII. Indiz. segn. lett. G, fogl. 57. 470 Appena può credersi la povertà, a cui era allora ridotta la corte di Aragona. Il Surita (Annales de Aragon. tom. IV, lib. XX, cap. 27. pag. 301) nondimeno ci racconta, che mancava anche il denaro per farsi i funerali al re Giovanni, e che fu di mestieri di dare in pegno tutte le gioje, e perfino il Toson d’oro di questo principe per dieci mila fiorini, per farne le spese. Oltrachè ci assicura nello stesso luogo, che la gente addetta al servigio dei sovrani andava creditrice di molte mesate del suo salario. 471 Reg. del Protonotaro dell’anno 1478.1479, XII. indiz. segn. let. F, fogl. 14, 17, 18. 472 Nello stesso Reg. 467 - 88 - Luna conte di Sclafani maestro portolano 473. Si dovea dirigere al regio tesoriero; ma poichè l’erario era esausto perciò il sacro consiglio determinò, che i mille fiorini, ossia la somma di once ducento segli pagasse sopra le tratte dei grani, che si estraevano dai porti, e regii caricadori, e perciò si ordinò al maestro portolano, che permettesse che il presidente del regno potesse estrarre o per se, o per mezzo di altri, franchi da ogni dazio, tanti grani, quanti i diritti della estrazione compissero la somma di mille fiorini. Prima che il conte di Prades arrivasse alla corte, era stato eletto il suo successore Gaspare de Spes, o che i Messinesi avessero fatto questo colpo, o che il re Ferdinando avesse voluto ricompensare i servigii di questo suo famigliare. Il dispaccio, in cui è dichiarato vicerè di Sicilia lo Spes, è dato nella villa Detaceres a’ 10 di marzo 1479 474, come in appresso diremo. Scrive il Maurolico 475, e con esso il Bonfiglio 476, che il Cardona fece ogni opra per non essere rimosso, ed esibì al re Ferdinando trenta mila scudi. Eletto già il nuovo vicerè, non sembra naturale che egli abbia avuto il coraggio di proporre al re di disfare ciò che avea fatto, sebbene esibisse una somma così considerabile, che sarebbe stata in verità una valida tentazione per Ferdinando nella penuria di denaro, in cui si trovava. Sospettiamo adunque con qualche fondamento che questa sia stata una spiritosa invenzione dei Messinesi, o una favola, che si fosse allora sparsa. Quel, che si sa, egli è, che il conte di Prades agli 11 di luglio fece a nome della nazione il ligio omaggio, al re Ferdinando, come costa dai capitoli del regno 477. Eravi a Tunisi Emmanuele Bovo ambasciadore regio incaricato di cercar la pace per il regno di Sicilia. Questi diede conto (per mezzo di Gabriele Ingariga suo procuratore) di quanto avea trattato col re di Tunisi, al presidente del regno conte di Adernò. Questi, siccome il re Giovanni era morto, nè sapea quali fossero i sentimenti del nuovo re di Aragona Ferdinando II, non istimò di risolvere nulla, se prima non udiva gli oracoli di questo sovrano, a cui spedì una fusta per informarlo di tutto. Dà conto di questa sua risoluzione al detto di Bovo, e lo esorta a continuare le pratiche, senza punto sbilanciarsi, finchè sarebbono arrivate le risposte della corte 478. Da questo documento de’ 4 di ottobre 1479 intendiamo, che ne’ giorni antecedenti le fuste tunisine aveano fatti schiavi sessanta fra Siciliani, e Maltesi, del che il presidente si duole, come di cosa ingiusta, mentre si stava trattando la pace; ed esorta [115] l’ambasciadore a fare ogni opra per ottenerne la liberazione. Ritornò la fusta colle risposte del re intorno all’affare di Tunisi; e da un documento, che noi abbiamo, ricavasi, che avesse il re Ferdinando voluto, che si congregassero i baroni, e i ministri per sentire i loro avvisi intorno al modo, che si dovesse tenere nel far la pace, o la tregua con quel re Africano, come in appreso fu eseguito. CAPO XIX. Gaspare de Spes vicerè. Raimondo Santapau, e Giovanni Valguarnera presidenti del regno, e di poi lo stesso Santapau, e Giuliano Centelles. Gaspare de Spes era signore della baronia di Alfasciarìa, e cameriere del re Ferdinando II, il quale quantunque fosse stato eletto vicerè fino dalli 10 di marzo, nondimeno non venne al governo di Sicilia, che nel novembre seguente; avvegnachè noi ritroviamo che la sua patente regia non fu registrata, che a’ 25 di detto mese 479, in cui, o nel seguente giorno dovè prendere il solito possesso. È d’uopo credere ch’egli godesse la piena grazia del suo padrone, e che fosse in grandissima estimazione presso di lui; giacchè lo elesse durante la vita nella carica di suo vicerè, e luogotenente: del quale onore non abbiamo altro esempio, che quello di Raimondo Perellos nell’anno 1441. I Siciliani, e particolarmente i Messinesi, che odiavano il conte di Prades, restarono compiaciuti, che segli fosse dato questo successore; ma la loro gioja fu di breve durata, come fra poco faremo rilevare. Le prime cure di questo viceregnante furono intorno alla pace, o tregua, che dovea stabilirsi col re di Tunisi. Chiamò adunque a consiglio i baroni, che si trovavano in Palermo, il senato di questa città, i maestri razionali, i giudici, e gli altri uffiziali della corte. Furono dispari i pareri loro; il marchese di Geraci opinò per la tregua; il maestro giustiziere fu di avviso, che si dovesse assolutamente far la pace, gli altri in parte si unirono al sentimento del primo, e in parte seguirono il voto del secondo: soggiungendo molti di essi, che la pace si dovesse fare con onore del monarca di Aragona, e di Sicilia. Il solo pretore co’ suoi senatori dichiarò, che questo affare meritava un più maturo esame, e si riserbò di conferire col consiglio, e cogli altri suoi 473 Reg. della regia cancell. dell’anno 1478-1479, XII. Indiz. fogl. 416. Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’an. 1479-1480, XIII. indiz. fog. 4. 475 Sic. Hist. lib. V, p. 201. 476 Sic. Hist. P. I, lib. X, p. 387. 477 Tom. I, pag. 513. 478 Reg. dell’uffizio del Prot. dell’an. 1479.1480 XIII. Indiz. segn. let. K, f. 40. 479 Reg. del Protonotaro dell’anno 1479-1480 XIII. Indiz. fog. 4. 474 - 89 - uffiziali prima di dare il voto a nome del magistrato. Questa varietà di opinioni indusse il vicerè a sospendere per allora ogni cosa, e a differirne la risoluzione in un tempo più opportuno 480. Anzi che questo vicerè fosse venuto al governo della Sicilia, si erano trovate nell’isola della Pantellaria cencinquantuna monete d’oro dell’augusto Teodosio, le quali pesavano due libbre, un’oncia, un trappeso, e un quarto. Giovanni Tommaso Moncada maestro giustiziere, che allora comandava, come presidente del regno, stimò opportuno di mandarne due al re Ferdinando, e di trattenere le restanti cenquarantanove nella regia tesoreria. Gaspare de Spes arrivato in Sicilia determinò di spedire anche queste alla corte, ordinando a’ 6 di febbraro 1480 a Niccolò Leofante tesoriere, che gliele consegnasse 481. Se queste medaglie sieno poi passate nel regio erario, non osiamo di assicurarlo. Quel ch’è certo egli è, che non ne restò in Sicilia neppure una, che avrebbe potuto servire per adornarne i nostri musei. E giacchè è caduto il discorso di monete, non dobbiamo trascurare di avvertire, che intorno al prezzo di quelle ch’erano in commercio, vi fosse stata in Sicilia qualche variazione; e che non avessero un valore fisso i reali d’oro, gli alfonsini, i docati veneziani, e i docati di camera, per il cui diverso prezzo nel trafficare il denaro, e nel ricambiare le derrate, nasceano allo spesso degl’inconvenienti. Volendo il nuovo vicerè darvi un opportuno riparo, con un dispaccio indiritto a tutte le università del regno stabilì il determinato valore delle medesime, e volle 482, che in avvenire il reale d’oro non valesse più di ventiquattro carlini, l’alfonsino 33 carlini, il ducato veneziano 32 carlini, e il ducato di camera 21 carlino, e 7 grana tutti in piccioli, sotto la pena a’ contravventori [116] di tre mila reali, da applicarsene tre parti al regio fisco, e la quarta a profitto del denunziante. Questo dispaccio è dato in Palermo a’ 6 di aprile dello stesso anno 1480, e fu promulgato nella stessa città due giorni dopo, cioè agli 8, come si avverte nello stesso registro. Temeansi ad ogni momento le armi di Maometto II. sempre gloriose in questo tempo, e si sospettava che non venissero un giorno, o l’altro ad invadere il nostro regno. Il vicerè avea presenti questi pericoli, e non lasciava di pensare alla difesa del medesimo; bisognava però prima pacificare i Siciliani cogli altri nemici. Oltre i Tunisini, dei quali abbiamo or ora parlato, molestavano i nostri mari i Genovesi. Egli dunque spedì alla corte di Napoli il regio segretario Orlando di Leo, e per mezzo di quel real principe, e della regina sua consorte trattò, e conchiuse nel mese di marzo 1480 un armistizio per un anno detto di fermo, e un altro anno chiamato di attinenza, prima che fosse rivocato. Ciò fatto, agli 8 del seguente aprile promulgò un bando, con cui ordinava a tutti i Siciliani sotto la pena della confiscazione de’ beni, che durante la detta tregua non osassero di offendere la comunità, e i cittadini di Genova, nè di ricevere ne’ loro porti corsali, che recassero danno a quella repubblica, nè di dar loro soccorso, ed ajuto veruno 483. Furono ubbidienti i Siciliani al comando viceregio; non così i Genovesi, i quali nulla curando l’armistizio convenuto, recarono loro danni considerabili. Non passò guari dalla stabilita tregua, che comparvero due galee genovesi, l’una di Urberto del Fiesco comandata da Giacomino di Montenegro, e l’altra di Agostino Campofregoso, padroneggiata da Paolo dello stesso cognome, ne’ mari di Palermo, e di Trapani, dove ne’ mesi di maggio si piantano certi ordigni per la pesca de’ tonni. Assalirono quei repubblicani, e rovinarono quanto si era ivi preparato; vi fecero delle prede; e uccisero, e fecero schiavi i pescatori, che ne stavano alla custodia, e con tutta sicurezza attendevano alla pesca. Non contenti di aver danneggiate le tonnare, vennero a terra, vi fecero del bottino, ed imprigionarono molti Siciliani, che obbligarono a forza a montare sulle galee. Restò il vicerè molto dispiaciuto delle ostilità commesse da’ Genovesi, e spedì tosto a Genova lo stesso di Leo, per far presente a quel Doge, e a’ senatori della repubblica quanto era accaduto, e per dimandarne il dovuto riparo 484; e nello stesso tempo ne scrisse alla regina di Napoli, ch’era stata col marito la mediatrice di questa tregua, dandole conto di quanto contro i patti aveano operato i Genovesi; ordinando al di Leo che andasse prima in Napoli a presentare questa lettera; e ad impegnare quella sovrana presso la repubblica, acciò i Siciliani fossero risarciti de’ danni sofferti 485. Si seppe subito in Genova la notizia delle ostilità usate dalle galee del Fiesco e del Campofregoso contro le convenzioni dinanzi fattesi. Quel comune ne restò rincresciuto, e Battista Montefregoso Doge di quella repubblica, per occorrere a quanto era passato, sotto li 13 di giugno 1480 scrisse due lettere, una al re di Aragona, e l’altra al vicerè Gaspare de Spes, nelle quali protestò, che quanto le due Galee aveano temerariamente fatto, non era punto accaduto col consenso della repubblica, la quale, fermata la tregua, avea subito spediti gli ordini opportuni, acciò durante il tempo di essa i siciliani non fossero per verun modo molestati da’ sudditi Genovesi. Scusava poi il fatto sulla massima che il principe, per quanto fosse potente, non può mai ovviare agli attentati de’ sudditi scellerati, e avvezzi a vivere di depredazioni, e di rapine, come 480 Reg. di Artale di Mingia Segr. dell’anno 1479-1480, Ind. XIII, conservato nella regia cancelleria al fogl. 53. Reg. della regia cancelleria dell’anno 1479.1480, XIII. indiz segn. lett. B, fogl. 90. 482 Reg. dell’uffizio del protonot. an. 1479.1480, XIII. indiz. segn. lett. I, fogl. 139, 140. 483 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’anno 1479-1480, XIII. indiz. segn. lett. I, fog. 140. 484 Reg. del Protonotaro dell’anno 1479-1480, XIII. indiz, segnato lett. I, f. 189. 485 Ivi fogl. 190, e 191. 481 - 90 - la stessa repubblica Romana, comunque potentissima, non potè mai ripararli. Promettea dipoi in detta lettera, che sarebbe stata sua la cura di gastigare severamente i delinquenti, e di far risarcire il danno fatto; e supplicava che i Genovesi, i quali soggiornano in Sicilia, fossero amichevolmente trattati, non essendo giusto che contro gl’innocenti si usassero i diritti di rappresaglia 486. Rispose Gaspare de Spes al Doge di Genova con lettera de’ 25 di giugno 1480 487, accettando le scuse, che quel capo della repubblica gli facea. Gli fe’ poi rilevare che dal suo canto egli non avea lasciato di [117] osservare i patti dell’armistizio; e dichiarò che se le galee siciliane avessero recato dei danni a’ sudditi della repubblica, cosa, che non era ancora arrivata alla sua notizia, egli, qualora fossero queste venute ne’ porti del regno, dove non erano ancor comparse, avrebbe ordinato che risarcissero il danno, come avea fatto per il passato: comandando che fossero a’ Genovesi restituite le mercatanzìe prese sopra di loro da’ Siciliani. Fe anche considerare al Doge quanto fosse vantaggiosa pe’ Genovesi la detta tregua, trafficando eglino con profitto in Sicilia. Del resto gli avvisò ch’egli avea già mandato in Aragona, e a Napoli Orlando di Leo, il quale avea ordine di passare poi a Genova, per assicurare la repubblica della fedeltà, con cui si era osservata la tregua in Sicilia, per dimandare il risarcimento del danno recato dalle galee genovesi, e per compromettersi a nome del re di Aragona, e suo di tutto ciò, che potesse conferire al decoro, e al vantaggio di quel comune. Anche i Mori nello stesso anno 1480 aveano fatte delle scorrerìe in Sicilia, recando de’ danni, e mettendo alla catena molti degli abitanti. Ciò ci costa dalla istruzione data dal vicerè al mentovato di Leo per il re di Napoli Ferdinando, nella quale duolsi che detti pirati si erano ricoverati nell’isola di Lipari, che allora appartenea al regno di Napoli; e domanda da quel sovrano le provvidenze, acciò vietasse che si permettesse a costoro l’asilo non solamente in Lipari, ma in tutti gli altri porti del suo regno, acciò privi di questo rifugio non potessero in avvenire così francamente invadere il regno di Sicilia 488. L’armata poderosissima di Maometto II da tanto tempo si era preparata, nè si sapea quale oggetto avesse 489 . Laonde i principi cristiani temeano per loro stessi. Ma più di ogni altro paventava il vicerè per la Sicilia, ch’era la più esposta. A fine dunque di provvedere alla sicurezza della medesima avea a’ 7 di giugno dello stesso anno 1480 eletto Antonio Ventimiglia marchese di Geraci 490 capitano generale delle armi per tutto il regno con plenipotenza di poter ordinare, e disporre quanto credea necessario per la conservazione dell’isola, dandogli l’alta e bassa giurisdizione, civile e criminale, cum potestate gladii, e ordinando a tutti gli altri capitani d’armi, baroni, regî uffiziali, ed università, che dovessero ubbidirgli, ed eseguire quanto egli fosse per prescrivere 491. Quando fu dato questo dispaccio non sapeasi ancora in Sicilia il destino a Rodi della flotta ottomanna. Quantunque i Cristiani dopo la battaglia persa dagli Ottomanni sotto Rodi, e la ritirata della loro armata, si fossero lusingati che il Gran Signore li avrebbe lasciati per qualche tempo tranquilli, fu nondimeno vana ogni loro speranza. Maometto II. divenne così furioso dietro alla notizia della mentovata disfatta, che senza ascoltar consiglio giurò l’estinzione di tutti i Cristiani, e fece tosto preparare una più poderosa armata, per dirigerla principalmente contro Ferdinando re di Napoli, che avea mandati de’ soccorsi a’ cavalieri di san Giovanni Gerosolimitano 492. La flotta ottomanna comandata da un nuovo [118] bassà venne a sbarcare nella Puglia, e pose l’assedio alla città di Otranto, che agevolmente prese, usando inudite scelleraggini contro gl’innocenti abitanti. La vicinanza della Sicilia fe’ temere una pari irruzione delle armi turchesche. Perciò il vicerè temendo il prossimo pericolo curò che fossero fortificate le città del regno, ch’erano le più esposte alla 486 Reg. del Protonotaro dell’anno 1479.1480, XIII. indiz. segn. lett. I, fogl. 192. Ivi fogl. 190. 488 Reg. del Protonotaro dell’anno 1479-1480, XIII. indiz. segn. lett. I, f. 188. 489 Si seppe poi ch’era diretta contro l’isola di Rodi posseduta da’ cavalieri dell’ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, dove ai 23 di maggio 1480 si presentò il bassà Misach Paleologo cristiano rinegato con una flotta di cento sessanta vele, che sbarcò cento mila uomini; della quale spedizione, per non ritornare a favellarne, diremo, che quei prodi cavalieri sotto la direzione del loro gran maestro Pietro d’Ambusson diedero prove inudite di valore; sostennero con coraggio l’assedio per lo spazio di ottantanove giorni, ebbero sopra i nemici una compiuta vittoria; ed obbligarono quel bassà a rimbarcarsi, menando seco quindici mila feriti; dopo che gliene furono nell’azione uccisi da nove mila. Questo tributo di lode si deve a quei campioni, che spargendo il loro sangue liberarono i paesi d’Italia da una certa rovina. 490 Questo cavaliere fu figliuolo primogenito del marchese Giovanni Ventimiglia tanto famigerato ai tempi del re Alfonso il Magnanimo; nè degenerò punto dalla virtù del padre nell’arte militare, contandosi innumerabili vittorie navali da lui ottenute, finchè visse, e fu il grande ammiraglio del nostro regno. 491 Reg. della Regia cancelleria dell’anno 1479-1480, XIII. indiz. segn. lett. A, fogl. 402. 492 Vuolsi che i Fiorentini abbiano raggirato l’animo di Maometto II, dandogli ad intendere che se non opprimeva il re di Napoli, da cui i cavalieri di Rodi traggevano considerabili soccorsi, non gli sarebbe mai riuscito d’imposessarsi della loro Isola. Con questa soprafina politica speravano di levarsi d’addosso il real principe Alfonso primogenito del re Ferdinando, che facea loro la guerra in Toscana. Riuscì questo disegno; imperciocchè entrate le armi maomettane nella Puglia, Ferdinando fu costretto a richiamare il figliuolo, e l’armata, con cui molestava i Fiorentini. 487 - 91 - invasione. Noi abbiamo nella regia cancelleria 493 un dispaccio segnato in Palermo a’ 30 di settembre 1480 indiritto a Pietro de Luna, arcivescovo di Messina, cancelliero, e consigliero del re, per cui gli dà commissione di girare per la valle di Mazara, e di visitare tutte le castella, e fortificazioni della medesima, per provvederle di gente armata, di viveri, e di attrezzi da guerra, ad oggetto che fossero in istato di difesa, dandogli la facoltà di convocare il consiglio così delle terre demaniali, che delle baronali, e d’imporre de’ dazî, per trarne del denaro per la sicurezza delle medesime. Mentre si davano queste disposizioni per la Sicilia da Gaspare de Spes, si scossero finalmente i principi d’Italia, e più che ogni altro il pontefice Sisto IV, i quali fecero lega contro il Turco, nella quale entrò ancora il re di Aragona. In Sicilia fu a quest’oggetto tenuto un parlamento in Palermo, che non sappiamo in qual mese, e in qual giorno fosse stato convocato, avvegnachè i nostri storici, e lo stesso Mongitore non ne fanno motto. In esso fu deliberato di dar soccorso al re di Napoli, che dietro la perdita di Otranto era assalito in Brindisi; e infatti furono tosto spedite in Puglia alcune navi armate. Siccome però non bastava il tempo per raccogliere il denaro per questo armamento, fu preso in parte dall’erario regio, il resto fu sborsato da’ mercadanti, a’ quali i deputati del regno si obbligarono in proprio nome di soddisfare 494. Costa questo fatto da un dispaccio viceregio sottoscritto in Messina a’ 23 di aprile 1481 495, in cui si rammenta il parlamento, e tutto ciò che si era in esso determinato, e si dà l’incarico a Paolo di Greco, che vada attorno per tutte le città, e luoghi soggetti alle stabilite contribuzioni, per esigere senza dilazione le loro quote a fine d’indennizare i deputati del regno, obbligati personalmente, dagl’interessi che soffrivano, e ciò sotto la pena a’ morosi di mille fiorini da applicarsi al regio fisco. Nel seguente anno 1482 corse la Sicilia un pericolo maggiore, che l’invasione dei Turchi. Fu la città di Messina attaccata dalla peste 496. Il Maurolico 497 ci avvisa questo infausto avvenimento, e racconta che fosse allor fama che l’avessero recata alcuni falconi venuti dall’Oriente allo Strategoto, e che restarono vittima di questo flagello dei soli Messinesi diciotto mila, oltre quelli che morirono di questo male ne’ luoghi circonvicini, s’è vero ciò che ne scrisse il Caruso 498. Ci è ignoto quali provvidenze abbia dato il vicerè per estirparla, od impedire che non facesse ulteriori progressi 499. Egli è certo però che fu di breve durata. I re di Aragona aveano sempre sofferto con dispiacere, che il regno di Granata fosse posseduto da’ Mori, co’ quali ora erano in guerra, ora in pace, e talvolta in tregua. L’anno 1481 persistea l’armistizio fra le due potenze; quando inaspettatamente, per quel che scrivono gli storici spagnuoli 500, Abil-Haffan re di Granata contro la fede dei trattati assalì la città di Zahera, passò a fil di spada porzione degli abitanti, e fece schiavi tutti gli altri. Questo fu il segnale di quella guerra micidiale, che durò dieci anni, nella quale Ferdinando adoprò ora l’arte, ora l’inganno; e che terminò coll’acquisto di quel [119] regno. Volendo il detto sovrano dare a questa guerra, che non era cagionata che dall’ambizione di dilatare i suoi stati, l’aspetto di guerra di religione, sotto il pretesto che il regno di Granata era divenuto l’asilo degli apostati, e degli scellerati, chiese, ed ottenne da Sisto IV, che non dava niente del suo, le decime sopra tutti i beni ecclesiastici della Sicilia. Fu incaricato dell’esazione Bernardo Margarit vescovo di Catania, cui spedì il re Ferdinando II. da Madrid a’ 20 di gennaro 1483, il dispaccio, che essendo stato presentato al vicerè Gaspare de Spes, questi lo comunicò a tutti i prelati, e alle altre persone ecclesiastiche del regno con suo viglietto viceregio degli 8 di maggio dello stesso anno dato in Palermo 501. Non contento Sisto IV. di avere accordate le decime sopra la Sicilia al re Ferdinando, per secondare le di lui mire contro il regno di Granata, volle inoltre nel medesimo anno allo stesso oggetto promulgare una crociata aprendo i tesori della chiesa a favore di coloro, che o di persona andassero a far la guerra contro i Mori di Granata, o che pagassero il denaro prescritto a misura della condizione di ciascheduno, che prendesse la bolla; accordando oltre l’assoluzione de’ più gravi, ed enormi delitti, indulgenze, dispense, e 493 Reg. dell’anno 1480.1481, XIV. indiz. segn. lettera A, fogl. 160. Forse questi sforzi de’ cristiani sarebbono stati inutili, se la morte non avesse reciso le fila della vita di Maometto II. a’ 2 di luglio. Ariadeno Baglivo di Negroponte, ch’era restato alla difesa della città di Otranto, e al comando dell’armata, udendo che il Gran Signore era già morto, e che i due suoi figliuoli Bajazette, e Zem, o Zizim si disputavano l’impero, fece una capitolazione con Alfonso figliuolo del re di Napoli, e abbandonando l’Italia, ci liberò dal pericolo in cui eravamo. 495 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1480.1481 XIV. indiz. segn. lett. A, f. 160. 496 Il Paroco Francesco Serio (Istor. Cronol. delle pestilenze di Sic. tom. II. della Sic. ricercata del Mongitore) fissa questa peste all’anno 1480 citando il Maurolico, le cui parole malamente capì. 497 Sic. Hist. lib. VI. pag. 203. 498 Mem. Stor. tom. III. parte III. lib. V, pag. 88. 499 Il Cannizzaro (nel Mss. de Relig. Pan. p. 602), e il Mongitore (Palermo divoto di Maria Vergine tom. 1, pag. 211) scrivono, che in detto anno fu anche la città di Palermo assalita dalla pestilenza. Noi non abbiamo altro monumento; ma se è vero quanto i suddetti scrittori attestano, bisogna credere, che questo male siesi dilatato fino alla capitale. 500 Surita Annales de Aragon. lib. XX, cap. XLII, e seg. e gli altri scrittori della nazione. 501 Reg. della regia cancellaria dell’anno 1482-1483 I. indiz. f. 243. 494 - 92 - privilegi considerabili 502. La bolla di questo indulgente pontefice è data in Roma a’ 4 di agosto 1482. Ma non ebbe corso in Sicilia, non sapremmo dire per qual motivo se non due anni dopo, giacchè il dispaccio del vicerè Gaspare de Spes, che ne comanda l’esecuzione, fu in Palermo sottoscritto a’ 12 di aprile 1484 503. Questo vicerè era in odio a tutta la nazione. La di lui alterigia, il dispregio con cui trattava la nobiltà, che volea in tutti i modi conculcare, la premura di farsi ricco colle spoglie dei nazionali, e sopratutto le pratiche da lui fatte, da che venne al governo della Sicilia, per sposarsi con Beatrice Spadafora erede del vasto stato di Sclafani, per cui questo ricco contado di poi passò in questa famiglia Spagnuola, lo rendeano l’oggetto della comune esecrazione. Accrebbe l’universale dispiacere, e particolarmente quello del baronaggio, la persecuzione di Arrigo Ventimiglia marchese di Geraci, e di Pietro Cardona conte di Golisano 504. Frequenti perciò erano i ricorsi della nazione, e degli offesi baroni al regal soglio. Ma siccome le doglianze de’ popoli non arrivano per lo più a penetrare ne’ gabinetti de’ sovrani, avvegnachè i ministri le soffocano nelle segreterìe; perciò continuava lo Spes a governarci dispoticamente, senza che il re di Aragona sapesse le lagrime de’ suoi Siciliani. È cosa però malagevole fra tanti lamenti, e tanti mezzi adoprati per farli giungere alle orecchie de’ clementissimi sovrani, che alcuno non vi arrivi. Ferdinando cominciò a sospettare che la condotta di questo vicerè fosse reprensibile; e gli amici suoi, che stavano a’ fianchi del principe, non potendola più occultare, lo consigliarono che fosse espediente, ch’egli venisse alla corte, dove avrebbe potuto colla sua presenza dileguare le sospicioni del monarca. Approvò egli questo consiglio, e col pretesto che dovesse trattare col re gravi affari ottenne il permesso di partire. Dovendo dunque allontanarsi dalla Sicilia, scelse per presidenti del regno Raimondo Santapau barone di Licodia, e di Butera, e Giovanni Valguarnera barone di Asaro, ch’erano due suoi amici, e ne [120] spedì il dispaccio a’ 31 di giugno 1483 505; quantunque non sia partito, che nel seguente anno 1484. Non dimorò egli alla corte di Aragona molto tempo; poichè noi lo vediamo ritornato in capo a un anno, e qualche mese, comparendo l’ultimo dispaccio de’ due presidenti lasciati nella sua lontananza ai 27 di giugno 1485, e tornando a vedersi sottoscritto lo Spes a’ 5 di luglio dello stesso anno 506. Seppe egli così bene schermirsi dalle accuse de’ Siciliani, che ottenne di ritornarsene al viceregnato, e vi venne più dispoticamente di prima. I presidenti, ch’egli avea lasciati, seguirono le di lui pedate, facendo delle estorsioni grandissime; e fra le altre erano stati accusati di non aver fatte fare le necessarie ricerche contro gli uccisori di Giovanni del Tocco giurisperito, e fratello di Leonardo del Tocco despota di Larta. Dopo il ritorno del vicerè furono incaricati Francesco Minutolo giudice della gran corte, e Luca Bellacera maestro razionale, giudice surrogato per la morte di Archimbao di Leofante, di formare il processo a’ due presidenti suddetti Santapau, e Valguarnera, non meno per le violenti esazioni fatte, che per avere impedite le prove contro di coloro, che ucciso aveano il Tocco. Leggesi il dispaccio del re Ferdinando con questa commissione nella regia cancellarìa 507, ed è dei 14 di novembre 1485. Questo affare non andò innanzi; il vicerè de Spes avrà saputo imbarazzare così questa matassa, che gli sarà riuscito di salvare i suoi amici. Continuava intanto egli a molestare il baronaggio, e le prime sue mire furono indiritte contro il maestro giustiziere, che forse era suo nemico, ed uno di coloro che gli aveano scritto contro. Si è sulla fine del capo antecedente raccontato, che questo cavaliere trovandosi privo di assegnamento, come presidente del regno, ed avendo fatte molte spese per conservarlo, col voto del sacro consiglio si avea fatto assegnare mille, e cinquecento fiorini di salario, e interinamente mille sopra l’estrazione de’ grani che si facea da’ porti di Sicilia, giacchè non potea questo denaro pagarsi dal regio erario. Egli non ne avea conseguito, che novecento cinquanta, cioè onze 190. Ci è ignoto cosa avesse rappresentato lo Spes alla corte di Aragona per mostrare, che non segli dovesse codesto salario; il vero fatto è, ch’egli ottenne che si obbligasse il maestro giustiziere a restituire quanto avea esatto, e ritornato in Palermo spedì a’ 10 di dicembre 1485 un dispaccio sottoscritto ancora da’ maestri razionali, e dal tesoriero, e dirizzato a Giacomo Marchese eletto commissario, affinchè 502 Non v’ha dubbio, che questa bolla non abbia arrecato al re Ferdinando II. moltissimo denaro. Sembrava una bella cosa con pochi bezzi guadagnarsi l’assoluzione de’ più esecrabili delitti, per un solo de’ quali i canoni penitenziali dell’antica chiesa faceano stentare parecchi anni i veramente contriti: e siccome il numero de’ scellerati è per cosi dire infinito, perciò infinite persone doveano alla giornata concorrere o per sè, o per mezzo del loro denaro a questa guerra politica di religione. 503 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1485.1486 IV. indiz. segn. lett. E, f. 341. 504 Questi due cavalieri per una discordia privata si chiamarono a duello. Gaspare de Spes, come se codesto fosse stato un delitto di stato, li perseguitò fino agli estremi. Al marchese di Geraci (famiglia tanto amata, e benemerita della corona) furono confiscati, siccome scrive il Fazello (Dec. II, lib. IX, cap. XI, pag. 192) i beni così stabili, che mobili, e fra questi due arieti di bronzo, che ora stanno nella galleria del regio palagio di Palermo, e ch’egli tenea nella terra di Castelbuono; dono fatto da Alfonso il Magnanimo al celebre Giovanni Ventimiglia in ricompensa de’ servigj fattigli nel sedare la sedizione di Siracusa. Il marchese Arrigo per scansare le violenze del vicerè fu costretto ad andarsene in Italia, e a ricoverarsi presso il duca di Ferrara suo parente. Il conte di Golisano, che soffrì gli stessi aggravj, non potè accomodare i fatti suoi, che donando allo Spes il Castello della Roccella, ch’era uno de’ feudi del suo Contado. 505 Reg. della regia cancell. dell’anno 1482.1483, II. indiz. fogl. 136. 506 Reg. della regia cancelleria, e del protonotaro dell’anno 1484.1485, III. Indiz. 507 Reg. dell’anno 1485.1486, IV. Indiz. - 93 - obbligasse il mentovato conte di Adernò a restituire fra lo spazio di otto giorni la somma che avea percepito , e con ordine, se nel prescritto termine non pagava, di entrare lui ne’ contadi, e terre del medesimo, e di esigere a forza le onze cento novanta, per poi consegnarle al regio tesoriero. Intanto in Napoli il baronaggio si era rivoltato contro il vecchio Ferdinando, non potendo più soffrire gli aggravî, da’ quali era oppresso dal real principe Alfonso II, il quale stante la decrepitezza del padre regolava ogni cosa a suo modo. Si era unito a’ malcontenti baroni il pontefice Innocenzo VIII nuovamente eletto, il quale sostenea il loro partito 509. Ferdinando nelle angustie, nelle quali si trovava, ricorse al re di Aragona, il quale comandò che dalla Sicilia segli mandassero mille uomini di cavalleria. Costa ciò da un dispaccio del vicerè Gaspare de Spes de’ 27 di maggio 1486, con cui si ordina ad Alferio di Leofante regio tesoriero, che pagasse al nobile Giovanni Valguarnera conte di Asaro onze 216 per soldo di due mesi per esso, e per trenta cavalieri armati, che andavano al servigio del re di Napoli, alla ragione di diciotto fiorini per cavaliere 510. Era l’impresa del regno di Granata, che cominciò l’anno 1481, molto difficile, e la spesa di questa guerra montava ad una somma considerabile di denaro, attaccandosi un ricco re, e una nazione assuefatta a [121] maneggiare le armi. Il re Ferdinando non avea gran tesori, e comunque colla politica introduzione del S. Uffizio avesse acquistato i beni di coloro, che per sottrarsi alla persecuzione di Fra Tommaso Torrecremata, che fu il flagello della umanità, abbandonavano i regni di Aragona, e avesse perciò impinguato il suo erario, nondimeno queste fonti dalla vorace guerra furono tosto diseccate. Quindi abbisognandogli de’ soccorsi scrisse al vicerè de Spes, che convocasse il parlamento, per avere delle sovvenzioni dalla Sicilia. Fu quest’assemblea radunata in Palermo nell’anno 1487, e verisimilmente nel mese di luglio 511. Nell’apertura del parlamento il vicerè non lasciò di dipingere co’ più vivi colori le circostanze, in cui si ritrovava il re, e il vantaggio che sarebbe risultato al cristianesimo, se si cacciavano i Mori dal regno di Granata; e per tal cagione richiese de’ soccorsi, acciò si potesse sostenere dal detto sovrano una guerra così importante. Ritrovò egli disposti i Siciliani ad ajutare il proprio monarca, i quali perciò di comune consenso offerirono un donativo di cento mila fiorini da pagarsi in tre rate. Fu eletto ambasciadore 512, per recare questa offerta alla corte, lo stesso vicerè de Spes 513. Questa ambascerìa l’obbligò a prepararsi per questo secondo viaggio per l’Aragona, e a destinare chi presedesse al regno nella di lui lontananza. Avrebbe egli voluto lasciare per presidenti del regno i suoi due amici, il barone di Butera, e quello di Asaro; ma, siccome questi era impiegato per ciò, che abbiamo detto, al servigio della corte di Napoli con un drappello di cavalleria, così in vece di questo elesse Giuliano Centelles, che era stato stratigoto di Messina. Il dispaccio viceregio, con cui furono dichiarati presidenti del regno Santapau, e il Centelles, è dato in Palermo istesso a’ 13 di luglio 1487 514. I primi incontri, ch’ebbe alla corte Gaspare de Spes, furono per lui favorevoli. Oltrechè arrivato in Valenza, e presentando al re Ferdinando il donativo del parlamento, ottenne molte delle grazie, ch’egli richiese in vantaggio del regno di Sicilia, come costa da’ capitoli del regno 515, rappresentando insieme al mentovato Sovrano, che per la confiscazione de’ beni fatta ad Arrigo Ventimiglia per il noto duello col conte di Golisano, veniva a vacare il posto di grande ammiraglio di Sicilia, fu dallo stesso monarca eletto egli a questo posto con un dispaccio reale sottoscritto a Saragoza a’ 12 di febbraro 1488. Questa grazia reale fu esecutoriata nel regno a’ 14 di settembre dello stesso anno 516. Non godè però egli molto tempo di questi vantaggi, come dimostreremo nel capitolo seguente. Sospettiamo che Raimondo Santapau poco fosse vissuto dopo la sua elezione di presidente del regno; imperciocchè noi veggiamo che ne’ dispacci viceregî non è sottoscritto, che Giuliano Centelles, ed in essi non vi si legge Praesidentes sul principio, come si sarebbe fatto, se continuava ad essere in questo impiego il barone di Butera; ma sempre costantemente Praesidens. Crediamo poi che sia morto, perchè non abbiamo documento, che ci additi ch’ei fosse stato deposto da questa carica. Abbiamo di Giuliano Centelles due carte interessanti, che non sarà discaro ai nostri legitori di sapere. I prelati, e coloro, che componevano l’ordine ecclesiastico, dopo il parlamento dell’anno 1487, in cui fu 508 508 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1485.1486 IV. Indiz., segnato colla lettera F, f. 123. Il motivo apparente del papa suddetto era quello, che per molti anni non era stato pagato il preteso censo sopra il regno di Napoli, e non si era fatta che la sola funzione di presentarsi la vigilia de’ santi Pietro, e Paolo il cavallo bianco; ma in verità vi si mosse perchè sperava ne’ torbidi, in cui era il regno di Napoli, di render grande con qualche signoria il suo figliuolo bastardo Franceschiello, che mandò in soccorso de’ rivoltati. 510 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1485.1486 IV. Indiz., segnato colla lettera F, f. 217. 511 Il Mongitore (Parlam. gen. di Sicilia, tom. I, pag. 107) fa memoria di questo parlamento, ma lo fissa all’anno 1488, nel che sbaglia, come si fa chiaro dal monumento, che or ora sarà riferito. 512 Mongit. Parlam. di Sic., tom. II, p. 107. 513 Non si sa, i parlamentarii avessero voluto dare quest’onore al vicerè per fargli cosa grata, o vero per allontanarlo per qualche tempo dalla Sicilia. Deve però esser certo ch’ei ne dovette restar compiacciuto, giacchè questa elezione lo mettea a portata di mostrare a Ferdinando, ch’era amato dalla nazione. 514 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1486.1487 V. Indiz., f. 467. 515 Tom. I, pag. 524, e seg. 516 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1488, VII. Indiz., segn. num. 2, f. 166. 509 - 94 - offerto al re di pagarsi in tre anni cento mila fiorini, pretesero, durante questo pagamento, di essere le loro chiese esenti dal pagamento delle decime imposte da Sisto IV. sopra tutti i beni delle medesime, e ne fecero vive istanze all’allora pontefice Innocenzo VIII. Questo papa giudicando ragionevole la loro pretensione, scrisse una bolla sotto i 18 di marzo del 1488 indiritta all’arcivescovo di Reggio, o al di lui vicario, in cui ordinò, che intimasse sotto la pena di scomunica agli esattori delle decime, che sospendessero di esigerle, per il triennio, in cui le chiese siciliane pagavano il donativo. Dispiacque questo passo dato da Innocenzo VIII. a’ monarchi di Aragona, i quali fecero capire al [122] medesimo, che i collettori esigendo le decime per ordine Sovrano, subito che costoro erano minacciati della scomunica, ne veniva lesa la loro maestà. Fecero anche intendere a S.S., che la dimanda del braccio ecclesiastico era irragionevole; avvegnachè l’imposizione delle decime era forzosa, nata da un comando pontifizio, quando il donativo era una oblazione libera, e volontariamente fatta. Restò convinto il papa dalle ragioni fattegli suggerire da’ sovrani mentovati; e perciò sotto i 12 di luglio dello stesso anno fe’ un’altra bolla, con cui rivocò la prima, e concesse, che si continuasse, nulla ostante il donativo, l’esazione delle decime. Questa seconda bolla fu intimata dal Centelles all’arcivescovo di Reggio, o al suo vicario, perchè fosse eseguita. Il dispaccio viceregio è dato in Palermo a’ 4 di agosto 1488 517. Prima di questo dispaccio ne abbiamo un altro del pari interessante la nostra storia; fu questo sottoscritto nella stessa città di Palermo sotto i 18 di giugno del medesimo anno 518. Bajazette II. sultano di Costantinopoli dopo di aver fatta la pace con Pietro Ambusson gran maestro dell’ordine Gerosolimitano, e dopo di essersi assicurato di non avere più che temere da Zisim suo fratello che quel gran maestro si era obbligato di far custodire sotto la più rigorosa guardia, e promesso di non mai consegnarlo a verun principe cristiano, o infedele, che potesse valersi de’ di lui diritti per turbare la pace dell’impero Turco 519, rivolse l’animo a molestare l’Italia. Innocenzo VIII. che guardava con ispavento l’armamento, che facea il gran signore, non avea trascurato di scrivere a tutti i principi, che aveano degli stati in Italia, perchè si collegassero per la comune difesa. Fu perciò avvertito il Centelles a stare all’erta per il regno di Sicilia, ch’ei governava. Avea questi avute ancora alcune notizie da Costantinopoli da’ suoi corrispondenti, i quali gli avvisavano, che fosse fama che quei preparativi si facessero per invadere le tre isole, di Malta, del Gozzo, e della Pantellarìa, per cui avrebbe dominato ne’ nostri mari. Avea inoltre saputo che già molte fuste di Turchi aveano fatte delle incursioni in Malta, e al Gozzo, dove aveano posto l’assedio, e resi schiavi molti abitanti, e che altre fuste de’ medesimi erano andate alla Pantellerìa, dove faceano ogni sforzo per ridurla cogli abitanti in servitù. Ebbe ancora l’avviso, che si sospettava una lega fra l’imperadore di Costantinopoli, e il re di Tunisi, nel qual caso la Sicilia, se non era difesa, sarebbe certamente divenuta la preda dei Musulmani. Essendo le cose in così cattivo stato, stimò il Centelles di convocare il sacro consiglio per dare con esso le necessarie provvidenze per la sicurezza del regno. Fu col parere de’ ministri risoluto di armare colla possibile sollecitudine non meno in Palermo, che in Messina, in Siracusa, e nelle altre città marittime, tutte le navi, galee, fuste, ed altre barche, che fossero ne’ loro porti, e di mandarle in soccorso delle isole assalite. Si stabilì ancora di sollecitare tutti i capitani, e capi di squadra, affinchè colla loro gente di armi accorressero dove il bisogno li chiamava, per guarentire il regno dalle temute invasioni. Perchè però era d’uopo di dare un capo a questa tumultuaria armata marittima, e terrestre, fu eletto coll’avviso de’ consiglieri per capitano generale della medesima Francesco de Patellis, o Abatellis maestro Portolano 520 con piena autorità di disporre ogni cosa a suo modo, affinchè fossero soccorse le isole suddette, cui fu diretto il dispaccio viceregio di sopra accennato, col quale era eletto a questo onorifico posto. Il re Ferdinando, cui stava a cuore la conservazione di questo regno, non trascurò di cooperarsi alla difesa di esso; e fatte armare cinquanta caravelle delle molte, che avea, le spedì in Sicilia, per difendere il regno, e le isole minacciate. Ordinò inoltre all’Abatellis, che quando gli fosse riuscito di fare sloggiare i Turchi da’ nostri mari, invadesse, e mettesse a sacco le principali città di Barberìa, e del resto dell’Affrica. Ogni cosa avvenne a seconda de’ desiderî del monarca: il prode Francesco obbligò le fuste turche ad abbandonare i mari di [123] Sicilia; e di poi a tenore degli ordini reali invase le primarie città della costa di Barberìa, e dopo di averle rovinate, e di averne tratto un ricco bottino, ritornò glorioso in Palermo 521, dove trovò già arrivato il nuovo vicerè di cui or ora favelleremo. 517 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1487.1488 VI. Indiz., segnato colla lett. A, f. 591. Nello stesso Reg. della regia cancelleria, f. 49. 519 Vertot, Hist. del Oltre de Malte, tom. III, lib. VIII, p. 148 e 149. 520 Sbaglia il p. abate Amico (nelle note al Fazello dec. II, lib. IX, cap. 11, nota 2) chiamandolo Federico; il vero suo nome fu Francesco. La sua famiglia dicesi ancora de Abatellis, cognome troppo rinnomato nella storia di Sicilia. Era egli conte di Cammarata, e in valore ed esperienza di guerra non la cedeva a veruno, come ne diede delle chiare prove in questa difficile, e scabrosissima commissione. 521 Surita, Annal. de Arag., tom. IV, lib. XX, cap. 79, p. 378 e seg. 518 - 95 - CAPO XX. Ferdinando de Acugna vicerè. Per quanto grandi fossero le premure fatte da Gaspare de Spes conte di Sclafani, e grande ammiraglio di Sicilia, per conservarsi il viceregnato di questo regno, che avea, come si è detto, ottenuto in vita dallo stesso re Ferdinando, non fu possibile che il conseguisse. Erano già penetrate alle orecchie di questo monarca le lagnanze degli oppressi Siciliani, ed erasi egli persuaso che costui fosso un tiranno, che angustiava colle sue angarìe, facendo enorme abuso dell’affidatagli autorità, i suoi vassalli. I principi per lo più sono amanti della giustizia, e non vogliono l’oppressione di alcuno: se delle volte compariscono ingiusti, e despoti, la loro ingiustizia, e il loro dispotismo non nasce da un animo cattivo, ma da’ cattivi rapporti dei loro ministri, che li sorprendono, e gl’ingannano. Se la sorte fa, che il vero a traverso di tanti impedimenti penetri ne’ loro palagi, e si presenti a’ loro occhi, allora sgannati dallo errore, in cui erano, puniscono i delinquenti, e danno sollievo agl’innocenti. Questo però accade assai di rado, ed è da riputarsi come un fortunato accidente, che siesi discoperta da Ferdinando l’iniquità del de Spes, e la ragionevolezza de’ lamenti de’ Siciliani. Non ostante adunque ch’egli l’avesse creato per vicerè perpetuo, lo privò di questa carica, e conoscendo i di lui troppo patenti delitti, lo confinò in una oscura prigione 522 in Cordova, da cui non fu liberato, che in capo a due anni. Volendo dunque provvedere di un vicerè il regno di Sicilia, scelse Ferdinando de Acugna; e siccome conobbe che la perpetuità delle cariche è sempre nociva, perciò lo elesse per soli tre anni, stabilendo così per legge che dovessero i vicerè essere cambiati in ogni triennio. La elezione di questo nuovo vicerè fu fatta a Valladolid a’ 6 di ottobre 1488 523. Non arrivò egli in Palermo, che nel seguente anno 1489 a’ 28 di febbraro. Venne da Trapani sopra una galeazza veneziana, e fe’ lo stesso giorno la pubblica entrata a cavallo in mezzo del maestro giustiziere, e di Federico Diana pretore della città di Palermo. Condusse seco il suo consultore, che fu Gaspare de Ribaldes, come costa da una cronaca Mss. 524. La scelta di questo vicerè rallegrò assaissimo i Siciliani, che non solamente erano stati liberati dalle mani dell’avidissimo conte di Sclafani, ma venivano governati da un uomo probo, e di grandissima esperienza nella difficile arte di reggere i popoli, e di cui avea il re Ferdinando una grandissima stima 525. Il tempo dimostrò come questa elezione fosse stata a proposito, essendo egli stato, come si dirà, incaricato di affari assai scabrosi, che portò a fine con molta destrezza. Il salario de’ vicerè allora non era, che di sole onze ottocento, somma tenue anche allora, che il denaro era scarso, per mantenersi con quella magnificenza, che conviene ad un governante, che fa le veci del sovrano. Il re Ferdinando conobbe ch’era necessario di accrescerlo, e perciò con un suo dispaccio de’ 3 di luglio 1489 sottoscritto al campo dinanzi la città di Baza glielo augumentò a novecentoventi. Questa grazia reale, che fu esecutoriata in Palermo a’ 18 di settembre 1489, fu dal vicerè, poi che arrivò in Sicilia, partecipata al tesoriere Alferio di Leofante, acciò de’ primi denari pagasse il salario suddetto così accresciuto, come il re ordinato avea. Questa carta viceregia è del 1° di settembre 1490 526. Abela lasciò scritto 527, ch’egli in questo istesso anno andò in Malta, dove diede molte provvidenze utili al buon governo. [124] Era stato il nuovo vicerè incaricato di formare il processo al conte di Sclafani suo antecessore, e di procedere contro di esso, trovandolo reo. Cominciò egli dal far confiscare tutti i beni, e gli effetti del medesimo, e quelli ancora della contessa sua moglie. Il dispaccio, per cui si ordina la suddetta confiscazione, è diretto allo stesso tesoriero Alferio di Leofante, comandandogli che amministrasse i beni confiscati a nome della camera del re 528. Fu questo biglietto viceregio sottoscritto in Palermo a’ 15 di novembre 1490. La saggia condotta tenuta da Ferdinando de Acugna, e gli elogî, che profondevano i Siciliani in suo favore, indussero il re Ferdinando II. a dispensare alla legge poco prima fatta, che i vicerè non dovessero restare nella carica, che soli tre anni; e con dispaccio sottoscritto nel campo presso Granata a’ 3 di luglio IX indizione 1491 lo confermò nel viceregnato per altri tre anni. Questa carta non fu esecutoriata in Palermo, che a’ 3 di ottobre X. indizione 1491 529. Dopo lo spazio di anni undeci venne a capo il re Ferdinando II. di conquistare il regno di Granata, avendolo il re moro, che si ritrovava agli estremi, cesso sotto alcune condizioni le più vantaggiose, che potè ottenere. Al primo di gennaro 1492 fu stipulata la capitolazione, e a’ 2 entrò il nostro monarca in quella 522 Surita, Annales de Arag., lib. XX, cap. XCII, pag. 370. Reg. della regia cancell. dell’anno 1488-1489, VII. indiz. pag. 74. 524 Vuolsi che la carica di consultore fosse stata istituita dall’imperadore Carlo V.; ma nondimeno noi nella citata cronaca ritroviamo il Ribaldes per consultore del vicerè Acugna. Forse sarà stato un gureperito, con cui egli consultavasi, non un ministro disegnato apposta, come è presentemente. 525 Surita Annales de Arag., lib. XX, cap. LXXIX, pag. 350. 526 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1490.1491, IX. Indiz., segnato colla lett. B, fogl. 11. 527 Malta Illust., lib. IV, nota 1, p. 434. 528 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1490.1491, IX Indiz., f. 112. 529 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1491.1492, X. Indiz., f. 74. 523 - 96 - capitale 530. Furono fatte grandissime feste per tutti i regni soggetti al monarca di Aragona. Noi abbiamo una lettera scritta dal medesimo alla Università, e a’ senatori della città di Palermo in data de’ 2 di gennaro 1492 dalla stessa città di Granata, con cui dà conto della vittoria ottenuta, e del possesso, che avea preso lo stesso giorno di quel regno: ordinando, che se ne rendessero pubbliche grazie all’Altissimo 531. Non può dubitarsi che per tutta la Sicilia, e in particolare in Palermo, non siensi fatte delle pompose feste per l’acquisto fatto dal re di Aragona, che accrescea notabilmente i suoi stati in Ispagna; a noi rincresce di non avere la relazione delle solennità della capitale in questa fausta occorrenza. La presa del regno di Granata fu funesta agli Ebrei. Siccome dietro a quella conquista furono discacciati i Mori da quel regno, che restò spopolatissimo; e di questa malintesa risoluzione ne fu commendato, come il difensore, e il sostegno della cattolica religione, il crudele P. Torrecremata, il quale ignorantemente credea, che il Dio de’ cristiani si pascesse, come un tempo Saturno presso i Cartaginesi, delle umane vittime; e avea egli acquistato un certo ascendente sopra i monarchi Aragonesi, de’ quali era confessore; suggerì, che sarebbe cresciuta assai più la di loro rinomanza di principi sostenitori del cristianesimo, se si determinavano a discacciare da’ loro regni anche gli ebrei, che erano i più perfidi nemici di Gesù Nazareno. Era già molto tempo, che questi utili trafficanti erano molestati nei regni di Spagna. L’ordine di dovere abitare in luoghi separati nelle città, e terre, dove fissato aveano la loro dimora, le persecuzioni del tribunale poco prima introdotto del S. Uffizio, di cui era capo il mentovato frate Domenicano, e la loro espulsione dall’Andalusia furono i forieri della disgrazia, che loro sovrastava. Dunque a’ 31 di marzo 1492 fu sottoscritta dal re Ferdinando la sentenza fatale, colla quale dentro lo spazio di tre mesi, e quaranta giorni di poi, si dava lo sfratto a tutti gli Ebrei, che dimorassero negli stati di S. M. Aragonese, sotto la pena di morte, e della confiscazione de’ loro beni, se prontamente non ubbidivano 532, vietandosi loro di estrarre dal regno oro, argento, o monete, e permettendosi solamente, che potessero permutare i loro beni o in mercanzie non vietate, o in cambî. A questo editto del Re fu unito un decreto terribile del S. Uffizio, con cui fu ordinato, che trascorso il termine stabilito dal re, ed altri nove giorni, niun cristiano potesse sotto gravi pene commerciare cogli Ebrei, e somministrare loro viveri per sussistere. Noi, tacendo ciò, che accadde ne’ regni di Spagna 533, diremo, che l’espulsione di questi sventurati accadde in Sicilia assai più [125] tardi 534. Essendo le lettere arrivate assai dopo, il termine loro prescritto a partire non cominciò a correre, che a’ 18 di giugno 1492. L’ottimo vicerè Ferdinando de Acugna, considerando l’abborrimento naturale, che aveano i Siciliani per la nazione Ebrea, e riflettendo, se promulgava il bando, che i Giudei sarebbero divenuti il zimbello di tutti, e sarebbero stati da per tutto insultati, pensò saggiamente di metterli prima sotto la protezione del governo; e perciò a’ 28 di maggio con dispaccio viceregio sottoscritto in Messina accordò a’ medesimi la salvaguardia così per le loro persone, che per i loro beni: ordinando, che per tutte le città, e terre del regno si promulgasse questo suo dispaccio dal pubblico banditore, acciò niuno potesse allegare ignoranza 535; e volendo che sopra le loro sinagoghe, e case si ergessero le armi del re di Aragona. Replicò questo stesso ordine a’ 31 dello stesso mese, e vietò inoltre ai Siciliani che potessero portare armi addosso, eccetto i soli uffiziali destinati alla custodia degli Ebrei, e delle loro sostanze 536. La voce sparsasi del loro sfratto già apportava moltissima confusione. Siccome eglino 530 Surita, Annales de Aragon. lib. XX. cap. 97. pag. 269 e 270. Del Vio, Privilegia Urbis Panor., p. 406. 532 Reg. degli atti, provisioni, e lettere dell’anno X. Indiz. dell’uffizio del Maestro Notaro dell’Eccmo. Senato di Palermo, p. 211. 533 Gli Ebrei ne’ regni di Aragona furono costretti, non avendo altro scampo, a partirsi, e passarono parte nel Portogallo, e nel regno di Navarra, parte nell’Africa, nell’Asia, e nella Turchia Europea, e parte in Napoli, in Venezia, e in altri paesi d’Italia. Vuolsi che sortissero dagli stati del re di Aragona cento settanta mila di questa nazione, il qual numero unito a quello de’ mori di Granata, che si erano rifuggiti nella Barberìa, cagionarono una spopolazione non indifferente. Il Surita (Annales de Aragon. Hist. del Rey Don Hernando, tom. V, lib. I, cap. 7, pag. 9 e seg.) quantunque mostri di lodare la determinazione del re Ferdinando, non lascia nondimeno di confessare, che molti opinarono che grande fu il danno, che questo monarca arrecò ai suoi regni, privandoli di tanta gente cosi industriosa, e che la conversione de’ Mori, e degli Ebrei era più sperabile, quando fossero rimasti in Ispagna, che permettendo loro di ritirarsi ne’ paesi degl’infedeli. 534 Aveano gli Ebrei in Sicilia assai prima sofferte delle contraddizioni. Fino da’ tempi del re Alfonso, e intorno all’anno 1455 i pp. Domenicani di Taormina aveano ricorso al pontefice Callisto III, dimandando che fossero levati da’ contorni del loro convento la Sinagoga, e il Cimitero degli Ebrei; e questo monarca volendo compiacere il papa, che avea sostenuta la loro istanza, ordinò a Lupo Ximenes de Urrea che li facesse demolire, destinando agli Ebrei un altro luogo, come questi con suo dispaccio viceregio fe’ eseguire (Reg. della regia cancelleria dell’anno 1455.1456, pag. 297), che fu sottoscritto nel dì ultimo di marzo 1456. Si è riferito ancora al capo XVI di questo libro il macello fattosi in Modica a’ 15 di agosto 1474, e ne’ paesi convicini di questi sventurati, e l’anno antecedente al loro sfratto, cioè l’anno 1491 nella città di Castiglione fu ucciso Bitone sommo loro sacerdote da’ due fratelli Andrea, e Bartolomeo Frisi, perchè dicesi che costui avesse buttato dalla finestra un sasso, con cui colpì l’immagine del Crocifisso, che nel dì delle Rogazioni era portata in processione. Questi fratelli, commesso l’omicidio, temendo il rigore della giustizia fuggirono in Ispagna, e come allora bolliva l’odio contro gli Ebrei, furono lodati di questa azione, e rimessi liberi in Sicilia. (Di Giovanni, Ebraismo della Sicilia, part. I, cap. 24, num. 20, p. 175). 535 Reg. degli atti, provisioni, e lettere dell’anno 1491.1492 dell’uffizio del Maestro Notaro del Senato di Palermo, p. 208. 536 Ivi, pag. 214. 531 - 97 - trafficavano co’ Cristiani, e co’ loro connazionali, per conseguenza vi erano de’ scambievoli crediti, e debiti, così fra gli Ebrei, e i Cristiani, come fra’ Giudei stessi, e perciò i tribunali di giustizia erano assordati da continovi ricorsi. Gli Ebrei inoltre, sapendo di dover tantosto partire, si faceano lecito di trafugare i loro beni, di barattare i loro stabili, e di nascondere le loro merci; e i Cristiani debitori dall’altro canto si studiavano d’isfuggire il pagamento con mille sutterfugî. Il provvido viceregnante per impedire le truffe, che poteano farsi dall’una, o dall’altra parte, con un dispaccio de’ 2 di giugno 1492 sospese da un canto ogni azione giudiziaria contro i Giudei, fino che non costassero i loro debiti; e dall’altro, per non dare a questi adito di barattare, cambiare, o nascondere i loro beni, ordinò a’ proti, e majorenti, che pubblicassero nel giorno del seguente sabato nelle loro sinagoghe la scomunica Maggiore more Hebraeorum contro coloro, che osassero di cambiare, o vendere a vil prezzo, o nascondere i loro beni, come egli vietava col suddetto dispaccio 537. Procurata così la sicurezza personale, e reale degli Ebrei, e date le provvidenze per gl’interessi de’ Cristiani, fe promulgare ai 18 di giugno a suon di tromba in Palermo, e in tutte le altre città, e terre del regno l’editto, che stabiliva la loro espulsione dentro lo spazio di tre mesi. Siccome però il loro numero in Sicilia era assai grande, giacchè facea montarsi a più di cento mila; ed era perciò a temersi da parte de’ medesimi qualche sollevazione; perciò l’avveduto ministro proibì loro sotto gravissime pene ogni, e qualunque uso di armi offensive 538. Le istruzioni date a’ ministri dalla corte, e dal vicerè per prevenire ogni disordine [126] nell’espulsione degli Ebrei, furono puntualmente da loro eseguite. Si collocarono in primo luogo le armi reali sopra le porte di tutti i Ghetti, e ad ogni casa di ciascuno ebreo. Fu di poi fatto l’inventario di tutti i mobili di ogni famiglia. Gli argenti, gli ori, le gioje, i drappi, e tutto ciò, ch’era prezioso, furono pesati, o misurati, e depositati in potere de’ Cristiani benestanti, e ben visti al governo, e il restante delle mobilie di minor prezzo fu posto nelle casse, che ben chiuse, e suggellate restarono nelle mani de’ rispettivi padroni. Fu ordinato indi che niun Cristiano ardisse con frode, e con violenza di impossessarsi de’ beni degli Ebrei, e fu prescritto a’ notari, che nel termine di due giorni consegnassero al governo, o a’ ministri disegnati dal medesimo, le copie di tutti i contratti fatti dagli Ebrei: ed a’ creditori, che fra quindici giorni dovessero palesare con autentiche prove la nota de’ loro crediti. Inoltre fu comandato a coloro, i quali aveano da’ medesimi in pegno ori, argenti, gioje, o altro, che dovessero nello spazio di sei giorni rivelarlo, e a quelli, che tenessero in deposito mobili, o schiavi, che dovessero subito manifestarlo. Agli Ebrei poi fu stabilito il termine di 24 ore per dar la nota di tutti i loro beni stabili. Per riguardo agli altri Cristiani, che avessero debito con essi in rendite, si comandò che incontanente lo dicessero; e da ultimo fu stabilito, che tutti coloro che si trovavano di aver fatto delle compre da’ Giudei dei beni stabili dal mese di aprile 1492 fino a’ 18 di giugno fossero tenuti di darne avviso al governo. Questi infelici sapeano già la vicina loro espulsione, e prevedendone gl’inconvenienti, si erano preparati a fare i loro ricorsi. In fatti appena fu promulgato a’ 18 di giugno il consaputo bando, che nel dì seguente si presentarono al vicerè, che trovavasi in Messina, gli ambasciadori di tutte le Giudeche di Sicilia, e lo stesso giorno fu spedito un altro memoriale allo stesso viceregnante dai Giudei di Palermo. Dimandavano eglino nelle mentovate due memorie, che questo governante dasse le necessarie provvidenze, perchè l’esecuzione del dispaccio si facesse con ordine, e senza che accadesse verun sinistro 539. Cercò il buon vicerè di render loro meno sensibile lo sfratto, e più sollecito il disbrigo de’ loro interessi, ordinando con suo dispaccio de’ 25 dello stesso mese, che tutto l’oro, l’argento, e le gioje, ch’erano nelle mani di diverse persone, passassero in potere di Giovanni Battista Lombardo in Palermo, e di altri ministri nelle restanti città, e che si potessero vendere coll’intervento del magistrato, depositandosi il denaro nelle mani de’ tesorieri; e ciò ad oggetto di potersi più agevolmente isbrigare i conti de’ debiti, e de’ crediti, così a vantaggio de’ Cristiani, che degli Ebrei 540. Per quanto saggie ed umane fossero le provvidenze date dal vicerè d’Acugna, per le quali restavano illesi i diritti de’ creditori, e i beni degli Ebrei, restarono gli uni, e gli altri delusi per un nuovo ordine venuto dalla corte di Aragona. Si pretese, non si sa con qual titolo, che gli Ebrei, anzi che partissero, dovessero pagare alla regia corte in capitale, e al quattro per cento tutte le gravezze, alle quali si erano soggettati dimorando nel regno. Fu perciò il detto vicerè costretto a promulgare due dispacci, l’uno diretto a tutti i regî ministri incaricati degli affari degli Ebrei, con cui ordina che restino sequestrati tutti i beni mobili, e stabili, mercatanzie, crediti, oro, argento, gioje, e tutto altro, che appartenesse a’ Giudei a nome della regia corte 541, proibendo che alcun creditore potesse esser pagato, nè che alcuno Ebreo potesse estrar nulla, nonostante 537 Ivi, pag. 216. Di Giovanni, Ebraismo della Sicilia, part. I, cap. 24, pag. 200. 539 Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1491. X. Indiz. f. 53 e 54. 540 Reg. del Protonotaro dell’anno 1491.1492, X. indiz. fogl. 58, e nell’uffizio del maestro notaro del Senato di Palermo reg. delle provisioni dell’anno X. indiz. pag. 220. 541 Reg. degli atti, provisioni, e lettere dell’uffizio del maestro notaro del Senato di Palermo pag. 227. 538 - 98 - qualsivoglia permissione dinanzi ottenuta; e l’altro indirizzato a’ proti, e majorenti, ordinando che pagassero alla ragione del quattro per cento il capitale de’ diritti, che la regia corte esigea sopra di loro 542. Questi amari bocconi, che dovettero inghiottire quei meschini, furono indorati con una larga esibizione, che non sarebbono punto soggetti a questi ordini, quando si fossero convertiti, ed avessero ricevuto il battesimo; dichiarandosi che allora sarebbono stati riputati come cittadini 543. Noi non la finiremmo mai, [127] se ci piacesse di addurre tutti i dispacci emanati in questa occasione. Solo diremo, che il vicerè, che stavasene a Messina, cercò tutti i mezzi di addolcire la disavventura di quegli infelici, ma non era in suo potere di renderne la condizione meno trista; fioccavano gli ordini dalla corte, che sembravano di non avere altro obbietto, che quello d’impinguare il regio erario colle loro spoglie. Pressati da ogni parte gli ebrei ora dai loro creditori, ora dalla cessazione del traffico, ora dai ministri della regia corte, che pretendevano cento mila fiorini per le gravezze perpetue, che si voleano da loro esigere, quantunque non dovessero più dimorare nel regno; nè sapendo come riparare a tanti mali, presero la risoluzione di ricorrere al Sovrano, dimandando la dilazione a partire di altri due mesi, ed offerendo per questa grazia un donativo di cinque mila fiorini. Speravano eglino di poter così accomodare meglio i loro affari 544. Non fu loro difficile l’ottenere quanto dimandavano: cinque mila fiorini stuzzicavano le orecchie dei regî ministri. Noi abbiamo il dispaccio viceregio dato in Messina a’ 24 di agosto 1492, con cui si differisce lo sfratto loro fino ai 18 di novembre dello stesso anno 545, e di poi ottennero una seconda dilazione fino ai 12 di gennaro 1493. Così furono pagati alla camera del Re centocinque mila fiorini, con cui furono ricattate le secrezie di Palermo, che il fisco avea vendute, e saldato il preteso diritto della regia corte furono dissequestrati i loro beni, e fu loro permesso, che potessero portarseli, trattene le gioje, gli ori, e gli argenti, che si accordò loro di poter ricambiare con altre massarizie. Arrivato finalmente il tempo della loro partenza, furono i medesimi costretti ad andarsene. Noi ci dispenseremo dal far quà la terribile pittura della maniera, con cui questi disgraziati furono trattati negli ultimi momenti della loro sventura, giacchè la natura istessa ne freme; ma non possiamo far di meno di non additare brevemente il modo barbaro, con cui furono discacciati. Non fu loro permesso di portar seco, che una veste usata, un matarazzo, una copertina di lana, o di saja, un pajo di lenzuola adoperate, pochissime vettovaglie, quante a stento bastassero per il viaggio, e soli tre tarini per il nolo di ciascheduno. Ciò però intendeasi delle persone facoltose, giacchè per le povere, che non aveano nè da dormire, nè da pagare il noleggio, si ordinò, che stessero a carico degli Ebrei più comodi, ai quali finalmente il vicerè, conoscendo l’ingiustizia, che si facea loro, concesse, mosso dalle loro lagrime, che si raddoppiassero le mobilie, trattane la veste, che dovesse esser una, ed usuale. Non ostante tutti questi aggravî, non intralasciarono i crudeli ministri di frugare, nell’atto che partivano, le loro materazze, e le vesti, non perdonando nemmeno a quelle delle donne, che la verecondia dovea lasciare illese, e questo affine di osservare, se tenessero nascoste gioie, argento o oro. Così accadde il tragico sfratto degli Ebrei, in cui se avesse avuto solamente luogo lo zelo della religione, lo giudichino i saggi. Da quanto abbiamo rammentato pare, che i Siciliani non abbiano comunemente approvato l’espulsione degli Ebrei; purnondimeno non saranno mancati di coloro, i quali, o per uno malinteso spirito di religione, o perchè sperassero di trarre eglino col traffico quel profitto, che si procurava quella industriosa nazione, ne furono contenti, ed in Catania, sia per adulare la corte, sia perchè pensassero quei cittadini, che fosse stata questa una gloriosa azione del re Ferdinando, fu questo sfratto fissato come un’epoca da contare gli anni. Noi abbiamo una lapide ivi eretta in occasione, che l’anno 1493 fu rifabbricato il palagio senatorio, in cui è notato l’anno terzo [128] della presa di Rosciglione, e l’anno primo della conquista del regno di Granata, e dell’espulsione degli Ebrei. Eccola tal quale la rapporta il p. abate Amico 546. + 3° ROSILIONE CAPTA GRANATA I° IVDEIS PVLSIS 542 Reg. del Protonotaro dell’anno 1491.1492, X. indiz. fogl. 104. Reg. del Maestro Notaro del Senato di Palermo, ivi, pag. 230. 544 Fu la loro dimanda appoggiata dal senato di Palermo, che in una memoria presentata al vicerè d’Acugna fa al medesimo intendere, che lo sfratto degli Ebrei, e in così stretto tempo, tendea alla rovina della capitale, e di tutto il regno (Reg. delle provisioni dell’anno 1491.1492, X. indiz. dell’uffizio del maestro notaro del senato di Palermo pag. 220). In questa memoria merita di essere avvertito che il senato dichiarò, che le cagioni che si assegnavano della espulsione degli Ebrei, erano tutte false; avvegnachè, nonostante la loro dimora, il regno era sempre rimasto costantemente attaccato alla fede cattolica, nè eglino aveano mai subornato alcuno dalla medesima, nè fatto nulla, che fosse in obbrobrio della nostra fede, come ne potea fare testimonianza l’inquisitore F. Antonio della Pegna, che dietro ad un diligente esame non avea trovato nè errore, nè scandalo nella fede cattolica. Difendea ancora i Giudei dall’accusa, che fossero usurari: assicurando che non mai esercitato aveano nel regno questo infame esercizio. Laonde conchiudea, che le lettere ottenute dal re per il loro sfratto erano surrettizie, e perciò come fondate su falsi rapporti, non doveano eseguirsi. 545 Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’anno 1491.1492, X indiz. f. 126. 546 Catana Illus. tom. III, lib. X, cap. IX, p. 286. 543 - 99 - MEDIO CLARIOR RESURGO: FERDINANDO. R. CVNAQVE. REGENTE M° CCCCLXXXXIII. Noi non sappiamo se il re Ferdinando, per lo sfratto dato agli Ebrei, o per la conquista del regno di Granata, o finalmente per avere acquistato le Indie, avesse ottenuto dalla santa sede l’onorifico titolo di Cattolico. Gli scrittori non sono uniformi, ma è più verisimile, che per tutte queste azioni ne fu decorato. Alessandro VI suo vassallo promosso al pontificato l’anno 1492 dopo la morte di Innocenzo VIII fra le molte cose, che oprò a favore del suo monarca, volle anche accordargli questo privilegio, che poi è passato ai suoi successori, qualunque ne fosse stato il motivo. Colla partenza degli Ebrei non terminarono i loro affari. Restavano molti crediti dei medesimi, e molto denaro, che eglino aveano dato in prestito, nè aveano potuto esigere prima di partire. Inteso il re Ferdinando di ciò, ordinò al vicerè de Acugna, che promulgasse un bando, con cui ordinasse sotto la pena di due mila fiorini a chiunque avesse roba degli Ebrei, o tenesse debito coi medesimi, che dovesse rivelarlo fra lo spazio di venti giorni, volendo che detta roba restasse sequestrata a nome della regia corte. Il dispaccio viceregio fu dato in Messina ai 25 di agosto 1493, e il bando fu tosto pubblicato per tutte le città, e terre del regno 547. Da Messina passò il de Acugna in Catania nell’anno 1494, dove era certamente nel mese di aprile, come costa da un dispaccio segnato in detta città agli 11 di esso mese, indirizzato al senato di Palermo, che viene rimproverato, perchè non avesse ancora, giusta l’ordine del Re comunicatogli, fatta fare la stima dei beni lasciati dai Giudei, e minacciato della pena di once cento applicabili al regio fisco, se con ogni prestezza non eseguiva il detto comando sovrano, e non trasmetteane la relazione della fatta stima 548. Vi si fermò allora poco tempo, e ripassò a Messina, dove trattenutosi qualche altro mese ritornò a Catania sugli ultimi di luglio, o nei primi di agosto dello stesso anno 549. Ivi fe egli esecutoriare la cedola reale segnata dal re Ferdinando nel castello di Tordesillas ai 15 di maggio antecedente, con cui gli era prorogato per altri tre anni il viceregnato 550. Tenne in detta città nel mese di ottobre il generale parlamento 551, in cui dimandò dei sussidî sotto il pretesto di tenere lontano il Turco, e ottenne un donativo di cento mila fiorini da pagarsi in tre anni, e inoltre i cinque mila fiorini per sè. Ma non godè molto tempo di questa grazia: morì egli nella detta città a’ 2 di dicembre dello stesso anno, e fu seppellito nella cattedrale 552 in una tomba marmorea erettagli da Maria Altavilla sua moglie. Evvi nel di lui mausoleo la seguente iscrizione. Jesus Maria. Hic Jacet D. Ferdinandus De Acunna Siciliae Prorex, Patria Castellanus, Patre Comite De Buendia, Illustri Scilicet Genere De [129] Acunna Genitus. Aspectu, Atque Animo Regius, Ac Virtutum Omnium Cumulus Litterarum Cultor, Et Armis Strenuus. Hunc Proborum Et Doctorum Chorus Deflet, Cujus Corpus Tametsi Terris Sit Conditum, Pia Tamen Anima Beatorum Obtinet Gloriam. Sulla tomba evvi il simulacro di questo vicerè genuflesso, in atto di adorare le reliquie di S. Agata, e intorno alla base vi si leggono i seguenti versi: Fernandus Cuneus, justus, prudensque, benignus Sicilie Prorex conditur hoc tumulo. Quem lacrymis Conjux decorat sua chara Maria Altavilla donans 553 hoc pietatis opus Moribus iste Cato fuerat, sed pectore Cesar In quo virtutum fulserat omne genus Ante oculos hunc semper habe virtutis amator 547 Reg. degli atti, provisioni, e lettere dell’an. 1492.1493, XI indiz. nell’uffizio del Maestro Notaro del Senato di Palermo pag. 184. 548 Reg. degli atti, provisioni, e lettere dell’anno 1493.1494, XII. ind. pag. 105. Questo ritorno del vicerè de Acugna a Catania dovette accadere fra i 15 di luglio, ed i 6 di agosto. Nell’archivio del senato di Catania (presso l’abate Amico Catana illus. t. II, lib. VII, cap. IV, pag. 353) conservasi un privilegio dallo stesso vicerè accordato al medesimo senato, con cui segli dà il diritto supremo di giudicare intorno agli affari della pubblica salute, quando evvi pericolo di peste, o di altro male epidemico nella città di Catania. Questo dispaccio è sottoscritto dal vicerè a’ 15 di luglio, in Messina: laonde trovandosi a’ 6 di agosto esecutoriata la lettera reale, di cui parleremo, è certo che il secondo viaggio di esso vicerè da Messina a Catania deve stabilirsi nel termine da noi additato. 550 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1493.1494, indiz. XII, fogl. 548. 551 Mongit. Parlam. di Sic. t. I, pag. 109. 552 Lasciò egli prima di morire nel suo testamento a’ monaci Benedittini, che allora erano i canonici della cattedrale di Catania, un gran podere, che possedea nella campagna di Palermo presso il palaggio detto della Zisa, coll’obbligo di celebrare una messa cotidiana per l’anima sua (Amico Catana illus. t. II, lib. VII, cap. IV, pag. 353). 553 Vincenzo Auria (Cronologia de’ sign. vicerè di Sicilia p. 23) legge diversamente cioè Avila condonans, ma noi abbiamo creduto di dovere adottare la lezione del P. abate Amico, che Catanese, e scrivendo in Catania dovea riscontrare la lapide sepulcrale. 549 - 100 - Sic Caelo, et terris nempe probatus eris Vixit annos XL. Obiit XI. Decembris 554 anno Salutis Domin. MCCCCLXXXXIV. 555 Sogliono per lo più le iscrizioni sepolcrali essere un’argomento equivoco del merito delle persone, per le quali sono fatte. Siccome sono elleno apposte ai tumoli dai parenti, o dagli amici dei defonti, spesso accade che siano esagerate, e delle volte mensognere le lodi, che loro sono date; e perciò uno storico, che scrive senza altri fondamenti che questi, va a risico di passare per bugiardo. Ma per conto del vicerè Ferdinando de Acugna sono gli scrittori tutti di accordo, che egli amò la giustizia, fu irreprensibile nei suoi costumi, fu dotato di una singolare prudenza, trattò i vassalli del re con somma benignità, e che in sostanza fu uno di quei rari governanti, che la provvidenza destinò ai Siciliani. Le virtù, di cui fu l’Acugna adornato, e la di lui gran bravura nell’arte militare indussero il re Ferdinando il cattolico a dispensare ben due volte alla legge, che avea stabilita l’anno 1491, che i vicerè non potessero durare nel governo, che soli tre anni. In Sicilia si pianse per questa perdita, e ne accrebbe il dolore la considerazione ancora, che fosse stato dalle invide parche rapito in un’età così fresca 556. CAPO XXI. Giovanni Tommaso Moncada maestro giustiziero, Giovanni la Nuça vicerè, Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo presidente del regno. Sebbene la lapide sepolcrale rapportata dal P. abate d’Amico, e che noi nello antecedente capo abbiamo riferito, porti la morte dell’Acugna agli 11 di dicembre: obiit XI Decembris, noi nondimeno abbiamo prescelta l’opinione dell’Auria, che lo dice morto a’ 2 dello stesso mese, e crediamo, che sia stato o errore dello scalpellino, o dello stampatore, il quale in vece di II. abbia posto XI. errore facile a commettersi, e in cui nelle iscrizioni spessamente osserviamo che siano caduti o i marmorarî, o gli amanuensi. Ci siamo mossi a pensar così dall’osservare, che Giovanni Tommaso Moncada maestro giustiziere comincia a dispacciare a’ 3 di dicembre 1494 557 ciò, che non potea fare, se non dopo la morte del vicerè Ferdinando de Acugna. Non troviamo nei nostri regî archivî verun dispaccio che accenni l’elezione del mentovato di Moncada per presidente del regno dopo la morte del riferito vicerè; e perciò abbiamo motivo di sospettare, o che siesi disperso, o che l’Acugna fosse morto [130] inaspettatamente, senza che abbia potuto dichiarare chi dovesse governare il regno, fino che il re Ferdinando avesse eletto il suo successore. È fra di noi una legge, che quando finisce di vivere un vicerè, perchè il regno non resti senza un governante, subentra nel governo il maestro giustiziero una col sacro consiglio, fino a che la corte non provveda altrimenti; e alla nostra età, in cui i vicerè non hanno più il diritto di scegliersi un successore, quando o muojono, o partono, e in cui non vi è più la carica di maestro giustiziero, resta la podestà nel sacro consiglio, di cui è capo il presidente della gran corte, che fa le veci di maestro giustiziero. Prese dunque le redini dei governo o per destinazione fattane dall’Acugna, o perchè questa è la costumanza nel regno il conte di Adernò Giovanni Tommaso Moncada, che godeva la suddetta insigne carica, e perdurò nell’esercizio di presidente, e di luogotenente del regno fino all’arrivo di Giovanni la Nuça eletto dal re di Aragona vicerè di Sicilia. Ci manca ancora la cedola reale, per cui venne questi prescelto alla detta dignità, e per conseguenza siamo anche privi dell’esecutoria del sovrano decreto 558. I nostri archivî, come più volte abbiamo osservato, sono mancanti, qualunque ne sia stata la cagione, o la negligenza di coloro, che li hanno in custodia, o la poca avvedutezza nel ben curare che si trasportassero ne’ medesimi le carte restate in Messina, ed in Catania, dove dimoravano i vicerè, o che finalmente si sieno perduti de’ volumi ne’ frequenti cambiamenti che si facean delle scritture della regia cancelleria, e dell’uffizio del protonotaro. 554 L’Auria suddetto vi legge: Obiit 2 decembris, nel che crediamo che l’abbia indovinato come diremo. Amico Catana illus. tom. II, lib. VII, cap. IV. p. 153 e 154. 556 Questo vicerè l’anno 1491 fu curioso di osservare nello interno gli avelli reali, che sono nel Duomo di Palermo, e consentendovi l’arcivescovo Giovanni Paternò, se ne fe’ l’apertura a’ 18 di ottobre. Fu aperto in primo luogo quello dell’augusta Costanza moglie dell’imperadore Federico. Voleasi di poi passare allo scoprimento degli altri sarcofagi; ma siccome i nobili disapprovarono quest’azione, dicendo che non conveniva d’inquietare le ceneri di tanti sovrani, il prudente vicerè fe’ soprassedere, e fe’ riporre ogni cosa nel primiero stato. Ne fu inteso il re Ferdinando, il quale non acconsentì che si facessero altre ricerche, e rimproverò la condotta del vicerè, e dell’arcivescovo. A nostri giorni all’anno 1781 nell’occasione di rifabbricarsi il Duomo furono di nuovo aperti i reali avelli, e la corte non solo non condannò questo discoprimento, ma ordinò inoltre, che si facesse una distinta relazione, che già è alle stampe, di ciò che vi si era trovato. Qual diversa maniera di pensare da un secolo all’altro! 557 Reg. della regia cancellaria dell’anno 1494.1495, XIII indiz. fogl. 130. 558 Possiamo congetturare, ch’egli fu eletto nel mese di febbraro 1495, imperciocchè il Surita (Hist. del Rey D. Hernando t. V, lib. II, cap. VIII, p. 67) racconta, che a’ 5 di detto mese fu eletto in di lui luogo per governatore di Aragona Giovanni Hernandez de Heredia per tre anni. Ora queste tali elezioni sogliono essere contemporanee, e verisimilmente precesse a’ 4 di febbraro l’elezione di Giovanni la Nuça in vicerè di Sicilia. 555 - 101 - Era Giovanni la Nuça giustizia maggiore di Aragona, ch’è l’uffizio il più grande, e il più cospicuo di quel regno, ed era anche stato vicerè nel regno di Valenza, e nel principato di Catalogna, e fu creduto il più opportuno a reggere il regno di Sicilia, così per l’esperienza che avea nell’arte di governare, come perchè sapesse a tempo, e a luogo opporsi a’ Francesi, che aveano portata la guerra in Napoli 559, e sostenere il re Alfonso nipote del re Cattolico. Non sappiamo quando questo vicerè sia arrivato in Sicilia; il Maurolico 560 solo ci dice ch’egli venne in Messina, e fu alloggiato nella casa di Giovanni Staiti. Dovette non ostante arrivarvi nell’anno 1495, e forse nel mese di aprile di esso anno; imperciocchè noi troviamo sottoscritto il maestro giustiziero ne’ dispacci sino a’ 23 di marzo 561, nè si vede il nome del nuovo vicerè la Nuça, che a’ 24 di aprile 1495 562. La prima cura ch’egli ebbe, appena posto il piede a Messina, fu quella di dar soccorso ad Alfonso II. re di Napoli, ch’era assalito nella Calabria da’ Francesi, e di provvedere ancora alla sicurezza del regno di Sicilia. Intimò dunque a tutti i baroni della nostra isola il servigio militare, e mandò tosto a Reggio di Calabria il barone di Mongiolino con cento lance 563. Da Messina il vicerè la Nuça venne a Palermo, dove in capo a poco tempo arrivò il re di Napoli Alfonso II. 564. Vi era egli venuto con quattro galee, sulle quali pose i [131] più preziosi arredi del suo palagio, e trecento cinquanta mila scudi. Fu egli onorevolmente ricevuto dal viceregnante, come si conveniva ad un sovrano, comunque sventurato, ma non volle entrare in città; avvegnacchè contava di ritirarsi, come fece, nella città di Mazara, città reginale appartenente alla regina vedova di Napoli, dove partendo colle stesse galee dal porto di Palermo portossi; e vuolsi che si fosse ritirato 565 in un monistero de’ Benedittini della congregazione di Monte Oliveto 566, con animo di vivere quietamente gli ultimi anni di sua vita. Non si trattenne molto tempo il vicerè la Nuça nella capitale; dovette egli ritornare in Messina per essere più a portata di sapere gli andamenti de’ Francesi nel regno di Napoli. Ivi in capo a poco tempo si ricoverò Ferdinando figliuolo di Alfonso II, il quale non potendo sostenere sul capo la vacillante corona lasciatagli dal padre, amò meglio di ritirarsi, sciogliendo prima i suoi vassalli dal giuramento di fedeltà; e partitosi da Ischia prese la via di Sicilia, e venne a Messina 567. Fu accolto dal vicerè, e da’ Messinesi con estremo amore, compassionando ognuno la disgrazia di questo amabile principe, degno di una miglior sorte. Alfonso allora padre del medesimo, udito l’arrivo del figliuolo, abbandonò Mazara, e veleggiò per Messina a fine di starsene col figliuolo, e colla real famiglia. Era cosa, che traggea le lagrime, il veder tanti principi sventurati discacciati da’ loro stati, e ridotti alla vita di privati. Il vicerè, e i Messinesi non lasciavano di confortarli, e di rendere questa condizione meno dura colla loro assistenza. Noi crediamo, non senza verosimiglianza, che nello stato deplorabile, in cui erano i loro affari, abbiano questi principi ammesso a parte delle proprie risoluzioni il vicerè de la Nuça, per trovarsi il modo da provvedervi, e che col di lui consiglio, e forse ancora co’ di lui uffizî alla corte di Aragona, siesi implorata la protezione del re Ferdinando il Cattolico, ch’era l’unico, che avrebbe potuto far fronte al re di Francia, ed obbligarlo a restituire l’invaso regno. Fu perciò spedito in Ispagna il segretario del re Ferdinando a quest’oggetto. Il consiglio parve allora opportuno; il re di 559 Mentre vivea Ferdinando re di Napoli figliuolo bastardo di Alfonso, Ludovico Sforza, detto il Moro, che avea usurpato il dominio del ducato di Milano, che appartenea a Giovanni Galeazzo suo nipote, ch’erasi sposato colla principessa Eleonora figliuola di Alfonso II, duca di Calabria, e principe ereditario di Napoli, temendo di essere sbalzato da Ferdinando padre di esso Alfonso, che avea una possente armata, si cooperò a chiamare le armi francesi, per dargli un diversivo, nel regno di Napoli. Gli fu agevole d’indurvi Carlo VIII giovane ambizioso di gloria, il quale credea ancora, per essere della schiatta de’ duchi di Angiò, di avere sul detto regno de’ diritti legittimi. Vuolsi che Alessandro VI pontefice vel’abbia anche chiamato, il quale poi, morto il re Ferdinando, ed ottenuta in isposa di Giuffrè suo figliuolo naturale Sancia bastarda di Alfonso II, si pentì, ma tardi, del passo che dato avea; e cercò inutilmente di dissuadere il re di Francia da questa impresa. L’armata francese entrò in Italia, e siccome Alessandro VI, temendo di peggio, accomodò i fatti suoi con Carlo VIII, le fu facile di passare in quel regno. 560 Sic. Hist. lib. IV, p. 204. 561 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1494.1495, XII indiz. fogl. 1. 562 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1494.1495, XII indiz. fogl. 255. 563 Surita, Hist. del Rey D. Hernando t. V, lib. II, cap. VIII, pag. 67. 564 Questo sovrano vedendo che tutto andava a rovina, e che i Francesi senza sfoderare la spada s’impossessavano del suo regno, al quale acquisto erano ajutati da’ principali baroni napolitani, che l’odiavano, o di sua volontà, o così consigliato dal papa, pensò di cedere la reale corona al suo primogenito Ferdinando ch’era l’idolo della nazione, e dei nobili, e di ritirarsi in Sicilia. Fu tarda questa determinazione, e quando non era più tempo di riparare alla perdita fatta, come si dirà in appresso. 565 Fleury Hist. Eccl., all’anno 1495. 566 Non abbiamo alcun documento, che in Mazara vi sia mai stato monistero de’ PP. Benedittini di monte Oliveto; laonde crediamo che questa sia più tosto una congettura cavata dal particolare amore, che questo sovrano avea per i padri Olivetani, come si cava dal Giannone, (Storia civ. di Nap. t. IV, lib. XXIX, p. 442). Il Lelli, (Storia della chiesa di Morreale in Giovanni IV arcivescovo, p. 85) vuole, che Alfonso da Mazara venne in Palermo, e da questa città passò a Morreale, dove fe’ vita monastica co’ monaci; altri scrivono, che visse coi religiosi in Messina: in somma intorno a questo suo monachismo quot capita, totidem studiorum millia. 567 Il Summonte (Hist. di Napoli, t. III, lib. IV, cap. II, p. 515) scrisse, che Ferdinando giunse a Messina a’ 20 di marzo 1495, nel che viene seguito dal Giannone (ivi cap. II, pag. 447); ma non è possibile che sia ciò accaduto in quell’anno; giacchè il vicerè la Nuça, che fu presente, non venne in Sicilia che nel mese di aprile 1495. Perciò dee questo fatto riportarsi all’anno seguente 1496. - 102 - Aragona prese parte negli affari di Napoli 568, e spedì Consalvo Fernandez della città di Cordova 569, detto per antonomasia il gran capitano, per discacciarne i Francesi 570. Non sappiamo, se il vicerè la Nuça si fosse ritrovato a Messina, quando vi venne Consalvo Fernandez colle truppe Aragonesi 571; i nostri scrittori non lo accennano, ma è assai [132] probabile, ch’ei o appena arrivato Consalvo Fernandez, o prima si fosse restituito in Palermo, essendo cessato il motivo di starsene in Messina; cioè quello d’invigilare agli andamenti dei Francesi nel regno di Napoli, essendo che n’era già incaricato il gran capitano. Egli è certo, che nel mese di settembre ritrovavasi questo vicerè in Palermo, dove forse gli era arrivata la proroga per un altro triennio nel viceregnato di Sicilia. Il dispaccio reale di questa conferma fu sottoscritto dal re Ferdinando il Cattolico nella villa di Alcmaran a’ 5 di luglio 1496, ma non fu registrato in Palermo, che a’ 25 del detto mese di settembre 572. Nel tempo, che questo vicerè era in Palermo, venne di nuovo nelle mani del nostro re l’isola delle Gerbe 573 . Possedeva quell’isola Yaja Ben Sahit Ben Sumuma, il quale era tributario di Muley Tumen re di Tunisi. Questi essendosi ribellato contro il suo sovrano, e temendo di soccombere, fe’ dire al la Nuça, che volentieri sarebbe divenuto vassallo del re di Sicilia, pagandogli il tributo, e dandogli l’entrata nell’isola, subito che fosse difeso contro il principe Tunisino. Siccome le Gerbe erano opportune a vantaggiare il commercio per l’Egitto, e per tutto il levante, e l’isola era ricca, accettò il vicerè di buon grado l’offerta; e dopo di avere segretamente concertato, per l’opera di due cristiani confidenti di Yaya ben Sahit, che segli sarebbono mandati de’ soccorsi, e ch’egli avrebbe consegnata la fortezza, e riconosciuto il re di Aragona per suo sovrano, spedì ivi le galee di Sicilia con truppe sotto il comando di Alvaro Nava. Questi arrivato all’isola non volle mettere a terra le soldatesche, se prima non segli consegnava il castello. Yaya non trovò disposti i suoi mori a renderlo, e perciò il Nava si preparava a ritornarsene in Sicilia. Quando uno de’ figliuoli di Yaya si accinse a persuadere quegl’isolani, prescrivendo loro che ubidissero, essendo questa la volontà di suo padre, e minacciando severi gastighi, se tosto non eseguivano il di lui volere. Parlò così coraggiosamente questo giovane, e atterrì in modo quei mori, che piegarono il collo a quanto loro si comandava, e a’ 18 di settembre 1497 furono sulla piazza inalberate le armi Aragonesi. Il Nava entrato nel castello, e provistolo di artiglierìa, e di tutto il bisognevole, vi lasciò per castellano un certo Margarito governatore della camera reale 574, e poi partì, e ritornò in Sicilia 575. In questo istesso anno 1497 morì in Salamanca il principe ereditario di Aragona Giovanni, qual perdita fu sensibilissima a quei sovrani. Scrive il Maurolico 576, che arrivata nel mese di novembre questa infausta notizia, il senato di Messina a’ 25 dello stesso mese promulgò un bando, con cui ordinò, che le botteghe della città restassero chiuse per lo spazio di nove giorni; e ciò è molto naturale, per addimostrare il cordoglio di quella città per la morte dell’erede del regno; ma soggiunge, che abbia anche prescritto, che niuno per lo spazio di sei mesi potesse radersi la barba; alla qual cosa non possiamo sottoscriverci, parendoci stravagante 568 Avea questo sovrano fatto antecedentemente lega co’ principi d’Italia, cui faceano ombra i progressi de’ Francesi, e si era prima unito co’ Veneziani, facendo con essi una confederazione di venticinque anni. Vi si erano uniti il papa pentito di aver chiamato il re Carlo in Italia, il duca di Milano, ed altri principi, non assegnando altra ragione della loro unione, che la difesa de’ loro stati: ad defensionem statuum (Sanuto, de bello Gallico apud Murat. Rer. Italic. script. t. XXIV, pag. 17). 569 Questo prode capitano avea date grandissime riprove del suo valore nell’acquisto fatto dal re Ferdinando del regno di Granata, ed allora gli Spagnuoli colle loro enfatiche espressioni l’aveano cominciato a chiamare El gran Capitan; sotto il qual nome poi fu comunemente additato dagli scrittori contemporanei. 570 Surita, Annales de Aragon Hist. del D. Rey Hernando, lib. II cap. VIII, p. 71. 571 Ci trarrebbe fuori di strada il racconto di ciò che fece allora il gran capitano. Diremo solamente, ch’egli racconsolò gli afflitti sovrani di Napoli, condusse seco Ferrandino in Calabria, dove prima ottenne una vittoria, e poi fu sconfitto da’ Francesi, e costretto a ritornare a Messina con quel re. Fatto più cauto tenne una condotta più prudente, e a poco a poco venne a capo di discacciare i Francesi, e di far riconoscere di nuovo Ferrandino per re di Napoli, il quale poco godette del piacere di avere riacquistata la perduta corona, giacchè se ne morì ai 5 di ottobre 1495, cui successe lo zio Federico, poichè Alfonso era già morto in Messina. 572 Reg. della regia cancellaria dell’anno 1496.1497, XV indiz. fogl. 32. 573 L’isola delle Gerbe era stata conquistata da Roggiero Loria grande ammiraglio del re Pietro l’anno 1284, e l’avea ottenuta in feudo. L’anno poi 1312 essendosi quei mori, che l’abitavano, sollevati contro la guarnigione che tenea in quel castello Margaritone Loria nipote di Ruggiero, fu spedito dal re Federico Giacomo Casellio con quattro grosse navi cariche di soldati per tenere a freno quei tumultuosi, il quale persuase la madre di Margaritone, giacchè non avea forze da sostenersi, di cedere al re quel castello. Siccome poi i sollevati continuavano nella loro ostinata ribellione; Federico spedì venti galee con gente armata per domarli, e gli riuscì di aver in potere tutta l’isola (Surita, Annales de Aragon t. II, lib. VI, cap. XIII, p. 18). Non conservò questo principe lungamente il suo acquisto. I governatori lasciati a reggere quell’isola vessarono con ingiustizia gli abitanti, i quali dopo di avere inutilmente ricorso, non vedendo che si apportava riparo alle loro disgrazie, perchè forse non penetravano i loro ricorsi alle orecchie di Federico, nell’anno 1335 si ribellarono, e coll’ajuto de’ Genovesi, e di Roberto re di Napoli, che unì tre sue navi alle galee di Genova, si liberarono dalle truppe aragonesi. (Surita ivi cap. XXV p. 113.) 574 Surita, Hist. del rey D. Hernando, lib. III, cap. 17, p. 136. 575 Il Surita, che rapporta questo acquisto, avverte che il re di Aragona non conservò molto tempo quella isola, imperocchè la fortezza non era ben munita, e quel che vieppiù angustiava le soldatesche, era appunto, che mancava di acqua, che bisognava far venire da lontani pozzi co’ cammelli, ciò che riusciva impossibile, quando era assediata. 576 Sican. Hist. lib. IV p. 205. - 103 - codesto ordine, e pregiudizievole a’ barbieri, che in quel [133] frattempo inabilitati a procacciarsi colla loro arte il vitto, sarebbero stati costretti a limosinare. Non sappiamo quali altre dimostrazioni di dolore siensi fatte nelle altre città, e sieno state ordinate dal vicerè Giovanni la Nuça. È certo che in Palermo ne furono fatte l’esequie con gran pompa 577, e ne fe’ l’orazione il vescovo di Cefalù. Morto nella fresca età di ventisette anni Carlo VIII. re di Francia a’ 17 aprile 1498, gli successe Luigi duca d’Orléans, che fu il duodecimo fra’ re di questo nome, il quale tra le prime sue occupazioni cercò sopra di ogni altra cosa di pacificarsi con Ferdinando il Cattolico, e l’ottenne; giacchè questo sovrano, deponendo per allora ogni pensiero della Italia, richiamò il gran capitano, cui ordinò, che consegnasse a Federico re di Napoli tutte le terre, che fino a quel punto avea ritenute nella Calabria 578. La Sicilia non avea allora che temere: le armi francesi dietro alla pace fra’ due re di Francia, e di Aragona, non erano rivolte che all’acquisto di Milano; e Federico re di Napoli era un amico, giacchè trovavasi colla corona in capo, mercè il valore del gran capitano, e delle truppe Aragonesi. Fummo perciò tranquilli tutto l’anno seguente 1499, in cui Giovanni la Nuça ebbe il piacere di vedersi confermato per la seconda volta nel viceregnato di Sicilia, quantunque i nazionali non ne fossero contenti, per un altro triennio. Il dispaccio reale fu dato nella città di Granata al primo di agosto 1499, e fu registrato poi nella regia cancelleria in Palermo a’ 28 del seguente settembre 579. Nello stesso mese di agosto 1499 furono tenuti in Palermo due parlamenti, l’uno ai 19, e l’altro a’ 21 dello stesso mese 580. L’oggetto del primo fu il far riconoscere per legittimo erede degli stati di Aragona il principe Michele figliuolo di Elisabetta primogenita del re Ferdinando. Fu fatto adunque il ligio omaggio a questo principe nelle mani del vicerè, il quale giurò ancora la conservazione dei privilegi del regno. Michele poco sopravisse, essendo morto a’ 20 di luglio 1500, per cui, non avendo avuto altri figli Elisabetta, ed essendo premorta al padre, divenne l’erede la secondogenita Giovanna, per la quale passò la monarchia nella casa d’Austria. Nell’altro parlamento fu dimandato un sussidio per la difesa del regno, e furono da’ parlamentarj accordati ducento mila fiorini in tre anni, da spendersi ad arbitrio del sovrano, ed ebbe il vicerè i soliti cinque mila fiorini di regalo. Conquistatosi da Ludovico XII il ducato di Milano, Federico re di Napoli si sentiva già piombare addosso le armi francesi, e perciò ricorse all’augusto Massimiliano, cui esibì quaranta mila docati, e inoltre quindici mila ogni mese, se veniva alla difesa del regno di Napoli. Quantunque ne avesse riportate delle grandiose promesse, ne fu da quel principe tradito, il quale senza contare sulla parola data, e sul denaro, che ricevuto avea, si pacificò col re di Francia. In questo stato di cose dovè Federico ricorrere a Ferdinando il Cattolico, di cui per altro diffidava, e per la pace fatta poco prima con Ludovico, e per le vecchie pretensioni, che la corte di Aragona credea di avere sul regno di Napoli; ma ne’ casi estremi bisogna, che colui che sta naufragando, si appigli a quella tavola che trova. Ferdinando colla consueta sua simulazione, in cui era singolare, accettò di difendere il regno di Napoli, e spedì subito con truppe il gran capitano, che venne in Sicilia, e sbarcò in Messina 581. Il gran capitano prima di portare le armi in Calabria, cominciò in Sicilia ad operare dispoticamente in tutto ciò, che riguardava il militare; nè di quanto determinava ne facea punto inteso il vicerè la Nuça. Così sul timore che il Turco non invadesse il nostro regno, fece fortificare i due castelli di Maniace, e di Agosta, e al primo destinò per castellano Luigi Peixo con una guarnigione di 159 soldati. Depose inoltre dalla carica di strategoto di Messina il conte di Condojanni, e da quella di capitano di armi di [134] Catania Guglielmo Moncada. Restò il vicerè dispiaciuto di queste risoluzioni fatte senza sua intelligenza, e ne fece delle alte lagnanze; ma indarno, poichè questo altiero soldato, che per altro dalla corte di Aragona avea ricevuto ogni potere, non ebbe alcun riguardo alle leggi di convenienza. Lasciò scritto il Pirri 582, che vien seguito dall’Auria 583, che agli 11 di agosto 1500 venne in Palermo la regina vedova di Ferandino re di Napoli, che avea nome di Giovanna, e ch’entrò in città a cavallo servita da Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo, che prese la destra, e dal vicerè Giovanni la Nuça, che si contentò di occupare la sinistra, e che dietro ad essi eravi il pretore della città. Soggiunge, che trattenutasi questa 577 Littara, de rebus netinis. Guicciardini, Storia d’Italia, lib. III p. 109. 579 Reg. dell’anno 1499.1450 f. 117. 580 Mongit. Parlam. di Sicilia, t. I, p. 111, e seg. 581 Non appartiene a questa cronologia il riferire come sia rimasto deluso il buon Federico in questa spedizione fatta dal re di Aragona, e come siensi anche ingannate le potenze Europee, che credevano che Ferdinando avesse veramente in animo di difendere il regno di Napoli contro i Francesi. Ma il fatto stà che segretamente erano convenuti il re di Francia, e il re di Aragona di spogliare Federico del regno di Napoli, e di dividerselo fra di loro. Si stabilì che questo trattato restato sarebbe occulto, sino che l’armata di Francia fosse arrivata a Roma (Guicciardini Storia d’Italia lib. V, p. 136). Ferdinando non solo si beffò di Federico re di Napoli, ma dello stesso re di Francia, come si dirà. 582 Not. Ecclesiarum Sicil., not. 6 Eccl. Mazariensis p. m. 518.519. 583 Cronologia de’ sign. vicerè di Sic. p. 23. 578 - 104 - principessa alquanti giorni in questa Capitale, partì per Mazara (città allora reginale, e appartenente al regno di Napoli) accompagnata da uno stuolo di nobili, e che fu ivi onorevolmente ricevuta dal decano della Cattedrale, essendo assente il vescovo. Non si può dubitare di questo fatto, costandoci dai registri del senato, e del protonotaro. L’arcivescovo di Palermo però non ebbe luogo in questa entrata, essendo stato preferito il pretore. Ecco come leggesi nel registro del senato 584: Et modo pro futuro tempore lu magnificu misser Girardu di Bonannu preturi di Palermo, comu preturi andava alla banda sinistra di lu vicerè, chi purtava la regina in gruppa, e l’arcipescopo di Palermu, lu quali vulìa lu dittu locu, nun ci fu cunsintutu, e così fu prifiruta la Cittati al Arciviscovu, e alla banda dritta di lu vicerè ci andava l’ambasciaturi dello serenissimo signor re nostro, lu quali era venuto colla signora di Napole. Et ita processit. Dalle quali parole, e da tutto l’atto di questa entrata rilevasi, che la regina non entrò a cavallo da sè, ai di cui fianchi era il vicerè, come disse il Pirri, ma fece la sua entrata in groppa del cavallo del vicerè; strana maniera di onorare quella sovrana, che ci addita quanti diversi fossero i costumi di quel secolo da’ nostri. Non sarà discaro ai leggitori di rapportare quà il principio dell’atto suddetto del senato, da cui possiamo ritrarre alcune altre circostanze: Die decimotertio Augusti IV. indiz. 1500. Venne in questa felice città di Palermo con sei galere di Napole la moglieri, che fu di re Ferrante figlio di re Alfonso re di Napole, perchè Napole fu presa da’ Francisi isto mense, dalla quali tre anni fu chacciatu re Fridericu Frati di quondam Alfonso, e pusau detta regina in casa dello quondam Guglielmo Ajutami-Christu appressu la porta di Termine, la quali sbarcau allu molu, e lu vicerè di questo regno la purtau in gruppa per fina a la pusata, la quali regina vinni in capu la tenda di la sua galea di pannu nigru, e non vossi festa nessuna per la sua venuta, era vistuta di nigru. Bisogna nondimeno dire, che questa regina si trattenne poco tempo in Mazara, giacchè l’anno seguente era in Napoli, prima che cominciassero le azioni militari dei collegati Francesi, e Aragonesi contro il re Federico. In questo istesso anno 1500 fu istituito in Palermo il monte della Pietà. L’oggetto di questo monte fondato dal senato era il sollievo de’ poveri, a’ quali si prestava il denaro, previo il pegno, senza che fossero obbligati a pagare veruna usura 585. Si davano inoltre a coloro, che non poteano andare agli Ospedali, i medicamenti gratuitamente, ogni volta che costasse la loro povertà. Il Cannizzaro 586 ci avvisa, che da principio furono destinate alcune stanze nel palagio senatorio per questa pia opera, e che poi l’anno 1591 fu eretto nel piano della pannerìa il nobile edifizio, che ora si osserva, in cui con più commodo vi si conservano i pegni, e vi sono le officine necessarie, come noi a suo luogo racconteremo. Il gran capitano, che non avea ancora portate le armi nel regno di Napoli, continuava a girare per la Sicilia per fortificarne le piazze, e dopo di essere ritornato da Agosta in Messina ai 17 di maggio 1501 deliberò di portarsi in Palermo. Era allora entrata in Sicilia la pestilenza, la quale particolarmente affligea le due città di Siracusa, e di Messina. [135] La città di Palermo si era conservata illesa. Venendo adunque Consalvo, Gerardo Bonanno che era pretore della città, vietò che i di lui soldati potessero aver pratica, ciò che irritò il gran capitano; ma conoscendo di poi la giustizia di questa proibizione, si contenne nel dovere, e si contentò di far sapere al vicerè, che egli era venuto per trattare col medesimo affari interessanti la corona: pregandolo, acciò fissasse un luogo per potersi seco abboccare. Il la Nuça perciò s’imbarcò, e andò in un giardino lungi dalla città, dove venne ancora Consalvo, e colle debite precauzioni conferirono fra di loro. Fra le cose, che stabilirono, fu la principale, che stante i pericoli, ai quali era esposta la Sicilia minacciata dal Turco, era di mestieri di obbligare i baroni feudatarî al servizio militare; e che siccome non vi era tempo per prepararsi, era miglior partito l’esigerlo da loro in denaro, e fu convenuto di far loro pagare due once per ogni soldato che dovessero consegnare 587. Dopo il congresso partì il gran Capitano, e ritornò in Messina 588. Finalmente si squarciò il velo, che tenea ascosa agli occhi di tutta l’Italia la ripartizione, che i re di Francia, e di Aragona aveano fra di loro fatta del regno di Napoli. Entrate nello stato della chiesa le truppe francesi, fu notificata dai rispettivi oratori in un Concistoro al Papa Alessandro VI, ed ai cardinali la 584 An. 1499.1500, IV indiz. p. 1. La gratuita prestanza di denaro, che faceasi ai poveri, di poi fu ristretta, forse perchè il monte non potea sussistere; e fu accordato che si pagasse la tenue usura dell’uno per cento. Così si è fatto fino all’età nostra; ma da pochi anni in quà esige il monte il cinque per cento. Giudicheranno i Teologi, se trattandosi di poveri possa esser permesso di esigere da’ medesimi cotanta usura. 586 Palermo sagro Mss. della biblioteca del senato di Palermo, p. 581. 587 Paolo Giovio, (vita del gran capitano, p. 57) scrisse, che Consalvo fu chiamato da’ Siciliani, che si dolevano dell’avarizia del vicerè la Nuça, e principalmente lo accusavano, ch’esigesse nelle tratte dei grani più di quel ch’era dalle leggi prescritto, e in danno del regio erario; che giunto in Palermo convocò il parlamento, e in pochi giorni diede ordine ad ogni cosa; e che nel partire rimproverò al vicerè i suoi eccessi, e lo ammonì a governare in avvenire con più di umanità, e di giustizia i Siciliani. Lo stesso accenna Gio: Battista Cafelicio, nella storia, ch’ei fece di questo gran capitano, p. 19. Noi non abbiamo adottato questo racconto, non costandocene la verità, giacchè gli scrittori nostri non ne fanno punto memoria, nè favellano del parlamento tenuto da Consalvo, che non sappiamo se avesse avuto la facoltà di convocare. 588 Maurolico, Sican. hist., lib. VI, p. 215. Serio, Storia cronologica delle pestilenze di Sicilia presso Mongitore, Sicilia ricercata, t. I. p. 481. 585 - 105 - convenzione fatta dai loro monarchi, e fu chiesta a nome dei medesimi 589 l’investitura, che Alessandro nemico di Federico re di Napoli 590 volentieri accordò, collegandosi inoltre cogli stessi sovrani per discacciare questo re dal suo regno. La bolla del Papa è dei 25 di giugno 1501 591. Noi ci asterremo dal raccontare come sia terminata questa scena 592, e come il re di Francia sia stato uccellato dal re Ferdinando, e dal di lui capitano Consalvo Fernandez. Chi ne è curioso, potrà leggerlo presso gli scrittori di Italia, e del regno di Napoli 593, e presso il Surita ancora 594. Ora, per ritornare al regno di Sicilia, e al vicerè Giovanni la Nuça, ebbe questi ordine dalla corte di convocare il parlamento generale, per chiedere ai Siciliani dei soccorsi. In esecuzione dei reali comandi congregò egli in Palermo l’anno 1502 gli ordini dello stato, e quantunque ei sapesse che il sussidio, che si ricercava, non era ad altro fine domandato, che per la guerra, che si facea nel regno di Napoli, nondimeno nel proporlo ai parlamentarî assegnò un’altra causa, cioè la fama sparsasi che il Turco stava facendo dei grandi preparamenti, coi quali potea invadere la Sicilia, e che perciò era necessario di premunirsi per mare, e per terra, [136] a fine di tenerlo lontano. Sapeano benissimo gli ordini dello stato che codesto era un pretesto, e che l’oggetto era un’altro; nondimeno volendo compiacere il re Ferdinando, esibirono per donativo trecento mila fiorini; ma per far comprendere che non ignoravano la cagione, per cui era dimandato questo aiuto, non diedero il proposto destino all’offerta, che faceano, ma lasciarono l’esibito denaro alla libera determinazione del sovrano, dicendo: Sua Maestà ndi fazzi quillo sia più so servicio como meglu a sua Altezza plazza 595. In fatti noi non troviamo nei nostri annali che siesi fatto alcun preparativo contro il Turco. In questo parlamento il vicerè non solo ebbe il solito donativo di cinque mila fiorini, ma fu anche con un’atto particolare eletto regnicolo, per essere così capace di ottenere le cariche, e i benefizî, che non sono destinati, che per i soli nazionali. Ebbero anche i consueti regali gli uffiziali regî, e il di lui cameriere maggiore. Fu destinato per ambasciadore del parlamento F. Rinaldo Montoro vescovo di Cefalù, il quale partitosi per la corte ottenne molte grazie, che sono registrate nei capitoli del regno 596. Un altro parlamento fu tenuto l’anno seguente 1503 nella città di Messina. Ferdinando il Cattolico, ed Elisabetta regina sua moglie dopo la morte del principe ereditario, che abbiamo mentovata, restarono privi di prole maschile, di modo che l’eredità dovea passare nelle femmine, la maggiore delle quali Elisabetta era morta, e morto era ancora l’unico figliuolo di lei Michele, come abbiamo detto; laonde divenne l’erede la secondogenita, chiamata Giovanna la Pazza, la quale era maritata con Filippo il Bello arciduca di Austria. Mentre dunque questo principe stavasi in corte dei suoceri siccome era certa la successione di Giovanna, e perciò del medesimo Filippo, fu stabilito di farli riconoscere per tutta la vasta monarchia di Aragona, come gli eredi del trono, e di far loro perciò giurare fedeltà da tutti gli stati. Fu per questa funzione destinata la città di Toledo, dove vennero i procuratori delle università, ed ai 15 di aprile 1502 giurarono il ligio omaggio a Giovanna, come primogenita, e all’arciduca, come marito di essa 597. Questa solenne riconoscenza dei successori al trono di Aragona, che fu fatta a Toledo l’anno 1502, si eseguì l’anno di appresso in Messina a’ 9 di Febbraro nel parlamento accennato, dove gli ordini dello stato giurarono fedeltà ai suddetti principi nelle mani del vicerè Giovanni la Nuça, che da Palermo era passato a Messina, e si obbligarono a riconoscerli per legittimi sovrani, dopo la morte del re Ferdinando il Cattolico, ed egli il la Nuça secondo le costituzioni del regno, giurò del pari a nome dei suddetti sovrani manutenere le leggi, i capitoli, e le costumanze del regno, e fe questo giuramento non solo come vicerè, ma inoltre come procuratore degli stessi principi in forza della commissione ricevuta sotto li 5 di ottobre dell’anno antecedente 1502 598. 589 Ferdinando per dare un colore a questo tradimento, coprì al solito cotale nera azione col manto della religione, dichiarando, ch’era venuto a far la lega col re di Francia, perchè Federico re di Napoli avea chiamato il soccorso del Turco (Guicciardini, Stor. d’Italia, lib. V, p. 137), ciò che non avea verun fondamento. 590 Alessandro VI volendo ingrandire la sua famiglia avea richiesto al re Federico di Napoli una delle di lui figliuole per isposa di Cesare Borgia suo bastardo, e pretendea che si dasse a questa principessa in dote il principato di Taranto. Questo sovrano, che credea indecoroso cotale parentado, ricusò costantentente di compiacere il papa, e quindi nacquero i dissapori con Alessandro, che giurò la rovina di questo principe. 591 Lunig, Codic. Dipl. ltal., tom. II, part. II, p. 311. 592 Federico re di Napoli irritato della condotta del suo parente Ferdinando il Cattolico, amò meglio di mettersi nelle mani del re di Francia, da cui fu ben trattato. Frattanto senza resistenza venne in potere de’ Francesi, e degli Aragonesi quel regno. Appena acquistato, nacquero delle quistioni nella ripartizione di alcuni luoghi, che non si erano nominati nel trattato. Queste differenze cagionarono delle battaglie fra’ Francesi, e gli Aragonesi, sino che questi ne discacciarono quelli, e restò Ferdinando unico padrone di tutto quel regno. 593 Guicciardini, Rainaldo, Summonte, Giannone, ed altri. 594 Hist. del Rey D. Hernando. 595 Mong. Parlam. di Sic. t. I, p. 123. 596 T. I, p. 532, e seg. 597 Surita, Hist. del Rey D. Hernando t. V, lib. IV cap. 55, p. 227. 598 Mongit., Parlam. di Sic. t. I, p. 129, e seg. - 106 - In questo istesso anno 1503 scrive lo storiografo canonico Antonio d’Amico 599, che il vicerè stesso fu dalla corte confermato per altri tre anni nel governo di Sicilia. Lo stesso attesta Vincenzo Auria 600; ma nè l’uno, nè l’altro adducono monumento di questa proroga, e noi, per quante diligenze fatte abbiamo nei regî archivî, non ne abbiamo potuto rinvenire verun vestigio. Nondimeno così dovette accadere; giacchè egli continuò nell’esercizio della sua carica fino all’anno 1505, nella quale non potea rimanere senza il previo dispaccio del sovrano. Laonde crediamo che questa cedola siasi perduta, o che sia rimasta in Messina, dove forse l’avrà ricevuta. Quale sia stata la condotta di Giovanni la Nuça dopo di avere ottenuta la terza conferma, non è a nostra notizia, ma verisimilmente sarà stata la stessa, e ce ne persuadiamo da quanto saremo per dire. In questo mentre avvenne che trafficando in Tunisi alcuni mercadanti genovesi, cioè Imperiale Dani e compagni, trasportandovi dei grani che traggevano dalla Sicilia, quantunque avessero dal Bey ottenuta una carta di salvacondotto, pure erano da quei Mori gravemente molestati; anzi abusando della forza, oltrachè tolsero a quei miseri trafficanti dieci mila ducati prezzo di venduto grano, li fecero anco metter in prigione, senzachè avesser potuto ottener giustizia da quel signore. Or quei mercadanti erano altronde debitori [137] allo erario regio di Sicilia di considerabile somma di denaro, ed essendo sequestrati in Tunisi li dieci mila ducati co’ quali avrebbero soddisfatto, ricorsero al vicerè La-Nuça, affinchè si cooperasse col re Tunisino per far loro riacquistare quella somma, e alle loro genti la libertà. Questo viceregnante adunque volendo compiacerli, ed insieme assicurare il credito alla regia corte, spedì a Tunisi il nobil uomo Polidoro Morana cavaliere trapanese cui consegnò le istruzioni sottoscritte in Messina a’ 20 d’aprile 1501, per le quali lo incaricava a far rilevare a quel moro sovrano la ingiustizia fatta a’ mentovati mercadanti, e a cercare la liberazione dei prigionieri loro aderenti, e la restituzione del denaro, facendogli conoscere che il dritto delle genti, e la giustizia così ricercavano, e che facendosi altrimenti lo stesso regno di Tunisi ne avrebbe sofferto de’ danni; avvegnachè i mercadanti intimoriti per lo soperchierie che si usavano loro si sarebbono in avvenire astenuti dall’arrecarvi dei viveri. Finalmente voleasi che si facesse capire a quel re che facendo la dovuta giustizia ordinando la restituzione del danaro, e la libertà degli schiavi, avrebbe reso un particolar servizio al sovrano della Sicilia, che avrebbe così riscosso il danaro dovuto dai mercadanti al suo regio erario. Si fermò per due anni e più Polidoro Morana in Tunisi inutilmente; per quanto egli si fosse adoperato non potè mai ottenere da quel principe moro la restituzione del danaro dovuto ai mercadanti genovesi, nè sappiamo se almeno gli fosse riuscito di far liberare dalla catena coloro che trovavansi imprigionati. Il vicerè adunque Giovanni la Nuça conoscendo vani i suoi sforzi, e considerando perdute le spese che s’erano fatte per mantenere in Tunisi questo ambasciatore, sotto li 10 luglio dell’anno 1505 scrisse una lettera a quel re dolendosi, che malgrado le sue premure non si era nello spazio di due anni e mesi fatta giustizia al suo ambasciatore; e pregandolo, giacchè lo affare andava così, a rimandarglielo, o coi denari, o senza; essendo sua volontà che non più differisca il Morana il suo ritorno in Sicilia. Intanto morì a’ 26 di novembre 1504 la regina Elisabetta moglie di Ferdinando il Cattolico. Era questa principessa l’erede del regno di Castiglia, che riputavasi il più vasto, e il più opulento, che avesse fin allora amministrato il detto re Cattolico; e per conseguenza per diritto di successione appartenendo alla di lei primogenita Giovanna, e a Filippo Arciduca marito di essa, ne dovea restar privo il re di Aragona. Per continuare nel possesso di questo florido regno avea egli indotto la regina sua moglie a prescrivere nel testamento, che quantunque la erede fosse la suddetta principessa Giovanna, ciò non ostante volea, che l’amministrazione della Castiglia restasse nelle mani del re di Aragona suo marito, fino che Carlo primogenito di essa sua figliuola fosse in età di governarlo. Questa testamentaria disposizione non andò a genio dell’Arciduca Filippo, il quale credendo lesi i suoi diritti, conte marito della erede, si accinse a contrastarla, e armando pretese d’impossessarsi della Castiglia, di cui cominciò a sottoscriversi re, da che seppe la morte della suocera 601. Considerando il re Ferdinando il Cattolico che privo della Castiglia diveniva in Ispagna un piccolo sovrano, giacchè l’Aragona e per estensione, e per entrate, e per potere a fronte della Castiglia era un menomo stato, pensò di sostenersi nell’amministrazione dell’eredità della figliuola, e di difendere colle armi alle mani il testamento della difonta regina 602. Poichè però a imprendere questa nuova guerra gli bisognava 599 Chronol. de los Virreyes de Sicilia, p. 15. Cronol. de’ sign. vicerè di Sic. p. 26. 601 Surita, Hist. del Rey D. Hernando t. V, cap. 84, lib. V, p. 349. Guicciardini, Hist. d’Italia, lib. VI, p. 184. 602 A far questo gli era d’uopo di pacificarsi col re di Francia, e di fortificarsi con nuove confederazioni. Chiese a Ludovico XII. madama Germana de Fox sorella cugina di esso per isposa, e fu convenuto, che quella parte del regno di Napoli, ch’era in potere degli Spagnuoli, ed appartenea a’ Francesi, si computasse come dote di questa principessa, e che Ferdinando fosse obbligato di pagare al re di Francia settecento mila docati, o, come vuole il Surita, (ivi t. VI, lib. VI, cap. 13, p. 21), cinquecento mila nello spazio 600 - 107 - molto denaro, così ordinò al vicerè la Nuça, che convocasse un nuovo parlamento per ottenere dai Siciliani un altro sussidio. Fu questa assemblea parlamentaria tenuta in Palermo nel mese di luglio dell’anno 1505 603, ed in essa venne a capo questo vicerè di ottenere un [138] donativo di trecentomila fiorini pagabili al solito nello spazio di tre anni, e anche il solito regalo per sè di cinque mila fiorini. La guerra fra il re Ferdinando, e l’arciduca Filippo, comunque minacciata, non ebbe mai principio. Questi due principi si temeano vicendevolmente, e forse non aveano animo di battersi; giacchè la vittoria da qualunque parte fosse accaduta, era sempre per essere dannosa al vincitore non meno, che al vinto. Si trattennero perciò in mutui complimenti, promettendo l’arciduca di voler dipendere nell’amministrazione della Castiglia da Ferdinando, e di dividerne con esso le rendite, e mostrandosi questi contento che il genero colla figliuola venissero in quel regno, purchè oltre l’offerta fattagli si contentasse, che ei potesse continuare a chiamarsi re di Castiglia. Restò però deluso l’astuto Ferdinando, quando all’arrivo dell’arciduca si vide abbandonato da’ principali signori di quel regno, e costretto a dimetterne l’amministrazione, a contentarsi di una pensione di venticinque mila scudi all’anno, e a partirsi dalla Castiglia con promessa di non più ritornarvi 604. Abbandonata la Castiglia andossene egli nel suo regno di Aragona, e dato tosto sesto ai suoi affari si determinò di venire in Italia per visitare il regno di Napoli nuovamente acquistato 605. Venuto adunque il re Ferdinando nel mese di Agosto 1506 in Barcellona, si dispose alla partenza, e a’ 4 del seguente settembre sciolse le vele, e prese la via d’Italia 606. Sbarcò in Genova, dove fu onorevolmente ricevuto da quel comune, e di là passò a Porto Fino per aspettarvi il buon vento per veleggiare verso Napoli 607 . Ivi gli arrivò la notizia della morte del genero in Burgos per una febbre pestilenziale, da cui fu attaccato, che in tre giorni lo trasse a morte nella fresca età di 25 anni. I grandi gliene scrissero, e lo pregarono che tornasse subito all’amministrazione della Castiglia, come era il volere della sua figliuola; ma egli non si dipartì punto dal disegno di visitare il regno di Napoli. Fermo adunque nella sua risoluzione partì da Porto Fino, e con buon viaggio venne a Gaeta, dove arrivò a’ 14 di ottobre dello stesso anno, d’onde, dopo di esservisi fermato alquanti giorni, si mosse, e recossi in Napoli al primo di novembre. L’arrivo del re Ferdinando il Cattolico in quella città spinse naturalmente il vicerè Giovanni la Nuça a portarsi colà per baciar la mano al suo sovrano. Il Caruso 608 opinò, che egli vi sia stato chiamato, attese le replicate lagnanze de’ Siciliani, e che il re stesso Ferdinando elesse per presidente del regno Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo. Noi però siamo di avviso che il la Nuça vi andò di sua spontanea volontà, quantunque forse il monarca Aragonese dopo il di lui arrivo, persuaso de’ giusti ricorsi della nazione abbia impedito che ritornasse. Ci moviamo a credere così, perchè osserviamo che il dispaccio, con cui è eletto presidente del regno il suddetto arcivescovo, è sottoscritto dallo stesso vicerè la Nuça, e vi si dice, ch’ei diviene a questa elezione in forza del privilegio, che avea di destinare un presidente nella sua lontananza 609. Partì egli prima de’ 17 di novembre, e dopo i tre dello stesso mese; imperocchè noi troviamo l’ultimo dispaccio di questo [139] vicerè dato a’ tre di novembre 610, e il primo dell’arcivescovo, come presidente del regno, a’ 17 dello stesso mese 611. Le querele de’ Siciliani contro il suddetto la Nuça non solo riguardavano il modo imperioso, ed aspro, con cui questo vicerè trattava tutti, e principalmente la nobiltà, ma anche i vizî del di lui figliuolo, ch’era così insolente, e di pessimi costumi, che si era attirato l’odio di tutti. Bisogna nondimeno confessare ch’ei non era punto condiscendente con questo; anzi avendolo trovato reo, e incorreggibile, con somma severità lo di dieci anni per ristoro delle spese fatte nella guerra di Napoli. Si unì ancora col re d’Inghilterra, e co’ Veneziani, da’ quali sperava degli appoggi contro il genero. 603 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 137. 604 Fra’ patti convenuti col genero fu stabilito, che gli si lasciava il regno di Napoli, e le scoperte isole nelle Indie occidentali, che avea acquistate il Colombo; nonostante che queste conquiste si fossero fatte coi denari, e colle soldatesche di Castiglia. Gli fu inoltre accordato, che fosse riconosciuto, mentre vivea, come gran maestro degli ordini di S. Jacopo di Alcantara, e di Calatrava. 605 Varie cagioni si apportano dagli storici, dalle quali credono che siesi indotto questo monarca a venire in Italia. Piace ad altri ch’egli soffrisse a malincuore di restare così negletto, dopo che avea fatta in Ispagna una comparsa così splendida. Opinano altri ch’ei vedendosi così povero, giacchè nè l’Aragona, nè le isole conquistate dal Colombo gli rendeano, quanto era necessario a vivere, sperasse colla sua vicinanza di trarre da Napoli, e dalla Sicilia molto danaro. Ma la vera cagione crediamo che sia stata la premura di togliere al gran capitano Consalvo l’assoluto potere, che si era usurpato nel regno di Napoli, di cui avea sospetti che se l’intendesse segretamente coll’arciduca suo genero. Egli più volte lo avea inutilmente richiamato, ma questi ora con un pretesto, ora con un altro si era scusato dall’ubbidire. 606 Surita, Hist. del Rey D. Hernando t. VI, lib. VI, cap. 31, p. 51. 607 Discordano gli scrittori, se il gran capitano sia andato a ritrovare Fernando sino a Genova. Il Guicciardini (Hist. d’Italia lib. 7 pag. 169), e il Surita (Hist. del Rey D. Hernando t. VI lib. VI cap. 31 p. 80) dicono di sì, ma il Giovio biografo di Consalvo lo nega, ed assicura che ei non andò ad incontrarlo, che al capo Miseno non molto lungi da Napoli (nella vita di Consalvo). 608 Mem. Stor. p. 3 lib. VI vol. V. pag. 110 e 111. 609 Reg. dell’an. 1506.1507 X. indiz., conservato nella regia cancellarìa, fogl. 150. 610 Reg. dell’anno 1506.1507, X indiz., conservato nella regia cancellarìa, pag. 68 e 69. 611 Ivi. - 108 - condannò a morte: sentenza, che si sarebbe eseguita, se il re Ferdinando, che trovavasi in Napoli, non avesse ordinato che non si effettuasse. Non ostante questo rigore usato contro il proprio figliuolo, era tuttavia il la Nuça esoso alla nazione per rapporti personali; e perciò crediamo che il re Ferdinando comunque non l’avesse rimosso, differiva nondimeno di giorno in giorno di accordargli la licenza di ritornare al governo del regno. O che questo temporeggiamento del re Cattolico affligesse all’estremo l’animo di questo vicerè, o ch’egli per altra cagione si fosse gravemente ammalato in Napoli, è certo che se ne morì a’ 18 di gennaro 1507, e colla di lui morte vacò il viceregnato di Sicilia. Nulla di singolare in questo intervallo oprò monsign. Paternò. CAPO XXII. Raimondo de Cardona vicerè. Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo, Guglielmo Raimondo Moncada presidenti del regno. Accaduta la morte del vicerè la Nuça, il re Ferdinando il Cattolico elesse per successore al medesimo nel viceregnato di Sicilia Raimondo de Cardona conte di Alveto. Era questi suo cavallerizzo maggiore, ed avea date chiare riprove del suo valore l’anno 1505 nella impresa di Orano, nella quale fu fatto capitan generale della flotta navale. Accomiatatosi egli dal sovrano partì con due galee da Napoli, dove si trovava, e veleggiò direttamente a Palermo, dove arrivò a’ 15 di aprile. Fece subito la pubblica entrata a cavallo in mezzo all’arcivescovo di Palermo, e al primo senatore, essendo impedito il pretore, e andò alla cattedrale, dove fe’ il solito giuramento, e prese possesso del viceregnato 612. Volle di poi fare un giro per tutta la Sicilia colle galee, e venne a fermarsi in Messina; dove s’intrattenne, fino che il re Ferdinando dimorò in Napoli. Ma dopo la partenza di questo sovrano ritornò in Palermo, e vi si fissò per tutto il tempo del viceregnato. Eravi allora in questa città un certo Gio. Luca Barberio, che vuolsi che fosse segretario regio, come lo chiama Luca Marineo 613, il quale era ancora procuratore fiscale del regio patrimonio. Costui esaminando le possessioni de’ feudi del nostro baronaggio, credè di trovarvi che molti si possedevano senza verun titolo, ed appartenevano al regio erario. Comunicò dunque al vicerè de Cardona quanto egli avea scoperto, cui fu gradito il progetto di rivangare la origine di codesti feudi, e trovandoli ingiustamente usurpati, rivendicarli al regio fisco; ed acciocchè la corte ancora lo sapesse, spedì lo stesso Gio: Luca Barberio in Ispagna per far presenti al re i diritti, che avea la corona sopra molti feudi, ch’erano nelle mani della nobiltà. Il baronaggio ne restò irritato; imperocchè molti di essi non aveano scritture, che legittimassero il loro possesso, quantunque immemorabile, e molti per trovarle doveano spendere molto denaro: e però pensarono alla prima occasione che si fosse presentata, di supplicare il re a non permettere, che fossero obbligati a render conto del loro possesso. Questa occasione l’ebbero presto, quando l’anno 1508 il mentovato vicerè per ordine del re Cattolico convocò il parlamento per i 7 di agosto nella città di Palermo. Il principal motivo, per cui Ferdinando dimandava delle sovvenzioni dal regno, era appunto per debellare i Mori dalla Barberìa, che infestavano la Sicilia non meno che la Spagna, e il regno di Napoli; allo che fare gli era uopo un’armata navale, ed un esercito, per mantenere i quali abbisognavano ingenti spese. Propensi i parlamentarî a soccorrere il re, gli offerirono un donativo di trecento mila fiorini, elessero per ambasciadore del parlamento lo stesso vicerè Raimondo de Cardona per domandare alcune grazie a sua maestà, [140] ed oltre il donativo di cinque mila fiorini solito darsi a’ vicerè, lo dichiararono regnicolo, ed originario di Sicilia, acciocchè potesse conseguire nel regno qualunque carica, ed uffizio 614. Or fra le grazie, che furono richieste dal parlamento, evvi la seguente 615: Perchè Joanluca Barberi è venuto a vostra altezza, undi si dici porta milli cosi senza raxunivili fundamenti, contra la quietitudini di li baruni di lu regnu, et loro barunii; cosa, che non impurtirìa, si non vexationi, et confusioni di li baruni; perchè multi volti su stati circati tutti li cosi, che lu dictu Joanluca porta, et ultimo loco lassati per cosi despreciati, maxime essendo una confirmationi di la diva memoria del re Don Alfonso, et nova donationi a tutti baruni di lo regno di loro barunìi: sua altezza per la promptità di lo animo, che sempre hanno mostrato, et mostrano dicti baruni in so servitio, voglia escludiri li pensieri di lo dicto Joanluca. Et quatenus opus esset ad majori cautela, et contentizza di dicti baroni confirmari iterum dictu capitulu del re Don Alfonso 616 612 Reg. del maestro di Cerimonie del Senato dell’an. 1506 X. Indiz. Epistolarum, lib. XIV, e XVII. 614 Mongit. parlam. di Sic., t. I. pag. 140. 615 Capit. regni Sicil. in Ferdinando II. cap. 63, pag. 555. 616 Questo è il capitolo 456 (Capit. regni Siciliae in Alphonso t. I pag. 382 e 383) in cui alla richiesta degli ambasciadori del parlamento fatta l’anno 1452 risponde il re: “Placet regiae majestati confirmare et de novo concedere eisdem Praelatis, marchionibus, Comitibus, Baronibus, et Feudatariis eorum Marchionatus, Comitatus, Baronias, et Feuda, hoc est habentibus de eis privilegia, seu contractus, secundum formam eorum privilegiorum seu contractuum, et non habentibus privilegia de novo concedere pro se, et suis heredibus ex suo corpore legitimè descendentibus.” 613 - 109 - già per vostra altezza alias confirmato, et jurato in la generali confirmationi di li capituli, et privilegî de ipso regno, aczoché de cetero non li pocza essiri più inferuta molestia, nè controversia alcuna di parti di lu procuraturi fiscali di vostra altezza. Raimondo de Cardona non andò egli stesso alla corte a presentare l’offerta del parlamento, e a richieder le grazie, che dimandavano gli ordini dello stato; ma spedì Cristoforo Brezena, il quale dopo di aver fatta l’offerta, come procuratore del Cardona, del donativo del regno, ed esposta la dimanda delle grazie richieste da’ parlamentarî, ottenne l’ultimo di giugno 1509 le determinazioni del sovrano intorno a ciò, che si cercava. La risposta per la istanza fatta di non essere il baronaggio vessato da Giovan Luca Barberi fu assai equivoca, per la quale l’accorto Ferdinando si lasciò la strada aperta di poter riacquistare al regio fisco i beni, che si possedevano da’ baroni senza alcun chiaro titolo 617. Noi avremo occasione di parlare nuovamente di Giovan Luca Barberio. Era vicerè in Napoli il conte di Ripacorsa, che fu chiamato in Ispagna, ed in suo luogo fu eletto dal re Ferdinando il nostro Raimondo de Cardona 618, il quale non volendo lasciare il regno senza governante, in virtù della facoltà, ch’ei avea nella cedola, in cui era stato eletto vicerè di Sicilia, scelse per presidenti del regno Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo, e Guglielmo Raimondo Moncada conte di Adernò, e maestro giustiziere del regno. La partenza del Cardona dalla Sicilia dovette accadere nel principio del mese di ottobre. Ci mancano i documenti e della cedola viceregia, con cui sono eletti i mentovati due presidenti del regno, e del possesso, ch’eglino prender dovettero prima di accingersi a governare la Sicilia, da’ quali si ricaverebbe il preciso giorno, in cui cominciarono a reggerci; e solo troviamo nella regia cancellarìa il primo lor dispaccio, in cui sono sottoscritti, come presidenti del regno, a’ 12 di ottobre dello stesso anno 1509 619. Giovanni Paternò di famiglia assai cospicua, e conosciuta fu uomo dottissimo. Vestì egli la cocolla Benedittina, e divenne così famoso nella giurisprudenza, che fu per sopranome detto il dottor fondamentale. Per i suoi meriti ebbe varî gradi nella sua religione, e fu [141] poi abate di S. Maria di Nuova Luce. Nel 1478 fu fatto vescovo di Malta, e di poi nel 1489 passò all’arcivescovado di Palermo: nella qual dignità dimorò fino alla morte, che accadde a’ 24 di gennaro 1511. Giulio II. lo destinò al sacro collegio de’ cardinali, e lo chiamò a Roma per dargli il cappello, ma egli era troppo vecchio, e poco dopo se ne morì. La chiesa di Palermo molto deve a questo generoso, e magnifico prelato. Le famose statue scolpite dal celebre Antonio Gagini, che faranno l’ornamento della Cattedrale che si sta con nuovo disegno rifabbricando, furono fatte lavorare di suo ordine. Fu egli, come abbiamo osservato, due volte presidente di questo regno di Sicilia. Nel museo del signor principe di Biscari evvi un medaglione coniato per questo prelato, nel di cui diritto osservasi il busto di questo presidente del regno con mitra in capo, attorno al quale leggesi: JOA. DE PATERNIONE MIL. EPS. PAN. ARPS. S. R. E. CAR. DES., cioè Joannes de Paternione militensis episcopus, Panormitanus archiepiscopus, sacrae romanae ecclesiae cardinalis designatus. Nel rovescio vi si vede il cappello vescovale, alla destra del quale sta il bacolo, e alla sinistra la croce, fra le quali insegne prelatizie, e sotto il cappello sta scritto: DOCTOR. FUNDAMENTALIS. MOR. MDXI. le quali ultime parole additano mortuus anno 1511. CAPO XXIII. Ugo de Moncada vicerè, Bernardino Bologna arcivescovo di Messina presidente del regno, e in caso di morte Pietro Sancez Catalayud. Fu di breve durata il governo dell’arcivescovo di Palermo, e del maestro giustiziere nella carica di presidenti del regno. Il re Ferdinando il Cattolico nello stesso tempo, in cui destinò Raimondo Cardona al viceregnato di Napoli, elesse per suo successore in quello di Sicilia Ugo Moncada, il di cui nome sarà sempre memorando negli annali della nostra storia, come si farà chiaro da quanto saremo per dire nel libro, che siegue. Era egli di Valenza cavaliere di Rodi, e priore di S. Eufemia; avea servito col carattere di capitano nelle truppe di Cesare Borgia figlio di Alessandro VI, detto il duca Valentino, che era del partito de’ Francesi, nella guerra per il regno di Napoli: ma disgustatosi del re di Francia, e passando a’ servigî del re Cattolico, venne anche a militare sotto le insegne aragonesi 620. Il gran Capitano conoscendone i meriti, e 617 Rispose questo monarca (Capit. regni Sic. in Ferdinando II, cap. 63 tom. I. pag. 555). “Placet regiae Majestati, quod habeatur ea ratio, qualis de jure habenda est, et quod subditi injustè non vexentur.” Per cui vietava solamente le ingiuste vessazioni, riserbandosi ogni ragione sopra i feudi alienati ogni volta, che secondo le leggi, gli appartenevano. Scrisse però il Caruso (Mem. Stor. p. III lib. VI t. III vol. V pag. 3), che riuscendo pregiudizievoli al baronaggio, e dannose al regno le accuse fiscali di questo ministro del real patrimonio, “si ebbe per bene di sospenderle, e di non innovare cosa alcuna su tal materia; e quel che è più, di dichiarare esoso, e perturbatore della pubblica tranquillità l’accennato Barbera,” e soggiunge, “che venne ciò confermato dal re cattolico”, ma non ne adduce prova alcuna. 618 Surita Hist. del Rey D. Hernando tom. VI lib. VIII cap. 67 pag. 207. 619 Reg. dell’an. 1509.1510, XIII indiz., f. 249. 620 Surita Hist. del Rey D. Hernando t. V, lib. V, cap. 68, pag. 303. - 110 - particolarmente il valore in guerra, e il disinteresse, nelle turbazioni, in cui era la Calabria per causa del conte di Ayelo governadore, il quale avea più a cuore il suo vantaggio, che il pubblico bene, deposto questi dalla carica, mandò a reggere quella provincia l’anno 1504 il mentovato de Moncada 621. Persuaso adunque il re Ferdinando dell’abilità di questo cavaliere, e grato a’ servigî fatti alla sua corona, lo promosse al viceregnato di Sicilia. Arrivò egli in Palermo a’ 7 di dicembre 1509, e lo stesso giorno prese il possesso del governo di Sicilia, portandosi al duomo, dove in presenza del senato, e del sacro consiglio fece il solito giuramento di osservare le leggi, le costituzioni, ed i capitoli del regno, e i privilegi della capitale 622. Era necessario, che si mettesse alla custodia del nostro regno un capitano così celebre; poichè nella guerra, che il re Ferdinando facea a’ Mori, eravamo a pericolo di essere da’ medesimi invasi, per dare un diversivo alle forze Aragonesi, che assediavano Orano, e voleano impossessarsi delle coste di Barberìa. Egli fu il primo, che alla carica di vicerè ebbe unita quella di capitano generale del regno, e delle isole adjacenti: onore, che in seguito ebbero quasi tutti i di lui successori vicerè, e presidenti del regno, ancorchè fossero ecclesiastici, e perciò nè cingessero spada, nè sapessero l’arte di combattere, e di reggere gli eserciti. Aveano già le armi aragonesi in questo stesso anno 1509 conquistata la città di Orano, presente il cardinal F. Francesco Ximenes arcivescovo di Toledo, il quale siccome avea progettato questo acquisto, e somministrato avea il denaro per la detta guerra, così volle intervenire all’assedio 623. Dietro a questo vantaggio avuto dal re Ferdinando, si pensò di conquistare la città di Bugìa, e ne fu dato l’incarico al grande ammiraglio Pietro [142] Navarro. Era il porto di essa città molto importante per la conquista dell’Africa, e riuscì a questo ammiraglio d’impossessarsene in breve tempo 624. Questi vantaggi fecero nascere la voglia di conquistare Tunisi, Algieri, e poi Tripoli; e siccome era noto il valore del Navarro, furono anche a lui appoggiate queste imprese. Non ci appartiene il riferire in questo luogo i fortunati successi delle truppe del re, che possono leggersi presso il Surita; basta a noi il dire, che 625 cadde Tripoli in loro potere 626. L’acquisto di Tripoli era interessante così per il commercio di Alessandria, ch’era allora l’emporio de’ mercadanti, che per la navigazione di tutto il levante. Il re Ferdinando volendo mantenerlo, determinò l’anno seguente 1511 d’incorporare quella piazza, e quel porto al regno nostro di Sicilia, e perciò ordinò al vicerè Ugo de Moncada, che prendesse a suo carico di tenerla ben presidiata, e soccorsa. Il vicerè adunque destinò per capitano e governatore di Tripoli Giacomo Requesens cavaliere Catalano, il quale conducendo seco mille e cinquecento soldati partì per portarsi al governo destinatogli. Si unirono a lui molti cavalieri Spagnuoli, e Siciliani 627, che correr vollero la stessa sorte, de’ principali de’ quali ci registrò i nomi il Surita 628. Fu in questa occasione provveduto che le galee Siciliane in avvenire dovessero sempre svernare nel porto di Tripoli 629. Erano già scorsi tre anni da che si era celebrato il parlamento generale, e perciò il vicerè, ricevutone l’ordine dalla corte, convocò il nuovo nella città di Palermo ai 10 di agosto 1511. Arrivato il prescritto giorno egli nella sala dell’antico palagio, ch’era chiamato lo Steri, esaggerò le grandi spese fatte dal re Cattolico per debellare l’audacia dei Mori dell’Africa, e gli acquisti già fatti contro i medesimi, e principalmente della città di Tripoli, che quel Sovrano avea già aggregata al regno di Sicilia 630; e mostrando la premura, che il detto 621 Surita ivi, pag. 337 e 338. Nel registro del maestro delle cerimonie del senato di Palermo dell’anno 1509, XIII indiz. 623 Surita Hist. del Rey D. Hernando tom. VI. lib. VIII cap. 30 pag. 181. 624 Surita ivi, lib. IX, cap. I, pag. 210. 625 Il Caruso (Mem. Stor. part. III, lib. VI, t. III, vol. VII, pag. 113) scrisse, che l’ammiraglio Pietro Navarro venne coll’armata in Messina, e provvedutosi del bisognevole passò a Tripoli, dove arrivò ai 25 di luglio, ed in tre ore se ne impossessò. Il Maurolico racconta (Sican. Hist. lib. VI, pag. 207), che ei fu mandato in Sicilia; ma non dice che sia andato in Messina, che veramente non era il porto, da cui passar dovea in Affrica. Laonde è più verisimile che sia venuto, come riferisce il Surita (Hist. del Rey D. Hernando tom. VI, lib. XI, cap. XVI, pag. 225), all’isola della Favignana, dove aspettò le galee di Napoli, e di Sicilia. Intorno poi al tempo ch’egli impiegò in questa conquista, non possiamo indurci a credere, che non abbia oltrapassate le ore tre; giacchè il Surita istesso ci narra, che dovette prima di altro impossessarsi del porto, dove trovò una valida resistenza dei Mori pronti a difendersi; che discacciati costoro, pose a terra la sua armata, ch’era di sopra ad otto mila uomini, e che schieratala si avviò verso la città, diede una battaglia che durò due ore, e ottenutane la vittoria entrò in città, dove gli convenne di superare le torri, e i baloardi, ne’ quali i Mori si battevano da disperati. Or tutte queste azioni non poteano farsi in così breve spazio di tempo, come opinò il Caruso. Crediamo ancora, che sia una favola ciò che soggiunge, cioè che il Navarro ritornò glorioso in Messina, conducendo i Mori, che avea ridotti in ischiavitù, e che vi fu accolto da quei cittadini con applauso. Gli scrittori messinesi lo tacciono, e il Surita (ivi pag. 226) scrisse, ch’egli senza partirsi da Tripoli, dimandò al re nuovi soccorsi per I’impresa di Tunisi. 626 Surita Hist. del Rey D. Hernando lib. VIII, cap. XVI pag. 226. 627 Crediamo che fossero nostri nazionali Ferdinando de Angulo, Archimbao di Leofante, Blasco Barresi, Antonio Ventimiglia, e Giovanni Antonio Moncada. 628 Hist. del Rey D. Hernando lib. IX, cap. 32, pag. 250. 629 Surita ivi. 630 Il Pirri (Sic. Sacra Not. 1. Eccl. Panorm. pag. m. 62) per addimostrare che Vittore arcivescovo di Palermo era Primate dell’Affrica, fra le altre prove adduce quella, che il vescovo di Tripoli è suffraganeo del medesimo, avvegnachè in ogni anno a’ 15 di 622 - 111 - Sovrano avea di acquistare interamente l’Africa, richiese per questo effetto un copioso donativo. Offerirono i parlamentarî a’ 13 dello stesso mese, dopo di avere conferito intorno alla dimanda fatta, un donativo di trecentomila fiorini da pagarsi fra il termine di tre anni. In codesto parlamento, in cui fu anche fatto al vicerè il dono di cinquemila fiorini, e l’atto, con cui era dichiarato nazionale, l’ordine demaniale si dolse che le università sue erano soverchiamente aggravate ne’ donativi; e chiese che si diminuissero le tasse per lo innanzi imposte, e che si dasse il permesso a quelle comunità, che non aveano patrimonio proprio, di poter imporre delle gabelle, con che, [143] pagato il donativo, restassero le gabelle issofatto estinte. Che se i deputati del regno pensassero di distribuire le tasse su i particolari, non potessero imporle sul numero delle persone, ma sopra le facoltà di ciascheduno 631. Fra le persone, che furono presenti a questo parlamento, vien nominato Diego de Vera. Questi dopo l’infelice esito, ch’ebbero le truppe Aragonesi nell’impresa delle isole delle Gerbe, era venuto in Palermo coll’Ammiraglio Navarro, ed era stato ivi lasciato a comandare mille soldati Spagnuoli, ch’erano sopravissuti alla sconfitta ivi avuta da’ Mori per l’ostinazione di Garzìa di Toledo, che contro il consiglio del Navarro avea voluto tentare in una stagione così calda l’impresa di quell’Isola. Codeste soldatesche, che verisimilmente erano arrivate in Palermo poco prima, che si celebrasse il parlamento suddetto, non erano state soddisfatte delle paghe loro dovute, e tratte dalla disperazione cominciarono a commettere delle insolenze, e principalmente rubavano i comestibili, assalendo a forza prima le botteghe, e poi le case de’ particolari, dalle quali estraevano i viveri senza volerli punto pagare. Queste ostilità solite a farsi nei paesi di conquista posero in tumulto il popolo. Il pretore e i senatori ne avvertirono il loro comandante Diego de Vera, acciò li tenesse a freno: protestandosi, ch’eglino non si rendevano mallevadori di ciò che avrebbe fatto la plebe, se i suoi soldati continuavano a molestarla. Questi cercò di riparare: ma come non avea modo di pagar loro i dovuti salarî, le di lui minaccie non erano ascoltate, e le sfrenate soldatesche seguitavano a commettere i soliti furti. Nel dì dunque 19 dello stesso mese di agosto, avendo elleno assalita, e spogliata la casa di un povero contadino di tutto ciò che vi era di viveri, alle grida di costui si mossero a tumulto gli abitanti, i quali, avendo alla testa Paolo Pollastra gentiluomo, presero le armi, e fecero mano bassa sopra tutti i soldati Spagnuoli, che incontrarono, e poterono trovare, sacrificandoli con orrenda carnificina al loro furore. Ne fu recata la notizia al vicerè, il quale sortì subito dal regio palagio accompagnato dal conte di Golisano, e da altri nobili, e arrivato al luogo della tumultuazione, tanto fe’, che finalmente giunse a sedarla, e ad impedire il macello del resto degli Spagnuoli, de’ quali vuolsi che ne fosse stata trucidata una buona parte. Quietati i sollevati, pensò il Moncada ad assicurarsi de’ capipopoli, e sopratutto del Pollastra, e fatto loro compilare il processo, condannò quelli al laccio, e questo a perdere il capo sotto la mannaja 632. Avea il vicerè Ugo de Moncada ottenuto fin dall’anno antecedente 1510 la conferma per altri tre anni nel viceregnato di Sicilia, sebbene non fosse ancora scorso il primo triennio. Il dispaccio reale era dato in Villa Mayoreti a’ 27 di febbraro 1510, e fu esecutoriato in Palermo a’ 16 del seguente aprile dello stesso anno 633. E siccome fu egli eletto capitano d’armi espressamente per marciare contro i Mori, così nello stesso dispaccio regio gli fu accordata la facoltà, nel caso che dovesse partire per la sua commissione, di eleggere uno, o due presidenti, che governassero la Sicilia in suo luogo 634. Finochè le armi Aragonesi sotto la condotta di Pietro Navarro prosperarono nell’Africa, il Moncada non si mosse dal nostro regno; ma come udì poi la disfatta, che nell’anno 1511 ebbero le medesime all’isola delle Gerbe, per cui fu d’uopo al Navarro di salvarsi in Palermo, come detto abbiamo, e come si era anche sparso, che l’armamento preparato dal re Ferdinando, comunque fosse fama, che serviva per continuare la guerra nell’Africa, in effetto avea un’altra destinazione 635, cominciò a temere, che i Mori assicuratisi [144] che non si armava contro di loro, e tronfi della vittoria ottenuta alle Gerbe, non passassero a ricuperare Tripoli piazza, e porto importantissimi, che agosto, chiamandosi a fare omaggio al medesimo tutte le chiese soggette a quella di Palermo, la prima, che vien nominata, è quella di Tripoli. Non sappiamo se questa sia la migliore delle prove; egli stesso ne dubita. 631 Mong. Parlam. di Sic. T. I, p. 143 e seg. 632 Fazello Dec. II, t. II, lib. IX. pag. 195. Aprile Cronol. di Sic. lib. II, cap. 4, pag. 258. Caruso Mem. Stor. t. III, part. III, lib. VI, vol. V. pag. 12, ed altri. 633 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1509-1510, XIII. indiz. fogl. 572. 634 Nello stesso reg. 635 La guerra contro i Mori fu creduta un pretesto del re Ferdinando, per potersi armare impunemente contro Ludovico XII, re di Francia, le di cui vittorie gli faceano ombra, temendo che non pensasse di riacquistare il regno di Napoli; e perciò sotto il mantello della religione armò, mostrando di voler conquidere i Mori, dal che dichiarò di non volersi ritrarre, se non li debellava interamente. Papa Giulio II, che si vuole che fosse a parte del vero obbietto di questo armamento, e ch’era nemico del re di Francia, secondò la politica del re Cattolico, e gli accordò le decime su i beni ecclesiastici dei suoi vasti stati. Questo Pontefice più soldato, che capo dalla chiesa, era irritato contro Ludovico, perchè questi si era cooperato a far celebrare un concilio generale in Pisa, per togliergli la Tiara, e scegliere in sua vece un più degno Papa; e dopo che tentò inutilmente tutti i mezzi per far cedere il Re suddetto, vedendosi alle strette, promulgò la lega assai prima da sè stabilita col re di Aragona, e coi Veneziani contro il sovrano di Francia a’ 5 di ottobre 1511 nella chiesa di S. Maria del Popolo. Allora si tolse il velo alla politica di Ferdinando, e si conobbe il vero fine, per cui avea armato (Guicciardini Hist. d’Italia lib. IX, e X.) - 112 - apparteneano già alla Sicilia. E perciò siccome egli era espertissimo nell’arte della guerra, si determinò di andare da sè stesso a Tripoli, ad oggetto di visitare quel porto, e quella città, e di darvi le necessarie provvidenze, perchè i Mori non potessero riacquistarla. La di lui partenza per Tripoli non accadde, che dopo i 12 di novembre 1512. Portossi egli in Messina per prepararvisi, e volendo eleggere un presidente, che governasse il regno, mentre era lontano, in forza della facoltà che avea dal re ricevuto nel dispaccio de’ 13 di aprile 1510, scelse a questa carica l’arcivescovo di quella città Bernardino Bologna. La cedola viceregia è data a’ 9 di novembre del detto anno 636. Questo arcivescovo trovavasi infermo, ed era a temersi ch’ei in pochi giorni non fosse per morire. Laonde volendo il Moncada provvedere al governo della Sicilia nel caso, che l’eletto finisse di vivere, a’ 12 dello stesso mese sottoscrisse un altro dispaccio, per cui creò per presidente del regno, sul timore che soccombesse al male il ridetto arcivescovo, il governatore della camera reginale Pietro Sanchez de Catalayud, altrimenti detto Centelles 637, il quale esercitò questa carica, quantunque il Bologna fosse sopravissuto fino al ritorno del Moncada. Noi abbiano le sottoscrizioni del Centelles fino a’ 18 di aprile 1513 638. Arrivato questo vicerè alla città di Tripoli trovò, ch’era cinta di altissime muraglie, per difender le quali era necessaria un’assai numerosa soldatesca, ch’ei non avea, nè potea richiedere dal re Ferdinando intento alla guerra col re di Francia. Quindi stimò più opportuno di farle devastare, e di contentarsi di fortificare il solo castello, dove lasciò una competente guarnigione. Date perciò le convenienti provvidenze, si rimbarcò, e tornossene in Sicilia all’esercizio della sua carica 639. Capitò egli nel fine del mese di aprile 1513, giacchè nel dì 26 compariscono suoi decreti 640. Trovò il Moncada nel suo ritorno, che di giorno in giorno andava languendo il commercio, e cercando le fonti di questo decadimento, si avvide, che queste erano le false monete, che correano per il regno, e la scarsezza in conseguenza del denaro di ottima qualità, ch’era divenuto assai raro. Per dar riparo a questi inconvenienti, e per liberare i trafficanti dagli ostacoli, ne’ quali urtavano, ordinò prima di ogni altro, che tutte le monete false fossero portate alla Zecca, affine di fondersi, e di coniarsi le nuove di giusto titolo, e valore, le quali unicamente si potessero adoprare nel commercio 641. Volendo di poi moltiplicare la moneta per il comodo de’ trafficanti, con un altro editto comandò, che tutti coloro, che aveano in casa argenti, ed ori, fossero costretti a portarli alla Zecca di Messina, ad oggetto di coniarsi 642 sulle galee 643. Sotto il governo di questo vicerè, e precisamente l’anno 1513 si fissò in Palermo il Tribunale del santo Uffizio nella forma, in cui durò fino all’anno 1782, in cui per comando del re nostro Ferdinando III. restò abolito. Non già che non vi fossero stati prima [145] degl’inquisitori, i quali, dopo che per bolla di Sisto IV. fu stabilito in Ispagna questo Tribunale, fossero venuti anche in Sicilia 644 per perseguitare i creduti rei di apostasìa, ma solo che di allora ebbero una dimora ferma, e una maniera costante di Tribunale per invigilare alla conservazione della religione cattolica 645. Il Pirri 646, seguendo le pedate del Paramo 647, racconta, che il re Ferdinando volle erigerlo in Palermo, perchè questa città era la capitale del regno, dove risedea il vicerè, e il sacro consiglio. L’abitazione, che fu allora assegnata agl’inquisitori, era l’antico regio palagio, dove dimoravano i re Normanni, che oggi è l’ordinaria residenza de’ vicerè, e de’ Tribunali. In quel tempo i 636 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1512.1513, I indiz. fogl. 214. Lo stesso ivi f. 228. 638 Lo stesso reg. f. 338. 639 Surita Hist. del Rey D. Hernando tom. VI, lib. X, cap. 48, pag. 347. 640 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1513.1514, II. indiz. f. 328. 641 In un Mss. di Filippo Paruta, che conservasi nella Bibliot. del Senato di Palermo (lett. R. num. 43 pag. 4) vien descritto l’ordine viceregio dell’anno 1513, con cui si comanda che i possessori delle monete false dovessero portarle alla Zecca, le quali, fuse che fossero, si dovessero coniare di nuovo, e per ogni oncia dell’argento, che ne risultava, si dovessero pagare a’ padroni soli dieci tarini. Questa provvidenza, ch’era per altro necessaria per abolire le false monete, fu nociva a’ benestanti, ai quali veniva diminuito considerabilmente il capitale, ed infatti molti di essi impoverirono. 642 Maurolico Sican. Hist. lib. VI, pag. 207. 643 Nel mentovato manoscritto del Paruta raccontasi, che nell’accennato dispaccio viceregio si stabiliva, che si dovessero restituire ai padroni in moneta d’oro, o di argento gli argenti, e gli ori, che consegnati aveano; e poichè abbisognava qualche tempo per coniarsi le nuove monete, era prescritto lo spazio di due mesi alla detta restituzione. 644 La bolla dell’erezione di questo formidabile tribunale fu da Sisto promulgata nell’anno 1480, e fu eletto per supremo inquisitore Fra Tommaso Torrecremata confessore dei sovrani di Aragona. Quantunque non riguardasse questa bolla che le Spagne, nondimeno gl’inquisitori stendendo la loro giurisdizione mandavano a quando a quando de’ soggetti in Sicilia per fare ricerca degli Eretici, e punirli. Tale fu F. Antonio della Penna Domenicano spedito l’anno 1487 dal supremo inquisitore Torrecremata. Questi però non avea luogo fisso, nè forma di tribunale. Laonde è da emendarsi il canonico Antonio Franchina (Breve rapporto del tribunale della inquisizione di Sicilia cap. 5, pag. 16), il quale rivolgendo senza criterio le carte dell’archivio dell’inquisizione, credette che in detto anno 1487 fusse eretto in Palermo l’accennato tribunale, quando l’epoca di questo stabilimento dee fissarsi l’anno 1513. 645 Paramo de Orig. Offic. Inquis. t. II, lib. II. 646 Chron. Reg. Sic. pag. 97. 647 Ivi. 637 - 113 - viceregnanti stavano al palagio de’ Chiaramontani nella piazza della Marina, ch’era volgarmente detto lo Steri. Ebbero poi assegnati altri siti per dimorarvi, come in seguito anderemo notando. Aveano sofferto malvolentieri i Palermitani che i loro ori, ed argenti si dovessero trasportare in Messina, per ivi ridursi in monete; e riputavano l’ordine viceregio non solamente pregiudizievole a’ diritti della capitale, ma dannoso ancora a’ suoi cittadini per i pericoli, che soffrir poteano ne’ trasporti i loro capitali. Aspettavano perciò qualche favorevole momento, per poter dimandare al monarca di Aragona di essere manutenuti nel possesso del privilegio accordato loro l’anno 1452 dal re Alfonso, con cui permettea la Zecca in Palermo. Arrivò la bramata occasione, quando il de Moncada convocò secondo il consueto il parlamento generale in Palermo a’ 12 di novembre 1514 648. Espose nell’apertura di questa adunanza il detto vicerè le spese ingenti fatte dal monarca per dilatare la religione cattolica nelle parti di Barberìa, e per difendere il regno di Sicilia dalle invasioni de’ Mori, per cui gli era mestieri di tenere in piedi delle armate navali, e degli eserciti di terra, e perciò richiese dei sussidî da’ fedeli Siciliani. Sebbene gli ordini dello stato sapessero benissimo, che gli armamenti del re Cattolico erano indiritti ad altro, che a questi fini; nondimeno non intralasciarono di cercare i mezzi da soddisfare i desiderî del loro sovrano, e malgrado le circostanze infelici 649 , nelle quali trovavasi allora il regno, esibirono i soliti trecento mila fiorini da pagarsi in tre anni, oltre il consueto regalo al vicerè di cinque mila. Richiesero di poi alcune grazie dalla clemenza del re, e per ottenerle elessero per ambasciadore lo stesso vicerè Moncada, il quale non potendo andarvi, sostituì Luigi Settimo maestro razionale del real patrimonio, che trovavasi uno de’ ministri consiglieri di sua maestà 650. Fra le grazie adunque, che doveano dimandarsi al re dal destinato ambasciadore del parlamento 651, eravi quella, di cui abbiamo fatta menzione, cioè che la città di Palermo [146] fosse conservata nel possesso della Zecca. Questo passo dato da’ Palermitani, a cui non consentirono i Messinesi, dispiacque estremamente a questi, che credevano di avere soli il diritto di coniare le monete, nè potendo altrimenti vendicarsene, tumultuarono contro lo stratigoto Giacomo Alliata barone di Castello a Mare, che non avea altro delitto, che quello d’esser nato palermitano: gridando, che non lo voleano più, e che bisognava discacciarlo dalla loro patria. I più saggi fra quei cittadini corsero subito per frenare i trasporti della plebe, e quando videro che non era possibile di acchetarla, pensarono di salvare dal furore di essa lo Alliata. E in fatti quei della famiglia Marchese mandarono al medesimo un cavallo, consigliandolo a sottrarsi, come fece, dalla rabbia popolare; e Niccolò Crisafi con altri cavalieri corse a Palermo ad avvisare il vicerè, perchè si smorzasse nel suo nascere l’acceso fuoco. Il Moncada tosto s’imbarcò sulle galee, ch’erano nel porto, e volò a Messina, dove entrato nel regio palagio chiamò i senatori, che forse aveano soffiato in questo incendio, e come rei li esiliò al monte Erice, oggi detto di S. Giuliano presso Trapani 652. L’ambasciadore del parlamento, offerendo al re il donativo, richiese le grazie, che i parlamentarî dimandavano, e fra queste quella, con cui si richiedea la Zecca in Palermo 653. L’accorto re Ferdinando conoscendo da una parte i danni, e gl’incomodi ch’erano inseparabili, tutte le volte che dovessero trasportarsi da Palermo fino a Messina gli ori, e gli argenti de’ benestanti, e dall’altra non volendo dispiaccre i Messinesi, 648 Mongit. Parl. gener. di Sicil. t. I, pag. 146. Dagli atti di questo parlamento noi ricaviamo due notizie interessanti. La prima è, che il danno sofferto dei benestanti nel cambiamento delle monete false montava a seicento mila fiorini, per cui molti mercadanti erano falliti. L’altra è, che da molti anni era mancata in Sicilia non solamente l’estrazione dei grani, ma quella ancora dei zuccheri; dal che rilevasi, che a quella età eranvi abbondanti fabbriche di questa merce, per le quali non solo si provvedea il bisogno del regno, ma inoltre si estraea il superfluo per uso degli stranieri. Ora siamo nella trista circostanza di doverci procurare i zuccheri dai paesi lontani, e osserviamo con sorpresa che il nostro regno, che una volta ne facea gran commercio colle altre nazioni, ed avea somministrate l’anno 1420 le canne di zucchero dette volgarmente cannemele al principe Arrigo di Portogallo, per piantarle nell’isola di Madera da questo signore scoperta (Robertson, Histoire d’Amérique lib. I), ora è costretto a mendicarli dai Francesi, e dagli Olandesi. 650 Mongit. Parl. gen. di Sicil. t. I, pag. 149 n. a. 651 Non vi fu forse parlamento, in cui si sieno dimandate tante grazie utili al regno, quanto questo. Imperocchè vi fu chiesto 1. che s’invitassero i mercadanti forestieri a recare oro, ed argento in Sicilia per monetarsi, e che per la manifattura il Re accordasse mille docati di donativo, isgravando i mercadanti suddetti dal pagarne l’opera; i quali così animati avrebbono ricambiata la moneta in compra di frumenti, ed altri generi: 2. che fosse permesso di comprare col denaro del donativo in ogni anno cinque mila docati di argento, e di oro, che subito monetato si sarebbe restituito al regio erario: 3. che la terza parte delle rendite dei prelati servisse per la necessaria moneta, che si sarebbe poi restituita ai loro procuratori: 4. che stessero sempre aperti i porti per l’estrazioni, senza imporsi un nuovo dazio: 5. che per tre anni fosse lecito di portare le derrate nei luoghi anche proibiti: 6. che per dieci anni gli zuccheri fossero esenti da ogni tributo; ed altre, che possono leggersi nei capitoli del regno (tom. I, in Ferdinando pag. 565 e seg.) 652 Maurol. Sican. Hist. lib. VI. pag. 207 e 208. 653 Da questo fatto, che costa dai capitoli del regno (t. I, pag. 669) si scopre la falsità di quanto scrisse il Bonfiglio (Hist. Sic. P. II, lib. I, pag. 401), il quale raccontando la tumultuazione accaduta in Messina lasciò registrato che dopo questi rumori fu sopraseduto nel parlamento dal fare la consueta dimanda della Zecca in Palermo. Oltrachè il parlamento non durò che quattro giorni, nel quale breve spazio non era possibile, che questa notizia fosse arrivata a Messina avesse suscitata ivi la mozione nel popolo, e che fosse giunto in Palermo l’avviso delle vertigini plebee di quella città, mentre il parlamento tuttavia durava. Egli è indubitato che l’ambasciatore del parlamento chiese alla corte la mentovata grazia. Noi più presto opiniamo che i Messinesi dopo il tumulto abbiano spedite persone al re Ferdinando, per impedire che si accordasse questo privilegio a Palermo in pregiudizio dei loro pretesi privativi diritti. 649 - 114 - cercò, come è in proverbio, di salvare capra, e cavoli: e negando a’ Palermitani la Zecca nella capitale, e a’ Messinesi il privativo diritto, che tutte le monete si dovessero coniare nella loro città, stabilì provvigionalmente, che si piantasse un’altra Zecca nella città di Termini: luogo comodo per i Palermitani, non essendo lontano che ventiquattro miglia dalla loro patria, dove però volle che andassero per presedervi gli uffiziali della Zecca di Messina a fine di non pregiudicare i privilegi di quella città 654. Giunse nell’anno seguente 1515 al Moncada la lieta notizia, che il re Ferdinando il Cattolico lo avea confermato per altri tre anni nel viceregnato di Sicilia, la quale quanto lo rallegrò, altrettanto dispiacque a’ Siciliani, che per diversi motivi, che accenneremo nel seguente libro, erano malcontenti del governo di questo cavaliere. La carta reale di questa conferma fu sottoscritta da quel monarca in Valladolid a’ 31 di gennaro dello stesso anno, ma non fu letta, e registrata in Palermo, se non a’ 19 del mese di marzo 655. Accadde nel seguente luglio del medesimo anno una battaglia marittima ne’ nostri mari, gloriosa per la nostra nazione. Il nostro commercio era inquietato da un famoso corsaro, che avea nome Solimano, il quale colle sue scorrerìe turbava i mari di Trapani, e di Marsala. Era ammiraglio della flotta siciliana Luigi Requesens, il quale volendo allontanare dalla nostra isola i corsari, sen’era andato sulla fine di luglio all’isola della Pantellerìa con animo di passare in Barberìa per tenere a freno gli armadori Moreschi. Comandava egli una nave, un galeone, e nove galee. La nave per causa de’ venti si era allontanata da quel [147] porto, quando si vide vicina una flottiglia di tredici fuste, che vedendola sola l’assaltarono per impadronirsene. Non potendo la nave ritirarsi, non soffiando alcun vento favorevole, dovette soffrire l’attacco, e coloro, che vi erano dentro, si disposero a difendersi, facendo uso della loro artiglierìa. Al rumore delle cannonate, che si udivano alla Pantellerìa, immaginò, com’era, il Requisens, che la sua nave fosse assalita da’ nemici, e volendola salvare, uscì tosto col galeone, e colle galee, e a forza di remi giunse al luogo del combattimento. I Mori essendo superiori, ed avendo il tempo propizio, volentieri attaccarono la battaglia; ma i nostri valorosi soldati, malgrado gli ostacoli, che si frapponeano, tennero fermo nella zuffa, che durò ben due ore, e ne restarono finalmente vittoriosi. Imperocchè, oltre di aver mandate a fondo tre fuste nemiche, s’impossessarono di altre sei, ed obbligarono le altre quattro malconcie a fuggirsene. Furono in questa azione fatti prigionieri quattrocento Mori, e cinquecento Turchi, senza contare il numero de’ morti, fra’ quali lo stesso Solimano ucciso con un colpo di cannone. Fra le bandiere conquistate si trovarono quelle della santa Sede, che lo stesso Rais Solimano sotto il pontefice Giulio II. avea guadagnato, quando si era impossessato di una galea pontifizia. Tornò il Requesens trionfante nel porto di Trapani, e diede subito conto al vicerè Moncada della vittoria ottenuta sopra i barbari. Stimò poi suo dovere lo spedire in Roma 656 a Leone X. le bandiere pontifizie, che gli furono presentate a nome del re di Aragona da Ramiro Nugnes de Gusman suo ambasciadore 657. Non sopravvisse molto tempo a questo fatto il nostro re Ferdinando. Quantunque egli non fosse molto vecchio, nonostante occupato sempre ai grandi affari della sua vasta monarchìa, ed ora che più di ogni altro, (poichè morto il re di Francia Ludovico XII, con cui si era pacificato, era salito su quel trono Francesco I. giovane intraprendente, e desideroso di riacquistare alla sua corona gli stati d’Italia, che avea perduti) dovea tenersi pronto a resistere alle armi di questo principe per difendersi, erasi molto indebolito nelle forze del corpo, e di giorno in giorno peggiorava. Perciò andossene nella città di Trussillo con animo di portarsi in Castiglia, dove sperava di respirare un’aria più salutare; ma crescendo sempre più i suoi mali, dovette soccombere alla comune sorte, e ai 23 658 di gennaro dell’anno 1516 finì di vivere all’età di sessantaquattro anni 659. Così terminò la razza de’ Sovrani Castigliani, e la nostra isola, come paleseremo nel seguente libro, passò sotto il dominio degli Austriaci. 654 Capit. Regni Sic. in Ferdinando II. cap. 70, pag. 569. Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1514.1515, III indiz. fogl. 114. 656 Surita, Hist. del rey D. Hernando, lib. X, cap. 67, p. 398. 657 Bisogna in questo luogo correggere tre errori del Caruso (Mem. Stor. tom. III, P. III, lib. VI, vol. V. pag. 116), che meritano di essere avvertiti. Vuol egli 1. che delle tredici fuste di Solimano sei furono sommerse, e sette prese: 2. che le insegne mandate al pontefice Leone X, erano non già della Santa Sede, ma dei Mori istessi: e 3. che l’ambasciadore di Spagna alla corte di Roma chiamavasi Rosario. 658 Il Muratori (Annali d’Italia all’anno 1516) fissò la morte di questo sovrano ai 15 dello stesso mese, ma noi abbiamo seguite le pedate del Surita scrittore della di lui vita, e spagnuolo, che dovea meglio che l’annalista italiano saperne il preciso giorno. 659 Surita, Hist. del Rey D. Hernando t. VI, lib. X, cap. 121, pag. 402. 655 - 115 - [148] LIBRO TERZO DE’ VICERÈ CHE GOVERNARONO LA SICILIA SOTTO I PRINCIPI AUSTRIACI Il re Ferdinando il Cattolico alla sua morte non lasciò dalle due mogli, ch’ebbe, alcun maschio, che gli avesse potuto succedere nella eredità della sua vasta monarchia. La primogenita delle femmine Isabella, la quale avea avuto due mariti, prima Alfonso principe di Portogallo, e poi il di lui cugino Emmanuello di Portogallo, e che a questo ultimo avea partorito un maschio, ch’era stato chiamato Michele della Pace, era morta nello stesso parto, e il principino, che diede ella alla luce, finì ancor esso di vivere all’età di due anni. Ricadde adunque il diritto della primogenita nella secondogenita la principessa Giovanna, che fu detta comunemente la pazza, la quale, come abbiamo osservato nel libro antecedente, si era accasata con Filippo il Bello arciduca d’Austria, dal qual matrimonio ne nacquero due maschi, cioè Carlo, e Ferdinando, che furono ambi imperadori di Occidente. Morto nel fiore della sua età l’arciduca Filippo, e subentrato per l’incapacità della figliuola Ferdinando il Cattolico al governo di Castiglia, Carlo andossene ne’ Paesi Bassi austriaci, e Ferdinando restò nella corte dell’avo colla madre. Ridotto agli estremi il monarca aragonese, nè volendo lasciare in balìa di una principessa priva di senno i governi de’ regni, stabilì, che sino che fosse arrivato da Brusselles il principe Carlo suo nipote, li reggesse interinamente il cardinal Ximenes arcivescovo di Toledo, uomo consumato nella politica, e nell’arte di amministrare i regni. Apertosi il testamento, sursero due pretensori al governo, durante l’assenza di Carlo il di lui fratello Ferdinando, il quale di poi, udendo che questa era la volontà dell’avo, cesse ad ogni diritto, ed Adriano, ch’era stato il plenipotenziario di Carlo alla corte dell’avo. I grandi della corte di Castiglia, e di Aragona erano di avviso, che dovessero escludersi Adriano, e Ximenes; il primo come straniero, e l’altro come frate. Fra queste differenze fu spedito un corriere al principe Carlo, il quale approvò la risoluzione del defunto re Cattolico, ed egli, lasciando per allora che l’arcivescovo di Toledo regolasse i suoi regni, si trattenne alcun altro tempo ne’ Paesi Bassi, ma prese tosto il titolo di re, e di correggente colla madre 660. CAPO I. Ugo de Moncada Vicerè. Simone Ventimiglia marchese di Geraci, e Matteo Santapau marchese di Licodia eletti presidenti del regno da’ Palermitani. Giovanni de Luna conte di Caltabellotta eletto presidente dal re. La morte di Ferdinando il Cattolico turbò l’animo del vicerè Moncada. Sapea egli quanto la nobiltà, e il popolo siciliano l’odiavano 661; e quindi temea, che sparsasene la fama, non fosse rimosso dal governo. Laonde cercò di tenerla occulta, sino che da’ nuovi sovrani non gli fosse arrivata la conferma nel viceregnato. Ma come era mai possibile in un paese marittimo, come è il nostro, dove arrivano ad ogni momento, e in tutti i porti [149] le navi, che arrecano le notizie, il tenere celata quella della morte del re di Aragona? Non passò guari, che una sorda voce si sparse per la città, che il re Ferdinando era già trapassato, e dalla capitale si divulgò per tutta l’isola. Ecco dunque il popolaccio messo in rumore, il quale gridava dappertutto, che finalmente si era liberato dalla dura schiavitudine, nella quale il tenea il Moncada, che era chiamato il tiranno, e l’assassino della Sicilia; giacchè colla morte suddetta era in lui cessata ogni autorità nel regno, e dovea il gran giustiziere assumerne il governo 662, fintanto che i nuovi sovrani non avessero altramente disposto; e che s’egli non tosto, cedendo alla amministrazione, si allontanava dalla Sicilia, bisognava obbligarvelo colla forza 663. Atterritosi a queste popolari minaccie il Moncada, e temendo di peggio, si era determinato da una parte di deporre le redini del governo, e di partirsene; ma dubitando dall’altra che lasciando la Sicilia senza governadore non ne potesse essere rimproverato, ed aspramente gastigato da’ sovrani, non sapea a qual partito appigliarsi. In questa dubbietà chiamò il sacro consiglio, e i giureperiti della capitale, a’ quali propose, se morto il re Ferdinando dovesse egli continuare nel governo, o partirsene, obbligandoli con giuramento a dirgli la verità; giacchè egli era disposto a fare ciò ch’eglino gli avrebbono consigliato. Tutti di 660 Sandoval, Historia della vida di Carlos V. lib. I, § XXI, e seg. Dispiacea sommamente ai nobili l’alterigia di questo cavaliere; riprovavano i buoni la sfrenatezza assai patente dei di lui costumi, in generale tutti esecravano la di lui avarizia; vizio, che si palesò nel viceregnato. Un governante superbo, scostumato ed avido non può piacere, che a pochi, i quali fomentando le di lui malnate passioni, migliorano i propri interessi. Questo è il carattere, che fanno di questo vicerè i nostri storici, e in particolare il Fazello (Deca II, lib. X, tom. III, pag. 158), scrittore contemporaneo, la di cui testimonianza diviene perciò rispettabile. 662 Soffiavano in questo tumulto, sebbene di soppiatto, il conte Pietro Cardona, Federico Abatellis, il conte di Cammarata, il marchese di Geraci, il marchese di Licodìa, ed altri magnati, ch’erano nemici giurati del Moncada. 663 Federico del Carretto de expulsione Hugonis de Moncada, nel primo tomo degli opuscoli di autori Siciliani pag. 6. 661 - 116 - accordo furono di avviso, ch’ei non potea sottrarsi dall’amministrazione del regno secondo le nostre prammatiche 664, senza incorrere nella indignazione dei sovrani. Questo consiglio, che fu anche appoggiato dai nobili, che erano del partito del Moncada, ed in particolare dal suo consanguineo il conte di Adrano, gli piacque all’estremo, e perciò la notte seguente chiamando al regio palagio gli stessi consiglieri, e quei pochi, che erano a sè addetti, fe’ stipulare un atto, con cui fu dichiarato legittimo governatore del regno, ed acciò non potesse essere molestato dal furibondo popolo, fe’ venire delle truppe per esservi custodito 665. Quanto oprato avea il Moncada non era ignoto ai principali baroni, che erano suoi nemici, i quali restarono irritati, che costui ad onta della comune dispiacenza volesse a forza mantenersi nell’amministrazione del regno, e che in queste risoluzioni non si fosse fatto alcun conto di loro, nè fossero stati chiamati a consiglio. Perciò per commuovere maggiormente il popolo, e per mostrare nello stesso tempo, che eglino non erano gli autori del tumulto, presero lo espediente di abbandonare la città, e quantunque la giornata fosse tempestosa, partirono, e andarono a starsene in Termini 666, lasciando rattristato il popolo, che attribuiva la partenza della nobiltà 667, alla brama di comandare, che avea il Moncada. Il basso popolo, trovandosi senza un capo o palese, o occulto, che lo guidi, difficilmente si muove a rumore. Laonde dopo l’allontanamento dei nobili sarebbe stata la città tranquilla, se non si presentava un’altra occasione per cui fu suscitata ad una nuova sollevazione. Ad intender questo aneddoto fa di mestieri il sapere, che nella espulsione dei Giudei che abbiamo raccontata nel libro antecedente, [150] molti di questa nazione, volendo profittare della grazia accordata loro di non essere molestati, se riceveano le acque battesimali, finsero per allora di voler divenire cristiani, e si fecero battezzare. Cessata di poi la loro persecuzione ritornarono tacitamente a vivere secondo la legge di Mosè. Non potè questa apostasìa essere così occulta, che non ne arrivasse la notizia alle orecchie degli inquisitori, i quali volendo gastigare questi finti cristiani, li condannarono a portare in avvenire un abito di color verde, al quale stesse cucita una croce di colore rosso, che fosse come il segnale della loro prostituzione. Non tutti gli uomini pensano ad uno stesso modo; dispiacea a taluni che costoro avessero per divisa quella stessa croce, che eglino calpestavano. In questo sentimento era Fr. Girolamo di Verona dell’ordine di S. Agostino detto per soprannome il Barbuto, il quale predicava in quell’anno nella chiesa di San Francesco durante il corso quaresimale. Questi adunque in una delle sue prediche recitate alla presenza del senato, e di un numeroso popolo disapprovò acremente dal pulpito la determinazione degli inquisitori, come cosa ignominiosa al nome cristiano, e disse, che era d’uopo di togliere dalle loro vesti questo salutifero segno della nostra redenzione 668. Appena sortito il popolo dalla chiesa di S. Francesco, seguendo il consiglio dell’inavveduto predicatore, si scagliò contro coloro degli Ebrei, che incontrava, strappando loro le vesti, maltrattandoli, dileggiandoli, e mandandoli malconci alle loro case: e ciò, che arrecò maggior meraviglia, fu, che anche le donne, senza aversi riguardo alla loro condizione, furono maltrattate, essendosi poste le mani addosso alle medesime. Sollevatosi così il popolo, si tornò a mormorare del vicerè, tacciandosi come colpevole, comunque egli non avesse parte alcuna nella risoluzione presa dagli inquisitori 669. Questo signore, che dopo la fuga dei nobili a Termini non sapea cosa eglino meditassero, e cercava i mezzi come potesse render vani i loro disegni, all’avviso di questa tumultuazione non perdette il coraggio, ma montato a cavallo, conducendo seco molti consiglieri, andò dove era più folto il popolo, e gridando viva il re Carlo, e la regina Giovanna, cercava di calmarlo. Ma veggendo che non era punto ascoltato, e che la plebe lo dispregiava, e mostrava di averlo in odio, prese lo espediente di rendersela amica con un altro mezzo, e fece per bocca del banditore promulgare, che ei liberavala dalla gabella della farina, che era sembrata sempre intollerabile, e che ordinava che tutti coloro, che si trovavano nelle carceri per debiti col 664 Non vi era certamente alcuna prammatica, che prescrivesse la continuazione de’ vicerè nel governo del regno, nonostante che fosse seguita la morte del sovrano; anzi si era sempre creduto che in codesto caso tutta l’autorità risiedesse nel maestro giustiziere. Noi abbiamo riferito nel libro primo di questa cronologia (capo unico) le controversie insorte fra la regina Bianca vicaria del regno, e Bernardo Caprera conte di Modica, e gran giustiziere, che dopo la morte di Martino il Vecchio pretese, che fosse cessato ogni potere nella vicaria, e ch’ei dovea governare il regno. La prima prammatica, che noi abbiamo, la quale prescrive che debbano i vicerè, malgrado la morte del sovrano, continuare nel reggimento, è quella di Carlo V, che fu appunto fatta per l’occasione di ciò, ch’era accaduto al Moncada. 665 Del Carretto loc. cit. pag. 7. 666 Fu detto ch’eglino avessero in animo di andare in Messina per trattare con quei cittadini il modo, con cui potesse cacciarsi il Moncada dalla Sicilia. Chi sa gli opposti sentimenti fra’ Palermitani, e Messinesi, si accorge agevolmente che non potea cadere nell’animo di questi cavalieri codesto proggetto. In fatti eglino non si mossero da Termini, dove dissero di essere andati per celebrare i funerali al re Ferdinando, la di cui morte tenea il vicerè ancor celata, sebbene il loro principal fine fosse quello di accrescere con questo allontanamento la confusione nel popolo. 667 Del Carretto, ivi pag. 8. 668 Sospetta il Fazello (Dec. II, lib. X, tom. III, p. III. 299), da cui abbiamo la relazione di questo fatto, che il dotto religioso non fosse punto mosso a così predicare da zelo di religione, ma incitato dalla nobiltà, che bramava che si dasse un nuovo impulso alla di già preparata sollevazione. 669 Fazello Deca II, lib. X, tom. III, pag. 199. - 117 - regio fisco, fossero liberati, arrecando così, per salvarsi, non piccolo danno agli interessi del sovrano. Queste generose proferte fatte al popolo non produssero il desiato effetto. La plebe diventa sempreppiù insolente, quando conosce di essere temuta; il tumulto, malgrado le grazie che si esibivano, lungi dal cessare, crescea a dismisura, gridando ciascheduno, che deponesse il comando, che era spirato colla morte del re. Il Moncada per non esporsi a maggiori oltraggi, pensò prudentemente di ritirarsi al regio palagio 670. Si persuadea questo vicerè, che l’unica maniera per fermare il corso a questa vertigine popolare sarebbe stata quella di ottenere dal re Carlo, e dalla regina Giovanna la conferma nel viceregnato; e siccome questa non era arrivata, nè potea così presto venire, volle con uno stratagemma far credere al popolo, che già giungeva la cedola reale della sua conferma; e fattane spargere la fama nel giorno antecedente, nel seguente si vide accostare al porto una barca, dove era il finto inviato, che recava le lettere del re. Il Moncada per dare maggior peso a questa invenzione, gli mandò all’incontro varî nobili del suo partito, acciò lo ricevessero, e lo conducessero al regio palagio. Corse la plebe alla marina per riconoscere costui, che credeva che fosse una persona di distinzione, e ben vestita; ma restò delusa, quando vide un’omicciattolo rozzo, e male in arnesi. Fu posto l’affare in ridicolo, e cominciò il popolo a beffarsi di costui, che credette che fosse un uomo delle galee del Moncada, che infingendosi inviato dal re, e dalla regina, recava le lettere modellate nello stesso palagio del vicerè, nè mancarono di coloro, [151] che giuravano di avere cenato con costui la sera antecedente in una delle osterie della città. Fu perciò schernito il supposto inviato, nè fu dato credito a quanto recava, che fu riputato come una vera cabala 671. Dato il primo passo, bisognava sostenerlo. Pretese il Moncada che costui era il leggittimo ministro spedito dai sovrani, e che le carte, che recava, erano autografe; e quindi ordinò che fossero chiamati i nobili, e quanti avessero la curiosità di leggerle nella casa del senato. Corsero molti per udirne la lettura, e siccome erano scritte latinamente, ed eloquentemente, e pochi le intendeano, fu dimandato che fossero ridotte in lingua volgare. Così fu eseguito: e gli astanti, quantunque sospettassero che fossero finte, nondimeno venerando i nomi dei sovrani, che ivi erano espressi, si tacquero, solo dispiaciuti di dover continuare sotto il giogo del Moncada, che riputavano assai duro ed intollerabile. Intanto un nuovo incidente fe’ scoppiare la sollevazione, i di cui semi trovavansi appiattati nei cuori dei Palermitani. Mentre il capitano della città, che era stato presente nella sala del senato alla lettura della supposta cedola, andava al regio palagio, forse per dar conto al vicerè del buon esito delle cose, un uomo del volgo lo fermò nella piazza della Marina, e gli chiese con arroganza una copia delle lettere reali. Si sdegnò questo ministro, ch’era Vincenzo Corbera barone di Meserandino, e rivolto a colui gli disse; che diritto hai tu uomo da nulla di farmi questa dimanda? che importa a te? ed accortosi che era armato contro le leggi, ordinò ai suoi birri, che lo legassero. Alle voci di questo insolente, che non volea lasciarsi disarmare, accorse una mano di sollevati, i quali sguainate le spade contro quei sgherri, li obbligarono a lasciarlo libero, e tale fu il terrore che arrecarono, che così eglino, come il capitano, furono costretti a fuggirsene 672. Parve allora, che strappato quel plebeo dalle mani de’ satelliti, fosse cessato ogni tumulto; ma all’improviso sulla sera fu veduta per la città una numerosa squadra di ragazzi, che sogliono sempre essere i forieri degli ammutinamenti, quali erano guarentiti da cento uomini, che li seguivano da lungi sotto la mentita veste di villani, che sotto i loro cappotti erano bene armati. Questi avvicinandosi al regio palagio minacciavano di fare aspra vendetta del Moncada da loro chiamato il tiranno, se tosto non partiva. Il tumulto si accrescea di momento in momento, giacchè accorreva il popolo a storme in parte per curiosità, e in parte per unirsi a’ sollevati. Non contenti delle minaccie, trassero dai baloardi i cannoni della città, e li collocarono dirimpetto al regio palagio, dichiarandosi che l’avrebbono posto a suolo, se il vicerè non partiva 673. Stavasene Ugone atterrito a questo inaspettato movimento; nè sapendo a qual partito appigliarsi, giacchè crescea a dismisura il numero dei tumultuanti, fe’ loro chiedere per mezzo di un suo familiare cosa mai volessero? La risposta fu breve, giacchè tutti di accordo dissero, che voleano che immantinente abbandonasse la città, minacciando di ucciderlo, se subito non ubbidiva. Chiese egli due giorni di tempo per soddisfarli, ma gli fu anche negato questo breve spazio, e gli fu prescritto, che raccolta la sua suppellettile immediate sen’andasse. Siccome ad imballar la roba vi volea qualche ora, i sollevati intolleranti di ogni dimora accesero i micci, e dando fuoco ai cannoni, cominciarono a battere le muraglie del regio palagio. Il Moncada, che stavasene alle vedette, si accorse dal lume delle palle infuocate, che fra’ popolari vi erano molti armati di corazza, e capì che non la sola plebe, ma i nobili ancora, e i cittadini cospiravano contro di lui. Laonde privo di ogni speranza, e temendo della vita, pensò a salvarsi; e senza far parola con alcuno, uscì 670 Fazello Deca II, lib. X. tom. III, pag. 199. Del Carretto ivi p. 9. Noi arrecheremo in seguito la notizia della vera carta reale, che fu poi spedita dal re Carlo, e dalla regina Giovanna, che il Moncada non ricevette, che in Messina, dove si era rifuggito, dopo che era stato cacciato da Palermo. Il che conferma che si fosse studiato il Moncada di raggirare il popolo con questa finzione. 672 Del Carretto loc. cit. pag. 11. 673 Del Carretto loc. cit. pag. 11. 671 - 118 - per la porta segreta del palagio in abito mentito, e andò a ricoverarsi nella vicina casa di Giovanni Antonio Resignano, e di là sotto la stessa veste passò alla marina, e s’imbarcò sopra una nave, con cui andò a Castellammare, d’onde in capo a due giorni prese la via di Messina. Accadde questo avvenimento tumultuoso ai 7 [152] di Marzo 1516, come ne fa fede il Fazello, che fu presente 674. Fu così occulta la fuga del Moncada, che non vi fu persona fra’ nobili, che erano con lui, che sene accorgesse; e lo stesso conte di Adrano suo parente non n’ebbe alcuno indizio. Cercavano adunque questi signori ogni angolo del palagio; e quando si avviddero, che egli era veramente scappato, pensarono ancora eglino a salvarsi, e parte per le porte segrete, parte colle funi scendendo dalle finestre, nella miglior maniera, che fu loro possibile, se ne fuggirono, non essendo restate nel palagio, che le soldatesche, che vi tenea il vicerè per sua custodia, le quali come videro, che erano sole, cominciarono a rubare tutto ciò, che era prezioso della mobilia del vicerè, e cariche di bottino, sulle sette ore della notte aprirono le porte del palagio all’inquieto popolo, che entratovi finì di saccheggiarlo fino al nascer del sole, in guisa che non vi restarono, che i nudi tetti, e le pareti. Assassinata la casa reale, e agitato sempre dalle stesse furie il popolo passò al palagio vecchio, dove dimorava lo inquisitore Tristano Calvete spagnuolo, e incolpandolo, come colui che in vece di tener lontana l’eresìa, stava tutto intento a far denari, a somma grazia gli accordò che si allontanasse da Palermo, come tosto egli fece essendosi imbarcato in una nave, che trovavasi nel porto 675. Arrivato il Moncada in Messina, prima di sbarcare, rappresentò a quei cittadini la tragedia, che gli era accaduta in Palermo, e dimandò, se eglino erano disposti a riceverlo come vicerè, o erano negli stessi sentimenti dei Palermitani; nel qual caso avrebbe continuato il viaggio fino nella Spagna, per esporre al re, come era stato crudelmente discacciato da tutta la Sicilia. I Messinesi, ai quali non era ignoto il tumulto di Palermo, udendone dalla bocca del vicerè tutta la storia, ebbero compassione di questo fuggitivo cavaliere, e dichiararono che l’avrebbono ricevuto come governante della Sicilia; e in fatti lo accolsero con tutti gli onori dovuti a questa carica. Veramente, come osserva Federico del Carretto 676, eglino non aveano verun motivo di restarne malcontenti; imperocchè non aveano da lui ricevuta alcuna molestia avendoli lasciati nel possesso dei loro privilegi; e per la gelosìa, che hanno sempre nutrito contro i Palermitani a cagione della preferenza, che vogliono sostenere, piacea loro di avere dentro le proprie mura il vicerè. Del resto, soggiunge questo scrittore, se eglino fossero stati aggravati, come gli altri Siciliani, non v’ha dubbio, che si sarebbono riuniti per discacciarnelo. Entrato adunque con sicurezza in quella città, prima di ogni altra cosa pensò di far consapevoli i sovrani di quanto gli era accaduto in Palermo, e sperando di mantenere a sè fedeli le altre città del regno, scrisse dappertutto delle circolari, esortandole a non imitare l’esempio de’ Palermitani, e liberandole da’ dazi, e da’ donativi, che pagar soleano, purchè si mantenessero nella dovuta ubbidienza. Questa generosità usata dal Moncada col voto del sacro consiglio, ch’era andato a Messina, a danno del regio erario, dispiacque nella corte del re Carlo; ed i consiglieri, per prevenirne l’accusa, non lasciarono di scriverne a quel sovrano, confessando di aver data questa provvidenza costretti dalla necessità; imperciocchè il baronaggio avea già rivoltati tutti nel regno, spargendo delle lettere, colle quali promettea di esimerli da ogni dazio, ogni volta che seguissero le pedate dei Palermitani; e perciò il vicerè, ed eglino, per tenere tranquille le università, e per impedire un maggior danno, aveano creduto espediente per allora lo accordare questa grazia, non ostante lo interesse, che ne soffriva il patrimonio del re. Così eglino si esprimono nella lettera indirizzata al re Carlo da Messina ai 10 del mese di aprile 1516 677. Le lettere circolari spedite dal Moncada, e le esenzioni accordate alle altre città, non partorirono il desiato effetto. Marciando sulle vestigia della capitale, le altre università non fecero verun conto delle esibizioni del vicerè, si sollevarono nella istessa maniera, abolirono di propria autorità le gabelle, e i dazî, e scelse ciascheduna da sè dei soggetti nobili, ai quali confidò la custodia, e la difesa delle proprie mura, e il governo dei cittadini. Così fecero Catania, Siracusa, [153] Girgenti, Lentini, Trapani, e in una parola tutto il resto della Sicilia, eccettuata Messina, e i suoi casali, dove unicamente era conosciuto come vicerè Ugo de Moncada. Ora per ritornare a Palermo, ch’era stata la prima molla di questa sollevazione, partito che fu il vicerè, ogni cosa restò nella massima confusione. Mancava la nobiltà, che o si era nascosta, o si era ridotta, come si è detto, nella città di Termini, e la plebe trovandosi senza freno, si facea lecita ogni scelleraggine, e sfogava il suo furore contro coloro ancora, che non aveano avuta parte veruna nel passato governo. Nella comune costernazione, in cui tutti erano, non osando alcuno di alzare il capo per opporsi alla torrente fu creduto da’ principali cittadini, che fosse necessario il richiamare i nobili da Termini, che soli avrebbono potuto in questa crisi universale dar riparo all’afflitta città. Furono perciò spediti de’ corrieri, ed invitati quei signori, che 674 Dec. II lib. X tom. III pag. 200 – Del Carretto loc. cit. p. 12 e 15. Del Carretto loc. cit. pag. 13. – Fazello Dec. II lib. X pag. 200. 676 Ivi pag. 14 e 15. 677 Registro del segretario Giovanni del Quadro dell’anno 1515-1516, IV indiz., conservato nella regia cancellarìa pag. 105. 675 - 119 - dimoravano a Termini, a volare al soccorso della propria patria. Furono lunga pezza incerti i cavalieri, se dovessero ritornare. Altri temeano di potere essere incolpati come fautori della tumultuazione, subitochè, partito il Moncada, si restituivano alla patria; altri diceano che appartenea al senato il sedare il popolo sollevato, e ch’eglino non doveano imbarazzarsi in un affare così critico. Ma il coraggioso Pietro Cardona conte di Golisano disse francamente, che trovandosi in iscompiglio la città di Palermo, ed essendo eglino implorati per soccorrerla, non era cosa giusta lo abbandonarla nelle mani di una plebe facinorosa, e disperata, e che il servigio del re cercava ch’eglino accorressero per salvarla. Fu seguito questo saggio consiglio, che si trovò di essere stato il migliore; giacchè al loro arrivo tornò la serenità in Palermo, i sediziosi furono posti a dovere, le leggi ripresero la loro forza, e i magistrati amministrarono con sicurezza la giustizia 678. Quietata la città, fu creduto necessario di certificare la corte di quanto era accaduto in Palermo, e in tutta la Sicilia, trattane la sola Messina co’ suoi casali, e di farla consapevole, come per opera della nobiltà si erano sopiti i moti popolari. Fu perciò spedito al re Carlo Antonello del Campo. Siccome però nell’anarchìa, in cui allora era il regno, bisognava darle un capo, che interinamente lo reggesse, si determinarono quei nobili palermitani, col consenso del popolo di scegliere Simone Ventimiglia marchese di Geraci, e Matteo Santapau marchese di Licodìa, i quali governassero coll’autorità di presidenti del regno, fino che il re avesse altramente disposto. Ammirabile fu la condotta di questi cavalieri, che guidando ogni cosa secondo i dettami dell’equità, tennero il regno nella più desiderabile tranquillità 679. In Brusselles nulla sapeasi di ciò, ch’era accaduto in Palermo, e il re Carlo fin dai 15 di marzo avea sottoscritta la cedola, che prorogava al Moncada il viceregnato di Sicilia per altri tre anni. Arrivò questa carta reale, ch’era la vera, al medesimo, mentre era a Messina nei primi del seguente aprile, ed egli la fece registrare in essa città a’ 12 dello stesso mese, come costa dal registro della regia cancellarìa 680. Era egli contento che il Re lo avesse confermato, e lusingavasi che il regno sarebbe finalmente ritornato sotto la sua ubbidienza. Con questa speranza dava le provvidenze, che credea utili al servigio del sovrano. Era egli stato avvisato che il re di Tunisi, il signore delle Gerbe, e molti corsali, volendo forse profittare delle vertigini, nelle quali era tutta la Sicilia, erano intenti a levare dalle mani del re di Aragona il porto, e la città di Tripoli; e quantunque fosse sicuro che la numerosa guarnigione, che presidiava quella piazza, avrebbe resi vani i loro sforzi, nondimeno, udendo la penuria de’ viveri, in cui trovavansi quei soldati, temea, se non si soccorrevano in tempo, ch’eglino costretti dalla fame non si arrendessero. La stessa scarsezza di vettovaglie cominciava a sentirsi a Messina dopo il suo arrivo, ed era suo interesse che questa città, ch’era stata l’unica, che lo avea riconosciuto, stesse nell’abbondanza. Non potea egli sperare di trarre i necessarî frumenti della Sicilia così per Messina, come per Tripoli; imperocchè i suoi ordini non erano eseguiti, e per tutto era vietato [154] che si estraessero viveri per Messina, o per altra parte. Laonde volendo provvedere ai detti bisogni scelse il nobile Giovanni Enguili ch’era quegli, che patroneggiava una sua barca, cui diede una piena, ed assoluta podestà di armarne delle altre, e di costeggiare i nostri mari, e di predare tutte le vettovaglie, che ritrovasse, trattene solo quelle, ch’erano destinate per Napoli, ordinandogli che dei primi grani, che avesse trovati, ne mandasse tosto una barca a Messina, e gli altri con cinquanta soldati spagnuoli li portasse a Tripoli, ricavando da Fra Dionisio di Moncada, ivi destinato ricevitore, la cautela di quanto avesse consegnato. Il dispaccio viceregio è segnato in Messina ai 13 aprile 1516 681, e registrato dal segretario di esso vicerè Giovanni de Quadro. Non restò libera la città di Messina, mentre il Moncada vi dimorava, da’ moti popolari. Fu prima sparso che la plebe volea abolite le gabelle civiche, e perciò molti cittadini erano di avviso, ch’era d’uopo che alcuni del loro ceto dovessero essere ammessi fra’ senatori per invigilare agl’interessi del popolo, e che non dovea tollerarsi che tutta l’amministrazione restasse nelle mani dei nobili, che disgravando sè stessi dal peso delle gabelle, lo imponevano quasi tutto agli altri cittadini. Erano alla testa dei plebei Giovancola Reggitano, Bernardo Tauronito, Francesco Safonzio, Giovanni Bernardo Casalaina, Bitto Mollica, ed altri cittadini benestanti. Fu ricorso al vicerè Moncada da costoro, che pretendeano che il popolo partecipasse alla magistratura, e da’ nobili, che lo voleano escludere. Dopo varî dibattimenti il Moncada compose questa differenza con istabilire che i senatori fossero sei, quattro de’ quali fossero dell’ordine patrizio, e due di quello de’ cittadini. Accomodate queste vertenze, fu abolito il senato, che stava per mettersi in possesso, e furono secondo il convenuto eletti i sei, due de’ quali furono il Mollica, e il Casalaina cittadini 682. 678 Del Carretto nel lib. cit. pag. 17, e seg. – Fazello nello stesso luogo pag. 201. Sotto il governo di questi presidenti fu aperta per la prima volta in Palermo la fiera di S. Cristina per lo spazio di quindici giorni. Aveano i Palermitani cercata questa grazia al re Ferdinando il Cattolico, che si era compiaciuto di accordarla (Capit. regni Sic. tom. II. in Ferdin. pag. 597,) ma il Moncada non l’avea voluto pubblicare. 680 Reg. dell’anno 1515.1516, IV indiz., pag. 666. 681 Manoscritto della Biblioteca del Senato di Palermo lett. P. 9. 682 Maurol. Sic. Hist. lib. VI, pag. 210 e 211. 679 - 120 - Pervennero finalmente a Brusselles le notizie delle peripezie accadute al Moncada in Palermo, e per tutto quasi il regno di Sicilia, ed arrivarono ancora gl’inviati spediti non meno dallo espulso vicerè, che dalla città di Palermo, e dalla nobiltà. Il re Carlo, che stante l’incapacità della madre governava la monarchìa, quantunque fosse assai giovane, giacchè appena compiuti avea gli anni diciotto, persuaso che il sovrano non dee precipitare le sue risoluzioni, non diede fede nè alle dimostranze del primo, nè alle querele, e legittimazioni dei secondi; ma con saggia condotta sospese per allora il giudizio di questo affare, e spedì in Palermo Diego dell’Aquila spagnuolo, sulla di cui onestà molto confidava, acciò sulla faccia del luogo deciferasse la verità de’ fatti, e ne lo informasse. Ebbe egli ordine di chiamare i baroni, su i quali cadea il sospetto, o che avessero procurata la mozione popolare, o che non l’avessero sedata, palesando loro, ed anche al popolo, esser sua reale volontà che il Moncada continuasse nel governo del regno, e che fosse da tutti riconosciuto come legittimo vicerè, così ricercando l’onore della sua corona 683. Adempì fedelmente Diego dell’Aquila la sua commissione. Arrivato in Palermo radunò i baroni, e siccome Pietro Cardona conte di Golisano ritrovavasi a Catania, per sedare alcuni 684 disturbi nati fra Girolamo Guerreri, e Francesco Paternò barone di Raddusa, non volle nulla proporre, prima che questo cavaliere, ch’era uno de’ principali, non fosse ritornato. Venne il Cardona invitato dalle lettere dell’Aquila, e allora questo inviato del re fe a’ nobili nota la volontà del sovrano. Risposero eglino, che, comunque riputassero indegno di comandare il Moncada, nondimeno per appalesare la venerazione, che nudrivano per i decreti del monarca, erano per la loro parte prontissimi ad ubbidire, e a riconoscerlo come il ministro destinato da Carlo a reggerli; ma che non era cosa agevole lo indurre a questo sagrifizio la indocile, irragionevole, ed irritata plebe; e perciò protestarono, che se mai al ritorno del Moncada nasceano de’ nuovi scompigli, che potessero arrecar disturbo a sua maestà, e danno al regno, sapesse il re che non era in loro potere il rimediarvi. Consigliarono perciò l’inviato suddetto ad esaminare con accuratezza lo stato delle cose, e a far presenti al sovrano i pericoli, ai quali stava esposto il ritorno dell’espulso vicerè. Approvò l’Aquila questo consiglio, e prese le [155] necessarie informazioni della condotta, che si era tenuta dal Moncada nel suo viceregnato, e da uomo onesto, qual era, manifestò con sincerità a Carlo lo stato, in cui si trovava la Sicilia 685. Questo monarca, che nudriva Pensier canuti in giovanile etate, e che fra le massime della politica riguardava, come la principale, la salvezza del popolo: Salus populi suprema lex esto, conobbe benissimo che la Sicilia non potea esser tranquillata, se non si allontanavano da essa il Moncada, e i principali baroni, che si credevano i motori della sedizione. Chiamò adunque alla Corte il Moncada, e i due conti di Golisano, e di Cammarata, rimettendo al suo esame questa gran contesa. Acciò poi non passasse in esempio che nelle rivoluzioni, che accadeano nelle città, gli abitanti si scegliessero coloro che dovessero interinamente governarli, levò di carica i due marchesi di Geraci, e di Licodìa, e scelse con dispaccio dato in Brusselles agli 8 di luglio 1516, che fu poi esecutoriato in Messina a’ 30 del seguente agosto 686, per presidente del regno, durante la lontananza del Moncada, Giovanni Vincenzo de Luna conte di Caltabellotta, che era strategoto di Messina; ed ordinò, che si annullasse quanto si era fatto in Sicilia contro il Moncada 687. Il conte di Caltabellotta si portò subito in Palermo, e seppe così saggiamente condursi col popolo, che si acquistò una grande riputazione non meno presso il re, che presso tutta la nazione. La sola terra di Bivona, ch’era di sua pertinenza, ebbe a dolersi del suo rigore 688. Ubbidendo ai comandi reali partì da Messina Ugone Moncada ai 28 di agosto 1516, e andossene a Reggio, d’onde prese la via delle Fiandre, dove tuttavia dimorava il re Carlo. Erano seco il famigerato giureconsulto Pietro di Gregorio, e Francesco Safonio, i quali vi andarono ancora come ambasciadori di Messina; ed inoltre Blasco Lanza, Geronimo Guerrieri, e Cesare Gioeni catanesi, i quali essendo del partito di Moncada si erano rifuggiti in Messina. Partirono ancora da Palermo, non sappiamo il preciso giorno, i due conti di Golisano, e di Cammarata, ai quali fecero compagnia molti altri nobili, e i due celebri giureperiti palermitani Federico Imperatore, ed Antonio Abrugnano 689. Arrivati gli uni, e gli altri a Brusselles diedero conto al re Carlo di ciò, che era accaduto in Sicilia, rifondendone ciascheduna parte la colpa nella parte contraria; giacchè il Moncada accusava come sediziosi, e autori della tumultuazione i magnati di Palermo, e questi all’incontro attestavano che la nota tirannide del 683 Del Carretto loc. cit. pag. 19. Fazello dec. II, lib. X, tom. III, pag. 202. 685 Del Carretto loc. cit. 686 Reg. di Giovanni de Quadro segr. dell’anno 1515.1516, IV indiz., conservato nella regia cancellarìa pag. 246. 687 Maurol. Sic. Hist. lib. IV, pag. 211. 688 I Bivonesi nell’anarchia, in cui trovavasi la Sicilia, unendosi alle altre città sollevate, tumultuarono e scossero il giogo del loro legittimo signore, che trovandosi strategoto di Messina fu creduto del partito del Moncada. Il conte perciò, preso il governo di Sicilia, pensò di punire i rubelli suoi sudditi, e facendo saccheggiare quella terra, la ridusse all’antica ubbidienza. 689 Amico Cat. Illustr. lib. VIII, cap. I, tom. II, pag. 369. – Del Carretto loc. cit. pag. 20. 684 - 121 - Moncada, e il suo inetto governo erano stati i motivi, per cui il popolo si era sollevato, e che dal canto loro lungi di dover essere castigati, erano anzi degni di premio, perchè aveano saputo frenare il furore del popolo, che era disposto a fare cose peggiori, e di aver così salvato il regno alla corona. Il re Carlo, ascoltate le loro difese scambievoli, conobbe che il Moncada era degno di ogni rimprovero 690; ma dall’altra parte concepì che non dovea restare impunito l’ardire dei Palermitani, che si erano sollevati e ne lo aveano vituperosamente discacciato. Perciò non volle da un canto permettere che il Moncada ritornasse al governo di Sicilia; ma volle dall’altro che fossero condannati con pena capitale i principali sediziosi, per essere di esempio il loro castigo in avvenire. Siccome poi gli premea che il suo regio erario non soffrisse la [156] menoma alterazione, che colle grazie accordate dal Moncada, e dal suo regio consiglio, e colle esenzioni, che i sollevati si erano procacciate, sofferto avea un considerabile interesse, ordinò che fossero risarciti a carico di tutta la nazione i danni, che il fisco sofferti avea 691. Così immaginò questo sovrano di aver dato riparo ai disordini del regno di Sicilia, il quale non restò nondimeno interamente tranquillo, essendo malagevole che il fermento una volta suscitatosi così di leggieri si sopisca, come or ora saremo per raccontare. CAPO II. Ettore Pignatelli conte di Monteleone prima luogotenente, e poi vicerè. Camillo Pignatello suo figliuolo, e Giacomo Alliata luogotenenti eletti. Il cardinale Errico Cardona arcivescovo di Morreale presidente del regno. Composte in quel modo, che il re Carlo credette il più opportuno, le differenze della Sicilia, per dare esecuzione a quanto ordinato avea, destinò egli per luogotenente del nostro regno, e capitano generale Ettore Pignatelli conte di Monteleone 692. L’elezione di questo cavaliere fu fatta in Brusselles ai 22 di febbraro dell’anno 1517, e il dispaccio regio fu tosto spedito in Palermo, dove risedea il conte di Caltabellotta, il quale ne ordinò subito l’esecutoria, che fu registrata ai 2 del seguente mese di marzo 693. Scrisse il Caruso 694, che questo conte trovavasi allora in Fiandra assai ben visto dal re Carlo, e dal suo favorito il sig. de Chevres, e di là lo fa venire a drittura in Palermo nel mese di aprile; ma il Maurolico 695 autore contemporaneo scrisse, che egli passato lo stretto si portò prima a Messina, e di poi si ridusse a Palermo, che era la città, in cui dovea eseguire i sovrani ordini. Possono questi due storici conciliarsi, essendo verisimile che il Pignatelli da Fiandra sia venuto in Calabria per visitare i suoi stati, e che passando indi il Faro sia andato prima a Messina. L’arrivo del Pignatelli in Palermo per testimonianza del Fazello 696 che era presente, fu al primo di maggio, non già in aprile, come piacque al Caruso. Alla di lui venuta cessò ogni potere nel conte di Caltabellotta. Preso il possesso della carica di luogotenente, e di capitano generale del regno, cominciò in questa capitale ad eseguire quanto gli era stato dai sovrani comandato. Noi abbiamo due suoi dispacci dei 4 dello stesso mese di maggio. Nel primo rapporta un’ordine reale dato in Brusselles ai 23 di dicembre 1516 con cui la regina Giovanna, e il re Carlo annullano quanto Ugone di Moncada nei scompigli, che erano accaduti nel regno, avea stabilito, così in riguardo ad esimere la nazione da alcune gabelle, e dal pagamento del donativo offerto nell’ultimo parlamento, come nell’accordare ad alcuni baroni il mero, e misto impero, per le quali grazie non avea la necessaria podestà; e vuole che non si tengano per accordate in alcun conto le dette concessioni, e che resti ogni cosa come prima. Comanda adunque il detto luogotenente del regno al gran giustiziere, ai giudici, ai maestri razionali, e agli uffiziali regî, ed ai baroni ancora, e marchesi, che sia tosto eseguito il real volere 697. L’altro contiene un’altra carta reale sottoscritta ai 14 di gennaro 1517, con cui rammentandosi l’elezione fatta dopo l’espulsione del Moncada dei due marchesi di Geraci, e di Licodìa come presidenti del regno, senza la previa elezione dei sovrani, si dichiarano nulli, casti, ed irriti tutti gli atti da loro fatti in forza di questa pretesa presidenza così in giudizio, come fuori di esso, non meno nelle cause 690 Noi abbiamo una testimonianza del pessimo governo di questo vicerè presso Paolo Giovio scrittore imparziale, e che lungi dall’avere interesse a discreditarlo, dovea cercare ogni modo, per quanto la verità comportava, di diminuire la gravità dei suoi delitti, essendo egli uno degli eroi, che commenda nella sua opera stampata a Firenze l’anno 1551, cioè nel tempo ch’erano ancor fresche le memorie del Moncada, che ha per titolo: Elogia virorum bellica virtute illustrium. Parlando ei di questo governante così scrisse: Ita Siciliae praefuit, ut ibi multa avaritiae, et crudelitatis monumenta relinqueret. 691 Del Carretto loc. cit. pag. 21. 692 Questo titolo di luogotenente, che noi vedremo dato in appresso ad altri governanti, sebbene equivaglia a quello di vicerè, perchè tanto è dire tenere il luogo del re, che fare le veci del re, nondimeno par che sia minore a quello, e superiore all’altro di presidente del regno; e infatti noi vedremo in questo istesso capo che il medesimo conte di Monteleone fu di poi con nuovo dispaccio dichiarato vicerè. 693 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1516.1517, V. indiz. f. 667. 694 Mem. Stor. P. III, lib. VII, tom. III, vol. V, pag. 125. 695 Sic. Hist. lib. VI, pag. 211. 696 Dec. II, lib. X, cap. un. pag. 202. 697 Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1516.1517 pag. 668. - 122 - civili, che nelle criminali. Questa lettera reale viene comunicata per l’esecuzioni al maestro giustiziere, e a tutti i tribunali del regno 698. Date queste prime provvidenze, che interessavano l’erario regio, e la tranquillità del [157] regno, consegnò ai due marchesi di Geraci, e di Licodìa un’altro dispaccio sovrano, per cui si prescrivea loro che nello spazio di otto giorni partissero dalla Sicilia, ed andassero in Napoli, dove star doveano agli ordini di Raimondo Cardona vicerè di quel regno. Fè poi carcerare venti dei principali capi della rivoluzione, riserbando a se quando gli paresse opportuno, di castigarli; e finalmente fe’ promulgare per mezzo del pubblico banditore l’indulto, che il re accordava agli altri Palermitani 699. Quantunque la plebe restasse allor contenta del perdono, che le veniva accordato era nondimeno timida; e sospettava che questa indulgenza non fosse finta, e che non si aspettasse un tempo più opportuno per castigarla. L’avere i sovrani trattenuti a Brusselles i due conti di Golisano, e di Cammarata, dei quali non si sapea se fossero liberi, o prigioni, e l’allontanamento, anzi l’esilio dei due marchesi di Geraci, e di Licodìa, che erano i principali magnati della Sicilia, facea dottare che si cercasse di privare il popolo di tutti gli appoggi, per potersi poi con più sicurezza aggravare la mano nel punirlo. Erano perciò costernati tutti coloro, che aveano presa parte nella tumultuazione, e dubitavano che questa segreta mina non fosse preparata da coloro, che stavano ai fianchi del Pignatelli, e da quelli, che erano stati del partito del Moncada, che era abbastanza rispettabile, e maggiore del loro, che colla lontananza di questi cavalieri andava di giorno in giorno indebolendosi. Fra i più colpevoli, che aveano avuta una gran parte nella espulsione del Moncada, eravi un certo Giovan Luca Squarcialupo, che l’anno antecedente era stato senatore, ed avea molto contribuito a sollevare il popolo. Questi era ancora reo di aver tentato di ferire in una processione Antonio Moncada conte di Adernò parente del vicerè di Moncada, contro di cui avea sfoderata la spada sotto pretesto di mantenere il posto, che segli dovea come senatore. Costui trovavasi per questo delitto in esilio, ed udendo che la città di Palermo era divisa in partiti, ed era cosa agevole l’istigare la plebe a nuova rivoluzione, molto più che il re Carlo era così lontano, nè in Sicilia, nè in Italia erano truppe, che potessero opporsi, immaginò che questa fosse l’occasione opportuna da fare un nuovo tentativo per disfarsi di tutto il partito di Moncada, e con questa mira se ne venne di soppiatto in Palermo. Trovò egli molti, che approvarono il suo disegno, e si confederarono con esso. I principali fra questi furono Francesco Barresi, Baldassare Settimo, Alfonso Rosa, e Pietro Spadafora, con altri nobili, ch’erano tutti aggravati di debiti. A questi erano uniti tre uomini facinorosi del popolo, cioè Giacomo Girgenti, Vincenzo Riza, e Vincenzo Zazara. Vuolsi però, che di soppiatto fomentasse questa sollevazione Guglielmo Ventimiglia barone di Ciminna, il quale avea un particolare odio con Ugone di Moncada, e co’ di lui partitarî. Lo Squarcialupo, che si era costituito loro capo, li radunò un giorno in una casina di campagna presso il castello di Margana 700. Ivi Giovan Luca, ch’era giovane di un grande ardire, e di un animo fermo, ed atto a tentare qualunque ardua impresa, rappresentò loro le calamità, in cui trovavasi involta la Sicilia, e l’imminente rovina della città di Palermo; li assicurò, che i conti di Cammarata, e di Golisano erano stati condannati a morte in Brusselles per ordine del re, leggendo ai medesimi certe mentite lettere, che ne descriveano il lugubre caso; e ch’era d’uopo di prevenire la tempesta. Con noi, soggiunse per animarli al tumulto, si uniranno immantinente gli altri Siciliani, che soffrono le stesse oppressioni, e noi saremo i loro condottieri. Che se per ventura saremo vinti, meglio sarà per noi il morire colla spada alla mano, che fuggire come pecore per essere di poi scannati. Lungi da’ nostri petti il timore, e l’orror della morte, accingiamoci all’impresa, o per ottenere la libertà, o per morire gloriosi 701. Fu applaudito il discorso dello Squarcialupo: tutti i congiurati dichiararono di essere pronti a seguirlo, e a liberare la patria dalla schiavitù. Fu poi convenuto, che non doveano ribellarsi contro il re, nè discacciare il Pignatelli dalla presidenza del regno, a’ quali conveniva restar fedeli, ma che bisognava solo trar [158] vendetta da’ quattro giudici della gran corte, dall’avvocato fiscale della medesima, e dai maestri razionali, che si credeano gli autori della persecuzione; e ch’era anche di mestieri il sagrificare tutti i fautori del Moncada, il sangue de’ quali per la sicurezza della città dovea necessariamente spargersi. 698 Nello stesso reg. del protonotaro, ed alla medesima pag. 668. Fazello dec. II, lib. X, pag. 202. 700 Federico del Carretto (nel citato libro pag. 23) dice, che siensi radunati nella chiesa di S. Giacomo di Mazara, ch’era segregata, e lontana dalla piazza, dove era più frequente il popolo; ma a noi è piacciuto di seguire il Fazello, ch’era allora in Palermo, e più a portata di sapere questi avvenimenti. (Dec. II, lib. X, p. 203). 701 Del Carretto nel lib. cit. p. 23. 699 - 123 - Acciò poi questo colpo non fallisse, fu stabilito di differirne l’esecuzione a’ 23 di luglio, in cui si celebravano nel duomo i vespri per la festa di Santa Cristina 702, a’ quali assistea il vicerè con tutto il sacro consiglio, nel qual giorno era agevole di trovarvi tutti quelli, che s’era determinato di levare dal mondo. Sciolto il congresso Giovan Luca si applicò a preparar tutto, affinchè la congiura avesse il desiato effetto, esortando i suoi compagni alla costanza, e cercandone degli altri, per accrescerne il numero. Ma le cospirazioni, perchè riescano, non debbono sapersi da molti, nè differirsi a lungo: imperocchè è assai malagevole, che, o per il numero di coloro, che ne sono a parte, o per la lunghezza del tempo, non ne traspiri la notizia. Già l’affare era pubblico per la città, e si sapeano perfino gli autori della congiura. Il Pignatelli, che n’era stato avvertito, stavasene inoperoso, nè pensava a soffocarla, nè i di lui ministri erano meno indolenti. Ognuno si maravigliava della loro infingardaggine, malgrado che di ora in ora crescesse la voce del vicino tumulto. Arrivato il giorno destinato da’ sollevati, un frate Francescano, che avea saputo fil filo tutta la cospirazione da Vincenzo di Benedetto fratello di Cristoforo, ch’era uno dei congiurati, andossene al palagio, dove dimorava il Pignatelli, e chiesta udienza, lo avvertì che non andasse nè egli, nè il sagro consiglio a’ vespri, che si sarebbono cantati nella cattedrale per l’imminente festa di Santa Cristina, palesandogli ciò, che dovea accadergli. Questo timido cavaliere, figliuolo della paura, si persuase di non esporsi al pericolo, ma senza dare, come dovea, altre provvidenze, si contentò di far sapere a chi appartenea, che non avrebbe tenuta la cappella reale, e pieno di spavento si chiuse col sacro consiglio nel real palagio dell’Osteri ch’era la sua abitazione. I congiurati, giunta l’ora, entrarono per la porta Nuova, che per la negligenza di chi governava trovarono aperta, e senza custodia, e andarono alla chiesa di S. Giacomo di Mazzara, dove dopo d’essersi ristorati aspettavano l’ora del vespro per eseguire il nero loro disegno. Giovan Luca non intralasciò di animarli a non perder coraggio, e a liberare la patria dalla tirannìa. Venuta l’ora si avviarono al duomo; ma qual fu la loro sorpresa nel vedersi fallito il colpo? Non trovando ivi le vittime, che voleano sacrificare, sfogarono il loro sdegno contro Paolo Gagio archivario della città, uomo pacifico, e mansueto, che trovavasi per caso in chiesa per assistere a’ divini uffizî, e crudelmente l’uccisero. Fatto questo sacrilego omicidio, quali tigri avide di sangue uscendo dalla chiesa camminarono per la strada del cassero, e arrivati alla piazza detta volgarmente la Loggia cominciarono a gridare: muojano gli empî, e i traditori della patria, per opera dei quali i conti (intendendo de’ conti di Golisano, e di Cammarata) sono stati condannati a morte. Con queste voci trassero molti della plebe a prendere le armi, e ad unirsi con loro. Cresciuti di numero corsero alla piazza della Marina 703, dove era il palagio reale, le di cui porte per ordine del Pignatelli trovarono chiuse, e continuarono la stessa cantilena: muojano gli empî ec. A queste voci si atterrirono il luogotenente, e quanti erano con lui. Crebbe poi il loro terrore, allorchè videro trasportati i cannoni dirimpetto la porta maggiore per buttarla a terra, e per aprirsi i sollevati il [159] varco all’entrata. Il conte di Monteleone irresoluto di ciò, che dovesse fare, fe’ loro dimandare che cosa mai volessero? Risposero, che volevano nelle mani i ministri del sacro consiglio; e richiesti di nuovo cosa mai ne volessero fare? dissero, che voleano ammazzarli; le quali parole da molti consiglieri, che erano nel palagio, ognuno può immaginarsi con quale animo fossero state ascoltate. Alcuni di essi, non trovando scampo, andarono a nascondersi nei più rimoti angoli della casa reale 704. Cercò con ogni modo il Pignatelli di sedare il tumulto, assicurando lo Squarcialupo, e gli altri congiurati, che i due conti di Golisano, e di Cammarata erano vivi, nè aveano sofferto alcun sinistro alla corte; ma come vide che cantava ai sordi, si nascose ancor egli dove meglio potè. Crescendo la notte augumentavasi il numero de’ tumultuanti, che parte per curiosità, e parte per desiderio di preda si univano cogli altri sollevati. Sulle tre ore facendosi giocare il cannone, e applicandosi le fascine alla porta del palagio, questa fu aperta, e l’audace popolo entrò furiosamente nella casa del re. Salite le scale, e trovando i sollevati il Pignatelli, senza punto oltraggiarlo, l’obbligarono ad andarsene al vecchio palagio presso Portanuova, dove al presente abitano i viceregnanti. Di poi cercando tutte le camere vi trovarono Niccolò Cannarella di Palazzuolo, abitante di Siracusa, uomo probo, e dotto nella scienza legale, e Giovan Tommaso Paternò catanese, uomo 702 Del Carretto loc. cit. disegna il primo di agosto, ad kalendas augusti, e il Fazello l’ultimo di luglio: II. kalendas augusti; ma l’uno, e l’altro sbagliano; la festa di S. Cristina si celebra a’ 24 di luglio, e perciò i vespri doveano cantarsi a’ 23; laonde crediamo che debbano ambidue emendarsi, e leggersi X. kalendas augusti. 703 Racconta il Fazello (Dec. II, lib. X, cap. unico pag. 204) testimonio oculare, che i congiurati vennero prima alla chiesa di S. Maria della Catena, e si radunarono nel coro, dove allo Squarcialupo arrivò uno svenimento, (o che si fosse atterrito dalla grandezza dell’impresa, o che fosse dispiacciuto che pochi del popolo lo secondassero) per cui cadde in terra destituto di sensi. Questo accidente sbalordì i di lui seguaci, e sarebbe stato agevole, se il Pignatelli avesse avuto più coraggio, di profittare di questo accidente, facendo trucidare i sollevati, ch’erano già avviliti nel vedere esangue il loro capo. Ma l’indolenza di questo cavaliere diè tempo a’ medesimi con aceto, e con altri rimedii di chiamare in sensi Giovan Luca, il quale dopo un’ora di svenimento ritornò nel primiero vigore, e fu in grado di montare a cavallo, e di proseguire il suo attentato. 704 Del Carretto nel libro cit. pag. 24, e 25. - 124 - del pari dotto, e costumato, che per sventura erano due dei giudici della gran corte, e uccisili senza pietà, e spogliatili delle proprio vesti, buttarono i loro cadaveri dalle finestre nella piazza della marina, tenendo il popolo le picche alzate per riceverli, che fu uno spettacolo orrendo, nuovo, e barbaro. Eravi nel palagio Gerardo Bonanno, maestro razionale, a cui era riuscito sotto la mentita veste di villano di sortire dalla porta segreta; ma mentre fuggiva fu preso dai sollevati, i quali con un nuovo modo crudele, dopo di averlo prima castrato barbaramente, lo ammazzarono. Per tutta la notte fu dato il sacco al regio palagio dell’avida plebaglia. Fatto giorno ai 24 di luglio si rivolsero i congiurati a cercar gli altri ministri, e partitarî del Moncada. Stava loro a cuore Priamo Capuccio, marsalese, che era l’avvocato fiscale della gran corte, ai di cui consigli attribuivasi il rigore, con cui operava il Pignatelli, uomo dottissimo, e singolare nella poesia. Costui si era ricoverato in una casetta di una feminuccia presso la chiesa di S. Giovanni dei Tartari. Dopo di averlo ricercato per lo spazio di quasi due giorni, finalmente i tumultuanti lo ritrovarono, e sfogarono contro di lui il loro sdegno; avvegnachè dopo di averlo strascinato vivo per le pubbliche strade, e di averlo piagato per tutto il corpo, gli diedero da ultimo la morte 705. Restava Blasco Lanza a compiere l’opra, e a saziare la rabbia di quei furibondi. Era egli stato amico del vicerè Moncada, e ne avea assunto la difesa a Brusselles alla presenza del monarca contro i Palermitani, e i due conti di Golisano, e di Cammarata, che ne sostenevano le parti. Si dubitò che fosse nascosto a S. Domenico; ne fu fatta indagine in tutti gli angoli, ma non si trovò; solo tutto il ricco mobile del Moncada era ivi conservato, di cui s’imposessò l’avido popolaccio. Non potendosi ritrovare il Lanza, fu saccheggiata la di lui casa, e trattane la nobile sua libreria, e tutti i mobili, ne fecero gran falò, nè di ciò contenti, incendiarono la casa medesima. Scappò dalle loro mani Giovanni Luna conte di Caltabellotta, che era stato presidente del regno alla partenza del Moncada, deposti i due marchesi di Geraci, e di Licodìa, il quale ai primi movimenti, andò a salvarsi nella città di Alcamo 706. Fu l’esempio dei Palermitani seguito da molte altre città del regno 707 , dove molti cominciarono a tumultuare contro coloro, che erano stati favorevoli al Moncada. I sollevati delle altre città, per rendersi più forti richiesero di collegarsi con quelli di Palermo, i quali divenuti più insolenti dall’osservare che veniva ricercato il loro [160] appoggio, già pensavano di impossessarsi del castello di Palermo, rendendosi così colpevoli di fellonia, quando non erano finallora stati, che di una tumultuazione. Il Pignatelli, che avrebbe dovuto, e potuto trovare i mezzi da riparare a così grande perturbazione di cose, stavasene timoroso nel vecchio palagio, nè prendea espediente veruno. Ma gli amanti della patria, che ne prevedevano la totale rovina, pensarono di fare da per loro ciò, che era conveniente per liberarla 708. E portatisi segretamente dal conte di Monteleone gli esposero, che prendevano a loro carico di salvar la città; solo chiesero, che ei ne pregasse Guglielmo Ventimiglia signore di Ciminna, col di cui braccio erano certi di compire l’opera. Il dottante Pignatelli, invece di animarli, li scoraggiva, facendo loro presente quanto fosse malagevole cosa il vincere quei facinorosi resi oramai potentissimi. Mostrossi di poi renitente ad affidarsi al signor di Ciminna che ei credea che fosse il capo occulto dei sediziosi; ma finalmente assicurato da Pompilio Imperatore, che potea riposare sulla fedeltà di questo cavaliere, si indusse a chiamarlo, e a pregarlo, acciò in compagnia degli altri cavalieri liberasse Palermo, e la Sicilia dalle presenti calamità 709. Quantunque il Ventimiglia conoscesse quanto fosse ardimentosa la commissione, l’accettò, e promise che avrebbe fatto ogni opra, affinchè restassero compiuti i desiderî del luogotenente del regno. Acciò però questo grande affare fosse condotto colla maggiore accortezza, fu pensato di fingere, che eglino fossero della fazione dei congiurati, per essere a portata di sapere le loro mire, e che il Pignatelli dal suo canto mostrasse di secondarli, affettando paura, nel che non avea da stentar molto. Così si sarebbono costoro addormentati, nè avrebbono sospettato delle insidie, che loro si tramavano. Pascevansi intanto lo Squarcialupo, e i suoi compagni di magnifiche idee, e già aveano stabilito di riformare gli abusi, facendone delle premure al conte di Monteleone. Questi secondo il convenuto approvava il loro zelo, e fu stabilito il dì 8 di settembre, che era il giorno della nascita della Gran Donna, in cui nella chiesa dell’Annunziata dirimpetto il convento di S. Cita, presente il suddetto governante, si sarebbono segnati i capitoli della riforma. Il Ventimiglia adunque stabilì 705 Del Carretto nel libro mentovato pag. 25. Del Carretto nel libro citato pag. 26. 707 Così in Catania si videro due fazioni, l’una sostenuta da Francesco Paternò barone di Raddusa, amico dell’espulso Moncada, e l’altra da Girolamo Guerrieri. Similmente in Girgenti vi furono delle scissure fra Pietro Monteaperto, e Baldassare Naselli barone del Comiso. Le medesime risse si videro in Trapani fra Simone Sanolemente, e Giacomo Fardella; e del pari in Termini, in Randazzo, e in altre città si diffuse lo spirito della sollevazione, altri sostenendo il partito del Moncada, altri volendolo annientare; e in queste tragedie molti furono uccisi, e le case, e i beni delle fazioni opposte furono o saccheggiati, o divorati dal fuoco. 708 Furono questi i due fratelli Francesco, e Niccolò Bologna parenti dello Squarcialupo, che preferivano il ben comune al particolare del loro congionto, cui più volte aveano inutilmente avvertito a ritrarsi dalla malvagia impresa, e inoltre Pompilio Imperatore, Pietro Afflitto, Alfonso Saladino, e Girolamo Imbonetto tutti dell’ordine patrizio. 709 Fazello dec. II, lib. X, tom. II, pag. 207. 706 - 125 - coi suoi compagni di valersi di questa occasione per fare mano bassa contro i sollevati, e trucidarli. Il Pignatelli, sebbene avesse promesso di intervenire a questo congresso, non ebbe animo di venirvi; tale era lo spavento, da cui era assalito, nel considerare l’imminente tragedia; e perciò ai 7 di settembre, senza farne parola a persona, uscì di notte dal suo palagio, accompagnato da un solo fedele servitore, ed imbarcatosi sopra una piccola nave se ne scappò a Messina 710. Spuntato il dì 8 di settembre si seppe la fuga del luogotenente del regno, la quale dispiacque da una parte ai congiurati, che lo riputarono come mancatore, ed infedele, violando la promessa loro fatta di compiere con essi l’opera della riforma, e costernò dall’altra i nobili, che si videro abbandonati, pria che si fosse eseguita la già concertata disfatta dei sollevati. Ma le cose erano così inoltrate, che non era più il caso di ritrarsi dall’impresa. Gli stessi nobili, mormorando della partenza del Pignatelli, suggerirono ai tumultuanti che poco importava se egli fosse, o nò presente, purchè si dasse nel parlamento una forma al governo della scompaginata città, esibendosi di volere essi ancora intervenirvi per cooperare coi loro voti al vantaggio della patria. Caddero nella trappola quei sconsigliati, e chiamarono il popolo alla chiesa dell’Annunziata. I primi ad entrare in quel tempio furono lo Squarcialupo, il Benedetti, e il Rosa, che furono seguiti dal Ventimiglia, dai due Bologni, da Pompilio Imperatore, dal Saladino, dall’Imbonetto, dall’Afflitto, e dagli altri loro compagni; nè i congiurati ebbero verun sospetto di tradimento per parte di costoro. Prima di cominciare la sessione fu creduto opportuno il far celebrare la messa 711. Mentre si assistea da tutti ai divini misteri, Guglielmo Ventimiglia fe’ cenno ai suoi [161] compagni, e immantinente Nicolò Bologna tratta la spada uccise Cristofaro di Benedetto; Pompilio Imperatore dall’altra parte assalì lo Squarcialupo, e trovandolo vestito sotto di corazza, cavato fuori un pugnale glielo conficcò nella gola, e lo fe morire, e Pietro Afflitto che era dietro di Alfonso Rosa, che stavasene ginocchioni ad ascoltar la messa, lo stese facilmente colla spada a terra. Furono trucidati molti altri congiurati dagli altri compagni del Ventimiglia, i di cui nomi la storia ci ha tacciuti. Sagrificati i tre principali capi, che abbiamo mentovati, Guglielmo Ventimiglia, per non dar campo agli altri sollevati di scuotersi dal terrore, e di mettere in tumulto la città, montò a cavallo, andò co’ suoi compagni, che lo seguivano a piedi, girando per le piazze, e gridando: Viva il re e la regina, e muojano i nemici della patria. Si unirono loro alcuni soldati spagnuoli, che spedì il castellano Ercole Infuxa, il che accrebbe il loro coraggio. Francesco Barresi nulla sapea della morte de’ suoi compagni, ma incontrato dal Ventimiglia alla piazza della marina, e avvertito da questi della tragedia accaduta alla Nunziata, deposte le armi, si contentò di andar prigione a Castellammare, salvando per allora la vita. Restava de’ principali Pietro Spadafora, che abitava all’Albergarìa; ma questi, sentendo la disgrazia de’ suoi, era montato a cavallo, e dando di sproni si era salvato fuori della città. Gli altri congiurati si dispersero cercando più tosto di nascondersi, che di continuare nella sedizione 712. Dissipata con un così felice successo la truppa de’ malcontenti, pensò il Ventimiglia di far tosto trasportar nel regio palagio tutte le armi, ch’erano nell’armerìa della città, e i cannoni, ed altre macchine da guerra, che erano su i baluardi, affinchè la plebe scossa dal primo terrore non tornasse a rivoltarsi. Ciò fatto i cavalieri si fortificarono nel detto real palagio, che guarnirono di soldatesche, e spedirono delle pattuglie per la città per custodire le strade, e per assicurarsi di coloro, ch’erano colpevoli di avere aderito alla sedizione. Tranquillata così la città, furono spediti al timido Pignatelli de’ corrieri per assicurarlo che tutto era in calma, giacchè i sollevati o erano morti, o si trovavano nelle carceri; e che perciò potea egli liberamente, e sicuramente ritornarsene. Comunque questa notizia lo rallegrasse, non volle nondimeno avventurarsi a venirsene in Palermo, se non era scortato da una numerosa truppa; e perciò pregò il vicerè di Napoli, acciò gli spedisse delle soldatesche per la sua sicurezza, e per mettere a dovere i sollevati. Gli furono quindi mandati in Messina cinque mila pedoni spagnuoli comandati da Ferdinando Larena, e mille cavalieri, alla testa de’ quali era Giovanni Guevara conte di Potenza. Con questa piccola armata partì il Pignatelli da Messina, e fatto allora coraggioso girò per le città, che aveano tumultuato, per far subire a’ sollevati la pena di aver vilipesa la maestà regia. Venne prima a Randazzo, dove condannò molti a diversi supplizî, e i meno rei alle carceri, dichiarando rubelli, e confiscando li beni a coloro, che se n’erano fuggiti. Da Randazzo passò a Catania, dove fe fare il processo a’ delinquenti, fe’ tagliare la testa a Francesco Asmario, a Francesco Tortoreto, e a Giovanni Arena, altri condannò alla forca, ed altri così nobili, che plebei furono banditi dal regno. A Termini nulla oprò, riserbandosi a gastigare quella città con farvi svernare, come fece, a spese della medesima le truppe, che seco menato avea. In Palermo finalmente, dove era stato il maggior numero de’ congiurati, condannò alla mannaja Francesco Barresi, che abbiamo mentovato, Bartolomeo Squarcialupo fratello di Giovan Luca fumoso 710 Del Carretto, loc. cit. pag. 29. – Fazello ivi. Vi venne dal vicino convento il P. Giacomo Corvello domenicano, il quale restò così abbattuto da ciò, che accadde mentre celebrava, e che noi or ora racconteremo, che infermatosi dal terrore in capo a otto giorni se ne morì. 712 Del Carretto loc. cit. pag. 30. – Fazello dec. II, lib. X, tom. III, pag. 208. 711 - 126 - giureperito, e Giacomo dello stesso cognome, ma non della stessa famiglia, e fe’ mettere a suolo le loro case. Molti rei della plebe morirono col laccio, altri furono condannati alla galea, ed altri ad una perpetua carcere 713 . Così fu gastigata questa sedizione, che per lo spazio di due anni, e mezzo vessato avea la Sicilia, e ritornarono nel regno i lieti, e tranquilli giorni. Arrivavano alla corte le continue notizie di quanto era accaduto in Palermo, e nel regno, ed erane il re Carlo molto afflitto: ma come poi seppe che era per opra di quei cavalieri ritornata la calma, e che dal [162] Pignatelli si era fatta rigorosa giustizia contro i rei, credette estinta interamente la sedizione, e perciò pose in libertà, ed accordò la licenza di ritornare alla patria a’ due conti di Golisano, e di Cammarata, e scrisse al vicerè di Napoli, che dasse lo stesso permesso a’ due marchesi di Geraci, e di Licodìa allontanati più presto per massime politiche, che perchè avessero veruna reità. Per compensare poi in qualche modo i servigî del Pignatelli lo elesse per tre anni col titolo di vicerè di Sicilia, luogotenente, e capitano generale. Il dispaccio di questa elezione è dato in Saragoza a’ 28 di maggio 1518 714. Non si era ancora fatta la funzione di riconoscersi col ligio omaggio i nuovi sovrani. Le vertigini, dalle quali era stato agitato il regno, erano state di ostacolo a questa solennità. Quietata l’isola, il Pignatelli convocò per i 6 di novembre dello stesso anno il general parlamento in Palermo. Nell’apertura di esso espose questo viceregnante, che due erano gli objetti, per cui si era fatta quella radunanza; l’uno perchè egli ricevesse dagli ordini dello stato il giuramento di fedeltà a nome della regina Giovanna e del re Carlo suo figliuolo; e l’altro per dimandare a’ medesimi un sussidio per le continove spese, che soffriva il regio erario a fine di conservare il regno contro le temute invasioni del Turco. Dopo le solite sessioni nel dì 11 dello stesso mese risposero i parlamentarî, ch’erano prontissimi a fare a’ nuovi sovrani il ligio omaggio, e per conto del donativo offerirono trecento mila fiorini da pagarsi senza eccezione veruna da tutti, e colla condizione che fossero comprese in detta offerta le somme innanzi esibite dalla università di Palermo, e da altre comunità separatamente. In questo incontro fu anche fatto al Pignatelli il consueto regalo di cinque mila fiorini, e fu egli dichiarato regnicolo, e per ciò capace di poter ricevere qualunque uffizio, o benefizio nel regno 715. Nello stesso giorno fu fatta la cerimonia del giuramento di fedeltà nelle mani dello stesso vicerè, che ne avea da’ sovrani la speciale procura: ed egli dal suo canto, ed a nome de’ monarchi giurò l’osservanza de’ capitoli, costituzioni, privilegi, immunità, e libertadi accordate dalle maestà loro, o dai loro predecessori agli ecclesiastici, ai baroni, alle città, a’ collegi, alle terre, a’ castelli, e ad altri luoghi del regno 716. Fu eletto per ambasciadore del parlamento lo stesso Pignatelli per recare al regio soglio l’offerta degli ordini dello stato, e chiedere alcune grazie, il quale in forza della podestà, che avea di sostituire, spedì a’ sovrani Niccolò l’Orefice, il quale portatosi in Ispagna ottenne sotto i 12 di maggio 1520 alcune grazie, 717 che possono leggersi nella raccolta dei capitoli del regno 718. Il denaro esibito dal mentovato parlamento ebbe in verità il destino, per cui era stato ricercato. Il re Carlo dispiaciuto delle continove scorrerìe, colle quali gli Algerini vessavano le coste di Spagna, e le città marittime di Napoli, e di Sicilia, si determinò di attaccare quella insolentissima nazione di Mori, che apportava lo spavento, e la desolazione a’ suoi stati, e perciò fe preparare una flotta, il di cui comando affidò ad Ugone Moncada, quello istesso, che fu nostro vicerè, sul di cui valore molto contava, cui ordinò di attaccare la città di Algeri. Messosi alla vela questo ammiraglio, ed arrivato presso quella città, fu assalita la sua squadra da una fiera tempesta il dì di S. Bartolomeo, 24 di agosto 1518, che la dissipò, e distrusse in parte, essendosi rotte in terra venti galee, ed altri vascelli, ed essendo periti quattro mila valorosi spagnuoli; fu perciò obbligato cogli avanzi miserabili della sua flotta di ritirarsi in Ibisa isola della Spagna. Risarcite le navi ebbe ordine di venirsene nel mediterraneo per guardare questo mare dalle incursioni de’ pirati 719. Indirizzò il Moncada le vele verso Trapani. Vuolsi che incontratosi con una [163] flottiglia di nove galee 713 Scrisse il Carretto (pag. 32) che coloro, che aveano ucciso i due giudici della gran corte, ed aveano buttato dalle finestre del regio palagio i loro esangui cadaveri, furono d’ordine del Pignatelli precipitati vivi dalla cima del castello, i quali cadendo, e rompendosi le ossa se ne morirono; ma il Fazello tace questo fatto. 714 Reg. della regia cancellaria dell’anno 1517.1518 VI indiz. pag. 379. 715 Mongit. Parl. gen. t. I, pag. 150 e seg. 716 Mongit. ivi dalla pag. 154, alla pag. 158. 717 Fra queste grazie è degna di essere osservata quella, che sta scritta al capitolo IV del re Carlo (capitoli del regno tom. II, pag. 9) cioè, che non ostante la morte del re, continovino i vicerè nella carica, fino che altrimenti fosse disposto. Questa legge fu fatta per evitare in avvenire i disturbi, che erano accaduti alla morte del re Ferdinando il Cattolico, essendo vicerè Ugone de Moncada, che noi abbiamo descritti nel capo antecedente. Dal che rilevasi che dissero il falso i giureperiti consultati allora dal Moncada, asserendo ch’eravi una prammatica, che prescrivea che i vicerè persistessero nel governo alla morte de’ sovrani, come noi abbiamo ivi avvertito alla nota 3. 718 Tom. I, pag. 5, e seg. 719 Questo fu l’apparente motivo, che si diede a questa spedizione del Moncada; ma la vera ragione, per cui fu mandato, fu appunto per difendere i regni di Napoli, e di Sicilia dalla invasione dei Francesi, essendosi venuto ad una aperta rottura fra Carlo, e Francesco I. re di Francia, che si contrastavano il serto imperiale vacante per la morte dell’imperatore Massimiliano I, che poi ottenne il nostro re Carlo eletto ai 28 di giugno 1519. - 127 - saracene attaccò battaglia, e disgraziatamente perdette due delle sue galee, e fu ferito con un dardo nella faccia, e con una palla di schioppo nella spalla. Dopo questa sventura venne nel porto di Marsala, dove si trattenne per sei mesi dopo che tre anni prima era stato discacciato dalla Sicilia 720. Nell’anno seguente partì Ugone Moncada da Marsala, e andò all’isola delle Gerbe, che conquistò a’ 13 di giugno, e rese tributaria al re di Sicilia, obbligando il signore di essa a pagare l’annuo censo di dodeci mila scudi 721. Mentre accadevano questi fatti in mare, il Pignatelli stavasene tranquillo a reggere il regno di Sicilia; ma nulla in questi primi anni del suo reggimento accadde, che fosse degno di essere registrato 722. Solo sappiamo ch’egli convocò nella città di Messina 723 per i 25 di giugno 1522 il generale parlamento 724, in cui espose, che l’augusto Carlo provocato da Francesco I. re di Francia era stato costretto a tenere in piedi molti eserciti in Ispagna, nelle Fiandre, e nella Italia per conservare i suoi stati; e che inoltre dovea mandarne degli altri in Ungherìa contro il Turco. Richiese perciò a’ parlamentarî, per supplire alle spese di questa guerra, un donativo di trecento mila fiorini, e più, se mai fosse possibile, stanti le ingenti somme, che abbisognavano per il mantenimento di tante armate. Gli ordini dello stato sotto i 29 dello stesso mese risposero alla dimanda del vicerè, facendo l’offerta al re de’ richiesti trecento mila fiorini, e a lui il solito dono di cinque mila. Fu eletto lo stesso conte di Monteleone per ambasciatore del parlamento, il quale nè andò, nè mandò persona alla corte, ma spedì le lettere, che annunziavano l’offerta de’ parlamentarî, e rapportavano la nota delle grazie, che si chiedeano a Cesare, le quali furono con alcune restrizioni accordate a’ 30 di agosto 1523, come costa dal dispaccio sottoscritto in detto giorno nel castello di Valladolid, che fu poi registrato in Palermo a’ 15 di marzo 1525 725. Mentre il Pignatelli dimorava in Messina cadde in una grave infermità nel mese di novembre dello stesso anno; e siccome dubitavasi, che potesse soccombere alla violenza del morbo, per non lasciare il regno senza governatore, scelse, giusta la podestà, che ne avea in caso di morte, due presidenti, Camillo Pignatelli signor di Borrello suo figliuolo, e Giacomo Agliata barone di Castello a mare del Golfo, ch’era luogotenente del maestro giustiziere. Il dispaccio viceregio, con cui eglino erano eletti, fu sottoscritto in Messina a’ 27 di novembre 1522 726. Si riebbe per allora dalla grave malattia, ma entrando il seguente mese di dicembre, tornò per una recidiva ad infermarsi, e con un altro dispaccio de’ 7 di esso mese rinnovò l’elezione dei medesimi nella carica di presidenti del regno 727. Questa ricaduta nondimeno non fu così micidiale, come sospettavasi, essendosi egli ristabilito in salute, ed essendo poi vissuto fino all’anno 1535. Intanto essendo [164] arrivata alla corte la notizia del pericoloso stato, in cui il Pignatelli trovavasi, e dei presidenti da lui eletti, l’augusto Carlo confermò la scelta da lui fatta con dispaccio dato a Valladolid agli 11 di gennaro del seguente anno 1523 728. Questi due presidenti del regno, comunque eletti ben due volte dal Pignatelli, e poi confermati dall’imperatore, non ebbero non ostante giammai l’esercizio di questa carica, non essendosi verificata la morte del vicerè, e restarono perciò col solo onore d’esservi stati prescelti. Arrivando l’anno 1523 si estinse la famosa ribellione, che alcuni Siciliani andavano ordendo, che noi abbiamo differito di raccontare, per darne ora la intera relazione: ribellione, che sarebbe stata fatale alla corona Austriaca, se si fosse compita. Ad intendere questo fatto è di mestieri avvertire, che fra gli esiliati dal Pignatelli per causa della espulsione di Ugone di Moncada, vi furono tre fratelli nobili della famiglia Imperatore, Giovan Vincenzo, Federico, e Francesco, sebbene quest’ultimo non fosse stato in verità bandito per avere avuta parte alla sedizione, ma solo perchè ferito avea Giovanni Cangelosi suo concittadino. Non avendo costoro potuto giammai ottenere il perdono, concepirono da disperati il disegno di togliere la Sicilia 720 Fazello dec. II, lib. X, pag. 209. tom. III. – Maurol. Sic. Hist. lib. VI, pag. 212. Fazello ivi. 722 Potrebbesi solo in questo luogo far menzione della bolla di Leone decimo romano pontefice ai 3 di giugno 1521, che fu promulgata in Palermo ai 6 di settembre dell’anno istesso (registro della libreria del senato di Palermo alla lettera P. 9) sebbene non appartenesse direttamente al nostro regno. Nelle investiture, che i papi accordavano a’ re di Napoli, era sempre preveduto il caso, che alcuno di quei monarchi potesse divenire imperadore di occidente; e allora era stabilito che il regno di Napoli ritornasse in potere della santa sede. Carlo dunque essendo stato eletto imperatore a’ 28 di giugno 1519, pretese Leone X che quel regno fosse ricaduto alla chiesa Romana. Non ostante l’augusto Carlo non intendea di cederlo, ed essendosi trattato questo affare molto tempo in Roma, dove sostenea gl’interessi del monarca delle Spagne il di lui ambasciadore presso quella corte Giovanni Emanuele cavaliere del toson d’oro, finalmente sotto certi patti, e condizioni si contentò Leone X, che non ostante la dignità imperiale, si mantenesse Carlo nel possesso del regno di Napoli. 723 Questo parlamento era stato prima convocato in Palermo; ma nati de’ disturbi per un progetto stravagante del conte di Cammarata, ch’era sostenuto, come fra poco diremo, da molti altri cavalieri, il Pignatelli ne differì le sessioni, ed ordinò che si trasferisse in Messina nel detto giorno, dove poi, carcerato il mentovato conte, e qualcuno de’ suoi aderenti, accadde ogni cosa pacificamente. 724 Mongit. Parl. di Sic. tom. I, p. 158. 725 Capit. regni Sic. tom. II, in Carolo p. 57. 726 Reg. della regia cancellaria dell’anno 1522.1523, XI indiz., p. 86. 727 Nello stesso registro pag. 98. 728 Reg. della regia can. dell’an. 1522.1523 p. 202. 721 - 128 - all’augusto Carlo, e di darla al suo rivale, e nemico Francesco I. Aveano eglino tratti al suo partito Niccolò Vincenzo Leofanti tesoriere di Sicilia, e Giovanni Sanfilippo ambasciadore della città di Palermo alla santa sede, a’ quali si unì ancora Giacomo Spadafora cavaliere messinese. Tutti costoro ritrovavansi a Roma, e s’indirizzarono a Marco Antonio Colonna generale del re di Francia. Questo cavaliere ebbe a caro il progetto, ma non avendo mezzi da eseguirlo, ne scrisse a Francesco I. Il detto sovrano avendo allora in animo di riacquistare lo stato di Milano, che veniva di perdere, sebbene accettasse la offerta, ne differì a miglior tempo la esecuzione. Intanto che si trattava colla Francia questo tradimento, Gian Vincenzo e Federico Imperatore ottennero la grazia di ritornare in Palermo. Lasciarono eglino in Roma Cesare altro loro fratello, che stava a’ servigî del cardinale Pompeo Colonna, che fu incaricato di continuare i maneggi colla corte di Francia, non ostante che i suoi germani avessero ottenuto il desiderato permesso di restituirsi alla patria. Essendo di poi venuta la risposta, che abbiamo riferita di Francesco I, Cesare sotto il pretesto di ripatriare venne a Palermo, e raccontò a’ fratelli lo stato, in cui era il loro progetto. Cercarono perciò Gian Vincenzo, e Federico di farsi uno rispettabile partito, e i primi, a’ quali comunicarono il segreto, furono il conte di Cammarata Federico Abatellis disgustato da molto tempo della corte di Spagna 729, e Gaspare Pepe girgentano, uomo popolare, ma intraprendente, i quali entrarono volentieri in questa cospirazione. Ritornato Cesare Imperatore in Roma vi trovò Pietruccio Gioeni cavaliere catanese, che vi aderì, e si compromise di trarvi anche i suoi concittadini. La morte del generale Colonna, e la viva guerra, che sostenne il re di Francia coll’augusto Carlo ruppero allora le fila di questa tela, sebbene Francesco I. non l’avesse mai persa di vista, e promesso avesse di mandare alla prima occasione una flotta in Sicilia per impossessarsene 730. Il vicerè Pignatelli, uomo dabbene, e poco accorto nel governo, non mai giunse ad aver sospetto di questa trama, quantunque fosse nota a molti. Nel convocare in Palermo il parlamento, di cui abbiamo parlato, che fu poi trasferito a Messina, si accorse, che vi erano dei malcontenti; ma non mai pensò, che potesse esservi un principio di ribellione. Il conte di Cammarata, sebbene convenisse cogli altri di offerire all’imperadore trecento mila fiorini, pretendea nondimeno, che questo denaro si dovesse solamente pagare dai due ordini ecclesiastico, e militare, sperando così di rendersi benevolo il popolo. Si unirono a questo sentimento il tesoriero Leofanti, e un altro Federico Abatellis signore di Cefalà con altri baroni; perciò il vicerè, [165] perchè queste dissensioni non prendessero piede, si attaccò allo espediente di trasportare il parlamento a Messina. Il conte di Cammarata volle tuttavia andarvi, e vi si portò accompagnato da un numeroso stuolo di persone armate. Questa inusitata compagnia diè sospetto, che ei avesse in animo di suscitare nuove turbolenze; e però per ordine del Pignatelli, quando si portò alla sala del parlamento, si vide inaspettatamente circondato dalle milizie, le quali carcerandolo lo condussero immediatamente sopra un naviglio, il di cui padrone ebbe commissione di trasportarlo in Napoli, e di consegnarlo a quel vicerè. La prigionia di questo torbido cavaliere, quantunque fattasi per altro motivo, sconcertò le mire de’ congiurati, i quali temendo che la cospirazione non si discuoprisse, spedirono di nuovo in Francia, per sollecitare la promessa flotta navale, Francesco Imperadore. Costui nel partire confidò la cagione, per cui andava, a Pietro Augello siciliano suo amico, e questi la partecipò a Matteo Graffeo cavaliere palermitano, i quali, o perchè si credessero rei di fellonia se tacevano, o perchè speravano un premio se propalavano il secreto, come scrisse il Fazello 731, ne diedero conto al duca di Sessa ambasciadore presso il pontefice Adriano VI. Questo abile ministro, volendo prevenirne le conseguenze, spedì con diligenza gente armata per assicurarsi di Francesco Imperatore, che fu raggiunto a Castelnuovo, e ricondotto in Roma. Confessò costui all’ambasciadore il suo delitto, e svelò tutta la trama. Fu perciò mandato dal duca di Sessa a Napoli ben custodito, acciò fosse sicuramente trasportato in Sicilia agli ordini del vicerè conte di Monteleone, che fu appieno avvertito della congiura, e dei nomi di coloro, che vi aveano parte. Era il Pignatelli a Messina dopo il parlamento, quando fu avvisato di questa nera trama. Fe perciò tosto imprigionare Niccolò Vincenzo Leofante, e fattolo mettere alla tortura con Francesco Imperatore, ne seppe per minuto tutta l’orditura, e i nomi dei complici, dei quali subito si assicurò, trattine due, che erano scappati 732 , e a forza di tormenti si cavò dalla loro bocca la confessione della propria reità. Il vicerè adunque, 729 Fino dai tempi del re Ferdinando il Cattolico, essendo vacata la contea di Modica, pretese il conte di Cammarata di appartenergli come a colui, che era erede della figliuola di Manfredi Chiaramonte, ch’era stata moglie di Giovanni Abatellis suo bisavolo. Ne fu nondimeno escluso, e ne restò investito il grande almirante di Castiglia parente dello stesso monarca. Ora lusingavasi il conte di Cammarata, che venendo la Sicilia per opra sua in potere dei Francesi, gli sarebbe riuscito agevole il riacquistare questa contèa, a cui credea di avere nitidi dritti, e perciò entrò con piacere in questa congiura tratto dall’interesse, che suole esser la molla di tutte le umane azioni. 730 Fazello dec. II, lib. X, t. III, p. 410, e 411. 731 Dec. II, lib. X, tom. III, pag. 211. 732 Vuolsi che Francesco Imperadore, mentre era prigione in Roma, abbia spedito Claudio Imperadore figliuolo bastardo di Giovan Vincenzo, per avvertire i congiurati; e che questi vestitosi da contadino partisse con una barca, e fosse arrivato in Palermo - 129 - compilatosi il processo, ordinò il dì 16 di giugno 1523, che nella pubblica piazza del Duomo di Messina si ergesse un tribunale, dove furono condotti alla presenza dei giudici i nove congiurati, che erano stati imprigionati, i quali furono dai medesimi condannati a varie pene; ma non fu per allora eseguita la sentenza, che per soli sei 733, agli altri tre si differì il castigo, fino che fosse arrivato da Napoli il conte di Cammarata, acciò colla loro testimonianza convincessero questo illustre magnate di fellonìa 734. Dopo la suddetta esecuzione contro alcuni dei congiurati si manifestò in Messina una micidiale pestilenza, la quale di poi si dilatò, ed afflisse molte città, e terre del regno; e fu così ostinata, passando da un luogo ad un altro, che durò presso a sette anni, non essendosene la Sicilia liberata, che l’anno 1530 735. Il Pignatelli perciò, non tenendosi sicuro in quella città, andossene ad abitare in Milazzo, dove questo male non era penetrato. Ivi dunque giunse da Napoli il conte di Cammarata, il quale sulle prime negò di essere entrato nella congiura, e solo si accusò reo di aver fatto assassinare Francesco Impitone tesoriero del re, perchè costui gli avea fatte delle stiracchiature intorno all’uffizio di maestro portulano, che esso conte esercitava; ma poi convinto dai compagni, e costretto dai tormenti confessò il delitto, e agli 11 di luglio dello stesso anno 1523 ebbe mozzato il capo nella piazza di quella città, [166] e nello stesso giorno furono impiccati il tesoriero Vincenzo Leofante, e Francesco Imperatore, i cadaveri dei quali furono indi squartati. Il signore di Cefalà, perchè era di un parlar vario, nè trovavasi ancor convinto, non subì per allora la dovuta pena; ma di poi ai 18 dello stesso mese fu decapitato nella città di Patti 736. Furono i loro beni acquistati al fisco 737, e così fu estinta questa pericolosa congiura 738. Ci è piacciuto, per non rompere il filo di questo racconto, di rapportarlo per disteso, senza accennare altri incidenti, che durante questa cospirazione accaddero. Dunque nell’anno istesso 1523 arrivarono in Messina i cavalieri di Rodi al primo del mese di maggio, o come scrisse il Maurolico 739 l’ultimo di aprile, dopo di essere stati discacciati da quell’isola da Solimano gran sultano di Costantinopoli, e costretti cogli abitanti a ricoverarsi in Italia. Fu assai compassionevole lo arrivo di questi prodi campioni, le di cui circostanze possono leggersi presso gli storici della religione detta di Malta 740. Il vicerè Ettore Pignatelli con Fabrizio suo fratello, e con Antonio di Lignamine arcivescovo di Messina andò all’incontro del vecchio Villiers dell’isola Adamo, quel valoroso gran maestro, che avea saputo così ben difendersi, nè avea reso l’isola di Rodi, che a vantaggiose condizioni; e dopo di avergli appalesato il suo dispiacere per la disgrazia che veniva di soffrire, gli esibì la città di Messina, quando volesse dimorarvi coi suoi cavalieri. Fu poi a questo gran maestro presentata una mula ben bardata, su cui montò, e prendendo la destra del vicerè, che era ancor egli a cavallo, e volle cedergliela, entrò in città, e venne al palagio di Salimbene Marchese barone della Scaletta, che gli fu assegnata per sua abitazione presso la chiesa di S. Giovanni appartenente al suo ordine, dove potea di leggieri assistere ai divini uffizî. Forse il gran maestro si sarebbe trattenuto in Messina, che era un porto molto opportuno per potere i cavalieri andare in corso contro i Mori; ma la peste, che eravisi introdotta 741, fe’ cambiare sentimenti a questo cavaliere, il quale volendo salvare la sua piccola truppa, dopo due giorni, da che furono giustiziati nella piazza di S. Giovanni i quattro primi congiurati, dei quali si è fatta menzione, cioè ai 18 di giugno, partì accompagnato fino alla barca dallo stesso vicerè, dal senato, e da tutta la nobiltà 742. In questo tempo arrivò al vicerè suddetto una cedola segnata in Pamplona ai 28 di novembre, con cui fu confermato per altri tre anni nel viceregnato di Sicilia 743. cinque giorni prima, che Francesco giungesse in Messina. Non si sa perchè i fratelli di questo non siensi approfittati di questa notizia, e siano caduti nelle mani della giustizia. Egli è certo, che coloro, che si salvarono, furono Perrucchio Gioeni, e Girolamo Leofante. 733 Vincenzo di Benedetto, e Claudio Imperadore, come meno rei, furono condannati all’esilio, e secondo il Fazello (dec. II, lib. X, pag. 212) mandati alla terribile fortezza Xativa nel regno di Valenza; ma secondo il Maurolico (Sic. Hist. lib. IV, pag. 216), ch’era in Messina, a Tripoli. I due fratelli Federico, e Giovan Vincenzo Imperadore, Giacomo Spadafora, e Giovanni Sanfilippo furono tutti e quattro condotti nella piazza di S. Giovanni, dove furono impiccati, e di poi squartati. 734 Furono questi Niccolò Vincenzo Leofante, Federico Abatelli signore di Cefalà, e Francesco Imperatore. 735 Mongit. Sic. ricercata tom. II, pag. 481. 736 Fazello dec. II, lib. X, pag. 214. 737 Le teste del conte di Cammarata, del signor di Cefalà, del Leofante, e di Francesco Imperadore furono mandate in Palermo, e poste nelle gabbie di ferro furono appese al palagio reale per esempio degli altri. Il Fazello (ivi) fa testimonianza che alla sua età ancora vi si osservavano; ma al presente più non veggonsi nè le teste, nè le gabbie: forse il tempo edace le avrà consunte, o le nobili famiglie, alle quali coloro appartenevano, le avranno fatte sparire. 738 Fu anche intrigato in questa congiura il cardinale Imperiale, detto volgarmente il cardinale di Volterra, di cui furono trovate presso Francesco Imperadore alcune lettere scritte al vescovo di Santes suo nipote, colle quali confortava Francesco I. all’impresa di Sicilia. Alle istanze dell’imperadore Carlo V, questo cardinale fu, per ordine del pontefice Adriano VI, carcerato nel castel Sant’Angelo, e gli fu compilato il processo, come a reo di maestà pontifizia (Guicciardini Hist. d’Italia lib. XV, pag. 434 e 435). 739 Sic. Hist. lib. IV, pag. 216. 740 Bosio, Vertot, ed altri. 741 Da ciò scorgesi l’errore del Sampieri (Iconol. di Maria Vergine lib. IV, cap. 10, pag. 486), che sognò che la peste entrò in Messina coll’arrivo di questi cavalieri, i quali scapparono appunto per non esserne attaccati, nè altrove la portarono. 742 Vertot Histoire de Malte lib. IX. 743 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1523.1524 XII indiz. f. 346. - 130 - Da Milazzo, dove era andato durante il contagio a ricoverarsi, il vicerè Pignatelli venne in Palermo, dove per particolare protezione del cielo non era quel male penetrato. Ivi gli arrivò una nuova conferma nel viceregnato sottoscritta dall’augusto Carlo ai 10 di luglio 1524 nella città di Stamburg in Germania, che ei fe’ poi registrare in Palermo ai 28 di ottobre dello stesso anno 744. Convocò dopo il suo arrivo nella capitale ai 30 di marzo dell’anno seguente 1525 il generale parlamento. Nell’apertura di esso espose questo cavaliere le spese ingenti, che avea sostenuto l’augusto Carlo per conservare i suoi stati, e principalmente il regno di Napoli assalito dai Francesi, e chiese trecento mila fiorini, che i parlamentarî, rispondendo alla di lui dimanda il dì 4 del seguente aprile, di buona voglia accordarono al medesimo [167] sovrano colla libertà di farne quell’uso, che gli paresse più conveniente. Fu fatto di poi un atto, con cui furono dichiarati regnicoli, e perciò capaci di concorrere ad ogni benefizio, Camillo Pignatelli, e i di lui tre figliuoli maschi, figlio, e nipoti del vicerè, cui fu anche accordato il solito regalo di cinque mila fiorini 745. Dovendosi di poi mandare un ambasciadore a Cesare per ricercargli alcune grazie, fu lo stesso vicerè eletto a portarne le suppliche all’imperiale trono. Non partì così presto per la corte il Pignatelli, ma differì la sua mossa fino al seguente anno 1526, in cui volendo lasciare un presidente del regno nella sua lontananza in forza della podestà datagli di poter sostituire, elesse ai 6 di luglio Errico de Cardona arcivescovo di Morreale, che fu poi cardinale di Santa Chiesa 746. Dopo di questa elezione andò in Trapani; partì tre volte da quel porto, e vi fu respinto dai venti; ma finalmente con prospero viaggio si mosse per la Spagna, dove arrivato presentò all’augusto Carlo l’offerta del parlamento, e richiese molte grazie così a nome del regno, come in particolare a nome della città di Palermo 747, che furono in parte rimesse all’arbitrio dello stesso vicerè. Queste grazie furono concesse nella città di Granata agli 11 di dicembre dello stesso anno 1526 748. Dopo che Francesco I fatto prigione alla battaglia di Pavia diede i suoi figliuoli il Delfino, e il duca d’Orleans per ostaggi, e così si pacificò apparentemente coll’augusto Carlo, e sortì libero ai 21 di febbraro 1526, nutrendo in cuore la volontà di vendicarsi, nello stesso anno ai 23 di maggio conchiuse una lega col papa Clemente VII, con Arrigo VIII re d’Inghilterra, cogli Svizzeri, coi Veneziani, e coi Fiorentini. Questa lega fu chiamata santa, perchè alla testa di essa eravi il romano pontefice, e quantunque fosse effettivamente contro l’imperadore Carlo V, questi nondimeno non era nominato, e solo attestavano le potenze collegate di essersi confederate per conservare la libertà d’Italia 749. Non vi volle molto ad intendere che a questi principi facea ombra la soverchia, ed illimitata potenza di Cesare, che erasi già reso padrone di tutta la Lombardìa, e lo capì più di ogni altro Carlo istesso, che volendo resistere a questo gran torrente, preparò innumerabili truppe per respingere i suoi nemici dovunque l’attaccavano. Il suo erario per tante spese, che fin’allora fatte avea, era esausto, e perciò non bastandogli i sussidî, che continuamente ricevea dai suoi vasti stati, fu perfino costretto a vendere porzione delle rendite della sua camera. Il nostro regno, che era del pari minacciato dagli eserciti della santa lega, dovette ancor esso concorrere ai bisogni del suo sovrano. Era già ritornato da Spagna Ettore Pignatelli col titolo di duca ottenuto dallo imperadore nel mese di febbraro 1527 750, il quale ebbe ordine di convocare il generale parlamento, che fu intimato in Palermo per li 15 del mese di marzo 1528. Prima di celebrarlo si ammalò gravemente, e perciò fu costretto a destinare di nuovo per presidente [168] del regno l’arcivescovo di Morreale Errico Cardona, come si fa palese dall’atto di elezione fatto in Palermo ai 25 di novembre 1527 751, ed egli cominciò a governarci durante la malattia del vicerè fino ai 12 di febbraro 1528. Ai 13 dello stesso mese riassunse il Pignatelli il 744 Reg. ivi dell’anno 1524.1525 XIII ind. f. 194. Mongit. Parl. di Sic. tom. I, p. 163 e seg. 746 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1525.1526 XIV indiz. f. 647. 747 Fra le grazie richieste a nome della città di Palermo fuvvi un prestito di quindici mila fiorini ad oggetto di potersi fabbricare i panni in detta città. Era stata accordata questa dimanda fin dall’anno 1514 dal re Ferdinando il Cattolico; ma per mancanza di artefici, che non si erano potuti trovare, non ebbe allora esecuzione. Ne fu rinnovata la dimanda all’augusto Carlo, che vi acconsentì. Noi siamo persuasi che l’arte di tessere i panni fosse antica in Palermo, e che poi siesi perduta. Il Baronio (de majestate panormitana lib. I, pag. 160 e 161), parlando di quella contrada, che tuttavia nominasi panneria, pretende che fino dai tempi del re Ruggiero siesi introdotta nel detto luogo codesta arte; ma noi sappiamo che questo re non v’introdusse che i drappi di seta, che diconsi panni serici, e che questi non si fabbricavano, che nel regio palagio. Laonde l’arte di tessere i panni di lana, e il luogo in cui si fabbricavano, li crediamo di una data posteriore. 748 Cap. regni Sic. tom. II, in Carolo V. imper. pag. 71, e seg. 749 Ebbe bene a pentirsi Clemente VII. di essersi imbarazzato in questa lega, essendo stato il primo a provarne i cattivi effetti; avvegnachè ai due di maggio dell’anno 1527 le truppe cesaree presero Roma d’assalto, ed egli fu costretto a ritirarsi a castel Sant’Angelo, dove fu assediato per lo spazio di sette mesi, nè potè sortirne libero, se prima non si umiliò a Cesare, e chiese da lui la pace, che gli fu accordata a durissime condizioni. 750 Non sappiamo precisamente il giorno, in cui il Pignatelli ritornò, ma dovette accadere fra i 17 e i 27 di esso mese, imperocchè nell’uffizio del protonotaro (reg. dell’anno 1526.1527, XV indiz.) ritroviamo che l’arcivescovo di Morreale dispacciò fino ai 17, e che il Pignatelli cominciò a dispacciare in Trapani, dove sarà verisimilmente sbarcato, ai 27 dello stesso mese. 751 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1527.1528 I indiz. f. 144. 745 - 131 - governo 752, e fu in grado di celebrare l’intimato parlamento. Nell’apertura di questa adunanza il duca di Monteleone espose ai parlamentarî le spese ingenti, che l’augusto Carlo avea dovute sostenere, per mettere in piede dei poderosi eserciti ad oggetto di opporli alle armate della lega, e perciò non solo richiese il sussidio triennale di trecento mila fiorini, ma anche la facoltà di poter vendere i beni del real patrimonio fino alla somma di trenta mila scudi, per potere col denaro, che ne avrebbe ritratto, far argine al torrente dei suoi nemici. Accordarono gli ordini dello stato il solito donativo, e fecero un atto, con cui dichiaravano di essere contenti, che lo augusto imperadore potesse vendere sino alla prescritta somma alcuni dei beni del real patrimonio 753. Di più i parlamentarî esibirono al duca di Monteleone di tenere a spese proprie dugento soldati da cavallo armati alla leggiera, con quattro capitani, e quattro alfieri, colla facoltà ad esso vicerè di eleggerli, purchè fossero o siciliani nati, o originati dalla Sicilia 754. Dopo il parlamento il duca di Monteleone andossene a Messina, forse per essere a portata di occorrere ai bisogni di Napoli. Mentre egli era in quella città, successe il secondo, così detto, caso di Sciacca, che sarà sempre memorabile nella nostra istoria. Non eransi mai smorzate le scintille dell’odio antico fra i signori de Luna conti di Caltabellotta, e i Perolli baroni di Pandolfina, che si erano suscitate l’anno 1453 nel primo caso di Sciacca, che noi abbiamo accennato nel libro II di questa storia cronologica 755. Era allora capo della famiglia de Luna Sigismondo giovane coraggioso, e pronto alle più ardite imprese, ed era alla testa dei Perolli Giacomo, il quale oltre di essere ricco, e potentissimo nella città di Sciacca, dove dimorava, ed avea un castello ben munito, ritrovavasi stretto amico del vicerè duca di Monteleone, avendo l’uno, e l’altro servito la regina Elisabetta moglie di Ferdinando il Cattolico nella Paggerìa. Queste circostanze, e in particolare i riguardi, che il Pignatelli usava verso di lui, lo rendevano altiero, ed esercitava in Sciacca una specie di tirannìa. I nobili di questa città soffrivano a malincuore la di lui prepotenza, e unitisi con Sigismondo, che per la vecchia emulazione, e per alcuni nuovi motivi abominava Giacomo, ne giurarono la rovina. Non furono ignote le trame dei suoi nemici a Giacomo, il quale prevedendo ciò, che ne sarebbe avvenuto, ne scrisse ai 6 di luglio 1529 efficacemente al vicerè, acciò vi dasse i pronti ripari. Questi spedì tosto in quella città Giacomo Statella barone di Mongelino cavaliere catanese, quale creò capitano d’armi, con soldatesche, ed ufficiali di giustizia, affin di impedire la civile guerra, che stava per scoppiare. Ci trarrebbe assai a lungo la storia di questa tragedia, se ci piacesse di additarne tutte le minute azioni; chi mai ne fosse curioso potrà leggerle presso il Sevasta 756. Noi diremo brevemente, che le cose erano così inoltrate, che non fu possibile allo Statella di rimediare al male; nei dì 19, 20, 21, 22, e 23 dello stesso mese di luglio corsero in Sciacca fiumi di sangue. Il primo ad essere sagrificato fu lo stesso Statella con tutta la sua gente; fu di poi assalito per tre giorni il castello, dove trovavasi il Perollo, che finalmente cadde nelle mani di Sigismondo de Luna. Il Perollo vedendosi agli estremi si era salvato in casa di un confidente, ma alla fine riconosciuto fu preso, e mentre era condotto alla casa del conte di Caltabellotta, fu ferito, e poi ucciso, prima che salisse le scale, dai masnadieri del conte. L’atroce morte dell’amico, e la fellonìa di Sigismondo de Luna, che avea ucciso il capitan d’armi, e le regie soldatesche spedite dal governo, penetrarono vivamente l’animo del vicerè, il quale col parere del sacro consiglio destinò due giudici della gran corte, Niccolò Pollastra, e Giovanni Ricanati contro il conte di Caltabellotta, e i di lui partitarî. Sigismondo ebbe l’ardimento di fare resistenza a costoro ancora; ma essendosi i giudici rinforzati con una piccola armata d’intorno a [169] due mila soldati per conquiderlo, trovandosi inferiore, scappò colla moglie, e i figliuoli al feudo della Verdura, dove tenea sempre pronto per ogni bisogno un naviglio, e imbarcatosi fuggì ai 13 di agosto, e andossene a Roma, dove era sul soglio pontifizio Clemente VII zio della moglie, sotto i di cui auspicî si ricoverò. Scappata questa preda ai giudici, sequestrarono a nome dell’imperatore tutti i beni del conte, e dei suoi compagni. Venuti poi a Sciacca castigarono i senatori, come rei di non avere impedito la desolazione della loro patria, condannarono ad una grossa ammenda i cittadini, che erano restati inoperosi; e spedendo da per tutto capitani d’armi alla seguela di coloro che n’erano fuggiti, l’ebbero tutti in potere parte uccisi, e parte prigioni, che subirono di poi la meritata pena. Non lasciò Clemente VII. di mediarsi per ottenere al conte Sigismondo la grazia; ma l’augusto Carlo, cui facea orrore il delitto di costui, fu sempre implacabile, e a stento finalmente accordò alla moglie, e ai tre figli del conte, e a Giovanni de Luna padre il perdono, conoscendoli innocenti, rendendo loro i beni confiscati. Raccontasi che Sigismondo, vedendosi chiuso ogni adito ad ottenere la grazia presso l’imperadore, vinto dalla disperazione si fosse buttato nel Tevere. Era il vicerè in Messina, quando accadde in Sciacca la catastrofe, che abbiamo brevemente raccontata. Ivi gli arrivò la conferma per tre altri anni nel viceregnato, la quale gli fu accordata con dispaccio 752 Nello stesso registro pag. 188. Mongit. Parl. di Sic. tom. I, p. 167, e seg, 754 Mongit. ivi pag. 172. 755 Cap. 14. 756 Famoso caso di Sciacca tratt. IV, cap. 12, e seg. 753 - 132 - dell’imperadore sottoscritto nella città di Genova ai 30 di agosto 1529, che poi fu registrato in Messina ai 30 di ottobre dello stesso anno 757. I cavalieri della religione di S. Giovanni Gerosolimitano erano in tal tempo senza una fissa dimora, vagando ora in un luogo, ora in un altro. Cercavano eglino di stabilirsi in una città marittima, da dove potessero agevolmente andare in corso per perseguitare i nemici della cristiana religione. Aveano sperato di ritornare nell’isola di Rodi, e di poi di fare dimora nella città di Modone nella Morèa; ma le pratiche usate nell’una, e nell’altra parte riuscirono vane, essendosi dai Musulmani scoperti i segreti maneggi, che eglino fatti aveano per impossessarsene. Finalmente non trovando altra dimora, si determinarono di accettare l’offerta fattagli dall’augusto Carlo, che esibì loro in feudo l’isola di Malta, e del Gozzo, e la città di Tripoli, essendosi per la mediazione del pontefice Clemente VII moderati alcuni degli articoli, che i ministri di Cesare apposti aveano nella concessione. Il diploma imperiale fu segnato a Castelfranco nel Bolognese ai 24 di marzo 1530, che può leggersi presso il Lunig 758. Fattosi di poi il loro capitolo generale a Siracusa nel dì 15 di aprile, tutti di accordo i cavalieri approvarono il trattato conchiuso da Filippo Villiers loro gran maestro 759. Il pontefice Clemente VII volle ancor egli dar forza, come capo della religione gerosolimitana, a questo trattato con una sua bolla segnata in Roma ai 25 di aprile dello stesso anno 760. Arrivarono i cavalieri, che di poi furono chiamati di Malta, in detta isola ai 26 di ottobre: prima però avea il gran maestro spedito in Sicilia il generale delle galee F. Ugo Caponi con altri cavalieri della religione, i quali ai 29 di maggio dello stesso anno fecero il giuramento di fedeltà nelle mani di Ettore Pignatelli duca di Monteleone vicerè, come si fa palese dall’atto promulgato dal Vertot 761. Nell’anno seguente 1531 ebbe ordine questo vicerè di convocare il generale parlamento. Era l’augusto Carlo vessato in Germania da Solimano, uno dei più guerrieri soldani, che abbia avuto l’impero di Costantinopoli, il [170] quale fino dall’anno 1521 molestava l’Ungherìa, e l’Austria ancora, e sebbene a Cesare sia sempre riuscito di respingerlo, non di meno gli era d’uopo di tenervi delle poderose armate per fargli fronte. L’inquietavano ancora i movimenti suscitati in Germania da Martino Lutero, e per l’una, e l’altra cagione gli fu d’uopo di far viaggi ora in Alemagna, ed ora in Italia per conferire col romano pontefice. Temea ancora che Solimano respinto dall’Ungheria, e dall’Austria non tentasse qualche invasione in Sicilia, e conoscea perciò il bisogno, in cui erano Siracusa, Trapani, e Milazzo di essere ben fortificate ad oggetto di potersi opporre ai tentativi degli Ottomani. Avea egli esausti i suoi tesori, spendendoli per la conservazione dei suoi stati, ed avea bisogno di altri sussidî per l’avvenire. Queste furono le cause, che assegnò il vicerè nell’apertura, per le quali si era convocato il parlamento. Fatte le solite sessioni ai 17 dello stesso mese fu risposto dagli ordini dello stato al medesimo coll’esibizione del solito donativo di trecento mila fiorini, da pagarsi secondo il costume in anni tre, e fu nello stesso tempo accordato ad esso duca di Monteleone il regalo dei cinque mila fiorini 762. Siccome poi interessava assaissimo la conservazione del nostro regno, così per fortificarsi le tre piazze additate di Siracusa, Milazzo, e Trapani, furono offerti altri cento mila fiorini nello spazio di cinque anni 763. Furono in questo parlamento dimandate diverse grazie, e fu eletto lo stesso vicerè Pignatelli per ambasciadore degli ordini dello stato. Non sappiamo che ei si fosse mosso dalla Sicilia per andare in corte, nè che abbia spedito persona, la quale in suo nome presentasse l’offerta, e facesse l’inchiesta di ciò, che i Siciliani desideravano; ma è certo, che l’augusto Carlo in Toledo ai 21 di marzo 1534 rispose a quanto dimandavano i parlamentarî 764, accordando diverse grazie, e riserbandosi di dare per le altre le sue provvidenze più opportunamente 765. 757 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1529.1530 III indiz. fogl. 21. Codex Italiae diplom. t. IV, P. II, p. 1400. 759 Il censo stabilito in riconoscenza del supremo dominio del re di Sicilia sopra le suddette isole non consiste che nell’offerta di un falcone, che il ricevitore di Malta, che dimora in Palermo, a nome della religione presenta al sovrano, se mai vi fosse o al vicerè. Questa funzione fu destinata di farsi, allora al primo di novembre nel dì di tutti i Santi. Di poi regnando Carlo III. re di Spagna fu differita a’ 4 dello stesso mese, ch’era il giorno consegrato al di lui nome, e così si è continuato fino al 1786, ma nell’anno seguente avendo il re aboliti tutti i giorni detti di gala, e stabilito il capo dell’anno per unica solennità, in cui va il senato, la nobiltà, e il ministero al regio palagio a complimentare il vicerè, fu risoluto che anche la presentazione del falcone si facesse nello stesso giorno, come già si è cominciato ad eseguire sono già quattro anni. 760 Vol. Mss. nella libreria del senato di Palermo lett. P. 9. 761 Hist. de Malte lib. IX, t. III, pag. 503. 762 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 173. 763 Mongit. ivi pag. 176. 764 Cap. regni Sic. t. II in Carolo pag. 93. 765 Ci è ignoto per qual ragione alle suppliche fatte dal regno non siesi risposto dall’augusto Carlo che dopo tre anni, e sospettiamo che il vicerè Pignatelli abbia voluto aspettare che questo principe fosse ritornato in Spagna, per farle presentare. Ciò però, che ci arreca maggior meraviglia, è appunto, che l’esecuzione delle dette grazie non ebbe luogo in Sicilia, che 28 anni dopo, che furono accordate, e dopo la morte dell’imperatore, cioè a’ 14 di gennaro 1562 mentre regnava Filippo II, trovandosi vicerè Giacomo della Cerda (Cap. reg. Sic. t. II, pag. 95.) 758 - 133 - Armava una poderosa flotta Solimano in Costantinopoli, e si dubitava che non avesse altro in mira, se non la conquista del regno nostro, e di quello di Napoli. In questo urgentissimo pericolo convenne a Carlo di ordinare che si convocasse un parlamento straordinario per trovare i mezzi da difendere la Sicilia. Fu questo tenuto ai 7 di marzo 1532, nel qual giorno, fatti presenti i timori di essere presto invaso il regno, come ne erano arrivate le notizie da Venezia, e da Ragusa, fe’ il vicerè concepire ai parlamentarî il bisogno, in cui erano di provvedere alla loro sicurezza; e perciò suggerì ai medesimi che si dovessero tosto armare dieci mila fanti per la difesa della Sicilia. Condiscesero a questa proposizione gli ordini dello stato, e si obbligarono a mantenere codesto numero di soldati per lo spazio di due mesi, nel qual tempo si sarebbe facilmente saputo il destino della flotta turca; essendosi obbligati gli ecclesiastici a somministrare il pagamento per due mila, i baroni per quattro mila, e per altrettanti le città demaniali. L’elezione dei capitani, e degli altri uffiziali si lasciava all’arbitrio del vicerè, purchè fossero scelti dei nazionali almeno di origine, e che la scelta si facesse di persone nate, o abitanti nelle città, e terre, che somministravano il denaro per il loro mantenimento 766. Non trascurò l’augusto Carlo di provvedere altronde alla sicurezza della nostra isola rendendosi forte per mare. Era suo ammiraglio il famoso Andrea Doria principe di Melfi, il quale era venuto al di lui soldo, dopo di avere abbandonato Francesco I re di Francia. Questi era l’unico, che potesse far fronte all’invitto Ariadeno comandante delle squadre del gran signore. Era questo conosciuto sotto il nome di Barbarossa, nome che facea tremare i cristiani. Cesare adunque ordinò al Doria, che radunasse colla maggiore sollecitudine una numerosa flotta, e che veleggiasse verso il levante, per impedire, che la classe ottomana entrasse nel [171] mediterraneo. Questi ubbidiente agli augusti comandi raccolse quante galee, e navi potè avere nel regno di Napoli, e fe’ venire quelle, che si armavano in Genova per conto dell’imperadore, e con questa poderosa armata, che oltre le navi era di quaranta galee, giunse a Messina ai 6 di agosto 1532. Fe’ tosto partecipe il duca di Monteleone del suo arrivo, e lo invitò a venire in quella città, giacchè dovea con esso trattare alcuni importanti affari, che interessavano la corona. Il Pignatelli, il quale forse credea, che l’etichetta ricercasse che il Doria venisse a trovarlo in Palermo, s’infinse ammalato e solo gli mandò le quattro galee siciliane, che erano nel nostro porto. Il principe di Melfi, che era abbastanza altiero, rispedì le dette galee in Palermo, alle quali ne aggiunse altre quattro delle sue, e fe’ nuove premure, affinchè il vicerè facesse questo viaggio, così ricercando il servizio di sua maestà Cesarea. Bisognò che il Pignatelli si arrendesse, ed imbarcatosi prese la via di Messina, dove giunse ai 18 dello stesso mese di agosto. Fu incontrato dallo stesso Doria, che lo ricevette nella sua galea capitana 767. Sbarcando ambedue alla porta della dogana, incontrati dall’arcivescovo, dallo strategoto, dal senato, e dalla nobiltà, andarono al regio palagio, dove furono fatte le conferenze 768. Era l’imperadore Carlo V ritornato dalla Germania in Italia sulla fine dell’anno 1532, e si era fermato in Modena, aspettando che il pontefice Clemente VII fosse venuto a Bologna, con cui dovea conferire due affari di somma importanza, cioè la lega dei principi Cristiani contro Solimano, e l’estinzione dell’eresìa di Martino Lutero. Il papa arrivò nella mentovata città agli otto di dicembre, dove si trasferì subito Cesare, e si intrattenne con esso per tutto il mese di febbraro dell’anno 1533. Mentre l’augusto Carlo era a Bologna confermò il duca di Monteleone per un altro triennio nel viceregnato di Sicilia. Questa fu l’ultima proroga ch’egli ottenesse. Il dispaccio è dato in essa città ai 12 dello stesso mese di febbraro, e fu poi registrato in Messina ai 27 del seguente maggio 769. Si trattenne il duca di Monteleone in Messina fino al mese di maggio dell’anno 1534. Avea egli avuta la commissione dall’imperatore di convocare un parlamento straordinario la di cui apertura fu disegnata per li 26 di aprile, nel qual giorno radunatisi i parlamentarî udirono le cagioni, per cui erano stati congregati: cioè a dire per ottenere un donativo straordinario di trecento mila fiorini, per far continuare il mantenimento dei dieci mila soldati per la custodia del regno, e per contentarsi gli ordini dello stato, che si alienassero tanti beni patrimoniali, quanti importassero la somma di cinquanta mila scudi annuali. Accudirono ben volentieri alle dimande i parlamentarî, i quali non intralasciarono di fare il solito dono di cinque mila fiorini al vicerè 770 . Un altro parlamento straordinario fu tenuto in questo stesso anno nel mese di settembre nella città di Palermo, dove da Messina si trasferì il duca di Monteleone. Fu intimato per il dì 13 di detto mese, venuto il qual giorno, il vicerè rappresentò ai parlamentarî, che la flotta turca avea poggiato verso ponente, e che era fama che Barbarossa si fosse impossessato della città, e del porto di Tunisi, per la di cui vicinanza era da temersi qualche invasione; giacchè in meno di due giorni potea Ariadeno comparire colla sua armata nei nostri mari. Mostrò perciò, che maggiori sarebbono così stati i pericoli del regno, e che quindi era necessario 766 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 179. Fu osservato allora che la galea siciliana, nella quale era il vicerè; tenne sempre alzato il pennone in presenza dell’ammiraglio, nè lo calò se non quando il Pignatelli entrò nella galea comandata dal Doria (Maur. Sic. Hist. lib. VI, pag. 120). 768 Maur. Sic. Hist. lib. VI, pag. 220. 769 Reg. della regia cancellaria dell’anno 1532.1533, IV indiz. fogl. 322. 770 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 189. 767 - 134 - di stare all’erta più di prima. A questo oggetto propose, che il denaro promesso dai parlamentarî per mantenere i dieci mila fanti fino a tutto il mese di dicembre, si accrescesse, acciò questa truppa continuasse a servire per tutto l’anno 1535. Che se paresse al sovrano, che fosse più espediente di armare per mare, allora il denaro in vece di erogarsi per il mantenimento delle truppe di terra, s’impiegasse per tenere una flottiglia, che unita alla flotta di sua maestà Cesarea tenesse lontani i Tunisini dai mari di Sicilia. Divennero gli ordini dello stato a prorogare il mantenimento dei dieci mila fanti per tutto il seguente anno, e lasciarono in libertà del vicerè lo [172] spendere quanto il regno contribuiva o per il soldo dei detti soldati, o per una spedizione marittima, o parte per le truppe di terra, parte per quelle di mare 771. Continuò in Palermo a stare il duca di Monteleone in vita fino al mese di marzo del seguente anno 1535, e nel settimo giorno di detto mese verso le ore tre finì di vivere 772. Erasi egli gravemente infermato sugli ultimi di febbraro, e vedendosi vicino a morte, per non lasciare il regno senza un governante, si determinò di dare un successore in forza del dispaccio, che avea ottenuto fin dall’anno 1534, confermato poi dalle seguenti cedole, in cui segli dava la facoltà di scegliersi uno, o più presidenti del regno nel caso, che andasse a soccombere; ed elesse a’ 2 di marzo Simone Ventimiglia marchese di Geraci 773. Durò egli nel viceregnato dall’anno 1517 fino all’anno 1535, cioè anni diciotto. Non fu questo cavaliere nè prode capitano, nè fino politico. Le sue azioni, che abbiamo raccontate, lo palesano per un uomo dottante, e irresoluto. Trovossi egli in verità in circostanze assai critiche, per le quali restò l’animo suo sempre inquieto; ma s’egli fosse stato più accorto, e avesse saputo prevedere le sedizioni, e castigarle nel loro nascere con coraggio, e risolutamente, sarebbe stato certamente meno turbolento il di lui governo. Ciò non ostante bisogna esser d’accordo ch’ei fu un vicerè amante della giustizia, pieno d’umanità, e pio. Noi dobbiamo alla di lui devozione verso il Patriarca S. Francesco di Paola suo compadre l’erezione, e la dotazione del monistero de’ Sette Angioli detto dal suo cognome de’ Pignatelli di monache Paoline, fatta in Palermo l’anno dell’era nostra cristiana 1532. Ci avvisa il padre Gaetani 774, che fu trovata l’anno 1516, in questa città una immagine de’ Sette Angioli, e che allora fu eretta una chiesetta in onore de’ medesimi. Venendo poi il duca di Monteleone, volle istituirvi una compagnia, che fe’ chiamare Imperiale, a cui egli stesso si arrollò, mettendo l’augusto Carlo, la città di Palermo, e il regno tutto sotto gli auspicî de’ Sette Angioli, ed eleggendovi un sacerdote che la reggesse, cui fu assegnata una rendita per sè, e per il mantenimento della chiesa, e della compagnia. Crescendo poi in esso la pietà verso i santi Angioli, volle fabbricarvi una badia di monache, sotto l’ordine di S. Francesco di Paola, di cui era divotissimo. Anche il convento de’ religiosi Paolotti, che sta fuori la porta di Carini, ed è dedicato a S. Oliva, fu opera della generosità del duca di Monteleone. Devesi ancora al medesimo la fondazione della nobile compagnia della Carità fattasi in Palermo l’anno 1533 775, il di cui principale istituto è quello di visitare giornalmente, e servire gl’infermi dell’ospedale di S. Bartolomeo, detto degli incurabili, presso la porta Felice, che guida al mare 776. L’amore suo per la giustizia rilevasi e dalle sue operazioni, e dalle utili leggi, e prammatiche, che questo buon vicerè 777 ci lasciò, le quali possono leggersi parte ne’ capitoli [173] del regno 778, e parte nelle prammatiche 779. La pompa funebre fatta nella di lui esequie fu assai splendida, e magnifica. Il di lui cadavere fu per allora sepolto nella chiesa di S. Maria degli Angioli de’ PP. Minori Osservanti, e di poi fu trasportato in Monteleone di Calabria suo feudo. 771 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 190. L’Auria (Cronol. dei signori vicerè p. 33), il Caruso (Mem. Stor. P. III, lib. VIII t. III, vol. II, p. 149), ed altri fissano la morte di questo vicerè nel mese di marzo 1534, ma si sono ingannati. Fu egli presente nei parlamenti or ora mentovati nel mese di maggio, e nel mese di settembre 1534, tenuti l’uno in Messina, e l’altro in Palermo, come si osserva nell’officina del regio protonotaro (registro dell’an. 1533.1534, ind. VII f. 322, e registro dell’anno 1534.1535, VIII indiz. fogl. 76), di modo che bisogna convenire ch’ei fosse vivo fino a’ 17 di settembre 1534; ma la prova maggiore è il dispaccio, che ora si apporterà dei 2 di marzo 1535, per cui dichiarò presidente del regno il marchese di Geraci. 773 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1534.1535 VIII indiz. f. 322. 774 Vitae Sanct. Siculorum t. II, p. 266. 775 Furono promotori di questa caritatevole opera due ottimi religiosi, cioè Fra Giovanni Battista da Ravenna carmelitano, e Fra Raffaello da Siena dell’ordine di S. Agostino. 776 Cannizzaro de religione Panormitana pag. 441. 777 Sembra che il Caruso (Mem. Stor. t. III, P. III, lib. VIII, vol. V, p. 149) non abbia avuta così buona opinione della condotta di questo vicerè; imperocchè raccontando la di lui morte, avverte, che ei poco prima di morire era stato chiamato alla corte di Spagna per giustificarsi. Su qual fondamento si appoggi questo scrittore è a noi ignoto, giacchè non addita verun monumento, da cui abbia tratto questo aneddoto, che ci pare inverisimile non meno per il silenzio di tutti gli altri storici, che per le replicate conferme, ch’egli ottenne nel viceregnato, e per l’ultima dell’anno 1533, che Cesare non avrebbe accordata, se avesse avuta ombra di sospetto, ch’ei si fosse malamente regolato nel governo del regno di Sicilia. Non intendiamo dipingerlo per un governante privo d’ogni menomo difetto, come per tale non l’abbiamo descritto, ma per un ottimo vicerè, persuasi della massima di Giovenale (Sat. XIII). Rari quippe boni numero; vix sunt totidem, quot Thebarum portae, vel divitis ostia Nili. 778 Cap. regni Sic. t. II, p. 28. 779 T. I, tit. II. pragm. IV, e V. 772 - 135 - CAPO III. Simone Ventimiglia marchese di Geraci presidente del regno. Non durò in questa sua presidenza del regno il marchese di Geraci Simone Ventimiglia, che appena sette mesi, nel qual tempo non si occupò in altro principalmente, che nell’agevolare la grande impresa di Tunisi, alla quale era inteso l’augusto Carlo. Già si è detto come il Barbarossa se n’era reso padrone, e come temeasi di ora in ora, che questo uomo intraprendente non tentasse di conquistare la Sicilia. Carlo, i di cui stati d’Italia venivano colla vicinanza di questo corsaro minacciati, si fissò in capo di farnelo snidare 780. Preparò adunque a questo oggetto una poderosa armata, che dal Giovio scrittore di quei tempi si fa montare 781 a settecento vele; ma da Federigo del Carretto autore ancor esso contemporaneo 782, e Siciliano a trecento quaranta legni, cioè a cento tra galee, e caravelle portoghesi, e ad altre dugento quaranta navi da trasporto. Da Genova vennero trenta galee; il pontefice Paolo III ne somministrò dodici comandate da Virginio Orsini, e molte altre galee con navi di carico, che portavano viveri, e provvigioni da guerra, doveano unirsi all’armata cesarea. Tutte queste galee, e navi vennero nel mese di maggio di questo anno 1535, in Palermo 783 , dove mandò il gran maestro di Malta quattro altro galee cariche di milizia, e inoltre un vascello, che portava cannoni, colubrine, armi, polvere, palle, ed altri attrezzi di guerra. Vi si unirono ancora alcune galee, e navi siciliane fabbricate negli arsenali di essa capitale, e di Messina, e fra queste galee ne fe’ costruire a sue spese due Giovanni Aragona marchese di Eraclèa, uno de’ principali magnati del regno, sulle quali s’imbarcarono molti giovani siciliani, i quali pieni di coraggio voleano tentare la sorte delle armi in questa spedizione. Questi venivano accompagnati da un’altra barca, la quale portava le vettovaglie, e le munizioni da guerra per servizio di essi. Avvisato l’augusto Carlo che l’armata destinata in Palermo era già pronta, e vicina a partire per l’Affrica, s’imbarcò da Barcellona al primo di giugno nella galea, che era venuta da Genova coll’ammiraglio Doria; e accompagnato dalle triremi di Spagna, e dalle caravelle portoghesi, prese la stessa strada, per unirsi alla flotta partita dalla capitale, e marciare verso Tunisi. Le due squadre si unirono a Cagliari capitale della Sardegna, d’onde veleggiando con prosperi venti in capo a cinque giorni arrivarono al porto Farina, che viene ancor chiamato capo d’Utica. Noi non accompagneremo questo augusto a Tunisi, nè rapporteremo ciò ch’ei vi operò col senno, e colla mano, giacchè questo racconto ci distrarrebbe di molto dal nostro argomento. Saremo solamente contenti di dire, che Carlo prima s’impossessò della Goletta, e poi inoltrandosi verso la città di Tunisi, ebbe nelle mani la medesima, e il castello ancora; che il Barbarossa se ne fuggi a Costantina, e che fu da esso Augusto intronizzato nel detto regno Mulei-Assen, che si costituì tributario al medesimo, ed accordò condizioni molto vantaggiose alla corona di [174] Spagna, e a’ regni, che Carlo possedeva in Italia 784 . Discacciato Ariadeno, e conquistato il regno di Tunisi, Carlo s’imbarcò contento di questa felice impresa, e soffiando i venti meridionali venne prima all’isola della Pantelleria, si avvicinò di poi a quella della Favignana, e del Marettimo, e giunse finalmente in Trapani a’ 20 di agosto con porzione dell’armata, avendo rimandata l’altra in Spagna colle caravelle del Portogallo. Dopo di essersi in quella città riposato alquanti giorni 785, e ristorato da’ patimenti, che per le fatiche della guerra, e i disastri del viaggio avea sofferto, pensò di portarsi alla capitale. Partitosi adunque da Trapani passò per Alcamo, e venne a Morreale, dove si trattenne qualche giorno, aspettando che fosse preparata ogni cosa per la sua entrata. Il presidente del regno Simone Ventimiglia coi magistrati, e con molta nobiltà partì da Palermo per andare incontro all’augusto sovrano, che trovò nel bosco di Partenico, e vi fu graziosamente accolto. Accompagnatolo sino a Morreale ritornò in Palermo per far disporre tutto ciò, ch’era necessario per ricevere, come si conveniva, questo gran principe, sebbene per la vicinanza con la città andasse spesso ad ossequiarlo. 780 Era signore di Tunisi Mulei-Assen, il quale era principe crudele, e avea fatto morire tutti i suoi fratelli, trattone uno, che si era salvato per ventura. Costui vedendosi sbalzato dalla sua signoria dal Barbarossa, considerò che non vi fosse altro mezzo per ritornavi, che quello di ricorrere a’ principi cristiani, a’ quali dava ombra un vicino così intraprendente, qual era Ariadeno. Venne dunque in Sicilia, s’è vero quanto scrisse il Caruso (Mem. Stor. P. III, lib. VIII, t. III, vol. V, p. 149), e da questo regno passò in Spagna, dove fece all’augusto Carlo la proferta di rendersi tributario del medesimo, ogni volta che fosse rimesso nel suo regno. L’imperatorc per assicurare i suoi due regni di Napoli, e di Sicilia dalle incursioni del Barbarossa, accettò l’offerta, e si accinse a questa impresa. 781 Libro XXVIII, ad ann. 1535. 782 De bello Africano lib. I, nel primo tomo della Raccolta di opuscoli di autori siciliani p. 47. 783 Del Carretto loc. cit. p. 46. 784 Del Carretto de bello Africano lib. II, pag. 70 e seg. Sandoval vida de Carlos l’Emperador V. tom. I, p. 385, e seg. 785 Scrisse il Caruso, ch’ei si fermò in Trapani soli quattro giorni (Mem. Stor. P. III, lib. VIII, t. III, vol. V, p. 150) ma s’inganna all’ingrosso; imperocchè il Sandoval (vida del Emperador Carlos V. lib. XXII, t. II, p. 292) rapporta copia di una letttera tratta dal suo originale, che l’augusto imperatore scrisse al Marchese di Canneto vicerè di Navarra, la quale è data in Trapani l’ultimo giorno di agosto, dal che rilevasi, che per lo meno vi dimorò dodici giorni, supposto ancora che ne fosse partito il primo di settembre, tanti correndone dai 20 di agosto, quando arrivò in quella città, ai 31 di esso mese. - 136 - Entrò in Palermo l’augusto Carlo nel dì 13 di settembre, montando su di un bellissimo, e ben bardato cavallo, che gli fu regalato dal senato di Palermo. Il Carretto ci descrive eloquentemente 786 l’ingresso dell’imperadore, e tutta la pompa, con cui fu ricevuto, e le feste, e le giostre 787, che furono fatte in questa fausta occasione. Si trattenne l’imperadore in questa città intorno a un mese, nel quale, sebbene fosse cessata ogni autorità nel marchese di Geraci presidente del regno, essendo presente il sovrano, non dimeno noi troviamo che fino a’ 15 del mese questi dispacciò 788. Forse Carlo nei primi tre giorni non volle applicarsi al governo, e lasciò che continuasse a reggere Simone Ventimiglia. Trascorsi questi giorni, che furono impiegati nel ricevere i complimenti de’ magistrati, e della nobiltà, e nell’ascoltare gli ambasciadori delle altre città, che venivano a rallegrarsi del felice successo delle sue armi in Tunisi, e del suo prospero arrivo in Sicilia, si applicò l’augusto principe agl’interessi del regno, dando le necessarie provvidenze per la felicità de’ suoi sudditi. Volle egli informarsi della polizia civile della capitale, come delle altre città: esaminò la maniera, con cui i magistrati amministravano la giustizia, e visitò ancora i regî archivî 789. Ciò fatto volle tenere questo imperadore il parlamento generale nel suo palagio, dove dimorava, della famiglia Ajutamicristo, che oggi appartiene a’ principi di Paternò, e ne stabilì l’apertura a’ 16 di settembre. Arrivato questo giorno ei assiso in soglio parlò per bocca del protonotaro Ludovico Sances 790 agli ordini dello stato, mostrando loro il piacere di aver visitato questo regno, come ei desiderato avea da che era arrivato alla [175] monarchia di Spagna, tanto per conoscere vassalli così fedeli, come per rimediare ad alcuni inconvenienti, principalmente sull’amministrazione della giustizia, intorno ai quali gli erano arrivate le querele della nazione; ma che le sue circostanze non gliel’aveano finallora permesso. Ora però ch’era andato a Tunisi per benefizio della repubblica cristiana, e di questo regno, e che gli era riuscito di farne sloggiare il corsaro Barbarossa, avea risoluto, prima di ritornare in Spagna, malgrado la sua malsana salute per le fatiche della guerra, e dei viaggi, di compiere, come avea fatto, questo suo desiderio. Dopo questo grazioso preambolo rappresentò loro le grandissime spese, che si erano fatte per questa impresa, e quelle che tuttavia far si doveano, per difendere questo regno; e li esortò, giacchè si trattava del loro benefizio, e di mantenere la cristiana religione, acciò col solito amore, e colla sincera fedeltà mostratagli in ogni tempo, si determinassero a contribuire straordinariamente una buona somma di denaro, con cui potesse egli supplire ai bisogni di questa impresa 791. Conobbero i parlamentarî quanto giuste fossero le cagioni, che spronavano l’augusto principe a dimandare questo sussidio, e dopo le sessioni tenute a questo oggetto, ai 22 dello stesso mese esibirono alla maestà sua un donativo straordinario di dugento cinquanta mila docati da pagarsi nello spazio di soli quattro mesi, giusta la ripartizione, ch’eglino ne fecero 792, mostrando così la loro riconoscenza per averli liberati dall’imminente pericolo del corsaro Ariadeno, e per aver loro fatto l’onore di visitarli. In questo incontro lo supplicarono, che si degnasse di riformare gli abusi, che si erano introdotti nell’amministrazione della giustizia, e di accordare alcune grazie, che conducevano al benefizio del regno 793. Queste grazie, che si richiesero dal parlamento, non furono che ventiquattro, alle quali fe’ S. M. imperiale agli 6 del seguente ottobre, prima di partire da Palermo, le sue risposte, come può osservarsi ne’ capitoli del regno 794. 786 De bello Africano lib. II, p. 75, e seg. Il Bonfiglio (Hist. di Sic. lib. III, parte II, p. 443) racconta, che nella famosa giostra, che si fece innanzi Carlo il giorno dietro al suo arrivo, furono dai Palermitani eletti per giudici in questo dibattimento i quattro ambasciadori della città di Messina, i quali decisero a favore di Pietro Ribera cavaliere palermitano. Noi non abbiamo altra testimonianza di questo fatto, e perciò ne sospendiamo il giudizio. 788 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1535.1536 IX indiz. fog. 10. 789 Siccome non avvisò che dovea far questa visita, così trovò che gli archivarii non aveano fatto veruno preparativo per riceverlo: ma l’umano principe, che non volea complimenti, si contentò di quei comodi, che vi trovò. Nell’archivio del protonotaro si osserva ancora appesa al muro una sedia di semplice legno, dove si assise l’augusto sovrano visitando quell’archivio, la quale in memoria si è conservata coll’iscrizione: Sedia di Carlo V. 790 La etichetta, e la gravità spagnuola ricercava, che nè il re, nè chi ne facesse le veci parlasse da sè nelle adunanze parlamentarie, ma che spiegassero i loro sentimenti per via del gran cancelliero, o del protonotaro. Questo costume si è conservato fra noi fino all’età nostra; ma nel viceregnato di Domenico Caraccioli marchese di Villamaina si è cominciata a sentire la voce dei governanti. 791 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 193, e seg. Registro dell’officina del protonotaro dell’anno 1535.1536 IX indiz. fogl. 20. 792 Difficoltavano allora gli ecclesiastici in forza delle canoniche sanzioni, e particolarmente per ciò che si era determinato nell’ultimo concilio del Laterano sotto Leone X, di pagare la loro quota del donativo, se non precedea il pontifizio rescritto, per non essere soggetti alle censure, e alle pene minacciate a’ controventori dal detto Sinodale Decreto. L’augusto Carlo perciò ne fe’ la dimanda al pontefice Paolo III, che con sua bolla dei 14 di febbraro 1536 diede la facoltà agli arcivescovi, a’ vescovi, agli abati, agli archimandriti, ed alle altre persone ecclesiastiche, di pagare la somma tassata in questo parlamento al braccio ecclesiastico, qual bolla fu registrata nell’officina del protonotaro (Reg. dell’anno 1535.1536 IX indiz. f. 153). Così sempre si è fatto; ma da pochi anni non si è creduto necessario di domandare questa permissione da Roma. 793 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 197, e seg. 794 Tom. I, in Carolo V. imper. p. 120 e seg. 787 - 137 - Conchiuso il parlamento, e dato l’ordine al buon governo della Sicilia, si dispose l’augusto principe a partirsi. Avrebbe egli desiderato di trattenersi di più nella capitale; ma volendo visitare il regno di Napoli, e dovendo poi passare in Roma per trattare col papa alcuni affari di molta considerazione, fu costretto ad abbandonarla. Parti egli a’ l4 di ottobre, e prese la via di Termini; di là passò per Polizzi, per Traina, per Randazzo, e per Taormina, e finalmente si ridusse a Messina, e si fermò nel monistero di S. Placido a’ 20 dello stesso mese. Entrò poi in città nel seguente giorno, dove fu ricevuto con pari pompa, che in Palermo, da quei nobili, e cittadini 795. Vi si fermò fino a’ 3 del seguente novembre, nel qual giorno con due galee passò lo stretto, e andò in Calabria 796; e attraversandola, e scorsa indi la Basilicata giunse a Napoli a’ 25 dello stesso mese. Prima di partire da Messina pubblicò varie prammatiche utili al regno, e dichiarò vicerè di Sicilia Ferdinando Gonzaga. [176] CAPO IV. Ferdinando Gonzaga vicerè. Giovanni Moncada maestro giustiziere, Arnaldo Albertino vescovo di Patti, Giovanni Aragona marchese di Terranova, Ambrogio Santapau marchese di Licodìa, Simone Ventimiglia marchese di Geraci, Alfonso de Cardona conte di Chiusa, Giovanni d’Aragona nuovamente eletto, e per la seconda volta Ambrogio Santapau presidenti del regno, e separatamente in diversi tempi. Era espediente che Carlo lasciasse al governo di Sicilia un vicerè, che fosse insieme eccellente politico, e valoroso capitano. I Tunisini erano malcontenti di Mulei-Assen uomo crudelissimo; e appena partito l’augusto Carlo, aveano cominciato a tumultuare; per cui bisognò che vi tornasse Andrea Doria, per frenare il loro ardire. Ed era perciò a temersi, ch’eglino un giorno, o l’altro non l’uccidessero, o lo discacciassero, che non richiamassero Barbarossa, il quale reso più forte non avrebbe lasciata invendicata l’offesa, che credea di avere ricevuta dall’imperadore, vengiandosene contro il vicino regno di Sicilia. Davano anche ombra i preparamenti, che stava facendo Solimano in Costantinopoli, di una poderosa armata marittima, e si sospettava ch’egli irritato, perchè il suo caro Ariadeno era stato discacciato da Tunisi, volesse per diritto di rappresaglia discacciare Cesare dal possesso della nostra isola. Ecco perchè piacque a questo principe di confidare la custodia nostra al Gonzaga. Questo cavaliere in verità avea tutti i requisiti per reggerci, e custodirci; avvegnachè, quantunque ancor giovane, era saggio, ed ornato di virtù, ed oltre a ciò era riputato per uno dei più bravi capitani, che avesse l’imperadore, come ne avea date recenti riprove così nell’impresa di Tunisi, in cui avea accompagnato il suo monarca, come nelle rivoluzioni dei Tunisini, che abbiamo accennato, quando fu mandato con Andrea Doria per comandare le truppe terrestri, avendo egli col suo coraggio molto cooperato ad estinguere la nata sollevazione. Eletto adunque Ferdinando al viceregnato di Sicilia, mentre stava ai fianchi dell’augusto Carlo in Messina, tostochè questo principe partì per la Calabria, prese il possesso lo stesso giorno della sua carica, e si dispose a partire per la capitale. Si mosse egli da Messina, conducendo i magistrati che erano ivi, agli 11 di novembre, e venne a Palermo 797. Non era appena arrivato, che fu costretto a partire, e ad abbandonare la Sicilia. Il re Carlo lo chiamò a Napoli per spedirlo alla difesa degli stati di Carlo III. di Savoja 798. Elesse perciò per presidente del regno Giovanni Moncada primo conte di Aitona, ch’era siniscalco di Aragona, e di Catalogna, e maestro giustiziere di Sicilia. Il dispaccio viceregio, in cui il Gonzaga solo dice di doversi portare in Napoli per alcuni affari 795 Il Bonfiglio descrive (Hist. di Sic. P. II, lib. III, p. 444) quanto oprarono i Messinesi per onorare l’imperadore, e fra l’altre cose racconta, ch’eglino gli fecero un donativo straordinario di tredici mila docati d’oro, ch’erano chiamati trionfi, e dice che questo dono fu assai gradito da Cesare, molto più ch’era offerto dietro a quello di dugento cinquanta mila docati fatto dal parlamento, alla quale contribuzione aveano ancor concorso i Messinesi. A noi fa grande impressione il silenzio del Maurolico autore contemporaneo, che fu presente a questa solennità, il quale nulla ci dice altro, se non che furono apparate le case, preparate delle caccie, e fatte altre spese dal pubblico: Diversoria, et hospita omni apparatu instructa, venationes ferarum exhibitas, et caetera publico sumctu subministrata. 796 Maurol. Sic. Hist. lib. VI pag. 222. 797 Maurolico Sic. Hist. lib. VI pag. 222. 798 Era morto a’ 24 di ottobre 1535, Francesco Sforza duca di Milano, senza lasciare eredi. L’augusto Carlo, che n’ebbe la notizia, mentre era in Napoli, pretese, che trovandosi estinta la linea sforzesca, quel ducato decadeva all’impero, e perciò spedì Antonio di Leva a prenderne il possesso. Francesco I, che credea di avervi de’ diritti, incaricò il suo ambasciadore che stava presso l’imperadore, acciò dimandasse in suo nome l’investitura di Milano, e non avendo ricevuta una risposta gradevole, pensò d’impossessarsene colle armi, e dimandò il passaggio per le Alpi delle sue truppe dal duca di Savoja. Questi essendosi negato, Francesco ne invase gli stati, ed occupò una buona parte del Piemonte, e della Savoja. Non avendo quel duca forze bastanti da respingerlo, ricorse al cognato l’augusto Carlo, il quale volendo soccorrerlo, ed insieme difendere il ducato di Milano, ordinò che se gli spedissero tutte le truppe, ch’erano in Lombardia al suo servigio, e chiamò dalla Sicilia il prode Gonzaga, acciò andasse a comandare la cavalleria Cesarea. - 138 - riguardanti il servigio di S. I. M., fu sottoscritto in Palermo a’ 20 di dicembre 1535 799. La di lui partenza dovette essere immediata, trovando noi dei dispacci sottoscritti dal nuovo presidente in Messina l’ultimo dì dello stesso mese di dicembre 800. L’imperadore approvò l’elezione del maestro giustiziere per presidente del regno, e la confermò con un altro dispaccio dato in Napoli a’ 12 di gennaro dell’anno di appresso 1535, che fu registrato in Palermo a’ 4 del seguente febbraro 801. Quel che si avesse fatto il Gonzaga nella guerra del Piemonte, non è del nostro argomento il riferirlo. L’esito delle armi cesaree fu infelice, l’augusto Carlo portando la guerra nel cuore della Francia con una [177] poderosa armata di cinquanta mila fanti, e trenta mila cavalli, oltre la flotta, che comandava Andrea Doria, ebbe la peggio, e fu costretto a ritornare in Italia. Ivi trattenutosi qualche tempo, e lasciando il marchese del Vasto per governatore di Milano, con una armata andò a Genova, e a’ 15 di novembre s’imbarcò, e ritornò in Ispagna. Fu allora incaricato il Gonzaga di ritornare al governo di Sicilia, dove noi crediamo che fosse arrivato nel mese di marzo 1537, giacchè l’ultimo dispaccio del maestro giustiziere è de’ 12 dello stesso mese 802. Era pur troppo necessaria alla Sicilia la dimora di questo vicerè, non già che si temessero i Francesi, ch’erano molto lontani, ma perchè ci facea paventare Solimano, che collegatosi con Francesco I re di Francia 803 teneva già lesta una formidabile armata per assisterlo, ed era a temersi che non piombasse su’ regni di Napoli, e di Sicilia. Arrivato questo vicerè in Messina si applicò a fortificare le città marittime del regno. Visitò tosto Siracusa, ed Agosta, ed ordinò che se ne ristorassero le muraglie. Ritornato a Messina, ch’era la chiave dell’oriente, diede le provvidenze, perchè si munisse di nuove fortezze, a fine di renderla atta a respingere gli Ottomani 804. Siccome però abbisognava molto denaro per queste fabbriche, e i cento mila fiorini, che per le fortificazioni si erano offerti nel parlamento dell’anno 1531 non erano stati bastanti, si determinò di convocare in detta città un parlamento generale, che fissò per i 10 del mese di aprile. Quattro furono i grandi affari proposti, e trattati in detta assemblea; 1° il donativo di trecento mila fiorini per le spese della guerra; 2° la proroga de’ cento mila per compire le fortificazioni; 3° il mantenimento di dieci mila fanti per la custodia del regno; e 4° finalmente la vendita di alcuni beni della camera per supplire alle spese della guerra. Queste dimande fatte dal vicerè nel dì dell’apertura furono bene accettate dagli ordini dello Stato, i quali dopo varie sessioni per regolare i pagamenti, e la vendita, nel dì 15 dello stesso mese accordarono le prime tre, a condizione nondimeno che niuno fosse esente, nemmeno i così detti Martellati 805. Per la quarta poi si contentarono che si vendessero i beni patrimoniali fino alla somma di cento mila ducati d’oro 806. In questa occasione i parlamentarî oltre il dono al vicerè di cinque mila fiorini, gli diedero altri tre mila ducati per ajuto di costa 807. Ottenuto il consenso del parlamento intorno a quanto avea richiesto, si applicò il Gonzaga prima di ogni altra cosa alla vendita de’ beni patrimoniali, e per quel, che scrivono i Messinesi 808, Antonio Balsamo cavaliere messinese comperò da lui la città di Taormina per la somma di trentamila scudi. Soffrirono di mal’animo quei cittadini di dover passare dal dominio del sovrano a quello di un privato, e prendendo a prestito altri trenta mila scudi, come piacque al Maurolico, o sessanta mila come racconta il Bonfiglio, ricomperarono la loro libertà. Per contentare il Balsamo, il vicerè gli diede in cambio la grossa terra di Francavilla, aggiungendovi l’onorevol [178] titolo di Visconte. Con questo denaro, e con quello che andavasi riscuotendo da’ donativi, fortificò il Gonzaga le città marittime, e particolarmente quella di Messina, dove gli 799 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1535.1536 IX indiz. f. 116. Nello stesso reg. f. 163 e 164. 801 Nello stesso reg. f. 214. 802 Reg. della regia cancellarìa dell’an. 1536.1537 X indiz. f. 244. 803 La lega, che Francesco I. fece col Turco scandalizzò allora i cristiani, parendo loro una empietà, che colui che portava in fronte il nobile titolo di re cristianissimo, si fosse unito col nemico della religione cristiana. Ora però non fa più orrore. La filosofia, separando la religione dalla politica, ha fatto conoscere che si può negli affari puramente mondani conservare l’armonìa co’ potentati di diversa credenza, senza che la religione ne soffra. Fu forse Francesco I. più colpevole nel sostenere colle sue armi i luterani della Germania, che nell’unirsi al Turco per impedire la Monarchia universale, cui parea, che aspirasse l’augusto Carlo. 804 Maurolico Sic. Hist. lib. VI, pag. 122. 805 Erano questi i servienti della religione di Malta ai quali era permesso di portare la Croce dimezzata, ed essendo questa insegna a guisa di un martello, erano eglino detti martellati. 806 Mongit. Parl. di Sic. tom. I, pag. 199, e seg. 807 Questo doppio regalo fatto dal parlamento al vicerè Gonzaga appalesa in quanta estimazione fosse questo cavaliere presso i Siciliani, e come si avesse egli attirato l’amore di tutti. Nel parlamento antecedente fatto alla presenza dell’augusto Carlo l’anno 1535 eglino aveano dimandato (Cap. reg. Sic. t. II, in Carolo V. p. 123) che il regno non dovesse più fare nell’occasione di offerirsi i donativi, alcun regalo nè a’ vicere, nè ai loro familiari; la qual cosa fu da Cesare lasciata al loro arbitrio. Dopo due anni non solo non negano al Gonzaga i consueti cinque mila fiorini, ma gli danno inoltre tre mila ducati, cioè altri cinque mila fiorini, se i ducati allora, come sospettiamo, valevano 12 carlini napolitani, quanto è dire, gli raddoppiano quel regalo, che non voleano più dare. Qual maggior prova dell’affetto della nazione verso questo vicerè? 808 Maurolico Sic. Hist. lib. VI, pag. 242. – Bonfiglio Sic. Hist. P. II, lib. III, p. 448. 800 - 139 - fu di mestieri il far diroccare case, chiese, e conventi, e di far spiantare giardini, e vigneti, affine di renderla impenetrabile a’ nemici. Mentre il vicerè Gonzaga si affaticava a mettere la Sicilia, e particolarmente Messina, Siracusa, ed Agosta in istato di difesa, l’imperatore era intento ad armare in mare una poderosa flotta per opporla all’armata di Solimano. Il Doria ebbe ordine di mettersi alla vela colle sue galee, e di andare prima a Napoli, dove avrebbe trovate le navi, e ventiquattro triremi di Spagna. Il pontefice Paolo III vi mandò ancora le sue galee. Con questa armata partì da Napoli il Doria, e venne a Messina, dove giunse ai 4 di luglio. Il vicerè Gonzaga lo accolse cortesemente, e conferì con esso intorno alle presenti circostanze, mostrandogli quanto avea finora fatto per mettere in sicuro il regno di Sicilia. Partito il Doria per andare incontro alla flotta ottomana, il Gonzaga lasciò Messina per portarsi in Palermo, affine di fortificare anche questa città capitale del regno 809. In questa occasione fe’ egli fabbricare un baluardo di pietra al luogo detto S. Maria dello Spasimo, ed un altro alla porta di Carini. Ne fe’ anche edificare due altri di terra piena, l’uno alla porta di S. Agata, e l’altro fra la porta di Carini, e quella di S. Giorgio. Fe anche dirupare le contramuraglie, che erano attorno alla città, e vi fe invece di esse delle profonde fossate. Ordinò, che si fondessero dieci pezzi di artiglieria, cioè cannoni, colobrine, mezzi cannoni, e mezze colobrine, i quali pezzi uniti agli altri, che avea la città, servirono per guarnire i detti baloardi. Volle che ogni cittadino impiegasse l’opera sua in questi lavori o da sè, o mandandovi un uomo a sue spese, e prescrisse alle terre convicine che mandassero ogni quindici giorni cinquanta uomini per lavorare in queste opere. Fu distribuita una gran quantità di polvere, e di palle di ferro per i baluardi, e furono eletti dal re due capitani d’armi, i quali dovessero ogni domenica far la rivista dei loro soldati, e ogni sera far montare la guardia ai medesimi. Poco dopo, che era venuto in Palermo il vicerè Gonzaga, vi arrivò Elisabetta sua moglie. Era questa dama sbarcata a Messina, mentre vi stava il marito, ai 2 di maggio, dove da quei cittadini era stata ricevuta con tutti i possibili onori 810. Partito il vicerè, passò questa principessa a Catania nel mese di settembre, forse per ammirarvi i portentosi effetti dell’eruzione del Mongibello accaduta dal primo di maggio in poi di quello anno 811, e dopo di esservisi trattenuta alcun tempo, continuò il viaggio per terra sino a Palermo, dove giunse ai 21 del seguente ottobre. Le fu preparato un superbo ponte, dove fu incontrata da dodeci dame giovani, che erano vestite parte di broccato, e parte di tela di oro, e di argento; aveano le cuffie tutte di oro sulle quali le berrette di tela con pennacchi. Con questa compagnia vestita in cotal modo bizarro, che oggi muoverebbe a riso, cavalcò la viceregina su di una bella chinea ben guarnita, montando anche le dodeci dame le proprie, anch’esse bardate nobilmente, e dopo avere girato per le principali strade della città fra i rimbombi delle artiglierìe, arrivò al palagio regio, dove trovò venti altre dame vestite nella stessa nobil foggia, che l’accolsero con molto onore 812. La città di poi, secondo il costume di quella età, le mandò in dono ventiquattro bacili di confetture colle [179] banderuole, nelle quali erano le armi di Palermo. Furono fatte nei dì seguenti diverse feste per l’arrivo di questa nobile dama 813. Allontanatosi dai petti dei Siciliani ogni timore, poichè la flotta ottomana, che credeasi che fosse per piombare sopra il nostro regno, si era avviata contro l’isola di Corfù posseduta dalla repubblica di Venezia, e dopo di averne imprigionati gli abitanti, e bruciatine i casali, stava intenta ad assediare la città, e la fortezza, che erano ben munite, si cominciò nella nostra isola a respirare, e a desistere dal continuo allarme, in cui erano i nazionali per la comune difesa. Intanto considerando i Veneziani la necessità di collegarsi colle altre potenze cristiane, fecero una confederazione coll’augusto Carlo, col di lui fratello Ferdinando re dei Romani, 809 In un manoscritto della libreria del senato (lettera Q. q. num. 11, pag. 6), che si dice del Paruta, ma che noi crediamo più antico, vi si nota che questo vicerè vi tenne un parlamento, in cui fu stabilito che s’imponessero in avvenire tre tarini per ogni salma di farina, affine di difendere la città. Per nome di parlamento non deve quà intendersi l’assemblea degli stati, ma il così detto consiglio, che suole convocarsi nei casi urgenti, ed è composto di tutti gli ordini della città. 810 Maurolico Sic. Hist. lib. VI, pag. 222. 811 Questa fu una delle più strepitose eruzioni di quel monte. Precessero i terremoti, che costrinsero gli abitanti a fuggirsene. Le ceneri, che vomitò, giunsero fino a Messina, coprirono le piante, e gli erbaggi, e siccome i bachi da seta ricusarono di pascersi delle frondi de’ mori, ch’erano asperse da quella polve, tutti se ne morirono. Il Maurolico (Sic. Hist. lib. VI, pag. 223) fa montare il danno recato alla sola Messina a dugento mila scudi. Agli 11 il monte si squarciò, e si videro uscire dalle sue aperture fiumi di fuoco, che consumavano vigne, giardini, orti, e la messe, ch’era già presso alla sua maturità. Cadde finalmente il sommo vertice della montagna. (Amico Catana Illustrata lib. VIII, cap. I, tom. II, pag. 388, e seg.) 812 Manoscritto della biblioteca del senato di Palermo let. Q. q. num. XI, pag. 7. 813 Fra le dimostrazioni fatte alla viceregina in questa occasione è degna di esser mentovata la Caccia artifiziale, che le fu data nella gran piazza della marina, e che viene minutamente descritta nel più volte riferito Mss. del Paruta (ivi). Compariva quella piazza come una campagna, dove stavano delle ninfe, e dei cacciatori, i quali prima fecero la caccia dei conigli, poi delle francoline per mezzo dei falconi indi di un lupo, e finalmente di un verro, di un daino, e di un porco castrato. Dopo la caccia vi fu una giostra fra due cavalieri per l’acquisto di una bella, la quale, mentre questi si battevano, se ne fuggì. Finalmente comparvero le ninfe inseguite dai Satiri, le quali rifuggiandosi sotto il palchetto, dove era la viceregina, intrecciarono una battaglia, ossia il giuoco dei caruselli, ch’essendo pieni d’acque odorifere, rompendosi sparsero intorno un gratissimo odore. - 140 - e col papa, alla quale furono invitati il re di Portogallo, quel di Polonia, e il duca di Prussia. Volevano chiamarvi il re di Francia, ma non fu possibile, stante la nimicizia coll’imperadore. La flotta era già lesta nella estate dell’anno 1538. Andrea Doria, che era alla testa dell’armata, venne a Messina ai 27 di esso anno, ad oggetto di passare di poi a Corfù per assalire la flotta turca, che era all’assedio di quella città. Il vicerè Gonzaga era andato colla moglie in Messina, e lo incontrò al lido di S. Agata 814. Siccome dovea egli ancora partire per questa spedizione, così volle lasciare nel regno un presidente, che ci reggesse durante la sua lontananza, ed in forza della facoltà concedutagli da S. M. Cesarea per dispaccio dato l’anno antecedente 1537 in Valladolid ai 20 di marzo, di scegliere, dovendo partire, per presidente del regno, chi più stimasse opportuno, si determinò di collocare in questa carica Arnaldo Albertino vescovo di Patti, ed inquisitore apostolico nel nostro regno. La cedola viceregia di questa elezione fu da lui sottoscritta nella stessa città di Messina ai 29 del mese di agosto 815. La partenza della flotta, che era di cento trentasette vele, in cui erasi imbarcato il Gonzaga, partì per Corfù l’ultimo giorno dello stesso mese 816. L’infelice esito di questa spedizione nella disfatta, che ebbe la flotta combinata al capo Figalo, ai 27 del seguente settembre, per cui Barbarossa ebbe la sorte di metterla in fuga, e di predare sei galee veneziane con altrettante navi da trasporto 817, e di far prigioni molti, anche dei nostri Siciliani, non ci fe’ molto desiderare il ritorno del vicerè Gonzaga. La flotta Cesarea dopo di avere all’improvviso assaltata, per risarcire l’onore delle armi imperiali, una città della Grecia detta Castelnuovo, fatti prigioni tre mila Turchi, e lasciativi da circa quattromila Spagnuoli di guarnigione, nel mese di dicembre ritornò a Messina, e con essa il vicerè, cui andarono all’incontro gli ambasciadori della città presso Cariddi 818. In questa occasione fu coniata al vicerè Gonzaga una medaglia, rappresentante nel diritto il busto di questo cavaliere vestito di usbergo, attorno al quale leggesi: FERD. GONZAGA D. DARM. VICER. SIC. GENERAL. CAR. V. IMP., e nel rovescio vi si scorge la suddetta città di Castelnuovo, che poggia su di un monte, e in distanza un aquila, sotto il di cui simbolo viene il Gonzaga, la quale punto non scoraggendosi nè dal mare frapposto, nè dall’altezza del monte, spinge verso il castello il suo volo con proposito di vincere, o di morire, coll’epigrafe: VIVO. O. MORTO. [180] Fu la valle di Demone, e soprattutto Messina in grave pericolo per un caso successo poco dopo il ritorno del vicerè. Gli Spagnuoli, che l’augusto Carlo avea lasciati alla custodia della Goletta, quando prese il regno di Tunisi, vedendosi mancare le paghe, si ammutinarono, e minacciarono di uccidere gli uffiziali, e di abbandonare quella interessante fortezza. I capitani usarono la possibile prudenza, e destrezza in un così critico incontro, e vennero a capo d’indurne molti ad aspettare che arrivasse il denaro, che si attendea di momento in momento; e a quelli, che persistevano nella tumultuazione, diedero il permesso di ritornare in Sicilia, dove sarebbono stati soddisfatti. Il Gonzaga non volendo che questa truppa di malcontenti dimorasse in Sicilia, ordinò loro che andassero a sbarcare nell’isola di Lipari; ma costoro, malgrado il divieto del vicerè, presero terra presso Messina. I cittadini chiusero le porte della città, e facendo giocare i cannoni, fecero ogni opra per tenerli lontani. Il Gonzaga ancora ordinò, che le dodici galee, che erano nel porto, ne uscissero, e facessero fuoco contro gli ammutinati. Costoro, dei quali ne morirono alcuni, si allontanarono, e dopo di avere saccheggiati i villani presso la città, vennero a Castanìa, indi al Faro, e poi s’impossessarono di Monforte, e di S. Lucia, rubando, e portando la desolazione dappertutto. Tentarono d’impadronirsi della popolosa terra di Castroreale, ma ne furono respinti, essendone rimasti morti intorno a dugento. Costernato il Gonzaga si imbarcò sulle galee, e venne a Milazzo per tentare, se vi fosse modo di ridurli colle buone; ma osservando inutile ogni pacifico tentativo, avvegnachè coloro protestavano, che non avrebbono deposte le armi, se non erano pagati fino all’ultimo obolo; per non ricevere da essi la legge, restituitosi a Messina, fe’ marciare Antonio Balsamo con tre mila uomini verso Taormina, Antonio Branciforte con quattro mila verso Patti, e Michele Spadafora con altri quattro mila verso la Novara. Costoro, sebbene avessero avuto ordine d’impedire i saccheggiamenti, non aveano non ostante la libertà di venire alle mani. Il saggio vicerè sapea pur troppo il valore di quei disperati Spagnuoli, e cercava colla massima di Fabio Massimo d’indugiare, aspettando dal tempo la salvezza della Sicilia. Intanto ebbe modo di guadagnare con promesse i capi dei malcontenti, i quali indussero i loro soldati a sottomettersi sotto la condizione di esser tosto pagati, e di ricevere il perdono. La convenzione fu stipolata a Linguagrossa, dove venne il Gonzaga, e giurò sulla sagrata ostia i patti convenuti. Pagati di poi i soldati, e divisili in diverse parti 814 Maurolico Sic. Hist. lib. VI, p. 224. Reg. della regia cancellerìa dell’anno 1537.1538 XI indiz. f. 652. 816 Maurolico Sic. Hist. lib. VI pag. 224. 817 Il Maurolico (ivi), scrisse, che Ariadeno non prese a’ Veneziani, che due galee, e cinque navi da trasporto; noi abbiamo seguito Federico del Carretto (de bello Africano lib. II, pag. 90, tom. , della Raccolta degli opuscoli di Aut. Sic.) che trattando questo singolare argomento, avrebbe dovuto essere più diligente ricercatore di tutte le menome circostanze. I Veneziani accusarono di perfidia il Doria, che nel più forte della battaglia li abbandonò, lasciando essi soli in ballo. 818 Maurol. Sic. Hist. lib. VI, pag. 224. 815 - 141 - della Sicilia, il Gonzaga ritornò a Messina 819. Sembrava che ogni cosa fosse finita; ma il Gonzaga dimentico del giuramento fatto, chiamando i capi sediziosi sotto varî pretesti a quella città, li fe’ tutti strangolare a’ 29 di aprile, qual gastigo ebbero altri in Vizzini, a Militello, a Lentini, e in altri luoghi 820. Il Gonzaga si trattenne in Messina fino agli ultimi del mese di ottobre 1539. Era egli stato chiamato dall’augusto Carlo in Spagna, sebbene se ne ignori il motivo 821; e perciò partì per la corte ne’ primi di novembre, lasciando per presidente del regno Giovanni d’Aragona Tagliavìa marchese di Terranuova, e ammiraglio della flotta siciliana, il [181] quale cominciò a governarci appena partito il vicerè 822. Non si trattenne il Gonzaga molto tempo alla corte: egli era troppo necessario al nostro regno; laonde nel mese di aprile dell’anno 1540 era già ritornato a Messina, trovando noi ch’ei cominciò a dispacciare dopo i 15 dello stesso mese. La prima occupazione dopo il ritorno di questo vicerè fu quella di convocare subito il parlamento in essa città, che intimò per gli 11 del seguente mese di maggio. Le spese che facea l’imperadore per le guerre, che sostener dovea contro il Turco, e contro i Francesi, erano ingentissime, ed aveano esausto il suo erario; i beni patrimoniali, che possedea la corona in Sicilia, si erano tutti o venduti, o alienati, in guisa che era ridotto Cesare a niente più trarre dalla nostra isola, che i soli donativi. Queste triste circostanze rappresentò nel dì dell’apertura il detto vicerè, e dimandò non solo l’ordinaria offerta de’ trecento mila fiorini, ma un’altra contribuzione per ricattare i beni della camera. Fu fatto il donativo de’ trecento mila fiorini, e per l’altra sovvenzione, quantunque il regno fosse nell’estrema strettezza, specialmente dopo i saccheggiamenti fatti dagli spagnuoli, nondimeno per compiacere il sovrano si contentarono i parlamentarî, che s’imponesse un tarino sopra ogni salma di frumento, e sopra ogni due salme d’orzo, o di altri legumi, che si dovessero estrarre da’ porti della Sicilia, purchè questo denaro s’impiegasse veramente nella ricompra de’ beni patrimoniali. In questo parlamento fu fatto il solito regalo al vicerè de’ cinque mila fiorini 823, e fu destinato per ambasciadore del parlamento Giovanni Marullo conte di Agosta, che richiese, ed ottenne varie grazie, che dimandò a nome del regno 824. Nel seguente agosto, avendo fatto il marchese di Villanuova come ammiraglio carcerare uno, nacque un susurro nel popolo messinese, che credea lesi i suoi privilegi, e gli fu d’uopo in quel furore di scapparsene. Si frappose il vicerè, e facendo liberare il carcerato, venne a capo di sedare il nascente tumulto, e di conciliare l’ammiraglio con quei cittadini 825. Dovea egli fra breve partire per l’impresa dell’Affrica, e bramava di lasciare il regno nella tranquillità. Il Doria era arrivato a Messina colla flotta navale per questa impresa fin dal mese di maggio, e dopo di avere raccolta una classe di cinquantanove galee, erasene andato in Puglia per difendere quella parte del regno di Napoli, ch’era minacciata dal Barbarossa. Dopo di avere battuti quei mari, osservandosi che dappertutto vi erano de’ corsari, fu risoluto di divider la gran flotta in tre flottiglie, che ebbero ordine di andare in diversi luoghi alla seguela di questi ladroni, e poi ridursi a Trapani, dove sarebbono venuti il Gonzaga, e il Doria per portar la guerra in Affrica, e per sottomettere le città del regno di Tunisi, che si erano rivoltate 826. Prima di partire da Messina volle il vicerè dar principio a quella fortezza, che poi dal suo nome fu detta il castello Gonzaga, la quale era molto necessaria alla difesa della città; e poichè bisognava molto denaro per 819 Maurolico Sic. Hist. lib. VI, pag. 225. Il Sandoval (vida del Emperador Carlos V. tom. II, lib. XXIV, pag. 350) racconta, che in Messina furono innalzate venticinque forche, e che in quella, che era più alta di tutte, fu appiccato un certo Eredia, ch’era stato uno dei principali, cui fu anche mozzata la mano. Non ci appartiene in questo luogo lo esaminare, come possa coonestarsi questo spergiuro contrario alle leggi divine, ed umane; la politica spesse volte per i suoi fini calpesta le sagrosante leggi. Noi sappiamo che il gran capitano Consalvo de Cordova dietro ad un simile giuramento tenne prigione il piccolo duca di Calabria figliuolo del re Federico di Napoli, che avea giurato di lasciare in libertà. Quel ch’è certo, egli è, che il nome di questo vicerè fu di poi in esecrazione alla nazione spagnuola. Il Giovio (lib. XXXVII) ci racconta, che ei fu intimato dal supremo consiglio di Castiglia a comparire per discolparsi, ma che l’augusto Carlo, che segretamente ne avea approvata la condotta, lo dispensò dall’andarvi. Che il Gonzaga sia andato in Spagna poco dopo questo fatto, non può dubitarsene, qualunque ne sia stata la causa. 821 Chi dice che vi andò per discolparsi dall’avere controvenuto a’ patti giurati co’ Spagnuoli, che si erano ammutinati; chi opina che vi fu chiamato per sedare la ribellione suscitatasi nella città di Gante nelle Fiandre; piace ad altri che Carlo volesse con lui concertare il modo da tenere il Turco lontano da’ suoi stati. Vi è chi crede che volesse consultarlo per la difesa del ducato di Milano, ch’era minacciato da Francesco I. re di Francia; e non mancano di quelli, che pensarono che Cesare volesse portar la guerra in Affrica, e ne volesse incaricare questo prode vicerè, ch’è forse la cosa più verisimile. 822 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1539.1540 XIII Indiz., f. 160 e seg. 823 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 219, e seg. 824 Maurol. Sic. Hist. lib. VI, p. 226. 825 Maurol. ivi p. 226. 826 Carlo V. dopo l’acquisto della città, e del castello di Tunisi, si era compromesso di ritornarvi per riconquistare tutte le altre città soggette a quel regno. Mulei-Assen non lasciava di assordargli le orecchie, ricordandogli la promessa, e vieppiù gli fe delle premure quando si vide traballare la corona in capo per le tumultuazioni dei Tunisini, che odiandolo a morte per le sue crudeltà, cercarono di scuotere il giogo. Mosso perciò Cesare da compassione, e volendo sostenere ciò, che avea fatto l’anno 1533, comandò al Gonzaga, e al Doria, che marciassero in Affrica, per sostenere quel re, e per conquistargli le altre città. 820 - 142 - questa fabbrica, indusse quei cittadini ad aggravarsi di tasse sopra i grani, sopra gli orzi, e sopra i vini, fino che quest’opera fosse compiuta. Ottenuto ciò fe’ tirare le linee del nuovo castello, e buttò egli stesso la prima pietra, e lasciando gli ordini, affinchè se ne continuasse il lavoro, a 23 di agosto partì condotto da sei galee del Doria da quella città, e venne a Palermo per darvi alcune disposizioni. Nel seguente mese fece anche il Doria mossa dalla stessa città con venti altre galee, e quindeci navi da trasporto, sulle quali eravi un buon numero di soldatesche, e veleggiò verso questa capitale, per prendervi a bordo il Gonzaga. Questi intanto lasciando a’ 21 di settembre per presidente del regno, durante la sua lontananza, [182] Ponzio Santapau 827 marchese di Licodìa 828, partì verso i 27 di settembre, e giunse all’isola della Pantellarìa, dove trovò le flottiglie, che, come abbiamo detto, s’erano mandate contro i corsari con ordine di ridursi a un dato tempo verso Trapani, e con esse fece vela per l’Affrica. Fu breve questa campagna; i Mori, quantunque sulle prime si fossero azzardati di fare colle truppe cesaree lo sperimento delle armi, conoscendo nondimeno ch’erano inferiori di forze, si esibirono di sottomettersi all’imperatore, purchè non stassero soggetti al barbaro loro re. Ma il Gonzaga, sapendo le intenzioni dell’augusto Carlo, li obbligò a riconoscere per sovrano Mulei-Assen. Vennero perciò in di lui potere Monistero, Maometta, e Siface 829, ch’erano le principali città del regno Tunisino. Il vicerè adempiuta la sua commissione, e lasciate alcune truppe spagnuole con diversi cannoni, che quel re gli avea dimandato per la sua custodia, si rimbarcò, e ritornò vittorioso in Sicilia 830. Il ritorno del Gonzaga in Messina dovette essere dopo i 10 di novembre, nel qual giorno troviamo sottoscritto l’ultimo dispaccio del marchese di Licodìa 831. Dopo il suo arrivo si applicò questo vicerè non solamente a fortificare la città suddetta, ma a girare per tutto il regno per dare le provvidenze necessarie per la conservazione delle città marittime, che sempre paventavano per i famosi corsari Barbarossa, e Dragutte, che infestavano i nostri mari. Ma l’oggetto suo principale era la nuova guerra, che Cesare pensava di fare agli Algerini. Altiero questo principe de’ felici successi, che aveano avuto le sue armi contro le città dell’Affrica soggette al regno di Tunisi, concepì il disegno di attaccare egli stesso gli Algerini, ch’erano coloro, che colle loro scorrerìe molestavano i regni di Spagna. Ordinò adunque l’anno 1541, che si preparasse un’armata più poderosa, che fosse possibile, per questa impresa, ed insieme prescrisse a’ due vicerè di Sicilia, e di Napoli, che allestissero galee, navi, e truppe; e volle che i più famigerati suoi capitani venissero a servirlo, fra i quali fu anche chiamato il nostro vicerè, il quale adunò tutte le galee siciliane, arrollò quanta gente potette, e fe’ caricare cento venti navigli di una prodigiosa quantità di viveri, e lasciando a’ 4 di settembre per presidente del regno 832 Simone Ventimiglia marchese di Geraci, agli 8 di settembre se ne partì. Prima di fare questi preparamenti avea il Gonzaga convocato d’ordine di sua maestà Cesarea un parlamento, che fu intimato nella città di Messina a’ 14 del mese di luglio 1541. Fe’ egli nell’apertura di quest’assemblea la pittura delle immense spese fatte da sua maestà Cesarea per tenere lontani i nemici della religione da’ suoi regni, specialmente dal nostro di Sicilia, rammentò la grande impresa di Tunisi, in cui fu presente lo stesso augusto Carlo, e palesò che questo principe già si accingea a farne una pari per assicurare la quiete della Sicilia, disposto ad andarvi di persona per meglio eseguirla 833. La risposta de’ parlamentarî fu resa dopo cinque giorni, cioè a’ 19 dello stesso mese. Eglino fecero rilevare al vicerè gli spessi e continovi donativi, che fatti aveano a sua maestà, e le somme erogate così per ristorare le fortificazioni della Sicilia, come per mantenere le truppe necessarie alla custodia della medesima; gli fecero inoltre [183] osservare lo stato deplorabile, in cui era il regno per la carestìa, che lo molestava in quell’anno, e per cui si dubitava se fossero per bastare i pochi frumenti, che vi erano, per il sostentamento dei nazionali fino alla nuova ricolta; e conchiusero coll’offerta di soli cento mila ducati, che sebbene fossero pochi al bisogno, erano non dimeno il più, che potesse allora contribuire la nazione 834. È di avvertire in questo parlamento per prova della penuria 827 Il Maurolico (Sic. Hist. lib. VI, p. 226) scrisse, che fu lasciato per presidente del regno il marchese di Geraci, e il Caruso (Mem. Stor., part. III, lib. VIII, tom. III, vol. V, pag. 156), il quale anche sbaglia nella cronologia, fissando questa partenza l’anno antecedente 1539, volle che fosse stato fatto presidente del regno il marchese di Terranova; ma noi colla scorta della cancellarìa non abbiamo adottati questi errori. 828 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1540.1541 XIV Indiz., f. 65. 829 Il Maurolico (Sic. Hist. lib. VI, p. 226) vi aggiunge anche Susa, e per la città di Siface racconta, che non volle punto sottomettersi a Mulei-Assen, e che ricomprò la sua libertà per ottomila scudi. 830 Federici del Carretto, De Bello Africano, lib. II, pag. 90 e 91, t. I della Raccolta degli Opuscoli di Autori Siciliani. 831 Reg. della regia cancelleria dell’anno 1540.1541 fogl. 113. 832 Nello stesso registro, anno 1541.1542, XV. Indiz. fogl. 8. 833 Questo parlamento, di cui parliamo, sfuggì alla nota diligenza del canonico Antonino Mongitore, e del di lui nipote il parroco Francesco Serio, che ristampò l’anno 1749 la raccolta fatta dallo zio dei parlamenti di Sicilia, cui fe’ delle note, e delle addizioni. Noi l’abbiamo già tratto dalle tenebre, e lo pubblicheremo nel terzo tomo de’ monumenti quando piacerà al cielo che si promulghi la nostra Storia de’ tempi, e civile del regno di Sicilia. Il Maurolico stesso messinese, e contemporaneo lasciò di rammentarlo. 834 Reg. dell’offizio del protonotaro dell’anno 1540.1541, XIV Indiz., f. 482 e seg. - 143 - grande di denaro, in cui era la Sicilia, che non fu esibito il solito regalo al vicerè, nè fu a’ regî segretarî, che servirono in quell’assemblea, fatta la consueta contribuzione. Andò il Gonzaga colla flotta, che avea preparata, in Majorica, ch’era il luogo destinato per unirsi la poderosa armata, e dove aspettò l’imperadore, che vi giunse poco dopo. Noi non parleremo di questa infelice spedizione. L’Augusto Carlo, che avea sempre trovata la fortuna prontissima a secondare le sue imprese, questa volta conobbe che la istabile Dea volge alcune fiate a’ suoi amici le spalle. I di lui principali uffiziali, e sopratutto l’ammiraglio Doria, ch’era così sperimentato nelle guerre marittime, sapendo quanto fossero incostanti, e pericolosi nella stagione forte autunnale i mari di Algeri, cercarono di dissuaderlo per allora da quella impresa, e gl’insinuarono a differirla a miglior tempo, potendo avvenire che l’infido elemento, e i venti furiosi di quella stagione attraversassero il suo disegno, ed arrecassero l’intera rovina all’armata; ma Carlo ostinato non seppe rimuoversi dal suo pensamento. L’esito di questa guerra fu tale, quale il Doria, e gli altri gran capitani l’aveano pronosticato. Una tempesta suscitatasi dopo ch’era sbarcato l’esercito, rese inabili le soldatesche ad operare, la flotta si disperse, e a gran stento l’imperadore, poichè perdette sopra a cinque mila uomini, si ridusse al lido, dove erano poche galee scampate dal naufraggio, ed indi prese il porto di Bugìa, di cui era signore. Ristorate poi le truppe co’ viveri, che gli recò Mulei-Assen, e licenziate quelle, che non dovevano accompagnarlo, tosto che il mare fu in bonaccia, partì per la Spagna, dove arrivò a 25 di novembre dello stesso anno 1541 835. Il nostro vicerè Ferdinando Gonzaga fu uno di quelli, ch’ebbe la sorte di salvarsi, e partì dal porto di Bugìa colle galee di Malta, e venne a sbarcare in Trapani tra i 24 e i 27 di novembre, trovando noi che a’ 24 finì di sottoscriversi il marchese di Geraci, e che ai 27 cominciò di nuovo a dispacciare il Gonzaga 836. Da Trapani si portò questo cavaliere in Palermo, dove si trattenne qualche mese, e nel marzo dell’anno seguente partì per Messina, dove giunse a’ 24 dello stesso mese. In capo a pochi giorni arrivò la viceregina, che nell’agosto dell’anno antecedente era andata a Napoli 837. Non v’ha dubbio che l’oggetto, per cui portossi a Messina, non potè essere altro, che la difesa dell’isola. Dopo la perdita fatta dall’imperatore sotto Algeri, altro non potevamo aspettarci, se non che quei barbari ingallozziti del felice evento di questa guerra, si fossero posti in mare per attraversare il nostro commercio, e per fare, se potea loro riuscire agevole, delle scorrerìe nei nostri lidi, e in quei di Calabria. Era perciò di mestieri lo stare in allarme per impedire le devastazioni, ed i danni, che costoro arrecar potessero, principalmente in Messina, in Melazzo, in Catania, in Agosta, ed in Siracusa, ch’erano i luoghi più esposti alle loro incursioni. Da Messina ritornò il Gonzaga a Palermo per accudire ancora alla difesa di questa capitale, ch’era del pari soggetta, come città marittima, alle incursioni dei Mori. In essa si trattenne poco tempo, avvegnacchè nel mese di dicembre di quest’anno 1542 ebbe necessità di partirsi. Sebbene noi ignoriamo il motivo per cui abbandonò la Sicilia, nondimeno sospettiamo ch’egli sia andato in Napoli per concertare col vicerè Pietro Toledo i mezzi da salvare i due regni di Napoli, e di Sicilia dai pericoli, dai quali erano minacciati, e ci rende verisimile questo sospetto la breve dimora, ch’ei fece fuori della nostra isola. Dovendo dunque lasciarci un presidente che ci reggesse, ne spedì il dispaccio ad Alfonso de Cardona conte di Chiusa, e Giuliana, che sottoscrisse in Palermo [184] a 6 dello stesso mese, colla condizione che non potesse esercitare questa carica, che dopo cinque giorni, ch’ei ne fosse partito, e colla clausola che veniva scelto a beneplacito dell’imperadore, e suo 838. Di questo presidente noi parleremo frappoco; per ora basta il dire ch’ei durò pochi giorni in questa carica, imperocchè il Gonzaga partì dopo i 15 del detto mese di dicembre, e già era ritornato agli otto di febbraro del seguente anno 1543, come costa dai registri della regia cancellarìa 839. Prima che partisse il Gonzaga, e durante il breve governo del conte di Chiusa, le due valli di Demone, e di Noto soffrirono dei danni nati dalle stesse viscere della terra, nè ne fu esente la stessa valle di Mazara. Dai 5 di agosto in poi, e fino al gennaro dell’anno seguente fu tribolato il regno da terribili e continui tremuoti; e tale ne fu lo spavento, che non ostante che fossero cessate le scosse, gli abitanti, particolarmente a Siracusa, seguitavano a starsene in campagna, nè si arrischiavano a ritornare alle proprie case nelle città 840. Il vicerè Gonzaga, e il presidente del regno non trascurarono da buoni governanti di dare tutte le necessarie provvidenze, affinchè si porgessero gli aiuti necessarî ai miseri abitanti, e s’impedissero i mali, che sogliono per conseguenza nascere dopo questi flagelli divini. Cessati appena i tremuoti, nuovi pericoli cominciarono a minacciare il nostro regno. Si era riacceso il fuoco della discordia fra l’imperadore Carlo V, e Francesco I re di Francia, che avea chiamato in soccorso il Sultano Solimano, il quale alle premure, che gliene facea il Barbarossa, volentieri aderì a collegarsi col re 835 Vertot, Histoire de Malte, liv. X, t. IV, p. 121. – Sandoval, Vida del Emperador Carlos V. t. I, lib. XXV. Reg. della regia cancellerìa dell’anno 1541.1542 XV Indiz., f. 324. 837 Maurolico, Sic. Hist., lib. VI, pag. 227. 838 Reg. della regia cancellerìa dell’anno 1542.1543, I. Indiz., f. 225. 839 Reg. ivi, f. 333, e 417. 840 Mongitore, Storia cronologica de’ terremoti, t. II. della Sicilia ricercata p. 393. 836 - 144 - francese. Sperava Ariadeno, durante questa guerra, d’invadere gli stati dell’augusto Carlo, ed in particolare di togliere dalle mani dei cavalieri Gerosolimitani, che erano i dichiarati nemici dei Maomettani, Tripoli, e Malta, che eglino possedeano 841. Fu detestata allora questa lega di Francesco I col Turco, e ognuno, che avea beni nel mediterraneo, dove il Barbarossa avea avuto ordine di venire con una possente squadra, pensava a casi suoi. La Sicilia era più che ogni altro regno esposta alle di lui incursioni, e il Gonzaga, cui era stata data in custodia, si occupò interamente a metterla in istato di difesa. Siccome però mancava il denaro, così fu costretto ad intimare per i 19 di febbraro un altro parlamento. Fu questa adunanza convocata in Palermo, e nel regio castello, dove allora abitavano i vicerè. I motivi di questa convocazione furono esposti nell’apertura del parlamento da questo cavaliere, il quale perciò richiese, che per salvare il regno dalle temute invasioni non solamente era necessario il solito donativo dei 300 mila fiorini, ma era d’uopo ancora che si prorogasse il pagamento dei cento mila fiorini per le fortificazioni, le quali, perchè si erano consumati i primi cento mila, non si erano potute compire, e che si arrollassero delle truppe necessarie alla difesa dell’isola. Comunque il regno fosse esausto, conobbero non ostante i parlamentarî, che trattandosi della propria conservazione, bisognava fare ogni sforzo per allontanare i pericoli, dei quali temeano; e perciò offrirono li soliti trecento mila fiorini, si contentarono che si imponessero altri cento mila per perfezionare le piazze, da pagarsi nello spazio di sei anni, e per conto delle truppe si tassarono di pagare nello spazio di sei mesi sessanta mila scudi per tenere tre mila fanti, promettendo di accrescerli ad otto mila, qualora si presentisse la vicina invasione dei Turchi 842. Essendo questo un parlamento ordinario, fu fatta anche al vicerè la solita offerta dei [185] cinque mila fiorini. Durarono le sessioni parlamentarie molti giorni; avvegnachè alla proposta fatta dal vicerè ai 19 di febbraro non fu risposto, che ai 4 del seguente marzo. Vollero i parlamentarî spedire alla corte il solito ambasciadore, e pregarono il vicerè, acciò s’incaricasse di presentare a Cesare lo esibito donativo, e di richiedergli a nome del regno alcune grazie, come egli fe’, e ne ottenne il regio beneplacito, ciò, che costa dai capitoli segnati da questo sovrano in Magonza agli 11 di agosto 1543. e pubblicati dal Cardona nel dì ultimo del mese di novembre dello stesso anno 843. Nel medesimo parlamento furono richiesti al ridetto vicerè alcuni provvedimenti, che ei in forza delle sue facoltà potea da sè dare, i quali riguardavano principalmente gli affari giudiziarî, e inoltre la licenza di introdursi nel regno la fabbrica dei panni, che ei volentieri accordò. Questi poi furono pubblicati dal Cardona istesso sotto li 30 aprile 1543 844. Dapoichè fu liberata la Sicilia dall’imminente pericolo dell’armata di Barbarossa, che era comparsa ai 23 di giugno nei mari di Messina, ed erane partita in capo a pochi giorni, il vicerè Gonzaga si dispose a partire di nuovo dalla Sicilia. L’augusto Carlo, dovendo venire in Italia, lo avea chiamato per valersene nella guerra, che sostenea contro il re di Francia. Egli adunque, volendo lasciare un presidente giusta la facoltà, che ne avea ottenuta dall’augusto Carlo per un dispaccio dato in Barcellona ai 30 di ottobre 1542, e registrato in Palermo ai 26 di febbraro dell’anno seguente, ritornò a scegliere lo stesso Alfonso Cardona conte di Chiusa, come costa dall’atto di elezione fatto in Palermo ai 30 di marzo 1543 845. Il Maurolico 846 non approva la elezione del conte di Chiusa, giacchè questo cavaliere era vecchio, ed era privo dei talenti necessarî per reggere la Sicilia, particolarmente nei presenti bisogni, in cui era allora per le imminenti temute incursioni dei Turchi, e ci racconta, che il Gonzaga lo scelse per fini di interesse, sperando che ei dasse in ricompenza di quest’onore la sua nipote erede dei suoi stati al figliuolo di questo vicerè. Petrus, (leggi Alphonsus) Cardona Clusii Comes senio gravis tunc regni praeses, quem Gonzaga substituerat, quo neptem ejus ex filio unicam haeredem nurum sibi adscisceret, in tanto Messanae, ac regni periculo somnolentia pressus oscitabat. Chi sà, se il Gonzaga, conoscendone l’insufficienza, non abbia perciò riserbato all’arbitrio dell’imperatore, e al suo il rimuoverlo? Checchesia del motivo, che ebbe il Gonzaga di darci per presidente il conte di Chiusa, egli è certo, che i Messinesi, temendo, giacchè erano privi di difesa, di non divenire il bersaglio degli Ottomani, ricorsero a Pietro Toledo vicerè di Napoli, il quale spedì tosto in loro soccorso delle truppe di fanti sotto il comando di 841 Anche Mulei-Assen temea che costui non invadesse il suo regno di Tunisi, e perciò consigliato dal Bali d’Alemagna castellano di Tripoli si determinò di portarsi dall’augusto Carlo, che già veniva in Italia, per ottener dal medesimo de’ soccorsi. Raccomandando dunque il suo regno a Francesco de Tova governatore della Goletta, fe’ vela verso la Sicilia, e arrivato felicemente in Trapani, venne a Palermo, dove fu con onore ricevuto nel palagio di Ajutami Cristo. Dopo di esservisi trattenuto per venti giorni, partì per Napoli, d’onde spedì all’imperadore, che era già a Genova, un messaggiero, cercando un abboccamento da S. M. imperiale. Carlo avea altro da pensare; e perciò gli fe’ dire, che non si muovesse da Napoli, e che trattasse col vicerè Toledo i suoi affari, per cui mezzo sarebbe stato egli ragguagliato di tutto. (Vertot, Hist. de Malte, lib. X, tom. IV, p. 139 e seg. – Fazello, dec. II, lib. X. t. 3. p. 240. – Maurolico – Del Carretto – ed altri). 842 Mongit. Parl. di Sic. tom. II, p. 224, e seg. 843 Cap. regni Sic. tom. II, in Carolo V. p. 151. 844 Cap. regni Sic. t. II, in Carolo V. p. 159. e seg. 845 Reg. della regia cancellaria dell’anno 1542.1543 I indiz. f. 423. 846 Sic. Hist. lib. VI, p. 228. - 145 - Pietro Mendoza spagnuolo 847, cui si unirono i conti di Sinopoli, di Sibari e di Nicotra. Giunse in verità tardi, e poi che la squadra turca era partita, questo aiuto; non lasciò nondimeno di rallegrare gli afflitti Messinesi, i quali temeano che non fosse per ritornare. Il conte di Chiusa, restò per quel che scrisse il Caruso, dispiaciuto 848 , che si fosse richiesto soccorso dal vicerè di Napoli, senza esserne stato prima consultato, e pensava di castigare severamente coloro, che l’aveano dimandato; ma temendo di non essere egli incolpato per la negligenza sua di aver trascurato di mettere quella città in istato di difesa, pensò che fosse miglior partito lo applicarsi a munire il regno. Ne era egli stato spinto dagli ordini di Cesare, il quale gli avea comandato, che convocasse un parlamento straordinario, così per un sussidio, che ei cercava nelle guerre col [186] re di Francia nelle Fiandre, e col Turco nell’Ungheria, come per una tassa da imporsi per mettere la nostra isola in istato di difesa. Egli perciò intimò questa straordinaria adunanza in Palermo per li 4 di marzo dell’anno 1544 849. Espose nel detto giorno questo presidente del regno agli ordini dello stato i comandi che avea ricevuti da Cesare; e questi fatta la loro sessione, e considerate le miserie, in cui era il regno per i continovi sovvenimenti, che era stato costretto di dare, ora per aiutare il monarca, ed ora per difesa propria, non poterono offerire al sovrano un donativo maggiore di cento mila ducati 850. Stabilirono inoltre che per la custodia dell’isola si mettessero nelle mani del presidente del regno cinquanta mila scudi, per la qual somma restavano contenti, che egli vendesse tanti grani sulle tratte dei frumenti, quanti erano necessarî per cavarne i suddetti cinquanta mila scudi, colla condizione, che vendendosi di più, i sopravanzi andassero in conto dei cento mila ducati, che doveano pagarsi in un anno, e col patto ancora, che il regno potesse, quando gli fosse commodo, ricattare la detta tassa sopra i frumenti 851. O che il Cardona conoscendo la sua insufficienza nata o dalla vecchiaia, o dalle infermità avesse richiesto all’augusto Carlo la sua dimissione, o che questo monarca persuaso che ei non fosse opportuno al governo della Sicilia nei pressanti pericoli, in cui ritrovavasi abbia pensato di rimuoverlo, egli è certo, che mentre questo monarca era in Spira nella Germania, sotto il pretesto, che era il conte di Chiusa infermo, gli tolse il governo dell’isola con dispaccio dei 28 di marzo dello stesso anno 1544, ed elesse in sua vece per presidente del regno, fino che non fosse ritornato il Gonzaga, Giovanni d’Aragona, e Tagliavia marchese di Terranuova, che avea occupata la stessa carica per destinazione fattane dal Gonzaga, come abbiamo detto in questo stesso capo all’anno 1539. Il dispaccio cesareo non fu registrato in Palermo, che agli 8 del seguente mese di maggio 852. Era veramente necessario un uomo attivo, e sperimentato al bisogno della Sicilia. Il Barbarossa avea saccheggiato le isole d’Ischia, e di Procida, dove avea fatti da mille e cinquecento schiavi. Lipari era stata presa; i suoi templi erano stati spogliati; le case svaligiate, e i miseri abitanti messi in ceppi al numero di settemila, che erano sopravvissuti dopo tanti disastri. La Sicilia perciò, e massimamente Messina, paventava un simile infortunio. Il marchese di Terranuova non trascurò di obbligare i cittadini a prendere le armi per la guardia di quella città, che era la più esposta. Vi furono anche chiamati i villani dei vicini paesi per fare delle fossate, e delle trincee, e furono anche obbligati alla custodia della città molti di Reggio, e dell’Abruzzo, che temendo le crudeltà del Barbarossa vi si erano ricoverati. In somma non fu intralasciato mezzo per provvedere alla sicurezza della medesima, la quale di poi si serenò all’arrivo di Giannettino Doria, che era venuto con trenta galee ben armate per tener lontano l’ammiraglio Ottomano 853. Dato, per quanto era in suo potere, ordine alla sicurezza della Sicilia, convocò il marchese di Terranuova per il dì 26 di gennaro 1545 uno straordinario parlamento in Palermo, nel qual giorno facendo considerare agli ordini dello stato le immense spese fatte dall’augusto Carlo non meno per resistere agli eserciti del re di 847 Questi, ch’era marchese della valle siciliana, viene dal Pirri (Chronol. reg. Sic. pag. 111) numerato fra i presidenti del regno in compagnia del conte di Chiusa. Il canonico Antonino Amico, mettendolo nella sua Cronologia de los Virreys ec. p. 22 l’unisce col conte di Chiusa, ma ci dice solo, ch’era capitano generale residente in Messina. Ripete le stesse parole dell’Amico Vincenzo d’Auria (Cronol. dei signori vicerè di Sicilia p. 39). Crediamo che abbiano questi due cronologisti meglio toccato nel segno, che il Pirri, quantunque siamo d’avviso che il Mendoza in Messina non abbia semplicemente esercitata la carica di capitan generale, ma siesi inoltre ingerito nel governo di quella città, e suo distretto indipendentemente dal Cardona; nel qual caso ancora non potea riputarsi che come uno strategoto, o governatore di quella città, non mai come un presidente del regno. 848 Mem. Stor. par. III, lib. VIII, vol. V, p. 159. 849 Il Caruso (Mem. Stor. par. III, lib. VIII, t. III, vol. V. p. 159) mentova due parlamenti tenuti dal conte di Chiusa, uno in Nicosia, e l’altro in Palermo; ma nè ci addita d’onde abbia tratto la notizia del parlamento di Nicosia, nè noi abbiamo veruno monumento, che la comprovi. 850 Merita di essere osservato negli atti di questo parlamento, che volendosi compresi tutti (trattine i soli poveri) alla contribuzione di questo donativo, vi sono per la prima volta nominati i Jaconi, o Diaconi salvaggi. Erano questi chierici ammogliati, i quali vestendo l’abito chericale, erano addetti al servizio della chiesa. Questi, che forse non aveano luogo, che nei due regni di Sicilia, e di Napoli, furono poi riformati dalla sacra congregazione di Roma l’anno 1623 sotto Gregorio XV. 851 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 231. 852 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1543.1544 II indiz. f. 393. 853 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 238, e seg. - 146 - Francia, che per allontanare il di lui collegato, cioè il gran signore, dall’Austria, che inoltrandosi vittorioso volea rapirgli, dimandò un nuovo sussidio. La Sicilia era spossata all’estremo per i frequenti donativi, che noi abbiamo rapportati, nè v’era maniera di poter compiacere il sovrano, stante la povertà, in cui erano particolarmente le città demaniali, e le terre baronali 854. Nondimeno la brama di [187] soddisfare in qualunque modo i desiderî dell’imperadore, li spinse ad offerire al medesimo cento mila scudi. Siccome però fu preveduto, che nelle presenti critiche circostanze non avrebbono potuto le comunità trarre dagli abitanti neppure un soldo, nè pagare la loro quota, così fu giudicato espediente, che il presidente del regno accordasse loro la facoltà, previo il consentimento del consiglio, di mettere nei loro territorî delle gabelle, e queste venderle, o darle a censo bollale, che fra noi chiamasi soggiogazione, per un dato tempo prefisso col volere dei cittadini, ad oggetto di pagare col capitale quella porzione del donativo, che dovessero 855. Per ripigliare il discorso del vicerè Gonzaga, che in questo istesso anno si restituì in Sicilia, è da sapersi che l’augusto Carlo s’avvalse del di lui valore per far fronte alle armi francesi, e lo spedì per suo luogotenente con un poderoso esercito nei Paesi Bassi, dove diede replicate prove della sua scienza militare, avendo respinto più volte il duca di Cleves, che a nome di Francesco I. era entrato ostilmente nel Brabante, e conservati gli stati Austriaci della bassa Germania al suo monarca. Passando di poi l’augusto Carlo unito al re d’Inghilterra a far la guerra nel cuore della Francia, il Gonzaga andò ancor egli a militarvi, ed essendosi cercata la pace frai due accaniti principi stracchi oramai di più guerreggiare, egli fu uno degli eletti plenipotenziarî per stabilirne i preliminari. Pacificatisi questi due sovrani col trattato de’ 17 di settembre 1544 potea il Gonzaga, e dovea ritornare al governo di Sicilia; ma sopravenutagli, dopo le fatiche della guerra, una grandissima, e pericolosa infermità in Mantova, dovette fermarvisi molto tempo, fino che si fosse interamente guarito. Rimesso in salute partì colla moglie, e i suoi figliuoli, e venne a Genova, dove imbarcatosi sulla flotta di quella repubblica veleggiò per il nostro regno, ed arrivò in Palermo al primo di novembre 1545 856, conducendo seco Pietro Cordova sacerdote spagnuolo, che l’augusto Carlo spediva come sindicatore de’ magistrati, contro i quali erano arrivati all’imperiale trono frequenti ricorsi 857. Recò egli seco il dispaccio imperiale colla firma dell’augusto Carlo in Brusselles a’ 9 di ottobre IV indizione 1545, per cui segli prorogava per altri tre anni la carica di vicerè di Sicilia, e dopo alcuni giorni, ch’era arrivato in Palermo, cioè agli 11 di novembre, ebbe egli la cura di farlo registrare 858. Si accorse pur troppo il Gonzaga al suo ritorno de’ disordini, ch’erano nati in Sicilia, mentre per sua commissione governavala il sonnolento Cardona. Era divenuta l’isola un nido di banditi, e di ladri, i quali commettevano nelle pubbliche vie ladronecci, ed altri enormi delitti, per la qual causa era impedito l’interno commercio a danno, e discapito di tutta la nazione. Volendo egli adunque riparare a questi mali, e risarcire l’errore, che commesso avea, eleggendo ben due volte per fini secondarî un uomo inettissimo al governo 859, immediatamente scelse due capitani d’armi, a’ quali assegnò un buon numero di soldati da cavallo, incaricandoli d’inseguire quei masnadieri, e di liberare il regno dalle loro vessazioni. Date queste pur troppo necessarie [188] disposizioni, intimò l’ordinario parlamento in Palermo da convocarsi per gli 11 di marzo dell’anno seguente 1546, in cui fu chiesto, ed accordato all’augusto Carlo il consueto donativo di trecento mila fiorini, e offerto al medesimo vicerè il solito regalo di cinque mila 860. Siccome i capitani d’armi, ch’ei avea spediti colla cavalleria per isconfiggere i ladri, doveano esser pagati; nè parea ragionevole cosa, che stessero costoro a carico del regio erario, ridondando il beneficio a favore della nazione: così egli nello stesso parlamento dimandò agli ordini dello stato, che si pagassero i soldi a costoro per il tempo, che aveano servito, e per qualche altro spazio ancora, in cui era necessario, che servissero, per nettare interamente il regno da quei pochi, che non erano ancora incappati nelle mani della giustizia, e per 854 La sola città di Patti fu privilegiata nel detto parlamento. L’ammiraglio turco Ariadeno dopo di avere apportati i danni, che abbiamo accennati, a Lipari, si era avvicinato alla detta città, non forse per altro, che per provvedere d’acqua la flotta. Gli abitanti all’approccio di costui sen’erano fuggiti, e la sua gente entrata in città, e trovandola deserta, la saccheggiò, e per fino rubò le campane dei templi a fine di fonderne dei cannoni. Trovandosi adunque i Pattesi, che poi ritornarono, allontanata l’armata turca, spogliati di tutti i loro averi, furono considerati come poverissimi, e perciò resi immuni dal pagamento del donativo (Del Carretto de bello Africano lib. III, t. I, della raccolta degli opuscoli di autori siciliani p. 113). 855 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 258, e seg. 856 Maurolico Sic. Hist. lib. VI, pag. 230 – Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1545.1546 IV ind. f. 490. 857 Qual esito avesse avuto la sindicatura del prete Cordova, non è indicato da’ nostri storici. I soli Messinesi Maurolico (Sic. Hist. lib. VI, p. 230), e Bonfiglio (Sic. Hist. P. II, lib. IV. p. 479) raccontano, che di Messina il conte d’Asaro strategoto di essa nella quaresima di quell’anno fu condannato per furti ed estorsioni fatte alla città dal detto Pietro di Cordova sindicatore. 858 Reg. della regia cancellerìa dell’anno 1545.1546 IV indiz. f. 209. 859 Scrive il Maurolico, che il Gonzaga appena ritornato ebbe prima d’ogni altro a cuore di far conchiudere le nozze da tanto tempo meditate fra Diana Cardona nipote del detto Alfonso, ed erede della Contea di Chiusa, e suo figliuolo; e che ne fe’ tosto celebrare gli sponsali, quantunque fosse quella dama già matura per aver marito, e il di lui figliuolo non avesse, che soli nove anni. Soggiunge, che fu festeggiato in Palermo questo accasamento con giostre, giochi di gente mascherata, e commedie (Sic. Hist. lib. VI, p. 230). 860 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 242. - 147 - render così una costante tranquillità a’ mercatanti, ed a’ viaggiatori. Parve assai giusta questa proposizione del vicerè ai tre bracci del parlamento, i quali accordarono once mille per le paghe suddette. Ma poichè non voleano aggravare la nazione, e altronde era rimasta qualche considerabile porzione dei 50 mila scudi, che nel parlamento straordinario dell’anno antecedente si erano tassati a pagare per la difesa del regno, perciò determinarono, che la detta somma si prendesse dal denaro sopravvanzato. Furono però eccettuati i quindici mila scudi, che la città di Palermo avea avuto in prestito da’ deputati, affine di piantare in Palermo la fabbrica dei panni, che si volle che restassero nelle mani del senato, in guisa che, se il restante non arrivava alle once mille, si stabilì, che ciò che mancava per compir questa somma, si dovesse pagare da tutto il regno 861 . Fu eletto per ambasciadore del parlamento Antonio Branciforte barone di Mirto, il quale portatosi a Ratisbona, dove era l’augusto Carlo, fe’ l’offerta del donativo nel dì ultimo di luglio dello stesso anno, e ottenne alcune delle grazie, che i parlamentarî aveano dimandato, come si può osservare nei capitoli del regno 862. Poco si trattenne presso di noi dopo il parlamento il vicerè Gonzaga. Era morto intorno a quel tempo Alfonso Avalos marchese del Vasto, ed uno dei più sperimentati capitani, che avesse avuto Cesare, il quale era governatore di Milano. Questo stato era la pupilla degli occhi di Carlo, e perciò bisognava sostituirgli un uomo del pari sperimentato, e prode, come l’Avalos. Tale fu riputato il nostro vicerè dal detto monarca, il quale gli ordinò, che abbandonato il regno di Sicilia, e scegliendo un presidente, fino ch’egli avesse pensato ad eleggere un vicerè, passasse tostamente a Milano per governare quello stato. Ferdinando adunque disponendosi alla partenza, ci lasciò per presidente del regno Ambrogio Santapau, marchese di Licodìa come costa dall’atto di elezione fatto in Palermo agli 11 di maggio 1546 863, e di poi partì. Da quanto abbiamo sparsamente raccontato di questo vicerè, che fu principe di Molfetta, e duca d’Ariano, ognuno di leggieri riconosce con quanta di ragione l’augusto Carlo l’abbia sempre avuto in estimazione, e siesi sempre di esso valuto nelle più scabrose contingenze. Guerriero singolare, politico eccellente, e saggio governante, che, malgrado il suo lungo viceregnato, seppe sempre farsi amare dai popoli. La Sicilia molto deve a questo cavaliere, avendola fortificata in tutti i lidi marittimi, e resa inaccessibile a’ nemici. In Palermo oltre i due baloardi di Santa Maria dello Spasimo, e della porta di Carini, migliorò, e rese più forte il castello, che guarda il Molo: i castelli di Trapani, di Milazzo, di Catania, di Siracusa, e di Agosta furono dal medesimo ristorati; ma più che ogni altra città gli deve quella di Messina, che nulla ostanti gli ostacoli, che incontrò a renderla forte, seppe così bene munire, cingendola di muraglie, ergendovi il castello Gonzaga, facendovi degli altri baloardi nelle sue colline, e riducendo a fortezza rispettabile il castello del Salvadore, che guarda lo stretto, e difende quello importante porto. Avea egli in animo di fortificare Lentini città molto opportuna a liberare il regno dalle incursioni dei Turchi; ma chiamato a Milano non potè eseguire quest’altro utile disegno. In Palermo istituì la nobile compagnìa del Santissimo Crocifisso detta de’ Bianchi, secondando le premure del P. Pietro Pecorella napolitano dell’ordine dei minori di S. Francesco, la quale caritatevolmente assiste i condannati al patibolo. [189] Evvi nel vestibolo di questa compagnia il busto di esso vicerè, e vi si legge la seguente iscrizione: Ferdinandi Gonzaga Siciliae Proregis, cujus auspiciis sacellum hoc Christo Crucifixo dicatum erectum est anno MDXXXXII. Vi si veggono ancora le sue armi col motto: Vetustissimae Gonzagae Prosapiae praeclara Insignia. Non contento egli di avere istituita questa nobile compagnia, e di esservisi arrollato, ne volle perpetuare la memoria con una prammatica 864 sottoscritta in Palermo agli 8 di settembre 1541, con cui ordinò al tribunale della gran corte, alla corte del capitano di Palermo, e a tutte le altre corti di giustizia criminale residenti in Palermo, che condannando alcun reo alla morte, dovessero tre giorni prima avvisarne la compagnia de’ bianchi, acciò prendendo sopra di sè la cura di prepararlo a morire, potesse disporre ciò, che fosse conveniente. Del breve governo del marchese di Licodìa nulla abbiamo da dire. Egli si fermò in Messina, dove dapprima esercitava l’onorifica carica di strategoto, e, mentre era ivi ricevè dal vicerè Gonzaga una seconda cedola data in Ratisbona ai 10 di giugno dello stesso anno 1546, in cui lo confermò presidente del regno, ch’ei fece registrare in detta città nel dì ultimo di luglio dello stesso anno 865. Dalla data di questa cedola ricaviamo, che il Gonzaga non andò direttamente al suo destino di Milano, ma si portò prima a Ratisbona, dove risedea l’augusto Carlo, per ricevere i sovrani oracoli intorno al nuovo governo di Milano. CAPO V. Giovanni de Vega vicerè di Sicilia. Ferdinando Vega suo figliuolo, Pietro d’Aragona cardinale arcivescovo 861 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 243, e seg. Tom. II in Carolo V. p. 167, e seg. 863 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1545.1546 IV indiz. fogl. 534. 864 T. I, pragm. tit. III. p. 302. 865 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1545.1546 IV indiz. f. 723. 862 - 148 - di Palermo presidenti del regno. Essendosi l’imperatore Carlo V. determinato di non più rimandare in Sicilia il principe di Molfetta Ferdinando Gonzaga, cui oltre il governo dello stato di Milano avea conferita ancora la insigne carica di capitan generale in tutta l’Italia, gli fu d’uopo, che destinasse un altro vicerè al nostro regno, e però scelse a questo posto Giovanni de Vega, come si fa chiaro dal suo imperiale dispaccio sottoscritto nella città imperiale di Aprun nella Svevia ai 24 del mese di dicembre 1546 866, che fu di poi registrato in Palermo nel dì ultimo di maggio del seguente anno 1547. Era il Vega riputato per un degno successore del Gonzaga dall’augusto Carlo, il quale se n’era servito con profitto nei maneggi dei più intrigati affari, e contava molto nello sperimentato di lui valore, che avea in diversi incontri riconosciuto. Stavasi egli, quando fu scelto per nostro vicerè, in Roma col carattere di ambasciadore imperiale presso il pontefice Paolo III, commissione allora scabrosissima, per le guerre, che teneano occupato l’augusto Carlo, così contro il re di Francia, come contro il Turco, e contro i principi della Germania, e per l’eresia di Lutero, che avea preso tanto piede in quelle regioni, per cui era necessario un ministro accorto, e diligente per tenersi amica la corte romana, che potea molto influire ad accrescere, o ad ismorzare questo incendio. Giunse egli in Palermo sulla fine del mese di maggio 1547, e vi si trattenne alcuni mesi. I principî del suo governo furono al sommo aspri, ed i Siciliani assuefatti alle maniere dolci del Gonzaga restarono atterriti nell’osservare l’eccessivo rigore, con cui operava. Il Caruso 867 racconta, ch’ei condannò a morte il marchese di Pietraperzìa, che dovette essere Guglielmo Barresi, uno dei principali baroni del regno, e un certo Covello avvocato. Bisogna essere d’accordo, che essendo il Gonzaga dimorato molto tempo fuori dell’isola, servendo nelle guerre il suo sovrano, si era introdotta una certa anarchìa nel regno, per cui i nobili, e i magistrati usavano delle prepotenze, e delle angarie, che i presidenti del regno non seppero, o non vollero gastigare, o perchè erano nazionali, o perchè sapeano, che breve sarebbe stata la durata della loro autorità, ed amavano più presto di lasciare correre i disordini, che di attrarsi l’odio di questi usurpatori, che terminata la loro presidenza poteano sperimentare nemici irreconciliabili. Il [190] Vega adunque volendo troncare le teste di questa nascente Idra, che tiranneggiava i popoli, si armò di uno eccessivo rigore, e diede il primo esempio, gastigando severamente uno dei più cospicui magnati, e uno dei più rinomati ministri. Noi avremo occasione in appresso di descrivere il carattere austero di questo vicerè, che spesse volte era scompagnato dalla prudenza, e diveniva perciò ingiusto. Partì il Vega da Palermo nei primi di settembre dello stesso anno, conducendo seco la sua famiglia, e tutti i magistrati, e imbarcatosi sulle galee di Sicilia andò a risedere in Messina, dove arrivò nel dì 9 di esso mese, e vi fu ricevuto colle solite onorificenze 868. Avea egli in mira di continuare le opere del suo antecessore, e di ridurre la Sicilia in istato da non più temere lo sbarco dell’armata Turca, o le scorrerie dei pirati. Avea intimato in detta città per li 28 di esso mese un generale parlamento per ordine di Cesare, nel qual giorno richiese un sussidio straordinario nelle presenti guerre, che l’augusto principe sostenea, così per difendere i suoi stati dalle invasioni del Turco, come per sostenere a fronte della nata eresìa di Lutero la sagrosanta cattolica religione 869. Congregatisi i tre bracci, dopo diverse sessioni ai 9 del seguente mese offerirono un donativo di centocinquantamila scudi, pagabili in tre volte, come si fa palese dagli atti di questa adunanza, nei quali fu accordato al vicerè il regalo di tre mila scudi, e fu egli dichiarato regnicolo. In questo istesso anno, essendo accaduta in Napoli la famosa tumultuazione contro il vicerè Toledo, il quale sotto il pretesto che le nate eresìe di Lutero, e di Zuinglio andavano serpeggiando nel regno 870, volea introdurre il temuto formidabile tribunale del S. Uffizio tanto abborrito da quella nazione; quindi questo vicerè richiese dei soccorsi di truppe così al Gonzaga allora governatore di Milano, come al nostro Giovanni de Vega, il quale non potendo sguernire la Sicilia, gli mandò solo ottocento fanti 871. Intanto il Vega si applicò a far calcolare la popolazione, che era in Sicilia, che noi chiamiamo: Enumerazione delle anime. Questa secondo le nostre memorie fu la seconda, che fu fatta in Sicilia nel presente secolo, e fu la prima sotto i principi Austriaci; giacchè quella, che la precesse, fu ordinata al vicerè la Nuça, vivendo Ferdinando il 866 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1546.1547 V indiz. f. 457. Mem. Stor. P. III, lib. VIII, t. III, vol. V, p. 162. 868 Maurolico Sic. Hist. lib. VI pag. 231. 869 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 246. 870 Scrisse il Giannone (Hist. del regno di Napoli lib. XXXII, capo V, p. 638, e seg.) che il celebre Bernardino Ochino cappuccino avea predicato in Napoli, e sparsi i semi del luteranismo, e ch’era seguito da altri, fra i quali numera Lorenzo Romano siciliano apostata de’ PP. Agostiniani, il quale dopo di avere sparsi in varj luoghi del regno gli errori del Zuinglio, era andato in Germania per vieppiù istruirsi della eresia allora dominante di Lutero, e poi ritornato in Napoli avea insegnata la logica di Melantone, e spiegava l’epistole di S. Paolo giusta i sentimenti di quello eresiarca. Di questo figliuolo della perdizione non parlano punto i nostri storici. 871 Muratori Annali d’Italia all’anno 1547 t. X, pag. 293. 867 - 149 - Cattolico, l’anno 1501. Furono trovate le famiglie, giusta ciò, che ne lasciò scritto il Fazello 872, montare in tutte le tre valli a 172267, e gli abitanti secondo il Mongitore 873, trattine quelli della città di Messina, che aveano il privilegio di non essere numerati, ad 818152. Siccome queste enumerazioni si fanno a due oggetti, e per distribuire equabilmente i pesi dei donativi, e per sapere quante persone possono trarsi da ciaschedun paese per la milizia, senza recar danno all’agricoltura, alla pastorizia, e alle arti necessarie; così ognuno dee persuadersi che codesti calcoli non sono mai esatti; avvegnachè ogni città, e terra cerca di fare apparire sempre minore il numero dei suoi abitatori, perchè meno uomini se ne traggano per la guerra, e minori pesi s’impongano alle medesime. Era oramai stanco, ed annoiato l’augusto Carlo dalle continove guerre, che sostenuto avea dachè era entrato al governo delle Spagne; e le tante fatiche personalmente sostenute ora in Italia, ora nella Germania, ora nella Francia, ora nelle Fiandre, e nel seno ancora degli stati Spagnuoli, alle quali non potea più reggere per il doloroso morbo della podagra, cui si era soggettato, non gli davano più il cuore di continuare in questo penoso esercizio. Laonde pensò di chiamare in Italia il suo primogenito il principe Filippo per affidargli il comando degli eserciti. Il viaggio di questo principe non potea eseguirsi senza dispendio, e il suo erario era esausto. Scrisse adunque al vicerè Giovanni de Vega, acciò ricercasse dal nostro regno [191] non solamente l’ordinario donativo dei trecento mila fiorini, ma inoltre qualche aiuto di costa non meno per il viaggio suddetto del suo figliuolo, che per la dote di sua figlia la principessa Maria, che già avea promessa per sposa all’arciduca Massimiliano figliuolo di Leopoldo suo fratello. Il Vega adunque partitosi da Messina ritornò nell’anno 1549 in Palermo, dove intimò per i 2 di aprile l’ordinario parlamento nella sala del regio palagio, e arrivato il detto giorno propose agli ordini dello stato le dimande dell’augusto Carlo, i quali dopo varî congressi nel dì 13 dello stesso mese diedero la risposta al vicerè, offerendo a Cesare oltre il solito donativo di trecento mila fiorini, altri cento mila scudi di straordinario sussidio, dei quali dodeci mila e cinquecento fossero destinati per dote dell’illustre sua figliuola, che andava a marito, ed ottantasettemila, e cinquecento per il viaggio dell’infante primogenito dell’imperadore, e per le altre spese, che far dovea S.M.I., protestando di non poter fare nelle angustie, in cui si trovava il regno, un donativo maggiore, come avrebbono desiderato 874. Furono in questo parlamento dimandate al solito alcune grazie, e fu eletto lo stesso vicerè, cui fu fatto il consueto regalo di cinque mila fiorini, per ambasciadore di quella assemblea. Queste grazie furono poi accordate l’anno 1550 seguente, sebbene non si fossero pubblicate in Palermo, che l’anno 1561 875, dal suo successore il vicerè Giovanni la Cerda 876. In questo istesso parlamento fu ancora proposto, che era necessario per la sicurezza del regno, che si compissero le fortificazioni cominciate dal Gonzaga, per le quali sarebbesi reso inespugnabile, e fu stabilita una tassa di cento mila scudi da pagarsi fra lo spazio di sei anni 877. Terminato questo parlamento, intento il Vega a munire il regno, partì nel seguente maggio da Palermo colla moglie, e andò a visitare la città di Catania, dove ordinò che vi si fabbricasse un altro baluardo; assistè egli stesso al taglio delle pietre necessarie per la detta fortificazione, e incaricò i capi di quella città, acciò invigilassero sopra i fabbricatori perchè questo bastione fosse colla possibile sollecitudine portato al suo termine 878. Noi crediamo che intorno a questo tempo siensi ancora fabbricati in Palermo i due baluardi, l’uno dei quali era detto volgarmente del tuono, che era frammesso tra le due porte Felice e dei Greci, e l’altro di là di quest’ultima porta verso il piano di S. Erasmo, che prese il nome dallo stesso vicerè, su cui stava uno scudo di marmo, in cui era scolpita la tanto decantata senza verun fondamento iscrizione: Vega dedit nomen et formam 879. 872 Dec. II, lib. X, t. III, p. 249 e 250. Mem. Stor. dei parlam. t. I, pag. 89. 874 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 249. 875 Cap. regni Sic. t. II, in Carolo V. p. 203. 876 Monsignor Francesco Testa nella raccolta dei capitoli del regno (t. II, p. 204 nota a) vedendo che nell’introduzione ai capitoli si mentova il parlamento dell’anno 1549, nè trovandone gli atti nella raccolta del Mongitore, scrisse che questi si erano perduti. Il paroco Francesco Serio, nella ristampa fatta dei parlamenti (t. I, p. 233 nota a) avverte di averli trovati nell’uffizio del protonotaro; ma non si accorse, che non ci diede, che gli stessi atti rapportati dal zio l’anno 1548, sebbene un poco più distesi. Basta leggere gli uni, e gli altri per vederne l’uniformità; la stessa indizione, che dovè cadere nell’anno 1549, lo stesso giorno 2 di aprile dell’apertura, lo stesso giorno 13 del medesimo mese, in cui fu data la risposta dai parlamentarj, lo stesso donativo così ordinario, che straordinario, e lo stesso foglio del registro del protonotaro appalesano, che gli uni, e gli altri non sono, che dello stesso parlamento. Vi si aggiunga, che il parlamento ordinario di tre in tre anni non potea cadere, che nell’anno 1549, imperciocchè l’antecedente si era celebrato l’anno 1546. Avrebbe perciò meglio fatto il Serio, se avesse avvertito, che questa adunanza si era tenuta nell’aprile dell’anno 1549, con cui avrebbe corretti in un colpo due errori, quello dello zio, che lo pose l’anno 1548, in cui nel mese di aprile non potea cadere la settima indizione, ma la sesta, e quella di Monsignore Testa, che credette di essersene perduti gli atti, senza replicarli inutilmente. 877 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 259. 878 Amico Cat. Illustr. lib. VIII, cap. I, tom. II, pag. 388. 879 Questi due forti, ch’erano muniti di cannoni, furono diroccati dal senato di Palermo; quel del tuono l’anno 1754, essendo pretore Giovanni Maria Ramondetta duca di Montalbo, e quel del Vega l’anno 1783, sotto la pretura di Girolamo Graffeo principe di 873 - 150 - Non avea il Vega ordinata la numerazione degli abitanti per il solo motivo di far soffrire eguali pesi a’ nazionali, ma vi si era indotto principalmente, perchè avea in animo, come fece, di tenere in piedi un corpo di dieci mila fanti, e di mille e cinquecento soldati da cavallo, per essere pronti ad ogni temuta [192] invasione dei nemici. Volle egli che queste milizie urbane fossero divise in tante compagnie soggette ai sargenti maggiori, che egli avea eletti in varie parti del regno. Costoro non aveano soldo assegnato, godeano nondimeno del foro militare, ed erano obbligati solamente in certi prescritti tempi di presentarsi ai sargenti suddetti per essere istruiti negli esercizî militari. Quando poi il bisogno ricercava ch’eglino servissero giornalmente, allora i benestanti erano nell’obbligo di sostentare loro, e i cavalli; erano esenti da questa tassa i baroni feudatarî, i quali altronde erano tenuti al servizio militare. Un’altra assai utile provvidenza diede il Vega per difendere il regno dalle subite invasioni: cioè fe’ ergere per tutto il nostro littorale delle torri dette di avviso con una giusta proporzionata distanza l’una dall’altra. Furono destinati due uomini in ciascheduna di esse, acciò dormendo l’uno, l’altro vegliasse, con cannocchiali, affine di scuoprire i legni, che sono nel mare, e le loro qualità. Questi poi doveano, come al presente anche fanno, sul tramontare del sole avvisare quante navi vi abbiano scoperte, facendo dei fuochi 880 l’uno dietro l’altro. Da poi che la prima torre dava il segno, era seguita cogli stessi segnali dall’altra più vicina, e così di mano in mano da tutte le altre, in guisa che nello spazio di meno di una ora era tutto il regno avvisato dei legni ch’erano nel mare. Se alcuna delle torri vedea un maggior numero di navi, che non si fossero scoperte dalle antecedenti, doveano i custodi di esse fare un maggior numero di segni. Durante il giorno doveano questi uomini fare continove osservazioni, e nel caso che comparivano in mare legni sospetti, erano in obbligo di avvisarne subito i magistrati della vicina città, o terra 881. Queste torri, sebbene si fossero finite di fabbricare l’anno 1553, ebbero nondimeno il suo cominciamento l’anno 1549. La condotta tenuta dal Vega per la conservazione del regno fu molto gradita all’augusto Carlo, il quale siccome pensava di valersi di lui per tenere a freno i Mori dell’Affrica, che molestavano colle continue scorrerìe i suoi stati, così e perchè n’era contento, e perchè volea adoprarlo nella nuova impresa, gli prorogò il viceregnato per altri tre anni con un dispaccio dato in Brusselles a’ 12 di marzo 1550; che fu poi registrato in Palermo a’ 15 di maggio dello stesso anno 882, e gli ordinò, che agevolasse, come meglio potea, la conquista delle città dell’Affrica. N’era padrone Rais Dragutte famoso corsaro il quale dopo di essersene impossessato, era divenuto formidabilissimo nel mediterraneo. I lamenti dei popoli di Sicilia, e di Napoli, che arrivavano all’imperiale trono, dolendosi eglino ch’era per loro cessato il commercio, erano spessi, e continuati; laonde Carlo col suo consiglio pensò, che la sicurezza di questi due suoi regni ricercava, che quel corsaro fosse discacciato dalle occupate città, e massimamente da Mahadìa, ch’era la sua piazza d’armi, e il suo ricovero, dove per il vasto suo porto i vascelli, e le galee di Dragutte si rifuggivano. Fu dapprima destinato a questa impresa Andrea Doria ammiraglio delle galee imperiali, alle quali si unirono quelle, che vi spedì Giulio III. romano pontefice, e le altre della religione di Malta, colle quali forze il Doria prese Calibia, e la città, e castello di Monistero 883. Questa prima impresa messe a portata l’armata cesarea di tentare l’acquisto di Mahadìa, ch’era il principale scopo di questa guerra. Avea Carlo sollecitati i due vicerè di Napoli, e di Sicilia, acciò dassero al Doria ogni soccorso. Il primo vi spedì Garzìa di Toledo suo figliuolo con ventiquattro galee, oltre le barche, che apportavano gli attrezzi da guerra, e le munizioni. Il nostro vicerè de Vega non contento di aver fatti i necessarî preparativi, volle andare egli stesso a questa guerra; e perciò invitò il Doria a venire in Sicilia non solo per guardare le coste dalle incursioni di Dragutte, ma per [193] prenderlo a bordo, giacchè si era determinato di essere a parte di questa gloria. Il Doria restò dispiaciuto dell’invito, che gli rapiva la palma, che il Vega si sarebbe attribuita, e lo avrebbe distratto dalle conquiste, che stava facendo contro i Mori; ma siccome le sue istruzioni portavano che non si dovesse dipartire dai voleri del Vega, che l’augusto Carlo riputava il più sperimentato dei suoi generali, fu costretto ad ubbidire, e venne a Palermo, d’onde poi partì collo stesso vicerè per Trapani. Questi prima di abbandonare la Sicilia elesse per presidente del regno Ferdinando suo figliuolo, e gliene spedì il dispaccio nella capitale ai 20 di giugno 1550 884. Questa scelta fu di poi approvata dall’augusto Carlo ai 21 di agosto Partanna. Nella presente maniera di assalire le piazze, per cui i nemici si avvicinano al lido colle barche piatte, e così si salvano da’ cannoni de’ baluardi, questi sono diventati inutili, e si sono credute più opportune le batterie a fil d’acqua. Col diroccamento di questi forti è divenuta la marina di Palermo più nobile, e più spaziosa. 880 Presso di noi questi fuochi sono chiamati Fani verisimilmente dalla parola greca Φανóς, che significa una lampade. 881 Le mentovate torri sono al numero di trentasette, i di cui custodi sono mantenuti dalla deputazione del regno, la quale per assicurarli dalla invasione di qualche piccolo legno, vi collocò sin d’allora de’ cannoni, e li munì di palle, e di polvere per difendersi. La città di Palermo poi a parte nelle sue riviere ne fe’ ergere altre dieci, che sono mantenute dall’erario civico, e per le quali è il pretore avvisato di ora in ora di qualunque novità, che accade nel mare, che bagna il suo territorio. 882 Registro della regia cancellarìa dell’anno 1549.1550, VIII indiz. fogl. 565. 883 Vertot Hist. de Malte lib. XI, tom. IV, pag. 162, e seg. 884 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1549.1550 VIII indiz. f. 641. - 151 - per dispaccio dato in Auspurg, registrato indi nella stessa città di Palermo ai 10 di settembre dello stesso anno 885. La risoluzione del Vega di andare personalmente alla guerra in Affrica ebbe a fare attraversare questo disegno. Garzìa di Toledo pretendendo di essere indipendente, non volea ubbidire al Vega, che come vicerè, e capitano generale credea che gli appartenesse in terra il supremo comando. Fu d’uopo che il Doria si framezzasse, e dopo varie difficoltà fu risoluto che ciascheduno comandasse con assoluto potere le truppe a se affidate, e che la campagna fosse regolata dal consiglio di guerra, e dalla pluralità dei voti, e che gli ordini si dassero a nome dell’imperadore, come s’egli fosse presente a quello assedio. Accomodate queste differenze nella stessa città di Trapani, dove erano nate, partì la flotta, e andò all’assedio di Mahadìa, che Dragutte avea fortificata, e munita di soldatesche, e d’armi. Il primo assalto fu dato da’ Siciliani per ordine del Vega, malgrado il contrario avviso degli altri uffiziali, e fu funestissimo, essendo restati vittima delle spade moresche tutti coloro, che si avvicinarono alla breccia. Questo scacco, ch’ebbero le truppe siciliane, e le malattie entrate nello esercito, che trassero molti a morte 886, faceano già pensare a sciogliere l’assedio. Devesi al coraggio di Garzìa di Toledo, e a quello de’ cavalieri di Malta l’acquisto di quella città e del castello. Eglino assalendo una muraglia, che stava dalla parte del mare, ch’era indifesa, entrarono coraggiosamente in città, ed apportandovi lo scompiglio, obbligarono coloro, che stavano alla difesa della trincea, e del castello, ad abbandonarli, per occorrere dove credeano, che fosse entrato tutto l’esercito nemico, dando così campo alle truppe spagnuole, e siciliane di assalire gli abbandonati posti, ed impossessarsi della città, e della fortezza 887. Accadde questa conquista nel dì 11 di settembre. Il Vega, che a torto si attribuì l’onore di questa impresa, dopo di avere fatto un ricco bottino 888, si rimbarcò col Doria per andare alla seguela della flotta di Dragutte, che scappava; ma essendo i venti contrarî ritornò a Trapani nei primi di ottobre, dove si trattenne fino al mese di giugno del seguente anno 1551 prima di restituirsi alla capitale 889. Nacquero allora de’ disturbi fra lui, e l’ammiraglio Doria. Pretendea egli che questi lasciasse una porzione della flotta per la [194] difesa della Sicilia, che potea essere assalita dall’inviperito Dragutte. Ricusava il Doria di compiacerlo, assegnando per motivo della sua renitenza, che le sue galee erano in gran parte rovinate, e bisognose di essere risarcite, e che non era prudenza lo avventurarle contro la flotta di quel corsaro, ch’era bene in ordine per combattere. Siccome il Doria era indipendente dal vicerè, malgrado il di lui disgusto, lo abbandonò, e andossene a Genova con tutta l’armata per riparare le sue navi. Non erano privi di fondamento i sospetti del nostro vicerè. Dragutte irritato della perdita fatta nell’Affrica ebbe modo di fare entrare nei suoi interessi Solimano imperatore dei Turchi, il quale suscitato ancora da Arrigo II. re di Francia determinò di far la guerra all’augusto Carlo, e creò Dragutte Sangiacco, ossia governatore dell’isola di Santa Maora, dandogli ogni potere per apportar le armi contro Cesare. Il Vega a vista dei pericoli, da’ quali era minacciato il regno, non solamente spedì, giusta l’ordine che ne avea avuto, le galee siciliane al Doria destinato da Carlo a perseguitare Dragutte, ma si applicò ancora a mettere tutta l’isola al coperto delle temute invasioni. Avea già egli, come si è detto, fortificato il castello di Catania, perfezionati i forti incominciati in Messina dal Gonzaga, ed innalzati due baluardi in Palermo. Ora crediamo, che ei siesi rivolto a fabbricare una nuova città presso quella di Lentini, i di cui abitanti erano sempre a rischio di essere sorpresi dai nemici, in un luogo erto, e inespugnabile, cui volle dare il nome dell’imperadore, e quello della città vicina, e la chiamò a quest’oggetto Carlentini. Per quanto però questo vicerè si fosse adoprato a fortificare la Sicilia, non perciò era sicuro di poterla difendere, se una flotta navale non battesse i nostri mari. Solimano, oltre la protezione accordata al Dragutte, avea già fatta allestire in Costantinopoli una poderosa armata, il di cui comando era affidato a Sinam Bassà. 885 Reg. ivi dell’anno 1550.1551 IX indiz. f. 17. Vuolsi, che fra quei, che lasciarono la vita, vi fosse Mulei-Assen, il quale spogliato dal figlio del proprio regno, abbandonato dai suoi, accecato, e carcerato, avea avuto modo di scapparne, e di ricoverarsi in Sicilia, dove per ordine dell’augusto Carlo era stato trattato nobilmente. O che questi spontaneamente si fosse esibito di andare in Affrica, sperando di potere ritornare al suo soglio, o che il Vega ve lo avesse con promesse invitato, contando sulle vecchie aderenze, che costui potea avere, di poter meglio riuscire nell’impresa, s’imbarcò coll’armata. Dovette egli morire di morte naturale, imperocchè essendo cieco non era in grado di adoprare le mani. 887 Vertot Hist. de Malte lib. XI, tom. II, p. 173. 888 Questo bottino fu considerabile, avvegnachè oltre le ricchezze de’ particolari, eranvi in quel porto molti magazzini di ricchi mercadanti, che furono saccheggiati. Il Vega ne distribuì porzione alle truppe, ne mandò una buona parte all’imperadore; assegnò alla religione, e cavalieri di Malta la loro quota, e regalò al Papa le bandiere turche, ed alcuni leoni dimesticati, e cani riccamente ornati con ori, ed argenti. Giulio III. gradì al sommo la notizia, e i doni mandatigli dal vicerè, come costa dalla lettera rapportata dal Rainaldo. (In ann. ad ann. 1550 t. XIV, p. 394 num. 46), dalla quale intendiamo, che era morto in questa spedizione il primogenito di esso vicerè, per cui venghiamo a sapere che Ferdinando, il quale ci fu lasciato per presidente, non era il primo. Di detto bottino non ebbe la città di Palermo, che la porta di ferro, che tuttavia esiste affissa alla porta da noi detta dei Greci, così chiamata dalla contrada, in cui i greci abitavano. 889 Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1550.1551, IX indiz. f. 41, e 495. 886 - 152 - Fu perciò esposto il pericolo, in cui erano i due regni di Napoli, e di Sicilia, all’augusto Carlo, il quale ordinò al Doria, che dopo di avere inutilmente inseguito il Dragutte, se n’era ritornato a Genova, che ne uscisse colla squadra, e venisse al soccorso de’ suddetti due regni. Il Vega ancora scrisse efficaci lettere al gran maestro, acciò per la comune sicurezza mandasse le galee della religione a Messina per unirsi all’armata cesarea, il che fu fatto, malgrado la opposizione del consiglio dei cavalieri di Malta 890. Mentre le flottiglie di Napoli, di Sicilia, e di Malta erano in Messina comparve nel principio di luglio dell’anno 1551 la formidabile armata di Solimano, e fermatasi a’ 10 di esso mese nello stretto, Sinam, che la comandava, fe’ dimandare a nome del suo Sultano al vicerè Vega, che fin da’ primi sospetti di questo armamento da Palermo era andato a risedere in quella città, che se gli restituissero Calibia, Monistero, e Mahadìa. Fu facile al vicerè lo schernirsi da questa dimanda, dichiarando, che questa richiesta era da farsi unicamente a Cesare suo padrone. Sinam, persuaso che la Sicilia fosse ben fortificata, si contentò di saccheggiare la sola città di Augusta, che il Vega non avea avuto ancora spazio di mettere in istato di difesa, e di poi veleggiò verso l’isola di Malta. Non appartiene a questa storia il racconto dell’assedio di questa isola, della sua liberazione per uno stratagemma inventato dal ricevitore di Malta, che risedea in Messina, e della perdita della città, e castello di Tripoli, ch’era posseduto da’ cavalieri di quella religione. Solo diremo che molto contribuì a queste disavventure lo stesso Vega, il quale o perchè veramente credesse che non fosse espediente di sfornire la Sicilia del pari minacciata dalla stessa armata turca, per soccorrere Malta, o perchè fosse personalmente nemico del gran maestro, che si era negato di dare la Croce con una grossa commenda a Saverio Vega uno de’ suoi figliuoli 891, è certo che alle vive istanze di quell’ordine ricusò sempre di ajutarlo, e non vi mandò che il tenue soccorso di dugento Calabresi villani, ch’erano atti a tutt’altro, che a menare le mani. Intanto i frequenti timori, da’ quali era agitato il nostro regno, avendo fatto cessare interamente l’esterno commercio, ed essendo perciò falliti molti mercadanti, cominciò a [195] mancare il denaro in Sicilia, e questa mancanza fe’ anche incagliare l’interno traffico dell’isola. Il Vega volendo ripararvi ordinò che tutto l’argento, e l’oro, che aveano i particolari, fosse trasportato nella zecca di Messina per ridursi in moneta; solo ne furono eccettuati i vasi sacri, e gli argenti di piccolo peso 892. Il Maurolico 893, ch’era autore vivente e dimorava in Messina, racconta che più di cento giumenti carichi di argenti, ed ori arrivarono in detta occasione in quella zecca. Si trattenne il Vega in Trapani, come si è detto, fino al mese di giugno 1551 894, e di là venne in Palermo, e subito passò in Messina, dove era necessario nelle presenti critiche circostanze, che risedesse; noi lo ritroviamo in quella città a’ 15 di questo mese 895. Avvicinavasi intanto il tempo dell’ordinario parlamento, che il Vega convocò nella città di Catania per il dì 30 di marzo dell’anno seguente 1552. Vi andò egli, ed alloggiò nella casa di Vincenzo Gravina, dove nel prescritto giorno, presenti gli ordini dello stato, fe’ l’inchiesta del solito donativo, che i parlamentarî accordarono nella stessa somma di trecento mila fiorini, ossia cento cinquanta mila scudi nel giorno 9 del seguente mese di aprile 896. Merita in questa occasione di essere commendata la generosità del vicerè, cui essendo stato offerto il regalo di seimila scudi, cioè una maggiore somma del consueto, forse in riguardo di quanto si era affaticato per la difesa del regno, egli avendo in considerazione lo stato deplorabile, in cui era la nazione, con ammirabile disinteresse lo ricusò 897. Venendo l’estate di quest’anno ricomparve nei mari di Messina l’armata ottomana forte di cento quindici vele, e comandata dallo stesso Dragutte. Ne restarono atterriti i Siciliani, e i Maltesi; ma il loro terrore fu di breve durata, avvegnacchè in capo a poco partì, e andò in Calabria, e poi ne’ mari di Procida, dove si trattenne aspettando inutilmente la flotta francese fino a’ 10 dei mese di agosto. In questo frattempo, in cui era cessato il timore dei Turchi, ebbe il vicerè il piacere di celebrare le nozze di Elisabetta sua figliuola con Pietro de Luna conte di Vivona, che furono solennizzate nel mese di luglio con somma splendidezza nella sala del regio palagio 898. In capo a poco, cioè a’ 15 di agosto, fu veduta di nuovo nello stretto di Messina la flotta turca, la quale dopo di aver fatto del guasto in Reggio, e ne’ casali convicini prese la via di levante. Comparve di poi nel seguente settembre la squadra francese comandata dal rubello principe di Salerno, la quale non vi si fermò, nè fe’ alla Sicilia alcun danno, ma direttamente navigò verso l’oriente per unirsi all’armata turca 899. 890 Vertot Hist. de Malte, lib. XI t. IV p. 189. Caruso Mem. Stor. P. III, lib. VIII, tom. III, vol. V, pag. 163. 892 Prammatica data in Trapani a’ 20 di marzo 1551. – Registro del prot. dell’anno 1550.1551 IX indiz. f. 389. 893 Sic. Hist. lib. VI, p. 253. 894 Reg. del Prot. dell’anno 1550.1551 IX indiz. f. 495. 895 Ivi f. 496. 896 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 263. 897 Mongit. ivi pag. 369. 898 Maurolico Sic. Hist. lib. VII, pag. 253. 899 Maurolico ivi. 891 - 153 - Fu più funesto al nostro regno l’anno seguente 1553. Il principe di Salerno nemico giurato dell’imperadore Carlo V, e ammiraglio del re di Francia avea ottenuto da Solimano, che la flotta ottomana ritornasse ne’ nostri mari per molestarci. Vi comparve in fatti a’ 6 di giugno con ottanta galee unite alle francesi il famoso Dragutte, e dopo di avere saccheggiato l’Abruzzo, venne in Sicilia, ed avendo recato considerabili danni alla città di Agosta, passò alla Licata, dove fe seicento schiavi, ed indi a Sciacca, dove deluso dagli stratagemmi di Antonio Amodei, che vi comandava, credendo che quella città fosse guernita di molte truppe, si astenne dal tentarne l’acquisto, e venne alla isola della Pantellerìa, dove s’impadronì del castello, trasse in ischiavitù da mille persone, e carico di bottino andossene in Corsica 900. Ritornò l’implacabile Dragutte nell’estate dell’anno seguente 1554 a comparire ne’ nostri mari; ma per nostra buona sorte non prese di mira la Sicilia, ma rivolse le prore verso il regno di Napoli, e in particolare cominciò a tempestare le provincie della Puglia. Ne fu avvisato il Doria, il quale quantunque fosse decrepito, s’imbarcò sopra una flotta di 60 galee, e venne nel principio di agosto in Messina, dove si trattenne tre giorni per conferire col nostro vicerè Vega, e diviato partì per assalire Dragutte, e difendere [196] l’afflitta Puglia. Non si fe’ però trovare quel corsaro, che carico di bottino sen’era ritornato in levante. Il Doria adunque se ne venne di nuovo dopo pochi giorni a Messina, e di poi prese la via di Genova, senz’avere nulla operato. Il vicerè de Vega non lasciò in queste occasioni di dare le necessarie provvidenze per impedire i maggiori danni, che gli Ottomani uniti a’ Francesi poteano arrecare alla Sicilia. Ma come vide che quelle flotte si erano allontanate, pensò di eseguire al più presto che potesse gli ordini imperiali. Carlo, essendo il suo erario dissanguato per le frequenti spese, che facea per conservare il nostro regno, comandò che si convocasse un parlamento straordinario, per avere un nuovo sussidio, che gli era necessario nelle presenti urgenti necessità. Fu stabilito il dì 2 di settembre dell’anno 1554 per questa radunanza, che si dovea tenere nella città di Messina. I parlamentarî in questa occasione conoscendo vero il bisogno di Cesare, e considerando la sicurezza del regno, a’ 9 di esso mese dopo di aver fatte le loro conferenze, offerirono al medesimo un donativo di cento mila scudi da pagarsi in due anni, venticinque mila scudi per ogni semestre, e perchè le università così demaniali, che baronali erano ancora esse esauste di denari, fu loro permesso d’imporre delle nuove gabelle, per supplire a quella porzione, che ciascheduna pagar dovea 901. Ricorrea il tempo dell’ordinario parlamento, e perciò, rimosso ogni sospetto dell’armata turca, il vicerè nel mese di novembre se ne ritornò in Palermo, dalla quale città era stato per qualche anno lontano, e convocò l’assemblea de’ tre ordini del regno per li primi di marzo 1555. Giunto il giorno dell’apertura del parlamento il Vega non solo dimandò a nome dell’augusto Carlo il solito donativo, ma inoltre la prorogazione di quello di cento mila fiorini per altri sei anni, affine di compiere le fortificazioni; e siccome i ponti del regno erano tutti rovinati, ciò che attraversava il commercio interno, richiese qualche sussidio per ripararli, ovvero per rifabbricarli. Condiscesero a’ voleri del vicerè i parlamentarî, e nel dì 8 dello stesso mese accordarono li soliti trecento mila fiorini, si obbligarono per altri cento mila in sei anni per le fortificazioni, ne assegnarono la somma di quarantotto mila, pagabili parimente nello spazio di sei anni, per le fabbriche, o ristori de’ ponti 902. Era poco prima venuto in Sicilia il conte Brocardo Persico a portare la lieta notizia, come il principe Filippo primogenito, già dichiarato re dal padre, era passato alle seconde nozze, ed avea sposata la regina Maria figliuola di Arrigo VIII, ed erede del regno d’Inghilterra 903. A questi in riconoscenza accordò il parlamento un regalo di mille once, come al vicerè fece il solito dono di cinque mila fiorini. Fu eletto per ambasciadore del parlamento lo stesso vicerè per far presentare questa offerta all’augusto Carlo, e richiedergli due sole grazie, che leggonsi ne’ capitoli del regno 904. Era veramente il vicerè de Vega in pessimo stato di salute, e desiderava di riposarsi per alcun tempo dalle fatiche del governo, e di respirare una migliore aria, per cui ne avea già ottenuto il permesso. Dopo il parlamento dunque si dispose alla partenza, ed in forza della podestà che avea di scegliere un presidente, durante la sua lontananza, elesse con dispaccio viceregio dato [197] in Palermo a’ 25 di aprile di quest’anno 900 Fazello tom. III, dec. II, lib. X, pag. 261. – Maurolico Sic. Hist. lib. IV, pag. 233. Mongit. Parl. di Sic. tom I, pag. 269. 902 Mongit. Parl. di Sic. tom I, pag. 274. 903 Nell’occasione di queste nozze, sembrando conveniente che questa gran regina si unisse in matrimonio con un re, l’augusto Carlo gli cesse il regno di Napoli, e il ducato di Milano. Deve in questo luogo correggersi l’errore del Giannone (Istoria civile del regno di Napoli lib. XXXII, cap. 7. p. 699), il quale scrisse, che gli fu anche cessa la Sicilia. Questo regno fu conservato da Cesare, e il Vega non ebbe da Filippo la conferma del viceregnato, come diremo, che a’ 26 di marzo 1556, dopo che il padre gli avea cesso tutti gli stati, che possedea in Europa, e nel nuovo mondo. Oltracchè nell’atto della rinunzia de’ 6 di febbraro 1556. (Sandoval, Historia del Emperador Carlos V, lib. XXXII, §. XXXVIII pag. 815), per cui l’augusto Carlo si spogliava a favore del figlio Filippo de’ suoi regni, questo principe è sempre nominato Rey de Ingalaterra y Napoles, e Maria sua moglie è detta Reyna de Ingalaterra, y Sennora etc. y de Reyno de Napoles, y Estado de Milan, senza punto nominarsi il nostro regno di Sicilia. Finalmente noi vedremo fra poco che Filippo non prese possesso del nostro regno, nè ricevette il ligio omaggio da’ Siciliani, che nell’anno 1556 nel parlamento, che allor si tenne in Messina nel mese di giugno. 904 Tom. II. in Carolo V. p. 222. 901 - 154 - il proprio figliuolo Ferdinando 905, ch’era stato un’altra volta in questa carica, quando egli era andato alla guerra d’Affrica l’anno 1550. Non ci si addita dove il detto vicerè sia andato: il canonico Amico 906, e dietro a lui l’Auria 907 vogliono, ch’ei fosse partito dalla Sicilia, ma a noi ostano i monumenti della cancellarìa regia, dai quali rileviamo che il di lui figliuolo non durò neppure un mese nel governo, e ch’ei lo riassunse prima di terminare il mese di maggio dello stesso anno 1555 908; laonde sospettiamo, che ei si fosse piuttosto ritirato nella campagna di S. Giovanni di Baida, la di cui aria avea altre volte sperimentato salubre 909. Questa elezione piacque all’imperadore, il quale la confermò con suo diploma dato in Brusselles nel dì ultimo di maggio del medesimo anno 910. La carta imperiale trovasi registrata giusta i volumi della cancellarìa regia nella città di Taormina ai 23 di giugno del mentovato anno 1555 911, dal che rileviamo che il vicerè si trovasse allora in quella città. Questo augusto principe o che fosse dispiacciuto della volubilità della fortuna, che sebbene gli fosse stata sempre favorevole, da qualche tempo se gli era mostrata ritrosa, specialmente nella guerra, che allora sostenea contro Arrigo II re di Francia: o che tormentato da’ dolori della gotta, che spesso lo visitava, si fosse nojato delle occupazioni, che sono inseparabili dalla sovranità, concepì il gran disegno di spogliarsi de’ regni che possedea, per godere la tranquillità di una vita privata. Fu dunque in Brusselles a’ 25 di ottobre 1555 la prima rinunzia, con cui cesse a Filippo suo primogenito la Borgogna, ed i Paesi Bassi 912. Non potè per allora cedergli gli altri regni, non sembrandogli prudente condotta lo abbandonare il figliuolo fra’ tumulti di una pericolosa guerra, e perciò volle prima tentare di rappacificarsi con la Francia. Sebbene però non gli fosse riuscito di ottener la pace da Arrigo II, gli venne non ostante fatto d’indurlo ad accordare una tregua di cinque anni, che fu sottoscritta a’ 5 di febbraro 1556, dopo la quale nel giorno sesto seguente fe’ la seconda rinunzia al medesimo principe di tutti gli altri regni, e stati, ch’ei possedea così in Europa, come nel nuovo mondo, e si ritirò, dopo di aver deposta la corona imperiale sul capo di Ferdinando suo fratello re de’ Romani, di Boemia, e d’Ungherìa nel vegnente anno alla Estremadura nel monistero di S. Giusto dei monaci di S. Girolamo, dove poi l’anno di appresso 1558 se ne morì. Chi fosse curioso di sapere la vita privata, che menò questo principe nel suo ritiro, potrà trovarla scritta presso il Sandoval, e più recentemente presso Robertson, che sono stati due suoi biografi. Investito il re Filippo, che noi chiameremo il secondo, come appellavasi in Ispagna, sebbene fra’ nostri re fosse stato il primo, de’ regni cedutigli dal padre, spedì in Sicilia Federico Enriquez fratello del conte di Modica, affine di ricevere in suo nome il giuramento di fedeltà da’ Siciliani. Per eseguirsi questo atto fu dal vicerè Giovanni de Vega, che trovavasi allora a Messina, convocato in detta città il generale parlamento a’ 7 di giugno dell’anno istesso 1556. Si congregarono i tre bracci del regno nel prescritto giorno nella cattedrale 913 , e fecero il ligio omagio nelle mani del mentovato Federico Enriquez, che stavasi seduto in un luogo eminente 914. Fatta questa ceremonia il detto di Enriquez fe a nome del nuovo re Filippo secondo il giuramento, con cui promettea di osservare tutti i privilegi, e capitoli del regno, esibendo la [198] carta reale consegnatagli dal nuovo monarca sottoscritta in Brusselles a’ 14 di febbraro del medesimo anno 915, e registrata in Messina. Siccome il vicerè de Vega era stato eletto dall’augusto Carlo, perciò spirava la sua autorità, ed era necessario che fosse confermato dal nuovo sovrano. Questo principe avea provveduto anche a questo, ed avea spedito la cedola di conferma da Brusselles a’ 24 di marzo, la quale fu registrata in detta città lo stesso giorno del parlamento a’ 7 di giugno 916, fu letta, e pubblicata in quell’assemblea 917, e di poi il Vega fe il solito giuramento, e prese possesso della carica conferitagli dal re Filippo II. Finalmente dopo altri minori atti si offerì all’Enriquez procuratore del Monarca un dono di sei mila scudi, e quattrocento scudi a Girolamo 905 Reg. della regia cancellaria dell’an. 1554.1555 XIII indiz. f. 350. Cronol. de los Virreyes, y presidentes del Reyno de Sicilia p. 54. 907 Cronologia de’ signori vicerè di Sicilia p. 45. 908 Reg. dell’anno 1554.1555 XIII indiz. f. 480, e 482. 909 La Rosa Mss. esistente nella libreria del senato di Palermo. 910 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1554.1555 XIII. Indiz. f. 484. 911 Ivi. 912 Sandoval Historia del Emperador Carlos V. lib. XXXII, § XXXVI, p. 813. 913 Nacque in questo parlamento una contesa fra il procuratore dell’arcivescovo di Messina, e quello di Palermo. Avea questi preso il primo luogo che quegli gli contrastava. Fu ricorso al vicerè Giovanni de Vega, il quale fatto esaminare l’affare dal suo regio consiglio, col voto di questo stabilì nello stesso giorno a’ 7 di giugno, che si dasse la preferenza al procuratore dell’arcivescovo di Palermo. Un altro atto fu fatto dallo stesso vicerè, con cui ordinò, che il priore di S. Giovanni di Messina sedesse immediatamente dopo tutti i procuratori degli arcivescovi, e dei vescovi. 914 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 278, e seg. 915 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 287. 916 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1555.1556 XIV indiz. f. 40. 917 Mongit. ivi p. 290. 906 - 155 - Manriquez, ch’era venuto in di lui compagnìa, e avea apportato lo indulto generale accordato da quel sovrano 918. Poco durò nel nuovo governo della Sicilia Giovanni de Vega. Gli aspri modi, ed il rigore, con cui trattava i Siciliani per ogni menoma mancanza, aveano irritati i loro animi, i quali, passando la corona di Sicilia sul capo di Filippo II, raddoppiarono i loro ricorsi, che inutilmente per lo addietro aveano fatto arrivare al trono del di lui padre, ed assordando le orecchie di questo sovrano lo mossero a compassione, e lo indussero a richiamarlo per rendere conto della sua condotta. Partì, comunque sotto il pretesto di sua infermità, a’ 3 di ottobre, e andò a Trapani, dove si trattenne sino alla fine del mese di febbraro 1557, sebbene avesse cessato di governare a’ 23 di esso mese, dopo di che prese possesso di presidente del regno il cardinale Pietro Aragona, e Tagliavia arcivescovo di Palermo. Imbarcatosi di poi sulle galee di Malta prese la via di Madrid, dove arrivato, conoscendosi giusti i lamenti de’ Siciliani, non fu più rimandato, avendo il re Filippo eletto per suo successore, come diremo nel seguente capo, Giovanni della Cerda duca di Medinaceli. Sarebbe stato il Vega la delizia della nazione siciliana, se alle virtù, di cui era adorno, avesse saputo unire la discrezione, e l’equità. Fu egli protettore de’ letterati, desioso di sollevare meschini, le lagnanze de’ quali volentieri ascoltava, e nemico delle prepotenze. Amava la giustizia, odiava la calunnia, e avea a cuore la salute degl’individui, prendendo particolar cura de’ pubblici ospedali. A lui debbonsi le vie del regno rese più comode per il traffico interno; a lui i ponti per la sicurezza de’ viandanti, quando sboccano i fiumi, e i torrenti; a lui le molte fortificazioni fatte in Sicilia, per le quali restò il regno assicurato dalle incursioni; a lui le torri di avviso, che abbiamo mentovate. Si cooperò egli ad accrescere il numero de’ giudici della gran corte, perchè la giustizia si facesse più speditamente; il pubblico banco della capitale, che vien detto la tavola di Palermo, da lui riconosce la sua fondazione. I collegi de’ Gesuiti, ordine allora nascente, eretti in Palermo, in Messina, ed in Catania furono opera sua, o della moglie, o del figlio presidente del regno. La università degli studî così celebre, che fu fondata in Messina, e fu causa di tanti litigî co’ Catanesi, devesi alle sue pratiche. Ma tutti questi pregi restarono oscurati dalla di lui alterigia, e dall’eccessivo rigore, con cui operava. Aspro dappertutto non perdonava a persona, comunque nobile, o costituita nelle grandi magistrature, che non lasciava di proverbiare con ingiurie, e di trattare con dispregio. Il Maurolico 919, la di cui testimonianza vale moltissimo, essendo stato scrittore contemporaneo, e molto stimato per la sua dottrina dallo stesso vicerè de Vega, ci descrive le crudeltà, ch’ei usava nel gastigare i delinquenti; imperocchè racconta, che per lievi colpe costumava il Vega di far dare la tortura anche a’ nobili, e che spesse volte li facea battere collo staffile. Per delitti di menoma conseguenza non esitava punto di fare inchiodare una mano al reo, a’ bestemmiatori poi facea delle volte forare la lingua, e spesso tagliare. Lo eccesso dunque della severità da lui usata rese odioso il di lui governo. Ci è ignoto se sia vero quanto lo stesso storico messinese soggiunge, cioè, ch’egli quanto era rigido cogli altri, altrettanto era indulgente in ciò, che riguardava sè stesso, o i suoi aderenti; non viene egli seguito in questo particolare racconto dagli altri nazionali scrittori. Di questo vicerè, oltre le cose già dette, [199] abbiamo due ordinazioni, che meritano di essere rammentate. L’una è il registro fatto l’anno 1553 di tutti gli arcivescovadi, vescovadi, abazìe e benefizî ecclesiastici, che anticamente appartenevano al regio padronato, giusta l’ordine, che ne avea ricevuto dall’imperadore Carlo V, di cui dona una epitome il Fazello sulla fine della sua storia 920, che non è punto esatta, scoprendosene alla giornata molti appartenenti al padronato regio, che non furono allora registrati. L’altra è la compilazione delle prammatiche, ch’ei ordinò che facesse il giureconsulto Girolamo Orlando, la quale non sappiamo, se siesi di poi compiuta, e pubblicata. L’elezione del cardinale di Aragona in presidente del regno fu fatta dal re Filippo II sino a tanto che non fosse venuto in Sicilia Giovanni della Cerda duca di Medinaceli eletto per vicerè di questo regno. Il dispaccio reale sottoscritto in Gant città delle Fiandre ha la data degli 8 di dicembre 1556; e fu registrato in Palermo a’ 15 di febbraro del seguente anno 1557 921. Il Vega per mostrare, che non partiva richiamato dalla corte, volle unire al dispaccio regio suddetto anche il suo prima di partire, costituendolo ancora egli presidente del regno con suo viglietto dato in Trapani a’ 23 di febbraro dello stesso anno 1557. Durò pochi mesi in questa dignità il detto cardinale, giacchè ne’ primi del seguente maggio cessò ogni sua autorità. Nulla egli oprò nel breve suo governo, che meriti di essere registrato. 918 Mongit. ivi p. 297. Sic. Hist. lib. VI, pag. 231. 920 Dec. II, lib. X, t. II, p. 261 e seg. 921 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1556.1557 XV indiz., f. 368. 919 - 156 - CAPO VI. Giovanni della Cerda duca di Medinaceli vicerè. Niccolò Caracciolo vescovo di Catania, Ferdinando de Silva marchese della Favara, e Bartolomeo Sebastiano vescovo di Patti presidenti del regno in diversi tempi. Persuaso il serenissimo Filippo II che non era del suo servizio, che il Vega continuasse nel governo della Sicilia, stantechè per il soverchio suo rigore era in esacrazione a tutta la nazione, si determinò di dargli un successore, ed elesse Giovanni della Cerda duca di Medinaceli. La cedola reale, con cui egli fu costituito in questa dignità, fu sottoscritta in Brusselles al primo di dicembre dell’anno 1556, che poi alla sua venuta fu registrata in Palermo ai 7 di maggio dell’anno di appresso 1557 922. Arrivò dunque questo nuovo vicerè in Palermo da Napoli ai 7 di maggio, e sbarcato lo stesso giorno sul ponte appostatamente preparato con un nobile arco trionfale, montò a cavallo, e fe la pubblica entrata accompagnato dal senato, dalla nobiltà, e dai magistrati, e venendo alla cattedrale prese solennemente il possesso, come vicerè nel giorno istesso, e poi cominciò ad esercitare la sua carica 923. La prima sua sollecitudine fu quella di convocare al più presto, che fosse possibile, un parlamento generale straordinario. Trovò egli il regio erario nella ultima desolazione, e inoltre che le truppe, e le galee, che servivano alla custodia del regno, e dei suoi mari, andavano in credito di dodici paghe. Il re Filippo II non era in grado di occorrere a questi bisogni; trovavasi egli di avere sulle spalle una guerra stipendiosissima suscitatagli dal pontefice Paolo IV, il quale malgrado la tregua convenuta dall’augusto Carlo suo genitore per cinque anni con Arrigo II re di Francia, avea indotto questo sovrano, sciogliendolo dal giuramento fatto, a riprendere le armi, e ad unirsi seco contro il monarca delle Spagne. Era perciò costretto a tenere delle armate nelle Fiandre, alle frontiere dei suoi regni spagnuoli, a Milano, e a Napoli, per resistere ai suoi nemici. Chiamò dunque il duca di Medinaceli il parlamento in Palermo per il dì 21 del seguente giugno, nel quale radunatisi gli ordini dello stato nel regio palagio, parlò ai medesimi rappresentando la necessità di soddisfare le soldatesche, e di continuare a sostenerne il peso per la custodia del regno, e l’impossibilità, in cui ritrovavasi il monarca di soccorrerlo per le guerre, dalle quali era oppresso, e chiedendo una straordinaria contribuzione ne’ pressanti bisogni, in cui era la Sicilia 924. Trovavasi il regno spossatissimo per i frequenti donativi, ch’era stato obbligato ad esibire all’augusto Carlo, che noi abbiamo [200] accennati: per il denaro somministrato per le fortificazioni, e il mantenimento delle truppe, che lo custodivano; e per quello che pagato avea affine di riparare le vie pubbliche, ed i ponti, per la mancanza dei quali era interdetto il commercio interno fra le città, e le terre. Le armate turche, che visitavano spesso i nostri mari, e le scorrerìe di Barbarossa, e di Dragutte, impedendo ogni traffico fuori della Sicilia, l’aveano anche ridotta alla estrema povertà. Ma ne’ casi estremi fa d’uopo di adoprare gli estremi ripari. Conosceano i parlamentarî che la sicurezza del regno esigea, che si pagassero le truppe, e le galee, e che si desse loro il soldo in qualunque modo in avvenire. In questo stato di cose risolvettero di offerire dugento mila scudi, per i quali, mancando la pecunia, si contentarono, che s’imponesse un dazio di un tarì per ogni salma di frumenti, e di altrettanta somma per ogni due salme di orzi, o di legumi, che si estraessero fuori del regno da qualunque porto, o di regio demanio, o delle terre dei baroni, e che questo dazio si potesse vendere per pagarsi col capitale l’offerto donativo 925. Volendo poi i parlamentarî rendersi benemerito il nuovo vicerè, non solo gli accordarono il privilegio solito, cioè di essere riputato come regnicolo, ma gli fecero anche il dono di dieci mila scudi, che alcun vicerè prima di lui non avea mai ricevuto. Arrigo II re di Francia non contento di essersi collegato col papa contro il nostro sovrano, cercò ancora l’appoggio del Turco, che fu invitato a portar la guerra nel regno di Napoli, per distrarre gli Spagnuoli dallo stato pontifizio, in cui erano già entrati 926. Solimano amico della Francia volentieri soccorse il re Arrigo, e spedì nel mediterraneo una flotta forte di ottantaquattro galee. L’avviso dell’avvicinamento di questa armata ottomana fu causa, perchè il duca di Medinaceli, abbandonando la capitale, si conducesse in Messina, per essere più a portata di sapere gli andamenti della medesima, e di provvedere alla custodia del regno. Partì egli da Palermo nel mese di agosto dello stesso anno, e agli 11 del medesimo arrivò in quella città, dove fu onorevolmente ricevuto 927. 922 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1556.1557 XV indiz. f. 589. Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1556.1557 XV indiz., f. 581. 924 Mongit. Parl. di Sicilia t. I, p. 298, e 299. 925 Mongit. ivi p. 300, e 301. 926 Fu sospettato allora, che il pontefice Paolo IV. fosse inteso di questa confederazione col Turco, e che fosse contento, che questi venisse alla sua difesa. Ci sembra strano questo sospetto, che darebbe un’orrida idea delle azioni di questo papa, e perciò noi siamo d’avviso ch’egli non abbia ricercata questa unione coi Musulmani, sebbene il re di Francia, senza ch’egli ne fosse stato consapevole, per i suoi interessi ve lo abbia chiamato, e che il Turco, quantunque indirettamente, abbia giovato alla santa sede. 927 Maurolico, Sic. Hist. lib. VI, pag. 235. 923 - 157 - A buona sorte de’ Siciliani la flotta turca non arrecò verun danno al nostro regno, e poco molestò quello di Napoli. La guerra cambiava aspetto; la rotta data ai Francesi a S. Quintino fece ritirare le loro truppe dal regno di Napoli, ed obbligò l’altiero Paolo IV a chieder la pace al monarca di Spagna. Giunse la lieta notizia di questa vittoria in Messina su i primi di settembre, e il duca di Medinaceli ordinò delle illuminazioni, e dei rendimenti di grazie all’Altissimo per avere felicitate le armi spagnuole 928. La concordia fra il Papa, e Filippo II non potè punto influire a pacificare questo principe col re di Francia. Irritato Arrigo II della strage, che si era fatta sotto S. Quintino, dei suoi Francesi, dove erano restati vittime delle spade spagnuole i più cospicui personaggi di Francia, volle ostinatamente continuare la guerra, e per distrarre le armi del re Cattolico, avea cercato, ed ottenuto dal Turco un’armata di centoventi galee, le quali nella primavera ventura doveano invadere i regni di Napoli, e di Sicilia. Il duca di Medinaceli informato del vicino pericolo, che minacciava la Sicilia, non si mosse da Messina, dove tenea pronta una flotta di galee per opporsi in ogni evento agli sforzi dei nemici. Come però era necessario molto denaro per il mantenimento delle soldatesche, e dei marinari, e già era vicino il tempo, in cui dovea celebrarsi il solito triennale parlamento, lo convocò in quella città per il mese di maggio 1558, così per chiedere il donativo dei trecento mila fiorini, come per dimandare una straordinaria contribuzione per mantenere la squadra delle galee, e le soldatesche. Fu questo parlamento differito più volte; il vicerè volea prima assicurarsi, che l’armata ottomana venisse veramente nei nostri mari, imperocchè non verificandosi la notizia non intendea egli di aggravare con un donativo straordinario il regno, che sapea [201] di essere nella ultima desolazione. Questa finalmente comparve agli 8 di giugno 929, ma non toccò per allora i nostri lidi, e veleggiò verso Reggio, e la Calabria, d’onde passò nel golfo di Salerno. Assicuratosi il duca di Medinaceli, che l’armata turca si era per allora allontanata, tenne il parlamento a’ 20 di giugno, e nell’apertura fe’ conoscere a’ parlamentarî l’imminente pericolo, in cui era la Sicilia, che non fosse invasa dall’armata ottomana nel ritorno, che avrebbe fatto dal regno di Napoli, e del bisogno, che vi era di stare allerta per respingerla; e a questo oggetto oltre il consueto donativo triennale, ne richiese uno straordinario, affine di continuare il mantenimento delle truppe, e delle galee. Volentieri aderì alla giusta dimanda del vicerè quella rispettabile adunanza, ed oltre l’ordinario donativo, accordò cento dieci mila scudi per la difesa del regno, che volle che si pagassero sopra le tande, che l’anno antecedente si erano imposte per ricattare il dazio del tarì imposto l’anno 1540 sotto il governo del vicerè Ferdinando Gonzaga 930. In questo parlamento ebbe il duca di Medinaceli il solito regalo di cinque mila fiorini. Finito il parlamento non istimò il vicerè di starsene rinchiuso dentro le mura di Messina per aspettarvi la flotta ottomana, ma pensò, giacchè era pronta la flottiglia delle galee siciliane, di andare verso i lidi di Calabria per spiare gli andamenti della medesima. Avea egli risoluto di fare questa mossa tosto che era passata l’armata turca agli 8 di giugno, e in fatti col parere del sacro consiglio avea eletto per presidente del regno Niccolò Maria Caracciolo vescovo di Catania, come costa dal dispaccio dato nella detta città ai 15 dello stesso mese 931. Ne differì di poi l’esecuzione, e volle prima celebrare il parlamento, dopo il quale eseguì il suo disegno. In capo a pochi giorni se ne ritornò; la classe turca dopo di avere danneggiato molte città del regno di Napoli, e di avervi fatte diverse migliaja di schiavi, vedendo che le altre città erano ben fortificate, e guarnite, andossene in Corsica, e di poi in Antibo, dove dovea unirsi colla flotta francese. Perciò il duca di Medinaceli non trovando il nemico fe’ ritorno in Messina. Una nuova rotta data a’ Francesi nel mese di luglio di quest’anno, per cui il re Filippo ricuperò Dunquerque, e la tregua, e poi la pace fattasi fra questo principe, e il re di Francia, fecero chiudere per conto degli Spagnuoli il tempio di Giano, e quietati così gli strepiti militari fu il re Cattolico in grado di ascoltare le voci dei suoi popoli, che dimandavano di essere liberati dalle scorrerìe dello infaticabile Dragutte, che da Tripoli inquietava il loro commercio. Concepì il nostro duca di Medinaceli l’alto disegno di fare snidare il detto corsaro da quel porto, e da quel castello, ch’ei avea così ben fortificati, e difesi con numerosa artiglieria, che li avea resi inaccessibili a qualunque potente flotta. Ne scrisse perciò in primo luogo a Giovanni della Valletta gran maestro della religione di Malta, che non gli fu difficile di fare entrare nello stesso progetto; avvegnachè Malta ancora era esposta alle irruzioni di quel pirata, ed ambidue convenendo della necessità di fare questo tentativo, ne fecero vive istanze al monarca Cattolico. Approvò questo principe il loro suggerimento, e perciò ordinò al duca di Sessa governatore di Milano, al duca d’Alcalà vicerè di Napoli, e a Giovanni Andrea Doria generale delle galee di Spagna, che unissero le loro forze, e le spedissero in Sicilia sotto gli ordini del duca di Medinaceli, che fu eletto capitano generale per questa impresa, volendo però che si avvalesse de’ consigli del gran maestro dell’ordine gerosolimitano, ch’era riputato il più prode capitano di quella età. La gelosìa, che suole spesso attraversare le idee le meglio concepite, entrò negli animi 928 Maurolico ivi. Maurolico Sic. Hist. lib. VI, p. 235. 930 Mongit. Parl. di Sic. t.. I, p. 303, e seg. 931 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1557,1558 fogl. 398. 929 - 158 - dell’ammiraglio, del governatore di Milano, e del vicerè di Napoli, i quali mal soffrendo che questo incarico fosse dato al nostro vicerè, sotto varî pretesti indugiarono di mandare le truppe, e le galee ordinate da Filippo II, in guisachè sopraggiunse l’inverno, prima che fosse pronta l’armata per questa spedizione. Il gran maestro di Malta, uomo di sperimentata abilità, conobbe che non era più tempo, sopravvenendo la rigida stagione, di tentare la presa di Tripoli, e fu d’avviso di differire questa campagna alla primavera ventura. Ma il vicerè nostro temendo che il re Cattolico non cambiasse sentimenti, o che per le solite cabale di corte non gli togliesse il comando di quest’armata, e immaginando [202] di trarre da questa impresa molta gloria, si affrettò a partire da Messina, dove si trovava, e lasciato per presidente del regno nella sua lontananza Ferdinando de Silva marchese della Favara, come costa dal dispaccio viceregio sottoscritto in detta città a’ 28 di ottobre 1559 932, s’imbarcò, e andossene a Malta, dove avea ordinato che si riducessero tutte le forze destinate per l’assedio di Tripoli, e vi giunse alla metà del mese di dicembre. Mentre in quell’isola si aspettavano le galee di Milano, di Genova, e di Napoli, Giovanni la Valletta fece alla presenza di questo vicerè la rivista delle truppe della religione, che avrebbono servito in questa occasione, che consistevano in mille e cinquecento uomini stipendiati dall’ordine, e in quattrocento cavalieri volontarî, che si erano esibiti di marciare contro gl’infedeli. Aspettò ben due mesi il duca di Medinaceli, prima che arrivassero i soccorsi ordinati dal monarca delle Spagne, nel qual tempo le soldatesche, che avea menate dalla Sicilia, si ammalarono, ma furono soccorse a tempo dalla carità di quei cavalieri 933. Radunatesi tutte le forze destinate all’assedio di Tripoli, prima di partire furono tenuti in presenza del duca di Medinaceli diversi consigli di guerra, ne’ quali intervennero oltre il Valletta i principali uffiziali per istabilire le operazioni di questa campagna. Fu in essi rappresentato lo stato, in cui era il porto, e il castello di Tripoli, cioè ch’erano fortificati nella miglior forma, e che Dragutte, oltre le numerose truppe, che vi avea introdotte, li avea forniti di tutte le necessarie provvigioni da bocca, e da guerra, risoluto di difendere fino alla morte quella interessante piazza. Il vicerè come era ottimo cavaliere, e bravo politico, così era privo di coraggio, e nell’arte della guerra poco sperimentato; laonde atterrito dalla difficoltà dell’impresa, propose che fosse meglio di conquistare l’isola delle Gerbe, che altre volte era appartenuta a’ re di Aragona. Il Valletta, comechè fosse d’accordo, che fosse agevole d’impossessarsi di questa isola, fe nondimeno riflettere che codesta era una impresa inutile; giacchè partita la flotta, colla stessa facilità i Mori l’avrebbono ripresa, non essendovi una piazza, che potesse far rispettare le armi spagnuole, e addusse altre ragioni, che per brevità intralasciamo. Ma quando vide che il duca era ostinato nella sua risoluzione, e che gli altri capitani, sebbene fossero dello stesso suo avviso, pure per riverenza taceano, prese lo espediente di protestare che la religione si era obbligata per la guerra contro Tripoli, e che cambiandosi direzione, egli non si credea tenuto a secondare il vicerè, e avrebbe negati i promessi soccorsi. Questa libera risposta colpì l’animo del vicerè, il quale conoscendo di quale importanza fosse lo avere seco i Maltesi, comunque stesse fermo nella sua opinione, finse di cambiare sentimenti, e di ritornare al primo progetto, e poichè il gran maestro dubitava di essere deluso, egli giurò sulla testa del re suo signore, e su quella del proprio figliuolo Gastone della Cerda, che non avrebbe menata la guerra altrove, che a Tripoli. Questa sacra promessa bastò a Giovanni della Valletta, perchè accordasse il promesso soccorso, e vi aggiungesse ancora dugento prigionieri maltesi, acciò potessero servire nello assalto di quella fortezza 934. Partì la flotta spagnuola a’ 10 di febbraro 1560, e preso il cammino verso l’Affrica, arrivò a’ 14 dello stesso mese all’isola delle Gerbe, fingendo i piloti che i venti ve l’avessero condotta, seguendo così i segreti ordini del vicerè. Avvertito Dragutte, che l’armata cristiana era in quei mari, spedì con due galee il famoso corsaro Ulucchiali, cui diè ordine di portarsi prima a quella isola per avvertire il signore della medesima del pericolo in cui era, e confortarlo a difendersi con coraggio, e di passare poi a Costantinopoli per sollecitare il gran signore a spedire la flotta in soccorso delle città di Affrica. Le due galee furono scoperte dalla nostra flotta, e il duca di Medinaceli staccò subito dall’armata un maggior numero di triremi per assalirle, e impossessarsene; ma le nostre galee spedite incontratesi con due navi alessandrine cariche di merci, trascurando il comando avuto, colla speranza di un ricco bottino, investirono queste, e diedero così agio all’Ulucchiali di scappare, e di andare a Costantinopoli 935. 932 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1559.1560 III indiz. f. 129. Vertot, Histoire de Malte, liv. XII t. IV, p. 467. 934 Vertot Histoire de Malte liv. XII, t. IV, pag. 368, e seg. 935 Il Vertot (Hist. de Malte liv. XII, t. IV, p. 32) lasciò registrato, che oltre all’Ulucchiali era sulle dette galee lo stesso Dragutte in persona, e che questi vedendosi inseguito, per scampare il pericolo, con una galea se ne ritornò a Tripoli, e mandò coll’altra l’Ulucchiali a Costantinopoli. Se l’ordine del duca di Medinaceli fosse stato eseguito, e le galee da lui spedite avessero preso, come era agevole, quelle in cui erano Dragutte, ed Ulucchiali, qual gloria non sarebbe stata quella del nostro vicerè, mettendo in catene questi due formidabili nemici de’ cristiani? Come sarebbe stato allora agevole la conquista di Tripoli priva del principale suo governatore, e del luogotenente di costui? Ecco come tante volte avviene, che falliscano per la malizia, e l’inavvertenza dei subalterni i gran colpi. 933 - 159 - Fingendo il duca di Medinaceli di volere [203] proseguire il cammino verso Tripoli, si fermò alle secchie di Palo, e siccome quell’aria era malsana, e le acque, comunque sembrassero fresche, e dolci, recavano alle truppe de’ dolori, e delle malattie, il commendatore de Tessieres comandante de’ Maltesi con altri capitani fecero istanza, che si abbandonasse quel luogo, e si andasse a Lengir vicino a Tripoli, ch’era in un sito salubre, e dove era un porto capace di assicurare la flotta dalle tempeste, e dall’armata turca. Ma Tripoli non era l’idolo del duca di Medinaceli, il quale levate le ancore si avvicinò di nuovo all’isola delle Gerbe, ch’era il progetto suo favorito. Ivi sbarcate le truppe si venne a giornata col signore dell’isola, e poichè la disciplina militare, che si osservava fra’ nostri, e le armi da fuoco, cui non erano usi quei Mori, li atterrirono, perciò costoro si diedero ad una vergognosa fuga, e il signore dell’isola fu costretto a rendere il castello, a riconoscere il re di Spagna per Monarca, e ad obbligarsi ad un annuo tributo. Il duca di Medinaceli ingallozzito di questa ridicola conquista, pensò di farvi ergere un castello per conservarla, e fatti venire i materiali, e gli operarî dalla Sicilia, si trattenne coll’armata sino che fosse compiuto. Stavasi intanto in Sicilia in grande agitazione; era precorsa la voce che la flotta turca sarebbe presto venuta ne’ nostri mari, e che si sarebbe unita a quella di Dragutte. Le forze spagnuole erano nell’Affrica, e il regno ritrovavasi senza difesa, nè avea speranza di trovare de’ soccorsi nè da Napoli, nè da Milano, nè da Genova, che aveano spedito le soldatesche, e le navi per l’impresa di Tripoli. Il presidente marchese della Favara volendo nella migliore forma provvedere alla custodia del regno, intimò per il primo di giugno dello stesso anno 1560, il servizio militare a tutti i baroni feudatarî, e stabilì la città di Piazza per il luogo, dove eglino coi proprî uomini, cavalli, ed armi si dovessero radunare. Quest’ordine poi fu differito fino ai 10 dello stesso mese, per dare a’ baroni più agio di andarvi 936. Il gran maestro la Valletta sentendo che il duca di Medinaceli si fermava all’isola delle Gerbe per farvi edificare un forte, e conoscendo quanto ciò fosse inutile, scrisse ai suoi, acciò cercassero di distrarlo da questo vano pensamento, molto più che la stagione calda già si avvicinava, e le milizie col caldo, e le fatiche in un’aria cattiva, qual’era quella, si sarebbono sicuramente ammalate; e ordinò a’ medesimi che se non riusciva loro di frastornarlo, dimandassero il loro congedo, e se ne ritornassero a Malta. In capo a pochi giorni ebbe notizia, come per ordine di Solimano erano già uscite da’ Dardanelli quaranta galee, che a questa flotta si univano altri venti legni di corsari, e in oltre le ventidue galee, che avea Dragutte, in guisa che diveniva questa un’armata di ottantadue vele assai formidabile, e superiore alla spagnuola; laonde spedì in tutta fretta un corriere eccitando il vicerè a ritirarsi, e a fuggire il pericolo. Non trascurò il comandante maltese dl far presente al medesimo lo stato delle cose, e di consigliarlo a partire, e lo stesso suggerivano il Doria, e gli altri capitani. Ma il duca di Medinaceli fu sordo alle loro rimostranze, persuaso che la flotta ottomana non sarebbe venuta a quella isola. Il comandante de Tessieres, vedendo la di lui ostinatezza, giusta gli ordini, che avea ricevuti dal gran maestro, dimandò licenza, e ritornò a Malta, dove appena arrivato se ne morì, avendo anche perduta in questa spedizione la maggior parte della sua gente 937. Apparve finalmente ai 7 di maggio l’armata turca verso la isola del Gozzo, e il gran maestro, tuttochè avesse a pensare ai casi suoi, pur non ostante attento sempre a salvare l’armata Cristiana, spedì con ogni sollecitudine un brigantino all’ammiraglio Doria per avvertirlo del vicino pericolo. Questi, cui giunse cotale notizia a’ 10 dello stesso mese, [204] trovavasi ammalato: nondimeno fe’ subito dire al vicerè, che se volea scampare il risico di perdere sè, e gli altri, bisognava senza dimora rimbarcare le truppe, e fuggire prima che spuntasse il giorno. La caparbietà del duca di Medinaceli in questa occasione non sa concepirsi; si negò egli di far subito questa mossa, sempre lusingandosi che la flotta ottomana non era indiritta verso la isola delle Gerbe; ma quando la vide la mattina seguente comparire, e che le truppe senza aspettare i suoi ordini s’imbarcavano, e fuggivano, restò costernato, nè sapea cosa si fare. Mustafà Cara supremo comandante dell’armata, attento a non perder questa preda, fe’ inseguire da’ suoi le fuggitive galee, e n’ebbe in potere venti, nelle quali era imbarcato Gastone della Cerda figliuolo del vicerè, che vi restò schiavo, e quattordici navi da trasporto col loro equipaggio. In questo stato di cose avvilito il vicerè corse al padiglione del Doria, che non s’era ancora imbarcato, raccomandandosi al medesimo, acciò lo salvasse. Questi volle che si aspettasse la notte, sopravenendo la quale prese a bordo il duca, e i principali uffiziali generali, e colla sua sperimentata abilità si trasse dal pericolo, ed isfuggendo la diligenza del nemico venne a Malta. Fu lasciato al castello delle Gerbe Alvaro de Gande con cinque mila uomini, che restò poi vittima dei Turchi con tutta la sua gente 938. Tale fu lo infelice esito di questa spedizione, che tutto debbesi alla incapacità, e alla ostinazione del duca di Medinaceli, che ne riportò eterna ignominia. Vergognandosi egli di fermarsi a Malta, dove la presenza del gran maestro, ai di cui consigli non avea voluto giammai aderire, gli era un continuo rimprovero delle sue 936 Reg. del protonotaro dell’anno 1559.1560, III indiz. f. 311. Vertot Hist. de Malte liv. XII, tom. IV, pag. 379. 938 Vertot, Hist. de Malte liv. XII, t. IV. p. 283, e seg. 937 - 160 - azioni, ne partì, e ritornò al governo del regno di Sicilia. Venne egli a Messina sugli ultimi di maggio, come costa dal registro della regia cancellarìa 939, da cui ricaviamo, ch’ei cominciò a dispacciare ai 30 di esso mese, e vi si trattenne affine di occorrere ai bisogni per il timore, che si avea dell’armata ottomana. Questi dubbî non erano vani; il Bassà Piali ritornato dalla Barbarìa invase in capo a poco la città di Agosta, e barbaramente la saccheggiò 940. Angustiato il duca di Medinaceli da tante sventure ebbe il piacere di vedersi confermato per altri tre anni per vicerè di Sicilia. Filippo II, che siccome non lo avea per buon soldato, così lo riputava un ottimo governante, gliene spedì la cedola da Toledo ai 23 di giugno, ch’ei fe’ registrare in Messina a’ 4 del seguente luglio 941. In questo stesso mese avea il ridetto nostro governante intimato un straordinario parlamento nella riferita città. L’oggetto principale di questa adunanza, che fu tenuta nel regio palagio l’ultimo di esso mese, era di rimpiazzare la perdita delle galee fatta nello stesso anno, per potersi poi spedire dei soccorsi alla isola delle Gerbe. Le circostanze allora del regno erano calamitose; e la carestia, e le visite dell’armata turca aveano ridotta la Sicilia in somma povertà. Nondimeno fu fatta l’oblazione di dugento mila scudi, e siccome questi non esistevano, fu preso il solito espediente d’imporre un dazio sulle tratte, e fu stabilito che per ogni salma di frumento, e per ogni due salme o di orzo, o di legumi s’imponesse un tarino, tre grani, e due piccoli, quale imposizione dovea poi pignorarsi per trarne il capitale, obbligandosi i parlamentarî a ricattarla nello spazio di quattro anni 942. In questa occasione gli ordini dello stato, avendo in considerazione le spese fatte dal vicerè nella sventurata spedizione di Tripoli, compassionando ancora la disgrazia accadutagli del figliuolo Gastone caduto in schiavitudine, e grati alla dolce, e plausibile maniera, con cui governava la nazione, gli fecero un dono di ventimila scudi 943. Mentre questo vicerè dimorava in Messina accadde in Palermo a’ 23 di settembre una tumultuazione, che quantunque fosse stata di poca durata, potea essere nondimeno dannosissima, ed apportare funeste conseguenze. Era stato questo anno sterilissimo, e quindi vi era una gran penuria di grani, i quali perciò crebbero a dismisura di prezzo. Costumavasi in Palermo a quella età, che il senato, come magistrato dell’Annona [205] provvedesse tutti i frumenti, ch’erano necessarî per il bisogno della città, e che somministrasse agli abitanti il pane sempre ad un dato peso. Ora avveniva negli anni carestosi, che l’erario della città soffriva grandissimi interessi, non solamente perchè comprando i grani ad un prezzo esorbitante, li vendea poi ridotti in pane assai meno di quel, che valeano; ma ancora perchè astenendosi i particolari dal far pane nelle proprie case, e provvedendosene ciascheduno dalle pubbliche piazze, grande era il consumo, che se ne facea, e doppiamente maggiore di quello, che faceasi negli anni ubertosi: lasciando di contare il prodigioso numero de’ miserabili, che vengono dai vicini paesi per satollarsi nella capitale, o di quelli, che vi corrono per comprare il pane di maggior peso, e ritornano di poi alle loro case. Noi avremo in questa storia spesse volte occasione di rammentare le calamità, in cui per non volere abbandonare questo sistema, trovossi il senato palermitano. Era pretore Girolamo del Carretto, per quel che scrisse il Caruso 944, barone di Racalmuto, seppure non fu Cesare Lanza, come meglio piacque a Vincenzo Talamanca 945; e questi considerando i gravissimi danni, che il patrimonio civico sostener dovea e per conto del prezzo eccessivo dei grani, e per conto della maggiore provvisione, che far sene dovea, convocò ai 23 di settembre il pubblico consiglio, a cui intervennero secondo il costume tutti gli ordini della città, ai quali propose, come l’unico mezzo da indennizare l’erario, quello di diminuire il peso del pane, e per conseguenza di impicciolirlo. Non avvi cosa in Palermo, che tanto disturbi il popolo, quanto la diminuzione del peso del pane. Assuefatto ad averlo sempre ad un modo, nè punto riflettendo alla diversità dei prezzi, che producono un divario considerabile, mal soffre che si faccia cambiamento alcuno a suo danno, e poco cura se l’erario civico fallisce. È cosa costante nella storia delle nazioni, e particolarmente nella nostra, che i movimenti popolari accadono quasi sempre per cagione del pane. Soffre la plebe con pazienza il caro prezzo di qualunque altra cosa, ma dove trattasi di pane, il vuole sempre abbondante, e a dolcissimo prezzo. Il progetto del pretore abbracciato dai nobili fu ributtato dai consoli delle arti, e dai plebei, i quali si negarono di darvi il consenso, ed uno di essi fu così temerario, ed ardito, che non avendo alcun riguardo per quel nobile consesso, buttò in mezzo alla sala in cui era radunato, uno dei pani della piazza, dichiarando che era abbastanza piccolo, senza che fosse d’uopo di diminuirlo di vantaggio. 939 Reg. dell’anno 1559.1560 III indiz. f. 549. Bosio Stor. della relig. Gerosol. tom. III, lib. XX, all’anno 1560. 941 Reg. ivi f. 223. 942 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 307. 943 Mongit. ivi pag. 312. 944 Mem. Stor. P. III, lib. IX, t. III, p. 179. 945 Elenco Universale pag. 81. 940 - 161 - Fu sciolto il consiglio, nè vi si determinò, se dovesse o no diminuirsi il peso del pane. I plebei, che aveano abbastanza addimostrato il loro animo nel palagio pretoriano, sortiti che ne furono, cominciarono ad eccitare a tumulto i loro compagni assai disposti ad ogni temerario attentato. Si fe capo del sollevato popolo un notaro della terra di Paola in Calabria, che chiamavasi Cataldo Tarsino, il quale guidando i tumultuanti al palagio suddetto, cominciò a fare strepito, e a minacciare quel rispettabile magistrato, e i nobili, che erano ivi restati, di metterli in pezzi, se non desistevano dal proposito, in cui erano, di impicciolire il pane. Era allora capitano della città Gastone del Porto barone di Summatino, il quale alla notizia delle mozioni popolari, montò a cavallo con gente armata, e venne al luogo del tumulto per sedarlo, e siccome volle far uso dell’autorità, e delle minaccie contro un popolo irritato, e privo di ragione, non fu ricevuto, che colle sassate, in guisa che ebbe a somma fortuna il sortire vivo dalle mani dei sollevati, sebbene ne scampasse malconcio, e ferito in testa. Un altro cavaliere, cioè Bernardino di Termine barone di Birribayda, che trovossi presente, per quietare la plebe, ebbe con un sasso fragellata una gamba 946. Rotto ogni argine i sollevati saccheggiarono la casa di Carlieri di Sguazza, e si divisero le armi, che erano in essa, e girando per la città così armati andavano in cerca di Andreotto di Lombardo, che era il segreto di Palermo, per farlo a brani; ma costui seppe nascondersi, nè soffrì altro danno, che il saccheggiamento della propria casa. Il pretore, i senatori, e i nobili, che erano con essi, disperso che fu il furibondo popolo per la città, affine di dar sacco alle case dei ricchi, ebbero modo di sortire dal palagio senatorio, e di rimettersi in sicuro a Castellammare. Finalmente si toccò con mani, che, [206] qualora la plebe bolle di rabbia, nè sente più il freno dell’autorità, o bisogna adoprare una forza maggiore, che la conquida, e distrugga, (il che sempre torna a danno della corona, e dello stato, che perde tanti individui, quanti vi restano uccisi) o bisogna far uso delle buone maniere, e degli artifizî per ridurla dolcemente al dovere. Mancava il primo modo da frenare i sollevati, perchè mancavano le soldatesche nella capitale, e il vicerè, che ritrovavasi a Messina, ne avea seco condotta una gran quantità per la infelice impresa di Tripoli; bisognò dunque tentare il secondo espediente, come l’unico per tranquillare la città. Eravi in Palermo Vincenzo del Bosco conte di Vicari, il quale era un cavaliere accetto al popolo, ed era dotato di una sopraffina prudenza. Fu questi pregato ad interporsi per procurare la comune quiete. Finse egli di sostenere il partito popolare, e così acquetò per allora la inferocita plebe. Ridottala a questo stato, ebbe campo di abboccarsi col capopopolo notar Cataldo, di cui trovavasi per fortuna compare, avendogli tenuto un di lui figliuolo al sacro fonte. Avutolo da solo a solo gli fe concepire in quale strano impegno fosse entrato, facendosi capo della più vile plebaglia, e gli fe rilevare che a lungo andare egli sarebbe stato la vittima della offesa maestà, non essendo verisimile, senza altri appoggi, che potesse costantemente sostenere la tumultuazione. Introducendosi così nell’animo di questo sedizioso, e facendogli presentire il pericolo, in cui si era messo, gli suggerì come amico, che il miglior partito per lui sarebbe stato quello di sottrarsi da questa impresa, e di fuggirsene la notte istessa a Paola sua patria. Piacque al Cataldo questo suggerimento, ed egli, senza far parola con persona, s’imbarcò, e andossene a rifuggire in Calabria. Non sapendosi la fuga di costui, temeasi dal senato, e dagli altri magistrati, che il popolo col favore delle tenebre assalisse il banco pubblico per saccheggiarlo. Furono perciò posti alla custodia del tesoro dugento uomini bene armati con alcuni cannoni di campagna, affine di difenderlo da qualunque oltraggio dei malviventi. Partito il Cataldo per lo stratagemma del conte di Vicari, siccome i sediziosi privi di guida non sapeano cosa dovessero fare, così i buoni cittadini sperarono, che presto sarebbe ritornata l’antica calma. La stessa notte si andarono cercando gli altri principali sediziosi, e fu agevole cosa di assicurarsene, i quali tostamente, costando la loro reità, furono affogati sopra alcune botti, e i loro cadaveri la mattina seguente 24 del mese si viddero appesi ai pali nella piazza della marina. Restò il popolo così atterrito a questo orrendo spettacolo, che niuno più ardì di profferir parola contro il senato. Così in poche ore fu estinto il tumulto che sarebbe stato perniciosissimo alla città, se la saggia condotta del conte di Vicari non lo avesse sedato felicemente al primo suo nascere. Notar Cataldo si trattenne molto tempo nella sua patria, ma di poi ritornò in Sicilia, dove fu carcerato, ed in capo a tre anni fu sentenziato a morte, avendo i giudici deciso, che gli fosse prima recisa una mano, e poi fosse impiccato, e squartato. Questa sentenza fu eseguita in Messina nel mese di agosto 1566 947. Il vicerè duca di Medinaceli, udendo la sollevazione suscitatasi in Palermo, si affrettò a venire, ma giunse quando già ogni cosa era tranquilla 948. 946 Talamanca Elenco Universale p. 81. Paruta Cron. Mss. di Pal. p. 8, nella libreria del Senato. – Caruso Mem. Stor. P. II, lib. IX, t. III, vol. V, pag. 181. 948 Il Caruso (ivi p. 179) lasciò registrato, che il vicerè raffrenò la furia dei tumultuanti, obbligò il Tarsino, e il Tursio suo compagno a salvarsi colla fuga, e gastigò i più colpevoli, che fe’ trovare una mattina appesi alle forche; ma noi abbiamo seguito la cronica Mss. di Palermo, che fu scritta in quell’anno, e la di cui testimonianza deve essere preferita a quella di questo scrittore vissuto assai dopo. 947 - 162 - Trovando intanto ogni cosa quieta, prima di ogni altro si applicò a sapere i nomi di coloro delinquenti, che non erano caduti nelle mani della giustizia, e non erano stati per conseguenza gastigati. A costoro fe’ sequestrare i beni a nome del fisco, acciò non restassero impuniti, perchè aveano avuta la sorte di scappare. Questa confiscazione fatta al Cataldo, e ai di lui complici, ch’erano fuggiti, apportò lo scompiglio nella capitale. Spesso avviene in cotali procedure, che gli innocenti restano confusi coi rei, e che sotto varî pretesti gli uffiziali del fisco, che non sogliono essere d’intemerata coscienza, e trovano il delitto laddove sperano di guadagnare, molestino coloro, che non sono punto colpevoli. L’università di Palermo perciò [207] accortasi de’ disordini, che nascevano alla giornata, per cui gl’ingordi ministri dissanguavano la gente dabbene, presentò al real trono efficaci suppliche, affinchè la M.S. si compiacesse di perdonare a’ delinquenti. Filippo II con reale clemenza accordò ai medesimi la richiesta venia, spedendo ordine al vicerè duca di Medinaceli, che promulgasse il generale indulto con certe riserve. Furono in esso eccettuati principalmente Cataldo Tarsino, e Manfredo di Tursio, e agli altri fu perdonato, riserbati nondimeno a coloro, i di cui beni erano stati in quella occasione dilapidati, i diritti di potere dai medesimi esserne indennizzati. Questo atto fu sottoscritto dal medesimo vicerè nella stessa città di Palermo a’ 20 di gennaro 949 dell’anno 1561 950. Ciò fatto volle tenere l’ordinario parlamento, che fu convocato ai 13 di aprile dello stesso anno nella ridetta città 951, e radunatisi gli ordini dello stato, seppero dal duca di Medinaceli, che il re Filippo, dopo la perdita dell’armata nell’isola delle Gerbe, avea in animo di prepararne una nuova per la difesa dei suoi stati, e particolarmente del regno di Sicilia; e perciò oltre il donativo ordinario, ricercava un sussidio straordinario per compiere questo suo progetto. I parlamentarî, non ostante la povertà del regno, conoscendo che trattavasi della propria sicurezza, si obbligarono di provvedere la flotta di altre sei galee per nove anni, le quali unite alle dieci, che manteneva il regno, avrebbono compito il numero di sedici; e perciò offerirono un donativo di trecento cinquant’uno mila scudi, quanti ne bisognavano nel detto spazio di nove anni per le spese delle dette sei galee. Si obbligarono ancora al donativo ordinario di trecento mila fiorini, e prorogarono per altri sei anni così quello di cento mila fiorini per le fortificazioni, come quello di quarantotto mila per la conservazione de’ ponti, facendo al vicerè il consueto regalo di cinque mila fiorini 952, e a’ di lui figliuoli l’atto, col quale erano dichiarati regnicoli. Dopo il parlamento fu la capitale occupata in feste, ed in tornei, che rallegrarono gli abitanti. Avea il duca di Medinaceli due figliuole, che volle onorevolmente collocare in Sicilia; l’una fu maritata col duca di Bivona, l’altra col duca di Montalto. Le nozze di queste due dame furono festeggiate dunque nella capitale, prima che il vicerè se ne partisse per ritornare a Messina, dove per il timore dei Turchi era più opportuno, ch’ei si trattenesse. Anzichè però egli partisse diede precisi ordini, perchè le pubbliche vie, che erano infestate da’ ladri, restassero sicure, mandando alla seguela de’ medesimi gente armata per conquiderli 953. Non sappiamo precisamente in qual giorno fosse partito, e quando fosse arrivato il vicerè in Messina. Mentre egli era in quella città, ebbe ordine dalla corte di Madrid di mandare alcuni vescovi al concilio di Trento, che il pontefice Pio IV con sua bolla dei 29 novembre 1560 avea riaperto. Accettata la bolla in Spagna ai 18 di agosto dell’anno seguente 1561 furono spediti gli ordini, acciò alcuni vescovi dei più dotti si portassero a quella sacra assemblea. La circolare del duca di Medinaceli diretta a diversi prelati della Sicilia è in data dei 27 settembre di quest’anno 954. In questa occasione verisimilmente accadde la perdita di sette nostre galee nello stretto di Messina, [208] che conquistò con tutto l’equipaggio il corsaro Dragutte, e in cui restò schiavo Niccolò Caracciolo vescovo di Catania 955, quello stesso che abbiamo detto che fu lasciato 949 Reg. del proton. dell’anno 1560.1561 IV indiz. f. 264. Da questo documento si detegge l’errore del Caruso, il quale scrisse, che questo movimento popolare fosse accaduto l’anno 1561. Imperocchè essendo questo successo nel mese di settembre, ed avendo dovuto precedere l’indulto, deve necessariamente riferirsi all’anno antecedente 1560. 951 Ne’ capitoli del regno sta scritto, che questo parlamento fu celebrato in Messina; codesto è un errore rilevato prima da Monsignor Francesco Testa (Cap. regni tom. II nota a pag. 239), e poi dal paroco Serio (Parl. di Sic. t. I, nota a pag. 314), e noi ce ne siamo anche persuasi dalla ispezione oculare degli atti di questa assemblea, che trovansi registrati nell’uffizio del protonotaro (registro dell’anno 1560.1561 IV indiz. f. 451). 952 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 314, e seg. 953 Uno dei più famigerati capi di costoro fu un certo Vincenzo Agnello, che sulle prime non potè cadere nelle mani della giustizia. Di costui raccontasi, che fosse stato così temerario, che venne sino alle porte della capitale con animo di uccidere un cavaliere della famiglia Afflitto suo particolare nemico, e che quando il vicerè da Palermo ritornava a Messina, si fosse fatto trovare su di una collina con un numeroso drappello dei suoi posto in ordinanza colla sua bandiera, ch’era un drappo in cui era dipinta la morte, quasi sfidandolo a battaglia, e che fe persino sonare le trombe; del che il duca di Medinaceli restò così irritato, che fatte raddoppiare le diligenze, lo fe’ imprigionare, e di poi senza ulteriori processi impiccare per la gola. 954 Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1561.1562, V indiz. f. 94. 955 Questo fatto, che dal Pirri (Not. Eccl. Sic. Not. 1 Eccl. Catan. pag. 69), si dice accaduto ai 24 di luglio 1559, dal Bonfiglio (Hist. di Sicilia P. II, lib. VI, p. 546) all’anno 1561, e dall’Aprile (Cron. di Sic. lib. II, cap. VI, p. 546), all’anno 1562, non si sa precisamente quando avvenne; e si ignora ancora, se il vescovo Caraccialo fu fatto schiavo andando al concilio, come scrisse il Bonfiglio, o ritornando per affari della sua chiesa, come opinò il Pirri. A noi è parso più verisimile quanto lasciò scritto il Bonfiglio, cioè che questa prigionìa sia accaduta nello andare il Caracciolo al concilio, sorpreso nel viaggio dal fiero Dragutte. Eccone le prove. 950 - 163 - presidente del regno l’anno 1558, quando il detto vicerè s’imbarcò verso la Calabria per ispiare gli andamenti dello stesso corsaro. Raccontasi a questo stesso tempo un’altra disgrazia accaduta a’ Siciliani presso il Marettimo, di cui parlano il Bonfiglio 956, e l’Aprile 957. Scrivono eglino, che una galea del corsaro Ulucchiali rinegato calabrese fu presa dai Cristiani, e portata in Messina fu comprata dal capitano visconte Cicala, e da Luigi Osorio. Il vicerè duca di Medinaceli, che ritrovavasi in quella città, ed era stato incaricato dal re Cattolico Filippo II di armare in Sicilia una flottiglia di galere, tolse ai ridetti cavalieri questa trireme da loro comprata, sotto il motivo che serviva per il sovrano. Dispiaciuti costoro di questa ostilità, partirono per Spagna a presentare al real soglio le loro doglianze per il torto, che credeano di avere ricevuto dal vicerè. Il Cicala s’imbarcò in una delle sue galee, e l’Osorio in una sua galeotta. Arrivati a Trapani, e passando per le isole Egati, uscì da una di esse, che dicesi il Marettimo, una galeotta turca, con due fuste. Queste assalirono la galeotta di Osorio, e di leggieri se ne impadronirono. La galeotta tenea a bada la galea del Cicala, ma sopraggiunte le fuste, questo capitano non fu in grado di sostenerne l’assalto, e vi restò schiavo coi suoi. Dicesi che fosse seco Scipione suo figliuolo. Il corsaro Dragutte avuta in mano questa [209] preda, mandò in dono a Solimano il capitano Cicala e il di lui figliuolo. Il sultano, che sapea quanto danno recato avea ai Musulmani il detto capitano, lo fe serrare nelle sette torri, dove se ne morì; tenne però presso di sè Scipione di lui figliuolo. Fu cosa agevole lo indurre questo sconsigliato giovanetto ad abjurare la fede di Gesù Cristo, e ad abbracciare la legge di Maometto. Conosciutisi di poi i talenti di questo garzone, fu tenuto presso il gran signore, che lo fe istruire nell’arte della guerra, e fe dei così rapidi progressi, dando dapertutto prove non equivoche del suo valore, che fu in grandissima estimazione presso i suoi sovrani, i quali non solo lo promossero all’onore di bassà, ma lo ferono poi generale di mare, e di terra, nel qual posto diè sempre attestati di coraggio, e di virtù, ed acquistò immense ricchezze. Noi favelleremo in altra parte di quest’opera del mentovato rinnegato sotto il nome di Sinam bassà. Queste continove prede, che faceano i Musulmani sopra i sudditi della corona di Spagna irritarono l’animo del re Filippo II, il quale mal soffriva che Dragutte, e gli altri corsali facessero delle scorrerìe nella Puglia, nello Abruzzo, e ne’ nostri mari, e più di ogni altra cosa gli rincrescea l’ardire di Dragutte, che orgogliosamente si era presentato ai lidi di Chiaja presso la città di Napoli, e vi avea fatta una considerabile preda di quei nazionali. Pensò adunque di rendere loro la pariglia, e di farli snidare dai mari soggetti alla sua monarchia. Considerava egli che costoro diventavano ognora più ardimentosi specialmente ne’ mari di Spagna, perchè aveano un sicuro asilo al Pegnone, volgarmento detto il Sasso di Velez. Era questa una fortezza innalzata su di uno scoglio dirimpetto Gibilterra, detta Pegnone, perchè il detto scoglio avea la forma di una grossa pina. Ivi stavano appiattati codesti corsali, e spiavano da lontano i legni, che sortivano dai porti della Spagna, e viaggiavano per il mediterraneo, e allo approcciamento dei medesimi, montando sulle loro galeotte, o fuste andavano addosso a quelle navi, e se ne rendevano padroni. Conobbe perciò il re suddetto, che finattanto che gli Affricani erano in possesso del Pegnone, non potea esservi alcuna sicurezza Il termine fissato dal pontefice Pio IV, per riaprirsi il Sinodo, fu il giorno di Pasqua dell’anno 1561, che cadde a’ 2 di aprile (Art de verifier les dates table Chronolog. all’anno 1561 p. 32). Ma siccome per il consueto suole accadere in cotali adunanze, che per la distanza dei luoghi, e per altri incidenti, che nascer sugliono, non possono i vescovi ritrovarsi al giorno prescritto, nè suole farsi l’apertura di un concilio generale, se non vi è un numero tale di prelati, per cui possa quell’adunanza chiamarsi ecumenica, perciò la prima sessione fu differita fino a’ 18 di gennaro dell’anno seguente 1562. (Art de verifier les dates Chron. des Conciles p. 236). Ora la schiavitù del Caracciolo dovette accadere nell’anno 1561 nè potè altrimenti avvenire, s’è vero, come scrive il P. Abate Amico (Cat. Illustr. lib. VIII, cap. 2, § III, t. II, p. 409), ch’ei fu trasportato in Affrica, e che agli 11 di agosto 1561 il pontefice, che fu dolentissimo di questa disavventura, destinò gli amministratori alla chiesa di Catania, e che fatto il riscatto, ritornò il ridetto prelato a Messina a’ 26 di maggio 1562, e subito passò alla sua chiesa, dove fu ricevuto fra gli evviva dei suoi diocesani. Essendo le cose così, come sia possibile, che trovandosi il Caracciolo agli 11 di agosto 1561 già schiavo, nel qual giorno il Papa destinò i curatori della lui chiesa, nè essendone ritornato, che a’ 26 di maggio 1562, abbia egli potuto essere presente alla prima sessione del concilio, che fu tenuta ai 18 di gennaro del detto anno? È dunque più naturale, che questo prelato si fosse imbarcato sulla flottiglia siciliana col vescovo di Majorca per andare in Italia, e poi passare a Trento, e che assalito dalla flotta di Dragutte fosse fatto schiavo nelle acque di Lipari, e presso Messina, e condotto in Affrica, dove restò in ischiavitù sino al maggio dell’anno 1562. Arrogesi in conferma della nostra opinione ciò, che scrisse il Bonfiglio, cioè che fra coloro, che furono presi, eravi l’avvocato fiscale Giovan Battista Seminara, che andava reggente in Spagna per la Sicilia. Or come mai è possibile, che costui, dovendo portarsi in Ispagna, fosse venuto in Sicilia col vescovo di Catania? La schiavitù adunque del Caracciolo avvenne, quando andava al concilio, e dovette succedere nel mese di ottobre 1561, dopo che il vicerè mandò l’ordine a’ 23 di settembre ai vescovi di ritornare al concilio, nel che dee emendarsi il Pirri, che la fissa nel mese di luglio. Quindi negli atti dei concilio di Trento stampati da Indico le Plat in Antuerpia l’anno 1779 alla sess. XV. che fu tenuta a’ 25 di gennaro 1552 vi si vede sottoscritto (pag. 167). Niccolò Maria Caracciolo vescovo di Catania, e vi si nota così a Turcis captus dum ad concilium pergeret. Che chè sia di ciò, è certo che le sette galee erano sotto il comando di Guimerano cavaliere di Malta, il quale comunque avesse potuto isfuggire l’incontro con Dragutte, e l’avesse dovuto, stante l’inferiorità delle sue forze, pur nondimeno volle azzardarsi, e vi restò perditore. Questo vescovo fu riscattato con una grossa somma di denaro, e dovè giurare di pagarne una maggiore nel caso, che fosse divenuto pontefice. Strana condizione, la quale nondimeno appalesa in quanta riputazione avessero i Mori questo prelato, che lo credettero degno della Tiara. 956 Hist. Sic. P. II, lib. VI, p. 545. 957 Cronol. di Sic. all’anno 1561 lib. II, cap. VI, pag. 294. - 164 - nel mediterraneo nè per gli Spagnuoli, nè per gli altri legni cristiani, che vi veleggiavano, e ch’era necessario di farneli sloggiare ad ogni costo. Ordinò adunque che si allestisse una potente squadra, la quale non solo servisse per la difesa di Orano, che attaccata inutilmente l’anno antecedente dagli Algerini veniva in quest’anno nuovamente dai medesimi minacciata di assedio, ma tentasse ancora di togliere loro il Sasso di Velez. Scrisse a quest’oggetto al nostro vicerè duca di Medinaceli, affinchè allestisse la flottiglia delle galee siciliane, e la spedisse in Ispagna. Siccome questo interesse era comune con tutti gli altri principi cristiani, così costoro furono invitati dal re Cattolico alla detta impresa, e questi volentieri vi concorsero. Vuolsi che la flotta già preparata fosse di centotredici galee 958, delle quali cinque erano della religione di Malta, otto del gran duca di Toscana, sei del Papa, otto del re di Portogallo, dodici di Giovanni Andrea Doria, tre del duca di Savoja, e il resto era tratto dai regni di Spagna, di Sicilia, e di Napoli. Il Muratori 959 restringe il numero delle galee a sole ottantasette. A queste triremi, delle quali dieci erano le nostre, erano unite intorno a cento navi bene armate, fra le quali contavasi un galeone portoghese di una enorme grandezza. Fu dato il comando di questa flotta a Garzìa di Toledo figliuolo del famoso Pietro di Toledo vicerè di Napoli, che si fe’ tanto onore nello assedio di Mahadìa, come abbiamo osservato nel capo antecedente. Questo comandante, avendo prima fatte le previsioni necessarie così di viveri, che di attrezzi da guerra, partì da Malaga a’ 10 di agosto, e giunse felicemente ad Alcalà città distante soli quindici miglia dal Pegnone. Fatto ivi smontare lo esercito, marciò con esso verso quella fortezza, e arrivato presso alla medesima vi fe’ piantare le batterie, e cominciò a far giocare l’artiglieria, ch’era comandata dal Doria. Al terzo giorno la guarnigione, atterrita alla vista di una così poderosa armata, nè sperando veruno vicino soccorso, abbandonò quel forte, lasciandovi per onore delle armi da circa trecento uomini, che furono la vittima de’ Cristiani, giacchè in parte furono trucidati, e in parte fatti schiavi. Venne perciò quel formidabile castello in potere di Garzìa di Toledo il quale, lasciandovi un presidio di ottocento, bravi [210] Spagnuoli, dopo questa breve, e fortunata spedizione se ne tornò, e in capo a poco tempo ricevette dal re Filippo il guiderdone delle sue azioni, essendo stato promosso, come fra breve diremo, al viceregnato di Sicilia. Non dimorò molto tempo il vicerè duca di Medinaceli in Messina, ma se ne ritornò a Palermo. Noi lo troviamo in questa città nell’anno 1562, in cui celebrò il parlamento. Il motivo di questa straordinaria adunanza fu la visita regia mandata dal re Cattolico per metter freno a’ varî disordini, ch’erano nel regno. Era molto tempo, che arrivavano al suo trono le doglianze dei Siciliani, i quali desideravano che si rendessero loro meno pesanti i dazî, e le imposizioni, e che si riformassero i tribunali per la più spedita, e meno dispendiosa amministrazione della giustizia. Disbrigatosi adunque questo monarca da’ più gravi affari, che lo aveano finallora occupato, mandò in Sicilia Marcello Pignone marchese dell’Orivolo suo consigliere, come visitatore, per dar riparo ai disordini, e procurare la tranquillità del regno. Arrivato questi in Palermo, il duca di Medinaceli convocò nel regio palagio agli 8 di dicembre di detto anno uno straordinario parlamento, a cui intervenne il regio visitatore, e propose a’ parlamentarî i motivi, per cui erano stati radunati, cioè di provvedere alla giustizia, e alla quiete de’ vassalli, rendendo più ordinati i tribunali, e più proporzionati i pesi, ch’eglino soffrivano. Fu la riforma dei Tribunali 960 stabilita, ed accettata; e per riguardo alla giusta ripartizione dei pesi gli stessi tre ordini dello stato, a’ quali fu lasciato l’arbitrio di trovare i modi più plausibili per istabilirla, pensarono di mettere due imposizioni per lo spazio di dieci anni. La prima di un tarino per oncia per tutto il regno sopra il prezzo di tutti i drappi di seta, di panno, e di pelo, e sopra tutte le altre merci, e robe. L’altra imposizione fu di un altro tarino sopra ogni libra di seta cruda. Da ciò, che ricavavasi da queste due gabelle, doveano i deputati del regno pagare al regio erario cinquanta mila scudi all’anno, coi quali si sarebbono mantenuti i mille fanti, e le dieci galee, che servivano alla custodia del regno; e ciò, che sopravanzava, dovea impiegarsi in ricatto delle rendite, che pagava la regia corte per le segrezie del regno 961. Fu da questo parlamento eletto per ambasciadore Ferdinando de Silva marchese della Favara, che abbiamo di sopra mentovato, come presidente del regno, l’anno 1559, per dimandare alcune grazie al sovrano, che furono accordate in Madrid con alcune riserve a’ 20 giugno 1563 962. 958 Bonfiglio Hist. Sic. P. II, lib. VI, p. 547. Annali d’Italia all’anno 1564 t. X, p. 334. 960 La riforma dei tribunali allora stabilita non può in questo luogo distesamente raccontarsi. Chi ne fosse curioso può leggerla nella stessa prammatica di Filippo II. de reformatione Tribunalium, e presso Monsignor Francesco Testa nella sua dissertazione de magistratibus Siculis (Cap. regni Sic. t. I, p. 23). Egli è certo che il Pignone fu il flagello dei ministri d’allora. Noi troviamo in un Mss., che dicesi del Signor di Giovanni (pag. 280), ch’ei fe’ dare la corda ad un certo Gisulfo maestro razionale, che compilò il processo a Pasquale la Mammana; condannò un altro maestro razionale chiamato Sollima, ed altri o bandì dal regno, o fe’ carcerare, o castigò colla confiscazione de’ beni, inguisachè ne restò atterrito tutto il ministero. Cotali visite per frenare l’arbitrario potere de’ ministri sono a quando a quando necessarie, e salutari; ma fa di mestieri che i visitatori sieno così incorruttibili, e fermi, come era il marchese dell’Orivolo. 961 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 321, e seg. 962 Cap. regni Sic. t. II, p. 244, e seg. 959 - 165 - Nell’accennato anno andava a spirare il triennale viceregnato del duca di Medinaceli, giacchè l’ultima proroga si era da lui ottenuta l’anno 1560. Filippo II restando contento del di lui governo, e sapendo ch’egli era tuttavia amato dai nazionali, volle confermarlo per altri tre anni, e ne spedì il dispaccio da Madrid a’ 2 di aprile, che fu poi registrato in Messina a’ 2 del giugno seguente 963. Ebbe nello stesso anno a’ 4 di dicembre fine il concilio di Trento, malgrado la dissensione dell’ambasciadore, e de’ vescovi di Spagna, che volevano che se ne continuassero le sessioni, non essendosi ancora abbastanza riparato a’ disordini della chiesa 964, e malgrado che non se ne fosse aspettato il consenso del re Cattolico. Alcuni fini politici, e il tedio dei vescovi, che disagiati, e lontani dalle loro diocesi stavano malvolentieri in quella città, lo fecero terminare alla sessione XXV. che fu tenuta in detto giorno. Il re Filippo II, sebbene restasse dispiaciuto di questa risoluzione, non ostante per [211] il bene della pace si contentò che fossero ricevuti, ed osservati gli atti di questo concilio nei suoi stati, come or ora diremo. Erasene ritornato il duca di Medinaceli in Messina, dove come si è detto, ricevuto avea la prorogazione del viceregnato. Ivi adunque l’anno 1564, convocò per i 2 di giugno l’ordinario parlamento, in cui domandò il solito donativo; e siccome era sembrata ai nazionali assai grave la prima gabella imposta nell’antecedente straordinaria adunanza fatta in Palermo l’anno 1562, il vicerè dichiarò, che S.M., restava contenta che si commutasse con un’altra imposizione. Gli ordini dello stato adunque congregatisi, dopo di avere risoluto di offerire al re i soliti trecento mila fiorini, si determinarono, giusta il permesso ricevutone, di abolire la imposizione sopra le sete, i panni, i peli, e le altre merci, ed in vece di essa risolvettero di mettere la gabella della macina, cioè di nove denari sopra ciascun tummino, ch’è una misura siciliana di farina; quale gabella si facea montare a cento mila scudi, ch’era il doppio di quanto prima si pagava, cioè di cinquanta mila scudi, che non bastava a sostener le truppe, e le galee, per cui era destinata. Dovea questa gabella ripartirsi sopra tutte le università, alle quali si lasciava non ostante la libertà di cambiarla in altre gabelle, ogni volta che fosse creduto più conveniente, purchè ognuno pagasse la quota, che dovea 965. In questo parlamento non troviamo fatto al vicerè il solito regalo di cinque mila fiorini; ma crediamo che se gli sia offerto, quantunque non si noti negli atti. Il dispaccio reale, con cui approvava il concilio Tridentino, e ne ordinava la esecuzione, fu sottoscritto dal re Filippo in Madrid a’ 17 di luglio del medesimo anno 1564, e sebbene fosse stato spedito al vicerè, affine di farlo promulgare in Sicilia, questi ciò non ostante stimò suo dovere il farne esaminare gli atti dai regî ministri, acciò osservassero se vi fosse in essi cosa, che pregiudicasse le regalìe. I giureconsulti destinati a questa indagine iscuoprirono, che alcuni dei decreti del concilio ferivano direttamente, o indirettamente la regia giurisdizione 966. Perciò il vicerè, prima di eseguire il reale comando, volle informare la M.S. la quale con lettera de’ 24 ottobre 967 da Madrid rispose, che restava soddisfatto delle difficoltà proposte da’ ministri; ma che nondimeno volea che si promulgasse il suo dispaccio; beninteso però, che accadendo verun caso, in cui erano lesi i diritti della sua monarchia, allora questi tali decreti lesivi non si eseguissero. Avuta questa risposta, il vicerè ai 18 di dicembre dello stesso anno promulgò l’ordine reale 968 dei 17 di luglio 969. Sebbene il triennio accordato al duca di Medinaceli nel governo di Sicilia dovesse durare fino all’anno 1566, pur non dimeno il re Filippo II, non avendo riguardo a quanto avea disposto, elesse prima di spirare questo termine Garzìa de Toledo per vicerè di Sicilia; il che, se sia riuscito grave al Cerda, può ognuno immaginarselo. Non ebbe egli animo di trovarsi presente all’arrivo del suo successore, che gli rapiva il non ancora spirato governo; e perciò volendo assolutamente partire, col voto del sacro consiglio elesse a’ 22 di 963 964 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1562.1563 VI indiz. f. 440. Sarpi storia del concilio di Trento lib. VIII, t. II, pag. m. 295. Pallavicini storia del detto concilio lib. XXIV, cap. 4, t. III, p. 805. 965 Mongit. Parl. di. Sic. t. I, pag. 332, e seg. Tre furono i capi principali, che i ministri regj della Sicilia credettero lesivi alla monarchìa. Il primo, che nel cap. XI. de reformatione della sessione XXIV, si concedea agli ordinarj, come delegati del Papa, di potere giudicare le cause degli esenti, le quali furono sempre riconosciute dal tribunale della regia Monarchia. Il secondo, perchè nella sessione XXII al capitolo VII. de reformatione, vietandosi ai legati a latere di accettare le appellazioni via gravaminis, si ordina che sia osservata la costituzione romana d’Innocenzo IV, che chiama cotali cause in Roma; il che arrecava pregiudizio, e dispendio ai vassalli del re. Il terzo finalmente riguardava il cap. III. de reformatione della sessione XXV, in cui prescrivendosi i limiti agli ordinarj, nei quali debbono contenersi nel fulminare le scomuniche, si permette loro che possano farne uso contro qualunque persona, e vi si soggiunge: Nefas autem sit seculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico judici, ne quem excommunicet; il qual decreto feriva direttamente la nostra prammatica catalana. 967 Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1565.1566 VII indiz. f. 709. 968 Queste due carte contenenti i due dispacci regj dei 17 di luglio, e dei 24 di ottobre 1564 furono pubblicate l’anno 1700 dall’avvocato Giuseppe Giusino nella collezione da lui fatta delle prammatiche, ma manca il dispaccio viceregio dei 18 di dicembre; ed inoltre vi è qualche differenza dall’originale, che rinviensi nell’officina del protonotaro: il che abbiamo creduto necessario di avvertire. 969 Reg. dell’uffizio del proton. dell’anno 1565.1566 VII indiz. f. 233. 966 - 166 - febbraro 1565 Bartolomeo Sebastiano vescovo di Patti per presidente del regno fino all’arrivo del nuovo [212] vicerè, e ne sottoscrisse il dispaccio alla torre del Faro, prima d’imbarcarsi 970. Questo allora effimero presidente del regno non durò nell’impiego che pochissimi giorni, giacchè ai due del seguente marzo, come si dirà nel qui appresso capo, arrivò il nuovo vicerè, il quale dovendo partire per la Goletta, ve lo confermò con nuovo dispaccio, come diremo. Il duca di Medinaceli fu un governante più presto amato dalla nazione. Era egli affabile con le persone di ogni ceto, che rallegrava con comedie 971, feste, conversazioni, e con cacce, delle quali di molto si dilettava. S’egli non avesse lasciato senza freno i ministri, che si faceano lecito di operare dispoticamente, per lo che fu di mestieri che il re Filippo mandasse il visitatore regio, che abbiamo mentovato, il di lui viceregnato sarebbe stato scevro da ogni imputazione. Nelle azioni militari, siccome abbiamo osservato, non corrispose a quanto egli stesso promettea. Era egli inetto alla guerra, timoroso, ed inflessibile nelle sue risoluzioni, per la quale caparbietà rovinò gl’interessi della corona, e a fortuna si salvò dalle mani dei Mori. Ebbe egli qualche disturbo colla religione di Malta, che, mentre il re Filippo II. era in guerra colla Francia, e con Paolo IV. romano pontefice, avea eletto per generale delle galee fr. Francesco di Lorena fratello del duca di Guisa; il che trovando questo vicerè contrario al trattato convenuto con Carlo V, in cui espressamente si era stabilito che il generale delle galee dovea essere un italiano, e della lingua di questa nazione, ordinò che fosse vietata la entrata a’ bastimenti di Malta nei porti della Sicilia. Fu di mestieri che il gran priore di Francia fr. Francesco di Lorena deponesse questa carica, di cui fu investito fra Giorgio Adorno balìo di Napoli, dopo di che ritornò l’armonia fra quella isola, e il nostro regno. CAPO VII. Garzìa de Toledo vicerè, Bartolomeo Sebastiano, Antonio Doria, Carlo d’Aragona presidenti del regno in diversi tempi. Garzìa de Toledo figliuolo di Pietro vicerè di Napoli era quello stesso, che noi abbiamo rammentato in questo istesso libro al capo V, quando determinatosi l’augusto Carlo di togliere dalle mani di Dragutte le città dell’Africa l’anno 1550, fu spedito dal padre colle galee, e le truppe napolitane; nella quale impresa diede così alte prove del suo valore, che la conquista di Mahadìa, di cui ingiustamente il vicerè de Vega si attribuì l’onore, fu dovuta principalmente al di lui coraggio. Avea anche date le prove della sua virtù militare, come abbiamo sopra divisato, l’anno 1564, quando fatto dal monarca delle Spagne general comandante dell’armata navale, s’insignorì del Pegnone: quel sicuro asilo, dove ricoveravansi i corsali dopo di aver fatte delle scorrerìe, e delle prede ne’ regni principalmente spagnuoli. Grato perciò il re Filippo II a questi considerabili servigî, che resi gli avea questo prode capitano, e volendonelo ricompensare, tuttochè non fosse spirata la proroga di tre anni accordata al duca di Medinaceli, non credette, che vi fosse un miglior premio proporzionato alle di lui fatiche, quanto era il viceregnato di Sicilia; e perciò ve lo promosse sotto i 7 di ottobre dello stesso anno 1564, come costa dal dispaccio sottoscritto in detto giorno a Madrid 972, e registrato nella regia cancellarìa a Messina. Un altro grave motivo spinse questo sovrano a spedire per vicerè il detto de Toledo; ed era quello di essere necessario in quelle circostanze un capitano sperimentato, che reggesse la Sicilia. Arrivò questo nuovo vicerè in detta città di Messina a’ 2 di marzo del seguente anno [213] 1565, ma non prese nella cattedrale di essa il possesso solenne della nuova carica, che a’ 22 di aprile, dopo di avere eseguita la commissione, che or ora diremo. I corsali affricani privi del famoso asilo del Pegnone, e vedendo la Spagna padrona ancora della Goletta, disperavano di poter più sussistere, e perciò ricorsero al vecchio Solimano, acciò li liberasse da vicini così formidabili. Era questi irritato contro i Cristiani, e particolarmente contro i cavalieri di Malta, che facendo continove prede ne’ mari di oriente, aveano da ultimo rapito il vascello detto delle sultane carico di ricche merci, che apparteneano in parte a Kuslin Agà capo degli Eunuchi, e ministro dei suoi piaceri, e in parte a molte favorite. Mosso adunque dalle premure fattegli dal custode delle beltà racchiuse nel serraglio, e dalle lagrime delle sue donne si determinò di assicurare la navigazione ne’ suoi mari, e in quelli dell’Affrica, e di cominciare dallo acquisto dell’isola di Malta, per cui fe segretamente preparare una poderosa armata 973. 970 Reg. della regia cancellarìa dall’anno 1564.1565 VIII indiz. f. 227. È memorabile fra le rappresentanze fatte fare da questo vicerè, l’atto così detto della Pinta, che fu la prima volta recitato nella imperial confraternità di S. Maria della Pinta: chiesa, ch’era nella piazza del regio palagio, ed ora non più esiste, quantunque ne porti il nome un’altra chiesa vicina. Noi ne abbiamo diffusamente scritto l’anno 1756 nel primo tomo delle memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia (p. II, pag. 45.), dove nominammo l’autore di questa rappresentanza, che fu Teofilo Folengo monaco Benedettino, detto dalle sue macaroniche Merlin Coccajo; descrissimo qual fosse l’argomento di quest’atto, ed accennammo le ingenti spese per eseguirlo, e quanto tempo durava. 972 Nel reg. della regia cancellarìa dell’anno 1564.1565. f. 280. 973 Vertot Hist. de Malte lib. XII, t. V, p. 405. 971 - 167 - Egli Solimano da uomo saggio, e prudente, prima di far partire la flotta, convocò un gran consiglio di guerra, in cui fu esaminato, s’era necessario, ed eseguibile per assicurare il commercio de’ suoi sudditi, il discacciare i cavalieri gerosolimitani dalla isola di Malta. Non furono i Bassà tutti di accordo; taluni di essi opinarono, che fosse agevole questa impresa: non mancarono però di quelli, a’ quali parve difficilissima. Fra questi furono i principali Aly il luogotenente di Dragutte, e il bassà Maometto il più vecchio di ministri militari. L’uno, e l’altro rappresentarono al gran signore, che i cavalieri di Malta erano capitani sperimentati nell’arte della guerra, e pronti, più presto che a rendersi, a spargere sino all’ultima goccia il proprio sangue nella difesa di quell’isola: che la flotta non avrebbe avuto i mezzi da sussistere: che dalla Spagna, dal Pegnone, dalla Goletta, e dalla Sicilia al primo avviso dell’arrivo dell’armata ottomana sarebbono venuti de’ considerabili, e poderosi soccorsi per la difesa di Malta; e che potea di leggieri avvenire, che le truppe musulmane da assedianti, che erano, si trovassero assediate e bloccate dalle flotte cristiane, che fossero accorse a sostenere i Maltesi. Non ostanti tutte queste ragioni l’animo del gran sultano trovavasi già preoccupato. Kuslin-Agà, che avea il maggiore interesse, come si è detto, per la perdita del galeone, avea saputo adoprare non solamente le carezze delle belle Giorgiane, e Circassiane, che erano molto atte a muovere il cuore di quel vecchio monarca, ma le voci ancora dello Iman, ossia del predicatore della corte, il quale in una delle prediche intorno alla carità, che dee esercitarsi verso i poveri, ed i miserabili, rappresentò con espressioni assai patetiche, e toccanti lo stato meschino, in cui trovavansi tante migliaia di Musulmani, che gemeano fra ceppi nell’isola di Malta, e fe così palesi i doveri, in cui era il principe di liberarneli, che Solimano pietoso, e pieno di religione si credette in debito di procurare prima di ogni altra cosa la salvezza dei suoi sudditi, che stavano presso i Maltesi in ischiavitudine. Essendo così sedotto dai singhiozzi delle sultane, e dalle insinuazioni dello Iman l’animo del gran signore, non gli parvero nè grandi, nè insormontabili le difficoltà proposte dal bassà Maometto, e dal luogotenente Aly, e si determinò nel consiglio alla impresa di Malta. Furono scelti per questa spedizione Pialy per ammiraglio, e Mustafà per generale in terra. Erano ambidue per le riportate vittorie in grandissima estimazione del gran signore di Costantinopoli, il quale raccomandò loro che andassero di accordo, ma soprattutto che non si discostassero dai consigli, e dai suggerimenti del famoso Dragutte, che era il più grande uomo di mare, che fosse nello impero ottomano, e nudriva un odio particolare, ed implacabile contro i cavalieri gerosolimitani. Unir doveansi alla gran flotta, che stava preparata, per ordine supremo molti vascelli, e galee, che comandava Ulucchiali rinegato calabrese, che recar dovea d’Alessandria quelle, che avrebbe spedite il governatore di Rodi, le altre di Hascen, e di Dragutte, e tutte le barche dei corsari della Barberìa, che ebbero ordine di avvicinarsi all’isola di Malta, e di aspettarvi la flotta imperiale 974. Fu ai ministri del consiglio prescritto il più rigoroso silenzio, fino che questo progetto non giungesse alla sua intera perfezione. Per quanto però segreti fossero questi [214] preparamenti, penetraronsi nondimeno da Malta, e dal re Filippo; e sebbene non sene sapesse precisamente il destino, pure sospettavasi che questo turbine potesse cadere o contro Malta, o contro il monarca delle Spagne. Questi dunque dichiarò capitan generale di mare il de Toledo, e spedendolo per vicerè di Sicilia gli ordinò, che si portasse prima alla Goletta di Tunisi per metterla in istato di difesa, e che poi passasse in Malta per consultare col gran maestro, quali fossero i mezzi per tener lontana la flotta ottomana da qualunque impresa, che tentar potesse contro quell’isola, o contro il regno nostro di Sicilia. Ecco perchè il Toledo appena arrivato in Messina, senza curarsi di fare la solenne funzione del possesso, si affrettò di partire per soccorrere la Goletta, e lasciò lo stesso Bartolomeo Sebastiano vescovo di Patti per presidente del regno nella sua lontananza, spedendogliene il dispaccio viceregio ai 4 del seguente aprile 975. Partì egli coll’accompagnamento di 29 galee bene armate, e cariche di soldatesche; e siccome gli tornava meglio di conferire col gran maestro la Vallette, prima di portarsi a quella piazza, andossene a Malta, dove ragionando col medesimo intorno alle diverse notizie, che ricevute aveano della flotta turca, convennero di assistersi reciprocamente con tutte le loro forze. Mancava quell’isola di provigioni da bocca, e di soldatesche, se mai era costretta a sofferire un lungo assedio; e il vicerè promise, tostochè fosse ritornato in Sicilia, di provvedernela abbondantemente, e per caparra della sua promessa vi lasciò come in ostaggio uno dei suoi figliuoli. Ciò fatto s’imbarcò per Tunisi, ed osservate le fortificazioni della Goletta, le fe riattare dove il bisogno lo ricercava, e a mille soldati, che vi erano di guarnigione, aggiunse altre quattro compagnie di milizie spagnuole, e tosto pensò di restituirsi in Sicilia. Venne allora in Palermo, dove fu con molta pompa ricevuto, ma vi si trattenne poco tempo, e di viato partì per ridursi a Messina, ove potea essere a portata di 974 975 Vertot Hist. de Malte lib. XII, t. IV, p. 412, e seg. Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1564.1565 VIII indiz. fogl. 285. - 168 - difendere quella città, e le altre, che poteano le prime essere assalite dalle armi ottomane 976. Noi lo troviamo già in quella città a’ 4 di maggio riprendere la cura del governo 977. Allontanatosi il Toledo da Malta, comparve nei mari dell’Affrica la squadra costantinopolitana forte di cento cinquantatrè galee, e galeotte, senza contare i legni da carico proporzionati a quelli di guerra, e agli 8 di maggio fu veduta alle alture dell’isola. Non appartiene al nostro argomento il riferire le provvidenze date dal gran maestro prima che la flotta comparisse, nè ciò, che questo prode campione coi valorosi cavalieri fece per impedire, che s’impossessassero i Maomettani di quell’isola 978. Fu incredibile il coraggio dell’uno e degli altri, i quali [215] sacrificando il proprio sangue con poche soldatesche respinsero sempre il nemico, gli uccisero intorno a trenta mila uomini, frai quali perdette la vita il famoso Dragutte ancora, ed obbligarono la flotta a ritirarsi. Noi non scriviamo la storia di Malta; gli scrittori della religione 979 raccontano distintamente tutte le circostanze di questa prodigiosa difesa, che durò fino ai 7 di settembre, in cui il generale Mustafà, disperando di poter più vincere, s’imbarcò, e ritornò a Costantinopoli coi rimasugli della poderosa oste, che avea seco recata. Restarono in quella occasione tutti sorpresi nell’osservare la condotta del nostro vicerè. Il gran maestro la Vallette appena comparsa la flotta Turca, cui dipoi si unì la flottiglia recata dal Bey di Algieri, scrisse subito al medesimo, acciò gli mandasse i promessi soccorsi, nè lasciò d’incaricare i cavalieri, che erano a Messina, acciò ve lo sollecitassero; ma il Toledo ora con un pretesto, ora con un’altro andava procrastinando, anzi scrive il Vertot 980, che Gian Andrea Doria, che trovavasi colle sue galee in Messina, si offerì al vicerè suddetto di condurre a Malta due mila uomini; lusingandosi, appoggiato all’attività della sua ciurma, che sarebbe penetrato fino ai piedi del castello S. Angelo, e vi avrebbe sbarcate le truppe prima, che la flotta ottomana levasse le ancore per inseguirlo: protestandosi, che poco curava la perdita delle sue galee, purchè avesse recato questo soccorso agli afflitti Maltesi: e che il vicerè, quantunque ne avesse commendata l’esibizione, col sutterfugio che non potea sguernire la Sicilia delle milizie, gli ordinò che andasse a Genova, e per le coste di Toscana, affine di prendere a bordo le truppe necessarie per questo particolare armamento 981 . Dopo quattro mesi d’indugio finalmente il Toledo si determinò a far quello, che fino allora avea ricusato di eseguire, e nel mese di agosto si partì colle galee, e colle truppe da Messina, e venne a Siracusa risoluto di recare egli stesso il tante volte negato soccorso. Per non lasciare il regno senza un governante, scelse per presidente del regno, durante la sua breve lontananza, Antonio Doria, marchese di Santo Stefano, e cavaliere 976 Vertot Hist. de Malte l. XII, t. IV, p. 413. e seg. Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1564.1565 VIII indiz. fogl. 351. 978 Varie voci atte ad atterrire i Maltesi spargea la fama menzognera, e principalmente che i generali musulmani aveano già la carta esatta di tutte le fortificazioni di Malta, e sapeano per lo appunto l’altezza, e la estensione delle loro muraglie, giacchè il gran signore avea avuto preventivamente la diligenza di fare delineare ogni cosa dai suoi più abili ingegneri, i quali travestiti in abito di pescatori aveano avuto tutto l’agio di misurarle. Il gran maestro niente sbigottito da questi avvisi, coll’approvazione del suo consiglio spedì le circolari, colle quali chiamava i cavalieri dell’ordine, ch’erano lontani, acciò venissero a difendere Malta; ordinò ai suoi agenti, che arrollassero quante truppe poteano, e mandò le galee, affinchè trasportassero nella isola armi, polvere, e provigioni così da guerra, che da bocca. Bello era il vedere come i cavalieri si affrettavano ad imbarcarsi per andare in soccorso della loro religione, e come i vecchi, che non erano atti a servire colle loro forze, si affaticavano nelle città nelle quali erano restati, a provvederla di soldatesche, di viveri, e di munizioni da guerra. Ogni giorno arrivavano in Malta nuovi campioni, e nuovi soccorsi, e il prode la Vallette, a misura che giungevano i suoi fratelli, e gli arrollati soldati, li distribuiva nei differenti posti, che più ricercavano una valida difesa (Vertot Hist. de Malte lib. XII, t. IV, pag. 419, e seg.) Questi ajuti, per quanto fossero stati con frequenti lettere sollecitati, furono ben pochi al bisogno, avvegnachè prima che arrivasse l’armata turca, i cavalieri non erano che settecento, non compresi i frati serventi, ed otto mila, e cinquecento erano gli altri soldati così prezzolati al soldo della religione, che cittadini, e paesani, dei quali si erano fatte alcune particolari compagnie (Bofio Stor. di Malta t. III, lib XX, all’anno 1565. Vertot nel luogo citato). Questo scarso numero di difensori è di ragione che sia avvertito; giacchè vieppiù ne riluce il coraggio, e la virtù di quei cavalieri, e la bravura, e conoscenza nell’arte militare del gran maestro la Valette, che con un pugno di gente a confronto della poderosa armata, che lo assaliva, seppe sostenere l’assedio di quattro mesi, e dopo di avere mandati all’altro mondo trentamila maomettani, ridusse il bassà Mustafà, e l’ammiraglio Pialy agli estremi, e il loro formidabile esercito fu nella necessità di fuggirsene. 979 Bosio Historia della relig. Gerosol. t. III, l. XX, all’anno 1565. – Vertot Hist. de Malte tom. IV, lib. XII, pag. 423, e seg., e t. V, lib. XIII, pag. 1, e seg. 980 Ivi t. V. pag. 22. 981 Tutti i politici di quella età si aguzzarono il cervello per indovinare la cagione di questa inusitata indolenza del Toledo. Egli avea fatte di ordine della sua corte grandiose promesse al gran maestro, ed aveagli perfino lasciato per ostaggio il proprio figliuolo, che vi lasciò la vita in questo assedio. Il suo valore era conto presso di ciascheduno, e si sapea ciò, che si era da lui operato nello assedio di Orano, e poi nello acquisto del Pegnone; nè mai si era di lui sospettato, che fosse figliuolo della paura. Tutte queste circostanze chiaramente addimostravano, che ei non ricusava di sua volontà di soccorrere l’isola di Malta, e che altra cagione dovette muoverlo a resistere alle premure del gran maestro, e a’ rimproveri, che continuamente gli venivano fatti dai commendatori della religione, ch’erano appresso di lui. Avea dunque egli dal re Filippo II segrete istruzioni di non muoversi. Questo monarca con una politica lenta, ed incerta, che spesso rovinò i suoi interessi, aspettava tutto dal tempo, sperando, che i soli cavalieri di Malta avrebbono difeso l’isola, e respinto il nemico, senza ch’ei arrischiasse nulla del suo. Intanto per questa condotta non sua fu sempre il Toledo in esecrazione presso coloro, che ignoravano i segreti comandi, ch’ei ricevuti avea dal suo sovrano. Quanto è dura la condizione di chi serve! 977 - 169 - del toson d’oro, cui spedì in detta città il dispaccio ai 24 dello stesso mese 982; e al primo del seguente settembre mosse le vele verso Malta, dove arrivò ai 6 di esso mese, ed ai 7 fe sbarcare le soldatesche, i viveri, e le munizioni da guerra da tanto tempo aspettate 983. Questo soccorso, sebbene fosse arrivato tardi, giacchè Mustafà, e il suo luogotenente Pialy già si erano risoluti di levare l’assedio, e di ritirarsi, come fecero, nondimeno rallegrò in parte i Maltesi, e potè in qualche modo conferire a intimorire vieppiù i comandanti ottomani, e ad indurli a partire più sollecitamente. Lo storico di Malta Vertot 984 lasciò scritto, che il Toledo dopo di avere posto il piede nell’isola, e di avere fatta la rassegna delle truppe, che avea recate, e dovea ivi lasciare secondo gli ordini ricevuti dalla sua corte, immediatamente se ne partì per ritornare in Sicilia, sebbene nell’atto che s’imbarcava, e si separava dagli uffiziali generali, avesse loro promesso che ai 13 o 14 dello stesso [216] mese sarebbe ritornato con un altro rinforzo di quattro mila uomini, che aspettava dall’Italia, e che contava che potessero già essere venuti in Messina. Noi però siamo di avviso, che ei non si fosse così presto imbarcato, e che fosse dimorato qualche altro giorno in quella isola, o che ritornando in Sicilia, sperando di arrecare un’altro soccorso a Malta, si sia astenuto di riprendere le redini del governo, fermandosi a Siracusa sino che fossero arrivate le milizie da Messina 985. C’induciamo a così opinare, perchè abbiamo osservato nei registri della regia cancellarìa, che il Doria continuò a reggerci sino ai 6 di ottobre 986, e che il Toledo non cominciò a dispacciare, che ai 9 dello stesso mese 987. Nel suo ritorno in Sicilia si applicò il vicerè a fortificarne le città marittime sulla certezza, in cui era, che Solimano sarebbe ritornato con più poderose forze ad inquietarci. Visitò principalmente Agosta, e conoscendo quanto questa città, come la più esposta per il suo vasto porto ad essere invasa dalla flotta ottomana, che avrebbe potuto ivi commodamente trattenersi, abbisognava di essere fortificata, ordinò che vi si ergessero alla bocca del porto due forti, ad uno de’ quali fu dato il di lui nome, e fu detto Garzìa, e all’altro il nome di sua moglie, che fu perciò chiamato Vittoria 988. Tutte le diligenze adoprate dal vicerè, per mettere la Sicilia in istato di difesa, e quelle, che facea il gran maestro la Vallette, per risarcire le fortificazioni della quasi distrutta isola di Malta, sarebbono stati inutili, se l’irritato Solimano giungea ad allestire la poderosissima flotta, che stava preparando per la primavera del seguente anno, con cui intendea non solo di discacciare per sempre i cavalieri dell’ordine dall’asilo, in cui dimoravano, ma di rapire ancora al re Cattolico la nostra isola, e il regno di Napoli. Questi preparamenti del gran sultano faceano tremare tutta l’Italia, e il re Filippo, che in questo anno non avea soccorso, come dovea, i Maltesi, vedendo ora più vicino il pericolo, si applicò seriamente ad assoldare trentamila uomini, de’ quali dodici mila erano destinati per la Goletta, e gli altri per soccorrere Malta, che poteano riputarsi come i due baluardi per resistere alla potenza ottomana. Questi provvedimenti dati dal monarca di Spagna furono notificati dal vicerè Toledo agli ordini dello stato a’ 18 di febbraro 1566 nell’apertura del parlamento fatto in detto giorno nel palagio vescovale di Catania, in cui ei fe palese, come il re avea speso per questo armamento un milione, e quattrocento mila ducati, e richiese da’ parlamentarî qualche straordinario sovvenimento. In detta occasione avendo questa assemblea conosciuto, che le spese fatte dal re tendevano alla sicurezza della Sicilia, offerì un donativo di cento venticinque mila scudi da pagarsi in due sborsi, l’uno nel dicembre di detto anno, e l’altro nel mese di marzo del seguente 1567 989. Fu accordato il privilegio di regnicolo così al vicerè, che a’ di lui figliuoli Pietro, e Luigi, e furono domandate al re alcune grazie, che leggonsi ne’ capitoli del regno 990, le quali, 982 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1564.1565 VIII indiz. f. 531. Vertot Hist. de Malte tom. V, lib. XIII, p. 90, e seg. 984 Vertot Hist. de Malte tom. V, lib. XIII, pag. 89. 985 Il nostro Vincenzo Auria (Cronol. de’ vicerè di Sicilia pag. 48.) racconta, che il Toledo ritornato in Sicilia raccolse nuove truppe, e ripartì con quarantotto galee per Malta, dove arrivò a’ 15 dello stesso mese di settembre, e fu accolto dal gran maestro con lagrime di tenerezza, e osservato il danno recato all’isola da’ Turchi, pieno di sdegno si rimbarcò per dar la caccia alla fuggitiva armata ottomana, che proseguì sino a Cerigo, ch’è alla imboccatura dello Arcipelago. Non reca egli veruna prova di quanto rapporta, e il silenzio di tutti i nostri storici, e de’ Maltesi ancora, che non avrebbono trascurato di avvisarcene, ci fa sospettare che l’affare non sia andato così; molto più che non è verisimile, che il vicerè partito al più da Malta agli 8 di settembre, abbia potuto venire in Sicilia, raccorre le truppe, che doveano essere a Messina, e ritornare a Malta a’ 15 dello stesso mese. In otto giorni, quanti ne corsero dagli 8 a’ 15, non poteano eseguirsi tante cose, quando non si volesse, che i soldati, che doveano radunarsi, e le galee, che doveano ritornare in Messina, e ricomparire con un nuovo soccorso a Malta, avessero le ali. Il Vertot (Hist. de Malte lib. XIII. tom. V, pag. 100.) ci avvisa, che la flotta turca fuggendo da Malta passò per la Sicilia, e che il vicerè, che trovavasi nel castello di Siracusa, la vide in alto mare, e fu certificato senza altro avviso, che Malta era stata liberata dallo assedio. 986 Reg. dell’anno 1565.1566, IX indiz. f. 63. 987 Nello stesso registro f. 66. 988 Vita Storia di Augusta pag. 48. 989 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 340, e seg. 990 Tom. II, pag. 261. 983 - 170 - secondo le istruzioni ricevute dalla corte, furono proviste dallo stesso vicerè in Messina a’ 9 di luglio dello stesso anno 1566, dopo il suo ritorno dalla spedizione marittima, che in appresso accenneremo. Per quanto i cavalieri di Malta si fossero affaticati per mettere la loro isola in grado [217] di difesa, e malgrado le spese fatte dal re Filippo per guarnire la Goletta, e somministrare truppe alla medesima religione, fu creduto che Solimano sarebbe venuto a capo di fare sloggiare quelli dalla loro abitazione, e di togliere a questo la forte piazza della Goletta; e avrebbe di poi più agevolmente arrecati de’ danni a’ regni di Sicilia, e di Napoli, se il gran maestro la Vallette non avesse concepito lo ardimentoso disegno di fare incendiare la di lui flotta formidabile nello stesso arsenale di Costantinopoli, come gli riuscì per mezzo di certe segrete corrispondenze, che avea in quella città 991. Questo incendio, che non potè interamente estinguersi, sconcertò i disegni di Solimano, e diè tempo al gran maestro di fortificarsi in Malta, e di fabbricarvi la nuova città, che fu detta dal suo nome la Valletta 992. Ne chiese egli il permesso al vicerè Toledo, mentre trovavasi nel parlamento a Catania, il quale vi spedì Vincenzo del Bosco conte di Vicari, e gran giustiziere del regno di Sicilia per osservare il luogo, dove si pensava di piantarla, e calcolare quanta ne potesse essere la spesa. Dietro alle relazioni di questo cavaliere conoscendo il vicerè l’utile, che ne sarebbe risultato, appoggiò la dimanda del gran maestro alla corte, e gli procurò un sovvenimento di cinquanta mila scudi, venti in vettovaglie, che furono spedite sopra alcune navi spagnuole scortate dal Doria, e trenta in denari, e vi spedì ancora dalla Sicilia molti operarî per sollecitare l’erezione della nuova città. Non tutta l’armata turca fu divorata dalle fiamme; le galee in parte scamparono l’incendio. Perciò Solimano ordinò al bassà che colle galee, che si erano salvate, scorresse i mari per tribolare i Cristiani. Costui a tradimento prese l’isola di Scio, nonostante, che i Genovesi fossero in tregua col sultano 993. Temendosi perciò di peggio il nostro vicerè unendo le galee di Spagna con quelle di Toscana, e di Genova, ch’erano al numero di 80, si pose in mare per cercare di cacciare questo corsaro da’ mari. Lasciò egli durante la sua lontananza per presidente del regno Bartolmeo Sebastiani vescovo di Patti, come costa dal dispaccio viceregio sottoscritto in Messina a’ 26 di marzo 1566 994, in cui si dice, che il fine per cui partiva era appunto per soccorrere la Goletta, che forse sarà stato un altro dei motivi, per cui s’imbarcava. Questa fu la terza volta, che sostenne questa carica il mentovato vescovo di Patti: ciò, che ci dà argomento ch’ei fosse un prelato sagace, e prudente. Era egli nato nel regno d’Aragona, ed era poi passato in Palermo, dove avea ottenuto nella cattedrale uno de’ canonicati di S. Giovanni degli Eremiti, ed era stato anche eletto inquisitore del tribunale del S. Uffizio. Fu poi promosso dallo augusto Carlo V. l’anno 1548 al vescovado di Patti, nel governo del quale si [218] portò con molta lode, avendo sostenuto gli interessi di quella chiesa, e nobilitate le cappelle, e il palagio vescovale. Ebbe qualche dissapore coll’austero, e superbo vicerè Giovanni Vega, il quale gli compilò il processo e gli fe’ sequestrare le rendite; del che si dolse amaramente l’arcivescovo di Palermo Pietro d’Aragona con Filippo II, il quale con dispaccio dei 23 di marzo 1556 ordinò al vicerè, che non s’intromettesse nell’accusa del vescovo di Patti, ch’ei richiamò a se per esaminarla. Questo istesso monarca grato a’ di lui servigî l’anno 1568 lo promosse all’arcivescovado di Tarragona, dove poi morì 995. Fu anche breve questa terza presidenza di Monsignor Sebastiani; imperocchè non durò che fino a’ 25 di maggio dello stesso anno, nel qual giorno ritornò dalla sua spedizione il Toledo 996. La flotta superiore, che ei comandava, e l’esservi anche ne’ nostri mari cinquanta galee de’ Veneziani, indussero il Pialy a non più arrischiarsi di vantaggio, e perciò si ritirò verso levante. Non temendosi dunque più le scorrerìe di Pialy, si 991 Vertot Histoire de Malte lib. XIII, tom. V, p. 208. La salute di Malta dipendea principalmente dalla difesa dei due porti, nei quali doveano necessariamente entrare le squadre nemiche per assediarla: era perciò d’uopo che nella penisola, che divide l’un porto dall’altro, vi fosse un castello, che potesse impedire l’approcciamento di qualunque nave. Il castello di S. Elmo era molto opportuno a questo effetto: ma oltre di essere piccolo, non trovavasi fabbricato secondo le regole dell’arte. Lo ingrandimento di questa fortezza fu il primo scopo del gran maestro; corresse egli tutte le irregolarità, la cinse con nuovi baluardi, e la rese formidabile ad ogni armata, che volesse entrare nell’uno, o nell’altro porto. Ciò eseguito immaginò, che se presso a quella penisola vi si fabbricasse una città difesa da muraglie, e da rivellini, nella quale si trasportasse il convento, allora non sarebbe più da temersi qualunque ridottabile nemico. Abitavano prima i cavalieri nel gran Borgo, il quale essendo nel basso, era dominato dalle colline, e dalle balze, che lo circondavano; di maniera, che occupate queste da’ nemici, era perigliosa cosa il difendersi; quando all’incontro trasportandosi i cavalieri nella ideata città presso il mentovato castello di S. Elmo, erano sicuri da ogni sorpresa, e in grado di potere difendere con più comodo quella fortezza, e di allontanarne il nemico. Ecco la cagione, per cui fu fabbricata la Valletta. 993 La mentovata isola di Scio nell’Arcipelago, detta ancora Chio, e Sio, appartenea ai signori Giustiniani di Genova, (sebbene di poi sia passata in potere dei Veneziani nell’anno 1696). Erano eglino in pace col Turco, e gli pagavano un annuo tributo. L’apparente motivo, per cui Solimano la conquistò, fu perchè aveano trascurato di pagare puntualmente il tributo, e perchè avvertito aveano i Maltesi dei preparamenti, che si erano fatti l’anno antecedente in Costantinopoli contro la loro isola. Il Pialy dopo di questa conquista venne nell’Adriatico, dove saccheggiò le coste della Puglia, e recò a’ Pugliesi innumerabili mali. Perciò i Veneziani, comechè fossero in tregua col Turco, temendo di simili sorprese, armarono cinquanta galee, e cominciarono a farsi vedere nell’Adriatico. 994 Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1565.1566, IX indiz. f. 344. 995 Pirri Not. Eccl. Sicil. Not. VI, Eccl. Pactens. pag. 413, 414. 996 Reg. del prot. dell’an. 1565.1566 IX indiz. f. 584. 992 - 171 - restituì il Toledo a Messina, dove licenziò le galee di Spagna, di Genova, e di Toscana, e riprese il governo della Sicilia. Non si trattenne non dimeno molto nel regno; avvegnachè fu egli chiamato alla corte di Madrid, e ne partì nel mese di ottobre, lasciando per presidente alla sua partenza Carlo d’Aragona, e Tagliavìa principe di Castelvetrano, duca di Terranova, grande ammiraglio, e contestabile del regno di Sicilia 997. Il dispaccio viceregio di questa elezione fu sottoscritto in Palermo a’ 18 di ottobre dello stesso anno 1566 998, dopo di che partì per la corte 999. Si trattenne in Spagna il Toledo fino al mese di maggio 1567, e nei primi di giugno di questo anno ricomparve in Sicilia, e riprese le redini del governo, non già per dimorarvi molto tempo, ma per celebrarvi il parlamento, e forse per riprendere il suo equipaggio, e la sua famiglia, giacchè, come diremo, in capo a pochi giorni se ne partì per non ritornarvi mai più. Questo era il parlamento ordinario, giacchè erano già scorsi i tre anni da che in Messina l’anno 1564 s’era tenuto l’altro simile parlamento. Ne fu fatta l’apertura agli 8 dello stesso mese, nella quale richiese il vicerè il solito donativo, e rappresentò ai parlamentarî le spese ingenti, che il re fatte avea per la conservazione del regno. Gli ordini dello stato fatte le solite sessioni ai 15 dello stesso mese diedero la loro risposta, ed oltre la consueta offerta di trecento mila fiorini, prorogarono ad altri anni sei il donativo di trentanove mila scudi all’anno per il mantenimento delle sei galee aggiunte alle dieci, che prima componevano la flottiglia siciliana 1000. Fu altresì prorogata la imposizione per tre anni dei cento mila fiorini per le fortificazioni, e dei quarantotto mila per la conservazione dei ponti, e finalmente fu offerto un altro donativo di ventimila scudi da pagarsi in tre anni per riattare i regî palagi, e fu fatto al vicerè il solito regalo di cinque mila fiorini 1001. Celebrato questo parlamento si affrettò il vicerè a partire coll’armata, ch’era sotto i suoi ordini, per eseguire i comandi del re di Spagna. Questo principe volendo domare i popoli della Fiandra, che si erano rivoltati, come abbiamo avvertito nella nota antecedente [219] avea scritto al governatore di Milano, e a’ due vicerè di Napoli, e di Sicilia, acciò preparassero tutte le forze, che potevano, per spedirle nelle Fiandre, dove egli pensava di andare personalmente; e siccome bisognava fare questa spedizione per la via d’Italia, giacchè i Francesi non avrebbono comportato, che l’armata passasse per il loro regno, così fu ordinato che la rassegna si facesse in Genova, dove perciò dovette portarsi il vicerè Toledo. Partì egli nel dì 27 di giugno, o poco dopo, imperocchè in detto giorno con un nuovo dispaccio confermò egli per presidente del regno il ridetto principe di Castelvetrano 1002. Per intendere l’origine di questa guerra, per cui fu chiamato Garzìa de Toledo, bisogna avvertire il passo irregolare dato dal re Filippo II, che fu la favilla, che accese quello incendio inestinguibile, che andò poi a terminare colla perdita della Olanda. Eransi sparsi in quelle provincie i semi del luteranismo, e del calvinismo. La vicinanza dei Tedeschi, e dei Francesi avea corrotti gli animi di alcuni individui delle Fiandre. Il monarca Cattolico, dubitando che questo veleno non serpeggiasse, giudicò di essere espediente di affogarlo in culla, e di purgare quegli stati dai pessimi umori, che vi erano introdotti. A far questo si avvalse di un mezzo violento, che in vece di guarire il male, lo inasprì vie maggiormente. Introdusse egli nei Paesi Bassi l’odiatissimo tribunale del S. Uffizio, e per renderlo più terribile, volle che fosse regolato a norma di quello di Spagna, che per rigore superava di gran lunga le inquisizioni di tutti gli altri paesi. Questo pesante giogo, che i loro maggiori non aveano punto sofferto, non solo atterrì coloro, ch’erano tinti della pece della eresìa ma i buoni, e gl’innocenti ancora, i quali temeano estremamente l’esorbitanze degl’inquisitori, e le cabale, e le imposture che i loro nemici sotto l’orpello della religione suscitar poteano contro di essi. Cominciarono adunque e gli uni, e gli altri a far prima delle rimostranze al real trono contro la minacciata introduzione del S. Uffizio. Non essendo state accettate le loro preghiere, principiarono a tumultuare, e 997 Questi speciosi titoli di grande ammiraglio, gran contestabile, gran giustiziere ec. non erano più, che vani nomi. Quelli di gran contestabile, di grande ammiraglio, e di gran siniscalco, non dimorando i principi nostri in Sicilia, da se erano caduti, nè n’erano restate, che le pure nomenclature, quello del gran protonotaro, ossia luogoteta, s’era abolito, restando un luogotenente, che semplicemente si dice protonot. Gli altri tre di gran giustiziario di gran camerlengo, e di gran cancelliere, dopo la riforma de’ tribunali fatta da Filippo II furono annullati, e in vece loro furono costituiti i tre presidenti, come luogotenenti, cioè quello della gran corte del gran giustiziere, quello del patrimonio del gran camerlengo, e quello del concistoro del gran cancelliere. Si legga l’erudito marchese di Villabianca intorno agli antichi uffizj del regno di Sicilia nella prima raccolta di opusculi di autori siciliani tom. VIII, e seg. 998 Reg. del protonotaro dell’anno 1566.1567 XI indiz. f. 46. 999 Non si accenna il motivo, per cui il Toledo sia andato alla corte coll’armata. Noi sospettiamo, che i torbidi nati nelle Fiandre per il tribunale del S. Uffizio, che volea Filippo introdurvi, come diremo, e che già scoppiavano in aperta guerra, lo avessero fatto chiamare a Madrid per consultare ciò che fosse necessario per sedare quel tumulto, e che vi abbia condotto delle truppe, se mai bisognavano. 1000 È da avvertirsi in questo luogo, come dagli atti di questo parlamento si ricava, che in quella età per mantenere una galea per un anno erano bastanti scudi sei mila, e cinquecento. 1001 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 344, e seg. 1002 Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1566.1567 X indiz. f. 461. - 172 - protestarono, che, se il re si ostinava a volere introdurre presso di loro il ridetto tribunale, si sarebbono sottratti dal dominio degli Spagnuoli. Irritato il re Cattolico, per sedare i sediziosi, volle adoprare il ferro. Invano la principessa Margherita governatrice delle Fiandre, invano il duca di Feria suo ministro gli suggerivano le vie dolci della moderazione, egli tenne fermo nel suo proposito, a cui forse lo istigavano ancora le insinuazioni di Roma, e non si fe’ poco ad ottenere da questo monarca, che non andasse come avea stabilito, di persona alla guerra. Destinò dunque alla testa dell’armata Ferdinando de Toledo duca di Alba, personaggio così altiero, e severo, che conferì moltissimo colle sue aspre maniere a distrarre interamente gli animi dei Fiaminghi dalla ubbidienza al proprio sovrano. In questa occasione fu dal re chiamato coll’armata il nostro vicerè Garzìa de Toledo per assistere co’ suoi consigli, e col suo valore il duca di Alba suo parente. Fu Garzìa de Toledo un prode, ed ottimo cavaliere; oltre la sua propria bravura, che abbiamo secondo le circostanze additata, egli si applicò a rendere prodi, e valorosi gli altri. Egli fu l’istitutore della congregazione, ossia accademia de’ cavalieri, che fu fondata in Palermo a’ 6 di ottobre 1566, e fu dedicata a S. Sebastiano. Era questa come un seminario di giovani cavalieri, che convivevano nel palagio di Ajutami Cristo, i quali si esercitavano nelle armi, e doveano esser pronti ad ogni bisogno della patria a radunarsi al ponte detto dell’Ammiraglio, o come altri vogliono della Medaglia, vestiti di armi bianche, ciascheduno accompagnato da un ajutante anche armato per combattere a favore della medesima. Fu costituito capo, e generale di quest’accademia il marchese de Avola, consigliere il barone di Fiume Salato, ed alfiere Carlo Marchese. L’impresa di questa congregazione era il detto Ponte, dove stava dipinto Orazio, che battendosi tenea lontani i nemici 1003 col motto: ipsa suos. Dal detto palagio vennero poi l’anno 1620 questi cavalieri ad abitare nella casa dirimpetto alla casa senatoria, dove oggi sta collocata l’officina della Posta, affine di essere a portata di occorrere al sollievo di quel magistrato, come si fa palese dalla iscrizione posta [220] allora sulla porta di quell’abitazione, che vien riferita dal Baronio: D. N. PHILIPPO III. HISP., ET SIC. REGE MAX. POTENTISS. EX AUCTORITATE D. FRANCISCI DE CASTRO COMITIS CASTRI PROREGIS NOBILISSIMI. EQUITUM. CONGREGATIONI,. QUAE. FLOS. EST,. ET ROBUR. PANORMI,. UT. SENATUI. VICINA,. ET. OMNIBUS. PACIS. BELLIQUE. TEMPORIBUS. PRESTO. SIT. DOMUM. EXTRUXERUNT. D. ALVARUS DE RIBADENERIA PRAETOR. POMPILIUS PLAYA BARO VATICANI. D. VINCENTIUS LA ROSA. D. JACOBUS LUCCHISI BARO CAMASTRAE. D. VINCENTIUS LANDOLINA. D. GASPAR BELLACERA BARO PEDAGOGI. D. FRANCISCUS LANZA BARO FICARRAE SENATORES M. DC. XX. Si applicò ancora questo vicerè a compiere le fortificazioni della Sicilia, e a nobilitare le due città sorelle Palermo, e Messina. Nella prima fe tagliare la nobile strada, che la divide da capo a fondo, che chiamasi volgarmente Cassaro con voce saracenica, ma nelle scritture vien detta la strada Toledo 1004, per la quale il senato dovette erogare ingenti somme di denaro, che servirono a comprar case, e a diruparle per rendere questa strada larga, e diritta 1005. Progettò anche per difendere le navi da’ venti, che si facesse un magnifico porto, che si cominciò a fabbricare pochi giorni dopo ch’ei si era partito. In Messina ancora vi fe edificare l’arsenale per collocarvi le galee 1006. S’egli fosse dimorato più tempo e più costantemente in Sicilia, maggiori opere avrebbe certamente imprese, e forse si sarebbe la giustizia, di cui mostrossi assai zelante, meglio amministrata; ma le molte commissioni, ch’ei ebbe nel suo viceregnato, per le quali gli fu d’uopo di starsene lontano, furono la cagione, per cui gli affari non andassero con quel buon ordine, ch’ei avrebbe desiderato. Malgrado però lo elogio, che noi facciamo di questo vicerè, se si ascoltano alcuni scrittori, eglino ne fanno un nero ritratto. Il Bosio 1007, ed altri lo accusano d’infingardaggine nel trascurare che fece di soccorrere l’afflitta isola di Malta: taccia, che si è da noi abbastanza di sopra dileguata. I Messinesi lo incolpano di una certa avidità di trar denari dappertutto, per poi spenderli a suo capriccio; di troppa superbia 1003 Baronio de Majestate Pan. lib. I. pag. 155. Si avverta, che questa strada allora non si stendea, come al presente, sino alla marina, ma arrivava solo fino al luogo, ove oggi sono le pubbliche carceri dette della Vicaria. Fu poi prolungata fino al lido del mare dal vicerè Marco Antonio Colonna, come si dirà in appresso. 1005 Per risarcire il senato de’ tesori, che avea profuso in questa occasione, gli fu accordato il così detto privilegio delle strade Toledo, e Macqueda, con cui restano assodate tutte le compre, che si fanno con questo privilegio, che si paga, nè possono i compratori mai più essere molestati per qualunque causa. 1006 Bonfiglio, Messina città nobilissima, lib. V, p. 35. 1007 All’anno 1565. 1004 - 173 - nel trattare coloro, a’ quali comandava, e di uno eccessivo rigore nel gastigare, e massimamente nello avere fatto strozzare notar Cataldo Tarsini dietro di avere ottenuto dal re il perdono; il che è falso 1008. Il Bonfiglio racconta ancora che molti lo condannavano, perchè avea lentamente inseguito l’armata turca, quando fuggiva da Malta, senza darle battaglia, e vincerla, come gli sarebbe stato agevole; e perchè avea involati trecento mila scudi di oro, che il re Filippo II mandato avea per bisogni della guerra. Ma ad uno scrittore messinese del calibro del Bonfiglio, ch’era irritato contro il Toledo, il quale avea fatto ogni studio per nobilitare la capitale, daremo noi fede in un racconto cotanto obbrobrioso a quell’onesto cavaliere, e che non è riferito da veruno degli storici contemporanei? Dopo di aver egli servito nel politico, e nel militare il suo sovrano, si ritirò a Napoli a menare una vita privata nel suo palagio di Chiaja 1009, dove morì al primo di [221] maggio 1577. Noi torneremo a mentovare questo vicerè, quando parlar dovremo della magnifica fontana pretoriana, ch’ei vendè l’anno 1574 al Senato di Palermo. Nell’anno 1567, in cui partì il Toledo, scrivono nella maggior parte i nostri storici, che fu in Sicilia una orribile scossa di terra, e che il Mongibello ne fu la cagione, il quale vomitò così ardenti fiamme, sassi, e cenere, che apportò danni immensi da quella parte, che guarda la città di Randazzo, e ne devastò in modo le campagne d’intorno, che inabilitò in avvenire i coloni a coltivare le terre. Così Giacomo Longo, che continuò la storia del Maurolico 1010, il Bonfiglio 1011, l’Aprile 1012, per intralasciarne tanti altri. Il Mongitore nella sua Storia Cronologica de’ Terremoti è di accordo cogli scrittori da noi accennati, quantunque voglia 1013 che questo flagello sia accaduto l’anno antecedente 1566. Il P. Abate Amico, che non cita de’ mentovati autori che il solo Longo, niega il fatto, e sostiene non esservi veruno monumento, che lo comprovi 1014. Discorda ancora dal Mongitore, e fa vedere dalle memorie di tutte l’eruzioni del Mongibello dall’anno 1536 fin all’anno 1604, che non ven’ebbe alcuna nè nell’anno 1566, nè nel seguente 1567. Se si dovesse giudicare di questo fatto dal numero degli autori, che ne scrissero, come suole la volgar gente opinare, il P. Abate Amico si avrebbe tutto il torto; ma fa gran peso a noi egli solo, che fu diligentissimo nel raccogliere i monumenti, che servivano agli annali della sua patria, ed ebbe per le mani gli archivî di quella città, alla di cui testimonianza aggiungiamo il silenzio del Massa, e del Carrera, che non ne fanno alcun motto. Il principe di Castelvetrano la di cui elezione fu nell’anno seguente 1568 confermata dal re Filippo II 1015, governò lodevolmente il regno nel tempo, che ne fu incaricato. Noi abbiamo di questo cavaliere una famosa prammatica nel primo suo governo, con cui regolò l’eccessive spese nel lutto, e prescrivendo in primo luogo quali persone potessero vestirsi a bruno, ordinò che non si potesse portare bruno più di un mese, vietò i parati neri nelle camere, proibì i così detti repiti, ossia i lamenti, che certe donne prezzolate faceano innanzi il cadavere del defunto, limitò il numero dei torchi a dodici, ciascheduno dei quali non dovea passare il peso di due rotoli, eccettuato se fosse stato il morto uno dei marchesi, o conti, o il loro primogenito: nel qual caso ne accordò ventiquattro, e diede altre provvidenze necessarie ad impedire le spese 1016. Questa prammatica fu promulgata dopo per l’istanza fatta dai deputati del regno nel parlamento celebratosi dal Toledo l’anno 1567, quantunque poi siesi coll’andare dei tempi messa in disuso, e sia stato perciò costretto il governo, come si dirà, a rinnovarla con alcune limitazioni giusta i costumi, le circostanze, e le usanze dei secoli. Mentre questo cavaliere ci reggea colla carica di presidente del regno, e precisamente nei primi giorni del suo governo, si cominciò la fabbrica del molo di Palermo, promossa dal Toledo, ma non potuta eseguirsi, mentre egli era in Sicilia, per i grandi preparamenti, che far si doveano, e per cercarsi il denaro necessario, la cui somma non era indifferente. In verità sembrava una cosa sconcia, che la capitale, dove molto si trafficava, restasse priva di un comodo porto per la sicurezza delle navi, che vi approdavano. Questo progetto molto utile fatto dal Garzìa si cominciò ad eseguire ai 29 di luglio 1567, quando il principe di Castelvetrano 1008 Maurolico, ossia Longo, Chron. Sic., p. 253. – Bonfiglio, Hist. Sic., part. II, lib. VIII, pag. 567. Il Vertot (Histoire de Malte, tom. V, lib. XIII, pag. 102) raccontando la lentezza, con cui questo vicerè avea sempre indugiato ad apportare i soccorsi a Malta, quando l’anno 1565 Solimano assediavala, ed essendo d’accordo, ch’ei così operava per le segrete istruzioni, che avea dal re Filippo II, ci narra, che questo monarca per allontanare da sè ogni sospetto, condannò altamente la condotta del Toledo, e che per mostrare di non avervi avuta parte veruna lo rimosse dopo qualche tempo dal viceregnato di Sicilia; e quantunque ne avesse ricevuti considerabili servigii, lo lasciò invecchiare a Napoli in una vita oscura, e senza dargli alcuna parte nel governo. Lo stesso dice il Bosio (all’anno 1565). Chi sa la nota simulazione di Filippo II, che non facea giammai penetrare i sensi interni del suo animo, può agevolmente persuadersi, che ei vietò al Toledo di soccorrere l’isola di Malta, e insieme per nascondere al mondo questo suo comando, lo sagrificò, lasciandolo in una vita oscura, quasichè ei di suo capriccio avesse abbandonato gli afflitti Maltesi, e avesse disubbidito ai suoi sovrani ordini. 1010 In Chron. apud Maurol. pag. 253. 1011 Hist. Sic. p. II, lib. VII pag. 567. 1012 Cronol. della Sic. lib. II, cap. VI pag. 300. 1013 Sic. Ricercata t. II, pag. 395. 1014 Catana Illustrata lib. VIII, cap. I, t. I, § VIII, pag. 414. 1015 Reg. della Regia Cancellaria dell’anno 1568.1569 XI lndiz. fogl. 17. 1016 Pragm. Regni Sic. t. I, tit. LXIV. 1009 - 174 - buttò la prima pietra, che servisse alle fondamenta del nuovo Molo, che per ripararlo dall’empito dei venti fu piantato sotto il monte Ercta detto da noi monte Pellegrino, come al presente esiste. Questa funzione fu fatta colla possibile sollennità, essendovi intervenuti la nobiltà, i magistrati, e il clero così secolare, che regolare, previe le preci prescritte dalla chiesa per ottenere da Dio le celesti benedizioni sopra un’opera così difficile, e dispendiosa. Arrivò nel tempo della presidenza di questo cavaliere il cardinale Alessandro Farnese [222] nipote del fu Paolo III pontefice, che l’imperadore Carlo V avea nominato fin dall’anno 1536 arcivescovo di Morreale. Volle egli visitare la sua chiesa, che non avea giammai vista, e celebrarvi un sinodo diocesano, come fece. Giunse egli in Palermo, dove fu accolto colle migliori dimostrazioni di onore, e fece la pubblica entrata a cavallo accompagnato dal presidente del regno suddetto, dallo arcivescovo, e dal pretore Ottavio del Bosco 1017 . Avea egli seco condotto, o, come altri vogliono, avea fatto precedere il celebre Onofrio Panvinio dell’ordine di S. Agostino, il quale ammalatosi nel convento del suo ordine, se ne morì ai 7 di aprile 1568. La memoria di questo illustre letterato volle lo storiografo di Napoli Francesco Daniele l’anno 1782, essendo in Palermo, perpetuare con una lapide, che fece ergere a sue spese presso l’altare maggiore della chiesa di S. Agostino, dove debbono essere le ossa del medesimo, essendo il luogo della comune sepoltura di tutti i religiosi. CAPO VIII. Francesco Ferdinando Avalos de Aquino marchese di Pescara vicerè. Il conte Giuseppe Francesco Landriano presidente del regno, e di poi Carlo di Aragona principe di Castelvetrano. Essendosi risoluto il re Filippo II di dare alla Sicilia un nuovo vicerè, elesse a questo ragguardevole posto Francesco Avalos de Aquino marchese di Pescara. Gliene fu spedito il dispaccio in Madrid agli 11 di aprile 1568 1018, sebbene egli non sia poi arrivato in Palermo, che ai 24 del mese di agosto dell’anno istesso; nel qual giorno fece la pubblica entrata a cavallo, e previo il solito giuramento nella cattedrale, prese il possesso della nuova carica 1019. Nel dì seguente di poi entrò anche pubblicamente in città la signora Isabella moglie del medesimo, corteggiata dalle dame e dalla nobiltà 1020. Volle il nuovo vicerè prima di ogni altra cosa celebrare l’esequie al principe Carlo il primogenito del re Filippo II, che poco prima era morto 1021. Fu questa lugubre funzione fatta nella cattedrale, che si trovò vestita tutta a lutto, dove intervennero col vicerè, che vi tenne la cappella reale, tutti i magistrati ingramagliati, e parimente la nobiltà in abito di lutto, e fu allora osservato con sorpresa che il P. Carminata Gesuita, che recitò l’orazione funerale, non comparve sul pergamo colla solita veste di sua religione, come costumano i regolari, ma avea egli del pari un simile abito di lutto, che il senato di Palermo a proprie spese gli preparò 1022. Entrando l’anno 1569 accaddero in Sicilia per conto della corte di Roma alcuni sconcerti, che tennero occupato l’animo del marchese di Pescara. Pio V romano pontefice promulgando secondo il consueto la bolla in Coena Domini, vi aggiunse una novità, che costernò le potenze cristiane; giacchè vietò [223] ai principi sotto la pena di scomunica di potere imporre nuovi dazî, e gabelle ai loro sudditi 1023, ed ordinò ai 1017 Così leggesi nel manoscritto di Gio: Battista la Rosa, il quale ci avverte ancora, che era allora arcivescovo di Palermo Ottavio Preconio. Quindi deve correggersi l’errore del Pirri (Sic. Sac. Not. in Eccl. Monregalensis pag. 433), e dell’abate D. Michiele del Giudice (tempio di Morreale; Vite degli arcivescovi pag. 73), i quali fissano la venuta di esso Cardinale nell’anno 1569, imperocchè in detto anno nè il principe di Castelvetrano era più presidente del regno, nè il Preconio più vivea, che secondo il Pirri (ib. not. 1 Eccl. Panorm. p. 182) morì ai 18 di luglio 1568, in cui perciò dee fissarsi l’arrivo di questo porporato. 1018 Reg. del protonotaro dell’anno 1567.1568 XI indiz. f. 278. 1019 Nello stesso registro. 1020 Paruta Mss. della libreria del senato p. 9. 1021 Il tragico fine di questo principe, unico allora rampollo di Filippo II, e nella età di 23 anni, fe inarcare le ciglia all’Europa tutta; nè mai se ne penetrò il vero motivo. Una notte improvisamente il monarca di Spagna accompagnato da guardie entrò nella camera di Carlo, che stava riposando, e tratte le carte, ch’erano nel di lui gabinetto, e quanto potea nuocergli, e fattegli inchiodare le finestre, lo lasciò in potere delle guardie, alle quali ordinò che osservassero tutti i di lui movimenti, e le di lui parole. In capo a qualche giorno lo fe racchiudere in una torre, e ne avvisò tutti i principi europei, non adducendo allora altra causa di questo eccessivo rigore, se non il servigio di Dio, e la serenità di sua coscienza. Volendo i politici ripescarne la vera cagione, non la indovinarono. Chi disse che il re Cattolico si fosse mosso da gelosia per l’affetto, che mostrava la regina sua madrigna per questo principe: chi perchè mormorava della condotta del padre, e dei di lui ministri: chi perchè proteggeva occultamente la ribellione degli Olandesi, e la eresia, che presso loro si era introdotta: chi perchè avea tentato di fuggirsene in Italia, dove avea delle aderenze. Morì questo infante ai 24 di luglio di violenta morte, e fu seguito ai 3 dello stesso anno dalla regina Elisabetta sua madrigna, che fu rapita da un morbo del pari violento. 1022 Paruta Mss. della libreria del senato pag. 10. 1023 Il Giannone (Istoria civile del regno di Napoli T. V. lib. XXXIII cap. IV, pag. 54) parla diffusamente di questo affare; ma s’inganna nel credere che questa Bolla fosse stata la prima volta promulgata da questo Pontefice. La Bolla in coena Domini fu assai più antica; e Pio altro non fece che accrescerne gli articoli. Questa costituzione cotanto perniciosa ai diritti dei sovrani non si legge più in Roma. La santa memoria di Clemente XIV conoscendone l’incoerenza, e l’esorbitanza, abolì col solito suo zelo, e prudenza l’uso di promulgarla; nel che è stato seguito dal regnante del pari saggio pontefice Pio VI. - 175 - parochi, che la leggessero nelle loro chiese nel giovedì santo ai popoli, e ne affiggessero gli esemplari alle porte delle medesime, e nei confessionali. Il marchese di Pescara nel nostro regno non volle accordare il viceregio beneplacito alla detta promulgazione, ma nondimeno i vescovi ubbidendo al Papa la fecero pubblicare, ed affigere. Ne scrisse perciò questo vicerè al monarca per sentire i sovrani suoi oracoli 1024. Un altro passo ugualmente pregiudizievole alla monarchia di Sicilia diede il riferito pontefice. Mandò egli nel regno monsignor Paolo Odescalco 1025 col titolo di Nunzio apostolico, e colla facoltà di regolare il regno negli affari ecclesiastici a nome della santa sede; il che era contro i patti convenuti fra il conte Ruggiero, ed Urbano II. E siccome il vicerè vietò che se gli ubbidisse, i frati, che allora erano soggetti a’ loro generali, ebbero da’ medesimi ordine che non assolvessero coloro, che ricusassero di accettare la bolla, o di ubbidire al Nunzio apostolico. Questa cosa apportava nel Regno la costernazione; giacchè gli abitanti o incorrevano lo sdegno del sovrano, se ubbidivano al papa, o erano privi dell’assoluzione, e della comunione ne’ sacramenti, se non vi aderivano. Il re Filippo per mezzo del suo ambasciadore, che risedea in Roma, fe alte lagnanze al santo Padre. In altri tempi forse questo monarca avrebbe dati esempli memorabili della sua indignazione, ma in quelle circostanze ognuno de’ potentati cattolici, come osserva il Muratori 1026, avea bisogno delle rugiade di Roma. Filippo in particolare sperava molto dal pontefice e per la rivoluzione de’ Mori, e per la ribellione de’ Paesi Bassi; e perciò l’affare terminò in semplici lagnanze. Ma un altro grande affare tenea agitato l’animo del vicerè. Ulucchiali famoso corsaro, ch’era stato il successore di Dragutte nel governo di Algeri, mal soffriva che il re di Tunisi Muley Amida fosse amico degli Spagnuoli, e tollerasse ch’eglino tuttavia possedessero la Goletta; e perciò piombando improvisamente sul di lui regno, ne lo spogliò 1027. Era governatore della Goletta un certo di Pimentel, il quale non trascurò di avvisarne tosto il marchese di Pescara, e questi temendo a ragione che quel corsaro, conquistato Tunisi, non tentasse di ricuperare la Goletta, fe subito partire Giovanni de Cardenas castellano di Palermo con una squadra di ventiquattro galee, tra le quali ve n’erano alcune napolitane, ed altre maltesi, sulle quali fe imbarcare un buon nerbo di truppe di fanterìa italiana, e spagnuola, e vi unì una gran quantità di barche da carico, sulle quali fe mettere le provvigioni da bocca, e da guerra per la difesa di quella importante piazza. Fratanto, siccome si era sparsa la fama, che in Costantinopoli si preparava una flotta per sostenere l’Ulucchiali nella impresa della Goletta, volle rinforzarla, spedendovi indi a poco un soccorso di altri due mila [224] uomini. Ma poi si seppe, che l’oggetto del gran Signore era l’acquisto del regno di Cipro posseduto da’ Veneziani 1028. Nel seguente anno convocò il marchese di Pescara il generale parlamento in Palermo nel mese di marzo, in cui rappresentò le varie occasioni, che doveano animare il regno ad offerire degli straordinarî donativi; 1024 Noi non ci occuperemo a far rilevare gli enormi pregiudizj, che colla bolla in coena Domini si arrecavano ai regj diritti, palesati dal vicerè Avalos alla corte di Madrid, per diverse cagioni. E prima perchè queste tali piaghe, che la bolla fa alle regalie, sono esattamente riferite da Pietro Giannone (Istor. civ. del regno di Napoli t. V, lib. XXXIII cap. 4, pag. 59): in secondo luogo, perchè questa tale bolla non più si pubblica, nè si affigge nel nostro regno, dopo che il nostro real sovrano Ferdinando III con suo regio dispaccio comunicato ai 5 di giugno dell’anno 1768 lo proibì, come diremo al libro IV di questa storia al capo XIX, e finalmente per la ragione addotta nell’antecedente nota. In questo secolo, in cui domina la filosofia, e la ragione i pregiudizj hanno perduta quella forza, che prima aveano si sono riconosciuti i limiti del sacerdozio, e dello impero; e la corte istessa di Roma sotto principi così moderati, e pieni di buon senso ha declinato dalle pretensioni irragionevoli, che per avanti avea. 1025 Muratori Annal. d’Ital. all’an. 1569, tom. X, pag. 407. 1026 Annali d’Italia all’anno 1569 t. X, pag. 407. 1027 Muley Amida ebbe la sorte di salvarsi con due suoi figliuoli, e venne a starsene in Palermo, dove era l’anno 1570. Imperocchè nel più volte riferito giornale del Paruta (pag. 10) noi leggiamo, che prendendo possesso della carica di pretore ai 22 di ottobre di quest’anno Fabio Bologna, vi furono tre giorni di feste in città, e che nell’ultimo giorno, cioè ai 24 di esso mese, fu veduta una cavalcata di settanta cavalieri vestiti di armi bianche con altri uffiziali, fra i quali vengono mentovati i due figliuoli di Muley Amida re di Tunisi. 1028 Questo regno famoso per la sua fertilità, e per l’amenità dell’aria, dove i poeti finsero che fosse nata la dea degli amori, era venuto in potere dei Veneziani per cessione fattane alla repubblica da una regina di famiglia Cornaro, ch’era stata moglie di Giacomo ultimo re di Cipro, il quale era morto senza lasciare posterità, e ne avea fatta erede la sua sposa. Lo amministrò questa repubblica per lo spazio di circa ottanta anni per mezzo dei suoi governatori. Ma la lontananza dal principe, ch’è sempre pregiudizievole agli stati, rendea costoro arbitri; e perciò la giustizia non era amministrata, e le cariche non erano distribuite ai meritevoli. Nacque quindi il malcontentamento, e la sedizione per scuotere l’odiato giogo. La repubblica avvisata dal suo bailo di Costantinopoli degli sconcerti, ch’erano in quel regno, cercò subito di sopirli con prudenza, e senza strepito, gastigando i colpevoli, ed allontanando quei potenti, che angariavano i popoli. Ma non stabilì, come era dovere, un nuovo stato di cose, per cui si tornò negli sconcerti di prima. I villani, che si vedeano maltrattati dai ricchi, ricorsero a Selimo per essere sottratti dalla tirannia, sotto della quale gemeano, e questo gran sultano, che soffriva di mal cuore la tregua accordata da Solimano ai Veneziani, si avvalse di questa congiuntura per dichiarare loro la guerra, di cui favelliamo. Concorsero a sostenere i Veneziani il re Cattolico, e il Papa; ma nata la controversia intorno alla persona, cui si dovesse dare il comando di tutta l’armata, pretendendolo del pari il Doria ammiraglio del re Filippo, Colonna il generale del Papa, e Zeno generale dei Veneziani, e discutendosi questo punto nei gabinetti dei rispettivi principi, accadde ciò, ch’era avvenuto in Roma nei tempi della repubblica: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. Il regno di Cipro venne quasi tutto in potere dei Turchi, che con una flotta di trecento vele sbarcarono nella isola, posero l’assedio a Nicosìa, che n’era la capitale, e la presero di assalto, intanto che in Candia, dove trovavasi la flotta combinata delle potenze cristiane, si aspettava la risoluzione dei gabinetti intorno alla preferenza dei generali. Quante belle imprese svaniscono per l’etichette, e le lungherie dei potentati! - 176 - cioè il maritaggio del re colla serenissima principessa Anna Maria, ch’era figliuola dell’imperadore Massimiliano II; le spese, che facea in Ispagna; la guerra, che sostenea nelle Fiandre; e gli apparecchi, che si faceano in Barbarìa colla potente armata navale, che si stava preparando in Costantinopoli 1029. Pur nondimeno soggiunse, che il re non volendo aggravare i suoi popoli, massime nella scarsezza de’ grani, che vi era allora nel regno, si contentava de’ soli ordinarî donativi 1030. Ringraziarono i parlamentarî la clemenza del re, che si era benignata di non esigere un sussidio straordinario, ed offerirono di buon grado i soliti trecentomila fiorini, prorogando per altri tre anni i donativi di 100 mila fiorini per le fortificazioni, di quarantotto mila per i ponti, e di venti mila per le fabbriche dei reali palagi, assegnarono inoltre tredici mila fiorini per la numerazione delle anime del regno, ed offerirono i consueti cinque mila fiorini al vicerè, cui fecero l’atto solito, con cui egli, e il di lui figliuolo erano abilitati ai benefizi, come regnicoli. Questo è il primo parlamento, in cui si fe’ per la prima volta un dono ancora al cameriere del vicerè nella somma di ducento scudi, che oggi è accresciuto a cinque cento, sebbene sia egli nell’obbligo di fare apparare, ed illuminare la sala del regio palagio, in cui si fa l’apertura del parlamento; e di più once 60 ai regî uffiziali. Non tardò ad essere il marchese di Pescara, malgrado le proteste fatte, costretto a convocare un parlamento straordinario. Lo sponsalizio già eseguito dal re colla figliuola dell’imperadore, l’obbligò a chiamarlo nella stessa città ai 25 di dicembre del medesimo anno: e nell’apertura persuase i parlamentarî, perchè, per dar prove al sovrano della loro gioja per il prospero, e felice matrimonio del medesimo, gli facessero un donativo straordinario. Piacque ai tre ordini, che si presentasse loro una così fausta occasione da mostrare il loro animo verso sua maestà, e furono di accordo di esibire al medesimo un donativo di cento venticinque mila scudi 1031. In questo parlamento, per togliere gl’inconvenienti, e le spese, che si faceano nello esigere i donativi, e le tande, fu stabilito, che si creassero tre così detti Percettori, uno per ciascheduna valle, i quali ne fossero [225] incaricati, e furono assegnati tre mila, e seicento scudi per anno per loro salario, cioè mille e duecento per ciascheduno. In questa istessa adunanza parlamentaria fu eletto per ambasciadore a nome dei tre bracci dello stato Carlo Avalos de Aquino fratello del vicerè, cui prima fu fatto l’atto, con cui era dichiarato regnicolo, ad oggetto di rallegrarsi a nome della nazione del felice maritaggio di sua maestà, ed offerirgli il donativo, che si era convenuto di esibire in questa occasione, e perchè questo cavaliere si potesse equipaggiare gli furono assegnati otto mila scudi 1032. Intorno a questo tempo il pontefice Pio V, spedendo a Madrid il cardinale Alessandrino, per congratularsi col re Cattolico per lo sponsalizio suddetto, si dolse col medesimo degli abusi esorbitanti, che si erano introdotti nella monarchia di Sicilia, e chiese a Filippo che vi si mettesse modo. Questo monarca, che siccome non volea perdere i reali suoi diritti, così volea risecare tutti gl’inconvenienti che accadeano, scrisse al vicerè marchese di Pescara, ordinandogli che facesse stendere dai ministri una carta, in cui si indicassero la maniera, colla quale si regolava il tribunale della regia monarchia, e gli abusi di esso, acciò confrontandolo colla memoria, che lo stesso porporato gli avea esibita, potesse ovviare ai disordini. Così eseguì il ridetto vicerè; ma le provvidenze date dal sovrano non arrivarono in Sicilia che dopo la di lui morte, come or ora in questo istesso capo diremo 1033. Non sopravisse molto tempo all’accennato parlamento questo vicerè; nel mese di marzo dell’anno seguente 1571 si ammalò egli nella stessa capitale, e crescendo la violenza del morbo, furono fatte ai 2 di aprile pubbliche preci all’Altissimo, per ottenere a così amabile cavaliere la sanità, e furono perfino esposte a questo oggetto le reliquie di santa Cristina, nel di cui patrocinio molto confidavano i Palermitani. Parve nondimeno che il cielo fosse sordo per allora ai desiderî di questi cittadini; laonde fu d’uopo di munirlo dei sagramenti nel dì 12 di aprile 1034. Nel giorno antecedente a questo, cioè agli 11, non volendo egli lasciare il regno senza un capo, scelse per presidente del regno Giuseppe Francesco Landriano milanese, che era allora stratigoto di Messina, fino che si fosse ristabilito, o che, se mai soccombea, il re avesse altrimente 1029 Non ancor sapeasi che il suo destino era per il regno di Cipro; e stava ancor preparandosi la poderosa flotta di 49, o 52 galee ordinata dal medesimo monarca al suo ammiraglio Doria, la quale comparve poi in Messina ai 13 del seguente agosto, e di là passò in Candia per unirsi all’armata veneziana, e alle galee pontifizie per occorrere in ajuto di quel regno. 1030 Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 350. 1031 Mongit. ivi, pag. 355 e seg. 1032 Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 360. 1033 Dovea passare qualche tempo prima che i ministri in Palermo stendessero la scrittura, in cui esaminati prima da una parte gl’inconvenienti esagerati dalla corte di Roma, e dall’altra i diritti regj, che restar doveano illesi, si dasse la maniera, colla quale dovesse in avvenire regolarsi il tribunale della monarchia, e prima che questa carta fosse considerata alla corte di Madrid, e fossero ivi stabiliti i provvedimenti, con cui salve le regalie se ne correggessero gli abusi. Ecco perchè non è verisimile, che siesi fatto così presto un concordato fra Filippo II, e il cardinale Alessandrino, che gli scrittori siciliani chiamano: Concordia Alessandrina, e credono stipulata in questo istesso anno 1570, come lasciò registrato il Pirri (Not. Sicil. Eccl. Not. VII, Ecclesiae Troinensis pag. 357), e dietro a questi il Dupino (Defence de la Monarchie de Sicile cap. XI, pag. 154). La così per errore chiamata Concordia Alessandrina non è che una lettera scritta dal re Cattolico da Madrid a’ 28 di dicembre 1571 al duca di Terranova presidente nel regno di Sicilia, della quale fra poco daremo conto. 1034 Paruta, Giornale Ms. nella libreria del senato di Palermo, p. 10. - 177 - determinato 1035. Nel dì di appresso, da che gli furono somministrati gli ultimi sagramenti, si sparse voce che ei fosse morto; ma fu una falsa dicerìa; avvegnachè per allora scampò dalle fauci della morte, e ne furono perciò rese grazie a Dio. Forse sarebbesi interamente guarito, se egli fosse stato più sobrio durante la convalescenza; ma siccome non seppe astenersi da certi piaceri, che erano pregiudizievoli alla di lui sanità, ricadde nel mese di giugno nella stessa infermità, e l’ultimo dì del seguente luglio se ne morì, senza che le preghiere ai santi, e le loro reliquie gli avessero punto giovato 1036. Era il marchese di Pescara nel fiore della sua età, quando fu rapito dalla morte; imperocchè non avea neppur compito l’anno quarantesimo. Fu di alta, e proporzionata statura, e bellissimo di volto, in guisa che e per la sua avvenenza, e per la fresca età, e per i piacevoli suoi costumi era divenuto l’oggetto idolatrato dalle dame del secolo. Mostrossi egli compiacente colle medesime, ed amò sopratutto una donzella nobile, ed insieme povera, con cui consumando di giorno in giorno le sue forze nelle lotte di Venere, dovette alla fine soccombere. [226] Intorno a questo cavaliere non sono uniformi i giudizî degli storici. Comunemente fu compianta la di lui morte; giacchè le maniere dolci colle quali trattava, la protezione che accordava alle scienze, ed ai letterati 1037, le premure che si diede per accrescere le fortificazioni e in Palermo, e
Scarica