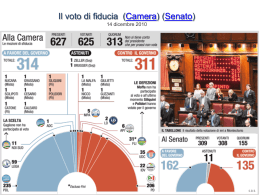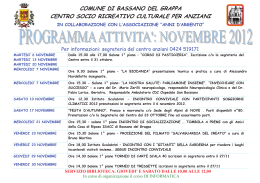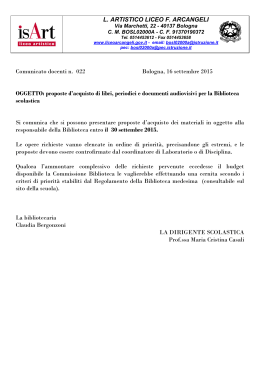la Biblioteca di via Senato mensile, anno iv Milano n.9 – ottobre 2012 UTOPIA L’occulta magia di Cornelio Agrippa di gianluca montinaro FONDO ANTICO Il console inglese amico di Canaletto di annette popel pozzo NOVECENTO Vittorini-Guttuso oltre i confini della realtà di laura mariani conti e matteo noja OTTOCENTO La rosa di Barbèra infiamma l’800 di beatrice porchera FONDO IMPRESA I sogni si avverano a Cinecittà di giacomo corvaglia la Biblioteca di via Senato - Milano MENSILE DI BIBLIOFILIA – ANNO IV – N.9/35 – MILANO, OTTOBRE 2012 Sommario 4 L’Utopia: prìncipi e princìpi L’OCCULTA MAGIA DI CORNELIO AGRIPPA di Gianluca Montinaro 11 BvS: il Fondo Antico JOSEPH SMITH, CONSOLE INGLESE A VENEZIA di Annette Popel Pozzo 18 BvS: il Fondo De Micheli VITTORINI, GUTTUSO E IL PROBLEMA DEL REALISMO di Laura Mariani Conti e Matteo Noja 29 IN SEDICESIMO - Le rubriche ITALIA GASTRONOMICA – SPIGOLATURE – CATALOGHI ANTICHI E MODERNI – RECENSIONI – MOSTRE – ASTE E FIERE 46 BvS: Fondo Edizioni di pregio “SMENS PAGINE & FIGURE” DI UNA RIVISTA ARTIGIANALE di Arianna Calò 51 BvS: l’Ottocento GASPERO BARBÈRA (1818-1880): UN EDITORE RISORGIMENTALE di Beatrice Porchera 55 BvS: Emeroteca IL DON PIRLONE GIORNALE DI CARICATURE POLITICHE di Valentina Conti 60 BvS: il Fondo di Fantascienza CAPITAN SALGARI AL TIMONE DI UN PERIODICO GENOVESE di Paola Maria Farina 65 BvS: il Fondo Impresa CINECITTÀ: LA FABBRICA DEI SOGNI COMPIE 75 ANNI di Giacomo Corvaglia 69 BvS: nuove schede RECENTI ACQUISIZIONI DELLA BIBLIOTECA DI VIA SENATO 72 BvS: il ristoro del buon lettore GLI INCANTESIMI DI LORENZO Consiglio di amministrazione della Fondazione Biblioteca di via Senato Marcello Dell’Utri (presidente) Giuliano Adreani, Carlo Carena, Fedele Confalonieri, Maurizio Costa, Ennio Doris, Fabio Pierotti Cei, Fulvio Pravadelli, Miranda Ratti, Carlo Tognoli Segretario Generale Angelo De Tomasi Collegio dei Revisori dei conti Achille Frattini (presidente) Gianfranco Polerani, Francesco Antonio Giampaolo Fondazione Biblioteca di via Senato Elena Bellini segreteria mostre Arianna Calò sala Campanella Valentina Conti studio bibliografico Sonia Corain segreteria teatro Giacomo Corvaglia sala consultazione Margherita Dell’Utri sala consultazione Paola Maria Farina studio bibliografico Claudio Ferri direttore Laura Mariani Conti archivio Malaparte Matteo Noja responsabile dell’archivio e del fondo moderno Donatella Oggioni responsabile teatro e ufficio stampa Annette Popel Pozzo responsabile del fondo antico Gaudio Saracino servizi generali Stampato in Italia © 2012 – Biblioteca di via Senato Edizioni – Tutti i diritti riservati Direttore responsabile Matteo Noja Progetto grafico e impaginazione Elena Buffa Coordinamento pubblicità Margherita Savarese Fotolito e stampa Galli Thierry, Milano Direzione e redazione Via Senato, 14 – 20121 Milano Tel. 02 76215318 Fax 02 782387 [email protected] www.bibliotecadiviasenato.it Bollettino mensile della Biblioteca di via Senato Milano distribuito gratuitamente L’editore si dichiara disponibile a regolare eventuali diritti per immagini o testi di cui non sia stato possibile reperire la fonte Immagine in copertina: Disegno di Federico Fellini per La Dolce Vita, Marcello Mastroianni Organizzazione Mostra del Libro Antico e del Salone del Libro Usato Ines Lattuada Margherita Savarese Ufficio Stampa Ex Libris Comunicazione Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana Reg. Trib. di Milano n. 104 del 11/03/2009 Ottobre Un tempo, era d’estate, era a quel fuoco, a quegli ardori, che si destava la mia fantasia. Inclino adesso all’autunno dal colore che inebria, amo la stanca stagione che ha già vendemmiato. Niente più mi somiglia, nulla più mi consola, di quest’aria che odora di mosto e di vino, di questo vecchio sole ottobrino che splende sulle vigne saccheggiate. da: Vincenzo Cardarelli, Poesie, Edizioni di Novissima, Roma 1936 ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 5 L’Utopia: prìncipi e princìpi L’OCCULTA MAGIA DI CORNELIO AGRIPPA Un testo “maledetto” nella Biblioteca di via Senato GIANLUCA MONTINARO L a Biblioteca di via Senato, nelle sue sale, conserva molti libri preziosi. Molti libri rari. Molti libri introvabili. Ma conserva anche libri “maledetti”, giudicati pericolosi nei secoli passati, e guardati ancora oggi con un misto di sospetto e timore. Nel Fondo Antico, fra i volumi del Canone dell’Utopia, ve n’è uno con un titolo che suona sinistro: La philosophie occulte, di Cornelio Agrippa di Nettesheim. Un senso di spaesamento coglie chi ne scorre le pagine, sbirciandone le tavole e le illustrazioni. Strani disegni e incomprensibili diagrammi alternano il testo. Formule alchemiche e frasi in lingue sconosciute saltano dai fogli. Ma da essi promana anche una conoscenza arcana, affascinante proprio perché non intellegibile. Sbaglierebbe a giudicare (come molti) colui che, con gli occhi del presente, volesse penetrare queste pagine. Impregnati di scientismo, fatichiamo ad ammettere che possano esistere “modi” differenti per percepire e conoscere. I mondi (animale, vegetale, terreno, ultraterreno…) e gli elementi, benché diversi fra loro, comunicano costantemente, parlando linguaggi metaforici e sincretici che la scienza non è in grado di cogliere. Posto da Dio al centro Nella pagina accanto: frontespizio de La philosophie occulte di Cornelio Agrippa, stampato all’Aja da Alberts nel 1727 Sopra: ritratto dell’autore, tratto dal frontespizio dell’edizione del De occulta philosophia del 1551 dell’esperienza gnoseologica, l’uomo deve quindi sforzarsi di comprendere non solo con la mente ma anche con i sensi. Il codice, sia esso composto da lettere o numeri, non va quindi inteso in senso “euclideo” ma “emozionale”, attraverso le similitudini, le corrispondenze e i rimandi. La philosophie occulte, è un’opera divisa in due tomi, stampati in 8vo. Impressa all’Aja da Rutgert Alberts nel 1727, è la traduzione in lingua francese di un testo originariamente scritto in latino: il De occulta philosophia, la cui prima edizione risale al 1533 (Colonia, senza indicazione dell’editore). Dell’autore, Enrico Cornelio Agrippa (1486-1535), storiografo di Carlo V e medico personale di Luisa di Savoia, si conoscono molti dati biografici. Nato a Colonia, ricevette il soprannome di Agrippa dal padre, che lo aveva derivato dall’antico nome latino della città: Colonia Agrippina. Col tempo Enrico latinizzò poi il proprio cognome in Cornelius e, vantando dubbie origini nobiliari, aggiunse il predicato “von Nettesheim”, dal nome di un villaggio presso Neuss, non lontano da Colonia. Fu il padre a trasmettergli le prime nozioni di astrologia, parallelamente agli studi scolastici che lo portarono a diplomarsi maestro di arti nel 1502. Intorno ai vent’anni andò a Parigi per frequentare la Sorbona. Qui entrò a far parte di un circolo di studenti, fondato da un italiano di nome Landolfo. Questo gruppo si dedicava allo studio delle scienze er- 6 metiche e Cornelio Agrippa, per la sua grande erudizione, vi divenne presto il principale punto di riferimento. Nel 1508, insieme a Landolfo, andò in Spagna, mettendosi al servizio del re Ferdinando: dopo qualche mese, guadagnato per i suoi meriti (così almeno egli diceva) il titolo di cavaliere, s’imbarcò da Valencia per approdare, dopo un viaggio avventuroso, in Francia, stabilendosi ad Avignone. Viaggiò poi fra la Borgogna e i Paesi Bassi, conoscendo Margherita d’Asburgo al quale dedicò il De nobilitate et praeecelentia foeminei sexus (Nobiltà e preminenza del sesso femminile). In questo trattatello Cornelio Agrippa sostenne la superiorità della donna rispetto all’uomo dal momento che già il nome della prima donna, Eva, che significherebbe ‘vita’, è più nobile di quello di Adamo, che vorrebbe dire ‘terra’. E anche l’esser stata creata dopo l’uomo sarebbe motivo di maggior perfezione. In più il corpo femminile galleggierebbe in acqua più facilmente. Infine la donna sarebbe più eloquente e più giudiziosa tanto che «filosofi, matematici e dialettici, nelle loro divinazioni e precognizioni sono spesso inferiori alle donne di campagna e molte volte una semplice vecchietta ne sa più di un medico». la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Nel 1509, fu invitato dall’università di Dole a commentare il De verbo mirifico di Johannes Reuchlin (1455-1522) nel quale l’umanista di Pforzheim univa, secondo gli insegnamenti ricevuti a Firenze, la tradizione cabalistica al neoplatonismo cristiano. L’interesse suscitato dalle lezioni di Cornelio Agrippa giunse alle orecchie del frate francescano Jean Catilenet che, durante la Quaresima del 1510, lo accusò di diffondere eresie giudaizzanti. Cornelio Agrippa lasciò velocemente il continente per l’Inghilterra, ove fu ospitato, a Oxford, da John Colet, un allievo di Marsilio Ficino. Qui scrisse la sua risposta a Catilenet, l’Henrici Cornelii Agrippae expostulatio super expositione sua in libro De verbo mirifico (che vide la stampa solo nel 1529), accusando il frate di non conoscere la scienza ebraica, e di aver mancato di confrontarsi direttamente e «cristianamente» con lui. Iniziò a lavorare sistematicamente al De occulta philosophia, di cui aveva già inviato un abbozzo dei primi capitoli al grande Giovanni Tritemio (1462-1516), abate e uomo di fede ma anche esoterista, crittografo e occultista, unitamente a una lettera nella quale chiedeva perché mai la magia Da sinistra: illustrazioni da La philosophie occulte, le tavole dei pianeti, la proporzione e la misura dei corpi umani ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 7 così altamente stimata dai filosofi antichi, venerata nell’antichità da sapienti e poeti, era divenuta nei primi tempi della religione sospetta e odiosa ai Padri della Chiesa ed era stata ben presto respinta dai teologi, condannata dai sacri canoni e proscritta dalle leggi [ ... ] l’unica causa è stata la depravazione dei tempi e degli uomini, grazie alla quale pseudo-filosofi, maghi indegni di questo nome, poterono introdurre esecrabili superstizioni e riti funesti [ ... ]e infine pubblicare quella quantità di libri che da per tutto circola e che va condannata, indegna del molto rispettabile titolo di magia [ ... ] così, ho ritenuto che sarebbe stata opera lodevole restaurare l’antica magia, la dottrina dei sapienti, dopo averla purgata degli errori di empietà e averla costituita su solide fondamenta. Nel 1511, nel pieno delle guerre che vedevano contrapposti gli Asburgo ai reali di Francia, e che si combattevano in buona parte sul suolo italiano, Cornelio Agrippa raggiunse la Penisola, con un misterioso incarico da parte dell’imperatore Massimiliano. Si fermò a Pavia per proseguire i suoi studi esoterici. Qui, nonostante le numerose assenze dovute a viaggi (non motivati e mai chiariti), si sposò, ebbe un figlio e venne nominato professore. Tenne un corso sul Pimandro, un testo esoterico attribuito a Ermete Trismegisto, scoperto cento anni prima in Macedonia dal domenicano Leonardo da Pistoia e tradotto in latino da Marsilio Ficino nel 1463. La guerra lo spinse a trasferirsi a Casale, sotto la protezione del marchese Guglielmo IX del Monferrato, ove scrisse il Dialogus de homine qui Dei imago est e il De triplice ratione cognoscendi Deum. In questi testi sostenne il valore della Cabala, attraverso la quale si può risalire alla completa conoscenza di tutte le cose, sia naturali che divine. Di nuovo in viaggio, raggiunse la Lorena. Qui fu coinvolto in un caso di stregoneria. Nel paese di Woippy una donna era stata fatta imprigionare con l’accusa di essere una maga. E’ lo stesso Agrippa a narrare la vicenda, in alcune sue lettere. Al principio dell’affare, un branco ignobile di contadini congiurati contro di lei ne invase la casa nel mezzo della notte. Questi depravati ubriachi di vino e di concupiscenza s’impadronirono della sventurata e di loro privata autorità, senza alcun diritto, senza mandato giudiziario, la gettarono nelle segrete di una loro casa. Sopra: illustrazione da La philosophie occulte, Dio e l’uomo Ciononostante i signori del capitolo la fecero condurre a Metz e la consegnarono nelle mani del loro giudice ordinario, l’ufficiale della curia episcopale. Venne stabilito un termine entro cui i contadini motivassero le loro azioni e queste canaglie ebbero l’audacia di denunciarla. In soli due giorni tanto poté prevalere l’iniquità degli inquisitori e della banda di poco di buono che l’ufficiale che l’aveva in custodia la consegnò per alcuni fiorini nelle mani dei suoi accusatori, la denuncia di quattro dei quali era già stata respinta in quanto noti delinquenti. La poveretta fu allora trasferita con l’aggiunta di insulti e bastonate, come si poté provare con testimoni. Così, detenuta in un carcere più che ingiusto, prostrata dalle molte ingiurie, non trascorse 8 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Sopra: illustrazioni da La philosophie occulte, i nomi di Dio, la loro potenza e virtù neppure una notte tranquilla, con gli accusatori liberi di godersela col vino e nell’orgia. Agrippa prese le difese della donna, finendo lui stesso però accusato di eresia. L’improvvisa morte dell’inquisitore (fatto che attirò ulteriori sospetti su Agrippa) e una dichiarazione d’innocenza giurata da parte dell’ufficiale della curia posero fine al processo. La cattiva nomea però lo spinse a rimettersi in viaggio: Colonia, Ginevra, Friburgo… e infine, nel 1524, Lione. Qui risiedeva Francesco I con tutta la corte, e qui Cornelio Agrippa riuscì a di- ventare medico della regina madre, Luisa di Savoia. La donna era ossessionata dall’astrologia (scienza verso la quale Agrippa era invece piuttosto scettico) e ripetutamente chiese oroscopi al suo archiatra. Agrippa si rifiutò, scorgendo seri pericoli nel caso le previsioni non si fossero avverate. Licenziato, raggiunse Anversa nel 1528, ove continuò a esercitare la professione medica. Nel 1529 scoppiò una epidemia di peste, e Agrippa si prodigò nella cura dei malati (diversamente dalla maggior parte degli altri medici che si erano allontanati alle prime avvisaglie del morbo). Finita l’epidemia i dottori fuggiti tornarono e accusarono un certo Jean Thibault di aver esercitato abusivamente la professione. Agrippa lo difese: «Si sono visti questi dottori scappare e abbandonare la popolazione senza curarsi dei giuramenti prestati nelle mani dei magistrati e degli obblighi contratti ricevendo lo stipendio dello Stato, mentre Jean Thibault e alcuni altri si prodigavano coraggiosamente per la salvezza della città. E ora questi medici scolastici, questi dottori sesquipedali, vorrebbero ingarbugliare con i loro sofismi, disputando sulla nostra salute e la nostra vita a forza di sillogismi cornuti». L’anno successivo, ormai in rotta coi colleghi, accettò il prestigioso incarico, offertogli da Margherita d’Asburgo, di consigliere, archivista e storiografo dell’imperatore, trasferendosi a Malines. Munito del privilegio imperiale, al riparo da attacchi e censure, iniziò a dare alle stampe numerose opere, fra cui la Caroli V coronationis historia, il De incertitudine et vanitate scientiarum et artium. Quest’ultimo, che conteneva numerosi attacchi a monaci e teologi scolastici, gli valse una proposizione di condanna dalla Sorbona la quale organizzò un pubblico rogo delle sue opere. Contro di lui fu sollecitato l’intervento dell’imperatore e Agrippa, non ricevendo da tempo il suo stipendio, finì in prigione per debiti. Liberato, sfuggì ai creditori tornando a Colonia ove scrisse, per difendersi, l’Apologia adversus calumnias e la Querela super calumnia. Riprese a viaggiare, finendo a Lione ancora in prigione, e morendo a Grenoble, assistito solo dal suo giovane discepolo Johann Weyer. Del De occulta philosophia circolavano numerose copie manoscritte, più o meno distorte. Era stato lo stesso Cornelio Agrippa a farlo conoscere per raccogliere pareri e idee. Nel 1531, appena ricevuta la nomina a storiografo imperiale, diede alle stampe il primo libro dell’opera, contemporaneamente ad Anversa e a Parigi, con una prefazione quantomeno curiosa. In essa Agrippa, disconoscendo il suo lavoro, ne giustificava la pubblicazione per- ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 9 Da sinistra: la proporzione del corpo umano; segni e caratteri per evocare gli spiriti; lettere e caratteri dei pianeti ché «circolando copie corrotte [ ... ] e prevenendo alcuni che (non so se più impazienti che impudenti) volessero stampare un libro così informe ho deciso di pubblicarlo io stesso. Sarebbe stato un delitto non lasciar morire questo frutto della mia giovinezza». Due anni più tardi, nel 1533, consegnò all’editore Hetorpio e al tipografo di Colonia Jean Soter i due libri mancanti che mai erano circolati in precedenza. Nel 1559, a Marburgo, comparve una quarta parte del De occulta philosophia: il De Caerimoniis Magicis (conosciuto anche come Libro del comando) trattato di magia cerimoniale ed evocazione degli spiriti, che Johann Weyer riconobbe come un apocrifo e che come tale è considerato tuttora. La fama del testo di Cornelio Agrippa sopravvisse al suo autore, con molte edizioni e ristampe dell’opera (fra cui quella, preziosa, conservata presso la Biblioteca di via Senato). Non diversamente da altri (come Gerolamo Cardano e Tommaso Campanella), nel De occulta philosophia Agrippa distinse la magia nera o demoniaca da quella naturale, che anticiperebbe quel che la natura produrrebbe da sola. Il mago sarebbe una sorta di acceleratore, che batte la natura sui tempi perché conosce l’ordine delle cose e sa congiungere quelle superiori con le inferiori, le attive con le passive, coniugare gli opposti, annullare le distanze. In quanto forma di conoscenza attiva, la magia è per Cornelio Agrippa «sommamente potente, piena di altissimi misteri, abbraccia la profondissima contemplazione delle cose più nascoste, la natura, la potenza, la qualità, la sostanza e la forza, nonché la conoscenza di tutta la natura». E poiché il suo sguardo non è parziale, ma pretende di abbracciare la totalità, è «l’assoluto compimento di tutta la nobilissima filosofia». Per Cornelio Agrippa la chiave di tutte le operazioni magiche è la «dignificazione dell’uomo ad una virtù e potestà sublime» costituita dal puro intelletto, vertice dell’anima. Per Cornelio Agrippa esistono tre mondi: l’Elementare, il Celeste e l’Intellettuale, investigati rispettivamente da tre scienze, la Fisica (o magia naturale) - che svela l’essenza delle cose terrene – la Matematica (o magia celeste) - che fa comprendere il moto dei corpi celesti - e la Teologia (o magia cerimoniale) - che fa comprendere «Dio, la mente, gli angeli, le intelligenze, i demoni, l’anima, il pensiero, la religione, i sacramenti, le cerimonie, i templi, le feste e i misteri». La Magia racchiude queste tre scienze traducendole in atto. Essa è «la vera scienza, la filosofia più elevata e perfetta il compimento di tutte le scienze»: è la scienza integrale della natura, tanto fisica che metafisica. 10 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Coloro che vorranno dedicarsi mente intese come forme pure ed eterne) che vengono infuse dall’Aniallo studio della Magia, dovranma del Mondo (ovvero Dio). La virno conoscere a fondo la Fisica, tù divina si promana, in generale coche rivela la proprietà delle cose munione, cosicché «tutte le qualità e le loro virtù occulte; dovranno occulte si diffondono sulle erbe, sulessere dotti in Matematica, per le pietre, sui metalli e sugli animali scrutare gli aspetti e le immagiattraverso il sole, la luna, i pianeti e le ni degli astri, da cui traggono stelle che sono superiori ai pianeti. E origine le proprietà e le virtù tale spirito ci sarà tanto più utile, delle cose più elevate; e infine quanto più sapremo separarlo dagli dovranno intendere bene la altri elementi e quanto meglio saTeologia, che dà la conoscenza Sopra: i pianeti e le linee della mano premo servirci delle cose in cui sarà delle sostanze immateriali che penetrato più abbondantemente». governano tutte queste cose. E’ l’operazione tentata dagli alchiPerché non vi può essere alcuna misti, che cercano di estrarre dall’oro il suo spirito per opera perfetta di Magia, e neppure di vera Magia, infonderlo agli altri metalli, «come noi abbiamo fatto e che non racchiuda queste tre facoltà. Alla base di tutto sono i quattro elementi che costituiscono tanto il mondo materiale che quello spirituale. Essi si trovano «anche nei cieli, nelle stelle, nei demoni, negli angeli e in Dio stesso, che è il creatore e l’animatore di tutte le cose», con la differenza di «essere allo stato di purezza e in tutta la loro potenza». Secondo Cornelio Agrippa ogni elemento ha delle peculiarità proprie. Alcune di esse sono note, altre non sono immediatamente conosciute se non addirittura segrete come, per esempio, il potere di «neutralizzare l’effetto di un veleno, di combattere gli antraci, di attirare il ferro». Tali peculiarità sono chiamate «occulte» perché «le loro cause ci sfuggono e lo spirito umano non può penetrarle. Perciò solo i filosofi hanno potuto, per lunga esperienza più che per ragionamento, acquistarne una parziale conoscenza». Esempi di poteri occulti sono il potere della Fenice di rinascere dalle sue ceneri, i pesci che vivono sottoterra, menzionati da Aristotele, le pietre che cantano, descritte da Pausania o le salamandre che vivono nel fuoco. I poteri occulti derivano alle cose dalle idee (platonica- Bibliografia Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, La philosophie occulte de Henr. Corn. Agrippa, conseiller et historiographee de l’empereur Charles V. Divisée en trois livres, et traduite du latin. Tome premier [-second]. A la abbiamo visto fare, pur non potendo produrre una quantità maggiore di oro da quella originaria». Le cose inferiori sono sottoposte alle superiori in un modo particolare, che fa sì che esse si ritrovino nel cielo «in un modo celeste», e quelle celesti si trovino in terra, «in un modo terrestre». Ciò che è in terra - pietre, piante ed animali riceve le sue proprietà dai pianeti e dalle stelle; così, nell’uomo, anche gli organi sono variamente influenzati dai corpi celesti: il cervello e il cuore dal Sole e dall’Ariete, gli arti e la bocca da Mercurio, il fegato e il ventre da Giove, i genitali da Venere e dallo Scorpione. Anche i caratteri e gli umori sono influenzati: la tristezza da Saturno, l’ira da Marte, la gioia da Giove, la sensualità da Venere. Gli influssi dei corpi celesti possono essere attratti mescolando opportunamente le cose naturali che posseggano le qualità di quei corpi, dal momento che una sola cosa non può comprendere tutti i poteri di un astro. La mescolanza sarà perfetta quando la riunione e il dosaggio siano fatti in «concordanza col cielo sotto una data costellazione» e in modo da ottenere un composto non facilmente scindibile, simile alle pietre. Haye, chez R. Chr. Alberts, 1727. 2 voll.; 8vo; pp. [22], 427, [1]; [2], 317, [1]. Volume I: 1 tavola incisa su rame fuori testo; 23 tavole incise nel testo; 10 illustrazioni incise su rame nel testo. Volume II: 10 tavole incise su rame fuori testo, 2 tavole incise a piena pagina nel testo; 4 illustrazioni incise nel testo; 2 vignette incise su rame sui frontespizi. Nota di possesso in fine al II volume: Le C[om]te de Merle-Lagorce. Legatura coeva in piena pelle marrone. ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 11 BvS: il Fondo Antico JOSEPH SMITH, CONSOLE INGLESE A VENEZIA Tra dipinti e libri: un contributo per la bibliofilia del Settecento ANNETTE POPEL POZZO R icostruire la biografia del console Joseph Smith (ca. 1674-1770) – benché sia universalmente noto in quanto proprietario di una stupenda e celebre raccolta di quadri, disegni, manoscritti e libri – non è compito facile in mancanza di molti dettagli. Le poche informazioni sicure ci dicono che studia a Londra alla Westminster School, dove pare abbia ricevuto un’ottima educazione, e che arriva poi a Venezia attorno all’anno 1700 come socio giovane del banchiere di fama internazionale Thomas Williams. La loro ditta commercia carni e pesci da Amsterdam, mentre la loro banca, scelta da molti nobiluomini inglesi come “casa finanziaria in Venezia“ sostiene anche case reali, tra i quali ad esempio il principe Eugenio di Savoia, che ricevette la considerevole somma di 250.000 sterline destinata a pagare le sue truppe. tico collezionista di manoscritti e libri preziosi. Spesso agisce anche come agente d’arte organizzando acquisizioni per conto di altri. Nel 1717 tratta l’acquisto dei codici medievali dei canonici regolari di San Giovanni di Verdara a Padova per conto del giovane Thomas Coke, Conte di Leicester, per 4.779 lire veneziane, compresa la sua mediazione per la compravendita. Bernardino Trevisani riceve nello stesso anno 2.358 lire per preziosi libri veneziani, ricordati da Montfaucon nel Diarium Italicum, e nel 1721 Smith riesce addirittura di assicurare al Conte di Leicester i famosi codici di Giulio Giustiniani.1 Per quanto riguarda l’arte è noto che l’incontro tra Smith e il vedutista e pittore veneziano Canaletto (1697-1768) fu decisivo per la carriera dell’ultimo. Mentre il console inizialmente fu un cliente di Canaletto (tra l’altro commissiona una serie di dodici vedute del Canal Grande), diventa in seguito il principale intermediario tra Canaletto e i collezionisti britannici, raggiungendo il culmine nella seconda metà degli anni trenta quando importanti nobili come il Conte di Fitzwilliam, il Duca di Bedford, il Du- Frontespizio del Catalogus librorum rarissimorum (Venezia, Pasquali, ca. 1755?), contenente 248 incunaboli provenienti dalla biblioteca di Smith Smith, che il Conte Horace Walpole chiamava non senza ragione The Merchant of Venice, non soltanto con chiara allusione alla commedia shakespeariana ma anche alla sua intelligenzia mercantile, dà prova di notevoli capacità come intenditore d’arte e diventa frene- ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 13 Nella pagina accanto: frontespizio della contraffazione de I quattro libri dell’architettura di Andrea Palladio, realizzata sempre su commissione di Smith da Pasquali nel 1768 circa. Sopra da sinistra: le illustrazioni nella contraffazione di Palladio furono incise su rame, mentre quelle originali del 1570 sono xilografie; a destra: la Basilica Palladiana a Vicenza, un tempo sede delle magistrature pubbliche ca di Leeds e il Conte di Carlisle iniziano a richiedere i quadri e le vedute del pittore veneziano. Non meno celebri le attività di Smith nell’ambito bibliofilo. Ebbe un debole per le aldine. Infatti viene considerato il primo collezionista (molto prima di Renouard) che abbia riunito sistematicamente le celebri edizioni decorate dall’ancora con il delfino uscite dai torchi del tipografo veneziano. Presso il nostro Fondo Antico si conserva per esempio una copia della Rhetorica ad Herennium di Cicerone, stampata da Aldo nel 1551, recante l’ex libris con lo stemma del console al contropiatto. Troviamo il suo nome anche in diverse imprese editoriali. “Smith fondò una casa editrice prendendo come socio e stampatore un giovane correttore di bozze di ottima cultura classica, Giovanni Battista Pasquali, il cui nome venne dato alla ditta per fornirle la necessaria connotazione italiana. Ma le lettere del modenese Pietr’Ercole Gherardi a L. A. Muratori, e lo scambio di corrispondenza tra il letterato fiorentino Anton Francesco Gori e lo stesso Smith dimostrano inequivocabilmente che era proprio quest’ultimo a finanziare la casa 14 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Da sinistra: dettaglio dell’olio su tela di Canaletto Venezia: il Molo verso ovest, con la colonna di San Teodoro a destra; dettaglio dell’olio su tela di Canaletto Venezia: la Riva degli Schiavoni verso est, entrambi commissionati da Joseph Smith editrice, nonché a dirigere e controllare la vita dell’impresa nei minimi particolari.”2 Eretta attorno al 1730, la stamperia raggiunge in meno di quindici anni gli altissimi livelli di grandi editori come Albrizzi e Zatta, celebri anche per le loro opere dotate di un ricco apparato illustrativo. Del resto, anche l’impresa editoriale di Smith e Pasquali presenta edizioni illustrate, dando incarico al pittore e incisore Antonio Visentini (16881782) – noto prevalentemente per le sue vedute incise dai quadri di Canaletto – di decorare molti dei suoi volumi. A testimonianza di questo impegno si sono conservati alcuni disegni, come per esempio quelli per le testate del Dizionario Universale delle Arti e delle Scienze di Ephraim Chambers, uscito in nove volumi nel 17481749. Anche la marca tipografica con al centro la figura di Minerva (dea della saggezza) che tiene un libro nella mano destra e appoggia la sinistra a uno scudo, con il motto “Litterarum felicitas”, cioè “La felicità delle lettere” è opera di Visentini. Il motto italiano serve inoltre da prestanome per l’omonima libreria che Smith apre accanto alla stamperia in campo San Bartolomeo vicino a Rialto.3 La gamma di pubblicazioni dell’editoria di Smith e Pasquali va da testi classici dell’antichità e della letteratura italiana attraverso opere di architettura, di religione, di filosofia e di storia fino a volumi di letteratura moderna. Nel Fondo Antico della nostra biblioteca si conservano esempi come i famosi Annali d’Italia in dodici tomi di Ludovico Antonio Muratori, stampati dal 1744 al 1749, come del resto Della Istoria d’Italia in due ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 15 tomi di Francesco Guicciardini, stampati dal 1738 al 1739, e sempre recanti le illustrazioni di Visentini. Smith e Pasquali erano anche i più grandi importatori di libri stranieri a Venezia, spesso con testi – come per esempio nel caso di Voltaire – ufficialmente vietati in quel periodo nella Repubblica veneziana. La loro libreria divenne così promotore, punto di ritrovo e riferimento agli studiosi delle idee illuministiche.4 Nel 1739 Pasquali stampa per Smith la Lettera d’un fisico, sopra la filosofia neutoniana, accomodata all’intendimento di tutti dal signor di Voltaire di Noël Regnault, e nel 1762 Il Cesare e il Maometto tragedie del signor di Voltaire trasportate in versi italiani con alcuni ragionamenti del traduttore a cura di Melchiorre Cesarotti. che con incisioni su rame. Tra gli altri, fu Johann Wolfgang von Goethe a comprarla, che durante il suo Viaggio in Italia, annotava nel diario al giorno 27 settembre del 1786: “Finalmente sono venuto in possesso delle opere del Palladio: non dell’edizione originale, quella con le tavole incise su legno, che ho vista a Venezia, ma di una copia esatta, anzi un facsimile su rame, curato da un uomo egregio, l’ex console inglese a Venezia, Smith. Bisogna riconoscere agl’inglesi il merito d’aver saputo apprezzare da tempo le cose belle e di saperle diffondere con eccellenza di mezzi.“6 Nel mese successivo, recandosi a Venezia, Goethe davanti alla tomba di Smith dichiara ancora: „Al Lido, non lontano dal mare, sono sepolti gl’inglesi […] ho trovato la tomba del valoroso Sono soprattutto due i progetti di Smith – o vogliamo chiamarli capricci di bibliofilia – che sono passati alla storia del libro. Per prima cosa, prepara una contraffazione del Decamerone di Boccaccio nell’edizione del 1527, stampata dagli eredi di Filippo Giunta, che in realtà però fatta nel 1729 dal veneziano Stefano Orlandelli, è diventata quasi più celebre dell’originale. Soltanto avendo entrambi versioni a confronto, come nel fortunato caso delle due copie del nostro Fondo Antico, una distinzione diventa abbastanza ovvia. Alberto Bacchi della Lega specifica nella Serie delle edizioni delle opere di Giovanni Boccaccio: “Questa ristampa però non imita talmente l’edizione originale che non si possa riconoscere di primo tratto per diverse ragioni, e cioè: che gli a, che hanno la testa a punta acuta nella prima edizione, l’hanno rotonda nella ristampa; che il carattere, usato nella edizione originale, è nuovo nella ristampa; che i ff. 42 e 108 nella ediz. originale sono numer. 24 e 168 e i ff. 101, 103 e 104 sono numer. sempre 102; errori corretti nella ristampa; che lo stemma Giuntino che in quest’ultima è della medesima dimensione sì nel principio che nel fine, nell’ediz. originale è nel frontespizio di forma più grande ecc.”5 Lo stemma del console, realizzato in penna, inchiostro bruno e colori ad acqua, e pensato per l’album dei disegni Il secondo capriccio bibliofilo riguarda invece la celebre prima edizione de I quattro libri dell’architettura di Andrea Palladio del 1570, che Smith prepara in una contraffazione nel 1768 circa, stampata da Pasquali, ma mantenendo tutte le caratteristiche dell’originale con la sola differenza di scambiare le illustrazioni xilografi- 16 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Sopra: Antonio Visentini, disegno per il Dizionario Universale di Ephraim Chambers. A destra: frontespizio della contraffazione del Decamerone console Smith e della sua prima moglie; essendogli debitore del mio primo esemplare del Palladio, gliene resi grazie sulla sua tomba non consacrata.“7 Smith usa la propria stamperia anche per la diffusione dei suoi cataloghi di libri rari. Mentre una prima edizione degli incunaboli contenente 227 esemplari esce ancora a Padova dalla tipografia Volpi-Comininana nel 1724 in 50 copie, già la seconda versione ampliata del 1755 circa, sempre stampata in poche copie, e contenente 248 incunaboli, viene preparata da Pasquali. Sfogliando le pagine della copia conservata presso la nostra biblioteca si revelano le preziosità appartenute al console, come la mitica princeps a stampa della Divina Commedia dantesca nell’edizione di Foligno del 1472, per citarne soltanto un caso. Nel 1755 finalmente il console pubblica sempre da Pasquali la sua Bibliotheca Smithiana, che essendo una prima edizione completa in due volumi, comprende più di 12.000 titoli di libri a stampa, ma anche i manoscritti (talvolta miniati) e i volumi d’arte grafica. Proprio in quel periodo, però, gli affari iniziano ad andare male. La guerra di successione austriaca (1740-1748) e la guerra dei Sette anni (1756-1763) hanno gravi conseguenze sul commercio europeo. Smith inoltre dispone di crediti presso aziende all’estero che cominciano a fallire. Gli viene risparmiato di vendere la stamperia, ma deve separarsi da “tutto lo stock e il contenuto della libreria e del magazzino, ceduti per 95.000 ducati (da pagarsi a rate) ai librai Giacomo Caramboli e Domenico Pompeati.“8 In questa fase iniziano anche le trattative per la pensata vendita della raccolta di libri, disegni, dipinti e ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 17 Marca tipografica della stamperia Pasquali (ca. 1740): disegno a penna e inchiostro bruno, realizzato da Antonio Visentini gemme a Giorgio III d’Inghilterra – un progetto che va in porto nel 1762, pagando a Smith la somma di 20.805 sterline.9 Mentre i dipinti raggiungono Windsor Castle, dove fino a oggi formano il nucleo della Royal Collection nel “Print Room“, i libri e manoscritti vengono donati da Giorgio IV alla British Library. Smith muore neanche dieci anni dopo nel 1770 a Venezia. La sua seconda moglie Elizabeth Murray (sorella del residente di Venezia), dalla biblioteca della NOTE FRANCES VIVIAN, Da Raffaello a Canaletto. La Collezione del Console Smith, Milano, Electa (Mostra Fondazione Giorgio Cini, 15 settembre – 18 novembre 1990), 1989, p. 14. 2 FRANCES VIVIAN, 1989, pp. 15-16. 3 Cfr. FRANCES VIVIAN, 1989, p. 16. quale si conserva presso il nostro Fondo Antico una copia del Goffredo, ovvero Gerusalemme liberata di Torquato Tasso del 1760-1761, vende il palazzo dei Santi Apostoli e ritorna definitivamente in Inghilterra. Ancora durante il Settecento si registrano varie vendite e aste con libri, stampe, disegni e quadri provenienti dalla raccolta Smith. Nonostante l’enorme dispersione (abbastanza usuale per raccolte private), le tracce si Smith si snodano attraverso le biblioteche mondiali intuendo la grandeur di una volta. FRANCES VIVIAN, 1989, p. 16. ALBERTO BACCHI DELLA LEGA, Serie delle edizioni delle opere di Giovanni Boccaccio, Bologna, 1875, p. 36. 6 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, Viaggio in Italia, Milano, Mondadori, 1983 (I Meridiani), p. 61. 4 5 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, 1983, pp. 96-97. 8 ASV, Notarile, Atti, notaio Ferdinando Uccelli, 26 settembre 1761, b. 13449, cc. 1331v-32. 9 FRANCES VIVIAN, 1989, p. 51. 7 ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 19 BvS: il Fondo De Micheli VITTORINI, GUTTUSO E IL PROBLEMA DEL REALISMO In Conversazione in Sicilia il nuovo senso della realtà LAURA MARIANI CONTI E MATTEO NOJA I llustrando il nostro fondo De cenzi, e delle incisioni non se ne fece Micheli, abbiamo più volte parpoi nulla, sino al 1986. lato di realismo nell’arte, come espressione tra le più significative del pensiero culturale e artistico nelChe Vittorini fosse attratto l’Europa del primo Novecento. Ridalle arti figurative e ne parlasse con ponendo sugli scaffali un testo congrande competenza, risulta evidente sultato da un nostro utente nei giorsin da uno dei suoi primi scritti, ni scorsi1, ci siamo imbattuti nel comparso su “L’Italia Letteraria” pensiero di Elio Vittorini riguardo nel 1932 e dedicato ad Arturo Martial realismo nell’arte sua contemponi. Dell’arte Vittorini parlò sempre ranea, in Guttuso e nella letteratura con estrema sensibilità e con chiara che egli frequentava. Soprattutto conoscenza critica. D’altronde era con riferimento a un suo testo dalla nipote di un grande scultore siracustoria travagliata, che trovò l’ediziosano che si era trasferito con le sue ne definitiva nel 1953, Conversazione statue a Firenze: Pasquale Sgandurin Sicilia. Il romanzo venne pubblira3. Nel capoluogo toscano Sgandurra aveva poi ospitato il giovane cato per la prima volta a puntate sulscrittore, con la moglie Rosa Quasila rivista “Letteratura’’ tra il 1938 e il modo4, nel 1930. Ma l’importanza 392. Con altro titolo comparve a Firenze nel 1941 (Nome e lagrime, Fi- A sinistra: Vittorini e Montale dello zio non si risolse nell’offrire un renze, Parenti, Collezione di Lette- a Firenze negli anni Trenta; tetto alla coppia che, accompagnata ratura. Romanzi e racconti, edizio- sopra: copertina dell’edizione Rizzoli dal figlioletto Giusto5, era appena ne di 350 copie per bibliofili); sem- del 1986 della Conversazione giunta da Gorizia. Sgandurra fu sopre nello stesso anno Bompiani lo prattutto l’uomo che introdusse pubblicò a Milano. Sequestato nel Vittorini nell’ambiente di “Solaria” 1943, ebbe una sua circolazione clandestina, divenendo (dove Elio divenne segretario di redazione) e che gli fece punto di riferimento per molti intellettuali antifascisti e conoscere, tra gli altri, Eugenio Montale. Con quest’ulun esempio per il neorealismo. Nel dopoguerra doveva timo il ventiduenne scrittore siciliano strinse un’affetessere ristampato accompagnato da un servizio fotogratuosa e duratura amicizia che li vide sui tavolini delle fico di Luigi Crocenzi e da illustrazioni di Guttuso. Nel Giubbe Rosse o del Paszkowski avidamente leggere e 53 uscì solo con la “collaborazione fotografica” di Crotradurre gli scrittori stranieri per poter guadagnare 20 qualche soldo6 e li vide pure, nei momenti di svago, appassionati spettatori dei gangster-movies di moda negli anni 307, tanto che, nelle fotografie dove sono ritratti insieme, i due sembrano atteggiarsi, nelle pose e nei vestiti, agli eroi impersonati da Edward G. Robinson, Douglas Fairbanks Jr., James Cagney, George Raft e Paul Muni. Fu in quel periodo che Vittorini chiamò a sé anche il cognato poeta Salvatore Quasimodo, presentandolo a tutti i nuovi amici. Evidentemente lo zio Pasquale Sgandurra gli aveva trasmesso quella sensibilità artistica che Vittorini mise in mostra in tutta la sua opera critica. Probabilmente gli insegnò a guardare le opere d’arte direttamente, senza lo schermo di false ideologie, diversamente dai molti che in quegli anni scrivevano nel settore. Sicuramente, per Vittorini, l’arte fu una passione for- la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 te, (cresciuta accanto a quella per la letteratura), che arrivò anche a condizionarne la scrittura creativa. «Nel 1912 la Sicilia faceva parte dell’Italia da cinquantadue anni, e le sue bande municipali suonavano nelle piazze Tripoli bel suol d’amore invece dell’Inno di Garibaldi, i suoi contadini andati soldato tornavano in licenza con la faccia spersa sotto il casco coloniale della guerra di Libia. Bagheria, a venti chilometri circa da Palermo sulla strada di Messina, era ancora una borgata borbonica di alcune migliaia di casupole e di nove o dieci grandiose ville di prìncipi tra gli aranceti della sua piana in declivio verso il mare: ancora senza fognatura, ancora senz’acqua potabile, ancora senza luce elettrica. Era a Bagheria che nasceva, in una casa con balconcino d’una via dal fondo non lastricato, Renato Guttuso. Ed era a Bagheria che Guttuso passava l’infanzia. Era tra Bagheria e Palermo che Guttuso passava l’adolescenza»8. Così, in Storia di Renato Guttuso e nota congiunta sulla pittura contemporanea lo scrittore racconta della nascita dell’amico pittore. Siciliani entrambi, si conobbero però all’ombra della Madonnina, a Milano, incontrandosi nelle riunioni del gruppo dei giovani artisti e intellettuali che si riconosceva nelle pagine di “Corrente”. In un’intervista del 1971, Guttuso ricordava così quel periodo: «A Milano conobbi Vittorini e abitammo per due stagioni nella stessa pensioncina a Bocca di Magra: lui, allora, era un corriere del PCI, viaggiava con la valigetta piena di manifesti e di stampa clandestina, correva l’Italia e scriveva Conversazione in Sicilia. Fu sulla scia di quel libro rivoluzionario e riecheggiandone il titolo, che dipinsi la mia Fucilazione in campagna, dedicata alla morte di Garcia Lorca, ucciso in quegli anni dai fascisti spagnoli»9. Storia di Renato Guttuso fa parte della seconda serie dei “Pittori italiani contemporanei” curata dalla celebre Galleria milanese del Milione. Vittorini aveva già dedicato ai disegni di Guttuso, un testo, in collaborazione con Duilio Morosini, edito dalle Edizioni di Corrente nel 1942; testo che verrà poi ripreso in Diario in pubblico e A sinistra: R. Guttuso, illustrazione per il IV capitolo della Conversazione, 1943; a destra: R. Guttuso, Uomo che legge il giornale, 1958, olio su tela ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano commentato da una breve nota. Il libro del 1960 ha più respiro rispetto a quello del ’42 e prende a pretesto la cronistoria dell’amico, puntuale e precisa, per parlare di come nell’arte contemporanea si stia superando il realismo, anche in relazione al percorso compiuto da Picasso, vero e proprio nume tutelare della loro generazione. «Ma gli anni ’39 e ’40 erano quelli della seconda ondata delle leggi razziali fasciste, della caduta di Barcellona e di Madrid, del patto di Ribbentrop con Molotov, dell’invasione tedesca della Polonia, dello sbarco tedesco in Norvegia, della guerra lampo tedesca attraverso la Francia, dell’Italia che entrava nel polverone sollevato dai tedeschi, dei bombardamenti tedeschi di Londra, e dei richiamati italiani mandati a fare i tedeschi sul- 21 le piste del deserto libico e su per i cocuzzoli delle “reni” della Grecia. Dipingere, scrivere, il pensare stesso erano attività sostanzialmente clandestine di fronte a queste cose. Chi vi impegnava tutto il proprio essere non poteva non rendersi conto che il fatto della loro coesistenza con queste cose le rendeva straordinarie: delle attività straordinariamente clandestine e clandestinamente straordinarie. Non erano in molti, in effetti, a rendersene conto. Non sono mai in molti gli artisti e gli uomini di cultura che impegnano tutto il proprio essere nel pensare, nello scrivere, nel dipingere. Ma Guttuso non si limitava a lasciarlo vedere nei suoi studi, nei suoi disegni, nei suoi nudi di donna, nelle sue nature morte. Egli si spingeva fino a dirlo in parole povere. “Le condizioni oggi”, scriveva nel “Selvaggio” del novembre ’39, “sono storicamente privilegiate, sempre che si abbia la forza e la li- 22 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Sopra: R. Guttuso, Natura morta con lampada (Natura morta con bucranio e lampada), 1940-41, olio su tela. A destra: due illustrazioni di Guttuso per la Conversazione, 1943 bertà interna necessarie in tempi così pericolosi. Se io potessi, per una attenzione del Padreterno, scegliere un momento nella storia e un mestiere, sceglierei questo tempo e il mestiere del pittore”»10. L’amicizia tra Guttuso e Vittorini sarà sempre testimoniata dalle parole dell’uno nei confronti dell’altro e viceversa. In Mestiere di pittore, Guttuso riporta alcune lettere all’amico. Una riguarda la monografia del Milione e comincia con queste parole: «Carissimo Elio, ancora con più commozione della prima volta, ho riletto, nelle bozze, il testo della monografia… È un discorso sulla pittura e sul modo d’essere (e d’essere stato) di un artista onesto, in questi anni… Ma quel che più conta nel tuo scritto […] è il caldo che vi circola dell’amicizia e della fi- ducia in me ed in una situazione, il riflesso autobiografico, il senso di esperienza vissuta e vivente che ci coinvolge. E di questo io ti sono molto grato, in profondo. E sai perché»11. E, prima dei saluti, conclude: «Ti ripeto che per me il tuo saggio è una bellissima e commossa impresa. Una testimonianza di cultura, nel senso più vero, meno parziale, della parola. Che io ne sia oggetto, mi dà una crisi di coscienza, e anche una profonda gioia; è un aiuto al mio lavoro, al chiarimento che cerco sempre di più»12. Ma Storia di Renato Guttuso è qualcosa di più che un omaggio a un amico: è in sostanza una dichiarazione di poetica che si collega a ciò che lo scrittore siracusano riteneva di aver raggiunto con uno dei suoi libri più conosciuti, cioè Conversazione in Sicilia, icona di una generazione intera, libro fondamentale nella sua propria storia di intellettuale, che, scritto durante la crisi susseguente ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano al dramma della guerra di Spagna, ha segnato profondamente tutte le successive esperienze dello scrittore. Libro che, nell’amicizia dei due intellettuali siciliani, rappresenta anche una sorta di giallo. Dichiarazione di poetica perché quando Vittorini racconta in Storia di Guttuso lo sviluppo dell’arte dell’amico, lo fa pensando a come si possa – dopo una guerra che ha cambiato drammaticamente il mondo fin dentro la natura delle cose – rappresentare ancora, con pittura e scrittura, la realtà. Il realismo ottocentesco, il verismo dei suoi conterranei (ma anche di tutta quella pletora di intellettuali più o meno importanti che avevano popolato le cronache italiane del primo Novecento) non è più valido. Si sente insoddisfatto del linguaggio che letteratura e arte esprimono; soprattutto quello dei suoi romanzi precedenti, e lo scrive a chiare lettere nella prefazione all’edizione in volume del Garofano rosso, dove confrontandolo con Conversazione in Sicilia scrive: «[quello del Garofano rosso] era un linguaggio che sembrava obbligatorio imparare per scrivere romanzi. Costituiva una tradizione di un secolo che si aggiornava più o meno ad ogni nuovo romanziere, in Italia e fuori. […] Ottimo per raccogliere i dati espliciti di una realtà, e per collegarli esplicitamente tra loro, per mostrarli esplicitamente nei conflitti loro, risulta oggi inadeguato per un tipo di rappresentazione nel quale si voglia esprimere un sentimento complessivo o un’idea complessiva, un’idea riassuntiva di speranze o insofferenze degli uomini in generale, tanto più se segrete. […] Cioè non riesce ad essere musica e ad afferrare la realtà come insieme anche di parti e di elementi in via di formazione. […] È come se ormai fosse un linguaggio ideografico. Non risponde più, vale a dire, al compito proprio di un linguaggio poetico: il quale è di conoscere e di lavorare per conoscere quanto, della verità, non si arriva a conoscere col linguaggio dei concetti»13. E oltre, parlando di Conversazione, dichiara: «… avevo bisogno di essere, anche scrivendo, “quello ch’ero diventato”, e avevo bisogno di dire una certa cosa che solo a dirla come dice le cose la musica, e come le dice il melodramma, come le dice la poesia, si poteva arrischiare, nel regno fascista d’Italia, di dirla in faccia al pubblico, e in faccia al re, in faccia al duce…»14. Secondo Vittorini, quindi, per cogliere la profonda realtà delle cose bisogna interrogarla con un linguaggio poetico che sappia coglierla nella sua essenza. E que- 23 ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 25 A sinistra: Guttuso negli anni Sessanta; sopra: copertina del saggio di Vittorini edito dal Milione; R. Guttuso, Oggetti nello studio (Natura morta con barattoli), 1957, olio su tela sto, dopo vari tentativi, egli riuscì a compierlo in Conversazione in Sicilia, trasformando il linguaggio realistico in allegorico: «Ad evitare equivoci o fraintendimenti avverto che, come il protagonista di questa Conversazione non è autobiografico, così la Sicilia che lo inquadra e accompagna è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome Sicilia mi suonava meglio del nome Persia o Venezuela. Del resto immagino che tutti i manoscritti vengano trovati in una bottiglia»15. Egli sente ogni discorso naturalistico, verista o realista sorpassato, ormai inadeguato a esprimere una situazione umana che è irreversibilmente cambiata, e che è nel suo divenire non ancora conclusa. Per lui è la trasfigurazione del reale nell’allegoria che rende ogni descrizione plausibile, utile a comprendere, criticare e trasformare il tempo presente. Per lui all’origine del romanzo è la poesia16 e solo la poesia, la musicalità della parola, è ciò che permette di esprimere quel qualcosa in più che contraddistingue la realtà. Il linguaggio intellettualistico dei romanzi ottocenteschi che Vittorini non sente assolutamente più suo, ha generato solo «… recensioni di personaggi, invece di personaggi, recensioni di sentimenti, invece di sentimenti, e recensioni di realtà, invece di vita…»17. L’allegoria quindi, che si approssima al mito e al simbolo, permette alla vita stessa di essere rappresentate. Cosa che ottiene nella Conversazione, dove il linguaggio allusivo e simbolico – che si potrebbe definire “classico” nel suo risultato rivoluzionario e innovativo, e che ricorda, per certi versi, il linguaggio di Malaparte – gli permette di “giungere dalla descrizione all’invenzione, dalla cronaca alla poesia”. Cosa che ritrova nell’arte contemporanea. In Storia di Guttuso, poco più di dieci anni dopo, nel 1960, lo scrittore torna infatti sull’argomento del superamento della realtà attraverso la poesia del gesto artistico e letterario e lo fa parlando del percorso intrapreso da Guttuso nella sua opera: «La liberazione dal complesso di colpa che Guttuso covava nei riguardi delle proprie doti tradizionali, liberazione ottenuta attraverso una 26 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Sopra: R. Guttuso, Tramonto sul lago di Varese, 1956, olio su tela; a destra: R. Guttuso, Tavolo da lavoro (Natura morta), 1958, olio su tela; a p. 28: copertine delle prime edizioni in volume delle opere di Vittorini (Il garofano rosso, 1948; Conversazione…, 1941) piena adesione a tali doti, è stata così feconda da riaccendere in sede di sostanzialità globale le grandi possibilità di pittore moderno che Guttuso aveva sempre impiegato entro i limiti delle sostanzialità particolari. Egli ora può raccogliere degli elementi tutti naturalistici, le foglie e le arance di un aranceto, o le gambe, le mani, gli occhi, i capelli, gli sguardi e i gesti di una folla, per formare un insieme che non è la descrizione di un aranceto o d’una folla (e tanto meno di sensazioni, di sentimenti o di idee riferibili a un aranceto o a una folla), ma una nuova prova di avvicinamento a quella raffigurazione spaziale che l’arte contemporanea va costruendo da parecchi decenni, in corrispondenza dei nuovi concetti e giudizi (si capisce anche psichici) sull’universo di cui la civiltà moderna ha avviato e non ancora concluso (poiché continua a mutare di livello tecnico e sociale) l’elaborazione: una nuova prova individuale, dico, di raffigurare plasticamente un modo “comune” di sviluppo d’un pensiero, una nuova e felice prova fatta in un particolare dell’universo stesso quale un aranceto o un movimento di folla che perciò non si fissa sul quadro come un luogo aneddotico o sentimentale e vi assume piuttosto la funzione ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 27 di “luogo di emergenza”, di luogo di trasformazione, di luogo che basta ancora poco e acquista la precisione e la forza significante di una “metafora”». Conversazione in Sicilia rappresenta però anche una sorta di piccolo mistero nel rapporto più che amichevole tra i due. Il romanzo aveva colpito molto il pittore siciliano, tanto da pensare di poterlo tradurre in immagini. Vittorini, dalla sua parte, aveva apprezzato l’amico anche nel ruolo di illustratore. Nella nota di commento alle illustrazioni guttusiane di Addio alle armi di Hemingway, nel numero 29 di “Il Politecnico”, annunciandone l’edizione italiana presso Mondadori, infatti scrive: «Esistono due buoni modi di illustrare un libro: corrispondere al suo linguaggio, al suo stile, o interpretare il fondo con un istinto di rabdomante che trova ciò che lo scrittore stesso non poteva sapere d’aver detto. Nell’illustrare Addio alle armi di Hemingway, Renato Guttuso ha seguito questo secondo modo e il risultato ci sembra bellissimo». Vittorini aveva piena fiducia nelle immagini, fotografie o disegni che fossero, nella loro resa della poeticità del testo. Tanto che sin dal 1941 aveva avviato un progetto con Guttuso per un’edizione illustrata del romanzo. Tale progetto era stato portato avanti sino al 1943. Poi, misteriosamente e silenziosamente, più niente. E ciò che colpisce è che nessuno ne fa più men- NOTE 1 Si tratta di Storia di Renato Guttuso e nota congiunta sulla pittura contemporanea, Milano, Edizioni del Milione, 1960. 2 Fu pubblicato nei seguenti fascicoli della rivista diretta da Alessandro Bonsanti: n. 2, aprile 1938, p. 67; n. 3, luglio 1938, p. 81; n. 4, ottobre 1938, p. 23; n. 1, gennaio 1939, p. 42; n. 2, aprile 1939, p. 97. 3 Sgandurra (1882-1956) era figlio di Don Salvatore, barbiere assai popolare allora a Siracusa, e all’occorrenza anche un coraggioso cerusico. Alto, biondo e con gli occhi azzurri come un antico normanno, Salvatore ispirò uno dei personaggi immortali della zione né si ricorda nulla. Neanche Bompiani, che negli anni 50 pubblicò il testo corredato solo dalle fotografie di Crocenzi. Nella Nota 1953 che viene apposta in calce alla nuova edizione, Vittorini spiega così le foto: «È stato nel 1950, tredici anni dopo la comparsa della prima puntata di Conversazione sulla rivista “Letteratura” di narrativa vittoriniana: il “Gran Lombardo” di Conversazione in Sicilia (Edmondo De Amicis, che nel 1906 entrò nella sua bottega nella Mastrarua, ne rimase affascinato e scrisse di «non aver mai incontrato nella sua vita un barbiere così colto»). Pasquale fu invece rinomato scultore e sue opere sono conservate in importanti musei e nelle chiese di Siracusa, Firenze, Torino, Montreal in Canada. Nel suo atelier si raccolsero numerosi artisti siciliani: Adorno, Majorca, Alfonso Ricca e molti altri. Tra questi, un giovane poeta, Sebastiano Vittorini (1883-1972, padre di Elio). Con lui Sgandurra darà vita a una lunga amicizia, tanto che poi Sebastiano ne sposerà la sorella Lucia. Elio e Rosa si sposarono nel 1927, dopo una finta fuga con matrimonio “riparatore”. Lo scrittore era però già “scappato” dalla Sicilia e a quel tempo risiedeva vicino a Gorizia, dove aveva trovato impiego prima come contabile e poi come assistente in una impresa edile. Dall’unione con la sorella di Quasimodo, nacque un primo figlio che, in onore di Malaparte, grande amico e promotore, venne chiamato Giusto Curzio. 5 Rosa Quasimodo, ricorda il soggiorno a Firenze col marito e col figlio Giusto nello studio di Via Faentina: «… A Firenze ci restammo. Era il 1930. Dormimmo per un po’ nello studio dello zio di Elio, Pasquale Sgandurra, scultore. Era pieno di statue. Dalle vetrate, la 4 28 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Firenze, che sono tornato in Sicilia a fotografare, con l’aiuto non solo tecnico del mio amico Luigi Crocenzi, gran parte degli elementi di cui il libro si intesse». Nel 1986, Sergio Pautasso curò per Rizzoli l’edizione che riuniva il testo a quei disegni di Guttuso che nessuno aveva mai visto. La sua nota terminava così: «Questa nuova edizione di Conversazione in Sicilia rende omaggio a Vittorini vent’anni dopo la morte e recupera un significativo momento dell’opera di Guttuso notte, entrava il chiarore della luna, e le statue così bianche ci facevano paura. Di giorno il piccolo Giusto offriva caramelle per ingraziarsi le statue, e le lasciava sui loro basamenti». 6 In realtà, è noto come i due (oltre a Gadda, Sbarbaro e molti altri scrittori e poeti) per le loro traduzioni si avvalessero, con spregiudicatezza e cinismo, dell’opera di una fascinosa e raffinata ebrea triestina nata Morpurgo e imparentata con i Michelstaedter e i Labò, moglie del pittore Paolo Rodocanachi. La signora Lucia Rodocanachi «fu appunto utilizzata dagli illustri amici nelle sue qualità di lettrice e traduttrice poliglotta, e spesso ridotta in questo al livello di anonimo negro» che altrimenti sarebbe rimasto ignorato. I disegni per Conversazione, benché provvisori, precedono di poco il famoso Gott mit uns, ma se li osserviamo nel loro insieme possiamo constatare che costituiscono anch’essi un ciclo disegnativo di non trascurabile portata nell’arco della sua produzione in quegli anni. Non credo che Crispolti e De Micheli, Marchiori e Trombadori se li sarebbero lasciati sfuggire nei loro saggi: l’occasione avrebbe consentito loro di ribadire il carattere culturale e l’importanza di Guttuso nella pittura italiana degli anni Quaranta; soprattutto di sottolineare ulteriormente la straordinaria capacità di rappresentazione per temi che impone la sua arte dal punto di vista della presenza sia qualitativa che quantitativa»18. Pur avendo solo sfiorato l’argomento, pensiamo di avere, come era nostra intenzione, suggerito dei percorsi, da pagina a pagina, da libro a libro, da scaffale a scaffale. I volumi citati, in nota e nel testo, sono infatti tutti presenti nei nostri Fondi, accanto ai molti altri “di e su” Vittorini e “di e su” Guttuso, in attesa che qualcuno voglia sfogliarli e studiarli. (G.C. Ferretti, L’editore Vittorini, Torino, Einaudi, 1992). 7 Nel 1932 Montale dedicherà un suo libro (La casa dei doganieri e altri versi, Firenze, Vallecchi, vincitore del Premio Antico Fattore 1931) “al dolce gangster Elio”. 8 E. Vittorini, Storia di Guttuso…, cit.; p. V. 9 Intervista a Mario Farinella, pubblicata su “L’Ora” di Palermo l’11 febbraio 1971. 10 E. Vittorini, Storia di Guttuso…, cit.; p. X. 11 R. Guttuso, Mestiere di pittore. Scritti sull’arte e la società, Bari, De Donato, 1972; p. 401. 12 Ibid., p. 403. 13 E. Vittorini, Il garofano rosso, [Milano], Arnoldo Mondadori Editore, 1948; pp. 16-17. Ibid., p. 27. E. Vittorini, Conversazione in Sicilia (Nome e lagrime), Milano, Bompiani, 1941; p. 273. 16 Riecheggiano le parole dell’amico Montale: «Nessuno scriverebbe versi se il problema della poesia fosse quello di farsi capire. Il problema è di far capire quel quid al quale le parole da sole non arrivano» (cit. in Masselli-Cibotto, Antologia popolare di poeti del Novecento, Firenze, Vallecchi, 1964, I, p. 237. 17 E. Vittorini, Il garofano rosso, cit.; p. 18 E. Vittorini, Conversazione in Sicilia. Illustrazioni di Renato Guttuso. Nota di Sergio Pautasso, Milano, Rizzoli, 1986; p. 236-7. 14 15 ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 29 inSEDICESIMO I TA L I A G A S T R O N O M I C A – S P I G O L AT U R E – C ATA L O G H I A N T I C H I E MODERNI – RECENSIONI – MOSTRE – ASTE E FIERE “DIVINUS ALITUS TERRAE” CON LE PAROLE DI PLINIO IL VECCHIO Agricoltura, Arte culinaria e Costumi in Mostra per l’Incontro Internazionale dei Partecipanti dell’Expo 2015 di annette popel pozzo na choix di titoli rari di agricoltura, arte culinaria e costumi in onore di un’Italia gastronomica – tutti titoli provenienti dalla Fondazione Biblioteca di via Senato – era in visione dal 10 al 12 ottobre presso il MiCo, Milano Congressi, in occasione dell’evento “IPM 2012 - International Participants Meeting”, che organizzato da Expo 2015 Spa presentava il tema scelto (Nutrire il pianeta, Energia per la vita) ai 105 Paesi che hanno già dato la loro adesione. La Mostra si è aperta con due importanti testi cinquecenteschi di gastronomia, che avvicinano il visitatore al gusto di ricette rinascimentali. Domenico Romoli detto il Panunto (fl. 1560) svolse mansioni di scalco per diverse case signorili, tra le quali anche Papa Giulio III (1550-1555). Il suo trattato La singolare dottrina di M. Domenico Romoli, sopranominato Panunto, dell’ufficio dello Scalco (pubblicato in princeps nel 1560) è una sorta di enciclopedia dell’arte gastronomica che descrive i compiti e i doveri dello scalco e però si ferma anche sulla natura e la qualità dei cibi, proponendo consigli di U dietetica pratica, per la preparazione di menù tanto di ogni giorno come di banchetti. Il contemporaneo Bartolomeo Scappi (1500-1577) fu invece il cuoco segreto (cioè privato) di Papa Pio V (1566-1572). E fu certamente tra i cuochi scelti di preparare i cibi per i cardinali durante il Conclave del 1549-1550, nel quale venne eletto il già citato Papa Giulio III. Una novità significativa della sua Opera, pubblicata per la prima volta da Michele Tramezzino nel 1570, consiste nel fatto di presentare “le figure che fanno bisogno nella cucina & alli reverendissimi nel conclave”. Sono proprio queste 28 tavole che costituiscono una documentazione preziosa dell’arte gastronomica cinquecentesca, con i suoi attrezzi e utensili. Il trattato contiene più di mille ricette, includendo le famose “paste all’italiana, ottenute della sfoglia casalinga, di cui Bartolomeo Scappi […] fornisce un elenco completo, dagli ‘annolini’ alle tagliatelle.” (Voce Gastronomia nella Treccani, www.treccani.it). Sugli aspetti teorici di un’etica conviviale e cortigiana, nonché agli usi e ai costumi ideali del perfetto cortigiano, si fermano invece Il libro del Cortegiano del conte Baldesar Castiglione (14781529), che era in Mostra nella famosa princeps di Aldo Manuzio del 1528, presentandosi inoltre in una bellissima copia con risguardi in pergamena e un pedigree di numerosi proprietari bibliofili, documentati attraverso i loro ex libris, e Il Galatheo, overo Trattato de’ costumi e modi che si debbono tenere o schifare nella comune conversazione di Giovanni Della Casa (1503-1556), che parlando 30 delle buone maniere a tavola consiglia tra l’altro di non grattarsi mangiando, di non riempirsi troppo la bocca, e peraltro sconsiglia di offrire da bere, considerata una “malattia d’oltrealpe”, per fortuna non ancora radicata in Italia. In Mostra c’erano anche rarità più esotiche come il trattato Archidipno, overo dell’insalata, e dell’uso di essa di Salvatore Massonio (1554-1624), nella prima edizione del 1627, la prima opera interamente dedicata all’insalata a cura la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 dell’Autore marchigiano, che non descrive soltanto numerose varietà di insalata, ma propone anche condimenti e ricette di sua invenzione. Altro testo affascinante e singolare sono I pomi d’oro di Giovan Francesco Angelita, stampati da Antonio Braida nel 1607 a Recanati. Questa prima e unica edizione, composta volutamente tra realtà e finzione, tratta i vari aspetti dei fichi e dei meloni che vanno dalla coltivazione attraverso la conservazione fino all’uso nelle varie ricette di cucina. A sinistra: la cucina nel Rinascimento (Opera di Scappi, 1570). Sopra dall’alto: L’economia del cittadino in villa di Vincenzo Tanara (1644); i Pomi d’oro di Giovan Francesco Angelita (1607). Nella pagina accanto: tavola nell’Opera di Scappi (sopra); illustrazione nella Pirotechnia di Biringucci (sotto a sinistra); illustrazione botanica nel Museo di piante rare di Paolo Boccone (sotto a destra) ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano Illustrata con curiose vignette, quasi d’impronta emblematica, Angelita aggiunge in fine anche un capitolo sulle lumache. L’edizione è tra l’altro una delle prime se non la prima opera ad essere stampata a Recanati, città natale di Giacomo Leopardi. La Zucca di Anton Francesco Doni (1513-1574), nella prima edizione del 1551-1552, che contiene anche i Cicalamenti, i Fiori, le Foglie e i Frutti, presenta numerose vignette curiose, ad esempio l’immagine di un giullare che cavalca un’aragosta. Vannoccio Biringucci (1480-ca. 1539), nella sua Pirotechnia del 1540, non fornisce soltanto al lettore il primo libro dedicato interamente alla metallurgia, ma descrive e illustra anche l’arte della distillazione. Questa tecnica fu introdotta nell’Europa medievale attraverso diversi testi arabi di chimica, ma ebbe maggiore diffusione grazie al Liber de arte distillandi del 1512, a cura dell’alchimista tedesco Hieronymus Brunschwig. Anche Giovan Battista Della Porta (ca. 1535-1615) nella sua Magia naturalis (in Mostra la prima edizione volgare De i miracoli et maravigliosi effetti dalla natura prodotti del 1560) considera la distillazione dell’acquavite, assieme alle maniere di conservare gli alimenti con particolare attenzione alla panificazione del grano e alla qualità del pane. Due secoli più tardi, il fiorentino Bartolomeo Intieri (1677-1757), anch’egli assai competente sui procedimenti per la macina del grano e la sua conservazione, progetta addirittura dei cassoni che ne garantiscono la preservazione. Le sue ricerche si trovano pubblicate nel trattato Della perfetta conservazione del grano del 1754 e vengono illustrate grazie a 31 stupende tavole ripiegate. In Mostra non manca ovviamente La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi (1820-1911), nella prima edizione del 1891, descritta dall’Autore come la “Storia di un libro che assomiglia alla storia della Cenerentola”, perché venne in effetti rifiutata da numerosi editori e ciononostante divenne il best-seller della cucina italiana, con più di 60 ristampe. Oltre a un ricco ricettario, il testo si rivela importante “in particolare per la storia del costume, poiché l’A. ha seguito la tradizione romana, italiana e paesana, avvalorandola in guisa che la ben curata cucina, privilegio di corti e ricchi, potesse diventare la tipica cucina borghese e popolare” (DBI 4, p. 368). La Mostra si è chiusa con uno sfolgorante cimelio della gastronomia italiana d’avanguardia: La cucina futurista di Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e Fillia (pseud. per Luigi Enrico Colombo, 1904-1936) nella mitica princeps del 1932, che si presenta in brossura originale di color giallo zafferano con titoli in rosso. Le ricette futuriste, per molti versi derivate da creazioni rinascimentali, sono in verità la base per la Nouvelle Cuisine italiana. 32 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 ET AB HIC ET AB HOC Morire è un atto indecente. Quaranta anni dopo, lo spirito di Flaiano è sempre attuale di laura mariani conti e matteo noja Il prossimo 20 novembre ricorre il 40° anniversario dalla morte di Ennio Flaiano. Nato il 5 marzo 1910, è stato uno dei più arguti intellettuali italiani del Novecento. Scrittore e commediografo, sceneggiatore e soggettista, giornalista, critico teatrale e di cinema, fu, dopo Leo Longanesi e con Marcello Marchesi, uno dei più “micidiali” creatori di aforismi. Di lui, la nostra Biblioteca conserva la prima edizione delle opere più importanti, da cui sono tratti i seguenti brani. Intellettuali da caffè Quest’accusa mi è stata rivolta spesso anche per lettera. Senza turbarmi, troppo, perché nasconde una certa verità cronistica. Le più belle serate per anni le ho trascorse nei caffè con persone la cui amicizia era già un giudizio, Cardarelli, Barilli, Longanesi. Mi è rimasto il debole di preferire il caffè al salotto, al club e all’anticamera. E il piacere di decidere un po’ dei miei gusti, anche teatrali. Pannunzio e Il Mondo Un particolare curioso, che non spiega tuttavia la ragione dei nostri ripetuti incontri, sempre nelle stesse posizioni, lui di direttore, io di redattore, è forse questo: di essere nati lo stesso giorno, nello stesso mese, nello stesso anno. La cosa ci faceva ridere. E’ chiaro – diceva Pannunzio – che io sono nato un’ora prima e il posto di direttore è toccato a me. Importanza della parola Io credo soltanto nella parola. Tutto il resto – il gesto, il silenzio – fa parte di atteggiamenti d’avanguardia. […] Nei miei racconti – dove non c’è certo la ricerca aurea di un Gadda – c’è una struttura tenuta nei limiti della correttezza. La parola è il messaggio stesso. Parlando porto il messaggio. Oggi nessuno parla, tutti si muovono, tutti si comportano, tutti gestiscono. Ogni successo in fondo è un malinteso Se tento di capirci di più, penso che la nostra epoca è caratterizzata proprio dal Successo. Invidio sinceramente chi lo cerca e, soprattutto, coloro che, avendolo ottenuto, non rinunciano a niente pur di alimentarlo. Li invidio perché la loro giusta preoccupazione è il segno di un profondo amore per il loro pubblico, oltre che per se stessi. Due amori che non riesco a nutrire. Forse invidio i pregiudizi della mia generazione post-dannunziana, che rifiutava di proposito il successo, se ne teneva anzi lontano, per non coinvolgere in un unico giudizio la propria vita e le proprie opere. E anche perché a decretarlo allora erano i male informati. Difficoltà di scrivere Ho scritto un libro. Quel che un amico mi rimprovera, con dolcezza ed anche simpatia, è che il dettato sia chiaro. Si capisce tutto. “Non devi aver faticato molto” mi dice con indulgenza. Rispondo che, al contrario, ho faticato moltissimo, che ho scritto e riscritto pagine infinite volte, poiché se avessi dato ascolto alla mia natura, tutto sarebbe rimasto nel vago e nell’oscuro. Sono italiano? 1 Mi telefona un tale per dirmi che sta facendo una piccola inchiesta e vorrebbe che gli rispondessi a questa domanda: di che nazionalità vorrei essere se non fossi italiano.[…] Che io sia italiano potrebbe essere innegabile: infatti mi piace dormire, evitare le noie, lavorare poco, scherzare, e ho un pessimo carattere, perlomeno nei miei riguardi. Bene, se non fossi italiano, a questo punto, non saprei che farci. Probabilmente, non sarei niente e questo dimostra, in fondo, che sono proprio italiano. Allora? La sua domanda è senza risposta. Si consoli pensando che per molti l’italiana non è una nazionalità, ma una professione. Sono italiano? 2 Leggo libri di autori italiani, classici e moderni, e ammiro i nostri artisti; e qui potrei dirmi americano. Adoro il sole, il mare caldo, l’Etruria e la Campania; e in questo potrei riconoscermi tedesco. Se visito un museo non parlo ad alta voce e se vado in una biblioteca non tento di portarmi via un libro o le sue illustrazioni. Sono forse svedese? Poeti e scrittori Si sa benissimo che gli scrittori più felici sono quelli che nascono da famiglie ricche. Il poeta può nascere povero: nella sua vita lascerà un volume, che avrà scritto sul marmo d’un tavolo di caffè, nelle soffitte, nella fame, nella miseria. Comunque la linfa della sua poesia resta. Ma lo scrittore no, deve aver tempo, deve mangiare, deve avere una macchina da scrivere o un tavolo, deve avere qualcosa di suo. Leggere Leggere è niente, difficile è dimenticare ciò che si è letto. 34 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 IL CATALOGO DEGLI ANTICHI Libri da leggere per comprare libri di annette popel pozzo GRAZER BUCHUND KUNSTANTIQUARIAT WOLFGANG FRIEBES Lista 112: libri dal Quattro al Seicento Numerosi i titoli d’argomento Italica nel catalogo del libraio antiquario austriaco. In offerta la rarissima prima edizione delle Opere poetiche del poeta napoletano barocco Giovanni Battista Basile (Mantova, per Aurelio e Lodovico Osanni, 1613). Contenente Delli madriali et ode, La venere addolorata, Le avventurose disavventure, Il pianto della Vergine, l’opera che è sconosciuta alla Libreria Vinciana viene attualmente censita in Italia soltanto nella Biblioteca Marciana (€ 6.000). Curioso anche il Distinto raguaglio dell’origine, e stato presente dell’ottava meraviglia del mondo, o sia della gran Metropolitana dell’Insubria, volgarmente detta il Duomo di Milano di Giovanni Giacomo Besozzo nella prima edizione di Milano, Carlo Federico Gagliardi, 1694 (€ 400 in legatura coeva di cartonato xilografato). Lo scritto contiene in fine un interessante Catalogo di tutti li Personaggi, che hanno Dignita, o Ufficio nella admiranda, & insigne Metropolitana di Milano (pp. 217-231). Abbastanza inusuale anche il testo di Bonaventura Pellegrini Secreti nobilissimi dell’arte profumatoria (Venezia, Curti, 1678) che contiene più di 250 ricette per la produzione di profumi. L’attualità del testo si individua anche nel fatto che fu ancora ristampato nel 1968 e 1993 rispettivamente. Sartoris, Gli elementi dell’architettura funzionale. Collaudo di F.T. Marinetti, stampata nel 1941 da Hoepli. Presentandosi in legatura originale in tela verde stampata, questa terza edizione viene considerata la più completa (€ 1350). In legatura editoriale in cartonato rigido arancione si presentano invece le Poesie di Anacreonte recate in versi italiani da Eritisco Pilenejo (pseud. di Giuseppe Maria Pagnini), stampate a Parma con i tipi Bodoniani nel 1793 (una di 200 copie; Brooks 488; € 700). Curioso è invece un manoscritto di 105 pagine numerate di un ricettario carpigiano dell’Ottocento. Tra le varie ricette descritte troviamo la Pasta per le spongate, l’Aranciata, la Mostarda Antiquariat Wolfgang Friebes Münzgrabenstraße 7 – A-8010 Graz www.friebes.at LIBRERIA ANTIQUARIA PAOLO BONGIORNO Lista Ottobre 2012 I titoli offerti dal libraio antiquario modenese nel suo ultimo catalogo per il mese di ottobre sono d’argomento vario: troviamo tra l’altro l’edizione di 36 progetti di ville di architetti italiani a cura dell’Esposizione Triennale internazionale delle arti decorative industriali moderne alla Villa Reale di Monza che contiene progetti di Gio Ponti, Alberto Sartoris e Giuseppe Pagano (Milano-Roma, Bestetti e Tuminelli, 1930). L’opera illustrata da 31 tavole a colori è in vendita per € 480. Fondamentale per l’architettura funzionale è l’edizione di Alberto Carpigiana, le Spezie finissime, l’Aloe polverizzazione, il Lucido da Scarpe, lo Sciroppo Alchermes e quello di accodio e di rattania, l’Acquavite Aniciata, la Tintura di Anici Romagna, il Rinfresco di mandorle amare, le Pillole Blanchard, la Tintura di China, l’Unguento rosato, l’Estratto di Belladonna, il Cerotto di S. Caterina, le Polvere del Frassoni, l’Unguento di Ginepro, l’Unguento egiziano, il Vino di china composto, i Cioccolatini purgativi, e lo Sciroppo di cicoria e rabarbaro (€ 280). Libreria antiquaria Paolo Bongiorno Via Lana 71 – 41124 Modena (www.bongiornolibri.it/Libreria_Paolo_Bo ngiorno/LIbreria_Bongiorno.html) ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano IL CATALOGO DEI MODERNI Libri da leggere per comprare libri di matteo noja GIRO D’ITALIA IN 500 LIBRI (CIRCA) La rete ha questo vantaggio: che si parte cercando una cosa e si torna con un’altra. Cercavamo infatti cataloghi di libri del Novecento e invece torniamo con un catalogo di storia locale che in gran parte ha libri usciti a cavallo tra Otto e Novecento. Ma non ce ne voglia nessuno: la storia locale è una passione difficile da sopire. Regione per regione il catalogo dal titolo Italiamia racconta, anche se sommariamente, 467 libri e 16 incisioni, rigorosamente divisi per regione, e all’interno della regione per località. Vale la pena di scorrerne le pagine: sicuramente ognuno troverà quanto gli serve per appagare le sue curiosità sopra la propria città o regione. Citiamo solo il primo numero del catalogo anche perché ci permette di ricordare un bibliografo molto noto, Alberto Bacchi della Lega (1848-1924). Riguarda l’importante Bibliografia dei vocabolari ne’ dialetti italiani raccolti e posseduti da Gaetano Romagnoli, edito a Bologna dal Romagnoli stesso nel 1876 (in 8º, p. 96; € 185). Bacchi della Lega, personaggio della Bologna di fine Ottocento, fu amico intimo e assiduo collaboratore di Carducci (anche per la Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli, edita dal Romagnoli), che storpiandogli il nome, lo chiamava Bacchilide, e amicissimo di Olindo Guerrini che lo fece bersaglio di molte delle sue numerose e, a volte, crudeli burle. Negli Aneddoti bolognesi, a cura di Alfredo Testoni e Oreste Trebbi (Formiggini, 1929; presente in Biblio- teca), viene narrato di quando Guerrini, dovendo partecipare a una tournée con una compagnia drammatica, si fece prestare il vestito da cerimonia dal Bacchi. Essendo di lui molto più magro, lo fece accomodare da un sarto. Finita la tournée lo restituì all’amico senza far menzione della correzione. Quando vi furono le feste per l’VIII centenario dell’Università di Bologna, a cui presenziava il re, Bacchi pensò bene di indossare il suo vestito elegante, ma si accorse troppo tardi che era tanto stretto, e «fu costretto ad assistere all’arrivo del Sovrano con un abito così lontano dalle regole dell’etichetta che gli rese più acerbo il cruccio per la burla patita». Studio Bibliografico SCRIPTORIUM Via Valsesia, 4 46100 Mantova (Italy) Tel./Fax +39 0376 363774 [email protected] FERDINANDO ONGANIA, EDITORE VENEZIANO Il sito di una libreria veneziana, linead’acqua, preannunciandoci un catalogo che non c’è, ci induce però a parlare di colui che è stato forse il più grande editore veneziano tra Otto e Novecento: Ferdinando Ongania (1842-1911). La sua figura, pressoché sconosciuta al di fuori di un ristretto gruppo di bibliofili e studiosi, è stata solo recentemente studia- 35 ta in maniera approfondita da Mariachiara Mazzariol (Ferdinando Ongania 18421911 editore in Venezia. Catalogo, stampato nella città lagunare proprio da lineadacqua edizioni con la Fondazione QueriniStampalia, nel 2011). Il nome di Ongania è senza dubbio legato all’importante opera La Basilica di San Marco in Venezia (1877-1888), «primo grande censimento iconografico del monumento marciano realizzato attraverso il “nuovo” mezzo fotografico, di cui egli fu coraggioso “mecenate”». Come pure colpiscono i suoi due album fotografici, Calli e canali in Venezia e Calli, canali e isole della laguna, pubblicati nel 1891 e nel 1893, straordinario documento della città di fine Ottocento (la libreria ricorda una propria edizione in facsimile del 2010, in tiratura limitata di 250 copie, stampata con la tecnica del retino stocastico). Ongania iniziò la sua attività rilevando nel 1871 la ditta Hermann Frederich e M. Münster, il cui negozio in piazza San Marco, sotto le Procuratie ai numeri 7274, era annoverato fra le più importanti e fornite librerie d’arte veneziane. Il suo catalogo era ricco di numerosi altri titoli, la maggior parte dei quali eccellenti prodotti dell’arte tipografica, omaggio alle molteplici glorie della Serenissima Repubblica. L’impegno e il coraggio imprenditoriale di quest’uomo, che non esitò a dissestare le proprie finanze pur di portare a termine i suoi ambiziosissimi progetti, non trovò allora e non ha trovato a lungo il giusto riconoscimento. linea d’acqua libreria antiquaria Calle della Mandola - San Marco 3717/d 30124 Venezia tel. +39 041 5232571 (retail) fax. +39 041 2413550 www.lineadacqua.it [email protected] 36 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 37 look! r u o y r o l o C look! TTutti utti i dir diritti itti sono riservati riser vati ai rispettivi rispettivi proprietari. proprietari. ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano Un mondo di divertimento. er timento. gr gruppopreziosi.it uppopreziosi.it rreziosi.it 38 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 PAGINE CHE PARLANO DI LIBRI Dall’utopia della poesia alla poesia degli archivi culturali: viaggio in due libri di matteo noja IL DELIRIO RAGIONATO DI UN POETA MANAGER on smettete di delirare, questo è il momento dell’utopia» Per Antonio Porta, al secolo Leo Paolazzi, tutta la vita fu il momento dell’utopia. Non smise mai di delirare nel senso che per lui la letteratura, la poesia soprattutto, era il luogo del delirio. Un delirio ragionato, apassionato, amoroso. Ne è testimonianza questo libro, «Mettersi a bottega» Antonio Porta e I mestieri della letteratura, edito dalle meritevoli Edizioni di Storia e Letteratura e che raccoglie gli atti di un convegno a cura dell’Università degli Studi di Milano, tenuto il 10 dicembre 2009. Per meglio delirare si era trovato uno pseudonimo che lo riportava allo charmant Carline per poter scrivere liberamente e che, al contempo, gli permetteva con il suo nome di applicarsi seriamente all’editoria e al giornalismo. In questo, seguendo il padre Pietro che, con Edilio Rusconi, aveva fondato nella seconda metà degli anni Cinquanta a Milano la casa editrice Rusconi e Paolazzi. Lavorando con testate come Gente, Eva, Rakam, persino il Corriere dello Sport – che riuscì personalmente a resuscitare e a salvare dalla chiusura – Leo/Antonio diede grande prova di doti manageriali. Fino ad arrivare alla direzione editoriale della Bompiani prima e della Feltrinelli poi. Doti manageriali che in pari misura applicava alla letteratura nel promuovere «N generosamente, a volte addirittura creare, giovani autori, lanciandoli nelle patrie lettere. Tutto senza perdere di vista la ricerca – che in letteratura e in poesia ha valore scientifico tanto quanto nella fisica nucleare – e le avanguardie, operando come segretario di redazione de “Il Verri” di Luciano Anceschi e entrando nel manipolo di poeti che sconvolgeranno la nostra letteratura con un libro edito proprio dalla Rusconi e Paolazzi, dal titolo apocalittico, I Novissimi. Di Apocalisse in Apocalisse, questo sarà un libretto che con la sua diffusione e successo provocherà nel convegno all’hotel Zagarella di Palermo la nascita del Gruppo ’63, una delle ultime valide espressioni dell’avanguardia in Italia. I saggi di «Mettersi a bottega», a cura di Alessandro Terreni e Gianni Turchetta, permettono oggi di addentrarsi nella poesia e nelle attività di Antonio/Leo con maggiore cognizione di causa. Da Umberto Eco che ci illustra la tecnica delle liste e il conseguente ritmo musicale che esse provocano nella poesia in generale da Omero in poi e, in particolare, nei versi dell’amico Antonio, a Enrico Testa che spiega come la forte tensione espressionistica che si può ravvisare nella poesia portiana derivi molto spesso dalla scelta di avvalersi di un “lessico comune non letterario”, dal suo “codice di comunicazione usuale”; da Niva Lorenzini che spiega l’insorgente neccesità per Antonio Porta di usare una ancora più marcata colloquialità per giungere alla fine a una poesia come diario, a Paolo Giovannetti che ci ricorda quanto sia stata importante per un’intera generazione l’antologia Poesia degli anni Settanta, dalla quale emersero molte giovani voci che altrimenti avrebbero faticato a trovare spazio. Non fu certo quello l’unico luogo, essendo quel periodo – il “decennio lungo del secolo breve” – fecondo di antologie poetiche, ma fu senza dubbio tra i più significativi. Maria Carla Papini e Stefano Raimondi, da diversi punti, si introducono in profondità nei versi e nelle opere di Porta, così come Terreni si interroga circa la retorica portiana. Giancarlo Majorino, sodale di tanti anni e di tante battaglie poetiche, affronta il libro più ricco della sterminata produzione portiana, quel Quanto ho da dirvi che nel 1977 raccoglieva la prima parte dell’opera di Porta, edita e inedita. Infine Carlo Formenti narra dell’avventura di “Alfabeta”, rivista simbolo della letteratura degli anni Ottanta, alla quale Porta partecipò attivamente accanto a Mario Spinella, Paolo Volponi, Gianni Sassi, Gino di Maggio, Nanni Balestrini, Leonetti, Pier Aldo Rovatti; e Maurizio Cucchi, che nella sua amicizia non ha mai potuto fare distinzioni tra Leo e Antonio, defindendolo uomo di “straordinaria coerenza”, lo ricorda come uno degli ultimi esempi di manager editoriale, dove le due accezioni messe accanto – quella di manager e quella di editoriale – non stridono come ora, che i manager “non distinguono la marmellata dai libri”. In chiusura un saluto, poche parole, di una persona che fu compagna ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano di Antonio Porta, Rosemary Liedl Porta: è soprattutto grazie a lei che la figura di quest’uomo gentile e generoso, di questo intellettuale onesto e rigoroso, non è stata dimenticata o, peggio, stereotipata in luoghi comuni. “«Mettersi a bottega». Antonio Porta e i mestieri della letteratura”. A cura di Alessandro Terreni e Gianni Turchetta. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2012, p.128, € 23,00 L’APPASSIONANTE MONDO DEGLI ARCHIVI CULTURALI olto spesso, nelle biblioteche, si cerca di parlare dei libri che ci circondano, delle carte che ci avviluppano nelle loro volute, dei documenti che ci attraggono per la loro finta oggettività; molto spesso sperimentiamo la difficoltà di farlo, anche perché, le raccolte stesse che inglobano un dato fondo specifico, lo perdono dentro di sé, cambiandone la natura, in un gioco infinito di specchi, diventando a ogni passo una cosa diversa da quella che era poco prima. Comprendiamo quindi l’imbarazzo di Lodovica Braida e Alberto Cadioli nel presentare questo quinto Quaderno di Apice, intitolato Collezionismo librario e biblioteche d’autore. Viaggio negli archivi culturali. La mancanza di omogeneità degli archivi che raccolgono documenti estremamente diversi tra loro; la presenza al loro interno di libri che diventano altro da sé in relazione a chi li ha collezionati e in qualche modo li ha alterati anche solo con la propria scelta (come ebbe a dire Luigi Crocetti «per il solo fatto di appartenere a una biblioteca personale – che sia di uno scrittore, di un collezionista o di un homme de lettres – i libri cambiano status, “da pubblicazioni a documenti personali anch’essi, carte M anch’essi”»); tutto ciò fa sì che sia difficile spiegarli e illustrarli. Da questa difficoltà l’esigenza, da parte dei curatori, di dedicare questo Quaderno ad alcune importanti biblioteche presenti in Apice – Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale, emanazione dell’Università Statale di Milano – nel tentativo non solo di farli conoscere nella loro consistenza, ma anche di inserirli in un progetto scientifico che ora appare più chiaro e riconoscibile. Il primo degli otto saggi che compongo il Quaderno, è di Andrea Carlino e riguarda Il mondo delle donne nella biblioteca del ginecologo Emilio Alfieri. Tra bibliofilia e bibliomania. Breve excursus di una delle prime biblioteche acquistate dall’Università Statale e che bene può documentare le varie motivazioni che hanno spinto il celebre ostetrico e ginecologo Emilio Alfieri (1874-1949) a comporre la sua raccolta: l’accumulazione per uso professionale, la bibliofilia e la bibliomania. Il secondo e il terzo saggio sono dedicati ad Antonello Gerbi (1904-1976) e alla sua biblioteca, nella sua particolare predilezione per ciò che riguardava il Sud America (a cura di Emilia Perassi) e nella sua interezza (a cura del figlio di Antonello, Sergio Gerbi). Valga a ricordo di questa biblioteca – ma forse di tutte – il ricordo affettuoso che ne lasciò Raffaele Mattioli (che dei libri e della conseguente follia se ne intendeva): «La sua biblioteca privata, sempre in disordine, sia perché continuamente riordinata e rimaneggiata, sia perché i libri arrivavano a ondate, in serie, in collane intere, era prima e più che uno strumento di lavoro, un baluardo contro il mondo e le miserie del mondo. Che i libri raccolti fossero 20, 30 o 50 mila, com’è stato scritto, non importa niente. Chi ama i libri non li conta. Un opuscolo di otto pagine e la corrispondenza di 39 Voltaire in cento e tanti volumi, hanno lo stesso valore ideale. Ogni “pezzo” ha il valore, ed è il riassunto emblematico di tutta la biblioteca. Ognuno rappresenta un desiderio, un attimo di vita, un proposito di nuove fatiche». I saggi di Edoardo Esposito ed Elisa Gambaro ci introducono a una delle più belle raccolte conosciute di prime edizioni del ’900, che nei suoi 1700 volumi circa delinea una sorte di canone estetico, soprattutto per quello che riguarda la prosa, della nostra letteratura tra le due guerre. Marta Sironi ci accompagna invece in un mondo immaginifico, fatto delle figure che hanno illustrato le testate delle cinquecento riviste che ha raccolto Piero Marengo e che oggi sono custodite in Apice: dalla figura legnosa e smilza del primo Pinocchio nel “Giornale per i Bambini” del 1882 alla parodia che il “Bertoldo” fece dell’“Omnibus” longanesiano, imitandone la prima pagina e titolandola “Autobus”. Il penultimo saggio, di Nicoletta Vallorani, riguarda infine la magnifica raccolta di libri per bambini che mise insieme Peter A. Wick, bibliotecario all’università di Harvard. Da ultimo, mentre i precedenti saggi sono stati tutti rivolti verso il passato, narrando di collezioni di libri già editi nei tempo che furono, quello di Goffredo Haus ci informa invece con dovizia di particolari di quanto offrano le nuove tecnologie per conservare meglio e meglio tramandare quel patrimonio che abbiamo la fortuna di custodire e quale sia il panorama che si delinea nel futuro per i nostri archivi e biblioteche. “Collezionismo librario e biblioteche d’autore. Viaggio negli archivi culturali.” A cura di Lodovica Braida e Alberto Cadioli. Skira, Milano 2012, p.109, € 25,00 LA TUA TV. SEMP PRE PIÙ GRANDE. 42 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 ANDANDO PER MOSTRE Spazi, moduli e figure: dall’ambiente primario alla geometria e alla luce di luca pietro nicoletti CARLO NANGERONI A BERGAMO uando torna da New York, dove è nato nel 1922, Carlo Nangeroni è un pittore informale, entrato in contatto con la Scuola del Pacifico prima ancora che si cominciasse a parlarne anche in Europa. Presto, però, la sua ricerca si sarebbe spostata in direzione di una sintesi Q cromo-luministica organizzata secondo schemi geometrici fissi ma di infinita variazione. Ne dà conto la mostra presso Colleoni proposte d'arte di Bergamo (dal 7 novembre al 22 dicembre), che riapre in spazi rinnovati con una nutrita personale del maestro. Attraverso una quarantina di opere scelte, infatti, viene offerta un suggestivo assieme delle ricerche del pittore intorno al tema del cerchio e CARLO NANGERONI COLLEONI PROPOSTE D’ARTE VIA C. BAIONI 19, BERGAMO 8 NOVEMBRE – 20 DICEMBRE 2012 TUTTI I GIORNI, ORARI: 9-12 e 15-19 INFO: TEL. +39 035 223300 propostedarte@colleoniroberto. [email protected] Sopra da sinistra: Carlo Nangeroni, Composizione, anni '80, acrilico su tela; Composizione, anni '90, acrilico su tela della sua raffigurazione. Il disco e il cerchio sono gli elementi base di una grammatica di variazioni infinita, entro la quale si enucleano precise serie di lavori che si interrogano, di volta in volta, su alcuni temi e schemi di base cui Nangeroni darà una continua e rinnovata vitalità, risolvendo di volta in volta i problemi della luce e del movimento (e della percezione visiva di conseguenza) all’interno di una struttura fissa, ma non inerte. Se nelle ricerche degli anni Sessanta il movimento a scorrimento era dato da raggruppamenti di dischi del medesimo colore secondo un percorso che si snoda sulla tela per indicazioni tonali (e vi ritornerà, con un nuovo approccio, dalla metà degli anni Novanta), negli anni Settanta e Ottanta il movimento dei dischi e delle righe verticali che percorrono la tela longitudinalmente come un fitto incannucciato, scorrendo le une sulle altre, sarà non solo sul piano ma anche in profondità, con effetti di avanzamento e arretramento delle singole sfere a seconda del tono e della scansione, ma anche per il suo intersecarsi con il motivo verticale. Nel prosieguo Nangeroni tornerà su un lavoro di tinte piatte e colori più accesi, lavorando su una tavolozza timbrica e con schemi più liberi, preoccupandosi meno del problema seriale. I dischi rimarranno ancora legati a uno schema di disposizione ortogonale, ma senza la necessità di dipingere materialmente tutta la serie per intero come in una vera e propria catena di montaggio: i dischi, ora, sembrano affiorare dal fondo in maniera polifonica, simultanea, come illuminazioni galleggianti ancorate in un punto preciso del quadro, ma che manifestano la loro presenza solo con una improvvisa apparizione. ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 43 IL CEMENTO DI MAURO STACCIOLI A sinistra: Mauro Staccioli, Condizione Barriera, 1971, ferro verniciato nero. Sotto: vista della mostra di Mauro Staccioli presso Mara Coccia a Roma ara Coccia Arte Contemporanea di Roma propone fino al 3 novembre una mostra di quindici opere in ferro e cemento dello scultore Mauro Staccioli, prendendo spunto dal recente volume dedicato da Bruno Corà all’artista e intitolato Gli anni di cemento 1968-1982 (Edizioni il Ponte, Firenze). In questo arco di tempo, l’opera di Staccioli segue una evoluzione tematica di progressiva chiarificazione di intenti e motivi. Nella materia dura e ruvida del cemento (ma di docile risposta alla colata in forme), infatti, l’artista ha messo a fuoco il proprio repertorio di forme primarie M votate, quasi per natura, a un rapporto dialettico con l’ambiente. «Pensare di fare scultura» annota Staccioli stesso, «significa costruirsi una forma: lavorare per costruire un linguaggio esplicito del pensiero organizzato e trasformare questa pratica in una forma tattile. Tattilità che deve sapersi sviluppare in una prassi riconoscibile; questa è stata la mia traccia, il mio modo per darmi una ragione esplicita del fare». E questa ragione esplicita, disadorna di compiacimenti formalistici e di tentazioni architettoniche, si chiarifica in rapporto CENTENARIO DI BRUNO CASSINARI DA CORRENTE el centenario della nascita, la fondazione “Corrente” di Milano propone fino al 30 ottobre, a cura di Anna Maria Bianconi e Nicoletta Colombo, un selezionato gruppo di opere di Bruno Cassinari (1912-1992), fra N le anime dell’omonimo gruppo e figura emblematica del picassismo del secondo dopoguerra. Vi si possono apprezzare undici dipinti e quattordici disegni provenienti da collezioni private, accompagnati da una scelta di documenti Sotto: Bruno Cassinari, La pesca con le lampare, 1953, cm 75x90, collezione privata d’archivio che evocano la storia del pittore, della sua adesione al movimento e dei suoi rapporti con Enrnesto Treccani, che a lui dedicherà alcune toccanti parole, in uno scritto del 1940: «Nei quadri di Cassinari la goccia di sangue viene alla luce. Nei quadri di Cassinari la goccia di sangue della sua terra si allarga, e già oggi ma sempre di più col tempo uomini diversi di molti paesi saranno aiutati a comprendere la propria fatica e a vivere meglio. Ora Cassinari lavora perché il suo cielo si spacchi, e non pesi più così forte sulla sua vita, come il cielo di Gropparello pesa sui vivi e sui morti del piccolo paese. In questo lo aiuteranno gli uomini, nemici e fratelli». allo spazio e all’intervento specifico sul luogo-ambiente. Nella loro arcaica, impenetrabile e solenne semplicità geometrica, infatti, le sue sculture marcano dei limiti nello spazio, delle soglie da superare, e creano dei percorsi del fruitore nell’ambiente circostante: non possono essere attraversate, anzi pongono dei limiti, come nel famoso “muro” per la Biennale di Venezia del 1978, o esaltano la sospensione del vuoto, come nel monumentale anello che accoglie oggi i visitatori della Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma. Sono operazioni concettuali attraverso la forma solida nel contesto. Ma anche in formati più contenuti, adatti agli spazi chiusi, i suoi ispidi cubi armati di aculei richiedono aria e silenzio: sono mute, dogmatiche e incombenti presenze pronte allo scontro. 44 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 ASTE, FIERE E MOSTRE-MERCATO Le aste autunnali con numerosi appuntamenti tra Italia, Francia, Germania e Inghilterra di annette popel pozzo WERTVOLLE BÜCHER UND HANDSCHRIFTEN, GEOGRAPHIE, REISEN, ATLANTEN, CHINA UND JAPAN, ALTE UND NEUE KUNST Asta dal 30 ottobre al 2 novembre Königstein im Taunus www.reiss-sohn.de Scegliere qualche titolo nei cinque cataloghi dell’asta autunnale di Reiss & Sohn per una breve presentazione in questa sede non è compito facile, considerando la ricchezza delle opere offerte. Particolarmente importante è l’Etymologicum magnum Graecum, uscito dai torchi di Zaccaria Calliergi a Roma il 8 luglio del 1499, battuto in asta l’ultima volta vent’anni fa. Si tratta della prima edizione del primo dizionario completamente stampato in caratteri greci e primo libro uscito dall’officina di Calliergi. La copia in asta (lotto 1393), a pieni margini (425x295 mm) in una legatura in piena pergamena cinquecentesca, parte con una stima di € 10.000. Un catalogo a sé forma la collezione asiatica sulla Cina e sul Giappone contenente quasi cento lotti. Particolarmente rara è la princeps delle Relationi della venuta degli ambasciatori giaponesi à Roma, sino alla partita di Lisbona di Guido Gualtieri del 1586 (lotto 2818, stima €12.000 in legatura moderna in pergamena). “L’incontro con la giovane ambasceria nipponica offre al G. il destro per ripercorrere la storia delle relazioni intrattenute dai pontefici romani, tramite l’Ordine gesuitico, con l’Estremo Oriente e soprattutto di superare un punto di vista esclusivamente occidentale anche se non esente da una certa idealizzazione” (DBI 60, p. 208). VENTE LIVRES ANCIENS ET DU XIXÈME SIÈCLE Asta del 31 ottobre Parigi www.alde.fr Tra i 325 lotti segnaliamo la prima edizione postuma del trattato gastronomico Il Trinciante di Vincenzo Cervio (Venezia, Tramezzino, 1581). Contiene tra l’altro “Il modo che si deve tenere in ricevere un Papa, un Re, e ogn’altro gran Principe tanto dalle Comunità, quanto dalli Signori particolari” con particolare attenzione a un protocollo da seguire (lotto 38, stima € 1.500-2.000). WERTVOLLE BÜCHER, MANUSKRIPTE, AUTOGRAPHEN, GRAPHIK Asta dal 5 al 7 novembre Monaco di Baviera www.hartung-hartung.de In asta la seconda rarissima edizione di Tycho Brahes, Astronomiae instavratae progymnasmata del 1603, censita al mondo in soltanto sette esemplari (lotto 239, stima € 80.000). La copia in offerta reca numerose annotazioni manoscritte in mano simile a quella di Giovanni Keplero. ASTA 60: HANDSCHRIFTEN & BÜCHER Asta dal 7 al 9 novembre Monaco di Baviera www.zisska.de Da Zisska la prima edizione del cimelio della teologia mistica medievale con il trattato Sermones super Cantica canticorum di Bernardo di Chiaravalle (Rostock, Fratres Domus Horti Viridis ad S. Michaelem, 1481; lotto 84, stima € 18.000). Attualmente nessuna copia viene censita in Italia. TRAVEL, ATLASES, MAPS & NATURAL HISTORY Asta del 15 novembre Londra www.sothebys.com LIBRI & STAMPE DAL XVI AL XXI SECOLO Asta dal 15 al 17 novembre Firenze www.gonnelli.it WERTVOLLE BÜCHER Asta dal 19 al 20 novembre Amburgo www.kettererkunst.de Segnaliamo la prima edizione completa in 3 volumi della rivista Genius a cura di Heise e Mardersteig, pubblicata dal 1919 al 1921 a Monaco di Baviera da Wolff (lotto 411100056, stima € 1.200). “Genius became one of the most scholarly and attractive art journals of the time” (Reed). In asta inoltre l’edizione dell’Opera di Lattanzio nella stimata pubblicazione di Vindelino da Spira del 1472 (lotto 411200708, stima € 18.000). L’esemplare (325x235 mm) contenente nove iniziali miniate in rosso, blu, verde e giallo e una rubricazione in rosso e blu, si presenta in legatura ottocentesca proveniente da Ampleforth Abbey. la Biblioteca di via Senato 45 Milano Questo “bollettino” mensile è distribuito gratuitamente presso la sede della Biblioteca in via Senato 14 a Milano. Chi volesse riceverlo al proprio domicilio, può farne richiesta rimborsando solamente le spese postali di 20 euro per l’invio dei 10 numeri MODALITÀ DI PAGAMENTO: • Inviare la scheda di abbonamento sottostante, unitamente a un assegno bancario intestato a “Fondazione Biblioteca di via Senato” • Pagamento in contanti presso la nostra sede: Fondazione Biblioteca di via Senato, via Senato 14, Milano Nome Cognome indirizzo a cui si intende ricevere la rivista Milano la Biblioteca di via Senato giu- telefono mail firma consento che i miei dati personali siano trasmessi ad altre aziende di vostra fiducia per inviarmi vantaggiose offerte commerciali (Legge 675/96) Barri la casella se intende rinunciare a queste opportunità 46 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 BvS: Fondo Edizioni di pregio “Smens pagine & figure” di una rivista artigianale La Nuova Xilografia di Verna e Schialvino tra semen e mens ARIANNA CALÒ “Smens pagine & figure”, semestrale di Nuova Xilografia; undici numeri stampati su torchi a braccia Fag e Saroglia con caratteri Garamond e Garaldus (nn. III e IV su carta GardaPat 13 prodotta dalle Cartiere del Garda, nn. V-XI su carta di cotone delle cartiere Magnani di Pescia). Esemplare n. 234/270; XI volume: esemplare 51/100. «S mens? Non è un acronimo, ma una parola che corteggia la “S”. La corteggia per amore della linea curva, sensuale nel significato di dar senso alla vita, e perché ricorda il lavoro di sgorbia sopra le tavolette di bosso e di pero. Forse è anche un verbo con il solo tempo presente, che accetta tutte le persone (io smens, tu smens… noi, voi, loro smens)». Sotto l’egida di una gazza ladra bianca e nera, monogama e ciarliera, “Smens” usciva con il suo primo numero nell’agosto del 1997, licenziata a Rivarolo Torinese dal torchio a braccia di Gianni Verna (n. 1942) e Gianfranco Schialvino (n. 1948), artisti xilografi fondatori nel 1987 dell’associazione Nuova Xilografia. Contro la prassi consolidata della produzione editoriale, “Smens” si Sopra: xilografia di Francesco Franco per il componimento di Nico Orengo, “Smens” VI. Nella pagina accanto: Incontro al destino, xilografia di Garrick Palmer in “Smens” VIII proponeva una missione programmaticamente donchisciottesca, ma orgogliosa: combattere il lento abbandono dell’uso della xilografia proponendola in un ritorno all’antica funzione originaria, quella che la voleva a corredo iconografico del testo scritto, a supporto ed esemplificazione della parola. «Questo inten- de essere SMENS: temi liberamente svolti da critici, filosofi, poeti, scienziati, scrittori, studiosi, illustrati con figure incise su matrici di legno e ricondotti, senza limiti di fantasia, nel solo ambito, concluso, dell’estetica della pagina»; autori e artisti sono stati chiamati a raccolta da Verna e Schialvino (“operativo cenacolo a due”, li chiamava Angelo Dragone) a dibattere sull’incontro tra due valori opposti, scelti a definizione di ogni singola uscita: bianco e nero, bene e male, verità e menzogna, sacro e profano e così via. I primi numeri, raccontano i protagonisti, sono dettati dallo stupore per l’invito a partecipare a un’idea visionaria e bizzarra; poi, allo stupore si sostituisce l’entusiasmo e la lista dei collaboratori che aderiscono a “Smens” si allunga e accresce per quantità e prestigio. Le xilografie, dapprima a carico quasi esclusivo di Verna e Schialvino, sono firmate dai più abili incisori di tutto il mondo, così come di alta levatura è la lista degli scrittori che contribuiscono inviando i propri brani originali e inediti. Con il rodaggio dei primi numeri, la qualità di questa rivista artigianale iniziava a perfezionarsi: a partire dal terzo numero si decise per l’inseri- ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano mento della tinta rosso minio, usata dai tipografi rinascimentali per spezzare il rigore della pagina monocromatica, poi l’apertura al colore è totale: nel numero che inaugurava il terzo anno di attività si annunciavano novità importanti, come le tinte personalizzate per ogni incisione, o l’uso, su consiglio di Enrico Tallone, di due varianti di inchiostro nero per il testo e le figure, o ancora l’introduzione della più nobile carta a mano delle cartiere Magnani di Pescia. Nel 2002, dopo cinque anni di attività, mostre e presentazioni in Europa, richieste di adesioni da vari paesi nel mondo, il decimo numero semestrale si apriva con la dichiarazione di nuovi e rinnovati progetti: cadeva il tema degli opposti, sostituito da argomenti monografici di valenza universale; le uscite programmate a cadenza annuale. Fu raddoppiato il numero delle pagine ma ridotta la tiratura da 270 a 100 esemplari, e bene fece la Bibliothèque Nationale de France a richiedere la rivista per catalogarla nella sezione dei libri rari. Al piano quinquennale fece seguito un solo e ultimo numero, l’undicesimo, dedicato alla Follia, stampato nel 2004 con l’espresso ringraziamento al Signore per aver finito. Finiva “Smens”, e con essa il visionario esperimento che, diceva Schialvino, aveva «riunito un grande numero di artisti, quasi un centinaio, e fatti cimentare con la xilografia, arte meravigliosa e antica, semplice e attuale, classica e rivoluzionaria. Insieme nella volontà di essere artisti, di parlare liberamente di poesia, mirare al bello, cercare un ideale da realizzare, e vivere con la consapevolezza di poterlo raggiungere». Esperimento che però era riuscito in tempi di avanguardie virtuali e digitali a creare una rivista che «odora di nerofumo, di piombo, di legno di bosso e di pero» (“Smens”, I). Don Chisciotte ogni tanto vince. 47 SPOGLIO RIVISTA I. Bianco e Nero (finito di stampare il 25 agosto 1997, ultimo quarto di Luna): Il rigore dei valori, Angelo Dragone; Eppure nera, di Guido Ceronetti; Triste, solitario y final di Nico Orengo; Candidus, albus, niger, ater di 48 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Da sinistra: xilografia di Gianni Verna per La Mantide, di Paola Pallottino, “Smens” V; Triste, solitario y final, xilografia di Gianni Verna a corredo del testo di Nico Orengo, “Smens” I; a destra: Discordia, xilografia di Gian Luigi Uboldi in “Smens” IX Federico Zeri; Monte Bianco, Monte Nero di Renato Romanelli; Il buio e il miele di Bruno Quaranta; Commento di Corrado Collin alla Gazza di Puskin; Al di là della verità unica di Remo Palmirani; Tra luce ed ombra di Mario Baudino; Scacchiera, di Ferruccio Pezzuto; Giocare alla guerra, di Roberto Carretta. Copertina di Schialvino, pubblicità della Filatura Botto Poala, Biella, incisa da Verna. Nei risvolti di copertina xilografie di Remo Wolf su legni di filo, e di Jean-Marcel Bertrand su legno di testa. II. Bene e Male (finito di stampare il 25 febbraio 1998, mercoledì delle Ceneri): Una stessa radice, di Angelo Dragone; Un bene amorale di Guido Ceronetti; Il corno opposto, Renato Romanelli; Il mistero del male, di Gianfranco Ravasi; Una momentanea imperfezione, di Vittorio Sgarbi; Il vertice supremo, di Elémire Zolla; E poi dall’ombra, di Nico Orengo; Una giustizia troppo lontana, di Elena Loewenthal; Malgrado quelle talpe, Roberto Sanesi; La via massonica, Remo Palmirani; Un matricidio, Roberto Carretta. In copertina xilografia di Verna; pubblicità del Maglificio Boglietti, Ponderano (Biella) incisa da Schialvino; nei risvolti di copertina xilografie di Francesco Tabusso e Roy Wood. III. Verità e menzogna (finito di stampare il 2 agosto 1998, nel mezzo del cammin di nostra vita): Sì se sì, se no sì di Giorgio Calcagno; Monssù Nietsche di Guido Ceronetti; Falsi d’Autore di Angelo Dragone; Danza con ventagli di Igor Man; Ego sum Veritas di Enzo Bianchi; Proiettati nella finzione di Bruno Quaranta; I Pinocchi degli archivi di Keith Botsford; Il postino G. di Paolo Bellini; Costruirsi il vero di Remo Palmirani; Darsela a bere di Renzo Barsacchi; Il campione di Renato Romanelli. Copertina di Schialvino; pubblicità di IB Italcart, Torino, incisa da Verna; nei risvolti di copertina: xilografia su legni di testa di Eugenij Bortnikov e linoleumgrafia di Giacomo Soffiantino. IV. Natura e cultura (finito di stampare il 21 marzo 1999 mentre lieve arriva la primavera): Una natura culturale di Adriana Zarri; Percezione ed espressione di Angelo Dragone; Philastroca Bagnae Caudae di Guido Ceronetti; Un eroe di terza classe di Remo Palmirani; Danza con ventagli di Igor Man (seconda parte); Il mito dei boschi di Mario Rigoni Stern; Troppa luce di Piero Biannucci; Coriandoli di Silvie Turner; Alla luna, Giacomo Leopardi con il Commento di Lorenzo ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 49 Da sinistra: DNA, xilografia su legno di testa di Simon Brett, “Smens” IV; Gianfranco Schialvino sul testo Monssù Nietzsche di Guido Ceronetti, “Smens” IV Mondo; Artificio e Natura di Nico Orengo; Una storia pelosa di Renato Romanelli. Copertina di Gianni Verna, Pubblicità di SATIZ spa incisa da Schialvino. Nei risvolti di copertina xilografie su legno di testa di Simon Brett e Francesco Franco. V. Sacro e profano (finito di stampare il 10 agosto 1999 mentre dal cielo cadono le stelle): Le misure del tempo di Elena Loewenthal; Campane, Nico Orengo; Santi senza Dio, Gianfranco Ravasi; A turiboli spenti di Guido Ceronetti; Il boccone del prete di Paolo Brunati; Per specula in aenigmatedi Michele Sovente; Con il falcetto d’oro di Mario Rigoni Stern; Girotondo di Bruno Quaranta; La mantide di Paola Pallottino; Lucri bonus odor di Remo Palmirani; Il senso dell’esistere di Angelo Mistrangelo; Una festa proibita di Roberto Carretta. Un disegno di Gianni Chiostri, copertina di Gianfranco Schialvino; xilografie di Leonard Baskin, Fernando Eandi, Francesco Franco, Marcello Guasti, Suzanne Reid, Piero Ruggeri, Gianfranco Schialvino, Gianni Verna. VI. Panem et circenses (finito di stampare l’11 febbraio 2000 sotto il volubile segno dell’Acquario): Almeno… di Alberto Si- nigaglia; The harbors of the moon di Norman Mailer, con traduzione di Nico Orengo; Nell’aria di Nico Orengo; Quiero di Pierre Louys; Musica lenta di Manuel Scorza; Il progetto Erode di Remo Palmirani; Nei giornali, Guido Ceronetti; A little red apple di Keith Botsford; La palla di Nausicaa, Bruno Quaranta; Edward mani di forbice di Luca Ragagnin. Copertina di Verna; xilografie di Sergio Agosti, Marina Bindella, Costante Costantini, Francesco Franco, Lea Gyarmati, Osvaldo Jalil, Raffaello Margheri, Giulia Napoleone, Gianni Verna, Elisabetta Viarengo Miniotti; pubblicità di Oasi Zegna incisa da Gianni Verna. VII. Sogno e realtà (finito di stampare il 29 settembre 2000 mentre nei tini canavesani fermenta l’erbaluce): Vogliono farci sognare, Alberto Sinigaglia; Per non dormire, Bruno Quaranta; They call it «Grumus Merdae», Alan Dugan; Pecore e Camomilla, Remo Palmirani; Cerchi concentrici di Adriana Zarri; La fabbrica del senso, Luca Ragagnin; Abbozzo, Mehmet Gayuk; Distanza, Stefano Delprete; Fu un sogno, Nico Orengo; L’anima di cartone, Paolo Brunati; Intridere le memorie, Vincenzo Gatti; Fantasmi, Roberto Carretta; Rossetto e Zainetto di Piero Soria. Xilografie di Mauro Baudino, Marina Bindella, Francesco Franco, Ugo Giletta, Ezio Gribaudo, Peter Lazarov, Bruno Missieri, Giulia Napoleone, Guido Navaretti, Alberto Rocco, Verna, Schialvino e Elisabetta Viarengo Miniotti; copertina di Schialvino, pubblicità di Regione Piemonte incisa da Gianni Verna. VIII. Volontà e destino (finito di stampare l’8 aprile 2001, domenica delle palme e di passione): La forza del destino, Alberto Sinigaglia; I dadi che corrono, Bruno Quaranta; Destino, Nico Orengo; 18 giugno 1815 (Ultimi versi su Napoleone) di Guido Ceronetti; La poetessa, Elena Varvello; Ubi Eva atzorai di Janus (tratto da Le repos du Diable, 1960); Fine di Marek, Giorgio Luzzi; La fin des temps di Paul Chanel Malenfant; Voluptas di Irving Feldman; Correre a Samarcanda, Angelo Dragone; Togetherness di Norman Mailer, Utz, Remo Palmirani. Vetrina della silografia storica italiana: Un linoleum di Felice Casorati, di Paolo Bellini. Xilografie di Nino Aimone, Jacques Benoit, Eugenij Bortnikov, Costante Costantini, Francesco Franco, Renato Galbusera, Garrick Palmer, Mario Gosso, Ezio Gri- 50 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Sopra: xilografia di Gianfranco Schialvino a piena pagina a corredo di Danza con ventagli di Igor Man, “Smens” III. A sinistra: Renato Galbusera, Eroe, in “Smens” IV baudo, Peter Lazarov, Guido Navaretti, Lucio Passerini, Suzanne Reid, Schialvino, Giacomo Soffiantino, Gianni Verna. Copertina di Verna, pubblicità Regione Piemonte incisa da Schialvino. IX. Verba-Res (finito di stampare il 4 ottobre 2001, giorno dedicato a San Francesco che visse povero): Segnali di fumo, Bruno Quaranta; In memoriam: Donald Mark fall di Alan Dugan; Una sera a Badalucco, Nico Orengo; A birthday present, John Whitwort; Gli archetipi e la poesia: il silenzio come matrice di Elémire Zolla; Davar, Elena Loewenthal; Corsivi assassini, Alberto Sinigaglia; Et verbum caro factum est, Gianfranco Ravasi; Schermale, Guido Ceronetti; Parler, Philippe Jaccottet, Scivola la canoa, Mario Luzi. Xilografie di Marina Bindella, Eugenij Bortnikov, Francesco Casorati, Claudia Cipollini, Raul Dal Tio, Patrice Favreau, Gerard Gaudaen, Penelope Jencks, Ugo Maffi, Guido Navaretti, Ugo Nespolo, Andrea Ruja, Gianfranco Schialvino, Gian Luigi Uboldi, Remo Wolf. Contiene un inserto ideato, composto a mano e licenziato dai torchi di Tallone Editore in occasione del quinto centenario dei tipi corsivi. X. Alfa e Omega (finito di stampare il 13 dicembre 2002 con un anno di ritardo e così sia): La fine, Elena Loewenthal; Ottobre, Marco de Carolis; Aurora, Nico Orengo; Courting song: Attack! Attack! Attack! di Alan Dugan; Il graffito e lo sfregio, Bruno Quaranta; L’alfa e l’omega di un’arte di Enrico Tallone; Ideale, Guido Ceronetti; Ma resiste la speranza, Alberto Sinigaglia; Il ciglio dei ricordi, Sergio Pent; Marcel Proust e la fine del mondo di Anna Giubertoni; Melancholia di Pino Mantovani; Ulisse di Flavio Russo; Vetrina della silografia storica italiana: Una figura isolata in se stessa, di Gianfranco Schialvino. Xilografie di Eva Aulmann, Bortnikov, Felice Casorati, Girolamo Ciulla, Raul Dal Tio, Renato Galbusera, Ugo Giletta, Carlo Giuliano, Mario Gosso, Emanuele Luzzati, Raffaello Margheri, Barry Moser, Guido Navaretti, Schialvino, Togo, Gianni Verna; copertina di Verna. XI. La follia (finito di stampare il 31 agosto 2004 ringraziando il Signore di aver finalmente finito): Folies-Bergeres, Bruno Quaranta; Zigomo, Luca Ragagnin; L’amico, Vasco Are; Little do I understand di Ann Bond; La tredicesima moglie, Piero Soria; Helmholtz’s rhymes, variante inedita di Aldous Huxley; The voice, Robert Penn Warren; Fu un lampo, Nico Orengo; Unruhe, Roberto Carretta; In una stanza silenziosa, Alessandro Defilippi; Storie di ordinaria pazzia torinese, variante inedita di Massimo Mila; Sul ritrovamento di un atlante disegnato da un folle o sia XXI stanze e una parentesi circa il rapporto di costui con il segno e la parola di Paolo Brunati; Vetrina della xilografia storica italiana: xilografie di Fortunato Depero e Lorenzo Viani; Pastelli russi, di Alberto Sinigaglia; La follia fuori testo: xilografie di Claudia Cipollini, Marcello Guasti e Guido Giordano. Copertina di Fortunato Depero e xilografie di Ugo Nespolo, Simon Brett, Barry Moser, Eugenij Bortnikov, Suzanne Reid, Guido Navaretti, Elettra Metallinò, Costante Costantini, Renato Galbusera, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Carlo Giuliano, Francesco Casorati, Girolamo Ciulla, Riccardo Cordero, Giansisto Gasparini, Vladimir Nasedkin, Piero Ferroglia, Lorenzo Viani. ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 51 BvS: l’Ottocento Gaspero Barbèra (1818-1880): un editore risorgimentale L’impresa di Barbèra attraverso gli esemplari della BvS 1 BEATRICE PORCHERA «M io Padre fu editore per vocazione; cominciò come fattorino di una bottega di tessuti, viaggiò per conto di una fabbrica di panni, ma dopo un breve impegno in una libreria di Torino, impegno che può considerarsi una vigilia d’armi, venuto a Firenze presso un editore, volle che la sua vita fosse quella del produttore di libri, e in essa concentrò tutta la sua energia, non cercando guadagni al di fuori di essa, non distraendosene in modo alcuno, lasciandosi da essa interamente assorbire […]»,2 così il figlio Piero riassunse gli esordi dell’attività dell’editore risorgimentale Gaspero Barbèra (1818-1880). Nato a Torino il 12 gennaio 1818 da Pietro e Rosa Guerra, mercanti di stoffe, Gaspero ricevette una discreta istruzione. A quindici anni cominciò a lavorare in un negozio di tessuti, ma continuò a coltivare il proprio amore per la lettura. Lasciata la città natale si recò a Magadino, nel Canton Ticino, dove fu impiegato come commesso per uno spedizioniere. Rientrato a Torino si avvicinò al mondo della quali cominciò a frequentare il Gabinetto Vieusseux. Ritratto di Gasparo Barbèra all’antiporta del volume Memorie di un editore pubblicate dai figli, Firenze, Barbèra, 1883 produzione libraria lavorando presso il libraio Fiore. In seguito si trasferì a Firenze dove, grazie all’interessamento di Giuseppe Pomba, ottenne un posto presso l’editore milanese Paolo Fumagalli, stabilitosi nella città toscana da una decina d’anni. Rimase da Fumagalli per pochi mesi, durante i Dopo un’altra breve parentesi lavorativa a servizio del bibliofilo Malagoli-Vecchi, nell’autunno del 1841 Barbèra fu assunto dall’editore Felice Le Monnier. Collaborò con quest’ultimo per ben quattordici anni durante i quali accrebbe la propria cultura, strinse rapporti con molti importanti letterati del tempo e fece propria la concezione di libro maturata da Le Monnier: non oggetto di lusso, ma bene di pubblica utilità destinato ai ceti medi e alle classi popolari.3 Nel 1854 il sogno di Gaspero di aprire una propria stamperia divenne realtà: entrò in società nella tipografia dei fratelli Beniamino e Celestino Bianchi, sull’orlo del fallimento, e diede vita alla “Barbèra, Bianchi e Comp. tipografi editori” che fin da subito si propose di contribuire con la propria attività al «decoro delle italiane Lettere».4 Il primo volume pubblicato dalla casa editrice fu Il supplizio d’un Italiano in Corfù di Niccolò Tom- 52 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Da sinistra: frontespizio del Supplizio d’un italiano in Corfù di Niccolò Tommaseo, prima opera pubblicata dalla Barbèra, Bianchi e Comp. tipografi editori nel 1855; frontespizio dell’opera Spagna di Edmondo De Amicis (Barbèra, 1873) giunta nel 1904 alla dodicesima edizione. Nella pagina accanto, da sinistra: frontespizio dell’opuscolo Toscana e Austria stampato da Barbèra nel 1859, costatogli un sequestro e una perquisizione della stamperia; brossura originale dei Poeti erotici del secolo XVIII, opera curata nel 1868 da Giosue Carducci per la “Collezione diamante” maseo. Uscito nel 1855, il libro recava l’impresa della rosa con l’ape e il motto petrarchesco “non bramo altr’esca”, divenuti da quel momento in poi identificativi delle edizioni Barbèra. Il loro significato venne spiegato dal tipografo stesso così: «L’ape che si avvicina alla rosa indica abbastanza il mio proposito di trascegliere, nelle mie pubblica- zioni, le opere più pregiate e non andare a casaccio».5 Il testo di Tommaseo fu fatto precedere da una prefazione di Gaspero in cui si affermava la volontà di dare inizio, con quel volume, a «una Collezione di opere belle e utili».6 L’opera inaugurò la fortunata “Collezione gialla” che arrivò a pubblicare 170 titoli di classici e di scrittori risorgi- mentali. L’anno successivo nacque invece la “Collezione diamante” di cui Barbèra scrisse: «Partii per Parigi nell’aprile dell’anno 1856. Strada facendo ebbi agio di intrattenermi con un libraio di Torino, il quale mi suggerì di ristampare i quattro Poeti nell’edizioncina piccola del Passigli, che non si trovava- ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano no più, ed il Passigli non era più tipografo, condotto disgraziatamente in rovina dai suoi nipoti scialacquatori. Accettai il suggerimento del libraio di Torino, e lo estesi non solo ai quattro Poeti, ma ai più famosi Prosatori e Poeti antichi ed anche moderni. Così nacque la Collezione Diamante, che mi fruttò molti elogî e in pari tempo molti guadagni. Gli elogî si riferivano alla scelta delle opere stampate in quella, ed al modo col quale venivano stampate».7 “Diamante” era il nome impiegato per indicare uno dei più piccoli caratteri tipografici e fu così utilizzato per identificare, per estensione, un formato estremamente piccolo. La collana fu inaugurata dalla Divina commedia di Dante Alighieri, cui fecero seguito nel 1857 le Rime di Francesco Petrarca e La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.8 Un ruolo preminente nell’affermazione dell’impresa ebbe Giosue Carducci, che fece il suo esordio proprio curando per la “Diamante” le Satire e poesie minori di Vittorio Alfieri (1858). Numerosi furono i volumi della fortunata collana affidati «al giovine oscuro predestinato alla gloria»,9 tra i quali quelli di Monti, Parini, Tassoni, Lorenzo de’ Medici, Salvator Rosa, Gabriele Rossetti e Cino da Pistoia.10 Per tutta la sua durata la “Collezione diamante” si propose di «restituire alla cultura italiana fondamento e tradizione, diffondendo quegli autori sui quali si intendeva solidamente basare una cultura nazionale autorevole e unitaria».11 Le entrate finanziarie garantite dal successo della collana permisero a Barbèra, sempre alla ricerca di miglioramenti tecnici, di rinnovare la propria ditta dal punto di vista tecnologico. Tra il 1858 e il 1859 la tipografia fiorentina pubblicò la “Biblioteca civile dell’Italiano”, collezione di cui si fecero editori Cosimo Ridolfi, Bettino Ricasoli, Ubaldino Peruzzi, Tommaso Corsi, Leopoldo Cempini e Celestino Bianchi, e che ospitò al suo interno l’opuscolo Toscana e Austria: «Era scritto da Celestino Bianchi, ma ispirato dagli uomini suddetti, i quali sottoscrissero l’opuscolo, a fine di rendersi solidali tutti quanti dirimpetto alla legge sulla stampa, nel caso che il Governo volesse perseguitare un libro, che altro scopo non aveva che di propugnare l’indipendenza dello Stato, e di mostrare appunto i danni, che a questa indipendenza erano provenuti per la preponderanza dell’Austria in Italia e per la occupazione austriaca in toscana nel 1849 e negli anni successivi».12 Il libretto uscì il 22 marzo 1859, nonostante un precedente 53 sequestro e una perquisizione della stamperia nella notte del 17 marzo. Il 30 aprile 1860 la società di Gaspero Barbèra con i fratelli Bianchi si sciolse e la stamperia assunse la denominazione “Ditta G. Barbèra”. La linea editoriale tenuta fino a quel momento proseguì. Tra le significative pubblicazioni del periodo conservate presso la Biblioteca di via Senato l’opuscolo La Camorra. Notizie storiche raccolte e documentate di Marc Monnier (1862) e Agli elettori. Lettera di Massimo D’Azeglio (1865), «un vero e proprio catechismo del cittadino elettore in uno Stato costituzionale, e più specialmente in uno Stato in recentissima formazione, com’era allora il Regno d’Italia».13 Accanto ai testi di carattere politico e letterario, continuarono a trovare spazio quelli scolastici: 54 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 vocabolari, traduzioni, libri di storia, di geografia e non solo. All’interno della “Collezione scolastica”, nata nel 1856, fu ad esempio edita La divina commedia di Dante Alighieri col comento di Raffaele Andreoli (1870), definito «il più bel commento moderno che si avesse»;14 mentre nella “Nuova collezione scolastica”, iniziata nel 1867, uscirono nel 1868 le Prose scelte di Galileo Galilei a mostrare il metodo di lui, la dottrina, lo stile; ordinate e annotate ad uso delle scuole dal professore Augusto Conti deputato. Ritratto di Ludovico Ariosto all’antiporta dell’Orlando furioso apparso nel 1858 nella “Collezione diamante” ma edizione con circa 30.000 copie vendute. Nello stesso 1873 iniziò per Gaspero Barbèra, colpito da paralisi progressiva, un lento declino. Sempre più ostacolato nel proprio lavoro dalla malattia e sempre più pessimista nei confronti della situazione culturale ed editoriale italiana, il tenace tipografo torinese si spense a Firenze il 13 marzo 1880. L’eredità paterna venne raccolta dai figli Piero e Luigi che, alla morte di Gaspero, assunsero la direzione della casa editrice. Tra le pubblicazioni di maggior successo degli anni Settanta è invece da ricordare Spagna di Edmondo De Amicis che, uscita nel 1873, giunse nel 1904 alla dodicesi- NOTE 1 Ho ripercorso la storia dell’attività di Gaspero Barbèra basandomi su alcuni dei numerosi esemplari, recanti l’impresa della rosa con l’ape, conservati sugli scaffali della BvS. Seppur passibile di integrazioni, la cospicua presenza dei lavori del tipografo torinese presso la nostra Biblioteca sottolinea il ruolo di primo piano ricoperto da Barbèra nella storia dell’editoria italiana. 2 P. BARBÈRA, Quaderni di memorie stampati «ad usum Delphini», Firenze, Barbèra, 1921, p. 401. 3 Cfr. DBI 6, pp. 153-155. 4 G. BARBÈRA, Memorie di un editore 1818-1880, Firenze, Barbèra, 1954, p. 103. 5 Ibi, p. 114. 6 N. TOMMASEO, Il supplizio d’un Italiano in Corfù, Firenze, Barbèra, Bianchi e Comp. tipografi editori, 1855, p. V. 7 G. BARBÈRA, Memorie di un editore 1818-1880, p. 127. 8 La “Collezione diamante” è conservata per intero presso la BvS. Cfr. M. PARENTI, Una celebre collezioncina minuscola, in ID., Rarità bibliografiche dell’Ottocento. Materiali e pretesti per una storia della tipografia italiana nel secolo decimonono, vol. I, Firenze, Sansoni antiquariato, 1953, pp. 37-62. 9 Annali bibliografici e catalogo ragio- nato delle edizioni Barbèra, Bianchi e C., e di G. Barbèra; con elenco di libri, opuscoli e periodici stampati per commissione (18541880), Firenze, Barbèra, 1904, p. 26. 10 Cfr. M.M. CAPPELLINI, A. CECCONI, P.F. IACUZZI, La rosa dei Barbèra. Editori a Firenze dal Risorgimento ai Codici di Leonardo, a cura di C.I. Salviati, Firenze, Giunti, 2012, pp. 36-43. 11 Ibi, p. 37. 12 G. BARBÈRA, Memorie di un editore 1818-1880, p. 152. 13 Annali bibliografici…, p. 182. 14 Ibi , p. 301. ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 55 BvS: Emeroteca Il Don Pirlone giornale di caricature politiche La satira come libera manifestazione del pensiero nel 1848-49 VALENTINA CONTI «P resentandomi la prima volta a voi, lettori carissimi quanti siete e sarete, uomini e donne, d’ogni condizione, d’ogni età, d’ogni capacità, d’ogni colore, è troppo giusto che io vi dica come sono venuto al mondo giornalistico, perché mi chiami così, come la pensi. Sono venuto in luce perché m’hanno stampato, m’hanno stampato perché, dopo avermi scritto, m’hanno messo in torchio, m’hanno scritto perché ne hanno avuto voglia. La libertà individuale è garantita! (Vedi lo Statuto Fondamentale)».1 Così “Il Don Pirlone” si presentò ai suoi lettori venerdì 1 settembre 1848. Si trattava di un giornale satirico stampato quotidianamente, eccetto le feste, formato da 4 pagine con numerazione progressiva dal Caricatura apparsa su “Il Don Pirlone” del 14 dicembre 1848. Il Papa è ironicamente rappresentato con sembianze di un pappagallo in gabbia che ripete ciò che dice Pulcinella. Sul fondo è presente un rivoluzionario, riconoscibile dal berretto frigio, che regge un orologio e il fuoco per accendere un cannone primo numero in poi e venduto a Palazzo Bonaccorsi a Roma al costo di 2 bajocchi durante il periodo della rivoluzione del 1848-49. In quegli anni l’Europa era scossa da lotte liberali e nazionali e nella penisola italica l’elezione di Pio IX al soglio pontificio, datata 16 giugno 1846, aveva scatenato un grande entusiasmo tra i sudditi che videro nel nuovo Papa un loro possibile alleato nelle rivendicazioni democratiche, speranza che presto risultò vana. Tra il 1847 e il 1849 ci fu un notevole sviluppo del libero giornalismo d’opinione anche grazie allo Statuto Fondamentale, concesso da Pio IX il 14 marzo 1848, che concedeva a qualsiasi cittadino la possibilità di pubblicare, purché in possesso di determinati requisiti e soggetto alla supervisione di un direttore responsabile. Nacquero così diverse testate umoristico-satiriche, tra le quali una delle più famose fu proprio “Il Don Pirlone”, ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 57 Nella pagina accanto: “Il Don Pirlone giornale di caricature politiche”, Anno 1 N. 1. Logo del quotidiano dal 1 settembre 1848 al 21 marzo 1849. Qui a destra dall’alto: caricatura del 23 febbraio 1849 in cui è particolarmente evidente lo spirito anticlericale del giornale. Il Papa, con un cavolo al posto della testa, riscrive il Vangelo al contrario, mentre altri canonici giocano a palla col suo cranio. In ogni illustrazione riferita a Pio IX appare la scritta Gaeta per ricordare la fuga del Pontefice. presentato da Michelangelo Pinto (1818-1910), fondatore e direttore della testata, con queste parole: «Videro gli uomini coscienziosi e assennati la gravezza del male, e avvisarono prontamente al rimedio […] un giornale di caricature politiche, che per antinomia si chiamò “Il Don Pirlone”, surse all’uopo; stimatizzò colla sferza del ridicolo i volti simulati e bugiardi, e la maschera cadde. Fu breve lotta e mortale. Squarciato il misterioso velo, vide la plebe per la prima volta l’idolo senza la tunica protettrice, ne scorse i piedi d’argilla e coll’alito lo rovesciò dal piedistallo gemmato: i fulmini che scagliavano cadendo, si spuntarono contro il freddo sarcasmo, sì ch’ei restò senza prestigio e senz’armi. Sotto i ripetuti colpi del ridicolo caddero così gl’inveterati abusi, gli esosi privilegi, le false dottrine. […] E perché edotti dalla esperienza sappiamo qual profonda traccia lascino nell’anima umana gl’incancellabili colpi del ridicolo, prendemmo col titolo di “Don Pirlone” il pensiero e lo spirito della caricatura politica onde lovossi a popolare celebrità il giornale che portò in Roma un tal nome. Mentre per altro, secondati dall’opera di valenti artisti, miriamo nelle incisioni a percuotere con l’ironia e col sarcasmo il vizio, l’ipocrisia, la menzogna, la viltà, il tradimento, imprendiamo con gravi parola a svolgere le cause e gli effetti che provocarono e seguirono le sciagure e le glorie avvicendatesi in breve ora in Italia. Fedeli saranno sempre i racconti, dolorose spesso le riflessioni, severi talvolta i giudizi, ingiusti mai».2 La testata fu realizzata dalle penne dei giornalisti più liberali del quotidiano “L’Epoca” e divenne famosa sia per la sua satira dissacrante, sia per le grandi tavole silografate, presenti in ogni numero, che ironizzavano sui personaggi dell’epoca e sull’indecisione politica dei regnanti, sempre accompagnate da intollerante spirito anticlericale. A metà dell’Ottocento la caricatura divenne uno strumento di lotta politica; ma in Italia non è possibile annoverare nomi di grandi disegnatori come Daumier, Grandville e Cham «non già perché mancassero nobili artisti in quell’epoca, ma perché la società italiana non aveva forma e costumi così definiti e propri da poter generare un artista che quei costumi riprovasse e dileggiasse».3 Il titolo “Il Don Pirlone”, che in romanesco significa “perdigiorno”, “scioperato piantagrane”, fu scelto per estrazione casuale, come spiegato nel primo numero del quotidiano: «scriva ciascuno in una scheda il nome, che vuole imporre al neopartorito: si pongano le schede entro un cappello (è inutile avverta che non v’era un’urna) la prima scheda partorita deciderà». Fu così che il nuovo quotidiano prese il nome da una maschera ideata nel 1711 dallo scrittore satirico Girolamo Gigli (1660-1772) a Siena come personificazione dell’ottuso benpensante, raffigurato quasi completamente nascosto da un cappello con la falda larga e da un lungo mantello gonfiato dal vento, il cui motto era “intendemi chi può, ch’i m’intend’io”. Il quotidiano a Roma ebbe un’enorme diffusione, raggiungen- 58 do i 1200 abbonati, ma nonostante il successo ottenuto, gli autori degli articoli e delle grandi caricature restarono sempre anonimi per timore di ripercussioni. Uno dei più acerrimi oppositori del giornale fu Pellegrino Rossi, ministro dell’Interno del governo pontificio, che tentò più volte di farlo chiudere; in particolare il 3 ottobre 1848 provò a censurarlo inviando una notificazione al Consiglio. Ne scaturì un clima di tensioni e polemica che si placò solo con l’assassinio del ministro avvenuto il 15 novembre dello stesso anno. “L’Epoca” diede notizia dell’omicidio, non giustificandolo, ma ricordando tra le colpe del defunto il suo accanimento contro “Il Don Pirlone” e svelando come avesse corrotto «i giudici perchè si pronunziassero contro quello di un’assurda condanna a schiacciare il coraggio sommo civile addimostrato e si ponea la prima pietra di schiavitù sulla libera manifestazione del pensiero». Il 22 marzo del 1849 “Il Don la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Nuova illustrazione della testata del quotidiano a partire dal 22 marzo 1849 Pirlone” mutò la sua veste grafica, al posto del borghese con cappello e mantello, apparve un rivoluzionario seduto alla scrivania con in mano una penna d’oca, con la cartina dell’Italia appesa al muro e un diavolo nero che gli sussurrava al- l’orecchio i fatti che sarebbero avvenuti: «Ecco ho finalmente gittato il mantello, e vedete là per terra il mio ampio cappellaccio. Ora è tempo di svestire gli abiti antichi e logori, ora è tempo di porsi sul capo il frigio berretto.4 […] La guerra dell’Austria è dichiarata e D. Pirlone quantunque prima gli paresse aver tutto il coraggio tuttavia sente in questo momento che ne ha più ancora di prima». Tale cambiamento avvenne dopo la fuga del Papa a Gaeta, ospite di Ferdinando II, evento che fu motivo di sberleffo ricorrente nelle pagine e nelle illustrazioni del giornale, e in seguito alla nascita della Repubblica Romana (9 febbraio 1849). Solo pochi mesi dopo, il 2 luglio 1849, “Il Don Pirlone” pubblicò il suo ultimo numero, in concomitanza con l’arrivo delle truppe francesi a Roma, ma il suo successo fu tale che, a distanza di anni dalla sua chiusura, ispirò due nuove testate: “Il Don Pirlone figlio: vero tribuno del popolo”5 del 1870 e il “Don Pirloncino” del 1872. Presso la Biblioteca di via Senato è presente una raccolta completa dei fascicoli del quotidiano “Il Don Pirlone” dal numero 1 del 1 settembre 1848 al numero 234 datato 2 luglio 1849. Ogni pubblicazione si apriva con un intervento di Don Pirlone che, parlando in prima persona, spiegava gli ultimi accadimenti inerenti alla storia di un’Italia in divenire. Continuava in seconda pagina con articoli di cronaca, solitamente riguardanti l’Austria e la Germania, letti sempre in chiave ironica e, dopo la pagina dedicata alla caricatura, si chiudeva il giornale con ipotetici interventi di personaggi reali ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 59 Nella pagina accanto: illustrazione ironica della presa di Malghera «la presa non fu colle armi, ma col Dagherrotipo». Qui a destra dall’alto: «Cara Italia non è tempo di dormire. Svegliati sollevati in massa. Non dare ascolto alle arti della diplomazia che ti siede accanto mascherata, e che si studia colla sua diabolica melodia di farti proseguire nel sonno in cui sei stata immersa finora», “Il Don Pirlone” 2 aprile 1849. «Con Alberto che fugge perseguitato dai spettri sacrificati nelle tre infamissime ere dei suoi tradimenti nel 1821 nel 1831 e nel 1848», “Il Don Pirlone” 1 giugno 1849 o inventati, oppure in alternativa, con una puntata di un romanzo storico. Spesso sull’ultima carta si leggeva anche la spiegazione dell’illustrazione. Nell’ultimo numero del “Don Pirlone” non c’erano cenni alla sua chiusura, anzi il romanzo storico prevedeva una continuazione. In tutte le pubblicazioni lo spirito sagace e satirico del quotidiano non risparmiò mai nessuno, a prescindere dalla carica che ricoprisse; il giornale rappresentò un importante esempio di libertà di stampa e di pensiero rispettando sempre la filosofia che si impose nel primo numero: «Vi debbo dir ora come la pensi. Vi sbrigo in tre parole: come mi pare». NOTE 1 Lo Statuto Fondamentale fu concesso da Pio IX il 14 marzo 1848 per regolamentare la legge sulla stampa. 2 MICHELANGELO PINTO, Don Pirlone a Roma. Memorie di un Italiano dal 1 settembre 1848 al 31 dicembre 1849, Torino, Stabili- mento Tip. Di Alessandro Fontana, 1850, p. IX. 3 LUIGI LONGANESI, in A. BATOLI, Roma in selci, Roma, L’Italiano Editore, 1934. 4 Copricapo a cui si attribuisce significato di libertà e rivoluzione. 5 “Scialbo settimanale di propaganda elettorale pubblicato dai fratelli Catufi. Il giornale divenne un foglio satirico fortemente anticlericale teoricamente legato alla sinistra ma portato a colpire le persone piuttosto che le idee. Sovente molto scandalistico”. DBI XXIV, p.391. 60 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 61 BvS: il Fondo di Fantascienza Capitan Salgari al timone di un periodico genovese Il maestro dell’avventura e la rivista “Per Terra e per Mare” PAOLA MARIA FARINA «S crivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli». Questo sosteneva il “capitano” Emilio Salgari (Verona, 21 agosto 1862 – Torino, 25 aprile 1911) che tanti lettori ha fatto volare con la fantasia attraverso racconti dalle ambientazioni esotiche e dalle trame avventurose; proprio lui che, nonostante l’appellativo che si diede, durante la sua vita non fu gran viaggiatore, ma si limitò a sognare e inventare storie in terre lontane coltivando così la propria passione per il mare.1 Salgari diede testimonianza del suo amore per l’avventura anche tramite la sua attività di giornalista e redattore, dapprima, tra il 1884 e il 1893,2 per il quotidiano veneto “L’Arena” e successivamente sulle pagine del settimanale “Per Terra e per Mare”, edito a Genova da Anton Donath tra il 1904 e il 1906 sotto la direzione dello stesso Autore veronese (la rivista si conserva presso la Biblioteca di via Senato). La presenza di Emilio Salgari nella città ligure è attestata stabilmente dal 1898,3 quando lo scrittore prese alloggio con la famiglia a Sampierdarena presso Casa Rebora in via Vittorio Emanuele n. 29, consolidando così i rapporti d’affari con l’e- un’incognita per gli studiosi a causa della scarsità di documenti che ne attestino i dati biografici.4 Fu attivo in Italia sin dal 1886 circa, editore e libraio a Genova in via Luccoli, con una predilezione verso la letteratura per ragazzi;5 pubblicò, tra l’altro, una delle prime traduzioni di Viaggio in Italia di Goethe e, oltre a distribuire testi in lingua inglese e traduzioni soprattutto dal tedesco, «vendeva grammatiche, dizionari, guide per i viaggiatori, classici, romanzi moderni e […] quei libri d’avventura che intrigavano i ragazzi, le giovani signore e gli adulti che amavano le letture d’evasione».6 Nella pagina accanto: “Per Terra e per Mare”, Anno II, n. 17: il numero contiene il racconto I Giganti dell’America del Sud che Emilio Salgari firmò con uno pseudonimo (S. Romero). Sopra: pagina che presenta la rubrica dedicata alle biografie di importanti viaggiatori (Anno II, n. 9) ditore genovese, che diede alle stampe in quell’anno Il Corsaro Nero, primo romanzo del ciclo antillano. Nato a Berlino nel 1857, Donath ha costituito per lungo tempo Donath fu, di fatto, il primo a comprendere le potenzialità di Salgari e dei suoi personaggi tanto che arrivò a firmare con il romanziere un contratto in esclusiva con cui si garantiva il lavoro continuativo dello scrittore in cambio di uno stipendio mensile fisso.7 Con tale editore Salgari pubblicò più di trenta romanzi e, dal 1899, curò la collana “Biblioteca Economica Illustrata per la Gioventù”, ma soprattutto diresse, anche dopo il rientro a Torino, il settimanale “Per Terra e per Mare” (1904-1906), pattuendo un 62 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 A sinistra: la rivista di Salgari non manca di un certo spirito umoristico, che viene talvolta espresso attraverso curiose vignette; l’illustratore Guido Petrai tratteggia ironicamente la figura del moderno cavaliere (Anno II, n. 2). Sopra: un articolo illustrato su un particolare tipo di farfalla: tra gli argomenti cui sono dedicate molte pagine del settimanale vi sono, infatti, quelli a carattere scientifico sugli animali (Anno II, n. 34) aumento del compenso pari a mille lire annue. La testata diretta dall’Autore si inseriva all’interno di quella nuova tendenza culturale tale per cui in tutto il Paese gli editori andavano cercando proposte letterarie innovative che guardassero soprattutto alle produzioni francesi e inglesi a carattere avventuroso; tale genere, infatti, iniziava proprio allora a destare un nascente interesse anche tra i giovani italiani, destinatari privilegiati dei molti nuovi periodici popolari.8 Il primo numero di “Per Terra e per Mare. Giornale di avventure e di viaggi” uscì all’inizio del 1904 e presentava otto pagine con il testo distribuito su colonne e accompagnato da immagini in bianco e nero, al costo di dieci centesimi a co- pia. Il nome della testata appariva sulla prima pagina a grandi lettere in stile Art Nouveau e al di sotto era ben leggibile la dicitura “diretto dal Capitano Cavaliere Emilio Salgari”. A partire dal numero 19 il titolo venne modificato in “Per Terra e per Mare. Avventure e viaggi illustrati. Scienza popolare e letture amene”, seguito dall’indicazione “giornale per tutti” scritta con caratteri quasi urlanti. ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 63 Sopra: grande fotografia che accompagna la descrizione della nave “Sardegna” (Anno II, n. 46): molti sono gli articoli di “Per Terra e per Mare” dedicati a flotte navali, imbarcazioni, sia civili sia militari, e armi da guerra. A destra: due illustrazioni a corredo di un lungo articolo sui pesci (Anno II, n. 39) Fin dal numero 1, in cui ben sei delle otto pagine erano occupate dalla prima puntata di un romanzo di Salgari (Jolanda, la figlia del Corsaro Nero), fu chiara l’anima autenticamente avventurosa del periodico; del resto, i fascicoli successivi, stampati dai Fratelli Armanino, non fecero che confermare, sia graficamente sia contenutisticamente, l’impostazione del numero d’esordio. Salgari «estendeva la sua pre- senza a quasi tutte le pagine del periodico»9 con articoli, bozzetti e racconti, sia lunghi sia brevi, che spesso firmava con pseudonimi che i ricercatori hanno cercato di svelare: Felice Pozzo afferma che «sulla base di riscontri precisi è […] possibile attribuire a Salgari gli pseudonimi di H. Barry, W. Churchill, Capitano Weill, Cap. J. Wilson, Massa, R. Hornill e Cap. G. Wattling».10 Alla luce di questi dati, tra i pezzi apparsi su “Per Terra e per Mare” tra il 1904 e il 1905, sono riconducibili alla penna salgariana: La pesca dei tonni (Anno I, n. 11), In mezzo all’Atlantico (Anno I, n. 16), Un tragico naufragio (Anno I, n. 18), I banditi della Manciuria (Anno I, n. 23), I pescatori dello stretto di Behering (Anno I, n. 24), Gli orrori della fame nell’India (Anno I, n. 26), Nella pampa (Anno I, nn. 27-28), Le grandi emigrazioni delle cavallette (Anno 64 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 È evidente quanto impegnativo potesse essere in questa impresa editoriale il compito affidato a Salgari, il quale, in qualità di direttore, si doveva occupare anche della revisione e correzione dei testi, oltre che della coordinazione dei vari redattori. Accanto ai testi narrativi d’avventura, di fantascienza e polizieschi, il periodico proponeva ai suoi lettori anche rubriche a carattere scientifico, naturalistico e geografico, con notizie e curiosità (nella sezione “Varietas”) che arricchivano e completavano le pagine, facendo da supporto ai racconti. A perfezionare l’identità della rivista contribuivano, dunque, in maniera sostanziale, anche i numerosi articoli sulla pesca, il mare, le armi, le navi, i sottomarini, insieme agli approfondimenti biografici sui più grandi viaggiatori della storia. Da quanto emerge, si può osservare come il forte elemento unificatore, simbolo riassuntivo della storia della testata, possa essere considerato il mare, che, da una parte, svolgeva una funzione narrativa fondamentale nei testi e, dall’altra, fu oggetto dei moltissimi articoli di approfondimento. Attraverso Salgari e i suoi racconti esotici «il mare, agitato o calmo che sia, entra nell’immaginario dei giovani lettori»,12 offrendo lo scenario perfetto per avventure e peripezie in luoghi lontani e sconosciuti. Se il ruolo dei lettori era piuttosto marginale (raramente, infatti, ne venivano pubblicate le lettere), ben più rilevante era il ruolo degli illustratori e dei fotografi che collaboravano con la testata; gli articoli, infatti, erano accompagnati da numerose immagini e vignette in bianco e nero che occupavano un posto importante sulle pagine della rivista. Tra i disegnatori chiamati a illustrare i racconti di “Per Terra e per Mare” c’erano Alberto della Valle (soprattutto per i testi salgariani), Arnaldo Tanghetti, Carlo Tallone, Yambo e Guido Petrai; accanto ai loro disegni, le fotografie erano utilizzate per integrare «i testi di carattere geografico e scientifico e quelli che presentavano le navi delle varie marine nazionali».13 Nel giugno del 1906 Salgari, dopo aver firmato un contratto con l’editore fiorentino Bemporad, lasciò la direzione del settimanale genovese che, senza il suo principale ispiratore, sopravvisse solo pochi numeri per poi chiudere definitivamente le pubblicazioni. NOTE 1 L’unica esperienza marinara documentata fu un viaggio di tre mesi su un mercantile lungo la rotta Venezia - Brindisi. 2 Gli articoli salgariani per il quotidiano veronese sono raccolti in EMILIO SALGARI, Una tigre in redazione. Le pagine sconosciute di un giornalista d’eccezione, a cura di Silvino Gonzato, Roma, Minimum Fax, 2011. 3 Vi rimase per due anni, fino al 1900. 4 FELICE POZZO, L’editore Anton Donath. Aggiornamento delle scoperte, in “La Berio”, n. 2-luglio/dicembre 2010, p. 56. 5 MATTEO LO PRESTI, Salgàri a Genova, in “Arte e Cultura”, n. 4-2011, p. 27 (versione online http://www.gruppocarige.it/gruppo/html/ita/arte-cultura/la-casana/2011_4/pdf/26-29.pdf; controllato il 410-2012). 6 CLAUDIO GALLO, Le avventure immaginarie di Emilio Salgari, in EMILIO SALGARI, Per terra e per mare. Avventure immaginarie, Torino, Nino Aragno editore, 2004, p. 10. 7 Ibi, pp. 56-58; vedi anche PIER LUIGI GARDELLA, La fortuna di Salgari e l’editore genovese, in “Il Giornale”, 9-08-2011 (versione online http://www.ilgiornale.it/news/fortuna-salgari-e-l-editore-genovese.html; controllato il 4-10-2012). 8 C. GALLO, Le avventure immaginarie di Emilio Salgari, p. 12. 9 Ibi, p. 16. 10 Ibi, p. 20. 11 Ibi, pp. 26-28 e, per uno spoglio completo della rivista, pp. 299-315. 12 ALBERTO CADIOLI, Montagne d’acqua e meduse trasparenti, in Amici di carta. Viaggio nella letteratura per i ragazzi, a cura di Ludovica Braida, Alberto Cadioli, Antonello Negri, Giovanna Rosa, Milano, Università degli Studi di Milano-Skira, 2007, p. 80. 13 Ibi, p. 17. I, n. 31), I giganti dell’America del Sud (Anno II, n. 17), Il castello degli spiriti (Anno II, n. 25), I lottatori giapponesi (Anno II, n. 31), L’intelligenza dei pappagalli (Anno II, n. 34), Un dramma nell’arcipelago greco (Anno II, n. 40) e La costruzione delle piramidi (Anno III, n. 3).11 Questa esperienza giornalistica di un autore come Emilio Salgari, sebbene breve e poco conosciuta, rappresenta un tassello prezioso per completare il ritratto dell’iniziatore del genere avventuroso nel nostro Paese; grazie alle sue parole sulle pagine di un periodico popolare, giovani e meno giovani, da Nord a Sud, hanno sognato di viaggiare “Per Terra e per Mare” guidati da un Capitano davvero speciale. ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 65 BvS: il Fondo Impresa Cinecittà: la fabbrica dei sogni compie 75 anni Storia del più importante centro di produzione cinematografica GIACOMO CORVAGLIA S ono trascorsi settantacinque anni dal primo film prodotto a Cinecittà. Dopo una serie di lungometraggi che avevano fatto conoscere la cinematografia italiana nel mondo, negli anni venti l’industria cinematografica italiana entrò in crisi venendo messa in ombra sia dalla cinematografia americana che da quella tedesca. Così nel 1931 il regime, che sosteneva fortemente l’importanza del cinema come strumento di propaganda, varò una legge tendente a penalizzare le importazioni e a stimolare la produzione nazionale. A raccontare questo periodo storico è il libro scritto da Francesco Savio, curato da Tullio Kezich e edito nel 1979 in tre volumi da Bulzoni Editore Cinecittà anni trenta. Parlano 116 protagonisti del secondo cinema italiano. Così recita la nota di copertina: «Nei tre volumi di Cinecittà anni trenta sono raccolte le 116 interviste che Francesco Savio realizzò fra il ’73 e il ’74 con altrettanti protagonisti del cinema italiano sotto il fascismo. Nella fedelissi- A destra: mappa propagandistica di Cinecittà. Sopra: copertina di Almanacco Bompiani 1980 ma trascrizione dai nastri, ne è uscita una vera e propria commedia umana dove attraverso testimonianze di prima mano si evocano splendori e miserie di un periodo sempre al centro dell’interesse degli storici. Per l’importanza, la vastità e l’originalità dei suoi contributi all’analisi del ventennio, Cinecittà anni trenta si colloca come un libro indispensabile nell’ambito degli studi cinematografici, una vera e propria pietra miliare. Ma è anche un libro che si può leggere come il grande romanzo di un’epoca, 66 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Sopra da sinistra: disegno di Federico Fellini per La strada, Giulietta Masina; disegno di Federico Fellini per La Dolce vita, Anita Ekberg scritto in presa diretta da un animatore incuriosito e partecipe, ironico e stimolante». Nel 1934 Luigi Freddi venne incaricato di costituire una “Direzione generale della cinematografia”, finalizzata al controllo ideologico, ma anche alla promozione del mezzo. Freddi, che in occasione di un viaggio negli Stati Uniti d’America si era appassionato agli aspetti produttivi della cinematografia americana, si impegnò nella promozione del cinema nazionale. Fra le iniziative della Direzione della cinematografia ci fu la costituzione dell’Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC), nel cui ambito nacque Cinecittà, i cui studi dovevano rappresentare l’industria propagandistica e cinematografica del paese. Venne individuata lungo la via Tuscolana un’area di circa 500.000 metri quadrati dove realizzare la nuova città del cinema. I lavori ebbero inizio il 26 gennaio 1936 con la posa della prima pietra e dopo soli quindici mesi, il 28 aprile 1937, Mussolini inaugurò i nuovi stabilimenti. Oltre ad essi venne prevista la creazione di un centro industriale cinematografico inte- grato che comprendeva stabilimenti di sviluppo, stampa e montaggio, la nuova sede dell’Istituto Luce e quella del Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 1937 vi furono prodotti 19 film fra i quali Il feroce saladino di Mario Bonnard, ispirato all’omonimo e famosissimo concorso di figurine bandito dalla Perugina. Nel 1940 furono girati 48 film, nel 1942 59 film, nel 1943 la produzione di pellicole crollò a 25 a causa della guerra e dal settembre del ‘43 il cinema fascista si trasferì a Venezia ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 67 nei padiglioni della Biennale. Negli ultimi due anni di guerra, gli stabilimenti di Cinecittà vennero prima occupati dai nazisti che li utilizzarono come luogo di concentramento di civili rastrellati nei dintorni di Roma, poi, dopo la liberazione della città, furono adibiti a ricovero per gli sfollati. Questo periodo storico ci viene raccontato nel volume Cinecittà 1. Industria e mercato nel cinema italiano tra le due guerre a cura di Riccardo Redi e Claudio Camerini ed edito da Marsilio Editore nel 1985 in occasione della IV Rassegna Internazionale Retrospettiva tenuta ad Ancona nel 1985. Nel 1947 venne girato nei suoi studi il primo film del dopoguerra: Cuore di Duilio Coletti ma è negli anni cinquanta, con le produzioni americane, i cosidetti kolossal, come Quo vadis? e Ben Hur che avvenne l’esplosione di Cinecittà. Tale boom ebbe origine dalla competitività economica degli studi romani, chiamati in seguito anche “la Hollywood sul Tevere”. Il successo delle produzioni americane introdusse nella società romana degli anni ‘50 nuovi fenomeni di costume quali il divismo e l’avvento dei fotografi invadenti più noti con il termine di “paparazzi”. La dolce vita è il film simbolo di questo periodo. Cinecittà divenne in quegli anni un mito, un Eldorado per belle ragazze e giovani attori in cerca di popolarità. Interessante in questo contesto il volume edito da Arnoldo Mondadori Editore nel 1988, Un regista a Cinecittà di Federico Fellini. Il regista racconta la sua prima volta in cui sentì parlare di Cinecittà: «Proprio in un cine- Disegno di Federico Fellini per La Dolce vita, Marcello Mastroianni giornale ho sentito per la prima volta quel nome: Cinecittà. Che anno era? Il 1936? Il 1937? Nelle immagini in bianco e nero si vedeva Mussolini attraversare un terreno che pareva un cantiere, tutto disseminato da baracche grandi come hangars, e capannoni più alti di quelli dei mercati generali. Procedeva a passo energico, remigando con le braccia, lungo viali desolati seguito da un codazzo di gerarchi fascisti in divisa, che facevano a gara nel fingere di stentare a tenergli dietro: “Il duce ha inaugurato gli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. L’Italia ha finalmente un proprio complesso per la realizzazione di film…”, recitava stentorea la voce dello speacher» e prosegue raccontando la prima volta a Cinecittà: «La prima volta che entrai a 68 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Sopra da sinistra: copertina di Cinecittà anni trenta. Parlano 116 protagonisti del secondo cinema italiano; copertina di Cinecittà 1. Industria e mercato nel cinema italiano tra le due guerre Cinecittà, che anno era? Il 1938, Il 1939? Facevo il giornalista e il direttore del giornale, che era un sarto e teneva sempre degli aghi fra i denti anche quando parlava ed era tutto intrico di fili, di nastri, di spilli, voleva un’ intervista con l’attore Osvaldo Valenti. Così quella mattina andai a Cinecittà. Fingevo una gran disinvoltura, come Fred MacMurray nei film dove faceva il giornalista, ma in realtà ero molto intimidito e rimasi sotto il sole a guardare a bocca aperta le torri, gli spalti, i cavalli, le torve palandrane, i cavalieri imbottiti di ferro e le eliche di aeroplani in funzione che sollevavano ovunque nuvoloni di polvere; richiami, grida, trilli di fischietto, il frastuono di enormi ruote in corsa, clamore di lance, spande, Osvaldo Valenti in piedi su una specie di biga dalle cui ruote spuntavano affilatissime lame e le urla terro- rizzate di una gran massa di comparse, un caos tenebroso, soffocante… ma, al di sopra di tutta quella confusione, una voce potente, metallica, tuonava ordini che parevano verdetti: “Luce rossa gruppo A attacchi sulla sinistra! Luce bianca gruppo barbari retroceda in fuga! Luce verde cavalieri e elefanti impennarsi e caricare! Gruppo E e gruppo F rovinare al suolo! IMME-DIA-TA-MEN-TE!!!”». L’industria cinematografica ebbe in quegli anni una discreta rilevanza economica per la città generando un ampio indotto legato sia alle produzioni che alla commercializzazione dei film, fatto di comparse, artigiani, operai, tecnici e impiegati, ma anche di impresari, imprenditori, produttori e artisti a caccia di occasioni. Dalla fine degli anni ‘60, con la crescita della televisione, la fine delle produzioni kolossal di carattere storico e la parallela crisi dell’industria cinematografica italiana, Cinecittà perse lentamente, per più di una ventina d’anni, il primato tecnico e produttivo che l’aveva resa mitica. Negli ultimi anni la privatizzazione degli stabili, gestiti da Cinecittà Studios SpA, e l’apertura di un settore interamente dedicato alle lavorazioni in digitale hanno reso gli studi particolarmente competitivi e i teatri di Cinecittà hanno ospitato i set di alcune grosse produzioni. Con la fusione fra Cinecittà Holding e Istituto Luce, nel maggio 2009 ha preso corpo la nuova realtà Cinecittà Luce, in cui si sintetizza il legame tra le profonde radici che risalgono al 1924, data di fondazione dell’originario Istituto Luce. La storia di Cinecittà viene così riassunta nell’Almanacco Bompiani 1980. Era Cinecittà. Vita, morte e miracoli di una fabbrica di film a cura di Oreste Del Buono e Lietta Tornabuoni. Nell’introduzione, chiamata Istruzioni per l’uso viene scritto «I fascisti, gli americani, Fellini. Sono loro, più che il cinema italiano, i protagonisti veri dei quarantadue anni di Cinecittà. Nata come Hollywood fascista, sogno d’imitazione d’un paese povero e megalomane; distrutta dalla guerra; rinata come una Hollywood coloniale per i kolossal americani; abbandonata dagli occupanti; conquistata da Fellini che vi gira tutti i suoi film, Cinecittà resta il più importante ed efficiente centro di produzione cinematografico europeo, ma rischia di sparire». ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano 69 BvS: nuove schede Recenti acquisizioni della Biblioteca di via Senato Novità per bibliofili arricchiscono i fondi antico e moderno Arianna Calò, Valentina Conti, Giacomo Corvaglia, Paola Maria Farina, Annette Popel Pozzo e Beatrice Porchera Audi Tradition (a cura di). I quattro anelli. La storia della Audi. Ingolstadt, Auto Union GmbH, 2009. Il volume ripercorre, attraverso numerose immagini e testo, la storia della famosa casa automobilistica tedesca. Si parte dagli esordi del 1899 quando fu fondata la August Horch & C.ie, la futura Audi, e la sua prima automobile del 1901, la Horch, sino ad arrivare ai successi dei modelli di oggi, sinonimo di lusso e alta qualità. (G.C.) Baretti, Giuseppe Marco Antonio (1719-1789); [Johnson, Samuel (1709-1794)]. An introduction to the Italian language containing specimens both of prose and verse [...] with a literal translation and grammatical notes, for the use of those who being already acquainted with grammar, attempt to learn it without a master. Londra, Andrew Millar, 1755. Rarissima prima edizione di quest’opera scritta da Baretti dopo aver lasciato l’Italia per l’Inghilterra a seguito di alcune controversie letterarie (un Cicalamento scagliato contro Giuseppe Bartoli) e di una certa insoddisfazione verso l’ambiente chiuso del proprio Paese. In Inghilterra fu subito accolto nei circoli di Samuel Johnson e Henry Thrale; nello stesso anno in cui Johnson pubblicava il suo prestigioso dizionario, Baretti dava alle stampe questa selezione di estratti da 37 autori italiani (tra cui Castiglione, Machiavelli, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Michelangelo, Petrarca e altri sino ad allora sconosciuti al pubblico inglese) con relativa traduzione a fronte. Johnson contribuì al testo scrivendo parte della Preface e due corpose note. Courtney & Smith, p. 73. Chapman & Hazen, p. 139. Fleeman I, pp. 483-485. Hazen, Prefaces, pp. 12-15. (A.C.) Basile, Giambattista (15751632). Il Pentamerone del cavalier Giovan Battista Basile, overo Lo cunto de li cunte trattenemiento de li peccerille di Gian Alesio Abbattutis. Napoli, Antonio Bulifon & Luca Antonio Di Fusco, 1674. Prima edizione con il titolo di Pentamerone e prima recante il nome dell’Autore sul frontespizio. Lo Cunto de li Cunti che è apparso postumo rappresenta il capolavoro di Basile. “Si tratta di una raccolta di fiabe di origine popolare, stese in dialetto napoletano. Dal punto di vista strutturale il B. vi riprende uno schema boccaccesco, che però nella sostanza, si può far risalire al più antico modello del Libro dei sette savi […] La narrazione è divisa in cinque giornate (da qui l’altro titolo, successivamente imposto all’opera, di Pentamerone), ognuna delle quali comprende dieci fiabe. Tra una giornata e l’altra sono inserite composizioni dialogate, sul tipo delle egloghe, di cui sono protagonisti servi, cuochi e dispensieri del palazzo principesco (anche in questo il riferimento al Decamerone è evidente). Al posto dell’ultima fiaba c’è la Scompetura de lo Cunto de li Cunti, pe chiudeturade la ‘ntroduttione de li Trattenemiente (Fine della Fiaba delle Fiabe e la Conclusione alla introduzione dei trattenimen- 70 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 ti). La maggior parte delle fiabe ha, come si è detto, origine popolare: la tradizione letteraria (visibilissima dal punto di vista strutturale e stilistico) è minima dal punto di vista tematico. Il B. non inventa spunti favolistici nuovi, riservandosi di compiere la sua parte di originale creatore artistico attraverso la rielaborazione formale” (DBI 7, pp. 78-79). Vinciana 3550. (A.P.P.) Breve descrizione dei bombardamenti delle principali piazze marittime del Regno di Tunisi eseguiti dalla squadra veneta, comandata dall’ammiraglio Emo. [S.l.], [s.n.], [dopo il 1786]. Un’unica copia censita in Italia presso la Biblioteca nazionale Marciana; edizione assente dai principali cataloghi internazionali. Si tratta del resoconto dettagliato delle operazioni di guerra condotte in Tunisia dalla flotta veneziana guidata dall’ammiraglio Angelo Emo (1731-1792) con i bombardamenti della Goletta (1795), di Fachs, di Biserta, di Susa (1796). Su Angelo Emo, DBI 42, pp. 623-625: “Il 6 marzo 1784 fu nominato capitano straordinario della flotta inviata contro Tunisi, che aveva dichiarato guerra alla Repubblica per la bruciatura di una nave veneziana carica di merci barbaresche, infetta di peste, ad opera della Reggenza di Malta: il 5 ottobre attaccò Susa, nell’aprile 1785 ripeté l’assalto per tre notti consecutive, dal 15 al 17 agosto bombardò Sfax e poi, nei giorni 1, 3, 5, 9 ottobre, avvalendosi inoltre delle famose batterie galleggianti di sua invenzione, anche La Goletta; dopo nuovi furiosi bombardamenti su Sfax, del 6, 18, 22 marzo, 30 aprile e 4 maggio 1786, la flotta veneziana dal 30 maggio al 10 agosto attaccò Biserta e, per la terza volta, dal 26 settembre al 6 ottobre, Susa, con gravissimi danni al porto e alle abitazioni civili”. (A.C.) Cadelli, Lucia. I Mantica e Pordenone. Pordenone, Editrice Euro ‘92, [2006]. Si tratta di uno studio sulla storia della famiglia MonterealeMantica, di cui si descrive anche il Palazzo in Pordenone restaurato nel corso degli anni ‘80 del XX secolo; i Mantica, di origini comasche, si stabilirono a Pordenone agli inizi del Quattrocento e si imparentarono in seguito con i Montereale, divenendo protagonisti di una delle stagioni di maggior splendore della città. Arricchitisi grazie al commercio di stoffe e spezie in Europa, i Mantica furono grandi mecenati e promossero l’arte e la letteratura in tutta la regione, rendendo la propria residenza luogo di incontro di artisti rinomati. Cuore della cultura pordenonese, il palazzo, che è stato testimone non solo dei fasti della famiglia, ma anche di tristi avvenimenti bellici, è stato riportato alla sua originaria bellezza, custode della storia locale. (P.M.F.) Cotton, Charlotte. La fotografia come arte contemporanea. Torino, Einaudi, 2010 (Piccola Biblioteca Einaudi. Mappe 24). Attraverso 238 riproduzioni fotografiche a colori l’Autrice del saggio analizza l’uso della fotografia come strumento per la creazione artistica e come forma d’arte contemporanea in se stessa, dagli anni ‘80 del secolo scorso a oggi. Il percorso si articola per singole tematiche e ogni capitolo è arricchito da illustrazioni, spesso corredate da didascalie molto dettagliate, che hanno la funzione di far meglio comprendere la sensibilità estetica e artistica che si vuole comunicare; sono più di 170 gli artisti presentati, tra i quali compaiono non solo nomi famosi a livello internazionale, ma anche giovani esordienti. (P.M.F.) Della Porta, Antonio Maria. Saggio di osservazioni e memorie sopra le principali malattie di Como nel 1780. Pavia, Monastero San Salvatore, [s.d. ma 1781]. Edizione originale estremamente rara, censita dall’ICCU in sole due copie conservate presso la Biblioteca nazionale Braidense e la Biblioteca comunale centrale di Milano. Nel Saggio, dedicato al conte Carlo di Firmian, l’Autore lariano descrive la storia delle malattie che l’anno precedente avevano travagliato la sua patria e ne spiega i rimedi, scegliendoli tra quelli da lui considerati più efficaci nella guarigione degli ammalati. (B.P.) Halard, François. Hettabretz. 50th out of ordinary. Bologna, Hettabretz, 2011. In occasione del 50esimo anniversario dalla fondazione si è voluto celebrare la storia del marchio offrendo allo sguardo di François Halard l’azienda, gli archivi e le opere d’arte che arredano gli ambienti di lavoro. Ne è nato così un libro che racconta le creazioni e svela i luoghi di lavoro. Di questo ottobre 2012 – la Biblioteca di via Senato Milano volume sono state tirate 1313 copie numerate. (G.C.) Longoni, Alberto (1921-1991). Beppe il pescatore. [Milano], Giorgio Lucini, 1967 (stampa 1968). Esemplare n. 163/250 di un’edizione limitata con contenitore a cartelletta fuori commercio disegnata appositamente da Alberto Longoni per gli amici di Giorgio Lucini. La narrazione è una favola ambientata nei dintorni del piccolo paese piemontese di Crodo, interamente raccontata attraverso immagini: l’edizione contiene [13] carte di tavola contenenti altrettanti disegni dell’eclettico artista Alberto Longoni. (V.C.) Maggiali, Giuseppe. Ragguaglio delle nozze delle maestà di Filippo Quinto, e di Elisabetta Farnese nata principessa di Parma re cattolici delle Spagne solennemente celebrate in Parma l’anno 1714., ed ivi benedette dall’eminentissimo sig. cardinale di S. Chiesa Ulisse Giuseppe Gozzadini Legato a latere del sommo pontefice Clemente Undecimo. Parma, Stamperia di S.A.S. di Parma, 1717. Antiporta allegorica incisa da Giovanni Battista Sintes su disegno di Ilario Spolverini (datata 1718) e 5 tavole ripiegate tra l’altro raffiguranti “L’entrata della processione trionfale” incisa da Theodor Verkruys (fl. 1707-1739), e datata 1716, su disegno di Ilario Spolverini (640x995 mm). Il disegno originale di Spolverini è conservato presso il British Museum. Prima edizione di un rinomato “festival book” del barocco italiano. L’edizione, nota per il suo apparato illu- strativo, descrive le nozze di Filippo V (1683-1746), re di Spagna, con Elisabetta Farnese (16921766), celebrate nel 1714 nella cattedrale di Parma. “This was the culminating event for the Farnese family’s dynastic ambitions, and its commemoration was ensured not only by this illustrated book, but also by the three series of narrative paintings that Duke Francesco Farnese commissioned from the local painter Ilario Spolverini” (Millard, Italian and Spanish Architectural Books, p. 341). Melzi II, 403. Vinet 567. Lipperheide 2755. Berlin Katalog 3060. Cicognara 1491. Ruggieri 837. Millard 109. (A.P.P.) Rock, Michael. Prada. Milano, Progetto Prada arte, 2009. Seconda edizione. Il volume, dopo un breve racconto della storia del marchio, illustra attraverso la fotografia tutto l’universo Prada. Nell’introduzione Miuccia Prada e Patrizio Bertelli scrivono: “Questo libro vuole ripercorrere e illustrare i molteplici aspetti attraverso i quali Prada si esprime: dalla moda alla comunicazione, dalla ricerca dell’eccellenza allo sviluppo tecnologico, dall’architettura all’arte”. (G.C.) Rolli, Paolo (1687-1785). Disamina del parere di M.r de Voltaire sulla poesia epica. Opera del Sig. Paolo Rolli tradotta dall’inglese in italiano da Pleuronio Misio pastore arcade. Napoli, presso il Porsile, 1779. Rara edizione, non censita dall’ICCU, della traduzione italiana dell’opera Remarks upon M. Voltaire’s Essay on the Epick Poetry of the 71 European Nations pubblicata per la prima volta in inglese nel 1728. È datata 1779 anche un’altra edizione del testo stampata a Berlino. Paolo Rolli fu poeta, librettista e traduttore; visse a Londra dal 1716 al 1744 dove fu precettore dei figli di Giorgio II e poeta ufficiale della Royal Academy of Music. (B.P.) Vegezzi Ruscalla, Giovenale (1799-1885). Note filologiche sovra VII vocaboli dinotanti uficio o dignità di persona nell’Asia che leggonsi nell’Orlando Furioso. Torino, Pomba, 1832. Raro opuscoletto contenente “poche illustrazioni etimo-filologiche intorno a sette vocaboli significanti uficio o degnità di persona in quella parte dell’Asia che noi chiamiamo Levante”. Si tratta dei termini Amostante, Argaliffa, Argariffa, Calife, Cadì, Cane, Diodarro, Papasso, Talacimanno. Manca a Bottasso. (A.C.) Veronelli, Luigi (1926-2004). Breviario libertino. Con tre acqueforti di Alberto Manfredi. [S.l.], [s.n.], (stampa 1984) (Le edizioni di Monte Vertine 4). Esemplare n. XXXIV di un’edizione limitata come scritto al colophon: “Stampato coi tipi della Tipografia Giuntina in Firenze, su carta «acquerello», nell’ottobre 1984. Di questa edizione sono state tirate n. 50 copie numerate da 1 a 50 e 40 copie numerate da I a XL fuori commercio, contenenti tre incisioni originali. Inoltre n. 2000 copie numerate da 51 a 2050 senza le incisioni originali”. Tutte e tre le acqueforti sono firmate dall’artista Alberto Manfredi (1930-2001). (V.C.) 72 la Biblioteca di via Senato Milano – ottobre 2012 Bvs: il ristoro del buon lettore Gli incantesimi di Lorenzo Shakespeariane tempeste di gusto a Forte dei Marmi GIANLUCA MONTINARO E infine si approda. E’ il magico volere a cui nessuno sfugge. Si approda sempre, dalle fatiche della vita e dai tormenti dell’animo. Spinti dalla forza del vento, sopraffatti dalle cime bagnate che sfuggono le mani lacerando la pelle, scossi dal «fischio del capitano», sconvolti dall’uragano scatenato… E’ il magico volere, che spinge a cercar salvezza sulle coste di un’isola inaspettata. Non segnata sulle carte ma non disabitata, anzi. E’ il destino che si compie. Là, in mezzo al Mediterraneo è l’isola di Prospero, lo spodestato duca di Milano protagonista della Tempesta di William Shakespeare (di cui la Biblioteca di via Senato possiede una preziosa edizione numerata, stampata a Lugano dall’Officina Bodoni nel 1924). Qui, ai piedi delle bianche Apuane, è l’isola di Lorenzo, incontrastato signore della Versilia. Allegria di naufragi. Camminando sull’isola, varcando la soglia del ristorante, lo si incontra. Lui, Lorenzo Viani, col suo charme senza tempo. Lui, pronipote di “quel Viani” (non mente la linea del sangue), felice prigioniero della sua stessa isola. Chiuso nel suo fortino versigliese, è dotato, come Prospero, di arcani poteri: costruisce magie e incantesimi per il piacere dei suoi ospiti. E come Prospero non teme confronti. Sulla sua isola al di fuori del tempo, ancorata ai piedi delle Ristorante Lorenzo Via Carducci, 61 Forte dei Marmi (Lu) Tel. 0584/89671 bianche Apuane, testimonia in corpore vivo l’arte del vivere, la sapienza del ricevere, la maestria dell’alta cucina. Anche Lorenzo, come Prospero, abita la sua isola con l’amata figlia, Chiara, ragazza di dolce bellezza, che ogni Ferdinando, «se il suo cuore non è volto altrove», vorrebbe fare «regina di Napoli». E con loro sono i fidi Libero Musetti, sommelier di rara competenza che, amando scrutare il mondo attraverso l’occhio fotografico, ne coglie bellezza e consunzione, dolore e beatitudine, e Gioacchino Pontrelli, talentuoso chef di lungo corso, entrambi capaci come Ariel di «volare, nuotare, but- tarsi nel fuoco e cavalcare sulla cresta delle ricciute nuvole grazie alle loro magiche facoltà». Ma, entità talattica, l’isola di Lorenzo, come l’isola di Prospero, vive un mondo parallelo a quello del quotidiano: qui «c’è qualche cosa di più di quanto accade in natura». Equoree geometrie non euclidee si dispiegano nella lunga teoria gustativa dei piatti. Può quindi accadere che le seppioline di fondale gratinate al forno al profumo di aglio gentile sorridano alle capesante su millefoglie di verdure con purea di patate e trucioli di tartufo. E che le storiche bavette sul pesce cedano il passo agli straordinari scampi dell’ultima cala aperti in forno, in un tripudio di aromi e gusti che rimane impresso, indelebile, nella mente. E commuove il cuore. Un Mersault di Jean-François Coche Dury, in evoluzione di almeno dieci anni, sarà dolce compagno di naufragio, in un’armonia perfetta di sapidità e acidità, profumo e struttura. «Magico potere d’incantesimi»; malia del luogo ove «ognun ritrova se stesso dopo che ognun se stesso avea smarrito». E quando Lorenzo, come Prospero, si leverà il suo mantello, nulla rimarrà. Né cucina, né teatro, né letteratura, né arte, né vita. Tutto svaporirà, come nebbia mattutina. E dell’isola, ai piedi delle bianche Apuane, non rimarrà che sogno, sogno di un sogno.
Scarica