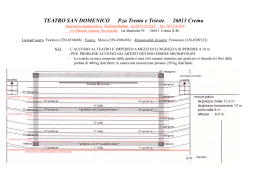La stagione teatrale 2012/2013 Appunti per approfondire temi e autori del nostro cartellone a cura di Carla Casadei Via Cavalieri 26 – 47921 Rimini Tel. 0541 704293/92 – Fax 0541 704306 www.teatroermetenovelli.it 1 SOMMARIO Stagione Teatrale 2012-2013: programma di spettacoli in abbonamento per le scuole…………..2 UN MARITO IDEALE........................................................................................................................... 3 LA TRAVIATA.......................................................................................................................................8 COSI' E' SE VI PARE..........................................................................................................................12 RAIN MAN..........................................................................................................................................18 ASPETTANDO GODOT........................................................................................................................22 LA GOVERNANTE...............................................................................................................................27 LAFONDAZIONE................................................................................................................................33 LA COSCIENZA DI ZENO...................................................................................................................37 Conclusione........................….............….......................................................................……………41 2 Stagione Teatrale 2012-2013 Programma di spettacoli in abbonamento per le scuole In tempo di crisi cosa può fare il teatro? Niente e tutto. Recentemente, con grande acutezza, il presidente Napolitano ha dichiarato che “dalla crisi si esce anche grazie alla cultura.” C'è una grande esigenza di recupero di una dimensione culturale, morale e ideale del teatro, del cinema, dell'arte in generale. In questi tempi difficili la cultura, infatti, può e deve costituire uno stimolo per recuperare fiducia in se stessi e negli altri. È con questo spirito che continua il progetto “Studenti a teatro” nella speranza e con l'obiettivo che il contatto della Scuola, sede di cultura per eccellenza, con il mondo del teatro nella multiformità delle sue forme, possa aprire orizzonti, suscitare interessi, fornire opportunità volte a formare una generazione di individui attivi, attenti al mondo e agli altri oltre che a se stessi, aperti e autonomi, dotati di spirito critico, consapevoli di sé e della realtà. È indispensabile per questo che la scuola fornisca a tutti i suoi utenti, dai più piccoli ai più grandi, “rose e libri” (é chiaro il riferimento a Il nuovo mondo di Aldous Huxley) per aiutarli ad imparare “ad amare il mistero e lo stupore del mondo” spezzando i meccanismi indotti dalla società dei consumi e favorendo la capacità di porre domande, di trovare un senso alle cose che li circondano in modo da rendere la scuola spazio condiviso di dialogo e ricerca della verità. In questa direzione si muove il cartellone della Stagione teatrale 2012-2013 presentando alle scuole otto spettacoli che scavano nel cuore dell'uomo, lo mettono a nudo, concretizzando quella che Marco Missiroli (giovane scrittore riminese di successo) definisce “la vocazione di scrittore che ha nella curiosità verso l'umanità l'unico motore autentico”. È proprio la “curiosità” che ha permesso ad autori come Wilde, Pirandello, Beckett...di penetrare nelle pieghe più segrete dell'animo umano, di coglierne tutte le sfumature, le inquietudini, i dubbi, le insicurezze, comprenderle e capirle senza prospettare soluzioni o dare risposte, ma perché ogni lettore e spettatore possa trovare, attraverso la riflessione, la “sua” risposta, una risposta personale agli eterni interrogativi che travagliano l'umanità. Dalla “scena” mancano quest'anno i grandi classici, sostituiti con spirito innovativo da autori come Brancati, Wilde, Pirandello, Svevo, Beckett che classici, comunque, possiamo ormai considerare, cui si aggiungono autori contemporanei come il santarcangiolese Raffaello Baldini e spettacoli decisamente “nuovi” come la trasposizione teatrale del film Rain Man e la Traviata di Giuseppe Verdi rivisitata sulla combinazione di musica e danza. I temi affrontati esaminano il mondo politico, la società, l'emarginazione, la diversità... temi forti, interessanti, toccanti e coinvolgenti che ci riguardano, e riguardano la vita di ognuno di noi in tutte le sue complesse e complicate sfaccettature con l'obiettivo di far pensare, di aiutarci a guardarci dentro con occhio vigile, orecchio attento e cuore aperto e sensibile. In questi momenti, infatti, in cui l'Italia si interroga con grande preoccupazione sulle capacità o meno di resistere alle difficoltà economiche, politiche, sociali, morali e culturali, grande può e deve essere la funzione del Teatro. Il teatro deve diventare specchio della nostra vita, rappresentarci a tutti i livelli per aiutarci ad evitare o uscire dall'alienazione, dalla nevrosi, dall'indifferenza, dal qualunquismo dominanti, per capire non solo come eravamo, ma come potremo essere. È un teatro rivolto ai giovani perché sappia, come in passato ha saputo fare, aiutarli a costruire nuovi sogni e nuove speranze. a cura di Carla Casadei 3 martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 novembre Oscar Wilde Un marito ideale con Roberto Valerio, Valentina Sperlì, Pietro Bontempo regia Roberto Valerio NOTIZIE BIOGRAFICHE SU OSCAR WILDE Nato a Dublino nel 1854, Oscar Wilde studia al Trinity College della città. Riesce a vincere una borsa di studio che gli dà la possibilità di andare ad Oxford dove la sua brillante intelligenza è stimolata dalle lezioni del critico d'arte John Ruskin e da Walter Pater il cui studio sul Rinascimento, dove si trova teorizzata una vita di intense emozioni estetiche, diviene una sorta di vangelo dell'estetismo. Si laurea a pieni voti nel 1878, abbandona Oxford e si stabilisce a Londra, dove entra in contatto con i circoli artistici e i salotti mondani più in vista della città. Eccentrico e ammirato conversatore, atteggia pose stravaganti e raffinate divenendo ben presto, soprattutto grazie ad una vera e propria campagna di autopromozione, uno dei personaggi più discussi della capitale e del paese. Amato e odiato, respinto e cercato, Wilde è il simbolo del nuovo movimento estetico e, nello stesso tempo, il bersaglio polemico per eccellenza di quanti ad esso rimangono estranei. Per questo nel 1882, in occasione della rappresentazione di un'opera che ridicolizza l'estetismo, viene chiamato negli Stati Uniti per un ciclo di conferenze, con lo scopo di presentare il soggetto vivente della parodia. Ma Wilde non si lascia imbrigliare e, nonostante l'ostilità del pubblico, insiste, recuperando soprattutto l'insegnamento di Ruskin, sull'importanza del bello come antidoto agli orrori della società industriale. L'anno dopo è a Parigi, poi ritorna a Londra; qui si sposa e inizia un'intensa attività giornalistica. Negli otto anni compresi tra il 1888 e il 1895 si concentra la maggior parte della sua produzione. Escono infatti le fiabe del Principe felice (1888) e di Una casa di melograni (1891), i racconti del Delitto di Lord Arthur Savile (1891), le riflessioni estetiche di Invenzioni (1891) e quelle politiche dell'Anima dell'uomo sotto il socialismo, in cui lo scrittore ostenta un anarchismo idealizzante, il celebre romanzo Il ritratto di Dorian Gray, manifesto dell'estetismo e del Decadentismo, le brillanti commedie Il ventaglio di Lady Windermere (1893), Una donna senza importanza (1894) e Un marito ideale (1895) e un vero e proprio capolavoro, L'importanza di chiamarsi Ernesto (1895). La sua opera teatrale più famosa resta, però, Salomé, sensibile ritrascrizione, per l'attrice Sarah Bernhardt, di un classico mito decadente. Scritta in francese nel 1891 e colpita dalla censura britannica, questa “tragedia in un atto” viene rappresentata solo nel 1896 a Parigi e non ottiene un grande successo né di critica né di pubblico. Pesa forse su questa incomprensione anche la dura condanna (due anni di lavori forzati) subita da Wilde per omosessualità: infatti, dopo il fallimento del suo matrimonio, ha una relazione amorosa con il giovane nobile inglese lord Alfred Douglas che suscita grande scandalo e la conseguente condanna. Dell'esperienza della reclusione resta La ballata del carcere di Reading, la più nota delle sue poesie, e anche una parte del De profundis (pubblicato postumo nel 1905, ma con molti tagli) che è una lunga epistola indirizzata ad Alfred Douglas in cui lo scrittore accusa l'amico di essere stato la causa della sua rovina. Uscito dal carcere Wilde non riesce a riconquistare il successo; denigrato dal pubblico che prima lo aveva acclamato, si ritrova solo, abbandonato da tutti, fatta eccezione per pochi fedeli amici tra cui quel Robert Ross che sarà suo esecutore testamentario e che nel 1901 dà alle stampe gli Aforismi, l'ultima splendida testimonianza della profonda riflessione “sottesa all'apparente frivolezza e al fine illusionistico gioco di una scrittura” che è invece estremamente efficace, nella sua limpida e a tratti 4 feroce critica nei confronti della società inglese fin siècle. Muore a Parigi, dove si era trasferito subito dopo aver scontato la pena, nel 1900. NOTIZIE SUL TESTO L'ultima e forse la più riuscita delle cosiddette “commedie salottiere” di Oscar Wilde (dopo Il ventaglio di Lady Windermere e Una donna senza importanza) è Un marito ideale, rappresentata per la prima volta nel gennaio del 1895 allo Haymarket Theatre di Londra con successo trionfale anche se dopo 111 repliche deve chiudere perché la sala era stata prenotata per altri impegni. Una successiva ripresa al Criterion sempre di Londra dura appena tre settimane a causa dello scandalo che travolge il suo autore. Comunque, dopo anni in cui i tre testi non vengono rappresentati, la commedia Un marito ideale in particolare ottiene grande successo in vari teatri di tutto il mondo. Dal testo vengono tratti nel 1948 e nel 1999 due films. L'azione si svolge in quattro atti, ambientati a Londra, in interni: la sala ottagonale e la stanza di soggiorno della casa di Sir Robert Chiltern in Grosvenor Square e la biblioteca di Lord Goring in Curzon Street, nello spazio di 24 ore. I personaggi, da Sir Robert a sua moglie Gertrude, a Lady Markby, a Mrs Marchmont, a Lord Goring appartengono all'aristocrazia e all'alta società londinese e vivono in ambienti eleganti e raffinati tra feste, ricevimenti e interessi politici. Nel I atto, la vicenda si svolge in un salone fastosamente arredato, “con un ampio arazzo francese del XVIII sec. che raffigura il Trionfo di Amore”, dove si muovono i vari personaggi ed in particolare i due personaggi-chiave: Sir Robert Chiltern, uomo politico “brillante” e di successo, sulla quarantina, dai modi distinti, di forte personalità, “molto ammirato da pochi, profondamente rispettato da molti”, e Mrs. Cheveley da poco giunta da Vienna. Tra i due la conversazione assume un tono completamente nuovo e diverso rispetto all'intonazione mondana e frivola che caratterizzava il conversare di tutti gli ospiti, di critica nei confronti della società londinese costituita da “un branco di stupidi che non parlano di niente”, “gente sciatta o di studiata eleganza”. Mrs Cheveley conosce il passato di Sir Robert, un passato che egli ha tenuto nascosto alla moglie e che cerca lui stesso di dimenticare perché lederebbe sicuramente la sua immagine di uomo integerrimo, di esemplare onestà, di “marito ideale”, come tutti lo ritengono. Mrs Cheveley sa che agli inizi della sua carriera politica ha tradito un segreto di Stato (vendendolo ad uno speculatore di Borsa), per raggiungere quel prestigio che poi ha effettivamente acquisito (è diventato Sottosegretario agli Affari Esteri) e lo ricatta ignobilmente per i suoi loschi traffici minacciando uno scandalo che lo getterebbe in un “pantano di fango”. Sarà l'intervento di Lord Arthur, “un impeccabile dandy”, a risolvere la questione a favore di Sir Robert e anche a convincere Lady Chiltern, che ha visto crollare vergognosamente l'immagine splendida del marito, a tornare a credere in lui, dato che non ha perso e non rischia più di perdere il suo prestigio. Su una struttura che sembra tradizionale, Oscar Wilde, “con il suo gusto per la battuta caustica, l'aforisma fulminante, il dialogo frizzante, il nonsense, il paradosso e il virtuosismo verbale”, scardina e abbatte ogni convenzionale ipocrisia. Tutti i personaggi ancorati alla loro eleganza si muovono in spazi angosciosi dove si annidano duelli, ricatti, compromessi: nessun personaggio “è come sembra”. Sir Robert, considerato da tutti “politico perfetto” e dalla moglie “marito ideale” nasconde nel suo passato un terribile segreto da cui si sente schiacciato “come un uomo su una nave che affonda”, per cui non ha “avuto rimorsi”, ma per cui, dichiara, ”ho elargito del denaro per tacitare la mia coscienza molte volte”; sua moglie Gertrude, donna apparentemente delicata e sensibile, modello di virtù, ha amato il marito solo per il suo potere, il suo prestigio, la ricchezza raggiunta e l'immagine che si era costruita di lui (“non è come gli altri”) e non lo accetta più ora che la “maschera” che ha 5 portato “per tutti questi anni” è caduta; Mrs Cheveley, a sua volta, nasconde dietro la maschera dell'eleganza e del fascino femminile un animo spregiudicato e scaltro, una costante tendenza all'inganno; infine Lord Goring, autoritratto di Wilde, giovane apparentemente disincantato e senza scrupoli, frivolo e superficiale, in realtà si rivela un individuo saggio, equilibrato, profondo conoscitore dell'animo e delle debolezze umane. Grazie a lui, abile mediatore, la vicenda ha buon fine. Questa volta le maschere, ad una ad una, cadono! ...e parliamo di cinema Un marito ideale G.B. 1948 regia di Alexander Korda, scenografia Cecil Beaton e Vincent Korda con Paulette Goddard, Michael Wilding, Hugh Williams, Diana Wynward Un giovane baronetto, sottosegretario, diventa uomo politico vendendo un segreto di stato. Incontra una vecchia fiamma che lo ricatta. Commedia molto british affidata a tre ingredienti principali: le toilettes della Goddard, deliziosa e perfida Lady Cheveley, il dialogo di Wilde e le scene di C. Beaton e V. Korda. Lieve satira contro la società inglese del tempo. G.B. 1999 regia di Oliver Parker con Cate Blanchett, Minnie Driver, Rupert Everett, Julienne Moore Un'attrice australiana (la Blanchett per Lady Gertrude Chiltern) e due americane (la Moore per Mrs.Cheveley, la Driver per Mabel Chiltern) in una compagnia di interpreti inglesi diretti con competenza dallo sceneggiatore-regista O. Parker che alla trasposizione della commedia di Wilde ha cercato di dare “ con un'invidiabile serie di slittamenti progressivi, un'impostazione più emotiva, mescolando malinconia e ironia e sottolineando l'attualità sui temi della corruzione e degli scandali politici” (Morandini). Come Lord Goring, anello di congiunzione tra i personaggi e alter-ego dell'autore, Everett è più romantico che incisivo. LO SPETTACOLO I tre atti del testo di O. Wilde sono ricongiunti da Roberto Valerio, regista, protagonista ed anche produttore, in un tempo solo che “scorre spedito come fosse un vaudeville”. Il sipario si apre su un sontuoso interno d'epoca: eleganti arredi (due tavoli di legno lavorato, un ampio canapè, alcune sedie) e un fondale di pannelli mobili che ruotando definiscono l'unico cambio d'ambientazione del testo. I sei attori in scena, rigorosamente con abiti adeguati, pronunciano alcune battute per poi muoversi a ritroso sul vorticoso effetto fonico di riavvolgimento di un nastro audio. Originale l'idea di presentare la vicenda come se fosse impressa in un vecchio disco che “all'inizio continua ad incepparsi ma poi ritrova la sua brillantezza” (D. Regatti). L'andamento a ritroso trova una conclusione con l'incipit della recita, in quell'incastro di dialoghi tra Sir Robert, la moglie Gertrude, la calcolatrice Mrs. Cheveley e Arthur Goring, intreccio tra affari e sentimenti, ricatti e ideali che vede in difficoltà Robert nell'interpretazione “riflessiva” di Roberto Valerio, spalleggiato e infine salvato da Arthur, un Pietro Bontempo in forma smagliante. È lui, in 6 tutto e per tutto, il perno, il deus ex machina della vicenda: l'equilibrio compromesso dall'avida Cheveley, una elegantissima Valentina Sperlì, perfida come il ruolo esige, viene ristabilito ”non senza batticuore” dal suo arguto personaggio, frivolo e profondo, leggero e feroce. Che sia lui, giovane ricco sfaccendato, emblema del disimpegno vacuo, disistimato dal padre, il Conte di Caversham, cavaliere della Giarrettiera (un vigoroso e felice Alarico Solaroli), adorato dalla “velleitaria” Gertrude (Chiara Degani), insidiato da Mrs.Cheveley, la chiave della situazione, è il perfido paradosso riservato da Wilde al pubblico vittoriano e al teatro borghese. È in questo modo che si deve leggere “l'asciugatura altamente teatrale” che Valerio applica al testo originale “distillandone una geometrica azione scenica da giocarsi con effetti filmici e straniamenti recitativi”. Grazie a tutti questi elementi e alla brillantissima recitazione, lo spettacolo risulta “delizioso e tutto effervescenza”. SPUNTI DI RIFLESSIONE Commedia farsesca, giocata sul feroce slittamento dei piani di verità in cui “niente è mai come sembra”: a farla da padrone è l'insieme di simulazioni e dissimulazioni cui sono costretti i personaggi nell'irrealizzabile velleità di essere ciò che non sono. L'utopia di Sir Robert, “marito ideale”, politico integro e idealista si rovescia radicalmente nella menzogna e nell'inganno, nel proposito di non perdere quello che ha accumulato in tutta la sua vita a livello di denaro e posizione, di non distruggere quell'immagine che ha dato di sé alla moglie e agli altri. Non è facile togliersi la maschera! È il perbenismo borghese che lo spinge all'inganno, ad assumere quella maschera che ormai fa parte di lui e da cui non può o non vuole liberarsi. Lo sorregge l'amore per Gertrude, un amore che si scopre non ricambiato o non ricambiato con la stessa intensità, perché non caratterizzato dall'accettazione dell'altro così com'è, ma per come appare: “ricordi di cose che mi hanno spinto ad amarvi...ricordi di parole che mi hanno spinto ad amarvi”. Consapevole di questo Robert si chiede: “perché voi donne non riuscite ad amarci con tutti i nostri difetti?...L'amore dovrebbe perdonare tutti i peccati, tranne il peccato dell'amore”. Non può non scaturire, a questo punto, una serie di domande che riguardano la sfera privata e i rapporti all'interno di una coppia: un marito, per essere ideale, deve anche impersonare la perfezione morale? Solo la perfezione può suscitare l'amore? Ma in questo caso è amore o venerazione di falsi idoli? È vero che le donne adorano quando amano e “quando perdiamo la nostra adorazione perdiamo tutto”? Non ha piuttosto ogni individuo, nella sua dimensione umana, diritto di essere venerato com'é, di poter mostrare le sue “ferite”, “di confidare le sue debolezze” alla donna che ama?. Giustamente lord Goring afferma che “la vita non può essere capita senza molta indulgenza”. La problematica di fondo di tutta l'opera è, però, sicuramente legata alla sfera politica, tema drammaticamente attuale anche nella nostra società che apre una serie di interrogativi sui concetti di moralità, integrità, compromesso, corruzione. È possibile una politica senza compromessi? Può l'uomo resistere al “vangelo dell'oro”? Tradire il suo onore per la “passione del potere”? La questione morale è un fatto privato o pubblico? È vero che la vita pubblica e quella privata sono cose diverse? Che “hanno leggi diverse” e si devono muovere su piani diversi? Tante domande cui è difficile dare risposte; è certo di sconcertante attualità la lezione di Machiavelli! Storia quanto mai contemporanea quella che Valerio porta sulle scene; niente di così cambiato dal 1895 ad oggi. Se differenza c'è è che Robert vorrebbe “che Dio gli avesse dato la forza di dire la verità...di vivere la verità...” mentre per i politici di oggi conta solo il potere, “il potere sugli altri uomini, il potere sul mondo”, “l'unica vera gioia di cui non ci si stanca mai”. È giusto, dobbiamo chiederci, che nessuno paghi per i propri errori, che nessuno affronti le proprie 7 responsabilità? Osserva Valerio nelle sue note di regia: “anche se il tipo di teatro che faccio non mira a lasciare messaggi, sono certo che si tratterà di un momento di riflessione fondamentale. Il fatto che poi venga affrontato in un genere come la commedia non toglie niente alla serietà della questione. Anzi, sono convinto che proprio questa leggerezza, quella di cui parla Italo Calvino nelle sue Lezioni americane, da non confondersi con la frivolezza, sia spesso il mezzo migliore per sviscerare alcune verità”. 8 martedì 4 dicembre La Traviata da La Traviata di Giuseppe Verdi con Monica Casadei regia di Monica Casadei NOTIZIE BIOGRAFICHE SU GIUSEPPE VERDI Cronologia delle opere e della vita 1813 - nasce a Roncole di Busseto da modesti commercianti e sin dalla tenera età prende lezioni di musica da don Pietro Baistrocchi, organista delle Roncole. 1823 - si trasferisce nella vicina Busseto per proseguire gli studi con Ferdinando Provesi, organista della Collegiata, e frequenta il liceo gesuitico. 1825 - inizia a lavorare nel negozio di A. Barozzi, presidente e mecenate della Società Filarmonica di Busseto per la quale scrive marce, sinfonie, concerti, musica vocale sacra e profana; risale al 1828 la prima Sinfonia eseguita durante le festività pasquali al Teatro di Busseto. 1829 - nonostante la sua provata abilità non vince il concorso per il posto di organista nel vicino paese di Soragna; nel 1831 si stablisce a casa di Barozzi ed intreccia una relazione con la figlia di lui Margherita. 1832 - la domanda di ammissione al Conservatorio di Milano viene respinta perché “forestiero”, perché supera i limiti di età di quattro anni e per la difettosa impostazione pianistica. Barozzi lo sostiene economicamente negli studi privati. 1835 - porta a termine la stesura lirica per due tenori e orchestra Io la vidi su testo di Calisto Bassi e compone un Tantum ergo per voce e organo. 1836 - dopo un lungo conflitto con le autorità ecclesiastiche, che volevano assegnare il posto vacante ad un altro, si insedia a Busseto come Maestro di musica comunale. Sposa Margherita Barozzi da cui avrà due figli. 1839 - trasferitosi a Milano, nonostante la morte dei figli manda in scena al Teatro alla Scala la sua prima opera Oberto, conte di San Bonifazio. Il successo gli procura una scrittura per Un giorno di regno, ossia Il finto Stanislao. 1840 - anno difficile per il compositore: muore la moglie e cade alla Scala Un giorno di regno. Nonostante il fiasco, nel 1842 gli viene affidato il Nabucco su libretto di Temistocle Solera che riscuote grande successo. Incontra la soprano Giuseppina Strepponi che poi diventerà la sua seconda moglie. 1844 – È l'anno de I Lombardi alla prima Crociata che trionfa alla Scala. La stella nascente di Verdi comincia a varcare le soglie dell'Italia per approdare al Kartnertortheater di Vienna, dove viene allestito il Nabucco. Inizia la collaborazione con Francesco Maria Piave per un'opera alla Fenice di Venezia.Concepisce l'idea di un'opera su Re Lear, progetto che non realizzerà. 1846 - alla Fenice ottiene successo Ernani (libretto di Piave su soggetto di Victor Hugo); la fama del compositore si diffonde pur trovando ostacoli con la censura che ne modifica più volte il libretto. Negli anni seguenti vengono allestite nei più importanti teatri: Giovanna d'Arco, Attila, Macbeth, definita dallo stesso Verdi “una delle più grandi creazioni umane”.A Londra alla presenza della Regina Vittoria dirige I Masnadieri (1847). 1848 - È a Milano, c'è la rivoluzione e Verdi scrive a Piave: “Non c'è e non ci deve essere che una musica grata alle orecchie degli Italiani del 1848. La musica del cannone!”. 1849 - a Roma cura la messa in scena al Teatro Argentina de La battaglia di Legnano, ultima opera “patriottica”, che ottiene grande successo “politico”. L'anno si chiude con l'esito “freddino” riscosso da Luisa Miller al San Carlo di Napoli. 9 1851 - “questo Rigoletto farà epoca nella mia vita”, pronostica Verdi prima della trionfale rappresentazione dell'opera alla Fenice. È avviata la cosiddetta “trilogia popolare” e anche la battaglia incessante con le censure di tutta Europa contro il soggetto “di ributtante immoralità e oscena trivialità” di Victor Hugo. 1853 - viene portato a termine il libretto de Il Trovatore che va in scena al Teatro Apollo di Roma con enorme successo, mentre è “un fiascone” la prima rappresentazione de La Traviata alla Fenice, dal romanzo Dame aux camélias di Dumas figlio alla cui lettura Verdi si era “infiammato”. 1855 - a Parigi consolida il suo successo europeo con Les Vespres siciliennes, successivamente con Le Trouvère. Un ballo in maschera approda a Roma dove riscuote un successo travolgente (1859). 1861 - È deputato nel primo parlamento unitario, l'anno seguente scrive l'Inno delle nazioni per la cerimonia di apertura dell'Esposizione Internazionale di Londra e mette in scena al Teatro Imperiale di San Pietroburgo La forza del destino. 1868 - a Milano incontra Alessandro Manzoni; nel 1871 con Aida inaugura il riaperto Teatro Kediviale de Il Cairo. 1874 – nella chiesa di San Marco dirige la prima Messa da Requiem nel primo anniversario della morte di Manzoni 1877 - “è finito! Salute a Noi (ed anche a Lui!!) Addio”. Così Verdi comunica a Boito di aver completato la partitura di Otello. L'opera va in scena alla Scala.Alla fine dello spettacolo la carrozza del compositore viene spinta a braccia dal pubblico entusiasta all'Hotel de Milan. Sempre alla Scala debutta nel 1893 Falstaff, un trionfo annunciato 1901 - un colpo apoplettico lo coglie il 27 gennaio all'Hotel de Milan. NOTIZIE SUL TESTO La Traviata, rappresentata per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia, non è subito capita, tanto che lo stesso Verdi parla, esagerando, di “un fiascone”. Rappresentata l'anno seguente al Teatro San Benedetto ottiene un grande successo, fino al successivo riconoscimento di capolavoro universale. Fonte dell'opera verdiana La dama delle camelie (1848) di Alexandre Dumas figlio per cui, inevitabilmente, Alfredo e Violetta si mescolano a Marguerite e Armand, protagonisti dello struggente romanzo, una storia che ha un solo merito, “quello di essere vera”, come è reale la società con il suo conformismo. Tale romanzo diviene prima dramma teatrale, poi opera lirica, poi balletto ed anche film. Da Eleonora Duse, a Sarah Bernhardt, da Maria Callas ad Alessandra Ferri, Marguerite-Violetta “con la voce, il canto o l'emozione del corpo che danza” ha fatto piangere intere generazioni. L'opera, in tre atti, è la storia d'amore di Alfredo Germont e della cortigiana Violetta Valery, tratta da Dumas su libretto di F.M.Piave. L'incontro tra Alfredo e Violetta avviene a Parigi in occasione di un sontuoso ricevimento nel salotto di casa della stessa Violetta. Germont, attratto dall'avvenente ospite, scioglie a lei un brindisi: “libiam ne' lieti calici” e l'assiste durante un malore dichiarandole l'amore che nutre per lei da un anno. Violetta, colpita e incredula consegna al giovane una camelia invitandolo a tornare l'indomani quando il fiore sarà sfiorito. Alfredo è raggiante, mentre Violetta, congedati gli ospiti, si interroga sulla possibilità che una donna del suo stato possa concedersi un vero amore. L'amore è sbocciato e i due vivono in campagna lontano dal clamore delle feste e della vita mondana. La visita di Giorgio Germont, padre di Alfredo, distrugge le speranze di riscatto di Violetta. Egli, infatti, le chiede brutalmente di troncare la scandalosa relazione con Alfredo. Violetta cede e con una lettera congeda l'amante e ritorna alla vita di sempre. Alfredo, deluso 10 dall'abbandono, roso dalla gelosia, la offende pubblicamente. Di nuovo a Parigi, Violetta è ormai consumata dalla tisi, senza denaro, ma felice che Alfredo sia venuto a conoscenza delle motivazioni della sua rinuncia. Il giovane Germont, al suo capezzale, le chiede disperatamente perdono. Violetta ha solo il tempo di donargli il ritratto di quando era bella e morire tra le sue braccia: “Gran Dio !...morir sì giovane, io che penato ho tanto!...” , mentre fuori impazza il carnevale. LO SPETTACOLO Traviata è il primo capitolo del progetto Corpo a corpo Verdi Trittico (2011-2013), coprodotto dal Festival Verdi e ispirato alla “trilogia popolare” del compositore. Seguirà entro il 2012 Rigoletto con debutto al Théatre de Suresnes Jean Vilar di Parigi e nel 2013 a Parma, in occasione del bicentenario della nascita di Verdi, l'intero Trittico con Trovatore in prima assoluta. La Traviata della Compagnia Artemis Danza-Monica Casadei rappresentata per la prima volta nel novembre del 2011 al Teatro Comunale di Ferrara è dedicata dalla Casadei (regia, coreografia, scene, luci e costumi) al padre morto pochi giorni prima del debutto. La coreografa, con la collaborazione di Luca Vianini (elaborazione musicale), conserva dell'opera verdiana i cori, le arie di Violetta, i duetti di Germont padre, mentre elimina le parti musicali di Alfredo se non per la scena riguardante l'offesa e il ripudio dell'amata: “questa donna conoscete”. L'elaborazione musicale combina parole e accenti chiave del testo in reiterate esclamazioni ( Addio, addio; È ben tardi!, È tardi!; Amami Alfredo) che costituiscono l'humus tragico sul quale la danza si fa più espressionista. Danza e opera, in una sorta di “viaggio coreografico”, duettano “dando corpo ad un fluire di immagini legato a doppio filo al dramma verdiano”. Lo spettacolo si apre mentre il coro, a luci accese, canta “libiam ne' lieti calici”, poi le luci si abbassano e compare Violetta replicata in sei danzatrici in abito bianco che ballano e mimano la feste, mentre l'Addio diviene ossessione come se la festa contenesse già l'epilogo. Gli abiti divengono rossi, poi ancora bianchi, poi vengono tolti e Violetta rimane nuda, indifesa, “senza filtri né paraventi”, nuda fuori e dentro. Il coro, personificazione della società, indossa abiti maschili, di colore nero; bianco e nero, quindi, il contrasto per eccellenza, apre una performance fondata sulle antinomie che accompagnano l'opera: amore e morte. Bianco e nero si dissolvono nel rosso delle passioni del cuore e nel bianco della purezza e della speranza, rappresentazione della molteplicità del sentire e della complicità emotiva dell'animo femminile. Grande efficacia e potenza caratterizza le danzatrici di Artemis Danza che portano sulla scena tante Violette: in abito bianco che, a dispetto della prostituzione, ruotano una sull'altra come “in una giostra di pupattole”; sono loro a portare avanti la storia. Da contraltare c'è un universo maschile in nero, duro e deciso; nasce una specie di lotta “corpo a corpo” danzato in un gioco di colori (appunto bianco, nero e rosso come il sangue) e musica. Appoggiandosi alle arie più famose di Verdi, la coreografia, dalla struttura semplice, rispetta l'antinomia bianco-rosso e trova il suo “clou” quando la stessa coreografa e regista “dalla forza neoespressionista” danza l'amore sanguinante e infinito (“cuore e delizia”), mentre una candida sposa prova ad incedere impettita senza riuscirci. Il cuore cede, ucciso dall'ipocrisia del coro che è l'ipocrisia della società. Una Traviata, quindi, dal punto di vista di Violetta: Violetta al centro di una società maschilista, Violetta moltiplicata in tanti elementi femminili, in “tanti spaccati del cuore”, Violetta disperata che aspira, pur cortigiana, a qualcosa di puro, Violetta contro cui si scagliano le regole borghesi rappresentate dal padre di Alfredo, simbolo di una società malsana. La coreografia, la compagnia, e la musica di Verdi insieme funzionano a meraviglia. La compagnia Artemis Danza affronta uno spettacolo di 90 minuti con una carica e un'energia straordinaria, 11 ottenendo una grande partecipazione e grande coinvolgimento da parte degli spettatori. SPUNTI DI RIFLESSIONE Lo spettacolo mantiene tutto il fascino e le suggestioni dell'opera di Verdi, pur senza gli elementi scenografici che caratterizzano l'opera. L'invocazione Amami Alfredo che in Verdi è subito dopo l'incontro decisivo tra Violetta e il padre di Alfredo è spostata nel finale e questo ha un preciso significato. È un urlo di disperazione, un grido di solitudine interiore da cui non c'è scampo, un'esplosione fisica di dolore, espressione di una ferita lacerante. A Violetta è infatti negata la speranza di un sentimento d'amore, il suo cuore gronda sangue (danza in abito rosso), sangue che è conseguenza della tisi, ma soprattutto dell'umiliazione subita e della conseguente sofferenza interiore. La ferita è provocata dall'esclusione, dal disprezzo, dal venir meno della speranza di una rinascita. Violetta è una donna vittima, come tante donne, delle convenzioni e dei condizionamenti sociali, delle ipocrisie borghesi, dei conformismi più oscurantisti. Come prostituta Violetta poteva essere integrata “nascostamente” nella società, da “cortigiana”; animata dal desiderio di uscire dal suo destino non può che essere punita dalla malattia, dall'abbandono, dal dispezzo, dalla morte. La società delle apparenze vuole il suo sacrificio. Non si può non riconoscere con amarezza che nella nostra società, dove è più importante apparire che essere, persistono concezioni assurdamente conservatrici. Con ancora maggior amarezza dobbiamo essere consapevoli che, mentre il perbenismo moralistico ottocentesco escludeva la prostituta dal contesto sociale, oggi le escort, che altro non sono che prostitute, sono considerate modelli di comportamento e di vita, oggetto di desiderio e di imitazione, perché famose e ricche. Sempre e comunque si tratta di un comportamento maschilista fondato sullo sfruttamento. E torniamo a parlare di ipocrisia della società. Il moralismo malsano, ancora dominante, non concede possibilità di riscatto, non considera le infinite e complesse ragioni del cuore umano, bolla e condanna indiscriminatamente in base a criteri indiscutibili. Nello spettacolo, Violetta, la gonna bianca, la gonna della “festa” che balla in mezzo alle altre un assolo di schiena rappresenta in maniera chiara ed emblematica la sua condizione di solitudine, di esclusione, il suo cammino verso la morte. È l'esclusione di chi è diverso e in questo caso di chi è al di fuori delle convenzioni. Si consuma drammaticamente il conflitto tra singolo e società, tra pubblica facciata e privato sentire. 12 martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 dicembre Luigi Pirandello Così è se vi pare con Giuliana Lojodice, Pino Micol, Luciano Virgilio regia di Michele Placido NOTIZIE BIOGRAFICHE SU LUIGI PIRANDELLO 1867 - nasce a Girgenti (oggi Agrigento) nella contrada chiamata Caos. Per questo Pirandello dirà emblematicamente : “io sono il figlio del caos”. 1880 - studia Lettere all’Università di Palermo. 1889 - si trasferisce all’Università di Bonn; pubblica la sua prima opera Mal giocondo,raccolta di poesie. 1891 - si laurea a Bonn con una tesi sui dialetti di Girgenti. 1894 - sposa Antonietta Portulano. 1897 - insegna a Roma letteratura italiana. 1903 - dissesto finanziario; primi segni della malattia mentale della moglie. 1904 - pubblica Il fu Mattia Pascal. 1908 - pubblica il saggio L’umorismo. 1910 - inizia la collaborazione con il “Corriere della sera”. 1911 - pubblica il romanzo Suo marito. 1913 - esce in volume il romanzo I vecchi giovani. 1915 - pubblica a puntate il romanzo Si gira, divenuto Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 1916 - rappresentazione di Pensaci, Giacomino!. 1917 - prima rappresentazione di Così è, se vi pare. 1919 - la moglie viene ricoverata in una casa di cura. 1921 - prima rappresentazione di Sei personaggi in cerca d’autore. 1924 - aderisce al fascismo. 1925 - legame affettivo con Marta Abba. 1926 - pubblica Uno, nessuno e centomila. 1930 - rappresentazione di Questa sera si recita a soggetto. 1934 - riceve il premio Nobel per la Letteratura. 1936 - muore il 10 dicembre; dieci anni dopo le ceneri vengono murate, secondo la sua volontà nella campagna di Girgenti. “Mie ultime volontà” I - Sia lasciata passare sotto silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiere, non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzii né partecipazioni. II - Morto, non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. III - Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accompagni, né parenti né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. IV - Bruciatemi. E il mio corpo, appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, neppure la cenere vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l’urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui. NOTIZIE SUL TESTO La “parabola in tre atti” Così è se vi pare, ricavata dalla novella La signora Frola e il signor Ponza suo genero del 1915, composta probabilmente tra il marzo e il maggio del 1917, viene rappresentata 13 per la prima volta nel giugno dello stesso anno al teatro Olympia di Milano dalla compagnia Virgilio Talli. Il dramma, pubblicato nel 1918 nella prestigiosa rivista quindicinale “Nuova Antologia”, entra contemporaneamente nella raccolta di testi teatrali Maschere nude. Il testo della “parabola” scandito in tre atti, “capolavoro del problematicismo pirandelliano” (De Castris) sin dal titolo è incentrato sulla dialettica tra la fiducia naturalistica (così è) e la restrizione relativistica (se vi pare); il titolo è come tagliato in due e la seconda parte sembra “il ripensamento o la correzione o il dubbio della prima” (G. Macchia). La commedia, rispetto alla novella, si presenta come una trasposizione e rielaborazione più complessa e articolata che coinvolge il numero e l'identità dei personaggi, la soppressione o l'inserimento di episodi, il testo dei dialoghi. Il racconto è costruito come un lungo monologo in cui confluiscono tutte le chiacchiere fatte in paese a proposito della curiosa vicenda dei due protagonisti, la signora Frola e il signor Ponza; nel passaggio al testo teatrale Pirandello deve dare un nome alla folla anonima che si concretizza in alcuni personaggi secondari, “giudici” della vicenda: il prefetto, il consigliere Agazzi, sua moglie Amalia, i signori Sirelli, altri “signori e signore” e Lamberto Laudisi. La funzione del narratore nel testo teatrale è scomparsa, ma il suo ruolo di ironico commentatore è assunto da Laudisi che sconvolge la mentalità dei borghesi benpensanti instillando il germe del dubbio sistematico. Viene meno anche la precisazione topografica perché invece che di Valdana, paese inesistente, si parla nel dramma genericamente di un capoluogo di provincia. La signora Ponza, di cui nella novella si parla pur rimanendo un'identità misteriosa, ha un ruolo fondamentale nella scena finale del dramma. In una qualsiasi cittadina di provincia giungono il signor Ponza, nuovo segretario di Prefettura, la moglie e la suocera provenienti da un paesino della Marsica distrutto da un terremoto (verificatosi in realtà nel 1915). La suocera va ad abitare nel centro della cittadina, mentre la coppia si stabilisce in un condominio di periferia. La strana situazione suscita in tutti i paesani (eccetto Laudisi) non poche curiosità, pettegolezzi, interrogativi e supposizioni a non finire: la signora Frola non può vedere la figlia e comunica con lei solo attraverso biglietti calati in un paniere, evita di fare visita alle signore della cittadina, il signor Ponza ogni sera si reca in visita dalla suocera e tra i due sembra regnare una grande armonia. Il perché madre e figlia non si possano né vedere né parlare tormenta gli altri abitanti. A favorire le più varie ipotesi contribuiscono le dichiarazioni contrastanti dei personaggi-chiave, ognuno dei quali racconta la “sua” verità. Secondo il signor Ponza la suocera è pazza: crede, infatti, che sia ancora viva la figlia morta invece da quattro anni. La donna che vive con lui è la sua seconda moglie che generosamente si presta allo scambio di biglietti con la signora Frola, secondo la quale pazzo è il genero che si crede vedovo e risposato; la moglie non è morta, ma è stata ricoverata in una casa di cura per essere sottratta all'affetto possessivo del marito che, tornato a casa, non l'ha riconosciuta, motivo per cui si è inscenato un secondo matrimonio. Il signor Ponza rivela anche che forse la suocera non è più pazza, “non sembra più pazza affatto”; a sua volta la signora Frola confida che il signor Ponza forse si è riavuto dalla sua alterazione pur continuando nella sua finzione “ per stare sicuro”, perché teme che la moglie gli possa essere di nuovo sottratta. Le continue e affannose ricerche per scoprire la verità da parte delle autorità non approdano a nulla; al paese d'origine tutto risulta “disperso o distrutto: municipio, archivio, stato civile”, non si trovano neppure superstiti del terremoto in grado di testimoniare. Sono in questione sia la categoria di identità (chi è veramente la moglie?) sia quella di verità: è pazza la suocera o il genero? Le autorità cittadine, nell'intento di arrivare ad una presunta “verità” oggettiva, mettono in scena una specie di inchiesta giudiziaria e di tribunale per cui, come osserva Macchia, il palcoscenico diventa una sorta di “camera di tortura” dove i “giudici”, o coloro che si ritengono tali, si fanno “carnefici degli altri”, dove si martirizzano i personaggi. Ma neanche il confronto diretto tra i due protagonisti risolve l'atroce dilemma. Per risolverlo, per tentare di scoprire il “vero”, il Prefetto convoca l'unica persona “che possa dire la 14 verità”, la signora Ponza; lei risolverà il mistero e allontanerà ogni dubbio. Ma neanche lei è in grado di rivelare una “verità” univoca e oggettiva: dichiara, infatti, di essere Lina, la figlia della signora Frola, ma anche Giulia, la seconda moglie del signor Ponza, concludendo con la sconcertante affermazione: “...per me nessuna!”... “Per me, io sono colei che mi si crede”. L'impossibilità di conoscere la verità, la negazione del concetto stesso di identità sono sintetizzati in quest'ultima memorabile battuta della signora Ponza e trovano suggello nella battuta finale e nella risata di Laudisi che fanno da epilogo: “Ed ecco, o signori, come parla la verità!... Siete contenti?... Ah! Ah! Ah!”, a tutta la vicenda. Tutta la commedia converge verso l'atto finale che dovrebbe, nelle aspettative della gente, essere risolutivo e che invece non risolve nulla. Le vicende si svolgono in un tipico salotto borghese, apparentemente secondo le convenzioni del teatro tradizionale; ben presto, però, ci si accorge che nell'opera di tradizionale rimane ben poco, dal momento che viene messa in discussione la stessa verità dei dati di fatto per cui si può solo approdare a una non-verità. LO SPETTACOLO Lo spettacolo riesce a riproporre con genialità la sicilianità e l'emblematicità dell'opera pirandelliana attraverso precisi accorgimenti scenografici: la rappresentazione inizia con una battuta che il cameriere della famiglia Agazzi rivolge alla padrona di casa, “i cannoli sono finiti”. Nel testo originale la battuta non c'è, ma “quel cannolo - dichiara Michele Placido, regista dello spettacolo permette di introdursi in una casa agrigentina anni '60, forse come l'avrebbe immaginata Pirandello... l'uso stesso del colore dialettale avrebbe fatto risaltare maggiormente l'aspetto provinciale di una certa Italietta ancora legata a reminiscenze esoteriche e magiche”. Inoltre, l'idea di rompere lo specchio del salotto di casa Agazzi permette non solo a Laudisi, ma a tutti i personaggi di cogliere il loro “doppio rivelarsi” nei suoi frammenti, le loro ambiguità; “i personaggi che appaiono e scompaiono senza avere la necessità delle tradizionali entrate e uscite” risultano presenze vane e inconsistenti. La prima immagine che colpisce lo spettatore del “ Così è...” è costituita, infatti, da uno specchio gigantesco rotto i cui pezzi in frantumi cadono verticalmente sul pavimento a formare idealmente e concretamente pareti e porte trasparenti che riflettono la casa borghese dove si svolge la vicenda. Tra le scene disegnate da Carmelo Giammello e con i costumi firmati da Sabrina Chiocchio si agitano e si arrovellano i personaggi: Giuliana Lojodice solenne e dolente signora Flora, quasi parodia di mito greco, Pino Micol signor Ponza dagli sfoghi controllatissimi grazie ad una dizione impeccabile e Luciano Virgili, ironico Laudisi, alter ego dello scrittore, il raisonneur che commenta la presunzione degli sciocchi indagatori. Placido, con una regia che è stata definita “spiritosa” (Masolino D'Amico), sapendo di poter contare su un “terzetto d'assi” spinge la messinscena verso una realtà italiana e provinciale che si tinge di grottesco. Laudisi ridacchia, la signora Frola arringa i persecutori come poche volte si è visto relativamente al personaggio, Micol, infine, disegna un Ponza che entra ed esce dalla presunta pazzia, personale o altrui, con la disinvoltura e la bravura di un mattatore accademico. Lo spettatore vive quasi un thriller, ma nello stesso tempo assapora e comprende Pirandello, “le sue pieghe le sue piaghe, il suo creare bandoli archetipici e scandalosi nel fondo dei cuori e dei cervelli”. (Rita Sala) Nelle sue note di regia Michele Placido descrive la commedia come una “satira filosofica” e un inno ai personaggi martirizzati di Pirandello, come un testo “non solo teatrale, ma anche una scrittura cinematografica che fa pensare al cinema di Hitchcock”. Non a caso il grande Kurosawa si è ispirato a questo testo per il suo film Rashòmon. 15 SPUNTI DI RIFLESSIONE L'efficacia del dramma dipende non tanto dalla sua dimensione “filosofica” che ne fa una sorta di manifesto del relativismo gnoseologico pirandelliano, quanto dal freddo accanimento con cui l'autore aggredisce la comune nozione di verità e mette a nudo il “sadismo” piccolo-borghese. Nella vicenda si contrappongono due mondi incomunicabili: quello della borghesia provinciale chiusa nelle sue false certezze e in uno sterile burocraticismo, protesa al raggiungimento “ della verità”, e quello della follia e della sofferenza che stravolge ogni criterio oggettivo. Tutto viene, però, forzato nel senso del paradosso e dell'assurdo, strumenti basilari del procedere umoristico di Pirandello. Il dramma presenta tre verità che si escludono a vicenda: quella del signor Ponza, quella della signora Frola, quella ambigua e dialettica della signora Ponza che peraltro non ha una “sua” verità. Infatti “si sdoppia” (J.M. Gardair) per dare ragione contemporaneamente al marito e alla madre che si allontanano insieme piangendo e consolandosi a vicenda. In un contesto in cui dominano la logica razionale e le convenzioni borghesi, le due verità non possono coesistere, la terza può solo affermare di non avere una identità propria. La confusione tra verità e menzogna, tra realtà e follia rimane inestricabile e la commedia si chiude sullo stupore sconcertato di ogni personaggio che vede delusa la sua assurda pretesa di scoprire la verità. Il finale enigmatico dell'opera è contrassegnato da un umorismo amaro e beffardo attraverso cui traspare chiaramente l'idea che alla realtà del mondo, delle vicende umane non corrisponda un'unica verità, ma soltanto infinite opinioni possibili che mutano con il mutare dei “giudici” e degli osservatori. Nelle varie scene vengono approfonditi alcuni motivi che sono al centro di tutta la produzione pirandelliana: il motivo dell'identità individuale (chi sono?), del rapporto individuoaltri, quello dell'essere in rapporto ad una dimensione sociale e quello, infine, centrale dell'impossibilità di un'unica “verità”. Rimangono aperti tutti gli umani interrogativi esistenziali che caratterizzano l'uomo di ieri e di oggi: Chi sono? Dov'è la realtà? Chi è il pazzo? Cos'è la normalità? Dov'è la giustizia? La dichiarazione della signora Ponza lascia tutti esterrefatti dal momento che tutti si aspettano da lei la soluzione del dilemma, l'agnizione, il riconoscimento finale dell'identità, che nel mondo di Pirandello non ci possono essere. Qualunque fosse stato, infatti, avrebbe rappresentato un “lieto fine” indicando quale delle due affermazioni era vera e quale dei due personaggi il pazzo: tutto sarebbe rientrato nella normalità, nell'assurda pretesa di una “normalità”. La scelta di Pirandello di lasciare l'ambiguità è tanto più trasgressiva in quanto non c'è indizio di follia nella signora Ponza: la sua dichiarazione è l'espressione di una condizione “normale” in cui l'identità è determinata di volta in volta in base a ciò che credono coloro con cui si entra in relazione. È significativo che sia la stessa signora Ponza, nell'ultima scena, a rassicurare “madre” e “marito”, sottoposti all'inquisizione degli altri, dicendo loro “con austera solennità”, “Non temete! Non temete! Andate via” quasi a rivelare un patto tra i tre personaggi che è destinato a rimanere segreto. Dimostrazione, questo, di quel pessimismo esistenziale che porta Pirandello alla convinzione che niente esiste, se qualcosa esiste non possiamo conoscerlo, se qualcosa esiste e possiamo conoscerlo, non possiamo comunicarlo agli altri, rivelandosi in tal modo, secondo quanto afferma G. Morra, erede dell'insegnamento di un altro grande siciliano, il sofista Gorgia di Lentini. Una particolare riflessione merita Laudisi, vero personaggio guida ed anche “epico” della vicenda. È lui, di volta in volta, a distinguere, analizzare, sottilizzare; attraverso i suoi ragionamenti paradossali, i suoi ammiccamenti, i suoi scoppi di riso mette in crisi, contesta, smonta la pretesa di una verità oggettiva sostenendone l'impossibilità; la verità non è nei fatti, ma nell'animo di chi li 16 vive e li osserva, non è assoluta ma relativa. Laudisi è il filosofo (tra l'altro è accusato di filosofia da Agazzi: “filosofia caro, filosofia!”), vocazione che può risultare attività perturbatrice e corruttrice secondo un'accezione negativa, qui svolta in una dimensione tipicamente basso-borghese, perbenistico-borghese; ma può anche risultare pericolosa soprattutto se introduce il dubbio sui principi costitutivi della società: Identità, Autorità, Ordine. Laudisi conclude ogni atto con una risata di scherno indirizzata agli abitanti di casa Agazzi e a tutti gli “inquirenti” e curiosi, di scherno per le pretese vane di quegli inquisitori di provincia, al cui gruppo sociale anche Laudisi appartiene. Ma egli è “filosofo”, non Prefetto, né Consigliere di Prefettura e perciò non coinvolto nell'ordine convenzionale del salotto o dell'ufficio. La sua filosofia lo distingue e separa dalla propria stessa famiglia, dal proprio gruppo, dalla propria classe. Solo lui può muoversi in entrambi i piani, può da un lato aggirarsi senza esserne irretito in quelle “stanze della tortura” che l'interno borghese rappresenta e dall'altro capire la non meno torturante dimensione che accomuna i tre sventurati “diversi”. L'unico personaggio davvero disposto a comprendere sa a priori che nulla si può appieno comprendere, che la verità è inconoscibile. Come il titolo, significativo è anche il sottotitolo parabola in tre atti”. Il termine “parabola” allude ad un racconto esemplare e dimostrativo; l'attenzione si sposta così, preventivamente, dalle vicende in sé ad un loro più ampio significato. ... e parliamo di cinema Rashòmon, Giappone 1950, regia di Akira Kurosawa con Toshiro Mifune, Masayuki Mori, Machico Kyo, Takashi Shimure Sceneggiatura Shinobu Hashimoto e A. Kurosawa, fotografia Kazno Miyagawa, scenografia So Matsuyama, musica Fumio Hayasaka. Intorno al 1100, sotto il portico di un antico tempio a Kyoto, un boscaiolo, un bonzo e un servo parlano della durezza dell'epoca e in particolare di un processo che si è svolto da poco nel quale sono state date di un delitto quattro diverse versioni tra loro contrastanti. Un bandito aveva aggredito e ucciso un samurai mentre in compagnia della moglie attraversava un bosco. Al processo testimoniano, fornendo ognuno la sua versione dei fatti, il bandito, il servo, la donna ed anche lo stesso samurai morto la cui anima è evocata da una maga. Anche in questo caso interrogativi a non finire. La donna è stata violentata? Era consenziente? Il marito è stato ucciso mentre fuggiva come un vigliacco o si è suicidato per evitare il disonore? A chi credere? Sotto la porta del tempio c'è un neonato abbandonato; il servo scappa, il boscaiolo invece decide di salvarlo adottandolo. Il bonzo, nonostante la triste storia di cui è stato testimone, per questo gesto del boscaiolo ritrova fiducia e, in modo diverso rispetto ai personaggi pirandelliani, si riconcilia con l'umanità. Scandito dal ritmo ossessivo di un bolero, è un film in cui le diverse componenti letterarie, psicologiche, psicanalitiche e drammatiche si fondono in una superiore unità filmica che rimanda al cinema muto e, contemporaneamente, anticipa la tecnica televisiva (Morandini). Giocato sul dinamismo dell'immagine, sui rapidi e intensi movimenti di macchina, su un montaggio di estrema precisione, Rashòmon si affida alla recitazione eccessiva degli attori rafforzata dal maquillage espressionista del muto. La fotografia ne accentua il carattere ambiguo ed onirico. (Di Giammatteo) Il film, vincitore del Leone d'oro a Venezia nel 1951 e dell'Oscar come miglior film straniero, ha 17 rivelato in occidente il cinema giapponese. L'opera vuole dimostrare l'inesistenza di una verità univoca e assoluta; di un avvenimento esistono tante versioni ugualmente valide quanti sono i protagonisti. Il bonzo capisce che l'unica cosa in cui si deve credere è la bontà del cuore umano. Evidente l'analogia con il dramma di Pirandello, anche se diversa la conclusione che nel film dà spazio alla speranza. Un critico americano disse che Kurosawa aveva imparato l'arte della fotografia da Fritz Lang, quella della rappresentazione teatrale da Pirandello e che era stato ispirato dalla musica di Ravel. E così “il suo cinema svolge la funzione di un meraviglioso intermediario”. 18 Martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 gennaio Rain Man adattamento per il teatro di Dan Gordon tratto dal film omonimo della MGM Compagnia della Rancia regia di Saverio Marconi Dal cinema al teatro ...e parliamo di cinema Rain Man- L'uomo della pioggia - USA 1988 regia di Barry Levinson soggetto Barry Morrow, sceneggiatura Ronald Bass e B. Morrow, fotografia John Scale, scenografia Ida Random, musica Hans Zimmer, montaggio Stu Linder con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino. Charlie Babbit, importatore di auto di lusso a Los Angeles, si trova in difficoltà finanziarie cui non riesce a trovare una soluzione. Si prende una vacanza a Palm Springs con la sua segretaria e amante, Susanna. Lì lo raggiunge la notizia che a Cincinnati è morto suo padre. Apprende che da lui ha ricevuto un'eredità irrilevante (una Buick Roadmaster del ‘49, un roseto), mentre l'intero patrimonio va ad un erede di cui non si conosce l'identità. Charlie trova l’auto presso la clinica Wallbrook di Cincinnati, dove sono ricoverati i malati di mente. Uno degli ospiti, Raymond, riconosce la macchina. Charlie apprende così dal dottor Bruner, lo psichiatra, che Raymond è suo fratello maggiore. Raymond soffre di una grave forma di autismo che gli impedisce i rapporti con gli altri, ma ha sviluppato una memoria eccezionale. Charlie, oppresso dai suoi problemi economici, decide di tentare una carta disperata: convincere il fratello a seguirlo a Los Angeles e a diventarne l'esecutore testamentario e il tutore. Inizia così il viaggio da Cincinnati a Los Angeles, un viaggio più lungo del previsto sulla vecchia Buick bianca, dal momento che Raymond non vuole prendere l'aereo né viaggiare sulle autostrade dato che conosce a memoria tutte le statistiche degli incidenti. Charlie, a poco a poco, scopre che era Raymond che da piccolo lo consolava quando aveva paura, ed incomincia a sentire un certo legame con lui, ma assediato dai creditori matura un'altra idea: sfruttare le capacità mnemoniche del fratello per giocare a Las Vegas. I soldi vinti permettono a Charlie di regolare i suoi affari, ma è ancora forte in lui il desiderio di poter usufruire dell'eredità di Raymond. Comprendendo, però, che Raymond sarebbe infelice lontano dalla clinica di Cincinnati, lo abbraccia e lo lascia andare con il dottor Bruner, anche se non vorrebbe separarsi da lui, e non per l'eredità. L'abilità del regista consiste nella contrapposizione tra le personalità dei due fratelli, osservate con il distacco di un'indagine scientifica: sia l'autistico, sia il mascalzone con l'acqua alla gola. Tra Cincinnati e Los Angeles attraverso la lunga tappa a Las Vegas, Rain Man non è il patetico confronto tra due fratelli che non si conoscono, e non potranno mai conoscersi, quanto un pittoresco road movie dove si alternano stupendi paesaggi del West, dolci e immense pianure del Missouri, luci notturne di Las Vegas, le colline della California, lo sfavillio di Los Angeles. Certo, l'ospedale di Wallbrook richiama alla mente gli analoghi ambienti di Qualcuno volò sul nido del cuculo di M. Forman, ma il problema psichiatrico cede presto spazio all'avventura di un incontro tra due esseri umani che imparano a conoscersi. Se Dustin Hoffman si affida ad una recitazione spoglia e atona, Tom Cruise appare sempre convincente nella vivacità, nel disagio, nella perfidia, nella prepotenza; spenta Valeria Golino nella parte di Susanna. (da F. Di Giammatteo) 19 Il film è vincitore nel 1989 di quattro premi Oscar: film, regia, sceneggiatura, attore protagonista e dell'Orso d'oro a Berlino. LO SPETTACOLO Rain Man ha debuttato nella versione teatrale nel 2008 all'Apollo Theatre di Londra con un adattamento curato da Dan Gordon; la versione italiana è diretta da Saverio Marconi con la regia associata di Gabriela Eleonori. Non è la prima volta che Marconi porta a teatro un film famosissimo (Sette spose per sette fratelli, Cabaret, Tutti insieme appassionatamente); ora ci riprova con un grande classico. Il passaggio dalla pellicola alle assi del palcoscenico è sicuramente non facile. Tutti ricordano, infatti, i grandi spazi del viaggio in macchina dei due protagonisti e la sfavillante Las Vegas, ma Marconi ama sempre sperimentare ed ha creato un notevole Rain Man che ricalca il film, tranne qualche particolare. Per questa “avventura” il regista si è affidato ad interpreti di grande calibro, con alle spalle importanti successi teatrali, cinematografici e televisisvi: Raymond, nel film Dustin Hoffman, è interpretato da Luca Lazzareschi, attore con un ampio repertorio drammatico che spazia dai classici ai testi contemporanei, che ci presenta un Raymond assolutamente credibile attraverso i gesti, le movenze, il passare ossessivamente da un piede all'altro, la testa di lato, lo sguardo fisso, le parole monotone. Al suo fianco, nel ruolo di Charlie, nel film Tom Cruise, Luca Bastianello, reduce da fiction televisive (Centovetrine) e dal teatro che unisce ad una straordinaria somiglianza fisica con Cruise, di cui riprende persino i movimenti della mascella, una interpretazione dalle diverse sfaccettature che rendono efficacemente l'evoluzione del personaggio. Accanto a loro altri bravi attori tra cui Valeria Monetti che ci dà nel ruolo di Susanna un personaggio forte, ma allo stesso tempo comprensivo e paziente, capace di grandi decisioni. La scenografia vivace, dinamica e accurata rende in maniera perfetta il viaggio in auto dei protagonisti, trasformandolo in un percorso affettivo e psicologico “pieno di onirici elementi geometrici” (Silvia Arosio), così importanti per la mente degli autistici. Lo spettatore può entrare in questo modo nella mente di Raymond e comprendere con rispetto un mondo visto con occhi “differenti”. La scenografia, di grande impatto, è infatti una specie di scatola a sezioni rettangolari, grigia, che sembra rispecchiare gli schemi mentali di Raymond; su di essa vengono proiettate le scene, calate dall'alto come fossero fondali, ed anche il caleidoscopio di immagini confuse ed emozionali che esplodono nella mente del “savant” nei momenti di crisi. I costumi sono identici a quelli del film. È uno spettacolo in cui si ride, ma come per il film di un riso amaro, empatico, riflessivo. Ci si commuove quando Charlie insegna al fratello a ballare o quando Raymond appoggia la testa sulla spalla del suo nuovo “migliore amico”. Dalla catarsi di tale gesto liberatorio all'amarezza del finale dove il “savant” riprende il suo zainetto e torna a chiudersi nell'ospedale. SPUNTI DI RIFLESSIONE Questo progetto teatrale costituisce per la Compagnia della Rancia l'occasione e l'opportunità di informare e sensibilizzare sul tema dell'autismo, oggi di sempre maggior diffusione. Il regista afferma: “conoscevo attraverso il film la storia di Raymond, ma solo grazie alla preziosa 20 collaborazione scientifica con l'Associazione Autismo Italia e al lavoro sul personaggio ho potuto scoprire questo universo. Sono rimasto profondamente colpito dalle statistiche che indicano 2 soggetti colpiti da autismo su 1000 e mi auguro che lo spettacolo possa puntare l'attenzione sull'unicità e complessità delle relazioni con le persone autistiche, non solo durante l'infanzia e l'adolescenza, ma soprattutto in età adulta”. Il personaggio di Raymond - dichiara sempre Marconi - è ispirato a Kim Peek, morto nel 2009 a 58 anni, colpito sin dalla nascita dalla cosiddetta “sindrome del saggio”, una alterazione neurologica rarissima che si manifesta solo nel 10% delle persone affette da autismo. Lo sceneggiatore B. Morrow che lo ha incontrato ad un convegno nel 1984 rimane colpito dalle strabilianti capacità di Kim, tra cui quella di memorizzare l'opera omnia di Shakespeare o i prefissi telefonici di tutti gli Stati Uniti e decide di dedicargli il film. Gli ultimi anni di Peek, attraverso conferenze e incontri, hanno avuto come unico obiettivo “l'appello ad imparare a riconoscere e rispettare le differenze negli altri trattandoli come vorreste essere trattati voi”. È questo il punto focale su cui verte la problematica del soggetto affetto da autismo, sindrome ancora “misteriosa” di cui sono chiari i sintomi con cui si manifesta mentre si sa poco o molto meno sulle cause e le possibili terapie. Non è lui che deve adattarsi al modo “normale” di guardare il mondo, ma sono i cosiddetti normali che devono cercare di entrare nel suo mondo, nel suo modo di ragionare, nel suo “caleidoscopio di immagini confuse ed emozionali”. L'autismo è “un disturbo straordinariamente enigmatico e nello stesso tempo così sottile e maligno nei suoi effetti che consente un progresso evolutivo e tuttavia non permette una completa integrazione nella comunità adulta”. (U. Frith, L'autismo, ed. Laterza). Si comincia a notare dall'infanzia, ma non è solo un disturbo infantile. L'etichetta “bambino affetto da autismo” mette in evidenza che prima e soprattutto c'è un bambino. L'handicap non va confuso con l'identità della persona anche se è facile cogliere negli occhi e negli atteggiamenti degli “altri” una reazione negativa di rifiuto, di estraniazione , in particolare conseguenza del fatto che spesso non ci sono segni esteriori evidenti di malattia. Anzi, osserva la Frith, “il bambino autistico colpisce chi lo osserva per la sua bellezza incantevole, un po' da altro mondo. È difficile credere che dietro quell'immagine da bambola si celi una malattia neurologica sottile ma devastante”. Si deve sempre ricordare che “l'altro”, comunque sia, ha una personalità distinta ed unica, un proprio modo personale di gestire le situazioni e la vita, che ognuno di noi ha il dovere di capire o di cercare di capire e penetrare. Questo concetto va applicato soprattutto nei confronti dei soggetti in cui la diversità è maggiore. Lo spettacolo, come il film, spiega la “malattia” dell'autismo ed evidenzia che grazie agli stimoli giusti e all'amore i soggetti colpiti possono arrivare a condurre una vita piena. Charlie che da bambino storpiava il nome del fratello Raymond in Rain Man riesce a capire il valore della diversità scoprendo il significato dell'amore incondizionato che significa anche rispettare la volontà dell'altro. L'attenta analisi del mondo degli affetti fa riflettere sulle dinamiche familiari e sociali così formative nella crescita della persona e nei suoi rapporti con se stessa e con gli altri. Il viaggio di Raymond e Charlie da Cincinnati a Los Angeles si può collegare al più recente e reale viaggio di un padre con il figlio autistico attraverso gli Stati Uniti raccontato in Se ti abbraccio non avere paura di F. Ervas. Diverse le motivazioni: la molla che spinge Charlie è l'interesse economico e Raymond lo subisce, quella del padre di vivere “insieme” al figlio un'avventura condivisa per “prendere il largo”, per fare insieme “il nostro” viaggio, contro l'opinione di tutti. In entrambi i casi, però, è un viaggio, potremmo dire di “formazione”, attraverso cui i personaggi, ciascuno a suo modo, effettuano una loro crescita a dimostrare la forza e la potenza dell'amore. Attraverso 21 l'esperienza del viaggio i due fratelli che non si conoscono riescono a stabilire un affiatamento insospettato e insospettabile anche se ognuno di loro prende una strada diversa, padre e figlio intensificano il loro legame che va oltre l'affetto padre-figlio grazie all'aver vissuto insieme un'esperienza unica, al di fuori delle convenzioni e delle consuetudini e, forse, irripetibile. 22 venerdì 8 febbraio Aspettando Godot di Samuel Beckett con Natalino Balasso e Jurij Ferrini regia di Jurij Ferrini NOTIZIE BIOGRAFICHE SULL'AUTORE Nato a Dublino nel 1906 da una famiglia anglo-irlandese di religione protestante, Samuel Beckett compie gli studi nella città natale dove si laurea con una tesi su Proust. Inizia la carriera accademica che interrompe nel 1928 quando si reca a Parigi come lettore di inglese presso la Sorbona. Si allontana da Parigi, compie vari viaggi in Europa, ma nel '37 si stabilisce definitivamente nella capitale francese dove rimane quasi ininterrottamente fino alla morte avvenuta nel 1989. Il periodo del secondo conflitto mondiale lo vede inizialmente neutrale e tollerato dalle autorità naziste, quindi costretto alla fuga per aver aderito alla Resistenza francese. Lascia Parigi per sottrarsi alla Gestapo e vi torna nel '45. Da questo momento la sua attività letteraria diviene particolarmente fertile. Solido conoscitore della cultura francese, inglese ed italiana, autore di saggi su Proust e Joyce (di cui ha sposato la figlia e che esercita su di lui e sulla sua opera un influsso determinante), Beckett pubblica negli anni '53-'54 un corpus unitario di tre romanzi: Molloy, Malone muore, L'Innominabile, nel '52 la commedia Aspettando Godot, cui seguono tra tante altre Finale di partita e Atto senza parole (1957), Giorni felici (1963), Non io (1973). Nel frattempo continua l'attività di narratore pubblicando nel '55 Novelle e testi per nulla. Nel '69 gli viene conferito il Nobel per la Letteratura che, come dice la motivazione “trae motivo di elevazione dalla messa a nudo del dissolvimento dell'uomo d'oggi”. A Parigi negli anni '50-'60 inizia ad avere successo un nuovo teatro che per le sue caratteristiche viene definito “teatro dell'assurdo” e “antiteatro”. Esso appare caratterizzato anzitutto dal ribaltamento non solo delle esperienze sceniche tradizionali, ma anche di quelle contemporanee legate al teatro filosofico di Sartre e al teatro epico e sociale di Brecht. Volutamente questa nuova esperienza drammaturgica rifiuta ogni schema contenutistico e psicologico legato ad una coerente interpretazione della realtà: partendo da situazioni irreali ed assurde, essa si sviluppa attraverso dialoghi volutamenrte incoerenti in cui il linguaggio diviene elemento indiretto di denuncia della situazione di insincerità, banalità e solitudine in cui si svolge la vita dell'uomo contemporaneo, schiacciato nella sua personalità e ridotto a cosa dai meccanismi inesorabili della vita d'oggi. È quindi teatro d'avanguardia nelle strutture sceniche e nel linguaggio e teatro d'implicita denuncia negli esiti artistici. Apparso nei primi anni '50 nei teatrini della Rive Gauche, conosce un grande successo internazionale a partire dal 1958 ed appare uno degli aspetti peculiari di quella che possiamo definire “la letteratura di contestazione al sistema di vita che si va imponendo”. Massimo esponente del cosiddetto “teatro dell'assurdo”, Beckett con le sue opere ha segnato una svolta determinante nella drammaturgia contemporanea. Egli propone, con disperata lucidità, la scena desolata di una impossibile tragedia tra personaggi privi di ogni coscienza o volontà e perciò spesso privi di ogni responsabilità; nemmeno il parlare può risolvere la solitudine assoluta dei suoi personaggi. Esseri fantasmatici, essi si esprimono in una sorta di dialogo tra sordi, costituito da frasi incredibili nella loro apparente banalità e angoscianti nella evidenza della loro quotidianità. Il tono di questa scoperta non è distaccato né tanto meno enfatico; consiste, invece, in una profonda simpatia, a volte sottilmente ironica e umoristica per la tristezza dei suoi personaggi 23 NOTIZIE SUL TESTO La fama di Samuel Beckett più che ai suoi romanzi è legata al teatro e, in particolare, ai due atti di Aspettando Godot, opera discussa al suo apparire, ma oggi considerata testo esemplare del teatro contemporaneo. Rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1953 al piccolo Théatre de Babylon, l'opera è estremamente lineare almeno per quanto riguarda i fatti e costituisce il testo più rappresentativo non solo di Beckett ma di tutto il teatro dell'assurdo. La commedia è suddivisa in due atti con la medesima scena: “Atto primo: Strada di campagna con albero. È sera...”. “Atto secondo: il giorno dopo. Stesso posto”. È un luogo qualunque, un nonluogo, dove spazio e tempo sembrano sospesi, su di una strada senza segno di vita tranne un albero brullo che nel II atto, unica differenza, mette un tenue germoglio.Alla ripetitività della scena corrisponde l'identità dei gesti, delle parole e degli atteggiamenti dei due personaggi. Due mendicanti, Vladimiro ed Estragone (Didi e Gogo) in aperta campagna consumano il tempo aspettando l'arrivo di un misterioso e sconosciuto Godot che sperano possa fornire loro una certa sistemazione. Di questo Godot non hanno entrambi nessuna idea, non l'hanno mai visto, non sanno chi sia e non sono nemmeno sicuri della data e del luogo dell'appuntamento né dell'esatto motivo dell'incontro. L'unica cosa di cui sono certi è che Godot dovrà dire o fare per loro qualcosa d'importante. Nell'attesa si scambiano frammenti di conversazione (“cerchiamo di fare un po' di conversazione”), attraverso frasi monche e convenzionali (“sarebbe meglio battere il ferro finché è caldo”, “come passa presto il tempo quando ci si diverte”, “a ciascuno la sua piccola croce”), parole vuote e banali, soliloqui disperati tra cui ritorna, intercalato come un ritornello, il riferimento all'attesa dell'arrivo costantemente rinviato di Godot o compiendo gesti inutili e senza senso (come il gioco del cappello). Hanno freddo e fame, si lamentano continuamente, pensano al suicidio, affermano ad ogni istante di volersene andare, ma non si muovono mai: “Andiamocene”, “Non si può...Aspettiamo Godot”. Arrivano ad un certo punto due viandanti, Pozzo e Lucky, di cui non si sa nulla, né da dove vengano né dove vadano. Pozzo è un uomo ricco e crudele che tiene Lucky ( il suo nome appare del tutto antifrastico dal momento che significa fortunato) per una corda legata al collo, trattandolo come uno schiavo o una bestia da soma. Lucky, che un tempo doveva essere un intellettuale, non parla se non in un assurdo monologo in cui ritorna ricorrente l'espressione “non si sa perché”. Un ragazzo alla fine del primo atto porta un messaggio da parte di Godot: l'enigmatico personaggio fa sapere che per quella sera non arriverà. Nel secondo atto si ritrovano gli stessi dialoghi smozzicati e privi di senso, le stesse lamentele, gli stessi propositi di suicidio da parte dei due barboni, “contenti” di trovarsi ancora insieme pur ricordando poco o nulla di quanto accaduto il giorno prima e ancora in attesa di Godot. Tornano Pozzo e Lucky, ma ora il primo è cieco e il secondo è muto. Quando i due si allontanano ricompare il ragazzo che riferisce che Godot non arriverà quella sera, sicuramente domani. Sui due mendicanti (i cui nomi alludono ad un'inusuale dimensione del vivere) accomunati nella disperata, inutile attesa, cala il sipario. Il testo di Beckett mette a fuoco una situazione esistenziale allucinata e stravolta, dove si assiste al dominio assoluto dell'assurdo. Tutto è statico, senza storia e senza svolgimento. Non c'è dialogo, perché non c'è una finalità da conseguire, ciò che sembra dialogo tra i due personaggi, si riduce a frammenti di parole, balbettii, puri suoni. Crolla definitivamente ogni raccordo sintattico, in quanto non avrebbe ragione di essere. Il discorso articolato presuppone, infatti,la presenza di un tessuto logico che qui manca completamente. Al suo posto subentra una vana ed esasperante attesa che si traduce in inattività, inerzia, indeterminazione, immobilità ossessiva ed estenuante, venuto meno ogni stimolo all'azione del pensiero e dello spirito. È il trionfo del non-senso. 24 LO SPETTACOLO L'occasione per questa messinscena - dichiara Jurij Ferrini regista dello spettacolo - nasce dall'incontro con Natalino Balasso attore, comico e autore di teatro, cinema e televisione, durante le prove de I Rusteghi di Carlo Goldoni. Entrambi alla ricerca di un testo che rispecchiasse la loro “attitudine alla comicità”, hanno trovato “nell'inossidabile potenza drammaturgica di Aspettando Godot” il materiale che cercavano. La loro teatralità li ha convinti ad orientare la lettura esistenzialista della tragedia di Beckett verso il comico, pur con l'intento di salvaguardarne tutta la carica emotiva e la tensione psicologica. Di qui il loro interrogarsi sul luogo scenico da rappresentare così ben tratteggiato dallo scrittore. Riusciranno Ferrini e Balasso a conservare, nella loro irresistibile comicità, la potenza drammaturgica dell'opera? Riusciranno a rendere vivi, attuali e sorprendenti “i mulinelli verbali, i dialoghi surreali” e la situazione metafisica dell'attesa? Lo spettacolo è ancora in fase di allestimento, quindi non ci resta che aspettare e...vedere. SPUNTI DI RIFLESSIONE Il valore dell'opera di Samuel Beckett e in particolare del suo teatro sta nell'avere, una volta per tutte, “ficcato il viso a fondo” nella situazione dell'uomo contemporaneo e nell'aver scoperto, una volta per tutte, un immobile e inalterabile nulla. Da questo nulla egli non ha più distolto lo sguardo tornando “a descriverlo sempre di nuovo, sempre lo stesso, sempre più intollerabile” (N.Chiaramonte). Non c'è possibiltà di fare breccia in questo nulla, di dare un significato ad una situazione esistenziale che di significati non ne ha, come non ne ha il mondo per cui tutto si consuma in una lunga, inutile attesa. Ci troviamo di fronte ad una “epifania del nulla” che richiama il Montale di “Forse un mattino...”. In questa opera il tema del non-senso, dell'assurdo del vivere, dell'incapacità dell'uomo di approdare a qualsiasi forma di logica, di verità, di certezza tocca il suo punto estremo; Beckett scarnifica e riduce all'essenziale la drammatica condizione dell'uomo contemporaneo in cui scopre il vuoto immobile e inalterabile. Vladimiro (conclusione del II atto) non sa quanto ci sia di vero in ciò che ha vissuto, se sia vivo o stia sognando, si immerge in riflessioni filosofiche sulla vita e sulla morte, ma alla fine del monologo si chiede “cosa ho detto?”. Anche le certezze più evidenti ed elementari vengono messe in forse e si confondono in una ambiguità irrisolvibile: non si sa, ad esempio, se il ragazzo che porta i messaggi sia sempre lo stesso, neanche lui è in grado di dire nulla su Godot. Un motivo ossessivamente ricorrente è il proposito manifestato da Didi e Gogo di andarsene che esprime l'esigenza di uscire da una condizione penosa di insensatezza e sofferenza, di evadere in qualche modo da una prigione oppressiva, ma non si presenta nessuna prospettiva e l'evasione risulta impossibile. Continuano ad attendere, vivono, possiamo dire, nell'attesa e quindi non vivono. Anche il progetto di un suicidio è costantemente rimandato: “C'impiccheremo domani...a meno che Godot non venga”; “Andiamo”, dice Vladimiro alla fine del dramma; “Andiamo” conferma Estragone, ma non si muovono. Ma chi è questo Godot di cui si parla costantemente e che non si vede mai? Le uniche informzioni ci provengono dal ragazzo del II atto che, alle precise richieste di Vladimiro risponde che gli “pare” che la barba di Godot sia bianca. Egli potrebbe rappresentare una speranza di salvezza, un'alternativa alla realtà intollerabile della condizione umana, ma forse anche un'allusione ad una dimensione religiosa: in Godot si può vedere la parola God, Dio, cui rimanda anche il particolare della barba bianca. D'altra parte il fatto che al suo nome cada il silenzio e si instauri un'atmosfera di paura potrebbe rappresentare la negazione di ogni speranza di tipo 25 religioso. Queste e altre ipotesi: attesa e assenza di Dio, terrore della fine del mondo per la minaccia atomica (è il periodo cruciale della guerra fredda), attesa di una svolta che restituisca il senso “alla vita universale”, sull'identità di questo enigmatico e misterioso personaggio che tale rimane; lo stesso Beckett, a chi gli chiedeva chi fosse Godot, rispondeva: “Se lo sapessi lo avrei detto nella commedia”. Stabilire che Godot è Dio, la Felicità o altro non ha molta importanza; importante è piuttosto coglierne la valenza simbolica; vedere in Vladimiro ed Estragone la piccola borghesia che se ne lava le mani, in Pozzo il capitalista che sfrutta brutalmente Lucky il proletario è legittimo, come è legittima la chiave cristiana per cui tutto, dall'albero che si trova sulla scena e che potrebbe rappresentare la croce, alla barba bianca di Godot, alle frequenti citazioni, si può spiegare con il Vangelo. Si potrebbe anche dire che Didi e Gogo, Pozzo e Lucky rappresentano l'umanità, il volto complesso e sfaccettato di un'umanità che “da sempre segue un copione a struttura circolare”, in un'attesa spesso vana. Il mondo rappresentato si presta a mille interpretazioni, a mille possibili congetture, ma, come afferma Carlo Fruttero, “discutere il messaggio di Beckett quando impotenza, decomposizione ed angoscia sono diventate moneta corrente sarebbe fargli torto; è interessante semmai notare che dopo mezzo secolo di decadentismo sempre più precipitoso egli raccoglie ciò che hanno seminato i suoi predecessori”. Sempre Fruttero definisce “la commedia esemplare, limite, costruita interamente intorno all'assenza del personaggio in grado non solo di salvare Vladimiro ed Estragone, ma gli spettatori stessi di cui i due mendicanti sono i rappresentanti sulla scena. Tale personaggio, goffamente imitato da Pozzo (la scena della descrizione del tramonto è un chiaro caso di teatro nel teatro) è l'eroe tragico, il che non impedisce a ciascuno di chiamarlo poi col nome che preferisce: Godot, Cristo, Tempo, Storia, Autre a seconda della sua personale prospettiva”. I due temi chiave del dramma: la precarietà della vita e l'impossibilità di fuggire il dolore danno la misura dell'assurdità dell'esistenza. Il sonno di Estragone (che si ripete più volte nel corso della vicenda) esprime quasi il rifiuto di vivere, mentre Vladimiro che lo sveglia per non sentirsi solo, testimonia l'esigenza dell'individuo di uscire dalle proprie ansie e di instaurare con gli altri un rapporto di solidarietà. Il loro “duetto” verbale è una vera antologia di relazioni private: essi sono contemporaneamente amici, coniugi, padre, figlio... e riproducono “a volo d'uccello” tutte le sfumature e le situazioni della psicologia umana e del teatro psicologico. Entrambi, quindi, e così gli altri personaggi, risultano espressione della condizione umana alienata: Vladimiro che non sa se sia sveglio o se stia sognando, riflette sulla realtà e sull'apparenza, sul breve tempo che intercorre tra la nascita e la morte, sull'abitudine che rende indifferenti al dolore altrui e al proprio, ma in uno stato di inconsapevolezza, senza pervenire ad alcuna soluzione. Il ragazzo che annuncia per l'indomani l'arrivo di Godot chiama Vladimiro con il nome di Alberto: i due personaggi non si riconoscono, anche se si sono incontrati il giorno prima. Nemmeno l'albero sullo sfondo della scena, unica forma di vita nel vuoto e nella desolazione che circonda i personaggi può rivelarsi un simbolo di speranza perché suscita in Estragone l'idea di suicidarsi. Si colgono in Beckett gli stessi temi dell'opera di Pirandello: alienazione, incomunicabilità, inconsistenza del vivere e capacità di guardare la realtà con ironia. La tragedia della condizione umana sfuma nella farsa clownesca, nel comico; si inseriscono infatti le gags più classiche ed elementari, da sempre usate nei circhi e nelle comiche cinematografiche per far ridere: pantaloni alle caviglie, pantaloni che cadono, la corda tirata che si spezza e fa cadere; i due barboni richiamano Stanlio e Ollio, che come loro portano la bombetta. L'opera rappresenta il dramma dell'uomo contemporaneo che vive in una consapevole solitudine, 26 affondato in un Nulla senza scampo e circondato da “gente” che non ha niente da dirsi. Eppure ognuno di noi aspetta il suo Godot che si potrebbe intendere, oggi, come un cambiamento, un cambiamento della nostra condizione esistenziale o più banalmente economica, del nostro modo di essere e di agire, del nostro stesso esistere. Poco importa allora se Godot è Dio, un'occasione o un uomo ricco e potente, sicuramente è una speranza! L'opera è quindi la rappresentazione della vita, di una condizione umana sciolta da ogni determinazione storica, simbolo del perpetuarsi della eterna vicenda umana. 27 Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 febbraio di Vitaliano Brancati La governante con Pippo Patavina, Giovanna Di Rauso, Max Malatesta regia di Maurizio Scaparro NOTIZIE BIOGRAFICHE SULL'AUTORE Vitaliano Brancati nasce nel 1907 a Pachino, in provincia di Siracusa, ed insegna inizialmente lettere in istituti magistrali a Caltanisetta e Catania. Trasferitosi a Roma, dal 1940 si dedica al giornalismo. Oltre che autore di romanzi, Brancati si dedica al teatro. Vive la giovinezza negli anni che vedono il sorgere e l'affermarsi del fascismo e come tanti giovani si entusiasma per la “rivoluzione” fascista, come esprime nelle sue prime opere: i drammi Fedor del 1926, cui seguono l'atto unico Everest, rappresentato a Roma nel 1930 e Piave (1932), messo in scena da A.G. Bragaglia. Superate queste posizioni, Brancati ha una profonda crisi che lo porta a ripudiare tutta la sua opera, teatrale e narrativa. Ritornato al teatro, pubblica nel 1938 la farsa Questo matrimonio si deve fare, mai rappresentata; seguono Le trombe di Eustachio (1942), e Don Giovanni involontario (1943), entrambe rappresentate a Roma; pubblica inoltre Raffaele (1948) e Una donna di casa (1950). L'ultima sua commedia La governante, proibita dalla censura, viene pubblicata nel 1952, con l'aggiunta di un pamphlet Ritorno alla censura che, insieme al precedente saggio I fascisti invecchiano del 1946, testimonia le sue ferme convinzioni radical-liberali, la sua vocazione di moralista e la sua pungente polemica contro l'ottusità dei governanti e della burocrazia d'allora. Negli ultimi anni di vita scrive anche soggetti cinematografici tra cui Anni difficili (1948), Anni facili (1953) e L'arte di arrangiarsi (1955) in collaborazione con Zampa e sceneggia una decina di film. Muore a Torino nel 1954. Negli anni giovanili Brancati aderisce al fascismo, come testimoniano le sue prime prove narrative e drammatiche intrise di dannunzianesimo e tese ad esaltare il regime. Una successiva presa di coscienza lo fa approdare all'antifascismo, al ripudio, come si è detto, di tutta la sua opera precedente e lo spingono a dare voce alla conquistata consapevolezza politica e a fare polemica politica “per vie indirette, nella critica di costume e nella veste di moralista politico” (E. Bacchereti). La sua prima opera veramente matura è Gli anni perduti (scritta tra il 1934 e il 1936 e pubblicata nel 1941), rappresentazione della vita provinciale di una città del sud, in cui è riconoscibile Catania, della sua esistenza torbida e sonnolenta che avvolge i personaggi in un clima opprimente di noia, di inerzia e di vuoto. Si fondono nel romanzo componenti che saranno poi costanti in Brancati: la satira di costume, risolta in toni caricaturali e grotteschi, e la tematica psicologico-esistenziale. Infatti lo scrittore non rappresenta solo la realtà inerte della borghesia siciliana, chiusa in un immobilismo e in un'abulia da cui non sembra in grado di uscire, ma coglie anche il dissidio esistenziale che non riguarda solo la provincia siciliana. Brancati supera la limitatezza di un realismo regionale di stampo meridionale: la descrizione di una monotona vita provinciale mette in luce, metaforicamente, la scissione dell'uomo del '900, la separazione, già evidenziata da Pirandello, tra la realtà interiore e quella esteriore, l'unica che l'uomo, come dietro una maschera, può manifestare. Ciò vale anche per Don Giovanni in Sicilia (1941) dove la rappresentazione del gallismo siciliano, cioè dell'esasperata ossessione erotica, si allarga dalla satira sociale alla pittura di una condizione esistenziale di frustrazione e di impotenza. La condizione dell'uomo siciliano scisso tra ciò che è e ciò che è costretto ad essere è ancora più 28 evidente in uno dei capolavori dell'autore, Il vecchio con gli stivali (1944), un racconto che descrive le disavventure di un pover'uomo, profondamente antifascista, costretto dalle circostanze a fingere di essere stato un fascista della prima ora. Il motivo del gallismo ritorna ne Il bell'Antonio (1949) e nell'incompiuto e postumo Paolo il caldo (1955): il loro erotismo esasperato viene presentato come manifestazione dell'assenza di valori etici. Quattro anni dopo la morte il primo ad interessarsi del teatro di Brancati è N. Borsellino che mette in risalto i tratti “nuovi” del commediografo rispetto al narratore indicandone l'anima etico-politica e il carattere polemico, la satira corrosiva come elementi distinguibili della sua drammaturgia. Dalle ultime opere sono stati tratti 4 film: Il bell'Antonio nel 1960, Don Giovanni in Sicilia nel 1967, Paolo il caldo nel 1973 e La governante nel 1974. NOTIZIE SUL TESTO La commedia in tre atti La governante, scritta da Brancati nel 1952, censurata perché “contraria alla morale”, viene rappresentata per la prima volta nel 1965 con l'interpretazione di Anna Proclemer, la moglie, per la quale l'autore aveva scritto il testo, e di Gianrico Tedeschi allo Stabile di Genova, in una fortunatissima produzione di Patroni Griffi. La scena è fondamentalmente sempre la stessa, la stanza di soggiorno dei Platania a Roma, un ambiente borghese come del resto le persone che ci vivono, all'ombra del Cupolone. Leopoldo Platania, di origine siciliana, si è trasferito a Roma da Caltanisetta con la famiglia: il figlio Enrico, la nuora Elena, i nipoti Enrichetto e Rosa, la domestica Iana, una giovane siciliana, fedele e devota cui sono tutti molto affezionati. Rappresentano la perfetta incarnazione del perbenismo del mondo borghese cui appartengono: benpensanti, tradizionalisti e moralisti, in particolare Leopoldo che, per quanto sembri essersi integrato nell'ambiente romano, è assolutamente incapace di accettare un'etica diversa da quella in cui è cresciuto e ricorda con nostalgia il mondo che ha lasciato: “il mio cuore è sempre là, a Caltanisetta, nella casa con le persiane verdi, perché le case devono avere le persiane non questa porcheria di saracinesche...”. Quando in casa Platania entra come governante Caterina Leher, una giovane francese di 25 anni, affascinante, colta, di religione calvinista, gli equilibri vengono meno. Caterina appare a tutti l'immagine di un modello di integrità e di virtù, “buona come un angelo”, “una donna straordinaria” che riesce a trovare affiatamento con tutti i membri della famiglia, in particolare con il severo capofamiglia, cattolico e integralista, con cui instaura un intenso rapporto dialettico. Entrambi sono dilaniati da profondi sensi di colpa: Leopoldo perché si sente responsabile del suicidio di sua figlia quindicenne, Caterina perché soffre la sua omosessualità che cerca di mascherare facendola ricadere sulla ingenua Iana. Con discrezione insinua nei suoi confronti sospetti e dubbi che provocano nella famiglia una reazione negativa e di rifiuto: non possono tenere in casa “una disgraziata”, “una maniaca”, una vera “fogna” e la licenziano senza alcuno scrupolo dato che “non era quello che credevamo”. Iana è costretta a tornare in Sicilia, ma sfortunatamente, per una serie di circostanze, muore durante il viaggio di ritorno. I Platania nel loro conservatorismo ipocrita non possono accettare una “devianza” simile, anche se ognuno di loro, al di là del perbenismo apparente, ha i suoi segreti da nascondere, i suoi inganni, i suoi intrighi; sono infatti tutti vittime dell'ipocrisia del loro mondo. Enrico, molto sensibile alla bellezza femminile, incarna il gallismo siciliano; Elena, donna fragile e insoddisfatta, frivola e civettuola trova compensazione alle sue frustrazioni nell'ammirazione maschile; Caterina, che non si perdona la sua omosessualità né la morte di Iana, cerca almeno apparentemente di essere di sostegno agli altri, di “capire gli altri e compatirli”, manovrandoli, invece, in maniera sottile e un 29 po' perversa. Ognuno cerca di mentire agli altri e a se stesso, in un inganno reciproco fino alla drammatica conclusione. Anche in questa opera lo scrittore siciliano rappresenta il clima oscurantista che contrassegnava l'Italia negli anni '50 e ne coglie le contraddizioni pubbliche e private. LO SPETTACOLO Sessanta anni dopo la sua pubblicazione lo Stabile di Catania, che ne aveva già prodotto nel 20012002 una edizione con la regia di W. Pagliaro, propone un nuovo allestimento del capolavoro teatrale di Vitaliano Brancati affidando la nuova regia all'estro di Maurizio Scaparro, con scene e costumi di Santuzza Calì (che ha pensato alle case degli anni Cinquanta creando atmosfere di “realismo sognato”), musiche di Pippo Russo e luci di Franco Buzzanca: spettacolo accurato che risolve e snoda molto bene i tre atti del testo scorrendo fluido e persuasivo in ogni momento. Il bravissimo Pippo Pattavina è chiamato per la terza volta a impersonare Leopoldo Platania che rende in modo realistico, commovente e convincente in ogni dettaglio come ad esempio nel muto smarrimento della lettura della missiva che porta al tragico epilogo della commedia; sembra che la parte sia stata scritta proprio per lui. La Caterina di Giovanna Di Rauso, l'ambigua istitutrice calvinista, risulta rigorosa, ma non sempre plausibile per certi eccessi di manierismo, ma di grande maestria nell'annullare la sua femminilità, variandola in torbida sensualità. “È un personaggio mascherato, che fa di sé un burattino, ingabbiata in quello che vorrebbe essere e non è”. Efficaci sulla scena Giovanni Guardiano, il fatuo Enrico Platania, Veronica Gentili, la nevrotica moglie Elena, Valeria Contadino che rende con bravura la spontanea semplicità naïf di Iana. Marcello Perracchio, nei panni stracciati del rassegnato portiere spedito in prigione al posto del potente barone, ci offre uno straordinario “cameo”. Max Malatesta, attore talentuoso, di straordinaria energia scenica, veste i panni dell'intellettuale Bonivaglia attraverso cui si intuisce un'accusa al vuoto narcisismo di certi intellettuali dell'epoca. Nelle note di regia Scaparro si dichiara soddisfatto di essere riuscito a riunire per questa pièce “come voleva Brancati” attori “siciliani” e attori “italiani” unendo alla “sicilitudine” la forza della miglior tradizione teatrale italiana e avvalendosi dell'approfondimento critico e dell'utile rilettura di Antonia Brancati. Viene in tal modo rispettato lo spirito dell'autore. L'opera di Brancati rivista da Scaparro riesce infatti a riproporre il tema-chiave: l'impari lotta tra l'uomo e l'esigenza di moralità, e la sostanza della vicenda che è più la calunnia che l'amore tra due donne, proponendoci una rilettura adatta ai nostri giorni, dove la moralità risulta quasi “un vecchio arnese”. Del resto in che cosa consiste la moralità? “La morale italiana, dichiara Alessandro, consiste tutta nell'istituire la censura”. La storia risulta, comunque, una metafora di un modo di essere dell'uomo sempre in difficile equilibrio tra realtà e finzione. SPUNTI DI RIFLESSIONE Come in tutte le opere di Brancati, anche ne La governante emerge il contrasto tra il vecchio mondo con i suoi “consunti” valori e una realtà più dinamica quale quella che caratterizza la grande città da cui i personaggi rimangono esclusi, ancorati come sono alle loro abitudini, alle loro ritualità, alle loro tradizioni patriarcali e ai loro pregiudizi. Evidente la satira di costume il cui significato va ben oltre l'aneddoto colorito del bozzettismo e del macchiettismo provinciali. L'opera è la rappresentazione di una società fortemente repressiva e intollerante, dominata da leggi 30 non scritte ma inderogabili che condannano i rapporti tra i sessi, ma soprattutto l'omosessualità, in particolare quella femminile, come una colpa perché non naturale (“è una natura che non va”, dichiara Leopoldo), frutto di “un cervello storto”, ma nasconde, ipocritamente, irrequietudini, sogni e aspirazioni morbose e accetta il “gallismo” come esaltazione della virilità. È questa la maschera che l'ipocrisia della società perbenista fa indossare ai suoi personaggi. Anche oggi siamo pieni di tabù e censure, ma forse la differenza con gli anni '50 è il modo con il quale si continuano a vivere. La società è elastica e tollerante, si concede il vizio privato purchè pubblicamente si continui ad essere degli apprezzati cittadini. Le censure hanno a che vedere più con l'opportunismo e meno con la moralità o il costume. L'ossessione erotica per la donna, vizio siciliano e non solo, è espressione, secondo l'autore, di incapacità di vivere, costituendo una sorta di variante deformata e grottesca dell'inettitudine che caratterizza molti protagonisti della letteratura del primo '900. Del resto non si parla di “incapacità di vivere” anche per Pascoli e D'Annunzio relativamente al modo di vivere la sessualità? Dongiovannesco in uno, inibito nell'altro? Nello scrittore Alessandro Bonivaglia, inoltre, non si può forse cogliere una sorta di pessimismo sveviano? Il dramma diviene, quindi, metafora dell'irresolutezza di una piccola borghesia incapace di slanci costruttivi, irretita in vane costruzioni mentali, “manifestazione dell'assenza di valori etici”. Le farneticazioni erotiche dei personaggi della provincia siciliana sono anche altro e rimandano ad altri vizi: le velleità eroiche, il prevalere delle apparenze e della parole sui fatti della contemporanea società italiana. Emerge sempre di sottofondo, dominante, la logica del potere, sia esso politico, sociale o culturale. I “ricchi” sono quelli che hanno il comando, come ci fa notare Alessandro: “non ho mai visto un ricco italiano proporre una legge che riduca i suoi guadagni per aumentare il benessere del suo Paese”. I padroni, si dice ancora, sono al di sopra di tutto, anzi addirittura “la volontà di Dio è che i padroni non figurino mai, perché non è giusto”. Le parole del portiere sono rivelatrici della condizione di oppressione cui le classi inferiori erano sottoposte (o sono?) ai nobili, ai baroni, ai don... a chi ha il danaro; è un'oppressione secolare cui non è neppure pensabile opporsi, che si deve accettare perché conseguenza di una condizione ormai radicata. Si ripropone, anche se siamo nel secondo Novecento, una situazione non diversa da quella descritta da Verga un secolo prima. Ma possiamo dire che oggi non è così? Il modo è più sottile, meno appariscente, ma non è cambiato molto: il potere ha sempre le unghie affilate. Anche la donna appare costretta a subire un ruolo di sottomissione all'uomo e alle convenzioni sociali: una donna perbene - sostiene Leopoldo - non può dire “devo ripagare mio marito con la stessa moneta” e aggiunge per essere ancora più chiaro “se fa le stesse cose di mio figlio le rompo la spina dorsale”. Niente di più illuminante! La stessa omosessualità trova un'ulteriore condanna perché femminile. Per Brancati nulla va come dovrebbe in quegli anni '50, anni in cui dirsi o solo pensarsi diverso è folle oltre che estremamente pericoloso. Non sfugge alla sua ironia neanche il ruolo della cultura e dell'intellettuale. La cultura che consideriamo (almeno utopisticamente) strumento di elevazione purtroppo non vede riconosciuto nessun ruolo formativo perché è considerata come qualcosa che non serve: cosa ce ne si fa della cultura? “La cultura non si mangia e non dà da mangiare, quando la pentola bolle non puoi mettere giù un libro!”, anzi talvolta se male utilizzata può divenire strumento di oppressione (come appare evidente anche ne I Promessi Sposi). L'intellettualità vuota e parolaia della Sicilia padronale è duramente colpita dall'ironia sferzante di Brancati che rappresenta in Alessandro Bonivaglia uno scrittore di successo, che qualcuno ha definito alter-ego dell'autore, se non altro per la sua arguzia e la sua ironia. Egli è il primo a capire che in casa Platania c'è qualcosa che non va, ma non ne fa un dramma. È vanitoso, un corteggiatore “ordinario”, uno che mette all'interno dei suoi libri tutto se 31 stesso, ma che nel quotidiano si allinea all'andazzo generale. Un anticonformista a parole, noioso e il più delle volte annoiato. La sua funzione e la sua importanza sono sopravvalutate dalla società superficiale e ignorante (di cui i Platania sono l'immagine) che ha bisogno di svago intellettuale per colmare dei vuoti sempre più percepibili. “Ieri quella di Alessandro era l'immagine critica del tipico intellettuale di sinistra, oggi di Alessandro se ne trovano a destra e a sinistra, in alto e in basso, ovunque”. (M. Iacone) Tante le riflessioni che possono scaturire dalla lettura e dalla visione del dramma, il cui personaggio chiave ed emblematico è sicuramente Caterina Leher, la governante, un mix di purezza e peccato, di verità e abiezione, di crudezza, rigore e fragilità. Fondamentalmente onesta, capace, come la considera Leopoldo, di “capire gli altri”, coerente con i suoi principi eppure al di fuori di ogni “schema”, colta e intelligente, non ha remore quando si tratta di difendere la sua immagine (la colpa va su Iana), di attaccare gli altri quando si sente scoperta o messa a nudo (come avviene con lo scrittore), è insinuante, intrigante e capace di dominare chi è più debole di lei; apparentemente forte ma non in grado di porsi contro i costumi e i valori del mondo cui lei stessa appartiene, e per questo dominata da conflitti interiori e sensi di colpa, espressione di quel “gioco di specchi” che è la commedia. È lei che fa esplodere le ipocrisie e le contraddizioni di un ambiente che vive a due passi da San Pietro, ma in un equilibrio precario, sotto l'ala conservatrice del patriarca, contraddizioni che non è in grado di gestire. La normalità - ci dice Brancati - “è solo un castello di carta, basta un soffio di vento e viene giù tutto” Oggi, forse, i gusti sessuali della “governante” non desterebbero più tanto clamore e simili reazioni e forse una Caterina del Duemila lotterebbe contro le ipocrisie dei suoi e dei nostri tempi. Lo stesso finale appartiene ad un'epoca remota rispetto a quella odierna in cui si costruiscono le carriere anche grazie alle “tipicità” sessuali. Inoltre la commedia di Brancati non subirebbe più alcuna censura, censura che spiegò all'Italia delle lettere che dalla fine del fascismo i tempi erano cambiati, ma gli uomini e i pensieri erano gli stessi. E speriamo che oggi non sia così. ...e parliamo di cinema Il bell'Antonio, It.-Fr.1960 di Mauro Bolognini con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Pierre Brasseur, Rina Morelli, Tomas Milian. Tornato da Roma nella natia Catania con la fama di “femminiere”, Antonio (Mastroianni) sposa Barbara (Claudia Cardinale), sceltagli dal padre (Pierre Brasseur), che dopo un anno chiede l'annullamento per impotenza di lui. Epilogo a sorpresa. Dal gran tema da opera buffa di Brancati, Mauro Bolognini ha tratto un film lirico più che satirico, carico di dolorosa malinconia. Lo spostamento dell'azione dalla fine degli anni '30 agli anni '50 è una delle cause del mutamento di stile: il film è una commedia di carattere più che di costume e sfiora la maniera nonostante la resa degli interpreti e il raffinato gusto dell'ambientazione. Un ottimo Mastroianni, una fulgida Cardinale, un suggestivo bianconero di Armando Nannuzzi che spesso ricorre alla profondità di campo. Sceneggiato, con il regista e Gino Visentini, da P.P. Pasolini che lo giudicò un film “un po' lento, un po' ambiguo, ma tuttavia pieno di una misteriosa e seducente suspense”, ha ottenuto la Vela d'oro al festival di Locarno. Don Giovanni in Sicilia, It. 1967 di Alberto Lattuada con Lando Buzzanca, Katia Moguy, Katia Christine, Ewa Aulin, Ludovico Toeplitz. Liberamente tratto dal regista dal romanzo di Brancati, l'azione del film è spostata negli anni '60 ed equamente distribuita tra Milano e Catania. L'avvocato Giovanni Percolla, “mascolo siculo di donne 32 gran trionfatore”, emigra al nord. Si sposa, s'arricchisce, ma la sua virilità va in tilt. Lattuada evita il cupo e amaro moralismo brancaliano, giocando in modi affettuosamente ironici con gli stereotipi della meridionalità. È più impietoso con riti, miti, volgarità della società produttivistica milanese. Fotografia Roberto Gerardi, musiche Armando Trovaioli. Paolo il caldo, It.1973 di Marco Vicario con Giancarlo Giannini, Rosanna Podrsrà, Adriana Asti, Gastone Moschin, Ornella Muti, Riccardo Cucciolla, Lonel Stander. Siciliano erotomane fa un triste bilancio di una vita consumata nell'egoismo .Il film non rende giustizia al romanzo di Brancati, un'opera difficile da leggere in controluce, estraendone gli aneddoti e privandoli di spessore. La governante, It. 1974 di Gianni Grimaldi con Turi Ferro, Martine Brochard, Vittorio Caprioli, Agostina Belli, Paola Quattrini, Umberto Spadaro, Pino Caruso. 33 martedì 26 febbraio La fondazione di Raffaello Baldini con Ivano Marescotti regia di Valerio Binasco NOTIZIE BIOGRAFICHE SU RAFFALLO BALDINI Raffaello Baldini nasce a Santarcangelo di Romagna, come Tonino Guerra, nel 1924 e muore a Milano nel 2005. Poeta dialettale e autore drammatico dal profondo respiro narrativo, esordisce con il volume E' solitèri (1977), raccolto poi in La nàiva (1982), con poesie che, cadenzate dal dialetto del suo paese natio, tratteggiano la vita e l'umanità del borgo attraverso le piccole grandi cose del quotidiano. I luoghi, la dura esistenza nelle campagne e il ritmo della parlata quotidiana emergono dall'intera opera poetica di Baldini, mantenendo sempre un gradevole spazio alla melodia delle parole. Seguono Furistìr (1988), Ad nòta (1995), storie lunatiche, a metà tra il sonno e la veglia, tra la rievocazione di folli imprese giovanili e le allucinazioni notturne. Per il teatro ha scritto tre monologhi di grande forza espressiva pubblicati da Einaudi: Carta canta, Zitti tutti! e In fondo a destra, nel 1998 e interpretati da Ivano Marescotti che ha anche portato in scena una riduzione teatrale del suo racconto Furistir. La sua ultima raccolta di poesie Intercity è uscita nel 2003, mentre La Fondazione, ultimo monologo teatrale, è pubblicato da Einaudi nel 2008. Nell'opera di Baldini la narrazione assume la caratteristica teatrale del monologo, si carica di tic linguistici, delle inflessioni del parlato. I suoi personaggi sono strani, nevrotici, un po' ipocriti e un po' cinici; in lunghi monologhi raccontano delle storie, si rivolgono ad altri personaggi generalmente silenziosi riproducendo la chiacchiera quotidiana in modo tanto realistico da sembrare l'esatta trascrizione di una registrazione. Nello stesso tempo, il flusso disordinato del parlato dialettale ne rivela l'assurdità e il non-senso. NOTIZIE SUL TESTO Il monologo teatrale di Raffaello Baldini La Fondazione, pubblicato da Einaudi nel 2008, risale agli ultimi anni di vita dell'autore che lo legge per la prima volta il 4 aprile 2004 al Teatro del Mare di Riccione. Dalla lettera inviata a Ivano Marescotti il 12 aprile risulta un diverso titolo, ancora però non in forma definitiva, Una Fondazione?, con questo commento dell'autore: “il punto interrogativo darebbe una punta - e anche un po' più di una punta - di ironia” ed anche un possibile titolo alternativo Non è micragna. Dal programma del Teatro del Mare si ricava che la lettura del testo è annunciata sotto un titolo ancora diverso, A chi lo dico?, “con esplicita messa in rilievo di uno dei temi centrali del lavoro: la coazione del dire che connota profondamente i monologhi in poesia e in prosa di Baldini”. In seguito l'autore opta definitivamente per La Fondazione, quarto e ultimo dei bellissimi monologhi degli anni '90: Zitti Tutti!, Carta canta, In fondo a destra, l'unico in italiano. Il testo in dialetto è accompagnato dall'attenta “traduzione” di Giuseppe Bellosi, amico di Baldini, studioso e poeta romagnolo, che ha lasciato “le frequenti e tipiche forme scempiate che ne invadono regionalmente l'italiano: profesore, colezionisti, leteratura, nonché certe accentazioni che in parole italiane riproducono la pronuncia romagnola”. (Clelia Martignoni). Il testo, un lungo monologo “scintillante, analitico, travolgente”, privo di punti, ma continuamente 34 interrotto da virgole e interrogativi, con una serie di a capo che scandiscono il discorso per aree e “transiti” tematici interni, richiede una lettura “d'un fiato”, ansiosa e quasi nevrotica, marcata da “un'estrema rapidità di dizione”(PierVincenzo Mengaldo). È questo il modo in cui lo stesso Lello faceva le sue memorabili letture. Di grande efficacia la ricerca del linguaggio parlato cui conseguono: il procedimento divagante, la ricostruzione del ritmo, della sintassi e dell'emotività del parlante, tra inciampi, incisi, fratture continue determinate dai cambiamenti di progetto del discorso, la serie di andirivieni, la grande stravaganza e lucidità di fondo di chi parla in equilibrio tra comicità e nevrosi, tra infinita loquacità e percezione del vuoto. Un io parlante, di 49 anni, impiegato nel Consorzio di bonifica del Marecchia, avviando il discorso da un personaggio marginale che poi viene abbandonato, racconta tra “dispersioni e dettagli a cumulo la sua piccola storia”, addentrandosi nelle stramberie dei suoi comportamenti. Dalla narrazione emergono, infatti, la crisi coniugale e soprattutto le sue fissazioni, “minimizzate e mitigate mentre appaiono esorbitanti, secondo un procedimento tipico di Baldini che affida la parola ad un locutore inattendibile”, la sua mania di collezionismo. È proprio a causa di questa mania di “colezionismo” che il narratore ha accatastato in casa una serie infinita di oggetti, di cianfrusaglie, “chiara compensazione dell'angoscia della perdita” della moglie. Raccoglie, infatti, e ammucchia di tutto: bottiglie, turaccioli, annate di quotidiani, chiavi vecchie, sveglie...convinto che non si deve buttare via niente, perché ogni cosa una sua vita, “una sua personalità”, anche se non serve “a me mi fa compagnia”. Gli oggetti più disparati sono disposti con un certo ordine, dal momento che “ci deve essere un posto per ogni cosa”, “la roba deve avere un suo ordine, una sua disposizione”, pur tenendo conto che ci vuole il cambiamento perché le cose “si stufano di stare sempre nello stesso posto”: “il cambiamento è la vita e queste cose vogliono vivere”. All'interno di questa narrazione emergono riflessioni, un po' bislacche e nello stesso tempo profonde, sull'animo umano, “un pozzo senza fondo”, sulla morte, sulla possibilità che la medicina arrivi a “trapiantare il sapere” perché un capitale così importante “non vada per i fossi, non sia lasciato andare”, perché non muoia insieme con tutti i sapienti che muoiono. Ma, nella sua elucubrazione, osserva anche che questa tecnica del trapianto “deve essere tenuta segreta – perché è come la bomba atomica, non possono avere tutti la bomba atomica”. È un susseguirsi di frasi tra l'intimo e il surreale, di pensieri che “non stanno in piedi”. Il pensiero che ad un certo punto lo attanaglia è il timore che tutta la “roba” che ha accumulato in anni di “lavoro”, vada perduta dato che i familiari - né la sorella, né il fratello, né tantomeno i nipoti - “capiscono” il valore che ha in casa. Di qui l'idea di “fare una Fondazione...senza scopo di lucro”: la casa deve rimanere com'è, “intestato tutto a questa Fondazione”, che deve diventare come un “museo”, ma non “un museo imbalsamato”, ma “che vive”, che può anche crescere, anzi “deve crescere”, un museo con una segretaria perché è necessario fare un inventario. Consapevole, pur nella sua ingenuità, che per fare una Fondazione “ci vogliono soldi”, vede una possibile soluzione nell'intervento economico del Comune, della Provincia, della Regione, sicuramente interessate dal momento che ha conservato tra le tante cose anche tutto il materiale della propaganda elettorale e delle elezioni: volantini, opuscoli, schede, lettere, manifesti... “tutte cose storiche” che costituiscono la sua vita, una parte di lui. Tali fantasticherie lo inducono ad un'altra amara consapevolezza: tutto quello che ha raccolto in una vita “per lasciare un segno di sé”, sarà buttato via, i parenti più interessati alla casa che alle cose elimineranno tutto e trasformeranno l'abitazione. Non può pensare che nulla rimanga, si sente come se buttassero via anche lui e decide di “smucchiare”: “sono io che ho ammucchiato, sono io che smucchio”. Il monologo si chiude con una battuta che è la chiara dimostrazione della condizione di isolato e di emarginato dell'io narrante:” Vedi che avevo ragione io?”, nella speranza o nel timore di una telefonata della moglie che gli è stata portata via. 35 LO SPETTACOLO La piéce, che debutta, in prima nazionale il 17 ottobre 2012 all'Arena del Sole di Bologna, vede come protagonista Ivano Marescotti, il perfetto interprete del testo di Baldini, contrassegnato da sottile ironia, malinconia e amarezza. Lo stesso Baldini ha consegnato il suo ultimo testo a Marescotti, dicendogli “fanne quello che vuoi”. Con la lettura di questo monologo, Marescotti si accinge a chiudere la trilogia dei testi dell'amico scrittore con cui ha condiviso il mondo e la cultura della Romagna e l'uso del dialetto; egli ricorda che Baldini diceva “in modo sacrale”: in dialetto non si può parlare di Dio, è impossibile, non ci sono i termini, mentre si può parlare con Dio, dimostrando di saper capire l'anima semplice della “sua” gente. Dalle interviste con Marescotti e Binasco si può cogliere il progetto di cogliere di questa tragedia rivestita di umorismo, comica e drammatica come la vita, l'aspetto comico, di andare oltre il teatro dialettale e farne un testo universale, un po' “clownesco”. Non ci resta che attendere! SPUNTI DI RIFLESSIONE “Testo di scavo” e di riflessione, amaro e poetico nello stesso tempo, è tutto centrato su un unico personaggio di cui si hanno poche informazioni che vengono riportate nel corso del monologo dallo stesso io narrante, in un ambiente indeterminato nonostante vengano fatti riferimenti a luoghi della nostra regione: Cesena, Bordonchio, Rimini, Marecchia, Bar Dovesi. Il protagonista-narratore è “un po' matto” - o forse, meglio, “strambo” - contemporaneamente irrazionale e logico, sensibile e soprattutto profondamente solo, di una solitudine che lo soffoca. Ha un suo lavoro, dei contatti sociali, ma sente dentro di sé un vuoto che dopo la separazione dalla moglie nessuno e niente riesce a colmare. È dunque sempre lui il personaggio marginale cui si è fatto riferimento? Vive da emarginato, da isolato, circondato da quelle mille cose che dovrebbero colmare quel vuoto, senza in fondo riuscirci. È impensabile in effetti che “le cose” possano sostituire degli affetti. Profondamente solo, fa della sua solitudine un privilegio e una condanna; come i grandi artisti decadenti, “sconta nevroticamente” nell'esistenza “l'arduo privilegio” della sua acuta sensibilità (Elio Gioanola). Attraverso gli oggetti più strani e il legame ossessivo verso di essi il nostro personaggio cerca di dare un senso, uno scopo alla sua esistenza, attribuendo un'anima a ciò che un'anima non ha, di trovare una compensazione al suo vuoto interiore; si vuole illudere di avere una vita piena, di non morire dentro. Per questo aspetto è la dimostrazione di quanto per ogni individuo siano importanti i legami affettivi e quali possano essere le conseguenze di tali carenze. Le “cose” sono il suo mondo e il loro venir meno è il suo stesso morire. Quando le cose cessano di essere, pure lui cessa. Dietro l'apparente follia, in questo anonimo personaggio si celano le inquietudini dell'uomo insoddisfatto di sé e del mondo che lo circonda. Animo malinconico e poetico, ama le bellezze della natura, la montagna (è “belissima”, “sta ferma lì”, non si muove, ma dà un senso di vastità) e soprattutto il mare (“che non sta mai buono...va...non va da nessuna parte ma va...non finisce mai”), le atmosfere tenui, la musica, la penombra (“non la 36 gran luce o il grande buio”) che lascia intravedere le cose, favorisce l'immaginazione, la fantasia: e senza fantasia non è possibile vivere. Il nostro personaggio senza nome e forse senza identità raccoglie di tutto per crearsi quel mondo di affetti di cui si sente deprivato: sono “cose” inutili, consumate, vecchie ma che hanno una storia. Anche noi, oggi, siamo circondati, invasi nelle nostre abitazioni da una miriade di oggetti, troppi, di cui non sappiamo nemmeno il nome e a cosa servono e che diventano in poco tempo obsoleti. I nostri “oggetti” devono essere sempre più “nuovi”, “all'ultimo grido”, non ci affezioniamo, ci servono per apparire, confermare il nostro status symbol. I vecchi non si riparano, si gettano o si riciclano. È un altro modo per nascondere o mascherare un vuoto. Non c'è un tempo preciso di riferimento alla “Storia” e questo contribuisce a dare al personaggio una valenza universale, a renderlo espressione di una condizione esistenziale, di quel “ male di vivere” che attraversa un tempo e una società, la nostra (Walter Pretolani). 37 martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 marzo La coscienza di Zeno di Tullio Kezich dal romanzo di Italo Svevo con Giuseppe Pambieri regia di Maurizio Scaparro NOTIZIE BIOGRAFICHE SULL'AUTORE 1861 – nasce a Trieste il 19 dicembre con il nome di Hector Aron Schmitz, da Franz e Allegra Moravia 1873 – viene mandato a studiare in Germania, al collegio di Segnitz presso Wurzburg. 1880 – è impiegato alla succursale triestina della Banca Union di Vienna. 1890 - esce a puntate su ”L’Indipendente” il racconto L’assassinio di via Belpoggio. 1892 - pubblica a proprie spese il romanzo Una vita . 1896 - sposa Livia Veneziani; l’anno dopo nasce la figlia Letizia. 1899 - esce a puntate su “L’Indipendente” il romanzo Senilità 1899 - entra nella ditta di vernici sottomarine del suocero. 1901 - inizia i suoi viaggi d’affari in Europa. 1905 - amicizia con James Joyce che insegna inglese a Trieste. 1908-1910 – legge Freud e si interessa di psicoanalisi. 1923 - pubblica La Coscienza di Zeno 1925 - articolo di Montale su Svevo. Inizia il “caso Svevo”. 1926 - sulla rivista “Le Navire d’argent “ vengono pubblicati alcuni estratti delle sue opere. 1927 - va in scena l’atto unico Un terzetto spezzato 1928 - inizia la stesura di un quarto romanzo, il cui protagonista doveva essere ancora Zeno. Muore in seguito ad un incidente stradale a Motta di Livenza (Treviso ) NOTIZIE SUL TESTO Il romanzo La coscienza di Zeno iniziato nel 1919, “quattro mesi dopo l'arrivo delle nostre truppe a Trieste, sotto la spinta di un attimo di forte e travolgente ispirazione”, e concluso nel 1922, viene pubblicato a Bologna nel 1923 presso Cappelli, a spese dell'autore. Eugenio Montale, lettore ed estimatore di Svevo, ha definito il romanzo “uno strano libro, stagnante eppure continuamente in moto”, affermazione che si può applicare a tutta la produzione letteraria dello scrittore triestino. Sarà proprio Montale nel 1925 a portare in Italia il caso Svevo e a riconoscerne “la singolare potenza” e la capacità di rappresentare “la modernità dell'indifferenza esistenziale e soprattutto del tema dell'inetto, dello sradicato incapace di scegliere e di decidere in cui si individua il profilo dell'uomo moderno europeo rivolto al proprio interno - non a caso si parla di “coscienza” - più che all'esterno, “un novissimo Ulisse”, “una sorta di Charlot borghese”.” Il romanzo è l'analisi della psicopatologia quotidiana di Zeno Cosini, personaggio enigmatico e ambivalente colto attraverso i ricordi grazie ai quali ricompone un passato rivissuto in modo del tutto personale. La “coscienza” del personaggio, operando spostamenti, rimozioni, mistificazioni e lapsus, tende ad allontanare sempre di più il momento del rendiconto oggettivo, a mascherare i vari momenti dell'azione come evidenzia nella prefazione il dottor S. riferendosi alle “tante verità e bugie ch'egli – Zeno - ha accumulato nella sua autobiografia. La vicenda è costruita sotto forma di diario, di memoriale autobiografico di natura privata, compilato da Zeno su invito dello psicanalista come “buon preludio alla psicanalisi”, psicanalista che viene deluso perché il paziente abbandona la cura. 38 Fratello di Alfonso ed Emilio, come scrive lo stesso Svevo, anche se si differenzia da loro “per la sua età avanzata e perché è ricco”, Cosini passa continuamente dai propositi più eroici alle disfatte sorprendenti. “Sposa e anche ama quando non vorrebbe. Passa la sua vita a fumare l'ultima sigaretta. Non lavora quando dovrebbe e lavora quando farebbe meglio ad astenersene. Adora il padre e gli fa la vita e la morte infelicissima. Rasenta una caricatura questa rappresentazione”, ed infatti il critico francese Crémieux afferma che Zeno “inciampa sempre nelle cose come Charlot! Se Zeno è un giudice inattendibile di se stesso, altrettanto inattendibile è lo psicanalista che lo ha in cura e che, come già detto, prende la parola nella Prefazione. Lo dimostrano la sua scarsa ortodossia freudiana (“gli studiosi di psicanalisi arricceranno il naso a tanta novità”), il suo carattere vendicativo (”le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia”), il forte interesse economico (“lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione”), il ricatto cui sottopone il paziente (“a patto che egli riprenda la cura”). La narrazione non costituisce un racconto organico, piuttosto un resoconto introspettivo che procede per grandi temi, per sondaggi su momenti particolari dell'esistenza, l'uno indipendente dall'altro e in sé concluso, attraverso cui Zeno rilegge, a distanza di tempo, il proprio passato scegliendo cosa dire e cosa non dire, interpretando e travisando gesti e atteggiamenti. Si alternano, in conseguenza di ciò, passato e presente, presente e passato, senza ordine apparente: il presente si insinua nel passato, il passato nel presente dando origine al cosiddetto “tempo misto”, misto di realtà e desiderio proprio come la coscienza. L'ansare di una locomotiva, “una locomotiva cha sbuffa” turba Zeno, attento ai minimi fatti, che devia la direzione della sua ricerca per scoprire che quel rumore gli ricorda l'affannoso respiro del padre morente, “quella locomotiva che trascina una sequela di vagoni su per un'erta, io l'ebbi, per la prima volta ascoltando... il respiro di mio padre”. Questo costituisce uno degli aspetti del “nuovo” romanzo. Infatti La coscienza di Zeno non presenta una struttura lineare, una trama unitaria, un racconto organico delle vicende del personaggio che sfocia in una conclusione (come avviene ne I Promessi sposi e , in genere, nel romanzo ottocentesco). Il romanzo di Svevo non racconta la vita di Zeno dall'inizio alla fine, ma segue un percorso tematico che affronta, di volta in volta, problematiche diverse attraverso nuclei tematici separati: Il fumo, La morte di mio padre, La storia del mio matrimonio, La moglie e l'amante, Storia di un'associazione commerciale e Psicanalisi, che si snodano secondo un libero filo interiore. Non viene dissolta solo la linearità del romanzo tradizionale, ma anche l'identità del personaggio. Zeno non è un personaggio statico; mentre si racconta, si analizza, riflette su se stesso, interpreta le proprie azioni: è in continua evoluzione. Tutto questo lo rende un narratore poco oggettivo e attendibile; con “la finzione del memoriale” Svevo toglie al suo romanzo l'autorità della storia vera, del fatto accaduto narrato obiettivamente. La realtà che si racconta è solo “il riflesso della soggettività ingarbugliata dell'io narrante, è una creazione della coscienza, non una realtà oggettiva, non la verità”. Come anche nell'opera pirandelliana è venuta meno la fiducia nella possibilità di fare un racconto oggettivo e addirittura nell'esistenza di una realtà oggettiva da raccontare. Non è più possibile un romanzo tradizionale con un inizio e una fine, ma un romanzo con una struttura aperta, inconclusa come la concezione della vita che esprime. Altro aspetto innovativo del romanzo sveviano consiste nel fatto che il protagonista non è più un “eroe”, piuttosto un “antieroe” o meglio un inetto. Del resto già Pirandello aveva rilevato che il romanzo moderno, il mondo moderno “non conosce eroi”. Alfonso Nitti, Emilio Brentani, Zeno Cosini sono personaggi inetti che assumono caratteri diversi e un diverso modo d'agire perché rappresentano tre stagioni diverse della vita. Ciò evidenzia il passaggio nell'autore da una concezione ancora positivistica della vita e della lotta per l'esistenza a una visione del disadatto come forma di resistenza all'alienazione della “civiltà degli ordigni”. Non più giovane, alla soglia dei sessant'anni, Zeno ha coscienza della sua nevrosi. Mentre Alfonso ed Emilio sono degli inetti che tentano inutilmente di combattere la loro natura, Zeno rinuncia alla lotta contro se stesso 39 giungendo alla consapevolezza della sua inettitudine e della ineluttabilità della “malattia” perché radicata nell'esistenza. Non si sottrae alla vita come Alfonso, non si rifugia nel sogno come Emilio, sa di essere malato, inetto e, come tale, si accetta. È consapevole che non esiste “salute”, che nessuno è “sano”, perché “la malattia” consiste nella vita stessa. L'inettitudine di Zeno si trasforma nell'ottica ironica e straniata di colui che svela la malattia della vita e della condizione storica in cui vive: diventa come gli altri uomini sani, un cinico profittatore di guerra, si sente sano perché si integra nel contesto completamente ammalato della vita “ormai inquinata alle radici”. Il giudizio sull'inetto è ormai ribaltato: non è bloccato in una forma definitiva, ma vive in una condizione di apertura e di disponibilità al mutamento che è l'unico modo di cogliere la fluidità delle occasioni e l'originalità della vita. Vengono infatti ne La coscienza di Zeno capovolti gli schemi acquisiti: il lottatore rappresentato nei primi romanzi da Macario e da Balli non risulta più il vincente. Guido muore per una serie di circostanze sfortunate, mentre Zeno il sognatore, il contemplatore riuscirà a trionfare, a diventare “il miglior uomo della famiglia” Malfenti. Al termine delle sue “confessioni” Zeno si ribella allo psicanalista che vorrebbe guarirlo togliendogli l'abitudine dello studio del suo animo e conclude che i veri malati sono gli altri, i presunti “sani”, coloro che, come il cognato Guido, si occupano soltanto della superficie della vita, secondo i valori dominanti della società borghese che impongono l'esibizione di quel che non si é e non si ha. LO SPETTACOLO La nuova impegnativa produzione del Teatro Carcano è basata sulla versione che Tullio Kezich ha elaborato nel 1964 del romanzo di Italo Svevo La coscienza di Zeno. La scelta di un testo così complesso è scaturita - dichiara il direttore di produzione Riccardo Pastorello - dal desiderio di tutelare “il nostro grande patrimonio letterario”. La coscienza di Zeno è infatti uno dei testi più riusciti della drammaturgia che deriva dalla letteratura per quanto riguarda la struttura e i temi che tratta. Il testo di per sé interessante è stato elaborato in modo efficace da Tullio Kezich. La regia è affidata ad uno dei più grandi maestri del teatro italiano Maurizio Scaparro che ha curato e allestito numerosi spettacoli e ricoperto importanti incarichi istituzionali, l'interprete principale Giuseppe Pambieri, uno degli attori più poliedrici delle nostre scene, La prima della pièce sarà il 12 gennaio 2012 al teatro Salieri di Legnano (VR) per cui non sono reperibili recensioni essendo lo spettacolo in fase di allestimento. SPUNTI DI RIFLESSIONE “Un uomo può avere solo due grandi fortune a questo mondo: quella di amare molto oppure quella di combattere vittoriosamente nella lotta per la vita. Si è felici in un modo o nell'altro ma non avviene spesso che il destino conceda ambidue queste felicità. Mi pare perciò dei caratteri umani, i felici son quelli che sanno rinunciare all'amore o quelli che si tolgono dalla lotta. Infelicissimi son quelli che si frazionano come desiderio o come attività nei due campi tanto opposti”. Il brano di Svevo da Diario per la fidanzata (3 gennaio 1896) è una riflessione sui tratti peculiari della sua personalità e insieme della natura umana. La condizione esistenziale di ogni persona gli appare in bilico tra la diffusa e comune aspirazione alla serenità, alla felicità e la minaccia ineluttabile della tristezza, dell'infelicità quasi che ogni individuo sia vincolato a oscillare e a scegliere tra il godimento della vita e l'indifferenza per la vita stessa. Il destino dell'uomo non offre scampo rispetto a simile, brusca alternativa; Svevo nota così che la dedizione alla felicità spesso conduce 40 alla superficialità, ad una concezione gretta e banale dell'esistenza: “Ho un grande timore che essendo felice diventerei stupido”. Viceversa l'apparente infelicità, l'indifferenza pessimistica per le passioni e le imprese della vita attiva gli sembrano “l'essenza della vita intellettuale”, il presupposto che può condurre l'uomo a capire meglio se stesso. È evidente l' intenzione di Svevo di prendere in esame la condizione dell'uomo moderno nella società borghese. Per esperienza diretta egli vive tale dualismo conflittuale della classe borghese di cui fa parte dove dominano l'operosità, l'opulenza e l'agiatezza mentre stentano a svilupparsi la cultura e l'arte che sono al più tollerate come occasioni di svago e di intrattenimento. La letteratura è considerata un mestiere proibito, una distrazione che non deve interferire con il lavoro e con il mondo degli affari. Proprio perché diviso tra lavoro borghese e vizio letterario Svevo, come Zeno e gli altri “inetti”, rispecchia nella sua opera la condizione di conflittualità dialettica tra due modelli alternativi: l'uno dominante impostato sull'agonismo, sull'ambizione, sul mito del successo (il “lottatore”), l'altro (il “contemplatore”, il “sognatore”) indirizzato alla ricerca contemplativa di una perfetta tranquillità dell'animo. La società di ieri e di oggi è spesso crudele: chi non rientra nel primo modello è un escluso, un emarginato, un vinto, direbbe Verga. Con Svevo diciamo “un inetto”. L'inetto non è comunque il vinto della narrativa verista che finisce schiacciato dagli ingranaggi di una società ingiusta e spietata, l'inetto è vittima di se stesso, delle sue tortuosità psicologiche, delle sue debolezze, delle sue contraddizioni, dello “scarto” tra i suoi propositi e le sue azioni, tra le sue intenzioni e i comportamenti effettivi. Inetto, quindi, perché passivo e inerte di fronte alla vita, perché non conformista e al di fuori dagli schemi e dalle convenzioni. Zeno concentra in sé tutti questi aspetti, si rende conto della sua diversità e ha un disperato bisogno di “salute” cioè di normalità, di integrazione: ma non riesce mai a coincidere con quella forma compiuta e definitiva di uomo. Il problema di fondo è quello della libertà dell'individuo in una società modernamente organizzata, della sorte di sconfitta e di eterna frustrazione che tocca a chi vuole salvaguardare la propria identità nello scontro con i ferrei ingranaggi collettivi. Di sconcertante attualità questa tematica che, in un modo o nell'altro, tocca ognuno di noi, ed anche l'interrogativo conseguente: in una realtà socio-culturale come la nostra è più positivo essere lottatori o contemplatori?, essere uomini borghesi integrati nel sistema o “inetti” abulici e sognatori? È importante che ognuno si ponga tali domande e tenti, almeno, di darsi una risposta! È certo un interrogativo cui non è facile rispondere e che pone, ancora una volta, il problema della diversità e della normalità. Da Svevo l'inettitudine è intesa non come malattia negativa, ma condizione privilegiata che sola può difendere la vita: il malato o il nevrotico, colui insomma che si pone come diverso nel contesto sociale, è la persona capace di assumere le difese della vita, sottraendola ai pericoli della più grave delle alienazioni, quella economica, di sacrificare la ricerca del piacere. In questo senso e in questa prospettiva il “malato” per eccellenza è l'artista che più di ogni altro riesce a cogliere dei traguardi. Contro la “malattia” dell'individuo e del mondo, Svevo sostiene, c'è un solo rimedio, una sola terapia, la “scrittura”: “fuori della penna non c'è salvezza”. Una terapia diversa lo renderebbe più normale, ma spegnerebbe le pulsioni vitali. Per questo l'ultimo Svevo difende la propria inettitudine che è una forma di resistenza all'alienazione circostante, di non-adattamento ai meccanismi alienanti della civiltà. Rispetto all'uomo efficiente, ma del tutto integrato nei meccanismi inautentici della società borghese, lo scrittore preferisce essere un dilettante, un abbozzo aperto a possibilità diverse e fondamentalmente se stesso. 41 Conclusione “L'Arte- il Teatro- si insinua sempre nelle spaccature della vita psichica” da Il manoscritto di Stephen Greenblatt Mai come in questo momento in cui le nostre vite sono “social” e troppo spesso virtuali, il teatro deve diventare una sorta di “grillo parlante” (da “La Voce”, giovedì 4 ottobre 2012) necessario come il grillo parlante per Pinocchio, perché interroghi lo spettatore, provochi turbamenti, offra occasioni valide di incontro in quello che rimane, come ha affermato Giampiero Piscaglia (direttore dell'Istituzione musica, teatro, eventi), “una delle poche agorà dove le persone si incontrano in carne ed ossa”, un'agorà reale e non virtuale, che è rimasto uno dei pochi frammenti di civiltà, un frammento di civiltà che dobbiamo cercare di salvaguardare a tutti i costi. Per noi e per i nostri giovani che ci proponiamo di far crescere ed educare per far sì che possano dare una risposta ai tanti interrogativi emersi”. 42 43 44
Scarica