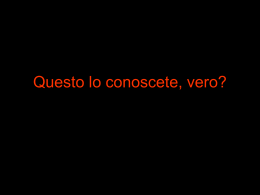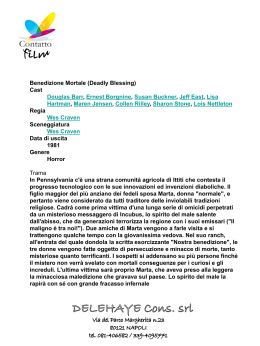MATILDE ASENSI L'ORIGINE PERDUTA (El Origen Perdido, 2003) Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. ARTHUR C. CLARKE I Il problema che intuivo appena quel pomeriggio, mentre indugiavo in piedi immobile tra la polvere, le ombre e gli odori di un vecchio edificio chiuso, era che essere metropolitano, progressista, scettico e tecnologicamente avanzato all'inizio del XXI secolo mi impossibilitava a prendere in considerazione qualsiasi cosa rimanesse fuori dall'ambito dei cinque sensi. In quel momento la vita, per un hacker come me, era soltanto un complesso sistema di algoritmi scritti in un linguaggio di programmazione su cui non esistevano manuali. In altre parole, io ero uno di coloro per i quali vivere significava imparare ogni giorno a gestire il proprio software senza avere avuto la possibilità di seguire corsi né il tempo per esercitazioni o prove. La vita era ciò che era, e per di più molto breve; la mia consisteva nel tenermi permanentemente occupato, senza pensare a niente che non avesse a che vedere con quanto facevo momento per momento, soprattutto se, come allora, stavo compiendo un reato punito dalla legge. Ricordo che mi fermai un secondo a osservare con stupore i particolari di quel teatro di posa in rovina che, un tempo per me molto lontano (venti o forse trent'anni prima), aveva brillato alla luce dei riflettori e vibrato alla musica dal vivo delle orchestre. Non erano ancora trascorse del tutto le ultime ore di quel giorno di fine maggio e il sole era già scomparso dietro i contrafforti dei vecchi studi televisivi di Miramar, a Barcellona, i quali, seppure chiusi e abbandonati, grazie ai miei amici e a me erano sul punto di essere riutilizzati per il loro scopo originario. Osservandoli dall'interno, come facevo io, e ascoltando l'eco delle voci famose che li avrebbero abi- tati per sempre, sembrava impossibile pensare che in pochi mesi si sarebbero trasformati in un altro hotel per turisti di lusso. Accanto a me, Proxi e Jabba si affannavano a montare l'apparecchiatura su un vecchio palco di legno scolorito fino al quale arrivava con difficoltà la luce dei lampioni in strada. I pantaloni di Proxi, neri e attillati, le coprivano appena le caviglie e quegli ossicini appuntiti, quegli spigoli, gettavano ombre enormi sulle sue gambe, lunghe e piene di ondulazioni, sotto le lampade al neon poste sulla pedana. Jabba, uno dei migliori ingegneri della Ker-Central, stava collegando la telecamera al computer portatile e all'amplificatore di segnali con rapidità e competenza. Nonostante fosse grande, grosso e gelatinoso, Jabba apparteneva a quella razza di tipi intelligenti, abituati al contatto con l'aria e il sole, che, sebbene induriti dalle mille battaglie con le regole della società civile, conservavano ancora qualcosa della disinvoltura dell'uomo primitivo nell'uomo moderno. «Ho terminato», mi disse Jabba, sollevando lo sguardo. La sua faccia tonda ammucchiava occhi, naso e bocca al centro del cerchio. Aveva raccolto dietro le orecchie ciocche disordinate di capelli rossi e lunghi. «I collegamenti sono attivati?» chiesi a Proxi. «Tra un paio di minuti.» Guardai l'ora. Le lancette dell'orologio, che uscivano direttamente dal naso del barbuto capitano Haddock, segnavano le otto meno cinque. Nel giro di mezz'ora, tutto sarebbe terminato. Al momento, l'antenna parabolica era già orientata e il punto di accesso pronto ad aprirsi; mancava solo che Jabba finisse di installare la connessione senza fili perché io potessi cominciare a lavorare. In quel preciso istante capii che cosa, già da un pezzo, mi risultava tanto familiare in quel teatro di posa: aveva lo stesso odore del divano della casa di mia nonna, a Vic, un odore di mobili vecchi, di sacchetti antitarme e di metallo ossidato. Era molto tempo che non parlavo con la nonna, ma non ne avevo colpa perché, ogni volta che prendevo la decisione di andarla a trovare, lei partiva per qualche luogo remoto del globo in compagnia delle sue folli amiche, tutte vedove e ottuagenarie. Senza dubbio sarebbe stata entusiasta di visitare i vecchi studi di Miramar perché ai suoi tempi era stata un'appassionata spettatrice del programma di Herta Frankel e della sua cagnetta Marylin. «È pronto», annunciò Proxi. «Sei già dentro.» Mi sedetti sul pavimento muffoso con le gambe incrociate e appoggiai il portatile sulle ginocchia. Jabba si piazzò accanto a me e si chinò per segui- re a video l'evoluzione dell'accesso. Mi inserii nei computer della Fondazione TraxSG usando la mia versione di «Sevendoolf», un noto cavallo di Troia che permetteva di accedere a sistemi remoti attraverso l'uso di «porte di servizio» (backdoor). «Come hai trovato la chiave?» volle sapere Proxi, sistemandosi sull'altro lato e assumendo la stessa posizione di Jabba. Proxi era una di quelle donne che non sapevo come considerare. Ogni parte del suo corpo era di per sé perfetta, e il viso, incorniciato da una lucente e corta chioma nera, era molto attraente, con il bel naso affilato e i grandi occhi scuri. L'insieme, però, non risultava armonioso, come se i piedi fossero di un'altra persona, le braccia un paio di taglie in più e la vita, benché sottile, troppo larga per i suoi fianchi sfuggenti. «Con la forza bruta?» azzardò. «Ho fatto delle prove con i computer di casa mia da quando è incominciato tutto questo», le risposi sorridendo. Mai, nemmeno sotto l'effetto del pentotal, avrei rivelato i miei più preziosi segreti a un altro hacker. Il sistema, che lavorava con Microsoft SQL Server e usava Windows NT per la sua rete locale, non disponeva della pur minima protezione; quella rete non aveva nemmeno l'antivirus aggiornato. L'ultima versione risaliva al maggio del 2001, esattamente all'anno prima. Era deprimente pirateggiare in queste condizioni, soprattutto dopo l'investimento in un'operazione di tale importanza. «Sono degli incoscienti...» Per un buon hacker, hacker da una vita come Jabba, alcune cose non erano concepibili né umanamente né tecnicamente. «Attenzione!» mi avvertì Proxi, appoggiandosi sulla mia spalla per osservare meglio il monitor. «Non toccare nessun file. Devono essere pieni di virus, worm e Spyware.»1 Proxi, che nella vita reale lavorava nel dipartimento di sicurezza della Ker-Central, conosceva fin nel minimo dettaglio le terribili conseguenze di quelle poche righe di codici nocivi. Infatti non c'era nemmeno bisogno di aprire quei cybertossici per attivarli; bastava farvi scorrere sopra il cursore incautamente. «Ecco la cartella dei logos», mi additò Jabba con l'indice puntato sullo schermo al plasma, che ondeggiò come una macchia d'olio. Non aveva fatto molta fatica a trovarla. L'ingegnere responsabile del sistema informatico della TraxSG, con molto buon senso, aveva battezzato questa cartella «Logos», e poi, supposi, era andato a bersi alcune birre per festeggiare la sua grande intelligenza. Avrei voluto lasciargli un messaggio di felicitazioni, ma mi limitai a esaminare il contenuto del computer e a trasferire, in sostituzione dei famosi disegni della TraxSG - il nome in verticale con lettere di tipo, dimensione e colore diverso -, un nuovo gruppo di logos che avrebbe mostrato la frase «Né canone né pirati» tutte le volte che qualcuno della Fondazione avesse avviato un computer, un programma o, semplicemente, si fosse scollegato. Inviai, inoltre, un file che sarebbe rimasto nascosto nelle profondità della macchina e che avrebbe rinnovato le modifiche quando qualcuno avesse tentato di cancellarle; così, risalire all'origine sarebbe costato moltissimo tempo e denaro. Questo file, fra le altre cose, avrebbe stampato su tutti i documenti un teschio con due tibie incrociate e, ancora, la frase «Né canone né pirati». Infine, feci una copia di tutti i documenti che trovai, relativi al fortunato canone che la Fondazione era riuscita a imporre ai produttori di software, e li distribuii generosamente attraverso Internet. Non mi restava che lanciare in rete, da quegli studi di Miramar, nel tempo che mancava a individuare l'apparecchiatura e bloccarla, la campagna che avevamo ideato per chiedere il boicottaggio di tutti i prodotti della TraxSG e incoraggiare la gente a comprare quegli stessi prodotti all'estero. «Dobbiamo tagliare la corda», ci avvisò Jabba con voce allarmata, guardando l'orologio. «L'addetto alla sicurezza passerà nei corridoi fra tre minuti.» Chiusi il portatile, lo poggiai sul pavimento e mi alzai scuotendomi la polvere dai jeans. Proxi coprì la pedana con una spessa tela per sottrarre l'impianto alla vista di eventuali curiosi; questo non avrebbe impedito che prima o poi lo scoprissero, ma almeno avrebbe concesso alla protesta alcuni giorni di proroga. Sarebbe stato divertente leggere la notizia sui giornali. Approfittando degli ultimi secondi di permanenza in quel luogo, mentre Proxi e Jabba si affannavano a raccogliere il resto del materiale, presi dallo zaino una bomboletta spray di vernice rossa, vi sistemai la valvola Harcore per tratti spessi e grandi e la agitai fino a sentire i colpetti metallici che indicavano che il composto era pronto. Poi, con una buona dose di vanità, tracciai su una parete un enorme cerchio e, dentro, una lunga linea ondulata che si avvolgeva a spirale e occupava in orizzontale tutto lo spazio. Quindi firmai con il soprannome con cui ero conosciuto: Root. Era il mio tag, la mia firma personale, visibile in molti luoghi presumibilmente inespugnabili. Se in questa occasione non lo avevo incluso nei computer della TraxSG - lo lasciavo sempre nei luoghi pirateggiati, reali o virtuali -, era perché non ero solo e non lavoravo per conto mio. «Andiamo!» incalzò Jabba dirigendosi con passo leggero verso le porte dello studio. Spegnemmo le lampade al neon e, con l'unica luce dei piccoli catarifrangenti di emergenza come guida, attraversammo i corridoi e scendemmo le scale veloci, senza far rumore. Negli scantinati si trovava lo sgabuzzino dei trasformatori con gli antidiluviani quadri elettrici degli studi. Lì, sul pavimento, confusa tra i nostri attrezzi di speleologia, una lastra di ferro dava accesso allo strano mondo sotterraneo che si nascondeva sotto l'asfalto di Barcellona; connessa in parecchi punti con i quasi cento chilometri di tunnel delle linee della metropolitana e delle ferrovie si trovava la colossale trama di gallerie della rete fognaria collegata con tutti gli edifici, i centri e le istituzioni ufficiali della città. Come New York, Londra o Parigi, Barcellona celava nelle sue viscere una seconda città, viva e piena di misteri al pari di quella in superficie esposta alla luce del sole e alle acque del mare. Questa città occulta, oltre a possedere i propri nuclei abitati, la propria vegetazione autoctona, i propri animali, e la propria unità di polizia, la cosiddetta «Unitat de subsòl»,2 contava anche su numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo per praticare uno sport - naturalmente illegale - noto come speleologia urbana. Mi tolsi l'elastico con cui tenevo raccolti i capelli e infilai il casco sistemandomi il sottogola. I nostri tre caschi Ecrin Roc erano dotati di led frontali3 fissati con clip, che mandavano una luce molto più bianca del normale ed erano molto meno pericolosi in caso di fughe di gas. Inoltre, se si fondeva uno dei led, ce n'era sempre un altro funzionante, cosicché non potevi mai trovarti completamente al buio. Come un distaccamento militare ben sincronizzato accendemmo i rilevatori di gas, sollevammo la lastra di ferro, su cui era stampigliato il marchio della società elettrica, e ci calammo in uno stretto passaggio verticale. Quest'ultimo scendeva a piombo per un lungo tratto in cui provammo, soprattutto Jabba, che era il più grosso dei tre, un'opprimente sensazione di claustrofobia. La straordinaria estensione della galleria era dovuta al fatto che gli studi di Miramar erano stati costruiti su una delle due colline di Barcellona, Montjuïc, e quindi si trovavano a un'altitudine elevata rispetto al livello del mare. Come in quasi tutti questi tipi di condotto, un quarto della galleria era occupato da cavi elettrici, a cui ci aggrappavamo per calarci. Indossavamo degli ingombranti guanti isolanti che ci intralciavano ulteriormente nella discesa. Raggiungemmo infine il tunnel di servizio che univa la Zona Franca con la Plaza de Catalunya. Se c'è qualcosa del sottosuolo che impressiona davvero, non sono le bisce né i ratti e nemmeno i tipi dall'aria spettrale che puoi incontrare sul tuo cammino; ciò che ti stringe realmente il cuore e ti chiude lo stomaco è il silenzio totale, l'assoluta oscurità e l'intenso odore di umidità vischiosa. Lì, in mezzo al nulla, il minimo rumore si amplifica e si distorce, e tutti i luoghi sembrano uguali. A Parigi, un paio di anni prima, nonostante fossimo accompagnati da un tizio del Gruppo Francese di Speleologia Urbana che conosceva le viscere della città meglio delle sue tasche, il mio gruppo si era perso per sette ore nelle gelide fognature medievali che perforano il bacino orientale della Senna. Non mi era mai più successo, ma quell'esperienza era stata tanto pericolosa da obbligarmi a prendere, da quel giorno, tutte le precauzioni possibili. Scendemmo ancora un po' utilizzando uno dei pozzi rapidi della rete fognaria, e, all'altezza della calle del Hospital, dopo la deviazione della conduttura all'allaccio dei collettori del Liceu - dove avevo disegnato il mio marchio, proprio accanto alla scaletta che portava alla vecchia sala delle caldaie -, una minuscola botola, sporca e corrosa dalla ruggine, ci permise di accedere alla rete di tunnel del metrò. Poca gente sapeva o ricordava che, a metà degli anni Settanta, era stato costruito un passaggio pedonale tra le stazioni del Liceu e di Urquinaona allo scopo di collegare le linee 3 e 4 e alleggerire l'affollata e labirintica stazione centrale di Catalunya. Trent'anni dopo il passaggio veniva utilizzato solo da noi e da una cinquantina di persone dei sobborghi che avevano fatto di quel sudicio e insalubre vermicaio un luogo di residenza abituale. Si trattava, per la maggior parte, di gente silenziosa e senza età tra cui c'erano ogni sorta di strani individui. A metà del passaggio, in cui regnava la puzza di urina e di sporcizia, c'era la vecchia porta metallica che dava su un livello inferiore di corridoi. Scendemmo delle scale metalliche e ci incamminammo verso l'imboccatura del tunnel che avevamo di fronte. Marciammo in fila per un centinaio di metri sul lato destro dei binari, con le orecchie tese per sentire se si avvicinava un treno (non sarebbe stato niente di strano, visto che avanzavamo lungo un segmento della linea 4), e ci fermammo davanti a uno stretto sportello difficilmente distinguibile nel muro annerito. Con la chiave che tenevo in una tasca dei jeans aprii il lucchetto, e, una volta dentro, Jabba lo chiuse con i chiavistelli di ferro che lo rendevano inespugnabile dall'esterno. Ai nostri piedi si apriva la solita botola che lasciava in vista una cavità verticale di quindici metri nella quale dovevamo calarci. Questo era sempre l'ultimo svago delle nostre scorrerie. Agganciammo i discensori ai mo- schettoni fissati alla vita e ci buttammo insieme a tutta velocità usando le corde che avevamo fissato in modo definitivo all'imboccatura. Quando dovevamo salire, naturalmente ci servivamo delle scale. Con grande rimbombo poggiammo infine i piedi sul pavimento del vecchio tunnel abbandonato dove c'era il nostro «Serie 100». Nessuno, a parte noi tre, ne conosceva l'esistenza. Si trattava di uno dei primi tratti di ferrovia suburbana realizzati in città, costruito poco dopo il 1925 dalla Compagnia del Gran Metro di Barcellona. Era a forma di Y, e la biforcazione si trovava precisamente nella calle Aragó, dove abitavo e dove aveva sede la mia società di software, la Ker-Central. Approfittando della corrente d'aria che arrivava attraverso le bocchette del soffitto, ci pulimmo dai residui di fango mentre risalivamo tranquillamente la caverna, tanto larga da consentire il transito di due grossi camion affiancati. Attorno a noi tutto era buio; lì era sempre notte e sempre autunno, ma eravamo in territorio sicuro e conosciuto. Cinquecento metri più avanti vedemmo il gigantesco manifesto pubblicitario di colore rosso in cui l'attore Willem Dafoe, per reclamizzare una marca di whisky, diceva qualcosa di molto profondo come «L'autenticità inizia in se stessi». Su richiesta di Proxi lo avevamo «comprato» nella stessa stazione della metro di passeig de Gràcia che avevamo in quel momento sopra le nostre teste, perché, secondo lei, si confaceva perfettamente alle attività che praticavamo nel «Serie 100». Jabba, seguendo un impulso irrefrenabile che nasceva dal passato di graffitaro, aveva dipinto sulla monumentale fronte dell'attore la parola Bufanúvols4 ed era rimasto tranquillo ad ascoltare il predicozzo di Proxi. Proprio alla biforcazione del tunnel, quasi all'altezza della fermata di passeig de Gràcia, si trovava il nostro centro di operazioni clandestine, il «Serie 100», un decoroso vagone abbandonato alla chiusura della linea delle Ferrovie Metropolitane. Quando lo scoprimmo fu il nostro grande giorno fortunato. Incagliato nelle sue rotaie da almeno quarant'anni, il «Serie 100» - come recitavano le targhe metalliche sulle fiancate - stava andando in rovina lustro dopo lustro nel generale oblio. Costruito in legno, con numerosi finestrini ovali, un interno bianco che conservava ancora i sedili posti in senso longitudinale e un'illuminazione a lampadine a incandescenza che pendevano dal soffitto, avrebbe meritato di stare in qualsiasi museo di treni del mondo. Tuttavia, per nostra fortuna, qualche funzionario incompetente lo aveva lasciato dormire il sonno dei giusti, e si era trasformato con gli anni in albergo per ratti, topi e ogni sorta di bestiacce. Avevamo passato molto tempo a togliere il sudiciume, a raschiare con la carta vetrata, a verniciare, a levigare il legno, a rafforzare i predellini e le giunture, a lucidare le targhe; quando era stato tanto splendente da abbagliare, e solido come una roccia, l'avevamo riempito di cavi elettrici, computer, monitor, stampanti, scanner e apparecchi radiofonici e televisivi di ogni genere. Avevamo fornito di illuminazione quella zona del tunnel e l'interno del vagone, e messo anche un piccolo frigorifero con alimenti e bibite. Erano trascorsi alcuni anni, da allora, durante i quali avevamo aggiunto nuove comodità e attrezzature più moderne. Appena entrato, e prima di avere avuto il tempo di liberarmi dello zaino, il telefono cui avevo trasferito le chiamate del cellulare cominciò a suonare. «Che ora è?» chiese Proxi a Jabba, che irrompeva in quel momento nel vagone. «Quasi le nove», rispose lui guardando con ansia gli schermi accesi dei computer. Aveva lasciato in esecuzione un programma che cercava di danneggiare con la forza bruta (provando milioni di possibili combinazioni alfanumeriche archiviate nei database) le chiavi di alcuni file di architettura di sistema. Il display del telefono indicava che stava chiamando mio fratello. Mi tolsi velocemente la maglia nera a collo alto e risposi mentre raccoglievo di nuovo i capelli in un codino. «Dimmi, Daniel.» «Arnau...?» La voce femminile non era quella di mio fratello, ma di mia cognata, Mariona. «Sono io, Ona, dimmi.» Proxi mi mise in mano una lattina di succo di frutta, aperta. «Sono ore che ti cerco!» esclamò lei con voce acuta. «Siamo in ospedale. Daniel sta male.» «Il bambino o mio fratello?» Mariona e Daniel avevano un figlio di un anno, il mio unico nipote, che si chiamava come suo padre. «Tuo fratello!» le sfuggì in tono impaziente. E, come se la mia confusione fosse un'incomprensibile stupidaggine, chiarì: «Daniel!» Per un momento rimasi paralizzato, senza reazioni. Mio fratello aveva una salute di ferro; non prendeva nemmeno l'influenza quando tutti andavano in giro con il fazzoletto in mano e la febbre, quindi l'idea che potesse essere in ospedale non mi entrava nella testa. Allora... un incidente. Con la macchina. «Eravamo a casa», cominciò a spiegarmi Mariona. «E all'improvviso è rimasto come inebetito, sembrava fuori di testa... Straparlava. Mi sono spaventata e ho chiamato il medico, e questo, dopo averlo visitato a lungo, ha richiesto un'ambulanza per portarlo all'ospedale. Siamo arrivati al Pronto Soccorso circa alle sette di sera. Come mai non rispondevi al telefono? Ti ho chiamato a casa, in ufficio... Ho chiamato la tua segretaria, Lola, Marc, tua madre...» «Hai chiamato Londra?» Ero così sconvolto che non trovavo le parole. «Sì. Ma tua madre era uscita. Ho parlato con Clifford.» Nel frattempo Proxi e Jabba si erano portati alle mie spalle, attenti alla conversazione. Non occorreva essere dei geni per capire che stava succedendo qualcosa di grave. «In che ospedale siete?» «Alla Custòdia.» Guardai l'orologio, frastornato, e calcolai quanto tempo avrei impiegato ad arrivarci. Avevo bisogno di una doccia, ma in quel momento era la cosa meno importante. Avevo della roba pulita nel «100» e potevo raggiungere il garage in cinque minuti, prendere l'auto e arrivare a Guinardò in altri dieci. «Vengo subito. Dammi un quarto d'ora. Il bambino è con te?» «Avevo un'alternativa, forse?» Nel suo tono c'era una nota irritata che tradiva ostilità. «Arrivo immediatamente. Tranquilla.» Proxi e Jabba erano rimasti a guardarmi immobili, in attesa di informazioni. Mentre mi cambiavo la maglia, le scarpe da ginnastica e i jeans, raccontai loro quello che mi aveva detto mia cognata. Senza esitare un momento, si offrirono di badare al piccolo Dani. «Andremo a casa quando Jabba avrà finito», annunciò Proxi. «Però, se hai bisogno di noi prima, devi solo chiamarci.» Abbandonai il «100» come un fulmine, percorsi il tunnel fino all'estremo opposto e salii per le scale verticali che portavano direttamente allo sgabuzzino degli arnesi per la pulizia della cantina della Ker-Central. Una volta lì, chiusi la copertura di ferro e uscii in garage, lo attraversai di corsa fino a raggiungere la mia auto, una Volvo color bordeaux posteggiata accanto alla Dodge-Ram rossa di Proxi e Jabba, gli unici veicoli ancora nel parcheggio a quell'ora della sera. Taheb, il vigilante, che stava cenando davanti a un piccolo televisore nella sua cabina di vetro blindato, mi seguì con gli occhi, impassibile; per fortuna, decise di aprirmi il cancello di sicu- rezza e di lasciarmi uscire senza propinarmi uno dei soliti discorsi sulla situazione politica del Sahara. Quando le ruote della Volvo toccarono il marciapiede, mi resi conto che era l'ora peggiore del giorno per circolare in città; centinaia di persone desiderose di arrivare a casa e di cenare davanti al televisore inondavano con le loro auto la calle Aragò. Sentii che mi saliva la pressione sanguigna e che iniziava la metamorfosi che mi avrebbe trasformato da cittadino pacifico a guidatore aggressivo, incapace di sopportare il benché minimo oltraggio. Percorsi la calle Consell de Cent fino a Roger de Llúria. Passai un semaforo rosso all'angolo di passeig Sant Joan con travessera de Gràcia per colpa di una Skoda che arrivava a tutta velocità dietro di me; in Secretari Colonia rimasi imbottigliato in un traffico spaventoso; ne approfittai per chiamare al cellulare di mio fratello e dire a Ona che stavo arrivando e che mi venisse incontro. La mole grigia del vecchio edificio della Custòdia era abbastanza deprimente. Sembrava un insieme di cubi pieni di minuscoli buchi. Se tutto ciò che poteva ideare un architetto dopo tanti anni di studio era quello, mi dissi mentre cercavo l'entrata per i veicoli, sarebbe stato meglio che si dedicasse a coprire fossi. Per fortuna, una grande quantità di macchine stava uscendo in quel preciso momento - doveva essere l'ora del cambio di turno del personale - così parcheggiai subito evitando di girare e rigirare attorno a quell'ignobile paradigma della volgarità. Non ero mai stato in quell'ospedale e non avevo idea di dove dirigermi. Ona, però, mi stava aspettando e, con il piccolo Dani addormentato tra le braccia, si avvicinò mentre io scendevo dall'auto. «Grazie per essere venuto subito», mormorò mentre, curvandosi per non svegliare il bambino, mi dava un bacio e sorrideva triste. Avvolto nelle pieghe di una copertina azzurra, Dani teneva la testa appoggiata sulla spalla della madre; aveva gli occhi chiusi e il ciucciotto in bocca. I suoi capelli, incredibilmente biondi e tagliati con precisione, erano tanto ricciuti che, a seconda di come batteva la luce, sembravano un'aura elettrica lampeggiante. In questo aveva preso da suo padre. «E mio fratello?» chiesi, avviandomi con lei verso la scalinata d'ingresso. «Lo hanno appena portato in reparto. Il neurologo è ancora con lui.» Superammo le porte dell'immenso edificio e attraversammo numerosi corridoi dalle pareti scrostate fino ad arrivare agli ascensori. L'originale rivestimento di marmo del pavimento non era più riconoscibile: dove le lastre non erano rovinate, si vedevano toppe di qualcosa di simile a caucciù nero che facevano sobbalzare le barelle spinte da ausiliari. A ogni angolo c'erano cartelli che indicavano luoghi poco desiderabili: «Chirurgia», «Riabilitazione», «Dialisi», «Prelievi di sangue», «Camere operatorie»... Anche nel cigolante ascensore nel quale ci stipammo con altre quindici o venti persone, molto simile per dimensioni e forma a un container portuale, aleggiava quell'odore caratteristico degli ospedali. Fredde luci bianche al neon, labirinti di corridoi e di scale, porte gigantesche con cartelli misteriosi (UCSI, TAC, UMP), gente con lo sguardo perso e smorfie di ansietà, preoccupazione o dolore sul volto, che passeggiava da un lato all'altro come se il tempo non esistesse... E infatti il tempo non esisteva all'interno di quell'officina di riparazione dei corpi, come se la vicinanza della morte fermasse gli orologi fin quando il medico-meccanico non dava il permesso di continuare a vivere. Ona mi camminava accanto sorreggendo la borsa con la roba di Dani e i quasi dieci chili di figlio. Mia cognata era molto giovane, ventun anni appena compiuti. Aveva conosciuto Daniel il primo anno di università, durante la lezione di Introduzione all'Antropologia che mio fratello teneva in facoltà; i due erano andati a vivere insieme poco dopo, in parte per amore e in parte, suppongo, perché Mariona era di Montcorbau, un paesino della Valle di Aràn, e i piccioncini non dovevano sentirsi a loro agio a condividere la loro intimità con le altre quattro studentesse aranesi che abitavano nello stesso appartamento in affitto di Ona. Fino ad allora Daniel era vissuto con me, ma un giorno, all'improvviso, era comparso sulla porta del salotto con il monitor del suo computer sotto il braccio, uno zaino sulle spalle e una valigia in mano. «Vado a vivere con Ona», aveva annunciato con uno sguardo allegro. Gli occhi di mio fratello erano di un colore sorprendente: un viola intenso che non si vedeva spesso. A quanto pareva li aveva ereditati dalla nonna paterna, la madre di Clifford, e lui ne era così orgoglioso che si era dispiaciuto quando gli occhi di suo figlio Dani, schiarendosi, erano rimasti semplicemente azzurri. Per sottolineare la diversa combinazione genetica dalla quale derivavamo, i miei erano color marrone scuro, come il caffè, uguale ai capelli, anche se le differenze fisiche finivano lì. «Congratulazioni», era stato tutto ciò che gli avevo risposto quel giorno. «Buona fortuna.» Non è che Daniel e io non andassimo d'accordo. Anzi: eravamo uniti come potevano esserlo due fratelli che si amano e che sono praticamente cresciuti da soli. Il problema era che, essendo entrambi figli di Eulàlia Sañé (la donna più chiacchierona della Cataluña e, da venticinque anni, dell'Inghilterra), dovevamo per forza venire fuori silenziosi. E, alla fin fine, nella vita si impara, si sperimenta, si matura, ma cambiare, in effetti, non si cambia molto, perché uno è quello che è sempre stato. Mio padre era morto nel 1972, quando io avevo cinque anni, dopo essere rimasto a letto per molto tempo. Conservo appena nella memoria un'immagine di lui seduto in poltrona, che mi chiama con la mano, ma non sono sicuro che sia reale. Di lì a poco mia madre si era sposata con Clifford Cornwall; Daniel era nato due anni dopo, quando io ne avevo appena compiuti sette. Gli avevano dato questo nome perché era identico in entrambe le lingue, anche se noi lo pronunciavamo sempre all'inglese, mettendo l'accento sulla «a». Il lavoro di Clifford all'Ufficio Stranieri lo obbligava a viaggiare incessantemente tra Londra e Barcellona, dove c'era il Consolato Generale, quindi avevamo continuato a risiedere nella casa di sempre, mentre lui andava e veniva. Mia madre, da parte sua, si occupava delle amicizie, della vita sociale e di seguitare a essere - o a considerarsi la musa spirituale del vasto gruppo di vecchi colleghi dell'università di mio padre, presso la quale era stato docente di Metafisica per più di vent'anni (era molto più vecchio di mia madre quando si erano sposati a Maiorca, di cui era originario), così Daniel e io avevamo vissuto un'infanzia abbastanza solitaria. Di tanto in tanto ci mandavano qualche mese a Vic, con la nonna, finché non si erano accorti che i miei voti a scuola iniziavano a essere orrendi a causa delle assenze. Allora mi avevano iscritto come interno al collegio La Salle, e mia madre, Clifford e Daniel erano andati a vivere in Inghilterra. In un primo momento avevo pensato che mi avrebbero portato con loro, ma una volta resomi conto che non sarebbe stato così, avevo assimilato senza problemi il fatto che avrei dovuto imparare a cavarmela da solo e che non potevo contare su nessuno, tranne mia nonna, che tutti i venerdì mi aspettava come un paracarro davanti all'uscita del collegio. All'epoca in cui avevo messo in piedi la mia prima azienda, l'Inter Ker, nel 1994, mio fratello, disperato per essersi allontanato dalle gonne di nostra madre, era ritornata a Barcellona per studiare Filologia Ispanica e, in seguito, il secondo ciclo del corso di Antropologia all'Università Autonoma. Da allora, e finché non se n'era andato dicendo: «Vado a vivere con Ona», avevamo condiviso la casa. Nonostante fosse introverso come me, la gente, in generale, apprezzava molto di più Daniel per la sua affabilità e dolcezza. Parlava poco, però, quando lo faceva, tutti gli prestavano attenzione e pensavano di non aver mai sentito niente di più appropriato e interessante. Come suo figlio, aveva sempre il sorriso sulle labbra, mentre io ero cupo e taciturno, incapace di sostenere una conversazione normale con qualcuno in cui non avessi riposto da molti anni tutta la mia fiducia. È vero che avevo degli amici (più che amici, buoni conoscenti) e che, per lavoro, mantenevo rapporti con gente di tutto il mondo, ma erano tipi strani come me, poco inclini a comunicare o disposti a farlo solo attraverso una tastiera. Le loro vite trascorrevano quasi sempre sotto la luce artificiale, e quando non erano di fronte a un computer si dedicavano a hobby pittoreschi, per esempio la speleologia urbana o i giochi di ruolo, collezionavano animali selvatici o studiavano funzioni frattali,5 molto più importanti, naturalmente, di qualsiasi persona vivente che avessero vicina. «... e continuava a ripetere che era morto e che voleva che lo seppellissi.» Dalla gola di Ona sfuggì un piccolo singhiozzo. Tornai di colpo alla realtà, rimasi abbagliato dalle luci al neon come se avessi camminato con gli occhi chiusi. Non avevo recepito niente di quello che mi aveva raccontato mia cognata. Gli occhi azzurri di mio nipote adesso mi osservavano attentamente dalla spalla della madre, e dal bordo del ciucciotto colava un sottile filo di bava. In realtà, più che guardare me, stava fissando l'orecchino che mi brillava sul lobo. Siccome suo padre ne portava uno uguale, rappresentava per il bambino un elemento familiare che ci identificava. «Hola, Dani!» mormorai, passandogli un dito sulla guancia. Mio nipote allargò il sorriso e la bava fluì liberamente fino al pullover di Ona. «Si è svegliato!» esclamò sua madre dispiaciuta, fermandosi in mezzo al corridoio. «Marc e Lola si sono offerti di tenerlo con loro, stanotte», le dissi. «Ti va bene?» Gli occhi di mia cognata si dilatarono manifestando una gratitudine infinita. Ona aveva i capelli castano chiaro e li portava molto corti, tagliati in modo tale che pareva sempre comicamente spettinata. Un'appariscente ciocca arancione le scendeva sulla guancia destra, mettendo in risalto le lentiggini e il bianco latteo della pelle del viso. Quella sera, però, più che una giovane dall'aspetto fresco e attraente sembrava una bambina spaventata che aveva bisogno della madre. «Oh, sì! Certo che mi va bene!» Con un movimento energico, tirò su Dani e se lo avvicinò al volto. «È vero che vai a casa di Marc e Lola, teso- ro?» gli chiese mostrando una gioia immensa, e il piccolo, ignaro che lo stavano manipolando, sorrise felice. Nonostante l'ospedale fosse pieno di cartelli che proibivano l'uso dei telefonini, sembrava che nessuno sapesse leggere e men che meno il personale sanitario, così, senza preoccuparmi troppo, presi il mio e chiamai direttamente il «100». Jabba e Proxi stavano per uscire. Mio nipote, che aveva una particolare predilezione per quei piccoli marchingegni che la gente si attaccava alla faccia, allungò fulmineo la mano tentando di strapparmelo. Io però ero stato più veloce, e il piccolo non riuscendo nell'impresa, si arrabbiò ed emise un sonoro urlo di protesta. Ricordo che in quel momento pensai che l'ospedale non fosse un luogo ideale per un bambino: primo, perché con le sue grida poteva disturbare gli ammalati; secondo, perché l'aria in quei posti era carica di strane malattie, o almeno così mi sembrava. Mariona, per distrarre Dani, si era seduta su una sedia di plastica verde accanto a un distributore di bottiglie d'acqua, e gli aveva dato un pacchetto di fazzolettini di carta che, per fortuna, sembravano interessarlo abbastanza. Le altre sedie erano rotte o macchiate, e avevano uno sgradevole aspetto disastrato. Si dice che le cure e i medici della sanità pubblica siano i migliori; sarà stato anche vero, ma quanto ad attrezzature e ospitalità, la privata le dà parecchi punti. «Arriveranno subito», dissi, sedendomi accanto a lei e porgendo a mio nipote il cellulare con la tastiera bloccata. Ona, che aveva visto il telefonino di mio fratello volare in aria e cadere sul pavimento in varie occasioni, tentò di impedirlo; io però insistetti; Dani smise di esistere a tutti gli effetti, divertendosi con il prezioso giocattolo. «Se Lola e Marc vengono a prenderlo», osservò mia cognata indicando il bambino con un gesto del mento, «potremmo aspettarli qui, nel caso che esca il medico e voglia parlare con noi.» «Daniel è in questo piano?» mi sorpresi, e girai il capo verso un lungo corridoio che si apriva alla nostra sinistra e sul cui vano d'entrata si leggeva «Neurologia». Ona annuì. «Te l'avevo già detto, Arnau.» Mi aveva colto in flagrante e non era il caso di fingere. Non riuscii, tuttavia, a evitare il gesto automatico di lisciarmi il pizzetto e, nel farlo, notai che avevo i peli duri e grumosi per l'umidità delle fogne. «Scusami, Ona. Sono... turbato per questa storia.» Abbracciai lo spazio con lo sguardo. «Penserai che sono pazzo, ma... potresti raccontarmi di nuovo tutto, per favore?» «Un'altra volta?» si stupì. «Mi era sembrato che non stessi ascoltando. Dunque... vediamo. Daniel è ritornato dall'università attorno alle tre e mezzo. Il bambino si era appena addormentato. Dopo pranzo abbiamo parlato un po' di... Be', non stiamo molto bene a denaro e, lo sai, io vorrei rimettermi a studiare, così... Alla fine Daniel è andato nel suo studio come tutti i giorni e io sono rimasta a leggere nel salotto. Non so quanto tempo sia passato. Questo impiastro», continuò riferendosi a Dani, che stava per lanciare il cellulare contro la parete per verificare che rumore faceva. «Eh! No, no, no! Dammelo! Restituiscilo ad Arnau!» Mio nipote, obbediente, allungò la mano per consegnarmelo, ma all'ultimo momento se ne pentì, ignorando con eleganza l'assurdità che gli chiedeva di fare sua madre. «Be'! Il caso vuole che mi sia addormentata sul sofà...» Ona tentennava cercando di ricostruire nella mente la cronologia degli avvenimenti. «Ricordo solo che mi sono svegliata con la sensazione che qualcuno mi stesse alitando in faccia. Quando ho aperto gli occhi mi sono spaventata a morte: Daniel era di fronte a me e mi guardava inespressivo, come in un film dell'orrore. Era inginocchiato, a meno di un palmo di distanza. Non ho urlato per miracolo. Gli ho chiesto di smettere di fare l'idiota perché lo scherzo non era divertente, e, come se non mi avesse sentito, ha continuato e mi ha detto che era appena morto e che voleva che lo seppellissi.» Sotto gli occhi di Ona erano comparse borse scure e gonfie. «Gli ho dato una spinta per alzarmi e sono saltata giù dal sofà. Ero molto spaventata, Arnau! Tuo fratello non si muoveva, non parlava, aveva lo sguardo vitreo, come se fosse morto davvero.» «E che cosa hai fatto?» Facevo fatica a immaginare mio fratello in una situazione simile. Daniel era il tipo più normale del mondo. «Quando ho capito che non era uno scherzo di cattivo gusto, e che non aveva nessuna reazione, ti ho cercato, ma non sono riuscita a trovarti. Lui si era seduto sul sofà, con gli occhi chiusi. E non si è più mosso. Ho chiamato il Pronto Soccorso e... mi hanno detto di portarlo qui, alla Custòdia. Ho spiegato che non ce la facevo ad alzarlo, che pesava trenta chili più di me e che si stava lasciando cadere in avanti come un fantoccio di pezza, che se non venivano ad aiutarmi sarebbe crollato a terra e si sarebbe spaccato la testa...» Gli occhi di Ona si riempirono di lacrime. «Intanto Dani si era svegliato e piangeva nel lettino... Mio Dio, Arnau, che incubo!» Mio fratello e io eravamo alti uguali, quasi un metro e novanta, ma lui pesava i suoi bei cento chili per colpa della vita sedentaria che conduceva. Difficilmente mia cognata avrebbe potuto sollevarlo dal divano e trasportarlo in un posto qualsiasi; aveva già fatto abbastanza tenendolo ritto. «Il medico ha impiegato mezz'ora ad arrivare», continuò a raccontare tra le lacrime. «Durante tutto quel tempo Daniel ha aperto gli occhi solo un paio di volte, per ripetermi che era morto, che voleva che lo coprissi con un lenzuolo e che lo seppellissi. Come una scema, mentre lo spingevo contro il sofà perché non cadesse a terra, ho tentato di ragionare con lui, spiegandogli che il suo cuore continuava a battere, che il suo corpo era ancora caldo e che stava respirando normalmente. Lui mi ha risposto che niente di tutto ciò significava che fosse vivo, perché era indiscutibilmente morto.» «È impazzito...» mormorai con amarezza guardandomi la punta delle scarpe da ginnastica. «E non è tutto! Al dottore ha dato la stessa spiegazione con qualche nuovo particolare, tipo che non aveva tatto, né olfatto, né gusto perché il suo corpo era un cadavere. Il medico allora ha estratto un ago dalla valigetta e con delicatezza, per non fargli male, lo ha punto su un dito.» Ona si interruppe un istante e mi strinse un braccio per attirare tutta la mia attenzione. «Non ci crederai... Gli ha ficcato l'ago in varie parti del corpo e... Daniel non si è neppure scomposto!» Devo aver fatto una faccia da imbecille perché, se c'era qualcosa che mio fratello non sopportava fin da piccolo erano le iniezioni. Cadeva stecchito alla vista apocalittica di una siringa. «Allora il dottore ha deciso di chiamare un'ambulanza e di portarlo alla Custòdia, dicendo che era meglio farlo vedere da un neurologo. Ho preparato Dani e siamo venuti qui. Lo hanno portato dentro e noi siamo rimasti in sala d'attesa finché un'infermiera non mi ha detto di salire a questo piano perché era stato ricoverato in Neurologia e che il medico avrebbe parlato con me dopo averlo visitato. Ti ho cercato dappertutto. Veramente...» disse pensierosa stringendo al petto il bambino, malgrado le irritate proteste di lui. «Dovremmo chiamare tua madre e Clifford.» Il problema non era chiamarli; il problema era come diavolo recuperare il cellulare senza che mio nipote piantasse una grana gigantesca. Iniziai così un cauto avvicinamento agitando nell'aria le chiavi della macchina finché non mi accorsi che sia il bambino sia mia cognata mi ignoravano e avevano rivolto lo sguardo verso un punto alle mie spalle. Due tipi con la faccia da funerale si stavano dirigendo verso di noi. Uno di loro, quello più vecchio, aveva un camice bianco sui vestiti di tutti i giorni; l'altro, di cor- poratura minuta, portava gli occhiali e indossava l'uniforme completa, zoccoli inclusi. «Siete parenti di Daniel Cornwall?» chiese quest'ultimo pronunciando il nome completo di mio fratello con un corretto accento britannico. «Lei è la moglie», dissi alzandomi in piedi: il più grande mi arrivava alle spalle e l'altro lo persi completamente di vista. «E io sono il fratello.» «Bene, bene...» esclamò il più anziano nascondendo le mani nelle tasche del camice. Il gesto, che aveva qualcosa di simile a quello di Pilato, non mi piacque. «Sono il dottor Llor. Il neurologo che ha visitato Daniel, e lui è lo psichiatra di guardia, il dottor Hernández.» Tolse la mano destra dalla tasca, non per stringerci la mano, ma per indicarci la strada per entrare in reparto. Forse il mio aspetto - orecchino, pizzetto e codino - non era di suo gradimento; forse gli dava fastidio la ciocca arancione di Ona. «Se siete tanto gentili da seguirmi nel mio studio, potremo parlare tranquillamente di Daniel.» Il dottor Llor si mise senza fretta al mio fianco lasciando che il giovane dottor Hernández accompagnasse Ona e Dani alcuni passi indietro. Tutta la situazione aveva un non so che di illusorio, di falso, di realtà virtuale. «Suo fratello, signor Cornwall...» cominciò a dire il neurologo. «Il mio cognome è Queralt, non Cornwall.» Il medico mi guardò in modo strano. «Lei mi ha detto di essere il fratello», biascicò con irritazione, come se fosse stato vilmente ingannato e stesse perdendo il suo preziosissimo tempo con un intruso. «Il mio nome è Arnau Queralt Sañé e mio fratello si chiama Daniel Cornwall Sañé. Qualche altro dubbio?» proferii con ironia. Se avevo detto che Daniel era mio fratello, che significava quella ridicola diffidenza? Come se al mondo esistesse solo un unico modello di famiglia! «Lei è Arnau Queralt?» si sorprese il neurologo, mettendosi di colpo a balbettare. «Lo ero fino a un momento fa», risposi, fermando dietro un orecchio una ciocca sfuggita dal codino. «Il proprietario della Ker-Central?» «Direi di sì, salvo che non sia capitato qualcosa di imprevisto.» Eravamo giunti davanti a una porta dipinta di verde con una targhetta che recitava il suo nome; Llor però esitava a oltrepassarla. «Un nipote di mia moglie, ingegnere delle telecomunicazioni, lavora nella sua ditta.» Dal tono intuii che i ruoli erano cambiati: il tipo dall'aspet- to strano non era più un poveretto qualsiasi. «Ah, sì?» risposi con disinteresse. «E di mio fratello che cosa mi dice?» Lui spinse la maniglia e aprì la porta con fare ossequioso. «Entri, prego.» Lo studio era diviso in due zone separate da un tramezzo di alluminio. Nella prima, molto piccola, c'era soltanto un vecchio scrittoio pieno di cartelle e di fogli con un enorme computer spento; la seconda, assai più grande, esibiva una formidabile scrivania in mogano sotto la finestra e, all'estremo opposto, un tavolo rotondo contornato da morbide poltrone di pelle nera. Le pareti erano stracolme di fotografie di Llor assieme a personaggi celebri e ritagli di giornale incorniciati, nei titoli dei quali spiccava il suo nome. Il neurologo, facendo una moina a Dani, scostò dal tavolo una delle poltrone per far accomodare Ona. «Prego...» mormorò. Il minuto dottor Hernández si sistemò tra Ona e me facendo cadere sul tavolo, con un colpo secco, una cartella gonfia che fino ad allora aveva tenuto sotto il braccio. Non sembrava molto felice, ma, in realtà, in quella stanza nessuno lo era, quindi che differenza faceva? «Il paziente Daniel Cornwall», iniziò a dire Llor con voce neutra, inforcando un paio di occhiali che aveva tirato fuori dal taschino del camice, «mostra una sintomatologia non frequente. Il dottor Hernández e io concordiamo sul fatto che potrebbe trattarsi di qualcosa di simile a una depressione acuta.» «Mio fratello depresso?» chiesi stupito. «No, non esattamente, signor Queralt...» mi chiarì, guardando lo psichiatra con la coda dell'occhio. «Vedrà, suo fratello presenta un quadro clinico abbastanza confuso di due patologie che di solito non si riscontrano congiuntamente nel medesimo paziente.» «Per un verso», intervenne per la prima volta il dottor Hernández, che mal dissimulava l'emozione di avere tra le mani in caso tanto raro, «sembra soffrire di quella che in letteratura medica si chiama illusione, o più propriamente sindrome di Cotard, diagnosticata per la prima volta nel 1788 in Francia. Le persone che ne sono colpite credono in modo inconfutabile di essere morte ed esigono, a volte persino in maniera violenta, di essere avvolte nel lenzuolo funebre e sepolte. Perdono la sensibilità delle membra, non rispondono a stimoli esterni, il loro sguardo si fa opaco e vacuo, il corpo rimane completamente sfibrato... Insomma, sono vivi perché noi sappiamo che lo sono, ma reagiscono come se fossero veramente morti.» Ona cominciò a piangere in silenzio senza riuscire a contenersi e Dani, spaventato, si voltò verso di me in cerca di appoggio, ma, vedendomi molto serio, finì per mettersi a frignare pure lui. Se Jabba e Proxi non venivano a prenderlo subito, sarebbe finita male. Siccome il pianto del bambino impediva la conversazione, Ona, tentando di calmarsi, si alzò e prese a passeggiare su e giù consolando il piccolo. Attorno al tavolo nessuno aprì bocca. Finalmente, dopo alcuni interminabili minuti, mio nipote smise di piangere e sembrò addormentarsi. «È molto tardi per lui», sussurrò mia cognata tornando a sedersi con cautela. «Dovrebbe essere a letto già da un pezzo e non ha nemmeno cenato.» Incrociai le mani sul tavolo e mi chinai verso i medici. «Bene, dottor Hernández», dissi. «E che soluzione c'è per questa sindrome di Cotard?» «Soluzione, soluzione...! Si consigliano il ricovero e la somministrazione di psicofarmaci. La prognosi, sotto terapia, di solito è buona, anche se, a dire il vero, in quasi tutti i casi si verificano delle ricadute.» «Gli ultimi studi sulla sindrome di Cotard», osservò il dottor Llor, che sembrava voler apportare il proprio granello neurologico di sabbia, «rivelano che è comunemente associata a un certo tipo di lesione cerebrale localizzata nel lobo temporale sinistro.» «Vuol dire che ha preso un colpo in testa?» chiese Ona, allarmata. «Assolutamente no», ribatté il neurologo. «Quello che voglio dire è che, pur senza aver subito un trauma, ci sono una o più zone dell'encefalo che non reagiscono come dovrebbero o, almeno, come ci si aspetta. Il cervello umano è formato da molte parti distinte che hanno funzioni differenti: alcune controllano il movimento, altre realizzano calcoli, altre ancora elaborano i sentimenti... Per fare ciò questi segmenti utilizzano piccole scariche elettriche e agenti chimici molto specifici. Basta che uno solo di questi agenti si alteri un po' per cambiare completamente il modo di lavorare di una zona cerebrale e, con esso, il modo di pensare, di sentire o di comportarsi. Nel caso della sindrome di Cotard, le tomografie dimostrano che esiste un'alterazione dell'attività nel lobo temporale sinistro... qui.» E accompagnò la parola con il gesto, appoggiando la mano sulla parte posteriore dell'orecchio sinistro. «Né più in alto né più in basso, e nemmeno più indietro.» «Come un computer cui si guasti un circuito, non è così?» I due medici corrugarono la fronte all'unisono, spiacevolmente sorpresi per l'esempio. «Sì, be'...» ammise il dottor Hernández. «Ultimamente è molto di moda paragonare il cervello umano al computer perché entrambi funzionano, diciamo, in maniera analoga. Però non sono uguali: un computer non ha coscienza di sé e nemmeno emozioni. Questo è il grave errore cui ci conduce la neurologia.» Llor non batté ciglio. «In psichiatria l'approccio è differente. Senza dubbio esiste una componente organica nella sindrome di Cotard, ma è pur vero che i suoi sintomi coincidono quasi totalmente con quelli della depressione acuta. Inoltre, nel caso di suo fratello, non si è potuta verificare questa alterazione nel lobo temporale sinistro.» «Comunque, siccome il paziente è sotto la mia responsabilità», intervenne Llor, e stavolta fu Hernández a non muovere neppure un muscolo della faccia, «ho pensato a una terapia choc con neurolettici, Clorpromazina e Tioridazina, e spero di poterlo dimettere entro quindici giorni.» «Ah! C'è un altro problema», ricordò lo psichiatra. «Daniel presenta, assieme alla sindrome di Cotard, che è la cosa più palese, segni evidenti di una patologia chiamata agnosia.» Sentii che qualcosa dentro di me si ribellava. Fino a quel momento ero riuscito a convincermi che tutto ciò fosse qualcosa di passeggero, che Daniel soffrisse di un'«illusione» che si poteva curare e che, una volta eliminata, mio fratello sarebbe tornato quello di prima. Però il fatto che si sommassero più malattie mi procurava una sensazione dolorosa. Guardai Ona e, dalla contrazione del suo volto, percepii che era angosciata quanto me. Il piccolo Dani, protetto dalla copertina azzurra e dalla madre, era caduto in un sonno profondo. E fu una fortuna perché in quel momento il mio cellulare, che il piccolo continuava a tenere stretto tra le mani, cominciò a emettere le note musicali che identificavano le chiamate di Jabba. Per fortuna, non si mosse nemmeno; emise solo un lungo sospiro quando la madre, non senza difficoltà, riuscì a estirparglielo. Chiedendo di Daniel al Pronto Soccorso, Jabba e Proxi erano riusciti a raggiungere l'atrio che dava accesso al reparto di Neurologia. Dopo avere terminato la breve conversazione, informai Ona, e lei, alzandosi adagio, si diresse verso la porta e uscì. «Aspettiamo la moglie di Daniel o proseguiamo?» mi chiese Llor con una certa impazienza. Il suo tono mi fece ricordare una cosa che avevo letto una volta: in Cina, anticamente, i medici percepivano gli onorari solo se salvavano il paziente, in caso contrario o non lo riscuotevano o la fami- glia li ammazzava. «Chiudiamo una volta per tutte», replicai pensando che gli antichi cinesi erano veramente molto saggi. «Parlerò io con mia cognata.» Il dottore più basso prese la parola. «Oltre che della sindrome di Cotard, suo fratello soffre di un'agnosia abbastanza marcata.» Portò gli occhiali fino alle sopracciglia e guardò inquieto il neurologo. «Come le spiegava Miquel... il dottor Llor, l'agnosia, una patologia molto più comune, appare essenzialmente in soggetti colpiti da emorragie o traumi in seguito ai quali hanno perduto una parte del cervello. Come vede, questo non è il caso di suo fratello e nemmeno quello dei pazienti con la sindrome di Cotard, e tuttavia Daniel è incapace di riconoscere oggetti o persone. Per farle capire meglio, suo fratello, che afferma di essere morto, vive in questo momento in un mondo popolato di cose insolite, che si muovono in modo assurdo e fanno strani rumori. Se lei gli mostrasse, per esempio, un gatto, lui non saprebbe che cos'è, e non saprebbe nemmeno che è un animale perché non sa cosa sia un animale.» Mi presi la testa tra le mani, disperato. Sentivo una pressione terribile alle tempie. «Non potrebbe riconoscere lei», continuò a spiegare il dottor Hernández, «e neppure sua moglie. Per Daniel tutti i volti sono degli ovali piatti con un paio di macchie nere nel punto dove dovrebbero stare gli occhi.» «La cosa brutta dell'agnosia», aggiunse Llor sfregandosi i palmi delle mani, «è che, come avviene per un'emorragia o per la perdita traumatica di una massa, non si può trattare né curare. Ebbene...» Lasciò la frase in sospeso, con uno stillicidio di speranza. «Le tomografie fatte a suo fratello rivelano che il suo cervello è in perfette condizioni.» «Come le ho già detto, non compariva nemmeno la disfunzione del lobo temporale», commentò Hernández, accennando per la prima volta un sorriso. «Daniel presenta solo i sintomi, non le patologie.» Lo guardai come se fosse un idiota. «E vuole spiegarmi che differenza c'è tra sommare due più due e sembrare che si sommino due più due? Mio fratello stamattina era normale, era andato al lavoro all'università ed era tornato a casa per pranzare con la moglie e il figlio, e adesso è ricoverato in ospedale con sintomi che 'simulano' una sindrome di Cotard e una agnosia.» Trattenni il respiro perché ero sul punto di sciorinargli una sfilza di insulti. «Bene, adesso basta! So che farete tutto il possibile per guarire mio fratello, dunque non discutere- mo su questo punto. Voglio solo sapere se Daniel tornerà a essere lo stesso di prima o no.» Il vecchio Llor, sorpreso dal mio improvviso accesso d'ira, si sentì obbligato a giustificarsi come se fossimo colleghi o amici da una vita. «Guardi, come regola generale, a noi medici non piace impegolarci in situazioni difficili, sa? Preferiamo non dare troppe speranze nel caso non vada a finire bene. Il malato guarisce? Stupendo, siamo grandi! Non guarisce? Avevamo già spiegato all'inizio ciò che poteva succedere.» Mi guardò con compassione e, appoggiando le mani sul tavolo, spinse indietro rumorosamente la poltrona prima di alzarsi in piedi. «Le dirò la verità, signor Queralt: non abbiamo idea di quello che sta succedendo realmente a suo fratello.» A volte, quando ti senti indifferente a tutto, quando aspetti che succeda qualcosa che ti cambi la vita, il destino decide di giocarti un brutto scherzo e ti colpisce al viso con un guanto di ferro. Allora ti guardi attorno, confuso, e ti chiedi da dove sia arrivato il colpo e perché all'improvviso ti manchi il terreno sotto i piedi. Daresti qualsiasi cosa per cancellare quello che è accaduto, rimpiangi la normalità, le vecchie abitudini, vorresti che tutto tornasse a essere come prima... Ma quel prima è un'altra vita, una vita alla quale, incomprensibilmente, non puoi più ritornare. Quella notte, Mariona e io rimanemmo con Daniel. La camera era molto piccola, con una sola poltrona, e per giunta così malridotta che la gommapiuma dell'imbottitura saltava fuori da ogni parte. Si trattava comunque della stanza migliore del reparto ed era singola, per cui ci toccava ancora ringraziarli. Mia madre chiamò poco dopo la riunione con Llor ed Hernández. Per la prima volta in vita sua fu capace di stare zitta per un bel po' e di prestare attenzione senza interrompere in continuazione per prendere la parola. In realtà era paralizzata. Non fu facile spiegarle quello che ci avevano detto i medici. Per lei tutto ciò che non era una malattia del corpo non aveva valore, per cui dovette fare un grande sforzo di comprensione per accettare l'idea che il suo figlio minore, benché fosse un omone con una salute di ferro, era diventato un malato di mente. Alla fine, con voce tremante, e dopo avermi chiesto un'infinità di volte di non dire niente alla nonna nel caso mi avesse chiamato, mi informò che Clifford stava già prenotando i biglietti per il volo in partenza da Heathrow alle sei e venticinque del mattino seguente. Non riuscimmo a riposare tutta la notte. Daniel apriva gli occhi in continuazione e parlava senza posa, frasi lunghe e ben articolate anche se strambe, deliranti: a volte si abbandonava a dissertazioni su argomenti che dovevano essere materia della sua disciplina, come l'esistenza di uno sconosciuto linguaggio primitivo i cui suoni avevano la stessa natura e sostanza di cose e di esseri viventi; altre volte spiegava con minuzia come si preparava la colazione al mattino, tagliando il pane con il coltello dal manico blu, raccogliendo le briciole con la mano sinistra, programmando il tostapane sui due minuti e il microonde sui quarantacinque secondi per scaldare la tazza di caffè. Non c'era dubbio che fossimo ambedue metodici e organizzati come nonna Eulàlia, dalla quale (in mancanza di una madre come Dio comanda) avevamo imparato quasi tutto. Ma l'argomento preferito da Daniel era la morte, la sua stessa morte, e si chiedeva angosciato come poteva riposare se non sentiva il peso del proprio corpo. Se gli davamo dell'acqua beveva, però diceva di non avere sete perché i morti non l'avvertono e, una volta in cui sfiorò il bicchiere con le dita, si sorprese e ci domandò perché gli mettevamo quella cosa fredda in bocca. Era come un burattino disarticolato che voleva soltanto riposare un paio di metri sottoterra. Non sapeva chi eravamo né perché gli stavamo vicino. A volte ci guardava fisso e i suoi occhi sembravano morti come quelli di vetro di un bambolotto. Infine, verso le sette del mattino, il sole cominciò a illuminare il cielo. I genitori di Ona arrivarono alcuni minuti dopo e mia cognata se ne andò con loro a far colazione lasciandomi solo con mio fratello. Avrei voluto avvicinarmi e dirgli: «Ehi, Daniel, alzati e andiamocene a casa!» e mi sembrava tanto possibile, tanto realizzabile che appoggiai più volte le mani sui braccioli della poltrona per alzarmi. In una di queste occasioni però mio fratello aprì di colpo gli occhi e mi snocciolò una tale sequela di idiozie che mi ridusse in frantumi e mi fece cadere le braccia. Poco prima che Ona e i suoi genitori ritornassero, guardando fisso il soffitto, incominciò a parlare con voce monotona di Giordano Bruno e della possibile esistenza di infiniti mondi nell'universo infinito. Osservandolo con affetto mi dissi che la sua follia, la sua strana malattia, poteva paragonarsi in qualche maniera a una di quelle pagine dalla struttura perfetta che si scrivono poche volte nella vita: entrambe contenevano una certa forma di bellezza che si poteva percepire soltanto dietro un'apparenza sgradevole. Poiché dovevo passare da casa prima di andare all'aeroporto, alle otto, senza aver chiuso occhio, me ne andai. Ero stanco, depresso, avevo un bisogno disperato di una doccia e di cambiarmi. Non avevo voglia di passare dall'ufficio, quindi, invece di utilizzare uno dei tre ascensori della società, usai quello privato. Quest'ultimo, controllato da un computer con riconoscimento vocale, faceva solo tre fermate: in garage, al piano terra (dove c'era la portineria e l'atrio della Ker-Central) e a casa mia, situata sul tetto dell'edificio e circondata da un giardino di cinquecento metri quadrati protetto da paratie opache di materiale isolante. Quello era il mio paradiso privato, l'idea di più difficile attuazione che avessi mai avuto in vita mia. Per realizzarla avevo dovuto far arrivare tutti gli impianti di raffreddamento, di riscaldamento e di elettricità all'ultimo piano, il decimo, e coprire il pavimento del tetto con rivestimenti impermeabilizzanti, isolanti termici, cemento poroso, terra coltivabile. Avevo assunto un'equipe di professionisti in paesaggistica e giardinaggio della Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Barcellona, e l'impresa americana che aveva costruito l'abitazione - una villetta di duecento metri quadrati, a un solo piano - era specializzata in materiali ecologici, domotica e sicurezza intelligente. Il progetto mi era costato quasi quanto il resto dell'immobile, ma senza dubbio ne era valsa la pena. Potevo affermare, senza mentire, che vivevo in mezzo alla natura nel centro della città. Quando le porte dell'ascensore si aprirono mi ritrovai finalmente in salotto. La luce entrava a fiotti dalle vetrate attraverso le quali vidi Sergi, il giardiniere, chino sugli arbusti di oleandro. Magdalena, la cameriera, passava l'aspirapolvere in una stanza in fondo. Tutto era pulito e ordinato, ma la sensazione di estraneità che avevo dentro di me si incollava alle pareti e agli oggetti se solo vi posavo lo sguardo. Non provai la rilassante emozione che mi invadeva ogni volta che arrivavo. Nemmeno l'acqua della doccia portò via, attraverso il tubo di scarico, il sudiciume dell'irrealtà, né ci riuscirono la colazione e le conversazioni telefoniche con Jabba e con Núria, la mia segretaria, né il viaggio attraverso El Prat con i finestrini dell'auto abbassati, né rivedere mia madre e Clifford dopo cinque mesi, né ovviamente contemplare di nuovo la vecchia mole della Custòdia, salire le sue scalinate, entrare in uno degli ascensori giganteschi e cigolanti, e ritornare nella stanza dove c'era mio fratello. Verso mezzogiorno lasciai mia cognata, Dani (Proxi lo aveva portato molto presto all'ospedale) e i genitori di Ona davanti al portone di casa, in calle Xiprer. Io ritornai alla mia. Lungo la strada il cellulare cominciò a squillare come in un giorno qualsiasi a quell'ora. Non risposi; mi limitai a bloccarlo in modo da lasciar passare solo le telefonate della mia famiglia e quelle di Jabba, Proxi e Núria. Il mondo degli affari avrebbe dovuto fermarsi per un certo periodo. Io ero come un processore bruciato per un sovraccarico. Ricordo solo che, dopo essere salito in ascensore, mollai i bagagli di Clifford e di mia madre nel corridoio e mi lasciai cadere sul letto come un fagotto. Il telefono stava suonando. Io non riuscivo a muovermi. Finalmente lo squillo si interruppe. Tornai a dormire. Dopo pochi istanti ricominciò. Una volta, due, tre... Silenzio. Era tutto buio; doveva essere notte. Il maledetto apparecchio insisteva. Feci un salto sul letto e mi misi seduto, con. gli occhi spalancati. Di colpo ricordai... Daniel! «Luce!» esclamai; la lampadina della testiera del letto si accese. L'orologio sul comodino segnava le otto e dieci della sera. «E mani libere.» Il sistema emise un leggero scatto per avvertirmi che aveva preso la chiamata al posto mio e che ora potevo parlare. «Sono Ona.» Ero intontito, non sapevo dove mi trovavo. Mi sfregai la faccia con le mani e mi strofinai i capelli, che aderivano alla testa come un casco. Le altre luci della stanza si accesero a poco a poco automaticamente e con delicatezza. «Dormivo», farfugliai, a mo' di saluto. «Sei alla Custòdia?» «No; a casa.» «Bene, allora dammi mezz'ora e vengo a prenderti. Se vuoi possiamo cenare lì, in caffetteria.» «No, Arnau», rifiutò mia cognata. «Non ti chiamo per questo. È che... be', ho trovato delle carte sulla scrivania di Daniel e... Non so come spiegartelo. È molto strano e sono preoccupata. Potresti venire a vederle?» Avevo il cervello in fiamme. «Carte? Che carte?» «Alcuni appunti. Una cosa molto strana. Forse sto farneticando, ma... Preferisco non dirtelo per telefono. Voglio che tu stesso li veda e che mi dia il tuo parere.» «Va bene. Arrivo subito.» Avevo una fame da lupo; divorai a tappe, mentre facevo la doccia e mi vestivo, la cena che Magdalena mi aveva preparato. Esitai un bel po' a decidere se dovevo mettermi i jeans come sempre o un altro tipo di calzoni più comodi per passare la notte in ospedale. Alla fine optai per i secondi; i jeans sono quasi uno stile di vita, ma all'ora della verità risultano molto rigidi, e alle cinque di mattina possono trasformarsi in perversi strumenti di tortura. Indossai quindi un pullover, i pantaloni neri di uno dei miei completi e delle vecchie scarpe di pelle che trovai nel guardaroba. Per fortuna non avevo ancora bisogno di rasarmi, quindi mi raccolsi i capelli e via. Presi una giacca dall'armadio, misi il cellulare in una delle tasche, infilai nello zaino il computer portatile, nel caso fossi riuscito a lavorare un po' quella notte, e mi diressi a casa di mio fratello. La calle Xiprer era una di quelle strade strette e alberate costeggiate ancora da vecchie villette abitate; vi si respirava l'atmosfera di una piccola città. Si dovevano fare molti giri e molte salite e discese per arrivare fin lì, e quando credevi che le difficoltà fossero terminate e che ti restasse solo da parcheggiare, scoprivi con orrore che i veicoli erano compressi su entrambi i lati della strada come sardine in scatola. Sarebbe stato un miracolo se quella sera la situazione fosse stata diversa, ma ovviamente non fu così, e finii per fare come sempre: salii con la metà sinistra dell'auto sul marciapiede. L'appartamento di Daniel e Ona si trovava al quarto piano di un edificio non molto vecchio. Io ero convinto che fosse abitato da un ramo clonato di Jabba, frutto di un misterioso esperimento genetico, perché tutte le volte che andavo lì incontravo in ascensore una replica quasi esatta del mio amico. Il fenomeno aveva incominciato a inquietarmi, tant'è che chiesi a Daniel se anche lui se ne fosse accorto. Mio fratello naturalmente era scoppiato a ridere, e mi aveva spiegato che si trattava di una famiglia molto numerosa che occupava diversi appartamenti dell'edificio e che, in effetti, tutti i suoi membri avevano una certa somiglianza con Marc. «Una certa somiglianza?» avevo esclamato indignato. «E dai! Sono tutti enormi e con i capelli rossi, ma la cosa finisce li.» «Io direi che sono identici.» «Non esagerare!» Ma ora mio fratello non era a casa sua e non potevo raccontargli, come facevo sempre, che in ascensore mi ero imbattuto di nuovo in un clone. Mi aprì la porta mia cognata, che, sebbene si fosse sistemata per uscire, era abbattuta e con le occhiaie. «Hai una brutta cera, Arnau», mi disse con un sorriso affettuoso. «Credo di non aver dormito molto bene», risposi entrando in casa. Nel corridoio che si apriva di fronte a me e che portava in salotto, una figura minuta avanzava con passo vacillante, trascinando, come Linus, un vecchio scialle con cui si copriva anche mezza testa. «È morto di sonno», commentò Ona, abbassando la voce. «Non agitarlo.» Non ne ebbi l'opportunità. A metà strada, la figura sciallata decise che non valeva la pena di sforzarsi e fece un mezzo giro ritornando dai nonni, che stavano guardando la televisione. Siccome il sofà era visibile dall'entrata, salutai i genitori di Ona con la mano mentre mia cognata mi tirava per il braccio sinistro per condurmi nello studio di Daniel. «Devi vedere questa cosa, Arnau», disse accendendo la luce. Lo studio di mio fratello era ancora più piccolo del mio guardaroba, lui però si era organizzato per sistemare dappertutto un'ingente quantità di altissimi scaffali di legno che traboccavano di libri, riviste, quaderni e schedari. Lo spazio centrale di tutto quel mare magnum era occupato dal tavolo da lavoro; era coperto da pile malferme di cartelline e di fogli che circondavano come alte mura alcune pagine di appunti, sui quali era posata una penna; a fianco c'era il computer portatile spento. Ona si diresse verso il tavolo e, senza spostare niente, si chinò sui fogli e vi mise un dito sopra. «Su! Leggi questo», mormorò. Io avevo ancora lo zaino in spalla, ma il bisogno impellente che trasmetteva la voce di Ona mi spinse ad avvicinarmi. Nel punto che lei indicava con il dito erano scritte alcune frasi con la grafia di Daniel che, anche se all'inizio si capivano abbastanza bene, alla fine risultavano quasi illegibili: «Mana huyarinqui lunthata? Non senti, ladro? «Jiwañta [...] Sei morto [...], anatatäta chakxaña, hai giocato a togliere la sbarra dalla porta. «Jutayañäta allintarapiña, chiamerai urlando il necroforo, chhärma, questa stessa notte. «Gli altri jiwanaqañapxi jumaru muoiono dovunque per te. «Achakay, akapacha chhaqtañi jumaru. Ahi, questo mondo non sarà più visibile per te! È la legge. Chiusa a chiave. «Kamachi [...], legge, lawt'ata, chiusa a chiave, Yäp...» Poi, come se Daniel stesse perdendo conoscenza mentre tentava ancora di scrivere, comparivano una serie di linee, di righe incerte che terminavano bruscamente verso il basso. Rimasi perplesso per alcuni secondi, quindi, incredulo, rilessi gli appunti ancora un paio di volte. «Che cosa ne dici, Arnau?» chiese Ona nervosa. «Non ti sembra un po' strano?» Aprii la bocca per dire... non so cosa, ma dalla gola non mi uscì nemmeno un suono. No, non era possibile. Era ridicolo pensare che quelle frasi fossero direttamente in relazione con la malattia di Daniel. È vero che la descrivevano punto per punto e che suonavano minacciose, ma quale mente nelle sue piene facoltà avrebbe potuto accettare qualcosa di tanto assurdo, cioè che l'ultima cosa che mio fratello aveva scritto prima di ammalarsi potesse avere in qualche modo a che fare con quello che gli era successo? Stavamo forse impazzendo anche noi? «Non so che dirti, Ona», balbettai. «Davvero. Non so che dirti.» «Daniel stava lavorando a questo quando...» «Lo so, ma non perdiamo la testa!» esclamai. Mia cognata teneva le mani sullo schienale della poltrona di suo marito e lo stringeva tanto forte da avere le dita contratte e le nocche bianche. «Pensaci, Ona. Come può questo foglio essere la causa dell'agnosia e della benedetta illusione di Cotard? Lo so che sembra che ci sia un'attinenza, ma è impossibile, è... grottesco!» Per alcuni interminabili istanti rimanemmo entrambi in silenzio, immobili, lo sguardo fisso sugli appunti di Daniel. Più leggevo quelle frasi, più crescevano in me timore, ansia, sospetto. E se la cosa gli avesse davvero nuociuto? E se fosse rimasto colpito da quello che leggeva e traduceva tanto che l'inconscio gli aveva giocato un brutto tiro trasformando quella specie di maledizione in una malattia reale? Non volevo dare ali all'immaginazione di Ona, quindi evitai di dar voce ai miei pensieri, comunque l'idea che mio fratello avesse potuto somatizzare quelle parole per una ragione qualsiasi fece breccia in me. Forse si era lasciato prendere eccessivamente dal lavoro o era esausto per il troppo studio; forse aveva superato il limite delle sue forze dedicando più energie e tempo del dovuto alla carriera professionale. Tutto poteva e doveva avere una spiegazione razionale, per quanto quei fogli scarabocchiati sembrassero indicare che Daniel era stato ipnotizzato... O qualcosa del genere. Che diavolo ne sapevo io di stupide stregonerie e incantesimi? Girai lentamente la testa per guardare Ona e mi accorsi che lei, a sua volta, mi stava fissando con gli occhi arrossati dalle lacrime. «Hai ragione, Arnau», sussurrò. «Hai completamente ragione. È una sciocchezza, lo so, ma per un momento ho pensato che...» Le passai un braccio attorno alle spalle e la attrassi a me. Lei si abbandonò, arrendevole. Era distrutta. «Non è facile per nessuno, Ona. Abbiamo i nervi a pezzi e siamo molto spaventati per Daniel. Quando si ha paura, ci si rifugia in qualsiasi cosa porti un po' di speranza, e tu hai creduto che, forse, se tutto era dovuto a una sorta di maledizione, con un altro po' di magia Daniel sarebbe potuto guarire, non è vero?» Lei rise piano e si passò una mano sulla fronte cercando di togliersi quelle idee folli dalla testa. «Su, andiamo in ospedale», mormorò sorridendo e sciogliendosi dal mio abbraccio. «Clifford e tua madre saranno sfiniti.» Mentre raccoglieva le sue cose e salutava i genitori e il bambino, io continuai a stare lì, davanti a quel dannato foglio di carta che mi pungeva il cervello come uno sciame di zanzare in estate. Eravamo molto vicino alla Custòdia e non sarebbe valsa la pena prendere l'auto, se non fosse stato per il mattino seguente, quando, stanchi e insonni, quei dieci minuti di camminata ci sarebbero sembrati un'eternità. «A che cosa stava lavorando Daniel?» chiesi a Ona senza staccare gli occhi dal semaforo rosso che ci teneva bloccati nella Ronda Guinardó. Mia cognata fece un lungo sospiro. «A quell'odiosa ricerca sull'etnolinguistica inca», spiegò. «Marta, la titolare della cattedra, gli aveva offerto una collaborazione nel periodo natalizio. Uno studio molto importante, gli aveva detto, una pubblicazione che avrebbe dato lustro al dipartimento... Frottole! Tutto quello che voleva era che Daniel facesse il lavoro sporco per poi prendersene il merito, come sempre. Sai come funziona.» Mio fratello era professore di Antropologia del Linguaggio presso il dipartimento di Antropologia Sociale e Culturale dell'università di Barcellona. Era sempre stato uno studente straordinario, un collezionista di allori accademici e, a soli ventisette anni, non avrebbe potuto arrivare più lontano in così breve tempo. Curiosamente, nonostante tutto, soffriva di un'inspiegabile rivalità nei miei riguardi; niente di esagerato, certo, ma i suoi frequenti commenti sui miei affari e il mio denaro non lasciavano luogo a dubbi; per questo, credevo io, si gettava in quel modo nel lavoro. Aveva davanti a sé un brillante futuro prima di ammalarsi. «Hai chiamato il dipartimento per avvisarli di quello che è successo?» «Sì. L'ho fatto stamattina, prima di andare a letto. Mi hanno detto che devo portare il certificato di malattia in modo che possano assumere un supplente che lo sostituisca.» Entrammo nella Custòdia passando attraverso un brulichio di gente silenziosa. Tornare lì mi procurò una strana sensazione: era un luogo estraneo e triste nel quale ero stato solo una volta in vita mia, eppure lo percepii come un prolungamento di me stesso, un ambiente familiare. Di sicuro la presenza di Clifford e di mia madre contribuiva abbastanza, ma ero certo che si trattasse, piuttosto, della carica emotiva della situazione. Daniel si trovava esattamente nella stessa situazione del mattino, quando lo avevamo lasciato. Non aveva mostrato alcun miglioramento, mi spiegò mia madre, ma non era nemmeno peggiorato, e questo era molto positivo. «A mezzogiorno è venuto a visitarlo lo psichiatra, il dottor Hernández», continuò a raccontarci senza alzarsi dalla poltrona; non sembrava per niente stanca. «Che uomo affabile! Vero, Clifford? Gentile e simpatico! Ci ha tranquillizzati molto, è vero, Clifford?» Clifford, in piedi accanto al letto del figlio, non le dava retta. Supposi che non si fosse mai mosso di lì. Feci alcuni passi verso di lui e mi fermai al suo fianco, a osservare Daniel: aveva gli occhi aperti, ma erano sempre senza vita, e non sembrava sentire niente di ciò che si diceva attorno a lui. «Il dottor Hernández... Diego, ci ha assicurato che Daniel si riprenderà molto presto e ci ha spiegato che le medicine che gli stanno dando incominceranno a fare effetto entro due o tre giorni, vero, Clifford? La settimana prossima lo avremo di nuovo a casa, vedrete! Ona, tesoro, non lasciare la borsa per terra. C'è l'armadio li. Quest'ospedale è davvero orribile! Perché non l'avete portato in una clinica privata? Non possiamo nemmeno sederci tutti!» protestò la mamma dalla poltrona. «Clifford, su, prova a vedere se le infermiere di questo turno sono più gentili delle altre e ci portano una sedia. Ci credereste? Ci hanno detto che non c'erano più sedie libere in tutto il piano. Che bugia! Ma dimmi tu come fai a dirglielo in faccia a una di queste... furie vestite di bianco. Che persone sgradevoli! Vero, Clifford? Perché non vai a chiedere? Di sicuro ci daranno almeno una panchetta, un seggiolino, non so... uno sgabello! Qualsiasi cosa andrà bene!» Ed effettivamente le infermiere ci diedero una sedia di plastica verde, come quelle della sala d'attesa, ma soltanto dopo che mia madre aveva superato la porta del piano per non tornare fino all'indomani. Dovevano averla presa come una questione personale e, sinceramente, la cosa non mi sorprendeva. Incrociai le dita affinché Clifford e mia madre ricordassero i codici di accesso di casa mia perché, in caso contrario, avrei dovuto recuperarli al commissariato di Via Laietana. Ona occupò la poltrona e si concentrò su un libro; io avvicinai la sedia a quella specie di banco con supplemento ribaltabile che faceva le veci di comodino e di tavolo da lavoro per il personale del reparto. Scostai la sca- tola di fazzoletti, la bottiglia d'acqua, il bicchiere di Daniel e il flaconcino contagocce con il collirio che dovevamo mettergli ogni tanto perché non gli si seccassero gli occhi, dato che non batteva abbastanza le palpebre. Tolsi dallo zaino il computer portatile (un costoso ultraleggero di poco più di un chilo di peso), lo aprii e lo sistemai in maniera tale da poter usare la tastiera comodamente e da lasciare uno spazio per il cellulare; avevo bisogno di collegarmi con l'intranet della Ker-Central per dare un'occhiata alla posta, rivedere gli impegni e le riunioni in sospeso ed esaminare i documenti che Núria mi aveva preparato. Lavorai per mezz'ora circa astraendomi dalla realtà, intento a risolvere, nel miglior modo possibile, gli affari urgenti della società; quando meno me lo aspettavo, udii una cupa risata provenire dal letto di Daniel. Attonito, sollevai lo sguardo al di sopra del monitor e vidi mio fratello con una strana curva disegnata sulle labbra. Prima che avessi il tempo di reagire, Ona era saltata dalla poltrona e si era chinata su di lui, che continuava a sorridere tristemente e a muovere le labbra come se stesse tentando di dire qualcosa. «Che cosa c'è, Daniel?» gli chiese lei, accarezzandogli la fronte e le guance. «Lawt'ata», rispose lui, e rise ancora nello stesso modo sconsolato di prima. «Che cos'ha detto?» volli sapere, stranito, avvicinandomi. «Non lo so, non ho capito!» «Sono morto», continuò Daniel con voce grave. «Sono morto perché gli yatiris mi hanno castigato.» «Per l'amor del cielo, tesoro, smettila di dire sciocchezze!» «Che cosa significa lawt'ata, Daniel?» gli chiesi, appoggiando una mano sul cuscino per abbassarmi, ma mio fratello girò la testa dall'altra parte e non riaprì più le labbra. «Lascia stare, Arnau», disse Ona, abbattuta, ritornando al libro e alla poltrona. «Non dirà nient'altro. Sai quant'è testardo.» Io però continuavo a chiedermi perché Daniel aveva riso in quel modo tanto curioso e pronunciato quelle strane parole. Che lingua era quella? «Quechua o aymara», mi chiarì Ona quando glielo domandai. «Sicuramente aymara. Il quechua era la lingua ufficiale degli incas, ma nella regione sud-orientale dell'impero si parlava aymara. Daniel ha dovuto imparare tutte e due le lingue per poter lavorare con Marta.» «In così pochi mesi?» mi sorpresi, tornando a sedermi e guardandola. Il programma che gestiva l'alimentazione del portatile aveva spento il monitor per risparmiare la batteria. Entro pochi minuti, se non avessi mosso il mouse o battuto un tasto, si sarebbe disattivato anche l'hard disk. «Tuo fratello ha una straordinaria predisposizione per le lingue, non lo sapevi?» «Anche in questo caso...» obiettai. «Be'...» mormorò lei corrugando la fronte e le labbra, «ha certamente lavorato molto duramente da quando ha cominciato a collaborare con Marta. Come ti ho detto, era come ossessionato. Arrivava dall'università, mangiava e si chiudeva nello studio tutto il pomeriggio. Comunque, presto ha abbandonato il quechua per dedicarsi all'aymara. Lo so perché me lo ha detto lui.» «Quel testo... quello che mi hai fatto vedere a casa tua... era scritto in aymara?» «Penso di sì.» «E quel lavoro di... hai detto di etnolinguistica inca?» «Sì.» «Che diavolo è?» «L'etnolinguistica è un ramo dell'antropologia che studia le relazioni tra la lingua e la cultura di un popolo», mi spiegò Ona. «Sai che gli incas non conoscevano la scrittura e che, pertanto, la loro tradizione è solo orale.» Che io lo sapessi era supporre molto da parte sua. A me tutto questo faceva venire in mente la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, le tre caravelle e i Re Cattolici. Se avessi dovuto situare in una carta geografica gli incas, i maya, gli aztechi, avrei fatto una confusione tremenda. «Marta, la docente di Daniel, è un'autorità nel campo», continuò a spiegarmi mia cognata con un'espressione infastidita; senza dubbio quella tale Marta le stava sullo stomaco e non sopportava che Daniel lavorasse con lei. «Ha pubblicato un sacco di studi, collabora con riviste specializzate di tutto il mondo e partecipa, come invitata, a tutti i convegni di antropologia dell'America Latina. È un personaggio importante, oltre che una vecchia boriosa e prepotente.» Incrociò le gambe con aria di sufficienza e mi guardò. «Qui, in Cataluña, oltre a occupare la Cattedra di Antropologia Sociale e Culturale della UAB, dirige il Centre d'Estudis Internazionals e Interculturals d'Amèrica Llatina ed è la presidentessa dell'Institut Català de Cooperació Iberoamericana. Ora puoi capire perché Daniel doveva lavorare per forza con lei: rifiutare la sua offerta avrebbe voluto dire la fine della sua carriera di ricercatore.» Mio fratello si muoveva inquieto nel letto, girando la testa da un lato all'altro e agitando le mani in aria. Di tanto in tanto mormorava di nuovo la parola incomprensibile che aveva pronunciato prima: lawt'ata. Doveva ripeterla per qualche ragione, ma, se questa ragione esisteva, lui era il solo a conoscerla. Diceva lawt'ata a voce bassa e si agitava; la ripeteva e rideva, stava zitto per un po' e ricominciava. «Va bene», assentii passandomi le mani sulle guance ispide. «Ma, lasciando perdere questa Marta, spiegami in che cosa consisteva esattamente il lavoro.» Mia cognata, che teneva il volume aperto su uno dei braccioli della poltrona, lo riprese pigramente, mise il segnalibro tra le pagine e lo chiuse, lasciandolo scivolare sulle gambe. «Non so se devo...» cominciò, insicura. «Ona, non ho intenzione di appropriarmi delle idee di Daniel e della docente.» Lei rise e allungò le maniche del maglione finché non riuscì a nascondervi le mani. «Lo so, Arnau, lo so! Ma Daniel mi ha raccomandato molto di non parlarne con nessuno.» «Senti... Io voglio solo capire ciò che sta succedendo.» Lei rimase assorta per alcuni secondi e, alla fine, sembrò aver preso una decisione. «Non dirai niente, vero?» volle sapere prima di svelare il grande segreto. «Con chi credi che possa parlare di etnolinguistica inca?» Risi. «Pensi veramente che una solfa simile possa interessare a qualcuno dei miei amici?» Anche lei rise, rendendosi conto della stupidaggine che aveva detto. «Dio mio, no! Sarebbero amici molto originali!» «Ti sei risposta da sola. Adesso spiegami ciò che Daniel ti ha detto di non riferire a nessuno.» «È una storia piuttosto complicata», iniziò, incrociando le braccia sul petto. «Un'amica di Marta, la professoressa Laura Laurencich Minelli, titolare della Cattedra di Storia e Civiltà Precolombiane dell'università di Bologna, è venuta a conoscenza, nei primi anni Novanta, di misteriosi documenti del XVII secolo trovati per caso in un archivio privato di Napoli, i cosiddetti documenti Miccinelli. Secondo quanto mi ha raccontato Daniel, questi documenti contenevano molti dati sorprendenti e strani sulla con- quista del Perù. Ma la cosa più straordinaria di tutte, per cui la professoressa Laurencich Minelli si era messa subito in contatto con la sua amica Marta Torrent, era che includevano la chiave necessaria a interpretare un sistema di scrittura incaica dimenticato, che dimostrava come quella non fosse una civiltà arretrata priva di alfabeto.» Ciò che Ona mi aveva appena raccontato doveva essere qualcosa di eccezionale, senza dubbio, perché mi scrutava aspettando una mia reazione entusiastica che, ovviamente, non ebbi. «Hai sentito quello che ti ho detto, Arnau?» indagò, perplessa. «I documenti Miccinelli dimostravano la falsità delle cronache spagnole, e affermavano con prove inconfutabili l'esistenza di una lingua scritta tra gli incas!» «Dai!... È magnifico!» colpii nel segno, senza capire del tutto la faccenda. Per fortuna, lei si rese conto della mia ignoranza e cercò di darmi una mano per tirami fuori d'impaccio. Era evidente che l'argomento la appassionava; non per niente, pensai, si era iscritta a quel corso di laurea e, secondo quanto mi aveva confessato il giorno prima, aveva intenzione di portarlo a termine. «Sai, Arnau, dimostrare che gli incas scrivevano è come scoprire che l'uomo non discende dalla scimmia... Qualcosa di impensabile, incredibile e stupefacente, capisci?» «Be', la teoria di Darwin è ancora solo una teoria», commentai. «Se, a questo punto, fossero stati in grado di dimostrarla, sarebbe la legge di Darwin.» Mia cognata si spazientì. Era molto giovane e le mancava la dose di pazienza necessaria per sopportare le stupidaggini altrui. La verità era che Darwin mi aveva sempre interessato; non era sorprendente pensare che non era mai stato trovato nemmeno uno delle migliaia di anelli mancanti che sarebbero potuti servire a dimostrare la teoria dell'evoluzione, non soltanto degli esseri umani, ma anche di tutti i tipi di animali e di piante? Qualcosa doveva pur dire, e a me sembrava molto strano. «Vuoi che continui a raccontarti a che cosa stava lavorando Daniel o no?» sbottò. Ci sono situazioni in cui è meglio spegnere il computer che scagliarlo a terra. Ona era soltanto una bambina con molti problemi, il peggiore dei quali stava sdraiato sul letto al centro della stanza. «Continua, ti prego», risposi affabile. «Mi interessa molto. Cerca però di capire che non so niente di queste cose.» Lei scoppiò a ridere, alleviando la tensione. Anche mio fratello si era calmato e sembrava che dormisse. «Poverino!» scherzò. «Daniel dice sempre che tu sei la prova vivente che non studiare è molto redditizio!» Sorrisi chinando il capo, rassegnato. Quella frase l'avevo sentita molte volte dalla bocca di mio fratello. Quando avevo sedici anni, mia madre, che allora viveva già a Londra, mi aveva regalato il mio primo computer, un piccolo Spectrum con il quale incominciai a programmare in BASIC. Facevo applicazioni molto semplici, che vendevo, con piccole modifiche, a un'infinità di aziende che si avvicinavano a quella stranezza che era l'informatica di gestione. Poco dopo avevo comprato un Amstrad e, quasi di seguito, un 286 clonato con scheda grafica. La domanda di programmi informatici da parte delle imprese e degli organismi ufficiali continuava ad aumentare. Ero stato uno dei pionieri di Internet, che allora non era nemmeno lontanamente la famosa World Wide Web,6 nata nel 1991, ma solo una caotica rete mondiale di reti locali che comunicavano tra loro con protocolli demenziali e risultati frustranti. Nel settembre del 1993, investendo tutto il denaro che avevo guadagnato come programmatore, avevo messo in piedi il primo provider della Cataluña, l'Inter Ker, e dato vita a un servizio di progettazione di pagine Web che utilizzava l'HTTP.7 In quel momento nessuno sapeva niente di Internet. Tutto era assolutamente nuovo e sconosciuto, un mondo per autodidatti che imparavano sul campo risolvendo i problemi a colpi di tastiera. La società andava bene, ma era evidente che tutto ciò non aveva futuro: la World Wide Web era territorio comanche, ed entro poco tempo avremmo dovuto scontrarci con altri colonizzatori per le briciole della torta. Per questo, nel 1996 avevo venduto l'Inter Ker e deciso di avviare un portale finanziario che offrisse tutte quelle informazioni (quotazioni di borsa, dati su banche, ipoteche e prestiti, tabelloni d'investimenti eccetera) che le aziende per le quali avevo programmato delle applicazioni riuscivano a ottenere a fatica e attraverso mezzi differenti. Si chiamava Keralt.com e aveva avuto un successo immediato. In capo a un anno avevo cominciato a ricevere offerte di acquisizione da parte degli istituti bancari più importanti del mondo. Nel 1999, lo stesso giorno in cui compivo trentadue anni, diventavo uno di quei tipi che nel Nordamerica chiamano ultraricchi vendendo la Keralt.com alla Chase Manhattan Bank per quattrocentosessanta milioni di dollari. La mia storia non era stata l'unica con queste caratteristiche né la più famosa; mi aveva- no superato nei profitti, per esempio, Guillermo Kirchner e i fratelli argentini Casares, María e Wenceslao, che avevano venduto il settantacinque per cento del loro portale Patagon.com al Banco Santander Central Hispano per cinquecentoventotto milioni di dollari. In fin dei conti l'importante della transazione non era stato tanto il denaro ricevuto, quanto il fatto che mi avessero comprato un'idea, solo una delle tante che io potevo concepire. Cosicché, con i dollari ben investiti, alcuni mesi dopo avevo iniziato a costruire la mia casa e aperto la Ker-Central, che si dedicava da un lato a programmare applicazioni di sicurezza per la rete (antivirus e firewall) e, dall'altro, a finanziare progetti innovativi nel campo dell'intelligenza artificiale applicata alla finanza (per esempio la creazione di reti neuronali per prevedere l'andamento dei titoli azionari). Ker-Central riceveva questi progetti, li studiava e, se rispondevano ai requisiti e soddisfacevano l'equipe di consulenti, li produceva e li finanziava, trattenendo ovviamente una percentuale molto alta dei profitti. Quello che nessuno della mia famiglia sembrava comprendere è che tutto ciò mi era costato anni di duro lavoro, di battaglie estenuanti e molte ore rubate al sonno. Ai loro occhi, la sorte mi aveva arriso per capricciosa velleità e quindi la mia fortuna era solo questo: fortuna, non frutto della fatica come nel caso di Daniel. «I documenti Miccinelli», continuò Ona sempre con il sorriso sulle labbra, «scritti da due gesuiti italiani missionari in Perù, erano composti da tredici fogli, uno dei quali, piegato, conservava al suo interno un quipu che...» «Che cos'è un quipu?» la interruppi. «Un quipu? Dunque, un quipu...» Sembrava che non riuscisse a trovare le parole adeguate. «È un grosso cordone di lana da cui pendono una serie di corde colorate piene di nodi. In base alla disposizione dei nodi, alla dimensione e alla distanza tra di loro, variava il significato. I cronisti spagnoli sostennero sempre che i quipus incas fossero strumenti di calcolo.» «Allora il quipu era una specie di abaco», suggerii. «Sì e no. Sì perché permetteva agli incas di tenere minuziosamente i conti delle imposte, delle armi, della popolazione dell'impero, della produzione agricola eccetera. No perché, secondo quello che si poteva dedurre dai riferimenti trovati in documenti minori e nella cronaca di Guamán Poma de Ayala, scoperta nel 1908 a Copenaghen, i quipus erano qualcosa di più di semplici strumenti di contabilità: narravano anche fatti storici, religiosi o letterari. Il problema fu che Pizarro e i successivi viceré del Perù si preoccuparono di distruggere tutti i quipus che trovarono, che erano molti, e di massacrare i quipucamayocs, gli unici che sapessero leggere i nodi. La loro interpretazione si perse per sempre e rimase solo l'oscuro ricordo del fatto che gli incas controllavano l'amministrazione dell'impero con delle esotiche corde annodate. Quando si scopriva un quipu in qualche tomba, finiva direttamente nella bacheca di un qualsiasi museo come curiosità. Nessuno sapeva leggerlo.» Qualcuno bussò alla porta con colpetti affrettati. Entrò nella stanza un'infermiera dagli enormi occhi sporgenti e la voce stanca; reggeva un vassoio pieno di intrugli. «Buona sera», salutò con gentilezza, dirigendosi verso Daniel. Siccome il tavolino era occupato dal computer e dal cellulare, posò il vassoio sul letto. «È l'ora della terapia.» Mia cognata e io le restituimmo il saluto e, come gli spettatori di un'opera teatrale che guardano gli attori sul palcoscenico, rimanemmo seduti e la seguimmo con lo sguardo. Conoscevamo il rituale per averlo osservato la sera precedente. Dopo aver fatto ingerire a mio fratello, con grande difficoltà per la sua mancanza di collaborazione, la compressa di Clorpromazina e le gocce di Tioridazina, l'infermiera gli infilò il termometro sotto un braccio e pose intorno all'altro il manicotto dell'apparecchio per la pressione. Faceva tutto con agilità e perizia, senza errori, muovendosi con la destrezza che le davano i molti anni di esperienza. Conclusa la prima fase, passò a una seconda, che non conoscevamo. «Vuoi fare due passi, Daniel?» gli chiese con voce energica e arrochita, incollando letteralmente la faccia a quella di mio fratello, che aveva riaperto gli occhi. «Come faccio a volere, se sono morto?» rispose lui, fedele al suo nuovo credo. «Preferiresti stare su una sedia?» «Magari sapessi che cos'è una sedia!» «Lo tiro su io», dissi alzandomi. Non potevo sopportare ancora a lungo quell'assurda conversazione. «Non si preoccupi», intervenne l'infermiera abbassando il tono di voce e facendomi un gesto con la mano perché non mi muovessi. «Devo fargli queste domande: bisogna verificare se ci sono dei miglioramenti.» «Sembra che non ce ne siano...» mormorò Ona. La donna le sorrise con affetto. «Ce ne saranno. È ancora presto. Domani starà molto meglio.» Poi, voltandosi verso di me mentre toglieva il manicotto dal braccio di Daniel e ritirava il termometro e le altre cose, aggiunse: «Insista a chiedergli se vuole fare due passi, lo faccia ogni volta che gli mettete le gocce negli occhi. Deve muoversi». «Non ho più un corpo», affermò Daniel guardando il soffitto. «Sì che ce l'hai, tesoro, e anche un gran bel corpo», esclamò lei, contenta, mentre usciva dalla camera. Ona e io ci guardammo cercando di trattenere le risa. Almeno qualcuno conservava il buonumore in quel luogo infame. La faccia di mia cognata, però, cambiò di colpo. «Le gocce!» sussurrò con un tono colpevole. Io annuii, le presi dal comodino e gliele porsi. Il computer si era spento del tutto e il cellulare aveva chiuso automaticamente il collegamento con Internet. Senza smettere di sussurrargli parole affettuose, Ona versò negli occhi viola di mio fratello quelle false lacrime. Io li osservavo attentamente, confermandomi per l'ennesima volta l'incrollabile decisione di non entrare mai a far parte di una comunità affettiva a due. Mi sembrava insopportabile l'idea di legare la mia vita a quella di un'altra persona, anche solo per un breve tempo. Se, trascinato dalle circostanze, qualche volta ero stato tanto pazzo da farlo, mi ero presto stufato di sopportare scempiaggini e avevo sempre finito per desiderare disperatamente di recuperare i miei spazi, il mio tempo e la mia presunta solitudine, nella quale mi trovavo a mio agio e libero di fare tutto quello che mi pareva. Come nel titolo di quel film di Manuel Gómez Pereira, mi chiedevo sempre perché lo chiamavano amore se volevano dire sesso. Mio fratello si era innamorato di Ona ed era felice di vivere con lei e con il figlio; a me piaceva la mia vita così com'era e non sentivo l'esigenza di essere felice, cosa che mi sembrava una pretesa lontana dalla realtà e una finzione senza fondamento. Mi accontentavo di non essere disgraziato e di godere dei piaceri passeggeri che la vita mi offriva. Che il mondo avesse senso attraverso la felicità mi sapeva di scusa a buon mercato per non affrontare la vita senza l'aiuto di nessuno. Quando Ona ritornò alla sua poltrona, io ripresi il discorso dei quipus. Qualcosa mi diceva che dovevo districare alcuni nodi. «Prima mi stavi parlando dei documenti Miccinelli e del sistema di scrittura incaica...» le dissi. «Ah, sì!» ricordò, sedendo sulla poltrona a gambe incrociate. «Be', il fatto è che, mentre Laura Laurencich Minelli studiava la parte storica e paleografica dei documenti, Marta Torrent esaminava il quipu che era stato cucito al foglio piegato, scoprendo così che c'era una relazione diretta tra i nodi e le parole quechua che comparivano scritte sopra le corde. Ne dedusse, ovviamente, di trovarsi davanti a una nuova Stele di Rosetta, che le avrebbe permesso di individuare la chiave perduta per decifrare tutti i quipus. Si trattava però di un lavoro di anni, così, con il permesso della proprietaria dell'archivio di Napoli, Clara Miccinelli, fece le copie di tutto il materiale e lo portò con sé a Barcellona.» «Una volta qui, la nostra cara Marta si mise all'opera per svelare i misteri di quell'antico sistema di scrittura», commentai, «ma, siccome era un lavoro titanico, cercò aiuto tra i più preparati e intelligenti dei suoi professori e scelse Daniel, cui propose di collaborare al progetto.» Sul volto di Ona ritornò l'espressione infastidita di prima. «Ona...» aggiunsi perplesso, «la docente non ha fatto altro che offrire a Daniel un'opportunità unica. Pensa se l'avesse data a un altro! Non capisco perché ti disturbi tanto che abbia pensato a Daniel per una cosa tanto importante.» «Marta Torrent ha offerto a Daniel soltanto il lavoro più improbo!» si irritò lei. «Tuo fratello lo aveva capito, sapeva fin dal principio che lei lo avrebbe sfruttato e che poi, quando sarebbe arrivata l'ora del riconoscimento e dei meriti accademici, lui non avrebbe ricevuto nemmeno un ringraziamento. È sempre così, Arnau! Si ammazzava di lavoro fuori dell'orario delle lezioni perché lei, comodamente seduta in cattedra, godesse dei risultati che lui otteneva.» Rimasi un po' sorpreso per quell'energica risposta. Le cose dovevano andare molto male all'università perché Ona si esprimesse in quella maniera. Di solito mia cognata era una ragazza gentile e tranquilla. Io avevo già sentito parlare degli abusi che si perpetravano nei dipartimenti, ma non avrei mai sospettato che proprio mio fratello fosse uno di quei poveri disgraziati ai quali succhiavano il sangue. Nonostante questo, fu la forma e non la sostanza delle parole di Ona che mi colpi. Daniel, probabilmente turbato dal tono della nostra conversazione, di colpo si agitò e cominciò a ripetere senza posa la parola che quella notte lo ossessionava. «Lawt'ata, lawt'ata, lawt'ata...» «C'è anche un'altra cosa che non capisco, Ona», proseguii pensoso. «Se il quechua era la lingua ufficiale dell'impero inca e il quipu di Napoli celava in sé la chiave in quechua, perché Daniel aveva abbandonato lo studio di questa lingua per dedicarsi completamente all'aymara?» Mia cognata inarcò le sopracciglia e mi guardò con i grandi occhi disorientati. «Questo non lo so», dichiarò infine, con un tono avvilito. «Daniel non me lo ha mai spiegato. Mi ha detto solo che doveva concentrarsi sull'aymara perché era sicuro che avrebbe trovato lì la soluzione.» «La soluzione a che cosa?» obiettai. «Ai quipus in quechua?» «Non lo so, Arnau!» ripeté. «Me ne sto appena rendendo conto.» Quando scrivevo il codice di un'applicazione, per quanto semplice fosse, non commettevo mai l'errore di supporre che, tra le migliaia di linee che lasciavo indietro, non rimanesse acquattato un errore fatale che avrebbe impedito il funzionamento del programma al primo tentativo. Dopo lo sforzo di ideare il progetto e di svilupparlo per settimane o mesi, restava ancora il lavoro più duro e appassionante: la disperata ricerca di quelle impercettibili imperfezioni di struttura che mandavano in rovina l'immenso edificio faticosamente costruito. Comunque non avrei mai affrontato il codice a mani vuote dato che, mentre scrivevo cose normali e algoritmi, un sesto senso mi segnalava dove si trovavano quelle zone oscure che in seguito, probabilmente, avrebbero costituito la fonte di tutti i problemi. E non dubitavo mai della verità di queste intuizioni. Quando, alla fine, lanciavo il programma per verificarne il funzionamento, finivo sempre per confermare la relazione tra gli errori finali e quelle zone oscure. Cercarli e trovarli era molto più interessante che correggerli; correggerli, infatti, era qualcosa di semplice e di meccanico, mentre scoprire il problema, incalzarlo, spinto da un presentimento o da un sospetto, aveva il sapore di gesta epiche, di Ulisse che tenta di raggiungere Itaca. Come se Daniel fosse un'applicazione di milioni di linee, il mio prezioso sesto senso mi stava avvertendo della presenza di zone scure correlate agli errori del suo cervello. Il problema era che io non avevo scritto quell'ipotetico programma che rappresentava mio fratello, quindi, nonostante sospettassi l'esistenza di dati sbagliati, non avevo modo di individuarli e ripararli. Passai il resto della seconda notte a lavorare e ad assistere Daniel, ma, quando la luce cominciò a entrare dalla finestra e Ona si svegliò, avevo già preso la decisione di dedicarmi completamente a quella questione e di verificare (se il mio sesto senso aveva ragione e se era fattibile) la probabile relazione tra l'agnosia e la sindrome di Cotard di Daniel da un lato, e il suo strano lavoro di ricerca dall'altro. Se stavo ingannando me stesso e, come avevo detto a Ona quel pomeriggio, tutto era causato dai nervi e dalla pau- ra che provavamo, l'unica cosa che potevo perdere era del tempo. E se poi Daniel avesse risposto alla terapia e fosse guarito, sarei stato tanto idiota da rimproverarmi di essere corso dietro a un ridicolo presentimento? Be', forse sì, ma non me ne importava niente. Quando arrivammo alla calle Xiprer, salii con mia cognata a casa sua per prendere il foglio scritto da Daniel perché volevo studiarlo quel pomeriggio. Uscii con una montagna di libri sugli incas e con le cartellette che contenevano la ricerca sui quipus. Andai a letto verso le nove e mezzo del mattino, con gli occhi arrossati, sfinito come non ero mai stato prima in vita mia. A causa del cambiamento di orario della veglia e del sonno, soffrivo del jet lag senza aver attraversato l'Atlantico, ma, anche se ero in quello stato, dissi al sistema di svegliarmi alle tre del pomeriggio perché avevo molto da fare e poco tempo per farlo. Ero profondamente addormentato quando la musica di Vivaldi, l'Allegro del Concerto per mandolino, cominciò a risuonare per tutta la casa. Il computer centrale selezionava tra le mie preferite una melodia diversa ogni giorno, secondo il periodo dell'anno, l'ora in cui dovevo alzarmi o il tempo che faceva fuori. Tutta la casa era costruita attorno alla mia persona e, con gli anni, si era prodotta una strana simbiosi tra il sistema di intelligenza artificiale che la regolava e me. Il sistema apprendeva e si perfezionava da sé in maniera tale che era arrivato a trasformarsi in una sorta di maggiordomo telepatico la cui unica preoccupazione era quella di servirmi e aver cura di me, come una madre. Le tende delle ampie porte-finestre che davano sul giardino si stavano riavvolgendo lentamente lasciando passare una tenue luce verde-blu, mentre lo schermo, che copriva completamente la parete di fondo, riproduceva il quadro La chiesa di Auvers, di Van Gogh. Era giorno e avevo ancora un sonno micidiale, quindi chiusi bene le palpebre, mi misi il cuscino sulla testa e supplicai: «Ancora cinque minuti», provocando la morte immediata degli effetti speciali. Il brutto fu che Magdalena, la domestica, immune al sistema di riconoscimento vocale, stava già entrando in camera con il vassoio della colazione. «Davvero vuoi continuare a dormire?» chiese un po' stupita, camminando rumorosamente sul parquet, spostando sedie, aprendo e chiudendo le ante dell'armadio e rimettendo la musica dopo aver pigiato il bottone sul comodino; se non mi ballò sulla testa era perché aveva più di cinquant'anni, ma, se avesse potuto, lo avrebbe fatto. «Ho pensato che non avresti avuto voglia del pranzo, quindi ti ho portato la solita colazione: succo d'arancia, tè con latte e pane tostato.» «Grazie», farfugliai da sotto il cuscino. «Come stava tuo fratello questa notte?» Non sapevo che diavolo stesse combinando, ma i cigolii, i colpi e i rumori vari continuavano. «Come prima.» «Mi dispiace», disse con voce triste. Magdalena lavorava già per me quando io e Daniel vivevamo ancora insieme. «Oggi dovrebbero cominciare a sentirsi gli effetti della cura.» «Me lo ha detto tua madre stamattina.» Sbam! Porte del giardino spalancate e corrente d'aria fresca che entrò come un uragano nella stanza. Perché diavolo avevo un sistema di controllo della temperatura e di ricambio dell'aria in tutta la casa? Secondo Magdalena, per niente. Meno male che era una bella giornata e che non mancava molto all'arrivo dell'estate; anche così, però, cominciai a starnutire più volte, la qual cosa finì per svegliarmi del tutto poiché avevo bisogno di prendere un fazzoletto. Essere un cittadino tecnologicamente avanzato aveva i suoi inconvenienti, e uno di questi era l'incapacità acquisita ad affrontare la natura a torso nudo, com'ero io in quel momento, con addosso soltanto i bermuda del pigiama. Feci colazione rapidamente mentre davo un'occhiata alla selezione di titoli dei giornali che Núria mi inviava ogni mattino sullo schermo della camera. Poi, così com'ero, senza lavarmi nemmeno la faccia, mi diressi verso lo studio - ampio concetto che inglobava tanto il luogo di lavoro quanto la sala dei videogiochi -, deciso a farmi una scorpacciata di cultura inca. «Mettimi in contatto con Jabba», dissi al computer mentre percorrevo il corridoio. Un secondo dopo la voce neutra di Jabba mi salutò nel momento in cui entravo nello studio. «Sei sotto?» gli chiesi, sedendomi sulla poltrona e cominciando a tormentare una graffetta. «Dove vuoi che sia?» rispose. «Ho bisogno del tuo aiuto e di quello di Proxi.» «Che succede?» si allarmò. «Come sta Daniel?» «Non ci sono cambiamenti.» I capelli sciolti e scarmigliati mi davano fastidio; me li legai sulla testa e li raccolsi sotto un vecchio berretto dei Barcelona Dragons. Da un mese circa avevo i biglietti per la partita del sabato seguente contro i Rhein Fire di Düsseldorf che si sarebbe disputata nello Stadio Olimpico di Montjuïc, ma, per come si erano messe le cose, temevo che non avrei potuto assistervi. «Ho bisogno di un favore.» «Spara.» «Ho davanti a me un mucchio di libri ai quali devo dare un'occhiata prima di andare in ospedale.» «Non vorrai che li legga per te.» «Non fare lo stronzo. Non si tratta di questo.» «Allora sbrigati! Ho del lavoro da fare.» «Ti esento. Hai il pomeriggio libero, e anche Proxi.» «Bene. Stupendo. Dovevamo proprio andare a comprare un divano. Ciao!» «Aspetta, idiota!» gridai. «Non puoi andartene.» «Ah, no? E allora perché mi dai il pomeriggio libero?» «Perché indaghi per me su una questione. Ho bisogno che tu e Proxi cerchiate in Internet tutto ciò che esiste su una lingua inca chiamata aymara.» Nel mio studio calò il silenzio più profondo, profondo come un pozzo senza fine. Cominciai a tamburellare con le dita sul tavolo in segno di impazienza, ma nemmeno allora mi rispose. «Sei ancora lì, testa di cazzo?» «No», replicò lui senza scomporsi. «Dai! Non è tanto difficile.» «Ah, no?» esclamò Jabba con il suo timbro di voce forte. «Non ho nemmeno capito quello che mi hai detto... Come diavolo faccio a cercarlo?» «Dai, lo sappiamo tutti quanto sei bravo.» «Ora non mi lisciare!» «Ho bisogno che tu faccia questa ricerca, Marc, parlo seriamente.» Di nuovo silenzio, però sapevo che stavo vincendo la battaglia. Sentii sbuffare dagli altoparlanti. «Spiegami di nuovo cos'è che dobbiamo cercare.» «Gli incas, gli abitanti dell'impero inca...» «Gli incas dell'America Latina.» «Proprio loro. Be', quei tipi parlavano due idiomi. Quello ufficiale dell'impero era il quechua, prevalente tra la popolazione; l'altro, l'aymara, si parlava nel sud-est. «Che sud-est?» «E che ne so io?» esplosi. Jabba credeva forse che io fossi ferrato su questo argomento? Per me era tutto un guazzabuglio! «Il sud-est dell'impero inca, penso.» «Allora vuoi sapere tutto sull'aymara che si parlava nel sud-est dell'impero inca.» «Esatto.» «Spero che tu abbia una buona ragione per costringere Proxi e me a passare il pomeriggio facendo ricerche sull'aymara del sud-est dell'impero inca, perché altrimenti rovinerò la tua società e farò in modo che ti sbattano in galera.» Non si devono mai prendere sottogamba le parole di un hacker. «Ho una buona ragione.» Ce l'avevo? «Va bene. Vado a prendere Proxi e andiamo al '100' a lavorare.» «D'accordo. Chiamatemi quando terminate.» «A proposito, non mi hai chiesto il risultato della campagna contro la TraxSG.» Lo avevo completamente dimenticato! Avevo l'hard disk mentale formattato a lunedì. «Com'è andata?» chiesi con un sorriso malvagio. «Stupendo! È su tutti i giornali di oggi. Quelli della TraxSG dovranno sudare sangue per uscirne bene. E non hanno idea dell'origine del boicottaggio.» Scoppiai a ridere. «Sono contento. Lascia che cerchino. Bene, aspetto una tua chiamata.» Sì, ciao. Ero di nuovo solo nel mio studio e in silenzio... Be', solo del tutto no, perché avevo sempre con me la tacita presenza del computer centrale. All'inizio avevo pensato di dargli un nome appropriato, qualcosa come Hal, il computer pazzo di 2002, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, o Abulafia, il povero computer di Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, oppure Johnny, per Johnny Mnemonic, ma avevo finito per non decidermi e non gli avevo affibbiato nessun appellativo. Se fosse stato un cane, lo avrei chiamato semplicemente Cane, ma si trattava di un potente sistema di intelligenza artificiale. Alla fine stabilii che, senza la mediazione di un nome, qualsiasi ordine pronunciato ad alta voce che non fosse chiaramente diretto a Magdalena, sarebbe stato rivolto al sistema. Diressi uno sguardo malinconico alla mia fantastica collezione di film in DVD e alle consolle di videogiochi, abbandonate sul tavolino di vimini: allungai la mano verso la pila di libri che avevo preso in casa di mio fratello. Per una scelta precisa, il mio studio era il più simile possibile alla cabi- na di una navicella spaziale (altra concessione al mio spirito ludico). Oltre allo schermo gigante che, come nel resto delle stanze della casa, occupava completamente una delle pareti, avevo un apparato simile a quello del «100», anche se con tre monitor soltanto, un paio di tastiere, alcuni registratori, due stampanti, una macchina fotografica digitale, uno scanner, un lettore di DVD e le consolle per i giochi. Tutto era color acciaio inossidabile o bianco immacolato, con poltrone, tavoli e librerie in alluminio, titanio e cromo. Le lampade erano alogene, di un tono celeste tanto freddo da conferire allo studio l'aria di una grotta scavata nel ghiaccio. Le lunghe file di libri sui ripiani e il tavolino basso di vimini erano, dunque, le uniche eccezioni di colore all'interno di quell'apparente iceberg, e per niente al mondo avrei rinunciato a quei volumi e, ovviamente, nemmeno al tavolino, un ricordo della mia vecchia casa del quale non ero disposto a privarmi. Con un sospiro di rassegnazione aprii uno dei tomi di storia di Daniel e cominciai a leggere. Per la verità all'inizio non capii granché, nonostante non fossi quello che poteva dirsi esattamente uno stupido. Gli storici che avevano scritto quelle dotte opere si erano impegnati a non calcolare il tempo nel modo abituale e parlavano di «Orizzonti» invece che di epoche «Orizzonte iniziale», «Orizzonte medio», «Orizzonte tardo», e periodi intermedi -, con il risultato che, almeno per un inesperto come me, era impossibile situare quello che stavano raccontando in un momento conosciuto della Storia. Quando, finalmente, trovai un quadro cronologico chiarificatore, risultò che l'impero inca, uno dei più potenti imperi del mondo, era arrivato ad avere trenta milioni di abitanti e a occupare un territorio che si estendeva dalla Colombia all'Argentina e al Cile, passando per l'Ecuador, il Perù e la Bolivia. Un impero durato meno di cento anni, caduto per mano di un miserabile esercito spagnolo di appena duecento uomini al comando di Francisco Pizarro, un tipo che, incredibilmente, non sapeva né leggere né scrivere e che era stato guardiano di porci nella sua Estremadura natale, lasciata molto presto in cerca di fortuna. Pizarro era partito da Panama nel 1531, al comando di una spedizione di varie navi che dall'America centrale si erano dirette verso sud attraverso il Pacifico: al passaggio scoprì terre e fondò città nelle isole della costa della Colombia e dell'Ecuador. Nessuno che non fosse un abitante originario di quei luoghi - cioè nessuno che non fosse un indio - aveva ancora attraversato le Ande, né lo avrebbe fatto per molti anni a venire. Nessuno aveva attraversato la selva amazzonica né visto mai il Perù, la Bolivia o la Terra del Fuoco. La conquista del Nuovo Mondo era partita dalla stretta striscia del continente (da Panama, chiamata allora Tierra Firme) e si era estesa verso nord e verso sud lungo la costa; quindi tutto quello che Pizarro contemplava dalla sua nave mentre si dirigeva, nel XVI secolo, verso un misterioso impero inca traboccante d'oro del quale aveva sentito parlare dagli indigeni, era Terra Incognita, cioè territorio sconosciuto. Pare che il termine «inca» designasse solamente il re; chiamare incas tutti gli abitanti dell'impero era stato un errore degli spagnoli. Quello Stato veniva chiamato dai suoi abitanti Tahuantinsuyu, Terra o Impero delle Quattro Parti, ed era nato nell'anno 1438 della nostra era sotto il governo dell'inca Pachacuti, il nono dei dodici incas esistiti fino all'arrivo di Pizarro, nel 1532, il quale fece ammazzare vilmente colui che era stato l'ultimo re, l'inca Atahualpa. Prima del regno di Pachacuti la memoria era confusa e incompleta poiché, in base a ciò che affermavano gli storici, era impossibile ricostruire quel che era accaduto data la carenza nelle civiltà andine di documenti scritti. L'archeologia aveva certamente svelato, e continuava a farlo, gran parte dell'oscuro passato chiarendo il periodo di migliaia di anni trascorsi da quando i primi abitanti attraversarono il gelido e navigabile stretto di Bering e colonizzarono il continente americano... O non era stato così? Le ultime scoperte infatti parlavano di grandi migrazioni giunte per mare dalla Polinesia. O non era stato nemmeno così? Non era chiaro, perché la professoressa Anna C. Roosevelt, direttrice del Dipartimento di Antropologia del Field Museum of Natural History di Chicago, aveva appena scoperto in Amazzonia un deposito di manufatti di circa mille anni più antichi di quel che si credeva, e che quindi toglievano, in linea di massima, validità alle teorie precedenti. In conclusione, i ritrovamenti archeologici differivano parecchio nella sostanza lasciando la questione dubbia e confusa come all'inizio. Uno dopo l'altro i ricercatori e gli studiosi finivano per riconoscere in una parte dei loro libri che, in realtà, non esistevano certezze su niente, e che i dati ipotizzati fino a quel momento potevano cambiare con una futura scoperta. E non c'era accordo neppure sulle teorie tratte dalle mitologie e dalle leggende raccolte dagli spagnoli. Però, in linea generale, si poteva affermare che, nella maggioranza dei casi, la versione finale era qualcosa di simile a questo: intorno all'anno 1100 della nostra era, un insignificante e bellicoso gruppo di incas era emigrato dal sud-est, dalle terre alte della cordigliera centrale delle Ande, alla valle di Cuzco, a nord, dove nei trecento anni seguenti avevano combattuto senza tregua con le tribù che abitavano la zona fino a conquistare il potere assoluto. All'inizio del XV secolo diedero vita a quello che sarebbe stato conosciuto come il Tahuantinsuyu, che ebbe fine all'inizio del XVI secolo con Pizarro. Come dire, poca cosa per tanto sforzo. Per quanto riguarda la religione, gli incas adoravano come divinità suprema Inti, il Sole, di cui si consideravano figli, anche se dall'inizio del regno del famoso inca Pachacuti la supremazia passò a Viracocha, e si finì per confonderli. Viracocha era un dio certamente strano che la gente chiamava «il vecchio del cielo», ma che invece era emerso dalle acque del lago Titicaca e aveva creato l'umanità per due volte non essendogli piaciuto il risultato del primo tentativo: aveva scolpito nella pietra una razza di giganti e gli aveva dato vita, però questi avevano presto cominciato a combattere tra loro, ragion per cui Viracocha li distrusse. Alcuni dicevano che lo avesse fatto con colonne di fuoco cadute dal cielo, altri con un terribile diluvio che li aveva affogati. Comunque il mondo, dopo quell'ecatombe, era rimasto al buio. Eliminati i primogeniti, e mentre Viracocha illuminava di nuovo il mondo facendo emergere il sole e la luna dal lago Titicaca, la seconda razza umana costruì e abitò la vicina città di Tiwanacu (o Tiahuanaco), le rovine archeologiche più antiche di tutta l'America del Sud. C'erano decine di versioni diverse. A parte il dilemma se la creazione della seconda razza aveva avuto luogo prima o dopo il diluvio - un evento che compariva ampiamente anche in tutte le leggende andine -, la cosa più degna di nota era il piccolo particolare che Viracocha era un ometto di media statura, di pelle bianca e dotato di una bella barba. Il dettaglio della pelle bianca non aveva una spiegazione chiara, naturalmente, ma quello della barba disorientava del tutto gli studiosi perché inconfutabilmente gli indigeni americani sono sempre stati imberbi. Per questo quando Pizarro e i suoi uomini, di pelle bianca - sudiciume a parte - e certamente barbuti, comparvero a Cajamarca, gli incas rimasero tanto perplessi da credere che fossero degli dei. Infine, in base a ciò che narravano le leggende con infinite variazioni, Viracocha aveva mandato i suoi stessi figli, Manco Capac e Mama Ocllo, a nord perché fondassero la città di Cuzco, capitale dell'impero, e dessero origine alla civiltà inca. I discendenti diretti dei figli di Viracocha furono gli autentici incas, i re o i membri della famiglia reale, nelle cui vene circolava un prezioso sangue solare che doveva mantenersi puro a ogni costo, ragion per cui si sposavano tra fratelli. Questi sovrani e aristocratici - uomini e donne - venivano chiamati Orejones, perché i loro costumi prescrivevano che si perforassero i lobi delle orecchie ai giovani di alto lignaggio per differenziarli dalle altre classi sociali. Quando i fori si erano sufficientemente allargati vi si inserivano grandi dischi d'oro a forma di sole, ornamento che simboleggiava l'origine divina e l'alta dignità. A mano a mano che venivo a conoscere la storia e definivo nella mia mente una tavola cronologica degli avvenimenti, riuscii a compilare un primo schema generale. Come se si trattasse di dipingere un grande quadro su una tela bianca ero già in grado di schizzare con il carboncino la scena completa con la corretta prospettiva; mi mancavano ancora, però, i colori, ma non potevo perdere tempo a cercarli: avevo passato il pomeriggio a leggere senza sosta. Alle otto il computer mi ricordò che dovevo cenare e prepararmi a uscire. La realtà mi cadde di colpo addosso. Battei le palpebre intontito, sollevando lo sguardo dai libri, e in alcuni decimi di secondo mi venne in mente non solo che dovevo fare una doccia, vestirmi e mangiare qualcosa, ma anche che Proxi e Jabba erano nel «100» e che Ona mi aspettava a casa sua entro un'ora. Siccome non volevo abbandonare la lettura fino al giorno dopo, presi lo zaino dall'attaccapanni all'entrata e vi ficcai dentro, precipitosamente, quei volumi che ancora non avevo esaminato e che, per ovvie ragioni, erano quelli dall'apparenza più noiosa e soporifera: la Nueva crónica y buen gobierno di Guamán Poma de Ayala - il libro di cui Ona mi aveva parlato la notte precedente -, i Comentarios reales dell'inca Garcilaso de la Vega, la Crónica del Perù di Pedro de Cieza de León e la Suma y narración de los Incas di Juan de Betanzos. Lo zaino pesava una tonnellata. Mentre cenavo mi chiamò mia madre per chiedermi quando saremmo arrivati. A quanto pareva Clifford non si sentiva bene e volevano tornare a casa presto. «Tuo fratello non è migliorato per niente», mi spiegò con una voce che faceva intuire una certa preoccupazione. «Diego dice che è ancora troppo presto per vedere dei risultati e che bisognerà aspettare un po' di più, ma Clifford si è innervosito e gli è venuta una delle sue emicranie.» In famiglia nessuno osava riconoscerlo a voce alta, ma era significativo che quelle tremende emicranie di Clifford fossero iniziate poco dopo il matrimonio con mia madre. «Chi è Diego?» domandai, ingoiando senza masticare il pezzo di sogliola che avevo appena messo in bocca. «Lo psichiatra di Daniel, Arnau! Tesoro, sei sempre tra le nuvole quando si tratta di cose importanti», mi rimproverò ancora una volta, e tutto perché io ero incapace di memorizzare i nomi, i cognomi e i titoli che a lei tanto piacevano e che padroneggiava da virtuosa, nonostante la sua lunga assenza. «È venuto anche Miquel... il dottor Llor, ti ricordi? Il neurologo. Oh, che uomo per bene! Vero, Clifford? Poverino, non può nemmeno rispondermi per il mal di testa! Sai, Miquel ha chiesto molto di te e ci ha detto che un nipote di sua moglie lavora alla Ker-Central e... bene, Clifford mi sta chiedendo di chiudere. Non tardate, Ona e tu, d'accordo? Siamo stanchi e vorremmo andare a letto presto. A proposito, Arnie, come posso dire a quella macchina che governa casa tua che non mi spenga la luce del comodino mentre sto leggendo? Ieri sera... Sì, Clifford, adesso riattacco! Me lo spiegherai dopo, tesoro. Non tardate!» Quando il sistema interruppe la comunicazione, avevo già terminato di cenare e stavo entrando nella doccia. Stupito per il silenzio di Jabba e Proxi, che non avevano dato segni di vita per tutto il pomeriggio, arraffai le mie cose e mi precipitai in garage. Alle nove meno un quarto arrivai a casa di mio fratello, ma questa volta non dovetti cercare un parcheggio perché Ona mi aspettava davanti alla porta con le braccia incrociate. Indossava una maglia nera e una gonna con un'alta cintura di cuoio. Durante il breve tragitto verso La Custòdia mi raccontò che aveva dormito solo un paio d'ore in tutto il giorno a causa del certificato medico di Daniel; prima aveva dovuto andare dal medico di famiglia a ritirarlo, e poi fino a Bellaterra per consegnarlo alla segreteria della facoltà. Clifford aveva veramente una brutta cera quando Ona e io entrammo nella stanza di Daniel. La sua pelle era di un preoccupante tono olivastro e sotto gli occhi aveva due gonfie borse scure. Nemmeno mio fratello quella sera esibiva il suo aspetto migliore: aveva urgentemente bisogno che qualcuno gli passasse un rasoio sulla faccia ed ebbi l'impressione che fosse piuttosto smunto, con le guance incavate e le ossa della fronte più pronunciate. Per contrasto mia madre appariva florida e stupenda come sempre, traboccante di energia e di vitalità. Nonostante avesse ricevuto tutto il giorno delle visite, come ci raccontò (i suoi vecchi amici, i suoi meno amici, i suoi conoscenti, i conoscenti dei conoscenti...), e nonostante la sua guerra privata con le infermiere e le ausiliarie del reparto, era in piena forma. Anche Miquel e Diego (il dottor Llor e il dottor Hernández) avevano partecipato all'intensa vita sociale della stanza, e mia nonna, senza che nessuno sapesse come fosse stata informata, aveva chiamato da Vic per chiedere di suo nipote e annunciare che sarebbe arrivata all'alba del giorno dopo. «E chiaramente, con tutto quel caos», concluse la mamma guardando con pena il marito, che languiva in silenzio sulla sedia di plastica, «Clifford si è sentito male. E il mio piccolo Dani, Ona? Pensi che potrò vederlo un momento, domani? Ovvio che se i tuoi genitori sono stravolti come noi... Un bambino stanca molto. Sicuramente con lui non ci si può fermare un secondo! Sto pensando» - si prese il mento con la mano per dimostrare che la sua riflessione era davvero profonda - «che se anche mia madre si ferma in casa di Arnau, potrebbe badare a Dani, non credi, Clifford? Sarebbe una soluzione fantastica.» «Mamma, Clifford non sta bene, ha una brutta cera», le ricordai. «Dovreste andare via.» «È vero», commentò distrattamente lei, alzandosi. «Andiamo, Clifford. A proposito, Arnau, spiegami che cosa devo fare perché la tua casa mi obbedisca. Non c'è mezzo, con queste nuove tecnologie! Non riesco a far funzionare niente. Non potresti vivere in una casa normale come tutti? Certo che sei strano, figlio mio. Chi l'avrebbe mai detto che avresti finito per dedicarti a tutte quelle stupidaggini infantili di computer e di videogiochi! Non crescerai mai, Arnie», mi rimproverò. Non aveva idea di quello che facevo realmente e non le interessava nemmeno saperlo. «Su, dimmi che cosa devo fare, altrimenti mi toccherà andare in albergo: quando entro in una stanza, quel sistema tanto intelligente non mi accende la luce; se voglio fare la doccia, l'acqua viene giù fredda; le ante degli armadi non si aprono e i canali della televisione cambiano da soli. Stamattina, mentre mi vestivo, ha cominciato a suonare un rullo di tamburo che si è interrotto soltanto quando è arrivata Magdalena e...» «Mamma», la bloccai con voce decisa. «Porta via Clifford.» «Hai ragione, hai ragione. Andiamo, Clifford.» Come poteva quella donna avere ancora voglia di parlare dopo aver passato l'intero giorno a conversare con questo e quello? «Ma non mi dici che cosa devo fare con la tua casa?» insistette prima di uscire. «Sì», risposi. «Cerca di stare zitta. Stai facendo impazzire il computer.» Lei rimase perplessa per qualche secondo, poi scoppiò a ridere allegramente. «Arnau, Arnau! Sei proprio cattivo!» E dicendo questo scomparve dalla nostra vista mentre Clifford salutava con un affettuoso cenno del capo e chiudeva la porta. «Finalmente!» esclamò Ona, che era rimasta accanto a Daniel da quando eravamo arrivati. «Scusami, Arnau, ma tua madre è snervante.» «A chi lo dici!» Mia cognata si chinò su mio fratello e gli diede un dolce bacio sulle labbra. Mi sorprese scoprire che non aveva osato farlo prima, davanti ai suoceri. Daniel, però, girò di scatto la testa verso la finestra, rifuggendo dal contatto. «Sai una cosa?» le dissi avvicinandomi a lei, che era rimasta pietrificata per il rifiuto. «Ora lo tiriamo su e gli facciamo la barba.» Ona, però, non reagiva, allora la presi per un braccio e la scossi dolcemente. «Su, Ona, aiutami.» Quando, dopo innumerevoli sforzi e liti, riuscimmo a far sedere Daniel sul bordo del letto, qualcuno bussò. Mia cognata e io guardammo in direzione della porta aspettandoci di veder entrare la prima infermiera della notte; invece udimmo altri colpetti. «Non stiamo aspettando nessuno, vero?» mormorò lei. «No», confermai. «Spero che non siano né Miquel né Diego.» «Avanti», fece lei alzando la voce. Rimasi di stucco quando vidi comparire sulla soglia le figure di Jabba e Proxi. Si notava sul loro volto la dolorosa impressione causata dalla vista di Daniel, ridotto a un fantoccio e insaccato in un orribile pigiama da ospedale. «Entrate», gli dissi invitandoli con un gesto a venire avanti. «Non vogliamo disturbare», farfugliò Jabba, che aveva una spessa cartella sotto il braccio. «Non disturbate affatto», assicurò sorridendo Ona. «Avanti, non rimanete lì.» «Sembra che siamo arrivati in un brutto momento...» commentò Proxi senza fare un passo. «Stavamo per...» rimasi senza parole perché, di colpo, mi resi conto che Lola e Marc non sarebbero venuti in ospedale a quell'ora senza un buon motivo. «Che cosa succede?» «Volevamo soltanto mostrarti alcune cose», spiegò Jabba, affannato, picchiettando sul voluminoso fascicolo, «ma possiamo rimandare a domani.» L'espressione del loro volto, però, dimostrava tutto il contrario e che, qualsiasi cosa fossero espressamente venuti a farmi vedere, era molto urgente. «Si tratta del boicottaggio alla TraxSG?» «No. Quello procede bene.» Dunque si trattava dell'aymara che si parlava nel sud-est dell'impero inca. «Ti dispiace se rimettiamo a letto Daniel?» chiesi a mia cognata. «Non tarderò molto.» «Stai tranquillo», mi incoraggiò lei riadagiandolo delicatamente. Era più facile coricarlo che alzarlo. «Vai con loro. Non preoccuparti.» Ma io ero preoccupato e non precisamente per Daniel. «Saremo nella caffetteria del pianterreno», le dissi. «Chiamami al cellulare, se hai bisogno di me.» Appena usciti in corridoio, dopo avere chiuso adagio la porta, guardai con ansia i due. «Che diavolo succede?» «Non volevi sapere tutto sull'aymara?» proruppe Proxi, la fronte aggrottata. Una volta fuori dalla stanza erano subito venuti al nocciolo della questione. «Sì.» «Allora preparati!» dichiarò Jabba dirigendosi verso la porta d'uscita del reparto. «Non sai dove ti sei cacciato!» «Di che cosa sta parlando?» chiesi a Proxi. «Sarà meglio sederci. È un consiglio da amica!» Non pronunciammo nemmeno una parola finché non arrivammo alla caffetteria camminando di buon passo dietro a Jabba, che pareva avanzare spinto da un motore a reazione. Sebbene non ci fosse molta gente, tutti i tavoli erano occupati da solitari parenti dei malati che cenavano con gli occhi fissi sul vassoio che avevano davanti. Il cibo, disposto in grandi contenitori di alluminio incassati nel bancone, aveva un aspetto sgradevole sotto i potenti faretti, come se lo avessero preparato con gli avanzi del rancio dei carcerati. Le persone che mangiavano - soprattutto donne di una certa età, educate a credere che le malattie e la morte non fossero cose da uomini - lo ingoiavano in silenzio, accettando con rassegnazione gli inconvenienti del ricovero di un famigliare. In fondo all'ampia sala, una cameriera, con addosso una goffa uniforme a righe bianche e blu, passava un panno umido sul tavolo di formica appena lasciato libero da una delle tante donne anziane. Con il vassoio sul quale traballavano le bibite, ne prendemmo possesso seguiti dallo sguardo di antipatia della cameriera. «Allora, vediamo. Che cosa avete scoperto di tanto grave?» «No, non grave», mi corresse Proxi. «Direi strano.» Jabba aprì la cartella e ne estrasse un fascio di fogli che sistemò al centro del tavolo. «Dai un'occhiata a questi.» «Per favore!» ribattei restituendogli le carte. «Non siamo a una riunione di lavoro. Raccontamelo.» Sembrava che non sapesse da dove cominciare e lanciava lunghi sguardi a Proxi mentre si scompigliava i capelli rossi. «All'inizio non trovavamo niente di insolito», cominciò lei, più decisa. «Quando Jabba mi ha spiegato quello che volevi ho pensato che fossi diventato matto, veramente... ma siccome quando hai una delle tue idee penso sempre la stessa cosa, non ti ho insultato troppo... Ti saranno fischiate le orecchie.» Jabba annuì ripetutamente. «Alla fine», continuò lei, «siamo andati al '100' e ci siamo messi all'opera. La faccenda sembrava intricata, ma, scomponendola in più parti, come se fosse un problema di strategia di programmazione, si semplificava molto. Avevamo diverse parole chiave: aymara, incas, linguaggio, idioma... C'era abbondanza di informazioni nella rete sull'argomento. L'aymara è una lingua ancora in uso nel sud del Perù e in Bolivia, e coloro che la parlano, gli aymaras o aymaraes, sono un pacifico popolo andino, di poco più di un milione e mezzo di persone, che faceva parte dell'impero inca. A quanto pare, nonostante l'aymara abbia convissuto con il quechua per secoli, i due non sono idiomi fratelli, cioè non provengono dalla stessa famiglia linguistica.» «In realtà, l'aymara non...» attaccò Marc, ma Proxi lo interruppe. «Aspetta un po', perché così lo confondiamo.» «Va bene.» «Ascoltami, Root.» «Lo sto facendo, Proxi.» «L'aymara... Be', conoscila solfa dell'origine delle lingue e tutta la tiritera?» «Stai parlando della Torre di Babele?» I due mi guardarono in modo strano. «Qualcosa del genere. I linguisti pensano che i cinquemila idiomi che esistono oggi sul pianeta probabilmente hanno avuto un'origine comune, una specie di protolinguaggio da cui derivarono tutti gli altri, inclusi quelli che si sono perduti per sempre. Questo protolinguaggio sarebbe come il tronco dell'albero da cui nascono molti rami; da ciascun ramo, altri ancora, e così fino alle cinquemila lingue di oggi, raggruppate in grandi famiglie linguistiche... Hai capito?» «Perfettamente. Ora parlami dell'aymara, se non ti dispiace.» «Non fare il somaro e ascolta», pretese Jabba. «Questo protolinguaggio originale...» «La lingua di Adamo ed Eva?» scherzai, ma Proxi mi ignorò. «... è conosciuto come nostratico e si calcola che sia esistito circa tredicimila anni fa. Cervelloni delle migliori università del mondo si bruciano i neuroni da mezzo secolo tentando di ricostruirlo.» «Molto interessante», mi lasciai scappare, annoiato. «Adesso saprai quanto, ignorante!» proruppe Jabba. «C'è tutta una corrente di pensiero all'interno della linguistica che lavora sulla teoria secondo cui l'aymara potrebbe essere quella prima lingua madre. Il tronco... Afferrato?» Rimasi di ghiaccio e il mio volto dovette rifletterlo perché il malumore del mio amico scomparve. «Infatti», disse Proxi, riprendendo la parola, gli occhi che le brillavano in modo strano, «l'aymara è molto lontano dall'essere una lingua qualsiasi. Stiamo parlando di una lingua perfetta, una lingua la cui struttura logica è talmente straordinaria che sembra più il risultato di un disegno preordinato che di un'evoluzione naturale. Gli aymaras chiamavano la loro lingua Jaqui Aru, che significa 'linguaggio umano', e la parola aymara significa 'popolo dei tempi remoti'.» «Ascolta questo...» intervenne Jabba frugando disperatamente tra i documenti sul tavolo; infine, dopo una lunga ricerca, trovò quello che voleva e mi guardò trionfante. «Il tipo che ha scritto Il nome della Rosa, Umberto Eco, è un semiologo di fama mondiale, e, tra gli altri, ha scritto un libro che si intitola La ricerca della lingua perfetta in cui dice: 'Il gesuita Ludovico Bertonio aveva pubblicato nel 1603 una Arte de lengua aymara e nel 1612 un Vocabulario de la lengua aymara (una lingua parlata ancor oggi tra Bolivia e Perù), e si era reso conto che si trattava di idioma di immensa flessibilità, capace di una incredibile vitalità neologizzante, particolarmente adatto a esprimere astrazioni, tanto da avanzare il sospetto che si trattasse dell'effetto di un 'artificio'. Due secoli dopo Emeterio Villamil de Rada8 poteva parlarne definendola lingua adamitica, espressione di 'una idea anteriore alla formazione della lingua', fondata su 'idee necessarie e immuta- bili' e dunque lingua filosofica se mai ve ne furono'.»9 Jabba mi fissò esultante. «Che ne dici, eh?» «Ma la cosa non finisce qui», fece notare Proxi. «Proprio per niente! Eco continua spiegandoci le caratteristiche in base alle quali l'aymara potrebbe qualificarsi come un linguaggio perfetto, anche se non si compromette del tutto con la teoria che sia un linguaggio artificiale.» «Un linguaggio artificiale?» esplosi. «Queste sono sciocchezze!» «Per fartelo capire», continuò pazientemente Proxi, «ci sono un mucchio di studiosi nel mondo che concordano nell'affermare che l'aymara è una lingua che sembra ideata in base alle stesse regole che si seguono oggi per scrivere linguaggi di programmazione informatica. È una lingua con due elementi di base, radici e suffissi, che di per sé non hanno alcun significato, ma che legati gli uni agli altri in lunghe catene li creano tutti... Come un linguaggio matematico! Inoltre», aggiunse notando che io aprivo la bocca per oppormi di nuovo, «il professore boliviano Ivan Guzmán de Rojas, un ingegnere informatico che da molti anni lavora a questa ricerca, afferma che le combinazioni dei suffissi aymaras obbediscono a una regolarità con proprietà di struttura algebrica, una specie di anello di polinomi con una tale quantità di astrazione matematica che è impossibile credere sia il prodotto di un'evoluzione naturale.» «Senza dimenticare», precisò Jabba, «che l'aymara non ha avuto un'evoluzione. Questa maledetta lingua, incredibilmente, si è mantenuta quasi intatta per secoli o millenni... circa tredici millenni, se fosse il nostratico.» «Non è variata per niente? Non è cambiata?» mi sorpresi. «Pare di no. Ha preso alcune parole dal quechua e dal castigliano negli ultimi secoli, molto poche, però. Gli aymaras credono che la loro lingua sia sacra, una sorta di regalo degli dei che appartiene a tutti senza distinzioni e che non deve modificarsi in nessun modo. Che cosa te ne sembra?» «Viracocha gli regalò il suo idioma?» volli sapere senza abbassare la guardia. «Viracocha?» si stupì Proxi. «No, no. Viracocha non compare per niente nelle leggende aymaras. Almeno non in quelle che abbiamo letto, vero, Jabba? La religione aymara si basa sulla natura: la fecondità, il bestiame, il vento, le tempeste... Vivere in armonia con la natura significa essere in armonia con gli dei; ne hanno uno per ciascun fenomeno naturale, anche se in cima a tutti c'è la Pachamama, la Madre Terra, e, se non ricordo male, anticamente c'erano anche un certo Thunupa, dio di... di che cosa, Jabba?» «Della pioggia o qualcosa del genere», suggerì lui, incerto. «Ecco, sì. Della pioggia e del lampo. Può darsi che, per influenza degli incas, credano in Viracocha, non so», continuò Proxi. «Affermano, comunque, di essere discendenti diretti dei fondatori di Tiwanacu, una città molto importante, vicino al lago Titicaca, che era già in rovina quando gli spagnoli la scoprirono. A quanto pare, Tiwanacu era una specie di monastero, il luogo sacro più importante delle Ande, e i suoi governanti, i Capacas, erano sacerdoti astronomi.» «Il problema è che nessuno ne sa niente», fece notare Jabba. «Sono tutte elucubrazioni, ipotesi e teorie più o meno fondate.» «E succede la stessa cosa con gli incas», dissi io ricordando le mie letture del pomeriggio. «Non riesco a capire come, pur vivendo nel XXI secolo, siamo ancora incapaci di spiegare certe cose.» «Perché sono cose che non interessano a nessuno, Root», mi chiarì Proxi con tristezza. «Soltanto a qualche tipo stravagante come tuo fratello. Perché tutto questo lo fai per Daniel, vero?» Mi agitai sulla sedia, un po' nervoso, e approfittai di quei pochi secondi per decidere se riferire o no i miei sospetti insensati. «Sputa», mi ordinò il mio grosso amico. Non ci girai attorno. Raccontai tutto quello che sapevo senza omettere nessun particolare, fornendo dati e non opinioni perché il loro giudizio, più imparziale del mio, mi aiutasse a uscire dal confuso groviglio di assurdità nel quale mi ero cacciato. I loro sguardi, mentre spiegavo la storia dei documenti Miccinelli, dei quipus e della maledizione scritta nel foglio trovato sul tavolo di Daniel, mi facevano sentire a disagio. Jabba e Proxi mi conoscevano come una buona mente analitica, capace di ideare il progetto più complesso in un paio di secondi e di trovare un ago logico in un pagliaio di incoerenze, cosicché, attraverso i loro occhi, mi stavo vedendo come un autentico svitato. Quando finalmente chiusi la bocca e, tanto per fare qualcosa, presi il bicchiere con la bibita, ero sicuro di essere caduto per sempre nel più oscuro abisso del ridicolo. «Non sei più quello di prima, Root», mi disse Jabba. «Lo so.» «Stavo pensando la stessa cosa», confermò Proxi. «Lo capisco.» «Mi sarei aspettato molto di più da te. Molto di più.» «Va bene, Jabba. Adesso basta!» «No, Root. Jabba ha ragione. Hai fatto la peggiore analisi della tua vita.» «Ha paura.» «Questo è chiaro.» «Bene. Adesso smettiamola», esclamai ridendo nervosamente. «Che diavolo sta succedendo?» «Non vuoi vederlo, amico mio. Ce l'hai davanti al naso e non vuoi vederlo.» «Che cos'ho davanti al naso? «Daniel ha decifrato la chiave dei quipus e ha tradotto la maledizione... Stai perdendo il tuo fiuto da hacker.» Gettò indietro i capelli rossi, che la luce bianca del neon schiariva, e mi osservò con aria di sufficienza. «Ti ho già detto», protestai, «che i quipus erano scritti in quechua e che mio fratello conosceva solo l'aymara.» «Lo hai verificato?» «Che cosa dovevo verificare?» «Se la maledizione era in aymara», continuò Proxi. «No. Non l'ho fatto.» «Allora perché continuiamo a parlarne?» brontolò Jabba infastidito. Proxi lo censurò con lo sguardo, poi mi disse: «Tuo fratello deve avere incontrato qualcuno che gli ha fatto sostituire il quechua con l'aymara. Daniel ha detto a Ona che la soluzione si trovava in quest'ultima lingua, come ci hai riferito. La domanda è... la soluzione a che cosa? Probabilmente a un quipu che non rispondeva alle regole in quechua che stava cercando. Hai guardato tutto quello che c'era nel suo studio?» «No, però ho portato molto materiale a casa. Domani gli darò un'occhiata.» «Vedi che non sei più quello di prima?» insisté Jabba, schioccando la lingua con disprezzo. «Non bisogna tralasciare altri due piccoli particolari», continuò Proxi. «Primo, l'aymara è una lingua strana che potrebbe avere qualcosa di più di una semplice somiglianza formale con i linguaggi di programmazione. Dimenticate per caso che gli stregoni, i maghi, e questo genere di persone compivano incantesimi pronunciando parole strane? Mary Poppins, senza andare tanto lontano... Mi ricorderò sempre Supercalifragilisticoespiralidoso», intonò alla Julie Andrews senza nessuna vergogna. «E più di recente Harry Potter», propose Jabba. «Oh, è fantastico!» esclamò Proxi, con aria sognante. «Alohomora! O- bliviate! Relaxo!» Quella era la mia migliore mercenaria, la favolosa ed esperta ingegnera che pagavo una fortuna all'anno per trovare errori nei nostri programmi e buchi in quelli della concorrenza? «E anche La bruja novata.» «Ecco!» gridai. «Tu dai corda a questa pazza!» «Treguna, Mekoides, Trecorum Satis Dee...» canterellò lei, senza accorgersi che tutti nella caffetteria la stavano osservando con un sorriso sulle labbra. «Treguna, Mekoides, Trecorum Satis Dee...» «Adesso basta! Ho afferrato il concetto, davvero. Le parole. È chiarissimo.» «Ma c'è qualcosa d'altro», soggiunse Jabba. «Proxi, diglielo.» «Cercando informazioni sugli aymaras e sulla loro lingua, ci siamo imbattuti in un documento molto strano su alcuni medici dell'antichità che curavano con erbe e parole. Sembra che utilizzassero un linguaggio segreto e magico. Abbiamo pensato che fosse una delle tante superstizioni e non vi abbiamo fatto caso, ora però...» «Eccolo!» la interruppe Jabba estraendo un foglio dalla caterva di documenti. «Gli yatiris, discendenti diretti della cultura tiwanacota, riveriti dagli incas, che li consideravano di stirpe nobile. Erano certamente aymaras, e venivano onorati dalla loro gente come saggi o filosofi. 'Molti etnolinguisti affermano'», lesse nervosamente, «'che la lingua parlata dagli yatiris non era altro che l'idioma segreto usato dai nobili Orejones quando si rivolgevano ai loro pari, ricorrendo al quechua quando si indirizzavano al popolo'.» «Yatiris!» esclamai allarmato. «Che cosa c'è?» chiese Proxi. «È quello che ha detto Daniel ieri. Ha detto che era morto perché gli yatiris lo avevano castigato! Ripeteva anche un'altra parola: lawt'ata.» «Che significa?» volle sapere Jabba. «Non ne ho la minima idea. Dovrò verificarlo.» «Prima lo avresti fatto immediatamente.» «Sii comprensivo, Jabba.» Proxi perorò la mia causa. «Suo fratello è malato e ricoverato in ospedale da due giorni.» Marc sbuffò. «Per questo si salva. Ma sta diventando un computer senza sistema operativo, una tastiera senza invio. Un triste monitor al fosforo verde, un...» «Marc!» lo riprese Proxi. «È sufficiente.» Jabba aveva ragione. Il mio cervello non stava funzionando con l'abituale lucidità. Forse era vero che avevo paura di prendere un abbaglio e di fare la figura dello stupido. Mi stavo muovendo su un terreno insidioso, a metà strada tra il mio mondo, razionale e ordinato, e il mondo di mio fratello, confuso e misterioso. Io mi ero proiettato verso il futuro, lui invece verso il passato, e ora non solo dovevo cambiare il mio modo di pensare e la mia scala di valori, ma anche rompere con alcuni pregiudizi di fondo e seguire un presentimento che non si fondava sulla realtà, bensì su strane approssimazioni storiche. «Lasciatemi tutto il materiale. Lo esaminerò questa notte e, domani, analizzerò con molta attenzione quello che ho preso in casa di Daniel. E ci andrò di nuovo per verificare quello che ho lasciato lì. Se entro un paio di giorni Daniel non sarà migliorato», dichiarai, guardandoli con determinazione, «andrò a parlare con la docente che gli ha affidato il lavoro e le chiederò aiuto. Lei deve saperne più di chiunque altro.» II Per la nostra disperazione e per quella dei medici, Daniel non migliorò affatto nei due giorni successivi. Diego e Miquel erano talmente perplessi per l'inefficacia dei loro farmaci che venerdì, alla fine, decisero di cambiargli la terapia. Nonostante questo Miquel riconobbe di fronte a mia madre che a quel punto, constatando la totale mancanza di progressi in tutti i sensi, nutriva qualche dubbio su una rapida e completa guarigione di mio fratello; al massimo, disse, si poteva sperare in un lieve miglioramento per la fine della settimana seguente o l'inizio di quella dopo ancora. Forse stava mettendo le mani avanti, magari esagerando, preparando il terreno per qualsiasi cosa potesse succedere; comunque ci lasciò annichiliti, soprattutto Clifford, che invecchiò di dieci anni in qualche minuto appena. La presenza della nonna alleggerì molto la tensione che gravava sulla famiglia; poche ore dopo il suo arrivo aveva organizzato i turni in maniera tale che potevamo ricostruire le nostre vite quasi normalmente, salvo che per dei piccoli aggiustamenti che non disturbavano nessuno poiché si trattava di stare con Daniel. La nonna era una donna energica e solida come una quercia, con una grande capacità di organizzazione e una testa infinitamente più attrezzata di quella di mia madre, che teneva a freno se eccedeva in sua presenza. Si impossessò rapidamente del turno di notte rimandando a casa me e Ona perché dormissimo nelle ore giuste. Non potei evitare di ipotizzare che, in breve, avrebbe trovato un mucchio di amiche e di conoscenti nella caffetteria dell'ospedale e che, presto, quel posto sarebbe stato simile alla piazza di Vic al mattino della domenica, dopo la messa. Avevo un appuntamento all'una con Marta Torrent nel suo studio all'università. Era sabato mattina - lo stesso sabato, primo giugno, in cui i Barcelona Dragons avrebbero giocato la partita contro i Rhein Fire di Dusseldorf - e c'era un tempo splendido; una di quelle mattine luminose che ti invitano ad andare in strada a passeggiare con la scusa di comprare un bel libro o un CD di buona musica. Mentre attraversavo con la mia auto i tunnel di Valvidrera in direzione dell'università autonoma, gli occhiali da sole ben aderenti al naso, continuavo a cercare di scoprire la password che avrebbe dato un senso ai frammenti del rebus che avevo trovato tra le carte e nello studio di mio fratello. Speravo con tutto il cuore che la professoressa potesse aiutarmi a risolverlo, perché la mia confusione era ancora più grande di quella che avevo provato la sera del colloquio con Jabba e Proxi nella caffetteria. Il giorno dopo quella conversazione ritornai nell'appartamento di Xiprer con i libri e i documenti che avevo con me, disposto a lavorare per il numero di ore necessario a capire in cosa diavolo si era cacciato Daniel. Dopo aver rovistato in cassetti, scaffali, cartelle e tutto quello che mi capitava tra le mani, feci una nuova classificazione, per mucchi, nei quali separai tutto ciò che era inca da quello che si riferiva all'aymara e, al loro interno, tutto ciò che aveva a che vedere con la storia da una parte, e con il linguaggio e la scrittura dall'altra. Quindi feci un altro mucchio con tutto quanto non aveva una precisa provenienza, e qui il materiale era talmente abbondante che dovetti anche distinguere tra i documenti scritti e quelli con immagini dove c'erano diagrammi, mappe, fotografie, fotocopie di fotografie e schemi scarabocchiati da mio fratello. La mia ripartizione forse non era delle più ortodosse, accademicamente parlando, ma era l'unico criterio che potessi adottare in quel momento. La prima cosa che attrasse la mia attenzione fu l'immagine di un cranio allungato nelle cui orbite restavano parti secche degli occhi. Superata la sgradevole impressione di quello sguardo sinistro, rimasi allibito dalla forma delle ossa: al posto della solita rotondità che parte dalla fronte e ar- riva alla nuca, quel teschio si prolungava verso l'alto come il copricapo di un nazareno, di forma conica e di proporzioni smisurate. Accanto a questa immagine, altre simili dimostravano che l'argomento aveva preoccupato abbastanza Daniel. Nella stessa cartellina trovai, inoltre, la fotografia di un muro di pietra con un gran numero di teste scolpite ed erose dal tempo e un ingrandimento digitalizzato e sfumato di uno strano omino senza corpo, tutto testa (dalla quale uscivano le braccia magre e delle gambe simili a cosce di rana), fornito di una folta barba nera e di un enorme copricapo rosso. Teste e ancora teste... Un altro enigma senza pari. Per di più scoprii, piegato, l'ingrandimento di una gigantesca faccia scolpita nella pietra di forma quadrangolare, con grandi occhi tondi e neri, che avrei giurato di avere già visto mille volte in vita mia, ma che ero del tutto incapace di localizzare. Doveva essere un inca, senza alcun dubbio, ma, siccome mio fratello non aveva fatto nessuna annotazione al riguardo, poteva trattarsi tanto del logotipo di una marca commerciale come di un sole - questo ricordava, poiché dalla faccia uscivano dei raggi - scolpito in una parete di Cuzco, Machu Picchu, Tiwanacu, Vilcabamba o in una delle rovine sparse nel territorio dell'antico impero che cominciavano già a risultarmi familiari. Trovai anche, tra le altre cose tutte ugualmente inutili, un disegno fatto a mano (con un pennarello rosso) dallo stesso Daniel, nel quale si vedeva, rappresentata in modo schematico, una piramide a gradini, di tre piani, al cui interno compariva una specie di vaso di forma quadrata dal quale uscivano quattro teste di felino, nella parte superiore, e sei teste di uccello ai lati e alla base. Dentro il vaso si attorcigliava un piccolo serpente con le corna. Sotto, mio fratello aveva annotato «Camera» e lo aveva sottolineato più volte con spesse righe. Un altro argomento che sembrava ossessionare Daniel erano i tessuti inca. Aveva, in un'altra cartelletta, decine di riproduzioni di stoffe decorate a quadratini e rettangoli dai colori straordinari. Ciascuna di quelle piccole forme geometriche mostrava al suo interno un disegno differente, e la vista si perdeva in quell'infinità di caselle poste in fila e incolonnate. Le stoffe erano molto diverse tra loro, nonostante fossero dello stesso stile, il medesimo che si poteva osservare anche in sei o sette fotografie di ceramiche bicchieri e boccali - conservate in un'altra cartella. Pure in questo caso non esisteva il minimo riferimento a ciò che poteva rappresentare ciascun oggetto, per cui mi ritrovai al punto di prima. In tutto quel mare magnum di informazioni inutili, si distinguevano un paio di grandi fotocopie piegate che stavano dentro un portadocumenti senza indicazioni. Erano le riproduzioni di alcune antiche mappe, piuttosto spiegazzate, che si rivelarono incomprensibili. Nella prima, dopo parecchi tentativi, riconobbi, a destra, la forma della penisola iberica e la costa occidentale dell'Africa, all'interno delle quali comparivano numerose figure umane e animali quasi indistinguibili su cui passavano (e si incrociavano) linee che partivano da varie rose dei venti di diverse dimensioni. Meglio preparato ora alla geografia dell'immagine, dedussi che ciò che si vedeva a sinistra era la costa americana, con i suoi fiumi e affluenti, molti dei quali partivano da una catena montuosa, le Ande, che costituiva la fine del disegno da quel lato; mancava infatti il profilo della costa del Pacifico, sostituita da un lungo testo scritto in minuscoli caratteri arabi. Nella seconda mappa, abbozzato su una specie di lenzuolo dall'orlo sfilacciato, si vedeva un grande lago circondato da linee e segni che sembravano orme di formica e, in evidenza, il rozzo tracciato di una città, a sud del lago, sotto cui si riusciva a leggere con qualche difficoltà, a causa dei ghirigori dell'antica grafia, «Sentiero degli indios yatiris» e, sotto, «Due mesi per terra», e ancora più in basso, in caratteri più piccoli, «Io, Pedro Sarmiento de Gamboa, dico che ciò è vero. Città dei Re, ventidue febbraio del millecinquecentosettantacinque». La cosa finalmente cominciava piano piano a chiarirsi: yatiris era una parola che conoscevo e che mio fratello utilizzava con frequenza nel suo delirio. Dovevo cercare di sapere di più sugli yatiris, mi dissi, perché sembravano godere di un ruolo da protagonisti nella storia e, inoltre, e questo era il lato curioso, secondo quell'antico nobiluomo spagnolo, Pedro Sarmiento de Gamboa, avevano un proprio sentiero che, dopo due mesi di cammino, andava a finire chissà dove. Il grosso della biblioteca di Daniel era composto da testi di antropologia, di storia, e da grammatiche varie. Negli scaffali più vicini al suo tavolo, sia a destra sia a sinistra, aveva sistemato a portata di mano i volumi sugli incas e un mucchio di vocabolari, tra i quali si trovavano quello pubblicato nel 1612 dal gesuita Ludovico Bertonio, Vocabolario de la lengua aymara, e quello di Diego Torres Rubio, Arte de la lengua aymara, del 1616. Era il momento di verificare che diavolo volesse dire lawt'ata. Dopo essere impazzito per un po' (perché in realtà non avevo idea di come si scrivesse), riuscii a trovare il termine a forza di consultare, una per una, tutte le voci che cominciavano con la lettera elle; così verificai che era un aggettivo e che significava «chiuso a chiave», la qual cosa mi ricondusse al messaggio della supposta maledizione, nella cui ultima riga, ricordai, comparivano queste parole. Ovviamente, ciò non risolse nulla, ma almeno capii che avevo sciolto un'incognita. Avevo in progetto di dare uno sguardo alle antiche cronache spagnole in quanto, tra le altre ragioni, oltre a un'enorme svogliatezza, avevo dedicato tutto il mio tempo a studiare linguistica e, più in particolare, linguistica aymara, facendo parecchie incursioni in rete per catturare informazioni più precise su questa lingua. Tutto ciò che Jabba e Proxi mi avevano raccontato era troppo esiguo rispetto a ciò che in realtà era l'aymara. Chiaramente io non conoscevo tante lingue come mio fratello; eccetto per il catalano, il castigliano e l'inglese, rimanevo disorientato come un neonato e potevo fare pochi confronti con altri idiomi naturali. Ma padroneggiavo bene i linguaggi di programmazione (Python, C/C++, Perl, LISP, Java, Fortran...), e ciò bastava e avanzava perché mi rendessi conto che l'aymara non era una lingua come le altre. Non poteva esserlo, poiché si trattava di un autentico linguaggio di programmazione. Era precisa come un orologio atomico, senza ambiguità, senza dubbi nei suoi enunciati, senza spazio per le imprecisioni. Nemmeno un diamante puro tagliato in modo insuperabile avrebbe uguagliato le sue proprietà di integrità, esattezza e rigore. Nell'aymara non erano previste frasi tanto stupide come quelle che da bambini ci facevano ridere per la loro incongruenza, come «il pollo è pronto da mangiare», per esempio. No, l'aymara non consentiva questo tipo di assurdo linguistico, e inoltre era vero che le sue regole sintattiche sembravano costruite a partire da una serie invariabile di formule matematiche che, applicate, davano come risultato una strana logica di tre valori - vero, falso e neutro -, al contrario di qualsiasi lingua naturale conosciuta, che rispondeva solo a vero o falso secondo la vecchia concezione aristotelica. In aymara, dunque, le cose potevano essere, realmente e senza equivoci, né sì né no né tutto il contrario. A quanto pareva, non c'erano altri idiomi al mondo che permettessero niente di simile e la cosa d'altra parte non doveva stupire, dato che parte della ricchezza che le lingue acquisivano in secoli di evoluzione consisteva precisamente nella sua capacità letteraria per le confusioni e le ambiguità. Così, mentre gli aymaras, che ancora usavano questa lingua in Sudamerica, se ne vergognavano e venivano emarginati in quanto poveri e arretrati indigeni senza cultura, la loro lingua proclamava ai quattro venti che provenivano da una civiltà molto più avanzata della nostra, o almeno capace di creare un linguaggio basato su algoritmi matematici di alto livello. Non mi sorprendeva per niente che Daniel fosse stato affascinato da queste sco- perte e che avesse abbandonato lo studio del quechua per dedicarsi totalmente all'aymara; quello che mi stupiva, invece, era che non avesse contato sul mio aiuto per comprendere tutti quei concetti tanto astratti e tanto lontani dalle discipline che lui conosceva e aveva studiato. Ricordavo che mi aveva chiesto in varie occasioni di scrivergli alcuni programmi semplici e molto specifici per conservare, classificare e recuperare informazioni (bibliografie, dati statistici, archivi di immagini...). Ma persino queste piccole applicazioni gli sembravano complesse e difficili da gestire, tanto che dubitavo molto del fatto che da solo sarebbe stato in grado di riconoscere le similitudini che presentava l'aymara con i moderni e sofisticati linguaggi di programmazione. E non trovai nemmeno da nessuna parte il famoso quipu in aymara immaginato da Jabba e Proxi. Da un lato, in materia di quipus, individuai solo un grosso faldone che conteneva le copie dei documenti Miccinelli, ma dava la sensazione, per il posto in cui era sepolto e per la sottile patina di polvere che si vedeva all'interno della copertina, che Daniel non lo toccasse da molto tempo; dall'altro, se quell'insieme di corde con nodi, o meglio la sua riproduzione grafica, si trovava da qualche parte nello studio, poteva essere all'interno del computer portatile di mio fratello, il fiammante IBM che gli avevo regalato a Natale e che era ancora connesso alla rete elettrica, alimentando una batteria sufficientemente carica. Pigiai il tasto di avvio. Il piccolo hard disk tornò subito in vita con un lieve ronzio e lo schermo si illuminò dal centro verso i bordi, mostrando le poche righe di istruzioni di file del sistema prima di far comparire la schermata azzurra di Windows. Mi appoggiai alla spalliera della sedia e, mentre mi sfregavo gli occhi stanchi, un inaspettato scintillio di luce arancione mi avvertì di un processo anomalo nell'avvio del sistema operativo. Battendo nervosamente le palpebre per mettere a fuoco la vista, mi trovai di fronte a una sorprendente richiesta di password. Non si trattava di una password del BIOS né di un'inutile password di rete di Windows; era un programma completamente differente che non avevo mai visto e che, per il suo disegno, sembrava essere stato scritto da un programmatore esperto che, ovviamente, non ero io. Rimasi di stucco. Per quale motivo mio fratello aveva bisogno di una protezione simile? Il programma non dava nessuna indicazione sulla lunghezza e sul tipo di password richiesta, cosicché richiamai Windows in modalità provvisoria per vedere se, in questa maniera, potevo eludere la benedetta richiesta. Rimasi ancora più sorpreso quando scoprii che nemmeno con questo truc- co né con altri simili - attraverso il BIOS - sarei riuscito a superare la barriera e che, pertanto, la porta sarebbe rimasta chiusa fino a che non avessi potuto contare su armi migliori per aprirla. Esistevano mille modi per infrangere quella ridicola misura di sicurezza, ma per riuscirci dovevo portarmi a casa il portatile. Così, per evitare tante seccature, decisi di provare prima con la logica, partendo dalla convinzione assoluta che mi sarebbe stato molto facile scoprire la password. Mio fratello non era un hacker e non aveva bisogno di proteggersi in modo esagerato. Ero sicuro che si fosse procurato quel software con qualche rivista di informatica o attraverso un collega, il che mi garantiva, tanto per cominciare, di decodificarlo in un baleno. «Ona!» gridai a pieni polmoni, girando un poco la testa indietro. Immediatamente udii un urletto felice di mio nipote, che doveva aver penato per essere stato costretto a rimanere lontano dallo studio. I suoi passi, mentre si avvicinava velocemente lungo il corridoio, mi avvertirono del pericolo. «Ona!» «Vieni qui, Dani!» sentii dire a mia cognata, che era andata dietro al bambino per impedirgli di entrare. «Dimmi, Arnau.» «Conosci la password del computer di Daniel?» «La password?» si sorprese lei, affacciandosi alla porta con in braccio il piccolo, che lottava per liberarsi e scendere a terra. «Non sapevo avesse messo una password.» Inarcai le sopracciglia e guardai di nuovo lo schermo arancione. «E quale supponi che possa essere?» «Non ne ho la più pallida idea. Stai fermo, Dani, per favore!... Immagino che non volesse che qualcuno del dipartimento curiosasse nel suo lavoro mentre era a lezione.» Strinse con forza le mani del figlio, che le tirava i capelli per divincolarsi, e si allontanò in direzione del salotto. «Ma non penso che per te sia un ostacolo insuperabile, no?» No. In teoria. Statisticamente, quasi il settanta per cento delle password che la gente utilizzava erano alfabetiche, cioè formate solo da lettere e, in generale, si trattava di nomi propri, sia di persone sia di luoghi o di oggetti. L'estensione della password alfabetica di solito non superava gli otto caratteri, era quasi sempre compresa tra i sei e gli otto, e raramente si usavano le maiuscole. Conoscendo un poco la persona di cui si voleva individuare la password, prima o poi si finiva per centrare il bersaglio provando con i nomi dei suoi famigliari, delle sue passioni, del luogo di nascita o di residenza eccetera. Tuttavia, dopo aver tentato senza successo varie volte, scoprii che Daniel non sembrava rientrare in quel settanta per cento di incauti: nessuna delle parole che usai servì a togliere la sicura. E io che pensavo di conoscerlo così bene da non lasciare niente di intentato! Decisi di provare con le regole base delle password numeriche. Quasi il cento per cento di queste era formato invariabilmente da sei cifre non perché alla gente piacessero di più le combinazioni di questa lunghezza, ma perché utilizzavano le date dei compleanni più significativi. Provai con quello di Daniel, di Ona, di nostra madre, di Clifford, di Dani... e, alla fine, disperato, ricorsi alle password più stupide che si incontrano di solito nella rete: «123456», «111111», e altre ingenuità del genere. Nemmeno queste funzionarono. Non mi rimaneva che portarmi il computer a casa e iniziare a nutrire maggior rispetto per mio fratello, che fino a quel momento avevo considerato un utente informatico non molto abile e poco creativo. Ebbi la conferma di quanto mi fossi sbagliato quando, già nel mio studio, verificai che nessuno dei collegamenti con i potenti programmi per l'individuazione delle password sortiva il minimo effetto. I miei dizionari di password erano i più completi che si potessero trovare e i programmi usavano la forza bruta con un'insuperabile potenza di calcolo, ma quella piccola applicazione continuava a resistere. Ero realmente confuso e riuscivo solo a pensare che Daniel avesse usato una parola in aymara di sufficiente lunghezza, la qual cosa ne avrebbe reso quasi impossibile l'identificazione. Dopo un paio d'ore, non mi rimase che ricorrere alla decifrazione incrementale, basata sulle combinazioni aleatorie di lettere o numeri, o di lettere e numeri insieme. Però, se non volevo dedicarci il resto della mia vita, dovevo mettere a lavorare, contemporaneamente, tutti i computer della Ker-Central e incrociare le dita perché il processo non si prolungasse all'infinito. Il problema era che molte delle macchine della società continuavano a mandare avanti dei lavori durante la notte, così programmai il sistema da casa in modo che utilizzasse solo quelle disponibili e i tempi morti di quelle occupate. Quel sabato mattina, mentre guidavo verso l'Autonoma, ancora non avevo trovato la password, ma non poteva mancare molto, e con quella speranza mi dirigevo al mio appuntamento con la professoressa e mi godevo il sole, la luce e la sensazione di normalità che la strada e la mia auto mi restituivano. Avevo lasciato i capelli sciolti, che arrivavano oltre le spalle, e avevo indossato uno dei miei vestiti nuovi, quello color beige, una camicia con il colletto alla coreana e scarpe di pelle. Se quella donna era tanto dura come diceva Ona, dovevo avere l'aspetto di un serio e rispettabile impren- ditore. L'Autonoma era un posto che mi piaceva abbastanza. Quando ci andavo per una riunione con quelli dell'Institut d'Investigació en Intel-ligència Artificial, mi sembrava di stare in una specie di grande città, moderna e accogliente, sui cui marciapiedi e giardini camminavano i professori e gli studenti, che si sparpagliavano sull'erba con i loro libri cercando l'ombra degli alberi. Nelle mattine d'inverno, la brina o la neve coprivano le zone verdi fino a che il sole di mezzogiorno non lasciava l'erba brillante e umida; ma in primavera si vedevano gruppi numerosi che assistevano alle lezioni all'aria aperta, sotto i raggi del sole. L'unica cosa che non mi piaceva di quel luogo erano gli edifici di un certo tipo, in particolare quelli delle facoltà più vecchie, costruiti in base alla moda degli anni Settanta, tanto amante di quei brutti fabbricati in cemento, alluminio e vetro che lasciavano allo scoperto i tubi-vene della struttura. Scossi la testa per allontanare i cattivi pensieri e decisi di chiedere informazioni a destra e a manca per non dover girare tutto il giorno. Ciononostante, e c'era da aspettarselo, finii per perdermi, dato che la ricca segnaletica del campus di Bellaterra più che orientare fuorviava. Meno male che avevo tempo in abbondanza, perché a un certo punto mi ritrovai all'uscita per Sabadell e, un'altra volta, in direzione di Cerdanyola. Finalmente raggiunsi il parcheggio semisotterraneo, lasciai l'auto e, cartella in mano, iniziai una piacevole passeggiata verso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dove si trovava il Dipartimento di Antropologia Sociale e della Preistoria in cui lavoravano mio fratello e Marta Torrent. Sfortunatamente quella facoltà era di quelle antiche, per cui dovetti percorrere lunghi corridoi grigi (le cui pareti erano ricoperte di poster, disegni e scritte varie) in cerca di un bidello che potesse darmi una mano. Non ebbi successo, forse perché era sabato, però imbattei in un gruppo di studenti che uscivano da un esame, i quali mi indicarono come muovermi in quel labirinto. Salii scale, percorsi corridoi, passai dov'ero già passato e, finalmente, nell'edificio B, mi trovai davanti a una porta anonima sulla quale un cartello mi annunciava che, dopo una difficoltosa navigazione senza bussola, ero riuscito ad arrivare in porto. Tolsi la mano sinistra dalla tasca e bussai adagio. Dietro si sentivano voci e rumori, quindi non mi aspettavo di ricevere indifferenza come risposta, ma questo fu esattamente quello che ottenni. Il secondo tentativo mi convinse che non c'era niente da fare: nessuno mi avrebbe aperto la porta; avevo quindi due opzioni: o la aprivo io senza riguardi o bussavo con più energia. E questo è ciò che feci. Senza pensarci due volte picchiai con tanta forza che dietro calò automaticamente un silenzio profondo e alcuni passetti leggeri vennero a ricevermi. Quando l'accesso fu libero, vidi quattro o cinque persone assolutamente immobili che mi guardavano con molta curiosità. «Sì?» disse come unico saluto la ragazza magrolina dai capelli corti e neri che mi aveva aperto la porta. Lei e le altre donne presenti mi squadrarono da capo a piedi mentre un sorrisino gli si disegnava negli occhi, ma non sulle labbra. Anche se ero abituato a notare questa reazione in quasi tutte le donne che non erano amiche né parenti, mi piaceva sempre che capitasse. L'umiltà non è negare quello che si ha di buono, questa è ipocrisia, ma riconoscerlo e accettarlo. «Cerco Marta Torrent.» «La dottoressa Torrent?» ripeté la ragazza, aggiungendo il titolo accademico nel caso lo avessi dimenticato. «Chi la cerca?» «Sono il fratello di Daniel Cornwall. Ho un appuntamento con lei all...» «Il fratello di Daniel!» esclamarono varie voci all'unisono, pronunciando il nome come si dice qui, con l'accento sull'ultima sillaba. E come se quel nome fosse uno straordinario biglietto da visita, tutti si alzarono dalle loro sedie e mi si avvicinarono. «Assomigli moltissimo a tuo fratello... anche se sei bruno!» si lasciò scappare una giovane con il mento pronunciato e una lunga frangetta mentre mi dava la mano. «Io sono Antonia Marì, collega di Daniel.» «Siamo tutti suoi colleghi», specificò un omino stempiato, capelli bianchi e occhiali di nichel. «Pere Sirera. Piacere. Hai parlato con me quando hai chiamato per avere un appuntamento con Marta.» Anche lui mi strinse la mano e lasciò il posto a un'altra. «Tu saresti l'informatico riccone, eh?» esclamò una donna di circa quarant'anni, con il collo che sporgeva da uno strambo vestito fiorato stile Giuseppina Bonaparte. «Sono Mercè Boix. Come sta Daniel?» «Sempre uguale, grazie», risposi. «Ma che cosa gli è successo esattamente?» indagò la tale Mercè. «Sappiamo che Mariona ha portato il certificato medico, però la dottoressa Torrent non ci ha spiegato niente», intervenne la ragazza della porta, chiudendola e aggiungendosi al gruppo. «Ci ha detto soltanto che è ricoverato alla Custòdia e che ha avuto un incidente», disse lentamente Pere Sirera. Sembrava pensare che, forse, non era una buona idea fare quell'interrogatorio. E aveva ragione. «Possiamo andare a trovarlo?» chiese Mercè. «Be'...» Quanti di loro erano amici di Daniel e quanti nemici, rivali o avversari? Chi era davvero preoccupato e chi era ansioso di sapere se aveva il tempo di occupare il suo posto prima del suo ritorno? «Per il momento non riceve visite...» Tossicchiai. «È svenuto. Ha perso conoscenza e gli stanno facendo delle analisi. I medici dicono che potrà tornare a casa la settimana prossima.» «Sono contenta!» affermò con un sorriso Giuseppina Bonaparte. «Eravamo così in pensiero!» Diedi alcuni colpetti sui pantaloni con la rigida cartella di cuoio comunicando la mia impazienza. Volevo vedere la professoressa e non potevo passare la mattinata chiacchierando in quella sorta di sala comunale piena di tavoli, sedie e armadi. «Ho un appuntamento con la dottoressa Torrent», mormorai. «Mi starà aspettando.» «Ti accompagno io», si offrì Antonia, quella della frangetta lunga, dirigendosi verso uno stretto corridoio, quasi invisibile dietro ad alcuni alti classificatori. «Porta i nostri saluti a Daniel!» «Certamente, grazie», dissi, seguendo la mia accompagnatrice. Sulla porta dello studio della professoressa c'era un poster con l'immagine gibbosa di un neandertaliano e la scritta: «Dalla scimmia all'uomo. Siviglia. VI giornata di Antropologia Evolutiva». Antonia bussò adagio sul battente di legno e schiuse la porta, introducendo il capo attraverso la fessura. «Marta, c'è il fratello di Daniel.» «Digli di entrare, per favore», concesse una voce bassa e modulata, tanto musicale che mi parve di ascoltare un'annunciatrice della radio o una cantante d'opera. La voce però mi ingannò perché, quando la ragazza con la frangetta si spostò di lato per farmi passare, scoprii che Ona non aveva esagerato circa l'età e il carattere della dottoressa Torrent. La prima cosa che notai furono i capelli corti quasi completamente bianchi e, tra questi e delle sopracciglia anch'esse bianche, una fronte accigliata che mi mise in allarme. Veramente l'espressione cambiò quando i suoi occhi, nascosti dietro occhiali moderni dalla montatura azzurra, molto stretti e con un cordoncino metallico appeso alle stanghette, si alzarono dai fogli che stavano esaminando per fissarsi su di me. Ma io avevo già avuto una sgradevole impressione che non mi avrebbe abbandonato per molto tempo. Se Ona aveva detto che era una strega, doveva essere così perché, a prima vista, non mi era sembrata altro. Lentamente, ma senza esagerare, si tolse gli occhiali, si alzò e girò attorno al tavolo, fermandosi a metà strada senza fare un minimo cenno di saluto. E non sorrideva nemmeno. Sembrava che io le fossi indifferente e quel colloquio fosse uno dei tanti inconvenienti che comportava la sua carica. Bisognava riconoscerle una cosa, però: vestiva con un'eleganza piuttosto insolita in chi si dedica allo studio e alla ricerca. Avevo sempre pensato che le professoresse universitarie di una certa età avessero la tendenza a non curare troppo il loro aspetto, ma, se questo era vero, la signora Torrent - che aveva una cinquantina d'anni e un corpo minuto e snello - non rispondeva a quel parametro. Indossava un tailleur di camoscio, tacchi alti e, come unici accessori, una collana di perle intonata agli orecchini e un largo braccialetto d'argento. Non portava l'orologio. Penso che andasse tutti i giorni a fare la lampada perché era molto abbronzata, al punto da non avere bisogno di fondotinta. «Avanti, signor Cornwall. Si segga, per favore», disse con quella bella voce che sembrava corrispondere a un'altra persona. «Mi chiamo Arnau Queralt, dottoressa Torrent. Sono il fratello maggiore di Daniel.» Se era stata sorpresa dalla differenza di cognome non lo diede a vedere, limitandosi a rioccupare la sua poltrona e a guardarmi fisso in attesa che iniziassi la conversazione. Per fortuna, da buon hacker, il mio bagaglio di abilità sociali - non quello intellettuale o lavorativo - era minimo e le mie risorse provenivano esclusivamente dalla determinazione e dalla forza di volontà, cosicché poggiai la cartella per terra e rimasi in silenzio, chiedendomi da dove dovevo cominciare e che cosa dovevo dire. Il brutto fu che quel silenzio si prolungò per moltissimo tempo perché la dottoressa Torrent era, naturalmente, una donna dura, con una flemma fuori dal normale, capace di rimanere imperterrita di fronte a una situazione che si stava facendo sempre più imbarazzante. «Spero di non disturbarla troppo, dottoressa Torrent», dissi infine accavallando le gambe. «Non si preoccupi», mormorò lei tranquilla. «Come sta Daniel?» Anche lei pronunciava il nome di mio fratello con l'accento sull'ultima sillaba. «Esattamente come il giorno in cui si è ammalato», le spiegai. «Non è migliorato.» «Mi dispiace.» Fu proprio in quel momento, né un secondo prima né un secondo dopo, che scoprii che mi trovavo nello studio di una folle e, cosa ancora peggiore, in sua rischiosa compagnia. Non so perché, ma fino ad allora la mia attenzione si era concentrata esclusivamente sulla professoressa, e non mi ero accorto che ero entrato nella cella psichiatrica di una pazza pericolosa. Se mio fratello aveva centinaia di volumi e di cartelle nel suo piccolo studio di casa, quella donna, godendo del doppio o del triplo di spazio, aveva la stessa congestione libraria e, per di più, aveva incastrato nei buchi gli oggetti più deliranti che si potessero immaginare: lance con punte in silice, brocche in ceramica dipinte grezzamente, pentole rotte a tre gambe, vasi con facce umane dagli occhi sporgenti, strambe sculture in granito di uomini e di animali, frammenti di rozze stoffe colorate appese in alto sulle pareti come fossero raffinati arazzi, lunghe lame di coltello con i bordi scheggiati, idoli antropomorfi con curiosi copricapi simili ai bussolotti per giocare a dadi e, come se non bastasse, su un piedistallo, in un angolo, una piccola mummia rinsecchita, contratta su se stessa, che guardava il soffitto con un gesto scomposto e un grido spezzato. Se avessi potuto avrei fatto come la mummia perché, inoltre, sostenuti da invisibili fili di nylon, a mezza altezza della stanza oscillavano un paio di bei teschi - dal cranio allungato! - mossi dai vortici dell'aria condizionata. Suppongo di aver fatto un bel salto sulla sedia dato che la professoressa, a mo' di risata, fece uno sbuffo dal naso e abbozzò la smorfia di un sorriso. Ma l'Ufficio d'igiene non aveva una rigorosa legislazione sulla sepoltura obbligatoria dei cadaveri o, comunque, sulla loro conservazione nei musei? «Di che cosa voleva parlarmi?» chiese, recuperata la sua compostezza, come se attorno a noi non ci fosse un cimitero. Avevo voglia di non rispondere, però capii che quello strano arredamento era parte di un gioco privato nel quale soltanto lei si divertiva, e controllai a tal punto i miei gesti e la mia voce che, almeno per questa volta, non ottenne il suo trofeo. «È molto semplice», dissi. «Non so se ne è a conoscenza, ma mio fratello soffre di due patologie chiamate agnosia e sindrome di Cotard. La prima non gli permette di riconoscere niente e nessuno, la seconda gli fa credere di essere morto.» I suoi occhi si spalancarono, incapaci di mascherare la sorpresa, e io pensai di aver segnato un punto. «Accidenti!» mormorò, scuotendo il capo come se non riuscisse a credere alle sue orecchie. «No, non lo sapevo... non sapevo niente di tutto que- sto.» La notizia l'aveva colpita abbastanza, e ne dedussi che doveva essere un po' affezionata a mio fratello. «Mi hanno informato dalla segreteria della facoltà che avevamo già il certificato medico, ma... non mi hanno letto la diagnosi, e Mariona non mi ha fornito molti particolari.» Parlando, la dottoressa mostrò una bianchissima fila di denti irregolari. «Sembra che non risponda alla terapia, ma ieri hanno cominciato a somministrargli una cura diversa e ancora non sappiamo che cosa accadrà. Oggi, in ogni caso, non ci sono stati cambiamenti.» «Mi dispiace moltissimo, signor Queralt.» E sembrava che le dispiacesse veramente. «Sì, be'...» Mentre con la mano destra raccoglievo la cartella dal pavimento, con la sinistra mi scostai i capelli dalla faccia, gettandoli indietro. «La questione è che Daniel delira. Passa il giorno e la notte a pronunciare parole astruse e a parlare di cose strane.» Non mosse nemmeno un muscolo del viso. E non batté ciglio. «Lo psichiatra che lo sta curando, il dottor Diego Hernández, della Custòdia, e il neurologo Miquel Llor non sanno come spiegarsi l'origine di quei deliri e suppongono che possano avere una relazione con il suo lavoro.» «Mariona non le ha detto...?» «Sì, mia cognata ci ha spiegato, più o meno, in che cosa consisteva la ricerca che Daniel stava facendo per lei.» Rimase impassibile, incassando freddamente l'accusa. Io continuai: «Nonostante ciò, i medici pensano che potrebbe trattarsi di qualcosa di più della pressione dovuta a un eccesso di lavoro. I suoi deliri in una strana lingua...» «Quechua, senza dubbio.» «... sembrerebbero confermarlo», proseguii. «Forse c'era qualcosa, qualche aspetto particolare della ricerca che lo preoccupava. Qualche circostanza che ha finito, per così dire, per mandare in corto circuito il cervello. I dottori Llor ed Hernández ci hanno chiesto di verificare se aveva avuto dei problemi, se aveva incontrato delle difficoltà specifiche che potessero averlo impressionato troppo.» Da quando avevo deciso di chiedere quel colloquio avevo escluso la possibilità di condividere con la professoressa i miei autentici (e continuavo a pensare anche ridicoli) timori, quindi inventai un pretesto relativamente verosimile nel quale dovevo coinvolgere per forza i medici. «Non so come potrei aiutarvi», dichiarò lei in tono neutro. «Non cono- sco i particolari che mi chiede. Suo fratello mi informava solo di tanto in tanto. Le dirò che nell'ultimo mese non è venuto a trovarmi una sola volta. Se vuole, posso confermarglielo consultando la mia agenda.» Quel piccolo dettaglio metteva ancor più in evidenza la riservatezza adottata da Daniel. «No, non è necessario», rifiutai aprendo la cartella ed estraendo alcuni dei documenti che avevo trovato nello studio di mio fratello. «Ho soltanto bisogno che mi orienti un poco rispetto al materiale che ho portato.» Una corrente elettrica attraversò immediatamente la stanza. Senza sollevare il capo riuscii a percepire che la professoressa si era irrigidita sulla poltrona e che una scintilla di aggressività era sprizzata dal suo corpo. «Questi documenti sono parte della ricerca che stava portando avanti suo fratello?» chiese con un timbro tagliente che mi fece stringere lo stomaco. «Be', le dirò...» replicai senza alterarmi e mantenendo il polso fermo mentre reggevo quelle copie di fronte a lei. «Ho dovuto studiare a fondo il lavoro di Daniel in questa settimana per cercare di rispondere alle domande che ci hanno fatto i medici.» La professoressa era tesa come una corda di violino e pensai che non avrebbe tardato a prendere uno di quei coltelli dagli scaffali per estrarmi il cuore e mangiarselo ancora caldo. Credo che tutti i sospetti e i tradimenti possibili passassero per la sua mente alla velocità di un lampo. Quella donna portava ben visibili le stigmate dell'infelicità. «Mi scusi un momento, signor Queralt», disse alzandosi e facendo il giro del tavolo. «Torno subito. Come ha detto che si chiama?» «Arnau Queralt», risposi, seguendola con lo sguardo. «Di che cosa si occupa, signor Queralt?» «Sono imprenditore.» «E che cosa fa la sua azienda? Produce qualcosa?» chiese dalla porta, sul punto di lasciarmi solo con tutti quei morti. «Potrei spiegarglielo in questo modo: vendiamo sicurezza informatica e sviluppiamo progetti di intelligenza artificiale per motori di ricerca in Internet.» Lasciò scappare un «Oh, capisco!» decisamente falso, e uscì come un fulmine, chiudendo la porta. Riuscivo quasi a sentirla attraverso le pareti: «Chi diavolo è questo tipo? Qualcuno sa se Daniel ha davvero un fratello con un cognome diverso che si occupa di informatica?» E probabilmente le mie supposizioni non erano molto lontane dal vero perché un mormorio di voci e di risa attraversò i muri sottili. Anche se non riuscii a capire le parole, il tono della conversazione - unito ai timori della professoressa e, soprattutto, al modo in cui mi guardava quando ritornò (esaminando i miei lineamenti uno per uno per verificare la somiglianza) - confermò i miei sospetti. Non potevo accusarla di essere eccessivamente diffidente: i documenti che avevo nella mia cartella facevano parte del suo lavoro di ricerca, un lavoro di grande risonanza accademica, secondo Ona, e, in fin dei conti, io ero un perfetto sconosciuto che faceva domande su qualcosa che, in generale, non mi riguardava affatto. «Mi dispiace per l'interruzione, signor Queralt», si scusò recuperando la padronanza di sé e riprendendo il suo posto senza togliermi gli occhi di dosso. «Non si preoccupi», le dissi con un sorriso gentile. «Come le dicevo, ho solo bisogno che mi dia alcune indicazioni. Ma prima lasci che la rassicuri: non vorrei che lei pensasse che io voglia utilizzare in modo inadeguato questo materiale. L'unica cosa che desidero è aiutare mio fratello. Se tutto ciò serve a qualcosa, molto bene; se così non fosse, avrò almeno imparato un paio di cose interessanti.» «Non ero preoccupata.» Già. E io non mi chiamavo Arnau. «Posso dunque mostrarle alcune immagini?» «Naturalmente.» «Prima di tutto, potrebbe spiegarmi perché i teschi che ha appeso al soffitto hanno quella forma appuntita?» «Ah! Lo ha notato! La maggior parte della gente, dopo averli scoperti, non alza più gli occhi e cerca di uscire dal mio studio il più presto possibile.» Sorrise. «Solo per questo valgono già tanto oro quanto pesano, anche se in realtà fanno parte del materiale didattico del dipartimento, come questa mummia...» La indicò con lo sguardo. «Ma a me servono da ottimo repellente per mosche e zanzare.» «Sul serio?» indagai stupito. Lei mi guardò incredula. «Certo che no! Era un modo di dire! Per mosche e zanzare intendevo visite sgradite e studenti fastidiosi.» «Ah! Come me!» Sorrise di nuovo senza dire niente. Era abbastanza chiaro. Sollevai lo sguardo un'altra volta per esaminare i teschi e riformulai la domanda. Dopo un lieve sospiro di rassegnazione, lei aprì uno dei cassetti della scrivania e prese un pacchetto di sigarette e un accendino. Sul piano c'era un piccolo portacenere di carta stagnola con la marca di una nota catena di caffetterie, e questo indicava che il suo vizio di fumare era clandestino, qualcosa le cui prove dovevano poter sparire rapidamente. Oltre al misero portacenere, c'erano anche alcune cartellette e i fogli che stava esaminando al mio arrivo. L'unico oggetto personale era una cornice d'argento di medie dimensioni la cui foto poteva essere vista soltanto da lei. Dove teneva il computer? Ormai non era concepibile un ufficio che ne fosse sprovvisto e, meno ancora, lo studio di una dirigente di dipartimento universitario. Quella donna era strana come un cavo coassiale in un fischietto. «Fuma?» «No, ma non mi dà fastidio.» «Stupendo!» Ero sicuro che per lei sarebbe stato indifferente, se mi avesse dato fastidio; quello era il suo studio. «Il suo interesse per i teschi ha qualcosa a che vedere con quello che ha nella cartella?» «Sì.» Assentì lentamente, come per assimilare la mia risposta, poi dichiarò: «Molto bene, vediamo... la deformazione del cranio era un costume di certi gruppi etnici dell'impero inca, che la usavano per distinguere le classi alte dal resto della società. La deformazione si otteneva applicando delle tavolette alle teste dei neonati e legandole forte con delle corde finché le ossa non prendevano l'aspetto voluto». «Quali gruppi etnici adottavano questa pratica?» «Be', in realtà si tratta di un'usanza anteriore agli incas. I primi crani deformati di cui si ha notizia sono stati rinvenuti nei siti archeologici di Tiwanacu, in Bolivia.» Si fermò un istante e mi guardò, dubbiosa. «Mi scusi, non so se ha sentito parlare di Tiwanacu.» «Non ne sapevo quasi niente fino a pochi giorni fa», le confessai, accavallando le gambe, «ma ultimamente penso di non leggere o parlare d'altro.» «Già. Lo immagino...» Esalò il fumo della sigaretta e si appoggiò alla spalliera, con le mani strette sull'orlo dei braccioli della poltrona. «Bene, Tiwanacu è la cultura più antica del Sudamerica e il suo centro politicoreligioso si trovava nell'omonima città, situata nelle vicinanze del lago Titicaca, oggi diviso in due dalla frontiera tra Bolivia e Perù.» Dalle acque del lago Titicaca, ricordai, era sorto Viracocha, il dio degli incas, per creare l'umanità, e questa, a sua volta, aveva costruito Tiwanacu. Io avevo anche visto un altro lago - un altro lago o lo stesso? - nella mappa disegnata da Sarmiento de Gamboa, quello del «Sentiero degli indios yati- ris». Più tardi sarei ritornato su questo. Ora dovevo terminare con i crani e le teste. «Mi stava dicendo», dissi per farle riprendere il filo, «che gli abitanti di Tiwanacu furono i primi a deformare le teste dei loro neonati per distinguere alcune classi sociali dalle altre.» «È vero. Anche altre culture lo fecero, ma per imitazione e mai nella stessa maniera. A Wari, per esempio, comprimevano la nuca, e nella costa orientale del Titicaca schiacciavano la fronte facendo sporgere le tempie.» «Wari? Che cos'è Wari?» chiesi. Compresi che era sul punto di mandarmi a quel paese perché, per lei, dare una lezione da asilo infantile era inappropriato e, inoltre, noioso. Potevo capirla. Era come se a me avessero chiesto come chiudere le finestre di Windows. «L'impero wari era il grande nemico dell'impero di Tiwanacu», recitò come se lo avesse spiegato mille volte. «Si pensa che Tiwanacu sia iniziato intorno all'anno 200 prima della nostra era con alcuni primitivi insediamenti di una civiltà chiamata Pukará, un popolo di cui ignoriamo quasi tutto, compreso se abbia fondato realmente Tiwanacu, ipotesi che, sicuramente, diventa giorno dopo giorno più improbabile. Infine, nove secoli più tardi, questi assestamenti raggiunsero la forma dell'impero. Wari comparve più tardi, nella valle di Ayacucho, a nord, e, per ragioni che non conosciamo, si mise contro Tiwanacu, che sembra essere stata una cultura di carattere eminentemente religioso governata da una casta sacerdotale. La cosa certa è che di Wari sappiamo poco. Gli incas non li hanno mai nominati. A proposito, non so se sa che chiamare incas tutti gli abitanti dell'impero è un errore: gli incas erano i re e si consideravano discendenti di una stirpe divina originaria di Tiwanacu.» Si, sapevo tutto questo. «Allora», ricapitolai, «le classi privilegiate delle culture andine anteriori agli incas si deformavano il cranio in un modo o nell'altro per emulare i tiwanacotas, che erano una sorta di arbitri dell'eleganza, ma non mi ha detto la provenienza di questi crani conici.» E puntai l'indice verso il soffitto. «Sono di Tiwanacu?» «Sì, in effetti sono di Tiwanacu. La deformazione frontoccipitale, che produce questa forma conica, fu cronologicamente la prima che si realizzò ed era esclusiva dei tiwanacotas.» «Anche gli incas praticavano questa deformazione?» «No, gli incas no. Gli unici che la continuarono furono i collas, i discendenti degli antichi abitanti di Tiwanacu.» «I collas?» Avevo già una confusione mentale impossibile da chiarire. «Ma i discendenti dei tiwanacotas non erano gli aymaras?» «I collas e gli aymaras sono lo stesso popolo. Collas è il nome che gli hanno dato gli spagnoli che avevano chiamato il loro territorio, la zona dell'altopiano che circonda il Titicaca, El Collao, poiché gli incas lo avevano battezzato precedentemente Collasuyo. La zona abbracciava, inoltre, gli altipiani della Bolivia e il nord dell'Argentina. I crani che lei vede qui provengono da Collasuyo; in particolare, come le ho già detto, da Tiwanacu.» Non c'era il minimo dubbio: tutto era semplice e chiaro nella storia del continente americano. Prima ci furono - o no? - i pukará, che diedero origine - o no? - ai tiwanacotas, che, a loro volta, erano gli aymaras, ma anche i collas, anche se ora si chiamavano di nuovo aymaras. Almeno questo lo avevo capito e lo fissai nella memoria prima che sfumasse come un sogno. Di fronte al pericolo che la cosa si complicasse indefinitamente, decisi che ormai ne sapevo abbastanza di teschi deformi e, senza pensarci due volte, estrassi dal mucchio di fotocopie di Daniel quella del muro di pietra con le innumerevoli teste in rilievo e la porsi alla professoressa, che spense la sigaretta contro il piccolo e fragile portacenere come se volesse ammazzarla. Dopo un prima occhiata, la sua faccia espresse disgusto. «Sa che cosa è questo, dottoressa?» «Tiwanacu», disse un po' infastidita, mettendosi gli occhiali con un gesto rapido ed esaminando attentamente il foglio. Non so perché, ma la sua risposta non mi sorprese troppo. «Le cosiddette Teste Pietrificate, cioè teste antropomorfe di pietra conficcate nei muri. Si trovano sulle pareti del Qullakamani Utawi, conosciuto come Tempietto semisotterraneo, un grande patio aperto situato nelle vicinanze del recinto Kalasasaya. Sa già che Tiwanacu è un complesso architettonico nel quale permangono resti visibili di sedici edifici, e questo fa appena supporre un quattro per cento del totale. Il resto si trova sottoterra.» Non sapevo che cosa avesse potuto causare l'evidente malessere che la professoressa reprimeva educatamente. Mentre le porgevo l'ingrandimento digitalizzato dell'omino senza corpo, l'antenato di Humpty Dumpty di Alice nel paese delle meraviglie, annotai mentalmente che non dovevo più chiederle niente su Tiwanacu; quello che volevo sapere lo avrei cercato su Internet, soprattutto le pagine con fotografie. «Non so che cosa sia questo», mi disse guardandomi al di sopra delle lenti. «Non l'ho mai visto in vita mia.» «Non è inca?» mi sorpresi. Lei lo esaminò con estrema attenzione, avvicinando e allontanando l'immagine; ne dedussi che gli occhiali dovevano funzionare in modo intermittente, come una lampadina consumata. Oppure aveva urgente bisogno di una visita oculistica. «No, non è inca», assicurò. «Né inca, né pukará, né tiwanacota, né wari, né, ovviamente, aymara.» «E non ha idea di quale potrebbe essere la sua origine?» Tornò a concentrarsi e corrugò le labbra come se stesse per dare un bacio, lasciandole così per alcuni secondi. Per sfortuna il gesto non si risolse in niente e io trattenni le risa come se avessi ingoiato una gomma da masticare per errore. «Posso dirle soltanto che è troppo figurativo. Il personaggio è perfettamente disegnato, con colori molto vivi e sfumature e gradazioni che gli danno volume. La barba lo colloca in Europa o in Asia e, per tutte queste ragioni, non deve essere anteriore al secolo XIV. Di sicuro farà parte di una rappresentazione molto più ampia, poiché i bordi ritagliano quello che sembra un paesaggio di pietre e di rami. L'unica cosa che mi risulta vagamente familiare è quel copricapo rosso, che potrebbe assomigliare ai tipici berretti collas che coprivano i crani deformi. Guardi con attenzione questi idoli», mi chiese, indicando le statuine con il copricapo a bussolotto. «Se vuole, può anche esaminarli più in dettaglio nell'opera di Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno. Suo fratello deve averne una copia.» «Sì, in effetti», confermai, riprendendo l'omino con una mano mentre con l'altra le porgevo la fotocopia della faccia quadrangolare con i raggi solari. «Tiwanacu», ripeté subito dopo aver dato un'occhiata, e di nuovo il suo volto si contorse e la sua voce, tanto particolare, assunse un timbro cupo. «Inti Punku, la Porta del Sole. Per secoli si è pensato che questa figura, che corona il monumento, fosse una rappresentazione del dio Viracocha. La scoperta di Wari ha fatto vacillare questa ipotesi e ora si preferisce parlare di uno sconosciuto Dio dei Bastoni, adorato da entrambe le civiltà.» «Per questo mi sembrava tanto familiare», commentai chinandomi leggermente sul tavolo per osservare l'immagine capovolta. La Porta del Sole. Era molto famosa. Si alzò come se le frullasse in testa un'idea importante e si avvicinò a uno scaffale da cui estrasse un grosso libro, che collocò sul tavolo davanti a me. Era un volume di fotografie, uno di quelli che quasi non hanno testo. Quando lei si scostò, nelle pagine aperte intravidi, a sinistra, la riproduzione di un blocco di pietra con un vano a mo' di porta nella cui parte superiore comparivano, in rilievo, tre bande orizzontali tagliate da una figura centrale di notevoli dimensioni; il suo volto, senza possibilità di errore, era quello che Daniel aveva ingrandito nella fotocopia. Nella pagina di destra si vedeva, con tutti i particolari, la stessa figura molto più grande, cosicché non solo ne riconobbi le sembianze, ma anche, inaspettatamente, ciò che aveva sotto i piedi - se si potevano chiamare piedi quel paio di monconi che gli uscivano dal tronco -, che altro non era se non la piramide a gradini di tre piani, disegnata da mio fratello con il pennarello rosso. Perché Daniel aveva ingrandito la testa ed evidenziato in rosso la base del Dio dei Bastoni? «Questa è la Porta del Sole, che in quechua si chiama Inti Punku, in aymara Mallku Punku, o Puerta del Cacique», mi spiegò. Io in quel momento non la stavo guardando e, pertanto, non potevo vedere la sua espressione, la sua voce tuttavia acquisiva sempre più delle tonalità cupe, cariche di irritazione, la qual cosa mi obbligò a sollevare gli occhi dal libro. Scoprii con sorpresa che aveva il viso imperturbabile di una statua e che solo le sue mani erano contratte per la tensione. «È il monumento più famoso delle rovine di Tiwanacu. È stato costruito con blocchi monolitici di pietra vulcanica di più di tredici tonnellate di peso, di circa tre metri di altezza, quattro di lunghezza e cinquanta centimetri di profondità. Il taglio della pietra è perfetto, preciso... Gli archeologi e gli esperti non si spiegano ancora come abbia potuto essere realizzato da un popolo che non conosceva né la ruota né la scrittura né il ferro né, e questo è ancora più sorprendente, il numero zero, tanto necessario per i calcoli astronomici e architettonici.» Forse la professoressa era una donna dura, forse anche un'arpia; sicuramente Ona non si sbagliava nelle proprie opinioni su di lei, ma io avrei aggiunto che era pazza da legare. Nel giro di pochi minuti era passata dall'essere tesa come una corda di violino alla normalità e di nuovo alla tensione senza che potessi spiegarmene le ragioni. La dottoressa Torrent non riusciva a mascherare un evidente carattere ciclotimico e non poteva farlo perché, anche se controllava i movimenti e i gesti del volto, la sua voce, così bassa e particolare, la tradiva. Quello era il suo tallone di Achille, la crepa che mandava in rovina la muraglia. Cercando una ragione logica che avrebbe potuto provocare il suo malumore, pensai che forse avevo prolungato eccessivamente la mia visita e che sarebbe stato opportuno an- darmene al più presto. Proprio in quel momento lei fissò gli occhi su di me, e il suo sguardo era talmente glaciale che fui sul punto di avviarmi verso la porta camminando umilmente all'indietro e facendo le riverenze, come i cortigiani quando si congedavano dall'imperatore. «Cos'altro ha in quel mucchio di fogli?» mi chiese a bruciapelo. «Vuole che gliene parli o preferisce vederli lei direttamente?» «Mi faccia vedere», ordinò tendendo il braccio perché le consegnassi il fascio di documenti. Non rimaneva molto da esaminare: oltre alle fotografie dei crani tiwanacotas, che lei non aveva ancora visto, mancavano solo il disegno della piramide a scalini, le riproduzioni dei tessuti e delle brocche decorate con file e colonne di quadrati, le fotocopie delle mappe delle rose dei venti e quelle di Sarmiento de Gamboa. Si soffermò a lungo a osservare il materiale come se tutto fosse nuovo per lei ed enormemente interessante. In capo a cinque o sei eterni e noiosissimi minuti aprì un cassetto del tavolo e ne tirò fuori una lente di ingrandimento come quella di Sherlock Holmes, ma di legno scuro e riccamente intagliato; così a prima vista, mi venne in mente che doveva valere un patrimonio. Un oggetto simile non si poteva trovare con facilità nei negozi di antiquariato di Barcellona. Con gli occhiali appoggiati sulla fronte, guardando attraverso la lente, esaminò le antiche mappe con un interesse straordinario, al punto da farmi pensare di aver commesso l'errore più grande della mia vita a combinare quell'incontro. Se mio fratello fosse guarito con la nuova cura e quella donna, per colpa mia, si fosse appropriata del materiale di ricerca, avrei fatto una gaffe inimmaginabile, ed era persino possibile che mio fratello non mi rivolgesse più la parola per il resto della sua vita... o della mia, a seconda di chi moriva prima. Finalmente, dopo moltissimo tempo, la dottoressa Torrent emise un lungo sospiro, poggiò la lente e i documenti sul tavolo e si tolse gli occhiali per guardarmi dritto negli occhi. «Tutto questo lo ha trovato in casa di Daniel?» chiese modulando la sua voce radiofonica in un modo che mi ricordò il sibilo di un serpente (o almeno come suonava il sibilo di un serpente nei film). «Sì, a casa sua», ammisi, pronto ad andarmene di corsa, con tutta la documentazione. «Mi permetta di farle una domanda... Lei crede che tutto questo abbia una relazione con la malattia di cui soffre suo fratello?» Schioccai la lingua prima di rispondere a quella domanda così diretta e, in quel breve spazio di tempo, appena un decimo di secondo, decisi che non avrei più detto mezza parola su niente. «Le ho già spiegato che i medici vogliono sapere se Daniel poteva aver avuto dei problemi con il lavoro.» «Già... Ma non mi riferisco precisamente a questo.» Appoggiò le mani sul bordo del tavolo e si alzò. «Vede, questo materiale, nel complesso, rivela che suo fratello seguiva una linea di ricerca molto diversa da quella che gli avevo affidato. Non vorrei che lei la prendesse a male... tuttavia, in qualche maniera che non riesco nemmeno a immaginare, Daniel ha preso in prestito questi documenti proprio da questo studio... Senza comunicarmelo.» Stava insinuando che mio fratello aveva rubato? Che imbecille! Mi alzai anch'io e la affrontai. Nonostante fossimo separati dall'ampio tavolo, la mia statura mi permetteva di guardarla dall'alto in basso con tutto il freddo disprezzo di cui ero capace. Ed ero capace di molto in situazioni come quella. Per una frazione di secondo, involontariamente, diressi lo sguardo verso la fotografia incorniciata che stava sul tavolo e che ora vedevo con chiarezza, e le mie retine ritennero il riflesso sul vetro di un uomo anziano barbuto e sorridente, con le braccia appoggiate sulle spalle di due ragazzi di una ventina d'anni. La tipica famiglia felice in stile americano. E Doris Day osava insultare mio fratello, la persona più onesta e corretta che io abbia mai conosciuto in vita mia! L'unica ladra era lei, che voleva impadronirsi nella maniera più sporca del lavoro di Daniel. «Ascolti, dottoressa Torrent», sillabai minaccioso. «Non perdo spesso il controllo, ma, se sta dicendo che mio fratello Daniel è un ladro, questa conversazione terminerà molto male.» «Mi dispiace che lei la prenda così, signor Queralt... Posso solo dirle che non si porterà di nuovo via questa documentazione.» Aveva coraggio, la dottoressa. «Se Daniel stesse bene, avrei con lui un colloquio, e sono sicura che risolveremmo questa deplorevole situazione. Siccome è malato, devo limitarmi a recuperare ciò che è mio e a chiederle di essere rispettoso e di osservare, per il bene di suo fratello, il silenzio più assoluto su questa faccenda.» Sorrisi e, con un rapido colpo di mano, recuperai i documenti che lei aveva lasciato sul tavolo, presumibilmente fuori dalla mia portata. Non ho mai sopportato l'imbecillità, e ancor meno gli insulti, e se uno stupido (o stupida, come in questo caso) qualsiasi immaginava di prendermi in giro e di impedirmi di fare quello che volevo, si sbagliava di grosso. «Mi ascolti bene, dottoressa. Non sono venuto qui con l'intenzione di li- tigare con il capo di mio fratello, ma non le consentirò nemmeno di inventare una storia nella quale Daniel è un ladro e lei una povera vittima derubata. Mi dispiace, signora Torrent, ma me ne vado portandomi via tutto.» E mentre lo dicevo infilai di nuovo nella mia cartella le fotocopie e le riproduzioni, e mi incamminai verso l'uscita. «Quando mio fratello starà meglio, risolverete tra di voi la questione. Buon giorno.» Aprii con un gesto brusco e me ne andai sbattendo la porta. Non c'era più nessuno nel dipartimento. Il mio orologio con il capitano Haddock segnava quasi le due e mezzo del pomeriggio. Ora di pranzo e, perché no, ora di sputare fuori tutti gli insulti che conoscevo contro quell'idiota; le dovettero fischiare le orecchie nei quaranta minuti che impiegai per arrivare a casa e per cancellarla per sempre dalla mia vita. Non andai alla partita e non ne sentii la mancanza. Passai la maggior parte del pomeriggio in ospedale con Daniel, poi andai a cena con Jabba, Proxi e Judith, un'amica di Proxi con la quale, anni prima, ero uscito per alcuni mesi. Judith era una persona stupenda di cui, sicuramente, ci si poteva fidare, e, anche in caso contrario, sarebbe stato lo stesso, perché prima di incontrarci nel ristorante Proxi le aveva raccontato tutto ciò che c'era da raccontare. Così stavano le cose. Di fronte al fatto compiuto, mi sfogai tranquillamente criticando la professoressa e, a forza di fare battute su di lei, finì per passarmi la rabbia. L'unico aspetto negativo della serata fu che, se non avessi avuto la casa piena di gente che diceva di essere la mia famiglia, Judith sarebbe rimasta da me; tra noi c'era ancora una certa attrazione fisica e a nessuno dispiaceva approfittare delle occasioni. Ma non era proprio il mio giorno fortunato e la cosa finì lì. Per risollevarmi, e siccome non avevo sonno, alle due di notte, dopo aver verificato che i computer dell'azienda continuassero a cercare la benedetta password di Daniel, decisi che era un momento come un altro per avventurarmi, infine, nelle maledette cronache dei conquistatori spagnoli. Ora non si trattava soltanto di confermare una stramba teoria; la faccenda si era trasformata per me in una sfida, in una questione di lealtà nei riguardi di mio fratello. Avevo sbagliato esponendo il suo lavoro alla rapacità del suo capo e dovevo compensarlo in qualche maniera. Se fosse guarito, grazie alla magia delle parole di cui parlavano Jabba e Proxi (e anche Judith, che si associò entusiasta all'idea) o alle medicine di Diego e Miquel (il che era più probabile), avrei avuto qualcosa di interessante da offrirgli, un'idea che lui potesse esplorare, un miraggio che, forse, avrebbe potuto fargli vincere un giorno un pre- mio Nobel umiliando così quell'idiota del suo capo. Cominciai, ovviamente, dalla Nueva Crónica y buen gobierno, scritta da Felipe Guamán Poma de Ayala all'inizio del XVII secolo. Mi scoraggiai al pensiero di affrontare i tre volumi che formavano l'immensa opera di quell'indio della nobiltà peruviana, che aveva creduto di poter commuovere l'anima compassionevole e cristiana del re Filippo III di Spagna narrandogli la verità di ciò che stava accadendo all'antico impero inca fin dai primi anni della conquista. Questo era, almeno, ciò che riferiva l'introduzione, oltre al difficoltoso pellegrinaggio del manoscritto finché non era stato scoperto a Copenaghen, all'inizio del XX secolo. Bevvi un paio di sorsi dalla mia bottiglia d'acqua e diedi una rapida occhiata agli appunti che mio fratello aveva lasciato, piegati, tra le pagine del primo volume. Per fortuna Daniel aveva scritto quegli appunti con il computer - stampandoli poi sui fogli usati dal Dipartimento di Antropologia Sociale - salvandomi così da uno dei due principali scogli contro i quali temevo di scontrarmi: decifrare la sua grafia e capire il contenuto. Quando cominciai a leggere, mi astrassi da tutto ciò che mi circondava e, senza rendermene conto, in quel preciso istante smisi di andare alla cieca e incominciai a percorrere, sulle orme di Daniel, il sentiero che lui aveva esplorato da solo appena alcuni mesi prima. Si diceva che, fin dal primo momento della scoperta dell'America, nel 1492, ai re spagnoli si presentò una questione giuridica sorprendente: dovevano giustificare la necessità della conquista e della successiva colonizzazione del Nuovo Mondo perché, in qualsiasi altro caso, la legislazione dell'epoca (come quella attuale) non permetteva che uno Stato distruggesse e usurpasse quello che non gli spettava. Esisteva la cosiddetta Legge Naturale che proteggeva il diritto dei popoli alla sovranità sui propri territori. Così i grandi dotti castigliani del XVI secolo dovettero lambiccarsi il cervello per trovare scuse assurde e motivi senza fondamento che permettessero di affermare inconfutabilmente che le Indie Occidentali non appartenevano a nessuno quando Colombo raggiunse le loro coste, perché gli indigeni che vi si trovavano non erano legittimi e non avevano dei veri re che potessero certificare la proprietà naturale del territorio. A tal fine, nel 1570, il nuovo viceré del Perù, don Francisco de Toledo, su mandato di Filippo II, ordinò una Visita Generale a tutto il territorio del vicereame per elaborare delle Informaciones in base alle quali si sarebbe dimostrato che gli incas avevano rubato la terra ad alcuni disgraziati, incolti e selvaggi indigeni che da allora erano vissuti sotto la loro tirannia; ciò avrebbe giu- stificato «legalmente» l'appropriazione dell'impero incaico da parte della corona spagnola. Questo, com'è ovvio, diede luogo a numerosi abusi, alla falsificazione di dati e alla modificazione della storia che i visitatori ascoltavano dalla bocca dei civilizzati, ben nuriti e, nella maggioranza, felici abitanti dell'impero. Questi, tanto per cominciare, non conoscevano il denaro perché non ne avevano bisogno, avevano riserve ovunque di alimenti per più di sei mesi e non stabilivano grandi diversità sociali tra uomini e donne, anche se svolgevano compiti differenti. Il mio sguardo si fissò, all'improvviso, su una frase curiosa: «Durante la Visita Generale ordinata dal viceré, fungeva da storico e Alfiere Generale un tale Pedro Sarmiento de Gamboa, che per cinque anni aveva percorso senza posa il Perù coloniale raccogliendo dagli indigeni più anziani di ogni luogo dati sociologici, geografici, storici ed economici». Pietro Sarmiento de Gamboa? Lo stesso Pietro Sarmiento de Gamboa del «Sentiero degli indios yatiris. Due mesi per terra»? Ero talmente euforico che non riuscii a evitare di alzarmi e di muovere un poco il mio scheletro al suono di un samba inesistente e silenzioso. Avevo un pezzo del rompicapo! Gli elementi cominciavano a combaciare. Era una vittoria di Pirro, ma era qualcosa di più di quello che sapevo prima. Lasciandomi trasportare dall'intuizione, feci una rapida ricerca nella rete su Pietro Sarmiento de Gamboa, e quale non fu la mia sorpresa quando scoprii che quel tipo era stato un personaggio molto importante nel XVI secolo, una figura di spicco. In base a ciò che diceva la pagina che stavo consultando, era stato navigatore, cosmografo, matematico, militare, storico, poeta e studioso delle lingue classiche. Non solo aveva esplorato il Pacifico e scoperto più di trenta isole, tra le quali le Salomone, ma era stato anche il primo governatore delle province dello Stretto di Magellano; aveva partecipato alle guerre contro gli incas ribelli, aveva effettuato la Visita Generale al vicereame del Perù, inventato uno strumento di navigazione chiamato balaustrino, (che serviva per calcolare in modo approssimato la longitudine, un dato sconosciuto ai suoi tempi) e scritto una Historia Incaica. Inoltre, era stato rapito dal corsaro Richard Grenville e condotto in Inghilterra, dove aveva stretto amicizia con sir Walter Raleigh e con la regina Elisabetta, con la quale comunicava in un perfetto latino. E, come se non bastasse, in due occasioni aveva dovuto vedersela con la Santa Inquisizione, che era pronta a bruciarlo vivo in qualsiasi pubblica piazza di Lima (chiamata allora Ciudad de los Reyes, Città dei Re) come stregone e astrologo, più precisamente per la fabbricazione di anelli d'oro che attira- vano la buona sorte. Accusato di negromanzia e di «pratiche magiche con strumenti», era stato costretto a scappare e a rifugiarsi a Cuzco. Dieci anni più tardi, esattamente con le stesse accuse (con la differenza che questa volta si trattava di un inchiostro capace di far nascere l'amore o qualsiasi altro sentimento in chi leggeva quello che si scriveva con tale mezzo), era finito nelle carceri segrete del Sant'Uffizio. Dunque, ero arrivato al punto di riuscire a leggere la mappa che Daniel aveva fotocopiato o, almeno, di poterla situare storicamente con una certa precisione perché Pedro Sarmiento de Gamboa aveva terminato la Visita Generale nel 1575, cinque anni dopo averla iniziata, e si era trasferito (o lo avevano portato) a Ciudad de los Reyes, dove, all'inizio di quello stesso anno, era stato processato dall'Inquisizione e incarcerato in luglio. Sarmiento affermava di aver terminato la mappa del «Sentiero degli indios yatiris» il 22 febbraio e, in base a un documento del Tribunale della Santa Inquisizione di Lima,10 nell'inventario degli oggetti confiscati a Sarmiento il 30 luglio dall'ufficiale giudiziario del Sant'Uffizio, don Alonso de Allaga, comparivano «tre tele dipinte di luoghi e di terre di indios». Secondo le enigmatiche note di mio fratello, quelle tele partirono per la Spagna molti anni dopo assieme ad altri oggetti e documenti di Sarmiento de Gamboa, rimasero nell'Archivio delle Indie di Siviglia per un secolo circa e ricomparvero per un breve periodo nella Casa del Commercio di quella stessa città prima di concludere il loro viaggio, va a sapere perché, nel Deposito Idrografico di Madrid, dove sembra si trovassero in quel momento e dove, ne dedussi, li aveva scoperti Daniel. Dovevo però ancora capire quale fosse il lago da cui partiva il «Sentiero degli indios yatiris», ma questa fu la cosa più facile di tutte, perché mi bastò cercare in rete una mappa dell'altopiano boliviano per scoprire che i profili del Titicaca corrispondevano proprio a quelli disegnati da Sarmiento de Gamboa e che la grande città che aveva tracciato a sud si adattava perfettamente all'ubicazione delle rovine di Tiwanacu. Quello che ancora non era molto chiaro era il percorso del sentiero che, partendo da lì, scendeva dagli oltre quattromila metri di altezza in cui si trovava la città per inoltrarsi nella foresta e seguire il corso di un fiume senza nome. Quest'ultimo riuscii a identificarlo nella mappa del mio schermo, per la complessità degli affluenti che, come il sistema circolatorio di un corpo umano, si intersecavano, si sovrapponevano e si intrecciavano fino a formare una matassa aggrovigliata di fili d'acqua impossibile da districare. Il disegno si interrompeva bruscamente a causa dello strappo di quello che io, in un primo momento, avevo preso per un lenzuolo con i bordi sfilacciati, cosicché non era possibile sapere dove conducesse quel sentiero di orme di formica che si addentrava nell'Amazzonia. Comunque non era rilevante per la mia ricerca; la cosa significativa l'avevo già trovata: nei cinque anni in cui aveva percorso il Perù per scrivere le Informaciones della Visita Generale, Pedro Sarmiento de Gamboa si era incontrato con gli yatiris a Tiwanacu e aveva disegnato una mappa che mio fratello aveva considerato importante, dopo di che l'Inquisizione lo aveva incarcerato per aver creato l'inchiostro magico. Mi imbattevo di nuovo nella magia delle parole, il «Supercalifragilisticoespiralidoso» che tanto piaceva a Proxi. Era ovvio che mio fratello aveva lasciato quegli appunti nel primo volume della Nueva Crónica y buen gobierno perché avevano una certa attinenza con il fatto che l'indio Felipe Guamán avesse sentito la necessità di scrivere quasi milleduecento pagine per confutare le menzogne delle Informaciones della Visita Generale. Mi armai quindi di coraggio, guardai l'orologio - erano quasi le quattro del mattino - e affrontai la lettura. Non avevo sonno ma, anche se lo avessi avuto, mi sarei svegliato soltanto dando uno sguardo alle straordinarie illustrazioni di quel libro. Abituato alle moderne immagini digitali create a computer, con vettori in movimento e milioni di colori, capaci persino di ricreare virtualmente la realtà, l'impatto con i rozzi disegni in bianco e nero di Guamán Poma fu brutale, devastante, come se una scarica elettrica mi avesse formattato l'hard disk del cervello lasciandomi disarmato di fronte a quelle grezze illustrazioni: ce n'erano quattrocento in totale, intercalate nel testo. Era come un fumetto in cui l'azione si visualizza e si sviluppa nelle vignette, con l'unica differenza che quell'opera aveva circa quattrocento anni. Ad attirare la mia attenzione fu, in primo luogo, un disegno in cui si vedeva Viracocha (nel quechua di Guamán, Vari Vira Cocha Runa) vestito di foglie sotto un sole brillante dal volto gioviale, simile a una di quelle faccine, dette smiley o emoticon, che circolano nella rete per rappresentare, in modo rapido e semplice, con segni di punteggiatura, stati d'animo o comportamenti. Per quello che riuscii a vedere, tutti i soli disegnati da Guamán avevano una faccia e tutti esprimevano con smorfie da emoticon il loro parere su ciò che appariva nella scena. Ma la cosa più significativa del disegno era la barbetta che, per ricordare la sua origine divina e non india, era stata messa a Viracocha: quattro peli di baffi e un pizzetto come il mio. Si distingueva un'altra immagine, quella di uno scudo con le armi reali o con simboli incas. Era evidente dalla forma che si trattava di un'imitazione degli scudi spagnoli e non dei rettangolari walqanqa, ma c'era qualcosa di geniale in quella mescolanza di un campo crociato, delimitato da decorazioni a volute barocche, con quelle ingenue rappresentazioni di un sole barbuto chiamato Inti, una luna chiamata Quya, una splendente stella a sedici punte, Willka, e un idolo antropomorfo situato su una collina. Frastornato dall'ubriacatura iconografica in bianco e nero in cui ogni scena era un mondo di particolari nel quale smarrirsi, persi la percezione dell'insieme ignorando completamente il color giallo fosforescente dei brani evidenziati da mio fratello, così come avrei ignorato tranquillamente un semaforo rosso mentre guidavo. Ci sono immagini, o tipi di immagini, musiche, odori, sapori o forme che hanno il potere di staccarci dal mondo reale, cosicché, fino a quando non mi ripresi dall'impressione, non notai che Daniel mi aveva di nuovo indicato la strada mettendo in evidenza in giallo fosforescente parole, frasi, paragrafi importanti. La prima sottolineatura si trovava sotto al disegno di un altro scudo barocco con altri simboli reali (un uccello, un certo tipo di palma, una piuma e due serpenti), e metteva in risalto una frase in cui si affermava che «loro», gli incas, erano originari della «laguna del Titicaca e di Tiahuanaco» e che gli otto fratelli e sorelle yngas primigeni, partendo dal «Collau», erano giunti a Cuzco e avevano fondato la città. Nel paragrafo seguente Guamán Poma, con la collaborazione biliosa di Daniel C, affermava, nientedimeno, che tutti coloro che avevano orexas, cioè orecchie, si chiamavano incas, gli altri no. In un primo momento mi preoccupai all'idea che gli oltre ventinove milioni di abitanti del Tahuantinsuyo che non facevano parte della nobiltà potessero essere privi di orecchie. Subito però ricordai la leggenda secondo cui i discendenti diretti dei figli di Viracocha formavano la nobiltà Orejona, che per distinguersi da coloro che non avevano sangue solare inseriva grandi dischi d'oro nei lobi delle orexas. Ed effettivamente era così, perché nella pagina seguente a quella dei secondi simboli si vedeva il primo inca, Manco Capac (Capac significava potente), con un oggetto rotondo su ciascun lato della testa simile a un enorme padiglione auricolare. Di colpo mi tornò in mente un particolare curioso. Proxi non aveva detto che i sacerdoti-astronomi che governavano Tiwanacu si chiamavano «Capacas»? Capac era forse una derivazione di Capaca? C'era soltanto un modo per verificarlo: usare il dizionario di Ludovico Bertonio, che però mio fratello aveva a casa sua. Non mi rimase altra soluzione che cercare in Internet, ma la fortuna mi arrise e non tardai a trovare un accesso libero al dizionario attraverso la biblioteca virtuale dell'università di Lima, in Perù. Un Bertonio trascritto nelle pagine web mi confermò, effettivamente, che Capaca voleva dire re o signore, anche se faceva notare che era una parola molto antica (lo diceva nel 1612) ormai caduta in disuso. Così le leggende incas avevano una parte di ragione e, forse, Manco Capac o Capaca e la sua sposa-sorella Mama Ocllo provenivano effettivamente da Tiwanacu, e da lì erano saliti verso nord per fondare Cuzco e l'impero inca. Manco Capac era abbigliato elegantemente. Indossava un grande mantello sul vestito, e aveva un cordone attorno alla testa con un ornamento sulla fronte, sandali aperti, lacci sotto le ginocchia e, nelle mani, uno strano parasole e una lancia. Ma ciò che attrasse maggiormente la mia attenzione furono le decorazioni del vestito: una fascia di tre righe di piccoli rettangoli uguali a quelli delle fotocopie dei tessuti di Daniel che attraversavano orizzontalmente la stoffa, all'altezza della vita. Questa volta, però, li osservai con più attenzione e scoprii al loro interno stelline, rettangolini, accenti allungati, rombi con dei punti nel centro. E i motivi si ripetevano tre volte ciascuno, in diagonale. Mi chiesi che cosa avessero di tanto insolito quei disegni da indurre mio fratello a raccoglierli. Mi fece sobbalzare la luce del grande schermo sulla parete, che si accese all'improvviso per informarmi che mia madre si era appena svegliata. Mentre mi voltavo a guardare, l'immagine si divise a metà e, sulla finestra destra, poco illuminata, comparve lei che saltava giù dal letto con una pudica camicia da notte di raso verde. La mia casa, ovviamente, era dotata di ogni genere di sensori di movimento, e inoltre il sistema di identificazione distingueva perfettamente ciascuno dei membri della mia famiglia. Sospirai avvertendo un'ondata di crescente disperazione mentre la osservavo avanzare per i corridoi come il Titanic verso l'iceberg. Persino quando percepii il suo sguardo sulla nuca e la sua immagine sul display mi segnalò che si trovava esattamente dietro di me, sulla soglia, nutrii ancora la vana speranza che prendesse un'altra direzione e sparisse. «Si può sapere che stai facendo a quest'ora?» mi rimproverò, venendo avanti e fermandosi di fronte allo schermo in cui poteva vedere se stessa con le braccia ad anfora, la camicia da notte verde, i capelli ritti e la faccia arrabbiata. «E si può sapere perché mi spii? Non ricordo di averti insegnato a spiare quando eri piccolo!» «Sto leggendo.» «Leggendo?» si indignò. «No, vedrai che alla fine dovrò fare quello che facevo quando avevi dieci anni! Spegnere la luce con le buone!» Mi misi a ridere. «E io accenderò una pila, come facevo allora.» Sorrise anche lei. «Credi che non lo sapessi?» chiese, avvicinando una poltrona e accomodandosi. La notte era persa. «Ricordo ancora i contenitori di pile, i cavi elettrici e quelle lampadine piccolissime con cui costruivi le torce per leggere sotto le coperte. Sai che tuo fratello ti ha copiato l'idea? Quando vivevamo a Londra e tu eri in collegio al La Salle, lui faceva la stessa cosa, con la differenza che tu leggevi fumetti e lui libri seri. Era molto sveglio per la sua età!» Avevo già detto che Daniel era il figlio preferito di mia madre? «Chaucer, Thomas Malory, Milton, Shakespeare, Marlowe, Jonathan Swift, Byron, Keats...» «Va bene, mamma. Ho sempre saputo quanto fosse intelligente mio fratello.» Per lei la cultura si riduceva al campo umanistico. La mia professione non avrebbe mai raggiunto la categoria di «rispettabile» e, ovviamente, non sarebbe mai stata altro che un passatempo adolescenziale. Mia madre guardava con più considerazione un ciabattino o un imbianchino che me; per lo meno il calzolaio o l'imbianchino facevano qualcosa di utile. Naturalmente, da questa prospettiva, Daniel aveva sempre la meglio: antropologo, docente universitario, erudito, accoppiato e con un bel figlio. Io che titoli avevo? Che cos'era questa storia di Internet? Perché ero ancora scapolo e non ero fidanzato? Perché non le davo dei nipoti? Nella sua ultima visita aveva detto chiaro e tondo che, sebbene avessi fatto i soldi, sarei sempre stato il più grande fallimento della sua vita, e in quel preciso momento avevo l'impressione che fosse sul punto di ripetere quella sgradevole considerazione. «Devi fare qualcosa, una volta o l'altra, Arnie», mi rimproverò affettuosamente. «Non puoi continuare così. Ormai hai trentacinque anni. Sei un uomo ed è ora che tu prenda delle decisioni importanti. Clifford e io abbiamo pensato di fare testamento... Sì, so che è ancora presto, ma Clifford si è incaponito e io, di certo, non mi tiro indietro. Sarebbe una sciocchezza, non ti pare? Te lo dico perché abbiamo pensato di lasciare a Daniel una parte maggiore che a te... Spero che non ti dispiaccia, tesoro. Lui non ha le risorse che hai tu, si sa che i professori non guadagnano molto. Inoltre ha un figlio e, probabilmente, ne avrà altri, perché lui e Ona sono ancora giovani. Quindi...» «Non mi dispiace, mamá», affermai, convinto. Che cosa me ne importava? E poi, per quello che ne sapevo, già da molto tempo mia madre lo aiu- tava con piccole somme di denaro mensili e pagandogli il mutuo dell'appartamento di calle Xiprer. Mi sembrava giusto che mio fratello ricevesse più di me, anche se non potevo evitare di notare la mano di Clifford dietro a tutto ciò. Clifford era un brav'uomo e ci volevamo bene, ma Daniel era suo figlio e io no. Per fortuna, comunque, a me non mancavano i soldi e a mio fratello, che guarisse o no, avrebbero sempre fatto comodo. «Certo, se tu avessi dei figli la questione non si sarebbe nemmeno posta. Per noi siete tutti e due perfettamente uguali. Sai quanto ti vuol bene Clifford. Ma finché rimani scapolo, non si discute. Comunque non stiamo per morire. Non ancora. Adesso che... ti dico anche un'altra cosa: se entro pochi anni troverai una brava ragazza come Ona e ti sposerai, o andrai a convivere o come si dice, e avrai dei figli, allora si rifà il testamento e basta!» Non potevo crederci. «Stai dicendo che se mi sposo e ho dei figli mi lascerai in eredità più denaro?» Mia madre riusciva sempre a sbalordirmi. Credeva forse che con quell'argomento totalmente inutile poteva obbligarmi a cambiare vita? Il labirinto dei suoi pensieri era proprio assurdo. «Certo! Credi che io, io!, sarei così ingiusta da fare delle discriminazioni tra i miei nipoti? Mai! Sarebbero tutti uguali per me! Come ti è venuta in mente una cosa simile? Arnau, per favore! Sembra che tu non conosca tua madre, figlio mio!» Stavamo parlando da appena cinque minuti di orologio e io ero già nauseato e con una terribile angoscia alla bocca dello stomaco. «Vieni con me, mamá», le dissi alzandomi e prendendole la mano come se fosse una bambina piccola. Aveva soltanto sessant'anni compiuti da poco e si conservava stupendamente, molto meglio della dottoressa Torrent, per esempio, che con quei capelli bianchi sembrava una vecchia. Mia madre, grazie alla ginnastica, alla chirurgia estetica e alle tinture, ne dimostrava appena cinquanta. «Dove andiamo?» volle sapere mentre si alzava a sua volta per seguirmi. «In cucina. Vado a prepararmi un tè e tu berrai un bicchiere di latte caldo.» «Scremato!» «Certo. E poi», le sussurrai percorrendo il corridoio e tenendola per mano, «andrai a letto e mi lascerai lavorare, d'accordo?» Fece una risatina allegra (le piaceva molto che Daniel e io la trattassimo in quel modo) e si lasciò guidare docilmente senza dire una parola. Ringraziai Viracocha quando vidi che beveva il latte senza aprire bocca e mi dava un bacio veloce sulla guancia prima di perdersi di nuovo nella penombra. Erano le cinque e mezzo del mattino di domenica. Ebbi la tentazione di uscire in giardino per contemplare il cielo, ma Guamán Poma mi stava aspettando e la notte ormai stava finendo. Non potevo andare a letto senza saperne un po' di più. Quando mia madre tornò a dormire, il sistema cancellò dal monitor sulla parete le immagini delle videocamere della sua stanza. Sapendo che poteva far giorno senza che me ne rendessi conto, dissi al computer di avvisarmi alle sette e gli chiesi informazioni su come procedeva la ricerca della password di Daniel. La risposta si proiettò sia sullo schermo gigante sia sui tre monitor che avevo distribuito nello studio; la password doveva essere una stringa superiore ai sei caratteri visto che, al di sotto di questi, nessuna combinazione aveva dato risultati. Scrissi un paio di istruzioni per avere un'istantanea del processo e controllare quale tipo di serie stesse verificando il sistema in quel momento. Una cinquantina di parole di sette caratteri comparvero sul fondo nero alternando maiuscole e minuscole, numeri, spazi bianchi e simboli speciali (punti esclamativi, parentesi, trattini, virgolette, parentesi quadre, barre, tildi, tutti i tipi di punti, accenti eccetera...). La faccenda si stava progressivamente complicando perché le combinazioni di nove o dieci caratteri avrebbero potuto consumare tutte le risorse del sistema. Se la parola non fosse comparsa subito, avrei dovuto chiedere aiuto. Mi girai con la sedia e, sorreggendomi con le mani sul bordo del tavolo dove c'erano i libri, tirai con forza e scivolai fin lì pattinando sulle rotelle per continuare a osservare i disegni mentre comparivano, a poco a poco, le frasi sottolineate da mio fratello con l'evidenziatore fosforescente. Il secondo inca, Sinchi Roca, compariva due pagine dopo il suo predecessore, vestito in modo molto simile e, naturalmente, con i suoi grandi orecchini ben visibili. Le varie righe evidenziate nella pagina vicina mi diedero un'informazione molto utile; Guamán Poma diceva che Sinchi Roca aveva governato Cuzco, conquistato tutti gli Orejones e l'intera Collasuyo con pochissimi soldati, perché i collas erano «deboli e pusillanimi, gente da poco». Un figlio di questo inca, il capitano Túpac Amaru, «conquistava, ammazzava e strappava gli occhi» ai collas più importanti. Per non lasciare dubbi su come lo faceva, Guamán Poma lo illustrava dettagliatamente con un altro disegno in cui si vedeva il capitano con delle lunghe pinze in mano lacerare un occhio a un povero prigioniero in ginocchio davanti a lui e con un curioso berretto a forma di portavasi stilizzato sul capo. Quindi, quello era un collaaymara! mi dissi esaminandolo con grande curiosità. In realtà, mi sembrava di conoscerlo da sempre. Su Sinchi Roca inca (il titolo regale si posponeva al nome), il cronista aggiungeva altri dati più rivelatori. Descrivendo minuziosamente i suoi vestiti, Poma de Ayala diceva che l'awaki del suo vestito, il disegno che si vedeva nell'illustrazione, aveva «tre strisce di tukapus» ossia tre file di piccoli rettangoli che contenevano dei segni molto simili ai simboli speciali del computer. Feci girare di nuovo la sedia, scivolai verso la tastiera e lanciai una ricerca generale in Internet su tukapu. Per mia disgrazia, comparvero solo due documenti che, alla fine, risultarono essere lo stesso in inglese e in spagnolo. Si trattava di uno studio intitolato Guamán Poma y su crónica ilustrada del Perú colonial: un siglo de investigaciones, hacia una nueva era de lectura, della dottoressa Rolena Adorno, docente di Letteratura Latinoamericana dell'università di Yale, Stati Uniti. Il lavoro era stupefacente per erudizione e profondità. Lo lessi con attenzione e, tra le molte cose interessanti che la dottoressa Adorno diceva di Guamán, trovai un paragrafo nel quale faceva riferimento agli studi sui tukapus di un certo Cummins, insistendo sul fatto che quel cronista svelava molto poco del significato segreto di quei disegni astratti su tessuto e, meno ancora, sul senso codificato dell'abaco che compariva nel disegno del khipukamayuq, o segretario dell'inca, che teneva i conti e registrava informazioni dinastiche e statistiche con i khipus. Capire che i khipus erano i quipus, cioè le corde con i nodi di cui mi aveva parlato Ona in ospedale, non mi costò molto; mi ero già abituato a vedere la stessa parola scritta in mille modi diversi, ma impiegai un po' di più a rendermi conto che il khipukamayuq era il quipucamayoc a cui aveva accennato mia cognata. Questa idea mi portò, ovviamente, a un'altra molto simile: se khipus poteva essere quipus e khipukamayuq poteva essere quipucamayoc, perché tukapus, cioè le caselle dei tessuti con i simboli, non poteva essere tucapus o tucapos o tocapus? Quando avviai la ricerca della prima opzione comparvero solo alcuni documenti di scarsa utilità; la seconda alternativa diede ancora meno risultati. Non mi rimaneva che provare con la terza prima di arrendermi. Questa volta ebbi fortuna: più di sessanta pagine contenevano la parola tocapus, e diedi per scontato che alcune di loro mi avrebbero spiegato perché mio fratello fosse tanto interessato (più di Rolena Adorno e di Cummins) a quei curiosi disegni tessili andini che sembravano avere dei significati segreti che Guamán Poma non aveva voluto rivelare. Fortunatamente, appena gettai lo sguardo ai titoli delle prime pagine mi imbattei in un nome noto: Miccinelli, documenti Miccinelli... Non erano quei manoscritti scoperti dall'amica della dottoressa Torrent in un archivio privato di Napoli che contenevano il quipu con nodi sul quale stava lavorando mio fratello? Certo, non c'era il minimo dubbio! Selezionai il link, caricai la pagina ed eccolo: «Actas del coloquio Internacional: Guamán Poma y Blas Valeva. Tradición Andina e Historia Colonial», della professoressa Laura Laurencich-Minelli, titolare della cattedra di Storia e Civiltà Precolombiane dell'università di Bologna. E che cosa aveva da dire la professoressa Laurencich-Minelli sui tessuti con strisce di tocapus? Lei non si occupava di quipus? No, ricordai, dei quipus si occupava Marta Torrent e, per delega, mio fratello Daniel; la professoressa Laurencich-Minelli studiava l'aspetto storico e paleografico dei documenti. I documenti Miccinelli, scoperti a metà degli anni Ottanta, erano due manoscritti gesuitici, Exsul Immeritus Blas Valeva Populo Suo e Historia et Rudimenta Linguae Pivuanovum, scritti nei secoli XVI e XVII e rilegati in un solo volume nel 1737 da un altro gesuita, padre Pedro de Illanes che, poco dopo, li vendette a Raimondo di Sangro, principe di Sansevero. Probabilmente l'allora re di Spagna Amedeo I (1870-1873), della casa Savoia, li fece arrivare a suo nipote, il duca Amedeo d'Aosta, che li regalò al maggiore Riccardo Cera, zio dell'attuale proprietaria, Clara Miccinelli, la quale li ritrovò nel suo archivio privato, l'Archivio Cera, nel 1985. Parte del secondo manoscritto, Historia et Rudimento Linguae Piruanorum, era stato compilato a Lima tra il 1637 e il 1638, dal padre italiano Anello Oliva, che vi aggiunse tre mezzi folia nei quali era disegnato il quipu letterario Sumac Ñusta e, piegate, alcune corde con nodi che formavano parte dello stesso, confezionate in lana. Senza dubbio, si trattava del quipu che Daniel stava studiando per incarico della professoressa Torrent. La questione era seria: i documenti dicevano che Guamán Poma era lo pseudonimo adottato da un gesuita meticcio chiamato Blas Valera (scrittore, linguista esperto in quechua e aymara e storico) e che i Comentarios Reales dell'inca Garcilaso de la Vega erano un plagio dell'opera inedita dello stesso Valera, il quale gliel'aveva affidata nel periodo in cui era sotto processo da parte dell'Inquisizione per essere il capo riconosciuto di un gruppo che, oltre a pretendere di mantenere viva la cultura inca, accusava gli spagnoli dei peggiori abusi, ruberie e crimini contro gli indios. Ma, cosa ancora più grave, i documenti affermavano in modo esplicito che Francisco Pizarro aveva sconfitto l'ultimo inca, Atahualpa, non in una vera battaglia, che avrebbe avuto luogo a Cajamarca, come narrava la storia, ma avvelenando i suoi ufficiali con del vino moscatel mescolato a rejalgar, che sembra fosse il nome che si dava a quei tempi all'arsenico. La professoressa Laurencich-Minelli abbinava a ciascuno di questi fatti un'ampia bibliografia documentale che dimostrava e completava tali affermazioni, ma, per quanto l'argomento fosse molto interessante, quello che mi serviva erano i riferimenti agli enigmatici tocapus, e non un'altra manciata di misteri. Finalmente, arrivai alla parte del saggio in cui compariva quello che cercavo e, subito dopo aver letto il sottotitolo della sezione, capii perché mio fratello, un antropologo del linguaggio, si era tanto interessato ai tessuti incas e ai loro disegni. In fondo, a questo punto non mi sarebbe dovuto costare molto dedurlo, visto l'andamento generale delle informazioni, ma, per un profano, tutti i mari sembrano uguali per il semplice fatto di non averli mai navigati. Il sottotitolo recitava «La scrittura mediante quipus e tessuti», e soltanto per questo avrei dovuto sentirmi totalmente idiota, per la mia cecità ma anche per qualcosa che, ora, appariva assolutamente chiaro: la professoressa conosceva la questione dei tocapus tanto quanto quella dei quipus perché, senza dubbio, sapeva le stesse cose che sapevo io in quel momento, o di più; i documenti Miccinelli non erano passati invano per le sue mani e l'autrice del saggio che stavo leggendo era una sua amica e collega. Allora, in base a ciò che diceva quell'amica della dottoressa Torrent, i documenti Miccinelli affermavano che sia i quipus a nodi sia i tessuti con tocapus erano come i nostri libri. Sebbene lei insistesse molto di più sui quipus, in una frase parlava della necessità di studiare attentamente le illustrazioni della Nueva crónica y buen gobierno di Guamán Poma-Blas Valera perché, «nel suo più segreto livello», conteneva testi scritti con i tocapus disegnati come ornamento sulla stoffa dei vestiti che, disponendo di adeguati mezzi umani e tecnici, si poteva arrivare a decifrare. Pensieroso, ritornai al libro di Guamán (ammesso che questo fosse il vero nome dell'autore) e ripresi a esaminare puntigliosamente le immagini che tanto mi avevano colpito. Osservai quelle strisce di tocapus sui vestiti con occhi nuovi, come se guardassi una parete piena di geroglifici egizi che, malgrado io non sapessi leggerli, erano comunque un linguaggio scritto formato da parole e ricco di concetti. Mi rimaneva solo un dubbio, e la verità era che non mi sentivo capace di risolverlo quella notte: in che lin- gua erano scritti i tocapus? Non c'era alcun dubbio che i nodi servissero a scrivere in quechua, l'idioma degli incas e dei loro sudditi, e avevo l'impressione che lo fossero anche i tocapus. Due sistemi di scrittura entrambi misteriosi, per la medesima lingua? Allora che diavolo aveva a che fare l'aymara con questa storia? «Posta per Jabba!» esclamai scoraggiato, senza muovermi. I monitor diventarono bianchi e il cursore nero lampeggiò all'inizio di un modello di mail scritte con il sistema di riconoscimento vocale. «Buon giorno a tutti e due», incominciai a dettare; le parole comparvero meccanicamente sugli schermi. «Guardate l'ora in cui vi mando questo messaggio e indovinerete come ho passato la notte. Ho bisogno di saperne di più sul linguaggio aymara. In particolare, qualsiasi relazione dell'aymara con qualcosa chiamata tocapus.» La macchina si fermò dopo la parola «chiamata». «Compito: t di Toledo, o di Orense, c di Cáceres, a di Alicante, p di Palencia, u di Urgell e s di Siviglia.» La parola si visualizzò immediatamente, scritta in modo corretto. «Memorizzare: tocapu. Significato: disegno tessile inca. Plurale: tocapus. Continuo a dettare il messaggio per Jabba. Mi interessa il quechua solo se compare in relazione con i tocapus e l'aymara, altrimenti no. Mi alzerò a mezzogiorno e, dopo pranzo, sarò in ospedale con Daniel, nel caso mi cercaste. In un'altra mail vi invio parte del materiale che non sono riuscito a decifrare, nel caso voleste darmi una mano. Buona domenica. Grazie ancora. Saluti, Root. Fine del messaggio per Jabba. Codificazione normale. Priorità normale. Inviare.» Presi dalla cartella di cuoio le fotocopie della mappa delle rose dei venti e dell'omino barbuto senza corpo (Humpty Dumpty) e li passai allo scanner più potente per dargli la migliore risoluzione possibile. I file che ne risultarono erano enormi, ma era meglio così, perché in quel modo Jabba e Proxi non avrebbero avuto anche il problema della mancanza di nitidezza. «Seleziona immagini uno e due», conclusi, mi adagiai sulla poltrona e appoggiai la faccia sul pugno sinistro. «Posta per Jabba. Aggiungere file selezionati. Fine della posta per Jabba. Codificazione normale. Priorità normale. Inviare.» I monitor si spensero e io, che avevo davanti la Nueva Crónica, continuai a sfogliarne meccanicamente le pagine finché non trovai un altro paragrafo sottolineato con l'evidenziatore giallo. In quel momento però i monitor tornarono a illuminarsi e comparve un messaggio del sistema che mi ricordava che erano le sette del mattino; subito dopo, con una magistrale dissolvenza, mostrò uno dei miei quadri preferiti: Harmatan, di Ramón Enrich. Come se quell'avviso avesse fatto suonare un allarme interiore, d'improvviso sentii una stanchezza infinita e mi si intorpidirono tutti i muscoli del corpo. Da quanto tempo stavo lì, seduto, navigando tra appunti e libri? Non ricordavo l'ora in cui avevo cominciato. Mentre sbadigliavo rumorosamente e mi stiravo sulla sedia in tutta la mia lunghezza fino a trasformarmi in un pezzo di legno, mi vennero in mente le innumerevoli notti passate in bianco davanti al computer a danneggiare sistemi. Erano sfide appassionanti che, quando avevano successo, ti lasciavano con l'ego tra le nuvole, la vanità nell'iperspazio e una soddisfazione personale che non aveva confronto con nessun'altra cosa al mondo. Quella notte, nonostante la stanchezza (o forse proprio per questo) mi sentivo altrettanto onnipotente e, in un delirio finale, prima di cadere sul letto in preda al sonno, decisi che, a partire da quel momento, avrei cambiato il mio tag per un acronimo di Arnau Capac inca, o di Potente Re Arnau. Francamente suonava bene. Bene come il dolce e un po' triste brano per pianoforte di Erik Satie con il quale mi addormentai, il frammento numero uno di Gymnopédies. Satie ha sempre detto che Gymnopédies significava «danza di donne spartane nude», ma quasi tutti erano d'accordo che se lo fosse inventato. A me, veramente, più che a donne nude, faceva pensare alle migliaia - se non milioni - di persone che erano morte in America lottando contro la tirannia e l'oppressione della corona e della chiesa spagnole. Quando mi svegliai, a mezzogiorno, udii degli strani rumori per la casa. In un primo momento pensai che fosse la nonna che si era svegliata presto, ma la nonna era una donna molto rispettosa e mai avrebbe fatto una baraonda simile mentre qualcuno dormiva. Poteva certo trattarsi di mia madre, che non aveva di questi riguardi, eppure lei e Clifford dovevano essere in ospedale dalle prime ore del mattino. Quindi, nella lista dei possibili colpevoli, rimanevano soltanto Magdalena e Sergi, il giardiniere, che però erano automaticamente esclusi poiché era domenica. Questa graduale riflessione alla Sherlock Holmes la feci mentre ero ancora più addormentato che sveglio, ma non c'è niente come un buon ragionamento logico, accompagnato da un sottofondo di rumori metallici, per schiarire anche il cervello più esaurito. Saltai giù dal letto e, con gli occhi ancora chiusi, avanzai a tentoni nel corridoio e mi diressi incespicando verso la fonte dello strepito. Meno male, pensai, che la nonna dormiva come un sasso. La scienza medica dice che le persone anziane hanno bisogno di meno ore di sonno della gente più giovane, ma, con i suoi ottant'anni e passa, doña Eulàlia Monturiol i Toldrà, tutta intelligenza, simile a uno di quei brillanti cristalli di quarzo pieni di punte, dormiva le sue dieci o undici ore tutti i giorni, senza che niente, nemmeno passare la notte in ospedale a occuparsi di uno dei suoi nipoti, alterasse questa sana abitudine. Sosteneva che la sua bisnonna, vissuta fino a centodieci anni, dormiva ancora più di lei e che pensava di superare di molto quell'età. Mia madre, inorridita per un simile sperpero di vita, la rimproverava duramente e le consigliava di ridurre il tempo di sonno alle sette ore raccomandate dagli specialisti. Ma mia nonna, cocciuta come solo lei sapeva essere, ribatteva che i medici di oggi non avevano nemmeno idea di cosa fosse la qualità della vita e che, a forza di passare il tempo a lottare accanitamente contro le malattie, si erano dimenticati di quella che era la regola di base per la buona salute: vivere come un papa. Aprii a fatica gli occhi quando raggiunsi il punto culminante del rumore, e vidi Jabba e Proxi sdraiati sul pavimento del mio studio circondati da fili elettrici, torri di computer - che identificai come provenienti dal «100» - e altri elementi vari di hardware. Avevo dimenticato che anche loro avevano libero accesso a casa mia. «Oh! Ciao, Root!» mi salutò Jabba spostando con l'avambraccio un groviglio di capelli rossi dalla faccia. Mi lasciai scappare una parolaccia abbastanza volgare e li maledissi ripetutamente mentre entravo nello studio e mi ficcavo nella pianta del piede destro un piccolo e affilato moltiplicatore di porte USB, il che ebbe l'effetto di prolungare la mia sfilza di imprecazioni. «Ora smettetela!» fu la prima cosa coerente che dissi. «Mia nonna sta dormendo!» Proxi, che non mi aveva nemmeno considerato durante la mia esplosione da bettola, alzò il capo da quello che stava facendo e mi guardò spaventata, lasciando perdere tutto. «Fermati, Jabba!» esclamò alzandosi. «Non lo sapevamo, Root, sul serio. Non ne avevamo idea.» «Venite con me in cucina e, mentre faccio colazione, mi racconterete che cosa state combinando!» Mi seguirono nel corridoio ed entrarono davanti a me con un'espressione mortificata. Chiusi la porta adagio per poter parlare senza disturbare nessuno. «Su! Cominciate!» dissi con durezza, andando verso le scansie dove c'erano i barattoli di vetro e le spezie. «Voglio una spiegazione.» «Siamo venuti ad aiutarti...» iniziò a dire Proxi, ma Jabba la interruppe. «Sappiamo da dove è uscito l'omino tutto testa.» Con il barattolo del tè in mano mi girai come un macinino per guardarli. Si erano seduti ai lati opposti del tavolo della cucina. Non ci fu bisogno di chiedere: sulla mia faccia era stampato un enorme punto interrogativo. «Sappiamo quasi tutto», si pavoneggiò il mio presunto amico con aria di sufficienza. «Sì, è vero», sottolineò Proxi, adottando lo stesso atteggiamento, «ma non te lo racconteremo perché non ci hai offerto niente, nemmeno un poco di quel caffè che ti stai preparando.» Sospirai. «È tè, Proxi», le annunciai mentre mettevo la quantità esatta di acqua nella piccola brocca di vetro. Il gusto per il tè mi era stato imposto da mia madre che, a forza, ci aveva abituati tutti da quando era andata a vivere in Inghilterra. All'inizio lo odiavo, ma con il tempo avevo finito per apprezzarlo. «Ah, allora non ne voglio!» Aspettai che si formassero le bollicine per accertarmi che la misura dell'acqua fosse giusta e, appurando che ne mancava ancora un po', ne lasciai cadere ancora un filino dalla bottiglia di acqua minerale. «Ti preparo un caffè», le disse Jabba alzandosi e dirigendosi verso la caffettiera che stava su una mensola. «Ne ho voglia anch'io. È che, dopo aver finito di mangiare, siamo subito venuti qui.» «Serviti», bofonchiai mentre infilavo la brocca nel microonde e programmavo il tempo sul display digitale. Jabba riempì con l'acqua del rubinetto la caffettiera. Era un bevitore compulsivo di caffè, ma, anche per questo, non aveva assolutamente gusto. «Chi mi racconta tutto?» insistei. «Te lo racconto io, sta' tranquillo», rispose Proxi. «Dov'è il caffè?» «È nel barattolo di vetro, accanto allo spazio vuoto dove c'era il barattolo del tè. Lo vedi?» «Il tuo 'Testa d'uovo', Root», continuò la mercenaria della sicurezza, «è uno dei minuscoli disegnini che compaiono nella mappa che ci hai mandato stanotte.» «Per meglio dire, stamattina», obiettai, senza prendere in considerazione l'informazione che avevo appena ricevuto. «Va bene, stamattina», mi concesse mentre l'uomo della sua vita buttava mucchi di caffè giamaicano nel filtro e lo premeva con tutto il cuore prima di avvitare la parte superiore. Strinsi le labbra e mi dissi che era meglio non continuare a guardarlo se non volevo finire per litigare con quel pezzo di animale. E, allora, mi resi conto di quello che aveva detto Proxi. «L'omino barbuto era nella mappa delle lettere arabe?» mi lasciai scappare, perplesso. «È proprio sopra la cordigliera delle Ande!» precisò Jabba scoppiando a ridere. «Con i piedini sui picchi, nella zona in cui dovrebbe esserci Tiwanacu!» «Del resto è molto piccolo, si vede appena. Devi prestare molta attenzione.» «O guardare con una lente di ingrandimento come abbiamo fatto noi.» «Per questo Daniel aveva fatto un ingrandimento digitalizzato.» Rimasi senza parole per alcuni secondi, poi, nonostante il microonde si fosse messo a fischiare, uscii dalla cucina come un fulmine e ritornai nello studio alla ricerca della cartellina nella quale avevo conservato la maledetta mappa dopo averla scannerizzata. Saltai sopra il materiale che ingombrava il pavimento e la recuperai ansiosamente, spiegandola. Sì, in effetti, quella macchia era il testone. Ma non si distingueva bene. «Luce, più luce!» esclamai come Goethe sul suo letto di morte, e immediatamente il sistema aumentò l'intensità della luce dello studio. Eccolo! Ecco il beato Humpty Dumpty, con la sua barba nera, il berretto dei collas e le sue cosce da rana! Era talmente piccolo che era appena visibile, quindi presi l'ingrandimento di Daniel per esaminarlo come se fosse la prima volta che lo vedevo. Accidenti alla «Testa d'uovo»! Lo avevo avuto davanti al naso tutto il tempo. «Prendi la mappa e vieni in cucina», mi disse Proxi dalla porta. Jabba era ancora in piedi di fronte al piano cottura in vetroceramica che fissava la caffettiera come se il fuoco necessario per scaldare l'acqua non fosse altro che quello dei suoi occhi. «Lo hai visto?» si affrettò a chiedermi quando richiudemmo la porta. «È incredibile!» esclamai, scuotendo il foglio di carta come fosse una banderuola. «Già!» convenne lei avvicinandosi al microonde. Indossava dei pantaloni elastici a fiori molto attillati e, sopra, una spessa camicia da taglialegna, aperta, che lasciava intravedere una maglietta bianca con le spalline sulla quale scintillavano le perline di varie collane. «Siediti, su! Mi occuperò io di quel tè nauseabondo.» La ringraziai di cuore. Anche se il tè le ripugnava, a Proxi riusciva sempre buonissimo. «Va bene», dichiarò il mio amico. «Ora sturati bene le orecchie e ascolta con attenzione quello che ti racconteremo. Se la faccenda dell'aymara era forte, questa è incredibile.» «Proprio per questo abbiamo deciso di aiutarti.» «Vedrai, è troppo per te, Root. Troppe cose, troppi libri, troppi documenti. Proxi e io siamo arrivati alla conclusione che questa storia richiedeva lo sforzo combinato delle nostre tre teste. Così, dando per scontato che non dirai di no, ci prenderemo una settimana di vacanze dalla Ker-Central e verremo qui tutti i giorni a darti una mano.» «Abbiamo bisogno di tanto tempo?» lo interruppi. «Inoltre, ti ricordo che ho già la casa piena di gente.» «Perché lavoriamo per questo tipo, Proxi?» borbottò Jabba contrariato. «Perché ci paga.» «È vero», si lamentò lui alzando il coperchio della moka per vedere a che punto era il caffè. «E perché ci è simpatico», continuò lei, terminando di versare l'acqua bollente nella teiera di porcellana, «perché gli piacciono le stesse cose che piacciono a noi, perché è pazzo come te e perché ci conosciamo da... quanto? Dieci anni? Venti?» «Lui e io da sempre», feci notare, anche se non era esattamente così. «Tu sei arrivata solo tre anni fa, quando ho messo in piedi la Ker-Central.» «È vero. È chiaro che per me è diventata un'eternità.» Jabba l'avevo incontrato in rete. Anche se vivevamo non troppo lontani (lui era di un paesino nei pressi di Girona) avevamo passato anni a programmare e a pirateggiare insieme senza conoscerci personalmente, portando a termine imprese clamorose che mantenevamo segrete, non come quegli hacker da strapazzo che si vantano delle loro piccole vittorie senza pensare che bisogna essere cauti nel parlare. Eravamo tutti e due dei tipi strani che non volevano né avevano bisogno di troppi contatti con esseri in carne e ossa, forse per timidezza o, chi lo sa, forse perché la nostra passione per l'informatica e i computer ci faceva sentire diversi dagli altri. Non seppi mai il suo vero nome fino a quando non lo assunsi all'Inter Ker, nel 1993. Avrei potuto affermare senza mentire che quell'adolescente grande, grosso e rosso di capelli che entrò nel bar in cui avevamo appuntamento quel pomeriggio era il miglior amico che avessi mai avuto e, senza dubbio, anch'io lo ero per lui, ma fino a quel momento non ci eravamo mai visti in faccia. Avevamo parlato poco. Gli avevo raccontato il mio progetto per l'impresa e mi aveva detto di sì, che avrebbe lavorato per me, solo se gli avessi permesso di proseguire i suoi studi. Aveva cinque anni meno di me e i suoi genitori, che erano agricoltori, si erano impegnati a fargli frequentare l'università, anche se avessero dovuto portarcelo a calci. Così era cominciata la seconda fase della nostra amicizia. Quando avevo venduto la Inter Ker, mi aveva seguito alla Keralt.com e, dopo, alla Ker-Central, ormai come ingegnere informatico. Era stato allora che entrambi avevamo conosciuto Proxi, venuta a lavorare nel dipartimento di sicurezza pochi mesi dopo l'avvio dell'impresa. La loro storia era stata un colpo di fulmine, un amore a prima vista. Il mio amico era rincretinito, aveva perso la testa per quell'informatica allampanata e sconcertante che ci dava dei punti. Ma lei non si era tirata indietro. Anche se non c'era bisogno che si sforzasse, l'aveva corteggiato sfacciatamente finché il poveretto non era caduto ai suoi piedi. Erano fatti l'uno per l'altra e, da allora - erano passati tre anni -, si erano separati soltanto per lavorare in uffici differenti dell'azienda. «Infine...» continuò lei, avvicinandomi la tazza e la teiera traboccante, «la questione, Root, è che ti stiamo regalando una settimana delle nostre scarse e sempre brevi vacanze annuali per scoprire in che cosa si era cacciato Daniel, perché più ne sappiamo e più strano si fa il tutto.» «Accetto la vostra offerta», dichiarai, osservando come Jabba prendeva la caffettiera per il manico per ritirarla bruscamente dalla piastra. «Ma perché qui, in casa? Perché non nel '100'? Staremmo più comodi.» «Comodi, dice!» si burlò lui, facendo cadere un filo di fumante e profumata pozione in due tazzine. «Quando hai chiamato Jabba per chiedergli di indagare sulla lingua aymara, gli hai detto che avevi un mucchio di libri da sfogliare.» «E abbiamo già visto quello che hai nello studio. Non possiamo portare tutto al '100'!» «Quanto sei andato avanti con le cronache?» «Poco, molto poco», riconobbi, poggiando la tazza nel centro del piattino. «Dobbiamo lavorare qui perché nel '100' non c'è posto per tutti questi libri, documenti e cartelle. Lì non c'è un solo tavolo libero. E, per non cominciare a contenderci i computer, abbiamo deciso di portarne alcuni da giù e collegarli al sistema.» Quando Proxi finì di parlare, tutti e tre eravamo finalmente seduti e tranquilli. Facendola scivolare sul tavolo, avvicinai la benedetta mappa delle rose dei venti e delle lettere arabe. «Bene, bene...» mormorai, osservando il piccolo Humpty Dumpty. «Raccontatemi che cosa avete appurato.» «Questo scartafaccio», cominciò Jabba, «è una riproduzione di ciò che rimane di un grande mappamondo disegnato nel 1513 da un famoso pirata turco chiamato Piri Reis.» «Come lo sai?» «Cosa vuol dire come lo so? Perché Proxi e io ci siamo presi la briga di visitare tutte le pagine di cartografia antica che ci sono nella rete. In realtà le mappe antiche rimaste non sono molte come si potrebbe supporre. Ce ne sono moltissime degli ultimi due o tre secoli, ma se si va più indietro, il numero si riduce tanto che puoi contarle sulle dita di poche mani.» «Una volta saputo che si trattava della mappa di Piri Reis, abbiamo iniziato a cercare tutto quello che c'era su di lui.» «E, per quanto ti possa sforzare», sentenziò Jabba, «non potrai mai immaginare ciò che abbiamo trovato.» «In uno dei link c'era una lista degli oggetti, delle persone e degli animali che compaiono nel mappamondo, e lì era menzionato il tuo 'Testa d'uovo', descritto come un mostro barbuto e senza corpo, di natura demoniaca.» «Volete dire che non lo avete scoperto usando una lente d'ingrandimento?» «Sì, lo abbiamo scoperto con la lente!» protestò Jabba irritato. «Anche se, lo ammetto, dopo aver saputo che si trovava lì. Ma individuarlo nella mappa è stato come cercare il pezzo di un puzzle in un sacchetto in cui ce ne sono altri cinquemila.» «Be'! Probabilmente non tanti», corresse Proxi, «però ci è costato abbastanza fatica.» «E ora ti racconteremo una storia. La storia più strana che tu abbia mai sentito in vita tua. Ma, attenzione...» osservò, alzando in aria gli indici di tutte e due le mani, «in questo racconto è tutto vero. Fino all'ultimo particolare. Qui non stiamo parlando di hobbit né di elfi. Chiaro?» «Chiaro!» Mi sentivo sui carboni ardenti. Non fu Jabba a raccontarmelo, ma Proxi, dopo aver bevuto un sorso di caffè e poggiato la tazza sul piattino. «Dopo la caduta dell'impero ottomano...» cominciò a narrare. «Non sembra che lo abbia fatto da tutta la vita?» mi domandò Jabba fingendo una profonda ammirazione. Risi e assentii convinto. «Ha detto romano o ottomano?» chiesi candidamente. «Siete degli imbecilli», dichiarò lei, sdegnata. «Gli imbecilli più imbecilli del mondo. Dopo la caduta dell'impero ottomano in seguito alla prima guerra mondiale, i governanti della nuova Repubblica di Turchia decisero di riscattare i preziosi tesori che erano rimasti nascosti per secoli nell'immenso palazzo del Topkapi, l'antica residenza del sultano, a Istanbul. Facendo l'inventario dei fondi, nel novembre del 1929, il direttore del Museo Nazionale, Halil non so che, e un teologo tedesco, Adolf Deissmann, scoprirono una vecchia mappa incompleta dipinta su pelle di gazzella.» «Come vedi ha passato tutta la mattina a studiare», commentò qualcuno che, immediatamente, si beccò una scoppola sulla testa rossa. Io tacqui nel caso continuassero a distribuirne altre ai presenti. «Come ti ha già detto questo ignorante», proseguì lei impassibile, «si trattava dei frammenti del grande mappamondo dell'ammiraglio della flotta turca, il famoso pirata e cartografo Piri Reis, disegnato da lui stesso nel 1513. La mappa rappresentava la Bretagna, la Spagna, l'Africa occidentale, l'oceano Atlantico, parte dell'America del nord, del sud e la costa antartica. Cioè esattamente quello che si vede in questa riproduzione.» Socchiusi gli occhi per guardare con più attenzione e cercai tutti i luoghi che lei aveva nominato. Naturalmente l'Atlantico, che occupava ampiamente il centro dell'immagine con il suo pallido colore azzurrognolo, si vedeva con chiarezza; era pieno di barchette, rose dei venti, linee, isole eccetera. La Bretagna, però, non era da nessuna parte, ma mi astenni da ogni commento. A destra si osservava senza nessun problema la Spagna e, sotto, la costa occidentale e panciuta dell'Africa, che mostrava al suo interno quello che sembrava un elefante circondato da re magi seduti a gambe incrociate. L'America del nord era un vago litorale attaccato al margine sinistro della presunta pelle di gazzella, come se fosse inclinato verso quel lato e si perdesse di vista a causa della circonferenza della Terra. L'America del sud invece si riconosceva perfettamente, con i fiumi principali, la cordigliera della Ande (l'omino con il copricapo rosso), gli animali... Soltanto il cono meridionale appariva strano perché, dove avrebbe dovuto esserci lo Stretto di Magellano, che metteva in comunicazione l'Atlantico con il Pacifico, la terra, senza interrompersi, faceva una svolta e ritornava verso est, come per cercare l'estremo sud dell'Africa, dal che dedussi che doveva trattarsi della costa antartica, per quanto rappresentata male. Ma, nonostante tutto questo, si poteva dire che Proxi aveva più o meno ragione. «Noti qualcosa di strano?» «Eh, sì», dissi convinto, indicando con un dito il punto in cui mancava lo Stretto di Magellano. «Questo non è corretto. Inoltre l'America del nord è ritorta. Ah! E questo elefante africano è troppo magro, la pancia si vede appena. Sembra un levriero con la proboscide.» «Tutto vero, Root», mi incoraggiò Jabba (eravamo di nuovo uniti di fronte a un'avversaria comune), «però c'è molto di più. Ricorda ciò che sai su Pizarro e gli incas, sulla scoperta del Perù.» «Non gli dare altri indizi, Giuda!» sbuffò Proxi. «Non fare così!» implorò lui. Mentre loro continuavano a punzecchiarsi, io tornai a osservare l'America del sud nella mappa di Piri Reis. Che cosa c'era di strano? Certamente Humpty Dumpty non era del tutto normale, ma il lama che si vedeva accanto a lui era disegnato abbastanza bene, e così i fiumi e le montagne. Che cosa c'era che non andava? Vediamo... Pizarro aveva sconfitto gli incas nel 1532, a Cajamarca, a un migliaio di chilometri a nord di Cuzco, probabilmente avvelenando tutti i nobili Orejones e catturando il loro ultimo re, Atahualpa inca, che aveva ucciso poco dopo. Da lì aveva avuto inizio il Vicereame del Perù e la distruzione sistematica dell'antico impero, l'istituzione del cristianesimo e dell'Inquisizione, la redazione delle prime cronache... Che diavolo mi stava sfuggendo? «Non ti viene in mente niente?» mi chiese Proxi. «No! Per la verità, no!» mormorai senza smettere di osservare, lisciandomi il pizzetto mentre mi chinavo sulla grande fotocopia come un allievo diligente. «Su, coraggio!» mi incitò Jabba, desideroso di una vittoria da parte mia. «Ti ripeto il dato fondamentale: la mappa è stata disegnata nel 1513.» «E con questo?» indagai irritato, ma si trattava più di una protesta che di una vera domanda. Non volevo aiuto, non desideravo una soluzione, e tutti e due lo sapevano. Era chiaro che avevo nella testa i dati necessari per risolvere l'enigma, quindi dovevo lasciarmi guidare dall'intuito, come se lavorassi in una di quelle zone buie del codice in cui solo una sensazione improvvisa ti fa raggiungere la meta. Ero di nuovo un intrepido Ulisse che tentava di dirigere la sua nave verso Itaca, un audace hacker che lottava per aprire qualcosa che era lawt'ata, «chiusa a chiave». Anche se mi dava fastidio, grazie a Proxi sapevo che dovevo partire dalle date. Ne avevo due: 1513, anno della mappa, e 1532, anno in cui Pizarro era infine arrivato a Cajamarca per intraprendere la conquista dell'impero inca. Tra il 1513 e il 1532 c'erano diciannove anni di differenza, stranamente a favore della mappa. In base al poco che sapevo, quando Pizarro era partito da Panama, nel 1531, nessuno aveva ancora mai visto il Perù, né la Bolivia, né il Cile, né la Terra del Fuoco. Pertanto era impossibile che, nel 1513, si conoscessero la forma e l'estensione della cordigliera delle Ande e il percorso dei grandi fiumi, e ovviamente era altrettanto impossibile che qualcuno avesse visto la zona del lago Titicaca e Tiwanacu e, ancor meno, che conoscesse i collas e i loro gusti in tema di copricapi. E in più quella mappa era stata disegnata nel 1513 da un turco! Può darsi che Colombo non avesse scoperto per primo il continente americano - rimanevano pochi dubbi, con la questione dei vichinghi -, ma i turchi? Dai! «Questa mappa è falsa», affermai, convinto. «È cronologicamente scorretta e pertanto, se è davvero antica, si tratta soltanto di una contraffazione tarlata.» I miei attenti spettatori sorrisero con orgoglio, soddisfatti. Gli occhi di Proxi si strinsero fino a trasformarsi in due sottili linee di ciglia. «Sapevo che te ne saresti reso conto!» esclamò. «Allora è veramente un falso?» chiesi inarcando le sopracciglia, sorpreso da quanto era stato facile. «Ma che falso! Figurati!» saltò su Jabba, sprezzante. «La mappa è autentica! Disegnata a Gallipoli, nei pressi di Istanbul, proprio dallo storico Piri Reis, nel 1513.» «No. Non può essere.» «Non ti avevo avvertito che, in questa storia, era tutto vero fino all'ultimo particolare? Ti avevo detto: 'Qui non stiamo parlando di hobbit e di elfi'. Rammenti?» «Non ha senso!» obiettai cominciando ad arrabbiarmi. «Nel 1513 non si sapeva come fosse il territorio del Nuovo Mondo. Anzi, sono pronto a giurare che credevano ancora di essere giunti in India-India, quella d'oriente.» «Hai ragione! E qui sta, precisamente, il nocciolo della questione. Come si è arrivati a fare questa mappa? Che non sia una falsificazione è dimostrato dal riconoscimento e dalla catalogazione da parte di organismi specializzati, oltre che dalle molteplici verifiche storiche che sono state effettuate per avvalorare tutto quanto ha una relazione con l'autore e con i numerosi dati che lo stesso Piri Reis apporta nelle annotazioni sparse in tutto il disegno, scritte in turco ottomano con caratteri arabi.» «Non incominciamo con le sciocchezze!» mi inalberai. «Di nuovo con i giochi di magia? Per favore! Questo mappamondo è falso e non c'è altro da dire. Deve essere stato disegnato diversi anni dopo ciò che afferma Piri Reis.» «Anni dopo, eh?» mi buttò in faccia Proxi, molto arrogante. «Allora perché è stata considerata autentica da tutte le organizzazioni cartografiche del mondo, e perché gli esperti, nonostante la sua esistenza li metta a disagio, non sono riusciti a dimostrare che si tratta di una falsificazione? Solo tu, Arnau Queralt, ti azzardi ad affermare questa cosa. Quanto sei bravo!» «Va bene! Supponiamo che sia autentica! Allora spiegami come diavolo è riuscito quel tale Piri Reis a disegnare le Ande quando ancora non si conoscevano.» Potevo accettare, con delle riserve, che l'aymara fosse un linguaggio algoritmico e matematico perché, in fin dei conti, stavamo parlando di qualcosa di calcolabile e di serio, ma mi avevano insegnato a disprezzare ogni mito assurdo, qualsiasi concetto erroneo che sapesse leggermente di eterodossia. Se fossi vissuto nel Medioevo o nel Rinascimento, forse la mappa di Piri Reis mi sarebbe servita per intraprendere una crociata libertaria contro le versioni ufficiali di una Chiesa repressiva, come fece, per esempio, Giordano Bruno con quella teoria dell'universo infinito della quale parlava Daniel nei suoi deliri. Ma io vivevo nell'Età della Scienza, nell'Era del Positivismo Scientifico, che aveva segnato chiaramente i limiti di ciò che era accettabile attraverso la logica e la verifica. Avevamo impiegato troppi secoli a liberarci dai ceppi della superstizione e dell'ignoranza per dare adito a spropositi fantasiosi. Jabba, nervoso, si alzò in piedi e cominciò a passeggiare per la cucina. Tanto i suoi jeans erano vecchi e consunti, quanto fiammante e impeccabile era la sua camicia blu comprata a New York, nella Quinta Strada, da Bergdorf Goodman. «Consideriamo una cosa alla volta», propose aggiustandosi meccanicamente alla vita i pantaloni logori. «La mappa di Piri Reis contiene molti segreti, non solo la discrepanza di date. Magari, analizzandone tutte le parti, troveremo qualcosa che ci dia un indizio. Tira fuori quello che sai, Proxi. Il testone non sta lì per caso, e Daniel aveva una ragione per conservare una copia del mappamondo.» «E non ti sembra abbastanza singolare che un turco, e pirata per di più, abbia disegnato il continente americano nel 1513? Andiamo! Neanche Cristoforo Colombo lo avesse portato con sé nella caravella!» «In questo hai una parte di ragione», convenne Proxi, lisciando con il palmo della mano un foglio piegato che aveva preso dal taschino della camicia da taglialegna. «La zona delle Antille è copiata, come afferma lui stesso, da una mappa di Cristoforo Colombo. In una delle iscrizioni riconosce di aver utilizzato quattro carte portoghesi contemporanee, due più antiche, dell'epoca di Alessandro Magno, e altre basate sulla matematica.» «Ecco!» affermai trionfante. «Non c'è niente di strano nel mappamondo di Piri Reis.» «Nelle annotazioni sulle fonti utilizzate», continuò imperturbabile, «che, se fai attenzione, non sono proprio quel che si dice molto precise, bisogna mettere in evidenza alcuni aspetti del frammento recuperato nel palazzo del Topkapi: nella mappa compaiono le isole Malvine, che non furono scoperte ufficialmente fino al 1592. Compaiono le Ande, che, come sappiamo, Pizarro visitò solo nel 1524, durante la sua prima e incompleta esplorazione verso il sud. Compare il disegno di un lama, mammifero sconosciuto nel 1513, come del resto il luogo esatto da cui nasce il corso del Rio delle Amazzoni. All'altezza dell'equatore sorgono dal mare due grandi isole che non esistono ai giorni nostri; le moderne esplorazioni sottomarine hanno dimostrato la presenza in quei punti di due cime montagnose appartenenti alla cordigliera che attraversa il fondo dell'Atlantico da nord a sud, e la stessa cosa succede con un gruppo di isole che furono scoperte solo nel 1958 sotto i ghiacci antartici.» Fui preso da una sensazione di rigidità generalizzata. In quella cucina non si muoveva nemmeno l'aria. Credo che persino il sistema, sempre all'ascolto, prestasse in quel momento una speciale attenzione. «Ma non è questa la cosa più interessante della mappa di Piri Reis», dichiarò Proxi alzando lo sguardo dal foglio e guardandomi in modo inespressivo. «Il meglio deve ancora venire. Come tu stesso hai notato, Root, l'estremo sud della Terra del Fuoco non termina per lasciare il passo al mare, mettendo in comunicazione i due oceani attraverso lo Stretto di Magellano. Nella mappa di Reis, l'estremo sud del continente si prolunga e si unisce, mediante un ponte di terra, a una strana Antartide senza ghiacci. Bene, quando fu scoperta la mappa, nel 1929, questo dato fu considerato un'ulteriore imprecisione prodotta dall'ignoranza dell'epoca in cui fu elaborata. Tuttavia...» «Tuttavia...» la incoraggiai. «Tuttavia sondaggi acustici realizzati nella zona da navi oceanografiche hanno dimostrato che quel ponte di terra che unisce l'America del sud e l'Antartide esiste, così come si vede nella mappa di Piri Reis, anche se ora si trova sotto il livello del mare. Sembra che fosse fuori dell'acqua e transi- tabile prima dell'ultima Era Glaciale. A parte il fatto che l'ultima Era Glaciale era durata, si dice, due milioni e mezzo di anni, con variazioni ed epoche calde in mezzo, il problema è che terminò dieci o undicimila anni fa. Quindi, parlando in senso figurato... o forse no», sottolineò, «l'Antartide è una penisola del continente americano.» Borbottai uno sproposito mentre mi strofinavo energicamente la faccia con le mani e Jabba si lasciava andare a una sarcastica risata soffocata. «Ma la sorpresa giunse al suo colmo quando, con l'aiuto della tecnologia dei satelliti, si scoprì che anche sotto i ghiacci antartici c'era la terraferma, particolare che non si conobbe fino al 1957, e si verificò che il tracciato delle coste, delle montagne, delle baie e dei fiumi che comparivano nelle fotografie a infrarossi prese dallo spazio coincideva esattamente con quello che vedi qui, disegnato dalla mano del nostro amico, il pirata turco. Non ci sono errori. Piri Reis aveva copiato l'Antartide da altre mappe, non c'è dubbio, ma da mappe che dovevano essere sorprendentemente antiche perché riproducevano questo continente non com'è da diecimila anni, ma com'era prima di essere coperto dai ghiacci.» Corrugai le labbra perplesso, e impiegai un'eternità ad articolare due parole di seguito. «E quindi», balbettai infine, «essendo stata scoperta a Istanbul, nel 1929, veniva eliminata la possibilità di una contraffazione realizzata con i dati ottenuti attraverso i satelliti, nel 1957.» «Eliminata, infatti», confermò Jabba continuando a passeggiare. «Vai avanti, Proxi, rimangono ancora alcune cose.» «Ancora?» esclamai. «Sì, certo. Ma con questo ho finito.» Si portò la tazza alle labbra, anche se il caffè ormai doveva essere freddo. «Il benedetto mappamondo utilizza un sistema di misurazione chiamato degli 'otto venti'. Non mi chiedere che cosa sia perché, anche se ho cercato di capirlo, non ci sono riuscita. So soltanto che funziona centrando con un compasso le differenti parti della mappa in angoli di venti gradi circa o qualcosa del genere. La questione è che utilizza questo, diciamo, arcaico sistema, ma anche una misura greca chiamata stadio, che equivale a 186 dei nostri metri. Una volta adattato alle grandezze geografiche moderne, il mappamondo è, stai ben attento», poggiò il dito indice al centro della mia fronte frastornata, «assolutamente esatto in tutte le sue proporzioni e distanze. Nonostante a prima vista appaia una mappa deformata e irreale, piena di falsità geografiche, risulta tanto precisa quanto la migliore delle nostre carte attuali, e rispecchia perfetta- mente la latitudine e la longitudine di tutti i punti del globo. La latitudine era conosciuta e utilizzata da tempi immemorabili perché aveva solo bisogno dell'aiuto del sole, ma il calcolo della longitudine non si è potuto effettuare fino al XVIII secolo, precisamente fino...» guardò i suoi appunti, «al 1761 perché mancavano le conoscenze di trigonometria sferica e gli strumenti geodetici. Piri Reis però, o le mappe antiche da cui copiò, indicava puntualmente i meridiani terrestri, e i suoi calcoli erano assolutamente corretti, e questo fa a pugni con quello che sappiamo oggi.» Piegò con cura il suo foglietto e lo rimise nel taschino della camicia decretando la fine della spiegazione. Mi girava la testa nel tentativo di trovare un senso a tutto. Stavamo volando senza paracadute per cieli pieni di turbolenze e ci mancava molto poco per cadere a picco e schiantarci al suolo. Come diavolo aveva fatto Daniel a ficcarsi in una storia simile? Che ci faceva mio fratello, il mio sensato e misurato fratello, in questi luoghi inaccessibili? «Sai perché noi informatici siamo dei cattivi amanti?» chiese Jabba sedendosi di nuovo davanti alla sua tazza vuota di caffè. «Cattivo amante sarai tu», contestai, preparandomi a sentire con rassegnazione una nuova e tremenda battuta da informatico. Ma Jabba era lanciatissimo. «Perché tentiamo sempre di fare il lavoro il più rapidamente possibile e, quando lo terminiamo, crediamo di aver migliorato la versione precedente.» «No, per favore, no!» gemetti, lasciandomi cadere sul tavolo in un gesto di disperazione che fece crepare dal ridere Proxi. Ci stavamo decomprimendo. La tensione accumulata, sommata alla confusione, ci avvicinava a quello stato di pressione insopportabile da cui bisogna scappare aprendo delle valvole. Guardai distrattamente l'orologio e vidi che erano quasi le sei meno un quarto del pomeriggio. «Mia nonna sta per svegliarsi», commentai con la guancia appoggiata al tavolo. «E allora?» sbuffò Jabba. «Forse morde?» Proxi continuava a ridere senza motivo, come se farlo le liberasse il cervello dalla nebbia. «Non fare lo stupido. È solo che dovrei già essere in ospedale.» «Allora vai. Noi continueremo a lavorare nel tuo studio.» «A che ora torni?» chiese lei incrociando le braccia e sedendosi. «Presto. In realtà non c'è bisogno di me. Ona, mia madre, Clifford e la nonna formano una squadra compatta e ben organizzata. Ma voglio sapere come sta Daniel.» «Allora», canterellò mia nonna dalla porta facendo sobbalzare Jabba e saltare in piedi me, «andiamoci insieme, lo vedi e ritorni.» Non l'avevamo sentita entrare e all'improvviso era li, in piedi, e ci guardava, con i capelli bianchi perfettamente pettinati, la sua elegante vestaglia colorata e le pantofole coordinate. «Nonna! Come hai fatto ad alzarti senza che il sistema se ne sia accorto?» Doña Eulàlia Monturiol avanzò verso la caffettiera con passo da regina. «Ma, Arnauet», la nonna mi chiamava Arnauet da quando ero piccolo, «è solo un volgare sensore di movimento come quello che ho in casa mia contro i ladri. Basta muoversi adagio.» Jabba e Proxi non riuscirono a trattenere le risate. «E ti sei dovuta muovere molto adagio!» protestai. «Per niente, l'ho studiato molto bene. Dovresti aumentargli la sensibilità.» E sorrise soddisfatta mentre si serviva una bella tazza di caffellatte che introdusse nel microonde. «Ciao, Marc, ciao Lola. Scusate se non vi ho salutato prima.» «Non ti preoccupare, Eulàlia», rispose gentilmente Proxi. «Hai un bella vestaglia. Mi piace molto.» «Sì? Se sapessi quanto poco mi è costata!» «Dove l'hai comprata?» «A Kuala Lumpur, due anni fa.» Proxi mi guardò, affascinata, inarcando leggermente un sopracciglio. «Allora, nonna», intervenni per non cambiare discorso, «dicevi che ti porto all'ospedale, mi fermo un momento e ritorno.» «Certo!» assentì scuotendo la testa. «Non so che cosa avete tra le mani, ma, a giudicare dalle vostre espressioni, sembra interessante.» Proxi aprì la bocca, ma solo per emettere un sospiro perché il calcio che le diedi da sotto il tavolo - e dire che ero scalzo - disarticolò le parole che stava per pronunciare. «È lavoro dell'azienda, nonna.» Lei si voltò verso di me, con il tovagliolo, il tazzone di caffellatte e il barattolo di biscotti e, mentre si avvicinava al tavolo, io mi sentii mancare a poco a poco sotto il suo sguardo. «Vediamo che cosa hai inventato ora, Arnauet», sillabò con tono tagliente sedendosi. «A tua nonna non puoi raccontare bugie.» «Non ti spiegherò niente!» le dissi riprendendomi. «Ti ho forse chiesto di farlo? Solo ripeto quello che ti ho sempre detto: tua nonna ha i raggi X negli occhi.» «Questo lo hai preso da un film, è vero, Eulàlia?» s'intromise Jabba, impulsivo come sempre. La nonna si mise a ridere mordicchiando un biscotto. «Su! Ora uscite dalla cucina e lasciatemi fare colazione in pace!» Ma non riusciva a trattenere le risa e, mentre percorrevamo il corridoio in direzione dello studio, la sentimmo tossire perché le era andato di traverso il boccone. «Quando sono con tua nonna, Root», commentò Jabba perplesso, «mi sento come se avessi di nuovo dieci anni.» «Bisogna tagliar corto con lei», conclusi. «Se non la freni, finisce per farti fare quello che vuole.» «È una dolce vecchietta molto pericolosa!» rise Proxi. «Ma tu la tieni sotto controllo, eh, Arnauet?» «Sì», concessi. «Mi è costato abbastanza, però sì.» «Si vede... Perché non andiamo in giardino?» «Per fare che cosa?» chiese Jabba. «Per prendere un po' d'aria e schiarirci le idee.» «Potremmo scendere nella stanza dei giochi della Ker-Central e usare un po' il simulatore. Ne hai voglia, Root?» «Non giocheremo con il simulatore!» si rifiutò tassativamente Proxi. «Ci giochiamo già abbastanza durante la settimana. Ho bisogno di respirare aria pura e vedere un po' di cielo. Ho il cervello intasato.» «Uscite voi», dissi. «Io, intanto, mi faccio una doccia e mi vesto.» «Vai bene così. Non vedo la necessità di...» «Proxi...» la rimproverò Jabba. «Ti aspettiamo in giardino.» Mi allontanai da loro sorridendo, pronto a rimanere sotto l'acqua per un bel po'. Il monitor della stanza da bagno mi fece vedere più volte la nonna che stava perquisendo a uno a uno tutti gli armadi e i cassetti della cucina. Non so che diavolo stesse facendo, ma non poteva essere niente di buono. Jabba e Proxi, da parte loro, passeggiavano tranquillamente tenendosi per mano e chiacchierando come se nella loro vita non fosse successo niente che fosse degno di menzione negli ultimi giorni. Guardandoli, nessuno avrebbe detto che avevano affrontato due misteri delle proporzioni del linguaggio aymara e della mappa di Piri Reis. In quel momento non sentii più i getti di acqua calda, nonostante cadessero su di me con una forte pressione. Tutto era una follia. Tutto. Stavamo forse per diventare paranoici? Una strana maledizione scritta in un linguaggio matematico; un popolo misterioso, l'aymara, che parlava quel linguaggio e che sembrava aver originato l'impero inca; una mappa dall'esistenza improbabile tracciata da un pirata turco, con un'enorme e mostruosa testa disegnata su alcuni picchi delle Ande che all'epoca ancora non si conoscevano; una docente universitaria pazza che accusava mio fratello di essere un ladro; due strane malattie mentali, dai sintomi soltanto apparenti, in rapporto con una strana maledizione. Circolo chiuso. Tornavamo all'inizio, lasciando da parte i quipus, i tocapus, gli yatiris, le deformazioni del cranio, Tiwanacu, il Dio dei Bastoni di Tiwanacu, la sua testa, il suo piedistallo, Sarmiento de Gamboa eccetera, cioè tutto ciò che continuava a essere lawt'ata. Se Daniel avesse potuto dirmi qualcosa! Se mio fratello avesse potuto darmi una mano, fare un po' di luce in quell'oscurità! Che cosa aveva detto la prima notte che Ona e io eravamo rimasti con lui in ospedale? Aveva parlato di un linguaggio, il linguaggio originale, di questo ero quasi sicuro, ma non riuscivo a ricordare le sue parole. In quel momento pensavo che delirasse e non vi avevo prestato molta attenzione. Appoggiando le mani contro i mosaici della doccia, strinsi forte le palpebre e corrugai la fronte nel vano tentativo di riportare alla memoria quelle poche frasi che ora, appena sei giorni dopo, mi sembravano tanto importanti. Era qualcosa di relativo ai suoni di quel linguaggio, ma che cosa? Mentre mi asciugavo e mi vestivo, continuavo a girare attorno al fugace ricordo sfiorandolo con la punta delle dita senza arrivare a coglierlo. In quel momento squillò il telefono. Guardai lo schermo della mia camera e lessi il numero e il nome della persona che mi aveva chiamato, ma non riconobbi né l'uno né l'altro. Non avevo mai sentito parlare di Joffre Viladomat non so che. «Rifiuta la chiamata», dissi al sistema, mentre utilizzavo un calzante per introdurre i piedi nelle scarpe da tennis senza dover disfare i nodi dei lacci. Trenta secondi dopo, Joffre Viladomat insisté. «Rifiuta la chiamata», ripetei, e il computer diede il tono occupato per la seconda volta. Nemmeno allora Viladomat si diede per vinto. Suppongo che, se le circostanze fossero state diverse, avrei ordinato un rifiuto sistematico di tutte le chiamate che provenivano da quel numero, ma dovevo tenere molto bassa la guardia perché, al terzo tentativo, anche se spazientito, risposi. Rimasi di sasso sentendo l'indimenticabile voce di contralto di una donna assolutamente detestabile. «Signor Queralt...» Perché la natura dotava persone così volgari come quella professoressa di strumenti tanto perfetti come quella voce? «Buona sera. Sono Marta Torrent, la direttrice del dipartimento di suo fratello.» «La ricordo perfettamente, dottoressa Torrent. Mi dica... che cosa desidera?» Non riuscivo a vincere lo stupore. «Spero che non la infastidisca che Mariona mi abbia dato il suo numero di telefono», disse con una modulazione intonata. «Che cosa desidera?» ripetei ignorando la sua affettata solennità. Lei rimase un secondo in silenzio. «Vedo che è seccato e, sinceramente, penso che non ne abbia alcun motivo. Sono io quella che dovrebbe essere arrabbiata e, tuttavia, la sto chiamando.» «Dottoressa Torrent, per favore, mi dica una volta per tutte che cosa desidera.» «Molto bene... Vede, non posso lasciare nelle sue mani il materiale che mi ha mostrato ieri nel mio studio. Lei crede che io abbia intenzione di rubare il lavoro di ricerca di Daniel, ma si sbaglia. Se potessimo parlare con più tranquillità...» «Mi scusi, ma mi sembrava che lei accusasse Daniel di essere un ladro.» «Soltanto una parte della documentazione è mia, lo riconosco; l'altra appartiene interamente a Daniel, anche se è ovvio che se l'è procurata in seguito. Si tratta di una situazione molto delicata, signor Queralt, parliamo di un lavoro importantissimo, che è costato tanti anni di ricerca. Vorrei che comprendesse che, se uno soltanto dei documenti che lei conserva andasse perduto o cadesse in mani sbagliate, sarebbe una catastrofe per il mondo accademico. Lei è un informatico, signor Queralt, e non può immaginare neanche lontanamente l'importanza di quel materiale. Me lo restituisca, per favore.» Non era solo la sua voce radiofonica, ma anche il suo modo di parlare. Ma né il suo tono né le sue espressioni potevano nascondere l'urgenza che la opprimeva. La professoressa aveva fretta di appropriarsi della documentazione. «Perché non aspetta che Daniel guarisca?» «Guarirà?» chiese, ironica. «Lei crede veramente che possa guarire? Ci pensi bene, signor Queralt.» Marta Torrent aveva di nuovo superato il limite, e ora in modo definitivo. «Se vuole la documentazione, presenti una denuncia al tribunale!» dissi con rabbia premendo il tasto di uscita per interrompere di colpo la comunicazione. «Rifiuta tutte le chiamate provenienti da questo numero», tuonai, «e anche tutte quelle che provengono dal titolare del numero, chiunque sia; quelle di Marta Torrent e quelle del dipartimento di Antropologia dell'università Autonoma di Bellaterra.» Uscii dalla stanza a grandi passi chiedendomi perché diavolo dovevo avere a che fare con gente di quella risma. Supponendo che Daniel fosse veramente un ladro, cosa cui non potevo credere in nessun modo, e che tutto quello che diceva quella strega fosse vero, non esisteva un'altra maniera per reclamare la documentazione? Doveva insultare mio fratello, chiamarmi a casa la domenica sera e insinuare che Daniel non si sarebbe mai ripreso? Chi diavolo credeva di essere quella donna? Non aveva coscienza? La faccenda del tribunale gliel'avevo detta molto seriamente. Solo se avessi ricevuto una citazione avrei cominciato a crederle e, anche in questo caso, dubitavo molto che sarei arrivato a sospettare anche lontanamente che mio fratello Daniel fosse capace di impadronirsi di documenti che non gli appartenevano. Persino da piccoli, quando prendeva qualcosa di mio, mi lasciava un biglietto! Mio fratello era incapace di rubare qualsiasi cosa, di appropriarsi di niente che non fosse suo, e di questo ero più che sicuro. L'unica conclusione possibile, pertanto, era che la signora Torrent avesse visto qualcosa nella documentazione di Daniel che l'aveva interessata moltissimo, qualcosa per cui era disposta a ferire, a insultare o a mentire vilmente. Forse avrebbe potuto convincere Ona, o qualsiasi altra persona che avesse meno carattere di me, ma la professoressa aveva avuto la sfortuna di incappare nel sottoscritto, e le sarebbe stato molto difficile mettere le mani sul lavoro di mio fratello. Non si diventa direttore di un dipartimento se si ha un cuore d'oro. Soltanto gli arrampicatori, i veri squali, sono capaci di riprodursi in ambienti molto competitivi, e la gente buona come mio fratello di solito è la loro vittima, il gradino che calpestano per salire. Ero andato da lei in cerca di aiuto e non avevo fatto altro che risvegliare il mostro. Non avrei mai dovuto mostrare il materiale di Daniel, ma ormai era troppo tardi per recriminare. Adesso si trattava di verificare il più rapidamente possibile che cosa in quelle carte avesse risvegliato l'ambizione della professoressa. Il lunedì mi svegliai alle otto, pronto a cominciare una lunga e dura giornata di lavoro. Non avvertivo, però, la normale pigrizia di un qualsiasi inizio di settimana. Quasi niente, infatti, era come prima che si ammalasse Daniel. Quella mattina non dovevo scendere in ufficio e ascoltare Núria che declamava la sfilza di colloqui e di riunioni previste per la giornata mentre io prendevo possesso della mia poltrona e il sistema mi collegava ai canali di informazione economica e delle borse di tutto il mondo. Non dovevo tenere videoconferenze con New York, Berlino, Tokyo e neppure riunirmi con tecnici e programmatori esperti di sistemi, reti neuronali, algoritmi genetici o logica sfumata. Il mio unico obbligo era quello di far tranquillamente colazione al sole e aspettare l'arrivo di Jabba e Proxi, che la sera prima avevamo fissato per le nove. Se n'erano andati a casa loro lasciando il mio studio, bisogna dirlo, ridotto uno schifo. La nonna arrivò puntuale dall'ospedale mentre sorseggiavo il tè e mi godevo il giardino di prima mattina. Dal tacchettio, dal suo modo di sbuffare e di rivolgersi a Magdalena e a Sergi mentre avanzava inesorabile verso il punto in cui mi trovavo, indovinai che aveva l'umore in tempesta e l'hard disk bloccato. Arrivò in giardino come un uragano, togliendosi il pesante golf che le piaceva indossare di notte in ospedale. Il suo viso alterato cambiò espressione quando mi vide e abbozzò un sorriso affettuoso che mascherava i ripetuti sospiri. «E dire che ero così contenta il giorno che misi al mondo tua madre!» fu la prima cosa che disse mentre si sedeva accanto a me e mi accarezzava la guancia a mo' di saluto. «Non dovresti prenderla sul serio, nonna», esclamai mentre mi stiracchiavo tendendo le braccia al cielo splendidamente azzurro. Era risaputo che se mia madre e mia nonna passavano insieme un paio di giorni, scoppiava la terza guerra mondiale. Questa volta l'inizio delle ostilità aveva avuto un certo ritardo perché si erano viste appena, ma, alla fine, e come ci si doveva aspettare, l'opportunità si era presentata in uno dei brevi incontri per i turni. «Sai già com'è.» «Per questo lo dico! Come ho potuto avere una figlia così tonta, Signore? Riconosco che suo padre era un poco sregolato, ma ha sempre fatto funzionare la testa. A chi assomiglierà questa ragazza? Sapessi quante volte me lo sono chiesto!» La ragazza, come la chiamava lei, aveva già varcato la frontiera dei sessant'anni. «Com'è andata la notte?» le chiesi per cambiare discorso. La nonna abbassò lo sguardo verso la teiera e aggiustò con cura un angolo del mio tovagliolo. «Daniel si è agitato molto», mi rispose. «Non ha mai smesso di parlare.» Rimanemmo in silenzio, osservando il passaggio discreto di Sergi accanto agli oleandri. «Vuoi qualcosa?» le domandai. «Un bicchiere di latte caldo.» «Scremato?» «Lascia perdere, per carità, autentica acqua sporca! No, latte intero, quello di sempre.» Non dovevo disturbarmi a chiederlo. Il sistema ritrasmetteva l'ordine a Magdalena in qualsiasi parte della casa si trovasse. «Ieri sera era molto tranquillo», notai, ricordando la mia breve visita. «Ieri sera, sì», convenne lei, ravviandosi stancamente i capelli, «ma poi... non so che cosa gli sia successo, non c'è stato verso di farlo dormire neanche con le pillole che gli danno. È stato terribile.» «Si muoveva?» chiesi speranzoso. «No, non si muoveva», mormorò la nonna con tristezza. «Era ossessionato dalla sua sepoltura. Voleva che lo coprissimo con un lenzuolo mortuario e lo seppellissimo. Meno male che, quando gli ho spiegato che queste cose non si usano più e che ora i defunti si cremano, non ha insistito. Perché avrà questa strana mania?» «È la sindrome di Cotard, nonna.» Lei fece una smorfia strana e mi guardò scuotendo la testa come per rifiutare le mie parole. «Dimmi una cosa, Arnauet», esitò. «Quello che Lola, Marc e tu state facendo ha a che vedere con Daniel, vero?» Un raggio di sole si avvicinò lentamente alla mia tazza, poi mi colpì negli occhi abbagliandomi. Stringendo le palpebre, annuii. Lei tornò a sospirare. «Servirebbe a qualcosa se ti riferissi quello che dice tuo fratello di notte o sarebbe una sciocchezza?» Che donna sveglia e intuitiva! Riusciva sempre a sorprendermi. Sorrisi mentre mi scostavo i capelli dal viso. «Raccontami, genio.» E mi chinai per schioccarle un bacio sulla fronte. Lei agitò una mano nell'aria per allontanarmi, ma non mi sfiorò nemmeno. «Te lo racconterò a patto che mi lasci fumare una sigaretta senza ama- reggiarmi la vita.» «Nonna, per favore! Alla tua età non dovresti fare queste cose!» «È proprio alla mia età che posso farle!» E, senza badare alle mie parole, prese dalla borsa un bel portasigarette di pelle e ne trasse una sigaretta con il filtro dorato. «I giovani di oggi non sanno ciò che è buono.» «Non farmi la predica.» «Sto forse parlando di religione? Parlo di godersi la vita! E poi, se mi rompi le scatole, me ne vado in camera mia e pace! Non ti racconto niente di quello che dice Daniel.» Ingoiai le proteste e, con la fronte aggrottata per manifestare il mio disgusto, la guardai esalare la prima nuvola di fumo. La cosa curiosa era che aveva cominciato a fumare molto tardi, a sessant'anni circa, influenzata dalle sue amiche pazze, e non c'era pranzo o festa alla fine dei quali non tirasse fuori il portasigarette. «Mariona mi ha spiegato che quelle parole strane che pronuncia appartengono a un linguaggio al quale stava lavorando per l'università», incominciò appoggiandosi allo schienale della poltrona di vimini. «Quechua, mi ha detto, o aymara. Non è sicura. Non mi chiedere di ripeterle perché non ne sarei capace. Però accenna spesso a una camera che si trova sotto una piramide, soprattutto quando è più nervoso. Allora parla di quella camera e dice che lì si nasconde il linguaggio originale.» Mi alzai di scatto appoggiando i gomiti sul tavolo e la guardai fisso. «E che cosa dice di quel linguaggio originale?» La nonna parve sorpresa della mia reazione, ma subito dopo tornò a puntare lo sguardo sugli arbusti che ci circondavano. «Dice molte cose, ma io credevo che fossero stupidaggini, per la verità. Quello che ripete spesso è che il linguaggio originale è formato da alcuni suoni strani che hanno proprietà naturali, o qualcosa del genere.» Dilatò le narici e strinse le labbra tentando di reprimere con discrezione uno sbadiglio. «Dice anche che questi suoni sono nella camera, che la camera è sotto una piramide e, mi è sembrato di capire, ma non farci molto caso, che la piramide ha una porta in cima.» Sospirò desolata. «Che tristezza, mio Dio! Il mio povero nipote Dani. Credi che guarirà?» Arrivò Magdalena da una delle porte che davano sul salotto reggendo un vassoio con un bicchiere di latte su un piattino. Dietro di lei, inquadrandola come un'ombra gigantesca, c'era Jabba e, accanto a lui, Proxi, con dei jeans elasticizzati che facevano apparire le sue lunghe gambe interminabili e stilizzate. Tutti e due avevano i capelli stranamente appiccicati, come se si fossero buttati addosso litri di gel e, siccome Jabba li aveva molto rossi e Proxi molto neri, il contrasto appariva quanto meno curioso. «Buon giorno,buon giorno!» esclamò Jabba lasciandosi cadere, pletorico ed eccessivamente espansivo, in una delle poltrone di vimini, che scricchiolò come se stesse per squarciarsi. Meno male che era robusta e aveva resistenti cuscini di tela. «È fantastico non dover andare a lavorare!» Proxi si sistemò tra mia nonna e me dando le spalle al sole, senza smettere di guardare, stupita, la sigaretta dalla quale il fumo si alzava in leggere volute. «Arrivi adesso dall'ospedale, Eulàlia?» le chiese. Mia nonna abbozzò un debole sorriso. «Sono appena arrivata, ma, se non vi dispiace, vado a dormire.» Si alzò lentamente, come se pesasse una tonnellata. «So che è una scortesia andarmene proprio ora, però sono molto stanca. Daniel ha trascorso una brutta notte. Glielo racconti tu, d'accordo, Arnauet?» «Non preoccuparti, nonna. Riposati.» «Buon riposo, Eulàlia», le augurò Proxi. «Buona notte, ragazzi», mormorò la mia assonnata antenata portando con sé il bicchiere di latte e il resto della sua dose di catrame e nicotina. «Volete fare colazione?» chiesi a quei due quando mia nonna scomparve all'interno della casa. «No, grazie, Root. L'abbiamo già fatta», mi spiegò Proxi. «Oltretutto non avresti cibo sufficiente da offrire a questo troglodita. Mangia di tutto, al mattino.» «Daniel ha passato una nottataccia?» indagò Jabba cercando di cambiare rapidamente discorso. La spessa cappa di grasso che ricopriva Jabba era qualcosa di molto intimo per lui. Suo fratello, infatti, dopo aver visto Jabba, l'enorme e flaccido verme che in Guerre stellari dirigeva la mafia intergalattica e perseguitava Harrison Ford (Han Solo) per riscuotere il denaro che questi gli doveva, aveva cominciato a chiamarlo così. «È stato molto agitato», gli spiegai, girando la poltrona in direzione del sole. Era molto gradevole starsene lì, nel giardino di casa, senza avere fretta di scendere in ufficio. «Ma non ha recuperato la capacità di muoversi. Mia nonna, però, mi ha riferito alcune delle cose che farfuglia nel delirio e mi pare che il cervello di mio fratello non sia tanto svanito come tutti credono.» «Che cos'ha detto?» chiese Proxi, interessata. «Parla del linguaggio originale.» «Che dici!» saltò su Jabba avvicinando la poltrona fino a incollarsi a me. «Del linguaggio originale? Dell'aymara?» «No, lui non nomina l'aymara. Afferma solo che c'è un linguaggio originale formato da suoni naturali. La prima notte che è stato ricoverato ha biascicato qualcosa di simile davanti a Ona e a me, ma finora non ero riuscito a ricordare le sue parole. Daniel aveva detto testualmente che esisteva un linguaggio primigenio i cui suoni erano inerenti alla natura degli esseri viventi e degli oggetti.» «L'aymara?» insisté il grosso verme mafioso. «No, lui non dice niente dell'aymara!» urlai incazzato. «Va bene! Ma sono sicuro che si riferisce all'aymara.» «E di che altro parla?» «Tenetevi forte... Mia nonna dice che Daniel ripete in continuazione che quei suoni sono nascosti in una camera, che questa camera è sotto una piramide e che questa piramide ha una porta sopra.» Calò nel giardino un silenzio tale che si poteva quasi sentire, nonostante gli schermi protettivi, il rumore soffocato del traffico della strada. Come spinti da un pensiero comune che si materializzò in significativi incroci di sguardi, senza una parola ci alzammo nello stesso istante e ci dirigemmo verso il mio studio. C'era un disegno fatto a mano da mio fratello da riesaminare, quello in cui si vedeva una piramide a gradini di tre piani che aveva un serpente con le corna all'interno e, in una nota, la parola «Camera». Io sapevo già, per averlo visto nello studio della dottoressa Torrent, che quella piramide non era che il piedistallo su cui poggiava il Dio dei Bastoni della Porta del Sole di Tiwanacu, e quindi avevamo un'idea precisa di dove si trovava la camera con il serpente all'interno della piramide; l'unica novità era che la porta non era nella cuspide. Si trattava certamente di un disegno simbolico, qualcosa di simile a una mappa e, in questo caso, sotto la Porta del Sole si poteva incontrare la suddetta piramide. «Bene...» mormorò Proxi tra i denti, dopo aver osservato il disegno. «Credo che i pezzi si stiano incastrando. Dobbiamo verificare la questione delle cronache prima di mezzogiorno.» Obbedimmo come agnellini. Mentre io riprendevo i tre tomi della Nueva Crónica y buen gobierno, Jabba si impossessò dei due enormi volumi dei Comentarios Reales de los Incas, e Proxi della Crónica del Perú di Pedro de Ciega de León e della Suma y narración de los Incas di Juan de Betanzos. Loro si sedettero su due grandi poltrone e io al mio abituale posto di lavoro al tavolo. In quel momento poteva sembrare una stupidaggine aver collegato tanti computer che, nonostante fossero accesi, servivano solo per far ondeggiare in modo sincronizzato sui loro schermi il logo della KerCentral... d'altronde, quale altro accorgimento poteva venire in mente a degli informatici che si disponevano ad affrontare argomenti astrusi e sconosciuti? Io, a volte, pensavo che nelle mie vene non circolasse sangue, ma un torrente di bit (piccole unità di informazione simili ai nostri neuroni) e che la mia materia fisica fosse composta da linee di codice. Dicevo sempre, per scherzo, che il mio corpo era un hardware, la mia mente un software e i miei organi sensoriali le periferiche che permettevano ai dati di entrare e uscire. Era esistito un tempo un mondo senza computer? Com'era la gente prima di potersi collegare attraverso la rete? Nel Medioevo sopravvivevano senza cellulare? Gli incas non avevano fibra ottica né DVD? Che strano era il passato! Soprattutto perché quelle persone non erano tanto diverse da noi. Senza dubbio, nonostante i nostri progressi tecnici, il mondo che ci era toccato in sorte era abbastanza assurdo e la nostra epoca era infestata da atrocità tali - attacchi terroristici, guerre, menzogne politiche, inquinamento, sfruttamento, fanatismi religiosi eccetera - che la gente non era più capace di credere che potessero succedere cose straordinarie. Ma noi eravamo lì per dimostrare che potevano accadere, e che cosa potevamo fare se non lasciarci coinvolgere? Lessi la cronaca di Guamán per tutta la mattinata, pagina dopo pagina, interessandomi ai disegni, cercando, con l'aiuto degli indici, tutti i riferimenti ai collas, agli aymaras e a Tiwanacu (che, in questa edizione, veniva dopo Tiauanaco, nome che aggiunsi alla collezione: Tiahuanaku, Tiahuanacu, Tihuanaku, Tiaguanacu e Tiahuanaco), ma non incontrai più frasi sottolineate da mio fratello né altri dati significativi. Trovai, però, molte curiosità che non avevano niente a che vedere con la nostra ricerca: la descrizione minuziosa delle torture e delle punizioni inflitte agli indios dai governatori o dalla Chiesa era degna del miglior cinema del terrore e la discriminazione sociale e razziale sopravvenuta in seguito alla comparsa di tutte le combinazioni possibili di spagnoli, indios e «neri della Guinea» era incredibile. Se io non scovai niente di veramente utile, Proxi smantellò Juan de Betanzos in meno di mezz'ora, e Jabba ebbe appena un po' più di fortuna con Garcilaso de la Vega. L'inca sembrava confondere gli aymaras con un altro popolo molto diverso, che viveva in un luogo chiamato Apurímac, a molta distanza dal Collao e dal lago Titicaca, parlava dei collas soltanto per rife- rirsi alle sconfitte che avevano subito da parte degli incas o per scandalizzarsi da buon cristiano della libertà delle loro donne di fare ciò che credevano del proprio corpo, prima di sposarsi. Forniva scarsi dati sugli edifici e sulla pianta di Tiwanacu; si limitava a parlare delle dimensioni megalitiche dei blocchi di pietra squadrata utilizzati: «... Pietre tanto grandi che la più grande ammirazione che provocano è immaginare quali forze umane potessero trasportarle dove ora stanno, come è vero che, a grandi distanze da lì, non ci sono né rupi né cave da cui si possano estrarre quelle pietre»; «E ciò che più desta ammirazione sono le grandi facciate di pietra costruite in diversi luoghi, molte delle quali sono di un pezzo solo, lavorate da una sola pietra da tutti e quattro i lati»; «E queste pietre sono grandi e le facciate fatte di un solo pezzo cosicché non si riesce a capire con quali strumenti e attrezzi si potessero lavorare». Poi, con tutta la flemma del mondo, riconosceva di aver copiato l'informazione dalla cronaca di Pedro de Cieza de León, alla quale Proxi stava lavorando in quel momento. L'unico dato curioso - o rivelatore, secondo il punto di vista - che Jabba trovò in Garcilaso, era una frase tra parentesi che compariva all'inizio del libro VII in cui l'autore, discendente da Orejones da parte di madre, spiegava che gli incas avevano imposto con la forza a tutti gli abitanti dell'impero di imparare la «lingua generale», ossia il quechua, e per questo avevano mandato maestri in tutte le province. E, come se niente fosse, afferma: «(E si deve sapere che gli incas avevano un'altra lingua particolare che parlavano tra di loro, che gli altri indios non capivano né gli era permesso di impararla, quasi fosse un linguaggio divino)». «Giurerei», mormorò Jabba, pensoso, «che abbiamo già letto qualcosa del genere.» «Certo!» dichiarai, e Proxi assentì. «Tu stesso mi hai detto che, cercando informazioni sugli aymaras e la loro lingua, avevi trovato un documento in cui si diceva che la lingua che utilizzavano gli yatiris per curare le malattie era la lingua segreta che gli Orejones parlavano tra loro.» «Ah, è vero!» esclamò dandosi un colpo sulla fronte con il palmo della mano. «Che asino! Gli yatiris!» Risentii in quel momento la voce di mio fratello: «Sono morto perché gli yatiris mi hanno castigato». E di colpo, senza sapere bene come, feci una sconvolgente associazione di idee alla velocità della luce: gli yatiris, quegli aymaras di stirpe nobile, discendenti diretti della civiltà tiwanacota, riveriti dagli incas e considerati dal loro popolo grandi saggi e filosofi, erano curiosamente anche strani medici che guarivano con le parole, come facevano gli stregoni; sembrava che possedessero un linguaggio segreto e magico che condividevano con gli Orejones, quelli dal sangue solare e tutta quella storia li. Se curavano con le parole perché non potevano anche far ammalare con le parole? E se il linguaggio divino di cui parlava Garcilaso non fosse stato altro che l'aymara, la lingua perfetta, matematica, l'idioma originale i cui suoni provenivano dalla natura stessa degli esseri viventi e delle cose? Ma perché gli yatiris avrebbero dovuto castigare Daniel? «I pezzi si stanno incastrando uno dopo l'altro», osservò di nuovo Proxi, che non si era resa conto della mia breve assenza. «Sapete che cosa penso? Penso che tutto ciò che stiamo esaminando converga verso due unici punti: Tiwanacu e gli yatiris. Lasciate che vi racconti brevemente quello che dice Cieza de León.» Il mio cervello, però, lavorava su un secondo piano: Pedro Sarmiento de Gamboa percorse il Perù dal 1570 fino al 1575 per scrivere le Informaciones della Visita Generale e, nel corso di quei cinque anni, si incontrò con gli yatiris a Tiwanacu - che ormai era solo un cumulo di rovine - e disegnò una mappa nella quale rappresentava un sentiero che partiva da lì, si addentrava poi nella foresta e conduceva a un luogo sicuramente importante. Appena terminata la mappa, l'Inquisizione lo aveva accusato di praticare la stregoneria e lo aveva rinchiuso nelle carceri segrete che il Sant'Uffizio aveva a Lima per aver creato un inchiostro che provocava un certo genere di sentimento in chi leggeva ciò che con esso veniva scritto. «Cieza era stato nominato Cronista Ufficiale delle Indie nel 1548», spiegò Proxi come introduzione al discorso, poggiando la suola delle scarpe sul bordo del vecchio tavolo di vimini. «E, a partire da quel momento, si dedicò a visitare i luoghi più importanti del Perù narrando fin nei minimi dettagli quello che vedeva e sentiva.» «Racconta anche quanto fossero libertine le donne prima del matrimonio?» chiesi con sarcasmo. «Anche», ammise malvolentieri Proxi. «E non era nemmeno un prete. Meno male che sono nata in questa epoca!» esclamò. «Credo che sarei morta se avessi dovuto sopportare un maschilista tanto retrogrado!» «Allora, che altro dice dei collas?» Jabba la bloccò rapidamente prima che le frecciate gli si rivolgessero contro. «Per esempio che deformavano le teste.» «Ah, sì?» Questo mi interessava molto. «Ascolta: 'Sul capo mettono dei cappelli a forma di mortai, fatti con la loro lana, che chiamano chullos'», lesse, «'e hanno tutti le teste molto allungate e con la regione cervicale affossata perché fin da bambini gliele schiacciano e le modificano come vogliono, come ho scritto'.» «Il cappello si chiama chullo!» esclamai divertito. «Che cos'è la regione cervicale?» volle sapere Jabba. «È la parte posteriore della testa, la nuca», gli spiegò Proxi. «C'è qualcosa che non mi quadra», dissi. «Perché dice che tutti i collas si schiacciavano la testa da piccoli? A me la professoressa ha detto che la deformazione del cranio si praticava solo tra le classi alte, come segno di distinzione.» «Ciascuno afferma una cosa diversa», borbottò la mercenaria. «Ogni archeologo e ogni antropologo ha la sua propria e differente versione dei fatti, e poi, con tutto quel guazzabuglio, gli storici montano una specie di teoria generale che non prende in considerazione un determinato tipo di questioni per non impegolarsi.» «E perché non si mettono d'accordo?» protestò Jabba. «Ci renderebbero la vita più facile!» «Non si può cavare il sangue da una rapa, Marc», sentenziai. «Se vuoi ti racconto di nuovo la rissa che hanno messo in piedi con i documenti Miccinelli.» «No, grazie mille», si affrettò a rispondermi, preoccupato che continuassi a parlare. «Proxi, presto, vai avanti con Cieza.» «Vediamo a che punto ero... Qui. Guardate, vi farò una sintesi e poi approfondiremo Tiwanacu, d'accordo? Allora, i collas raccontarono a Cieza de León che discendevano da una civiltà molto antica, anteriore al diluvio, ma che non sapevano molto di quegli antenati. Assicuravano di essere stati un Paese molto grande che, prima degli incas, aveva grandi templi e venerava i sacerdoti. Poi la popolazione abbandonò gli antichi dei e adorò Viracocha, che era sorto un giorno dalle acque della grande laguna Titicaca per creare il sole e sconfiggere le tenebre nelle quali era immerso il mondo dopo il diluvio. Come gli egizi, veneravano e mummificavano i loro morti ed erigevano per loro importanti edifici in pietra chiamati chullpas.» «E che cosa dice di Tiwanacu?» chiesi notando che Proxi aveva terminato il riepilogo. Lei abbassò gli occhi sul libro, sfogliò un paio di pagine avanti e indietro e cominciò a leggere: «'Ritengo queste antichità le più antiche di tutto il Perù; si pensa che, molto tempo prima che gli incas regnassero, fossero già stati costruiti alcuni di questi edifici perché ho sentito affermare a degli indios che gli incas costruirono i grandi edifici del Cuzco con la forma che avevano i muri o le pareti che si vedono in questo luogo'». «Che modo di parlare! Non si capisce niente!» «Stai zitto, Jabba! Continua a leggere, Proxi, per favore!» «'Ho chiesto ai nativi, alla presenza di Juan Varagas (che è colui che comanda su di loro), se questi edifici erano stati costruiti al tempo degli incas, e risero di questa domanda ribadendo ciò che avevano già detto, che prima che quelli regnassero erano già stati costruiti, che loro non potevano dire né affermare chi li aveva fatti, ma che avevano saputo dai loro antenati che quello che si vedeva lì era stato costruito in una sola notte.'» «Che accidenti avrà voluto dire?» brontolò Jabba, che si agitava sulla poltrona come un'animale in gabbia. «Che i collas assicuravano che Tiwanacu era stata costruita molto prima dell'arrivo degli incas e che, secondo i loro antenati, tutti gli edifici erano stati eretti in una sola notte.» «Cieza, inoltre», proseguì Proxi imperturbabile, «fa una dettagliata descrizione delle rovine così come le vide durante la sua visita.» «Hai una mappa di Tiwanacu, Root?» «Finora non mi era servita.» «Se dobbiamo situare la Porta del Sole e capire che cosa dice Cieza, dovremmo scaricarne una da Internet.» «Dopo lo facciamo», le dissi senza muovermi. «È ora di pranzo.» Il suo viso si illuminò e fece per balzare su dal sofà come se patisse tutta la fame del mondo, ma il breve arpeggio di accompagnamento del messaggio che apparve sugli schermi frustrò brutalmente la sua mossa. Dopo quasi quattro giorni di ricerca incessante e a pieno regime, il sistema aveva trovato la password del computer di Daniel. Se qualcuno mi avesse assicurato che mio fratello sarebbe diventato un giorno il presidente degli Stati Uniti probabilmente non gli avrei creduto. Se me lo avesse giurato, dato per scontato e mi avesse mostrato i documenti che lo accreditavano come tale, alla fine avrei dovuto accettarlo, certo, ma avrei mantenuto le mie riserve fino al giorno in cui avesse preso possesso della carica, e persino allora avrei pensato che era un sogno strano da cui avrei finito per svegliarmi. Bene, fu esattamente quello che provai quando ebbi davanti ai miei occhi la password scelta da mio fratello per proteggere il suo computer: (¯`Dån¥ëL´¯) Dodici caratteri, non uno di più non uno di meno, il doppio del normale, e inoltre i più imprevedibili e impossibili da indovinare. Nessuno usava quel tipo di password, nessuno aveva tanta immaginazione - o tanta prudenza -, nessuno era, in definitiva, tanto raffinato, soprattutto perché poche applicazioni ti permettevano di utilizzare stringhe tanto lunghe e, meno ancora, simboli tipografici tanto pittoreschi. Soltanto programmi molto sofisticati o al contrario programmini modesti elaborati da hacker di scarso valore permettevano un simile esibizionismo crittografico, e, anche in questo caso, ciò che mi stupiva era che Daniel avesse fatto questo sfoggio di fantasia e di cautela informatica così poco consono a lui. Non si smette mai di imparare... Jabba e Proxi non riuscivano a credere ai loro occhi. Entrambi mostrarono prima il più grande stupore, poi l'assoluta certezza che quella password non l'avesse inventata Daniel. «Non offenderti, Root», mi disse Proxi da esperta della materia, posandomi una mano sulla spalla, «ma tuo fratello non possiede il livello informatico necessario per conoscere l'esistenza di queste chiavi in ASCII.11 Metterei una mano sul fuoco che l'ha copiata da qualche parte e sono sicura che non me la brucerei.» «Comunque non cambia nulla», balbettai, ancora scombussolato per la scoperta. «Sì, certo. È la cosa meno importante in questo momento», affermò Jabba tirandosi su i pantaloni fino a dove glielo permetteva la pancia. «Quello che dobbiamo fare ora è conservare una copia di sicurezza della chiave e andare a mangiare.» Naturalmente non gli badammo; rimase così a proclamare la sua fame nel deserto, mentre Proxi e io ci addentravamo nelle viscere del portatile con uno strano senso di insicurezza per quello che ci aspettava lì dentro. Quando ebbi il controllo della macchina, lanciai un'occhiata al contenuto dell'hard disk e rimasi colpito dalla grande quantità di spazio occupato per le poche cartelle che c'erano nella directory principale. Ma il mistero si chiarì subito quando verificai che al suo interno le cartelle si ramificavano all'infinito con innumerevoli archivi di immagini e con gigantesche applicazioni (una delle quali era la barriera della password). Così passammo rapidamente al computer centrale per poterla infrangere a sei mani da diversi terminali. Quando si utilizza qualsiasi programma di computer, come regola generale si avvia nel modo eseguibile, cioè tradotto nel freddo linguaggio binario che utilizza la macchina: una lunga serie di zeri e di uno il cui senso è impossibile da comprendere per un essere umano. Per questo motivo si utilizzano linguaggi intermedi, linguaggi che, in forma di codice, dicono al computer quello che il programmatore vuole che faccia. In quel codice si suole inserire commenti e spiegazioni che il processore ignora al momento di lavorare e che servono ad aiutare a capire il funzionamento dell'applicazione ad altri programmatori e a facilitare il lavoro di revisione. Quindi, quando ci trovammo davanti il codice del programma delle chiavi di accesso, capimmo che avevamo a che fare con qualcosa di insolito. Un programma di computer presenta molte similitudini con un'opera musicale, un libro, un film o una ricetta di cucina. La sua struttura, il suo ritmo, il suo stile e i suoi ingredienti permettono di identificare o almeno di avvicinarsi molto all'autore che vi sta dietro. Un hacker non è che una persona che pratica la programmazione informatica con un certo tipo di passione estetica e che si identifica con un certo tipo di cultura che non si riduce semplicemente a un modo di essere, di vestire o di vivere, ma anche a una maniera speciale di vedere il codice, di capire la bellezza della sua composizione e la perfezione del suo funzionamento. Per il codice di un programma quella bellezza deve solo rispettare due norme elementari: semplicità e chiarezza. Se si può fare in modo che il computer esegua un ordine con una sola istruzione, perché utilizzarne cento o mille? Se si può trovare una soluzione brillante e semplice a un problema concreto, perché copiare pezzi di codice da altre applicazioni e rappezzarle male? Se si possono classificare le funzioni una dietro l'altra in modo chiaro, perché complicare il codice con salti e giri che servono solo a rallentarne il funzionamento? Quello che avevamo davanti, però, era il lavoro sporco di uno o più programmatori inesperti che avevano tranciato altre applicazioni e avevano riempito con migliaia di linee di codice inutile un programma che funzionava bene, quasi per miracolo... Sembrava uno di quei lavori scolastici che si facevano copiando pagine intere da libri ed enciclopedie fino a ottenere un pastiche leggibile che si abbelliva con una pomposa considerazione finale. «Che diavolo è questa porcheria?» gridò lamentosamente Jabba, inorridito. «Avete visto le note del codice?» chiese Proxi puntando l'indice verso il suo schermo. «Mi ricorda qualcosa...» mormorai mordendomi le labbra. «Mi è molto familiare. Lo avevo già visto prima.» «Anch'io», confermò la mercenaria, pigiando i cursori per muoversi verso l'alto e verso il basso rapidamente. «Giurerei che viene dall'Oriente», azzardai. «Pakistan, India, Filippine...» «Filippine», confermò Proxi senza il minimo dubbio. «Dalla Facoltà di Informatica della Scuola universitaria AMA, di Manila.» «Ricordami di aumentarti lo stipendio.» «Quando vuoi esattamente che te lo ricordi?» «Era solo un modo di dire.» «Proprio per niente!» Jabba non voleva lasciarsi sfuggire l'occasione. «Io ho sentito come glielo hai detto!» «Va bene. D'accordo!» farfugliai girando la sedia per mettermi di fronte a loro. «Riprenderemo il discorso quando sarà finita questa storia, sul serio. Ora dammi altri dati sui programmatori, Proxi.» «Studenti dell'ultimo anno di Informatica. La Scuola universitaria AMA è la più prestigiosa delle Filippine, si trova nel distretto finanziario di Makati e dalle sue aule sono usciti autentici geni come l'esecrabile Onel de Guzmán, autore del virus 'I Love You', che infettò quarantacinque milioni di computer di tutto il mondo e che mi costrinse a lavorare come una matta per un mese per impedire che i nostri sistemi si contagiassero. Questi ragazzi programmano per pagarsi gli studi e per trovare lavoro in Occidente. Sono svegli, sono poveri e hanno accesso a Internet. Hanno bisogno di guadagnare denaro e richiamare l'attenzione.» «E come è riuscito Daniel ad avere un programma del genere?» «Ho analizzato le note del codice alla ricerca di indizi», precisò Jabba, «ma non c'è niente, e dubito molto che sia comparso in una rivista di informatica, perché di solito sono attente a quello che pubblicano. E nemmeno il nome del programma dice molto: 'JoviKey'... 'La chiave di Jovi'? Impossibile da sapere. L'unica cosa che mi viene in mente è che Daniel lo abbia trovato in Internet, ma mi stupirebbe, perché i programmi che si mettono in rete a uso gratuito sono soliti riportare il copyright, e questo ne è privo.» «E non è normale», commentò Proxi alzando il dito in alto a mo' di Cristo pantocratore. «No, non lo è», ammisi perplesso. Di malavoglia, verso le tre del pomeriggio, facemmo una pausa per mangiare sul terrazzo, ma nel giro di mezz'ora ritornammo nello studio per continuare a spulciare il contenuto del portatile. Magdalena ci portò il tè e il caffè, e il pomeriggio passò in un baleno ad aprire applicazioni, a studiare ed esaminare fotografie e testi. E lì c'era tutto. Non ci eravamo sbagliati. Avevamo seguito i passi di Daniel con una precisione millimetrica, rivedendo in un'intensa e difficile settimana quello che lui, completamente solo, aveva trovato in sei mesi. La sua fatica non era stata vana perché le scoperte archiviate nella documentazione erano veramente straordinarie. Aveva realizzato un lavoro brillante, immenso, per cui non c'era da meravigliarsi se si era ritrovato esaurito e con i nervi a pezzi. In base a quello che deducemmo dalle sue caotiche note e dagli schemi, lavorando sul quipu quechua dei documenti Miccinelli che Marta Torrent gli aveva affidato, il mio intelligente fratello si era trovato in mille e una occasione in grandi difficoltà che lo avevano portato alla convinzione che non fosse il quechua puro l'idioma che si utilizzava normalmente per scrivere con i nodi. Ricercando, aveva scoperto in Garcilaso de la Vega il riferimento al linguaggio segreto degli Orejones, che, sebbene con influenze e infiltrazioni di quechua, si era rivelato in sostanza l'aymara. A partire da quel momento, come poi avremmo fatto noi tre, aveva intuito quanto di strano ci fosse in quella lingua e quindi aveva abbandonato le cordicelle per concentrarsi sui tocapus, i quadratini e i disegni tessili. La lettura di Guamán Poma e degli altri cronisti lo aveva infatti portato a pensare che questo fosse il sistema di scrittura della «Lingua sacra», come lui la chiamava. Aveva studiato con impegno, e più imparava più si convinceva che tutto racchiudeva un antico mistero legato al potere delle parole. Aveva scoperto gli yatiris, Tiwanacu e, con nostra sorpresa, anche una strana venerazione per le teste da parte degli aymaras, che lui collegava con il potere delle parole. Per questo si era dedicato a collezionare fotografie di crani deformati e per questo la mappa di Piri Reis aveva attratto la sua attenzione. Daniel supponeva che, in tempi molto antichi, forse alcuni millenni prima della nostra era, gli aymaras (o i collas o i pucaras) avessero adorato un dio che assomigliava a Humpty Dumpty capoccione. Perciò si era impegnato a svelare l'antichità della mappa, per determinare in quale momento storico gli aymaras avessero professato quella devozione per un dio megalocefalo che lui identificava con un ulteriore e più umanizzato Dio dei Bastoni. Tuttavia, non era sicuro che quella rappresentazione simbolizzas- se realmente un dio, come tutti dicevano, e tanto meno Viracocha, che riteneva fosse un'invenzione inca, creata in un tempo molto vicino all'arrivo degli spagnoli. Doveva aver fatto molti tentativi per interpretare i testi scritti nei tocapus, perché c'erano centinaia di riproduzioni passate allo scanner, di tessuti e oggetti in ceramica con la stessa decorazione. Immagazzinava disperatamente esempi su esempi in cerca della chiave che gli permettesse di confermare che quei disegni geometrici erano in realtà un sistema di scrittura. Le cartelle con quelle riproduzioni in formato digitale erano interminabili e la loro catalogazione non sembrava avere il minimo senso poiché i nomi erano composti da lunghe file di cifre non correlate tra loro. A quel punto trovammo il programma informatico che alla fine gli aveva svelato la chiave. Si chiamava «JoviLoom» (forse «il telaio di Jovi»?) e, come il fratello gemello «JoviKey», non aveva copyright ed era composto da milioni di istruzioni ovviamente rubate e, in più, strutturate male e unite ancora peggio. E, di nuovo e impensabilmente, il mostro funzionava e invadeva, da solo, la quasi totalità dell'hard disk. Avremmo avuto bisogno di alcune teste in più e di altre settimane di lavoro per poterlo esaminare per intero. Ma con le indagini che avevamo fatto ne avevamo a sufficienza, e la nostra prima e ovvia conclusione fu che quegli hacker filippini erano ammiratori di Bon Jovi, il famoso gruppo di hard rock del New Jersey. «JoviLoom» era, fondamentalmente, un programma di gestione di database. Fin qui, tutto normale. E non risultava nemmeno spettacolare il fatto che gestisse immagini al posto di sequenze di informazioni, perché c'erano centinaia di programmi che lo facevano. Di nuovo, tutto regolare. La cosa curiosa era che, quando si avviava, si aprivano due finestre verticali, una accanto all'altra, e che nella prima compariva un campionario di più di duecento piccoli tocapus ordinati in file di tre che potevano essere selezionati a uno a uno con il cursore e trascinati fino alla finestra contigua per riprodurre il disegno di tutti i tessuti. Allora, dopo aver confermato che avevi terminato di «tessere» il testo che volevi, il programma trasformava il bozzetto in una linea continua di tocapus e seguiva questo filone alla ricerca di catene identiche. Se ne trovava due uguali, spezzava la linea in frammenti cominciando dalla prima lettera (o tocapu) della catena (o parola) incontrata, e iniziava di nuovo la ricerca cominciando dal secondo tocapu del disegno. Quello che, in fin dei conti, faceva «JoviLoom» era qualcosa di simile a ciò che si realizzava in quel passatempo chiamato «paroliere» in cui si cercano coincidenze di sequenze, anche in senso verticale, diagonale, o contrario. Così, da un manto rettangolare, per esempio, decorato con un numero determinato di tocapus, si potevano trarre innumerevoli combinazioni e trasformazioni che davano, come risultato finale, una serie di matrici (come nel passatempo) che racchiudevano le presunte parole trovate, che «JoviLoom» ricollocava e separava seguendo un ordine logico conforme alla sua ubicazione originale. Una volta composto il testo in questa maniera, cioè adattandolo alla forma grammaticale latina, mancava solo la traduzione, ma questo non era compito di «JoviLoom», che si limitava a offrirne generosamente una versione anarchica formata da radici e suffissi aymaras in apparente confusione. Sembrava che un solo tocapu potesse rappresentare sia una lettera (sicuramente consonanti e basta) sia una sillaba di due, tre e anche quattro lettere, o persino una parola completa, da cui deducemmo che ciascuno di loro poteva avere un senso simbolico che rappresentava un concetto o una cosa, e un senso fonetico, che rappresentava un suono. Ma «JoviLoom», a volte, metteva insieme anche due o tre tocapus quando doveva dare un unico suffisso o radice. «A me sembra», cominciò a dire Jabba, tutto concentrato sul suo foglio, «che siano parole composte, come 'portachiavi o 'contachilometri'.» «Spegni il cervello, intelligentone!» gli ordinò Proxi. Volendo, «JoviLoom» forniva anche una versione stampata del risultato, ma, per quello che ne sapevamo dell'aymara, sarebbe stato lo stesso. «E se questa assurda manciata di consonanti non fosse aymara?» chiesi improvvisamente allarmato. «E che diavolo dovrebbe essere?» replicò Jabba. Tuttavia da quel momento cadde su di noi il dubbio, sotto forma di un pesante silenzio. Eravamo coscienti di essere in trappola, perché non avevamo modo di confermare che quel guazzabuglio senza vocali corrispondesse al linguaggio dei collas. E in quel disgraziato momento a mia nonna venne in mente di venire a salutare prima di recarsi in ospedale, così la poverina se ne andò senza che nessuno si degnasse di rivolgerle nient'altro che grugniti. Fortunatamente, poco dopo trovammo, nei file archiviati in una delle cartelle del programma, un mucchio di «parolieri» già frazionati e, assieme a questi, nel file di testo con lo stesso nome, la loro versione in caratteri latini che formava le parole ricostruite e completate da Daniel e... oh, sorpresa!... il testo in cui risultava che era in aymara. Certamente queste ricostruzioni continuavano a essere del tutto inintelligibili per noi, ma almeno potevamo cercare alcuni termini nei dizionari di Ludovico Bertonio e Die- go Torres Rubio e capirne il significato. Inoltre, alcuni di questi file erano anche stati tradotti da mio fratello, ma, in previsione del loro contenuto (per esempio, Amayan marcapa hiuirinacan ucanpuni cuna huchasa camachisi, ovvero: «Dal morto nel suo paese i mortali in quello si fa sempre un peccato») decidemmo che quelli che erano arrivati a un punto morto quel giorno eravamo noi tre, soprattutto perché ci era piombata addosso la notte e Clifford e mia madre ci stavano aspettando da più di un'ora per cenare. Anche se la giornata era stata straordinariamente fruttuosa, la scoperta più spettacolare la facemmo il giorno seguente, il martedì, poco dopo aver iniziato il lavoro. Quasi per caso ci imbattemmo, all'interno del computer di Daniel, in un documento abbastanza grande chiamato Tiwanacu.doc, archiviato in modo incomprensibile in una delle affollate cartelle di immagini. Quale non fu la nostra sorpresa quando scoprimmo che si trattava di una curiosa raccolta di traduzioni di testi aymaras i cui originali, deducemmo, dovevano trovarsi nella vasta collezione fotografica di tessuti e ceramiche. I frammenti erano di dimensioni diverse, alcuni molto grandi, altri piccoli, di una o due righe appena; tutti però parlavano di un luogo mistico e sacro chiamato Taipikala, per cui all'inizio non capimmo perché diavolo il file si chiamasse Tiwanacu. «Taipikala», secondo Daniel, significava «Pietra di mezzo» o «Pietra centrale», e lì, in Taipikala, aveva avuto luogo la nascita del primo essere umano, figlio di una dea venuta dal cielo chiamata Oryana e di alcune specie di animali terrestri. Dopo aver partorito settanta creature e, pertanto, aver compiuto largamente la sua missione, la dea se n'era tornata nelle profondità dell'universo dalle quali era venuta. La sua numerosa discendenza - sembra che fossero giganti che vivevano centinaia di anni - eresse in suo onore Taipikala, e continuò ad adorarla per millenni in quel luogo finché un terribile cataclisma (tanto grande che fece sparire il cielo, il sole e le stelle) e un successivo diluvio che sommerse la «Pietra centrale» e quasi tutta la popolazione distrussero per sempre la razza dei giganti, i cui malaticci e deboli discendenti cominciarono a crescere meno di generazione in generazione e a morire molto prima. Ma, siccome avevano conservato gli insegnamenti di Oryana e sapevano utilizzare i suoni della natura e parlare il linguaggio sacro, continuarono a essere yatiris. Credo che fu a quel punto che cominciammo ad avere chiaro di che cosa si trattasse. Se sgrossavamo il mito e rimanevamo con i dati significativi, la leggenda raccolta nei frammenti sparsi dei tocapus convalidava quello che noi, per conto nostro, avevamo scoperto. Accettammo anche che Taipikala avesse tutte le carte in regola per essere Tiwanacu, e questo fu confermato dai dati che acquisimmo in seguito. Molto tempo dopo il diluvio, Willka, il sole, finalmente ricomparve, e lo fece sorgendo dalle tenebre in un punto situato al centro della grande laguna chiamata Kotamama (Titicaca?), attaccata a Taipikala. Lì fu visto per la prima volta e gli stremati e probabilmente congelati esseri umani, nel timore che scomparisse di nuovo, lo adorarono in tutte le maniere possibili, offrendogli cerimonie e sacrifici con tutta la devozione che si può immaginare. La città di Taipikala rinacque dalle ceneri sotto il governo degli yatiris più saggi, chiamati Capacas, che fecero del culto del sole l'asse centrale della loro nuova e timorosa religione. Willka non poteva scomparire ancora, ne dipendeva la continuità degli esseri umani. Se Willka se ne fosse andato sarebbero morti, e con loro, come erano stati sul punto di constatare, la natura al completo. Così il sole divenne un dio e Taipikala la sua città santuario. Lì, con una grande cerimonia, si legava Willka alla pietra dei solstizi, la cosiddetta «pietra per legare il sole», con una grossa e lunga catena d'oro che lo ancorava allo spazio-tempo. Nonostante tutto, di tanto in tanto il sole si liberava dalla catena e spariva, e il terrore invadeva gli abitanti di Taipikala. Ma i Capacas tornavano a legarlo stretto alla pietra e non gli permettevano di andarsene. Non dimenticarono Oryana, però lei ormai non c'era più e Willka era, agli effetti pratici e immediati, molto più importante e necessario. Come importante e necessario era anche Thunupa, un nuovo dio creato dalla paura, il quale simboleggiava il potere dell'acqua e del lampo che annuncia la tempesta. Thunupa non era rilevante come Willka, tuttavia i due erano complementari rispetto al compito di evitare un nuovo disastro. Inoltre, dal diluvio, le stagioni delle piogge erano cambiate in modo strano e i raccolti non erano più abbondanti come prima. Willka e Thunupa, il sole e l'acqua, erano gli dei principali del pantheon di Taipikala. Gli yatiris divennero i depositari e i guardiani della sapienza antica, e quindi presto si trovarono al culmine del potere sociale e religioso. Il mondo era cambiato molto; persino la laguna Kotamama, che prima arrivava ai moli del porto di Taipikala, ora si trovava a una distanza considerevole, ma loro continuavano a conservare il potere di guarire le malattie e di trattenere il sole nel cielo giorno dopo giorno. Presto costituirono una casta a parte: parlavano un linguaggio proprio, studiavano con meticolosità il firmamento, potevano predire gli avvenimenti e insegnavano il modo di portare l'acqua dalla grande laguna ai lontani campi coltivati per ottenere abbondanti raccolti nonostante il freddo che, dal tempo del diluvio, flagellava la zona. Il luogo più sacro di Taipikala era la Piramide del Viaggiatore, un posto appartato dal resto degli edifici nel quale si custodivano delle grandi piastre d'oro sulle cui lucide superfici fu scritta, affinché nessuno dimenticasse, la memoria della creazione del mondo, la venuta di Oryana, la storia dei giganti e del diluvio, la rinascita dell'umanità dopo il ritorno del sole, e tutto ciò che gli yatiris sapevano dell'universo e della vita. La Piramide del Viaggiatore conteneva, inoltre, importanti disegni che mostravano il firmamento e la Terra prima e dopo il cataclisma, ospitava il corpo stesso del Viaggiatore e ciò che gli serviva per percorrere i mondi che lo aspettavano nell'aldilà fino al suo ritorno. Tutto ciò era pensato per aiutare l'umanità futura nel caso in cui fosse successo un disastro. Anche se la lettura di tutte quelle leggende aymaras era piacevole, bisognava riconoscere che erano soltanto delle favole per bambini che non ci fornivano nessun dato veramente interessante. Molti frammenti di testo, tra quelli raccolti religiosamente da mio fratello, elogiavano la saggezza, il coraggio e gli straordinari poteri degli yatiris e dei suoi Capacas, ma, dal momento che le informazioni provenivano da tessuti e da ceramiche di datazione molto posteriore, era ovvio che tutto era necessariamente colorato dal mito e dalla bellezza prodotti dalla nostalgia, e quindi non ci serviva a niente. Gli yatiris facevano molte cose, va bene, e con ciò? Buon per loro. Punto e basta. Ma quando Proxi stava già cominciando a farfugliare parolacce contro Taipikala e Jabba era andato in cucina in cerca di qualcosa da mangiare, comparve, finalmente, il primo frammento realmente utile: gli yatiris, sacerdoti di Willka e discendenti diretti dei giganteschi figli di Oryana, possedevano un sangue sacro che non potevano mescolare e, pertanto, erano obbligati a riprodursi soltanto tra di loro. «Caspita, come sono contenta!» esclamò Proxi, in preda a un'improvvisa soddisfazione. «La casta degli yatiris non era formata soltanto da uomini!» «È evidente che ci fossero anche le donne», accettò Jabba, divorando un pacco di biscotti. «Ma finora nessun documento lo aveva detto.» «Fate sempre lo stesso errore!» Proxi ci additò in modo accusatorio. «Date per scontato che le parole senza genere si riferiscano solo agli uomini.» «Non è vero», scattai. «È che Daniel mette l'articolo plurale maschile davanti a 'yatiris'.» «E Daniel che cos'è?» brontolò lei con tono spregiativo. «Un altro uomo. Che non sbaglia mai! Ti ricordi, Jabba, di quello che abbiamo letto sull'uso del genere quando cercavamo informazioni sull'aymara?» Jabba annuì con la bocca piena senza smettere di masticare freneticamente. Lei continuò: «In quella lingua perfetta, non esiste grammaticalmente differenza di genere per le persone. Non esiste lei o lui, né pronomi femminili o maschili». «È lo stesso», farfugliò Jabba lanciando in aria particelle di biscotto sminuzzato. «E nemmeno gli aggettivi hanno un genere», proseguì Proxi. «Non c'è differenza, per esempio, tra nuovo e nuova o tra bello e bella.» «È lo stesso.» «Esattamente! Quindi la parola 'yatiris' può riferirsi sia a uomini sia a donne.» «Ammesso che sia vero», osai commentare anche a rischio di morire nel tentativo, «non è quello che ci interessa in questo momento. Va bene, c'erano delle donne tra gli yatiris, ma a me sembra più importante la faccenda del sangue sacro che non si poteva mescolare. Non vi ricorda gli Orejones?» Jabba, che aveva la bocca piena, quasi soffocò tentando di rispondermi. Dopo essersi schiarito più volte la voce colpendosi il petto con la mano, e aver posato sul tavolo il pacco di biscotti per allontanare la tentazione, mi disse, accigliato: «Non ti sei reso conto che è la medesima storia che ci hai raccontato su Viracocha, ma senza Viracocha? Ricordi? Le due razze umane, quella dei giganti che lui distrusse con colonne di fuoco e con il diluvio, e l'altra, dalla quale ebbero origine gli incas. Le leggende coincidono persino sul fatto del sole. Non ci hai detto che Viracocha lo aveva fatto sorgere dal lago Titicaca per illuminare il cielo dopo il diluvio?» Lanciai una raffica di improperi per la mia mancanza di prontezza. Jabba aveva ancora una volta ragione e io arrivavo tardi sull'argomento, ma feci finta di niente guardando verso lo schermo del portatile, come se fosse la sorpresa quella che mi frenava la lingua. Mentre noi due continuavamo a leggere, Proxi si mise a lavorare su un altro computer. La osservai affannarsi con diversi motori di ricerca in Internet mentre la storia imbastita da mio fratello con la sua selezione di testi scritti con i tocapus andava avanti. Non le chiedemmo che cosa stesse facendo perché, se avesse trovato qualcosa, ce lo avrebbe detto. La cronaca elaborata da Daniel raccontava che a un certo momento si era verificato uno spettacolare terremoto sull'altopiano, che era costato la vita a centinaia di persone e aveva mandato in rovina i principali edifici di Taipikala, già fatiscenti per gli anni, per il precedente cataclisma e il successivo diluvio. Fu una rovina totale. Di fronte all'entità del disastro, si rese necessario prendere una serie di decisioni importanti, la qual cosa provocò un forte dissidio tra i Capacas governanti. Il poema o la canzone nella quale si narrava l'accaduto - quasi due fogli di versi con gli opportuni e insistenti ritornelli - ci spiegava le ragioni del contrasto, ricordava quanto era stato doloroso lo scontro e quanto dignitose e corrette erano state reciprocamente le diverse fazioni. La contesa terminò con l'allontanamento dalla città di un nutrito gruppo di Capacas, yatiris e contadini che diedero inizio a un esodo verso il nord, attraverso la cordigliera. Dopo molto tempo, questo gruppo di persone giunse in una bella e soleggiata vallata, e i Capacas decisero che quello era il luogo idoneo per fondare una seconda Taipikala, che chiamarono Cuzco, «l'ombelico del mondo», per analogia di significato con «la pietra centrale». Ma le cose non funzionarono come avevano previsto e la necessità di guerreggiare continuamente con le popolazioni vicine produsse la comparsa di un capo militare, lo yatiri Manco Capaca, noto anche come Manco Capac. Niente popodimeno che il primo inca. La realtà e la leggenda tornavano a fondersi davanti ai nostri occhi man mano che venivamo a conoscenza della versione aymara della storia. Ma c'era di più: i Capacas di Cuzco, che avevano mantenuto il loro ruolo di sacerdoti e di guaritori, con il tempo presero il nome di kamilis, e la loro origine, apparentemente, si perse nel corso della formazione del grande impero. Si fusero (o confusero) con alcuni medici chiamati kallawayas, che curavano la nobiltà inca Orejona e che si guadagnarono la fama di possedere una lingua propria, un linguaggio segreto che nessuno capiva e che serviva come segno di identità. Le loro tracce si dissolvevano irrimediabilmente mentre i testi che parlavano degli yatiris di Taipikala davano la prova della loro sopravvivenza nonostante le grandi difficoltà che avevano dovuto affrontare. Dopo il terremoto la città non tornò più a essere quella di prima. I suoi abitanti e la gente che era vissuta nelle vicinanze si dispersero a poco a poco e comparvero piccoli stati sovrani (Canchi, Cana, Lupaca, Pacaje, Caranga, Quillaca...) sul genere dei regni di Taifas.12 «Eccolo!» esclamò Proxi. «Ascoltate quello che ho trovato in una rivista boliviana: 'Gli indigeni la chiamavano Tiwanaku. Si narra che un giorno, un secolo prima, Tinca Pachakutej contemplasse le antiche rovine e, ve- dendo arrivare un messaggero, gli disse: Tiai Huanaku (siediti, guanaco). E la frase coniò il nome. Probabilmente nessuno voleva raccontare ai nuovi conquistatori che il nome della città perduta nel tempo era Taipikala (la pietra di mezzo). E ancor meno che lì il dio Viracocha aveva iniziato la creazione e che quella era la pietra di mezzo, ma del centro dell'universo.'13 Credo che questa stupidaggine di 'Siediti, guanaco' la racconti anche Garcilaso de la Vega», commentò con disprezzo. «Bene, dunque abbiamo la conferma», dissi, «che Taipikala era il nome originale di Tiwanacu, anche se c'erano pochi dubbi in proposito.» «Ho solo bisogno di verificare un particolare», annunciò lei, ritornando al suo computer. «Voglio essere sicura che Taipikala-Tiwanacu avesse un porto per le acque del Titicaca.» «Sarà difficile trovare qualcosa del genere», osservai. «Soprattutto perché il lago ha cambiato nome.» «Più difficile di quello che abbiamo cercato finora?» chiese con un sorrisetto ironico. I suoi begli occhi scuri brillavano di intelligenza. Potevo capire che cosa Jabba avesse visto in lei, al di là delle strane curve e dei dislivelli delle sue forme. «No, più difficile no», risposi. «Allora, lasciatemi lavorare un po' in pace.» «Ma ti stai perdendo tutta la faccenda degli yatiris», la avvertì Jabba, agguantando di nuovo il pacco di biscotti abbandonato. «Me lo racconterete dopo.» Gli yatiris rimasti a Taipikala dopo il terremoto dovettero riorganizzare la vita della città, che ormai non era che un ricordo di ciò che era stata. Lottarono per conservare le loro antiche conoscenze e si adattarono a vivere nelle rovine. Risistemarono alcuni templi per le cerimonie e alcuni locali in cui vivere, ma non riuscirono a smuovere le grandi pietre con la facilità con cui lo avevano fatto i loro antenati, i giganti, cosicché Taipikala non tornò a splendere sotto la luce del sole sebbene conservasse lamine d'oro e d'argento sulle porte e sui muri, e pietre preziose su steli, bassorilievi e sculture; e nemmeno i pavimenti e i terrazzi, di colore verde e rosso negli anni di splendore, apparivano come prima, perché ora l'area era praticamente abbandonata. Gli yatiris si rifugiarono nei loro studi sul firmamento e proseguirono nelle loro ricerche. Continuarono a curare con le parole e a prevedere il futuro, per cui seppero prima degli altri che un grande esercito invasore stava per arrivare e che il loro mondo era giunto alla fine. Si prepararono quindi all'evento. «Se tutto ciò fosse vero, amico!» mormorò Jabba. «E allora? Se lo fosse?» «Quanti libri di storia bisognerebbe modificare!» disse, e rise così sonoramente che temetti per il sonno di mia nonna. «Mi preoccuperebbe di più includere i giganti nei programmi di studio.» «E va bene! È tutta una menzogna. Ti piace di più?» Non replicai, però sorrisi. In fondo, e nonostante tutto, mi aveva sempre attirato l'idea di diventare un guerrigliero zapatista, e non potevo negare di essere formalmente un autentico hacker, quindi modificare tutti i libri di storia e far studiare a scuola i giganti, la mappa di Piri Reis e tutto ciò che mettesse in ridicolo la verità costituita mi sembrava una grande idea. I testi che Daniel aveva tradotto e ordinato stavano terminando (il file era di una trentina di pagine ed eravamo già alla numero venticinque), ma, a mano a mano che ci avvicinavamo alla fine, le cose si andavano facendo più interessanti. Un lungo brano spiegava che, di fronte ai ripetuti avvertimenti delle stelle sull'approssimarsi di un grande esercito nemico, gli yatiris di Taipikala decisero di nascondersi tra la popolazione dei regni collas vicini, facendosi passare per contadini e commercianti. Ma prima di abbandonare per sempre le mura di Taipikala, dovevano fare qualcosa di importante, come si spiegava in ulteriori frammenti. Il compito fondamentale consisteva nel nascondere il Viaggiatore. Non potevano allontanarsi senza lasciarlo ben protetto, lui e tutto ciò che d'importante conteneva la sua tomba, che era molto, perché la piramide e la camera sepolcrale comparivano chiaramente riportate nei bassorilievi della porta che delimitava l'edificio. Tolsero la porta, la sostituirono con un'altra senza decorazioni e, per due anni, si affannarono a innalzare una collina di terra e di pietre per occultare la piramide. Quando finalmente terminarono la fatica, due piogge di stelle caddero una notte dal cielo; la seconda era molto più forte della prima e lasciò grandi scie splendenti che avvertirono gli yatiris dell'arrivo di un secondo esercito che avrebbe distrutto il primo e avrebbe cambiato il mondo per sempre. Scrissero allora tutto questo in lastre d'oro in cui dicevano dove si sarebbero nascosti fino a che non si fosse compiuta la distruzione. Si introdussero di nuovo nella camera attraverso uno dei corridoi che portavano alla piramide da luoghi che solo gli yatiris conoscevano, lasciarono lì le lastre e sigillarono di nuovo tutto, aggiungendo maggiori protezioni e difese. Avrebbero fatto in modo che Willka non scomparisse un'altra volta, ma, se lo faceva, gli umani sopravvissuti avrebbero potuto trovare le loro conoscenze. E allora arrivarono gli Incap rúnam...14 «Saranno certamente gli incas.» «Saranno.» Gli yatiris, confusi tra la gente dei centri abitati e delle città conquistate, li videro passare. Al comando stava Pachacuti (o Pachakutej, come lo chiamava la rivista boliviana), il nono inca. Era molto alto e dal volto rotondo, abbigliato con un vestito rossiccio che sfoggiava due lunghe strisce di tocapus che andavano dal collo ai piedi e coperto con un grande manto verde. Taipikala perse il suo nome e prese quello di Tiwanacu, senza che se ne conoscesse la ragione. Così la chiamavano gli Incap rúnam e così rimase fino all'arrivo dei viracochas15 gli uomini bianchi e barbuti che parlavano una lingua strana dal suono di un ruscello che cadeva su un letto di pietre. La gente aveva una tremenda paura dei viracochas, esseri avidi che rubavano l'oro, l'argento e le pietre preziose, che schiavizzavano e ammazzavano gli uomini e i bambini e violentavano le donne. Come gli Incap rúnam anni prima, che avevano portato Viracocha, anche gli spagnoli portarono il loro dio, ma lo imposero con la forza della frusta e dei bastoni, distrussero i vecchi templi e, con le stesse pietre, costruirono dappertutto chiese. «E dovette essere in questa magnifica epoca», commentai seguendo il filo dei miei pensieri, «che Pedro Sarmiento de Gamboa si incontrò con gli yatiris nel Collao, nella zona di Tiwanacu. Stiamo parlando, quindi, dell'anno 1575.» «Circa quarant'anni dopo che Pizarro uccidesse l'ultimo inca a Cajamarca e conquistasse l'impero», disse Proxi. «Esatto.» Ancora peggio della schiavitù, delle torture e della nuova religione furono le febbri letali che decimarono la popolazione dopo l'arrivo dei conquistadores. Dovunque questi passassero, i nativi morivano a migliaia, colpiti da malattie misteriose che gli yatiris non conoscevano e che non potevano curare. Anche questi cominciarono a morire, e allora, prima che scomparisse chi poteva conservare l'antica sapienza, decisero di portare a termine il proposito che li aveva spinti a lasciare Taipikala; così un giorno, semplicemente, se ne andarono. Nessuno sapeva dove, ma alcuni componimenti di pochi versi esprimevano la gioia degli aymaras per essere riusciti a porsi in salvo. E questo era tutto. Daniel non aveva aggiunto nient'altro. Cercammo e ricercammo nell'hard disk per verificare se ci fossero altre informazioni, ma non trovammo nessun documento significativo. E non trovammo nemmeno la trascrizione della maledizione fatta da «JoviLoom», e la cosa ci sorprese abbastanza. «Sapete che cosa mi diceva mia madre quando ero piccolo?» chiese Jabba a Proxi (che era ancora immersa nelle sue ricerche) e a me. «Che noi non eravamo stati tanto brutali con gli indios del Sudamerica quanto gli inglesi con quelli del Nordamerica. L'unica cosa che ci possiamo rimproverare è di avere generato figli meticci, e che mentre nel nord, dove li ammazzavano, ne sono rimasti pochi nelle riserve, nel sud vivono felicemente nei propri Paesi come buoni cristiani.» La madre di Jabba era madrilena, ma anche la mia mi aveva raccontato la stessa storia quando avevo pochi anni. Quella idea peregrina delle nostre madri era, senza dubbio, il risultato della mentalità nazionalista e cattolica dell'epoca franchista. Doveva essere stato un argomento ripetuto fino alla nausea per molto tempo per tacitare le nostre coscienze. Se gli inglesi erano peggiori di noi, allora noi spagnoli non eravamo tanto cattivi; potevamo, in confronto, essere persino buoni e aver agito a meraviglia. La Cataluña non aveva partecipato con la Castiglia alla conquista dell'America - il regno di Castiglia, logicamente, voleva tutta la ricchezza poiché aveva scoperto il continente -, ma, fin dal principio, dal secondo viaggio di Colombo, catalani, aragonesi, valenziani... siamo andati nelle Indie e ci siamo stabiliti lì. «Che cosa pensi di tutta questa storia degli yatiris, Jabba?» gli chiesi, lisciandomi il pizzetto. «Non so, non so, il fatto è...» Rimase pensieroso un momento poi inarcò le sopracciglia, allarmato. «Un momento! Non dobbiamo andare a Tiwanacu in cerca della Piramide del Viaggiatore, vero?» A me non era nemmeno passato per la testa. «Ora che me lo dici...» risposi. Si adombrò. La prospettiva di salire su un aereo lo paralizzava. Volava, naturalmente; andava in qualsiasi parte del mondo e non diceva di no né poneva ostacoli, ma con l'assoluta convinzione che andava a morire, che non avrebbe più messo piede in terra. Per lui ogni viaggio in aereo era un'accettazione rassegnata della morte. «Dovremmo studiare a fondo Tiwanacu», propose, «e individuare la Piramide del Viaggiatore. Magari l'hanno aperta da secoli e oggi non contiene più niente!» «Magari!» Si schiarì la voce in modo sonoro e deciso. «Quante mappe di Tiwanacu volete?» disse. «Quante ce ne sono?» gli domandai chinandomi sulla tastiera del mio computer. Lui si mise al lavoro sul suo. «Tre o quattro abbastanza accettabili. Il resto non vale niente.» «Mandale in stampa.» «Prima lascia che le ritocchi un po'. Sono abbastanza piccole e a bassa risoluzione.» «Io leggerò tutto ciò che c'è su Tiwanacu», avvertii. «Tu prova con Tiahuanaco e con tutte le variazioni possibili.» «Vi aiuto», fece presente la mercenaria. La stampante laser stava espellendo i pezzi della seconda mappa quando Magdalena ci avvisò che il pranzo era pronto. Avevamo passato un paio di giorni frenetici e avevamo ancora un lavoro impressionante da fare: la ricerca di Tiwanacu in Internet mi offriva più di tremilatrecento documenti da verificare e gli altri non avevano avuto miglior fortuna. O cominciavamo ad applicare dei filtri o saremmo diventati vecchi nel tentativo. Ma, prima di ogni altra cosa, bisognava mangiare. Con il caffè bollente nelle tazze ritornammo nello studio sapendo che ci aspettava un pomeriggio molto lungo. Regredimmo agli anni della scuola facendo lavori manuali per ricomporre le mappe con colla e nastro adesivo e, una volta ricostruite, le fissammo alle pareti con puntine da disegno per farci un'idea più chiara del sito archeologico. Ammassati al centro, con il nord verso l'alto e il sud verso il basso, c'erano tre monumenti principali: il più importante del sito, il più colossale e maestoso, era l'Akapana, una gigantesca piramide di sette gradini con una base di circa duecento metri di lunghezza e un po' meno di larghezza, della quale attualmente non rimaneva quasi niente, appena il dieci per cento delle pietre originali. Secondo gli esperti, era servita come deposito di acqua e di materiali, come pure per celebrare riti di carattere religioso, anche se altrove avevamo letto che la sua funzione principale era quella di osservatorio astronomico. Di recente, gli archeologi avevano scoperto al suo interno una complessa rete di strani canali a zigzag che avevano interpretato come semplici condutture, anche se, chiaramente, questa era solo un'ipotesi. In un primo momento pensammo che Akapana potesse voler dire Viaggiatore, ma rimanemmo delusi perché la sua traduzione letterale poteva significare sia «Da qui si misura» sia «Qui c'è un'anatra selvatica bianca». «Magari ci fosse Daniel a darci una mano!» sospirò Proxi. «Se avessimo Daniel, non staremmo facendo tutto questo», replicò Jabba, e io assentii. Sopra l'Akapana, a nord, si vedevano altri due edifici: uno, a destra, molto piccolo, che risultò essere il Tempietto semisotterraneo - quello che aveva le pareti coperte dalle teste scolpite nella pietra - e un altro, molto più grande, il Kalasasaya, un tempio cerimoniale a cielo aperto costruito con arenite rossa e andesite verde, di cento metri per lato, innalzato a mo' di piattaforma sul terreno e recintato da un muro di contenimento che delimitava un grande cortile rettangolare a cui si accedeva attraverso una scalinata di sei gradini scavata in una sola pietra. Da quello che si vedeva, questo enorme tempio era costruito con blocchi di più di cinque metri di altezza e di cento tonnellate di peso che, come diceva la pagina ufficiale del Museo di Tiwanacu, erano stati trasportati da distanze di oltre trecento chilometri. «Caspita! Come ci sono riusciti? Non conoscevano nemmeno la ruota!» «Lascia perdere, Proxi», le imposi. «Non abbiamo tempo per svelare tanti misteri.» «A me tutto questo fa venire in mente le piramidi d'Egitto», commentò Jabba. «Le stesse pietre ciclopiche, lo stesso mistero sul modo di trasportarle, lo stesso tipo di costruzione, la non conoscenza della ruota...» «E il sangue sacro», aggiunsi, scherzando. «Non dimenticare il sangue sacro. I faraoni egizi si sposavano con le proprie sorelle per preservare la purezza del sangue e anche loro si credevano figli del Sole. Come si chiamava? Amon?... Ra?...» «Proprio così. Ridi! Ma ride bene chi ride ultimo!» «Sentite questa...» mormorò Proxi, con gli occhi fissi sul monitor. «Ancora una cosa strana?» chiesi. «Ho trovato un'informazione su un tale Arthur Posnansky, un ingegnere navale, cartografo e archeologo che ha scritto più di cento opere su Tiwanacu nella prima metà del XX secolo. Questo archeologo ne ha studiato le rovine per tutta la vita ed è arrivato alla conclusione che fu costruita da una civiltà con tecnologia e conoscenze molto avanzate rispetto a noi. Dopo aver misurato, rappresentato in mappe e analizzato il sito, applicando complicati calcoli e utilizzando il cambiamento della posizione della Terra rispetto alla sua orbita con il Sole, ha concluso che Tiwanacu era stata costruita quattordicimila anni addietro, e questo coinciderebbe con la storia degli yatiris.» «Suppongo che l'archeologia accademica rifiuti totalmente questa teori- a», commentai. «Ovviamente! L'archeologia accademica non può accettare che sia esistita una civiltà superiore diecimila anni fa, quando si suppone che l'uomo si vestisse con pelli di animali e vivesse in caverne per proteggersi dal freddo dell'ultima era glaciale. C'è, però, un vasto settore di archeologi che non solo l'accetta come buona, ma che la sostiene contro ogni contestazione. Sembra che Posnansky, morto da tempo, continui a essere una celebrità in Bolivia.» «Potrebbe essere stata costruita quattordicimila anni fa?» si stupì Jabba. «Vallo a sapere...» risposi. «A Tiwanacu tutto è molto strano.» Una volta discesa la scalinata del tempio Kalasasaya si attraversava una grande porta di pietra massiccia e, molto in fondo, a destra, si riusciva a individuare la sagoma della Porta del Sole, con il bassorilievo del Dio dei Bastoni e del presunto piano della camera dei suoni naturali, ma all'unanimità decidemmo, per andare sul sicuro, di rimandarne l'esame fino a quando non avessimo conosciuto a menadito gli altri resti archeologici. Dunque, scendendo la scalinata, proprio nel centro del cortile di Kalasasaya, c'era una strana scultura chiamata Monolito Ponce, di circa due metri di altezza, che rappresentava un essere dagli occhi quadrati. Certi archeologi, abbastanza categorici nella loro interpretazione, affermavano che si trattava dell'immagine di un monarca o di un sacerdote, ma la verità era che non si sapeva chi fosse. Nel cortile c'erano anche alcune curiose statue raffiguranti uomini di etnia ignota, con grandi baffi e con un pizzetto molto simile al mio. «Ma Kalasasaya vuol dire 'viaggiatore' o no?» si spazientì Jabba. «No», gli rispose Proxi. «Ho appena letto che significa 'i pilastri diritti'.» Anche il piccolo Tempietto semisotterraneo, situato a est del Kalasasaya, aveva steli di uomini con la barba. «Comincio a pensare», commentò Jabba, «che ci siano troppi barbuti da quelle parti; però gli indios d'America non hanno barba sul viso, vero?» «È vero», risposi. «Nessuno lo direbbe, vedendo Tiwanacu!» Attaccato al tempio di Kalasasaya, a sinistra, c'era un'altra piccola costruzione di dimensioni simili a quelle del Tempietto semisotterraneo. Era Putuni, 'il luogo adatto', un palazzo quadrangolare del quale si conservavano alcuni blocchi della facciata e il portale d'entrata che, in passato, era sigillato con una grande pietra che lo rendeva inespugnabile. I conquistadores, vedendo una tale protezione, pensarono che vi si nascondessero ricchi tesori e provocarono danni considerevoli senza trovare assolutamente niente: all'interno c'era soltanto una grande quantità di spazi vuoti a forma di casse di pietra di un metro e trenta centimetri di larghezza per uno e quaranta di lunghezza e uno di altezza. A prescindere dalla forma quasi quadrata e dalla misura, gli spagnoli ritennero che fossero dei sepolcri; perciò Putuni fu conosciuto da allora come il Palazzo dei Sepolcri, anche se non c'era alcuna prova a favore di questa supposizione. Si diede per scontato che in ciascuna di quelle cavità ci fosse stata una mummia con tutti gli oggetti necessari al suo passaggio nell'aldilà, dato che gli aymaras credevano che la morte fosse una sorta di viaggio con biglietto di andata e ritorno alla vita, qualcosa di simile alla reincarnazione. Per loro un morto era solo un sairi, cioè un viaggiatore. «Ci siamo!» urlai. «Non fare l'idiota, Arnau!» sbottò Proxi. «Non ci siamo per niente. Putuni non è una piramide, no?» «E allora... il viaggiatore?» «Jabba, per favore, digli di tacere!» «Taci, Root!» La piramide di Akapana, il Tempietto semisotterraneo, il tempio di Kalasasaya e il palazzo Putuni formavano un nucleo compatto di edifici al centro dell'area di scavi di Tiwanacu, ma, sparsi attorno, in migliore o peggiore stato di conservazione, ce n'erano molti altri, la maggioranza dei quali non erano nemmeno citati nelle pagine sul complesso archeologico né riprodotti nei piani e nelle mappe. Tuttavia i nomi di quattro di quei luoghi comparivano qua e là con una certa frequenza: Kantatallita, Quirikala, Puma Punku e Lakaqullu. Scoraggiati, pensammo che, se nessuno di questi aveva una relazione con la descrizione fatta da Daniel nei suoi deliri, avremmo avuto un problema grave; scavare a Tiwanacu era al di fuori delle nostre possibilità legali, economiche e di tempo. Di Kantatallita, o «Luce del mattino», non rimaneva niente, soltanto alcuni resti sparsi nel luogo in cui probabilmente sorgeva; ma, tra questi, c'era una curiosa porta che culminava in un arco. Fonti diverse affermavano che Kantatallita era stato un edificio di quattro pareti orientate verso i quattro punti cardinali, con un cortile centrale nel quale, secondo alcuni, si trovava il laboratorio in cui lavoravano gli architetti di Tiwanacu: erano stati trovati modelli di alcuni palazzi, ornamenti ed elementi architettonici. Secondo altri vi si celebravano cerimonie in onore di Venere, l'astro più brillante del cielo dopo il Sole e la Luna, noto anche come Stella del Mat- tino poiché era molto visibile all'alba, la qual cosa era in sintonia con il nome del luogo. Inoltre, a conferma di questa seconda teoria, tra il materiale ornamentale si distinguevano e abbondavano i motivi allegorici di Venere. Forse era utilizzato come tempio e insieme come laboratorio. Nessuno poteva confermare un'ipotesi o l'altra. Quirikala, o Kerikala, «il forno di pietra», era presumibilmente il palazzo-residenza dei sacerdoti tiwanacotas. Era stato poco considerato dagli studiosi ed erano ancora visibili alcuni muri abbastanza rovinati che non suggerivano niente. Come d'altronde le pietre di molte delle costruzioni di Tiwanacu, quelle di Quirikala erano state impiegate per costruire antichi edifici a La Paz e in altre città vicine, e le più pesanti erano state frammentate con le trivelle e utilizzate come calcinacci nella realizzazione della strada ferrata Guaqui-La Paz (così erano scomparse Putuni, Kalasasaya e la maggioranza delle statue). Puma Punku era invece un'altra cosa. Non è che fosse rimasto molto in piedi, tanto per cambiare, ma dava l'impressione di essere stato un luogo importante. Puma Punku, «La Porta del Puma», era definita come il secondo tempio per importanza dopo quello di Kalasasaya, anche se la maggioranza delle informazioni la descrivevano come una piramide identica a quella di Akapana, ugualmente gigantesca e maestosa, con la quale avrebbe formato una specie di coppia a distanza, in quanto le due erano lontane un chilometro l'una dall'altra, con Puma Punku a sudest. Secondo le ricognizioni archeologiche la piramide era ancora quasi intera sottoterra, e pertanto si sarebbe potuta recuperare un giorno, quando ci fosse stato il denaro per riportarla alla superficie. Anche Puma Punku avrebbe avuto sette terrazzi colorati alternativamente in rosso, verde, bianco e azzurro, e, tutto attorno, ci sarebbe stata una vasta area alla quale si poteva accedere attraverso quattro portici, simili alla Porta del Sole; ne rimanevano solo tre, mezzi distrutti, che presentavano bassorilievi a motivi solari. Tra le rovine e i frammenti che, senza ordine né criterio, erano disseminati nel luogo, si potevano distinguere ancora alcuni blocchi che avevano formato parte della pavimentazione dell'area; raggiungevano le centotrenta tonnellate di peso ed erano i blocchi, estratti dalle cave, più colossali di tutto il Sudamerica. Ma «la Porta del Sole» racchiudeva altri segreti che rallegrarono Proxi. «Finalmente!» esclamò. «Era quello che stavo cercando!» «E quasi non lo trovavi, eh?» la mortificò Jabba. Una parte del perimetro di Puma Punku era delimitata da due grandi dar- sene portuali che, attualmente, erano coperte da terra secca e da rocce scoscese che trasformavano il paesaggio in uno spazio in apparenza privo di senso. A prescindere dal fatto che il lago Titicaca distava quasi venti chilometri, gli studi geologici realizzati nella zona avevano rilevato importanti accumulazioni di sedimenti marini e di fossili di origine chiaramente acquatica, e le decorazioni rinvenute tra i resti di Puma Punku mostravano innumerevoli fregi che rappresentavano dei pesci. «La storia degli yatiris ricostruita da Daniel è reale!» esclamò Proxi soddisfatta. «La laguna Kotamama-Titicaca giungeva fino ai moli del porto di Taipikala-Tiwanacu. Non è fantastico?» «Ripetilo, per favore!» risi. «Hai creato un perfetto scioglilingua.» «Non fate tanto baccano, incoscienti», borbottò in malomodo il grosso e insopportabile verme. «Non abbiamo ancora trovato la nostra Piramide del Viaggiatore e ci rimane da analizzare soltanto quella miseria di Lakaqullu.» «Tranquillo. Sicuro che si trova lì», mi sentii obbligato a dire, ma, quando incominciammo a cercare informazioni sul «cumulo di pietre» (questa era la traduzione del nome), avrei voluto ingoiare quelle parole: Lakaqullu era, per dirla in qualche modo, un minuscolo promontorio perduto a nord dell'area di Tiwanacu, molto più in alto del resto degli edifici, che aveva, come unico carattere distintivo, una porta scolpita nella pietra, conosciuta come la Porta della Luna (per opposizione alla Porta del Sole, anche se esteticamente non avevano niente a che vedere l'una con l'altra). «Primo requisito, trovato!» annunciò Proxi. «Di che cosa stai parlando?» le chiesi. «Bah, stupidaggini! Non farci caso.» Anche se non lo sembrava affatto, Lakaqullu era stato il luogo più sacro e temuto di Tiwanacu. Nonostante non si fossero effettuati scavi nella zona, era stata rinvenuta a una certa profondità, nella piccola collina, un'infinità di ossa umane vecchie di centinaia di anni, soprattutto teschi. «Secondo requisito, trovato!» proclamò di nuovo Proxi. E non ci fu bisogno di dire altro. Jabba e io capimmo automaticamente che ci stavamo avvicinando all'obiettivo: in base alla cronaca degli yatiris, la Piramide del Viaggiatore si trovava isolata dal resto delle costruzioni ed era il luogo più sacro di Taipikala. Il riferimento ai teschi era un punto in più a favore di questa teoria. Secondo tutti gli esperti, la Porta della Luna era un'opera incompiuta, circostanza che si verificava anche in Puma Punku e in altri edifici, come se i costruttori avessero avuto una gran fretta di allontanarsi da lì abbandonando scalpello e martello dalla sera alla mattina. Quella peculiarità le conferiva il triste aspetto di un semplice vano aperto sovrastato da un architrave liscio e da due stipiti di pietra privi di bassorilievi o di altri ornamenti. «Terzo requisito, signori!» annunciò trionfante Proxi. «Questo non l'ho capito», commentai nervoso. «Gli yatiris lasciarono di corsa Taipikala perché lessero nel cielo che stavano per arrivare gli Incap rúnam e, poi, gli spagnoli. Per nascondere la Piramide del Viaggiatore la coprirono con una collina di terra e di pietre, tolsero la porta originale, che mostrava nei bassorilievi la piramide e la camera che c'era sotto, e ne misero un'altra, nella parte superiore, senza ornamenti. Non credo che avessero avuto tempo per i motivi ornamentali. Jabba, tu che sei vicino ai dizionari, che parola utilizzavano gli aymaras per dire 'piramide'? Cioè, come direbbero 'Piramide del Viaggiatore'?» «Quanto sei pesante, tesoro!» si lamentò Marc torcendo il busto per riuscire a prendere i libri. «Allora...» farfugliai, «sotto quel promontorio dovrebbe trovarsi la piramide di tre piani disegnata ai piedi del Dio dei Bastoni.» «Tu aiuta Jabba e io vedrò che cosa riesco a trovare qui.» Quando Proxi organizzava il lavoro, nessuno discuteva i suoi ordini, nemmeno il capo (che ero io), quindi presi uno dei dizionari e cominciai a cercare. Nel giro di pochi minuti, e dopo essermi consultato a bassa voce con Jabba per non disturbare Proxi, facemmo un'altra scoperta che riferimmo alla mercenaria quando, finalmente, la vedemmo con la fronte distesa: gli aymaras non usavano la parola «piramide»; per loro, quelle costruzioni erano montagne, cumuli, promontori... «Riepilogando», spiegai, «la parola che usavano al posto di piramide era 'qullu'.» «Come in Lakaqullu?» «Come in Lakaqullu», assentii, «che, oltre che 'cumulo di pietre', significa anche 'piramide di pietre'.» «Esattamente quello che fecero gli yatiris per occultare il Viaggiatore, una piramide di terra e pietre.» «E tu, hai trovato quello che cercavi?» le chiese Jabba competitivo. «Certo!» esclamò lei sorridente. «Il governo della Bolivia ha un portale molto buono, con una stupenda pagina di informazioni turistiche. Se cerchi Tiwanacu», premette rapidamente un paio di tasti per portare l'articolo in primo piano, «puoi trovare meraviglie come questa: 'La Porta della Luna è situata sopra una piramide quadrata a tre scalini'.» «Nient'altro?» chiesi dopo una pausa. «Solo questo?» «Che cosa vuoi di più?» si sorprese. «Considerati soddisfatto, ragazzo! Abbiamo individuato l'unica piramide di tre scalini di tutta Tiwanacu», disse guardando Jabba, «e lui chiede se il commento sulla Porta della Luna dice qualcosa di più! Sei proprio strano, Root!» «Il fatto è che tutta questa robaccia mi esaspera.» «Ti esaspera?» mi domandò Jabba. «Che cosa diavolo ti esaspera?» «Ma non ve ne rendete conto?» replicai, alzandomi. «La cosa diventa seria! Non lo vedete? Tutta questa follia è vera! C'è una maledizione, un linguaggio perfetto, dei tipi che affermano di discendere dai giganti e che posseggono il potere delle parole... E c'è una maledetta piramide di tre piani a Tiwanacu», sbraitai infine, gettandomi come un pazzo sulle cartellette e mettendo a soqquadro i fogli finché non trovai quello che cercavo, mentre Proxi e Jabba, paralizzati, mi seguivano con lo sguardo. Avevo scoperto in modo inconfutabile che la storia che stavamo trattando come fosse un gioco era qualcosa di molto reale e pericoloso. «Mio fratello non ha né agnosia né sindrome di Cotard! 'Non senti, ladro?'» cominciai a leggere animatamente senza abbassare il volume. «'Sei morto, perché hai giocato a togliere la sbarra dalla porta. Chiamerai urlando il necroforo questa stessa notte. Gli altri muoiono dovunque per te. Ahi, questo mondo non sarà più visibile per te! È la legge. Chiusa a chiave'.» Agitai il foglio. «Ecco che cos'ha mio fratello!» Mi lasciai cadere su un divano e tacqui. Anche Proxi e Jabba non aprirono bocca. Ciascuno di noi rimase solo con i propri pensieri per alcuni lunghi minuti. Non eravamo pazzi, ma non sembravamo nemmeno troppo sani. La situazione appariva demenziale e, tuttavia, allora più che mai, il miraggio di guarire Daniel con quelle maledette arti magiche diventava reale. Mio fratello non sarebbe guarito mai con le medicine, pensai. Non esisteva nessun farmaco contro una programmazione cerebrale scritta in codice aymara dagli yatiris. L'unica maniera di disattivare la programmazione era quella di utilizzare lo stesso linguaggio, applicare la medesima magia, stregoneria, incantesimo o quel che diavolo c'era nelle parole segrete impiegate dai sacerdoti dell'antica Taipikala. Per qualche ragione che non riuscivo a comprendere, in quel testo (probabilmente ricavato da uno delle centinaia di tessuti con tocapus copiati nel computer di Daniel, trasformato in alfabeto latino dal maledetto «JoviLoom» e parzialmente tra- dotto a metà da mio fratello) qualcuno aveva inserito una maledizione per castigare un ladro colpevole di aver rubato qualcosa che si nascondeva dietro una porta... o sotto una porta. «Ehi!» gridai, alzandomi. «Mi è appena venuta un'idea!» Quei due, con una faccia più da morti che da vivi, mi guardarono a loro volta. «Daniel stava lavorando esclusivamente su materiale riguardante Tiwanacu, giusto?» Entrambi annuirono. «La maledizione viene da Tiwanacu! Mio fratello sapeva della camera. Lui stesso ci ha lasciato un disegno del piedistallo del Dio dei Bastoni, segnalando molto chiaramente dove si trovava nascosto l'oro degli yatiris con tutte le loro conoscenze. E sa, perché non smette di ripeterlo nei suoi deliri, che in quella camera è custodito il segreto del potere delle parole. Aveva scoperto l'esistenza reale della Piramide del Viaggiatore: la camera si trova in una piramide, dice, e sopra la piramide c'è una porta. Lakaqullu, amici! Lakaqullu! Lui sapeva come arrivarci e, quando l'ha scoperto, si è imbattuto in quella maledizione, la maledizione che protegge la camera.» Proxi batté le palpebre cercando di riflettere sulle mie parole. «Ma allora», notò perplessa, «perché non colpisce pure noi?» «Perché non conosciamo l'aymara! Se non ne conosciamo il codice, non può colpirci.» «Però abbiamo la trascrizione del testo in aymara», insisté lei, «e l'abbiamo letta.» «Sì, ma ripeto che non ci danneggia perché non conosciamo l'aymara. Il codice funziona con dei suoni, con quei benedetti suoni naturali. Noi possiamo leggere il testo in aymara, però non riusciremmo mai a pronunciarlo correttamente. Daniel sì... e lo ha fatto. Per questo ne è stato colpito.» «Dunque il codice», balbettò Jabba a fatica, «in realtà contiene una specie di virus.» «Esatto! Un virus dormiente che si attiva soltanto in determinate condizioni, come quei virus informatici che cominciano a cancellare l'hard disk nell'anniversario di un atto terroristico o i venerdì tredici del mese. In questo caso, la condizione che attua la programmazione è il suono, un tipo di suono che noi non siamo in grado di riprodurre.» «Allora quelli che parlano aymara, o chiunque conosca l'aymara, potrebbero esserne colpiti», azzardò Proxi. «Marta Torrent, senza andare tanto lontano, no?» Esitai per qualche secondo, incerto sulla risposta da dare. «Non so...» borbottai. «Immagino che se lo udisse o lo leggesse a voce alta, sì.» «Bisognerebbe verificarlo», propose Jabba. «Chiamiamola.» Proxi e io sorridemmo. «Comunque», dissi. «È indispensabile andare a Tiwanacu ed entrare nella camera.» «Tu sei pazzo!» esclamò Marc, facendo un salto sulla sedia e affrontandomi. «Ti rendi conto della sciocchezza che hai appena detto?» Lo guardai con tutto il sangue freddo del mondo prima di rispondere. «Mio fratello non guarirà se non entriamo in quella camera e non troviamo una soluzione. Lo sai anche tu.» «E che cosa facciamo una volta lì?» replicò. «Prendiamo una pala e cominciamo a scavare? Oh! Mi dispiace, signor poliziotto boliviano, non sapevo che questo fosse un sito archeologico protetto!» «Non ricordi quello che diceva la cronaca degli yatiris?» gli chiese Proxi. Jabba era talmente nervoso che la guardò senza capire. «Dopo aver portato a termine la costruzione della collina che oggi è Lakaqullu, quei tipi si videro costretti a ritornare nella camera, e lo fecero, cito a memoria, attraverso uno dei due corridoi che portavano fino alla piramide da un luogo che solo loro conoscevano. Quando uscirono, ne rafforzarono difese e blindaggi.» «La parola non è esattamente blindaggi», la corressi. «Be', quella che è», borbottò. «Credevo di parlare con persone intelligenti.» «E vuoi che noi troviamo quei corridoi?» le domandò Jabba, incredulo. «Ti ricordo che da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, e non lo dico solo in senso figurato.» Proxi, che fino a quel momento era rimasta seduta, si alzò e avanzò verso le mappe di Tiwanacu affisse alla parete. «Sapete?» disse senza guardarci. «Il mio lavoro consiste nel trovare errori nei sistemi informatici, falle nella sicurezza dei programmi più potenti che esistano sul mercato, inclusi i nostri. Non sto dicendo di essere la migliore, però sono molto brava, e so che a Taipikala c'è una breccia che posso trovare. Gli yatiris sono stati dei magnifici programmatori, ma non hanno nascosto il loro codice perché rimanesse eternamente occulto. Che senso avrebbe aver inciso tutte quelle lastre d'oro destinate a un'ipotetica u- manità sopravvissuta a un secondo diluvio universale?» Si mise le braccia sui fianchi e scosse la testa con decisione. «No. L'entrata alla camera esiste, ne sono sicura; è soltanto nascosta, mascherata perché non sia scoperta prima che il suo contenuto possa tornare utile. L'hanno protetta dai ladri, non dai bisogni dell'umanità. Anzi, non ho il minimo dubbio che l'accesso alla camera sia aperto e disponibile, direi persino che ce l'abbiamo davanti al naso. Il problema è che non lo vediamo.» «Forse perché non abbiamo ancora esaminato la Porta del Sole», suggerì Jabba. «Forse perché lo troveremo solo se lo cerchiamo sul posto, a Tiwanacu», ribattei. Gli occhi neri di Proxi brillavano quando si rivolse a noi. «Su, al lavoro!» esclamò. «Tu, Marc, cerca tutte le fotografie della Porta del Sole che riesci a scovare e stampale ad alta risoluzione; tu, Root, cerca tutte le informazioni sulla Porta e imparale a memoria. Io mi occuperò del Dio dei Bastoni.» Senza nascondere la sua soddisfazione, Jabba mi guardò trionfante. La sua proposta era risultata vincente... Per il momento, pensai. Pochi secondi dopo, mia nonna si affacciò discretamente per salutarci. Questa volta, però, ci comportammo in modo più educato e rispondemmo con sorrisi gentili anche se distratti. Se in quel momento avessi saputo che non ci saremmo visti per tanto tempo, mi sarei alzato per darle un bacio e l'avrei salutata, ma non lo sapevo, e se ne andò senza che le rivolgessi la parola. Erano passate da poco le sette di sera e il mio corpo cominciava a scricchiolare come una sedia vecchia. «Perché non cerchiamo un documento che ci dica, anche di passaggio, se la Porta del Sole avrebbe potuto essere un tempo a Lakaqullu?» chiese Jabba all'improvviso. Proxi lo guardò con un sorriso. «È una buona idea. Lo faccio io.» «Usa un filtro per limitare la ricerca», le consigliò Jabba andandole vicino e appoggiando i gomiti sul tavolo. «Tiwanacu', 'Lakaqullu' e 'Porta'?» «E qualcosa di più! Aggiungi 'Porta del Sole' e 'spostare', per esempio, dato che gli yatiris la trasferirono.» «Va bene. Ecco fatto!» Io andavo avanti con il mio lavoro, cercando tutto ciò che si riferiva alla Porta, il che era già molto. «Solo cinque documenti?» sentii dire a Jabba. «Pochi, no?» Proxi non gli rispose. Allora mi voltai e la vidi puntare il dito sullo schermo, indicando qualcosa. Ricordo che pensai che avrebbe lasciato un'impronta digitale della dimensione di un camion. Poi, tutti e due si chinarono all'unisono sul monitor senza dire una parola e rimasero a lungo immobili, tanto che, alla fine, mi stancai di vedere le chiappe di Jabba davanti alla mia faccia e mi alzai per avvicinarmi. «Che cosa succede?» chiesi. Ora erano loro che sembravano non aver voglia di parlare. «Ehi! Sono qui!» dissi. Allora Jabba si scostò un po' per consentirmi di guardare lo schermo e io mi infilai tra i due. La prima cosa che vidi fu una foto in primo piano, piuttosto ben riuscita, della dottoressa Torrent, la quale esibiva un leggero sorriso. La pagina era tratta da un quotidiano boliviano, El nuevo día, e il titolo informava che la famosa antropologa spagnola era appena arrivata a La Paz per prendere parte ai nuovi scavi di Tiwanacu. Il resto dell'articolo, che recava la data di quello stesso martedì, 4 giugno, diceva che Marta Torrent, la quale era stata così gentile da intrattenersi con il giornalista non appena scesa dall'aereo nonostante la stanchezza del lungo viaggio, si sarebbe aggregata all'equipe dell'archeologo Efraín Rolando Reyes, che aveva iniziato recentemente gli scavi a Puma Punku con l'intenzione di riportare alla luce la piramide gemella di Akapana o, almeno, parte di essa. Questa impareggiabile donna, antropologa di professione e archeologa per vocazione, era riuscita a includere la piramide di Puma Punku nel piano di finanziamento del Programma di Ricerca Strategica in Bolivia grazie ai suoi importanti contatti con il governo boliviano e alla grande influenza che aveva sugli ambienti culturali ed economici del Paese. «Abbiamo davanti a noi un enorme lavoro della durata di diversi mesi. Bisognerà rimuovere tonnellate di terra», aveva detto. La docente spagnola, che amava più il lavoro sul campo che quello nello studio, proveniva da una famiglia di archeologi con una lunga tradizione di esplorazioni a Tiwanacu, come il prozio Alfonso Torrent, stretto collaboratore di don Arturo Posnansky, e come il padre, Carlos Torrent, che aveva trascorso oltre metà della vita tra le rovine tentando di ricostruire il periodo preincaico e studiando la Porta del Sole. Lei aveva ereditato la passione della famiglia e il suo cognome le permetteva di evitare i molti ostacoli con i quali spesso si erano scontrati altri ricercatori. Prova di ciò era l'autorizzazione a iniziare gli scavi preliminari a Lakaqullu ottenuta pochi giorni prima, per telefono, dalla Spagna. «Nessuno si interessa di Lakaqullu perché è un monu- mento minore, ma sono pronta a dimostrare che si sbagliano tutti.» «Ci riuscirà», aveva terminato il giornalista. «È... in Bolivia!» balbettò Proxi, spaventata. Jabba vomitò una sfilza tale di improperi che alla professoressa dovettero fischiare le orecchie dall'altro lato dell'Atlantico. Io non fui da meno: li espressi in catalano e in castigliano, tirai fuori anche tutti quelli che conoscevo in inglese. Sentii il sangue ribollirmi nelle vene; l'improvviso viaggio della professoressa in Bolivia confermava la sua intenzione di approfittare delle scoperte fatte da mio fratello. «È andata a cercare la camera», mugugnai pieno di veleno. «Sa di Lakaqullu...» disse Jabba perplesso. «Sa tutto, la...» «Tranquilla, Proxi.» «Tranquilla? Come puoi dirmi di stare tranquilla, Marc? Non capisci che entrerà nella camera prima di noi? Non potremo più aiutare Daniel!» «Per iniziare gli scavi ci vorrà del tempo», osservai portandomi le mani alla testa non so se per sistemarmi i capelli o per frenare pensieri assassini. «Utilizzeremo questo lasso di tempo per arrivare a Tiwanacu», sostenne Proxi con fermezza. Jabba impallidì immediatamente. Sembrava sconvolto. «Trovami Núria!» urlai al sistema. Il monitor sulla parete mostrò la simultanea composizione di vari numeri telefonici finché non ottenne una risposta. Núria si trovava a casa sua da più di due ore e la sua voce espresse l'ansia che la mia inaspettata chiamata le aveva causato. La rassicurai dicendole che non era accaduto niente di grave, dovevo solo chiederle un favore. «Ho bisogno che trovi tre biglietti per il primo volo diretto in Bolivia.» «Vuoi che vada in ufficio?» mi chiese. «No, non serve. Collegati al sistema e fallo da casa.» «Li vuoi per ieri o mi dai un margine di tempo?» «Per ieri.» «Lo supponevo. Va bene, entro pochi minuti ti mando le prenotazioni.» Jabba e Proxi si erano alzati e mi osservavano con le facce serie. «Quanto ci si impiega per arrivare in Bolivia?» chiese Jabba accigliato. «Non lo so», risposi, ed era vero; non ero mai andato nel continente americano, «ma non deve essere molto. Se Marta Torrent mi ha chiamato domenica pomeriggio, sarà partita quella stessa sera o al massimo lunedì mattina, ed è arrivata in tempo per rilasciare l'intervista che è uscita oggi sul giornale. Vuol dire circa otto o dieci ore, suppongo.» «Quanto poco sai della vita, Root! Dimentichi un piccolo particolare», mi buttò in faccia lui, tornando a sedersi davanti al computer. «Nel migliore dei casi, c'è uno sfasamento di sei o sette ore tra noi e l'America.» «Marc sta tentando di dirti», mi spiegò Proxi, imitandolo, «che quando in Spagna sono le nove di sera, in Bolivia gli orologi segnano, all'incirca, le tre del pomeriggio e che, se Marta Torrent è partita ieri mattina ed è arrivata otto o dieci ore dopo, a questo bisogna sommare la differenza, e quindi il tempo reale di volo potrebbe aggirarsi sulle sedici ore.» Ma non durava sedici ore. Quando Núria mi chiamò per informarmi sui particolari, la cosa risultò essere molto peggiore. Dalla Spagna non c'era un volo diretto per la Bolivia. L'opzione migliore era raggiungere Madrid al mattino e, da lì, prendere un aereo per Santiago del Cile, dove, se non c'erano ritardi, avremmo potuto volare, con degli scali, fino a La Paz. Durata stimata del viaggio: ventidue ore e venti minuti. L'alternativa era andare da Barcellona ad Amsterdam, da lì prendere un aereo per Lima, Perù, e poi un altro per La Paz. Totale: ventuno ore e cinquantacinque minuti. La faccia di Jabba era come una di quelle maschere giapponesi che si mettono gli attori per rappresentare il demonio o uno spirito maligno che ritorna sulla Terra in cerca di vendetta. «Quando parte il volo per Amsterdam?» «Alle sette meno venti del mattino. Ah! Non avete bisogno di visto. Date le buone relazioni tra i due Paesi», mi spiegò Núria, «è sufficiente il passaporto, e potete fermarvi tre mesi usando solo la carta d'identità.» «Prenota per Marc, per Lola e per me, e cercaci un buon hotel a La Paz, per favore. Lascia aperta la data dei biglietti di ritorno.» «Quanto tempo starete via?» «Sempre che ritorniamo...» mugugnò Jabba. «Magari lo sapessi!» risposi io. III Definire un incubo quel lungo viaggio con Marc non è abbastanza. Nel primo tratto, da Barcellona fino all'aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam, non riuscimmo a fargli aprire gli occhi una sola volta, né a fargli allentare la presa sui braccioli, né, ovviamente, a fargli articolare una sola parola. Era un fagotto rigido con un'espressione di immensa angoscia dipinta sul volto. Proxi, che era già abituata, si godette moltissimo il viaggio; proponeva continuamente nuovi argomenti di conversazione, insensibile al dramma che si svolgeva accanto a lei. Invece io, che non avevo mai viaggiato in aereo con Jabba in vita mia, non riuscivo a smettere di guardarlo, allibito per la forza con cui aggrottava la fronte, serrava le palpebre, contraeva le labbra e si aggrappava al sedile. Ero affascinato dallo spettacolo. Sia che gli rivolgessi la parola sia che gli offrissi un bicchiere d'acqua, era la stessa cosa: i suoi muscoli non si rilassavano nemmeno per un secondo. Quando arrivammo all'immenso aeroporto Schiphol, circa alle nove del mattino, era esaurito per la tensione, pallido, sudato; aveva uno sguardo vitreo che sembrava quello di un malato terminale. Mentre guardavamo le vetrine e consumavamo qualcosa in uno dei bar dell'aeroporto (il nostro volo partiva alle undici), si rianimò un poco e tornò a essere il Jabba pungente e acido che tanto bene conoscevamo. Ma fu solo un miraggio perché, quando gli altoparlanti ci convocarono per l'imbarco sul volo della KLM con destinazione Aruba e Lima, si trasformò di nuovo in una grande statua di sale che avanzava con movimenti da robot. Sfortuna volle che, a metà del viaggio, attraversassimo una zona di turbolenze che durò almeno quarantacinque minuti. I denti di Jabba cominciarono a stridere, le braccia e le mani si contrassero ancora di più, e premeva con tanta forza sul poggiatesta che pensai che avrebbe finito per staccarlo. Non avevo mai visto soffrire così una persona e giunsi alla conclusione che, se fossi stato lui, nemmeno ubriaco sarei salito su un aereo, anche se la mia vita fosse dipesa da questo. Sinceramente, non ne valeva la pena. Era disumano che qualcuno dovesse sopportare una cosa simile, e soprattutto un tipo grande, forte e spaccamontagne come Jabba. Non vedevo perché volare dovesse piacere a tutti. Facemmo scalo nell'aeroporto Reina Beatrix di Aruba, nelle Antille, attorno alle tre del pomeriggio ora locale, anche se lì erano già cinque ore meno che in Spagna, e decollammo di nuovo alle quattro. Fino a quel momento avevamo rispettato la tabella di marcia prevista, quindi, se non ci fossero stati inconvenienti, saremmo arrivati in Perù con il cielo ancora chiaro. Era curioso muoversi nella stessa direzione del sole avendolo sempre accanto quasi nella stessa posizione. Il giorno avanzava, senza che noi ne avessimo la percezione. Il povero Jabba, che aveva rifiutato il cibo che gli avevano offerto, era ormai soltanto un relitto umano quando, finalmente, atterrammo all'aeroporto Jorge Chávez di Lima. Quindici ore reali di volo era molto di più di quello che poteva sopportare. Aveva i capelli color terracotta per il sudore, e incollati alla testa come un casco. «Per caso gli è capitato qualcosa in aereo e non me lo ha raccontato?» chiesi a Proxi mentre salivamo sull'autobus che ci avrebbe portato al terminal. Faceva freddo in Perù, molto più che in Spagna, quindi mi tirai su il colletto della giacca e notai che respiravo con un po' di fatica. «No, non gli è capitato niente», mi chiarì lei. «La paura di volare non ha necessariamente una ragione. Potrebbe averla, certamente, ma in realtà è un attacco di ansia. Jabba non riesce a controllarla. Non preoccuparti per lui, Root. Non puoi guarirlo.» «Ma... guardalo», le sussurrai all'orecchio perché l'interessato non mi sentisse. «Sembra un morto vivente. Ed è così da quando siamo partiti da El Prat stamattina!» «Ascoltami, Arnau», mi ordinò. «Lascialo stare. Non c'è niente che possa calmarlo. Lui è convinto che aereo sia sinonimo di morte e vede continuamente se stesso e me in quegli ultimi momenti di panico, mentre precipitiamo nel vuoto in picchiata fino a schiantarci al suolo. Quando arriveremo in Bolivia gli passerà.» «La scimmia pazza», mormorai. «Che cosa?» «Ho letto una volta che gli antichi greci chiamavano così l'eccessiva immaginazione, quella che provoca fantasie che accelerano i battiti cardiaci e ci ossessionano in modo distruttivo.» «È una buona definizione. Mi piace. La scimmia pazza», ripeté, reggendosi a una delle barre verticali dell'autobus, già completamente pieno. Il veicolo si mise in marcia e attraversò le grandi piste lucenti sotto una luce che era già quella del tramonto. Avevamo a disposizione poco più di un'ora prima del nostro prossimo e ultimo volo. «Dovrei chiamare mia nonna», dissi pensieroso. «Non ho potuto salutarla e voglio sapere come sta Daniel.» «In Spagna è mezzanotte passata, Root», mi disse lei gettando un'occhiata al suo orologio da polso. «Lo so. È proprio per questo che la chiamo. Ora sarà in ospedale, e starà leggendo.» «O dormendo.» «O più probabilmente chiacchierando nel corridoio con un suo coetaneo.» «Ho la nausea», disse in quel momento Jabba, sorpreso. «È puro sfinimento», gli rispose Proxi accarezzandogli il viso. Dopo aver passato un'ora e mezzo in un bar senza che ci chiamassero per l'imbarco per la Bolivia, ci avvicinammo a uno dei banconi delle informazioni per chiedere che cosa stesse succedendo. E meno male che l'avevamo fatto perché, altrimenti, non avremmo saputo che l'aereo della Taca Airlines che doveva portarci a La Paz aveva un ritardo di due ore a causa di problemi tecnici non precisati. Ne approfittai per chiamare la nonna, la quale mi raccontò che Daniel stava come prima, senza variazioni né in bene né in male, e che gli avrebbero cambiato un'altra volta la terapia. Si mostrò molto interessata al mio stato di salute perché notò la mia respirazione affannosa, e quando le dissi che Jabba non stava bene perché aveva paura dell'aereo e che aveva la nausea per la tensione nervosa, si allarmò oltremisura. «Dio mio, e ancora non siete arrivati a La Paz!» esclamò preoccupata. «Vai subito a un bancone qualsiasi e chiedi dell'ossigeno per tutti e due», ordinò. «Ma che stupidaggini stai dicendo, nonna?» «Il mal di montagna, Arnauet. Il mal di montagna è molto fastidioso! Te lo dico io, che ne ho sofferto varie volte. Per favore, camminate molto adagio e respirate lentamente. E bevete tanta acqua, di continuo, due o tre litri ciascuno, come minimo!» Come avevamo fatto a non pensare al maledetto mal di montagna? Era stato a causa della fretta. Era una questione di buon senso ricordare che quando si va in un Paese andino si soffre lo sgradevole mal di montagna per mancanza di ossigeno nell'aria, che ne è molto povera. La cosa strana era che Jabba saliva montagne di tremila metri quasi tutti i fine settimana, ma chiaramente ora era ridotto uno schifo per la sua paura degli aerei. «Se ti vergogni a chiedere l'ossigeno», concluse lei, «quando arrivate a La Paz bevete un infuso di coca. Mate de coca, lo chiamano loro, come gli argentini. Vedrai... vi sentirete subito meglio.» Anche se sapevo che non se la sarebbe presa, mi astenni dal fare un commento sarcastico; preferii non pensare alla mia santa nonna che ingeriva alcaloidi della coca. A mezzanotte circa atterrammo in Bolivia, all'aeroporto di El Alto, a La Paz. Il nome era molto appropriato perché si trovava a più di quattromila metri di altezza; il freddo era insopportabile e i nostri vestiti si rivelarono grottescamente insufficienti. Eravamo partiti da Barcellona quasi ventiquattro ore prima, ma per noi era sempre lo stesso giorno, mercoledì 5 giugno. Durante l'ultimo volo ci avevano informato con precisione degli effetti del mal di montagna e ci avevano spiegato i rimedi per combatterlo, che erano gli stessi che mi aveva consigliato mia nonna. Ma, mentre ci dirigevamo con un radio-taxi privato verso l'hotel, situato nel centro della città - curiosamente nella calle Tiahuanacu - il nostro stato cominciò a rivelarsi allarmante: avevamo nausea, sudori freddi, mal di testa, ronzii alle orecchie e tachicardia. Per fortuna, appena oltrepassammo la porta dell'albergo, si presero cura di noi, e ci sommersero di sorrisi gentili e gesti di comprensione. «Il dottore sale subito a visitarvi», ci disse il portiere, «e il servizio in camera vi porterà dei mate de coca. Vedrete come vi faranno bene. E, se mi permettete, vi darò il consiglio che diamo a tutti gli stranieri: 'Mangiare pochino, camminare adagino e dormire soli soletti nel proprio lettino'. Buona permanenza a La Paz.» Nonostante quello che potrebbe sembrare, i boliviani non hanno un accento eccessivamente marcato. Mi sorprese perché non me lo aspettavo, ma era così. Parlavano con giri di parole, espressioni e un modo di pronunciare la «esse» molto particolari, e questo non solo non risultava stridente, ma posso affermare che era persino più dolce dell'intonazione delle isole Canarie, per esempio, alla quale noi spagnoli siamo tanto abituati. Ben presto non notai nemmeno più la differenza e, curiosamente, noi stessi assimilammo una cadenza speciale, catalano-boliviana, che ci accompagnò per molto tempo. È vero che l'aspro mate de coca e il Sorochipil, che ci prescrisse il medico dell'hotel, lenirono gli sgradevoli sintomi, ma non riuscirono a restituirmi le forze sufficienti a uscire dalla camera per i due giorni seguenti. Il corpo mi pesava come fosse di piombo e respirare era uno sforzo spossante. Mia nonna mi chiamava di frequente per sapere come stavo, ma non riuscivo a risponderle se non con gemiti soffocati. Proxi, che si era ripresa subito, veniva a trovarmi spesso e mi raccontava che Jabba dormiva tanto profondamente che non riusciva a svegliarlo nemmeno gettandogli dell'acqua sulla faccia. L'unica cosa che posso dire è che, dal mio letto di dolore, capivo molto bene il mio amico, al quale mi sentivo accomunato a distanza. Quei giorni servirono almeno ad adattarci al cambio di fuso orario e a far dimenticare a Jabba il boccone amaro del viaggio. Il venerdì pomeriggio, finalmente, fummo in grado di uscire a fare due passi. La Paz è una città tranquilla, in cui non esiste altra delinquenza che quella di piccoli furti a turisti distratti. Quindi, con i documenti e il denaro ben protetto nelle tasche interne, camminammo beatamente per le vie del centro, godendoci l'atmosfera tanto differente dalla nostra e tanto ricca di odori e colori vari. Il ritmo generale era lento (forse a causa della mancanza di ossigeno, chissà), e tutto trasmetteva una sensazione di calma assolutamente sconosciuta. Da quasi tutte le vie si riusciva a vedere, sullo sfondo, le alte e lontane montagne innevate che circondavano la vallata su cui era stata costruita La Paz. Secondo quello che ci avevano detto in hotel, la popolazione era in maggioranza india, tuttavia nelle strade che percorremmo abbondavano i bianchi e i cholos, cioè i meticci. Ci sorprendemmo molto rendendoci conto che quelli che lì chiamavano indios altro non erano che aymaras di stirpe pura, discendenti degli antichi padroni e signori di quelle terre, ancora in possesso di una lingua prodigiosa che, incredibilmente, veniva disprezzata come indice di analfabetismo e di scarsa cultura. Era difficile accettare quelle assurde idee; noi rimanevamo a osservare affascinati i venditori di strada scuri di pelle e con i capelli neri dai riflessi blu, e le meticce con le ampie gonne e la bombetta, come fossero autentici yatiris di Taipikala. Ero talmente entusiasta che mi avvicinai a uno di loro, che stava dietro a un banco di oggetti per turisti, e gli chiesi di dirci alcune frasi in aymara. L'uomo all'inizio parve non aver capito, ma poi, quando vide il mazzetto di boliviani,16 si lanciò a recitare una specie di poesia, che naturalmente non capimmo. Non ce n'era bisogno perché, finalmente, sentivamo parlare aymara, l'autentico aymara, ed era la lingua più diabolicamente ostica che avessi mai ascoltato in vita mia. Aveva il suono dei tamburi di Calanda, ma senza ritmo, a colpi irregolari, con strane aspirazioni e gorgoglii in alcune sillabe, schiocchi di lingua ed emissioni esplosive di suoni dalla gola o dalla bocca. Per alcuni secondi restammo paralizzati, increduli di fronte a quella cascata di effetti acustici inverosimili e, quando reagimmo, fu per salutare il venditore, che ci rispose «Jikisinkama!» con un sorriso gentile (qualcosa come «Arrivederci!»), e per continuare la nostra passeggiata nelle vicinanze della chiesa di San Francesco con la sensazione di essere di nuovo sotto l'effetto del mal di montagna. Attorno a noi i cantastorie narravano le loro favole in mezzo a capannelli che si formavano per ascoltarli e a bancarelle di tessuti, oggetti magici, collanine, statuine e berretti di alpaca che attraevano un numero sempre maggiore di acquirenti locali e di turisti come noi. «Quelli erano», si azzardò infine a commentare Proxi, molto stupita, «i famosi suoni naturali?» Camminavamo tutti e tre ben imbacuccati nelle nostre giacche e cappotti perché, mentre in Spagna l'estate era alle porte e faceva un tempo magnifico, lì, nell'emisfero sud, cominciava il duro inverno della stagione secca. «Non c'è dubbio che lo fossero», mormorai avanzando con precauzione sul selciato sconnesso. Nella via stretta e affollata circolavano soltanto alcune motociclette a passo di tartaruga. La Paz era una città di muri ocra e marroni ai quali si sovrapponevano i vistosi colori dei ponchos, delle gonne, dei copricapi e dei mantelli degli aymaras. In tutte le strade, le case basse avevano balconcini chiusi da grate, pieni di fiori e di panni stesi ad asciugare. «Il linguaggio originale», borbottò Jabba, guardando avanti con determinazione. «Il probabile linguaggio di Adamo ed Eva i cui suoni sono quelli della natura, formati dalla stessa sostanza degli esseri viventi e delle cose. E che sostanza! Se i risultati sono questi...» «È incredibile come quel tipo sia riuscito a riprodurre simili fischi e suoni con la bocca e la gola», aggiunsi ammirato. «E si suppone, inoltre, che siano parole con un senso. Che pasticcio!» «Mi dispiace per voi», commentò la mercenaria mentre si avvicinava a una bancarella, «ma questo pasticcio è la lingua più perfetta del mondo, sia o no la lingua di Adamo ed Eva. Ed è l'autentico codice di programmazione che contiene i segreti degli yatiris.» Il venditore ambulante, che aveva sentito le ultime parole di Proxi, si emozionò visibilmente e cominciò a gesticolare eccitato. «Ascoltate, avete notato questi bei prodotti? Io sono yatiri e posso offrirvi i migliori feti di lama e gli amuleti più efficaci. Guardate, guardate... Volete erbe medicinali? Bastoni di Viracocha? Foglie di coca? Ve lo posso assicurare: non ce ne sono di migliori in tutto il mercato.» «Lei è yatiri?» chiese Proxi facendo l'ingenua. «Certo, signorina. Questo è il Mercato degli Stregoni, sa? Qui siamo tutti yatiris.» «Credo che dovremmo comprare qualche guida turistica della Bolivia», mi sussurrò Jabba all'orecchio. «O siamo più persi di un polipo in un garage o qui c'è qualcosa che puzza di bruciato.» «Non siamo venuti per turismo», risposi sfregandomi il naso gelato. «Siamo qui per entrare nella camera segreta di Lakaqullu.» Mentre parlavo, fui sul punto di comprare un bastone di Viracocha, non tanto per sete di ricerca, quanto per portare un regalo a mio nipote al nostro ritorno. I bastoni di Viracocha erano una pallida riproduzione in legno dei bastoni del Dio della Porta del Sole, dipinti a colori sgargianti e con nappe di lana di lama a una delle estremità. Non lo feci perché pensai che Ona mi avrebbe gettato dalla tromba delle scale se avessi dato a suo figlio l'arma perfetta per distruggerle la casa. «Va bene. Niente turismo. Ma ti avverto che, intanto, stiamo facendo una figuraccia.» Alla stazione degli autobus, come chiamavano le fermate casuali dei desueti mezzi di trasporto o dei vecchi furgoncini per il trasporto urbano, trovammo un chiosco per le informazioni turistiche dove riuscimmo ad avere una pianta della città e alcuni opuscoli. Ma presto ci accorgemmo che la pianta era abbastanza inutile se nelle vie non c'erano i cartelli con i rispettivi nomi, e che gli opuscoli fornivano pochi dati su ciò che avevamo davanti e ancora meno su una cosa tanto necessaria come un buon ristorante in cui pranzare o cenare. A parte questo, in una rivista trovammo alcuni dati sul Mercato degli Stregoni, dove pareva che fossimo stati, nel quale gli yatiris, «nome in aymara dei guaritori», secondo l'opuscolo, vendevano prodotti tradizionali per la salute e per la buona sorte. Per cui, sull'orlo della depressione, decidemmo di goderci ancora un po' la passeggiata in quel labirinto di stradine lastricate dall'inconfondibile aspetto coloniale, gremite di eleganti edifici e di numerose chiese in stile barocco andino ricche di curiosi motivi incas piuttosto pagani. Riuscimmo a cenare, finalmente, nel bar di un vecchio hotel chiamato Paris, che si trovava in un angolo della plaza Murillo, e ci piacque da matti tutto ciò che ci servirono, che era abbondante e piccantissimo: incominciammo con una zuppa di choclo (mais), di yuca e di quinoa17 che non poteva essere più gustosa. Continuammo con il piatto chiamato paceño, a base di patate, fave e formaggio, e con una jakhonta di carne che Proxi e io riuscimmo appena ad assaggiare e che un Jabba completamente guarito e con una fame di tre giorni consumò in abbondanza. La ragazza che serviva ai tavoli - le cameriere le chiamavano meseras e i camerieri garsones -, si presentò come Mayerlin, ci raccomandò di visitare un club vicino, La Naira, in calla Jaén, dove avremmo potuto bere del mate prima di ritirarci in camera, e ascoltare Enriqueta Ulloa, una famosa cantante aymara, e il gruppo Llapaku, il migliore nel campo della musica folcloristica andina. Nella via ancora piena di gente, si sentiva una baraonda di voci in castigliano e in aymara, superata dalle grida dei bambini che vendevano bigliet- ti e scandivano il lungo percorso dei mezzi di trasporto, pericolosamente appesi all'esterno delle portiere sgangherate, senza che nessuno sembrasse preoccuparsi della loro incolumità. I venditori dei mercatini popolari che prima avevamo visitato si preparavano ormai a tornare a casa, caricandosi sulle spalle grossi fagotti che molto probabilmente pesavano il doppio o il triplo di loro stessi. Era un mondo strano in cui non si vedeva gente parlare in continuazione al cellulare o correre da un lato all'altro, né distogliere lo sguardo quando, casualmente, incrociavano il nostro. No, lì ti guardavano fisso e ti sorridevano lasciandoti imbarazzato e senza reazioni. A volte quello che rende le cose sorprendenti non è tanto ciò che si vede, anche se diverso dal paesaggio abituale, quanto ciò che si percepisce in modo inconscio attraverso gli altri quattro sensi, e tutti i segnali che ricevevamo ci indicavano con molta chiarezza che ci trovavamo in un universo differente, in un'altra dimensione. Nel club La Naira, pieno zeppo, gustammo, in un'atmosfera calda, la bella musica che i Llapacu eseguivano con strumenti tipici delle alte Ande (il charango, il siku con la doppia fila di canne, i tamburi...) e le canzoni di Enriqueta Ulloa, dotata di una voce assolutamente straordinaria, vibrante e ricca di suoni armonici. Con dispiacere ce ne andammo presto perché il giorno dopo dovevamo alzarci all'alba, ma arrivammo all'hotel abbastanza allegri e pieni di energia per affrontare quello che ci aspettava. Seguendo le indicazioni di uno dei gestori dell'hotel, ci alzammo alle sei del mattino (era ancora buio pesto) in modo da essere pronti, attorno alle sette, per prendere un taxi privato per Tiwanacu. Il problema dei taxi a La Paz è che sono collettivi, cioè funzionano come piccoli autobus. L'alternativa è chiamare una delle ditte di radio-taxi e avvertire subito che sei disposto a pagare i boliviani che ti chiedono, a patto che non ti facciano viaggiare con altra gente. Il fatto di andare in taxi fino alle rovine aveva un'altra ragione particolare: i cosiddetti autobus, che coprivano un percorso di settanta chilometri, erano in realtà vecchi e potenti camion in cui si viaggiava in compagnia di persone, prodotti del mercato e animali, tutti ammucchiati nello stesso spazio ridotto. Ma, se pensavamo che con un veicolo privato avremmo viaggiato come nelle nostre auto a Barcellona, ci sbagliavamo di grosso; la strada era stretta e piena di buche, e il nostro autista si impegnò a sorpassare pericolosamente chiunque si trovasse davanti a noi senza preoccuparsi dei dirupi montani né delle ruote che stridevano in curva. Impiegammo quasi due ore per arrivare a Tiwanacu e, quando scen- demmo dal taxi, avevamo i muscoli irrigiditi per il panico e il cervello intorpidito. Ma eravamo lì. A Tiwanacu. O meglio ancora a Taipikala, «la pietra centrale», un luogo che avevamo studiato così tanto che ci sembrava di conoscerlo come la nostra casa. Eravamo ancora circondati dalle montagne innevate dalle cime stupefacenti, tra le quali si distingueva quella dell'Illimani, un monte sacro di oltre seimila metri di altezza. Non avevo l'abitudine di guardare attraverso spazi tanto vasti, poiché, in città, gli edifici limitano piacevolmente la vista e, sul posto di lavoro, lo fanno gli schermi dei computer, quindi tutte quelle cime bianche in lontananza e quell'immensa distesa di cielo limpido mi frastornarono un po'. Il nostro tassista, che ostentava il pomposo nome di Yonson Ricardo, ci lasciò sotto l'entrata principale del sito archeologico e promise di ritornare all'ora di pranzo; lui avrebbe passato la mattinata nella vicina località di Tiahuanaco, costruita per la maggior parte con pietre estratte dalle rovine. Grati per il tepore del sole in quel gelido mattino, iniziammo la dolce salita verso Taipikala. Una barriera di filo spinato proteggeva, a perdita d'occhio, la zona archeologica. Sarebbe stato difficile infiltrarsi in quel luogo al di fuori dell'orario di visita. Presi il portafoglio per pagare il biglietto d'entrata e, in quel preciso momento, mi venne in mente un piccolo particolare: «E se ci troviamo faccia a faccia con la professoressa?» chiesi rivolto a Jabba e a Proxi che, sotto lo sguardo attento delle guardie di sicurezza che vigilavano appostate dietro la cancellata, tentavano di mettere insieme le monete per i quindici boliviani a testa del costo del biglietto. Mi guardarono sconcertati per un paio di secondi, poi Jabba si strinse nelle spalle e Proxi, più pragmatica, staccò da un espositore un panama e me lo infilò sulla testa. In quella biglietteria, come recitava il cartello che c'era sulla finestrella, avevano strani articoli di ogni genere a disposizione dei turisti, dai berretti e dagli occhiali da sole fino agli ombrelli e ai bastoni che si trasformavano in sedie pieghevoli. «Sistemato», disse. «Raccogli i capelli e nascondili sotto il panama. Non credo che ti riconoscerebbe se si trovasse da queste parti.» «No, di certo», risposi con rabbia. «E meno ancora se mi taglio le gambe e mi abbasso di mezzo metro.» «Ma, Root, oggi è sabato, e di sabato non si lavora! Sarà a La Paz, tranquillizzati!» «Ma se è nei paraggi e mi imbatto in lei?» insiste. «La saluti se ne hai voglia, altrimenti no», disse Jabba. «Capirà che siamo qui per cercare la stessa cosa che cerca lei», obiettai testardo. L'uomo della biglietteria cominciava a spazientirsi. «Non piantare grane e compra il biglietto d'entrata, una buona volta. Di tutti lei conosce solo te, e siccome noi l'abbiamo vista in fotografia, possiamo riconoscerla prima che ti veda.» Tranquillizzato, pagai e attraversai la soglia che dava accesso a Tiwanacu. Dimenticai all'istante tutto ciò che mi era passato per la testa dal giorno della mia nascita. Taipikala era grandiosa, immensa, stupefacente... No, in realtà era molto di più: era incredibilmente bella. Il vento soffiava libero per quegli illimitati spazi coperti di rovine. Un sentiero serpeggiante si apriva di fronte a noi e portava fino al Tempietto semisotterraneo, una fossa quadrata scavata nella terra, a destra del quale si trovava l'immensa piattaforma del tempio di Kalasasaya, di cui potevamo distinguere, nonostante la lontananza, i blocchi di pietra alti più di cinque metri e di cento tonnellate. Tutto lì era colossale ed emanava grandezza ed energia, e l'erba che lo ricopriva non gli toglieva nemmeno una punta di maestosità. «Sto soffrendo di allucinazioni», mormorò la mercenaria mentre ci incamminavamo verso il Tempietto. «Mi sembra di vedere gli yatiris.» «Non sei l'unica», sussurrai. In silenzio percorremmo l'avvallamento del Tempietto, di uno o due metri di profondità, osservando le strane teste scolpite che sporgevano dalla parete. Jabba fu il primo a notare qualcosa di strano. «Guardate!» esclamò a pieni polmoni. «Quello che vedo lì non è la testa di un cinese?» «Ma dai!»lo burlò Proxi. Però aveva già diretto lo sguardo verso il punto segnalato da Jabba. Era vero: la testa era chiaramente quella di un orientale, con due occhi indiscutibilmente obliqui. Due o tre teste più in alto ce n'era un'altra che presentava tratti inequivocabilmente africani: naso largo, labbra grosse... Dopo aver girato attorno guardando in alto e in basso, non c'era più il minimo dubbio: nelle centosettantacinque teste di cui parlava l'opuscolo informativo, erano rappresentate tutte le razze del mondo: zigomi pronunciati, occhi sporgenti, rotondi, a mandorla, infossati... «Che cosa dice la guida a questo proposito?» volli sapere. «Ne dà varie interpretazioni», lesse Proxi, che si era appropriata del libro. «Dice che, probabilmente, era costume dei guerrieri tiwanacotas esibire qui le teste mozzate dei nemici dopo la battaglia e che, con il passare del tempo, dovettero scolpirle nella pietra perché durassero. E aggiunge che questo luogo potrebbe anche essere stato una specie di facoltà di medicina dove si insegnava a diagnosticare le malattie che si presume siano rappresentate in queste facce. Ma, siccome non ci sono prove a favore dell'una o dell'altra interpretazione, finisce per dire che la cosa più probabile è che si tratti di una semplice conferma dei contatti che Tiwanacu ebbe con le diverse civiltà e razze del mondo.» «Con i neri e con i cinesi?» si stupì Jabba. «Questo non lo specifica.» «Figlio mio...» dissi posando una mano paterna sulla spalla del mio amico, «su questa città misteriosa non hanno nessuna dannata idea, quindi scemo chi dà la sua versione dei fatti. Non farci caso. Rimettiamoci al lavoro.» Era un peccato, pensai, che la Bolivia non disponesse del denaro sufficiente per avviare degli scavi a Tiwanacu, ed era una vergogna che gli organismi internazionali non fornissero i fondi necessari per aiutare il Paese in quest'opera. Ma nessuno era interessato a scoprire che cosa si nascondeva in quella strana città? «E quel tipo con la barba?» insisté Jabba indicando con il dito una delle tre stele di pietra che si ergevano al centro dell'area. Era la stele più alta e vi era scolpita la figura di un uomo dagli occhi enormi e rotondi, con dei folti baffi e un bel pizzetto. Indossava un lungo mantello e, su entrambi i lati, si distinguevano le sagome di un paio di serpenti che si alzavano da terra fino alle sue spalle. «La guida dice che è un re o un sacerdote molto importante.» «L'immaginazione al potere! Non potrebbero cambiare argomento? Comincio ad annoiarmi.» «Dice anche che questi serpenti sono, nella cultura tiwanacota, il simbolo della conoscenza e della saggezza.» «Allora è questo che rappresenta il rettile cornuto all'interno della stanza di Lakaqullu.» «Andiamocene da qui», ordinai dirigendomi per primo verso il Kalasasaya. Eravamo quattro gatti a visitare le rovine di Tiwanacu, più un gruppo di allievi accompagnati dai loro professori, che facevano un baccano tremendo a breve distanza da noi. Di fronte a tanta solitudine umana, il mio timore di incontrare la professoressa aumentò: se quella donna aveva tanti contatti politici in Bolivia, una semplice telefonata alla polizia che ci accusava di essere ladri di reperti archeologici le sarebbe bastata per toglierci di mezzo e impedirci di entrare nella camera prima di lei. E sarebbe stata la sua parola contro la nostra. Mentre salivamo con prudenza la grande scalinata del Kalasasaya, apparve a poco a poco davanti ai nostri occhi una figura familiare e maestosa che risultò essere il Monolito Ponce, chiamato così dall'archeologo che lo aveva scoperto, Carlos Ponce Sanjinés. Ma, nonostante la sua imponente presenza che sembrava dominare l'immensa spianata del Kalasasaya, i nostri sguardi e i nostri passi si diressero automaticamente e direttamente verso il lontano confine del tempio a destra del quale si intravedeva la forma inconfondibile della Porta del Sole. Tutta la storia era cominciata lì, nei bassorilievi di quella porta, con la copia fatta a mano da Daniel della piramide di tre piani che serviva da supporto al Dio dei Bastoni. In quel momento, mentre continuavo a camminare, non potei evitare di sentire un nodo alla gola. Come sarebbe stato felice mio fratello di vedere le sue idee in azione e le sue scoperte sul punto di essere confermate! Riuscivo quasi a vederlo al mio fianco, zitto, silenzioso, ma con un sorriso di soddisfazione che andava da un orecchio all'altro. Aveva lavorato come un negro per svelare il segreto degli yatiris e, quando era sul punto di riuscirci, era caduto prigioniero delle sue stesse scoperte. Un giorno, quando fosse guarito, avrei rifatto quel viaggio con lui. Continuammo ad avanzare verso la grande Porta e, a mano a mano che si riducevano i metri che ci separavano da essa, tutti e tre entrammo in una specie di campo magnetico che ci attraeva con la stessa forza con cui la gravità ci faceva aderire al suolo. Alla vista di quella sagoma che si stagliava contro il cielo, la mia mente fece un salto alla sera precedente alla nostra partenza, pochi minuti dopo aver chiesto a Núria di prenotarci i voli e l'albergo... ... Avevamo ancora tempo prima dell'ora di cena, e prima che Jabba e Proxi andassero a casa loro a preparare le valigie riprendemmo la ricerca sulla Porta, l'unica cosa di Tiwanacu che ci mancava da esaminare. Marc si era impegnato a cercare immagini e a stamparle, Lola a studiare il misterioso Dio dei Bastoni e io a raccogliere tutte le informazioni esistenti sul monumento. La professoressa mi aveva detto che la Porta pesava più di tredici tonnellate e il dato sembrava essere confermato dalle pagine di Internet che trattavano l'argomento. Sulle misure i dati erano discordi anche se, in generale, si aggiravano attorno ai tre metri di altezza per quattro di larghezza. Sullo spessore non avevo trovato divergenze: per parere unanime era di mezzo metro. La Porta del Sole segnalava il passaggio da nessun luogo al nulla. La sua ubicazione era assolutamente fittizia e nessuno sembrava conoscere la sua reale provenienza; alcuni dicevano, per una lontana somiglianza, che fosse la quarta porta di Puma Punku, quella che mancava, altri che proveniva da un monumento non più esistente, altri ancora dalla piramide di Akapana... Nessuna notizia era certa, ma il vero mistero era come una pietra di tredici tonnellate avesse potuto essere spostata e lasciata cadere in quel recinto di Kalasasaya nel quale adesso si trovava. Il monumento presentava una crepa larga e profonda che saliva in diagonale dall'angolo superiore destro del vano, dividendo il fregio in due. Secondo la leggenda, quello squarcio era stato prodotto da un lampo. Però, anche se le tempeste elettriche erano frequenti sull'altopiano, difficilmente questo fenomeno avrebbe potuto produrre una crepa simile in un blocco di durissima trachite. La spiegazione più probabile era che, rovesciandosi, si fosse spaccata, ma nemmeno questo era chiaro. Nell'altro lato della porta c'erano cornici e nicchie tanto perfette che era difficile capire come fossero riusciti a lavorarle senza l'aiuto di macchinari moderni, e la stessa cosa si poteva dire del fregio sulla facciata principale con il suo straordinario Dio dei Bastoni al centro. Il dio era compito di Proxi, ma, al momento di leggere le descrizioni della Porta, si faceva fatica a separare ciò che si diceva di lui da tutto il resto. In quel modo scoprii che la quasi totalità dei documenti affermava che la figura senza gambe rappresentava Viracocha, il dio inca, e la cosa mi ripropose il problema dell'assoluta disinformazione che esisteva sulla materia. La maggioranza degli esperti, secondo quello che mi aveva detto la professoressa, aveva abbandonato da tempo questa teoria, ed erano pochi quelli che dimostravano di esserne a conoscenza. Il Dio dei Bastoni avrebbe continuato a essere Viracocha per molto tempo e le quarantotto figure che gli stavano a fianco ventiquattro su ogni lato, in tre file di otto ciascuna - non avrebbero smesso di essere quarantotto cherubini per il semplice fatto di avere le ali e un ginocchio piegato nell'atto di correre o di fare una riverenza. E non importava che alcune di loro avessero delle belle teste di condor su corpi umani; finché nessuno dimostrava il contrario, molti continuavano a vedere in quelle figure zoomorfe dei folletti alati del tutto simili agli angeli. Alcuni degli archeologi più affermati avevano formulato, senza il minimo ritegno, la strana teoria che il fregio fosse un calendario agricolo e i personaggi rappresentati non simboleggiassero altro che i trenta giorni del mese, i dodici mesi dell'anno, i due solstizi e i due equinozi. Forse era vero, ma si doveva avere molta immaginazione - o certamente migliori conoscenze delle mie - per avventurarsi in un'ipotesi simile, soprattutto perché alcuni di loro assicuravano anche che il calendario della Porta del Sole, oltre che agricolo, potesse essere venusiano, con duecentonovanta giorni distribuiti in dieci mesi. Nonostante ciò, nel momento in cui il mio scetticismo e la mia sfiducia sfioravano i limiti del sopportabile, ebbi una sorpresa enorme. Stavo leggendo tranquillamente quando mi imbattei in un'affermazione che mi scioccò. Un ricercatore di nome Graham Hancock aveva scoperto che nella Porta del Sole erano rappresentati un paio di animali presumibilmente estinti molte migliaia di anni prima, in un'epoca nella quale, secondo la scienza ufficiale, Tiwanacu non esisteva ancora. Nella parte inferiore del fregio, in una quarta fascia di ornamenti che non avevo notato, si riconoscevano con molta chiarezza le teste di due cuvieronius, una a ogni estremità dei quattro metri di architrave e, in un'altra parte, una testa di toxodonte. La cosa incredibile era che tutte e due le specie erano scomparse dalla superficie del pianeta - assieme a molte altre in tutto il mondo - dieci o dodicimila anni prima, alla fine dell'era glaciale, senza che nessuno fosse riuscito a spiegarsene la ragione. Mi alzai e presi tutti gli ingrandimenti fotografici della Porta del Sole che Jabba stava stampando. Eccetto il fatto che avevo visto la quarta banda, non riuscii a individuare se non certe forme imprecise di bassorilievi; quindi, dopo averci pensato un momento, mi diressi in camera di mia nonna con la speranza di trovare degli occhiali da lettura, ed ebbi fortuna perché sul tavolino da notte ne aveva due dentro le relative custodie. Ritornai nello studio e porsi una di quelle improvvisate lenti di ingrandimento a Jabba, che seguiva le mie tracce come un setter che fiuti la preda. Non trovammo da nessuna parte il toxodonte, un erbivoro molto simile al rinoceronte senza corno sul naso, forse perché non eravamo in grado di vederlo, ma individuammo subito i cuvieronius, che erano identici agli elefanti attuali, inconfondibili con le loro grandi orecchie, le proboscidi e le zanne. Stavano sotto la terza e quarta colonna dei folletti alati, a partire dai bordi. Era sorprendente osservarli e confermare in modo inconfutabile che la Porta del Sole aveva più di diecimila anni poiché era impossibile che gli artisti tiwanacotas fossero riusciti a vedere un elefante in vita loro; non ne erano mai esistiti nell'America del sud, quindi poteva trattarsi solo di cu- vieronius, un mastodonte antidiluviano i cui resti fossili ne testimoniavano la presenza nel continente fino alla loro repentina e inspiegabile scomparsa dieci o dodicimila anni prima. «E secondo gli archeologi quando fu costruita Tiwanacu?» chiese confuso Jabba. «Duecento anni prima della nostra era», risposi. «Ossia duemiladuecento anni fa, non è così?» Assentii con un grugnito. «Ma non combacia... Non combacia con questi animaletti né con la mappa di Piri Reis né con la presunta antichità del linguaggio aymara né con la storia degli yatiris...» In quel momento, Proxi fece un salto di gioia sulla sedia e si voltò a guardarci. Le brillavano gli occhi. «Vi risparmierò le cose inutili e andrò direttamente a quello che ci interessa», esclamò. «Secondo gli ultimi studi sull'argomento il Dio dei Bastoni potrebbe essere in realtà Thunupa, vi ricordate? Il dio del diluvio, quello della pioggia e del fulmine.» «Accidenti! Tiwanacu è piccola, eh?» dissi con sarcasmo. «Sembra che quei segni che ha sulle guance siano lacrime», continuò a spiegare lei, «e i bastoni simbolizzerebbero il suo potere sul fulmine e sul tuono. Il nostro amico Ludovico Bertonio riporta un dato molto curioso nel suo famoso dizionario: Thunupa, dopo la conquista, si trasformò in Ekeko, un dio che, attualmente, continua ad avere molti adepti tra gli aymaras perché, secondo l'archeologo Carlos Ponce Sanjinés,18 la pioggia, proprio perché era scarsa, è diventata sinonimo di abbondanza. Ed Ekeko è il dio dell'abbondanza e della felicità.» «Molto fantasioso», borbottò Jabba. Lei non si scompose. «Quindi gli aymaras continuano ad adorare Thunupa dopo migliaia di anni. Non è fantastico? La questione è, come sapete, che la mappa della camera si trova sotto i piedini di questo dio e...» Trascinò a lungo la «e» mentre alzava il tono per sottolineare quello che stava per dire. «E risulta che il nome del dio ha un significato molto speciale.» Il suo volto si aprì in un largo sorriso di soddisfazione. «Sapete che cosa vuol dire Thunu in aymara?» «Se mi lasci consultare il dizionario di Bertonio...» dissi facendo il gesto di alzarmi. «Puoi consultare quello che vuoi, ma prima lascia che te lo dica io. Thunu, in aymara, significa una cosa occulta, nascosta, come il bulbo di una pianta sottoterra, e la desinenza 'pa' mette Thunu in relazione con la terza persona singolare. Thunupa, quindi, vuol dire che c'è qualcosa di occulto sotto la figura del dio. Il dio indica il luogo.» Jabba e io restammo in silenzio per alcuni istanti a riflettere sul fatto che i vari pezzi continuavano a incastrarsi gli uni negli altri in maniera sorprendente. «Magari è semplice», osservò Jabba, con voce insicura. «Non è semplice», esclamò Proxi continuando a sorridere. «È perfetto!» «Questo non ci dice niente di nuovo!» obiettai con energia. «Sapevamo già che il dio indicava il luogo. Ma dove sono gli accessi alla camera?» «Usa la logica, Arnauet: se finora tutto è rappresentato nel fregio della Porta del Sole, anche gli accessi ai corridoi segreti devono comparirvi. E se compaiono, come si spera, li abbiamo avuti sotto il naso fin dall'inizio, non credi?» Io la fissavo con occhi spalancati. «Osserva questo ingrandimento del Dio dei Bastoni», proseguì lei imperterrita, allungandomi un foglio. «Descrivimi la piramide di tre piani.» «Dunque... Come dice il nome stesso, è una piramide e ha, in effetti, tre piani. Vi compaiono una serie di bestie strane e un quadrato con un serpente con le corna.» «E che altro?» mi incoraggiò Proxi, quando tacqui. «Nient'altro», risposi, «però, se vuoi che ti descriva anche il dio, lo faccio.» «Vedi che cos'ha il dio nelle mani?» «I bastoni.» «E in che direzione puntano i bastoni?» «E dove devono puntare?» borbottai esasperato. In quel momento, notai qualcosa. «Dovrebbero essere rivolti verso l'alto, no?» Lei sorrise. «Ma, in realtà, è come se il dio li tenesse al contrario: il becco dei condor, o di quel che sono, è rivolto verso...» «Verso?...» «Verso il basso. È piuttosto strano, no?» «E in che direzione puntano questi bastoni capovolti?» insisté. «Verso queste strane cose che sporgono da... dalla piramide. Avevi ragione tu», mormorai restituendole il foglio, che lei abbandonò sul tavolo. Mi arrabbiai molto con me stesso. Come potevo essere stato tanto imbecille? Avevo osservato a lungo quei rilievi della piramide, da quando ave- vo scoperto il disegno di mio fratello, e anche se sembrava incredibile, proprio perché erano strani, non gli avevo prestato la minima attenzione. Erano un ornamento, solo un altro ornamento. Il mio cervello li aveva ignorati completamente perché mi risultavano incomprensibili. «Come vedi, dal gradino inferiore della piramide», concluse lei, «parte una linea orizzontale verso destra e verso sinistra che dovrebbe rappresentare il suolo, ma curiosamente di lì a poco torna a salire verso l'alto disegnando una sorta di camini su entrambi i lati, coperti da due oggetti strambi e senza senso.» «Sono come...» mormorò Jabba esaminando un'altra riproduzione del dio. «Veramente non so come sono! Potrebbero simboleggiare elmetti di guerrieri?» «Sì, e anche animali extraterrestri o navi spaziali», scherzò Proxi. «Osserva che ciascuno ha un occhio solo, rotondo e profondo, identico agli occhi del dio. Che cosa importa? In realtà non credo siano altro che un segno. Nel luogo in cui queste cose compariranno a Tiwanacu, lì ci saranno gli accessi ai corridoi. Ce ne dici, Root?»... ...Non ricordavo con esattezza quello che le avevo risposto quella sera, ma, ovviamente, suppongo di essermi dichiarato d'accordo con lei. Tutta quella conversazione, sostenuta poco prima di fare i bagagli per il viaggio in Bolivia, mi era ritornata alla mente nel breve spazio di tempo che impiegammo a percorrere la distanza che ci separava dall'autentica e originale Porta del Sole. Forse il mal di montagna aveva cancellato due giorni interi della mia vita, ma senza dubbio aveva risparmiato l'ultima ora di lavoro a Barcellona. E adesso eravamo lì, di fronte alla Porta, separati solo da una debole recinzione di filo spinato. I miei occhi si fissarono immediatamente sulla figura centrale del dio, che, visto dal vivo, con i suoi rilievi e le ombre prodotte dalla luce del sole, sembrava un mostriciattolo dalle intenzioni malvagie. Era Thunupa, il dio del diluvio, che nascondeva un segreto. I suoi occhi rotondi fissavano il vuoto, le sue braccia a V reggevano i bastoni, dai suoi gomiti e dalla cintura pendevano teste umane. Sul petto si ripeteva l'immagine del serpente che compariva ai suoi piedi nella camera segreta che avremmo tentato di raggiungere, anche se ancora non sapevamo bene come. Ed ecco la piramide di tre piani, con i suoi corridoi interni che terminavano con teste di puma e di condor, con le entrate laterali che sembravano camini coperti da quegli strani elmetti da guerrieri che potevano anche essere animali extraterrestri o navi spaziali dotate di occhi. Jabba, che continuava a spostarsi a destra e a sinistra della Porta, si lasciava andare a esclamazioni di ammirazione alla vista dei suoi amici elefanti-cuvieronius, tanto inconfondibili da gridare allo scandalo per l'indifferenza della scienza ufficiale, una scienza che diceva di reggersi su ciò che era empiricamente dimostrabile. Bene, ecco la prova indiscutibile che almeno la Porta doveva essere stata costruita quando quei mastodonti pullulavano sull'altopiano, cioè, come minimo, undicimila anni prima. Eppure nessuno sembrava farci caso, come alla mappa di Piri Reis. Non potei fare a meno di chiedermene ancora una volta il perché. Doveva esserci una ragione. La paura del ridicolo accademico non poteva essere un motivo tanto forte da impedire la ricerca della verità. È vero, nel Medioevo l'Inquisizione puniva l'eresia con la morte, ma adesso che ragione poteva esserci? «Bene, eccoci qui», commentò Proxi scattando fotografie con la sua minuscola macchina digitale. Avevamo con noi una buona attrezzatura informatica di dimensioni ridotte che ci avrebbe permesso di lavorare in albergo, se ce ne fosse stato bisogno. Avremmo solo dovuto scaricare le immagini in uno dei portatili per ottenere gli ingrandimenti e la stampa di ciò che ci serviva. In realtà, però, per colpa del mal di montagna, non avevamo ancora installato niente, e io cominciavo a provare rimorso per il mucchio di messaggi che mi aveva probabilmente mandato Núria e che aspettavano una risposta. «È incredibile!» esclamai. «Una settimana fa nemmeno ci sognavamo di venire a Taipikala e oggi siamo qui.» «Spero che la fatica sia servita a qualcosa», osservò Jabba, pieno di risentimento, passando vicino a noi nel suo andirivieni davanti ai cuvieronius. «Su! Non perdiamo altro tempo», dissi. «Abbiamo ancora molto da fare.» In realtà di Akapana non rimaneva molto, soltanto un paio di enormi terrazze di pietra che sporgevano da una collina coperta d'erba. Credemmo per fede che quella fosse una piramide di sette piani perché non c'era nessun segno che lo dimostrasse. Nella parte superiore della collina, sulla quale salimmo da dietro, c'era una specie di fossa, presumibilmente il deposito in cui si raccoglieva l'acqua piovana per farla circolare nei canali serpeggianti scoperti di recente e di cui nessuno conosceva in realtà la funzione. Ma, visto che si erano costruiti dei canali, perché con quella forma così strana, se non si dovevano vedere? Proxi fece una risatina da carogna. «Se pensate che sia tutto quanto un disastro», ci avvertì, «aspettate Lakaqullu, che non può essere molto meglio.» «Sarà sicuramente peggio», confermai demoralizzato, ricordando che Lakaqullu era completamente sottoterra. A mano a mano che il sole si alzava nel cielo e il giorno avanzava, la temperatura si faceva più gradevole. Finimmo per sbottonare le giacche e toglierci i pullover, annodandoli in vita perché non ci tenessero caldo. Ci fu un momento in cui mi sentii persino fortunato perché avevo sul capo il cappello di panama, e ciò che apprezzammo infinitamente furono le scarpe comode che ci permettevano di salire colline, camminare su terra e rocce e superare con facilità frammenti di vecchie pietre intagliate che abbondavano dappertutto. Il numero di visitatori aumentava con il calore e si vedevano gruppi sparsi qua e là. Gli alunni rumorosi che ci precedevano scomparvero dalla nostra vista e dalle nostre orecchie, sicuramente per svolgere un'attività scolastica sedentaria e, al posto loro, cominciarono ad assordarci le cicale, con il loro frinire monotono. Il percorso tra le rovine ci portò poi a Puma Punku, a un chilometro di distanza dalla sua presunta gemella, Akapana. Qui, oltre ad appurare che in effetti i motivi ornamentali erano marini e che indubbiamente la pietra, per la sua perfezione, doveva essere stata lavorata con uno strumento, qualunque esso fosse, che gli aymaras avevano utilizzato come trapano meccanico, rimanemmo con poco più di ciò che già avevamo: il caos totale in un mare di massi giganteschi. Svoltando la collina ci imbattemmo, però, in qualcosa di inaspettato: una recinzione metallica che delimitava una zona in cui, senza alcun dubbio, si stava effettuando uno scavo. C'era della gente, nel perimetro, che indossava lo stesso berretto o lo stesso cappello texano o dei panama, maglietta, pantaloni corti e robusti scarponi da cui spuntavano i calzini. Erano in totale una dozzina di persone che salivano e scendevano scale a pioli e trasportavano delle casse da una parte all'altra. A un'estremità della recinzione avevano alzato una grande tenda militare di tela (il quartier generale, probabilmente) con il simbolo dell'UNAR, l'Unità Nazionale di Archeologia Regionale. «Così il sabato non si lavora, eh?» chiesi ironicamente. «Taci e gira sui tacchi», bisbigliò Jabba prendendomi per un braccio. «Ma... che succede?» «Che lei è qui, non la vedi?» sussurrò Proxi dando le spalle all'accampamento e camminando lentamente nella direzione opposta. «È quella con la maglietta rossa.» Prima di voltarmi per seguire i miei amici, ebbi il tempo di intravedere la donna di cui parlava Proxi, ma mi sembrò impossibile che fosse Marta Torrent. «Non è lei», mormorai, mentre ci allontanavamo con un'aria da turisti disorientati. «Quella non è la professoressa.» «L'ho vista in faccia, quindi non fermarti e continua a camminare.» «Non fate gli scemi, per favore!» esclamai dopo aver fatto il giro della collina, fuori dal campo visivo degli scavi. «Quella donna con la maglietta rossa non aveva né la corporatura né il piglio di una cinquantenne elegante e raffinata, d'accordo? Era tutta impolverata e metteva in mostra delle gambe stupende.» «Jabba ti sta dicendo che l'abbiamo vista in faccia. Ma se le uscivano persino i capelli bianchi da sotto il cappello!» «Mi gioco la testa che vi siete sbagliati.» Io ricordavo una donna matura, elegante, che indossava un tailleur classico, calzava scarpe dal tacco a spillo, portava orecchini e collana di perle, un largo bracciale d'argento e degli occhiali stretti, con la montatura azzurra e un cordoncino metallico. Si muoveva con grazia e aveva una voce e un modo di parlare piuttosto sofisticati. Che diavolo aveva a che vedere tutto questo con quella donna molto più giovane, con un cappello texano, scarponi sporchi, maglietta sudicia dalle maniche corte e vecchi pantaloncini militari, che sollevava casse come uno scaricatore di porto? Ma per favore! Neanche fosse il dottor Jekill e mister Hyde. «D'accordo, ci siamo sbagliati, però allontaniamoci, prima che le venga in mente di venire qui.» Ritornammo verso l'Akapana come se fossimo inseguiti dal diavolo. «Forse dovremmo andarcene», mormorò Jabba preoccupato. «Yonson Ricardo verrà a prenderci dalle ore quattordici in poi», ricordò Proxi, ripetendo l'espressione usata dal tassista, che ci aveva lasciato senza fiato, «e mancano ancora più di due ore.» «Però abbiamo il suo numero di cellulare», dissi, imitando anch'io il modo di parlare del boliviano. «No, non ce ne andremo», attaccò lei, decisa. «Cercheremo gli accessi alla camera di Lakaqullu e studieremo il modo di entrarci, esattamente come avevamo pensato, ma staremo molto attenti alla gente che si avvicinerà.» All'incrocio seguente voltammo a sinistra dirigendoci verso Putuni, il Palazzo dei Sepolcri. Secondo la guida lì avevano abitato i sacerdoti di Tiwanacu, in alcune stanze dai muri colorati situate proprio nelle cavità più profonde del terreno. Questa informazione ci stupì abbastanza perché, in base a quel che avevamo letto a Barcellona, la presunta residenza dei Capacas e degli yatiris era stata Kerikala, l'edificio che stavamo per visitare. La verità era che non ci restava molto da esaminare, dato che non potevamo nemmeno più vedere quella presunta porta inespugnabile che aveva disorientato i conquistadores facendogli credere che vi si nascondessero grandi tesori. Kerikala fu la penultima delusione, anche se non dovrei chiamarla così perché, se prendiamo in considerazione il passato, anche i resti dell'Acropoli di Atene sono di poco conto rispetto all'epoca del suo splendore. Comunque, non si poteva negare che conquistadores e oriundi insieme avevano compiuto un bel lavoro di sistematica e tenace distruzione. Forse la vicina Tiahuanaco (soprattutto la sua cattedrale) e la ferrovia Guaqui-La Paz erano motivo di orgoglio nazionale o avevano una funzione sociale realmente importante, ma niente giustificava la devastazione che avevano provocato in un luogo tanto importante e insostituibile come Taipikala. E finalmente arrivammo a Lakaqullu, a nord di Kerikala. Non riuscivamo a credere di essere veramente lì, anche se «lì» si riassumeva in due parole: un ponticello di terra rossiccia con quattro gradoni di pietra che portavano a una porta di andesite verde talmente semplice e priva di ornamenti che sarebbe potuta tranquillamente essere stata prodotta da una qualsiasi moderna fabbrica di laterizi. Attorno a noi la campagna era chiusa da una siepe che aveva la stessa altezza della recinzione di filo spinato che circondava Tiwanacu. Sforzando un poco la vista, oltre il recinto si scorgevano camion e autobus in movimento. «Tutto qui?» chiesi di malumore. Non so che cosa mi aspettassi, forse qualcosa di più appariscente, più bello o, invece, di così brutto da richiamare la mia attenzione. Erano i resti più poveri e miseri che avessimo visto quella mattina a Taipikala e a Lakaqullu. Non c'era niente e, quando dico niente, voglio dire letteralmente niente. Eravamo soli di fronte alla scalinata. Gli altri visitatori non si degnavano nemmeno di avvicinarsi; era lontano dalle rovine e non c'era veramente nulla da vedere. «Senti, Root», mi disse Proxi con un tono di sfida, «hai i piedi per terra?» «Certo. Non vorrai che mi metta a fluttuare!» «Bene! Sotto le tue scarpe c'è il segreto che può restituire il senno a tuo fratello.» Rimasi impietrito. Proxi aveva ragione: sotto i miei piedi, non si sapeva a quale profondità, c'era la camera che gli yatiris avevano sigillato prima di andare in esilio, e lì si nascondeva il segreto del loro strano linguaggio di programmazione. Se mio fratello aveva una speranza di recuperare la sua vita, questa si trovava, come aveva detto la mercenaria, sotto le mie scarpe. Era un luogo sacro, il luogo più importante di Taipikala. Gli yatiris avevano lasciato lì molte cose di valore in attesa di ritornare un giorno o perché fossero di aiuto all'umanità in difficoltà. Nessuno lo sapeva tranne noi e, forse, la dottoressa Torrent, che aveva annunciato con grande risonanza di essere pronta a dimostrare al mondo che Lakaqullu era un sito importante. «Molto bene», cominciai, carico di nuova energia. «Dividiamoci. Si suppone che da queste parti ci siano i segni che indicano l'accesso alle gallerie.» «La Porta è il centro», disse Jabba salendo i gradini e collocandosi di fronte a questa con le braccia aperte e toccando gli stipiti. «Se la piramide di tre piani è quadrata, come abbiamo letto, e i camini sono due, come appare sul piedistallo del dio Thunupa, dobbiamo supporre che questa porta ne segnali la posizione. Quindi tu, Root, vai a destra», e con la mano mi indicò la direzione, «e tu, Proxi, vai a sinistra.» «Senti, bello», protestò lei, appoggiando le mani sui fianchi, «e tu che cosa faresti?» «Vigilare che non arrivi la professoressa. Non volete che ci becchi, no?» «Che faccia tosta!» esclamai ridendo e avviandomi in linea retta dal lato destro della Porta della Luna, verso est. «Lo conosciamo bene!» gridò Proxi allontanandosi nella direzione opposta. Mi addentrai tra le erbacce che mi arrivavano alle ginocchia, con una sgradevole sensazione di apprensione. Il mio habitat naturale era la città, con il suo inquinamento, il suo cemento, il trambusto, e il mio terreno abituale era l'asfalto. Il profondo silenzio e il costante canto delle cicale che colpivano le mie orecchie non mi facevano sentire a mio agio, e tanto meno camminare in campagna calpestando la vegetazione nella quale si avvertiva l'allarmante presenza di animaletti sconosciuti. Non sono mai stato un bambino che collezionava scarabei, bachi da seta o lucertole. Nella mia attuale casa di Barcellona non entrava neanche una mosca, né una formica, né nessun altro tipo di insetto, e questo nonostante avessi il giardino, poiché Sergi faceva molta attenzione a evitarlo. Io ero un cittadino abituato a respirare aria inquinata e aria condizionata, a guidare una buona automobile nelle vie affollate e a comunicare con il mondo attraverso le tecnologie più avanzate, quindi la natura non era salutare per il mio organismo. Datemi un punto di appoggio e solleverò il mondo, aveva detto Archimede; datemi un cavo di fibra ottica e un computer e sfiderò il mondo o lo cambierò rivoltandolo, ma non fatemi camminare in mezzo alla natura come Heidi perché mi sentirò male. Bene, ma ora mi trovavo lì e mi trascinavo tra le erbacce con la schiena piegata come uno schiavo raccoglitore di cotone, scostando con le mani nude i cespugli per riuscire a esaminare il terreno in cerca di qualcosa che assomigliasse a un elmo di guerriero, un animale extraterrestre o una navicella spaziale. Una bella grana! «Stai deviando, Arnau!» mi gridò Jabba. «Vai un po' a destra!» «Potevi venire qui tu, testa di cavolo...» mormorai a denti stretti facendo quello che mi diceva. Avanzavo un passo alla volta, molto lentamente, schivando i sassi sparsi sul terreno e nascosti dall'erba, e tentando di non farmi mordere le dita da formiche enormi. Avevo appena percorso una trentina di metri quando udii un'esclamazione alle mie spalle. Mi voltai e vidi Jabba che scendeva velocemente i gradini e correva verso Proxi. Non ci pensai due volte e mi misi anch'io a correre come un pazzo sperando che non le fosse successo niente e che tutta quell'agitazione fosse stata provocata dalla scoperta di una delle entrate. Quando li raggiunsi, Proxi era china, con un ginocchio a terra, e puliva con la mano quella che sembrava una piccola targa commemorativa, di quelle che hanno un testo roboante inciso nella pietra. Anche Jabba si piegò e io feci lo stesso, ansimando per la fatica della corsa. Al centro della lastra c'era il nostro elmetto da guerriero o navicella spaziale, lo stesso disegno che compariva nella piramide di tre piani ai piedi di Thunupa. Se non avessimo saputo che tutto ciò obbediva a un proposito strategico ideato cinquecento o seicento anni prima, la lastra sarebbe sembrata uno dei tanti frammenti di pietra che rivestivano Taipikala. Ma, nonostante sporgesse appena dal suolo, fosse nascosta dalle erbacce e coperta da terriccio rosso e dalla sterpaglia, era, né più né meno, la serratura che ci avrebbe permesso (o impedito) di calarci fino alla stanza degli yatiris. «Bene, e ora che facciamo?» chiesi, ripulendo anch'io la pietra con il palmo della mano. «Tentiamo di sollevarla?» propose Jabba. «E se ci vede qualcuno?» «Proxi, fai la guardia.» «E perché io?» obiettò lei, risentita. «Perché sollevare pietre», le spiegò Jabba con tono paterno, «è un lavoro da uomini.» Lei si alzò adagio e, pulendosi le mani sui pantaloni, mormorò: «Quanto siete idioti». Jabba e io cominciammo a tirare la lastra verso l'alto, ciascuno da un lato, ma quella, ovviamente, non si sollevò nemmeno di un millimetro. «Idioti?» farfugliai prendendo di nuovo lo slancio e tirando. «Perché idioti?» Nemmeno il secondo tentativo servì a niente, cosicché tutti e due cominciammo a spingerla simultaneamente verso un lato per vedere se riuscivamo a muoverla poiché, forse, non era molto spessa. «Perché una chiave segreta si può scoprire impiegando la forza bruta», rispose Proxi, «come abbiamo fatto con la password del computer di Daniel, ma un codice si può capire solo usando l'intelligenza. E non ho bisogno di ricordarvi che gli yatiris lavoravano con un codice, intelligentoni! Si tratta di un linguaggio, e le lingue non si imparano memorizzando migliaia di parole a caso, pensando che, tra di loro, ci siano quelle dell'idioma che vogliamo apprendere... che è quello che, in fin dei conti, state facendo voi due in questo momento.» Stremato, mi alzai per guardarla. «Che cosa vuoi dire con tutta questa solfa?» «Di smettere di fare gli scemi e di cominciare a usare il cervello.» Giusto. Aveva un senso. Tutta quella storia era un gioco di luci e ombre, per cui prendersela brutalmente con la lastra poteva non servire a niente. «E come la apriamo?» chiesi. Jabba si era seduto per terra a gambe incrociate, come un Buddha panciuto. «Non lo so», mormorò Proxi, aggrottando la fronte e fotografando la targa da varie angolazioni, «però è tutto nella Porta del Sole, quindi sarebbe una buona idea tornare a esaminarla. Ci sono molti particolari cui ancora non abbiamo prestato attenzione.» «Il problema è che sono quasi le due», dissi guardando l'orologio. Rimanemmo tutti e tre in silenzio, pensosi. «E io ho una fame tremenda», annunciò Jabba. «Andiamo», decise Proxi. «Diremo a Yonson Ricardo di portarci a mangiare qui vicino. Torneremo nel pomeriggio.» Mi chinai per ricoprire la lastra con la terra che avevamo rimosso, e Marc sistemò le erbacce a manate. Poi ci dirigemmo verso l'uscita. «Vi rendete conto che si sta avverando tutto quello che abbiamo scoperto a Barcellona?» domandò Proxi con un tono di intima soddisfazione mentre passavamo davanti alla biglietteria. Non le rispondemmo. Aveva ragione ed era una sensazione fantastica. Yonson Ricardo ci stava aspettando con un largo sorriso sulle labbra, appoggiato a una portiera del suo taxi. Naturalmente poteva essere contento perché, senza fare praticamente niente, quel giorno avrebbe guadagnato un mucchio di soldi. Quando gli chiedemmo di accompagnarci a mangiare lì vicino gli si illuminò il viso. Guidando come un pazzo, tanto per cambiare, ci portò fino al paese di Tiahuanaco, a pochi minuti dalle rovine, e lo attraversò in un lampo. Il villaggio era bello, con case basse, ben tenuto e gradevole. Le venditrici aymaras, con le loro voluminose gonne multicolori, i mantelli con le frange e le lunghe trecce nere che sporgevano dalla bombetta, vendevano al minuto per le strade peperoncini secchi, limoni e patate rosse. Come ci spiegò Yonson Ricardo, se le donne aymaras tenevano la bombetta di lato significava che erano nubili, se la portavano ben sistemata sulla testa che erano sposate. «La cattedrale di Tiahuanaco, signori! San Pietro!» ci informò mentre passavamo davanti a una piccola chiesa in stile coloniale con molte biciclette parcheggiate vicino all'inferriata. Ovviamente riuscimmo appena a dare un'occhiata perché, quando finì di gridare, eravamo ormai abbastanza distanti. Mi sarebbe piaciuto visitarla per vedere se le pietre conservavano resti di antichi rilievi tiwanacotas, ma Yonson Ricardo, sollevando un grande polverone, stava già fermando l'auto davanti a una casetta color ocra che, con lettere bianche dipinte sulla facciata, si presentava come «Hotel Tiahuanacu». Sulla parete esterna c'era una grande insegna della birra più famosa della Bolivia, la Taquiña Export. «Il miglior ristorante del luogo!» Incrociammo gli sguardi per dirci discretamente che avevamo seri dubbi al riguardo, scendemmo dall'auto ed entrammo nel locale. Yonson Ricardo sparì nella cucina del ristorante dopo averci presentato a don Gastón Ríos, il proprietario dell'hotel, che, molto gentilmente, ci accompagnò a un tavolo e ci raccomandò la trota alla griglia. Il sole entrava dalle finestre e la sala da pranzo era abbastanza piena di gente che conversava molto animatamente producendo un rumore di fondo che ci obbligava a parlare a voce alta. «Sembra che il nostro tassista riscuota la sua percentuale in cucina per portare qui i turisti», gridò Proxi, con un sorriso. «In questo Paese devono arrangiarsi», dissi. «Sono molto poveri.» «I più poveri di tutto il Sudamerica», assentì lei. «Mentre pativate il mal di montagna, ho letto i giornali e sembra che più del settanta per cento della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà. I governi dittatoriali degli anni Settanta hanno fatto salire il debito estero al di sopra dei quattro milioni di dollari, ma la cosa tremenda è che quel denaro non era destinato al Paese, ma, secondo un tizio19 citato nell'articolo, quasi i tre quarti sono stati depositati in conti personali presso banche nordamericane. Quindi, da allora, i boliviani pagano più tasse, hanno perduto il lavoro, non hanno quasi copertura sanitaria, non ricevono istruzione eccetera, e tutto per restituire il denaro di cui si sono impadroniti quattro ladri. I più poveri di tutti, quelli che vivono nella miseria più nera, sono gli indigeni che non hanno altra soluzione per sopravvivere che quella di coltivare la coca.» «Non riesco a capirlo!» fremette Jabba, adirato. «In Spagna, chiedi un prestito alla banca ed esigono persino il certificato di battesimo di tua madre. Qualsiasi Paese governato da mascalzoni, invece, chiede prestiti multimilionari al Fondo Monetario Internazionale o alla Banca Mondiale senza problemi: ecco i milioni, amico, per farne quello che vuoi. Poi tutti patiscono per restituirli, anche se muoiono di fame. Vi giuro che non lo capisco!» Indignati e arrabbiati, continuammo a parlare dell'argomento escogitando soluzioni che non erano alla portata di tre sventurati individui persi per il mondo, e quindi mangiammo, senza sapere che cosa fosse, una specie di zuppa con delle patate molto strane e un sacco di spezie. Quando ci stavano per cambiare i piatti, mettendoci davanti le trote, la porta della sala da pranzo si aprì ancora una volta per far entrare un numeroso gruppo di gente con magliette, pantaloni corti e rozzi scarponi di cuoio. E sì, la professoressa era in testa alla comitiva assieme a un tizio con la testa rapata a zero, occhiali e una corta barba grigiastra. Stavano conversando animatamente, seguiti da una truppa di giovani archeologi. Facevano più baccano loro che tutto il resto della sala. Don Gastón, con una gentilezza che sprizzava rispetto e deferenza, si diresse verso di loro e li accompagnò verso un grande tavolo sul fondo, che sembrava aspettarli. Mi si gelò il sangue nelle vene. Se ci vedeva, eravamo perduti. Anche i miei amici si erano accorti del suo arrivo, e tutti e tre, pietrificati come statue, seguimmo con lo sguardo la docente. Lei, per fortuna, non ci aveva notato, distratta com'era dalla conversazione con don Gastón e con il calvo. Presero tutti posto attorno alla lunga tavola e continuarono a fare chiasso con grande eccitazione. Sembravano contenti. «Non possiamo restare qui», mormorò Proxi. Non riuscimmo a sentirla. «Che cosa dici?» «Che non possiamo restare qui!» gridò. «Ma non possiamo nemmeno andarcene», la avvertii. «Se ci alziamo, ci vedrà.» «E allora che cosa facciamo?» tentennò Jabba. Ma ormai era tardi. Con la coda dell'occhio intravidi Marta Torrent che posava uno sguardo distratto su tutti i tavoli della sala e, di colpo, lo fermava sul nostro, poi su di me. Mi studiò con attenzione, e la sua espressione da allegra divenne seria e concentrata. «Mi ha visto.» «Cazzo!» esclamò il mio amico. Non valeva la pena continuare a comportarsi come bambini che giocano a nascondino. Dovevo affrontare quello sguardo e mostrare che anch'io la riconoscevo, quindi mi voltai, la osservai con la stessa serietà con cui mi esaminava lei e ressi la sfida con tutta la freddezza del mondo. Nessuno di noi fece il minimo gesto di saluto e nessuno distolse gli occhi. Io conoscevo già il gioco, per cui questa volta non mi colse impreparato. Non sarei stato io quello che si tirava indietro o si scoraggiava. E rimanemmo così per alcuni secondi che, come mai mi era capitato, mi sembrarono davvero eterni. Quando la situazione era ormai insostenibile, il calvo si chinò verso di lei e le disse qualcosa. Continuando a guardarmi fisso, la dottoressa gli rispose e subito dopo si alzò spingendo la sedia indietro e percorse il tavolo in tutta la sua lunghezza. Stava venendo verso di me, e anch'io, come uno specchio, mi alzai, posai il tovagliolo stropicciato accanto al piatto e avanzai verso di lei. Ma non molto. Non per venirle incontro a metà strada. Era lei che doveva avvicinarsi al mio territorio, quindi mi fermai dopo due passi dando le spalle a Jabba e a Proxi. Sono sicuro che lei si rendesse conto della mia intenzione. I miei amici avevano indovinato in pieno quando l'avevano riconosciuta negli scavi di Puma Punku e io mi ero sbagliato, frenato da un'idea preconcetta su come quella donna doveva essere e vestire. Purtroppo con il suo nuovo aspetto sembrava molto più umana e più giovane, e questo mi diede fastidio. Per fortuna potevo ancora contare su quello sguardo di ghiaccio che mi restituiva la sicurezza e la sensazione di essere in grado di riconoscere il nemico. Aveva i capelli bianchi in disordine, con il segno circolare del cappello, e gli abiti da lavoro le toglievano di dosso, di colpo, quasi dieci anni. Quella sorprendente trasformazione non mi sfuggì, soprattutto perché era già di fronte a me, a pochi passi di distanza. Dovevamo offrire un'immagine curiosa perché la sua testa mi arrivava esattamente all'altezza delle spalle, ma, nonostante ciò, non dava l'impressione di essere più bassa di me. Tale era la forza che emanava. «Sapevo che l'avrei vista da queste parti molto presto, signor Queralt», intonò come saluto con la sua bella voce profonda. «E io ero sicuro di incontrarla venendo a Tiwanacu, dottoressa Torrent.» Rimanemmo in silenzio per alcuni istanti, sfidandoci con lo sguardo. «Perché si trova qui?» volle sapere, anche se non sembrava avere nessun dubbio al riguardo. «Per che cosa è venuto?» «So già che per lei è indifferente», risposi con le braccia conserte, «ma per me mio fratello è la persona più importante del mondo e sono disposto a fare qualsiasi cosa pur di aiutarlo.» Mi guardò in modo strano e, inaspettatamente, abbozzò un sorriso. «Allora, o Daniel mi ha rubato più materiale di quello che lei ha portato nel mio studio, o lei e i suoi amici...» disse guardando appena verso il tavolo, dietro di me, «siete molto svegli e avete ottenuto in pochi giorni quello che ad altri è costato anni di duro lavoro.» «Sorvolerò sulla sua ripetuta accusa di furto perché non vale la pena discutere con lei, dottoressa Torrent. Il tempo chiarirà le cose e lei si pentirà in un modo o nell'altro di avere insultato in questa maniera mio fratello, ne sia certa...» dichiarai facendomi da parte e usando un tono esageratamente educato. «Questi sono i miei amici, Lola Riera e Marc Martí. Lei è la dottoressa Torrent, di cui tanto vi ho parlato.» Si alzarono tutti e due e le tesero la mano, che la professoressa strinse senza cambiare l'espressione dura del volto. In realtà nessuno sorrideva. Poi si rivolse a me. «Come lei ha detto, il tempo chiarirà le cose, signor Queralt. Non ne dubiti. Intanto, e dato che non posso sapere quali siano le sue reali intenzioni, mi permetta di ricordarle che qualsiasi scavo realizzato a Tiwanacu senza le necessarie autorizzazioni è un reato molto grave che, in questo Paese, si paga con pene che potrebbero mantenere lei e i suoi amici in carcere per il resto delle vostre vite.» «Molto bene, dottoressa, ma mi permetta di ricordarle, a mia volta, che anche il furto, il plagio o quel che è di materiale di ricerca è punito in Spagna, e che il suo prestigio potrebbe naufragare per sempre, assieme al suo incarico all'università e al suo buon nome.» Lei sorrise con ironia. «Si rammenti di quello che sta dicendo», e si voltò allontanandosi lentamente, con l'andatura elegante che già avevo notato a Barcellona e che non si intonava per niente al suo aspetto attuale. Mi mossi rapidamente per ritornare al mio posto, mentre Marc e Lola continuavano a stare in piedi come quei pupazzi che hanno un peso nella parte inferiore e che, per quanto uno li spinga, ritornano sempre dritti. «Volete sedervi una benedetta volta?» dissi con rabbia. «Non è successo niente, va bene? Quindi, su, mangiamo. Le trote si stanno raffreddando.» «È allucinante», balbettò Proxi, lasciandosi cadere sulla sedia come un sacco. «Tremendo! Avete sentito come ci ha minacciato?» «Se ho sentito?...» fece Jabba turbato. «Ho ancorale budella attorcigliate all'idea di trovarmi, a sessant'anni, in un carcere boliviano.» «Non fateci caso! Non vi avevo detto com'era? Non vi avevo forse avvertito? Così avete potuto verificarlo di persona. È disposta a qualsiasi cosa pur di non farsi rovinare la scoperta! Una scoperta che è di mio fratello!» Marc e Lola mi guardarono in modo tale da farmi capire che la professoressa era riuscita a farli dubitare. «Sei sicuro, Arnau?» mi chiese Proxi. «Non offenderti, per favore, ma... Sei proprio sicuro?» Feci schioccare la lingua e sospirai. «Tu conosci Daniel, Lola. Non posso offrirti niente di più.» Lei abbassò il capo, mortificata. «Hai ragione, scusami. È che quella donna parla con una tale convinzione che è capace di far dubitare persino lo Spirito Santo!» «Per quanto mi sforzi», aggiunse Jabba di malumore, «non posso immaginare Daniel che ruba. Ma devo riconoscere che quell'imbecille mi ha fatto dubitare di lui.» «Allora, ritorniamo a Tiwanacu o no?» chiese Proxi. «Certo che ci ritorniamo. Anche se oggi non ci siamo riusciti, almeno continueremo a studiare il modo di entrare.» Terminammo di mangiare avvolti in un silenzio cupo e, dopo aver pagato il conto, ce ne andammo da lì senza rivolgere nemmeno uno sguardo alla professoressa. Yonson Ricardo ci condusse alle rovine e promise di ritornare alle sei per riportarci a La Paz. Ma non avevamo lo stesso buon umore del mattino. Camminavamo a testa bassa e seri, notando come il freddo si stesse facendo più intenso a mano a mano che avanzava il pomeriggio. Come malconci sopravvissuti a un naufragio ritornammo alla Porta del Sole e, alla luce del giorno che stava declinando, ci dedicammo a esaminare i molti particolari che quella meravigliosa opera d'arte conteneva nei suoi disegni, soprattutto nella figura del dio Thunupa. Qualsiasi dettaglio sembrava essere pieno di significato, ma il problema reale era che, almeno io, avevo la mente altrove e facevo fatica a concentrarmi su ciò che stavamo cercando. La mia testa divagava, rapita dallo sguardo malizioso del dio, da quegli occhi rotondi che sembravano sondare la mia interiorità facendo risuonare echi familiari di un passato lontano e sconosciuto. Sapevo che lì c'era una verità, ma mi mancavano gli strumenti necessari per interpretarla. Mi sentivo indifeso nella mia ignoranza; volevo capire perché persone normali e comuni - come Marc, Lola e io - avessero adorato migliaia di anni prima quell'essere senza gambe; perché quello che adesso era soltanto un richiamo per i turisti era stato un dio potente - forse temuto, forse amato -, con i suoi bastoni rovesciati che nessuno sapeva interpretare; e perché la scienza temesse tanto per la propria immagine di infallibilità e avesse tanta paura di accettare verità che superavano i limiti della sua comprensione o di porsi domande che potessero condurre a risposte imbarazzanti. Stanco di stare in piedi e di respirare un'aria tanto povera di ossigeno, mi lasciai cadere sulla nuda terra e incrociai le gambe come un indiano davanti alla recinzione di filo spinato, senza preoccuparmi dell'assalto delle formiche giganti. Ero stufo di non capire e non mi importava che la professoressa, o chiunque altro, passasse di lì e mi vedesse seduto per terra come un visitatore incivile. Proxi e Jabba si erano allontanati per osservare minuziosamente da una certa distanza la figura; io, invece, me ne stavo fermo quasi sotto la Porta e pensavo di non muovermi più. Amareggiato per essere venuto fin lì e aver fallito, sollevai lo sguardo verso il dio come sperando che potesse riparare al torto. E lo fece. Fu uno sprazzo di intelligenza, un'illuminazione. Il posto in cui ero seduto mi poneva quasi ai piedi di Thunupa e, guardando verso l'alto, la prospettiva della porta cambiò di colpo offrendomi una nuova immagine del dio che inaspettatamente chiariva tutto. Come aveva fatto a non venirci in mente prima? Dovevamo supplicare! «Bisogna supplicare!» gridai come un pazzo. «Venite, venite! Ecco la chiave: bisogna supplicare l'aiuto del dio!» Proxi e Jabba, che si stavano avvicinando di corsa, capirono quello che volevo dire e si lasciarono cadere in ginocchio accanto a me guardando verso l'alto, alzando gli occhi verso Thunupa, il dio del diluvio al quale bisognava chiedere aiuto se una simile catastrofe si fosse verificata ancora. «Lo vedete?» urlai. «Lo vedete? Guardate i bastoni!» Dalla nostra posizione, i becchi dei condor con cui terminavano i bastoni erano conficcati in cavità rotonde e profonde che, come occhi identici a quelli del dio, avevano gli elmetti o navicelle spaziali o animali extraterrestri che coprivano i camini. Ciò che vedevamo con molta chiarezza era il dio che impugnava quei bastoni e li incastrava con forza nelle cavità rotonde. «Ecco che cos'era, ecco che cos'era...» salmodiava Proxi, rapita. «Ed era così semplice!» «Ma dovevamo supplicare!» esclamai pieno di entusiasmo. «Soltanto inginocchiandosi davanti al dio si poteva scoprire il messaggio.» «E ha tutto il senso del mondo», convenne Jabba. «Come hai detto tu, Proxi, gli yatiris, andandosene, nascosero l'entrata della camera solo fino a quando ciò che conteneva non fosse risultato necessario. E la necessità porta alla supplica. Osserva, per di più, la posizione delle figure delle bande laterali: sembra che implorino in ginocchio. Dovevamo averlo notato prima.» «Hai ragione», ammisi, esaminando i falsi cherubini alati. «Loro suggerivano che cosa bisognava fare. Come abbiamo fatto a non vederlo?» «Perché non ci abbiamo fatto caso. Gli yatiris hanno lasciato tutto in vista.» «No, no... Qualcosa non funziona. Quella porta è molto più antica», obiettò Proxi pensierosa, «migliaia di anni più antica dell'arrivo degli incas e degli spagnoli.» «È molto probabile che tutto ciò fosse stato pianificato fin dal diluvio», dissi io, alzandomi e scuotendomi i pantaloni, «e che i Capacas e gli yatiris del XVI secolo avessero portato a termine un piano predisposto migliaia di anni prima. Non dimenticate che possedevano segreti e conoscenze che si tramandavano di generazione in generazione, e questo poteva benissimo essere uno di essi. Erano degli esseri speciali che sapevano ciò che era accaduto diecimila anni prima e anche quello che dovevano fare nel caso di una catastrofe o di un'invasione.» «Stiamo facendo delle congetture!» protestò Jabba. «In realtà, non sappiamo nemmeno se riusciremo ad aprire gli accessi, quindi per quale ragione ci facciamo tante domande su ciò che non potremo mai sapere?» «Jabba ha ragione», mormorò Proxi alzandosi. «La prima cosa è verificare se possiamo conficcare un bastone con il becco di condor nell'occhio della figura della targa.» «Come se fosse facile!» mi sorpresi. «Dove diavolo...» E improvvisamente ricordai. «I bastoni che vendono gli yatiris al Mercato degli Stregoni di La Paz!» «Incrocia le dita perché domani, domenica, ci sia quel benedetto mercato», borbottò Jabba. «Allora andiamo via», proposi. «Oggi, comunque, siamo venuti soltanto per esaminare il terreno. Non siamo pronti per entrare.» «Domani avremo molto da fare», confermò Proxi avviandosi all'uscita attraverso la spianata di Kalasasaya, «quindi chiama Yonson Ricardo al cellulare perché venga a prenderci.» La domenica mattina ci alzammo tardi e facemmo colazione con calma prima di andare al mercato che, per fortuna, come ci avevano detto in albergo, «si svolgeva» tutti i giorni. Ci dirigemmo, passeggiando e godendoci il sole, verso la calle Linares, vicino alla chiesa di San Francesco, pronti a incontrarci con gli yatiris del XXI secolo, ignari, così sembrava, della loro autentica origine e dei loro antenati. Il mercato era così affollato di gente che non potevamo fare nient'altro che lasciarci portare dalla marea, una marea che, per la nostra disperazione, avanzava con la lentezza di un ghiacciaio. Avrebbero dovuto vedere, quei boliviani, che cos'era un pomeriggio di sabato nelle Ramblas e nel passeig de Gràcia di Barcellona! «Vuole che le legga il destino nelle foglie di coca, signore?» mi chiese dalla sua bancarella una yatiri dal volto tondo e dalle guance che sembravano due mele. Continuavo a sorprendermi della normalità e dell'allegria con cui circolava la coca da quelle parti. Dovetti ricordare a me stesso che lì era un prodotto consumato da migliaia di anni per non sentire la fame, la stanchezza e il freddo. «No, molte grazie», le risposi. «Avrebbe, invece, dei bastoni di Viraco- cha?» La donna mi guardò in modo indecifrabile. «Quelle sono stupidaggini, signore», rispose; la corrente umana mi allontanava. «Souvenir per turisti, e io sono un'autentica kallawaya... una yatiri», mi chiarì, pensando che la mia faccia sorpresa derivasse dall'ignoranza, mentre era tutto il contrario: ricordavo molto bene come la cronaca degli yatiris di Taipikala narrasse che i Capacas - che erano andati a Cuzco e avevano conservato il ruolo di medici della nobiltà Orejona - erano stati poi conosciuti come kallawayas. «Posso offrirle qualsiasi medicina di cui abbia bisogno», aggiunse. «Ho erbe per sanare tutti i mali, persino quelli d'amore. Amuleti contro gli spiriti maligni e offerte per la Pachamama.» «No, grazie», ripetei, «cerco solo bastoni di Viracocha.» «Allora vada nella calle Sagàrnaga», mi disse gentilmente. «Li troverà.» «E dov'è?» le chiesi voltandomi a guardarla, ma ormai non mi sentiva, concentrata com'era su altri probabili clienti che passavano davanti alla sua bancarella. I banchi erano pieni di prodotti variopinti, ma su tutti abbondavano i feti di lama, che avevano un aspetto abbastanza ripugnante alla luce del sole. Sembravano polli mummificati, sebbene avessero quattro zampe e la pelle nera per essere stata seccata o affumicata. Li esibivano come trofei, a grappoli, e i banchi più grandi e ricchi ne esponevano ancora di più, accanto a sacchetti di cellophane che sembravano contenere caramelle (ma che non lo erano) avvolte in brillanti carte colorate, oppure vicino a bottiglie che imitavano quelle di champagne (con il tappo rivestito di alluminio giallo o rosso) e che risultavano essere di vino frizzante mescolato a strane erbe, o ancora appesi a ganci su una quantità enorme di bustine che davano l'impressione di contenere semi di fiori, ma nascondevano invece intrugli per fare fatture o per toglierle. Insomma, bisognava vedere per credere. Davanti a ogni bancarella c'erano yatiri-kallawaya, contenti delle proprie conoscenze e del proprio ruolo e convinti del potere sacro dei propri prodotti. Proxi continuava a scattare fotografie a destra e a manca: ora era un bambino aymara che vendeva palloncini pieni d'acqua, ora una vecchia che offriva tessuti multicolori con disegni molto simili, anche se non uguali, ai tocapus per mezzo dei quali anticamente i suoi antenati comunicavano per iscritto. Jabba, invece, pronto a correre tutti i rischi, si metteva in bocca qualsiasi cosa gli offrissero da assaggiare, senza badare all'igiene né ai possibili effetti secondari. Non poteva ammalarsi perché aveva uno stomaco a prova di bomba, ma io no, e soltanto a vederlo succhiare ossicini di origine sconosciuta e ingoiare impasti dai colori incerti mi sentivo male. Per fortuna, appena girato l'angolo, cominciammo a vedere bancarelle con articoli diversi, come pulcini di lana, pupazzi dalle gambe corte, collane, profumi da pochi soldi, statuette femminili molto strane... «Hai visto?» mi chiese Jabba indicando le dieci o quindici statuette che rappresentavano una donna incinta con grandi orecchie e testa conica. «Oryana!» «Vogliono una Madre Orejona?» ci chiese immediatamente il venditore quando si accorse del nostro interesse. «Madre Orejona?» ripetei. «La dea protettrice del focolare domestico, signore», spiegò lo yatiri sollevando una immagine. «Protegge la casa, la famiglia e, soprattutto, le donne incinte e le madri.» «È incredibile», farfugliò Jabba a bassa voce. «Continuano ad adorare Oryana dopo migliaia di anni!» «Sì, ma non sanno chi sia in realtà», ribattei facendo un cenno al venditore per dirgli di mostrarmi i pupazzi con le gambe corte; uno di quei mostriciattoli poteva essere il regalo perfetto per Dani. «Il signore vuole un Ekeko, il dio della buona sorte?» Jabba e io ci guardammo significativamente mentre il venditore mi porgeva un pupazzo di plastica che raffigurava un omino di razza bianca, con i baffi e le gambe corte come quelle del Viracocha di Tiwanacu. E non c'era da stupirsi, dato che, come sapevamo, il Dio dei Bastoni altro non era che Thunupa, il dio delle pioggia e del diluvio, divenuto attraverso i secoli Ekeko. Il pupazzo portava il tipico copricapo andino di lana, a forma di cono e con i copriorecchie, e aveva tra le mani una spaventosa chitarra spagnola. «Non vorrai comprarlo, vero?» si allarmò Jabba. «Ho bisogno di un regalo per mio nipote», gli spiegai molto serio dando al venditore i venticinque boliviani che mi chiedeva. «Quello di cui hai bisogno è uno psichiatra. Il povero bambino avrà gli incubi per anni.» Incubi? Non che Ekeko avesse un aspetto gradevole, in verità, ma ero sicuro che Dani lo avrebbe apprezzato e si sarebbe divertito a distruggerlo. «Qui, qui!» ci chiamò a un tratto Proxi indicando una bancarella in cui c'erano un mucchio di bastoni di Viracocha. Sul tavolo di legno erano esposti decine di bastoni che terminavano con teste di condor e, con grande gioia dello yatiri, ne comprammo cinque, cioè tutti quelli che misuravano tra ottanta centimetri e un metro, poiché queste erano, a occhio, le dimensioni del Thunupa della Porta e dei suoi bastoni originali. Mangiammo in un ristorante della zona e continuammo a fare i turisti per il resto del pomeriggio, fino all'ora di ritornare in albergo. Avevamo parecchio da fare, quindi chiedemmo che ci portassero la cena nella camera di Proxi e Jabba, che era più grande, e ci concentrammo sugli aspetti pratici del lavoro che ci attendeva il giorno seguente. Prima, però, mi collegai a Internet per scaricare la posta. Avevo ventotto messaggi, per la maggior parte di Núria; li lessi tutti e concentrai le differenti risposte in una mail molto lunga. Proxi, intanto, aveva collegato la fotocamera digitale all'altro portatile e stava scaricando le fotografie scattate a Tiwanacu. Fece un ingrandimento a grandezza naturale della lastra di Lakaqullu e lo stampò in più parti sulla piccola stampante da viaggio. Se, con un po' di fortuna, fossimo riusciti a introdurre il bastone nella fessura dell'elmetto da guerriero, quello che sarebbe successo in seguito era un mistero totale, ma, anche così, c'erano alcuni particolari che avevamo ben chiari: avremmo circolato per corridoi che non venivano percorsi da cinquecento anni, non avremmo avuto illuminazione, forse saremmo incappati in bestiacce o in trappole, e, cosa più importante di tutte, avremmo avuto bisogno di portare il «JoviLoom» perché non ci sarebbe servito a niente arrivare nella camera del Viaggiatore, se non fossimo stati capaci di leggere le lastre d'oro. Il traduttore era indispensabile e quindi tutte le batterie del computer portatile (quella originale e quelle di scorta) dovevano essere cariche e a disposizione. Preparammo una lista delle cose da acquistare il giorno dopo, prima di partire per Tiwanacu, tenendo presente che il materiale doveva occupare il minor spazio possibile per non destare la curiosità delle guardie, che avevamo visto perquisire occasionalmente cartelle e zaini. Come dicevano le guide, alcuni turisti poco scrupolosi tentavano di portarsi via delle pietre come ricordo. Scartammo subito l'idea di entrare di sera, fuori dell'orario di visita, come avevamo pensato di fare in un primo momento, perché, dopo essere stati sul posto, tutti e tre convenimmo che sarebbe stato un suicidio vagare al buio in quel terreno pietroso con il rischio di ferirci o di spaccarci la testa. Lo avremmo fatto quindi di pomeriggio, con la luce, approfittando dell'isolamento di Lakaqullu e della scarsa sicurezza della recinzione. Il mattino seguente percorremmo da un capo all'altro il centro di La Paz e i lussuosi quartieri residenziali di Sopocachi e di Obrajes, nella parte bassa della città, dove c'erano centri commerciali, banche, gallerie d'arte, cinema... Lì, in negozi diversi, acquistammo tre lampade frontali a led della Petzl, tre Mini-Maglite (sottili come una biro e non più lunghe del palmo di una mano), un paio di rotoli di corda per speleologia, guanti antiabrasione, dei piccoli binocoli Bushnell, una bussola Silva modello Eclipse99 e alcuni coltelli multiuso Wenger. Potrebbe sembrare un controsenso l'aver trovato con facilità queste marche così costose in un Paese tanto povero e indebitato, ma, a parte il fatto che la Bolivia era una meta comune per gli alpinisti, data la sua vicinanza con gli Stati Uniti disponeva dei migliori e più moderni prodotti persino molto prima che arrivassero in Spagna, e questo lo appurammo con i nostri stessi occhi nei negozi di informatica di Sopocachi. Una cosa differente era che la maggioranza della popolazione potesse permetterseli - e ovviamente non poteva -, però c'erano, a disposizione dei ricchi del Paese e dei turisti danarosi. A mezzogiorno ritornammo in albergo e chiamammo Yonson Ricardo per chiedergli se, quel pomeriggio, poteva riportarci a Tiwanacu. «No, non posso», ci disse senza alcuna esitazione, «perché oggi è giorno di riposo per la mia società di taxi e potrei avere dei problemi con il sindacato, ma vi lascerò in buone mani, in quelle di mio figlio Freddy, che vi porterà con la sua auto personale. Voi gli pagherete la stessa somma che avete dato a me l'altro giorno. Vi sta bene?» Molto giusto non ci sembrava, perché il padre l'avevamo pagato per un giorno intero di lavoro ed era già trascorsa quasi la metà di quel lunedì, e poi Freddy non era un tassista, ma non valeva la pena complicarsi la vita per quelle minuzie né discutere per una quantità di boliviani che in euro risultava ridicola, quindi accettammo. Freddy era un guidatore ancora più temerario del padre, ma eravamo talmente preoccupati per quello ci attendeva che non ci importava schiantarci contro un qualsiasi vecchio catorcio carico di animali o essere sbalzati fuori dalla strada principale e ribaltati giù per l'altopiano. Per fortuna non accadde niente di tutto questo e atterrammo vivi a Taipikala, con i nostri bastoni di Viracocha in mano a mo' di souvenir, come turisti che arrivassero direttamente dal Mercato degli Stregoni. Nessuno ci fermò né ci perquisì le borse. Pagammo i biglietti ed entrammo tranquillamente, decisi in primo luogo a dare un'occhiata agli scavi di Puma Punku per verificare se la professoressa si trovava nei paraggi. E c'era: la vidi chiaramente attraverso il binocolo, seduta a un tavolo, intenta a scrivere su un grosso qua- derno. Quindi ci incamminammo verso Lakaqullu facendo un lungo giro attorno al Tempietto semisotterraneo per non essere scoperti. Quando ci lasciammo alle spalle il palazzo di Putuni, rimanemmo soli nella vasta distesa che ci separava dal nostro obiettivo. Non c'era anima viva e il vento freddo si era fatto più forte, non trovando edifici a ostacolarlo, e sferzava l'erba senza pietà da una parte all'altra. Camminavamo in silenzio, agitati per ciò che avremmo fatto. Jabba e Proxi si presero per mano; io mi chiusi ancora di più in me stesso facendomi piccolo, come sempre quando avevo paura. In Spagna non mi aveva mai spaventato trasgredire una regola, né lasciare il mio tag nei posti più sorvegliati e proibiti, né infiltrarmi con il mio computer in sistemi ufficiali per ottenere quello che mi ero proposto, ma mai in vita mia mi era venuto in mente di entrare con la forza in un monumento archeologico con il rischio di danneggiarlo e, per di più, in un Paese straniero, come in questo caso. Non avevo idea di che cosa potesse succedere, sentivo di non controllare la situazione, e questo mi innervosiva e mi spaventava, anche se non lo davo a vedere per niente, perché il mio passo continuava a essere fermo e i miei gestì decisi. Con sarcasmo pensai che in quello la dottoressa e io ci assomigliavamo abbastanza: tutti e due sapevamo nascondere i nostri veri pensieri. Trovammo la seconda targa con l'elmetto alla stessa distanza dalla Porta della Luna della prima, ma in direzione est. Pensammo che sarebbe stata una buona idea esaminarla con attenzione prima di cominciare a introdurre bastoni, nel caso ci fosse stato bisogno di inserirli in tutte e due contemporaneamente. Era esattamente uguale all'altra, anche se molto più rovinata, e, già che c'eravamo, decidemmo di cominciare da questa per risparmiare tempo. Jabba strinse con forza il bastone più corto, quello di ottanta centimetri, e lo infilò adagio nell'occhio dell'animale extraterrestre. La lastra, assieme al metro quadrato di erbacce che aveva attorno, cominciò ad affondare pian piano, senza rumore, con Jabba e uno dei miei piedi sopra. Impauriti, balzammo indietro per uscire dal piccolo ascensore che si perdeva nelle profondità della terra, mentre Proxi dava libero sfogo alla gioia e si chinava a guardare. «L'entrata!» gridò sovrapponendo la sua voce al lontano rumore di pietre che veniva dal fondo. A me il cuore batteva a mille all'ora e, per la scarsa quantità di ossigeno di cui potevo disporre, avvertii un senso di nausea e dovetti sedermi immediatamente. Ma non ero l'unico: nello stesso momento Marc, bianco come uno straccio, si lasciò cadere a terra. «Che cosa vi succede?» chiese sorpresa Proxi, spostando lo sguardo dall'uno all'altro. Siccome si era chinata per vedere, le nostre teste erano ora allo stesso livello. «Che porcheria di aria hanno in questo Paese!» sbottò Jabba, boccheggiando come una triglia sulla coperta di un peschereccio. «Ecco», sbuffai, «dai la colpa all'aria.» Ci guardammo e scoppiammo a ridere. Eravamo tutti e due lì, come anatre con le vertigini, mentre Proxi sprizzava entusiasmo. «Non valiamo niente», mi disse Jabba, recuperando a poco a poco il colore in volto. «Sono d'accordo con te.» Dal fondo di quella buca si alzava una puzza di tomba sconfortante, un'esalazione di umidità melmosa che rivoltava lo stomaco. Mi chinai assieme a Proxi per guardare e vidi dei gradini di pietra pericolosamente inclinati che si perdevano nell'oscurità più profonda. Presi la torcia elettrica dalla mia borsa e la accesi: gli scalini scendevano tanto che non si riusciva a scorgerne la fine. «Dobbiamo scendere lì?» farfugliò Jabba. Non replicai perché la risposta era scontata. Senza pensarci due volte mi alzai, fissai attorno al capo la lampada frontale, la accesi e, come un minatore, cominciai a scendere con molta attenzione per quella stretta e disagevole scalinata che sembrava portare al centro della Terra. E non ci stava nemmeno un piede completo in ogni gradino, per cui dovevo girarlo un po' di lato per non perdere l'equilibrio a ogni passo. A mano a mano che scendevo, il muro che avevo di fronte mi faceva da soffitto alzandosi e riducendo il suo angolo rispetto alla superficie, e presto non avrei avuto nessun punto di appoggio. Mi fermai per alcuni secondi, indeciso. «Che cosa sta succedendo?» chiese Proxi da una considerevole altezza. «Niente», risposi, e continuai a scendere soffocando le grida disperate del mio istinto di sopravvivenza. Sentivo pulsare le tempie e avevo la fronte gelata. Per proseguire, mi obbligai a pensare a mio fratello, là a Barcellona, nel suo letto d'ospedale, con il cervello fuso. «Non ho più punti di appoggio», avvertii. «Il pozzo si è allargato troppo.» «Illumina bene attorno a te.» Ma, per quanto girassi la testa da un lato all'altro, attorno a me non c'era niente se non uno spazio vuoto, delimitato, al di là delle mie braccia, da pareti di pietra perfettamente incastrate, come quelle che si vedevano per tutta Tiwanacu. Per fortuna gli scalini cominciarono ad allargarsi e allungarsi. «Tutto bene, Root?» Il vocione di Jabba arrivò fino a me rimbombando tra le pareti. «Tutto bene!» esclamai con forza, ma era una di quelle frasi che si dicono tanto per dire, quando non si vedono chiaramente le cose. La discesa si prolungò per più tempo di quello che avrei voluto. Una qualsiasi delle gallerie verticali del sottosuolo di Barcellona era un'autostrada a otto corsie in confronto a questa. Avevo i palmi delle mani sudati e sentivo la mancanza della mia attrezzatura da speleologo: al minimo slittamento, con quel muschio nero e scivoloso che copriva tutto, le mie ossa si sarebbero fracassate contro le pietre del fondo e, anche se fossi rimasto vivo, per Jabba e Proxi sarebbe stato molto duro tirarmi fuori da lì. Per questo scendevo lentamente, prendendo tutte le precauzioni possibili, puntellando molto bene un piede prima di poggiare l'altro e con tutti i sensi all'erta per evitare qualsiasi barcollamento. Il primo segnale che ero arrivato fu un lieve cambiamento nell'aria: di colpo si fece meno stagnante, più leggera e secca, e capii che mi avvicinavo a un grande spazio. Un minuto dopo la mia lampada frontale illuminò la fine della galleria e l'inizio di un corridoio abbastanza ampio da contenerci comodamente tutti e tre. «Vedo la fine», annunciai. «C'è un corridoio.» «Finalmente è finita questa maledetta scala!» sentii tuonare Jabba. In quel momento stavo superando l'ultimo gradino e illuminavo il tunnel che avevo di fronte. Non c'era altro da fare che seguirlo e andare avanti. Proxi mi raggiunse e il rumore dei passi di Jabba annunciò la sua imminente comparsa accanto a noi. «Avanti?» indagai, anche se in realtà non si trattava di una domanda. «Avanti», rispose lei, coraggiosa. Avanzammo nel tunnel nello stesso ordine in cui eravamo discesi. Era lunghissimo, quasi come il camino, ma in senso orizzontale e perfettamente cubico. Il pavimento, il soffitto e i muri erano costruiti anch'essi con grandi blocchi incastrati gli uni negli altri. Non so che cosa sperassi di trovare al termine di quel lungo corridoio che non finiva mai, ma di certo non era quello che scoprii. Mi si gelò il sangue nelle vene per la paura. Notai che Proxi mi era venuta vicino, in silenzio, e mi aveva preso per un braccio mentre le nostre due lampade frontali mettevano a fuoco una gigantesca testa di condor che ci guardava con occhi ciechi dal fondo del corridoio. «Caspita!» mormorò lei, riprendendosi dal soprassalto. «È impressionante!» Sentii un fischio acuto e vidi una terza luce sul mostro. Era Jabba. Anche lui stava osservando l'enorme testa che chiudeva il corridoio a circa tre metri di distanza da noi. «E adesso che facciamo?» chiese inquieto. «Non ne ho idea», farfugliai. Nella parte alta del tunnel, la pietra si curvava disegnando la fronte dell'animale e scendeva fino ai grandi occhi rotondi, un paio di circoli perfetti collocati su un becco enorme che cadeva in verticale e si assottigliava quasi fino a sfiorare il suolo. Da entrambi i lati si poteva vedere una piccola porzione della parte inferiore del becco. Proxi scattò varie fotografie con la macchina digitale che, a causa dell'oscurità, regolò automaticamente l'intensità del flash al massimo, emettendo lampi abbaglianti. «Ma da qui non si può passare», ripeteva Jabba. «Lo vedremo», affermò Proxi risoluta, mettendo al riparo la fotocamera e avanzando verso la colossale scultura che sembrava sul punto di mangiarsela in una sola beccata. «Aspetta! Non fare pazzie!» esclamò Jabba. Io mi voltai a guardarli, e in quel momento di confusione i raggi luminosi delle lampade danzarono sul condor e sulle pareti. In un batter d'occhio mi parve di scorgere qualcosa vicino alla testa dell'uccello; allora, ignorando i miei compagni, feci una panoramica della zona con la mia luce e notai, a destra, uno strano pannello con delle incisioni. «Oh!» proruppe Proxi quando lo vide. «Spero che non si tratti di una maledizione aymara», aggiunse Jabba. «Ricorda che non ci può colpire», sussurrai. «Speriamo.» Ci avvicinammo con tutte le precauzioni del caso, non si poteva mai sapere, e ci fermammo davanti ai cinque tocapus intagliati nella roccia e incorniciati in una piccola modanatura. Alle nostre spalle il gigantesco profilo destro del becco del condor appariva decisamente minaccioso. «Su! Tira fuori il portatile», mi suggerì Proxi, di nuovo con la macchina fotografica tra le mani, pronta a scattare altre foto. «Bisogna tradurre con il 'JoviLoom'.» «Speriamo di non andare incontro a qualche guaio», si innervosì il verme codardo. Mi sedetti per terra e appoggiai la schiena contro la scultura, dopo averla osservata con apprensione, poi tolsi il computer dalla custodia e lo accesi. Incrociai le gambe e, quando il sistema fu pronto, attivai il traduttore di mio fratello. Le due finestre si aprirono e, trascinandole con il piccolo mouse del portatile, trasportai dall'una all'altra i cinque tocapus che comparivano sul muro. Il primo conteneva un rombo, il secondo una specie di meridiana con una riga orizzontale al centro; il terzo qualcosa di simile a una tilde allungata e più sinuosa; il quarto un asterisco formato da tre lineette incrociate, e il quinto due linee orizzontali parallele, molto brevi, simili a un segno di uguale. Confermai che avevo terminato di «tessere» e il programma cominciò le sue suddivisioni e i suoi allineamenti. Non tardò molto a dare lo strano risultato: «Sei diviso due, radice di tre.» «'Sei diviso due, radice di tre'?» esclamai, sorpreso. «Una divisione?» Jabba non poteva credere alle sue orecchie. Aveva gli occhi sgranati. «Una divisione! E che diavolo dovremmo farne di una ridicola e assurda divisione? Che aiuto ci dà sapere che sei diviso due è uguale a tre?» «Non è esattamente questo ciò che dice», obiettai. «Ma è quello che vuol dire!» «Non lo sappiamo.» «Mi stai dicendo che...» «Qui c'è dell'altro!» gridò Proxi dall'altro lato del condor. Rimisi il portatile nella custodia e mi alzai con un balzo correndo verso Jabba, che era già scattato in avanti. Sul lato sinistro della bestia, intagliati nel muro, comparivano altri cinque tocapus quasi identici a quelli di prima, anch'essi incorniciati nella stessa piccola modanatura. «Che storia!» esclamai avvicinandomi a quest'altro pannello. Il primo, il quarto e il quinto dei tocapus erano uguali, il secondo e il terzo, invece, erano differenti. Quando gli sguardi interrogativi dei miei compagni confluirono su di me, capii che dovevo sedermi di nuovo e introdurre i tocapus nel telaio di Jovi. La traduzione risultò, di nuovo, un pasticcio totale: «Sei moltiplicato cinque, radice di tre». «E che cosa me ne importa se gli yatiris decoravano le loro pareti con formule matematiche?» disse Jabba. «La questione è che questo uccellino», e propinò una sonora manata al mostruoso becco, «chiude il corridoio. È finita. Punto. Torniamo in superficie.» «Forse si tratta di risolvere un problema», ragionai. «Esattamente. E se siamo tanto bravi da risolverlo, la testa del condor si aprirà come una porta e potremo passare dall'altra parte. Bella maniera di aiutare l'umanità in difficoltà! Bella banda di...» «Ascoltatemi, tutti e due», ci interruppe Proxi, mettendo fine alla discussione. «Abbiamo due dati chiari e semplici: da un lato 'Sei diviso due, radice di tre' e, dall'altro, 'Sei moltiplicato cinque, radice di tre'. Lo stesso numero, cioè il sei, si divide in due e moltiplica di cinque dando come risultato in entrambi i casi un tre. Ovviamente, qui gatta ci cova.» «Sì», ammisi. «Ma cosa cova?» «La differenza. Dev'essere la differenza», notò lei. «I tocapus discordanti sono quelli che ci danno le informazioni.» «Allora, forza!» la incoraggiai. «Forse bisogna pigiarli o qualcosa del genere. Provaci, vediamo che succede.» Lei si avvicinò con decisione al pannello di fronte al quale ci trovavamo e premette il secondo e il terzo tocapu. Non accadde nulla. «In realtà non affondano sotto la pressione. Rimangono fissi.» «Proviamo con il pannello di destra», proposi. Lo raggiungemmo e Proxi ripeté l'operazione. Ma nemmeno questa volta successe niente. «Come per l'altro», mormorò. «Non si possono premere.» Ci riprovò e poi, senza voltarsi, scosse la testa. «Torniamo all'altro pannello e premiamo i tocapus che ci mancano», mormorai. Ancora una volta ci scontrammo con il fallimento più assoluto. Nessuno dei dieci tocapus rispondeva alla pressione della mano. Non erano pezzi staccati. Erano scolpiti direttamente nel muro. «Non capisco...» si lamentò la mercenaria. «E adesso che facciamo?» «Forse dobbiamo scoprire ancora qualcosa», dissi. «Forse questi due pannelli sono solo un modello, una copia che ci indica come trovare la soluzione.» «Certo, e poi la gridiamo al vento», intervenne Jabba. «È assurdo!» «No, non lo è. Lasciami pensare», replicai. «Deve avere un senso!» «Ma che senso vuoi che abbia?» continuò a protestare lui. «Si suppone che gli yatiris abbiano nascosto il loro segreto perché un'umanità distrutta e bisognosa potesse svelarlo? Bene. Questa sembra una corsa a ostacoli! E inoltre chi ci dice che si tratti di un modello? Non possiamo saperlo.» «Sei fuori strada, Jabba», gli spiegai. «Quello che c'è lì dentro non è cibo. Gli yatiris non erano la Croce Rossa. Non ci sono medicine né coperte. Ciò che hanno nascosto prima di andarsene è la conoscenza, un insegna- mento... Se, come si suppone, si tratta del potere delle parole, di un codice orale di programmazione, ha senso che ci siano delle chiavi cifrate di accesso. Forse non si tratta di un modello, è vero. Forse ci stanno insegnando qualcosa. Credo che, se risolveremo questo enigma, apprenderemo qualcosa che ci sarà utile più avanti.» «Non sforzarti, Root», scherzò il verme, e mise le mani sui fianchi, fissandomi cupo. «Ma non ti rendi conto? Se questi due pannelli sono un modello, dovrebbe essercene un altro che indica la soluzione. E dove sta, eh?» «Qui!» gridò Proxi da un luogo imprecisato. «Che diavolo...» cominciai a dire seguendo Jabba, che correva in cerca di Proxi. Per fortuna, la massiccia schiena del mio compagno, che barcollò per la frenata, bloccò anche la mia corsa perché, svoltando attorno al becco, ci saremmo scontrati con il corpo della mercenaria, che era sdraiata a faccia in su, con la testa sotto quella dell'uccello. «Qui ci sono nove tocapus», disse, e la sua voce risuonò attutita dalla scultura. «Te li descrivo, Root, o vieni a vederli?» Quella donna era temeraria come il demonio. «E perché non li memorizzi e non li inserisci tu nel computer?» le risposi. «D'accordo. È una buona idea», convenne, uscendo dal nascondiglio. «Come ti è venuto in mente di ficcarti lì sotto? Sei pazza?» la rimproverò Jabba. «Perché era logico, no? Mancava un pannello e doveva pur essere da qualche parte. La testa del condor era l'unica cosa che ci restava da esaminare.» «Ma ti sei buttata a terra senza pensarci due volte. E se lo avessero messo sopra?» obiettai. «Sarebbe stato il passo seguente», ammise pacifica, prendendomi il portatile dalle mani. La osservammo mentre trafficava con il telaio informatico e notammo che sospirava profondamente prima di alzare la testa per lanciarci un'occhiata stupefatta. «'Due diviso due, radice di uno'», mormorò. «'Due moltiplicato cinque, radice di...'» «Di che?» la incalzai. «Di non si sa. Ti ricordo che ci sono soltanto nove tocapus e nei due pannelli laterali ce ne sono dieci.» «Allora è questo che bisogna verificare», dissi. «E non può essere tanto difficile... In realtà, se esaminiamo bene i quattro testi di cui disponiamo, si può indovinare la logica occulta della chiave. Vediamo.» Presi il portatile e avviai il processore di testo scrivendo poi le quattro premesse. «'Sei diviso due, radice di tre', 'Sei moltiplicato cinque, radice di tre', 'Due diviso due, radice di uno', 'Due per cinque, radice di...', mettiamo X, va bene? Trasformiamolo in numeri. Supponiamo che Jabba avesse ragione dicendo che erano semplici divisioni e moltiplicazioni. Sei diviso due è uguale a tre e sei moltiplicato per cinque è uguale a trenta.» «No, la frase dice tre, non trenta», sottolineò lui. «Già, ma c'è un fattore con il quale non abbiamo fatto i conti: secondo quello che mi ha detto la professoressa, gli incas e le civiltà preincaiche, nonostante le loro profonde conoscenze matematiche e astronomiche, non conoscevano il numero zero e, pertanto, non usavano il numero arabo che rappresenta il nulla, il vuoto.» «Va bene, Root, d'accordo», ammise Proxi andando come sempre al concreto. «Ma le civiltà che non conoscevano lo zero, sapevano rappresentare perfettamente le decine, le centinaia, le migliaia... Usavano, semplicemente, simboli diversi o ripetevano lo stesso tante volte, a seconda di quello che gli serviva. La tua teoria non regge.» «No, no, regge», protestai, «perché stiamo parlando di radici. Della parte irriducibile e inalterabile della parola o di un'operazione matematica, e ricorda che il linguaggio aymara è formato da radici alle quali si aggregano suffissi ad infinitum per formare tutte le parole possibili. Osserva le frasi: 'Sei diviso due, radice di tre', e 'Sei moltiplicato cinque, radice di tre'. Se elimini lo zero nel risultato della moltiplicazione per cinque, la radice è la stessa di quella della divisione per due.» «E questo vuol dire che aggiungere degli zeri non altera la radice numerica», convenne Proxi riflettendo a voce alta. «La radice continua a essere la stessa qualsiasi segno o annotazione usi per rappresentare le decine e le centinaia.» «Esatto!» approvai. «E osserva la seconda operazione: 'Due diviso due, radice di uno', cioè due diviso due è uguale a uno, e 'Due moltiplicato cinque, radice di... x', come avevamo detto, ossia due moltiplicato per cinque uguale a dieci. Pertanto la radice è uno.» «L'unica cosa che mi è chiara», commentò Jabba, «è che, se togli gli zeri, dividere per due è lo stesso che moltiplicare per cinque.» «Sembra assurdo...» sorrisi. «No», dichiarò Proxi, «è coerente con un simbolismo numerico: se togli il vuoto, il nulla, che è lo zero, e rimani con il sostanziale, che è la radice, che differenza fa dividere o moltiplicare? Il risultato è lo stesso.» «D'accordo. Va bene», arguì Jabba. «E a che cosa ci serve aver capito questo?» Lola, con un sorriso, si chinò lievemente verso di lui e, prendendogli la testa tra le mani, gli diede un bacio sulla guancia. Di solito non erano molto espansivi davanti agli altri, quindi la cosa mi sorprese. «Anche se non sembra», mi disse, «in questo corpo da peso massimo c'è un'anima sensibile e intelligente.» Poi, mentre l'attonito Jabba si prendeva il suo tempo per reagire, lei si alzò e, con gesto agile, si buttò di nuovo a terra a corpo morto, sistemandosi sotto il becco del condor, per il quale non sembrava avere il minimo rispetto. Una volta lì, si girò a pancia in su e la vedemmo tastare la pietra con sicurezza. Il quel momento non sapevamo che cosa stesse facendo, anche se era facilmente presumibile, ma, di colpo, l'enorme blocco che formava la fronte, gli occhi e la parte superiore del becco, si sollevò con uno strepito di roccia e di metallo che ricordava quello di una lastra di pietra che sfrega contro un'altra o un ponte di ferro sotto il peso di un camion in movimento. Chiaramente ciò che strideva o cigolava non poteva essere ferro, perché il ferro era sconosciuto nell'America precolombiana. Jabba, spaventato, saltò verso Proxi a una velocità tale che non distinsi i suoi movimenti; lo capii dopo, quando la trascinò per i piedi per tirarla fuori da sotto la testa del condor. Io, da parte mia, ero paralizzato. La scena risultava piuttosto surreale: seduto a gambe incrociate osservavo Jabba che tirava fuori Proxi mentre la bocca del condor si apriva come la visiera di un casco con un rumore assordante che sarebbe potuto essere quello della fine del mondo. Ci avrebbe divorato tutti e tre? Perché io sarei stato incapace di muovermi per salvarmi la vita. Ma non ci divorò. Si fermò proprio all'altezza del soffitto e lì rimase, offrendo alla vista un nuovo corridoio, identico a quello in cui ci trovavamo. Jabba, pallido e ansimante come un cavallo, aggredì Proxi. «Che diavolo hai fatto, eh?» le gridò. «Tu non hai la testa a posto! Avresti potuto ammazzarti e far morire anche noi!» «Prima di tutto non urlare con me», rispose lei senza guardarlo e rimettendosi in piedi. «Secondo, sapevo perfettamente quello che facevo. Quindi calmati, altrimenti ti verranno di nuovo le vertigini.» «Le ho già, le vertigini, al pensiero che potevi morire schiacciata da questa vecchia pietra!» Lei, con calma, si diresse verso la bocca dell'uccello. «Ma non sono morta, e nemmeno voi. Per cui, forza! Andiamo!» «Che cosa hai fatto, Proxi?» le domandai, seguendola all'interno del becco aperto. Jabba, ancora furioso, era fermo nello stesso posto. «L'unica cosa ovvia che si poteva fare: se la radice di 'Due moltiplicato cinque' era l'uno, c'era solo un tocapu tra i diciannove che rappresentava questo numero, quello che indicava il risultato di 'Due diviso due, radice di uno', così sono ritornata sotto il mento del condor e, in effetti, il tocapu che il 'JoviLoom' segnalava come simbolo dell'uno ha ceduto sotto la pressione della mia mano. Dopo, sai che cosa è successo.» Mentre mi dava questa spiegazione, attraversammo la bocca dell'uccello e arrivammo nel nuovo corridoio. Mi preparavo a chiamare con un grido Jabba perché si affrettasse a raggiungerci, quando mi sembrò di sentire un «clic» metallico e, immediatamente, il becco del condor cominciò a chiudersi. Proxi si voltò, spaventata. «Marc!» urlò a pieni polmoni, ma il rumore delle pietre era troppo assordante. «Marc, Marc!» Prima che la visiera di pietra si richiudesse, il mio grasso amico si lanciò attraverso l'apertura come se si stesse tuffando in una piscina. Per un istante vidi in pericolo le sue gambe, che erano rimaste dall'altro lato, senza avere il tempo di reagire, e, mentre Proxi e io lo afferravamo per le mani e lo tiravamo disperatamente, un muro laterale di quasi un metro di larghezza, uscito dalla parete sinistra, cominciò a chiudere la parte posteriore della testa dell'animale. Per fortuna, anche se Proxi dovette ritrarsi in tutta fretta per non essere schiacciata, all'ultimo momento riuscii a dare uno strattone definitivo al braccio di Jabba, che uscì tutto intero anche se sporco e ammaccato. Mi lasciai cadere a terra, esausto, e osservai il soffitto del corridoio rischiarato dalla mia lampada frontale, il cui fascio di luce si muoveva al ritmo accelerato del mio respiro. Quell'aria tanto povera di ossigeno ci annientava convertendo qualsiasi sforzo in una fatica sovrumana che ci faceva salire il cuore in gola. «Non farlo mai più, Marc!» sentii Proxi mormorare. «Mi hai sentito bene? Non fare più scemenze del genere!» «Va bene!» rispose lui mortificato. Tentai di alzarmi, ma non ci riuscii; mi costava troppo. Non mi sarebbe dispiaciuto rimanere lì un po' a riposare e a riprendere fiato ma, ovviamente, chi avrebbe potuto sdraiarsi per riposare all'interno di una piramide ti- wanacota sepolta sottoterra da centinaia di anni, su un duro pavimento di pietra che si indovinava pieno di bestiacce e con l'unica via d'uscita bloccata da un muro scorrevole e da una gigantesca testa di condor? Non era il caso. Quindi, facendo appello a tutta la mia forza di volontà, riuscii a rimanere seduto, con il capo appoggiato sulle ginocchia piegate. E allora compresi con assoluta chiarezza dove mi trovavo. Nella mia mente apparve il disegno della pianta nascosta nel piedistallo di Thunupa, nella Porta del Sole, e ricordai che, dalla camera centrale in cui si nascondeva il serpente cornuto, uscivano quattro lunghi colli sormontati da una testa di puma, e sei che terminavano con una testa di condor ai lati e alla base. Ciò voleva dire che avevamo appena superato la prima testa di condor della parte destra (dato che eravamo entrati dal camino situato a est della Porta della Luna) e ci trovavamo nel collo. Se non mi sbagliavo, dopo una piccola salita verso il cuore della piramide, saremmo arrivati alle pareti della camera. «Ehi, voi due!» esclamai sorridendo. «Se smettete di fare gli stupidi un momento vi dico qualcosa di interessante.» «Spara!» Spiegai del collo del condor, ma loro non parvero molto colpiti. È vero che non era una novità; sapevamo già che il piedistallo era una mappa, ma a me non era ancora passato per la testa, fino a quel momento, che il suolo che stavo calpestando corrispondesse esattamente alla figura scolpita sotto il Dio dei Bastoni. «Su, andiamo», proposi, alzandomi con difficoltà. «Ora dovremmo trovare una scala o qualcosa di simile.» «Spero che sia così... e non un'altra prova del demonio», gracchiò Jabba. «Che cosa mi hai appena promesso?» lo rimproverò Proxi, guardandolo in malomodo. «Sì, va bene! Non mi lamenterò più.» «Speriamo», gli dissi avviandomi. «Rispetto sempre le mie promesse!» «Vediamo se è vero; mia nonna avrebbe retto più di te.» «Io farei subito il cambio!» disse Proxi, ridendo. E allora, mentre mi mettevo la borsa in spalla, notai il pilastro di pietra proprio alla mia destra, quasi attaccato alla parete. Sembrava una di quelle fontanelle dei giardini fatte in modo che i bambini possano bere (aiutati), ma non giocare con l'acqua. Mi avvicinai adagio e vidi che sopra, come un libro sul leggio, c'era una specie di tavoletta di pietra della dimensione di un foglio A4, piena di piccole perforazioni senza un ordine preciso. Jabba e Proxi si avvicinarono per guardare. «Che cos'è?» chiese lui. «Credi che sia venuto qui sapendo tutto?» protestai mettendomi la pietra in testa. «È un cappello.» «Non ti dona per niente», commentò Proxi scrutandomi con occhi esperti e accecandomi con il flash. «Ce la portiamo via?» «Certo», affermò lei. «Direi che stava qui esattamente perché la prendessimo. Chi lo sa? Forse ci servirà più tardi.» La riposi nella borsa e, quando me la misi sulla spalla, notai che il suo peso si era decuplicato. Camminammo a lungo, attenti ai più piccoli particolari, ma, nonostante la mia convinzione di trovare in fretta una scalinata o una rampa, il corridoio continuava a essere in piano e non si intravedeva alcuna salita. «Qualcosa non mi quadra», mormorai dopo quindici minuti. «Nemmeno a me», convenne Proxi. «Dovremmo salire nel collo del condor per raggiungere il muro esterno della camera e invece stiamo avanzando in senso orizzontale da molto tempo.» «Quanto abbiamo impiegato a percorrere il corridoio precedente?» chiese Jabba. «Una decina di minuti», risposi. «Siamo già andati oltre.» Ma, non appena il mio amico chiuse la boccaccia, un'altra testa di condor si parò davanti a noi. Era molto più piccola della precedente e sporgeva dal centro di un solido muro di pietra. Sentii che il mio umore diventava da grigio a nero quando notai che, a destra e a sinistra della testa, la parete era tappezzata di tocapus piuttosto grandi. Il sospetto di un'altra trappola aymara mi bloccò il cervello. «Bene, siamo qui», disse Proxi quando ci fermammo con le facce inespressive di fronte all'animaletto. «Tira fuori il portatile, Root.» «Lo stavo facendo», replicai, ma in realtà stavo pensando che, se quella piccola testa di pietra era il condotto attraverso il quale dovevamo passare, Jabba avrebbe avuto molte difficoltà ad attraversarlo. «No, no, aspetta!» esclamò lui all'improvviso, allontanandosi. «Osserva bene! Sono le figure inginocchiate che ci sono ai lati del Dio dei Bastoni!» E poggiò l'indice su alcuni tocapus che comparivano sulla parete destra. Additava sopra, sotto, ai lati. I folletti alati, che alcuni confondevano con degli angeli, spuntavano, senza ordine né criterio, dal testo aymara. «Quelli da questa parte hanno tutti teste di condor.» «Sì, come sulla porta», confermai. «E questi qua...» Proxi si piazzò alla sua sinistra. «Teste umane.» «Seguono un ordine? Sono simmetrici?» volli sapere, arretrando per abbracciare con lo sguardo tutta la parete. Contai i tocapus che c'erano nella fila superiore di ogni pannello (cinque) e quelli che c'erano sulle prime colonne (dieci), quindi, in totale, si trovavano cento tocapus, cinquanta su ciascun lato, e dieci di questi erano folletti alati: cinque con la testa di condor a destra, e cinque con teste umane a sinistra. E non ci fu bisogno che qualcuno rispondesse alle mie domande perché, con la visione panoramica, e una volta individuati i dieci elementi discordanti, la forma che disegnavano era facilmente riconoscibile: la punta di una freccia su ciascun lato, che indicava la testa al centro. Se questa non le avesse separate avrebbero formato una X. «Puoi vederlo», commentò Proxi. «Simmetria perfetta.» «Dovremmo tradurre il testo per sapere che dice», propose Jabba. Un lontano fragore di rocce giunse dal fondo del corridoio facendoci trasalire. «Che diavolo è stato?» proruppi. «Tranquillo, amico», mi rassicurò Jabba con un tono provocatorio. «Non può succederci niente di male; ormai siamo rinchiusi qui dentro. Nel caso non te ne fossi reso conto, se non riusciamo a risolvere l'enigma rimarremo imprigionati in questo posto finché non marciamo vivi.» Lo guardai senza dire una parola. Quella maledetta idea mi era già passata per la mente, ma non avevo voluto darle importanza. Non saremmo morti lì, ne ero sicuro. Un sesto senso mi diceva che ancora non era giunta la mia ora, e mi rifiutavo di prendere in considerazione persino la possibilità che non fossimo capaci di risolvere qualsiasi difficoltà potesse sorgere. Saremmo arrivati fino alla camera, a qualsiasi costo. La calma e la freddezza del mio sguardo dovettero colpirlo. Abbassò gli occhi, imbarazzato, e si voltò di nuovo verso i tocapus del lato destro. Non era il momento di arrabbiarsi o di farla lunga, quindi pensai che dovevo aiutarlo a uscire dalla situazione di disagio in cui si era messo da solo. «Che cosa diciamo sempre a Barcellona?» gli chiesi. Non si girò. «Il mondo è pieno di porte chiuse e noi siamo nati per aprirle tutte.» «Questa frase l'ho appesa alla parete del mio studio», commentò Proxi con voce allegra, dando anche lei una mano a Jabba. «D'accordo», rispose lui, voltandosi a guardarci con un mezzo sorriso sulle labbra. «Siete riusciti a svegliare la mia parte di animale informatico. Poi però non addossatemi delle colpe.» Prese il portatile e si sedette davanti al pannello di sinistra, quello con le figure alate con testa umana, e cominciò a copiare i tocapus nel «JoviLoom», mentre Proxi e io studiavamo la parete e le figure zoomorfe. Effettivamente né nelle fotografie che avevamo esaminato a casa né sulla stessa Porta del Sole avevamo notato i curiosi particolari che presentavano quegli omini. Sembrava che corressero, se volevi vederli correre, ma potevano anche sembrare inginocchiati, se pensavi che il loro atteggiamento fosse implorante. L'artista che li aveva creati aveva certamente ricercato l'ambiguità del gesto perché non fosse chiara l'indicazione che si dovesse supplicare Thunupa per trovare il modo di entrare a Lakaqullu. Tutti avevano ali, delle ali molto grandi, anche se, ora che avevamo l'opportunità di vederle da vicino, sarebbero anche potute essere considerate come delle cappe mosse dal vento. Tutti avevano inoltre un bastone rovesciato, identico a quello che Thunupa teneva nella mano sinistra, ma non terminava con una testa di condor, bensì con quella di un animale che sembrava un'anatra con il becco schiacciato in alto o un pesce dalla bocca enorme. Quelli che avevano la testa di uccello, situati a destra, guardavano in alto, verso il cielo, e i loro corpi erano girati verso il centro, verso il condor di pietra; quelli che avevano teste umane, davanti alle quali stava seduto Jabba con il computer, avevano il corpo e lo sguardo rivolti alla grande testa sul muro. «Bene», disse infine Jabba, «la traduzione è letterale e non è molto chiara, ma il testo dice qualcosa come: 'Le persone stanno per terra, vi affondano le ginocchia e posano lo sguardo su cose inutili'.» «Che assurdità!» esclamai perplesso. «Il mondo non è cambiato per niente, in centinaia di anni!» Jabba si alzò e si avvicinò al secondo pannello, concentrandosi di nuovo sul lavoro. Il suo comportamento era cambiato, e questo era rassicurante. «Le persone stanno per terra, si inginocchiano e posano lo sguardo su cose inutili?» mi chiese Proxi, come se io avessi la risposta al dilemma. Mi limitai ad alzare le spalle con un gesto che voleva dire che io ne sapevo quanto lei, cioè niente. I folletti alati continuavano ad attrarre la mia attenzione. Se il loro aspetto era strano di per sé, ancora più strani erano i disegni che comparivano dentro ai loro corpi, come il lungo serpente all'interno delle ali o cappe, i piccoli labirinti sul petto, e il collo e la testa che uscivano dalle loro gambette, le braccia, la pancia e tutto il resto, senza par- lare delle inspiegabili leve e bottoni sui volti e i simboli dei copricapi. Erano mezzi uomini, mezzi animali e mezze macchine. Evidentemente qualcosa di indefinibile e di molto stravagante. «Ecco il secondo testo», ci informò Jabba. «'Gli uccelli si alzano come per volare, fuggono veloci e posano lo sguardo sul cielo'.» «Credo che tutto questo non ci serva a niente», commentai. «Io invece credo di sì», ribatté Proxi. «Non sappiamo ancora come utilizzarle, ma sono sicura che non siano frasi messe lì a caso.» «È gente che padroneggia il potere delle parole», mi riprese Jabba con il fervore del neofita. «Non metterebbe sentenze filosofiche senza senso su una porta chiusa che si deve aprire. Su, Root, usa il cervello!» «D'accordo!» ammisi a denti stretti. «Sicuramente sono la chiave per aprire il becco di questo condor.» «Allora, forza! Al lavoro!» disse, facendo segno di sederci accanto a lui. «Prima devo parlarvi di una cosa che ho scoperto», annunciò Proxi dirigendosi verso il pannello con le teste di uccello. «Tutti i tocapus sono scolpiti nel muro, ma le figure sono bottoni che si possono premere, come nella prova precedente, nella quale il tocapu che rappresentava il numero uno si poteva pigiare per mettere in moto il meccanismo. Qui bisogna senza dubbio digitare una combinazione, come nelle casse automatiche.» E, dicendo questo, cominciò a premere le figure, una dietro l'altra, per dimostrarci che si abbassavano e che erano, in realtà, come i tasti di un quadro di comando. «No!» urlò disperatamente una voce alle nostre spalle. «Si fermi! Non continui!» In alcuni decimi di secondo, e prima che avessimo il tempo di reagire alle grida, il suolo cominciò a tremare e ad aprirsi come se un terremoto lo stesse scuotendo. Le pietre accostate con una perfezione che stupiva gli esperti si dissestarono lasciandoci appena il tempo di saltare fuori da quelle che sprofondavano e di sostenerci come pazzi su quelle che erano rimaste al loro posto. E, di colpo, dopo alcuni secondi angoscianti - il sisma non durò molto di più - un silenzio totale invase il luogo avvertendoci che il disastro era terminato. Io non riuscivo a muovere nemmeno un muscolo, sdraiato bocconi contro la lastra di pietra sulla quale mi ero arrampicato vedendo che quella che avevo sotto i piedi stava sprofondando. «State bene?» chiese dal fondo del corridoio la voce che prima aveva gridato per avvertirci del pericolo e che ora mi sembrò tremendamente familiare; quel timbro grave di contralto e quella cadenza non potevano che appartenere alla professoressa Marta Torrent. Ma nella mia mente non c'era spazio per lei, per chiedermi che diavolo ci facesse li, perché anzitutto dovevo verificare che cosa ne era stato di Proxi e di Jabba. «Dove siete?» gridai sollevando il capo. «Marc! Lola!» «Aiutami, Arnau!» urlò il mio amico da un punto dietro di me. Mi alzai e, sotto una sottile nube di polvere, scorsi la mole di Jabba che stava bocconi su una lastra separata dalla mia da un salto di un metro. La sua testa e le sue braccia pendevano nel vuoto. «Proxi sta cadendo! Aiutami!» Feci un balzo e mi buttai a terra, accanto a lui. Credo di non avere mai provato tanta angoscia come quando vidi la faccia di Lola che ci guardava da una crepa senza fine, dal cui fondo la separava soltanto la mano di Marc che stringeva la sua. Mi trascinai fino all'orlo e tesi il braccio per agguantarla per un polso e tirarla su con tutte le mie forze. A poco a poco riuscimmo a sollevarla, ma facevamo molta fatica, come se una forza invisibile la trascinasse verso il basso moltiplicandone il peso. I suoi occhi ci guardavano fisso e supplicavano un aiuto che la bocca, chiusa per il panico, non riusciva a chiedere. Notai che qualcuno posava il piede accanto a me, perché mi sfiorò, e poi vidi un altro braccio allungarsi verso Proxi e afferrarle la mano. Con la forza di tre persone Lola tornò su rapidamente e poggiò il piede sulla pietra sulla quale ci trovavamo tutti. Soltanto allora, abbracciata a Jabba, cominciò a singhiozzare adagio, sfogando il panico che ancora provava, e soltanto allora guardai la professoressa che, con le mani sui fianchi, respirava profondamente per lo sforzo e osservava i miei amici con la fronte aggrottata. Misi una mano sulla spalla di Lola che si voltò sciogliendosi dalla stretta di Marc per abbracciarmi, senza smettere di piangere. La strinsi anch'io con forza e notai che i battiti del mio cuore si placavano. Anche se pareva incredibile, Proxi era stata sul punto di morire proprio davanti ai nostri occhi. Quando mi lasciò per tornare tra le braccia di Jabba, mi voltati verso l'antropologa. «Grazie», mi sentii obbligato a dirle. «Grazie per l'aiuto.» «È stata un'imprudenza», commentò lei, gentile come sempre. «È possibile», replicai. «Ovviamente lei non si è mai sbagliata e per questo non può capire gli errori degli altri.» «Mi sono sbagliata spesso, signor Queralt, ma ho passato una vita intera negli scavi archeologici e so quello che non si deve fare. Voi non ne avete idea. Bisogna essere molto cauti e diffidenti. Non ci si deve mai distrarre.» Mi guardai attorno. Il pavimento del corridoio, fino a dove arrivava la luce della mia lampada frontale, adesso era un cumulo disordinato di pietre, simili a tante isole separate non dal mare, ma da larghe crepe. Per fortuna la via d'uscita non era stata ostruita; si poteva saltare da una lastra all'altra senza troppi rischi, ma, onestamente, la situazione era cambiata in modo radicale, per me, per non parlare di Marc e Lola: ora sapevamo che c'era pericolo, un reale pericolo di morte, in quello che stavamo facendo. «Per quanto affonda il terreno?» chiesi alla professoressa. «All'incirca per dieci metri», mi rispose avvicinandosi. «A partire da lì, il terreno è stabile.» «Possiamo ritornare in superficie?» «Non credo», la sua voce suonava tranquilla, priva di ansietà. «La prima testa di condor e il muro posteriore hanno sbarrato l'uscita da quel lato.» «Quindi dobbiamo proseguire.» Lei non rispose. «Come ci ha scoperti?» chiesi senza voltarmi. «Come è arrivata fin qui?» «Sapevo che sareste venuti», rispose. «Sapevo quello che pensavate di fare. Ero preparata.» «Ma l'abbiamo vista impegnata negli scavi e non c'era nessuno nei dintorni, quando abbiamo trovato l'entrata.» «Sì che c'era. Uno degli studenti era appostato sulla collina di Kerikala. Gli avevo chiesto di sorvegliare Lakaqullu con il binocolo e di avvertirmi della vostra comparsa. Anche se la vegetazione nascondeva l'ingresso, non mi è stato difficile trovarlo perché vi ho visti entrare e sparire.» A questo punto mi voltai a guardarla. Era serena e, come sempre, sembrava sicura di se stessa e delle sue scelte. «E lei è entrata da sola nel camino e nel corridoio?» «Camminavo a poca distanza da voi. Seguivo le luci delle torce. Sono arrivata in tempo per sentirla raccontare ai suoi amici quello che le avevo spiegato nel mio studio sulla non conoscenza dello zero nella civiltà tiwanacota.» Le avevamo servito su un vassoio d'argento la soluzione per aprire la prima testa di condor. «E quando pensava di comunicarci la bella notizia della sua presenza?» chiesi con rabbia mal dissimulata. «Al momento opportuno», dichiarò senza scomporsi. «Naturalmente.» Eravamo tutti in un bel pasticcio. Da una parte lei continuava imperterri- ta ad approfittare fino in fondo delle nostre scoperte e di quelle di mio fratello; dall'altra una sua sola parola poteva mandarci dritti in carcere per aver trasgredito le leggi boliviane danneggiando un monumento archeologico unico al mondo e, per di più, «Patrimonio dell'Umanità». I piatti della bilancia erano perfettamente equilibrati, almeno fino a quando non avremmo lasciato la Bolivia. Se ci fossimo riusciti. «Senta, dottoressa», avevo un leggero mal di testa, quindi chiusi gli occhi e mi massaggiai delicatamente la fronte, «facciamo un patto. Io voglio soltanto trovare una soluzione per la malattia di mio fratello. Se lei ci aiuta» - per non dirle «se non ci denuncia e ci permette di continuare» - «potrà prendersi il merito di tutto ciò che scopriremo, d'accordo? Sono sicuro che Daniel preferisca rinunciare al successo accademico piuttosto che rimanere come un vegetale per il resto della sua vita.» La professoressa mi guardò in modo indefinibile per alcuni secondi e infine abbozzò un sorriso. Chi non sorriderebbe quando gli regalano ciò che più desidera? «Accetto la sua offerta.» «Bene, che cosa sa lei di tutta questa storia?» Quella donna cinica tornò a sorridere in modo enigmatico e rimase in silenzio per un bel pezzo. «Molto di più di quanto lei si immagina, signor Queralt», disse infine, «e sicuramente molto più di lei e dei suoi amici, quindi non perdiamo tempo e mettiamoci al lavoro. Dobbiamo togliere una sbarra aymara, ricorda?» Jabba e Proxi, abbracciati, ci osservavano stupiti. Dall'espressione dei loro volti intuii che erano d'accordo con la mia decisione di integrare la dottoressa nella nostra squadra. Non era il momento delle prove di forza o delle sfide in situazioni di disparità. Appena tornati a casa, però, pensavo di assumere il migliore staff di avvocati della Spagna per intentarle la causa più grande della storia del mondo e farla finita con lei per sempre. Questo la dottoressa non se lo aspettava; quindi, per il momento, potevamo sospendere le ostilità. Ogni cosa a suo tempo. La professoressa saltò di pietra in pietra fino a portarsi il più vicino possibile al muro con la testa di condor. Aveva lasciato ai miei piedi uno zaino vecchio e consunto. «Vediamo... che cosa abbiamo qui?» mormorò esaminando i tocapus. «'Le persone rimangono a terra, si inginocchiano e fissano i loro occhi sulle cose superflue'», lesse con una scioltezza sbalorditiva. «Gli uccelli si levano in volo, si danno un rapido slancio e fissano i loro occhi verso l'al- to.'» Rimanemmo perplessi. La professoressa leggeva l'aymara come se fosse la sua lingua, dando dei punti alla traduzione del telaio di Jovi. Poi, forse per dimostrare fino a che punto padroneggiava la materia, spiegò a voce alta il suo ragionamento. «Queste frasi», disse incrociando le braccia sul petto, «sono un gioco di parole la cui finalità è di opporre l'idea di passività e di stanchezza a quella di movimento e di trasformazione; gli umani rimangono fermi sulla terra, mentre gli uccelli si evolvono sostituendo la terra con il cielo. In poche parole, stiamo parlando dell'utilizzo delle forze dinamiche per ottenere un cambiamento.» Non so se si aspettava che noi tre dicessimo qualcosa, ma, siccome parlava come se stesse impartendo una lezione, rimanemmo zitti. «In ogni caso, le figure degli adoratori della Porta del Sole compaiono mescolate con il testo e formano figure triangolari con vertici che puntano alla testa del condor. Se considerassimo tutte e due le tavole come una sola e numerassimo le file e le colonne dall'uno al dieci, come in una scacchiera...» si pizzicò il labbro inferiore tra il pollice e l'indice, assorta, «la figura cambierebbe radicalmente, allora avremmo due linee diagonali che si incontrano al centro, una formata da due uccelli e da tre umani, l'altra da due umani e tre uccelli.» «Cinque», si lasciò scappare Proxi, che seguiva con grande interesse la spiegazione. «Le due linee diagonali sommano cinque figure ciascuna. Lo dico perché sono convinta che tutto ciò abbia a che vedere con la prova precedente, quella di moltiplicare per cinque e dividere per due.» «Senza dubbio si tratta di un avanzamento di conoscenze e di abilità», rispose la dottoressa Torrent. «Ci mostrano qualcosa e non ne richiedono l'applicazione pratica. Siamo degni di accedere a un potere superiore o, invece, la nostra incapacità mentale ci chiude le porte?» Io ascoltavo allucinato le due donne, soprattutto la dottoressa. Aveva un modo di ragionare assolutamente scientifico e un modo di spiegarsi pedagogico, e Proxi, la nostra Proxi, captava l'onda come un radar reagendo in sintonia. «Ascolti, dottoressa...» la interruppe Jabba. «Non può parlare come una persona normale? Deve sempre essere tanto ricercata?» Marta Torrent lo fissò stringendo gli occhi come se si concentrasse per emettere dei raggi gamma che lo avrebbero trasformato in una pozza di plasma, e pensai che sarebbe scoppiato il finimondo se non fossi interve- nuto per fermarlo. Comunque fu in quell'occasione che appresi che gli occhi stretti della dottoressa erano il passo precedente a un'incontenibile risata. Non si offese e non reagì come una Nemesi inferocita; le sue risate, invece, risuonarono nella galleria e si moltiplicarono rimbalzando dal suolo squarciato alle pareti. Sembrava che fossimo circondati da un coro di baccanti. «Oh! Mi dispiace, signor...» si scusò tentando di smettere di ridere. «Non ricordo il suo nome, mi perdoni.» «Marc. Mi chiamo Marc», rispose lui di malavoglia. Io pensai: Bond. James Bond. Ma non dissi niente. «Marc, mi scusi. Non volevo assolutamente. È che, sa, i miei figli e i miei allievi si burlano sempre di me per il mio modo di parlare. E questo mi ha divertita. Spero di non averla offesa.» Jabba scosse il capo e le diede le spalle per mettere in chiaro la sua indifferenza, ma io, che lo conoscevo bene, sapevo che gli era piaciuta la risposta. Quella situazione stava diventando piuttosto problematica. «Molto bene, vediamo», mormorò Proxi alla professoressa. «Se numeriamo le file e le colonne, come lei ha detto, dall'uno al dieci, la diagonale con tre condor e due umani ha le sue cinque figure situate nelle caselle 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 e 10-10, mentre la diagonale con tre umani e due condor le ha in 1-10, 3-8, 5-6, 7-4 e 9-2. Pertanto la più regolare è quella dei tre condor.» Io avevo già eseguito rapidamente varie operazioni mentali con i numeri e stavo arrivando alla conclusione che la serie irregolare mancava di senso matematico, mentre quella regolare corrispondeva, pari pari, ai primi cinque numeri interi, il risultato dei quali, diviso per due e moltiplicato per cinque, aveva la stessa radice. «Bisogna premere le cinque figure della diagonale con tre condor», disse allora il grosso verme corpulento. «E perché?» chiesi. Mi aveva battuto di nuovo. «Ma non lo vedi, Root?» mi rimbeccò Proxi. «Due, quattro, sei, otto e dieci sono divisibili per due e moltiplicabili per cinque con la stessa radice, mentre l'altra serie manca di logica.» «Sì, l'ho notato», osservai avvicinandomi. «Ma perché bisogna premere le cinque figure?» «Perché sono cinque, signor Queralt, cinque distribuite in due tavole. Cinque e due, i numeri della prima prova. Inoltre, seguendo l'idea contenuta nelle frasi, i condor implicano movimento mentre le figure umane sug- geriscono immobilità. Nella diagonale delle cinque cifre divisibili per due e moltiplicate per cinque ci sono tre condor; nell'altra, invece, ci sono tre umani.» «Forse il numero tre ha qualcosa a che vedere con la prova successiva», ipotizzò Jabba. Proxi corrugò la fronte. «Vediamo se riusciamo a essere più positivi!» gli ricordò. «Che cosa ho detto?» protestò lui. «Va bene, ma... se premiamo quella combinazione e il terreno sprofonda completamente sotto i nostri piedi?» domandai con apprensione. «Il terreno non sprofonderà», mormorò Proxi. «Il ragionamento è logico e coerente. Chiaro come un loop infinito.» «Che cos'è un loop infinito?» volle sapere la Torrent. «Un gruppo di istruzioni in codice che rimandano eternamente l'una all'altra», le spiegò. «Qualcosa di simile a 'Se Marc ha i capelli rossi allora saltare ad Arnau e se Arnau ha i capelli lunghi, allora tornare a Marc'. Non finisce mai perché è un comando assoluto.» «A meno che io non mi tagli i capelli e Marc non se li tinga di biondo. Allora non sarebbe più assoluto.» Era una buona battuta, ma non sembrò divertire le donne, per cui noi due, che avevamo riso, rimanemmo in silenzio. «Comunque», proposi reprimendo l'ultimo inadeguato sorriso e parlando il più giudiziosamente possibile per recuperare la dignità perduta, «tre di noi dovrebbero retrocedere fino alla zona del corridoio in cui il terreno è ancora integro, e uno, assicurato a una corda, dovrebbe rimanere qui per premere la combinazione. Nel caso in cui il terreno finisse per sprofondare, noi altri tre lo sorreggeremmo.» «Come sarebbe lo sorreggeremmo'? Tu ti stai tirando indietro?» insinuò discretamente Jabba. «Né tu né io possiamo essere questa persona, perché pesiamo troppo. Lo capisci? Dev'essere una di loro due. Non è una questione di coraggio, ma di sovraccarico.» «È stato molto chiaro, signor Queralt», convenne la professoressa senza scomporsi. «Premerò io i tocapus.» E, davanti a un tentativo di protesta da parte di Proxi, alzò la mano per fermarla. «Non è per offenderla, Lola, ma io sono più magra, quindi peso meno. Chiusa la discussione. Datemi quella corda e allontanatevi.» «È sicura, Marta?» chiese Proxi, non molto convinta. «Io pratico l'ar- rampicata e potrei cavarmela meglio.» «Questo è da vedere. È tutta la vita che lavoro negli scavi e so salire e scendere per mezzo di una corda, quindi allontanatevi. Su! Non perdiamo altro tempo.» In un batter d'occhio assicurammo Marta con una corda e ci ritirammo verso il fondo del tunnel saltando di lastra in lastra fino a raggiungere un terreno sicuro, quindi ci legammo anche noi in modo da poter esercitare la massima tensione se fosse successo un incidente. Dalla distanza in cui ci trovavamo, le nostre luci illuminavano appena la parete di fondo, per cui non vedevamo ciò che faceva la professoressa e io stavo ancora aspettando che tutto saltasse in aria, con i muscoli tesi, quando un rumore, come di tuono in lontananza, si scatenò sulle nostre teste. Quando alzammo lo sguardo, le lampade frontali misero a fuoco una stretta striscia di pietre, proprio al centro del soffitto, che, come un nastro adesivo che si stacca, cominciava a caderci addosso. «Dottoressa Torrenti» gridai a pieni polmoni. «Sta bene?» «Perfettamente.» «Allora venga qui così sciogliamo la corda e ci allontaniamo da quello che ci sta cadendo addosso.» «Che cosa succede?» chiese. La sua voce era più vicina. «Non è il momento di dare spiegazioni», borbottò Jabba. «Corra!» La corda si afflosciò tra le nostre mani mentre la recuperavamo, e finalmente vedemmo la dottoressa Torrent spiccare l'ultimo salto verso di noi. In quel momento la striscia di pietre del soffitto fu quasi sul punto di schiacciarci, quindi ci scansammo verso i muri laterali e ci attaccammo a questi come francobolli. Anche così, però, la cosa rischiò di spianare la pancia del più grasso di noi. Solo allora ci accorgemmo che era scesa in diagonale, e che si trattava in realtà di una scala di incredibile lunghezza, che partiva dall'alto della piccola testa del condor e terminava ai nostri piedi invitandoci a salire. Però, malgrado la situazione fosse chiara, non ci decidevamo a staccarci dalla parete. Rimanevamo lì, con gli occhi vitrei per il panico e le narici che vibravano freneticamente per eliminare la polvere caduta dal soffitto. Fu Proxi a reagire per prima. «Signore, signori...» mormorò. «Il collo del condor.» «Del primo o del secondo?» chiese Jabba con voce cavernosa. Era rimasto addossato alla parete tenendosi la pancia. «Del primo», affermai senza muovermi. «Ricorda il disegno della map- pa di Thunupa.» Marta ci scrutò a uno a uno, scura in volto. «Siete tanto svegli come sembrate», domandò, «o tutto questo lo avete ricavato dai documenti di suo fratello, signor Queralt?» Stavo per risponderle, ma Proxi mi anticipò. «Supponiamo che lo abbia scoperto Daniel, visto che la sua documentazione ci ha dato i riferimenti necessari per verificarlo. Ma non tutto era nelle sue carte.» «Io non scrivo mai tutto quello che so», mormorò lei passandosi le mani tra i capelli per togliersi la terra che le era caduta addosso. «Probabilmente perché non sa tutto», conclusi dirigendomi verso il primo gradino della scala, da cui partivano due grosse catene che salivano verso l'alto, «o perché non sa nulla.» «Sarà per questo», replicò lei con fredda ironia. Cominciai a salire con attenzione quegli scalini frastagliati, senza passamano, che erano caduti dall'alto. «Questo è oro?» chiese Proxi. Mi voltai e vidi che stava esaminando una delle catene. «È oro?» ripetei meravigliato. La dottoressa passò una mano sui gradini per togliere la patina di sporcizia e la luce della sua lampada frontale, molto più grande e antiquata delle nostre, illuminò una brillante superficie dorata. Proxi, tanto per cambiare, cominciò a scattare fotografie. Se fossimo usciti di lì, avremmo avuto un fantastico album della nostra odissea. «Sì, lo è», confermò categoricamente Marta Torrent. «Ma la cosa non deve sorprendere, perché l'oro abbondava in queste terre finché non arrivammo noi spagnoli, e, inoltre, i tiwanacotas lo consideravano sacro per le sue stupefacenti proprietà. Sapevate che l'oro è il metallo più straordinario di tutti? È inalterabile e inossidabile, duttile e facilmente malleabile; può trasformarsi in fili sottili come capelli o in grossi e resistenti anelli di catena come questi. Né il tempo né alcuna sostanza presente in natura può intaccarlo. È un conduttore elettrico insuperabile, non provoca allergie, non è reattivo, e non dimentichiamo che ha uno degli indici di riflessione della luce più alti del mondo, in quanto rimanda persino i raggi infrarossi. È talmente forte che i motori delle navi spaziali sono rivestiti d'oro perché è l'unico metallo in grado di sopportare le altissime temperature generate al loro interno senza liquefarsi come il cioccolato nella mano.» Nella cronaca degli yatiris, che mio fratello aveva elaborato in testi spar- si, si diceva già che avevano lasciato il loro legato scritto nell'oro perché era il metallo sacro, che durava eternamente. Ma perché un'antropologa specialista in etnolinguistica aveva svolto una ricerca su questo metallo? Lei ci guardò e dovette leggere la domanda sui nostri volti. «Mi sorprese molto scoprire che gli yatiris redigevano i loro testi su lastre d'oro, come saprete già. Non riuscivo a comprenderne la ragione. Pensavo che se avessero voluto lasciare dei messaggi su un supporto davvero robusto avrebbero potuto usare la pietra, per esempio. Invece mostravano un interesse esagerato per scrivere sull'oro, e questo mi aveva incuriosita. Senza dubbio è preferibile alla pietra. Molto più sicuro, inalterabile e resistente.» «Per questo scrissero su lastre d'oro», osservò Proxi, «e le conservarono nella camera del Viaggiatore prima di abbandonare Taipikala.» La dottoressa Torrent sorrise di nuovo. «Taipikala, effettivamente. E il Viaggiatore... Siete ben informati!» «Dobbiamo restare qui per sempre?» feci notare riprendendo la mia lenta e prudente ascesa. Nessuno mi rispose, però tutti si mossero per seguirmi. Perché la dottoressa ci aveva propinato quella lezione sull'oro? Sarebbe stato un errore chiederci direttamente quello che sapevamo; allora ci aveva teso una trappola. Aveva reagito in modo ostentato quando avevamo menzionato Thunupa, riconoscendo l'appellativo meno divulgato del Dio dei Bastoni, facendoci capire che ne sapeva quanto noi (durante il colloquio nel suo studio non lo aveva citato). Aveva poi fatto lo stesso con il nome segreto di Tiwanacu, Taipikala, e con il Viaggiatore. In qualche modo ci stava dicendo che lei conosceva perfettamente la storia. Ma non potevo dimenticare la sua frase: «Mi sorprese molto scoprire che gli yatiris redigevano i loro testi su lastre d'oro, come saprete già». Quel «come saprete già» non era una domanda, ma un'affermazione. Le cose che ci aveva raccontato sul metallo prezioso erano dati cui tutti potevano accedere, informazioni di scarsa importanza. Meno una frase. Era chiaro che si aspettava una reazione da parte nostra. Voleva verificare se noi sapevamo delle lastre d'oro? La cosa più divertente era che, comunque, aveva ottenuto quello che stava cercando; Proxi le aveva risposto con due dati importanti: Taipikala e il Viaggiatore. Ora Marta Torrent intuiva fin dove arrivavano le nostre conoscenze e, nel caso ci interessasse, ci aveva anche detto, a modo suo, quello che sapeva lei, perché fosse chiaro che era molto di più di quello che sapevamo noi, dato che aveva analizzato in profondità persino particolari insignificanti come quello dell'oro. Stava definendo i confini delle sue conoscenze e sondando i nostri. Era sveglia come il demonio. E quei misteriosi yatiris? Perché avevano protetto così tanto le loro conoscenze più importanti? Nella cronaca si diceva chiaramente che, se si fossero ripetuti un cataclisma e un diluvio simili a quelli dell'epoca dei giganti, gli umani scampati avrebbero potuto trovare il loro legato, un legato che avrebbe fornito loro un codice con un potere impressionante. Forse non li avrebbe aiutati a sopravvivere o a mangiare o a non ammalarsi ma, per lo meno, non si sarebbe perduto per sempre. Qualcuno sarebbe stato in grado di custodirlo. E quindi era quello lo scopo di quei tizi con tutta la solfa della Piramide del Viaggiatore: non avevano intenzione di aiutare un'umanità in difficoltà, come avevamo creduto seguendo una linea di pensiero tracciata da mio fratello, ma impedire che le loro conoscenze si perdessero per sempre. Era comunque indifferente l'uso che si sarebbe potuto fare di quel potere. La cosa fondamentale era che si mantenesse nel tempo. Rimasi di ghiaccio quando lo scoprii. A ogni gradino che salivo, il mio punto di vista sulla situazione andava modificandosi. Eravamo venuti lì con un'idea sbagliata, con un'idea che ci aveva accecati impedendoci di scoprire la verità. Nessuno di noi si aspettava che, accedendo alle conoscenze segrete degli yatiris, ci saremmo appropriati di un potere unico al mondo, capace di cose straordinarie come ciò che era capitato a mio fratello. C'era però qualcuno che forse ci aveva pensato, e che per questo sfidava in modo tanto aggressivo i probabili rivali. La dottoressa Torrent si comportava così perché tentava di sapere fino a che punto ambivamo a quello strano e pericoloso privilegio? Forse lo voleva per se stessa? E, se era così, a che scopo? Per pubblicare la sua scoperta su riviste di antropologia e ottenere riconoscimenti accademici? In questa nuova ottica quei propositi apparivano ridicoli. Quale governo al mondo avrebbe lasciato una simile possibilità nelle mani di una docente universitaria? Aveva delle buone ragioni per dirmi, quando mi aveva telefonato a casa, che non poteva lasciare nelle mie mani il materiale di Daniel e che si trattava di una situazione molto delicata! Quali erano state le sue esatte parole? «Se solo uno dei documenti che lei conserva si perdesse o cadesse in mani sbagliate, sarebbe una catastrofe per il mondo accademico.» Per il mondo accademico o per il mondo in generale? «Lei non può immaginare l'importanza che ha quel materiale.» No, forse allora non lo immaginavo, però adesso sì, ed era vitale che la professoressa non avesse accesso alle conoscenze degli yatiris. Quando arrivai in cima, mi trovai di fronte a un enorme muro di blocchi di pietra, in un corridoio che si perdeva nel buio a destra e a sinistra. Se i nostri calcoli erano corretti, quel muro era la parete esterna della camera del Viaggiatore, la camera del serpente cornuto, quindi i corridoi avrebbero formato intorno un percorso quadrato e, sia da un lato sia dall'altro, saremmo arrivati alla porta di entrata. «Finalmente!» sospirò Proxi quando mi raggiunse. Mi chinai verso di lei rapidamente e le parlai all'orecchio. «Lola, ascoltami con attenzione: la professoressa non deve entrare nella camera con noi.» «Sei pazzo?» esclamò allontanandosi per guardarmi. La sua lampada mi accecò per alcuni istanti. Battei le palpebre e vidi mille lucette impresse nella retina. «Non le possiamo permettere di entrare, Lola. Vuole il potere delle parole.» «Anche noi.» «Che cosa state bisbigliando voi due?» chiese Jabba con voce potente raggiungendo l'ultimo gradino. La professoressa arrivò proprio dietro di lui. Lola mi guardò come se fossi diventato pazzo e si voltò verso di lui. «Niente, cretinate di Root.» «Allora non dire più cretinate, Root.» «Root... radice?» si stupì Marta Torrent. «Perché lo chiamate 'Radice'?» «È il mio...» Che fastidio dover spiegare a una neofita i soprannomi della rete! «... il mio nick, il mio tag. In Internet, ci chiamiamo tra di noi con degli pseudonimi. Tutti lo fanno. Root deriva dal nome della cartella principale di qualsiasi computer, la cartella radice, cioè Root. Nei computer con sistema operativo Unix si riferisce all'utente principale.» «E i vostri quali sono?» chiese a Marc e a Lola. «Il mio è Proxi e quello di Marc è Jabba. Proxi viene da Proxi, il nome di una macchina che si comporta come server di accesso a Internet, che archivia nella memoria i contenuti delle pagine perché le visite seguenti siano più rapide. È come un filtro che accelera il processo e che, nello stesso tempo, serve a difendere l'utente dai virus, dai worm e dalle altre porcherie che circolano in rete. Io lavoro nel dipartimento di sicurezza della Ker-Central», si giustificò, «la società di Arnau. Di Root. Per questo motivo ho scelto Proxi.» «E Jabba?» insisté Marta, guardando il verme dai capelli rossi che aveva un'espressione minacciosa. «Jabba non significa niente», sbuffò lui, dandole le spalle e avanzando nel corridoio di destra. «Davvero?» si sorprese lei. «Niente?» Lola e io ci scambiammo un'occhiata ansiosa e, abbassando la voce, chiesi alla professoressa di non insistere. «A me ricorda qualcosa», commentò lei in un sussurro. «Credo di averlo già sentito.» «Guerre stellari», mormorò Proxi dandole un indizio. «Guerre?...» Parve ricordare di colpo di che personaggio stavamo parlando perché spalancò gli occhi e sorrise. «Ah, certo, certo! Lo so.» «Allora non glielo dica», osservai andando verso Jabba, che si allontanava infastidito. Quando lo raggiunsi gli passai amichevolmente un braccio attorno alle spalle e gli dissi sottovoce: «Non possiamo permettere che la professoressa entri nella camera». «Non essere paranoico, amico. Non sappiamo ancora se riusciremo a entrarci noi.» «Credi davvero che voglia il potere delle parole soltanto per pubblicare la sua scoperta in una rivista?» Jabba sembrò aver afferrato immediatamente, e annuì guardandomi con aria complice. Il corridoio era immenso. Nonostante ci trovassimo in un livello superiore e quindi nella parte più piccola della piramide, la camera centrale era enorme, di dimensioni tali che per percorrere la metà di uno dei lati impiegammo un tempo considerevole. Lì il pavimento era stabile, e l'aria cupa, in cui si respirava a fatica, era carica di corpuscoli invisibili che le davano peso e consistenza. Ma, avanzando lentamente attraverso quella spaziosa galleria dal soffitto alto, provammo la sensazione positiva che stavamo arrivando alla fine, che al di là del muro alla nostra sinistra si trovava il segreto per cui avevamo attraversato l'Atlantico. La mia unica preoccupazione era Marta Torrent. Non riuscivo a immaginare un modo per fermarla e impedirle di entrare nella camera. «Posso farvi una domanda?» disse lei in quel preciso momento, rompendo il silenzio. «Prego», borbottò Jabba. «Come avete fatto a imparare l'aymara in così poco tempo?» «Non abbiamo imparato l'aymara», risposi, continuando a respirare a fatica. «Utilizziamo un traduttore automatico che abbiamo trovato nel computer di mio fratello.» «Davvero?» fece con sarcasmo la professoressa. «Il 'JoviLoom'.» «Lo conosce?» si stupì Proxi. Marta Torrent rise. «Certo che lo conosco. È mio!» esclamò. «Certo, come no?» dissi ironico. «Tutto è suo, non è vero, dottoressa? Il 'JoviLoom', il 'JoviKey', l'Università Autonoma di Barcellona... E perché non il mondo? Vero, dottoressa? Anche il mondo è suo e, se non lo è ancora, lo sarà, no?» Lei preferì ignorare il mio tono polemico. «Avete anche il 'JoviKey'? Però!» In quel momento poteva anche scoppiare una guerra nucleare. Come poteva venirle in mente di dire che mio fratello Daniel le aveva rubato anche quei programmi? L'avrei lasciata legata in quella piramide a morire d'inedia. «Voi sapete che cosa significa il nome di questi programmi?» ci chiese con aria di sfida. «Il 'Telaio di Jovi'?» rispose Proxi, acida. «La 'Chiave di Jovi'?» «Sì, effettivamente», replicò lei, «di Jovi. Ma di Joffre Viladomat, mio marito.» Un forte rintocco di campane risuonò dolorosamente nel mio cervello e rimasi impietrito, barcollante come se avessero usato la mia testa come batacchio. «Joffre Viladomat?» balbettai. Era proprio quello il nome apparso sullo schermo del sistema di casa quando la dottoressa Torrent mi aveva chiamato per telefono. Tutti si fermarono a osservarmi, e quella che mi fissava con maggiore soddisfazione era proprio la professoressa, che non riuscì a dissimulare un crudele sorrisetto di trionfo. «Joffre Viladomat. Jovi per gli amici fin dagli anni dell'università.» «Suo marito è programmatore?» chiese diffidente Jabba. «No, mio marito è economista e avvocato. Ha un'impresa nelle Filippine che agisce da intermediaria tra le zone di produzione per esportazioni del Sudest asiatico e le società spagnole.» «Credo di non avere capito», bofonchiò Marc. «Joffre compra prodotti fabbricati nel Sudest asiatico e li vende alle im- prese interessate. Si potrebbe dire che è una specie di intermediario che procura alle ditte spagnole merci a basso costo di produzione. Ha l'ufficio a Manila e da lì compra e vende merci di vario genere come jeans, elettrodomestici, palloni da football o programmi informatici. Io gli chiesi, due anni fa, un paio di applicazioni per tradurre l'aymara e un codice per proteggere il mio computer portatile. Joffre commissionò i programmi a un'impresa filippina di software e, nel giro di alcuni mesi, mi inviò il 'JoviKey' e il 'JoviLoom', che erano stati ideati seguendo le mie indicazioni e con i miei database.» «Sta forse dicendo che suo marito», sillabò lentamente Proxi, rossa di rabbia, «compra prodotti fabbricati in condizioni disumane da lavoratorischiavi del Terzo Mondo e li vende a note ditte spagnole, che così risparmiano sui costi e sulle tasse che comporterebbero fabbricarli nel nostro Paese, nonché sulle spese di previdenza sociale dei lavoratori spagnoli?» Marta sorrise con un misto di ironia e compassione. «Vedo che lei conosce il panorama economico mondiale. Certo, Joffre si dedica esattamente a questo; e non è l'unico, del resto.» Avrei dovuto accorgermi che il suo volto e la sua voce rivelavano qualche tipo di storia personale complicata nascosta dietro quelle parole, ma io in quel momento non potevo occuparmi di sottigliezze del genere. Difatti mi sentivo tanto demoralizzato e depresso che niente, a parte l'incubo orrendo di scoprire che mio fratello aveva rubato quei programmi informatici (e forse anche la documentazione trovata nel suo studio, come la dottoressa aveva sempre sostenuto), niente, ripeto, poteva superare le barriere della mia mente. Era incredibile, impensabile, che Daniel avesse fatto qualcosa di simile. Mio fratello non era così, non era un ladro, non era il tipo che si impossessava di cose che appartenevano ad altri. Non sapeva rubare, non lo aveva mai fatto e, inoltre, non ne aveva bisogno. E poi perché portar via di nascosto il materiale di ricerca di un'altra persona, del suo capo, se aveva una fantastica carriera davanti e avrebbe potuto ottenere molto di più in pochi anni con le sue sole forze? Troppi perché... Perché avrebbe dovuto prendere quei due maledetti programmi e, ora, costringermi a dubitare di lui e della sua onestà mentre giaceva ammalato e incapace di difendersi in un letto di ospedale? Maledizione, Daniel! Io avrei potuto darti applicazioni molto migliori di quelle due porcherie «Jovi» buone a niente! Avevi bisogno di un traduttore automatico di aymara? Bene, potevi chiedermelo! Avrei mosso cielo e terra per trovartelo! «Arnau.» «Sì?» gridai. «Sì, sì, sì...» La mia voce urtò le pareti di pietra e mi svegliai. Davanti a me c'erano Marc, Lola e la professoressa che mi fissavano preoccupati. «Stai bene?» mi chiese Lola. Per abitudine, suppongo, effettuai automaticamente un rapido esame della situazione. No, non stavo bene; stavo male, molto male. «Certo che sto bene!» affermai rivolgendomi a lei. Marc si intromise. «Ehi, tu! Basta, capito? Non c'è bisogno di parlarle con questo tono!» «State tranquilli tutti e due!» gridò Lola allontanando Marc con una mano. «Non è niente, Arnau, non preoccuparti. Ora calmiamoci, d'accordo?» «Voglio andare via da qui», dissi disgustato. «Mi dispiace, signor Queralt», mormorò la dottoressa Torrent impedendomi di ritornare verso la scala. Un gesto stupido perché, in realtà, non c'era nessuna possibilità di tornare indietro. Non c'era via d'uscita. In quel momento, però, non me ne importava. Non sapevo bene quello che facevo né quello che dicevo. «Che cos'è che le dispiace?» replicai seccato. «Mi dispiace di essere causa del suo malessere.» «Non è colpa sua.» «In parte sì, perché volevo che scoprisse la verità e non ho evitato nessuna occasione per riuscirci senza pensare che potevo ferirla.» «E lei che diavolo ne sa?» la aggredii. «Mi lasci in pace!» «Potresti controllarti un po'», disse Jabba alle mie spalle. «Faccio quello che mi pare. Lasciatemi in pace tutti quanti.» E, liberandomi della borsa, mi lasciai andare come un fantoccio scivolando piano a terra con la schiena appoggiata alla parete della camera. «Ho bisogno solo di qualche minuto. Proseguite senza di me. Vi raggiungerò.» «Non possiamo lasciarti qui, Root!» disse Proxi preoccupata, inginocchiandosi davanti a me e osservando le ombre inquietanti che ci circondavano. «Ricordi che ci troviamo parecchi metri sottoterra, rinchiusi dentro una piramide precolombiana che ha centinaia o migliaia di anni?» «Lasciami, Proxi. Non soffocarmi.» «Non fare il bambino, Root», mi rimproverò con affetto. «Sappiamo che è stato un colpo basso, che sei distrutto, ma non possiamo lasciarti qui, cerca di capire!» «Non soffocatemi», ripetei. Lei sospirò e si rialzò. Pochi istanti dopo sentii che si allontanavano e le loro luci si persero in lontananza. Rimasi solo a riflettere, con la mia lampada come unica fonte di luce, seduto per terra, con le braccia attorno alle ginocchia piegate. A pensare a quell'idiota di mio fratello, a quel decerebrato (e mai parola era stata più appropriata) che era stato capace di commettere un'imbecillità simile. Di colpo capii che non lo conoscevo. Avevo sempre pensato che fosse un po' strano e avesse i suoi lati oscuri, come tutti, ma ora sospettavo che fossero più grandi e più bui di quello che credevo. Mi passarono per la testa molte immagini di lui, frammenti di conversazioni tenute nel corso degli anni e, misteriosamente, le impressioni incomplete e parziali presero a poco a poco la forma di idee concrete che si adattavano meglio ai particolari che non mi ero mai soffermato ad analizzare. Daniel che rideva di me perché avevo ottenuto tutto ciò che avevo senza aver messo piede all'università; Daniel che proclamava davanti alla famiglia che io ero la prova vivente del fatto che non studiare era molto più redditizio che rovinarsi la vista sui libri, come faceva lui; Daniel sempre senza un soldo in tasca nonostante la brillante carriera, e con una compagna e un figlio a carico; Daniel che accettava a denti stretti denaro da nostra madre e rifiutava sistematicamente qualsiasi offerta di aiuto da parte mia... Daniel Cornwall, mio fratello, il tipo che tutti apprezzavano per la cordialità e il sorriso perenne. Sì, d'accordo, ma era chiaro che aveva sempre voluto avere qualcosa di simile a quello che avevo io, e lo voleva senza sforzarsi tanto quanto si sforzava per ottenere molto meno, quasi niente, all'università. Non c'era altra spiegazione. Ora che, sfortunatamente, me ne rendevo conto, ricordavo che Daniel era sempre stato il primo a sostenere quella stupida opinione che la mia famiglia aveva di me, secondo la quale la fortuna mi aveva sempre arriso e mi aveva accompagnato per tutta la vita. Se non mi sbagliavo, in realtà lui aveva solo voluto accelerare un processo che gli risultava gravoso e avvicinare un futuro che gli appariva lontano. Per questo aveva approfittato dell'occasione che gli offriva la dottoressa Torrent con quella ricerca sui quipus in quechua. In qualche maniera aveva scoperto il materiale della professoressa sui tocapus e sull'aymara, e si era reso conto che poteva ottenere molto più rapidamente ciò che il destino gli avrebbe comunque riservato di lì a qualche anno. Anche lui era un vincente, un tipo sveglio che sapeva approfittare della fortuna quando gli si presentava, come me, il furbetto che si era arricchito senza un titolo universitario in tasca. Quasi potevo vederlo mentre parlava con nostra madre alimentando la leggenda in base alla quale io non facevo niente che valesse realmente la pena, e nonostante questo, come si poteva vedere, vivevo sotto una buona stella. Come si poteva spiegare, altrimenti, l'acquisizione della Keralt.com da parte della Chase Manhattan Bank? Che cos'era stato se non un gran colpo di fortuna in cui non c'entrava per niente il valore di ciò che avevo ideato, sviluppato e ingrandito lavorando come un mulo e rubando per anni ore al sonno? Fino a quel momento non mi era mai importato che la mia famiglia la vedesse in questa maniera. Mi infastidiva un po', è vero, ma pensavo che tutte le famiglie avessero le loro manie e non valesse la pena prendersela o lottare contro quella falsa immagine. Per me era sufficiente che mia nonna capisse e riconoscesse la verità. Ma adesso non era più così. Ora la storia acquistava le giuste proporzioni, dato che aveva generato un problema molto più grande: l'infelicità di mio fratello. Era Daniel quello che doveva vedersela con una denuncia per furto se Marta Torrent avesse avuto voglia di presentarla; era Daniel quello che alla fine doveva fare i conti con la sua carriera di docente e ricercatore; era Daniel quello che doveva sopportare la vergogna davanti a nostra madre, nostra nonna, Clifford, Ona e, in futuro, se non si fosse trovata una soluzione, anche davanti a suo figlio. Per non parlare dell'eventualità di dover passare un bel po' di tempo in carcere, la qual cosa avrebbe finito per mandare a picco per sempre la sua vita. Guardai il cerchio luminoso proiettato dalla mia lampada frontale sul pavimento del corridoio e sulla parete di fronte, e presi coscienza di dove stavo e del perché ero lì. Recuperai il contatto con la realtà dopo l'attacco di rabbia e naturalmente il mio primo pensiero fu quello di chiedermi perché diavolo dovevo sopportare tutto questo per aiutare un imbecille come Daniel, ma per fortuna ci riflettei: nemmeno lui si meritava di trascorrere il resto della sua vita ridotto a un vegetale. Nonostante tutto, dovevo cercare di salvarlo. Sarebbe arrivato il momento di chiarire le cose e di contrattare con Marta quello che c'era da contrattare. E io che pensavo di farle causa quando saremmo tornati a casa! Dovevo rimangiarmi le mie parole, le mie intenzioni e i miei pensieri. Bene, quando Daniel ne fosse stato in grado, lui e io avremmo dovuto parlare a lungo, e questa conversazione gli avrebbe lasciato il segno per il resto dei suoi giorni. Con un sospiro mi alzai e mi misi la borsa sulle spalle. In quel momento tre luci si accesero a pochi metri di distanza. «Stai meglio?» chiese la voce di Proxi. «Non eravate andati via?» domandai. «Come facevamo ad andarcene? Sei scemo!» fece notare Marc. «Abbiamo fatto finta, abbiamo spento le lampade e ci siamo seduti ad aspettare.» «Allora su, andiamo», dissi unendomi a loro. Le nuvole nere non scomparvero del tutto dalla mia testa e nemmeno il mio umore migliorò, ma riprendemmo il cammino, in silenzio, e in qualche modo compresi che era ancora importante continuare su quella strada. Poco dopo raggiungemmo l'angolo dove terminava il corridoio e che ci portava a sinistra attraverso un nuovo passaggio. Quando ci imbattemmo nella prima gigantesca testa di puma che sporgeva dal muro della camera, capimmo che eravamo sulla buona strada poiché, secondo la mappa del dio Thunupa, quella parte del tunnel aveva quattro di quelle teste, due delle quali (quelle di mezzo) fiancheggiavano l'accesso alla camera del serpente cornuto. Comunque ci fermammo un po' a esaminarla, per ogni evenienza. Lì però non c'erano tocapus; era solo un'impressionante e spaventosa scultura che, per le orecchie e per il muso, poteva essere un puma ma che, in realtà, sembrava una strana combinazione di un pagliaccio dal naso rotondo con una testa di serpente al posto della bocca. «Penso», osservò Jabba, «che sia uno con una maschera di puma. Capite che cosa voglio dire?» Naturalmente tutti rispondemmo di no. «C'era un dio antico che si metteva una testa di leone a mo' di casco e la pelle gli scendeva sulla schiena.» «Ercole», feci notare. «E non era un dio.» «Va bene, fa lo stesso. Comunque la testa dell'animale lo copriva solo fino al naso e gli lasciava scoperte la bocca e le guance. E questo è quello che sembra questa strana bestia: uno che porta una testa di fiera che gli lascia mezza faccia scoperta. Come una maschera.» E aveva ragione. In effetti, tutta quell'arte taipikalense, o quel che era, appariva molto strana. Potevi guardarla da vari punti di vista e darne interpretazioni diverse, tutte valide. Quella noiosa di Proxi faceva foto su foto come se avesse una capacità illimitata di archiviare immagini; doveva avere la più grande scheda disponibile perché altrimenti non si capiva come fosse in grado di continuare a scattare. Di lì a pochi minuti riprendemmo a circumnavigare la camera del Viaggiatore. Nonostante il mio stato d'animo, non mi sfuggì un particolare: la dottoressa Torrent era molto taciturna e assorta nei suoi pensieri. Mi venne in mente che, forse, avrei potuto avvicinarmi per chiederle scusa per tutte le assurdità che le avevo detto dal giorno in cui mi ero presentato nel suo studio all'università. Ma scacciai subito l'idea dalla testa perché non era né il momento né il luogo e anche perché non ne avevo voglia. Ero già abbastanza nervoso per conto mio per caricarmi di altri fastidi. Finalmente, dopo circa duecento metri, vedemmo sporgere dal muro sinistro la seconda testa di puma. «L'entrata!» esclamò Proxi, raggiante. Quando arrivammo all'altezza della bestiaccia vedemmo che subito dopo c'era una porta gigantesca, o qualcosa che sembrava una porta, perché si trattava di un'immensa e rettangolare lastra di pietra levigata che andava dal soffitto fino al pavimento e che misurava circa quattro metri di altezza per due di larghezza. «Ecco l'altra testa», segnalò la dottoressa Torrent. Effettivamente la grande porta di pietra aveva una testa di puma su ciascun lato, e queste erano esattamente uguali alla prima che avevamo esaminato. «E il pannello di tocapus?» chiese il mio amico. «Forse è sotto la testa», disse Proxi, «come nel primo condor. Buttiamoci per terra.» «Ehi, tu, fermati!» la frenò Jabba trattenendola per il braccio perché non gli scappasse. «Questa volta ti devi comportare bene, d'accordo? Mi sdraierò io per terra.» «E perché?» «Perché ne ho voglia. Sono stufo di doverti salvare da pericoli di ogni genere. Già ne abbiamo superati due e dicono che non c'è due senza tre, quindi spostati.» Proxi andò accanto a Marta mormorando improperi; vidi che la dottoressa sorrideva. Forse stava dicendo qualcosa di divertente, ma non lo capii. Tuttavia l'espressione del suo volto cambiò a una velocità vertiginosa e io mi voltai seguendo il suo sguardo e la sua lampada frontale. Proprio al centro della porta c'era un riquadro con qualcosa dentro. «Aspetta, Marc!» esclamai, avvicinandomi. «Qui c'è qualcosa. Guarda.» Il riquadro si trovava a circa dieci centimetri dalla mia testa, quindi dovetti alzarmi in punta di piedi per vederlo bene. Anche il mio amico, appena più basso di me, riuscì a vedere i minuscoli tocapus mostrati da quella specie di incisione, ma Proxi e Marta Torrent (soprattutto quest'ultima) non avrebbero potuto farlo neanche saltando su un tappeto elastico. Si trattava del pannello di tocapus più piccolo che avessimo trovato fino ad allo- ra, situato, inoltre, a un'altezza veramente scomoda. «Dammi il binocolo, Jabba», sentii dire a Proxi. «È nella mia borsa. Ma non provarci; non funzionerà. Non riusciresti a vedere, è troppo vicino.» «È vero.» «Passami la macchina fotografica, Proxi», dissi. «Scatterò una foto e lo vedremo sullo schermo del computer.» «Buona idea», esclamò lei porgendomi il piccolo apparecchio. Scattai varie istantanee mettendo a fuoco per intuizione, e incominciai a scaricare il contenuto della scheda nel portatile. Proxi aveva fatto esattamente sessantadue fotografie, e per di più ad alta risoluzione, cosicché trascorse un bel po' di tempo prima di poter osservare il contenuto del nuovo pannello sul monitor. Non ricordandomi che Marta leggeva l'aymara perfettamente, pensai che avrei dovuto copiare quei tocapus a uno a uno nel «JoviLoom», ma, in quel momento, quando stavo per esprimere la mia intenzione a voce alta, sentii che cominciava a tradurre il testo. «'Non senti, ladro? Sei morto perché hai giocato a togliere la sbarra dalla porta. Chiamerai urlando il necroforo questa stessa notte...'» «Si fermi, Marta!» esclamò Proxi, allarmata, chiudendo bruscamente il portatile. La dottoressa sussultò. «Che cosa succede?» «Queste parole sono quelle che Daniel stava traducendo quando si è ammalato», le spiegai io. «Ma davvero...» «Posso dirle il resto, se vuole», continuai, «ce l'ho qui tradotto.» E aprii di nuovo il portatile per cercare la copia del documento. «Allora lei conosce anche il segreto dell'aymara, della lingua perfetta?» si affrettò a chiedere Jabba alla professoressa mentre io saltavo da una cartella all'altra. «Certo che lo conosco», rispose lei, passandosi una mano sulla fronte. «Lo ha scoperto mio padre, Carlos Torrent. Dopo aver lavorato per molti anni negli scavi con gli aymaras, questi gli raccontarono in segreto che gli antichi yatiris avevano il potere di guarire o di far ammalare con le parole, di far sì che la gente suonasse strumenti musicali senza averli imparati o di trasformare i cattivi in buoni e viceversa. Secondo gli indios, potevano cambiare lo stato d'animo e persino il carattere o la personalità di chiunque. Erano leggende, è chiaro, ma quando scoprii il sistema di scrittura per mezzo dei tocapus trovai molte allusioni a quel potere e capii che quello che mio padre aveva considerato pura fantasia era vero. I Capacas, i sacerdoti tiwanacotas, conoscevano l'antico Jaqui Aru, il 'Linguaggio umano', che era, praticamente senza variazioni, la lingua aymara che si parlava fino alla conquista dell'altopiano da parte degli incas e degli spagnoli, e che non era cambiata perché era sacra per coloro che la usavano. Purtroppo da quel momento incominciò a recepire piccole influenze dal quechua e dal castigliano. Non era cambiata per niente, ma aveva acquisito alcune parole nuove da queste lingue.» «Ecco qui», la interruppi. «'Non senti, ladro? Sei morto perché hai giocato a togliere la sbarra dalla porta. Chiamerai urlando il necroforo questa stessa notte. Gli altri muoiono dovunque per te. Ahi, questo mondo non sarà più visibile per te! È la legge. Chiusa a chiave'.» «Non è completo», spiegò Proxi alla dottoressa. «Ma Daniel non è riuscito a finire. In quel momento è stato colpito dalla sindrome di Cotard e dall'agnosia.» «A partire da allora, cioè, crede di essere morto», aggiunsi io, «chiede a gran voce di essere sepolto e non riconosce niente e nessuno.» «Già!» affermò lei. «È come una maledizione per chiunque apra quella porta con l'intenzione di rubare. La domanda iniziale dà già l'idea del proposito: 'Non senti, ladro?' È un messaggio per i ladri, per coloro che hanno la precisa intenzione di impadronirsi di ciò che c'è dietro la porta. Gli indios di queste terre non chiudevano mai le case né i templi. Non che non conoscessero le chiavi e le serrature, ma non ne avevano bisogno. Le usavano solo per proteggere i documenti di Stato molto importanti o il tesoro della città. Nient'altro. Si sorpresero molto, infatti, quando videro che gli spagnoli usavano spranghe e catenacci, e pensarono che avessero paura di loro. Ancora oggi, quando un aymara esce, mette un palo all'entrata per segnalare che non c'è e che la casa è vuota. Nessun vicino o amico oserebbe entrare. Se qualcuno toglie quel palo è perché va a rubare, da qui l'espressione usata nell'avvertimento. Penso che questo testo sia come un allarme antifurto: se vieni per portare via quello che non è tuo, ti succederanno queste cose, ma se non hai intenzione di rubare allora la maledizione non avrà effetto, non ti succederà niente. Pensate che è scritta con dei tocapus, quindi, molto probabilmente, voleva impedire l'entrata proprio ai ladri aymaras.» «Non è detto che sia per forza così», obiettai. Mi seccava l'idea che quella maledizione potesse colpire solo i ladri, cioè gente come Daniel. «Anche i pannelli di prima erano scritti in aymara e con i tocapus, e si trattava di rebus o di combinazioni per aprire le teste dei condor o per abbassare delle scale.» «Noi abbiamo un'altra teoria, dottoressa Torrent», spiegò Jabba, che aveva captato quello che si nascondeva dietro la mia obiezione. «Crediamo che colpisca chiunque conosca l'aymara, come Daniel e lei. È un tipo di codice che funziona con suoni naturali, quei diabolici suoni della lingua perfetta che abbiamo sentito al nostro arrivo in Bolivia e che vanno dagli schiocchi della lingua ai gorgoglii e ai versi gutturali. Dei suoni che Daniel e lei potete produrre e capire, persino con la mente, leggendo in silenzio, ma noi no; per questo la maledizione non ci colpisce.» Lei sembrò meditare alcuni secondi. «Sentite», disse infine, «credo che vi sbagliate. Ho studiato l'argomento più a lungo di voi. Per questo ho dato l'incarico a Daniel di portare avanti la ricerca sui nodi, sui quipus in quechua; io non avevo tempo per farlo. Da circa vent'anni mi dedicavo all'aymara e ai tocapus. Deduco che conoscerete anche la storia dei documenti Miccinelli, quindi non entrerò in dettagli. Basti dire che, dal mio punto di vista di capo del dipartimento, Daniel era il ricercatore più dotato per lavorare con Laura Laurencich, la mia collega di Bologna, e inoltre era intelligente, brillante, ambizioso. Gli affidai un incarico che chiunque avrebbe desiderato per il suo curriculum, ho avuto fiducia in lui piuttosto che in altri professori più anziani e con maggiori diritti acquisiti, ma credevo in lui, nel suo grande talento. Ciò che non mi passò per la testa fu che potesse approfittare della libertà di accesso al mio studio e ai miei archivi per rubare un materiale che mi era costato molti anni di lavoro e che in più era ben protetto. O almeno era quello che credevo... Mai mi sarei aspettata questo da Daniel, perciò rimasi di sasso quando lei, signor Queralt, si presentò davanti a me con dei documenti che nessuno, eccetto me, aveva mai visto.» Si fermò alcuni istanti, sorpresa per aver affrontato quell'argomento quasi senza rendersene conto, in maniera indiretta, e mi guardò con una certa aria colpevole. «Ma, tornando a noi», proseguì, «per la mia esperienza dell'argomento, ovviamente molto maggiore di quella di Daniel e della vostra, sono convinta che gli yatiris non avrebbero potuto concepire maledizioni universali, maledizioni che avrebbero potuto colpire persino il redattore del testo. Capite?» Ci guardò come se fossimo dei suoi allievi e lei stesse impartendo una lezione magistrale. «I pannelli delle teste di condor, signor Queralt, non sono proprio lunghi come Don Chisciotte, vero? Nel primo, erano brevi testi di cinque tocapus che per arrivare alla soluzione venivano ripetuti nel pannello seguente, e anche in quello che c'era sotto il becco del condor. Si trattava semplicemente di un insieme di figure che, non so se avete avuto modo di osservarlo, persino a prima vista (esaminando il loro ordine e la ripetizione) portavano a trovare la risposta corretta anche non conoscendo l'aymara. La stessa cosa succedeva con i grandi pannelli della seconda testa: anche qui l'enigma era risolvibile a vista analizzando con attenzione la disposizione delle figure sulle due linee che formavano la X. Qui invece abbiamo un testo completo che inizia con un avvertimento ai ladri che sanno leggere l'aymara. Se, come dice lei, Marc, il contenuto colpisce chiunque sappia pronunciare e capire i suoni di questo linguaggio, gli stessi yatiris e i loro Capacas ne avrebbero subito l'effetto. Credetemi se vi dico che questo strano potere non funziona così. È talmente perfetto che può distinguere con precisione il destinatario specifico di un messaggio da quelli che non lo sono. Per questo penso che dobbiate lasciarmi leggere il testo. Ovviamente non spiegherà il modo di aprire la porta, ma potrebbe comunicare qualcosa di interessante.» Sospirò profondamente e rimase pensosa per un decimo di secondo. «Comunque la cosa peggiore che potrebbe capitare è che voi abbiate ragione e che, pertanto, dopo averlo letto, io possa avere gli stessi sintomi di Daniel.» Scoppiò in una sorprendente risata. «In tal caso, per favore, si affretti a trovare una cura per suo fratello e per me, signor Queralt.» Rimanemmo avviliti dopo il lungo discorso. Che argomenti avremmo potuto addurre per confutare ciò che affermava? Ci scambiammo sguardi dubbiosi e rassegnati e, dopo un gesto affermativo di Jabba, richiamai sullo schermo la foto del pannello della porta e porsi il computer alla professoressa che, senza la minima esitazione, riprese la traduzione dal punto in cui l'aveva lasciata: «Vediamo: 'Dappertutto gli altri muoiono per te e, ahi! il mondo non sarà più visibile per te. È la legge, quella che è chiusa a chiave, quella giusta. Non devi disturbare il Viaggiatore. Non hai diritto di vederlo. Non ci sei più, vero? Ora supplichi che ti diano sepoltura e non riconosci né i tuoi parenti né i tuoi amici. Che queste parole proteggano la nostra origine perduta e il nostro destino'.» Forte! pensai osservando attentamente la dottoressa (e lo stesso stavano facendo Jabba e Proxi). Ma lei era contenta. Non le era successo niente e ci guardava trionfante. «Geniale, non le sembra?» chiese. «Continuo a star bene. Il potere ha indovinato che la mia intenzione non è quella di rubare. O forse io so che non ho intenzione di rubare e per questo non mi ha colpito.» E se non voleva rubare per quale motivo era lì? Tutti eravamo arrivati fino a quella porta con l'intento di appropriarci di qualcosa che non era nostro e che non avrebbe aiutato l'umanità in difficoltà, ma avrebbe solo salvato uno dei ladri contro quelli che la maledizione proteggeva. Ero abituato a seguire la logica di qualsiasi complicato sviluppo di codice, e tanta ambiguità mi sconcertava. C'era solo una spiegazione: che fosse proprio la coscienza a determinare gli effetti delle parole e, quindi, qualsiasi altro elemento non avrebbe modificato le cose. E adesso era indifferente anche il mio vecchio sospetto sulla dottoressa: il fatto che stesse lì, fresca come una rosa, dimostrava che la sua ambizione era unicamente accademica. Tutta quella storia di controllare il mondo, come i cattivi dei fumetti, era sbagliata. Se quella fosse stata la sua intenzione, il furto duro e puro per conquistare il potere, avrebbe fatto la fine di Daniel. E mio fratello purtroppo era finito così perché sapeva di aver rubato il materiale di Marta con quello scopo, anche se ignorava che la maledizione autentica che probabilmente aveva trovato in qualche tessuto (e vai a sapere chi aveva copiato il disegno e da dove lo aveva tratto senza capirlo), si trovava proprio sulla porta della camera del Viaggiatore. Era la cattiva coscienza di mio fratello ad avergli giocato quel brutto scherzo. «A ogni modo...» brontolò Jabba, guardando di traverso l'immensa lastra di pietra levigata, «il problema è che continuiamo a non sapere come aprirla.» «Io lo so», dichiarò Proxi, alzando tutte e due le mani e agitandole come fossero girandole. «Lo sai?» chiesi a bocca aperta. «Non farci caso!» esclamò Jabba con un gesto di rassegnazione. «Si è montata la testa. Si sta esaltando.» «Ma guarda quanto sei scemo! Quando mai ho scherzato con queste cose?» Ora fu Jabba che la guardò sorpreso. «Vuoi dire che sai davvero come aprire la porta?» «Certo!» disse lei molto soddisfatta, ma subito dopo strinse le labbra meno convinta. «Be', almeno credo...» «Perché non ce lo spiega, Lola?» le chiese l'antropologa, molto interessata. Proxi, invece di rispondere, mi fissò socchiudendo misteriosamente gli occhi. Io rimasi sbalordito. «Arnau lo sa. Parla, oracolo.» «Io lo so?» balbettai. «Sei sicura?» «Sicurissima», confermò. «Che cos'hai nella tua borsa che pesa tanto?» Aggrottai le sopracciglia pensoso, e subito ricordai. «La tavoletta di pietra forata.» Marta Torrent assunse un'espressione interrogativa. «Quando abbiamo superato la prima testa di condor», le spiegò Proxi mentre io aprivo la borsa per prendere il reperto, «abbiamo trovato una lastra di pietra, della stessa misura di quel pannello della porta, con dei fori che coincidono, più o meno, con la dimensione dei tocapus del riquadro, e ho idea che, sovrapponendola, scopriremo quello che abbiamo bisogno di sapere.» «Ha ragione», convenne Marta. «Posso vederla?» mi chiese tendendo la mano. Sarei stato molto maleducato a dire di no. «Già. È vero che ha la stessa misura del pannello, e anche i fori hanno la stessa dimensione dei tocapus.» «Perciò», dissi, «o funziona come una maschera che lascia in vista alcuni tocapus che ci diranno qualcosa, o bisognerà premere i tocapus che restano liberi.» «E come sapremo qual è l'orientamento giusto?» chiese Jabba. «Non lo sapremo finché non la sovrapponiamo», affermai. Ma l'operazione non sembrava per niente facile. Io potevo porre la maschera di pietra sul pannello, però in tal caso nessuno poteva vedere i tocapus, e se era Jabba a reggere la pesante lastra allora il poco che vedevo non serviva a niente perché non l'avrei capito. Era troppo rischioso premere i tocapus senza sapere se dicevano o no qualcosa. Poteva succedere come nella prova precedente, il pavimento cominciare a sprofondare o il soffitto caderci sulla testa. Quindi optammo per il vecchio e sicuro metodo della fotografia. Jabba disegnò un puntino nella parte inferiore della pietra con una biro, per segnare l'orientamento, poi la sovrappose al pannello e io scattai la foto con le braccia alzate. Quindi la girammo e ripetemmo l'operazione. Quando scaricammo le due immagini nel portatile, Marta si mise al lavoro. «La prima fotografia non ha senso», commentò scrutando coscienziosamente il monitor, «ma nella seconda il testo sembra molto chiaro: 'Togli la sbarra dalla porta e per te sarà visibile quello che è chiuso a chiave, il Viaggiatore e le parole, origine e destino'.» «D'accordo», mormorai infastidito, «e come facciamo a togliere la maledetta sbarra dalla porta? Bell'aiuto! Non vedo nessuna sbarra.» «Tranquillo!» mi disse Jabba. «Non è necessaria nessuna sbarra. Premeremo i tocapus.'» «E se il pavimento sprofonda?» «Chi non risica non rosica», osservò Proxi. «Lei cosa ne dice, dottoressa?» «Proviamo. Al minimo segnale di pericolo, corriamo via.» «O ci aggrappiamo alle teste di puma», suggerì Jabba. Poiché ero il più alto, toccò a me l'onore di premere uno dopo l'altro i simboli aymara che la maschera lasciava scoperti. Quando pigiai l'ultimo, sentii, all'altezza dell'ombelico, un rumore secco come di aria compressa liberata di colpo. Abbassai in fretta la testa, spaventato, e vidi una barra verticale di pietra, spessa come il manico di una scopa e lunga fino a terra, staccarsi dal resto della porta protendendosi verso di me. «Che paura!» esclamai con il cuore in gola. «Ho pensato che stesse per crollare tutto.» «Scostati, Arnau», disse Jabba. «Facci vedere.» «Un'altra prova dell'abilità dei tiwanacotas», mormorò con ammirazione Marta Torrent. «Non avevo mai visto una struttura di pietra tanto perfetta. Questo pezzo era invisibile fino a un secondo fa.» La lunga barra era fissata al centro a una più piccola, che sporgeva da un foro. «E ora che cosa facciamo?» chiese Jabba. «La facciamo girare, la tiriamo o la spingiamo di nuovo dentro?» «'Togli la sbarra dalla porta e per te sarà visibile quello che è chiuso a chiave'», citò la professoressa. «Lasciate fare a me», intervenne Proxi, mettendosi davanti e muovendo le dita come una pianista o, meglio, come un ladro prima di incominciare a cercare la combinazione di una cassaforte. Ma fu preda dell'ansia quando, non appena prese la barra di pietra e la tirò leggermente, questa si staccò dal suo supporto e le rimase tra le mani, che oscillarono per il peso inatteso. La stava ancora fissando perplessa quando la lastra di pietra dalla quale si era staccata la barra incominciò a cigolare e a stridere mentre una forza meccanica la sollevava pian piano. La camera del Viaggiatore si stava aprendo. Formammo spontaneamente una fila compatta davanti all'apertura che si allargava, uno accanto all'altro, in silenzio, in attesa, pronti ad affrontare le cose più inaudite o strane che avessimo mai visto in vita nostra. La dottoressa Torrent, che fu la prima a vedere ciò che c'era all'interno, si lasciò sfuggire un grido di sorpresa. Davanti a me c'era ancora la pietra e, anche se avessi potuto chinarmi a guardare, ero come paralizzato, e non solo per l'aria fredda che usciva a fiotti da lì. Quando infine la luce si sparse dalla mia fronte per la camera e si perse nel buio profondo, anch'io mi lasciai scappare un'esclamazione di sorpresa: un mare di oro brillante si estendeva per parecchi metri davanti ai nostri piedi fino all'invisibile fondo di quel magazzino da zona industriale preincaica. Un mucchio di lastre d'oro, di circa un metro di altezza per più di un metro e mezzo di larghezza, erano impilate l'una sull'altra, formando file perfette che si addentravano fino al fondo oscuro lasciando uno stretto passaggio al centro. Era impossibile sapere quante di quelle file c'erano da sinistra a destra, perché non se ne vedeva la fine. Vedevamo solo che ce n'era una quantità enorme e che, per tradurre tutto, ci sarebbero voluti anni di duro lavoro e avremmo avuto bisogno della collaborazione di molta gente per ricavarne una storia completa. Quante lastre c'erano in vista, solo in vista? Cinquantamila, centomila? Cinquecentomila? Era una cosa incredibile! Qual era l'inizio? E qual era la fine? Erano classificate in base a un sistema sconosciuto o per temi, per epoche, per Capacas? La dottoressa Torrent fu la prima a entrare. Fece un passo esitante, poi un altro, e si fermò. Il suo volto rifletteva i bagliori dorati che le lampade frontali traevano da quell'oceano aureo sul quale non sembrava che fosse caduto, in cinquecento anni, neanche un granello di polvere. Era affascinata, emozionata. Tese la mano destra per toccare la lastra più vicina a sé ma, siccome non riusciva a raggiungerla, fece un passo avanti, insicura, e continuò ad avanzare come una barchetta in mezzo a una tempesta, infine posò il palmo della mano sul metallo. Vedemmo emanare da lei il raggio azzurro di un arco voltaico che si irradiò fino al soffitto, ma fu solo un'impressione. Piegò le ginocchia e si accovacciò passando le mani sui tocapus incisi sulle lastre con la stessa delicatezza con cui avrebbe accarezzato il cristallo più fragile del mondo. Per lei era il culmine di tutta una vita di ricerca e di studio. Che cosa stava provando quella strana donna, mi chiesi, davanti alla biblioteca più completa e antica di una civiltà perduta su cui aveva indagato per tanti anni? Doveva essere una sensazione straordinaria. Io fui il secondo a entrare nella camera, ma, al contrario della dottoressa, non mi fermai ad ammirare quei testi scritti nell'oro. Continuai a camminare in linea retta attraverso il corridoio accompagnato da Marc e Lola, che guardavano affascinati a destra e a sinistra. L'aria fredda di quel luogo odorava di officina meccanica, di una strana mescolanza di grasso e di benzina. «Che cosa dice la lastra che sta esaminando, dottoressa?» le chiese Jabba avvicinandosi a lei. Con la sua particolare voce da violoncello, Marta Torrent rispose: «Parla del diluvio universale e di ciò che accadde in seguito». Non potei fare a meno di sorridere. Era come se io avessi chiesto a Núria, la mia segretaria, come aveva passato il fine settimana e lei, tranquillamente, mi avesse risposto che era stata a cena nella Stazione Spaziale Internazionale. Per questo risi, una risata incontenibile, per la sproporzione tra la domanda e la risposta. Ma che altro ci si poteva aspettare da una situazione come quella? «Perché ridi, Arnau?» chiese Lola avvicinandosi e scattando fotografie, da quella brava reporter che era. «Rido delle cose che ci stanno capitando», risposi senza riuscire a fermarmi. Allora anche lei rise e Marc la imitò e, alla fine, persino la dottoressa Torrent, che ora ci seguiva, fu contagiata dalle nostre stupide risate che risuonarono e si persero nella camera del serpente cornuto, che, ovviamente, era soltanto un po' più piccola dei lunghissimi corridoi che la circondavano, per questo mi ricordava un magazzino industriale di dimensioni gigantesche. Dopo aver camminato per un bel po' tra quei milioni di lastre d'oro, fui colto da una certa inquietudine: dove poteva trovarsi esattamente la cura per i ladri come Daniel? Quale di quelle lastre dorate spiegava il modo di restituire il senno a uno che si credeva morto e che non riconosceva niente di quello che lo circondava? Mi dissi che era ancora presto per preoccuparsi perché, forse, la dottoressa sarebbe stata in grado di trovare le lastre sulle quali si parlava del potere delle parole. Ma, di fronte a ciò che vedevo, l'intuito mi diceva che quel che pensavo fosse una cosa semplice, dopo tutta la fatica che avevamo fatto per arrivare fin lì, si sarebbe trasformato in un arduo lavoro di molti anni, e per giunta senza garanzia di successo. Da dove diavolo avevamo tratto la convinzione che la cura per Daniel si nascondesse in quella maledetta camera? Al momento, che si sapesse, solo una persona al mondo, la dottoressa Torrent, poteva leggere l'aymara, e neanche nei suoi sogni più belli sarebbe stata capace di portare a termine un compito di un'entità simile; solo per introdurre quei dati in una montagna di computer che avessero utilizzato una versione migliorata del maledetto «JoviLoom», ci sarebbe voluta l'intera popolazione di Barcellona... e avrebbe dovuto lavorare sodo per diversi lustri. Mi sentii cadere le braccia; decisi di non demoralizzarmi anzitempo e di continuare a camminare fino al termine del corridoio per vedere se gli yatiris avevano deciso di lasciare il rimedio farmaceutico un po' più a portata di mano. Giungemmo a metà della camera come naufraghi che remano alla deriva per un'eternità, ma alla fine scorgemmo in fondo un muro lontano, e questo ci incitò ad affrettare il passo perché, con l'aiuto delle piccole ma potenti torce Mini-Maglite, ci era parso di individuare, ai piedi della parete, qualcosa di simile a un container su cui c'erano molte casse. Man mano che ci avvicinavamo l'immagine si faceva più nitida, ma non per questo capimmo di che cosa si trattasse; non somigliava a niente che potessimo identificare a prima vista. Neanche quando fummo a un passo riuscimmo a definire quello che stavamo vedendo. Fu necessario arrivare fin lì, salire sul gradino di pietra e chinarci, per capire che quello che avevamo preso per un altare era un enorme sarcofago d'oro di alcuni metri di lunghezza per uno di altezza, quasi identico a quelli dei faraoni egizi, tranne che qui l'estremità del catafalco era appuntita. Le quattro casse, che all'inizio ci era parso fossero situate sul presunto altare, erano altrettante bare di dimensioni non comuni, collocate su mensole di pietra che sporgevano dalla parete ad altezze diverse. Incassate nel muro, ai lati del sarcofago principale, c'erano due lastre della stessa dimensione della grande pedana; quella di sinistra conteneva un testo con tocapus; quella di destra il disegno di ciò che sembrava un paesaggio cubista. In quel preciso istante un suono assordante ci fece voltare a tutta velocità verso il punto da cui venivamo. «Che diavolo succede?» gridò Jabba. Per un momento temetti che crollasse tutto, ma il rumore era molto localizzato, ritmico, individuabile... «La porta si sta chiudendo!» urlai. «Scappate!» esclamò Jabba incominciando a correre per il corridoio trascinando Proxi per mano. Né io né la dottoressa Torrent li seguimmo. Era inutile. La porta era troppo lontana. A quel punto il rumore cessò. «Tornate qui», dissi ai due fuggiaschi mettendo le mani sulla bocca a mo' di megafono. «Ormai non possiamo più uscire.» Ritornarono a capo chino, furiosi. «Perché non abbiamo previsto che potesse accadere qualcosa di simile?» mormorò Marc, trattenendo a malapena la rabbia. «Perché non siamo tanto svegli come gli yatiris», gli disse la dottoressa Torrent. Passato il momento di sconcerto, rivolgemmo lo sguardo ai sarcofagi d'oro. Osservavamo con attenzione quelle casse dorate e ciascuno di noi si chiedeva in silenzio come diavolo saremmo usciti da lì. Tanto per fare qualcosa, salimmo sul gradino di pietra e rimanemmo inebetiti, senza sapere che dire né che fare davanti a quelle sagome scolpite sui coperchi dei sarcofagi (per lo meno del principale e dei due situati più in basso). Figure molto realistiche rappresentavano dei tipi strani che, se era vero ciò che vedevamo, dovevano misurare circa tre metri e mezzo di altezza, esibire delle belle barbe e aver subito la deformazione frontoccipitale. «I giganti?» mormorò Lola, impaurita. Ma nessuno rispose alla sua domanda semplicemente perché non ci usciva la voce. Se erano i giganti, la cronaca degli yatiris aveva detto la verità. In tutto. «Non può essere..,» borbottai infine di malumore. «No, non può essere! Aiutami, Jabba!» gridai spostandomi verso un lato del sarcofago principale e infilando le dita tra la cassa e il coperchio per alzarlo. Erano lisci al tatto, ma gelati. Marc mi seguì come un'ombra, anche lui di malumore, e con la forza della rabbia riuscimmo a sollevare quel pesante coperchio d'oro che all'inizio scivolò con facilità per poi cadere pesantemente al suolo dall'altro lato con grande frastuono. Un'improvvisa e sorprendente zaffata di benzina mi salì al naso. La voce della dottoressa ci scosse. «Vi rendete conto della stupidaggine che avete appena fatto?» disse molto tranquilla. Lola le era andata vicino e sembrava anche lei arrabbiata. «Avreste potuto mandare in malora per sempre una seria e delicata ricerca su questa urna. Nessuno vi ha mai detto che non si deve toccare niente quando si fa una scoperta archeologica?» «Avete appena fatto la stronzata più grande del mondo», dichiarò Proxi appoggiando le mani sui fianchi e fulminando Jabba con lo sguardo. «Non c'era nessuna necessità di aprire il sarcofago.» Io non ero disposto a sentirmi colpevole. «Sì che c'era», assicurai con voce vibrante. «Non mi importa se, una vol- ta usciti da qui, verrà un esercito di archeologi a sigillare questo luogo per i prossimi cento anni, ma ora è nostro e abbiamo lavorato molto duramente per trovare una cura che restituisca il senno a Daniel. E sai una cosa, Proxi? Non credo che la troveremo... non qui», e tesi il braccio destro comprendendo lo spazio che avevamo alle spalle. «Oppure tu saresti in grado di individuare le lastre d'oro che ci possano spiegare il modo per farlo? Se dentro questo sarcofago c'è un gigante, voglio almeno andarmene con la certezza che gli yatiris dicevano la verità e che abbiamo una speranza. Se non c'è, potrò tornare a casa con la coscienza tranquilla e stare ad aspettare che le medicine e il tempo facciano effetto.» Appena finito di parlare, abbassai lo sguardo per osservare il sarcofago scoperchiato e quasi schiattai dalla paura: un largo volto d'oro mi contemplava con vuoti occhi felini da una testa di dimensioni straordinarie dalla quale sporgeva un cranio conico con un copricapo fatto interamente di pietre preziose. Alle orecchie aveva degli enormi cerchi d'oro con turchesi. Il mio sguardo percorse quel corpo interminabile e si fermò a osservare un pettorale molto deteriorato di perline bianche rosse e nere che disegnavano raggi solari attorno alla figura dell'Humpty Dumpty di Piri Reis, e su questo pettorale poggiava un'incredibile collana fatta di piccole teste umane d'oro e d'argento. Le braccia della mummia erano scoperte e lasciavano vedere una pelle molto sottile e incartapecorita sotto la quale si scorgeva un osso quasi polverizzato. I polsi, invece, erano coperti da larghi braccialetti fatti con piccole conchiglie che il tempo aveva rispettato, non come le mani gigantesche che invece sembravano artigli d'aquila carbonizzati poggiati su un torace che sporgeva dal pettorale d'oro. Le dimensioni di ciascun osso, che pareva disegnato con la sabbia, facevano veramente paura. Notai che Lola e Marta Torrent mi erano venute vicino e percepii il ritrarsi istintivo dei loro corpi. Le gambe del Viaggiatore - poiché quello era, senza dubbio, il famoso Sariri che gli yatiris tanto proteggevano - erano addobbate da un tessuto con frange, molto consunto, sul quale si poteva ancora distinguere il disegno originale di tocapus; e i piedi, gli enormi piedi, calzavano sandali d'oro. Avevamo di fronte i resti del Viaggiatore, un gigante di oltre tre metri che confermava, da un lato, il mito di Viracocha, il dio inca, il cosiddetto «vecchio del cielo», che aveva creato nelle vicinanze di Tiwanacu una prima umanità che non gli era piaciuta, una razza di giganti che aveva distrutto con colonne di fuoco e con un terribile diluvio, lasciando il mondo al buio; e, dall'altro lato, avvalorava la cronaca degli yatiris. Questa soste- neva che dal cielo era discesa una dea chiamata Oryana la quale, in seguito all'unione con un animale terrestre, aveva partorito un'umanità di giganti che vivevano centinaia di anni e che, dopo aver costruito e abitato Taipikala, erano scomparsi in seguito a un terribile cataclisma che aveva spento il sole e provocato un diluvio, lasciandoli infermi e debilitati fino a trasformarli nell'umanità piccola e dalla vita breve che ora eravamo. Marc espresse ad alta voce quello che io avevo in mente. «Ciò che mi infastidisce è che, alla fine, la Bibbia ha ragione con la storia del diluvio, proprio ora che nessuno ci crede più.» «Come no, Marc?» esclamò la dottoressa Torrent continuando a osservare il Viaggiatore. «Io ci credo. Anzi, sono assolutamente convinta che sia accaduto davvero. Ma non perché la Bibbia narri che Jahvè, scontento dell'umanità, abbia deciso di distruggerla con un diluvio durato quaranta giorni e quaranta notti, ma perché il mito di Viracocha racconta esattamente la stessa cosa, e anche la mitologia mesopotamica, nel Poema di Gilgamesh, dove si narra che il dio Enlil mandò un diluvio per annientare l'umanità e che un uomo chiamato Ut-Napishtim fabbricò un'arca nella quale mise in salvo tutti i semi e le specie animali del mondo. E se ne parla anche nella mitologia greca e in quella cinese, dove un tale Yu costruì per tredici anni degli enormi canali che salvarono parte della popolazione dal diluvio. Non le basta?» chiese, voltandosi verso di lui. «Nei libri sacri dell'India, il Bhagavata Purana e il Mahabharata, si narra del diluvio in tutti i particolari, e si ripete la storia dell'eroe e della sua barca salvatrice. Anche gli aborigeni dell'Australia hanno il mito del Gran Diluvio che distrusse il mondo per poter creare un nuovo ordine sociale, e pure gli indiani del Nordamerica raccontano una storia simile, e gli eschimesi e quasi tutte le tribù dell'Africa. Non le sembra curioso? A me sì. Molto.» Insomma, tante coincidenze non potevano essere una casualità. Forse era vero che c'era stato un diluvio universale, forse i libri e i miti sacri avevano bisogno di una revisione scientifica, una lettura laica e imparziale che svelasse la storia autentica trasformata in religione. Perché negargli a priori ogni validità? Forse contenevano verità importanti che noi ci stavamo rifiutando di accettare solo perché sapevano di superstizione e di incenso. «E quando si suppone che sia avvenuto?» chiese Jabba. «Questo è un altro dato interessante», commentò la dottoressa mentre si chinava a esaminare il gonnellino con frange del Viaggiatore. «Si potrebbe dire che quasi tutte le versioni sono abbastanza concordi: tra gli ottomila e i dodicimila anni fa.» «Alla fine dell'era glaciale...» mormorai ricordando improvvisamente la mappa del pirata turco, il nostratico, la misteriosa sparizione di centinaia di specie in tutto il pianeta (come il cuvieronius e il toxodonte) eccetera. Ma la dottoressa non mi ascoltava. «'Questo è Dose Capaca, che intraprese il viaggio a seicentoventitré anni'», lesse a voce alta. «È quello che dice il tessuto che copre le gambe?» chiese Proxi chinandosi verso i fragili resti del gigante. «Sì», rispose Marta Torrent, «ma forse il tessuto e alcuni degli oggetti sono posteriori di vari secoli al corpo. Non possiamo saperlo.» Colpita da un'idea improvvisa, la professoressa si diresse verso la lastra d'oro con tocapus incassata nella parete, alla sinistra dei sarcofagi. Vi si fermò davanti, alzò la testa per illuminare le incisioni e incominciò a tradurre: «'Avete appreso come si scrive la lingua degli dei e state leggendo queste parole? Meritate di conoscerne anche i suoni. Venite a cercarci. Né la morte del sole né l'acqua torrenziale né il trascorrere del tempo ci hanno distrutto. Venite e vi aiuteremo a vivere. Dite: veniamo a cercarvi perché vogliamo apprendere. Non portate la guerra perché non ci troverete. Vogliamo che portiate solo il desiderio di conoscenza'». La sua fantastica voce da annunciatrice radiofonica aveva impresso un tono solenne alle parole del messaggio, per cui Marc, Lola e io rimanemmo a bocca aperta. «È uno scherzo, vero?» osservai riprendendomi con sforzo. «Non credo, signor Queralt.» «Ma... è impossibile che esistano ancora. Questo lo hanno scritto prima di andarsene e non sembra probabile che sopravvivano da qualche parte aspettando l'arrivo di qualche visitatore che passi di qui e legga il messaggio.» «Di quei tipi ormai non rimane niente!» ruggì Marc. «Qualcuno li avrebbe già visti e lo avrebbero detto nei telegiornali. Inoltre il messaggio non ha alcun senso. Incomincia con una domanda ridicola che invalida tutto il resto. Tutto ciò è opera di qualche truffatore.» «Perché è ridicola la domanda con cui inizia il messaggio?» volle sapere la professoressa rivolgendosi a lui. «Perché... come fanno a sapere che la gente arrivata fin qui ha imparato a leggere queste lastre d'oro? Se non sappiamo neanche come uscire da questa piramide! Se non ci fosse lei o non avessimo il 'JoviLoom' di suo marito, nessuno di noi vivrebbe abbastanza a lungo da poter decifrare que- sta maledetta scrittura dei tocapus.» Jabba sembrava veramente arrabbiato. Malgrado il freddo, sul collo e sulla schiena della sua maglietta c'erano grandi chiazze di sudore. «Le ricordo che siamo chiusi qui dentro e che non mangiamo ormai da molte ore. Se non troviamo il modo di tornare in superficie creperemo in pochi giorni, tempo insufficiente e condizioni fisiche pessime per chi deve imparare una lingua senza aiuto.» «Non è così, Marc», replicò lei aggrottando la fronte. «Guardi il muro. Osservi con attenzione questi disegni.» E indicò l'alta striscia di bassorilievi che correva lungo tutta la parete di blocchi di pietra. Come automi cominciammo a camminare lentamente esaminando le figure composte da un grande tocapu seguito da una scena di arte tiwanacota nella quale se ne rappresentava il significato come in un manuale scolastico che serve per imparare a leggere. «Notate che il primo tocapu del muro è anche il primo che compare nel messaggio», ci spiegava Marta Torrent, «e il secondo e il terzo che formano, come potete vedere attraverso il disegno, il verbo capire o comprendere con i suffissi di terza persona e di azione realizzata o di passato remoto, sono anche il secondo e il terzo del testo eccetera. Mi ero accorta, leggendo il contenuto della lastra, che il messaggio era stato scritto esclusivamente con tocapus a contenuto figurativo e simbolico. Nessuno di questi rappresentava il suono di una lettera o di una sillaba fonetica. Il messaggio era molto ben studiato per essere rappresentato in forma figurata sulla parete. Osservate, per esempio, questo omino che incide con un piccolo martello e uno scalpello la lastra. Il tocapu precedente è la radice del verbo scrivere.» «Sarebbe a dire», intervenni io continuando a camminare, «che gli yatiris lasciano un messaggio che si può tradurre o, almeno, capire parzialmente in poco tempo. Danno per scontato che devono rivolgere il loro invito a gente che non conosce la loro lingua né la loro scrittura. Avevano pensato molto bene a tutto. Ma, se i conquistadores fossero arrivati fin qui? Immaginate per un momento Pizarro che entra con il suo cavallo in questa camera. Credete che nessuno si sarebbe reso conto che queste figure erano un sillabario litografico?» «Ne dubito molto, signor Queralt», mi rispose la professoressa, affascinata come me dalle straordinarie rappresentazioni incise sulle pareti. «Innanzi tutto, perché gli yatiris si sono dati tanta pena a nascondere questo luogo, e non è necessario che le ricordi tutto quello che abbiamo dovuto fare per arrivare in questa camera. Ma, anche se Pizarro vi fosse arrivato (e per fortuna ciò non è avvenuto, altrimenti non sarebbe rimasto niente di tutto questo), non sarebbe stato in grado di capire quello che vedeva. Era analfabeta, non conosceva le lettere e il loro funzionamento e, come lui, si può supporre, nemmeno il suo esercito di ruffiani e avventurieri. Forse qualche sacerdote che conosceva il latino ci sarebbe riuscito, ma sarebbe arrivato dopo che tutto l'oro era stato fuso in lingotti e mandato in Spagna; non si sarebbe vista né la lastra della parete con il messaggio né l'altra, che rappresenta una mappa e che non abbiamo ancora esaminato.» Come spinti da una molla, tutti e quattro girammo su noi stessi senza battere ciglio, e la cosa ci fece sorridere; riprendemmo il cammino verso i sarcofagi finché non li raggiungemmo e ci collocammo di fronte alla lastra. «Senti, Proxi», dissi passandole un braccio attorno alle spalle. «Perché non scatti qualche foto al signor Dose Capaca e non a questa mappa?» «Alla mappa, sì», rispose lei, «al gigante non oso. So che la luce potrebbe danneggiarlo. Nei musei non ti lasciano fare fotografie.» «Ma solo perché vogliono che compri le cartoline all'uscita!» esclamò Jabba. «No, Marc, no», si allarmò la professoressa. «Lola ha ragione. La luce concentrata del flash potrebbe alterare le proprietà chimiche della mummia avviando processi biologici di decomposizione. Io vi pregherei, anzi, di rimettere a posto la copertura del sarcofago per non danneggiare ulteriormente il Viaggiatore con l'ossigeno.» «A proposito...» mormorai rivolto verso la professoressa, prendendo Jabba per un gomito e portandolo verso il sarcofago per obbedire all'ordine. «Perché questo posto sa di benzina? Non lo ha notato?» «Non si preoccupi, signor Queralt. C'è una spiegazione logica. Nel processo di mummificazione praticata in questa zona dell'America del sud si utilizzavano il bitume, ottenuto come residuo della distillazione del petrolio, e delle resine di vario genere che, unite al bitume e sottoposte al processo di affumicamento, producono un forte odore di olio da motore anche dopo centinaia di anni.» «Dopo migliaia di anni, dottoressa», scandì Jabba ansimante, aiutandomi a riporre il coperchio sul sarcofago. «Perché questi sono gli anni che ha questo Capaca nelle ossa.» Proxi, intanto, fotografava la strana mappa disegnata nella seconda lastra d'oro. «Non so che dirle, Marc», mormorò Marta Torrent. «Non sono una bio- archeologa, e le mie conoscenze sulla mummificazione si limitano alle tecniche impiegate nel periodo del Perù incaico. Comunque è sorprendente che il corpo si sia conservato in queste condizioni. Non sono in grado di immaginare quali arti abbiano impiegato gli yatiris per far sì che durasse otto o diecimila anni. Mi sembra assolutamente straordinario. In realtà, direi che è inaudito.» «Be'! Inaudito o no», replicai tornando vicino a lei, «tutto questo locale sa di benzina, nonostante i cinque corpi giacciano chiusi in pesanti sarcofagi d'oro.» Lei rimase in silenzio per alcuni istanti, poi si pizzicò il labbro inferiore tra il pollice e l'indice in un gesto molto peculiare che mi ricordava mia madre nel momento di recitare la pantomima intitolata «Sto pensando intensamente». «Quando incontreremo gli yatiris», disse infine con estrema calma, «glielo chiederemo. Va bene?» Jabba scoppiò in una sonora risata che risuonò per tutta la sala. «Molto bene, dottoressa, molto bene!» disse. E continuò a ridere come un matto, senza rendersi conto che Lola, Marta Torrent e io lo guardavamo assolutamente seri. «Che cosa c'è?» domandò infine sorpreso, asciugandosi le lacrime. «Non vi siete divertiti?» All'improvviso una luce illuminò il suo cervello. «Ah, no! Proprio no!» esclamò a pieni polmoni. «Non credo che vi seguirò in questa follia. Ma se non sappiamo nemmeno come uscire da qui! Vi manca forse qualche rotella?» Continuammo tutti e tre a guardarlo senza sorridere. Dovevamo sembrare un trio di pazzi pericolosi che contemplavano freddamente la loro vittima prima di andarle incontro con intenzioni criminali, ma per fortuna non c'erano testimoni che potessero raccontarlo, salvo Jabba, certo, e lui potevamo farlo tacere facilmente corrompendolo con una bustarella. «Su una cosa ha ragione», sottolineò Proxi. «Dobbiamo prima uscire da qui.» «Giusto!» fu il mio intelligente contributo. «Allora su! Muoviamoci!» scherzò Marc sedendosi sul gradino di pietra che reggeva il sarcofago. «È molto tardi e ho fame. Sono anche stanco e ho bisogno di una doccia quando arriveremo in albergo. Oh, ma... sono le undici e mezzo di sera, ora locale! È meglio fermarsi qui, che cosa ve ne pare? Ci facciamo una dormitina e domani mattina vedremo il da farsi.» «Taci, Marc», gli ingiunse Proxi prendendo posto accanto a lui. «Non dicevi che i pannelli dei tocapus del secondo condor avevano risvegliato la tua parte di animale informatico? Allora, perché non metti in moto quel magnifico cervello di hacker e non analizzi la situazione come se fosse la sfida di un codice?» Mi lasciai cadere a terra davanti a loro, e aprii la borsa. «Si segga con noi, dottoressa Torrent», le dissi. «Forse qualcosa succederà.» «Potrebbe cominciare a chiamarmi soltanto Marta», rispose lei sedendosi con le gambe incrociate accanto a me. Faceva freddo in quel maledetto posto. «Va bene, ma sappia che a me piaceva molto che mi chiamasse signor Queralt. Nessuno mi chiama mai così.» Jabba e Proxi risero. «È che non hai l'aspetto di un signore, Arnauet», celiò Proxi. «Con quella chioma, quell'orecchino e quel pizzetto da cavaliere dell'Ottocento sembri un poeta romantico o un pittore piuttosto che un uomo d'affari.» Le sciocchezze proseguirono ancora per alcuni minuti. Come altre volte da quando era cominciata quella strana storia, avevamo bisogno di rilassarci. Eravamo esausti, ed era piacevole dimenticare per un momento la realtà che ci circondava, sarcofagi inclusi. Ma, alla fine, restammo in silenzio. «Non abbiamo percorso tutto il perimetro della camera», feci notare dopo un po'. «Certo», confermò il mio amico. «Forse stiamo perdendo tempo, e invece c'è una bella porta socchiusa da qualche parte.» «Non sognare», gli disse Lola accarezzandogli i capelli e mettendogli a posto una ciocca scomposta. «Be'! Qualcosa di simile», insisté lui. «Un buco nel soffitto o qualcosa del genere. Penso che dovremmo separarci. Siamo quattro, no? Ciascuno segue una parete. Se non troviamo niente...» «Non è una buona idea», lo interruppi. «Quello a cui tocca la parete con la porta deve percorrere il corridoio o uno dei lati per arrivare, e sarebbe una perdita di tempo. Propongo di dividerci in due gruppi. Partiamo da qui, dai sarcofagi, poi ciascun gruppo percorre un lato e ci incontriamo vicino alla porta. Verifichiamo se si apre, altrimenti torniamo qui attraverso il corridoio e ricominciamo. Dev'esserci per forza un'uscita.» La mia idea fu accettata perché, ovviamente, era molto buona, ma non ci fu l'occasione per metterla in pratica. Prima di separarci, ci venne in mente di esaminare la pedana di pietra del sarcofago del Viaggiatore e il risultato fu che, proprio dove Jabba aveva poggiato i piedi per togliere e rimettere il coperchio, c'era un nuovo pannello di tocapus. Incredibilmente lo aveva calpestato senza accorgersene e, per fortuna, non era successa nessuna disgrazia. Se l'ambiente fosse stato illuminato, lo avremmo individuato subito, ma poiché l'unica luce era quella delle lampade frontali, la zona dietro al sarcofago era rimasta per tutto il tempo nella più totale oscurità. «Ha un senso, Marta?» chiese Lola, chinandosi. La professoressa diede un'occhiata e assenti. «'Avete già appreso come si scrive la lingua degli dei? Venite a cercarci e vi aiuteremo a vivere. Non portate la guerra perché non ci troverete. Vogliamo che portiate solo il desiderio di conoscenza.'» «Ma non è la stessa cosa che dice la lastra d'oro?» si arrabbiò Jabba. «Non esattamente.» Marta corrugò la fronte e rimase a guardare il piccolo pannello, pensierosa. «È solo una parte del messaggio originale», e allungò il collo a sinistra per osservarlo. «Sono frasi del messaggio, ma non ci sono tutte.» «Bene», risi. «Siamo di nuovo in marcia. Mettiamo in moto i cervelli.» «E quali frasi mancano?» chiese Proxi. Marta Torrent, torcendo di nuovo il collo, le mise in evidenza... «Manca un pezzo della domanda iniziale, esattamente la parte che dice'... e state leggendo queste parole'. E poi manca questa frase completa: 'Meritate di conoscerne anche i suoni'. La frase seguente la mantiene, ma la fonde con la quinta, componendone una sola e facendo sparire 'Né la morte del sole né l'acqua torrenziale né il trascorrere del tempo ci hanno distrutto'. Manca anche il sesto enunciato, 'Dite: veniamo a cercarvi perché vogliamo apprendere', e poi il resto è uguale.» «Non ha né capo né coda!» mormorò Proxi. «Non credo che la chiave sia in quello che manca», replicai, «bensì in quello che rimane.» «E anche questo non ha né capo né coda», protestò Jabba, tirando fuori dai pantaloni la maglietta per sedersi più comodamente a terra. «Potrebbe ripeterlo, Marta?» «'Avete già appreso come si scrive la lingua degli dei?'» rilesse lei con voce spenta. «'Venite a cercarci e vi aiuteremo a vivere. Non portate la guerra perché non ci troverete. Vogliamo che portiate solo il desiderio di conoscenza'.» «Qui gatta ci cova», mormorai lisciandomi il pizzetto nervosamente. «La sento miagolare però non la vedo.» La dottoressa si avviò verso il suo zaino e ne trasse una piccola borraccia che mandò riflessi metallici alla luce delle torce. Di colpo mi resi conto di essere più assetato di un deserto. «Volete un po' d'acqua?» ci offrì. «Sono molte ore che non beviamo.» «Sì, per favore!» si lasciò scappare Proxi con tutto il cuore. Che trio di idioti! Come mai non avevamo pensato di portarci dell'acqua? Una bussola Silva ultimo modello, un coltello multiuso Wenger e un binocolo Bushnell, ma, all'ora della verità, né acqua né cibo. Complimenti! «Non ce n'è abbastanza per quattro», si scusò la dottoressa, «quindi, per favore, bevetene poca.» Ricordo l'angoscia che provai quando il liquido mi scivolò in gola e mi cadde, freddo, nello stomaco vuoto. Riuscivo solo a pensare che o ci sbrigavamo o, come aveva detto prima Marc, in poche ore saremmo stati in pessime condizioni fisiche. «Non avrà anche qualcosa da mangiare, vero, Marta?» le chiese il mio amico con un'espressione del viso che mostrava quanto fossero cupi i suoi pensieri. «No, mi dispiace. Ho solo dell'acqua. Ma stia tranquillo», gli disse incoraggiante, «non ci fermeremo qui a lungo. Dobbiamo risolvere solo un piccolo enigma, e oggi ne abbiamo risolti molti, quindi non c'è da preoccuparsi.» Di colpo, una luce si accese nel mio cervello, proprio dietro alla lampada frontale. «E se anche questo enigma si potesse risolvere osservando i pannelli, Marta?» le chiesi. «Ha affermato che, analizzando l'ordine, la disposizione e la ripetizione dei tocapus si poteva trovare la risposta corretta.» Lei inarcò le sopracciglia, sorpresa, e sorrise. «Può darsi che lei abbia ragione, Arnau.» «Se si tratta di un codice», affermai aprendo il portatile, «sono molto bravo.» «E anche noi!» proruppe Jabba. «Hai fatto qualche foto del testo della lastra d'oro, Proxi?» «Sono ancora nella macchina fotografica, assieme a quelle della mappa.» «Allora scattane una del pannello che c'è per terra», le chiesi io, «e poi le confronteremo sul monitor. Se c'è una struttura logica, la troveremo.» E la trovammo. La professoressa aveva ragione. Tutti gli enigmi degli yatiris si potevano risolvere sia attraverso il contenuto sia attraverso la forma. Quei tipi, se ancora esistevano, dovevano essere veramente svegli e strani. Con l'immagine della lastra da una parte e quella del pannello dall'altra, scoprimmo una ripetizione (solo una) che dava la risposta al problema. Era talmente semplice e chiara che meravigliava per la sua composizione. Avrei dato un mucchio di soldi per assumere alla Ker-Central lo o la yatiri che aveva messo insieme quel rompicapo. Si partiva da un'idea molto semplice: c'era una frase che offriva la chiave, che era la chiave, e che, al tempo stesso, conteneva l'idea fondamentale del messaggio, e questa frase era: «Dite: veniamo a cercarvi perché vogliamo apprendere». I tocapus con i quali era scritta erano gli unici che si ripetevano nel testo, sparsi qui e là nelle frasi del breve messaggio. Per questo le avevano scelte, separandole dall'insieme. «Veniamo a cercarvi» si formava con i tocapus che comparivano in «Venite a cercarci e vi aiuteremo a vivere», e bisognava solo invertire i segni che indicavano le persone dei verbi. «Perché» si trovava, tale quale, in «Non portate la guerra perché non ci troverete». «Vogliamo» era l'inizio dell'ultima frase: «Vogliamo che portiate solo il desiderio di conoscenza», e «apprendere» era il tocapu radice di «appreso» in «Avete già appreso come si scrive la lingua degli dei». Semplice e chiaro, come deve essere un buon codice. Quando prememmo in sequenza i tocapus che formavano la frase, il pannello si divise in due assieme alle parti di quello che fino a quel momento era stato un unico e gigantesco blocco di pietra, e, come le saracinesche di una sentina, i lati sprofondarono e lasciarono in vista una minuscola scala di pietra che scendeva verso il fondo. Anche se può apparire strano, ormai queste cose non ci impressionavano più. Eravamo sfiniti, distrutti e, soprattutto, cercavamo disperatamente di uscire dalla maledetta Piramide del Viaggiatore che già avevamo avuto il piacere di salutare. Sentivamo il bisogno di tornare alla superficie e di vedere il cielo, di respirare aria pura, di cenare abbondantemente e di buttarci sul letto per dormire dodici o quindici ore senza interruzione. Scendemmo la scala senza voler prestare attenzione al piccolo dettaglio che stavamo sprofondando ancora di più nella terra invece di risalire, ma durò poco. Dopo una ventina di gradini ci trovammo in uno stretto corridoio roccioso che proseguiva in linea retta, e che andò avanti in linea retta per un'ora. E poi, per due. E quando stava già per trascorrere la terza ora ci rendemmo conto che ave- vamo già lasciato dietro di noi Tiwanacu-Taipikala e che dovevamo trovarci a vari chilometri di distanza in direzione ovest, in base a ciò che diceva la bussola. Finalmente, già verso le quattro del mattino, più morti che vivi, ci imbattemmo in altre scale che risalivano. Ma prima, ovviamente, non poteva mancare la sorpresa finale. Avevo appena poggiato il piede sul primo gradino - io ero davanti agli altri - dopo aver verificato che non fosse coperto da muschio e non fosse scivoloso, quando la voce roca e snervata di Jabba, alle mie spalle, mi scosse dal letargo. «Root, ti sei perso qualcosa.» Mi voltai, più per guardare lui che per capire a che diavolo si riferiva sembrava un fagotto, con le occhiaie e un orribile ombra rossiccia di barba sul volto trasparente - e vidi che, senza muoversi, indicava una specie di nicchia aperta nella parete a mezza altezza, situata proprio all'inizio della scala. Indietreggiai di un passo e mi piazzai davanti alla cavità, prendendo dalla tasca la piccola torcia Maglite perché non ero in grado neppure di chinare la testa per illuminare il buco. Lì, come nel leggio che avevamo scoperto dopo aver superato la prima testa di condor, c'era un altro oggetto di pietra che diceva «prendetemi». Era un semplice cerchio, una lastra rotonda di circa venti centimetri di diametro e di quattro o cinque di altezza, bucata nel centro come un grosso e pesante braccialetto. La professoressa, l'ultima della fila, sorpassò Proxi, che non si era scomposta, e si fermò accanto a Jabba per osservare l'oggetto. «Avete notato che ha una freccia incisa?» esclamò con voce stanca. Era vero. Il cerchio di pietra mostrava una punta di freccia molto semplice - due linee che convergevano all'estremità - scolpita nella parte superiore. «Dobbiamo portarci via questa ciambella?» s'informò Jabba sprezzante. Aveva indubbiamente fame. «Io direi di si», risposi. «Ma, questa volta, non tocca a me perché io già mi sono caricato l'altra tavoletta.» «Che faccia tosta hai», si lamentò, ma lo prese con la mano destra e, quando lo sollevò, si udì un rumore di ruote dentate e di pulegge in cima alle scale. Senza darci il tempo di reagire, un'improvvisa folata di aria fresca ci sfiorò e penetrò dal naso nei polmoni. «L'uscita!» esclamai felice, e, senza pensarci, mi lanciai su per le scale con il cuore a mille. Dovevo uscire da quel buco. La prima cosa che vidi fu il cielo meravigliosamente pieno di stelle. Non ne avevo mai viste tante. E poi, tutto intorno a me, l'aperta campagna, completamente buia. Subito dopo sentii un freddo mortale, come se mi avessero messo in un congelatore. Incominciai a starnutire per il brusco cambiamento di temperatura e, mentre gli altri stavano uscendo all'aperto e si stavano riprendendo dalla claustrofobia, consumai diversi fazzoletti di carta per quell'improvviso raffreddore. Dovevamo essere a vari gradi sotto zero, e indossavamo solo i vestiti leggeri del giorno prima. Di lì a poco, anche Jabba e Proxi incominciarono con gli starnuti, e la cosa si trasformò in un concerto. Soltanto Marta pareva in piena salute, quasi immune al gelido freddo notturno dell'altopiano. La vidi guardare in una direzione e nell'altra, molto tranquilla, e infine decidersi per la seconda. «Il paese di Tiahuanaco non è molto lontano», disse, iniziando a camminare attraverso quella buia steppa siberiana. Noi, con i fazzoletti in mano, la seguimmo come agnellini mansueti. «Come fa a saperlo?» le chiesi tra uno starnuto e l'altro. «Perché quel picco lì», e indicò un'immensa e lontana ombra quasi impossibile da riconoscere nel buio della notte, «è l'Illimani, il monte sacro degli aymaras, e il paese si trova da quelle parti. Conosco bene questo luogo. Giocavo qui da piccola.» «In questa landa?» si sorprese Lola. «Sì, in questa landa», mormorò Marta continuando a camminare. «Venni per la prima volta in Bolivia con i miei genitori a tre mesi. Rimanevo a Barcellona solo durante l'anno scolastico, e fu così finché mi sposai, ebbi i miei figli e mi laureai. Si potrebbe dire che sono mezza boliviana. I miei amici erano i bambini di Tiahuanaco, e i nostri genitori ci lasciavano liberi di correre tutto il giorno per questa campagna. Trentacinque anni fa da queste parti non sapevamo neanche che cosa fosse un turista.» Marc, Lola e io battevamo i denti seguendo con passo leggero la professoressa. Impiegammo poco più di mezz'ora ad arrivare alla periferia del paese e ci avviammo all'albergo di don Gastón, che rimase di stucco quando ci vide comparire alla porta del suo locale così poco vestiti. Quando riconobbe Marta, ci invitò a entrare e svegliò tutta la casa. Ci portarono coperte e un brodo caldo, e accesero il camino gettandovi legna come se si dovesse alimentare una nave a vapore. Marta diede a don Gastón delle spiegazioni succinte che l'uomo accettò senza fiatare. Poi ci accompagnò nelle nostre stanze e ci promise che nessuno sarebbe venuto a disturbarci per nessuna ragione al mondo. Barcollando mi feci una doccia prima di andare a letto e poi, finalmente, mi addormentai come un sasso. IV Mi svegliai attorno alle cinque del pomeriggio e, quando scesi nella sala da pranzo, Marc e Lola erano già pronti e mi aspettavano, tranquilli, leggendo i quotidiani boliviani. Mentre facevo colazione, mi raccontarono che la professoressa era andata via dopo aver mangiato e aveva lasciato un biglietto per noi con un numero di telefono, pregandoci di metterci in contatto con lei al nostro ritorno a La Paz. Don Gastón, da buon amico di Marta, ci fece pagare la cifra minima per la permanenza di un giorno senza extra né consumazioni, e ci procurò uno dei pochi taxi che c'erano in paese per tornare a La Paz. Viaggiammo in compagnia di due cholas con la treccia nera e la bombetta che caricarono nel portabagagli due grosse pezze di stoffa multicolore e non aprirono bocca per tutto il tragitto; probabilmente gli mancava l'aria perché nei sedili posteriori c'eravamo anche Proxi e io (per Jabba non ci sarebbe stato posto). Quando attraversammo le porte del nostro hotel, ci sentimmo a casa. Sembrava così strano pensare a tutto ciò che ci era successo che optammo semplicemente per non pensarci più. Era come se ci fosse un buco nel tempo. Potevano essere passati mesi o anni, perché le ore si erano dilatate in modo straordinario e non riuscivamo a credere che fosse trascorso soltanto un giorno dal momento in cui eravamo usciti di lì. Il buco era anche nelle nostre teste. Salimmo nell'ascensore in silenzio ed entrammo tutti e tre nella mia stanza. Marc sembrava preoccupato. «Che cosa me ne faccio della ciambella?» mi chiese una volta chiusa la porta. Lola si gettò sul sofà e, senza pensarci due volte, accese il televisore. Voleva recuperare la ragione e la stupida scatola le restituiva una certa sensazione di normalità. «La metteremo in cassaforte.» Le nostre stanze disponevano di casseforti nascoste negli armadi. Non erano certo un modello di sicurezza, ma offrivano una minima garanzia per gli oggetti di maggior valore. Prima di andarmene vi avevo riposto i miei orologi del capitano Haddock. «Ci mettiamo anche il portatile e la macchina fotografica di Proxi?» «Vuoi perdere di vista le prove, forse?» gli chiesi mentre prendeva posto davanti allo scrittoio e accendeva il computer. «Dobbiamo scaricare tutte le immagini che rimangono nella scheda di memoria della fotocamera e copiarle su un CD. Metteremo poi tutto al sicuro nella cassaforte assieme alla ciambella. Il resto dell'apparato rimane fuori, così possiamo continuare a lavorare.» «Hai ancora voglia di proseguire con la solfa di prima?» mi chiese Lola con tono aggressivo dal sofà. «No, ti assicuro che l'unica cosa che voglio è uscire a fare due passi, cenare, andare in un locale in cui cantino dal vivo e, una volta lì, bermi tutta la birra che hanno a disposizione.» «La metà dello stock è mia», mi avvertì Jabba. «La metà», acconsentii. «Solo la metà.» «Che sciocchezze state dicendo?» si stupì Proxi. «Ma se voi non bevete!» «Cara Lola», le dissi. «Non me ne importa niente. Voglio ubriacarmi lo stesso.» «E io pure», aggiunse il mio amico. Naturalmente non lo avremmo fatto perché non ci piaceva l'alcool (salvo in occasioni speciali e nelle feste comandate nelle quali, come tutti, sapevamo godere di un bicchiere di buon vino o di un po' di spumante), ma fare una simile dichiarazione a voce alta e in modo così fermo e così tipico di uomini audaci e decisi ci dava un grande conforto interiore, ed era un'autentica riaffermazione della nostra virilità. Mentre trasferivo tutte le foto, i dati e i documenti nel CD, Marc andò in camera sua per fare una doccia e cambiarsi. L'unico movimento di Lola era quello del suo pollice destro per cambiare canale con il telecomando. Quando presi il cerchio di pietra per riporlo nella cassaforte assieme al CD, notai che nella parte posteriore aveva un buco molto strano, un incavo a forma di triangolo con due lati uguali e il terzo più corto e un po' curvo verso l'esterno, come un formaggino. Pensai di mostrarlo a Lola, ma ero sicuro che, se lo avessi fatto, mi avrebbe morso, così, senza esaminarlo ulteriormente, lo misi al sicuro. Poco prima di uscire dall'hotel, Jabba propose di telefonare a Marta. Pian piano ci riprendevamo e ritornavamo a essere persone, ma continua- vamo a non pensare a tutto ciò che ci era accaduto nelle catacombe di Taipikala. «Non chiamiamola oggi», risposi. «Domani è un altro giorno.» «Ma ci sta aspettando. Chiamala almeno per dirle che parleremo domani.» «Non scocciarmi!» «Chi ha il numero di telefono?» insisté testardo. «Ce l'ho io», disse Proxi. «E non te lo darò. La penso anch'io come Root: domani è un altro giorno. Ora andiamo a cenare nel miglior ristorante di La Paz. Ho bisogno di aria inquinata, di alta cucina, di molta gente attorno a me e di traffico.» «Mi metto in lista», dissi avanzando verso l'esterno mentre il portiere ci apriva la strada. Ma Jabba non desistette. Continuò ad assillarci mentre camminavamo godendoci la zona moderna di La Paz, con i suoi alti edifici, le strade piene di traffico, i semafori - ai quali naturalmente nessuno faceva caso -, le luci della città che si accesero proprio all'inizio della nostra passeggiata, la gente che parlava al cellulare, le insegne pubblicitarie luminose che lampeggiavano dai tetti... Insomma, le meraviglie della civiltà. Ma il mio amico non riusciva ad accettare che Marta Torrent stesse aspettando una chiamata che non arrivava. Nominare Marta non solo mi teletrasportava alla Piramide del Viaggiatore, ma anche all'arrabbiatura per la storia di Daniel, e quindi mi si rivoltavano le budella tutte le volte che quel noioso tirava fuori l'argomento. Alla fine, disperando di farlo tacere, tirai fuori il cellulare e tra un piatto e l'altro di squisito cibo europeo feci il numero sul biglietto che Lola mi aveva passato attraverso la tavola. Mi rispose la voce di un uomo con un forte accento boliviano, che subito, quando dissi chi ero e chiesi di Marta, mi mise in comunicazione con lei. Era tutto molto surreale. Erano appena trascorse alcune ore da quando ci eravamo separati da quella donna e la situazione era imbarazzante perché ero passato dal detestarla con tutto il cuore a sentirmi colpevole di fronte a lei; con l'aggiunta sgradevole del fatto che l'esperienza vissuta insieme aveva creato dei legami di confidenza che in quel momento non mi sembravano per niente reali. Era come chiamare una ex fidanzata con cui sei rimasto in cattivi rapporti e che, improvvisamente, devi incontrare per una questione urgente. «Dove siete, Arnau?» fu la sua prima frase. Già la voce mi innervosì. «A cena in un ristorante», risposi togliendomi il tovagliolo dalle gambe e posandolo sul tavolo per mettermi più comodo. «In quale ristorante?» «Il La Suisse.» «Ah, ma siete proprio qui, a Sopocachi!» «Sì. A cena.» «Vi farebbe piacere prendere un caffè in casa di amici miei quando finite?» Ero tentato di risponderle di no con rudezza, ma mi controllai. Premetti il tasto di esclusione del microfono, guardai i miei amici e riferii loro la proposta. «Marta Torrent ci invita a prendere un caffè dopo cena. Che cosa ve ne pare?» «Dove?» chiese Marc; Proxi fece una faccia scocciata e disse ripetutamente di no con il capo. «In casa di amici suoi.» «Per me va bene», rispose il verme che si stava ingozzando di formaggi svizzeri. «Che te ne pare, Proxi?» «È un'ora che dico di no. Non mi hai visto scuotere la testa?» «Be', allora niente. Dille di no, Root, che ci vediamo domani.» Lasciai il tasto del muto e appoggiai di nuovo il cellulare all'orecchio. «La casa dei suoi amici è molto lontano da qui?» chiesi. «No! Proprio accanto a dove state cenando», rispose Marta. Proxi mi guardava con un grande punto interrogativo sul volto. «Mi dia l'indirizzo e arriveremo entro un'ora.» E guardai l'orologio. «Alle dieci e mezzo in punto.» Quando terminai avevo un coltello davanti al naso. «Non eravamo rimasti che fino a domani non ne avremmo fatto niente?» chiese Proxi con una luce minacciosa negli occhi neri. Assentii dolorosamente. «E allora?» Il coltello si avvicinò di alcuni millimetri. «Sono curioso», mi giustificai con goffaggine. «Marc voleva andare e io voglio sapere perché la professoressa ci tiene così tanto a vederci questa sera stessa. Ho pensato che poteva essere importante. Inoltre», aggiunsi abbassando lo sguardo sul piatto, «prima la finiamo con questa storia, meglio è. Non possiamo rimanere a vivere in Bolivia, e mio fratello è ancora in ospedale.» Nominare Daniel provocò un imbarazzante silenzio. «Se riusciamo...» balbettò Proxi pochi istanti dopo. «Se riuscissimo...» «A guarirlo?» l'aiutai a terminare. «Sì», mormorò guardandomi negli occhi. «Che farai? Come gestirai la situazione?» «Non ne ho idea. Suppongo che prima dovrò parlare con la professoressa per chiederle che cosa ha intenzione di fare, se aprirà un'inchiesta amministrativa o qualcosa del genere. Dopo vedremo. In questo momento», tergiversai, «non lo so, non riesco a pensarci.» «Forse, se offri una grossa quantità di denaro alla facoltà...» insinuò Jabba. «Marta Torrent non sembra una persona che si fa comprare», lo interruppe Proxi. No, non lo sembrava assolutamente. Rimanemmo zitti ancora un po', quindi parlammo di cose poco importanti finché non uscimmo dal ristorante. Passeggiammo fino alla plaza de Isabel la Católica e svoltammo nella calle Pedro Salazar fino al centro San Francisco, un insieme di case residenziali in stile coloniale che conservavano una certa aria andalusa, con muri bianchi, finestre chiuse da grate e piante dappertutto. Quando suonammo il campanello, la luce di una telecamera a circuito chiuso ci illuminò. «Hola», disse la professoressa. «Seguite la strada principale fino in fondo e, a destra, vedrete la casa. Si chiama 'Los Jazmines'.» Il centro residenziale sembrava abitato da gente benestante. Il viale che stavamo percorrendo era pulito, illuminato e ornato da vasi di fiori su entrambi i lati. La casa «Los Jazmines» era una villetta di due piani con il tetto rosso e un portone di legno a due battenti. Uno di questi era aperto e lasciava intravedere Marta con il volto sorridente e una nuova immagine che faceva dimenticare l'Indiana Jones degli scavi, con quella camicetta bianca ricamata in rosso e una gonna rossa e attillata che la trasformavano di nuovo nella docente dell'Università Autonoma. «Avanti», disse con cordialità. «Come state? Avete riposato?» «Non abbastanza», replicò Proxi con un sorriso affabile (e ipocrita). «E lei?» «Oh, io sto benissimo!» esclamò cedendoci il passo. Dietro di lei, una coppia piuttosto bizzarra ci aspettava con le mani tese. «Vi presento. Lei è la dottoressa Gertrude Bigelow e lui è suo marito, l'archeologo Efraín Rolando Reyes, con il quale lavoro a Tiwanacu da quasi vent'anni. Vero, Efraín?» «Anche di più!» scherzò lui. «Piacere di conoscervi, amici», aggiunse. Efraín Rolando era il tipo calvo con il quale Marta era entrata nel ristorante di don Gastón il sabato precedente, quando l'avevamo incontrata per la prima volta, quello con gli occhiali e la barbetta brizzolata. La moglie, la dottoressa Bigelow, era una nordamericana alta, snella e sgraziata, dai capelli ondulati color paglia raccolti in uno chignon, e coperta, perché non si poteva dire vestita, con un lungo saio estivo a fiori. Tutti e due indossavano sandali di cuoio. «Gertrude», spiegò Marta, «è medico, per questo ho detto dottoressa. Non come Efraín e me che siamo dottori in discipline umanistiche.» Mi sentivo sempre a disagio quando conoscevo gente nuova e dovevo essere gentile con degli sconosciuti. Per me era un autentico mistero l'ansia del mondo intero di uscire e mettersi in relazione con gli uni e con gli altri, e più erano meglio era, né capivo perché avere molti amici fosse considerato una vittoria... e l'inverso una sconfitta, chiaro. Feci lo sforzo abituale e strinsi la mano all'archeologo e alla dottoressa mentre Marta portava a termine le presentazioni. Poi ci invitarono a entrare in salotto, un'ampia stanza zeppa di strani e brutti oggetti d'arte tiwanacota. Sul lungo sofà bianco, una grande fotografia incorniciata delle rovine scattata al tramonto, in bianco e nero, dava un'idea precisa della passione di quel tale Efraín. Ci sedemmo attorno a un tavolo basso e quadrato di legno chiaro - come tutti i mobili di quella sala - e la dottoressa Bigelow, facendo un gesto a Marta perché rimanesse con noi e non la seguisse, sparì discretamente dalla porta. «Vi metterò al corrente», disse la dottoressa Torrent. «Efraín e Gertrude sanno già tutto di quello che abbiamo scoperto la notte scorsa. Efraín e io abbiamo condiviso per molti anni lo stesso interesse per la cultura tiwanacota e per i suoi grandi misteri, e siamo stati complici in questa ricerca i cui documenti, Arnau, sono stati trovati nel mio studio da suo fratello.» «Rispetto a questo, Marta...» incominciai a dire, ma lei alzò una mano come un vigile urbano e mi interruppe. «Non discutiamone adesso, Arnau. Ci sarà tempo per farlo. In questo momento le uniche due cose importanti sono, da un lato, restituire la salute a Daniel, e, dall'altro, continuare con la ricerca dal punto in cui ci troviamo ora. Faremo tabula rasa e, dato che abbiamo interessi comuni, lavoreremo tutti con spirito collaborativo. Che ve ne pare?» Annuimmo senza aprire bocca anche se, curiosamente, Jabba, Proxi e io approfittammo dell'occasione per cambiare di posizione contemporanea- mente. «Non preoccupatevi per ciò che è capitato a Daniel», disse l'archeologo. «Soprattutto lei, Arnau. Quello che Marta e io vorremmo è che tutti lavorassimo assieme lasciando da parte questo argomento. È molto facile giudicare da fuori, come faccio io, lo so, ma le assicuro che ricordare la faccenda può solo turbare il progetto. Meglio concentrarsi sulle cose importanti, non è d'accordo?» Noi assentimmo di nuovo e cambiammo ancora posizione. In quel momento ritornò la dottoressa Bigelow reggendo un vassoio. Marta ed Efraín si chinarono per togliere dal tavolo tutte le cianfrusaglie e le riviste, e i minuti seguenti trascorsero nella distribuzione delle tazze, dei tovaglioli, dei cucchiaini, del caffè, del latte e dello zucchero. Quando finalmente tutti fummo serviti e comodi, inclusa la nordamericana, riprendemmo la conversazione. «Questo Paese», spiegò Marta, «è ricco di leggende sulle antiche civiltà che sopravvivono nascoste nella giungla. La regione amazzonica si estende su sette milioni di chilometri quadrati, il che significa che l'America Latina è occupata da foreste quasi nella sua totalità e che soltanto le coste oceaniche sono abitate; la grande maggioranza dei Paesi condividono queste mitologie. L'esistenza di grandi tesori, di culture millenarie, di mostri preistorici, fa parte in generale del folclore dell'America Latina. Senza andare troppo lontano, non dobbiamo dimenticare la leggenda di El Dorado o Paitití, la famosa città d'oro che si suppone si trovi, in base alle nuove frontiere, qui in Bolivia. Naturalmente, nessuno crede realmente a queste cose, non in modo ufficiale, ma la verità è che i governi che condividono la giungla amazzonica inviano ripetutamente spedizioni alla ricerca di miniere d'oro e tribù di indios sconosciute.» «E hanno successo?» chiesi con un sorriso ironico, sorriso che si interruppe di colpo quando bevvi il primo sorso di caffè. Nella mia vita lo avevo assaggiato molte volte e carico! Era proprio il meraviglioso caffè della Bolivia o in quella casa amavano il cianuro? «Sì», mi rispose la dottoressa Bigelow, sorprendendomi perché fino a quel momento non aveva aperto bocca. «Si, hanno successo. Io stessa ho fatto parte dell'equipe medica in un paio di queste spedizioni e siamo sempre ritornati con materiale interessante. In tutte e due abbiamo individuato piccoli gruppi di indios di tribù sconosciute che sono fuggiti quando ci hanno visto, dopo averci lanciato delle frecce. Non vogliono avere contatti con i bianchi.» Parlava con un forte accento nordamericano, molto nasale, addolcendo le «erre», ma senza traccia della musicalità e delle espressioni boliviane. Forse tutte e due le cadenze erano incompatibili sulle sue labbra, nonostante la fluidità con cui articolava il castigliano. «Si suppone che esistano ancora nella foresta un centinaio di gruppi di indios con cui nessuno è mai venuto in contatto», ci spiegò l'archeologo. «In effetti il Brasile, essendo il Paese che possiede la maggior parte della giungla, ha delle vaste riserve di territori dove sia i cercatori d'oro sia le industrie del legno e quelle petrolifere sia i cacciatori di frodo non possono entrare perché lì ci sono stati avvistamenti casuali di tribù sconosciute. La politica attuale è quella di preservarli dal contatto con la civiltà per evitare la loro distruzione, poiché, tra le altre cose, li contageremmo con le nostre malattie e potremmo annientarli.» «Be', Efraín», obiettò sua moglie, poggiando la tazza sul vassoio, «il fatto che la creazione di riserve riesca a tenere lontano gli indesiderati non è assolutamente vero.» «Lo so, tesoro!» replicò lui sorridendo. «Ma questa è la teoria, no?» La calvizie lucida dell'archeologo mandava riflessi quando muoveva la testa. Io sentivo ancora in gola l'amaro della terribile bevanda, e avevo la bocca piena di fondi di caffè. «Sentite, amici», continuò Efraín accarezzandosi la barba, «il mondo intero pensa che sia stato scoperto tutto, rappresentato in carte geografiche e identificato. Non c'è niente di più falso e lontano dalla verità. Ci sono ancora luoghi sulla Terra dove i satelliti non arrivano e dove non sappiamo cosa ci sia, e la foresta amazzonica è una parte importante di questi luoghi. Lo chiamano vuoto geografico.» «Un tempo si chiamava Terra Incognita», fece presente Marta bevendo un sorso del suo caffè. Mi aspettavo che vomitasse o facesse una smorfia di disgusto, ma sembrò che le piacesse molto. «Cercate di trovare una mappa della foresta boliviana», ci sfidò Efraín, che dimostrava una cinquantina d'anni. «Non la troverete. Non esiste!» «Io non ho mai visto questi buchi... vuoti geografici di cui lei parla in nessun atlante o mappamondo», dichiarò Jabba. «Per convenzione si riempiono del colore del territorio che li circonda», chiarì l'archeologo. «Non ha mai sentito parlare della lunga ricerca delle sorgenti del Nilo nel XIX secolo?» «Certo!» rispose Marc. «Ho visto molti film e mi sono cavato gli occhi su vecchi videogiochi sull'argomento. Burton, Stanley e tutta quella gente, no?» L'archeologo non rispose alla domanda. «Lei sa che al giorno d'oggi, in pieno XXI secolo, nell'Amazzonia ci sono moltissimi fiumi dei quali si ignora la sorgente? Sì, non si sorprenda. Le ho già detto che i satelliti non possono vedere tutto e, se la giungla è molto folta, come realmente è, risulta impossibile sapere che cosa ci sia sotto. Lo stesso fiume Heath, senza andare tanto lontano! Nessuno sa da dove nasca, tuttavia è tanto importante da segnare la frontiera tra il Perù e la Bolivia.» «Va bene», obiettai, «ma tutto ciò a che cosa ci porta?» «A sostenere l'ipotesi che gli yatiris esistono», dichiarò Marta senza scomporsi, «che molto probabilmente sono sopravvissuti durante tutto questo tempo e che, pertanto, organizzare la nostra spedizione di ricerca non è una follia come quella di Lope de Aguirre.»20 «Lei dimentica un piccolo dettaglio, Marta», ribattei con sarcasmo. «Non sappiamo dove siano gli yatiris, cioè, non sappiamo se sono nella selva amazzonica. Non le sembra un po' azzardato dare per buona una simile supposizione? Forse si sono nascosti in qualche grotta delle Ande o tra gli abitanti di un villaggio. Perché no?» Lei mi guardò inespressiva per alcuni secondi, incerta se farmi comprendere la mia ignoranza e stupidità in un modo delicato o no. Per fortuna, si trattenne. «Che cattiva memoria ha, Arnau! Forse non si ricorda della mappa di Sarmiento de Gamboa?» mi chiese con un sorrisetto ironico appena accennato. «Lei me ne ha portato una copia nello studio, quindi deduco che l'avrà esaminata, non è vero? Io ho trovato quella mappa disegnata da Sarmiento sopra una tela che si è rotta, negli archivi del Deposito Idrográfico di Madrid circa sei anni fa. Ricorda il messaggio? 'Sentiero degli indios yatiris. Due mesi per terra. Io, Pedro Sarmiento de Gamboa, dico che ciò è vero. Città dei Re, ventidue di febbraio del millecinquecentosettantacinque'.» Rimasi inebetito. Era vero: le mie indagini sopra quella mappa piena di segni che sembravano orme di formica mi avevano portato fino all'Amazzonia, anche se in quel momento non mi era sembrato un dato importante perché non ne comprendevo il significato. «Bastava sovrapporre la mappa rotta su una cartina della Bolivia», aggiunse Marta, allungandosi sul sofà, «per scoprire che rappresentava il lago Titicaca, le rovine di Tiwanacu e, partendo da lì, un sentiero che si addentrava chiaramente nella selva amazzonica. Sono convinta che sia assolutamente fattibile iniziare la ricerca degli yatiris.» Lola che, contrariamente alle sue abitudini, era rimasta persino più zitta della dottoressa Bigelow, si chinò in avanti e lasciò la tazza sul tavolo, senza assaggiare il beveraggio, esibendo una faccia molto stanca. «Lo avevamo già pensato quando eravamo dentro alla camera del Viaggiatore, Marta», ricordò, «ma ora qui, in città, mentre beviamo un caffè, le cose sembrano differenti. Le ricordo che la mappa che abbiamo trovato sulla lastra d'oro era solo un disegno fatto con linee e punti sul nulla. Mi dispiace, ma credo proprio che sia una follia.» «Non abbiamo ancora studiato a fondo quella mappa, Lola», replicò calma l'antropologa. «E non abbiamo esaminato tutto il materiale fotografico che lei ha preso molto opportunamente nella piramide. Noi, e mi riferisco a Gertrude, a Efraín e a me stessa, siamo disposti a provarci. Efraín e io perché abbiamo passato tutta la vita a lavorare su questo argomento, e Gertrude perché, come lei stessa vi ha raccontato, conosce la foresta e la questione degli indios con cui nessuno ha avuto contatti, ed è convinta che potremmo incontrare gli yatiris. Se voi non volete venire, vi chiederei di lasciarci tutto il materiale di cui disponete.» Mi fissava senza battere ciglio, in attesa di una risposta. «In cambio io», aggiunse di fronte al mio ostinato silenzio, «dimenticherei la faccenda di Daniel, ovviamente entro certi limiti. Ma potremmo trattare.» Ora la riconoscevo. Era di nuovo la Marta Torrent con la quale ero entrato in intimità nel suo studio all'università. Quando si mostrava così cinica mi sentivo bene, rassicurato, in grado di parlarle negli stessi termini e di portare avanti la gara in condizioni di parità. Persino il fatto di vederla di nuovo con la gonna, gli orecchini e il largo braccialetto d'argento, mi aiutava a collocarla nel posto giusto. «Aspetta, Marta», mi anticipò la dottoressa Bigelow. «È giusto che dimentichi la storia di Daniel, se è quello che vuoi, ma non gli hai lasciato fare le sue considerazioni sulla spedizione. Forse non ci sarà bisogno di nessuna negoziazione. Che ne dite?» chiese a tutti e tre. Stavano giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo per disorientarci oppure era di nuovo la mia sfiducia verso l'essere umano in generale? «Che cosa ne dici, Arnau?» mi chiese Lola, ma Marc mi anticipò ancora una volta. «Noi vogliamo solo guarire Daniel dalla maledizione aymara. Se voi intendete andare nella foresta, è un vostro problema, però potremmo darvi i documenti in cambio della cura, cioè, se ci portate il rimedio...» «Lascia fare a me, Marc», lo interruppi. Il mio amico era lanciato e, in fondo, voleva evitare a tutti i costi che fossimo coinvolti in uno strano viaggio nella selva amazzonica. Potevo capirlo, ma non ero d'accordo con lui. «Quando abbiamo cominciato questa conversazione, Efraín e lei, Marta, ci avete offerto di lavorare in gruppo. Avete parlato di collaborazione. Ora vedo che quello che volevate in realtà era prendervi il materiale e tenerci lontani da questa storia.» «Questo non è vero», protestò l'archeologo. «Glielo posso assicurare. Già sapete quanto sia impulsiva Marta. A priori non si fida di nessuno. È vero, amica mia?» «È vero, Efraín», mormorò lei, e aggiunse, come per scusarsi: «Sono andata troppo avanti. Mi dispiace. Ho l'abitudine di anticipare i pensieri degli altri e so che per voi un viaggio nella foresta è impensabile. Per questo sono arrivata alla conclusione che avreste rifiutato l'offerta di unirvi alla nostra spedizione e ho avuto paura che vi portaste via il materiale o che non voleste condividerlo con noi». Rilassai i muscoli e mi tranquillizzai. Io, al suo posto, avrei pensato la stessa cosa. Solo non sarei stato tanto diretto. Potevo però capire la sua diffidenza. «Be', che cosa ne pensate?» ci chiese la dottoressa yankee. «Venite con noi?» Jabba aprì la bocca in modo ostentato per dire qualcosa ma, altrettanto ostentatamente, Proxi gli propinò un tremendo pestone che fece male persino a me. Il mio amico chiuse la bocca di colpo. «Io vengo», risposi molto serio. «Non mi piace assolutamente l'idea, ma penso che ci dovrei provare. È mio fratello che ha bisogno di aiuto e, anche se sono sicuro che voi fareste tutto il possibile per trovare la cura che gli serve, non potrei restarmene tranquillo ad aspettare. Inoltre, e perdonatemi se sono troppo sincero, se per caso non la trovaste, penserei che è stato perché non vi ho accompagnato, perché voi non avete prestato l'attenzione necessaria o perché, non essendo il vostro obiettivo principale, lo avete trascurato senza rendervene conto. Quindi devo venire, ma non posso parlare a nome dei miei amici... loro hanno già fatto molto e devono prendere da soli una decisione.» Guardai Marc e Lola e aspettai. Jabba, con la fronte aggrottata, rimase muto. «Li conteresti come giorni di ferie?» mi chiese Lola, sospettosa. «Certo che no», ribattei, offeso. «Non sono così stronzo.» «Scusa, Arnau, però bisogna sempre diffidare dei capi, in particolare se sono amici. Sono i peggiori.» «Non so da che pianeta tu venga, figlia mia», replicai molto scocciato, «ma non credo che tu abbia motivo di lamentarti di me.» «No, se non devo averlo», affermò lei pacata. «Ma mia madre mi ha insegnato fin da piccola che le precauzioni non sono mai troppe, e come esperta di sicurezza informatica lo confermo. Be', se non li conti come giorni di ferie, allora veniamo con te.» «Anch'io dovrò dire la mia, no?» protestò Jabba. «Non sono d'accordo con questa decisione che è stata presa a nome mio. Io non voglio andare nella foresta. Neanche morto penso di andare in un posto tanto pericoloso! Mi piace molto la natura, è vero, però sempre che sia una natura normale, europea... senza animali selvatici né tribù di indios che lanciano frecce all'uomo bianco.» Proxi e io ci guardammo. «Arnau è più fifone di te», lo incoraggiò lei, «eppure ci andrà senza protestare.» «Lui ha il fratello ammalato e io no.» «Va bene», disse Lola, cambiando atteggiamento, «allora non venire. Andremo Root e io. Tu puoi tornartene a Barcellona ad aspettarci.» Questo argomento sembrò colpirlo. L'idea di essere separato dal gruppo, emarginato, restituito a Barcellona come un pacco e, soprattutto, il fatto che Lola vagabondasse per il mondo senza di lui, correndo il rischio di cadere tra le braccia di un altro (la foresta, si sa, è molto afrodisiaca e i selvaggi molto magri e attraenti), era più di quello che potesse sopportare. Fece una faccia da orfano pentito e uno sguardo perduto e lamentoso. «Come faccio a lasciarti andare senza di me?» si lagnò debolmente. «E se ti succede qualcosa?» «Di sicuro qualcuno mi darà una mano, non ti preoccupare.» Marta, Efraín e Gertrude ci guardavano sconcertati. Non erano ancora sicuri se la scena che si svolgeva davanti ai loro occhi era un conflitto serio o una cretinata qualsiasi. Con il tempo sarebbero arrivati ad abituarsi e a non dargli la minima importanza, ma in quel primo colloquio sembravano confusi. Bisognava fare qualcosa. Non era neanche giusto trascinare una situazione di imbarazzo per i nostri anfitrioni. «Su, smettila di fare l'idiota», lo ammonii. «Vieni e basta. Sai che Lola non ammetterà mai che ha paura di andare senza di te.» «Che cosa?» si sorprese lei. «Arnau, tu sì che sei idiota.» Le feci un significativo cenno di intesa perché capisse la mia manovra, ma sembrò non accorgersene. «D'accordo, verrò», concesse Marc. «Però le spese sono tutte a tuo carico.» «Certamente.» Marta, che aveva già avuto occasione di conoscere (un po') Jabba dentro la piramide, fu la prima a reagire. «Molto bene. Allora, deciso. Andremo tutti e sei. Siete d'accordo di trovarci qui domani per iniziare a lavorare sulla mappa d'oro?» Io assentii. «E i suoi scavi a Tiwanacu?» chiesi. «Sospesi fino al nostro ritorno per formalità burocratiche», disse Efraín con un largo sorriso sulle labbra. «E ora volete un bel sorso di acquavite di Tarija? È la migliore che abbiate mai assaggiato, ve lo assicuro!» Con il nostro apparato informatico al completo e con il materiale che avevamo preso dalla piramide (ciambella inclusa), il giorno seguente prendemmo un taxi e ci presentammo a metà mattinata in casa di Efraín e Gertrude. Marta alloggiava sempre lì quando si trovava in Bolivia; era come una seconda casa per lei poiché, come ci disse, passava in Bolivia almeno sei mesi all'anno. Io mi chiesi che tipo di matrimonio fosse il suo, con un marito che viveva nelle Filippine e lei che passava da un estremo all'altro del mondo nella direzione contraria. Ma in fin dei conti quello non era un problema mio, anche se Proxi non si astenne dal lavorare di fantasia sull'argomento per alcuni giorni. Quel mercoledì, 12 giugno, era fresco e autunnale, per cui non ci dispiacque sacrificarlo per esaminare la benedetta mappa cubista della camera. Dovevamo trovarle un senso, per cui Efraín era ricorso, già di buon mattino, a tutti i suoi conoscenti e amici dei ministeri e dell'esercito per scovare la cartografia più dettagliata della Bolivia esistente fino a quel momento. Un paio di borsisti di Tiwanacu e una recluta la portarono poco dopo il nostro arrivo, e ci colpì osservare l'enorme quantità di zone del Paese, specialmente dell'Amazzonia boliviana, che comparivano vuote e con la scritta «Senza dati». Quelle cartine certamente non erano semplici. Erano le migliori e le più dettagliate carte ufficiali del Paese, quindi non avevano perso tempo a colorare i vuoti geografici. Ci sembrarono particolarmente scoraggianti gli ingrandimenti delle zone inesplorate chieste da Efraín. E fu osservando quei vuoti bianchi che capii quello che ci aveva detto la sera prima: il mondo non è stato esplorato nel- la sua totalità né rappresentato nelle cartine geografiche, e i satelliti non lo controllano tutto per quanto si impegnino a farci credere il contrario. Ingrandimmo sia le immagini della mappa della lastra d'oro sia quelle delle mappe di Sarmiento de Gamboa, e per farlo utilizzammo anche i computer e le stampanti di Efraín e di Gertrude. Nel frattempo, gli mettemmo un po' a posto i sistemi operativi Windows rendendoli più stabili ed efficienti in modo che non gli apparissero i famosi schermi azzurri di errori gravi. Il risultato degli ingrandimenti fu una sovrapposizione perfetta tra i punti significativi di entrambe le mappe con la sorpresa che, dove terminava quella di Sarmiento, terminava anche quella della lastra d'oro, che mostrava appena un tratto in più di sentiero, il quale finiva bruscamente in un triangolo identico al formaggino della faccia posteriore della ciambella. Gli raccontai la mia scoperta del giorno precedente e presi il cerchio di pietra dalla mia borsa per mostrarglielo. «Non capisco che relazione ci possa essere», obiettò Marta, poggiandolo delicatamente sul tavolo dopo averlo esaminato. «Deve essere una specie di biglietto da visita. Il limite del sentiero significa che lì ci sono gli yatiris», e mise il dito nel punto corrispondente della mappa d'oro. «Dobbiamo soltanto sovrapporre questo schizzo sulle cartine militari e verificare l'ubicazione del loro rifugio.» Era più facile dirlo che farlo. Le carte militari erano grandi come lenzuola e, in confronto, i nostri ingrandimenti sembravano tovaglioli, cosicché fummo obbligati a ristampare in un formato più grande, e per parti, lo schizzo tratto dalla lastra della camera per non diventare matti e non accecarci. Quando finalmente raggiungemmo l'obiettivo, ponemmo una lampada nella parte inferiore del grande tavolo della sala da pranzo, che aveva il piano di vetro, per poter vedere bene l'itinerario e disegnarlo con la matita sulla cartina militare. Ovviamente risultò molto più semplice e chiaro quando arrivammo in una delle zone bianche di vuoto geografico più grandi della Bolivia, perché si vedeva nettamente la riga nera del bozzetto che avanzava inesorabile verso l'interno di quel nulla per finire nel triangolo perfettamente visibile: una minuscola piramide in un deserto gigantesco. «Che territorio è questo?» chiesi scoraggiato. «Arnau!» mi riprese Lola. «Non vedi la scritta 'Senza dati' che c'è al centro?» «Certo che la vedo», dichiarai. «Ma anche così questa zona del Paese avrà pure un nome, no?» «Be', certo», mi rispose Efraín abbassando gli occhiali e chinandosi sul tavolo. «Si trova a nord-est del Paese, tra le province di Abel Iturralde e Franz Tamayo.» «Qui le province hanno nomi di persone?» si stupì Marc. «Molte sì», spiegò Gertrude con un sorriso. «Alcune furono battezzate con la forza durante la dittatura. Franz Tamayo era, fino al 1972, la famosa terra di Caupolicàn.» «Ah, ora sì che mi è chiaro!» esclamò l'archeologo alzandosi. «Il nostro sentiero degli indios yatiris si addentra nel parco nazionale Madidi, una delle riserve naturali protette più importanti dell'America del sud.» «E allora perché è tutto bianco?» domandò Lola indicando l'enorme vuoto geografico. «Se si tratta di un parco nazionale, se ne dovrebbe conoscere l'interno.» «Ho appena finito di dirlo, Lola», insisté l'archeologo. «È una riserva naturale protetta di dimensioni straordinarie. Guardi che cosa dice qui: diciannovemila chilometri quadrati. Sa quant'è? Moltissimo. Una cosa è rappresentare i confini su una mappa, e un'altra, molto diversa, è che qualcuno ci sia già stato. Inoltre non tutta questa Terra Incognita fa parte del parco. Un parco nazionale boliviano dovrebbe terminare alle frontiere con altri Paesi, ma qui si vede con molta chiarezza che il territorio ignoto si estende anche all'interno del Perù e del Brasile. E poi osservi con attenzione questo contorno sottile all'inizio del parco che si trova fuori dal vuoto geografico. Questa zona la si conosce.» «Qui si vede solo foresta», obiettò Marc. «E che cos'altro vuole che ci sia in un parco naturale amazzonico?» gli rispose Marta indicando poi Tiwanacu sulla cartina militare. «Gli yatiris lasciarono Taipikala attorno al 1575, data in cui Sarmiento de Gamboa ha accesso, non sapremo mai come, all'informazione relativa al loro percorso di fuga. Prima di questo stavano morendo a causa delle malattie che gli spagnoli avevano portato dall'Europa e vivevano separati e nascosti tra le comunità agricole dell'altopiano, confusi tra i contadini.» Il dito della professoressa seguiva con delicatezza la linea disegnata a matita sulla cartina militare. «Se ne andarono in direzione di La Paz, ma non vi entrarono, incamminandosi invece verso gli alti picchi innevati della cordigliera Real e li attraversarono approfittando della gola formata dal bacino del fiume Zongo fin dove sfocia nel Coroico, che li portò fino alle miniere d'oro del Guanay. Da lì continuarono la discesa verso la foresta seguendo il corso del fiume Beni. Forse utilizzarono delle imbarcazioni o forse no, è difficile saperlo, anche se l'itinerario, ovviamente, è tracciato seguendo sempre i corsi d'acqua.» «Ma i conquistadores avrebbero scoperto facilmente un gruppo di barche cariche di indios», fece notare Lola. «Senza dubbio», convenne Marta, e sia Efraín sia Gertrude assentirono. «È difficile immaginare come abbiano potuto farlo, se davvero lo hanno fatto. Inoltre, ricordiamoci della frase di Sarmiento de Gamboa: 'Due mesi per terra'. Forse erano fuggiti a piedi simulando una carovana commerciale per giustificare i lama carichi di fagotti; o forse l'hanno fatto in piccoli gruppi, per famiglie, anche se questo sarebbe stato molto più pericoloso, soprattutto all'interno della foresta. Osservate come l'itinerario si allontana qui dal fiume Beni e si addentra in piena giungla, in territorio inesplorato.» «Tutta quella zona sta dentro il parco nazionale Madidi», commentai io. «Ci si potrà entrare?» «No», disse seccamente la dottoressa Bigelow. «Tutti i parchi hanno una normativa molto rigida su questo punto. Per potervi accedere sono necessari dei permessi speciali che si ottengono solo per ragioni di studio o di ricerca. Ora stanno un po' allentando le regole perché l'ecoturismo e il turismo di avventura in queste zone naturali cominciano a rappresentare un'importante fonte di reddito anche per le comunità indigene, ma i visitatori possono entrare solo con un'autorizzazione e possono percorrere unicamente degli itinerari prefissati che non si inoltrano troppo nella giungla e che non presentano eccessivi pericoli.» «Che tipo di pericoli?» volle sapere Marc, con un interesse patologico. «Caimani, serpenti velenosi, giaguari, insetti...» enumerò Gertrude impassibile. «Ah, bisogna che vi vacciniate», aggiunse, guardandoci tutti e tre. «Dovreste andare subito in una farmacia a comprare delle siringhe e poi recarvi al Policlinico Internazionale, che non è molto lontano, per farvi vaccinare contro la febbre gialla e il tetano.» «Dobbiamo comprarci le siringhe?» si stupì il mio amico. «Be', i vaccini sono gratuiti, ma le siringhe bisogna portarsele.» «E dobbiamo andare proprio adesso?» mi demoralizzai. «Sì», rispose Gertrude. «Prima è e meglio è. Non sappiamo quando partiremo, quindi non conviene perdere tempo. Vi accompagno io, se volete. Saremo di ritorno in una trentina di minuti.» Mentre raccoglievamo le nostre cose e, guidati dalla dottoressa Bigelow, uscivamo dalla casa in direzione di una farmacia, mi voltai a guardare Efraín e Marta: «Intanto pensate a come diavolo spiegare la ricerca che vogliamo fare nel parco Madidi perché ci diano i permessi di entrata». «Che ci creda o no», mi rispose l'archeologo calvo, «era quello che avevo in mente.» Ci lasciammo bucare al Policlinico Internazionale, un posto che non mi ispirava fiducia finché non verificai che le misure igieniche erano accettabili. Allora tesi il braccio convinto che non sarei morto per un'infezione o un ascesso, sebbene non fossi del tutto tranquillo circa gli effetti collaterali dei vaccini. Quello del tetano già lo avevo fatto un paio di volte nel corso della mia vita (anche se solo la prima dose), e non ricordavo che mi avesse provocato alcuna reazione, ma quello della febbre gialla mi preoccupava abbastanza anche dopo aver saputo che poteva solo causare un po' di mal di testa e qualche linea di febbre. Infatti mi sentii poco bene il resto del giorno, anche se devo ammettere che mi capitava solo quando ci pensavo. Tornammo a casa di Gertrude ed Efraín e, siccome era già quasi l'ora di pranzo, andammo in un ristorante vicino. Quando eravamo già al secondo - carne di lama stufata - tornai a porre il problema che mi martellava: «Avete pensato al modo di ottenere i permessi?» Marta e l'archeologo si guardarono con la coda dell'occhio prima di rispondere. «Non li chiederemo», disse lui appoggiando le posate sul piatto. Gertrude saltò su come se l'avesse punta uno scorpione. «Ma... perdio, Efraín! Che cosa stai dicendo? Non si può entrare senza permesso!» «Lo so, tesoro, lo so.» «E allora?» Il tono della dottoressa Bigelow era incalzante. «Non faccia così, su», le rispose lui utilizzando improvvisamente una strana formula di rispetto che, in realtà, in Bolivia era la forma più vicina e più intima per rivolgersi a un famigliare. «Sa già che non ce lo darebbero.» «Come no», obiettò lei utilizzando la stessa formula, «deve solo raccontare ai suoi amici del ministero della ricerca sugli yatiris.» «E quanto tempo crede che ci vorrebbe prima di uscire sul giornale? Lei sa meglio di me come vanno le cose qui. Prima di arrivare all'entrata del parco, ci sarebbero già cento archeologi intenti a passare al setaccio la zona e la storia degli yatiris verrebbe raccontata da tutti i giornali.» «Ascoltami, Efraín, non possiamo entrare nella foresta senza che nessuno lo sappia... è una follia!» «Sono d'accordo con te, Gertrude», sottolineò Marta, intervenendo nella conversazione, «e l'ho già detto a Efraín. Inoltre avremo bisogno di guide indigene che conoscano la giungla e loro tre», indicò con il mento Marc, Lola e me, «non sono mai stati li, non sanno che cos'è l'Inferno verde'. Noi potremo difenderci, ma loro no. Sarebbero vulnerabili a tutto.» «No, se li proteggiamo bene», la interruppe l'archeologo chinandosi per parlare a voce più bassa. «Sentite, vi rendete conto di quanto sia importante questa storia? Qualsiasi indiscrezione sarebbe la fine del nostro lavoro, e non solo questo: vi immaginate che cosa potrebbe succedere se le conoscenze degli yatiris cadessero nelle mani di gente senza scrupoli? Se questi saggi sono veramente nella foresta, il loro potere potrebbe convertirsi in una questione di sicurezza nazionale o, ancora peggio, in un commercio come quello delle armi di distruzione di massa.» L'archeologo mi era simpatico. Era un tipo che parlava chiaro e che andava al nocciolo della questione. Quel pericolo lo avevo percepito anch'io mentre eravamo nella Piramide del Viaggiatore, quando pensavo che Marta avesse interessi diversi da quelli accademici nella ricerca del potere degli yatiris di Taipikala. Efraín era arrivato a una conclusione fredda, ma reale: maneggiavamo materiale sensibile, uranio arricchito, e, se non stavamo attenti, potevamo provocare una situazione catastrofica che sarebbe sfuggita al nostro controllo. «Ma sarà quello che accadrà quando li incontreremo», disse Marta ritornando alla carne di lama che si stava raffreddando nel suo piatto. «No, perché noi diffonderemo le conoscenze con il più grande rispetto del mondo, disinnescando il detonatore del pericolo attraverso riviste scientifiche di diffusione internazionale! Se la questione ci sfuggisse dalle mani, gli yatiris potrebbero finire in posti terribili, come la base militare di Guantànamo, trasformati in cavie da laboratorio, e noi, tutti e sei, sparire in qualche misterioso incidente.» Fece un gesto nell'aria come per mettere delle virgolette alle parole. «Capite quello che voglio dire, no? Il potere delle parole, del linguaggio, il controllo del cervello umano attraverso i suoni è qualcosa di troppo attraente per qualsiasi governo. E questo è un lavoro di ricerca storica e archeologica, per cui dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili e non parlarne con nessuno.» «Non so se stai esagerando, Efraín», mormorò Marta, «o se ti avvicini troppo alla verità. Comunque la prudenza mi sembra una buona misura, sempre se non suppone di mettere in pericolo la nostra vita.» «La cosa più pericolosa è la foresta, amica mia», ribatté lui affettuosamente, «lo sai, e l'unico problema sarebbe, se facciamo come dico io, portare loro tre nell'Inferno verde. Ma te lo ripeto: siamo in grado di proteggerli.» Tuttavia io non ero molto sicuro di questo. Volevo aiutare mio fratello, però se farlo significava trasformarmi in cibo per i puma saremmo finiti male tutti e due. «Perché non ingaggiamo guide indigene come ha suggerito Marta?» chiesi, bevendo un lungo sorso dal mio bicchiere di acqua minerale. Avevo la gola secca. «Perché nessuno verrebbe con noi se non abbiamo i permessi ufficiali», mi spiegò Efraín. «Pensi che le comunità indigene di quelle zone sono quelle che forniscono di guardaparco il Sernap, il Servizio Nazionale delle Aree Protette. Chi potrebbe conoscere meglio degli indios la foresta che devono salvaguardare? Qualsiasi guida ingaggiassimo sarebbe il cugino, il fratello, lo zio o il vicino di un guardaparco del Madidi, quindi non andremmo molto lontano, non ne dubiti. Inoltre, sono comunità assai piccole, villaggi di alcune centinaia di abitanti. Nel momento in cui uno di loro si assentasse, tutti saprebbero dove è andato, con chi e perché.» «Anche se li corrompessimo con una buona quantità di denaro?» insistei. «In quel caso troveremmo solo le guide meno degne di fiducia», fece notare Gertrude, molto sicura di quello che diceva, «quelle che ci abbandonerebbero nella giungla da un momento all'altro portandosi via tutto il materiale e il cibo che possono caricarsi. Non vale la pena rischiare.» «E non possiamo andare senza guide, vero?» chiese Jabba preoccupato. «Sarebbe un suicidio.» «Noi abbiamo la miglior guida che potremmo desiderare», esclamò Efraín con fierezza, gonfiando il petto. «Tu che dici, Marta?» La professoressa assentì guardando la dottoressa Bigelow con un sorriso, ma non mi sembrò del tutto convinta di ciò che affermava. «Ti viene in mente qualcuno migliore di lei?» insisté l'archeologo. Marta fece ripetutamente segno di no con il capo; io però percepii ancora un'ombra di dubbio dietro i suoi gesti contenuti e i sorrisi. La dottoressa Bigelow, cercando di giustificare l'entusiasmo del marito, si rivolse a noi e con naturalezza ci spiegò che aveva passato gli ultimi quindici anni della sua vita a lavorare per Relief International, una ONG nordamericana che procurava medici itineranti alle comunità indigene isolate di tutti i Paesi del mondo. Lei, oltre a coordinare le equipe mediche che lavoravano con le comunità rurali dei contrafforti delle Ande, faceva parte di una di esse, e si era vista obbligata in numerose occasioni ad addentrarsi nella foresta tropicale per raggiungere un gruppo indigeno isola- to. Per questo la segreteria nazionale del ministero della Salute e della Previdenza Sociale era ricorsa ai suoi servizi per le due spedizioni ufficiali che il governo boliviano aveva inviato in Amazzonia, all'interno delle proprie frontiere, in cerca di indios che non avessero mai avuto contatti con i bianchi. «E, proprio per la mia esperienza, posso garantire», concluse, «che io sola non basto come guida di una spedizione che si addentra in territorio sconosciuto con tre persone che non hanno mai messo piede in una foresta in vita loro.» «Nemmeno se vigileremo su di loro costantemente?» chiese Efraín deluso. «Dovremo fare molto di più che vigilare costantemente», ribatté lei, «non potremo perderli di vista nemmeno per un istante.» «Ciascuno di noi si farà carico di uno di loro.» Trovata la soluzione. Efraín posò con fermezza tutte e due le mani sul tavolo. «Non gli toglieremo gli occhi di dosso e cercheremo di insegnargli tutto ciò che sappiamo sui potenziali pericoli della foresta. Mi impegno a riportarli indietro sani e salvi.» L'idea che badassero a noi come fossimo bambini dell'asilo, con un'attenzione personalizzata, mi sembrò un buon motivo per tranquillizzarmi. Notai lo stesso sollievo sul volto di Marc e di Lola. «C'è un altro problema, Efraín», obiettò di nuovo la dottoressa. «Credo che tu non ti sia fermato a pensare che, se ci scoprono dentro il parco, la pagheremo molto cara. Sarà un vero scandalo.» «Be'...» mi intromisi, «se ci scoprono sarà perché hanno deciso di eliminare dei vuoti geografici e non credo che succederà in questo preciso momento, no? In quanto allo scandalo, dottoressa Bigelow, credo che sia già incluso nel prezzo del biglietto. Se noi corriamo dei rischi per aiutare mio fratello, voi avete i vostri importanti interessi per cercare gli yatiris. Marta lo ha chiarito bene ieri: ha lavorato con Efraín tutta la vita su questo tema, e lei, Gertrude, si ripromette di incontrare degli yatiris che non hanno mai avuto contatti con nessun essere umano da cinquecento anni. Questo è il prezzo.» La dottoressa sorrise. «Si sbaglia, Arnau», ribatté con un accento strano. «Questa è solo una piccola parte del mio prezzo.» Marta ed Efraín si scambiarono sguardi d'intesa e sorrisi. «Di che cosa sta parlando, Gertrude?» chiese Lola, molto interessata. Il suo istinto di mercenaria si era risvegliato. «Da quando sono venuta a conoscenza del segreto degli yatiris», cominciò a spiegare la dottoressa appoggiando le posate sul piatto e aggiustandosi i capelli ondulati, «sono ossessionata da quello che voi chiamate il potere delle parole, dalla capacità del linguaggio aymara di produrre effetti strani negli esseri umani attraverso i suoni. Come medico ho provato una forte curiosità e ho passato gli ultimi anni a conciliare il mio lavoro in Relief con la ricerca scientifica sull'influenza del suono sul cervello. Ho una mia teoria sull'argomento, e il mio prezzo, Lola, è di verificare se sono nel vero.» Attorno alla tavola calò il silenzio. «E... qual è questa teoria?» osai chiedere, incuriosito. La cosa si faceva promettente. «È troppo noioso», si scusò lei, sfuggendo il mio sguardo. «Su, tesoro!» protestò suo marito. «Non vedi che muoiono di curiosità? Abbiamo tempo.» «Diglielo, Gertrude», aggiunse Marta. «Lo capiranno perfettamente.» La dottoressa Bigelow cominciò a giocherellare con le briciole che c'erano sulla tovaglia. «Va bene», disse. «Se non capite qualcosa, chiedetemelo.» Con un rapido gesto incrociò le braccia sul tavolo ed emise un sospiro. «Allora», iniziò a spiegare, «negli ultimi cinquant'anni si sono fatti molti passi avanti nello studio del cervello umano. Non sapevamo quasi nulla e, di colpo, tutti si sono messi a studiare ciò che questo organo così perfetto è capace di fare. Attualmente continua a essere un grande mistero e utilizziamo ancora il cinque per cento della sua immensa capacità, ma abbiamo progredito molto e siamo in grado di tracciare una mappa abbastanza completa delle differenti aree e delle funzioni. Sappiamo anche che l'immensa attività elettrica del cervello, che emette un'infinità di tipi di onde, fa sì che neuroni individuali o gruppi di neuroni emettano sostanze chimiche che controllano il nostro stato d'animo e i nostri sentimenti, e pertanto i comportamenti che ne conseguono. Queste sostanze, o neurotrasmettitori, nonostante circolino dappertutto, possono operare in luoghi abbastanza specifici con risultati assai differenti. Si conoscono più di cinquanta neurotrasmettitori, ma i più importanti sono sette: dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, glutammato, e gli oppiacei conosciuti come encefaline ed endorfine.» «Un momento!» esclamò Marc, alzando la mano. «Ha detto che queste sostanze che circolano nel cervello sono le cause dei nostri sentimenti?» «Sì, in effetti è così», confermò Gertrude. «È fantastico!» si entusiasmò. «Siamo macchine programmabili come i computer.» «E il codice che ci gestisce sono questi neurotrasmettitori», aggiunsi io. «Esatto», confermò lui, il cui cervello da ingegnere andava e veniva a velocità quantiche. «Se scrivessimo con neurotrasmettitori potremmo programmare le persone.» «Fatemi continuare», ci pregò la dottoressa Bigelow, con un marcato accento yankee. «Quello che vi sto dicendo non è una teoria, è scientificamente provato già da anni, e oggi ne sappiamo molto di più. Che ne dice, Marc, se io le spiegassi che, stimolando elettricamente una zona del lobulo temporale del suo cervello e quindi attivando certi neurotrasmettitori, posso fare in modo che lei abbia una profonda esperienza mistica e che si convinca di vedere Dio? Questo è vero, è empiricamente provato, come lo è che non si è trovata nessuna zona del cervello dove ha radici la felicità, sebbene ci siano quelle del dolore, tanto fisico come dell'anima, e dell'angoscia. Se la dopamina circola nel suo cervello, lei proverà piacere, ma solo per il tempo in cui quel neurotrasmettitore è attivo. Quando non lo è più, la sensazione o il sentimento spariranno. Se è molto indaffarato o concentrato in un lavoro, una parte del suo cervello chiamata amigdala, che genera le emozioni negative, rimarrà inibita. Per questo dicono che mantenersi occupato cura tutti i mali. Insomma, la questione è che tanto la paura quanto l'amore, la timidezza, il desiderio sessuale, la fame, l'odio, la serenità eccetera nascono perché c'è una sostanza chimica che si attiva attraverso una piccola scarica elettrica. Per essere più esatti, c'è un tipo speciale di neurotrasmettitori, i cosiddetti neurotrasmettitori peptidici, che lavorano in un modo molto più preciso e che fanno sì che uno odi il colore giallo, abbia voglia di ascoltare musica o di leggere un libro o si senta attratto da quelli che hanno i capelli rossi», e terminò guardando Lola con un sorriso. «O abbia paura di volare», aggiunse Marc. «Certo.» «Quindi l'aymara contiene un tipo di onda elettromagnetica», azzardò Proxi, ma non sembrava sicura di quello che stava dicendo, «che gli yatiris sanno utilizzare.» «No, Lola», contestò Gertrude agitando i capelli color paglia. «Se la mia teoria è esatta, ed è quello che voglio scoprire in questo viaggio, si tratta di qualcosa di molto più semplice. Io credo, piuttosto, che l'aymara sia la lingua più perfetta che esista. Efraín e Marta me lo hanno spiegato molte volte e, anche se lo capisco appena, so che hanno ragione. Ma io credo che, in realtà, si tratti di un veicolo perfetto per bombardare il cervello con dei suoni. Avete visto la tipica scena da film nella quale un bicchiere di cristallo esplode quando si produce vicino un suono molto forte o molto acuto? Il cervello risponde nello stesso modo quando lo si bombarda con onde sonore.» «Esplode?» scherzò Jabba. «No. Va in risonanza. Risponde alla vibrazione del suono. Sono convinta che l'aymara faccia in modo che un determinato tipo di onde possa essere prodotto dagli organi della fonazione della bocca e della gola e che arrivi al cervello attraverso l'orecchio attivando i neurotrasmettitori che provocano questo o quello stato d'animo, questo o quel sentimento. E se ciò che attiva sono gli specializzatissimi neurotrasmettitori peptidici, ne può risultare quasi qualsiasi cosa.» «E l'aymara che si parla ancora oggi?» chiesi incuriosito. «Perché non produce gli stessi effetti? Per le piccole influenze del quechua e del castigliano degli ultimi cinquecento o seicento anni?» «No, non penso», rispose la dottoressa. «La mia teoria, come vi ho detto, è che l'aymara sia il veicolo perfetto per produrre i suoni che alterano il cervello, ma in che ordine o sequenza bisogna produrli affinché provochino l'effetto desiderato? È stato un solo suono della maledizione che ha colpito suo fratello a causare tutto o si è trattato piuttosto di una determinata combinazione di suoni? Credo che gli yatiris pronuncino le parole precise nell'ordine necessario.» «In conclusione: le formule magiche di sempre», disse con ironia Lola vedendo confermata la sua teoria. «Non è per banalizzare, proprio per niente, però vi siete resi conto che la vecchia espressione delle fiabe, la famosa abracadabra, potrebbe contenere i principi della teoria di attivazione dei neurotrasmettitori?» «Sarebbe interessante fare uno studio su questo tema!» feci notare. «Taci. Ti conosco!» esclamò Marc, preoccupato. «Lasceresti perdere tutto per buttarti su questo argomento.» «Quando mai l'ho fatto?» mi indignai. «Molte volte», confermò Lola con indifferenza. «L'ultima, il giorno in cui hai scoperto un misterioso documento con alcune parole in aymara che sembravano avere una relazione con la malattia di tuo fratello.» La dottoressa Bigelow, Marta ed Efraín ci ascoltavano perplessi. «Be', sarebbe interessante», brontolai infastidito. Non ero disposto a dargliela vinta. «Sono d'accordo con lei, Arnau», disse sorridendo la dottoressa Bigelow. «Ecco perché seguirò Efraín e Marta in questa folle avventura. Verificare se le mie teorie sono corrette è il mio unico scopo.» Efraín sorrise soddisfatto e ci guardò gonfio di orgoglio. «Allora?» chiese. «Andiamo a cercare gli yatiris?» Tutti assentimmo senza esitare, incluso Marc. Sapevamo che stavamo dicendo sì alla più grande follia della storia, ma era proprio quella qualità di insensatezza e di assurdità a rendere una sfida irrinunciabile. «E quando si parte?» chiese Proxi sollevando la tazza di spesso, amaro e sabbioso caffè boliviano. Conoscevo quella luce particolare nei suoi occhi neri: era la stessa che sprigionava quando si trovava davanti a una sfida. Sinceramente, avrei preferito che la sfida si potesse affrontare con tastiera e monitor, ma siccome era impossibile tanto valeva lasciarsi trascinare dalla scarica di adrenalina di una avventura così stravagante. «Se riusciamo a preparare il materiale, studiare la zona, procurarci i mezzi di trasporto e farvi un corso accelerato di sopravvivenza nella giungla», scherzò Efraín, «possiamo partire lunedì prossimo.» Con una lista in mano più lunga della quaresima (elaborata da tutti il pomeriggio prima, al ritorno dal ristorante), Lola e io uscimmo il giovedì mattina dall'hotel per le compere. Avevamo anche un elenco dei negozi in cui avremmo trovato il materiale: dalle tende da campeggio, le amache, i sacchi e le zanzariere fino ai piatti, i filtri e le pastiglie per depurare l'acqua, la carta igienica e l'insettifugo. Andammo in giro tutto il giorno e ordinammo che tutto ciò che compravamo ci fosse recapitato in albergo, da dove saremmo partiti il lunedì seguente, dopo aver lasciato le nostre cose a casa di Efraín e di Gertrude e aver pagato il conto. Ci trovammo in grande difficoltà a chiedere i machete per aprirci un varco nella foresta, ma il negoziante, con calma, ci mostrò diversi modelli, fino ai più affilati, grandi e pericolosi, e ci raccomandò una marca tedesca che, secondo lui, produceva le migliori lame d'acciaio. Mentre consumavamo il denaro del fondo per i rifornimenti, Marta si diresse a El Alto, il quartiere più elevato della città dove si trovava l'aeroporto in cui eravamo atterrati al nostro arrivo a La Paz. Lì c'era anche il terminal della TAM (Trasporto Aereo Militare), l'unica compagnia che offriva voli tra La Paz e Rurrenabaque, località che serviva da punto di partenza per la visita al Parco Nazionale Madidi. L'al- ternativa per raggiungerla era la tristemente famosa Carretera de los Yungas, più nota come Carretera de la Muerte per i numerosi incidenti stradali che si verificavano lungo i suoi terribili pendii e curve, ma a parte questa ragione ovvia per non utilizzarla, c'era anche il problema del tempo: ci volevano quindici o venti ore per arrivare a Rurrenabaque. E questo nella stagione secca dell'anno, perché in quella delle piogge non si sapeva. Marta ebbe fortuna e, anche se fino all'ultimo non ne fummo sicuri, ottenne i sei passaggi per lunedì 17 giugno; ci trovavamo in alta stagione turistica e, a causa della grande domanda, erano stati autorizzati dei voli supplementari. Ci costarono, in totale, circa settecento euro più un acconto per la prenotazione dei voli di ritorno. Non conoscevamo la data con certezza, ma supponevamo che fosse verso la fine del mese, quindi, se non volevamo rimanere senza volo per La Paz in piena operazione di partenza e arrivo, dovevamo prenotare. Gertrude ebbe difficoltà a trovare il materiale medico per la valigetta dei medicinali. La sua posizione di collaboratrice del Relief International in Bolivia risultò più un ostacolo che un aiuto. Dai distributori che fornivano la sua ONG ottenne i prodotti di base, come la soluzione fisiologica, gli analgesici, le bende, gli antibiotici, le siringhe e gli aghi usa e getta, ma non riuscì a procurarsi, senza richiamare l'attenzione, l'antidoto contro il veleno di serpente, il cosiddetto siero antiofidico polivalente, né la siringapistola necessaria per iniettarlo. Impiegò in questo compito e in altri simili tutto il giovedì, il venerdì e il sabato, mentre Efraín e Marc studiavano la zona del Madidi e il modo di entrare nel parco senza essere scoperti. Una delle prime cose che trovarono sul parco, navigando in rete, fu un'intervista fatta a un tale Pedro Pelissier Sanchiz, un conoscente di Efraín e di Marta già direttore del Museo di Etnografia della Bolivia, autore dell'unica mappa etnica di questo Paese. Pelissier Sanchiz si diceva sicuro dell'esistenza di tribù sconosciute nella regione del Madidi, nelle ignote sorgenti del fiume Heath e nella valle del fiume Colorado. Ma la cosa più sorprendente era che, secondo lo studioso, uno di quei gruppi che non avevano mai avuto contatti con l'uomo bianco era quello dei Toromonas, una tribù misteriosamente scomparsa durante la guerra del caucciù del XIX secolo. Secondo la leggenda, i Toromonas erano stati grandi alleati degli incas, che avevano aiutato a sparire nella foresta con i loro grandi tesori, dopo la sconfitta subita dagli spagnoli. Questi dati storici sembravano certi e avevano creato la leggenda della città perduta di El Dorado o Paitití, nascosta nell'Amazzonia. Tuttavia, i Toromonas si davano per scomparsi da più di un secolo e risultavano ufficialmente estinti, per questo le dichiarazioni di Pelissier Sanchiz sulla possibilità che continuassero a esistere tra i gruppi del Madidi rafforzava la nostra convinzione che gli yatiris potessero trovarsi in una situazione simile. In realtà, nessuno sapeva ciò che c'era in quei vuoti geografici, ed erano famose le sfortunate spedizioni del colonnello britannico Parcy Harrison Fawcett nel 1911 (incaricato di disegnare le frontiere della Bolivia con il Perù, il Brasile e il Paraguay) o del norvegese Lars Hafskjold nel 1997, dei quali non si erano più avute notizie dopo che si erano addentrati nella zona. Il Madidi era dunque un buco nero geografico qualificato dalla rivista National Geographic21 e da un rapporto del Conservation International22 come la maggiore riserva mondiale di biodiversità, nella quale, per esempio, si potevano trovare più specie di uccelli che in tutto il territorio dell'America del nord. Le informazioni che Marc ed Efraín stavano scaricando dalla rete e che ci riferivano la sera, quando ci riunivamo tutti a cena, disegnavano un panorama sempre più ampio e tremendo della folle spedizione nella quale ci eravamo imbarcati. Stavamo tutti in silenzio, ma io come gli altri mi chiedevo se non stavamo facendo un errore, se non saremmo finiti come quel colonnello britannico o come quell'esploratore norvegese. La necessità di non rompere il cordone ombelicale con la civiltà mi spinse a comprare, l'ultimo giorno e all'ultimo momento, un piccolo apparato composto da un GPS23 per conoscere la nostra posizione in qualsiasi momento e un caricabatteria per il cellulare e il portatile, che pensavo comunque di portarmi nella foresta. Non volevo morire senza mandare al mondo un ultimo messaggio per segnalare dove potevano trovare i nostri corpi per rimpatriarli in Spagna. La sera della domenica chiamai mia nonna e parlai con lei a lungo. Se c'era qualcuno capace di comprendere l'assurdità che stavamo per fare, quella persona era lei: infatti non si sorprese per niente al mio racconto, e anzi mi incoraggiò con grande entusiasmo. Avrei giurato che le sarebbe piaciuto moltissimo prendere il mio posto e giocarsi la pelle nell'Inferno verde, l'unica espressione che Efraín, Marta e Gertrude usavano per riferirsi alla foresta amazzonica. Mi raccomandò di essere prudente e di non correre rischi inutili, ma in nessun momento mi disse di non farlo. Mia nonna era energia pura, e fino al suo ultimo respiro avrebbe continuato a essere la persona più viva di tutto il pianeta Terra. Ci mettemmo d'accordo di non dire niente a mia madre e io le promisi di mettermi in contatto con lei appena possibile. Mi raccontò che stavano pensando di portare Daniel a casa, dato che restare in ospedale non serviva a niente e, in quel momento, fui sul punto di confessarle del furto del materiale dallo studio di Marta. Non lo feci per un istinto egoista e assurdo: se ci fosse capitato qualcosa di male durante la spedizione, il reato di mio fratello sarebbe stato prescritto in quello stesso istante, quindi non valeva la pena di far soffrire la nonna per cose che, se non potevo farne a meno, le avrei raccontato al ritorno a Barcellona. La domenica, con tutto il materiale pronto e immagazzinato in albergo, Marc ed Efraín continuavano a raccogliere informazioni sul Madidi che Gertrude, Marta, Lola e io leggevamo velocemente passandoci i fogli da uno all'altro man mano che uscivano dalla stampante. Il parco era stato istituito dal governo boliviano il 21 settembre del 1995, facendo coincidere i suoi confini con quelli di altri parchi nazionali (il Manuripi Heath, l'Area Natural de Manejo Integrado Apolobamba e la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas). Il clima era tropicale, caldo e con un'umidità del cento per cento, la qual cosa trasformava in un incubo qualsiasi sforzo fisico. Le ricognizioni aeree e le fotografie dal satellite rivelavano che la parte meridionale era caratterizzata da profonde vallate e da alti pendii, mentre la regione subandina presentava regioni montuose con altitudini che potevano raggiungere i duemila metri. Quindi, per quel poco che sapevamo del nostro itinerario, avremmo dovuto lasciare quelle regioni alle nostre spalle per addentrarci subito nella zona delle pianure seguendo il bacino del fiume Beni e poi deviare verso le valli e i pendii del sud. «C'è qualcosa che non quadra», commentò Lola preoccupata, alzandosi dal sofà e avvicinandosi alle mappe militari ancora spiegate sul tavolo. «Se, come abbiamo calcolato, la distanza tra Taipikala e il punto finale del tracciato della mappa d'oro è di circa quattrocentocinquanta chilometri e, nel viaggio attraverso la montagna, a passo moderato si possono percorrere a piedi circa quindici o venti chilometri al giorno, qualcosa non funziona... perché si impiegherebbe meno di un mese ad arrivare al triangolo, però Sarmiento de Gamboa parla di due mesi.» «Be', per il nostro bene spero che ti sbagli», le disse Marc, scocciato. «Ricorda che abbiamo comprato viveri solo per quindici giorni.» «E del resto non potremmo caricarne di più», feci notare. La nostra riserva di alimenti era stata calcolata togliendo i chilometri che avremmo percorso in aereo da La Paz fino a Rurrenabaque. Una volta lì, il percorso che ci separava dal triangolo della mappa era di poco più di cento chilometri, quindi, tenendo conto dell'inesperienza di Lola, di Marc e della mia, dei possibili incidenti e del fatto che dovevamo aprirci la strada a colpi di machete, avevamo deciso di essere generosi e di distribuire fra tutti e sei le provviste di cibo per un paio di settimane, cioè calcolando anche i cento chilometri di ritorno. Eravamo convinti che ci sarebbe bastato e avanzato, però preferivamo prevenire la fame poiché, una volta nella foresta, quello che non avevamo non avremmo potuto comprarlo in nessun negozio e sarebbe stata un'esperienza molto sgradevole vedere il mio amico Marc rosicchiare i tronchi degli alberi o dare un morso al primo serpente che gli passava davanti. La sera prima del volo verso Rurrenabaque non riuscii a chiudere occhio. Ricordo che mi ci volle tutta la notte per rispondere alle e-mail di Núria su problemi di lavoro e che rimasi trasognato a contemplare come filtrava la luce dell'alba attraverso le fessure delle persiane. Ci sono momenti in cui uno ignora come è arrivato fin lì, in cui non sa spiegare come sono successe le cose che lo hanno portato fino a una determinata situazione. Rammentavo vagamente di avere organizzato un boicottaggio contro il canone della Fondazione TraxSG e che mia cognata mi aveva chiamato per dirmi che Daniel si era ammalato. Fino a quel giorno la mia era stata una buona vita. Forse solitaria (be', lo ammetto, abbastanza solitaria), ma mi piaceva quello che facevo ed ero contento di quello che avevo ottenuto. Non mi concedevo molto tempo per pensare, come stavo facendo in quel momento, in quella stanza d'albergo, a migliaia di chilometri da casa. Avevo la sensazione di aver vissuto dentro una bolla nella quale non sapevo né quando né come ero entrato. Forse ero nato già lì dentro e, nello stesso momento in cui lo pensai, capii che era vero. Se tutto fosse tornato un giorno alla normalità, mi dissi, avrei continuato a dirigere la Ker-Central finché non mi fossi stancato e poi l'avrei venduta per buttarmi su un'altra occupazione o su un affare che mi interessava di più. Era sempre stato così: quando qualcosa diventava routine e non mi occupava ventiquattro ore su ventiquattro, lo abbandonavo e cercavo di nuovo il cuore della bolla con un'attività che mi obbligasse a superare i miei limiti e che mi impedisse di pensare, di rimanere solo con me stesso senza nient'altro da fare che vedere sorgere il sole attraverso delle finestre socchiuse come stavo facendo allora. Forse non sarei ritornato dalla foresta, pensai, forse ci aspettavano pericoli troppo grandi per tre novellini, due dilettanti e una pseudoesperta, ma, comunque, mi sentivo meglio di quanto non mi fossi sentito in tutta la vita. Ero fuori dalla bolla, e contemplavo il mondo reale, rischiando molto di più che ricevere un virus nel mio computer o perdere dei milioni in un investimento sbagliato. Improvvisamente intuivo che c'erano altre cose al di là del mio ristretto mondo virtuale, in cui suonava la mia musica preferita, c'erano i miei libri e potevo contemplare finché volevo i quadri che mi piacevano. In fondo, mi dissi, avrei dovuto ringraziare Daniel quando fosse guarito - dopo avergli spaccato la faccia, metaforicamente parlando per avermi dato l'opportunità di uscire da un'esistenza perfetta e incasellata. Tutta quella storia degli aymaras aveva rotto i miei schemi e mi aveva fatto affrontare una parte di me che non conoscevo. Ero mai stato forse più vivo di quando attraversavo il corridoio formato dalle lastre d'oro nelle viscere di una piramide preincaica o di quando come un pazzo traevo conclusioni dai dati lasciati dai cronisti spagnoli sulla conquista dell'America nel XVI secolo? Non sapevo esattamente come definire ciò che provavo in quei momenti, ma avrei osato affermare che era qualcosa di molto simile alla passione, a una passione che mi faceva scorrere più in fretta il sangue nelle vene, e mi faceva aprire gli occhi, affascinato. Quando Marta e Lola vennero a chiamarmi per scendere a far colazione, circa alle dieci del mattino, mi trovarono addormentato in poltrona con i piedi scalzi sul tavolo e gli stessi vestiti che indossavo il giorno prima. Quella mattina dovevo fare qualcosa di molto importante: dovevo tagliarmi i capelli prima di prendere il volo della TAM verso Rurrenabaque. Marta mi aveva avvertito che i capelli lunghi nella foresta erano un richiamo per ogni tipo di bestia. L'aereo decollò a mezzogiorno dall'aeroporto militare di El Alto, e nei cinquanta minuti che impiegammo ad arrivare il paesaggio e il clima si modificarono radicalmente: dal fresco, secco e più o meno urbanizzato altopiano situato a quattromila metri di altezza, passammo a un ambiente spossante, caldo e selvaggio tremila metri più in basso. Io avevo la ferma convinzione che i militari ci avrebbero fermato quando i nostri bagagli di oltre cento chili fossero passati attraverso il controllo di sicurezza (per i machete e i coltelli), ma se pochi aeroporti nel mondo mettevano in pratica questi controlli anche dopo gli attentati dell'11 settembre, a El Alto ancora meno, cosicché le pericolose armi furono imbarcate senza la minima difficoltà. Efraín ci spiegò che in qualsiasi volo diretto verso zone della foresta era inevitabile che i viaggiatori portassero questi strumenti con sé, e che non erano considerati delle armi. Come speravamo, non ci chiesero nemmeno i documenti, e fu meglio così, perché Marc, Lola e io avevamo soltanto la carta d'identità spagnola, non potendo rischiare di perdere o di rovinare nella foresta i passaporti che ci avrebbero riportati a casa quando tutto fosse terminato. Il povero Marc se la passò di nuovo molto male durante il volo e, anche se il viaggio fu breve e gradevole, con una voce che faceva fatica a uscire giurò che sarebbe tornato in Spagna in nave. Inutilmente tentammo di spiegargli che non c'erano più grandi linee marittime che offrissero viaggi in transatlantico come all'epoca del Titanic: lui giurò e spergiurò che o ne trovava una o rimaneva a vivere in Bolivia per sempre. L'autobus della TAM - o, come lo chiamavano lì, la buseta - ci raccolse in piena pista di atterraggio per trasportarci fino agli uffici della compagnia nel centro di Rurrenabaque, anche se chiamare pista il morbido prato coperto di erba alta e fiancheggiato da due muri di bosco come segnalazione era solo un generoso eufemismo. Il giorno in cui fosse piovuto, osservò Lola spaventata, quella striscia di terra si sarebbe trasformata in un pantano inutilizzabile. Una volta nel centro di Rurrenabaque, circondati da turisti di tutte le nazionalità in attesa di visitare il parco, entrammo in uno dei bar della località e mangiammo qualcosa prima di uscire in cerca di un veicolo che ci conducesse fino alle vicinanze del luogo attraverso cui pensavamo di infiltrarci nel Madidi. Fummo fortunati perché all'imbarcadero - centro nevralgico e sociale di Rurrenabaque - rimaneva soltanto una Toyota sgangherata parcheggiata vicino al fiume Beni; riuscimmo ad affittarla per pochi boliviani dal proprietario, un vecchio indio di etnia tacana che disse di chiamarsi don José Quenevo, il quale, con mezze parole incomprensibili, si impegnò anche a portarci personalmente sin dove volevamo con un piccolo supplemento. L'immagine del Beni era impressionante, a quell'ora del pomeriggio: il letto era largo come quattro autostrade, e sull'altra riva si vedevano le case di mattoni crudi con il tetto di foglie di palma del villaggio di San Buenaventura, gemello minore di Rurre (come gli oriundi chiamavano la località, per abbreviare). Sei o sette canoe di legno, lunghe come vagoni di treno e tanto snelle che i suoi occupanti stavano seduti in fila, attraversavano il fiume da un villaggio all'altro con carichi di verdure e animali. Per qualche motivo, e nonostante l'aria soffocante, mi sentivo fantasticamente bene guardando il paesaggio di colline verdi, l'ampio fiume e il cielo azzurro coperto da nubi bianche; l'enorme zaino che avevo sulle spalle mi pesava appena, mi sentivo ottimista e leggero come una piuma mentre saltavo nella parte posteriore della sudicia camionetta di don José, che non sarebbe potuta essere più fangosa neanche se le avessero svuotato addosso una betoniera. Efraín si sedette davanti con il vecchio autista tacana e gli chiese di portarci fino alla vicina località di Reyes, dove pensavamo di accamparci per alcuni giorni. Prima che passasse mezz'ora, come ci eravamo accordati, incominciammo a bussare sul soffitto della cabina e dicemmo a Efraín a voce alta, affinché don José potesse sentirci, che volevamo scendere lì e fare il resto della strada a piedi. Il nostro autista fermò il veicolo in mezzo a quel sentiero tortuoso che era la carretera per Reyes - non avevamo incontrato nessun mezzo di trasporto e non si vedeva un'anima viva nei dintorni - e, prima di abbandonarci nel nulla, ci avvertì che avevamo ancora una lunga ora di cammino per arrivare alla nostra meta e che ci conveniva affrettarci prima che ci sorprendesse la notte. Ma c'era ancora un sole splendente, mitigato solo dalle falde dei cappelli dei quali ci eravamo provvisti tutti e sei. Io portavo il panama che mi ero comprato a Tiwanacu per nascondere i miei lunghi capelli agli occhi di Marta e, anche se ora questi riposavano in una pattumiera di La Paz - me li ero tagliati quasi a zero -, in verità svolgeva perfettamente il suo autentico ruolo di ripararmi dal sole e dalle punture delle zanzare che, come nubi grigiastre, volteggiavano intorno a noi nonostante il repellente con il quale ci eravamo cosparsi. Dopo un'infinità di manovre per girare il suo veicolo sconquassato e aver ripreso la strada verso Rurre, don José sparì dalla nostra vista e, finalmente, rimanemmo completamente soli sul limitare della foresta amazzonica. Efraín prese una delle mappe dalla tasca dei pantaloni e la spiegò in terra. Con l'aiuto del mio ricevitore GPS scoprimmo che, come avevamo previsto, eravamo molto vicini a una delle baracche di controllo dei guardaparco del Madidi; il piano consisteva nell'aspettare nascosti che calasse la notte per scivolare oltre il recinto passando proprio sotto il naso delle guardie addormentate. Quella manovra era molto pericolosa perché addentrarsi nella foresta di notte e al buio significava rischiare di imbattersi in un puma, un serpente o un tapiro furioso, però pensavamo di superare i confini senza essere visti e di trovare un posto in cui dormire in attesa del sorgere del sole. A partire da quel momento ci aspettava una lunga settimana di cammino ininterrotto lungo l'itinerario tracciato nella mappa della lastra d'oro che io stesso mi ero incaricato di registrare punto per punto nel GPS, in modo che ci indicasse costantemente la direzione corretta. Ci addentrammo nella parte occidentale della foresta che, non essendo molto folta e formata da snelli palmeti, risultò facile da attraversare. Camminavamo leggeri, senza fatica, e fu allora che Marta e Gertrude ci spiegarono che quell'energia che sentivamo era l'effetto opposto a quello del mal di montagna, poiché ora c'era molto più ossigeno nell'aria per il cambio di altitudine, e che lo sperimentavano tutti quelli che scendevano dall'altopiano verso la foresta. «Ci durerà alcuni giorni», aggiunse Gertrude che chiudeva la fila, «quindi cerchiamo di approfittarne il più possibile.» La suddivisione delle responsabilità era stata preparata democraticamente la sera prima: Marc era caduto nelle mani di Gertrude e, pertanto, camminava davanti a lei occupando il penultimo posto; Lola era toccata a Marta e quindi camminava davanti a Marc; io appartenevo a Efraín che apriva la strada con il machete in mano, anche se, siccome ero molto più alto di lui, dovevo abbassare di frequente la testa per non ferirmi. A mano a mano che avanzavamo la vegetazione cambiava impercettibilmente; il sottobosco - cioè l'erba, i cespugli e gli arbusti - diventava più frondoso e fitto, mentre i tronchi delle palme erano più grossi, soffocati da piante rampicanti, e si alzavano formando con le loro chiome una copertura, a quindici o venti metri dalle nostre teste, che lasciava appena passare la luce. Il caldo appiccicoso provocato dall'umidità cominciava a fare sentire i suoi effetti. Per fortuna avevamo comprato dei vestiti adatti alla foresta: tutti indossavamo delle magliette con le maniche lunghe che eliminavano il sudore all'istante, si asciugavano in fretta e offrivano un impareggiabile isolamento termico tanto dal freddo quanto dal caldo, e i nostri pantaloni erano antivento, traspiranti, impermeabili, oltre che elastici, e potevano trasformarsi in un batter d'occhio in lunghi o corti secondo quel che serviva. Finalmente, un'ora e mezza dopo aver abbandonato la strada, ci imbattemmo in una radura nel bosco in cui c'era un enorme cartello con un lungo messaggio di accoglienza che diceva «Bienvenidos - Welcome. Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi» e, sotto, il disegno di una divertente scimmia appesa alle lettere su un fondo giallo. Proprio dietro il cartello, mezza sepolta nell'esuberante vegetazione, una capanna dalle pareti di legno e dal tetto di foglie di palma bloccava l'accesso alla zona protetta, ma, con nostra sorpresa, la casetta sembrava essere del tutto abbandonata e non si percepiva la presenza di nessun essere umano nelle vicinanze, guardaparco o no. Efraín si diresse verso Gertrude in silenzio e le mise una mano sulla spalla, attirandola a sé in modo che non potesse essere vista dalla casa. Tutti e sei ci acquattammo nella vegetazione e, in silenzio, ci liberammo degli zaini e ci preparammo ad aspettare che l'oscurità fosse completa. Dal terreno su cui ci eravamo seduti sembrava sprigionare il calore di una stufa, un'aria torrida, fradicia e decomposta. Tutto frusciava, crepitava e, man mano che si avvicinava il crepuscolo, i rumori aumentarono fino a diventare assordanti: il frinire delle cicale diurne si sommava allo stridere dei grilli notturni e delle cavallette, intercalati da strani ululati che provenivano dalla sommità degli alberi e dal chiasso che facevano le rane del vicino Beni con il loro gracidare ritmico. E come se ciò non bastasse per far venire un collasso a Marc, Lola e me, metropolitani di ultima generazione, il buio fitto che ci avvolgeva cominciò a riempirsi di luci che svolazzavano intorno a noi e che provenivano da alcune bestie ripugnanti che i nostri tre accompagnatori cacciavano con le mani mentre, con voci piene di tenerezza, mormoravano: «Lucciole, che belle!'» Be', le belle lucciole misuravano qualcosa come quattro centimetri, cioè erano lucciole giganti, e mandavano bagliori più simili a quelli di un fanale da marina che di un dolce insetto che succhia il nettare. «Qui è tutto molto grande, Arnau», mi sussurrò Gertrude. «Nell'Amazzonia tutto ha una dimensione spropositata e colossale.» «Ricorda il colonnello britannico Percy Harrison Fawcett che scomparve in questa zona nel 1911?» mi chiese bisbigliando Efraín. «Sembra che fosse amico di sir Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes. Sir Arthur scrisse anche un romanzo stupendo, Il mondo perduto, in cui comparivano animali giganteschi e che sembra ispirato ai racconti del colonnello Fawcett e alle sue imprese in queste terre.» Non replicai ma mi tolsi il cappello e, agitandolo, tentai inutilmente di spaventare le lucciole che, consapevoli della loro dimensione e quantità, decisero che le stavo invitando a un gioco divertente e si ostinarono ad avvicinarsi a me sempre di più. La parte del mio corpo che mi sembrava più vulnerabile era la nuca, nuda dopo il taglio di capelli, e sentivo dei brividi al solo pensiero che qualcuno di quegli insetti potesse sfiorarmi con le ali. Non mi ero ancora abituato ad avere il collo scoperto. Credo che quella fosse la prima volta in cui mi imposi di cambiare atteggiamento. Attorno a me tutto era natura nel suo stato più puro e selvaggio. Non si trattava del mio giardino cittadino, ben curato e accudito da un giardiniere professionista che si preoccupava di non far entrare insetti in casa. Io qui non avevo il minimo potere decisionale e non potevo esercitare nessuna influenza su ciò che mi circondava perché non era un ambiente addomesti- cato. In realtà eravamo noi gli intrusi, e per quanto mi infastidissero il caldo, gli insetti e il fitto sottobosco, o mi adattavo o avrei finito per diventare un peso per la spedizione e per me stesso. Che senso aveva ricordare che, a migliaia di chilometri, disponevo di una casa piena di schermi giganti connessi a un sistema di intelligenza artificiale il cui unico scopo era quello di rendermi la vita comoda, pulita e gradevole? Mosso da un impulso inconscio tirai fuori il cellulare dallo zaino e lo accesi per verificare se funzionava. Il livello della batteria era buono e anche il segnale di copertura del satellite. Sospirai sollevato. Ero ancora in contatto con il mondo civilizzato e speravo di continuare a esserlo per le due settimane seguenti. «Nostalgia di Barcellona?» mi domandò a bassa voce Marta. Non potevo vederla in viso perché il sole si era nascosto velocemente ed eravamo al buio. «Suppongo di sì», risposi spegnendo il cellulare e rimettendolo a posto. «Questa è la foresta, Arnau», mi disse lei. «Qui la sua tecnologia non serve molto.» «Lo so. Mi abituerò all'idea poco per volta.» «Faccia attenzione, signor Queralt», mormorò in tono scherzoso. «Dal momento in cui abbiamo lasciato La Paz niente dipende più dalla sua volontà. La foresta si farà carico di dimostrarglielo. Cerchi di essere rispettoso o finirà per pagarla cara.» «Andiamo?» chiese Efraín in quel momento. Assentimmo e ci alzammo recuperando le nostre cose. Era chiaro che lì non c'erano guardaparco di nessun genere e che, a quell'ora, non si sarebbero presentati, quindi non correvamo nessun rischio passando attraverso l'entrata. «Non è piuttosto irregolare che ci sia un ingresso senza vigilanza?» chiese Lola sistemandosi al suo posto nella fila. «Sì, certo che è irregolare», rispose Gertrude senza abbassare la voce e mettendosi lo zaino a spalla, «però è anche abbastanza frequente.» «Soprattutto in questi ingressi secondari attraverso i quali non passa quasi mai nessuno», fece notare Efraín addentrandosi decisamente nella radura. L'oscurità era totale, e, nonostante lo avessi davanti a me, riuscivo appena a vederlo. Superammo lo stretto passaggio aggirando il cartello e il posto di vigilanza vuoto e ci inoltrammo finalmente nel Madidi. I suoni della foresta erano terrificanti come i suoi silenzi, improvvisi e all'apparenza senza ragione. In una frazione di secondo tutto taceva in modo sorprendente e si udivano solo i nostri passi sul fogliame, poi, in modo altrettanto inaspettato, ritornavano i rumori, le grida e gli strani sibili. Dopo aver percorso cento o duecento metri - non potevo saperlo con sicurezza perché misurare le distanze per intuizione non era mai stato il mio forte - Efraín si fermò e lo sentii trafficare finché una luce, piccola all'inizio e poi intensa e brillante, si accese nella sua lampada a gas e ci illuminò. Anche Marc accese la sua, e Marta, che era dietro di me, lo imitò in modo che la nostra marcia si facesse più rapida e sicura. Finalmente poco dopo trovammo un angolo nel folto della vegetazione, vicino a un ruscello, e decidemmo che era il luogo perfetto per accamparci quella notte. Dopo aver acceso le lampade, una nube di insetti prese a volteggiare attorno a noi. Gertrude ci fece esaminare bene il terreno prima di iniziare a montare le tende: in base a quello che ci disse, nella foresta esistono molti tipi di formiche abbastanza pericolose e dovevamo assicurarci di non trovarci vicino a nessun formicaio o a nessun termitaio, più facilmente riconoscibile per la sua elevata forma conica. Disponemmo le tende in semicerchio davanti al ruscello e accendemmo un fuoco per tenere lontani gli animali che potessero sentirsi attratti dal nostro odore e da quello del nostro cibo. Secondo Gertrude, le fiere non erano tanto feroci ed erano abituate a fuggire quando sentivano la presenza umana, salvo, è chiaro, che avessero fame e che il boccone apparisse indifeso; in questo caso il dramma era servito. Ma un buon fuoco, affermò, ci avrebbe tenuti al sicuro per tutta la notte. Cenammo abbondantemente e siccome era ancora presto - gli orologi segnavano poco più delle otto - rimanemmo a chiacchierare e a goderci la temperatura mite. Io non ero mai stato boy-scout, e non ero mai andato in un campeggio né avevo fatto parte di nessun club di escursionisti, quindi quella era la mia prima esperienza di conversazione attorno a un fuoco; non posso affermare che mi fosse piaciuto perché parlammo solo di cose di cui dovevamo tener conto noi tre novellini per non avere un incidente. Il cielo, comunque, era pieno di stelle grandi e brillanti come non ne avevo mai viste e mi trovavo in una situazione assolutamente anomala e straordinaria per colpa di quelle persone che conoscevano il potere delle parole. Rimasi in silenzio mentre gli altri parlavano; osservavo i volti di Marc e di Lola illuminati dalle fiamme, sapendo che stavano bene, che trovarsi li gli piaceva molto e che, in un modo o nell'altro, avrebbero trovato la maniera di affrontare le difficoltà che potevano presentarsi. In me, invece, di fronte al fatto di vivere quell'avventura nella natura, c'era soltanto una determinazione razionale. Quel luogo, nonostante fosse una radura vicina a un ru- scello limpido e dal suono piacevole, non era il mio luogo e, ovviamente, non presupponeva un grande cambiamento rispetto alla parte di Inferno verde che avevamo attraversato quel pomeriggio, in cui tutto pungeva, mordeva o graffiava. Finalmente, verso le dieci, andammo a dormire, dopo aver messo al riparo i viveri e ripulito i resti della cena per non attrarre nessun visitatore notturno. Efraín e Gertrude condividevano la tenda, chiaramente, io stavo con Marc, e Lola con Marta, perché la professoressa e io non dovessimo dormire sotto lo stesso tetto di tela plastificata. Anche se c'era bel tempo e malgrado ci trovassimo nella stagione secca dell'anno, a mezzanotte, mentre tutti stavamo dormendo o tentando di farlo - come nel mio caso - la bella notte stellata si rannuvolò e, senza che capissimo da dove erano uscite le nubi portatrici di pioggia, venne giù dal cielo un acquazzone di quelli storici, accompagnato da un forte vento da sud che fu sul punto di divellere i picchetti. Il fuoco si spense e non riuscimmo ad accenderne un altro perché la legna era bagnata, quindi fummo obbligati a rimanere di guardia per non servire da cena a qualche animale feroce. Quando finalmente si fece giorno e la tempesta proseguì per la sua strada allontanandosi da noi, eravamo del tutto esauriti e inzuppati; la temperatura, secondo quello che segnava il mio GPS, era scesa a quindici gradi, cosa insolita per un bosco tropicale, ma fantastica per la camminata che ci aspettava quel giorno, disse Gertrude molto contenta. Dopo aver consumato una colazione ricca di alimenti energetici, riprendemmo il cammino in direzione nord-est aprendoci il sentiero a colpi di machete. Era sfibrante, per cui a turno occupammo il primo posto della fila per ripartirci la fatica. Alla seconda manche la mia mano destra cominciò a infiammarsi e, quando mi toccò la terza, avevo già delle dolorose bolle che minacciavano di rompersi da un momento all'altro. Gertrude me le bucò, vi applicò una pomata e mi bendò con molta cura, poi dovette fare la stessa cosa a Marta, Lola, Marc e a se stessa. L'unico che si salvò fu Efraín, che aveva le mani incallite per il recente lavoro negli scavi di Tiwanacu. In quelle condizioni, con il bosco ancora gocciolante per la pioggia notturna e il terreno trasformato in fanghiglia scivolosa nella quale i piedi affondavano fino alle caviglie, riuscivamo appena ad avanzare, con l'aggravante che quella mattina, forse per la tempesta, gli insetti erano particolarmente aggressivi e l'intensità dei loro assalti aumentava a mano a mano che il sole saliva nel cielo. Ma l'autentico problema non erano gli insetti, né il fango e nemmeno la boscaglia o gli alberi, che ora presentavano una varietà di specie e non erano più soltanto palme. Il vero problema che dovevamo affrontare erano le sottili liane che pendevano dai rami come ghirlande natalizie, formando solide mura legnose che bisognava tagliare a colpi di machete. Erano un incubo, un inferno, e quando ci fermammo a mangiare vicino a un ruscello che, nonostante fosse segnalato nelle mappe con una tenue linea azzurra, non pareva avere nessun nome, eravamo distrutti. Soltanto Marc sembrava stare meglio degli altri, tuttavia non era nemmeno in grado di aprire la bocca per articolare una parola. Rimanemmo seduti vicino al piccolo corso d'acqua, con le mani tese come se stessimo chiedendo l'elemosina. Di colpo Lola scoppiò a ridere. Non sapevamo perché ma, senza una ragione, la imitammo tutti e cominciammo a ridere come matti senza riuscire a smettere, per pura disperazione. «Penso che sia stata la peggiore esperienza della mia vita!» esclamò Efraín, abbandonando il capo sulla spalla di Gertrude per soffocare le risa che gli impedivano di parlare. «Io non lo penso», aggiunse Marta. «Ne sono del tutto sicura.» «Figuratevi per noi», bofonchiò Marc agitando le mani bendate per scacciare mosche, vespe, farfalle e api che ci giravano attorno. «Capite ora perché è detto 'Inferno verde'?» chiese Gertrude. «Non so se riuscirò a sopportare due settimane in queste condizioni», commentai, colpendomi la nuca con il palmo della mano bendata per ammazzare una zanzara. «Ci abitueremo», mi incoraggiò Lola sorridendo. «Vedrai.» «E siamo appena agli inizi!» osservò Efraín, togliendosi lo zaino dalle spalle e alzandosi. «Non si preoccupi, compare, si può sempre fare di più di ciò che si pensa. Vedrà che entro alcuni giorni diventerà un perfetto indio.» «L'indio lo sto già facendo», mormorai, assolutamente convinto. Efraín si tolse la maglietta e gli stivali e, con i pantaloni addosso, senza pensarci due volte, si buttò in acqua creando un grande caos e spruzzandoci tutti. Ne aveva veramente un gran bisogno visto che lo si poteva confondere con una scultura di terracotta. Era l'una, e camminavamo dalle sei del mattino, ma per me quelle ore si erano dilatate all'infinito. Mentre gli altri seguivano Efraín nel suo attacco di follia e si buttavano anche loro in acqua per lavarsi e spassarsela un po', io consultai le mappe e il GPS scoprendo, costernato, che eravamo avanzati soltanto di poco più di sei chilometri. Ci trovavamo a 14° e 17' di latitudine sud e a 67° e 23' di longitudine ovest. Nemmeno se avessimo trovato una carrozzabile nella foresta saremmo arrivati quella sera ad accamparci nel punto previsto. L'idea di percorrere una ventina di chilometri al giorno era stata un'autentica sciocchezza, e lo stesso valeva per aver contato sulla maggiore energia acquisita scendendo dall'altopiano e avendo a disposizione più ossigeno. «Coraggio, Arnau», mormorai parlando a me stesso. «Le cose non possono certo peggiorare più di così.» E siccome anch'io ero ricoperto da una crosta secca che mi si accumulava sulla pelle, decisi che avevo bisogno di un bagno. Non ero mai stato tanto sudicio in vita mia, unto, appiccicoso e maleodorante. Era naturalmente un'esperienza nuova che dovevo sopportare con coraggio, ma questa andava proprio contro i miei più elementari principi. La marcia del pomeriggio non fu migliore di quella del mattino, solo un po' più lenta perché eravamo stanchi e con la schiena dolorante per il grande peso degli zaini. Lola, inoltre, reggeva a mano un sacchetto di plastica con un paio di chiocciole catturate nelle vicinanze del ruscello e sembrava che non le dispiacesse portarsi dietro quei due animaletti le cui conchiglie erano solo un po' più piccole di una ciambella di Maiorca. Lungo il cammino ci imbattemmo in larghe colonne di formiche che avanzavano tra i cespugli. Dato che misuravano circa due centimetri ciascuna, la processione risultava impressionante. La colonna più ampia era composta da alcuni esemplari color rossiccio che trasportavano enormi pezzi di foglia tra le mandibole e si dirigevano verso un monticello di terra di quasi mezzo metro di altezza. «È un termitaio?» chiese Lola. «No», rispose Gertrude. «I termitai sono molto più grandi. È un formicaio. A volte le formiche costruiscono strutture simili per proteggere meglio gli accessi alle loro gallerie sotterranee.» Marc emise un lungo fischio. «Devono essere delle gallerie enormi!» La dottoressa Bigelow assentì. «Probabilmente stiamo camminandoci sopra da diversi chilometri senza saperlo.» «Queste formiche sono pericolose?» si affrettò a chiedere Marta. «Non lo so, ma io, nell'incertezza, non le toccherei. Potrebbero dare febbre alta e dolori per alcuni giorni.» Prima che diventasse buio, ci fermammo in una piccola radura tra gli alberi. «Passeremo la notte qui», annunciò Efraín, conficcando con attenzione il machete nel terreno con un colpo secco del polso. «Qui?» si sorprese Marc. «Qui non possiamo piantare le tende.» «Non lo faremo, signor informatico», rispose l'archeologo sempre energico. «Oggi dormiremo sulle amache, sotto le zanzariere.» «All'aperto?» mi lamentai. «All'aperto. Il fango non ci permetterebbe di piantare le tende.» «Esaminiamo prima il terreno», ci ricordò Gertrude, «e anche la corteccia degli alberi. Poi vedremo se possiamo fermarci.» C'erano effettivamente delle formiche, ma in file ridotte di esemplari più piccoli, che avanzavano a una a una e non sembravano pericolose. Chiudemmo bene gli zaini dopo averne tolto il cibo per la sera, accendemmo le lampade a gas e ci preparammo per la notte. Eravamo esausti. Accendemmo anche un bel fuoco al centro per riscaldare la cena e proteggerci dagli animali selvatici. Ricordo che ero mezzo intontito mentre cenavo, ma non ci fu pietà per nessuno: alla fine tutti dovemmo pulire i nostri piatti, i bicchieri e le posate con l'acqua delle borracce e poi legare le amache ai grossi tronchi a una buona altezza, scostando le liane e annodandole perché non ci dessero fastidio. Poi appendemmo le zanzariere ai rami bassi, ce le lasciammo cadere addosso facendo ben attenzione a non lasciarvi dentro nessun insetto e ci coricammo. Ma, nonostante la notte prima non avessi chiuso occhio e la marcia del giorno fosse stata dura, non mi fu facile conciliare il sonno. Come diavolo ci si sistemava in quella rete per non essere trasformato in un arco dolorante, con le vertebre lombari ad angolo retto? E io non ero l'unico. Si sentivano cigolare le corde delle amache di Marc e di Lola che sfregavano contro i tronchi quando tentavano di bilanciarsi rivoltandosi disperatamente come me ed emettendo frequenti gemiti di dolore. Ma ero così sfinito che non riuscivo nemmeno a rivolgergli la parola. Pensai che non dovevo assolutamente agitarmi, qualsiasi muscolo mi facesse male, perché così sarei riuscito ad addormentarmi; tuttavia, alla luce del falò, l'immagine che videro in quel momento i miei occhi stanchi aprendosi un istante fu quella di sei bianche crisalidi che penzolavano sul terreno coperto da enormi serpenti di color giallo con macchie nere a forma di rombo sulla schiena e piccoli occhi brillanti. Mi si gelò il sangue nelle vene, feci un salto sulla dannata amaca e sentii come se mille aghi mi si piantassero in tutto il corpo. «Efraín», chiamai con la voce più tranquilla possibile. Ma l'archeologo russava dolcemente dormendo il sonno dei giusti e non mi sentì. «Gertrude», tentai. «Efraín.» «Che cosa succede, Root?» mi chiese Lola rigirandosi come un involtino primavera all'interno della sua amaca per potermi vedere. Non le dissi niente. Indicai soltanto il terreno con un dito perché abbassasse lo sguardo e capisse. Allora aprì la bocca terrorizzata e dalla sua gola uscì un grido acuto e interminabile che provocò mille rumori nella foresta, mille grida, gracchi, bramiti, trilli, gorgheggi, sibili e ululati. Ma il suo era più forte di tutti. Le improvvise esclamazioni di spavento di quelli che erano stati svegliati si sommarono alla baraonda. «Che cosa succede?» gridò Gertrude, mentre Efraín, ancora addormentato, si toglieva il cappello dalla faccia e afferrava il machete che aveva lasciato piantato nel tronco dentro la sua zanzariera. Lola continuava a gridare e Marc a lanciare maledizioni troppo brutali per qualsiasi orecchio umano. Marta fu l'unica che, sebbene sveglia e allarmata, non perse il controllo. Io continuavo a indicare il terreno come un sonnambulo, con un movimento meccanico di cui non ero nemmeno cosciente. Quando Gertrude seguì la direzione della mia mano con lo sguardo, vide finalmente le bestiacce che, ritte o strisciando attorno al fuoco, tappezzavano il suolo della nostra stanza da letto. «Buoni, buoni...» disse quieta. «Calmatevi.» «Ma che diavolo succede, accidentaccio?» esclamò Efraín tentando di tenere gli occhi aperti. «Tranquillo, caro», gli disse. «È solo una famiglia di pucararas che è venuta a scaldarsi accanto al fuoco.» «Solo?» ripeté Marc, spaventato. «Senta, Gertrude», aggiunsi io, «la situazione non è delle migliori, capisce?» «Certo che lo capisco. Guardate bene queste creature perché dovete imparare ad allontanarvi da loro senza allarmarle, nel caso ne incontraste qualcuna lungo il cammino. Sono i serpenti velenosi più grandi che esistano, della famiglia dei serpenti a sonagli, anche se le pucararas non ne hanno, e da loro proviene il siero antiofidico che ho nella valigetta. Si cibano solo di piccoli animali, non di esseri umani. Il calore le ha attratte. Lasciamole in pace. Quando il fuoco si spegnerà se ne andranno.» «La foresta ne è piena», confermò Marta calma. «Piena, in effetti. Quindi non preoccupatevi. Semplicemente, non calpestatele camminando, non molestatele. Ora siamo al sicuro sulle amache. Anche ieri sera certamente sono venute all'accampamento, ma qualcuno se n'è accorto?» «E meno male che non ce ne siamo accorti!» esclamai irritato. «Quando si spegnerà il fuoco se ne andranno. Credetemi.» «Bene», disse Marc, «ma a quel punto arriveranno i puma, i leoni, le iene...» «Qui non ci sono leoni, Marc», gli spiegò Gertrude, cercando di nuovo una posizione comoda nell'amaca. «Vuol dire che ci sono iene?» si allarmò il mio amico. «Dormite, accidenti», farfugliò Efraín ridiventato una crisalide. Nemmeno quella notte, con le pucararas che serpeggiavano sotto le mie vertebre lombari, chiusi occhio. E con questa facevano due. Mai avevo sentito il pericolo tanto vicino. Fino a quel momento, tutte le situazioni rischiose che avevo attraversato nella mia vita erano state preventivamente pianificate e le loro ipotetiche conseguenze (una caduta nei collettori delle fognature di Barcellona o un virus nei computer) non implicavano una minaccia mortale. Ma ero tanto stanco che le mie facoltà mentali non funzionavano, sentivo il panico sprizzarmi da tutti i pori e il mio cervello sonnambulo non smetteva di creare immagini spaventose che continuavano a riproporsi in modo compulsivo. Il fuoco si consumò e le pucararas, effettivamente, se ne andarono, ma, nelle due ore che mancavano all'alba, rimasi in un dormiveglia agitato, sottoposto come un torturato alle idee più assurde che potessi immaginare. Volevo tornare a casa, stare con mia nonna, giocare con mio nipote, e vedere mio fratello. Desideravo solo queste piccole cose che, da quell'amaca, sembravano lontane e molto preziose. Quando raggiungi un limite e hai davanti l'abisso - o ti sembra l'abisso quello che hai davanti - tutto ciò che è superfluo scompare e quello che è veramente importante si fa evidente e chiaro come la luce. Analizzai l'ordine con cui mi erano venuti alla mente i desideri: primo, la mia casa, cioè il mio spazio, il mio luogo, la proiezione di me stesso, il rifugio dove sentirmi sicuro, dove c'erano i miei libri, la mia musica preferita, le mie consolle di videogiochi, la mia collezione di film, il mio giardino... Poi la nonna, la persona più straordinaria del mondo, colei che consideravo la mia radice diretta con la vita e con la mia origine, saltando il triste anello di una madre tonta, superficiale e debole. Poi mio nipote, quel testone grazioso e intelligente che, comunque, mi ispirava tenerezza e affetto senza nessuna ragione speciale, solo perché era mio nipote e poco di più. E, per ultimo, mio fratello, quell'imbecille di mio fratello, per la cui salute mentale dovevo starmene imbozzolato in quell'amaca in mezzo alla foresta. Era perché condividevamo una buona quantità di geni? La mia stanchezza non mi permetteva di scavare tanto a fondo nelle ragioni che potevo avere per amarlo nonostante tutto. «Sveglia, amici! Ora di colazione!» La nostra sveglia, il buon Efraín, aveva deciso che, alle cinque del mattino, avessimo già dormito abbastanza. Quando saltai giù dall'amaca, sentii delle fitte persino nella carta d'identità. Camminammo senza pausa per sette ore, sopportando il calore sfibrante che ci regalava quel nuovo giorno e facendoci strada con la forza tra le liane. Le mie mani e quelle dei miei compagni erano talmente malridotte che le sentivamo appena, ma che cosa importava? Noi tre c'eravamo trasformati in zombie, in automi, perché se io ero distrutto, bisognava vedere le facce di Marc e di Lola: pallidi fantasmi senza vita animati da una pozione magica per risuscitare i morti. Se avessimo continuato così, non saremmo arrivati a destinazione. Meno male che potevamo sfruttare quei pochi giorni di energia straordinaria che ci offriva il cambiamento di altitudine, perché altrimenti saremmo morti. Nemmeno quella sera riuscimmo a montare le tende, quindi si ripeté la sgradevole avventura con le pucararas, ma il mio corpo disse che ne aveva abbastanza di stupidaggini, che sopportava solo quelle necessarie e non una di più, e alla fine riuscii a dormire senza interruzione e a svegliarmi al mattino abbastanza riposato. Tutto perfetto se non fosse stato per la spessa nebbia che ci avvolgeva e che non mi permise di distinguere che cosa fosse che pesava sulle mie gambe come un cane danese. Quando mi voltai per alzarmi, pensando che si trattasse di un ramo o dello zaino di qualcuno dei miei compagni, il danese mostrò di avere quattro agili e veloci zampe dotate di unghie affilate che mi graffiarono attraverso i pantaloni. «Cazzo! Che cos'è?» esclamai con l'adrenalina che mi scorreva a fiotti nelle vene mentre lottavo per distinguere attraverso la nebbia che cosa diavolo corresse sul mio corpo in quella maniera. Dal tronco al quale avevo legato l'estremità della mia amaca, un paio di occhi che sembravano coperti da un'armatura mi osservavano fissamente: un lucertolone più lungo del mio braccio e con degli appariscenti colori verde, bruno e giallo era lì, immobile, in atteggiamento di allerta, con una strana coda bifida ritta e una minacciosa cresta alzata grande come un ventaglio. «Scenda dall'amaca molto adagio, Arnau», mi consigliò Gertrude. «Come, adagio?» chiesi senza muovermi. «Come se avesse tutte le ossa rotte.» «Ah, d'accordo. Meno male.» «È velenoso o qualcosa del genere?» chiese Lola, angosciata, mentre io mi sforzavo di scivolare millimetro per millimetro, senza oscillare, verso il suolo. «No, in realtà no», rispose Gertrude con voce divertita. «Questi gechi o lucertole dell'Amazzonia sono totalmente inoffensivi.» Mi sentii un autentico imbecille appeso all'amaca in una posizione davvero ridicola, e anch'io risi quando posai i piedi a terra e il mio ritmo cardiaco tornò alla normalità. Il povero animale, quando saltai, si mise a correre su per il tronco veloce come un bolide. «Avete notato che aveva due code?» commentò Efraín mentre accendeva un nuovo fuoco per preparare la colazione. «Era ripugnante!» commentò Lola con il fastidio dipinto in faccia. «Questi gechi di solito hanno due code», ci spiegò l'archeologo mentre Marta metteva a scaldare l'acqua, «perché, siccome gli cade con molta facilità e gliene cresce un'altra velocemente, qualsiasi piccolo taglio o graffio nella prima fa sì che gli esca la seconda.» «Che schifo!» quasi gridò Lola. «Per favore, possiamo cambiare argomento?» «Bella maniera di cominciare la giornata», dissi per consolarmi. Marc stava già masticando i suoi biscotti ai cereali con cioccolato. «A me sembrava carino», farfugliò. «Mi sarebbe piaciuto fotografarlo e metterlo come sfondo nello schermo del mio computer in ufficio.» Avevamo la nostra fotocamera digitale ed Efraín aveva la sua, ma se qualcuno ne avesse tirata fuori una dallo zaino per soddisfare l'insano desiderio del verme intergalattico, sarei stato capace di ucciderlo. Le macchine servivano per il nostro incontro con gli yatiris, non per fotografare animali ripugnanti. «Tu sei fuori di testa», dissi a Marc con disprezzo. «Se il lucertolone avesse dormito sulle tue gambe, avrei voluto vedere se ti sarebbe piaciuto ricordarlo ogni mattina accendendo il computer.» «Io conservo sempre un bel ricordo di chi ha condiviso con me il letto», dichiarò in tono scherzoso. «Parla solo di me», chiarì Lola, con un sospiro annoiato. Quel giorno avanzammo a un buon ritmo cosicché coprimmo un tragitto di ventidue chilometri. I dolori muscolari scomparvero camminando e le mani si coprirono a poco a poco di calli lì dove si erano formate le bolle. Le mie unghie erano rotte e nere, e il terriccio mescolato al sudore cominciava a macchiarmi la pelle di scuro che non andava via nemmeno con l'acqua dei fiumi e delle lagune senza nome che incontravamo sul nostro cammino. Non facevo più caso nemmeno ai piedi gonfi dentro gli stivali né al peso disumano degli zaini sulle reni e sulle spalle. Ci si abitua a tutto. Il sabato, quando secondo i nostri calcoli ci trovavamo già a poca distanza dalla meta - avevamo percorso più di sessanta chilometri ed eravamo in territorio inesplorato - il paesaggio si trasformò misteriosamente: gli alberi diventarono molto più grandi raggiungendo trenta o trentacinque metri di altezza, formando un tetto impenetrabile che ci obbligava a camminare nella penombra opprimente nella quale tutto era freddo e oscuro e non c'erano segni di vita animale. Erano talmente ricchi di piante rampicanti e di liane che se ne distinguevano appena i tronchi, molti dei quali superavano i tre metri di diametro alla base; erano degli autentici giganti della foresta. I fiori scomparvero lasciando il posto a un paesaggio dipinto esclusivamente con tonalità di verde, e il terreno si coprì di un'alta e intricata boscaglia piena di rovi che ci laceravano la pelle e i pantaloni trasformando il tessuto antivento HyVent e la fodera antisudore in penosi brandelli. Ci legammo dei fazzoletti attorno alle gambe per non ferirci, ma fu inutile: le spine di quelle piante erano come lame di bisturi. Tutto acquisì il tono ombroso di una natura che non sembrava gradire le visite, se si poteva utilizzare quel paragone tanto umano rispetto alla stranezza del luogo. Persino l'odore cambiò: tutto sapeva di muffa e di vegetazione in decomposizione. La domenica fu ancora peggio; sembrava che gli alberi si avvicinassero gli uni agli altri cercando il modo di sbarrarci il cammino. Avevamo addosso tutti i vestiti che ci eravamo portati, compresi gli asciugamani che avevamo annodato attorno alla faccia, alle braccia e, soprattutto, attorno alle gambe, ma era impossibile evitare le ferite. Quel bosco pareva respingerci, avvertendoci che ci conveniva tornare da dove eravamo venuti. Quella sera, seduti attorno al fuoco, coperti da chiazze di Betadine come fossimo una nuova specie di animali dalla pelle maculata, commentammo stupiti quanto penoso doveva essere stato per gli yatiris attraversare quella boscaglia carichi di tutti i loro averi e accompagnati dalle famiglie. Era quasi impossibile immaginare una simile impresa. Nessuno di noi riusciva a spiegarselo. «Forse stiamo sbagliando strada», insinuò Marc, smuovendo con un ramoscello verde le braci del falò. Avevamo lavorato duramente per ripulire una piccola parte di terreno dalla vegetazione e da ogni genere di insetti e di serpentelli. «Ti assicuro che la strada è quella giusta», gli garantii verificandolo con il GPS. «Non abbiamo deviato assolutamente dall'itinerario tracciato dalla mappa della Piramide del Viaggiatore.» Efraín, che aveva ancora tra le mani il piatto con parte della cena (riso e verdure in scatola) si aprì in un sorriso. «Vi rendete conto che domani o dopodomani al più tardi li incontreremo?» Sul viso di tutti si disegnò un'espressione soddisfatta. «Avranno costruito una città come Taipikala in un posto come questo?» chiese Gertrude con gli occhi accesi. «Sono impaziente di verificarlo», disse Marta lasciandosi cadere comodamente su uno zaino. «Se lo hanno fatto deve trattarsi di un luogo impressionante... e vivo», aggiunse mostrando una certa emozione. «Soprattutto vivo. Penso che sarebbe la soddisfazione più grande della mia vita entrare in una Tiwanacu abitata e traboccante di attività. Che cosa ne dici, Efraín?» «Non so...» rispose lui con un sorriso puerile sul volto. «Sì, credo che mi sentirei anch'io come il re del mondo, il primo archeologo ad avere l'opportunità di fare un viaggio nel tempo! Tiwanacu viva... non so, davvero, non riesco a immaginarlo.» «Non voglio fare la guastafeste», li interruppe Lola slacciandosi gli scarponi, «però avete pensato come avrebbero potuto portare fin qui pietre di cento tonnellate? Non per niente, ma dubito molto che ci siano cave di andesite in questa zona.» «Non ce ne sono neanche vicino a Tiwanacu», obiettò Marta. «Per costruire quel luogo sull'altopiano dovettero trasportarle da molti chilometri di distanza.» «Sì, però, e la foresta?» insisté la mia amica, cocciuta. «E i conquistadores? Qualcuno avrebbe visto massi di dimensioni impossibili che si addentravano nella boscaglia, senza contare che dovevano trasportarli attraverso posti come questo.» «Un mio collega», disse Efraín, «famoso archeologo boliviano, ha esposto un'ottima teoria su come i tiwanacotas riuscirono a muovere quei massi impressionanti. In base agli studi, duemilaseicentoventi operai potrebbero trascinare un blocco di andesite di dieci tonnellate utilizzando lunghe strisce di cuoio fabbricate con non ricordo quante pelli di vigogna e facendolo scivolare su un terreno coperto da alcuni milioni di metri cubi di argilla.» «Ah, bene!» si lasciò scappare Marc esagerando il sollievo provato alla notizia. «Allora è risolto! Prendiamo tutte le vigogne dell'altopiano, le ammazziamo per ottenere il cuoio necessario a fabbricare corde lunghissime e resistenti alle quali si possono aggrappare duemilaseicentoventi persone che, inoltre, devono anche portare argilla sufficiente a coprire il monte Illimani, più i duemila litri d'acqua che servono per inumidirla e, camminando sopra questo fango scivoloso, trascinano per ottanta o cento chilometri un masso di dieci tonnellate di peso...» Sospirò e continuò a smuovere le braci. «Bene, nessun problema. Adesso ho capito.» «L'immagine mi ricorda i film di Hollywood», osservai, «nei quali migliaia di schiavi ebrei trascinavano, sotto i colpi di frusta dei loro aguzzini, i massi per costruire le piramidi d'Egitto.» «Be', ma questo è falso», commentò Efraín. «Le scoperte più recenti affermano che in Egitto non esisteva la schiavitù.» Non ebbi nessuna reazione nel sentire ciò che diceva Efraín. Ricordavo ancora Charlton Heston, che interpretava Mosè ne I dieci comandamenti, strappare la frusta dalle mani della guardia egizia che colpiva gli schiavi ebrei. «Questi calcoli dei duemilaseicento operai non funzionano per i massi di cento tonnellate di Tiwanacu, vero?» chiese Lola, insicura. «No», rispose Marta. «Questi calcoli non spiegano come abbiano potuto trasportare né quelli di cento tonnellate né quelli di centoventi. E nemmeno quelli di cinquanta o di trenta. È solo una teoria, ma è la più accreditata in mancanza di una migliore. Anche se non è molto solida.» «Pertanto», proseguì la mercenaria, pensosa, «se nessuno sa veramente come li hanno spostati, potrebbero anche averli portati nella foresta.» «È proprio quello che speriamo», convenne Marta sorridente. «Vedremo», mormorai dissimulando uno sbadiglio. «Ormai non manca molto, compare», mi disse Efraín con grande convinzione. Ed era vero. Dopo una domenica e un lunedì di battaglie all'ultimo sangue con la vegetazione e i fusti legnosi e flessibili delle piante rampicanti che univano gli alberi tra di loro in un sinistro abbraccio, il martedì, a metà mattina, d'improvviso il sottobosco si fece meno folto e i tronchi si distanziarono abbastanza da lasciarci avanzare senza usare il machete. Persino il sole sembrava penetrare con facilità tra le alte cime che toccavano il suolo con le loro lunghe, snelle braccia sotto le quali mi piaceva molto passare. Sembrava che si disegnassero percorsi davanti a noi, percorsi che, anche se ci erano parsi larghi e netti fin dal principio, erano comunque stretti sentieri che si andavano allargando portandoci verso un bosco sempre meno fitto. Di colpo inciampai in qualcosa. Tesi le braccia per mantenere l'equilibrio e finii per appoggiarmi alla schiena di Efraín. «Arnau!» esclamò Marta sorreggendomi dagli spallacci dello zaino. «Quasi mi uccido», grugnii, guardando il posto in cui avevo messo il piede in fallo. L'acuta punta di una pietra chiaramente lavorata da mani umane sporgeva dal suolo. Ci chinammo tutti per esaminarla. «Siamo vicini», ribadì Efraín. Appena cinquanta metri dopo ci imbattemmo in un basso muro coperto da un folto muschio verde e costruito con grosse pietre incastrate le une nelle altre alla maniera di quelle di Tiwanacu. Le grida di una famiglia di scimmie urlatrici mi fecero sobbalzare. «Siamo arrivati», annunciò Lola, portandosi al mio fianco. «E gli yatiris?» chiese Marc. Non si udivano altri rumori che quelli della foresta e, ovviamente, nessun'altra voce umana a parte le nostre. E tanto meno si vedeva qualcuno; solo quel muro verde rovinato in qualche punto. Un cupo presagio cominciò a girarmi per la testa. «Andiamo avanti», mormorò l'archeologo imboccando il sentiero di destra. «Un momento, Efraín», esclamò Gertrude che aveva lasciato cadere lo zaino a terra e lo stava aprendo con gesti abili e rapidi. «Aspetta, per favore.» «E adesso che cosa succede?» brontolò lui con un gesto di impazienza. Gertrude non gli rispose, ma prese dal suo zaino qualcosa che sembrava una carta di credito e la alzò per farcela vedere. «Succeda quel che succeda», disse molto seria, «devo registrare le voci degli yatiris.» E, detto questo, liberò dai pantaloni un lembo della maglietta e fece aderire il piccolissimo registratore grigio alla pelle lattiginosa del ventre. Sembrava uno di quei cerotti per smettere di fumare che si mettono i dipendenti dalla nicotina per disintossicarsi, solo un poco più grande. «Per non perderle, vero?» commentò Lola. «Esattamente. Non voglio correre rischi. Ho bisogno delle loro voci per poterle studiare.» «Ma registra con una buona qualità?» «È digitale», le spiegò Gertrude. «Sì, registra con una qualità molto buona. Il problema sono le pile, che durano solo tre ore. Ma queste mi basteranno.» A pochi metri di distanza trovammo un'entrata. Tre porte identiche alla Porta della Luna di Lakaqullu formavano un varco di grandezza veramente ciclopica mantenuto in perfetto stato. Nella parte superiore del vano centrale, il più grande - di circa quattro metri di altezza - si intravedeva un tocapu sullo stile di uno scudo nobiliare, ma il muschio che lo copriva non permise che Marta o Efraín potessero identificarlo. Il luogo era completamente abbandonato. Gli yatiris lo avevano lasciato già da molto tempo, ma soltanto Gertrude osò dirlo a voce alta: «Non ci sono». E fu sufficiente perché tutti accettassimo quella verità che ci stava torturando il cervello. «Puoi mettere via il registratore», mormorò Efraín, contrariato. No, gli yatiris non c'erano. La strana città che si intuiva dall'altra parte dell'entrata - di fattura chiaramente tiwanacota - era tutta una rovina, ingoiata dalla vegetazione e devastata dall'abbandono. Tuttavia, pur sapendo che non vi avremmo trovato niente, ci inoltrammo all'interno e proseguimmo in silenzio per una specie di strada ai cui lati si alzavano ancora case di due piani, costruite con grandi blocchi perfettamente uniti senza malta. Molte erano crollate, ma altre conservavano persino i tetti di lastre di pietra. E tutto di color verde, un verde brillante che luccicava sotto la luce del sole per le gocce di rugiada. Continuammo a scendere fino ad arrivare a una piazza quadrata di grandi dimensioni, costruita probabilmente a imitazione del tempio di Kalasasaya. Nel centro, un enorme monolito appoggiato su un piedistallo di pietra nera riproduceva il tipico gigante barbuto di Tiwanacu. Questa volta, però, scorgemmo una maggiore somiglianza con il Viaggiatore che riposava nella camera segreta della piramide di Lakaqullu: più di tre metri di altezza, occhi felini, grandi orecchie adorne con le pietre circolari e piatte che gli aymaras e gli incas inserivano nei lobi e con la testa conica risultato della deformazione frontoccipitale. Gli yatiris erano stati lì, su questo non c'era il minimo dubbio, e vi avevano trascorso il tempo necessario per costruire una nuova e bella città simile a quella che avevano abbandonato nell'altopiano. Si distinguevano anche, disseminate per la piazza, stele di pietra come quelle di Tiwanacu, con immagini scolpite di esseri antropomorfi barbuti rivolti alle quattro strade che si aprivano agli angoli, attraverso una delle quali eravamo entrati. «Andiamo da quella parte», ordinò Efraín incamminandosi a destra. Mentre seguivamo la direzione indicata dall'archeologo e ci addentravamo in un'altra strada identica a quella di prima, mi resi conto che a nulla era valso lo sforzo che avevamo fatto per attraversare la foresta, correndo mille pericoli: gli yatiris non c'erano e non sapevamo che cosa ne fosse stato di loro. La mappa della lastra d'oro terminava proprio nel punto in cui ci trovavamo, quindi non avevamo idea della direzione da seguire, e poi, per che cosa? Forse gli yatiris non erano più da nessuna parte, cosa che sembrava la più probabile; forse si erano estinti, erano dispersi, erano stati assaliti da tribù selvagge ed erano morti. E quello era il nostro capolinea, la fine delle speranze. A partire da quel momento non ci restava più niente da fare. Be', sì: tradurre i milioni di lastre d'oro della Piramide del Viaggiatore nel caso un giorno saltasse fuori un modo per guarire Daniel, se non era ancora morto o se non morivamo tutti. Tanta maledetta foresta, tanto viaggiare, tante punture di insetti e tanti rischi per niente. Eravamo rimasti a mani vuote. Forse avremmo potuto rendere più agevole il processo di traduzione delle lastre d'oro migliorando il «JoviLoom» di Marta e automatizzando il trattamento delle immagini. Oppure, se avessi investito dei soldi nel progetto che, senza dubbio, si sarebbe avviato tra la Spagna e la Bolivia (sarebbe stato sotto la direzione di Marta ed Efraín), non avremmo impiegato tanti anni nelle traduzioni e magari l'informazione che ci serviva sarebbe comparsa proprio all'inizio o poco dopo. Esisteva anche la possibilità di trovare in qualche luogo del pianeta un'equipe di neurologi in grado di neutralizzare l'effetto della maledizione con una droga o una cura sperimentale. Non si erano forse realizzati, negli gli anni della guerra fredda, esperimenti di lavaggio del cervello, programmazioni mentali e cose del genere? Dovevamo solo tornare a casa e riprendere il lavoro dall'inizio seguendo un altro percorso. Per fortuna il denaro non era un problema e, inoltre, avrei anche potuto vendere la Ker-Central. Insomma, mi stavo già annoiando. La strada era molto lunga e la foresta aveva fatto crescere arbusti tanto vigorosi tra le crepe delle pietre che il terreno si sollevava in parecchi punti. Alla fine incontrammo un edificio enorme che, per il suo aspetto, sarebbe potuto essere un palazzo o una residenza importante. Sembrava in buo- no stato, ed Efraín si incamminò verso l'ingresso. «Non entrerà lì dentro, vero?» chiese Marc, diffidente. «Dobbiamo scoprire che cosa è successo agli yatiris», rispose l'archeologo. «Forse non è un luogo sicuro», avvertì Marta. «Se prendiamo delle precauzioni contro i crolli, possiamo entrare», brontolò lui, senza voltarsi. In quel momento mi parve di vedere qualcosa che si muoveva nella parte superiore dell'edificio. Forse era stato un effetto del sole, certamente l'ombra di un uccello, perché udii anche un trillo molto acuto provenire dallo stesso punto, quindi non vi prestai molta attenzione. Ero assai più preoccupato per Efraín che, senza alcuna precauzione, come lui diceva, era entrato nel palazzo con passo fermo. «Efraín, non fare sciocchezze!» gli gridò Marta. «Esci e continuiamo a girare per la città!» «Ascoltami!» urlò Gertrude, mettendo le mani intorno alla bocca a mo' di megafono. «Esci immediatamente da lì! Non te lo ripeterò!» Ma l'archeologo non rispose e noi, smarriti, ci lanciammo verso l'interno temendo che gli fosse accaduto qualcosa. Ci trovammo di colpo in un'ampia sala con alcune pareti crollate dalla quale partiva una grandiosa scalinata su cui cominciammo a salire con cautela verso il piano superiore, osservando il cielo attraverso gli squarci del tetto. Improvvisamente l'archeologo apparve in cima con un gran sorriso sulle labbra. «Se sapeste le meraviglie che ci sono qui!» ci disse, e poi, con lo stesso entusiasmo e senza fare una pausa, ci bloccò seccamente. «No, non salite. Il pavimento e le pareti sono in pessime condizioni.» «E adesso dobbiamo uscire?» protestò Lola. «Di quali meraviglie parla?» chiesi, girando sui talloni per riprendere la discesa. «Ci sono dei bellissimi bassorilievi sulle pareti del piano superiore», spiegò Efraín, mentre scendeva, «e sotto i rampicanti si riesce a vedere che sono dipinti in verde e rosso, suppongo per ricordare i colori predominanti dell'andesite di Tiwanacu. Dovevano provare una grande nostalgia della loro vecchia città. C'è anche una riproduzione della figura barbuta che sta al centro della piazza che abbiamo attraversato.» «Hai fatto delle foto?» gli chiese Gertrude vedendolo con la fotocamera tra le mani. La dottoressa si era rilassata vedendo che il marito stava bene, e ora lo guardava accigliata e con aria minacciosa. Se fossi stato in lui mi sarei preoccupato, ma Efraín era talmente soddisfatto che non si accorgeva di niente. «Ve le farò vedere», promise. «Ora usciamo.» Con la coda dell'occhio mi parve di scorgere qualcosa di grande che scivolava alla velocità del vento attraverso il buco di un muretto in rovina, sulla mia sinistra. Mi voltai velocemente ma non vidi niente. Iniziai a pensare che stavo impazzendo e che avevo le allucinazioni, ma siccome ero molto cocciuto e diffidente, mi diressi lì, pronto a verificare con i miei stessi occhi. «Che cosa succede, Arnau?» si affrettò a chiedermi Marta quando mi vide cambiare direzione. «Niente», mentii. «Voglio solo vedere che cosa c'è lì dietro.» Non c'era nulla. Sporsi il capo con cautela quando finii di parlare e scoprii uno spazio completamente vuoto. Senza dubbio tanti giorni passati nella foresta mi avevano frastornato. Uscimmo al sole e riprendemmo il cammino in discesa alla ricerca di altri edifici importanti o che almeno attirassero la nostra attenzione, ma quello che c'era verso le mura esterne giaceva in una totale rovina sotto un groviglio di vegetazione e di alberi enormi. Ritornammo sui nostri passi e decidemmo, dato che ormai era ora, di fermarci a mangiare nella piazza e montare l'accampamento ai piedi del monolito del gigante, facendo della sua base di pietra nera il deposito degli zaini e del resto dell'equipaggiamento. Riscaldammo l'acqua sul fornello a gas per prepararci una zuppa e decidemmo che ancora non eravamo pronti a gettare la spugna: avremmo percorso quella città da una parte all'altra, da un estremo all'altro, fino a scoprire che cosa fosse successo agli yatiris e perché se ne fossero andati; se poi fossimo riusciti a sapere dove, meglio ancora. «Sì, meglio», puntualizzò Marc con sarcasmo mentre apriva una scatoletta, «ma non abbiamo alimenti sufficienti per seguirli. Siamo arrivati fin qui con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia, quindi ci rimane cibo solo per sei giorni. Per sette con gli avanzi, ma niente di più.» «Va bene, torneremo a casa quando finiremo di esplorare questo luogo», affermò Efraín. «Non possiamo fermarci», insisté Marc. «Non ha sentito quel che ho detto? Non abbiamo viveri!» «Non ci succederà niente se non mangeremo molto l'ultimo giorno», commentò Gertrude. «Quando lasceremo il Madidi recupereremo i chili perduti.» «Senta, dottoressa, non scherzi», tuonò il mio amico. «Forse voi potete sopportare di camminare un giorno intero attraverso la foresta senza mangiare, ma io no, e tutto il tempo che passiamo qui a studiare questo luogo è tempo perso.» «Abbiamo le coordinate del posto», osservò Lola solidarizzando con Marc, che conosceva abbastanza per sapere che, se non ingollava la quantità di cibo necessaria, poteva trasformarsi in un pericolo. «Possiamo tornare quando vogliamo con un elicottero.» Efraín e Marta si scambiarono gesti affermativi. «Va bene», rispose Marta. «Quando terminiamo di mangiare raccogliamo le nostre cose e ce ne andiamo.» «Mi dispiace, Root», mi disse Lola guardandomi con aria colpevole. «Anche a me», mormorò Marc. «Non so perché dite questo», replicai, ma lo sapevo già; avevo girovagato qua e là mentre loro parlavano. Se in quella città c'era qualcosa che indicava che gli yatiris continuavano a vivere da qualche parte, la nostra partenza ci avrebbe impedito di trovarlo e quindi mio fratello doveva continuare a stare con il cervello sconnesso fino al nostro ritorno a bordo di un comodo elicottero. Ma era anche possibile che non ci fosse niente a suggerire tale eventualità e quindi la cosa era indifferente. Come Marta mi aveva detto una volta, niente dipendeva più dalla mia volontà dal momento in cui avevo messo piede in quella foresta, o, ancora più precisamente, dal momento in cui era cominciato il problema di Daniel; e questa era una grande lezione che io, il tipo che voleva sempre tenere tutto sotto controllo, che non interveniva in niente che non potesse dirigere e gestire, stavo apprendendo a ceffoni. «Le prometto, Arnau», disse Marta molto seria e molto cosciente del filo dei miei pensieri, «che farò tutto quello che posso per risolvere il problema di Daniel il più presto possibile.» «Grazie», le risposi seccamente più per nascondere la mia frustrazione che per rifiutare la sua promessa, una promessa che non solo pensavo di ricordarle al momento opportuno, ma anche di trasformare in un progetto serio di lavoro al quale io stesso pensavo di partecipare. «Chi ha la pietra che abbiamo portato via da Tiwanacu?» chiese Efraín in quel momento con una mano appoggiata sul piedistallo della statua e con un'espressione strana sul volto. «Io», rispose Marc. «Le spiacerebbe darmela?» «Dev'essere in fondo allo zaino», ribadì Marc, alzandosi. «Dovrò svuotarlo.» «Su, lo faccia. Le prometto di prepararle un buon piatto di quinoa, dopo.» A tutti noi parve di cogliere qualcosa di strano nell'atteggiamento dell'archeologo; continuammo a osservarlo mentre Marc rovesciava le sue cose in cerca della ciambella. «Va bene, amici! Ve lo spiego!» disse Efraín ridendo della nostra espressione interrogativa. «Venite a vedere quello che ho trovato per caso ai piedi del gigante.» Gertrude, Lola e Marta erano già lì prima che avesse finito di parlare e osservavano il punto in cui l'archeologo aveva appoggiato la mano. Io mi avvicinai e mi sporsi tranquillamente al di sopra delle loro teste. Una piccola protuberanza nella pietra nera, che sembrava un formaggino, e di dimensioni molto simili a quelle dell'incavo triangolare della ciambella, compariva nel centro dello zoccolo, ai piedi del monolito. Marc si avvicinò con il cerchio di pietra e lo porse a Efraín, il quale lo collocò sulla sporgenza constatando che vi si incastrava alla perfezione, dato che la ciambella non si muoveva neanche di una virgola. Subito capimmo che la punta della freccia scolpita nella parte superiore indicava senza il minimo dubbio l'angolo della piazza dalla quale partiva una delle strade che non avevamo percorso, che stava proprio tra quella da cui eravamo arrivati e quella che scendeva verso il palazzo dei bassorilievi. Un forte fischio, acuto e chiaramente non emesso da un animale, giunse dall'alto. Avemmo appena il tempo di alzare lo sguardo per cercare l'origine dello sgradevole suono, quando tutti i tetti degli edifici della piazza si riempirono di alte figure armate di terribili lance che puntavano proprio verso di noi. Tutto era successo con tale rapidità che nessuno di noi mosse un muscolo né pronunciò una parola né emise un grido. Immobili, trasformati in statue di sale, contemplavamo quella scena dantesca nella quale decine di índios nudi ci minacciavano con le lance dalle terrazze e dai tetti dai quattro lati della piazza. Capii, senza alcun dubbio, che quelle lance dalla punta affilata erano realmente pericolose. Forse, se mi avessero minacciato con una carabina o una pistola, l'ignoranza, che è molto audace (posto che non avevo visto una di queste armi in tutta la mia vita, salvo naturalmente nei film), mi avrebbe impedito di provare paura. Ma quelle lunghissime picche alte almeno quanto coloro che le impugnavano, mi paralizzarono per il terrore; quasi potevo sentirle penetrare dolorosamente nella carne. Influiva anche, suppongo, l'aspetto feroce di quegli indios: ovviamente non potevamo vederli bene da dove ci trovavamo, ma pareva che avessero il volto coperto da facce con terrificanti maschere nere che facevano gelare il sangue. Passavano i secondi e non si muoveva neanche l'aria. «Che facciamo?» sussurrai calcolando il tono di voce necessario perché mi sentissero i miei compagni ma non gli indios dai tetti. Ma quei selvaggi dovevano avere un udito felino perché, come protesta per le mie parole, o come minaccia, tornarono a emettere il fischio acuto che rompeva i timpani e che provocava il silenzio più profondo nella foresta che ci circondava. Una lancia che non vidi passò con un sibilo affilato al mio fianco e si conficcò profondamente in uno dei nostri zaini. Il rumore secco che fece piantandosi e lacerando il tessuto impermeabile si ripeté molte volte, quindi supposi che colpissero i nostri bagagli da varie direzioni e che, in realtà, quello che volevano era mantenerci fermi e zitti. Naturalmente ci riuscirono: come me, i miei compagni dovettero sentire un freddo mortale salire dai piedi alla testa, un freddo che al suo passaggio lasciava i muscoli contratti e gravemente compromessa qualsiasi possibilità di respirare. Allora apparve di fronte a noi, dalla strada segnalata dalla ciambella di pietra, quello che doveva essere il capo, circondato da cinque guardaspalle dall'aspetto aggressivo e ostile. Camminavano a passo lento e altero, come se si sentissero molto superiori a noi, poveri stranieri che avevamo avuto la sfortuna di calpestare il suolo sbagliato. Mi dissi che, se per caso c'eravamo imbattuti in una di quelle tribù di indios che avevano rarissimi contatti con i bianchi e che li uccidevano come avvertimento affinché nessuno entrasse più nel loro territorio, come era capitato molte volte in Brasile negli ultimi anni - questo me lo aveva raccontato Gertrude nella foresta, quando non avevamo più la possibilità di pentirci e di tornare indietro -, stavamo freschi. I nostri corpi senza vita sarebbero apparsi nelle vicinanze di un luogo civilizzato come vistosi e strategici cartelli di divieto d'entrata. Il capo, comandante, leader, cacique o quel che era, si piazzò di fronte a me che, per essere rimasto dietro gli altri al di sopra delle loro teste per vedere come si incastrava la pietra nel triangolo, ora mi trovavo sulla linea di fuoco. Era un uomo alto e magro, molto più alto della statura media che avevo osservato negli indigeni della Bolivia, e anche la sua pelle era di un colore differente, tra il rossiccio e l'abbronzato, invece del solito colore scuro ramato. Era scalzo, indossava un gonnellino lungo che gli arrivava fino alle ginocchia e un copricapo di vistose piume d'uccello. Sfoggiava un grande tatuaggio sul volto - quello che io avevo preso per una maschera di forma quadrata e di color nero, che partiva sotto le ciglia delle palpebre inferiori e terminava in una linea orizzontale disegnata dalla piega delle labbra che arrivava fino alle orecchie. Ovviamente non era una pittura che si potesse togliere con un po' d'acqua: era un tatuaggio in piena regola, e anche i suoi cinque accompagnatori ne esibivano uno, ma di colore blu scuro. Avevano dei lineamenti scolpiti, più simili agli spigoli dritti e sottili degli aymaras che alle forme tondeggianti delle tribù amazzoniche. Il tipo mi fissò a lungo, senza parlare. Forse era giunto all'erronea conclusione che io fossi il capo di quel gruppo di bianchi per la mia statura elevata, ma non avevo modo di smentirlo, cosicché sostenni il suo sguardo più per terrore che per fare lo spaccone. Poi, quando si stancò, con lo stesso passo lento e altero si diresse verso i miei compagni e lo persi di vista. Non osai voltarmi, ma il silenzio continuò, quindi ritenni che non stesse accadendo niente di nuovo. Improvvisamente, il tipo borbottò qualcosa. Rimasi in attesa supponendo che ora le lance ci avrebbero trafitto senza misericordia, ma non successe, e allora il capo tornò a ripetere le stesse parole gridando, con un tono più impaziente. Nel silenzio della piazza, l'eco del suo vocione risuonava da un lato all'altro. Le scimmie urlatrici tornarono a gridare dalle cime degli alberi vicini. Quando per la terza volta ripeté il suo messaggio, ora in malo modo, mi girai adagio e vidi che Marc e Gertrude si voltavano anche loro. Il capo aveva alzato il braccio destro mostrando nella mano il cerchio di pietra e, indicandolo con la sinistra, ripeté per la quarta volta ciò che sembrava una domanda prepotente. Fu Gertrude che, forse per la sua precedente esperienza di rapporti con le tribù amazzoniche che non avevano mai avuto contatti con i bianchi, gli rispose a nome di tutti. «Questa pietra», disse con una voce molto dolce, come se fosse una domatrice di fiere che si rivolgesse al più cattivo dei suoi animali, «l'abbiamo portata via da Tiwanacu... da Taipikala.» «Taipikala!» esclamò trionfante l'impiumato, e, con nostra sorpresa, i suoi uomini, quelli che lo accompagnavano e quelli che erano rimasti sui tetti, ripeterono in coro la parola con lo stesso entusiasmo. Poi, siccome sembrava che non fosse stato sufficiente, alzò di nuovo il cerchio di pietra e, rivolgendosi a Gertrude, le fece un'altra incomprensibile tirata. Lei lo guardò senza battere ciglio e non gli rispose. Questo sembrò infastidire il capo, che fece alcuni passi verso di lei, fino a fermarsi a poco meno di un metro di distanza, e tornò a mostrarle la pietra e a ripetere l'enigmatica domanda. «Digli qualcosa, cara», supplicò Efraín a voce bassa. «Digli qualsiasi cosa.» Il cacique lo trapassò con lo sguardo mentre uno dei guardaspalle alzava la lancia e la puntava verso l'archeologo. Gertrude si innervosì. Le mani le tremavano mentre, con lo stesso tono tranquillo di prima, incominciò a raccontare la storia completa della ciambella di pietra. «L'abbiamo trovata a Taipikala, dopo essere usciti da Lakaqullu, dove siamo stati chiusi dentro la camera del Viaggiatore, il... sariri.» Ma il capo non sembrò impressionarsi per nessuna delle parole magiche che la dottoressa Bigelow si sforzava di pronunciare. «Siamo stati lì», continuò a dire Gertrude, «in cerca degli yatiris, i costruttori di Tai...» «Yatiris!» proferì il tipo alzando di nuovo la ciambella in aria con un gesto di soddisfazione, e le sue truppe lo imitarono rompendo il silenzio della foresta. Sembrava che potesse bastare. Il capo e i suoi cinque uomini ci passarono davanti per tornare alla strada da cui erano comparsi, mentre le file di lancieri scomparivano dai tetti. Ma se qualcuno di noi sperava che fosse finita e che se ne andassero via, si sbagliava di grosso: i lancieri riapparvero da tutte le parti, riempiendo la piazza; il capo si bloccò a metà strada e si voltò a guardarci. Fece uno strano gesto con la mano e un gruppo di energumeni uscì dalle file per lanciarsi contro di noi come se volessero ammazzarci. Invece ci superarono e, fermandosi di fronte al monolito, raccolsero gli zaini crivellati e il resto delle nostre cose portandoli davanti all'impiumato, che con un altro gesto elegante della mano ordinò di distruggere tutto. Davanti ai nostri occhi increduli quei vandali lacerarono gli zaini e ne sparsero il contenuto per terra: strapparono i vestiti, le tende, ruppero gli spazzolini da denti, i rasoi, le mappe, i pacchetti di cibo... Frantumarono con le pietre tutto quello che era metallico (borracce, bicchieri, scatolame, la valigetta di Gertrude con tutto il suo contenuto, i machete, le forbici, le bussole...); fracassarono senza pietà, sbattendoli ripetutamente contro il suolo, i cellulari, le macchine fotografiche digitali, il GPS e il mio computer portatile. Se anche fosse rimasto qualcosa non completamente a pezzi, mentre alcuni ammucchiavano a calci i resti del disastro, comparve un uomo molto vecchio che si intrattenne a lungo a sfregare un paio di bastoncini - li aveva tirati fuori da una piccola borsa di pelle - finché comparve un filo di fumo, dopo di che bruciò un ciuffo di stoppie con le quali diede fuoco alla pira dei nostri averi. Non rimase assolutamente niente quando tutto quel cerimoniale terminò, eccetto le amache, che i selvaggi avevano separato da tutto il resto lasciandole da parte. Ma solo queste e quello che indossavamo sopravvissero alla barbarie. Se dopo tutto ciò avessero deciso di lasciarci in vita, il loro gesto gentile non avrebbe più avuto importanza perché senza cibo, bussola o machete non avevamo la minima possibilità di ritornare alla civiltà. Sicuramente tutti e sei stavamo pensando la stessa cosa, in quel momento, e lo verificai udendo un pianto sordo dietro di me che poteva provenire solo da Lola. Poi, con la pira che ancora fumava, ciascuno di noi fu legato saldamente da un indio e, seguendo i passi del comandante, il suo seguito e il suo esercito, fummo condotti all'uscita della piazza. Solo allora i miei neuroni reagirono, e cominciai a tirare le fila della situazione. Forse fu perché prendemmo la strada segnalata dalla freccia scolpita nel cerchio di pietra - la stessa dalla quale era comparso il capo -, il fatto è che, sommando due più due, il risultato era quattro: gli indios ci stavano spiando dal momento in cui eravamo giunti alle rovine; io stesso li avevo intravisti mentre si muovevano in modo furtivo attorno a noi, e poi erano apparsi improvvisamente nell'attimo preciso in cui avevamo collocato il cerchio di pietra sul piedistallo del monolito. Inoltre, l'impiumato aveva preso il cerchio e con questo in mano aveva reagito visibilmente quando Gertrude aveva pronunciato le parole magiche «Taipikala» e «yatiris». Ora, dopo aver impedito qualsiasi tentativo di fuga da parte nostra, ci portavano con loro seguendo la stessa direzione indicata dal cerchio di pietra. Tutti questi dati conducevano a due conclusioni ovvie: o questi tipi erano proprio gli yatiris inselvatichiti dopo aver sperimentato un'involuzione verso la barbarie come quella subita dal gruppo di studenti de Il signore delle mosche di William Golding, oppure ci stavano portando dagli yatiris, cioè esattamente dove volevamo andare, anche se non in quel modo o in quel momento. «Sentite», disse Efraín armandosi di coraggio e tentando, suppongo, di trasmettercelo, «avete notato che non ci hanno fatto del male e che ci stanno portando nella direzione giusta?» L'indio che lo teneva per il braccio lo scrollò senza pietà per farlo tacere. Sarebbe stato diverso se si fosse trattato di Jabba, che sovrastava la sua sentinella in altezza, in larghezza e in spessore, ma Efraín, pur avendo una struttura fisica che superava quella media dei boliviani, arrivava appena alla spalla del suo guardiano. Il mio, che pure era abbastanza aitante, mi arrivava all'altezza del collo, ma io non avevo la minima intenzione di in- nervosirlo, soprattutto ora che sapevo che non ci avrebbero ammazzato e che ci conducevano dove volevamo andare. Mentre lasciavamo la città uscendo da una porta simile a quella per cui eravamo entrati e scendendo dei grandi scalini disuguali e rotti, dedussi in silenzio che non dovevamo trovarci molto lontani dalla nostra meta, visto che avevano mandato in malora tutto il cibo che avevamo con noi, e loro non avevano addosso altro che le lance. Il fatto che avessero rispettato le amache poteva significare sia che quella notte avremmo dormito nella foresta sia che, semplicemente, le avrebbero tenute per sé, e quindi prima dell'imbrunire avremmo incontrato gli yatiris. Ma, naturalmente, quando uno fa una deduzione tanto speculativa dovrebbe poter contare su un'informazione completa, possedere tutti i dati, perché, se così non è, le conclusioni possono essere tanto errate come alla fine risultarono essere le mie: non incontrammo gli yatiris prima dell'imbrunire e neanche il giorno dopo e nemmeno quello dopo ancora né per tutta la settimana; e le amache, in effetti, furono il nostro letto quella notte e le molte notti seguenti. Camminammo tutto il pomeriggio percorrendo stretti sentieri misteriosamente aperti nella boscaglia. Gli indios non avevano machete né niente di affilato con cui tagliare la vegetazione, cosicché si faceva abbastanza fatica a intuire l'origine di quelle piste, eppure erano lì e facevano molte curve e giri strani. Solo alcuni giorni dopo scoprimmo che erano gli animali a crearle nel loro vagare per la foresta in cerca di acqua o di cibo, e che gli indios sapevano trovarle per istinto e utilizzarle per spostarsi da una parte all'altra. Dal loro punto di vista, era uno spreco di energie aprirsi una strada a colpi di machete visto che esisteva un altro metodo molto meno faticoso. Questi sentieri o piste di solito incominciavano e terminavano in piccoli ruscelli, laghi, fonti, cascatelle o zone acquitrinose - che pure c'erano e che attraversammo -, e quel primo pomeriggio ci incamminammo lungo un piccolo canale d'acqua tra il verdastro e il nero, e lo seguimmo in senso contrario al suo corso fino al tramonto. Su ciascun lato c'erano arbusti e vegetazione intricata che si attorcigliava intorno ai tronchi degli enormi alberi che formavano la barriera tra l'acqua e la terra, proiettando una fitta ombra sulle nostre teste con i loro folti rami che si intrecciavano a un'altezza incredibile. Le radici aeree di molti di quei giganti pendevano come tende che ci rendevano difficile il passaggio ma, invece di tagliarle a coltellate come avevamo fatto noi fino a quel giorno, gli indios le scostavano con le mani, apparentemente senza sentire le punture delle spine di cui erano coperte in abbondanza. L'aria era umida e appiccicosa, e quando, per qualche ragione che ignoravamo, il capo ordinava di fermarsi un momento, il silenzio di quel luogo ombroso risultava opprimente e le voci echeggiavano come se ci trovassimo dentro una grotta. Attraversammo una zona nella quale tafani delle dimensioni di elefanti ci attaccavano senza pausa e un'altra con anguille elettriche le cui grandi teste, sfiorandoci le gambe attraverso gli strappi dei pantaloni, scaricavano una corrente simile a un'intensa puntura di ago. D'improvviso, nel posto più ombreggiato di quel canale che stavamo percorrendo da tutto il pomeriggio, si udirono delle grida laceranti che sembravano urla di anime in pena. Avvertii uno sgradevole brivido lungo la schiena e mi si rizzarono i peli per il terrore; ma gli indios reagirono con entusiasmo arrestando la marcia e ordinandoci a gesti di rimanere quieti e in silenzio mentre loro allungavano il collo verso l'alto in cerca di non sapevamo che cosa. Le grida continuavano in modo disarmonico e con note differenti.' Il mio guardiano si tolse dalla spalla una cinghia dalla quale pendeva una piccola scatoletta e due tubicini, che unì formandone con grande abilità uno solo; dalla scatoletta tolse una corta freccia che aveva a una delle estremità una piccola pallina di pasta e la introdusse attraverso la parte larga di quella che, senza dubbio, era la prima cerbottana autentica - e anche falsa - che vedevo in vita mia. Si portò il tubo alle labbra e continuò a osservare intensamente le altissime cime degli alberi che formavano una cupola su di noi. I guardiani degli altri miei compagni fecero lo stesso, e quindi rimanemmo temporaneamente liberi, anche se ci limitammo a scambiarci sguardi di incoraggiamento e sorrisi di circostanza. Le grida delle anime in pena cominciavano a definirsi e avevano un suono simile a «tócano, tócano». Finalmente alcuni indigeni scoprirono il nascondiglio del gruppo canterino perché si sentirono dei rumori secchi e brevi come spari di pistole ad aria compressa e una baraonda tra i rami provocata dalla caduta di oggetti da grande altezza. Per sfortuna, una di quelle strane bestie precipitò a pochi centimetri da me sollevando un'enorme quantità d'acqua che mi bagnò da capo a piedi. L'animale era un bel tucano abbastanza grosso con un formidabile becco di quasi venti centimetri di lunghezza e un piumaggio sulla coda di un incredibile colore zafferano. Purtroppo non era ancora morto (aveva la freccia piantata tra il petto e una delle ali) cosicché, quando il mio guardiano tentò di prenderlo, si difese ed emise dei sonori lamen- ti allarmando moltissimo gli indios che incominciarono a gridargli qualcosa in tono concitato. Ma, prima che questi avesse tempo di agire, migliaia di uccelli, invisibili fino a quel momento, vennero fuori dal nulla e incominciarono a scendere verso di noi, infuriati, saltando di ramo in ramo con le enormi ali spiegate ed emettendo delle urla terrificanti dai becchi aperti. Credo che il terrore che provai fu così grande che feci un gesto involontario di protezione incrociando le braccia davanti alla faccia ma, grazie al cielo, prima che quei parenti lontani dei protagonisti de Gli uccelli di Alfred Hitchcock ci distruggessero, il mio guardiano riuscì a dominare l'uccello ferito torcendogli il collo senza pietà. La fine dei suoi gemiti lamentosi fece terminare di colpo l'attacco e i tucani scomparvero nella foresta come se non fossero mai esistiti. Lola era impallidita e si appoggiava a Marta, che non aveva un aspetto migliore, ma che tuttavia proteggeva con un braccio le spalle di Gertrude attirandola a sé. Marc ed Efraín erano pietrificati, incapaci di muoversi o di articolare un suono, cosicché, quando gli indios gli misero i giganteschi animali morti sulle braccia, come fecero con me, avevano ancora lo sguardo perso senza rendersi conto di quello che trasportavano. La foresta che stavamo attraversando non aveva niente a che vedere con quella che avevamo conosciuto fino ad allora. Se, dal momento in cui eravamo entrati di nascosto nel Madidi, io avevo creduto di capire l'espressione «Inferno verde» che usavano Marta, Gertrude ed Efraín, mi sbagliavo di grosso. Quella che avevamo visto fino a quel momento era una foresta quasi civilizzata, quasi addomesticata in confronto a questo mondo selvaggio e delirante nel quale ci muovevamo ora. La sensazione di pericolo, di violento panico che ebbi pensando a queste cose fu mitigata da un'idea molto strana: se nel mondo virtuale dei computer la chiave perché le cose funzionassero stava nello scrivere un buon codice - un codice pulito e ordinato, senza cicli assurdi né istruzioni superflue -, nel mondo reale dell'autentico «Inferno verde» dovevano pure esistere delle regole simili, e coloro che conoscevano il codice e sapevano scriverlo correttamente perché tutto funzionasse erano gli abitanti di quel luogo, gli indios che ci accompagnavano. Loro forse non se la sarebbero cavata davanti a un computer né davanti a un comune semaforo ma, senza dubbio, conoscevano persino i più piccoli elementi dell'ambiente in cui ci trovavamo. Avevano previsto l'attacco dei tucani quando il loro compagno ferito aveva emesso lamenti e sapevano perfettamente ciò che bisognava fare (ammazzarlo per obbligarlo a tacere), mentre noi, cittadini tecnologicamente avanzati, non vedevamo nient'altro che foglie, tronchi e acqua; loro potevano decifrare i segnali del codice che «l'Inferno verde» utilizzava e sapevano rispondere di conseguenza. Osservai con attenzione quegli indios tatuati e dall'aspetto primitivo, e capii con certezza che eravamo uguali, identici in tutto, applicavamo soltanto le medesime capacità all'ambiente differente che c'era toccato in sorte. Non erano più stupidi perché non disponevano della luce elettrica o non avevano un lavoro dalle nove alle cinque; in ogni caso erano dei privilegiati perché avevano a portata di mano una grande abbondanza di risorse e perché sapevano utilizzarle con poca fatica e tanta intelligenza. Il rispetto che provai in quel momento crebbe con il passare dei giorni. Quella sera mangiammo tucano arrostito (che risultò essere una carne molto tenera e saporita) e uova di iguana che i nostri anfitrioni tirarono fuori da certi buchi negli alberi con la stessa facilità con cui li avrebbero presi, inscatolati, dallo scaffale di un qualsiasi supermercato. Gli enormi lucertoloni rimanevano paralizzati sul tronco, senza muoversi, vedendo come gli indigeni si portavano via tranquillamente le loro uova, di circa quattro centimetri di lunghezza, che erano molto appetitose tanto crude quanto arrostite sulle pietre roventi del falò. Per finire, consumammo in grandi quantità dei frutti molto maturi, dalle dimensioni di grosse mele, che, curiosamente, profumavano e sapevano di ananas anche se non lo erano, e avevano molti semi e poca polpa. Mangiammo di più e meglio di come avevamo fatto fino ad allora, con tutto quell'insipido cibo liofilizzato, inscatolato, conservato o in polvere e, quando tendemmo le amache gli indios avevano le loro, fatte con sottili fibre vegetali, che, piegate, stavano in una mano - dormii saporitamente, senza preoccupazioni, e sognai che arrivavo con la mia auto a calle Xiprer per andare a trovare Daniel e la sua famiglia, e che tutta la strada era libera per parcheggiare dove volevo, senza dover lasciare il veicolo sul marciapiede. Non potei raccontare tutto questo ai miei compagni di sventura perché i nostri guardiani non ci lasciarono parlare tra di noi fino a due giorni dopo, quando ritennero che ormai non fosse più necessario controllarci perché avevamo capito la situazione. In realtà l'avevamo capita quasi subito e, se qualcosa ci mancava per accettarla con stupore e soddisfazione, lo scoprimmo quella prima notte, dopo aver cenato, quando i nostri gentili anfitrioni, stanchi del cibo e della camminata, passarono un bel po' di tempo attorno al fuoco raccontando cose divertenti che li facevano ridere moltissimo. In quelle storie o racconti c'era un termine che ripetevano di continuo, la maggior parte delle volte indicando se stessi o la totalità dei presenti: né più né meno che «Toromo- nas». In fondo, mi dissi dopo aver scambiato uno sguardo significativo con Marta, quel tipo, l'autore della mappa etnica della Bolivia - come si chiamava? Pelissier Sanchiz, sì, proprio lui, Pelissier Sanchiz -, aveva avuto ragione nell'affermare che potevano ancora esserci dei Toromonas nella regione del Madidi, quella tribù forse scomparsa durante la guerra del caucciù del XIX secolo e che, secondo la storia, era stata la grande alleata degli incas che si erano nascosti nella foresta amazzonica per fuggire dagli spagnoli (la leggenda aggiungeva che erano scappati portandosi via il mitico tesoro conosciuto come El Dorado). Ma quello che né la storia né Pelissier Sanchiz sapevano era che i Toromonas non avevano aiutato gli incas propriamente detti, bensì alcuni abitanti dell'impero - incas pertanto per i cronisti spagnoli -, che erano i saggi yatiris, i sacerdoti Capacas del popolo aymara, il «Popolo dei tempi remoti» che, provenienti da TiwanakuTaipikala, «la pietra centrale», fuggivano dagli spagnoli, dalla loro crudeltà e dalle loro malattie contagiose portandosi via non El Dorado (quello lo avevano lasciato nella camera del Viaggiatore), ma il tesoro più importante che possedevano: la loro lingua sacra, l'antico Jaqui Aru, il «linguaggio umano», i cui suoni erano della stessa natura e sostanza degli esseri viventi e delle cose. I Toromonas avevano trovato le parole magiche di cui avevano bisogno nella piazza della città in rovina, ma noi quella notte trovammo la nostra, intessendo così una relazione che sarebbe durata molto più a lungo di quanto in quel momento immaginavamo. Nel corso della prima settimana camminammo senza sosta seguendo piste e fiumi, e addentrandoci sempre più in una foresta che cambiava aspetto nel giro di pochi giorni. A volte era amichevole ed entusiasmante, come quando raggiungemmo la vetta di una sierra e vedemmo ai nostri piedi, fino a dove la vista si perdeva in qualsiasi direzione, le cime degli alberi in cui, come in un tappeto dai colori cangianti, si intrecciavano immobili nuvole bianche. Altre volte era ostile come il peggiore dei nemici e bisognava stare in guardia continuamente per evitare le punture delle formiche soldato, delle zanzare, delle api, i morsi delle tarantole, dei serpenti, dei pipistrelli, dei caimani e dei piraña, i pesci che più abbondano in Amazzonia. Vedemmo puma e giaguari in varie occasioni, che non mostrarono mai l'intenzione di attaccarci; e falchi, aquile, scimmie e formichieri (veramente molto saporiti: la loro carne assomigliava a quella dell'oca). Gli indios mettevano da parte i lunghi artigli dei formichieri e, quando ci fermavamo a mangiare o a dormire, li affilavano con delle pietre fino a farne dei veri e propri pericolosi coltelli. Con il tempo Marc, Efraín e io ci abituammo a raderci con questi artigli. Osservare i Toromonas e imparare da loro diventò un'ossessione. Se Marc e io dicevamo sempre che il mondo era pieno di porte chiuse e che noi eravamo nati per aprirle tutte, quegli indios conoscevano la maniera di aprire le porte dell'Inferno verde e io volevo imparare a infrangere le chiavi del codice della foresta. Marc e Lola si burlavano di me; Marta, però, da buona antropologa, veniva con me quando mi inserivo in un gruppo di indios che svolgeva qualche curiosa attività. Ci lasciavano muovere liberamente, con un misto di compassione e di ironia simile a quella che provano i genitori per i loro figli più piccoli e impacciati, ma subito scoprirono che il nostro interesse era autentico e ci concessero una posizione privilegiata all'interno del piccolo esercito arrivando a chiamarci con i nostri nomi quando trovavano qualcosa che pensavano potesse interessarci. Era una lezione che avrei tuttavia preferito saltare se mi fosse stato possibile. Due o tre giorni dopo avere lasciato le rovine notai che avevo un ascesso enorme nel polpaccio destro. Non ci avevo fatto caso, pensando che fosse una semplice infiammazione causata da una delle mille punture e dai piccoli tagli che ci procuravamo con le piante, ma poco dopo il bubbone cominciò a suppurare e a gonfiarsi sempre di più provocandomi un dolore tanto forte che mi faceva zoppicare. Gertrude cominciò a preoccuparsi quando un altro foruncolo simile mi comparve sul dorso della mano sinistra e si gonfiò tanto che arrivò un momento in cui più che una mano sembrava un guanto da boxe. Non avevamo antibiotici né analgesici, e la povera dottoressa Bigelow non era in grado di aiutarmi. Il giorno in cui Marc ed Efraín dovettero aiutarmi a camminare, sorreggendomi per le braccia, i Toromonas capirono che stava succedendo qualcosa di strano. Uno di loro - il vecchio piromane che aveva dato fuoco alle nostre cose - fece in modo che mi posassero a terra e mi esaminò la mano e il polpaccio con l'occhio clinico di un medico che per tutta la vita ha visto le stesse malattie nei suoi compaesani. Si mise in bocca delle foglie di qualcosa che sembrava tabacco e le masticò per un bel po' lasciando cadere fili di saliva color marrone dalle labbra. Mi sentivo così male che non riuscii a fare neppure il gesto di ritrarre la mano quando il vecchio sputò adagio sulla dolorosissima infiammazione per poi osservare attentamente l'ascesso finché non si formò una piccola apertura, un vulcano sulla superficie, e spuntò qualcosa che si muoveva. Credo che giurai, maledissi e bestemmiai fino a rimanere rauco, mentre Marc ed Efraín mi trattenevano con la forza per non farmi muovere. Lola si sentì male e dovette allontanarsi con Marta, anche lei provata dalla scena. Solo Gertrude seguiva l'operazione mentre io pronunciavo tutte le imprecazioni che conoscevo. Il vecchio indio, con due dita, estrasse dalla mia mano gonfia una larva bianca di circa due centimetri, che si lasciò prendere senza opporre resistenza, intontita dal succo di tabacco che il vecchio aveva gentilmente preparato per me. Fu più difficile togliere la seconda larva perché era più grossa ed era rimasta più a lungo abbrancata alla mia carne. A gesti il vecchio, che risultò essere lo sciamano della tribù, mi spiegò che erano larve di tafani e che, come le zanzare quando succhiano il sangue, avevano una predilezione speciale per alcune persone piuttosto che per altre. Logicamente tutto questo risvegliò la passione investigativa di Gertrude Bigelow, dottoressa e antropologa dilettante, che da quel momento in poi si appiccicò come una patella al vecchio sciamano affascinata dalle cose nuove che andava via via imparando. Dopo quella sgradevole esperienza, trascorsi il resto del viaggio scacciando come un pazzo i tafani che mi si avvicinavano, e anche i miei compagni svilupparono una forte diffidenza verso questi insetti, per cui, alla fine, ci aiutavamo gli uni con gli altri nel compito di tenerli lontani dato che erano capaci di pungere attraverso i vestiti. L'unica cosa buona fu che, quando il vecchio mi tolse le larve, gli ascessi si chiusero e cicatrizzarono perfettamente in un paio di giorni con l'aiuto di un olio che gli indios ricavavano dalla corteccia di un albero dalle foglie color verde scuro e dai fiori bianchi molto simili a quelli del gelsomino, olio che ottenevano piantando uno degli affilati artigli di formichiere in un punto qualsiasi della pianta. Il modo in cui lo sciamano mi alleviava il dolore era un'altra storia: mi obbligava a mettere i piedi scalzi sul terreno umido che c'era accanto agli stagni e poi mi applicava le grosse teste di anguille elettriche sulla mano e sul polpaccio. Non c'è neanche bisogno di dire che questo provocava una serie di scosse che curiosamente agivano come anestetico facendo sparire il dolore per alcune ore. Quegli indios sapevano trarre profitto da ogni cosa e trovare nell'ambiente che li circondava tutto ciò di cui avevano bisogno. Da uno strano albero che proliferava sulle rive dei fiumi estraevano una resina bianca che aveva un profumo penetrante di canfora e che teneva lontane le temibili formiche soldato e le zecche. Dovevano solo strappare un pezzo di corteccia e lasciar fluire la resina, che poi applicavano su alcune parti del corpo o sugli alberi a cui legavano le amache. Con il tempo, naturalmente, finim- mo per imitarli - che è il miglior modo di imparare - e, per esempio, quando i nostri vestiti diventarono dei cenci, decidemmo che era una buona idea tagliare sopra le ginocchia quello che rimaneva dei pantaloni, sopportando come loro le piccole ferite e le contusioni a cui, effettivamente, finimmo per non far più caso. La verità è che, quasi senza accorgermene, subii una importante trasformazione. E non solo io, ma anche i miei civilizzati compagni, che finirono per adattarsi perfettamente al ritmo di vita quotidiano nella foresta e alle insolite abitudini dei Toromonas. Nonostante l'umidità e le costanti punture degli insetti godemmo di un'eccellente salute durante tutto il viaggio, e questo era dovuto, secondo quello che disse Gertrude, al fatto che in Amazzonia, come regola generale, i luoghi paludosi e ricchi di vegetazione sono più salubri di quelli secchi per l'assenza di calore tropicale. Non sentivamo più la stanchezza e riuscivamo a camminare con un buon ritmo per tutto il giorno senza arrivare distrutti al calare della notte. Imparammo a mangiare e a bere cose inimmaginabili - a Marc, naturalmente, non fece schifo mai niente -, a tacere e a concentrarci per ore, in stato di allerta di fronte ai segnali della foresta. Nel mio caso fu una metamorfosi molto più spettacolare perché di tutti e sei ero il meno appassionato alla natura e il più scrupoloso e maniacale. In quel breve periodo di tre settimane diventai un tipo capace di sparare con la cerbottana, di distinguere sia l'albero dalla corteccia rossiccia e rugosa dal quale estraevamo una bevanda molto nutriente (che, anche se puzzava di gatto morto, aveva esattamente il sapore del latte di mucca), sia la liana velenosa che pestavamo e agitavamo nelle acque dei fiumi per ammazzare i pesci che ci servivano poi come pranzo o cena. Arrivai anche a sapere, per esperienza diretta e per un tardivo consiglio toromona, quali foglie potevamo usare come carta igienica e quali contenevano delle tossine dalle quali conveniva tenersi lontani. E imparai a riconoscere la scia silenziosamente disegnata nell'acqua dai caimani o dagli anaconda mentre ci bagnavamo nei fiumi. È chiaro che tutto questo non era niente. Era appena la base, l'indispensabile per sopravvivere. Non si può imparare in pochi giorni ciò che necessita della pratica di una vita intera. Io ero solo un turista privilegiato, non un viaggiatore vecchio stile, di quelli che passavano mesi e persino anni nel luogo che volevano conoscere, e, come un turista qualsiasi, la mia visione di quel mondo era la stessa che percepivano i membri di un viaggio organizzato tipo «Tutta la Grecia in quattro giorni compresa una crociera tra le isole». Ero cosciente di questo, però. Come l'adrenalina fluiva a fiotti nelle mie vene quando rompevo le protezioni di un sito con informazioni proibite o mi infilavo nella rete fognaria del Nou Camp per lasciare il mio tag disegnato sulle pareti della sala stampa, ora non potevo evitare di combattere la mia supina ignoranza su tutto ciò che mi circondava. Una sera, già molto vicini alla nostra meta, mentre parlavamo prima di dormire, Lola mi guardò e scoppiò a ridere. «Quando tornerai a casa», farfugliò tra i singulti, «continuerai a chiedere a Sergi di proteggerti dalle piccole innocenti bestioline del tuo giardino?» Marc, malmesso perché il pomeriggio prima aveva toccato un insetto e dopo, senza rendersene conto, si era asciugato il sudore dalla faccia con le mani provocandosi un'orticaria che lo stava ammazzando, scoppiò in una risata che fece voltare verso di noi alcuni Toromonas rimasti anche loro a parlare vicino al fuoco. «Se ti vedesse ora chi ti conosce, Root, amico mio! Ah, quando lo racconterai in ufficio!» «Tu starai zitto», gli dissi molto serio, «se non vuoi che ti sbatta fuori.» «Non stai parlando sul serio, vero?» mi chiese Gertrude, preoccupata. Avevamo cominciato a darci del tu dopo aver lasciato la città in rovina, senza sapere bene perché. Ora, il lei lo utilizzavamo alla maniera dei boliviani, solo per le cose più personali, e Marc e Lola, per scherzo, si erano abituati a usarlo per rivolgersi l'uno all'altra quando discutevano. Il mondo a rovescio. «Certo che parla sul serio», le spiegò Marc, scostandosi con molta cautela ciuffi rossicci dalla fronte con il dorso delle mani doloranti. «Mi ha già licenziato più di una volta. Per quanto appaia calmo e padrone di se stesso, quando si arrabbia diventa una bestia.» «Ha licenziato anche me un paio di volte», ricordò Lola, lisciando i brandelli di quello che rimaneva dei suoi costosissimi pantaloni di tessuto HyVent. «Ma lo fa senza rendersene conto. In fondo è buono. Strano, ma buono.» «Strano?» rise Marta. «Gli strani sono loro», osservai impassibile. «Guardali e dimmi se non lo sono. A me sembrano stranissimi.» «Noi non abbiamo venduto un portale di Internet alla Chase Manhattan Bank per una palata di milioni di dollari a trent'anni appena compiuti», fece notare Marc, mettendo in evidenza la parte aneddotica della mia biografia che colpiva di più. Marta, Efraín e Gertrude si voltarono a guardarmi veloci come saette. «È vero?» chiese l'archeologo molto sorpreso. «Spiegacelo un po', amico.» Feci una faccia sprezzante e indicai con il mento il grassone. «Sapete perché lo chiamiamo Jabba?» «Sei un...» disse Marc furioso, ma Lola lo zittì mettendogli una mano sulla bocca. «Non mi interessa un cetriolo perché lo chiamate in quel modo», disse Efraín usando un'espressione molto boliviana. «È vera là faccenda della Chase Manhattan Bank? Non te la caverai spifferando i fatti del tuo migliore amico!» La foresta aveva fatto in modo che perdessimo anche gli ultimi rimasugli di comportamento sociale civilizzato. C'era, ormai, qualcosa de Il signore delle mosche in noi. «Sì, è vero», ammisi a denti stretti, «ma ho speso tutto nella costruzione della mia casa e nell'avviamento della mia azienda attuale, la Ker-Central.» Non era del tutto esatto, chiaramente, ma avevo sempre pensato che parlare di denaro fosse una cosa sconveniente. «Allora devi avere una casa impressionante», mormorò Marta spalancando gli occhi. «Ce l'ha, ce l'ha», sospirò Lola facendo capire che era la casa dei suoi sogni. «Dovreste vederla per crederci. Eh, Marc?» «Sì, ma che cosa vi prende stasera?» protestai. «E la tua azienda è molto grande?» si informò Gertrude piena di curiosità. «In Bolivia non ti conoscono!» scherzò Marc. Ebbi la tentazione di alzarmi e di dargli un bel paio di pizzicotti sulle guance grasse, arrossate e irritate. «Questo qui è uno dei pochi geni europei di Internet. Tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale applicata alla rete è passato per le sue mani.» Nessuno parlò, ma mi parve di sentire (virtualmente) un'esclamazione corale di stupore che usciva dalle loro bocche chiuse. «Senti», dissi a Jabba mettendolo in guardia, «visto che sei arrivato fino a questo punto te lo dirò chiaro: forse metterò in vendita la Ker-Central. Ci sto pensando.» Marc e Lola diventarono bianchi come stracci. «Non dire sciocchezze!» riuscì a replicare il verme dai capelli rossi facendo un grande sforzo per riprendersi dallo spavento. «Cerchiamo di non litigare, stasera!» «Guarda che cosa sono diventato!» esclamai voltandomi verso di lui. «Sto per compiere trentasei anni e sono un imprenditore noioso, uno che passa la giornata a firmare scartoffie. Ho bisogno di cambiare, di fare qualcosa che mi piaccia davvero. E non parlo di quella stupidaggine di essere felice», aggiunsi in tono serio. «Come Gertrude ci ha spiegato a La Paz, non c'è nessun pezzetto del nostro cervello dedicato a qualcosa di tanto insignificante e volgare. In realtà sto parlando di fare qualcosa che mi diverta, qualcosa che faccia parte del mondo reale.» «Hai bisogno di nuove sfide», affermò Marta. «Sì, qualcosa di simile», ammisi a denti stretti; mi sentivo a disagio a espormi così. «Non voglio essere l'amministratore finanziario delle idee altrui. Non fa per me.» «Allora, se ne hai abbastanza, dai a me la Ker-Central, ma non venderla! Anch'io ho contribuito a crearla!» «Ti ho già detto che ci sto ancora pensando. D'accordo?» «Guardati le spalle!» mi avvertì prima di chiudere la bocca in modo definitivo, almeno per quella sera. Non se ne parlò più. Non se ne presentò l'occasione. All'indomani, dopo aver attraversato una piccola vallata incorniciata da altissime montagne che superammo attraverso una pericolosa gola, ci trovammo, nelle prime ore del pomeriggio, in una foresta totalmente diversa da quella che avevamo visto fino ad allora. La penombra era completa e il terreno pantanoso e freddo era ricoperto da felci insolitamente alte e grandi che si aprivano delineando degli stretti passaggi attraverso un bosco che si poteva definire ombroso. Addentrandoci, ci sentivamo come il povero Gulliver nel paese dei giganti. Gli enormi alberi, separati tra loro di quel tanto che bastava per non divorarsi gli uni con gli altri, oppure caduti a terra, abbattuti dalla vecchiaia, misuravano tra i novanta e i cento metri di altezza, quasi come un qualsiasi grattacielo di New York, ma la cosa impressionante erano i tronchi, la cui circonferenza, a occhio, poteva misurare all'incirca venti o venticinque metri. Io avevo sentito parlare dei famosi baobab africani, talmente grandi che erano stati utilizzati come case, stalle, carceri e bar nei quali potevano stare fino a cinquanta persone alla volta. Quando ero piccolo avevo persino visto in un libro uno di questi baobab al quale avevano fatto un buco nel tronco per poter costruire una strada carrozzabile senza abbatterlo, trasformandolo nell'unico tunnel vivente attraverso cui passavano senza alcuna difficoltà grandi camion. Ma i colossali mostri che si ammassavano in quell'angolo sperduto dell'Amazzonia erano molto più grandi dei baobab. Efraín disse che poteva trattarsi di sequoie, gli alberi più alti del mondo, ma lui stesso si smentì ricordando che le sequoie, che si trovavano quasi esclusivamente sulla costa ovest degli Stati Uniti, misuravano sì oltre cento metri di altezza, ma i tronchi non raggiungevano mai la larghezza di quelli che avevamo attorno a noi. Le gigantesche radici affondavano nel fango molle (che trasudava una leggera nebbiolina dall'odore di putrefazione) e le cime si perdevano tra le nuvole, impossibili da scorgere, nascoste anche dai rami che si piegavano per l'enorme peso. C'erano zone in cui tra il compatto tappeto di felci, gli impressionanti tronchi che quasi si toccavano, le lunghissime liane, i rampicanti che pendevano da non si sapeva dove attorcigliati in autentici nodi gordiani, sembrava impossibile che qualcosa non appartenente al regno vegetale potesse vivere lì. Invece c'era almeno un animale che non vedemmo ma che sentimmo. All'inizio, quando il suo canto arrivò per la prima volta alle nostre orecchie, pensai che ci fosse una persona nei pressi che canticchiava una bella melodia, ma subito il tono si fece più acuto e mi sembrò di ascoltare un flauto, uno strumento che, senza dubbio, aveva bisogno di qualcuno che lo suonasse. Esaminai con estrema attenzione la fredda vegetazione attorno a noi perché il canto si sentiva molto vicino, ma non vidi nessuno. Era una musica incredibilmente bella e, di certo, proveniva da un flauto. Gli indios sorridevano e facevano dei commenti tra di loro, mentre i miei compagni esibivano la stessa faccia sbigottita che avevo io di fronte al fenomeno dell'artista vicino e invisibile. Di colpo, le note languide e dolci del flauto si trasformarono in una specie di stridore, quindi cadde il silenzio. Di lì a poco il canto umano riprese per convertirsi in flauto e terminare con quello sgradevole suono. Quando la stessa composizione arrivò da posti diversi contemporaneamente fummo costretti ad accettare la realtà: era il canto di un uccello straordinariamente dotato, ma in fin dei conti uccello. Quello era un mondo di dei, non di persone, il nostro gruppo sembrava una piccola fila di formiche che si perdeva nella vegetazione. Infine i sentieri sparirono all'improvviso, divorati dalla vegetazione, e i Toromonas si arrestarono; il capo, che era in testa al nostro gruppo, alzò un braccio ed emise un grido che risuonò nel bosco e che provocò schiamazzo tra i rami. E poi niente. Ci fermammo lì, tranquilli, aspettando non si sa bene che cosa. Pochi minuti dopo si udì un grido simile proveniente da un luogo distante e solo allora il capo toromona abbassò il braccio e si rilassò. Ma non ci muovemmo, e subito dopo Marta, in tono pacato, mise le mani nelle tasche dei pantaloni consunti e disse ad alta voce: «Penso che siamo arri- vati, amici miei». «Arrivati? Dove?» chiese quel sempliciotto di Marc. «A Osaka, Giappone», gli dissi molto serio. «In territorio yatiri», gli spiegò lei lanciandomi uno sguardo di rimprovero. «Non si vede nessuno», mormorò Efraín, preoccupato. «Io però ho la sensazione che ci stiano osservando», disse Lola, attaccandosi a Marc. Senza accorgercene, avevamo formato un cerchio mentre aspettavamo di riprendere la marcia o qualche indicazione da parte loro. «Sì, anch'io ho questa sensazione», confermò Gertrude portandosi la mano allo stomaco e lasciandocela. «Be', è probabile che lo stiano facendo», concesse Marta annuendo. «Di sicuro gli yatiris sono curiosi di sapere chi siamo e perché siamo comparsi qui all'improvviso accompagnati dai Toromonas.» Io dissentii muovendo i piedi perché mi si stavano congelando. «Che ci faceva un esercito tanto numeroso di Toromonas nascosto tra le rovine di quella città abbandonata nella foresta?» chiesi per fornire una traccia. «Erano lì per caso o qualcuno li aveva mandati a cercarci?» «Su, Arnau, non mi dirai che gli yatiris li hanno mandati a prenderci nel giorno e nell'ora esatta, vero?» obiettò Lola. «Non lo so, ma ricordo di aver letto una cronaca nella quale si affermava che quei tipi, quando vivevano a Taipikala, avevano predetto che sarebbero arrivati gli incas e gli spagnoli, stranieri che vivevano esattamente sull'altra sponda dell'oceano. Forse sono fantasie, io però non ci metterei la mano sul fuoco.» «Sono fantasie», ripeté Marta assentendo. «La cosa più probabile è che i Toromonas vivano a poca distanza da quelle rovine e che mettano delle sentinelle nel caso si avvicini qualcuno con il cerchio di pietra. Che siano alleati degli yatiris non c'è dubbio, ma da qui a dire che li abbiano mandati a cercarci perché sapevano del nostro imminente arrivo, ce ne vuole.» Tacemmo di colpo perché, con la coda dell'occhio, ci accorgemmo che i Toromonas cominciavano a muoversi. La cosa strana era che non andavano avanti, ma che ci circondavano, nonostante il sentiero tra i giganteschi alberi fosse abbastanza ampio. A poco a poco ci chiusero in un cerchio stretto e noi, stupefatti, osservavamo ciò che facevano senza capire quel che stava capitando; tutti però avevamo una certa sensazione di allarme che si rifletteva nell'inquietudine dei nostri volti. Qualcosa di strano stava accadendo. Quando vedemmo avvicinarsi il capo con il vecchio sciamano e la sua guardia del corpo, capimmo la situazione. «Che diavolo sta succedendo?» chiese Marc allarmato, passando un braccio attorno alle spalle di Lola. «Mi piacerebbe saperlo», rispose Marta con la stessa voce fredda e grave che usava quando era arrabbiata. Il capo si pose di fronte al nostro piccolo gruppo, ci guardò in modo imperscrutabile e indicò il sentiero dal quale eravamo arrivati. E siccome non ci muovevamo, il suo braccio si allungò in quella direzione e ripeté imperiosamente il gesto. Ci stava ordinando di passare davanti a loro e di percorrere quel sentiero tra le felci. «Che facciamo?» chiese il mio amico. «Quello che ci ordinano», rispose perplesso Efraín, prendendo Gertrude per mano e iniziando a camminare. «Questa cosa non mi piace per niente», mormorò Marc. «Se ti viene in mente qualche buona alternativa», gli dissi prendendo Marta per un braccio e incitandola a venire con me, «ti regalo la KerCentral. Parola.» «Vale quella di mettersi a correre come pazzi?» chiese con un sorriso ironico. «No, quella no.» «Lo sapevo», disse a Lola, chiudendo la fila. Siccome non ero del tutto sicuro, mi voltai a guardare i Toromonas per vedere se ci stavano puntando contro le loro lance o qualcosa del genere, ma gli indios continuavano a stare immobili in mezzo alla foresta, osservandoci senza battere ciglio. Il capo manteneva un atteggiamento dignitoso e lo sciamano sorrideva. Era la fine di un'altra tappa di quell'incredibile avventura. Mi chiesi se li avremmo rivisti, dato che senza il loro aiuto ci sarebbe stato impossibile ritornare alla civiltà. Ma chi poteva sapere quale sarebbe stata la fine di quello strano viaggio? Trenta metri più in là, il sentiero si restringeva come la punta di una matita e si interrompeva di colpo. Arrivammo sino alla fine e ci fermammo, senza sapere che cosa fare. Si supponeva che dovessimo aspettare, o forse dovevamo ritornare dai Toromonas? Le felci si mossero un poco alla mia destra. Girai la testa in quella direzione. Un braccio nudo apparve all'improvviso scostando le foglie e mi trovai a meno di un metro da un tipo alto come me, un po' più vecchio e vestito con una specie di maglietta lunga e senza maniche, stretta in vita da una fascia verde. Il tipo, che portava dei grandi dischi d'oro nei lobi delle orecchie, mi guardò a lungo senza mutare espressione e poi esaminò uno per uno tutti i miei compagni. Aveva dei tratti tipicamente aymaras, con zigomi alti, naso affilato e occhi vagamente felini. La pelle, però, era molto chiara, tanto chiara che, pur non essendo bianca come la nostra, non si poteva dire che fosse nemmeno lontanamente simile a quella degli indigeni. Eravamo pietrificati. Pietrificati e fuori combattimento; per cui, quando ci invitò a seguirlo, tutti e sei trasalimmo in modo un po' scortese. L'uomo si addentrò di nuovo tra le felci che si chiusero dietro di lui nascondendolo, e noi rimanemmo lì, immobili, con la faccia da imbecilli. Di lì a pochi secondi ricomparve e ci fissò corrucciato. Era strano. Le sue sopracciglia seguivano direzioni opposte: tutte e due disegnavano la forma sinuosa della tilde della eñe, ma, mentre una andava verso il basso, verso il naso, l'altra saliva verso la fronte. Se ne stava lì, a scrutarci da sotto quelle strane sopracciglia aspettando che ci muovessimo e lo seguissimo. Uno dopo l'altro attraversammo la verde barriera inoltrandoci in quell'immenso mare di foglie senza dire mezza parola, a disagio per una situazione che però aspettavamo da tanto tempo. Io fui il primo a entrare. Mi seguiva Efraín. Lo yatiri - non c'era dubbio che lo fosse - andò dritto verso uno degli alberi senza fermarsi né cambiare direzione, e, stupito, lo vidi entrare per un'apertura, una porta molto bassa lavorata rozzamente nel tronco, che ci condusse a un corridoio buio nel quale mi sentii come dovevano sentirsi i camion che attraversavano il tunnel del baobab africano. L'albero era vivo e vi circolava di sicuro la linfa, che emanava una fragranza intensa, un aroma simile a quello del cedro. In fondo al passaggio, di pochi metri di lunghezza, si scorgeva una luce; ne dedussi che lì ci aspettavano molti yatiris, ma mi sbagliavo: quei tipi avevano scavato il centro dell'albero creando un'enorme sala tubolare dalla quale partiva una rampa intagliata nelle pareti della pianta che saliva a spirale verso l'alto. Delle ciotole di pietra piene d'olio in cui bruciava uno stoppino erano state collocate ad altezze diverse illuminando in modo spettacolare quello strano camino. «Jiwasanakax jutapxtan!» esclamò la nostra guida in tono secco, come se fosse convinto che non l'avremmo capito. «Che cos'ha detto?» chiesi a Marta in un sussurro. «È aymara», mormorò lei, affascinata. «Chiaro», risposi. «Cosa ti aspettavi?» «Non so...» sussurrò senza riuscire a nascondere un largo sorriso di felicità. Non le avevo mai visto un'espressione tanto piacevole dipinta sul viso. «Bene, ma che cos'ha detto?» insistei. «Vuole che andiamo con lui», mi tradusse a bassa voce. Lo yatiri cominciò a salire per l'agevole rampa e allora mi resi conto, mentre lo seguivo, che il legno dell'interno di quel grande albero aveva una struttura molto massiccia, infatti non accusò nemmeno il peso dei nostri corpi: non ci fu né un ondeggiamento né la minima oscillazione. Alla luce delle lampade a olio, appariva di un gradevole color giallo solcato da lunghe venature marroni iridescenti, ed era lucidato e verniciato con un tipo di resina brillante decisamente scivolosa. La cornice sulla quale avanzavamo usciva dalla parete stessa a forma di cuneo (più grossa alla base) e terminava con un piccolo bordo largo e appena rialzato. Non aveva quindi nessun tipo di corrimano, per cui se qualcuno voleva saltare nel vuoto poteva farlo senza ostacoli. Non so per quanto tempo salimmo, ma fu abbastanza. Ci impiegammo parecchio ad arrivare fino al luogo in cui la salita dolce terminava direttamente in un'altra porta, che attraversammo dietro al simpatico yatiri. Dopo aver superato un altro breve tunnel ci trovammo in un ampio corridoio che metteva in comunicazione con un'altra porta dell'albero di fronte, a circa quindici metri di distanza. Era gradevole perché eravamo di nuovo vicini alla luce del sole che, a quell'altezza, riusciva a filtrare tra i rami. Marc si mise al mio fianco e dietro venivano Marta e Lola, seguite da Efraín e Gertrude. Mi incuriosì vedere che sotto di noi un altro passaggio all'aperto portava fino al tronco alla nostra destra. Osservando con maggiore attenzione, mi accorsi che più in basso e anche sulle nostre teste una fitta rete di strade simili collegava i colossali alberi che avevamo attorno. E, cosa più incredibile di tutte, queste arterie erano costruite con i rami giganteschi che nascevano dai tronchi, modellati e lavorati per arrivare da un lato all'altro in modo naturale: alcuni andavano verso l'alto, altri verso il basso, altri si ritorcevano, altri si livellavano e tutti si incrociavano ad altezza diversa, in modo che, se cadevi - anche se pareva abbastanza improbabile che qualcosa del genere potesse succedere vista l'ampiezza dei passaggi - sarebbe stato solo per un paio di metri fino al livello inferiore. Quei tizi avevano smesso di costruire città megalitiche - con una tecnica che rasentava la perfezione - per modellare la natura viva con la stessa genialità e adattarla alle loro necessità. Lo feci notare a Marc a gesti, e anche agli altri, che assentirono facendomi capire che erano stupiti quanto me. Quando entrammo nell'albero seguente ci trovammo in una specie di enorme piazza illuminata anch'essa da ciotole piene d'olio. Un piccolo gruppo di yatiris discuteva in lontananza vicino a una scala che sembrava salire e scendere verso altre piante simili. Lì c'erano le prime donne che incontrammo, le quali, a differenza degli uomini, indossavano delle camicette corte e ampie e delle gonne che arrivavano fino ai piedi. Tutte quelle persone avevano vestiti dai colori sgargianti, come quelli degli aymaras nei mercatini di La Paz, e tutte portavano alle orecchie i tipici dischi d'oro, gli orecchini presumibilmente incas, che, secondo la leggenda, permettevano di distinguere i possessori di uno speciale sangue solare da quelli che non l'avevano. Efraín ci spiegò che la tunica maschile si chiamava unku e che il suo uso era stato proibito, dopo la conquista, dagli spagnoli, che avevano imposto per legge l'uso dei pantaloni. Uomini e donne, senza eccezione, calzavano sandali di cuoio e si coprivano con dei mantelli che arrivavano fino alle ginocchia. Erano molto alti rispetto alla media, di pelle chiara e con i capelli neri dai riflessi blu, occhi scuri dallo sguardo curioso e tratti aymaras, anche se, e questo era un dato che attirò fortemente la nostra attenzione, tutti gli uomini esibivano sul volto l'ombra scura di una corta barba. Nessuno ci rivolse il minimo cenno di saluto o di benvenuto; tutti si ritirarono verso la scala, come se avessero paura, e fecero il gesto di coprirsi mezza faccia con un lembo del mantello. C'erano delle panche scolpite in una parte di quella gigantesca piazza, e da queste due uomini e una donna abbastanza in età, che probabilmente stavano conversando fino al nostro arrivo, ci esaminarono, con le facce serie e impassibili. La donna si rivolse alla nostra guida a voce alta. «Makij qhipt' arakisma!» Il nostro yatiri le rispose e continuò a camminare verso l'uscita facendo un cenno di saluto con il capo. «Che cosa hanno detto?» volle sapere Marc voltandosi verso Marta. Lei assentì come un'alunna diligente che ha capito perfettamente la lezione, poi ci guardò con gli occhi brillanti e disse, nervosa: «La donna anziana gli ha chiesto di sbrigarsi e di non perdere tempo, e lui le ha risposto che i Capacas ci stavano aspettando e che tutto si sarebbe svolto molto in fretta». Efraín venne avanti per intervenire nella conversazione. «Ci portano dai Capacas, amici!» esclamò, emozionato. «Non ci posso credere!» «Chissà se eseguiranno qualche rituale di sacrifici umani con noi!» si lasciò scappare Marc con una voce carica di emozione. Quando uscimmo dall'albero, sentimmo voci e risa provenire da un luo- go sopra di noi, ma non vedemmo nessuno. Udimmo anche dei latrati e ci guardammo gli uni con gli altri con gli occhi spalancati: c'erano dei cani, in quel posto! Incredibile. Ma non tanto se pensavamo alle finestre e alle porte che c'erano nei tronchi vicini e che sembravano appartenere a case abitate da persone che non riuscivamo a scorgere. La rete di rami trasformata abilmente in passaggi si riproduceva all'altro lato dell'albero, e anche dopo aver attraversato il seguente e l'altro e l'altro ancora... Anche se risultava impossibile vedere più di un paio di tronchi giganteschi su ciascun lato, non c'era dubbio che quella era una grande città vegetale dalla quale erano state eliminate le liane e le piante rampicanti, e nella quale la natura era stata profondamente rispettata, visto che non si vedeva nessun tipo di pedana, di piattaforma artificiale, di tavolato o di impalcatura. Sembrava che la nostra guida ci stesse conducendo lungo un percorso studiato in modo tale che non incontrassimo nessuno. Ovviamente ci riuscì: non incrociammo neppure un essere umano finché non arrivammo di fronte a un tronco di smisurate dimensioni verso cui convergevano un gran numero di corridoi aerei dagli alberi vicini, separati da una certa distanza. Era decisamente il tronco più grande che avessimo visto fino a quel momento, ma non aveva né rami né foglie. Sembrava che fosse stato colpito da un fulmine che lo aveva segato a partire dal punto in cui incominciava la sua chioma. Appariva imponente, mutilato e grandioso, e fui certo che quello fosse il luogo verso cui ci stavamo dirigendo, dato che aveva l'aspetto di un centro importante di potere e di governo. Scendemmo curvando per uno dei passaggi leggermente inclinato, verso un grande portone di legno che si schiuse pian piano come per magia alla nostra comparsa. Due yatiris vestiti con il solito costume apparvero dal fondo buio e aspettarono che la nostra guida - la quale ci ordinò di fermarci dove eravamo - facesse alcuni passi verso di loro. Poi ci permisero di accedere all'interno dell'albero mutilato e noi rimanemmo di gelo non perché facesse freddo, ma per lo sfoggio e la ricchezza di quel luogo: immensi tappeti di tocapus appesi al soffitto separavano gli spazi come dei divisori, il suolo era coperto di lastre d'oro lavorate a sbalzo con scene che sembravano tratte dalla lontana vita di Taipikala. Centinaia di lampade a olio illuminavano l'interno e dappertutto c'erano cassapanche, poltrone e tavoli costruiti in uno stile mai visto che utilizzava come materiali l'oro e il legno. La guida ci fece avanzare un poco e ci ingiunse di nuovo di aspettare. «Mä rat past'arapi», disse con molta boria prima di sparire. Se pensava che non lo capissimo, perché si preoccupava di parlarci e per giunta in quel modo? Efraín lo tradusse: «Ha detto che andava a passare un momento non so dove». «Non ha detto dove», chiarì Marta. «Mi sembrava.» «Che cosa dicono i tocapus?» chiese Lola, avvicinandosi a quello che avevamo più vicino. Era un arazzo impressionante, di sei o sette metri di altezza. «Questo, precisamente», incominciò a spiegare la professoressa, esaminandolo con attenzione, «è una specie di invocazione a una dea... Ma non ne fa il nome. Sicuramente sarà la Pachamama, la Madre Terra, perché parla della creazione dell'umanità.» «Questo qui», indicò Efraín dall'altro lato della sala, «narra come i giganti scomparvero con il diluvio.» «Questi tizi hanno una fissazione patologica per gli stessi temi, non vi pare?» commentò Marc, perplesso. Girammo per la sala per un po', guardando le cose che avevamo attorno, ma la mia mente era molto lontana. Riuscivo solo a pensare che, dopo tanto tempo e le molte cose che ci erano accadute, era arrivato finalmente il momento in cui dovevo riuscire a ottenere, in qualche modo, che quei tizi mi spiegassero come fare uscire Daniel dal letargo. «Sei preoccupato?» mi chiese Marta all'improvviso. Mi era venuta vicino senza che me ne accorgessi. «No, preoccupato no. Forse nervoso.» «Osserva bene», mi disse, parlando come se fosse in cattedra. «È un'occasione unica per recuperare una parte perduta della storia.» «Lo so», risposi guardandola con un sorriso. La durezza che la caratterizzava aveva finito per piacermi, e mi trovavo a mio agio con il suo tono a volte troppo sprezzante. In realtà non se ne accorgeva; per lei non aveva la stessa valenza che per chi lo riceveva. «È molto più importante di quello che immagini. Potrebbe essere unica.» «Io voglio una formula magica per neutralizzare la maledizione», affermai. «Tu che cosa vuoi?» «Voglio poter studiare la loro cultura, che mi permettano di ritornare con un'equipe dell'università per portare a termine un lavoro di ricerca complementare alla pubblicazione della scoperta del linguaggio scritto della cultura tiwanacota, che sarebbe la prima parte di...» «D'accordo, d'accordo!» la interruppi ridendo. «Credo che mi daranno quello che chiedo per l'umiltà della mia richiesta. Tu vuoi tutto!» Marta si fece di colpo molto seria, guardando dietro di me: la nostra guida yatiri era ricomparsa tra i divisori sul fondo e ci faceva dei gesti perché ci avvicinassimo. «Il lavoro è tutta la mia vita», disse lei aspramente, incamminandosi. Entrammo in una sala enorme, delimitata da pareti di arazzi con disegni di tocapus che ondeggiavano come se una dolce brezza li muovesse. Ondeggiavano anche le fiamme delle lampade a olio e i capelli grigio scuro dei quattro anziani, due donne e due uomini - entrambi con i baffi - che ci aspettavano seduti su impressionanti scranni d'oro. Avevano collocato per noi a una distanza considerevole sei sgabelli di legno molto più umili. La nostra guida ci fece capire a segni che dovevamo sederci, e chinando il capo in direzione degli anziani scomparve. Quelli erano i Capacas, i governanti degli yatiris, eredi dei sacerdoti astronomi che avevano retto Tiwanacu, e ci stavano guardando con un'indifferenza talmente grande che sembrava quasi che non ci fossimo. Non li incuriosiva vedere sei bianchi vestiti in maniera strana comparsi di colpo nella loro città? E, poi, come si chiamava quella città? Taipikala Due? E perché non avevano la testa a forma di cono come i loro antenati? Forse non praticavano più la deformazione frontoccipitale? Che delusione! Vidi che Marta ed Efraín si scambiavano occhiate per mettersi d'accordo su chi doveva iniziare la conversazione ma, prima che si decidessero, un quinto personaggio yatiri si presentò sulla scena, comparendo da dietro i tendaggi alle spalle dei Capacas. Era un giovane di forse vent'anni che entrò correndo e cercò, senza troppo successo, di fermarsi per non cadere bocconi ai piedi degli anziani; con grande sforzo si bilanciò finché non riuscì a stare in equilibrio. Notammo che mormorava delle parole a testa china - indossava un unku rosso con una fascia bianca e portava sulla fronte un nastro anch'esso rosso - e rimaneva quieto in quella posizione mentre i Capacas decidevano. Finalmente sembrarono acconsentire a ciò che il giovane diceva loro; questi si raddrizzò e, mettendosi da una parte, si rivolse a noi ad alta voce per farsi sentire nonostante la grande distanza. «Il mio nome è Arukutipa e sono un indio ladino. Sono pronto a servire le signorie vostre affinché possiate comunicare con i nostri Capacas più autorevoli.» Rimasi pietrificato. Come mai quel ragazzo parlava un castigliano antico con un accento stretto e così poco comprensibile? E, inoltre, perché accusava se stesso di essere una cattiva persona?24 Marta, però, veloce come un lampo, si lanciò in una rapida spiegazione: «Il nome di questo ragazzino, Arukutipa, significa in aymara 'il traduttore, colui che ha facilità di parola', e afferma di essere un indio 'ladino'; così chiamavano nell'America coloniale del XVI secolo gli indigeni che conoscevano il latino o le lingue romanze, cioè che parlavano il castigliano. Quindi gli yatiris ci offrono un interprete per comunicare con loro. Hanno conservato il castigliano appreso prima della fuga nella foresta!» «Ma allora», fece notare Efraín stupito, «non immaginano che possiamo conoscere la loro lingua.» «Aspetta, li sorprenderò», disse Marta con un sorriso perspicace, e, voltandosi verso i Capacas, esclamò: «Nayax Aymara parlt'awa». Gli anziani rimasero impassibili; solo il giovane Aruku-quel-che-era fece un gesto di sorpresa rivolto ai Capacas. Non ci fu scambio di parole, e, tuttavia, Aruku-quel-che-era si rivolse di nuovo a noi parlando a nome degli anziani: «I nobili Capacas dicono che le signorie vostre sono persone intelligenti e sagge, molto istruite, ma devono procedere per un cammino chiaro e senza controversie, per cui è bene che le parole siano spagnole di Castiglia e che non sorga nessun male o danno dalle suddette parole». «Ma, ma... che diavolo ha detto?» farfugliò Marc, che era diventato più rosso del solito e sembrava una caldaia sul punto di sprigionare di colpo il vapore. «In quale maledetta lingua sta parlando?» «Parla in castigliano», lo calmai. «Il castigliano che parlavano gli indios del Perù nel XVI secolo.» «Non vogliono che usiamo l'aymara», si dolse Efraín. «Chissà per quale motivo.» «Lo hai sentito», lo consolò Gertrude; aveva un luccichio negli occhi che rivelava l'intensità delle emozioni che si agitavano dentro di lei. «Non vogliono malintesi. Non vogliono problemi con la lingua. Preferiscono comunicare in castigliano.» «Certo, siccome la loro lingua non cambia, pensano che nemmeno le altre lo facciano!» si indignò il mio amico. «Ma io non capisco quello che dice quel ragazzino! Per me è come se parlasse cinese.» «Lo capisci perfettamente», borbottò Lola. «È che non ne hai voglia. Fai uno sforzo. Preferisci che Marta ed Efraín parlino con loro in aymara e che noialtri rimaniamo fuori dal gioco? Su! Con quello che ci è costato arrivare fin qui!» «I Capacas hanno compreso che le loro signorie sono persone istruite, ma ora vogliono sapere come sono venuta a conoscenza di questo regno di Qalamana.» «Qalamana!» esclamò Marta. «Questa città nella foresta si chiama Qalamana?» «Qalamana, signora.» «'Quella che non si arrende mai'», tradusse Efraín. «Un nome molto appropriato.» «I nobili Capacas vogliono sapere», insisté Aruku-quel-che-era, «come lor signori sono venuti a conoscenza di questo regno.» «Arukutipa», disse Marta, «mi piacerebbe sapere se i Capacas ci capiscono quando parliamo in castigliano. Lo dico perché è una storia molto lunga, e, se dovrai tradurla, non finiremo mai.» Arukutipa, spostando il peso del corpo da un piede all'altro, indeciso, girò la testa verso gli anziani un paio di volte. «I Capacas, signora, non vi capiscono», farfugliò infine. «Non sono indios ladini.» «Bene, allora cercherò di essere breve...» disse Marta prendendo la parola e affrontando la narrazione della storia che aveva portato alla scoperta di quel regno, dal momento in cui il suo prozio, Alfonso Torrent, aveva cominciato a lavorare con don Arturo Posnansky a Tiwanacu, all'inizio del XX secolo. Mi accorgevo sempre di più che la maniera migliore di conoscere Marta, di conoscerla veramente, era quella di ascoltarne la straordinaria voce, che conteneva la stessa musica di cui era fatta. Solo lì, nei suoni che uscivano dalla sua gola, nell'intonazione che le imprimeva, nelle parole che sceglieva e nelle frasi che costruiva, si trovava l'autenticità di quella donna, che si nascondeva e si difendeva come un riccio di mare. Ed esattamente come avevo pensato quel lontano giorno nel suo studio, la sua voce era anche il suo tallone d'Achille, il punto debole attraverso il quale la verità usciva a fiotti senza che lei se ne rendesse conto. Arukutipa era un traduttore simultaneo fantastico; gli anziani, mentre lo ascoltavano ripetere il racconto di Marta, assentivano quando bisognava farlo, inarcavano le sopracciglia nel momento opportuno e manifestavano preoccupazione o compiacimento quando era logico, cioè quando Marta terminava di dire cose che potevano provocare quelle espressioni. Non lo vidi esitare una sola volta. Non chiese che gli si ripetesse nemmeno una frase, e dire che il nostro castigliano e il suo erano abbastanza diversi e c'erano termini attuali di difficile interpretazione per chi non avesse informazioni su tutto ciò che era accaduto tra il secolo XVII e il XXI. Infine Marta parlò di Daniel. Disse che, come lei, era professore in un'università spagnola e che, lavorando ai suoi ordini, aveva scoperto per caso la maledizione della Piramide del Viaggiatore. Per disgrazia, disse, ne era stato colpito, e allora si voltò verso di me, mi presentò come il fratello di Daniel e mi cedette la parola perché io terminassi di raccontare la storia e facessi la mia richiesta. Naturalmente lo feci nella maniera più eloquente possibile, senza perdere di vista neanche per un momento che quei tipi dovevano sapere che la maledizione poteva aver colpito Daniel perché la sua coscienza non era pulita; però, come Marta, evitai per discrezione quella parte e chiesi con gentilezza una soluzione al problema. Poi Efraín raccontò dall'inizio la nostra spedizione attraverso la foresta fino all'arrivo a Qalamana con i Toromonas. Arukutipa ripeteva instancabilmente le nostre parole - per quello che potevamo supporre; non lo sentivamo, ma vedevamo che ci prestava attenzione e muoveva le labbra senza tregua - e, quando terminammo, dopo aver parlato per quasi un'ora, il ragazzo fece un sospiro di sollievo così forte che non potemmo evitare di sorridere. Rimanemmo silenziosi e immobili, attenti ai mormorii che ci arrivavano dal fondo della sala. Infine Arukutipa si voltò verso di noi: «I nobili Capacas chiedono il nome della strana donna dai capelli bianchi». «Parlano di te, Marta», sussurrò Gertrude con un sorriso. Lei si alzò e disse il suo nome. «Signora», le rispose Arukutipa, «i Capacas sono lieti della sua visita e dicono che la signoria vostra potrà ascoltare il rimedio per il castigo dell'ammalato dell'ospedale, il fratello del gentiluomo alto di corpo, e che questo farà cessare il dolore e la follia. Ma, dicono i Capacas, signora, che, dopo aver ascoltato il rimedio, le signorie vostre dovranno lasciare Qalamana per sempre e non parlare mai di questa città agli altri spagnoli.» Marta si incupì. «Questo è impossibile», affermò con la sua voce più grave e glaciale. Il povero ragazzo rimase senza fiato, come inebetito. «Impossibile?» ripeté incredulo, e poi lo tradusse in aymara. I Capacas rimasero imperturbabili. Quei tipi non si alteravano per niente. E allora accadde la prima delle cose strane che avremmo visto quel giorno. La donna Capaca, seduta all'estrema destra, fece un breve discorso a voce alta e Marta spalancò gli occhi, sconcertata. «La donna anziana ha detto», mormorò Efraín, «di obbedire perché, altrimenti, nessuno di noi uscirà vivo da qui. «Però!» esclamò Marc con l'aria spaventata. Marta rispose qualcosa in aymara all'anziana. «Le ha detto», ci tradusse Efraín, abbastanza sorpreso e diffidente, «che non c'è problema, che nessuno di noi parlerà mai di Qalamana con nessuno.» «Ma... questo non è possibile!» si lasciò scappare Gertrude. «È diventata matta o che cosa? Marta!» la chiamò. Lei si voltò e, per una strana ragione, indovinai che aveva subito lo stesso tipo di manipolazione di Daniel. Non avrei potuto spiegare perché lo avevo capito, ma nei suoi occhi c'era qualcosa di vitreo che riconobbi al primo sguardo. Gertrude le chiese di avvicinarsi con un gesto della mano e Marta si accovacciò davanti a lei. «Non puoi accettare questo accordo, Marta. Il lavoro di tutta una vita e il lavoro di Efraín andrebbero persi. E dobbiamo verificare in che cosa consiste il potere delle parole. Hai idea di quello che hai detto?» «Certo che lo so, Gertrude», affermò la professoressa Torrent con la sua solita fronte aggrottata, come quando qualcuno o qualcosa la infastidiva. «Però dovevo accettare. Non possiamo lasciare Daniel così com'è per sempre, non credi?» «Certo che no!» si lasciò scappare Efraín con un tono di voce abbastanza aggressivo. «Ovviamente no! Ma devi contrattare come al mercato, Marta, non puoi cedere subito. Questa gente non ha idea di quello che è accaduto nel mondo dal XVI secolo, e per loro voi spagnoli continuate a essere il nemico dal quale devono proteggersi. Alzati e tratta, amica, tira fuori le tue qualità. Su!» In quel momento l'anziano Capaca seduto vicino alla donna che stava all'estrema destra disse qualcosa a voce alta. La faccia di Efraín cambiò; la sua arrabbiatura si mutò in una grande tranquillità. «Va bene, Marta», dichiarò, cercando una posizione più comoda sullo sgabello, «lascia perdere. Non importa. Continueremo a fare ciò che facevamo prima come se non avessimo mai messo piede in questa città. Non possiamo danneggiare questa gente.» «Che cosa sta succedendo?» chiese Lola spaventata, guardando Marta e me. «Li stanno riprogrammando», affermai del tutto convinto. «Stanno utilizzando il potere delle parole.» «Come osano?» saltò su Marc, con uno sguardo di sfida. «Lascia perdere, Arnau», mi disse Marta. Il suo sguardo era di nuovo del tutto normale, senza quel luccichio acquoso che avevo notato prima e che scintillava ora negli occhi di Efraín. «Ti hanno manipolato, Marta!» esclamai, indignato. «Non sei tu quella che sta prendendo questa decisione. Sono loro! Svegliati, per favore.» «Sono sveglia, te lo assicuro», affermò categoricamente lei con il suo tono abituale. «Sono completamente sveglia, serena e tranquilla. So che hanno utilizzato il potere delle parole con me, me ne sono accorta. Ho notato come si realizzava il cambiamento di opinione dentro di me. È stato come un'esplosione di lucidità. Ma ora la decisione di mettere Daniel davanti a qualsiasi ambizione è la mia, tanto mia come quella di non essere disposta a lasciare che ci uccidano perché ci rifiutiamo di promettere di non parlare a nessuno di questa città. Sono io che decido, anche se fai fatica a crederlo.» «E io sono d'accordo», affermò Efraín. «Sono totalmente d'accordo con Marta. Possiamo ancora chiedergli di darci delle risposte su ciò che vogliamo sapere, ma non è necessario riportare l'informazione e attirare qui tutti i ricercatori del mondo, che finirebbero per distruggere questa civiltà in un batter d'occhio.» «È da pazzi!» mi arrabbiai, e, rivolgendomi ai Capacas, declamai: «Arukutipa, di' ai tuoi capi che il mondo è cambiato molto da quattrocento anni a questa parte, che noi spagnoli non dominiamo più il mondo, che non abbiamo nessun impero e che non siamo un Paese conquistatore né bellicoso! Viviamo in pace da molto tempo! E digli anche che utilizzare il potere delle parole per piegare la gente al proprio volere non è da persone degne e oneste!» Avevo terminato la mia arringa in piedi, agitando le mani come un oratore appassionato, e i miei compagni mi guardavano come se fossi impazzito. Marc e Lola, che mi conoscevano da molto più tempo, avevano soltanto fatto una faccia spaventata anche se, sicuramente, per il timore della reazione dei Capacas; però Marta, Gertrude ed Efraín avevano gli occhi spalancati per la sorpresa che gli aveva provocato il mio energico intervento. Arukutipa aveva tradotto le mie parole quasi nello stesso tempo in cui le pronunciavo, quindi, quando finii di gridare, gli anziani erano già al corrente del mio messaggio. Per la prima volta mi sembrò di cogliere un'espressione di perplessità sui loro volti rugosi. Di nuovo rimasero a bocca chiusa, ma il ragazzo dalla banda rossa mi trasmise la loro risposta: «I Capacas chiedono di sapere se sono finite le battaglie e lo spargimento di sangue e la scomparsa della gente dal regno del Perù». «Naturalmente sì!» esclamai. «Tutto ciò è finito da centinaia di anni. Noi spagnoli non governiamo più queste terre. Ci hanno cacciati. Esistono molti Paesi differenti con i loro propri governi e tutti hanno buone relazioni con la Spagna.» Ora sì che si notò con chiarezza la confusione sui loro volti. Secondo me capivano perfettamente il castigliano a prescindere dal lavoro di Arukutipa. «I viracochas cristiani non governano nel Perù?» chiese il traduttore con voce flebile. «No!» ripetei, avanzando di qualche passo per dar forza alle mie parole. Disgraziatamente lo feci, perché, nascosto dai grandi arazzi, un esercito di yatiris con archi, lance e protetti da piccoli scudi rettangolari, invisibile fino a quel momento, si parò velocemente e rumorosamente come una barriera difensiva tra i Capacas e noi, le armi puntate. «Cazzo, ci ammazzeranno!» disse Marc vedendo che la faccenda si faceva seria. «Che cosa succede ora?» chiesi ad Arukutipa, che però non riuscivo a vedere. «Le signorie vostre non devono avvicinarsi», rispose il ragazzo. «Succederebbe una falcidia a causa delle pestilenze spagnole.» «Che pestilenze?» mi esasperai. «Morbillo, peste, influenza...» «Le armi biologiche della Conquista», dichiarò Marta con tristezza. «Gli studi più recenti dicono che nelle grandi epidemie che si sono verificate nel vecchio Tahuantinsuyo dal 1525 al 1560 è morto il novanta per cento della popolazione dell'impero inca, il che significa l'estinzione di milioni e milioni di persone in meno di quarant'anni.» «Vuol dire che ne sopravvissero solo il dieci per cento», commentai, e un'idea mi attraversò la mente. «In che anno gli yatiris lasciarono l'altopiano?» «Attorno al 1575», mi rispose Marta. «È la data della mappa di Sarmiento de Gamboa.» «Sono immunizzati!» esclamai. «Quelli che sopravvissero e arrivarono fin qui avevano prodotto anticorpi contro tutte quelle malattie e, pertanto, hanno trasmesso l'immunità genetica ai discendenti. Non possiamo contagiarli!» «Va bene. Ora cerca di spiegarlo a loro», disse Marc. «Raccontagli che cosa è un germe, un batterio o un virus, poi gli parli degli anticorpi e di come funzionano i vaccini e, quando avranno tutto molto chiaro, spiegagli questa storia dell'immunità genetica.» Sospirai. Marc aveva ragione. Ma non ci si perdeva niente a tentare. «Senti, ragazzo», dissi ad Arukutipa. «Le pestilenze spagnole non esistono più. Tutto è finito contemporaneamente alle battaglie e allo spargimento di sangue. So che è difficile da credere, ma ti sto dicendo la verità. Per giunta, la guida che avete mandato a prenderci quando siamo arrivati con i Toromonas e che ci ha accompagnati fin qui è stato molto vicino a noi. Potete verificare che non gli è successo niente, che sta bene.» «Luk'ana morirà per sua propria volontà, signore», assicurò il ragazzo con disinvoltura. Tutti sussultammo. «Ora sta solo aspettando le signorie vostre per portarvi via da qui. Poi offrirà la sua vita per non farci ammalare. La città lo ricompenserà per il suo servizio.» «Questi tipi sono pazzi, Root!» esclamò Marc con tutto il cuore. «Andiamocene da qui subito!» «Non sarà necessario che muoia, Arukutipa», sillabò la «donna strana dai capelli bianchi». «Non gli succederà niente. Come ha detto Arnau, il gentiluomo alto di corpo, le pestilenze spagnole sono finite. È cambiato tutto, ma voi continuate ad avere le vecchie paure di quattrocento anni fa.» Si fece silenzio dall'altra parte del muro di soldati finché, d'un tratto, questi si ritirarono in modo spettacolare scomparendo di nuovo dietro gli arazzi. Sembrava che la situazione si fosse normalizzata e che i Capacas si sentissero più tranquilli. «Davvero il potere non è esercitato da un viceré e non ci sono governatori né alcaldi né giudici?» insisté il giovane traduttore, ancora incredulo di fronte a cambiamenti tanto grandi e insospettati. «No, non c'è nessun viceré, e non ci sono né governatori né colonizzatori spagnoli», rispose Marta. «E la Santa Inquisizione?» «È sparita! Anche in Spagna non esiste più.» Il ragazzo tacque per alcuni secondi e poi si chinò verso gli anziani come se questi gli stessero dicendo qualcosa. «I Capacas vogliono sapere di chi sono vassalli le signorie vostre.» «Di nessuno!» risposi, adirato. «Vassalli... Ci mancherebbe solo questo!» «La Castiglia non ha re?» si stupì Arukutipa. «Non c'è la Santa Cattolica Reale Maestà?» «Sì, sì, c'è un re in Spagna», intervenne Lola inaspettatamente, «però non governa, non ha il potere dei suoi antenati. E comunque voi continuate a farci domande senza darci nessuna informazione in cambio. Possiamo raccontarvi tutto quello che volete, ma anche noi vogliamo sapere delle cose.» Ci fu agitazione sia in fondo alla sala sia tra di noi. Eravamo perplessi per l'audacia della mercenaria. «Ne avevo già fin sopra i capelli delle loro domande», mi assicurò lei a bassa voce a mo' di spiegazione. Arukutipa si alzò e la guardò. «I nobili Capacas chiedono il nome della donna dal naso lungo e dalla corporatura snella.» «Ora stanno parlando di te, Lola», scherzò di nuovo Gertrude. «Verrà anche il tuo turno, dottoressa», replicò lei alzandosi in piedi e dichiarando il suo nome come se fosse in un processo. «Doña Lola», cominciò a dire Arukutipa, «i Capacas dicono che chieda alla signoria vostra che cosa vuole sapere; loro risponderanno con verità quello che sanno.» «Un momento, un momento!» si alterò Efraín, afferrando Lola per un braccio per obbligarla a voltarsi verso di noi. «Mettiamoci d'accordo sulle domande che farai. Forse non avremo un'altra occasione.» «È chiaro, no?» rispose Marta, senza alterarsi. «Abbiamo due grandi incognite: una, il potere delle parole; l'altra, la storia dei giganti, i resti di uno dei quali abbiamo avuto il piacere di vedere a Taipikala.» «Queste sono due domande», arguii. «Bene, possiamo provarci», azzardò Efraín. «Forse risponderanno a entrambe.» «Per favore», mormorò Gertrude con voce supplicante, «prima la domanda sull'aymara e sul suo potere. È la cosa più importante.» «Tutte e due le cose lo sono, cara», commentò Efraín. «Datemi retta, per favore. Prima la domanda sull'aymara.» «Va bene», disse Lola, rivolgendosi di nuovo al traduttore e ai Capacas. «Voglio sapere», disse, «com'è che avete la capacità di manipolare la gente, di cambiarla, guarirla o farla ammalare utilizzando le parole.» Il povero Arukutipa doveva sudare sangue mentre traduceva la richiesta di Lola perché, a prescindere dalla distanza, gli si notava l'agonia sul volto e non smetteva di stringersi le mani e di sfregarsele come se dovesse controllarne il tremore. La sua conversazione con i Capacas fu molto più lunga del normale. Fi- no a quel momento gli avevamo visto scambiare solo due o tre frasi, anche se il ragazzo faceva poi lunghe tirate o domande; questa volta, però, il dibattito andò avanti per diversi minuti. Ebbi l'impressione che non discutessero dell'opportunità o della scarsa convenienza di rivelarci il loro segreto, ma piuttosto di come, quanto e che cosa dirci esattamente. Qualcosa ci avrebbero detto, non ne ebbi il minimo dubbio, ma tutto? Soltanto una parte? «Le parole hanno il potere», attaccò improvvisamente Arukutipa rivolgendosi a Lola, che era rimasta in piedi in attesa. Poi fece un passo indietro e si ritirò dando spazio ai Capacas. I quattro anziani si alzarono e chiudendo i pugni li posero, incrociandoli, sulle spalle. Cominciarono quindi a canticchiare una strana salmodia in aymara. All'inizio Marta ed Efraín rimasero colpiti, senza fiato, ma lentamente, sempre con lo sguardo fisso sui Capacas, finirono per rasserenarsi. Marta, suggestionata dalla cantilena, cominciò a tradurre per noi con voce monocorde le parole degli anziani, ma sarebbe stato lo stesso se non lo avesse fatto perché, in modo inspiegabile, le capivamo. Non sto dicendo che ciò che accadde fosse un miracolo come il dono delle lingue che gli apostoli ricevettero dallo Spirito Santo in Pentecoste. Proprio il contrario. La vera ragione per cui riuscivamo a intendere ciò che salmodiavano i vecchi Capacas era contenuta nella stessa storia che la cantilena narrava. Alla fine confondevo la voce di Marta con ciò che udivo nella mia testa e non avrei saputo distinguere un mormorio dall'altro. Erano diversi, ma dicevano la stessa cosa ed entrambi erano ipnotici. Al principio sulla Terra non c'era vita, dicevano gli anziani, e un giorno la vita arrivò dal cielo su grossi massi fumanti che caddero dappertutto. La vita sapeva quali forme doveva creare, quali animali e piante, perché era tutto scritto al suo interno con il linguaggio segreto degli dei. E tutto si riempì di esseri viventi che occuparono la Terra, il mare e l'aria, e comparve l'essere umano, identico a quello che ora è, salvo per la sua limitata intelligenza, appena superiore a quella di una formica. Non aveva casa, né un'occupazione, e si copriva con logore pelli di animali e con le foglie degli alberi. A quei tempi tutto era molto grande, di dimensioni colossali. Anche gli uomini e le donne erano grandi, molto più grandi di adesso, ma i loro cervelli erano molto piccoli, piccoli come quello di un rettile, perché la vita si era sbagliata e non aveva letto correttamente le istruzioni. Allora gli dei videro che quello che avevano fatto era buono, ma che non tutto andava bene né andava come doveva andare, così mandarono Oryana. Oryana era una dea che veniva dalle profondità dell'universo. Era quasi come una donna di quelle che popolavano la Terra, dato che la vita scriveva le stesse cose dappertutto, sebbene ci fossero piccole differenze. Ma, a volte, come era successo con gli esseri umani, si sbagliava, allora gli dei dovevano intervenire anche se non piaceva loro farlo. Oryana era diversa da noi solo in un paio di cose: aveva delle orecchie molto grandi e la testa conica. Quando arrivò sulla Terra mescolò la sua vita con quella di alcuni esseri umani, e lo fece riscrivendo la forma che doveva avere l'intelligenza dell'uomo. Diede alla luce settanta creature, tutte con un cervello molto grande, un cervello perfetto, identico al suo, capace di raggiungere qualsiasi risultato e di realizzare qualsiasi impresa eroica, e insegnò ai figli e alle figlie a parlare. Diede loro il linguaggio, il suo linguaggio, e disse che era sacro e che con questo avrebbero potuto riscrivere la vita e guidare quella mente perfetta che ora possedevano. Disse loro che li aveva creati uguali in tutto agli dei e che dovevano conservare quella lingua, il Jaqui Aru, senza cambiarla né snaturarla perché era di tutti e che a tutti doveva servire per guidare la grande intelligenza che ora possedevano. Mentre insegnava questo e molte altre cose ai suoi figli, quelli costruirono, lì dove erano nati, una città in cui vivere, che chiamarono Taipikala, abbellendola come la città dalla quale proveniva la madre. Impararono a ottenere bevande dalla fermentazione delle nuove piante che, come il mais, Oryana aveva loro donato, e a produrre miele per mezzo di un insetto che lei aveva portato e che prima non c'era, l'ape. Impararono a lavorare i metalli, a filare e a tessere, a studiare il cielo, a calcolare, a scrivere... E, quando tutto fu ben avviato, duecento anni dopo il suo arrivo, la dea Oryana se ne andò. Trascorsero i millenni e i discendenti di Oryana o Orejona - come l'avevano chiamata in seguito per le sue grandi orecchie - popolarono il mondo creando città e culture in tutto il pianeta. Si susseguirono molte ere, ma il Jaqui Aru fu conservato senza modifiche, e tutti sapevano usare il potere che aveva. Tuttavia, nonostante la proibizione, si verificarono in luoghi diversi alcuni cambiamenti che portarono all'incomprensione tra i popoli e alla perdita delle antiche conoscenze. L'essere umano, in generale, smise di utilizzare i grandi poteri del proprio perfetto cervello, poteri che, in definitiva, non era mai arrivato a conoscere in tutta la loro vastità. A Taipikala, però, mantennero la lingua di Oryana e, per rispetto, continuarono a inserire dei cerchi d'oro nei lobi delle orecchie e a deformarsi il cranio fino a farlo diventare conico come quello della dea. Per questo la città divenne un luogo molto importante e gli yatiris i custodi dell'antica saggezza. In quel mondo antico, narravano i Capacas, non c'erano né ghiacci né deserto, né freddo né caldo; semplicemente non c'erano stagioni e il clima era sempre temperato. Una protezione di vapore acqueo avvolgeva la Terra e la luce arrivava tenue e soffusa. L'aria era più dolce e le piante crescevano tutto l'anno, per cui non era necessario seminare né raccogliere poiché c'era sempre abbondanza di ogni cosa. E c'era ogni genere di animali, non ne mancava nessuno, ed erano molto più grandi di quelli di adesso, come le piante, e tutto proseguiva secondo il progetto della vita. Finché un giorno sette massi grandi come montagne piombarono dal cielo colpendo la Terra con una violenza tale da farla tremare e le stelle cambiarono posto nel firmamento. Si alzarono enormi nuvole di polvere, che oscurarono il Sole, la Luna e le stelle, avvolgendo il mondo in una notte buia. I vulcani si svegliarono in tutto il pianeta squarciando la superficie terrestre, eruttando grandi quantità di fumo, cenere e lava; ci furono terremoti spaventosi che mandarono in rovina le città e non lasciarono in piedi nessuna costruzione fatta dagli uomini. Un turbine di tizzoni ardenti, che bruciavano la pelle provocando piaghe inguaribili, tinse di rosso la terra e l'acqua, avvelenandola. Il fuoco arse alberi e vegetazione e alcuni fiumi evaporarono, lasciando secchi i loro letti. Torridi uragani avanzarono impetuosamente devastando tutto, annientando in un istante interi boschi. Gli uomini e gli animali, disperati, cercarono rifugio nelle grotte e negli abissi per sfuggire alla morte, ma pochi ci riuscirono. Allora, appena alcuni giorni dopo, sopraggiunse all'improvviso un freddo intenso, sconosciuto, seguito da grandi piogge e inondazioni che fortunatamente spensero gli incendi che stavano ancora consumando il mondo. E apparve la neve. E tutto ciò accadde tanto in fretta che molti animali rimasero imprigionati nel ghiaccio mentre fuggivano o partorivano o si sfamavano. Il fango coprì tutto. Precedute da un fragore assordante, gigantesche onde, avanzando come solidi muri d'acqua che nascondevano l'orizzonte, si abbatterono sulla Terra trasportando fino alle cime delle montagne i resti degli animali marini morti. Era cominciato quello che i popoli del mondo chiamarono il diluvio. Piovve senza tregua per quasi un anno. A volte, quando il freddo era molto intenso, la pioggia si trasformava in neve e poi tornava a piovere e l'acqua inondava di nuovo tutto. Dal giorno in cui era cominciato il disastro non si era più visto il sole. La catastrofe fu globale. Si persero i contatti con gli altri popoli, con le città. Non seppero più niente gli uni degli altri; scomparvero molte specie di animali e di piante che prima erano straordinariamente abbondanti: si estinsero per sempre in quel periodo. Ne rimase il ricordo solo su alcuni bassorilievi di Taipikala, e in molti casi nemmeno quello. I pochi sopravvissuti che erano riusciti a vedere la fine di quella lunga e catastrofica notte si ammalarono e si indebolirono, in preda al terrore. E non ebbero nemmeno la consolazione di ritrovare il loro mondo così come era prima. La Terra era stata completamente distrutta ed era necessario ricrearla. Un giorno, molto tempo dopo, la nube oscura che copriva il mondo si ritirò e il sottile strato di vapore acqueo che avvolgeva la Terra se ne andò con essa. Smise di piovere e i raggi del sole si mostrarono in tutta la loro potenza, producendo terribili scottature e inaridendo il terreno. Pian piano gli esseri viventi si adattarono alla nuova situazione e la vita scrisse di nuovo su ciò che era rimasto secondo le sue eterne istruzioni. Ma ora gli anni avevano cinque giorni in più di prima perché la Terra si era inclinata sul proprio asse (come dimostrato dal nuovo orientamento delle stelle nel cielo) ed erano comparse le stagioni dell'anno, che obbligavano, se si voleva mangiare, a seminare e a raccogliere nei periodi indicati. Bisognò modificare tante cose tra le quali i calendari e le forme di vita. E si ricostruirono le città, tra cui Taipikala, ma gli esseri umani ora erano molto deboli e il lavoro li esauriva. I bambini nascevano infermi e con gravi deformazioni, morivano senza arrivare a crescere. La Terra si ricostituì con relativa facilità, e la natura impiegò poco a riprodursi a partire dai suoi stessi resti, però gli uomini e le donne, e persino alcuni animali, impiegarono secoli a recuperare la normalità, e, mentre quei secoli trascorrevano, si resero conto che la loro vita si accorciava sempre più e che i figli e i nipoti non si sviluppavano regolarmente. Gli yatiris dovettero prendere le redini della situazione dal principio, almeno nel proprio territorio. Quello che era accaduto oltre le loro frontiere era qualcosa che non potevano controllare. Era necessario recuperare l'autorità per porre fine al caos, al terrore, alla barbarie in cui era caduta l'umanità. Crearono riti e idee nuove; trovarono spiegazioni semplici per tranquillizzare la gente. Con il tempo solo loro conservarono il ricordo di ciò che c'era prima e di ciò che era accaduto. Il mondo si ripopolò, si diede vita a nuove civiltà e a nuovi popoli che dovevano ricominciare dal nulla e lottare duramente per sopravvivere. Molti diventarono selvaggi e pericolosi. Gli yatiris e la loro gente ora erano gli aymaras, «il popolo dei tempi remoti», perché sapevano cose che gli altri non comprendevano e conservavano il loro linguaggio sacro e il suo potere. Persino gli Incap rúnam, quando arrivarono a Taipikala per annetterla al Tahuantinsuyo, conserva- vano in parte il ricordo di chi erano gli yatiris e li rispettarono. La cantilena dei Capacas ebbe fine. Una delle anziane pronunciò altre parole, ma non riuscii più a comprenderle. L'incantesimo, o quel che diavolo era, era terminato. «Il resto della storia», disse Marta per concludere, traducendo le parole della Capaca, «lo conoscete già.» Mi sentivo calmo e sereno, come se, invece di stare seduto su quello sgabello ad ascoltare una storia sulla distruzione del mondo, stessi ascoltando musica nel salotto di casa mia. Quei tipi avevano fatto qualcosa alla mia testa mentre ci parlavano di Oryana e di tutto il resto. Marc, Lola e io eravamo giunti all'errata conclusione che, non conoscendo l'aymara, non potevamo subire quelle strane influenze. Non era vero: il potere delle parole superava la barriera della lingua e si infiltrava nei nostri neuroni, qualsiasi lingua questi parlassero. Come aveva supposto Gertrude, l'aymara era un veicolo per il potere, una lingua perfetta, quasi un linguaggio di programmazione che permetteva di combinare i suoni necessari per rivoltarti il cervello. L'aymara - il Jaqui Aru - era la tastiera che aveva permesso di programmare i cervelli perfetti di quei primi figli di Oryana, dotandoli di quelle applicazioni necessarie per vivere. Qualsiasi cosa quei tipi mi avessero fatto nella testa, mi stava permettendo di stabilire una serie di relazioni che non mi sarebbero venute in mente nemmeno in un milione di anni. Montagne di idee attraversavano la mia mente, ed erano tutte diverse, sconcertanti e, ovviamente, non condivisibili con gli altri in quei momenti. Di colpo, disponevo di una lucidità mentale incredibile e mi sembrava che quei Capacas continuassero a giocare con il mio cervello, creando nuovi percorsi di comprensione. Anche i miei compagni stavano vivendo un'esperienza analoga alla mia, perciò, quando si concluse la salmodia degli anziani, ci fu un lungo silenzio. Nessuno di noi riusciva a parlare, impegnato com'era a cercare di afferrare al volo i pensieri. La cantilena dei Capacas conteneva, molto probabilmente, una grande quantità di suoni capaci di alterare i nostri cervelli, di svegliarli. Forse eravamo passati dall'utilizzarne il cinque per cento all'usarne momentaneamente il sei o il cinque e mezzo per cento, e ne eravamo coscienti. Allora compresi anche quello che mi aveva detto Marta quando l'avevo accusata di essere stata manipolata dagli yatiris perché acconsentisse a non parlare mai di Qalamana: avevano usato il potere delle parole anche con me, eppure non sentivo di essere stato invaso da idee o pensieri di altri. Ero, come aveva detto lei, sveglio, sereno, molto rilassato, e sapevo che tutto ciò che c'era nella mia testa era mio. Ero io, e solo io, che occupavo la mia mente e che, come Marta, vedevo con chiarezza quanto fosse inutile portare alla luce tutto quello, puntare i riflettori o le telecamere su Qalamana oppure, e sarebbe stato anche peggio, togliere il potere dalle mani degli yatiris per porlo in quelle di scienziati al servizio di governi armati o di gruppi terroristici, dei quali il mondo era pieno in un'epoca in cui tutte le ideologie e tutti i sistemi si erano corrotti. «Quindi...» mormorò Lola portandosi le mani sulla testa come se volesse reggerla o comprimere quello che c'era dentro, «di un'era glaciale di due milioni e mezzo di anni, niente. Tutto accadde in pochissimo tempo... Per questo i mammut compaiono ancora congelati nei ghiacci della Siberia, tanto freschi da alimentare con la loro carne generazioni di eschimesi.»25 La sua voce ci restituì la capacità di parlare. «Sono cose da pazzi», balbettò Marc, scuotendo la testa in segno di diniego e tentando di scacciare un pensiero che non sembrava essere di suo gradimento. «Credo che abbiamo tutti troppe cose nella testa», dissi io, alzandomi con difficoltà per distendere il corpo e la mente. E fui quasi sorpreso di scoprire che adesso sapevo quello che volevo fare della mia vita al ritorno a Barcellona, a casa, ai luoghi che sembravano lontani e inesistenti in quella situazione ma che, senza dubbio, in poco tempo si sarebbero trasformati di nuovo in realtà. Lentamente uscimmo da quello stato di concentrazione profonda in cui ci aveva immerso la cantilena. La mia testa cominciò a ridurre la velocità e le idee smisero di accavallarsi. «La visita delle signorie vostre finisce qui», disse la voce di Arukutipa dal fondo della sala. «Devono partire ora stesso da Qalamana e non ritornare.» Marta si inasprì. «Abbiamo accettato di non parlare della vostra città né di voi né del potere delle parole per metterli in salvo da... da altri spagnoli, ma non capisco la proibizione di ritornare. Vi abbiamo già detto che non governiamo questi territori e che non ci sono più pestilenze, quindi se non rappresentiamo un pericolo perché non possiamo ritornare? Alcuni di noi vorrebbero apprendere altre cose sulla vostra civiltà e sulla vostra storia.» «No, doña Marta», rispose il ragazzo, «le signorie vostre non devono es- sere disobbedienti e superbe. Andate e ritornate con i Toromonas fino alla città di Qhispita, nella foresta, e, quando arriverete a Taipikala, restituite la pietra che vi ha guidato da Qhispita a Qalamana.» «Qhispita significa 'in salvo'», ci tradusse Efraín. «Sta dicendo», si allarmò Marc, non facendo caso all'archeologo, «che dobbiamo ritornare a Lakaqullu, ripercorrere tutta la piramide e rifare di nuovo quelle prove per lasciare la ciambella di pietra nel luogo dove l'abbiamo trovata, che era proprio alla fine del cammino?» «Non ti preoccupare», lo tranquillizzò Marta a bassa voce. «Ci siamo impegnati a non parlare di Qalamana e dei suoi abitanti, ma dobbiamo ancora decidere per conto nostro che cosa ne faremo della ciambella, della Piramide del Viaggiatore e delle sue lastre d'oro. Comunque, ricordo perfettamente il posto attraverso il quale siamo saliti alla superficie, e quindi, se decidiamo di restituirla, basterà entrare in senso contrario.» «Sembra che loro si aspettino che abbiamo cura di ciò che hanno lasciato lì», mormorai. «Non si dimentichi, Marta», disse Efraín guardandomi male e stringendo le mani in un gesto di supplica, «che sono il direttore degli scavi a Tiwanacu, e che lei fa parte della mia equipe. Non possiamo lasciar perdere questa opportunità unica, amica mia. Lei stessa ha ottenuto, attraverso le sue conoscenze, un'autorizzazione speciale per scavare a Lakaqullu.» «La signoria vostra deve desistere dal suo errore», ordinò in quel momento Arukutipa a Efraín, «per meritare così la nostra lealtà e il nostro rispetto per sempre. E anche doña Marta deve rinunciare.» Marta, alzandosi per farsi sentire con chiarezza - anche se, in realtà, loro ci sentivano benissimo nonostante parlassimo a sussurri perché conoscevano il contenuto della nostra discussione -, ribatté: «Si sta studiando e portando alla luce la vostra antica città di Taipikala, liberandola dalla terra che si è accumulata su di essa per centinaia, o meglio, migliaia di anni. Se non lo facciamo noi, lo faranno altri, altri che non avranno tanta considerazione né riguardi. Non potete impedirlo. Già da molto tempo le rovine di Taipikala o di Tiwanacu, come l'avevate chiamata quando vi invasero gli Incap rúnam, attraggono i ricercatori di tutto il mondo. Noi siamo la vostra migliore opzione. La vostra unica opzione», rimarcò. «Se Efraín e io continuiamo a lavorare lì come stiamo facendo adesso, potremo impedire che vi trovino e far conoscere quello che c'è nella Piramide del Viaggiatore da un punto di vista neutro e scientifico, perché no... anche nascondendo informazioni in modo che nessuno sappia mai della vostra esistenza, come ci siamo impegnati. Se altri, ora o fra cento anni, arrivassero fino a Lakaqullu, sarete perduti perché entro pochi giorni compariranno qui, a Qalamana.» Il ragazzo, che aveva già tradotto il discorso di Marta, si ritirò per lasciare che gli anziani riflettessero sulla risposta da dare. Poco dopo fece un passo avanti e riprese il suo posto. Nessuno aveva pronunciato una sola parola. «I nobili Capacas sono molto preoccupati per Taipikala e per il corpo di Dose Capaca, il Viaggiatore», spiegò, «e anche per quello che ha detto doña Marta dei ricercatori di ogni parte del mondo e per le tante lezioni, dottrine e testimonianze che hanno lasciato nell'oro, ma pensano che don Efraín e doña Marta possono fare il lavoro così come ha detto doña Marta, e fare così un favore agli yatiris di Qalamana. I Capacas ora vi daranno il rimedio per il castigo del malato dell'ospedale, e poi le signorie vostre dovranno lasciare Qalamana per sempre.» «Che mania!» sbuffò Marc. Ma io stavo pensando a quanto erano fiduciosi gli yatiris: dei tipi strani e contagiosi, fra i quali c'erano pericolosi spagnoli, si presentavano improvvisamente alla loro porta e gli dicevano che tutto quello per cui si erano nascosti non esisteva più, e gli yatiris, intelligenti com'erano, invece di metterlo in dubbio ci credevano senza discutere; in più i tizi strani facevano credere che, per il loro bene, dovevano consegnare le chiavi della loro antica casa. Non mi entrava nella testa che gente così speciale potesse essere tanto semplice e ingenua. Anche se, mi dissi sorpreso, forse senza che lo sapessimo ci avevano sottoposto a un tipo di prova con il potere delle parole e, come era capitato a Marta con la maledizione che aveva colpito Daniel, l'avevamo superata perché, in realtà, avevamo detto la verità. «E quindi, doña Marta, prestate attenzione e vi forniremo il rimedio per l'ammalato.» L'anziana che stava a sinistra si alzò e parlò. «Jupaxusutaw ak munta jinchu chhiqhacha jichhat uksarux waliptaña.» Guardai Marta e vidi che aveva le sopracciglia inarcate in un gesto di indescrivibile sorpresa. «Tutto qui?» balbettò. «Solo questo?» «Solo questo, doña Marta», rispose il giovane Arukutipa. «Ma tenetelo ben custodito nella testa perché dovrete ripeterlo.» «Credo di averlo memorizzato anche se, nel dubbio, mi piacerebbe ripeterlo. Mi spaventa l'idea di sbagliarmi quando saremo lì.» «Non serve, ma se volete...» «Jupaxusutaw ak munta jinchu chhiqhacha jichhat uksarux waliptaña», pronunciò molto lentamente. «Che significa?» chiesi a Efraín abbassando la voce. «Una stupidaggine, amico. 'Lui è ammalato e voglio questo: che il vento che penetra nelle orecchie lo guarisca subito.'» «Tutto qui?» mi sorpresi. «Marta ha pronunciato le stesse parole», rispose lui, tornando a occuparsi della conversazione con Arukutipa e i Capacas. Ma la conversazione era arrivata al termine. Il traduttore, chinando il capo, stava congedandosi da noi e i Capacas si erano alzati solennemente dando per concluso l'incontro. Un poco sconcertati, li imitammo. Dietro il grande arazzo che stava a sinistra comparve la nostra guida, il simpatico Luk'ana, con la stessa espressione di disprezzo, e le stesse strane sopracciglia, che aveva quando se n'era andato. Forse sapeva già che gli avevamo salvato la vita, o forse no, comunque la sua faccia non dimostrava il minimo ringraziamento né il minimo sollievo per non dover morire quella notte stessa. «Andate in pace da questa città di Qalamana», ci salutò Arukutipa. I Capacas non si disturbarono neanche a dire questo; si limitarono ad andarsene da dove erano venuti con la stessa indifferenza con cui erano entrati in quella sala due o tre ore prima. Luk'ana ci indicò con un gesto di seguirlo, e, dietro a lui, ritornammo nell'immenso vestibolo di quel grandioso tronco. Io mi ero quasi dimenticato dello strano mondo in cui ci trovavamo e la sua realtà mi sorprese di nuovo quando fummo nell'atrio in cui ora non c'erano più le guardie. La guida prese da un tavolo una delle lampade a olio accesa e la porse a Lola, poi ne diede un'altra a Gertrude e così fece finché tutti non avemmo tra le mani una di quelle ciotole di pietra luminose. Allora, con un piccolo sforzo, aprì da solo le due pesanti ante del portone e ci rendemmo conto che fuori era buio, che l'aria che entrava era fredda, quasi gelida. Mentre parlavamo con i Capacas era calata la notte. Percorremmo in senso contrario lo stesso labirinto aereo di rami che avevamo seguito per arrivare fin lì, solo che ora camminavamo più lentamente, osservando con curiosità le luci che provenivano dalle finestre delle case costruite all'interno degli alberi. Era un'immagine soprannaturale che ti rapiva, più simile a un disegno di Escher che a una foresta tropicale, cosicché, in mancanza di una macchina fotografica con cui rubare al tempo quell'istante, feci uno sforzo per trattenere nella memoria fino ai più piccoli particolari, perché probabilmente non sarei più ritornato in quel luogo e nessuno oltre a noi avrebbe saputo della sua esistenza; sarebbe stato così un ricordo unico al quale, sicuramente, sarei ritornato nel corso della mia vita molte volte. Attraversammo l'immensa piazza illuminata, ora deserta, e l'ultimo ponte vegetale fino al tronco dell'albero che conduceva all'uscita. Discendemmo in silenzio la rampa e arrivammo alla sala tubolare inferiore dove Luk'ana, fermandosi, ci ordinò con un gesto di lasciare le lampade a terra e di entrare nel tunnel buio che ci avrebbe riportati nella foresta. Allora Marta si voltò e parlò alla nostra guida. «Yuspagara.» L'altro rimase impassibile. «Yuspagara», insisté lei, ma Luk'ana mantenne la sua faccia da giocatore di poker. «Non ci crederete, ma lo sto ringraziando.» «Lascia perdere, su», le dissi prendendola per un gomito e spingendola dolcemente verso il tunnel. «Non ne vale la pena.» «Ciao, accidenti a te!» sentii dire a Efraín quasi contemporaneamente. E tutti e sei ci introducemmo nell'oscurità del tunnel senza che questa volta si vedesse nessuna luce al fondo. Quell'uscita al buio fu il nostro saluto al mondo degli yatiris. Quando arrivammo all'esterno, scostando con le mani le felci giganti che nascondevano l'entrata, avanzammo come ciechi verso il sentiero che avevamo lasciato nelle prime ore del pomeriggio, camminando in linea retta per non perderci. Ma, dopo aver scansato le ultime foglie simili a piume, la tenue luce di alcuni falò ci illuminò, facendoci battere le palpebre. Alcuni secondi più tardi intravedemmo a distanza i Toromonas seduti attorno al fuoco che chiacchieravano animatamente, aspettandoci. Ci accolsero con gesti sobri e grandi sorrisi. Sembrava che ci stessero dicendo che avevamo avuto un grande onore a essere stati ricevuti in quel mondo arboreo e che, per questo, ora eravamo più degni di rispetto. Il capo toromona ci chiamò a gesti e ci invitò a sederci con il suo gruppo e con il vecchio sciamano, e lui stesso ci offrì le parti più succulente della grossa scimmia urlatrice che si stava arrostendo lentamente sul fuoco. Dormimmo lì quella notte e sentimmo un freddo tremendo. Per fortuna, gli indios avevano utilizzato per i falò della legna speciale che ardeva liberando molto calore, e che mantenne miracolosamente accese le fiamme fino all'alba del giorno dopo, quando riprendemmo il lungo cammino verso la città in rovina che ora sapevamo chiamarsi Qhispita, probabilmente un antico insediamento temporaneo yatiri che era servito da testa di ponte verso Qalamana quando avevano deciso di fuggire dall'altopiano. Non avevamo idea di come avremmo raggiunto, da Qhispita, l'uscita del Parco Nazionale Madidi, ma eravamo sicuri che avremmo trovato una soluzione a mano a mano che ci si presentava il problema. Era sorprendente il nuovo modo che avevamo di affrontare le cose; stavamo perdendo alla velocità della luce i resti della nostra vecchia pelle di cittadini. Era la mattina di martedì 16 luglio ed erano esattamente trenta giorni che eravamo partiti da La Paz. Avevamo ancora un altro mese davanti per percorrere la strada di ritorno verso la civiltà, ma quel tempo passò volando, soprattutto le tre settimane che impiegammo ad arrivare a Qhispita, perché durante il giorno continuavamo ad apprendere un'infinità di cose utili dai Toromonas e la sera sostenevamo lunghe conversazioni vicino al fuoco ricordando e analizzando i momenti passati con i Capacas degli yatiris. Durante i primi giorni ci risultò impossibile parlarne. Tutti e sei avevamo una specie di blocco che non ci permetteva di accettare ciò che era successo. Ci rifiutavamo di riconoscere pubblicamente l'idea mortificante che avevamo vissuto un'esperienza inspiegabile dal punto di vista razionale. Non era facile ammettere qualcosa del genere. Ma, da buoni figli del positivismo scientifico, finimmo per affrontare il discorso dalla prospettiva meno disonorevole. Ciascuno di noi aveva trattenuto frammenti diversi della storia che ci era stata trasmessa mediante quello strano canto, e pertanto la prima discussione che sostenemmo fu sulla maniera in cui avevano compreso il messaggio quelli di noi che non capivano l'aymara. C'erano solo due spiegazioni possibili: una era la telepatia e l'altra la voce di Marta, che aveva tradotto senza pausa tutto quello che gli anziani narravano. Sapevamo che la telepatia non era una menzogna, che durante tutto il XX secolo e soprattutto durante la guerra fredda tra gli USA e l'URSS, l'argomento era stato studiato molto seriamente e la sua pratica era più che verificata, però anche in questo caso suonava molto male, troppo da circo equestre, più da indovini da fiera che da lavoro di laboratorio, quindi alla fine optammo per adottare la versione politicamente corretta: era stata la voce di Marta, sovrapposta alla cantilena, ad averci realmente trasmesso il contenuto della storia. Non nominammo in nessun momento la mancanza di comunicazione verbale tra Arukutipa e i Capacas, lasciando da parte la questione come se non ce ne fossimo accorti. In modo inconscio ci stavamo comportando come gli studiosi che tanto avevamo criticato per non aver affrontato coraggiosamente gli enigmi di Taipikala. Con il passare dei giorni, tuttavia, cominciammo ad analizzare il messaggio. Lola, come sempre, fu la prima a farlo. «Non per darvi fastidio», si scusò anticipatamente una sera, mentre eravamo seduti intorno al fuoco, «ma non posso levarmi dalla testa l'idea che, secondo i Capacas, l'ultima era glaciale non è durata due milioni e mezzo di anni, ma è stata il risultato di una catastrofe più o meno breve occorsa per l'impatto di giganteschi meteoriti sulla superficie terrestre.» «Non possiamo crederci», osservò Marc. «Va contro tutta la geologia moderna.» «Darei qualsiasi cosa per una sigaretta», mormorò Marta. «Non hai più fumato da quando siamo partiti da La Paz, eh?» le disse Gertrude soddisfatta. «State cambiando discorso?» chiese Lola con tono permaloso. «No, assolutamente», replicò Marta, tirandosi su per guardarla. «Sapevo che prima o poi avremmo dovuto parlare di tutto questo. Ecco perché ho proprio bisogno di fumare una sigaretta.» «Io, comunque, sono convinta che ci sia molta verità nella storia che ci hanno raccontato», affermò Gertrude. «Anche la parte che riguardava la vita scesa dal cielo in pietre incandescenti?» chiese Marc ironico. «Non pensare che sia tanto strano», obiettai io, strappando un filo d'erba dal terreno e attorcigliandolo tra le dita. «Questo è esattamente ciò che affermano le ultime teorie sulla comparsa della vita sulla Terra. E siccome non c'è modo di spiegare come diavolo ha avuto origine, adesso dicono che è venuta da fuori; che il DNA, il codice genetico, è arrivato in groppa a un meteorite.» «Lo vedi?» sorrise Gertrude. «E se continuiamo a indagare troveremo molte altre cose del genere.» Lola si schiarì la voce. «Ma, allora...» disse incerta, «che cosa significa che la vita ha creato contemporaneamente tutti gli animali e le piante del mondo? E la teoria dell'evoluzione?» Ecco il mio argomento preferito, mi dissi, caricando rapidamente le batterie. Gertrude mi anticipò: «Be', la teoria dell'evoluzione non è più accettata da molti. Può sembrare strano, ma negli Stati Uniti è un argomento che da molti anni è oggetto di ricerca per motivi religiosi. Sapete già che nel mio Paese c'è una forte corrente fondamentalista... i suoi fautori si sono impegnati da tempo a dimostrare che la scienza si era sbagliata e che Dio aveva creato il mondo così come narra la Bibbia». «Davvero?» si sorprese Marc. «Scusa se te lo dico, Gertrude», osservò la mercenaria con la sua abituale franchezza, «ma voi yankee siete molto strani. A volte avete... Insomma, mi hai capito.» Gertrude annui. «Sono d'accordo», ammise sorridendo. «Bene, e perché hai parlato dei fondamentalisti?» chiesi. «Ne ho parlato a proposito, be'... In realtà chiamano se stessi creazionisti. E hanno trovato le prove.» «Le prove che Dio ha creato il mondo?» sobbalzai. «No, in realtà no!» rispose lei divertita. «Le prove che la teoria dell'evoluzione non era corretta, che Darwin si era sbagliato.» Efraín sembrava conoscere bene l'argomento perché di tanto in tanto assentiva; Marta, invece, si agitò come se l'avesse morsa un serpente velenoso. «Gertrude», protestò, «non ci possono essere prove contro l'evoluzione! È ridicolo, andiamo!» «Ciò che non c'è, Marta», obiettai, «sono le prove dell'evoluzione. Se la teoria di Darwin fosse già stata dimostrata», e ricordai che avevo detto le stesse cose a mia cognata Ona non molto tempo prima, «non sarebbe una teoria, sarebbe una legge, la Legge di Darwin, e così non è.» «Non mi ha mai convinto questa teoria che discendiamo dalla scimmia, anche se sembra molto logica», mormorò Marc, mordicchiando un filo d'erba. «Non c'è nessuna prova che dimostri che discendiamo dalla scimmia, Marc», gli dissi. «Nessuna. Che cosa credi che sia la storia dell'anello mancante? Una favola? Se prestiamo fede a quello che ci hanno detto i Capacas, non troveremo mai l'anello mancante perché non è mai esistito. Probabilmente noi mammiferi discendiamo dai rettili, ma dei numerosissimi esseri intermedi e malformati che dovettero esistere per migliaia di milioni di anni per fare il salto da una creatura perfetta a un'altra altrettanto perfetta, non si è trovato nessun fossile. E succede la stessa cosa per qualsiasi altra specie di cui abbonda il pianeta.» «Non posso credere alle mie orecchie!» mi rimproverò Lola. «Ora sembra che tu, una mente razionale e analitica come poche, sia uno stupido ignorante.» «Non me ne importa niente», risposi. «Ciascuno può pensare ciò che vuole e avere i dubbi che preferisce, o no? A me nessuno può proibire di chiedere prove dell'evoluzione. E, al momento, non me le danno. Sono stufo di sentir dire in televisione che gli uomini di Neandertal sono nostri antenati quando, geneticamente, abbiamo meno a che vedere con loro che con le scimmie.» «Però erano esseri umani, no?» si stupì Marc. «Sì, però un altro tipo di esseri umani, molto diversi da noi», puntualizzai. «E quali erano queste prove che hanno trovato i fondamentalisti del tuo Paese, Gertrude?» chiese Lola. «Oh, be', non le ricordo tutte a memoria in questo momento, mi dispiace. Parlare di ciò che ci hanno narrato gli yatiris mi ha riportato alla mente vecchie letture degli ultimi anni. Ma vediamo...» Si raccolse con le mani i capelli ondulati e sporchi, legandoli sulla testa. «Una di queste era che in molte parti del mondo si sono trovati resti di scheletri fossili di mammiferi e di dinosauri negli stessi strati geologici,26 cosa impossibile in base alla teoria dell'evoluzione, orme di dinosauri e di esseri umani nello stesso posto, per esempio nel letto del fiume Paluxy, in Texas.27 E l'altra cosa che ricordo è che, secondo gli esperimenti scientifici, le mutazioni genetiche risultano sempre nocive, quando non mortali. È quello che diceva prima Arnau sui milioni di esseri malformati che mancherebbero per passare da una specie ben adattata a un'altra. La maggior parte degli animali mutati geneticamente non rimangono in vita il tempo sufficiente per trasmettere queste alterazioni ai loro discendenti e, inoltre, nel corso dell'evoluzione, mancherebbero due animali di sesso diverso con la stessa mutazione apparsa per caso nei loro geni per assicurare la continuazione del cambiamento, cosa che è statisticamente impossibile. Loro ammettono che esiste la microevoluzione, cioè che qualsiasi essere vivente può evolversi in alcune piccole caratteristiche: gli occhi azzurri nei luoghi in cui c'è poca luce o la pelle nera dove il sole è molto forte, o una statura più alta a causa di un'alimentazione migliore eccetera. Ciò che non accettano per niente è la macroevoluzione, cioè che un pesce possa trasformarsi in scimmia o un uccello in rettile o, semplicemente, che una pianta possa dar luogo a un animale.» Tutti ascoltavamo con attenzione Gertrude. Lanciai un'occhiata furtiva al volto di Marta: aveva quell'espressione terribile che minacciava tuoni e fulmini. «Basta!» interruppe bruscamente. «Ci possono essere molte spiegazioni per quello che ci hanno narrato i Capacas. Ciascuno è liberissimo di restare della sua opinione. È assurdo discutere di queste cose. Mi rifiuto di continuare. Ciò che dobbiamo fare è studiare a fondo la documentazione della Piramide del Viaggiatore e rispettare le nostre promesse: Efraín e io pubblicheremo le nostre scoperte... e che gli scienziati, i creazionisti e i pagani cerchino pure per conto loro quello che vogliono.» «Ma c'è dell'altro, Marta», sussurrò enigmaticamente Gertrude. «Dell'altro? A che cosa ti riferisci?» chiese lei, distratta. Gertrude prese dalla tasca posteriore dei suoi pantaloni il piccolo registratore digitale che ci aveva mostrato il giorno del nostro arrivo nella città in rovina. «Non c'è più molta carica, però...» Premette un piccolo pulsante e si udì molto lontana la voce di Arukutipa che diceva: «Le parole hanno il potere». Non ci fece sentire altro; spense il piccolo apparecchio e tornò a riporlo prima che i Toromonas potessero vederlo. Rimanemmo muti dallo stupore. Gertrude aveva registrato il colloquio con i Capacas! Questo apriva un mondo di infinite possibilità. «Avrò bisogno del vostro aiuto», disse a Marc, a Lola e a me. «Non posso passare questa registrazione a nessuno perché la studi, ma voi avete computer per effettuare un'analisi delle frequenze delle voci dei Capacas.» Quello era esattamente in linea con i miei nuovi progetti. «Conta su di me», affermai molto sorridente. Sostenemmo conversazioni molto simili a questa, sera dopo sera, durante le settimane che impiegammo per arrivare a Qhispita. Ogni tanto, stufi, cambiavamo argomento e allora parlavamo di noi stessi e delle nostre vite. Marc, Lola e io raccontammo del nostro «Serie 100», nascosto in un binario abbandonato nel sottosuolo di Barcellona, spiegammo l'uso che ne facevamo, condividendo per la prima volta con altre persone le nostre attività di hacker. Marta, Efraín e Gertrude ci ascoltavano senza batter ciglio, stupiti e perplessi per le cose che non immaginavano nemmeno lontanamente che si potessero fare con un semplice computer. La differenza di una decina d'anni tra loro e noi presupponeva un abisso generazionale in materia informatica, abisso approfondito dal rifiuto - incomprensibile dal mio punto di vista - che gli eruditi in campo umanistico amano esibire come distintivo di classe. Marta ed Efraín si difendevano con la posta elettronica e con alcune applicazioni di base, e questo era tutto. Durante quelle settimane comunque arrivammo a conoscerci abbastanza bene. In un'altra occasione fu rivelato, finalmente, il segreto del matrimonio di Marta, che tanto aveva intrigato Lola. Il famoso Joffre Viladomat, per ragioni di lavoro, era andato nel Sudest asiatico cinque anni prima, mandando in rovina quel poco che rimaneva del suo matrimonio con Marta Torrent. I loro due figli, Alfons e Guillem, rispettivamente di diciannove e ventidue anni, vivevano a Barcellona durante l'anno scolastico ma, quando arrivavano le vacanze, partivano di corsa verso le Filippine per stare con il padre e con Jovita Pangasinan (la nuova compagna di Joffre). Secondo Marta, Jovita era una donna affascinante che si trovava molto bene con Alfons e Guillem, quindi le relazioni tra tutti loro erano cordiali. Lola emise un lungo sospiro di sollievo quando sentì il finale della storia e non cercò di dissimulare il suo antico interesse per l'argomento. Una di quelle sere, Marc, Lola e io stringemmo un accordo sul futuro della Ker-Central, che si sarebbe trasformata in una società anonima. Io avrei mantenuto delle azioni e loro due si sarebbero spartiti il resto, finanziando l'acquisto con prestiti bancari. A partire da quel momento io sarei stato libero e loro avrebbero diretto de facto l'impresa. L'edificio sarebbe stato ancora mio e la Ker-Central mi avrebbe pagato un affitto; naturalmente, io avrei mantenuto la mia casa nell'attico. Tutti volevano sapere a che cosa pensavo di dedicarmi quando sarei «andato in pensione», ma tenni la bocca chiusa e non riuscirono a strapparmi neanche una parola. Da buon pirata informatico, dominavo l'arte di custodire molto bene i miei segreti fino al momento di entrare in azione (e ancora di più dopo). Mi fecero domande con molta insistenza e forse, solo forse, avrei dato qualche indizio se non fosse stato perché, pur avendo chiaro quello che desideravo fare, avevo bisogno di un aiuto molto concreto per verificare la maniera migliore di portarlo a termine; e perché, facendo i salti mortali, già da alcune settimane stavo elaborando un piano per pirateggiare, mentre cercavo di ottenere quell'aiuto, il luogo apparentemente inespugnabile e probabilmente molto ben protetto che lo racchiudeva. Una sera, due settimane dopo aver iniziato il viaggio di ritorno, i Toromonas si fermarono in una radura e ci fecero capire di rimanere lì mentre loro si organizzavano in gruppi e sparivano nella giungla in direzioni diverse. Rimanemmo soli per un paio di ore, piuttosto sorpresi per quello strano abbandono. L'impressione era che i Toromonas avessero qualcosa da fare, qualcosa di importante, ma che sarebbero tornati quando avessero terminato. E fu così. Poco prima dell'imbrunire ritornarono con degli strani oggetti in mano: pezzi di grossi tronchi cavi, dei piccoli frutti rotondi che sembravano zucche, rami, pietre, legna e della cacciagione per la cena. Lo sciamano era l'unico che era andato via da solo e che ricomparve senza nulla, portando a spalle solo la sua borsa di medicine. Velocemente gli uomini si suddivisero i compiti e, mentre alcuni accendevano i fuochi per cucinare il cibo, altri incominciarono a vuotare i frutti, gettando a terra la polpa e i semi, ripulendo e tagliando i rami in frammenti della dimensione di un braccio. Stavano organizzando qualcosa, ma non riuscivamo a immaginare che cosa. Calò la notte sulla foresta; gli indigeni erano molto animati durante la cena. Lo sciamano, invece, si tenne in disparte, un poco al margine dei nostri gruppi, sul limitare della vegetazione e nella penombra, tanto che riuscivamo appena a vederlo. Non mangiò, non bevve niente; rimase immobile in un angolo senza che nessuno si rivolgesse a lui nemmeno per offrirgli un po' d'acqua. Quando l'ultimo Toromona finì di cenare, un pesante silenzio cadde a poco a poco sull'accampamento. Noi eravamo sempre più sconcertati. Il capo diede improvvisamente degli ordini, gli uomini si alzarono e i falò furono spenti. L'oscurità ci avvolse perché la luce della luna era appena un riflesso biancastro nel cielo; rimasero accesi soltanto alcuni rami che gli indigeni reggevano in alto. Allora gli uomini ci sollevarono da terra prendendoci per un braccio e ci obbligarono a sederci di nuovo fino a formare un ampio cerchio al centro della radura, mentre tutti loro stavano attorno a noi. Sapevamo che non ci avrebbero fatto niente di male e che tutto quello faceva parte di una cerimonia o di uno spettacolo, ma era impossibile non provare un certo nervosismo perché sembrava che ciò che sarebbe successo ci riguardasse direttamente. Io temevo che Marc in un momento qualsiasi tirasse fuori qualcuna delle sue, ma non lo fece; era molto tranquillo e direi persino che quella nuova esperienza gli piacesse. A questo punto lo sciamano si sistemò all'interno del cerchio. Piantò una canna nel terreno e, con un affilato artiglio di formichiere, fece due tagli profondi a forma di croce nella parte superiore di questa. Poi separò i quattro lati in modo che reggessero nel centro una ciotola nella quale lasciò cadere una manciata di steli e di foglie che prese dalla sua borsa delle medicine. Con l'artiglio cominciò a tagliare tutto a strisce molto piccole come se stesse preparando una zuppa alla julienne, e, quando terminò, ne raccolse un pugno e lo strinse con forza. Un liquido calò attraverso la sua mano e cadde nella ciotola. Ripeté l'operazione molte volte, finché rimase solo una pasta secca che lanciò con forza nel folto della foresta. In quello stesso istante, un Toromona incominciò a battere con un bastone su uno dei tronchi cavi che avevano portato dalla foresta producendo un suono grave e regolare. Il vecchio sciamano tolse la ciotola dalla canna e ne bevve molto lentamente il contenuto. Allora, di colpo, la scena accelerò: qualcuno estrasse la canna dal suolo e la fece sparire, mentre quattro dei cinque guardaspalle del capo circondarono il vecchio, sdraiato in terra, e lo sostennero saldamente per le braccia e per le gambe. Il ritmo del tamburo crebbe. Lo sciamano cominciò ad agitarsi, tentando di alzarsi, ma i forzuti glielo impedirono. Il vecchio lottò come un leone, urlò come un animale ferito, ma tutti i suoi sforzi per liberarsi risultarono inutili. Poi si quietò. Rimase completamente calmo; gli uomini lo lasciarono libero e si allontanarono in silenzio. Pareva che nel mondo ci fossero solo quel vecchio, come morto, e noi sei che lo circondavamo. Il suono del tamburo si fece sempre più lento. Come i battiti di un cuore tranquillo. Quella situazione si prolungò per molto tempo, finché, adagio, lo sciamano si alzò. Sembrava drogato, aveva gli occhi arrovesciati. Qualcuno gli avvicinò un piccolo oggetto e glielo mise in mano; era uno di quei frutti che avevano svuotato prima di cena e che avevano trasformato in una specie di maraca riempiendolo di sassolini e di semi. Lo sciamano cominciò a ballare davanti a noi, muovendo la maraca al ritmo del tamburo. Cantava qualcosa di incomprensibile e saltava di tanto in tanto come una scimmia. A un certo momento scosse in modo indiavolato la maraca davanti alla faccia di Gertrude, che si ritrasse con un'espressione spaventata, poi rimase fermo come una statua. Si inginocchiò davanti a lei e con la mano libera tracciò per terra alcuni simboli. Tornò ad alzarsi, agitando lo strumento, e fece di nuovo un giro completo del cerchio saltando e cantando, per andare a pararsi di fronte a Marc, al quale non piacque che gli battessero davanti alla faccia il sonaglio. La medesima scena si ripeté di fronte a ciascuno di noi. Quando arrivò il mio turno, il vecchio mi guardò fisso con i suoi spaventosi occhi stralunati, agitò di nuovo la maraca e si chinò per disegnare dei ghirigori. Non erano però righe a caso quelle che tracciava, bensì la sua mano in trance schizzò senza dubbio un uccello. La cerimonia terminò quando, con quattro bruschi colpi di tamburo, lo sciamano crollò a terra. I forzuti del capo lo raccolsero e lo portarono all'interno della foresta, da dove non tornò fino al mattino seguente, proprio in tempo per riprendere la marcia verso Qhispita. Pareva che stesse meglio e ci sorrise da lontano quando ci vide. In quel momento sapevamo già che ciò che era successo la notte prima era un regalo che ci avevano fatto i Toromonas. Ce ne rendemmo conto quando, finalmente, riuscimmo a vedere tutti i disegni. A Efraín, lo sciamano aveva disegnato una piramide di tre gradini nel cui interno si distingueva un serpente. Marta ricevette la stessa piramide ma, su questa, lo sciamano aveva disegnato un uccello identico al mio. A Marc e a Lola toccò la stessa testa umana con diverse aureole unite da raggi che, più che aureole di santo, sembravano resistenze di lampadine a incandescenza. Gertrude pensò all'inizio che il suo disegno raffigurasse un lucchetto, ma dopo scoprì che si trattava di una borsa per le medicine come quella dello sciamano, perché questi aveva aggiunto i piccoli ornamenti di piume che pendevano dalla sua. Quei disegni erano il nostro futuro, le cose che ci interessavano e alle quali pensavamo di dedicarci: Efraín e Marta a Lakaqullu, la piramide di tre gradini con la sua camera dei tesori; Marc e Lola alla Ker-Central, una società promotrice di progetti di intelligenza artificiale; Gertrude a esercitare la medicina tra gli indios dell'Amazzonia, ma da un nuovo versante, un poco più curandero e sciamanico; e io... be', che diavolo significava l'uccello che era toccato sia a Marta sia a me? Non avevo intenzione di spiegarlo. Finsi di non capire e rimasi in silenzio. Deliberatamente lasciai che gli altri, Marta inclusa, si scervellassero tentando di interpretarlo. Finalmente, lunedì 5 agosto arrivammo a Qhispita e ci fermammo davanti alla stessa porta attraverso la quale eravamo usciti come prigionieri. I Toromonas si congedarono da noi in quel momento. Il capo posò le mani sulle spalle a tutti e sei, uno dopo l'altro, pronunciando amichevolmente delle parole che non comprendemmo, poi lui e i suoi uomini si addentrarono di nuovo nella foresta e scomparvero. Non erano persone molto espansive. Pochi minuti dopo entrammo nella città e salimmo lentamente in direzione della piazza. Avanzavamo storditi: in confronto alle sei settimane passate nella foresta, quelle rovine ci sembrarono il massimo della civiltà, con le strade lastricate e le case con muri e tetti. Raggiungemmo la piazza e, in silenzio, contemplammo gli edifici vuoti e il solitario ed enorme monolito centrale, quello che riproduceva il gigante barbuto con i tratti del Viaggiatore di Lakaqullu. Vicino al piedistallo di pietra nera si vedevano ancora i resti carbonizzati di quelle che erano state le nostre cose. Come mendicanti affamati rivoltammo le ceneri in cerca di qualcosa che si fosse salvato, ma non era rimasto niente. Tutto quello che avevamo erano le nostre amache, un paio di cerbottane e alcuni denti affilati. Questo e la grande quantità di conoscenze acquisite dai Toromonas. Nelle ultime notti avevamo discusso di come saremmo potuti tornare da soli fino a Rurrenabaque. Ricordando le mappe incenerite, sapevamo che camminando sempre in direzione ovest avremmo finito per trovare il grande fiume Beni, e che da lì avremmo dovuto soltanto seguirne il letto fino alla sorgente per raggiungere prima o poi le località gemelle di Rurrenabaque e San Buenaventura. All'andata avevamo seguito fedelmente le indicazioni delle mappe di Sarmiento de Gamboa e della lastra d'oro, ma ora avremmo dovuto cavarcela con le nostre sole risorse. Quando stabilimmo in che direzione tramontava il sole, iniziammo la marcia attraverso la foresta. Non eravamo più le stesse persone che erano arrivate in quella città abbandonata cariche di moderne tecnologie e di cibi confezionati. Ora sapevamo cacciare, scuoiare, fare un fuoco, proteggerci dai pericoli nascosti, dai puma alle formiche soldato, passando per i tafani e i tucani, e sapevamo come seguire i sentieri tracciati dagli animali, strappare una liana e berne il contenuto d'acqua se avevamo sete, oppure curarci un ascesso con grasso di serpente o di lucertola. No, non eravamo più per niente le stesse sei persone (tre hacker, una dottoressa, un archeologo e un'antropologa) che erano arrivate con zaini di tessuto impermeabile ad alta traspirabilità fino alle rovine di Qhispita. Impiegammo due giorni e mezzo a raggiungere il Beni e da lì altri due giorni per trovare un villaggio chiamato San Pablo nel quale vivevano soltanto tre o quattro famiglie indigene che, ovviamente, non avevano telefono né sapevano che cosa fosse. Disponevano però di alcune magnifiche canoe con le quali si offrirono di portarci fino a un altro insediamento, Puerto de Ixiamas, a cinquanta chilometri in direzione della sorgente. Avevamo previsto la reazione che il nostro aspetto disastrato e la nostra improvvisa comparsa potevano causare in chiunque ci vedesse, per cui raccontammo una storia truculenta su un incidente aereo nel quale avevamo perduto tutto e una drammatica storia di sopravvivenza nella foresta. Quelle persone, che avevano un aspetto persino peggiore del nostro, ci guardavano senza capire molto bene quello che gli stavamo raccontando (era gente semplice, che conosceva poco il castigliano), ma, nonostante questo, ci diedero da mangiare, ci permisero di dormire in una delle loro capanne di legno e, il giorno dopo, ci portarono fino a Puerto de Ixiamas, che risultò non essere molto più grande di San Pablo, però c'era un telefono. Un tele- fono che aveva la linea solo quando si metteva in moto un vecchio generatore a benzina e che, anche così, offriva poche garanzie di funzionamento. Dopo un paio d'ore di infruttuosi tentativi attraverso varie centraline locali, Efraín riuscì a mettersi in comunicazione con uno dei suoi fratelli, e a informarlo della nostra situazione. Il fratello, un pacifico professore di matematica poco portato a simili scossoni, reagì con sufficiente sangue freddo e si impegnò ad aspettarci due giorni dopo nell'ultima località sulla riva prima di Rurrenabaque, Puerto Brais, con vestiti e danaro. Eravamo ai confini del mondo, in un angolo sperduto della foresta, dove non arrivava mai nessuno e dove non avevano l'abitudine di vedere dei bianchi né di sentire parlare il castigliano. Continuavamo a rasentare la Terra Incognita ma, a bordo delle canoe della gente del fiume, arrivammo nella data prevista a Puerto Brais, a circa quindici chilometri dalla nostra destinazione, dove effettivamente il fratello di Efraín, Wilfredo, con lo stupore dipinto sul volto, ci ricevette con grandi abbracci e con una valigia. Non riuscimmo a passare inosservati in quel piccolo imbarcadero e nemmeno nel baretto nel quale ci ripulimmo e ci cambiammo, ma, quando salimmo sull'ultima imbarcazione diretta a Rurre, sembravamo dei tranquilli turisti che ritornavano da una gradevole passeggiata nei dintorni. Siccome avevamo perduto le prenotazioni pagate all'arrivo, Wilfredo aveva dovuto comprare a El Alto i sette biglietti aerei per La Paz per il volo che partiva quella sera stessa (continuavano a effettuare voli speciali per i turisti), cosicché passammo il pomeriggio seduti prima in un bar e poi in un parco, tentando di non farci notare troppo. All'ora prevista ci dirigemmo tranquillamente verso gli uffici della TAM, da dove partiva il pulmino diretto all'aerodromo con la pista erbosa. Atterrammo finalmente a El Alto alle dieci passate della sera e ci congedammo da Wilfredo prima di salire in due radio-taxi che ci condussero alla casa di Efraín e Gertrude. Non avevo mai provato una commozione forte come quella che sentii attraversando all'interno di un veicolo le strade di La Paz. La velocità mi sorprendeva. Era come essere stati per molto tempo su un altro pianeta ed essere tornati sulla Terra. Tutto mi sembrava nuovo, strano, rapido e troppo rumoroso, inoltre faceva un freddo secco invernale al quale non ero abituato. Gertrude ed Efraín andarono dai vicini che avevano una copia delle chiavi della loro casa, nell'eventualità che succedesse qualcosa. Con queste aprirono la porta e solo allora capimmo che eravamo veramente ritornati. Ci guardammo e sorridemmo senza dire una parola, smarriti come un gruppo di bambini il primo giorno di scuola. Le valigie di Marc e Lola e le mie erano nella stanza degli ospiti. Ci facemmo una doccia, ci rivestimmo con i nostri abiti, ci sedemmo su sedie normali intorno al tavolo della sala da pranzo e, usando piatti, posate e tovaglioli, consumammo una magnifica cena che ci portarono da un ristorante vicino. Poi, ancora piuttosto intontiti per il cambiamento, accendemmo la TV e rimanemmo a bocca aperta vedendo le immagini sullo schermo e sentendo le voci, la musica. Tutto continuava a essere molto strano, ma quello che mi sorprendeva di più era vedere gli altri ben pettinati, con le mani e le unghie pulite, con i pantaloni lunghi, le gonne, le camicette, le maglie immacolate e senza strappi. Sembravano diversi. C'era qualcosa, tuttavia, che non potevo rimandare. Erano quasi due mesi che mi ero congedato da mia nonna con la promessa di mettermi in contatto con lei non appena mi fosse stato possibile, pensando che sarebbe stata questione di un paio di settimane. La chiamai. In Spagna erano le sei del pomeriggio. Come qualsiasi nonna del mondo, la mia si era preoccupata perché non aveva mie notizie ma, nonostante ciò (era stata sul punto di chiamare la polizia boliviana almeno un paio di volte, secondo quello che mi disse), era riuscita a tenere mia madre sotto controllo convincendola che io stavo bene e che la chiamavo di frequente. «E dove le hai detto che sono?» le chiesi. «È per non fare una gaffe al mio ritorno.» «Sai che io non mento mai», rispose con fermezza. No, per favore! pensai inorridito. Che diavolo le avrà raccontato? «Che eri andato nella foresta dell'Amazzonia a cercare dei rimedi naturali per guarire Daniel. Delle erbe. Non puoi immaginare la faccia che ha fatto tua madre! Lo ha subito raccontato a tutti i suoi amici come se fosse qualcosa di molto chic. Hai mezza Barcellona che ti aspetta morta di curiosità.» Avrei voluto ammazzarla se non fossi stato tanto felice di sentirla e di ritornare, per così dire, alla normalità. «Le hai trovate, Arnauet?» «Ho trovato che cosa?» «Le erbe... be', quel che è. Mi capisci.» Emise un lungo sospiro e mi diede l'impressione che in realtà stesse mascherando l'emissione del fumo di una sigaretta. «L'ho dovuto raccontare tante volte per colpa di tua madre che quasi sono arrivata a crederci davvero.» «È possibile, nonna. Lo sapremo al nostro ritorno.» «Tuo fratello è a casa. Lo abbiamo portato qui dall'ospedale un mese e mezzo fa. Non è migliorato per niente... il poveretto continua a stare come prima della tua partenza. Ora non parla nemmeno più. Spero che il tuo rimedio serva a qualcosa. Non vuoi dirmi di che si tratta?» «Ti sto chiamando da casa di amici e questa è una telefonata internazionale, nonna. Te lo racconterò quando sarò lì, d'accordo?» «Quando torni?» mi chiese. «Quando riusciremo ad avere i biglietti per la Spagna. Chiedi a Núria. La chiamerò subito perché si occupi di tutto. Lei ti terrà informata.» «Che voglia ho di vederti!» «Anch'io, nonna», dissi sorridendo. «Ah, a proposito! C'è una cosa che devo chiederti. Cerca il momento giusto perché possa rimanere solo con Daniel. Non voglio che nessuno aspetti nella stanza né in salotto, né che prepari la cena in cucina. La casa deve essere vuota. Inoltre verrò con un'altra persona» «Arnau!» si scandalizzò. «Non ti sarà venuto in mente di portare uno sciamano indio a casa di tuo fratello, vero?» «Come vuoi che porti uno sciamano!» mi innervosii. «No, si tratta di Marta Torrent, il capo di Daniel.» Ci fu un lungo e significativo silenzio all'altro capo del filo. «Marta Torrent?» disse infine con voce esitante. «Non è la strega della quale parla Ona?» «Sì, proprio lei», ammisi, guardando Marta furtivamente e osservando come Lola e lei ridevano di qualcosa che stavano guardando in TV. «Ma è una gran brava persona, nonna. Te la presenterò. Vedrai che ti piacerà. È lei quella che guarirà Daniel.» «Non so, Arnauet...» tentennò. «Non la vedo bene, questa idea di portare Marta Torrent a casa di Ona e di tuo fratello. Ona potrebbe offendersi. Sai che considera Marta responsabile della malattia di Daniel.» «Senti, nonna, non obbligarmi a raccontarti certe cose ora.» Mi arrabbiai. Ricordare le stupidaggini che mio fratello e mia cognata raccontavano su Marta mi metteva di malumore. «Tu fai quello che ti dico io e lascia a me il resto. Fai in modo che la casa rimanga vuota e che Marta e io possiamo entrare senza che nessuno lo sappia.» «Mi metti nei guai, figlio mio!» «Tu sei brava, nonnina», scherzai. «Se non lo fossi, non so che fine avrebbe fatto questa famiglia. Ma insisto nel dirti che mi stai mettendo in una situazione molto difficile con tua cognata.» «La risolverai bene», la incoraggiai, chiudendo la conversazione. «Ci vediamo fra pochi giorni. Riguardati, d'accordo?» Quando mi tolsi l'auricolare dall'orecchio dopo aver parlato con mia nonna e con Núria, non era più la civiltà quella che mi sembrava strana, ma il ricordo della foresta. Come per magia, avevo recuperato le abitudini normali e sentivo che tornavo a essere lo stesso Arnau Queralt di prima. Ma no, mi dissi. Sicuramente non del tutto. EPILOGO Due giorni dopo, il 16 agosto, salimmo sull'aereo che ci avrebbe portato in Perù. Questa volta ci muovevamo nella direzione contraria al sole, quindi il nostro arrivo in Spagna era previsto per la domenica 18, anche se il viaggio durava pressappoco ventidue ore. Ci congedammo da Gertrude ed Efraín a El Alto con grandi abbracci, scambiandoci la promessa di rivederci presto in un Paese o nell'altro. Marta sarebbe ritornata in Bolivia all'inizio di dicembre per continuare gli scavi a Lakaqullu durante le feste natalizie. Io avevo con me la registrazione di Gertrude della conversazione con i Capacas. «Raccontami tutto», mi chiese per l'ennesima volta, «e tienimi al corrente di quello che troverai.» «Non essere pesante, per favore!» la riprese Efraín stringendomi con forza la mano. «Non ti preoccupare, dottoressa», le dissi. «Saprai tutto, minuto per minuto.» Prima di decollare, Marc prese delle pastiglie che gli aveva dato Gertrude e che lo misero fuori combattimento prima che l'aereo si alzasse in aria. Facemmo fatica a svegliarlo quando atterrammo all'aeroporto di Lima e anche nei successivi aeroporti nei quali facemmo scalo. Le pastiglie di Gertrude (ne aveva una buona scorta) lo mantennero in stato di coma fino all'arrivo in Spagna e, come riconobbe più tardi, quel viaggio fu il più gradevole che avesse mai fatto. «Quale miglior modo di morire», brontolava sonnolento all'aeroporto di Schiphol, «che farlo senza rendersene conto?» Prima che ciascuno degli aerei su cui ci imbarcavamo accendesse i motori e le pastiglie facessero di nuovo effetto, si congedava con tristezza da Proxi, da Marta e da me (soprattutto da Proxi) «nel caso non ci rivedessimo più». La cosa giunse a un punto tale che giurai su ciò che avevo di più caro che non avrei più viaggiato in aereo con lui per il resto della mia vita. Lola non aveva altra soluzione che sopportarlo, io però potevo risparmiarmi quelle situazioni drammatiche. Finalmente, dopo l'ultimo volo, quello che ci avrebbe portati dall'Olanda a Barcellona, Marta e io ci sedemmo tre file dietro a quella di Marc e Lola. Era il momento che aspettavo per parlare tranquillamente con lei del problema di Daniel. «Hai preso già una decisione riguardo a mio fratello?» le chiesi poco dopo che ci avevano servito il vassoio del pranzo. Fino a quel momento avevamo parlato di computer e lei mi aveva chiesto con molto interesse di mostrarle la mia «casa robotica», come la chiamava. Non rispose subito alla mia domanda. Rimase in silenzio per alcuni secondi fingendo un grande interesse per i manicaretti poco genuini che avevamo davanti. Avrei preferito di gran lunga un bel pezzo di tucano arrostito a quelle porcherie. Marta si schiarì la voce. «Se guarisce», mormorò portandosi una forchettata di insalata scondita alla bocca, «mi piacerebbe parlare con lui prima di fare qualsiasi passo.» «Penso tu abbia paura che io ti chieda di non denunciarlo.» «Sono sicura che non lo faresti.» Sorrisi. «No, non lo farei», confessai mettendo da parte il vassoio, e mi voltai a guardarla quel tanto che mi permetteva lo spazio angusto. «Ma mi piacerebbe sapere quali decisioni potresti prendere.» «Il furto del materiale di ricerca di un dipartimento è una cosa molto seria, Arnau. Non pensare che mi sarà facile decidere per un verso o per l'altro. Non riesco ancora a credere che Daniel sia stato capace di appropriarsi dei documenti del mio archivio. Mi sono chiesta molte volte perché lo abbia fatto. Non riesco a capirlo.» «Anche se ti costa crederlo, lo ha fatto per me», le spiegai. «Non per colpa mia e nemmeno per farmi un favore. Anch'io ho pensato e ripensato a questo fatto e, anche se tutti siamo ciechi quando si tratta della nostra fa- miglia, credo che mio fratello abbia sempre sentito una forte rivalità nei miei confronti. Gelosia, sicuramente, o invidia. Non saprei.» «Bramosia di primogenitura?» insinuò lei un po' per scherzo e un po' sul serio. «Bramosia di vittoria facile, di guadagno rapido.» «È il tuo caso?» si stupì. «No, assolutamente. Ma lui lo ha sempre pensato. O ha voluto vederla così. O si è sbagliato o ha capito male. Che importanza ha? Quello che conta è che per ottenere il successo con la scoperta del potere delle parole ti ha rubato il materiale su Taipikala.» «Efraín e io non eravamo andati avanti come lui», ammise, e scartò anche lei il cibo dopo un paio di tentativi infruttuosi di mandarlo giù. «Daniel è molto intelligente.» «Lo so. Lo siete tutti e due. La somiglianza non è solo fisica. Per questo avevo tanta fiducia in lui e nelle sue capacità. Ma non posso fingere di non sapere quello che ha fatto. Cerca di capire... sono il capo del dipartimento e uno dei miei professori ha commesso un reato che un giorno potrebbe ripetere.» «Forse no», asserii. Lei rimase di nuovo in silenzio. «Forse no», ammise di lì a poco, «però sono diffidente per natura e non posso ignorare quella parte del cervello di Daniel che gli ha permesso di entrare nel mio studio e di rubare il materiale dai miei archivi. Può darsi che non lo rifaccia, è vero, ma non c'è qualcosa in lui che funziona male? Qualcosa che, quando desidera una cosa lontana dalle sue possibilità, gli dice: 'Avanti, sai come ottenerla'?» «Avrà bisogno di aiuto.» «Sì, ne avrà bisogno. Deve imparare di nuovo che ci sono delle regole e dei limiti, che non possiamo sempre ottenere ciò che desideriamo e che non ci sono scorciatoie né treni ad alta velocità per arrivare dove vogliamo, che qualsiasi conquista richiede molta fatica.» «Tutti commettiamo degli errori.» «Certo. Per questo ho bisogno di sapere che cosa c'è nella sua testa prima di prendere qualsiasi decisione. Forse anche tu dovresti spiegargli nei particolari quanta fatica ti è costato avere quello che hai.» Presi in considerazione le sue parole. Certo che avevo in mente di parlare con Daniel, non per raccontargli la mia vita, ma per spiegargli con determinazione quello che pensavo della sciocchezza che aveva commesso. Forse Marta aveva ragione. Forse sarebbe stato più opportuno fare quello che diceva lei, ma come potevo parlare con mio fratello di queste cose? Dubitavo di riuscirci. «Cambiando argomento...» continuò lei girandosi come poteva sulla poltrona per guardarmi in faccia. «Non sarebbe meglio che restassi sola con Daniel quando dovrò ripetergli la frase che mi hanno insegnato gli yatiris?» «La ricordi, vero?» mi preoccupai. «Certo che me la ricordo, non essere sciocco! Come potrei dimenticare una cosa tanto importante? Be', che cosa pensi del fatto che devo rimanere sola con lui? Credo sarebbe molto duro fungere da strega della tribù in presenza della tua famiglia.» Scoppiai a ridere. «Tranquilla», dissi infine, «mia nonna ha già spiegato a tutti che sono stato in Amazzonia in cerca di erbe magiche. Sa anche che deve trovare un momento in cui la casa di Daniel sia deserta perché possiamo andarci noi due. Il problema è già risolto.» «Quanti anni ha tua nonna?» si stupì. «Deve essere molto anziana.» «Be', la conoscerai!» Atterrammo a Barcellona alle due del pomeriggio. La madre di Lola ci stava aspettando all'aeroporto. Né Marta né io accettammo la sua offerta di portarci a casa con la sua auto. Marc stava male e aveva bisogno di mettersi a letto al più presto. Noi avremmo condiviso un taxi. «Ci dirai come risponderà Daniel alla frase degli yatiris?» mi chiese Lola a bassa voce mentre ci salutavamo. «Vi chiamerò appena lo abbiamo fatto. Comunque vada.» «Non dimenticarti di quello che abbiamo concordato rispetto alla KerCentral», articolò a fatica Marc con lo sguardo vitreo. «Domani stesso metterò la questione nelle mani dei commercialisti», gli risposi. «Cerca di riposare, stanotte... fai pena.» «Lo so, lo so...» mormorò mentre seguiva la madre di Lola come un agnellino, trascinando il carrello con il bagaglio. «Chiamaci, Root», insisté Proxi con l'aria preoccupata. «Quando tutto sarà finito andremo tutti e quattro a cena, d'accordo?» propose guardando Marta. «Certo», disse la professoressa sorridendo. «Vi siete resi conto che, mentre eravamo nella foresta, avete smesso di chiamarvi con i vostri soprannomi da internauti?» «Peccato che tu non sia una hacker!» le rispose Proxi abbracciandola e allontanandosi a passo lento dietro al malandato Jabba e a sua madre. «Ma può darsi che ti appassioni, vedendo la casa di Arnau.» «E il '100'», aggiunse Marta con un largo sorriso. «Voglio anche conoscere il '100'.» Proxi alzò una mano per salutarla. «Bene», annunciai, «è ora di prendere un taxi.» Arrivammo prima a casa mia, perché Marta viveva nella zona alta, nella Bonanova, quindi la vidi allontanarsi nella macchina che svoltò salendo per il passeig de Gracia. «Chiamami quando dobbiamo andare a trovare Daniel», mi disse prima di salutarci con la stessa faccia seria e tranquilla di sempre. Mentre salivo in ascensore mi chiesi quando l'avrei chiamata, quale sarebbe stato il momento migliore per farlo. Bene, mi dissi, la risposta era facile: quando fossi riuscito a liberarmi dal benvenuto famigliare che mi aspettava. L'avrei invitata a cena quella sera stessa... O era troppo presto? Be', e allora? L'avrei chiamata. Volevo sapere che cosa pensava dei miei progetti e che cosa mi avrebbe detto su come intendevo portarli a termine. Per il momento, quando si fosse aperta la porta dell'ascensore, avrei dovuto affrontare il problema delle erbe medicinali. Il giorno dopo aver parlato con mia nonna per telefono da La Paz, ero andato al Mercato degli Stregoni e avevo comprato una pozione schifosa che, secondo lo yatiri che la vendeva in flaconi di vetro unti, provocava la passione nella donna amata. Per me andava bene qualsiasi cosa purché sembrasse davvero una formula speciale preparata appositamente per mio fratello, e quello spesso liquido marrone ne aveva tutto l'aspetto. Quindi, dopo aver salutato Clifford e abbracciato mia nonna, quando mia madre ebbe terminato finalmente la sequela di baci schioccanti, le consegnai con solennità i sudici recipienti e le dissi che, dopo aver consultato tutti gli stregoni amazzonici registrati nel censimento boliviano, non avevo alcun dubbio che un'infusione con alcune gocce di quel prodotto al mattino e alla sera avrebbe restituito il senno a Daniel. Non volevo che lei diffondesse tra i suoi amici più fantasie del necessario, per cui ridussi i particolari e mi limitai a parlare delle comunità indigene visitate lungo il fiume Beni durante il nostro viaggio. Clifford, da buon inglese, sembrava restio all'esperimento, ma non osò aprire bocca davanti alla moglie che si era entusiasmata per gli esotici flaconcini. Immediatamente si attaccò al telefono e cominciò a raccontare a Ona tutta l'avventura, e io, approfittando dell'occa- sione, me la filai alla chetichella in camera mia dove feci una doccia, mi cambiai e mi feci la barba lasciandomi di nuovo il pizzetto. Mia nonna mi aveva detto che ero più magro, più bello, e abbronzato per la prima volta in vita mia, il che era vero. Avevo i capelli ancora abbastanza corti e continuavo a portare l'orecchino, che ora spiccava molto di più sulla pelle bruciata dal sole e dall'aria. Di quel volto affilato, pallido e urbano che avevo quando ero partito rimaneva molto poco. Ma c'erano anche altri cambiamenti. Lo scoprii quando aprii bocca per chiedere al sistema di mettermi in contatto con Marta e mi resi conto che non avevo idea di come parlare con una macchina dotata di un'intelligenza forse tanto artificiale quanto lo nostra. Rimasi impietrito per la scoperta. Quello che ci aveva raccontato Gertrude sul cervello e i neurotrasmettitori, quello che avevamo appreso sul potere dei suoni per programmare e deprogrammare la mente e persino l'esempio dello sciamano, che era entrato in trance al ritmo del tamburo e della maraca, mi avevano lasciato un dubbio che poteva riassumersi nella tipica domanda del mondo informatico: che differenza c'è tra sommare due più due, come facciamo noi umani, e simulare di sommare due più due, come fanno i computer? Il risultato è sempre lo stesso, quattro, in qualunque modo ci si arrivi, e in questo caso ciò che mi sorprendeva era che la strada risultava essere sostanzialmente la stessa: un numero infinito di connessioni elettriche, veloci come la luce, che viaggiavano attraverso i neuroni, nel nostro caso, o il silicio, nel caso delle macchine. Molte cose erano cambiate in me durante quegli ultimi due mesi e mezzo in cui avevo imparato cose strane, e ora, con mia sorpresa e quasi contro la mia volontà, attribuivo al sistema senza nome che controllava la mia casa una personalità propria che mai mi sarebbe venuto in mente potesse avere. E che, infatti, non aveva, mi dissi infastidito, scuotendo la testa per allontanare idee assurde dalla mente. Sapevo che dovevo dargli gli ordini con un tono di voce autoritario perché capisse che erano diretti a lui e non a Magdalena, però dalla bocca mi usciva solo una voce educata che voleva chiedere le cose con un «per favore» del tutto inefficace. Dovetti fare uno sforzo per obbligarmi a ricordare come avevo programmato la comunicazione ma, dopo un paio di tentativi senza che mi desse retta, incominciai ad arrabbiarmi: era diventato autonomo o si era danneggiato? Per fortuna mi venne in mente di guardare lo schermo gigante e lì c'era questo messaggio: «Numero telefonico bloccato. Disattivare il blocco e digitarlo?» Risi di me stesso e della mia distrazione, e solo dopo alcuni secondi capii che il sistema stava tentando di dirmi qualcosa di importante. Bloccato il numero di Marta? Come bloccato? «Che diavolo mi succede!» esclamai ad alta voce. «Sono rimbecillito!» Mi ero di colpo ricordato che la sera di quella lontana domenica in cui Marta mi aveva chiamato per reclamare il suo materiale su Taipikala e sugli aymaras, avevo ordinato al sistema di rifiutare tutte le chiamate provenienti da quel numero e tutte quelle che provenivano dal titolare di quel numero, comprese quelle del dipartimento dell'università. «Sbloccare!» gridai. Pochi secondi dopo sentii la voce di Marta. «Sì?» «Marta, sono Arnau.» «Hola, Arnau. Che succede? Dobbiamo andare a casa di Daniel?» «No, no...» risi. «Ti va di andare a cena stasera? Vorrei parlare con te di alcune cose.» Si fece un silenzio sorprendente all'altro capo del telefono. «Sì, certo», rispose infine. «Ti sembra un po' presto?» le dissi mentre mi allacciavo l'orologio. «Preferisci che ci vediamo domani o dopodomani?» «No, assolutamente. Mi va benissimo.» «A che ora passo a prenderti?» Quella conversazione era incredibile. Mai avrei fatto prima un tentativo tanto sfacciato per avvicinarmi a un altro essere umano. In situazioni simili mi sembrava di dover abbandonare il mio tranquillo pianeta per entrare in relazione con entità che non comprendevo: per questo non lo facevo e non fraternizzavo con nessuno. Con Marta, però, era diverso. Avevo condiviso con lei il giorno e la notte per due mesi e la stavo invitando a cena in assoluta tranquillità e confidenza. «Vieni quando vuoi», rispose. «In realtà non sto facendo niente. Mi ero appena seduta sul divano e avevo acceso la prima sigaretta degli ultimi due mesi.» «Allora non farlo», le dissi. «Che te ne importa?» «Fumare mi piace, e non mi priverò di questo piccolo piacere. Non farmi la predica, d'accordo?» «Va bene. Allora, posso venire subito?» «Certo. Dovresti già essere qui.» Questo mi piacque. E mi piacque anche salire di nuovo sulla mia auto e stringere con forza il volante mentre guidavo. Era poco più tardi delle sei e mezzo della sera e, nonostante fossi stato ventiquattro ore in aereo e avessi sorvolato l'Atlantico, mi sentivo il re del mondo. Mia madre mi aveva rinfacciato che uscissi «con un'amica» senza prima passare a trovare mio fratello e mio nipote, ma feci finta di non sentirla ed entrai in ascensore. Per fortuna, se il «sostegno» che ci avevano dato i Capacas avesse funzionato, mi sarei liberato di tutti loro molto prima di quanto immaginassero. Ciascuno a casa propria e Dio con tutti... non era quello che diceva la saggezza popolare? Mio fratello lo avrei visto quando mi toccava, e, per ciò che riguardava mio nipote, appena un momento prima avevo tirato fuori dalla valigia il piccolo pupazzo che gli avevo comprato al Mercato degli Stregoni di La Paz per farglielo rompere nello stesso momento in cui lo vedeva. Ebbi la fortuna di trovare un parcheggio proprio in una viuzza vicina all'abitazione di Marta, una casa antica di due piani e un solaio, con la facciata annerita dall'inquinamento e un giardinetto. Lei mi aprì la porta. «Questo edificio non ha microfoni né sensori né videocamere», mi avvertì con ironia appena entrai. «Lo dico nel caso tu ti senta a disagio. Se gridi, non c'è nessun computer che ti possa rispondere. Mi dispiace.» Era una casa molto grande, con i pavimenti in parquet, soffitti alti e mobili antichi. C'erano libri dappertutto, persino nei corridoi, in grandi librerie di legno che coprivano le pareti. Non mi aspettavo niente di diverso: la casa stava a Marta come Marta stava alla casa. «E non hai nemmeno una consolle di videogiochi? Sai, una Playstation o un Gameboy», le chiesi mentre entravamo nel salotto le cui alte finestre davano sul giardino. «Questi ce li ho», riconobbe con un sorriso, abbandonandosi sul divano. Anche se l'ambiente era diverso, lei era tornata a essere la Marta della Bolivia, o almeno così mi sembrò, con la differenza che lì indossava vestiti invernali e qui portava un semplice vestito con le spalline. «Le camere sono al piano superiore. Lì ne troverai qualcuna, se ti servono. Non reprimerti.» Mi sedetti su una poltrona, di fronte a lei, anche se non mi misi comodo. Ero nervoso; cominciai a giocare con un accendino che trovai accanto a un portacenere di pietra nel quale c'erano diversi mozziconi. «Non avevi detto che avresti fumato una sigaretta sola?» chiesi sorpreso. «Be', avevo bisogno di nicotina per recuperare i mesi perduti.» Decisi di venire al nocciolo della questione. «Ho bisogno del tuo aiuto, Marta. Devi spiegarmi... cioè, voglio lavorare con voi a Tiwanacu.» Lei scoppiò a ridere. «Era questo che non volevi dire quando ti chiedevamo che cosa avresti fatto dopo il 'pensionamento'?» «Più o meno.» «Sei piuttosto impreciso. Spiegati meglio.» «Voglio collaborare, voglio far parte dell'équipe.» Mi stavo spiegando come un libro aperto. «Il problema è che non ho nessun tipo di preparazione accademica. Sono un imprenditore, un imprenditore di Internet. Come faccio a lavorare con voi negli scavi, con quale compito? Per cominciare avrei pensato di fornire a Efraín e a te i programmi informatici e i computer di cui avete bisogno per tradurre le lastre d'oro della Piramide del Viaggiatore. Li scriverei io stesso o migliorerei quelli di Joffre. Tornerei a fare il programmatore», sorrisi, «come quando avevo vent'anni. Vorrei però partecipare in qualche altra maniera, non soltanto come informatico.» «Be'...» esitò lei, «non so. Dovrei pensarci. Certamente, se dipendesse soltanto da me non avrei il minimo problema. Credo che mi piacerebbe molto lavorare con te. Gli scavi, però, sono finanziati dal governo boliviano...» «E da imprese private», la interruppi. «Sì, e da imprese private che vogliono scaricare imposte e crearsi una buona immagine, non essere parte integrante degli scavi.» «Va bene. Allora, che cosa devo fare?» «Se è soltanto per questo», celiò, «mi deludi. Credevo che nascondessi un interessante segreto.» «Può darsi che abbia un segreto», ammisi, chinandomi per avvicinarmi a lei. «O forse due. Che te ne pare?» «Così va meglio», disse con un largo sorriso. «Il mio primo segreto è questo: lavorerei con voi solo quando tu sarai in Bolivia. Nel periodo che passerai qui, a Barcellona, all'università, viaggerei per il mondo. Farò il cacciatore di leggende sull'origine dell'umanità.» «Ma questo è ciò che fanno i creazionisti di cui parlava Gertrude!» si preoccupò. «No. Loro collezionano prove contro la teoria dell'evoluzione. Che si occupino di questo, dato che lo fanno da molto tempo. Io parlerò con gente strana, come gli yatiris. Andrò in Africa, in Asia, in America del nord, in America del sud, in Australia...» «Ora capisco il disegno che ti ha fatto lo sciamano dei Toromonas», si lasciò scappare spalancando gli occhi. «L'uccello, ora è chiaro!» Ricordava che anche a lei aveva fatto lo stesso disegno? Lo avremmo verificato. «Cercherò dovunque», continuai con entusiasmo, «cercherò persino sotto le pietre per raccogliere tutte le leggende che parlino della creazione del mondo e degli esseri umani. Sono convinto che sarò in grado di fare uno studio molto serio con tutto ciò che troverò e di cui scoprirò significative coincidenze e potrò stabilire interessanti parallelismi. Non dimenticare che sono stato programmatore di codici per molti anni e che ho imparato a estrarre dati da frammenti di informazioni. Il mio problema, però, è che, quando avrò tutto il materiale e sarò ritornato a Barcellona per lavorarci su, non saprò come farlo. E torniamo al punto di partenza: mi manca la preparazione accademica. Bisognerà classificare, ordinare, scrivere... Utilizzo diversi linguaggi di programmazione e posso scrivere milioni di istruzioni con questi, ma non sono capace di redigere un piccolo saggio storico o scientifico.» Marta mi guardava del tutto sorpresa. Era arrivato il momento. «Perché non lavori con me, Marta? Perché non vieni con me?» Lo avevo tirato fuori. Sentii il sudore scorrermi per la nuca. Lei spalancò la bocca. «Mi hai chiesto di venire con te?» balbettò infine. «Passeremmo tutto il tempo necessario con Efraín e Gertrude in Bolivia per portare avanti gli scavi di Lakaqullu e dedicarci alla Piramide del Viaggiatore. Io potrei occuparmi dei compiti, diciamo, clandestini», sorrisi, «come portar via il corpo di Dose Capaca e nasconderlo in un luogo scelto da voi che conoscete la zona.» Parlavo senza respirare, senza fare pause. Parlavo come mia madre. «O di eliminare dalla camera del Viaggiatore tutti i riferimenti alla fuga degli yatiris nella foresta o anche di chiudere il tunnel di uscita in cui abbiamo trovato la ciambella di pietra che ha preso Efraín. Forse sarebbe una buona idea che tu chiedessi un'aspettativa all'università o una borsa di studio di quelle che vi danno per la ricerca. Non so, come sembra meglio a te. Così potremmo viaggiare e potremmo conoscere i dogon, gli hopi, i navajos... tutti quei popoli che custodiscono vecchie leggende sul diluvio e sulla creazione del mondo. Sei mesi in Bolivia e sei mesi qui, a mettere insieme le informazioni.» «Ma...» «Così potrei anche lavorare con Gertrude sul nastro con le voci dei Capacas di Qalamana. Ho scoperto che mi incuriosisce molto il funzionamento del cervello, come, a suo tempo, mi incuriosì il funzionamento dei com- puter. Di nuovo mi mancano, chiaramente, gli strumenti necessari. Non sono medico. Ma nemmeno quando ho cominciato a programmare con uno Spectrum sapevo niente, e guarda dove sono arrivato; quindi credo di poter imparare molto da Gertrude e, stando in Bolivia, lavoreremo meglio.» «Arnau...» «Un'altra cosa che mi è venuta in mente è che potremmo passare l'estate a lavorare a Taipikala e l'inverno in altri luoghi, così, tra un viaggio e l'altro, avrai la possibilità di ritornare a casa per stare con i tuoi figli. O hanno ancora bisogno di te e non puoi lasciarli soli? Perché questo cambierebbe un po' i piani e...» «Taci!» Mi zittii di colpo. «Ascolta», disse lei portandosi le mani alla testa, «penso che tu sia pazzo. Non so se ho capito bene quello che vuoi dirmi. Parli in codice e mi stai confondendo.» Rimasi in silenzio, con le labbra serrate perché vedesse che non avevo intenzione di dire una sola parola in più. In realtà avevo già fatto la mia mossa. Un autentico hacker non rivela mai i suoi segreti, ma, quando è il momento di agire, lo fa con fermezza. «Che cosa ne pensi se andiamo a cenare», propose penetrandomi con lo sguardo, «e valutiamo tutto tranquillamente dall'inizio mentre ci servono un sacco di cose che non mangiamo da tanto tempo? C'è un ottimo ristorante qui vicino.» «Va bene», dissi. «Ma è presto. Sono solo le otto meno un quarto.» «Non per noi, che andiamo ancora con l'orario della Bolivia e lì è già ora di pranzo. Inoltre, ti ricordo che stamattina, sull'aereo, non abbiamo toccato cibo.» Questo era vero. Io, però, non avevo fame. Avevo appena fatto una delle cose più difficili della mia vita e sembrava che i problemi non fossero terminati. Ma voleva che glielo dicessi in aymara o cosa? «Lo sciamano dei Toromonas ci ha disegnato lo stesso uccello.» «Vado a prendere le mie cose», disse andando velocemente verso la porta del salotto. «Aspettami.» La cosa si stava facendo difficile. «Ascolta», la fermai. «No, ora no.» «Sì, ora sì», insistei. «Vieni con me in cerca di storie antiche che possono contenere delle verità. Sono sicuro che ci troveremo bene. Formiamo una bella squadra.» Mi scrutò con un'espressione eccessivamente diffidente. «E se non funziona», proseguii, «chiudiamo e amici come prima. Io continuerò a viaggiare e tu mi aiuterai al mio ritorno.» «Sei pazzo da legare, lo sai?» mi buttò in faccia. «E poi, credi di poterti presentare a casa mia e dirmi tutte queste stupidaggini senza prepararmi? Che maniere! Ascoltami, ho nove anni più di te, e posso garantirti che sei il tipo più freddo e meno spiritoso che abbia mai conosciuto. Ti rendi conto delle stupidaggini che hai detto?» Bene! Non potevo più assillarla o avrebbe finito per cacciarmi via. «Pensaci, d'accordo?» risposi. «E ora andiamo a cena. Su, vai a prendere le tue cose. Ti aspetto.» Restammo completamente soli al ristorante per un paio di ore. I turisti di agosto non arrivavano fino a quella zona e i nativi avevano lasciato in massa la città. E questo senza considerare che in estate nessuna persona sana di mente sarebbe uscita in strada tanto presto, a meno che non avesse intenzione di morire liquefatta sull'asfalto. Ritornai a casa verso l'una di notte, stanco per il lungo viaggio, per il diverso fuso orario e per aver utilizzato tutte le risorse e il mio fascino personale per attirare Marta nella rete che tessevo lentamente davanti ai suoi occhi facendo in modo che non se ne accorgesse. No, non la intrattenni con il racconto della mia vita né la annoiai con i quattro particolari divertenti della mia esistenza. Mi limitai ad ascoltarla, a guardarla e ad ascoltarla, e a capire quello che le interessava perché, per rompere le protezioni di un sito sicuro che si vuole pirateggiare, la prima cosa da fare è conoscere i punti deboli del sistema e cercare di scoprirne i codici di accesso. Quando infine ritornai a casa e mi buttai sul letto, anche se avrei voluto ripensare a quello che ci eravamo detti per migliorare la mia strategia, non ci riuscii; sprofondai nel sonno nel giro di pochi secondi e non mi svegliai che dodici ore dopo. All'indomani, quando aprii gli occhi, mi sentii euforico e soddisfatto: ero sicuro di aver aperto una breccia, piccola, nel muro di difesa. Il mondo era pieno di porte chiuse e io ero nato per aprirle tutte. Non avevo dubbi che Marta fosse una sfida che valeva la pena affrontare. Dopo colazione ciondolai un po' per la casa e per il giardino e mi godetti la piacevole sensazione di essere ritornato. Anche se non ero stanco, camminavo lentamente per pura pigrizia, trascinando i piedi come un vecchio, ma, nonostante ciò, la sfortuna mi fece arrivare fino allo studio e mi co- strinse a sedermi davanti a uno dei computer per vedere se avevo posta. Non mi interessavano per niente i messaggi di lavoro, quindi controllai solo l'indirizzo personale; pensavo che la pagina d'entrata fosse satura, invece avevo solo dieci miserabili messaggi, cinque dei quali erano di Proxi ed erano di quella stessa mattina. Un particolare curioso attirò la mia attenzione: erano in codice e dovetti decifrarli prima di chiedermi perché si fosse presa tanto disturbo. Proxi aveva estratto dal CD in cui avevamo riprodotto tutto il materiale di Lakaqullu una selezione di fotografie delle cose più interessanti della Piramide del Viaggiatore e, sinceramente, sentii un nodo in gola nel rivedere i caschi dei guerrieri delle lastre che segnavano l'accesso ai camini, i grandi occhi rotondi e gli affilati becchi di pietra delle teste di condor, i bassorilievi dei pannelli dei tocapus delle prove, la scala che si era staccata dal tetto appesa a due grosse catene d'oro, le teste di puma che custodivano l'immensa porta attraverso la quale si accedeva alla camera, il pannello con la maledizione originale che aveva colpito Daniel e che io stesso avevo fotografato per poterlo vedere sullo schermo del portatile, le file interminabili di lastre d'oro piene di tocapus, l'enorme sarcofago di Dose Capaca con la testa appuntita per la deformazione frontoccipitale, il murale con le figure che aiutavano a comprendere l'invito ad andare alla ricerca degli yatiris, la lastra con la mappa che conduceva a Qhispita... Rimasi a lungo frastornato davanti al monitor, a osservare ripetutamente le immagini. Per fortuna in casa non c'era nessuno oltre a me, quindi ne trasferii alcune sugli schermi giganti e ne apprezzai la visione in formato quasi reale mentre la mia mente ritornava a quei fantastici momenti e alle cose che ci erano accadute li. Purtroppo i Toromonas avevano bruciato la macchina fotografica di Proxi e non avevamo nessun altro ricordo della nostra permanenza nella foresta e a Qalamana se non la registrazione di Gertrude con le parole dei Capacas che ora era nelle mie mani. Per un momento ebbi la tentazione di ascoltarla, di verificare che effetto avrebbe prodotto il potere delle parole in quella stanza della mia casa. Ma non lo feci. Se alla fine i miei progetti fossero andati a buon fine, perché non dare a Gertrude la soddisfazione di lavorare assieme su quel tema mentre Marta ed Efraín si spellavano le mani a Tiwanacu? Prima di tutto, comunque, dovevo chiamare la professoressa. «Hai un computer in casa con la connessione a Internet?» le chiesi a bruciapelo appena alzò il ricevitore. «Naturalmente.» «Allora dammi il tuo indirizzo di posta elettronica. Ti mando qualcosa che ti piacerà.» «Sai che a volte sei più strano di quel disgraziato di Luk'ana che ci ha guidato a Qalamana?» «Sì, è vero», ammisi subito, senza prestarle molta attenzione; l'indifferenza faceva parte del piano. «Che cosa fai stasera?» Rimase in silenzio. «Ah, aspetta, lo avevo dimenticato!» le dissi ridendo. «Prima salutare, poi chiedere. Ciao! Che cosa fai stasera?» Sapevo che stava sorridendo. «Pensavo di finire di svuotare la valigia e di fare un po' di ordine. Mi sono svegliata tardissimo e ti ricordo che ieri non ho avuto tempo di fare niente.» «Pensavo che potresti venire a vedere la mia casa. Mi hanno lasciato completamente solo. Che ne dici?» «Vuoi tenermi nascosta?» chiese con evidente doppia intenzione. Ma io disponevo ormai di alcune chiavi per accedere al suo modo di reagire e, naturalmente, come lei sapeva molto bene, erano altre le cose che avevo in mente. «In realtà, stavo pensando...» «Non continuare», mi interruppe. «Mandami quello che volevi che vedessi e poi ne riparliamo. Dammi un attimo di respiro.» Annotai con attenzione il suo indirizzo di posta elettronica e riattaccammo. Mentre portavo a termine l'invio delle fotografie, chiamò mia nonna. «Arnauet? Senti, sono a casa di Daniel.» «Dimmi.» «Dovresti venire e stare con tuo fratello per un po'. Ti va bene?» Se mi andava bene? Mi andava malissimo. Era orribile, la peggior cosa che potesse capitarmi. Avevo cose molto più importanti da fare quel pomeriggio, e non ci volevo rinunciare per niente al mondo. Ma, mentre ero sul punto di lasciarmi sfuggire una bordata di sbuffate e di parole sgradevoli, mi resi conto che mia nonna aveva gente attorno e quindi non parlava con chiarezza. Aveva sicuramente intenzione di lasciarmi solo con mio fratello. «Vuoi dirmi che hai trovato il modo di portarli tutti fuori?» «Sì, mi dispiace. Dovresti fermarti con lui almeno due o tre ore. Sì, lo so... sarai stanco per il viaggio, ma...» Si sentiva in sottofondo la voce di mia madre che diceva che, se ero stanco, era perché ero uscito non appena arrivato. «In conclusione, Arnauet, dato che sei ritornato, abbiamo pensato di approfittare un po' di te. Noi siamo esauriti. Lo capisci, vero? Se rimani con Daniel, Clifford, tua madre, Ona, Dani e io possiamo andare a fare due passi, a comprare dei vestiti per il bambino e a prendere qualcosa. Ne abbiamo bisogno, Arnauet.» «Sei unica, nonna.» «Su, non protestare!» mi sgridò, e mia madre, con un tono che non lasciava adito a dubbi, gridò che dovevo stare con mio fratello, che protestassi o no. «Di' a tua figlia che ho sentito.» «Lo sa già», rispose la nonna molto divertita. «Lo ha detto vicino al telefono perché lo sapessi. Va bene, basta così. Quanto impiegherai ad arrivare?» «Un'ora. Devo andare a prendere Marta.» «Allora, visto che vieni solo», puntualizzò mia nonna perché mi fosse chiaro che sarebbe stato meglio far aspettare Marta in macchina fino a quando loro non fossero usciti, «ricordati di prendere quel pupazzo così brutto che hai portato a Dani e che ci hai fatto vedere ieri sera.» «È un dio.» «Fa lo stesso. È comunque di cattivo gusto. Su, non tardare.» Conclusione, i miei magnifici piani per quel pomeriggio erano appena sfumati. Bisognava aspettare e, francamente, questo non mi piaceva. Qualcosa mi diceva che Marta sarebbe venuta a casa mia. Be', avrei potuto verificarlo. Avevamo ancora tutta la sera davanti. La chiamai. «Ciao! Hai visto le foto?» le chiesi quando alzò la cornetta. «Le sto guardando.» Si indovinava dalla sua voce che stava sorridendo. «Sembra incredibile, no?» «È vero. Io ho provato la stessa cosa.» «È un materiale fantastico. Lola ha fatto un bel lavoro. È strano rivedere tutte queste cose da qui, da casa!» «A proposito di case...» «Ci ho pensato», annunciò prontamente. «Preferisco rimandare la visita a quando Daniel sarà guarito. Facciamo le cose per bene.» «D'accordo», accettai tranquillo. Rimase in silenzio, sorpresa. «'D'accordo'? Pensavo che avresti insistito.» «No, assolutamente. Se tu preferisci rimandare a dopo la guarigione di Daniel, mi va bene. Comunque», dissi molto seriamente, «mi ha appena chiamato mia nonna. Devo stare con Daniel un paio d'ore perché la famiglia al completo va a fare spese.» Ci mise alcuni secondi a reagire, poi scoppiò a ridere. «Va bene! Hai vinto tu!» esclamò senza smettere di ridere. «Andiamo a casa di tuo fratello, poi vedremo.» Mentre andavo a prenderla in auto, mi rimproverai di avere tanta stupida fiducia nella benedetta frase dei Capacas. Se non avesse funzionato, se quel sortilegio, maleficio, incantesimo non avesse funzionato, Daniel avrebbe continuato a essere un vegetale a lungo o, nel peggiore dei casi, per il resto della sua vita. Lo dissi a Marta quando salì in macchina e, per il resto del tragitto fino alla calle Xiprer, discutemmo nervosamente sulle alternative: tradurre alla maggiore velocità possibile le lastre d'oro della Camera del Viaggiatore, cercare di ritrovare Qalamana sorvolando l'immensa zona in cui probabilmente si trovava, far sentire a Daniel il nastro registrato da Gertrude... Eravamo nervosi per molte faccende, ma stavamo per affrontare la peggiore di queste. «Ricordi la frase, vero?» le chiesi per l'ennesima volta mentre uscivamo dall'auto parcheggiata, come sempre, sul marciapiedi all'angolo della via. «Sei pesante, Arnau. Ti ho già detto che la ricordo perfettamente.» «Ehi!» la chiamai mentre si allontanava verso la caffetteria in cui le avevo chiesto di aspettare la mia chiamata. Lei si voltò e nei suoi occhi vidi qualcosa che mi piacque. «Sai che non ho il tuo numero di cellulare?» Si avvicinò con un sorriso e me lo ripeté un paio di volte mentre io cercavo di memorizzarlo con attenzione nel mio telefono. Poi si allontanò lentamente. Mi fermai a osservarla finché non svoltò l'angolo e sparì. Mi costò molto dirigermi verso il portone della casa di Daniel. Mi aprì mia madre da sopra e, mentre attraversavo l'atrio e salivo i tre o quattro gradini che portavano all'ascensore, vidi di schiena uno di quei tipi con i capelli rossi che assomigliavano tanto a Jabba. Un giorno, mi dissi, verrò in questa casa e se ne saranno tornati tutti sul loro pianeta; non incontrerò più nessuno di loro. Risi a bocca chiusa e il tipo mi guardò con la coda dell'occhio, pensando, suppongo, che fossi pazzo. Ona mi ricevette sulla porta e mi abbracciò stretto. Aveva un aspetto migliore di quando ero partito per la Bolivia. Aveva recuperato il sorriso e appariva di nuovo forte e allegra. «Su, entra, sciamano della foresta!» scherzò. «Ti hanno detto che sei peggio di tuo fratello? Andartene in Amazzonia da un giorno all'altro e ritornare due mesi dopo con una pozione miracolosa!» «Gli sta facendo molto bene», sentenziò mia madre, arrivando dal corridoio con il nipotino in braccio. «Direi persino che mi sembra più vivo, non so... Vero, Clifford? Clifford e io lo stavamo dicendo stamattina dopo avergli fatto bere la prima infusione con le gocce... vero, Clifford? Ho notato subito qualcosa di strano in Daniel, qualcosa di diverso.» Ona mi rivolse uno sguardo d'intesa perché non credessi neanche una mezza parola di quello che diceva mia madre (come se fosse stato possibile!), mentre io prendevo Dani e lo sollevavo fino al soffitto. Faceva un caldo infernale in quella casa. Anche così il mio nipotino indossava, come sempre, la sciarpetta strettamente annodata. «Guarda che cosa ti ho portato!» gli dissi mostrandogli l'Ekeko. «Davvero, Arnie, non capisco come tu abbia potuto comprare una cosa simile al bambino. Con tutte le cose belle che ci saranno state nella foresta! Questo pupazzo è orribile!» In quel momento, mio nipote lo lanciò in aria con grande gioia e sgambettò perché io lo poggiassi a terra e lui potesse distruggere comodamente il pupazzo. «Vedi. Che cosa ti dicevo?» continuò mia madre. «Gli durerà dieci minuti! Hai la testa tra le nuvole, figlio mio. Avresti dovuto portargli qualcosa che potesse conservare finché non diventa grande, come ricordo del viaggio di suo zio. Ma invece, no, chiaro! Gli porti un pupazzo orrendo che il bambino romperà prima che ce ne andiamo.» Mio nipote giocava a calcio con l'Ekeko nel corridoio. A volte la gamba andava verso un lato o verso l'altro, e allora non riusciva a far andare il dio verso il salotto come era sua intenzione, ma con il tentativo seguente il successore del Dio dei Bastoni, di Thunupa, percorreva un metro in più pulendo il pavimento. Il bambino era felice. Il regalo era azzeccato. «Su, andatevene», disse una voce flebile e tremante dal divano in fondo. «O chiuderanno i negozi.» Era mia nonna. Perché aveva quella voce così strana? «Tu non vai con loro?» le chiesi con lo sguardo interrogativo, mentre salutavo Clifford, che, come Ona, era migliorato abbastanza dall'ultima volta che lo avevo visto. Il tempo fa sì che ci abituiamo a tutto, persino alle esperienze più dolorose. «Tua nonna ha appena avuto le vertigini», annunciò mia madre, «e non abbiamo fatto in tempo a chiamarti. Ma non vuole rovinarci la serata e ha insistito perché uscissimo senza di lei. Potrai badare a lei, Arnie? Ti lasciamo con tuo fratello e tua nonna, quindi hai doppio lavoro. Se peggio- rasse...» disse, prendendo la borsa e porgendo a Clifford la sacca di Dani con i pannolini, i biberon, il cambio di biancheria e tutta quell'incredibile quantità di cose di cui hanno bisogno i bambini per andare in un posto qualsiasi. «Mi stai ascoltando, Arnau?» «Certo che ti ascolto, mamma», mormorai distrattamente, lanciando a mia nonna, di nascosto, uno di quegli sguardi da far paura. «Ti stavo dicendo che se la nonna peggiora devi chiamarmi immediatamente al cellulare. Starai bene, mamma?» le chiese, chinandosi verso di lei per darle un bacio di saluto. Mia nonna, facendo una faccia di circostanza, si lasciò baciare e sospirò con tristezza. «Non vi preoccupate per me. Divertitevi.» Uscirono tutti di nuovo in corridoio in direzione della porta e mia madre si voltò per sussurrarmi: «Non ti impressionare quando entri nella stanza di tuo fratello. Il letto debilita, lo sai. È molto deperito e smunto, ma è normale in questa situazione. Non ti preoccupare. E non perdere di vista la nonna. Doveva succedere, prima o poi! Vero, Clifford?» Clifford assentì senza una parola. «Poverina, aveva tanta voglia di fare una passeggiata assieme a tutti noi! E all'ultimo momento si è sentita male. Ma, che le piaccia o no, è ormai molto anziana, e queste cose succedono alla gente della sua età. Attenzione a lei, Arnau! Speriamo che non le capiti qualcosa... Abbi cura di tutti e due, eh? Poi, al nostro ritorno...» «Eulàlia», la chiamò Ona dal pianerottolo, con la porta dell'ascensore aperta. «Bene, noi andiamo, ma quello che ti stavo dicendo...» Io spingevo la porta dell'appartamento per obbligarla ad andarsene. «Quello che ti stavo dicendo è che stasera ceneremo tutti qui. Tutta la famiglia riunita. D'accordo?» Neanche morto! pensai. Ho cose molto più interessanti da fare, stasera! «Eulàlia», insisté Ona. «Stanno chiamando l'ascensore da un altro piano.» «Vengo, vengo. Bene, ricordati di tutto quello che ti ho detto, Arnie.» «Sì, mamma.» E chiusi la porta di colpo voltandomi verso la più grande bugiarda del mondo, pronto a dirgliene quattro. Ma lei si era già alzata dal divano, fresca come una rosa, e mi aspettava in piedi sorridendo. Potevo notare il suo ottimo aspetto grazie alla luce del pomeriggio che entrava dal balcone. «Sai che sei un'imbrogliona e che dovrai confessarti molte volte per quello che hai fatto questo pomeriggio?» le gridai avanzando verso di lei a passi da gigante. «Zitto! Possono sentirti», mi disse con la faccia preoccupata, portandosi un dito alle labbra. «Vieni qui. Pensavi che me lo perdessi? Assolutamente no! E poi me lo devi. Ti ho coperto per due mesi. Dov'è Marta?» «Nella caffetteria girato l'angolo, quello dove parcheggio sempre l'auto.» «Spero che non la vedano!» «La conosce soltanto Ona e non penso che la noti», risposi sedendomi e fissando le piante che mia cognata teneva sul terrazzo. Nello spazio più piccolo che si possa immaginare si ammucchiavano decine di vasi con ogni tipo di fiori. «Dovresti sentire che cosa dice Ona di lei! Se viene a sapere che è venuta a casa sua, ammazza me e te!» «Devo dirti una cosa, nonna», spiegai con tutta la sofferenza possibile prendendola per mano e obbligandola a sedersi accanto a me. Sapevo che ciò che le avrei detto su Daniel le avrebbe dato un grande dolore, ma non c'era soluzione; lei era la più lucida della famiglia e, se riuscivamo a guarire Daniel, avrei avuto bisogno del suo aiuto per affrontare quello che necessariamente sarebbe successo in seguito. Inoltre, le sciocchezze che la mia famiglia diceva di Marta dovevano terminare. Incominciai mettendola al corrente delle ricerche sui quipus e i tocapus, senza entrare in dettagli per non confonderla. Nella maniera più dolce e breve possibile le parlai del furto del materiale dallo studio della professoressa e di quello che era successo con la maledizione. E, mentre le spiegavo che cosa eravamo andati a cercare veramente nella foresta e quello che vi avevamo trovato, telefonai a Marta per dirle di salire. Mia nonna si abbatté quando seppe la verità. Era la donna più forte che conoscevo (be', anche Marta lo era, ma avevo visto la nonna affrontare nella vita problemi molto seri e risolverli con assoluta fermezza), tuttavia, quando seppe che suo nipote Daniel aveva rubato documenti importanti dallo studio del suo capo, crollò e cominciò a piangere. Mai, fino a quel momento, l'avevo vista spargere una sola lacrima, quindi rimasi di gelo, a pezzi. Fortunatamente reagii abbracciandola con forza. Le dissi che tra me e lei avremmo fatto il possibile e l'impossibile per aiutare Daniel. In quel momento squillò il campanello, la lasciai un attimo e andai al citofono per aprire il portone. Poi, mentre Marta saliva, corsi di nuovo accanto a lei, ma, sorpreso, notai che si era riavuta e aveva gli occhi completamente asciutti. «E questa donna, la professoressa», mi chiese diffidente, «viene per aiutare Daniel dopo quello che lui le ha fatto?» «Nonna!» la rimproverai, andando di nuovo di corsa verso la porta; suonavano di nuovo il campanello. «Marta è una brava persona. Anche tu lo faresti... Chiunque lo farebbe.» «Suppongo di sì», la sentii dire mentre aprivo la porta. Davanti a me c'era la donna verso cui ciascun membro della mia famiglia provava qualcosa di diverso e di polemico. Compreso io. «Prego, entra», la invitai. Mia nonna stava venendo in corridoio per riceverla. «Nonna, questa è Marta Torrent, il capo di Daniel. Marta, questa è mia nonna Eulàlia.» «Grazie per essere venuta», le disse la nonna con un sorriso. «Piacere di conoscerla. Suppongo che Arnau le abbia già spiegato, più o meno, la stupidaggine che pensiamo di fare.» «Tentar non nuoce, vero? Ti ringrazio molto di essere qui. E, per favore, dammi del tu. Quando si hanno più di ottant'anni il lei si sopporta male.» Marta sorrise e tutti e tre avanzammo lentamente verso il fondo della casa. La porta della camera di mio fratello, che era socchiusa, si trovava esattamente tra l'entrata del salotto e un'estremità del divano, di fronte al piccolo tavolo rotondo da pranzo. «Volete prendere qualcosa prima di?...» propose mia nonna senza sapere come terminare. «Io non voglio niente», rifiutai nervoso. «Nemmeno io, grazie. Preferisco vedere Daniel, prima. Se...» Marta tentennò. «Se la cosa non riesce bene, allora sì che avrò bisogno di un caffè molto forte. E, naturalmente, di una sigaretta.» «Anch'io sono una fumatrice!» esclamò mia nonna con l'allegria di una sorella di confraternita che ne incontra un'altra. «Andiamo, Marta?» le dissi aprendo la porta e guardandola. Lei assentì. Le persiane erano alzate e le finestre aperte, anche se parzialmente nascoste dalle tende. La camera era un forno, a quell'ora del pomeriggio. Di fronte a noi c'era il piccolo guardaroba che Daniel e Ona avevano costruito in un angolo della stanza. Facendo un paio di passi a sinistra, si arrivava a quello che era rimasto della stanza, occupata quasi completamente dall'enorme letto al cui centro stava mio fratello. La sua vista mi sgomentò. Daniel sembrava un morto autentico. Era scoperto e portava una maglietta e dei pantaloncini corti da pigiama. Aveva perso almeno quindici o venti chili e, come aveva detto mia ma- dre, aveva un aspetto molto deperito. In quel momento aveva gli occhi aperti, ma non si voltò a guardarci quando entrammo. Rimase immobile, assente. Le braccia erano abbandonate sul lenzuolo. Mia nonna gli andò vicino e, dopo aver preso un contagocce dal comodino, gli mise un paio di gocce in ciascun occhio. «Sono lacrime artificiali», ci spiegò. «Non batte sufficientemente le palpebre.» «Lascia venire Marta al tuo posto», le chiesi. Mia nonna ci guardò con una tristezza infinita. Suppongo che le causasse ancora dolore ciò che le avevo raccontato circa il furto, ma da donna pragmatica qual era soffriva anche perché stava combattendo con se stessa per non farsi illusioni rispetto a ciò che poteva accadere. Sistemò i capelli a Daniel e accomodò anche il cuscino sul quale appoggiava il capo, poi, molto serena, venne verso di me, che osservavo la scena dai piedi del letto. Marta prese il suo posto al fianco di mio fratello e rimase in silenzio a osservarlo. Mi sarebbe piaciuto sapere che cosa stava pensando. In realtà loro due si conoscevano da molto tempo e avevano lavorato assieme per diversi anni. Lui la disprezzava e la criticava davanti a Ona, e Marta invece? Che cosa pensava di lui, oltre a riconoscere che era molto intelligente? Non me lo aveva mai detto. «Spero sinceramente che vada tutto bene», mormorò lei, sollevando il capo per guardarmi. «Ora come ora non trovo un senso a tutto questo, Arnau. Mi sembra terribilmente assurdo.» «Non preoccuparti», la incoraggiai. «Non gli farà male e non potrebbe stare peggio di quanto già sta, quindi continua.» «Su, figlia mia. Provaci.» Marta si chinò su Daniel e si passò una mano sulla fronte come per fugare gli ultimi dubbi. «Jupaxusutaw ak munta jinchu chhiqhacha jichhat uksarux waliptaña», disse molto lentamente, a voce alta, senza smettere di guardarlo. Mia nonna, discretamente, mi obbligò ad abbassare il capo e mi chiese all'orecchio che cosa volessero dire quelle strane parole. «È una formula», le spiegai. «L'importante non è quello che dice, ma i suoni che emette pronunciando la frase.» E Daniel mosse un braccio. Lo fece molto lentamente, verso l'alto, e poi lo lasciò cadere in grembo. Marta fece un passo indietro, impressionata, e mia nonna si mise le mani sulla bocca per soffocare un grido di gioia che le straripò, però, dagli occhi. Quasi senza interruzione Daniel girò la testa sul cuscino e fissò il suo sguardo su di noi. Batté un paio di volte le palpebre, corrugò le sopracciglia e si inumidì le labbra secche come se si svegliasse da un lungo sonno, poi tentò di dirci qualcosa, ma la voce non gli uscì dalla gola. Marta, che ancora non riusciva a credere a ciò che vedeva, si scostò per lasciare il posto a mia nonna, che si era avvicinata seguita dallo sguardo di Daniel, che aveva di nuovo girato la testa. Questa volta tentò anche di sollevarla, ma non ci riuscì. Mia nonna si sedette sul bordo del letto e gli accarezzò la fronte e i capelli. «Mi senti, Daniel?» gli chiese con tenerezza. Mio fratello si schiarì la voce, poi tossì. Provò di nuovo a sollevare la testa e ci riuscì in parte. «Che cosa succede, nonna?» fu la prima frase che pronunciò. La sua voce aveva un suono strano, come se fosse raffreddato e avesse la faringite. La nonna lo abbracciò forte, ma Daniel, facendo uno sforzo, la strinse e poi la allontanò. Lei sorrideva. Prima che potesse dirgli qualcosa, mio fratello si rivolse a Marta e a me. Tentò di muovere i muscoli del volto, ancora irrigiditi, dando origine a una smorfia irriconoscibile. «Ciao, Arnau», disse con voce stonata. «Ciao, Marta.» «Sei stato molto ammalato, figlio mio», gli spiegò la nonna, obbligandolo ad appoggiare di nuovo la testa. «Molto ammalato.» «Ammalato?...» si sorprese. «E Ona? E Dani?» Marta rimase ferma, mentre io facevo il giro del letto e mi sedevo di fronte a mia nonna. «Come ti senti?» gli domandai. Daniel, facendo dei gesti di dolore, come se avesse delle fitte per tutto il corpo, appoggiò le braccia e si alzò lentamente per portarsi alla mia altezza, adagiando la schiena sul capezzale. «Mi sento confuso», mormorò; la voce gli si schiariva a poco a poco, «perché un momento fa stavo lavorando nello studio e ora dite che sono stato molto malato. Non capisco.» «A che cosa stavi lavorando, Daniel?» gli chiesi. Lui aggrottò la fronte tentando di ricordare e, di colpo, si fece luce nel suo cervello. Il suo volto espresse timore e i suoi occhi saltarono oltre la mia spalla per posarsi sulla professoressa. «Che cosa ci fai qui, Marta?» le chiese, intimorito. Ma, prima che lei potesse rispondergli, attirai la sua attenzione posandogli una mano sul braccio. «Sei stato malato per tre mesi, Daniel, per colpa di una maledizione aymara», gli dissi molto serio, fissandolo. Lui trasalì. «Sai di che cosa sto parlando; non c'è bisogno di altre spiegazioni. Marta è venuta per guarirti. Ti ha svegliato lei. Abbiamo fatto molta fatica a trovare la cura di cui avevi bisogno. Tra pochi giorni ti racconterò tutto. Ora devi riposare e riprenderti. Ne riparleremo quando starai meglio. D'accordo?» Mio fratello assentì, ma l'espressione di timore non si cancellò dal suo volto. Gli battei una mano sul braccio in modo rassicurante e mi alzai. Andai verso Marta, che continuava a guardare Daniel ferma e silenziosa. «Noi ce ne andiamo», annunciai. «Tra poco saranno qui mamma, Ona, Dani e tuo padre. Sono usciti a fare due passi, ma, quando la nonna li chiamerà per dare la bella notizia della tua guarigione, ritorneranno immediatamente. Ah, un'altra cosa! Non dire niente alla famiglia della maledizione né degli aymaras. D'accordo?» Mio fratello abbassò lo sguardo. «D'accordo», mormorò. «Ciao, Daniel!» lo salutò Marta. «Ci vediamo.» «Quando vuoi», gli rispose lui. Non era opportuno che rimanessimo lì. La nostra presenza, ora che sapeva ciò che gli era capitato, non gli faceva per niente bene. Era inquieto e nervoso. Sarebbe arrivato il momento di parlare, non appena fosse stato meglio. Diedi un bacio a mia nonna, che ci salutò con uno sguardo di comprensione, presi Marta per mano e uscii con lei dalla stanza. «Ha funzionato», disse sorridendo e inarcando le sopracciglia per esprimere la sua perplessità. «Ha funzionato», ripetei del tutto soddisfatto. Sì, aveva funzionato, ma, a partire da quel momento, a mio fratello toccava un lungo rosario di analisi cliniche e, quel che era ancora peggio, la sollecita attenzione di nostra madre. Tutti si sarebbero stupiti della sua guarigione, così come si erano stupiti della sua repentina malattia. Ma noi sapevamo la verità, e quella verità passava per lo strano potere delle parole, per la straordinaria capacità dei suoni di programmare la mente. Avevamo molto lavoro da fare, ma era un lavoro appassionante: il cervello, il diluvio, gli yatiris, le antiche leggende sulla creazione del mondo e degli esseri umani... Tuttavia, a parte i nostri nuovi progetti, i grandi cambiamenti e le molte foreste che ci rimanevano da esplorare, la cosa più importante era aver capito che alcune moderne tecnologie e alcune recenti scoperte scientifiche erano collegate in modo inesplicabile alla vecchia magia del passato, ai miti delle antiche civiltà. Passato, presente e futuro misteriosamente intrecciati. «Sei stato poco affettuoso con Daniel», mi disse Marta mentre uscivamo. «Sono stato come potevo essere. Non avrei potuto agire in maniera diversa.» Era vero. Le cose non sarebbero più tornate a essere come prima, ed era un bene che fosse così, pensai guardando Marta e ricordando il giorno in cui mi ero presentato nello studio della facoltà e lei, tanto seria e cauta, era scoppiata a ridere notando la mia faccia inorridita alla vista della mummia rinsecchita e dei teschi appesi. Avrebbe avuto effetto la mia strategia di hacker? Sarebbe venuta con me o avrebbe insabbiato la cosa? «Bene, Marta», le dissi chiudendo la porta della casa. «Abbiamo guarito Daniel. Ora...» «Che cosa vuoi fare?» tagliò corto lei con un tono canzonatorio. Sorrisi. «Ti piacerebbe visitare il '100'?» NOTE 1 Piccole applicazioni di software che si installano nei sistemi senza che il proprietario ne sia a conoscenza e che monitorano tutte le attività del computer inviando tali informazioni a server generalmente commerciali. 2 Unità del sottosuolo (in catalano nel testo originale). [N.d.T.] 3 Light Emitting Diode (LED). Piccolo diodo che emette luce. 4 Vanitoso, in catalano. 5 Parte della Teoria del Caos. Le forme apparentemente caotiche della natura, come quelle degli alberi, delle nubi, delle montagne, delle coste eccetera, possono essere descritte e riprodotte mediante formule matematiche. 6 Significa, approssimativamente, ragnatela globale. 7 HyperText Transfer Protocol. 8 La lengua de Adán (La lingua di Adamo), 1870. 9 Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta, Editori Laterza, RomaBari 1993. 10 Historia del tribunal de la Inquisición de Lima, 1569-1820. Volume II, Appendice documentale dello storico peruviano Carlos A. Mackehenie (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante). 11 American Standard Code for Information. Il codice ASCII riunisce tutti i caratteri di testo e tutti i segni di punteggiatura in una tavola standard rappresentandoli come numeri. 12 Ogni regno musulmano sorto in Spagna dopo la caduta del califfato di Cordova, nel 1031. [N.d.T.] 13 R. Sagàrnaga, Tiwanacu Historia del asalto al cielo, Revista Escare, 18-10-02. Arqueología. Diario La Razón digital, Bolivia. 14 Secondo Blas Valera, citato da Garcilaso de la Vega (Libro I, cap. VI), «vassalli dell'Inca», cittadini del Tahauntinsuyo, il Regno delle Quattro Regioni. 15 Così gli incas chiamavano gli spagnoli, per il loro aspetto fisico simile a quello del dio Viracocha. 16 Moneta nazionale della Bolivia. 17 Cereale americano simile al grano saraceno [N.d.T.] 18 C. Ponce Sanjinés, Thunupa y Ekeko Estudio Arqueológico acerca de las efigies precolombinas de dorso adunco, Accademia Nacional de Ciencias de Bolivia, La Paz 1969. 19 Gregorio Iriarte, economista, citato in «Bolivia las consecuencias de la derida externa», Marie Dennis. NACLA, North American Congress on Latin America, vol. 31, n. 3, novembre/dicembre 1997 20 Avventuriero spagnolo del XVI secolo, famoso per la sua spedizione in cerca del leggendario El Dorado, lungo l'alveo del Rio delle Amazzoni, che terminò con un tentativo di creare un regno indipendente in piena foresta. 21 Marzo 2000, edizione in castigliano. 22 A biological Assessment of the Alto Madidi Region and adjacent areas of Northwest Bolivia, 1991. 23 Global Position System, o Sistema Globale di Posizionamento. I ricevitori GPS permettono di determinare la posizione in qualsiasi luogo del pianeta mediante i segnali di una rete di satelliti chiamata NAVSTAR, di proprietà degli USA. 24 Il termine «ladino» è recepito nell'accezione negativa e significa scaltro, imbroglione [N.d.T.] 25 Richard Stone, Mammot The Resurrection of an Ice Age Giant, Il mammut. La resurrezione del gigante dei ghiacci, Piemme, Milano 2002. 26 «El origen de los mamíferos», National Geographic, aprile 2003. La Vanguardia Digital, edizione del 4 giugno 2002, sezione «La Vanguardia de la Ciencia», articolo della Agenzia EFE, «Un yacimiento en Rumania aporta nuevas pruebas sobre la coexistencia de dinosaurios y mamíferos en Europa». 27 Hans-Joachim Zillmer, Darwins Irrtum, terrore di Darwin, Piemme, Milano 2000. FINE
Scarica