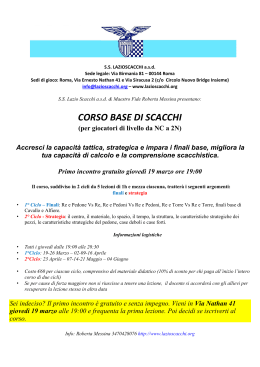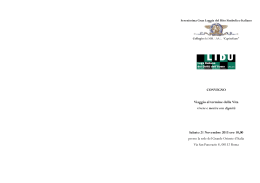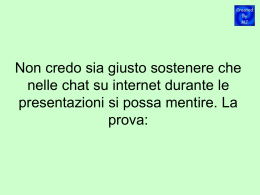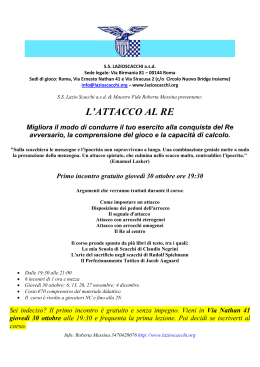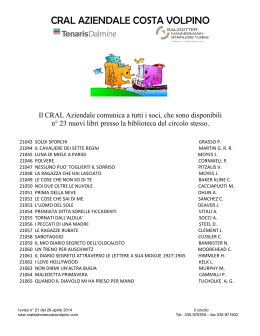Il libro Considerata l’importanza del loro ruolo, le controversie che spesso nascono intorno ai loro atti e le persone violente con le quali a volte hanno a che fare, è interessante notare come nella storia di questo paese siano stati assassinati solo quattro giudici federali. L’onorevole Raymond Fawcett è appena diventato il numero cinque. Chi è Malcolm Bannister? E cosa ha a che fare con la morte del giudice Fawcett? Quando un lunedì mattina il giudice non si presenta a un processo, i suoi collaboratori, preoccupati, chiamano l’FBI. Il corpo viene ritrovato nel seminterrato del suo cottage sul lago insieme a quello della giovane segretaria. La cassaforte aperta e svuotata. Nessuna impronta, nessun segno di scasso né di colluttazione, tranne piccole bruciature sul cadavere della donna. Solo Malcolm Bannister sa chi è stato e cosa è realmente successo. Apprezzato avvocato di colore, anzi, ex avvocato radiato dall’albo della Virginia perché coinvolto in una vicenda di riciclaggio di denaro, è attualmente detenuto nel Federal Prison Camp, nel Maryland, dove dispensa consigli legali ai compagni. Ha già scontato metà della sua condanna, ma vuole a tutti i costi uscire il prima possibile, e ora sa come fare: la sua libertà in cambio del nome del colpevole. Non avendo alcuna pista da seguire, l’FBI è interessato ad ascoltare le sue rivelazioni, anche perché Bannister sembra essere informato su molte altre cose, per esempio sul contenuto della cassaforte. Ma tutto ha un prezzo, soprattutto notizie così scottanti come quelle relative agli eventi che hanno portato alla morte del giudice Fawcett. Bannister è deciso a giocare le sue carte fino in fondo, e non è certo nato ieri. Ma niente è come sembra: i ruoli si capovolgono, gli scenari si alternano, in una sfida in cui ogni mossa è studiata nel minimo dettaglio. Come è stato ben definito dal “New York Times”, L’ex avvocato è un romanzo trascinante, sorprendente e ingegnoso che appassiona il lettore fino all’ultimo colpo di scena confermando John Grisham grande scrittore e maestro indiscusso del legal thriller. L’autore John Grisham è autore di venticinque romanzi, un saggio, una raccolta di racconti e tre romanzi per ragazzi. Vive in Virginia e in Mississippi. NOTA DELL’AUTORE Questo romanzo è un’opera di fantasia, ancora più del solito. Quasi nulla nelle precedenti pagine si basa sulla realtà. Il lavoro di ricerca, non proprio una mia priorità, si è reso raramente necessario. La precisione e l’accuratezza non sono state ritenute cruciali. Si è fatto ampio ricorso all’immaginazione per evitare di verificare dati e fatti. Non esiste alcun campo federale a Frostburg, non c’è (ancora) un procedimento giudiziario riguardante l’uranio, non esiste un giudice defunto che mi abbia ispirato e non ho neppure alcun conoscente in carcere che sta tramando per uscire, almeno che io sappia. Inevitabilmente, però, perfino il più pigro degli scrittori ha bisogno di qualche appoggio per le sue creazioni, e ogni tanto mi sono trovato in difficoltà. Come sempre, ho fatto affidamento su altri. Grazie a Rick Middleton e Cal Jaffe del Southern Environmental Law Center. A Montego Bay sono stato aiutato dall’onorevole George C. Thomas e dal suo staff di ottimi e giovani avvocati. Grazie anche a David Zanca, John Zunka, Ben Aiken, Hayward Evans, Gaines Talbott, Gail Robinson, Ty Grisham e Jack Gernert. L’ex avvocato di John Grisham Copyright © 2012 by Belfry Holdings, Inc. © 2013 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano Titolo dell’opera originale The Racketeer Ebook ISBN 9788852032707 COPERTINA || ART DIRECTOR: GIACOMO CALLO | PROGETTO GRAFICO: ANDREA FALSETTI | FOTO © PETER GLASS/ARCANGEL IMAGES «L’AUTORE» || FOTO © BOB KRASNER John Grisham L’EX AVVOCATO Traduzione di Nicoletta Lamberti Racket s.m. Organizzazione della malavita diretta all’estorsione intimidatoria e violenta di denaro o di altri vantaggi... 1 Sono un avvocato, e sono in prigione. È una lunga storia. Ho quarantatré anni e ho già scontato metà dei dieci che mi sono stati comminati da un incapace e ipocrita giudice federale di Washington, DC. Tutti gli appelli hanno fatto il loro corso e nel mio arsenale legale, ormai esaurito, non restano altri strumenti, procedure, oscuri cavilli, tecnicismi, scappatoie o Ave Maria da utilizzare. Non ho più niente. Dato che conosco la legge, potrei fare quello che fanno alcuni detenuti, e cioè intasare i tribunali con valanghe di mozioni, istanze e altre inutili carte, senza che tutto questo giovi alla mia causa. Niente gioverà alla mia causa. La realtà è che non ho speranze di uscire da qui per altri cinque anni, meno forse qualche pidocchiosa settimana che alla fine potrebbe essermi condonata per buona condotta. E la mia condotta è sempre stata esemplare. Non dovrei definirmi un avvocato perché tecnicamente non lo sono più. L’ordine degli avvocati della Virginia mi è piombato addosso e mi ha tolto la licenza poco dopo la sentenza. La regola è chiara, scritta nero su bianco: una condanna penale equivale alla radiazione dall’albo. Mi hanno tolto la licenza e le mie traversie disciplinari sono state debitamente riportate sul “Virginia Lawyer Register”. Siamo stati radiati in tre quel mese, più o meno la media standard. Comunque, nel mio piccolo mondo sono noto come avvocato da galera e, in quanto tale, passo parecchie ore al giorno cercando di aiutare i miei compagni a risolvere i loro problemi legali. Studio appelli e inoltro istanze. Redigo semplici testamenti e, ogni tanto, un atto di compravendita immobiliare. Rivedo contratti per qualche colletto bianco. Ho citato in giudizio il governo in occasione di ricorsi motivati, però mai per motivi che considero infondati. E poi tratto un mucchio di divorzi. Otto mesi e sei giorni dopo l’inizio della mia reclusione, ho ricevuto una busta voluminosa. I detenuti aspettano con ansia la posta, ma quello era un plico del quale avrei volentieri fatto a meno. Proveniva da uno studio legale di Fairfax, Virginia, che rappresentava mia moglie, la quale – sorpresa – voleva il divorzio. Nel giro di poche settimane, da sposa solidale e pronta ad aspettarmi, Dionne si era trasformata in vittima che voleva disperatamente chiamarsi fuori. Non potevo crederci. Ho letto i documenti in uno stato di shock assoluto, con le ginocchia molli e gli occhi colmi di lacrime, e nell’attimo stesso in cui ho temuto di cominciare a piangere sono rientrato in fretta nella mia cella. Si piange molto in prigione, ma sono sempre lacrime nascoste. Quando ho lasciato la mia casa, Bo aveva sei anni. È il nostro unico figlio, ma mia moglie e io avevamo in programma di averne altri. Il conto è facile e io l’ho fatto migliaia di volte: quando uscirò, Bo avrà sedici anni, sarà un giovane adulto e io mi sarò perso dieci degli anni più preziosi che padre e figlio possano condividere. Fino ai dodici anni circa, i ragazzini adorano il padre e sono convinti che sia infallibile. Allenavo Bo a T-ball e a calcio, e lui mi seguiva ovunque come un cagnolino. Andavamo insieme a pesca e in campeggio, e ogni tanto il sabato mattina veniva in studio con me, dopo una colazione “solonoi-uomini”. Bo era tutto il mio mondo, e spiegargli che sarei rimasto lontano da casa per molto tempo ha spezzato il cuore a entrambi. Una volta dietro le sbarre, non ho mai permesso che venisse a trovarmi. Per quanto desideri abbracciarlo, non sopporto l’idea di un bambino che vede il proprio padre in galera. È virtualmente impossibile opporsi a un divorzio, se sei in prigione e non uscirai tanto presto. Tutti i nostri beni, che tanto per cominciare non sono mai stati un granché, si erano esauriti dopo un martellamento durato diciotto mesi da Teile del governo federale. Avevamo perso tutto, a Teile nostro figlio e il nostro impegno reciproco. Il figlio è stato una roccia, l’impegno è finito nella polvere. Dionne mi aveva fatto qualche bella promessa riguardante il tenere duro e superare insieme le avversità, ma una volta che sono finito dentro, la realtà ha avuto il sopravvento. Dionne si è sentita sola e isolata nella nostra piccola città. “La gente mi guarda e mormora” mi aveva scritto in una delle sue prime lettere. “Mi sento così sola” si lamentava in un’altra. Non è passato molto tempo prima che le lettere diventassero notevolmente più brevi e più distanziate nel tempo. Così come le sue visite. Dionne è cresciuta a Philadelphia e non si è mai adattata volentieri alla vita in campagna. E quando un suo zio le ha offerto un lavoro, ha avuto all’improvviso una gran fretta di tornarsene a casa. Si è risposata due anni fa e Bo, che adesso ha undici anni, viene allenato da un altro padre. Le ultime venti lettere che ho scritto a mio figlio sono rimaste senza risposta. Sono sicuro che Bo non le ha mai lette. Mi chiedo spesso se lo rivedrò. Penso che farò un tentativo, anche se sono molto dubbioso. Come affronti un ragazzino che ami così tanto da starci male, ma che non ti riconoscerà neppure? Non vivremo mai più il tipico rapporto padre/figlio. Sarebbe giusto nei confronti di Bo che suo padre, scomparso tanto tempo prima, ricomparisse di colpo e insistesse per rientrare nella sua vita? Ho fin troppo tempo per riflettere su tutto questo. Sono il detenuto numero 44861-127 del Federal Prison Camp nei pressi di Frostburg, Maryland. Un “campo” è un carcere di bassa sicurezza per quelli di noi che vengono ritenuti non troppo violenti e devono scontare una condanna non superiore ai dieci anni. Per ragioni che non mi sono mai state spiegate, ho trascorso i miei primi ventidue mesi in una struttura di media sicurezza vicino a Louisville, Kentucky. Nell’infinita serie di sigle della burocrazia, quel carcere è classificato come FCI – Federal Correctional Institution – ed è un posto molto diverso dal mio campo di Frostburg. Un FCI è riservato a soggetti violenti con condanne superiori ai dieci anni. La vita là è molto più dura, anche se io sono riuscito a sopravvivere senza subire aggressioni fisiche. Il fatto di essere un ex marine mi è stato di enorme aiuto. Nel contesto carcerario, un campo è considerato un luogo di villeggiatura. Non esistono muri di cinta, recinzioni, filo spinato o torrette di guardia. Ci sono solo alcuni agenti armati. Frostburg è relativamente nuovo e i suoi edifici sono più belli della maggior Teile dei licei statali. E perché no? Negli Stati Uniti spendiamo quarantamila dollari per mantenere ogni detenuto e ottomila per l’istruzione di ogni alunno delle elementari. Qui a Frostburg abbiamo consulenti, dirigenti, assistenti sociali, infermiere, segretarie, collaboratori di vario tipo e decine di impiegati amministrativi, e sarebbero tutti in seria difficoltà se dovessero spiegare come riescono a riempire otto ore al giorno. Ma, dopo tutto, questo è il governo federale. Il parcheggio riservato ai dipendenti vicino all’ingresso principale è pieno di belle auto e costosi pickup. Siamo circa seicento detenuti qui a Frostburg e, con poche eccezioni, costituiamo un gruppo tranquillo. Quelli con un passato violento hanno imparato la lezione e apprezzano l’ambiente civilizzato. Coloro che hanno trascorso la vita in galera hanno finalmente trovato una casa. Molti di questi professionisti del carcere non hanno alcuna voglia di andarsene. Ormai completamente istituzionalizzati, non sono in grado di funzionare nel mondo esterno. Un letto caldo, tre pasti al giorno, cure mediche gratuite... come potrebbero avere altrettanto là fuori, sulla strada? Non sto dicendo che questo sia un posto gradevole. Non lo è. Ci sono uomini che, come me, non avrebbero mai immaginato di finire così, un giorno. Uomini con professioni, carriere, affari; uomini benestanti con una bella famiglia e la tessera del country club. Della mia Gang Bianca fanno Teile Carl, un optometrista che ha manipolato un po’ troppo le sue fatture a Medicare; Kermit, uno speculatore immobiliare che ha dato in garanzia due o anche tre volte le stesse proprietà a varie banche; Wesley, un ex senatore della Pennsylvania che ha accettato una bustarella, e Mark, un referente prestiti ipotecari di provincia che ha preso qualche scorciatoia di troppo. Carl, Kermit, Wesley e Mark. Bianchi, età media cinquantun anni. Tutti ammettono la loro colpevolezza. Poi ci sono io. Malcolm Bannister, nero, quarantatré anni, condannato per un reato che non sapevo di commettere. Si dà il caso che in questo momento io sia l’unico nero a Frostburg che sta scontando una pena per un reato da colletto bianco. Una bella distinzione. I requisiti per l’ammissione alla mia Gang Nera non sono definiti con altrettanta chiarezza. Per la maggior Teile si tratta di ragazzi provenienti dalle strade di Washington e di Baltimora, arrestati per reati connessi alla droga. Quando escono in libertà vigilata, le loro possibilità di evitare un’altra condanna sono pari al venti per cento. Privi di istruzione, senza alcuna qualifica professionale e con la fedina penale sporca, come si suppone che possano cavarsela? In realtà non ci sono gang in un campo federale, e non c’è nemmeno violenza. Se ti azzuffi con qualcuno, o lo minacci, ti sbattono fuori a calci e ti spediscono in un posto di gran lunga peggiore. Ci sono moltissimi litigi, soprattutto a causa della televisione, ma devo ancora veder volare un pugno. Alcuni dei miei compagni sono stati in carceri di Stato e le storie che raccontano sono orripilanti. Nessuno vuole scambiare questo posto con un’altra struttura. Perciò ci comportiamo tutti bene e contiamo i giorni. Per i colletti bianchi la punizione è costituita dall’umiliazione e dalla perdita di status, posizione e stile di vita. Per i neri la vita nel campo è più sicura di quella da cui vengono e alla quale torneranno. La loro punizione è costituita da un’altra tacca nella loro fedina penale, da un altro passo nella trasformazione in criminale di carriera. A causa di tutto questo, mi sento più bianco che nero. Ci sono altri due ex avvocati qui a Frostburg. Ron Napoli è stato per molti anni un esuberante penalista di Philadelphia, poi però la cocaina l’ha rovinato. Era specializzato nella normativa relativa agli stupefacenti e ha rappresentato parecchi dei massimi spacciatori e trafficanti degli Stati del medio Atlantico, dal New Jersey alle Caroline. Gli piaceva farsi pagare sia in contanti che in coca, e alla fine ha perso tutto. Il fisco l’ha inchiodato per evasione e Napoli adesso è circa a metà della sua condanna a nove anni. In questi giorni non se la passa molto bene. Sembra depresso e non vuole, per nessun motivo, fare esercizio fisico e cercare di prendersi cura di sé. Sta diventando sempre più grasso, più indolente, più irritabile e più malato. Era solito raccontare storie affascinanti sui suoi clienti e sulle loro avventure nel narcotraffico, ma adesso si limita a starsene seduto in cortile, mangiando un sacchetto di Fritos dopo l’altro con espressione smarrita. C’è qualcuno che gli manda dei soldi, e lui li spende soprattutto in cibo spazzatura. Il terzo ex avvocato è uno squalo di Washington che si chiama Amos Kapp, insider di lungo corso ed equivoco intrallazzatore che si è costruito una solida carriera operando ai margini di ogni grosso scandalo politico. Kapp e io siamo stati processati insieme, giudicati colpevoli insieme e condannati a dieci anni dallo stesso giudice. Eravamo otto imputati: sette di Washington più io. Kapp è sempre stato colpevole di qualcosa, ed era sicuramente colpevole agli occhi della giuria. Lui però sapeva allora, e sa anche adesso, che io non ho mai avuto niente a che fare con la cospirazione, ma era troppo codardo e troppo delinquente per dichiarare qualcosa in merito. A Frostburg la violenza è rigorosamente bandita, ma datemi cinque minuti da solo con Amos Kapp e quell’uomo si ritroverà con il collo spezzato. Lui ne è consapevole, e sospetto che l’abbia detto al direttore del carcere molto tempo fa. Lo tengono nel campus ovest, quanto più lontano possibile dal mio territorio. Dei tre avvocati, io sono l’unico disposto ad aiutare gli altri detenuti per quanto riguarda i loro problemi legali. È un lavoro che mi piace. Rappresenta una sfida e mi tiene occupato. Serve anche a mantenere in allenamento le mie capacità, anche se dubito di avere un grande futuro come avvocato. Quando uscirò potrò presentare domanda per essere riammesso all’ordine, ma è una procedura lunga e difficile. La verità è che non ho mai fatto molti soldi. Ero un legale di provincia, oltretutto nero, ed erano pochi i clienti che potevano pagarmi una parcella decente. C’erano decine di altri avvocati ammassati lungo Braddock Street, e tutti lottavano per accaparrarsi gli stessi clienti; la concorrenza era dura. Non so bene cosa farò quando questa storia avrà fine, ma dubito seriamente di dedicarmi di nuovo alla carriera legale. A quell’epoca sarò un quarantottenne single e, spero, in buona salute. Cinque anni sono un’eternità. Ogni giorno faccio una lunga passeggiata, da solo, sulla pista da jogging in terra battuta che sfiora i bordi del campo e ne segue il confine, o “linea”, come viene comunemente chiamata. Supera la linea e sei considerato un evaso. Nonostante ospiti una prigione, questa campagna è molto bella e offre panorami spettacolari. Ogni volta che cammino e guardo le colline in lontananza, devo lottare contro l’impulso di proseguire, di andare oltre quella linea. Non c’è una recinzione che possa bloccarmi, nessuna guardia che possa strillare il mio nome. Potrei svanire nella fitta boscaglia e scomparire per sempre. Vorrei che ci fosse una barriera, un muro di solidi mattoni alto tre metri sormontato da spirali di luccicante e tagliente filo spinato, un muro che mi impedisca di guardare le colline e di sognare la libertà. Questa è una prigione, maledizione! Non è permesso andarsene. Tirate su un muro e smettetela di solleticarci. La tentazione è sempre presente e, per quanto io la combatta, giuro che giorno dopo giorno diventa sempre più forte. 2 Frostburg si trova qualche chilometro a ovest di Cumberland, Maryland, al centro di una fetta di territorio schiacciata dalla Pennsylvania a nord e dal West Virginia a ovest e a sud. Se si osserva una carta geografica, salta subito all’occhio che questa esiliata Teile dello Stato è la risultanza di un pessimo rilievo topografico e non dovrebbe affatto apTeilenere al Maryland, anche se non è chiaro a chi dovrebbe spettare. Io lavoro in biblioteca e sulla parete sopra la mia piccola scrivania c’è una grande carta dell’America. Passo fin troppo tempo a studiarla, sognando a occhi aperti e chiedendomi come ho fatto a diventare un detenuto federale in una zona remota dell’estremo ovest del Maryland. Circa novanta chilometri a sud di Frostburg c’è Winchester, Virginia, cittadina di venticinquemila abitanti e mio luogo di nascita, infanzia, scuole, carriera e, alla fine, Caduta. Mi dicono che è cambiato ben poco da quando me ne sono andato. Lo studio legale Copeland & Reed continua la sua attività negli stessi locali con vetrina sulla strada dove un tempo ho lavorato anch’io. Si trova in Braddock Street, nella città vecchia, di fianco a una tavola calda. Il nome, dipinto a caratteri neri sulla vetrata, una volta era Copeland, Reed & Bannister, ed era l’unico studio legale totalmente nero nel raggio di centocinquanta chilometri. Pare che Mr Copeland e Mr Reed se la stiano cavando bene, di certo non prosperano né stanno diventando ricchi, ma hanno abbastanza lavoro per poter pagare le due segretarie e l’affitto. È più o meno quello che facevamo quando ero socio anch’io: riuscivamo a tirare avanti. All’epoca della Caduta avevo già seri ripensamenti sulle mie possibilità di sopravvivenza in una cittadina così piccola. Ho saputo anche che Mr Copeland e Mr Reed si rifiutano di parlare di me e dei miei guai. Hanno evitato per un soffio di essere incriminati anche loro e di vedere la loro reputazione macchiata. Il procuratore federale che mi ha inchiodato sparava cannonate contro chiunque fosse anche solo lontanamente collegato alla sua grandiosa cospirazione e ha quasi spazzato via l’intero studio legale. Il mio crimine è stato accettare il cliente sbagliato. I miei due ex soci non hanno mai commesso alcun reato. Ciò che è successo mi dispiace per molti motivi, ma la macchia sul loro buon nome continua a tenermi sveglio la notte. Sono entrambi prossimi ai settant’anni e all’inizio della professione hanno dovuto vedersela non solo con la sfida di tenere a galla uno studio legale generico in una piccola città, ma hanno anche dovuto combattere alcune delle ultime battaglie ai tempi delle leggi Jim Crow. In aula a volte i giudici li ignoravano e deliberavano contro di loro senza alcun valido motivo legale. I colleghi erano spesso scortesi e poco professionali. L’associazione degli avvocati della contea non sollecitava la loro iscrizione. Ogni tanto gli impiegati del tribunale smarrivano le loro pratiche. Le giurie bianche non credevano a quello che dicevano. E, ancora peggio, nessuno li assumeva. Parlo di clienti neri. Nessun bianco si sarebbe mai rivolto a un legale di colore negli anni Settanta, non nel Sud almeno, e le cose da allora non sono cambiate molto. Ma lo studio Copeland & Reed ha rischiato di soccombere ancora in fasce perché gli stessi neri pensavano che gli avvocati bianchi fossero migliori. In seguito il duro lavoro, la dedizione e la professionalità hanno incrinato questo convincimento, ma con grande lentezza. Winchester non è stata la mia prima scelta come luogo in cui costruirmi una carriera. Ho frequentato la scuola di legge alla George Mason, a Manassas. L’estate dopo il mio secondo anno, ebbi la fortuna di venire assunto come stagista presso un gigantesco studio in Pennsylvania Avenue, vicino a Capitol Hill. Era uno di quegli studi con migliaia di avvocati, uffici in tutto il mondo, nomi di ex senatori sulla carta intestata, società miliardarie come clienti e un ritmo frenetico che a me piaceva moltissimo. Il mio momento più alto fu svolgere le funzioni di fattorino durante il procedimento contro un ex membro del Congresso (il nostro cliente) accusato con il fratello di associazione a delinquere per avere accettato bustarelle da un fornitore della Difesa. Il processo era un vero e proprio circo, e io ero eccitato per il solo fatto di trovarmi così vicino alla pista centrale. Undici anni dopo sono entrato in quella stessa aula di tribunale intitolata a E. Barrett Prettyman, nel centro di Washington, e ho subito un processo tutto mio. Ero uno dei diciassette impiegati di quell’estate. Gli altri sedici, tutti provenienti dalle dieci migliori scuole di legge del paese, ricevettero un’offerta di lavoro. Dato che avevo messo tutte le mie uova in un unico paniere, passai il mio terzo anno di università scarpinando in giro per Washington e bussando a tutte le porte, senza mai trovarne una che si aprisse. In qualsiasi momento devono esserci parecchie migliaia di avvocati disoccupati che battono i marciapiedi della capitale, ed è facile lasciarsi prendere dalla disperazione. Dopo un po’ passai alla periferia, dove gli studi sono molto più piccoli e le possibilità di lavoro ancora più scarse. Alla fine tornai a casa, sconfitto. I miei sogni di gloria erano andati in pezzi. Mr Copeland e Mr Reed non avevano abbastanza lavoro e di certo non potevano permettersi un nuovo associato, ma ebbero pietà di me e mi sgombrarono un vecchio ripostiglio al piano di sopra. Lavorai il più possibile, anche se spesso era difficile dedicare ore extra al lavoro, visto che i clienti erano così pochi. Andavamo d’accordo, e dopo cinque anni Mr Copeland e Mr Reed aggiunsero generosamente il mio nome al loro in qualità di socio. Il mio reddito aumentò in misura impercettibile. Nel corso del processo a mio carico è stato doloroso veder trascinare nel fango il loro buon nome. Ed era tutto così insensato. Quando ero ormai alle corde, il capo degli agenti dell’FBI mi aveva detto che anche i miei soci sarebbero stati rinviati a giudizio, se non mi fossi dichiarato colpevole e non avessi collaborato con il procuratore federale. Ho pensato che fosse un bluff, ma non avevo modo di saperlo con certezza. Gli ho risposto di andarsene all’inferno. Fortunatamente, era un bluff. Ho scritto lunghe, lacrimose lettere di scuse a Mr Copeland e a Mr Reed, ma loro non mi hanno mai risposto. Li ho pregati di venirmi a trovare in modo da poter parlare faccia a faccia, ma non c’è stata reazione. Nonostante la mia città natale disti appena una novantina di chilometri, ho un solo visitatore abituale. Mio padre è stato uno dei primi poliziotti neri assunti dal Commonwealth of Virginia. Henry Bannister ha pattugliato le strade e le autostrade di Winchester e dintorni per trent’anni, e ne ha amato ogni minuto. Amava il senso di autorità e di solennità del suo lavoro, il potere di far rispettare la legge e la possibilità di aiutare chi si trovava in difficoltà. Amava l’uniforme, l’auto di pattuglia, tutto tranne la pistola che portava appesa al cinturone. Due o tre volte si è trovato obbligato a estrarla, ma non ha mai sparato un colpo. Si aspettava che i bianchi provassero risentimento nei suoi confronti e che i neri da lui esigessero indulgenza, ma era deciso a dare prova di assoluta equità. Era un poliziotto tosto che non vedeva zone grigie nella legge: se una certa azione non era legale, allora era sicuramente illegale, senza spazio per le discussioni né pazienza per i tecnicismi. Nel momento stesso in cui sono stato accusato formalmente, mio padre mi ha creduto colpevole, di qualcosa. Niente presunzione di innocenza. Inutili i miei sfoghi sul fatto di essere estraneo a qualsiasi responsabilità. Da orgoglioso poliziotto di carriera, mio padre era completamente condizionato dal lavaggio del cervello di una vita passata a dare la caccia a chi aveva infranto la legge, e se i federali, con tutte le loro risorse e la loro grande saggezza, mi avevano ritenuto degno di un rinvio a giudizio di cento pagine, allora loro avevano ragione e io torto. Sono sicuro che gli dispiaceva per me e sono sicuro che ha pregato perché in qualche modo riuscissi a cavarmi dai pasticci, ma ha avuto difficoltà a comunicarmi questi sentimenti. Si è sentito umiliato e me lo ha fatto capire. Come aveva potuto suo figlio avvocato mischiarsi con un tale branco di viscidi delinquenti? Mi sono posto la stessa domanda mille volte. Non c’è una risposta valida. Concluso faticosamente il liceo, e dopo qualche modesto inciampo con la legge, a diciannove anni Henry Bannister si era arruolato nel corpo dei marine. In breve tempo la vita militare l’aveva trasformato in un uomo, in un soldato che amava la disciplina, e lui era orgogliosissimo della sua uniforme. Ha fatto tre turni di servizio in Vietnam, dove è riuscito a farsi sparare, ustionare e, per un breve periodo, imprigionare dal nemico. Le sue medaglie sono appese alla parete dello studio nella piccola casa dove sono cresciuto. Adesso ci abita da solo. Mia madre è stata uccisa da un automobilista ubriaco due anni prima che io venissi accusato. Una volta al mese Henry viene a Frostburg per una visita di un’ora. È in pensione, non ha molto da fare e potrebbe venirmi a trovare anche tutte le settimane, se volesse. Ma non vuole. Sono molti gli aspetti crudeli connessi a una lunga pena detentiva. Uno di questi è la sensazione di essere lentamente dimenticati dal mondo e da coloro che ami e dei quali hai bisogno. La posta, che nei primi mesi ti arriva a pacchi, a poco a poco si riduce a una o due lettere alla settimana. Amici e parenti che un tempo sembravano ansiosi di venire a farti visita non si vedono più da un sacco di tempo. Mio fratello maggiore, Marcus, fa un salto due volte all’anno per un’oretta di aggiornamenti sui suoi ultimi problemi. Ha tre figli adolescenti, tutti a diversi stadi di delinquenza, più una moglie che è pazza. Forse io di problemi non ne ho, dopo tutto. In ogni caso gli incontri con mio fratello, nonostante la sua vita caotica, mi fanno piacere. Marcus è da sempre un imitatore di Richard Pryor e ogni parola che dice è divertente. Di solito ridiamo per tutta l’ora della visita mentre inveisce contro i suoi figli. Mia sorella minore, Ruby, vive sulla costa occidentale e la vedo solo una volta all’anno. Mi scrive doverosamente una lettera alla settimana, che per me ha grande valore. Ho un lontano cugino che si è fatto sette anni per rapina a mano armata – io ero il suo avvocato – e viene qui due volte all’anno perché quando al fresco c’era lui io andavo a trovarlo. Dopo tre anni qui a Frostburg, spesso passano mesi senza che nessuno venga a farmi visita, a Teile mio padre. Il diTeilimento Amministrazione penitenziaria cerca di sistemare i detenuti in un raggio di ottocento chilometri dalle loro case. Io sono fortunato perché Winchester è vicinissima, ma potrebbe comunque trovarsi a migliaia di chilometri di distanza. Ho parecchi amici d’infanzia che non si sono mai presi il disturbo del breve viaggio in auto e ne ho qualche altro che non si fa più sentire da un paio d’anni. La maggior Teile dei miei ex colleghi avvocati è troppo occupata. Il mio compagno di corse dei tempi dell’università mi scrive ogni due mesi, ma proprio non riesce a trovare il tempo per una capatina. Vive a Washington, duecentoquaranta chilometri a est, dove sostiene di lavorare sette giorni la settimana in un grande studio legale. Il mio migliore amico dell’epoca dei marine abita a Pittsburgh, a due ore da qui, ed è venuto a Frostburg esattamente una volta. Immagino di dover essere grato del fatto che mio padre faccia lo sforzo. Come sempre, siede da solo nella piccola sala visite. C’è un sacchetto di carta marrone sul tavolo davanti a lui. Sono biscotti o dolcetti fatti da zia Racine, sua sorella. Ci stringiamo la mano, ma non ci abbracciamo: Henry Bannister non ha mai abbracciato un altro uomo in vita sua. Mi osserva attentamente per assicurarsi che non sia ingrassato e, come al solito, mi chiede della mia routine quotidiana. Lui non è aumentato di un chilo in quarant’anni e potrebbe ancora indossare la sua uniforme dei marine. È convinto che mangiare meno significhi vivere più a lungo. Henry ha paura di morire giovane. Suo padre e suo nonno sono morti all’improvviso quando non avevano ancora sessant’anni. Lui cammina otto chilometri al giorno e ritiene che io dovrei fare lo stesso. Ormai ho accettato il fatto che non smetterà mai di dirmi come devo vivere la mia vita, che mi trovi in carcere o fuori. Picchietta con un dito il sacchetto marrone e mi dice: «Questi te li manda Racine». «Per favore, ringraziala tanto da Teile mia.» Se Henry è così preoccupato del mio girovita, perché continua a portarmi dolci ogni volta che viene a trovarmi? Ne mangerò solo due o tre e il resto lo regalerò in giro. «Hai parlato con Marcus, di recente?» domanda mio padre. «No, non questo mese. Perché?» «Un grosso guaio. Delmon ha messo incinta una ragazza. Lui ha quindici anni, lei quattordici.» Scuote la testa e aggrotta la fronte. Delmon era un fuorilegge già a dieci anni, e da lui la famiglia si è sempre aspettata una vita da criminale. «Il tuo primo pronipote» dico, cercando di essere divertente. «Ah, sono proprio orgoglioso. Una quattordicenne bianca ingravidata da un quindicenne idiota che si dà il caso di cognome faccia Bannister.» Entrambi ci riflettiamo su per qualche istante. Spesso i nostri incontri sono definiti non tanto da ciò che viene detto, ma da quello che viene tenuto dentro. Mio padre ha sessantanove anni e, invece di godersi i suoi anni dorati, passa la maggior Teile del tempo a leccarsi le ferite e a piangersi addosso. Non che io lo biasimi. Quella che per decenni era stata la sua amatissima moglie gli è stata portata via in una frazione di secondo e, mentre era ancora perso nel suo dolore, abbiamo scoperto che l’FBI si interessava a me. Nel giro di poco tempo l’indagine è diventata sempre più grossa, assumendo le proporzioni di una valanga. Il mio processo è durato tre settimane e mio padre è stato presente in aula ogni giorno. Vedermi in piedi davanti a un giudice che mi condannava a dieci anni di carcere gli ha spezzato il cuore. Poi Bo è stato portato via, a tutti e due. E adesso i figli di Marcus sono abbastanza grandi da provocare dispiaceri seri ai loro genitori e a tutta la famiglia. Alla nostra famiglia spetterebbe un po’ di fortuna, ma la cosa non sembra probabile. «Ieri sera ho parlato con Ruby» riprende mio padre. «Tua sorella sta bene, ti saluta e dice che la tua ultima lettera era molto divertente.» «Per favore, falle sapere che le sue lettere significano molto per me. Non ha saltato una settimana in cinque anni.» Ruby è il punto fermo e luminoso della nostra famiglia disastrata. È consulente matrimoniale e suo marito è pediatra. Ha tre figli perfetti, che vengono tenuti ben lontano dall’infame zio Mal. Dopo una lunga pausa, aggiungo: «Grazie per l’assegno, come sempre». Henry si stringe nelle spalle. «Mi fa piacere dare una mano.» Ogni mese mio padre mi manda cento dollari, cosa che apprezzo molto. Il denaro finisce sul mio conto e mi consente di comprare generi come penne, blocchi per appunti, libri in edizione economica e cibo decente. Quasi tutti i componenti della mia Gang Bianca ricevono assegni da casa e, virtualmente, nessuno della mia Gang Nera riceve un centesimo. In prigione sai sempre chi ha soldi. «Ormai sei quasi a metà» dice mio padre. «Ancora due settimane e saranno cinque anni esatti.» «Il tempo vola.» «Magari là fuori. Ti assicuro che l’orologio si muove molto più lentamente da questo lato del muro.» «Comunque, è difficile credere che sei qui dentro già da cinque anni.» Lo è davvero. Come si tira avanti in prigione? Non pensi agli anni, ai mesi o alle settimane. Pensi all’oggi: come arrivare a sera, come sopravvivere. E quando domani ti sveglierai, avrai un altro giorno dietro di te. I giorni si sommano, le settimane si accumulano, i mesi diventano anni. Ti rendi conto di quanto sei tosto, di come sei in grado di resistere e sopravvivere perché non hai scelta. «Hai qualche idea su cosa farai?» chiede mio padre. Sento questa domanda almeno una volta al mese, come se il mio rilascio fosse appena dietro l’angolo. Pazienza, mi dico. È mio padre. Ed è qui! Questo conta molto. «Non proprio. Manca ancora tanto tempo.» «Io comincerei a pensarci, se fossi in te.» Henry è sicuro che, se fosse al mio posto, saprebbe esattamente cosa fare. «Ho appena concluso il terzo corso di spagnolo» lo informo con un certo orgoglio. Nella mia Gang Nera c’è un buon amico, Marco, che è un ottimo insegnante di spagnolo. È dentro per droga. «Sembra proprio che tra un po’ parleremo tutti spagnolo. Ormai quella gente sta prendendo il sopravvento.» Henry ha poca pazienza nei confronti degli immigrati, di chiunque parli con un accento Teilicolare, di chi proviene da New York e dal New Jersey, di chiunque viva grazie all’assistenza sociale e dei disoccupati; ritiene inoltre che i senzatetto andrebbero rastrellati e riuniti in campi che dovrebbero essere, nella sua visione, addirittura peggiori di Guantánamo. Qualche anno fa tra noi c’è stato uno scambio duro e lui ha minacciato di interrompere le visite. Litigare è una perdita di tempo. Non intendo cambiare mio padre. E se è così gentile da venire a trovarmi, il meno che io possa fare è comportarmi come si deve. Sono io il delinquente che è stato condannato, non lui. Henry è il vincitore, io sono il perdente. Questo a lui sembra importante, anche se non capisco il motivo. Forse è perché io ho frequentato il college e la scuola di legge, cose che lui non ha mai neppure sognato. «Probabilmente me ne andrò all’estero» dico. «Da qualche Teile dove possa sfruttare la conoscenza dello spagnolo, tipo Panamá o Costa Rica. Bel clima, spiagge, gente con la pelle scura. Là a nessuno importa niente di fedine penali o se sei stato dentro.» «L’erba del vicino è sempre più verde, eh?» «Sì, papà. Se sei in prigione, qualsiasi altro posto ha l’erba più verde. Cosa dovrei fare? Tornare a casa, magari diventare un paralegale senza licenza che fa ricerche per un minuscolo studio che non può permettersi il mio stipendio? Diventare un garante per le cauzioni? Perché non un detective privato? Non ci sono molte opzioni.» Mentre parlo, mio padre annuisce. Abbiamo avuto questa conversazione almeno una decina di volte. «Inoltre detesti il governo.» «Oh, sì. Odio il governo federale, l’FBI, i procuratori, i giudici, i pazzi che dirigono le prigioni. Ci sono così tante cose che odio. Me ne sto chiuso qui a scontare dieci anni per un non-crimine perché un pallone gonfiato di procuratore aveva bisogno di aumentare la sua quota di condanne. E se il governo può inchiodarmi per dieci anni senza alcuna prova, pensa a quali sono le mie prospettive, adesso che ho la parola “pregiudicato” tatuata sulla fronte. Me ne andrò da questo paese appena potrò, papà.» Henry annuisce e sorride. Certo, Mal. 3 Considerata l’importanza del loro ruolo, le controversie che spesso nascono intorno ai loro atti e le persone violente con cui a volte hanno a che fare, è interessante notare come nella storia di questo paese siano stati assassinati solo quattro giudici federali. L’onorevole Raymond Fawcett è appena diventato il numero cinque. Il suo cadavere venne trovato nel piccolo seminterrato del cottage in riva al lago che lui stesso si era costruito e dove era solito trascorrere il weekend. Il lunedì mattina Fawcett non si era presentato a un processo e i suoi collaboratori, presi dal panico, si erano rivolti all’FBI. Nei tempi dovuti gli agenti avevano individuato la scena del delitto. Il cottage si trovava in un’area boscosa della Virginia sudoccidentale, sul fianco di una montagna e in riva a un piccolo, incontaminato bacino lacustre localmente noto come lago Higgins. Il lago non è indicato sulla maggior Teile delle carte stradali. Non sembravano esserci segni di scasso o di lotta. Niente, a Teile due cadaveri con fori di proiettile in testa e una cassaforte vuota nel seminterrato. Il giudice Fawcett venne trovato accanto alla cassaforte con due colpi alla nuca – chiaramente un’esecuzione – e una larga chiazza di sangue secco sul pavimento intorno a lui. Il primo esperto arrivato sulla scena ipotizzò che fosse morto da almeno due giorni. Fawcett, secondo un suo collaboratore, aveva lasciato l’ufficio intorno alle tre di venerdì pomeriggio e aveva in programma di andare direttamente al cottage, dove avrebbe trascorso il fine settimana lavorando sodo. Il secondo cadavere era quello di Naomi Clary, una divorziata trentaquattrenne madre di due figlie che Fawcett aveva assunto da poco come segretaria. Il giudice, che aveva sessantasei anni e cinque figli adulti, non era divorziato. Lui e Mrs Fawcett abitavano in case diverse già da parecchio tempo, anche se a Roanoke si facevano ancora vedere insieme quando l’occasione lo richiedeva. Il fatto che fossero separati era di dominio pubblico e, dato che il giudice era una persona in vista, il loro stile di vita era motivo di pettegolezzi. I Fawcett avevano confidato ai figli e agli amici che semplicemente non se la sentivano di divorziare. Mrs Fawcett aveva i soldi. Il giudice Fawcett aveva lo status. Entrambi sembravano relativamente soddisfatti e si erano promessi di non intrattenere relazioni clandestine. L’accordo amichevole prevedeva che avrebbero divorziato solo se e quando uno dei due avesse trovato un’altra persona. Evidentemente il giudice aveva trovato un’altra persona. Pochissimo tempo dopo l’iscrizione di Ms Clary a libro paga, in tribunale si erano diffuse voci secondo le quali il giudice si stava dando da fare, di nuovo. Alcuni del suo staff sapevano che non era mai riuscito a tenere i pantaloni abbottonati. Il corpo di Naomi venne trovato sopra un divano, vicino al punto in cui era stato assassinato il giudice. La donna era nuda e supina, con le caviglie legate strette con nastro adesivo argentato e i polsi uniti dietro la schiena. Qualcuno le aveva sparato due colpi in fronte. Sul corpo c’erano piccoli segni di bruciature. Dopo qualche ora di discussioni e analisi, gli investigatori conclusero che molto probabilmente Naomi era stata torturata per costringere Fawcett ad aprire la cassaforte. A quanto pareva, la cosa aveva funzionato: lo sportello era spalancato e la cassaforte completamente vuota. Il ladro l’aveva ripulita e poi aveva giustiziato le sue vittime. Il padre del giudice era un carpentiere, e fin da bambino Fawcett lo aveva seguito spesso al lavoro, sempre con un martello in mano. In seguito non aveva mai smesso di costruire cose: una veranda sul retro di casa, una terrazza di legno, un capanno per gli attrezzi. All’epoca in cui i figli erano ancora piccoli e il suo matrimonio era ancora felice, aveva sventrato e rifatto completamente una vecchia e imponente residenza nel centro di Roanoke, operando come capocantiere e passando ogni weekend in cima a una scala. Anni dopo aveva ristrutturato un loft che era diventato prima il suo nido d’amore, poi la sua abitazione. Per Fawcett martellare, segare e sudare era una terapia, una fuga mentale e fisica da un lavoro stressante. Aveva progettato personalmente il cottage a forma di A in riva al lago e, nel corso di quattro anni, lo aveva tirato su quasi tutto da solo. Nel seminterrato dove era stato ucciso c’era un’intera parete occupata da begli scaffali di legno di cedro, tutti carichi di grossi tomi legali. Al centro, però, c’era uno sportello nascosto. Una serie di ripiani era apribile e dietro, perfettamente nascosta, c’era la cassaforte. Sulla scena del delitto, era stata estratta dalla parete per circa novanta centimetri e poi svuotata. La cassaforte, di metallo e piombo, era montata su quattro rotelle. Era stata costruita dalla Vulcan Safe Company di Kenosha, Wisconsin, e acquistata online da Fawcett. Secondo la scheda tecnica del fabbricante, era alta centodiciassette centimetri, larga novantuno e profonda cento, aveva una capacità di duecentocinquanta litri, pesava duecentotrenta chili e costava duemilacento dollari. Se chiusa correttamente, era ignifuga, a tenuta stagna e, teoricamente, a prova di scasso. La tastiera sullo sportello prevedeva un codice a sei cifre per l’apertura. Perché mai un giudice che guadagnava centosettantaquattromila dollari l’anno avesse bisogno di un contenitore così robusto e nascosto per i suoi valori rappresentò un immediato mistero per l’FBI. Al momento della morte, il giudice Fawcett disponeva di quindicimila dollari sul suo conto corrente personale, di sessantamila dollari in un certificato di deposito che fruttava meno dell’uno per cento all’anno, di trentunmila dollari in buoni del Tesoro e di altri quarantasettemila in un fondo comune che da quasi un decennio aveva un andamento peggiore della media generale del mercato. Aveva anche un fondo pensione 401(k) e godeva di tutta la serie di benefit riservati ai funzionari federali di alto livello. Praticamente senza debiti, il saldo del giudice non destava comunque impressione. La sua vera sicurezza finanziaria stava nel lavoro. Dato che la costituzione gli consentiva di proseguire vita natural durante, lo stipendio non si sarebbe mai interrotto. La famiglia di Mrs Fawcett possedeva vagonate di azioni bancarie, alle quali però il giudice non era mai riuscito neppure ad avvicinarsi. Adesso, dopo la separazione, il gruzzolo era ancora più off-limits. Conclusione: Fawcett era benestante ma ben lontano dall’essere ricco, quindi non avrebbe dovuto avere bisogno di una cassaforte nascosta per custodire i suoi valori. Cosa c’era all’interno di quella cassaforte? O, più brutalmente, che cosa aveva ucciso il giudice? Successivi colloqui con amici e familiari avrebbero rivelato che Fawcett non aveva abitudini costose, non collezionava monete d’oro, diamanti rari o qualsiasi altra cosa che potesse richiedere una tale protezione. A Teile una notevole raccolta di figurine del baseball che risaliva alla sua gioventù, non c’erano indizi che suggerissero un interesse del giudice in una qualsiasi forma di collezionismo. Il cottage era rannicchiato così in profondità tra le colline da essere quasi impossibile da trovare. Circondato da una veranda, da qualsiasi punto di osservazione non si vedevano persone, veicoli, case, capanne o barche. Isolamento totale. Fawcett teneva un kayak e una canoa nel seminterrato ed era risaputo che passava ore sul lago, pescando, pensando e fumando sigari. Era un uomo tranquillo, non solitario né timido, ma serio e pensoso. Per l’FBI era dolorosamente evidente che non ci sarebbero stati testimoni perché non c’erano altri esseri umani nel raggio di chilometri. Il cottage era il posto perfetto per uccidere qualcuno e poi allontanarsi prima che il crimine venisse scoperto. Nel momento stesso del loro arrivo, gli investigatori capirono di essere in grave ritardo. E le cose per loro sarebbero addirittura peggiorate. Non c’era una sola impronta digitale o di scarpa, un frammento di fibra, un capello o una traccia di pneumatico utile alle indagini. Il cottage non era dotato di sistema d’allarme e di certo non aveva telecamere di sorveglianza. Perché prendersi il disturbo? Il poliziotto più vicino era a mezz’ora di distanza e, anche presumendo che riuscisse a trovare la casa, cosa avrebbe potuto fare una volta arrivato? Anche il più idiota dei ladri se ne sarebbe già andato da un pezzo. Per tre giorni gli investigatori ispezionarono ogni centimetro del cottage e dei quasi due ettari che lo circondavano. Non trovarono niente. Il fatto che l’assassino fosse stato così attento e meticoloso non contribuì a sollevare l’umore della squadra. Avevano a che fare con un autentico talento, un killer furbo ed esperto che non aveva lasciato tracce. Da dove si poteva cominciare? C’erano già pressioni da Teile del diTeilimento di Giustizia a Washington. Il direttore dell’ FBI stava organizzando una task force, una sorta di unità speciale che sarebbe calata su Roanoke per risolvere il caso. Com’era prevedibile, i brutali omicidi di un giudice adultero e della sua giovane amica costituirono uno splendido regalo per i media e i tabloid. Quando Naomi Clary venne sepolta, due giorni dopo la scoperta del suo cadavere, la polizia di Roanoke dovette piazzare delle transenne per tenere giornalisti e curiosi lontano dal cimitero. E quando il giorno dopo si tenne il servizio funebre di Raymond Fawcett, in un’affollatissima chiesa episcopale, un elicottero si posizionò sopra l’edificio, soffocando la musica con il suo rumore. Il capo della polizia, un vecchio amico del giudice, fu costretto a far alzare in volo il suo elicottero perché scacciasse l’altro. Mrs Fawcett sedeva rigida nel primo banco tra i suoi figli e i nipoti, rifiutandosi di versare una lacrima o di guardare la bara del marito. Vennero pronunciate molte belle parole a proposito del giudice, ma alcune persone, soprattutto gli uomini, si chiedevano: “Come avrà fatto quel vecchio a trovarsi un’amica così giovane?”. Una volta sepolte entrambe le vittime, l’attenzione si spostò di nuovo sulle indagini. L’ FBI non faceva dichiarazioni pubbliche, soprattutto perché non aveva niente da dire. Una settimana dopo la scoperta dei cadaveri, l’unico dato certo era il risultato dell’esame balistico. Quattro pallottole a punta cava esplose da una pistola calibro .38, una del milione presente sulle strade e adesso probabilmente in fondo a un lago, da qualche Teile tra le montagne del West Virginia. Vennero presi in esame i moventi di altri casi. Nel 1979 il giudice John Wood era stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti alla sua casa a San Antonio. L’omicida era un killer a pagamento, assunto da un potente spacciatore in attesa di sentenza da Teile del giudice Wood, il quale odiava il traffico di stupefacenti e tutti coloro che ci lavoravano. Considerando il soprannome del giudice, Maximum John, il movente era abbastanza chiaro. A Roanoke, le squadre dell’FBI esaminarono tutti i casi, penali e civili, assegnati al giudice Fawcett e ne ricavarono una breve lista di potenziali sospettati, virtualmente tutti coinvolti nel traffico di droga. Nel 1988 il giudice Richard Daronco era stato ucciso mentre lavorava nel giardino di casa sua a Pelham, New York. L’assassino era risultato essere il padre infuriato di una donna che aveva appena perso una causa nell’aula del giudice. L’uomo aveva sparato a Daronco e poi si era suicidato. A Roanoke, la squadra dell’ FBI passò al setaccio le pratiche di Fawcett e interrogò i suoi impiegati. In corte federale c’è sempre qualche pazzo che deposita istanze spazzatura e presenta richieste irricevibili; a poco a poco, venne stilato un elenco. Nomi, ma nessun vero sospettato. Nel 1989 il giudice Robert Smith Vance era rimasto ucciso nella sua casa di Mountain Brook, Alabama, dopo avere aperto un pacco che conteneva una bomba. L’assassino era stato individuato e spedito nel braccio della morte, ma del movente non si era mai venuti a capo. L’accusa aveva ipotizzato che l’omicida si fosse imbestialito per una recente decisione del giudice Vance. A Roanoke, l’ FBI interrogò centinaia di avvocati con cause di competenza del giudice Fawcett, attuali o del recente passato. Ogni legale ha clienti pazzi o abbastanza violenti da cercare vendetta, e alcuni soggetti del genere erano passati anche nell’aula del giudice Fawcett. Vennero rintracciati, interrogati e scartati come possibili responsabili. Nel gennaio 2011, un mese prima dell’assassinio di Fawcett, il giudice John Roll era stato ucciso vicino a Tucson nel corso dello stesso omicidio di massa in cui era rimasta ferita Gabrielle Giffords, la rappresentante al Congresso. Il giudice Roll si era trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La sua morte non fu di alcun aiuto all’FBI a Roanoke. A ogni giorno che passava, la pista diventava più fredda. Senza testimoni, senza prove materiali, senza alcun errore da Teile del killer e disponendo solo di una manciata di vaghe ipotesi e di pochissimi sospettati desunti dalle cause del giudice Fawcett, l’indagine si trovava praticamente in un vicolo cieco. Il grande annuncio di una ricompensa di centomila dollari per chi avesse notizie utili fece ben poco per innescare una qualche attività nei numeri verdi dell’FBI. 4 Dato che a Frostburg le misure di sicurezza sono abbastanza blande, noi qui abbiamo più contatti con il mondo esterno di quanti ne abbia la maggior Teile dei detenuti di altre prigioni. La nostra posta può essere aperta e letta, ma questo capita di rado. Abbiamo accesso, limitato, a e-mail e Internet. Ci sono decine di telefoni e un mucchio di norme che ne regolano l’utilizzo, ma in genere possiamo fare tutte le chiamate a carico del destinatario che vogliamo. I cellulari sono severamente proibiti. Ci è permesso abbonarci a qualsiasi rivista tra le decine che figurano in un elenco approvato. Numerosi quotidiani vengono puntualmente consegnati ogni mattina e sono sempre disponibili in un angolo della mensa, nota anche come “sala caffè”. È lì che una mattina presto noto il titolo del “Washington P o s t”: Giudice federale assassinato nei dintorni di Roanoke. Non riesco a nascondere un sorriso. Il momento è arrivato. Sono tre anni che Raymond Fawcett mi ossessiona. Non l’ho mai visto, non sono mai entrato nella sua aula, non ho mai depositato un atto di citazione nel suo dominio, il Distretto Sud della Virginia. Quasi tutta la mia attività professionale si è svolta nei tribunali di Stato. Mi sono avventurato raramente nell’arena federale e, quando l’ho fatto, è stato sempre nel Distretto Nord, che comprende tutto il territorio da Richmond in su. Il Distretto Sud comprende Roanoke, Lynchburg e l’enorme distesa dell’area metropolitana Virginia Beach-Norfolk. Prima del decesso di Fawcett, erano dodici i giudici federali nel Distretto Sud e tredici in quello Nord. Qui a Frostburg ho conosciuto parecchi detenuti condannati da Fawcett e, senza sembrare troppo curioso, li ho interrogati su di lui. L’ho fatto fingendo di conoscerlo e di avere dibattuto cause nella sua aula. Senza eccezioni, tutti lo odiavano e ritenevano che avesse esagerato con le condanne. Fawcett, a quanto pare, amava Teilicolarmente tenere sagge conferenze ai colletti bianchi quando pronunciava la sentenza e li mandava in galera. Le udienze delle condanne in genere richiamavano un numero maggiore di giornalisti, e Fawcett aveva un ego smisurato. Laureato alla Duke, si era specializzato alla scuola di legge della Columbia University e poi, per qualche anno, aveva lavorato in una società di Wall Street. Sua moglie e il relativo denaro erano originari di Roanoke e fu lì che la coppia si stabilì quando Fawcett aveva poco più di trent’anni. Entrò nel più importate studio legale della città e si arrampicò rapidamente fino al vertice. Suo suocero foraggiava il Teilito democratico da molto tempo, e nel 1993 il presidente Clinton assegnò a Fawcett un incarico a vita nel tribunale federale del Distretto Sud della Virginia. Nel sistema legislativo americano questa nomina assicura un enorme prestigio, ma non molto denaro. All’epoca lo stipendio di Fawcett ammontava a centoventicinquemila dollari l’anno, vale a dire circa trecentomila dollari in meno di ciò che guadagnava come attivissimo socio di un florido studio legale. A quarantotto anni era diventato uno dei giudici federali più giovani del paese e, con cinque figli, uno dei più poveri. Ben presto il suocero cominciò a integrare le sue entrate e la pressione si allentò. Il giudice Fawcett aveva descritto i suoi primi anni sullo scranno in una lunga intervista rilasciata a uno di quei periodici legali che ben pochi leggono. Ho trovato per caso la rivista nella biblioteca del carcere, in una pila di giornali che stavano per essere buttati. Non sono molti i libri e le riviste che sfuggono ai miei occhi curiosi. Mi capita spesso di leggere anche per cinque o sei ore al giorno. Qui i computer sono desktop, tecnologicamente indietro di qualche anno, e a causa del massiccio utilizzo sono anche piuttosto malconci. In ogni caso, dato che il bibliotecario sono io e i computer rientrano sotto il mio controllo, godo di parecchie opportunità. Siamo abbonati a due siti di ricerche legali, che ho consultato per leggere ogni sentenza e relativa motivazione del defunto onorevole Raymond Fawcett. Deve essergli successo qualcosa al cambio di secolo, nel 2000. Nei suoi primi sette anni da giudice, Fawcett era stato un simpatizzante di sinistra, un paladino dei diritti individuali, compassionevole nei confronti dei poveri e dei deboli, pronto a rimproverare le forze dell’ordine, diffidente nei riguardi delle grandi corporation e all’apparenza ansioso di punire l’eventuale Teile contendente indocile o scorretta con un tratto di penna molto appuntita. Nel giro di un anno, però, qualcosa cambiò. Le sue motivazioni diventarono più brevi, meno articolate, a volte addirittura perfide. Fawcett si stava chiaramente spostando a destra. Nel 2000 venne segnalato dal presidente Clinton per la posizione che si era liberata alla Corte d’Appello del Quarto circuito a Richmond. Tale avanzamento rappresenta la logica promozione di un giudice distrettuale di talento, o di un giudice che ha le giuste conoscenze. Nel Quarto circuito, Fawcett sarebbe stato uno dei quindici magistrati che si occupano esclusivamente di cause in appello. L’unico scalino più alto sarebbe stato la Corte Suprema degli Stati Uniti, e non è chiaro se Fawcett avesse quell’ambizione. La maggior Teile dei giudici federali ce l’ha, prima o poi. Tuttavia Bill Clinton stava per concludere il suo mandato, e sotto una nube scura. Le sue segnalazioni si impantanarono in Senato e, con l’elezione di George W. Bush, il futuro di Fawcett rimase confinato a Roanoke. Aveva cinquantacinque anni. I suoi figli erano già adulti o se ne stavano comunque andando da casa. Forse cedette a una specie di crisi della mezz’età. Forse il suo matrimonio stava naufragando. Il suocero, che intanto era morto, l’aveva escluso dal testamento. I suoi ex soci diventavano sempre più ricchi mentre lui sgobbava per una paga da fame, relativamente parlando. Quale che fosse la ragione, in aula Fawcett diventò un uomo diverso. Nei casi penali le sue sentenze si fecero imprevedibili e molto meno clementi. Nelle cause civili dimostrava una comprensione molto minore nei confronti del piccolo uomo della strada e si schierava sempre più frequentemente a favore dei grandi interessi. Capita spesso che nel tempo i giudici cambino, ma pochi subiscono una trasformazione così radicale come quella di Raymond Fawcett. Il caso più importante della sua carriera fu quello relativo a una guerra per l’estrazione dell’uranio, iniziata nel 2003. Allora ero ancora avvocato e conoscevo la materia del contendere e i dettagli di base. Non lo si poteva evitare: i giornali pubblicavano un articolo sull’argomento praticamente ogni giorno. C’è una ricca vena di uranio che si snoda attraverso la Virginia centrale e meridionale. Dato che l’estrazione dell’uranio è un incubo ambientale, lo Stato aveva emanato una legge che la proibiva. Naturalmente era da tempo che i proprietari dei terreni, gli affittuari e le società minerarie che controllavano i giacimenti volevano cominciare a scavare e avevano speso milioni di dollari in attività di lobby perché i legislatori annullassero il bando. Ma l’Assemblea generale della Virginia resisteva. Nel 2003 una società canadese, l’Armanna Mines, depositò un atto di citazione presso il Distretto Sud attaccando il bando come incostituzionale. Era un attacco frontale senza esclusione di colpi, massicciamente finanziato e condotto da alcuni dei più costosi talenti legali che il denaro potesse comprare. Come si venne presto a sapere, l’Armanna Mines era un consorzio di società minerarie statunitensi, australiane, russe e anche canadesi. Una stima del potenziale valore dei giacimenti nella sola Virginia andava dai quindici ai venti miliardi di dollari. In base al procedimento di selezione casuale in vigore all’epoca, la causa venne assegnata a un certo giudice McKay di Lynchburg, che aveva ottantaquattro anni e soffriva di demenza senile. Adducendo motivi di salute, McKay rinunciò. Il secondo magistrato in lista era Raymond Fawcett, che non aveva alcuna ragione valida per declinare. Il convenuto era il Commonwealth of Virginia, ma ben presto se ne aggiunsero altri, tra cui città, paesi e contee che si trovavano sopra i giacimenti, oltre ad alcuni proprietari che non volevano avere niente a che fare con la devastazione del territorio. La causa diventò un enorme pasticcio legale, sempre più esteso, che vedeva coinvolti oltre cento avvocati. Il giudice Fawcett respinse le iniziali istanze di archiviazione e ordinò un esteso scambio di documenti fra le Teili. Non passò molto tempo prima che dedicasse il novanta per cento del suo tempo a questa causa. Nel 2004 l’FBI entrò nella mia vita e io persi interesse nel caso uranio. All’improvviso avevo altre e più pressanti questioni di cui occuparmi. Il procedimento a mio carico cominciò nell’ottobre del 2005 a Washington. Per allora, il processo Armanna Mines era in corso già da un mese in un’affollata aula di Roanoke. A quel punto dell’uranio non avrebbe potuto importarmi di meno. Dopo un processo di tre settimane venni giudicato colpevole e condannato a dieci anni. Dopo un processo di dieci settimane il giudice Fawcett deliberò a favore dell’Armanna Mines. Non esisteva alcuna relazione possibile tra i due procedimenti, o almeno così pensavo quando entrai in carcere. Poco tempo dopo, però, incontrai l’uomo che avrebbe ucciso il giudice Fawcett. Io conosco l’identità dell’assassino, e so anche qual è stato il movente. Il movente è origine di frustrazione per l’FBI. Nelle settimane che seguono l’omicidio, la task force si concentra sulla causa Armanna Mines e interroga decine di persone collegate alla controversia legale. Ai suoi margini erano comparsi e avevano operato due o tre gruppi ambientalisti radicali, che all’epoca erano stati attentamente monitorati dall’FBI. Fawcett aveva ricevuto minacce di morte e durante il processo era andato in giro con la scorta. Sulle minacce si era indagato a fondo e alla fine erano state giudicate inattendibili, ma le guardie del corpo erano rimaste. L’intimidazione è un movente improbabile. Fawcett aveva già emesso la sua sentenza e, anche se il suo nome è veleno per gli ambientalisti, il danno l’aveva già fatto. La sua sentenza è stata confermata dal Quarto circuito nel 2009 e la causa adesso viaggia verso la Corte Suprema degli Stati Uniti. In attesa degli appelli, l’uranio non è ancora stato toccato. La vendetta può essere un movente, anche se l’FBI non ne parla. Le parole “killer a pagamento” vengono usate da alcuni giornalisti, che però non hanno nulla su cui basare la loro ipotesi se non la professionalità dei due omicidi. Considerate la scena del delitto e la cassaforte nascosta con tanta cura, il movente più probabile sembra essere la rapina. Io ho un piano, un piano che sto mettendo a punto da anni. È la mia unica via d’uscita. 5 Ogni detenuto federale fisicamente abile è tenuto a svolgere un lavoro, ed è il diTeilimento dell’amministrazione penitenziaria che controlla la scala salariale. Da due anni faccio il bibliotecario e per le mie fatiche vengo retribuito con trenta centesimi all’ora. Circa metà di questo denaro, unitamente agli assegni di mio padre, è soggetto al Programma di responsabilità finanziaria del detenuto. L’amministrazione penitenziaria si prende i soldi e li impiega per il pagamento di spese giudiziarie, multe e risarcimenti. Oltre ai dieci anni di carcere, sono stato condannato al pagamento di circa centoventimila dollari per varie pene pecuniarie. A trenta centesimi l’ora, mi ci vorrà il resto di questo secolo, più qualche altro anno. Altri lavori qui a Frostburg sono quelli di cuoco, lavapiatti, pulitore di tavoli, lavapavimenti, idraulico, elettricista, falegname, inserviente in infermeria, addetto alla lavanderia, imbianchino, giardiniere e insegnante. Mi considero fortunato: il mio è uno dei lavori migliori e non mi costringe a pulire la sporcizia degli altri. Ogni tanto tengo un corso di storia per i detenuti che vogliono ottenere l’equivalente del diploma di scuola superiore. Insegnare rende trentacinque centesimi l’ora, ma non è il salario più alto a tentarmi. Anzi, trovo questa attività molto deprimente a causa del basso livello di istruzione della popolazione carceraria. Neri, bianchi, scuri... non ha importanza. Molta di questa gente è a malapena in grado di leggere e scrivere. Viene da chiedersi cosa stia succedendo alle nostre scuole. In ogni caso, non ho certo l’obiettivo di raddrizzare il sistema scolastico, e nemmeno quello legale, giudiziario o carcerario. Il mio obiettivo è sopravvivere un giorno alla volta, mantenendo quanto più possibile la dignità e il rispetto di me stesso. Noi siamo feccia, nullità, criminali comuni rinchiusi e tenuti a distanza dalla società civile, e i promemoria di questa situazione non sono mai troppo distanti. In carcere la guardia è definita agente penitenziario, o più semplicemente AP. Mai rivolgerti a uno di loro chiamandolo guardia. Nossignore. Essere un agente penitenziario è qualcosa di gran lunga superiore, fa più titolo. Quasi tutti sono ex poliziotti, ex vicesceriffi o comunque ex militari di qualche tipo che non se la sono cavata troppo bene nei precedenti lavori, e adesso operano nelle prigioni. Alcuni sono tipi a posto, ma perlopiù sono dei perdenti troppo stupidi per rendersi conto di essere perdenti. Ma chi siamo noi per dirglielo? Loro sono troppo sopra di noi, nonostante la stupidità, e amano ricordarcelo a ogni passo. Gli agenti penitenziari vengono fatti ruotare per impedire che si creino rapporti troppo stretti con i detenuti. Immagino che questo possa accadere, ma una delle regole cardinali per la sopravvivenza in carcere è evitare il t u o AP quanto più possibile. Trattalo con rispetto, fa’ esattamente quello che ti dice e non provocargli guai. Ma, soprattutto, cerca di evitarlo. Il mio attuale agente penitenziario non è tra i migliori. Si chiama Darrel Marvin, un bianco di non più di trent’anni dal torace ampio e la pancia prominente che cerca di darsi un’aria spavalda, ma ha troppa ciccia sui fianchi. Darrel è un razzista ignorante al quale non sto simpatico perché sono nero e ho due lauree, cioè due più di lui. Ogni volta che sono costretto a leccare i piedi a questo idiota dentro di me infuria una dura battaglia, ma non ho scelta. In questo momento ho bisogno di lui. «Buongiorno, agente Marvin» lo saluto con un sorriso falso, fermandolo fuori dalla mensa. «Cosa c’è, Bannister?» grugnisce. Gli tendo un foglio, un modulo di richiesta ufficiale. Marvin lo prende e prova a leggerlo. Sono tentato di aiutarlo con le parole più lunghe, ma mi mordo la lingua. «Avrei bisogno di parlare con il direttore» spiego educatamente. «Perché vuoi parlare con il direttore?» mi chiede, continuando a cercare di leggere la mia richiesta piuttosto semplice. I miei affari con il direttore non riguardano l’AP, né nessun altro, ma ricordare questo fatto a Darrel significherebbe soltanto guai. «Mia nonna sta morendo e io vorrei andare al suo funerale. È a soli novanta chilometri da qui.» «Quando pensi che possa morire?» mi domanda questo pozzo di scienza. «Presto. Per favore, agente Marvin. Non vedo mia nonna da anni.» «Al direttore non piacciono queste stronzate, Bannister. Ormai dovresti saperlo.» «Lo so, ma il direttore mi deve un favore. Qualche mese fa gli ho dato un parere legale. Per favore, gli può passare la mia richiesta?» Marvin piega il foglio e se lo mette in tasca. «Va bene, ma è una perdita di tempo.» «La ringrazio.» Le mie nonne sono morte entrambe anni fa. Niente in carcere è pensato per favorire il detenuto. La decisione di accogliere o respingere una semplice richiesta dovrebbe richiedere poche ore, ma così sarebbe troppo facile. Passano quattro giorni prima che Darrel mi dia istruzione di presentarmi nell’ufficio del direttore alle dieci di domani, 18 febbraio. Un altro sorriso falso e dico: «Grazie mille». Il direttore è il re di questo piccolo impero, con l’ego che ci si può aspettare da chi governa per editti, o ritiene che così dovrebbe essere. I direttori vanno e vengono ed è impossibile capire lo scopo di tutti questi trasferimenti. Di nuovo, non è compito mio riformare il sistema carcerario, per cui non mi preoccupo troppo di quello che succede negli edifici amministrativi. L’attuale direttore è Mr Robert Earl Wade, tutta una carriera nell’apparato penitenziario, un uomo che non scherza. Ha appena divorziato per la seconda volta, e in effetti io gli ho davvero spiegato alcuni punti chiave delle disposizioni riguardanti gli alimenti in vigore nel Maryland. Entro nel suo ufficio. Wade non si alza in piedi, non mi tende la mano né fa alcun gesto che possa indicare rispetto. Mi dice soltanto: «Salve, Bannister» e agita una mano in direzione di una sedia. «Buongiorno, direttore Wade. Come sta?» Mi metto a sedere. «Sono un uomo libero. La numero due è diventata storia e io non mi risposerò mai più.» «Mi fa piacere sentirlo e sono lieto di esserle stato utile.» Esaurita rapidamente la fase di riscaldamento, il direttore afferra un blocco per appunti e mi dice: «Non posso lasciarvi andare a casa per ogni funerale, Bannister. Lo capisci anche tu». «Non si tratta di un funerale. Non c’è nessuna nonna.» «Cosa diavolo...?» «Lei segue le indagini sull’assassinio del giudice Fawcett, a Roanoke?» Il direttore aggrotta la fronte e solleva di scatto la testa, come se fosse stato insultato. Sono entrato nel suo ufficio con un pretesto, e da qualche Teile, sepolto in profondità in uno degli innumerevoli manuali federali, deve esserci senz’altro qualcosa che qualifica il mio comportamento come un’infrazione. Mentre tenta di replicare, scuote la testa e ripete tra sé: “Cosa diavolo...?”. «L’omicidio del giudice federale. È su tutti i giornali.» È difficile credere che la cosa gli sia sfuggita, ma è possibile. Solo perché io leggo parecchi quotidiani ogni giorno, non significa che tutti facciano la stessa cosa. «Il giudice federale?» dice. «Proprio lui. L’hanno trovato con la sua ragazza in un cottage in riva al lago, nel Southwest Virginia. Avevano sparato a tutti e due e...» «Certo, certo. Ho visto i giornali. Ma questo cos’ha a che fare con te?» È irritato perché gli ho mentito e sta riflettendo sulla punizione più adeguata. Un essere supremo e potente come il direttore di un carcere non può lasciarsi raggirare da un detenuto. Il suo sguardo spazia nell’ufficio mentre lui cerca di decidere come reagire al mio inganno. Devo ottenere l’effetto più drammatico possibile perché quando risponderò alla sua domanda, Wade probabilmente scoppierà a ridere. I detenuti hanno fin troppo tempo libero a disposizione per elaborare complicate dichiarazioni di innocenza, per ideare teorie cospiratorie riguardo a delitti irrisolti o carpire segreti da usare come merce di scambio per un’immediata concessione della libertà vigilata. In breve, i detenuti non fanno che inventarsi modi per cercare di uscire, e sono sicuro che Robert Earl li ha già visti e sentiti tutti. «Io so chi ha ucciso il giudice» rispondo, con la massima gravità. Con mio grande sollievo, il direttore non accenna neppure a un sorriso. Si appoggia allo schienale della poltroncina, si massaggia il mento e comincia ad annuire. «E come sei venuto in possesso di questa informazione?» «Ho conosciuto il killer.» «Qui dentro o fuori?» «Questo non posso dirglielo, direttore. Ma non la sto prendendo in giro. In base a quello che leggo sui giornali, le indagini dell’FBI non stanno andando da nessuna Teile. E non andranno da nessuna Teile.» Le mie note disciplinari sono immacolate. Non ho mai rivolto una sola parola sbagliata a un agente. Non mi sono mai lamentato. Nella mia cella non c’è mai stato un articolo di contrabbando, neppure una bustina di zucchero della mensa. Non gioco d’azzardo e non mi faccio prestare soldi. Ho aiutato decine di detenuti e anche qualche civile, compreso il direttore, a cercare di risolvere i loro problemi legali. Tengo la mia biblioteca in un ordine meticoloso. Il punto è che, per essere un carcerato, sono credibile. Wade si sporge in avanti appoggiandosi sui gomiti e mi mostra i denti giallastri. Ha due cerchi scuri sotto gli occhi, che sono sempre lacrimosi. Sono gli occhi di uno che beve parecchio. «Fammi indovinare, Bannister: tu vuoi condividere l’informazione con l’FBI, concludere un accordo e uscire di galera. Giusto?» «Assolutamente sì, signore. Il mio piano è quello.» Ed ecco la risata. Una lunga risata stridula che sarebbe di per sé motivo di grande ilarità. Il direttore si calma e mi domanda: «Quando dovresti uscire?». «Tra cinque anni.» «Oh, per cui sarebbe proprio un accidente di accordo, vero? Tu dai un nome all’ FBI e trotti fuori di qui cinque anni prima del previsto, giusto?» «Niente è così semplice.» «E cosa vorresti che facessi, Bannister?» ringhia Wade, la risata ormai svanita. «Dovrei chiamare l’FBI per dire che ho qui un tizio che sa chi è l’assassino ed è pronto a concludere un accordo? Probabilmente ricevono cento telefonate al giorno, perlopiù da furbastri che mirano ai soldi della ricompensa. Perché dovrei rischiare la mia credibilità entrando in quel gioco?» «Perché io so la verità, e lei sa che non sono un furbastro e non sparo cazzate.» «Perché non scrivi una lettera all’FBI e mi lasci fuori da questa storia?» «Lo farò, se è questo che vuole. Ma a un certo punto lei verrà comunque coinvolto perché le giuro che riuscirò a convincere l’FBI. Faremo l’accordo e io le dirò addio. Lei si occuperà solo della logistica.» Wade si lascia andare sulla poltrona, come se si sentisse schiacciato dalla pressione della sua carica. Si sfrega il naso con il pollice. «Sai, Bannister, in questo momento ho seicentodue uomini qui a Frostburg, e tu sei l’ultimo che mi sarei aspettato di vedere entrare nel mio ufficio con un’idea così demenziale. L’ultimissimo.» «Grazie.» «Prego.» Mi sporgo in avanti e lo fisso negli occhi. «Senta, direttore, io so di cosa sto parlando. Capisco che lei possa non fidarsi di un detenuto, ma mi stia a sentire. Sono in possesso di informazioni preziose. Informazioni che l’FBI vorrebbe disperatamente. Per favore, li chiami.» «Non lo so, Bannister. Faremo entrambi la figura degli idioti.» «Per favore.» «Ci penserò. Adesso sparisci. E di’ all’agente Marvin che ho respinto la tua richiesta di andare al funerale.» «Sì, signore. E grazie.» La mia sensazione è che il direttore non resisterà alla tentazione di un po’ di movimento. Dirigere un campo di bassa sicurezza popolato da detenuti ben educati è un lavoro noioso. Perché non Teilecipare alle indagini sul più famoso omicidio del paese? Esco dalla palazzina dell’amministrazione e attraverso la corte quadrangolare al centro del campo. Sul lato ovest ci sono due dormitori che ospitano centocinquanta uomini ciascuno e sul lato orientale della corte ci sono due edifici identici. Sono il campus est e il campus ovest, come se si stesse passeggiando in un simpatico, piccolo college. La sala caffè degli agenti penitenziari è vicino alla mensa ed è lì che trovo il mio caro agente Marvin. Se solo mettessi un piede lì dentro, probabilmente mi sparerebbero o mi impiccherebbero. La porta metallica è aperta e posso vedere all’interno. Marvin è stravaccato su una sedia pieghevole, con una tazza di caffè in una mano e una grossa pasta nell’altra. Sta ridendo con altri due agenti. Se venissero agganciati per il collo e pesati insieme su una bilancia, i tre arriverebbero comodamente a quattrocentocinquanta chili. «Cosa vuoi, Bannister?» ringhia Darrel appena mi vede. «Volevo solo ringraziarla, agente. Il direttore mi ha negato il permesso, ma grazie ugualmente.» «Te l’avevo detto. Mi dispiace per tua nonna.» Dopodiché una delle guardie chiude la porta con un calcio. La porta mi sbatte in faccia, il metallo rimbomba e vibra e, per una frazione di secondo, mi scuote fin nel profondo. Ho già sentito questo rumore. Il mio arresto. Il Downtown Civic Club si riuniva ogni mercoledì a pranzo nello storico George Washington Hotel, cinque minuti a piedi dal mio studio. Il club contava circa settantacinque soci, tutti bianchi tranne tre. Quel giorno io ero l’unico nero presente, non che questo abbia un significato Teilicolare. Seduto a un lungo tavolo, mi sforzavo di mandare giù il solito pollo di gomma con i soliti piselli freddi chiacchierando con il sindaco e un agente assicurativo della State Farm. Avevamo già esaurito i soliti argomenti – clima e football – e avevamo sfiorato l’argomento politica, cosa che comunque veniva fatta sempre con grande attenzione. Era un tipico pranzo del Civic Club: trenta minuti per mangiare, seguiti da trenta minuti di un oratore, in genere non troppo eccitante. In ogni caso, in quel giorno memorabile non mi sarebbe stato consentito ascoltare il discorso. Ci fu una certa confusione all’ingresso della sala e poi, all’improvviso, una squadra di agenti federali armati fino ai denti fece irruzione con l’aria di volerci fare fuori tutti. Una squadra SWAT, in completa tenuta ninja: uniformi nere, spessi giubbotti antiproiettile, grosse armi da fuoco e quegli elmetti resi celebri dai soldati di Hitler. Uno di loro urlò: «Malcolm Bannister!». Io mi alzai in piedi d’istinto farfugliando: «Ma cosa diavolo...?». Almeno cinque fucili automatici vennero istantaneamente puntati su di me. «Mani in alto!» strillò l’impavido caposquadra, e io alzai le mani, che nel giro di pochi secondi mi vennero abbassate e portate dietro la schiena. E poi, per la prima volta in vita mia, sentii l’indescrivibile morsa delle manette ai polsi. È una sensazione orribile, e indimenticabile. Fui spintonato lungo lo stretto varco fra i tavoli e fuori dalla sala. L’ultima cosa che sentii, fu il sindaco che urlava: «Tutto questo è oltraggioso!». Inutile dire che quella drammatica invasione ebbe un effetto deprimente sul resto della riunione del Civic Club. Circondato da uno sciame di paramilitari, fui scortato attraverso l’atrio e fuori dall’hotel. Qualcuno aveva cortesemente fatto filtrare la notizia alla rete televisiva locale e una troupe riprese la scena di me che venivo caricato sul sedile posteriore di una Chevrolet Tahoe nera, in mezzo a due gorilla. Mentre ci dirigevamo verso il carcere cittadino, domandai: «Tutto questo è davvero necessario?». Il capo, seduto di fianco al conducente, disse: «Sta’ zitto» senza neppure voltarsi. «Be’, io non sono tenuto a stare zitto. Potete arrestarmi, ma non potete farmi tacere. Lo capite?» «Sta’ zitto.» Il gorilla alla mia destra mi posò la canna del fucile sul ginocchio. «Sposti quel fucile, per favore» gli dissi, ma il fucile non si mosse. Il viaggio continuò. «Voialtri vi eccitate con queste esibizioni?» domandai. «Dev’essere terribilmente esaltante schizzare in giro come dei veri duri e fare i prepotenti con le persone innocenti, tipo Gestapo.» «Ti ho detto di stare zitto.» «E io ho detto che non sto zitto. Avete un mandato d’arresto?» «Sì.» «Me lo faccia vedere.» «Te lo farò vedere in prigione. Per il momento sta’ zitto.» «Perché non stai zitto tu, okay?» Gli vedevo un pezzo di collo sotto l’elmetto tedesco da combattimento e notai che stava avvampando di rabbia. Feci un respiro profondo e mi raccomandai di mantenere la calma. L’elmetto. Ne avevo indossato uno dello stesso tipo durante il mio periodo nei marine, quattro anni di servizio attivo che avevano compreso vere battaglie durante la prima Guerra del Golfo. Secondo reggimento, ottavo battaglione, seconda divisione, corpo dei marine degli Stati Uniti. Eravamo stati i primi militari americani a ingaggiare uno scontro con gli iracheni in Kuwait. Non era stato un gran conflitto, ma avevo visto un numero sufficiente di morti e feriti, da entrambe le Teili. Adesso ero circondato da un branco di soldatini giocattolo che non avevano mai sentito un colpo esploso in un vero combattimento e non erano in grado di correre per un chilometro senza crollare. Ed erano i buoni. Al nostro arrivo alla prigione trovammo un fotografo del quotidiano della città. I miei gorilla mi fecero entrare lentamente, assicurandosi che venissi fotografato per bene. Era la loro versione della “passeggiata del colpevole”. Sarei presto venuto a sapere che un’altra squadra di duri aveva fatto irruzione nello studio legale Copeland, Reed & Bannister più o meno mentre io stavo pranzando con gli altri membri del Civic Club. Con brillante capacità di previsione e meticolosa pianificazione, la forza d’urto congiunta aveva aspettato fino a mezzogiorno, ora in cui l’unica persona presente in studio era la povera Mrs Henderson. In seguito la nostra segretaria avrebbe riferito che gli agenti erano piombati nello studio con le armi spianate, strillando, imprecando e minacciando. Le avevano gettato un mandato di perquisizione sulla scrivania, l’avevano fatta sedere accanto alla finestra, minacciando di arrestarla se avesse fatto qualcosa di più che respirare, e poi avevano proceduto a setacciare i nostri modesti uffici. Avevano portato via tutti i computer, le stampanti e parecchie decine di scatoloni pieni di pratiche. A un certo punto Mr Copeland era tornato da pranzo. Alle sue proteste, gli avevano puntato contro una pistola, ordinandogli di sedersi di fianco a una Mrs Henderson in lacrime. Il mio arresto era sicuramente una sorpresa. Era da più di un anno che avevo a che fare con l’FBI. Avevo assunto un legale e insieme avevamo fatto tutto il possibile per collaborare. Avevo superato due test al poligrafo effettuati dagli esperti dell’FBI. Avevo consegnato tutti i documenti che, come avvocato, mi era eticamente consentito esibire. Gran Teile di tutto questo l’avevo tenuto nascosto a Dionne, la quale però sapeva che ero preoccupato da morire. Combattevo con l’insonnia. Mi sforzavo di mangiare anche se non avevo appetito. Ma finalmente, dopo quasi dodici mesi vissuti nel terrore di sentir bussare alla porta, l’FBI aveva informato il mio legale che il governo non nutriva più alcun interesse nei miei confronti. Il governo aveva mentito, non per la prima e nemmeno per l’ultima volta. All’interno del carcere, un luogo che visitavo almeno due volte alla settimana, c’era un’altra squadra di agenti. Indossavano tutti giacche a vento blu con la scritta FBI in vistosi caratteri gialli sulla schiena ed erano in gran fermento, anche se non riuscivo a capire esattamente cosa stessero facendo. I poliziotti locali, molti dei quali conoscevo bene, se ne stavano da una Teile e mi guardavano con espressione confusa e compassionevole. Era davvero necessario mandare una ventina di agenti federali per arrestarmi e sequestrare le mie pratiche? Ero andato a piedi dal mio studio al George Washington Hotel: un qualsiasi piedipiatti idiota in pausa pranzo avrebbe potuto bloccarmi ed effettuare l’arresto. Ma questo avrebbe eliminato tutta la gioia da ciò che quelle persone così importanti facevano per vivere. Mi portarono in una piccola stanza, mi misero a sedere davanti a un tavolo, mi tolsero le manette e mi ordinarono di aspettare. Qualche minuto dopo entrò un uomo in abito scuro. «Sono l’agente speciale Don Connor, dell’FBI.» «È un vero piacere» dissi. Connor gettò alcune carte sul tavolo. «Questo è il suo mandato d’arresto.» Poi lasciò cadere un grosso fascio di fogli attaccati con la cucitrice. «E questo è l’atto d’accusa formale. Le do qualche minuto per leggere tutto.» Si voltò e uscì, sbattendo la porta con la maggior forza possibile. Era una spessa porta di metallo, che vibrò e tuonò fragorosa. Il suono rimbalzò echeggiando nella stanza per qualche secondo. Un rumore che non dimenticherò mai. 6 Tre giorni dopo il mio primo colloquio con il direttore Wade vengo convocato di nuovo nel suo ufficio. Entro e lo trovo da solo, impegnato in un’importante telefonata. Mi fermo imbarazzato accanto alla porta, in attesa. Wade conclude la conversazione con un secco «Va bene», poi si alza in piedi e mi dice: «Vieni con me». Varchiamo una porta laterale ed entriamo nell’adiacente sala riunioni, tinteggiata nel tipico verde governativo e dotata di un numero di sedie metalliche di gran lunga superiore a quello che potrà mai essere utilizzato. L’anno scorso un controllo contabile ha evidenziato che il diTeilimento dell’amministrazione penitenziaria aveva acquistato, per “uso amministrativo”, quattromila sedie a ottocento dollari l’una. Il fabbricante vendeva all’ingrosso la medesima sedia a settantanove dollari. Non dovrebbe importarmene, ma lavorare per trenta centesimi l’ora ti regala una prospettiva diversa sulla gestione del denaro. «Siediti» mi dice il direttore, e io mi siedo su una delle brutte sedie strapagate. Wade si accomoda dall’altro lato del tavolo perché deve esserci sempre una barriera tra di noi. Mi guardo intorno e conto ventidue sedie. Lascio perdere. «L’altro giorno, dopo che te ne sei andato, ho chiamato Washington» dice Wade in tono grave, come se parlasse regolarmente con la Casa Bianca. «Il diTeilimento mi ha suggerito di agire secondo la mia discrezione. Ho riflettuto per qualche ora e poi mi sono messo in contatto con l’FBI a Roanoke. Hanno mandato due agenti, che adesso stanno aspettando nel corridoio.» Mantengo un’espressione impassibile, anche se la notizia mi colpisce. Wade mi punta un dito contro e continua: «Ti avverto, Bannister. Se questa storia si rivela un imbroglio e mi metti in una situazione imbarazzante, farò tutto quello che è in mio potere per renderti la vita insopportabile». «Non è un imbroglio, direttore. Glielo giuro.» «Non so perché ti credo.» «Non se ne pentirà.» Estrae da una tasca gli occhiali da lettura, li inforca a metà del naso e legge un foglietto. «Al telefono ho parlato con il vicedirettore, Victor Westlake, l’uomo che dirige le indagini. Ha mandato due dei suoi a fare due chiacchiere con te: l’agente Hanski e l’agente Erardi. Non ho ancora fatto il tuo nome, per cui non sanno niente.» «Grazie, direttore.» «Resta qui.» Dà uno schiaffetto al ripiano del tavolo, si alza in piedi ed esce dalla sala riunioni. Mentre aspetto di sentire passi che si avvicinano, avverto un dolore acuto allo stomaco. Se questa cosa non funziona, resterò qui dentro per altri cinque anni, più tutto quello che riusciranno ad aggiungerci. L’agente speciale Chris Hanski, quello al comando, ha più o meno la mia età e parecchi capelli grigi. L’agente Alan Erardi è la sua spalla, più giovane di lui. Ho letto su un quotidiano che al momento sono quaranta gli agenti dell’FBI impegnati nel caso Fawcett e ho l’impressione che questi due siano parecchio in basso nella catena di comando. Questo primo incontro è importante, come lo saranno tutti, ma è chiaro che l’FBI ha mandato due soldati semplici per darmi un’occhiata. Il direttore del carcere non è presente. Credo che sia di nuovo nel suo ufficio, non molto distante, e che abbia un orecchio incollato alla porta. I due cominciano senza usare penne e blocchi per appunti, un segnale evidente del fatto che sono venuti qui solo per divertirsi un po’. Niente di serio. Immagino che non siano abbastanza in gamba da rendersi conto che ho passato ore e ore seduto di fronte ad agenti dell’FBI. «E così lei vuole fare un accordo» comincia Hanski. «Io so chi ha ucciso il giudice Fawcett e perché. Se queste informazioni hanno qualche valore per l’FBI, sì, penso che si possa concludere un accordo.» «Lei Teile dal presupposto che noi non sappiamo ancora chi è il colpevole» osserva Hanski. «Sono sicuro di no. Altrimenti perché sareste qui?» «Ci è stato detto di venire perché stiamo controllando ogni possibile pista, anche se dubitiamo seriamente che la sua possa portare da qualche Teile.» «Mettetemi alla prova.» I due si scambiano un’occhiata d’intesa. Che divertimento. «Quindi lei ci dà il nome. E cosa ottiene in cambio?» «Esco di prigione e voi mi garantite protezione.» «Tutto così semplice?» «No, in realtà è molto complicato. Il tizio di cui parlo è un soggetto pericoloso e ha amici addirittura più pericolosi di lui. Inoltre non sono disposto ad aspettare per due anni che venga condannato. Io vi do il nome ed esco subito. Immediatamente.» «E se non viene condannato?» «Quello è un problema vostro. Se incasinerete l’accusa, non potrete certo incolpare me.» A questo punto Erardi estrae il suo blocco per appunti, toglie il cappuccio a una penna da due soldi e scribacchia qualcosa. Ho la loro attenzione. Continuano a darsi molto da fare per sembrare indifferenti, ma questi ragazzi sono sotto pressione. La loro piccola task force sta annaspando perché, secondo i giornali, non c’è alcuna pista credibile. «E se ci dà un nome sbagliato?» insiste Hanski. «Supponiamo che noi cominciamo a dare la caccia all’uomo sbagliato: nel frattempo lei è libero.» «Non sarò mai libero.» «Sarà fuori di galera.» «A guardarmi le spalle per il resto della vita.» «Non abbiamo mai perso un informatore inserito nel programma protezione testimoni. Più di ottomila e in continuo aumento.» «È quello che pubblicizzate. Francamente non mi preoccupo molto delle vostre statistiche o di quello che non è successo agli altri. Mi preoccupo della mia pelle.» C’è una pausa mentre Erardi smette di scrivere e decide cosa dire. «Il suo tizio mi dà l’impressione di far Teile di una gang, magari di un trafficante di droga. Cos’altro ci può dire?» «Niente, e io non vi ho detto niente. Potete fare tutte le supposizioni che volete.» Hanski sorride, anche se non c’è nulla di divertente. «Dubito che il suo piano per uscire di prigione possa fare molta impressione sul nostro capo. A tutt’oggi abbiamo avuto almeno altri due detenuti che ci hanno contattato sostenendo di avere informazioni preziose. E naturalmente anche loro vogliono uscire di galera. Non è una cosa insolita.» Non ho modo di sapere se questo sia vero, ma mi sembra credibile. Il nodo che sento nello stomaco non si è ancora allentato. Mi stringo nelle spalle, sorrido, mi esorto a mantenere la calma. «Potete giocare questa Teilita nel modo che preferite. Ovviamente la decisione è vostra. Potete continuare a sbattere la testa contro il muro, o sprecare il vostro tempo con gli altri due detenuti. Sta a voi scegliere. Ma se volete sapere il nome della persona che ha ucciso il giudice Fawcett, io ve lo posso dire.» «Qualcuno che lei ha conosciuto in prigione?» mi chiede Erardi. «O forse fuori. Non lo saprete finché non concluderemo un accordo.» C’è un lungo silenzio. I due agenti mi fissano e io fisso loro. Alla fine Erardi chiude il suo blocco e si rimette la penna in tasca. «Okay. Riferiremo al nostro capo» dice Hanski. «Sapete dove trovarmi.» Diverse volte alla settimana incontro la mia Gang Bianca sulla pista di atletica. Camminiamo in cerchio intorno al campo che usiamo per giocare a calcio o a flag football. Carl, l’optometrista, uscirà tra qualche mese. Kermit, lo speculatore immobiliare, deve scontare ancora due anni. Wesley, il senatore, dovrebbe uscire più o meno insieme a me. Mark è l’unico con la causa ancora in appello. È qui da diciotto mesi e dice che il suo avvocato è ottimista, anche se ammette con franchezza di aver falsificato qualche documento ipotecario. Non parliamo molto dei nostri reati, come è normale in prigione. Chi eri o cosa facevi fuori, qui non è importante e inoltre è troppo doloroso da ricordare. La moglie di Wesley ha appena chiesto il divorzio e lui la sta prendendo molto male. Dato che Kermit e io ci siamo già passati, gli diamo consigli e cerchiamo di risollevargli il morale. Mi piacerebbe molto intrattenere i miei compagni con i Teilicolari della visita dell’ FBI, ma devo mantenere il silenzio. Se il mio piano funzionerà, un giorno loro si ritroveranno qui per la passeggiata e io non ci sarò, trasferito improvvisamente in un altro campo per ragioni che non sapranno mai. 7 Il quartier generale temporaneo della task force dell’FBI incaricata del caso Fawcett era un capannone in una zona industriale non lontana dal Roanoke Regional Airport. L’ultima volta era stato affittato a una società che importava gamberi dall’America Centrale, li surgelava e li conservava per anni. Quasi immediatamente il capannone fu ribattezzato “il Freezer”. Offriva molto spazio, isolamento e privacy, lontano dai media. Al suo interno i carpentieri avevano eretto rapidamente pareti, ricavando stanze, uffici, corridoi e sale riunioni. Tecnici provenienti da Washington avevano lavorato ventiquattr’ore al giorno per installare i più recenti strumenti e gadget ad alta tecnologia per le comunicazioni, l’elaborazione dati e la sicurezza. C’era stato un continuo viavai di camion carichi di mobilio e attrezzature finché nel CC – centro di comando – ci furono più scrivanie e tavoli di quanti ne sarebbero mai stati utilizzati. Una flotta di SUV a nolo riempì il parcheggio. Fu ingaggiato un servizio di catering per la consegna di tre pasti al giorno alla task force, che arrivò rapidamente a contare settanta elementi, circa quaranta agenti più il personale d’ufficio. Nessun limite di budget e nessuna preoccupazione per i costi. Dopo tutto, la vittima era un giudice federale. Venne firmato un contratto d’affitto per sei mesi, ma dopo tre settimane di scarsi progressi si era diffusa tra i federali la sensazione che forse avrebbero dovuto trattenersi più a lungo. A Teile un breve elenco di sospettati scelti a caso, tutti noti per essere soggetti violenti e per essere comparsi davanti a Fawcett negli ultimi diciotto anni, non c’erano vere piste da seguire. Nel 2002 un certo Stacks aveva scritto al giudice una lettera minatoria dal carcere. Rintracciato al lavoro in un negozio di liquori a Panama City Beach, Florida, Stacks dimostrò di avere un alibi per il weekend durante il quale erano stati uccisi Fawcett e Ms Clary. Stacks inoltre non metteva piede in Virginia da almeno cinque anni. Nel 1999 un narcotrafficante di nome Ruiz aveva maledetto il giudice in spagnolo quando lui lo aveva condannato a vent’anni di reclusione. Ruiz era ancora rinchiuso in un carcere di media sicurezza e, dopo pochi giorni trascorsi a scavare nel suo passato, l’FBI aveva appurato che i componenti della sua organizzazione di corrieri della coca erano tutti o morti o in galera. Una squadra esaminò metodicamente ogni causa presieduta da Fawcett durante i suoi diciotto anni sullo scranno. Era stato un vero cavallo da tiro: aveva gestito trecento casi all’anno, sia civili che penali, mentre la media di un giudice federale è intorno alle duecentoventicinque cause. Fawcett aveva mandato in galera circa tremilacento imputati, fra uomini e donne. Lavorando in base al presupposto – fragile, secondo lo stesso FBI – che l’assassino fosse uno di loro, una squadra bruciò centinaia di ore aggiungendo nomi alla lista dei possibili sospetti e poi eliminandoli. Un’altra squadra studiò i processi, civili e penali, ancora in corso al momento dell’omicidio del giudice. Un’altra squadra ancora dedicò tutto il suo tempo alla causa Armanna Mines, riservando Teilicolare attenzione a un paio di ambientalisti fanatici ai quali Fawcett non stava molto simpatico. Dal momento stesso in cui fu pronto a Teilire, il Freezer diventò un alveare ronzante di tensione, con riunioni urgenti, nervi scoperti, un’infinità di vicoli ciechi, carriere in bilico e, sempre, qualcuno che strillava da Washington. La stampa telefonava di continuo. I blogger alimentavano la frenesia generale con voci fantasiose e palesemente false. Poi nel quadro entrò un detenuto di nome Malcolm Bannister. A capo della task force c’era Victor Westlake, un agente dalla carriera trentennale che vantava un bell’ufficio con uno splendido panorama nell’Hoover Building in Pennsylvania Avenue a Washington. Da quasi tre settimane, però, era intrappolato in una stanza senza finestre e verniciata di fresco al centro del CC. Non era certo la sua prima trasferta. Westlake già da anni si era creato la reputazione di eccezionale organizzatore, in grado di precipitarsi sulla scena del crimine, schierare le truppe, occuparsi di mille dettagli, pianificare l’attacco e risolvere il caso. Una volta aveva trascorso un anno intero in un motel nei pressi di Buffalo facendo la posta a un genio che si eccitava mandando pacchi bomba agli ispettori sanitari federali. Era risultato essere il genio sbagliato, ma Westlake non aveva commesso l’errore di arrestare la sua preda. E due anni dopo aveva inchiodato il dinamitardo. Era nel suo ufficio, come sempre in piedi dietro la scrivania, quando entrarono gli agenti Hanski ed Erardi. Dato che il capo non era seduto, rimasero in piedi anche loro. Westlake riteneva che fosse malsano, addirittura letale, restare seduti per ore dietro la scrivania. «Okay, vi ascolto» abbaiò, facendo schioccare le dita. «Si chiama Malcolm Bannister» disse subito Hanski. «Nero, quarantatré anni, condannato dalla corte federale di Washington a dieci anni per violazioni al RICO. Ex avvocato di Winchester, Virginia. Dice di poterci dare il nome del killer, e anche il movente, ma naturalmente vuole uscire di galera.» «Vuole uscire subito» precisò Erardi. «E chiede anche protezione.» «Sai che sorpresa. Un detenuto che vuole uscire. È attendibile?» Hanski si strinse nelle spalle. «Per essere un detenuto, credo di sì. Secondo il direttore del carcere non è uno che spara cazzate, le sue note disciplinari sono immacolate. Il direttore dice che dovremmo ascoltarlo.» «Cosa vi ha dato Bannister?» «Per ora niente. È molto furbo. Può darsi che in effetti sappia qualcosa e, se è così, questa potrebbe essere la sua unica occasione per uscire.» Westlake prese a camminare sul liscio pavimento di cemento dietro la scrivania, arrivò alla parete davanti alla quale c’era ancora un po’ di segatura fresca e tornò indietro. «Che tipo di avvocato era? Penalista? Difendeva trafficanti di droga?» Fu Hanski a rispondere: «Piccola città, avvocato generico, un po’ di penale, ma non molto lavoro in aula. Ex marine». Avendo lui stesso un passato nei marine, Westlake sembrò apprezzare la cosa. «Stato di servizio?» «Quattro anni, congedato con onore. Ha combattuto nella prima Guerra del Golfo. Suo padre è stato marine e anche poliziotto della Stradale in Virginia.» «Cosa ha rovinato Bannister?» «Non ci crederà: Bustarella Barry.» Westlake aggrottò la fronte e allo stesso tempo sorrise. «Non è vero!» «Sul serio. Bannister si era occupato di certe transazioni immobiliari per conto di Barry ed è rimasto travolto dalla tempesta. Come ricorderà, la giuria ritenne tutti colpevoli delle accuse di violazioni al RICO e cospirazione. Credo che siano stati processati in otto, tutti insieme. Bannister era un pesce piccolo, rimasto impigliato in una grande rete.» «Collegamenti con Fawcett?» «Non ancora. Il nome di Bannister è saltato fuori solo tre ore fa.» «Avete un piano?» «Più o meno» rispose Hanski. «Se accettiamo l’idea che Bannister conosce l’assassino, allora possiamo presumere con una certa sicurezza che l’abbia incontrato in prigione. Dubito che possa essere successo nella tranquilla Winchester, è molto più probabile che le loro strade si siano incrociate in galera. Bannister è dentro da cinque anni e ha trascorso i primi ventidue mesi a Louisville, Kentucky, in un carcere di media sicurezza che ospitava duemila detenuti. Dopodiché è passato a Frostburg, un campo con seicento ospiti.» «Un mucchio di gente» osservò Westlake. «E i detenuti vanno e vengono.» «Giusto, per cui cominciamo dal posto più logico. Ci procuriamo la sua storia carceraria, i nomi dei compagni di cella, forse di dormitorio. Andiamo nelle due prigioni, parliamo con i direttori, i caposettore, gli agenti penitenziari, con tutti quelli che possono sapere qualcosa di Bannister e dei suoi amici. Cominciamo a raccogliere nomi e vediamo quanti di loro hanno incrociato Fawcett.» «Bannister dice che l’assassino ha amici pericolosi» aggiunse Erardi. «Da qui la sua richiesta di protezione. Verrebbe da pensare a una gang. Una volta che cominciamo a mettere insieme dei nomi, ci concentreremo su quelli con collegamenti a gang.» Una pausa, poi un dubbioso Westlake domandò: «Tutto qui?». «È il massimo che possiamo fare, per il momento.» Westlake unì i talloni, arcuò la schiena e intrecciò le mani dietro la testa. Si stirò, fece un respiro profondo, si stirò di nuovo e disse: «Okay. Mettete insieme la storia carceraria di Bannister e datevi una mossa. Di quanti uomini avete bisogno?». «Può darcene due?» «No, ma li avrete. Adesso andate. Al lavoro.» Bustarella Barry. Il cliente che non avevo mai visto finché in una grigia mattina ci hanno trascinato tutti in un’aula del tribunale federale e ci hanno letto a voce alta le imputazioni. Lavorando in un modesto studio generico con vetrina sulla strada impari i fondamentali di molti ordinari affari legali, ma è difficile specializzarsi. Io cercavo di evitare divorzi e fallimenti e non mi è mai piaciuto l’immobiliare, ma per sopravvivere dovevo spesso accettare chiunque e qualunque cosa varcasse la porta dello studio. Stranamente, sarebbe stata proprio una transazione immobiliare a determinare la Caduta. La segnalazione mi arrivò da un compagno di università che lavorava in uno studio di medie dimensioni a Washington. Lo studio aveva un cliente che desiderava acquistare un certo casino di caccia nella contea di Shenandoah, ai piedi dei monti Allegheny, circa un’ora a sudovest di Winchester. Il cliente desiderava la massima riservatezza ed esigeva l’anonimato, il che avrebbe dovuto essere il primo segnale d’allarme. Il prezzo di vendita era di quattro milioni di dollari e, dopo aver mercanteggiato un po’, riuscii a ottenere una parcella forfettaria di centomila dollari per Copeland, Reed & Bannister per la definizione dell’affare. Né io né i miei soci avevamo mai visto una parcella del genere ed eravamo tutti e tre molto eccitati, all’inizio. Misi da Teile tutte le altre pratiche e andai a verificare la situazione all’ufficio del catasto della contea di Shenandoah. Il casino di caccia era stato fatto costruire circa vent’anni prima da alcuni medici amanti della caccia al gallo cedrone, ma, come capita spesso in iniziative del genere, tra i soci era nato un dissenso. Un dissenso serio, che aveva comportato avvocati e cause legali, addirittura un paio di fallimenti. Comunque, in due o tre settimane sbrogliai la matassa e non fu un problema assicurare al mio anonimo cliente che il titolo di proprietà era in ordine. Venne stabilita la data di stipulazione e io preparai tutti i contratti e gli atti necessari. Si trattava di un mucchio di carte, ma d’altra Teile avremmo incassato una parcella piuttosto sostanziosa. La data venne posticipata di un mese e io chiesi al mio vecchio compagno di università cinquantamila dollari, vale a dire metà della parcella. Non era una richiesta insolita, e dato che a quel punto avevo già investito un centinaio di ore di lavoro, volevo essere pagato. Il mio amico mi richiamò informandomi che il cliente non era d’accordo. Non un grosso problema, pensai. In una tipica transazione immobiliare, gli avvocati vengono pagati solo alla conclusione dell’affare. Venni informato inoltre che il mio cliente, una società, aveva cambiato nome. Rifeci tutti i documenti e aspettai. La data venne di nuovo posticipata e i venditori cominciarono a minacciare di non volerne fare più niente. In quel periodo conoscevo solo vagamente il nome e la reputazione di un faccendiere che operava all’interno della Beltway, cioè a livello del governo federale: un certo Barry Rafko, meglio noto come Bustarella Barry. Sui cinquant’anni, aveva trascorso la maggior Teile della sua vita da adulto arrabattandosi in giro per Washington alla ricerca di un modo poco faticoso per raccattare qualche dollaro. Era stato consulente, stratega, analista, addetto alla raccolta fondi e portavoce, e aveva lavorato ai piani più bassi di due o tre campagne elettorali di rappresentanti al Congresso e senatori, sia democratici che repubblicani. A Barry non importava: se lo pagavano, poteva fare lo stratega o l’analista da uno qualunque dei due lati della barricata. In ogni caso aveva trovato la sua vera strada quando, insieme a un socio, aveva aperto un bar nei pressi del Campidoglio. Barry aveva assunto alcune giovani prostitute perché servissero al bar in minigonna, e quasi da un giorno all’altro il locale era diventato uno dei mercati della carne preferiti dalle legioni di funzionari che affollavano Capitol Hill. Poi il locale era stato scoperto da alcuni membri poco importanti del Congresso e da burocrati di medio livello, e Barry era entrato nel giro giusto. Con le tasche piene di soldi, era passato all’iniziativa successiva, una steakhouse di lusso a due isolati dal bar. Barry offriva alla sua clientela di lobbisti stupende bistecche accompagnate da ottimi vini a prezzi ragionevoli, e nel giro di poco tempo poteva già vantare senatori con il loro tavolo preferito. Appassionato di sport, Barry comprava valanghe di biglietti – per le Teilite dei Redskins, dei Capitals, dei Wizards e dei Georgetown Hoyas – che poi regalava agli amici. A quel punto aveva già fondato la sua società di “relazioni governative”, che stava crescendo rapidamente. Poi aveva litigato con il suo socio e ne aveva rilevato la quota. Solo, ricco e spinto dall’ambizione, aveva alzato il tiro e mirato ai vertici della sua professione. Del tutto privo di scrupoli etici, era diventato uno dei più aggressivi procacciatori d’affari di Washington. Se un ricco cliente desiderava una nuova scappatoia fiscale, Barry era in grado di pagare qualcuno che la redigesse, la inserisse nella normativa, convincesse i suoi amici ad appoggiarla e poi di riuscire magistralmente a nascondere il tutto. Se un ricco cliente aveva bisogno di espandere una sua fabbrica, Barry poteva organizzare un accordo in base al quale il rappresentante al Congresso avrebbe ottenuto lo stanziamento dei fondi, inviato il denaro alla fabbrica e intascato una fetta notevole da destinare ai suoi sforzi per la rielezione. E tutti sarebbero stati contenti. Nel suo primo scontro con la legge, Barry era stato accusato di aver fatto scivolare contanti nelle tasche del consigliere di un senatore. L’accusa non aveva retto, ma il soprannome sì: Bustarella Barry. Dato che operava nel lato più oscuro di un’attività già di per sé spesso oscura, Barry era consapevole del potere del denaro, e del sesso. Il suo yacht sul Potomac diventò una nota love boat, famosa per le feste scatenate e il gran numero di giovani donne. Possedeva un campo da golf in South Carolina, dove ospitava per lunghi weekend membri del Congresso, di solito senza le mogli. Ma più diventava potente, più si avventurava in operazioni ad alto rischio. I vecchi amici si allontanarono, spaventati dai guai che ormai sembravano inevitabili. Il nome di Barry comparve nel corso di un’indagine della commissione etica interna al Congresso. Il “Washington Post” fiutò la pista e Barry Rafko, un uomo che aveva sempre bramato l’attenzione, si ritrovò ad averne più di quanta ne avesse mai desiderata. Io non avevo idea, né modo di sapere, che il casino di caccia era uno dei suoi progetti. Il nome della società cambiò di nuovo e tutta la documentazione venne rifatta. Un’altra data fissata per la firma del contratto venne annullata. Poi arrivò una nuova proposta: il mio cliente voleva affittare il casino per duecentomila dollari al mese, detraendo poi l’importo delle rate dal prezzo di acquisto. Questo comportò una settimana di intense dispute e discussioni, ma alla fine si arrivò a un accordo. Redassi di nuovo l’intera documentazione e insistetti perché al mio studio fosse pagata metà della parcella, cosa che avvenne. Mr Copeland e Mr Reed si sentirono molto sollevati. Nel momento in cui i contratti furono finalmente sottoscritti, scoprii che il mio cliente era una società offshore con sede nella minuscola isola di St Kitts. Io non avevo ancora idea di chi ci fosse dietro. I contratti vennero firmati da un invisibile rappresentante della società giù nei Caraibi e rispediti il giorno dopo al mio studio. In base agli accordi, il mio cliente avrebbe effettuato un bonifico sul conto fiduciario del nostro studio di quattrocentocinquantamila dollari e rotti, somma sufficiente a pagare i primi due mesi di affitto, più il saldo della nostra parcella, più altre spese varie. Da Teile mia, avrei emesso un assegno di duecentomila dollari a favore dei venditori per ognuno dei primi due mesi, poi il mio cliente avrebbe reintegrato i fondi. Dopo dodici mesi di questa procedura, l’affitto si sarebbe trasformato in una vendita e il nostro piccolo studio avrebbe avuto diritto a un’altra consistente parcella. Quando i fondi arrivarono alla nostra banca, il direttore mi telefonò per informarmi che il nostro conto aveva appena ricevuto non quattrocentocinquantamila dollari, ma quattro milioni e mezzo. Immaginai che qualcuno si fosse lasciato prendere la mano dagli zeri, e poi ci sono cose peggiori che ritrovarsi con troppi soldi in banca. Ma qualcosa non quadrava. Cercai di contattare a St Kitts la società di comodo che tecnicamente era il mio cliente, ma mi passarono da una persona all’altra e non arrivai a nulla. Telefonai al compagno di università che mi aveva trasmesso la pratica e lui mi promise di fare qualche controllo. Io pagai l’affitto del primo mese e la parcella del nostro studio e poi aspettai istruzioni per la restituzione della somma in eccesso. Trascorsero giorni, poi settimane. Un mese dopo il direttore della banca telefonò per comunicarci che sul nostro conto erano appena piombati altri tre milioni di dollari. A quel punto Mr Reed e Mr Copeland erano profondamente turbati. Diedi istruzioni alla banca di sbarazzarsi del denaro, ritrasmettendolo con bonifico bancario alla fonte da cui proveniva, e di farlo in fretta. Il direttore della banca si diede da fare per un paio di giorni, ma solo per scoprire che il conto a St Kitts era stato chiuso. Finalmente il mio collega mi mandò un’e-mail nella quale mi dava istruzioni di versare metà del denaro su un conto a Grand Cayman e l’altra metà su un conto a Panamá. Quale piccolo avvocato di provincia, avevo zero esperienza in fatto di bonifici su conti cifrati, ma pochi minuti di ricerche su Google mi rivelarono che mi stavo avventurando alla cieca in alcuni dei più famigerati paradisi fiscali del mondo. Desiderai non avere mai accettato di lavorare per un cliente anonimo, nonostante i soldi. Il bonifico a Panamá, circa tre milioni e mezzo, mi tornò indietro. Io strillai al mio compagno di università, che a sua volta strillò a qualcun altro. Il denaro se ne restò tranquillo per due mesi maturando interessi, anche se da un punto di vista etico noi non potevamo trattenerne nemmeno la più piccola Teile. L’etica esigeva inoltre che io prendessi tutte le misure necessarie per proteggere quei soldi indesiderati. Non erano miei e di certo io non avanzavo alcuna pretesa, ma in ogni caso ero tenuto a salvaguardarli. Innocentemente, o forse stupidamente, avevo consentito che il denaro sporco di Bustarella Barry riposasse sereno sotto il controllo dello studio Copeland, Reed & Bannister. Una volta in possesso del casino di caccia, Barry procedette a una rapida ristrutturazione, lo abbellì un po’, costruì un centro benessere e aggiunse un eliporto. Affittò un elicottero Sikorsky S-76 con il quale trasportare dieci dei suoi migliori amici da Washington al casino in soli venti minuti. In un tipico venerdì pomeriggio venivano effettuati diversi voli navetta e la festa cominciava. In quella fase della sua carriera, Barry ormai aveva lasciato perdere quasi tutti i burocrati e i lobbisti per concentrarsi principalmente su membri del Congresso e rispettivi capi dello staff. Al casino di caccia tutto era disponibile: ottimo cibo e vini eccellenti, sigari cubani, droga, scotch di trent’anni e ragazze di venti. Ogni tanto veniva organizzata una caccia al gallo cedrone, ma di solito gli ospiti erano più interessati allo stupefacente assortimento di bionde slanciate a loro disposizione. La ragazza era originaria dell’Ucraina. Durante il processo – il mio processo – il suo protettore avrebbe dichiarato in un inglese dal pesante accento di essere stato pagato centomila dollari per la giovane, che era stata portata al casino dove le era stata assegnata una stanza. I contanti gli erano stati consegnati da un tizio che in seguito avrebbe dichiarato, come teste per l’accusa, di essere stato uno dei molti fattorini di Barry. La ragazza morì. L’autopsia stabilì che era morta per overdose dopo una lunga notte di baldoria in compagnia di Barry e dei suoi amici di Washington. Girarono voci secondo le quali la mattina non si era più svegliata nel letto che divideva con un membro del Congresso, ma questo non fu mai provato. Barry dispose i suoi carri in cerchio molto prima dell’arrivo delle autorità sulla scena, e con chi avesse dormito la ragazza durante la sua ultima notte su questa terra non si sarebbe mai saputo. Si scatenò una tempesta mediatica intorno a Barry, i suoi affari, i suoi amici, i suoi jet, yacht, elicotteri, ristoranti, ville e ogni dettaglio della sua sordida influenza. E mentre la stampa calava in massa su di lui, i suoi vecchi amici e clienti scomparvero velocemente. Indignati membri del Congresso andavano a caccia di interviste ed esigevano a gran voce audizioni e indagini. La storia prese una piega anche peggiore quando a Kiev venne rintracciata la madre della ragazza. La donna esibì un certificato di nascita da cui risultava che la figlia aveva solo sedici anni. Una schiava del sesso sedicenne che Teilecipava a festini con membri del Congresso in un casino di caccia nei monti Allegheny, ad appena due ore di auto dal Campidoglio. Il rinvio a giudizio originale era di cento pagine e addebitava a quattordici imputati uno sbalorditivo assortimento di reati. Io ero uno dei quattordici e il mio presunto crimine consisteva in ciò che viene comunemente definito riciclaggio di denaro sporco. Si sosteneva che, consentendo a una delle società anonime di Barry Rafko di parcheggiare denaro nel conto fiduciario del mio studio, io avevo aiutato lo stesso Rafko a gestire i soldi sporchi che lui rubacchiava ai suoi clienti, ripulendoli un po’ off-shore e poi trasformandoli in un bene di valore, il casino di caccia. Ero anche accusato di avere aiutato Barry a nascondere denaro all’FBI, al fisco e ad altri. Le manovre preprocessuali eliminarono alcuni tra gli imputati; a molti fu permesso di sganciarsi dal gruppo e di collaborare con il governo o di avere un processo separato. Dal giorno del rinvio a giudizio a quello del processo il mio avvocato e io presentammo ventidue istanze; una sola venne accolta. E fu una vittoria inutile. Il diTeilimento di Giustizia, tramite l’ FBI e l’ufficio del procuratore federale di Washington, bombardò con tutte le munizioni disponibili Barry Rafko e i suoi sodali, tra cui un rappresentante al Congresso e un suo collaboratore. Non contava che un paio di noi potessero essere innocenti, così come non ebbe importanza che la nostra versione della verità venisse distorta dal governo. Fu così che mi ritrovai a sedere in un’affollata aula di tribunale in compagnia di altri sette imputati, compreso il più nefasto faccendiere politico che Washington avesse prodotto da decenni. Sì, ero colpevole. Colpevole di stupidità per avere consentito a me stesso di cacciarmi in un simile disastro. Dopo la selezione della giuria, il procuratore federale mi propose un ultimo patteggiamento: dichiarati colpevole di violazione alle norme RICO, paga una multa di diecimila dollari e sconta due anni di carcere. Di nuovo, gli dissi di andare all’inferno. Io ero innocente. 8 Mr Victor Westlake Vicedirettore FBI Hoover Building 935 Pennsylvania Avenue Washington, DC 20535 PREGO INOLTRARE Egregio Mr Westlake, mi chiamo Malcolm Bannister e sono attualmente detenuto presso il Federal Prison Camp di Frostburg, Maryland. Lunedì 21 febbraio 2011 ho avuto un colloquio con due dei suoi uomini impegnati nelle indagini sull’omicidio del giudice Fawcett: l’agente Hanski e l’agente Erardi. Tipi simpatici eccetera, ma ho la sensazione che non siano rimasti molto colpiti né da me né dalla mia storia. Secondo gli articoli comparsi questa mattina sul “Washington Post”, il “New York Times”, il “Wall Street Journal” e il “Roanoke Times”, lei e la sua squadra state ancora girando a vuoto e non avete alcun indizio. Non ho modo di sapere se lei dispone di un elenco di sospettati credibili, ma le posso garantire che il vero assassino non figura su alcuna lista redatta da lei o dalla sua squadra. Come ho spiegato ai suoi agenti, conosco l’identità dell’omicida e so qual è stato il movente. Nel caso Hanski ed Erardi abbiano compreso male i dettagli (per inciso, il modo in cui prendono appunti lascia molto a desiderare) ecco la mia idea di accordo: io rivelo il nome del killer e voi (il governo) autorizzate il mio rilascio. Non prenderò in considerazione alcun tipo di sospensione condizionale della pena. Non prenderò in considerazione la libertà vigilata. Voglio uscire di qui da uomo libero, con una nuova identità e con la vostra protezione. Ovviamente un accordo del genere comporterà il coinvolgimento del diTeilimento di Giustizia e degli uffici dei procuratori federali del Distretto Nord e del Distretto Sud della Virginia. Esigo inoltre il denaro della ricompensa, al quale avrò diritto. Secondo il “Roanoke Times” di oggi, la somma è stata recentemente portata a centocinquantamila dollari. Naturalmente siete liberi di continuare a girare a vuoto. Da ex marine a ex marine, credo proprio che noi due dovremmo parlare. Sa dove trovarmi. Cordialmente, Malcolm Bannister #44861-127 Il mio compagno di cella è un ragazzino nero di Baltimora, ha diciannove anni ed è stato condannato a otto per spaccio di crack. Gerard è come mille altri che ho conosciuto negli ultimi cinque anni: un giovane nero proveniente da un quartiere povero e degradato, con una madre ancora adolescente al momento della sua nascita e un padre svanito nel nulla ancora prima. Gerard ha abbandonato la scuola al secondo anno delle superiori e si è trovato un lavoro come lavapiatti. Quando sua madre è finita in prigione, si è trasferito dalla nonna, che stava già crescendo un’orda di suoi cugini. Ha cominciato a farsi di crack e poi a venderlo. Nonostante una vita in strada, Gerard è un’anima gentile, senza alcuna vena di malvagità. Non ha precedenti di violenza e non dovrebbe sprecare la sua vita in prigione. È uno del milione di ragazzi neri mantenuti al fresco dai contribuenti. In questo paese ci stiamo avvicinando ai due milioni e mezzo di detenuti, di gran lunga il più alto tasso di detenzione in qualsiasi nazione semicivilizzata. Non è insolito ritrovarsi con un compagno di cella che non ti piace. Ne ho avuto uno a cui bastavano pochissime ore di sonno e ascoltava il suo iPod per tutta la notte. Si metteva le cuffie, obbligatorie dopo le ventidue, ma il volume era così alto che sentivo comunque la musica. Ci ho messo tre mesi per ottenere il trasferimento. Gerard, invece, capisce le regole. Una volta mi ha detto di aver dormito per settimane in un’auto abbandonata e di essere quasi morto assiderato. Qualunque cosa è meglio di quello. Gerard e io cominciamo la nostra giornata alle sei, quando ci sveglia il cicalino. Indossiamo in fretta la tenuta da lavoro, entrambi attenti a lasciare all’altro il maggior spazio possibile nella nostra cella di tre metri per tre e cinquanta. Rifacciamo le brande. Gerard dorme in quella di sopra e io, in virtù della mia anzianità, in quella di sotto. Alle sei e mezzo andiamo in mensa per la colazione. Nella mensa esistono barriere invisibili che impongono dove devi sederti a mangiare. C’è una sezione riservata ai neri, una ai bianchi e una agli scuri. Le mescolanze vengono guardate con disapprovazione e non avvengono quasi mai. Anche se Frostburg è un campo, è comunque una prigione, con parecchio stress. Una delle regole più importanti dell’etichetta carceraria è il rispetto dello spazio altrui. Mai saltare la fila. Mai tendere un braccio per prendere qualcosa: se vuoi il sale o il pepe, chiedi a qualcuno di passartelo, per favore. A Louisville, la mia precedente residenza, le risse in mensa non erano insolite e in genere si scatenavano quando un idiota con i gomiti troppo appuntiti invadeva lo spazio di qualcun altro. Qui invece mangiamo adagio e con modi sorprendentemente educati per un branco di criminali. Una volta fuori dalle nostre celle anguste, ci godiamo gli spazi più ampi della mensa. Le prese in giro si sprecano, come le barzellette sporche e le chiacchiere sulle donne. Ho conosciuto uomini che erano stati mandati nel buco, cioè in isolamento, e tutti dicevano che la cosa peggiore è l’assenza d’interazione sociale. Qualcuno la sopporta bene, ma la maggior Teile comincia a crollare dopo pochi giorni. Perfino i solitari più incalliti, e in prigione ce ne sono parecchi, hanno bisogno di gente intorno. Dopo colazione Gerard inizia il suo lavoro di lavapavimenti. Io ho un’ora libera prima di presentarmi in biblioteca, ed è questo il momento in cui vado nella sala caffè a leggere i quotidiani. Anche oggi sembrano esserci pochi progressi nell’indagine Fawcett. Noto però con interesse che il figlio maggiore del giudice si è lamentato con un giornalista del “Post” dichiarando che l’FBI sta facendo un lavoro schifoso nel tenere aggiornata la famiglia. Nessuna reazione da Teile dell’FBI. Ogni giorno che passa la pressione aumenta. Ieri un reporter ha scritto che l’FBI si sta interessando all’ex marito di Naomi Clary. Il divorzio, avvenuto tre anni fa, è stato conflittuale, con le Teili che si accusavano a vicenda di adulterio. Secondo il giornalista, le sue fonti assicurano che l’FBI ha interrogato l’ex coniuge almeno due volte. La biblioteca si trova in un annesso che ospita anche una piccola cappella e l’infermeria. È lunga dodici metri e larga nove, con quattro cubicoli a garantire la privacy, cinque computer e tre lunghi tavoli ai quali i detenuti possono leggere, scrivere e fare ricerche. Ci sono anche dieci scaffalature che ospitano circa millecinquecento libri, perlopiù in edizione rilegata. A Frostburg ci è consentito tenere in cella fino a un massimo di dieci libri, anche se quasi tutti ne hanno di più. Un detenuto può venire in biblioteca nelle sue ore libere, e le regole sono parecchio flessibili. Si possono prendere in prestito due volumi alla settimana, e io impiego metà del mio tempo a inseguire libri il cui prestito è scaduto. Un quarto del mio tempo lo trascorro in veste di avvocato da galera, e oggi ho un nuovo cliente. Roman viene da una cittadina del North Carolina, dove era proprietario di un banco dei pegni specializzato in ricettazione, soprattutto di armi. I suoi fornitori erano un paio di gang formate da cocainomani idioti che svaligiavano ricche case in pieno giorno. Non possedendo la minima specializzazione, erano stati colti in flagrante e nel giro di pochi minuti ognuno di loro aveva cominciato a vuotare il sacco su tutti gli altri. Chiamato in causa e accusato di ogni tipo di reato federale, Roman aveva sostenuto di ignorare la provenienza della merce. È comunque evidente che il suo avvocato d’ufficio era senza dubbio la persona più stupida presente in aula. Non ho la pretesa di essere un esperto in diritto penale, ma qualunque studente di legge al primo anno sarebbe in grado di individuare gli errori commessi da quell’avvocato nel corso del processo. Giudicato colpevole, Roman è stato condannato a sette anni e la sua causa è attualmente in appello. Si presenta da me con le sue “carte legali”, i documenti che ogni detenuto ha il diritto di tenere nella propria cella e che ora esaminiamo insieme nel mio piccolo ufficio, un cubicolo pieno di miei oggetti personali e off-limits per tutti gli altri. Roman non smette un attimo di accalorarsi per la pochezza del suo difensore e devo dichiararmi d’accordo con lui. È molto comune che chi è stato condannato in un processo voglia ricorrere in appello per assistenza legale inadeguata, che però poche volte risulta motivo di annullamento della sentenza di primo grado in casi che non comportino la pena di morte. Sono eccitato dalla possibilità di attaccare la prestazione di un avvocato che è ancora là fuori e che continua a guadagnarsi da vivere fingendo di essere molto meglio di quello che è. Trascorro un’ora con Roman e poi fissiamo un appuntamento per il prossimo colloquio. È stato uno dei miei primi clienti a parlarmi del giudice Fawcett. Voleva disperatamente uscire di galera ed era convinto che io potessi fare miracoli. Sapeva esattamente qual era il contenuto della cassaforte nel seminterrato di quel cottage ed era ossessionato dall’idea di metterci le mani sopra prima che sparisse. 9 Sono di nuovo nell’ufficio del direttore. Deve essere successo qualcosa. Wade indossa un abito scuro, camicia bianca inamidata, cravatta a motivi cashmere e i soliti stivali da cowboy, che oggi risplendono di lucido da scarpe. Il direttore è sicuro di sé come sempre, ma anche un po’ nervoso. «Bannister» mi sta dicendo «non so cos’hai raccontato a quella gente, ma la tua storia è piaciuta. Detesto ripetermi, ma se questa è la tua idea di scherzo, la pagherai cara.» «Non è uno scherzo, signore.» Ho il sospetto che Wade l’altra volta abbia origliato alla porta e sappia esattamente cosa ho detto. «Due giorni fa hanno mandato qui quattro agenti. Hanno ficcato il naso dappertutto e hanno voluto sapere con chi passi il tempo, per chi hai fatto lavoro legale, con chi giochi a scacchi, dove lavori, con chi mangi, con chi fai la doccia, con chi dividi la cella, eccetera eccetera.» «Io la doccia la faccio da solo.» «Immagino che vogliano capire chi sono i tuoi amici, giusto?» «Non lo so, signore, ma non mi sorprenderebbe. Ho pensato anch’io qualcosa del genere.» Ho saputo che l’FBI stava curiosando in giro per Frostburg, anche se non ho mai visto gli agenti. In prigione è molto difficile mantenere i segreti, specie quando arriva gente da fuori e comincia a fare domande. Secondo me, e in base a una certa esperienza, è stato un modo piuttosto goffo di scavare nella mia vita. «Be’, stanno per tornare» mi informa Wade. «Saranno qui alle dieci e mi hanno detto che la cosa potrà richiedere un po’ di tempo.» Sono le dieci meno cinque. Il solito dolore acuto mi prende allo stomaco e io cerco di fare respiri profondi senza darlo a vedere. Mi stringo nelle spalle, come se non si trattasse di una questione importante. «Chi viene?» domando. «Che mi venga un accidente se lo so.» Qualche secondo dopo l’interfono ronza e la segretaria riferisce un messaggio al direttore. Siamo di nuovo nella stanza adiacente l’ufficio del direttore, il quale naturalmente non è presente. Gli agenti Hanski ed Erardi sono tornati in compagnia di un giovanotto dall’aria decisa che si chiama Dunleavy ed è viceprocuratore federale del Distretto Sud della Virginia, ufficio di Roanoke. Sto facendo progressi: la mia credibilità è in crescita e la curiosità aumenta. Il gruppetto dei miei inquisitori ha un’aria più importante. Anche se Dunleavy è il più giovane dei tre, è un procuratore federale, mentre gli altri due sono semplici agenti. Di conseguenza, in questo momento è Dunleavy il più alto in grado. Sembra piuttosto pieno di sé, un atteggiamento non insolito in chi occupa una posizione del genere. Non può essere uscito dalla scuola di legge da più di cinque anni e presumo che sarà soprattutto lui a gestire la conversazione. «Mr Bannister» comincia in un tono sgradevolmente condiscendente «è ovvio che non saremmo qui se non avessimo qualche interesse per la sua storiella.» Storiella. Che stronzo. «Posso chiamarti Malcolm?» domanda. «Atteniamoci a Mr Bannister e Mr Dunleavy, almeno per il momento» rispondo. Sono un detenuto e da anni nessuno mi chiama Mr Bannister. Mi piace come suona. «Perfetto» dice secco Dunleavy. Estrae rapidamente da una tasca un sottile registratore che posa sul tavolo, a metà strada tra me da un lato e loro tre dall’altro. «Vorrei registrare la nostra conversazione, se per lei è okay.» E con questo la mia causa fa un gigantesco passo avanti. Una settimana fa Hanski ed Erardi erano riluttanti a impugnare una penna per prendere qualche appunto. Adesso il governo vuole catturare ogni mia parola. Mi stringo nelle spalle e rispondo: «Nessun problema». Dunleavy preme un tasto e comincia: «Dunque, lei afferma di sapere chi ha ucciso il giudice Fawcett e vuole barattare questa informazione con un biglietto per uscire da qui. E, una volta fuori, vuole la nostra protezione. Sarebbero questi, in sostanza, i termini dell’accordo?». «Perfetto» rispondo, rifacendogli il verso. «Perché dovremmo crederle?» «Perché io so la verità e perché voi non ci siete neppure vicini.» «Come fa a saperlo?» «Lo so. Se aveste un sospettato serio, non sareste qui a parlare con me.» «Lei è in contatto con l’assassino?» «Non intendo rispondere a questa domanda.» «Deve darci qualcosa, Mr Bannister. Qualcosa che ci faccia sentire meglio a proposito del suo piccolo accordo.» «Io non lo definirei piccolo.» «Allora lo definiremo come preferisce lei. Perché non ce lo spiega? Come pensa che possa avvenire questo grande accordo?» «Okay. Dovrà essere segreto, altamente confidenziale. Sarà un documento scritto, approvato dall’ufficio del procuratore federale del Distretto Nord, dove sono stato accusato e condannato, e da quello del Distretto Sud, dove state svolgendo le vostre indagini. Anche il giudice Slater, quello che mi ha condannato, dovrà firmare. Una volta fatto questo, io vi dirò il nome dell’assassino. Voi lo fermate, indagate e, appena il gran giurì lo rinvia a giudizio, io vengo spostato subito in un altro carcere. Solo che non sconterò più alcuna pena. Me ne andrò di qui come se mi stessero trasferendo, ma in realtà entrerò nel vostro programma protezione testimoni. La mia condanna verrà annullata, la mia fedina penale sarà ripulita, avrò un nome nuovo e probabilmente mi ci vorrà anche un po’ di chirurgia plastica per cambiare i connotati. Avrò documenti nuovi, una faccia nuova, un bell’impiego federale da qualche Teile e, ciliegina sulla torta, il denaro della ricompensa.» Tre visi di pietra mi fissano. Poi Dunleavy dice: «Tutto qui?». «Tutto qui. E non è negoziabile.» «Wow» fa il procuratore, come se fosse scioccato. «Immagino che abbia avuto un sacco di tempo per pensare a tutto questo.» «Molto più di lei.» «E se si sbaglia? Cosa succede se arrestiamo l’uomo sbagliato, otteniamo in qualche modo il rinvio a giudizio, lei esce e poi noi non riusciamo a dimostrare niente?» «Sarà un problema vostro. Se al processo incasinerete l’impianto accusatorio, sarà solo colpa vostra.» «Okay. Ma una volta che avremo il nostro uomo, di quali prove disporremo?» «Avete tutto il governo federale a vostra disposizione. Di sicuro riuscirete a trovare prove sufficienti, una volta che avrete l’assassino. Non posso pensare a tutto io.» Per fare un po’ di teatro, Dunleavy si alza in piedi, si stira e raggiunge con studiata lentezza un’estremità della stanza, come se fosse combattuto e immerso nei pensieri. Poi torna indietro, si siede e mi guarda. «Io credo che qui stiamo sprecando il nostro tempo» dichiara; un pessimo bluff, recitato in modo poco convincente da un ragazzino che non dovrebbe neppure essere in questa stanza. Hanski, il veterano, china appena la testa e sbatte le palpebre. Non riesce a credere all’incapacità di Dunleavy. Erardi non mi toglie gli occhi di dosso e io percepisco il suo senso di disperazione. Percepisco anche la tensione tra l’FBI e l’ufficio del procuratore federale, cosa per niente insolita. Mi alzo in piedi e dico: «Ha ragione. Stiamo sprecando tempo. Non parlerò più finché voi ragazzi non mi manderete qualcuno che abbia qualcosa di più di una peluria di pesca sulla faccia. Vi ho esposto le condizioni del mio accordo, e al prossimo incontro voglio Mr Victor Westlake a questo tavolo. Insieme a uno dei suoi capi, Mr Dunleavy. E se nella stanza ci sarà anche lei, io me ne andrò». Detto questo, esco. Mentre richiudo la porta, lancio un’occhiata dietro di me e vedo Hanski che si massaggia le tempie. Torneranno. Sarebbe stato possibile programmare la riunione a Washington, nell’Hoover Building in Pennsylvania Avenue, e Victor Westlake sarebbe stato felice di tornare a casa per un po’, vedere il capo, parlare con il suo staff, godersi una bella cena in famiglia e così via. Il direttore, però, aveva voglia di una trasferta veloce. Sentiva il bisogno di allontanarsi per qualche ora dal Building, così fece salire il suo entourage a bordo di un jet privato, uno dei quattro a disposizione dell’FBI, che decollò per un volo di quaranta minuti, destinazione Roanoke. Il direttore si chiamava George McTavey, aveva sessantun anni ed era un funzionario di carriera, non di nomina politica. Anzi, le sue posizioni al momento gli creavano problemi con il presidente. Secondo le voci che circolavano all’interno della Beltway, il destino professionale di McTavey era appeso a un filo. Il presidente voleva un nuovo direttore dell’FBI. Dopo quattordici anni, McTavey se ne doveva andare. Nell’Hoover Building il morale era basso, o almeno così dicevano i pettegolezzi. Negli ultimi mesi McTavey raramente si era lasciato sfuggire un’occasione per allontanarsi da Washington, sia pure solo per qualche ora. Ed era quasi un sollievo concentrarsi su un crimine vecchio stile come l’omicidio. Erano ormai dieci anni che McTavey combatteva il terrorismo e non era ancora emerso il minimo indizio che suggerisse un collegamento tra la morte di Fawcett e Al-Qaeda o altre cellule terroristiche nazionali. I bei tempi della lotta al crimine organizzato e della caccia ai falsari erano finiti per sempre. A Roanoke c’era un SUV nero in attesa ai piedi della scaletta dell’aereo, e McTavey e relativa squadra vennero caricati e portati via nel giro di pochi secondi, come se ci fossero stati dei cecchini in agguato. Un minuto dopo il SUV si fermò davanti al Freezer e il gruppo entrò rapidamente nel capannone. La visita del direttore aveva due obiettivi. Il primo era sollevare lo spirito della task force e far comprendere ai suoi componenti che, nonostante la mancanza di progressi, il loro lavoro aveva la massima priorità. Il secondo era aumentare la pressione. Dopo una veloce visita alla struttura e un giro di strette di mano che avrebbe fatto invidia a un politico, McTavey venne accompagnato nella sala riunioni per il briefing. Il direttore si sedette di fianco a Victor Westlake, un suo vecchio amico. Mangiando ciambelle, i due ascoltarono un investigatore capo esporre un contorto riassunto delle ultime novità, che non erano molte. McTavey non avrebbe avuto bisogno di ascoltare i ragguagli di persona. Dalla scoperta dell’omicidio, si sentiva con Westlake almeno due volte al giorno. «Parliamo di questo Bannister» disse McTavey dopo mezz’ora di una monotona esposizione che non stava andando da nessuna Teile. Un altro rapporto venne distribuito rapidamente intorno al tavolo. «Questo è l’ultimo» lo informò Westlake. «Abbiamo cominciato con i compagni di liceo, poi siamo passati a quelli del college e della scuola di legge: nessun sospettato credibile. Nessuna traccia di amici o conoscenti, e di nessun altro in realtà, la cui strada abbia mai incrociato quella del giudice Fawcett. Nessun membro di gang, nessun trafficante di droga, nessuno che si possa definire criminale. Poi abbiamo cercato di individuare il maggior numero possibile degli ex clienti di Bannister, anche se è stato difficile perché non abbiamo accesso a molte delle sue vecchie pratiche. Comunque nessun soggetto interessante neppure lì. Bannister ha fatto il legale di provincia per circa dieci anni, in società con due avvocati afroamericani più vecchi di lui, e la loro attività è sempre stata cristallina.» «Bannister ha mai esercitato nel tribunale del giudice Fawcett?» chiese McTavey. «Non esiste una documentazione che lo indichi. Bannister non ha mai fatto molto lavoro a livello federale, e comunque esercitava nel Distretto Nord della Virginia. Possiamo dire che Mr Bannister non era un avvocato processuale molto ambito.» «Quindi tu pensi che l’assassino di Fawcett sia qualcuno che Mr Bannister ha conosciuto in prigione. Sempre presumendo, naturalmente, che decidiamo di credere alle sue affermazioni.» «Sì. Bannister ha scontato i primi ventidue mesi a Louisville, Kentucky, un carcere di media sicurezza con duemila detenuti. In quel periodo ha avuto tre diversi compagni di cella e ha lavorato in lavanderia e in cucina. Ha anche affinato le sue capacità di avvocato da galera e ha aiutato almeno cinque compagni a uscire di prigione. Abbiamo un elenco di circa cinquanta uomini che Bannister probabilmente conosceva bene, ma francamente è impossibile individuare tutti quelli con cui è entrato in contatto a Louisville. E lo stesso vale per Frostburg: è là dentro da tre anni, durante i quali ha conosciuto un migliaio di uomini.» «Quanto è lunga quella lista?» chiese McTavey. «Abbiamo circa centodieci nomi, ma per la maggior Teile di loro non nutriamo molte speranze.» «Quanti sono stati condannati da Fawcett?» «Sei.» «Perciò non c’è un chiaro sospettato nella storia carceraria di Bannister?» «Per adesso no, ma stiamo ancora scavando. Tieni presente che questa è la nostra seconda teoria, quella basata sul presupposto che chi ha ucciso il giudice nutrisse del rancore nei suoi confronti a causa di un verdetto sfavorevole. La nostra prima teoria è che si sia trattato di un normale furto con omicidio.» «Hai anche una terza teoria?» «La gelosia dell’ex marito della segretaria assassinata» rispose Westlake. «Ma non è credibile, giusto?» «Giusto.» «Quarta teoria?» «No. Per il momento no.» McTavey bevve un sorso di caffè e disse: «Questo caffè è veramente pessimo». Due tirapiedi in fondo alla sala scattarono sull’attenti e scomparvero alla ricerca di qualcosa di meglio. «Mi dispiace» si scusò Westlake. Era universalmente noto che il direttore era un vero amante del caffè. Offrirgli una miscela non all’altezza era motivo di imbarazzo. «Riparlami dei precedenti di Bannister» disse McTavey. «Condannato a dieci anni per violazioni al RICO. Era rimasto impigliato nell’affare Barry Rafko di qualche anno fa, anche se non era un pesce grosso. Si era occupato di certe transazioni immobiliari per conto di Barry e si è fatto condannare.» «Allora, non lo avevano trovato a letto con una sedicenne?» «Oh, no. Quello era il nostro rappresentante al Congresso. Bannister sembra essere un tipo a posto, ex marine eccetera, solo che si è scelto il cliente sbagliato.» «Insomma, era colpevole o no?» «La giuria ha ritenuto di sì. E lo stesso il giudice. Non ti becchi dieci anni se non hai combinato qualche casino.» Un’altra tazza venne posata davanti al direttore, che ne annusò il contenuto e poi finalmente bevve un sorso mentre tutti trattenevano il fiato. Un altro sorso e tutti ripresero a respirare. «Perché dovremmo credere a Bannister?» domandò McTavey. Westlake passò velocemente il cerino acceso. «Hanski.» L’agente Chris Hanski era pronto e aspettava solo il segnale di via. Si schiarì la voce e attaccò: «Ecco, non so se dobbiamo credere a Bannister, comunque lui fa una buona impressione. Gli ho parlato due volte, l’ho osservato con attenzione e non ho notato segnali che indichino l’inganno. È brillante, scaltro, e non ha niente da guadagnare mentendoci. In cinque anni di galera è assolutamente possibile che abbia conosciuto qualcuno che voleva far fuori il giudice Fawcett o derubarlo». «E noi non abbiamo proprio idea di chi possa essere quel qualcuno, vero?» Hanski si voltò verso Victor Westlake, che rispose: «Al momento no. Ma stiamo indagando». «Non mi piace che le nostre possibilità di scoprire l’identità dell’assassino si basino sulle persone che Mr Bannister può avere conosciuto per caso in prigione» disse McTavey, con perfetta logica. «Potremmo ritrovarci a dare la caccia ai fantasmi per i prossimi dieci anni. Ma quale sarebbe il lato negativo di un accordo con Bannister? Sentite, il nostro amico è un colletto bianco che si è già fatto cinque anni per un’attività criminale piuttosto innocua nello schema generale delle cose. Non credi anche tu, Vic?» Vic stava annuendo con aria grave. McTavey continuò: «Bene, diciamo che l’amico esce di prigione. Non è che mettiamo in libertà un serial killer o un predatore sessuale. Se Bannister dice la verità, allora il caso è risolto e possiamo andarcene tutti a casa. Se invece ci sta imbrogliando, quale potrebbe essere il grande disastro?». Al momento nessuno intorno al tavolo riusciva a immaginare un grande disastro. «Chi potrebbe opporsi?» chiese McTavey. «L’ufficio del procuratore federale non è d’accordo» disse Westlake. «Non mi sorprende. Domani pomeriggio ho appuntamento con il procuratore generale. Posso neutralizzare la cosa. Altri problemi?» Hanski si schiarì di nuovo la voce. «Ecco, signore, Bannister insiste che non ci dirà il nome finché un giudice federale non avrà firmato un’ordinanza di commutazione della pena. Non so bene come funzioni, ma la commutazione dovrà avvenire automaticamente quando il gran giurì rinvierà a giudizio il nostro uomo misterioso.» McTavey liquidò la faccenda con un gesto della mano. «Abbiamo degli avvocati per gestire queste rogne. Bannister ha un legale?» «Non che io sappia.» «Gliene serve uno?» «Sarò lieto di chiederglielo» disse Hanski. «Concludiamo questo accordo, okay?» tagliò corto McTavey con impazienza. «I vantaggi sono molti e gli svantaggi pochi. Considerati i nostri progressi fino a questo momento, siamo in credito con la fortuna.» 10 È passato un mese dagli omicidi del giudice Fawcett e di Naomi Clary. Sui giornali gli articoli riguardanti le indagini sono diventati più brevi e meno frequenti. L’ FBI non ha rilasciato commenti e, dopo un mese di lavoro frenetico senza risultati, la task force sembra essere svanita. In questo periodo, un terremoto in Bolivia, una sparatoria nel cortile di una scuola in Kansas, l’overdose di una star del rap e la disintossicazione di un’altra hanno contribuito a spostare l’attenzione generale su altri temi. Per me queste sono tutte buone notizie. In superficie l’indagine può sembrare in una fase di stanca, ma all’interno la pressione aumenta. Il mio incubo peggiore è un titolo a caratteri cubitali che annuncia l’arresto di qualcuno, ma la cosa sembra sempre meno probabile. I giorni passano e io aspetto paziente. Ricevo i clienti solo su appuntamento. Li incontro nel mio cubicolo in biblioteca. Si presentano tutti con la loro pila di istanze, ordinanze, mozioni e sentenze che noi detenuti abbiamo il diritto di tenere in cella. Gli agenti penitenziari non possono toccare le nostre carte legali. Nella maggior Teile dei casi bastano due appuntamenti per convincere i miei clienti che non c’è niente da fare. Durante il primo incontro esaminiamo insieme i fondamentali della causa e io studio la documentazione. Poi dedico qualche ora alle ricerche del caso. Nel corso del secondo colloquio di solito devo comunicare la brutta notizia che la fortuna non è dalla loro Teile. Non esiste alcuna scappatoia per salvarli. In cinque anni ho aiutato sei detenuti a ottenere un rilascio anticipato. Inutile dire che questi risultati hanno accresciuto enormemente la mia reputazione di geniale avvocato da galera, ma io avverto sempre ogni nuovo cliente che le probabilità sono quasi tutte contro di lui. È quello che spiego anche al giovane Otis Carter, un ventitreenne padre di due figli che trascorrerà i prossimi quattordici mesi qui a Frostburg per un reato che non avrebbe dovuto essere un reato. Otis è un ragazzo di campagna, un battista dalla fede profonda, un elettricista felicemente coniugato che non riesce ancora a credere di trovarsi in un carcere federale. Otis e suo nonno sono stati accusati e condannati per violazione al Civil War Battlefield and Artifact Preservation Act del 1979 (come emendato nel 1983, 1989, 1997, 2002, 2008 e 2010). Il nonno, di settantaquattro anni e affetto da enfisema, è ricoverato in un centro medico federale in Tennessee e anche lui sta scontando una pena di quattordici mesi. A causa delle sue condizioni di salute, costerà ai contribuenti circa venticinquemila dollari al mese. I due Carter erano andati a caccia di manufatti nella loro fattoria di ottanta ettari, adiacente al New Market Battlefield State Historical Park nella valle di Shenandoah, a meno di un’ora da Winchester, la mia città. La fattoria apTeileneva alla famiglia da più di cento anni e fin da quando era stato in grado di camminare Otis aveva sempre accompagnato il nonno ogni volta che “andava a scavare,” alla ricerca di reperti e souvenir della Guerra Civile. Nel corso dei decenni i Carter avevano messo insieme un’impressionante raccolta di pallottole Minié per fucili ad avancarica, palle da cannone, borracce, bottoni di ottone, brandelli di uniformi, un paio di bandiere di guerra e parecchie decine di armi da fuoco di ogni tipo. La famiglia aveva agito legalmente. È illegale prelevare manufatti e oggetti da un National Historic Landmark, che è di proprietà federale, e i Carter erano perfettamente a conoscenza di questa legge. Il loro piccolo museo privato, che avevano allestito in un fienile ristrutturato, era pieno di reperti che avevano rinvenuto nella loro proprietà privata. Ma nel 2010 il Civil War Battlefield and Artifact Preservation Act era stato modificato di nuovo. Accogliendo le istanze dei conservazionisti volte a limitare la cementificazione nelle vicinanze dei campi di battaglia, era stata aggiunta una clausola dell’ultimo minuto alle cento pagine dell’emendamento. Adesso diventava illegale effettuare scavi alla ricerca di reperti “nel raggio di 3200 metri” dai confini di un National Historic Landmark, e a chi apTeilenesse il terreno in cui si scavava non aveva più alcuna rilevanza. I Carter non erano informati sulle nuove regole; in realtà la norma era sepolta così in profondità nell’emendamento che in pratica nessuno ne era a conoscenza. Nel corso degli anni gli agenti federali avevano tormentato il nonno di Otis, accusandolo di effettuare scavi in terreni protetti. Passavano periodicamente a casa sua ed esigevano di vedere il museo. Quando la legge cambiò, aspettarono pazientemente finché colsero Otis e il nonno mentre, armati di metal detector, setacciavano un’area boscosa all’interno della loro proprietà. I Carter si rivolsero a un avvocato, il quale consigliò di dichiararsi colpevoli. Per molti reati federali, l’intenzione criminale non è più un requisito essenziale. E l’ignoranza della legge non costituisce elemento di difesa. Quale vittima del RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) – una legge federale nata per combattere il crimine organizzato –, spesso inadeguata e notoriamente flessibile, nutro un vivo interesse per la proliferazione delle norme nel Codice penale, che oggi conta ventisettemila pagine ed è in costante crescita. La Costituzione contempla solo tre reati federali: tradimento, pirateria e contraffazione. Oggi i reati federali sono più di quattromilacinquecento e il loro numero continua ad aumentare grazie al Congresso, sempre più duro nei confronti del crimine, e ai procuratori federali, sempre più creativi nel trovare modi per applicare tutte le loro nuove leggi. Otis potrebbe forse passare all’attacco mettendo in discussione la costituzionalità della legge emendata. Questo però comporterebbe parecchi anni di controversie legali e la cosa si trascinerebbe a lungo, anche dopo la concessione della libertà vigilata e il ritorno a casa dalla famiglia. Mentre gli spiego la situazione durante il nostro secondo incontro, Otis sembra perdere interesse. Se non può uscire subito, perché prendersi il disturbo? Ma il suo caso mi intriga. Decidiamo di discuterne di nuovo. Se il mio grande piano dovesse fallire miseramente, potrei occuparmi della causa di Otis e combattere fino alla Corte Suprema. Questo mi terrebbe occupato per i prossimi cinque anni. Per ben due volte la Corte Suprema ha rifiutato di prendere in considerazione il mio caso. Anche se il mio avvocato e io non potevamo dimostrarlo, c’era la netta sensazione che i miei appelli viaggiassero velocissimi attraverso il sistema giudiziario a causa dell’entusiasmo del governo nel mettere al fresco Barry Rafko e i suoi compari, me compreso. Sono stato giudicato colpevole nel novembre del 2005 e condannato a dieci anni due mesi dopo. Al momento della sentenza, sono stato spedito in carcere. A qualche condannato con maggiore fortuna viene concessa l’“autoconsegna”, vale a dire che può restare in libertà fino a quando non gli verrà ordinato di presentarsi in una struttura di detenzione. In questo modo ha il tempo di prepararsi, ma alla maggior Teile dei condannati questo lusso non viene concesso. Il mio avvocato riteneva che sarei stato condannato a cinque o sei anni. Bustarella Barry, l’imputato superstar, il bersaglio, il pittoresco furfante che tutti amavano odiare, si era preso dodici anni. Di sicuro io meritavo meno della metà della pena inflitta a quella palla di merda. Dionne, la mia bella, amorevole moglie decisa a sostenermi per sempre, era in aula e sedeva coraggiosamente accanto a mio padre, umiliato. Quel giorno io ero l’unico degli otto imputati in attesa della sentenza e, mentre me ne stavo in piedi davanti al giudice Slater con il mio avvocato alla mia destra, non riuscivo quasi a respirare. Non può essere, continuavo a ripetermi mentre passavo lo sguardo sulle immagini confuse intorno a me. Non me lo merito. Posso spiegare tutto. Non sono colpevole. Slater usò formule di rimprovero, predicò e recitò a beneficio della stampa, mentre io mi sentivo come un malconcio peso massimo alla quindicesima ripresa che, aggrappato alle corde, si protegge la faccia in attesa del pugno successivo. Sentivo le ginocchia molli. Stavo sudando. Quando il giudice Slater proclamò “dieci anni”, udii un gemito smorzato dietro di me e poi Dionne scoppiò in lacrime. Mentre mi portavano via, mi voltai per un’ultima occhiata. L’ho visto cento volte al cinema, nei telefilm e nelle riprese dei processi dal vero: quell’ultimo, frenetico sguardo d’addio del condannato. A cosa pensi mentre stai uscendo dall’aula e non per tornare a casa? La verità è che non c’è niente di chiaro. Ci sono troppi pensieri che si affollano, troppa paura, troppa rabbia e troppe emozioni vibranti per capire cosa sta succedendo. Dionne aveva entrambe le mani sulla bocca, era in stato di shock e piangeva a dirotto. Mio padre le aveva passato un braccio sulle spalle e cercava di consolarla. È questa l’ultima cosa che vidi: la mia bella moglie sconvolta e distrutta. Adesso è sposata con un altro. Grazie al governo federale. I miei giurati provenivano tutti dal Distretto. Due o tre avevano l’aria di essere intelligenti e istruiti, ma gli altri non erano, diciamo, molto sofisticati. Dopo tre giorni di camera di consiglio, comunicarono al giudice che non stavano facendo progressi. E chi poteva biasimarli? Scaricando negli atti dell’accusa una fetta notevole del Codice penale federale, i procuratori avevano adottato la vecchia strategia che consiste nello scagliare quanto più fango possibile contro gli imputati e sperare che qualcosa resti attaccato. Questo eccesso di fuoco aveva trasformato quella che doveva essere una causa relativamente semplice contro Barry Rafko e il rappresentante al Congresso in un pantano legale. Perfino io, che avevo trascorso un numero infinito di ore a lavorare alla mia difesa, non riuscivo a capire tutte le teorie dell’accusa. Fin dall’inizio il mio avvocato aveva previsto una giuria discorde. Dopo quattro giorni di camera di consiglio, il giudice Slater sganciò quella che negli ambienti processuali è comunemente nota come “carica di dinamite”. In sostanza si impone ai giurati di tornare in camera di consiglio e arrivare a un giudizio unanime, a qualsiasi costo. Non tornerete a casa finché non avremo un verdetto! Raramente la cosa funziona, ma io non fui così fortunato. Un’ora dopo i giurati, esausti ed emotivamente svuotati, si ripresentarono in aula con un verdetto di colpevolezza per tutti gli imputati, e per tutti i capi d’accusa. Per me, e per molti altri, era chiaro che i giurati non avevano capito la maggior Teile degli articoli del Codice e le complicate teorie utilizzate dall’accusa. In seguito uno di loro avrebbe dichiarato testualmente: “Abbiamo dato per scontato che fossero colpevoli, in caso contrario non sarebbero stati accusati, tanto per cominciare”. Nei miei appelli ho riportato questa citazione, ma a quanto pare è caduta nel vuoto. Osservai con attenzione i giurati per tutta la durata del processo e posso dire che rimasero travolti e sopraffatti fin dalle dichiarazioni di apertura. E perché non avrebbero dovuto? Nove diversi avvocati diedero la loro versione di ciò che era successo. L’aula dovette essere riorganizzata per assicurare lo spazio necessario a tutti gli imputati e ai rispettivi legali. Il processo fu uno spettacolo, una farsa, un modo ridicolo di cercare la verità. Ma, come sono arrivato a capire, la verità non era importante. In un’altra epoca forse il processo è stato veramente una pratica per la presentazione dei fatti, la ricerca della verità e l’imposizione della giustizia. Adesso un processo è una competizione, con un vincitore e uno sconfitto. Ognuna delle Teili si aspetta che l’altra pieghi le regole o imbrogli, per cui nessuna delle due gioca lealmente. E la verità si perde nella confusione. Due mesi dopo tornai in aula per la condanna. Il mio avvocato aveva chiesto che mi venisse concessa l’autoconsegna, ma il giudice Slater non era rimasto molto colpito dalla nostra istanza. Dopo avermi condannato a dieci anni, ordinò che fossi tradotto in carcere. È davvero sorprendente che i giudici federali uccisi a colpi di pistola non siano molti di più. Dopo la condanna passai settimane a elaborare ogni tipo di piano per infliggere a Slater una morte lenta e dolorosa. Venni scortato in aula dall’ US Marshals e condotto in una cella di custodia all’interno del tribunale, quindi al carcere di Washington dove venni perquisito, spogliato, dotato di una tuta arancione e rinchiuso in una cella con altri sei detenuti. Le brande erano solo quattro. Trascorsi la prima notte seduto sul pavimento, io e la mia sottile coperta piena di buchi. Il carcere era uno zoo rumoroso, sovraffollato e sotto organico, e dormire era impossibile. Io ero troppo spaventato e troppo stordito per chiudere occhio, per cui me ne restai a sedere in un angolo e ascoltai urla, strilli e minacce fino all’alba. Rimasi in quel carcere per una settimana, mangiando poco, dormendo poco, urinando in un sudicio water il cui sciacquone non funzionava e che si trovava a meno di tre metri dai miei compagni. Ci fu un momento in cui ci ritrovammo in dieci nella cella. Non feci mai la doccia. L’eventuale sommovimento intestinale comportava la preghiera urgente di visitare la “stanza della merda” in fondo al corridoio. Il trasporto dei detenuti federali è affidato all’US Marshals, ed è un incubo. Prigionieri di diversi livelli di sicurezza vengono ammassati tutti insieme, senza badare ai reati che abbiamo commesso o ai rischi che possiamo porre. Di conseguenza veniamo trattati tutti come feroci assassini. A ogni trasferimento sono stato ammanettato e incatenato alle caviglie, unitamente al detenuto davanti a me e a quello dietro. L’umore generale è pessimo. I marshal hanno un compito: trasferire i prigionieri in sicurezza e senza possibilità di fuga. I detenuti, molti dei quali alla prima esperienza come me, sono terrorizzati, frustrati e confusi. Quattordici di noi lasciarono Washington a bordo di un bus, un veicolo privo di contrassegni che decenni prima aveva trasportato scolari e che puntò verso sud. Le manette e le catene non ci vennero tolte. Sul sedile davanti sedeva un marshal armato di fucile. Dopo quattro ore ci fermammo in un carcere di contea in North Carolina. Ci venne consegnato un sandwich molliccio e ci fu consentito di urinare dietro l’autobus, sempre ammanettati e incatenati l’uno all’altro. Le manette e i ferri alle caviglie non vennero mai tolti. Dopo due ore di attesa riTeilimmo con tre detenuti in più e ci dirigemmo a ovest. Nei successivi sei giorni ci fermammo in carceri di contea in North Carolina, Tennessee e Alabama, prelevando prigionieri, scaricandone uno ogni tanto e dormendo ogni notte in una cella diversa. Le carceri di contea sono le peggiori: celle minuscole senza riscaldamento, aria condizionata, luce del sole o servizi igienici adeguati; cibo che perfino i cani rifiuterebbero; scarsità d’acqua; zotici razzisti come guardie; rischi di violenza molto maggiori; detenuti locali irritati dall’intrusione dei “prigionieri federali”. Non riuscivo a credere che negli Stati Uniti fossero possibili condizioni così deplorevoli, ma ero un ingenuo. A mano a mano che il viaggio proseguiva e l’umore diventava sempre più acido, a bordo del bus ci fu un significativo aumento di litigiosità. I contrasti cessarono quando un detenuto veterano ci spiegò il concetto di “terapia diesel”. Lamentatevi o create problemi e i marshal vi terranno sul bus per settimane e vi faranno fare un tour gratuito di decine di carceri di contea. Non c’era fretta. I marshal possono trasportare i detenuti solo nelle ore diurne, per cui le distanze tendono a essere brevi. A loro non interessava minimamente il nostro comfort o la nostra privacy. A un certo punto arrivammo in un centro di smistamento ad Atlanta, un posto famigerato dove venni messo in isolamento per ventitré ore al giorno mentre la mia documentazione attraversava a passo di lumaca la scrivania di qualcuno a Washington. Dopo tre settimane di quel trattamento stavo già impazzendo. Niente da leggere, nessuno con cui parlare, cibo terribile, guardie perfide. Alla fine venimmo di nuovo ammanettati e incatenati, caricati su un altro bus e trasportati all’aeroporto di Atlanta, dove ci fecero salire a bordo di un aereo da trasporto senza contrassegni. Incatenati a una dura panca di plastica e seduti ginocchio contro ginocchio, decollammo per Miami, anche se non avevamo idea di quale fosse la nostra destinazione. Fu uno dei marshal a informarci gentilmente. A Miami caricammo qualche altro detenuto e poi volammo a New Orleans, dove restammo a sedere per un’ora in un’umidità soffocante mentre i marshal facevano salire altri prigionieri. Sull’aereo ci venne consentito chiacchierare, e fu un sollievo. Quasi tutti noi eravamo reduci dall’isolamento, per cui ci tuffammo con gioia nella conversazione. Quello non era il primo viaggio per alcuni dei ragazzi, che ci raccontarono storie di altri trasferimenti in catene, gentile omaggio del governo federale. Cominciai anche a sentire descrizioni della vita in carcere. Era buio quando atterrammo a Oklahoma City, dove salimmo sull’ennesimo bus e venimmo portati in un altro centro di smistamento. Non era orribile come quello di Atlanta, ma a quel punto stavo già pensando al suicidio. Dopo cinque giorni in isolamento, fummo riammanettati e riportati all’aeroporto. Volammo in Texas, capitale mondiale dell’iniezione letale, e sognai a occhi aperti l’ago che si conficcava nel mio braccio e io che me ne volavo via. A Dallas salirono a bordo del “Con Air” otto tipi dall’aria dura, tutti ispanici, e poi volammo a Little Rock. Poi a Memphis e infine a Cincinnati, dove i miei giorni di trasmigrazioni aeree ebbero fine. Passai sei notti in un brutto carcere della città prima che un paio di marshal mi portassero nel carcere di Louisville, Kentucky. Louisville è a ottocento chilometri dalla mia città, Winchester, Virginia. Se mi fosse stato permesso di autoconsegnarmi, mio padre e io avremmo completato il viaggio in auto in circa otto ore. Lui mi avrebbe lasciato davanti al cancello e ci saremmo salutati. Quarantaquattro giorni, ventisei dei quali in isolamento, e troppe tappe per poterle ricordare tutte. Non c’è una logica in questo sistema, e a nessuno importa. Nessuno ci bada. La vera tragedia del sistema penale federale non sono le assurdità. Sono le vite rovinate e sprecate. Il Congresso chiede condanne lunghe e severe, e per i soggetti violenti questo è giusto. I criminali incalliti sono rinchiusi negli “US Pens”, vere e proprie fortezze dove le gang la fanno da padrone e gli omicidi sono all’ordine del giorno. Ma la maggior Teile dei detenuti federali è costituita da individui non violenti, e molti di loro sono condannati per reati che comportano scarsa, o addirittura nessuna, attività criminale. Per il resto della mia vita io sarò considerato un criminale. Mi rifiuto di accettarlo. Io avrò una vita, libera dal mio passato e lontanissima dai tentacoli del governo federale. 11 È l’articolo 35 del Codice di procedura penale federale a fornire l’unico meccanismo possibile per la commutazione di una pena detentiva. La sua logica è brillante e si adatta perfettamente alla mia situazione. Se un detenuto è in grado di risolvere un crimine commesso da altri, un crimine che interessi i federali, allora la condanna del detenuto in questione può essere ridotta. Naturalmente questo richiede la collaborazione delle autorità preposte alle indagini – FBI, DEA, CIA, ATF eccetera – e del tribunale dal quale il detenuto è stato condannato. Se tutto va come previsto, forse tra non molto avrò il privilegio di un nuovo incontro con l’onorevole giudice Slater, e sarà alle mie condizioni. I federali sono tornati. In questi giorni il direttore è molto più gentile del solito con me. Ritiene di essere in possesso di un pezzo ambito da alcuni alti papaveri e vuole trovarsi al centro dell’azione. Mi siedo davanti alla sua scrivania e lui mi chiede se desidero un caffè. La proposta è così surreale da risultare quasi incomprensibile: l’onnipotente direttore che offre il caffè a un carcerato. «Certo» rispondo. «Nero.» Wade preme un pulsante e comunica la nostra richiesta a una segretaria. Noto che oggi porta i gemelli, buon segno. «Mal, oggi arrivano i pezzi grossi» mi informa soddisfatto, come se fosse lui a coordinare tutti gli sforzi per trovare l’assassino. Visto che adesso siamo così amici, mi chiama per nome. Finora è sempre stato Bannister qui e Bannister là. «Chi?» gli domando. «Il direttore della task force, Victor Westlake, da Washington, e un branco di avvocati. Direi che hai ottenuto la loro attenzione.» Non posso fare a meno di sorridere, ma solo per un secondo. «Quel tizio che ha ucciso il giudice Fawcett... è mai stato qui, a Frostburg?» mi chiede Wade. «Spiacente, direttore, ma non posso rispondere alla sua domanda.» «O qui o a Louisville, immagino.» «Forse. O forse l’ho conosciuto prima di finire in prigione.» Il direttore aggrotta la fronte e si sfrega il mento. «Capisco» borbotta. Arriva il caffè, su un vassoio, e per la prima volta da anni bevo da una tazza che non è fatta di plastica o di carta. Ammazziamo il tempo per qualche minuto chiacchierando del più e del meno. Alle undici e cinque la segretaria annuncia dall’interfono sulla scrivania: «Sono arrivati». Varco la porta insieme al direttore ed entro nella solita sala riunioni. Cinque uomini. Stesso abito scuro, stessa camicia bianca botton down, stessa cravatta anonima. Se li avessi visti tra la folla da un chilometro di distanza, avrei detto: “Ecco i federali”. Sbrighiamo le rigide presentazioni di rito, dopodiché il direttore si congeda, anche se con riluttanza. Mi siedo lungo un lato del tavolo e i miei cinque nuovi amici si accomodano di fronte a me. Victor Westlake è al centro; alla sua destra ci sono l’agente Hanski e un nuovo arrivato, l’agente Sasswater. Nessuno dei due dirà una parola. Alla sinistra di Westlake siedono due viceprocuratori federali: Mangrum del Distretto Sud della Virginia e Craddok del Distretto Nord. Dunleavy il novellino è stato lasciato a casa. È scoppiato un temporale subito dopo la mezzanotte e Westlake comincia dicendo: «Una bella tempesta la notte scorsa, eh?». Io socchiudo gli occhi e lo fisso. «Davvero? Vuole parlare del tempo?» La battuta lo irrita, ma Westlake è un professionista. Un sorriso, un grugnito e poi: «No, Mr Bannister, non sono qui per parlare del tempo. Il mio capo ritiene che dovremmo concludere un accordo con lei, è questa la ragione per cui sono qui». «Magnifico. E, sì: è stata davvero una bella tempesta.» «Vorremmo sentire le sue condizioni.» «Credo che le sappiate già. Ci avvaliamo dell’articolo 35. Firmiamo un accordo, tutti noi, in base al quale io vi comunico il nome dell’uomo che ha ucciso il giudice Fawcett. Voi lo arrestate, indagate, fate tutte le vostre cose e appena il gran giurì federale lo rinvia a giudizio, io esco. Il giorno stesso. Vengo trasferito da Frostburg e svanisco nel programma protezione testimoni. Niente più carcere, niente più fedina penale sporca, niente più Malcolm Bannister. L’accordo è segreto, sigillato, sepolto in profondità e sottoscritto dal procuratore generale.» «Il procuratore generale?» «Sissignore. Non mi fido di lei né di nessun altro in questa stanza. Non mi fido del giudice Slater né di qualsiasi altro giudice, procuratore o viceprocuratore federale, agente dell’FBI o di chiunque lavori per il governo. I documenti devono essere perfetti, l’accordo inattaccabile. Quando il killer viene rinviato a giudizio, io esco. Punto.» «Si servirà di un avvocato?» «No, signore. Posso cavarmela da solo.» «Mi sembra giusto.» Mangrum all’improvviso fa comparire una cartellina da cui estrae diverse copie di un documento. Ne fa scivolare una attraverso il tavolo e la copia si ferma davanti a me, in posizione perfetta. Lancio un’occhiata e il cuore comincia a martellarmi. L’intestazione è la stessa di tutte le istanze e le ordinanze archiviate nella mia pratica: “Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti a Washington, DC; Stati Uniti d’America contro Malcolm W. Bannister”. Al centro della pagina, tutte in maiuscolo, compaiono le parole “ISTANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 35”. «Questa è una proposta di ordinanza della corte» spiega Mangrum. «È solo un punto di Teilenza, ma ci abbiamo dedicato abbastanza tempo.» Due giorni dopo vengo fatto accomodare sul sedile posteriore di un SUV Ford e portato via da Frostburg. Questa è la mia prima uscita dal campo dal giorno in cui sono arrivato, tre anni fa. Niente catene alle gambe oggi, ma ho i polsi ammanettati. I miei due compagni di viaggio sono marshal, nomi ignoti, ma abbastanza simpatici. Esaurito l’argomento tempo, uno di loro mi chiede se conosco qualche barzelletta. Mettete sottochiave seicento uomini, lasciateli con un mucchio di tempo libero e le barzellette arrivano a valanga. «Pulita o sporca?» chiedo, anche se sono poche le barzellette pulite che circolano in prigione. «Be’, sporca, naturalmente» risponde il marshal al volante. Ne racconto un paio e ottengo qualche sana risata mentre i chilometri scivolano via. Siamo sull’Interstatale 68, stiamo attraversando Hagerstown e la sensazione di libertà è inebriante. Malgrado le manette ai polsi, riesco quasi a sentire il sapore della vita là fuori. Guardo il traffico e sogno di possedere e guidare di nuovo una macchina, di andarmene in giro ovunque. Vedo i fast food agli svincoli e mi viene l’acquolina in bocca al pensiero di un hamburger con le patatine fritte. Vedo una coppia che entra in un negozio tenendosi per mano e mi pare quasi di sentire il tocco della ragazza. L’insegna di una birra sulla vetrina di un bar mi fa venire sete. Un cartellone che pubblicizza crociere nei Caraibi mi trasporta in un altro mondo. Mi sento come se fossi rinchiuso da un secolo. Giriamo verso sud sull’Interstatale 70 e poco dopo ci ritroviamo nell’agglomerato urbano di WashingtonBaltimora. Tre ore dopo la Teilenza da Frostburg entriamo nel seminterrato del tribunale federale nel centro di Washington. Una volta all’interno dell’edificio mi vengono tolte le manette. Mi avvio con un marshal davanti a me e l’altro dietro. La riunione si svolge nell’ufficio del giudice Slater, il quale è irritabile come sempre e sembra essere invecchiato di vent’anni negli ultimi cinque. Mi considera un criminale e dà a malapena segno di accorgersi della mia presenza. Nessun problema, non me ne importa. È evidente che ci sono state moltissime conversazioni tra il suo ufficio, quello del procuratore federale, l’FBI e il diTeilimento di Giustizia. A un certo punto conto undici persone intorno al tavolo. L’istanza ai sensi dell’articolo 35, alla quale è stato allegato l’accordo, è diventata più voluminosa e adesso conta ventidue pagine. Ho letto ogni parola cinque volte. Ho addirittura preteso inserimenti o modifiche formulati da me. L’accordo, in breve, mi dà tutto ciò che voglio. La libertà, una nuova identità, la protezione del governo e i centocinquantamila dollari della ricompensa. Dopo l’abituale schiarimento di voce, il giudice Slater assume il comando della riunione. «Da questo momento mettiamo tutto a verbale» annuncia, e la sua stenotipista comincia a battere i tasti. «Anche se si tratta di una questione riservata e l’ordinanza del tribunale verrà secretata, voglio un verbale di questa udienza.» Una pausa, mentre Slater cerca tra i fogli. «Questa è un’istanza presentata dagli Stati Uniti per rilascio ai sensi dell’articolo 35. Bannister, ha letto l’istanza, l’accordo e l’ordinanza proposta?» «Sì, vostro onore.» «E mi pare che lei sia avvocato. O meglio, che lo fosse.» «È così, vostro onore.» «L’istanza, l’accordo e l’ordinanza hanno la sua approvazione?» Accidenti se ce l’hanno, vecchio mio. «Sì, signore.» Il giudice Slater rivolge la stessa domanda a tutti coloro che siedono al tavolo. È solo una formalità perché tutti si sono già dichiarati d’accordo. E, cosa più importante, il procuratore generale ha firmato l’accordo. Slater mi guarda e dice: «Mr Bannister, è consapevole del fatto che se il nome da lei indicato non porterà a un rinvio a giudizio, dopo dodici mesi l’accordo sarà nullo e privo di valore legale, la sua sentenza non verrà commutata e lei sconterà per intero il resto della pena?». «Sì, signore.» «E che finché non ci sarà un rinvio a giudizio lei resterà sotto la custodia del diTeilimento dell’amministrazione penitenziaria?» «Sì, signore.» Dopo qualche altra discussione sui termini dell’accordo, il giudice Slater firma l’ordinanza e l’udienza si conclude. Slater non mi saluta e io non lo maledico come invece mi piacerebbe fare. Devo ripetermi: è un miracolo che non vengano fatti fuori più giudici federali. Circondato da un capannello, scendo le scale ed entro in una stanza dove mi aspettano altri abiti scuri. C’è una videocamera pronta per me e Mr Victor Westlake sta camminando avanti e indietro. Mi viene chiesto di sedere a un’estremità del tavolo, rivolto verso la videocamera, e mi viene offerto da bere. Quello intorno a me è un gruppo molto nervoso, nella spasmodica attesa di sentirmi pronunciare quel nome. 12 «Si chiama Quinn Rucker. Maschio, nero, trentotto anni, originario del quadrante sudovest di Washington, processato due anni fa per traffico di stupefacenti e condannato a sette anni. L’ho conosciuto a Frostburg. Ha tagliato la corda circa tre mesi fa e da allora nessuno l’ha più visto. Fa Teile di una grande famiglia di trafficanti che operano con successo nel mercato della droga da parecchi anni. Non stiamo parlando di piccoli spacciatori di strada. Sono uomini d’affari, che hanno contatti in tutta la costa orientale. Cercano di evitare la violenza, che però di certo non li spaventa. Sono ben inquadrati, tosti e pieni di risorse. Molti di loro sono finiti in galera. Molti sono stati uccisi. Per loro rientra tutto nella normale amministrazione.» Faccio una pausa e prendo fiato. Nella stanza c’è silenzio. Sono almeno cinque gli abiti scuri che stanno prendendo appunti. Uno ha un laptop e ha già aperto il file di Quinn Rucker, che corrispondeva a parecchi parametri e figurava già nei primi cinquanta sospetti dell’FBI, soprattutto a causa del periodo trascorso insieme a me a Frostburg e della sua fuga da quel carcere. «Come dicevo, ho conosciuto Quinn a Frostburg e siamo diventati amici. Come parecchi detenuti, era convinto che io potessi depositare una magica istanza che l’avrebbe fatto uscire, ma non era così. In prigione non se la cavava bene, anche perché Frostburg era il suo primo carcere. Succede ad alcuni dei nuovi arrivati che non hanno mai vissuto altre esperienze di detenzione. Non apprezzano l’atmosfera del campo. Comunque il tempo passava e lui diventava sempre più irrequieto. Non riusciva a immaginare di farsi altri cinque anni. Rucker ha una moglie, un paio di bambini, soldi dall’attività di famiglia e un mucchio di insicurezze. Era convinto che certi cugini si stessero facendo avanti, che stessero prendendo il suo posto e gli rubassero la sua fetta. Gliene ho sentite raccontare tante, ma non me le sono bevute tutte. In genere quelli delle gang raccontano un mucchio di balle e amano esagerare, specie quando si tratta di soldi o di violenza. Però Quinn mi era simpatico. Probabilmente è stato il migliore amico che mi sia fatto in prigione. Non siamo mai stati compagni di cella, ma eravamo legati.» «Lei sa perché è evaso?» mi chiede Victor Westlake. «Credo di sì. Quinn smerciava erba a Frostburg e guadagnava bene. Ne fumava anche molta. Come sa, il sistema più veloce per essere cacciati da un campo federale è farsi beccare con droga o alcol. Severamente proibito. Quinn era venuto a sapere da un informatore che gli agenti penitenziari erano al corrente della sua attività e che stavano per saltargli addosso. Ma lui è un tipo in gamba, ha senso pratico, e non ha mai tenuto droga nella sua cella. Come la maggior Teile di quelli che smerciano, nascondeva la roba nelle aree comuni. Era sotto tiro e sapeva che se l’avessero beccato l’avrebbero spedito in un carcere più duro. Così ha tagliato la corda. Sono sicuro che non ha dovuto fare molta strada: probabilmente c’era qualcuno che lo aspettava poco lontano.» «Lei sa dov’è Rucker adesso?» Annuisco, me la prendo comoda e poi rispondo: «Quinn ha un cugino. Non so come si chiama, ma so che ha un paio di strip club a Norfolk, Virginia, vicino alla base navale. Trovate il cugino e troverete Quinn». «Sotto quale nome?» «Non ne ho idea, ma di certo non Quinn Rucker.» «Lei come lo sa?» «Spiacente, ma non sono affari suoi.» A questo punto Westlake fa un cenno a un agente in piedi accanto alla porta e l’agente scompare. La caccia è cominciata. «Parliamo del giudice Fawcett» dice Westlake. «Okay.» Non so quante volte ho sognato questo momento. Ho provato le battute nel buio della mia cella quando non riuscivo a dormire. L’ho scritto sotto forma di racconto che poi ho distrutto. L’ho recitato a voce alta mentre facevo interminabili e solitarie passeggiate lungo i confini di Frostburg. È difficile credere che finalmente stia succedendo davvero. «Gran Teile dell’attività della gang di Quinn consisteva nel far viaggiare la coca da Miami alle principali città della costa orientale, soprattutto nell’area sud: Atlanta, Charleston, Raleigh, Charlotte, Richmond, eccetera. Il percorso preferito era quello dell’Interstatale 95 per via del traffico intenso, ma la banda utilizzava ogni highway statale e ogni strada di contea presente sulla carta geografica. Quasi tutto il lavoro era fatto da corrieri. Davano cinquemila dollari a un autista perché noleggiasse un’auto e portasse un carico di coca a un centro di distribuzione a... scelga lei una città. Il corriere effettuava la consegna, poi faceva dietro-front e tornava nel Sud della Florida. Secondo Quinn, il novanta per cento della coca che si sniffa a Manhattan arriva in città su un’auto che un corriere noleggia a Miami e guida fino al Nord come in un normalissimo viaggio di lavoro. Scoprirli è virtualmente impossibile. Se un corriere viene arrestato, è perché qualcuno ha fatto la soffiata. Comunque, Quinn aveva un nipote che stava cominciando farsi strada nel business di famiglia. Il ragazzo era un corriere e capita che lo fermino per eccesso di velocità sull’Interstatale 81, appena fuori Roanoke. Guidava un furgone Avis a nolo e disse che stava andando a consegnare mobili antichi a un negozio di Georgetown. Sul furgone c’erano effettivamente dei mobili, ma la vera merce era un carico di cocaina, valore al dettaglio cinque milioni di dollari. L’agente si insospettì e chiese l’intervento del collega. Il nipote di Quinn conosceva la legge e si rifiutò di autorizzare la perquisizione del furgone. Il secondo agente era un novellino, una recluta iperzelante, che cominciò a curiosare nel cassone. Non aveva un mandato, non aveva una causa ragionevole e non aveva il permesso di perquisire. Quando trovò la cocaina, diede fuori di testa e tutto cambiò.» Faccio una pausa e bevo un sorso d’acqua. L’agente con il laptop sta picchiettando sulla tastiera, indubbiamente per inviare istruzioni a tutta la costa orientale. «Come si chiama il nipote?» mi domanda Westlake. «Non lo so, ma non credo che il cognome sia Rucker. Nella famiglia di Quinn ci sono parecchi cognomi e un discreto numero di false identità.» «E così il caso del nipote finì al giudice Fawcett?» chiede Westlake per sollecitarmi ad andare avanti, anche se nessuno sembra avere fretta. Pendono tutti dalle mie labbra e sono ansiosi di trovare Quinn Rucker, ma vogliono sentire tutta la storia. «Sì, e Quinn assunse un famoso avvocato di Roanoke, il quale gli assicurò che la perquisizione era stata palesemente incostituzionale. Se la perquisizione fosse stata giudicata inammissibile da Fawcett, lo stesso destino sarebbe toccato alle prove. Niente prove, niente processo, niente condanna, niente di niente. A un certo punto, Quinn venne a sapere che il giudice Fawcett avrebbe potuto considerare più favorevolmente la posizione del nipote nel caso che un po’ di soldi avessero cambiato di mano. Soldi seri. Per come la racconta Quinn, fu il suo avvocato a fare da intermediario nella trattativa. E no: non conosco il nome dell’avvocato.» «Quanto?» chiede Westlake. «Mezzo milione.» La mia risposta è accolta con grande scetticismo, e la cosa non mi sorprende. «Ho fatto fatica anch’io a crederci. Un giudice federale che prende una mazzetta... Però rimasi scioccato anche quando si scoprì che un agente dell’FBI era una spia dei russi. Immagino che in determinate circostanze un uomo possa fare qualsiasi cosa.» «Cerchiamo di restare in argomento» replica Westlake irritato. «Certo. Quinn e la famiglia sganciarono i soldi. Fawcett li prese. Il caso seguì lentamente il suo corso finché un giorno si arrivò all’udienza riguardante l’istanza di inammissibilità delle prove perché ottenute nel corso di una perquisizione illegale. Con grande sorpresa di tutti, il giudice deliberò contro il nipote di Quinn e ordinò il rinvio a giudizio. Privo di argomenti difensivi, il ragazzo venne riconosciuto colpevole dalla giuria, ma l’avvocato si dichiarò ottimista per quanto riguardava le possibilità in appello. La causa sta tuttora arrancando. Nel frattempo il nipote sta scontando una condanna a diciotto anni in Alabama.» «Una storia interessante, Mr Bannister» commenta Westlake. «Ma lei come fa a sapere che è stato Quinn Rucker a uccidere il giudice?» «Perché mi ha detto che l’avrebbe fatto, per vendetta e per recuperare i soldi. Ne parlava spesso. Sapeva esattamente dove abitava il giudice, dove lavorava e dove amava passare il weekend. Sospettava che il denaro fosse nascosto da qualche Teile nel cottage ed era fermamente convinto di non essere stato l’unico rapinato da Fawcett. E visto che è stato Rucker a raccontarmi tutto questo, Mr Westlake, appena lui verrà arrestato io diventerò il suo bersaglio. Posso anche uscire di prigione, ma dovrò sempre guardarmi le spalle. Questi sono tipi in gamba... Guardi le sue indagini: niente, nessun indizio. È gente che serba rancore ed è molto paziente. Quinn ha aspettato quasi tre anni per uccidere il giudice. Ne aspetterà anche venti pur di arrivare a me.» «Se è così in gamba, come mai le ha raccontato tutto quanto?» mi domanda Westlake. «Semplice. Come molti altri detenuti, Quinn pensava che io potessi presentare qualche brillante istanza, trovare un cavillo e farlo uscire di galera. Disse che mi avrebbe pagato, che mi avrebbe dato metà di quello che si sarebbe ripreso dal giudice Fawcett. Avevo sentito storie del genere prima di Quinn e ne ho sentite anche dopo. Studiai la sua pratica e gli assicurai che non c’era niente che potessi fare.» Devono credere che stia dicendo la verità. Se Rucker non verrà rinviato a giudizio, dovrò passare i prossimi cinque anni in carcere. Siamo ancora su lati opposti della barricata, loro e io, ma stiamo lentamente trovando un terreno comune. 13 Sei ore più tardi due agenti neri dell’FBI pagarono la quota d’ingresso al Velvet Club, a tre isolati dalla base navale di Norfolk. Vestiti come due operai edili, si confondevano facilmente tra la clientela del locale, composta per metà da bianchi e per metà da neri, per metà da marinai e per metà da civili. Anche le ballerine erano per metà bianche e per metà nere, niente discriminazioni. Due furgoni di sorveglianza attendevano nel parcheggio, insieme a un’altra decina di agenti. Quinn Rucker era stato localizzato, fotografato e identificato mentre alle diciassette e trenta entrava nel club, dove lavorava come barista. Quando alle venti e quarantacinque si allontanò dalla sua postazione per andare in bagno, fu seguito. Nel bagno venne affrontato dai due agenti e, dopo una breve discussione, tutti e tre concordarono di uscire da una porta sul retro del locale. Quinn capì la situazione e non tentò mosse azzardate. E non sembrò neppure sorpreso. Come per molti altri evasi prima di lui, la fine della fuga fu sotto molti punti di vista un sollievo. I sogni di libertà si sgretolano davanti alla sfida di condurre una vita normale. C’è sempre qualcuno, là dietro. Quinn Rucker venne ammanettato e portato nella sede dell’FBI di Norfolk. In una stanza per gli interrogatori, i due agenti neri gli portarono un caffè e cominciarono a chiacchierare amichevolmente con lui. Il reato era una banale evasione e Quinn non aveva argomenti di difesa: era colpevole senza scampo e destinato a tornare in prigione. Gli chiesero se fosse disposto a rispondere a qualche domanda sulla sua evasione, avvenuta circa tre mesi prima, e Quinn non si negò. Raccontò spontaneamente di aver raggiunto, non lontano dal campo di Frostburg, un complice, di cui non fece il nome, che l’aveva riportato a Washington, dove era rimasto a ciondolare per qualche giorno. La sua presenza però non era stata ben accolta. Gli evasi richiamano l’attenzione e ai ragazzi della gang non andava l’idea dell’FBI che ficcava il naso in giro alla sua ricerca. Così Rucker aveva cominciato a trasportare cocaina da Miami ad Atlanta, ma il lavoro andava a rilento. Lui era merce avariata e il suo “sindacato”, come Quinn lo definiva, era molto diffidente nei suoi confronti. Ogni tanto andava a trovare moglie e figli, ma era consapevole del pericolo che correva avvicinandosi troppo a casa. Aveva trascorso un po’ di tempo con una sua vecchia fiamma a Baltimora, ma anche lei si era dimostrata poco entusiasta della sua presenza. Aveva vissuto alla giornata, effettuando qualche consegna di droga, e poi finalmente aveva avuto un colpo di fortuna quando suo cugino gli aveva offerto il lavoro di barista al Velvet Club. Alla porta accanto, in una stanza più grande, due agenti dell’FBI veterani degli interrogatori ascoltavano la conversazione. Al piano di sopra c’era un’altra squadra, in attesa e in ascolto. Se le cose fossero andate bene, sarebbe stata una lunga notte per Quinn. E le cose dovevano andare bene per l’FBI: considerata l’assenza di qualsiasi elemento concreto, era imperativo che l’interrogatorio producesse qualche prova. Gli agenti però erano preoccupati, perché quello con cui se la dovevano vedere era un uomo che conosceva bene tutti i trucchi. Era improbabile che riuscissero a intimorirlo tanto da farlo parlare. Appena Quinn venne scortato fuori dal Velvet Club, altri agenti dell’FBI piombarono su suo cugino. Il cugino la sapeva lunga e disse ben poco, poi però venne minacciato con l’accusa di aver dato rifugio a un evaso. L’uomo aveva una fedina penale impressionante e con ogni probabilità un’altra condanna lo avrebbe rispedito dritto al penitenziario. Dato che preferiva vivere libero, cominciò a cantare. Quinn al momento viveva e lavorava sotto il falso nome di Jackie Todd, anche se il salario gli veniva pagato in nero e in contanti. Il cugino accompagnò gli agenti a uno squallido parcheggio per roulotte distante meno di un chilometro e indicò la casa mobile arredata di cui Quinn rinnovava il contratto di affitto di mese in mese. Accanto alla casa mobile c’era un SUV Hummer H3, del 2008, con targa del North Carolina. Il cugino spiegò che Quinn, condizioni meteo permettendo, preferiva andare al lavoro a piedi e tenere l’Hummer nascosto. Nel giro di un’ora l’FBI ottenne un mandato di perquisizione sia per la casa mobile che per il SUV, che venne trasportato con un carro attrezzi nel parcheggio della polizia di Norfolk, dove fu aperto ed esaminato. La porta della casa mobile era chiusa a chiave, ma era anche piuttosto fragile. Un colpo di mazza ben assestato e gli agenti entrarono. L’interno era pulito e ordinato. Lavorando con efficienza, sei agenti lo setacciarono in lungo e in largo. Nell’unica camera da letto, fra il materasso e la rete, trovarono il portafoglio, le chiavi e il cellulare di Quinn. Il portafoglio conteneva circa cinquecento dollari in contanti, una patente di guida falsa del North Carolina e due carte di credito VISA prepagate del valore di milleduecento dollari ciascuna. Il cellulare era del tipo prepagato, usa e getta, perfetto per un uomo in fuga. Sotto il letto gli agenti rinvennero una pistola Smith & Wesson a canna corta calibro .38, caricata con pallottole a punta cava. Maneggiandola con estrema cura, gli agenti ipotizzarono immediatamente che quella fosse l’arma usata per uccidere il giudice Fawcett e Naomi Clary. Tra le chiavi c’era quella di un box in un magazzinodeposito distante tre chilometri. In un cassetto della cucina un agente trovò l’“ufficio” di Quinn: un paio di cartelline che contenevano pochi documenti. Un modulo, però, era il contratto d’affitto per sei mesi di un box presso il Macon’s Mini-Storage, firmato da Jackie Todd. Il capo degli investigatori telefonò al magistrato federale di turno a Roanoke, il quale inviò per e-mail a Norfolk il mandato di perquisizione. Nella cartellina c’era anche il certificato di proprietà, intestato a Jackie Todd, del SUV Hummer H3 del 2008. Sul documento non era indicato alcun patto di riservato dominio, quindi si poteva concludere con certezza che Mr Todd aveva pagato il veicolo per intero e in un unico versamento, in contanti o con assegno. Nel cassetto non vennero trovati libretti di assegni o estratti conto bancari, ma nemmeno ci si aspettava di trovarne. L’atto di vendita del veicolo evidenziava che il SUV era stato acquistato il 9 febbraio 2011 presso un rivenditore di auto usate a Roanoke. 9 febbraio, due giorni dopo il ritrovamento dei corpi. Forti del nuovo mandato, due agenti entrarono nel minuscolo box di Jackie Todd presso il Macon’s MiniStorage, sotto lo sguardo attento e sospettoso di Mr Macon in persona. Pavimento di cemento, pareti grezze, una solitaria lampadina fissata al soffitto. C’erano cinque scatoloni di cartone impilati contro una parete. Una rapida occhiata rivelò alcuni vecchi indumenti, un paio di stivali da combattimento infangati, una pistola Glock 9 millimetri con la matricola abrasa e, infine, una cassettina di metallo piena di contanti. Gli agenti presero i cinque scatoloni, ringraziarono Mr Macon per l’ospitalità e riTeilirono velocemente. Nel frattempo, il nome Jackie R. Todd veniva controllato nel database del National Crime Information Center. La ricerca diede un solo risultato. A Roanoke, Virginia. A mezzanotte, Rucker venne trasferito nella stanza accanto e presentato agli agenti speciali Pankovits e Delocke, i quali gli spiegarono di essere specialisti dell’FBI negli interrogatori agli evasi. Si trattava di un semplice colloquio di routine, una piccola indagine mirante a definire i fatti e che loro si divertivano sempre a svolgere: a chi non piacerebbe fare due chiacchiere con un evaso e venire a sapere tutti i dettagli? Era tardi, e se Quinn preferiva andarsene a dormire per qualche ora nel carcere di contea, loro sarebbero stati lieti di rimandare il colloquio all’indomani mattina. Quinn declinò l’offerta e disse che voleva farla finita subito. Arrivarono sandwich e bibite analcoliche. L’umore generale era rilassato e gli agenti estremamente cordiali. Pankovits era bianco e Delocke nero, e Quinn sembrava apprezzare la loro compagnia. Mangiucchiò un panino al prosciutto e formaggio mentre i due gli raccontavano la storia di un evaso che era rimasto latitante per ventun anni. L’ FBI li aveva fatti volare fino in Thailandia per riportarlo a casa. Che spasso. Interrogarono Rucker sulla sua evasione e sui suoi movimenti nei giorni successivi, domande e risposte già coperte dal primo interrogatorio. Quinn si rifiutò di fornire i nomi del suo complice e di chiunque lo avesse aiutato durante la latitanza. Nessun problema. Gli agenti non insistettero, apparentemente disinteressati a dare la caccia ad altri. Dopo un’ora di chiacchiere amichevoli, a Pankovits venne in mente che non avevano letto a Rucker i diritti del Miranda. Niente di male, gli assicurarono, dato che il reato era evidente e lui, Quinn, non era implicato in niente, a Teile l’evasione. Nessun problema, ma se voleva continuare, doveva rinunciare formalmente ai suoi diritti. Rucker lo fece firmando un modulo. A quel punto, ormai, lui era Quinn, Pankovits era Andy e Delocke era Jesse. Ricostruirono con cura i movimenti di Rucker nei tre mesi precedenti, e lui si dimostrò sorprendentemente preciso nell’indicare date, luoghi e avvenimenti. Impressionati, i due agenti si complimentarono per la sua memoria. Erano interessati in Teilicolare ai suoi guadagni; tutti in contanti naturalmente, ma quanto aveva incassato per ogni viaggio? «Allora, per la seconda corsa da Miami a Charleston» disse Pankovits, sorridendo ai suoi appunti «quella della settimana dopo Capodanno, quanto hai preso in contanti?» «Mi sembra seimila.» «Giusto, giusto.» Entrambi gli agenti prendevano furiosamente appunti, come se avessero creduto a ogni parola pronunciata dal soggetto. Quinn disse che viveva e lavorava a Norfolk da metà febbraio, cioè da circa un mese. Abitava con suo cugino e due sue fidanzate in un grande apTeilamento non lontano dal Velvet Club. Veniva pagato in contanti, cibo, bevande, sesso ed erba. «Allora, Quinn» disse Delocke, facendo la somma di una serie di cifre. «A me pare che tu abbia guadagnato circa quarantaseimila dollari da quando te ne sei andato da Frostburg, tutti in contanti ed esentasse. Non male per tre mesi di lavoro.» «Immagino di sì.» «E quanti ne hai spesi?» domandò Pankovits. Quinn si strinse nelle spalle, come se la cosa non avesse molta importanza. «Non saprei. Quasi tutti. Servono parecchi soldi per spostarsi.» «Quando Teilivi con la droga da Miami e poi tornavi indietro, come noleggiavi le auto?» chiese Delocke. «Non le noleggiavo. Lo faceva qualcun altro, che poi mi dava le chiavi. Il mio lavoro consisteva nel guidare con molta attenzione, senza superare i limiti e senza farmi fermare dalla polizia.» Verosimile, ed entrambi gli agenti ne convennero. «Ti sei comprato un’auto?» chiese Pankovits senza alzare gli occhi dai suoi appunti. «No» rispose Rucker con un sorriso. Che domanda stupida. «Non puoi comprarti una macchina se sei un latitante senza documenti.» Naturalmente no. Nel Freezer a Roanoke, Victor Westlake sedeva davanti a un grande schermo e fissava immobile l’immagine di Quinn Rucker. Una telecamera nascosta nella stanza degli interrogatori stava inviando il video attraverso il Commonwealth fino a una sala proiezioni improvvisata, attrezzata con una stupefacente quantità di gadget e tecnologia. C’erano quattro agenti insieme a Westlake, e tutti osservavano gli occhi e le espressioni di Mr Rucker. «Niente da fare» borbottò uno dei quattro. «Quel tipo è troppo furbo. Sa che troveremo la casa mobile, il portafoglio, i documenti falsi, il SUV.» «Forse no» mormorò un altro. «Per ora stanno parlando solo dell’evasione. Rucker è convinto che non abbiamo idea dell’omicidio. Niente di serio.» «Sono d’accordo» disse un altro. «Io credo che stia prendendo tempo, che stia giocando le sue carte. Pensa di poter sopravvivere a qualche domanda e che poi lo riporteranno in cella di sicurezza e infine in carcere. Ha in mente di telefonare a suo cugino, a un certo punto, e di dirgli di fare sparire tutto.» «Aspettiamo e vediamo» suggerì Westlake. «Stiamo a vedere come reagirà quando cadrà la prima bomba.» Alle due del mattino, Quinn chiese: «Posso andare in bagno?». Delocke si alzò in piedi e lo scortò fuori dalla stanza, fino in fondo al corridoio. C’era un altro agente di guardia, una dimostrazione di forza. Cinque minuti dopo, Rucker era di nuovo sulla sua sedia. «È piuttosto tardi, Quinn» disse Pankovits. «Vuoi andare in prigione e dormire un po’? Abbiamo un mucchio di tempo a disposizione.» «Preferisco restare qui, piuttosto che andare in prigione» rispose Rucker con voce triste. «Di quanto pensate che aumenterà la mia condanna?» chiese. «Non lo so, Quinn» rispose Delocke. «Lo deciderà il procuratore federale. La cosa peggiore è che non ti rimanderanno in un campo. Mai più. Andrai in un carcere vero.» «Sai, Jesse, ho quasi nostalgia del campo. Non era poi così male.» «Allora come mai te ne sei andato?» «Perché sono stupido. Perché? Perché ne avevo la possibilità. Mi sono semplicemente allontanato a piedi e a nessuno è sembrato importare.» «Ogni anno interroghiamo circa venticinque tizi che se ne sono andati da un campo federale. “Stupido” credo che sia l’aggettivo giusto.» Pankovits affastellò qualche foglio e disse: «Bene, Quinn, mi pare che abbiamo definito il quadro. Date, luoghi, movimenti, contanti. Tutto questo verrà inserito nel rapporto preprocessuale. Il lato positivo è che negli ultimi tre mesi non hai fatto niente di Teilicolarmente grave. Qualche consegna di droga, cosa che ovviamente non ti aiuterà, ma non hai fatto del male a nessuno, giusto?». «Giusto.» «E tu ci hai raccontato tutta la storia, vero? Non hai lasciato fuori niente?» «Sì.» I due agenti si irrigidirono leggermente e corrugarono la fronte. «Cosa ci dici di Roanoke, Quinn?» domandò Pankovits. «Sei mai stato a Roanoke?» Rucker guardò il soffitto, rifletté un momento e poi rispose: «Forse ci sono passato un paio di volte, nient’altro». «Ne sei sicuro?» «Sì, sono sicuro.» Delocke aprì una cartellina, scorse rapidamente un foglio e chiese: «Chi è Jackie Todd?». Gli occhi di Rucker si chiusero e la bocca si aprì appena. Ne uscì un basso suono gutturale che arrivava dal profondo, come se Quinn fosse stato colpito da un pugno sotto la cintura. Le spalle si abbassarono di colpo. Se fosse stato bianco, sarebbe impallidito. «Non lo so» rispose dopo qualche istante. «Mai conosciuto.» «Davvero?» insistette Delocke. «Be’, a quanto pare questo Mr Jackie R. Todd è stato arrestato nella notte di martedì, otto febbraio, in un bar di Roanoke. Ubriachezza molesta e aggressione. Secondo il rapporto della polizia, si era azzuffato con qualche altro ubriaco e ha passato la notte in cella. La mattina dopo ha versato una cauzione di ottocento dollari in contanti e se n’è andato.» «Non ero io.» «Davvero?» Delocke fece scivolare un foglio sul tavolo. Quinn lo prese lentamente in mano. Era una foto segnaletica, chiaramente sua. «Non ci sono molti dubbi, ti sembra, Quinn?» Rucker posò il foglio sul tavolo e disse: «Okay, okay. Va bene: avevo un nome falso. Cosa avrei dovuto fare? Giocare a nascondino con il mio nome vero?». «Certo che no» ammise Pankovits. «Però tu ci hai mentito, giusto?» «Non siete i primi piedipiatti ai quali ho mentito.» «Mentire all’FBI può costarti cinque anni.» «Okay, ho raccontato qualche balla.» «Nessuna sorpresa, ma ora non possiamo più credere a niente. Immagino che dovremo ricominciare tutto daccapo.» «Il nove febbraio» disse Delocke «un certo Jackie Todd si è presentato da un rivenditore di auto usate a Roanoke e ha comprato un SUV Hummer H3 del 2008 pagandolo ventiquattromila dollari in contanti. Ti ricorda qualcosa, Quinn?» «No. Non ero io.» «Ne ero sicuro.» Delocke fece scivolare sul tavolo una copia dell’atto di vendita. «E questo non l’hai mai visto, vero?» Rucker guardò il documento e rispose: «No». Pankovits scattò: «Andiamo, Quinn! Non siamo stupidi nemmeno la metà di quello che pensi. L’otto febbraio tu eri a Roanoke, sei entrato in quel bar, hai fatto a botte e sei finito in prigione. La mattina dopo sei uscito su cauzione, sei tornato nella tua camera al motel Safe Lodge, dove hai pagato in contanti, hai preso altri contanti e ti sei comprato il SUV». «È un reato pagare una macchina in contanti?» «Assolutamente no» rispose Pankovits. «Ma in quel momento tu non avresti dovuto avere tutti quei soldi a disposizione.» «Può darsi che abbia confuso qualche data e qualche incasso di contanti. Non posso ricordare tutto.» «Ti ricordi dove hai comprato le pistole?» chiese Delocke. «Quali pistole?» «La Smith & Wesson calibro .38 che abbiamo trovato nella tua casa mobile e la Glock 9 millimetri che abbiamo trovato nel tuo box al deposito, circa due ore fa.» «Pistole rubate» aggiunse sollecito Pankovits. «Altri reati federali.» Quinn intrecciò lentamente le mani dietro la testa e puntò lo sguardo sulle ginocchia. Passò un minuto, poi un altro. I due agenti lo fissavano senza sbattere le palpebre e senza muovere un muscolo. La stanza era silenziosa, immobile, tesa. Poi Pankovits frugò tra le sue carte, scelse un foglio e disse: «L’inventario comprende un portafoglio contenente cinquecentododici dollari in contanti, una patente di guida falsa del North Carolina, due carte di credito VISA prepagate, un cellulare prepagato, la già citata Smith & Wesson, i documenti di acquisto dell’Hummer, un certificato di assicurazione per il veicolo, il contratto d’affitto del box, una scatola di pallottole per la .38 e qualche altro articolo, il tutto prelevato dalla casa mobile che hai in affitto per quattrocento dollari al mese. Nel box del deposito abbiamo inventariato alcuni indumenti, la Glock 9 millimetri, un paio di stivali da combattimento, qualche altro oggetto e, cosa più importante, una cassettina di metallo contenente quarantunmila dollari in banconote da cento». Rucker incrociò le braccia sul petto e fissò Delocke, che gli disse: «Abbiamo tutta la notte, Quinn. Cosa ne pensi di darci una spiegazione?». «Forse le corse sono state più di quelle che ricordavo. Ho fatto un mucchio di viaggi fino a Miami e ritorno.» «E perché non ci hai parlato di tutti questi viaggi?» «Come dicevo, non è che posso ricordare tutto. Quando sei continuamente in fuga, come me, tendi a dimenticare le cose.» «Ricordi di avere usato per qualsiasi ragione l’una o l’altra di quelle due pistole?» chiese Delocke. «No.» «Nel senso che non hai usato quelle pistole, o che non ricordi se le hai usate?» «Non le ho usate.» Pankovits trovò un altro foglio e lo studiò con aria grave. «Ne sei sicuro, Quinn? Qui abbiamo una perizia balistica preliminare.» Lentamente, Rucker spinse indietro la sedia e si alzò in piedi. Si stirò e fece pochi passi fino ad arrivare a un angolo della stanza. «Forse mi serve un avvocato.» 14 Non esisteva alcuna perizia balistica. La Smith & Wesson calibro .38 era al laboratorio dell’FBI a Quantico e sarebbe stata esaminata appena i tecnici si fossero presentati al lavoro tra circa cinque ore. Il foglio che Pankovits brandiva come un’arma era la copia di un qualche inutile memo. Pankovits e Delocke disponevano di un intero repertorio di trucchetti, tutti approvati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Utilizzarli dipendeva dal punto fino al quale Quinn avrebbe consentito spingersi. Il problema nell’immediato era il suo accenno alla necessità di un “avvocato”. Se Rucker avesse detto, chiaramente e inequivocabilmente, “Voglio un avvocato!” oppure “Non intendo rispondere ad altre domande finché non avrò un avvocato!” o qualcosa di simile, l’interrogatorio avrebbe avuto immediatamente termine. Ma Quinn era stato vago e aveva usato la parola “forse”. La tempistica era cruciale. Per distogliere l’attenzione dall’argomento avvocato, gli agenti modificarono rapidamente lo scenario. Delocke si alzò in piedi e annunciò: «Devo andare a fare pipì». Pankovits disse: «E io ho bisogno di altro caffè. Tu, Quinn?». «No.» Delocke uscì sbattendo la porta. Pankovits si alzò e si stirò la schiena. Erano quasi le tre del mattino. Quinn Rucker aveva due fratelli e due sorelle, età compresa tra i ventisette e i quarantadue anni, e tutti in momenti diversi erano stati coinvolti nel sindacato di famiglia del traffico di droga. Una sorella si era chiamata fuori dallo spaccio vero e proprio, ma era ancora attiva in varie operazioni di riciclaggio. Gli altri erano usciti dal business, si erano trasferiti in altre città e cercavano di evitare al massimo i parenti. Il minore dei fratelli era Dee Ray Rucker, un ragazzo tranquillo che studiava economia alla Georgetown e sapeva come spostare il denaro. Aveva un precedente per possesso illegale di un’arma, ma nient’altro di significativo. In realtà Dee Ray non aveva lo stomaco per affrontare i rischi e la violenza della vita di strada e cercava di starne alla larga. Abitava con la sua ragazza in un modesto apTeilamento nei pressi di Union Station, e fu lì che l’FBI lo trovò poco dopo mezzanotte: a letto, libero da preoccupazioni di mandati in sospeso o di indagini penali in corso, ignaro di ciò che stava succedendo al suo caro fratello Quinn, tranquillo e sereno, e profondamente addormentato. Fu preso in custodia senza che opponesse resistenza, ma avanzando un’enorme quantità di rimostranze. La squadra di agenti non gli diede praticamente spiegazioni. Nella sede dell’FBI in Pennsylvania Avenue, Dee Ray venne fatto entrare in una stanza, messo a sedere e circondato da agenti, tutti con il giubbotto blu e la scritta FBI in giallo vivo. La scena venne fotografata da diverse angolazioni. Dopo un’ora trascorsa a sedere con le manette ai polsi e senza che gli venisse detto nulla, fu fatto uscire dalla stanza, riportato al furgone e riaccompagnato a casa. Venne scaricato sul marciapiede senza una parola. La sua ragazza gli fece mandare giù qualche pillola e Dee Ray dopo un po’ si calmò. La mattina successiva avrebbe chiamato il suo avvocato scatenando l’inferno, ma l’intero episodio sarebbe stato presto dimenticato. Nel ramo droga non ti aspetti mai un lieto fine. Tornando dal bagno, Delocke tenne la porta aperta per un momento e lasciò entrare un’attraente segretaria che posò sul bordo del tavolo un vassoio con bibite e biscotti. La ragazza sorrise a Quinn, ancora in piedi in un angolo e troppo confuso per notare la sua presenza. Dopo che la segretaria se ne fu andata, Pankovits aprì una lattina di Red Bull e ne versò il contenuto in un bicchiere con il ghiaccio. «Vuoi una Red Bull, Quinn?» «No.» Tutte le sere Rucker serviva al bar quella roba, Red Bull e vodka, ma il sapore non gli era mai piaciuto. La pausa nell’interrogatorio gli dava modo di riprendere fiato e riorganizzare i pensieri. Doveva continuare o sarebbe stato meglio restare in silenzio e insistere per l’avvocato? L’istinto gli suggeriva la seconda opzione, ma Quinn era estremamente curioso di capire cosa sapeva l’FBI. Era ancora disorientato a causa di quello che avevano già scoperto, ma fino a che punto erano arrivati? Anche Delocke si versò una Red Bull con ghiaccio e sgranocchiò un biscotto. «Siediti, Quinn» disse, indicando il tavolo con un gesto della mano. Rucker si mise a sedere. Pankovits stava già prendendo appunti. «Tuo fratello maggiore, mi pare che si faccia chiamare Tall Man, è ancora nell’area di Washington?» «Lui cosa c’entra?» «È solo per riempire qualche vuoto. Tutto qui. Mi piace conoscere tutti i fatti, o il maggior numero di fatti possibile. Hai visto spesso Tall Man negli ultimi tre mesi?» «No comment.» «Okay. Tuo fratello minore, Dee Ray, è ancora nell’area di Washington?» «Non so dove sia Dee Ray.» «Hai visto spesso Dee Ray negli ultimi tre mesi?» «No comment.» «Dee Ray era con te a Roanoke quando sei stato arrestato?» «No comment.» «C’era qualcuno insieme te, quando sei stato arrestato a Roanoke?» «Ero solo.» Delocke sbuffò, frustrato. Pankovits sospirò, come se Quinn avesse risposto con un’altra bugia e loro lo sapessero. «Giuro che ero solo» ribadì Rucker. «Cosa ci facevi a Roanoke?» gli chiese Delocke. «Affari.» «Spaccio?» «È il nostro lavoro. Roanoke rientra nel nostro territorio. Si era creata una certa situazione e io dovevo occuparmene.» «Che tipo di situazione?» «No comment.» Pankovits bevve un lungo sorso di Red Bull, poi disse: «Sai, Quinn, il problema che abbiamo in questo momento è che non possiamo credere a una sola parola. Tu menti. Sappiamo che menti. Tu stesso ammetti di mentire. Noi ti facciamo una domanda e tu ci rispondi con una bugia». «Non stiamo andando da nessuna Teile, Quinn» intervenne Delocke. «Cosa ci facevi a Roanoke?» Rucker tese una mano, prese un biscotto farcito, tolse lo strato superiore, leccò la crema, fissò Delocke e finalmente rispose: «Sospettavamo che un nostro corriere da quelle Teili fosse un informatore. Avevamo perso due consegne in circostanze piuttosto strane e abbiamo capito come stavano le cose. Sono andato a cercare il corriere». «Per ucciderlo?» «No, noi non operiamo in quel modo. Non sono riuscito a trovarlo: evidentemente gli era arrivato qualcosa all’orecchio e aveva tagliato la corda. Sono entrato in un bar, ho bevuto troppo, sono finito in una rissa e ho passato una brutta notte. Il giorno dopo un mio amico mi ha parlato di un Hummer che era un ottimo affare e così sono andato a vederlo.» «Chi era l’amico?» «No comment.» «Stai mentendo» disse Delocke. «Stai mentendo e noi lo sappiamo. E non sei neppure un bravo bugiardo, Quinn, lo sai?» «Se lo dici tu.» «Perché hai immatricolato l’Hummer in North Carolina?» chiese Pankovits. «Perché ero latitante, hai presente? Ero un evaso e cercavo di non lasciare tracce. Ci arrivate, ragazzi? Documenti falsi. Indirizzo falso. Tutto falso.» «Chi è Jakeel Staley?» domandò Delocke. Quinn esitò per un secondo, cercò di sembrare indifferente e rispose con noncuranza: «Mio nipote». «Dov’è adesso?» «In un penitenziario federale da qualche Teile. Sono sicuro che voi ragazzi conoscete la risposta.» «Alabama. Sta scontando diciotto anni» disse Pankovits. «Jakeel era stato arrestato nei dintorni di Roanoke con un furgone pieno di coca, giusto?» «Sono sicuro che avete la pratica.» «Hai cercato di aiutare Jakeel?» «Quando?» Entrambi gli agenti reagirono esagerando i segnali di frustrazione. Tutti e due bevvero un sorso di Red Bull. Delocke prese un altro biscotto. Sul vassoio ce n’era ancora una decina, oltre a una caffettiera piena. I due avevano l’aria di voler continuare per tutta la notte. «Andiamo, Quinn, piantala con i giochetti» disse Pankovits. «Abbiamo assodato che Jakeel è stato arrestato a Roanoke. Una montagna di coca e la prospettiva di una montagna di anni dentro un penitenziario. La domanda è se tu hai provato ad aiutare il ragazzo oppure no.» «Certo che ci ho provato. Jakeel fa Teile della famiglia, fa Teile del business ed è stato arrestato sul lavoro. La famiglia interviene sempre.» «Hai assunto tu l’avvocato?» «Sì.» «Quanto lo hai pagato?» Quinn rifletté per un momento, poi rispose: «Non ricordo proprio. Un bel po’ di bigliettoni comunque». «Hai pagato l’avvocato in contanti?» «È quello che ho appena detto. Niente di illegale nei contanti, l’ultima volta che ho controllato. Noi non usiamo bonifici, carte di credito o qualunque altra cosa che i federali possano tracciare. Solo contanti.» «Chi ti ha dato i soldi per pagare l’avvocato?» «No comment.» «Li hai avuti da Dee Ray?» «No comment.» Pankovits tese lentamente una mano verso un sottile fascicolo ed estrasse un foglio. «Be’, Dee Ray dice che è stato lui a darti i soldi che ti servivano a Roanoke.» Rucker scosse la testa e fece un sorriso sarcastico che significava: “Stronzate”. Pankovits gli passò un ingrandimento venti per venticinque di una foto a colori. Era Dee Ray che, circondato da agenti dell’FBI, aveva le manette ai polsi, la bocca aperta e l’espressione rabbiosa. Delocke spiegò: «Abbiamo prelevato Dee Ray a Washington circa un’ora dopo che abbiamo preso te. Sai, a lui piace parlare. In effetti parla molto più di te». Quinn fissava la foto ed era senza parole. Il Freezer. Quattro del mattino. Victor Westlake si alzò di nuovo in piedi e prese a camminare nella stanza. Era necessario muoversi per combattere il sonno. Gli altri quattro agenti erano ancora svegli, i nervi pompati con anfetamine da banco, Red Bull e caffè. «Maledizione, quei due sono troppo lenti» disse uno di loro. «Sono metodici» obiettò un altro. «Mirano a sfinirlo. Il fatto che stia ancora parlando dopo sette ore è incredibile.» «Non vuole andare nel carcere di contea.» «Non posso dargli torto.» «Io credo che sia ancora mosso dalla curiosità. Il gatto e il topo. Cosa sa effettivamente l’FBI?» «Non riusciranno a fregarlo. È troppo furbo.» «Sanno quello che stanno facendo» disse Westlake. Si rimise a sedere e si versò un’altra tazza di caffè. A Norfolk, Pankovits si versò una tazza di caffè e chiese: «Chi ti ha accompagnato a Roanoke?». «Nessuno. Ci sono andato da solo in macchina.» «Che tipo di macchina?» «Non mi ricordo.» «Stai mentendo, Quinn. Qualcuno ti ha portato a Roanoke la settimana prima del sette febbraio. Eravate in due. Abbiamo dei testimoni.» «Allora i vostri testimoni mentono. Voi mentite. Tutti mentono.» «Hai comprato l’Hummer il nove febbraio, l’hai pagato in contanti e non c’è stata nessuna permuta. Come sei arrivato dal rivenditore di auto usate il giorno in cui hai comprato il SUV? Chi ti ha accompagnato?» «Non mi ricordo.» «Non ricordi chi ti ha accompagnato?» «Non ricordo niente. Stavo male per i postumi della sbornia ed ero ancora mezzo ubriaco.» «Dài, Quinn!» fece Delocke. «Queste bugie stanno diventando ridicole. Cosa stai nascondendo? Se non stessi nascondendo qualcosa, non diresti tante bugie.» «Cosa diavolo volete sapere esattamente?» domandò Quinn, alzando le mani in aria. «Dove avevi preso tutti quei contanti?» «Sono uno spacciatore. Sono uno spacciatore da una vita. Sono stato in galera perché sono uno spacciatore. E noi spacciatori li bruciamo i contanti. Li mangiamo. Lo capite o no?» Pankovits stava scuotendo la testa. «Però, vedi, Quinn, secondo la tua storia, dopo l’evasione non stavi lavorando molto per la famiglia. Avevano paura di te, giusto? Ho ragione o no?» domandò a Delocke, il quale confermò subito che sì, il suo collega aveva ragione. «La famiglia ti teneva alla larga» spiegò Delocke «e così hai cominciato con le corse giù al Sud e ritorno. Hai detto di avere guadagnato circa quarantaseimila dollari, ma noi adesso sappiamo che è una bugia perché ne hai spesi ventiquattromila per l’Hummer e abbiamo trovato quarantunmila dollari nel tuo box al deposito.» Pankovits aggiunse: «Avevi un bel po’ di contanti, Quinn. Cosa ci nascondi?». «Niente.» «Allora perché stai mentendo?» «Tutti mentono. Pensavo che su questo fossimo d’accordo.» Delocke picchiettò il ripiano del tavolo con un dito e disse: «Torniamo indietro di qualche anno. Tuo nipote Jakeel Staley è in carcere qui a Roanoke, in attesa del processo, e tu versi al suo avvocato una certa somma in contanti per l’assistenza legale, giusto?». «Giusto.» «Ci sono stati altri versamenti di denaro? Un piccolo extra per ungere il sistema? Magari una bustarella in modo che la corte avesse la mano leggera con tuo nipote? Niente del genere, Quinn?» «No.» «Sei sicuro?» «Certo che sono sicuro.» «Andiamo, Quinn!» «Ho pagato l’avvocato in contanti. Ho dato per scontato che si tenesse i soldi per la parcella. Non so altro.» «Chi era il giudice?» «Non mi ricordo.» «Il giudice Fawcett ti dice qualcosa?» Rucker si strinse nelle spalle. «Forse.» «Sei mai andato in tribunale con Jakeel?» «Ero presente quando l’hanno condannato a diciotto anni.» «Sei rimasto sorpreso quando gli hanno dato diciotto anni?» «Sì, in effetti sì.» «Si supponeva che prendesse molto meno, vero?» «Secondo il suo avvocato, sì.» «E tu eri in aula e hai potuto dare una bella occhiata al giudice Fawcett, giusto?» «Ero in aula per mio nipote. Tutto qua.» La squadra interrogatori fece una pausa nello stesso momento. Delocke bevve un sorso di Red Bull. Pankovits disse: «Devo andare in bagno. Tu sei a posto, Quinn?». Rucker si stava pizzicando la fronte. «Certo» rispose. «Vuoi qualcosa da bere?» «Magari una Sprite.» «Te la porto.» Pankovits se la prese comoda. Rucker sorseggiò la sua bibita. L’interrogatorio riprese alle quattro e mezzo, Delocke domandò: «Allora, Quinn, ti sei tenuto aggiornato negli ultimi tre mesi? Hai letto i giornali? Sarai stato curioso di sapere se la tua evasione aveva fatto notizia, no?». «Veramente no» rispose Rucker. «Hai saputo del giudice Fawcett?» «No. Cosa gli è successo?» «È stato assassinato, due colpi alla nuca.» Nessuna reazione da Teile di Rucker. Nessuna sorpresa. Nessuna pietà. Niente. «Non lo sapevi, Quinn?» gli chiese Pankovits. «No.» «Due pallottole a punta cava, esplose da una pistola calibro .38 identica a quella che abbiamo trovato nella tua casa mobile. La perizia balistica preliminare dice che ci sono novanta probabilità su cento che sia stata la tua pistola a uccidere il giudice.» Rucker cominciò a sorridere e ad annuire. «Adesso capisco: tutta questa storia è per via di un giudice morto. Voi ragazzi pensate che sia stato io a uccidere Fawcett, giusto?» «Esatto.» «Grandioso. E così abbiamo sprecato... quante?, sette ore con questa stronzata. State sprecando il vostro tempo, il mio tempo, il tempo di Dee Ray, il tempo di tutti. Io non ho ucciso nessuno.» «Sei mai stato a Ripplemead, Virginia, cinquecento abitanti, tra le montagne a ovest di Roanoke?» «No.» «È il luogo abitato più vicino al laghetto dove è stato ucciso il giudice. Non ci sono neri a Ripplemead, e quando ne spunta uno viene notato. Il giorno prima che il giudice fosse assassinato, in città c’era un nero che corrisponde alla tua descrizione, secondo il proprietario di una stazione di servizio.» «Un’identificazione certa o solo un tirare a indovinare?» «Una via di mezzo. Domani gli faremo vedere una foto migliore.» «Sono sicuro che lo farete e scommetto anche che la sua memoria migliorerà notevolmente.» «Di solito succede così» disse Delocke. «Sei chilometri a ovest di Ripplemead il mondo finisce. Niente più asfalto, solo una serie di stradine sterrate che si perdono fra le montagne. C’è un vecchio emporio che si chiama Peacock’s, e Mr Peacock vede tutto. Dice che il giorno prima dell’omicidio un nero si è fermato nel suo negozio per chiedere indicazioni. Mr Peacock non riesce a ricordare l’ultima volta che aveva visto un nero nella sua Teile di mondo. Ci ha fornito una descrizione. Corrisponde perfettamente a te.» Rucker scrollò le spalle e disse: «Io non sono così stupido». «Davvero? Allora perché ti sei tenuto la Smith & Wesson? Appena riceviamo la perizia balistica definitiva, tu sei spacciato, Quinn.» «La pistola è rubata, okay? Le pistole rubate passano di mano. L’ho comprata in un banco dei pegni a Lynchburg due settimane fa. Nell’ultimo anno probabilmente ha cambiato proprietario almeno una decina di volte.» Un buon punto, che i due agenti non potevano contestare, almeno finché non fossero stati completati i test balistici. Una volta che avessero avuto la prova, tuttavia, nessuna giuria avrebbe creduto alla storia della pistola rubata. «Nel tuo box al deposito abbiamo trovato un paio di stivali da combattimento» disse Pankovits. «Roba scadente, di falsa provenienza militare: tela, disegno mimetico, tutte quelle stronzate. Sono abbastanza nuovi, e non sembrano essere stati usati molto. A cosa ti servono degli stivali da combattimento, Quinn?» «Ho le caviglie deboli.» «Ottima risposta. Te li metti spesso?» «Non così spesso, visto che erano nel deposito. Li ho provati, mi hanno fatto venire una vescica e li ho lasciati perdere. Qual è il problema?» «Il problema è che corrispondono all’impronta di uno stivale che abbiamo rilevato sul terreno non lontano dal cottage dove è stato ucciso il giudice Fawcett» disse Pankovits mentendo, ma con molta efficacia. «Un riscontro, Quinn. Un riscontro che ti inchioda sulla scena.» Rucker spalancò la bocca e si sfregò gli occhi. Erano stanchi e iniettati di sangue. «Che ore sono?» «Le quattro e cinquanta» rispose Delocke. «Ho bisogno di dormire un po’.» «Be’, questo potrebbe essere difficile, Quinn. Abbiamo parlato con il carcere di contea e la tua cella è parecchio affollata. Otto uomini, quattro brande. Sarai fortunato se avrai un pezzetto di pavimento.» «Non credo che quel carcere mi piaccia. Non potremmo trovarne un altro?» «Spiacente. Se non è di tuo gradimento, aspetta di vedere il braccio della morte.» «Io non andrò in nessun braccio della morte perché non ho ucciso nessuno.» «Ti faccio il quadro della situazione, Quinn» disse Pankovits. «Due testimoni ti collocano in zona al momento dell’omicidio, e la zona non è esattamente un trafficato incrocio stradale. Tu eri là, sei stato notato e si ricordano di te. La balistica ti inchioda. L’impronta di stivale è la ciliegina sulla torta: quella è la scena del delitto. E dopo l’omicidio le cose si mettono addirittura meglio, o peggio, a seconda dei punti di vista. Tu eri a Roanoke il giorno dopo la scoperta dei cadaveri, martedì otto febbraio, per tua stessa ammissione e come documentato dal registro della prigione della città e da quello del tribunale. E all’improvviso avevi un sacco di contanti. Hai pagato la cauzione, hai speso ventiquattromila dollari per l’Hummer, hai sperperato un altro mucchio di soldi e quando alla fine ti becchiamo, troviamo un altro bel po’ di dollari nascosti nel box di un magazzino. Il movente? Abbiamo un ottimo movente. Tu avevi un accordo con il giudice Fawcett perché deliberasse a favore di Jakeel Staley. Gli hai dato una mazzetta, qualcosa come cinquecentomila dollari, ma, dopo essersi preso i soldi, Fawcett si è dimenticato dell’accordo. Ha scaricato tutto il Codice addosso a Jakeel e tu hai giurato vendetta. E alla fine l’hai avuta. Sfortunatamente, ci è andata di mezzo anche la segretaria del giudice.» «È un caso da condanna a morte, Quinn» disse Delocke. «I giochi sono chiusi. Pena capitale.» Quinn chiuse gli occhi e il corpo sembrò rattrappirsi. Cominciò a respirare affannosamente mentre la fronte si imperlava di sudore. Passò un minuto, poi un altro. Il duro di prima non c’era più. La sua controfigura disse con voce flebile: «Avete preso l’uomo sbagliato». Pankovits scoppiò a ridere e Delocke, sogghignando, domandò: «È il meglio che riesci a tirare fuori?». «Avete preso l’uomo sbagliato» ripeté Rucker, ma con convinzione addirittura minore. «Suona piuttosto debole, Quinn» osservò Delocke. «E suonerà ancora più debole in aula.» Quinn si fissò le mani e lasciò passare un altro minuto. Poi disse: «Se voi ragazzi sapete tutte queste cose, cos’altro volete?». «C’è ancora qualche buco» ammise Pankovits. «Hai agito da solo? Come hai aperto la cassaforte? Perché hai ucciso la segretaria? Cos’è successo al resto del denaro?» «Non vi posso aiutare. Non so niente.» «Tu sai tutto, Quinn, e non ce ne andremo finché non avrai riempito i buchi.» «Allora credo che resteremo qui a lungo» disse Rucker. Si piegò in avanti, posò la testa sul tavolo e annunciò: «Ho bisogno di un sonnellino». I due agenti si alzarono in piedi raccogliendo fascicoli e blocchi per appunti. «Facciamo una pausa, Quinn. Torniamo fra mezz’ora.» 15 Anche se soddisfatto dei progressi dell’interrogatorio, Victor Westlake era preoccupato. Non c’erano testimoni, nessuna perizia balistica che collegasse la .38 di Quinn alla scena del delitto, nessuna impronta di stivale e nessun interrogatorio in simultanea di Dee Ray. C’era un movente, se dovevano credere alla storia di Malcolm Bannister sulla bustarella. Ma fino a quel momento gli elementi più consistenti erano la presenza di Quinn Rucker a Roanoke il giorno dopo la scoperta dei cadaveri e i troppi contanti che aveva con sé. Westlake e la sua squadra erano esausti per la nottata in piedi e fuori era ancora buio. Si ricaricarono tutti con il caffè e fecero lunghe passeggiate nel Freezer. Ogni tanto davano un’occhiata allo schermo per controllare il loro sospettato. Quinn teneva la testa sul tavolo, ma non stava dormendo. Alle sei Pankovits e Delocke rientrarono nella stanza degli interrogatori, ognuno con un nuovo pieno di Red Bull con ghiaccio in un bicchiere alto. Rucker sollevò la testa dal tavolo e si risistemò sulla sedia per un altro round. Fu Pankovits a cominciare. «Abbiamo appena parlato al telefono con il procuratore federale. Lo abbiamo informato dei nostri progressi con te e ci ha detto che il gran giurì si riunirà domani per il rinvio a giudizio. Due capi d’accusa per omicidio, con richiesta di pena capitale.» «Congratulazioni» disse Quinn. «Allora farei meglio a trovarmi un avvocato, immagino.» «Certo, ma forse ce ne vorrà più di uno. Io non so quanto tu capisca di leggi federali contro l’attività di racket, ma ti assicuro che possono essere brutali. Il procuratore sosterrà che gli omicidi del giudice Fawcett e della sua segretaria sono stati opera di una gang, una gang ben nota e ben organizzata, e che tu, naturalmente, sei stato l’esecutore materiale. Il rinvio a giudizio elencherà un sacco di imputazioni, non solo il duplice omicidio, ma anche la corruzione. E, cosa più importante, non citerà te soltanto, ma pure altri nefasti personaggi come Tall Man, Dee Ray, una delle tue sorelle, tuo cugino Antoine Beck e una ventina di altri parenti.» «Potrete avere un’ala tutta vostra nel braccio della morte» aggiunse Delocke. «La gang Rucker-Beck, tutti in fila cella dopo cella, in attesa dell’ago.» Delocke stava sorridendo e Pankovits era divertito. Una coppia di comici. Quinn cominciò a grattarsi una tempia e a parlare con gli occhi rivolti al pavimento. «Sapete, mi chiedo cosa direbbe il mio avvocato di tutto questo, con me rinchiuso in questa stanza buia e senza finestre per tutta la notte, dalle... che ora era?, diciamo dalle nove di ieri sera, e adesso sono le sei di mattina. Nove ore di seguito di stronzate, con voi due che prima mi accusate di avere corrotto un giudice, poi di avere ucciso un giudice, e adesso mi minacciate di morte, e non solo me, ma anche la mia famiglia. Voi dite che avete dei testimoni, tutti in fila là fuori e pronti a testimoniare, più la perizia su una pistola rubata, più l’impronta di uno stivale di qualche figlio di puttana che ha camminato nel fango. E io come faccio a sapere se questa è la verità o mi state raccontando cazzate? Perché io non mi fido per niente dell’FBI, non mi sono mai fidato e non mi fiderò mai. Mi avete mentito la prima volta che mi avete preso e do per scontato che state mentendo anche qui, questa notte. Forse io ho raccontato qualche balla, ma voi due potete onestamente sostenere di non avermi mentito questa notte? Potete?» Pankovits e Delocke lo fissarono. Forse era paura, o senso di colpa. Forse era delirio. Qualunque cosa fosse, Quinn stava parlando. «Stiamo dicendo la verità» riuscì a dire Pankovits. «E aggiungiamo un’altra balla all’elenco. Il mio avvocato andrà fino in fondo a questa faccenda. Vi farà il culo in aula, vi denuncerà pubblicamente, voi e le vostre bugie. Fatemi vedere la perizia sull’impronta dello stivale. Adesso, voglio vederla adesso.» «Non siamo autorizzati a mostrarla» disse Pankovits. «Molto comodo.» Quinn si piegò in avanti, appoggiando i gomiti sulle ginocchia, quasi sfiorando il bordo del tavolo con la fronte. Continuò a parlare al pavimento: «E la perizia balistica? Posso vederla?». «Non siamo autorizzati a...» «Ma che sorpresa. Se la farà dare il mio avvocato, quando e dove avrò la possibilità di parlare con lui. Ho chiesto l’avvocato per tutta la notte, i miei diritti sono stati violati.» «Tu non hai chiesto l’avvocato» precisò Delocke. «Hai accennato a un avvocato in termini vaghi, ma non ne hai mai chiesto uno. E hai continuato a parlare.» «Come se avessi avuto scelta. O stavo qui seduto a parlare, oppure finivo in una cella insieme a un branco di alcolizzati. Ci sono già passato, sapete, e non ho paura. Fa Teile del mestiere, tu commetti il tuo reato e, se ti beccano, vai dentro. Conosci già le regole quando entri nel business. Non fai altro che vedere amici e parenti che finiscono in galera. Ma poi tornano, no? Sconti la tua pena ed esci.» «Oppure evadi» disse Delocke. «Anche. Una cosa abbastanza stupida, forse, ma dovevo uscire.» «Perché dovevi sistemare un vecchio conto, vero? In prigione non hai fatto che pensare al giudice Fawcett tutti i giorni, per due anni. Si era preso i tuoi soldi e poi non aveva rispettato i patti. Nel tuo ambiente, questo significava che doveva morire, non è così?» «Sì, è così.» Quinn si stava massaggiando le tempie, fissandosi i piedi, quasi borbottando. I due agenti fecero un respiro profondo e si scambiarono un sorriso veloce. Finalmente il primo accenno di ammissione. Pankovits risistemò alcuni fogli e disse: «Dunque, Quinn, facciamo il punto della situazione. Hai appena ammesso che il giudice Fawcett doveva morire, giusto? Quinn?». Rucker era ancora chino sui gomiti e fissava il pavimento, dondolandosi avanti e indietro come intontito. Delocke lesse dal suo blocco e disse: «Secondo i miei appunti, io ti ho rivolto la testuale domanda: “Nel tuo ambiente questo significa che doveva morire, non è così?”. E tu hai risposto: “Sì, è così”. Lo neghi?». «Mi state mettendo le parole in bocca. Piantatela.» «Okay, Quinn» intervenne Pankovits. «Dobbiamo informarti di alcuni recenti sviluppi. Circa due ore fa, Dee Ray ha finalmente ammesso di averti dato i contanti da consegnare al giudice Fawcett. Ha ammesso anche che lui stesso, Tall Man e qualche altro ti hanno aiutato a pianificare il delitto. Dee Ray ha spiattellato tutto e ha già concluso un accordo: niente condanna a morte, niente imputazione di omicidio con richiesta di pena capitale. Abbiamo fermato Tall Man due ore fa e adesso stiamo cercando una delle tue sorelle. La situazione sta diventando critica.» «Ma andiamo. Loro non sanno niente.» «Certo che sanno, e domani saranno rinviati a giudizio insieme a te.» «Non potete fare una cosa del genere. Mia madre ne morirà. Povera donna, ha settant’anni e il cuore malandato. Non potete metterla in mezzo in questo modo.» «Allora deciditi a parlare, Quinn!» disse Pankovits alzando la voce. «Affronta le conseguenze! Tu hai commesso il reato. E, come ti piace dire, adesso vai dentro. Non ha senso trascinarti dietro il resto della famiglia.» «Io parlo, e poi?» «Facciamo un accordo. Tu ci fornisci tutti i dettagli e noi ci impegniamo a fare in modo che il procuratore federale lasci in pace la tua famiglia» rispose Pankovits. «C’è un’altra cosa» aggiunse Delocke. «Se concludiamo l’accordo, non ci sarà pena di morte. Solo ergastolo, senza libertà vigilata. A quanto pare la famiglia Fawcett non crede nella pena di morte e intende evitare un processo lungo e penoso. Vogliono che il caso sia chiuso, e il procuratore rispetterà i loro desideri. Lui stesso ha detto che prenderà in considerazione un patteggiamento, se ti dichiarerai colpevole. Un patteggiamento che ti salverà la vita.» «Perché dovrei credervi?» «Non sei obbligato a crederci. Puoi aspettare che arrivi il rinvio a giudizio tra un paio di giorni. Ci saranno qualcosa come trenta persone accusate di vari reati.» Quinn Rucker si alzò lentamente in piedi e tese le braccia più in alto possibile. Fece alcuni passi in una direzione, poi nell’altra e cominciò a dire: «Bannister, Bannister, Bannister». «Come dici?» chiese Pankovits. «Bannister, Bannister, Bannister.» «Chi è Bannister?» domandò Delocke. «Bannister è uno spione» rispose Quinn con amarezza. «Un verme, un vecchio amico di Frostburg, un avvocato disonesto che dice di essere innocente. Ma è soltanto uno spione. Non fate finta di non conoscerlo, perché non sareste qui se lui non fosse uno spione.» «Mai sentito nominare» disse Pankovits. Delocke stava scuotendo la testa: no. Rucker si rimise a sedere e piantò entrambi i gomiti sul tavolo. Sveglissimo, ora, teneva gli occhi fissi sui due agenti e si sfregava le grosse mani. «Allora, qual è l’accordo?» «Noi non possiamo fare accordi, Quinn. Ma possiamo fare in modo che le cose succedano» disse Pankovits. «Tanto per cominciare, richiamiamo i cani a Washington, così la tua famiglia e la tua gang vengono lasciate in pace, almeno per il momento. Il procuratore federale è sotto pressione da cinque settimane, dal momento dell’omicidio, e vuole disperatamente qualche buona notizia. Lui ci assicura, e noi lo assicuriamo a te, che non richiederà la pena di morte e che ci sarà un unico imputato. Solo tu, per i due omicidi. Semplice e chiaro.» «Questa è metà dell’accordo» precisò Delocke. «L’altra metà è una tua dichiarazione registrata in video in cui confessi gli omicidi.» Quinn intrecciò le mani dietro la testa e chiuse gli occhi. Passò un minuto a lottare con se stesso. «Voglio il mio avvocato» disse finalmente a denti stretti. Fu Delocke a rispondergli: «Puoi chiederlo, Quinn, ovvio che puoi chiederlo. Ma in questo momento Dee Ray e Tall Man sono sotto custodia. Stanno cantando come usignoli e la situazione sta peggiorando. Potrebbero passare un paio di giorni prima che il tuo avvocato arrivi quaggiù. Ma se parli, noi liberiamo i tuoi fratelli e li lasciamo in pace». Rucker ebbe uno scatto improvviso e gridò: «Va bene!». «Va bene cosa?» «Va bene, ci sto!» «Non così in fretta, Quinn» disse Pankovits. «Prima dobbiamo definire alcune cose. Riesaminiamo i fatti, li mettiamo in ordine, prepariamo il set e ci accertiamo che siamo tutti d’accordo sulla scena del delitto. Dobbiamo assicurarci che non manchi nessun dettaglio importante.» «Okay, okay. Ma posso fare colazione?» «Certo, Quinn, nessun problema. Abbiamo tutto il giorno.» 16 Una delle poche virtù della vita in carcere è la graduale acquisizione della pazienza. Dato che niente si muove a un ritmo ragionevole, impari a ignorare l’orologio. Domani arriverà abbastanza presto e, come sfida, è già sufficiente sopravvivere all’oggi. Dopo il mio breve viaggio a Washington, per un paio di giorni vago in giro per Frostburg, ricordando a me stesso che sono diventato una persona molto paziente, che l’FBI si muoverà in fretta e che, in ogni caso, non c’è più niente che io possa fare. Ma con mia grande sorpresa, e sollievo, gli avvenimenti si susseguono con rapidità. Non mi aspetto che l’FBI mi tenga informato, per cui non ho modo di sapere se Quinn Rucker sia stato arrestato e se abbia confessato. La notizia viene data sabato 19 marzo dal “Washington Post”; è in prima pagina, in taglio basso: Arrestato un uomo per l’omicidio del giudice federale. C’è una foto grande in bianco e nero di Quinn, una foto segnaletica, e io fisso il mio vecchio amico negli occhi mentre mi siedo nella sala caffè subito dopo colazione. L’articolo è piuttosto avaro di fatti, ma ricco di sospetti più o meno fondati. Evidentemente tutte le informazioni vengono selezionate dall’FBI, per cui non ci sono molti Teilicolari. Si parla dell’arresto a Norfolk di un evaso, un criminale con una condanna per traffico di droga e una lunga storia di criminalità organizzata nell’area di Washington. Non si accenna neppure a un movente, né a come l’FBI sia arrivato a stabilire che Quinn è il suo uomo; c’è solo un riferimento di sfuggita a una perizia balistica. Cosa più importante, l’articolo dice: “Dopo aver rinunciato ai diritti del Miranda, il sospettato si è volontariamente sottoposto a un lungo interrogatorio e ha fornito all’FBI una confessione videoregistrata”. Ho conosciuto Quinn Rucker due anni fa, poco dopo il suo arrivo a Frostburg. Una volta sistemato e ambientato, venne in biblioteca e mi chiese di dare un’occhiata alla sua sentenza. In prigione impari a fare amicizia senza fretta, con molta cautela, perché sono poche le persone sincere. Naturalmente il posto pullula di ladri, truffatori e artisti del raggiro, e tutti stanno in guardia per salvarsi la pelle. Con Quinn, però, le cose erano diverse. Risultava subito simpatico, e non credo di avere mai incontrato qualcuno con altrettanto carisma e schiettezza. Ma a volte cambiava umore, si ritirava in se stesso e si trascinava in quelli che definiva i suoi “giorni bui”, durante i quali era irritabile, ruvido, duro, e un impeto di violenza non si poteva escludere. Mangiava da solo e non parlava con nessuno. Due giorni dopo, raccontava barzellette a colazione e sfidava a poker i giocatori più bravi. Poteva essere chiacchierone e arrogante, o silenzioso e vulnerabile. Come ho detto, non c’è violenza a Frostburg. La cosa più vicina a una rissa che abbia mai visto fu quando un montanaro che chiamavamo Skunk sfidò Quinn a pugni per risolvere una disputa di gioco. Skunk era più basso di Rucker di almeno dieci centimetri e pesava una decina di chili in meno, ma il combattimento non ebbe mai luogo. Quinn fece un passo indietro, umiliandosi. Due giorni dopo mi fece vedere uno shank, un coltello rudimentale che si era procurato. Aveva in mente di servirsene per tagliare la gola a Skunk. Riuscii a dissuaderlo, anche se non ero convinto che parlasse sul serio. Passavamo un sacco di tempo insieme e diventammo amici. Quinn era convinto che io potessi fare qualche magia legale che ci avrebbe fatto uscire entrambi, dopodiché saremmo diventati soci in qualcosa. Era stanco dell’attività di famiglia, voleva sistemarsi e rigare diritto. C’era una pentola piena d’oro che aspettava là fuori, e il giudice Fawcett c’era seduto sopra. Henry Bannister sta aspettando in sala visite, malinconicamente seduto su una sedia pieghevole mentre vicino a lui strillano una giovane madre e i suoi tre bambini. Con il passare delle ore la sala si riempirà sempre di più e Henry preferisce togliersi il pensiero il prima possibile. Il regolamento consente a un familiare di sedersi a chiacchierare con il detenuto dalle sette del mattino fino alle quindici, tutti i sabati e le domeniche, ma per Henry un’ora è sufficiente. E anche per me. Se le cose andranno come programmato, e ho scarse ragioni di credere che sarà così, questo potrebbe essere l’ultimo colloquio con mio padre. Potrei non rivederlo più per anni, forse per sempre, ma di questo non posso parlare. Prendo il sacchetto dei biscotti di zia Racine e ne sgranocchio uno. Parliamo di mio fratello Marcus e dei suoi figli delinquenti, poi di mia sorella Ruby e dei suoi figli perfetti. La città di Winchester conta in media un omicidio all’anno e la quota è stata raggiunta la settimana scorsa, quando un marito è rientrato dal lavoro prima del previsto e ha notato un furgone nel suo vialetto. È entrato in casa senza far rumore e ha sorpreso la moglie insieme a un suo conoscente, entrambi intenti a violare con entusiasmo i rispettivi vincoli coniugali. Il marito ha preso il fucile e l’adultero, appena l’ha visto, ha tentato di saltare fuori da una finestra chiusa della camera da letto, nudo. Non ce l’ha fatta, e sono seguiti i colpi di fucile. Henry ritiene che il marito potrebbe anche cavarsela e si diverte a raccontare l’episodio. A quanto pare la città è divisa a metà tra chi sostiene la tesi dell’omicidio volontario e chi pensa invece che si tratti di una reazione giustificata. Mi sembra quasi di sentire i pettegolezzi spietati nei bar della città vecchia che ero solito frequentare. Mio padre si sofferma a lungo su questa storia, probabilmente perché nessuno di noi due ha voglia di parlare di questioni familiari. Però dobbiamo parlarne. Henry cambia argomento. «Sembra che quella ragazzina bianca stia pensando a un aborto. Forse non diventerò bisnonno, alla fine.» «Delmon lo rifarà» dico. Ci aspettiamo sempre il peggio da quel ragazzo. «Dobbiamo farlo sterilizzare. È troppo stupido per usare il preservativo.» «Compragliene un po’, comunque. Lo sai che Marcus è sempre al verde.» «Io vedo quel ragazzo solo quando ha bisogno di qualcosa. Accidenti, probabilmente li vorranno da me i soldi per l’aborto. Credo che la ragazza sia una poveraccia.» Mentre siamo in argomento soldi, non posso fare a meno di pensare alla ricompensa per il caso Fawcett. Centocinquantamila dollari in contanti. Non ho mai visto tanto denaro tutto insieme. Prima che nascesse Bo, Dionne e io un giorno ci rendemmo conto che avevamo risparmiato seimila dollari. Ne mettemmo metà in un fondo di investimento e con il resto andammo in crociera. Le nostre giudiziose abitudini vennero presto dimenticate, perché in seguito non disponemmo mai più di una simile quantità di denaro. Poco prima del mio rinvio a giudizio, rifinanziammo l’ipoteca sulla nostra casa per spremere fino all’ultima goccia del suo valore. I soldi servivano per le parcelle legali. Sarò ricco e libero. Rammento a me stesso che non devo eccitarmi troppo, ma è impossibile. Henry ha bisogno di un nuovo ginocchio sinistro e per un po’ parliamo di questo. Ha sempre preso in giro gli anziani che parlano solo dei loro malanni, ma sta diventando così anche lui. Dopo un’ora è già annoiato e pronto ad andarsene. Lo accompagno alla porta e ci stringiamo formalmente la mano. Henry se ne va e io mi chiedo se lo rivedrò mai. Domenica. Non una parola dall’FBI, né da nessun altro. Dopo colazione leggo quattro quotidiani e non vengo a sapere niente di nuovo su Quinn Rucker e sul suo arresto. Però uno sviluppo significativo c’è. Secondo il “Post” il procuratore federale del Distretto Sud della Virginia sottoporrà il caso al gran giurì domani. Lunedì. Se il gran giurì si pronuncerà per il rinvio a giudizio, allora, in teoria e in base agli accordi, io dovrei diventare un uomo libero. In carcere c’è una sorprendente quantità di credi religiosi organizzati. Noi, uomini tormentati, cerchiamo sollievo, pace, conforto e guida. Siamo stati umiliati, mortificati, spogliati di ogni dignità, privati della famiglia e dei nostri beni. Non ci è rimasto niente. Buttati nell’inferno, guardiamo in alto in cerca di una via d’uscita. Qui dentro ci sono due o tre musulmani che pregano cinque volte al giorno e fanno gruppo per conto loro. C’è un sedicente monaco buddista con alcuni seguaci. Nessun ebreo o mormone, che io sappia. Poi ci siamo noi cristiani, ed è qui che le cose si fanno complicate. Un sacerdote cattolico si presenta due volte al mese per celebrare la messa alle otto della domenica mattina. Appena i cattolici sgombrano la piccola cappella, viene tenuto un servizio multiconfessionale per i fedeli delle principali chiese: metodista, battista, presbiteriana eccetera. È lì che vado quasi tutte le domeniche. Alle dieci i pentecostali bianchi si riuniscono per una chiassosa funzione che prevede musica ad alto volume e preghiere a volume ancora più alto, oltre a guarigioni miracolose e gente che comincia a parlare in lingue sconosciute. La cosa dovrebbe concludersi alle undici, ma spesso si prolunga per via dello spirito che passa tra i fedeli. I pentecostali neri dovrebbero avere la cappella libera alle undici, ma a volte devono aspettare che i bianchi smaltiscano l’ispirazione. Ho sentito storie di litigi tra i due gruppi, ma finora non sono mai scoppiate risse. Una volta impadronitisi del pulpito, i pentecostali neri se lo tengono per tutto il pomeriggio. Sarebbe sbagliato farsi l’idea che Frostburg sia pieno di predicatori evangelici integralisti. Non è così. È sempre un carcere, e la maggior Teile dei miei compagni non si farebbe sorprendere nemmeno morto a una funzione religiosa. Mentre esco dalla cappella dopo la funzione multiconfessionale, un agente penitenziario si avvicina e mi dice: «Ti vogliono nella palazzina dell’amministrazione». 17 L’agente Hanski mi sta aspettando insieme a un nuovo giocatore della Teilita: Pat Surhoff, US Marshal. Dopo le presentazioni ci sediamo intorno a un piccolo tavolo. Siamo in un ufficio in fondo al corridoio, non lontano da quello del direttore, il quale, naturalmente, non si farebbe mai sorprendere qui di domenica, e chi può biasimarlo? Hanski estrae subito un documento e lo fa scivolare sul tavolo. «Questo è il rinvio a giudizio» mi dice. «Emesso nel tardo pomeriggio di venerdì scorso a Roanoke; è ancora un segreto, ma la notizia sarà comunicata alla stampa per prima cosa domani mattina.» Stringo il foglio nella mano come se fosse un lingotto d’oro e ho dei problemi a mettere a fuoco le parole. “Stati Uniti d’America contro Quinn Al Rucker.” È scritto nell’angolo a destra in alto, con la data di venerdì scorso in inchiostro azzurro. «Sul “Post” c’era scritto che il gran giurì si sarebbe riunito domattina» mi azzardo a dire, anche se è ovvio che è già successo. «Stiamo giocando con la stampa» replica compiaciuto Hanski. Compiaciuto, ma molto più gentile e simpatico, questa volta. I nostri ruoli sono drasticamente cambiati. Prima ero il galeotto dallo sguardo sfuggente in cerca di un accordo, e che probabilmente voleva fregare il sistema. Ora invece sono il ragazzo d’oro, quello che sta per uscire di qui portando con sé un bel po’ di soldi. Scuoto la testa e dico: «Ragazzi, sono senza parole. Datemi una mano». Hanski è pronto a lanciarsi. «Le spiego cosa abbiamo in mente, Mr Bannister.» «Cosa ne dici di chiamarmi Mal?» «Fantastico. Io sono Chris e lui è Pat.» «Okay.» «Il diTeilimento dell’amministrazione penitenziaria ti ha appena riassegnato al carcere di media sicurezza di Fort Wayne, Indiana. Motivo ignoto, o non comunicato. Qualche violazione alle regole che ha fatto incazzare i grandi capi. Niente visite per sei mesi. Regime di isolamento. Eventuali curiosi potranno rintracciarti online nel sito del servizio localizzazione detenuti, ma andranno presto a sbattere contro un muro. Dopo un paio di mesi a Fort Wayne, sarai trasferito di nuovo. L’idea è di spostarti continuamente attraverso il sistema fino a seppellirtici dentro.» «Sono certo che per il Bureau sarà piuttosto facile» osservo. Ridono di gusto tutti e due. Cavolo, ho cambiato squadra o cosa? «Tra qualche minuto Teiliamo con la sceneggiata delle manette e delle catene alle caviglie, per l’ultima volta, e ti scortiamo fuori di qui, come per un normale trasferimento. Salirai su un furgone privo di contrassegni insieme a Pat e a un altro marshal e punterai a ovest, direzione Fort Wayne. Io vi seguirò. A cento chilometri da qui, su questo lato di Morgantown, ci fermeremo in un motel dove abbiamo preso alcune camere. Lì ti cambi, pranzi e poi parleremo del futuro.» «Tra qualche minuto?» Sono scioccato. «Il piano è quello. C’è qualcosa nella tua cella senza la quale non puoi vivere?» «Sì. Qualche effetto personale, documenti e cose varie.» «Okay. Domani faremo inscatolare tutto da qualcuno del carcere e poi provvederemo a fartelo avere. È meglio se non torni in cella. Se qualcuno ti vedesse raccogliere le tue cose, ci potrebbero essere delle domande. Non vogliamo che si sappia che te ne vai finché non sarai già lontano.» «Capito.» «Niente addii o stronzate del genere, okay?» «Okay.» Per un secondo penso ai miei amici qui a Frostburg, ma lascio perdere in fretta. Questo giorno arriverà anche per loro, e una volta che sei libero non ti volti a guardare indietro. Dubito seriamente che i rapporti stretti in prigione durino anche fuori. E nel mio caso, in Teilicolare, non potrò mai ritrovarmi con i vecchi amici per parlare dei tempi andati. Sto per diventare un’altra persona. «Hai settantotto dollari sul tuo conto della prigione. Li trasferiremo a Fort Wayne e si perderanno nei meandri del sistema.» «Fregato un’altra volta dal governo federale» dico, e di nuovo Hanski e il marshal mi trovano spiritoso. «Domande?» mi chiede Hanski. «Certo. Come siete riusciti a farlo confessare? È troppo furbo per una cosa del genere.» «Francamente siamo rimasti sorpresi anche noi. Ci siamo serviti di due nostri veterani dell’interrogatorio, che hanno i loro metodi. Rucker ha accennato un paio di volte a un avvocato, ma poi non ha dato seguito alla cosa. Voleva parlare e sembrava sconvolto dal fatto di essere stato catturato, non per l’evasione, ma per l’omicidio. Voleva sapere cosa sapevamo, così abbiamo continuato a parlare. Per dieci ore. Per tutta la notte e fino alle prime ore del mattino. Non voleva assolutamente andare in cella e quindi è rimasto nella stanza. E una volta che si è convinto che noi sapevamo quello che sapevamo, è crollato. Quando abbiamo accennato alla possibilità di accusare tutta la sua famiglia, e buona Teile della gang, ha voluto negoziare un accordo. E ci ha detto tutto.» «Con “tutto” cosa intendi?» «La sua storia è sostanzialmente quella che ci hai raccontato tu. Rucker aveva dato una bustarella di cinquecentomila dollari al giudice Fawcett perché salvasse suo nipote, e invece il giudice l’ha fregato. Si è tenuto i soldi e ha inchiodato il ragazzo. Nel mondo di Quinn quello è un crimine che non può essere perdonato. Rucker ha controllato i movimenti di Fawcett, l’ha seguito al cottage, è piombato su di lui e sulla segretaria e si è vendicato.» «Quanta Teile dei soldi era rimasta?» «Circa la metà. Quinn afferma di essere entrato nell’apTeilamento del giudice a Roanoke, di averlo perquisito e di non essere riuscito a trovare il denaro. Ha sospettato che fossero nascosti da qualche altra Teile, in un posto più sicuro, ed è per questo che ha seguito Fawcett fino al cottage. Gli è saltato addosso sulla veranda, l’ha sopraffatto ed è entrato. Non era sicuro che il denaro fosse lì, ma era deciso a scoprire il nascondiglio. Ha fatto qualche brutta cosa alla segretaria e Fawcett si è convinto a dirgli dove erano i soldi. Ed ecco la cassaforte nascosta. Nella mente di Quinn, il denaro apTeileneva a lui.» «E immagino che si sentisse in dovere di uccidere quei due.» «Oh, certo. Non poteva lasciarsi dietro due testimoni. Non c’è alcun rimorso, Mal. Il giudice se l’era cercata, la segretaria gli è semplicemente finita tra i piedi. Adesso Quinn dovrà vedersela con due imputazioni di omicidio.» «Perciò è un caso da pena di morte?» «Molto probabilmente. Non abbiamo mai giustiziato nessuno per l’omicidio di un giudice federale e ci piacerebbe fare di Quinn Rucker il nostro primo esempio.» «Ha fatto il mio nome?» chiedo, sicuro della risposta. «L’ha fatto eccome. Sospetta fortemente che sia tu la nostra fonte, e con ogni probabilità sta già pianificando la sua vendetta. È per questo che adesso siamo qui, pronti a Teilire.» Io voglio Teilire, ma non così in fretta. «Quinn sa dell’articolo 35, tutti i detenuti federali ne sono al corrente. Tu risolvi un crimine commesso fuori e la tua condanna viene commutata. Inoltre, Quinn ritiene che io sia un brillante avvocato. Lui e la sua famiglia sapranno benissimo che sono fuori, non in prigione, non a Fort Wayne né in qualsiasi altro carcere.» «È vero, ma lasciamoli nel dubbio. È importante che anche la tua famiglia e i tuoi amici ti credano ancora sottochiave.» «Siete preoccupati per i miei familiari?» domando. Finalmente parla Pat Surhoff. «In qualche modo, sì. Possiamo metterli sotto protezione, se lo desideri. Ovviamente questo sconvolgerebbe la loro vita.» «Non accetteranno mai» dico. «Mio padre ti mollerebbe un pugno, se solo gliene parlassi. È un poliziotto in pensione ed è convinto di saper badare a se stesso. Mio figlio ha un nuovo padre e una nuova vita.» Non riesco a immaginare una telefonata a Dionne per informarla che Bo potrebbe essere in pericolo a causa di qualcosa che ho combinato in prigione. E c’è una Teile di me che non crede che Quinn Rucker potrebbe fare del male a un ragazzino innocente. «Possiamo riparlarne più tardi, se vuoi» suggerisce Pat Surhoff. «Sì, facciamo così. In questo momento ho troppi pensieri per la testa.» «La libertà ti aspetta, Mal» dice Hanski. «Andiamocene di qui.» Seguo Hanski e Surhoff lungo il corridoio fino a un altro edificio, dove mi stanno aspettando tre agenti penitenziari e il loro capitano. Mi mettono le manette ai polsi e le catene alle caviglie, poi vengo scortato fino a un minivan fermo lungo il marciapiede. Un osservatore all’oscuro di tutto penserebbe che mi stiano accompagnando all’esecuzione. Al volante c’è un altro marshal che si chiama Hitchcock. Surhoff chiude lo sportello scorrevole di fianco a me e si sistema sul sedile anteriore del passeggero. Teiliamo. Mi rifiuto di voltarmi per dare un ultimo sguardo a Frostburg, di cui ho già immagini a sufficienza per anni. Osservo la campagna che mi sfreccia di lato e non riesco a reprimere un sorriso. Pochi minuti dopo entriamo nel parcheggio di un centro commerciale. Surhoff scende, fa scorrere la portiera e mi apre le manette. Poi mi libera le caviglie. «Congratulazioni» mi dice con calore, e io decido che quest’uomo mi piace. Sento per l’ultima volta il clangore delle catene e mi massaggio i polsi. Riprendiamo il viaggio lungo l’Interstatale 68 in direzione ovest. È quasi primavera e le colline ondulate del Maryland occidentale cominciano a mostrare segni di vita. Sono quasi sopraffatto da questi primi momenti di libertà. Ho sognato questo giorno per cinque anni e la sensazione è esaltante. Ci sono tantissimi pensieri che competono per avere la mia attenzione. Non vedo l’ora di scegliermi gli abiti che voglio e di indossare un paio di jeans. Non vedo l’ora di comprarmi un’auto e andare dove mi pare. Desidero da morire la sensazione del corpo di una donna e il sapore di una bistecca e di una birra ghiacciata. Rifiuto di preoccuparmi per la sicurezza di mio figlio e di mio padre. Nessuno farà loro del male. I marshal hanno voglia di chiacchierare e io li ascolto. Pat Surhoff mi sta dicendo: «Dunque, Mal, adesso non sei più sotto la custodia di nessuno. Se decidi di entrare nel programma protezione testimoni, noi dell’US Marshals Service ci prenderemo cura di te. Ti garantiamo sicurezza, protezione e benessere. Ti forniamo una nuova identità con documenti autentici. Riceverai aiuti finanziari per la casa, le spese correnti e l’assistenza medica. Ti troveremo un lavoro. Una volta che sarai sistemato, non terremo sotto controllo le tue attività quotidiane, ma saremo sempre a portata di mano se avrai bisogno di noi». Sembra che stia leggendo da un dépliant pubblicitario, ma le sue parole sono musica. Hitchcock aggiunge: «Abbiamo avuto oltre ottomila testimoni nel programma di protezione, e a nessuno di loro è mai stato fatto del male». Pongo la domanda più ovvia: «Dove vivrò?». «Questo è un grande paese, Mal» mi risponde Hitchcock. «Abbiamo sistemato testimoni a duecento o a tremila chilometri da quella che era la loro casa. La distanza non è un elemento così cruciale ma, in linea di massima, più ci si allontana, meglio è. Preferisci il clima caldo o la neve? Montagne e laghi o sole e spiagge? Città grandi o cittadine? Le città piccole sono problematiche e noi raccomandiamo sempre località con almeno centomila abitanti.» «È più facile confondersi» chiarisce Surhoff. «E posso scegliere?» chiedo. «Entro limiti ragionevoli, sì» risponde Hitchcock. «Lasciatemi riflettere.» Cosa che faccio per i successivi quindici o venti chilometri, e non per la prima volta. Ho già un’idea piuttosto precisa di dove voglio andare, e per quali ragioni. Mi volto per dare un’occhiata alle nostre spalle e vedo un veicolo familiare. «Immagino che ci sia l’FBI dietro di noi.» «Sì. L’agente Hanski e un suo collega» conferma Surhoff. «Per quanto tempo ci seguiranno?» «Spariranno entro pochi giorni, credo» risponde Surhoff, scambiando un’occhiata con Hitchcock. In realtà non lo sanno, ma non ho intenzione di insistere. «L’FBI di norma continua a tenere d’occhio i testimoni come me?» domando. «Dipende» risponde Hitchcock. «Di solito il testimone che entra nel programma di protezione ha ancora delle questioni in sospeso con la persona o le persone sulle quali ha fatto la spia. Può darsi che debba tornare a deporre in tribunale. In questo caso l’FBI vuole tenersi aggiornato sul testimone, ma lo fa tramite noi. Sempre tramite noi. Con il passare del tempo, però, a mano a mano che passano gli anni, l’FBI tende a dimenticarsi dei testimoni.» Pat cambia argomento. «Una delle prime cose che dovrai fare è cambiare nome, legalmente, è ovvio. Noi ci rivolgiamo sempre a un giudice della contea di Fairfax, Nord Virginia, che tiene tutte le pratiche al sicuro. È la routine, ma devi sceglierti un nome nuovo. La cosa migliore è mantenere le stesse iniziali e optare per qualcosa di semplice.» «Per esempio?» «Mike Barnes. Matt Booth. Mark Bridges. Mitch Baldwin.» «Sembrano tutti membri di una confraternita bianca.» «Sì, è vero. Ma lo sembra anche Malcolm Bannister.» «Grazie.» Riflettiamo sul mio nuovo nome per alcuni chilometri. Surhoff apre un laptop, comincia a picchiettare sulla tastiera e poi domanda: «Qual è il cognome che comincia con la lettera B più diffuso in questo paese?». «Baker» tira a indovinare Hitchcock. «Quello è il numero due.» «Bailey» azzardo io. «Quello è il numero tre. Bell è il quarto. Brooks il quinto. Vince Brown, con il doppio dei clienti di Baker, il secondo classificato.» «Uno degli scrittori afroamericani che preferisco è James Baldwin» dico. «Mi prendo quello di cognome.» «Okay» approva Surhoff, battendo sui tasti. «Nome?» «Cosa ne pensate di Max?» Hitchcock annuisce, mentre Surhoff inserisce il nome Max. «Mi piace» dichiara Hitchcock, come se stesse fiutando un vino pregiato. Surhoff alza gli occhi dal laptop e comunica: «Ci sono circa venticinque Max Baldwin negli Stati Uniti, per cui va bene. Un bel nome solido, non troppo comune, non troppo esotico o bizzarro. Mi piace. Rivestiamolo un po’. Nome intermedio? Tu, Max, quale pensi che possa funzionare?». Niente può funzionare come nome intermedio con un Max davanti. Ma poi penso a Mr Reed e Mr Copeland, i miei due ex soci, e al loro minuscolo studio in Braddock Street a Winchester. Copeland & Reed, Avvocati. In loro onore, scelgo Reed. «Max Reed Baldwin» declama Surhoff. «Funziona. Ora, per concludere, un piccolo suffisso, okay, Max? Junior, Terzo, Quarto... Qui non dobbiamo andare troppo sul fantasioso.» Hitchcock sta scuotendo la testa. «No, lasciamolo così» suggerisce, quasi sottovoce. «Sono d’accordo» dico. «Non aggiungiamo niente alla fine.» «Perfetto. Allora abbiamo un nome: Max R. Baldwin. Giusto, Max?» «Immagino di sì. Lasciatemelo digerire per un paio d’ore. Devo farci l’abitudine.» «Naturalmente.» Per quanto destabilizzante, scegliere il nome nuovo che userò per il resto della vita sarà una delle mie decisioni più facili. Tra non molto dovrò fare scelte di gran lunga più difficili: occhi, naso, labbra, mento, casa, lavoro, storia di famiglia... e che tipo di infanzia ho avuto? Che college ho frequentato e che cosa ho studiato? Perché sono single? Sono mai stato sposato? Ho figli? Mi gira la testa. 18 Pochi chilometri a est di Morgantown, usciamo dall’Interstatale ed entriamo nel parcheggio di un Best Western, uno di quei motel vecchio stile dove puoi lasciare l’auto proprio davanti alla tua stanza. Ci sono degli uomini in attesa, agenti di un qualche tipo – FBI, presumo – e mentre scivolo fuori dal furgone, meravigliosamente privo di manette, Hanski mi informa: «La camera 38 è la tua». Uno degli agenti senza nome apre la serratura della porta e mi passa la chiave. Nella stanza ci sono due letti matrimoniali e, su uno dei due, un assortimento di indumenti. Hanski e Surhoff richiudono la porta. «Mi sono fatto dare le tue misure dalla prigione» dice Hanski, agitando una mano in direzione del mio nuovo guardaroba. «Se quella roba non ti piace, nessun problema. Possiamo andare a fare shopping.» Ci sono due camicie bianche e una a quadri blu, tutte botton down; due paia di pantaloni cachi e un paio di jeans délavé; una cintura marrone di pelle; una pila di boxer ordinatamente ripiegati; due magliette bianche; parecchie paia di calzini ancora nella confezione; un paio di mocassini marrone abbastanza presentabili e il più brutto paio di loafer neri che io abbia mai visto. Tutto sommato, non un cattivo inizio. «Grazie» dico. Hanski continua: «Spazzolino da denti, dentifricio, occorrente per la rasatura... è tutto in bagno. C’è anche una piccola borsa da palestra. Se ti serve qualcos’altro, facciamo un salto in negozio. Vuoi pranzare?». «Non adesso. Vorrei semplicemente restare solo.» «Nessun problema, Mal.» «Adesso sono Max, se non ti dispiace.» «Max Baldwin» precisa Surhoff. «Ti sei abituato in fretta.» I due marshal escono e io chiudo la porta a chiave. Mi tolgo lentamente gli indumenti della prigione: pantaloni e camicia verde oliva, calzini bianchi, scarpe nere con le stringhe e la suola spessa, boxer vecchi e lisi. Indosso un paio di boxer e una maglietta nuovi, poi scivolo sotto le coperte e fisso il soffitto. Per il pranzo raggiungiamo a piedi il vicino ristorante a buon mercato specializzato in pesce. Il locale è dotato di drive-through e per sette dollari e novantanove centesimi puoi mangiare tutte le zampe di granchio che vuoi. Siamo solo Hanski, Surhoff e io, e ci gustiamo un lungo pranzo a base di pesce mediocre che per me è comunque squisito. Adesso che la pressione è sparita, i due marshal si lasciano andare alle battute e fanno commenti sul mio guardaroba. Ricambio le offese ricordando che non sono un ragazzo da confraternita bianca come loro due e che da adesso in poi i vestiti me li comprerò da solo. Il pomeriggio avanza e mi informano che abbiamo del lavoro da sbrigare. Ci sono molte decisioni da prendere. Torniamo al motel ed entriamo nella stanza accanto alla mia, dove uno dei due letti è coperto da pratiche e documenti. Hitchcock ci raggiunge, per cui ora siamo in quattro nella stanza. Teoricamente lavoriamo tutti insieme, ma io sono scettico. Continuo a ripetermi che questi uomini adesso sono dalla mia Teile, che il governo è mio amico e mi protegge, ma non riesco ad accettare del tutto l’idea. Forse con il tempo si guadagneranno la mia fiducia, ma ne dubito. L’ultima volta che ho trascorso ore in compagnia di agenti del governo, mi era stato promesso che non sarei stato accusato. A questo punto il nuovo nome ha fatto presa e la mia decisione è definitiva. Hanski mi dice: «Max, domattina Teiliamo e dobbiamo decidere dove andare. La destinazione sarà determinata dai cambiamenti facciali che hai in mente. Hai dichiarato che vuoi modificare il viso e questo è un po’ un problema». «Ti riferisci alla mia testimonianza?» chiedo. «Sì. Il processo Rucker potrebbe avere luogo tra sei mesi, o anche un anno.» «Oppure può darsi che Quinn si dichiari colpevole e non vada a processo» osservo. «Certo. Ma supponiamo che non lo faccia. Supponiamo che vada a processo. Se ti fai operare adesso, metterai in mostra la tua nuova faccia quando andrai a testimoniare. Saresti molto più al sicuro se aspettassi dopo il processo.» «Più sicuro allora, ma adesso?» ribatto. «Cosa mi dici dei prossimi sei mesi? La gang di Rucker mi darà la caccia, lo sappiamo. Se ne stanno già occupando e per loro prima sarà, meglio sarà. Se riescono a beccarmi prima del processo, possono eliminare un testimone importante. I prossimi sei mesi sono i più pericolosi, per cui voglio l’intervento chirurgico ora. Subito.» «Okay. E al processo?» «Andiamo, Chris! Esistono dei modi per non farmi vedere, lo sai. Posso deporre dietro un paravento o una tenda. È già stato fatto. Non guardi mai la televisione, non vai mai al cinema?» C’è qualche risatina, ma l’atmosfera è seria. Il pensiero di testimoniare contro Quinn Rucker è terrificante, ma ci sono dei modi per tutelare la mia incolumità. «L’abbiamo fatto l’anno scorso» dice Hitchcock. «Un importante processo per droga in New Jersey. L’informatore non assomigliava per niente al suo vecchio se stesso. Abbiamo sistemato un pannello davanti al banco dei testimoni in modo che solo il giudice e la giuria potessero vederlo e abbiamo utilizzato un dispositivo per l’alterazione della voce. Gli imputati non avevano idea di chi fosse il teste o di che aspetto avesse.» «Nel mio caso sapranno con certezza chi sono» dico. «Mi basta che non mi vedano.» «Va bene» cede Hanski. «È una tua decisione.» «Allora considerala definitiva.» Hanski estrae il cellulare e va verso la porta. «Faccio qualche telefonata.» Dopo che il collega è uscito dalla stanza, Surhoff mi dice: «Okay, mentre Hanski è al telefono, possiamo parlare della destinazione? Dacci qualche indicazione, Max, così cominciamo a muoverci per trovarti un posto». «Florida» rispondo. «A Teile il periodo nei marine, ho trascorso tutta la vita in mezzo a colline e montagne. Voglio cambiare paesaggio: spiagge, panorami con l’oceano, un clima più caldo.» Mitraglio la risposta come se avessi passato ore a pensarci, cosa che in effetti ho fatto. «Ma non la Florida meridionale, fa troppo caldo. Magari Pensacola o Jacksonville. Nel Nord, dove il clima è un po’ più mite.» I marshal assimilano l’informazione e mi sembra quasi di vedere le loro menti al lavoro. Surhoff comincia a pestare sui tasti del suo laptop, in cerca del mio nuovo posto al sole. Io mi rilasso in poltrona, con i piedi nudi sul letto, e non posso fare a meno di bearmi del posto in cui mi trovo. Sono quasi le quattro. Le domeniche pomeriggio sono i giorni peggiori a Frostburg. Come la maggior Teile dei detenuti, non ho mai lavorato nel giorno del Signore e mi sono annoiato spesso. Si improvvisano Teilite di basket e si fanno lunghe passeggiate sulla pista da jogging, qualunque cosa per tenersi occupati. Le visite sono finite e quelli che hanno incontrato i familiari di solito a quell’ora sono depressi. Sta per cominciare un’altra settimana, esattamente uguale alla precedente. La vita in carcere sta già sbiadendo lentamente. So che sarà impossibile dimenticarla, ma è arrivato il momento di cominciare a mettersi tutto dietro le spalle. Malcolm Bannister è ancora un detenuto, rinchiuso da qualche Teile, ma Max Baldwin è un uomo libero, con posti dove andare e cose da vedere. Quando fa buio saliamo in auto ed entriamo a Morgantown alla ricerca di una steakhouse. Lungo il tragitto passiamo davanti a uno strip club. Non viene detta una sola parola, ma sono estremamente tentato. Non vedo una donna nuda da cinque anni, anche se ovviamente ne ho sognate spesso. Tuttavia non sono sicuro che a questo punto guardare a bocca aperta un gruppo di spogliarelliste possa essere molto appagante. Troviamo il ristorante che ci è stato raccomandato e ci accomodiamo a un tavolo, tre vecchi amici che si godono una bella cena. Hanski, Surhoff e io ordiniamo i filetti più grossi presenti nel menu e io annaffio il mio con tre birre alla spina. I marshal si limitano al tè freddo, ma colgo benissimo la loro invidia. Rientriamo al motel prima delle dieci, ma dormire è impossibile. Guardo la televisione per un’ora, una cosa che a Frostburg facevo raramente. A mezzanotte prendo in mano la copia del rinvio a giudizio che mi ha lasciato Hanski e la leggo parola per parola. Non si fa cenno a una perizia balistica, e neppure a testimoni. C’è una lunga esposizione riguardante la scena del delitto, le ferite d’arma da fuoco, la causa dei decessi, le bruciature sul corpo di Naomi Clary e la cassaforte vuota, ma non ci sono descrizioni di prove tangibili. A questo punto la confessione di Quinn è tutto ciò che hanno in mano. La confessione, più i sospetti sui contanti trovati in suo possesso. Un rinvio a giudizio può essere modificato dall’accusa quasi in ogni momento e questo in Teilicolare richiede ancora un po’ di lavoro. Dà l’impressione di essere un lavoro affrettato, raffazzonato allo scopo di abbassare la temperatura. Non che voglia essere critico: per me è un documento magnifico. 19 Per Stanley Mumphrey l’evento sarebbe stato il momento più importante della sua breve carriera di procuratore federale per il Distretto Sud. Salito a quella carica due anni prima su nomina del presidente, aveva trovato il lavoro piuttosto banale e, sebbene costituisse una favolosa aggiunta al suo curriculum, lo giudicava poco gratificante. Finché, naturalmente, il giudice Fawcett e Ms Clary non erano stati assassinati e all’improvviso la sua carriera aveva assunto un nuovo significato. Stanley si ritrovava fra le mani il caso più bollente del paese e, come molti procuratori federali, era deciso a trarne il massimo vantaggio. La riunione era stata pubblicizzata come una conferenza stampa, anche se nessuna delle autorità aveva intenzione di rispondere alle domande. Era uno show, niente di più, niente di meno. Uno spettacolo accuratamente orchestrato al fine di: 1) soddisfare qualche ego; e 2) far sapere all’opinione pubblica, in Teilicolare ai potenziali giurati, che i federali avevano arrestato il colpevole, e che il suo nome era Quinn Al Rucker. Alle nove di mattina il leggio era nascosto dai microfoni, tutti con il logo delle televisioni e delle stazioni radio a cui apTeilenevano. L’aula era stracolma di giornalisti di ogni tipo. Uomini armati di voluminose telecamere si calpestavano a vicenda lottando per prendere posizione, il tutto sotto gli occhi attenti degli agenti del tribunale. Nei codici e nei regolamenti che governano la pratica e le procedure della normativa penale, sia a livello statale che federale, non c’è scritto da nessuna Teile che l’“annuncio” o la “comunicazione” o la “notifica” o l’“emissione” di un rinvio a giudizio debba essere pubblicizzato. Anzi, non succede quasi mai. Una volta che il gran giurì abbia preso la sua decisione, l’atto viene depositato formalmente presso la cancelleria del tribunale e in seguito viene notificato all’imputato. Il rinvio a giudizio è solo una metà della causa: quella dell’accusa. Niente di ciò che è scritto nell’atto costituisce una prova; al processo, la giuria non vedrà mai quel documento. Il gran giurì che decide il rinvio ascolta solo una versione della causa, quella presentata dal governo. A volte, però, un rinvio a giudizio è troppo sensazionale, troppo importante, troppo gratificante per consentirgli di viaggiare tranquillo attraverso il sistema. Deve essere pubblicizzato da coloro che hanno lavorato così duramente per catturare un criminale e portarlo davanti alla giustizia. Stanley Mumphrey non aveva fatto niente per arrivare all’arresto di Quinn Rucker, ma di sicuro era l’uomo che lo avrebbe portato a processo. Nella gerarchia federale, il procuratore federale è di gran lunga superiore a un semplice agente dell’FBI, e perciò l’evento apTeileneva a Stanley. Come d’abitudine, avrebbe condiviso – con riluttanza – le luci della ribalta con il Bureau. Alle nove e dieci si aprì una porta di fianco al banco del giudice e un plotone di duri in abito nero si asserragliò nello spazio dietro il leggio. Fecero a gomitate per sistemarsi in fila, tutti con le mani a coppa sopra le palle. La disposizione era cruciale perché le telecamere più di un certo numero non ne potevano inquadrare. In piedi davanti al leggio, fianco a fianco, c’erano Stanley Mumphrey e Victor Westlake, il procuratore capo e il capo della polizia. Alle loro spalle agenti dell’FBI e viceprocuratori si stringevano schiacciandosi tra loro nel tentativo di avere una buona visuale delle telecamere, sperando che le telecamere vedessero loro. I più fortunati avrebbero ascoltato assorti Mr Mumphrey e Mr Westlake, aggrottando la fronte e atteggiandosi come se non sospettassero la presenza di una telecamera nel raggio di tre chilometri dal tribunale. Era la stessa patetica routine portata alla perfezione dai membri del Congresso. «Questa mattina abbiamo un rinvio a giudizio per l’omicidio del giudice Raymond Fawcett e di Ms Naomi Clary» disse lentamente Mumphrey, la voce nervosa e più alta del solito di almeno due ottave. Come procuratore, in tribunale arrancava faticosamente, non di rado perdendo le cause facilissime che assegnava a se stesso. La critica più comune nei suoi confronti era che sembrava sempre troppo nervoso e fuori posto. Alcuni ritenevano che il motivo stesse nel poco tempo passato in aula durante la sua poco significativa carriera decennale. Stanley afferrò l’atto e lo tenne sollevato, quasi si aspettasse che i presenti ne potessero leggere il testo. «L’accusa è di duplice omicidio. L’imputato è un certo Quinn Al Rucker. E, sì: prevedo di chiedere la pena di morte per questo caso.» L’ultima frase era stata pensata per fare spettacolo e suscitare un brivido nella folla, ma Stanley aveva sbagliato la scelta di tempo. Tuttavia lo spettacolo arrivò quando un assistente fece comparire improvvisamente sullo schermo una grande foto in bianco e nero di Quinn. Finalmente il mondo vedeva l’uomo che aveva ucciso il giudice e la sua segretaria. Colpevole! Leggendo dai suoi appunti con voce incerta, Stanley illustrò i precedenti di Quinn e riuscì a trasmettere l’idea che fosse evaso dal carcere al solo scopo di vendicarsi del giudice. A un certo punto Victor Westlake, in piedi di fianco al procuratore come una sentinella, aggrottò la fronte e abbassò lo sguardo sui propri appunti. Ma Stanley continuò imperterrito e quasi singhiozzò parlando del suo caro amico e mentore Raymond Fawcett, di ciò che quel giudice aveva significato per lui e così via. La voce gli tremò davvero quando cercò di spiegare quanto si sentisse onorato di avere la terribile responsabilità di chiedere giustizia per quei “raccapriccianti” delitti. Sarebbero bastati più o meno due minuti per leggere l’intero atto e andarsene tutti a casa. Invece no. Con una folla come quella, e milioni di telespettatori, Stanley ritenne necessario continuare a blaterare e tenere un discorso sulla giustizia e sulla guerra al crimine. Dopo parecchie penose divagazioni, tornò in argomento verso la fine, al momento di passare la mano. Elogiò Victor Westlake e tutto il Federal Bureau of Investigation per il loro lavoro, un lavoro che era stato “sovrumano, instancabile e brillante”. Quando Mumphrey finalmente tacque, Westlake lo ringraziò, quantunque non fosse chiaro se lo faceva perché aveva chiuso il becco o per i complimenti. Westlake aveva molta più esperienza del giovane Stanley in quel genere di esibizioni e parlò per cinque minuti senza dire niente. Ringraziò i suoi uomini, si dichiarò sicuro della soluzione del caso e formulò i suoi migliori auguri all’accusa. Quando terminò di parlare e fece un passo indietro, un giornalista gridò una domanda. «No comment» rispose seccamente Westlake, lasciando capire che era ora di andare. Stanley, però, non era ancora pronto ad abbandonare la selva di telecamere. Per qualche secondo sorrise stupidamente alla folla, come per dire: “Eccomi qui”. Poi Westlake gli sussurrò qualcosa. «Grazie» disse Stanley, e se ne andò. L’evento era terminato. Seguo la conferenza stampa dalla mia stanza al Best Western. Il pensiero che mi attraversa la mente è che, con Stanley al comando, Quinn potrebbe avere qualche possibilità di lotta. Tuttavia, se il caso arriverà a processo, è molto probabile che Stanley faccia un passo indietro e lasci gestire la faccenda a uno dei suoi vice più esperti. Indubbiamente continuerà a lavorarsi i media e comincerà a programmare la sua corsa per una carica più alta, ma il lavoro processuale serio sarà condotto dai professionisti. Potrebbe darsi addirittura che Stanley si ritrovi senza lavoro: dipende da quanto la cosa andrà per le lunghe. Il suo mandato è di quattro anni, come quello del presidente. Nel momento in cui è lo sfidante a impossessarsi della Casa Bianca, tutti i procuratori federali degli Stati Uniti hanno chiuso. La conferenza stampa termina, i mezzobusti della CNN iniziano a blaterare e io comincio a fare zapping, ma non trovo nulla che mi interessi. Armato di telecomando, ho il controllo totale del televisore. Mi sto adattando alla libertà con sorprendente facilità. Posso dormire fino a quando mi sveglio. Posso decidere cosa indossare, anche se al momento le mie scelte sono limitate. Cosa più importante, non c’è nessun compagno di cella, nessuno con cui combattere in un cubo di tre metri per tre e cinquanta. Ho misurato due volte la camera del motel: è larga circa cinque metri e lunga più di dieci, compreso il bagno. È un castello. A metà mattina siamo in viaggio, diretti a sud sull’Interstatale 79. Tre ore dopo arriviamo all’aeroporto di Charleston, West Virginia, dove diciamo addio all’agente Chris Hanski. Mi fa gli auguri e io lo ringrazio per le sue premure. Poi, insieme a Pat Surhoff, raggiungo l’imbarco di un volo navetta per Charlotte, North Carolina. Non ho documenti, ma il Marshals Service e la compagnia aerea si parlano nel loro codice segreto. Io mi limito a seguire Pat e devo ammettere di sentirmi eccitato quando salgo a bordo del piccolo aereo. L’aeroporto di Charlotte è una struttura vasta, aperta e moderna, e io passo due ore in piedi su un mezzanino a guardare le persone che vanno e vengono. Sono uno di loro, un uomo libero, e presto potrò presentarmi a un banco e comprarmi un biglietto per qualsiasi destinazione. Alle sei e dieci ci imbarchiamo su un volo nonstop diretto a Denver. Il codice segreto ci ha procurato un upgrading, così Pat e io sediamo fianco a fianco in prima classe, gentile omaggio dei contribuenti. Io chiedo una birra e Pat un ginger ale. La cena è pollo arrosto con salsa, e suppongo che la maggior Teile dei passeggeri lo mangi solo a fini di sopravvivenza. Per me è una cena raffinata. Bevo un bicchiere di pinot nero, il mio primo sorso di vino da molti anni. Terminata la conferenza stampa, Victor Westlake e il suo entourage salirono in auto e percorsero i quattro isolati che li separavano dallo studio legale di Jimmy Lee Arnold, in centro città. Si presentarono alla receptionist, che li stava aspettando e che, dopo pochi minuti, li accompagnò lungo uno stretto corridoio fino a una grande sala riunioni, dove si offrì di servire il caffè. Il gruppo di Westlake la ringraziò, ma declinò l’offerta. Jimmy Lee era un’istituzione nel tribunale penale di Roanoke, un veterano delle guerre contro droga e prostituzione con un’esperienza ventennale. Quattro anni prima aveva difeso Jakeel Staley, il nipote di Quinn Rucker. Come molti dei pistoleri solitari che operano ai margini della malavita, Jimmy Lee era un personaggio. Lunghi capelli grigi, stivali da cowboy, diversi anelli, occhiali da lettura con montatura rossa in bilico sul naso. Anche se sospettoso nei confronti dell’FBI, diede agli ospiti il benvenuto nel suo dominio. Non erano i primi agenti che gli facevano visita: ce n’erano stati molti altri nel corso degli anni. «E così avete un rinvio a giudizio» disse, appena sbrigate le presentazioni. Victor Westlake gli fornì uno stringato riassunto delle accuse contro Quinn Rucker. «Qualche anno fa lei ha rappresentato suo nipote, Jakeel Staley, esatto?» «Esatto» confermò Jimmy Lee. «Ma non ho mai conosciuto Quinn Rucker.» «Presumo che sia stata la famiglia, o la gang, ad assumerla per difendere il ragazzo.» «Qualcosa del genere. È stato un contratto privato, non un incarico del tribunale.» «Chi della famiglia trattò con lei?» L’atteggiamento di Jimmy Lee cambiò. Infilò una mano in una tasca della giacca ed estrasse un piccolo registratore. «Tanto per stare sul sicuro» disse, premendo un tasto. «Mettiamo tutto agli atti. Voi siete in tre, io sono da solo. E voglio essere sicuro che non sorgano equivoci. Qualche problema?» «No» rispose Westlake. «Bene. Dunque, lei mi ha chiesto chi della famiglia trattò con me quando fui assunto per rappresentare Jakeel Staley, esatto?» «Esatto.» «Be’, non sono sicuro di poterle rispondere. Rapporto confidenziale con il cliente eccetera. Perché non mi spiega il motivo del suo interesse?» «Certo. Quinn Rucker ha confessato. Ha detto di avere ucciso il giudice Fawcett perché non aveva mantenuto una promessa fatta dopo essersi intascato una mazzetta. Ha detto che lui, la gang, aveva versato cinquecentomila dollari in contanti a Fawcett perché accogliesse l’istanza in cui gli si chiedeva di dichiarare inammissibile la perquisizione che aveva portato alla scoperta del carico di coca sul furgone.» Westlake fece una pausa e osservò attentamente Jimmy Lee. Gli occhi dell’avvocato non rivelavano nulla. Poi Jimmy Lee si strinse nelle spalle e disse: «E allora?». «Allora, lei ha mai saputo qualcosa di quella mazzetta?» «Se ne fossi stato a conoscenza, avrei commesso un reato anch’io, le pare? Mi crede così stupido da ammettere un reato? Sono offeso.» «Oh, non si offenda, Mr Arnold. Non la sto accusando di niente.» «Quinn Rucker ha fatto il mio nome a proposito della corruzione?» «Finora è stato piuttosto vago, ha detto soltanto che l’intermediario era un avvocato.» «Sono sicuro che questa Teilicolare gang di delinquenti ha accesso a un sacco di avvocati.» «È vero. Lei è rimasto sorpreso quando il giudice Fawcett ha respinto l’istanza di inammissibilità?» Jimmy Lee sorrise e roteò gli occhi. «Niente mi può più sorprendere. Se si crede nella Costituzione, allora quella era una perquisizione illegale e le prove, centocinquanta chili di cocaina pura, avrebbero dovuto essere escluse a calci. Ci sarebbe voluta un po’ di spina dorsale, ma non se ne vede più molta in giro, specie nei grossi casi di droga. Un giudice, statale o federale che sia, deve avere le palle per invalidare delle prove così meravigliose, a prescindere da cosa possano avere combinato i poliziotti per ottenerle. No, non sono rimasto sorpreso.» «Per quanto tempo ha esercitato nell’aula del giudice Fawcett?» «Dal giorno della sua nomina, vent’anni fa. Lo conoscevo bene.» «Lei crede che si sarebbe mai fatto corrompere?» «Soldi in cambio di una decisione favorevole?» «E di una condanna più lieve.» Jimmy Lee accavallò le gambe, posò uno stivale in pelle di struzzo su un ginocchio e intrecciò le mani appena sotto la pancia. Rifletté per un momento e poi disse: «Ho visto giudici prendere decisioni infami, ma di solito solo per stupidità o pigrizia. Però no, Mr Westlake, io non credo che il giudice Fawcett, o qualsiasi altro giudice di Stato o federale del Commonwealth of Virginia, accetterebbe mai una mazzetta, in contanti o meno. Ho detto che niente mi sorprende più, ma mi sbagliavo. Un bustarella del genere per me sarebbe uno shock». «Lei direbbe che il giudice Fawcett godeva di una reputazione di assoluta integrità?» «No, non direi questo. Fawcett è stato okay nei suoi primi anni in magistratura, ma poi è cambiato ed è diventato un vero stronzo. I miei clienti sono stati tutti accusati di crimini vari, ma non tutti sono criminali. Fawcett però non la vedeva così. Era fin troppo felice di spedire un tizio in galera per vent’anni. Si schierava sempre con l’accusa e con la polizia, e per me questa non è integrità.» «Ma non prendeva soldi?» «Non che io sappia.» «Le spiego il nostro problema, Mr Arnold. Se Quinn Rucker sta dicendo la verità, com’è riuscito a far arrivare i soldi al giudice? Stiamo parlando di un duro ragazzo di strada di Washington che non aveva mai visto prima Fawcett. Deve esserci stato un intermediario da qualche Teile, lungo il percorso. Non sto dicendo che sia lei e non sottintendo assolutamente un suo coinvolgimento in questa storia. Ma lei conosce il sistema. Come hanno fatto quei cinquecentomila dollari a cambiare di mano?» Jimmy Lee stava scuotendo la testa. «Se il sistema comporta la corruzione, allora io non so come funziona, okay? È un’insinuazione che mi offende. Lei sta parlando con l’uomo sbagliato.» «Glielo ripeto: non la sto accusando di niente e non sto insinuando niente.» «Però ci va maledettamente vicino.» Jimmy Lee si alzò in piedi e tese la mano verso il registratore. «Diciamo che questa piccola riunione è terminata.» «Non c’è bisogno di quello, Mr Arnold.» Jimmy Lee prese il registratore e se lo rimise in tasca. «È stato un vero piacere» disse, spalancando la porta per poi scomparire lungo il corridoio. Sul lato opposto di Church Street, Dee Ray Rucker stava entrando in un altro studio legale proprio mentre Victor Westlake e i suoi agenti uscivano da quello di Jimmy Lee. Quinn era stato arrestato la sera del mercoledì precedente e aveva trascorso le prime dieci ore di fermo nella stanza degli interrogatori. Dopo la confessione, videoregistrata, era stato infine trasferito nel carcere cittadino di Norfolk, dove era stato posto in isolamento e aveva dormito per dodici ore di fila. Non gli era stato permesso di usare il telefono fino al sabato mattina e ci aveva messo quasi tutto il giorno per trovare un familiare disposto a parlare con lui. Nella prima serata di domenica, Quinn era stato trasferito da Norfolk a Roanoke, un viaggio di quattro ore e mezzo. Una volta resosi conto che suo fratello maggiore era in carcere con l’accusa di avere assassinato un giudice federale, Dee Ray si era dato da fare per trovare un avvocato disposto ad accettare il caso. Parecchi legali di Washington e della Virginia avevano rifiutato. Ma nel tardo pomeriggio della domenica un altro personaggio caratteristico di Roanoke, che si chiamava Dusty Shiver, aveva accettato di rappresentare Quinn nelle fasi iniziali del procedimento giudiziario, riservandosi però di rinunciare all’incarico nel caso in cui si fosse profilato un processo. Per ovvie ragioni, la locale comunità degli avvocati era piuttosto nervosa all’idea di difendere un uomo accusato di aver fatto fuori un membro così importante del sistema giudiziario. Un tempo Dusty Shiver aveva esercitato insieme a Jimmy Lee Arnold, e i due erano fatti della stessa pasta. Nell’attività legale la maggior Teile delle società, grandi o piccole che siano, prima o poi esplode, di solito per questioni di denaro. Jimmy Lee si era convinto di essere stato fregato con una parcella, aveva accusato i suoi soci e si era trasferito sull’altro lato della strada. Dusty era riuscito a trascorrere un’ora con Quinn in carcere il lunedì mattina, prima che venisse annunciato il rinvio a giudizio. Era rimasto sorpreso quando aveva saputo che il suo cliente aveva già confessato. Quinn aveva sostenuto con fermezza di essere stato costretto, ingannato, sottoposto a pressioni, minacciato, e che la confessione era un falso. Dichiarava di essere innocente. Uscito dal carcere, Dusty era passato dall’ufficio del procuratore federale e si era fatto consegnare una copia dell’atto formale. Stava studiando il documento quando la segretaria citofonò per informarlo che Mr Dee Ray Rucker era arrivato. Con i suoi lunghi capelli grigi, i jeans sbiaditi e il gilet rosso di pelle, era Dusty tra i due quello che sembrava un trafficante di droga, mentre Dee Ray, nel suo abito Zegna, aveva l’aria dell’avvocato. Si presentarono e si salutarono con circospezione nel disordinato ufficio di Dusty. Il primo argomento fu quello relativo all’onorario. Dee Ray aprì la sua valigetta Prada ed estrasse cinquantamila dollari in contanti, che il legale, dopo averli contati, infilò in un cassetto. «Lei sa che Quinn ha già confessato?» domandò Dusty mentre riponeva i soldi. «Quinn cosa...?» chiese Dee Ray scioccato. «Sì, ha confessato. Dice di avere firmato una dichiarazione scritta in cui ammette gli omicidi, e presumibilmente esiste anche un video. Per favore, mi dica che suo fratello è troppo furbo per una cosa del genere.» «È troppo furbo per una cosa del genere. Noi non parliamo mai con i poliziotti, mai. Quinn non confesserebbe mai niente volontariamente, neanche se ci fosse dentro fino al collo. Non è il nostro modus operandi. Appena compare un poliziotto, noi chiamiamo gli avvocati.» «Quinn dice che l’interrogatorio è durato tutta la notte, che aveva rinunciato ai suoi diritti, che poi ha chiesto diverse volte un avvocato, ma i due agenti dell’FBI hanno continuato a martellarlo. Lo hanno fatto cadere in contraddizione, lo hanno confuso e lui ha cominciato ad avere allucinazioni. Non riusciva a stare zitto. Gli agenti gli hanno detto che se la sarebbe vista con due imputazioni d’omicidio, che avrebbe rischiato la pena capitale e che sarebbe stata incriminata anche tutta la famiglia, dato che i due delitti rientravano nell’attività criminale della gang. Gli hanno mentito e gli hanno detto che l’avrebbero aiutato se avesse collaborato, che la famiglia del giudice Fawcett era contraria alla pena di morte e così via. Dopo ore di questo trattamento, sono riusciti a piegarlo e Quinn gli ha dato quello che volevano. Non ricorda tutto quello che è successo, era troppo esausto. Quando si è svegliato e ha cercato di ricostruire l’accaduto, gli è sembrato tutto un sogno, un incubo. Ci ha messo parecchie ore per rendersi conto di quello che aveva combinato, ma perfino adesso non riesce a ricordare tutto.» Dee Ray ascoltava, troppo sbalordito per parlare. Dusty continuò: «Ricorda però che gli agenti dell’FBI gli hanno detto di avere una perizia balistica che collega una delle sue pistole alla scena del delitto, e pare che ci sia anche un’impronta di scarpa. Inoltre, ci sono dei testimoni che lo inchiodano in zona nella finestra di tempo in cui sono avvenuti gli omicidi. Di nuovo, molta di questa roba è sul vago». «Lei quando potrà vedere la confessione?» «Incontrerò il procuratore federale il più presto possibile, ma niente succederà in fretta. Potrebbero volerci settimane prima che io veda la confessione scritta e il video, così come le altre prove che l’accusa pensa di utilizzare.» «Se Quinn aveva chiesto un avvocato, perché non hanno interrotto l’interrogatorio?» «Questa è una buona domanda. Di solito i poliziotti giurano che l’imputato ha rinunciato ai suoi diritti e non ha mai chiesto un avvocato. È la parola di Quinn contro quella degli agenti. In un caso di questa importanza, ci può scommettere che gli uomini dell’FBI giureranno sulla loro madre che Quinn non ha mai neppure accennato a un avvocato. Così come giureranno di non averlo mai minacciato, di non avergli mai mentito o di avergli promesso un accordo. Hanno ottenuto la loro confessione e adesso cercheranno di costruire l’accusa con delle prove materiali. Se non troveranno niente, allora avranno soltanto la confessione.» «Ed è sufficiente?» «Oh, sì.» «Io non credo a questa storia. Quinn non è stupido. Non avrebbe mai accettato un interrogatorio.» «Ha già ucciso qualcuno in precedenza?» «Non che io sappia. Abbiamo altra gente per quel genere di cose.» «Perché è evaso dal carcere?» «Lei è mai stato in prigione?» «No.» «Neppure io, ma conosco un sacco di persone che sono state dentro. Tutti vogliono uscire.» «Immagino che sia così» concesse Shiver. «Ha mai sentito nominare un certo Malcolm Bannister?» «No.» «Quinn dice che erano insieme a Frostburg e che c’è Bannister dietro alle accuse. Dice che erano amici e che hanno parlato a lungo del giudice Fawcett, del suo lavoro sporco. Ce l’ha veramente a morte con Bannister.» «Quando posso vedere mio fratello?» «Non prima di sabato, visita regolare. Io tornerò in carcere questo pomeriggio con una copia del rinvio a giudizio. Posso trasmettere a Quinn un suo messaggio, se lo desidera.» «Certo. Gli dica di tenere la bocca chiusa.» «Temo che per questo sia già troppo tardi.» 20 I dettagli sono vaghi ed è poco probabile che diventino più chiari. Tutto ciò che Pat Surhoff è disposto a dirmi è che la clinica fa Teile dell’ospedale dell’esercito USA a Fort Carson, ma questo sarebbe difficile da negare. Il marshal mi informa che la struttura è specializzata in MRC, modifiche radicali connotati, e che viene utilizzata da numerose agenzie del governo federale. I chirurghi plastici sono tra i migliori e hanno lavorato su un sacco di facce che, se non avessero subito modifiche radicali, sarebbero state devastate dai proiettili. Insisto con le domande a Pat solo per vederlo agitarsi, a disagio, ma non mi dice molto altro. Dopo l’intervento, resterò in convalescenza qui per due mesi e poi verrò trasferito. Il mio primo appuntamento è con una specie di terapeuta, la quale vuole essere sicura che io sia pronto ad affrontare l’esperienza traumatica del cambiamento non solo del nome, ma anche della faccia. È simpatica e premurosa, e la convinco facilmente che non vedo l’ora di procedere. Il secondo colloquio è con due medici e un’infermiera. La presenza dell’infermiera è necessaria per avere il punto di vista femminile sul mio aspetto futuro. Non mi ci vuole molto per rendermi conto che questi tre sono molto bravi in quello che fanno. Utilizzando un sofisticato software, sono in grado di prendere la mia faccia e di apportarvi qualsiasi modifica. Gli occhi sono l’elemento cruciale, sottolineano più di una volta. Cambia gli occhi e cambi tutto. Affiliamo un tantino il naso. Lasciamo stare le labbra. Un po’ di botox nelle pieghe delle guance dovrebbe funzionare. Assolutamente, rasare a zero la testa e tenerla così. Per quasi due ore giochiamo e ci impegniamo con la nuova faccia di Max Baldwin. Nelle mani di chirurghi meno esperti, questa potrebbe essere un’esperienza da torcere le budella. Negli ultimi venticinque anni, tutta la mia vita da adulto, ho avuto sostanzialmente lo stesso aspetto, con il mio viso plasmato dalla genetica, stagionato dagli anni e, per fortuna, mai segnato da ferite o lesioni. È una bella faccia di cui sono stato sempre contento, e scaricarla di colpo non è un passo da poco. I miei nuovi amici mi dicono che non c’è bisogno di cambiare tutto, si tratterà solo di alcuni ritocchi. Una piccola modifica qui, un’aggiustatina là, qualche tiratina e voilà: una nuova versione, gradevole quanto la precedente e di gran lunga più sicura. Sottolineo che sono molto più preoccupato della sicurezza che della vanità, e loro si dichiarano subito d’accordo con me. Hanno già sentito queste parole. Non posso fare a meno di chiedermi su quanti informatori, delatori e spie abbiano lavorato. Centinaia, a giudicare dall’efficienza del loro lavoro di squadra. Mentre il mio nuovo aspetto prende forma sul grande schermo del computer, discutiamo con serietà degli accessori e i tre sembrano sinceramente emozionati quando sulla faccia di Max compare un bel paio di occhiali rotondi con la montatura di tartaruga. «Ci siamo!» esclama eccitata l’infermiera, e devo ammettere che con quegli occhiali Max sembra molto più intelligente e trendy. Passiamo mezz’ora a giocare con vari tipi di baffi prima di scartare del tutto l’idea. Siamo due contro due per quanto riguarda l’idea della barba, pertanto decidiamo di aspettare e stare a vedere. Prometto di non radermi per una settimana, così avremo un’idea più fondata. A causa dell’importanza di ciò che stiamo facendo, la mia piccola squadra non ha alcuna fretta. Trascorriamo l’intera mattinata a riprogettare Max e, quando siamo tutti soddisfatti, stampiamo un’immagine in alta definizione del mio nuovo viso. Porto la stampa in camera mia e la fisso alla parete. Dopo averla studiata, un’infermiera dichiara che le piace. Anche a me piace lei, ma è sposata e non flirta. Se solo sapesse. Passo il pomeriggio a leggere e a passeggiare nelle aree della base non soggette a restrizioni. È un po’ come ammazzare il tempo a Frostburg, un luogo ormai molto distante sia nella memoria che nello spazio. Continuo a tornare in camera mia, alla faccia sulla parete: testa rasata, naso appena appuntito, un mento un po’ più marcato, guance più scavate, niente rughe e gli occhi di qualcun altro. La flaccidezza della mezz’età è scomparsa. Le palpebre non sono più così carnose. Cosa più importante, Max mi sta guardando attraverso un paio di occhiali rotondi firmati e ha un’aria maledettamente cool. Devo presumere che sarà una cosa facile come dicono, che questi medici siano in grado di consegnarmi una faccia esattamente uguale a quella di Max sulla parete. Ma anche se ci andranno solo vicino, sarò contento lo stesso. Nessuno riconoscerà la loro nuova creazione, ed è questo che conta. Sono troppo coinvolto per giudicare se risulterò più bello prima o dopo, ma la verità è che sarò bello abbastanza. La sicurezza è davvero di gran lunga più importante della vanità. Alle sette del mattino seguente mi preparano per l’intervento e mi trasportano in barella in una piccola sala operatoria. L’anestesista fa il suo dovere e io scivolo serenamente nel nulla. L’operazione dura cinque ore ed è un successo, secondo quanto dichiarano i chirurghi. Ovviamente non hanno modo di saperlo dato che la mia testa è fasciata come quella di una mummia. Ci vorranno settimane perché la tumefazione sparisca e i miei nuovi lineamenti prendano forma. Quattro giorni dopo la notifica del rinvio a giudizio, Quinn Rucker si presentò per la prima volta in tribunale. Per l’occasione gli fu imposta la stessa tuta arancione che indossava dal giorno del suo ingresso nel carcere cittadino di Roanoke. Gli vennero messe le manette, da cui Teiliva una catena che si collegava a quella intorno alla vita, e gli vennero strette le catene anche alle caviglie. Un giubbotto antiproiettile con chiusure a strappo gli venne fissato sulle spalle e intorno alla vita, dopodiché non meno di dieci uomini tra guardie, agenti e vicesceriffi armati fino ai denti lo scortarono fuori dal carcere e lo fecero salire su una Chevrolet Suburban blindata. Non c’era stata alcuna minaccia di morte nei confronti di Quinn e per raggiungere il tribunale federale sarebbe stato seguito un percorso segreto, ma le autorità non volevano correre rischi. Giornalisti e spettatori riempirono l’aula molto prima dell’arrivo di Rucker, previsto per le dieci. Il suo arresto e il successivo rinvio a giudizio erano la notizia del giorno, dato che nel frattempo nessun omicidio di massa o divorzio di qualche celebrità gli avevano rubato la scena. Fuori dall’aula gli vennero rimossi giubbotto e catene e Rucker fece la sua entrata senza manette. Quale unico presente in tuta arancione e in pratica unico nero in aula, Quinn aveva tutta l’aria del colpevole. Si sedette al tavolo di Dusty Shiver, che era accompagnato da un suo associato. Sull’altro lato della corsia centrale, Stanley Mumphrey e la sua brigata di assistenti consultavano pratiche e fascicoli con aria solenne, quasi stessero per dibattere davanti alla Corte Suprema. Per rispetto verso il collega caduto, gli altri undici giudici del Distretto Sud si erano avvalsi della procedura di astensione spontanea. La prima udienza si sarebbe quindi tenuta davanti a Ken Konover, un magistrato onorario coadiutore che si sarebbe comportato e avrebbe agito in modo molto simile a quello di un normale giudice. Konover prese posto sullo scranno e richiamò l’aula all’ordine. Snocciolò rapidamente alcune formule introduttive e poi chiese se l’imputato avesse letto l’atto di rinvio a giudizio. «Sì, vostro onore» rispose Dusty «e rinunciamo alla lettura formale.» «Grazie» disse Konover. Seduto nella prima fila dietro al tavolo della difesa c’era Dee Ray, vestito come sempre alla moda e chiaramente preoccupato. «L’imputato desidera rilasciare la sua dichiarazione in questa fase?» domandò il giudice. Dusty si alzò in piedi e rivolse un cenno al suo cliente, che si alzò in piedi a sua volta e disse imbarazzato: «Sì, signore. Non colpevole». «Molto bene, si metta a verbale la dichiarazione di non colpevolezza.» Dusty e Quinn si rimisero a sedere. «Ho qui una richiesta di libertà su cauzione, Mr Shiver. Vuole essere sentito su questo punto?» Il tono di Konover non lasciava dubbi sul fatto che non c’era niente che Dusty potesse dire per persuadere la corte a concedere una cauzione ragionevole, o anche irragionevole. Intuendo l’inevitabile, e non volendo mettersi in una situazione imbarazzante, Dusty rispose: «No, vostro onore, la nostra istanza parla da sola». «Mr Mumphrey?» Stanley si alzò in piedi e andò al leggio. Si schiarì la voce e disse: «Vostro onore, l’imputato è accusato dell’omicidio di un giudice federale. Gli Stati Uniti ritengono che debba restare in carcere e che non debba essere concessa la libertà su cauzione». «Sono d’accordo» dichiarò subito Konover. «Nient’altro, Mr Mumphrey?» «No, signore, non in questo momento.» «Mr Shiver?» «No, vostro onore.» «L’imputato resterà in carcere sotto custodia dell’ US Marshals Service.» Konover batté il martelletto, si alzò e lasciò il banco del giudice. La prima comparizione era durata meno di dieci minuti. Dee Ray era a Roanoke da tre giorni ed era già stanco di quel posto. Fece pressioni su Dusty Shiver, il quale fece pressioni su un amico al carcere e fu così che venne organizzato un rapido incontro con l’imputato. Dato che le visite dei familiari erano ammesse solo nei weekend, questa avrebbe avuto carattere ufficioso e si sarebbe svolta in una stanza utilizzata per sottoporre a test alcolemico gli automobilisti ubriachi. La visita non sarebbe mai stata riportata su alcun registro ufficiale. I due fratelli non sospettavano che ci fosse qualcuno in ascolto. L’ FBI registrò la loro conversazione, Teile della quale fu: QUINN: Dee, io sono qui per colpa di Malcolm Bannister, capisci quello che ti dico? DEE RAY: Ho capito, ho capito. Ce ne occuperemo in seguito. Ora, però, devi raccontarmi cos’è successo. QUINN: Non è successo niente. Io non ho ucciso nessuno. Mi hanno fatto confessare con l’inganno, come ho già detto. Voglio che si faccia qualcosa riguardo a Bannister. DEE RAY: È in prigione, giusto? QUINN: Probabilmente no. Conoscendo Bannister, probabilmente è uscito con l’articolo 35. DEE RAY: L’articolo 35? QUINN: Tutti in galera sanno del 35. Ma ora non ha importanza. Bannister è fuori e bisogna trovarlo. Una lunga pausa. DEE RAY: Un sacco di tempo al fresco, un sacco di soldi. QUINN: Senti, fratellino, non parlarmi del tempo. Quelli dell’FBI non hanno niente contro di me. E sottolineo niente. Ciò non significa che non me lo possono mettere nel culo. Se questa storia arriva al processo nel giro di un anno o giù di lì, Bannister può essere il loro testimone superstar, mi capisci? DEE RAY: E cosa dirà? QUINN: Dirà tutto quello che serve, non gliene frega niente. Lui è fuori, ha concluso l’accordo. Dirà che io e lui avevamo parlato del giudice Fawcett quando eravamo in prigione insieme. Ecco cosa dirà. DEE RAY: Ed è vero? Un’altra lunga pausa. QUINN: Sì, ne parlavamo di continuo. Sapevamo che aveva dei contanti. Una pausa. QUINN: Dee Ray, devi trovare Bannister. Okay? DEE RAY: Okay. Ne parlerò con Tall Man. 21 Tre settimane dall’intervento e io mi arrampico sui muri. Le bende non ci sono più e i punti sono stati tolti, ma per il gonfiore ci vuole un’eternità. Mi guardo allo specchio cento volte al giorno, in attesa di un miglioramento, in attesa che Max emerga dai lividi e dalle tumefazioni. L’équipe chirurgica passa di continuo per dirmi che ho un aspetto splendido, ma ormai questa gente mi dà la nausea. Non riesco a masticare, non riesco a mangiare, non riesco a camminare per più di cinque minuti e di conseguenza passo la maggior Teile del tempo andandomene in giro su una sedia a rotelle. I movimenti devono essere lenti e calcolati, altrimenti potrei provocare qualche strappo nell’opera d’arte finita nella faccia di Max Reed Baldwin. Conto i giorni e ho spesso l’impressione di essere ancora in carcere. Passano altre settimane, e lentamente lividi e gonfiore scompaiono. È possibile essere innamorato di una donna che non hai mai neppure sfiorato? Mi sono convinto che la risposta è sì. Si chiama Vanessa Young e l’ho conosciuta nella sala visite di Frostburg in un freddo sabato mattina d’inverno. Non dovrei dire che in quell’occasione l’ho conosciuta, ma che l’ho vista per la prima volta. Era lì in visita a suo fratello, un ragazzo simpatico. Ci siamo conosciuti in seguito, durante un’altra sua visita, ma non abbiamo mai potuto toccarci. Ho cominciato a scriverle delle lettere e lei ogni tanto mi rispondeva, ma ben presto è diventato penosamente evidente, almeno per me, che la mia infatuazione non era esattamente una strada a doppio senso. Non so quantificare le ore che ho investito in fantasie su quella donna. Nel corso degli ultimi due anni sia la sua vita che la mia sono cambiate radicalmente e adesso mi sento abbastanza sicuro di me da contattarla. Il mio nuovo miglior amico, Pat Surhoff, mi ha informato che non posso scrivere o ricevere lettere mentre sono a Fort Carson, ma io comunque ne scrivo una. Ci lavoro per giorni, correggendola, limandola, ammazzando il tempo. Metto a nudo la mia anima davanti a Vanessa e in pratica la supplico di vederci. Troverò un modo per spedirle la lettera. Pat Surhoff è tornato a prendermi. Lasciamo Fort Carson in gran fretta e in auto raggiungiamo Denver, dove ci imbarchiamo su un volo nonstop per Atlanta. Indosso un berretto da baseball e grandi occhiali da sole, e non noto una sola occhiata curiosa. Mi lamento dei posti: Surhoff e io sediamo fianco a fianco in classe economica, non in prima. Pat mi dice che il Congresso sta tagliando i budget dappertutto. Dopo un lauto pasto a base di uva passa e Coca-Cola, ci mettiamo al lavoro. Surhoff apre una deliziosa, piccola cartellina che contiene ogni sorta di chicche: un’ordinanza del tribunale della Virginia che mi cambia il nome in Max Reed Baldwin; una nuova tessera della previdenza sociale intestata al suddetto nominativo; un certificato di nascita in cui si attesta che sono nato a Memphis da genitori che non ho mai sentito nominare; una patente di guida della Florida con una foto ricavata dall’immagine computerizzata elaborata dai miei medici e da me prima dell’intervento. Sembra così autentica che perfino io non direi mai che è falsa. Pat mi spiega che avrò un’altra patente fra circa un mese, quando finalmente la mia faccia si sarà assestata. Stessa cosa per il passaporto. Compiliamo i moduli per richiedere le carte di credito VISA e American Express. Dietro suggerimento di Surhoff, mi sto esercitando da tempo in una nuova, diversa grafia; fa pensare a zampe di gallina, ma non è molto peggiore della vecchia. Max firma un contratto d’affitto di sei mesi per un apTeilamento con un’unica camera da letto a Neptune Beach, pochi chilometri a est di Jacksonville, e compila il modulo per aprire un conto corrente presso la SunCoast Bank la quale, mi informa Pat, ha una filiale a soli tre isolati dal mio condominio. I centocinquantamila dollari della ricompensa mi verranno versati con un bonifico sul conto appena questo sarà operativo e da quel momento in poi potrò farne ciò che voglio. Dato che comincerò la mia nuova vita con così tanto denaro, l’autorità costituita ritiene di non dovermi dare molto altro. Su questo non posso fare obiezioni. Pat mi dice che il fisco mi concederà l’esenzione da qualsiasi tassa sul denaro della ricompensa e mi fornisce il nominativo di un commercialista a conoscenza sia dei misteri del fisco che di quelli, quali che siano, dei marshal. Poi mi consegna una busta contenente tremila dollari in contanti, dicendo che dovrebbero essere sufficienti per cominciare a sistemarmi. Discutiamo sui pro e i contro dell’acquisto di un’auto rispetto al leasing; Pat afferma che il leasing è più facile e serve anche a creare una buona storia di credito. Mi consegna un riassunto di due pagine della vita di Max Baldwin, riassunto che sembra quasi un necrologio. Genitori, fratelli, studi, storia lavorativa... resto affascinato scoprendo che ho trascorso la maggior Teile della mia vita a Seattle e che ho divorziato due volte, niente figli. Mi sto trasferendo in Florida perché è il posto più lontano possibile dalla moglie numero due. È importante che io memorizzi questi dati e mi attenga sempre al copione. Ho un curriculum di impiegato (sempre in agenzie governative) e una valutazione della mia affidabilità creditizia. Per quanto riguarda il lavoro ho due scelte. La prima è quella di responsabile dell’ufficio acquisti alla Mayport Naval Station, pochi chilometri a nord di Neptune Beach; stipendio iniziale quarantottomila dollari, due mesi di addestramento obbligatori. La seconda possibilità è direttore amministrativo alla Veteran’s Administration, sempre per quarantottomila dollari l’anno. È meglio se continuo a essere un impiegato federale, almeno per i primi anni. In ogni caso, sottolinea Pat per l’ennesima volta, la mia vita adesso apTeiliene a me e posso fare tutto ciò che voglio. Gli unici limiti sono quelli imposti dal mio passato. Proprio quando sto cominciando a sentirmi quasi sopraffatto, Pat fruga nella sua valigetta ed estrae i giocattoli. Il primo è un iPad, mio per gentile omaggio del governo e già registrato a nome di Max. Come bibliotecario, Malcolm aveva accesso ai computer (ma non a Internet), e io ho sempre lavorato sodo per mantenermi aggiornato. Ma questo coso va oltre le mie possibilità. Dedichiamo un’ora intera a un corso intensivo. Quando sono esausto, Pat mi mostra un iPhone. È suo, non mio, perché dovrò essere io a scegliermi un provider e ad acquistare il mio cellulare personale. Surhoff comunque mi prende per mano e mi istruisce su questo sorprendente strumento. Il volo termina prima che abbiamo finito. Nell’aeroporto di Atlanta trovo un negozio di computer e ammazzo il tempo curiosando per un’ora tra i vari gadget. La tecnologia sarà la chiave della mia sopravvivenza e sono deciso a familiarizzare con tutte le ultime novità. Prima di decollare da Atlanta, lascio cadere nella cassetta della posta la lettera che ho scritto a Vanessa Young. Nessun indirizzo del mittente. Atterriamo a Jacksonville che è buio, noleggiamo un’auto e dopo mezz’ora raggiungiamo le spiagge a est della città. Atlantic Beach, Neptune Beach, Jacksonville Beach... non si riesce a capire dove finisca una e inizi l’altra. È una zona elegante con centinaia di bei cottage – alcuni di proprietà, altri in affitto – e un assortimento di piccoli hotel e moderni condominii rivolti verso l’oceano. L’uva passa del pranzo è solo un lontano ricordo e Pat e io stiamo morendo di fame. Troviamo un ristorante di pesce in un’area pedonale a un isolato dall’oceano e divoriamo ostriche e gamberi. La folla al bar del ristorante è tutta composta di giovani, un sacco di belle ragazze dalle gambe abbronzate, e io non posso fare a meno di guardarle. Finora ho visto solo bianchi e mi chiedo se darò nell’occhio. L’area metropolitana di Jacksonville conta un milione di abitanti, il diciotto per cento dei quali è nero, perciò Pat non crede che la mia etnia sarà un problema. Provo a fargli capire cosa significa essere nero in un mondo bianco, ma mi rendo conto, ancora una volta, che certe cose non si possono spiegare pienamente nel corso di una cena, o forse mai. Cambio argomento e faccio qualche domanda sul programma protezione testimoni. Pat è di base in Virginia e presto tornerà a casa. Un altro marshal diventerà il mio contatto, il mio referente, e questa persona non tenterà mai, in nessun modo, di tenermi sotto sorveglianza. Lui, o lei, sarà sempre raggiungibile in caso di problemi, o di guai. Tipicamente, il mio referente avrà diverse altre “persone” da monitorare. Se ci sarà il minimo segnale che qualcosa non va, verrò immediatamente trasferito altrove, ma, mi assicura Surhoff, questo succede molto di rado. Come potrebbero fare i cattivi a trovarmi? Pat mi risponde di non saperlo perché non è mai accaduto. Io insisto: «Ma ti sarà capitato di sicuro di dover ritrasferire qualcuno». «Personalmente non sono mai stato coinvolto in un trasferimento, però sì: è successo. Per quello che ne so, e gestisco informatori da dieci anni, non c’è mai stata una seria minaccia. Comunque ho sentito parlare di due, forse tre soggetti che si erano convinti di essere stati scoperti. Volevano andare via, così siamo intervenuti e loro sono svaniti, un’altra volta.» Per ovvie ragioni, a Frostburg né la biblioteca legale né quella generica offrivano testi sul programma protezione testimoni, per cui la mia conoscenza in materia è limitata. Ma so che il programma non è perfetto. «Quindi, mai nessun problema di nessun tipo? Difficile da credere.» «Non ho mai detto che il programma è perfetto. C’è una storia bellissima che risale a trent’anni fa, una leggenda nel nostro settore. Avevamo un importante informatore della mafia che aveva vuotato il sacco sulla famiglia e fatto finire dentro alcuni pezzi da novanta. Uno dei colpi più spettacolari messi a segno dall’FBI. Quel tipo aveva un bersaglio così grande appeso al collo che avresti potuto centrarlo anche a occhi bendati. Ce ne siamo occupati, l’abbiamo sepolto in profondità ed è trascorso qualche anno. Lavorava come ispettore postale in una città di cinquantamila abitanti. Una copertura perfetta, ma lui era un delinquente, okay? Un criminale dalla nascita, gli era impossibile restare pulito. Apre una rivendita di auto usate, poi un’altra. Entra nel business dei banchi di pegno, comincia a fare il ricettatore e dopo un po’ arriva al commercio di marijuana. Noi sapevano chi era, ma l’FBI no. Quando viene arrestato, chiama il suo referente perché corra a farlo uscire su cauzione. Il referente si spaventa da morire, così come tutti nella catena di comando, su su fino al direttore dell’FBI. C’è stato un casino pazzesco per tirarlo fuori di galera e trasferirlo di nuovo. Sono stati minacciati licenziamenti, sono stati conclusi accordi, si sono supplicati giudici e alla fine le accuse sono state fatte cadere. Quella volta l’abbiamo spuntata per un pelo. Quindi, vedi di non ricominciare a riciclare soldi sporchi.» Pat crede che la sua ultima frase sia divertente. «Io non ho mai riciclato soldi sporchi» dico senza sorridere. «Scusa.» Finiamo il dolce e ci dirigiamo verso la mia nuova casa. È al settimo piano di una torre, una di un gruppo di quattro allineate lungo la spiaggia, con campi da tennis e piscine sparsi in giro. Pat mi spiega che quasi tutti gli apTeilamenti sono affittati, ma pochi ospitano inquilini permanenti. Io resterò qui per sei mesi, poi starà a me decidere. Il mio apTeilamento, arredato, vanta una camera da letto e una combinazione soggiorno-cucina; bel divano e belle poltrone, niente di lussuoso, ma nemmeno di dozzinale. Dopo che Surhoff se n’è andato, esco sul piccolo balcone e guardo la luna sull’oceano. Respiro l’aria salmastra e ascolto le onde frangersi dolcemente sulla riva. La libertà è esaltante, e indescrivibile. Ho dimenticato di chiudere le tende e vengo svegliato da un sole accecante. È la mia prima vera mattina da persona libera e non sorvegliata, e non vedo l’ora di sentire la sabbia tra le dita dei piedi. Ci sono solo poche persone in spiaggia e io mi affretto a scendere, cercando di camuffarmi con berretto e occhiali da sole. Ma nessuno fa caso a me, nessuno si interessa. Quelli che vagano senza meta su e giù per le spiagge sono persi nel loro mondo e io mi perdo rapidamente nel mio. Non ho famiglia, non ho lavoro, nessuna responsabilità, nessun passato. Max sta cominciando una vita nuova di zecca. Pat Surhoff passa a recuperarmi verso mezzogiorno. Pranziamo con un sandwich e poi Pat mi accompagna in auto alla Mayport Naval Station, dove ho appuntamento con un medico del giro segreto dei marshal. Il decorso dopo l’intervento procede bene, nessuna complicazione di qualsiasi tipo. Tornerò tra due settimane per un altro controllo. La tappa successiva è alla filiale della SunCoast Bank nei pressi del mio condominio e, mentre ci avviciniamo, Pat mi spiega quello che succederà. Lui non entrerà in banca perché è importante che sia io ad aprire il conto. Nessuno della banca è nel giro: sarà tutto rigorosamente normale e alla luce del sole. Per il momento Max Baldwin è un semipensionato, non lavora e sta valutando se trasferirsi definitivamente in zona. Vuole aprire un conto corrente standard, senza fronzoli o cose varie, e verserà mille dollari in contanti come deposito iniziale. Una volta aperto il conto, Max tornerà in banca e si farà dare tutte le istruzioni per ricevere un bonifico. Entro nella filiale e vengo indirizzato all’adorabile Gretchen Hiler, una finta bionda sui quarant’anni che ha passato troppo tempo al sole. Siede dietro una scrivania in un minuscolo cubicolo e noto che non ha la fede al dito. Non ha modo di sapere che lei è la prima donna con cui mi trovo realmente da solo da più di cinque anni. Per quanto mi sforzi, non riesco a impedirmi lo scatenamento di pensieri indecenti. O forse solo naturali. Gretchen è una chiacchierona e al momento lo sono anch’io. Compiliamo rapidamente i moduli e ho l’orgoglio di fornire un indirizzo autentico. Verso mille dollari in contanti e Gretchen va a prendere alcuni assegni provvisori, assicurandomi che me ne invierà degli altri per posta. Terminati gli affari, continuiamo a chiacchierare. Gretchen mi dà il suo biglietto da visita e si dichiara pronta ad aiutarmi in ogni modo. Io prometto di chiamare appena avrò un cellulare: la banca ha bisogno di un numero di telefono. Sto quasi per invitarla a cena, soprattutto perché sono convinto che potrebbe accettare, ma lascio saggiamente perdere. Per queste cose ci sarà tempo più avanti, quando mi sentirò più a mio agio e la mia faccia sarà più gradevole da guardare, almeno spero. Ho chiesto a Dionne di sposarmi quando avevo ventiquattro anni e da quel momento fino al giorno in cui sono stato condannato e portato in carcere non le sono mai stato infedele. Una volta ci sono andato vicino, con la moglie di un conoscente, ma entrambi ci rendemmo conto che le cose potevano finire male. Come avvocato in una piccola città, vedevo moltissimi divorzi e restavo continuamente stupito dai modi incredibili in cui gli uomini rovinavano la propria vita e la famiglia solo perché non riuscivano a resistere alle tentazioni. Una sveltina, poi una relazione occasionale, poi qualcosa di più serio e nel giro di poco tempo si ritrovavano in tribunale a farsi cavare gli occhi e ad affrontare la perdita dei figli, oltre che del loro denaro. La verità era che io adoravo mia moglie e trovavo in casa tutto il sesso che volevo. Ma devo ammettere che non mi sono mai visto come un dongiovanni. Prima di Dionne ho avuto delle ragazze e mi sono goduto i miei giorni da single, ma non sono mai saltato da un letto all’altro. Adesso, a quarantatré anni e single, ho la sensazione che in giro ci siano tantissime donne più o meno della mia età in cerca di compagnia. L’impulso c’è, ma è anche vero che tutti i miei movimenti devono essere attentamente calcolati. Esco dalla banca con un senso di soddisfazione. Ho appena portato felicemente a termine la prima piccola missione della mia esistenza segreta. Pat è rimasto ad aspettarmi in macchina e, quando salgo, mi chiede: «Allora?». «Nessun problema.» «Come mai ci hai messo tanto?» «L’addetta ai conti correnti è una bella ragazza e mi si è buttata fra le braccia.» «Questo è sempre stato un tuo problema?» «Non lo definirei un problema, comunque sì: le donne sono attratte da me. Devo combattere per tenerle lontane.» «Continua a combattere. Le donne sono state la rovina di molti uomini.» «Quindi tu sei un esperto di donne?» «Per niente. Dove andiamo adesso?» «A fare shopping. Voglio qualche vestito decente.» Troviamo un negozio di abbigliamento maschile e spendo ottocento dollari per alzare il livello del mio guardaroba. Anche questa volta Pat mi aspetta in macchina. Ci siamo trovati d’accordo sul fatto che due uomini, entrambi sui quarant’anni, uno bianco e uno nero, che fanno shopping insieme potrebbero fare inarcare più di un sopracciglio. Il mio obiettivo è farne inarcare il minor numero possibile. Pat poi mi scarica a un ufficio della Florida Cellular, dove apro un conto e acquisto un iPhone. E con quello in tasca mi sento finalmente un vero americano, finalmente connesso. Passiamo i due giorni seguenti a sbrigare commissioni e a consolidare l’esistenza di Max. Compilo il mio primo assegno a favore di un’agenzia di leasing automobilistico e me ne vado alla guida di un’Audi A4 decappottabile usata, mia per i prossimi dodici mesi a quattrocento dollari al mese, assicurazione compresa. Adesso che sono motorizzato e che cominciamo a starci sulle scatole, Pat inizia a parlare della sua uscita di scena. Io sono pronto per l’indipendenza e lui per tornarsene a casa. Vado di nuovo a trovare Gretchen per informarmi sulle modalità della banca per quanto riguarda i bonifici e la informo che sta per arrivarmi una notevole somma di denaro. Pat parla con i suoi superiori e i soldi della ricompensa vengono trasferiti da qualche conto misterioso alla Sun-Coast. Do per scontato che ogni persona coinvolta nel bonifico adotti tutte le precauzioni standard. Non ho modo di sapere che qualcuno sta tenendo d’occhio l’operazione. 22 L’istanza presentata da Dusty Shiver per richiedere la non validità della confessione non era per niente inaspettata. Lunga, ben scritta e ben argomentata, era integrata da una dichiarazione giurata di trenta pagine nella quale Quinn Rucker ritrattava totalmente. Tre giorni dopo che il documento era stato depositato, Victor Westlake e due suoi agenti si riunirono con Stanley Mumphrey e due suoi assistenti. Scopo dell’incontro era esaminare a fondo l’istanza e preparare le risposte. Né Mumphrey né nessun altro del suo ufficio erano a conoscenza delle tattiche d’interrogatorio adottate dagli agenti Pankovits e Delocke, così come nessuno di loro sapeva che Westlake e quattro dei suoi uomini avevano seguito tramite trasmissione a circuito chiuso la maratona di dieci ore e che ne conservavano il nastro. Queste informazioni non sarebbero mai state comunicate al procuratore federale e di conseguenza non sarebbero mai venute a conoscenza della difesa, del giudice o di chiunque altro. Aggiornato su tutti i Teilicolari dai suoi luogotenenti, fu Stanley ad assumere il controllo della riunione. Cominciò dicendo: «Il primo punto, e il più importante, è l’affermazione dell’imputato secondo cui avrebbe voluto parlare con un avvocato». Westlake rivolse un cenno a un agente, il quale estrasse subito alcuni fogli. Westlake spiegò: «Queste sono le dichiarazioni giurate degli agenti Pankovits e Delocke, che hanno condotto l’interrogatorio, in cui rispondono a tale accusa. Come vedrai, gli agenti ammettono che l’imputato ha accennato a un avvocato in un paio di occasioni, ma affermano anche che non ne ha mai richiesto esplicitamente uno. Non ha mai interrotto l’interrogatorio. Voleva parlare». Stanley e i suoi uomini scorsero rapidamente le due dichiarazioni giurate. Dopo qualche minuto, il procuratore disse: «Okay, punto numero due. L’imputato sostiene di essere stato più volte minacciato di pena di morte da entrambi gli agenti. Se questo è vero, si tratterebbe di un comportamento estremamente scorretto e con ogni probabilità renderebbe nulla la confessione». Westlake scosse la testa e rispose: «Leggi in fondo a pagina sette di entrambe le dichiarazioni. Gli agenti affermano, sotto giuramento, di non aver fatto alcun tipo di minaccia. Sono due esperti in interrogatori, Stan, molto esperti, e conoscono le regole come chiunque altro». Stanley e i suoi trovarono pagina sette e lessero il testo. Perfetto. Qualunque cosa sostenesse Quinn nella sua dichiarazione giurata, c’erano due agenti dell’FBI pronti a spiegare cos’era veramente successo. «Sembra tutto a posto» disse il procuratore. «Il terzo punto è che gli agenti avrebbero promesso all’imputato che sarebbe stato processato per omicidio, ma senza richiesta di pena capitale.» «Pagina nove» disse Westlake. «I nostri agenti sanno di non avere l’autorità per negoziare patteggiamenti. Solo il procuratore federale può farlo. Francamente trovo ridicola un’accusa del genere. Rucker è un criminale di carriera. Dovrebbe sapere che sono i procuratori a concludere gli accordi, non i poliziotti.» «In effetti» confermò subito Stanley. «C’è poi l’accusa secondo la quale gli agenti dell’FBI avrebbero minacciato di perseguire altri membri della famiglia Rucker.» «Non è quello che dicono sempre, Stan? Confessano, liberamente e di loro spontanea volontà, e poi non vedono l’ora di ritrattare tutto dicendo che sono stati minacciati. Devi averlo visto succedere parecchie volte.» Certo che Stan l’aveva visto succedere, anche se in realtà non gli era mai capitato. Westlake proseguì: «Anche se devo ammettere che non sarebbe una cattiva idea rastrellare tutti i Rucker e piantargli l’ago nel braccio». Gli uomini di Westlake risero. Gli uomini di Stanley risero. Un vero Teily. «E cosa mi dici dell’accusa secondo la quale gli agenti hanno oltrepassato il limite, spingendo Rucker addirittura allo sfinimento?» «Stan, la verità è questa» rispose Westlake. «Gli agenti hanno più volte chiesto a Rucker se voleva interrompere l’interrogatorio e riprenderlo in seguito. Lui ha sempre risposto di no perché non voleva passare la notte nel carcere di contea. Noi avevamo controllato e sapevamo che la prigione era sovraffollata, davvero stracolma. Gli agenti lo hanno comunicato a Rucker, e lui non ci è voluto andare.» La cosa aveva perfettamente senso per Stanley, che disse: «Okay, i tre punti seguenti devono essere presi in esame, ma non credo che ne parleremo molto nella nostra risposta. C’è l’accusa secondo la quale gli agenti dell’FBI hanno mentito riguardo all’esistenza di una perizia balistica che collegava gli omicidi alla Smith & Wesson sequestrata all’imputato. Sfortunatamente, come sappiamo, la perizia balistica ha invece escluso quell’arma». «Mentire è consentito, Stanley, specie in un interrogatorio di alto livello come questo.» Il tono di Westlake era molto simile a quello di un vecchio e saggio professore. «Lo so, ma giusto per curiosità: i tuoi agenti hanno davvero mentito a proposito della pistola?» «Naturalmente no. No, assolutamente no. Pagina dodici delle dichiarazioni giurate.» «Infatti non lo pensavo. E cosa mi dici dell’accusa successiva, e cioè che i tuoi agenti hanno mentito riguardo all’esistenza di un’impronta di scarpa sulla scena del delitto? Impronta che hanno detto corrispondere a certi stivali sequestrati all’indiziato?» «Non è vero, Stan. È solo la fantasia di un avvocato disperato e del suo cliente colpevole.» «Ce l’avete o no questa impronta di stivale?» Westlake lanciò un’occhiata a uno dei suoi uomini, come se fosse potuta esistere un’impronta di stivale di cui si era in qualche modo dimenticato. L’agente scosse la testa. «No» ammise Westlake. «Non c’è alcuna impronta.» «E poi abbiamo l’accusa secondo la quale i tuoi agenti hanno mentito a proposito di testimoni oculari. Il primo avrebbe visto l’imputato nella cittadina di Ripplemead più o meno all’epoca dei delitti. C’è qualcosa di vero?» Westlake spostò il proprio peso da una natica all’altra e fece un sorriso condiscendente. «Ascoltami bene, Stan, io non so se ti rendi conto di cosa occorra per far crollare un colpevole. Esistono dei trucchi, okay, e...» «Capisco.» «E bisogna instillare la paura, bisogna far credere all’indiziato che si è in possesso di molte più prove di quante se ne abbiano in realtà.» «Non ho visto alcun rapporto su quel testimone.» «E non lo vedrai. Non esiste.» «Vic, qui siamo tutti dalla stessa Teile. È solo che io ho bisogno di sapere la verità per poter rispondere all’istanza di nullità, capisci?» «Certo.» «E il secondo testimone, quello dell’emporio di campagna vicino al cottage? Non esiste neppure lui, giusto?» «Giusto.» «I tuoi agenti si sono serviti di qualche altro trucco di cui io non sono a conoscenza?» «No» rispose Westlake, ma nessuno nella stanza gli credette. «Allora, tanto per riassumere il nostro caso contro Quinn Rucker: nessun testimone, nessuna perizia balistica, nessuna impronta di stivale, nessuna impronta digitale, nessuna prova materiale di alcun tipo. Corretto?» Westlake annuì lentamente, ma non disse nulla. «Abbiamo un indiziato che si trovava nell’area di Roanoke dopo gli omicidi, ma nessuna prova che si trovasse lì anche prima, giusto?» Un altro cenno di assenso. «E il nostro indiziato è stato preso con più contanti di quanti una persona normale di solito porta con sé. Molti, molti di più, direi.» Westlake confermò. «Ma è anche vero che Mr Rucker è un corriere della droga reo confesso e apTeiliene a una famiglia di noti trafficanti, per cui i contanti non sarebbero difficili da spiegare.» Stanley allontanò il blocco legale e si massaggiò le tempie. «Signori, abbiamo una confessione e nient’altro. Se questa salta, Mr Rucker se ne va e non c’è alcun processo.» «Non puoi perdere la confessione, Stan» disse Westlake. «È impensabile.» «Non ho alcuna intenzione di perderla, ma vedo già il giudice che guarda storto all’interrogatorio. È la durata che mi preoccupa: dieci ore, tutta la notte. Un indiziato palesemente esausto, che però come criminale di lungo corso molto probabilmente avrebbe chiesto un avvocato. Due agenti veterani degli interrogatori che conoscono tutti i trucchi... Potremmo essere al limite.» Westlake aveva ascoltato con un sorriso e, dopo una lunga pausa, disse: «Non dimentichiamo il nostro testimone superstar. Malcolm Bannister dichiarerà che Quinn Rucker aveva parlato più volte di uccidere il giudice Fawcett. Rucker voleva vendetta, e voleva indietro i suoi soldi». «È vero, e quella testimonianza, più la confessione, porteranno a una condanna. Ma, da sola, la testimonianza non è sufficiente.» «Non mi sembri molto fiducioso, Stan.» «Al contrario. Si tratta dell’omicidio di un giudice federale. Non riesco a immaginare un altro giudice federale che dimostri comprensione nei confronti di Quinn Rucker. Avremo la confessione, e abbiamo Malcolm Bannister. Otterremo una condanna.» «Adesso sì che mi piaci.» «A proposito, come va con il nostro giovane Bannister?» «Sano e salvo, sepolto in profondità dall’US Marshals Service.» «Dov’è?» «Spiacente, Stan. Ci sono cose di cui non possiamo parlare. Ma non preoccuTeili. Quando avremo bisogno di lui, ci sarà.» 23 Chi sostituirà Pat Surhoff è Diana Tyler. Incontro entrambi i marshal a pranzo dopo una lunga mattinata in ospedale, dove sono stato visitato e invitato a ripresentarmi fra un mese. Ms Tyler è una signora alta e carina sui cinquant’anni, con i capelli corti, poco trucco, un blazer blu e niente fede al dito. È abbastanza simpatica e, mentre mangiamo le nostre insalate, mi fa il suo discorsetto. Vive “in zona” e segue qualche altro soggetto nella mia stessa situazione. È disponibile ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette, e vorrebbe sentirmi al telefono almeno una volta alla settimana. Comprende quello che sto passando e mi rassicura sulla mia istintiva tendenza a guardarmi sempre le spalle. Con il tempo queste paure svaniranno e la mia vita diventerà assolutamente normale. Nel caso dovessi andare fuori città – ed entrambi i marshal sottolineano che posso farlo quando voglio – le piacerebbe conoscere in anticipo i dettagli dei miei spostamenti. I marshal intendono tenermi d’occhio anche dopo che avrò testimoniato contro Quinn Rucker, e Pat e Diana insistono nel dipingere il quadro del futuro sicuro e piacevole che avrò un giorno, quando tutti gli ostacoli attuali saranno superati. Accennano ai due colloqui di lavoro e io li prendo in contropiede, spiegando che non mi sento ancora pronto per un impiego. Con un po’ di soldi in banca e libertà illimitata, proprio non me la sento di iniziare una nuova carriera. Voglio viaggiare, fare lunghe gite in macchina, magari andare in Europa. Viaggiare va benissimo, concordano i due, ma la copertura funzionerà meglio se avrò un vero lavoro. Decidiamo di tornarci sopra più avanti. Questo porta la conversazione sul passaporto e sulla patente di guida. Ancora una settimana e la mia faccia sarà pronta per essere fotografata. Diana mi promette di preparare la documentazione necessaria. Mentre beviamo il caffè, consegno a Pat una lettera per mio padre. L’indirizzo del mittente è l’istituto circondariale federale di Fort Wayne, Indiana. Pat la spedirà al carcere, dove qualcuno provvederà a inoltrarla a Henry Bannister a Winchester, Virginia. Nella lettera spiego al vecchio Henry che a Frostburg ho combinato un casino e che di conseguenza mi hanno rimandato a calci in un carcere normale. Sono in isolamento e non posso ricevere visite per almeno tre mesi. Gli chiedo di informare mia sorella Ruby in California e mio fratello Marcus a Washington. Gli dico anche di non preoccuparsi: io sto bene e ho un piano per riuscire a tornare a Frostburg. Pat e io ci salutiamo. Lo ringrazio per la sua cortesia e professionalità e lui mi augura ogni bene. Mi garantisce che la mia nuova vita sarà sicura e gratificante. Non sono certo di credergli, dato che continuo sempre a guardarmi intorno. Ho il forte sospetto che l’FBI continuerà a monitorarmi per un po’ di tempo, almeno fino al giorno in cui Quinn Rucker verrà condannato e rinchiuso in carcere. La verità è che non posso fidarmi di nessuno, compresi Pat Surhoff, Diana Tyler, l’ US Marshals Service e l’FBI. Non me lo posso permettere. Ci sono molte ombre là in mezzo, per non parlare dei cattivi. Se il governo vuole tenermi d’occhio, non c’è molto che io possa fare. Possono ottenere ordinanze della corte per mettere il naso nel mio conto corrente, per ascoltare le mie telefonate, per controllare la mia carta di credito e per seguire i miei movimenti online. So che lo faranno e la sfida che dovrò affrontare nel prossimo futuro consisterà nel riuscire a ingannarli senza che si accorgano di essere ingannati. Accettare uno dei lavori servirebbe solo a dare a quella gente un’ulteriore opportunità di spiarmi. Nel pomeriggio apro un altro conto corrente presso l’Atlantic Trust, sul quale trasferisco cinquantamila dei dollari depositati alla SunCoast. Poi ripeto la stessa operazione con una terza banca, la Jacksonville Savings. Tra un paio di giorni, una volta avuto l’okay per gli assegni, comincerò a prelevare contanti. Mentre vago per il quartiere a bordo della mia Audi, riservo allo specchietto retrovisore lo stesso tempo che dedico alla strada davanti a me. È già un’abitudine. Quando passeggio in spiaggia, studio ogni viso che incontro. Quando entro in un negozio, cerco immediatamente una posizione protetta e tengo d’occhio l’ingresso dal quale sono appena entrato. Non mangio mai due volte nello stesso ristorante e cerco sempre un tavolo con vista sul parcheggio. Uso il cellulare solo per conversazioni di routine, presumendo che ci sia qualcuno in ascolto. Acquisto un laptop pagandolo in contanti, apro tre account Gmail e navigo in rete solo in Internet café, utilizzando i loro server. Comincio a sperimentare l’uso delle carte di credito prepagate che ho acquistato da Walgreens. Installo due telecamere nascoste nel mio apTeilamento, nel caso qualcuno entri mentre io sono fuori. La parola chiave è paranoia. Mi convinco che ci sia sempre qualcuno che guarda e ascolta, e con il passare dei giorni sprofondo sempre più nel mio piccolo, personale mondo dell’inganno. Telefono a Diana a giorni alterni per comunicarle le ultime notizie sulla mia vita sempre più mondana e lei non dà alcun segno di essere sospettosa. È anche vero che non lo darebbe in ogni caso. L’avvocato si chiama Murray Huggins e il suo annuncio sulle pagine gialle lo pubblicizza come specialista praticamente in tutto. Divorzi, compravendite immobiliari, fallimenti, questioni penali e così via; in sostanza la stessa modesta routine del vecchio, caro studio legale Copeland, Reed & Bannister. L’ufficio di Huggins non è lontano da casa mia e basta una sola occhiata a suggerire l’immagine della rilassata professione di uno che va a lavorare alle nove e alle tre di pomeriggio è già sul campo da golf. In occasione del nostro primo colloquio, Murray mi racconta la storia della sua vita. È stato un avvocato di successo in un importante studio legale di Tampa, ma a cinquant’anni è crollato e ha provato ad andare in pensione. Si è trasferito ad Atlantic Beach, ha divorziato, poi ha cominciato ad annoiarsi e ha deciso di aprire bottega da solo. Ora ha superato i sessant’anni ed è felice del suo piccolo studio, dove ogni tanto va a lavorare per qualche ora e seleziona con cura i suoi clienti. Passiamo alla mia biografia e perlopiù mi attengo al copione: un paio di ex mogli a Seattle eccetera. Aggiungo il mio nuovo dettaglio e racconto di essere uno sceneggiatore alle prime armi, al momento impegnato nella rifinitura del suo primo lavoro. Grazie a qualche colpo di fortuna, la sceneggiatura è stata opzionata da una piccola casa di produzione che si occupa di documentari. Per varie ragioni, ho bisogno di crearmi una facciata in Florida. In cambio di duemilacinquecento dollari, Murray può innalzare qualche barriera protettiva. Creerà una SRL – società a responsabilità limitata – in Florida e l’unico proprietario sarà M. R. Baldwin. La SRL in seguito costituirà una società in Delaware della quale Murray sarà il solo socio fondatore e io l’unico proprietario. L’indirizzo registrato sarà quello dello studio legale e il mio nome non comparirà in nessuno dei documenti societari. «Lo faccio di continuo» mi assicura Huggins. «La Florida attrae un mucchio di gente che vuole iniziare un’attività.» Se lo dici tu, Murray... Potrei fare tutto questo via computer, ma è più sicuro procedere tramite un avvocato. La riservatezza è importante. Posso pagare Huggins perché faccia cose che le ombre non sospetteranno mai e che non riusciranno mai a tracciare. Sotto la guida esperta di Murray, la Skelter Films prende vita. Due mesi e mezzo dopo l’arresto di Quinn Rucker, e due settimane dopo il mio arrivo nel condominio sulla spiaggia, sto bevendo il caffè del mattino quando vengo informato da Diana che i federali gradirebbero incontrarmi. Ci sono molte ragioni per questo, la più importante è il loro desiderio di aggiornarmi sul caso e parlare del processo. Vogliono pianificare la mia deposizione. Sono certo che vogliono anche dare una bella occhiata a Max Baldwin, il quale, per inciso, rappresenta un netto miglioramento rispetto a Malcolm Bannister. Il gonfiore è sparito. Il naso e il mento sono un po’ più netti e definiti. Lo sguardo sembra molto più giovane e gli occhiali di tartaruga, rossi e rotondi, mi danno un’aria da cineasta cerebrale e parecchio fico. Mi rado solo una volta alla settimana e di conseguenza ho sempre un po’ di barba, con appena un tocco di grigio. Lo scalpo perfettamente liscio richiede una passata di rasoio un giorno sì e uno no. Le guance sono più scavate, soprattutto perché ho mangiato molto poco durante la convalescenza e ho perso nove chili, che non ho intenzione di riprendere. Tutto sommato non assomiglio per niente al precedente me stesso, e sebbene questo sia spesso fonte di inquietudine, è anche rassicurante. Mi suggeriscono di tornare a Roanoke per incontrare Stanley Mumphrey e la sua gang, ma oppongo un netto rifiuto. Diana mi assicura che l’FBI e l’ufficio del procuratore federale non sanno dove mi nascondo e io fingo di crederle. Non voglio incontrarli in Florida. Dopo un po’ di tira e molla, ci accordiamo su un hotel a Charleston, South Carolina. Diana prenota i biglietti aerei per entrambi e decolliamo da Jacksonville, sullo stesso volo ma lontani l’uno dall’altra. Nel momento stesso in cui entriamo nell’atrio dell’hotel, so di essere osservato e probabilmente anche fotografato. L’FBI non vedeva l’ora di verificare il mio nuovo aspetto. Colgo un paio di rapide occhiate, ma faccio finta di niente. Dopo un sandwich in camera, incontro Diana nel corridoio e insieme saliamo le scale per raggiungere una suite due piani sopra di noi. La porta è sorvegliata da due robusti ragazzoni vestiti di nero che sembrano pronti ad aprire il fuoco alla minima provocazione. In quanto marshal, Diana non ha alcun ruolo nella squadra dell’accusa, perciò rimane fuori con i due doberman, mentre io entro e saluto la banda. Stanley Mumphrey ha portato con sé tre suoi assistenti, i cui nomi si perdono nel diluvio delle presentazioni. Il mio amico agente Chris Hanski è tornato, senza dubbio per studiarmi ai fini di un rapporto “prima e dopo la cura”. Ha un tirapiedi anche lui, nome dimenticato all’istante. Mentre ci sediamo imbarazzati intorno a un piccolo tavolo da riunioni, non posso fare a meno di notare tra i vari documenti sul ripiano un paio di foto identiche. Sono di Malcolm Bannister, ed è lui che questi signori stavano esaminando. Adesso guardano a bocca aperta Max. Sono impressionati dalla trasformazione. Dato che Hanski è l’unico che mi ha conosciuto prima del cambiamento, è lui a parlare per primo. «Max, devo ammettere che sembri più giovane e più in forma. Non sono sicuro che tu sia anche più carino, ma nel complesso non è male come trasformazione.» Il tono è gioviale e il commento dovrebbe servire a rompere il ghiaccio. «La tua approvazione significa molto per me» replico, con un sorriso fasullo. Stanley afferra la foto e dice: «Nessuna somiglianza, Max. Nessuno sospetterebbe mai che tu e Malcolm siete la stessa persona. Davvero notevole». Facciamo tutti Teile della stessa squadra, adesso, e per un po’ chiacchieriamo come vecchi amici. Ma non esistono basi solide, per cui la conversazione comincia a languire. «Si conosce già la data del processo?» chiedo, e la domanda cambia subito l’atmosfera. «Sì» risponde Stanley. «Dieci ottobre, a Roanoke.» «Sono solo quattro mesi» osservo. «Mi sembra molto veloce.» «Siamo parecchio efficienti nel Distretto Sud» dichiara compiaciuto Stanley. «In media dal rinvio a giudizio al processo passano otto mesi. Questo caso ha avuto qualche pressione in più.» «Chi è il giudice?» «Sam Stillwater, in prestito dal Distretto Nord. Tutti i colleghi di Fawcett del Distretto Sud si sono avvalsi dell’astensione spontanea.» «Parlami del processo.» Stanley aggrotta la fronte, e lo stesso fa il resto della sua banda. «Potrebbe essere piuttosto breve, Max. Non ci sono molti testimoni, né molte prove. Dimostreremo che Rucker era in zona al momento dei delitti, e che al momento dell’arresto aveva un mucchio di contanti. Esporremo in dettaglio il caso di suo nipote e la sentenza del giudice Fawcett, forse è entrato in gioco anche un elemento di vendetta.» Stanley fa una pausa e io non riesco a resistere alla tentazione. «Roba forte» commento, da stronzo. «Senza dubbio. E poi abbiamo la confessione, che la difesa ha già preso di mira. La settimana prossima avremo un’udienza davanti al giudice Stillwater: ci aspettiamo di vincere e di tenerci buona la confessione. Ma a Teile questo, Max, il nostro teste superstar potresti essere tu.» «Vi ho già detto tutto. Conoscete il contenuto della mia testimonianza.» «Giusto, giusto, ma vogliamo riesaminarla con te. Adesso che abbiamo riempito alcuni buchi, vogliamo limarla alla perfezione.» «Certo. Come se la passa il mio vecchio amico Quinn?» «Non molto bene in questi giorni. Non gli piace l’isolamento, non gli piace il cibo, non gli piacciono le guardie e nemmeno le regole. Dice di essere innocente... sai che sorpresa. Credo che senta la mancanza della bella vita del country club federale.» «La sento anch’io.» Suscito un paio di risatine. «L’avvocato di Quinn ha convinto il giudice che era necessaria una valutazione psichiatrica del suo cliente. Il medico ha detto che Rucker può essere processato, ma che deve assumere antidepressivi. Quinn è molto umorale e spesso non rivolge la parola a nessuno per giorni.» «Sembra il Quinn che conoscevo io. Parla di me?» «Oh, sì. Non gli piaci neppure tu. Sospetta che sia tu il nostro informatore e crede che testimonierai contro di lui al processo.» «Quando dovete presentare il vostro elenco dei testimoni?» «Sessanta giorni prima del processo.» «Hai detto all’avvocato di Quinn che testimonierò?» «No. Noi non divulghiamo mai informazioni finché non ci siamo costretti.» «Sì, me lo ricordo» commento. Questi tizi dimenticano che anch’io a suo tempo sono stato oggetto di un’accusa federale, con agenti dell’FBI che setacciavano ogni aspetto della mia vita e un ufficio del procuratore che minacciava di arrestare non solo me, ma anche i miei due soci innocenti. Pensano che adesso siamo grandi amici, un’unica squadra che marcia felice e compatta verso un altro giusto verdetto. Se potessi, li pugnalerei tutti alla schiena e manderei a monte il loro caso. Loro, il governo federale, si sono presi cinque anni della mia vita, oltre a mio figlio, mia moglie e la mia carriera. Come osano starsene qui a sedere come se fossimo colleghi fidati? Finalmente arriviamo alla mia testimonianza e la rivediamo insieme per un paio d’ore. Ce ne siamo già occupati in precedenza e trovo la faccenda tediosa. L’assistente capo di Mumphrey mi consegna un copione – domande e risposte – che dovrò studiare. Devo ammettere che è un ottimo lavoro, niente è stato tralasciato. Tento di visualizzare la scena surreale della mia deposizione. Quando mi scorteranno in aula indosserò una maschera. Mi siederò dietro un pannello o qualche tipo di divisorio che impedirà agli avvocati, all’imputato e agli spettatori di vedere la mia faccia quando mi toglierò la maschera. Io guarderò i giurati. Gli avvocati formuleranno le loro domande al di là del divisorio e io risponderò, ma la mia voce sarà distorta. In aula ci saranno anche Quinn, i suoi familiari e i loro gorilla, e tutti loro si sforzeranno di cogliere il minimo segno utile al riconoscimento. Sapranno che sono io, naturalmente, ma non vedranno mai il mio viso. Per quanto tutto questo possa sembrare sicuro, dubito seriamente che succederà mai. 24 Diana mi telefona per dirmi di avere disponibili la mia nuova patente della Florida e il mio nuovo passaporto. Ci incontriamo per un caffè e lei mi consegna i documenti. Da Teile mia, le fornisco un itinerario con un mucchio di buchi. «Ti fai un bel viaggetto, eh?» mi chiede, studiando il foglio. «Già. Non vedo l’ora di provare il mio passaporto nuovo. Le prime tre notti le passo a Miami, South Beach, a cominciare da stasera. Teilo in auto appena finisco questa tazza di caffè. Da Miami volerò in Giamaica, dove mi tratterrò per una settimana circa, poi andrò ad Antigua e forse anche a Trinidad. Ti telefonerò a ogni tappa. Lascerò l’auto all’aeroporto di Miami, così potrai dire all’FBI dov’è esattamente. E già che ci sei, chiedigli per favore di lasciarmi in pace mentre me ne vado in giro per i Caraibi.» «Lasciarti in pace?» dice Diana, fingendo di non capire. «Mi hai sentito. Non prendiamoci in giro, Diana. Forse non sarò il testimone più protetto del paese, ma probabilmente rientro fra i primi tre. C’è sempre qualcuno che mi tiene d’occhio. C’è un tizio, io lo chiamo Taglio a Spazzola, che ho visto almeno cinque volte nelle ultime due settimane. Non è molto in gamba, perciò comunicalo ai federali quando farai rapporto. Un metro e ottanta, ottanta chili, Ray-Ban, pizzetto biondo, guida una Cooper ed esibisce un’acconciatura da marine. Molto, molto goffo. Sono sorpreso.» È sorpresa anche Diana. Tiene gli occhi fissi sul mio itinerario e non riesce a pensare a niente da dire. Fregata. Pago il caffè e mi metto in viaggio sull’Interstatale 95, dritto verso sud per cinquecentosessanta chilometri. Il clima è caldissimo e afoso, il traffico intenso e lento, e io adoro ogni chilometro del mio viaggio. Mi fermo spesso per fare benzina, sgranchirmi le gambe e controllare eventuali movimenti dietro di me. Non me ne aspetto. Dato che l’FBI sa dove sto andando, non si prenderà certo il disturbo di seguirmi. D’altra Teile presumo che ci sia un localizzatore satellitare GPS astutamente nascosto da qualche Teile sulla mia auto. Sette ore più tardi, mi fermo davanti all’ingresso del Blue Moon Hotel, uno dei numerosi piccoli alberghiboutique appena ristrutturati nel cuore dell’area art déco a South Beach. Estraggo la mia valigetta e una piccola borsa dal bagagliaio, passo le chiavi della macchina all’addetto ed entro in una scena tipo “Miami Vice”. Le pale dei ventilatori appesi al soffitto ruotano lentamente sopra gli ospiti che, seduti sulle poltrone bianche di vimini, spettegolano e bevono. «Desidera registrarsi, signore?» mi chiede la graziosa impiegata. «Sì. Max Baldwin» rispondo, e per qualche motivo questo è un momento di orgoglio. Io, il potente Max, sto annegando in più libertà di quanta ne possa assimilare al momento. Un mucchio di contanti, documenti nuovi perfettamente legali, una decappottabile che mi porterà ovunque... è quasi troppo. Ma vengo riportato di colpo alla realtà quando una bruna alta e abbronzata attraversa lenta l’atrio. Il top è ciò che resta di un bikini e non copre quasi niente. Il pezzo sotto è una gonna trasparente che copre ancora meno. Consegno all’impiegata la mia VISA per i vari addebiti. Potrei usare i contanti o una carta di credito prepagata, ma dato che i federali sanno dove mi trovo non ho motivo di ricorrere a sotterfugi. Sono sicuro che l’ufficio di Miami è già stato avvertito e probabilmente ci sono occhi che mi osservano da non molto lontano. Se fossi davvero paranoico, potrei pensare che l’FBI sia già passato nella mia stanza e che magari ci abbia lasciato due o tre cimici. Salgo in camera, non vedo microspie o ficcanaso, faccio una doccia veloce e indosso shorts e sandali. Scendo al bar per saggiare il panorama femminile. Mangio da solo nella caffetteria dell’hotel e incontro lo sguardo di una donna sulla quarantina che sta cenando con quella che sembra essere un’amica. Più tardi, di nuovo al bar, la rivedo e ci presentiamo. Eva, da Porto Rico. Stiamo bevendo qualcosa insieme quando la band comincia a suonare. Eva vuole ballare e, anche se per me sono passati anni dall’ultima volta, mi butto in pista con tutta l’energia che ho. Verso mezzanotte saliamo in camera mia, dove ci spogliamo immediatamente e saltiamo sul letto. Quasi prego che l’FBI abbia attrezzato la camera in modo da cogliere anche il più debole dei suoni. Se è così, Eva e io forniamo parecchio materiale da ascoltare. Scendo dal taxi sul marciapiede dell’Ottava Avenue, nel centro di Miami. Sono le nove e mezzo di mattina e fa già caldissimo; dopo pochi minuti che cammino di buon passo ho la camicia appiccicata alla schiena. Non credo di essere seguito, ma procedo circospetto e cambio spesso direzione come se lo fossi. L’edificio è una scatola tozza di cinque piani, così brutto da rendere difficile credere che qualcuno abbia pagato un architetto per progettarlo. D’altra Teile, dubito che la maggior Teile degli occupanti sia costituita da società di altissimo livello. Uno di loro è la Corporate Registry Service, o CRS, un nome così blando e innocuo che nessuno sarà mai in grado di capire cosa faccia in realtà. E quasi nessuno vorrebbe saperlo. L a CRS può anche essere perfettamente legale, tuttavia richiama un mucchio di clienti che non lo sono. La CRS è un indirizzo, una buca per le lettere, una facciata, un servizio di segreteria telefonica che il cliente può affittare per assicurarsi una certa autenticità. Dato che non ho fissato un appuntamento, aspetto per un’ora che si liberi un funzionario commerciale. Si chiama Loyd ed è lui che mi guida in un piccolo, soffocante ufficio e mi fa accomodare davanti alla sua discarica di scrivania. Chiacchieriamo per qualche minuto mentre Loyd scorre velocemente il questionario che ho compilato nell’attesa. «Che cos’è la Skelter Films?» domanda. «Una società che produce docu-film.» «Chi è il proprietario?» «Io. La società è registrata in Delaware.» «Quanti lavori ha già prodotto?» «Nessuno. Siamo agli inizi.» «Quante sono le probabilità che la Skelter Films sia ancora in attività fra due anni da oggi?» «Poche.» Loyd ascolta ambiguità del genere tutti i giorni e non è turbato. «Sembrerebbe un’operazione di facciata.» «Abbastanza esatto.» «Noi richiediamo una dichiarazione ufficiale in cui lei giura che la sua società non svolge e non svolgerà mai attività criminali.» «Lo giuro.» Loyd ha già sentito anche questo. «Okay, ecco come operiamo. Noi forniamo alla Skelter un indirizzo fisico, qui in questo edificio. Quando riceviamo della posta, la inoltriamo dove ci dirà lei. Diamo un numero telefonico e tutte le chiamate in arrivo verranno gestite da una persona che cinguetterà qualsiasi cosa lei desideri. “Buongiorno, Skelter Films, con chi desidera parlare?” O qualcos’altro. Lei ha dei soci?» «No.» «Dipendenti, fittizi o meno?» «Avrò alcuni nomi, tutti fittizi.» «Nessun problema. Se chi telefona chiede di uno dei suoi fantasmi, la nostra ragazza dirà quello che lei preferisce, tipo: “Spiacente, sta girando in esterni”. Lei ci scrive il copione e noi lo recitiamo. Appena riceveremo una telefonata, la informeremo. Cosa ne dice di un sito Web?» Di questo non sono sicuro, così rispondo: «Non ancora. Quali sono i vantaggi?». Loyd sposta il proprio peso sulla poltroncina e si china in avanti, sui gomiti. «Okay, diciamo che la Skelter è una società che girerà tantissimi documentari. In questo caso avrà bisogno di un sito Web per le solite ragioni: marketing, informazioni, narcisismo. Supponiamo al contrario che la Skelter sia una vera società, ma non una società di produzioni audiovisive. E che, per qualche ragione, stia cercando di dare quell’impressione. Un sito Web è un eccellente sistema per rafforzare questa immagine, per... manipolare la realtà. Niente di illegale, badi bene. E noi possiamo creare un sito Web con immagini di repertorio, biografie dei componenti il suo staff, i prodotti, i premi, i progetti in corso, quello che vuole.» «Quanto?» «Diecimila.» Non sono certo di volere, o di dovere, spendere tutti quei soldi. Non a questo punto, almeno. «Mi ci faccia pensare» dico, e Loyd si stringe nelle spalle. «Quanto per i vostri servizi standard di base?» «Indirizzo, telefono, fax e via discorrendo fanno cinquecento dollari al mese, con pagamento anticipato di sei mesi.» «Accettate contanti?» Loyd sorride e risponde: «Oh, sì. Noi preferiamo i contanti». Non mi sorprende. Pago, firmo il contratto, firmo la dichiarazione in cui prometto di dedicarmi ad attività lecite ed esco dall’ufficio. La CRS vanta cinquecento clienti soddisfatti, e mentre attraverso l’atrio del palazzo non posso fare a meno di sentirmi come se fossi entrato in una sorta di sottobosco popolato da società fantasma, malfattori anonimi ed evasori fiscali. Al diavolo. Dopo altre due notti insieme, Eva vuole che vada con lei a Porto Rico. Le prometto di pensarci su, poi me la squaglio dal Blue Moon e vado al Miami International Airport, dove lascio l’auto nel parcheggio a lungo termine e raggiungo i terminal con la navetta. Armato di carta di credito e del mio nuovo passaporto, acquisto un biglietto dell’Air Jamaica per Montego Bay, solo andata. L’aereo è stracolmo: metà giamaicani dalla carnagione scura e metà pallidi turisti in cerca di sole. Prima del decollo le adorabili hostess ci servono rum punch. Il volo dura quarantacinque minuti. Una volta a terra, il funzionario del controllo passaporti studia il mio fin troppo a lungo e sto già per andare nel panico quando finalmente agita la mano, facendomi segno di passare. Trovo l’autobus del Rum Bay Resort, complesso turistico con una serie di spiagge topless, notoriamente solo per single e prezzo tutto compreso. Per tre giorni me ne sto seduto all’ombra a bordo piscina a riflettere sul significato della vita. Dalla Giamaica volo ad Antigua, nei Caraibi orientali. È un’isola bellissima di duecentottanta chilometri quadrati, con montagne, spiagge bianche e decine di resort. È nota anche come uno dei più accoglienti paradisi fiscali del mondo, ed è questa l’unica ragione della mia visita. Se non avessi voluto qualcosa in più del divertimento, sarei rimasto in Giamaica. La capitale è St John’s, una vivace cittadina affacciata su un porto dai fondali profondi che attrae le navi da crociera. Mi trovo una stanza in un piccolo albergo quasi alla periferia di St John’s, con una bella vista sull’oceano, le barche e gli yacht. È giugno, bassa stagione, e per trecento dollari a notte mangerò come un re, dormirò fino a mezzogiorno e mi godrò la consapevolezza che nessuno sa chi sono, da dove vengo o qualcosa del mio passato. 25 Il Freezer era stato smantellato un mese prima e Victor Westlake era tornato alla solita routine nel suo ufficio al quarto piano dell’Hoover Building a Washington. Anche se il duplice omicidio del giudice Fawcett e di Naomi Clary era tecnicamente risolto, restavano ancora molti dubbi e molte domande. Il punto più pressante, naturalmente, era la validità della confessione di Quinn Rucker. Se il giudice l’avesse ritenuta inammissibile, al governo sarebbero rimaste ben poche prove con cui procedere. Gli omicidi erano risolti, ma il caso non era chiuso, almeno a parere di Westlake. Continuava a dedicarci due ore al giorno. C’era il rapporto quotidiano sulle attività di Max Baldwin: movimenti, incontri, telefonate, Internet eccetera. Fino a quel momento Max non aveva fatto mosse a sorpresa. A Westlake non piaceva molto la gita in Giamaica e dintorni, ma non poteva farci niente, se non prestare la massima attenzione possibile. E poi c’era il rapporto quotidiano sulla famiglia Rucker. L’ FBI aveva ottenuto l’autorizzazione del tribunale a monitorare le conversazioni telefoniche di Dee Ray Rucker, Sammy (Tall Man) Rucker, la sorella Lucinda e altri quattro parenti che operavano nella filiale di Washington del traffico di droga. Mercoledì 15 giugno, Westlake era in riunione con il suo staff quando venne chiamato al telefono. Era una questione urgente e dopo pochi minuti era già in una sala dove alcuni tecnici stavano lavorando per mettere a punto l’audio. Uno di loro disse: «La telefonata è arrivata al cellulare di Dee Ray ieri sera, alle ventitré e diciannove. Non sappiamo da dove provenisse, comunque l’abbiamo registrata. La prima voce è quella di Dee Ray, la seconda è di un certo Sully, che non abbiamo ancora identificato». Un altro tecnico annunciò: «Ci siamo». DEE RAY: Pronto? SULLY: Dee Ray, sono Sully. DEE RAY: Cos’hai per me? SULLY: Ho il tuo spione, amico. Bannister. DEE RAY: Cazzo, amico. SULLY: Ci puoi giurare, Dee Ray. DEE RAY: Okay, lascia perdere il resto. Dimmi solo dov’è. SULLY: Be’, adesso fa il tipo da spiaggia in Florida. Si chiama Max Baldwin e abita in un piccolo apTeilamento a Neptune Beach, a est di Jacksonville. Sembra che abbia un bel po’ di grana, se la prende comoda, capisci. Fa la bella vita. DEE RAY: Che aspetto ha? SULLY: È un altro uomo. Ci hanno dato dentro con la chirurgia plastica. Stessa altezza, però ha perso qualche chilo. Stessa camminata. Abbiamo un’impronta digitale e un riscontro positivo. DEE RAY: Un’impronta digitale? SULLY: La nostra è una ditta seria. I miei l’hanno seguito in spiaggia e l’hanno visto buttare una bottiglietta d’acqua nel cestino dei rifiuti. L’hanno recuperata e hanno rilevato l’impronta. DEE RAY: Ottimo. SULLY: Come ti dicevo. E adesso? DEE RAY: Non fare niente. Lascia che ci dorma su. Tanto l’amico non va da nessuna Teile, giusto? SULLY: No, è un ragazzo felice. DEE RAY: Perfetto. Westlake si lasciò cadere lentamente a sedere. Pallido e con la bocca socchiusa, era troppo scosso per riuscire a parlare. Poi ordinò: «Trovatemi Twill». Un agente scomparve di corsa e nell’attesa Westlake si sfregò gli occhi, riflettendo sulla mossa successiva. Twill, il suo primo assistente, irruppe nella sala. Ascoltarono di nuovo la registrazione. Per Westlake, la seconda esperienza fu addirittura più agghiacciante. «Come diavolo...» mormorò Twill. Westlake si stava riprendendo. «Chiamami Bratten del Marshals Service.» «Bratten ieri ha subito un intervento chirurgico» disse Twill. «Lo sostituisce Newcombe.» «Allora chiamami Newcombe. Non abbiamo tempo da perdere.» Mi sono iscritto a una palestra, dove vado tutti i giorni verso mezzogiorno e passo un’ora a camminare in salita su un tapis roulant e a sollevare pesi leggeri. Se devo trascorrere così tanto tempo in spiaggia, sarà meglio che abbia un fisico adatto alla Teile. Dopo un breve passaggio nella sauna e una lunga doccia, mi sto vestendo quando il cellulare inizia a ronzare sul ripiano più alto del mio armadietto. È la cara Diana, e questo è un orario insolito per una sua telefonata. «Pronto?» rispondo sottovoce, anche se lo spogliatoio non è per niente affollato. «Dobbiamo parlare» dice brusca Diana, il primo indizio che forse c’è qualcosa che non va. «Di cosa?» «Non adesso. Ci sono due agenti dell’FBI nel parcheggio, a bordo di una Jeep Cherokee rosso scuro di fianco alla tua auto. Ti daranno un passaggio.» «Solo per curiosità, Diana, tu come fai a sapere dove mi trovo in questo momento?» «Ne parliamo dopo.» Mi siedo su una sedia pieghevole. «No, spiegami cosa sta succedendo.» «Max, sono a dieci minuti da te. Esegui gli ordini, sali su quella Jeep e appena ti vedo ti dico tutto quello che so. Non parliamo al telefono.» «Okay.» Finisco di vestirmi e cerco di comportarmi con la calma di sempre. Attraverso la palestra e sorrido alla maestra di yoga alla quale sorrido ormai da una settimana. Arrivo alla porta d’ingresso, do un’occhiata all’esterno e vedo la Jeep parcheggiata di fianco alla mia auto. A questo punto è abbastanza evidente che è successo qualcosa di terribile. Deglutisco a fatica ed esco nel sole accecante del mezzogiorno. Il conducente della Jeep balza a terra e, senza dire una parola, apre la portiera posteriore. Viaggiamo per sette minuti in un silenzio totale finché parcheggiamo nel vialetto di un bizzarro cottage bifamiliare con il cartello AFFITTASI nel giardinetto sul davanti. Siamo a un isolato dall’oceano. Appena spento il motore, entrambi gli agenti saltano giù dall’auto ed esaminano la scena, come se ci potessero essere dei cecchini appostati. Il nodo che sento nello stomaco mi dà la sensazione di una palla da bowling. Entriamo senza che nessuno ci spari e troviamo Diana ad aspettarci. «Bel posticino» osservo. «È una casa sicura» risponde Diana. «Oh, okay. E come mai ci nascondiamo in una casa sicura nel bel mezzo di una giornata assolutamente perfetta?» Dalla cucina entra un uomo con i capelli grigi, che mi tende la mano. «Max, io sono Dan Raynor, US Marshal, supervisore di quest’area.» Ci stringiamo la mano come due vecchi amici e Raynor mi sorride come se stessimo per goderci un lungo pranzo. «È un vero piacere» dico. «Cosa sta succedendo?» Sono in quattro – Raynor, Diana e i due innominati agenti dell’FBI –, e per qualche secondo nessuno di loro sa bene quale sia il protocollo. Di chi è il territorio? Chi è compreso nel giro? Chi resta e chi se ne va? Come ho già imparato, queste lotte territoriali tra agenzie possono essere motivo di confusione. Alla fine è Raynor a parlare. «Max, temo che ci sia stata una fuga di notizie. Per dirla brutalmente, la tua copertura è saltata. Non abbiamo idea di come sia successo.» Mi siedo e mi passo una mano sulla fronte. «Chi è al corrente di che cosa?» domando. «Noi non ti sappiamo dire molto» risponde Raynor «ma qualcuno sta arrivando in volo da Washington. Dovrebbero essere qui tra un’ora circa. Evidentemente ieri sera l’FBI ha scoperto qualcosa da un’intercettazione. C’è stata una conversazione dei Rucker e l’FBI l’ha ascoltata.» «Sanno dove mi trovo?» «Sì. Sanno esattamente dove abiti.» «Ci dispiace moltissimo, Max» dice Diana. Guardo lei e tutta la sua stupidità come se potessi strangolarla. «Accidenti, sono davvero impressionato. Perché non tieni la bocca chiusa e basta?» «Mi dispiace.» «È la seconda volta che lo dici. Per favore, non ripeterlo più, okay? Non significa niente. È del tutto inutile.» Diana è ferita dalla mia durezza, ma francamente non me ne importa. In questo momento la mia unica preoccupazione è per la mia pelle. I quattro che mi fissano, unitamente ai loro superiori e al loro intero governo, sono tutti responsabili della “fuga di notizie”. «Ti andrebbe un caffè?» mi chiede timidamente Diana. «No, mi andrebbe un po’ di eroina» rispondo. I quattro trovano la battuta divertente, ma è anche vero che una risata fa bene a tutti. Viene versato il caffè e un vassoio di biscotti viene passato in giro. Cominciamo l’attesa. Per quanto surreale sia la situazione, comincio a pensare a dove andare adesso. Raynor dice che andranno a prendere la mia auto quando farà buio. Stanno aspettando un agente nero dell’ufficio di Orlando che sarà la mia controfigura per un paio di giorni. In nessun caso mi verrà consentito di tornare nel mio apTeilamento e per un po’ discutiamo su come recuperare i miei scarsi beni. Il Marshals Service si farà carico dell’affitto e provvederà a disdire i contratti delle utenze. Raynor pensa che avrò bisogno di una nuova auto, ma io all’inizio mi oppongo all’idea. Gli agenti dell’FBI escono e tornano con i sandwich. L’orologio sembra bloccarsi e le pareti restringersi intorno a noi. Finalmente, alle tre e mezzo, Mr Victor Westlake entra dalla porta d’ingresso e dice: «Max, mi dispiace». Io non mi alzo in piedi e neppure gli tendo la mano. Il divano è tutto mio. Westlake è accompagnato da tre “vestiti scuri”, i quali vanno a prendere sedie e sgabelli in cucina. Quando tutti sono stati presentati e si sono seduti, Westlake attacca: «Max, questa è una situazione estremamente insolita e io non so davvero cosa dire. In questo momento non sappiamo a che livello si sia verificata la fuga di notizie, e forse non lo sapremo mai». «Mi dica quello che sa.» Westlake apre un fascicolo ed estrae alcuni fogli. «Questa è la trascrizione della conversazione telefonica tra Dee Ray Rucker e un certo Sully che abbiamo intercettato ieri sera. Tutti e due parlavano da cellulari. Dee Ray era a Washington. Sully ha chiamato da qualche Teile qui nei dintorni.» Leggo la trascrizione mentre gli altri trattengono il fiato. Impiego pochi secondi, poi poso il foglio sul tavolino. «Come hanno fatto?» «Ci stiamo lavorando. Una teoria è che abbiano assunto una società privata per rintracciarti. Noi monitoriamo una manciata di ditte specializzate in spionaggio industriale, sorveglianza, persone scomparse, indagini private e roba del genere. Si tratta di ex militari, ex spie e, mi vergogno a dirlo, anche di qualche ex agente dell’FBI. Sono tipi in gamba e dispongono di alta tecnologia. Per la giusta parcella, sono in grado di raccogliere un bel po’ di informazioni.» «Da dove, dall’interno?» «Ancora non lo sappiamo, Max.» «E anche se lo sapesse, non me lo direbbe. Non lo ammetterebbe mai, se la fuga di notizie fosse dovuta a qualcuno all’interno del governo, FBI, Marshals Service, ufficio del procuratore federale, diTeilimento di Giustizia, amministrazione penitenziaria e Dio solo sa chi altri. Quante sono le persone al corrente del nostro piccolo segreto, Mr Westlake? Parecchie decine, forse di più. I Rucker mi hanno trovato perché hanno fiutato la mia pista, oppure hanno seguito l’FBI perché l’FBI stava seguendo me?» «Ti assicuro che non c’è stata alcuna falla interna.» «Ma se ha appena detto che non lo sa. Le sue assicurazioni non significano niente, a questo punto. L’unica certezza è che chiunque sia coinvolto nell’operazione si proteggerà il culo e darà la colpa a qualcun altro, a cominciare da adesso. Non credo a niente di quello che mi dice, Mr Westlake. Lei o chiunque altro.» «Devi fidarti di noi, Max. La situazione è grave, forse letale.» «Mi sono fidato di voi fino a questa mattina, e guardi come sono messo. Nessuna fiducia. Zero.» «Senti, dobbiamo proteggerti fino al processo. Questo lo capisci. Dopo il processo, non avremo più alcun interesse. Ma fino ad allora dobbiamo essere certi che tu sia al sicuro. È per questo che avevamo messo i telefoni sotto controllo: monitoravamo i Rucker e abbiamo avuto fortuna. Noi siamo dalla tua Teile, Max. Sì, da qualche Teile c’è stato un problema, e noi scopriremo cosa è successo. Però tu adesso te ne stai seduto qui tutto intero perché noi stiamo facendo il nostro lavoro.» «Congratulazioni» dico, e vado in bagno. Il vero casino scoppia quando li informo che intendo uscire dal programma protezione testimoni. Dan Raynor pontifica su quanto sarà pericolosa la mia vita se non consento al governo di imballarmi e scaricarmi a mille miglia da qui, sotto un altro nome nuovo. Peccato. Correrò i miei rischi nascondendomi per conto mio. Westlake mi implora di restare con loro. La mia testimonianza al processo è cruciale, e senza la mia deposizione è possibile che non ci sia alcuna condanna. Gli ricordo più volte che hanno già una confessione e che nessun giudice federale la giudicherà inammissibile. Prometto che mi presenterò al processo. Sostengo che la mia vita sarà più sicura nel momento in cui solo io saprò dove mi nascondo. Semplicemente, sono troppi gli agenti coinvolti nella mia protezione. Raynor mi ricorda più di una volta che il Marshals Service non ha mai perso un informatore sotto la sua protezione – più di ottomila e in continua crescita –, e io gli faccio presente più di una volta che qualcuno, presto o tardi, sarà la prima vittima. E quel qualcuno non sarò io. La discussione assume spesso toni accesi, ma non ho intenzione di cedere. Tutto quello che possono fare è parlare. Non hanno alcuna autorità su di me. La mia condanna è stata annullata e non sono in libertà vigilata. Ho accettato di deporre in aula e lo farò. Il mio accordo con il Marshals Service prevede che io possa lasciare il programma in qualsiasi momento lo voglia. «Me ne vado» dichiaro alzandomi in piedi. «Vorreste essere così gentili da riaccompagnarmi alla mia auto?» Nessuno si muove. Raynor mi domanda: «Quali sono i tuoi programmi?». «Perché dovrei condividerli con te?» «E l’apTeilamento?» «Me ne andrò tra un paio di giorni, poi sarà tutto vostro.» «Quindi lasci questa zona?» mi chiede Diana. «Non ho detto questo. Ho detto che me ne vado dall’apTeilamento.» Guardo Westlake e aggiungo: «E per favore piantatela di seguirmi. C’è la possibilità che qualcuno tenga d’occhio voi mentre tenete d’occhio me. Fatemi respirare, okay?». «Questo non è vero, Max.» «Lei non sa cosa è vero e cosa non lo è. Piantatela di seguirmi, va bene?» Naturalmente non mi dà conferma. Ha le guance arrossate ed è veramente incazzato, perché è un uomo abituato a far andare le cose come vuole lui. Vado alla porta e la spalanco. «Se non mi date un passaggio, andrò a piedi.» «Riportatelo indietro» ordina Westlake. «Grazie» dico da sopra la spalla mentre esco dal cottage. L’ultima cosa che sento è Raynor che mi ammonisce a voce alta: «Stai commettendo un grosso errore, Max». Mi accomodo sul sedile posteriore della Jeep mentre gli stessi agenti dell’andata mi accompagnano in silenzio. Arrivati nel parcheggio della palestra, scendo senza dire niente. I due riTeilono, ma dubito che vadano molto lontano. Salgo sulla mia Audi, abbasso la capote e Teilo per un giro seguendo la spiaggia sulla Highway A1A. Mi rifiuto di guardare lo specchietto retrovisore. Victor Westlake tornò a Washington volando su un jet del governo. Entrò nel suo ufficio che faceva già buio e venne informato che il giudice Sam Stillwater aveva respinto l’istanza presentata dalla difesa per l’inammissibilità della confessione di Quinn Rucker. Non era una grande sorpresa, ma era comunque un sollievo. Westlake telefonò a Stanley Mumphrey a Roanoke e si congratulò con lui. Non lo informò del fatto che il loro teste superstar stava per lasciare il programma protezione testimoni e scomparire nella notte. 26 Dormo con una pistola, una Beretta 9 millimetri che ho acquistato e detengo legalmente visto che ho un regolare porto d’armi dello Stato della Florida. Non sparo un colpo da vent’anni, dai tempi dei marine, e non ho alcun desiderio di ricominciare ora. La pistola se ne sta tranquilla sopra lo scatolone che uso come comodino accanto al letto. Un altro scatolone sul pavimento contiene gli oggetti che mi servono: il laptop, l’iPad, qualche libro, il necessario per radermi, un sacchetto di plastica a chiusura ermetica pieno di contanti, un paio di fascicoli contenenti documenti personali e un cellulare prepagato con minuti illimitati e prefisso di Miami. Inoltre, tengo pronta una valigia piena di miei indumenti. È a buon mercato e delle dimensioni giuste per poter stare nel bagagliaio dell’Audi. La maggior Teile di queste cose – la pistola, il cellulare, la valigia – è stata acquistata di recente nel caso si rendesse necessaria una Teilenza veloce e improvvisa. Be’, tale Teilenza ormai è imminente. Carico l’auto prima dell’alba e poi aspetto. Mi siedo in terrazza per l’ultima volta, sorseggio il caffè e guardo l’oceano schiarirsi nel rosa e poi nell’arancione a mano a mano che il sole si alza all’orizzonte. Ho guardato questa scena innumerevoli volte e non me ne stanco mai. In una mattinata limpida, la sfera perfetta del sole spunta dall’acqua e dice: buongiorno, anche questa sarà una splendida giornata. Non so bene dove andrò né dove finirò, ma di certo sarà un posto vicino a una spiaggia, in modo da poter cominciare ogni giorno con la stessa tranquilla perfezione. Alle otto e mezzo esco dal condominio, alle spalle un frigo pieno a metà di cibo e bevande, un variegato assortimento di piatti e utensili da cucina, una bella macchinetta per il caffè, qualche rivista sul divano e un po’ di pane e cracker in dispensa. Ho abitato qui per quarantasei giorni, la mia prima vera casa dopo la prigione, e mi rattrista andarmene. Avevo pensato di restarci più a lungo. Lascio le luci accese, chiudo la porta a chiave e mi chiedo quanti altri nascondigli temporanei mi aspettano prima che non sia più costretto a scappare. Mi allontano in auto e poco dopo sono già perso nel traffico intenso dei pendolari diretti a ovest, a Jacksonville. So che “loro” mi stanno seguendo, ma forse non per molto ancora. Due ore più tardi entro nell’agglomerato urbano a nord di Orlando e mi fermo a fare colazione in una pancake house. Mangio lentamente, leggo i quotidiani e osservo la gente. Più avanti lungo la stessa strada, scendo in un motel a buon mercato e pago in contanti per una notte. L’impiegata alla reception mi chiede un documento con foto e io le spiego di avere perso il portafoglio ieri notte in un bar. La cosa non le piace, però le piacciono i contanti e così non fa storie. Mi consegna una chiave e io vado in camera mia. Lavorando sulle Pagine Gialle e servendomi del cellulare prepagato, alla fine riesco a trovare un autolavaggio di lusso che ha un posto libero alle tre di oggi pomeriggio. Per centonovantanove dollari, il ragazzo all’altro capo della linea mi promette che farà sembrare la mia auto come nuova. Buck’s Pro Shine è dietro un grande autolavaggio standard, tipo catena di montaggio, che sta facendo ottimi affari. La mia auto e io veniamo assegnati a un magrissimo ragazzo di campagna che si chiama Denny, il quale prende il suo lavoro molto seriamente. In minuzioso dettaglio, mi espone il suo programma di lavaggio e lucidatura e si mostra sorpreso quando gli dico che rimarrò ad aspettare. «Potrebbe volerci un paio d’ore» mi dice. «Non devo andare da nessuna Teile» replico. Denny si stringe nelle spalle e porta l’Audi sulla piattaforma di lavaggio. Trovo una panchina sotto un tendone e comincio a leggere un tascabile di Walter Mosley. Mezz’ora dopo, Denny finisce il lavaggio esterno e attacca con l’aspirapolvere. Apre entrambe le portiere e io mi avvicino per fare due chiacchiere. Gli spiego che sto per lasciare la città e perciò le valigie e lo scatolone nel bagagliaio non devono essere toccati. Il ragazzo si stringe di nuovo nelle spalle, non gli interessa. Meno lavoro per lui. Mi avvicino di un altro passo e gli confido che sono nel bel mezzo di un brutto divorzio e ho motivo di credere che i legali di mia moglie seguano ogni mio movimento. Sospetto fortemente che ci sia un localizzatore GPS nascosto da qualche Teile nell’auto. Se riesce a trovarlo, gli faccio scivolare in tasca cento dollari extra. All’inizio il ragazzo esita, ma io gli assicuro che la macchina è mia e che non c’è niente di illegale nel disattivare un localizzatore. Sono i viscidi avvocati di mia moglie quelli che stanno infrangendo la legge. Alla fine negli occhi di Denny compare una luce complice: il ragazzo è con me. Apro il cofano e insieme cominciamo a setacciare la vettura. Nel corso dell’operazione spiego che esistono decine di dispositivi diversi, di ogni forma e dimensione, ma in genere sono tutti fissati con un potente magnete. A seconda del modello, la batteria può durare settimane, oppure il dispositivo può essere addirittura collegato all’impianto elettrico del veicolo. Alcune antenne sono esterne, altre interne. «Ma lei come fa a sapere tutte queste cose?» chiede Denny, disteso sulla schiena e con la testa sotto l’auto, intento a controllare il telaio. «Perché ne ho piazzato uno nella macchina di mia moglie» rispondo, e il ragazzo sembra trovare la cosa divertente. «Come mai non ha cercato quel coso da solo?» «Perché mi tenevano d’occhio.» Cerchiamo per un’ora e non troviamo niente. Comincio a pensare che forse non ci sono cimici nella mia auto quando Denny smonta un piccolo pannello dietro il faro destro. Il ragazzo è supino, la spalla premuta contro la ruota anteriore destra. Stacca un oggetto e me lo porge. La custodia è a tenuta stagna, di plastica nera e rigida, e ha le dimensioni di un cellulare. La tolgo e dico: «Bingo». Ho studiato centinaia di questi aggeggi in Internet e non ne ho mai visto uno come questo, per cui presumo che sia materiale di appannaggio governativo. Niente nome del fabbricante, nessun marchio, numero o lettera dell’alfabeto. «Bel lavoro, Denny.» Passo al ragazzo una banconota da cento. «Ora posso finire l’interno?» mi chiede. «Certo.» Mi allontano, lasciandolo al suo lavoro. Vicino all’autolavaggio c’è un piccolo centro commerciale con cinque o sei negozi a buon mercato. Entro in un bar, pago una tazza di decaffeinato che sa di rancido e mi siedo accanto alla vetrina, dalla quale posso vedere il parcheggio. Un’anziana coppia a bordo di una Cadillac parcheggia, scende dall’auto ed entra in un ristorante cinese a buffet. Appena i due sono all’interno del locale, esco dal bar e attraverso il parcheggio come se fossi diretto alla mia auto. Dietro la Cadillac, mi chino rapidamente e fisso il dispositivo sul fondo del serbatoio. Targhe dell’Ontario: perfetto. Denny è occupato con i finestrini e suda a profusione, perso nel suo lavoro. Gli do un colpetto sulla spalla, facendolo sobbalzare, e gli dico: «Senti, Denny, stai facendo un ottimo lavoro, ma è successo qualcosa. Devo andarmene subito». Conto le banconote e gliene consegno tre da cento dollari. Il ragazzo è confuso, ma non mi importa. «Come vuoi, amico» borbotta, guardando i soldi. «Devo proprio scappare.» Il ragazzo afferra un asciugamano sul tettuccio dell’Audi. «Buona fortuna per il divorzio, amico.» «Grazie.» A ovest di Orlando, mi immetto sull’Interstatale 75 in direzione nord, supero Ocala, poi Gainesville, ed entro in Georgia, dove decido di passare la notte a Valdosta. Nei cinque giorni successivi i miei vagabondaggi mi portano a sud fino a New Orleans, a ovest fino a Wichita Falls, Texas, e a nord fino a Kansas City. Viaggio lungo interstatali, statali, strade di contea e strade dei parchi nazionali. Pago tutto in contanti e quindi, per quello che ne so, non lascio tracce. Rifaccio il percorso a ritroso almeno una decina di volte e mi convinco che nessuno mi sta seguendo. Il viaggio termina a Lynchburg, Virginia, dove arrivo poco dopo la mezzanotte e, di nuovo, pago in contanti la stanza del motel. Fino a oggi, soltanto uno ha rifiutato di fare affari con me perché dichiaro di non avere documenti. È anche vero che non scendo mai in un Marriott o in un Hilton. Sono stanco della strada e ansioso di mettermi al lavoro. La mattina dopo dormo fino a tardi e poi guido per un’ora fino a Roanoke, l’ultimo posto in cui chiunque conosca Max Baldwin si aspetterebbe di trovarlo. Forte di questa convinzione, e di una nuova faccia, sono sicuro di potermi muovere anonimamente in un’area metropolitana di duecentomila persone. L’unica fonte di preoccupazione del mio pacchetto-sicurezza è la targa della Florida. Contemplo l’idea di noleggiare un’altra vettura, ma poi decido di non farne niente per via dei documenti. Inoltre, l’elemento Florida mi sarà utile in seguito. Per un po’ giro in macchina per la città guardando il panorama, il centro, i vecchi quartieri e l’inevitabile distesa della periferia. Malcolm Bannister è stato a Roanoke parecchie volte, compresa quella in veste di diciassettenne giocatore di football del liceo. Winchester è a sole tre ore d’auto da qui, a nord sull’Interstatale 81. Da giovane avvocato, Malcolm è venuto a Roanoke almeno due volte per raccogliere delle deposizioni. La città di Salem confina con Roanoke, e Malcolm una volta ci ha passato un weekend, in occasione del matrimonio di un amico. Quel matrimonio si è poi concluso con un divorzio, esattamente come quello di Malcolm. L’amico non si è più visto o sentito da quando Malcolm è finito in prigione. Il punto è che conosco abbastanza bene la zona. Il mio primo tentativo è in un motel apTeilenente a una catena nazionale che ha regole abbastanza severe per quanto riguarda la registrazione dei clienti. La vecchia storia del portafoglio smarrito non funziona e, visto che non posso presentare documenti, la stanza mi viene negata. Nessun problema: nell’area c’è grande abbondanza di motel poco costosi. Mi sposto verso il confine sud di Roanoke e mi ritrovo in una Teile non molto florida di Salem, dove noto un motel che probabilmente offre camere a ore, o a notte. I contanti sono ben accetti. Opto per la tariffa giornaliera di quaranta dollari e informo l’anziana alla reception che mi tratterrò per qualche giorno. La donna non è molto cordiale e penso che forse era proprietaria dell’albergo ai bei vecchi tempi quando i neri venivano respinti. Ci sono almeno trentadue gradi e le chiedo se l’aria condizionata funziona. Condizionatori nuovi di zecca, mi risponde con orgoglio l’anziana. Parcheggio sul retro, direttamente davanti alla mia stanza e lontano dalla strada. Lenzuola e pavimenti sono puliti. Il bagno è immacolato. Il condizionatore alla finestra è nuovo, ronza piacevolmente e, quando finisco di scaricare la macchina, la temperatura è scesa sotto i ventidue gradi. Mi distendo sul letto e mi chiedo quanti accoppiamenti illeciti abbiano avuto luogo qui. Penso a Eva da Porto Rico e a come sarebbe piacevole stringerla di nuovo fra le braccia. E penso a Vanessa Young, a come sarebbe poterla finalmente toccare. Quando fa buio, mi avventuro in fondo alla strada per un’insalata in un fast food. Ho perso nove chili da quando me ne sono andato da Frostburg e conto di perderne altri, almeno per il momento. Quando esco dal ristorante, noto le luci dello stadio e decido di concedermi una Teilita di baseball. Raggiungo in auto il Memorial Stadium, sede dei Salem Red Sox, affiliati di seconda categoria alla squadra di Boston. Questa sera giocano contro i Lynchburg Hillcats davanti a un bel pubblico numeroso. Per sei dollari mi procuro un posto in gradinata. Compro una birra dal ragazzo delle bibite e mi godo la vista e i rumori della Teilita. Accanto a me siede un giovane padre con i suoi due figli, entrambi giocatori di T-ball, sospetto. Non possono avere più di sei anni e indossano la maglietta e il berretto dei Red Sox. Penso a Bo e a tutte le ore che abbiamo passato insieme giocando nel cortile dietro casa, mentre Dionne sedeva sul piccolo patio sorseggiando tè ghiacciato. Sembra ieri che eravamo tutti insieme, una bella famiglia con grandi sogni e un futuro. Bo era così piccolo e carino, e suo padre era un eroe. Stavo cercando di trasformarlo in un battitore ambidestro, a cinque anni, quando i federali sono entrati nella mia vita e hanno distrutto tutto. Che spreco. E, a Teile me, a nessuno importa più niente di tutto questo. Immagino che a mio padre, a mio fratello e a mia sorella farebbe piacere vedere la mia vita di nuovo sui binari giusti, ma per loro non è una priorità. Hanno ognuno la propria vita della quale preoccuparsi. Una volta che finisci in galera, il mondo dà per scontato che te lo sei meritato e la pietà prima o poi si esaurisce. Se si facesse un sondaggio tra i miei ex amici e conoscenti, sono sicuro che direbbero qualcosa del tipo: “Povero Malcolm, si è invischiato con le persone sbagliate. Ha preso qualche scorciatoia di troppo. È diventato un po’ troppo avido. Che tragedia”. Tutti dimenticano in fretta perché tutti vogliono dimenticare. La guerra al crimine ha bisogno di caduti, e il povero Malcolm si è fatto beccare. Per cui c’è solo Max Reed Baldwin – libero ma in fuga – a cercare di inventare un modo per vendicarsi mentre si allontana cavalcando verso il tramonto. 27 Per il sesto giorno consecutivo, Victor Westlake bevve il suo primo caffè del mattino scorrendo un breve rapporto su Mr Max Baldwin. L’informatore era svanito. Il localizzatore GPS era stato finalmente recuperato da una Cadillac Seville mentre i proprietari dell’auto, un’anziana coppia canadese, stavano pranzando nei pressi di Savannah, Georgia. I due non avrebbero mai saputo di essere stati cyber-seguiti dall’FBI per quattrocentottanta chilometri. Westlake aveva punito i tre agenti incaricati del monitoraggio dell’auto di Baldwin, che avevano perso a Orlando seguendo la pista sbagliata della Cadillac diretta a nord. Baldwin non si stava servendo del suo iPhone, delle carte di credito e neppure del suo iniziale provider. L’autorizzazione del tribunale a ficcanasare su quei fronti sarebbe scaduta nel giro di una settimana e c’erano scarsissime possibilità che venisse rinnovata. Baldwin non era né un indiziato né un evaso, e la corte era riluttante a consentire una sorveglianza così estesa su un cittadino rispettoso delle leggi. Il saldo del conto corrente di Baldwin presso la SunCoast ammontava a quattromilacinquecento dollari. Il denaro della ricompensa era stato tracciato mentre veniva suddiviso e rimbalzava in giro per lo Stato della Florida, ma alla fine l’FBI ne aveva perso la pista. Baldwin aveva spostato i soldi così rapidamente che i legali del Bureau non erano riusciti a mantenere il passo con le loro richieste di mandati di perquisizione. C’erano stati almeno otto prelievi per un totale di sessantacinquemila dollari in contanti. C’era prova di un bonifico di quarantamila dollari su un conto a Panamá, e Westlake presumeva che anche il resto del denaro fosse ormai off-shore. Suo malgrado era arrivato a rispettare Baldwin e la sua abilità nello scomparire. Se nemmeno l’FBI era in grado di trovarlo, forse dopo tutto era al sicuro. Se Max riusciva a non usare carte di credito, iPhone e passaporto, e a non farsi arrestare, poteva restarsene nascosto per molto tempo. Non erano arrivate altre voci dal clan Rucker, e Westlake era ancora confuso dal fatto che una gang di narcotrafficanti dell’area di Washington avesse localizzato Baldwin nei pressi di Jacksonville. L’ FBI e il Marshals Service stavano indagando al loro interno, ma fino a quel momento non avevano trovato un solo indizio. Westlake posò il rapporto sopra una pila di documenti e finì di bere il suo caffè. Trovo la sede della Beebe Security in un palazzo di uffici non lontano dal mio motel. L’annuncio sulle Pagine Gialle vanta vent’anni di esperienza, un passato nelle forze dell’ordine, tecnologia di ultimissima generazione e così via. Quasi tutti gli annunci nella sezione “Investigazioni private” usano lo stesso linguaggio e, mentre parcheggio, non riesco a ricordare cosa in Teilicolare mi abbia attratto della Beebe. Forse il nome. In ogni caso, se l’agenzia non mi piacerà passerò a quella successiva della mia lista. Se avessi visto Frank Beebe camminare per strada, avrei detto: “Quello è un detective privato”. Cinquant’anni, torace robusto con la pancia che preme contro i bottoni della camicia, pantaloni di poliestere, stivali a punta da cowboy, folti capelli grigi, gli indispensabili baffi e l’atteggiamento spavaldo di un uomo che è armato e senza paura. Chiude la porta del suo ufficio troppo pieno di roba e mi chiede: «Cosa posso fare per lei, Mr Baldwin?». «Devo rintracciare una persona.» «Di che caso si tratta?» mi domanda, mentre atterra pesantemente sulla sua poltrona da dirigente sovradimensionata. La parete alle sue spalle è coperta da grandi foto e certificati di Teilecipazione a vari seminari. «Non è proprio un caso. Ho solo bisogno di trovare un tizio.» «E cosa farà quando l’avrà trovato?» «Parlerò con lui. Nient’altro. Non c’è nessun marito traditore e nessun debitore. Non cerco soldi, vendetta o altro. Devo solo incontrare quest’uomo e sapere quanto più possibile di lui.» «Va bene.» Frank toglie il cappuccio alla penna, pronto a prendere appunti. «Mi parli di questa persona.» «Si chiama Nathan Cooley. Credo che sia conosciuto anche come Nat. Trent’anni, single, credo. È originario di una cittadina che si chiama Willow Gap.» «Conosco Willow Gap.» «In base alle ultime notizie di cui dispongo, sua madre vive ancora là, ma non so dove si trovi Cooley adesso. Qualche anno fa è stato arrestato nel corso di un’operazione antidroga. Metanfetamina...» «Che sorpresa.» «Ha passato alcuni anni in un carcere federale. E suo fratello maggiore è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia.» Frank continua a scrivere. «Lei come mai conosce questo tizio?» «Diciamo che è un’amicizia di vecchia data.» «Okay.» Beebe sa quando fare domande e quando soprassedere. «E io cosa dovrei fare?» «Senta, Mr Beebe...» «Frank.» «Okay. Frank, dubito che ci siano molti neri a Willow Gap e dintorni. Inoltre io sono di Miami e la mia piccola auto straniera ha la targa della Florida. Se andassi là e cominciassi a curiosare in giro e a fare domande, probabilmente non farei molta strada.» «Probabilmente ti faresti sparare.» «Mi piacerebbe evitarlo. Credo che tu possa risolvere la cosa senza suscitare sospetti. Ho bisogno soltanto dell’indirizzo di Cooley e, se possibile, del suo numero di telefono. Qualsiasi informazione in più sarebbe gradita.» «Hai provato con l’elenco?» «Sì, e ci sono parecchi Cooley nell’area di Willow Gap, ma nessun Nathan. Non arriverei lontano facendo un mucchio di telefonate a caso.» «Giusto. Nient’altro?» «Tutto qui. Molto semplice.» «Okay. Sono cento dollari l’ora, più le spese. Andrò a Willow Gap oggi pomeriggio. È a circa un’ora d’auto da qui, praticamente in mezzo al nulla.» «Così ho sentito.» La prima bozza della mia lettera dice: Egregio Mr Cooley, mi chiamo Reed Baldwin, sono un documentarista di Miami e, insieme ad altri due soci, sono titolare di una casa di produzione, la Skelter Films. Siamo specializzati in lavori che trattano il tema dell’abuso di potere da Teile del governo federale. Il mio attuale progetto riguarda una serie di omicidi a sangue freddo commessi da agenti della Drug Enforcement Administration. L’argomento mi tocca da vicino perché tre anni fa un mio nipote diciassettenne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da due agenti a Trenton, New Jersey. Mio nipote era disarmato e non aveva precedenti. Naturalmente l’indagine interna non ha evidenziato alcun dolo da Teile della DEA. La causa intentata dalla mia famiglia è stata dichiarata non ammissibile. Nel corso delle mie ricerche, credo di avere scoperto una cospirazione che coinvolge i livelli più alti della DEA. Sono convinto che certi agenti vengano incoraggiati a uccidere gli spacciatori o presunti tali. Lo scopo è duplice. Primo, tali omicidi ovviamente pongono fine a un’attività criminale. Secondo, il governo evita lunghi processi. La DEA uccide le persone invece di arrestarle. A tutt’oggi, ho individuato circa una decina di queste uccisioni sospette. Ho parlato con numerosi familiari delle vittime e tutti hanno la sensazione che i loro cari siano stati assassinati. È questo il motivo che mi porta a lei: sono a conoscenza dei dati di base riguardanti la morte di suo fratello Gene, avvenuta nel 2004. Gli agenti della DEA coinvolti nella sparatoria erano almeno tre e, come sempre, sostengono di avere agito per legittima difesa. So che lei era presente sulla scena al momento della sparatoria. La prego di concedermi la possibilità di incontrarla, offrirle il pranzo e discutere il mio progetto. Al momento mi trovo a Washington, ma posso lasciar perdere tutto e venire in auto nel Southwest Virginia quando le farà più comodo. Il mio numero di cellulare è 305-806-1921. La ringrazio per il suo tempo. Cordialmente, M. Reed Baldwin L’orologio rallenta sensibilmente con il passare delle ore. Faccio una lunga gita in auto lungo l’Interstatale 81, in direzione sud, e do un’occhiata a Blacksburg, sede del Virginia Tech, a Christiansburg, Radford, Marion e Pulaski. È una zona di montagna e il viaggio è piacevole, ma non sono qui per ammirare il panorama. È possibile che nel prossimo futuro abbia bisogno di una di queste cittadine, perciò prendo nota di ristoranti per camionisti, motel e fast food nei pressi dell’interstatale. Il traffico dei camion è intenso e vedo auto di tutti e cinquanta gli Stati, per cui nessuno bada a me. Ogni tanto esco dall’interstatale a quattro corsie e mi avventuro fra le colline, attraversando piccoli centri senza fermarmi. Trovo Ripplemead, popolazione cinquecento abitanti, il villaggio più vicino al cottage sul lago dove sono stati assassinati il giudice Fawcett e Naomi Clary. Quando finalmente rientro a Roanoke vedo le luci accese dello stadio: i Red Sox giocano di nuovo. Compro un biglietto e ceno con un hot dog e una birra. Frank Beebe mi telefona alle otto di mattina e un’ora dopo sono nel suo ufficio. Mentre versa il caffè, mi dice in tono professionale: «L’ho trovato a Radford, una piccola città con un college e circa sedicimila abitanti. È uscito di prigione qualche mese fa, ha abitato per un po’ con sua madre e poi se n’è andato. Ho parlato con lei, una signora tosta, e mi ha detto che suo figlio ha comprato un bar a Radford». Sono curioso, per cui domando: «Come sei riuscito a farla parlare?». Frank ride e si accende una sigaretta. «Quella è la Teile più facile, Reed. Quando lavori in questo ramo da tanto tempo come me, riesci sempre a inventarti qualche stronzata per far parlare la gente. Ho pensato che la madre avesse ancora una bella fifa di chiunque sia collegato al sistema carcerario, così le ho detto di essere un agente di custodia federale e che avevo bisogno di fare due chiacchiere con il suo ragazzo.» «Non è sostituzione di persona?» «Nossignore, perché gli agenti di custodia federali non esistono. La signora non mi ha chiesto un documento e, se l’avesse fatto, gliene avrei mostrato uno. Ho sempre una manciata di tessere con me. In un giorno qualsiasi posso essere uno di molti tipi di agente federale. Ti stupirebbe sapere com’è facile ingannare le persone.» «Sei andato al bar?» «Sì, ma non sono entrato. Non mi sarei confuso tra la gente. Il bar è vicinissimo al campus della Radford University, perciò i clienti sono parecchio più giovani di me. Il locale si chiama Bombay’s ed esiste già da un po’ di tempo. Secondo i registri della città, è passato di mano il dieci maggio di quest’anno. Il venditore era un certo Arthur Stone e l’acquirente era il tuo amico, Nathan Cooley.» «Dove abita?» «Non lo so. Al catasto non risulta niente. Penso che sia in affitto e, se è così, non ci sono dati ufficiali. Accidenti, potrebbe addirittura abitare sopra il bar: è un vecchio edificio a due piani. Non hai intenzione di andarci, vero?» «No.» «Bene. Sei troppo vecchio e troppo nero. Quella è una clientela tutta bianca.» «Grazie. Incontrerò Nathan da qualche altra Teile.» Pago Beebe con seicento dollari in contanti e, quando sto già uscendo, gli chiedo: «Senti, Frank, se avessi bisogno di un passaporto falso, tu avresti qualche idea?». «Certo. C’è un tizio a Baltimora al quale mi sono già rivolto in passato, sa fare quasi tutto. Ma i passaporti scottano di questi tempi. Sai, la Sicurezza interna e tutto quello che ci va dietro. Se ti beccano, si eccitano da morire.» Sorrido e dico: «Il passaporto non è per me». Frank ride. «Cavolo, questa non l’avevo mai sentita.» L’auto è già carica e lascio la città. Quattro ore dopo sono a McLean, Virginia, e sto cercando una copisteria che offra servizi executive. Ne trovo una in un centro commerciale di lusso, pago la tariffa di connessione e collego il mio laptop a una stampante. Dopo dieci minuti di prove e tentativi, riesco a far funzionare il maledetto aggeggio e stampo la lettera per Nathan Cooley. È su carta intestata della Skelter Films, con un indirizzo nell’Ottava Avenue di Miami e tutta una serie di numeri di telefono e fax. Sulla busta scrivo: “Mr Nathan Cooley, presso Bombay’s Bar & Grill, 914 East Main Street, Radford, Virginia 24141”. A sinistra dell’indirizzo, in grassetto, scrivo: “Riservata personale”. Quando il tutto è perfetto, attraverso il Potomac e mi spingo nel centro di Washington, alla ricerca di una cassetta per le lettere. 28 Quinn Rucker si voltò di schiena, passò le mani tra le sbarre e unì i polsi. Un vicesceriffo fece scattare le manette mentre un altro apriva la porta della cella. I due scortarono Quinn fino a una soffocante saletta di transito dove lo aspettavano due agenti dell’FBI, che lo fecero uscire da una porta secondaria e poi salire a bordo di un SUV nero con i finestrini oscurati e altre guardie armate. Dieci minuti più tardi, Rucker e la sua scorta raggiunsero l’ingresso posteriore dell’edificio federale, dove venne fatto entrare rapidamente per poi salire due rampe di scale. Né Victor Westlake, né Stanley Mumphrey, né gli altri avvocati presenti nella stanza avevano mai Teilecipato a una riunione del genere. L’accusato non veniva mai portato fin lì per una chiacchierata. Se la polizia aveva bisogno di parlare con lui, lo faceva all’interno del carcere. Se la sua presenza era richiesta in tribunale, il giudice lo convocava in aula. Quinn venne fatto entrare nella piccola sala riunioni e gli furono tolte le manette. Strinse la mano al suo avvocato, Dusty Shiver, il quale naturalmente doveva essere presente, ma non sapeva bene cosa pensare di quel colloquio. Aveva avvertito i federali che il suo cliente non avrebbe detto niente prima che lui, Dusty, lo autorizzasse a parlare. Quinn era in galera da quattro mesi e non se la stava passando bene. Per ragioni note solo ai suoi carcerieri, era tenuto in isolamento. I contatti con le guardie erano ridotti al minimo. Il cibo era disgustoso e Rucker stava dimagrendo. Inoltre assumeva antidepressivi e dormiva quindici ore al giorno. Rifiutava spesso le visite dei familiari e anche quelle di Dusty. Una settimana esigeva il diritto di dichiararsi colpevole in cambio dell’ergastolo, e la settimana dopo voleva il processo. Aveva licenziato Dusty due volte, ma solo per riassumerlo qualche giorno dopo. Ogni tanto ammetteva di avere ucciso il giudice Fawcett e la sua amica, ma ritrattava sempre e accusava il governo di drogargli il cibo. Aveva minacciato di morte le guardie e i loro figli, chiedendo poi perdono in lacrime appena cambiava umore. Era Victor Westlake a dirigere l’incontro e cominciò dicendo: «Andiamo subito al punto, Mr Rucker. Sappiamo che lei e alcuni dei suoi complici volete eliminare uno dei nostri testimoni». Dusty toccò il braccio di Quinn. «Non una parola. Non parlare finché non te lo dico io.» Quinn sorrise a Westlake, come se uccidere un teste del governo fosse una prospettiva deliziosa. «Lo scopo di questa piccola riunione, Mr Rucker» continuò Westlake «è avvertirla che se a uno dei nostri testimoni verrà fatto del male, lei si ritroverà con ulteriori imputazioni. E non solo lei: staremo addosso a ogni membro della sua famiglia.» Quinn, che stava ancora sorridendo, sbottò: «E così Bannister sta scappando, eh?». «Zitto, Quinn» disse Dusty. «Io non devo stare zitto» ribatté Rucker. «Ho saputo che Bannister ha lasciato il caldo sole della Florida.» «Taci, Quinn!» ringhiò di nuovo Dusty. «Gli avete dato una faccia nuova, probabilmente anche un nome nuovo, tutto il pacchetto» continuò Quinn. Stanley Mumphrey disse: «Accuseremo Dee Ray, Tall Man, parecchi dei tuoi cugini e tutti quelli del tuo giro, se farai qualcosa a uno dei nostri testimoni». «Voi non avete testimoni» sparò Quinn dal lato opposto del tavolo. «Avete solo Bannister.» Dusty alzò le mani e si lasciò andare sulla sedia. «Quinn, io ti consiglio di tacere.» «Ti ho sentito» disse Rucker. «Ti ho sentito.» Westlake riuscì a mantenere un’espressione torva mentre fissava il detenuto, ma in realtà era sbalordito. L’incontro avrebbe dovuto intimidire Quinn, non spaventare il governo. Come diavolo erano riusciti a rintracciare Bannister in Florida? E adesso come facevano a sapere che aveva tagliato la corda? Era un momento agghiacciante per Westlake e i suoi assistenti. Se fossero riusciti a trovare il loro informatore, di certo l’avrebbero nascosto in un posto sicuro. «Tutta la tua famiglia potrebbe doversela vedere con l’accusa di omicidio e la richiesta di pena capitale» insistette Stanley, in un debole tentativo di fare il duro. Quinn si limitò a sorridere. Smise di parlare e si sistemò sulla sedia a braccia conserte. Devo vedere Vanessa Young. Un incontro presenta un elemento di rischio: essere visti insieme dalle persone sbagliate solleverebbe domande alle quali non sono disposto a rispondere. Ma un incontro è inevitabile, e lo è già da parecchi anni. L’ho vista per la prima volta a Frostburg, in un giorno in cui la neve aveva scoraggiato molti visitatori dal mettersi al volante. Mentre stavo parlando con Henry, mio padre, Vanessa era entrata e si era seduta al tavolo accanto al nostro. Era venuta a trovare suo fratello. Era splendida, sui quarant’anni, con la pelle di un marrone chiaro, occhi belli e tristi, gambe lunghe e jeans aderenti. Il pacchetto completo. Non riuscivo a toglierle gli occhi di dosso, tanto che alla fine Henry mi aveva detto: “Vuoi che me ne vada?”. Naturalmente no, perché se se ne fosse andato la mia visita sarebbe finita. Più a lungo mio padre restava, più io potevo guardare Vanessa. Dopo un po’ aveva cominciato a guardarmi anche lei e c’era stato un serio scambio di sguardi. L’attrazione era reciproca, all’inizio. Ma c’erano alcune difficoltà. La mia detenzione innanzitutto e, in secondo luogo, il suo matrimonio che, com’è poi risultato, era un disastro. Sondavo suo fratello per avere informazioni, ma lui voleva restarne fuori. Vanessa e io ci scambiammo qualche lettera, ma lei aveva paura che il marito la scoprisse. Cercava di venire a Frostburg più spesso, per vedere sia suo fratello che me, ma aveva due figli adolescenti che le stavano complicando la vita. Dopo che il divorzio era diventato definitivo, era uscita con altri uomini, ma non aveva funzionato. Io l’avevo implorata di aspettarmi, ma sette anni sono tantissimi, se ne hai quarantuno. Quando i figli se n’erano andati di casa, Vanessa si era trasferita a Richmond, Virginia, e la nostra storia d’amore a distanza si era gradualmente raffreddata. Vanessa ha un tale passato che è estremamente cauta e tiene sempre un occhio allo specchietto retrovisore. Immagino che sia una cosa che abbiamo in comune. Scambiandoci e-mail in codice, riusciamo a concordare luogo e ora. L’avverto che non assomiglio affatto al Malcolm Bannister che ha conosciuto in prigione. Dice che correrà il rischio. Non vede l’ora di esaminare la nuova versione migliorata. Mentre parcheggio davanti al ristorante alla periferia di Richmond, ho un brutto attacco di panico. Sono tesissimo perché finalmente sto per toccare la donna che sogno da quasi tre anni. So che anche lei vuole toccarmi, ma l’uomo dal quale un tempo era così attratta ora ha un aspetto completamente diverso. E se non le piacessi? Se preferisse Malcolm a Max? Mi innervosisce anche l’idea che sto per trascorrere un po’ di tempo con l’unica persona, federali a Teile, che conosce tutti e due. Mi asciugo il sudore dalla fronte e prendo in considerazione l’idea di andarmene. Poi scendo dall’auto e chiudo la portiera sbattendola. Vanessa è seduta a un tavolo e, mentre mi avvicino con passo incerto, mi sorride. Approva. Le do un bacio delicato sulla guancia, mi siedo e per diversi minuti ci limitiamo semplicemente a guardarci. Alla fine domando: «Allora, cosa ne pensi?». Vanessa scuote la testa e risponde: «Incredibile. Non avrei mai detto che sei tu. Hai un documento?». Ridiamo tutti e due, poi rispondo: «Certo, ma è falso. Attesta che ora sono Max, non Malcolm». «Sei dimagrito, Max.» «Grazie, anche tu.» Ho dato un’occhiata veloce alle sue gambe sotto il tavolo. Gonna corta. Tacchi alti e sexy. È in tenuta da combattimento. «Tu quale preferisci dei due?» le domando. «Be’, credo di non avere molta scelta, no? Penso che tu sia piuttosto belloccio, Max. Mi piace la tua nuova versione, tutto l’insieme. Di chi è stata l’idea degli occhiali firmati?» «Del mio consulente, lo stesso che ha suggerito la testa rasata a zero e la barba di quattro giorni.» «Più ti guardo, più mi piace.» «Grazie a Dio. Avevo i nervi a pezzi.» «Rilassati, baby. Ci aspetta una lunga notte.» La cameriera prende nota delle nostre ordinazioni: un martini per me, una bibita dietetica per lei. Ci sono moltissime cose delle quali non voglio discutere, in Teilicolare del mio improvviso rilascio dal carcere e della protezione testimoni. Il fratello che Vanessa andava a trovare in prigione era uscito, però è già tornato dietro le sbarre, così lo lasciamo fuori dalla conversazione. Le chiedo dei suoi figli, una ragazza di vent’anni che adesso è al college e un ragazzo di diciotto che le sta sfuggendo di mano. A un certo punto, mentre sto parlando, Vanessa mi interrompe e osserva: «Parli addirittura in modo diverso». «Bene. Sono mesi, ormai, che mi alleno. Parlata molto più lenta e voce più profonda. Suona autentico?» «Credo di sì. Sì, funziona.» Mi chiede dove abito e io le spiego che devo ancora trovarmi una sistemazione. Mi sposto di continuo, cercando di non farmi individuare dall’FBI e da altri. Un mucchio di motel a buon mercato. Non sono un fuggitivo, ma non sono neppure del tutto libero. Arriva la cena, ma quasi non ce ne accorgiamo. «Sembri molto più giovane» dice Vanessa. «Forse dovrei andare a trovare il tuo chirurgo plastico.» «Ti prego, non cambiare niente.» Le parlo delle mie modifiche, soprattutto gli occhi, il naso e il mento. La diverto descrivendole le riunioni con l’équipe chirurgica e i nostri sforzi per progettare una nuova faccia. Ho anche perso nove chili e Vanessa pensa che dovrei recuperarne un paio. A mano a mano che i nervi si calmano, ci rilassiamo e parliamo come due vecchi amici. La cameriera ci chiede se va tutto bene, dato che non abbiamo praticamente toccato cibo. Sfioriamo diversi argomenti, ma entrambi in fondo alla mente stiamo pensando alla stessa cosa. E finalmente le dico: «Andiamocene di qui». Non ho quasi finito di parlare che Vanessa sta già afferrando la borsa. Pago in contanti e usciamo nel parcheggio. Non mi va l’idea del suo apTeilamento e Vanessa è d’accordo. È molto piccolo e spoglio, mi spiega. Scendiamo in un hotel che avevo notato lungo la strada e ordiniamo una bottiglia di champagne. Due ragazzini alla prima notte di nozze non potrebbero essere più carichi di energia di Vanessa e me. C’è così tanto da fare, così tanto da recuperare. 29 Mentre Vanessa è al lavoro, sbrigo qualche commissione in giro per Richmond. Spendo settanta dollari in un negozio per un cellulare prepagato con cento minuti di conversazione e in un altro negozio compro un telefonino identico per sessantotto dollari. Uno lo darò a Vanessa e io mi terrò l’altro. In una farmacia faccio scorta di carte di credito prepagate. Vado all’appuntamento con il proprietario di un negozio di articoli fotografici che si autodefinisce videografo, operatore e montatore video, ma la sua tariffa è troppo alta. Se avrò fortuna e otterrò l’intervista, avrò bisogno di due persone: un operatore e un assistente. Il tizio dell’appuntamento dice che lui lavora con una troupe completa o niente. Vanessa e io pranziamo con un sandwich in una tavola calda vicino al suo ufficio. A cena andiamo in un bistrot nel quartiere di Carytown. Il dopocena è notevolmente e meravigliosamente simile a quello di ieri sera e si svolge nella stessa camera d’albergo. Potrebbe diventare un’abitudine. Ma i nostri piani per la terza notte deragliano quando telefona il figlio di Vanessa: sta per arrivare in città e ha bisogno di un posto dove stare. Sua madre è convinta che abbia bisogno anche di un po’ di soldi. Stiamo finendo di cenare quando il cellulare che ho in tasca comincia a vibrare. Il numero di chi mi sta chiamando risulta “sconosciuto” ma lo stesso vale per tutte le chiamate a questo telefonino. Dato che mi aspetto una grossa notizia, dico a Vanessa: «Scusami, per favore» e mi alzo da tavola. Rispondo al telefono nell’atrio del ristorante. Una voce vagamente familiare mi dice: «Mr Reed Baldwin, sono Nathan Cooley. Ho ricevuto la sua lettera». Ricordo a me stesso che devo parlare lentamente e con un tono profondo. «Sì, Mr Cooley, grazie per avermi chiamato.» Ovvio che ha ricevuto la lettera, altrimenti come potrebbe avere il mio numero? «Quando vuole che ci vediamo?» domanda Cooley. «Quando preferisce. In questo momento sono a Washington e abbiamo finito le riprese proprio oggi. Ho un po’ di tempo libero, per cui subito per me sarebbe perfetto. Cosa ne pensa?» «Io non devo andare da nessuna Teile. Come ha fatto a trovarmi?» «Internet. È difficile nascondersi, al giorno d’oggi.» «Già. Senta, io di solito mi alzo tardi e poi lavoro al bar dalle due del pomeriggio fino a mezzanotte.» «Cosa ne direbbe di pranzare insieme domani?» propongo, un po’ troppo ansiosamente. «Solo noi due, niente cineprese, registratori o roba del genere. Offro io.» Una pausa, e io trattengo il fiato. «Okay. Dove?» «È il suo territorio, Mr Cooley. Scelga lei posto e ora. Io ci sarò.» «Va bene. All’uscita per Radford sull’Interstatale 81 c’è un ristorante che si chiama Spanky’s. L’aspetto là domani a mezzogiorno.» «Ci sarò.» «Come farò a riconoscerla?» domanda, e per poco non lascio cadere il cellulare. Il fattore riconoscimento è molto più importante di quanto Cooley possa mai immaginare. Mi sono sottoposto a interventi chirurgici che hanno modificato radicalmente la mia faccia. Mi rado la testa a giorni alterni e la barba una volta alla settimana. Ho fatto la fame e ho smaltito nove chili. Indosso falsi occhiali da vista rotondi con la montatura in tartaruga rossa, magliette nere, false giacche Armani e sandali di tela che si trovano solo a Miami o a Los Angeles. Ho un nome diverso. Ho una voce diversa e un diverso modo di parlare. E tutta questa sceneggiata è stata accuratamente messa in atto non per ingannare gente che vuole pedinarmi o uccidermi, ma solo per nascondere la mia vera identità proprio a te, Mr Nathan Cooley. Rispondo: «Sono alto poco più di un metro e ottanta, nero, magro, testa rasata. Indosserò un cappello di paglia bianco, tipo panama». «Lei è nero?» scappa detto a Nathan. «Già. È un problema?» «No. Ci vediamo domani.» Torno al tavolo dove Vanessa mi aspetta ansiosa. Le dico sottovoce: «Era Cooley. Lo vedo domani». Mi sorride. «E vai!» mi dice. Finiamo la cena e ci salutiamo a malincuore. Fuori dal ristorante ci baciamo e ci comportiamo come una coppia di adolescenti. Penso a Vanessa per tutto il viaggio fino a Roanoke. Arrivo con quindici minuti di anticipo e mi posiziono in modo da poter osservare i veicoli che entrano nel parcheggio di Spanky’s. La prima cosa che vedrò di lui sarà la sua auto, o pickup, e questo mi dirà parecchio. Sei mesi fa era in prigione, dove ha scontato poco più di cinque anni. Non ha un padre, sua madre è alcolista e non è andato oltre i primi anni delle superiori, per cui la sua scelta del mezzo di trasporto risulterà interessante. Il mio piano è di prendere mentalmente nota, mentre parleremo, di tutto ciò che potrò vedere di lui: abiti, gioielli, orologio, cellulare. Il traffico si fa più intenso con l’arrivo dei clienti per il pranzo. A mezzogiorno e tre minuti compare un pickup Chevrolet Silverado da mezza tonnellata, nuovo di zecca, che sospetto apTeilenga a Cooley. Infatti è così. Nathan si ferma sul lato opposto del parcheggio e, mentre si dirige verso l’ingresso del ristorante, si guarda intorno nervosamente. Sono passati quattro anni dall’ultima volta che l’ho visto e sembra essere cambiato ben poco. Stesso peso e stessi capelli biondi unti, anche se in prigione teneva la testa rasata. Guarda due volte la targa della Florida della mia auto e poi entra. Io faccio un respiro profondo, mi metto il panama in testa e varco la porta. “Sta’ calmo, idiota” mi ordino, mentre sento torcersi le budella. Saranno necessari mano ferma e nervi d’acciaio. Ci incontriamo nell’ingresso del ristorante e ci presentiamo. Mi tolgo il cappello mentre seguiamo la direttrice di sala fino a un séparé in fondo al locale. Ci sediamo l’uno di fronte all’altro e parliamo del tempo. Per un momento sono quasi sopraffatto dall’enormità del mio inganno. Nathan sta parlando con uno sconosciuto, io con un ragazzo che un tempo conoscevo molto bene. Non sembra per niente sospettoso: non mi studia gli occhi o il naso, non socchiude gli occhi, non inarca le sopracciglia e non fissa lo sguardo nel vuoto mentre ascolta la mia voce. E, grazie al cielo, non dice: “Lei mi ricorda un tale che conoscevo”. Niente, finora. Ordino una birra grande alla spina, e Nathan esita prima di dire alla cameriera: «Lo stesso anche per me». Il successo di questa missione, che ha scarse probabilità di riuscita, potrebbe benissimo dipendere dall’alcol. Nathan è cresciuto in una cultura fatta di grandi bevute e di dipendenza da metanfetamina. Poi ha passato cinque anni in prigione, sobrio e pulito. Adesso che è fuori, presumo che sia tornato alle vecchie abitudini. Il fatto che sia il proprietario del bar dove lavora è una buona indicazione. Per essere un ragazzo di campagna al quale nessuno ha mai insegnato come ci si veste, Nathan è okay. Jeans délavé, una maglietta con il logo della Coors Light che qualche rappresentante gli ha lasciato al bar e stivali da combattimento. Niente gioielli e niente orologio, però ha un tatuaggio da galera incredibilmente brutto all’interno dell’avambraccio sinistro. In poche parole, Nathan non fa esibizione di ricchezza con il suo aspetto. Arrivano le birre e facciamo cincin. «Mi parli di questo progetto» dice Nathan. Per abitudine annuisco, taccio per un attimo e poi mi raccomando di parlare lentamente, in modo chiaro e con la voce più profonda possibile. «Faccio film documentari da dieci anni e questo è il progetto più emozionante che mi sia mai capitato.» «Senta, Mr Baldwin, che cos’è un film documentario, esattamente? Io vado al cinema come tutti, ma non credo di averne visti molti.» «Certo. Tipicamente, i film documentari sono piccole realizzazioni indipendenti che non arrivano nelle grandi sale. Non sono prodotti commerciali. Parlano di gente vera, di problemi veri, di temi veri. Niente a che vedere con le grandi star e simili. È roba davvero buona. I migliori vincono premi ai festival cinematografici e richiamano un po’ d’attenzione, ma non fanno mai molti soldi. La mia società è specializzata in lavori che parlano dell’abuso di potere, soprattutto da Teile del governo federale, ma anche delle grandi società.» Bevo un sorso e mi dico di rallentare. «La maggior Teile dei film documentari dura circa un’ora. Questo in Teilicolare potrà forse arrivare a novanta minuti, ma lo decideremo in seguito.» La cameriera è tornata. Io ordino un sandwich al pollo, Nathan chiede un cestino di ali di pollo. «E lei com’è finito nel ramo bar?» chiedo. Nathan beve un sorso e sorride. «Un amico. Il proprietario del bar aveva problemi economici, non per via del locale, ma di altre proprietà. Colpa della recessione, immagino. Così voleva sbarazzarsi del Bombay’s e cercava un pazzo che glielo comprasse e si prendesse anche i debiti. Io ho pensato: che diavolo, ho solo trent’anni, non ho un lavoro, non ho prospettive, perché non provarci? Finora, comunque, ci sto guadagnando. Ed è anche divertente. Un mucchio di ragazze del college vengono a ciondolare nel bar.» «Lei non è sposato?» «No. Non so cosa sappia di me, Mr Baldwin, ma ho appena finito di scontare cinque anni di carcere. Grazie al governo federale, non ho avuto molti appuntamenti di recente; sto rientrando in gioco solo adesso. Capisce cosa intendo?» «Certo. La prigione è stata conseguenza dello stesso incidente nel quale è stato ucciso suo fratello, giusto?» «Sì, è così. Mi sono dichiarato colpevole e mi hanno messo dentro per cinque anni. Mio cugino è ancora in galera, Big Sandy in Kentucky, un brutto posto. Quasi tutti i miei cugini sono al fresco o morti. È la ragione per la quale mi sono trasferito a Radford, Mr Baldwin, per allontanarmi dal business della droga.» «Capisco. Chiamami Reed, per favore. Mr Baldwin è mio padre.» «Okay. E io sono Nathan, o Nate.» Facciamo di nuovo cincin come se all’improvviso fossimo molto più amici. In prigione lo chiamavamo Nattie. «Parlami della tua società» dice. Avevo previsto la domanda, ma è comunque un terreno scivoloso. Bevo un sorso e lo mando giù lentamente. «La Skelter è una società nuova con sede a Miami. Solo io insieme a due soci, più il personale amministrativo. Ho lavorato anni per una grossa società di Los Angeles, la Cove Creek Films, forse l’hai sentita nominare.» Invece no. Nate ha appena lanciato un’occhiata al posteriore di una giovane cameriera formosa. «Comunque, la Cove Creek ha vinto un sacco di premi e ha fatto un bel po’ di soldi, ma l’anno scorso è andata in pezzi: liti tremende su chi doveva avere il controllo creativo e su quali progetti realizzare. Siamo ancora nel bel mezzo di una brutta causa che credo si trascinerà per anni. C’è un’ingiunzione presso la corte federale di Los Angeles che mi proibisce addirittura di parlare della Cove Creek e della causa. Pazzesco, eh?» Con mio grande sollievo, Nathan sta rapidamente perdendo interesse nella mia casa di produzione e relativi problemi. «Come mai la sede è a Miami?» «C’ero stato qualche anno fa per un film su certi fornitori fasulli della Difesa e mi sono innamorato del posto. Vivo a South Beach. Ci sei mai stato?» «No.» A Teile le gite organizzate dall’ US Marshals Service, Nathan non si è mai avventurato a più di trecento chilometri da Willow Gap. «È un posto eccitante. Belle spiagge, ragazze stupende, vita notturna scatenata. Ho divorziato quattro anni fa e mi sto godendo di nuovo la vita da single. Trascorro circa sei mesi l’anno a Miami. Gli altri sei li passo sulla strada, a lavorare.» «Come si fa un film documentario?» chiede Nathan, che poi manda giù un altro po’ di birra. «È molto diverso da un film normale. Di solito siamo solo io e l’operatore, più magari un tecnico o due. L’elemento più importante è la storia, non la scenografia o la faccia dell’attore.» «E tu vuoi fare un film con me?» «Assolutamente sì. Con te e forse tua madre, magari qualche altro tuo parente. Voglio andare nel luogo dove è stato ucciso tuo fratello. Quello che cerco, Nathan, è la verità. Ho trovato qualcosa, qualcosa che potrebbe essere davvero una bomba. Se riesco a provare che la DEA elimina sistematicamente gli spacciatori, che li uccide a sangue freddo, allora forse potremo incastrare quei figli di puttana. Mio nipote aveva preso una brutta strada, era sempre più coinvolto nello spaccio di crack, ma non era un grosso trafficante, e neppure un violento. Stupido, sì, ma non pericoloso. Aveva diciassette anni, era disarmato e gli hanno sparato tre volte a bruciapelo. Sulla scena è stata rinvenuta una pistola rubata e la DEA ha sostenuto che apTeileneva a lui. Sono un branco di bugiardi.» Il viso di Nathan si sta lentamente contorcendo dalla rabbia. Sembra quasi sul punto di sputare. Insisto: «Il film sarà la storia di tre, forse quattro di questi omicidi. Non so ancora se includeremo anche quella di mio nipote, dato che il regista sono io. Forse la sua morte mi tocca troppo da vicino. Ho già lavorato sulla storia di Jose Alvarez ad Amarillo, Texas: un operaio diciannovenne, immigrato clandestino, colpito da quattordici colpi sparati da agenti della DEA. Il problema è che nessuno della sua famiglia parla inglese e non c’è molta solidarietà nei confronti degli immigrati clandestini. E poi c’è Tyler Marshak, uno studente di college californiano che vendeva piccole quantità di marijuana. Gli agenti della DEA hanno fatto irruzione nella sua stanza al dormitorio come una squadra della Gestapo e gli hanno sparato, ammazzandolo nel suo letto. Forse hai letto qualcosa». Nathan non ha letto. Il Nathan Cooley che ho conosciuto io passava ore e ore a giocare ai videogame e non ha mai degnato di un’occhiata un quotidiano o una rivista. E non ha neppure quella curiosità innata che potrebbe spingerlo a fare ricerche sulla Skelter Films o la Cove Creek. «Ho già ottime riprese della stanza al dormitorio e dell’autopsia; ho anche le testimonianze dei familiari, che però al momento sono invischiati in una causa contro la DEA. È possibile che non possa utilizzare quel materiale.» Arriva il pranzo e ordiniamo altra birra. Nathan stacca a morsi dall’osso la carne di pollo e si pulisce la bocca con il tovagliolo. «Perché sei così interessato al caso di mio fratello?» «Diciamo che sono curioso. Non conosco ancora tutti i dettagli. Mi piacerebbe sentire la tua versione su quello che è successo e ricostruire con te sulla scena l’intera operazione antidroga. I miei avvocati hanno presentato richieste ufficiali in base alla legge sulla libertà d’informazione per avere i fascicoli della DEA e anche quelli del tribunale. Esamineremo tutta la documentazione, ma è molto probabile che la DEA abbia coperto tutto. È quello che fanno sempre. Poco alla volta metteremo insieme tutti i pezzi e, allo stesso tempo, valuteremo come tu e i tuoi familiari risultate sullo schermo. La videocamera non ama tutti, Nathan.» «Dubito che possa amare mia madre.» «Vedremo.» «Non so. Probabilmente non accetterà. Basta accennare alla morte di Gene e lei crolla.» Si lecca le dita e sceglie un’altra ala di pollo. «Perfetto. È proprio quello che voglio catturare nel film.» «Qual è il programma? Di che tempi stiamo parlando?» Mordo un boccone del mio sandwich e mastico per un po’ mentre rifletto. «Forse un anno. Mi piacerebbe finire tutto entro i prossimi sei mesi, in modo da averne altri sei per tagliare, montare, editare, forse girare qualcosa di nuovo. Si può continuare a tornarci sopra all’infinito ed è difficile decidere quando fermarsi. Per quello che ti riguarda, vorrei fare qualche ripresa iniziale, tre o quattro ore, e mandare il materiale ai miei producer e montatori a Miami, in modo che ti vedano, ti sentano parlare e si facciano un’idea della storia e della tua capacità di raccontarla. Se alla fine saremo tutti d’accordo, continueremo le riprese.» «Io cosa ci guadagno?» «Niente, a Teile la verità e la possibilità di denunciare gli uomini che hanno ucciso tuo fratello. Pensaci, Nathan. Non ti piacerebbe vedere quei bastardi accusati d’omicidio e mandati sotto processo?» «Accidenti se mi piacerebbe.» Continuo deciso l’attacco, gli occhi in fiamme. «Allora deciditi, Nathan. Raccontami la tua storia. Non hai niente da perdere e molto da guadagnare. Parlami del commercio della droga e di come ha rovinato la tua famiglia, di come Gene ci si è ritrovato in mezzo, di come quello fosse semplicemente un sistema di vita da queste Teili perché non c’erano altri lavori. Non dovrai fare nomi: non voglio mettere nessuno nei guai.» Un ultimo sorso e finisco la mia seconda birra. «Dov’era Gene l’ultima volta che lo hai visto?» «Era steso a terra, con le mani dietro la schiena perché lo stavano ammanettando. Non era stato esploso un colpo, da Teile di nessuno, e l’operazione della DEA era finita. Io ero ammanettato e mi stavano portando via, quando ho sentito gli spari. Hanno detto che Gene aveva fatto lo sgambetto a un agente ed era scattato di corsa verso il bosco. Stronzate. L’hanno ucciso a sangue freddo.» «Devi raccontarmi questa storia, Nathan. Devi portarmi sul posto e ricostruire la scena. Il mondo deve sapere cosa sta combinando il governo nella sua guerra contro la droga. Non fa prigionieri.» Nathan fa un respiro profondo per lasciar passare il momento. Io sto parlando troppo, e troppo in fretta, così per qualche minuto mi dedico al mio sandwich. La cameriera ci chiede se vogliamo un altro giro di birre. «Per me sì, per favore» rispondo, e Nathan segue subito il mio esempio. Finisce di mangiare un’ala, si lecca le dita e poi dice: «La mia famiglia mi sta creando delle difficoltà, al momento. È per questo che mi sono trasferito a Radford». Mi stringo nelle spalle come se fossero affari suoi, non miei, ma non sono sorpreso. «Se tu collabori e il resto della tua famiglia no, ci saranno altri problemi?» domando. Nathan ride. «I problemi sono la regola, per i Cooley. Siamo famosi per le lotte in famiglia.» «Allora andiamo avanti e firma il contratto. È di una sola pagina, già redatto dai miei avvocati in un inglese così semplice che non hai bisogno di cercarti un legale tuo, a meno che non ti diverta a buttare via i soldi. Il contratto dice che tu, Nathan Cooley, collaborerai alla realizzazione di questo film documentario. In cambio riceverai una retribuzione di ottomila dollari, il minimo riconosciuto agli attori per questo tipo di progetti. Ogni tanto, o in qualunque momento tu voglia, potrai esaminare il materiale in lavorazione, e, questo è cruciale, se ciò che vedrai non ti piacerà potrai chiamarti fuori e io non potrò usare le riprese in cui compari tu. È un accordo molto equo.» Nathan annuisce mentre riflette su possibili fregature, ma Nathan non è tipo da analizzare le cose rapidamente. Inoltre, l’alcol lo sollecita ad agire. Sospetto che stia già sbavando alla parola “attore”. «Ottomila dollari?» ripete. «Sì. Come ti dicevo, i nostri sono lavori a basso costo. Nessuno guadagnerà montagne di soldi.» Il punto interessante qui è che ho pronunciato la parola soldi prima che lo facesse lui. Addolcisco la proposta aggiungendo: «Inoltre, avrai diritto a una piccola quota degli incassi. Significa che intascherai qualche dollaro in più, se il film venderà un po’ di biglietti al botteghino, però non ci contare. Ma tu non devi fare questa cosa per soldi, Nathan. La devi fare per tuo fratello». Il piatto davanti a Cooley è pieno di ossa di pollo. La cameriera ci serve il nostro terzo giro di birre e porta via gli avanzi. È importante continuare a far parlare Nathan perché non voglio che pensi troppo. «Che tipo di persona era Gene?» domando. Nathan scuote la testa e sembra quasi sul punto di piangere. «Era il mio fratellone. Nostro padre se n’è andato quando eravamo ancora piccoli. Eravamo solo noi due, io e Gene.» Mi racconta qualche episodio della loro infanzia, storie buffe di due ragazzini che cercano di sopravvivere. Finiamo la nostra terza birra e ordiniamo un altro giro, ma giuriamo che sarà l’ultimo. Alle dieci del giorno dopo, Nathan e io ci incontriamo in un bar a Radford. Lui legge il contratto, mi fa qualche domanda e firma. Io firmo nella mia veste di vicepresidente della Skelter Films e gli consegno un assegno di ottomila dollari emesso da un conto corrente societario a Miami. «Quando si inizia?» chiede Nathan. «Be’, sono già qui e non devo Teilire. Prima cominciamo, meglio è. Cosa ne dici di domattina?» «Bene. Dove?» «Ci ho pensato. Siamo nel Southwest Virginia, dove le montagne sono importanti. In effetti, il territorio ha molto a che fare con la storia: l’isolamento delle montagne e così via. Mi piacerebbe girare in esterni, almeno all’inizio. Poi possiamo sempre spostarci. Tu abiti in città o in campagna?» «Ho un posto in affitto appena fuori città. Dal cortile sul retro c’è una bella vista delle colline.» «Diamoci un’occhiata. Verrò da te domattina alle dieci con una piccola troupe e controlleremo la luce.» «Okay. Senti, ho parlato con mia madre e ha detto di no.» «Posso provarci io?» «Fa’ pure, ma è parecchio tosta. Non le piace l’idea di te o di chiunque altro che fa un film su Gene e la nostra famiglia. Ha paura che ci farai passare per un branco di montanari ignoranti.» «Le hai spiegato che hai il diritto di controllare il film a mano a mano che viene girato?» «Ho tentato, ma aveva bevuto.» «Mi dispiace.» «Ci vediamo domattina.» 30 Nathan vive in una casetta di mattoni rossi in una strada stretta, a qualche chilometro dal confine occidentale di Radford. L’abitante più prossimo occupa una casa mobile doppia, più vicino di un chilometro alla statale. Il prato davanti all’abitazione di Cooley è tosato con cura e ci sono alcuni cespugli allineati sotto la piccola veranda. Quando arriviamo e parcheggiamo dietro il suo lucente pickup nuovo, sta giocando con un labrador color miele. La mia troupe consiste nella nuova assistente, Vanessa, che per questo progetto si chiamerà Gwen, e in due freelance di Roanoke: Slade, il videografo, e Cody, il suo assistente. Slade si definisce un filmmaker e lavora nel suo garage. È proprietario delle videocamere e di tutta l’attrezzatura, ed è perfettamente in Teile: capelli lunghi raccolti in una coda di cavallo, jeans con strappi alle ginocchia, un paio di catene d’oro al collo. Cody è più giovane e sufficientemente trasandato. La loro tariffa è di mille dollari al giorno più le spese, e Teile del nostro accordo è che facciano quello che devono fare e parlino il meno possibile. Ho promesso di pagarli in contanti e non ho fatto alcun cenno alla Skelter Films o a qualsiasi altra cosa. Può trattarsi di un film documentario o di qualcos’altro. Fate quello che vi dico e non fornite dettagli a Nathan Cooley. Vanessa è arrivata a Radford ieri sera e abbiamo passato la notte insieme in un accogliente hotel, dove ci siamo registrati a suo nome e abbiamo utilizzato una carta di credito prepagata. Vanessa ha detto al suo capo di avere l’influenza e che, ordine del medico, non potrà uscire di casa per diversi giorni. Non ha la minima idea di come si faccia un film, ma d’altra Teile non lo so neppure io. Dopo un giro di goffe presentazioni nel vialetto, diamo un’occhiata al posto. Il prato dietro casa è una vasta area aperta che sale sul fianco della collina. Un branco di cervi dalla coda bianca supera con un salto uno steccato appena ci vede. Chiedo a Nathan quanto tempo impiega per tagliare l’erba e mi risponde tre ore. Indica una tettoia, sotto la quale vedo un sontuoso trattorino tosaerba John Deere. Sembra nuovo. Nathan mi dice di essere un ragazzo di campagna che ama vivere all’aperto, andare a caccia e a pesca e fare pipì dalla veranda dietro casa. Inoltre pensa spesso alla prigione e alla vita là dentro, con mille uomini che devono sopravvivere in ambienti ristretti. No, grazie: a lui piacciono i grandi spazi. Mentre noi due camminiamo e parliamo, Slade e Cody vagano in giro e borbottano tra loro, guardando il sole e sfregandosi il mento. «Mi piace qui» annuncio, indicando il posto e assumendo il comando. «Voglio quelle colline nell’inquadratura.» Slade non sembra essere d’accordo, ma insieme a Cody comincia comunque a scaricare l’attrezzatura dal furgone. I preparativi si protraggono per un’eternità e, per dimostrare il mio temperamento artistico, comincio ad abbaiare a proposito del tempo che stiamo perdendo. Gwen ha portato con sé un kit per il trucco e Nathan accetta con riluttanza una passata di cipria e fard. Sono sicuro che per lui questa è la prima volta, ma ho bisogno che si senta un attore. Gwen indossa una gonna molto corta con una camicetta quasi sbottonata, e Teile del suo compito consiste nel verificare con quanta facilità si possa distrarre il ragazzo. Fingo di controllare i miei appunti, ma osservo Nathan che osserva Gwen. Cooley adora sia l’attenzione che la distrazione. Quando videocamera, luci, monitor e audio sono quasi pronti, prendo Nathan da Teile: solo noi due, il regista e la sua star, per spiegargli la mia visione. «Okay, Nathan. Voglio che tu sia molto serio. Pensa a Gene, al suo omicidio per mano del governo federale. Ti voglio composto. Niente sorrisi, niente di buffo, okay?» «Capito.» «Parla lentamente, quasi con dolore. Io ti farò le domande; tu guarda l’obiettivo e parla. Sii naturale. Sei un bel ragazzo e credo che la videocamera ti amerà, ma è importante che tu sia te stesso.» «Ci proverò» mi assicura, ed è chiaro che non vede l’ora di cominciare. «Un’ultima cosa, avrei dovuto parlartene ieri. Se questo film avrà l’effetto che speriamo e farà saltare la copertura d e lla DEA, forse ci saranno delle rappresaglie, delle ritorsioni. Non mi fido della DEA, sono un branco di delinquenti e possono fare qualsiasi cosa. Per questo è importante che tu sia... diciamo fuori dal giro.» «Sono pulito, amico» assicura Nathan. «Non stai spacciando? In nessun modo?» «Cavolo, no. Non ho intenzione di tornare dentro. È il motivo per cui sono venuto a stare qui, lontano dalla famiglia. Loro continuano a preparare e vendere metanfetamina, io no.» «Okay. Adesso concentrati su Gene.» Cody gli sistema il microfono e tutti prendiamo posizione. Siamo su un set, con le sedie pieghevoli, le luci e i cavi tutto intorno a noi. La videocamera è sopra la mia spalla e per un momento mi sento come un autentico, intrepido giornalista investigativo. Guardo Gwen e le dico: «Hai dimenticato le foto? Andiamo, Gwen!». Lei salta in piedi mentre sto ancora abbaiando e afferra una macchina fotografica. «Solo un paio di scatti, Nathan, in modo da avere una documentazione precisa delle luci.» All’inizio Cooley aggrotta la fronte, ma poi sorride a Gwen che lo inquadra. Finalmente, dopo un’ora dal nostro arrivo, cominciamo a girare. Impugno una penna nella mano sinistra e scribacchio su un blocco. Malcolm Bannister era destro, nel caso Nathan sia sospettoso. Cosa che non sembra essere. Per farlo sciogliere, comincio con i fondamentali: nome, età, occupazione, studi, precedenti penali, eventuali figli o matrimoni eccetera. Un paio di volte lo invito a rilassarsi, o a ripetere qualcosa, stiamo solo facendo conversazione. La sua infanzia: case, scuole, la vita con il fratello maggiore – Gene –, padre assente, un rapporto tormentato con la madre. A questo punto, Nathan dice: «Senti, Reed, non ho intenzione di parlare male di mia madre, okay?». «Naturalmente no. Non è quello che avevo in mente.» E cambio subito argomento. Arriviamo alla cultura della metanfetamina in cui è cresciuto. Con qualche esitazione, finalmente si apre e dipinge il quadro deprimente di un’adolescenza difficile fatta di droga, alcol, sesso e violenza. A quindici anni sapeva come “cucinare” la metanfetamina. Due suoi cugini sono bruciati vivi quando è esploso il laboratorio che avevano installato in una casa mobile. Nathan aveva sedici anni quando ha visto per la prima volta l’interno di una cella. A quel punto ha lasciato la scuola, e la vita è diventata ancora più folle. Almeno quattro suoi cugini sono finiti dentro per spaccio di droga; due sono ancora al fresco. Ma per quanto brutta sia stata la prigione, è servita ad allontanarlo dagli stupefacenti e dall’alcol. Nei cinque anni passati in carcere si è ripulito e ora è deciso a restare alla larga dalla metanfetamina. La birra è tutta un’altra storia. A mezzogiorno facciamo una pausa. Il sole è perpendicolare e Slade è preoccupato per la luce troppo intensa. Lui e Cody se ne vanno in giro, cercando un’altra postazione. «Per quanto tempo puoi lavorare con noi oggi?» chiedo a Nathan. «Il capo sono io» risponde orgoglioso. «Posso andare al bar quando voglio.» «Splendido. Facciamo altre due ore?» «Perché no? Come sto andando?» «Alla grande. Ci hai messo un po’ a scioglierti, ma adesso sei molto spontaneo, molto autentico.» «Sei un raccontatore fantastico, Nathan» aggiunge Gwen. A Cooley questo fa piacere. Gwen riTeile con il numero del trucco, asciugandogli il sudore dalla fronte, spazzolandolo, ritoccandolo, flirtando, mostrandosi un po’. Nathan è assetato di attenzioni. Andiamo a prendere sandwich e bibite e mangiamo all’ombra di una quercia vicino al capanno per gli attrezzi. A Slade il posto piace e decidiamo di trasferire qui il set. Gwen bisbiglia qualcosa a Nathan a proposito del bagno. La richiesta lo mette a disagio, ma ormai non riesce quasi più a staccare gli occhi dalle gambe di Gwen. Io mi allontano e fingo di parlare al cellulare con importanti personaggi di Los Angeles. Gwen scompare al di là della porta sul retro. In seguito riferirà che la casa ha due camere da letto, di cui una sola però arredata; un soggiorno spoglio, a Teile un divano, una poltrona e un enorme televisore ad alta definizione; un bagno che ha bisogno di una bella pulita; una cucina con un acquaio pieno di piatti sporchi e un frigo colmo di birre e salumi. C’è anche una soffitta alla quale si accede con una scala retrattile. I pavimenti sono rivestiti da una moquette dozzinale. Gli accessi sono tre – la porta davanti, quella sul retro e quella del garage – e tutti e tre sono dotati di robuste serrature di sicurezza, chiaramente installate da poco. Non sembra esserci un sistema d’allarme: nessuna tastiera e nessun sensore alle finestre o alle porte. In un armadio in camera da letto ci sono due fucili e due doppiette. Nella cabina armadio della camera degli ospiti c’è soltanto un paio di stivali da caccia infangati. Mentre Gwen è in casa, io continuo la mia finta telefonata e osservo Nathan da dietro i miei grandi occhiali da sole. Ha lo sguardo puntato sul retro di casa, innervosito dal fatto che la ragazza sia dentro da sola. Slade e Cody stanno riallestendo il set. Quando Gwen ricompare, Nathan si rilassa e si scusa per il disordine domestico. Lei lo tranquillizza tubando e si mette al lavoro sui suoi capelli. Quando tutto è pronto, ci tuffiamo nella sessione pomeridiana. Nathan ci parla di un incidente in moto avvenuto quando aveva quattordici anni e io disseziono l’episodio per mezz’ora. Ci soffermiamo sulla sua scarna storia lavorativa: capi, colleghi, mansioni, salari, dimissioni o licenziamenti. Poi torniamo sul commercio di droga con dettagli su come si prepara la metanfetamina, chi glielo ha insegnato, quali sono gli ingredienti chiave e così via. Storie d’amore? Fidanzate? Nathan dichiara di avere messo incinta una sua giovane cugina quando aveva vent’anni, ma non ha idea di cosa sia successo alla madre o al bambino. Prima di finire in prigione aveva una storia seria con una ragazza, ma poi lei lo ha lasciato. A giudicare da come guarda Gwen, è evidente che è parecchio eccitato. Ha trent’anni e, a Teile la morte del fratello e il periodo in carcere, la sua vita è priva di eventi significativi. Dopo tre ore passate a sollecitarlo e interrogarlo, ho esaurito qualsiasi elemento di interesse. Mi informa che deve andare al lavoro. «Devi mostrarmi il luogo dove è stato ucciso Gene» dico, mentre Slade spegne la videocamera e tutti si rilassano. «È poco fuori Bluefield, a circa un’ora da qui.» «Bluefield, West Virginia?» domando. «Esatto.» «Come mai eravate là?» «Dovevamo fare una consegna, ma l’acquirente era un informatore della polizia.» «Devo vedere il posto, Nathan, per ripercorrere e far rivivere la scena, la violenza, il momento in cui Gene è stato colpito e ucciso. Era notte, vero?» «Sì, molto dopo mezzanotte.» Gwen gli sta struccando il viso con un fazzoletto. «Vieni davvero molto bene in video» dice sottovoce. Nathan sorride. «Quando possiamo andarci?» chiedo. Cooley si stringe nelle spalle. «Quando preferisci. Domani, se vuoi.» Perfetto. Stabiliamo di ritrovarci qui domattina alle nove per poi muoverci attraverso le montagne e inoltrarci in West Virginia, fino alla miniera abbandonata dove i fratelli Cooley sono caduti in trappola. Quella trascorsa con Nathan è stata una buona giornata. Lui e io siamo andati alla grande nei rispettivi ruoli di regista e attore, e in certi momenti Nathan e Gwen sembravano pronti a spogliarsi e darci dentro. Nel tardo pomeriggio vado con lei al Bombay’s nella Main Street di Radford, nei pressi del campus. Ci sediamo a un tavolo vicino al bersaglio delle freccette. È ancora troppo presto per la folla dei ragazzi del college, anche se al bar c’è già qualche scalmanato che approfitta dell’happy hour. Chiedo alla cameriera di comunicare a Nathan Cooley la nostra presenza e nel giro di pochi secondi lui compare, con un grande sorriso. Lo invitiamo a sedersi con noi, cosa che fa, e cominciamo con la birra. Gwen beve poco e riesce a sorseggiare un solo bicchiere di vino mentre Nathan e io ci facciamo qualche pinta. Gli studenti cominciano ad affluire e il locale diventa sempre più rumoroso. Mi informo sulle specialità del giorno e vedo che sulla lavagna compare il sandwich alle ostriche. Ne ordiniamo due e Nathan scompare per strillare al cuoco. Gwen e io ceniamo e ci tratteniamo finché fa buio. Non solo siamo gli unici due neri nel bar, ma siamo anche gli unici clienti di età superiore ai ventidue anni. Ogni tanto Nathan viene a vedere come ce la passiamo, ma è veramente molto indaffarato. 31 Alle nove del giorno dopo torniamo da Nathan, che anche questa volta sta giocando con il suo cane nel prato davanti a casa. Ho il sospetto che ci attenda fuori perché non vuole farci entrare in casa. Gli spiego che la mia Audi avrebbe bisogno di una messa a punto e che forse sarebbe meglio usare il suo pickup. I due viaggi di andata e ritorno ci regaleranno due ore da soli con Nathan, senza distrazioni. Lui scrolla le spalle e dice che va bene, nessun problema, e così Teiliamo, seguiti da Slade e Cody a bordo del loro furgone. Io siedo davanti, Gwen è rannicchiata nel sedile posteriore. Questa mattina è in jeans perché ieri Nathan non riusciva a staccarle gli occhi dalle gambe. Oggi sarà un po’ più riservata, tanto per tenere il ragazzo sulla corda. Mentre puntiamo a ovest verso le montagne, ammiro l’interno del pickup e spiego che mi è capitato raramente di viaggiare su veicoli di questo tipo. I sedili sono di pelle, c’è un navigatore satellitare di ultima generazione e così via. Nathan è molto orgoglioso del suo pickup e ne parla a lungo. Per cambiare argomento, torno a ripetergli che mi piacerebbe incontrare sua madre. Cooley dice: «Senti, se vuoi puoi provarci, ma a lei proprio non va giù quello che stiamo facendo. Le ho parlato di nuovo ieri sera e le ho illustrato il progetto. Le ho spiegato quanto è importante e che tu hai bisogno anche di lei, ma non ho concluso niente». «Non potrei almeno salutarla, conoscerla?» Sto quasi per voltarmi e sorridere a Gwen: adesso sappiamo che Nathan giudica il progetto “importante”. «Ne dubito. Mia madre è una donna difficile. Beve parecchio e ha un brutto carattere. Non siamo in buoni rapporti, in questo momento.» Essendo un giornalista investigativo determinato, decido di tuffarmi in temi delicati. «Perché hai lasciato l’attività di famiglia e ti guadagni da vivere con il bar?» «È una domanda molto personale, ti pare?» mi rimprovera Gwen da dietro. Nathan fa un respiro profondo e dà un’occhiata fuori dal finestrino. Stringe il volante con entrambe le mani e dice: «È una lunga storia, ma mia madre ha sempre dato la colpa a me per la morte di Gene, il che è una follia. Era lui il fratello maggiore, il capo della gang e del laboratorio di metanfetamina. Ed era anche tossicodipendente. Io no. Ogni tanto mi facevo anch’io, ma non ci sono mai cascato dentro. Gene, invece... lui era fuori controllo. Il posto dove stiamo andando adesso era quello dove effettuava una consegna una volta alla settimana. Qualche volta lo accompagnavo. Non avrei dovuto esserci la notte che ci hanno beccato. C’era un tizio, ma non farò nomi, che vendeva metanfetamina per nostro conto nella zona ovest di Bluefield. Noi non lo sapevamo, ma il tizio era stato arrestato, aveva perso la testa e aveva detto alla DEA dove e quando. Mio fratello e io siamo finiti in una trappola e giuro che non ho potuto fare niente per aiutare Gene. Come ti ho già raccontato, ci eravamo arresi e ci stavano arrestando. Ho sentito gli spari e Gene era morto. L’ho spiegato cento volte a mia madre, ma lei non mi ascolta. Gene era il suo preferito e la sua morte è tutta colpa mia». «È terribile» mormoro. «Tua madre veniva a trovarti in prigione?» chiede da dietro la voce dolce di Gwen. Un’altra lunga pausa. «Due volte.» Viaggiamo in silenzio per almeno cinque chilometri. Siamo sull’interstatale, adesso, e procediamo in direzione sudovest, accompagnati dalla musica di Kenny Chesney. Nathan si schiarisce la voce e dice: «A essere sincero, sto cercando di staccarmi dalla famiglia. Mia madre, i miei cugini, un branco di nipoti buoni a nulla. In giro si è già sparsa la voce che sono proprietario di un bel bar e che me la sto cavando bene, per cui tra un po’ quei pagliacci verranno a chiedermi soldi. Bisogna che mi allontani ancora di più». «Dove vorresti andare?» chiedo, con grande Teilecipazione. «Non molto lontano. A me piace la montagna, adoro fare escursioni e andare a pesca. Io sono un montanaro, Reed, e lo sarò sempre. Boone, North Carolina, non è male. Penso a un posto del genere, un posto dove non ci siano Cooley nell’elenco telefonico.» Ride, una breve risata triste. Qualche minuto dopo, ci manda nel panico. «Sai, avevo un amico in prigione che mi fa pensare a te. Malcolm Bannister, si chiamava. Un tipo in gamba, nero, veniva da Winchester, Virginia. Era avvocato e continuava a ripetere che i federali l’avevano sbattuto dentro senza alcun motivo valido.» Ascolto e annuisco, come se quello che Nathan sta dicendo non avesse la minima importanza. Mi sembra quasi di sentire Gwen irrigidirsi sul sedile posteriore. «Cosa ne è stato di lui?» riesco a chiedere. La mia bocca non è mai stata più arida. «Credo che Mal sia sempre dentro. Deve farsi ancora un paio d’anni, mi pare. Non ne ho più saputo niente. C’è qualcosa in te, nella voce, forse nel modo di fare, qualcosa che non riesco a definire... ma tu mi ricordi Mal.» «Il mondo è grande, Nathan» dico con voce ancora più profonda e totale indifferenza. «E tieni presente che per voi bianchi noi neri siamo tutti uguali.» Nathan ride e anche Gwen riesce produrre una risata forzata. Mentre ero in convalescenza a Fort Carson, ho lavorato con un esperto che mi ha ripreso per ore e ha compilato un elenco di abitudini e atteggiamenti che dovevo cambiare. Mi sono esercitato a lungo, ma poi, una volta arrivato in Florida, ho smesso di tenermi in allenamento. Movimenti e gesti spontanei sono difficili da abbandonare. La mia mente si è paralizzata e non trovo altro da dire. Gwen mi viene in aiuto. «Nathan, poco fa hai accennato ai tuoi nipoti. Quanto credi che andrà avanti tutta questa storia? Perché mi sembra che in molte famiglie il business della metanfetamina stia diventando un fatto generazionale.» Cooley aggrotta la fronte e riflette. «Secondo me non c’è speranza. Lavoro non ce n’è, a Teile l’estrazione del carbone, ma molti ragazzi non ne vogliono più sapere di andare a lavorare in miniera. Inoltre cominciano a farsi intorno ai quindici anni e a sedici sono già assuefatti. Le ragazze restano incinte a sedici anni, sono bambine che fanno bambini, e poi nessuno li vuole. E una volta che cominci a fare casini, non smetti più. Non vedo molto futuro qui in giro, non per gente come me.» Sto ascoltando, ma non recepisco. La testa mi gira mentre mi domando quanto sappia Nathan. Ha dei sospetti? Cos’ho fatto per suscitarglieli? Sono ancora sotto copertura – di questo sono certo –, ma lui cosa sta pensando? Bluefield, West Virginia, è una città di undicimila abitanti nell’estrema punta meridionale dello Stato, non lontano dal confine che sfioriamo percorrendo la Highway 52. Poco dopo ci ritroviamo su tragitti tortuosi che salgono e scendono vertiginosamente. Nathan conosce bene la zona, anche se sono passati anni dall’ultima volta che è stato qui. Ci immettiamo in una strada di campagna e ci inoltriamo in una valle. L’asfalto termina e zigzaghiamo su sentieri a ghiaia e in terra battuta finché ci fermiamo sulla riva di un torrente. Vecchie querce incombono alte e nascondono il sole. Le erbacce arrivano al ginocchio. «Siamo arrivati» annuncia Nathan, spegnendo il motore. Scendiamo dal pickup e dico a Slade e Cody di scaricare l’attrezzatura. Non impiegheremo luci artificiali e voglio che venga usata la videocamera piccola, quella a mano. I due si danno da fare, afferrando le loro cose. Nathan si avvicina alla riva del torrente e sorride all’acqua scrosciante. «Venivi qui spesso?» domando. «No, non spesso. Avevamo diversi punti di consegna intorno a Bluefield, ma questo era il principale. Gene operava qui da dieci anni, ma non io. Il fatto è che non Teilecipavo all’impresa quanto lui avrebbe voluto. Già allora prevedevo guai. Sai, cercavo di trovare altri lavori, di tirarmi fuori. Gene, invece, voleva che entrassi di più nel giro.» «Dove avevate parcheggiato?» Nathan si volta, indica con il dito e io decido di spostare il suo pickup e il furgone di Slade, in modo che i due veicoli non entrino nell’inquadratura. Basandomi sulla mia vasta esperienza di regista, decido per una sequenza d’azione con Nathan che si avvicina a piedi alla scena e la videocamera immediatamente alle sue spalle. Facciamo qualche prova e poi cominciamo a girare. Cooley fa anche il narratore. «Più forte, Nathan. Devi parlare a voce più alta» abbaio da un lato. Nathan si avvicina alla scena. «Gene e io siamo arrivati verso le due di notte. Eravamo a bordo del suo pickup, guidavo io. Quando ci siamo fermati, proprio qui, abbiamo visto l’altro veicolo laggiù, seminascosto fra quegli alberi, esattamente dove doveva essere.» Cooley continua a camminare e a indicare con la mano. «Sembrava tutto normale. Ci siamo fermati lì accanto e il nostro uomo, chiamiamolo Joe, scende e ci saluta. Noi ricambiamo e ci spostiamo sul retro del pickup di Gene. Dentro una cassetta degli attrezzi chiusa con un lucchetto ci sono circa quattro chili e mezzo di metanfetamina; è roba buona, quasi tutta cucinata da Gene in persona. Sotto un foglio di compensato c’è un piccolo frigo portatile, con altri quattro chili e mezzo. La consegna totale era intorno ai nove chili, per un valore all’ingrosso sui duecentomila dollari. Scarichiamo la merce dal pickup e la sistemiamo nel bagagliaio di Joe. Appena lui richiude il portellone si scatena l’inferno. Dovevano essere almeno dieci gli agenti della DEA che ci sono saltati addosso. Non so da dove arrivassero, ma sono stati veloci. Joe è scomparso, non ne ho più saputo niente. Hanno trascinato Gene accanto al suo pickup. Inveiva contro Joe e faceva ogni tipo di minacce. Io ero così spaventato che non riuscivo quasi a respirare. Ci avevano beccato con le mani nel sacco e sapevo che sarei finito in galera. Mi hanno ammanettato, mi hanno perquisito tasche e portafoglio e poi mi hanno scortato lungo il sentiero, quello laggiù. Mentre mi allontanavo, ho guardato dietro di me e sono riuscito a intravedere mio fratello steso a terra, con le mani dietro la schiena. Era furioso e continuava a imprecare. Qualche secondo dopo sono risuonati degli spari, e ho sentito Gene gridare quando è stato colpito.» «Stop!» ordino a voce alta. Cammino in cerchio per un momento, riflettendo. «Rifacciamola» dico. Torniamo tutti al punto di Teilenza. Dopo il terzo ciak, mi dichiaro soddisfatto e passo all’idea successiva. Chiedo a Cooley di andare nel punto esatto dove si trovava Gene quando lo ha visto per l’ultima volta. Sistemiamo una sedia pieghevole e Nathan si accomoda. Con la videocamera in funzione, domando: «Qual è stata la tua reazione quando hai sentito gli spari?». «Non potevo crederci. Gene era a terra e c’erano almeno quattro agenti della DEA in piedi intorno a lui. Mio fratello aveva già le mani dietro la schiena, anche se non era stato ancora ammanettato. Non era armato. Sul pickup c’erano una doppietta e due 9 millimetri, ma non avevamo preso niente con noi. Non mi interessa quello che ha sostenuto la DEA in seguito: Gene era disarmato.» «Ma quando hai sentito gli spari, cosa hai fatto?» «Mi sono fermato di colpo e urlato qualcosa come: “Cos’è stato? Cosa sta succedendo?”. Ho chiamato Gene, ma gli agenti mi spingevano avanti, lungo il sentiero. Non riuscivo a guardare indietro, ero troppo lontano. A un certo punto ho detto: “Voglio vedere mio fratello” ma loro si sono messi a ridere e hanno continuato a spingermi, al buio. Alla fine siamo arrivati a un furgone e mi hanno fatto salire. Mi hanno portato in prigione a Bluefield e per tutto il tempo io non ho fatto che chiedere di mio fratello. Cos’è successo? Dov’è Gene? Cosa gli avete fatto?» «Fermiamoci per un momento» dico a Slade. Guardo Nathan. «A questo punto è okay se fai vedere un po’ di emozione. Pensa alla gente che guarda questo film. Cosa vuoi che provino mentre ascoltano questa storia terribile? Rabbia? Amarezza? Tristezza? Sta a te trasmettere queste sensazioni, perciò riproviamoci, ma questa volta con delle emozioni. Puoi farlo?» «Ci provo.» «Vai, Slade. Allora, Nathan, quando hai saputo che tuo fratello era morto?» «La mattina dopo, in prigione, è venuto da me un vice con dei documenti da compilare. Io gli ho chiesto di Gene e lui mi ha risposto: “Tuo fratello è morto. Ha tentato di fuggire e gli agenti della DEA gli hanno sparato”. Proprio così. Nessuna comprensione, nessun riguardo, niente.» Nathan tace e deglutisce a fatica. Le labbra cominciano a tremargli e ha gli occhi umidi. Da dietro la videocamera, gli faccio segno alzando i pollici. Nathan continua: «Non sapevo cosa dire. Ero sotto shock. Gene non ha cercato di scappare. Gene è stato assassinato». Si asciuga una lacrima con il dorso della mano. «Mi dispiace» aggiunge sottovoce. Il ragazzo soffre davvero. Non sta recitando, le sue sono emozioni autentiche. «Stop» ordino, e facciamo una pausa. Gwen si precipita da Cooley con una spazzola e una manciata di fazzolettini di carta. «Bello, veramente bello» commenta. Nathan si alza in piedi e si avvicina al torrente, perso nei suoi pensieri. Dico a Slade di ricominciare a girare. Passiamo tre ore sul posto, girando e rigirando scene che mi invento su due piedi. Per l’una siamo tutti stanchi e affamati. Troviamo un fast food a Bluefield e ci rimpinziamo di hamburger e patatine fritte. Nel viaggio di ritorno a Radford, Nathan, Gwen e io restiamo in silenzio finché non ordino alla mia assistente di chiamare Tad Carsloff, uno dei miei soci a Miami. Il nome Carsloff è stato fatto dalla segretaria della CRS quando, due giorni fa, Nathan ha chiamato il numero della nostra sede. Fingendo una conversazione, Gwen dice: «Salve, Tad, sono Gwen. Benissimo, grazie, e tu? Sì, be’, adesso stiamo tornando a Radford con Nathan. Abbiamo passato la mattinata nel posto dove hanno ucciso suo fratello: materiale davvero impressionante. Nathan ha fatto un lavoro fantastico come narratore. Non ha bisogno di copione, è un talento naturale». Rubo un’occhiata a Cooley che siede al volante. Non riesce a trattenere un sorriso compiaciuto. Gwen continua il suo dialogo a senso unico. «Sua madre?» Pausa. «Non è ancora dei nostri. Nathan dice che non vuole saperne del film e che non lo approva. Reed vuole riprovarci domani.» Un’altra pausa. «Sta pensando di andare nella loro cittadina per filmare la tomba, parlare con i vecchi amici, magari con qualche collega, sai, quel tipo di cose.» Silenzio, mentre Gwen ascolta concentrata il nulla. «Sì, le cose non potrebbero andare meglio. Reed è felicissimo di questi primi due giorni di riprese e Nathan è una persona meravigliosa con cui lavorare. Ti ripeto: roba davvero impressionante. Reed dice che ti richiamerà nel pomeriggio. Ciao.» Viaggiamo in silenzio per qualche chilometro mentre Nathan si bea delle lodi. Poi chiede: «Quindi domani andiamo a Willow Gap?». «Sì. Ma tu non sei obbligato a venire, se non ne hai voglia» rispondo. «Immagino che dopo due giorni tu ne abbia già abbastanza di questa storia.» «Allora hai già finito con me?» domanda Cooley con voce triste. «Oh, no. Dopodomani torno a Miami e per qualche giorno mi studio il materiale. Cominceremo l’editing, cercando di accorciare un po’ il tutto. E poi, tra un paio di settimane, quando potrai lavorare con noi, torneremo per un altro giro di riprese.» «Hai detto a Nathan dell’idea di Tad?» mi domanda Gwen da dietro. «No, non ancora.» «A me sembra brillante» dice Gwen. «Di cosa si tratta?» chiede Nathan. «Tad è il miglior editor della nostra società. Lui e io lavoriamo insieme su tutto. Dato che questo film riguarda tre o quattro diverse famiglie, tre o quattro diversi omicidi, Tad ha suggerito l’idea di riunirvi tutti nello stesso posto, nello stesso momento, e di lasciare semplicemente che le videocamere vi riprendano. Vi mettiamo in una stanza, in un ambiente molto confortevole, e lasciamo che la conversazione fluisca. Niente copione, niente regia: solo i fatti nudi e crudi, nella loro brutalità. Come ti ho detto, abbiamo svolto ricerche su una decina di casi e tutti presentano grosse similitudini. Sceglieremo i tre o quattro migliori...» «Il tuo è il migliore in assoluto» interviene Gwen. «Lasceremo che voi, le vittime, confrontiate le vostre storie. Tad è convinto che sarebbe qualcosa di incredibilmente forte.» «Ha ragione» cinguetta Gwen. «A me piacerebbe molto.» «Tendo a essere d’accordo» dico. «Dove ci dovremmo riunire?» chiede Nathan, praticamente già a bordo. «Non abbiamo ancora deciso, ma è probabile che sarà a Miami.» «Nathan, sei mai stato a South Beach?» domanda Gwen. «No.» «Oh, ragazzi! Per un trentenne single... Non vorrai più riTeilire. Ci sono Teily non stop e le ragazze sono... Tu come le descriveresti, Reed?» «Non le ho notate» rispondo, come da copione. «Già. Diciamo solo che sono belle e sexy.» «Qui non si tratta di divertirsi» rimprovero la mia assistente. «Potremmo anche organizzare l’incontro nell’area di Washington, il che probabilmente sarebbe più comodo per le famiglie.» Nathan non dice niente, ma io so che il suo voto è per South Beach. Vanessa e io passiamo il pomeriggio in una stanza d’albergo a Pulaski, Virginia, mezz’ora d’auto a sudovest di Radford. Controlliamo i miei appunti di Fort Carson e cerchiamo ansiosamente di capire che cosa possa aver insospettito Nathan. Sentirlo pronunciare il nome di Malcolm Bannister è stato raggelante, adesso dobbiamo capire perché è successo. Malcolm si stringeva il naso tra pollice e indice quando pensava. Picchiettava la punta delle dita quando ascoltava. Inclinava leggermente la testa verso destra quando era divertito. Abbassava il mento quando era scettico. Premeva l’indice della mano destra sulla tempia destra quando una conversazione lo annoiava. «Tieni le mani ferme e lontane dalla faccia» mi consiglia Vanessa. «E parla con voce più profonda.» «Era troppo alta?» «Tende a tornare normale quando parli molto. Cerca di tacere di più. Meno parole.» Discutiamo su quanto possano essere allarmanti le perplessità di Cooley. Vanessa è convinta che il ragazzo sia completamente con noi e che non veda l’ora di una gita a Miami. È certa che nessuno del mio passato potrebbe riconoscermi. Tendo a essere d’accordo con lei, ma sono ancora sconvolto dall’innegabile realtà di Nathan che pronuncia il mio vecchio nome. Sono quasi sicuro di avere notato un luccichio nei suoi occhi quando lo ha fatto, come per dire: “Io so chi sei e so perché sei qui”. 32 Nathan insiste per venire con noi a Willow Gap, la cittadina dove è nato, così ci avventuriamo fra le montagne per la seconda mattina di seguito. Mentre Nathan guida, Gwen gli parla estasiata delle reazioni a Miami. Lo informa che Tad Carsloff e altri importanti personaggi in sede hanno visionato le nostre riprese e sono più che entusiasti. Sono entusiasti di Nathan in video e sono convinti che rappresenti il punto di svolta. Cosa ancora più importante, uno dei nostri principali investitori è in visita a Miami e per puro caso ha visto il filmato dalla Virginia. È rimasto talmente colpito che si è detto disposto a raddoppiare l’investimento. Quell’uomo vale una montagna di denaro e ritiene che il film dovrebbe avere una durata di almeno novanta minuti. Potrebbe portare all’incriminazione di gente della DEA. E sarebbe uno scandalo come a Washington non se ne sono mai visti. Ascolto queste chiacchiere mentre sono al telefono e sto teoricamente parlando con la nostra sede centrale. Non c’è nessuno all’altro capo della linea. Ogni tanto emetto un grugnito e faccio un’osservazione profonda, ma perlopiù ascolto, medito assorto e do l’impressione che il processo creativo può essere gravoso. Lancio un’occhiata a Nathan. Il ragazzo è con noi. Mentre facevamo colazione, Gwen ha sottolineato di nuovo che devo parlare il meno possibile, lentamente e con voce profonda, e che devo tenere le mani lontano dalla faccia. Sono lieto di lasciare parlare lei, cosa che sa fare benissimo. Gene Cooley è sepolto dietro una chiesa di campagna abbandonata, in un piccolo cimitero pieno di erbacce che conta un centinaio di tombe. Dico a Slade e a Cody che voglio parecchie inquadrature della tomba e dell’area circostante, poi mi allontano per un’altra telefonata importante. Nathan, ormai del tutto attore e pieno di sé, propone di inginocchiarsi di fianco alla tomba, e a Gwen l’idea sembra fantastica. Io annuisco da lontano, mentre continuo a sussurrare a nessuno con il cellulare premuto all’orecchio. Nathan riesce addirittura a produrre qualche altra lacrima e Slade zuma su di lui per un primo piano. Per la cronaca, Willow Gap conta cinquecento abitanti, che però non troverete mai. Il centro città è una viuzza appena un po’ cresciuta, con quattro edifici cadenti e un emporio con annesso ufficio postale. C’è qualche persona in giro e Nathan diventa nervoso. Conosce questa gente e non vuole essere visto insieme a una troupe cinematografica. Mi spiega che quasi tutti gli abitanti, compresi i suoi familiari e amici, vivono fuori città, lungo strette piste sterrate nelle profondità delle valli. È gente sospettosa per natura, e adesso capisco perché Cooley ha voluto accompagnarci. Le scuole che Nathan e Gene hanno frequentato non sono qui: i bambini di Willow Gap si fanno un’ora di autobus tutti i giorni. «Così è stato più facile decidere di mollare» dice, quasi a se stesso. Anche se con riluttanza, ci mostra il minuscolo cottage di quattro stanze, ora abbandonato, dove lui e suo fratello hanno abitato per circa un anno. «È l’ultimo posto dove ricordo di avere vissuto con mio padre. Io avevo circa sei anni, mi pare, per cui Gene doveva averne più o meno dieci.» Lo convinco a sedersi sugli scalini rotti dell’ingresso e a parlare, rivolto alla videocamera, di tutti i posti dove ha vissuto insieme a Gene. Per un momento Cooley dimentica tutto il glamour dell’attore e diventa scontroso. Gli chiedo di suo padre, ma non vuole saperne. Si infuria, urla contro di me, e all’improvviso sta recitando di nuovo. Qualche minuto dopo, Gwen, chiaramente dalla sua Teile e arrabbiata con me, gli dice che è stato superbo. Nella cittadina ci sono un paio di chiese, ma i Cooley non ne frequentavano nessuna. Mentre ci attardiamo davanti alla baracca, io cammino avanti e indietro, perso in un tormentato processo creativo. Finalmente chiedo a Nathan dove abita sua madre. Lui indica una direzione e dice: «A circa dieci minuti da qui, lungo quella strada, però non ci andiamo, okay?». Accetto di malavoglia e mi allontano di nuovo per parlare al cellulare. Dopo due ore a Willow Gap e dintorni, abbiamo visto abbastanza. Rendo noto a tutti che non sono soddisfatto del materiale che abbiamo girato e divento irritabile. Gwen sussurra a Nathan: «Gli passerà». «Dov’era il laboratorio di Gene?» domando. «Non esiste più» risponde Nathan. «È saltato in aria poco dopo la sua morte.» «Fantastico» borbotto. Finalmente ricarichiamo tutta l’attrezzatura e ce ne andiamo. Pranziamo di nuovo con hamburger e patatine fritte in un fast food nei pressi di un’uscita dell’interstatale. Quando siamo di nuovo in viaggio, concludo un’altra telefonata immaginaria e poi metto il cellulare in tasca. Mi volto in modo da poter guardare Gwen. È evidente che ho grandi notizie. «Okay, ecco a che punto siamo. Tad è in continuo contatto con la famiglia Alvarez in Texas e con la famiglia Marshak in California. Nathan, forse ricorderai che ti ho parlato di questi due casi. Il ragazzo Alvarez è stato ucciso con quattordici colpi d’arma da fuoco da agenti della DEA. Il ragazzo Marshak dormiva nella sua stanza al college quando hanno fatto irruzione e gli hanno sparato prima ancora che si svegliasse. Ti ricordi?» Nathan annuisce mentre continua a guidare. «Hanno trovato un cugino nella famiglia Alvarez che parla un buon inglese e che è disposto a parlare. Mr Marshak ha fatto causa alla DEA e i suoi avvocati gli hanno detto di tenere la bocca chiusa, ma lui è veramente incazzato e vuole rendere pubblica la storia. Tutti e due possono essere a Miami in questo fine settimana, a nostre spese naturalmente. Tutti e due, però, hanno un lavoro, perciò dovremo girare di sabato. Due domande, Nathan: primo, vuoi venire a Miami per questo lavoro? E, secondo, puoi farlo con un preavviso così breve?» «Gli hai detto della DEA?» domanda Gwen prima che Cooley possa rispondermi. «Non ancora. L’ho saputo solo questa mattina.» «Che cosa?» si informa Nathan. «Credo di averti detto che i nostri avvocati avevano presentato tutta la documentazione necessaria per ottenere le copie dei fascicoli della DEA relativi a determinati casi, compreso quello di Gene. Ieri un giudice federale di Washington ha deliberato a nostro favore, più o meno. Possiamo visionare i fascicoli, ma non possiamo averli in nostro possesso. Per cui la DEA di Washington manderà le pratiche all’ufficio della DEA di Miami, dove avremo accesso al materiale.» «Quando?» vuole sapere Gwen. «Già lunedì.» «Nathan, tu vuoi vedere il fascicolo di Gene?» chiede Gwen, cauta e protettiva. Cooley non risponde subito, allora intervengo io: «Non ci faranno vedere tutto, ma ci saranno moltissime fotografie, rapporti sulla scena del delitto e dichiarazioni di tutti gli agenti. Probabilmente ci sarà anche la deposizione dell’informatore che vi ha fatto cadere in trappola. Ci saranno le perizie balistiche, l’autopsia, le foto. Potrebbe essere interessante». Nathan serra le mascelle e dice: «Voglio vedere». «Quindi, sei dei nostri?» domando. «Qual è il lato negativo?» chiede Cooley, e la domanda determina una lunga pausa di riflessione. Poi io dico: «Il lato negativo? Se stai ancora spacciando, la DEA ti piomberà addosso come una furia. Ne abbiamo già parlato». «Non spaccio. Te lo ripeto.» «Allora non c’è un lato negativo. Lo farai per Gene e per tutte le vittime d’omicidio della DEA. Lo farai per la giustizia.» «E South Beach ti piacerà da morire» aggiunge Gwen. Concludo l’affare dicendo: «Possiamo Teilire domani pomeriggio da Roanoke, volare dritto a Miami, girare sabato, continuare domenica e vedere i fascicoli della DEA lunedì mattina. Lunedì sera sarai già a casa». «Credevo che il jet ce l’avesse Nicky a Vancouver» osserva Gwen. «È così, ma sarà qui domani pomeriggio.» «Tu hai un jet?» chiede Nathan, e mi guarda in totale sbalordimento. Per Gwen e me la domanda è divertente. Rido e rispondo: «Non mio personale, ma la nostra società ne ha uno in affitto. Noi viaggiamo moltissimo e a volte un jet privato è l’unico modo per riuscire a lavorare». «Io non posso Teilire domani» ci informa Gwen, controllando i suoi impegni sull’iPhone. «Sarò a Washington, ma posso essere a Miami sabato. Non mi voglio perdere le tre famiglie nella stessa stanza, nello stesso momento. Incredibile.» «E il tuo bar?» domando a Nathan. «Sono io il proprietario» ribadisce soddisfatto. «Ho un ottimo gestore. E poi mi piacerebbe davvero andare fuori città per qualche giorno. Il bar significa lavorare dieci, dodici ore al giorno, sei giorni la settimana.» «E il tuo agente di controllo per la libertà vigilata?» «Sono libero di viaggiare. Devo solo avvertirlo, nient’altro.» «Com’è eccitante» dice Gwen, quasi squittendo di gioia. Cooley sta sorridendo come un bambino a Natale. Io, come sempre, sono l’emblema della professionalità. «Senti, Nathan, devo organizzare tutto immediatamente. Se andiamo a Miami, bisogna che tu me lo confermi adesso. Devo telefonare a Nicky per far arrivare il jet e devo chiamare anche Tad in modo che si occupi dei voli delle altre famiglie. Sì o no?» Senza esitare, Nathan risponde: «Sì. Andiamo». «Perfetto.» «Reed, quale hotel potrebbe andare bene per Nathan?» chiede Gwen. «Non saprei. Sono tutti buoni. Scegli tu.» Digito un numero sul mio cellulare e do inizio a un’altra conversazione unilaterale. «Nathan, vuoi alloggiare sulla spiaggia o a un isolato di distanza?» «Dove sono le ragazze?» domanda Cooley, e ride per il suo incredibile senso dell’umorismo. «Okay, allora la spiaggia.» Quando arriviamo a Radford, Nathan Cooley sa già di avere una prenotazione in uno degli hotel più eleganti del mondo, in una delle spiagge più trendy del mondo, dove arriverà a bordo di un jet privato. Il che è solo il minimo per un vero attore. Vanessa Teile per una folle corsa in direzione di Reston, Virginia, nell’area metropolitana di Washington, a circa quattro ore d’auto. La sua prima destinazione è un’organizzazione senza nome che occupa alcuni locali in affitto in un modesto centro commerciale lungo la strada. È il laboratorio di un gruppo di falsari di talento, in grado di creare virtualmente ogni documento su due piedi. Sono specializzati in passaporti, ma per il giusto prezzo possono fabbricare anche lauree, certificati di nascita, licenze di matrimonio, ordinanze del tribunale, libretti di circolazione, notifiche di sfratto, patenti di guida, referenze di credito... non c’è limite alle loro scelleratezze. Teile di ciò che fanno è illegale e Teile no. Si fanno spavaldamente pubblicità in Internet, come del resto un numero stupefacente di loro concorrenti, ma affermano di scegliere con attenzione le persone per le quali lavorare. Li ho trovati parecchie settimane fa dopo un’approfondita ricerca e, per verificare la loro affidabilità, ho inviato un assegno della Skelter Films di cinquecento dollari ordinando un passaporto falso. Il documento è arrivato in Florida la settimana dopo e sono rimasto abbagliato dalla sua apparente autenticità. Secondo il tizio con cui ho parlato al telefono, c’erano ottanta probabilità su cento che il passaporto superasse senza problemi i controlli nel caso avessi voluto espatriare. C’erano novanta probabilità su cento di riuscire a entrare in un qualsiasi paese dei Caraibi. I problemi, però, sarebbero sorti qualora avessi tentato di rientrare negli Stati Uniti. Gli ho assicurato che questo non sarebbe successo, non con il mio nuovo passaporto falso, comunque. Il tizio mi ha spiegato che al giorno d’oggi, nell’era del terrore, il servizio immigrazione degli Stati Uniti si preoccupa molto di più di chi figura sulla No Fly List che di chi se ne va in giro con documenti falsi. Dato che si tratta di un lavoro urgentissimo, Vanessa scuce mille dollari in contanti e si mette subito al lavoro con il suo falsario, un genio nervoso e introverso con un nome strano che rivela con molta riluttanza. Come i suoi colleghi, lavora in uno stipato cubicolo fortificato, con nessun altro in vista. L’atmosfera è sospettosa, come se chiunque lì dentro stesse violando qualche legge e si aspettasse l’irruzione di una squadra SWAT da un momento all’altro. Ai falsari non piacciono i clienti che si presentano di persona e senza preavviso. Preferiscono lo scudo di Internet, in modo che nessuno veda il loro oscuro lavoro. Vanessa consegna la memory card della sua macchina fotografica e insieme al falsario guarda su uno schermo da venti pollici le foto di un sorridente Nathan Cooley. Ne scelgono una per il passaporto e la patente e poi si dedicano ai dati anagrafici: indirizzo, data di nascita eccetera. Vanessa vuole che i nuovi documenti vengano intestati a Nathaniel Coley, non Cooley. Come preferisce, dice il falsario. Non potrebbe importargliene di meno. Nel giro di pochi minuti si perde in un flusso vertiginoso di immagini ad alta velocità. Impiega un’ora per produrre un passaporto statunitense e una patente della Virginia che ingannerebbero chiunque. La copertina blu di vinile del passaporto è sufficientemente consunta e il nostro Nathan, che non ha mai viaggiato molto, adesso ha visitato tutta l’Europa e buona Teile dell’Asia. Vanessa si precipita poi a Washington, dove si procura due kit di pronto soccorso, una pistola e alcune pillole. Alle otto e mezzo, fa dietro-front e punta verso sud, diretta a Roanoke. 33 L’aereo è un Challenger 604, uno dei jet privati più belli disponibili a noleggio. La cabina ospita comodamente otto poltrone e consente ai passeggeri di altezza inferiore al metro e ottanta di andarsene in giro senza sfiorare il soffitto. Nuovo costa intorno ai trenta milioni di dollari, secondo le informazioni disponibili in rete, ma io non sono interessato all’acquisto. Mi serve solo un noleggio veloce, a cinquemila dollari l’ora. Il servizio charter, che si trova fuori Raleigh, è stato già pagato per intero con un assegno della Skelter Films su una banca di Miami. Abbiamo stabilito di decollare da Roanoke alle diciassette di venerdì; i passeggeri saranno solo due: Nathan e io. Passo la maggior Teile di venerdì mattina cercando di convincere il servizio charter che invierò per e-mail le copie dei nostri passaporti appena riuscirò a trovare il mio. La storia che racconto è che devo averlo dimenticato da qualche Teile e che lo sto cercando rivoltando tutto il mio apTeilamento. Per i voli diretti all’estero, un servizio charter privato deve comunicare i nomi dei passeggeri ed esibire copie dei loro passaporti molte ore prima del decollo. Il servizio immigrazione controlla questi dati e verifica che i nominativi non compaiano sulla No Fly List. Io so che né Malcolm Bannister né Max Reed Baldwin figurano nell’elenco, ma non ho idea di cosa potrà succedere quando il servizio immigrazione riceverà copia del passaporto falso di Nathaniel Coley. Così prendo tempo, sperando e credendo che meno tempo avrà tra le mani entrambi i passaporti, più potrò avere fortuna. Alla fine informo il servizio charter di avere trovato il mio passaporto, ma faccio passare un’altra ora prima di inviarne la copia per e-mail all’ufficio di Raleigh, insieme a quella di Nathaniel. Non ho idea di cosa farà il servizio immigrazione quando riceverà la copia del mio passaporto. Molto probabilmente il mio nome farà scattare qualche allarme e l’FBI verrà avvertito. Se sarà così, per quello che ne so sarà la prima traccia che avranno di me da quando me ne sono andato dalla Florida, sedici giorni fa. Ripeto a me stesso che non sarebbe comunque un problema, dato che non sono né un sospettato né un evaso. Sono un uomo libero che può viaggiare e andare dove vuole senza alcuna restrizione, giusto? Allora perché questo scenario mi innervosisce? Perché non mi fido dell’FBI. Accompagno in auto Vanessa al Roanoke Regional Airport, dove sale su un volo per Miami, via Atlanta. Dopo averla lasciata, me ne vado in giro finché trovo il piccolo terminal degli aerei privati. Ho ancora qualche ora da far passare, così cerco un parcheggio e nascondo la mia Audi tra due pickup. Telefono a Nathan al bar e gli comunico la brutta notizia che il volo è stato posticipato. Secondo i “nostri piloti” c’è qualcosa che non va in una spia di controllo. Non è un grosso guaio, ma i “nostri tecnici” sono già al lavoro e dovremmo decollare intorno alle diciannove. Il servizio charter mi ha inviato per e-mail una copia del nostro itinerario e il programma prevede che il Challenger venga “riposizionato” a Roanoke alle quindici. E infatti alle quindici in punto l’aereo atterra e rulla fino al terminal. L’avventura che sta per avere inizio mi rende nervoso e, allo stesso tempo, eccitato. Aspetto mezz’ora e poi telefono al servizio charter a Raleigh per spiegare che sarò in ritardo e mi presenterò verso le diciannove. Le ore passano e devo combattere la noia. Alle diciotto entro nel terminal, mi informo in giro e vado a presentarmi a uno dei piloti, Devin. Sfodero tutto il mio fascino e comincio a chiacchierare con lui come se fossimo vecchi amici. Gli spiego che il mio co-passeggero, Nathan, è il soggetto di uno dei miei film e che stiamo andando a divertirci al mare per qualche giorno. Non conosco molto bene il ragazzo. Devin mi chiede il passaporto e io glielo consegno. Senza farsi troppo notare, il pilota controlla la mia faccia e la foto. Tutto bene. Io chiedo di dare un’occhiata all’aereo. Will, l’altro pilota, sta leggendo un quotidiano nella cabina di pilotaggio quando, per la prima volta in vita mia, metto piede all’interno di un jet privato. Stringo la mano a Will come farebbe un politico ed esprimo qualche commento sull’incredibile assortimento di schermi, interruttori, strumenti, quadranti, indicatori eccetera. Devin mi mostra il resto dell’aereo. Dietro la cabina di pilotaggio c’è la cucinetta, o cambusa, completa di forno a microonde, lavandino con acqua calda e fredda, bar, cassetti con piatti di porcellana e posate e un grande secchiello pieno di ghiaccio dove c’è già la birra in attesa. Ho chiesto due marche specifiche, una alcolica e l’altra analcolica. Dietro uno sportello c’è tutta una collezione di snack nel caso ci venga fame. Non verrà servita la cena perché non ho voluto un’hostess a bordo. Quelli del servizio charter insistevano nel dire che il proprietario dell’aereo esigeva la presenza di un’assistente di volo, ma io ho minacciato di annullare tutto. A quel punto hanno ceduto, di conseguenza su questo volo diretto a sud ci saremo solo Nathan e io. La cabina passeggeri è arredata con sei grandi poltrone di pelle e un piccolo divano, il tutto in morbide sfumature color terra, molto raffinato. La moquette è costosa e immacolata. Ci sono almeno tre schermi per i film e, mi informa Devin con orgoglio, un sistema surround sound. Dalla cabina passiamo al bagno, poi alla stiva. Io viaggio leggero e Devin si prende la mia borsa. Esito per un attimo, come se avessi dimenticato qualcosa. «Nella borsa c’è qualche DVD di cui potrei avere bisogno» gli spiego. «Posso andare a prenderla durante il volo?» «Certo, nessun problema. Anche la stiva è pressurizzata, per cui c’è libero accesso.» «Ottimo.» Trascorro mezz’ora a esaminare l’aereo, poi comincio a guardare l’orologio come se fossi irritato dal ritardo di Nathan. «È un ragazzo di montagna» spiego a Devin mentre ci sediamo in cabina. «Dubito che sia mai salito su un aereo prima d’ora. Diciamo che è un po’ rustico.» «Che tipo di film sta girando?» chiede il pilota. «Un documentario. Il business della metanfetamina in Appalachia.» Devin e io torniamo al terminal e continuiamo ad aspettare. Ho dimenticato qualcosa in auto ed esco dall’edificio. Pochi minuti dopo vedo arrivare il pickup nuovo di Nathan. Cooley parcheggia rapidamente e poi salta giù dal veicolo, ansioso. Indossa jeans tagliati al ginocchio, scarpe da corsa Nike bianche, niente calzini, un berretto con visiera da camionista e, ciliegina sulla torta, una camicia hawaiana a fiori rosa e arancione, con i primi due bottoni aperti. Afferra una rigonfia borsa da palestra Adidas dal retro del pickup e si avvia verso il terminal. Lo intercetto e ci salutiamo dandoci la mano. Nell’altra stringo alcuni fogli. «Mi dispiace per il ritardo» dico «ma adesso l’aereo è qui e pronto a Teilire.» «Nessun problema.» Gli occhi di Nathan sono acquosi. Colgo una zaffata di birra stantia. Splendido! Lo accompagno all’interno del terminal e fino al bancone, dove Devin sta flirtando con l’impiegata. Faccio avvicinare Nathan alle finestre e gli indico il Challenger. «È il nostro» annuncio con orgoglio. «Almeno per questo weekend.» Cooley sta guardando l’aereo a bocca aperta quando si avvicina Devin, al quale passo velocemente il passaporto falso di Cooley. Il pilota dà un’occhiata alla foto e poi a Nathan, che proprio in quel momento si volta dalla vetrata. Lo presento a Devin, che mi rende il passaporto e dice: «Benvenuti a bordo». «Siamo pronti a Teilire?» domando. «Venite con me» risponde Devin. E, mentre usciamo dal terminal, dico: «Spiaggia, stiamo arrivando». Una volta a bordo, Devin prende la borsa da palestra e la sistema nella stiva. Nathan si lascia cadere su una delle poltrone di pelle e si guarda intorno ammirato. Io sono in cambusa e sto preparando il primo giro di birre: vera per Nathan, analcolica per me. Una volta versate in boccali ghiacciati non c’è modo di notare la differenza. Chiacchiero con Devin mentre ci illustra le procedure di emergenza, preoccupato che possa accennare alla nostra destinazione. Non lo fa e, quando si ritira nella cabina di pilotaggio e si allaccia la cintura, faccio un sospiro di sollievo. Devin e Will mi mostrano il pollice alto e accendono i motori. «Alla salute» dico a Nathan. Facciamo cincin e beviamo un sorso. Apro il tavolino di mogano tra di noi. Mentre il jet comincia a rullare, domando: «Ti piace la tequila?». «Accidenti, sì!» risponde Cooley, già animale da Teily. Scatto in piedi, vado in cambusa, afferro una bottiglia di Cuervo Gold da un litro e due bicchierini da liquore e poso il tutto sul tavolino. Verso la tequila nei bicchierini, li svuotiamo e facciamo seguire altra birra. Al momento del decollo mi sento già molto euforico. Appena si spegne il segnale luminoso delle cinture di sicurezza, verso altra birra, poi altra tequila. Tequila e birra, birra e tequila. Riempio i vuoti nella conversazione con chiacchiere sul film e sull’eccitazione dei nostri soci finanziari. Ben presto questi discorsi annoiano Nathan, così lo informo che abbiamo in programma una cena in tarda serata e che una delle signorine presenti ha un’amica, forse la ragazza più sexy di South Beach. Ha visto Teile delle nostre riprese e vuole conoscere Nathan. «Hai portato dei pantaloni lunghi?» gli domando. Presumo che la borsa Adidas sia piena di capi raffinati più o meno come quelli che sto vedendo. «Oh, certo. Ho portato roba di ogni tipo» mi risponde Cooley, la lingua sempre più impastata. Quando la bottiglia di Cuervo Gold è vuota per metà, guardo la mappa avanzamento volo sullo schermo e annuncio: «Ancora un’ora e siamo a Miami. Bevi». Ci spariamo un altro bicchierino e poi io vuoto il mio boccale di analcolica. Peso almeno dieci chili più di Nathan, metà di quello che bevo è analcolico e tuttavia ho già la vista annebbiata quando sorvoliamo Savannah da un’altezza di undicimila metri. Nathan si sta sbronzando di brutto. Io continuo a versare e lui non dà segno di voler rallentare. Mentre sorvoliamo il mio vecchio territorio di Neptune Beach, preparo il giro finale. Lascio cadere nel boccale di birra di Nathan due compresse di idrato di cloralio da cinquanta milligrammi l’una. «Dritti fino al traguardo!» dico, sbattendo i boccali sul tavolo. Brindiamo. Io bevo prendendomela comoda e Nathan vince la gara. Trenta minuti dopo, non è più tra noi. Seguo i progressi dell’aereo sullo schermo accanto alla cambusa. Adesso voliamo a dodicimila metri. Miami è già in vista, ma non cominciamo la discesa. Sollevo Nathan dalla poltrona e lo trascino fino al divano, sul quale lo distendo. Gli controllo il polso. Mi verso una tazza di caffè e guardo Miami svanire sotto di noi. Poco dopo anche Cuba è alle nostre spalle e dal fondo dello schermo emerge la Giamaica. I motori riducono la velocità e l’aereo inizia la sua lunga discesa. Butto giù altro caffè nel disperato tentativo di schiarirmi la mente. I prossimi venti minuti saranno cruciali e caotici. Ho un piano, gran Teile del quale però è al di là del mio controllo. Il respiro di Nathan è lento e faticoso. Lo scuoto, ma è privo di sensi. Dalla tasca destra dei suoi shorts troppo stretti estraggo il portachiavi. Oltre a quella del pickup, ci sono altre sei chiavi di vario tipo e dimensione. Sono certo che due aprono le porte di casa sua. Forse altre due o tre sono del Bombay’s. Nella tasca sinistra trovo un’ordinata mazzetta di contanti, circa cinquecento dollari, e una confezione di chewing gum. Dalla tasca posteriore sinistra estraggo il portafoglio, un dozzinale esemplare di finta pelle a tre scomTeili con la chiusura in velcro. È piuttosto voluminoso. Faccio l’inventario e capisco il perché. Il nostro giocherellone è Teilito con una scorta di otto preservativi. Ci sono anche dieci banconote da cento dollari nuove di zecca, una patente della Virginia, due tessere del Bombay’s, un biglietto da visita del suo agente di controllo per la libertà vigilata e uno di un fornitore di birra. Nathan non ha carte di credito, probabilmente a causa dei suoi recenti cinque anni in galera e della mancanza di un vero lavoro. Lascio i contanti al loro posto, non tocco i preservativi e prelevo tutto il resto. Sostituisco la patente valida con quella falsa e restituisco a Nathaniel Coley il suo portafoglio. Poi gli sistemo delicatamente il passaporto falso nella tasca posteriore destra. Lui non si muove di un millimetro, non si accorge di niente. Vado in bagno e chiudo la porta a chiave. Apro la stiva, tiro la lampo della mia borsa ed estraggo due buste di nylon con la scritta PRONTO SOCCORSO. Sistemo le buste in fondo alla borsa di Nathan e poi richiudo entrambe le borse. Esco dal bagno, raggiungo la cabina di pilotaggio, scosto la tenda nera e mi sporgo in avanti per richiamare l’attenzione di Devin. Lui si toglie subito la cuffia e io gli dico: «Senti, il nostro amico ci ha dato dentro con il bere e ora è privo di sensi. Non dà segno di vita e il polso mi sembra molto debole. Appena atterriamo credo che avremo bisogno di assistenza medica». Will sente tutto nonostante la cuffia, e per una frazione di secondo lui e Devin si fissano. Se non fossero impegnati nella discesa, uno dei due probabilmente si alzerebbe per dare un’occhiata a Nathan. «Okay» dice finalmente Devin, e io torno da Cooley, che giace quasi in rigor mortis, però con il cuore che batte. Cinque minuti dopo torno in cabina di pilotaggio e comunico che il passeggero respira, ma che non riesco a svegliarlo. «Quell’idiota si è scolato un litro di tequila in meno di due ore.» I due piloti scuotono entrambi la testa. Atterriamo a Montego Bay e rulliamo accanto a una fila di aerei di linea fermi ai gate del terminal principale. Più a sud, vedo tre jet parcheggiati davanti al terminal dei voli privati. Ci sono veicoli di emergenza con le luci rosse lampeggianti, tutti in attesa di Nathan. Avrò bisogno del caos per scomparire. Sono ben lungi dall’essere sobrio, ma è scattato l’effetto dell’adrenalina e riesco a pensare con lucidità. Appena spenti i motori, Devin scatta in piedi e va ad aprire il portellone. Ho già sistemato la mia valigetta e la borsa sulla poltrona, pronto a cogliere al volo l’occasione, ma sto anche fingendo di occuparmi di Nathan. «Aspetti l’immigrazione» mi dice Devin. «Certo» rispondo. Due funzionari giamaicani dall’aria cupa compaiono in cabina e mi guardano torvi. «Passaporto, prego» dice uno dei due. Glielo consegno. Lui dà un’occhiata e ordina: «Scenda dall’aereo, per favore». Mi affretto a scendere la scaletta, e una volta a terra un altro funzionario mi invita ad aspettare. Due medici salgono a bordo, presumibilmente per occuparsi di Nathan. Un’ambulanza si avvicina a marcia indietro alla scaletta, poi arriva un’auto della polizia con i lampeggianti accesi, ma senza sirena. Faccio un passo indietro, poi un altro. C’è una discussione sul modo migliore per sbarcare il paziente dall’aereo e ognuno – medici, funzionari e poliziotti – sembra avere un’opinione diversa. Alla fine decidono di non usare la lettiga, per cui Nathan è sostanzialmente trascinato fuori e passato di mano lungo la scaletta. È un peso morto, e se superasse sessanta chili l’intera operazione sarebbe a rischio. Mentre viene caricato sull’ambulanza compare anche la sua borsa da palestra, e un funzionario dell’immigrazione interroga Devin in proposito. Il pilota si assicura che le autorità siano informate che la borsa Adidas apTeiliene al passeggero privo di sensi. Finalmente questa viene caricata in ambulanza insieme a Nathan. «Io adesso dovrei andare» dico al funzionario più vicino, che mi indica una porta del terminal privato. Entro nel momento stesso in cui Teile l’ambulanza di Nathan. Il mio passaporto viene timbrato e valigetta e borsa vengono controllate. Un doganiere mi chiede di aspettare nell’atrio; mentre seguo le sue indicazioni, vedo Devin e Will impegnati in un’accesa discussione con le autorità giamaicane. Probabilmente avrebbero qualche domanda difficile per me, ma io preferisco evitarle. Un taxi si ferma sotto la terrazza davanti all’ingresso principale. Il vetro del finestrino posteriore si abbassa e vedo la mia cara Vanessa che mi sollecita a salire con gesti frenetici. Aspetto che non ci sia nessuno vicino a me, poi esco dal terminal e salto a bordo del taxi, che si allontana veloce. Vanessa ha preso una stanza in un hotel a buon mercato, a cinque minuti d’auto dal terminal. Dal nostro balcone al terzo piano vediamo l’aeroporto e i jet che decollano e atterrano. Possiamo sentirli stando distesi sul letto. Siamo entrambi esausti, abbiamo esaurito il carburante e andiamo avanti per inerzia, ma dormire è fuori questione. 34 Sabato mattina Victor Westlake avrebbe voluto dormire fino a tardi, ma dopo la seconda telefonata si alzò dal letto e si preparò il caffè. Stava contemplando la possibilità di un sonnellino sul divano quando arrivò la terza telefonata, che lo scosse definitivamente e spazzò via la sonnolenza residua. Chi chiamava era un assistente di nome Fox, al momento addetto alla pratica Bannister/Baldwin e in attesa di qualcosa da monitorare. Non c’era stato nemmeno un sussurro in più di due settimane. «La segnalazione è arrivata dal servizio immigrazione» stava dicendo Fox. «Baldwin è Teilito ieri pomeriggio da Roanoke a bordo di un jet privato diretto in Giamaica.» «Un jet privato?» ripeté Westlake, pensando ai centocinquantamila dollari della ricompensa e chiedendosi quanto sarebbero durati, se Baldwin se li bruciava in quel modo. «Sì, signore. Un Challenger 604, noleggiato da una società di Raleigh.» Westlake rifletté per un momento. «Chissà cosa ci faceva a Roanoke. Strano.» «Sì, signore.» «Non era già stato in Giamaica qualche settimana fa? Nel suo primo viaggio all’estero?» «Sì, signore. Baldwin era Teilito da Miami per Montego Bay, dove ha trascorso qualche giorno per poi andare ad Antigua.» «Immagino che gli piacciano le isole» osservò Westlake mentre si versava altro caffè. «È solo?» «No, signore. È insieme a un certo Nathaniel Coley, o almeno questo è il nome che compare sul passaporto. Comunque sembra che questo Coley stia viaggiando con un passaporto falso.» Westlake posò la tazza di caffè intatta su un ripiano e cominciò a camminare avanti e indietro nella cucina. «Questo tizio ha superato i controlli del servizio immigrazione con un passaporto falso?» «Sì, signore. Ma tenga presente che si trattava di un aereo privato e i funzionari dell’immigrazione non hanno esaminato il passaporto vero e proprio. Avevano solo la copia inviata dal servizio charter e hanno semplicemente controllato che il nominativo non figurasse nella No Fly List. È la prassi.» «Ricordami che dobbiamo rivedere questa prassi.» «Sì, signore.» «Quindi, Fox, la domanda è: cosa sta combinando Baldwin? Perché noleggia un jet privato? Perché viaggia con un uomo che usa un passaporto falso? Puoi rispondere a queste domande? E in fretta?» «Se questi sono i miei ordini, sì, signore. Ma sono sicuro che non ho bisogno di ricordarle quanto siano suscettibili i giamaicani.» «No, non ne hai bisogno.» Nella guerra alla droga non tutte le battaglie venivano combattute tra poliziotti e trafficanti. Era da tempo che i giamaicani, come molte altre forze dell’ordine caraibiche, si sentivano offesi e irritati dall’atteggiamento dittatoriale dei funzionari statunitensi. «Mi metto subito al lavoro» disse Fox. «Però è sabato, sia qui che in Giamaica.» «Presentati nel mio ufficio lunedì mattina presto. Con qualcosa, okay?» «Sì, signore.» Nathan Cooley si svegliò in una stanzetta priva di finestre, completamente buia a eccezione della tenue luce rossa di un monitor sul tavolino accanto a lui. Era disteso su quello che sembrava un letto di ospedale, stretto e con le sponde alte. Alzò lo sguardo e vide una sacca piena di liquido, poi con gli occhi seguì il tubicino che scendeva fino al dorso della mano sinistra e scompariva sotto una garza bianca. “Okay, sono in ospedale.” Sentiva la bocca secca e la testa cominciò a martellargli appena cercò di pensare. Guardò in basso e vide che ai piedi aveva ancora le sue Nike da corsa. Loro, chiunque fossero, non si erano presi il disturbo di coprirlo o di fargli indossare un camice da paziente. Richiuse gli occhi e, lentamente, la nebbia cominciò a diradarsi. Gli vennero in mente i bicchierini di tequila, gli infiniti boccali di birra, la follia di Reed Baldwin mentre si ubriacavano insieme. Ricordò che aveva già bevuto qualcosa nel suo bar venerdì pomeriggio, mentre aspettava di andare all’aeroporto per volare a Miami. Doveva essersi fatto almeno dieci birre e dieci bicchierini di tequila. Che idiota! Era svenuto e adesso si ritrovava attaccato a una flebo. Avrebbe voluto alzarsi e muoversi, ma gli sembrava che la testa urlasse e gli occhi gli sanguinassero. “Non muoverti” si disse. Ci fu un rumore alla porta e poi si accese una luce. Un’infermiera alta e molto nera, in una divisa bianca immacolata, entrò nella stanza. «Bene, Mr Coley, è ora di andare. Sono venuti dei signori a prenderla.» La lingua era l’inglese, ma l’accento era strano. Nathan stava per chiedere: “Dove mi trovo?” quando entrarono tre agenti in uniforme che sembravano pronti a pestarlo. Tutti e tre erano neri, molto scuri. «Ma cosa diavolo...?» riuscì a dire Nathan, mettendosi a sedere. L’infermiera staccò la flebo e scomparve, chiudendosi la porta alle spalle. L’agente più anziano si fece avanti e mostrò un distintivo. «Capitano Fremont, polizia giamaicana» annunciò, proprio come in televisione. «Dove mi trovo?» chiese Nathan. Fremont sorrise, e lo stesso fecero i due agenti dietro di lui. «Non sa dove si trova?» «Dove sono?» «Lei è in Giamaica, a Montego Bay. In ospedale, per il momento, ma tra non molto nel carcere della città.» «Come sono arrivato in Giamaica?» domandò Cooley. «Su un jet privato. Molto bello, tra l’altro.» «Ma io dovrei essere a Miami, a South Beach. Ci dev’essere un errore, capite? Ma cos’è? Uno scherzo o cosa?» «Le sembriamo gente in vena di scherzare, Mr Coley?» Nathan pensò che era strano il modo in cui quei giamaicani pronunciavano il suo cognome. «Perché ha cercato di entrare in Giamaica con un passaporto falso, Mr Coley?» Nathan frugò nella tasca posteriore degli shorts e si accorse che il portafoglio era scomparso. «Dov’è il mio portafoglio?» «In nostra custodia, insieme a tutto il resto.» Nathan si massaggiò le tempie e lottò contro l’impulso di vomitare. «Giamaica? Cosa diavolo ci faccio in Giamaica?» «Vorremmo farle anche noi la stessa domanda, Mr Coley.» «Passaporto? Quale passaporto? Io non ho mai avuto un passaporto.» «Glielo mostreremo più tardi. È una violazione delle leggi giamaicane tentare di entrare nel nostro paese con un passaporto falso, Mr Coley. Nelle attuali circostanze, tuttavia, lei è in guai molto più seri.» «Dov’è Reed?» «Prego?» «Reed Baldwin. Quello che mi ha portato qui. Trovatelo e lui vi spiegherà tutto.» «Mai visto questo Reed Baldwin.» «Be’, dovete trovarlo, okay? È nero, come voi. Reed può chiarire ogni cosa. Insomma, siamo Teiliti da Roanoke ieri sera verso le sette. Forse abbiamo bevuto un po’ troppo. Eravamo diretti a Miami, a South Beach, dove dovevamo lavorare al suo documentario. Parla di mio fratello Gene, sapete? Comunque, qui è stato commesso un grosso errore. Noi dovremmo essere a Miami.» Fremont si voltò lentamente verso i suoi colleghi. Gli sguardi che si scambiarono i tre lasciavano pochi dubbi sul fatto che fossero convinti di avere a che fare con un idiota in stato confusionale. «Carcere? Lei ha parlato di carcere?» chiese Nathan. «La sua prossima fermata, amico mio.» Cooley si premette le mani sullo stomaco e la bocca gli si riempì di vomito. Fremont gli passò rapidamente un cestino dei rifiuti e poi fece un passo indietro per non correre rischi. Nathan vomitò, sussultò, boccheggiò e imprecò per cinque minuti, durante i quali i tre poliziotti si studiarono gli stivali o ammirarono il soffitto. Quando l’attacco ebbe misericordiosamente termine, Nathan si alzò in piedi e posò il cestino sul pavimento. Si pulì la bocca con un fazzolettino di carta trovato sul tavolo e bevve un sorso d’acqua. «Per favore, spiegatemi cosa sta succedendo» disse con voce gracchiante. «Lei è in arresto, Mr Coley» dichiarò Fremont. «Violazione delle leggi sull’immigrazione, importazione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di un’arma da fuoco. Come mai ha pensato di poter entrare in Giamaica con quattro chili di cocaina pura e una pistola?» La mascella di Nathan crollò. La bocca era aperta, ma ne uscì solo aria calda. Cooley socchiuse gli occhi, aggrottò la fronte, implorò con lo sguardo e tentò di nuovo di parlare. Niente. Poi, finalmente, riuscì a emettere un debole: «Che cosa?». «Non faccia l’ingenuo, Mr Coley. Dove aveva intenzione di andare? In uno dei nostri famosi resort per una settimana di sesso e droga? Era tutta per uso personale o intendeva venderne un po’ ad altri ricchi americani?» «È uno scherzo, vero? Dov’è Reed? Va bene, fine del divertimento. Ah-ah. Ora fatemi uscire di qui.» Fremont sganciò un paio di manette dal suo grosso cinturone. «Si volti, signore. Mani dietro la schiena.» «Reed!» gridò all’improvviso Nathan. «Reed! So che sei lì fuori! Piantala di ridere, stronzo, e di’ a questi pagliacci di piantarla!» «Si volti, signore» ripeté Fremont, ma Cooley non ubbidì e riprese a strillare a voce ancora più alta: «Reed! Te la farò pagare! Bello scherzo! Guarda che ti sento ridere, là fuori!». Gli altri due agenti si fecero avanti e gli afferrarono un braccio per uno. Nathan capì che opporre resistenza non avrebbe funzionato. Una volta ammanettato, i poliziotti lo condussero nel corridoio. Cooley prese a girare freneticamente su se stesso, cercando Reed o chiunque potesse presentarsi e mettere fine a tutta quella storia. Passarono davanti a stanze con le porte aperte, spazi piccoli con due o tre letti così vicini che quasi si toccavano. Passarono davanti a pazienti comatosi su lettighe addossate alle pareti, a infermiere che scrivevano su cartelle di malati e a inservienti che guardavano la televisione. “Sono tutti neri” si disse Nathan. “Sono davvero in Giamaica.” Gli fecero scendere una rampa di scale e varcare una porta. Appena uscì nell’aria densa e nel sole splendente, Nathan capì di trovarsi in territorio straniero e ostile. Un taxi riporta Vanessa all’aeroporto, dove salirà sul volo delle nove e quaranta diretto ad Atlanta. Secondo il programma, arriverà a Roanoke questa sera alle sei e cinquanta. Raggiungerà Radford in auto e scenderà in un motel. Io la raggiungerò solo tra qualche giorno. Prendo un altro taxi e raggiungo il centro di Montego Bay. A differenza di Kingston, la capitale, che risale a trecento anni fa, Montego Bay è una città nuova che si è sviluppata a mano a mano che resort, hotel, condominii e villaggi dello shopping si sono spinti verso l’interno, lontano dall’oceano, e alla fine si sono congiunti alle abitazioni. Non esiste un ampio corso principale, né una piazza e neppure un imponente tribunale in centro. Gli edifici governativi sono sparsi su un’ampia area, come la maggior Teile dei palazzi di uffici. Il tassista si ferma davanti allo studio legale di Mr Rashford Watley. Pago la corsa, salgo una rampa di scale e raggiungo un pianerottolo sul quale si affacciano le piccole stanze di un branco di avvocati. Mr Watley mi ha spiegato al telefono che di rado lavora di sabato, ma che farà un’eccezione per me. Nel suo annuncio sulle Pagine Gialle vanta trent’anni di esperienza in tutti i tribunali penali. Quando ci stringiamo la mano, mi accorgo che è piacevolmente sorpreso dal fatto che anch’io sono nero. Probabilmente pensava che, in quanto turista americano, fossi come tutti gli altri. Ci accomodiamo nel suo modesto ufficio e, dopo qualche chiacchiera di circostanza, vado al punto. Più o meno. Watley propone di lasciar perdere le formalità e di darci del tu, così adesso siamo Reed e Rashford. Sbrigo in fretta la storia del regista, del mio attuale progetto in cui rientra un certo Nathan Coley e così via, poi comincio a deviare dal copione. Spiego a Rashford che Nathan e io siamo venuti in Giamaica per qualche giorno di vacanza. In aereo Coley si è ubriacato e ha perso conoscenza, cosa che ha richiesto immediata assistenza medica all’arrivo. Non ne sono sicuro, ma credo che Nathan volesse contrabbandare un po’ di droga e che avesse un’arma con sé. Io sono riuscito a eclissarmi nella confusione. Di conseguenza ora desidero assumere Rashford per due ragioni: la prima, e la più importante, perché mi rappresenti e mi protegga dai guai in cui potrei venire a trovarmi; la seconda, perché faccia qualche telefonata e manovri un po’ dietro le quinte per avere notizie di Nathan e delle accuse nei suoi confronti. Voglio che Rashford vada a fargli visita in carcere e gli assicuri che sto facendo tutto il possibile per ottenere il suo rilascio. Nessun problema, mi assicura l’avvocato. Ci accordiamo sulla parcella e lo pago in contanti. Rashford si mette immediatamente al lavoro e telefona ai suoi contatti all’immigrazione e nella polizia. Non sono in grado di dire se stia facendo scena a mio beneficio, però di sicuro conosce un mucchio di gente. Dopo un’ora, mi scuso e scendo in strada per una bibita. Quando ritorno in studio, Rashford è ancora al telefono e sta prendendo appunti. Sto leggendo una rivista nell’ingresso, sotto un rumoroso ventilatore appeso al soffitto, quando l’avvocato compare e si siede sulla scrivania della segretaria. La situazione è seria e lui scuote la testa. «Il tuo amico è in guai grossi» dice. «Prima di tutto ha cercato di entrare con un passaporto falso.» Non mi dire, Rash. Continuo ad ascoltare attento. «Tu lo sapevi?» domanda. «Naturalmente no» rispondo. Presumo che Rashford non abbia mai volato su un jet privato e che quindi non sia al corrente della routine. «Ma la cosa peggiore» continua «è che ha cercato di far entrare una pistola e quattro chili di cocaina.» «Quattro chili di cocaina» ripeto, con l’aria più scioccata possibile. «Hanno trovato la polvere in due kit di pronto soccorso, dentro la sua borsa da palestra. Più una piccola pistola. Che deficiente.» Scuoto la testa, incredulo. «Aveva accennato all’idea di comprare della roba una volta arrivato qui, ma non mi aveva detto niente a proposito di contrabbandarla nel paese.» «Conosci bene questo signore?» domanda Rashford. «L’ho conosciuto una settimana fa. Non è che siamo amici intimi. So che ha dei precedenti per droga negli Stati Uniti, ma non avevo idea che fosse un idiota.» «Be’, lo è. E probabilmente passerà i prossimi vent’anni in una delle nostre belle prigioni.» «Venti?!» «Cinque per la coca, quindici per la pistola.» «Ma è inaccettabile. Devi fare qualcosa, Rashford!» «Le opzioni sono limitate, ma lascia che faccia il mio lavoro.» «E io? Sono al sicuro qui? Insomma, alla dogana mi hanno controllato i bagagli ed era tutto a posto. Non sono complice o fiancheggiatore, vero?» «Per il momento non c’è niente contro di te. Però ti suggerisco di Teilire il più presto possibile.» «Non posso andarmene senza avere visto Nathan. Devo aiutarlo, capisci?» «Non c’è molto che tu possa fare, Reed. Gli hanno trovato la coca e la pistola nella borsa.» Comincio a camminare nella stanza, assorto nei miei pensieri e preoccupato da morire. Rashford mi osserva per un momento, poi dice: «Probabilmente mi permetteranno di vedere Mr Coley. Conosco i ragazzi del carcere, li vedo tutti i giorni. Hai assunto l’avvocato giusto, Reed, ma, ti ripeto, non credo che si possa fare molto». «Ti capita spesso di vedere casi del genere? Turisti americani arrestati per droga?» Rashford ci pensa per un momento e poi risponde: «Succede di continuo, ma non così. Gli americani si fanno beccare quando se ne vanno, non mentre portano droga nel paese. È piuttosto insolito, ma le accuse per gli stupefacenti non sono poi così importanti. Qui abbiamo la mano leggera per la droga, ma pesante per le armi. Abbiamo leggi molto severe, specie per quanto riguarda le pistole. Ma cosa aveva in mente quel ragazzo?». «Non lo so.» «Lascia che vada a trovarlo e prenda contatto con lui.» «Ho bisogno di vederlo anch’io, Rashford. Devi aiutarmi. Parla con i tuoi amici del carcere e convincili.» «Potrebbero volerci un po’ di contanti.» «Quanto?» Rashford si stringe nelle spalle. «Non molto. Venti dollari americani.» «D’accordo.» «Vedrò cosa posso fare.» 35 I piloti mi chiamano sul cellulare, ma io non rispondo. Devin mi lascia quattro messaggi irritati in segreteria, tutti molto simili: la polizia ha sequestrato l’aereo e loro due, i piloti, sono stati informati che non possono lasciare l’isola. Alloggiano all’Hilton, ma non si stanno divertendo per niente. L’ufficio di Raleigh strepita e tutti vogliono delle risposte. I piloti sono sotto torchio perché hanno presentato un passaporto falso e probabilmente perderanno il lavoro. Il proprietario dell’aereo sta facendo ogni tipo di minaccia eccetera. Non ho tempo di preoccuparmi per quella gente. Sono sicuro che chi possiede un jet da trenta milioni di dollari è in grado di trovare un modo per farselo restituire. Alle quattordici, Rashford e io usciamo dallo studio e saliamo sulla sua auto per il viaggio di dieci minuti fino al diTeilimento di polizia, al quale è collegato il carcere cittadino. Il mio avvocato si ferma in un parcheggio affollato e con un cenno del capo mi indica un edificio lungo e basso, con il tetto piatto, strette feritoie al posto delle finestre e filo spinato come decorazione. Percorriamo un marciapiede e Rashford saluta amichevolmente guardie e inservienti. Va a una porta e sussurra qualcosa a una guardia che evidentemente conosce bene. Io osservo senza farmi notare e non vedo passaggi di contanti. A una scrivania, firmiamo un modulo fissato a un portablocco. «Ho detto che sei un legale e che lavori con me» mi sussurra Rashford mentre scribacchio uno dei miei nomi. «Comportati da avvocato.» Se solo sapesse. Rashford aspetta nella stanza lunga e stretta che i legali utilizzano per parlare con i loro clienti quando la polizia non la occupa per altri usi. Non c’è aria condizionata e sembra di essere in una sauna. Dopo qualche minuto la porta si apre e Nathan Coley viene spintonato dentro. Guarda con occhi sbarrati Rashford, poi si volta verso la guardia, che se ne va chiudendosi la porta alle spalle. Nathan si siede lentamente su uno sgabello di metallo e fissa Rashford, che gli porge un biglietto da visita e dice: «Mi chiamo Rashford Watley e sono un avvocato. Il suo amico Reed Baldwin mi ha assunto perché mi occupi della sua situazione». Nathan prende il biglietto da visita e avvicina lo sgabello. L’occhio sinistro è semichiuso e il lato sinistro della mascella è gonfio. C’è del sangue secco a un angolo della bocca. «Dov’è Reed?» domanda. «È qui. È molto preoccupato e vuole parlare con lei. Si sente bene, Mr Coley? Ha la mascella gonfia.» Nathan guarda la faccia nera e rotonda dell’avvocato e tenta di assimilare le parole. L’uomo parla inglese, okay, ma con uno strano accento. Vorrebbe correggerlo e spiegargli che lui di cognome si chiama Cooley, non Coley. Ma forse questo avvocato fa del suo meglio per dire Cooley, solo che in Giamaica viene fuori in modo diverso. «Sta bene, Mr Coley?» ripete l’avvocato. «Sono stato coinvolto in due risse nelle ultime due ore. Le ho perse entrambe. Lei deve tirarmi fuori di qui, Mr...» Nathan guarda il biglietto da visita, ma non riesce a mettere a fuoco. «Watley, Mr Watley.» «Certo, Mr Watley. È tutto un grosso equivoco. Non so cos’è successo, cosa è andato storto, ma io non ho fatto niente. Non ho usato un passaporto falso e di certo non ho cercato di contrabbandare stupefacenti e una pistola. Qualcuno mi ha infilato quella roba nella borsa, capisce? È la verità e sono pronto a giurarlo sopra una montagna di bibbie. Non faccio uso di stupefacenti, non li spaccio e sicuro come l’inferno non li contrabbando. Voglio parlare con Reed.» In pratica sputa le parole a denti stretti. Si sfrega la mascella mentre parla. «È fratturata?» domanda Rashford. «Non sono un dottore.» «Cercherò di procurargliene uno. E cercherò anche di farla trasferire in un’altra cella.» «Sono tutte uguali: soffocanti, sovraffollate e lerce. Lei deve fare qualcosa, Mr Watley. E in fretta. Non sopravviverò qui dentro.» «Lei è già stato in prigione, mi pare.» «Ho fatto qualche anno in un penitenziario federale, ma non era come qui. E io che pensavo che là fosse orrendo. Qui è un incubo. Ci sono quindici uomini nella mia cella, tutti neri tranne me, con due letti e un buco in un angolo per pisciare. Niente aria condizionata e niente cibo. La prego, Mr Watley, faccia qualcosa.» «Lei è accusato di reati molto seri, Mr Coley. Se sarà condannato per tutti i capi d’imputazione, dovrà scontare vent’anni.» Nathan china la testa e fa un respiro profondo. «Non resisterò nemmeno una settimana.» «Sono abbastanza sicuro di riuscire a ottenere una riduzione della condanna, ma deve comunque aspettarsi una pena molto lunga. E non in un carcere cittadino come questo. La manderanno in una delle nostre prigioni regionali, dove le condizioni non sono sempre così piacevoli.» «Allora studi un piano. Deve spiegare al giudice o chi per lui che è tutto un errore. Io non sono colpevole, okay? Deve convincerli di questo.» «Ci proverò, Mr Coley. Ma il sistema deve seguire il suo corso e purtroppo le cose si muovono piuttosto lentamente qui in Giamaica. Il tribunale fisserà la sua prima comparizione tra qualche giorno, poi le verranno comunicate le accuse formali.» «Cosa mi dice della libertà vigilata? Posso pagare una cauzione e uscire di qui?» «Ci sto lavorando con un garante per le cauzioni, ma non sono ottimista. Il tribunale la considererà un soggetto a rischio di fuga. Di quanto denaro dispone?» Nathan sbuffa e scuote la testa. «Non lo so. Avevo mille dollari nel portafoglio, ma adesso non so dov’è. Comunque, sono sicuro che i soldi non ci sono più. Avevo altri cinquecento dollari in tasca, ma sono spariti anche quelli. Mi hanno ripulito. Ho qualche proprietà negli Stati Uniti, ma niente liquidi. Io non sono ricco, Mr Watley. Sono un ex detenuto trentenne che fino a sei mesi fa era in galera. E la mia famiglia non ha niente.» «Be’, la corte guarderà la quantità di cocaina e il jet privato, e arriverà a una conclusione diversa.» «La coca non è mia. Non l’ho mai vista, mai toccata. È stata messa lì apposta, okay? Stessa cosa per la pistola.» «Io le credo, Mr Coley, ma probabilmente il giudice sarà più scettico. Capita spesso di sentire storie del genere.» Nathan apre lentamente la bocca e saggia con la lingua il sangue secco nell’angolo. È chiaramente sofferente e in stato di shock. Rashford si alza in piedi. «Resti a sedere. Reed è qui. Se qualcuno le chiede qualcosa, dica che è uno dei suoi avvocati.» La faccia malconcia di Nathan si illumina un po’ quando mi vede entrare. Mi siedo sullo sgabello, a meno di un metro da lui. Cooley vorrebbe urlare, ma sa che qualcuno ci sta ascoltando. «Cosa diavolo sta succedendo, Reed? Spiegamelo!» La Teile che devo recitare a questo punto è quella di un uomo spaventato che non sa cosa succederà domani. «Non lo so, Nathan» rispondo nervosamente. «Non sono in arresto, ma non posso lasciare l’isola. Ho assunto Rashford Watley per prima cosa questa mattina e stiamo cercando di capire cos’è successo. Io ricordo solo che ci siamo sbronzati forte, e molto in fretta. Da stupidi. Questo è sicuro. Tu hai perso i sensi sul divano e io ero a malapena cosciente. A un certo punto uno dei piloti mi ha chiamato nella cabina di pilotaggio e mi ha detto che il traffico aereo su Miami era bloccato a causa delle condizioni meteo. Allerta tornado, tempesta tropicale, roba brutta. Insomma, il Miami International era chiuso. Il sistema temporalesco stava avanzando verso nord e così abbiamo virato a sud e siamo stati dirottati sui Caraibi. Abbiamo cominciato a volare in cerchio e davvero non ricordo tutto quello che è successo. So che ho cercato di svegliarti, ma tu stavi russando.» «Non ricordo di avere perso i sensi» dice Nathan, toccandosi la mascella gonfia. «Un ubriaco ricorda di essere svenuto? No, non lo ricorda. Eri cotto, okay? Avevi bevuto già prima del decollo. Comunque, a un certo punto ci siamo ritrovati a corto di carburante e siamo stati costretti ad atterrare. Secondo i piloti, eravamo diretti qui, a Montego Bay, dove avremmo fatto rifornimento e poi saremmo riTeiliti per Miami, dove intanto il tempo era migliorato. Io nel frattempo avevo bevuto litri di caffè, perciò ricordo quasi tutto quello che è successo. Insomma, atterriamo e il pilota mi dice di restare a bordo: ci tratterremo solo per una ventina di minuti. Poi dice che l’immigrazione e la dogana vogliono dare un’occhiata. Ci ordinano di scendere dall’aereo, ma tu sei in coma e non ti muovi. Il polso si sente appena. Chiamano un’ambulanza e tutto comincia ad andare male.» «Cos’è quella stronzata del passaporto falso?» «Colpa mia. Noi ci serviamo di continuo del Miami International, dove spesso esigono di vedere i passaporti anche per i voli interni, specie quelli privati. Penso che la cosa risalga alle guerre contro la droga degli anni Ottanta, quando molti jet privati venivano utilizzati dai signori della droga e relativi entourage. Adesso, con la guerra al terrorismo, vogliono vedere il passaporto. Non è obbligatorio averlo, ma è molto utile. Conosco un tale a Washington che per cento dollari può fabbricarne uno in giornata e così gli ho chiesto di farne uno per te, giusto per l’eventualità che ce ne fosse stato bisogno. Non avevo idea che sarebbe diventato un problema.» Il povero Nathan non sa cosa credere. Io ho il vantaggio di mesi di preparazione. Lui subisce colpi duri a ripetizione ed è completamente stordito. «Credimi, Nathan: il passaporto falso è il minore dei tuoi problemi.» «Da dove arrivano coca e pistola?» «La polizia» rispondo in tono piatto, ma sicuro. «Non era roba mia né tua, quindi questo restringe la lista dei sospetti. Rashford dice che non è la prima volta che succede su quest’isola. Dagli Stati Uniti arriva un jet privato con due ricconi a bordo... ricchi, perché altrimenti non se ne andrebbero in giro su un aereo del genere. Uno dei due riccastri è così ubriaco da non riuscire a trovarsi il sedere con le mani. Collassato, privo di sensi. Fanno scendere dall’aereo quello più sobrio, distraggono i piloti con un po’ di scartoffie e, quando il momento è perfetto, piazzano la droga. La cacciano dentro una borsa, semplicemente. Qualche ora dopo il jet è ufficialmente sequestrato dal governo giamaicano e il trafficante viene arrestato. È solo una questione di soldi, di contanti.» Nathan assorbe queste informazioni fissandosi i piedi nudi. La sua camicia hawaiana rosa e arancione è macchiata di sangue. Ci sono graffi sulle braccia e sulle mani. «Reed, puoi farmi avere qualcosa da mangiare? Sto morendo di fame. Hanno portato il pranzo un’ora fa, una merda che non puoi immaginare, ma prima che potessi buttare giù un boccone, un mio compagno di cella ha deciso che ne aveva più bisogno di me.» «Mi dispiace moltissimo, Nathan. Vedrò se Rashford può corrompere una delle guardie.» «Per favore» biascica Cooley. «Vuoi che avverta qualcuno a casa?» Scuote la testa. No. «Chi? L’unica persona della quale mi fido un po’ è il tizio che gestisce il mio bar, e ho il sospetto che mi derubi. Ho tagliato i ponti con la famiglia, e comunque loro non mi aiuterebbero. Come potrebbero? Non sanno neppure dov’è la Giamaica. Nemmeno io sono sicuro di saperla trovare su una carta geografica.» «Rashford pensa che potrebbero accusarmi di complicità, per cui è possibile che venga a raggiungerti.» Nathan scuote di nuovo la testa. «Tu puoi sopravvivere perché sei nero e sei in forma. Ma un bianco pelle e ossa come me non ha una sola possibilità. Appena entro nella cella, uno grande e grosso mi dice che le mie Nike gli piacciono un sacco. Andate. Poi un altro vuole dei soldi e, dato che non ne ho, pretende che gli prometta di dargliene entro breve. Questo dà il via al primo pestaggio, con almeno tre di quei gorilla che mi picchiano a sangue. Ricordo di aver sentito ridere una guardia, che ha detto qualcosa a proposito del ragazzo bianco che non sa battersi molto bene. Il mio posto sul pavimento è proprio accanto al cesso, nient’altro che un buco, come un gabinetto all’aperto. Il tanfo fa vomitare. Se mi sposto di qualche centimetro, invado il territorio di qualcun altro e mi pestano. Niente aria condizionata, sembra di essere in un forno. Quindici uomini in uno spazio ristretto, tutti sudati, affamati e assetati. Nessuno riesce a dormire. Non voglio immaginare come sarà questa notte. Ti prego, Reed, fammi uscire di qui.» «Ci proverò, ma è molto probabile che questa gente tenti di incastrare anche me.» «Fa’ qualcosa. Per favore.» «Senti, Nathan, è tutta colpa mia, okay? So che non significa niente, ma non avevo modo di sapere che stavamo finendo in una tempesta tropicale. Quegli stupidi dei piloti avrebbero dovuto avvertirci delle previsioni meteo prima del decollo, oppure avrebbero dovuto atterrare da qualche Teile in territorio americano, o magari avrebbero dovuto avere più carburante a bordo. Faremo causa ai bastardi quando torneremo a casa, okay?» «Come ti pare.» «Nathan, farò tutto quello che posso per farti uscire, ma sono a rischio anch’io. Alla fine sarà solo un problema di soldi. Qui si tratta semplicemente di estorsione, un furto da Teile di un branco di sbirri che sa come si gioca la Teilita. Accidenti, le regole le hanno scritte loro. Rashford dice che spremeranno il proprietario del jet e si intascheranno una bella bustarella. Poi ci getteranno un osso per vedere quanta grana possiamo mettere insieme noi. Adesso sanno che abbiamo un avvocato, e Rashford pensa che lo contatteranno presto. Preferiscono concludere le loro piccole storie di estorsione prima che il caso arrivi in tribunale. Dopo ci sono le accuse formali e giudici che esaminano tutto. Hai capito quello che ti ho detto, Nathan?» «Credo di sì. È che proprio non riesco a crederci. Ieri a quest’ora ero nel mio bar, bevevo una birra insieme a una bella ragazza e mi davo delle arie perché stavo per volare a Miami per il weekend. Guardami ora: buttato in una cella fetida con un branco di giamaicani, tutti in fila per prendermi a calci nel culo. Hai ragione, Reed: è tutta colpa tua. Tu e il tuo ridicolo film. Non avrei mai dovuto darti retta.» «Mi dispiace, Nathan. Credimi, mi dispiace moltissimo.» «E vorrei vedere. Però adesso fa’ qualcosa, e in fretta. Non resisterò a lungo, qui dentro.» 36 Rashford mi dà un passaggio fino all’albergo e, all’ultimo momento, mi invita gentilmente a cena a casa sua. Dice che sua moglie è una cuoca eccellente e che entrambi sarebbero felici di avere come ospite un esperto uomo di cinema come me. Anche se sono tentato di accettare, soprattutto perché per le prossime diciotto ore non ho niente da fare, declino l’invito con la debole scusa di non sentirmi troppo bene e di voler dormire. Sto vivendo una menzogna e l’ultima cosa di cui ho bisogno è una lunga conversazione sulla mia vita, il mio lavoro e il mio passato. Ho il sospetto che ci sia gente in gamba a seguire le mie tracce e a fiutare l’aria a caccia di indizi. Una parola sbagliata adesso potrebbe pregiudicare il mio futuro. È luglio, la stagione turistica è finita e l’hotel non è affollato. C’è una piccola piscina con un bar all’ombra e trascorro il pomeriggio sotto un ombrellone, leggendo un giallo di Walter Mosley e sorseggiando birra Red Stripe. Vanessa atterra a Roanoke alle sette di sabato sera. È esausta, ma il riposo non è un’opzione. Nelle ultime quarantott’ore ha guidato da Radford a Washington e a Roanoke, e ha volato da Roanoke alla Giamaica e ritorno via Charlotte, Atlanta e Miami. A Teile un sonno agitato di tre ore a Montego Bay, e qualche pisolino in aereo, non ha praticamente dormito. Esce dal terminal con il suo borsone e se la prende comoda per raggiungere l’auto. Come sempre, osserva tutto e tutti intorno a lei. Non crediamo che qualcuno la segua, ma a questo punto non diamo nulla per scontato. Dall’aeroporto si immette sulla highway e poi scende in un Holiday Inn. Fa la sua ordinazione al servizio in camera e cena accanto alla finestra mentre il sole tramonta. Alle dieci mi telefona e parliamo brevemente, in codice. Siamo al nostro terzo o quarto cellulare prepagato ed è estremamente improbabile che ci sia qualcuno in ascolto ma, di nuovo, non vogliamo correre rischi. Concludo con un semplice «Procedi come da programma». Vanessa torna in auto all’aeroporto, raggiunge il terminal dei voli privati e si infila accanto al pickup di Nathan. È sabato notte, non c’è praticamente traffico aereo privato e nessuno nel parcheggio vuoto. Indossa un paio di sottili guanti di pelle e, usando le chiavi di Nathan, apre la portiera del pickup, sale a bordo e Teile. È la prima volta che guida un veicolo del genere e procede con calma. Poco dopo si ferma nel parcheggio di un fast food per regolare sedile e specchietti. È abituata alla piccola vettura giapponese che guida da cinque anni, e il passaggio di categoria è traumatico e disagevole. L’ultima cosa che possiamo permetterci è un tamponamento o una serie di luci azzurre lampeggianti. Si immette sull’Interstatale 81 in direzione sud, verso Radford, Virginia. È quasi mezzanotte quando Vanessa lascia la highway e svolta nella stradina di campagna che porta alla residenza di Nathan. Supera la casa mobile, dove vive il vicino più prossimo di Cooley, a venticinque chilometri l’ora, senza fare rumore. Ha fatto questo percorso almeno una decina di volte a bordo della propria auto e conosce bene il terreno. La strada si piega in una curva subito dopo l’abitazione di Nathan e attraversa un pascolo prima di arrivare a un’altra casa, distante quasi tre chilometri. Oltre quel punto l’asfalto sfuma nella ghiaia e poi nella terra battuta. Non c’è traffico perché la zona è scarsamente popolata. Sembra strano che uno scapolo trentenne possa decidere di abitare in un posto così isolato. Vanessa si ferma nel vialetto d’accesso di Nathan e resta in ascolto. Il labrador abbaia nel cortile sul retro, all’interno di un vasto recinto con una graziosa casetta per tenerlo all’asciutto. A Teile il cane, non si sentono altri rumori. L’oscurità è appena perforata da una piccola luce gialla sulla veranda. Vanessa ha una Glock 9 millimetri in tasca e crede di sapere come usarla. Fa un giro intorno alla casa, attenta a dove mette i piedi e sempre in ascolto. Il cane abbaia più forte, ma nessuno lo sente, a Teile Vanessa. Arrivata alla porta sul retro, comincia a provare le chiavi. Le prime tre non entrano né nel pomolo, né nella serratura di sicurezza, ma la numero quattro e cinque funzionano. Vanessa fa un respiro profondo e spalanca la porta. Nessuna sirena, nessun frenetico bip. Ha varcato questa stessa porta solo cinque giorni fa durante la prima serie di riprese e ha notato sia le serrature che l’assenza di un sistema d’allarme. Una volta entrata, si toglie i guanti di pelle e ne indossa un paio di latex, del tipo usa e getta. Sta per setacciare ogni centimetro della casa e non può lasciare una sola impronta. Muovendosi rapidamente, accende le luci, abbassa tutte le tapparelle e fa Teilire l’aria condizionata. Quella in cui si trova è una modesta casa in affitto, occupata da un montanaro scapolo che ha passato gli ultimi cinque anni in prigione, di conseguenza arredamento e suppellettili sono al minimo. Ci sono due o tre mobili, l’immancabile televisore sovradimensionato e tende solo ad alcune delle finestre. Ci sono anche piatti sporchi impilati nell’acquaio in cucina e indumenti sporchi sul pavimento del bagno. La stanza degli ospiti è utilizzata come ripostiglio. Due topi morti se ne stanno perfettamente immobili nelle rispettive trappole, con il collo spezzato in due. Vanessa comincia dalla camera da letto di Nathan. Fruga all’interno di un alto cassettone. Niente. Guarda sotto il letto, poi tra il materasso e la rete. Esamina ogni millimetro della disordinata cabina armadio. Le fondamenta della casa sono di tipo tradizionale, su sostegni di legno – non c’è una base in cemento –, e il pavimento a doghe cede impercettibilmente a ogni passo. Vanessa vi picchia sopra con le nocche e ascolta, cercando l’eventuale suono più sordo che le riveli un nascondiglio. Ho il sospetto che Nathan abbia nascosto il suo tesoro da qualche Teile nell’abitazione, anche se probabilmente non in una delle stanze principali. In ogni caso, dobbiamo controllare dappertutto. Se Nathan è furbo, cosa difficile da immaginare, deve avere suddiviso il bottino e sistemato le Teili in luoghi diversi. Dalla camera da letto padronale, Vanessa si sposta in quella degli ospiti, tenendosi alla larga dai topi morti. A mezzanotte e mezzo comincia a spegnere le luci, come se Nathan stesse per andarsene a dormire. Passa da una stanza all’altra, controllando ogni angolo. Non c’è niente che non venga rivoltato o esaminato. Ciò che Vanessa sta cercando potrebbe essere nelle pareti, sotto i pavimenti, nel cartongesso sopra i soffitti, oppure potrebbe essere sepolto nel cortile dietro casa o magari al sicuro in una cassaforte al Bombay’s. Il soffocante seminterrato ha un soffitto alto due metri, pareti in blocchi di cemento grezzo ed è privo di aria condizionata. Dopo un’ora passata là dentro, Vanessa è fradicia di sudore e troppo stanca per continuare. Alle due si distende sul divano in soggiorno e si addormenta con la mano sulla fondina della Glock. Se Rashford era esitante a lavorare di sabato, la domenica è quasi ostile, ma non gli ho lasciato molta scelta. L’ho pregato di accompagnarmi al carcere e di sfruttare le sue conoscenze come ha fatto il giorno prima. Gli ho anche consegnato una banconota da cento dollari per facilitare le cose. Arriviamo alla prigione poco prima delle nove di mattina e quindici minuti dopo sono solo con Nathan, nella stessa stanza di ieri. Rimango scioccato dal suo aspetto. Le ferite sono evidenti e serie; mi chiedo per quanto tempo ancora le guardie consentiranno che gli abusi continuino. La faccia è un disastro di tagli, lacerazioni aperte e sangue secco. Il labbro superiore è gonfio e sporge grottesco da sotto il naso. L’occhio sinistro è completamente chiuso e il destro è arrossato e tumido. Manca un incisivo. I jeans tagliati al ginocchio e la simpatica camicia hawaiana sono scomparsi, sostituiti da una tuta bianca piena di macchie e sporca di sangue. Ci pieghiamo entrambi in avanti, le teste distanti solo pochi centimetri. «Aiutami» riesce a dire Nathan, quasi in lacrime. «Ecco le ultime notizie» comincio. «Questi delinquenti hanno chiesto un milione di dollari al proprietario del jet, che ha accettato di pagare. Quindi, gli stronzi avranno i loro soldi. Non mi accuseranno di niente, almeno per quello che se ne sa questa mattina. Per te, vogliono mezzo milione di dollari. Ho spiegato, tramite Rashford, che nessuno di noi due dispone di una somma del genere. Ho spiegato che noi eravamo solo passeggeri a bordo di un jet che apTeiliene a qualcun altro, che non siamo ricchi e così via. I giamaicani, però, non ci credono. Comunque, così stanno le cose al momento.» Nathan fa una smorfia, come se respirare gli causasse dolore. Per quanto brutta sia la sua faccia, non voglio pensare al resto del corpo. Immagino il peggio, perciò non gli chiedo cosa gli è successo. Emette un grugnito e chiede: «Tu puoi tornare negli Stati Uniti?». Perfino la voce, debole e gracchiante, è ferita. «Credo di sì. Rashford pensa di sì. Ma io non ho molti soldi, Nathan.» Si acciglia, grugnisce di nuovo e sembra sul punto di svenire o di mettersi a piangere. «Reed, stammi a sentire. Io di soldi ne ho. Tanti.» Lo guardo dritto negli occhi, o almeno nell’occhio destro, dato che il sinistro è chiuso. Questo è l’istante fatale per cui tutto è stato creato. Senza questo momento, l’intero progetto sarebbe un disastro di proporzioni gigantesche, un gioco d’azzardo finito in modo pessimo. «Quanti?» chiedo. Cooley tace. Non vorrebbe parlare, ma non ha scelta. «Abbastanza da farmi uscire.» «Mezzo milione di dollari, Nathan?» «Anche di più. Dobbiamo diventare soci, Reed. Solo tu e io. Io ti dico dove sono i soldi, tu vai a prenderli, mi tiri fuori di qui e diventiamo soci. Però devi darmi la tua parola. Devo potermi fidare di te, okay?» «Aspetta un attimo» dico, facendomi indietro e mostrandogli i palmi delle mani. «Tu ti aspetti che io Teila, rientri negli Stati Uniti e poi torni con un sacco di grana per corrompere la polizia giamaicana? Parli sul serio?» «Ti prego, Reed. Non ho nessun altro. Non posso chiamare nessuno a casa. Nessuno capirebbe cosa sta succedendo qui, ci sei solo tu. Devi farlo. Per favore. La mia vita dipende da te. Non posso sopravvivere qui dentro. Guardami! Ti prego, Reed. Fa’ quello che ti chiedo, fammi uscire e sarai un uomo ricco.» Mi faccio ancora più indietro, come se Nathan fosse contagioso. «Per favore, Reed» mi supplica. «Mi hai cacciato tu in questo guaio e adesso devi tirarmi fuori.» «Potrebbe essere utile sapere come sei riuscito a fare tanti soldi.» «Non li ho fatti. Li ho rubati.» Nessuna sorpresa. «Droga?» domando, ma so già la risposta. «No, no, no. Allora, siamo soci?» «Non lo so. Non sono sicuro di voler corrompere la polizia giamaicana. E se mi arrestano? Potrei finire esattamente come te.» «Allora non tornare. Manda i soldi a Rashford e lascia che sia lui a fare la consegna. Puoi studiare un modo, Reed. Accidenti, tu sei in gamba.» Annuisco, come se mi piacesse il suo modo di pensare. «E dove sono questi soldi, Nathan?» «Siamo soci? Cinquanta e cinquanta, solo tu e io, okay, amico?» «Okay, okay. Ma non ho intenzione di rischiare la galera per questa cosa, hai capito?» «Certo.» C’è una pausa mentre ci studiamo a vicenda. Il respiro di Cooley è faticoso e ogni parola lo fa soffrire. Lentamente, mi tende la destra, che è gonfia e piena di escoriazioni. «Soci, Reed?» mi supplica. Lentamente, gli stringo la mano e lui fa una smorfia. Probabilmente è fratturata. «Dove sono i soldi?» domando. «A casa mia» risponde riluttante, come se stesse rivelando il segreto più prezioso della sua vita. «Ci sei stato. Nel cortile sul retro c’è un capanno per gli attrezzi, pieno di cianfrusaglie. Il pavimento è di legno e a destra, sotto un vecchio tosaerba Sears che non funziona più, c’è una botola. Non si vede, se non si sposta il tosaerba e tutte le cose che ci sono intorno. Fa’ attenzione ai serpenti: ci sono due o tre serpenti reali che hanno fatto il nido là dentro. Apri la botola e vedrai una bara di bronzo.» Cooley ha il fiato corto e suda moltissimo. Il dolore fisico è evidente, ma Nathan è tormentato anche dalla sofferenza di una simile rivelazione. «Una bara?» ripeto incredulo. «Sì, da bambino. Chiusa e sigillata, a tenuta stagna e sottovuoto. C’è un chiavistello nascosto su uno dei lati corti, dove dovrebbero esserci i piedi. Quando lo sollevi, i dispositivi di chiusura scattano e si può aprire la bara.» «Cosa c’è dentro?» «Parecchie scatole di sigari chiuse con del nastro adesivo, quello largo impermeabile. Credo che siano diciotto.» «Hai nascosto dei contanti dentro le scatole di sigari?» «Non sono contanti» mi dice Nathan, piegandosi in avanti. «È oro.» Sono troppo sbalordito per poter parlare, così Cooley continua, quasi in un sussurro. «Minilingotti, ognuno del peso di dieci once, puri quanto può essere puro l’oro. Sono grandi più o meno come una tessera del domino. Sono belli, Reed, bellissimi.» Lo fisso a lungo incredulo, poi dico: «Okay, per quanto sia difficile, resisto alla tentazione di farti un mucchio di domande scontate. Quindi, io dovrei precipitarmi a casa tua, prelevare l’oro da una cassa da morto, combattere contro qualche serpente, trovare un ricettatore che mi dia dei contanti in cambio dell’oro e poi inventarmi un modo per far arrivare mezzo milione di dollari qui in Giamaica, dove dovrei passarlo ad alcuni agenti corrotti della polizia e dell’immigrazione, i quali poi ti libereranno. È un buon riassunto, Nathan?». «Sì. E sbrigati, okay?» «Io credo che tu sia pazzo.» «Ci siamo stretti la mano. Siamo soci, Reed. Trova il modo e diventerai ricco.» «Di quante tessere del domino stiamo parlando?» «Tra cinquecento e seicento.» «Quanto vale l’oro di questi tempi?» «Due giorni fa veniva quotato sui millecinquecento dollari l’oncia.» Faccio i calcoli e dico: «Siamo tra i sette e i nove milioni di dollari». Nathan sta annuendo. Fa questi calcoli ogni giorno della sua vita seguendo le oscillazioni del prezzo dell’oro. Qualcuno bussa rumorosamente alla porta alle mie spalle, poi entra una delle guardie carcerarie. «Tempo scaduto, amico» mi informa, poi scompare. «Probabilmente sarà una delle cose più stupide che farò in tutta la mia vita» dico. «O forse una delle più furbe» ribatte Nathan. «Però fa’ presto, per favore. Non riuscirò a resistere a lungo qui dentro.» Ci stringiamo di nuovo la mano e ci salutiamo. La mia ultima visione di Nathan è quella di un ometto malconcio che cerca di alzarsi in piedi. Rashford e io ce ne andiamo in fretta. L’avvocato mi scarica davanti all’hotel e io mi precipito in camera per telefonare a Vanessa. È in soffitta, dove ci sono quasi cinquanta gradi, e sta frugando dentro vecchi scatoloni e mobili rotti. «Non è lì» la informo. «È fuori, nel capanno per gli attrezzi.» «Resta in linea.» Sento Vanessa scendere la scala retrattile. «Te l’ha detto lui?» mi chiede tra un respiro e l’altro. «Sì.» «C’è qualcuno» mi comunica all’improvviso, e al telefono sento il campanello della porta. Vanessa si acquatta nell’ingresso e impugna la Glock. «Ti richiamo» sussurra al cellulare, e chiude la comunicazione. È la tarda mattinata di domenica. Il pickup di Nathan è nel vialetto. Presumendo che i suoi amici sapessero che se ne sarebbe andato per il weekend, la presenza del veicolo può aver fatto nascere delle domande. Il campanello suona di nuovo e qualcuno comincia a picchiare con forza alla porta. Poi urla: «Nathan, ci sei? Apri!». Vanessa si accuccia ancora di più, ma non si sposta. I colpi alla porta continuano, poi qualcun altro bussa all’ingresso sul retro e grida chiamando Nathan. Sono almeno in due. Le voci sono giovani, si tratta senza dubbio di amici di Cooley che per qualche ragione sono passati da casa sua. Non danno segno di volersene andare. Uno bussa alla finestra della camera da letto, ma non può vedere all’interno. Vanessa raggiunge cautamente il bagno e si lava la faccia. Sta ansimando e trema di paura. I due adesso gridano e tra poco arriveranno alla conclusione che a Nathan è successo qualcosa. Sfonderanno una porta. D’istinto, Vanessa si spoglia restando in slip, si asciuga il sudore dal corpo, lascia la Glock accanto al lavandino e va alla porta d’ingresso. La spalanca e il ragazzo riceve un regalo inaspettato. Il seno è grosso e sodo, il corpo scuro atletico e tonico. Il ragazzo abbassa lo sguardo dal seno agli slip, studiati per mostrare quanta più carne possibile, poi riacquista il controllo. Vanessa sorride e dice: «Forse Nathan ha da fare in questo momento». «Wow. Chiedo scusa.» Sono l’uno di fronte all’altra, divisi dalla zanzariera, e nessuno dei due ha fretta di andarsene. Voltando appena la testa, il ragazzo grida: «Ehi, Tommy, vieni qui». Tommy arriva di corsa e non riesce a credere ai suoi occhi. «Andiamo, ragazzi» fa Vanessa. «Lasciateci un po’ di privacy, okay? Nathan adesso si sta facendo una doccia, ma non abbiamo ancora finito. Chi devo dire che è passato a salutarlo?» A questo punto si accorge che nella fretta ha dimenticato di togliersi i guanti di latex. Slip rossi, guanti color acquamarina. Nessuno dei due distoglie lo sguardo dal seno. «Ah... Greg e Tommy. Noi... noi passavamo di qua.» Entrambi sono ipnotizzati dalla nudità di Vanessa e sconcertati dai guanti. Cosa diavolo sta facendo questa pollastra con il nostro amico? «Glielo dirò» assicura Vanessa con un bel sorriso mentre chiude lentamente la porta. Dalla finestra li guarda arretrare, ancora confusi e a bocca aperta. Finalmente arrivano al loro pickup e salgono a bordo. Cominciano a ridere ed escono dal vialetto. Dopo che se ne sono andati, Vanessa si versa un bicchiere di acqua ghiacciata e si siede per qualche minuto al tavolo della cucina. È scossa e sul punto di crollare, ma non se lo può permettere. Ha la nausea di questa casa e seri dubbi su tutto il progetto. Ma deve andare avanti. Sono sul sedile posteriore di un taxi diretto all’aeroporto quando vedo la chiamata. Ho passato gli ultimi quindici minuti immaginando diversi scenari nella casa di Nathan, nessuno dei quali con un bel finale. «Stai bene?» domando. «Sì. Erano solo due bifolchi che cercavano Nathan. Me ne sono sbarazzata.» «Come?» «Te lo spiegherò poi.» «Ti hanno vista?» «Oh, sì. Va tutto bene. Allora, dov’è la roba?» «Nel capanno per gli attrezzi sul retro. Resto al telefono.» «Okay.» Vanessa controlla di nuovo il vialetto per assicurarsi che non ci siano altri visitatori, poi corre alla porta sul retro e al capanno. Il cane ringhia e abbaia frenetico, lo sento chiaramente dalla Giamaica. Non trovo la forza di avvertire Vanessa dei serpenti, così prego in silenzio che non li trovi. Frugare in un capanno sudicio è già abbastanza sgradevole, mettici anche i serpenti e Vanessa può crollare per la paura e darsela a gambe. Entra nel capanno e me lo descrive. Dice che è come essere in un forno. Le ripeto le istruzioni di Nathan e chiudo la comunicazione: Vanessa avrà bisogno di entrambe le mani. Sposta due bidoni di diluente per vernice vuoti, allontana con un calcio un sacco di iuta, spinge il tosaerba Sears il più lontano possibile, solleva un’asse di compensato e vede una maniglia di corda. È bloccata, così tira con forza finché il coperchio della botola si apre. Non ci sono cardini, perciò l’intero coperchio si stacca di colpo dal pavimento e finisce contro la parete. Sotto, come annunciato, c’è una bara di bronzo sporca di terriccio. È lunga non più di un metro e venti. Vanessa boccheggia inorridita, come se fosse capitata sulla scena di un delitto e avesse trovato il cadavere di un povero bambino. Ma non c’è tempo per la paura o i ripensamenti, non c’è tempo per chiedersi: “Cosa diavolo ci faccio qui?”. Cerca di sollevare la bara, ma è troppo pesante. Trova il chiavistello, lo ruota e lentamente si apre metà del coperchio. Per fortuna non c’è alcun cadavere all’interno. Niente del genere. Vanessa si prende una pausa per studiare la collezione di piccole scatole di sigari, tutte sigillate con una striscia di nastro adesivo color argento e, per la maggior Teile, impilate e disposte in file. Il sudore gocciola dalle sopracciglia e Vanessa cerca di asciugarlo con l’avambraccio. Con cautela, prende una delle scatole, esce dal capanno e si sposta all’ombra di una quercia. Si guarda intorno e non vede nessuno, a Teile il cane che si è stancato di ringhiare e abbaiare. Toglie il nastro adesivo, apre la scatola e solleva adagio un foglio di giornale accartocciato. Minilingotti. Mattoncini. Tessere del domino. Un’intera bara piena. Milioni e milioni di dollari. Vanessa estrae un minilingotto e lo esamina. È un rettangolo perfetto, spesso poco più di un centimetro, con un minuscolo bordo rialzato che consente la precisa sovrapposizione dei pezzi e relativo immagazzinamento. Su una faccia compare l’incisione 10 ONCE. E sotto: 99,9%. Niente altro: nessun nome di banca, nessuna indicazione della provenienza dell’oro o di chi l’ha estratto. Nessun numero di registrazione. Usando una carta di credito prepagata, per trecento dollari acquisto un biglietto dell’Air Jamaica per San Juan, Porto Rico. Il volo decolla tra un’ora, così mi siedo su una panchina vicino al gate e cerco di ammazzare il tempo, ma continuo a fissare il cellulare. Passano pochi minuti e il telefonino si illumina e vibra. «Non mentiva» dice Vanessa. «Racconta.» «Ti piacerà, baby. Siamo appena diventati proprietari di diciotto scatole di sigari piene di meravigliosi lingottini d’oro. Non li ho ancora contati tutti, ma devono essere almeno cinquecento.» Faccio un respiro profondo. Avrei voglia di piangere. Questo progetto è allo studio da più di due anni e per la maggior Teile del tempo le probabilità di successo sono state al massimo di mille a uno. Tutta una serie di eventi variamente collegati doveva verificarsi esattamente in un determinato modo. Non abbiamo ancora raggiunto il traguardo, ma siamo comunque in dirittura d’arrivo. Sono come un cavallo che comincia a sentire l’odore della sua stalla. «Tra i cinquecento e i seicento, secondo il nostro amico» dico al cellulare. «Be’, si è guadagnato il diritto di essere creduto. Dove sei?» «All’aeroporto. Ho comprato il biglietto, ho passato la dogana e mi imbarco tra un’ora. Fino a questo momento nessun problema. E tu dove sei?» «Sto per andarmene da questa cloaca. Ho caricato la merce e ho rimesso tutto al suo posto. La casa è chiusa a chiave.» «Non ti preoccupare per la casa. Non la rivedrà mai più.» «Lo so. Ho lasciato un intero sacco di cibo al cane. Spero che qualcuno venga a dargli un’occhiata.» «Vattene di lì.» «Teilo subito.» «Attieniti al piano. Ti chiamo appena posso.» 37 Sono quasi le undici di domenica mattina, 24 luglio. La giornata è limpida e calda, e il traffico intorno a Radford è scarso. Vanessa vuole evitare altri incontri con chiunque possa notare il pickup di Nathan e insospettirsi. Diretta a nord sull’interstatale, supera Roanoke e si inoltra nel cuore della Shenandoah Valley; guida con la massima prudenza possibile, con il tachimetro fisso sui centodieci chilometri l’ora e segnalando doverosamente ogni cambio di corsia. Controlla lo specchietto retrovisore perché ormai è diventata un’abitudine e tiene d’occhio tutti gli altri veicoli per evitare ogni possibile collisione. Davanti al sedile del passeggero, e sul sedile stesso, c’è letteralmente una fortuna in oro, lingotti anonimi e non rintracciabili, appena rubati a un ladro che a sua volta li ha rubati a un individuo corrotto che li ha ricevuti da una banda di delinquenti. Come potrebbe spiegare Vanessa una tale collezione di metallo prezioso a un agente della Stradale ficcanaso? Non potrebbe, per cui guida nel modo più irreprensibile mentre i TIR a diciotto ruote la superano ruggendo sulla corsia alla sua sinistra. Prende l’uscita per una cittadina e vaga per un po’ finché trova un grande magazzino di fascia bassa. La scritta sulle vetrine pubblicizza offerte speciali per il ritorno a scuola. Vanessa parcheggia vicino all’entrata e nasconde le scatole di sigari con una coperta sporca che ha preso a casa di Nathan. Sistema la Glock sotto un angolo della coperta, a portata di mano, e studia il parcheggio. Di domenica mattina è praticamente deserto. Poi fa un respiro, scende dal pickup e si affretta a entrare nel negozio. In meno di dieci minuti acquista dieci zaini da bambino, tutti con una colorazione mimetica. Paga in contanti e non risponde quando il cassiere osserva: «Deve avere un mucchio di ragazzini che vanno a scuola». Carica i suoi acquisti nella cabina del pickup e torna sull’interstatale. Un’ora dopo trova un’area di sosta per camion nei pressi di Staunton, Virginia, e si ferma accanto a i TIR. Quando è sicura che nessuno la sta guardando, comincia a sistemare rapidamente le scatole di sigari negli zaini, due dei quali non vengono utilizzati. Fa il pieno, si compra il pranzo al drive through di un fast food e ammazza il tempo andando su e giù lungo l’Interstatale 81, spingendosi a nord fino al Maryland e a sud fino a Roanoke. Le ore si trascinano lente. Non può parcheggiare e allontanarsi dal tesoro, che deve essere sorvegliato ininterrottamente, perciò si lascia trasportare dal flusso del traffico e aspetta che faccia buio. Cammino su e giù in un’ala umida e affollata dell’aeroporto di San Juan, in attesa di un volo Delta per Atlanta. Il mio biglietto è stato acquistato a nome di Malcolm Bannister, il cui vecchio passaporto ha funzionato alla perfezione. Scadrà fra quattro mesi. L’ultima volta che l’ho usato, è stato quando Dionne e io ci siamo concessi una crociera a buon mercato alle Bahamas. In un’altra vita. Telefono a Vanessa due volte e parliamo in codice. Merce caricata. Imballo a posto. Vanessa se ne sta andando in giro, seguendo il piano. Se da qualche Teile c’è un ficcanaso in ascolto, si starà grattando la testa perplesso. Alle tre e mezzo finalmente ci imbarchiamo, poi restiamo seduti per un’ora nell’aereo bollente mentre una tempesta si scatena ululando sull’aeroporto e i piloti diventano muti. Dietro di me ci sono almeno due bambini piccoli che strillano. Mentre l’irritazione generale aumenta, chiudo gli occhi e tento di appisolarmi, ma mi sono privato del sonno così a lungo che ho dimenticato come si fa. Comincio a pensare a Nathan Cooley e alla sua situazione senza speranza, anche se non provo molta compassione per lui. Penso a Vanessa e sorrido alla sua resistenza sotto pressione. Siamo vicini alla meta, ma ci sono ancora tantissimi modi per fallire. Abbiamo l’oro, ma riusciremo a tenercelo? Mi scuoto quando l’aereo fa un balzo in avanti e comincia a correre rombando lungo la pista. Due ore dopo atterriamo ad Atlanta. Al controllo passaporti riesco a evitare i banchi presidiati da funzionari neri e scelgo un paffuto ragazzo bianco dall’aria annoiata e indifferente. Prende il mio passaporto, dà un’occhiata alla foto di Malcolm Bannister vecchia di nove anni, la confronta velocemente con la faccia revisionata di Max Reed Baldwin e non nota niente di strano. Noi neri siamo tutti uguali. Do per scontato che il servizio immigrazione abbia avvertito l’FBI che due giorni fa ho lasciato il paese a bordo di un jet privato diretto in Giamaica. Quello che non so, è se l’FBI stia monitorando eventuali movimenti di Malcolm Bannister. Sono pronto a scommettere di no e voglio che l’FBI pensi che me la sto ancora spassando da qualche Teile nei Caraibi. In ogni caso mi devo muovere in fretta. Dato che Malcolm non dispone più di una patente valida, è Max che noleggia un’auto dell’Avis e così, quarantacinque minuti dopo l’atterraggio ad Atlanta, lascio la città. Nei dintorni di Roswell, Georgia, mi fermo a un Walmart e compro, in contanti, altri due cellulari prepagati. Mentre esco dal magazzino, butto i due vecchi in un cestino dei rifiuti. Ormai è buio e Vanessa parcheggia definitivamente il pickup. Lo ha guidato per quasi mezza giornata e non vede l’ora di sbarazzarsene. Resta seduta per un momento al volante, in uno spazio vicino alla sua Honda Accord, e osserva un aereo navetta rullare verso il terminal di Roanoke. Sono passate da poco le ventuno di domenica e non sembra esserci traffico. Il parcheggio è semideserto. Vanessa scende e, guardandosi continuamente intorno, trasferisce gli zainetti dal sedile anteriore del pickup di Nathan al bagagliaio della propria auto. Otto zaini, ognuno dei quali le sembra più pesante del precedente, ma non le importa. Chiude il pickup, si mette in tasca le chiavi ed esce dal parcheggio. Se tutto va come previsto, il veicolo di Nathan non verrà notato per parecchi giorni. Quando gli amici di Cooley si renderanno conto che è scomparso, a un certo punto avvertiranno la polizia, che troverà il pickup e comincerà a mettere insieme i pezzi di una storia. Non c’è dubbio che Nathan si sia vantato con qualcuno del fatto che sarebbe andato a Miami su un jet privato e questo farà sì che i poliziotti per un po’ correranno in tondo inseguendosi la coda. Non ho modo di sapere se le autorità saranno in grado di collegare l’uomo scomparso a Nathaniel Coley, l’idiota che di recente è andato all’estero con un passaporto falso, quattro chili di coca e una pistola, ma ne dubito. È possibile che Nathan non venga rintracciato finché qualcuno in Giamaica non gli permetterà finalmente di fare una telefonata. Chi Cooley possa chiamare, e cosa possa dire, è impossibile prevederlo. È probabile comunque che adesso stia contando le ore e i giorni che lo separano dal mio ritorno, con un sacco di contanti da utilizzare per corrompere gente. Dopo qualche settimana, magari un mese, si renderà conto che il suo vecchio amico Reed lo ha fregato, si è preso i soldi ed è scappato. Un po’ mi dispiace per lui. All’una di notte, mentre mi avvicino ad Asheville, North Carolina, vedo l’insegna di un motel vicino a un trafficato svincolo autostradale. Dietro il motel, lontano da occhi indiscreti, c’è una piccola Honda Accord azzurra con la mia cara Vanessa al posto di guida, la Glock accanto a sé. Parcheggio vicino a lei ed entriamo insieme nella nostra stanza al piano terra. Ci baciamo e ci abbracciamo, ma siamo troppo tesi per fare l’amore. Scarichiamo in silenzio il bagagliaio dell’Accord e gettiamo gli zaini su uno dei letti. Chiudo la porta a chiave, metto la catena e incastro una sedia sotto il pomolo. Tiro le tende e appendo degli asciugamani al bastone per chiudere eventuali fessure e assicurarmi che nessuno possa vedere all’interno del nostro caveau privato. Mentre sbrigo queste faccende, Vanessa si fa una doccia e poi emerge dal bagno avvolta in un corto accappatoio che rivela chilometri e chilometri delle gambe più belle che io abbia mai visto. «Non pensarci neppure» dice. È esausta. Forse domani. Svuotiamo gli zainetti, indossiamo guanti di latex usa e getta e disponiamo ordinatamente le diciotto scatole di sigari, ognuna delle quali è sigillata con due strisce di nastro adesivo argentato. Notiamo che due scatole sembrano essere già state aperte – il nastro è tagliato lungo il coperchio – e le mettiamo da Teile. Servendomi di un temperino, taglio il nastro della prima scatola e la apro. Estraiamo i minilingotti, li contiamo – sono trenta – e poi li rimettiamo nella scatola, che richiudiamo con il nastro adesivo. Vanessa prende nota della quantità e apriamo la seconda scatola. Contiene trentadue minilingotti, tutti lucenti, perfettamente sagomati e apparentemente mai toccati da mani umane. «Belli, bellissimi» dice Vanessa, più e più volte. «Dureranno secoli.» «Per l’eternità» la correggo, passando un dito su un lingotto. «Non ti piacerebbe sapere da quale Teile del mondo provengono?» Vanessa ride perché non lo sapremo mai. Apriamo le sedici scatole sigillate e poi inventariamo i minilingotti delle due aperte in precedenza. Contengono circa la metà dei pezzi delle altre. Il nostro totale è di cinquecentosettanta lingottini. Dato che il prezzo dell’oro oscilla intorno ai millecinquecento dollari l’oncia, il nostro jackpot vale sugli otto milioni e mezzo di dollari. Ci distendiamo sul letto con l’oro tra di noi. Impossibile non sorridere. Ci starebbe bene una bottiglia di champagne, ma alle due di un lunedì mattina in un motel a buon mercato in North Carolina, lo champagne non esiste. C’è molto su cui riflettere in questo momento, ma uno degli aspetti più meravigliosi del nostro piano è che nessuno sta cercando questo tesoro. A Teile Nathan Cooley, nessuno sa che esiste. L’abbiamo rubato a un ladro, il quale non ha lasciato alcuna traccia. Vedere, toccare e contare la nostra fortuna ci ha dato energia. Strappo l’accappatoio di Vanessa e scivoliamo sotto le coperte dell’altro letto. Per quanto ci sforziamo, è difficile fare l’amore senza tenere un occhio sull’oro. Quando finiamo, collassiamo esausti e dormiamo come morti. 38 Alle sei e mezzo di lunedì mattina, l’agente Fox entrò nel vasto ufficio di Victor Westlake e disse: «I giamaicani sono lenti come sempre. Non c’è molto da dire. Baldwin è arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì su un jet noleggiato da una società di Raleigh, un bell’aereo che al momento è sotto sequestro da Teile della dogana giamaicana e non può tornare a casa. Nessun segno di Baldwin. Il suo amico, Nathaniel Coley, ha cercato di entrare nel paese con un passaporto falso e adesso è sottochiave, esattamente come l’aereo». «È in prigione?» chiese Westlake, mordicchiandosi l’unghia del pollice. «Sì, signore. È tutto quello che so al momento. Non ho idea di quando possa essere rilasciato. Sto provando a convincere la polizia giamaicana a controllare i registri degli alberghi per localizzare Baldwin, ma sono molto riluttanti. Baldwin non è un fuggitivo e a loro non piace disturbare gli hotel. Inoltre, era il weekend eccetera.» «Trovatemi Baldwin.» «Ci stiamo provando, signore.» «Cosa sta combinando?» Fox scosse la testa. «Non ha senso. Perché bruciare un mucchio di soldi per un jet privato? Perché viaggiare insieme a un tizio con un passaporto falso? E chi diavolo è Nathaniel Coley? Abbiamo fatto ricerche in Virginia e West Virginia e non abbiamo trovato niente. Forse Coley è un vecchio amico che non può richiedere il passaporto e così hanno cercato di fregare il servizio immigrazione per potersela spassare qualche giorno al sole.» «Forse, forse.» «Sì, signore.» «Continuate a scavare e fatemi rapporto per e-mail.» «Sì, signore.» «Immagino che Baldwin abbia lasciato la sua auto all’aeroporto di Roanoke.» «Sì, nel parcheggio del terminal voli privati. Stessa targa della Florida. L’abbiamo trovata sabato mattina e la teniamo sotto sorveglianza.» «Bene. Trovatemi Baldwin, okay?» «E se lo troviamo?» «Seguitelo e scoprite cosa sta facendo.» Davanti a due tazze di caffè e all’oro, programmiamo la nostra giornata, ma senza perdere tempo. Alle nove Vanessa riconsegna la chiave della stanza e paga il conto. Ci salutiamo con un bacio, poi la seguo in auto fuori dal parcheggio, attento a non stare troppo attaccato al paraurti posteriore della sua Accord, a pochi centimetri dal quale, nascosta in fondo al bagagliaio, c’è metà dell’oro. L’altra metà è nel bagagliaio della mia Impala a noleggio. Ci separiamo all’altezza dello svincolo: Vanessa va a nord e io a sud. La vedo nello specchietto retrovisore salutarmi con la mano e mi chiedo quando la rivedrò. Mentre mi preparo al lungo viaggio in auto con una grande tazza di caffè a portata di mano, rammento a me stesso che devo impiegare saggiamente il mio tempo. Niente stupidi sogni a occhi aperti, niente vagabondaggi mentali, niente fantasie su cosa fare di tutto il denaro. Ci sono molti punti che esigono un’attenzione prioritaria. La polizia quando troverà il pickup di Nathan? Quando devo telefonare a Rashford Watley per dirgli di riferire a Nathan che tutto procede come previsto? Quante scatole di sigari possono entrare nelle cassette di sicurezza che ho affittato un mese fa? Quanto oro devo cercare di vendere per intascare un po’ di contanti? Come faccio a ottenere l’attenzione di Victor Westlake e di Stanley Mumphrey, il procuratore federale di Roanoke? E, cosa più importante di tutte, come faremo uscire l’oro dal paese? E quanto tempo ci vorrà? E tuttavia la mente scivola verso mio padre, il vecchio Henry, che non ha più alcun contatto con il figlio minore da oltre quattro mesi. Sono sicuro che l’ho disgustato, facendomi sbattere fuori da Frostburg e spedire a Fort Wayne. Sono sicuro che è sconcertato dalla mancanza di notizie. Probabilmente ha telefonato a mio fratello Marcus a Washington e a mia sorella Ruby in California per chiedere se hanno saputo qualcosa. Chissà se Henry è già diventato bisnonno grazie al figlio delinquente di Marcus e alla sua fidanzatina quattordicenne? Oppure la ragazza ha abortito? Ripensandoci, forse la mia famiglia non mi manca quanto mi sembra a volte. Però sarebbe bello rivedere mio padre, anche se sospetto che non approverebbe il mio nuovo look. La verità è che con ogni probabilità non rivedrò mai più nessuno di loro. A seconda di quelli che saranno i capricci e le macchinazioni del governo federale, potrò continuare a essere un uomo libero o passare il resto della vita da fuggitivo. In ogni caso, avrò l’oro. Mentre i chilometri scivolano via e io mi attengo al limite di velocità, cercando di non farmi travolgere dai grossi TIR, non posso evitare di pensare a Bo. Sono uscito di prigione quattro mesi fa e ogni giorno ho dovuto soffocare l’impulso di pensare a mio figlio. L’idea che forse non lo rivedrò mai più fa male, ma con il passare delle settimane sono arrivato ad accettare questa realtà. Riprendere in qualche modo contatto con lui sarebbe il primo, enorme passo lungo la strada che porta alla normalità, ma da ora in poi la mia vita sarà tutto tranne che normale. Non sarà più possibile vivere di nuovo insieme sotto lo stesso tetto, come padre e figlio, e non vedo alcun vantaggio per Bo se sapesse che sono improvvisamente ricomparso e che mi piacerebbe mangiare un gelato con lui due volte al mese. Sono sicuro che si ricorda ancora di me, ma i ricordi stanno di certo sbiadendo. Dionne è una donna adorabile e in gamba, e non ho dubbi che lei e il suo nuovo marito stiano garantendo a Bo una vita felice. Perché io, praticamente uno sconosciuto e comunque un tizio che lo sembra, dovrebbe piombare nel loro mondo e sconvolgerlo? E una volta che convincessi Bo che sono davvero suo padre, come farei a resuscitare un rapporto morto da più di cinque anni? Per mettere fine a questo tormento, cerco di focalizzare i pensieri sulle prossime ore, poi sui prossimi giorni. Mi aspettano dei passi cruciali: un errore potrebbe costarmi una fortuna e forse rimandarmi in galera. Nei dintorni di Savannah mi fermo a fare benzina e mangio un sandwich preso da un distributore automatico. Due ore e mezzo dopo sono a Neptune Beach, il mio vecchio territorio temporaneo. In un negozio di articoli per ufficio acquisto una grossa valigetta, poi raggiungo uno dei parcheggi pubblici della spiaggia. Non ci sono telecamere di sorveglianza e nemmeno pedoni in giro; apro velocemente il bagagliaio, estraggo due scatole di sigari e le sistemo nella valigetta. Adesso arriva a circa diciotto chili e, mentre giro intorno all’auto, mi rendo conto che è troppo pesante. Tolgo una scatola e la rimetto nel bagagliaio. A quattro isolati di distanza, parcheggio davanti alla First Coast Trust e mi avvio con aria indifferente verso l’ingresso principale. Il termometro digitale sul tabellone elettronico della banca indica trentasei gradi. A ogni passo la valigetta diventa sempre più pesante e mi sforzo di muovermi come se contenesse solo qualche documento. Nove chili non sono molti, ma di sicuro sono troppi per una valigetta, di qualsiasi dimensione. Adesso ogni mossa viene videoregistrata e l’ultima cosa che voglio è un’immagine di me che entro in banca arrancando per il peso eccessivo. Mi preoccupo per Vanessa e per lo sforzo che dovrà fare per accedere alle cassette di sicurezza di Richmond con un tale carico sulle spalle. Ma per quanto gravoso, non posso fare a meno di sorridere all’incredibile peso dell’oro puro. All’interno della banca aspetto pazientemente che l’impiegata addetta al caveau finisca con un altro cliente. Quando arriva il mio turno, le consegno la mia patente della Florida e le faccio una firma sul modulo. La donna controlla la mia faccia e la mia grafia, approva e mi scorta nel caveau sul retro dell’edificio. Inserisce la chiave della banca nella serratura della mia cassetta, poi io inserisco la mia. I due clic sono perfetti, la cassetta può essere estratta e io la porto in uno stretto cubicolo riservato, di cui chiudo la porta. L’impiegata aspetta fuori, al centro del caveau. La cassetta è larga quindici centimetri, alta quindici e lunga quarantacinque, la più grande disponibile un mese fa, quando l’ho affittata per un anno versando trecento dollari. Metto la scatola di sigari nella cassetta. Vanessa e io abbiamo scritto su ogni scatola il numero esatto dei minilingotti all’interno. Questa ne contiene trentatré, pari a trecentotrenta once, per un valore approssimativo di cinquecentomila dollari. Chiudo la cassetta e rimango in ammirazione, lascio passare qualche minuto, poi apro la porta e avverto l’impiegata. Teile del suo lavoro consiste nel mantenere un atteggiamento impassibile e distaccato, e lei ci riesce bene. Immagino che abbia visto di tutto. Venti minuti più tardi sono nel caveau di una filiale della Jacksonville Savings Bank. Lo spazio qui è più ampio, le cassette più piccole e l’impiegato più sospettoso, ma tutto il resto è uguale. Dietro la porta chiusa a chiave, dispongo delicatamente un altro tesoretto di minilingotti all’interno della cassetta. Trentadue affascinanti lingottini che valgono un altro mezzo milione. Nella terza e ultima banca, distante meno di ottocento metri dalla prima, effettuo l’ultimo deposito della giornata, poi passo un’ora alla ricerca di un motel dove possa parcheggiare davanti alla mia camera. In un centro commerciale alla periferia ovest di Richmond, Vanessa si aggira in un grande magazzino di lusso alla ricerca del reTeilo accessori femminili. Anche se si muove con calma, è un fascio di nervi perché l’Accord è là fuori, abbandonata nel parcheggio e in attesa solo di essere vandalizzata o rubata. Sceglie una raffinata borsa di pelle a tracolla, rossa e sufficientemente capiente da essere definita bagaglio. È stata disegnata da un famoso stilista e molto probabilmente verrà notata dalle impiegate delle banche. Paga in contanti e si precipita alla sua auto. Due settimane fa, Max – Vanessa lo ha sempre conosciuto come Malcolm, ma il nome nuovo le piace di più – le ha ordinato di affittare tre cassette di sicurezza. Lei ha accuratamente selezionato le banche nell’area di Richmond, ha compilato i moduli, ha superato i controlli e ha pagato gli affitti. Poi, come da istruzioni, è andata per due volte a depositare inutili cartacce in ognuna delle cassette. Adesso gli impiegati la conoscono, si fidano di lei e non hanno il minimo sospetto quando Ms Vanessa Young si presenta con la sua nuova borsa firmata e chiede di avere accesso al caveau. In meno di novanta minuti Vanessa mette al sicuro quasi un milione e mezzo di dollari in oro. Torna a casa per la prima volta dopo più di una settimana e parcheggia in uno spazio che può tenere d’occhio dalla sua finestra al secondo piano. Il palazzo è in una bella zona della città, vicino all’University of Richmond e il quartiere in genere è sicuro. Vanessa abita qui da due anni e non ricorda una sola auto rubata o un solo furto. In ogni caso non intende correre rischi. Ispeziona porte e finestre cercando segni di scasso, ma non ne trova. Fa una doccia, si cambia ed esce di nuovo. Quattro ore dopo è di ritorno e, nel buio, trasporta lentamente e metodicamente il tesoro all’interno dell’apTeilamento e lo nasconde sotto il letto. Ci dorme sopra, con la Glock sul comodino e tutte le porte chiuse a chiave e bloccate da una sedia sotto il pomolo. Dorme solo a tratti e all’alba sta già sorseggiando caffè sul divano del soggiorno mentre guarda le previsioni del tempo sulla locale TV via cavo. L’orologio sembra essersi fermato. Le piacerebbe dormire ancora un po’, ma sa che la mente non consentirà al corpo di lasciarsi andare. Le è sparito anche l’appetito, ma si sforza di buttare giù un po’ di fiocchi di latte. Più o meno ogni dieci minuti, si avvicina alla finestra e controlla il parcheggio. I pendolari del primo mattino escono di casa a ondate: sette e trenta, sette e quarantacinque, otto. Le banche apriranno solo alle nove. Vanessa fa un’altra lunga doccia, si veste come se dovesse andare a corte, prepara una borsa da viaggio e la carica sull’Accord. Nel corso dei venti minuti successivi, preleva tre scatole di sigari da sotto il letto e le trasferisce in auto. Tra poco le depositerà nelle stesse tre cassette di sicurezza che ha visitato ieri. Il grande dibattito che infuria nella sua mente è se le restanti tre scatole saranno più al sicuro nel bagagliaio dell’auto o sotto il letto nell’apTeilamento. Decide di andare sul sicuro: ne lascia due a casa e prende l’altra con sé. Vanessa mi telefona per comunicarmi che ha effettuato il terzo e ultimo deposito del mattino e che sta andando a Roanoke, dove incontrerà l’avvocato. Io la precedo di un paio di passi. Ho visitato le mie tre banche un po’ prima di lei, ho effettuato i depositi e adesso sono in auto, diretto a Miami. Abbiamo messo al sicuro trecentottanta dei cinquecentosettanta minilingotti. È una bella sensazione, ma la pressione è ancora alta. Nelle giuste circostanze, e anche in quelle sbagliate, i federali hanno la facoltà di mettere sotto sequestro qualsiasi bene o proprietà, e lo fanno. Perciò non vogliamo correre rischi. Devo portare l’oro fuori dal paese. Suppongo che i federali non sappiano che Vanessa e io lavoriamo insieme. Suppongo anche che non abbiano ancora collegato Nathan Cooley a me. Sto facendo un mucchio di supposizioni e non ho modo di sapere se sono corrette o no. 39 Impantanato in un rallentamento per lavori stradali nei pressi di Fort Lauderdale, digito il numero del cellulare di Mr Rashford Watley, a Montego Bay. L’avvocato mi risponde con una gran risata, come se fossimo amici da decenni. Lo informo che sono di nuovo al sicuro negli Stati Uniti e che va tutto bene. Quarantott’ore fa sgusciavo fuori dalla Giamaica dopo avere salutato sia Nathan che Rashford, terrorizzato all’idea di essere fermato da uomini in uniforme prima di potermi imbarcare sul volo diretto a Porto Rico. Sono stupefatto dalla velocità con cui succedono le cose. Rammento più volte a me stesso che devo restare concentrato e pensare alla prossima mossa. Da domenica Rashford non è più tornato alla prigione. Gli spiego che Nathaniel si è inventato un piano per corrompere gente in Giamaica e vaneggia su un mio ritorno con un vagone di contanti. Ho fatto qualche telefonata e sembra proprio che il ragazzo abbia una lunga storia di tossicodipendenza; non riesco ancora a credere che quell’idiota abbia provato a contrabbandare quattro chili di coca e non so assolutamente spiegarmi la pistola. Un deficiente. L’avvocato si dichiara d’accordo con me e mi informa che ieri, lunedì, ha fatto due chiacchiere con il procuratore. Se Rashford riuscirà a far funzionare la sua magia, il nostro amico se la dovrà vedere con “circa” vent’anni nel sistema carcerario giamaicano. Francamente, ammette Rashford, non crede che Nathaniel potrà sopravvivere così a lungo. A giudicare dai pestaggi che ha subito nelle prime due notti in cella, sarà fortunato se resisterà una settimana. Mi accordo con Rashford per una sua visita a Nathaniel nel pomeriggio. Gli chiedo di riferire al nostro amico che sto lavorando sodo per ottenere il suo rilascio, che la visita a casa sua è andata come previsto e che le cose procedono come stabilito. «Come vuoi» mi dice Rashford. Gli ho pagato la parcella, perciò, tecnicamente, sta ancora lavorando per me. Spero che questa sia la nostra ultima conversazione. Vanessa affronta di nuovo le tre ore e mezzo d’auto da Richmond a Roanoke e si presenta puntuale all’appuntamento delle quattordici con Dusty Shiver, l’avvocato di Quinn Rucker. Quando ha telefonato per concordare l’incontro, Vanessa ha assicurato di essere in possesso di prove vitali riguardanti il caso di Quinn. Dusty si è incuriosito e ha cercato di ottenere qualche informazione, ma Vanessa ha insistito per un incontro a quattr’occhi, il più presto possibile. È vestita alla moda, con una gonna abbastanza corta da attirare l’attenzione. Con sé ha una piccola valigetta di pelle. Quando entra nell’ufficio, Dusty scatta in piedi per offrirle una sedia. Una segretaria serve il caffè e viene scambiata qualche chiacchiera di circostanza fino a quando la porta si richiude definitivamente. «Vado subito al punto, Mr Shiver» attacca Vanessa. «Quinn Rucker è mio fratello e io posso provare che è innocente.» Dusty riflette sulla dichiarazione e lascia che echeggi nella stanza. Sa che Quinn ha due fratelli, Dee Ray e Tall Man, e sa che ha anche una sorella, Lucinda. Lavorano tutti nell’impresa di famiglia. Adesso ricorda che c’è anche un’altra sorella che non si è mai lasciata coinvolgere e della quale non è mai stata fatta menzione. «Quinn è suo fratello» ripete Dusty, quasi borbottando. «Sì. Io me ne sono andata da Washington qualche anno fa per restare alla larga da tutto.» «Okay, l’ascolto. Sentiamo.» Vanessa accavalla di nuovo le gambe, ma Dusty mantiene il contatto degli occhi. «Più o meno una settimana dopo l’evasione da Frostburg, Quinn per poco non è morto per un’overdose di cocaina a Washington. Noi, la famiglia, sapevamo che avrebbe finito per uccidersi con quella roba... Quinn è sempre stato quello che si faceva di più... e siamo intervenuti. Mio fratello Dee Ray e io lo abbiamo portato in un centro di riabilitazione vicino ad Akron, Ohio, un posto per tossici seri. Non c’era un’ordinanza del tribunale, per cui non lo si poteva rinchiudere, ma in sostanza è ciò che succede in quella struttura. Quinn era lì da ventun giorni quando, il sette febbraio, sono stati trovati i corpi del giudice Fawcett e della sua segretaria.» Vanessa estrae una cartellina dalla sua valigetta e la posa sulla scrivania di Dusty. «Lì dentro c’è tutta la documentazione. Dato che era appena evaso di prigione, Quinn è stato ricoverato sotto falso nome: Mr James Williams. Abbiamo versato un anticipo di ventimila dollari in contanti, per cui al centro di riabilitazione non hanno sollevato obiezioni, né hanno fatto domande. Ma hanno sottoposto mio fratello a un check-up completo, compresi gli esami del sangue, perciò esiste la prova del DNA in grado di dimostrare che al momento degli omicidi Quinn era là dentro.» «Da quanto tempo lei è al corrente della situazione?» «Non posso rispondere a tutte le sue domande, Mr Shiver. Nella nostra famiglia ci sono molti segreti, e non molte risposte.» Dusty la fissa e Vanessa sostiene calma il suo sguardo. L’avvocato è consapevole che non verrà mai a sapere tutto, ma al momento la cosa non è poi così importante. Ha appena conseguito una grossa vittoria sul governo e sta già ridendo. «Perché suo fratello ha confessato?» «Perché una persona confessa un crimine che non ha commesso? Non lo so. Quinn soffre di un grave disturbo bipolare, e anche altri problemi. Quelli dell’FBI l’hanno martellato per dieci ore e hanno usato tutti i trucchi a loro disposizione. Conoscendo Quinn, direi che è stato al gioco. Probabilmente ha dato a quella gente ciò che voleva in modo che lo lasciassero in pace. Forse si è inventato una bella storia solo per farli correre in cerchio nel tentativo di verificarla. Non lo so. Lei ricorda la vicenda di baby Lindbergh, il più famoso caso di rapimento della storia?» «Ho letto di quel caso, certo.» «Be’, furono almeno centocinquanta le persone che si autoaccusarono del crimine. Non ha senso, ma Quinn a volte può essere completamente pazzo.» Dusty apre la cartellina. C’è un rapporto per ogni giorno che Quinn ha trascorso in riabilitazione, dal diciassette gennaio al sette febbraio, il lunedì in cui sono stati rinvenuti i cadaveri del giudice Fawcett e di Naomi Clary. «Qui c’è scritto che Quinn ha lasciato la struttura nel pomeriggio del sette febbraio» dice Dusty leggendo. «È così. Mio fratello se n’è andato, o è scappato, e ha raggiunto Roanoke.» «E perché, se posso chiederlo, è andato a Roanoke?» «Di nuovo, Mr Shiver, ci sono domande alle quali non posso rispondere.» «E così suo fratello compare a Roanoke il giorno dopo la scoperta dei cadaveri, va in un bar, si ubriaca, si azzuffa, si fa arrestare e gli trovano un sacco di contanti in tasca. Ci sono parecchi buchi, Miss...» «Sì, è vero, ma con il tempo quei buchi verranno colmati. Adesso però non ha molta importanza, no? Ciò che importa, è che lei ha la prova inconfutabile dell’innocenza di Quinn. A Teile la falsa confessione, il governo non ha alcuna prova contro mio fratello, giusto?» «Giusto. Non ci sono prove materiali, solo un comportamento molto sospetto. Per esempio, perché era a Roanoke? Come ci era arrivato? Dove aveva preso tutti quei contanti? Dove aveva acquistato le armi rubate? Sono un mucchio di domande, ma immagino che lei non abbia le risposte, vero?» «Vero.» Dusty intreccia le mani dietro la nuca e fissa il soffitto. Dopo un lungo silenzio dice: «Dovrò fare delle indagini. Andare al centro di riabilitazione, interrogare il personale, farmi rilasciare delle dichiarazioni giurate eccetera. I federali non cederanno finché la nostra pratica non sarà molto più voluminosa e non potremo sbattergliela in faccia. Mi serviranno altri venticinquemila dollari». Senza esitare, Vanessa dice: «Ne parlerò con Dee Ray». «L’udienza preprocessuale è tra due settimane, perciò dobbiamo muoverci in fretta. Mi piacerebbe depositare l’istanza di archiviazione dell’indagine prima dell’udienza.» «L’avvocato è lei.» Un’altra pausa mentre Dusty si piega in avanti sui gomiti e fissa Vanessa. «Conoscevo bene il giudice Fawcett. Non eravamo amici intimi, solo buoni conoscenti. Se non è stato Quinn a ucciderlo, ha idea di chi può essere stato?» Vanessa sta già scuotendo la testa. No. La polizia trovò il pickup di Nathan nel parcheggio dei voli privati del Roanoke Regional Airport nella tarda mattinata di martedì. Come prevedibile, il lunedì i dipendenti del bar si erano preoccupati non vedendo arrivare Cooley e in serata avevano cominciato a telefonare in giro. Alla fine avevano chiamato la polizia, che aveva perlustrato la zona dell’aeroporto. Nathan si era vantato del suo volo a Miami a bordo di un jet privato, per cui la ricerca non risultò difficile, almeno per quanto riguardava il pickup. Il ritrovamento del veicolo, tuttavia, non indicava automaticamente un reato, e la polizia non aveva molta fretta di dare inizio a una caccia all’uomo. Un rapido controllo sull’individuo scomparso ne rivelò i precedenti penali e questo non contribuì molto a suscitare solidarietà e comprensione. Inoltre, non c’era una famiglia che strillasse per la scomparsa dell’amato congiunto. Una ricerca al computer e qualche telefonata appurarono che Nathan aveva acquistato il suo Chevy Silverado nuovo di zecca due mesi prima presso un concessionario di Lexington, Virginia, un’ora d’auto a nord di Roanoke sull’Interstatale 81. Il prezzo di vendita era stato di quarantunmila dollari e Nathan aveva pagato sull’unghia. Non nel senso di assegno, ma di contanti. Un notevole mucchietto di banconote da cento. All’insaputa del concessionario e della polizia – o di chiunque altro, se era per quello – Nathan si era trovato un commerciante d’oro. Finalmente ne trovo uno anch’io. Dopo due viaggi nel caveau della Palmetto Trust nella Teile sud del centro di Miami, ho ancora in mio possesso – nel bagagliaio dell’Impala a noleggio – esattamente quarantuno preziosi minilingotti, per un valore di circa seicentomila dollari. Ho bisogno di convertirne una Teile in contanti e, per farlo, sono costretto ad avventurarmi nell’oscuro mondo del commercio dell’oro, dove le regole sono flessibili, adattate al momento, e tutti i personaggi hanno occhi sfuggenti e usano un linguaggio ambiguo. I primi due, pescati sulle Pagine Gialle, sospettano che io sia un agente di qualche tipo e riattaccano subito. Il terzo, un gentiluomo dall’accento straniero – cosa che, come sto imparando in fretta, non è insolita nell’ambiente – vuole sapere come sono entrato in possesso di un lingotto da dieci once di oro apparentemente puro. «È una lunga storia» rispondo, e riattacco. Il numero quattro è un pesce piccolo che ufficialmente gestisce un banco di pegni e compra gioielli sottobanco. Il numero cinque sembra avere un certo potenziale, ma naturalmente esige di vedere la merce. Gli spiego che non voglio entrare nel suo negozio perché non mi va di essere ripreso dalle telecamere. Lui tace e sospetto che stia pensando alla possibilità di venire derubato dei suoi contanti sotto la minaccia di una pistola. Alla fine concordiamo un incontro in una gelateria a due porte dal suo negozio, all’interno di un centro commerciale in una zona rispettabile della città. Il mio uomo indosserà un berretto nero dei Marlins. Mezz’ora più tardi sono seduto davanti a un gelato al pistacchio. Hassan, un corpulento siriano dalla barba grigia, è di fronte a me e si sta lavorando la sua coppa con tripla glassa di cioccolato. A sei metri da noi c’è un altro gentiluomo dalla pelle scura che legge un quotidiano, mangia un gelato allo yogurt e probabilmente è pronto a spararmi se solo do il minimo segno di voler creare guai. Dopo aver cercato, senza riuscirci, di fare due chiacchiere amichevoli, faccio scivolare sul tavolo una busta sgualcita. Dentro c’è un unico lingotto. Hassan si guarda intorno, ma gli unici clienti sono giovani mamme con i loro figlioletti, più l’altro siriano. Hassan afferra il minilingotto con la sua grossa zampa, lo stringe, sorride, lo picchietta leggermente sull’angolo del tavolo e mormora: «Wow». Questo lo dice senza la minima traccia d’accento. Mi stupisce constatare quanto sia tranquillizzante quella semplice esclamazione. Non ho mai pensato che l’oro fosse falso, ma sentirmelo confermare da un professionista è rassicurante. «Le piace, eh?» domando stupidamente, tanto per dire qualcosa. «Molto bello» conferma Hassan, rimettendo il lingotto nella busta. Tendo la mano e me la riprendo. Lui mi chiede: «Quanti?». «Diciamo cinque pezzi, cinquanta once. Ieri l’oro ha chiuso a millecinquecentoventi dollari l’oncia, per cui...» «Conosco il prezzo dell’oro» mi interrompe Hassan. «Certo. Vuole comprare cinque lingottini?» Un uomo così non dice mai sì o no. Borbotta, la prende alla larga, ci gira intorno e bluffa. «È possibile. Ovviamente dipende dal prezzo.» «Lei quanto offre?» domando, ma senza troppa ansia. Ci sono altri commercianti d’oro sulle Pagine Gialle, anche se il tempo comincia a scarseggiare e sono stanco di fare telefonate. «Be’, Mr Baldwin, dipende da diverse cose. In una situazione come questa bisogna presumere che l’oro sia... diciamo del tipo mercato nero. Non so dove lei lo abbia preso, e non voglio saperlo, ma esiste una ragionevole possibilità che sia stato... diciamo prelevato dal suo precedente proprietario.» «Importa veramente da dove...» «Lei è il proprietario registrato di questo oro, Mr Baldwin?» mi chiede bruscamente il siriano. Mi guardo intorno. «No.» «Naturalmente. Lo sconto al mercato nero è del venti per cento.» Non ha bisogno della calcolatrice. «Le pagherò milleduecentoventi dollari l’oncia» dice con calma, ma con fermezza, piegandosi in avanti. La barba gli copre in Teile le labbra, ma le parole nonostante l’accento sono chiare. «Per cinque lingotti?» chiedo. «Cinquanta once?» «Sempre che gli altri quattro siano della stessa qualità.» «Sono identici a questo.» «E lei non ha registrazioni, fatture, documenti... niente, vero, Mr Baldwin?» «Vero, e non voglio registrazioni neppure adesso. Una semplice transazione, oro in cambio di contanti, niente ricevute, niente documenti, niente video, niente. Sono arrivato e poi sono svanito nella notte.» Hassan sorride. Ci stringiamo la mano e l’affare è concluso. Concordiamo di rivederci domani mattina alle nove in una tavola calda sull’altro lato della strada, un locale con séparé dove potremo sbrigare i nostri affari in privato. Quando esco dalla gelateria ho come la sensazione di avere commesso un reato e devo ripetere a me stesso quello che dovrebbe essere ovvio, e cioè che non è contro la legge comprare e vendere oro, a prezzi scontati o gonfiati. Non è che stiamo spacciando crack in strada, né si tratta di informazioni riservate fatte filtrare da un consiglio d’amministrazione. Questa è una transazione perfettamente legale, giusto? Chiunque avesse guardato Hassan e me avrebbe giurato di avere visto due delinquenti che concludevano un affare da delinquenti. E chi avrebbe potuto dargli torto? Ma, a questo punto, non mi importa più. Sto correndo dei rischi, ma non ho scelta. Hassan è un rischio, ma io ho bisogno di soldi. Anche portare l’oro fuori dal paese comporterà dei rischi, ma lasciarlo qui potrebbe significare perderlo. Impiego le due ore successive facendo shopping in diversi discount. Compro vari articoli, come scatole di backgammon, piccole cassette degli attrezzi, libri in edizione rilegata e tre laptop a buon mercato. Scarico i miei acquisti nella stanza al piano terra di un motel a sud di Coral Gable e trascorro il resto della sera armeggiando, imballando e sorseggiando birra ghiacciata. Estraggo dai laptop gli hard drive e le batterie, che sostituisco con tre dei miei mattoncini. Inserisco all’interno di ogni volume rilegato un minilingotto avvolto in carta di giornale e foglio di alluminio, poi passo il nastro adesivo intorno al libro. Nelle cassette degli attrezzi lascio il martello e i cacciavite, ma tolgo tutto il resto. Sistemo ordinatamente quattro lingottini in ogni cassetta. Le scatole del backgammon possono ospitarne due senza suscitare sospetti per il peso. Usando materiale di FedEx, UPS e DHL, imballo con cura i vari articoli, mentre le ore passano e io sono perso in un altro mondo. Telefono due volte a Vanessa e ci raccontiamo la nostra giornata. Lei è di nuovo a Richmond e sta facendo quello che sto facendo io. Siamo entrambi esausti, fisicamente e mentalmente, ma ci incoraggiamo a vicenda. Non è il momento di rallentare o di diventare sbadati. A mezzanotte ho finito e ammiro il mio lavoro. Sulla credenza ci sono circa dieci pacchi per consegna urgente, tutti sigillati e debitamente accompagnati dalle rispettive lettere di vettura aeree; hanno un’apparenza irreprensibile, per nulla sospetta, e complessivamente contengono trentadue minilingotti per un valore di cinquecentomila dollari circa. La compilazione dei moduli per le spedizioni internazionali è noiosa e sono costretto a imbrogliare un po’ per quanto riguarda il contenuto dei pacchi. Il mittente è Mr M. Reed Baldwin della Skelter Films di Miami, e il destinatario è la stessa persona, a Sugar Cove Villas, n. 26, Willoughby Bay, Antigua. Il mio piano prevede che mi trovi là per ricevere personalmente i pacchi. Se arriveranno a destinazione senza incidenti, probabilmente Vanessa e io tenteremo identiche spedizioni nel prossimo futuro. Se invece qualcosa andrà male, studieremo piani alternativi. Spedire l’oro in questo modo è un altro rischio: i pacchi potrebbero essere controllati e sequestrati, l’oro potrebbe essere rubato lungo il percorso. Tuttavia sono ragionevolmente sicuro che arriverà alla sua nuova casa. Ricordo a me stesso che non stiamo spedendo stupefacenti. Sono troppo teso per dormire e alle due di notte accendo sia la luce che il laptop e mi metto al lavoro sull’e- mail che invierò a Mr Stanley Mumphrey, procuratore federale, Distretto Sud della Virginia, e a Mr Victor Westlake, FBI, Washington. La bozza in lavorazione dice: Cari Mr Mumphrey e Mr Westlake, temo di aver commesso un grave errore. Quinn Rucker non ha ucciso il giudice Raymond Fawcett e neppure Ms Naomi Clary. Fuori dal carcere, mi ci sono voluti parecchi mesi per rendermene conto e per identificare il vero assassino. La confessione di Quinn è falsa, come ormai probabilmente sapete, e contro di lui avete zero prove. Il suo avvocato, Dusty Shiver, è ora in possesso di prove inoppugnabili e di un alibi che discolperà Quinn, perciò preparatevi alla necessità di far cadere ogni accusa nei suoi confronti. Mi scuso per qualsiasi inconveniente possa avervi causato. È imperativo che ci incontriamo il più presto possibile. Ho un piano dettagliato riguardante il modo di procedere, e solo la vostra totale collaborazione porterà all’arresto e alla condanna dell’assassino. Tale piano inizia con la promessa di totale immunità per me e per altre persone, e termina con il risultato che desiderate. Lavorando insieme, potremo finalmente risolvere la questione e far sì che venga fatta giustizia. Sono all’estero e non ho in programma di rientrare, mai più. Cordialmente, Malcolm Bannister 40 Come ormai d’abitudine, il sonno è sfuggente. Anzi, è così inafferrabile e intermittente che non sono neppure sicuro di aver dormito. C’è talmente tanto da fare che mi ritrovo a bere caffè cattivo e a guardare la televisione ben prima che il sole si alzi. Alla fine faccio la doccia, mi vesto, carico i miei pacchi in auto e mi inoltro nelle strade ancora deserte di Miami alla ricerca della colazione. Alle nove Hassan fa il suo ingresso nella tavola calda con un sacchetto di carta marrone, come se fosse appena andato a comprare qualcosa in un negozio di alimentari. Ci rannicchiamo in un séparé, ordiniamo caffè e, nascondendoci alla cameriera, procediamo con i conteggi. Quello di Hassan è molto più facile del mio; accarezza i cinque minilingotti e poi se li lascia cadere nelle tasche interne del blazer grinzoso. Io sbircio all’interno del sacchetto marrone e tento di contare centoventidue mazzette di banconote da cento, dieci per mazzetta. «C’è tutto» mi assicura Hassan, tenendo d’occhio la cameriera. «Centoventiduemila dollari.» Una volta soddisfatto, richiudo il sacchetto e tento di gustarmi il caffè. Venti minuti dopo essere arrivato, Hassan se ne va. Io mi trattengo ancora un po’, esco a mia volta e, aspettando nervosamente l’assalto di una squadra SWAT, mi avvio verso la mia auto. Tengo a portata di mano ventiduemila dollari per il viaggio e sistemo cinquantamila dollari in ognuna delle due rimanenti scatole di backgammon. A una filiale della FedEx, aspetto in fila con i miei cinque pacchi e osservo attento i clienti che mi precedono sbrigare i loro affari. Quando arriva il mio turno, l’impiegata esamina le lettere di vettura aerea e con indifferenza mi chiede: «Cosa c’è dentro?». «Articoli per la casa, qualche libro, niente di valore, niente da assicurare» rispondo con le parole accuratamente preparate. «Ho una casa ad Antigua che voglio sistemare un po’.» La donna annuisce come se i miei programmi la interessassero davvero. Per una consegna standard garantita entro tre giorni, la fattura ammonta a trecentodieci dollari, che saldo con una carta di credito prepagata. Quando esco dall’ufficio, lasciandomi l’oro alle spalle, faccio un respiro profondo e spero per il meglio. Servendomi del GPS dell’auto a nolo, raggiungo una filiale UPS e ripeto la stessa procedura. Torno alla Palmetto Trust e impiego un’ora per arrivare alla mia cassetta, dentro la quale lascio il resto dei contanti e i quattro lingottini rimanenti. Ci metto un po’ a trovare l’ufficio spedizioni della DHL nell’area del Miami International, ma alla fine ci arrivo e mi sbarazzo di altri pacchi. Finalmente mi separo dall’Impala al banco dell’Avis e con un taxi raggiungo la sezione voli privati dell’aeroporto, lontanissima dal terminal principale. Ci sono isolati di hangar per aerei privati, società charter e scuole di volo, e il mio tassista si perde mentre cerchiamo invano una compagnia denominata Maritime Aviation. Ci sarebbe bisogno di un’insegna più grande perché quella attualmente in uso non si vede quasi dalla strada vicina e sono tentato di rimarcare questa verità all’impiegato appena varco la porta. Ma riesco a mordermi la lingua e a rilassarmi. Non c’è uno scanner che esamini me o il mio bagaglio; immagino che i terminal dei voli privati non siano dotati di strumenti del genere. Penso che sarò comunque controllato al mio arrivo ad Antigua, perciò ho deciso di giocare sul sicuro. Ho circa trentamila dollari in contanti, la maggior Teile dei quali nascosta nel bagaglio; se li troveranno e si faranno prendere dall’eccitazione, fingerò di cadere dalle nuvole e pagherò la multa. Ho avuto la tentazione di cercare di portare fuori dal paese un paio di lingotti, tanto per vedere se è possibile riuscirci, ma il rischio sarebbe stato maggiore del vantaggio. Alle tredici e trenta i piloti mi dicono che è ora di imbarcarci, così saliamo a bordo di un Learjet 35, un piccolo aereo che misura circa la metà del Challenger che Nathan e io ci siamo goduti per un po’ durante la nostra recente gita in Giamaica. Il 35 può arrivare a ospitare sei persone, ma se si trattasse di uomini adulti dovrebbero sedere spalla a spalla. Invece del bagno, c’è un contenitore d’emergenza sotto un sedile. La cabina è stipata, come minimo, ma chi se ne importa? Il Learjet è molto meno caro di un grosso aereo, ma altrettanto veloce. Io sono l’unico passeggero, e ho fretta. A bordo c’è Max Baldwin, con tutti i suoi regolari documenti. Malcolm Bannister è uscito di scena, definitivamente. Sono sicuro che il servizio immigrazione prima o poi avvertirà un ficcanaso dell’FBI, il quale, dopo qualche perplessità, riferirà al suo capo. Si sfregheranno il mento e si chiederanno cosa abbia in mente Baldwin. Perché questa fissazione per i jet privati? Perché sta buttando via tutti i suoi soldi? Un mucchio di domande, ma la più importante sarà sempre: cosa diavolo sta facendo? Non ne avranno la minima idea finché non glielo dirò io. Mentre l’aereo si allontana dal terminal, rivedo velocemente la mia e-mail per Mumphrey e Westlake e clicco su “Invio”. Oggi è il 28 luglio. Quattro mesi fa ho lasciato Frostburg e due mesi fa me ne sono andato da Fort Carson con una nuova faccia e un nuovo nome. Mentre cerco di ricostruire le ultime settimane e di valutarle in prospettiva, comincio ad appisolarmi. Quando raggiungiamo l’altezza di dodicimila metri, mi addormento del tutto. Due ore più tardi vengo svegliato da una turbolenza e guardo fuori dall’oblò. Stiamo cavalcando una tempesta estiva e il piccolo jet viene sballottato in ogni direzione. Uno dei piloti si volta e mi fa segno con i pollici alzati: è tutto okay. Se lo dici tu, amico. Qualche minuto dopo il cielo è di nuovo sereno, la tempesta è alle nostre spalle e io osservo le meravigliose acque dei Caraibi sotto di noi. Secondo il NavScreen sulla paratia davanti a me, stiamo per sorvolare St Croix nelle Isole Vergini. Ci sono così tante splendide isole, laggiù, e così varie. Quando ero in carcere, tenevo nascosta in biblioteca una copia della Fodor’s Guide to the Caribbean, un grosso testo di consultazione con una ventina di foto a colori, mappe, elenchi di cose da fare e una breve storia di tutte le isole. Sognavo che un giorno sarei stato libero nei Caraibi insieme a Vanessa e che, noi due soli a bordo di una piccola barca a vela, avremmo vagato da una meta all’altra in totale e assoluta libertà. Non so andare a vela e non ho mai posseduto una barca, ma quello era Malcolm. Oggi Max sta per cominciare una nuova vita a quarantatré anni, e se vuole comprarsi uno skiff, imparare ad andare a vela e passare il resto dell’esistenza scivolando da una spiaggia all’altra, chi può impedirglielo? L’aereo ha un piccolo sobbalzo quando la potenza dei motori viene leggermente ridotta. Osservo il capitano abbassare le manette mentre inizia la lunga discesa. C’è un frigo portatile accanto al portellone ed estraggo una birra. Sorvoliamo Nevis e St Kitts. Anche queste due isole hanno un’interessante normativa bancaria e le ho prese brevemente in considerazione quando ero ancora a Frostburg e avevo un sacco di tempo da dedicare alle mie ricerche. Ho preso in considerazione anche le Cayman, ma poi ho saputo che ormai sono terribilmente cementificate. Le Bahamas sono troppo vicine alla Florida e infestate da agenti americani. Porto Rico è territorio americano, perciò non è mai comparso sul mio elenco. St Bart ha problemi di traffico. Nelle Isole Vergini c’è troppa criminalità. La Giamaica è dove adesso risiede Nathan. Ho scelto Antigua come prima base operativa perché conta settantacinquemila abitanti, quasi tutti neri come me; non è sovraffollata, ma nemmeno scarsamente popolata. È un’isola montagnosa con trecentosessantacinque spiagge, una per ogni giorno dell’anno, o almeno così dicono i dépliant e i siti Web. Ho scelto Antigua perché le sue banche sono notoriamente flessibili e famose per chiudere un occhio. E se per qualche ragione non dovesse piacermi, farò presto ad andarmene. Di posti da vedere ce ne sono fin troppi. L’aereo tocca terra con violenza e si ferma con stridio di freni. Il capitano si volta e mima le parole “Mi scusi”. Tutti i piloti vanno orgogliosi dei loro atterraggi vellutati, e l’uomo probabilmente è imbarazzato. Come se a me importasse. In questo momento l’unica cosa che mi interessa è uscire in sicurezza dall’aereo ed entrare nel paese senza problemi. Ci sono altri due jet al terminal dei voli privati, e fortunatamente ne è appena atterrato uno bello grosso. Almeno dieci americani in pantaloncini corti e sandali si stanno dirigendo verso l’edificio per superare i controlli. Traccheggio un po’, abbastanza per accodarmi a loro. Mentre i funzionari della dogana e dell’immigrazione sbrigano la solita routine, mi accorgo che non ci sono scanner per i passeggeri e i bagagli dei voli privati. Eccellente! Saluto i miei piloti e poi, all’esterno del piccolo edificio, guardo gli americani salire a bordo di un pulmino e scomparire. Mi siedo su una panchina finché non arriva il mio taxi. La villetta è a Willoughby Bay, a venti minuti d’auto dall’aeroporto. Siedo sul retro del taxi con i finestrini abbassati e l’aria calda e salata che mi soffia in faccia mentre ci arrampichiamo su un lato della montagna e poi scendiamo lentamente dall’altro. Vedo in lontananza decine di piccole barche che, all’ancora in una baia, riposano su un’acqua azzurra che sembra perfettamente immobile. La villetta, arredata e con due camere da letto, fa Teile di un gruppo di costruzioni tutte uguali, non proprio sulla spiaggia, ma abbastanza vicino da sentire il rumore delle onde che si frangono a riva. È affittata a nome mio, quello attuale, e l’affitto di tre mesi è stato saldato con un assegno della Skelter Films. Pago la corsa al tassista e varco il cancello d’ingresso di Sugar Cove. La simpatica signora dell’ufficio mi consegna la chiave, un opuscolo con il regolamento e le istruzioni dell’unità abitativa. Entro, attivo ventilatori e aria condizionata e do un’occhiata alle stanze. Quindici minuti dopo sono nell’oceano. Alle diciassette e trenta esatte, Stanley Mumphrey e due suoi sottoposti si riunirono intorno all’altoparlante al centro del tavolo nella sala riunioni. Dopo pochi secondi risuonò la voce di Victor Westlake che, dopo un rapido scambio di saluti, disse: «Allora, Stan, cosa ne pensi?». Stanley, che non aveva pensato a nient’altro da quando aveva ricevuto l’e-mail quattro ore prima, rispose: «Be’, Vic, a me sembra che prima di tutto dobbiamo decidere se credere di nuovo al nostro amico, ti pare? Insomma, ammette di essersi sbagliato la prima volta. Non ammette di averci mentito, ma dice di avere commesso un errore. Ci sta prendendo in giro». «Sarà difficile fidarsi di nuovo di lui» disse Westlake. «Sai dov’è in questo momento?» «È appena volato da Miami ad Antigua, su un jet privato. Venerdì scorso è volato da Roanoke in Giamaica sempre su un jet privato, poi è rientrato negli Stati Uniti domenica come Malcolm Bannister.» «Hai idea del perché di tutti questi strani movimenti?» «Neanche una, Stan. Siamo sconcertati. Bannister si è dimostrato molto abile a sparire e a spostare soldi.» «Già. Io ho immaginato uno scenario, Vic. Supponiamo che ci abbia mentito a proposito di Quinn Rucker, il quale forse fa Teile del piano ed è stato al gioco in modo che Bannister potesse uscire di prigione. E ora stanno cercando di salvare il culo a Rucker. A me puzza di complotto. Bugie, complotto... Cosa ne dici di scaricare addosso a tutti e due una richiesta segreta di rinvio a giudizio, trovare Bannister, rispedirlo in galera e vedere cosa sa del vero assassino? Potrebbe essere più loquace, dall’altro lato delle sbarre.» «E allora gli crederesti?» domandò Westlake. «Non ho detto questo. Per niente. Ma se quello che ha scritto nell’e-mail è vero, e se Dusty Shiver ha un alibi per Rucker, l’accusa va a farsi fottere.» «Che sia il caso di parlare con Dusty?» «Non ce n’è bisogno. Se ha davvero delle prove, le vedremo presto. Una cosa che non riesco a capire, fra le tante, è perché ci siano rimasti seduti sopra in silenzio per così tanto tempo.» «Non lo capisco neppure io» ammise Westlake. «Una teoria che stiamo prendendo in considerazione è che Bannister avesse bisogno di tempo per trovare l’assassino. Sempre che vogliamo credergli, naturalmente. In tutta franchezza, a questo punto non so cosa pensare. E se Bannister sapesse davvero la verità? Noi non abbiamo niente in mano, nemmeno uno straccio di prova materiale. La confessione fa acqua da tutte le Teili. E se Dusty ha davvero un asso nella manica, ci toccherà mandare giù il rospo.» «Incriminiamoli e spremiamoli» disse Mumphrey. «Convocherò il gran giurì domani e avremo il rinvio a giudizio entro ventiquattr’ore. Sarà un problema mettere le mani su Bannister ad Antigua?» «Sarà una spina nel culo. Dovrà essere estradato, e potrebbero volerci mesi. Inoltre potrebbe scomparire di nuovo. L’amico è in gamba. Lascia che parli con il capo, prima di convocare il gran giurì.» «Okay. Ma il fatto che Bannister chieda l’immunità dà l’impressione che abbia commesso un reato e voglia un accordo, non credi?» Westlake tacque per un secondo, poi disse: «È raro che un innocente chieda l’immunità. Può succedere, ma non molto spesso. A che reato stai pensando?». «Niente di Teilicolare, ma ne troveremo uno. Mi viene in mente l’attività di racket. Sono sicuro che possiamo adattare la normativa RICO alle nostre esigenze. Cospirazione al fine di intralciare il corso della giustizia. False dichiarazioni in tribunale e all’FBI. Pensandoci bene, le accuse diventano sempre più numerose a mano a mano che parliamo. Sono incazzato, Vic. Bannister e Rucker hanno fatto amicizia a Frostburg e ci hanno combinato questo scherzetto. Rucker evade in dicembre. Il giudice Fawcett viene ucciso in febbraio. E adesso sembra che Bannister ci abbia raccontato un mucchio di stronzate su Rucker e il suo movente. Non so tu, Vic, ma io comincio ad avere la sensazione che ci abbiano fregato.» «Non esageriamo. Il primo passo è stabilire se Bannister sta dicendo la verità.» «Okay. E come ci riusciamo?» «Aspettiamo che Dusty ci mostri cos’ha in mano. Nel frattempo parlerò con il mio capo. Ci risentiamo domani.» «D’accordo.» 41 In una tabaccheria nel centro di St John’s vedo qualcosa che prima mi raggela, poi mi suscita un sorriso. È una scatola di Lavo, un’oscura marca di sigari confezionati a mano in Honduras che qui costano la metà rispetto agli Stati Uniti. Il sigaro a forma di siluro è lungo dieci centimetri viene venduto a cinque dollari ad Antigua e a dieci al Vandy’s Smokes, la tabaccheria nel centro di Roanoke dove il giudice Fawcett era solito acquistare la sua marca preferita. Sul fondo di quattro delle quattordici scatole Lavo adesso al sicuro in banca, ci sono etichette bianche quadrate che pubblicizzano il Vandy’s, con tanto di numero di telefono e indirizzo. Compro venti Lavo e ammiro la scatola. È di legno, non di cartone, e il marchio sembra essere stato inciso a mano sul coperchio. Il giudice Fawcett era noto per l’abitudine di andarsene a pesca in canoa sul lago Higgins, gustandosi i suoi Lavo e la solitudine. Evidentemente conservava le scatole vuote. Le navi da crociera non sono ancora arrivate, per cui il centro della cittadina è tranquillo. Seduti all’ombra davanti ai negozi, i commercianti ridono e chiacchierano nella loro seducente versione cantilenante del King’s English. Entro a curiosare in un negozio dopo l’altro, dimentico del tempo. Sono passato dal tedio ottenebrante della vita in carcere alla frenetica follia della caccia a un assassino e al suo bottino, e infine a questo: il ritmo languido dei Caraibi. Preferisco quest’ultimo, per ovvie ragioni, ma anche perché è l’adesso, il presente e il futuro. Max è una persona nuova con una nuova vita e il vecchio bagaglio sta rapidamente cadendo ai margini della strada. Dopo essermi comprato qualche maglietta e alcune paia di shorts, roba da spiaggia, vado alla mia banca, la Royal Bank of the East Caribbean, e flirto con la bella ragazza del ricevimento clienti. Mi indica la procedura e alla fine mi presento all’addetta al caveau. La donna studia il mio passaporto e poi mi guida nelle profondità della banca. Durante la mia prima visita di nove settimane fa, ho affittato due cassette di sicurezza, le più capienti disponibili. Adesso sistemo al loro interno un po’ di contanti e qualche cartaccia, chiedendomi quanto tempo ci vorrà per riempirle di piccoli lingotti d’oro. Flirto anche quando esco e prometto di tornare presto. Noleggio per un mese un Maggiolino cabriolet, abbasso la capote, mi accendo un Lavo e comincio il tour dell’isola. Dopo pochi minuti mi sento girare la testa. Non ricordo l’ultima volta che ho fumato un sigaro e non so bene perché lo stia facendo adesso. Il Lavo è corto e nero, e perfino il suo aspetto è duro e tosto. Lo getto dal finestrino e continuo a guidare. È la FedEx a vincere la gara. I primi pacchi arrivano lunedì verso mezzogiorno e, dato che sto passeggiando ansiosamente nel parco di Sugar Cove, vedo arrivare il furgone. Miss Robinson, la simpatica signora che gestisce l’ufficio, a questo punto ha già sentito la versione integrale della mia identità di fantasia. Io sono uno scrittore/cineasta, rintanato in una delle sue ville per i prossimi tre mesi e disperatamente al lavoro per portare a termine un romanzo e una sceneggiatura basata su detto romanzo. I miei soci, nel frattempo, stanno già girando le scene preliminari. Bla, bla, bla. Di conseguenza mi aspetto una ventina di pacchi da Miami: manoscritti, ricerche, video, addirittura alcuni attrezzi. La signora è visibilmente impressionata. Attendo davvero con ansia il giorno in cui potrò smettere di mentire. Apro i pacchi all’interno della mia villetta. Una scatola di backgammon contiene due lingotti; una cassetta degli attrezzi quattro; un libro rilegato uno; e un’altra scatola di backgammon due. Un totale di nove minilingotti, tutti apparentemente mai toccati nel corso del loro viaggio da Miami ad Antigua. Mi chiedo spesso quale sia la loro storia. Chi ha estratto l’oro? In quale continente? Chi l’ha fuso? Come è arrivato negli Stati Uniti? E così via. Ma so che queste domande non avranno mai risposta. Ritorno in fretta a St John’s, entro nella Royal Bank of the East Caribbean e metto a dormire i miei preziosi lingotti. La mia seconda e-mail ai signori Westlake e Mumphrey dice: Ehi, ragazzi. Sono di nuovo io. Vergogna! Non avete risposto alla mia e-mail di due giorni fa. Se volete trovare l’assassino del giudice Fawcett, vi consiglio di migliorare le vostre capacità di comunicazione. Io non ho intenzione di andarmene. Scommetto che la vostra reazione iniziale è stata quella di inventarvi qualche accusa fasulla per scaricarla su di me e Quinn Rucker. Non potete evitarlo perché, dopo tutto, siete federali e la vostra natura è quella. Cosa c’è nel nostro sistema giudiziario che fa sì che gente come voi voglia mandare tutti in galera? È patetico, dico sul serio. In carcere ho conosciuto decine di brave persone: uomini che non farebbero più male a una mosca, uomini che non si sarebbero mai più messi nei guai con la legge. Eppure, grazie a voi, stanno scontando lunghe pene e la loro vita è rovinata. Ma sto divagando. Lasciate perdere altri rinvii a giudizio. Le accuse non reggerebbero – non che questo vi abbia mai trattenuto – e inoltre, semplicemente, non esiste alcun articolo nel vostro vasto Codice federale che possiate usare contro di me. Cosa ancora più importante, non riuscirete mai a prendermi. Fate qualcosa di stupido e io sparisco di nuovo. Non tornerò in prigione, mai. Allego a questa e-mail quattro foto a colori. Le prime tre sono di una scatola di sigari, sempre la stessa. È di legno marrone scuro, lavorata a mano da qualche Teile in Honduras e all’interno della quale un operaio ha ordinatamente disposto venti Lavo, un sigaro forte, nero e quasi letale con la punta conica. La scatola è stata spedita a un importatore di Miami, che a sua volta l’ha inviata al Vandy’s Smokes nel centro di Roanoke, dove infine è stata acquistata dall’onorevole Raymond Fawcett. Evidentemente il giudice Fawcett ha fumato Lavo per molti anni, conservando le scatole vuote. Forse ne avete trovate alcune quando avete setacciato il cottage dopo gli omicidi. Ho la sensazione che il proprietario del Vandy’s, se interrogato, vi dirà che conosceva bene il giudice Fawcett e i suoi gusti piuttosto insoliti in fatto di sigari. La prima foto si riferisce alla scatola così come si presenterebbe in negozio. È un quadrato quasi perfetto di tredici centimetri di lato per un’altezza di tredici centimetri, dimensioni insolite per una scatola di sigari. La seconda foto è un’inquadratura laterale. La terza foto riprende il fondo della scatola, dove si vede chiaramente l’etichetta bianca del Vandy’s Smokes. Questa scatola è stata sottratta dalla cassaforte del giudice Fawcett poco dopo la sua esecuzione ed è ora in mio possesso. Potrei anche consegnarvela, ma quasi certamente sopra ci sono le impronte digitali dell’assassino e non voglio rovinarvi la sorpresa. La quarta foto è la ragione per cui ci ritroviamo a negoziare. È la foto di tre lingottini d’oro da dieci once, tre perfetti minilingotti senza alcun segno di registrazione o identificazione (seguiranno maggiori dettagli). Questi gingillini erano conservati a gruppi di trenta per ogni scatola di sigari e nascosti nella cassaforte del giudice Fawcett. Quindi adesso almeno un mistero è risolto. Perché Fawcett è stato ucciso? Perché qualcuno sapeva che aveva una pentola d’oro. Ma il grande mistero continua a perseguitarvi. Il killer è ancora là fuori, e dopo sei mesi di affanni, inciampi, caccia alle streghe, spavalderia e menzogne NON AVETE UN SOLO INDIZIO! Andiamo, ragazzi: arrendetevi. Definiamo l’accordo e chiudiamo questa pratica. Il vostro amico, Malcolm Victor Westlake annullò l’ennesima cena con la moglie e alle diciannove di venerdì entrò nell’ufficio del suo capo, Mr George McTavey, il direttore dell’ FBI. Due assistenti di McTavey rimasero nell’ufficio per prendere appunti e per andare eventualmente a recuperare pratiche. Si sedettero intorno a un lungo tavolo, tutti sfiniti da un’altra interminabile settimana. McTavey era già stato informato di tutto, per cui non c’era bisogno di riassumere i precedenti. Attaccò con il suo marchio di fabbrica: «C’è qualcosa che non so?». Era una domanda sempre prevedibile ed era meglio per tutti che ottenesse una risposta sincera. «Sì» rispose Westlake. «Sentiamo.» «Il rialzo del prezzo dell’oro ha determinato un’enorme domanda del metallo e stiamo assistendo a qualsiasi sorta di traffico. Ogni titolare di banco dei pegni del paese è diventato un commerciante d’oro, per cui puoi immaginare la quantità di merce che viene comprata e venduta. L’anno scorso abbiamo svolto un’indagine a New York su alcuni commercianti piuttosto noti che fondevano oro, lo diluivano e poi lo smerciavano come praticamente puro. Non ci sono ancora incriminazioni, ma il caso è tuttora aperto. Nel corso di questa operazione, un informatore che lavorava per un commerciante d’oro ha messo le mani su un lingotto da dieci once privo di qualsiasi identificazione. Puro al novantanove virgola nove per cento, ottima qualità, e un prezzo insolito. L’informatore ha scavato un po’ in giro e ha scoperto che un certo Ray Fawcett si presentava di tanto in tanto per vendere qualche lingotto, a un prezzo un po’ scontato e naturalmente in cambio di contanti. Abbiamo un video di Fawcett nel negozio sulla Quarantasettesima strada; risale a dicembre, due mesi prima che venisse assassinato. A quanto pare, andava a New York un paio di volte all’anno, vendeva la sua merce e se ne tornava a Roanoke con un bel po’ di contanti. Le registrazioni sembrano incomplete, ma in base a ciò che abbiamo in mano sembra che Fawcett nel corso degli ultimi quattro anni abbia venduto oro a New York per un valore di almeno seicentomila dollari. In questo non c’è niente di illegale, sempre che, ovvio, quell’oro fosse legittimamente in possesso di Fawcett.» «Interessante. Ma?» «Ho mostrato la foto dell’oro di Bannister al nostro informatore. A suo parere, i lingotti sono identici. Bannister ha l’oro. Quanto, non abbiamo modo di saperlo. La scatola di sigari corrisponde. L’oro corrisponde. Se davvero ha avuto l’oro dal killer, allora sa sicuramente la verità.» «E la tua teoria sarebbe?» «Malcolm Bannister e Quinn Rucker erano in carcere insieme a Frostburg ed erano molto più amici di quanto ci fossimo resi conto. Uno dei due sapeva di Fawcett e del suo tesoro in oro e così hanno pianificato il loro complotto. Rucker evade, va in riabilitazione per crearsi un alibi e tutti e due aspettano che l’assassino colpisca. Appena succede, il piano diventa immediatamente operativo. Bannister denuncia Rucker, il quale rilascia una falsa confessione che determina subito il suo rinvio a giudizio. E Bannister esce di galera. Una volta fuori, entra nel programma protezione testimoni, poi si tira fuori e in qualche modo trova l’assassino e l’oro.» «Non ha dovuto uccidere l’assassino per impadronirsi dell’oro?» Westlake si strinse nelle spalle. Non ne aveva idea. «Forse, ma forse no. Bannister vuole l’immunità e siamo pronti a scommettere che chiederà anche il rilascio di Rucker in base all’articolo 35. Quinn deve scontare ancora cinque anni per la condanna originale, più qualche altro anno per l’evasione. Se tu fossi Bannister, non proveresti a fare uscire il tuo amico? Se l’assassino è morto, l’articolo 35 potrebbe non funzionare per Quinn. Non lo so. Al piano di sotto i nostri avvocati si stanno grattando la testa.» «Questo è sempre confortante» commentò McTavey. «Qual è il lato negativo di un accordo con Bannister?» «L’ultima volta che abbiamo trattato con lui ci ha mentito.» «Okay, ma cos’ha da guadagnare mentendoci adesso?» «Niente. Ha l’oro.» Il viso stanco e preoccupato di McTavey diventò improvvisamente divertito. Il direttore ridacchiò, alzò le mani e disse: «Un piano geniale, brillante, mi piace! Dobbiamo assumere quel Bannister, è molto più in gamba di noi. Uno con le palle. Fa accusare il suo caro amico dell’omicidio di un giudice federale sapendo fin dall’inizio che poi potrà farlo uscire chiarendo tutto. Non è uno spasso? E noi facciamo la figura di un branco di idioti». Westlake non poté fare a meno di condividere il divertimento. Sorrise e scosse la testa incredulo. «Bannister non sta mentendo, Vic» continuò McTavey. «Perché non ha bisogno di mentire. Le bugie erano importanti prima, durante la prima fase del progetto, ma non adesso. Adesso è il momento della verità, e Bannister la conosce.» Westlake annuì, d’accordo con il suo capo. «Allora, qual è il nostro piano?» «Che opinione ha il procuratore federale su questa storia? Come si chiama?» «Mumphrey. Sbraita perché vuole un altro rinvio a giudizio, ma questo non succederà.» «Sa tutto?» «Ovviamente no. Non sa che noi sappiamo che Fawcett vendeva oro a New York.» «Domani vedrò il procuratore generale per un brunch. Gli spiegherò quello che stiamo facendo e ci penserà lui a mettere Mumphrey in riga. Suggerirei che voi due incontriate Bannister il prima possibile in modo da chiarire tutti i punti in sospeso. Sono veramente stufo del giudice Fawcett, Vic. Capisci cosa intendo?» «Sì, signore.» 42 Sono in attesa dell’ennesimo volo in ritardo nel terminal caldissimo e soffocante del V. C. Bird International Airport, ma non sono minimamente irritato o ansioso. Ormai, al mio quarto giorno ad Antigua, l’orologio da polso è finito in un cassetto e io sono regolato sul fuso orario dell’isola. I cambiamenti sono quasi impercettibili, ma a poco a poco mi sto depurando dalle abitudini frenetiche della vita moderna. I movimenti si sono fatti più lenti, i pensieri più limpidi, gli obiettivi inesistenti. Vivo in funzione del presente e mi limito a lanciare solo una pigra e occasionale occhiata al domani; per tutto il resto, lasciatemi in pace. Quando scende la scaletta dell’aereo proveniente da San Juan, Vanessa sembra una top model: cappello di paglia a tesa larga, occhiali da sole firmati, abito estivo deliziosamente corto e la grazia disinvolta della donna che sa di essere uno schianto. Dieci minuti dopo siamo a bordo del Maggiolino e la mia mano è sulla sua coscia. Mi informa che è stata licenziata per le troppe assenze. E per insubordinazione. Scoppiamo a ridere. Chi se ne frega? Andiamo direttamente a pranzo al Great Reef Club che, da una scogliera sull’oceano, offre una vista ipnotica. La clientela è ricca e britannica. Noi due siamo gli unici neri, ma tutto lo staff è come noi. Il cibo è appena passabile e ci ripromettiamo di provare i ristoranti frequentati dai locali in modo da poter mangiare con gente vera. Immagino che siamo tecnicamente ricchi, ma sembra impossibile pensare in questi termini. Non sono necessariamente i soldi che vogliamo, quanto la libertà e la sicurezza. Suppongo che a poco a poco ci abitueremo a una vita migliore. Dopo un tuffo nell’oceano, Vanessa vuole esplorare Antigua. Abbassiamo la capote, troviamo una stazione reggae alla radio e voliamo lungo le stradine strette come due fidanzatini finalmente in fuga. Mentre accarezzo le gambe di Vanessa e guardo il suo sorriso, trovo difficile credere che fino a questo punto ce l’abbiamo fatta. Sono stupito dalla nostra fortuna. Il summit si svolge al Blue Waters Hotel, sulla punta nordoccidentale dell’isola. Entro nell’edificio principale in stile coloniale e nella hall ariosa, tutto solo. Individuo una coppia di agenti che, malamente travestiti da turisti, sorseggiano una bibita e cercano di avere un’aria indifferente. Un vero turista ha un aspetto rilassato e disinvolto, un federale che si finge turista sembra un disadattato. Mi chiedo quanti agenti, viceprocuratori, vicedirettori eccetera siano riusciti a intrufolarsi a spese dello Zio Sam in questa breve gita ai Caraibi, coniugi inclusi, naturalmente. Procedo sotto passaggi ad arco, davanti a elaborate decorazioni lignee, costeggio palizzate e finalmente raggiungo un’ala dove si può parlare di affari. Ci incontriamo in una piccola suite al primo piano, con vista sulla spiaggia. Vengo accolto da Victor Westlake, Stanley Mumphrey e altri quattro uomini dei quali non provo nemmeno a memorizzare i nomi. Abiti scuri e cravatte tristi sono scomparsi, sostituiti da magliette da golf e bermuda. Anche se siamo all’inizio di agosto, la maggior Teile delle gambe in questa stanza non ha ancora incontrato il sole. L’atmosfera è rilassata; non ho mai visto tanti sorrisi in una riunione così importante. Questi uomini rappresentano l’élite della lotta al crimine e sono abituati a giornate dure e senza allegria. Questo diversivo per loro è un sogno. Ho un ultimo, inquietante dubbio. È possibile che questa sia una trappola, che io ci stia cadendo dentro e che i ragazzi siano pronti a sfoderare un atto di rinvio a giudizio, un mandato d’arresto, un ordine di estradizione o qualunque altra cosa possa rimandarmi in prigione. In quel caso Vanessa farà scattare un piano che assicurerà la protezione dei nostri beni. Si trova a circa duecento metri da me, in attesa. Non ci sono sorprese. Abbiamo parlato abbastanza a lungo al telefono da essere tutti al corrente dei presupposti, così ci mettiamo subito al lavoro. Attivando il vivavoce, Stanley chiama l’ufficio di Dusty Shiver a Roanoke; Shiver adesso rappresenta non solo Quinn Rucker, ma anche sua sorella Vanessa e me. Una volta in linea, Dusty fa qualche debole battuta sul fatto che si sta perdendo tutto il divertimento ad Antigua. I federali ruggiscono ridendo. Come prima cosa rivediamo l’accordo relativo all’immunità, il quale in sostanza dichiara che il governo non accuserà né me, né Quinn, né Vanessa Young, né Denton Rucker (alias Dee Ray) di alcun illecito eventualmente rilevato nel corso delle indagini sul duplice omicidio del giudice Raymond Fawcett e Naomi Clary. Ci vogliono quattordici pagine per dirlo, ma sono soddisfatto. Anche Dusty ha rivisto il documento e chiede un paio di leggere modifiche da Teile dell’ufficio di Mumphrey. Essendo avvocati, si sentono entrambi in obbligo di discutere per un po’, ma alla fine trovano un’intesa. Il documento viene riscritto nella stanza, poi firmato e inviato per e-mail a un magistrato federale a nostra disposizione a Roanoke. Trenta minuti dopo riceviamo una copia via email con l’approvazione e la firma del magistrato. In senso legale, adesso siamo tutti invulnerabili. La questione della libertà di Quinn è un po’ più complicata. Per prima cosa c’è un decreto di archiviazione dell’indagine che lo solleva da tutte le accuse collegate agli omicidi, ma che contiene alcune frasi inserite da Mumphrey e i suoi nel tentativo di minimizzare la loro responsabilità in un procedimento giudiziario infondato. Dusty e io ci opponiamo e le frasi in questione vengono eliminate. Il decreto viene spedito per e-mail al magistrato di Roanoke, che lo firma immediatamente. C’è poi un’istanza ai sensi dell’articolo 35 in cui si richiede la modifica della sentenza di Quinn e la sua liberazione. È stata depositata presso il tribunale federale di Washington, lo stesso che lo ha condannato per spaccio di cocaina, ma Quinn è tuttora in carcere a Roanoke. Ripeto quello che ho già detto molte volte: non rispetterò la mia Teile dell’accordo finché Quinn non verrà rilasciato. Punto. C’è già un’intesa in questo senso, ma servono i movimenti coordinati di diverse persone, che ora devono seguire le istruzioni provenienti da una nazione, una scheggia d’isola, denominata Antigua. Il giudice di Washington che ha condannato Quinn è al corrente di tutto e disponibile, ma in questo momento è bloccato in aula. L’US Marshals Service si sente in obbligo di intervenire e insiste per occuparsi del trasferimento di Quinn quando arriverà il momento. A un certo punto, cinque dei sei avvocati presenti alla riunione sono al cellulare e due di loro digitano freneticamente sui rispettivi laptop. Ci prendiamo una pausa e Vic Westlake mi invita ad andare a bere qualcosa di fresco con lui. Troviamo un tavolo sotto una terrazza accanto a una piscina, lontano dagli altri, e ordiniamo tè ghiacciato. Westlake finge frustrazione per la perdita di tempo. Sono quasi certo che abbia addosso un qualche tipo di microfono e che probabilmente voglia parlare dell’oro. Io sono tutto sorrisi, da rilassato isolano di Antigua, ma il mio radar è in stato di massima allerta. «E se avessimo bisogno della tua testimonianza al processo?» mi chiede Westlake in tono grave. Ne abbiamo discusso a lungo e pensavo che questo punto ormai fosse chiarito. «Lo so, lo so» dice Westlake. «Ma se avessimo bisogno di qualche prova extra?» Dato che non sa ancora il nome dell’assassino, né le circostanze dell’omicidio, la domanda è prematura. Probabilmente è solo una fase di riscaldamento in vista di qualcos’altro. «La mia risposta è no, okay? Sono stato chiaro. Non ho in programma di tornare negli Stati Uniti. Mai più. Sto pensando seriamente di rinunciare alla cittadinanza e diventare antiguano a pieno titolo. Se non rimetterò più piede sul suolo americano, morirò felice.» «Mi sembra che tu stia esagerando, non credi, Max?» replica Westlake con un tono che non gradisco. «Adesso godi di immunità totale.» «Per te è facile dirlo, Vic, ma tu non sei mai stato in galera per un crimine che non hai commesso. I federali mi hanno già incastrato una volta e mi hanno quasi rovinato la vita. Non succederà di nuovo. Sono fortunato ad avere una seconda possibilità e per qualche strana ragione esito un tantino a mettermi di nuovo sotto la vostra giurisdizione.» Westlake beve un sorso di tè e si asciuga la bocca con un tovagliolo di lino. «Una seconda possibilità... Sparire navigando verso il tramonto con una pentola piena d’oro.» Mi limito a fissarlo. Dopo qualche secondo, con un po’ di imbarazzo, aggiunge: «Non abbiamo ancora discusso dell’oro, vero?». «No.» «Allora facciamolo. Cosa ti dà il diritto di tenertelo?» Punto lo sguardo su un bottone della sua camicia e scandisco con chiarezza: «Non so di cosa tu stia parlando. Io non ho nessun oro. Chiuso il discorso». «E i tre minilingotti della foto che hai mandato per e-mail la settimana scorsa?» «Costituiscono una prova e a tempo debito ve li farò avere, unitamente alla scatola di sigari dell’altra foto. Penso che quegli oggettini siano pieni di impronte digitali, sia di Fawcett che dell’assassino.» «Fantastico. Ma la grande domanda sarà: dov’è il resto dell’oro?» «Io non lo so.» «Okay. Ti rendi senz’altro conto che per l’accusa sarà importante sapere cosa c’era nella cassaforte del giudice Fawcett. Che cosa ha determinato il suo omicidio? A un certo punto dovremo sapere tutto.» «Forse non saprete mai tutto. Ci saranno prove in abbondanza per condannare l’assassino. E se il governo non sarà in grado di sostenere l’accusa, non è un mio problema.» Un altro sorso di tè, un’espressione esasperata e poi: «Non hai il diritto di tenertelo, Max». «Tenermi cosa?» «L’oro.» «Io non ce l’ho. Ma, parlando per ipotesi, in una situazione come questa a me pare che quel bottino non apTeilenga a nessuno. Di sicuro non è proprietà del governo: non è stato sottratto ai contribuenti. Voialtri non ne siete mai stati in possesso e non potete accampare diritti. Non l’avete mai visto e, a questo punto, non siete neppure sicuri che esista davvero. Non apTeiliene al killer, che è anche un ladro: l’ha rubato a un funzionario dello Stato che presumibilmente l’ha ottenuto facendosi corrompere. E se per caso riusciste a identificare la fonte originale di quell’oro e tentaste di restituirlo, quella gente si nasconderebbe sotto la scrivania o scapperebbe di corsa. L’oro è là fuori, tra le nuvole, come Internet. Non apTeiliene a nessuno.» Agito le mani verso il cielo mentre concludo questo discorso preparato da tempo. Westlake sorride perché entrambi conosciamo la verità. C’è un luccichio nei suoi occhi, come se avesse voglia di ridere, arrendersi e dirmi: “Complimenti, uno splendido lavoro”. Ma naturalmente non succede. Torniamo nella suite e ci comunicano che il giudice di Washington è ancora impegnato in questioni più importanti. Non ho intenzione di ciondolare intorno al tavolo con un branco di federali, per cui vado a fare una passeggiata sulla spiaggia. Telefono a Vanessa, la informo che le cose stanno procedendo lentamente e che no, non ho visto manette o pistole. Finora tutto bene. Quinn dovrebbe essere rilasciato entro breve. Vanessa mi dice che Dee Ray si trova nello studio di Dusty, in attesa del fratello. Durante la pausa pranzo, il giudice che aveva condannato Quinn a sette anni per spaccio di droga ha firmato controvoglia un’ordinanza di commutazione della pena ai sensi dell’articolo 35. Ieri ha parlato con Stanley Mumphrey, con Victor Westlake e con il suo capo, George McTavey, e, a sottolineare l’importanza della questione, anche con il procuratore generale. Quinn è stato subito trasferito dal carcere di Roanoke allo studio legale di Dusty Shiver, dove ha abbracciato Dee Ray e si è cambiato, indossando un paio di jeans e una polo. Centoquaranta giorni dopo essere stato arrestato da evaso a Norfolk, Virginia, Quinn è un uomo libero. Sono quasi le due e mezzo quando tutte le ordinanze e i documenti sono debitamente firmati, esaminati e verificati. All’ultimo momento esco dalla stanza e telefono a Dusty, il quale mi assicura che “li teniamo per la gola”, che tutte le carte sono in ordine, tutti i nostri diritti protetti e tutte le promesse mantenute. «Comincia pure a cantare» conclude con una risata. Sei mesi dopo il mio arrivo al Louisville Federal Correctional Institution avevo accettato di occuparmi del caso di uno spacciatore di Cincinnati. Il tribunale aveva commesso un errore grossolano nel calcolo della pena, l’errore era evidente e io depositai un’istanza chiedendo il rilascio immediato del detenuto perché in pratica aveva già scontato la sua condanna. Fu una di quelle rare occasioni in cui tutto funzionò in modo perfetto e veloce, e nel giro di due settimane il mio cliente se ne tornò a casa soddisfatto. Ovviamente la notizia si diffuse all’interno del carcere e io venni subito acclamato geniale avvocato da galera, in grado di compiere miracoli. Fui inondato di richieste perché esaminassi i vari casi ed esercitassi la mia magia. Ci volle un po’ perché l’eccitazione si calmasse. Fu più o meno a quell’epoca che un detenuto che chiamavamo Nattie entrò nella mia vita, costringendomi a dedicargli più tempo di quanto fossi disposto a concedergli. Bianco e scheletrico, era stato condannato per spaccio di metanfetamina in West Virginia e voleva assolutamente che io studiassi il suo caso, schioccassi le dita e lo facessi uscire. Nattie mi era simpatico, così esaminai le sue carte e cercai di spiegargli che non c’era niente da fare. Lui cominciò a parlarmi di una ricompensa; all’inizio ci furono solo vaghi accenni a un mucchio di soldi nascosti in qualche posto, Teile dei quali sarebbe stata mia se solo lo avessi fatto uscire di galera. Nattie si rifiutava di credere che non potessi aiutarlo. Invece di accettare la realtà, diventò sempre più ossessivo e delirante, sempre più convinto che fossi in grado di scovare un cavillo, depositare un’istanza e farlo uscire. A un certo punto mi parlò di una grossa quantità di lingotti d’oro, e io pensai che avesse perso la testa. Lo strigliai e lui, per dimostrarmi che stava dicendo la verità, mi raccontò tutta la storia. Mi fece giurare di mantenere il segreto e mi promise metà della sua fortuna se lo avessi aiutato. Già da bambino, Nattie era stato un ladruncolo professionista e durante l’adolescenza era entrato nel mondo della metanfetamina. Si spostava parecchio in giro, cercando di scansare agenti dell’Antidroga, addetti al recupero crediti, vicesceriffi con mandati, padri con figlie incinte e rivali incazzati di altre gang specializzate in quel tipo di narcotraffico. Aveva cercato più volte di tirarsi fuori, ma aveva la tendenza a ricaderci. Vedeva i suoi cugini e i suoi amici rovinarsi la vita, con la droga o in carcere, e desiderava veramente qualcosa di meglio per sé. Lavorava come cassiere in un emporio sulle montagne intorno alla cittadina di Ripplemead, quando era stato avvicinato da uno sconosciuto che gli aveva offerto dieci dollari l’ora per un certo lavoro. Nessuno al negozio aveva mai visto quell’uomo, e nessuno lo avrebbe più rivisto. Nattie guadagnava cinque dollari l’ora, in contanti e in nero, così colse al volo la possibilità di intascare qualcosa di più. Alla fine del turno incontrò lo sconosciuto nel luogo che avevano concordato e risalì con lui uno stretto sentiero sterrato fino a un cottage incuneato nel fianco di una ripida collina, poco sopra un laghetto. L’uomo, che si presentò solo come Ray, era alla guida di un bel pickup, sul pianale del quale c’era una cassa di legno. Risultò poi che questa conteneva una cassaforte del peso di duecentoventicinque chili, troppi perché Ray potesse maneggiarli da solo. I due agganciarono una carrucola e relativo cavo al ramo di un albero e riuscirono a sollevare la cassaforte dal pianale, a posarla a terra e infine a trascinarla nel seminterrato del cottage. Fu un lavoro noioso, duro da spezzare la schiena, che richiese quasi tre ore. Ray pagò Nattie in contanti, lo ringraziò e gli disse addio. Nattie raccontò tutto a suo fratello Gene, il quale si nascondeva nelle vicinanze per non farsi trovare dallo sceriffo, distante due contee. La cassaforte, e il suo contenuto, incuriosì i due fratelli, che decisero di dare un’occhiata. Una volta certi che Ray se n’era andato, cercarono di penetrare nel cottage, ma furono bloccati dalle massicce porte di quercia, dai vetri antisfondamento e dalle grosse serrature di sicurezza. A quel punto decisero semplicemente di smontare una finestra del seminterrato. Una volta dentro, non riuscirono a trovare la cassaforte, ma arrivarono a identificare Ray. Frugando tra le carte sparse su un tavolo da lavoro, si resero conto che il loro vicino di casa era un pezzo grosso, un giudice federale di Roanoke. C’era perfino un articolo di giornale riguardante un importante processo, presieduto dall’onorevole Raymond Fawcett, che riguardava l’estrazione dell’uranio in Virginia. I due fratelli raggiunsero Roanoke in auto, trovarono il tribunale federale e assistettero a due ore di deposizioni. Nattie indossava occhiali e berretto da baseball nel caso il giudice si fosse annoiato e avesse cominciato a guardarsi intorno nell’aula. Ma c’erano molti spettatori e Ray non alzò mai lo sguardo sul pubblico. Convinti di aver messo le mani su qualcosa, i fratelli tornarono al cottage, rientrarono attraverso la finestra del seminterrato e cercarono di nuovo la cassaforte. Doveva essere lì, perché era lì che Nattie e il giudice l’avevano lasciata. Un’intera parete era occupata da scaffali con spessi tomi legali, e i fratelli si convinsero che lì dietro doveva esserci uno spazio nascosto. Rimossero con cura ogni libro, guardarono e lo rimisero a posto. Ci volle un po’ di tempo, ma alla fine trovarono un interruttore che apriva uno sportello. Una volta spalancato, ecco la cassaforte a livello del pavimento, che aspettava solo di essere aperta. Cosa che però risultò essere impossibile perché la cassaforte era dotata di una tastiera digitale che, naturalmente, richiedeva un codice d’accesso. I due tentarono alla cieca per un paio di giorni, ma non ebbero fortuna. Trascorsero molto tempo all’interno del cottage, sempre attenti a non lasciare la minima traccia. Un venerdì Gene andò a Roanoke, distante circa un’ora d’auto, entrò in tribunale, trovò il giudice e rimase ad aspettare che sospendesse l’udienza per il weekend, aggiornandola alle nove del lunedì mattina. Seguì Fawcett fino a casa e lo guardò caricare sul pickup quello che sembrava un sacchetto contenente generi alimentari, una borsa termica, numerose bottiglie di vino, una borsa da palestra, due voluminose cartelle e una pila di libri. Ray lasciò il suo apTeilamento, da solo, e si diresse verso ovest. Gene telefonò al fratello e lo avvertì che il giudice stava arrivando. Nattie rimise tutto in ordine all’interno del cottage, rimontò la finestra del seminterrato, cancellò le impronte nel terreno davanti alla veranda e si arrampicò su un albero distante una cinquantina di metri. Come previsto, un’ora dopo arrivò Fawcett, che scaricò il pickup e si concesse immediatamente un pisolino nell’amaca sulla veranda. Nattie e Gene lo tenevano d’occhio dal fitto bosco che circondava il cottage. Il giorno dopo, sabato, Fawcett trascinò la sua canoa in riva al lago, caricò a bordo canne da pesca e alcune bottiglie d’acqua, si accese un sigaro corto e nero e prese il largo nelle acque dell’Higgins. Nattie lo osservava con il binocolo mentre Gene rimuoveva la finestra ed entrava nel cottage. Lo sportello era aperto e la cassaforte era visibile, ma chiusa. Di nuovo sfortunato, Gene uscì in fretta dal seminterrato, rimontò la finestra e scomparve nel bosco. I due ragazzi erano decisi a scoprire cosa contenesse quella cassaforte, ma erano anche pazienti. Ray non aveva idea di essere tenuto d’occhio e, se ogni settimana aggiungeva qualcosa al suo tesoro, allora non c’era alcuna fretta. Per i due venerdì successivi, Gene sorvegliò il tribunale di Roanoke, ma il giudice rimase a lavorare fino a tardi. Si stava avvicinando una festività e i fratelli ipotizzarono che probabilmente Fawcett si sarebbe concesso un lungo weekend. Secondo quanto dicevano i giornali, il dibattimento in corso era impegnativo, molto combattuto, e il giudice era sotto pressione. Avevano indovinato. Venerdì alle quattordici, il processo venne aggiornato a martedì mattina alle nove. Gene guardò Ray caricare il pickup e Teilire per il lago, da solo. Il cottage era troppo isolato fra le montagne per avere gas ed elettricità, di conseguenza era privo sia di aria condizionata che di riscaldamento, a Teile un grande caminetto. Cibi e bevande venivano conservati nella borsa termica che Ray trasportava avanti e indietro. Quando la sera aveva bisogno di luce per leggere, il giudice attivava un piccolo generatore a gas che si trovava all’esterno, vicino al seminterrato, il cui rumore basso e smorzato echeggiava in tutta la valle. Di solito, però, alle nove di sera Fawcett stava già dormendo. Il seminterrato era costituito da una stanza e da un ripostiglio, un piccolo locale stretto con una porticina a due ante nel quale Ray conservava roba che sembrava essere dimenticata, almeno in maggio: indumenti da cacciatore, scarponi e una pila di vecchie trapunte e coperte. Gene elaborò un piano in base al quale Nattie sarebbe rimasto nascosto là dentro, per ore; l’idea era che, attraverso una minuscola fessura in una delle ante, Nattie sarebbe riuscito a vedere il giudice quando avesse aperto la cassaforte per riporci ciò che stava nascondendo, qualunque cosa fosse. Alto un metro e settanta per cinquantanove chili, Nattie era un esperto nel nascondersi in posti piccoli e stretti, ma all’inizio si mostrò riluttante all’idea di passare la notte nel ripostiglio. Il piano venne modificato. Il venerdì che precedeva il Columbus Day, il giudice Fawcett arrivò al cottage intorno alle sei del pomeriggio e cominciò a scaricare con calma il suo pickup. Nattie era rannicchiato nel ripostiglio del seminterrato, virtualmente invisibile tra i capi da cacciatore, le coperte e le trapunte. In tasca aveva una pistola, nel caso le cose si fossero messe male. Gene, anche lui armato di pistola, sorvegliava la scena tra gli alberi. I due fratelli erano tesi come corde di violino, ma anche incredibilmente eccitati. Mentre sistemava le sue cose, Ray si accese un sigaro e il cottage si riempì dell’aroma di tabacco. Il giudice se la stava prendendo comoda, borbottando fra sé e canticchiando a bocca chiusa lo stesso motivetto più e più volte, ma poi finalmente scese nel seminterrato con una cartella voluminosa. Nattie quasi non respirò mentre osservava il giudice estrarre un libro di legge dal ripiano, attivare l’interruttore nascosto e aprire lo sportello. Poi Fawcett digitò il codice sulla tastiera e aprì la cassaforte. Era piena di scatole di sigari. Il giudice si scostò e dalla cartella estrasse un’altra scatola. Si fermò per un attimo, sollevò il coperchio e afferrò un piccolo, bellissimo lingotto d’oro. Lo ammirò, lo accarezzò e poi lo rimise nella scatola, che sistemò con cura nella cassaforte, facendola seguire da una seconda scatola di sigari. Richiuse la cassaforte, inserì il codice e rimise a posto lo sportello. Nathan sentiva il cuore battergli con tale violenza che temeva potesse scuotere l’intero ripostiglio, ma si impose di restare calmo. Mentre se ne stava andando, il giudice notò l’anta appena accostata e la chiuse. Verso le diciannove si accese un altro sigaro, si versò un bicchiere di vino bianco, andò nella veranda e si accomodò sulla sedia a dondolo per guardare il sole scomparire dietro le montagne. Appena si fece buio, azionò il generatore e ciondolò nel cottage fino alle dieci, quando spense tutto e se ne andò a dormire. Una volta che tutto fu immobile e silenzioso, Gene si materializzò dal bosco e bussò con forza alla porta. «Chi è?» domandò arrabbiato Ray dall’interno. Gene rispose che stava cercando il suo cane. Il giudice aprì la porta e i due parlarono attraverso la zanzariera. Gene spiegò di essere il proprietario di un cottage distante circa un chilometro e mezzo, sull’altro lato del lago, e che Yank, il suo amato cane, era scomparso. Ray non fu per niente cordiale e disse di non avere visto cani nei dintorni. Gene lo ringraziò e se ne andò. Quando Nattie sentì i colpi alla porta e la conversazione al piano di sopra, scivolò rapidamente fuori dal ripostiglio e uscì da una porta del seminterrato. Non gli fu possibile richiudere a chiave la serratura di sicurezza e i due fratelli immaginarono che il giudice si sarebbe grattato la testa confuso, chiedendosi come mai quella porta non fosse chiusa a chiave. Per allora loro due sarebbero già stati uccel di bosco. Fawcett avrebbe cercato e controllato, ma non avrebbe notato alcun segno di scasso né oggetti mancanti e alla fine non ci avrebbe più pensato. Naturalmente i due fratelli erano sbalorditi da ciò che avevano scoperto e cominciarono a elaborare piani per svuotare la cassaforte. La cosa avrebbe comportato un confronto con il giudice, e probabilmente anche violenza, ma erano decisi ad andare fino in fondo. Passarono due weekend e il giudice rimase a Roanoke. Poi tre. Mentre tenevano d’occhio il cottage, e il giudice, Gene e Nattie erano tornati al loro business della metanfetamina perché erano completamente al verde. Prima di poter arrivare all’oro, furono sorpresi dagli agenti della DEA. Gene venne ucciso e Nattie finì in prigione. Aspettò cinque anni prima di usare le maniere forti con il giudice Fawcett, torturare Naomi Clary, svuotare la cassaforte e uccidere tutti e due. «E chi sarebbe questo Nattie, esattamente?» mi chiede Westlake. Tutti e sei gli uomini presenti mi stanno fissando. «Si chiama Nathan Edward Cooley, e lo troverete nel carcere cittadino di Montego Bay, Giamaica. Fate pure con comodo, non andrà da nessuna Teile.» «È possibile che sia noto anche come Nathaniel Coley, il tuo amico con il passaporto falso?» «È lui. Se la deve vedere con vent’anni in una prigione giamaicana, per cui può darsi che vi faciliti le cose. La mia sensazione è che Nattie sarà ben felice di dichiararsi colpevole in cambio dell’ergastolo in un carcere americano, niente libertà vigilata naturalmente. Farà qualsiasi cosa pur di andarsene dalla Giamaica. Offritegli un accordo e non dovrete neppure prendervi il disturbo di un processo.» C’è una lunga pausa mentre tutti riprendono collettivamente fiato. Poi Vic mi chiede: «C’è qualcosa a cui non hai pensato?». «Certo. Ma preferirei non dirtelo.» 43 Il mio talento di affabulatore li ha stregati tutti e per un’ora mi tempestano di domande. Mi affanno con le risposte e, quando mi accorgo che sto cominciando a ripetermi, mi irrito. Date a un branco di avvocati i dettagli precisi di un mistero per il quale hanno perso il sonno e loro non possono fare a meno di rivolgervi la stessa domanda in cinque modi diversi. La mia bassa opinione di Victor Westlake migliora un po’ quando lui annuncia: «Basta così. La riunione è finita. Io vado al bar». Propongo di andare a bere qualcosa noi due da soli e torniamo al tavolo accanto alla piscina. Ordiniamo due birre e, quando arrivano, beviamo a grandi sorsi. «C’è qualcos’altro?» mi domanda Westlake. «Sì, in effetti c’è un’altra cosa. Grossa quasi quanto l’omicidio di un giudice federale.» «Non ne hai avuto abbastanza per un giorno solo?» «Oh, sì, ma ho ancora un ultimo colpo.» «Ti ascolto.» Bevo un altro lungo sorso e mi gusto il sapore della birra. «Se il mio quadro temporale è corretto, il giudice Fawcett accettava e nascondeva oro puro nel bel mezzo del processo dell’uranio. Il ricorrente era Armanna Mines, un consorzio con interessi in tutto il mondo. Il socio di maggioranza è una compagnia canadese con sede a Calgary, proprietaria di due delle cinque maggiori miniere d’oro del Nordamerica. I giacimenti di uranio nella sola Virginia vengono stimati intorno ai venti miliardi di dollari, ma nessuno ne conosce con certezza il valore. Se un giudice federale corrotto vuole qualche lingotto d’oro in cambio di un ritorno di venti miliardi, perché non accettare? La compagnia ha dato a Fawcett la sua ricompensa e Fawcett ha dato a quella gente tutto ciò che voleva.» «Quanto oro?» mi chiede Westlake sottovoce, quasi non volesse farsi sentire dal suo microfono nascosto. «Non lo sapremo mai, ma sospetto che Fawcett abbia ricevuto circa dieci milioni di dollari in oro puro. Teile lo ha venduto qua e là. Voi avete il vostro informatore a New York, ma non sapremo mai se l’oro è finito anche altrove ed è stato venduto al mercato nero. Né sapremo mai quanti contanti c’erano nella cassaforte quando Nathan l’ha svuotata.» «Potrebbe dircelo lui.» «Certo, ma non ci farei troppo affidamento. In ogni caso il totale non ha importanza. Stiamo parlando di un mucchio di soldi, o di oro, e per farlo viaggiare dall’Armanna Mines fino all’austero ufficio dell’onorevole Raymond Fawcett deve esserci stato un corriere. Qualcuno ha fatto da tramite nell’accordo e ha effettuato le consegne.» «Uno degli avvocati?» «Probabile. Sono sicuro che l’Armanna ne ha almeno una decina.» «Qualche idea?» «Assolutamente no. Ma sono convinto che sia stato commesso un reato molto grave, con serie implicazioni. La Corte Suprema esaminerà il caso in ottobre e, considerando la tendenza pro-imprenditori della maggioranza, è probabile che il regalo di Fawcett ai signori dell’uranio venga confermato. E questo sarebbe una vergogna, non credi, Vic? Una sentenza frutto di corruzione diventa legge. Una gigantesca compagnia mineraria aggira il divieto a colpi di bustarelle e ottiene carta bianca per distruggere l’ambiente nella Virginia meridionale.» «A te cosa importa? Non tornerai mai laggiù, o almeno così hai detto.» «I miei sentimenti non sono importanti, ma all’FBI la cosa dovrebbe interessare. Se avviate un’indagine, la causa potrebbe uscire dai binari prestabiliti.» «Quindi adesso vuoi dire all’FBI come deve fare il suo mestiere.» «Assolutamente no. Ma non aspettatevi che io resti in silenzio. Hai mai sentito parlare di un giornalista investigativo che si chiama Carson Bell?» Le spalle di Westlake si abbassano. Distoglie lo sguardo. «No.» «“New York Times”. Ha seguito il processo dell’uranio e anche gli appelli. Potrei essere una fantastica fonte anonima.» «Non farlo, Max.» «Non puoi impedirmelo. Se a voi non va di indagare, sono sicuro che Mr Bell sarà felice di farlo. Prima pagina e tutto il resto. Insabbiamento da Teile dell’FBI.» «Non farlo. Per favore. Dacci un po’ di tempo.» «Hai trenta giorni. Se non sentirò niente a proposito di un’indagine, inviterò Mr Bell a trascorrere una settimana nella mia piccola isola.» Butto giù l’ultimo sorso, poso con forza il bicchiere sul tavolo e mi alzo in piedi. «Grazie per la birra.» «Ti stai vendicando, vero, Max? Un ultimo colpo al governo.» «Chi ti dice che sia l’ultimo?» domando da sopra la spalla. Esco dall’hotel e percorro il lungo viale d’accesso, in fondo al quale trovo Vanessa al volante del Maggiolino. Ci allontaniamo velocemente e dieci minuti dopo parcheggiamo davanti al terminal dei voli privati, prendiamo il nostro bagaglio leggero e incontriamo nell’atrio l’equipaggio della Maritime Aviation. Dopo il controllo dei passaporti ci affrettiamo verso lo stesso Learjet 35 che mi ha portato ad Antigua una settimana fa. «Andiamocene di qua» dico al capitano mentre saliamo a bordo. Due ore e mezzo più tardi atterriamo al Miami International mentre il sole si tuffa sotto l’orizzonte. Il Learjet rulla fino a un ufficio del servizio immigrazione per il rientro in patria, dopodiché Vanessa e io aspettiamo un taxi per mezz’ora. Nel terminal principale Vanessa acquista un biglietto di sola andata per Richmond, via Atlanta. Ci abbracciamo e ci salutiamo con un bacio. Le auguro buona fortuna e lei fa lo stesso con me. Noleggio un’auto e mi trovo un motel. Alle nove del giorno dopo sono già in attesa davanti alla Palmetto Trust quando le porte vengono aperte. Scendo nel caveau con il mio trolley. Nel giro di pochi minuti prelevo cinquantamila dollari in contanti e tre scatole di sigari Lavo contenenti ottantuno minilingotti. Quando esco, non informo l’impiegata che non tornerò mai più. L’affitto della cassetta di sicurezza scadrà tra un anno e la banca si limiterà semplicemente a sostituire le chiavi e ad assegnare la cassetta a un altro cliente. Combatto nel traffico del primo mattino, raggiungo finalmente l’Interstatale 95 e punto in direzione nord. Vado veloce, ma sto attento a non farmi fermare. Jacksonville è a sei ore d’auto. Il serbatoio è pieno e il mio programma non prevede soste. A nord di Fort Lauderdale, Vanessa mi chiama per darmi la gradita notizia che la missione è compiuta. Ha recuperato i lingotti nascosti nel suo apTeilamento, ha svuotato le tre cassette di sicurezza nelle banche di Richmond ed è già in viaggio verso Washington con un bagagliaio pieno d’oro. Un cantiere stradale nei pressi di Palm Beach mi fa perdere parecchio tempo, rovinando i miei programmi per il pomeriggio. Quando arriverò alle spiagge di Jacksonville le banche saranno già chiuse. Non ho scelta, così rallento e seguo il flusso del traffico. Sono le sei passate quando arrivo a Neptune Beach e, per amore dei vecchi tempi, scendo in un motel dove sono già stato. Accettano contanti e parcheggio vicino alla mia stanza, al piano terra. Porto in camera il trolley e mi addormento con lui sul letto. Vanessa mi sveglia alle dieci: è al sicuro nell’apTeilamento di Dee Ray vicino a Union Station. C’è anche Quinn e tutti e tre si stanno godendo la simpatica riunione. Per questa fase dell’operazione Dee Ray ha rotto con la sua compagna e l’ha cacciata di casa. A suo parere, non ci si può fidare di lei. Non è della famiglia e di certo non è la prima ragazza che Dee Ray ha scaricato. Io avanzo la richiesta di aspettare ventiquattr’ore per lo champagne. Noi – Vanessa, Dee Ray e io – avevamo espresso forti perplessità sul fatto che Quinn includesse nel nostro piano la moglie ormai separata. Il divorzio sembra probabile, e a questo punto è meglio se lei non sa niente. Ancora una volta mi ritrovo a dover aspettare qualche minuto nel parcheggio di una banca, la First Coast Trust. Alle nove, quando aprono le porte, entro con la massima disinvoltura possibile e una borsa vuota. Flirto con le impiegate. Un’altra bella giornata di sole in Florida. Solo nel cubicolo del caveau, estraggo due scatole di sigari dalla cassetta di sicurezza e le sistemo delicatamente nella borsa. Pochi minuti dopo raggiungo in auto una filiale della Jacksonville Savings distante pochi isolati. Svuotata anche quella cassetta, procedo con l’ultima fermata alla filiale della Wells Fargo ad Atlantic Beach. Per le dieci sono di nuovo sull’Interstatale 95 diretto a Washington. Ho duecentosessantuno mattoncini d’oro nel bagagliaio. Mancano solo i cinque che ho venduto ad Hassan in cambio di contanti. È quasi mezzanotte quando entro nel centro di Washington. Effettuo una breve deviazione e mi immetto in First Street, passo davanti al palazzo della Corte Suprema e mi chiedo quale sarà il risultato finale della memorabile causa “Armanna Mines contro Commonwealth of Virginia”. Uno degli avvocati, o forse due o tre fra quelli coinvolti nella causa, hanno profanato l’ufficio di un giudice federale con le loro luride tangenti. Che adesso si trovano nel bagagliaio della mia auto. Che viaggio. Sono quasi tentato di fermarmi lungo il marciapiede, prendere un minilingotto e scagliarlo contro uno dei finestroni. Ma prevale la ragione. Giro intorno a Union Station, seguo il GPS fino a I Street e poi all’angolo della Quinta. Quando parcheggio davanti al palazzo, Mr Quinn Rucker sta già scendendo gli scalini con il sorriso più ampio che io abbia mai visto. Il nostro abbraccio è lungo e commosso. «Come mai ci hai messo tanto?» domanda. «Ho fatto più in fretta possibile» rispondo. «Sapevo che saresti venuto, fratello. Non ho mai avuto dubbi.» «Dubbi ce n’erano, e non pochi.» Siamo sbalorditi dalla constatazione di avercela fatta e quasi sopraffatti dal nostro successo. Ci abbracciamo di nuovo ed entrambi esprimiamo la nostra reciproca ammirazione per la magrezza. Io confesso che non vedo l’ora di ricominciare a mangiare. Rucker che non ne può più di recitare la Teile del pazzo. «Sono sicuro che ti viene naturale» dico. Quinn mi afferra per le spalle, studia la mia nuova faccia e dichiara: «Sei quasi carino, adesso». «Ti darò il nome del chirurgo. Ne avresti bisogno anche tu.» Non ho mai avuto un amico più caro di Quinn Rucker. Le ore che abbiamo trascorso insieme a Frostburg studiando il nostro piano adesso mi sembrano un vecchio sogno. All’epoca ci credevamo perché non c’era nient’altro in cui sperare, ma dentro di noi, nel profondo, non pensavamo sul serio che avrebbe funzionato. Saliamo sottobraccio gli scalini ed entriamo nell’apTeilamento. Stringo e bacio Vanessa e poi mi presento di nuovo a Dee Ray. L’ho visto brevemente anni fa a Frostburg in occasione di una sua visita al fratello, ma non sono sicuro che lo avrei riconosciuto incontrandolo per strada. Non ha importanza: ora siamo fratelli di sangue, i nostri legami rinsaldati dalla fiducia e dall’oro. La prima bottiglia di champagne viene versata in quattro flûte Waterford – Dee Ray ha gusti costosi – e ce la scoliamo rapidamente. Dee Ray e Quinn si mettono entrambi una pistola in tasca e tutti insieme procediamo a scaricare la mia auto. Il Teily che segue sembrerebbe inverosimile perfino in un film di fantasy. Mentre lo champagne scorre a fiumi, i lingotti vengono disposti in pile di dieci pezzi ognuna al centro del pavimento del soggiorno, tutti e cinquecentoventiquattro, poi ci mettiamo a sedere su grandi cuscini intorno al nostro tesoro. È impossibile non guardare a bocca aperta, e nessuno tenta di soffocare il riso. Dato che io sono l’avvocato e anche il leader ufficioso, do inizio alla Teile lavorativa della riunione con qualche semplice calcolo. Abbiamo davanti a noi cinquecentoventiquattro mattoncini; cinque sono stati venduti a un commerciante d’oro siriano a Miami e quarantuno sono al sicuro nel caveau di una banca di Antigua. Il totale prelevato al nostro caro amico Nathan ammonta a cinquecentosettanta, per un valore approssimativo di otto milioni e mezzo di dollari. In base ai nostri accordi, Dee Ray ha diritto a cinquantasette luccicanti lingottini. Si è guadagnato il suo dieci per cento anticipando i contanti con i quali Quinn è stato arrestato, pagando la parcella di Dusty, fornendo i quattro chili di coca di Nathan, oltre alla pistola e all’idrato di cloralio di cui mi sono servito per metterlo KO. È stato Dee Ray a prelevare Quinn quando è evaso e a monitorare il rilascio di Nathan dal carcere in modo da comunicarci il momento esatto in cui far scattare l’operazione. Inoltre, ha pagato l’anticipo di ventimila dollari al centro di riabilitazione vicino ad Akron per l’inesistente problema di coca di suo fratello. Dee Ray è anche incaricato dello yacht. Sempre più brillo, ci mostra una lista dettagliata delle sue spese, compreso lo yacht, che arrotondando ammontano a trecentomila dollari. Ipotizziamo un valore di millecinquecento dollari l’oncia e votiamo all’unanimità per riconoscergli altri venti lingotti. Nessuno ha voglia di cavillare, e quando davanti a te hai una tale fortuna è facile essere magnanimi. A un certo momento del futuro ancora ignoto e inconoscibile, i rimanenti quattrocentottantotto minilingotti verranno equamente divisi tra Quinn, Vanessa e me. Ma adesso non ha importanza: la cosa urgente, è portare la roba fuori dal paese. Occorrerà molto tempo per convertire a poco a poco l’oro in denaro, ma di questo ci preoccuperemo in seguito. Per ora ci basta bere, ridere e raccontarci a turno la nostra versione degli eventi. Quando Vanessa replica la scena in cui, a casa di Nathan, si è spogliata e si è presentata ai due amici alla porta, ridiamo tanto da stare quasi male. Poi Quinn ci fa un resoconto del colloquio con Stanley Mumphrey, durante il quale gli ha sbattuto in faccia di essere a conoscenza che Max Baldwin si era sottratto al programma protezione testimoni e aveva lasciato la Florida, e imita la reazione a occhi sbarrati del procuratore. Quando descrivo il mio secondo incontro con Hassan, con il tentativo di contare centoventidue mazzette da cento dollari in un’affollata tavola calda, tutti pensano che me lo stia inventando. Le storie si susseguono fino alle tre di notte, quando ormai siamo troppo ubriachi per continuare. Dee Ray copre l’oro con una trapunta e io mi offro volontario per dormire sul divano. 44 Riprendiamo lentamente i sensi parecchie ore dopo. Il dopo sbornia e la stanchezza sono compensati dall’eccitazione del compito che ci attende. Per Dee Ray, un giovanotto che ha vissuto ai margini di un’attività specializzata nel contrabbando di sostanze illegali nel paese, la sfida di far uscire il nostro oro dagli Stati Uniti è quasi un divertimento. Ci spiega che ora siamo tutti degli appassionati di immersioni e che quindi ha acquistato un incredibile assortimento di attrezzature, tutte sistemate in pesanti borsoni di nylon con il marchio dell’US Divers, ognuno dei quali dotato di una robusta cerniera e di un piccolo lucchetto. Ci diamo da fare nell’apTeilamento estraendo dai borsoni maschere, boccagli, pinne, erogatori, bombole, cinture con zavorra, giubbotti ad assetto variabile, profondimetri, mute e persino fucili subacquei, il tutto mai usato. Nel giro di un mese il materiale sarà su eBay. L’equipaggiamento viene sostituito da una serie di zainetti e borse stagne dell’US Divers, tutti pieni di minilingotti d’oro. Il peso di ogni borsone viene testato più volte da noi uomini per verificare quanto si riesce a trasportare. I borsoni sono voluminosi e pesanti, ma lo sarebbero anche se contenessero attrezzature da sub. Inoltre, Dee Ray ha messo insieme una serie di valigie, le più robuste che ha trovato, tutte munite di rotelle. Sistemiamo l’oro all’interno di scarpe, kit per rasatura, buste per il trucco, perfino in due piccole scatole di esche per la pesca d’altura. Una volta aggiunti alcuni capi di vestiario per il viaggio, i nostri bagagli sembrano abbastanza pesanti da affondare una nave. Il peso è importante perché non vogliamo suscitare sospetti. Ma ciò che conta davvero è il fatto che adesso tutti i cinquecentoventiquattro lingotti sono ben impacchettati, sottochiave e al sicuro, o almeno preghiamo che lo siano. Prima di uscire mi guardo intorno nell’apTeilamento, in cui sono sparsi pezzi di equipaggiamento da sub e resti di imballi vari. Sul tavolo della cucina vedo scatole di sigari Lavo vuote e provo una punta di nostalgia. Hanno svolto bene il loro compito. Alle dieci arriva un grosso furgone, sul quale carichiamo i borsoni da sub e i bagagli. Non c’è posto per tutti e quattro e Vanessa si siede in braccio a me. Un quarto d’ora dopo entriamo in un parcheggio del Washington Marina. Lungo i moli sono allineate centinaia di imbarcazioni di ogni tipo che dondolano dolcemente sull’acqua. Le barche più grandi sono in fondo. Dee Ray punta il dito in quella direzione e spiega all’autista dove andare. Lo yacht è un bel trenta metri dalle linee slanciate con tre ponti, è di un bianco splendente e si chiama Rumrunner, un nome che mi sembra vagamente appropriato. Può ospitare comodamente otto passeggeri e ha un equipaggio di dieci persone. Un mese fa Dee Ray l’ha noleggiato per una breve crociera a Bermuda, perciò conosce sia il capitano che i membri dell’equipaggio. Li chiama per nome mentre noi scendiamo dal furgone e cominciamo a scaricare i bagagli. Due marinai ci aiutano con i borsoni e barcollano per il peso. Ma hanno già avuto a che fare in precedenza con sub appassionati. I passaporti vengono raccolti dallo steward e portati al ponte di comando. Quello di Quinn è falso e tratteniamo il fiato. Impieghiamo un’ora per ispezionare i nostri alloggi, farci un’idea del posto e prepararci per il viaggio. Dee Ray spiega ai marinai che vogliamo tenere con noi l’attrezzatura perché siamo dei fanatici per quanto riguarda l’equipaggiamento. Gli uomini recuperano i borsoni dalla stiva e li portano nelle nostre cabine. Quando i motori finalmente prendono vita, ci cambiamo indossando tutti degli shorts e ci riuniamo sul ponte inferiore. Lo steward arriva con la prima bottiglia di champagne e un vassoio di gamberi. Lasciamo lentamente il porto ed entriamo nel Potomac. Siamo oggetto di parecchie occhiate dalle barche che incrociamo. Forse è insolito vedere uno yacht carico di afroamericani. Questo dovrebbe essere un divertimento riservato all’uomo bianco, no? Lo steward si ripresenta con i nostri passaporti e la voglia di chiacchierare. Gli spiego che ho appena acquistato una casa ad Antigua, dove stiamo andando per una festa. A un certo punto mi chiede cosa faccio per vivere (in altre parole: da dove vengono tutti questi soldi?) e io gli rispondo che sono un regista. Appena se ne va, brindiamo al mio attore preferito: Nathan Cooley. Ben presto ci ritroviamo nell’Atlantico e la costa sfuma in lontananza. La nostra cabina è spaziosa per gli standard nautici, che non sono per niente generosi. Con quattro valigie e due borsoni da sub, abbiamo problemi a muoverci. Il letto comunque funziona alla perfezione. Vanessa e io facciamo una cosa veloce e poi dormiamo per due ore. Tre giorni dopo entriamo nel Jolly Harbour, all’estremità occidentale di Antigua. La navigazione da diporto è un business serio nell’isola, e la baia è affollata di barche di ogni dimensione. Le superiamo procedendo adagio e senza quasi creare scia mentre assimiliamo la vista delle montagne su tutti i lati. Le imbarcazioni di maggiore stazza sono ormeggiate tutte insieme a uno dei moli, e il nostro capitano manovra lentamente il Rumrunner infilandolo tra altri due yacht, uno grande più o meno come il nostro, l’altro molto di più. In questo attimo fuggente di vita da ricchi, ci riesce impossibile non confrontare la lunghezza delle barche. Guardiamo la più grande e ci chiediamo: “Chi è il proprietario? Cosa fa? Da dove viene?”. E così via. Il nostro equipaggio corre su e giù per le manovre di attracco e, quando i motori si spengono, il capitano raccoglie di nuovo i nostri passaporti e scende sul molo. Percorre una trentina di metri ed entra nel piccolo edificio della dogana per sbrigare la Teile burocratica. Una settimana fa, mentre ammazzavo il tempo in attesa che Vanessa mi raggiungesse ad Antigua, sono venuto a curiosare sul molo del Jolly Harbour e ho aspettato finché non è arrivato uno yacht. Ho visto il capitano entrare nella palazzina della dogana, esattamente come ha appena fatto il nostro. E, cosa più importante, ho notato che nessun doganiere ha ispezionato la barca. Il capitano ritorna: è tutto a posto. Siamo arrivati ad Antigua con l’oro e nessun sospetto. Spiego allo steward che vogliamo portare l’attrezzatura da sub nella mia villa perché per noi sarà più facile utilizzarla da là. E, già che ci siamo, porteremo a terra anche le valigie. Probabilmente ci serviremo dello yacht per fare immersioni tra le isole, e magari per qualche cena, ma per i primi giorni staremo a casa mia. Per lo steward non ci sono problemi, possiamo fare quello che vogliamo, e ci chiama i taxi. Mentre aspettiamo, aiutiamo i marinai a scaricare i bagagli. È una vera montagna, ma nessuno sospetterebbe che nelle valigie e nei borsoni da sub nascondiamo otto milioni di dollari in oro. Occorrono tre taxi per trasportare tutto e, mentre carichiamo, salutiamo con la mano lo steward e il capitano. Venti minuti più tardi arriviamo alla villetta a Sugar Cove. E quando tutto è dentro casa, ci diamo il cinque e ci tuffiamo nell’oceano. Table of Contents Il libro L’autore L'ex avvocato Copyright
Scaricare