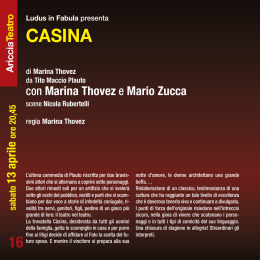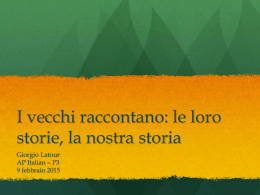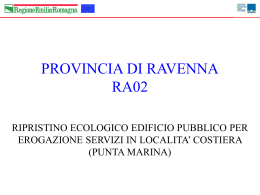1 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA C.O.I.R.A.G. Training Laboratorio di gruppoanalisi L’ombra della follia Allieva Mariolina Blanda Relatrice Irene Caponetto Tesi di fine corso A.A.2000/2001 2 Posso soltanto dire che, senza sapere d’averli punto cercati, mi ritrovai davanti, vivi da poterli toccare, vivi da poterne udire perfino il respiro, quei sei personaggi che ora si vedono sulla scena. E attendevano, lì presenti, ciascuno col suo tormento segreto e tutti uniti dalla nascita e dal viluppo delle vicende reciproche, ch’io li facessi entrare nel mondo dell’arte, componendo delle loro persone, delle loro passioni e dei loro casi un romanzo, un dramma o almeno una novella. Luigi Pirandello 3 Introduzione La scelta di parlare di questo caso, in questo elaborato, è stata quasi immediata e ha cominciato a farsi avanti già dai primi mesi del percorso. Mi sono interrogata più volte sull’argomento e penso che si possano trovare più di una motivazione a tale decisione: la prima di queste è che, nel momento in cui ho cominciato a pensare alla tesi, Marina era la paziente che seguivo da più tempo e con la quale si era potuto costruire un tipo di setting che, più delle altre situazioni, potesse essere definito psicoterapeutico. Inoltre mi sentivo molto coinvolta nella relazione, sentivo di risuonare molto e questo mi ha stimolato a voler affrontare un lavoro critico, anche riguardo ai miei vissuti in relazione alla paziente. Penso di aver posto come elementi centrali questi vissuti, anche perché è attraverso questi ultimi che mi sono mossa per andare avanti nel lavoro con la paziente e che hanno, forse, fatto da guida per accedere al suo mondo interno. Questa relazione è caratterizzata da un tipo di comunicazione emozionale molto intensa, o almeno è così che io l’ho percepita, che forse mi ha portato a scegliere, in qualche pagina, di utilizzare parole forti per descrivere la relazione con la paziente, parole come “frammentazione” o “crollo dei confini” che hanno la funzione di descrivere miei particolari vissuti nella relazione e che non hanno a che fare con il loro significato scientifico che rimanderebbe ad un quadro psicotico che in questo caso non è presente. E’ come se l’utilizzo di questi termini così forti fosse indotto dalla paziente che ha la capacità di portare una certa modalità relazionale che suscita delle emozioni molto intense e che incontra una modalità altrettanto pronta a risuonare: quella del terapeuta. Ho scelto, quindi, di soffermarmi molto sui contenuti emotivi che circolavano di volta in volta, mettendo spesso in primo piano le mie risonanze, e sottolineando anche i momenti in cui ho sentito di colludere con la paziente, non allo scopo di rilevare un errore ma perché penso che anche il riconoscimento di questi aspetti abbia portato elementi validi al processo terapeutico. Forse tutto ciò ha compromesso la chiarezza di questo lavoro, suscitando, probabilmente, un senso di confusione nel lettore, ma è davvero una confusione del mio scritto? Io penso, piuttosto, che sia una modalità che ha caratterizzato la relazione terapeutica, almeno per un po’ di tempo, e attraverso la quale stiamo riuscendo, forse molto lentamente, a dare senso al caos che ci circonda. Un terreno di comunicazione, quello del caos, sul quale ci siamo incontrate, io e la paziente, e abbiamo cominciato a comunicare. 4 1. Il Setting Ho ritenuto opportuno introdurre una cornice contestuale che ho definito, appunto, setting secondo un’accezione gruppoanalitica. La costruzione del setting terapeutico è ciò che determina la nascita di una relazione terapeutica, di un campo mentale relazionale all’interno del quale paziente e terapeuta possono dare vita alle rappresentazioni del proprio mondo interno, delle proprie gruppalità interne. E' una cornice stabile ma che nello stesso tempo si evolve. Il modello gruppoanalitico compie una distinzione fra set e setting, il primo riguarda un campo procedurale, costituito da variabili visibili e da considerare come “l’ossatura spazio-temporale dell’incontro”, il secondo è da considerare come campo mentale, nel quale operano variabili meno visibili; “…in questo senso è stato definito come uno spazio mentale per il mentale e costituisce il punto fondativo del pensiero dell’analista che, nel corso dell’esperienza analitica, diventa campo comune condiviso nella relazione con i suoi pazienti”. 1 “Il setting è lo sfondo, il non Io, il deposito delle parti indifferenziate, di tutti gli scontati, delle teorie di riferimento che costituiscono gli istituti di paziente e psicoterapeuta.” 2 Come accade in teatro, il setting determina lo scenario e le regole del gioco affinché la rappresentazione, il processo terapeutico, abbia luogo. Alla luce di quanto detto, penso che una descrizione introduttiva del contesto entro cui si colloca il caso sia utile, soprattutto per il fatto che, essendo un contesto pubblico, molte variabili sono date a prescindere dal terapeuta e il rischio che possano sfuggire o essere date per scontate potrebbe minare la costruzione della relazione terapeutica; infatti, il caso di cui parlerò in questo lavoro tesse la sua trama all’interno di un preciso contesto organizzativo, pubblico, con delle caratteristiche precise, che partecipa, insieme con altre variabili, ad un ben definito setting terapeutico che farà da sfondo e da contenitore, al dipanarsi della scena terapeutica e che favorirà l’attribuzione di nuove trame di significato. 1.1 L’organizzazione del centro di psicoterapia analitica Il caso si inserisce nel contesto del Centro di Psicoterapia Analitica Individuale dell’ASL 3 di Torino. 1 Profita G., Ruvolo G., Il setting nel lavoro psicologico con individui, gruppi e organizzazioni, in Profita G., Ruvolo G., (a cura di) Variazioni sul setting,, Raffaello Cortina Editore, Milano,1997. 2 Burlini, A. M., Galletti, A., Psicoterapia “attuale”, Franco Angeli, Milano,2000. 5 Penso sia utile descrivere l’organizzazione del Centro riguardo ai casi, poiché la presa in carico non avviene in modo diretto, ma ci sono dei passaggi che, in qualche misura, entrano nella futura relazione terapeutica e, spesso, diventano determinanti. Esistono tre équipe che sono interessate nella presa in carico dei pazienti: un’équipe di consultazione, una di trattamento e una di psicoterapia. I pazienti non prendono direttamente contatto con il Centro, ma telefonano alla segreteria del DSM dove richiedono un appuntamento, che è fissato con uno psicologo della consultazione. A questo livello, gli interventi proposti da tale équipe sono psicoterapie brevi o counseling, tranne nei casi in cui si ritiene, attraverso un preciso screening, che il paziente non è da consultazione e deve essere inviato ad un'altra équipe. In queste situazioni, lo psicologo che ha effettuato i primi colloqui con il paziente presenta il caso durante una riunione settimanale detta di “passaggio casi”, alla quale sono presenti tutti i responsabili; l’équipe di trattamento prende in carico tutti quei casi che richiedono un intervento d’équipe, che hanno a che fare con la cronicità, con percorsi terapeutici che si collocano più sul versante “supportivo”.3 Nel momento in cui è riconosciuta la possibilità, per il paziente, di intraprendere un percorso psicoterapeutico di tipo analitico, è presentato il caso dal responsabile durante una riunione, a cadenza settimanale, dell’équipe del Centro di psicoterapia. I criteri di valutazione adottati per la presa in carico di un paziente sono collegati all’età del paziente, alle sue capacità introspettive e di elaborazione, alla motivazione, alle ipotesi psicodiagnostiche e prognostiche etc. E’ data anche particolare importanza al tipo di lavoro che il paziente svolge, per dare priorità a quei casi in cui l’attività ha a che fare con il sociale; il caso di cui parlerò, infatti, è stato sottoposto con una certa urgenza, poiché la paziente frequenta un corso per diventare infermiera professionale ed è quotidianamente impegnata, al momento solo come tirocinante, in reparto ospedaliero. 1.2 Il luogo dell’incontro: una nicchia terapeutica Inizialmente il Centro di psicoterapia era situato all’interno di un edificio dove erano presenti anche altri servizi divisi su tre piani. Gli spazi a disposizione per i terapeuti del centro consistevano in tre stanze e una sala d’aspetto da condividere con la terapia familiare. Ciò creava una certa confusione, soprattutto quando capitava che alcune 3 G. O. Gabbard (1994), Psichiatria psicodinamica, Raffaello Cortina editore, Milano, 1995. 6 famiglie discutessero dietro la porta della stanza di psicoterapia o suonassero ripetutamente il citofono perché un paziente “impaziente” stava provando tutti i campanelli dell’ASL finché qualcuno non si decidesse ad aprire. Dopo qualche mese c’è stato un cambiamento di sede, ciò ha comportato molti vantaggi, ma, anche, degli svantaggi. La nuova struttura rimane un po’ isolata rispetto ad altri servizi, è un piano terra di un edificio di due piani, chiuso da una porta che si apre dall’interno con un meccanismo “antipanico”, in modo tale che, chiudendo a chiave dall’esterno, è possibile uscire spingendo il maniglione, ma è impossibile entrare senza possedere le chiavi. Ciò fa del centro una sorta di spazio protetto, come un’isola su cui è difficile approdare se non facendo tutti i passaggi “obbligatori” sopra descritti. Forse ciò rispecchia la posizione che il Centro di Psicoterapia analitica occupa all’interno del Dipartimento e i rapporti che intercorrono con i servizi, in altre parole le dinamiche istituzionali, ma l’argomento sarebbe complesso e lo spazio a disposizione non ci consente di affrontarlo. Questo spazio “protetto” per certi punti di vista non lo è per altri, poiché si è rivelato spesso pericoloso dimenticare la porta aperta o, per qualcuno, rimanere da solo fino a tardi; essendo precedentemente la sede dell’ambulatorio spesso arrivano dei pazienti che vorrebbero entrare perché convinti di trovare lì il loro medico, spesso con reazioni molto violente ai tentativi di chi tenta di inviarli da un’altra parte; per il fatto che non ci sia una segreteria o personale infermieristico a fare da filtro si è arrivati alla decisione di “barricarsi” dentro e aprire soltanto ai pazienti che hanno un “regolare” appuntamento. Ciò consente, nello stesso tempo, ad ogni terapeuta di usufruire di una stanza nel giorno e nell’orario concordato, garantendo costanza e continuità del setting, senza il rischio che qualcuno possa interrompere aprendo la porta all’improvviso o il movimento caotico che, inevitabilmente, si presenta in un servizio aperto al pubblico. Una sorta di “nicchia psicoterapeutica”. 1.3 Il modello di riferimento I terapeuti del Centro hanno, prevalentemente una formazione Psicoanalitica di stampo freudiano o junghiano. I casi sono seguiti all’interno di un setting analitico individuale e le variabili relative al contesto, alle quali si faceva prima riferimento, consentono la costruzione e il mantenimento di un setting quanto più possibile rigoroso per svolgere tale tipo di lavoro. 7 In questo senso, è attribuita notevole importanza ai primi colloqui, nei quali deve essere affrontato, e successivamente elaborato il passaggio dal terapeuta della consultazione, che vede inizialmente il paziente, al terapeuta del Centro che seguirà il caso. E' utile, a tale scopo, osservare il tipo di transfert che il paziente instaura sin dai primi colloqui, ed eventualmente analizzare il transfert laterale verso la precedente terapeuta. Il caso è stato sottoposto a supervisioni individuali periodiche con la tutor del mio tirocinio, che mi hanno aiutato a focalizzare l’attenzione sulla relazione terapeutica che stava prendendo forma attraverso l’analisi del transfert e del controtransfert. Si è valutato insieme, di volta in volta, gli strumenti da utilizzare nei vari momenti del lavoro, stabilendo quando fosse utile un’interpretazione, o adottare strategie meno intrusive più tollerabili per la paziente, in quella fase del percorso. Il contenuto delle supervisioni ha mirato maggiormente al perfezionamento della tecnica utilizzata: ciò mi ha permesso di colmare alcune lacune rispetto alla mia formazione, potendo venire in contatto in modo più diretto con la tecnica psicoanalitica. Ciò, almeno inizialmente, mi ha creato un po’ di confusione, poiché, essendo il mio modello di riferimento quello gruppoanalitico (che pur si colloca all’interno della matrice di pensiero psicoanalitica), non ritrovavo quei codici, e quelle coordinate che lo caratterizzano e con i quali avevo più familiarità (ah queste appartenenze!). Pur riconoscendo entrambi la relazione come oggetto privilegiato di analisi, le difficoltà di fondo si consolidavano su la diversa connotazione che la gruppoanalisi dà ai termini “transfert e controtransfert”. Questi, infatti, nascono in un contesto che interpreta la relazione analitica in modo più unidirezionale mentre la gruppoanalisi li utilizza in una prospettiva in cui la relazione terapeutica crea un campo mentale animato dalle proprie gruppalità interne che si intrecciano con quelle del paziente. “La gruppalità interna è l’esito della internalizzazione, attraverso processi identificatori, dell’insieme di relazioni delle quali l’individuo, sin dalla nascita, entra a far parte come elemento personale di una circolarità di significazioni e di intenzionamenti”4 Si preferisce usare l’accezione di “campo contrasferale” considerato come “non solo ripetizione, ma via via anche, come può esserlo la vita, luogo dell’incontro e della costruzione comune del nuovo […] In questo senso anche l’inconscio, più che accumulo 4 Napolitani, D., Maggiolini, A., Gruppalità interna (o gruppo interno), <Rivista Italiana di gruppoanalisi>, n.1, 2. 8 del passato e sede del rimosso, può essere considerato […] il luogo del futuro, di ciò che non c’è ancora e che attende di palesarsi e rendersi visibile”.5 La dimensione gruppale sembrava sfuggirmi, sin dall’inizio della relazione, come se la paziente fosse appiattita in una dimensione individuale che non permetteva di andare oltre e che mi metteva fortemente in difficoltà; mi sono chiesta spesso se ciò dipendesse dal fatto che mi trovavo “sospesa” tra due modelli e non riuscissi a capire all’interno di quale mi stessi muovendo e perché, o avesse a che fare con nodi problematici della paziente, ma, forse, la risposta più probabile e che entrambe queste cose influissero su queste difficoltà, che anche grazie al lavoro critico che ho dovuto fare per questo elaborato sono riuscita parzialmente a dare un maggiore significato a quanto stava accedendo. Non è da escludere che questa difficoltà iniziale, data dallo “scontro” tra due modelli, rispecchiasse alcune tematiche riguardanti la paziente ed emerse nel corso della psicoterapia, riguardanti la difficoltà ad integrare parti contrastanti di Sé e del mondo. Quello che mi mancava e che mancava alla paziente, era, forse, solo lo spazio per elaborare, per favorire un’integrazione nella mia mente che mi consentisse di ritrovarmi e di ritrovarla, e forse questo spazio si identifica con questa tesi. 1.4 Il passaggio del caso Stavo svolgendo il tirocinio al Centro di psicoterapia analitica individuale da quasi un mese quando, durante una riunione d’équipe, è stato presentato il caso di Marina e mi è stato chiesto di seguirlo. Marina aveva concluso il ciclo di colloqui previsto con un terapeuta della consultazione, la dott.ssa XXX, ed era stata segnalata per intraprendere un percorso psicoterapeutico. Prima di vedere la paziente, ho avuto un incontro con la mia tutor al fine di poter essere informata su quali fossero le dinamiche che questa organizzazione sul “passaggio casi” favoriva, in relazione all transazione da un terapeuta all’altro; essendo un elemento centrale dei primi colloqui avrei dovuto proporre uno spazio necessario affinché la paziente potesse verbalizzare i suoi vissuti riguardo il cambio di terapeuta; tale passaggio, infatti, ha rievocato tutti quei temi relativi all’abbandono, alla fiducia (o all’affidarsi), alla relazione, sin dai primi colloqui. Già i primi due gravitano attorno alla 5 Lo Verso G., Profita G., Il setting psicologico clinico come campo contransferale, in Lo Verso G., Le relazioni soggettuali, Bollati Boringhieri, Torino, 1994. 9 domanda “Perché non riesco ad instaurare delle relazioni soddisfacenti?”, e parla di un sogno che riguarda la morte, l’abbandono; sono, inoltre, numerosi i riferimenti che Marina fa alla dott. XXX, almeno nel primo periodo di psicoterapia. Le informazioni sulla storia della paziente, che pervengono alla riunione d’équipe, sono poche e riguardano quasi totalmente la sua storia, finita male, con un ragazzo di nome Giorgio. Marina ha ventiquattro anni, studia per diventare infermiera professionale e richiede il primo appuntamento perché sente di stare troppo male sia a causa della rottura con Giorgio, sia per il modo in cui si è conclusa la storia: lui si è ammalato di leucemia e sente, o vede, una presenza, non si sa bene se angelica o demoniaca, o entrambe. Dopo la riunione e un incontro con la tutor, decido di fissare un appuntamento a Marina, ma, quasi subito, mi imbatto anch’io in tutti quei complicati passaggi che prima ho descritto: la prassi per fissare il primo appuntamento segue uno schema ben definito. Occorre telefonare alla segreteria del DSM alla quale si dà la disponibilità del giorno e dell’ora che da lì sarà comunicata alla paziente. Spesso capita che in questo passaggio si perda qualcosa, così come è capitato in questa occasione: io ho fissato appuntamento per il 14 di novembre dello scorso anno, ma Marina non si è presentata. Ho chiamato la segreteria chiedendo se la paziente avesse comunicato loro qualcosa, ma ho ricevuto una risposta negativa. Mi ero già fatta l’idea che non l’avrei vista più, poiché cose del genere capitano di frequente, ci sono pazienti che si tirano indietro all’ultimo momento, o che, infastiditi dal passaggio di terapeuta, decidono di abbandonare. Pochi giorni dopo un collega mi riferisce che una paziente, di cui non ricordava il nome, aveva telefonato per me al Centro di Psicoterapia per fissare un altro appuntamento, visto che non si era potuta presentare al precedente; al collega sembrava di ricordare che il cognome corrispondesse a quello di Marina, ma non ne era sicuro. Decido di telefonarle (avevo un numero di cellulare fornitomi dal DSM) per concordare un altro appuntamento, ma scopro che Marina non aveva mai telefonato e all’appuntamento non si era presentata per il fatto che la segreteria glielo aveva fissato per il 14 dicembre, non novembre. Alla fine, dopo molta fatica e una buona dose di mistero, riesco ad incontrare Marina, per la prima volta, l’1 dicembre. 10 2. Una nuova relazione Dopo tutte le traversie di fronte alle quali mi sono trovata per vedere questa paziente, sembra essere arrivato il momento di incontrarla. Le fantasie che mi affollano la mente sono innumerevoli, alimentate dalle difficoltà iniziali che hanno ritardato questo incontro e dalla storia quasi inesistente di questa persona che ha suscitato grandi curiosità. 2.1. L’incontro Il giorno dell’appuntamento Marina arriva in anticipo, precedendomi; è seduta in sala d’attesa che sfoglia una delle riviste poste sul tavolino, sembra una ragazzina indifesa, dimostra meno della sua età e mi fa molta tenerezza. Ha un abbigliamento molto semplice, non c’è nulla che si nota particolarmente, anche il viso è acqua e sapone, ha un’espressione dolce e anche il suo modo di parlare lo è. Mi presento e la faccio accomodare nella stanza. Comincia, immediatamente, a parlarmi del suo ex fidanzato, Giorgio, riferisce dettagliatamente della sua presunta malattia (la leucemia), della sua improvvisa guarigione che le desta dei sospetti, e della presenza di questo angelo, Oscar, che sarebbe il responsabile della rottura e della fine della storia. Infatti Giorgio spaventato da questa presenza, che da angelo buono sembra essere diventato demone cattivo, allontana Marina per non correre il rischio di poterle fare del male. I primi incontri sono carichi di perché, è come se la paziente fosse in cerca di risposte che possano permetterle di rassegnarsi, o che possano rassicurarla; ma in fondo sembra essere convinta che il suo ex ragazzo possa essere schizofrenico, anche perché, essendo allieva infermiera, ha avuto l’occasione di leggere alcuni libri sull’argomento. Comincio a chiedermi dove sia Marina in tutto questo, con chi mi sto relazionando? Lei sembra molto spaventata, e forse la domanda che cerca di porre e che non riesce a porre è “sono come lui?” Parla della sua sensazione, percepita durante questa relazione, di sentirsi simile a lui, di percepirsi, in alcuni momenti, come “deviata”; è come se tutta questa situazione non le permettesse di svolgere la sua vita di sempre, non riesce più a svolgere le attività che prima svolgeva con interesse, è come svuotata e ha difficoltà a percepirsi come diversa dall’altro. Già nella prima seduta, mi racconta due sogni: il primo riguarda la morte del suo ex fidanzato, la sensazione è molto dolorosa e lei si trova a dover “fare i conti” con questo 11 lutto. La paziente riconosce come simile la sensazione che lei prova nella realtà, come se in questo momento la sua vita girasse attorno alla elaborazione della separazione da Giorgio. Tutto ciò rispecchia molto dolore ma stimola anche degli interrogativi: mi chiedo come possa, una storia durata solo due mesi, invadere il campo vitale della paziente e, specularmente, lo spazio del nostro colloquio? Sembra tutto appiattito sulla figura di questo ragazzo, ma cosa significa per Marina? Qual è la perdita, il lutto di cui si parla? Cosa significa per lei sentirsi deviata? Questo sarà un punto cruciale della psicoterapia, ma riuscirà ad essere verbalizzato solo dopo un anno di sedute. Nel secondo sogno scopre di avere un tumore, è molto spaventata, ma è come se lo sapesse già. E’ come se la fine di questa storia, la perdita di Giorgio, abbia preso il sopravvento su tutti gli aspetti della vita di Marina, la sta assorbendo quasi totalmente; nel sogno scopre di avere un tumore, come se questa persona le fosse entrata dentro invadendo, non solo il suo corpo, ma il suo Sé. La sensazione che provo è quella di cercare e non riuscire a trovare Marina, come se in quella stanza ci fosse poco di lei, al contrario dell’ex fidanzato. Continua a risuonarmi una frase che emerge spesso sin dal primo colloquio, e che potrebbe essere la chiave che permette l’accesso all’universo Marina: “Io non mi percepisco più”. Sono solo io che non la trovo o, forse, anche lei sente di essersi perduta? Forse quello che mi chiede è proprio l’essere aiutata a ritrovare, a ripercepire quelle parti del suo Sé che sono sfuggite nel rapporto con Giorgio…o in quali altre relazioni? Questo sembra molto difficile da scoprire, c’è l’impossibilità di poter accedere all’universo familiare di Marina, per molto tempo mi sono basata solo su fantasie che potessero dare una possibile interpretazione di quegli aspetti della personalità che avevano a che fare con confini rigidi, con il controllo, con la paura, l’aggressività e la colpa. Spesso mi sono chiesta quale fosse il percorso obbligato che Marina stava percorrendo, o, meglio, di chi fosse. 2.2 Andar per terapeuti Penso sia da tenere in considerazione l’influenza che ha avuto, nella formazione di un campo contransferale, il passaggio obbligato di terapeuta che Marina si è trovata a sperimentare: il tralasciare qui questo passaggio eluderebbe tutti quegli aspetti che hanno avuto a che fare con la costruzione dell’alleanza terapeutica. Il proponimento era quello di portare la paziente a parlare di questa ennesima separazione al fine di poter 12 elaborare questo passaggio; il collegamento tra dentro e fuori sembra essersi creato facilmente, anche se, inizialmente, era poco trattabile per Marina. I riferimenti al precedente terapeuta sono numerosi sin da subito “come avevo già detto al dott. XXX”, e nel primo colloquio si presenta già, tra le righe, la domanda “riuscirò mai ad instaurare delle relazioni soddisfacenti?”, “sarò ancora abbandonata?”. Si può ipotizzare che queste riflessioni fossero correlate, anche se non in maniera del tutto diretta, alla nuova relazione nascente: si riferiva, probabilmente, alla possibilità di avere una relazione soddisfacente con me e alla precedente relazione terapeutica (e potremmo aggiungere sentimentale, per connotare questo isomorfismo fra “dentro” e “fuori”) conclusa con un abbandono, anche se annunciato. Anche le diverse allusioni fatte alla madre, alla freddezza materna, e all’incontro con un suo ex ragazzo che porta in una delle prime sedute e dice “mi sono sentita riscaldata”, sembrano sottintendere delle allusioni che riguardano questo rapporto terapeutico, o non ancora terapeutico. Ho cercato di tenere in considerazione questi e altri aspetti transferali che si presentavano nei primi incontri, astenendomi, inizialmente, dall’introdurre elementi interpretativi che, vista la precocità della situazione, sarebbero stati troppo intrusivi. L’obiettivo che mi sono posta, dopo i primi colloqui, al fine di favorire un’elaborazione di tale passaggio, è stata la rigorosa costruzione di un setting che potesse contenere, almeno inizialmente, le ansie che la paziente presentava, e potesse favorire la costruzione di un’alleanza terapeutica che ci potesse permettere di concepire un lavoro insieme. Infatti in questa prima fase, molta attenzione è stata posta alla formulazione di un contratto terapeutico che ha posto le basi per una relazione stabile e priva di ambiguità6, e che ha permesso alla paziente di elaborare le fantasie relative ad un ulteriore abbandono. 6 Etchegoyen, R., H. (1986), I fondamenti della tecnica psicoanalitica, Astrolabio, Roma, 1990. 13 3. La storia familiare: un’assenza o un’eccessiva presenza? “In gruppoanalisi, la psicopatologia si evidenzia come eccesso di presenza o di assenza dei mondi relazionali familiari rispetto al bambino: assenza o presenza che gli impediscono di acquisire una sua soggettività”. 7 Marina sembra proporre dei modelli familiari saturanti e nello stesso tempo un vuoto relazionale che ne fa intravedere l’assenza. Non so se possono coesistere l’uno e l’altro, se un’eccessiva presenza può trasformarsi in un’assenza, e viceversa, ma ciò che attraversa questa relazione terapeutica ha a che fare con entrambi questi aspetti, e la sensazione che spesso mi attraversa è che, forse, ciò che manca a me è una rete all’interno della quale collocare la paziente. Una peregrinazione da un modello relazionale ad un altro senza la possibilità di poterli connettere. Da ciò una percezione distorta di Sé, instabile e mutevole che sembra essere, di volta in volta diversa, dipendente dall’altro polo relazionale. Parallelamente, sembra che tutte le strade siano già state tracciate, e se pur sembra intravedersi una separazione a favore di un espressione creativa del Sé, ci si rende conto che è solo apparente, e che un’altra strada, già tracciata precedentemente, si sta percorrendo. La percezione è quella di essere in contatto con diverse Marina, o con diverse parti del Sé che, per emergere, ne devono sopprimere altre e che mi fanno sentire, controtransferalmente, tanti terapeuti diversi che, di volta in volta, si relazionano con la parte emergente. Ciò mi ha fatto sentire spesso confusa, come se la paziente mi buttasse lì tutto il suo caos e io lo subissi senza riuscire a trovare il filo conduttore. Penso che la strutturazione di questo capitolo ne sia il rispecchiamento, come se la decisione di dividere i paragrafi in tal modo, come se fossero dei compartimenti stagni, fosse una decisione non casuale e isomorfa a ciò che è emerso nella relazione terapeutica. 3.1. La mamma: vittima o carnefice? Marina è la seconda di due figlie femmine, e pare abbia un rapporto molto confidenziale con la sorella, Eleonora, più grande di lei di qualche anno. Entrambe vivono con i genitori e spesso, la paziente parla della sorella come “punto di riferimento”, però la sua presenza all’interno delle sedute sembra un po’ marginale, 7 F. Di Maria, G. Lo Verso, G. Lavanco, Il visibile e l’invisibile. Conversazione sulla gruppoanalisi, Edizioni Angelo Guerini,1993. 14 come se ci fosse difficoltà a parlare di questo rapporto in modo approfondito ed esclusivo. Avverto questo problema su tutto il versante familiare, soprattutto all’inizio ho dovuto formulare delle richieste esplicite per ottenere delle informazioni che, altrimenti, non sarebbero arrivate spontaneamente. Il padre è pensionato, la madre non lavora, ha smesso dopo la nascita della prima figlia e non ha più ripreso. Dopo qualche colloquio noto che Marina comincia a parlare spontaneamente della madre, e prevale un tono lamentoso e di denuncia nei suoi confronti per la carenza di “coccole” che emerge come unico ricordo infantile; durante una seduta una “rivelazione”, come se avesse ricordato improvvisamente un particolare che le era sfuggito: “Mi viene in mente che io non sono stata voluta da mia madre, ha anche tentato l’aborto per non avermi perché voleva tornare a lavorare. Me lo ha detto mia zia, dice però che è strano che io mi senta rifiutata, perché era piena di attenzioni, bastava che mi stropicciassi gli occhi…Io credo di essere stata psicosomatica, forse già da bambina percepivo qualcosa…avevo la colite.” Marina non ha mai frequentato l’asilo, a causa della sua salute cagionevole e fino all’inizio delle scuole elementari è stata a casa con la mamma. Noto particolare difficoltà a parlare della sua infanzia, l’attenzione si sposta con estrema facilità ad eventi più recenti, o all’ennesimo ragazzo che le piace e che funge, in seduta, da copione per riempire lo spazio che potrebbe diventare un vuoto inquietante, o questa è la mia sensazione. Mi colpisce la quasi totale assenza di ricordi infantili, o l’impossibilità ad evocarli, tranne questo bisogno di coccole negate. La figura materna è spesso associata a situazioni che hanno a che fare con il giudizio, il controllo e il senso di colpa. Dopo qualche mese, Marina porta in seduta una situazione difficile che si presenta al tirocinio, con il suo infermiere affiancatore, e che vive in modo molto angosciante: “Mi sento il suo fiato sul collo…mi sento valutata (è anche vero che è lì per valutare!), sgridata, controllata, tratta come una bambina…” Questa situazione è associata a sensazioni che Marina vive in relazione alla madre: “Mi viene in mente che io e mia sorella abbiamo litigato con mia madre, lei ci vuole controllare…per carità è giusto, ma…noi piangevamo…mia sorella più per la rabbia…io avevo in mente, come quando ero piccola, mi faceva sentire in colpa…io ero la più piccola, ero a casa con lei e si sfogava con me.” 15 Qualche volta emerge un tono che risuona diverso, come un bisogno di giustificare, di dare della madre un’immagine diversa; allora si notano delle precisazioni del tipo “sto estremizzando, però”, o delle dichiarazioni spontanee: “…però, per come è stata cresciuta è fantastica…In questi ultimi anni ho capito che non posso pretendere che mia madre comprenda me, ma anzi, devo essere prima io a comprendere lei…” Quello che riesco a sapere è che la mamma di Marina è stata cresciuta da una zia e non dalla madre, e anche lei, si sente più legata a questa zia che non alla nonna materna. Queste informazioni mi fanno fare delle fantasie su possibili modelli transgenerazionali, ma rimangono al livello di fantasie perché non riesco ad approfondire mai l’argomento, è come se fosse tabù, come se qualcosa impedisse la possibilità di soffermarsi su alcuni contenuti, difficoltà che sento anch’io attraverso la mia, isomorfa, difficoltà a porre delle domande in proposito. Dopo le vacanze estive, ha cominciato ad emergere più chiaramente tale problema, ad essere verbalizzato senza, però, che ci fosse lo spazio per poterne parlare: “…ogni volta che, dopo una seduta, mi trovo a pensare alla mia infanzia mi sento molto angosciata, comincio a stare male di nuovo…come se ci fossero delle porte chiuse che non possono essere aperte…” Il messaggio sembra molto chiaro, ma provo delle sensazioni contrastanti, sento di dover rispettare i tempi della paziente ma, nello stesso tempo mi sento manipolata, mi chiedo se Marina sia veramente una vittima o, da qualche parte dentro di lei ci anche un carnefice. Quanto sperimentato da me, all’interno della relazione, forse rispecchia, in qualche misura, ciò che attraversa la relazione madre figlia: è come se dalle parole di Marina emergessero due, quasi contrastanti immagini della madre, quella che non dà coccole, che è fredda, che controlla, che giudica che fa sentire in colpa, da un lato, e quella che ha dovuto smettere di lavorare, che ha dovuto occuparsi di una figlia malata e stare attenta anche a come si stropicciava gli occhi dall’altro. Da un punto di vista relazionale possiamo ipotizzare che esista un gioco di ruoli, tra madre e figlia, tra paziente e terapeuta, che segue il modello vittima/carnefice, dove poco importa chi fa le veci dell’uno o dell’altro, è l’unico spazio di relazione possibile. Anche nella relazione terapeutica assistiamo ad un alternarsi di attacchi terroristici e ricostruzioni che rischiano di travolgere paziente e terapeuta in un circolo perverso incontrollato. Ma ciò sarà approfondito più avanti. Questo modello relazionale mi ha fatto sentire, spesso, imprigionata in un ruolo che, a seconda dei casi, mi portava al desiderio di coccolarla o di rimproverarla, 16 sperimentando sensazioni molto vicine a quelle della tenerezza e della rabbia. Mi rendo conto di sapere poco della famiglia di origine, e rifletto sul fatto che la difficoltà a parlarne è sia da parte della paziente, che evita l’argomento, sia da parte mia, che non riesco a trovare il collegamento al percorso e il modo per porre delle domande. Marina si sente “senza una collocazione e incatenata”, ha “bisogno di una vita propria”, ma chi la incatena, o che cosa, cosa le impedisce di avere una collocazione sua, cosa le impedisce di sentire che esiste una vita sua? Queste domande mi “tormentano” per diverso tempo, come se qualcosa mi passasse di continuo davanti gli occhi, senza la possibilità di vederla: come un segreto inviolabile, ma quale segreto? 3.2 Il cambiamento di corso di studi: curare ed essere curati Uno dei contenuti che sembrano, per Marina, più significativi, e che viene fuori con notevole facilità, è la sua decisione di abbandonare la facoltà di farmacia, che frequentava da tre anni, per iscriversi alla scuola per infermieri professionali. Questa decisione ha stimolato delle reazioni, al livello familiare, che mi hanno permesso di conoscere qualcosa in più sul clima e sulle relazioni, e che hanno suggerito delle nuove ipotesi di lavoro. “…sono dovuta andare via da casa per venti giorni, perché mi sono sentita offesa da tutto quello che mi ha detto mia madre. Mi sono sentita trattata come un’incapace, come se dovessi andare a lavorare in Corso Regina…per mia madre era come una regressione…” Durante quei giorni, Marina è stata a casa di una zia (moglie del fratello del padre), con la quale dice di andare molto d’accordo e che l’ha accolta in casa facendo da intermediaria con la madre. Dal tono con cui sono descritti questi momenti, appare molta determinazione in Marina riguardo questa scelta, dimostra una fermezza che non sembrava presente prima, o che non sembra appartenerle. “Sono stata sempre condizionata da mia madre in tutte le mie scelte, se dovevo prendere un vestito lo prendevo, per esempio rosso, perché sapevo che a lei piaceva rosso. Adesso non lo faccio più, non voglio mettere da parte me stessa…” Adesso è al II anno di corso e sta ottenendo ottimi risultati, si impegna e molto e, inizialmente, è arrivata in psicoterapia dicendo che il suo malessere non le consentiva 17 di poter svolgere le attività che la appassionavano tanto, in particolare il tirocinio: sembrava una delle preoccupazioni maggiori. Da un lato sento che questa descrizione possa dare delle indicazioni sul bisogno Marina di farsi spazio, di separarsi, sul bisogno di affermare se stessa , da un’altra parte, però, mi ha creato numerosi interrogativi. La mia impressione, infatti, è che la scelta di diventare infermiera non sia del tutto esente da intenzionamenti8, da un lato alimentata dal fatto che anche la sorella e la zia di Marina lo sono, da un altro perché dentro di me risuonava qualcosa riguardo al sentirsi in trappola senza via di uscita, come un leone in gabbia. Come se in quei momenti non potessi fare a meno di colludere con la paziente, di identificarmi con lei, senza la possibilità di riuscire a guardare le cose da un altro punto di vista, mi sentivo “appiattita”, con le mani legate senza riuscire ad individuarne il motivo, come se non fosse possibile andare oltre dei percorsi obbligati che lei stessa mi impone e che non riesco né a riconoscere, né a infrangere. Mi chiedevo cosa potesse significare in questa famiglia essere infermiere, cioè curare? Chi deve essere curato, e perché? Qual è il senso del curare e dell’essere curata per Marina? Ho spesso la sensazione che l’unica possibile relazione per lei sia la relazione di cura: lei si presenta in psicoterapia come molto malata, come una bambina indifesa che ha bisogno di essere accudita, dove l’unico atteggiamento “riconosciuto” è quello della sofferenza e tutte le situazioni che vengono a crearsi portano, inevitabilmente, ad una scelta “obbligata” che conduce al malessere: non c’è altra scelta; mi sono chiesta spesso perché Marina vuol essere malata, quale comunicazione è implicita nell’essere malati? Nello stesso tempo, l’alternativa è quella di curare, facendo l’infermiera ma non solo, anche all’interno di altre relazioni, fra cui quella terapeutica, si mette in atto questa dinamica altalenante fra il curare ed essere curati. Queste forti sensazioni mi fanno pensare ad una presenza saturante che porta Marina a “dover essere” in un certo modo: brava infermiera, brava bambina, brava paziente…che ha molta “cura “delle relazioni, fino a quando il malessere irrompe con tutta la sua violenza, quando lei stessa sente di essere impigliata in questa rete che non la riconosce come effettivamente è (o come vorrebbe essere) o forse che lei stessa non riconosce. Il fatto è che questa rete, che potrebbe essere l’espressione delle relazioni 8 Di Maria, F., Lavanco, G., L’individuo, il nomade e il gruppo: la quarta persona del singolare, in Di Maria, F., Lavanco, G. (a cura di), Al di là dell’individuo, Ila Palma, Palermo, 1993. 18 familiari, su più livelli, per molto tempo non è riconosciuta neanche in psicoterapia, o ne è accuratamente tenuta fuori, come se ci fosse una difficoltà congiunta, e collusiva, tra me e lei affinché alcune cose possano essere tenute nascoste. Solo in seguito scopro che anche al livello familiare molte cose sono state tenute nascoste a Marina. 3.3 Tra le figure paterne Marina non parla quasi mai del padre, è una figura che rimane sullo sfondo, come un grande assente, la prima volta che ne parla, viene fuori quasi in contrapposizione alla figura materna: “…con mio padre ho un rapporto più sereno, forse non ne ho parlato perché è una figura più insignificante”. Si corregge, o tenta di correggersi dopo questa affermazione, dicendo di non voler dire questo, ma non riesce a trovare un termine più appropriato. Lo vede come più tenero e malleabile che si contrappone alla rigidità della madre della quale è succube. Ricorda che durante i venti giorni di assenza da casa “mio padre mi chiamava spesso per dirmi di tornare, mia madre non mi ha mai fatto una telefonata”. Qualche tempo dopo la figura paterna riemerge quasi inaspettatamente e con caratteristiche del tutto diverse, sembra stia parlando di una persona diversa. E’ molto arrabbiata col fidanzato, con se stessa (forse anche con me, ma non è ancora possibile poterlo dire) e comincia a parlare del padre: viene fuori una parte taciturna, quasi indisponente, che, invece di dimostrare la rabbia, si tiene tutto dentro. “Dovrebbe essere giusto vivere le emozioni fino in fondo, nel dolore e nella gioia…non come fanno loro …” Mi sento molto confusa, non riesco a connettere questa figura nel flebile filo che tenta di connettere tutti gli elementi che Marina porta di sé in seduta, è come se mi proponesse una molteplicità di aspetti, anche contrastanti fra loro, creando questo clima confusivo e di spaesamento che attraversa la relazione terapeutica. Una confusione che circola fra me e lei e che dà una forte connotazione al campo terapeutico. Qual è il filo conduttore? E’ come se fosse la costruzione di un puzzle dove, però, mancano dei pezzi, si cercano ma è difficile trovarli, forse sono ben nascosti. L’unica possibilità è quella di portare dei frammenti, fare in modo di connetterli quanto più possibile, spesso con molta fatica e molta sofferenza, o almeno, è quello che percepisco io. E’ come se prendano corpo diverse figure, più o meno contrastanti e, allo stesso modo, parti di Sé altrettanto contrastanti, che entrano in relazione con aspetti 19 differenti del mondo. Un avvicendamento di relazioni, o di rappresentazioni di relazioni, una diversa dall’altra, separate quasi come compartimenti stagni che ripropone transferalmente, nella relazione terapeutica. Io, di volta in volta, sperimento diversi ruoli, impersono diversi personaggi, mi sento madre buona che accudisce, con l’impulso di abbracciarla e coccolarla, madre rigida e giudicante, padre silenzioso e assente, ecc. Una sfilata di personaggi che affollano la relazione terapeutica, presentandosi senza un’integrazione all’apparente caos. La stessa Marina ha definito il suo corpo come un teatro “dove si affollano una serie di personaggi…”, ma fra un personaggio e l’altro rimane un vuoto incolmabile, “un vuoto che rimbomba”. Penso che manchi la rete che possa sostenerli, il copione che assegna le parti e che recita il dramma familiare. 3.4 Le relazione con il partner: le richieste impossibili Marina approda alla psicoterapia per una storia finita male, con un ragazzo di cui sembra essere molto innamorata. Mi chiedo, immediatamente, quale fosse il messaggio che si celava dietro questa storia. Sembrava impossibile per, Marina, in quel momento, svelare qualcosa di sé, se non attraverso Giorgio; ma perché, proprio la storia con Giorgio, aveva scatenato questa sofferenza, ormai diventata ingestibile, qual era la comunicazione che, attraverso di lui doveva venire alla luce? Ho impiegato molto tempo per capire, per connettere la storia con Giorgio ed inserirla in un quadro più ampio che riguardasse Marina, la sua storia personale e, principalmente, familiare, per trovare quell’elemento mancante che precludeva l’avvicinamento al suo mondo interno, di ciò parlerò più avanti. Mi sono sentita spesso frustrata, come se si andasse avanti con estrema fatica ma con la sensazione di trovarsi sempre ad uno stesso punto di partenza che era quello di un’apparente frammentazione9: la relazione terapeutica sembrava un insieme di pezzi che risultavano incompatibili fra loro, resistenti ad ogni tentativo di connessione. Per qualche tempo è come se Giorgio fosse stato messo un po’ da parte, pur rimanendo sempre sullo sfondo della relazione terapeutica, ci sono state delle allusioni, dei cenni, ma sembrava ben lontano dall’essere la causa della sofferenza di Marina. Lei stessa lo ha messo da parte, sia non parlandone più, sia parlando di altre storie e di 9 Il termine “frammentazione” che ho usato si riferisce ad un vissuto che mi ha attraversato in alcuni momenti del percorso, connotato da sensazioni molto forti che riguardavano più una mia risonanza interna che un reale stato di frammentazione, in senso clinico e psicopatologico, della paziente. 20 altre sofferenze, molto diverse dalla precedente. Io credo di avere colluso con lei in questo tentativo di allontanare Giorgio dalla psicoterapia, come se non ci fosse lo spazio per poterne parlare, come se non avesse una collocazione; adesso posso aggiungere che forse il motivo era che non gli si poteva dare senso, non si poteva riconoscere come significante. In questi mesi Marina si è “innamorata” altre volte, ha avuto un’altra storia, anche questa finita, e ho avuto l’impressione che, attraverso queste relazioni, si presentasse spesso, in psicoterapia, una sorta di riproponimento delle relazioni familiari. La storia con Andrea si presenta dopo appena un mese, dice di essersi sentita “riscaldata” da questo incontro. E’ un ragazzo con cui ha già avuto una storia, due anni prima, finita male per incompatibilità; finita molto male, visto che lui l’ha lasciata senza preavviso e per telefono, o almeno questo è quello che riporta Marina e per cui sembra avere sofferto molto. Quello che sembra cercare nel partner, è un sostituto della figura materna che possa “risarcirla” di tutte quelle coccole che le spettavano di diritto e che, da bambina, non ha avuto, ma la persona che sta con lei è più vicino alla figura del padre, così ostinatamente silenzioso che provoca una rabbia incolmabile. Andrea è “chiuso, riservato, taciturno”, e Marina sente di non avere bisogno di questo, però sembra accettare le cose così come si presentano, forse più per adesività al terapeuta (devo essere una brava paziente) che per una sua elaborazione personale. Ci sono tutte le premesse affinché i bisogni di Marina siano frustrati, la sensazione che provo è che non ci sia scampo, un’altra gabbia è stata costruita e, ancora una volta, non c’è possibilità di movimento. La storia con Andrea diventa un elemento centrale delle sedute, prevale il tono lamentoso e di protesta, che risuona in modo molto simile a quello utilizzato nei confronti della madre. Riemergono tutte quelle ansie e quelle paure che la paralizzano, e che non le permettono più di svolgere la sua routine quotidiana. “Non dormo più, non mangio più, non ho più voglia di andare al tirocinio…” Marina chiama queste paure “paure abbandoniche”, e le pone sempre in relazione al rapporto con la madre; perde di vista il proposito iniziale di accettare Andrea così com’è, questo ragazzo “non mi riempie”, non lo sente presente, comincia ad avanzare delle richieste che diventano sempre più pressanti e che vanno inevitabilmente incontro ad una frustrazione. Ciò si ripercuote con violenza nella relazione terapeutica, mi trovo a sperimentare un forte 21 malessere nei confronti della paziente che continua a creare delle situazioni che mi mettono fortemente in difficoltà. Per un breve periodo mi chiama al cellulare con un tono quasi aggressivo, perché sta male ed io devo aiutarla, ogni mio tentativo di rimandare alla seduta successiva cade nel vuoto, quello che vuole sapere è cosa deve fare per stare meglio: una domanda impossibile per una risposta impossibile con il risultato inevitabile di essere frustrata. Il disagio che provo è molto forte, mi sento prima di tutto invasa, violata nei miei spazi (anche perché mi chiama di sabato pomeriggio), controllata e impotente, mi rendo conto di essere molto arrabbiata. Riflettendo sulle mie sensazioni mi rendo conto che la paziente, probabilmente, stava facendo in modo che io sperimentassi i suoi vissuti, le sue paure e i suoi disagi, ed io risuonavo quasi all’unisono con lei. Questa sorta di “riconoscimento” mi ha permesso di superare il momento difficile, portando in seduta ciò che era avvenuto fuori, ridando il senso che al di fuori del setting poteva andare perduto, in acting vuoti di significato. Tutte le dinamiche attraversate portano a situazioni senza via d’uscita, dove l’unica strada percorribile è quella della sofferenza. La storia con Andrea ha favorito l’emergere di queste dinamiche e probabilmente ha permesso a Marina di prendere contatto, di riconoscere, e forse, di cominciare ad elaborare la presenza di quei modelli relazionali che sembrano renderla prigioniera, all’interno dei quali è preclusa l’espressione dell’essere nella sua complessità, a favore di un campo relazionale, univoco e unidirezionale, che schiaccia la rappresentazione di sé in una dimensione di vuoto incolmabile, il vuoto del malessere e come vedremo in seguito proprio della malattia. 3.5 La meditazione e le regole Parallelamente alla psicoterapia, Marina stava portando avanti un percorso di meditazione che sembrava assorbirla in modo rilevante. Tale percorso, iniziato prima della “scelta della psicoterapia”, non era il primo e sembrava fosse legato alla figura di un maestro di yoga, particolarmente significativo. Marina, inizialmente, accomunava le due esperienze vedendole come due percorsi che potevano portarla alla consapevolezza di Sé, una sorta di viaggio all’interno di se stessi. Io vivevo una forte contraddizione, come se questo percorso potesse ostacolare il percorso psicoterapeutico, contraddizione esplicitamente dalla paziente stessa. che in seguito, è stata espressa 22 Il gruppo di meditazione poneva delle regole ferree, la principale delle quali era “essere single”, che, secondo me, si presentavano in opposizione alle regole che sottostanno alla costruzione del setting gruppoananlitico; come se da un lato la psicoterapia offrisse la possibilità di portare all’interno di una relazione il proprio mondo relazionale, la dimensione gruppale, e dall’altro la meditazione si opponesse a tutto ciò negando ogni possibile relazione e professando la singolarità, l’individualità per un viaggio dentro se stessi. Questo aspetto mi creava molta confusione, non mi era chiaro come questo percorso poteva inserirsi nel quadro che tentavo di costruire di Marina e con Marina, sembrava contrastante e creava molte contraddizioni. Mi trovavo a sperimentare delle emozioni contrastanti riguardo questo “spazio estraneo”, sentivo una difficoltà al livello personale, ma anche al livello di setting rispetto al portare nel “campo terapeutico” un oggetto che, in qualche modo, ne negava le fondamenta stesse. Una seduta, in particolare, è stata determinante per uscire da questa dialettica senza fine nella quale sentivo imprigionate meditazione/psicoterapia, paziente/terapeuta. Lei stessa sentiva di vivere forti contraddizioni e parla di una telefonata di Andrea, ricevuta mentre si stava recando a Firenze con il gruppo di meditazione: “Mi sono sentita un’altra persona, un muro. In un altro momento ricevere una sua telefonata mi avrebbe riscaldata, ma, in quel momento, mi sono sentita molto fredda e distante. Non lo avevo neanche riconosciuto!”. Come se Andrea avesse varcato un confine che fosse proibito, avesse invaso un luogo al quale non poteva accedere. Successivamente mi parla di un problema avuto con la madre riguardo alla meditazione: dopo la scoperta di alcuni opuscoli illustrativi si è molto arrabbiata con lei per la scelta di questo percorso accusandola di avere cambiato religione. Marina sembra sconvolta, come se fosse stato oltrepassato un confine fra due aspetti della sua vita che stava tenendo separati, come se stesse navigando nel caos. E’ molto arrabbiata con la madre, si sente una vittima, mai libera di poter fare le sue scelte: “…col fatto che ero di salute cagionevole, mia madre ha preso il posto di chi deve prendere le decisioni per me”. Io sentivo il suo tono alterato, la sentivo molto arrabbiata, ma sentivo una forte difficoltà ad immedesimarmi, a comprendere il suo turbamento: mi tornava in mente l’immagine della sua libreria, abitualmente spolverata dalla madre, con gli opuscoli lasciati quasi in esposizione. Per la prima volta non riuscivo a vedere, in Marina, la vittima, ma piuttosto, in quel momento, mi sembrava l’artefice della catastrofe. Come vedremo più avanti, 23 questa modalità si riproporrà altre volte creando situazioni difficili, in cui Marina si propone con tutto il suo malessere, nella sua posizione di vittima, ma con il sospetto che in lei si nasconda anche un carnefice. Continua per qualche tempo a parlare di meditazione ma cominciava a farsi strada, in lei, la paura che tutto ciò potesse essere d’ostacolo al suo percorso; per un po’ di tempo non capivo, effettivamente, quale fosse il percorso che intendeva Marina, ho sperimentato l’ansia riguardo alla possibilità che potesse scegliere di far solo la meditazione, ma forse ciò che sperimentavo erano quelle paure che la paziente stessa definisce “abbandoniche” e che hanno trovato terreno fertile nel mio mondo interno. Ho provato a chiederle se effettivamente questi due percorsi potessero conciliarsi e così comincia a parlare di regole e della necessità di negare la relazione con l’altro che ostacolerebbe il cammino spirituale dentro se stessi, che farebbe andare disperse quelle parti di Sé che tentiamo di scoprire. Mi sento frustrata e arrabbiata, sento il pericolo di rimanere incastrata nella trappola, vedo il rischio di creare un’opposizione alla meditazione che scivolerebbe in un conflitto difficilmente gestibile. La paziente mi sta dicendo che, forse ha difficoltà a tollerare le regole del setting, probabilmente il disagio nasce dal fatto che la relazione terapeutica non ha ancora assunto quelle caratteristiche di stabilità che dovrebbe offrire, ancora non ci si può fidare. Marina aggiunge: “Forse è più facile la strada della meditazione, perché ci si relaziona e si rende conto solo a se stessi, mentre nella relazione con l’altro devi rendere conto anche all’altro…” Però sta infrangendo le regole, cosa significa per Marina infrangere le regole? Forse dare vita a quelle rappresentazioni di Sé che hanno a che fare con l’essere ribelle, dall’uscire fuori da uno schema già prestabilito che la condanna ad essere una brava bambina, una brava paziente ecc. Ma ha anche a che fare con la psicoterapia? La mia rabbia sembra svanire quando comincio ad avere la percezione che tutto ciò si possa collegare alla psicoterapia: è come se portasse la meditazione come una difesa ad entrare nel rapporto terapeutico. La regola è un grosso problema nel rapporto tra la meditazione e la psicoterapia intesa come rapporto con l’altro, è come se mi stesse chiedendo “come faccio a fare la psicoterapia? Forse è più facile fare da soli.” Attraverso il ri-conoscimento di questo nesso tra psicoterapia e meditazione, credo si sia innescato un processo elaborativo che ha permesso alla paziente di abbandonare, 24 gradualmente, il percorso “meditativo” favorendo la costruzione dell’alleanza terapeutica. 4 La relazione terapeutica e le prime ipotesi di lavoro Come abbiamo già visto, il primo contatto con un terapeuta avviene a causa di una relazione infelice. Si fa molta fatica a capire dove sia la paziente in mezzo alle molteplici informazioni che emergono sul ragazzo in questione. Il periodo di consultazione è stato effettuato da un altro terapeuta, e Marina sin da subito ha introdotto la sua figura nei nostri colloqui, e spesso, nei primi incontri, ho avuto la sensazione che la paziente vivesse come una ripetizione obbligata ciò che già era stato detto in consultazione. Si presenta come una bambina bisognosa che ha bisogno di essere accudita, abbandonata dal fidanzato e anche un po’ dalla mamma che sente così fredda e, a volte, ostile. La domanda esplicita che emerge nei primi colloqui sembra riferita a Giorgio, il fidanzato che l’ha lasciata; è come se volesse scoprire, tramite le competenze di uno psicologo, se, effettivamente, come pensa lei, questo ragazzo si possa definire schizofrenico. Ci sono degli elementi che sfuggono al controllo e che vengono fuori quasi come buttati lì per caso: “Mi sono sentita deviata, non mi percepisco più.” Queste affermazioni mi risuonano dentro con una certa intensità, al di là dei termini “tecnici” da lei utilizzati per definire la malattia di Giorgio, e che forse servivano a rassicurarla, vedo una bambina indifesa, molto spaventata dagli eventi che potrebbero prendere il sopravvento su di lei, un po’ nascosta dalle sue stesse parole. In un primo momento, ho pensato che ci fossero molte difese ad entrare in una relazione terapeutica, Marina vuol essere rassicurata, ma rimane lontana, è difficile stabilire un contatto, però nello stesso tempo si trovava lì di fronte a me e per sua scelta. Ho cercato di lavorare soprattutto su questo, nelle prime fasi del percorso, cercando di costruire una cornice stabile nella quale Marina potesse sentirsi contenuta, e che le permettesse di venir fuori, superando la paura “di abbandonarsi” che lei stessa riuscirà a verbalizzare dopo un po’ di tempo. E’ come se in alcuni momenti mi stesse chiedendo: “Io sono una figlia abortita dalla dott.ssa XXX, lei cosa fa?” Sente di dovere 25 essere risarcita attraverso la richiesta di grandi coccole tanto da farmi sentire l’impulso, e anche in modo molto intenso, di alzarmi ed abbracciarla, ma non ha capito di non averne più l’età. E’ come se chiedesse una prestazione materna sia ai ragazzi sia a me, si presenta molto bisognosa. Parallelamente cerca di eliminare la distanza che esiste tra me e lei dicendomi che si sentirebbe meglio se io le dessi del tu, o ponendomi delle domande personali. Le ipotesi di lavoro da cui sono partita gravitavano attorno alla possibilità di creare un clima emotivo che potesse accogliere ciò che stava emergendo, offrendo alla paziente quel contenimento “sicuro” di cui aveva bisogno per “scoprirsi”, accogliere, quindi, quella bambina bisognosa, così spaventata di essere di nuovo abbandonata, e di essere lasciata in balia di se stessa con la terrificante sensazione di non percepirsi più, rimandandole, nello stesso tempo, che chi mi si presentava davanti era, però una persona adulta che era in grado di accudire se stessa. Le domande erano tante, ma, per il momento, era meglio tenerle in sospeso: cosa spaventava tanto Marina, cosa significava veramente “non percepirsi”, come si collocava all’interno del suo mondo relazionale familiare questa oscillazione fra l’avvicinamento e l’allontanamento nel rapporto con l’altro? Ho la sensazione che il mio, fino ad ora, sia stato un lavoro di scoperta, molto lenta, del mondo della paziente, portato avanti con molta fatica, sia da parte mia sia da parte sua, con momenti di estrema apertura che si contrappongono a momenti di chiusura difensiva e che lei stessa ha imparato a riconoscere. Se da un lato sento Marina molto presente nella relazione, a volte molto impegnata in un lavoro di elaborazione personale, altre volte lei stessa denuncia il bisogno di non andare oltre, sente come un muro, una forte sofferenza che si cela dietro contenuti che rimangono per molto tempo tabù, e che io sento di dover rispettare o forse ne sono costretta. C’è, infatti, sullo sfondo una Marina più dura che quando si sente troppo invasa nel rapporto con l’altro decide di troncare, di dare un taglio netto e ritirarsi; questo messaggio passa in modo chiaro nella relazione terapeutica, in alcuni momenti mi ha creato un certo disagio, ma in altri l’allontanamento dalla terapeuta si è rivelato utile per recuperare alcuni aspetti riguardanti la nostra relazione e una matrice relazionale più profonda che affonda le sue radici nella storia transgenerazionale di Marina. Il percorso terapeutico è caratterizzato da questi allontanamenti e avvicinamenti che ho imparato non solo a tollerare ma anche a rispettare. Ho a che fare spesso con una 26 ragazzina spaventata che verbalizza questa paura in modo molto chiaro: “Ero molto eccitata a venire qui, perché è come se da un lato avessi questa voglia di aprirmi, ma nello stesso tempo ho paura…non di scoprirmi ma…che lei possa entrarmi dentro, questo pensiero mi fa arrabbiare.” Sento un forte disagio di fronte alla rivelazione di queste paure, come se la paziente mi attribuisse dei poteri quasi onnipotenti quando io, invece, mi sento molto insicura. Rifletto molto su ciò che sta passando al livello relazionale, forse anch’io ho determinato questo disagio con un atteggiamento un po’ incalzante ed indagatorio, come se dovessi scoprire a tutti i costi delle parti di Marina che invece non vogliono venir fuori; la paziente mi ha indicato la strada, mi sta avvisando, forse, del fatto che se non vado più cauta lei può disperdersi, può sparire, può essere "invasa”. Dalla sua posizione, io ho a disposizione questo potere, e devo stare attenta ad utilizzarlo, devo rispettare i suoi deboli confini che sembrano delineati in modo molto grossolano e precario, apparentemente rigido. Al livello relazionale si propone la paura della perdita dei propri confini nella relazione con l’altro, una dinamica che “invade” la relazione e che si pone al centro del campo terapeutico e che deve essere osservata. Quello che ho fatto è proprio la creazione di una relazione altra che potesse essere, piano piano, avvicinata e alla quale si potesse attribuire significato, inserendola all’interno di una rete più vasta di significazione che sembrava inesistente. Come se la paziente offrisse dei frammenti che difficilmente trovano un filo logico o una trama di significato e che fanno piombare in uno stato confusivo di allarme e di malessere. Soprattutto all’inizio, era come se Marina portasse in seduta tutti gli aspetti relazionali della sua vita che, sembrava non potessero comunicare fra loro: la madre era tenuta all’oscuro delle sua relazione col partner, della psicoterapia e della meditazione, il partner non sapeva della meditazione e della psicoterapia, il gruppo di meditazione non doveva sapere della sua relazione e della psicoterapia ecc. Una fatica enorme a gestire tutto ciò mantenendolo separato e a proporre di volta in volta aspetti diversi di Sé, a seconda del contesto relazionale. La psicoterapia è diventato un luogo in cui tutti questi compartimenti stagni potessero confluire, un momento in cui poter gettare un filo che li collegasse. Forse la funzione della psicoterapia in quel momento era quella di gettare un ponte, creare dei nuovi nessi che potessero dare senso a questo stato di non integrazione e di caos. 27 Fondamentale è la funzione del setting, che offre quella cornice più o meno stabile che è al di fuori della relazione terapeutica, ma nello stesso tempo la attraversa e ne è attraversato, che favorisce l’espressione del sintomo e della sofferenza, consentendo la costruzione di nuove connessioni, di nuove matrici di senso dove inscrivere il sintomo stesso. “Il setting è anche qualcosa che evolve, si co-costruisce e si trasforma: in questo senso può anche essere definito un organizzatore psichico di carattere transpersonale, campo mentale condiviso che consente di pensare i fenomeni e i sintomi e di dare significato ad essi e di creare nuove connessioni e relazioni.”10 Un setting così pensato diventa uno strumento necessario affinché le gruppalità interne del paziente e del terapeuta interagiscano, dando vita a quelle rappresentazioni di relazioni che affondano le loro origini nel lì e allora e si rispecchiano nel qui e ora; un’area transizionale che consente l’incontro tra paziente e terapeuta, un’area intermedia che Winnicott definirebbe area di gioco: “La psicoterapia ha luogo là dove si sovrappongono due aree di gioco, quella del paziente e quella del terapeuta. La psicoterapia ha a che fare con due persone che giocano insieme”.11 Quello che ho fatto con Marina è forse qualcosa che si può definire gioco, un gioco in cui spesso si è trovata la paziente stessa a dettare le regole e il terapeuta a seguirle: una forma di collusione o una strategia? Forse l’uno e l’altro; il problema è che non sempre si può capire a quale gioco si stia giocando, come se mancassero dei pezzi, delle regole che si sono andate costruendo, però in questo percorso. Il gioco più frequente, che si presenta in modo immutabile e insistente (una coazione nevrotica?) è quello della bambina che sta male per colpa di una mamma cattiva (psicoterapeuta cattiva) che la fa stare male: “è colpa tua se sto male!”. Ma nello stesso il modello della salute cagionevole, indispensabile affinché ci si prenda cura di lei: “Io so che ti interesserei a me solo se sto male”. Un gioco fra paziente e terapeuta dove c’è chi sta male e c’è chi cura, dove non necessariamente chi cura deve essere il terapeuta, dove c’è chi distrugge e c’è chi deve ricostruire. Uno scambio relazionale molto intenso che ci coinvolge per molto tempo, con enormi difficoltà ad uscire fuori da questo gioco perverso che, a volte, sembra diventare un agito senza pensiero. 10 11 Lo Verso, G., Le relazioni soggettuali, Bollati Boringhieri, Torino, 1994. Winnicott, D., W. (1971), Gioco e realtà, Armando, Roma, 1993. 28 Come abbiamo visto all’inizio, il setting terapeutico comprende anche tutte quelle variabili che hanno a che fare con il contesto organizzativo del Centro di psicoterapia e dell’intero DSM, e questo comporta che i protagonisti del gioco non sono da soli, ma sullo sfondo è presente sempre qualcosa di “estraneo” alla relazione che ha a che fare con tale contesto, rendendo anche più difficile il gioco stesso e l’attribuzione di significati, con il rischio di trovarsi coinvolti in dinamiche che sfuggono “all’intimità” della situazione terapeutica e minacciano di invischiarne i protagonisti in azioni vuote e stereotipate. Riuscire a riportare all’interno della relazione quegli elementi apparentemente estranei, mi ha permesso di dare una svolta alla relazione, come vedremo in dettaglio più avanti. Solo giocando a questo gioco, sono riuscita a trovare quegli anelli mancanti che mi torturavano all’inizio e che avevano determinato l’innalzamento delle difese per le quali Marina mi sembrava inaccessibile. A tal scopo mi rendo conto di aver riservato poca attenzione alla formulazione di una diagnosi che inserisca la paziente in una categoria psicopatologica: ho pensato che ciò avrebbe potuto allontanarmi dalla possibilità di giocare con lei. Ad ogni modo, nel corso dei colloqui, da ciò che ho osservato, credo di essermi fatta un’idea sul profilo psicopatologico della paziente e, al di là di ogni etichettamento, la sua funzione si è rivelata utile all’interno del gioco ai fini di formulare delle ipotesi di lavoro che pensavo fosse utile seguire. L’idea che mi sono fatta è che Marina presenti un disturbo di personalità che si manifesta nella situazione terapeutica attraverso la messa in scena inconscia di “modalità relazionali disturbate”.12La sua modalità pervasiva di instabilità nelle relazioni interpersonali, che Marina ripropone fuori e dentro la relazione terapeutica; l’immagine e la percezione di Sé, molto instabile fino a giungere alla disperata affermazione “io non mi percepisco”; il problema dei confini che, costruiti in modo rigido e inflessibile, possono essere facilmente violati facendole sperimentare la sensazione che l’altro possa entrarle dentro; il bisogno di attenzione che si esprime a diversi livelli, con la mamma, con il partner, con la terapeuta, e che la portano ad attirare l’attenzione soprattutto attraverso l’esplicitazione del bisogno di cure, rendendosi malata; il modo in cui utilizza il corpo, in particolare il viso, per attirare la mia attenzione, venendo in 12 Nucara, G., Menarini, R., Pontalti, C., La famiglia e il gruppo: clinica gruppoananlitica e psicopatologia, in Di Maria, F., Lo verso, G., La psicodinamica dei gruppi, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995. 29 seduta, solo raramente, e in modo discordante dal suo abituale, vistosamente truccata, soprattutto le labbra, tanto da farmi venire in mente immagini inquietanti come quella del diavolo, o quella più rassicurante del clown. In base a tutte queste considerazioni si potrebbero riconoscere in lei dei tratti istrionici, o borderline, o isterici, ma non credo sia importante ciò, quanto l’aver identificato delle modalità relazionali, nelle quali entro a far parte anch’io e che può essere utile riconoscere anche in relazione al fatto che tali modalità andranno ad intrecciarsi con le mie: ciò è utile per sapere che tipo di gioco si presenta sulla scena e in che modo si può collocare all’interno di quell’universo familiare che per diversi mesi è stato negato. E’ come se qualcosa impedisse a Marina di percepirsi come persona, assoggettandola ad una rappresentazione vuota di modelli relazionali familiari, dove è impossibile attribuire un significato. “La capacità mitopoietica della famiglia di costruire relazioni significative tra la propria storia, la storia degli antenati, e il nuovo progetto storico del bambino, permette al bambino stesso di organizzarsi come sintesi dialettica all’interno di questi tre campi: di fondarsi come persona. Se invece la famiglia non riesce a dare senso al nesso esistente fra le due storie e quella delle generazioni precedenti, anche il nuovo progetto storico del bambino sarà minato da aree senza senso, potenzialmente psicopatogene: lo sviluppo mentale e l’organizzazione intrapsichica del bambino (e successivamente dell’adolescente) saranno ostacolate o, comunque, complicate dalla storia transgenerazionale, invece che esserne supportate.”13 Sento il peso di questa storia familiare che per molto tempo rimarrà esclusa dal campo mentale della situazione terapeutica, dandomi la sensazione di muovermi nel buio; il cammino verso una nuova attribuzione di senso passerà attraverso la possibilità di poter attraversare questa storia transgenerazionale, o alcuni aspetti di essa. 5. Tornando dalle vacanze… Ho scelto di parlare più dettagliatamente delle sedute che si sono svolte nelle settimane successive al rientro dalle vacanze estive poiché ritengo che sia stato un periodo molto significativo, per paziente e terapeuta, che è stato connotato da grossi movimenti emozionali che hanno portato la stessa relazione terapeutica ad una svolta. 30 5.1. La Sicilia come “spazio transizionale” Ci siamo lasciate a Luglio con grandi speranze, da parte di Marina, per questo viaggio in Sicilia: racchiudeva l’illusione di un ritrovamento di sé, in un luogo estraneo lontano da casa e dove l’unica a poterla “accudire” era Marina stessa. Una sorta di prova da superare, una prova di resistenza al sentimento di abbandono, tema principale nell’ultima seduta prima delle vacanze. P: “Il fatto è che le vacanze, il viaggio, tutte queste separazioni mi magonano…però non lo sto sentendo tanto come le altre volte…ho bisogno di staccare di prendermi un po’ di autonomia…” Al suo rientro mi dice queste parole: “Questa interruzione mi è servita…sono riuscita a riprendermi da sola dai momenti di sconforto…ho avuto delle sensazioni in Sicilia, anche se ero da sola, perché stavo bene con le persone che mi circondavano…non sono più sicura di volere una persona…è già un po’ di tempo che le parole “per sempre” mi spaventano” Ho la sensazione che la psicoterapia sia elemento centrale di queste sedute, come se da un lato ci fosse quasi l’esigenza di una separazione, di una propria autonomia, anche dalla relazione terapeutica, però, dall’altro, l’unico posto possibile dove andare in vacanza senza sperimentare quel profondo senso di abbandono è la Sicilia, l’unico posto dove si può stare bene. Mi ricorda molto i bambini winnicottiani che per tollerare l’assenza della madre creano illusoriamente un surrogato dell’oggetto d’amore nell’oggetto transizionale, probabilmente tale funzione è stata assunta dalla Sicilia, in quanto terra d’origine della psicoterapeuta. Ma ciò ha anche determinato forti risonanze in me, emozioni profonde che mi hanno allontanato, provvisoriamente dalla relazione terapeutica, ho sentito come una chiusura verso l’esterno, come se dovessi nascondermi da Marina come se fosse sbagliato sperimentare un certo tipo di emozione così profonda e così personale. Avevo paura di essere scoperta. Ho riflettuto molto su queste dinamiche, è stato molto faticoso, l’intreccio tra questi due mondi relazionali, quello della paziente e il mio, era inestricabile, come se fosse, per me, ancora impossibile riuscire a guardarmi dentro, rispetto ad alcune tematiche che Marina mi stava sbattendo violentemente in faccia in seduta, e ad operare una distinzione tra quanto ci fosse di esclusivamente mio, personale e quanto non appartenesse alla paziente. Avevo la sensazione che Marina sapesse ciò che stavo provando, e questa consapevolezza ha determinato la chiusura: mi stavo difendendo. Sentivo la difficoltà ad andare avanti, e dentro di me si faceva strada l’ipotesi che tale 13 Ibidem. 31 difficoltà non poteva essere superata fino al momento in cui non avessi trovato il modo di elaborare questi passaggi e trovato lo spazio per verbalizzarli: dovevo riportare nell’hic et nunc della situazione terapeutica quello che teneva me e Marina impegnate a duemila chilometri di distanza, dovevo creare una connessione di senso, che tenesse conto del “qui e ora” ma anche del “lì e allora” di paziente e terapeuta. Penso sia utile riportare un colloquio per intero per comprendere meglio come è avvenuto questo passaggio. Arriva con notevole anticipo. Comincia subito a parlare e io mi sento molto confusa, non riesco a seguirla e mi chiedo continuamente cosa mi stia dicendo. P: “Ho ripensato a Giorgio…la voglia di stare da sola, questo ritiro forse dipende da questo…pensare di stare per sempre con una persona mi spaventa, penso alla mutevolezza…” Per diversi minuti ho la sensazione che continui a girare intorno a questo discorso, continua a dire di stare bene ma percepisco qualcosa nel tono delle sue parole che suona come un lamento. Il filo logico è impeccabile è tutto molto, forse troppo, razionale. P: “Forse sto facendo filosofia…” T: “Pensavo al fatto che mi parla di questo ritiro dalle relazioni, però arriva in anticipo… P: “Lo sapevo che me lo avrebbe detto!” (ride) T: Mi parla di questo stare bene ma io mi sento confusa, il suono è come quello di un lamento per qualcosa che non va…” Il tono ritorna come prima, il mio intervento sembra non avere stimolato alcuna riflessione, si ripetono le stesse parole che mi risuonano come vuote, iperazionali. P: “Oggi è come se fossi andata a ruota libera, di solito seleziono quello che devo dire…oggi è come se avessi aperto il cervello e avessi fatto uscire fuori tutto. Mi sento molto confusa, forse ha ragione Marina, ha fatto uscire fuori tutto, ma tutto cosa? Forse sono meno rilassata della paziente. E’ come se questo modo di riempire la seduta con queste parole, per me vuote di significato, fosse invece fondamentale per lei, come se la cosa fondamentale fosse poter stare con me. Ha bisogno di stare con me, e per fare ciò è stato indispensabile portare la psicoterapia in Sicilia e la Sicilia in psicoterapia. Il lamento mi fa pensare ad un bimbo piccolo, facendomi risuonare, ancora una volta in modo molto intenso, un bimbo che ha bisogno di sperimentare che si può stare insieme e ci si può allontanare senza sentire l’abbandono. Chi di noi sia il bambino in quel momento non lo so, anch’io mi sono sentita profondamente piccola, trascinata quasi 32 con violenza in quella dimensione spazio temporale che mi riporta a tutti quei vissuti di abbandono, di separazione, ancora così vivi e reali e forse solo parzialmente elaborati. P: “Mi viene da pensare al fatto che quando sono tornata dalla Sicilia mi sono sentita triste, lì ho conosciuto delle persone più aperte alla relazione, più aperte verso il mondo, poi sono tornata qua e …vero che ero in vacanza…però ho pensato che qui non mi è mai capitato di avere una compagnia come riferimento…lì è un modo di vivere diverso… T: “E’ come se mi dicesse, da un lato che ha voglia di allontanarsi, chiudersi alle relazioni, dall’altro pensa con nostalgia alle sue vacanze e all’apertura verso gli altri che ha riscontrato. Mi faceva molto riflettere anche il fatto che questa psicoterapeuta è siciliana…” P: (Ride) “A questo ci avevo pensato…forse dipende anche da me, al fatto che io posso non essere disposta all’apertura, e che in Sicilia ero io disposta all’apertura…dipende anche da me… Ritorna con insistenza il tema del “per sempre”: queste parole continuano a rimbombarmi nella testa come se volessero dire qualcosa di più profondo rispetto al semplice riempimento del tempo della seduta. T: “pensare ad una relazione per sempre fa paura…mi chiedevo se potevamo portare qui dentro questo discorso.” P: “Pensare alla psicoterapia per sempre?” T: “Anche pensare ad una psicoterapia per sempre fa paura?” P: “Sì” Silenzio P:” Mi veniva da pensare al fatto che ho avvertito dei cambiamenti, se penso alla Marina di un anno fa mi sembra bambina. Penso che, se non avessi ottenuto questi risultati, avrei pensato di smettere, di cambiare…ci sono stati dei momenti negativi, anche nei confronti della psicoterapia…è come se fosse cambiato il mio modo di affrontare la vita…Non capisco come fanno quelle persona che stanno dieci o quindici anni in psicoterapia senza avvertire cambiamenti, non voglio una risposta da lei, mi chiedevo solo com’è possibile. Io ho notato questi piccoli cambiamenti ed è passato solo un anno. T: Ci fermiamo qua. Con le sue ultime affermazioni Marina mi fa sentire molto gratificata, ma nello stesso tempo una sorta di “campanello d’allarme” si insidia nella mia mente impedendomi di godere a pieno del “successo” da lei annunciato. Dal ritorno dalle vacanze continua a dire di stare bene, di essere riuscita a prendersi cura di sé, cosa che le risultava impossibile fino a pochi mesi fa, mi sta forse dicendo che non ha più bisogno di me. Per quanto ami la Sicilia, non credo che abbia alcunché di miracoloso, e stentavo a credere che il solo contatto con il territorio e le persone del luogo avessero potuto operare un tale miglioramento, ma forse ciò che stava emergendo in modo più evidente era che Marina stava facendomi sperimentare “il senso di abbandono” (il suo, il mio, i nostri), 33 dicendomi che questa psicoterapia “per sempre” poteva essere spaventosa, dicendomi di stare bene, di potercela fare da sola. 5.2 La seduta in maschera La seduta successiva sembra un fulmine a ciel sereno, forse anche Marina ha avuto paura di scoprirsi troppo con il suo stare bene, e quel senso di abbandono che avevo percepito era qualcosa che ci stava accomunando, che stava sperimentando anche lei, a tal punto che l’unico modo per arginare queste emozioni troppo intense era quello di star male di nuovo, di essere ancora curata. E’ una seduta molto confusa, dove è percepibile la difficoltà a rintracciare un filo logico dietro le parole, mi sento molto frustrata dalla sensazione di avere fatto dei passi indietro. Arriva puntuale e noto subito il suo viso che rimanda un immagine molto inquietante: contrariamente al suo solito, acqua e sapone, ha il viso vistosamente truccato, soprattutto le labbra, in modo così eccessivo che rimanda ad un’immagine inquietante, in parte, forse anche ridicola. Sento quest’immagine come contrastante, quasi stridente rispetto a ciò che è comunicato verbalmente, come se fossi di fronte a due canali di comunicazione che esprimono contenuti diversi, se non opposti. Mi viene in mente il clown come immagine archetipica che G. Moretti descrive come re dell’ambivalenza, oscillante fra i diversi aspetti della realtà e come rappresentante di tutti gli aspetti incomprensibili della nostra normalità: “Il clown…sa far accettare al normale esperienze che altrimenti risulterebbero inaccettabili…”14 Penso che ci sia dietro questa maschera il tentativo di comunicare qualcosa non altrimenti comunicabile, o qualcosa che deve essere nascosto dietro un travestimento, che si traduce in una difficoltà, per entrambe, soprattutto all’interno di questa seduta, a percepire quali siano i personaggi che stiamo rappresentando sulla scena. P: Sono stata triste in questi giorni, mi sono sentita molto sconfortata…ho avuto un problema con una mia amica sabato sera…era di cattivo umore e io pure. Avevo anche il mio ciclo, ha influito sicuramente, le ho detto che se dovevamo stare insieme per stare male era meglio che l'accompagnavo a casa. Non è che mi sono sentita in colpa…è come se sentissi che non mi fa stare bene stare con delle persone in questo momento…sento che potrei avere bisogno di stare con due mie amiche che, però, abitano lontano…Poi ho ripensato alla psicoterapia…pensavo come a uno strumento per capire…oggi venendo qua non pensavo ad una funzione consolatoria…Ho pensato anche alla seduta precedente, al perché...al 34 per sempre. Ho fatto un sogno: ero una figlia abusata dal padre e dovevo denunciare la cosa…non so se ero io che dovevo denunciare, ma ero chi aiutava a denunciare… La seduta continua con un susseguirsi di argomenti che non sembrano avere collegamento fra loro, è come se non riuscissi ad essere “dentro” la relazione, in questa circostanza, come se guardassi dal di fuori e mi sembrasse tutto inesorabilmente confuso e senza senso. P: Ripenso alle relazioni, è come se mi stufassi, quando passo due giorni con la stessa persona ho bisogno di andarmene a casa e stare per i fatti miei a disintossicarmi…poi penso a mia sorella, ha una storia “normale” ma io non la vorrei così, mi spaventa…poi ho ripensato a Giorgio, a quello che ho provato… Forse ho colluso con la paziente tirandomi fuori dalla relazione, rendendomi spettatore quasi passivo, forse al fine di non “abusare” di questa figlia che si sente minacciata dalle relazioni. Marina parla di un percorso altalenante di avvicinamento e allontanamento, ma il tutto sembra avvenire in modo brusco ed eccessivo, come se l’avvicinamento porti ad un rischio disperdersi nell’altro, e l’allontanamento non possa che avere lo stesso epilogo. Sembra che questa ragazza debba fare una fatica enorme per difendere i suoi confini, apparentemente così rigidi da tenere separati tutti i frammenti del suo mondo, ma anche così fragili da non poterle permettere di entrare in relazione senza sperimentare la paura di disperdersi. Sembra però che, intorno a lei, siano stati posti dei paletti in modo tale che ogni strada sembra portare ad un percorso obbligato di sofferenza, ancora una volta non c’è possibilità di scelta 6. Attentati terroristici e sconfinamenti La settimana successiva Marina mi comunica che comincerà il suo tirocinio in psichiatria e che dovrà svolgerlo nella medesima ASL in cui si svolge il nostro percorso. Questa rivelazione mi coglie impreparata, Marina dice di essere preoccupata e io mi sento molto in ansia. Il problema della paziente è che all’interno della scuola non vuole comunicare che è in psicoterapia e teme di rischiare che, se si dovesse scoprire la cosa, possano “etichettarla”. Anch’io ho dei motivi per sperimentare l’ansia di essere etichettata, non ricordo di aver esplicitato alla paziente la mia posizione all’interno del Centro e temo che possa scoprire da altri che sono una tirocinante. In ogni caso ciò che 14 Moretti, G., Un clown sul divano, Moretti & Vitali, Bergamo, 1998. 35 si presenta è una situazione in cui dei confini che dovevano separare delle aree incompatibili, o forse sarebbe meglio dire dei ruoli, si stanno assottigliando fino ad un inevitabile “sconfinamento”. P: Ho fatto un sogno: un pomeriggio dormivo da una mia amica, sul divano…era come se fossi vigile, sentivo le voci nell’altra stanza, ma non riuscivo ad aprire gli occhi e avevo la sensazione di gridare veramente ma nessuno mi sentiva. C’erano degli esseri, fantasmi, spiriti…, che mi giravano intorno, e io li scacciavo e gridavo aiuto…mi sentivo nel film di Casper…Mi sento infastidita…e che ci sono delle cose che, tipo parlare e pensare alla mia infanzia, che mi fanno male…è come se ci fossero delle porte chiuse…mi sento come la ragazzina che deve coprire una marachella, che ha paura di essere scoperta, ma non so cosa sto nascondendo, come se però non potessi riuscire a nascondere…mi sento sconfinata. T: Quello che ha detto, il suo tirocinio in psichiatria, il sogno…come se ci fosse in tutto questo il rischio di sconfinare: i fantasmi che ci invadono, ci infastidiscono, il rischio che la sua tutor possa sapere della psicoterapia, e forse anche il venire in contatto con i pazienti psichiatrici può spaventare… P: Sì, ho molta paura…da un lato mi interessa molto però dall’altro ho paura di essere travolta da queste persone...per me gli schizofrenici sono delle persone pure, come se avessero la possibilità di agire senza inibizioni, però questo fa paura è tutto sconfinato. Pensavo alla tesi: mi piacerebbe farla in psichiatria ma è più complicato, non ho materiale e non ci sono docenti che potrebbero darmi una mano, allora ho pensato di farla in cardiologia, sarebbe più facile…ma il fatto di farla in psichiatria…mi piace di più, sarebbe una sfida, però è difficile…anche il contatto con queste persone, forse per chi sta in repartino è peggio, io farò solo le domiciliari, anche se non mi piace fare le domiciliari…Penso che la linea di confine fra normalità e patologia sia molto debole…che io possa essere trascinata… In una seduta Marina dice di sentirsi come un calderone dove stanno bollendo tante cose, e la fiamma è così alta che c’è il rischio che possa fuoriuscire qualcosa senza poterlo controllare. Questa immagine mi torna in mente nella seduta che ho descritto e anche nelle sedute successive: è come se una serie di aspetti problematici stiano prendendo forma nelle relazione e la mia impressione e che ciò possa avvenire in modo imprevisto e incontrollato. Nelle ultime sedute ricorre questo tema del sentirsi sconfinati, Marina ha di nuovo l’impressione di non percepirsi e ritorna a parlare di Giorgio che diventa un pensiero ricorrente. Mi sembra un ritorno alle origini, per qualche tempo non riesco a comprendere ciò che si anima nella relazione, mi sento impotente e paralizzata. Mi trovo a riflettere spesso sulla famiglia di Marina della quale non so praticamente nulla. Da qualche cenno della paziente ho intuito che la madre deve aver avuto un infanzia difficile, ma perché non se ne può parlare: cosa si nasconde, cosa non può essere 36 detto? E’ come se mi mancasse il contorno, la cornice, dove poter collocare Marina e ciò che attraversa la relazione terapeutica, come se mancassero dei riferimenti. Il fatto di non sapere quasi nulla del versante transgenerazionale della famiglia mi creava un senso di disagio anche riguardo a questa tesi: come è possibile, in una psicoterapia gruppoanalitica, non riuscire ad entrare dentro la storia familiare della paziente? Forse era una mia incapacità, o dipendeva dalle difese di Marina? Non mi sono data una risposta, ma queste riflessioni mi hanno posto nella condizione mentale di poter collegare questa mia difficoltà con delle difficoltà al livello familiare che risuonavano come un tabù; cominciava a sorgere una forte curiosità nei confronti di questa nonna che non aveva cresciuto la figlia, non si sa perché, e di questa zia che aveva dovuto prendersi cura della mamma di Marina. Il giorno in cui Marina avrebbe dovuto cominciare il tirocinio in psichiatria ricevo una sua telefonata: il tono della voce è secco, quasi duro, mi dice che l’ha incontrata in ambulatorio un collega, con cui ha avuto due colloqui per una terapia farmacologica, il quale ha denunciato che lei fosse in carico presso il servizio alla caposala, che a sua volta ne ha parlato con la sua tutor, docente della scuola. Mi telefonava perché, a seguito di questo evento, era stata assegnata ad un altro ambulatorio con orari diversi, per cui avremmo dovuto spostare i nostri appuntamenti. Intuisco dal tono della sua voce che quest’episodio l’ha profondamente turbata, mi rendo conto che, nella seduta successiva, dovrò arginare, contenere questa rabbia dilagante che invade Marina. Ho l’impressione, in riferimento alla seduta precedente, che Marina mi stia comunicando che i suoi confini sono stati violati, come se qualcuno avesse violentemente sconfinato e ciò che tentava di tenere nascosto è venuto fuori in modo violento: come se un attentato dall’esterno (o dall’interno?) avesse spazzato via le sue “torri” e adesso si trova scoperta, con il rischio sempre maggiore che qualcuno possa “entrarle dentro”. Ho preferito non parlare, per il momento con il collega riguardo l’accaduto, ho pensato fosse più utile cogliere il vissuto della paziente e viverne l’autenticità nella relazione terapeutica; ho scorto il rischio, nell’approfondire l’accaduto al di fuori della relazione terapeutica, di riproporre un modello che si rifà a quello medico/paziente, una ricerca di dati oggettivi che mi avrebbero fatto perdere il contatto empatico con Marina, quando invece l’unica cosa che mi sembrava importante era “essere con” lei nella relazione, di cogliere il disagio da un punto di vista fenomenologico. 37 “I fenomeni che nel singolo incontro ci si mostrano non sono osservabili in maniera neutrale e astorica, non si possono ridurre a dati oggettivi, elencabili e, in un certo modo, ordinabili. Il loro pieno significato, più esattamente il loro senso, si dischiude soltanto di fronte a quell’investigatore che è toccato ad essi, a quello che è stato indicato come <osservatore partecipe>, in un difficile (ma necessario) equilibrio coesistenziale.”15 Al di là di ciò che può essere realmente accaduto, dell’eventuale acting out del collega, che potrebbe essere anche una fantasia della paziente, mi sono soffermata sulla sensazione che stessi assistendo ad un già visto, come se queste catastrofi appartenessero alla modalità relazionale di Marina che, in quel momento, si stava riproponendo nel contesto della relazione di cura. Ho associato l’episodio alla scoperta degli opuscoli della meditazione da parte della madre: già allora avevo avuto l’impressione che Marina fosse sia la vittima sia l’artefice, così come in quest’ultima situazione. Nei tre colloqui successivi Marina porta in seduta la catastrofe, che travolge violentemente anche la relazione terapeutica, per poi operare un riavvicinamento, una ricerca di una nuova complicità. Seduta I: P: Mi sento molto delusa, il dott. yyy poteva parlarne con me, sono stata scavalcata. Capisco che era giusto per la mia tutela, ma prima poteva parlarne con me…Ora anche nei confronti dell’istituzione mi sento delusa, quindi anche la psicoterapia…sento come un rifiuto…Quello che provo adesso è come se fossi difesa…ritirata, come se dovessi piano piano riavvicinarmi, con la paura che riavvicinarmi mi faccia soffrire. Come se dovessi andare cauta… T: Sta dicendo che devo andare cauta? P: (sorride) Sì, probabilmente è così. Seduta II: P: Mi sento molto confusa… T: Come si sente nei confronti della psicoterapia, adesso? P: …Mi sento come nei confronti delle mie amiche quando sento il bisogno di allontanarle…come se sentissi il bisogno di allontanarmi…c’è una forte delusione, la paura di poter essere delusa che mi fa allontanare…come se mi sentissi tradita. T: Forse tutto ciò ci mette di fronte al problema del segreto professionale, come se ci fosse il rischio che possa essere infranto… 15 Ballerini, A., Callieri, B., Breviario di psicopatologia. La dimensione umana nella sofferenza mentale, Feltrinelli, 38 P: Forse la paura di una perdita di interesse… T: Le ricorda qualcosa… P: Mi vengono in mente quelle situazione in cui ho allontanato delle amiche…quando mi sono riavvicinata ho notato distacco, una certa diffidenza…Per il resto al tirocinio sto bene, nelle riunioni d’équipe sento discutere di casi e in un certo senso mi sento rassicurata, come se pensassi che io non sto così male. Certo la paura rimane, ancora non ho visto pazienti… Seduta III: P: Mi sento confusa…Non è più come prima quando perdevo tutto l’interesse, adesso riesco a fare quello che devo fare e se mi impongo di uscire poi mi diverto…è che sento come il bisogno di starmene a casa da sola…però anche il bisogno di socializzare…poi in questo periodo pensavo alla perdita dei punti di riferimento…per esempio mia sorella, ha questa storia, non che non sia più un punto di riferimento, ma lo è meno. Ho pensato anche alla psicoterapia…è un periodo che sento un cambiamento, un’evoluzione, ma non riesco a delineare, a capire cosa…Sento questo bisogno di autonomizzarmi, di una vita mia…ho pensato anche alla psicoterapia, ma nello stesso tempo ho paura se penso di smettere…non riesco a capire quali sono i miei bisogni…mi sento senza una collocazione, mi sento incatenata. Da quando sono tornata dal viaggio è come se non stessi più bene a Torino, non mi piace il clima, non mi sembrano più così importanti le amicizie che avevo…sicuramente dipende da me ma una giornata di sole è un’altra cosa rispetto al grigio… T: Ho fatto delle fantasie…Mi viene da chiedere se sta cercando complicità…Come se mi stesse dicendo “lei che è siciliana si che mi può capire!” Anche la scelta del viaggio…Forse un po’ in opposizione alla diffidenza e alla paura della volta scorsa. P: Si ci ho pensato anch’io al fatto che lei è siciliana…Forse un tentativo di riavvicinamento…Mi viene in mente che tutte le volte che ho allontanato qualcuno e poi ho tentato di riavvicinarmi ho sentito molta diffidenza, per cui ho rinunciato…qua è diverso, è come se fosse possibile allontanarsi e avvicinarsi senza diffidenza…è la prima volta. Rileggendo in chiave clinica l’accaduto è come se Marina tendesse a collocarsi in un clima di conflitti, di crolli e di caos. Questo apparente crollo dei confini, che sembra sempre determinato dall’esterno, fino a che punto non è dipendente dal tipo di campo relazionale che la paziente tende a determinare? Il fatto che il tirocinio le sia imposto è un dato oggettivo, è verosimile, ma fino a che punto Marina non poteva inventare una scusa per cambiare ASL? “L’attacco terroristico” è piombato dall’esterno distruggendo ciò che era stato faticosamente costruito, ma forse si può ipotizzare una partecipazione dall’interno che ha favorito la catastrofe. Sembra essere presente un atteggiamento ambivalente nei confronti della psicoterapia, da un lato si rischia di far crollare tutto, Milano, 1996. 39 dall’altro si cerca una nuova alleanza con il rischio di “crollare insieme sotto le bombe”: una nuova alleanza in attesa di una nuova guerra. Ripenso alla figura del clown. “Il clown è, al tempo stesso, artefice e vittima del caos; così come egli è, anche, minaccia e vittima dell’ordine. Nella continua lotta fra folle e caos nessuno riesce mai a prevalere sull’altro; nessuno vince né soccombe, in un perenne stabile equilibrio. Tutto ciò nasce da un’insufficiente autoidentificazione e differenziazione tra Sé e il mondo…manca un rapporto oggettuale in cui l’Io sia l’autore, il punto di partenza che va da Sé all’oggetto.”16 Marina mi dice di sentirsi rassicurata nelle riunioni di équipe, non si sente così malata, poi ritorna a parlare di Giorgio, che l’aveva fatta sentire deviata: per questo Marina aveva deciso di rivolgersi ad uno psicoterapeuta. Forse quella sensazione di non riuscire a collocare, a delineare che attraversa sia me sia la paziente, sta cominciando a prendere forma, e intravedo sullo sfondo la minaccia della malattia. Marina vuole essere rassicurata, ma cosa la minaccia? Cerca la mia complicità, dopo aver cercato di “allontanarmi”: cosa vuol dire per lei essere troppo vicini o troppo lontani? Cosa si sta drammatizzando sulla scena terapeutica? Sento un campanello d’allarme, come se quanto è successo, e gli sviluppi successivi possano trascinarmi all’interno di un vortice di collusioni dal quale sarebbe difficile poter venire fuori. 7. Un pezzo mancante del puzzle: nuove ipotesi di lavoro Ho cercato di condurre la seduta successiva in base a queste riflessioni sull’accaduto, tenendo conto del pericolo che stavamo correndo ma anche avendo la sensazione che tutto ciò potesse essere utile per nuovi sviluppi nella relazione: poteva permetterci di guardare più da vicino alcuni fenomeni, senza il pericolo di star male. P: Ho ripensato alla difficoltà di mettere insieme dei pezzi…Forse ha a che fare col fatto che da piccola dovevo tenere le cose nascoste a mia madre per fare quello che io ritenevo giusto…anche la meditazione, io la ritenevo utile per me in quel momento, non facevo niente di male… T: Anche in quell’occasione c’è stata un’esplosione, è scoppiata una bomba…Fino a che punto Marina è vittima? In fondo aveva lasciato gli opuscoli in evidenza…Anche qui fino a che punto Marina non ha nessuna voce in capitolo sulla scelta del tirocinio? E’ scoppiata la bomba con il rischio di far “crollare” anche la relazione terapeutica, e poi un riavvicinamento...una ricostruzione… 40 Silenzio molto prolungato. P: E’ come se io mi buttassi completamente nelle cose. Se manca un mattone alla base è meglio distruggere per ricostruire…anche con le mie amiche, quando le allontano, è come se volessi buttare giù… Marina continua a dire delle frasi che sembrano vuote di significato, come se riempisse il tempo. T: …è come se si percorresse una strada obbligata, che porta alla sofferenza. Silenzio P: E’ un modo per attirare l’attenzione, come quando ero piccola o adolescente e stavo male per non affrontare certe situazioni, perché non mi sentivo adeguata… T: Malessere per non affrontare l’inadeguatezza. Allora si può dire che da piccola stava male perché non sarebbe stata “adeguata” per avere attenzioni, non le meritava…? P: Penso che sia proprio lì il problema. Silenzio T: Mi viene in mente il modo in cui è cresciuta sua madre. Non abbiamo mai avuto modo di parlarne, però si può provare a d’immaginare come si sente una bambina cresciuta da una zia…può sentire di non meritare le attenzioni della madre…Ha voglia di parlarne? P: Sì ci ho pensato, ma non si parla mai dell’argomento, anche se io tento di farla parlare lei non dice nulla…Io penso che lei e le mie zie debbano essere arrabbiate, loro lo dicono, lei no…Mia nonna è psichiatrica…e non è un punto di riferimento…tiene la casa in condizioni disastrose…non le si può parlare perché parla sempre lei e non fa discorsi che hanno molto senso. Andava a lavorare nei campi e mia madre fino all’età di cinque anni ha vissuto con la zia…Si è sempre disinteressata dei figli, anzi mia madre ha avuto la zia, ma le sue sorelle no, lei era piccola quando si doveva occupare di loro… Ci sono molti silenzi nel corso della seduta, e quasi tutto lo spazio, anche nelle successive sedute, è occupato dalla figura di questa nonna che, per la prima volta, abbiamo la possibilità di fare entrare nella situazione terapeutica . Marina è visibilmente agitata e non riesco a farmi una chiara immagine di questa nonna “psichiatrica”, ma ne percepisco l’intrusività perché è così che si presenta nel campo relazionale. T: Cosa intende quando dice che sua nonna è psichiatrica? P: Non si può stare accanto a lei, non riesce a fare un discorso…parla sempre lei, dice tante cose senza senso, fa saltare i nervi… (Dopo un lungo silenzio) Un ultima cosa, io provo un po’ di vergogna per questa nonna, non ho mai fatto venire delle amiche in casa sua, e anche quando veniva in ospedale a trovare mio cugino, io mi vergognavo, anche tutti gli altri… Viene fuori così questo personaggio scomodo, che mi permette forse di superare, almeno per il momento, quei vissuti di confusione che attraversavano la relazione terapeutica. E’ come se fosse stato gettato un ponte che permette di collegare alcuni di 16 Moretti, G., op. cit. 41 quei vissuti di frammentazione che mi sembrava accomunassero me e Marina. Un nodo cruciale che, forse può consentire di formulare nuove ipotesi di lavoro, più specifiche che consentirebbero di superare quella sensazione di trovarsi all’interno di una stanza buia che non si conosce; come il pezzo mancante di un puzzle che ci permette di andare ancora un po’ oltre nel nostro lavoro. La nonna “psichiatrica” rappresenta la risposta ad alcune domande che avevo lasciate in sospeso, rappresenta la minaccia, la paura della malattia, del contagio, la paura di sentirsi deviata e di non percepirsi. Questa nonna è tenuta lontana, è rifiutata, ma invade tutto lo spazio e non si può fare a meno di parlare di lei; come se fosse paragonabile ad un fiume in piena che invade tutti gli spazi. Si può ipotizzare che ci sia un collegamento tra quanto sta emergendo e la paura di Marina che gli altri possano entrare dentro, forse il collegamento è la malattia mentale: la domanda iniziale non era, in fondo, una richiesta di rassicurazione sul fatto che lei non fosse deviata come Giorgio? Anche il problema relativo al tirocinio assume degli aspetti nuovi: “non posso fare il tirocinio se non vicino alla mia terapeuta che mi protegge dalla malattia mentale.” Marina sembra portatrice di un pensiero familiare che non può essere condiviso apertamente: la madre non parla, non può neanche dietro un invito esplicito della figlia, per cui quest’ultima diventa portatrice di un disagio transgenerazionale, che rischia di travolgerla nel vortice dell’etichettamento della malattia mentale. Un gruppo tutto al femminile che irrompe nel campo terapeutico con tutta la sua intrusività. Mi sembra una sorta di eredità che Marina ha ricevuto e dalla quale non riesce a liberarsi, sentendosi incastrata, senza una collocazione, senza autonomia, e minacciata dal fantasma della malattia. Per altri versi sembra proprio che Marina cerchi di essere malata, come se l’unica strada possibile per entrare in relazione fosse quella della sofferenza, dell’essere curati e del curare. Penso che sia un piccolo passo in avanti per la co-costruzione di una storia, la storia di una relazione dove interagiscono le gruppalità interne del paziente e del terapeuta, una dimensione dinamica, in evoluzione dove è impossibile pensare di fermare un’immagine per poterla osservare, perché nel momento in cui lo facciamo è già svanita. “Mettendo fra parentesi ogni impostazione ideologica, ogni teoria che si sovrapponga alle realtà umane (normali o patologiche), non si può non essere colpiti, se si ascoltano i pazienti fino in fondo, dal fatto che i sintomi (i segni portatori di significato) 42 costituiscano qualcosa di camaleontico che cambia, e si trasforma, in relazione ai modi con cui ci confrontiamo con i pazienti, e in relazione alla radicalità con cui riusciamo a fondare un discorso, un incontro, un dialogo autentico.”17 La necessità è quella di formulare, o riformulare, sempre delle nuove ipotesi che ci permettano di essere insieme al paziente, di non allontanarci inseguendo un miraggio, attraverso la possibilità di esserci nella relazione. 17 Ballerini, A., Callieri, B., op. cit. 43 Conclusioni Il lavoro con Marina continua, e penso che stia attraversando un periodo molto fertile in cui è possibile avvicinarsi a quei temi che in altri momenti avrebbero determinato una fuga. Questa ragazza arriva dopo una relazione fallimentare con un ragazzo che lei stessa definisce schizofrenico, anche se questo elemento è rimasto per un po’ un non senso piano piano acquisisce un significato in relazione ad un tirocinio in ambito psichiatrico e alla comparsa sulla scena di una nonna, anche questa definita psichiatrica e che irrompe con violenta intrusività. Tutto questa mi sembra che vada a comporre un quadro in cui l’immagine che sembra prevalere sia quella della paura della follia, come se Marina ne fosse in qualche modo l’erede, e che abbiamo trovato all’interno di una storia transgenerazionale. Lei riempie il silenzio rimbombante di sua madre che è come paralizzata, incapace di avvicinarsi a questo personaggio e che forse evita, ed è come se Marina fosse colei che deve dar voce a qualcosa che circola a livello familiare: stanno emergendo, infatti, altre figure, che cominciano a dare forma a questo romanzo, a questo dramma o a questa novella familiare di cui Marina è portatrice. Il tema della follia è come un ombra che la segue inesorabilmente, e che , come l’ombra di Peter Pan, le è stata cucita addosso sin dalla nascita. Lei ha il terrore di essere malata e si sente rassicurata dalle riunioni di équipe perché può prendere le distanze dai pazienti psichiatrici, non sentirsi come loro, curarli. La scelta di fare l’infermiera, porsi quindi nella posizione di chi cura, piuttosto che di chi deve essere curato è un modo che ha trovato Marina per stigmatizzare la paura, per scampare il pericolo. Queste riflessioni mi fanno da guida, in questo momento, nella relazione con la paziente, sono le ipotesi sulle quali sto basando il nostro lavoro affinché si possa raggiungere una consapevolezza che in questo momento non c’è. La consapevolezza di quest’ombra che ci segue come un fardello che per il momento è troppo dolorosa da riconoscere e che resta sullo sfondo, nella mente del terapeuta aspettando il momento in cui la paziente sarà in grado di voltarsi per guardarsi dietro. 44 Bibliografia Ballerini, A., Callieri, B., Breviario di psicopatologia. La dimensione umana della sofferenza mentale, Feltrinelli, Milano, 1996. Burlini, A. M., Galletti, A., Psicoterapia attuale, Franco Angeli, Milano, 2000. Di Maria, F., Lavanco, G. (a cura di), Al di là dell’individuo, Ila Palma, Palermo, 1993. Di Maria, F., Lo Verso, G., Lavanco, G., Il visibile e l’invisibile. Conversazione sulla gruppoanalisi, Edizioni Angelo Guerini, Milano, 1993. Di Maria, F., Lo Verso, G., (a cura di) La psicodinamica dei gruppi ,Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995. Etchegoyen, R., H. (1986),I fondamenti della tecnica psicoanalitica, Astrolabio, Roma, 1990. Gabbard, G., O. (1994), Psichiatria psicodinamica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995. Lo Verso, G., Le relazioni soggettuali, Bollati Boringhieri, Torino, 1994. Moretti, G., Un clown sul divano, Moretti & Vitali, Bergamo, 1998. Pirandello, L. (1921), Sei personaggi in cerca d’autore, Orsa Maggiore Editrice, Torriana (FO), 1993. Profita, G., Ruvolo, G., (a cura di) Variazioni sul setting, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1997. Winnicott, D. W. (1971), Gioco e realtà, Armando, Roma, 1993. 45 Indice Introduzione p.2 1. Il setting p.3 1.1 L’organizzazione del centro di psicoterapia analitica p.3 1.2 Il luogo dell’incontro: una nicchia terapeutica p.4 1.3 Il modello di riferimento p.5 1.4 Il passaggio del caso p.7 2. Una nuova relazione p.9 2.1 L’incontro p.9 2.2 Andar per terapeuti p.10 3. La storia familiare: un’assenza o un’eccessiva presenza? p.12 3.1 La mamma: vittima o carnefice? p.12 3.2 Il cambiamento di corso di studi: curare ed essere curati p.15 3.3 Tra le figure paterne p.17 3.4 La relazione con il partner: le richieste impossibili p.18 3.5 La meditazione e le regole p.20 4. La relazione terapeutica e le prime ipotesi di lavoro p.23 5. Tornando dalle vacanze… p.28 5.1 La Sicilia come “spazio transizionale” p.29 5.2 La seduta in maschera p.32 6. Attentati terroristici e sconfinamenti p.33 46 7. Un pezzo mancante del puzzle: nuove ipotesi di lavoro p.38 Conclusioni p.42 Bibliografia p.43 Indice p.44
Scarica