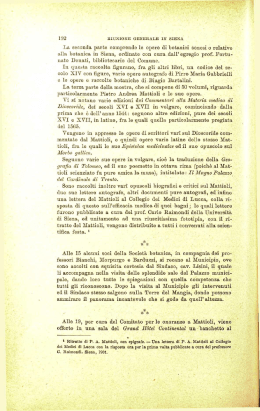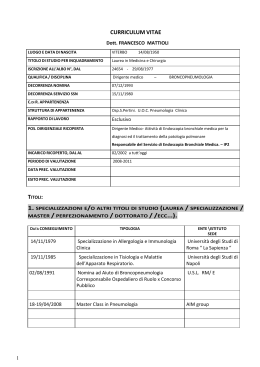GIANFRANCO CONTINI ULTIMI ESERCIZÎ ED ELZEVIRI (1968-1987) 1988 I 988 GIULIO FINAUDI EDITORE S. P. A., TORINO ISBN 88.06-59911-9 GIULIO EINAUDI EDITORE RICORDO DI RAFFAELE MATTIOLI «Io sono un terrone», disse tra il vanto e l'ironia Raffaele Mattioli, ergendosi, come soleva, in tutta la sua statura: gesto sottolineato dal piccolo bavero del soprabito, striscia di velluto bruno. Allora la grande alluvione demografica, conseguente al tratto di penna con cui Luigi Einaudi aveva biffato le prescrizioni limitative della migrazione interna, da anni aveva innovato il panorama dell'Italia d'oggi. Ma Mattioli intendeva soprattutto rifarsi ai Potenti della cultura venuti dal Sud. Abruzzese per cui la prima metropoli è la capitale del Reame, si era fatto braccio secolare di Croce non solo per la grandezza dell'uomo e l'uguale amore fisico del libro, ma perché egli aveva seguito lo schema corografico tradizionale nella sua regione. Si sa un po' meno del suo rapporto con un altro Dominatore suo vicino, D'Annunzio. Già volontario di guerra, Mattioli era stato volontario fiumano. Ricordo una notte quasi intera passata nei suoi quartieri romani a illustrare a una sua congiunta e a me (si era accercinato in capo una sciarpa della signora, così da simulare un gentiluomo del Settecento) la sua avventura col Comandante: era un'avventura svolta tutta in dialetto aprutino, nell'uso del vernacolo D'Annunzio dimetteva la fatica della maschera quotidiana e ritrovava nostalgicamente la semplicità dell'infanzia. Il termine gergale, in sua bocca affettuoso, indicava che aveva adottato una sede diversa dai grandi suoi amici, l'unica cogente della sua professione. E in sostanza si sentiva anche milanese, anzi di quel «midollo e tuorlo» della città, se posso usare le meravigliose catacresi di Giovanni Villani, che si ritaglia fra piazza della Scala, via Bigli e San Fedele; dove del resto Milano ricorda nobilmente il suo nome. Un implicito «Raffaele Mattioli Milanese» reggeva il sontuoso dono, procurato alla comune città adottiva, dei 384 Epicedi libri di «Arrigo Beyle / Milanese» procedenti via Firenze da Civitavecchia. Ma per il «midollo e tuorlo» Mattioli si trovava in contubernio col maggiore dei milanesi, a cui non è necessario essere ideologicamente conniventi per iscriversi alla sua dilezione: una delle ultime ricerche promosse, non saprei dire se ultimate, da Mattioli spettava all'identificazione della casa di don Ferrante, sulla quale aveva un'ipotesi di lavoro che intendeva far verificare negli archivi. Di don Alessandro egli è riuscito a evitare il famedio. Laico di buona civiltà (una volta che l'arcivescovo Montini venne a impartire la benedizione pasquale agli edifici della Commerciale, Mattioli come padrone di casa assistette e al congedo ringraziò; ma il futuro Paolo VI: «No, — rispose, — tocca a me ringraziare perché so il sacrificio che Le è costato», parole da cui Mattioli ricavò grande stima «politica» per il prelato) — laico dunque di buona civiltà, Mattioli ottenne di poter riposare in un sepolcro terragno innanzi a un'arca del chiostro che avvolge l'abbazia di Chiaravalle. Il punto quasi si perde nel groviglio delle strade industriali, ma il rosso del mattone secolare tocca il cuore dell'appassionato di storia, qual era l'ospite accolto; e tutt'attorno si spiega il gran fascio dei binari in curva lungo il quale pendolava ebdomadariamente il treno dell'infaticabile tessitore tra Milano e il Sud. E il nostro sguardo di passeggeri ruota a cercare la sua impronta e ne ricava non so quale consolante proseguimento di presenza. Per quanto ciò possa sembrare scandaloso, confesso di aver perduto il ricordo del nostro primo incontro, che congetturo propiziato dall'amico Schiaffini. Tenderei tuttavia a non ricavarne un'interpretazione interamente disonorevole per la mia memoria: la cancellazione significa la immediata trasformazione in (felice) abitudine, quale con le persone familiari. Per anni ho spiato il suo passaggio settimanale da Firenze, spesso seguito da un incontro bdtons rompus nella villa di Nozzole, che dava su una campagna arsa e solitaria come in una predella del Quattrocento: questa sua scelta di umanista in Toscana aveva il colore del tempo — legato all'ultimo fiore di Firenze nella cultura italiana —, e dovette o seppe, pur con lacerazioni, liberarsene. Fosse tra i cuscini polverosi di via de' Pescioni o nella luce solatia di piazza della Scala (dove per un pezzo ammirai una Milano giovanile di Boccioni, che poi ritrovai spaesata a Roma) o l'aria larga e pontificia di Santi Apostoli, lui appariva più che mai alius et idem, investigatore senza parerlo troppo e scintillante delle curiosità della giornata. Ricordo di Raffaele Mattioli 385 Una sola volta mi accadde di perder la calma, e posso anche dirne l'occasione, la guerra di Suez nel '56; Mattioli, seguace della Storia, ne aderiva ai dettami; segnalo l'aneddoto perché terminò da parte sua su un «L'avrei abbracciato». Se merito l'onore di essere chiamato suo amico, dirò che l'amicizia è più vasta del comportamento. I miei migliori amici, il socialista Ettore Tibaldi come il nazionalista Carlo Emilio Gadda, assunsero una parte che, nella storia fatta coi se, avrei profondamente avversata, quella dell'interventista. Quanto a Mattioli, ricordava di essersi lanciato in guerra «sportivamente, io che non so neanche andare in bicicletta». Passava per eccentrico, in realtà usava di tutta (ma sola) la libertà che gli era concessa, di parola e di fatto. Ricordo, nei primi tempi della conoscenza, di essere andato con lui a Verona in un'estate torrida: la macchina doveva restare ermeticamente chiusa, per evitare la piccola malattia che aborriva; a stornare la quale adibiva magicamente un medicamento fino a inverosimili multipli dei massimi concessi. Era notorio che questo mercante di danaro non portava danaro addosso; e, realizzato uno dei suoi infiniti libri, magari una gioia non brochée odorosa della miglior carta, poco si curava di farlo diffondere, pago che esistesse. Pure, la più solenne prova della saggezza di questo grande lavoratore era quella di non prender vacanze, ma di distribuire quotidianamente la sua vacanza entro la giornata, cominciandola con gesti di otium. La sua temerità, anche ostentata, conosceva sottilmente il limite: m'incaricò una volta nel '68 di studiare un piano per un'università privata ideata da non ricordo che azienda, e non riprese il discorso, con quei modi negativi che aveva per farsi capire a volo. Non saprei dire se l'esser stato assistente di Luigi Einaudi, cioè proprio di uno fra i più raffinati scrittori fuori della letteratura (non per niente Roberto Longhi ne raccolse, come raccontava volentieri, le dispense),. abbia avuto un significato per la sua vita di imprenditore culturale (anomalo). Certo c'era forte disparità fra il liberista e il keynesiano «bordeggiante a sinistra» (per applicargli un'invenzione di Montale), e li univa la passione di cercatori per il libro di economia (li univa o li metteva in concorrenza per strappare al mercato una rarissima editio princeps di Ricardo o di Adam Smith). Né l'uno né l'altro furono dei decadenti. Nulla potrebbe dirsi più antitetico a Mattioli dello scritto Per un catalogo di Renato Serra. Lettore, e forse non solo lettore, di poesia (a me è capitato di leggere un suo degno sonetto da Shake- 386 Epicedi speare), Mattioli favorisce però, ad esempio nella collezione Ricciardi, la storia, l'economia, perfino la filologia, con moderno squilibrio; dello stesso ordine le sue frequentazioni letterarie, che non furono, fuori dei confratelli della sua professione, di letterati militanti «puri» quanto di uomini di cultura, dai circoli di De Lollis e di Croce a Bacchelli e a Solmi. Con debita lentezza si forma lo scrittore Mattioli. Se fossimo più giovani, diremmo che ricorderemo per un pezzo l'attesa della sua relazione annua sull'attività della sua Banca. Un Galiani aggiornato pareva reggere la penna che vergava quei capolavori di spirito, dove perfino il non tecnico stava, o s'illudeva, a suo agio. Ma una pagina si voltava nella storia. Uomini piccoli, di cui è già caduto il nome, affrettarono la sua uscita dai ruoli. (Perfino a un ignaro come me gli accadde di dire infuriato: «Hanno toccato anche il reddito fisso! »). Egli ebbe la ventura di non durare nella quiescenza. Progettava di riempirla con uno scritto denso, di poche pagine (ne aveva parlato con l'amico Piero Sraffa, il teoreta a lui più vicino), in cui condensare il succo speculativo della sua lunga esperienza. Non fece a tempo. Assistemmo, proprio qui a Firenze, al primo assalto, che sembrò futile, portato alla sua salute. Fu come il primo ridicolo accidente toccato a Ivan IljFé. La sua fine parve storicamente tempestiva, sentimentalmente precoce. [Parole lette a Firenze il 24 novembre 1986 e stampate in un opuscolo collettivo dello stesso titolo generale (Firenze 2957, pp. 19-23); anticipate su «Ragioni Critiche» di Bellinzona, gennaio-febbraio 19871.
Scaricare