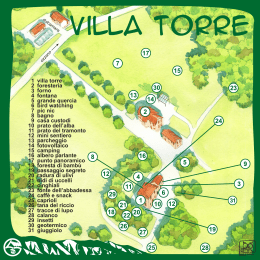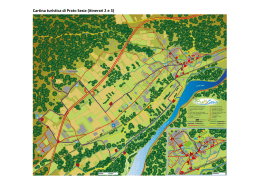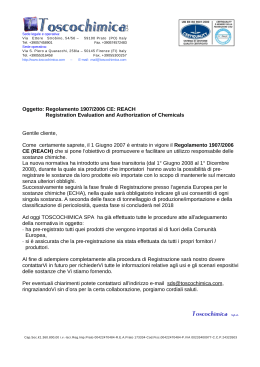UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA Dipartimento di studi su mutamento sociale, istituzioni giuridiche e comunicazione CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN Teoria dell’informazione e della comunicazione CICLO XXIV La voce limpida di Dolores Prato. Mito e antimito di Roma capitale TUTOR Chiar.mo Prof. Paola Magnarelli DOTTORANDO Dott. Valentina Polci COORDINATORE Chiar.mo Prof. Hans-Georg Grüning ANNO 2011 1 INDICE Capitolo uno Dolores Prato, donna e intellettuale tra Otto e Novecento I. II. III. IV. Una donna del secolo scorso……………………………………………………………p. 1 La ricerca di un credo tra cattolicesimo e comunismo………………………………….p. 10 Dolores: “piccola e coraggiosa donna degli anni Trenta” in lotta con il Fascismo……..p. 20 Dolores Prato e Rina Faccio/Sibilla Aleramo: un confronto……………………………p. 31 Capitolo due Giornalista a Roma I. II. III. IV. L’innamorata dei luoghi e delle parole………………………………………………….p. 47 Storia di una pubblicista: la collaborazione a “Paese Sera”…………………………….p. 56 Gli articoli, “il ventre di Roma”: Dolores Prato e Matilde Serao……………………….p. 64 Articoli editi, inediti e rari: una bibliografia…………………………………………….p. 78 Capitolo tre Voce fuori coro: il libro su Roma mai pubblicato I. II. III. IV. Il progetto iniziale e la vicenda editoriale…………………………………………….p. 100 Un testo in costruzione: la struttura e il pensiero……………………………………..p. 105 Una scrittura del frammento: il materiale del Gabinetto Vieusseux………………….p. 113 Voce fuori coro: per un inizio di lettura………………………………………………p. 117 Capitolo quattro Mito e antimito di una capitale I. II. III. IV. V. Roma capitale: una cruciale storia risorgimentale……………………………………p. 148 “L’Unità d’Italia: un assassinio per Roma”. Sul filo di Voce fuori coro………….....p. 161 “Quando gli italiani entrorno a Roma…”. Dagli articoli la voce limpida di Dolores..p. 170 Il Fascismo, il mito di Roma e l’implacabile piccone risanatore……………………..p. 182 Anniversari, centenari e altre storie di un antimito…………………………………...p. 194 Appendice Raccolta degli articoli di Dolores Prato: editi, inediti e rari…………………………………p. 203 Bibliografia…………………………………………………………………………………….p. 373 2 Capitolo uno Dolores Prato, donna e intellettuale tra Otto e Novecento I - Una donna del secolo scorso Non è facile associare Dolores Prato a una certa idea di Novecento, forse perché non è possibile collocare questa donna, scrittrice, giornalista, in una qualunque casella preconfezionata. Non è stata fra le protagoniste della rivoluzione femminile, ma ne è stata un esempio; ha trasgredito al suo destino, ma con un atto inconsapevole; non ha vissuto in maniera estrema la sua vita privata e sessuale, ma lo strappo con il modello donna-moglie-madre, tipico dei questo passaggio fra diciannovesimo e ventesimo secolo, è indiscutibile. Nessuna figura culturale, più o meno nota, o studiata, del secolo scorso, è assimilabile a Prato. Non lo sono Maria Montessori, Sibilla Aleramo, Matilde Serao e neanche Armida Barelli o Lina Merlin, pur avendo tutte queste “ribelli” del Novecento uno o più tratti importanti in comune con Dolores Prato. La parabola esistenziale di quest’ultima ha avuto un andamento che potrebbe sembrare tipico di chi ha vissuto gli anni dell’emancipazione femminile, ma ha delle caratteristiche che la rendono inusuale: è cominciata con un abbandono duro, come può esserlo quello di una madre che all’inizio non vuole riconoscere una figlia e poi l’affida alle cure di due cugini; ha attraversato una fase di profonda vicinanza con la fede, tra un convento-collegio e una frequentazione assidua con l’ambiente cattolico dei gesuiti; ha raggiunto il suo culmine, cambiando direzione, quando Dolores ha preso a vivere tra cultura e salotti intellettuali romani, con un’anima sempre in bilico tra cattolicesimo e comunismo. Ma la cattolicità, spesso intransigente e radicale, è la chiave nascosta 3 che forse permette di leggere e interpretare nella giusta prospettiva tutte le prese di posizione di Dolores di fronte agli eventi e ai momenti storici: il suo essere antifascista, più che una derivazione della vicinanza al comunismo, probabilmente è da intendersi come rifiuto di un culto e di un credo diversi da quello cristiano cattolico; il piccone mussoliniano, che si abbatté su Roma distruggendone alcuni tratti, alcuni monumenti, alcuni scorci, intaccandone l’integrità, era deplorevole in quanto corruttore di un universalismo religioso sancito dalla Storia. Così come, ad esempio, l’odio vero di Prato nei confronti dei “Piemontesi” e dei Savoia era sì frutto del suo essere antimonarchica, ma soprattutto era il sentimento di rifiuto e opposizione di chi vedeva nell’annessione di Roma e delle Marche al Regno d’Italia la causa della devastazione di un mondo, fisico e valoriale, puro, “popolare”, universale. Anche la sua scrittura, sempre in evoluzione e alla ricerca di una forma definita, poi seguì una direzione contraria rispetto a quella canonica, conquistando una propria identità forte solo nel momento in cui tornò all’immediatezza e alla verità, quasi alla purezza, del mondo infantile. Affrontare Dolores Prato è una questione complessa, che richiede digressioni nella storia di Otto e Novecento, dall’Unità d’Italia all’erezione di Roma a capitale; dal Fascismo, con le sue numerose implicazioni sociali, all’antifascismo, fino al referendum tra monarchia e repubblica e oltre, e che implica anche uno sguardo critico e d’insieme sulle trasformazioni della società italiana lungo tutto un secolo, con i suoi protagonisti, le sue rivoluzioni, le sue contraddizioni. Non ultimo, come si accennava, quella di Dolores Prato è una storia connotata dal genere, di una donna che, partita da una condizione sociale di costrizione (a otto anni era entrata in un Educandato salesiano per giovani fanciulle di famiglie nobili, in una piccola cittadina dell’entroterra maceratese, e lì era rimasta fino ai 18 anni), ha poi proseguito su una delle strade femminili “secondo natura” in quella parte di secolo, quella cioè della formazione all’insegnamento, con l’iscrizione al Magistero di Roma, e poi, all’improvviso, con un moto dell’anima forse inconsapevole, rientrando in possesso di una propria libertà, peraltro mai vissuta prima, anche sentimentale, fino a conquistare un ruolo da protagonista, in qualche modo, della Roma della seconda metà del Novecento. E questa emancipazione è stata anche il fil rouge della sua storia di scrittrice: liberata dalle briglie linguistiche di un’adolescenza vissuta fra le mura di un convento in cui le parole erano “disinfettate”, in balia di un italiano aulico e toscaneggiante, passato da filtri clericali, è approdata al successo quando è tornata alla sua natura primordiale, peraltro in totale autonomia rispetto alla categoria, molto diffusa in quegli anni, di scrittura “femminile” o rivoluzionaria. Intellettuale dal carattere particolarissimo, vivace e sagace osservatrice del mondo, esasperata negli anni dal groviglio di solitudine, egocentrismo, ristrettezze economiche e sensibilità che era la sua vita, rispondendo a un questionario propostole da un gruppo di Sarzana (Liguria) che stava 4 preparando una pubblicazione, Dolores Prato si presentava così: Dunque io sono Dolores Prato (per la gente del mio mondo sono più semplicemente Dolores), nata nella romanissima via di Parione e passata a balia nell’agro romano, in una famiglia di butteri dove parve che dovessi anche restare; ma poi fui trapiantata nelle Marche, in una zona delle più nascoste e più genuine. Sono insegnante di lettere e pubblicista […] “Esperienze che condussero all’esordio della carriera”. Debbo capovolgere il vostro quesito. Esperienze che mi condussero al blocco della carriera…La principale il Fascismo sotto il quale non potei né insegnare, né scrivere…tanto meno far di conto! Chiedete anche le circostanze in cui si svolse la mia carriera…la mia non è stata una “carriera” ma una lotta per sopravvivere […] Le mie collaborazioni sono giornalistiche varie. “Opere in corso”…Tante!!! Se trovassi un editore ne potrei sfornare anche tre all’anno e tutte caratterizzate da una personalissima originalità; nessuna improvvisata, giacché esse sono state pensate e ripensate nei lunghi anni di una difficilissima attesa il cui compimento non fu che il principio di altre difficoltà1. Leggere Dolores, di qualunque scritto si tratti, dai romanzi agli articoli di giornale, dai sogni agli infiniti appunti e frammenti, dà subito il senso di una donna dalla doppia anima: autoironica e depressa, forte e divorata dalla solitudine, combattiva e sconfitta. Le riflessioni estemporanee, così come le pagine rielaborate e corrette in modo quasi maniacale, restituiscono una brillantezza, una puntualità e un acume fuori dal comune. Come in questa lettera a Luciano Moretti2: La depressione è stato sempre il mio stato normale (nonostante che sia sempre apparsae appaia tuttora come una specie di energia atomica) […] Il giorno è un’agonia solitaria, la notte una morte paurosa. Tu che conosci i telai delle donne marchigiane puoi capire questa mia immagine che semplifica l’idea. La mia vita è stata intessuta su un ordito di dolore. A forza di sogni, di buona volontà, ho intessuto su quell’ordito una trama tristissima sì, ma che era pur simile alla vita. Da qualche tempo non tramo più, l’ordito è solo e sta formando la frangia della vita, basterà che io tagli quei fili3. Dolores Prato ha vissuto aderendo alla vita, con un senso profondo, autentico, ma nel suo atteggiamento sono sempre percepibili, seppur latenti, uno sguardo infantile e un difficile contatto con il mondo adulto, l’“esterno”. Come se la sua esistenza fosse stata percorsa dall’eco continua del suo incipit: “Sono nata sotto un tavolino”4. E’ questo l’inizio del capolavoro di Prato, Giù la piazza non c’è nessuno, il punto di 1 Lettera del 21.8.1969, Archivio contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, Gabinetto Vieusseux, Firenze (d’ora in poi ACGV), Fondo Prato, Corrispondenza, Pd 74, in Stefania Severi, Dolores Prato. Voce fuori coro, il lavoro editoriale, Ancona 2007, pp. 7-8. 2 studente, allievo di Dolores a San Ginesio, che fu amico della scrittrice per tutta la vita. 3 in Stefania Severi, L’essenza della solitudine. Vita di Dolores Prato, Sovera Multimedia, Roma 2002, p. 106. 4 Dolores Prato, Giù la piazza non c’è nessuno, Quodlibet, Macerata 2009, p. 3. 5 partenza della perfetta riproduzione del micromondo di Treia, protagonista e sfondo dell’infanzia della scrittrice, e anche momento in cui iniziano i ricordi e la coscienza, quando, abbandonata dalla madre “meccanica”5, Dolores viene affidata agli zii Domenico e Paolina Ciaramponi. “Il primo fatto storico della mia vita, intreccio di paura e meraviglia, fu sotto quel tavolino”. Mi ci ero nascosta perché il portone aveva sbattuto, dunque lo zio rientrava. Lo zio aveva detto: “Rimandala a sua madre, non vedi che ci muore in casa?”. Ambiente non c’era intorno, visi neppure, solo quella voce. Madre, muore, nessun significato, ma rimandala sì, rimandala voleva dire mettila fuori della porta. Rimandala voleva dire mettermi fuori del portone e richiuderlo […] Sedevo sui mattoni. Molliche indurite mi si conficcavano nella pelle come sassolini. Quel primo pezzetto di mondo immagazzinato dalla mia memoria lo vedo come adesso vedo la mia mano che scrive. Mattoni rettangolari color crosta di pane, uno coricato, uno dritto, facevano un tessuto a spina6. Inevitabile il collegamento con un altro “ricordo sotto il tavolo”, quello di Virginia Woolf, che, proprio come Prato, mette in atto un procedimento della memoria in cui al ricordo si affianca la ricostruzione della visione – in una sorta di itinerario dello sguardo – di cui fa parte anche ciò che non si vede: Ricordo, poi, la vastità e il mistero della landa buia sotto il tavolo della stanza dei giochi, dove sembrava in corso un’avventura senza fine, benché il tempo passato là sotto fosse in realtà così breve. Là mi imbattei in tua madre7, nella penombra circoscritta per fortuna dalla luce del camino, e popolata di gambe e di sottane. Galleggiavamo insieme come navi su un oceano immenso, quando lei mi chiese se i gatti neri avessero la coda. Risposi che no, non l’avevano, dopo una pausa in cui la sua domanda parve cadere echeggiando giù per vasti abissi prima immoti. Più avanti ci fu tra noi qualche consapevolezza delle potenzialità dell’altra8. Dolores nacque a Roma, da una relazione fra Maria Prato e un avvocato calabrese. Venne registrata all’anagrafe il 12 aprile 1892 come Dolores Olei, nata il 10 aprile da “madre che non consente di essere nominata”: dopo pochi giorni la madre ci ripensò e diede alla bambina il proprio cognome, ma alla fine del mese la mise a balia da due contadini di Sezze, in Ciociaria, e, infine, l’affidò ai suoi due cugini di Treia, Domenico, sacerdote, e sua sorella. Questo senso di abbandono, di solitudine, di assenza, è stata la cifra dell’esistenza di Dolores, ed è diventata anche quella del suo scrivere. Scrive Niva Lorenzini nel suo saggio critico La scrittura in 5 Ivi, p. 21. Ivi, p. 3. 7 sua sorella vanessa, madre di Julian, cui Woolf dedica questo pezzo del 1907. 8 Virginia Woolf, Reminiscenze, in Momenti di essere. Scritti autobiografici, la Tartaruga edizioni, Milano 1977, (trad. it. di A. Bottini), p. 37. 6 6 conclusa di Dolores Prato9: Dolores non cerca compatimento: la sua solitudine è caparbia, persino irritante, nella sua radicalità. Il microcosmo che descrive, trasferito in invenzione linguistica, eccede i termini della commiserazione o del compianto: è arte pura, impegno di una riedificazione totale del proprio margine di esistenza, costruita con una tensione e un vigore intellettuali mai affievoliti. E, in effetti, anche se chiunque l’abbia conosciuta parla di Dolores come di una donna sempre affetta da vittimismo esagerato, a volte con motivazioni frutto della sua stessa immaginazione, dall’altra parte non ha potuto fare a meno di rilevarne anche la grande forza, forse anche derivante da una voglia di riscatto privato. La vita di Dolores potrebbe vedersi, infatti, come un “documento di storia sociale”, di cui fa parte, in un primo momento, il destino sacrificale della protagonista, connaturato alla condizione femminile e con le deprivazioni ad essa associate, non ultime quelle della perdita della parola e della cancellazione dell’identità: emblematico, in questo senso, il periodo di reclusione nell’educandato salesiano delle suore della Visitazione di Treia, luogo in cui crescevano e si istruivano le fanciulle dell’aristocrazia locale (e non solo), e in cui Dolores riuscì ad entrare nel 1902 per volontà della zia Paolina che fece valere gli antenati nobili della piccola “Dolò” (i conti Duranti, i marchesi Torelli, i conti Bosdari, gli Sciava, e i Castracane10). Proprio quel collegio, che privò Dolores delle sue “parole” e della sua identità, lasciò un segno indelebile nella scrittrice: un segno che si trasformò da negativo a positivo quando, in tarda età, arrivò per Prato l’illuminazione, il momento della riappropriazione di sé stessa e della propria lingua. L’educandato fu anche il luogo in cui Dolores prese atto della sua diversità, non solo rispetto alle altre educande, ma, più in generale, forse, rispetto al mondo. Affido al passo dedicato alla “brocca” (che ogni educanda portava con sé in collegio), del libro Le Ore, il pensiero di Prato su questo argomento: Se la mia brocca doveva essere io, io com’ero? Era l’unica brocca diversa da tutte: secca, dritta, senza pancia, alta tanto che non poteva stare nel supporto del lavamano […] Percorrendo il dormitorio dove ogni comò aveva a fianco due lavamani, s’incontrava quella brocca fuori posto: una nota caduta dal pentagramma, una stecca nel coro […] Dove la comperò [lo zio] forse quella brocca era unica, tutte le altre con poche differenze erano uguali tra loro, ma lui scelse quella perché quella brocca ero io: diversa da tutte e vergognosa di esserlo11. 9 In AA.VV., Il timbro a fuoco della parola. Voci in dialogo con Dolores Prato, Edizioni Città di Treia, Treia 2000, p. 28. 10 cfr. Dolores Prato, Le Ore, a cura di Giorgio Zampa, Adelphi, Milano 1994, p. 20. 11 Ivi, p. 136. 7 Dolores di certo era una donna non convenzionale. Non convenzionale, e straordinaria. Era convinta che “le vite trascorse senza grandi scosse, senza tormenti, senza pianti inconsolabili, senza drammi spirituali, debbano essere vite pallide, scialbe, capaci di poco…Il terreno rende tanto più profondamente è spezzato dall’aratro”12. Dopo la clausura, uscita dal collegio, si trasferì a Roma per frequentare il Magistero: fu questo il periodo della vicinanza a diversi padri spirituali, in una sorta di prosecuzione in direzione del destino che conduceva a un mondo fra cattolicesimo e insegnamento (era sua idea di farsi suora e tornare a Treia per prendere in mano le sorti dell’Educandato). Dopo la laurea prese ad insegnare lettere in alcune scuole statali: a Sansepolcro, in Toscana, poi a San Ginesio e Macerata, nelle Marche. Dolores nella vita quotidiana aveva una sorta di distacco aristocratico che le derivava dal suo prediligere frequentazioni altolocate, sia socialmente che intellettualmente, ma anche dal suo considerarsi fortemente provata dalla vita. Proprio questo atteggiamento élitario la fece essere insegnante esemplare per alcuni, ma non per tutti. Non amava la massa e, per sua stessa ammissione, considerava questo un “difetto pedagogico”: si dedicava con molto trasporto e passione agli allievi più ricettivi e promettenti trascurando gli altri. Dopo San Ginesio se ne andò a Milano, per insegnare nella Scuola di cultura e d’arte di Vincenzo Cento, ma anche per seguire l’avvocato Domenico Capocaccia, le cui idee comuniste iniziarono ad insinuarsi in Dolores per non lasciarla più. Il loro era un rapporto sentimentale niente affatto equilibrato: lei era innamorata, lui no. Ma anche Prato, in fondo, aborriva l’idea dell’uomo e della donna comuni, così come quella di un rapporto “normale”: anche questo, forse, le impedì di avere legami sentimentali che facessero intravedere la possibilità di una concreta risoluzione, ad esempio nel matrimonio. Così finirono male l’amore con Paolo Toschi (che praticamente neppure iniziò), quello con Capocaccia, e, soprattutto, andò a male il rapporto – sempre in bilico tra il morboso e il sentimentale - con Andrea Gaggero. Un rapporto, quest’ultimo, che ha dominato i sentimenti di Dolores per molti anni – e di cui parleremo più approfonditamente in seguito -, toccando le più varie sfaccettature, dalla disperata rincorsa all’amore madre-figlio, dalla passione (di lei verso lui) all’odio. Le sue resistenze ad aderire al Fascismo, così come la politica stessa del Regime nei confronti delle donne, avevano poi portato a un allontanamento di Prato dalle scuole pubbliche. Collaborava con l’“Enciclopedia italiana”, ma non guadagnava abbastanza da viverci. Faceva lavori di traduzione (conosceva l’inglese e il tedesco) e di editoria per la SEI, che, però, non sempre accettava. Era rimasta senza occupazione fissa, finché, nei primi anni Trenta, aveva preso ad occuparsi di 12 Lettera a Maria Paoli, in Severi, L’essenza della solitudine, cit., p. 71. 8 Andreina Brusa, una ragazza torinese afflitta da gravi problemi mentali e che i genitori vollero affidare alle cure di un medico romano. Raggiunta così una parziale stabilità economica, Dolores riprese a coltivare assiduamente le sue amicizie. Fin da ragazza fu circondata da figure, soprattutto femminili, di grande personalità, a partire dalla Madrina del collegio di Treia, suor Margherita Maria Masi (tra l’altro, grande amica del Gran maestro della massoneria Adriano Lemmi), con cui il rapporto continuò per molti anni anche dopo l’uscita dall’Educandato. Tra le sue compagne del collegio c’erano Antonietta e Olga Manzoni, e tra quelle del Magistero Luigia Tincani13 (per Dolores, “Gina”), che nel 1939 fonderà con padre Ludovico Fanfani l’Istituto pareggiato di Magistero “Maria Santissima Assunta” per le religiose, oggi Lumsa, e Bianca Torriglia, madre del senatore e ministro Adriano Ossicini. Amiche della Dolores adulta saranno Elsa Paccagnella, membro del Partito d’azione e poi dell’Udi (Unione donne italiane), Lina Brusa Arese, la giornalista Giuliana Galimberti, moglie di Renato Mieli (e madre di Paolo), Jutta Bruto, moglie dello scrittore Stefano D’Arrigo. Le frequentazioni, comunque, di uomini e donne, segnarono profondamente la sua esistenza. Nel corso della sua lunga vita, Prato ha tessuto una tela fatta di decennali corrispondenze, nella maggior parte dei casi con letterati, filosofi, poeti, teologi, uomini politici, artisti, giornalisti, padri spirituali. Voleva lavori che non le rubassero il tempo per leggere giornali, fare i suoi studi, tenere una fitta corrispondenza, incontrare intellettuali e artisti. Tra le sue frequentazioni ci sono stati l’editore Alberto Anodo e il giornalista, letterato e critico d’arte Arturo Lancellotti; lo scrittore cattolico Giuseppe Urbani ed Ernesto Bonaiuti, che era diventato lo storico ufficiale del modernismo italiano; ancora, il pittore marchigiano Arnoldo Ciarrocchi e l’attore Alessandro Moissi. Dolores amava starsene a Roma, in casa, e ricevere. A cena da lei, con un piatto di pasta fumante, nella seconda metà del secolo, si incontravano Concetto Marchesi, Igino Giordani14, Mario Vinciguerra, Libero Bigiaretti: era un vero e proprio salotto culturale, dove si riunivano letterati e politici di ogni partito. Dolores, però, nonostante la rete vastissima di contatti con il mondo “fuori”, viveva spesso ripiegata su sé stessa: “soffriva di narcisismo, escludeva il mondo: non aveva visto i morti durante la guerra”15. Il suo era un carattere difficile, senza dubbio, una sorta di strano connubio di purezza e morbosità, di slanci affettivi ed egoismo. Comunque, lei, la sua vita, le sue disgrazie, vere, presunte 13 Luigia Tincani, fondatrice della congregazione delle Missionarie della scuola e della Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa) di Roma, morì a Roma nel 1976. Nel 1987 la Santa Sede ha dato il via al suo processo di beatificazione; il 27 giugno 2011 papa Benedetto XVI le ha attribuito il titolo di Venerabile, perché ha vissuto il Vangelo in maniera eroica e ha scelto il cammino della santità. Dolores aveva già intuito la sua santità in una lettera dell’ 8.7.1969. 14 Igino Giordani, direttore de “La Via”, era uno dei pensatori cattolici, esponente del Partito popolare italiano e cofondatore dei Focolarini, che Prato continuò a frequentare nonostante la sua svolta “a sinistra”. 15 1925-1927 Il racconto di Padre Paolo Silva, in Severi, L’essenza della solitudine, cit., p. 75. 9 o ingigantite, erano al centro della sua attenzione, e non di rado pretendeva che lo fossero anche di quella degli altri. Abbandonando la Dolores intima e privata, prima di addentrarci nelle parti più specifiche di questo lavoro, relative a Prato giornalista, è indispensabile compiere un rapido excursus sulla produzione della scrittrice, tanto originale quanto sfortunata a livello editoriale. Innanzitutto, il genere letterario in cui possiamo collocare tutti i lavori di Prato, almeno quelli editi fino ad oggi, è l’autobiografia, “specifico” femminile nell’Italia del Novecento: se Philippe Lejeune parla, in generale, di autobiografia come “atto di identità attraverso il quale si dà forma e significato alla propria vita”16, l’autoanalisi, le strategie di rappresentazione del rimosso connotano in modo macroscopico una scrittura subalterna come quella femminile, che deve fare i conti con i fluttuanti confini tra rimosso, rimovente e censura sociale e individuale17. Sia che si tratti di memorie private, apparentemente non destinate alla pubblicazione, sia che si tratti di atti pubblici di testimonianza di sé, l’atto della scrittura, nelle donne più che mai, si connette con la costruzione della personalità; non a caso la letteratura femminile del secolo XX in Italia si apre con il romanzo autobiografico Una donna di Sibilla Aleramo (1906) e con Una giovinezza del secolo XIX , memorie di Neera del 1917, per proseguire intorno ai nomi di Fausta Cialente, Gianna Manzini, Anna Banti, Alba De Céspedes, scrittrici tutte di forte impronta soggettiva, e, nella generazione successiva, con Paola Masino, Natalia Ginzburg, Lalla Romano, e ancora Dacia Maraini, Rosetta Loy, Francesca Sanvitale, Francesca Duranti, Elisabetta Rasy. Sarebbe, a mio avviso, atto di ingiustizia quello di continuare a lasciare nell’ombra, in questo contesto, il nome e l’opera di Dolores Prato: da Scottature (1965) a Le Ore (1994), da Giù la piazza non c’è nessuno (1997) a Campane a Sangiocondo (2009) fino all’ultimo pubblicato, Sogni (2010), siamo di fronte a pagine fra le più significative del secolo scorso, che hanno alla base un “genio” diverso ma di pari, se non superiore, rilevanza e interesse se confrontato con gli altri nomi del panorama letterario novecentesco. Giù la piazza e Le Ore possono definirsi due capitoli, seppur differenti nello stile e nel ritmo, di un unico grande romanzo su Treia: il primo relativo agli anni dell’infanzia, tra le mura di casa degli zii, le strade e le piazze, in un’esistenza con pochi affetti e molti personaggi; il secondo relativo all’adolescenza nel collegio della suore della Visitazione e a quella vita “apparente”. Campane a Sangiocondo (una pseudoautobiografia) è il romanzo su San Ginesio, piccolo paese dell’entroterra maceratese in cui Dolores insegnò dal 1922 al 1927: una storia, in parte inventata, ma ricca di tradizioni, aneddoti, luoghi, personaggi della realtà. Sogni, infine è il risultato di un laboratorio che 16 Philippe Lejeune, Il patto autobiografico, Il Mulino, Bologna 1986, p. 9. cfr. Virginia Woolf, Le donne e la scrittura, a cura di Michèle Barrett, La Tartaruga edizioni, Milano 1990, (trad. it. di A. Bottini) e Id., Ore in biblioteca e altri saggi, a cura di Paola Splendore, La Tartaruga edizioni, Milano 1991. 17 10 raccoglie quarant’anni di sogni di Prato. Non è tutto, perché tracce di autobiografismo, quando non protagoniste, sono presenti anche in moltissimi dei suoi articoli: Dolores, pur scrivendo per decenni, a partire dal 1950, su pagine nazionali come quelle di “Paese Sera”, non era una giornalista pura, tutt’altro, e il suo commento o la sua idea sui fatti diventava, in effetti, il senso e la particolarità dell’articolo stesso. Parlando degli scritti di Prato si approda alle sfortunate vicende editoriali che hanno investito ogni suo lavoro, senza eccezioni, e che hanno contribuito, purtroppo, a una non conoscenza di Prato scrittrice quasi fino al 2009, anno in cui, con la riedizione di Giù la piazza, la critica italiana ha acceso finalmente la luce su questa autrice. Giù la piazza uscì per la prima volta nel 1980, per i tipi di Einaudi, quando Dolores aveva ottantasette anni: le millecinquecento cartelle dattiloscritte originali furono tagliate da Natalia Ginzburg per esigenze editoriali, e la versione che ne uscì fu un terzo del manoscritto pratiano. Fu una vera ferita per l’autrice, che non vide mai portato alla luce il suo libro così come lei lo aveva scritto. Nel 1997, grazie al lavoro di Giorgio Zampa, il romanzo venne pubblicato per intero da Mondadori e nel 2009, in un nuova edizione, da Quodlibet. Le altre due uniche pubblicazioni che Dolores poté toccare con mano, in vita, furono Scottature, un racconto lungo che le valse anche il Premio Stradanova nel 1965, e Sangiocondo (questo il primo titolo con cui uscì il romanzo su San Ginesio nel 1963): entrambi in autoedizione, e per questo vissuti in modo ostile dall’autrice, che riteneva nota di demerito il non aver trovato un editore disponibile a pubblicare. Tutta la vita di Dolores fu, in fondo, un lungo processo di scrittura, tanto da riempire una incredibile mole di fogli, foglietti, carte, oggi in gran parte conservate per volontà della scrittrice, e grazie all’aiuto dei suoi amici Giorgio Zampa, Fausto Coen, Ines e Filippo Ferrari, nell’archivio contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux di Firenze. I miei manoscritti sono tanti che oramai tutta la casa è solo un cassetto. Che cosa siano io non lo so; il li chiamo “narrazioni”. Scrivo dove mi capita, anche ai margini dei giornali; comodissimi quelli dell’Osservatore Romano; una sigla in un angolo per distinguere a quale lavoro andranno aggregati e poi tutto alla rinfusa. In questo periodo che tento di recuperare il materiale per il libro sull’adolescenza, la mia casa pare un magazzino di carta straccia. […] Tutti questi manoscritti sono l’attaccamento e lo strazio della mia vita. Perché non siano buttati dopo la mia morte, dove, a chi lasciarli?18 Una domanda cui è stata data una risposta. 18 Lettera del 1979 a Giuseppe Longo, direttore de “L’Osservatore politico-letterario”, in E. Frontaloni (a cura di), Cronologia, in D. Prato, Sogni, Quodlibet, Macerata 2010, p. XXXVIII. 11 II - La ricerca di un credo tra cattolicesimo e comunismo L’oscillazione continua tra istanze cattoliche e pensiero laico di impostazione comunista fa di Dolores una antesignana dei “cattocomunismi”; del resto non poteva essere né incondizionatamente cattolica né profondamente comunista, perché si sentiva “diversa”19. E’ molto controverso il pensiero di Prato su Chiesa e Comunismo, e più in generale su politica e religione. La doppia anima di Dolores, cattolica e comunista, è dovuta alla sua vita e alle figure principali che l’hanno abitata. La formazione infantile e adolescenziale della scrittrice fu profondamente cattolica, sebbene segnata da due impronte assai differenti. I primi rudimenti culturali, infatti, li ricevette dallo zio prete, Domenico Ciaramponi, da lei affettuosamente chiamato Zizì, amante della scienza e della medicina. Un sacerdote del tutto particolare, soprattutto se se ne ricostruisce un ritratto, tra il reale e il misterioso, seguendo il filo di Giù la piazza: erudito, frequentatore dei territori della galvanoplastica, Domenico si faceva da sé i liquori e restaurò con la foglia d’oro tutto il soffitto della chiesa di San Francesco a Treia. Studiava la cabala e il lotto, realizzò un autoritratto per l’Accademia Georgica e, nel 1900, partito per l’Argentina in cerca di fortuna dopo la rottura con la curia, creò un marchio, il “Balsamo Ciaramponi”, un unguento a base di erbe naturali contro i reumatismi, la sciatica e le contusioni20. Dopo i primi anni, felici, per Prato arrivarono, invece, i lunghi anni nell’educandato delle suore della Visitazione di Treia, collegio salesiano dove la formazione era affidata a suor Maria Margherita Masi, la Madrina: qui l’esistenza era fondata sull’osservanza obbligata di precetti religiosi, e le stagioni si susseguivano per avvicendare cerimonie liturgiche e pratiche di vita quotidiana reiterate. L’annullamento di Dolores in quel “non luogo”, “la distruzione che fu mia”21, nacque con un urlo, e un pettine spezzato. Quando la zia cominciò a lisciarmi i capelli per portarmici e tornare a casa sola, con un urlo di belva pugnalata le strappai di mano il pettine e lo spezzai, spezzata io stessa da quell’imminenza che distruggeva ogni dubbio. La furia con cui spezzai il pettine avrebbe spezzato una trave. Spezzavo me stessa con un urlo diabolico e gesto infernale, dato che spezzarmi bisognava, poi tutto cadde nel niente per me. Gli altri videro un automa silenzioso e calmo22. 19 S. Severi, Dolores Prato.Voce fuori coro. Carteggi di una intellettuale del Novecento, il lavoro editoriale, Ancona 2007, p. 17. 20 cfr. E. Frontaloni, Glossario dei personaggi, in D. Prato, Sogni, cit., p. 760. 21 D. Prato, Le Ore, cit., p. 327. 22 Ivi, p. 15. 12 Di fronte alla ferma volontà della zia di far entrare Dolores nel collegio (“quell’inutile incubatrice di adolescenti”, come lo definì Prato) per farle avere un’educazione da vera signora, la piccola Lolita non poté nulla, se non abbandonarsi a uno scatto di rabbia. “Il mio primo atto di violenza concluse la lunga infanzia, se l’infanzia può mai concludersi”23. In fondo fu un grande cambiamento di parole, per il resto, un peggioramento, piantarono nella mia coscienza scrupoli, paure, ossessioni, che Zizì, prete, non aveva mai sognato. Rovinarono la mia vita24. Non potevo più essere quella che ancora non aveva spezzato il pettine25. Per le educande ospitate nel collegio non esistevano sviluppo, crescita, evoluzione individuale, se non nella rinuncia di sé. Come se varcando quella soglia solenne, misteriosa, semibuia, per me paurosa, automaticamente qualcosa in me si capovolgesse, per un segno di mortificata vergogna, Zizì, il mio Zizì meraviglioso che non faceva prediche, che sapeva tutto, che sorrideva sempre con un sorriso dove c'era moto, arguzia, intelligenza, un sorriso mai ritrovato sulla terra, il mio Zizì lo nascosi dietro la fredda parola di “zio”, anzi “lo zio”. E mamma Paolina diventò zia, anzi “la zia”. [...] Nascosi i nomi coi quali li avevo chiamati dal giorno che mi avevano raccattata, nascosi il bene che mi legava a quei due vecchi, nascosi la pena di averli lasciati, nascosi tutto quello che era stato fino allora e cominciai ad essere quell’altra, quella delle parole diverse26. Gli anni dell’educandato determinarono, inoltre, un peculiarissimo plurilinguismo pratiano, di cui parleremo in modo più approfondito in seguito: a fianco del doppio registro, dialetto trejese-lingua bassa/italiano alto, si fece spazio l’italiano selettivo e toscaneggiante, legato alle origini lucchesi della Madrina. La figura di suor Margherita Maria Masi fu centrale nella vita di Dolores: con lei Prato instaurò un rapporto, tra il morboso e il venerante, che durò moltissimi anni; un rapporto che portò la scrittrice a pensare per lungo tempo di prendere i voti, per poter poi succedere alla Madrina nella direzione dell’Educandato di Treia. A questi anni in collegio l’autrice farà risalire, nelle riflessioni dell’età matura, la sua “deformazione religiosa”. 23 Ivi, p. 16. Ivi, pp. 330-331. 25 Ivi, p. 21. 26 Ivi, p. 333-334. 24 13 La formazione giovanile proseguì nello stesso universo di valori. Nell’ottobre del 1912 Dolores sostenne l’esame di ammissione alla facoltà di Magistero a Roma: si trasferì, insieme alla zia Paolina, dapprima dalla sorella di sua madre, poi in pensionati per lo più retti da suore. In questo periodo si rafforzò la sua granitica, e a tratti intransigente, identità cattolica. Gli anni del Magistero, fondamentali per la sua preparazione (tra i suoi docenti Luigi Pirandello, Giustino Ferri, Giuseppe Manacorda), furono anche gli anni degli incontri con Gina Tincani, le Missionarie della scuola, e Bianca Torriglia (poi Ossicini). Con Tincani, da ferventi cattoliche, si scambiavano lettere in cui parlavano della loro partecipazione a cerimonie religiose, a incontri di preghiera, a conferenze, a visite alle chiese per visitare le tombe dei martiri27. In un bigliettino datato 1914, Gina faceva riferimento a un “triplice patto” stretto tra lei e Dolores: presumibilmente, questo consisteva nella reciproca assistenza, nel riunirsi in una comunità spirituale, e nella consacrazione a Dio nella castità28. E’ evidente, anche in questo rapporto, la forza e la preponderanza del credo cattolico nella vita della giovane Dolores, che aveva sempre in mente l’idea di un futuro nell’Educandato di Treia. Risale a questi anni anche la sua frequentazione dell’ambiente dei Gesuiti. Dolores ebbe numerosi padri spirituali: padre Paolo Silva, che era anche giornalista e redattore de “La civiltà cattolica”; padre Guido Mattiussi, e padre Cesare Goretti dei conti Miniati, questi ultimi due docenti nell’Università Gregoriana. A queste figure la giovane Prato chiedeva consigli su molte questioni esistenziali, e anche consigli sull’argomento della sua tesi: alla fine Dolores seguì la strada indicata da padre Goretti e scrisse una tesi sul carteggio intercorso tra don Antonio Bartolini, un letterato casentinese, e i puristi Pietro Fanfani e Prospero Viani. Il suo fervore religioso la rendeva spesso intransigente, tanto che i suoi amici la definivano “più nera del papa nero” (così veniva chiamato popolarmente il generale dei Gesuiti). Non è escluso che Dolores, proprio negli anni Venti, fosse venuta in contatto anche con don Giuseppe De Luca, una delle personalità culturali e religiose più ricche e complesse del Novecento29: in quel periodo, infatti, De Luca, di sei anni più giovane di Dolores, e quindi appena ventiduenne, strinse amicizia con Giovanni Papini (che poi divenne amico anche di Prato) e cominciò a collaborare con la terza pagina de “Il Popolo”, chiamato da don Luigi Sturzo. Tra l’altro, De Luca collaborò con l’“Enciclopedia italiana” e all’“Osservatore Romano”, pagine che ospitarono anche la firma di Dolores, ed ebbe tra i suoi amici più cari don Ennio Francia, originario di San Ginesio, che anche Prato conosceva bene. Don Ennio Francia stesso collaborava con l’“Osservatore Romano”, per la critica d’arte e la cronaca politica, e anche con l’“Avvenire” (più 27 cfr. S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 122. Ivi, p. 125. 29 Nel 1941 De Luca fondò la casa editrice Edizioni di storia e letteratura, dedicata a edizioni specialistiche in ambito storico, filologico e letterario. 28 14 tardi fu ospitato dall’organo della Democrazia Cristiana, “Il Popolo”, diretto da Giordani, sulle pagine della cultura): il sacerdote, uomo conservatore ma antifascista, nel periodo della dittatura scrisse alcuni editoriali che fecero sequestrare quattro volte i due quotidiani della Chiesa, non sottoposti a censura preventiva30. Un cambiamento radicale, per Prato, avvenne nel 1927, quando scelse di andare a vivere a Milano per insegnare all’Accademia Libera di cultura e arte del pedagogista Vincenzo Cento, fratello di Fernando Cento, vescovo di Macerata, e per seguire l‘avvocato Domenico Capocaccia, di cui si era innamorata, e con cui ebbe una relazione. L’incontro con Capocaccia, membro del Pci, fu determinante per la sua conversione dall’area cattolica a quella comunista. Attraverso Vincenzo Cento, Dolores aveva conosciuto Ernesto Bonaiuti, presbitero, storico, teologo, antifascista, che fu scomunicato dalla Chiesa per aver difeso il movimento modernista: Bonaiuti fu prima esonerato dalle attività didattiche, sulla base dei Patti Lateranensi, fu privato della cattedra universitaria per essersi rifiutato di giurare fedeltà al Fascismo31. Forse proprio lui fu la causa di una rilettura critica di Prato della sua incondizionata adesione alle posizioni cattoliche. Oltre a Bonaiuti, facevano parte della cerchia di amici Dolores anche lo scrittore cattolico Giuseppe Urbani e il pittore marchigiano Arnoldo Ciarrocchi, di cui Luciano Moretti scriveva: “Lui stava con i comunisti cattolici, un gruppo di giovani che Dolores definiva d’intelligenza, cultura ed esperienza mostruose. Un gruppo in cui lei si trovava bene”32. Prato non fece mai dichiarazione di voto, e di certo era più legata alle persone che ai partiti, ma di sicuro fu antifascista. “La sua fervida fantasia e il suo atteggiamento vittimistico l’indussero in seguito ad affermare che era stata perseguitata in quanto ebrea”33. La storia della persecuzione antisemita venne fuori nel 1946, quando Capocaccia, ormai funzionario del Partito Comunista, commissario governativo del “Corriere d’Informazione” di Milano (poi divenuto “Corriere della Sera”) e collaboratore dell’Ansa, si interessò al ritorno di Prato all’insegnamento: chiese a Dolores un promemoria della sua situazione di ex insegnante, in cui mettesse in evidenza i motivi per cui avrebbe avuto diritto di rientrare in ruolo, e lei “inventò” questa “bugia”34. 30 Durante l’occupazione tedesca di Roma del 1943-44 don Ennio si impegnò per proteggere ebrei e comunisti dalle persecuzioni. Il suo essere uomo di fede, di cultura e d’arte sfociò, nel 1941, nell’istituzione della Messa degli Artisti (a cui partecipavano, tra gli altri, l’architetto Enrico Del Debbio, gli attori Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Rossela Falk, gli scrittori Giovanni Papini, Giuseppe Ungaretti, Maria Bellonci), che nel 1953 trovò sede nella chiesa di Santa Maria in Montesanto a piazza del Popolo. 31 Cfr. Giorgio Boatti, Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini, Einaudi, Torino 2001 e Helmut Goetz, Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, La Nuova Italia, Milano 2000. 32 in S. Severi, L’essenza della solitudine, cit., p. 99. 33 S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 13. 34 Il racconto di Luciano Moretti. 1943-1950, in S. Severi, L’essenza della solitudine, cit., p. 101. 15 E’ tuttora controversa e misteriosa la questione delle sue origini ebraiche. Il cognome Prato, da un lato, le confermerebbe, così come i tratti somatici della scrittrice: il colore della pelle, i capelli corvini, il naso e i lineamenti marcati. Ma con uno sguardo all’albero genealogico, risalendo fino ai nonni di Dolores, si arriva a Carlo Emanuele Prato, nonno materno, che secondo la testimonianza diretta di Ines e Filippo Ferrari fu Governatore di Narni e, soprattutto, ricevette onorificenze dal Vaticano. Elementi, questi, che difficilmente sarebbero compatibili con radici ebraiche. Tuttavia Prato insistette sempre su questo punto. Nell’articolo Rivivendo con Vinciguerra scriveva nell’attacco: “Tra perseguitati e accantonati dal regime ci si cercava per sentirci meno soli”; in Italiana spaesata in Italia continua: “Io sono di origine ebraica e senza religione”. E così via, in moltissimi dei suoi scritti, comprese le lettere. Si legge in una lettera a Enzo Golino del 16.9.1980: Pieno di inesattezze il pezzo: dice che prima di questo lavoro (il riferimento è a Giù la piazza, appena pubblicato), oltre al libro pubblicato in Polonia, io avrei scritto solo “qualche elzeviro”. Non qualche, ma tanti, cominciando naturalmente dopo la guerra, prima m’era precluso per il Fascio e per Sion35. Ma la verità sulle sue origini è probabilmente quella riportata in un pro-memoria scritto da Prato stessa, riportato per intero nel prossimo paragrafo, in cui Dolores afferma: “Bench’io non sia di razza ebraica, per il mio nome che appartiene anche a gente israelita, ebbi seccature e noie”. Comunque, la lucidità dei suoi giudizi sulla contemporaneità, e nello specifico sul Regime, sempre accompagnati da un velo di pessimismo, era una costante. Scriveva nel 1944, alla fine della guerra, a Luciano Moretti: Mi hanno definita [i clandestini scrittori-partigiani] “la donna più antifascista” non se sia vero, so che ho sempre visto e ora a cose sfasciate mi meraviglio di quella vista come d’un miracolo del quale non m’ero accorta. Ma non andiamo mica bene ora…e non andremo bene per chissà quanto tempo! Però per consolarmi mi dico: almeno non c’è più via Tasso…non abbiamo più paura delle perquisizioni, delle razzie36. Nel 1947, all’indomani della vittoria della repubblica sulla monarchia, scriveva sempre a Moretti: Io mi sono appartata dal mio vecchio mondo da che vedo che i nostri crocifissori di oltre 20 anni, tornano tutti ad esserlo e noi pochi (che in periodo fascista ci credevamo tanti) si fanno concessioni (io no) e compromessi perché il fascismo il male più grande non l’ha fatto con la rovina materiale nostra e del paese, ma con l’inquinare la mentalità italiana già di per sé portata 35 36 ACGV, Fondo Prato, Pd 237, in S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 113. S. Severi, Voce fuori coro, p. 46. 16 alle vuote esaltazioni patriottarde e pagliaccesche. Tuttavia quel poco filo che ancora lega me alla gente è con gente di sinistra37. Quando ci fu il referendum monarchia-repubblica si dimostrò accesa repubblicana. Ce l’aveva a morte con la monarchia, “tra Mussolini e la Monarchia avrebbe salvato Mussolini”38. Il perché del suo odio non si basava sulla cattiva condotta del re, ma su precedenti storici: la monarchia si era annessa le Marche e Roma. “Questa fu l’unificazione dell’Italia sotto la monarchia che livellò, coartò, distrusse le nostre caratteristiche regionali sotto l’ideale casermistico”39. Il meglio, secondo Prato, sarebbe stato rimanere sotto il governo del papato. Sembra importante riportare qui il testo di un articolo-sfogo, sicuramente mai pubblicato, che Prato ha conservato tra i suoi materiali, riguardante proprio la sua avversione ai Savoia. Non siamo abbastanza antimonarchici perché anche i giornali che sono per la repubblica portarono senza nessun commento la notizia che essendo la moglie di Umberto Carignano (Maria José) a villeggiare a Castel Porziano, nell’incendio di parte di quel bosco, restò separata dai figli che erano a giocare sulla spiaggia finché i pompieri non glieli ebbero ricondotti. Una madre che soffre per i figli è sempre rispettabile, sia pur una Carignano, ma che la stampa italiana non abbia sentito che la notizia andava taciuta o commentata, è stata una mancanza d’intuito per il dolore del nostro popolo. Mentre i bimbi d’Italia (esclusi i figli dei ricchi e degli arricchiti che nella totalità sono un’esigua minoranza) non conoscono più villeggiature, né al mare, né al monte, né al piano, i figli di chi volle la guerra, togliendo così ai nostri bimbi non solo gli svaghi dei campi o dei mari, ma il pane e le vesti, passano da una villeggiatura ad un’altra, giocano sulla spiaggia “loro”, godono indisturbati i beni dell’Italia. Li hanno salvati, va bene, ma che non ce ne parlino per non farci sentire raddoppiato il cruccio per i nostri poveri bimbi vittime del padre, del nonno, del “cugino” del nonno, di tutti gli antenati di quei tre o quattro Carignano che giocano sulla spiaggia “loro”. (m’accorgo ora di non saper con sicurezza quanti siano i figli del luogotenente e…me ne rallegro!)40 37 S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 47. Ivi, pp. 100-101. 39 Ivi, p. 100. 40 Fondo Ferri Ferrari (Sant’Angelo in Vado). 38 17 Dopo la fine della guerra, Dolores pensò di intraprendere una sua rivoluzione e di iscriversi al Partito Comunista, e ne fece carico a Capocaccia, che però tergiversò: Ci tengo a dirti che la tua “iscrizione” non è affatto in pericolo. Le cose dovranno maturarsi secondo il mio inesorabile proposito. Ho paura che la tua rivoluzione social-religiosa non si possa facilmente effettuare in Italia. E’ già tanto difficile quella a solo contenuto sociale; figurarsi se ci si dovesse aggiungere anche un pizzico di religione! Proprio perché gli italiani non sono religiosi. Ma può essere che io mi inganni41. In Dolores c’è sempre stata, comunque, una grande ribellione verso tutti gli schemi precostituiti, compresi quelli politici. Scriveva, infatti, contemporaneamente per “Paese Sera” e per l’”Osservatore Romano”, oltre che per altri giornali cattolici. Dichiarava di aver trovato la rovina della sua vita nell’educazione religiosa, poi però, a volte, riemergevano le intransigenze cattoliche che avevano caratterizzato la sua gioventù, fino a mostrarla vicina al cattolicesimo conservatore di Lefebvre. Come in una lettera alla principessa Elvina Pallavicini, a cui Prato scrisse nel 1977 in occasione di un omaggio che la principessa tributò a monsignor Lefebvre: L’omaggio che si renderà a Monsignor Lefebvre è la voce di tutti noi che non accettiamo di essere eretici perché non crediamo che la Chiesa ci abbia potuto ingannare per tanti secoli. […] Proprio adesso che dal monolito comunista esce l’incrinante nocetta di pluralismo, perché la Chiesa vuole imporre a tutti quelle spesso ridicole ammodernature di cui si può avere ripugnanza come io l’ho della nuova Messa? A parte il latino, che è cosa discutibile: è meglio che la gente capisca qualche parola in più o che resti raccolta nell’emozione di quel mistero linguistico col quale, pregando col prete, deve rivolgersi a Dio? Tanto Dio è solo mistero; inutile voler capire. Del resto quei laici che si alternano avanti a un trespolo in funzione di piccolo podio e leggono il loro pezzetto, fanno pietà con quel “Preghiamo” attaccato a ciò che hanno letto come se ne fosse il punto. L’“Oremus” della nostra Messa era un’apertura di silenziosa preghiera, non era una conclusione. […] Dicono che il nostro è aristocratico distacco. No. E’ una più semplice interpretazione. Adesso tutto è teatro. Il teatro ha inquinato il Vaticano II42. Ancora una volta, torna l’adesione di Prato ai valori cattolici su cui aveva costruito la sua identità fino agli anni del Magistero. Dolores coltivava l’amicizia con il senatore del Pci, Umberto Terracini, e, allo stesso tempo, quella col democristiano Arnaldo Forlani. Anche se si era rivoltata contro la Chiesa, il cristianesimo lo portava sempre dentro, e anche se si sentiva sempre più “compagna” non disdegnava di portare avanti le amicizie con ferventi cattolici, come quelle con Luigia Tincani, Maria Benedetta Salvati, 41 42 Lettera del 1 marzo 1946 (fondo ferri-Ferrari), in S. Severi, L’essenza della solitudine, cit., p. 101. ACGV, Fondo Prato, Pd 173, in Severi, Voce fuori coro, cit., pp. 84-86. 18 Igino Giordani o col magistrato Torquato Ferrari. Ancora Capocaccia le scriveva in proposito: Ammiro il tuo candido zelo per mettere d’accordo Marchesi con Giordani – la Democrazia Cristiana col Comunismo…Io credo a un’intesa fra le due correnti come a un fenomeno d’assorbimento. Ci sarà domani un comunista dotato di pensiero cristiano43. Questo dualismo fu costantemente presente in Dolores, e per lei assolutamente naturale. Coltivava sempre le sue amicizie, che inglobavano personaggi e personalità molto diversi: oltre a Giordani e Concetto Marchesi, c’erano Paolo ed Ebe Toschi, Adriano Tilgher, Agostino e Lori Turla. E nonostante la sua vicinanza al Pci, era sempre capace di prendere le distanze dal comunismo quando non ne approvava scelte e indirizzi. Un esempio di questo atteggiamento si ritrova in una lettera a Coen del 1971, in cui Prato spingeva l’amico a fare i primi passi per un giornale tutto suo (la “Voce”): Non ti rendi conto di quello che tu hai dato al partito? “Paese Sera” è tuo e tu l’hai messo in mano a tutti. Tu hai fatto in modo che la gente incontrasse su quelle pagine non la bestia comunista che vedeva altrove, ma un amico che la pensa un po’ diversamente. Tu sì, hai dato al Comunismo un volto umano. Tu hai fatto per il Comunismo quello che non hanno fatto i suoi dirigenti tutti insieme…Sono loro che non potranno mai ricompensarti anche se sapessero farlo44. Il rapporto della scrittrice con la sinistra fu ulteriormente alimentato dalla sua relazione con Andrea Gaggero, don Gaggero, della congregazione dei Filippini. Gaggero, conosciuto negli anni ’50 al Collegio Cultorum Martyrum, dove Dolores si recava spesso alla ricerca di materiale su Roma antica e moderna (così come al Te Roma Sequor e all’Istituto di studi romani sull’Aventino) fu determinante nella vita di Prato. Quella che doveva esser una relazione amicale assunse negli anni le più varie sfaccettature: lei lo chiamava “figlio“, ma si trattò di amore, in qualche modo, e questa relazione fu importante per lei anche sotto il profilo della sua coscienza di scrittrice. Le idee cattocomuniste di Dolores, già rilevate da Capocaccia, trovavano in Gaggero quasi la perfetta incarnazione. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, infatti, la sua chiesa dei Filippini, a Genova, era diventata base di appoggio dell’attività partigiana. Arrestato il 6 giugno del 1944 dalla polizia repubblichina, a seguito di una perquisizione dell’oratorio, Gaggero fu torturato e deportato, prima nel campo di concentramento di Gries (Bolzano), e poi nel lager di Mauthausen. Liberato nel maggio del 1945, riprese il suo impegno sacerdotale e diede il suo sostegno al Partito della Sinistra 43 44 S. Severi, L’essenza della solitudine, cit., p. 102. Ivi, p. 129. 19 Cristiana; quando, nel 1950, partecipò al II congresso mondiale dei Partigiani per la pace e lesse il suo discorso, arrivò il richiamo ufficiale del Sant’Uffizio, che poi, nel 1953, lo sospese “a divinis”. Fu Dolores ad accogliere Gaggero nel suo appartamento di Roma, in via Fracassini 4, quando questo era in attesa di giudizio da parte della Santa Sede, e da quel momento iniziò una relazione complicata, complessa, che segnò e ossessionò Dolores per molto tempo. Tramite Gaggero, Premio Stalin per la pace nel 1954, Prato conobbe Palmiro Togliatti e Aldo Capitini, il “Gandhi italiano”, promotore insieme a lui della marcia per la Pace Perugia-Assisi nel 1961. In questo periodo Dolores prese a frequentare la “Casa Rossa” dello scultore Giuseppe Mazzullo, docente dell’Accademia di belle arti di Roma. La casa-studio di via Sabazio, non lontano da piazza Istria, era un punto di incontro per intellettuali di sinistra, un vero e proprio salotto frequentato da artisti e scrittori, fra cui Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sinisgalli, Renato Guttuso, Nino Cordio, Stefano D’Arrigo e Jutta Bruto. Anche l’idea di universalismo e nonviolenza fu sempre presente nel pensiero della scrittrice, e questo si evidenzia nella posizione filoaraba assunta nel conflitto israelo-palestinese. Sul rapporto fra Dolores, il comunismo e la pace, è indicativa, infatti, la lettera inviata a Fausto Coen il 6 gennaio 1968: E’ chiaro che il mio dissenso, irriducibile, senza concessione alcuna, è per la posizione presa dal partito comunista riguardo alla questione ebraica. Premetto che concetto Marchesi, quando gli capitava di mettersi a tessere i miei elogi, raccogliendo le ragioni del suo peana, finiva sempre con queste parole: “e soprattutto perché non capisce niente di politica”. Dunque convinti tutti, cominciando da me, che io non capisco niente di politica. Però quando fui a Mosca con Andrea, per quasi due mesi, riportai l’impressione che gli ebrei non fossero amati. E si che in quel tempo m’era difficile (per non dire impossibile) ammettere che il comunismo potesse avere dei torti; allora il bello su quel terreno io lo facevo nascere anche dove proprio non c’era. Però che l’antisemitismo fosse incluso nel comunismo, facevo fatica a nasconderlo a me stessa […] Vedevo tante cose che non capivo dove l’unica cosa chiara era il torbido. Questo torbido, pensavo, sarà la politica, io di politica non m’intendo; quindi potevo anche non aver capito nulla sulla questione ebraica. Ma che il comunismo lassù covasse ostilità contro gli ebrei, un giorno ne ebbi una tale conferma che il dubbio non fu più possibile. Me ne tornai qui con quella pena; però ero convinta che i sovietici avrebbero capito e corretto quell’errore che li legava proprio ai nazisti. Invece non è stato così. E qui da noi i dirigenti comunisti neppure in questo hanno saputo prendere una posizione indipendente. Chiamano “sporca” la guerra del Vietnam, e lo è, ma allora come si dovrebbe chiamare la loro ostilità contro Israele? Lurida, per lo meno. Mettersi contro Israele è mettersi contro il diritto umano. Parlano d’Israele come se fossero passati duemila anni dall’ultima strage e invece è proprio il muro del pianto ad avere duemila anni. E ieri sera Enzo Siciliano viene a “distinguere” […] gli Ebrei da quelli di Tel Aviv. Ma faccia il 20 favore, allora porti la distinzione anche tra quelli che nei lager sono morti e quelli che sono tornati; quanti ce ne sono tra questi che sono vivi perché si sono nutriti della morte degli altri? Qualcuno criticabile tra questi tornati, c’è. E con questo? Il campo di sterminio resta l’orrore finora insuperato. […] Mille volte sono stata sul punto di chiederti la spiegazione di quello spaventoso atteggiamento comunista (perché dove il comunismo prenderà piede, se la dura così, non sarà una bella vita per gli Ebrei). Forse tu mi risponderesti che è la politica e allora dedurrei che la politica è “sporca” perché questa è guerra, altro che pace! Il pacifismo e le sue dimostrazioni non hanno niente a che fare con la PACE. Pur avendo vissuto ogni momento della sua esistenza nella tensione verso un insieme di valori in cui credere e in cui identificarsi, sicuramente fu l’assoluta indipendenza intellettuale di Prato la dote migliore di questa donna così originale. 21 III - Dolores: “piccola e coraggiosa donna degli anni Trenta” in lotta con il Fascismo Vale la pena soffermarsi su Dolores insegnante e antifascista, perché un’osservazione più a fuoco su questi punti conduce a documenti rari e importanti, fra cui un preziosissimo, e inedito, “testamento ideologico” pratiano, e, oltretutto, permette di approfondire il legame di questa donna con la provincia di Macerata. Nel dicembre 1918, superati gli esami di licenza al Magistero, Prato, grazie all’interessamento di padre Cesare Goretti Miniati, ottenne un posto da insegnante a San Sepolcro, nel Regio Educatorio Istituto di San Bartolomeo: nella cittadina toscana visse uno strano “idillio” con Paolo Toschi, un amore vissuto in modo asincrono – prima si innamorò lui, poi lei, ma a quel punto lui si era avvicinato alla sua futura moglie, Ebe Palazzeschi - che fece soffrire molto Dolores, e che creò un nugolo di chiacchiere che, nel 1921, portarono all’allontanamento di Prato dalla scuola. Nel 1922 Dolores arrivò a Macerata, dove le venne assegnata una supplenza. Qui iniziarono i contatti con il vescovo della città, Ferdinando Cento, e, quando nel 1922 morì la Madrina, dell’educandato di Treia, Dolores chiese subito di poter tornare nel collegio per insegnare. L’esperienza durò solo cinque mesi, per profondi contrasti su temi didattici e di fede con la nuova superiora del collegio. Nell’estate di quello stesso anno, Prato ricevette l’incarico di insegnare italiano e storia nella Regia Scuola Promiscua Matteo Gentili di San Ginesio, un piccolo borgo medievale dell’entroterra maceratese. Ricorda Febo Allevi nel suo Liberty e Belle Epoque da un angolo visuale di provincia, peraltro unico scritto in cui si parla di Dolores nel suo passaggio ginesino: Scomparsa da circa una dozzina di anni, chi scrive la rivede come attraverso una cortina di vetro, seduta in cattedra al posto del maestro titolare nella sua quarta (o quinta) classe elementare, circondata dai suoi giovani allievi, presenti alla lezione di tirocinio, la cui ritmica successione non comportava alcun disagio pratico, perché l’ampio ex convento agostiniano ospitava (ed ha continuato ad ospitare fino a circa un trentennio fa) con le Normali (odierne Istituto magistrale) le tre classi inferiori preparatorie e le elementari medesime45. L’esperienza ginesina di Prato durò in tutto cinque anni, dal 1922 al 1927: erano gli anni dell’ascesa 45 Febo Allevi, Liberty e Belle Epoque da un angolo visuale di provincia, in Atti del XXXI Convegno del Centro Studi Storici Maceratesi “Vita quotidiana e tradizioni popolari nel maceratese”, Abbadia di Fiastra 18-19 novembre 1995, Macerata 1997, p. 147. 22 del Fascismo. Le scuole Normali, che dopo la riforma Gentile del 1923 divennero Istituti Magistrali46, erano le scuole per la formazione dei maestri, e avevano un ruolo cruciale nei primi decenni del Novecento: proprio l’insegnamento elementare, infatti, costituiva un importante canale di mobilità ascendente, più per gli uomini che per le donne. Era una professione che permetteva di far progredire il proprio status sociale, senza che per questo fosse richiesto il possesso di un titolo di studio accademico (bastava una Scuola Tecnica o Complementare più la Normale). L’ingresso nella scuola Normale era il trionfo di una famiglia intera, fiera di vedere uno dei propri membri uscire da una condizione inferiore; trionfo del maestro, che consigliando questo orientamento aveva visto gusto; a volte, era anche il trionfo di un paese intero, dell’alunno, candidato onorevole che arrivava alla Normale attraverso strade difficili47. La scuola ginesina era mista, per maschi e femmine, con alcuni allievi più vecchi di Dolores, sposati e con figli, e queste erano cose che a Prato non piacevano. Il direttore, professor Sartori, stimava molto questa insegnante che si faceva apprezzare per le sue lezioni vivaci e appassionate, soprattutto se riguardavano Dante e la Divina Commedia48; i ragazzi e le ragazze le volevano bene. In particolare, le si affezionò un allievo, Luciano Moretti, con cui restò in contatto, e amica, per tutta la vita. Moretti, nato a Ripe San Ginesio nel 1906, frequentò fin dai primi anni di vita il pittore Guglielmo Ciarlantini e il suo maestro, Adolfo De Carolis. A San Ginesio conobbe Dolores, e il loro legame, sempre privilegiato e speciale, si trasformò, negli anni, da rapporto tra alunno e insegnante a fraterna complicità elettiva. Il carteggio tra i due durò più di trent’anni. Dolores gli fu vicina nel matrimonio con Olga Spinosi, nella nascita dei due figli Paolo e Marco, e lo introdusse, nella capitale, nel suo gruppo di amici (Coen, Marchesi, D’Arrigo, Mazzullo). Luciano fu vicino alla scrittrice quando questa iniziò a sistemare l’enorme mole di appunti e materiali che sarebbero diventati il romanzo della sua infanzia: Giù la piazza non c’è nessuno49. A San Ginesio, Dolores andò a pensione presso la famiglia Barbi, cui versava 300 lire al mese (lo stipendio era di circa 7 mila lire annue). Di questo periodo della vita di Dolores Prato non si hanno testimonianze importanti, oltre la corrispondenza con don Pacifico Ciabocco50, e qualche lettera a 46 Con Regio decreto del 6 maggio 1923 il corso di studi aumentò da 6 a 7 anni: i primi quattro anni costituivano il Corso inferiore, gli ultimi tre il Corso superiore. Cfr. Perry Willson, Italiane. Biografia del Novecento, Editori Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 122-136. Delle 153 Scuole Normali esistenti nelle Marche prima del ’23, ne furono soppresse 66, ma quella di San Ginesio restò (ed è attiva anche oggi come liceo Sociopsicopedagogico). Cfr. Antonietta Langiu e Liduina Durpetti, Maestre & Maestri in Italia fra le due guerre, in “Quaderni del consiglio regionale delle Marche”, anno IX, n. 54, Ancona 2004, p. 115, e Augusta Palombarini, Storie magistrali. Maestre marchigiane tra Otto e Novecento, Edizioni università di macerata, Macerata 2009. 47 A. Langiu e L. Durpetti, op. cit., p. 102. 48 In questo periodo Dolores Prato iniziò a imbastire una serie di saggi e profili su questo argomento. Cfr. Elena Frontaloni, Cronologia, in Dolores Prato, Sogni, a cura di Elena Frontaloni, Quodlibet, Macerata 2010, p. XXXI. 49 Cfr. E. Frontaloni, Glossario dei personaggi, in D. Prato, Sogni, cit., pp. 792-793. 50 Conservata nell’Archivio contemporaneo “Bonsanti” del Vieusseux, Fondo Prato, serie Pd, e anche nel fondo Ferri- 23 Oscar Piatti51, maestro e appassionato di storia e cultura locali: questi, in effetti, furono due dei pochissimi amici che Dolores frequentò a San Ginesio in maniera assidua, perché, per il resto, le sue relazioni sociali potevano definirsi rare, quasi inesistenti. Le sue frequentazioni si limitarono a due ambienti: la chiesa e la scuola, dal momento che non aveva una famiglia. Prato aveva, come è noto, e come si può dedurre dal romanzo su San Ginesio, Campane a Sangiocondo, un rapporto molto stretto con don Pacifico e la sua famiglia, e conosceva, anche se in maniera più superficiale, tutti gli altri sacerdoti che operavano in quella piccola comunità. Fra i suoi amici, oltre a Piatti, poi, si possono annoverare sicuramente Alceste Murri compositore e musicista, i coniugi Alfredo Salvucci e Bice Lami, suoi colleghi alla scuola Normale: di fatto, proprio grazie a loro, Dolores Prato conobbe e vide per la prima volta Domenico Capocaccia (entrambi erano stati padrini di battesimo di Maria, la figlia dei Salvucci); inoltre, tra gli amici di questa stessa famiglia c’era anche il pedagogista Vincenzo Cento52, direttore di quell’Accademia Libera di Cultura e Arte dove Prato andò ad insegnare, a Milano (città dove Dolores visse il suo amore per Capocaccia e si “convertì”, in qualche modo, al comunismo). Se si esclude questo sparuto circolo di persone, Dolores può dirsi una presenza mai integrata nella vita vera del paese. Fedele alla sua indole selettiva e un po’ snob, che in parte coincideva anche con l’isolamento voluto, in generale, in quel periodo storico, dalla classe degli insegnanti, portati a rinchiudersi in piccole cerchie di persone “per bene” e al di sopra della “massa”53, Prato non amava frequentare la piazza e le strade del paese come luoghi di aggregazione: per lei erano importanti i luoghi più delle persone, e quello che la appassionava veramente erano la storia e le tradizioni locali, di cui divenne peraltro profonda conoscitrice. Questo suo distacco creò un velo di ostilità da parte dei ginesini, che, probabilmente non vedevano di buon occhio la presenza di una donna indipendente e vulnerabile, colta, che presentava gli atteggiamenti “antifascisti”, tipici dei cattolici puristi che non accettavano che una politica si trasformasse in religione54. Fu così che Dolores, che a differenza di molti insegnanti e insegnanti cattolici, non accettava la liturgizzazione della politica, avvertendo il cerimoniale come offensivo rispetto alla Chiesa, finì nel mirino di un giornale cittadino, dai toni caustici e umoristici, dal titolo “Padre Lavinio”55. Fondato e diretto da un personaggio originale quale era il capitano Quintilio Ferrari. 51 Le lettere fra Dolores e Piatti sono state donate dalla famiglia Piatti all’Accademia Georgica del Comune di Treia. 52 Cfr. “voce” (a cura di Francesco Muzzioli), in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 23, Edizioni dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1979. 53 Langiu e Durpetti, op.cit., p. 262. 54 Cfr. E. Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1994. 55 Il titolo era ispirato alla figura di padre Lavinio, ben descritta da Allevi nel suo Liberty e Belle Epoque (cit., p. 90): “Nelle parrocchie rurali non mancava poi il curato semplicione o per difetto di raziocinio o di dottrina. […] Nei parlari di tutti ricorreva allora la dabbenaggine di un certo Padre Lavì, il quale appunto con la sua insipienza grossolana ne aveva combinate molte di baggianate esilaranti in varie chiese della vallata del Fiastra, dove svolgeva il suo servizio 24 Clementini, il giornaletto ginesino (equivalente dei foglietti, anche parrocchiali, che circolavano in quel periodo in molti altre piccole e medie realtà) era stampato nello stabilimento tipografico Affede di Macerata e uscì saltuariamente tra gli anni Venti e Trenta, anche se qualche numero fu stampato anche dopo la Seconda guerra mondiale. Una pubblicazione assolutamente originale, di cui oggi, purtroppo, restano pochissime copie (probabilmente si contano sulle dita di una mano)56, ma in cui, forse non a caso, troviamo riferimenti a Dolores Prato. Sono cinque i numeri rintracciati, di cui tre corrispondenti al periodo in cui Prato visse a San Ginesio57. Riportiamo qui di seguito l’intestazione dei fogli: 1. Padre Lavinio del 29 luglio 1923 Viserba-Rimini – Numero unico – Costa baiocchi 4, col cambio b. 8 TITOLO: “Padre Lavinio al mare. Giornale umoristico nomade”. Esce quando può, a seconda dei fondi. Direzione, amministrazione presso l’Hotel “Bologna”. “O donne mie devote,/ vestite con decenza/ oprate con coscienza,/ nel nome di gesù”. P. Lavì (moralista) 2. Padre Lavinio dell’8 giugno 1924 Sanginesio – Numero unico – costa cent. 40 TITOLO: “Padre Lavinio. Umoristico – idrofobo – felino”. “O populu devotu,/ ve faccio reverenzia,/ daciateme ‘dienza/ che parlo de Jesù”. P. Lavinio. Direzione e amministrazione presso il caffè Corradini. In questo numero si legge un tagliente attacco proprio a Dolores, in cui ritroviamo palesato proprio il ritratto, per quanto “strabico”, della Dolores antifascista: religioso, ed in seno ai suoi parrocchiani. Es. Di fronte ai fedeli commossi fino alle lacrime nell’ascolto della Passione di Cristo, Padre Lavì invitava ad asciugarsi le lacrime e a non pensarci più, perché tutto risaliva a un tempo così lontano da confondersi con la leggenda o la favola: “E’ tanto che è stato, chi lo sa se è vero!?”. 56 Conservate nella biblioteca comunale Mozzi-Borgetti di Macerata e nella biblioteca privata del prof. Febo Allevi, anche questa a Macerata. Introvabili, invece, nelle case ginesine. 57 Gli altri due numeri sono uno del 1936 e l’altro del 1951, quindi relativi a periodi non di nostro interesse. 25 SUPPOSIZIONI ATROCI “Ci viene riferito che una certa signorina Dolores è nemica aperta del fascismo, dei fascisti e di questo Giornale (che ci ha niente a che vedere). Perché? Per quanto abbiamo pensato, ponzato, riflettuto, considerato, indagato, domandato, supposto, ritenuto, sospettato, annusato, non ci risulta la ragione vera, plausibile, possibile, giusta, ammissibile, attendibile, imprescindibile, inconfutabile, inalienabile, palpabile, bevibile, digeribile…ecc. di tanta verbosa contrarietà. Da informazioni assunte cautamente e direttamente presso i capri responsabili, possiamo solennemente, sicuramente, indefecabilmente, e con la massima garanzia di serietà, affermare che nessuno dei componenti il fascio maschile ginesino, nasconde delle animosità contro la succitata signorina, anzi da qualche indiscrezione trapelata c’è stato facile intuire che quei cari giovanotti non solo non la disprezzano, ma la vedono con piacere e con maggior piacere la vedrebbero più frequentemente se Ella concedendosi qualche lasso di tempo tra una mistica funzione e l’altra si offrisse agli sguardi furiosamente inutili che continuamente frugano la piazza ov’Ella fugacemente e raramente appare. E chi sa che in qualche turgido cuore non battano già i sei cilindri possenti di una passione incipiente, che infine rompendo inutili lacci si scagli alla conquista fortunosa della Sfinge ermetica e antifascista? Noi brancoliamo nel mistero perché quanto sopra si riferisce a quei cari giovanotti, ma chissà però che Ella non abbia dei solidi argomenti che anche impugnati la pongano sotto la luce più fulgida della Ragione, spiegando così tutta la bellezza recondita di quest’Anima umile ed incompresa che vive nell’ascetica attesa di un avvenire sempre più…grande, glorioso e trionfante per non mai più morire e così sia!... Con me poi francamente non ce se la doveva prendere. Se cominciamo a farci del male tra noi riligiosi!... (P. Lavinio) Nello stesso numero appare un trafiletto, con ogni probabilità apocrifo, firmato da Prato nel ruolo di direttrice della regia Scuola Normale. Dolores annuncerebbe addirittura la sua volontà di recarsi direttamente a Roma, al ministero di Giustizia e Affari di Culto, e da don Luigi Sturzo, per protestare contro l’imposizione fatta alla scuola dal “fascio invadente” di partecipare a una manifestazione. 26 LETTERA APERTA ALL’ILL.MO SIGNOR SINDACO DI SANGINESIO Protestiamo col relativo timore di Dio e dei SS. Nostri Patroni contro la penetrazione invadente del fascio di questa Città (secondo il Conte Morichelli) il quale irriverentemente s’è creduto autorizzato invitarci (o imporci) o partecipare con Questa timoratissima scolaresca ad un corteo per una ricorrenza che non ha niente a che vedere con la nostra santa Religione inconcussa o col P.P. Intanto per Sua norma Io - dolores…amente – partirò quanto prima per Roma per elevare al Ministro dei Culti Grazia ecc – e forse anche a don Sturzo – la espressione della nostra indignazione. Con i sensi ed i controsensi della nostra stima La ossequiamo. F.ti: LA DIRETTRICE UN PROFESSORE P.C.C Il Segretario PA Targa. 3. Padre Lavinio del 30 agosto 1926 TITOLO: “Padre Lavinio. Organo ufficiale dei cultori del riso. (Senza fissa dimora)” Anche in questo numero ecco apparire poche righe che, sarcasticamente, vogliono provocare la scrittrice. Si legge nella terza pagina: ANNUNZI ECONOMICI MATRIMONIALI “Mistica fanciulla, bruna, formosa, serafica, cerca anima gemella disposta a sgranare seco lei il rosario della vita”. (Dolores – casella S. Antonio) 27 Importante, per la nostra riflessione, il pezzo comparso sul secondo fascicolo. Era firmato “la direttrice”, perché a un certo punto fu proposto a Prato di assumere temporaneamente la direzione della scuola di San Ginesio. Che far da direttrice non fosse facile lo sperimentò sulla sua pelle, infatti fu travolta nello scandalo di un documento contraffatto da un alunno. Ci fu un’inchiesta e il giovane fu denunciato all’autorità giudiziaria e al Ministero. Lei dovette rispondere d’aver lasciato i timbri in luoghi non sicuri, rischiò anche di perdere l’insegnamento58. Che ci fosse stato, realmente, un problema con dei timbri incustoditi sottratti da uno studente è fatto provato, ma la bacchettata da parte del Ministero a Dolores sembra attribuibile anche, e forse in misura maggiore, alla renitenza di questa a prendere la tessera fascista e ai suoi tentativi di circoscrivere, grazie al suo ruolo, le pretese del regime59. Nell’ottobre del 1925, infatti, la distruzione di ogni indipendenza delle istituzioni scolastiche veniva compiuta con provvedimenti approvati dal Gran Consiglio, insieme alla soppressione del diritto di sciopero e allo scioglimento di tutti i partiti politici, tranne quello fascista. Con i “Provvedimenti per la difesa dello Stato”, nel novembre del 1926, una delle cosiddette “leggi fascistissime”, fu approvata e resa legale a persecuzione di chi non accettava il regime. A proposito della scuola, il discorso del duce pronunciato il 22 giugno 1925 fu esplicito: Il governo esige che la scuola si ispiri alla idealità del fascismo, esige che la scuola non sia, non dico ostile, ma nemmeno estranea al fascismo o agnostica di fronte al fascismo; esige che tutta la scuola, in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi insegnamenti, educhi la gioventù italiana a comprendere il fascismo e a rinnovarsi nel fascismo e a vivere nel clima storico creato dalla civiltà fascista60. La saldatura fra ideologia, Stato, partito e sindacato corporativo, che determinò la morte del libero associazionismo dei docenti, era già iniziata con la pratica imposizione di una Corporazione nazionale della scuola, trasformata, dopo tre anni, nel 1926, in Associazione nazionale insegnanti fascisti (Anif) e, nel 1931, in Associazione fascista della scuola, soggetto che riuniva docenti di tutti gli ordini, primario, secondario e universitario61. 58 S. Severi, L’essenza della solitudine. Vita di Dolores Prato, Sovera Editore, Roma 2002, p. 71. Cfr. E. Frontaloni, Cronologia, in D. Prato, Sogni, cit., p. XXXIII. 60 B. Mussolini, Scritti e discorsi, Hoepli, Milano 1934, vol. V, p. 217 e cfr. Katia Colombo, La pedagogia filosofica di Giovanni Gentile, Franco Angeli, Milano 2004, p. 162; inoltre vedi Mario Isnenghi, L’educazione dell’italiano. Il fascismo e l’organizzazione della cultura, Cappelli, Bologna 1973. 61 Jurgen Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-1943), La Nuova Italia, Firenze 1996, pp. 293-303. 59 28 Tornando a Prato, e al suo rapporto con il regime fascista, possiamo affermare che la sua esperienza fu diversa da quella della maggior parte degli insegnanti italiani, che, nel complesso, si adattò senza grosse resistenze alle direttive del regime, anche se la fascistizzazione fu spesso superficiale. Molti insegnanti, formatisi nel clima culturale della guerra, continuarono a svolgere il loro lavoro come avevano sempre fatto, senza concedere al Fascismo niente di più che un’adesione generica. Favorevoli o meno al Regime, avevano comunque, in gran parte, un giudizio positivo sull’attività dell’Opera Nazionale Balilla (ONB) e della Gioventù Italiana del Littorio (GIL). Diverse erano, invece, le sfumature di giudizio sul Fascismo nel suo complesso: alcuni, le donne soprattutto, erano affascinati dalla personalità dell’“Uomo” che aveva saputo restaurare l’ordine e la disciplina. Il concetto di Fascismo, per loro, coincideva con quelli di Ordine, Patria e Nazione, e in nome di questo nazionalismo sarebbero state accettate le guerre di espansione. Pochissimi le condannavano. Non mancavano, inoltre, coloro che, o per tradizione familiare o per convinzione acquisita, avevano subito visto i lati negativi del Fascismo, ma non erano riusciti a non rimanerne coinvolti. Dolores, invece, non nascose mai la sua avversione per il Fascismo, che, anzi, manifestò nei fatti, con “azioncelle piccole piccole”, come lei stessa le definisce, o “pazzie”. Un documento inedito, fra i tanti rintracciati durante la ricerca tra i materiali e gli scritti di Prato, a mio avviso un “testamento ideologico” di rara fattura, forse una delle pagine più significative e nascoste della scrittrice, ci svela una Dolores tenace e forte contro il potere, una donna che non ha mai fatto concessioni, e non ha mai smesso di lottare per seguire i suoi ideali. Vista l’importanza e la profondità delle riflessioni e dell’argomento, si riporta qui il testo integrale, conservato dai coniugi Ferri Ferrari. Comunicazione del dottor Fausto Coen contenente un pro-memoria di Dolores Prato Caro Zampa, se avessi potuto, come avrei tanto desiderato, unirmi a voi nel ricordo di Dolores Prato, mi sarei limitato a leggere questo breve pro-memoria trovato tra le carte che, insieme agli amici Ferrari, abbiamo salvato per affidarle al Vieusseux. Ti sarò grato se lo farai tu. Si tratta di un appunto che Dolores Prato aveva buttato giù alla caduta del fascismo, sollecitata, probabilmente, da amici che volevano aiutarla a trovare finalmente un lavoro all’altezza delle sue capacità. In questo appunto Dolores Prato racconta la sua pertinace ostilità al fascismo; è la modesta, oscura lotta di una piccola e coraggiosa donna degli anni Trenta. Oggi sembrano, tutto sommato, cose di poco conto, ma non lo so e ci aiutano, forse, anche a capire alcuni dei misteri della nostra cara amica scomparsa. Ti prego, leggilo tu, è breve. 29 “Carissimi, questo è il compito più difficile che faccio da che cominciai ad andare a scuola, perché confessare le proprie colpe è facile e fa bene all’anima, ma confessare i propri meriti avvilisce, tanto più quando i cosiddetti meriti sono azioncelle piccole piccole; io non so ciò che valgano, perciò racconto, più che per dire fatti da includere in un pro-memoria, perché voi conosciate una parte della mia anima. Incominciai l’insegnamento alle scuole medie superiori con l’avvento del fascismo e insieme cominciò la mia ostentata avversione per il fascismo. La scuola offriva un mezzo efficace e facile per fare quotidiana opera di raddrizzamento di idee, di critica, di condanna e per non lasciar morire il ricordo e la fede nella libertà. Ne approfittai in tutte le maniere, con presidi, con presidi consezienti e con presidi ostili. Nei due anni in cui ebbi l’incarico ministeriale, avendo in mano ogni mezzo per la nostra battaglia, con intima soddisfazione posso dire che non ne lasciai inoperoso alcuno: rifiuto di esporre la bandiera per i loro diversi annuali, rifiuto di mandare la scolaresca ad ingrossare i loro cortei, rifiuto di presenziare con la mia presenza le loro funeree commemorazioni, rifiuto di obbligare la scolaresca ad acquistare la loro stampa. Dopo due anni di incarico, ripresi l’insegnamento come supplente, continuando una lotta sempre più difficile per l’aumentata diffusione del morbo fascista. Dovetti aggiungere armi nuove alle vecchie, fu la volta dell’umorismo, della presa in giro, per esempio, un certificato medico comprovante un ascesso all’ascella destra per evitare il saluto fascista nell’occasione della visita del Ministro della Scuola. La vita nella scuola mi fu resa sempre più difficile, ma, finalmente, un concorso mi riuscì, mi riuscì splendidamente per esplicita dichiarazione della commissione esaminatrice, nel salutarmi alla fine della prova, confermata dalla prima stesura della graduatoria, ma, quando uscì il bollettino ufficiale, io risultavo in coda, neppure fra gli idonei. Il mistero lo svelò un impiegato del telegrafo, un fedele delle nostre idee, che, credendo di potermi salvare con la sua indiscrezione, mostrò la copia del telegramma che da Macerata era stato spedito a Roma perché la commissione esaminatrice fosse avvertita dei demeriti fascisti della candidata Dolores Prato. Altri anni di dolorosi tentativi per trovare un lavoro che non richiedesse un impossibile asservimento. Non seppi fare o non fui fortunata; non posso giudicare io, mi fa velo la miseria, la fame, non metaforica, il pianto, l’abbandono di tanti anni che non cerco di contare per rabbrividire, di anni del lavoro, della vita, assassinati. Al colmo della stanchezza non cercai più, mi adattai a fare l’infermiera a un’inferma di mente; non mi sarebbe mancato il vitto e l’alloggio e intanto mi illudevo di poter preparare dei lavori da pubblicare, a fascismo caduto, e non sapevo che, vivendo sola, a contatto continuo con una pazza lucida, è un’utopia pensare di lavorare; è già tanto se non si impazzisce. Da tredici anni io vivo così, eppure sono riuscita anche ad abbozzare dei lavori, a coordinarli certo no, e ad aspettare la liberazione. E anche in questi lunghi anni non ho cessato un istante di resistere al fascismo e di offenderlo come potevo. 30 Il bisogno di guadagnare e il desiderio di uscire da questa vita deprimente non mi hanno mai spinto a pubblicare un lavoraccio per ragazzi che avrebbe avuto successo, solo perché, dovendo operare alcuni tagli, ne sarebbe derivata una certa simpatia per la monarchia; eppure avevo tanto bisogno di guadagnare. Lasciai pure cadere la proposta di un giro nella Spagna, perché gli articoli avrebbero dovuto comparire sul quotidiano “regime fascista” di Farinacci. Incontrata per caso una persona vicinissima a Mussolini, che si mise a mia disposizione per tutto ciò che io volessi, invitandomi insistentemente a Palazzo Venezia, io mai risposi, benché la gente ben pensante mi dicesse che, così sola e povera com’ero, disprezzare simile occasione era pazzia. Ebbene, io commisi infinite volte di queste pazzie. In questi ventidue anni di passione, ho avuto minacce di olio di ricino, di manganello e pericolo, miracolosamente sventato, di perquisizione; bench’io non sia di razza ebraica, per il mio nome che appartiene anche a gente israelita, ebbi seccature e noie. Neppure una volta ho fatto il saluto fascista, anche se incontravo quei loro minacciosi cortei impennacchiati dalle funebri banderuole; mai un applauso, anche se capitavo per caso in mezzo a frenetici applaudenti; mai una volta, neppure per curiosità, ho ingrossato, con la mia persona, le loro incoscienti adunate. Ma, sempre, con commenti, con ostentate espressioni di disprezzo, col chiaro e tondo voltar le spalle, cercavo di distinguermi dai servi, rispondevo con sferzate se mi davano del voi, dopo che questo fu comandato. Da famiglie ben pensanti fui radiata perché non mi rassegnavo a evitare la risata o la frecciata antifascista; la paura della gente crebbe tanto che io avevo cominciato con lo scrivere sui muri, dato che parlare non si poteva proprio più. E’ poco, lo so, ma concessioni non ne ho fatte; non potevo lottare che così”. Concessioni, Dolores Prato non ne ha fatte a nessuno, non soltanto al fascismo che visceralmente odiava, ma nemmeno a tutto ciò di cui non era persuasa, nei principi come nei gusti o nelle mode, nelle cose grosse e nelle piccole. Credo che il suo “cattivo carattere”, insieme alle sue doti naturali di vera scrittrice, vada oggi ricordato; si dice cattivo carattere per la riluttanza ad ammettere che una persona ha semplicemente carattere. E’ un aggettivo che tradisce il dispetto di dovere ammettere negli altri questa rara e preziosa qualità. Il breve pro-memoria della Prato è un pezzo di tristissima storia patria. C’è un antifascismo con l’a maiuscola, entrato ormai nei libri di storia, rievocato dal cinema e dalla televisione, che si esprime negli illustri nomi di coloro che seppero dire di no e abbandonarono l’Italia, ma c’è anche un antifascismo piccolo, modesto, sconosciuto, che, chi ha vissuto quegli anni, sa che non è meno eroico, perché non aveva nemmeno il conforto della notorietà. Il pro-memoria di Prato ci aiuta, forse, a spiegare anche i lunghi anni che hanno inaridito un felice 31 estro narrativo in una ossessionante inattività coatta, che hanno fatto perdere occasioni importanti e disperdere energie, impedendo il realizzarsi di quello che, solo molto più tardi, si è potuto realizzare e che, forse, le hanno fatto intraprendere, per molto tempo, strade diverse da quelle che, così sicuramente, in un Paese libero e civile, Dolores Prato avrebbe potuto imboccare. E questo documento offre anche la “soluzione” dell’enigma che ancora caratterizza la figura di Dolores Prato, riguardante le sue origini. Prato ebrea o no? Verità o finzione? “In questi ventidue anni di passione, ho avuto minacce di olio di ricino, di manganello e pericolo, miracolosamente sventato, di perquisizione; bench’io non sia di razza ebraica, per il mio nome che appartiene anche a gente israelita, ebbi seccature e noie”, si legge nel documento appena riportato. E l’enigma è definitivamente sciolto. Significativo, per concludere compiutamente questo excursus sulla lotta di Prato contro il Fascismo, può essere anche il passo di una lettera che Dolores scrisse a Capocaccia nel febbraio del 1945 riportato, e contestualizzato, da Elena Frontaloni nella dettagliata Cronologia che introduce i Sogni di Dolores, in cui la scrittrice esprime il suo aspro giudizio sugli intellettuali fascisti riciclatisi, tra Liberazione e immediato dopoguerra, al nuovo clima politico: Crederò al rinnovamento intellettuale della nostra povera gente solo quando non sentirò più i vecchi nomi, e ne sentirò dei nuovi … Purtroppo però i vecchi nomi sono ancora ricercati perché la mentalità piccoloborghese degli italiani è un fatto costituzionale e si ha paura del nome nuovo … Sta attento, Doni, chiudi il cuore e apri solo il cervello. E’ doloroso, lo so, ma questo dobbiamo fare se vogliamo sopravvivere dopo la nostra agonia lunga come il centro della nostra vita, altrimenti rivivranno questi uomini che vissero allora, vivono ora, solo perché non soffrirono mai come noi soffrimmo! E questo è vero anche se qualcuno di loro può presentare una piccola persecuzioncella, un partigiano ospitato, un silenzio subito. Allora bisogna chiedere: la data! 1939…1940…1941…1942…troppo tardi signori! Allora era facile essere antifascista!62 62 in D. Prato, Sogni, cit., p. XXXIV. 32 IV - Dolores Prato e Rina Faccio/Sibilla Aleramo: un confronto Per completare il quadro d’insieme sulla vita di Dolores Prato e la formazione della sua personalità e del suo pensiero, può essere interessante tentare un paragone con una scrittrice che ha avuto maggiore fortuna e notorietà: Sibilla Aleramo. Perché Prato e Aleramo? Perché come tratto di comune via all’emancipazione hanno quello di essere state giornaliste, anche se in tempi e modo diversi, e perché hanno avuto un legame cruciale con le Marche e la provincia di Macerata. Perché sono state entrambe scrittrici, ma anche giornaliste, e simboli diversi, assolutamente significativi, di quel viaggio lento, difficile e probabilmente incompiuto, ma sicuramente “magico”, che è stata le storia delle donne nel passaggio tra Otto e Novecento63. E’ in quest’ottica inedita, infatti, che la presente ricerca si propone di ripercorrere, e in qualche modo comparare, la vita di queste due donne. Due donne che si sono sempre sentite “diverse”, segnate, l’una consciamente (Sibilla), l’altra forse a livello inconsapevole (Dolores), dal doloroso processo dell’emancipazione femminile, che ha come spezzato in due le loro esistenze: da giovanissime, intrappolate in una gabbia sociale in cui, a cavallo fra i due secoli della contemporaneità, si entrava inermi, quasi fosse un’adesione “secondo natura”, a donne che si rivoltano alle rispettive condizioni. Sibilla Aleramo anche fisicamente, lasciando marito, figlio, e la città in cui era prigioniera (Porto Civitanova) alla ricerca della libertà personale e artistica; Dolores Prato prendendo in mano la sua formazione intellettuale e politica dopo aver conosciuto un uomo del Partito comunista italiano, l’avvocato Domenico Capocaccia, ed essersi trasferita a Milano, da San Ginesio, per seguirlo, oltre che per andare a insegnare all’Accademia Libera di Cultura e Arte del pedagogista Vincenzo Cento. Entrambe hanno vissuto credendo profondamente nel pacifismo, entrambe sono state antifasciste (Dolores tutta la vita, e convintamene; Sibilla no, tanto che, negli anni del regime, arrivò a chiedere più volte aiuto a Mussolini per le sue difficoltà economiche, e a iscriversi all’Associazione nazionale fascista donne artiste e letterate), e alla fine entrambe si sono riconosciute, seppure in modo diverso, e con una diversa consapevolezza, nel Partito comunista italiano. Ad avvicinare i due profili anche un livello intimo-familiare marcato dalla solitudine: Dolores, come abbiamo visto, non conobbe mai l’affetto e la presenza di una famiglia, neanche quella di origine, e non costruì mai una relazione stabile con nessuno; Sibilla, con alle spalle una famiglia di quattro figli, segnata dall’adulterio del padre e dall’internamento della madre (poi suicida) nel 63 Cfr. Anna Bravo, Margherita Pelaja, Alessandra Pescarolo, Lucetta Scaraffia, Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2001. 33 manicomio di Macerata, cercò comunque di restare nei ranghi delle convenzioni sociali di fine ‘800, e di una realtà piccola e di provincia come quella di Porto Civitanova, sposandosi e diventando madre. Ma alla fine decise di seguire la sua natura libera, andandosene e allontanandosi dal figlio. E sebbene la sua vita sia poi stata costellata di relazioni sentimentali, passioni, amori, morì sola. Queste due donne, insomma, che in prima analisi potrebbero sembrare due universi fra i più distanti, in effetti potrebbero dirsi unite dall’aver affrontato i delicati e rivoluzionari passaggi culturali, sociali, politici di Otto e Novecento con una tenacia fuori dal comune, ciascuna vivendo come due vite, con un confine segnato da una rottura ben definita. Ma partiamo dal tratto “territoriale”, maceratese, e d’origine. Il legame tra Prato e Treia e San Ginesio, come abbiamo visto, era viscerale, sentimentale e “reale”, nel senso di fortemente ancorato alle cose materiali, alle strade, alle piazze, ai panorami, alle case, alle pietre. Era un rapporto simbiotico privilegiato, che prescindeva dalle persone, in cui esse intervenivano, anzi, quasi in modo superficiale. Talmente questi due paesi segnarono la sua esistenza, che la scrittrice ne fece i protagonisti degli unici romanzi compiuti e pubblicati mentre era in vita, seppure con tutti gli incidenti, i tagli e le insoddisfazioni, differenti (ma sempre presenti) da caso a caso. Ovviamente, uno squilibrio di “amorosi sensi” rendeva Prato molto più vicina a Treia rispetto a San Ginesio, ma di queste relazioni fra Dolores e i luoghi parleremo in dettaglio più avanti. Quanto alla realtà familiare di Prato, il suo sentirsi “bastarda integrale”64, anche in senso proprio, non avendo né un padre né una madre riconoscibili in quel ruolo, e la sua solitudine derivante dall’abbandono, permearono tutta la sua vita e la sua produzione scritta e, forse, furono anche la causa più o meno conscia della infelice vita sentimentale della donna. Dolores non solo non si sposò e non ebbe figli, ma non visse mai relazioni amorose chiare, serie, tanto che è difficile sapere e capire quali siano stati in realtà gli uomini che hanno condiviso con lei qualche tratto di vita, e in che modo l’abbiano fatto: Capocaccia, Gaggero, Toschi, sono stati storie insolute, vissute in modo totale da Dolores, con gradi di profondità diversi, in nessun caso ricambiate con la stessa intensità. Diversa l’inferenza dei luoghi nella vita della giovane Rina Faccio. Arrivò in treno da Milano a Porto Civitanova nel luglio del 1888, quando aveva 12 anni, e con lei arrivarono suo padre Ambrogio, ingegnere, e sua madre Ernesta Cottimo, casalinga, le sorelle Jolanda e Corinna e il fratello Aldo. L’armonia del paesaggio del luogo in cui stava andando ad abitare la incantò: Sole, sole! Quanto sole abbagliante! Tutto scintillava, nel paese dove io giungevo: il mare era una grande fascia argentea, il cielo un infinito riso sul mio capo, un’infinita carezza azzurra allo 64 D. Prato, Giù la piazza, cit., p. 687. 34 sguardo che per la prima volta aveva la rivelazione della bellezza del mondo. Che cos’erano i prati verdi della Brianza e del Piemonte, le valli e le Alpi intraviste ne’ miei primi anni, e i dolci laghi ed i bei giardini, in confronto di quella campagna così soffusa di luce, di quello spazio senza limite sopra e dinanzi a me, quell’ampio e portentoso respiro dell’acqua e dell’aria?65 Ma da subito Rina si accorse di essere arrivata in un piccolo borgo, una “cittaduzza” che l’avrebbe presto soffocata. Se la vita sociale ed economica di Civitanova e del Porto aveva una sua vivacità, infatti, le attività culturali sembravano del tutto assenti, e non c’erano scuole al di sopra delle elementari. Impiegata fin da giovanissima nella fabbrica di bottiglie del padre, Rina venne a contatto personalmente con il mondo operaio, e lasciò gli studi, riprendendoli poi da autodidatta. La sua formazione afferiva al mondo del lavoro, con la particolare venatura positivistica e anticonformista che derivava da una famiglia in cui il padre era un professore di chimica e scienze un po’ fuori dalle righe: Mio padre, scienziato ed ateo, aveva ereditato da mio nonno, mazziniano, alcuni concetti morali, sincerità, lealtà, onestà, libertà […] E ad essi uniformava la propria esistenza, e dai miei primissimi anni me li trasmise, come una specie di religione, umana religione, unitamente a un senso panteistico e commosso di tutte le cose66. La madre aveva lasciato in lei un altro tipo di impronta: Mi veniva da lei quella pavida sensibilità tutta femminea, gelosa e quasi morbosa, quell’inclinazione al sogno alla chimera al mito, quel segreto anelito al ritmo, quell’istinto profondo di dedizione, per i quali, fin d’allora, fanciulletta […] io ero un fremente embrione della donna che poi son stata e ancora sono67. Questi erano i tratti della giovane donna che tentò di iscriversi alla Società del tiro a segno civitanovese, ma che il prefetto, con decreto, non accettò in quanto minorenne (e tacitamente in quanto donna), e che praticava il nuoto per sentire quel senso di autonomia e di libertà che esaltava la sua persona, in un’epoca in cui le ragazze si limitavano a bagnarsi appena sulla riva del mare. 65 Sibilla Aleramo, Una donna, Gruppo Editoriale L’Espresso, Milano 2003, p. 16. Sibilla Aleramo, Un amore insolito. Diario 1940-1944, Feltrinelli, Milano 1977, p. 43. 67 Sibilla Aleramo, Esperienze d’una scrittrice, in Andando e stando, a cura di R. Guerricchio, Feltrinelli, Milano 1997, p. 3. 66 35 Facendomi cullare dall’onda per ore ed ore sotto il sole ardente, sfidando il pericolo coll’allontanarmi a nuoto dalla riva fino a non esser più visibile, io mi unificavo con la natura e 68 sfogavo insieme l’esuberanza del mio organismo . Ma proprio nella città della costa maceratese Rina, a soli 17 anni, sposò Ulderico Pierangeli, dipendente nella sua stessa fabbrica, l’uomo che l’aveva violentata: un matrimonio riparatore della “tragedia silenziosa” che l’aveva vista protagonista. Subito dopo aveva lasciato il posto nella vetreria, ottenendo dal padre una modesta rendita e continuando a svolgere, in casa, piccoli lavori di contabilità per la ditta. Rina aveva poi dovuto affrontare il trauma del tentato suicidio della madre, che, una mattina del 1890, si era lasciata cadere da un balcone; aveva rotto il rapporto con il padre quando aveva scoperto che questo aveva un’amante, ed era stata cacciata dalla fabbrica perché lo aveva giudicato. Ma questa stessa donna aveva una concezione moderna della famiglia, e rimase letteralmente impressionata alla messinscena del dolore da parte dei familiari quando il 25 marzo 1895, otto giorni prima che nascesse suo figlio, morì il suocero: “appresi la retorica del lutto”69. “Nel paese regnava una grande ipocrisia”70. In questo punto profondo è il solco che divide Faccio da Prato: per Dolores, infatti, i gesti, i rituali, le “retoriche paesane” erano simbolo del mondo della sua infanzia felice, del mondo che a lei piaceva e a cui si sentì legata fino alla fine. Ma torniamo a Porto Civitanova, dove il 2 aprile 1895 nacque Walter. Rina, a poco a poco, prese coscienza del fatto che la maternità stava spegnendo in lei ogni progettualità, le stava procurando “un’incapacità sempre maggiore di vedere, di volere, di vivere”. Era la deficienza fondamentale della mia vita che si faceva sentire. In me la madre non s’integrava con la donna: e le gioie e le pene purissime in essenza che mi venivano da quella cosa palpitante e rosea, contrastavano con un’instabilità, un’alterazione di languori e di esaltamenti, di desiderii e di sconforti, di cui non conoscevo l’origine e che mi facevano giudicare da me stessa un essere squilibrato e incompleto71. Importante questo difficile rapporto con la maternità - altro passaggio cruciale tra Otto e Novecento - vissuto da entrambe le scrittrici-giornaliste. Per quanto riguarda Faccio/Aleramo si tratta di un nodo indagato più e più volte, sia da lei stessa, a partire dal romanzo-manifesto Una donna72, sia dalla critica a lei contemporanea e successiva. Quando lasciò dietro di sé il figlio di sei anni, Rina conosceva la legge, e sapeva che difficilmente 68 S. Aleramo, Una donna, cit., p. 29. Ivi, p. 56. 70 Ivi, p. 56. 71 Ivi, p. 63. 72 pubblicato nel 1906 dalla Sten (società tipografico-editrice nazionale) di Torino, dopo essere stato rifiutato sia da Treves che da Baldini & Castoldi. 69 36 avrebbe potuto riaverlo, ma non voleva continuare a vivere con un uomo che non amava e che non stimava (e che l’aveva stuprata) in nome del figlio. Le pagine del suo libro, fin da subito un caso letterario, sollecitavano la riflessione proprio su temi cruciali come il valore sociale della maternità, il contrasto ragione-sentimenti, il rapporto con l’uomo e la sessualità, la dipendenza economica nel matrimonio, la prostituzione dell’anima e quella del corpo, il diritto alla felicità. La scelta di abbandonare la casa coniugale, correndo il rischio di perdere il figlio veniva presentata, nel libro, come una difesa della dignità della donna e della madre, una doverosa ribellione in nome del diritto alla felicità e alla libertà personale. Rina rimase povera: dopo che il marito le aveva negato l’autorizzazione a ricevere un’eredità, poteva contare solo su collaborazioni saltuarie a riviste e giornali. Aveva dalla sua fascino, intelligenza, nonchalance verso le difficoltà materiali, grandi capacità di scrittura, coraggio. Attraverso questa lunga iniziazione Faccio si preparava a diventare Sibilla Aleramo. Con il figlio, spesso invocato nella scrittura e spesso rimpianto, non riuscì mai a ricucire il filo interrotto. Morì sola, sorretta dall’idea di una fratellanza con gli sfruttati mediata dall’adesione al Partito comunista. In Dolores Prato, il rapporto con la maternità è un’acquisizione nuova, che nel presente lavoro prende spunto da uno stralcio di una lettera che Prato scrisse a Luciano Moretti, suo allievo prediletto a San Ginesio, nel 1941, in occasione della nascita di Paolo, primogenito di questi. Se un giorno l’agio di tante ore serene che ci lasciassero vicini mi portasse a dire il fondo di quella mia tragedia della quale in genere dico solo qualche episodio esteriore, dovrei confessarvi che tutto il mio fallimento, tutto il mio disumano dolore hanno la loro causa nel non aver avuto un figlio. Quando ho capito che era necessaria questa rinuncia se non volevo dare a lui la vita che altri ha dato a me, vita fuori legge, bella come dono in sé perché frutto di un grande incontro primitivo e naturale, ma orribile nella serie infinita delle contingenze quali la società ce le impone, allora io credo che veramente fui finita. E odiai tutti i bimbi che vedo e che non conosco, adorai tutti quelli che corteggiavano un poco la mia vita. Sono ancora abbastanza intelligente per non capire che quell’odio è amore andato a male73. Altro brevissimo accenno si trova in una lettera al magistrato Torquato Ferrari: La gioia profonda me la dà solo la creazione. Me l’avrebbe data un figlio, ma un figlio mio, non uno trovato74. Dolores non parlava mai della sua mancata maternità, dei figli che non aveva avuto. E per questo sembrano ancora più preziosi i manoscritti – poche pagine – che Ines Ferri e Filippo Ferrari hanno selezionato, proprio per questo lavoro, sull’argomento. In un primo stralcio, che Prato stessa aveva 73 Lettera del fondo Ferri-Ferrari. Il riferimento è a Andrea Gaggero, e al loro strano multiforme rapporto, che prevedeva anche una declinazione madre-figlio. 74 37 intitolato Figli, è riportata proprio la lettera a Moretti, ma con l’aggiunta di un’introduzione altrettanto importante: Quassù, a Monte Cavo, mi è venuta la buona novella…Olga e Luciano aspettano un bimbo. Anche io l’ho tanto aspettato!!! Ecco alcune parti della lettera che, stamani, appena giorno, ho scritto a Olga…(se la leggesse chi mi sente sempre dire male dei bimbi…chi mi vede voltar la testa dall’altra parte per non guardarli!)75 Un altro foglio, invece, contiene una riflessione che vede protagonista Doni (come Dolores chiamava Domenico Capocaccia), e che rivela anche come la relazione con l’avvocato fosse importante per lei, tanto da farle pensare a un figlio. Quando ancora sognavo di avere un figlio pensavo sempre che nel periodo di “attesa” avrei parlato in plurale - Doni, ti prego, vieni tu vicino perché noi non possiamo muoverci. - Noi abbiamo sete - Noi ti amiamo tanto E avrei preteso che gli altri mi avessero dato del “voi” - Volete questo fiore? - Se non vi disturbo ecc. Unico caso in cui dare del “voi” è giusto. Unico caso in cui parlare col “noi” è giusto. Difatti quando mi sento dire col “voi” mi pare di essere doppia. In calce, nella stessa pagina, Dolores scriveva anche, alludendo a un progetto di scrittura in cui, probabilmente, avrebbe voluto affrontare il periodo di maturità della sua vita (dopo l’infanzia e l’adolescenza trattate in Giù la piazza e in Le Ore): Nel mio lavoro introdurre questo atteggiamento creando con grazia una scena di finzione nel tempo in cui amavo in cui immagino di essere incinta e recito la parte del noi e del voi. Considerazioni estemporanee, con le quali non è possibile tratteggiare un pensiero pratiano nei confronti di un argomento tanto importante, quale è quello dei figli e della maternità, che invece Sibilla Aleramo ha indagato in profondità, pur se dolorosamente, e lungo tutto il corso della sua vita. Unica sfumatura che si potrebbe azzardare, pensando a Prato, è che il fatto stesso che la scrittrice non abbia mai affrontato la questione, così importante nella vita di una donna, in qualunque modo la si pensi, è un sintomo di quell’atteggiamento ingenuo, quasi infantile, che ha caratterizzato il suo modo di affrontare le relazioni sentimentali e, in generale, i rapporti con gli altri. Forse è il segno di una Dolores mai cresciuta, in realtà, nel modo di relazionarsi con le 75 Fondo Ferri-Ferrari. 38 persone, a fronte di un atteggiamento contrario quando si trattava di osservare il mondo, la società, la storia e i cambiamenti: uno sguardo acuto, curioso, profondo, mai banale, preparato, unico. Sicuramente Prato e Aleramo hanno vissuto ponendo un’attenzione particolare ai loro sentimenti non per forza storie sentimentali – e ricercando e inseguendo un proprio credo, religioso, politico o estetico che sia. A proposito di Rina/Sibilla: La sofferta convivenza con il marito non le aveva impedito di dedicarsi ai suoi interessi culturali di cimentarsi con la scrittura di articoli e novelle. Nel 1898 era una giovane promessa del giornalismo e del femminismo. Dopo essersi separata dal marito e dal figlio nel 1902, Rina iniziò una convivenza con il poeta Giovanni Cena. Nel 1906 pubblicò un libro che fece scalpore, Una donna: vi difendeva, in nome di tutte le donne, il diritto di seguire la propria vocazione, di essere autonoma e padrona di sé, anche a costo di rinunciare al figlio. Quel libro rappresentò l’inizio di una nuova vita, l’assunzione di una nuova identità, quella di Sibilla Aleramo, lo pseudonimo con cui aveva firmato la sua opera. Alla ricerca della libertà sia personale sia artistica, spesso vissuta all’insegna dell’eccesso e della trasgressione, rimase fedele tutta la vita76. Gli amori di Sibilla non furono mai tenuti nascosti, neanche quando la passione fu per una giovane intellettuale ravennate, Lina Paoletti77, o per l’attrice Eleonora Duse, o quando furono brevi, come quelli, tra gli altri, con Vincenzo Cardarelli, Giovanni Papini, Giovanni Boine, Umberto Boccioni, Salvatore Quasimodo, Julius Evola78. La realtà è questa: ch’io ero nata per ascoltare e per tradurre certe voci dello spirito; ero nata per un’opera che mi trascendeva, obiettiva quanto può esserla l’opera poetica.79 E con la stessa chiave di lettura, quella che parte dalla consapevolezza di essere di fronte a una donna “nata per tradurre certe voci dello spirito”, “nata per un’opera” che la “trascendeva”, si può ricostruire la continua ricerca di un credo, laico, di Aleramo. Il percorso del pensiero politico di Sibilla, se di qualcosa di simile si può parlare, ha un tracciato impervio e spesso contraddittorio: femminista, pacifista, fascista, ma subito dopo il 1945 convinta comunista, iscritta al Pci, impegnata attivamente nel partito e collaboratrice dell’“Unità”. Nonostante la sua adesione al Futurismo, che in politica finì per pappoggiare correnti 76 E. Scaramuzza, La santa e la spudorata. Alessandrina Ravizza e Sibilla Aleramo. Amicizia, politica e scrittura, Liguori Editore, Napoli 2007, pp. 4-5. 77 In seguito diventata l’amante di Eleonora Duse. 78 Da due delle sue storie sono anche nati due romanzi epistolari: l’amore per Giulio Parise, condirettore della rivista “Ur”, è descritto nella raccolta di lettere Amo dunque sono (Mondadori, 1927), mentre quello tormentato e passionale vissuto con il poeta Dino Campana è stato pubblicato nel 2000, da Feltrinelli, nel libro Un viaggio chiamato amore. Lettere 1916-1918. 79 Conti Bruna, Morino Alba (a cura di), Sibilla Aleramo e il suo tempo. Vita raccontata e illustrata, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 85-86. 39 nazionalistiche ed interventiste, Sibilla dimostrò di non abbandonare mai il suo credo femminista e il pacifismo che ne derivava. Molti furono gli articoli, come quelli scritti in occasione della guerra di Libia o della prima guerra mondiale, in cui rese nota la sua voglia di estraneità ai conflitti, additando gli uomini come unici colpevoli, poiché incapaci di mettere a tacere il proprio istinto di conquista e l’odio verso le altre razze80. Il fervore femminista, la sua militanza, intanto, si addolcivano: prendeva forma la donna letterata che si ergeva a paladina delle donne. Quando venne il regime fascista, Sibilla sembrò avvicinarsi all’antifascismo, firmando il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, ma in realtà, negli anni tra le due guerre, si trovò in più occasioni a chiedere aiuto al duce in persona, e, avendo ottenuto un vitalizio, a rendere omaggio al regime (ad esempio con le poesie Visita a Littoria e Sabaudia, nel 1934). Di fatto, però, la sua attenzione ai problemi sociali e al femminismo nasceva da un senso personale di giustizia maturato sin dalla gioventù, e la denuncia dell’oppressione non corrispondeva a una reale maturazione e coerenza politica81: soltanto nel secondo dopoguerra si iscrisse al Pci, dedicandosi poi a un impegno politico e sociale sempre più intenso, che la portò a fare lunghi viaggi nei Paesi dell’Est, a collaborare con le Case del popolo e i circoli ricreativi legati al partito. Negli ultimi anni della sua vita, Sibilla affermava di sentirsi finalmente libera di errare, di vivere come se fosse possibile tutto ciò che era impossibile, e di sentirsi sollevata dalla necessità dell’amore82. Tutto questo si sublimava nella militanza nel partito: Ora sono libera per sempre dall’amore, amore per un singolo, ma vivo, come allora, per un’idea83. La mia adesione mi vien dettata dalla coscienza di compiere un dovere, e insieme rappresenta per me come il coronamento della mia vita di scrittrice e di donna. Tutta la mia opera di quarant’anni è stata ispirata dalla fede in un più giusto e più umano avvenire della nostra specie: della nostra specie tutta quanta, uomini e donne di tutta la terra. Ho lavorato fin dalla prima giovinezza, non soltanto per la redenzione della femminilità, per l’affermazione di un’autonoma spiritualità femminile, ma anche perché il popolo venisse elevato a un’esistenza degna (…) Ed io, poeta e donna desidero di far parte di questa grande comunità84, che mi conferma la mia visione antica di un mondo in cui ogni persona viva e operosa sarà in grado di sentire l’esistenza e lo stesso lavoro sotto specie di poesia85. Sibilla, sebbene lontana dalla riflessione politica capace di elaborare soluzioni valide e concrete, ma, piuttosto, legata a un certo idealismo, visse comunque un impegno politico e una vicinanza al 80 cfr. Piera Forni, Sibilla e Rina: l’Aleramo tra giornalismo e letteratura, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2005, p. 10. 81 Ivi, p. 11. 82 Ivi, p. 73. 83 Alba Morino (a cura di), Diario di una donna. Inediti 1945-1960, Feltrinelli, Milano 1978, p. 229. 84 quella del partito. 85 In A. Morino, Diario, cit., pp. 74-75. 40 Pci a cui Dolores non arrivò mai, tanto che, nonostante avesse richiesto la tessera più volte, l’iscrizione non le venne mai concessa. Al contrario, Sibilla venne iscritta nel febbraio del 1946, e in seguito si legò molto a Palmiro Togliatti, ma anche a Giancarlo Pajetta, Umberto Terracini, Pietro Ingrao, Nilde Jotti e Concetto Marchesi, e incontrò Italo Calvino, Cesare Pavese, Giorgio Bassani, e ancora Cesare Zavattini, Elio Vittorini, Ada Gobetti, Natalia Ginzburg. Proprio fra le amicizie si cela un contatto tra Prato e Aleramo. Il primo biglietto di Dolores a Concetto Marchesi, ad esempio, cui seguì una corrispondenza subito confidenziale tra il 1948 e il 1950, è datato giugno 194786, dunque negli stessi anni in cui Marchesi era in contatto con Sibilla. Anche la conoscenza da parte di Dolores di Umberto Terracini, senatore del Pci, sua moglie Marialaura e il figlio Massimo Luca, avvenuta tramite Andrea Gaggero, risale al 195487, e, quindi, verosimilmente nello stesso periodo in cui esisteva una frequentazione fra il senatore e Sibilla. Il fatto poi che Aiutatemi a dire, libro di poesie di Sibilla, presentasse una prefazione di Concetto Marchesi e due disegni di Renato Guttuso88, entrambi nella cerchia di amici di Prato (Guttuso frequentava, come Dolores, la “Casa Rossa” dello scultore Giuseppe Mazzullo, ritrovo di molti intellettuali romani), apre un’altra possibilità di incontro fra le due. Di sicuro Dolores aveva incontrato Sibilla nel salotto letterario di Paolo e Ebe Toschi, a metà degli anni ’50, e ne scrisse al suo amico Torquato Ferrari: Io l’ho sempre disprezzata, tanto che ho rifiutato di darle la mano. Si atteggiava a sinistra, ma in realtà era mantenuta dagli industriali. E’ stata per anni ospite di Pirelli: esibiva le pellicce regalatele e che poi vendeva; e di casa Savoia: sosteneva di dover scrivere un libro, il che le consentiva di passare mesi e mesi a capri a loro spese. Con Franco Matacotta89 aveva, accanto a dei formidabili litigi, trasporti estatici persino ridicoli, specie nel periodo in cui vissero a via Margutta. Mi raccontò Pino90 una volta andando a trovarli nella stanzona che dividevano sopra i tetti, dopo che si erano riappacificati e dopo una delle loro fragorose rotture, fu accolto dai loro sorrisi beati e da queste parole: “Peccato che non c’eri al tramonto: avessi visto che volo di colombi nel cielo”. Volo di colombi! Erano Piccioni di sicuro, quegli stessi che gli cacavano nella stanza91. Dunque anche se universi molto distanti, quelli di Sibilla e Dolores si sono sfiorati: le due hanno vissuto a Roma contemporaneamente, frequentato entrambe uomini (a volte gli stessi), di spicco della politica e della cultura nella capitale degli anni Quaranta e Cinquanta (Aleramo, oltretutto, aveva un rapporto di amicizia con la mondana Berenice, al secolo Jolena Baldini, giornalista di 86 S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 40. Ivi, p. 64. 88 Edizioni di cultura sociale, Roma 1951. 89 Poeta, giornalista e insegnante di italiano. 90 Pino Brunamontini che, come Matacotta, era originario di Fermo. 91 S. Severi, L’essenza della solitudine, cit., p. 116. 87 41 “Paese Sera”, collega di Dolores). Altra considerazione nuova che si può fare, stabilendo un contatto tra Dolores Prato e Sibilla Aleramo, è quella relativa al loro ruolo nella società del Novecento in quanto giornaliste. Se, infatti, l’attività di Aleramo giornalista è in qualche modo conosciuta e studiata, quella di Prato è stata completamente dimenticata fino ad oggi, tanto che non esistono tracce e studi sulla sua produzione giornalistica, seppur significativa. Dolores Prato è stata soffocata da infelici vicende editoriali, tanto che fu una scrittrice “emergente” a quasi novant’anni. Ma dalla fine della seconda guerra mondiale fu anche giornalista, pubblicista, collaboratrice di importanti testate nazionali e periodici locali. I suoi articoli furono ospitati prevalentemente dalle pagine di “Paese Sera”, ma alcuni pezzi uscirono anche su “L’Osservatore Romano”, “Il giornale d’Italia”, “Il Globo”, “Nuova Repubblica”, “Il Quotidiano”, organo dell’Azione Cattolica, e dal settimanale cattolico “La Via”. Sibilla Aleramo, nota più che altro come scrittrice e poeta, cela un percorso giornalistico molto interessante, quello che da fervente femminista la trasforma in femminile e altro. Per la conquista del successo nel giornalismo Rina Faccio dovette attendere i primi mesi del 1899, quando le fu affidato il compito di organizzare l’Inchiesta sul femminismo, promossa dall’avvocato Guglielmo Gambarotta, convinto sostenitore dell’importanza del femminismo nella riforma del diritto da lui auspicata. La sua carriera di giornalista l’avrebbe condotta ad essere direttore del settimanale milanese “Italia femminile”, e in seguito a collaborazioni importanti con “l’Unità” e “Noi donne”, con “Vita moderna” e “il Marzocco” di Firenze, dopo essere passata anche sulle pagine di periodici fascisti. I suoi primi articoli femministi erano comparsi su “Cordelia”, giornale di un moderato emancipazionismo, “Cronache del Rinascimento etico-sociale”, foglio mensile dell’Unione Morale, “Vita Internazionale”. Nei primi anni trascorsi a Civitanova, Rina si era gettata nella lettura, e a sedici anni vide pubblicato il suo primo articolo su “L’Ordine” di Ancona, il 26-27 luglio 189292. Era una “cronaca mondana” della “colonia bagnante” da Porto Civitanova, che aveva come modello di riferimento gli articoli che D’Annunzio andava pubblicando in quegli anni sulla “Tribuna” di Roma. Uscirono poi su “La Sentinella” di Osimo i primi racconti pubblicati da Rina: Reseda: Leggendo (18 agosto 1892) e Reseda: Dall’album di una vecchia signora (1 settembre 1892)93. In autunno Rina inviò delle “scenette di famiglia” all’editore Treves di Milano, ma la pubblicazione venne rifiutata. Nel luglio 92 Sul ritaglio originale, conservato presso l’Archivio dell’Istituto Gramsci, compare scritto di pugno dalla Aleramo “il mio primo articolo”. 93 A queste prime prove narrative di Aleramo ha dedicato un’esauriente analisi critica Rina Guerricchio nella sua Storia di Sibilla, Nistri-Lischi, Pisa 1974. 42 del 1893 uscirono altri articoli di Faccio su “La Sentinella”: Beata solitudo sola beatitudo, il 5 luglio, firmato Nira, e Sulla spiaggia marchigiana, il 13 luglio94, in prima pagina, non firmato ma riconducibile a lei, con cui invita signore e signorine romane (“care luminose stelle della vita”) a trascorrere qualche giorno a Porto Civitanova in riva al mare, come l’anno prima, e magari negli stabilimenti balneari di “due buoni vecchietti”: da Sante e da Ferraretto. Rina scrive con pseudonimi di Nira o Reseda. La rivelazione dello pseudonimo di Rina, così come quello di suo marito Ulderico Pierangeli (Rico) viene fatta da Giuseppe Natalucci sulla “Sentinella” del 26 gennaio 1893 proprio in occasione del matrimonio dei due (che si erano sposati il 21 gennaio): Fa freddo e nevica […] Chi di questi giorni se ne sta realmente bene è il nostro amico e collega in giornalismo Rico (al secolo Ulderico Pierangeli) il quale univasi jeri (l’articolo è datato 22 gennaio) in matrimonio con la gentile, colta e leggiadra Sig.a Rina Faccio, anche essa collaboratrice della Sentinella sotto lo pseudonimo di Reseda. Al ritorno della coppia nuziale dal Municipio, ebbe luogo un delizioso luncheon in casa dell’Ing. Faccio: poscia col treno delle 7,14 pom., gli sposi, accompagnati dai nostri migliori auguri, partirono per Torino95. Nel 1894 Rina giornalista valicò i confini provinciali attraverso la pubblicazione di due articoli sul giornale torinese “La Gazzetta del popolo della domenica”: il 22 luglio uscì Piccole poste, in cui Rina descriveva la sua passione per la rubrica omonima, e il 18 novembre Amiche perdute – (Fantasia), riflessione sulle amicizie del passato ormai finite e sui ricordi di questi legami che spesso provocano sofferenza. Impossibile non leggere tra le righe la solitudine della giovane Faccio a Porto Civitanova. Nel 1898, dopo la “presa di coscienza”, i contenuti di Rina giornalista assumono un’altra profondità, e lasciano intravedere i primi tratti di un nuovo profilo, quello di Sibilla Aleramo. Escono tre articoli importanti: Club femminile, in “Gazzetta letteraria” (26 marzo), Visioni di pace, in “Presente e avvenire” (1 luglio), e Marca negletta (La Regione di Giacomo Leopardi), in “La Vita internazionale” (5 luglio). Il primo cita l’opera di Scipio Sighele Donna nova, studio sul movimento femminile in Inghilterra e Scandinavia in cui si trova la parola “emancipazione”; gli ultimi due, invece, fanno riferimento a L’Europa giovane96 di Guglielmo Ferrero, intellettuale, storico e sociologo che dedicò un capitolo al “terzo sesso”, quello delle spinters, le donne nubili (“zitelle”) che svolgevano un ruolo molto attivo nella società inglese di fine secolo soprattutto nei campi dell’istruzione femminile e dei diritti politici delle donne. Nella società inglese […] la donna restata nubile non è condannata alla schiavitù sinché la sua 94 Cfr. Pier Luigi Cavalieri, Sibilla Aleramo. Gli anni di Una donna. Porto Civitanova 1888-1902, Cattedrale, Ancona 2009, pp. 136-137. 95 Ivi, p. 126. 96 Guglielmo Ferrero, L’Europa giovane. Studi e viaggi nei Paesi del Nord (nuova edizione), Garzanti, Milano 1946. 43 bellezza sia interamente sfiorita: essa può avere tutta la sua libertà, può guadagnarsi la vita, agire, viaggiare, godere il mondo e la vita in tutta la sua vastità. Tante attrattive rieccitano l’innato egoismo della donna – infinitamente superiore all’egoismo mascolino – e la donna deliberatamente rifiuta di compiere i suoi doveri verso la specie. Perché contrarre matrimonio? Il matrimonio significa l’alienazione, a profitto di un uomo, dimezza la propria libertà; il contratto è cattivo e molte donne rifiutano di firmarlo, poco curandosi dei piaceri a cui rinunciano; quelle che verso questi piaceri siano portate, possono tanto più variamente e liberamente soddisfarsi, restando libere.97 Fin dai primi articoli si delineò in lei un certo interesse per la questione femminile, anche se il suo periodo femminista, cioè propriamente attivo nel movimento delle donne, può essere datato dal 1897 al 1910, esattamente gli anni in cui, grazie alla numerosa presenza delle donne in fabbrica, la questione femminile si confrontava con quella operaia98. Nei primi articoli da “vera” giornalista (il suo lavoro come pubblicista si colloca dal 1898 al 1952 circa), in particolare, si esprimeva con toni rivendicativi per spingere le donne ad avviare la formazione di una propria autocoscienza in grado di liberarle dal controllo maschile e di portarle verso un’auspicata rivendicazione dei propri diritti, sia politici che sociali99. In questo senso va anche interpretata anche la sua breve collaborazione con “L’Italia Femminile” (ottobre 1899gennaio 1900) con la rubrica In Salotto, fortemente criticata e poi soppressa dallo stesso editore, Lamberto Mondaini, a cui non piaceva il taglio femminista di Faccio100. Rina era una femminista nuova, le sue interlocutrici privilegiate erano le giovani, in base alla convinzione che da loro, quindi anche da se stessa, partisse la spinta al progresso e alla rigenerazione sociale: “elevarsi, imporsi beneficamente, fecondare luce, pace, progresso, diventando educatrici della società, rigeneratrici della coscienza umana”101. Altra sua preoccupazione, una costante dell’emancipazionismo italiano fin dall’epoca risorgimentale, era quella di farsi ascoltare dagli uomini, convincerli della serietà e del valore intellettuale delle donne, dimostrare che la richiesta di un lavoro extradomestico retribuito non aveva nulla a che fare con la leggerezza, ma con la dignità umana. Il successo nel giornalismo iniziò, abbiamo detto, nel 1899, con l’Inchiesta sul femminismo promosso da Gambarotta, per la quale Rina organizzò un Comitato promotore a Roma. Grazie a quell’inchiesta Faccio divenne la nuova direttrice de “L’Italia femminile”: fu l’investitura ufficiale 97 Ferrero, op. cit., pp. 341-342 Cfr Piera Forni, Sibilla e Rina: l’Aleramo tra giornalismo e letteratura, Centro editoriale toscano, Firenze 2005, p.13; per una storia di genere cfr. A. Bravo, M. Pelaja, A. Pescarolo, L. Scaraffia, Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea, cit. 99 Cfr. Annarita Buttafuoco e Marina Zancan, Svelamento: una biografia intellettuale, Feltrinelli, Milano 1988. 100 Cfr. P.L. Cavalieri, op. cit., e Daniela Zanetti, Istantanee allo specchio. Bibliografia di Sibilla Aleramo giornalista, in «IG. Informazioni», II, n. 4, 1991. 101 Rina Faccio, Il femminismo in Italia, in Sibilla Aleramo, La donna e il femminismo. Scritti 1897-1910, Editori Riuniti, Roma 1978, p. 61. 98 44 a erede delle emancipazioniste della generazione precedente, e l’occasione per allargare la rete delle sue conoscenze e stabilire contatti che si riveleranno determinanti nella sua vita. Rassicurata dalla possibilità di guadagnarsi da vivere con l’attività giornalistica, alla fine del febbraio 1902, Rina lasciò definitivamente le Marche e si trasferì a Roma, sperando in una separazione consensuale dal marito, con l’affido del figlio Walter. Ma il bambino andò in collegio, e non gli fu consentito di incontrare la madre, che rivide soltanto da adulto. La separazione dal marito fu vissuta da Rina come una progressiva liberazione: dopo anni di lotta e di negazione si era riconquistata il diritto all’amore, e con il poeta Giovanni Cena ebbe la convinzione di poter realizzare quel rapporto alla pari vagheggiato da fanciulla. Ma nel 1910 Sibilla lasciò il suo compagno, e il 1911 segnò una fase nuova: il 9 aprile uscì sul “Marzocco” il suo saggio più famoso, Apologia dello spirito femminile102, in cui puntava il dito contro la subordinazione intellettuale delle donne e denunciava la mancanza nella scrittura femminile di quell’“impronta tutta speciale” che avrebbe dovuto caratterizzarla103. Da femminista, dunque, Aleramo volle diventare una scrittrice “femminile”, affermando la necessità che le scrittrici sprigionassero la loro energia femminile, mettendo sensualità nelle parole, come stavano iniziando a fare, in Italia, Annie Vivanti e, in Francia, Madame de Noailles e Colette Willy104. Nello stesso anno Sibilla si avvicinò a “La Voce”105, vivace periodico culturale fiorentino fondato da Giuseppe Prezzolini. Nel 1913 Sibilla tornò a Roma, avendo deciso di aderire al Futurismo dopo aver contattato Marinetti, poi l’anno dopo, a Milano, assunse la direzione della rivista “La Grande Illustrazione” per la parte letteraria106. Durante il primo conflitto mondiale, i suoi articoli si destreggiavano tra l’esaltante retorica interventista e il dissenso contro la guerra che nasceva dalle sue idee femministe, ma la sua produzione si concentrò soprattutto sulla poesia. Nel 1924, su proposta di Adriano Tilgher e Giovanni Amendola, Aleramo fu tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti. Sempre assillata da problemi economici (sorte che l’accomunava a Dolores Prato), cercava aiuto ovunque, e chiese insistentemente di poter collaborare con “Il Corriere della Sera”, prima a Luigi Albertini, poi a Pietro Croci: nell’ottobre del 1928 Sibilla andò persino da D’Annunzio, a Gardone, ma, nonostante un’attesa di un mese e mezzo, non riuscì a realizzare quell’intervista al Vate che avrebbe potuto aprirle le porte al “Corriere”, probabilmente anche perché D’Annunzio stesso non aveva gradito la sua sottoscrizione al Manifesto di Croce. Sfumò così anche la speranza di una collaborazione fissa al quotidiano, il cui 102 in S. Aleramo, Andando e stando, cit. cfr. E. Scaramuzza, op. cit., pp. 213-214. 104 Ivi, p. 215. 105 Tra i collaboratori c’erano Giovanni Papini, Gaetano Salvemini, Giovanni Amendola, Benedetto Croce, Giovanni Boine. 106 E. Scaramuzza, op. cit., p. 244. 103 45 direttore, Maffio Maffii, le era ostile. Dagli appunti e dalle letture di quei giorni nacque comunque un articolo, che uscì il 7 dicembre su tre testate: la “Fiera Letteraria”, “Il Secolo XIX”, “Il Mattino”. Ospite di D’Annunzio, questo il titolo, era un insieme dei pezzi del repertorio romantico di Aleramo, un misto di vecchie utopie e vecchie illusioni. Su tutte, quella della vita come opera o di un capolavoro di vita equivalente a un capolavoro d’arte. Il millenovecentotrenta si apre per le lettrici italiane con un colpo secco di forbici. L’anno è quello in cui quotidiani e rotocalchi ammanniscono in salsa rosa al pubblico femminile il piatto prelibato delle nozze di Edda Mussolini, primogenita del Duce, con Galeazzo Ciano. E’ anche l’anno in cui “Critica Fascista” propone come modello ideale alle fidanzate e alle mogli della nazione una donna che sappia diventare “tre, cinque, dieci volte mamma”, e che soprattutto si mostri “poco elegante, non troppo bella, di corporatura normale, poco accurata”. Le forbici, affilatissime e lucenti, sono quelle di Attilio, principe dei parrucchieri romani. Con un gesto irrevocabile, appena il tempo di un “brivido”, recidono di netto “la chioma lunga” e “gloriosa” di Sibilla Aleramo, che all’evento si affretta a dedicare una prosa pubblicata in febbraio su “Novelle Novecentesche”, mensile di racconti per signore e signorine107. E’ Margherita Ghilardi, in un saggio sulle giornaliste degli anni ‘30-’50, a regalarci questa potente immagine che, in qualche modo, inquadra il momento cardine del percorso complesso compiuto dalle donne per il pieno e diretto accesso al diritto di cittadinanza. Un cammino che, in Italia, dall’Ottocento si è protratto fino alla caduta del Fascismo e alla ricostruzione repubblicana, e che ha visto nella stampa politica delle donne un luogo di importanti slanci innovatori. Sibilla Aleramo rinunciò al “ricco, dolce nodo”, strumento di seduzione e romanzesco simbolo del piacere, per scelta: una scelta di ribellione, una forma di emancipazione. Non era una perdita, piuttosto una “conquista della civiltà”. Il pezzo di costume scivola nell’articolo di fondo, il resoconto in apparenza frivolo e svagato di una piccola avventura personale si trasforma riga dopo riga in rflessione accorata intorno alla condizione della donna e a quel futuro ormai prossimo in cui avrà finalmente acquisito una “coscienza il più possibile chiara della diversità tra la sua compagine intellettuale e quella virile, e, in luogo d’averne onta”, saprà “metterla in valore e farla accettare all’uomo” quale “elemento non già inimico ma integratore”108. L’approdo finale del lungo viaggio di Sibilla Aleramo attraverso il giornalismo italiano fu al quotidiano “l’Unità”, nel febbraio del 1948. Una collaborazione che per lei risultò problematica perché aveva la sensazione di esprimersi “propagandisticamente”: 107 Sibilla Aleramo, Capelli corti, in “Novelle Novecentesche”, febbraio 1930, n.9, pp. 3-5, in Ghilardi Margherita, Tempo di svolte. Scrittrici e giornali in Italia dagli anni Trenta agli anni Cinquanta, in Franchini Silvia, Soldani Simonetta (a cura di), Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, Franco Angeli, Milano 2004, p. 154. 108 Ivi, p.155 e cfr. S. Aleramo, Andando e stando, cit. 46 Non concepisco più una pagina d’arte, di poesia […] Questo lavoro tra giornalistico e politico, mi costa uno sforzo inenarrabile: e non mi rende il minimo indispensabile per vivere109. Qualche anno più tardi le fu affidata la rubrica Sibilla risponde, titolo poi trasformato in I colloqui di Sibilla Aleramo. Nell’articolo di apertura, intitolato L’Unità delle donne, Sibilla spiegava gli obiettivi di questo spazio: doveva essere un campo di studio e di dibattito per permettere alle donne di prendere confidenza con il proprio modo di pensare, per tirar fuori la propria sensibilità e abituarsi al confronto con gli altri110. Della partecipazione di Aleramo alla questione “femminile”, anche negli ultimi anni di vita, è testimone la sua stessa biografia: le colonne dell’“Unità” da lei gestite erano un angolo dedicato alle donne e alla loro diversità di pensiero e dell’anima rispetto agli uomini; dal 1947, poi, importante fu la sua presenza nell’Unione Donne in Italia, la cui presidente era Rita Montagnana, moglie di Palmiro Togliatti, e che approdò alla sua nomina, nel 1949, nel comitato direttivo nazionale. Questa panoramica su Aleramo giornalista – quanto a Prato, un’indagine approfondita sarà al centro del prossimo capitolo – è utile per abbozzare qualche considerazione comparativa. Per Sibilla il giornalismo fu un istinto giovanile e un mezzo per sviluppare e diffondere il proprio modo di pensare la società, e il ruolo della donna in particolare: era il veicolo del suo credo, femminista prima, femminile poi. Nella vita di Dolores, invece, il giornalismo arrivò tardi, negli anni Cinquanta, quando aveva quasi sessanta anni, e non aveva niente a che fare con l’impegno politico o con un’idea da trasmettere. Dolores giornalista era una critica attenta e arguta sul mondo contemporaneo, anche se la realtà di riferimento dei suoi articoli aveva principalmente i confini geografici di Roma e gli argomenti riguardavano la storia e le architetture della città, dei suoi quartieri, o le tradizioni, in specie religiose. Quelli di Dolores erano articoli che spesso esulavano dalla cronaca, o comunque ne traevano spunto per parlare d’altro: erano, sono, digressioni pratiane sulla romanità e su Roma, città distrutta nel suo carattere universale innanzitutto dall’Annessione, dal suo divenire capitale d’Italia, ma anche dal Fascismo e dalla tendenza alla “globalizzazione” della società contemporanea. Mentre in Aleramo fortissimo è l’idealismo, che resta nella dimensione del pensiero (femminista e non), della poetica, dell’estetica della vita, in Prato, al contrario, gli articoli parlano di muri e di pietre, di palazzi e vecchie storie di strada, di taxi e di ghirlande natalizie. Se Sibilla ricerca una scrittura femminile, tratteggiandone anche i tratti 109 110 In A. Morino (a cura di), Diario di una donna, cit., p. 80. Cfr. P. Forni, op. cit., p.80. 47 essenziali, Dolores è scrittrice dell’immediatezza, e ignora completamente il problema della differenza di genere, nella scrittura come nella vita. Entrambe, e questo le accomuna, scrivono per giornali vicini al Pci: Sibilla per l’organo ufficiale, “l’Unità”, Dolores per il secondo quotidiano per importanza, “Paese Sera”, ma la prima lo fa per adesione al partito, la seconda più per l’amicizia con Fausto Coen e l’attaccamento a quelle pagine che per una questione politica. Due giornalismi, insomma, profondamente diversi, nelle forme e nelle motivazioni, ma due giornaliste che in comune hanno la forza, la personalità dirompente, un acume critico del tutto speciale e riconoscibile. Caratteristiche, queste, che hanno le loro radici nella storia personale delle due donne. Una storia complessa, fatta di traumi, mancanze e ricerche, una storia intrisa di Novecento. 48 Capitolo due Giornalista a Roma I – L’innamorata dei luoghi e delle parole I luoghi che più hanno influito su di me sono: uno stretto e lungo paese marchigiano pigramente disteso sul crinale di una collina addormentata; Roma immensa e profonda nei suoi tre millenni di vita presenti in quei minuti particolari che sfuggono alla distruzione e alla coreografia, Roma, tutta, con la terra, lo spazio, la luce dove essa sorge. Io sento i luoghi più della persona umana111. Dolores Prato è “l’innamorata dei nomi”112, e anche l’innamorata dei luoghi. Tutti i suoi viaggi, ogni spostamento, ogni cambio di casa (da Treia, a Roma, San Sepolcro, San Ginesio, Macerata, poi Milano e ancora, e definitivamente, Roma) creavano in lei “nuove comunioni e amicizie ambientali”. Instaurava, ogni volta, “corrispondenze” con i paesaggi, la loro storia, la loro eternità, e trasferiva tutto sulla carta, sui suoi innumerevoli biglietti, nei manoscritti, negli articoli per i giornali. Non è un caso che i suoi romanzi abbiano come protagoniste le sue città dell’anima. Dire Dolores Prato, e Giù la piazza non c’è nessuno, è dire Treia, con i suoi luoghi, i suoi personaggi, i suoi abitanti, la sua lingua; è il tempo dell’infanzia della scrittrice, affidata alle cure dello zio prete, Zizì, e di sua sorella Paolina. La scansione interna del libro è marcata, più che dalla memoria cronologica degli avvenimenti, da quella dei luoghi: dal tavolino menzionato nell’incipit, alle stanze della casa degli zii, fino alle strade, agli edifici, agli interni delle case visitate nel corso 111 S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 8. D. Prato, Le Ore, cit., p. 330. L’innamorata dei nomi è anche il titolo del bel saggio di Franco Brevini sull’opera autobiografica di Dolores Prato, pubblicato nel 1989 dalle edizioni Città di Treia. 112 49 dell’infanzia. Gli eventi, ovviamente, non mancano, ma affiorano a poco a poco, in ordine cronologico, quasi come se fossero un corollario della metafora spaziale del percorso “domestico, cittadino, paesaggistico”113. Le Ore, romanzo incompiuto, in qualche modo séguito di Giù la piazza, è il racconto degli anni di Prato nell’educandato salesiano delle suore della Visitazione114, sempre a Treia: sono gli anni della formazione e della clausura, anni di una vita apparente115, in cui il tempo è escluso e tutto passa in assenza di vicende e sentimenti. “A Treia, c’erano strade, case, mobili, persone. In Convento corridoi, cappelle, celle, dormitori, monache e parole, parole, parole da non finire”116. Dolores sembra come navigare in una vita sospesa, che nulla ha in comune con quella lasciata al di là del portone del convento, a partire dal dover dare del “lei” alle sue compagne. E il distacco è marchiato a fuoco dal fatto che nulla trapela dalla vita di fuori. In collegio, si cerca di eliminare il passato e ogni legame che ricorda la piccola cittadina di Treia: si tenta di farlo, e in parte ci si riesce. “Io niente seppi più, niente vidi più, non ci fu più il tempo, non ci furono più i luoghi, non ci fu più nulla, neppure l’assenza del mio Zizì”117. Anche lo spazio perde la sua normale dimensione: quello del monastero è un mondo a parte, “un mondo che confinava solo con l’aldilà; stava al confine fra Dio e la terra [...] Un grosso pallone frenato ancorato da Dio in quel punto del paese”118. La sua Treia divenne, in qualche modo, un non-luogo; ma l’amore per il paese al di là del muro rimaneva intatto. Treia: meraviglioso il legame di Dolores con questo paese. In una lettera del 18.11.1976 a Giovanni Spadolini, che Prato non conosceva personalmente, ma che contattò alla vigilia di un viaggio di questi proprio a Treia, con la scusa che “tra i pochissimi vantaggi della vecchiaia c’è una maggiore libertà nell’abbordare celebri personaggi”, si legge: Treja non l’ho più rivista da quando eravamo bambine insieme [...] Quel luogo è per me il luogo mitico che forse tutti hanno nella vita [...] Scrivo di volata perché lei si porti dentro il mio nome e zitto zitto, da solo, lo dica a Treja, alla sua aria, al grande cielo di lassù, da quelle finestre di dove lo guarderà se gliene lasceranno il tempo. Dica a Treja che l’amo come non amerò il Paradiso. Mentre lei starà là io lavorerò (a Giù la piazza) unita attraverso di lei a quel paese che ha la più bella piazza del mondo [...] Allora “oriundo” lei, “adottiva” io, uniamoci in spirito nel 113 Cfr. L’antibiografia di Dolores Prato, in Oltrecanone. Per una cartografia della scrittura femminile, a cura di A.M. Crispino, Manifestolibri, Roma 2003, pp. 33-46. 114 Cfr. Augusta Palombarini, Lo scandalo dell’alfabeto. Educazione e istruzione femminile nelle Marche tra Otto e Novecento, Affinità Elettive Edizioni, Ancona 2004. 115 Questa è la definizione che Giorgio Zampa dà della vita di Dolores Prato dopo l’ingresso in collegio, cfr. D. Prato, Le Ore, cit., p. 341. 116 D. Prato, Le Ore, cit., p. 253. 117 Ivi, p. 15. 118 Ivi, p. 12. 50 nome di Treja scritto come si pronuncia119. E poi San Ginesio, dove Dolores Prato ha insegnato Lettere dal 1922 al 1927, con una breve pausa a Macerata, che è la sua Sangiocondo. Ne parla così, Dolores, al parroco ginesino protagonista “metà vero metà inventato” del romanzo, don Pacifico Ciabocco (don Pacì) annunciando il suo imminente arrivo a San Ginesio insieme ai coniugi Ferrari e D’Arrigo120: Voglio vedere solo voi, Tullia e tutto il paese mio bello; voglio andare sul colle almeno due volte, a ore diverse per ritrovare certe luci lontane viste solo a San Ginesio. Andremo nella Collegiata, perché quella resta tua, a San Gregorio, sul piazzale della scuola e per me sarà un’emozione così forte che non so se mi farà bene o male121. Campane a Sangiocondo122, è un travagliato e sofferto racconto a soggetto cinematografico che ha come protagonisti il paese (San Ginesio) e il suo parroco, don Pacì. Nei pochi anni di permanenza Dolores si era appassionata alla storia del paese, ne aveva letto le fonti, intuito e assorbito tradizioni, manie, profili e orizzonti: le pagine di Sangiocondo sono un altro esempio fulgido delle corrispondenze-comunioni ambientali che Prato instaurava con i luoghi, e della sua curiosità. Questo il parere dell’amico scrittore Agostino Turla sul dattiloscritto di Campane a Sangiocondo che Dolores gli inviò:: Il tuo paese, così reale con le sue montagne e le sue valli, le sue abitudini e le sue stagioni, si trasforma a poco a poco in un leggendario paese di fiaba [...] L’artista che sei è presente con tutta la sua forza creatrice [...] Un’opera nella quale hai trasfusa tutta la luce dei tuoi occhi assassini123. E così Concetto Marchesi, in una lettera del 30.8.1948: Dunque fino a che il protagonista è il paese, con le sue case, le sue chiese, le sue storie, le sue fiabe, i suoi personaggi d’ambiente, tutto procede di sorpresa in sorpresa in una continuata e rinnovata felicità di immagine e di espressione [...] Questo tuo manoscritto mi ha rivelato quale sarà il tuo libro, il libro veramente tuo, che non avrà rivali [...] e darà vita alle cose che sanno parlare a te così argute e profonde. Sarà la “Roma dell’Anno Santo“124. 119 S. Severi, Voce fuori coro, cit., pp. 25-26. Viaggio che poi non ci fu. 121 S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 71. 122 Prato, Campane a Sangiocondo, a cura e con un saggio di Noemi Paolini Giachery, Avagliano Editore, Roma 2009, rimasto inedito fino al marzo del 2009 (se si esclude l’edizione Pax, in polacco, del 1965 e la pubblicazione Sangiocondo, poi La rosa muscosa, delle edizioni Campana di Roma, del 1963, entrambe autofinanziate), 123 S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 89. 124 Ivi, p. 88. 120 51 Importante notare questo passaggio su Roma: fu l’unico luogo che Prato amò profondamente e sul quale non scrisse nessun romanzo. Per accostare criticamente, e in modo compiuto, l’opera giornalistica di Dolores Prato, occorre soffermarsi su un altro suo “amore”, quello per i nomi, per le parole, forse ereditato dallo zio Domenico e dal muoversi di Dolores, dalla nascita fino agli anni del Magistero, in ambienti religiosi, dove fondamentale è l’importanza del Verbo. La particolarissima sensibilità linguistica di Prato, la sua originalità, sono un elemento imprescindibile dai suoi scritti. Nel 1987 e 1988 escono presso l’editore Scheiwiller, in due volumi e a cura di Giorgio Zampa, Le Ore e Le Ore II – Parole, due testi poi riuniti in un unico romanzo da Adelphi nel 1994. Parole, straordinaria autobiografia linguistica della scrittrice, raccoglie schede scritte da Prato lungo il corso degli anni. Vi si leggono appunti di vocaboli usati a casa degli zii, appartenenti alla borghesia romagnola (un italiano alto, ma non astratto), quelli usati per le strade di Treia ma proibiti in casa (il dialetto: lingua bassa, plebea, concretissima), e le trasformazioni che questi avevano subito all’interno delle mura del collegio, con le sfumature lucchesi e toscaneggianti imposte dalla Madrina. “Alcune parole non avevano varcato la clausura, sicché per allora caddero nel buco nero [...] In genere erano cose pratiche, reali” 125 . Gli appunti di Prato sono divisi in quattordici sezioni, ognuna con un titolo, come ad esempio Parole perdute, Le stesse cose a casa/in collegio, In paese e lì dentro, e ogni scheda è una dichiarazione di insostituibilità di ciascun termine. Le mie cerase grosse, rosse, lucide, così belle quando erano a coppia Zizì me le metteva a cavalcioni sulle orecchie, in collegio divennero ciliegie, ed erano piccole, pallide, opache, a stento ne trovai due unite. Di nascosto me le mettevo sulle orecchie, ma sapevo di non essere provocante con quelle cerase false126. In paese era sempre zinale, diventava parananza quando era bianco e colorato, di tessuto grosso messo solo per le fatiche grosse, bucato, conserve, pulizie grosse. In collegio fu grembiule e basta. La parananza la portavano le monache cuciniere ma come la chiamassero non so127. “Un piccolo museo iconografico”, come la definisce splendidamente, a mio avviso, Toni 125 D. Prato, Le Ore, cit., p. 266. Ivi, p. 258. 127 Ivi, p. 321. 126 52 Maraini128, che continua: Dolores parla a immagini; la descrizione è naturalista, talvolta iperrealista nella maniera in cui la cosa designata viene enfatizzata e isolata; ma il “verismo” naturalista vibra con inquietante intensità. Potremmo pensare alla maniera di isolare gli oggetti operata da Moranti – ma in realtà siamo più vicini a Magritte. La distanza che separa “forcelle” da “forcine” è favolosa, enigmatica e senza scampo. Si appartiene all’una o all’altra sponda linguistica, ma resta mistero il perché129. Sull’aspetto linguistico pratiano, fino ad oggi la critica ha sottolineato l’esigenza, in Dolores adulta - un bisogno sia morale che psicologico, fisico - di recuperare la “sua” lingua, la lingua di Treia, dopo che l’esperienza nell’educandato delle Visitandine aveva “disinfettato”130 il suo vocabolario rendendolo convenzionale, letterario, toscaneggiante e passato, oltretutto, da un filtro clericale. La mia trasformazione avveniva attraverso le parole. [...] Come se varcando quella soglia solenne, misteriosa, semibuia, per me paurosa, automaticamente qualcosa in me si capovolgesse [...] nascosi tutto quello che era stato fino allora e cominciai ad essere quell'altra, quella delle parole diverse”131. “Una vita sballottata, travestita, camuffata dalle parole”132, definisce Prato stessa i suoi anni nell’educandato. Gli anni del collegio sono anni in cui è strettissimo il nesso fra espropriazione linguistica e delegittimazione in senso psicologico, insicurezza. E questo senso di incertezza, diversità, di forte inappartenenza a luoghi, persone, oggetti, eventi, iniziato con l’abbandono da parte della madre e dal non avere un padre, fu una costante di tutta la sua esistenza, tanto che Dolores stessa si definì una “bastarda integrale”133. Ma nonostante le costrizioni esteriori, e interiori se pensiamo proprio al linguaggio, la memoria dell’infanzia continuò ad agire in Dolores Prato, in modo più o meno cosciente, lungo tutto il corso della sua vita, fino alla liberazione finale, quasi una rivelazione: il momento in cui, ottantenne, cominciò a lavorare sulla mole enorme di materiale linguistico scritto e raccolto negli anni, sui fogliettini, gli appunti, le pagine compiute, i frammenti, e recuperò le sue parole, tornando ad essere l’altra, e abbandonando “quella delle parole diverse”. 128 T. Maraini, La struggente sutura, in AA.VV., Il timbro a fuoco, cit., p. 87. Ivi, p. 87. 130 “Lì dentro entravano solo parole disinfettate”, scrive Dolores in Le Ore, cit., p. 278. 131 Ivi, p. 333-334. 132 Ivi, p. 284. 133 D. Prato, Giù la piazza, cit., p. 687. 129 53 La spinta narrativa, che portò Prato alla conclusione del suo capolavoro, Giù la piazza, e alla stesura, quasi completa, del romanzo sui suoi anni di formazione, Le Ore, nasce proprio dal linguaggio, dal recupero dall'evocazione di quelle parole che aveva modificato, perduto, abbandonato. Dolores Prato iniziò a scrivere del suo passato nel momento in cui la memoria sollecitata rigettò nel presente tutta la ricchezza e la complessità del triplice vocabolario dell'infanzia e dell'adolescenza, legato al dialetto di Treia, alla parlata settentrionale degli zii, all'universo lessicale del convento. La scrittrice, a un certo punto della sua esistenza, sentì la necessità di ritrovare le proprie radici e sé stessa: lo fece ridando vitalità a una lingua logorata e svuotata dall'uso, impoverita dalla consuetudine, al suo peculiare idioma che il tempo aveva reso scontato, per ricongiungersi con il primo sguardo aperto sulle cose, quello dell'infanzia e dell’adolescenza. Ebbene, secondo gli studiosi (pochi) che finora si sono occupati di Dolores Prato, la rivelazione pratiana arriva in tarda età, con il recupero di quella “Dolò ‘ndo stai? Viè qqui...sta commé”134, ritornando “a quell’età piccola, che non invecchia”, con il ritorno alla fase germinale del linguaggio, e della vita, quando si identificano le parole con le cose. Io abito ancora a Treia pur non avendola mai più vista da quell’età piccola che non invecchia. Io amo dire Affrica come lì si diceva135. Stiamo parlando di una donna, poi insegnante, giornalista e scrittrice, che percepisce la lingua, i nomi, come “l’anima delle cose e delle persone”: per Dolores Prato le parole sono la realtà. Potremmo parlare, per Prato, di una sorta di neoplatonismo: i nomi, per lei, sono saturi di un’età e di una realtà identificatissime, ben oltre il normale concetto semiotico. Mizzau e Lorenzini parlano di “realismo” pratiano, in fondo una sintesi fra l’innamoramento per i luoghi e le cose e quello per le parole. La prima, in particolare, definisce Dolores Prato come “antesignana della école du regard136 del nouveau roman. Un realismo, quello di Prato, difficile da definire, a tratti spoglio, a tratti carico di valenze emozionali, e che si affida alla forza icastica delle parole, che appena pronunciate si fanno immagine visiva. Anche l’uso delle parole è frutto dell’amore per i luoghi: l’insistere sul dettaglio, l’accumulazione, caratteristiche specifiche di Dolores, non sono virtuosismi, ma volontà di restituire la sostanza e la consistenza dell’ambiente. 134 Ivi, p. 45. D. Prato, Le Ore, cit., p. 249. 136 M. Mizzau, Dolores Prato: assenze e presenze, in AA. VV., Il timbro a fuoco della parola, cit., p. 14. 135 54 Per me Roma fu tartaruga, bicchiere di fragole, gita sott’acqua137. Questa rieducazione, questa autoanalisi che andava di pari passo con la critica nei confronti di una pedagogia e una cultura postunitaria gravate (a suo avviso) dallo stesso vizio, quello, cioè, di uniformare la lingua sul livello dell’italiano alto, impegnò, dunque, tutta l’esistenza di Dolores, tanto che Giorgio Zampa138 scrive: L’aspetto più singolare, nel caso di Dolores, è rappresentato dalla sua evoluzione. Ritengo che pochi, neppure dopo lunghe, laboriose analisi, potrebbero trovare in quanto lei ha lasciato una originalità sua propria prima del 1972, quando aveva superato gli ottanta. I manoscritti superstiti, quelli almeno di carattere narrativo, non solo non fanno intravedere la vitalità dell’autrice, ma alimentano il dubbio di trovarsi di fronte a tentativi modesti, per non dire maldestri139. Il fatto che Zampa specifichi “quelli almeno di carattere narrativo”, potrebbe far pensare che anche il primo curatore dell’opera di Prato, nonché suo grande amico, avesse intravisto qualcosa di diverso nella produzione giornalistica di Dolores. A mio avviso, infatti, non è troppo azzardato affermare che il percorso esistenziale e linguistico di Prato, che condusse infine alla mirabile scrittrice che conosciamo oggi, trovò nel giornalismo il terreno dove svilupparsi: non è forse proprio del giornalismo usare parole vere di tutti i giorni, aderire ai fatti, chiamare le cose con il loro nome, e farlo in modo che tutti comprendano il linguaggio che si sta utilizzando? Forse proprio il giornalismo restituì a Dolores il meccanismo di riappropriazione della realtà che era venuto meno durante gli anni di formazione nel collegio treiese: i suoi articoli, scritti prima del 1972, d’altra parte, sono scritti in una lingua tutt’altro che letteraria, “apparente”, alta. Leggere i pezzi di Prato è vivere o rivivere un’esperienza che ha il sapore della quotidianità, un sapore che è dato dai colori, dai toni, dallo stile quasi parlato. I suoi articoli, a volte, sembrano chiacchiere ascoltate per strada dalla vicina di casa, o racconti fra amici, o spiegazioni-illustrazioni di Roma dispensate durante una visita guidata non strutturata. Il carattere degli articoli ha molto a che fare con l’autobiografismo, basti pensare al grande utilizzo della prima persona o al riferimento esplicito a sé stessa, anche nei titoli (Verdi mi pacciono di più, 137 D. Prato, Giù la piazza, cit., p. 23. Giorgio Zampa (San Severino Marche 1921-2008) è stato critico letterario, giornalista e traduttore. Esperto d’arte, di Montale e di letteratura tedesca, è stato redattore del “Mondo”, condirettore di “Letteratura”, collaboratore del “Corriere della sera” e “La Stampa”. Appassionato ammiratore di Dolores Prato (che in un certo senso può essere considerata una sua creatura), fu lui a curare la pubblicazione de Le Ore e Le Ore II. Parole, e fu sempre lui, nel 1997, a restituire per intero l’universo ricco di luoghi, parole e sentimenti di Giù la piazza non c’è nessuno, per Mondadori. 139 G. Zampa, Introduzione, in D. Prato, Giù la piazza, cit., p. X. 138 55 Italiana spaesata in Italia, Non siamo abbastanza antimonarchici); è poi un fiume in piena, Dolores, nei suoi articoli, quanto a suggestioni, emozioni, sensazioni e riflessioni personali. Tutti elementi, questi, che si discostano nettamente dal giornalismo puro. Questo atteggiamento, mai distaccato dalle cose e dagli eventi, risponde in maniera naturale al pensiero di Prato, secondo cui, come scriveva all’amica Lina Brusa Arese il tre dicembre 1977: Io credo che ogni scrittore è autobiografico, a meno che non sia politicamente o socialmente impegnato, benché è dubbio allora che sia scrittore e se o è l’autobiografismo non esula neppure di lì. Persone sufficientemente poco sincere possono nascondere l’autobiografismo, non lo potranno mai gli schietti come te e come me140. La sua cifra giornalistica seguiva in qualche modo l’istinto: Dolores prendeva spunto da una data, da una circostanza, da un avvenimento, da uno scorcio, e cominciava a divagarci intorno, mescolando notizie storiche e impressioni personali. In Prato, e nella sua scrittura, tutto cambiò quando si convinse che la verità è immediatezza141. Il passaggio sarà molto evidente, più avanti, quando andremo ad analizzare più in dettaglio i contenuti e la forma dei suoi articoli. Ma intanto, a sostegno della tesi che anche il giornalismo rappresentò, per Dolores, una tappa fondamentale in questo processo di riconquista di sé e della sua lingua, riportiamo una straordinaria pagina di Giù la piazza, in cui si percepisce con chiarezza come Roma (città di Prato giornalista) e Treia (città di Prato scrittrice) fossero in uno stesso luogo profondo dell’anima di Dolores. Soprattutto, è interessante notare come, in questo brano, si ripresenti uno schema peculiare degli articoli pratiani che parlano della città, fatto di dettaglio-epifaniaricordo/racconto/storia. Ancora una volta, l’esperienza giornalistica mostra i segni della sua influenza sul modo di scrivere-percepire-raccontare la vita della scrittrice matura, quella di indiscusso valore, che merita un posto di prim’ordine nel panorama letterario italiano del Novecento. Ma dal collegio esplosi a Roma e qui di colpo, quando in un labirinto della vecchia città lessi “Piazza dell’Olmo di Treja”, uscì fuori tutta la tenerezza fascinosa di quel paese che m’ero portata dentro senza saperlo. Fu la prima delle tante epifanie. Ho ricercato quella piazza, non l’ho più trovata. Forse non c’è, forse non c’è ma stata. Ma io la vidi quella targa di un’epoca in cui vicoli, strade, piazze, avevano il nome della loro essenza popolare; vidi il piccolo capriccioso slargo; l’albero non avrebbe potuto trovarci il suo centro, stava dove stava, l’olmo di Treja; non lo toccai. Ero fissa sul nome Treja: copriva tutta Roma. Ma se il nome Treja non è stato mai piantato a Roma come albero, c’è disperso come cenere: a Campo de’ Fiori fu arso vivo Pomponio Rustici, prete di Treja. Questo è sicuro come è sicuro che Treja scorre da sempre nelle acque del Tevere [...] Roma e Treja hanno in comune il mistero del nome. Roma nome-maschera, quello che 140 141 Ivi, p. XIX. Come scrisse su un appunto all’inizio della sua opera in fieri Voce fuori coro. 56 nascondeva il suo vero; come non sapremo mai quale fu questo nome, così non sapremo mai quale nume stravolto o mascherato dette il nome a Treja. Etimologia esatta non c’è: qualcosa s’intravvede attraverso un velo fluttuante e scompare. Da un irrecuperabile mistero nacque Treja le cui lettere furono sempre su per giù quelle della terra. Io la chiamerò paese, ma essa è città. La restituì alla dignità civica un papa che ne riscosse un monumento librato nell’aria; in bronzo il suo ritratto a mezzo busto; il resto pietra, slancio, luce; sta alto nello spazio come un gigantesco ostensorio e per fondo non potrà mai avere che il cielo142. 142 D. Prato, Giù la piazza, cit., p. 5. 57 II – Storia di una pubblicista: la collaborazione a “Paese Sera” Dolores Prato restituì comunque la sua Roma, ma solo ai suoi contemporanei, attraverso il giornalismo. La maggior parte dei suoi articoli, pubblicati soprattutto su “Paese Sera” negli anni Cinquanta-Settanta, sono su Roma e i suoi monumenti, i suoi misteri, le sue strade, le sue tradizioni, la sua storia. Dolores iniziò a scrivere sulle pagine di questo giornale fin dagli esordi: “Paese Sera”, edizione pomeridiana del “Paese”, infatti, nacque il 6 dicembre 1949 su iniziativa del Partito comunista italiano, che lo sostituì a “Repubblica” come voce legata al partito, e il primo articolo di Prato su questa testata, rinvenuto in questo lavoro di ricerca, è datato 19 maggio 1950. La formula di questo nuovo giornale, elaborata dal suo direttore “di fatto”143, Fausto Coen, che instaurerà un rapporto di grande amicizia (e che durò tutta la vita) con Dolores, era cucita addosso al pubblico romano: sfruttava le notizie di cronaca nera, era flessibile nelle valutazioni riguardanti le sinistre e, naturalmente, aveva un forte piglio polemico verso i gruppi di potere. Il decollo fu lento, ma lo spirito sarcastico e di protesta che circolava fra i titoli e i corsivi di “Paese Sera”, che talvolta diventava “qualunquismo di sinistra”144, piaceva ai romani, borghesi o proletari che fossero. Nel 1956, quando la pubblicazione in Occidente del rapporto segreto di Krusciov sui crimini di Stalin e sul culto della personalità scosse il movimento comunista, creando un vero e proprio trauma nelle file della sinistra, il Pci poteva contare su una notevole forza nel campo editoriale-giornalistico. All’“Unità” si andava infatti affiancando il successo di “Paese Sera”, che intanto si era affermato come il più diffuso giornale romano della sera, staccando nettamente i due concorrenti, “Il Giornale d’Italia” e “Momento sera”145. Delle ragioni di questo successo offre una bella lettura Piero Ottone: “Un giornale, per avere successo, deve avere una sua personalità, una sua fisionomia, un suo carattere. E poi bisogna che la personalità sia una personalità vincente; che si presenti nel momento giusto, e che piaccia”146. “Paese Sera” ebbe una sua personalità, e per questo si affermò. Aveva una natura composita, perché nasceva come giornale di partito, sia pure in posizione appartata rispetto all’organo ufficiale che era “l’Unità” (con cui visse sempre una feroce concorrenza), ma la sua anima giornalistica, distinta da 143 Direttore era allora Tomaso Smith, di cui Coen era il braccio destro. Paolo Murialdi, Dalla Liberazione al centrosinistra, in Valerio Castronovo e Nicola Tranfaglia (a cura di), La stampa italiana dalla Resistenza agli anni Sessanta, Editori Laterza, Roma-Bari 1980, p. 248. 145 Sull’importanza che andava assumendo il giornale si ricordi che sulle denunce di Krusciov contro Stalin “l’Unità”, in un primo momento, tacque, “Paese Sera”, invece, decise di riportare i brani principali del rapporto per non lasciare campo libero ai giornali borghesi. Cfr. Paolo Murialdi, La stampa italiana dalla liberazione alla crisi di fine secolo, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 127. 146 In Edo Parpaglioni, C’era una volta “Paese Sera”, Editori Riuniti, Roma 1998, p. XI. 144 58 quella politica, di battaglia, era molto importante. “Paese Sera” presentava l’aspetto più civile del comunismo italiano, e per questo poteva lavorarci tranquillamente anche chi comunista non era, e il caso di Dolores Prato, personalità sempre contrastata per quanto riguarda un “credo”, che si sentiva assolutamente libera nei giudizi, ne è una prova. “”Non era un giornale obiettivo, ma un giornale compiuto – continua Ottone – un giornale con una faccia riconoscibile, che piaceva. Paese Sera aveva uno stile. Aveva inoltre una coscienza, che lo induceva a schierarsi dalla parte giusta, quando il partito si schierava dalla parte sbagliata”147. In questo contesto, ben si collocava la voce nitida di Dolores Prato, con i suoi elzeviri particolari, mai banali, coinvolgenti. Nel 1960 Prato partecipò al concorso internazionale Premio “Città di Roma”, che sarebbe stato assegnato a un gruppo di articoli sulla città, con quattro pezzi pubblicati proprio su “Paese Sera”, che le valsero il secondo posto. Questa la motivazione della giuria: Nei quattro elzeviri di Dolores Prato la scrittrice unisce alla finezza delle notazioni una moderna, libera, indagine di costume e una bella consapevolezza urbanistica. Nella sua prosa di qualità la storia di illustri monumenti e di vecchi rioni romani si affianca a quella dei nuovi quartieri in un sentimento di contemporaneità, di notevole efficacia148. Ebbe a che dire sul fatto di essere arrivata seconda e non prima, la combattiva Prato, che ritenne di non aver vinto “solo perché i miei elzeviri erano pubblicati su un giornale di sinistra”. Tutti i componenti della giuria, sosteneva, erano convinti che fosse lei a meritare il primo premio, ma altrettanto convinti “che non si poteva fare questa cosa sgradita ai clerico-conservatori di assegnare il “primo” primo premio a una collaboratrice dei sovversivi”149. L’Archivio contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux, che raccoglie alcuni articoli pubblicati di Dolores Prato insieme a molti di quelli inediti che la stessa scrittrice conservava nel suo appartamento-archivio di via Fracassini 4, a Roma, nella serie “Articoli” (Pg 1143), contiene ventiquattro pagine di quotidiani corrispondenti ad altrettanti elzeviri firmati, ciascuno corredato da una o più versioni dattiloscritte della giornalista. Gli articoli furono pubblicati in larga parte su “Paese sera”, ma sono presenti anche altre testate, quali “La Via”, “Il Quotidiano”, “Il Globo”. Gli argomenti trattati sono i monumenti, i misteri, le tradizioni, i rioni di Roma, le ricorrenze religiose, il Tevere. I titoli Dolores Prato li decideva da sola, completi di occhiello e sommario, e, nei rari casi in cui 147 Ivi, p. XII. In S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 9. 149 Lettera del 20.11.1960 a Fausto Coen, in S. Severi, Voce fuori coro, cit., pp. 18-19. 148 59 venivano cambiati, partiva immediatamente la lettera di lamentela al direttore del giornale. Come accadde, ad esempio, il 18 gennaio 1960: Carissimo Coen150 […] Nell’ultimo articolo pubblicato il vostro “Vecchia Roma” oltre ad essere usato e strausato, non risponde al mio scritto, dove se mai si finisce col parlare non della Roma vecchia, ma antica. Il mio “Resistenza di Roma” abbracciava tutto l’articolo riassumendolo con una parola. Roma che resiste ai guastatori come può. Con un albero, con un sasso, magari sottoterra151. A volte capitava che il fastidio per l’aver visto pubblicato un titolo diverso veniva evidenziato con un appunto direttamente sulla pagina del quotidiano che conservava, come nel caso di Due millenni di storia… in cui Prato aggiunse a penna: “(titolo vero) Torni l’Augusteo al suo posto. Questo “sarcofago” è del giornale”. Anche per quel che riguarda la lunghezza dei pezzi Dolores era una giornalista poco incline alle regole: faceva fatica a restare nei limiti assegnati, e spesso provava a mandare qualche riga in più. Carissimo Coen, eccoti l’articolo per il 21 aprile. C’era tanto da dire che ho fatto fatica a contenerlo nei limiti che tu richiedi. M’era venuto in mente di farne due articoli, ma non sapendo che cosa tu ne avresti pensato, ho finito con ridurre e farne uno solo….però passando i limiti stabiliti di un dieci righe. Dato che è per il natale di Roma, me lo perdoni? In avvenire non lo farò più152. L’autocritica era un’attività quotidiana e costante per Dolores, e questa attitudine si riproponeva anche nell’attività giornalistica. Con la limpidezza che le era connaturata, giudicava i suoi pezzi, anche nelle sue lettere al direttore: Carissimo Coen, eccoti un articolo che ti può servire per sabato, dato che domenica 29 è S. Pietro. Leggilo sino alla conclusione; credo che ti piacerà. Grazie per aver pubblicato Il piccolo Repubblicano che, a confronto con gli altri miei articoli, risultava un po’ scadente. Questo è degno di te e di me (stavo per aggiungere: “e del pontificato nostro”!) almeno così mi pare153. Qualche esempio, poche righe, un assaggio significativo per comprendere alcune sfumature caratteriali e professionali di Prato. Ma torniamo alle origini, al rapporto fra Dolores Prato e il giornalismo, completamente dimenticato dalla letteratura e dai pochi saggi di critica disponibili ad 150 Fausto Coen, all’epoca direttore di “Paese Sera”. Dolores Prato aveva conosciuto Coen nei primi anni ’50, quando lui era già direttore di “Paese Sera”: Coen ricoprì questo ruolo fino al 1967, quando diventò direttore editoriale del quotidiano romano. Nel 1972 passò a “Il Globo” come consulente editoriale e lì restò fino al 1975. 151 In S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 17. 152 Lettera del 18 aprile 1959. Fondo Ferri-Ferrari. 153 In S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 165. 60 oggi154, e che bisogna recuperare. Se, infatti, in questi ultimi anni si sta cercando di riportare alla luce l’opera letteraria sommersa di quella che più di qualcuno ha definito una delle più interessanti protagoniste della letteratura del secolo scorso, quale fu Prato, grazie al lavoro congiunto di Giorgio Zampa, Franco Brevini, Stefania Severi, Elena Frontaloni155, Niva Lorenzini, Grazia Livi, Fiammetta Cirilli, Antonella Maraini, Marina Mizzau, Marina Zancan, insieme ad altri studiosi, e al contributo fondamentale di Ines Ferri e suo marito Filippo Ferrari, amici di Dolores e custodi nel loro fondo privato di Roma di molte delle lettere e delle carte della scrittrice, oltre che della sua memoria, poco o niente si è fatto per indagarne l’estro giornalistico. Del mondo del giornalismo Dolores Prato ha sempre fatto parte, e quel mondo ha sempre guardato con attenzione. Sono molti i riconoscimenti attribuiti alla giornalista, tra questi il secondo premio (mezzo milione di lire) al concorso internazionale “Città di Roma”, nel 1960 - come abbiamo visto e il secondo al concorso giornalistico Pallavicini, nel 1972, con Il Tevere ex-biondo un amico da salvare, pubblicato su “Il Globo”. Che essere giornalista, per lei, fosse un aspetto fondamentale della sua vita, tanto da “identificarla” (“sono insegnante e pubblicista”156), lo conferma anche una lettera destinata al giornalista Enzo Golino, in cui esprime la sua rabbia per un articolo di Marialivia Serini uscito su “l’Espresso” subito dopo la pubblicazione di Giù la piazza: Pieno di inesattezze il pezzo: dice che prima di questo lavoro, oltre al libro pubblicato in Polonia, io avrei scritto solo “qualche elzeviro”. Non qualche, ma tanti, cominciando naturalmente da dopo la guerra, prima m’era precluso per il Fascio e per Sion. Cominciai a pubblicare su quotidiani e riviste, ma ben presto, incontrato Fausto Coen, imboccai la sua scia e da allora ci furono solo Paese Sera e Globo con un solo tradimento per Pacciardi.157 Spediva spesso i suoi articoli migliori agli amici, per un giudizio, ed era un’abitudine quella di conservare pezzi di altri che riteneva interessanti, perché riguardanti qualche suo amico o perché, magari, si sarebbero potuti rivelare utili per la sua futura (mai avvenuta) pubblicazione su Roma. Prato seguiva, con passione, e scrupolosamente, la sorte dei suoi articoli, dai tagli, ai titoli, alla collocazione nella pagina e nel giornale. Tuttavia, di questo rapporto Prato-giornalismo gli studiosi che di lei si sono occupati finora, si sono fatti un’idea: per Dolores, “poligrafa, tessitrice di innumerevoli rapporti epistolari, decisa, a un certo punto, ad affermarsi sul piano narrativo”158, scrivere articoli sarebbe stato un “ripiego” rispetto alla sua vocazione letteraria, una incombenza 154 Per lo più pubblicati nelle edizioni Città di Treia, con scarsa diffusione. Di recente pubblicazione, nel 2011, la raccolta Sogni, di Dolores Prato, a cura di Elena Frontaloni, Quodlibet, Macerata 2010. 156 vedi nota n. 1. 157 ACGV, Fondo Prato, Pd 237, in S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 113. 158 G. Zampa, Introduzione, in D. Prato, Giù la piazza, cit., p. X. 155 61 necessaria per far fronte ai bisogni economici dopo che il rifiuto ad allinearsi con il regime fascista la costrinse ad abbandonare la scuola, unico mezzo di sostentamento. Il mio lavoro cercherà di smentire quella certezza, che ritengo frutto di un’analisi del tutto superficiale su questo fronte d’indagine. Inappellabile il suo attaccamento alla professione se leggiamo la lettera del 6.3.1967 a Coen: Fausto, stanno facendo la revisione nell’albo dei pubblicisti, dovrei mandare, già da molto tempo, la dichiarazione del Direttore del giornale dove collaboro. Me la fai, per favore? Se perdo quell’iscrizione perdo l’unica cosa che mi permetta un viaggio, l’unico modo di evadere, almeno una volta all’anno, dal sepolcro di pena che è questa casa in rovina con me159. Inoltre Dolores così scriveva a Giorgina Morbidelli, insegnante elementare e sindaco di Treia dal 1970 al 1975, pochi anni prima di morire: Di roba pubblicata ho poco: un volume in polacco tradotto da Campane a Sangiocondo e molti elzeviri. Questi sì sono belli. Molti vorrebbero riunirli in un volume, ma io non ho la forza di rivederli, non per correggerli ché non ne hanno bisogno, ma per togliere il motivo per cui furono pubblicati160. E ancora, in una lettera a Coen del 21 dicembre 1970: Avevo bisogno di dirti quanto il tuo giornale mi ha fatto male rifiutando quella serie di articoli sul centenario […] Non avevo mai collaborato al giornale con tanta tenacia, ma questa era la volta buona perché un materiale ricchissimo e originale era lì pronto, diviso per articoli, quasi tutti già stesi, bastava volta per volta una revisione. Ero contenta per me, ma anche per te: finora fra tutto quello che è uscito sul centenario niente è trattato dal mio punto di vista; più o meno è il solito fritto misto. Tu mi suggeristi di farne un libro. L’idea era giusta, ma dove trovare l’editore? E’ difficile fare un lavoro senza quell’appoggio, sai già che resterà nel tradizionale cassetto anche se io non ce lo metto. La vita d’una donna vecchia e sola è orribile; di più con le mie difficoltà visive e uditive, ogni azione, ogni gesto sono faticosi. La desolazione è assoluta. Solo nel lavoro ritroverei la gioia161. Riunire quegli articoli in una raccolta è stato uno dei principali intenti della ricerca, che ha avuto, fin dal primo momento, l’intenzione di risarcire, in qualche modo, la scrittrice di un’altra parte, 159 In S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 167. Dolores Prato, Le mura di Treia e altri frammenti, a cura di G. Zampa, edizioni Città di Treia, Treia 1992, p. 117. 161 Fondo Ferri-Ferrari. Le sottolineature sono nell’originale. 160 62 ricca e pregevole, della sua produzione “sospesa”: quella giornalistica, appunto, che Prato difendeva e portava avanti con fortissima convinzione anche a ottant’anni. In un’altra lettera all’amico Coen, datata 24 marzo 1970, di commento alle sorti di un suo pezzo sul colore dei taxi (Verdi mi piacciono di più) “tagliato benché fosse corto, apparso e subito ritirato. L’elemosina che si fa a una seccatrice”, Dolores sottolinea, ancora una volta il suo amore per questo mestiere, evidentemente molto più che un ripiego: In una giornata un po’ morta come il lunedì è apparso il mio pezzo. Apparizione, nel significato della parola, apparso e scomparso, come un fantasma.. I tassinari che la pensano come me, sarebbero stati contenti di leggerlo. Non ne hanno avuto il tempo. Oramai non ho più dubbi: la mia firma non è gradita al giornale. Ci ho messo a convincermene! L’amavo quel giornale che mai mi ha amata. Avevo confuso il giornale con te e ho sbagliato. Di fatti provanti che io non piacevo al giornale ne ho una catena. Ma lo sentivo anche se i fatti mancavano, come sentono le persone ferite. Per questo la mia collaborazione è stata così rara. Dovevo ogni volta riacquistare fiducia, credere che i miei giudizi e le mie sensazioni fossero sbagliati. Ma di cose scritte per il giornale che confondevo con te, ne ho a mucchi. Spunti, pagine intere, asterischi, frammenti. Sto facendo una pratica notarile per il lascito dei miei manoscritti; alcuni amici disporranno dei pochissimi soldi, del valore della mia biblioteca che ne ha assai, dei mobili e oggetti trasformabili in denaro, per la loro pubblicazione. Ebbene, non so ora esattamente quanti saranno, ma un buon volume uscirà fuori di sicuro con quel che ho scritto per il tuo giornale e che non ho mai mandato. Avrà anche valore retroattivo, te l’assicuro162. Nonostante la sua notevole capacità di scrittura e il suo rapporto di fiducia con Fausto Coen; e nonostante che lo stesso Coen, in una lettera del quattro settembre 1970 diretta a Dario Paccino163 in cui chiedeva di pubblicare un “servizio foto-descrittivo su Cortona” di Dolores, la definisse “una nostra ottima collaboratrice da tanti anni”, “una persona studiosa e veramente competente”, Prato non fu mai considerata una delle firme di “Paese Sera”, né annoverata tra i collaboratori di spicco. Forse a torto, e probabilmente anche per il fatto di non essere mai stata considerata, in vita, un nome importante della letteratura italiana. Il giornale non le affidò mai neanche uno spazio fisso, una rubrica, che pure Dolores bramò a lungo, in diverse occasioni, e con diverse proposte, come si può leggere in questo passaggio, uno dei tanti in cui Prato sottopone a Coen il suo sconforto per la marginalità cui “Paese Sera” sembrava relegarla: Tante volte ti buttai là l’idea di qualche rubrica. Mai sono stata spinta a farlo; una risposta dubbiosa ha spento sempre nel dirla la mia proposta. Potevi provare, eri sempre in tempo a 162 163 Fondo Ferri-Ferrari. Le sottolineature sono nell’originale. Giornalista che si occupava delle riviste del Touring Club. La lettera proviene dal fondo Ferri-Ferrari. 63 rifiutarla164. Con ogni probabilità Dolores avrebbe voluto ricavarsi, sulle pagine di “Paese Sera”, uno spazio analogo a quello, passato ormai alla storia, della “treccia di Berenice”: la rubrica “Settevolante”, firmata da Berenice, al secolo Jolena Baldini. Pubblicata tutti i giorni, la rubrica aveva come logo una lunga treccia (da qui il nome) disegnata, nell’ordine, da Renato Guttuso, Renzo Vespignani e Corrado Cagli. C’era di tutto in quelle novanta righe: la mostra di pittura, l’intervista all’attore del momento, l’uscita di un libro, storie di cani gatti e canarini, il dialogo con un tassista, l’annuncio di un premio letterario, le frivolezze e le maldicenze del generone stravaccato nei ristoranti di Roma o in bella mostra al circolo del tennis Paioli. Un capitoletto di quella rubrica, “Cocktail”, era un bazar di notizie: amori finiti o sbocciati, furti di bici, auto e moto, ricette culinarie, ricevimenti nelle ambasciate, tutte le curiosità e i fatti del variopinto mondo della celluloide e della tivvù, i cambi di casa, gli acquisti e le vendite delle ville al mare o in montagna, il colore del pigiama di un politico, il prezzo dei gioielli di Bulgari, le disavventure di un critico teatrale, il conseguimento di una laurea, l’ultimo disco di successo165. Quando arrivò a “Paese Sera”, nel 1949, Berenice scriveva piccole notizie che raccoglieva fra i galleristi di via del Babuino. Era molto amica di Sibilla Aleramo, e frequentava il Club degli artisti in cui circolavano Ungaretti, Mafai, Moravia. Aveva libero accesso agli studi più esclusivi: Guttuso, Levi, Mazzacurati, Mafai, Attardi Schifano, Treccani, De Chirico. Due vite, due carriere, quelle di Berenice di Dolores, evidentemente parallele, destinate a non incontrarsi, né socialmente né umanamente. Nel 1955 fu proprio Fausto Coen a voler trasformare il materiale raccolto da Berenice in rubrica fissa, inventandosi il nome della rubrica e lo pseudonimo della giornalista. Per Dolores, al contrario, uno spazio riservato non arrivò mai, così come non arrivò mai il successo come pubblicista, certo più per motivi legati al suo carattere che per capacità: consegnava in ritardo, scriveva articoli spesso troppo lunghi, chiedeva di poter intervenire su articoli già inviati, aveva scarsa capacità di adattamento, nel lavoro come nella vita. A volte, l’originalità della trattazione andava di pari passo con la complessità dei pezzi, e questo rendeva i suoi articoli non accessibili al vasto pubblico del giornale; la totale libertà di giudizio di Dolores, inoltre, le impediva di valutare se i contenuti fossero più o meno adatti alle pagine di un quotidiano. Ma proprio in questo risiede, in fondo, l’unicità di Prato come figura del giornalismo italiano, femminile e non. 164 165 Lettera del 24 marzo 1970, fondo Ferri-Ferrari. E. Parpaglioni, op. cit., p. 50. 64 “Paese Sera”, in crisi anche per la forte concorrenza di nuovi quotidiani come “la Repubblica” e “Reporter”, fu chiuso d’ufficio, e all’improvviso, il 3 aprile 1983 dalla Impredit, società che lo aveva acquistato da Amerigo Terenzi. Grazie all’intervento del presidente della Repubblica Sandro Pertini, che ricevette al Quirinale una delegazione di operai e tipografi in rivolta, a una sottoscrizione di lettori, e alla battaglia in tribunale condotta dai giornalisti superstiti, il primo dicembre dello stesso anno il giornale tornò in edicola. Quando però, nel 1987, Claudio Fracassi lasciò la direzione per fondare il settimanale “Avvenimenti” iniziò un lunga agonia fatta di interruzioni e riprese, fino alla chiusura nel novembre del 1989. Un ultimo tentativo di risuscitarlo, nel novembre 1993, durò poco: nel luglio del 1994, il direttore Renzo Foa annunciò la cessazione definitiva delle stampe. 65 III – Gli articoli, “il ventre di Roma”: Dolores Prato e Matilde Serao Sembra interessante, in questa sede, tentare un’analisi più approfondita riguardo ai contenuti degli articoli di Dolores Prato raccolti in questo lavoro. Gli eventi che più immediatamente contano, per la giornalista come per la scrittrice, sono i riti religiosi, i cibi preparati nelle festività, i rituali della tradizione, come le ghirlande del Natale, o i cambiamenti sociali, anche piccoli, minuti, come la diversità nel linguaggio contemporaneo rispetto al passato, l’utilizzo di vocaboli stranieri e le “odiose importazioni”166 provenienti dall’America, l’aver uniformato il colore dei taxi a quello delle altre città europee (Verdi mi piacciono di più), il cambio dei nomi degli autobus (Piccolo funerale). Particolarmente a cuore stanno a Dolores i santi, il martirologio, tanto che aveva anche proposto a “Paese Sera” una rubrica con il santo del giorno. Impossibile non risentire, in questa propensione, l’eco degli anni trascorsi nel collegio della Visitazione di Treia, dove la lettura del martirologio – come in tutti i conventi - era un rito quotidiano167. Basta citare alcuni titoli: Santi, beati e parenti di oggi, 25 giugno, San Pietro pescatore, La nuova chiesa di Sant’Eugenio, S. Francesco di Sales e Angelica Arnaud, Il santo bisestile, Il nostro protettore. Di certo, quello che si manifesta immediatamente è la forte presenza di Roma e della sua storia, che si tratti di monumenti, urbanistica, architetture, rioni, tradizioni. Roma e la sua essenza, il suo essere, nel profondo e per nascita, la capitale universale del cattolicesimo e del suo “popolo”. A Roma si arriva, da Roma si può anche partire se non ci si resta, ma per Roma non si transita. Roma è una meta, non è una strada. Forse per questo ogni sua espressione, materiale o spirituale, simbolica o storica, assume il significato della strada. Ne deriva che le strade a Roma sono di tutti i generi e le genti che questo hanno capito, verso di lei, o contro di lei, hanno sempre camminato. Anticamente nel Foro era segnato il centro della città che rappresentava anche il centro ideale del mondo gravitante verso quel punto. […] Strada semovente fu il trionfo pagano prima, e la processione cristiana poi. Strada di purificazione il millenario pellegrinare dell’umanità a questa mèta. Strada d’interiore elevazione l’affluire qui dei grandi spiriti del mondo. Strada d’arte vitale quella degli ertisti che costituiscono un ininterrotto pellegrinaggio senza punte giubilari. I secoli hanno portato a Roma pellegrini di tutte le specie: della fede, della curiosità, dell’arte, 166 167 In Per favore!, pezzo contro l’uscita in fascicoli della “gloriosa storia americana, sia pure sotto costo”. Cfr. D. Prato, Le Ore, cit. 66 del lavoro. Tutto questo pellegrinare del mondo verso Roma conferma la ricchezza intuita di strade d’ogni genere: della morale e del pensiero, dell’arte e della vita, del cuore e della fede, strade invisibili lanciate di qui all’assalto del cielo. (Una strada di Roma) Protagonisti di molti articoli e approfondimenti sono il Tevere e Trastevere, un fiume e un rione che Prato aveva studiato nelle loro trasformazioni, che sentiva profondamente romani e rappresentativi della sua Roma, un quartiere e due sponde in cui amava perdersi passeggiando, tanto che troviamo un articolo di ben venti cartelle intitolato Divagazioni tiberine, insieme a Terminata la Festa de noantri Trastevere torna ai trasteverini, Trastevere: terra dove ogni leggenda è vera, Trastevere misterioso, o, come abbiamo visto, il paginone dedicato sul “Globo”, Il Tevere ex-biondo un amico che dobbiamo salvare. “Ora incomincio il tuo inno di lode, o Trastevere!” Per lo spazio di un secondo, tanto da stendere la mano per prendere la penna, ho creduto che avrei scritto così. Una di quelle tante pulviscolari condizioni, brevi più di un respiro, che si avvertono come vere e nell’immediato finire sono già false. Sciogliere un inno di lode a Trastevere! E’ semplicemente ridicolo. Trastevere si dice. Nel dirlo qual è il suo massimo elogio, e nel riconoscere l’impossibilità di farlo compiutamente è la confessione della sua grandezza. Trastevere tutto fatto di terra color d’ora. Di terra color d’oro il monte, di terra color d’oro la pianura che si abbassa sotto l’acqua a reggere il passaggio del fiume che porta sciolto quel colore. […] Trastevere, estremo ramo di gente etrusca che si fermò sulla sponda destra del fiume a guardare la grandezza nascente della gente latina all’opposta sponda. Roma crescente lo fissava sospesa e non volle col Trastevere risoluto ponti duraturi; ne bastava uno solo e purché fosse di legno, materia soggetta all’ascia e al fuoco. Trastevere che è poi stato sempre un poco una piccola Etruria, che è tuttora una piccola Roma nella grossa Roma come il giallo di un fiore è il cuore di un fiore. Trastevere che di fronte alla Roma dei sette colli, fu e restò la Roma di un solo colle, ma del più alto, Trastevere è stato sempre temuto.; è troppo dignitoso e fiero. Trastevere, terra dove forse la leggenda è vera tanto essa è umana, e dove la verità è leggendaria tanto essa è bella. Bella come l’aspetto statuario della sua gente, di quella poca che ci resta veramente trasteverina. […] Qualunque ne sia la ragione, è bello che Trastevere abbia una strada chiamata Roma Libera. Tutto il mondo è pieno di sepolcri e dappertutto ci sono tombe con un angelo o un genio 67 nell’atto di spegnere la falce, simbolo della vita, capovolgendola contro terra, ma solo a Trastevere in una tomba così, fu scolpito: “Buona notte, mastro Jacopo”. Io sostengo che bisogna amare Trastevere anche per quel “buona notte”. Bisogna amare Trastevere per lo zelo con cui la sua farmacia, la seconda di tutta Roma, si occupò di diffondere farmaci per sedare gli isterismi femminili. Bisogna amare Trastevere che fu sempre in prevalenza terra di lavoratori, tanto che S. Benedetto di lì portò via il suo “prega e lavora”. Bisogna amare Trastevere perché S. Francesco lo scelse per sua dimora e per quella del suo primo convento romano; tutti sappiamo quali erano i suoi criteri di scelta. Dobbiamo amarlo perché il Petrarca fu incoronato poeta da un trasteverino; perché sul Granicolo trovò l’estremo rifugio il Tasso; perché qui Raffaello incontrò la gioia viva della sua vita. Capita di divagare così col pensiero, vagando per Trastevere; capita di pensare a queste e a tante altre cose perché la ricchezza del rione è inesauribile tanto che si possono anche incontrare frammenti di vita simili a pensieri. […] Inutile dire, inutile fare, lo spirito di Trastevere fu e resta “naturaliter popularis”, naturalmente repubblicano. (Trastevere: terra dove ogni leggenda è vera) Soprattutto, Dolores voleva restituire, con i suoi “elzeviri”, come lei stessa li definisce in diverse occasioni, il sapore della Roma antica, “vera”, con il suo colore, la sua anima e, perché no, il suo ventre. Per ventre, in Prato, potremmo intendere sia la parte popolare, verace, originale di Roma - la pancia, in qualche modo - ma anche ciò che si trova nella Roma sottoterra, in ciò che è nascosto; e, allargando il concetto, nella Roma antica che è sempre più nascosta a un primo sguardo, ma che spunta ogni tanto, qua e là, restituendo il sapore della Roma universale. E di questa ricerca pratiana troviamo esempi in diversi articoli, di cui qui riportiamo alcuni passi fra i più significativi: La chiesa proprio bella non è, anzi qualcuno dice senz’altro che è brutta. Ma brutta o bella che sia, porta almeno sui suoi muri e sugli edifici annessi, il colore di Roma. Oramai sono così rare le costruzioni nuove che ripetono quel nostro colore di terra arrossata cotta dal sole, che quando ne sorge qualcuna che non sia color pisellino o bianco-calce, ma di quella tinta calda, intensa, suggerita dal nostro orizzonte e dal nostro clima, si è disposti ad assolvere anche più di una 68 stonatura architettonica. Se in S. Eugenio stonature ci sono, il colore le assolve (La nuova chiesa di S. Eugenio) Svelare il ventre, come si è detto, è anche, per Dolores Prato, raccontare quello che non si vede, la Roma invisibile alla luce del sole, che però, a volte, per uno studio particolare o per un incontro casuale, può all’improvviso manifestarsi: come l’identità della Cecilia sepolta nel Cemetero di Callisto, accanto alla cripta dei papi, partendo da alcuni scritti dell’archeologo Belvederi; o come la scoperta di una basilica sotterranea sotto una villa ai Parioli, compiuta seguendo i passi di alcune persone incontrate per strada. Catacombe: sepolcreti sotterranei, stretti, lunghi, tortuosi, umidi, bui, dove mai penetrò il sole, parrebbe dovessero accogliere tutto ciò che è negazione di luce e di vita, tutte le tenebre e tutte le morti di questo povero mondo. Invece, sulla faccia della terra, non c’è luogo da cui emani tanta luce come dal buio di quelle sotterranee gallerie mortuarie. Luce di vita; luce di martirio; luce di fede; luce di dottrina; luce di poesia, luce di sicure speranze; luce di miriadi di piccole lucerne; luce di nomi che illuminano ancora di vita quelle caverne, dove la morte non entrò neppure con un segno, con un grafito, con una parola, con un simbolo. “Lucina” è uno di questi nomi luminosi, forse il più luminoso: quello che ripetendosi con insistente uniformità attraverso i primi secoli cristiani, li costella di tanta luce, come se a ogni poco s’accendesse una lampada viva nell’ombra sotterranea delle catacombe. […] La “Cecilia”, dormente nel Cemetero di Callisto, accanto alla Cripta dei Vescovi di Roma, potrebbe essere quella stessa matrona “Lucina” del III secolo: attiva, coraggiosa, pietosa, di cui si è accennato. […] Questa “Cecilia-Lucina”, sarebbe assai più grande e più vera di quella, che la leggenda ci tramandò come “Cecilia martire”. Lucina viva solo per una formidabile forza operosa, acquista un volto nell’orante della Cripta di “Cecilia”; attenua la lucentezza del suo nome, perché noi vi possiamo scorgere attraverso la nobile figura di una donna dei “Cecili”. In questa nostra epoca devastata materialmente e spiritualmente, l’archeologo puro, che freddamente esamina muri e scavi; che matematicamente stabilisce misure, nomi e date, non trova più posto nelle nostre folle cieche ed affamate, che chiedono solo pane per il corpo e luce per l’anima. Ma un archeologo come il Belvedere, dalle cui parole e dai cui scritti io ho inteso attingere 69 questa luce, che ho cercato di riflettere, in cui l’archeologia ha accentuato e approfondito il suo carattere sacerdotale, deve essere benedetto per la luce di vita, che trae da quegli oscuri sepolcreti, per offrirla alla nostra morta “cecità”. E nel suggerirci l’ipotesi della identità delle due donne, dà a noi il conforto di riallacciare la nostra fatica e il nostro patire quotidiani a quelli di “Cecilia-Lucina”, che, come noi, visse la sua vita, superata però da una carità, che noi non conosciamo più. (Da Cecilia a Lucina) E, ancora, da Il mondo sottoterra: Il quartiere dei Parioli, uno dei più moderni, che passa per aristocratico per la gente ricca che l’abita, è uno dei più antipatici di tutta Roma. Un quartiere che potrebbe appartenere a qualsiasi città privo com’è di ogni carattere romano. Non ha neppure un rudero, neppure una colonna antica, neppure una facciata barocca, neppure il colore di Roma perché quassù le case sono di tutte le tinte esclusa quella tipica della città. Per ritrovare Roma in questo quartiere bisogna sforzarsi a pensare che una di queste strade banali, segue il tracciato della Salaria Vetus, ma è troppo poco […] Pochi giorni fa passando per una di quelle strade dove le ville son più grandi e più folto il verde, dove i massicci cancelli stanno sempre chiusi, vidi gente silenziosa che infilava uno di quei cancelli semiaperto, si inoltrava per un viale, prendeva a sinistra un sentiero bordato di limoni che scendeva lentamente, voltava, scompariva. Non poteva certo andare tutta dai signori della villa anche perché quella gente era popolo. Voglio dire che c’erano giovani e vecchi, poveri e ricchi, operai e preti, gente che veniva da tutte le classi, da tutte le condizioni, da tutte le età. Sfilava silenziosa, rapida, sicura, entrava, procedeva, voltava, scompariva. Passai anch’io il cancello, percorsi il viale di mimose, scesi per il sentiero di limoni, voltai e mi ritrovai in un piazzale con una fontana nel mezzo, prospiciente la villa che dal di fuori non si immaginava così grande. Intorno a un tavolo di ferro c’erano delle seggiole a sdraio che erano state piegate e raccolte, vigilate tuttavia da un domestico. Ma quella gente non guardava intorno, andava dritta verso una porticina quasi nascosta nel fianco della villa, la varcava, ne era inghiottita. “Catacombe”, dissi tra me. Ed era curioso che la gente di oggi, avviata alle catacombe, avesse quell’andatura furtiva, rapida, silenziosa, come quella che attribuiamo ai primi cristiani quando nascostamente si riunivano laggiù dove seppellivano i loro martiri. Varcai la soglia della piccola porta ed ecco subito l’umido e il buio catacombale. Una scala a chiocciola s’inabissava sotto terra, i gradini corrosi mostravano grafiti e lettere; sui muri, 70 rischiarati da candele, epigrafi tronche, pezzi di marmo coi noti segni cemeteriali. E la scala scendeva quanto non avrei supposto, pareva di dover arrivare al centro della terra. Un lontano canto corale cominciò a sentirsi, si avvicinò, il chiarore di candele non viste rischiarò le tenebre, un Kyrie poderoso esplose al termine della scaletta, ed io mi trovai in una ampia altissima basilica sotterranea. Un vescovo, dei celebranti, dei sacerdoti addetti al servizio, un gruppo di chierici cantori. Tutti indossavano i paramenti all’antica, morbidi, fluttuanti, cadenti, raccolti in ampie pieghe. Il calice, la pisside, il turibolo uguali a quelli che si usavano nei primi secoli. Il sacerdote che dirigeva il coro voltava le spalle, ma le mani che si alzavano e abbassavano, spiccavano brune dal bianco della cotta. Nel gruppo dei cantori erano rappresentate tutte le razze. Un piccolissimo cinese dalla voce così limpida che quando si elevava sola dava più sensazione di luce che di suono. Un giovanissimo negro dal ciuffo crespo sulla fronte sprigionava una voce così cupa che pareva fosse il riflesso sonoro del suo colore. Due giapponesi con gli immancabili occhiali, un indiano alto e potente, un rhodesiano, due o tre sudanesi, tutta l’Africa, tutta l’Asia erano rappresentate in quel complesso corale, nonché l’Europa e l’America. Il celebrante era australiano, il diacono malese. Quando, leggendo il vangelo disse le parole: “Amen, amen, dico vobis” sentii quanto era bello questo ritorno di verità. La chiesa di Roma è andata per il mondo annunziando a tutti “In verità, in verità vi dico”, ed ecco che dalle più lontane regioni del mondo delle creature che hanno appresa da noi la buona novella, vengono e ce la ripetono, così come fanno i fratelli quando sono buoni, che fra di loro si ripetono i racconti che hanno imparato dai grandi. Un sacerdote nero come l’ebano fasciato da un ampio drappo di seta bianca, reggeva la mitria del vescovo. Coreografia, se volete, ma oltre a questa c’è un simbolo, oltre a questo c’è una sostanza, il mondo intero affratellato in un’idea che è partita da Roma, il mondo intero che nel rivolgersi a Dio prega e canta nella lingua di Roma. Quella folla che avevo visto sfilare silenziosa stava lì, ammassata, in piedi, raccolta, tuffata in una penombra satura di incenso. Potremmo quindi parlare, per Dolores Prato e i suoi articoli, del “ventre di Roma”? Crediamo di sì. In letteratura, la parola “ventre”, nel titolo, appare due volte, in due volumi molto diversi: Il ventre di Parigi, di Emile Zola, e Il ventre di Napoli, di Matilde Serao. Il primo, scritto nel 1873, era il terzo libro del ciclo dei Rougon-Macquart168; il secondo, del 1884, era la raccolta di alcuni articoli pubblicati, in seguito alla devastazione di Napoli causata dell’ennesima ondata di colera, sulle 168 Il ciclo dei Rougon-Macquart è la storia naturale e sociale di una famiglia sotto il Secondo Impero, un’opera di venti romanzi, pubblicati da Zola tra il 1871 e il 1893, che si estende su cinque generazioni e che comprende ben 1200 personaggi. 71 pagine di “Capitan Fracassa”169, che ai tempi occupava un posto rilevante come espressione di un giornalismo polemico e brillante. Il ventre, dunque, è qualcosa che fa riferimento agli aspetti collegati in qualche modo alla pancia, alle viscere, alla parte meno nobile dell’essere umano, al suo essere “animale”, preda degli istinti bassi, carnali. In Zola, il ventre di Parigi erano le Halles Centrales, i mercati generali, dove il popolo trovava il cibo, anche se talvolta cibo andato a male. Lo scrittore, fedele al suo realismo-naturalismo, rende al lettore la più dettagliata panoramica sui diversi generi alimentari presenti alle Halles, dalle variazioni di colore, agli odori, alle tipologie. Ma il ventre della città era anche il luogo meno nobile socialmente, più basso e becero: lì viveva e circolava il popolo minuto, lì il protagonista, Florent, oppositore del governo di Napoleone III, si ritroverà schiacciato dalla meschinità e dagli intrighi dell’ambiente dei piccoli negozianti, e finirà arrestato e deportato170. In Serao, il ventre di Napoli è la parte malata, malconcia, fetida, ma anche povera, misera, di quella miseria che ispira pietà e rabbia. Anche qui, il richiamo è agli stessi concetti di “bassezza”, sociale e morale, si potrebbe dire, rapportati alla vita più “esteriore” e alle osservazioni più superficiali relative alla città. Efficace la frase, Voi non lo conoscevate, onorevole Depretis, il ventre di Napoli. Avevate torto, perché voi siete il Governo e il Governo deve saper tutto. Non sono fatte pel Governo, certamente, le descrizioncelle colorite di cronisti con intenzioni letterarie, che parlano della via Caracciolo, del mare glauco, del cielo di cobalto, delle signore incantevoli e dei vapori violetti del tramonto: tutta questa retorichetta a base di golfo e di colline fiorite, di cui noi abbiamo già fatto e oggi continuiamo a fare ammenda onorevole, inginocchiati umilmente innanzi alla patria che soffre; tutta questa minuta e facile letteratura frammentaria, serve per quella parte di pubblico che non vuole essere seccata per racconti di miserie. Ma il governo doveva sapere l’altra parte; il governo a cui arriva la statistica della mortalità e quella dei delitti; il governo a cui arrivano i rapporti dei prefetti, dei questori, degli settori di polizia, dei delegati; il governo a cui arrivano i rapporti dei direttori delle carceri; il governo che sa tutto: quanta carne si consuma in un giorno e quanto vino si beve in un anno, in un paese; quante femmine disgraziate, diciamo così, vi esistano, e quanti ammoniti siano i loro amanti di cuore; quanti mendichi non possano entrare nelle opere pie e quanti vagabondi dormano in istrada, la notte; quanti nullatenenti e quanti commercianti vi siano; quanto renda il dazio consumo, quanto la fondiaria, per quanto s’impegni al Monte di Pietà e quanto renda il lotto. Quest’altra parte, questo ventre di Napoli, se non lo conosce il Governo, chi lo deve conoscere? E se non servono a dirvi tutto, a che sono buoni tutti questi impiegati alti e bassi, a che questo immenso ingranaggio burocratico che ci cista tanto? E, se voi non siete la intelligenza suprema del paese che tutto conosce e a tutto provvede, perché siete ministro? […] Sventrare Napoli? Credete che basterà? Vi lusingate che basteranno tre, quattro strade, attraverso i quartieri popolari, per salvarli? Vedrete, vedrete, quando gli studi, per questa santa 169 Tra i suoi collaboratori, “Il Capitan Fracassa” annoverava Gabriele D’Annunzio, Edmondo De amicis, Eduardo Scarfoglio, Cesare Pascarella, Luigi Lodi. Vedi Valerio Castronovo e Nicola Tranfaglia (a cura di), La stampa italiana nell’età liberale, Editori Laterza, Roma-Bari 1979. 170 E. Zola, Le ventre de Paris, Fasquelle, Paris 1997. 72 opera di redenzione, saranno compiuti, quale verità fulgidissima risulterà: bisogna rifare. Voi non potrete sicuramente lasciare in piedi le case che si sono lesionate dalla umidità, dove al pianterreno vi è il fango e all’ultimo piano si brucia nell’estate e si gela nell’inverno; dove le strade sono ricettacoli d’immondizie, nei cui pozzi, da cui si attinge acqua così penosamente, vanno a cadere tutti i rifiuti umani e tutti gli animali morti; e che hanno tutte un pot-bouille, una cosiddetta vinella, una corticina interna in cui le serve buttano tutto; il cui sistema di latrine, quando ci sono, resiste a qualunque disinfezione [...] Voi non potete lasciare in piedi certe case dove al primo piano è un’agenzia di pegni, al secondo si affittano camere a studenti, al terzo si fabbricano fuochi artificiali: certe altre dove al pianterreno vi è un bigliardo, al primo piano un albergo dove si pagano tre soldi per notte, al secondo una raccolta di poverette, al terzo un deposito di cenci. Per distruggere la corruzione materiale e quella morale, per rifare la salute e la coscienza a quella povera gente, per insegnare loro come si vive – essi sanno morire, come avete visto! – per dir loro che essi sono fratelli nostri, che noi li amiamo efficacemente, che vogliamo salvarli, non basta sventrare Napoli: bisogna quasi tutta rifarla171. E’ difficile leggere queste righe da Il ventre di Napoli, di Matilde Serao, e non creare immediatamente un collegamento con Dolores Prato e i suoi scritti su Roma. Certo, le epoche erano diverse, i motivi che muovevano la scrittura anche, ma i toni, i modi diretti e decisi con cui le due donne giornaliste si rivolgevano ai detentori del potere, la denuncia insita in poche righe, l’attaccamento “amoroso” alla città e la conoscenza profonda di questa, non possono passare inosservati. Il ventre di Napoli, prima di essere stampato da Treves (Milano 1884), comparve come inchiesta giornalistica: “un’inchiesta concitata, nervosa, del tutto moderna”172, scrive Banti nella sua monografia su “Donna Matilde”. Pagine scritte per la rabbia e la pietà che Serao provava nel vedere lo scempio della sua amata città devastata dal colera, e anche per rispondere, in qualche modo, ad Agostino Depretis che, inorridito per le condizioni igieniche di Napoli, aveva affermato: “Bisogna sventrare Napoli”. Serao, nei suoi articoli, descriveva in maniera molto accurata e dettagliata la condizione edilizia e umana della vecchia città. Da ognuno di questi, che via via approfondivano un particolare aspetto di Napoli (Bisogna sventrare Napoli, Quello che guadagnano, Quello che mangiano, Gli altarini, Il lotto, Ancora il lotto, L’usura, Il pittoresco, La pietà173) emergeva l’anima antica, calda, viva, e nello stesso tempo immutabile, di ogni abitante della città. Certi personaggi, come quelli presenti nei capitoli dedicati all’usura e al lotto; certi quartieri, come quelli descritti nel capitolo sul pittoresco, si colorano e si ravvivano della partecipazione accorata dell’autrice che, mentre denuncia mali e vizi conclamati, ad essi si lega con il filo della sua napoletanità. L’occhio indagatore di Serao, dunque, non è quello del cronista sceso a Napoli per raccontare al proprio lettore le suggestioni che lo hanno colpito, ma è l’occhio scrupoloso e implacabile di una sua 171 Matilde Serao, Il ventre di Napoli e altre storie, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2005, pp. 11-16. Anna Banti, Matilde Serao, Utet, Torino 1956, p. 95. 173 Questi i capitoli della prima parte del libro, denominata Venti anni fa. 172 73 cittadina che ne conosce i segreti, e dal pittoresco e variegato mondo che l’ha nutrita sa estrarre l’essenza di una natura portentosa, che si perpetua e si rinnova, ma sempre nel dolore. Come Dolores conosceva tutto di Roma, Matilde conosceva tutto di Napoli: il disegno delle straducole di Porto con i loro infimi mestieri, via dei Mercanti, via di Mezzocannone la Vicaria, la Sezione Mercato, il Lavinaio. Tutti i quartieri fatiscenti e luridi dove si annidava e brulicava la povera gente. Il ventre di Napoli mostrava con passione, finezza di osservazione e senza indulgenze, i problemi della città, verso cui Serao aveva dimostrato un’attenzione costante, come testimoniano molti articoli del “Piccolo”, del “Giornale di Napoli”, della “Domenica letteraria”. E il rimedio, secondo Serao, non poteva essere far passare per questi quartieri tre o quattro grandi strade, distruggendo le tane di chi non aveva altro riparo: bisognava “rifare”. La seconda parte del libro, intitolata Adesso e scritta nel 1904, nacque come constatazione, a venti anni di distanza, di ciò che era stato fatto per Napoli. Il giudizio di Serao questa volta è spietato, cioè privo della pietà che aveva ispirato la prima parte. C’erano strade che continuavano a essere frequentate da ladri che sbucavano dai vicoli e aggredivano passanti, e perfino carrozze, lungo il nuovo Rettifilo, il quale avrebbe dovuto rappresentare la rinascita, il risanamento, la redenzione di una città che ora contava seicentomila abitanti. Alcuni vizi e deformità parevano insanabili, ma Serao non voleva più sopportarli, e condannava coloro che si erano limitati a costruire bei palazzi, spendendovi molto del denaro destinato al risanamento, e trascurando i quartieri più poveri, dove il degrado era rimasto immutato. “Da quanti anni non viene, qui, un sindaco, un assessore?”174. E, in una certa misura, la stessa appassionata denuncia sembra essere lanciata da Dolores Prato nei suoi articoli, e anche nel suo Voce fuori coro, come avremo occasione di approfondire in seguito. Anche nelle vite da giornaliste delle due donne, pur nella profonda diversità, anche di ruoli – Serao ebbe sempre un posto di prim’ordine, fino a fondare e dirigere quotidiani importanti come “Il Mattino” e “Il Giorno” – possiamo riscontrare un trait d’union. Innanzitutto nella lunga durata, quarantennale per Prato, cinquantennale per Serao: donne che scrissero su giornali di rilievo del Novecento, voci critiche, taglienti, limpide, che ritraevano con occhio fuori dal comune Roma e Napoli. Poi nell’essere entrambe giornaliste della capitale: Dolores sempre, Matilde per un breve periodo (nel quale, comunque, fondò il “Corriere di Roma” dopo aver sposato Edoardo Scarfoglio). Entrambe, da sottolineare, con un’idea precisa, sebbene per certi aspetti molto diversa l’una dall’altra, su Roma, grande capitale. Se dell’idea di Dolores abbiamo accennato, e parleremo approfonditamente nell’ultimo capitolo, 174 M. Serao, op. cit., p. 88. 74 presentando mito e antimito di Roma capitale, di Serao riportiamo un significativo passaggio, tratto dall’articolo La conquista di Roma, pubblicato sul “Fanfulla della Domenica” del 12 luglio 1885, che ben sintetizza il suo punto di vista: Roma è stata e sarà sempre la città della forza, della politica e degli affari [...]; anche nell’ultima incarnazione non l’hanno potuta prendere che le armi, e non la conquisteranno che i milioni [...], uscite per un momento dai vostri sogni mistici e guardate l’immensa trasformazione che i milioni vanno inducendo nella forma e nello spirito di Roma [...]. Figuratevi Roma fra dieci anni [...]. Ciò che la terrà sotto il piede conquistatore sarà qualche potentissimo istituto di credito, ove clericali e liberali sederanno fraternamente intorno alla medesima cassa. E siate pur certo che anche l’archeologia verrà a patti coi milioni, se non vorrà vedere i suoi domini scomparire sotto l’invasione delle società edificatrici175. Serao, con questo articolo, rispondeva al collega Giulio Salvadori, giornalista di “Cronaca Bizantina”, che aveva affermato che Roma sarebbe stata conquistata solo dall’“Ideale” e si sarebbe data solo a chi poteva assicurarle una terza volta la conquista del mondo. E lo faceva scevra di ogni ottimismo, contrastando quell’idea di Roma protesa alla riacquisizione di un primato e all’affermazione di un destino di potenza, civiltà e cultura, che Angelo Sommaruga , editore audace e moderno che aveva fondato “Cronaca Bizantina” e molte altre riviste letterarie con sede nella capitale, portava avanti con convinzione. E questo nonostante che avesse fatto emergere, al contempo, la complessità di Roma: sede del Parlamento, della corte e del Vaticano, aggredita dalla speculazione edilizia e da loschi traffici, conquistata dai “buzzurri”, contesa dalla “parassitaria nobiltà nera”, “specchio della degradazione e corruzione degli ideali risorgimentali”176. Matilde Serao, si è detto, ebbe un rapporto molto speciale, intenso, prolungato con il giornalismo italiano, e, soprattutto, con quello napoletano, negli anni in cui Napoli viveva il crepuscolo della sua vicenda di capitale di un Regno e stentava a inserirsi in un discorso nazionale di produttività economica e nuova coscienza civica. Per lei, il giornalismo era il modo più moderno e costruttivo per entrare in contatto, quotidianamente, con il suo pubblico. Serao scrisse per “Giornale di Napoli”, “Roma Capitale”, “Fanfulla della domenica”, “Nuova antologia”, “Cronaca Bizantina”. Nel “Capitan Fracassa”, si mostrò attenta ai nuclei tematici che l’accompagneranno per tutta la vita e nei cinquant’anni di giornalismo. Restarono salde e consolidate le sue idee politiche, letterarie e sociali: Matilde Serao “non ha svolgimento, non ha storia, tutto quello che è a vent’anni, lo è a cinquanta, a sessanta”177. Fu sempre in aperta polemica con il femminismo e il movimento di emancipazione della donna, si 175 Wanda De Nunzio Schilardi, Matilde Serao giornalista, Edizioni Micella, Lecce 1986, p. 45. Ivi, p. 45. 177 Ivi, p. 36. 176 75 oppose al divorzio, fu fedele alla monarchia, interpretò sempre e con grande sensibilità i bisogni delle classi umili, ma rimase una fervente oppositrice del socialismo e delle forze di sinistra. Negava idee politiche alle donne, capaci, a suo avviso, solo di sentimenti (Alla lega della democrazia, “Il Piccolo”, 26 aprile 1880) e contestava al genere femminile il diritto di voto (Votazione femminile, “Il Piccolo”, 2 settembre 1878)178. Scrisse sull’Esposizione universale di Torino, sui rapporti franco-russi, sui veglioni del carnevale romano, sull’urbanistica umbertina, sulla pittura napoletana. E il giornalismo scandì anche le tappe della sua vita di donna. Il 28 febbraio 1885 sposò infatti il grande giornalista Edoardo Scarfoglio, cinico, ironico, mordace, dissacratorio, amico degli intellettuali meridionali più in vista quali Gabriele D’Annunzio, il pittore Francesco Paolo Michetti, lo scultore Costantino Barbella. Con lui fondò il “Corriere di Roma”, in cui scrivevano, tra gli altri, Giovanni Verga, Antonio Fogazzaro, Giuseppe Giacosa; l’intento era quello di farlo diventare il nuovo “messia giornalistico”, che potesse svolgere la missione dell’incivilimento della società come era nei programmi degli intellettuali post-risorgimentali. Serao appoggiò l’impresa con passione ed entusiasmo, inaugurò la famosa rubrica Api, Mosconi e Vespe, che rimase costante in tutti i giornali in cui lavorerà in seguito, firmandosi “gibus”, pseudonimo aristocratico e parigino (gibus era un cappello a cilindro nato in Francia), indicativo del fatto che quello era uno spazio riservato a cronaca modana, note di costume, articoli di saper vivere. I coniugi Serao-Scarfoglio tornarono poi a Napoli, e con il “Corriere di Napoli”, fondato nel 1888, portarono nella città partenopea il giornalismo moderno, la pagina della cultura, quella letteraria, la prosa del romanzo, i servizi dall’estero. Ancora, aprirono “Il Mattino” (lui direttore, lei condirettrice), in cui Serao dedicò molti pezzi alla sua amica Eleonora Duse: il matrimonio e la collaborazione col giornale finirono nel 1902. Forte delle passate esperienze, e ormai famosa, Serao fondò, da sola, prima la rivista letteraria “Il settimanale” e poi, nel 1904, “Il Giorno”: con questo quotidiano iniziò una guerra aperta al “Mattino”. “Il Giorno” era l’emanazione della volontà, del cervello e dei gusti di Matilde Serao, non più sopraffatta dalla personalità del marito; aveva ambizioni grandi, ma non riuscì a diventare un grande giornale di informazione, né un giornale politico, né fu capace di essere stimolo morale e intellettuale, ma ebbe grande successo, pur nella sua tendenza a commentare moralisticamente e sentimentalmente gli avvenimenti. La linea politica del giornale, che era quella di Serao, può essere così riassunta: fede monarchica, opposizione ai movimenti e ai partiti di sinistra, antibellicismo e antifascismo179. 178 Ivi, p. 28. Cfr. Wanda De Nunzio Schilardi, “Il Giorno” e il fascismo (con inediti), in AA.VV., Matilde Serao tra giornalismo e letteratura, a cura di Gianni Infusino, Guida editori, Napoli 1981, pp. 73-102. 179 76 Quanto allo stile, Serao ebbe chiare le scelte letterarie da operare fin dagli esordi: rifiutava il realismo, troppo materiale. Era una riserva ideologica, filosofica quasi. Scriveva a Gaetano Bonavenia: “Non mando nulla a “La Farfalla”: il loro esclusivo realismo non è il mio. Io intendo per realismo la vita tutta, con la sua poesia altissima e la sua modesta prosa, con i suoi slanci generosi e le sue meschinità reali – intendo la passione tumultuosa e gli amori soavi -. Noi vediamo questi giovani in preda ad uno strano delirio: vogliono un solo lato, lo sporco, come i romantici ne volevano solo il poetico”180. Serao preferiva il bozzetto, una rappresentazione, cioè, del tessuto sociale e delle storie individuali attraverso una descrizione volutamente esteriore, accompagnato da una prosa copiosa e colorita, a volte anche con qualche eccesso e forzatura. Rievocava aspetti, ambienti, figure, della più gremita e misera vita napoletana, con sicura intuizione della psicologia individuale e collettiva, specie femminile181. In conclusione, se Anna Banti, nella sua monografia, afferma che per Matilde Serao il giornalismo era stato un modo si procurarsi di che vivere, una facile scorciatoia verso il benessere, dannoso per la sua attività di romanziera (considerazione applicata dai più anche alla carriera giornalistica di Dolores Prato), sembra invece chiaro che per Serao il giornalismo ebbe tutt’altra importanza, fino a considerarlo la sua più antica vocazione182. “Matilde Serao coincide con il ritratto della città, il ritratto segreto e commosso, trepidante e acceso, vibrante e straziato di una città che esprime la sua grandezza non già attraverso l'opulenza ed il sorriso, ma con la miseria ed il pianto183”. L’ispirazione ai problemi, alle condizioni di vita e ai sentimenti del popolo restò un momento determinante e centrale in alcuni libri fra i più importanti di Serao. La sua frenesia sul lavoro, la sua straordinaria professionalità come giornalista e direttrice del “Giorno”, il quotidiano da lei fondato nel 1904, capace di scrivere sul tamburo qualsiasi pezzo fosse necessario per completare ogni giorno l’edizione del giornale, su qualsiasi argomento, la resero una presenza ingombrante ma leggendaria, di indiscussa autorevolezza, a Napoli (e non solo a Napoli) negli anni fra Ottocento e Novecento. Eccentrica e determinata, nonostante il suo irritante antifemminismo teorico (spesso in contrasto con i caratteri delle protagoniste delle sue storie), è un personaggio di sconcertante modernità, che, in buona sostanza, costituì per le donne italiane un modello di riferimento a lungo ineguagliato. E’ un modello che si basa soprattutto su una personalità aggressiva e capace di affermarsi in qualsiasi ambiente, da quello tutto maschile, sprezzante e difficile per le donne, del giornalismo professionista, in cui “Matildella” seppe imporsi con la sua studiata camaraderie e la celebre, contagiosa risata, che faceva dimenticare ai suoi colleghi la sua caparbia tenacia sul lavoro, a quello dei salotti aristocratici, dove si imponeva invece, a dispetto della sua apparenza fisica 180 Ivi, p. 29. In Enciclopedia bibliografica universale, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2007, v. 17, p. 559. 182 In W. De Nunzio Schilardi, Serao giornalista, cit., p. 21. 183 Mario Stefanile, Labirinto napoletano: studi e saggi letterari su scrittori di ieri e di oggi, ESI, Napoli 1958, p. 44. 181 77 inelegante e goffa, con la forza magnetica della sua personalità184. Una donna, una giornalista, che ha dei tratti comuni con Dolores Prato non secondari e che, come Prato, ci ha restituito un ritratto-bozzetto della sua città particolare, diverso, in qualche modo unico. Gli articoli di Matilde Serao, e poi il libro, tempestivamente pubblicato, ebbero un immediato successo, sancito poi dal giudizio di Benedetto Croce: Tutto ciò che la Serao aveva notato sulla vita e il carattere della plebe napoletana, e che le aveva porto argomento di bozzetti [...] venne fuori nel 1884, nell’occasione del terribile colera che infierì nella città e dopo la visita del re Umberto alle luride strade e case dove abitava la plebe, quando il ministro Depretis che aveva accompagnato il re e per la prima volta fatto conoscenza di quell’orrido cumulo di miserie, uscì nella frase, divenuta per qualche tempo celebre: “Bisogna sventrare Napoli”. E la Serao scrisse una serie di articoli col titolo Il ventre di Napoli: pagine tirate d’un fiato, descrizioni rapide, aneddoti narrati con semplicità, calorosa eloquentissima perorazione a pro del popolo napoletano, piena di quell’affetto materno del quale ella possiede il segreto [...] E io confesso di preferire i bozzetti e le novelle, e fin gli articoli del Ventre di Napoli, scorretti e quasi improvvisati ma spontanei, al quadro sapiente, ch’è troppo sapiente, del Paese della cuccagna185. Le pagine tirate d’un fiato, le descrizioni rapide, gli aneddoti narrati con semplicità potrebbero essere quelle di Dolores Prato su Roma, senza dover ricorrere ad ulteriori aggettivazioni, con la sola differenza, evidente, che in Prato manca completamente il “calore materno” verso la gente, le persone, che viene sostituito con un amore profondo per l’architettura della città. Ad accomunare le due scrittrici giornaliste, sicuramente, l’attitudine all’osservazione che diventa motore narrativo, una percezione visiva fortissima, che si fa quasi fisica, e che trasforma le scrittrici in testimoni e protagoniste di un’esperienza della città. Se esiste una componente “femminile” nelle due scritture, la si può cercare proprio nello sguardo che si mette al livello dei dettagli, e quasi soppesa gli oggetti, in modo di strappare la descrizione all’astrattezza attraverso un rapporto carnale con le cose, le case, i monumenti, Roma (per Dolores), Napoli (per Matilde). All’unisono, infine, la denuncia verso lo “sventramento” che avrebbe dovuto, in entrambi i casi, “guarire” la città e che si era invece rivelato, in molti casi, un’operazione politica che truccava e mascherava contraddizioni profonde. Molti i punti in comune fra i due approcci giornalistici di fronte alla propria città, dunque, che potrebbero anche far pensare a una lettura di Matilde Serao da parte di Dolores, che sicuramente avrebbe apprezzato e condiviso tanto realismo e tanta passione, e soprattutto, avrebbe notato il coraggio di una donna che un giorno, di fronte alla propria città ferita, 184 185 Antonia Arslan, Introduzione, in M. Serao, op. cit., p. IX. Benedetto Croce, La letteratura della nuova Italia, vol. III, Laterza, Bari 1915, p. 165. 78 decise di puntare il dito contro il primo ministro. 79 IV – Articoli editi, inediti e rari: una bibliografia Per ognuno di questi pezzi, che la stessa Dolores Prato conservò in raccolte chiamate Articoli, riporto qui i passi più significativi, per avere un assaggio di ciò che di veramente particolare, originale, a tratti sagace, sicuramente notevole anche dal punto di vista giornalistico-letterario, questa ricerca vuole far riemergere. D’altra parte, anche gli articoli pubblicati sono ormai perle rare, praticamente sconosciute a tutti, e meritano di ritrovare spazio. A) EDITI E RARI, con foglio di giornale (ACGV, Pg 1-143; fondo Ferri-Ferrari) 1. Da Cecilia a Lucina, in “Il Quotidiano”, 2 dicembre 1945, p. 2; occhiello: Peregrinazioni romane; impaginazione: apertura della pagina “Cronaca di Roma”; collocazione dattiloscritto: Pg 1-3. L’articolo è una riflessione storica, e morale, che prende spunto dagli scritti dell’archeologo Giulio Belvederi sull’identità della Cecilia sepolta nella zona più sacra del cimetero di San Callisto, accanto alla cripta dei Papi. Una Cecilia “di cui nulla si sa con certezza, e che forse non patì neppure il martirio”, ma che nel V secolo divenne “martire” (Santa Cecilia), forse “per un martirio della vita non meno doloroso” di quello di sangue. L’ipotesi è che Cecilia sia la Lucina, donna patrizia caritatevole, che nel III secolo donò un suo campo sull’Appia, che diventerà poi il cimetero di Callisto, ma che non viene neanche nominata nella sua catacomba. 2. I gatti insidiano l’eternità di Roma, in “Paese Sera”, 19 maggio 1950, p. 3; impaginazione: taglio centrale; collocazione: Pg 4. Particolarissima considerazione a proposito di Roma, dove eternità è “sopravveste di continuità”, dove tutti i caratteri della vecchia-antica Roma “sopravvivono nella nuova con la longevità delle sue statue che, spezzate e mutilate, fanno ancora di essa una strana città abitata da gente viva e da gente di pietra”. Ma questa eternità edilizia, religiosa, linguistica, è incrinata dal gatto: unico elemento nuovo – introdotto in città solo dopo il Mille, nonostante fosse conosciuto dai tempi dell’antico Egitto – di Roma, “immigrato, invasore, diabolico, e antiromano”, per il suo non essere mai diventato Roma, restando gatto. 80 3. Una strada di Roma, in “La Via”, 20 maggio 1950, p. 3; impaginazione: taglio centrale; collocazione: Pg 5-8. “A Roma si arriva, da Roma si può anche partire se non ci si resta, ma per Roma non si transita. Roma è una meta, non è una strada. Forse per questo ogni sua espressione, materiale o spirituale, simbolica o storica, assume il significato della strada”. I secoli hanno portato a Roma pellegrini di tutte le specie, segno, per Prato, “della ricchezza inaudita di strade d’ogni genere: della morale e del pensiero, dell’arte e della vita, del cuore e della fede”. La strada di cui si parla nel pezzo è però la strada luminosa, la “vera Via dei Pellegrini”, che si forma intorno a mezzogiorno all’interno della chiesa della Trinità dei Pellegrini, dove nel Giubileo del 1550 San Filippo Neri ospitava chi veniva a Roma attraverso le strade del mondo. 4. La Repubblica sta sul Quirinale tra le antiche memorie e le bugie, in “Paese Sera”, 3 giugno 1950, p. 3; occhiello: Da quattro anni abita in un luogo ricco di suggestioni e di storia; sommario: Il colle più alto di Roma e il più salubre – Un minestrone ad arco che illumina soltanto uno sgabuzzino da cui si affacciavano i papi e i re – Il panorama più bello della città minacciato dai palazzi che sorgono con troppa fretta e con troppa ingordigia d’altezza; impaginazione: apertura; collocazione: Pg 9-11. Storia e suggestioni storiche del colle più alto di Roma, che attraverso lente e continue trasformazioni è diventato ora “un poco bugiardo”: c’è la bugia della scritta sul piedistallo dei due colossi attribuiti a Fidia e Prassitele, le bugie architettoniche delle facciate dei palazzi e dei finestroni che si affacciano su piccoli spogliatoi, delle porte finte, della balconata sul alto della piazza che si affaccia ormai sui palazzi. “Da tutto questo che si può dedurre per la nostra Repubblica che risiede lassù, il luogo è fasto o nefasto?” 5. Terminata la Festa de noantri Trastevere torna ai trasteverini, in “Paese Sera”, 2 agosto 1950, p. 4; sommario: I misteriosi caratteri del popolare rione scompaiono d’un colpo una volta l’anno quando il pubblico vi si riversa da ogni parte della città; impaginazione: taglio basso; collocazione: Pg 12-14. 81 Scorcio su Trastevere, “rione misterioso”, e sul popolo trasteverino, che “galleggia sulla banalità”, ma “singolare e inconfondibile”. “Trastevere è una terra di mistero per certe sue indeterminate promesse spesso chiuse in una parola come quella che sta dentro il nome delle carceri”: “Regina Coeli” era il convento dove le suore, ogni 4 ore, suonavano a festa e cantavano l’antifona della letizia (“Regina Coeli laetare, alleluia!”). Ora, “scomparsi il convento e la chiesetta, resta un nome (del carcere) promettente letizia”. 6. Una bella funzione, in “Paese Sera”, 27 febbraio 1951, p. 3; occhiello: La cerimonia al liceo Visconti; impaginazione: taglio basso; collocazione: Pg 15-17. Al centro dell’articolo la commemorazione del IV centenario della fondazione del Collegio. “Una bella funzione” è un modo di commentare tipico dei romani, “che, a forza di vedere spettacoli di tutti i generi, sono indifferenti a tutti”. Prato è spietata contro un funzione sì, “bella no”, “servita per fare in una scuola laica l’esaltazione dell’insegnamento clericale”, conclusasi con la distribuzione “né giusta né di buon gusto” di un opuscolo del ’40 con “le rituali esaltazioni fasciste”, in cui si leggeva: “Camerati, evviva Pio XII”. 7. La nuova chiesa di S. Eugenio, in “Paese Sera”, 6 giugno 1951, p. 3 impaginazione: taglio basso; collocazione: Pg 18-19. Pezzo sull’apertura della nuova chiesa dedicata allo “sconosciuto” Sant’Eugenio, offerta in dono al regnate Papa Pio XII, battezzato col nome di Eugenio. Chiesa “che proprio bella non è, anzi qualcuno dice senz’altro che è brutta, ma porta almeno sui suoi muri e sugli edifici annessi, il colore di Roma”. “Colore di terra arrossata cotta dal sole […], di quella tinta calda, intensa, suggerita dal nostro orizzonte e dal nostro clima che fa assolvere anche più di una stonatura architettonica”. 8. Trastevere: terra dove ogni leggenda è vera, in “Paese Sera”, 1 settembre 1951 p. 3; impaginazione: taglio basso; collocazione: Pg 20-22. Vero inno a Trastevere, “estremo ramo di gente etrusca che si fermò sulla sponda destra del fiume a guardare la grandezza nascente della gente latina all’opposta sponda”, “una piccola Roma nella grossa Roma come il giallo di un fiore è il cuore del fiore, “terra dove forse la leggenda è vera tanto essa è umana, e dove la verità è leggendaria tanto essa è bella”. Trastevere, allo spirito “naturaliter popularis, naturalmente repubblicano”. 82 9. La via di tutti i popoli, in “La Via”, 15 novembre 1952, p. 4; impaginazione: apertura; collocazione: Pg 23-27. “Strada di tutti i popoli” è il nome che Prato suggerisce in sostituzione di “via della Conciliazione”, “l’enorme vuoto che strada non è, piazza nemmeno” risultato della distruzione della “Spina”, la fila di case che divideva quella strada di Roma in “due corridoi tra case, palazzi, chiese, fontane e tante botteghe strette una addosso all’altra perché ci volevano stare tutte […] Due strade strette e soffocate che preparavano gli animi per meglio avvertire quelle due immensità”: la piazza e il tempio di San Pietro. Oltre a ripercorrere la storia della Spina e di quella visuale rovinata (“lo scempio”) Dolores propone di dar seguito all’idea dell’amico Torquato (Ferrari?), e “nobilitare il qualche modo quella banale composizione” di panchine e portalampade innalzando al posto dei sedili le statue dei santi protettori di tutte le nazioni del mondo. Da cui il nome “via di tutti i popoli”. 10. Le ghirlande, in “Paese Sera”, 25 dicembre 1956, p. 4; impaginazione: spalla sinistra; collocazione: Pg 28-30. La ghirlanda, corona fatta di fiori e fronde, “miracolo di Roma che aveva resistito al tempo, ebbe il suo colpo fatale con l’annessione”. Dolores Prato, prendendo spunto dal fatto che la tradizione delle ghirlande natalizie non esisteva più, ormai, manifesta in questo articolo la sua contrarietà a Roma capitale d’Italia. “La città che era stata per secoli un meraviglioso paese universale, ridotta a capitale di uno stato particolare, perdette pian piano ciò che dell’antichità classica era sopravvissuto per oltre due millenni. Da nord a sud affluì su Roma gente che l’invase, ne distrusse le piccole e grandi tradizioni che erano il suo meraviglioso patrimonio, la sua attività, unica al mondo, la trasformò in città simile a tutte le altre. E così fu distrutta anche l ghirlanda che era sopravvissuta proprio per indicare il Natale”. 11. Chi aveva ragione?, in “Paese Sera”, 29-30 gennaio 1957, p. 3; impaginazione: spalla sinistra; collocazione: Pg 31-32. Storia della disaccordo sorto tra San Francesco di Sales, vescovo-principe di Ginevra, e la santa baronessa di Chantal a proposito di Angelica Arnaud, abbadessa di Port Royal che chiedeva negli ultimi anni della sua vita di essere accolta tra le “visitandine”, ultima tra le ultime. San Francesco non volle farla entrare nel suo convento della Visitazione, la baronessa avrebbe voluto che questo accadesse. Chi aveva ragione? “Lo vedremo in paradiso”, rispondeva Francesco di Sales alla stessa Chantal. 83 12. Ricordo (“Incontro con Marchesi”), in “Paese Sera”, 19-20 marzo 1957, p. (non leggibile); impaginazione: spalla sinistra; collocazione: Pg 33-36. Un ricordo in ricordo di Concetto Marchesi, grande umanista e amico di Dolores. Non un coccodrillo, ma una riflessione sul funerale partecipatissimo di Marchesi: in apparenza “l’opposto del piccolo funerale che (Marchesi) desiderò quella sera” in cui con Dolores si mise a seguire il baldacchino di un uomo diretto al cimitero dei poveri a Prima Porta; “quella sera del piccolo funerale egli non credette di turbare il viaggio di quel morto col seguirlo tenendo me per mano: eravamo unità; unità col sentimento e con la speranza della povera gente. Il giorno che Marchesi se ne andò a me pareva che buttasse a tutti una speranza e un invito all’unione e che la folla lo raccogliesse. Solo in apparenza, Marchesi, non ebbe il funerale che desiderava quella sera, perché quella folla che lo seguiva era anch’essa unità”. Aveva un’anima sola, quella del comunismo 13. Un Natale e una Pasqua quest’anno si sovrappongono, in “Paese Sera”, 20-21 aprile 1957, p. 2; occhiello: Una singolare congiunzione di feste; sommario: Un incontro che avviene una volta ogni molti anni – Il significato delle pagane Palilie – Parabola del 21 aprile; impaginazione: apertura; collocazione: Pg 37-38. Il 21 aprile 1957 si sovrappongono nello stesso giorno il “Natale di Roma”, festa antichissima in cui a ogni cittadino era fatto obbligo di coronarsi di fiori, e la pasqua di risurrezione. Prato ripercorre le origini e la storia di questi riti pagani e cristiani. 14. Neve d’agosto, in “Paese Sera”, 6-7 agosto 1957, p. 3; impaginazione: spalla sinistra; collocazione: Pg 39-42. Articolo sulla storia dell’Esquilino e sulla leggenda della neve caduta sul “monte” in un 5 agosto della seconda metà del quarto secolo: evento straordinario che portò all’erezione della chiesa di Santa Maria Maggiore (ad nives) e che ogni anno viene commemorato con una cerimonia floreale (neve di petali di fiori che scende dal soffitto). 15. San Pietro pescatore, in “Paese Sera”, 28-29 giugno1958, p. 3; impaginazione: spalla sinistra; collocazione: Pg 43-49. 84 Vedi articolo San Pietro. 16. Vecchia Roma, in “Paese Sera”, 13 gennaio 1960, p. 3; impaginazione: spalla sinistra; collocazione: Pg 50-51. Il titolo che Prato aveva scelto per questo articolo era, in realtà, Resistenza romana o Resistenza di Roma. Un titolo che venne poi cambiato, non senza ribellione della giornalista, che esprimeva il senso dello scritto: “La vera Roma è ridotta simile al corpo di un martire: spezzata, dispersa, esposta a frantumi sotto forma di reliquia”. Dolores sostiene che la vera vecchia Roma resiste ancora in qualche piccola strada, scorciatoia, certi pini, qualche muro del colore naturale della città. E racconta del giorno in cui, per caso, seguendo un brulicare di gente, scoprì una basilica (di San Giacinto) sotto una villa dei Parioli. “Nel profondo della terra, un uomo, continuando nel modo e nello spirito l’antichissima figura del fessore, parlava così e il canto di un gruppo cosmopolita riempiva di voci latine le volte di una insospettata basilica. Pareva che Roma, perseguitata all’esterno dalla speculazione edilizia, anche monastica, si rifugiasse sottoterra come gli antichi cristiani”. 17. La spina, in “Paese Sera”, 22-23 gennaio 1960, p. 3; occhiello: “Una Roma dimenticata”; impaginazione: spalla sinistra; collocazione: Pg 52-54. L’articolo ripercorre di nuovo (vedi La via di tutti i popoli) la storia e la distruzione della Spina, strada doppia e angusta che conduceva all’immensità di piazza San Pietro, oggi sostituita da via della Conciliazione. 18. Due millenni di storia sul sarcofago di Augusto, in “Paese Sera”, 30-31 gennaio 1960, p. 3; occhiello: “Il fregoli degli edifici storici romani”; sommario: “Nacque tra due strade vitali, la Flaminia e il Tevere, e per parecchi secoli conobbe gli splendori pagani della vita e della morte, dominando il traffico terrestre e fluviale della capitale. Da sepolcro a fortezza”; impaginazione: apertura; collocazione: Pg 55-57. Vite e morti del mausoleo di Augusto, che da sepolcro si trasformò in “Mons Augustus” (quando nel Medioevo venne ricoperto da una coltre di terra), e che dopo il mille divenne fortezza. Poi ancora distruzione, divenne vigne e terra, e in seguito anfiteatro per i giochi (“Il Corea”), magazzino e, ancora, sala concerti: l’Augusteo. “Un tempio dell’arte e tutto il mondo 85 ce lo invidiò. Ma arrivò anche l’ultimo concerto […] Il fatidico piccone, simbolo di un’epoca, cominciò l’opera sua […] vide il sepolcro vuoto e repellente come una cassa da morto usata Finita la sistemazione della zona, quel povero rudero gareggiò in miseria e bruttezza con l’antesignana di tutto lo scatolame nazionale, la scatola dell’Ara Pacis”. Dolores Prato richiede di nuovo una sala, un auditorium, con l’antico nome di “Augusteo”. 19. Il santo bisestile, in “Paese Sera”, 1 maggio 1960, p. 3; occhiello: S. Giusto torna ogni quattro anni; sommario: Come nacque febbraio col suo giorno bisesto – Il Martirologio romano segue l’uso del calendario giuliano – Le regole del lunario – Duecento chiese dedicate alla Madonna e cinquanta al Salvatore; impaginazione: taglio basso; collocazione: Pg 58-60. Pensieri intorno a San Giusto, il santo festeggiato il 29 febbraio, e perciò ogni quattro anni. Un’“ingiustizia” del martirologio cui “corrisponde” – ravvisa Prato – un’“ingiustizia romana”: nella città delle mille e mille chiese non ce n’è neanche una dedicata a quel santo, anche se tra la decina di Giusti esistenti “alcuni avrebbero meritato almeno una chiesetta”. 20. Il Pantheon: il più enigmatico monumento romano, PRIMA PARTE, in “Paese sera”, 16 gennaio 1965, p. 3 occhiello: “Itinerari misteriosi nel tempo”; sommario: “Non si è mai saputo di certo come, quando, perché sorse – La sorte di questo edificio segue molto da vicino quella del suo eterno abitatore: il gatto”; impaginazione: spalla destra; collocazione: Pg 64-66. Alla scoperta del Pantheon, misterioso e simile al gatto. “Rutture e rabberci, demolizioni e ricostruzioni, forature e rattoppi, deturpato e restaurato, più volte soffocato da case e stambugi e più volte liberato, esso non ha mai svelato il mistero delle sue origini. Qualunque cosa sia venuta alla luce, ha complicato l’enigma”. Chi ci dirà mai cosa fece veramente Agrippa? Il Pantheon “è simile a quelle creature umane che all’anagrafe sono segnate come figli di nessuno”, e poi, essendoci dentro tutti gli dei, è impossibile dare a uno di loro un posto preminente. Ma “l’epoca in cui questo misterioso olimpo sarebbe sorto coincide con quella in cui il gatto, animale sacro e misterioso, per la prima volta posò le sue zampe sul suolo romano (quando Augusto assoggettò l’Egitto) e il suolo dove le posò è proprio lì”. “Pantheon e gatti sono contemporanei, apparvero insieme gli uni vicino all’altro e insieme sono rimasti e si assomigliano. Difficili da capire loro, difficile da capire lui”. 21. Il primo tempio pagano che diventò Basilica – SECONDA PARTE, in “Paese Sera”, 31 86 gennaio 1965, p.3; occhiello: Itinerari misteriosi nel tempo: il Pantheon; sommario: Un compromesso fra l’illegale imperatore bizantino Foca e il Senato di Roma – Un nome popolaresco e affettuoso Maria Rotonda; impaginazione: apertura; collocazione: Pg 61-63. Focus sul Pantheon, primo tempio pagano trasformato in chiesa cristiana. Fu ceduto al Papa con un compromesso che ne permise la riapertura, dopo due secoli, nel primo decennio del VII secolo. Venne dedicato alla Madonna e a tutti i martiri, poi fu chiamato “Maria Rotonda”, nome che gli rimase per circa un millennio, “finché col trasporto qui della capitale diventando tutti dotti e retorici, si perse l’affettuosa confidenza che avevamo con i nostri monumenti e restaurammo il Pantheon senza dimenticare l’acca”. 22. Oggi la festa della patrona degli automobilisti, in “Paese Sera”, 9 marzo 1967, p.7; occhiello: Santa Francesca Romana; impaginazione: spalla destra; collocazione: Pg 67-68. Storia di “Ceccolella”, nome familiare romano per santa Francesca Romana, patrona degli automobilisti (romani), bastonata sia dagli angeli che dai demoni. 23. S. Francesco di Sales, in “l’Osservatore Romano”, data: 1967, p. 3; impaginazione: spalla destra; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. Vedi Il nostro protettore 24. Italiana spaesata in Italia, in “Paese Sera”, 19 marzo1968, p. ?; occhiello: E’ obbligatorio sapere l’inglese? collocazione dattiloscritto: Pg 112; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. Vera e propria protesta di Dolores Prato “contro l’abuso di parole e frasi anglosassoni nei giornali […] Inutili stupidi e servili esotismi che pronunciamo spesso in modo ridicolo”. E commenta: “E’ assurdo che anche la stampa di sinistra ci abitui alla lingua di quelli per i quali essa non ha eccessiva simpatia. Dunque anche essa si piega ad una confusa sudditanza 87 colonialista, altrimenti si farebbe obbligo di adoperare le parole della lingua dei lavoratori italiani”. “Io sono di origine ebraica e senza religione, all’infuori di uno stupefatto timore avanti al mistero che la scienza sposta, ma non spiega, però sono profondamente, orgogliosamente italiana”. 25. Verdi mi piacciono di più, in “Paese sera”, 23 marzo 1970, (uscito tagliato), p ?; occhiello: Nel colore di Roma il colore dei Taxì; collocazione dattiloscritto: Pg 121; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. “Ce li avevano promessi, cominciano ad arrivare e ce li terremo i brutti taxì gialli”. Inizia così un articolo che è una bellissima parentesi sul colore di Roma, “quello rossiccio dei mattoni cotti da secoli di sole, quello dei muri del Campidoglio di Ostia all’ora del tramonto, crosta di pane contadino cotto al forno”, ma è anche una denuncia sulle scelte degli architetti in merito ai colori dei nuovi palazzi (la “distruzione coloristica”). E sul giallo dei taxi, in sostituzione del verde: “lo paventavo quel brutto colore […] Prima quel colore aveva una sua bruttezza in potenza, ora l’aveva in atto: brutto senza condizionale”. 26. 1971, l’anno dei centenari, in “Paese Sera”, 10 gennaio 1972, p. (non leggibile); collocazione manoscritto: Pg 72; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. “Nella stampa di allora la presa di Roma era spesso una notiziola in fondo, prima dei rebus e degli indovinelli. Del resto i contemporanei avevano poco da rallegrarsi: Roma, da città originale e unica, stava decadendo a capitale del Regno Sabaudo. Con l’avvento della Repubblica, se l’avessero epurata, un centesimo di quel che era si sarebbe salvato, invece fu mantenuta nel suo ufficio riconoscendole anche gli anni di anzianità. Per questo il 1970 fu l’anno del “Centenario” e forse per reazione il 1971 è stato l’anno dei centenari”. Da qui si apre un lungo elenco ricco di curiosità e commenti: Marcel Proust avrebbe cento anni, così come Paul Valéry, Grazia Deledda, don Luigi Sturzo, Luigi Albertini, Trilussa, “quel che Proust faceva con la fiumana della Recherche, su la francese società bene di allora, lo faceva lui, con minore curiosità e maggiore pena, sulla borghesuccia società della piccola Italia unitaria”, e ancora l’attore Ruggero Ruggeri, il pittore Giacomo Balla, il poeta Francesco Chiesa, della legge delle Guarentigie, delle Folies Bergéres, dell’arrivo a Roma della regina Margherita e dell’Aida di Verdi. Il 27 novembre, poi, ricorreva il centenario del Parlamento, che si era riunito a Roma per la prima volta cento anni prima. “Aveva titubato nella scelta del locale, poi decise per la Curia Innocenziana, l’odierno Montecitorio, e fece bene, il luogo è abituato alle lotterie”. 27. Il Tevere ex-biondo un amico che dobbiamo salvare, in “Speciale Il Globo”, 29 giugno 1972, p. 9; 88 occhiello: E’ stato per secoli veicolo di traffici, luogo di svago e di bellezza. I muraglioni costruiti cento anni fa per difenderci dalle alluvioni lo hanno trasformato in un corso d’acqua fetido e inutile; impaginazione: paginone speciale sul Tevere; collocazione: Pg 69-70. Il Tevere e i suoi porti, fulcro della vita e dei commerci romani. “Sempre capriccioso, girò qua e là coprendo o scoprendo: presso ponte Cavour coprì un pezzo di Roma, lì sotto ci sono strade e case, e nel 1575 perse addirittura la testa, cambiò percorso e si mangiò un pezzo di Ostia antica […] Un rimedio per questi straripamenti era necessario, ma bisognava studiarne un altro, quello dei muraglioni è brutto senza discussione […] La campagna allora scorreva dentro la città insieme col fiume […] Senza margini la vita scivolava sino all’acqua […] Quelle due sponde si rifecero con la più ottusa e brutale uniformità. Tanta varietà di bellezza sostituita d un monotono nulla”. Poi un lungo e dettagliato elenco delle altre “distruzioni” e degli “atterramenti” per mano di “Re Piccone”. “Ci avevano tolto il fiume con i muraglioni, ce ne avevano resa difficile la vita arginando il lungotevere con muri […] Il Tevere che è una realtà, ce l’hanno resa un sogno […] Se lo amiamo dobbiamo salvarlo”. 28. Rivivendo con Vinciguerra, in “Nuova Repubblica”, 17 dicembre 1972, pp. 4-5; collocazione: Pg 113; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. Articolo sulla prigionia e la morte di Mario Vinciguerra, nel trigesimo della morte, in cui si legge anche dell’amicizia di Prato con Adriano Tilgher. “Tra perseguitati e accantonati dal regime ci si cercava per sentirci meno soli”. Del suo amico Vinciguerra Dolores ricorda: “L’onestà portata a quella esasperazione poteva anche essere antipatica, quella rigidezza poteva anche essere scambiata per superbia, era invece involontaria denuncia della sconfinata disonestà in cui viviamo”, ma anche “la gattofilia, non quella di moda, ma quella pensierosa avanti al mistero dell’animale, l’avevamo in comune” (si parla nel pezzo dei loro due gatti: Minou, di Dolores, e Sniff, di Vinciguerra), e gli oggetti di carta, piccoli piccoli, che faceva in prigione. “Capanne, casette, uccellini e fiori, organetti e farfalle, pipistrelli e stelle”, lui, “leggero come i suoi giochetti”. 29. S. Francesco di Sales e Angelica Arnaud, in “L’Osservatore Romano”, 11 agosto (?), p. ?; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. Vedi Chi aveva ragione? 89 B) DA RINTRACCIARE In questa sezione riporto gli articoli di cui è possibile ipotizzare un periodo di pubblicazione, per l’oggetto a cui si riferiscono o in base ad alcuni indizi presenti nelle corrispondenze che Dolores teneva, soprattutto con Fausto Coen, e anche gli articoli che, per misure e tematiche affrontate, possono far pensare a un’avvenuta pubblicazione. Tuttavia, la chiusura della sede di “Paese Sera”, e l’assenza di un archivio del giornale stesso, ne rendono molto difficoltosa la ricerca. Del quotidiano, per di più, si hanno archivi, ma microfilmati, nelle due Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, e il tipo di supporto rende alquanto ardua la reperibilità dei pezzi. 30. Un sogno di Shakespeare realizzato da Reinhardt – Il film è del 1933, potrebbe essere un raro pezzo di Prato pubblicato in qualche testata minore; collocazione: Pg 105. Recensione della versione cinematografica del “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare realizzata dal regista Max Reinhardt. “Dopo averla vista possiamo supporre che il cinema trionferà ormai d’ogni più superba fantasia”. 31. Il figliuol prodigo – Il film è del 1934, anche questo potrebbe essere stato scritto per la stessa testata minore del pezzo su Sogno di Reinhardt; collocazione: Pg 106. Recensione del film di Luis Trenker “Figliuol prodigo”, “un film che arriva alla nostra anima direttamente come il canto del poeta detto da lui stesso”. “Luis Trenker ci aiuta ad essere più buoni e a pregare. Quando sullo schermo non ci sono che due nubi tra le quali s’apre un ventaglio di luce che rischiara le cime bianche dei monti, e la musica del maestro Becce prende un’andatura mistico-corale, chi non ha sentito che quel quadro era un atto di fede e la musica una preghiera?”. 32. Piccolo repubblicano – uscito su “Paese Sera” nel giugno 1958. Scriveva Prato in una lettera a Coen del 26.6.1958: “Grazie per aver pubblicato il Piccolo repubblicano”186; collocazione: fondo Ferri-Ferrari. 186 In S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 165. 90 Le celebrazioni per i diversi fatti che costituirono la formazione e l’affermazione della nostra costituzione repubblicana, sono così modeste, così timide che forse non stona la piccola celebrazione di un piccolo repubblicano di quel tempo in cui con tanta speranza si preparava la nostra Repubblica”. Episodio che si svolge tra Dolores e Stefano, cinque anni, figlio di una sua amica. “Per Favore, non mi chiamare più piccolo Repubblicano perché a me il re non piace neppure lì […] Se mai dimmi ‘piccolo pubblicano”. 33. Piccolo funerale – risale agli anni tra il 1950 e il 1960: in alcune foto storiche di Roma, infatti, compaiono autobus con i numeri al posto delle lettere già dal 1960; collocazione: Pg 95; “Oggi accompagniamo alla sepoltura le tabelle degli autobus con le ultime lettere. Addio ST, addio FL, addio NT, addio MP, addio CP, con voi muoiono tanti piccoli pezzetti di Roma […] Ci tolgono quelle coppie di lettere in cima agli autobus e le sostituiscono coi numeri […] Per i più la lettera, oltre al suono, ha una facciata, un nome, un colore, un’antipatia o una simpatia”. “E perché Roma non assomiglia che a se stessa, poteva ben permettersi il lusso di avere delle indicazioni autofilotranviarie diverse da quelle di Milano, di Berlino, di Parigi”. 34. Una nonna tutta da scoprire – probabilmente pubblicato: Dolores aveva scritto una serie di reportage da Cortona (non rinvenuti) che Coen, nel settembre del 1970, aveva sponsorizzato presso il suo amico Paccino del Touring Club italino. Nella stessa lettera del 4 settembre (fondo Ferri-Ferrari) scriveva: “Su Paese Sera probabilmente pubblicheremo alcuni articoli veri e propri”; collocazione: fondo Ferri-Ferrari. Breve fotografia storica della città di Cortona “che, stando all’anagrafe leggendaria, sarebbe la nonna di Roma”: Dardano partì da Cortona, sua patria, per andarsene a fondare Troia; da Troia partì Enea per andare nel Lazio e gettare i presupposti per la futura Roma. “Cortona, città che si gusta in ogni angolo, in ogni prospettiva […] allontana da sé il nome di nonna: ma se proprio lo è, allora bisogna riconoscere che è la Marlene Dietrich delle città”. 35. 1970 finestre – probabilmente pubblicato su “Paese Sera” (in una lettera a Bruno Fiore del 5 novembre 1973 Dolores Prato dice che con questo articolo vuole partecipare al concorso giornalistico “Luigi Vanvitelli” di Caserta); collocazione: Pg 73-75. In questo articolo sul bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli, in cui si ripercorrono le maggiori opere dell’architetto, tra cui ovviamente la Reggia di Caserta (ma anche la “deliziosa chiesetta della Misericordia di Macerata”), Prato non perde l’occasione di scrivere anche del “nefasto centenario di Roma capitale d’Italia”, caduto tre anni prima, in cui “intervennero anche 91 i preti, non per celebrare le esequie, ma per assolverne la rovina”. “Nel 1970 invece di quel disgraziato ricordo di Roma, sarebbe stato meglio celebrare le 1970 finestre di Caserta, una coincidenza che non si ripeterà più”. 36. Il lenzuolo piegato – pubblicato sul “Globo” nel novembre del 1973, come si deduce da una lettera del fondo Ferri-Ferrari che il direttore del quotidiano, Antonio Ghirelli, scrisse a Prato il 12 novembre 1973; collocazione: Pg 102. La Sacra Sindone viene qui indagata nei suoi più piccoli particolari da una Prato che si e ci pone diversi interrogativi sulla reliquia conservata a Torino. “Mettersi sulla strada dei pro e dei contro è interessante anche per i dubbi che camminano affiancati a loro”. E poi “in tante ipotesi passate, presenti e future, il fatto meno ipotetico, anzi l’unico certo e che smentisce tutta l’iconografia cristiana, è il segno delle stimmate […] Di qualunque natura esse siano, false lo sono sempre, lo dice la Sindone con l’impronta che ci lasciò un uomo sicuramente crocifisso con chiodi. Un corpo umano non può sostenersi appeso a due chiodi infilati nel metacarpo, vale a dire, tra le dita non ancora divise; la carne si straccerebbe […] Perché invece gli stigmatizzati hanno tutti queste ferite delle mani fuori posto? […] Che se in questi fenomeni ci fosse qualcosa che trascende la patologia umana, bisogna dire che con i nostri errori Iddio ci si diverte”. 37. Un po’ dei tanti centenari (addio al 1974) – tipico pezzo di Prato di fine/inizio anno; probabilmente pubblicato su “Paese Sera”; collocazione: Pg 79. Elenco dei centenari di eventi e personaggi celebri e importanti. “ma per i romani c’è anche il centenario di una loro bottega di carta, oggetti di cancelleria e piccola stamperia […] In quella cartoleria, la cui romanità nobilita anche le banali sacchette di plastica, si riflette quella che fu la sorte della città e del papato dopo l’annessione: sceso il Piemonte per distruggere e assorbire, fu assorbito e niente distrusse, neppure il potere temporale”. 38. Divagando per Trastevere – probabilmente pubblicato su “Paese Sera”; collocazione: Pg 94. “Ora incomincio il tuo inno di lode, o Trastevere!” Per lo spazio di un secondo, tanto da stendere la mano per prendere la penna, ho creduto che avrei scritto così. Una di quelle tante pulviscolari convinzioni, brevi più di un respiro, che si avvertono come vere e nell’immediato finire sono già false. Sciogliere un inno di lode a Trastevere! E’ semplicemente ridicolo. Trastevere si dice. Nel dirlo qual è, è il suo massimo elogio, e nel riconoscere l’impossibilità di farlo compiutamente è la confessione della sua grandezza. Trastevere tutto fatto di terra color d’oro. Di terra color d’oro il monte, di terra color d’oro la pianura che si abbassa sotto l’acqua a reggere il passaggio del fiume che porta sciolto quel colore. 92 39. 11 febbraio 1626 – probabilmente pubblicato per un anniversario di uno dei concordati; collocazione: Pg 111. La data indica il giorno in cui fu ratificato il “concordato” fra l’Etiopia e Roma, fra il Negus Seltàn Sagàd e Papa Urbano VIII, con cui il negus abiurò l’eresia e giurò fedeltà alla chiesa di Roma. Prato spera nel giorno in cui “si ridarà fede all’antico patto”, considerando anche la data, 11 febbraio (nel 1929 giorno dei Patti Lateranensi), significativa in questo senso per la Chiesa italiana. 40. Per favore! – impossibile datarlo, ma probabilmente pubblicato in concomitanza con l’uscita di fascicoli sulla storia americana; collocazione: Pg 114. Pezzo contro l’uscita in fascicoli “della gloriosa storia americana, sia pure sotto costo”, una delle tante “odiose importazioni” provenienti dall’America. “In democrazia anche i paesi coloniali hanno diritto di esprimere un loro desiderio, tanto più quelli che lo sono appena […] Se importare si deve, importiamo qualcosa che ci serva. Proprio di storia non sappiamo che farcene. Ce ne abbiamo tanta che potremmo riempirne i mercati del mondo!”. “per cortesia, risparmiateci la diffusione che ci state promettendo”. 41. Il nome segreto – probabilmente pubblicato. Il manoscritto è della lunghezza standard e di tema affine agli altri pezzi che Dolores scriveva per “Paese Sera”: collocazione: Pg 116. “Chi è Roma, come si chiama, noi non lo sappiamo, né mai lo sapremo. “Roma” è un nomemaschera, quello sovrapposto al vero, messo per essere visto, per essere detto e soprattutto per nascondere l’altro”. Perché in realtà, sostiene Prato, anche per Roma, come per le altre città dell’antichità, fu necessario tenere segreto il nome perché se i nemici fossero arrivati a conoscerlo avrebbero evocato la divinità protettrice conducendola in un altro luogo; e la città, priva di quella protezione, cadeva in arbitrio del nemico. Dolores parla di alcune ipotesi di nome: l’arcano Bona o Ope Consiva, Angerone, dea del silenzio, oppure Flora o Venere, che nel culto segreto era invocata come Amor. “Dato che i preromani leggevano all’inverso, il nome volgare potrebbe derivare dalla stessa parola: Amor letto al rovescio”. 42. Il rione di cui si parla oppure Trastevere misterioso – probabilmente pubblicato su “Paese Sera” – deducibile da lunghezza e argomento; Collocazione: Pg 120. 93 Ancora un ripercorrere la storia di Trastevere e dei suoi abitanti, delle sue chiese e dei Santi che passarono di là. “Il mondo ha sempre guardato con simpatia o con timore a questo forte e leale rione che nell’evolversi della storia ha costantemente preceduto, mai seguito […], come fecero le monache di Regina Coeli che cantarono all’infinito quel “laetare” che tutto il mondo brama di poter presto ripetere in un necessario avvento di giustizia e di pace, perché proprio non ne può più”. 43. Roma, non altro – appunto in calce: “dice Luciani: E’ di una gentilezza che non perdona”, quindi probabilmente pubblicato; collocazione: Pg 122. Pezzo aspro e polemico sull’Anno Santo, il Giubileo, che porterà a Roma “turisti-pellegrini che non dovranno neppure faticare a cercare un ufficio postale, gireranno in autobussetti per raccogliere lettere e cartoline mentre le nostre vanno al macero”. “Si suggerisce di cominciare ad ispezionare i nostri servizi igienici. Chi ispezionerà la gente in arrivo che può portarci infezioni più seriamente delle cozze di Napoli? […] Riguardo a Roma quella splendida fusione di arte arcorea ed edilizia, può essere distrutta, ma, per carità, che non lo vedano i turistipellegrini”. “SI sventra, si sopraeleva, atei e religiosi allargano, modificano, sempre in vista dell’Anno Santo e Roma, un pezzetto alla volta sta finendo di andarsene. Cominciò a finire quando non fu più Roma, ma Capitale; da 105 anni la stanno distruggendo e l’Anno Santo le darà la sua scoppola”. 44. Dal presepio al mondo – probabilmente pubblicato su “Paese Sera” a Natale di qualche anno; collocazione: Pg 124. Il tema è ancora quello della ghirlande natalizie, “corone di mortella”, che appese fuori dai portoni di Roma segnalavano che all’interno di quella casa c’era un presepe da vedere. Segue una difesa del presepe (contro l’albero di Natale), “espressione collettiva di vita”, “il più antico partigiano della pace”. 45. Il mondo sottoterra – probabilmente, in questa versione, uscì su “Paese Sera”, tanto che una versione per Giordani subì piccole modifiche (vedi sotto); collocazione: Pg 125. E’ il racconto della scoperta della basilica sotterranea, sotto una villa dei Parioli. Il pezzo è stato poi ripreso quasi interamente nell’articolo “Vecchia Roma”, pubblicato su “Paese Sera”, già citato. Questa è una versione più marcatamente polemica contro i Parioli, il quartiere “più antipatico” di Roma. 94 46. Il mondo sottoterra – appunto: “questo rivisto per Giordani”, quindi pubblicato probabilmente su “La Via”; collocazione: Pg 143. Rivisitazione focalizzata sulla varietà delle etnie che si era presentata agli occhi di Prato in quel “mondo sottoterra”, ai Parioli, “il più insignificante dei quartieri che passa per aristocratico perché lo abita molta gente ricca. Privo d’ogni carattere romano, potrebbe appartenere a qualsiasi città”. C) INEDITI 47. Come era Roma – Il titolo è stato dedotto da un appunto di Prato: “forse vale per Come era Roma – dunque probabilmente INEDITO; Collocazione Pg.117 “Roma che cosa era prima che dal nord le venisse appioppata la funzione di capitale d’Italia? Politicamente era il capoluogo della Comarca, ma questo nessuno lo sapeva. Essa per se stessa era una piccola città addormentata in un verde secolare con un suo strano carattere di immensità. Piccola ed immensa”. A Roma “solo l’universale aveva diritto di cittadinanza”, per la sua luce, la forma del suo spazio, il suo cielo, e “forse per la coincidenza di un particolare punto astrologico con uno magnetico”. A Roma si riversava il fior fiore dell’intelligenza internazionale. “Soprattutto era una città voluttuosa. Il “carpe diem” se non fosse nato qui forse non sarebbe nato altrove, perché Roma ti dà la bellezza delle sue luci e delle sue notti diffusa nel senso eterno del suo non essere”. 48. Divagazioni tiberine – INEDITO in questa versione integrale ma pubblicato “in pezzi”; collocazione: Pg 118. E’ il testo unico da cui sono stati tratti gli articoli “Il Tevere ex-biondo” e “Trastevere dove ogni leggenda è vera”, pubblicati, come citato sopra. E’ una dettagliata e lunghissima (circa 20 cartelle) “divagazione” su Tevere, Trastevere e gli “sventramenti” e la cementificazione che li hanno trasformati per sempre. 49. Il nostro protettore – INEDITO - non viene pubblicato, come scrive Coen in una lettera del 18.3.1952 (fondo Ferri-Ferrari), perché la maggioranza dei lettori di “Paese Sera” “avrebbe 95 avuto la sorpresa di sentir parlare su un giornale che non ha odore d’incenso, a lungo e troppo benevolmente, di santi e di miracoli”. collocazione: Pg 119 E’ uno dei pezzi sui Santi del giorno che Dolores amava scrivere. Chi è Francesco di Sales vescovo-principe di Ginevra, nostro patrono. Il pezzo è una sintesi biografica del Santo, la descrizione di un uomo, disinvolta e priva della tradizionale impronta agiografica. Perché, dice Prato, “E’ uno di noi, può essere il nostro protettore […] Quest’uomo che fondava un ordine religioso dove si insegnava che tutte le cose devono restare nella loro pace, che anche le porte vanno chiuse con dolcezza, quest’uomo, su qualunque sponda noi si sia, può essere nostro amico giacché egli volle essere ponte che supera e unisce”. 50. Distruzioni autorizzate – E’ un articolo scritto il giorno dopo che una frana di tufo si è verificata alle pendici dei Parioli; difficilmente Prato riusciva a uscire nei tempi imposti dalla cronaca: probabilmente INEDITO; collocazione: Pg 127. Commento a un fatto di cronaca: la frana di tufo che si è verificata il giorno prima alle pendici dei monti Parioli su viale Tiziano. Prato qui accusa la società Shell, che ha scavato per “allargare la sua piazza”. Lo chiama “fatto doloso”, e ripercorre le tappe nella storia che hanno manomesso questo punto della città. 51. Santi, beati e parenti di oggi, 25 giugno – non abbastanza strutturato per essere un articolo: probabilmente INEDITO; collocazione: Pg 76-78. Elenco dei santi celebrati il 25 giugno. 52. Una giornata di Dolores Prato – INEDITO - appunto: “Accomodando un poco, spiegando qualcosa. Un bell’articolo per rivista”; collocazione: Pg 80. Cronaca del 21 settembre 1978, San Matteo. Dolores racconta della sua visita alla mostra fotografica della galleria di piazza Rondanini, dove vuole vedere “solo le foto marchigiane”. Poi si fa condurre in giro per le stanze di quel palazzo, dove lei era stata in collegio, in cerca della sua camera e di quella delle sue amiche. Scopre che la sua guida è di Penna San Giovanni. E ricorda un po’ le Marche, un po’ i suoi giorni di studentessa. 96 53. Un falso miracoloso – INEDITO - Questo dovrebbe essere l’articolo non inviato da “Paese Sera”. Scriveva Dolores a Coen il 24.3.1970: “Avevo già pronto un altro pezzo che avrebbe suscitato interesse, groviglio grottesco, misterioso, patetico, in anni come i nostri, le stimmate di p. Pio, della sua fedele ecc. ecc e in ultimo una domanda a scienziati che nessuno ha ancora fatto. Ma non manderò più nulla”187; collocazione: fondo Ferri-Ferrari. 54. Non ci sono più ghirlande per il Natale – INEDITO - Prima versione, più lunga, da cui è stato tratto l’articolo “Ghirlande”, già citato. Prato stessa ha appuntato accanto al titolo “da prenderci notizie per un lavoro più grande su Roma - come articolo l’ho tutto tagliato”; collocazione: Pg 107-108. 55. Ringraziamento a Giovanni XXIII – INEDITO – E’ del 1959; COen scriveva in una lettera del 27.4 1959: “Carissima, l’articolo sui nomi di Pio e Giovanni non va bene perché è un nuovo duro attacco a Pio XII (che non c’è più) e un inno al nuovo Papa (nei confronti del quale è bene procedere con una certa cautela)”188; collocazione: Pg 109-110. “Con papa Pacelli si è chiusa la dozzina dei papi autonominatisi Pii, e non sappiamo se questo nome voleva rappresentare un proposito, una affermazione, o una semplice imitazione affettiva. Pio è un nome brutto e freddo, è senza colore, senza passione, senza musicalità, è un nome monotono e tisico”. Segue il racconto di tutti i Pii. “Sia benedetto Papa Giovanni che ci ha dato un nome largo, disteso, un nome che Cristo sicuramente amò perché sempre si amano i nomi degli amici prediletti […] Per grazia di Papa Roncalli venne Giovanni, un nome vasto e riposante, un nome che sa di cascina e di Ultima Cena”. D) da INES FERRI – Sant’Angelo in Vado - INEDITI Secondo Ines Ferri, questi articoli, raccolti in una cartellina dalla stessa Dolores, non pubblicati, andrebbero datati dal 1930 al 1950, e sarebbero comunque antecedenti agli altri. 187 188 In S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 173. Ivi, p. 166. 97 56. Una piantina di cicoria – INEDITO E’ un racconto autobiografico sull’innamoramento di Dolores verso il poeta Paolo Toschi: lui, “un cipresso alto e solo su una cima”; lei, la “piccola piantina di cicoria” ai suoi piedi, che non avrebbe dato alcun disturbo. Un rapporto che inizia e finisce, per lui, con un bacio. Perché poi l’amore scoppia tra Toschi e un’amica di Dolores, Ebe Palazzeschi (il nome è svelato da un appunto di Ines Ferri, che scrive anche che il paesaggio è quello dei dintorni di Sansepolcro, dove Prato e Toschi insegnavano). 57. Il fiore dell’uomo – INEDITO Racconto della prima volta – almeno così scrive la scrittrice - in cui Dolores, per uno scherzo del destino, vede “il fiore dell’uomo”, il membro maschile, di un conoscente che le sedeva di fronte in treno. “Per l’impertinenza di un bottone che sfilò la testa dal cappio dell’asola, per il complice disordine della biancheria sottostante, mi si mostrò, da un pertugio, il fiore dell’uomo”. 58. Un coltello - INEDITO Dolores racconta un fatto di cronaca nera (due ragazze che avevano ucciso a coltellate un’amica e il figlio piccolo per rubare una volpe), e lo collega a una storia di “povera gente”, storia come tante nell’Italia del dopoguerra, attraverso un oggetto: lo stesso coltello usato per uccidere, e abbandonato su un muretto, diventa un prezioso oggetto per la signora povera che lo trova per strada, perché con quella punta può pulire bene il palombo, pesce che costa poco e che piace ai suoi figli. Alla fine, il marito legge sul giornale i fatti di cronaca e restituisce il coltello alla questura. “La dignitosa povertà di quella famiglia dove, per caso, entrò lo strumento del delitto, direi che è superiore alla bassezza del delitto stesso. Questo, pur nel suo orrore, si spiega nelle sue origini con cause contingenti, con colpe nostre ed altrui, l’elevatezza di quella povera gente non ha cause, non è un’eccezione, è l’onestà innata di gran parte del popolo italiano”. 59. Quel giorno e quella notte (25 luglio 1945) - INEDITO “Il fascismo è caduto, Mussolini è finito, la radio ne darà la notizia alle 9 e mazza di stasera. Guai a te se lo dici a qualcuno”. A rivelare in anticipo la caduta del Fascismo a Dolores è Torquato Ferrari, amico magistrato (suocero di Ines Ferri): questo pezzo è la cronaca del 25 luglio 1945 di Dolores. 60. Così parlò un santo (versione bozza) Vedi sotto. 98 61. Non siamo abbastanza antimonarchici - INEDITO L’articolo è riportato integralmente nel testo. E) INEDITI - “AMORE PER” – (ACGV Pg 1-143 e fondo Ferri-Ferrari) Anche questi scritti sono stati conservati, come indicato da Prato, fra gli Articoli. In realtà credo di non sbagliare nell’affermare che ci troviamo di fronte a una sorta di piccola raccolta sull’”amore” universalmente inteso: è la stessa Dolores a sottotitolare ogni pezzo con “amore per …” o “amore di…”. Dal lavoro di ricerca sono emersi ben otto testi, tutti inediti, non particolarmente brillanti però a livello di scrittura. Sono raccontini autobiografici, spunti per riflessioni sulla natura, sul genere umano e sulle diverse forme di amore che abitano la nostra esistenza. Forse uno andò in stampa: in calce a “Suturazioni”, infatti, Prato scrisse “come non pubblicato”. 62. Lievità – amore del reale collocazione: fondo Ferri-Ferrari e Pg 83. Un episodio, tra sogno e realtà, sulla spiaggia, un giorno di sole. “Sentii me stessa come una piccolissima creatura abbandonata alla terra, con le braccia larghe, a croce, le mani piene di sole e il vento sul corpo steso come un tiepido velo fluttuante che mi copriva tutta. Vivevo in uno di quei momenti in cui pare di essere sollevati in un senso strano di lievità”. Poi, dove l’acqua viene e va, arriva una tartaruga, con gli occhi “tormentati dalla sabbia”, ma la bagnina accorsa non si affretta nel portarla sotto la doccia per sciacquarli. Ne seguono riflessioni sulle tragedie umane, le “assenze di Dio”, “i suoi ritardi”. “Smarrita in mezzo a tanta fluttuante lievità la pesantezza del tuo corpo tozzo e duro mi ha ributtata con un tonfo nel senso del reale delle cose che così come sono superano in bellezza tutta la bellezza sognata. Tu non capisci ed è meglio, ma io ho fatto con te come l’ubriaco che guarda con simpatia chi lo rimette sulla strada giusta”. 63. Una tragedia sulla spiaggia – amore per il dolore del creato collocazione: fondo Ferri-Ferrari e Pg 89. “La spiaggia non era deserta. Era popolata come sempre; solo che al posto della gente grossa, nuda e sciocca, c’era una piccola gente, ma altrettanto numerosa, di grosse formiche alate portate dalla tempesta della notte”. Formiche con ali con cui non potevano volare, perché le 99 formiche da riproduzione hanno “ali per un solo volo, quello nuziale”. Sbattuta dall’acqua, stordita, “ognuna di quelle formiche avrà creduto alla inevitabilità del suo dolore così come noi […] Certo era convinta che le ali sono fatte per rimanere appiccicati sulla terra”. Mentre poi un esercito di formiche le sale addosso pungendola, Prato immagina di essere parte di una catena di mondi, di cui il più grande osserva il più piccolo, e dove i meccanismi, corporei e non, si riproducono e si innescano identici. “Mi alzai di scatto, mi scrollai di dosso le povere bestiole, e me ne andai come se ne va quella gente seminuda che continuava a pestare le formiche senza vederle. Me ne andai urtata con me stessa, e con l’universo intero, trascinandomi dietro tanta melanconica vergogna”. 64. Giù per i Tiratori – amore del mistero collocazione: fondo Ferri-Ferrari e Pg 86-88. Un passeggiata lungo una strada di San Ginesio, detta “i Tiratori”, si rivela per Dolores un’intensa esperienza di comunione con la natura, quasi un matrimonio. 65. Così parlò un santo – amore dell’amore collocazione: Pg 85. Il santo di cui si parla è Padre Cesare, “un santo un poco disubbidiente perché non riusciva a contenere la sua carità dentro i confini dell’orario conventuale”: “certo che agli occhi dei piccoli legulei della morale ipocrita, egli appariva come un ribelle, un rivoluzionario”. Dolores racconta la storia di Maria, giovane donna rimasta incinta prima del matrimonio, che Padre Cesare non condannò affatto per l’amore e il suo frutto: “Le imponevo di vivere e vincere la paura del mondo accettando una vita che non sarebbe stata, né facile, né lieta. Le promettevo do sfidare con lei il mondo per la sacra legge della vita. Molte altre cose le dissi e, infine, la benedissi”. 66. Il grande nevrastenico – amore della potenza Collocazione: Pg 81. Racconto del mare, “il grande nevrastenico”, elemento con cui Dolores ebbe sempre un rapporto molto stretto e particolare lungo tutto il corso della sua vita. “Sia come vuole, il mare però continua imperterrito a brontolare e a schiaffeggiare la terra. E io crederò alla potenza umana quando verrà un uomo che saprà costringerlo a tacere”. 67. Illusioni – amore di ciò che non è collocazione: Pg 84. Dolores nuota in un tratto di mare non sicuro per le correnti, rincorrendo quella che, sul pelo dell’acqua, sembra una lunga grossa perla. Ma quando raggiunge e stringe nella mano il suo tesoro scopre che si tratta di una fialetta per iniezioni con una goccia d’acqua sporca dentro. 100 68. Tra poveri – amore della vita oppure Mezzo uovo di cioccolato collocazione: fondo Ferri-Ferrari e Pg 82. Povera Dolores, povera la sua amica di tanti anni prima, “Cia”, Lucia …., che ha il marito in carcere. Mezzo uovo di cioccolato è la condivisione tra poveri. 69. Suturazioni (Rimarginare) – amore scanzonato collocazione: fondo Ferri-Ferrari. Storia, quasi breve saga familiare, di Rosa e Pippetto: “La signora Rosa sapeva bene che il suo sangue era buono e perciò le sue ferite si cicatrizzavano senza morire e lo sapeva pure il signor Pippetto, un uomo lungo, secco allampanato che pareva la carestia accanto alla rossa abbondanza della signora Rosa”. “Lei, suo marito e la loro vita rappresentavano proprio una di quelle bizzarre rimarginature che solo il destino sa compiere”. 101 Capitolo tre Voce fuori coro: il libro su Roma mai pubblicato I – Il progetto iniziale e la vicenda editoriale C’è un altro modo di leggere Roma, sempre guidati da osservazioni, descrizioni, riflessioni, tutte nel prepotente e schietto corsivo pratiano, ma è necessario ricorrere a migliaia di fogli di appunti autografi, tutti raccolti nella serie Pm del Fondo Dolores Prato dell’Archivio contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux di Firenze: quattro faldoni, una serie suddivisa in 41 cartelle, in cui vengono custoditi tutti gli appunti preparatori per la stesura di Voce fuori coro, il pamphlet sulla distruzione di Roma, inziata con l’elezione della città a capitale d’Italia che la scrittrice aveva pensato per il centenario del 1970. Che il libro fosse in progetto e in costruzione lo rivela subito un appunto scritto da Dolores su un cartoncino: Osservazioni per chi legge: da “extra corum cantare” degli antifonari ho dedotto il titolo: “VOCE FUORI CORO”189 Il titolo, dunque, era già stato deciso, e con esso, in modo del tutto evidente, il senso che quella 189 Autografo, Archivio contemporaneo “Bonsanti” del Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze, Fondo Prato, Pm 20. 102 pubblicazione avrebbe dovuto avere: Prato voleva parlare di Roma, della sua Roma, come mai nessuno aveva fatto. Senza allinearsi con i governanti di turno, né con la Chiesa, ma in piena autonomia e libertà, in modo crudo, appassionato, parziale. Senza diplomazia, una meravigliosa e intensa voce fuori coro. Dice Carlo Bo: “La verità è l’immediatezza, tutto qui”. Verissimo. Abbandonarmi alla mia immediatezza per essere più efficace190. Questo libro sarà originale per arretratezza191. Ragione di questo libro è che un velo bugiardo è su tutte le commemorazioni. Noi altri facciamo un lamento perché noi pensiamo solo a Roma città costruita e città vivente192. Per Prato significava assecondare l’impulso, che, come vedremo, sentiva in modo particolarmente forte, di andare controcorrente rispetto alle commemorazioni tradizionali, alle pubblicazioni che sarebbero nate in occasione del centenario, alle rappresentazioni che, insomma, si sarebbero date di quella data così significativa nella storia del Risorgimento italiano. Su un ritaglio di giornale Dolores appuntava: “Ma è indubbio che se esiste occasione per dare agli avvenimenti storici una luce falsa, questa si presenta inevitabilmente nelle rievocazioni celebrative”193. Ma ricostruiamo il lungo e impervio percorso che Voce fuori coro dovette affrontare, prima di naufragare definitivamente tra il rifiuto di case editrici e il mancato spazio nelle pagine dei quotidiani. Alla fine degli anni Sessanta, in previsione delle celebrazioni del centenario di Roma capitale, dunque, Dolores prese a lavorare a un testo su Roma e i piemontesi, I piemontesi a Roma, che poi rielaborò per realizzare un pamphlet. Preparò uno schema del libro, e lo inviò a Federico Alessandrini, vicedirettore dell’“Osservatore Romano”, il quale così le rispose il 28 giugno 1969: Gentile Signora, con grande ritardo le restituisco il dattiloscritto che, tanto gentilmente, a suo tempo volle inviarmi. Per noi e personalmente per me, questo è un momento di lavoro intensissimo ed 190 ACGV, Fondo Prato, Pm 1 ACGV, Fondo Prato, Pm 1 192 ACGV, Fondo Prato, Pm 1 193 ACGV, Fondo Prato, Pm 1 191 103 esigente. Mi perdoni. Ho letto lo schema; se, come sembra, il suo intento è quello di scrivere un “pamphlet”, debbo dire che il disegno è pienamente riuscito. Il libro, peraltro, avrà un effetto traumatico sul senso comune che da oltre un secolo la mitologia scolastica viene alimentando negli italiani, sia pure con angolazioni diverse, a seconda dei tempi, delle stagioni, dei venti. Alla mitologia di destra, infatti, corrisponde quella di sinistra. Quanto all’editore possibile non saprei cosa dirle perché le mie relazioni con quel mondo sono quasi inesistenti: ci vorrebbe qualcuno che non avesse paura di tirare i sassi in piccionaia. Torno a scusarmi e la saluto con viva cordialità. F. Alessandrini194 Quello schema, a celebrazioni terminate, arrivò nelle stanze di una casa editrice, che amò l’idea e fissò il termine di consegna del dattiloscritto. Prato non riuscì a rispettarlo, e mandò le prime cento pagine: l’editore alla fine si rifiutò di pubblicare perché l’opera venne ritenuta “troppo di destra”. Non so, io mi sono attenuta a quella verità che la retorica ha velata e deturpata. Un esempio: nel 1870 a Roma c’erano sette palazzotti divisi in tanti appartamenti ognuno dei quali era dato gratis a una vedova. Perché deve essere giudicato retrogrado se uno dice che il “deprecato” governo pontificio lasciò sette di queste istituzioni e dopo cento anni di “illuminato” governo laico non ce n’è neppure una? Lo sforzo non indifferente che ho fatto per mettere insieme quel lavoro è stato inutile195 Dolores continuò a pensare al libro anche a celebrazioni terminate. “Un pamphlet sulla distruzione in tutti i sensi che ha subito Roma per averla costretta a diventare capitale d’Italia”. Inviò lo schema a un’altra casa editrice (non meglio identificata), che lo apprezzò, ma che, dopo aver letto le prime cento pagine, decise di non pubblicare. Avevo avuto delle noie per una pubblicazione giudicata troppo di destra, il mio lavoro secondo loro lo era di più. Non so, io mi sono attenuta a quella verità che la retorica ha velata e deturpata196. La stessa idea fu lanciata da Dolores in veste giornalistica. Nel settembre del ’69 propose a Fausto Coen una sorta di rubrica settimanale “tutta orientata su Roma. Risorgimento, unità, capitalato (!) 194 ACGV, Fondo Prato, Corrispondenze, Pd 99, in S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 20. Lettera del 25.4.1972 a Ettore Della Riccia, Fondo Ferri-Ferrari, in S. Severi, op. cit, p. 20. 196 S. Severi, op. cit., p. 20. 195 104 romano sempre sotto il punto di vista di Roma”197, con cui avrebbe voluto accompagnare l’anno del centenario di Roma capitale: Questo pezzo è una casuale anticipazione del lavoro che ti proporrò a voce. Per tutto l’anno centenario di Roma Capitale d’Italia una serie di articoli contestatari. Sono tanti che si potrebbe cominciare a buttarli fuori da questo scorcio del ’69. Ma ne parleremo a voce. Cercherò anche di racimolare più appunti che posso: “da dire a Fausto, da domandare a Coen perché, che ne dice lui di questo?”198 […] “Paese Sera” rifiutò la proposta. Qualche mese dopo Prato tornava a proporre la rubrica: Aspetto, aspetto, aspetto, per mesi. E intanto molti giornali hanno cominciato a farlo, nella Stampa, Vittorio Gorresio ecc. ecc. Molto più ricca la documentazione mia; senza paragone l’originalità e l’umorismo199. Non se ne fece nulla, e fu una grande delusione per Dolores, che con la solita schiettezza, in proposito scrisse all’amico Coen il 21 dicembre 1970200: Avevo bisogno di dirti quanto il tuo giornale mi ha fatto male rifiutando quella serie di articoli sul centenario […] Non avevo mai collaborato al giornale con tanta tenacia, ma questa era la volta buona perché un materiale ricchissimo e originale era lì pronto, diviso per articoli, quasi tutti già stesi, bastava volta per volta una revisione. Ero contenta per me, ma anche per te: finora fra tutto quello che è uscito sul centenario niente è trattato dal mio punto di vista; più o meno è il solito fritto misto. Ma Dolores non si scoraggiava e continuava a promuovere il suo progetto anche due anni dopo. Scriveva, infatti, sempre a Coen, nel gennaio 1971: Non ho potuto cercare gli appunti che ti avrebbero spiegato che cosa intendo dire con quei brevi interventi contestatari. Trafiletti, qualche volta una semplice battuta come un “per finire”. Uno era, me lo ricordo, “sull’equilibrismo” di Berengario che io non so neppure chi sia201. Non arrivò mai una risposta positiva, né per il libro, né per la serie di articoli, né per la rubrica, e tutti gli appunti e le riflessioni di Dolores sono rimasti soltanto nei foglietti, sulle pagine di giornali, 197 Ivi, p. 172. Fondo Ferri-Ferrari, in Severi, op. cit., p. 171. 199 Ivi, p. 172. 200 Fondo Ferri-Ferrari. 201 Ivi, p. 174. 198 105 nel retro dei cartoncini delle partecipazioni matrimoniali ora conservate al Vieusseux. Tutto, comunque, ad oggi interamente inedito. 106 II – Un testo in costruzione: la struttura e il pensiero Del pamphlet Voce fuori coro, che dovrebbe essere stato completato da Prato a celebrazioni terminate, non resta che uno schema dell’impianto, qualche nota sul metodo da utilizzare per la composizione finale di tutto il materiale, e una straordinaria, per quantità e qualità, mole di scritti autografi. Di seguito riportiamo alcuni stralci contenuti nella serie Pm, cartella 1: tagliare, tagliare tagliare tagliare finché rimane solo, ma chiara e forte, la struttura del libro, ciò che voglio dire Se sarà difficile trovare un editore non dimenticare la casa editrice Adelphi che pubblica cose originali. Questo libro sarà originale per arretratezza. In generale Le notizie polemiche non metterle insieme, ma scaglionarle secondo i tempi della distruzione e della trasformazione di Roma. Esempio: Le ridicole notizie sui discorsi alla breccia del 20 sett. metterli quando c’è da dire uno scempio distruttivo o costruttivo. Tenere a mente - Non esagerare con la presa in giro. Questa riservarla soprattutto a Roma. - Non includere nella retorica Carducci – certo amor patrio, anche se roboante, era sacro. - Sempre Roma – solo Roma. Capitalismo - Breccia e di tutto un po’ lungo il primo anno di annessione che sarà il prototipo degli altri 107 Papato – popolo romano – monarchia sabaudi e buzzurri – sguardo d’insieme sulle diversità delle due cose - Distruzioni in generale – Esquilino distruzioni e brutture – città piemontese - Distruzioni nella città e relative brutture – Ponte – Regola – Trevi ecc ecc. - I Prati di castello – città piemontese addomesticata - Le celebrazioni annuali. La prima del 25imo (?). Quel che non c’è più, le ville e altre cose – quel che c’è di brutto - In particolare il Monumentaccio e il Palazzaccio - Poi il discorso procede di celebrazione in celebrazione, cinquantenari, 75enni ecc. Ognuno è uno sguardo sugli ulteriori danni e sulle brutture. Le celebrazioni inoltre ospiteranno in maggiore quantità le buffonate retoriche. - Questi riepiloghi venticinquennali incontreranno l’epoca littoria – seguita dalla guerra - La ripresa con la ripresa di tutto- distruzioni e brutture - Siamo arrivati a oggi, si guarda indietro. Che cosa poteva essere fatto per evitare o almeno limitare la distruzione di Roma? - La sua salvezza assoluta sarebbe stata una costituzione diversa. Niente annessione. Città libera sede del papato. O ancora, si trova un altro abbozzo di impianto generale: 1° parte 1 - Dalla Breccia in su, divagando tra sabaudi, distruzione, cose ridicole 2 - Richiamando al punto giusto che cosa era il popolo romano 3 - Che cosa era il papato 4 - Riprendere all’interruzione del numero 1 e proseguire sino alla guerra del ‘15 5 - Guerra fino al 1920 circa ridimensionando il re soldato 2° parte 1- La fine vera di Roma, il concordato – abbandonata alla sua piccola missione 2 - Riprendere l’opera del fascismo sin dal principio e proseguire nei suoi guai per Roma 3 - La guerra – Italia distrutta a metà – Roma violata anche lei 108 4 - La Repubblica non attenua i guai romani, li accresce come un cancro nel suo incontrollato sviluppo 3° parte 1 - L’unità – un guaio per tutto il paese è un assassinio per Roma 2 - L’unità possibile per l’Italia era la federativa 3 - E per Roma? Che si poteva fare? 4 - Lasciarla com’era, costruire a monte o a valle un’altra città. Un male meno grosso del presente 5 - Unica salvezza era lasciarla al Papa 6 - E ora? Ora non c’è più niente da fare. Il poco rimasto si salverebbe solo trasportando la capitale Dunque Prato aveva ben chiara la mappatura mentale sottesa a questo progetto, e aveva pronti moltissimi scritti suddivisi per argomento, con un appunto o una sigla in cima al foglio che conteneva le sue “istantanee” di volta in volta: era, come la stessa scrittrice ripete in diverse corrispondenze, una riscrittura della storia di Roma “dalla parte di Roma”. Una visione delle devastazioni, delle distruzioni che mutarono l’essenza della città: quando questa divenne capitale, finendo nelle mani dei Savoia e dei piemontesi; quando subì il piccone di Mussolini e le retorica fascista; quando la Chiesa perse il potere temporale; quando arrivò la guerra; quando si affermò il capitalismo industriale. Dolores voleva dedicare una parentesi ai Savoia, che lei letteralmente odiava perché avevano distrutto l’universalità di Roma in seguito all’Annessione, e ne avevano deturpato il colore e il calore originario con il loro grigio ideale casermistico, con la loro mentalità così diversa, riducendo Roma a capitale di un piccolo Stato, quando invece Roma – secondo Prato - era per sua natura universale. Sabaudi Parlarne un poco 1 - alla venuta 2 - alla morte di Vittorio 1878 109 3 - al venticinquesimo 4 - all’avviarsi della 1° guerra 5 - alla vergognosa fine Seguendo proprio questo piccolo schema, riportiamo piccoli frammenti inediti di questa voce fuori coro, tratti dalla serie Pm 3: Distruzione Attraverso la breccia, “il buco” come lo chiamarono i milanesi, entrò in Roma la distruzione totale. I bersaglieri correvano, i profittatori anche. Con un plebiscito talmente unanime in cui votarono anche i morti, Roma e la comarca furono annesse e l’unità raggiunta. 1911 Crearono un mondo di cartapesta, un pezzetto per ogni regione del mondo, un pezzetto per ogni regione italiana, e la coppia reale, lui più piccolo di sempre perché lei con i grandi cappelli di quell’epoca era più alta mezzo metro, su e giù, ogni giorno un pezzetto ad inaugurare quell’immenso presepio al vero. E parlando di anni caratterizzati dall’erezione di molti monumenti e dalla “retorica”, Prato non perdeva occasione per lanciare velenose stoccate anti Savoia202: E aggiungere tutti i principi sabaudi, una pletora in Piemonte, ma lì era giusto. 202 Su Prato anti Savoia è in corso di pubblicazione un articolo di Fiammetta Cirilli, “Il ritorno degli italiani a Roma”. Aspetti di una polemica antisabauda nelle pagine di Dolores Prato, in Pre-sentimenti dell’Unità d’Italia dal Duecento all’Ottocento, Atti del Convegno di studi (Roma, Casa di Dante, 24-27 ottobre 2011), Salerno editrice, Roma (uscita prevista primo semestre 2012). Nell’articolo Cirilli fa anche menzione di una versione di Voce fuori coro, conservata nell’Archivio contemporaneo del Vieusseux, nella serie Prose, Pf 7, composto da sette capitoli (Buco, Non voleva essere liberato, L’alluvione trascina anche un re, Primi passi del nuovo stato, Se ne vanno insieme, Fondata sui conventi) per un totale di 136 cartelle, ma si tratta di un esperimento di scrittura molto embrionale rispetto al materiale contenuto nella serie Pm studiata nel presente lavoro di ricerca. 110 Certo che in questa profluvia di monumenti l’essere più monumentato era il cavallo, destinato con le sue mirabili linee a dare nobiltà e grandezza alla figura umana, anche alle altezze203. retorica E c’era un fascio di miti: il coraggio, la virilità, l’eroismo, legati dalla gloria con un bel fiocco liberty retorica Aveva invaso la zona della tragedia “morto per il re e per la patria”. Per la patria passi, ma per il re! A quella gente che moriva lasciando qualcosa del suo re, non veniva in mente che questo il giorno dopo continuava il suo mestiere, prime pietre inaugurazioni, lettura di discorsi preparati dal maestro, ricevimenti per genetliaci?204 Una quantità discreta di appunti fanno capo alla figura e al pensiero di Carlo Cattaneo: Dolores ne sintetizza alcune idee centrali, condividendole, ritaglia alcuni stralci di giornali che ne illustrano la tesi federalista, lo commenta. unità o confederazione A 20 anni dal compimento della famosa unità che, secondo loro unità non era senza Roma, lo stato accentrato aveva già palesato la sua enorme insufficienza, ma chi la denunciava la cosa pareva eretico tanto avevano mescolato le due idee unità e centralizzazione. Senza un centro, il palo dei tendoni da circo, come si reggerebbe il tutto? confederazione L’Italia è un paese di piccole repubbliche una verità lapalissiana che nessuno riconosce205 Cerchiato un articolo su Cattaneo, Prato commenta a fianco: “L’Italia non è serva degli stranieri ma dei suoi”; su un foglietto scrive: 203 ACGV, Fondo Prato, Pm 3. ACGV, Fondo Prato, Pm 6. 205 ACGV, Fondo Prato, Pm 7. 204 111 Cattaneo che camminava “sempre sulla via dei fatti” era per la federazione. Egli teneva conto dei caratteri delle singole regioni perché sosteneva essere un errore “il divorzio fra intelligenza e natura”. Con l’unità come fu fatta questo errore fu compiuto. Dolores è anche contraria all’ingresso del capitalismo a Roma: non vuole, o non avrebbe voluto, l’industrializzazione della città, e aveva previsto per il suo libro un capitolo Industria. Capitalismo. La programmazione prevede per Roma un maggior sviluppo industriale, perché Roma essendo la capitale deve avere la capacità di essere al livello produttivo dell’Italia d’oggi!! Su questo argomento non so proprio nulla. Leggo, non vado alla ricerca della verità. E quel che leggo è un gioco a mosca cieca. Quello piange perché Roma non è città industriale e auspica capannoni e ciminiere, quell’altro è soddisfatto perché da quel che già c’è è chiaro Roma è già e lo sarà sempre di più città industriale. Io non ne voglio sapere. Così come non vorrei vedere uno schifoso bubbone che puzzasse sul mio corpo206. Oltre all’unificazione, altre parti dell’opera riguardano l’Anno Santo, il Fascismo, le sue distruzioni, la sua retorica, le due guerre mondiali, insomma, tutte le tappe principali della storia contemporanea della capitale. Originali sono la tesi sostenuta da Dolores Prato - ovvero l’unica salvezza per Roma, per evitare la sua “distruzione”, sarebbe stata “una costituzione diversa, niente annessione, una città libera sede del papato” - e anche lo stile e la lingua utilizzati, una sorta di “scrittura del frammento”, fatta di abbozzi, aneddoti, memorie, che risponde a una spinta all’accumulazione conservativa. In Voce fuori coro Dolores delinea un antimito che si contrappone, e a volte si confonde, con il mito di Roma proposto da politica e letteratura. Il taglio particolare degli scritti di Prato su Roma, definibile come “papista” in quanto nostalgico della città come capitale universale del cattolicesimo – si tratta, del resto, di una posizione condivisa da illustri predecessori favorevoli alla causa dell’unità italiana, come lo storico tedesco Ferdinand Gregorovius – spiega la difficoltà, della quale l’autrice si duole amaramente nel suo epistolario, che testate progressiste come “Paese Sera” ebbero, a metà 206 ACGV, Fondo Prato, Pm 16-20. 112 del XX secolo, ad accettare gli articoli, e dunque anche l’alta percentuale di inediti in un corpus di rara qualità letteraria. Scriveva Dolores, ad esempio: Roma al papa Non è esatto: Roma città libera. Moltissimi la consideravano una soluzione giusta che non avrebbe scombussolato i cattolici di tutto il mondo, e che, aggiungiamo noi centenari posteri, avrebbe conservato Roma. Roma lasciata al papa. Il capitalismo non politico, ma economico è stata la seconda causa della distruzione di Roma. Gli uomini non contano, tanto meno il carattere e la bellezza di una città, quel che conta è l’interesse delle società prima fra tutte quella immobiliare. Su una Roma papalina quella speculazione avrebbe attecchito molto meno. Roma al papa Con Roma restata al papa, sarebbe rimasto tanto del suo colore. I preti qui non sarebbero corsi a mettersi in calzoni, avrebbero continuato a sventolare le loro tonache, le loro faraglioline, i preti rossi del germanico avrebbero ancora chiazzato la città come un passaggio di papaveri. Forse S. Pietro verrebbe incendiata come una volta dalla luce accesa dai sampietrini invece che da manovre di commutatori elettrici Con Roma lasciata sola per se stessa, si sarebbe evitato in parte il malanno del turismo. Ci sarebbero stati i pellegrini, ma questi sono diversi dai turisti, non producono servilismo, se mai sopportazione207. E, in una frase, Prato era capace di fissare la sintesi del suo pensiero complesso intorno a Roma capitale. Un pensiero che può essere condiviso o meno, ma che senza dubbio è ancora incredibilmente attuale: 207 ACGV, Fondo Prato, Pm 8. 113 Lasciando Roma al papa si conservava quella unica, inarrivabile, piccola, immensa città che era allora Roma e tutta Italia non sarebbe stata del papa (oppure dei preti) (come è ora). Si conservava a questa città quella sua universalità spirituale sostituita ora da una grottesca universalità cinematografica fatta di semiprostituzione, di miserabili scandalucci, universalità di intimità coniugali che come in una lanterna magica si fanno e disfanno, e tutti ne parlano, tutti ne scrivono, nella città ritornata al papa perché intorno non vedono altro208. 208 ACGV, Fondo Prato, Pm 8. 114 III – Una scrittura del frammento: il materiale del Gabinetto Vieusseux Probabilmente risulterebbe azzardato parlare, per Dolores Prato, di una scrittura del frammento, stante comunque il presupposto che questa definizione, associata a Prato, non vuole far riferimento all’esperienza di ricerca di nuove forme d’espressione che, nell’Italia dei primi del Novecento, vide nelle pagine della rivista “La Voce”, sotto la direzione di Giuseppe De Robertis, uno dei terreni più fecondi: i vociani Scipio Slataper, Giovanni Boine, Camillo Sbarbaro, Piero Jahier, infatti, ricercavano un’autentica verità esistenziale attraverso il rinnovamento del linguaggio letterario, superando la tradizionale distinzione fra poesia e prosa, prediligendo il frammento lirico. Ma di certo tutta l’esperienza linguistico-letteraria di Prato si è fondata sull’accumulazione conservativa di abbozzi, annotazioni, appunti, pensieri estemporanei, e questo non solo come premessa all’esercizio autobiografico, che si è poi concretizzato nella ri-costruzione dell’infanzia per Giù la piazza non c’è nessuno e dell’adolescenza per il libro sul collegio, Le Ore, ma anche nella preparazione del libro su Roma. Gran parte delle carte di Dolores, conservate nell’Archivio “Bonsanti” del Vieusseux e suddivise in serie che per lo più rispettano una classificazione per argomenti (Corrispondenza, Prose letterarie, Appunti, Articoli, Raccolta di sogni, Materiale su Roma capitale d’Italia…), si connota per la presenza predominante di frammenti (“Ma 300, forse 400 sogni; centinaia, forse migliaia di aforismi; materiale per almeno 5 libri su Roma, poco meno si dante; materiale biografico in abbondanza; una grande quantità di piccoli saggi, brevissimi, ma originali piacevoli e interessanti anche se tristi”209). Scriveva Dolores alla sua amica Lina Brusa Arese il 6 gennaio 1980: Tu sai come ho fatto sempre (per alcuni lavori da decenni, per altri dalla prima giovinezza in su). Scrivere quel che mi viene in mente; un accenno per non dimenticare un fatto; un’immagine nuova; una nuova riflessione, ora di un lavoro ora di un altro; mettere in alto la sigla di quel tale lavoro e giù nel calderone. Mezzi metri cubi di carte di tutte le dimensioni, sino ai margini di giornali; di lì bisogna dividere […] Per fortuna da qualche tempo ho cercato di rimediare […] sicché ora una certa divisione c’è, ma ci sono ancora scatole e scatole mai aperte210. L’accumulo, la conservazione per anni, la sedimentazione dei materiali, per lo più frammenti appunto, erano il modus operandi di Prato: la scrittura era un processo finale di sintesi, tormentato, 209 Lettera a Alessandro Bonsanti del febbraio-marzo 1983, quando la donazione degli scritti di Dolores si stava perfezionando, in S. Severi, Voce fuori coro, cit., p. 179. 210 In G. Zampa, Cronaca della vita apparente, in D. Prato, Le Ore, cit., p. 355. 115 complesso, difficile. E in questo sta, anche, l’anomalia pratiana, se messa a confronto con l’officina creativa di altre voci del Novecento letterario211. I miei lavori che sono rimasti aperti per tutta la vita senza mai concluderli, si sono elefanticamente arricchiti di materiale. Ora tutto quel materiale è un guaio serio, esige una fatica improba, ma voglio farla anche se continuo a non poter far nulla212. Tra le serie archivistiche del Fondo Prato, ricchissima, in questo senso, è quella riservata agli Appunti, che contiene un laboratorio di scrittura allo stato primordiale, a struttura aperta, che ingloba i nuclei generativi di alcune opere poi portate a termine ma, soprattutto, è una dimostrazione visiva e tattile del metodo di lavoro di Dolores, e anche delle ragioni che l’hanno portata, negli anni, ad intraprendere alcuni percorsi narrativi, autobiografici, o letterari in senso ampio. Se, invece, andiamo ad analizzare la materia spesso minima, disorganica, eterogenea, che ha poi trovato una forma nei romanzi autobiografici di Prato, capiamo che la scrittura di questa donna ultraottantenne è stato un processo di recupero insieme intellettuale e psicologico, che, in fondo, ha consegnato allo stesso destino di irresolutezza l’opera e la vita stessa. Forse per Parole, seconda parte del libro Le Ore, invece, potremmo osare un accostamento con la poetica del frammento più propriamente intesa. Questo testo, emblema del plurilinguismo di Dolores, si compone di schede: e se alcune, come abbiamo detto in precedenza, sono una dichiarazione di insostituibilità di un termine, altre, invece, descrivono il sentimento di trasformazione attraverso le parole dell’identità stessa di Dolores, nel passaggio dal fuori al dentro dell’educandato. Molte raggiungono un tale livello di ricercatezza, di brillantezza di stile, che sembra possibile un accostamento – con tutte le dovute cautele - con il frammento lirico più propriamente inteso. A casa avevo sempre detto: niente, in convento imparai a dire nulla. Questa paroletta mi dette veramente il senso di avere acquistato signorilità, aristocrazia. Era così elegante quel nulla! Mi pareva ovale come la forma di un cammeo213. Ritrovai un nome di donna che era anche di fiore. In convento era solo di fiori. Ma quei fiori io non li ricordo più. Ricordo: Bisogna ancora innaffiare le artemisie. …In quel mazzo manca l’artemisia. 211 Sull’andamento frammentario/cumulativo della scrittura di Prato cfr. Fiammetta Cirilli, Per una lettura di “Giù la piazza non c’è nessuno” di Dolores Prato, 11 giugno 2011, in www.puntocritico.eu. 212 Lettera del 20 gennaio 1980 a Lina Brusa Arese, in D. Prato, Le Ore, cit., p. 355. 213 D. Prato, Le Ore, cit., p. 300. 116 Com’era? Forse violacea come una vedova o come le vecchie signore eleganti che amano il viola214. Cambiavano le parole le cose restavano le stesse, cambiava la vita più che all’esterno dentro. Cambiava il sentimento (oppure) Ci si sentiva cambiate215. Ma se il frammentismo investiva, tradizionalmente, la sfera intima, dell’analisi dei sentimenti e degli aspetti morali della vita, o l’autobiografia, per Dolores Prato anche la rilettura della storia di Roma, dei centodieci anni dall’unità d’Italia fino al 1970, poteva essere affidata a quelli che lei definiva “aforismi”, “trafiletti”, “semplici battute” in qualche modo compiuti. In effetti, il materiale del Vieusseux comprende sia stralci di quello che doveva essere il pamphlet originale, a volte dattiloscritti, quindi abbastanza lunghi, sia, a mio avviso, i frammenti che avrebbero sostituito il progetto originario del libro andando a costituire la “rubrica” pensata (da lei) per “Paese Sera”. La sensazione, di fronte a quell’ingente mole di fogli e scritti pratiani, è che alcuni siano nati per restare frammenti, unici quanto a brillantezza, acume, incisività. La serie Roma capitale d’Italia, nel Fondo Prato denominata Pm, comprende, dicevamo, 41 cartelle, ciascuna delle quali raccoglie materiale omogeneo per argomento. In questa sede, essendo il lavoro di ricerca principalmente incentrato sull’attività giornalistica di Prato, abbiamo tentato un primo approccio al lavoro su Roma, procedendo per affinità di atteggiamento: la Dolores che traspare, in maniera un po’ filtrata, senza spigoli vivi, negli articoli su Roma, è la scrittrice che, contemporaneamente, si dedicava a Voce fuori coro per creare qualcosa di estremamente diverso dalle pubblicazioni uscite in occasione del centenario: voleva distinguersi per originalità e arretratezza, e ci riuscì, ma non trovò nessuno – per dirla con Alessandrini - che non avesse paura di tirare sassi in piccionaia. Lo studio e la trascrizione sono stati limitati, ad oggi, alle prime nove cartelle, vale a dire fino al 1929 e ai Patti Lateranensi, che per Prato segnarono un punto di non ritorno (per le altre è stata possibile soltanto una lettura d’insieme, con focus sulle parti dedicate alle “distruzioni”): 11febbraio 1929 214 215 Ivi, p. 263. Ivi, p. 328. 117 Roma è definitivamente abbandonata allo Stato che la distrugge. Il suo antico sovrano, che finora l’aveva reclamata, sia pure accademicamente, come fanno i re che non mollano i loro presunti diritti per generazioni e secoli, il Papa, dopo soli 59 anni la riconosce proprietà di altri. I sovrani veri non fanno così anche se sanno d’essere ridicoli. Era nell’idea di Dolores suddividere il lavoro su Roma capitale in due parti: la prima doveva finire cronologicamente nel 1928, con Roma non ancora riconosciuta capitale dai papi; la seconda doveva iniziare, infatti, con il riconoscimento da parte del Vaticano dell’Italia unita e di Roma come legittima capitale. Nello specifico, il materiale corrispondente a quest’idea si presenta, al Vieusseux – su indicazione della stessa Prato, così diviso: Pm 1: Cose da fare lungo la stesura; Pm 2: Appunti: capitalismo romano/Roma capitale d’Italia. 1879-1888; Pm 3: Appunti: capitalismo romano/Roma capitale d’Italia. I trentennio. Dopo il regicidio fine I trentennio e fino alla I guerra; Pm 4: Riassunto I periodo. I trentennio; Pm 5: II parte dopo la I guerra; Pm 6: Fascio – guerra dopo; Pm 7: Federazione; Pm 8: Roma al Papa; Pm 9: Roma capitale. 118 IV – Voce fuori coro: per un inizio di lettura In questo paragrafo riportiamo le trascrizioni della serie Pm effettuate fino ad ora. Per non inficiare la completezza dell’opera, seppure in fieri, e per non togliere al lettore la possibilità di uno sguardo d’insieme, riportiamo anche le parti che sono state già citate e quelle che verranno riportate nel capitolo quattro, funzionali alla ricostruzione del mito e antimito di Roma capitale tratteggiato da Dolores Prato, cuore e tesi di questo lavoro di ricerca. 119 Osservazioni per chi legge Da “extra corum cantare” degli antifonari ho dedotto il titolo: “VOCE FUORI CORO” Dice Carlo Bo: “La verità è l’immediatezza, tutto qui”. Verissimo. Abbandonarmi alla mia immediatezza per essere più efficace. 120 Pm 1 Cose da fare lungo la stesura (ISTRUZIONI) Se sarà difficile trovare un editore non dimenticare la casa editrice Adelphi che pubblica cose originali. Questo libro sarà originale per arretratezza. In generale Le notizie polemiche non metterle insieme, ma scaglionarle secondo i tempi della distruzione e della trasformazione di Roma. Esempio: Le ridicole notizie sui discorsi alla breccia del 20 sett. metterli quando c’è da dire uno scempio distruttivo o costruttivo. Dovrei avere assolutamente Hermann Grimm – Le distruzioni di Roma – Firenze 1886 – traduttore C. V. Giusti (+ vedi p. 6) Tenere a mente - Non esagerare con la presa in giro. Questa riservarla soprattutto a Roma. - Non includere nella retorica Carducci – certo amor patrio, anche se roboante, era sacro. - Sempre Roma – solo Roma. Capitolone Che cosa era Roma prima di quel nefasto buco sulle Aureliane? -----Descrivere sorvolando Roma edilizia. Le strade – il colore – la vi (cancellata) -----E intorno le ville, gi… Per questo dentro il cassetto fascicolo a parte Capitalismo - Breccia e di tutto un po’ lungo il primo anno di annessione che sarà il prototipo degli altri Papato – popolo romano – monarchia sabaudi e buzzurri – sguardo d’insieme sulle diversità delle due cose - Distruzioni in generale – Esquilino distruzioni e brutture – città piemontese - Distruzioni nella città e relative brutture – Ponte – Regola – Trevi ecc ecc. - I Prati di castello – città piemontese addomesticata - Le celebrazioni annuali. La prima del 25imo (?). Quel che non c’è più, le ville e altre cose – quel che c’è di brutto - In particolare il Monumentaccio e il Palazzaccio - Poi il discorso procede di celebrazione in celebrazione, cinquantenari, 75enni ecc. Ognuno è uno sguardo sugli ulteriori danni e sulle brutture. Le celebrazioni inoltre ospiteranno in maggiore quantità le buffonate retoriche. - Questi riepiloghi venticinquennali incontreranno l’epoca littoria – seguita dalla guerra 121 - La ripresa con la ripresa di tutto- distruzioni e brutture - Siamo arrivati a oggi, si guarda indietro. Che cosa poteva essere fatto per evitare o almeno limitare la distruzione di Roma? - La sua salvezza assoluta sarebbe stata una costituzione diversa. Niente annessione. Città libera sede del papato. 1881 La frenesia delle costruzioni prese un po’ tutti. Roma era o non era capitale? Dunque doveva essere grande, popolosa come Parigi, perciò case, case, case perché la gente vi proliferasse. E dove? Ma più vicini possibile alla Vecchia Roma; Esquilino, Termini, Prati, Macao, Sant’Agnese, S. Lorenzo. Roma nella fantasia frenetica d’allora, va oltre, diventa immensa, si comperano vigne, orti, terreni da pascolo a prezzi di terreni fabbricabili, si rivendono, si spezzettano, si passano di mano in mano, e intanto si atterrano gli alberi per costruirvi quelle case, quelle fabbriche che vi cominceranno a sorgere mezzo secolo più tardi. Diventavano tutti costruttori. Il capomastro poteva essere l’architetto e l’ingegnere di se stesso, e così sorgevano case immense, brutte e mal fatte. 1886 - Sul posto del convento di Santa cecilia in Trastevere sorge la scuola “regina Margherita” Si inaugura un tratto di via Palermo, di fronte alla galleria Margherita in via Depretis Si demolisce il palazzotto Sciarpa per allargare via delle Muratte Si continua a demolire e costruire per formare il corso Vittorio Continuano il polverone e il sorgere di bruttissime costruzioni Con la scusa dell’igiene si svolgeva una catena d’interessi, e Roma cambiava faccia A Santa Marta la fanteria Teatri A tempo di Pio IX - Il Pallacorda che poi diventò Metastasio aveva già dai primi anni del secolo un duplice macchinario, per burattini e per attori, che era il migliore d’Europa L’Apollo, già Tordinone (?) Il Valle Il Capranica Il Fiano, l’Ornani, e la Fenice erano solo per burattini Il Pace Teatro Alibert L’Argentina Il Quirino (?) Teatro degli Imperiti (?) Teatro del Pavone Il teatro del Fico, poi delle Muse Il naufragio Il Valletto Il Goldoni (Vaudeville) Il Goldoni Lo Sferisterio Il Mazzini (?) La Renella 122 Capitalismo tagliare, tagliare tagliare tagliare finché rimane solo, ma chiara e forte, la struttura del libro, ciò che voglio dire 1887 anno di Dogali 1896 Adua 1911 Libia 1935 Etiopia Spagna 1915 1940 Settarismo La corona offerta dalla massoneria nel 1907 al monumento di Garibaldi porta questa dedica: “Al Gran Maestro Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita” Vederlo il monumento da vicino. Troverò altri spunti. Vedere da che parte è “O Roma o morte” Cap Si stampa spesso “legge delle garanzie” invece di guarentigie con cui è diventata storica. Io adoperare l’una e l’altra. Cap Ragione di questo libro è che un velo bugiardo è su tutte le commemorazioni. Noi altri facciamo un lamento perché noi pensiamo solo a Roma città costruita e città vivente. (su ritaglio di giornale) “Ma è indubbio che se esiste occasione per dare agli avvenimenti storici una luce falsa, questa si presenta inevitabilmente nelle rievocazioni celebrative. Basterebbe, per rendersene conto, andarsi a rileggere molto di quello che è stato scritto qualche mese fa nel nostro Paese, in occasione del centenario di Porta Pia. chiamarlo sempre Patrimonio di San Pietro, il piccolo statarello piegato dalle eroiche truppe italiane. capitalismo Tenersi sempre sul tono, e che appaia, che nell’annessione hanno ragione quelli che ci tramandarono l’incontenibile entusiasmo, e quelli che attestano la disapprovazione, la freddezza, l’ostinata avversione. C’erano tutte e due le cose. Vedere il casino dell’Aurora e “palazzo grande” della Villa Ludovisi, ora sepolto dalle nuove costruzioni. La storia dei tentativi di sopprimere i gesuiti, dell’abolizione degli ordini, se serve si può vedere a pag. 31 123 l’Universo illustrato del 1872, forse 73. Papato 2 libri necessari per poter dire bene la condizione di Roma all’epoca della presa: Collezione Roma Cristiana – diretta da Galassi Palazzi 1°) Antonio Martini – Arti, mestieri e fede nella Roma dei papi – Cappelli – 1965 2°) Vincenzo Monachino – La carità cristiana in Roma – 1968 Papato La storia, in un capitolo di Carducci, c’è tutta in breve, se ne avessi bisogno per qualche chiarimento Illustrazione Italiana 1895 pag. 156 vol. 2 Pio IX fece la prima comunione il 2 febbraio (Purificazione) 1803 quanti anni aveva? 1° parte 1 - Dalla Breccia in su, divagando tra sabaudi, distruzione, cose ridicole 2 - Richiamando al punto giusto che cosa era il popolo romano 3 - Che cosa era il papato 4 - Riprendere all’interruzione del numero 1 e proseguire sino alla guerra del ‘15 5 - Guerra fino al 1920 circa ridimensionando il re soldato 2° parte 1- La fine vera di Roma, il concordato – abbandonata alla sua piccola missione 2 - Riprendere l’opera del fascismo sin dal principio e proseguire nei suoi guai per Roma 3 - La guerra – Italia distrutta a metà – Roma violata anche lei 4 - La Repubblica non attenua i guai romani, li accresce come un cancro nel suo incontrollato sviluppo 3° parte 1 - L’unità – un guaio per tutto il paese è un assassinio per Roma 2 - L’unità possibile per l’Italia era la federativa 3 - E per Roma? Che si poteva fare? 4 - Lasciarla com’era, costruire a monte o a valle un’altra città. Un male meno grosso del presente 5 - Unica salvezza era lasciarla al Papa 6 - E ora? Ora non c’è più niente da fare. Il poco rimasto si salverebbe solo trasportando la capitale Titolo suggerito da don Gabriele Voce fuori coro “extra corum cantare” Sabaudi Parlarne un poco 124 1. 2. 3. 4. 5. alla venuta alla morte di Vittorio 1878 al venticinquesimo all’avviarsi della 1° guerra alla vergognosa fine 125 Pm 2 Appunti: capitalismo romano/Roma capitale d’Italia. 1879-1888 1881 Il Vaticano chiede il permesso di poter trasportare, nella notte tra il 12 e il 13 luglio, la salma di Pio IX dal sepolcro provvisorio in S. Pietro a quello definitivo a S. Lorenzo fuori le mura. Per prudenza da una parte e dall’altra si scelse la notte. Ma la passione valica ogni prudenza e intorno a quel morto scoppia una indegna gazzarra. I cattolici con fiaccole accese si univano al breve corteo formandone via via uno più imponente, l’altra folla non aveva da seguire un proprio morto, ma accorse numerosa per spezzare quell’accompagno. Si gridò !a fiume, a fiume” ed era certo un grido d’odio questo; gli altri gridavano “viva il papa re” ed era un grido stupido questo. Quella cassa con dentro un morto andava alla pace del sepolcro in una mischia deplorevole, finché per salvarla fu scaricata su un carretto spinto in furia fin dentro la basilica di S. Lorenzo della quale si chiusero le porte come in un tempestoso assedio. Questo dopo 11 anni di quella famosa breccia della quale raccontavano che appena caduta si sentì come un ruggito l’urrà del popolo romano. Una retorica e una falsatura più intelligente avrebbe reso meno ridicola quella breccia che si apre con gli urrà come la parete ultima di un traforo alpino. Settarismo Il segreto postale non era sempre rispettato, nelle cose più delicate a curia si serviva o di criptografia (?) o di comunicazioni orali. 1889 un’incursione della polizia mise a soqquadro a Bologna l’Opera dei Congressi. In Piemonte dal 1850 abrogato il foro ecclesiastico – pazienza – ma nessun ente morale poteva vendere o comperare – protesta del vescovo – sua detenzione per un mese, di nuovo arrestato poi esiliato. 1885 – soppressione delle corporazioni religiose. Queste leggi piemontesi furono estese all’Italia. Nel 1866 istituzione matrimonio civile, tolto ogni valore legale a quello religioso. Stesso anno i beni delle associazioni religiose se li prende lo Stato. Stesso anno – tolte molte feste religiose Nel periodo – vescovi costretti all’estero, processati, impediti di entrare nelle loro diocesi 1887 monumenti-retorica Una discussione, di quelle che piacciono tanto per come doveva essere il monumento ai caduti di Dogali, aveva l’aria di non finire, quando intervenne un romano, don Leopoldo Torlonia, stufo dei tanti monumenti che già popolavano la Roma monarchica. S’era trovato in uno sterro, pochi mesi addietro, un obelisco egiziano. Era un trofeo delle vittorie romane in Africa, innalziamo quello per una sconfitta, è africana anche questa. Tutti contenti, si alzò l’obelisco e Roma ebbe qualche pupo di meno (ritaglio di giornale – Anticlericalismo, dal Messaggero 1881) 126 1884 Non c’era possibilità d’intesa. Zuffa, dentro e fuori della chiesa con carabinieri e delegato con la sciarpa, altro che urrà di romani quando fecero quel buco sulle mura Aureliane! La stampa liberale offendeva la religione, i romani fecero un triduo di riparazione alla Minerva chiuso col grido “Viva Maria”, i liberali che erano entrati in chiesa fischiavano, gli altri allora gridarono “viva il papa re!”. In piazza Colonna più tardi altri squilli contro gli schiamazzi degli anticlericali. Monarchia Della traballante monarchia quel colle del Vaticinio era il tormento, quel che faceva lo faceva sempre in ista del papato. Ed ecco che per dare una sede all’accademia dei Lincei non si scelse il palazzo Corsini alla Lungara perché era bello e degno di una sede culturale, ma per la sua “ubicazione, al di là del Tevere in vista e in prossimità del Vaticano”. La luce della cultura di fronte all’oscurantismo. Ma all’inaugurazione, presenti le loro maestà (1886) il Lanciani invece di adulare e gioire, denunciò le distruzioni che si stavano facendo a Roma. Cap Il nuovo regno dietro la sua trionfalistica retorica aveva anche la sua paura. Per paura che manovre internazionali portassero a ripristinare un governo pontificio, si mise con i tedeschi. Due Kaiser e in mezzo un reuccio nuovo di zecca. Cap – monarchia 1887 (17 novembre domenica) Attentato di Passamonte a Napoli “Cairoli salvi il Re” grida la regina a …???, come lo sono spesso le donne: “La poesia di casa Savoia è distrutta”. Forse non era mai esistita, ma lei era scusabile se lo ignorava. Bombe e tumulti altrove, specialmente nelle ex legazioni pontificie dove è sempre vivo il sentimento repubblicano. Non si può proprio dire che la monarchia sia unitariamente amata. 1882 Il governo propone di aprire un Foro Vittorio Emanuele dietro il Pantheon. 1882 – Disordini A Caprera il 2 giugno muore Garibaldi. Alcuni giorni dopo nel grande corte di cordoglio che dal Popolo si mosse per il Campidoglio, avvennero strane cose. La folla per le strade fu presa dal panico, fuggiva impazzita, spezzava le vetrine per rifugiarsi nei negozi. Un subbuglio che intralciò il corteo con statue ed ????, arrivò tardi in Campidoglio e quasi nessuno l’aveva visto. Pareva una rivendicazione di papa Mastai. Cap – 1880 Demolito Palazzo Piombino, il principe costruì il palazzo di via Veneto, dove poi abitò la regina Margherita. I Savoia a Roma furono costretti ad abitare a casa d’altri. 127 1881 Politica estera L’Italia che si era incoronata da sé come Napoleone, mettendosi sulla testa la gloria di Porta Pia, sul campo internazionale soffriva di una certa solitudine. Aveva rispettato Roma come luogo sacro, forse avrebbe migliorato le amicizie che cercava con tanto desiderio 128 Pm 3 Appunti: capitalismo romano/Roma capitale d’Italia I trentennio dopo il 900 esposizione Restò galleria d’arte moderna coperta di ornati. Ogni tanto nelle ripuliture le hanno tolto qualche aggeggio ornamentale, ogni tanto un pezzetto di più di muro liscio. Ne aveva troppi, d’accordo, ma siccome brutto lo è, era meglio un brutto originale. Almeno segnava un’epoca. Papato - questa e le simili in principio di questo periodo, vale a dire dopo il regicidio. Nel grigiore di quell’Italietta brillava la grandezza di Leone XIII. Il governo italiano lo considerava repubblicano e socialista, certo era il più giovane nell’Italia di quel tempo, coi suoi tanti anni. Quel vecchio che nel centenario di Cristoforo Colombo gli dedica un’enciclica esaltandolo come uomo, non come santo uomo, e fa di lui la più intelligente commemorazione di tutta Italia che pur si sbracciava a farne. dal 70 al 900 - Esposizioni Che epoca curiosa, se non ci fosse stata la Prussia fagocitatrice (?) di fratelli e origini tedeschi, il dramma della Francia, la caduta del potere temporale dei papi, si sarebbe potuta distinguere come epoca delle esposizioni; si succedono in ogni parte del mondo, le grandi, pullulano le piccole in ogni città. Anche in Italia, a considerare quante ce n’erano si sarebbe detto che non aveva altri problemi. Invece per mangiare la gente partiva per l’estero coi fagotti di stracci e offriva braccia e intelligenza. 1911 Tutto a rilento andava, anche alle feste per il cinquantenario dell’unità ci arrivarono col cuore in gola e tutto fu inaugurato senza essere finito. Ma la guerra no, la guerra fu subito inaugurata e proprio per l’anniversario della freccia. Come un lampo scoppiò la guerra alla Turchia per la Tripolitania. La guerra sbocciò in mezzo a quel mondo di cartapesta. 1911 Crearono un mondo di cartapesta, un pezzetto per ogni ragione del mondo, un pezzetto per ogni regione italiana, e la coppia reale, lui più piccolo di sempre perché lei con i grandi cappelli di quell’epoca era più alta mezzo metro, su e giù, ogni giorno un pezzetto ad inaugurare quell’immenso presepio al vero. Di cartapesta era anche un baraccone a piazza Colonna, nel posto dove avevano abbattuto il palazzo Piombino. Se si fosse trovato quanto avrebbero fatto prima a costruire inutile mondo. 1911 La guerra continuò, ma bastò metterci i piedi per annettere quella parte d’Africa. Le annessioni erano una epidemia dell’epoca. Un paio di mesi di guerra e insieme agli effetti delle nostre artiglierie “ecco che resta della fastosa resistenzeresidenza...ecc” a mutilati felici a file d’impiccati a partenze euforiche si parla già delle nuove terre italiane. Son già italiane, anzi lo erano sempre state perché Roma le aveva dominate quelle terre, quindi annessioni, 129 per celebrare il 50° di queste altre annessioni che fecero l’unità. Tripoli, Bengasi, Tobruk ??? gente che fugge, gente che applaude - conquiste di cartapesta come l’esposizione etnografica. A palazzo Venezia: merli guelfi e finestre crociate. Demolito il palazzo Torlonia, gli contrapposero con le assicurazioni l’affermazione ghibellina: merli a coda di rondine e finestre bifore. Con questi scherzucci si creava la terza Roma. E’ la retorica, il fine politico, non esclusi i libri scolastici di storia Patria che aumentano a dismisura le misure reali anche notevoli di certi personaggi. Quando avveniva quella perquisizione armata in cui perse la vita Giuditta Gaviani, i contemporanei parlavano di quella scaramuccia con morti e feriti. Null’altro. Poi di tra quei morti s’alzò altissima la figura di Giuditta. Era anche commovente quella retorica che diventava forza quando si ripeteva con comparse travestite da romani, le feste palilie. Cortei, carri, cocchi, bighe, senatori, consoli, e una folla in vesticciola corta. Bastava quella e due bande laterali ed era fatto romano. La serietà con cui si ponevano avanti all’obiettivo prova che si sentivano trasformati da quella mascheratura. retorica-monumenti Erano tanti che la stampa s’era fatta una sua frase introduttiva come “ma procediamo con ordine” nei fatti di cronaca. Diceva “Ancora un monumento” e spesso la critica era per la sua posizione. Marniani (o Mamiani), per esempio, che era uomo d’azione e d’impeto, non doveva essere monumentato seduto in poltrona con addosso la pelliccia, ma in piedi, magari inalberante un pugno chiuso, se allora fosse stato di moda. (seguito?) e sui piedistalli degli uomini monumentati, sedute o in piedi una pleiade di Italie, col turbante di torri, ma tutte vistosamente poppute. Altrettanto popputa è la legge di Quintino Sella, ma per distinguerla dall’Italia ha dietro la testa un’aureola di raggi come gli spilloni di Lucia Mondella (forse non è vero dei raggi, forse erano solo nel bozzetto - vedere) da aggiungere tutti i principi sabaudi, una pletora in piemonte, ma lì era giusto. Certo che in questa profluvia di monumenti l’essere più monumentato era il cavallo, destinato con le sue mirabili linee a dare nobiltà e grandezza alla figura umana, anche alle altezze. Ma i monumenti non spuntavano solo a Roma, tutte le città italiane diventavano fungaie di Garibaldi, di Vittori e altri personaggi bianchi o bronzei. retorica E c’era un fascio di miti: il coraggio, la virilità, l’eroismo, legati dalla gloria con un bel fiocco liberty (trovare un’altra cosa) retorica s’ingabbiarono aquile e lupe. A Roma erano stati solo elementi decorativi, architettonici. Perché i romani non odiano nessun animale, ma amano solo il gatto. Di aquile e lupe non se ne fanno nulla. 130 Pm 4 Riassunto I periodo I trentennio La famiglia Savoia Carignano si affannava a stringere relazioni con le case regnanti estere, ma succedeva anche che alcuni regnanti nel restituire le loro visite si rifiutassero di venire a Roma, ma scegliessero o Venezia o Milano. La presenza del papa disturbava non poco i primi passi dell’Italia monarchica. L’alluvione dei protestanti fu un guaio non per questioni teologiche, dogmatiche, rituali, no, ma per il carattere della città che essi offersero e guastarono impiantando le loro chiese di stile esotico in punti nei quail la loro presenza ci sta come il famoso cavolo a merenda. Pm 6 Fascio – Guerra dopo Retorica Aveva invaso la zona della tragedia “morto per il re e per la patria”. Per la patria passi, ma per il re! A quella gente che moriva lasciando qualcosa del suo re, non veniva in mente che questo il giorno dopo continuava il suo mestiere, prime pietre inaugurazioni, lettura di discorsi preparati dal maestro, ricevimenti per genetliaci? Distruzioni epoca fascista Li chiamavano “risanamenti”… Fascismo I fascisti che morivano con cristiana e retorica rassegnazione dentro la camicia nera, portavano la stessa confusione e la stessa tetraggine nelle loro costruzioni. 1860 fascismo Garibaldi aveva tentato di abolire il titolo di eccellenza, Mussolini non lo abolì, ma lo raddrizzò come un fioretto puntato al cuore. Prima si diceva “sua eccellenza”, si girava al largo, quasi timorosi di accostarsi direttamente, Mussolini fece dire all’Italia l’Eccellenza, Noi Eccellenza. 1922 “Maestà io vi porto l’Italia di Vittorio Veneto”. Con questa frase entrò (oppure: questa frase fu la porta per la quale la colossale imperiale retorica ci rese tanto ridicoli). 131 La pazzia fascista – capitalismo Che cosa non ha sofferto Roma in quel periodo? Basta ricordare il facciatone che si sovrappose alla facciata del palazzo delle esposizioni con quelle 4 enormi scuri che certo ebbero il vanto di essere allora e sempre per i secoli futuri le più colossali scuri sporgenti dai più colossali fasci littori. Montagnola su cui lo fanno correre – fascismo – capitale Quel bersagliere che ha tolto una luce unica, era in certe ore, al di là dei fornici una corsia di luce, l’alta semita pareva deificata. Il bersagliere è e sarà sempre un elemento simpaticissimo della nostra compagine nazionale, ma invece di issarlo su quell’alto massiccio piedistallo dove non si sa come faccia a correre così, l’avessero messo in terra, era più vero e la visione di quella luce restava perché non è il bersagliere a nasconderla ma quella. Testaccio – distruzioni Già i contemporanei, quelli che avevano il senso di Roma, chiamavano “ignobili” le costruzioni di Testaccio. Quando poi diventammo impero e il re savoiardo divenne imperatore etiopico, la frenesia distruttiva ecc. ecc. Portarono su il Leone di Giuda (?) e lo misero ai piedi dell’obelischetto di …??. Deve essere scappato perché non c’è più. Mentre alla passeggiata archeologica c’è sempre quella ridicola stonatura dell’obelisco di Axum. Fascio 1900-1932 manomesso esternamente, internamente il Palazzo Artolli (?). Demolito, tagliato, saloni distrutti, portali asportati non è più lui. Fascismo La via di S. Gregorio, una delle più suggestive di Roma era chiusa in fondo dall’Arco immenso di Costantino. Giù, largo, spazio per le quadrate legioni, la via fu slabbrata, in fondo il piccolo arco pare un souvenir. Demolizioni – i fascisti Questi si facevano vanto di demolire senza pietà. Buttarono giù tra piazza Barberini e S. Bernardo, buttarono giù all’Argentina per isolare i templi, buttato giù a piazza dell’Ara Coeli, così furono distrutti non solo gli edifici, ma anche la piazza. La via dell’Impero (ora dei fori imperiali) fu una distruzione di quanto i secoli vi avevano accumulato e di quanto, in una zona così ricca, veniva alla luce durante gli scavi. Se mantenere un monumento scoperto con gli scavi serviva alla sua demagogica esaltazione, tutto di guadagnato, ma sulla via dell’Impero era la via che importava per i prossimi trionfi, il passo dell’Oca non sopporta sassi nel suo cammino, sicché addosso anche ai vecchi monumenti se stavano nel percorso di quella fatidica strada. Sventramenti per l’augusteum (il pavimento che ci vidi). 132 Postfacista La repubblica a cui siamo arrivati con tante guerre perdute dalla monarchia, la dissero fondata sul lavoro. Perché? Che vuol dire lavoro? Lavoratori siamo tutti dal Papa, al presidente della Repubblica, all’uomo che raccoglie la carta straccia. E allora? Non era meglio fondata sulla legge? Temperature varie In questa nostra Italia centro-meridionale così duramente provata dalla guerra, in cui tanto ci si rallegrò che l’Italia settentrionale avesse sofferto minori distruzioni, le cosa stanno com’erano un anno e mezzo fa – dove l’iniziativa privata non si è sostituita al governo – Paesi distrutti, campi cosparsi di mine, uomini e bestie che muoiono nel tentativo di riordinare la terra sconquassata. Gente che morì assiderata lo scorso inverno come altra ne morrà nel prossimo. Uomini e greggi che cominciano a scendere per i tratturi chiedendo l’elemosina di un tetto a qualcuno meno sfortunato. Alcune zone si presentano così morte da dare l’impressione che la vita non vi possa più risorgere. Ogni tanto arriva qui qualcuno che, appoggiato a un muro, racconta con parola monotona e lo sguardo spento avventure orribili. Relitti umani che l’onda della miseria sbatte qui come a un porto. E in questo porto si raccolgono le miserie e i dolori atoni della nostra popolazione e di quella che vi affluisce. Di fronte a casa mia s’allunga il Monte Parioli che ospita il quartiere dei ricchi, ma i fianchi rocciosi della collina ogni giorno presentano un buco che ieri non c’era. E’ una nuova grotta aperta alla gente più miserabile, quella che non reclama, che s’è adattata al suo destino. Il monte è tutto un dedalo di cavità naturali e di catacombe, tra poco diventerà una città cavernosa di trogloditi. ----Vittorio Emanuele Carignano dalla sua villa a Marechiaro, scende in mare la mattina e pesca per 6 ore; poi pranza, legge i giornali e ritorna a pescare. La sua vecchia moglie pesca anche essa, ma lei con la figlia più matura va a pescare alla spiaggia di Coroglio, di fronte a Nisida. Invece la nuora preferisce la spiaggia riservata che costeggia la tenuta di Castel Porziano. Spiagge diverse, ma sempre spiagge, l’aria del mare fa bene! ---La vedova di un avvocato che lotta come una leonessa per difendere la vita d’oggi e quella di domani dei suoi cinque figli e per risolvere gli innumerevoli problemi che si chiamano: libri per la scuola, scarpe, cappottini per l’inverno, anemia della ragazza dodicenne, occhiali per il piccino al quale si sta già sviluppando un grave inconveniente alla vista, parlava pochi giorni fa calma, melanconica, assorta, accorata via via che frugava nella sua pena: - Il tormento maggiore, diceva, è quello di dovere essere parziale coi miei figli. Parziale per essere giusta. Non si possono comperare le uova per tutti, ma Graziella ne ha assoluto bisogno; avrebbe avuto bisogno di supernutrizione, del mare, della campagna, invece chiusa qui dentro e col mangiare razionato dalla mia severità…Ogni tanto l’uovo a lei lo devo dare e guardando gli altri io urlerei di pena. Il pane lo tolgo spesso ai più piccoli, specialmente se vedo che sono stati quieti e hanno sprecato meno energie, per darlo al più grande che studia il doppio per saltare un anno e dà ripetizioni per guadagnare qualche cosa. Io tolgo ad uno per dare ad un altro dopo aver riflettuto quale ha più bisogno di questa cosa e quale può farne a meno, ma le assicuro che il non poter dare a tutti i figli la stessa vita è un dolore tale che se mi si aprisse il cuore lo si vedrebbe sanguinare. ---- 133 Una giovane contadina mette al mondo un figlio illegittimo che per fortuna nasce morto. Non fa nulla, bisogna farlo sparire lo stesso. Suo padre e sua madre l’aiutano, ma sono sospettati e arrestati. Finiscono col confessare. Stavano facendo il sapone, buttarono nella caldaia il cadaverino. Mezzo infallibile per non lasciar tracce. - E poi avrete venduto quel sapone, non è vero? Chiede il giudice I tre imputati scattano offesi. - Per chi ci prende, signor giudice? Noi non facciamo mercato nero; il sapone l’abbiamo adoperato per usi familiari! ---Si apre apposta una chiesa per i poveri dei dormitori pubblici, per quelli che non hanno neppure quel tetto provvisorio; un sacerdote celebra proprio per loro, parla solo per loro. Professori e studenti, signore e ragazze, servono quei poveri, li ripuliscono, li forniscono di quei indumenti che durante la settimana hanno raccolto e preparato. Non danno, lasciano prendere. La roba è lì sugli scaffali della sagrestia, ognuno prende quello che gli serve. Una grande cesta è nel mezzo colma di pane, ognuno prende quello che gli manca. Si cerca di dare a questi poveri la sensazione che essi hanno diritto a prendere quello di cui hanno bisogno, non è un’elemosina, e coloro che li servono hanno l’umile fraternità di chi vuol farsi perdonare d’essere meno povero. Una donna dal viso emaciato, ma bello, dall’espressione più tragica che dura, con un bimbo scalzo in braccio, s’aggira avanti a quei scaffali e guarda senza prendere nulla, forse non trova. Una signora nota che con una mano ogni tanto stringe i piedini nudi del suo bimbo come per riscaldarli, le si avvicina e indicandole un paio di scarpine le dice: - Mi pare che quelle gli andrebbero bene. La donna guarda le scarpine, e i piedi del suo pupo come se gliele misurasse con gli occhi, poi, senza mutare d’espressione, risponde severa: - Il mio può farne a meno, noi un buco per ripararci ce l’abbiamo, quella là invece sta in una baracca sconquassata sul fiume, non c’è rimasta più che la lamiera del tetto, le faccia prendere a quella. E s’allontana mentre s’avvicina la donna del fiume con in braccio un bimbo che non si sa se sia morto o vivo. Dolores Prato “Con questi episodi concludere il libro sulla guerra Minore. Dopo una tempesta il rio scorre torbido per fango e pietre finché pian piano si rischiara. La vita sarà così? Oppure: La guerra rimescola il fondo torbido dell’umanità. Non è ancora decantata”. Acqua Acetosa Quadro: emergeva l’abside a metà quasi come ora. Gli uomini portavano ciuffi di fiaschi appesi a un bastone appoggiato sulle spalle. A sinistra un gran casale con torre. Anche qui c’era la pace immensa di Roma: mucche accasciate, donne sonnecchianti sedute in terra, uomini in piedi solenni com’era solenne il luogo; terra abbandonata che preannunciava la solitudine dell’Agro; acqua che si rilasciava sulla terra come fanno ora le signore sul divano quando si rilasciano. 134 Citazioni - Capitale “Il mito imperiale romano è sempre ricomparso nelle epoche di servitù enfatica e barocca, nel XVII, nel fascismo. L’identificazione dell’Italia e della moderna Roma con Roma antica, il culto dei moderni, ha sempre gravato sull’anima italiana come un’istanza di senilità”. “Il risorgimento, questo eroico tentativo di una minoranza, si staccò da quell’eredità”. “In Italia, specialmente, nell’ultimo ventennio, la donna è stata tenuta ad un livello sociale ben basso. Già prima che l’Italia fosse unificata, la donna italiana aveva goduto in alcuni stati del voto amministrativo e nel Lombardo Veneto anche della eleggibilità. Con l’unità d’Italia perdette simili diritti” (Ines Zaccheo, “Risveglio”, anno I n. 3) “Il Medioevo è come spazzato via dal vento, con tutto lo spirito storico del passato”. Così scriveva Gregorovius (I, IX) ritornato a Roma dopo che questa era stata annessa al Piemonte, dichiarava che Roma aveva perduto il suo incanto…se l’avesse vista nel fascismo, povero Lui! Epoca fascista I cancelli attirarono spesso l’attenzione del governo a Roma. Un papa una volta li fece mettere sulle porte delle osterie perché chi voleva bere bevesse di fuori, in piedi, per evitare la corte nell’interno e le risse che ne seguivano. I Piemontesi misero cancelli ai monumenti e alle fontane. Mussolini, il liberatore, li tolse per fare cannoni, che non bastarono lo stesso. Il fascismo ci ha tolto tutto. Anche l’“est locanda” che aveva resistito alle immissioni barbariche dei piemontesi, si trasformò nel banale “affittasi” e poi non ci fu più bisogno neppure di quello per le fortunate guerre. Distruzioni fascismo All’epoca della liberazione del mausoleo d’Augusto, capato come si capa un torso di broccolo, e dell’incassettamento dell’Ara pacis…tra le altre cose fu demolita una casa che non aveva in sé nessun interesse tolto che il proprietario ci si era sbizzarrito a decorarla con formule chimiche perché l’aveva costruita con i soldi che aveva ricavato da una sua fortunata formula. Lì dov’era quella casa c’è un vuoto che gli altri non vedono, ma io sì perché salii un giorno sulla terrazza di casa. Spesso torno lassù; nulla mi sostiene, ma vedo quel che allora vidi come se qualche acido di quella formula avesse inciso la lastra della mia memoria. Distruzioni fasciste – argentina Era un piccolo cortile in una delle più piccole case in quel silenzio che dalla piazzetta di San Nicola di Cesarini si diluiva tuttintorno. C’erano delle colonne, si diceva che fossero del tempio d’Ercole, che di lì partivano i vaticini, che la colossale statua prima trafugata e poi ritrovata fosse stato il simulacro di quel tempio, nei muri del cortiletto era visibile un portico medioevale, in un angolo c’era un pesco. Gli amanti delle antichità, i forestieri, giravano per quelle straducce alla ricerca del cortiletto, quando l’avevano trovato e le colonne “di Ercole” erano davanti agli occhi, era un tuffo di emozione specialmente se in un angolo del portichetto medioevale il pesco era in fiore. Ora a chi importano più quelle colonne nude, anche se hanno ritrovato il loro nome vero, lì all’aria aperta, come due scheletri? 135 Fascisti - argentina Per fare una inaugurazione strombazzata per il 21 aprile 1929 si sacrificò l’integrità di quei resti antichi che erano riapparsi col sacrificio di un pezzo della città. Non era l’archeologia in sé ad animarli, era la possibilità di acquistarsi meriti. Sotto alla chiesa di San Nicola de’ Cesarini si ritrovarono i resti (abside) dell’antico tempio medioevale Distruzioni, epoca fascista – per la via dell’Impero Cacciate le persone per abbattere le case, restarono i gatti, il foro …iano(?) ne era pieno, anche loro sterminati. Epoca fascista 9 novembre 1926. Il partito popolare è sciolto. Gli atti e documenti di sua pertinenza sono sequestrati ed il numerario confiscato. Le dittature a fondo splendido come la napoleonica, o splendido fasullo come la fascista, si compiacciono di nomi classici, ritornano a una classicità della quale pretendono di essere i veri continuatori. Così per Napoleone la Toscana era tornata l’Etruria, per il fascismo… Fascio La gente a cui si demoliva la casa fu deportata fuori, in lontani agglomerati che non ebbero neppure il nome di Borgo, ma furono chiamate borgate. Isolata quella gente non trovava più lavoro, splendide dimore degne del grandissimo popolo italiano, risultarono peggiori in tutto di quelle da dove erano stati cacciati. E a quelle borgate affluirono gli abusivi, i non controllati, i “non sono nessuno”. Roma vide anche lo sconcio di quei motti, assiomi scritti/posti come fastigi. Distruzioni – fascismo Riprende, come all’epoca dell’annessione, la furia degli sventramenti di quel che di storico era rimasto nel centro della città. Si distrusse come allora, e mentre allora si costruiva borghese, ora si costruisce littorio, grande, imponente, monumentale, rosso e bianco, e statue nerborute. Secondo Mussolini all’Augusteo “liberato” sarebbero arrivate tutte le genti d’Italia e tutti i popoli del mondo. Ebbe tempo anche lui per convincersi che se prima, visto e non visto, scoperto a pezzetti tra le case, desuntane l’immensità in quel cerchio altissimo dentro il quale risuonò la più bella musica del mondo, aveva ancora un fascino, ridotto a quel torsolo che è nessuno lo guarda più in faccia. Il 22 ottobre 1934 numerosi gesti storici, primo colpo di piccone, primo scoperchiamento di tegole/coppi, prima palata di melma per incominciare l’isolamento dell’Augusteum che deve essere compiuto per il bimillenario di Augusto nel 1937. Poi vennero i primi colpi di piccone. Li dava lui ed erano celebrati come un rito eroico. “Cedo la parola al piccone” disse Mussolini dopo aver inaugurato la distruzione della zona augustea. La meta sudante (dire che era, come era) abbattuta perché “le quadrate legioni” reduci da conquistati imperi, 136 potessero il giorno del trionfo sfilare col marziale passo dell’oca senza aprire le file avanti a quell’ostacolo. Fu abbattuta, ma sul piano dell’asfalto fu segnato un grande cerchio. C’è tuttora. Era la circonferenza della vasca dentro la quale la fontana versava le sue acque. Il ministerione delle finanze era arretrato sulla via XX settembre, l’edilizia fascista che aveva il culto del dritto e del vasto pensò di tagliare su quel filo quanto sporgeva dopo il ministero sino allo slargo di santa Susanna. Tra gli edifici c’era quello del granaio, interessante opera secentesca, e la fontana del Mosè. Mentre discutevano dove questa sarebbe andata a finire il sacro piccone demolitore abbatté i granai, ormai orfanotrofio, mentre continuava la discussione per il Mosè arrivò la guerra e la fontana restò dov’è. Inaugurata nel 1902 la via dell’Impero essa risultò un vuoto retorico per il quale erano state distrutti tanti isolati di case di tutte le epoche e tutte le chiese che erano sul cammino di questo vuoto furono distrutte. Troppe cose non furono capite. Fra le tante quella che isolare un monumento è rimpicciolirlo; Fontana di Trevi deve il suo successo spettacolare non solo a se stessa, ma anche al piccolo ambiente dove è raccolta. Fascismo Tra le tante conciliazioni ci fu quella per antonomasia. La Chiesa diceva bravo al fascismo. In realtà nella chiesa era come nel resto del paese: più gli antifascisti che i fascisti, però come il paese pareva tutto fascista perché il re così pareva, la chiesa perché il Papa aveva trovato nel suo capo l’uomo della provvidenza. Ma per la Chiesa durò assai meno. Papa Ratti morì alla vigilia del giorno in cui avrebbe dovuto scoppiare il suo fulmine sul fascismo, fulmine … da un lungo brontolare di … Quella “via dell’Impero” che, declamavano, aveva scoperto e messo in luce i fori imperiali, in realtà non li aveva che scavalcati, distruggendoli e sotterrandoli, lasciando in vita di qua e di là quel che rimaneva. Distrutta così anche quella suggestione che emanava da quei resti affiorati dai muri, tra finestre e case, dalle svolte delle strade. Ora isolati così hanno l’arido della pomice cariata non c’è più l’humus della vita. Chiamare, come fu chiamato, “passo romano” lo stecchito “passo dell’oca” proprio dei tedeschi è puerile. E il legittimo, non è quasi sempre forzosamente legittimo? Comunque il Savoia aveva firmato fedeltà allo Statuto Se il 22 ottobre il Carignano non fu spergiuro, meglio per lui, ma che con la Costituzione pasticciò sempre chi può negarlo? La tirannide può anche essere necessaria, ma allora chi ha giurato la libertà si ritira e lascia decidere il popolo. Capitale La divisione ci fu e fu profonda e durò a lungo. Per più di mezzo secolo la bandiera tricolore non riuscì ad entrare in chiesa, neppure per funerali speciali. Portate alte e fluttuanti fino alla soglia della chiesa lì venivano abbassate e appoggiate al muro come una fascina tricolore. Fascismo Sotto i tedeschi in pratica ritornò in vigore il diritto d’asilo. E non dimenticare che conventi, sia maschili che femminili, erano pieni di rifugiati, le parrocchie, le chiese, 137 persino i campanili erano stipati di gente nascosta. Capitale o papato Lo sfacelo, Roma non fu più capitale, le capitali erano altre due: Brindisi a sud, Salò a nord. Roma nel dolore, nella fame, nell’eccidio, nell’abbandono di chi l’aveva tolta a se stessa, tornò ad essere di se stessa protetta dal Papa. Capitale Dal balconcino di Palazzo Venezia il 9 maggio 1936 Mussolini annunziò al mondo che era “riapparso l’impero sui colli fatali di Roma” così come si può riaprire un grande magazzino. Palazzo Venezia pensò che fosse ritornato il carnevale di una volta. Ma il 10 giugno 1940 dallo stesso balconcino proclama la guerra. Palazzo Venezia freme. Ora ci faranno anche per distruggere Roma. E continuarono per decenni, finché durò quella piatta retorica patriottarda (intanto sopraggiungerà quella esagitata di D’Annunzio) a chiamarla “la Roma degli italiani” senza che li trattenesse il pensiero che quella povera italiana era una delle regine del mondo. 138 Pm 7 Federazione unità o confederazione A 20 anni dal compimento della famosa unità che, secondo loro unità non era senza Roma, lo stato accentrato aveva già palesato la sua enorme insufficienza, ma chi la denunciava la cosa pareva eretico tanto avevano mescolato le due idee unità e centralizzazione. Senza un centro, il palo dei tendoni da circo, come si reggerebbe il tutto? confederazione L’Italia è un paese di piccole repubbliche. una verità lapalissiana che nessuno riconosce [in rosso] cerchiato un articolo su Cattaneo “L’Italia non è serva degli stranieri ma dei suoi” Cattaneo che camminava “sempre sulla via dei fatti” era per la federazione. Egli teneva conto dei caratteri delle singole regioni perché sosteneva essere un errore “il divorzio fra intelligenza e natura”. Con l’unità come fu fatta questo errore fu compiuto. Pm 8 Roma al Papa Roma al Papa Roma e il papato, prosecutore di forme, alcune sostanziali, dell’impero romano, avevano fatto da secoli corpo unico. Il popolo non stava peggio di come stava altrove, per molte cose stava meglio. Non capiva perché Roma dovesse essere “restituita” all’Italia, Roma non le era mai appartenuta. L’Italia, semmai, era appartenuta a lei. Attraverso la breccia, “il buco” come lo chiamarono i milanesi, entrò in Roma la distruzione totale. I bersaglieri correvano, i profittatori anche. Con un plebiscito talmente unanime in cui votarono anche i morti, Roma e la comarca furono annesse e l’unità raggiunta. Lagrime e retorica del tempo. 139 Lo straripamento del Tevere portò a Roma anche il re, ma ce lo depositò per poco; non era pronta la casa e lui del resto non aveva ancora finito di passar sopra alla sua coscienza religiosa. A Roma ogni palazzo aristocratico era una reggia, ma nessuno gliela offerse. Si dovette prendere un palazzo del papa, quello di Montecavallo. Roma al papa Non è esatto: Roma città libera. Moltissimi la consideravano una soluzione giusta che non avrebbe scombussolato i cattolici di tutto il mondo, e che, aggiungiamo noi centenari posteri, avrebbe conservato Roma. Roma lasciata al papa Il capitalismo non politico, ma economico è stata la seconda causa della distruzione di Roma. Gli uomini non contano, tanto meno il carattere e la bellezza di una città, quel che conta è l'interesse delle società prima fra tutte quella immobiliare. Su una Roma papalina quella speculazione avrebbe attecchito molto meno. Roma al papa Una città che si è autocostruita in tutto il mondo allora conosciuto, non doveva ridursi ad appartenere a uno stato. Doveva essere libera e sola. oppure che non si è costruita solo qui, ma in tutto il mondo, solo del mondo doveva restare. Roma al papa Con Roma restata al papa, sarebbe rimasto tanto del suo colore. I preti qui non sarebbero corsi a mettersi in calzoni, avrebbero continuato a sventolare le loro tonache, le loro faraglioline, i preti rossi del germanico avrebbero ancora chiazzato la città come un passaggio di papaveri. Forse S. Pietro verrebbe incendiata come una volta dalla luce accesa dai sampietrini invece che da manovre di commutatori elettrici. Con Roma lasciata sola per se stessa, si sarebbe evitato in parte il malanno del turismo. Ci sarebbero stati i pellegrini, ma questi sono diversi dai turisti, non producono servilismo, se mai sopportazione. Lasciando Roma al papa si conservava quella unica, inarrivabile, piccola, immensa città che era allora Roma e tutta Italia non sarebbe stata del papa (oppure dei preti) (come è ora). Si riservava a questa città quella sua universalità spirituale sostituita ora da una grottesca universalità cinematografica fatta di semiprostituzione, di miserabili scandalucci, universalità di intimità coniugali che come in una lanterna magica si fanno e disfanno, e tutti ne parlano, tutti ne scrivono, nella città ritornata al papa perché intorno non vedono altro. 140 Pm 9 Roma capitale dividere il lavoro in due parti. Finire la prima al 1928 - Roma ancora non riconosciuta capitale dai papi. 2° - dal 1929 - il vaticano riconosce lo stato d’Italia e Roma sua legittima capitale. 11 febbraio 1929 Roma è definitivamente abbandonata allo Stato che la distrugge. Il suo antico sovrano, che finora l’aveva reclamata, sia pure accademicamente, come fanno i re che non mollano i loro presunti diritti per generazioni e secoli, il Papa, dopo soli 59 anni la riconosce proprietà di altri. I sovrani veri non fanno così anche se sanno d’essere ridicoli. La seconda parte comincerà dopo che si è conclusa la chiacchierata sui sabaudi, sulle distruzioni, dopo l’intermezzo di l’unità e i suoi guai. L’unità può stare anche alla fine prima della conclusione. 141 da Pm 16 -20 Esquilino La capitale ha decolorato Roma. Una città che era tutta, anche se piccola, colore di crosta di pane ben cotta, colore di sole al tramonto su tela grezza, colore di caldo e i mattone cotto, come poteva essere capita dai nordici piemontesi che venivano giù con nel cuore e nel cervello i colori grigi delle loro città porticate per rendere anche più grigia l’aria dove l’uomo cammina? Ed ecco Piazza Vittorio esempio di grigio e di criptoportico, ecco i quartieri umbertini dove pure qualche volta il colore di Roma fa macchia tra il grigiore delle altre cose/case. Certo su quella casa nel suo nascere spirò l’alito amoroso di un qualche romano. Incameramenti - verso la fine della prima parte Uno stato che veniva a manomettere i religiosi, che ne prendeva case ed averi, ma non aveva neppure la fantasia di trovare nomi nuovi. Così il carcere femminile continuò a chiamarsi “Le Mantellate” come se dentro vi si aggirassero pudiche vergini. E a uno dei più brutti carceri, un edificio che è la realizzazione di un incubo, dettero uno dei più dolci nomi che sia possibile dare “Regina coeli” solo perché lì c’era una chiesina, e prima un convento anche con quel nome che non se l’erano dato le religiose, ma il popolo l’aveva dato a loro. Perché non erano monache il cui umore assecondasse i tempi dell’anno liturgico che alterna lutto e gioia, attesa e sollievo, obbedienza e festa. Quelle suore erano sempre in festa, esse onoravano la madonna perpetuando il tripudio che comincia con la Pasqua, finisce con l’incanto dell’Ascensione per passare al raccoglimento e all’azione della Pentecoste. E’ il periodo in cui la chiesa tripudia ripetendo Alleluja, alleluja e si rivolge alla Madonna: “Regina coeli cantare, alleluja, resurrescit, sicut discit, alleluja. Regina coeli laetare, alleluja”. Questa antifona che è solo del tempo pasquale, esse la ripetevano tutto l’anno, tutto l’anno allelujavano; scendevano in chiesa più volte al giorno e cantavano Regina coeli laetare alleluia, interrompevano il sonno della notte per cantare ancora Regina coeli, laetare alleluia. Le persone che entravano in quella chiesina facilmente s’imbattevano nel coro squillante di voci argentine del Regina coeli. * E Regina coeli fu il nome che diventò delle monache e del luogo. *Le parole sono cose vive, le parole diventano anima nostra, nostro sorriso e nostro pianto. Le suore che davano la vita nella ripetizione di quel canto allelujante assorbivano per forza un po’ della sua letizia. Quel luogo fu scelto per costruire il tetro carcere, come sempre mancò la fantasia per scegliere un nome, lasciarono quello al carcere. Battezzavano tutto col nome del loro re, potevano chiamarlo Reale carcere Vittorio Emanuele II. Era suo, il suo governo l’aveva costruito, il nome gli spettava, invece no, lo dettero alla magnifica biblioteca dei gesuiti per la quale lui non aveva fatto altro che rubarla (se è troppo dire incamerarla). Tevere Si dice sempre che il fiume fu incarcerato dai muraglioni. Nessuno dice che tutta la città che confluiva al Tevere fu imprigionata. Era una città fluviale da quella parte, scendeva dolce verso l’acqua, nelle strade che vi sboccavano si avvertiva il chiarore dell’acqua assolata Avanti a questa città fluviale furono alzati gli argini che la chiusero come le muraglie i cortili delle carceri. I lungotevere a sinistra del fiume, quelli che hanno incarcerato Roma fiumarola, sembrano belli perché non guardiamo più la Roma del seminterrato. A San Rocco, in linea d’aria, gli camminiamo a metà facciata, e via Giulia, le scuole dei Fiorentini, (cercare le vie prima e dopo S. Rocco) tutte strade semisepolte dai bastioni. Tevere Quei muraglioni qualcosa hanno fatto, ma non per questo sono meno brutti. Se avessero visto com’era bella 142 quella Roma che lambiva le acque e anche quando ci si specchiava, in cui il fiume era parte viva della città come la gente che vi scendeva. Quell’acqua era a livello delle case, vivevano insieme. Del fiume hanno fatto un pozzo profondo, un canale. Potevano arrivare allo stesso scopo con altri mezzi. Ma si sa, i lavori dei governi moderni sono politica, utilità pubblica, è una cosa per conquistare approvazioni. Bisognava decidere di fare quei muraglioni al più presto, così si poteva dire: Romani, quello che i papi non vi hanno fatto in tanti secoli, ve lo fa subito re Vittorio, lo scomunicato. E così via il suggestivo porto di Ripetta alla cui guardia stavano due chiese. Una corsa di pochi passi e dall’acqua si stava in chiesa. Ora quelle chiese stanno giù sprofondate e la gente che cammina sul lungotevere, le guarda dall’alto. capit Tutto si restrinse in Roma divenendo capitale d’Italia, materialmente e spiritualmente. Il Tevere reso non più atto alla navigazione ne è un simbolo. Grande chiavicone a cielo aperto. Tevere Roma non è più una città fiumarola, è una città divisa da un canale che potrebbe anche chiamarsi fogna scoperta, come lo era la cloaca massima quando attraversava il foro prima che la coprissero. Parte 1 Roma si è allargata, non è più una città, è una marea di cose. Ma è difficile che in qualsiasi punto si scavi non ritorni alla luce qualcosa, statua o frammento, colonna o capitello, arco o muro (commento a lavori che si stanno facendo in tutta Roma nel 1890, 1885 e 1915…) Archeologia - Distruzione delle rovine – Colosseo. 74 e anche prima Finora le rovine vivevano insieme col popolo romano. Quell’esedra abbracciava una casetta, quell’arco ne ricopriva un’altra, quella colonna entrava dentro una casa e ne reggeva il crocifisso in cima al letto, il vaso di mentuccia stava sopra un capitello, e il simulacro di Minerva custodiva la porta di un forno. Con quella valanga di furiosi e incoscienti innovatori incominciò subito la rovina delle nostre rovine che dura tuttora in un processo ormai inarrestabile. Solo l’abbandono di Roma come capitale riuscirebbe a salvare quello che è ancora salvabile. Perché è proprio l’abbandono che le conserva. Il cemento che le unisce alla vita, è la loro conservazione, e la terra. La terra le custodisce, l’aria le sgretola. Incominciò subito quell’opera di isolamento, che riduce le rovine a scheletri. E siccome l’entusiasmo dei buzzurri era poderoso, si cominciò dal Colosseo. Prima di tutti gli estirpatori: via le erbacce e gli arbusti che macchiano di verde il caldo colore romano. Le radici, è vero, dilatano, ma cementano anche. Non era comunque necessaria la Scolastica per distinguerle. Comunque il Colosseo fu tosato e sbarbato mentre i guastatori demolivano i tabernacoli della via Crucis lungo l’arena e le cappellette nascoste in qualche angolo di quel gigantesco labirinto di volte e di archi. Alcune di quelle oscure cappellette erano assai più suggestive della grotta di Massabielle. La gente vi riposava, ci chiacchierava e pregava anche. E nonostante le ripetute e molteplici e ostentate proteste di rispetto alla religione, la grande croce che s’innalzava nel mezzo dell’anfiteatro fu abbattuta. Nelle chiese si facevano tridui per la salvezza del Colosseo, per riparazione della sua profanazione. Arrivò anche un pellegrinaggio di protesta e devozione. La gente baciava quella terra bagnata dal sangue dei martiri. Che importa che fosse terra di riporto giacché ci avevano pensato i secoli e i frangipane a buttare per aria la vera arena? La devozione fa a meno della storia e dell’archeologia, ma non della tradizione. (Vedi Parfum de Rome di Veuillot) 143 La sofferenza per questa distruzione non era tanto dei romani che guardavano i fatti della loro città come chi legge un libro di storia su fatti che già conosce, con acutezza di giudizio, ma senza meraviglia, senza emozione. ,Ma erano i cattolici stranieri a ribellarsi e a soffrire di più. Essi venivano a Roma come a un prolungamento spirituale della loro patria, e trovavano che era diventata un’altra cosa, una patria anch’essa sua straniera alla loro. E con quella furia distruttiva dei nuovi venuti essi trovavano Roma come chi torna a casa e la trova sconvolta dai ladri. Appunti Roma febbraio 1964 Non si parla che del ritrovamento della ragazza mummificata a Grotta rossa, ma nessuno dice che il sarcofago fu sventrato da una escavatrice meccanica. Un sarcofago spezzato, se non si può fare a meno, si deve vedere…ma le altre piccole cose distrutte? Che progresso!!! Articoli vari sulla distruzione della Roma sotterranea per colpa del Metrò (“Le date sono a servizio elettorale. Ma presto o tardi la cosa si farà. Roma restata popolana non aveva bisogno i distruggere il nostro patrimonio archeologico sotterraneo” - Capitalismo) Fine San Marino compie quest’anno (1971) i suoi 1671 anni, della sua vita repubblicana sul Titano. “Sessantadue chilometri quadrati di roccia diciottomila abitanti”. Nel 1870 alla presa di Roma aveva compiuto, essa li compie il 3 settembre, 1570 dunque fu nel 300 – S. Marino celebrava i suoi 1570 anni di vita repubblicana. _ Se proprio Roma doveva essere capitale d’Italia, la si doveva lasciare com’era e costruire a parte la città nuova, magari verso il mare. Tutte quelle paratie di cemento che circondano Roma per chilometri, spinte tutte verso una sola direzione. La capitale d’Italia ora sarebbe nel mare e Roma non sarebbe stata distrutta. Quel che poteva essere fatto – Capitalismo Se l’Italia unificata aveva lasciato Roma intatta e intangibile, come una città dello spirito, avendo già lasciata intatta S. Marino, la città della libertà, si sarebbe fatta erigere nella sua compagine due eccezionali monumenti che l’avrebbero resa eccelsa ed unica più assai del Colosseo nazionalizzato Chi l’ha detto che una capitale deve essere sovrappopolata? Non potrebbe essere solo capitale, solo uffici e rappresentanza? Quel che si poteva fare Quella dolce minuscola chiesina della Madonna del Riposo, il riposo che offriva sostando da lei chi percorreva la campagna prossima a Roma, è incarcerata in un coacervo (adopero questa parola brutta che risponde alle affastellate costruzioni moderne) di brutture. Non si vede più. Per vederla bisogna cercarla. Dietro la sovrasta un immane orrendo caseggiato. Se invece di quel caseggiato lì, le si fosse lasciato alle spalle uno sazio alberato, avrebbe costituito un punto di bellezza romana tra le brutture italiane, dato che il colore di Roma, per fortuna, glielo hanno mantenuto. 144 Non è necessario che il governo risieda nella capitale. Si creava la città burocratica, ministeriale, e si soddisfaceva la fregola (è volgare) di quelli che morivano se non avevano come capitale la prestigiosa Roma, facendola capitale, ma lasciandola com’era. Quel che poteva essere fatto - minimo – finale Costruendo in prossimità di un monumento o edificio ragguardevole per arte o per storia, tenere una certa distanza e nelle proporzioni regolarsi su quello del medesimo. Esempio: la torre degli Anguillara che potentemente emergeva nello spazio per chi andava verso Trastevere, ora è un aggeggio davanti a un enorme casone che la sovrasta. La chiesina della Madonna del riposo quella che era una felice pausa nel cammino dei piedi e nell’ansia dell’anima, campagnola, ma graziosa, ora è una specie di baracchetta davanti agli edifici che le sorgono giganteschi non solo ai lati delle due strade che da lei divergono, ma alle sue spalle. Essa poggia su quei casoni. Se si fosse lasciato un po’ di spazio alberato dietro di lei, in modo che la sua rustica grazia risaltasse, anche la zona, bruttissima, ne avrebbe guadagnato. Ora essa è un nome per indicare una fermata degli autobus. Quel che si potrebbe fare La pubblicità che obbliga a guardare se stessa, sottrae lo sguardo a quel poco di architettura visibile al disopra del garage pubblico. Non capitale, cascherebbe molta pubblicità, si svuoterebbe un po’ il garage e Roma un poco riapparirebbe. Quel che si doveva fare – Capitalismo Un anello di terra intorno alla città, come ora ci sono le mura vaticane, grande quel tanto che permettesse a Roma di sedere regina nel suo agio solenne più di un tempio. Genericamente capitolo Industria. Capitalismo La programmazione prevede per Roma un maggior sviluppo industriale, perché Roma essendo la capitale deve avere la capacità di essere al livello produttivo dell’Italia d’oggi!! Su questo argomento non so proprio nulla. Leggo, non vado alla ricerca della verità. E quel che leggo è un gioco a mosca cieca. Quello piange perché Roma non è città industriale e auspica capannoni e ciminiere, quell’altro è soddisfatto perché da quel che già c’è è chiaro Roma è già e lo sarà sempre di più città industriale. Io non ne voglio sapere. Così come non vorrei vedere uno schifoso bubbone che puzzasse sul mio corpo. Si lamentano che Roma non sia una città industriale, e lo è già troppo, il lamento ha qualcosa di stanti, in un’epoca in cui i segni stanchezza dell’industrializzazione non mancano. Necessaria lo sarà, ma bella no, sana no, e allora perché non lasciare immune una città come Roma? Roma così, sola in se stessa, meta di tutto il mondo non avrebbe avuto bisogno dell’industria che è bruttezza, ciminiere, capannoni, fumo, smog. Non discuto su nulla io, figuriamoci sull’industrializzazione! Se il mondo ha infilato quella svolta è segno che la sua strada è quella. Ma che essa distrugga la bellezza è indiscutibile (sicuro). Avere salvato una città come Roma dall’industria non sarebbe stato un gran male. C’è tanto posto al mondo per quei brutti agglomerati, e tante città che li reclamano. Le città industriali stanno tutte diventando delle cappe mortali per i morbosi idrocarburi aromatici policlici 145 dovuti alla combustione della benzina del carbone e della nafta. E Roma la vorrebbero ancora più industriale. Una donna bella colta voluttuosa, può anche non saper cucire a macchina. Industrie - ci vogliono per sfamare la gente che arriva. Ma sarebbe molto difficile dire: lavoro sì, ma altrove. Lasciamo almeno l’aria pulita a Roma, gli avete tolto il suo incommensurabile verde, lasciatele l’aria. L’industria sarà necessaria, io non discuto, io divago, necessaria forse, sicuramente crudele. Si toglie l’acqua agli uomini per darla agli stabilimenti industriali. Necessaria, forse, ma brutta: con i suoi capannoni, con le sue ciminiere rovina qualunque bel paesaggio. Necessaria, forse, ma fagocitatrice di bellezza, non solo abbatte alberi che non ricresceranno mai più, ma polverizza le gemme (pietre preziose) che non risplenderanno mai più. (accanto a articolo su mancanza d’acqua, ndr) Dal mostro industriale si sarebbe salvata Roma. Che i piccioni nuocciano è fuor di dubbio, ma che si voglia dire che guastano più loro delle industrie è ridicolo perché in questo articolo si diceva questo, ma vedi chi parla? (accanto ad articolo su Venezia, ndr) Per la conservazione di una città le industrie sono deleterie. Il Papa non le avrebbe certo avute e Roma non ne sarebbe stata deturpata. Genericamente capitolo Distruzioni Sventramenti – Il martirio di Roma sventrata è paragonabile solo al martirio dei cani infissi su una tavola e spaccati; sventrati da vivi dopo aver tagliato le corde vocali perché gli ululati disturberebbero il lavoro di sventramento. 1876 sventrata la città per aprire il cosiddetto corso Vittorio Emanuele. Le torri che non furono distrutte furono strette fra case più alte di loro, come averle distrutte. Distruzioni costruzioni - La Roma nuova è un incubo. Percorrerla è tentare di uscire dall’incubo senza riuscirci. Distrutta anche la conoscenza della città. Il popolo prima la conosceva come il proprio corpo. Adesso se si invita a una funzione o un funerale a Santa Maria sopra Minerva si aggiungerà “Piazza della Minerva”, se a San Lorenzo in Lucina, “Piazza S. Lorenzo in Lucina” Proprio come si fa con i minorati psichici. La cupola aveva bisogno di uno spazio adeguato alla sua grandezza. Da Piazza Risorgimento, da viale delle Milizie non la si doveva scorgere, come adesso, emergere da un monte di case. Sono innamorata delle porte, maghi (?) di portoncini, che scompaiono a vista d’occhio e bisognerebbe di ognuno fare il disegno. Se lo tento, ma io non so disegnare, sono tutti diversi, ognuno con la propria fisionomia, come gli uomini, possono essere simili, assomiglianti, uguali mai. Ce n’è uno dietro Regina Coeli l’ho disegnato e stracciato. Se buttano giù Regina Coeli come pare, addio portoncino. “distrutto” Distrutto il linguaggio che era schietto e forte. Ora è un romanesco italiano, lingua cinematografara ridicola e smidollata. Distruzioni di prospettiva senza nulla demolire Un esempio: All’epoca dei papi in fondo alla scalinata di Trinità dei monti non c’erano quelle verticali bancarelle di fiori che ci sono ora che spezzano e fermano la discesa molleggiante delle scale. La scala arrivava dolce al piano stradale risollevandosi appena un poco con la barcaccia, perché allora chiesa obelisco 146 balaustra scale fontana facevano una cosa sola all’occhio. Le pareti fiorite e fronzute spezzano interrompono quell’unità. I fiori sono parte viva di Piazza di Spagna, verissimo; tanto vero che c’erano anche al tempo dei papi. Le ciociare stavano sedute sui scalini, o passeggiavano su e giù offrendo mazzetti di fiori. Qualche canestro posato sullo scalino, era il rifornimento. Si trovò la piccola mummia di una ragazza appartenente alla famiglia degli Scipioni, aveva ancora accanto la pupa che era stata seppellita con lei. Si osannò al ritrovamento, ma non si dette nessun peso che la ruspa aveva già frantumato una parte del sarcofago, non si chiese nulla della grande quantità che avrà distrutto prima di fermarsi avanti a quel ritrovamento. Come per la ragazza degli Scipioni ora che sta su alle Terme, così per tutto il resto. A Roma c’erano i ragazzini e i regazzini, i bambini, pochi, erano di fuori. Ora ci sono solo i bambini, i regazzini sono morti. Distrutte furono le vecchie opere di beneficienza e di carità che costellavano Roma come gli orti e i giardini. Distrutte o incamerate, falsate, sbattezzate. Ai nomi della loro nascita sovrapposti i nomi. Roma è stata distrutta. E pensare che continuano ancora a chiamarla “la città eterna”. I resti lasciati sepolti hanno spesso più fascino di quando sono portati alla luce, e stanno più sicuri anche. Esempio lampante le navi del lago di Nemi, si sapeva che c’erano, se ne portava su ogni tanto un pezzo, si sapeva tutto di loro ma stavano sott’acqua, si portarono su (…….???), non ci sono più (ma è vero proprio che non ci sono più?) Le distruzioni operate dall’edilizia che avanza nella campagna sono incredibili se non fossero documentate: torri, acquedotti, resti di ville imperiali, mausolei, catacombe, archi, sepolcreti, strade lastricate duemila anni fa, tutto viene distrutto. La villa di Livia/o, quella villa che aveva il verde dei canneti e dell’erba, il colore dei fiori anche sulle pareti, è rovinata; il sepolcro dei Nasoni rovistato come un sacco. La località ad Saxa Rubra, carica di storia, splendida per bellezza naturale, manomessa. La via Nomentana perché si chiama così? Perché porta a Nomentum, di Nomentum c’erano i resti come di Roma l’abbiamo al Foro, e lì sopra hanno costruito una borgata e c’è da ringraziare la strafottente ignoranza se non le hanno appiccato il nome di nuova Nomentum. Anche sulla Collateria, il luogo di Collatia che andava custodito e studiato, sepolto da una borgata. La Villa dei Gordiani, immensa, troppo spazio occupava, l’hanno costretta alla coabitazione, tra i ruderi e le casacce nuove. Anche Fidenae, la stessa sorte, una borgata sopra, gli avanzi della villa ad duas lauros sgretolati con tale lentezza da dare l’idea di sadismo edilizio, perché questo procede distruggendo quello. I borghi medioevali sventrati, torri abbattute come se fossero erbaccia, e quel che non si può distruggere incapsulato tra le casacce, oppresso dalle caserme umane. Così sono finite molte teorie di acquedotti che erano il simbolo mondiale del fascino delle campagne romane, se sono in piedi fanno da spartitraffico nelle strade. I sepolcri che lungo le strade consolari ne punteggiavano il percorso distrutti o sventrati in quantità. Ed è meglio distogliere lo sguardo dalla via Appia, quel sogno di strada romana concessa alle dive, ai divi, ai miliardari perché stiano un poco, ma solo un poco dentro il filo stradale. Quella strada che è stata asfaltata per il comodo delle macchine. Quella via Appia che aveva sempre il suono dell’alba, dove le pecore tintinnando passavano su quei selci dove da duemila anni passavano. Quella via Appia dove si procedeva fermandosi e parlando sottovoce. Quella via Appia che s’imboccava per andare a Callisto dove non era penetrata ancora la modernità salesiana, di dove si veniva via carichi della religiosità che senza parole conferivano i Trappisti che ti avevano anche rifocillato con latte e cioccolata, il latte delle loro mucche che tra palme e rose qualche volta si intravvedevano. Direi che è meno doloroso lo scempio delle altre vie consolari, brutale e banale, di questo mascherato e ipocrita/ Più su, qualche parola insistente sui sepolcri, sui santuari, esempio quello profanato dai fratelli Arvali. 147 Importantissimo per le distruzioni Le catacombe, una rete fitta e intricata a più piani, molte sono nate e ci si può scendere, si possono ammirare e studiare, ci si può meditare, molte sono ignorate o si sa a un pressappoco che lì ci sono. La ruspa le scoperchia, tombe le (?) sono risparmiate, la terra fu portata via duemila anni fa. Si tace, si butta giù ferro e cemento e su quel suolo sacro all’asta e alla frode ecco il casone con le bagnarole alle finestre. Distruzioni L’incongruenza non solo dei fatti, ma anche delle parole che qualche volta irritano di più cominciò con l’annessione e dura tuttora. Una foto, didascalia: “Il palatino liberato dalle costruzioni che lo nascondevano”. …è liberato quel passo che resta da un mare di distruzioni. Però sotto a una foto del Campidoglio non troverete mai la didascalia: “Il Campidoglio nascosto dal monumento che gli abbiamo costruito accanto”. Per fortuna non fecero in tempo a realizzare tutte le pazzie che venivano in mente ai non romani calati quaggiù dopo l’annessione. Prova di pazzia sarebbe stata più assai del monumentaccio, la sistemazione di Piazza Navona, uno sguardo alla foto di quel bozzetto e ogni dubbio di sanità mentale scompare. Tutto senza giudizio, sventramenti e costruzioni. Buttate fondamenta poderose a casaccio, seppellite, chiuse vene d’acqua che prima defluivano al Tevere e ora stagnano e crescono sotto la città che comincia ad affondare. Non è giusto dire che in tutto questo mercimonio di capitali, di politica, di sfruttamenti, di speculazione, quella che ne è vittima deturpata e ormai morente, è solo Roma? Costruzioni edilizia – Roma Non bastavano i corvi italiani a precipitarsi a beccare pezzi di Roma, ma anche branchi di corvi stranieri si mescolarono con gli italiani, in generale erano banchieri che spuntavano qui per il buon affare. Una capitale da mettere insieme in fretta e furia non è occasione che capiti tutti i giorni. Distruzioni Un giro di parole, sempre quello, a ogni scoperta fatta e non potuta nascondere denuncia l’assassinio della città: “…venuta in luce sotto…” Dunque prima ci hanno fabbricato sopra, dopo le cose vengono alla luce. Il sopra di quel “sotto” è spesso un casone della mole della sede dell’Inps. Sepolcreti ricchissimi di ritratti in marmo, di epitaffi, di statue venivano svuotati e il materiale venduto all’estero andava ad arricchire musei e collezioni private. Il disastro cominciò subito con la calata degli architetti torinesi subito dietro ai bersaglieri, alle prostitute e ai più furbi speculatori. Buona gente, innamorata a ragione della Torino, ma che non capì nulla di Roma. Torino era bella? Sì, e tanto anche! Dunque bisognava fare che Roma assomigliasse il più possibile a Torino. Strade parallele intersecate da strade parallele, una scacchiera, una salina se volete, ma Torino è bella così, è il resto di un castro, nacque caserma, Torino, il piano ce l’ha le strade possono andar dritte. Roma no, Roma è già fabbricata, Roma è scoscendimento, Roma è sorpresa, strade a gomito, a giravolte, a curve. Che scandalo per i torinesi, tanto lo scandalo delle strade storte li accecò che non s’avvidero che Roma ne aveva già tante di strade dritte, aveva la sistina, le quattro fontane, la viminale che pur salendo e scendendo dai tre colli, dritte lo sono e proprio per quelle prospettive di sali e scendi, una meraviglia inimitabile; Roma aveva la lungara, la lunga retta e la lungarina che la precedevano, aveva via Giulia, vie, dritte e belle così Torino forse non ne ha. E le tre strade che dal popolo si aprono a ventaglio non sono forse dritte? Dall’obelisco del Popolo non se n’erano accorti che si vedeva il Campidoglio? Forse no, tanto è vero che poco dopo la 148 coprirono col più brutto dei monumenti della terza Roma. E lo stradone di San Giovanni, non va dritto? Dal Colosseo puntava su San Giovanni senza una grinza. Ce n’erano tante di strade dritte, ma lo scandalo di quelle storte li accecò, non le videro e giudicarono che questa nuova capitale dovesse avere almeno un quartiere a scacchiera e i portici. Questi romani - solo quello, immenso, ma inutile di San Pietro che per andare a casa al riparo non serve, per i negozi neppure. Anche quelle avvenute in Vaticano sono imputabili al fatto di avere destinato Roma capitale dello Stato italiano. Santa Marta, era la chiesa della confraternita dei domestici del Vaticano, stava là, accanto all’ospedale dello stesso nome (o di San Carlo) – distrutta nel 1930. Tritone Beata vergine de Stria, una chiesetta che era intonata alla sua strada, ora è un parente povero seduto fianco a fianco con quelli che si son rifatti, soffocato dai gomiti dei vicini che profittano del frontone più stretto della facciata sottostante e si allargano sulle sue desime (?): due pezzi della facciata affittati a una società pubblicitaria – sotto la baracchina per la vendita a catena dei biglietti della lotteria nazionali. Del resto chi passa di là chi guarda la chiesa? Di fuori non possono guardarla neppure quelli che c’entrano. Tra queste una delle più insopportabili è la distruzione dell’armonia qualche volta, bene o male, conservata. Un esempio, l’Albergo Bernini, avanti a quella fontana si erge come un villano fiero del suo corpaccione, avanti al suo signore. Carcerati gli acquedotti abbattuti i pini. Sorgerà il quartiere dell’Appia nuovo brutto come di più non sarebbe possibile. Demolizioni Per avere un’idea di quel che è stato distrutto, pensare a Trastevere. A destra e a sinistra del vialone c’è ancora qualche pezzo di Trastevere, benché manomesso in gran parte. Quel vialone che lo spacca in due, bisogna svuotarlo degli alberi e del traffico, e allora si che lo spazio di quanto fu distrutto (però vedere la pianta prima). Quel vuoto è un esempio delle distruzioni perpetrate dall’Italia. Distruzioni 1875 Demolito il palazzo Piombino per far posto alla galleria mutanda. Le buffonate intorno a Porta Pia bisogna vederle in Bonetti pag. 296. Una città improvvisata sulle rovine di secolari edifici. 1878 A gennaio comincia la manomissione del Pantheon - si seppellisce provvisoriamente Vittorio Emanuele tra l’altare maggiore e quello di S. Anastasio – Per seppellire bisogna demolire. 1877 - Cominciano le espropriazioni per i lavori del Tevere. Una delle prime un pezzo di giardino della Farnesina - Abbattuti i due torrioni di porta del Popolo per aprire i fornici laterali - Si terminava il palazzone delle Finanze - Per fare la via del Quirinale si dovette alterare S. Silvestro – per finire via Nazari (Ma in realtà via Nazionale) i muraglioni Aldobrandini e Rospigliosi, sostenevano i giardini. 149 Capitolo quattro Mito e antimito di una capitale I - Roma capitale: una cruciale storia risorgimentale In questo percorso di ricerca, sviluppato nei difficoltosi meandri degli scritti prevalentemente inediti di Dolores Prato, è obbligatorio ripercorrere le tappe storiche e capire le cause che portarono a stabilire proprio qui la capitale dell’Italia uscita dal Risorgimento nazionale. Attraverso la puntualizzazione di determinati argomenti – dalla questione edilizia a quella del Tevere, dalle vicende dei cattolici al rapporto con il Nord e il Sud – si può comprendere meglio il posto che Roma assunse nell’insieme della società nazionale e dello Stato. Non una capitale accentratrice e potente, cervello del paese, ma un centro economicamente e socialmente arretrato, che ben si prestava a quei compromessi su cui la classe dirigente erigeva la sua costruzione. La stessa politica dei governanti, seppure ammantata di frasi sui valori patriottici e morali di Roma, fu tale da impedire in realtà un adeguato progresso della città in senso moderno. L’Italia non ebbe mai in Roma la sua forza propulsiva, la sua guida, il suo cuore pulsante216. La classe dirigente risorgimentale, via via che cominciò a prendere coscienza di sé e dei propri compiti nazionali e liberali, andò orientandosi intorno all’aspirazione di Roma capitale. E ciò accadde, seppure in forme diverse, tanto tra i cattolici che tra i liberali, tanto tra i federalisti che tra 216 Alberto Caracciolo, Roma Capitale, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 21. 150 gli unitari accentratori, lasciando solo a piccoli gruppi di sostenere qua e là posizioni diverse. La stessa esistenza materiale di Roma come nucleo urbano era legata fondamentalmente al ruolo di capitale della cattolicità. Roma pontificia era stata sede dei più stridenti contrasti, dove allo sfarzo e alla potenza di capitale del mondo cattolico si opponeva la miseria infinita, materiale e civile, del popolino, dei mendicanti, dei guitti del contado, come luogo dove la tradizione culturale e artistica del passato annegavano nella desolante immobilità e grettezza del presente. “Roma deve tutto al papa, dicevano i difensori della Curia: se perdesse il papa e passasse all’Italia, osservava Casoni217, essa “vedrebbe allora che differenza passa fra l’essere capitale del Regno d’Italia e l’essere la metropoli del mondo intero”. “Roma deve ai papi la sua miseria, la sua ignoranza - replicavano dalla parte opposta – I papi per averla soggetta l’hanno voluta mendicante, codarda e l’hanno perciò condannata all’odio e alla superstizione”218. Roma era un agglomerato popoloso, cresciuto rapidamente: da 130 mila abitanti della Restaurazione a 220 mila censiti subito dopo l’unione all’Italia. Ma non poteva reggere il confronto, come dimensioni e come intima costituzione, con le ricche metropoli europee, da Parigi a Londra, da Bruxelles ad Amburgo. In più Roma era parassitaria, consumava e non produceva. Lo stato delle industrie era deplorevole, e anche quella di qualche rilievo, la tessile, si svolgeva in piccolissimi opifici a gestione familiare o in istituti caritativi.: la lana prodotta nell’Agro romano non bastava a far fronte alla concorrenza straniera. Lo stesso valeva per le industrie meccaniche e metallurgiche Ragioni di una capitale Roma fu prima di tutto, nel movimento nazionale, una forza unificatrice di straordinaria importanza morale. Se una tradizione comune si poteva trovare a tutta la Penisola, questa tradizione si chiamava Roma. La potenza di Roma antica e l’autorità di Roma papale sono gli elementi caratteristici, che determinano e quasi riempiono di sé la storia italiana di due millenni. Come sede del Pontefice Roma imponeva direttamente in una vasta regione il suo dominio statale, e in varia misura esercitava la propria influenza anche nel resto d’Italia, su corti sovrane, ambienti di cultura, strati di proprietà fondiaria e clero. Le antiche tradizioni neoguelfa e ghibellina di Roma conservavano immutato il loro peso retorico e culturale: il problema della Chiesa romana era sempre in piedi. Mazzini (e con lui la maggior parte della democrazia e della massoneria italiana) era tra coloro che proponevano la lotta a fondo. Roma papale era per lui un peso (abusi, vergogne, oscurantismo) e un 217 218 Giambattista Casoni, Roma e Parigi. Impressioni e memorie, Bologna 1862, cfr. Caracciolo, op. cit., p. 29. Luigi Pianciani, La Roma dei Papi, Edgardo Perino, Roma 1892, cfr. Caracciolo, op. cit., p. 29. 151 ostacolo decisivo, non c’era altra soluzione che di rovesciarla. La lotta degli italiani “non sarà in favore, ma contro la costituzione attuale della Chiesa romana”219. “Quando la nazione italiana si sveglierà quel nodo sarà, dovrà essere tagliato”220. Qui dovrà sorgere un potere politico radicalmente innovatore, che si esprima nella Costituente italiana. Diverge nettamente l’idea neoguelfa, soprattutto quella di Gioberti: il papato non va distrutto ma attirato o quantomeno neutralizzato in modo da garantire l’avvicinamento al fronte patriottico di larghi strati religiosi o politicamente prudenti che seguono la Chiesa. Roma deve avere un posto nella futura costruzione nazionale come centro della Lega italica (della stessa idea di centralità di Roma Torelli, Balbo, d’Azeglio). Gioberti diventa l’interprete dell’opinione moderata, vuole far entrare nel contenuto della fede tutta la civiltà liberale: cerca di portare alla lotta tutta la borghesia, anche le sue parti più arretrate, lanciando il manifesto Del primato morale e civile degli italiani (1843). Il progetto giobertiano è una confederazione con un supremo centro politico e ideale che è Roma (accanto alla cattolicità c’è sempre il richiamo all’“antichità imperiale”). Per Gioberti l’idea e il prestigio di Roma concorreranno in modo decisivo a completare la potenza politico-militare del Piemonte, e insiste nel voler creare un asse Piemonte-Roma, che si divida i compiti di propulsione politico-militare e ideologico-religioso221. Dopo il 1849, Gioberti rivendica la necessità di una nuova Roma (estende la condanna che prima infliggeva al solo gesuitismo), e anche Mazzini dice che “dopo la Roma degli imperatori, dopo la Roma dei papi, verrà la Roma del popolo”222: Gioberti e Mazzini, l’uno neoguelfo e l’altro democratico, concorrono nell’indirizzare profondamente l’opinione pubblica a vedere in Roma il simbolo e il compimento delle aspirazioni nazionali. Anche dopo l’episodio della fallita Repubblica romana del ’49, resta la rivendicazione di Roma come centro e capitale d’Italia, che anzi da questo infelice ma glorioso episodio esce rafforzata. Fra tanto parlare di idealità, di tradizione, di mito, anche per la Destra storica, i cui esponenti erano molto concreti nella scelta dei mezzi di lotta, la pretesa su Roma si fondava su considerazioni pratiche e realistiche: Roma era l’unica capace di apparire “neutrale” fra tutte le città italiane. Neutrale geograficamente, per la posizione abbastanza distante dalle estremità della penisola; neutrale politicamente, perché priva di una classe dirigente locale capace di entrare in concorrenza con quella del nucleo piemontese; neutrale economicamente, per la sua debolezza produttiva, che rappresentava un buon motivo per preferirla ad altre più minacciose dal punto di vista 219 The Pope and the Italian Question, Londra, 1846-47, in Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini, Cooperativa Tipografico-Editrice Paolo Galeati, Imola 1906-1912, p. 252. 220 Ivi, p. 291. 221 Cfr. Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, III, Quaderno 19 (Risorgimento italiano), pp. 1957-2078. 222 Discorso all’Assemblea costituente della Repubblica romana, 6 marzo 1849, in www.senato.it/documenti/repository/relazioni/biblioteca/scaffale_memoria/Mazzini_a_roma. 152 egemonico223. Nonostante la volontà della classe dirigente liberale, l’affermazione del principio di Roma capitale avvenne dopo una lunga lotta, di Cavour contro gruppi e personalità dello stesso moderatismo, fino alla solenne affermazione del 25 marzo 1861, nel primo discorso dopo la proclamazione del regno d’Italia: La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. E’ il sentimento dei popoli che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande stato. Roma è la sola città d’Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali, tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d’oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un rande stato. Convinto, profondamente convinto, di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza appello al patriottismo di tutti i cittadini d’Italia e dei rappresentanti delle più illustri delle sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi Possiamo dichiarare all’Europa, affinché chi ha l’onore di rappresentare questo paese a fronte alle potenze estere, possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall’intera nazione. […] Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta che Roma, Roma sola, deve essere la capitale d'Italia. […] Noi dobbiamo andare a Roma, ma a due condizioni, noi dobbiamo andarvi di concerto con la Francia, inoltre senza che la riunione di questa città al resto d’Italia possa essere interpretata dai cattolici. in Italia e fuori, come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo, cioè, andare a Roma, senza che perciò l’indipendenza vera del Pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma senza che l’autorità civile estenda il suo potere sull’ordine spirituale. Ecco le due condizioni che debbono verificarsi perché noi possiamo andare a Roma senza mettere in pericolo le sorti d’Italia224. Le resistenze più forti e pericolose erano quelle dei cattolici, preoccupati dell’offesa alla Chiesa e al Pontefice nel dover convivere nello stesso luogo con la monarchia liberale: concetti che, pochi anni più tardi, avrebbe sviluppato Stefano Jacini mettendosi a capo dei clerico-conservatori “antiromani”. Massimo d’Azeglio, nel ’60, parlava dell’ambiente malsano di Roma, tradizionalmente esposto a tirannidi, violenze e pressioni extra legali e proponeva Firenze capitale. Cavour, invece, e con lui larga parte della classe dirigente piemontese e nazionale, sentiva forte l’esigenza di Roma capitale, soprattutto per scongiurare il rischio di tendenze municipalistiche e di uno spezzarsi particolaristico e regionale del movimento unitario. 223 Cfr. A. Caracciolo, op. cit., p .41. In Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour: raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei Deputati, 1863-1872, v. 11, in www.fondazionefeltrinelli.it. 224 153 Si giunse quasi unanimi al voto del 27 marzo 1861 alla Camera, che fissava ormai l’istanza di Roma capitale e che fu seguito di lì a poco da un analogo pronunciamento del Senato. “L’Italia ha bisogno di Roma”, divenne la parola d’ordine. Roma, lo Stato pontificio, la scelta della capitale d’Italia furono grandi problemi per le sorti della nazione italiana, ma grandi e scottanti anche per l’assetto dell’Europa intera. Qui, in ogni momento, potevano scontrarsi rivoluzione e reazione, libero pensiero e cattolicità. Qui si decidevano le sorti politiche della Penisola italiana, con i conseguenti inevitabili spostamenti dell’equilibrio europeo. Nella questione romana si impegnavano il prestigio e l’influenza di grandi potenze come la Francia, l’Austria, l’Impero britannico. La politica francese nasceva dall’esigenza dell’imperatore Napoleone III di bilanciarsi tra le correnti democratiche e quelle cattoliche del proprio Paese. Un antico interesse consigliava di non creare nella Penisola un rivale pericoloso e potente, bensì soltanto un satellite: la resistenza nel concedere Roma al Piemonte era connessa a queste preoccupazioni di un’Italia troppo forte. Finché il papa possedeva la sovranità su un territorio, la cui esistenza o la cui devoluzione alla vicina monarchia dipendevano da Parigi, si poteva mercanteggiare tra Italia e Santa Sede; a partita chiusa, l’Italia non avrebbe più dovuto chiedere niente alla Francia. In quest’ottica si inserì il progetto napoleonico di una confederazione italiana con Roma sede di un papa presidente. Diversa la posizione inglese: più aperto il riconoscimento del diritto su Roma, più decisa la condanna del regime pontificio. Questo sia perché l’Inghilterra liberale era tradizionalmente critica verso la Curia romana, sia per intralciare la supremazia della Francia: far uscire il Regno sabaudo dall’impasse avrebbe riequilibrato i poteri nel Mediterraneo. Roma capitale avrebbe voluto dire un colpo ai francesi “protettori del papa” e un aiuto a rendere l’Italia più indipendente e forte nella politica europea. In Italia il contrasto tra “francesi” e “antifrancesi” fu profondo e durevole, con la Sinistra che accusava la Destra di servilismo verso Napoleone e l’Impero. Roma capitale era l’ultima e definitiva sanzione del Risorgimento, il suggello all’Italia una, indipendente, libera. Gli anni fino al 1870 furono pieni di esitazioni e contrasti, finché nel ’70, quasi inaspettatamente, si andò a Roma e lì si trasportò senza eccessive resistenze la capitale politica e amministrativa del Regno. Roma italiana, opposta a Torino piemontese, a Firenze del compromesso, alla corte del papa, era per molti sinonimo di rinnovamento e di rivoluzione. Al Partito d’azione, ai repubblicani, pareva ancor sempre che da lì dovessero prendere inizio le nuove sorti politiche d’Italia. La “Roma del popolo” di Mazzini era la città santa repubblicana, nella quale ora, come vent’anni 154 prima, si voleva vedere adunata la Costituente della nazione. Il Campidoglio era anche un simbolo di riforma religiosa e morale. La fierezza nazionale e gli impulsi rivoluzionari facevano sognare la missione mondiale di una metropoli non più sede del prete, ma banditrice del pensiero libero e della moderna civiltà. Non poteva esistere altro luogo capace di sostituire Roma in questo compito di riforma spirituale225. Roma era una rivendicazione popolare nonostante le limitazioni della cittadinanza, ma era una soluzione avversata dai cattolici e probabilmente da una parte delle masse contadine, peraltro del tutto ininfluenti politicamente. Tuttavia, la posizione anticonformista di Dolores Prato sulla questione può dipendere dall’eco di una antica fedeltà rimasta, anche e forse soprattutto a livello popolare, negli ex-territori dello Stato pontificio. Fra Nord e Sud Il 20 settembre 1870 si chiude un periodo storico: un sistema di fini a lungo perseguiti (l’unità nazionale, la costruzione di uno Stato liberale) si è attuato. Da quel momento, però, emergono più chiaramente la “questione sociale” e l’embrione della “questione meridionale” (è scoppiato un movimento antistatale e contadinesco di massa noto come “brigantaggio”); la legge per l’alienazione dei beni ecclesiastici ha scosso il sistema della proprietà terriera; mutano i termini della “questione romana”, con la presa di Roma e il Papa ridotto in Vaticano; nasce la necessità di una conciliazione e il problema del posto che deve spettare a Roma. Roma, che non è stata la forza motrice essenziale del Risorgimento, ad eccezione dell’esperienza “troppo” democratica della Repubblica del ’49, non potrà allo stesso modo essere il centro propulsivo del nuovo Stato. “Ci si rendeva conto adesso, nell’atto di trasferire la capitale, che l’asse del paese si sarebbe in qualche modo spostato”226. “La postura di Firenze concilia mirabilmente le esigenze dell’Italia settentrionale con quella meridionale, mentre Roma s’accosta troppo al Mezzogiorno”, diceva Jacini227 in un discorso al Senato. Subito dopo la breccia di Porta Pia sembrava a molti che Roma fosse caduta nelle mani piuttosto dei piemontesi che degli italiani. “Piemontesi” erano chiamati con disprezzo i nuovi venuti dai clericali. Da Torino venivano i principali personaggi del nuovo Stato, e anche buona parte degli istituti e dei gruppi finanziari che, fin dall’inizio, accorsero ad investire i loro capitali nell’economia romana. La 225 A. Caracciolo, op. cit., pp. 53-54. Ivi, p. 63. 227 Ivi, p. 63. 226 155 Servadio, impegnatissima nell’espansione edilizia a Roma, faceva capo alla Banca di Torino e alla Sconti e sete, così come il grande complesso delle costruzioni dell’Esquilino, condotto dall’impresa omonima, era sostenuto per metà da genovesi – la Banca italiana costruzioni e la Compagnia commerciale italiana - per metà dalla Compagnia fondiaria italiana, con azioni appartenenti per un terzi a un gruppo subalpino. Gli immigrati settentrionali e toscani prevalevano non solo per importanza, ma anche per numero. Subito dopo il ’70, i provenienti dalle province del vecchio Regno sardo e i toscani superavano, in percentuale, tutti gli altri immigrati, e già dieci anni dopo i non romani e gli stranieri erano più degli abitanti nati nella città (166.311 contro 134.156)228. Il trasporto della capitale divenne forza attrattiva sia per tutti gli impiegati dello Stato che da Torino si erano trasferiti a Firenze e ora confluivano a Roma, sia di una moltitudine di persone in cerca di fortuna, provenienti prevalentemente dal Mezzogiorno: una moltitudine “rumorosa, irrequieta, procacciante e, nonostante le apparenze etniche, meno omogenea all’antica popolazione romana del toscano o del piemontese infiorentinato”229. Con il passare del tempo la “meridionalizzazione”, prima avvertita come pericolo, divenne realtà: dal Sud salirono borghesi senza futuro, contadini, popolani, ma anche un ceto burocratico fatto di napoletani, siciliani, calabresi, o piccoli commercianti e artigiani dell’Abruzzo e della Campania. La fusione delle persone e dei costumi fu ardua. La scossa del 20 settembre creò un diaframma tra i “caccialepre” o “neri” (così venivano chiamati gli amici del regime pontificio) e gli “usurpati”, i “conquistatori” (come venivano definiti i nuovi venuti), e questa divisione partiva dai vertici, Quirinale e Vaticano, per scendere fino agli strati del popolo. Se questi mutamenti […] colpivano le classi elevate, la popolazione romana degli altri ceti restava impressionata da altri fatti. In primo luogo, il diluvio di giornali dai quali era stata sommersa Roma. In pochi mesi comparvero centinaia di testate di giornali umoristici, politici, letterari. Essi agitavano confusamente le idee di libertà e dell’avvenire di Roma e del nuovo stato, condendo il tutto con accese polemiche verso l’antico regime pontificio e con tutte le salse dell’anticlericalismo. Da parte cattolica, usufruendo delle libertà, fra cui quella di stampa, garantite dal governo italiano, non si esitava a rispondere per le rime, e altrettanto si faceva dai pulpiti delle chiese più frequentate. Ma anche alle altre novità portate dallo Stato italiano i romani fecero presto l’abitudine, con quel tanto di sufficienza, di ironia e di scetticismo che deriva loro dalla lunga frequenza con la storia. Erano arrivati, infatti, i “buzzurri”, come li chiamarono, cioè i funzionari del nord che subito si fecero costruire un quartiere a immagine di Torino (la zona di piazza Vittorio) e introdussero nuove abitudini e nuovi costumi230. 228 Comune di Roma, Annuario statistico di Roma, Roma 1885, v. II, cfr. A. Caracciolo, op. cit., p. 66. A. Caracciolo, op. cit., p. 67. 230 in Roma Capitale d’Italia. Nel primo centenario, a cura del Ministero della Pubblica Istruzione, Arnoldo Mondadori Editore, Verona 1971, p. 186. 229 156 Carovita e caro alloggi resero in breve gravissima la situazione degli strati popolari, e il problema delle abitazioni cresceva con lo scatenarsi della speculazione edilizia connessa con l’incremento repentino della popolazione. Allo stesso tempo, c’era anche chi poté avvantaggiarsi immediatamente del regime sopravvenuto: i “poteri forti” legati al mondo della finanza. Ma, nel passaggio dal vecchio al nuovo, si creò nello stesso popolo romano una divisione netta tra coloro che ormai affiancavano le proprie sorti a quelle della nazione italiana, capeggiati da gran parte della borghesia ricca e degli intellettuali, e quanti speravano nella restaurazione, avendo in odio i “piemontesi”, e si legavano sempre più alla Curia e al clero. Tra i “neri” anche numerose schiere del popolino, in particolare di donne, che avevano vissuto degli impieghi e delle elemosine della Chiesa e dei signori della corte pontificia. Fin dal primo giorno i clericali si presentarono come difensori dell’autentico animo di Roma. Da subito, in Vaticano e negli ambienti cattolici si cominciò a parlare di stranieri e di piemontesi opposti al genuino popolo di Roma; si revocò tutto quanto era possibile delle tradizioni del “buon tempo antico”; si cercò di confondere feste religiose e popolari dei romani. Quotidiani intransigenti si chiamavano “Moniteur de Rome”, “Giornale di Roma”, “Corriere di Roma”, “Romano di Roma”. Nel frattempo, l’amministrazione comunale diventava il luogo più tipico e adatto per la collusione sul terreno economico per la presenza di clericali, principi romani, mercanti di campagna e rappresentanti della finanza e degli intellettuali settentrionali. L’avvenire della città: verso l’ampliamento urbano All’indomani della scelta della capitale, tutto il partito liberale concordava sul fatto che la superiorità del nuovo regime sul vecchio doveva apparire nel volto stesso della città: bisognava dunque liberarla dalle brutture e dalle piaghe tradizionali perché diventasse più bella e più grande dell’antica. Un programma che piaceva a tutti i patrioti, ai potenti della finanza e alla classe dominante nazionale, ma che trovava esitazione nei gruppi della borghesia e del conservatorismo romano, che non concepivano le colossali opere di trasformazione e gli immensi investimenti proposti dalla grande finanza settentrionale. Sta di fatto che tutto quello che era speculazione sulle aree, grandi profitti e improvvisi crolli, caro alloggi, espansione urbana, si sarebbe poi sviluppato sulle basi gettate nei primi anni e nei primi mesi: l’arrivo di amministrazioni centrali, corpi militari, attività giornalistiche, culturali, associative, l’afflusso di intere famiglie da altre regioni, provocarono crescente richiesta di locali di ogni tipo. In 157 questo quadro, corporazioni religiose ed enti ecclesiastici si affrettarono a vendere tutto quello che poterono, prima di essere colpiti dalle leggi eversive in preparazione. Famiglie nobili si disfecero di ville e palazzi, che prima sembravano intoccabili per ragioni di prestigio. I profitti furono insperati. In pochi mesi il suolo edificabile di Roma subì un vasto trasferimento di proprietà: anche i proprietari delle ville, i “vignaroli” e gli ordini religiosi che traevano dalle terre le loro rendite avevano venduto tutto a una cerchia ristretta di gruppi finanziari, come la Compagnia fondiaria italiana, la Italo-germanica, la Banca di credito romano, la Banca generale di Roma. Il futuro della città era in mano a questi pochi gruppi capitalistico-finanziari. La trasformazione edilizia della città non la dominavano lo Stato o il Comune, ma i privati e gli speculatori. Per Quintino Sella231, Roma avrebbe dovuto essere il luogo della scienza e del dibattito intellettuale, dei poteri di governo, dell’amministrazione, dei poli essenziali della giustizia, dell’istruzione e della ricerca scientifica. Un atteggiamento politico, questo, particolarmente moderno e avanzato, che però era affiancato da un elemento in controtendenza con le aspirazioni locali. Sella, infatti, respingeva l’idea che a Roma si spostasse anche il centro di gravità dell’economia nazionale: a Roma non poteva stabilirsi il nucleo industriale, commerciale e produttivo del Paese. L’idea della Destra per lo sviluppo della città era che si edificasse all’interno delle mura, verso la zona alta, verso l’Esquilino. Al contrario, per gli ambienti della Sinistra la direttiva per la nuova città era quella di costruire quartieri lungo il Tevere, a Testaccio e ai Prati di Castello, fuori dalla cinta della Roma dei papi. A rappresentare questa seconda idea di Roma è Luigi Pianciani, figura di grande rilievo in quegli anni, vecchio patriota del Partito d’azione: nei suoi discorsi esalta la “nuova Roma”, la “terza Roma”, la “Roma del popolo” e protesta contro il “prete”. La sua volontà, subito abbracciata dalle maggiori società imprenditrici, è di realizzare opere monumentali e di quartieri nuovi al di là delle vecchie mura. In questo modo si sanciva che le mura della Roma pontificia non segnavano più i confini della città. Questo progetto fu anche visto come tentativo di accerchiare il Vaticano, soprattutto in ambienti clericali232. Due modi di vedere il futuro della capitale che, a grandi linee, mostrano due concezioni politiche antitetiche: Sella diventò di fatto il punto di convergenza delle forze più retrive – vecchia proprietà fondiaria nobiliare ed ecclesiastica, gruppi monopolistici settentrionali – che avevano un visione comune di una Roma stagnante e “tranquilla”; l’espansione verso i Prati e il Tevere, invece, era cara ai democratici e a quanti volevano rompere con il passato, sognando una città ricca di industrie e con quartieri per operai, commercianti e imprenditori. 231 Quintino Sella (Mosso, 7 luglio 1827 – Biella, 14 marzo 1884) fu scienziato, economista, politico. Fu ministro delle Finanze nei governi Rattazzi, La Marmora e Lanza, e raggiunse in pochi anni il pareggio del bilancio. 232 Cfr. Alberto Caracciolo, I sindaci di Roma, Donzelli, Roma 1993. 158 Proprio da questi contrasti interni alla classe dirigente derivò il carattere disorganico, anarchico e saltuario dello sviluppo urbano della capitale. L’inondazione del Tevere del dicembre 1870 colpì l’immaginazione dei contemporanei oltre misura e valse l’arrivo di re Vittorio Emanuele II, per la prima volta a Roma capitale d’Italia. Il problema dell’arginamento e della sistemazione del fiume, e anche del suo rapporto con l’agglomerato urbano, diventò una delle questioni fondamentali, e lo restò per anni. C’era chi proponeva soltanto la sistemazione del corso attuale con modesti lavori di arginamento tramite l’elevazione di muraglioni, e chi, invece, voleva deviare l’alveo furori città. Tra questi ultimi c’era anche Garibaldi, cui non sfuggì il significato della battaglia intrapresa per il Tevere, e che sapeva che le sue proposte suonavano come sfida al partito di potere. Il progetto Garibaldi-Baccarini233 venne presentato alla Camera nel 1875, dove fu approvato all’unanimità. Venne varata la legge, ma il consiglio dei lavori pubblici si dichiarò contrario: per Garibaldi, che si era ritirato a Caprera, fu un grave colpo. I grandi costi dei lavori e gli interessi particolaristici bloccarono i lavori per lungo tempo. Qualche prospettiva sembrò offrire la salita al governo della Sinistra, con Depretis e Crispi: ma l’impresa di Garibaldi era troppo lontana dalle forze e dalla mentalità della nuova classe dirigente. Questioni insolute e sempre ricorrenti furono anche la bonifica dell’Agro romano e il porto di Roma, che sarebbe dovuto nascere lungo un Tevere navigabile e utilizzabile per lo sviluppo commerciale. Le ragioni dell’insuccesso nell’impresa del porto di Roma sono in fondo le stesse che segnano il fallimento di ogni tentativo per l’industrializzazione della capitale. Lo sbocco al mare non è concepibile altro che nel quadro di una città produttrice ed economicamente progredita. I gruppi pi o meno grandi che di volta in volta si battono per questa prospettiva sono invece ripetutamente sconfitti e prevale sempre, come vedremo ancora, il concetto di “capitale tranquilla”, senza grandi industrie o agglomeramenti operai234. La città di Roma nella questione romana In uno studio su Roma capitale necessariamente ha grandissima importanza la questione del papato, della Chiesa, del mondo cattolico che lì risiedevano. La storia di Roma capitale d’Italia è piena di urti e di attriti, di accomodamenti fra i due poteri che si trovavano domiciliati sulle due rive del 233 234 Alfredo Baccarini, ingegnere e politico di ispirazione liberale. A. Caracciolo, Roma capitale, cit., p. 128. 159 Tevere. Eppure, di fronte alle parate dell’anticlericalismo, che faceva della città eterna il simbolo dei propri principi, e alle accese manifestazioni religiose (politiche anch’esse) con cui rispondeva il partito clericale, i governanti italiani riuscirono ad operare in modo da attutire i motivi di frizione e alimentare quelli di convergenza. Con la caduta del dominio temporale della Chiesa, il venti settembre 1870, Roma perse però anche una tradizionale risorsa di vita e vaste categorie lavoratrici e di mondo minuto rimasero colpite, ma il vero cataclisma fu per la Santa Sede, il patriziato romano, le istituzioni religiose. Nel ’70, con la perdita delle rendite dai possedimenti territoriali, il Vaticano si trovò, impreparato, ad affrontare i nuovi drammatici problemi di bilancio. La Chiesa, non volendo apparire mantenuta da un regime che l’aveva spogliata dei propri averi, tentò di vivere ancora con i redditi delle sue proprietà e con la carità dei fedeli, ma le leggi eversive, che dall’Italia si erano estese anche alla provincia romana, colpirono anche queste fonti tradizionali. Per di più, l’Obolo di San Pietro era sempre più insufficiente e la Santa Sede rischiava anche di rimanere sotto scacco delle comunità nazionali (vedi quella francese), le uniche capaci di salvarla dalla bancarotta. Iniziò così la tendenza a investire in banche italiane ed estere, e specialmente in quelle interessate alle attività economiche di Roma. In Parlamento, parallelamente, i sostenitori della soppressione dei privilegi ecclesiastici si scontravano con i più prudenti, che non volevano approfondire il solco con l’ambiente cattolico e, soprattutto, temevano reazioni di natura internazionale. Un colpo decisivo venne assestato, con legge del 27 maggio 1873, alla manomorta ecclesiastica, che “doveva cessare”. Un’apposita giunta liquidatrice dell’Asse ecclesiastico della città di Roma, inoltre, dopo poco più di un anno (1875) aveva venduto oltre un terzo del patrimonio immobiliare e mobiliare, facendo scendere i prezzi degli immobili sul mercato romani con sempre meno circolazione di capitale locale. Compratori di beni ecclesiastici erano famiglie patrizie, di cui molte legate al Vaticano, e della stessa cerchia erano i nomi delle grandi famiglie che misero in vendita palazzi, ville e vigne entro le mura cittadine: le ricchezze ricavate vennero poi affidate alle istituzioni di credito, che convogliarono nelle imprese di ingrandimento della città, finché via via questo genere di affari risultò gestito direttamente da molti esponenti dell’antica aristocrazia. Compromesse le tradizionali fonti di reddito, Vaticano, corporazioni religiose e magnati cattolici romani si rivolgono dunque sempre più verso investimenti d’altra natura. Ogni qualvolta un ente ecclesiastico entra nel giro del mercato delle aree fabbricabili, la concretezza dei fatti e del denaro lo induce a dimenticare l’abitudine della manomorta, a superare i pregiudizi, per godere gli insospettati vantaggi del libero commercio235. […] La presenza dei cattolici nelle imprese speculative fiorenti a Roma diventa più frequente, più noncurante di 235 Ivi, p. 146. 160 affiancarsi a liberali e governativi, fino a divenire aperta e massiccia236. Rivolta all’inserimento dei cattolici nella struttura intima della società romana, nella vita associata e nell’apparato amministrativo della capitale fu l’Unione romana, fondata sul finire del 1871 per le elezioni amministrative. L’Unione raccoglieva simpatie di più d’uno in campo liberale: era vista come il partito conservatore del domani. Contraltare alla Primaria società romana e al partito più intransigente, appariva come un’organizzazione autorizzata e rappresentativa della Chiesa. Il suo indirizzo moderato, già caratteristico sotto Pio IX, e favorito ancor di più da Leone XIII, portò l’Unione a presentarsi unita con i liberali conservatori, nel desiderio che “onesti e abili amministratori siano mandati a seder nei consigli del comune”237: una grande alleanza tra conservatori di idee cattoliche e di idee liberali. L’Unione romana, anche se non vantava la maggioranza, diresse la cosa pubblica in comune e alla provincia ininterrottamente fino al blocco Nathan. Essa rappresentava, in sostanza, un mondo di interessi che sempre più venivano a coincidere con quelli dell’alta finanza e della borghesia italiana. Interessi che segnavano il passo del programma amministrativo dei cattolici. La febbre edilizia che investì Roma per sette-otto anni dopo il 1880 non aveva precedenti, in nessun luogo: frenesia di affari e corsa all’investimento in terreni e case alimentavano speculazioni che attiravano imprenditori da ogni parte d’Italia, e che creavano fortune immense atterrandone rapidamente altre. Tutto lasciava prevedere la crisi. In ogni parte della città, edifici e strade incompiute testimoniavano una situazione pesante nel mercato immobiliare, dal futuro incerto. La legge speciale sul concorso dello Stato nelle opere edilizie della capitale fu carica di conseguenza sullo sviluppo della città, e rappresentò la premessa a tutto il periodo della “febbre edilizia”. Tra le maggiori opere pubbliche il Palazzo di giustizia, il Policlinico, caserme, ponti sul Tevere, la continuazione di via Nazionale, la demolizione del ghetto. Con il nuovo piano regolatore del 1883 (cui ne sarebbero seguiti altri due fino alla prima guerra mondiale), poi, si generò un fenomeno di inurbamento irregolare e di anarchia edilizia: le banche, infatti, trovata difficile la speculazione nell’orbita del piano regolatore per il valore acquistato dai terreni fabbricabili, che esse stesse avevano contribuito a elevare, cercarono di spostare l’indirizzo volgendo lo sguardo al suburbio. Quasi all’improvviso si tracciarono dieci quartieri suburbani fuori 236 237 Ivi, p. 148. cfr. Ivi, p. 158. 161 le porte Pia, Salaria, San Lorenzo, Pinciana, Portese, San Giovanni, Flaminia, Trionfale: una superficie di 898 mila metri quadri ai quali si aggiungevano i 2 milioni 800 mila metri quadrati del comune. Fu dunque sotto la spinta degli interessi di alcuni potenti e di grandi banche che cambiò la fisionomia della città, al di fuori di qualsiasi previsione. E il comune rimase travolto. Questo piano fu fatale per lo sviluppo urbanistico, perché esso, più che orientarsi verso un ampliamento della città prevalentemente in una singola direzione, in modo da limitare le funzioni del vecchio centro, contemplava l’adattamento e la trasformazione di tutta la città, e costruzioni nuove in ogni direzione. Si costruì dunque caoticamente, ma specialmente si sventrò in profondità. Il caso più clamoroso fu via Nazionale che, anziché limitarsi a collegare il vecchio centro alla stazione Termini, diventò l’asse di attraversamento dell’intera città. Altre opere vennero intraprese sotto l’assillo delle necessità igieniche. Venne così distrutto il ghetto e venne rasa al suolo la zona dell’Arenula; indubbiamente erano opere indispensabili sotto il profilo della profilassi contro il colera che, a quell’epoca, costituiva una minaccia permanente. Tuttavia si deve lamentare che tali opere non siano state eseguite con maggior cautela, bonificando, ripulendo, sfoltendo, senza demolire interi quartieri. Cominciò invece la sistematica distruzione della Roma medioevale che sarebbe stata completata sotto il fascismo. Una specie di frenesia sembrava aver preso tutti238. 238 Roma capitale d’Italia, cit., p. 204. 162 II - “L’unità d’Italia: un assassinio per Roma”. Sul filo di Voce fuori coro 1881 La frenesia delle costruzioni prese un po’ tutti. Roma era o non era capitale? Dunque doveva essere grande, popolosa come Parigi, perciò case, case, case perché la gente vi proliferasse. E dove? Ma più vicini possibile alla Vecchia Roma; Esquilino, Termini, Prati, Macao, Sant’Agnese, S. Lorenzo. Roma nella fantasia frenetica d’allora, va oltre, diventa immensa, si comperano vigne, orti, terreni da pascolo a prezzi di terreni fabbricabili, si rivendono, si spezzettano, si passano di mano in mano, e intanto si atterrano gli alberi per costruirvi quelle case, quelle fabbriche che vi cominceranno a sorgere mezzo secolo più tardi. Diventavano tutti costruttori. Il capomastro poteva essere l’architetto e l’ingegnere di se stesso, e così sorgevano case immense, brutte e mal fatte. Comincia così la lunga traversata nella storia di Roma raccontata, in qualche modo, da una Dolores Prato senza freni né filtri, volutamente schierata dalla parte dei nostalgici di Roma com’era: una città di piccoli miracoli nascosti fra scoscendimenti, curve e vicoli, una città del popolo, ma anche del papa, una città nata per essere capitale non di uno Stato particolare ma per sua natura universale. Dal Risorgimento alla breccia di Porta Pia, passando per il ventennio fascista e le due guerre mondiali, fino all’“oggi” di una brillante intellettuale intenta a scrivere un pamphlet di rottura con la storiografia classica dominante, una carrellata di immagini e racconti restituiscono una realtà diretta e comprensibile a tutti. Alla base, però, una minuziosa ricostruzione della cronologia degli interventi distruttivi-costruttivi che cambiarono radicalmente l’aspetto di Roma a partire dal 1870. Per Dolores Prato, l’annessione di Roma e la sua trasformazione in capitale rappresentarono “un assassinio”, la “distruzione” di una “città del popolo”: “La Roma nuova è un incubo. Percorrerla è tentare di uscire dall’incubo senza riuscirci”. 163 Tutto si restrinse in Roma divenendo capitale d’Italia, materialmente e spiritualmente. Il Tevere reso non più atto alla navigazione ne è un simbolo. Grande chiavicone a cielo aperto. […] La capitale ha decolorato Roma. Una città che era tutta, anche se piccola, colore di crosta di pane ben cotta, colore di sole al tramonto su tela grezza, colore di caldo e di mattone cotto, come poteva essere capita dai nordici piemontesi che venivano giù con nel cuore e nel cervello i colori grigi delle loro città porticate per rendere anche più grigia l’aria dove l’uomo cammina? Ed ecco Piazza Vittorio esempio di grigio e di criptoportico, ecco i quartieri umbertini dove pure qualche volta il colore di Roma fa macchia tra il grigiore delle altre case239. La colpa di tutto era dei “piemontesi”, e dei Savoia. Il disastro cominciò subito con la calata degli architetti torinesi subito dietro ai bersaglieri, alle prostitute e ai più furbi speculatori. Buona gente, innamorata a ragione della Torino, ma che non capì nulla di Roma. Torino era bella? Sì, e tanto anche! Dunque bisognava fare che Roma assomigliasse il più possibile a Torino. Strade parallele intersecate da strade parallele, una scacchiera, una salina se volete, ma Torino è bella così, è il resto di un castro, nacque caserma, Torino, il piano ce l’ha le strade possono andar dritte. Roma no, Roma è già fabbricata, Roma è scoscendimento, Roma è sorpresa, strade a gomito, a giravolte, a curve. Che scandalo per i torinesi, tanto lo scandalo delle strade storte li accecò che non s’avvidero che Roma ne aveva già tante di strade dritte, aveva la sistina, le quattro fontane, la viminale che pur salendo e scendendo dai tre colli, dritte lo sono e proprio per quelle prospettive di Sali e scendi, una meraviglia inimitabile; Roma aveva la lungara, la lunga retta e la lungarina che la precedevano, aveva via Giulia, vie, dritte e belle così Torino forse non ne ha. E le tre strade che dal popolo si aprono a ventaglio non sono forse dritte? Dall’obelisco del Popolo non se n’erano accorti che si vedeva il Campidoglio? Forse no, tanto è vero che poco dopo la coprirono col più brutto dei monumenti della terza Roma. E lo stradone di San Giovanni, non va dritto? Dal Colosseo puntava su San Giovanni senza una grinza. Ce n’erano tante di strade dritte, ma lo scandalo di quelle storte li accecò, non le videro e giudicarono che questa nuova capitale dovesse avere almeno un quartiere a scacchiera e i portici240. 239 240 ACGV, Fondo Prato, Pm 16. ACGV, Fondo Prato, Pm 16-20. 164 E ancora: Uno stato che veniva a manomettere i religiosi, che ne prendeva case ed averi, ma non aveva neppure la fantasia di trovare nomi nuovi. Così il carcere femminile continuò a chiamarsi “Le Mantellate” come se dentro vi si aggirassero pudiche vergini. E a uno dei più brutti carceri, un edificio che è la realizzazione di un incubo, dettero uno dei più dolci nomi che sia possibile dare “Regina coeli” solo perché lì c’era una chiesina, e prima un convento anche con quel nome che non se l’erano dato le religiose, ma il popolo l’aveva dato a loro. Perché non erano monache il cui umore assecondasse i tempi dell’anno liturgico che alterna lutto e gioia, attesa e sollievo, obbedienza e festa. Quelle suore erano sempre in festa, esse onoravano la Madonna perpetuando il tripudio che comincia con la Pasqua, finisce con l’incanto dell’Ascensione per passare al raccoglimento e all’azione della Pentecoste. E’ il periodo in cui la chiesa tripudia ripetendo “Alleluja, alleluia” e si rivolge alla Madonna: “Regina coeli cantare, alleluja, resurrescit, sicut discit, alleluja. Regina coeli laetare, alleluja”. Questa antifona che è solo del tempo pasquale, esse la ripetevano tutto l’anno, tutto l’anno allelujavano; scendevano in chiesa più volte al giorno e cantavano “Regina coeli laetare alleluia”, interrompevano il sonno della notte per cantare ancora “Regina coeli, laetare alleluia”. Le persone che entravano in quella chiesina facilmente s’imbattevano nel coro squillante di voci argentine del Regina coeli. E Regina coeli fu il nome che diventò delle monache e del luogo. Le parole sono cose vive, le parole diventano anima nostra, nostro sorriso e nostro pianto. Le suore che davano la vita nella ripetizione di quel canto allelujante assorbivano per forza un po’ della sua letizia. Quel luogo fu scelto per costruire il tetro carcere, come sempre mancò la fantasia per scegliere un nome, lasciarono quello al carcere. Battezzavano tutto col nome del loro re, potevano chiamarlo Reale carcere Vittorio Emanuele II. Era suo, il suo governo l’aveva costruito, il nome gli spettava, invece no, lo dettero alla magnifica biblioteca dei gesuiti per la quale lui non aveva fatto altro che rubarla (se è troppo dire incamerarla)241. L’opera di trasformazione della città, nel lessico di Prato, diventa “distruzione”, “sventramento” (questi sono anche i titoli da lei scelti per i capitoli del suo libro). Di tutto ciò che fu abbattuto, degli scavi, delle costruzioni, la scrittrice fa un elenco infinito e dettagliatissimo, con tanto di documentazione storica datata. 241 ACGV, Fondo Prato, Pm 16. 165 Finora le rovine vivevano insieme col popolo romano. Quell’esedra abbracciava una casetta, quell’arco ne ricopriva un’altra, quella colonna entrava dentro una casa e ne reggeva il crocifisso in cima al letto, il vaso di mentuccia stava sopra un capitello, e il simulacro di Minerva custodiva la porta di un forno. Con quella valanga di furiosi e incoscienti innovatori incominciò subito la rovina delle nostre rovine che dura tuttora in un processo ormai inarrestabile. Solo l’abbandono di Roma come capitale riuscirebbe a salvare quello che è ancora salvabile. Perché è proprio l’abbandono che le conserva. Il cemento che le unisce alla vita, è la loro conservazione, e la terra. La terra le custodisce, l’aria le sgretola. Incominciò subito quell’opera di isolamento, che riduce le rovine a scheletri. E siccome l’entusiasmo dei buzzurri era poderoso, si cominciò dal Colosseo. […] Via le erbacce e gli arbusti che macchiano di verde il caldo colore romano. Le radici, è vero, dilatano, ma cementano anche. […] Comunque il Colosseo fu tosato e sbarbato mentre i guastatori demolivano i tabernacoli della via Crucis lungo l’arena e le cappellette nascoste in qualche angolo di quel gigantesco labirinto di volte e di archi. Alcune di quelle oscure cappellette erano assai più suggestive della grotta di Massabielle. La gente vi riposava, ci chiacchierava e pregava anche. E nonostante le ripetute e molteplici e ostentate proteste di rispetto alla religione, la grande croce che s’innalzava nel mezzo dell’anfiteatro fu abbattuta. Nelle chiese si facevano tridui per la salvezza del Colosseo, per riparazione della sua profanazione. Arrivò anche un pellegrinaggio di protesta e devozione […] La sofferenza per questa distruzione non era tanto dei romani che guardavano i fatti della loro città come chi legge un libro di storia su fatti che già conosce, con acutezza di giudizio, ma senza meraviglia, senza emozione. Ma erano i cattolici stranieri a ribellarsi e a soffrire di più. Essi venivano a Roma come a un prolungamento spirituale della loro patria, e trovavano che era diventata un’altra cosa, una patria anch’essa sua straniera alla loro. E con quella furia distruttiva dei nuovi venuti essi trovavano Roma come chi torna a casa e la trova sconvolta dai ladri242. O ancora: L’incongruenza non solo dei fatti, ma anche delle parole che qualche volta irritano di più 242 ACGV, Fondo Prato, Pm 16-20. 166 cominciò con l’annessione e dura tuttora. Una foto, didascalia: “Il palatino liberato dalle costruzioni che lo nascondevano”. …è liberato quel passo che resta da un mare di distruzioni. Però sotto a una foto del Campidoglio non troverete mai la didascalia: “Il Campidoglio nascosto dal monumento che gli abbiamo costruito accanto”. Per fortuna non fecero in tempo a realizzare tutte le pazzie che venivano in mente ai non romani calati quaggiù dopo l’annessione. Prova di pazzia sarebbe stata più assai (?) del monumentaccio, la sistemazione di Piazza Navona, uno sguardo alla foto di quel bozzetto e ogni dubbio di sanità mentale scompare. Tutto senza giudizio, sventramenti e costruzioni. Buttate fondamenta poderose a casaccio, seppellite, chiuse vene d’acqua che prima defluivano al Tevere e ora stagnano e crescono sotto la città che comincia ad affondare. Non è giusto dire che in tutto questo mercimonio di capitali, di politica, di sfruttamenti, di speculazione, quella ch ne è vittima deturpata e ormai morente, è solo Roma? Particolare, quasi viscerale, è il legame della scrittrice-giornalista con il Tevere. Del fiume conosce la storia, le storie che lo avevano attraversato, il colore e l’odore, il profondo valore simbolico ed economico che aveva rappresentato. Nelle sue parole è vivo il rapporto fra il Tevere e i romani, il significato di “Roma fumarola”. In particolare, Dolores non accetta la costruzione dei muraglioni come soluzione al problema delle esondazioni. Si dice sempre che il fiume fu incarcerato dai muraglioni. Nessuno dice che tutta la città che confluiva al Tevere fu imprigionata. Era una città fluviale da quella parte, scendeva dolce verso l’acqua, nelle strade che vi sboccavano si avvertiva il chiarore dell’acqua assolata Avanti a questa città fluviale furono alzati gli argini che la chiusero come le muraglie i cortili delle carceri. I lungotevere a sinistra del fiume, quelli che hanno incarcerato Roma fiumarola, sembrano belli perché non guardiamo più la Roma del seminterrato. A San Rocco, in linea d’aria, gli camminiamo a metà facciata, e via Giulia, le scuole dei Fiorentini, (cercare le vie prima e dopo S. Rocco) tutte strade semisepolte dai bastioni. Quei muraglioni qualcosa hanno fatto, ma non per questo sono meno brutti. Se avessero visto com’era bella quella Roma che lambiva le acque e anche quando ci si specchiava, in cui il fiume era parte viva della città come la gente che vi scendeva. Quell’acqua era a livello delle case, vivevano insieme. Del fiume hanno fatto un pozzo profondo, un canale. 167 Potevano arrivare allo stesso scopo con altri mezzi. Ma si sa, i lavori dei governi moderni sono politica, utilità pubblica, è una cosa per conquistare approvazioni. Bisognava decidere di fare quei muraglioni al più presto, così si poteva dire: Romani, quello che i papi non vi hanno fatto in tanti secoli, ve lo fa subito re Vittorio, lo scomunicato. E così via il suggestivo porto di Ripetta alla cui guardia stavano due chiese. Una corsa di pochi passi e dall’acqua si stava in chiesa. Ora quelle chiese stanno giù sprofondate e la gente che cammina sul lungotevere, le guarda dall’alto. Dolores non si esimeva da giudizi taglienti sulla monarchia e il nuovo assetto politico in cui si muoveva l’Italia appena nata: Il nuovo regno dietro la sua trionfalistica retorica aveva anche la sua paura. Per paura che manovre internazionali portassero a ripristinare un governo pontificio, si mise con i tedeschi. Due Kaiser e in mezzo un reuccio nuovo di zecca243. Ed era sua intenzione scrivere anche capitoli su Quel che poteva essere fatto. Costruendo in prossimità di un monumento o edificio ragguardevole per arte o per storia, tenere una certa distanza e nelle proporzioni regolarsi su quello del medesimo. Esempio: la torre degli Anguillara che potentemente emergeva nello spazio per chi andava verso Trastevere, ora è un aggeggio davanti a un enorme casone che la sovrasta. La chiesina della Madonna del riposo quella che era una felice pausa nel cammino dei piedi e nell’ansia dell’anima, campagnola, ma graziosa, ora è una specie di baracchetta davanti agli edifici che le sorgono giganteschi non solo ai lati delle due strade che da lei divergono, ma alle sue spalle. Essa poggia su quei casoni. Se si fosse lasciato un po’ di spazio alberato dietro di lei, in modo che la sua rustica grazia risaltasse, anche la zona, bruttissima, ne avrebbe guadagnato. Ora essa è un nome per indicare una fermata degli autobus244. Un altro tema molto caro a Dolores è l’industrializzazione di Roma, nonostante lei stessa dichiari: “Di questo argomento non so proprio nulla. Leggo, non vado alla ricerca della verità. E quel che leggo è un gioco a mosca cieca. Quello piange perché Roma non è città industriale e auspica 243 244 ACGV, Fondo Prato, Pm 2. ACGV, Fondo Prato, Pm 16-20. 168 capannoni e ciminiere, quell’altro è soddisfatto perché da quel che già c’è è chiaro, Roma è già e lo sarà sempre di più città industriale”245. E in effetti, la questione che si pose ai governanti all’indomani dello spostamento della capitale a Roma riguardo al carattere industriale o meno che la città avrebbe dovuto avere, sull’esempio delle altre capitali, è un argomento controverso e dalle molte sfaccettature. Anche a trenta o quaranta anni dal venti settembre, se andiamo a leggere la storia di Roma capitale, non troveremo la costruzione di nuove industrie, se non di poche, e che ebbero breve vita. Ma le motivazioni dietro al mancato decollo industriale della città non sono soltanto economiche. Le attività di lucro connesse allo sviluppo di Roma, è vero, distraevano i capitali che avrebbero potuto essere impegnati nell’attività produttiva. La speculazione edilizia creava enormi profitti, e questo andava inevitabilmente a scapito di altri settori di investimento. In particolare i capitali più propriamente romani, che in gran parte avevano legami con il Vaticano, e la stessa Santa Sede non vedevano buone ragioni per abbandonare pubblici servizi, costruzione di case, compravendita di terreni e per dedicarsi alla creazione di opifici, anche perché questo li avrebbe messi faccia a faccia con il proletariato, i suoi scioperi, le sue organizzazioni. E non si sarebbe potuto chiedere neanche a gruppi industriali e finanziari ormai radicati in altre regioni di promuovere lo sviluppo industriale di Roma, che poi sarebbe diventata diretta concorrente delle fabbriche madri. Roma, dunque, si differenziava sempre più nella sua struttura economica dalla grandi metropoli industriali e progredite dei principali Paesi europei e di altre regioni italiane. Roma non viveva di vita propria, ma si muoveva e si disponeva intorno alle sopravvivenze della sua tradizione di città turistica e di centro religioso, e soprattutto intorno alle attività amministrative di capitale dello Stato unitario. La scelta di fare di Roma una “capitale tranquilla” fu solo una scelta economica dovuta alla mancanza di capitali, o fu anche espressione di un preciso disegno e intervento politico? Una tradizione antica, anteriore persino alla liberazione di Roma dallo Stato pontificio, come abbiamo visto, rendeva la classe dirigente italiana preoccupata che non si creasse nella capitale un centro troppo importante. Per la Destra, essere contrari a Roma città economicamente avanzata era un fatto di “formazione”. Oltre ai riferimenti espliciti di Quintino Sella, su cui ci siamo soffermati precedentemente, chiare sono anche le parole del ministro Finali in occasione della distribuzione dei premi agli alunni dell’Ospizio di San Michele il 30 ottobre 1875: Non è mica che io creda che Roma sia per trasformarsi in una grande città industriale, ché anzi neppure lo desidero. Io non desidero che qui sorgano quelle grandi officine, nelle quali dell’operaio non si richiede intelligenza ed arte, ma poco più di una forza meccanica. Non so poi neppure immaginare che si innalzino le camminiere delle officine accanto agli obelischi ed 245 ACGV, Fondo Prato, Pm 16-20. 169 alle colonne di questa monumentale città; e che i vortici di fumo si avvolgano intorno alle sue cupole246. Ma questi timori, in fondo, sono gli stessi anche nella Sinistra, sia nel periodo di opposizione che in quello di governo. Senza limitazioni di partito, sorgevano gli “adoratori del passato” che ritenevano “la mancanza di industrie provvidenziale e desiderabile in Roma, appunto perché le agglomerazioni operaie minaccerebbero la tranquillità, contaminerebbero la contemplazione del Foro romano”247. Trascorso il periodo di stagnazione che seguì la grande crisi edilizia nei primi del Novecento, le discussioni per Roma fanno trapelare nuove esplicite resistenze di governo contro l’industrializzazione. E lo sviluppo di Roma, in questo senso, resta un’illusione anche con Giolitti, nonostante le molte speranze che i contemporanei riponevano in quest’uomo dalla mentalità più agile e moderna dei suoi timorosi predecessori. Neanche l’amministrazione di Ernesto Nathan, col suo disegno di una “Terza Roma” (popolare, anticlericale, democratica, istruita), voleva una città industriale, e neppure una capitale dominante e accentratrice. Ci vuol altro prima che Roma scenda alla lotta industriale con Biella, Schio ed altri centri, dotati d’energia in abbondanza, di mano d’opera abile e a buon mercato, di facili comunicazioni, di regioni attigue agiate, densamente popolate, che assicurano l’esito di buona parte del prodotto. L’industriale che si cacciasse nella mischia a Roma, vada a San Paolo, vada a Testaccio, andrebbe presto colle ossa rotte248. Dolores Prato, in merito all’industrializzazione di Roma, non ha dubbi, né se si parla di periodo post-unitario né in seguito: Si lamentano che Roma non sia una città industriale, e lo è già troppo, il lamento ha qualcosa di stanti, in un’epoca in cui i segni stanchezza dell’industrializzazione non mancano. Necessaria lo sarà, ma bella no, sana no, e allora perché non lasciare immune una città come Roma? Roma così, sola in se stessa, meta di tutto il mondo non avrebbe avuto bisogno dell’industria che è bruttezza, ciminiere, capannoni, fumo, smog. Non discuto su nulla io, figuriamoci sull’industrializzazione! Se il mondo ha infilato quella svolta è segno che la sua strada è quella. Ma che essa distrugga la bellezza è indiscutibile 246 cfr. A. Caracciolo, Roma capitale, cit., p. 248. Ivi, p. 248. 248 E. Nathan, La terza Roma, in Nuova antologia, 1 agosto 1916. 247 170 (sicuro). Avere salvato una città come Roma dall’industria non sarebbe stato un gran male. C’è tanto posto al mondo per quei brutti agglomerati, e tante città che li reclamano. Una donna bella colta voluttuosa, può anche non saper cucire a macchina. Dal mostro industriale si sarebbe salvata Roma. Il Papa non le avrebbe certo avute e Roma non ne sarebbe stata deturpata249. 249 ACGV, Fondo Prato, Pm 16-20. 171 III – “Quando gli italiani entrorno a Roma…”. Dagli articoli la voce limpida di Dolores Come era Roma250 Un sessantenne di oggi domandava spesso a suo nonno che gli raccontasse della breccia di porta Pia e del governo Subalpino dato che egli sapeva tante cose che i libri di scuola ignoravano. Prima di andare a scuola era la nonna a raccontare e cominciava sempre con “c’era una volta”; adesso era il nonno e incominciava sempre: “Quando gli italiani entrorno a Roma…” e un giorno non poté farne a meno, lo interruppe: - Scusa, sai, ma voialtri che eravate? Si drizzò il vecchio, parve raccogliersi in dignità e rispose come se incidesse una pietra: - Noantri erimo romani! Questi i romani, ma Roma che cosa era prima che dal nord le venisse appioppata la funzione di capitale d’Italia? Politicamente era il capoluogo della Comarca, ma questo nessuno lo sapeva. Essa per se stessa era una piccola città addormentata in un verde secolare con uno strano carattere di immensità. Piccola e immensa. Piccola nel raccolto del suo abitato. Piccola nel nucleo, diffusa nella continuità spaziosa delle sue ville, dei suoi orti, dei suoi giardini, delle sue vigne, delle sue rovine distese al sole tra alberi erba e cespugli in larghi spazi piani o scoscesi parlanti di immensità. I broccoli, l’insalata, i cavoli, i pomodori, il rosmarino insieme con le rose, i giaggioli e il glicine, crescevano fianco a fianco di rovine e monumenti noti in tutto il mondo. Roma era inimmaginabile per chi non l’aveva vista, superiore all’aspettativa per chi l’aveva sentita raccontare: sfuggiva a qualunque schema, era Roma. Qualcuno dice che era un grosso paesotto fatto di basiliche, di chiese, di antichi monumenti, di palazzi, di conventi, di ville di rovine di giardini, di fontane, che nella sua campagna aveva chiese come san Giovanni, santa Balbina, i santi Quattro san Pancrazio, nelle cui piazze periferiche, come la Barberini, potevano anche flettersi e riposare i buoi scesi dall’olmata dei Cappuccini, dove nelle casupole le porte delle botteghe si spalancavano all’esterno come persiane, una piazza rurale che aveva nel mezzo la fontana del Tritone, a un lato la fontanella delle api sulla conchiglia e dall’alto guardava in giù un palazzo superbo. Un grosso paesotto, ma fatto di sorprese uniche nel mondo a cominciare dalla gente. C’era già la stazione, lassù a 250 ACGV, Fondo Prato, Pg 118. 172 Termini tra campi ville e solenni rovine; dentro le rovine una delle più belle chiese del mondo; di fronte all’esedra che faceva da facciata a questa chiesa, monsignor De Merode stava tracciando quella strada che sarà detta poi via Nazionale; una serie di sorprese e di meraviglie, di umili e umane armonie librate in quella sua inconfondibile immensità. Da che cosa era data quella sua immensità nella quale solo l’universale aveva diritto di cittadinanza? Dalla forma del suo spazio, certo, dalla sua luce, dal suo cielo, certissimo, ma ci doveva essere qualche altra cosa. Potrebbe essere forse la coincidenza di un particolare punto astrologico con uno magnetico ugualmente particolare a fare di questa città che vi è germinata una città unica destinata ad essere sola come è solo chi sta sul trono o sulla croce. Dolores Prato giornalista è sicuramente da annoverare tra i nostalgici della “vecchia Roma”, quelli che, di fronte alle distruzioni, alle edificazioni, agli sventramenti della città avvenuti a partire dall’annessione fino al ventennio fascista per costruire una capitale e perpetuare il mito di Roma, la “città eterna”, hanno sempre cercato fra i viottoli, nelle vie immense, nei giardini, dietro alle svolte di una strada e nelle facciate dei palazzi quella “Roma sparita” che rimane custodita, come memoria unica, negli acquarelli di Ettore Roesler Franz (Roma, 1845-1907). Centoventi vedute di Roma, suddivise in quattro parti, che fissavano sulla tela la città condannata irreparabilmente a sparire, di cui la prima serie da 40 venne fatta conoscere per la prima volta all’Esposizione di belle arti, a Roma, nel 1883, per inaugurare il palazzo eretto in via Nazionale da Pio Piacentini: tanto furono ritenuti preziosi questi acquarelli che furono acquistati subito dal Comune di Roma per 18 mila lire. In essi si potevano ritrovare il ghetto, le mura romane e medievali, quelle di Aureliano, la chiesa della Morte, i ponti Cestio e Fabricio, la torre di Belisario, la torre della Contessa Matilde, quella degli Anguillara, la tomba di Caio Sulplicio, la chiesa di San Bartolomeo, i giardini della Farnesina con gli ultimi scavi fatti, la basilica medievale di Santa Crispina e molto della Roma che già nel 1883 non esisteva più o che, di lì a poco, sarebbe scomparsa in seguito alla trasformazione della città. Prima dell’esposizione “internazionale”, però, Franz aveva già fermato con le sue opere il Tevere e il suo divenire in 16 acquarelli “privati”. “Il sig. E. Roesler-Franz – scriveva Luigi Bellinzoni in suo articolo sul “Popolo Romano” del 20 marzo 1881 – un acquerellista giovane, che ha abbandonato le vie del commercio nelle quali era già ben inoltrato, per votarsi col fervore del neofita alla esistenza burrascosa dell’artista, ha compreso che la sua città natale andava a perdere per le esigenze della vita moderna e de’ suoi nuovi destini, la caratteristica sua più impressa di romanticismo, caratteristica che, oltre al formare l’incanto dei touristes ed adescare le voglie del pittore, serve di dilucidazione storica ai tempi bui del medio- 173 evo”251. Roesler-Franz anticipava l’opera dei demolitori della vecchia Roma anche di poche settimane, per poter fermare nel colore le immagini che sarebbero poi scomparse per sempre. Cancellate, sparite, distrutte. Per lui era “un vero piacere poter gareggiare in velocità con i demolitori”. La Roma che egli amò e ci ha tramandato non è quella dei monumenti insigni, dei palazzi principeschi, ma quella delle umili e povere case mescolate e confuse con qualche dimora baronale; la città degli intimi giardinetti, dei balconcini fioriti, dei freschi pergolati lungo le rive del fiume, dei tetti bassi e sconnessi cui spesso sovrasta l’elegante cupola di una chiesa del seicento e la torre medioevale del barone, talvolta alta, superba, poderosa, tal’altra mozza, misero avanzo e testimonio delle lotte baronali e di quelle tra nobili e popolo. Una Roma con ritmi di esistenza ancora primordiali, ma straordinariamente umana, “offerta” all’uomo. Pur con le sue impressionanti carenze nel meccanismo sociale, nell’evoluzione civile. Una città tutta orti, vigne, ville e campagna, mestieri e piccolo artigianato, ambulanti, carri e carretti. E l’impianto medioevale di certe abitazioni, poste all’ombra della maestà rinascimentale, dell’eccelso capriccio barocco. Con il fiume protagonista e onnipresente, bello di una bellezza che non ritroveremo mai più. Questa è dunque la Roma riflessa nelle famose, o, secondo altri, troppo famose vedute. Una Roma di cui riportava fedelmente, sempre, i muri screziati, macchiati, tassellati dal tempo. Ma talvolta si compiaceva pure di atmosfere piovose, per far risultare lucente il selciato e riflettere nelle pozzanghere lembi di cielo. E quando lo fa riconferma ancora una volta i caratteri di una Roma sempiterna252. In Dolores Prato, nei suoi articoli per “Paese Sera”, così come abbiamo visto in Voce fuori coro, troviamo le stesse sensazioni di sgomento, turbamento e sconcerto di fronte alle rapide e febbrili trasformazioni che Roma subì a seguito del suo nuovo status di capitale del Regno d'Italia. Sensazioni che, ai tempi, animarono i romani e alcuni artisti e intellettuali europei: in molti casi le trasformazioni furono percepite come delle vere e proprie distruzioni, sia ad esempio dallo storico dell'arte tedesco Herman Grimm, che nel 1886 diede alle stampe il pamphlet La distruzione di Roma253, sia da un artista come Ernest Hébert, che a questo tema dedicò il dipinto “Roma sdegnata” per rendere omaggio a questa per lui perduta Roma. La città mutata, caratterizzata da una nuova e straordinaria vitalità, aveva provocato in molti un amaro e aspro rimpianto della città silente che avevano conosciuto ed amato, di quel luogo incantato dove le vestigia del passato e la grande tradizione classica avevano rappresentato una inesauribile fonte di ispirazione. Appena un mese dopo la breccia di Porta Pia, il 30 ottobre 1870, Ferdinand Gregorovius, grande storico della Roma del Medioevo, commentava l’avvenuta annessione di Roma scrivendo nei suoi Diari: “Roma perderà l’aria di repubblica mondiale, che ho respirato diciotto anni. Essa discende al 251 Livio Jannattoni, Roma sparita negli acquarelli di Ettore Roesler Franz, Newton Compton editori, Roma 1981, p. 8. Ivi, p. 15. 253 Herman Grimm, La distruzione di Roma, tradotta da C.V. Giusti, Loescher, Torino-Roma-Firenze1886. 252 174 grado di capitale degli italiani […] Il medio evo è stato spazzato via dalla tramontana con tutto lo spirito storico del passato. Roma ha perduto il suo incanto”254. Dolores giornalista è unita a questi grandi intellettuali di fine Ottocento da un comune sentire, del tutto evidente in questo passaggio dall’articolo Le Ghirlande (“Paese Sera”, 25 dicembre 1956) Ma questo miracolo romano che aveva resistito al tempo, ebbe il suo colpo fatale dall’annessione. La città che era stata per secoli un meraviglioso paese universale, ridotta a capitale di uno stato particolare, perdette pian piano ciò che dell’antichità classica era sopravvissuto per oltre due millenni. Da nord e da sud affluì su Roma gente che l’invase, ne distrusse le piccole e grandi tradizioni che erano il suo meraviglioso patrimonio, la sua attività, unica al mondo, la trasformò in città simile a tutte le altre. E quando subito dopo, nello stesso articolo, richiama: Quell’epoca favolosa in cui Roma era dei romani che vi abitavano e del mondo intero che vi passava. La distruzione per mano dei “Piemontesi”, come tema dominante, ricorre come filo rosso in tutta la sua produzione giornalistica, a volte scritta con toni sprezzanti direttamente sulla pagina, nero su bianco, altre come leit motiv percepibile, anche nella rievocazione nostalgica di una Roma che non esiste più. Fisicamente, nelle architetture e nelle strade, nei monumenti e nelle piazze, o nelle sue tradizioni e nei suoi antichi costumi e valori. Quel pianoro in vetta all’Esquilino dove prima dell’annessione di Roma all’Italia, la grande basilica s’alzava solitaria tra vigne, ville, e campi e dove i piemontesi precipitati quaggiù dopo il 1870, distruggendo secolari bellezze, costruirono il loro orribile quartiere, un casellario di caserme civili ( in Neve d’agosto, “Paese Sera”, 6-7 agosto 1957) Senza sconti è la descrizione della nuova Roma in confronto alla città “autentica” del passato in 254 Ferdinand Gregorovius, Diari Romani. 1852-1874, a cura di A. M. Arpino, Avanzini e Torraca, Roma 1967, p. 528. 175 Vecchia Roma (“Paese Sera”, 13 gennaio 1960): La vera Roma è ridotta simile al corpo di un martire: spezzata, dispersa, esposta a frantumi sotto forma di reliquia. Ci sono ormai, dentro e fuori le mura, quartieri interi così significanti e standardizzati che potrebbero essere trasferiti in qualunque altra città, senza togliere nulla a Roma. Eppure a guardar bene qualche suo residuo si insinua tra quegli agglomerati di case e di casoni, perché il suo carattere è così prepotente che a volte basta un albero e qualche sasso a legittimare il bastardume dilagante. Il quartiere dei Parioli sta tra quelli che per il cattivo gusto edilizio e coloristico non hanno neppure l’attenuante della povertà, di cui si valgono gli orribili casamenti di certe zone periferiche. Eccone una strada: via Denza, che sale ondulando su per quelle aristocratiche alture; il suo movimento in ascesa è già Roma; è già Roma la luce che ne consegue; è già Roma la scorciatoia a scaletta che a un tratto sbuca dal fondo, in mezzo ai cipressi; certi alberi superstiti delle vecchie vigne, certi pini vasti come nuvole, benché prigionieri tra i muri, sono sensibilmente vecchia Roma; qualche muricciolo di cinta è tinteggiato con quello che fu il naturale colore della città; un superstite portale campagnolo, grande e semplice come un gigante si volge un poco di lato quasi vergognoso della sua mole, quasi pauroso d’esser notato, sta lì come un vecchio e decaduto proprietario, ospitato per forza di contratto dai nuovi compratori sempre in attesa di un appiglio che ne autorizzi lo sfratto. La strada sinuosa e lenta, sulla sommità dell’altura cambia nome e pendenza e prosegue su di un falso piano tra piccole ville che si affacciano presuntuose sulla strada, tra grandi ville che, superbiose, se ne allontanano, tra piccoli parchi che, stretti dai nuovi palazzi, lustri come servizi igienici, paiono immensi. Lo stesso articolo si chiude così: Pareva che Roma, perseguitata all’esterno dalla speculazione edilizia, anche monastica, si rifugiasse sotto terra come gli antichi cristiani. La devastazione del trapasso è ben sintetizzata anche in un altro notevole articolo, probabilmente rimasto inedito, Roma, non altro, che inizia così: Politica o religione, quella che ci rimette sempre è Roma, non quale entità amministrativa e 176 presidenziale della Nazione, ma ROMA come entità a sé stante: le sue case, i suoi monumenti, le sue strade, i suoi alberi, la sua luce, la sua anima. Più avanti, nell’esplicitare il movimento – non gradito – che il Giubileo sta procurando alla sua città Dolores continua: Spariscono prati, chiamiamoli praticelli (per chi non ha la lira il soldo è bono), per stenderci il tappeto d’asfalto necessario per le ruote gommate. Si costruisce dove era proibito, in forma provvisoria, dicono, per l’Anno Santo: che cosa è il provvisorio e quanto sia benedetto, ognuno lo sa. Si sventra, si sopraeleva, atei e religiosi allargano, modificano, sempre in vista dell’Anno Santo e Roma, un pezzetto alla volta sta finendo di andarsene. Cominciò a finire quando non fu più Roma, ma Capitale; da 105 anni la stanno distruggendo e l’Anno Santo le darà la sua scoppola; solo per questo duole. Il linguaggio vaticano è un velluto sempre soffice, anche le cose dure le dice con tono armonioso; a me piace, tempera la durezza della nostra società. Ma “le perplessità”, le “inquietudini” che esprime per l’occasione, tratte fuori dall’armonia, sono pretese logistiche belle e buone. Per difendere Roma dovrebbe ripetersi la Resistenza, una resistenza alle pretese dell’Anno Santo e all’interessata collaborazione dei veri lucratori. Sferzante e irriverente, verso i “Piemontesi”, i potenti, la Chiesa, Dolores Prato lo è spesso nei suoi articoli. Come in questo passaggio in Il primo tempio pagano che diventò basilica – Itinerari misteriosi nel tempo: il Pantheon (“Paese Sera”, 31 gennaio 1965) L’edificio cristiano aveva assunto un altro nome: Maria Rotonda. Per un millennio più qualche secolo fu il suo, finché col trasporto qui della capitale diventando tutti dotti e retorici, si perse l’affettuosa confidenza che avevamo con i nostri monumenti e restaurammo il Pantheon senza dimenticare l’acca. O ancora in 1971, l’anno dei centenari (“Paese Sera”, 10 gennaio 1972) Nel 1871 fu fatto il primo censimento della popolazione italiana. Appena l’ebbero ammucchiata, vollero contarla. Quest’anno, forse, per celebrare il centenario di quel pastorizio avvenimento, si è ripetuta la conta. 177 E nello stesso articolo prosegue: Però nel 1871 anche Roma ebbe la sua piccola Folies-Bergères, fu l’arrivo della regina Margherita, ancora principessa, ma già carica di perle a niagara, già ottima professionista del sorriso. In una città come Roma, dove al vertice per secoli e secoli non c’erano state che tonache, piviali e mozzette, quella donna fece colpo. Essa fu l’unica cosa accetta a molti, non a tutti naturalmente, perché la resistenza all’annessione si spense lentamente e anche ora, isolato e latente, qualche piccolo focolaio dura. L’apparizione a Roma di Margherita, grifagna nei lineamenti, mascherata però da uno splendido sorriso, compie anche essa i suoi 100 anni. Per la prima volta per le strade dell’Urbe, dove il Papa passava disegnando crocette nell’aria, passava ora una sovrana ingioiellata che piegando la testa di qua e di là accennava lievi saluti rubacuori. Per comprendere la particolarità della voce di Dolores rispetto alle voci ufficiali, riportiamo un passo proprio sull’arrivo a Roma della principessa Margherita tratto da Roma capitale d’Italia. Nel primo centenario, libro che nel 1971 veniva distribuito gratuitamente dai centri di Lettura e Informazione, a cura del ministero della Pubblica Istruzione – direzione generale per l’Educazione popolare. Ben presto, anche se la corte doveva tardare a trasferirsi, i romani ebbero una specie di vicecorte perché il principe ereditario Umberto ebbe il comando delle truppe dislocate a Roma e con lui si trasferì la sua giovanissima consorte, la principessa Margherita. Questa donna aggraziata, collocata al vertice della vita mondana, divenne il simbolo e il centro della profonda trasformazione psicologica cui venne sottoposta la città. Costituì una lieta sorpresa per i romani trovarsi di fronte, dopo tanta consuetudine di sottane prelatizie, un’autentica sottana femminile. Non era disgiunto nella principessa un sorriso luminoso, accompagnato da un’istintiva capacità di accattivarsi sia gli umili che gli uomini di cultura e le dame della aristocrazia. Quando poi, dopo l’effettivo trasferimento del governo e della corte, all’inizio di luglio del ’71, la giovane coppia principesca cominciò ad aprire i salotti del Quirinale – dai quali peraltro preferiva tenersi il più possibile lontano re Vittorio, più amante di residenze campestri e di riserve di caccia che non di appartamenti ex-pontifici – si ebbe la sensazione di un vero e proprio cambiamento di costume. Nella corte del Quirinale cominciarono ad affluire la vecchia aristocrazia romana (ad eccezione di quella che il 20 settembre aveva chiuso i portoni dei palazzi, in segno di protesta, e si era isolata in atteggiamento sdegnoso) e l’aristocrazia discesa coi Savoia da altre regioni; ma anche altri salotti si aprirono in varie case patrizie attorno a grandi dame che gareggiavano con la principessa255. 255 in Roma Capitale d’Italia, cit., pp. 182-184 178 Altro esempio di ironia tagliente in Un po’ dei tanti centenari (addio al 1974): Ma per i romani c’è anche il centenario della loro bottega di carta, oggetti di cancelleria e piccola stamperia. Dietro i bersaglieri di Porta Pia scesero i piemontesi: “assumevano” tutto quello che toglievano; tra gli assunti anche le cartiere tanto più che erano “meridionali” quindi bisognose di luce nordica. Assunsero e si “stabilirono” con un vasto “negozio” in via Frattina. Ma cosa provinciale non può assorbire cosa universale; il senso dell’universale a Roma era anche nei robivecchi. Appena tre anni e il vasto negozio in mano ai Zampini fu romano. Lo scoppio del consumismo li sloggiò da Via Frattina, entrarono più a dentro, nel cuore della vecchia Roma. In quella cartoleria, la cui romanità nobilita anche le banali sacchette di plastica, si riflette quella che fu la sorte della città e del papato dopo l’annessione: sceso il Piemonte per distruggere e assorbire, fu assorbito e niente distrusse, neppure il potere temporale. Dolores Prato, inoltre, ha fatto in qualche modo per il Tevere, con carta e penna, quello che Roesler Franz fece con i suoi pennelli. Una serie di articoli ci restituiscono la sua storia, e la storia di Trastevere, con minuziosa dovizia di particolari, con descrizioni-ritratti degli stessi paesaggi, delle stesse atmosfere. Un esempio è l’articolo Il Tevere ex-biondo un amico che dobbiamo salvare, in “Il Globo”, 29 giugno 1972, che ci sembra utile riportare in gran parte: Un rimedio per questi straripamenti era necessario, ma bisognava studiarne un altro, quello dei muraglioni è brutto senza discussione e più brutto è stato che per fare simile bruttura si sia mutilata la città in quel suo dolce scivolare verso l’acqua alla quale era unita per sempre. Case si specchiavano sull’acqua e terrazze e giardini sempre verdi e chiese e teatri e palazzi. Tra siepi di rose, arbusti d’aranci, spalliere di mortella e pergolati, s’affacciavano sul fiume osterie che magari si autoproclamavano “ orti Aureliani”. San Giovanni dei Fiorentini sorgeva dalle onde del fiume, di là dell’acqua, altri campanili, altre case, a fianco la fuga della via Giulia che andava a tuffarsi nel Tevere: Sull’altra sponda si alzava il Palazzo Salviati, poi cominciavano le case della Lungara, lungo il fiume, luminosa e vivace diventata ora un melanconico seminterrato. La campagna allora scorreva dentro la città insieme col fiume. Si mescolava ai giardini, alle 179 rovine, cedeva il posto alle case, sosteneva le terrazze, piegava i suoi alberi nell’acqua come se volesse sciacquarceli. I muraglioni la seppellirono sotto uno strato di terra, di pietre, di mattoni. Erano strette le une alle altre le case che sorgevano sul muro della cinta aureliana che dal Popolo piegava sul fiume, dopo quel tratto, sorgevano sempre dall’acqua, ma più vicine o più lontane dalla riva. Senza margini la vita scivolava fino all’acqua; piccolo mercati di pesce intorno a una cesta; passarelle ad archi digradanti che portavano dentro il fiume; barche, colonne spezzate, e piccole spiaggette con gente stesa al sole. La Renella, la più grande, il nome è rimasto, era una confluenza di luce e di vita perché il popolo aveva lì anche il teatrino dell’Impero celeste, marionette meccaniche, maschere specialmente, delizia dei bambini, riposo dei grandi. Tutto distrutto. La passeggiata di Ripetta, o passeggiata del Tevere perché il fiume la sciacquettava e luccicava accanto un’assolata passeggiata ombreggiata dalle piante; sfiorata al tramonto dall’ombra delle vele che passavano sul fiume, si chiama ancora passeggiata ma ci si sguscia solo e a fatica, chi l’attraversa lo fa a suo rischio e pericolo. E quel casone lungo e desolato che ora tenta di guardare il fiume da un fosso, l’apostolico ospizio di San Michele, cittadella della libertà del lavoro, era vivo e lieto con gli alberi davanti e poco più in là i velieri e i barconi che stavano in porto. E i due porti più grandi quello di Ripetta e di Ripagrande dove la gente si affacciava a guardare le navi ormai a vapore che scendevano da Nord o risalivano da Sud? Uno spettacolo caratteristicamente portuale che il Tevere non vedrà mai più. Via di Ripetta e il Tevere, erano due strade a livello, uno d’acqua l’altra di selci. Sulla distruzione dello splendido porto di Ripetta piangeva persino la stampa governativa. Qualcosa che scaricasse il Tevere a monte quando ci fossero le piene, questo ci sarebbe voluto e il bel fiume continuerebbe ancora a scorrere tra le sorprese delle due sponde che erano inesauribili. I muraglioni dovevano superare l’altezza di quella piena che aveva battezzata Roma capitale d’Italia: In un certo senso voleva dire rendere stabile quella piena nel tratto cittadino. Nella piena il fiume s’annulla, in fondo ai muraglioni si nasconde. Quelle due sponde si rifecero con la più ottusa e brutale uniformità. Tanta varietà di bellezza sostituita da un monotono nulla. Gli ingegneri che li progettavano pur riconoscendo che non c’era fiume più navigabile del Tevere, lo resero malamente utile solo a convogliare le fogne. Quell’imprigionamento del fiume non andava a genio quasi a nessuno. La legge alla camera fu votata con 150 palle bianche e 108 nere e al Parlamento i romani erano ben pochi. L’appalto per l’inalveamento del fiume veniva ogni tanto ripetuto; ognuno traeva al suo profitto, i muraglioni alle prime piene cedevano. La caduta di un pezzo suggeriva i rimedi per tutto il resto; provando e riprovando costarono tanto che i governativi spiegavano ai romani che 180 erano degni di Roma antica. Un’antichità si paga: centocinque milioni di allora costò imprigionare quel fiume sovrano che ora si muove tra i muri come i carcerati che prendono aria. E ringraziamo il regio governo che non ci tolse l’isola Tiberina, il progetto di “ toglierla di mezzo” c’era. La proposta fu bocciata perché ebbe paura delle “opinioni volgari” e di quelle degli archeologi. Accenno di distruzioni, non elenco, per carità! Distrutti la chiesa di S. Giustino e Giovita, ospizio e ospedale annessi, l’arco dei Bresciani, Palazzo Gaetani, poi dei Cestini, palazzo Castellani il cui portico era uno dei più belli di Roma. Demolita la torre degli Stefaneschi e quella degli Albertazzi. Demolito l’ospedale dei Pazzarelli sopra l’Acqua Lanciana che finì di essere fontana di sorgente viva, ridotta ad un rubinetto uscente da un muro. Demolito il vecchio ospedale di Santo Spirito. Ponte Sisto pareva tenuto su da due braccia di Roma che si protendevano nell’acqua, isolato e tutto demolito intorno anche se erano costruzioni del ‘300, giù l’orologio, giù il fontanone, immagazzinati i pezzi, ricercati poi per ricostruirlo dall’altra parte, non tutti ritrovati, trasformato il ponte con l’aggiunta di due marciapiedi protetti da un’orribile balaustra in ghisa. Rovinati ponte e Catello Sant’Angelo. Due bastioni e lo splendido camminamento in pietra, “empiamente distrutti” diceva la stampa contemporanea, affreschi, pietre diamantate, sculture, al magazzino. Demolite le due testate di ponte Sant’Angelo che avevano resistito 17 secoli, gli archi centrali lasciati soli in mezzo alla corrente stavano per crollare. Pio IX aveva costruito quel ponte sospeso di ferro, arioso e bello chiamato dei Fiorentini che, privo di arcate, non ostacolava il flutto del fiume. Era stato un lavoro di tale perfezione che il mondo lo considerò una gloria del suo pontificato. Egli ne aveva seguito i lavori, approvate le modifiche, accettati i miglioramenti come un competente e un innamorato. Sopravvisse ai muraglioni funzionando a meraviglia: fu abbattuto lo stesso. Demoliti il teatro Apollo, il primo costruito in Roma dopo gli antichi, il Politeama e l’Ahlambra. Altra irreparabile distruzione fu quella del palazzo Altoviti di fronte a Castello. Era una costruzione cinquecentesca: la loggia a colonne sul fiume, dipinta dal vasari, un quadro indimenticabile per chi una volta sola l’aveva vista. Roma, quella consenziente all’annessione e quella contraria, unite nella stessa pena, supplicava il ministero della Pubblica Istruzione di non fare atterrare il palazzo, di salvare le sue parti più interessanti per lo meno, per lo meno il portico a specchio del Tevere. Niente da fare. Atterrare, tutto! Il popolo e Pasquino parlavano di Re Piccone. Gli allagamenti cessarono dopo i muraglioni? Nella Roma bassa sì, ci fu miglioramento, lì ogni piccola piena allagava, ma se il Tevere cresce davvero una parte di Roma si allaga lo stesso. Quando le piene sono state di quelle grosse è capitato che un pezzo di muraglione sia caduto 181 trascinando alberi e fanali. Nel 1915 per andare a San Pietro ci volle la barca. La piena del 1870, quella che battezzò l’annesione e portò il re, raggiunse i metri 17,22. Quella del 1938 che la superò di 33 centimetri, non fu molto disastrosa per il centro, per l’isola moltissimo, ma allagò tutto il nord di Roma facendone un lago. Circoli, ritrovi, tennis, ministeriali o sociali, hanno bloccato per loro solo quel pendio al fiume che avrebbe dovuto essere di tutti, ci tirano su costruzioni che coprono la vista dell’acqua, ma queste anche se lunghe ad un certo punto finiscono e si ritroverebbe quel paesaggio per il quale si va a spasso, invece ne occludono la vista con muri di siepi. Eppure il rispetto al paesaggio dovrebbe essere un paragrafo del rispetto del codice del cittadino. Il cittadino ha il diritto di godere di quel paesaggio, si può invocare la Costituzione per difendere un particolare panoramico. Ma chi si ribella? Forse qualche povero funzionario che cammina senza riuscire a vedere di là, l’altra sponda del fiume. Ci avevano tolto il fiume con i muraglioni, ce ne avevano resa difficile la vista arginando i lungotevere con muri invece di balaustre, come i ponti, muri non balaustre e spesso arrivati nel mezzo, di dove si amerebbe guardare giù perché parrebbe di essere sospesi sull’acqua, eccoti davanti una parete massiccia. Muri, muri, sempre muri, anche se ipocritamente sono fatti con innocenti alberelli. Il Tevere che è una realtà, ce l’hanno resa un sogno. Ma nessuno si ribella. Passo bellissimo, in cui è racchiuso tutto l’amore di Dolores Prato per la sua Roma, che non è quella in cui cammina negli anni ’50-’70 (in cui principalmente svolge la sua professione di giornalista), ma quella del passato; una città che non torna, ma che non potrà mai essere cancellata in via definitiva da nessun intervento, seppur nefasto, dell’uomo e dei governi che si succederanno. Le forme e i colori di Roma hanno ispirato gli artisti di tutti i secoli. Guardando quei quadri del sei, del sette, del primo ottocento, cadi in balia di una struggente meraviglia. Ma se davvero c’erano quelle cose, Roma era troppo bella. E allora si vorrebbe conoscere di più quell’altro genere di bellezza, quello dei secoli di mezzo, che la celebrarono miracolosa anche per la sua bellezza. Roma fu per quell’epoca la città miracolosa in cui avvengono i fenomeni più strani; città i cui edifici hanno migliaia di porte; città la cui folla è fatta di statue; città tutta di marmo e d’oro. Fantasie che provengono non da un popolo solo, ma da razze diverse, che perciò nascono dalla stupefatta meraviglia di chi la vide e la racconta. Queste fantasie provano la magnificenza di questa città e il culto che di lei 182 restò anche nei secoli cosiddetti bui. Roma è stata sempre una città del mondo fuori del mondo. Questa sua strana unicità la fece un punto, un centro di attrazione. Nella prima metà dell’ottocento c’era in Roma una società cosmopolita meravigliosa: Dame che sanno di greco e di latino, di arte e di storia, di pittura e di musica, che cantano e suonano in scelti concerti e in gite campagnole con la chitarra. Spiritose e interessanti nella conversazione. Perché era il fior fiore dell’intelligenza internazionale che si riversava a Roma. Storici, archeologi, pittori, musicisti, filosofi, scultori ogni parte del mondo risiedevano a Roma e attendevano alle loro opere come nel proprio paese. A leggere le cronache di oggi e quelle di ieri, pare che allora i trasporti fossero supersonici e che adesso ci si muova con la posta a cavalli. Quell’andirivieni di re, regine, imperatori, imperatrici, regnanti o in esilio, quel correre qui di principi dinastici di ogni parte del mondo, e quella fiumana di duchi, di marchesi, di conti, che affluiva e defluiva, par gente che voli; mentre le rare visite di oggi sono concertate un ano prima, e il programma ci è noto sei mesi prima, e se ne viene uno quest’anno, passeranno forse altri anni prima che ne ritorni un altro. Per il clima, per lo spazio, per il temperamento della gente, per il fascino delle sue rovine, per quel governo unico al mondo in cui l’edito si mescolava al canto gregoriano e all’odor d’incenso, per quella melanconia dei funerali notturni e quegli scoppi trionfali della polifonia, Roma era soprattutto una città voluttuosa. Il “carpe diem” se non fosse nato qui forse non sarebbe nato altrove, perché Roma ti dà la bellezza delle sue luci e delle sue notti diffusa nel senso eterno del suo non essere. (Come era Roma) 183 IV - Il Fascismo, il mito di Roma e l’implacabile “piccone risanatore” L’importanza simbolica di Roma raggiunse il suo culmine durante il Fascismo, quando la città divenne centro propulsivo della “nuova Italia” voluta da Mussolini e subì determinanti politiche urbanistiche e sociali256. Il mito di Roma entrò stabilmente a far parte dell’immaginario politico del regime, rappresentando l’orizzonte di valori a cui doveva ispirarsi l’“uomo nuovo”: l’adozione di riti e simboli mutuati da un’originale interpretazione dell’antichità romana permise di presentare l’ideologia della “romanità” (con il principio della subordinazione dell’individuo alla collettività nella famiglia, nella religione, nell’educazione militare, nelle leggi) come tratto identitario della nazione. Le dittature a fondo splendido come la napoleonica, o splendido fasullo come la fascista, si compiacciono di nomi classici, ritornano a una classicità della quale pretendono di essere i veri continuatori. (Dolores Prato, Voce fuori coro) Nell’universo ideologico fascista lo stesso evento della presa del potere, la marcia su Roma, si caricò di significato. Era la conquista della capitale da parte delle nuove forze rivoluzionarie contro il logoro Stato liberale che ne aveva svilito il prestigio, ma anche l’ideale ritorno in città dei legittimi eredi spirituali della grandezza e dei fasti della Roma imperiale. Nacque il “Natale dell’Urbe”, 21 aprile, che addirittura nel 1924 divenne festa nazionale. Durante la prima celebrazione ufficiale del Natale di Roma, Mussolini pronunciò un famoso discorso, citato in tutti gli studi sulla Roma fascista, in cui delineava le linee da seguire nel procedere al ridisegno della città: I problemi di Roma, la Roma del XX secolo, mi piace dividerli in due categorie: i problemi della necessità e i problemi della grandezza. Non si possono affrontare questi ultimi se i primi non siano stati risoluti. I problemi della necessità sgorgano dallo sviluppo di Roma e si racchiudono in questo binomio: case e comunicazioni. I problemi della grandezza sono di altra specie: bisogna liberare dalle deturpazioni mediocri tutta la Roma antica, ma accanto all’antica e alla medioevale bisogna creare la monumentale Roma del XX secolo. Roma non può, non deve essere soltanto una città moderna, nel senso ormai banale della parola, deve essere una città degna della sua gloria e questa gloria deve rinnovare incessantemente per tramandarla, 256 Cfr. Italo Insolera Italo, Roma fascista nelle fotografie dell’Istituto Luce, (con alcuni scritti di Antonio Cederna), Editori Riuniti-Istituto Luce, Roma 2001. 184 come retaggio dell’età fascista, alle generazioni che verranno257. Nelle celebrazioni di questa data, e di quella dell’avvento del Fascismo, raramente mancavano solenni inaugurazioni di interventi urbanistici voluti dal Duce. Parte integrante della politica di rilancio del mito di Roma fu infatti la definizione di un nuovo spazio pubblico che fosse simbolo di una cultura politica, dalla toponomastica alla connotazione forte degli edifici fascisti, da piazza Venezia al Vittoriano al Foro Mussolini: il Fascismo aspirava a conquistare, come la “Roma dell’impero” e la “Roma dei papi”258, un suo frammento di eternità, consegnando alla storia la “Roma di Mussolini”259. Alla città andava restituita l’antica grandezza, cancellando ciò che secoli di decadenza avevano oscurato. Nella mitologia fascista era autenticamente romano soltanto ciò che riguardava il passato imperiale della città. Fra cinque anni Roma deve apparire meravigliosa a tutte le genti del mondo: vasta, ordinata, potente come fu ai tempi del primo impero di Augusto. Voi continuerete a liberare il tronco della grande quercia da tutto ciò che ancora l’aduggia. Farete largo intorno all’Augusteo, al Teatro di Marcello, al Campidoglio, al Pantheon. Tutto ciò che vi crebbe attorno nei secoli della decadenza deve scomparire. Entro cinque anni da Piazza Colonna per un grande varco deve essere visibile la mole del Pantheon. Voi libererete anche dalle costruzioni parassitarie e profane i templi maestosi della Roma Cristiana. I monumenti millenari della nostra storia devono giganteggiare nella necessaria solitudine260. La trasformazione monumentale del centro storico di Roma cambiò il volto della capitale. Gli sventramenti fascisti sono stati interpretati dalla critica come una vistosa manifestazione di quella generale “incultura” urbanistica italiana affermatasi dopo l’Unità, frutto della vanità e del delirio personale di Mussolini, o, alternativamente, in un’ottica di maggiore complessità, come in stretta relazione con l’importanza assunta dal modello di Roma nell’ideologia fascista. Roma di Mussolini: non è una frase convenzionale per indicare dal nome del Duce la Roma del tempo fascista. […] Quando noi parliamo della Roma di Mussolini, adoperiamo una frase che corrisponde alla realtà nel senso più stretto e letterale. Nella grande opera di trasformazione di Roma, che da dodici anni si va compiendo sotto i nostri occhi, nella formazione del nuovo volto che l’Urbe Eterna va assumendo, la volontà di Benito Mussolini agisce in pieno; è quella che vigila, consiglia, comanda261 257 E. D. Susmel (a cura di), Opera omnia di B. Mussolini, La Fenice, Firenze 1951-1963, v. XX, p. 235. Cfr. Luigi Fiorani, Adriano Prosperi (a cura di), Roma, la città del papa: vita civile e religiosa del giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla, Einaudi, Torino 2000. 259 E. Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 150 260 Discorso di Mussolini in occasione dell’insediamento ufficiale del Governatorato, 31 dicembre 1925, in Susmel, op. cit., vol. XXII, p. 48. 261 A. Munoz, Roma di Mussolini, Roma 1935, pp. 9-10. 258 185 In ogni caso, la politica di trasformazione monumentale di intere aree del centro cittadino, nonostante l’assenza di un progetto unitario, affermò per la prima volta un’idea di capitale univoca e ben definita: una città-guida emergente, in uno Stato fortemente accentrato. L’annullamento di ogni parvenza di autonomia locale, con il processo nazionale dell’accentramento dei poteri, si completò nel 1925 con l’istituzione del Governatorato (guidato da Filippo Cremonesi), che realizzò la “fascistizzazione” dello Stato. Il duce era il principale ispiratore, l’ideatore, il realizzatore degli interventi che avrebbero cambiato il volto di Roma, e il clima fu di generale approvazione nei confronti dei programmi di rinnovamento, anche tra architetti e esponenti della cultura. Anche uno dei protagonisti di questa trasformazione, Marcello Piacentini, il più influente degli architetti romani, era partito da posizioni critiche nei confronti degli sventramenti post-unitari, ma poi, nel 1916, rielaborando l’idea di Quintino Sella, aveva proposto la creazione di un nuovo centro ad est della città storica per alleggerire l’area dei vecchi rioni dalle funzioni direzionali, favorendo così la conservazione della “vecchia Roma”. Secondo Piacentini, non era la città in generale ad essere intangibile, ma la sua bellezza. Dove questa non esisteva, bisognava crearla. Fu così che nacque il tema delle due città: una Roma “nuova”, moderna metropoli, con il baricentro a Termini, e una “vecchia” Roma, in cui si doveva valorizzare la solenne e aristocratica tranquillità. A fianco della proposta di Piacentini, si mise in evidenza quella di Gustavo Giovannoni, principale teorico del “diradamento edilizio”. Per Giovannoni, i problemi della viabilità e del risanamento igienico-sanitario nel centro storico non andavano affrontati con sommari e indiscriminati sventramenti, che avrebbero allontanato gli abitanti, ma con mirate e limitate demolizioni che però avrebbero permesso notevole libertà d’azione262. Un principio, quello del diradamento, che fu formalmente accolto dalla commissione incaricata di redigere la variante al piano regolatore del 1909, ma che non si adattava ai propositi di grandiosità monumentale e al carattere rappresentativo dell’edilizia fascista, e fu quindi sostanzialmente ignorato. L’idea prevalente era che, per esaltare al meglio le qualità artistiche di un monumento, fosse necessario isolarlo, e, inoltre, rimaneva in vigore la pratica haussmaniana di aprire grandi assi viari nel tessuto urbano delle capitali. Un altro elemento che contribuì ad accrescere il consenso internazionale nei confronti della politica urbanistica del regime fu il ruolo centrale attribuito all’opera di scoprimento dei resti archeologici. La “redenzione” delle testimonianze sommerse della 262 Leonardo Di Mauro e Maria Teresa Perone, Gli interventi nei centri storici: le direttive di Mussolini e le responsabilità della cultura, in Silvia Danesi e Luciano Patetta (a cura di), Il razionalismo e l’architettura in Italia durante il fascismo, Electa, Milano 1994, pp. 38-42. 186 Roma antica fu salutata con entusiasmo da alcuni dei massimi rappresentanti della cultura archeologica e del classicismo europeo, che esternarono una vera e propria infatuazione per il Fascismo e per il suo capo. L’opera dell’“implacabile piccone risanatore” iniziò nel 1924 con la demolizione delle case tra la salita del Grillo e il Vittoriano: il problema impellente era il rapporto del monumento a Vittorio Emanuele II con il resto del nuovo centro costituito da piazza Venezia, e portare alla luce i Mercati Traianei e il Foro di Augusto. Negli sventramenti, all’importanza degli interessi archeologici, funzionali soprattutto alla politica propagandistica e simbolica del regime, si univa la necessità della modernizzazione della città, in particolare riguardo alla mobilità263. Emblematica la sintesi di questo concetto, che Dolores Prato chiude in tre righe di Voci fuori coro: Fascisti - argentina Per fare una inaugurazione strombazzata per il 21 aprile 1929 si sacrificò l’integrità di quei resti antichi che erano riapparsi col sacrificio di un pezzo della città. Non era l’archeologia in sé ad animarli, era la possibilità di acquistarsi meriti. Gli interventi più massicci (e che hanno fatto più discutere architetti, archeologi, giornalisti, polemisti, per lo più antifascisti) furono quelli per la realizzazione di via dei Fori Imperiali264 (“Inaugurata nel 1902 la via dell’Impero essa risultò un vuoto retorico per il quale erano state distrutti tanti isolati di case di tutte le epoche e tutte le chiese”265), via del Mare, via della Conciliazione, e una serie di sistemazioni come quella di piazza Augusto Imperatore. Quella “via dell’Impero” che, declamavano, aveva scoperto e messo in luce i fori imperiali, in realtà non li aveva che scavalcati, distruggendoli e sotterrandoli, lasciando in vita di qua e di là quel che rimaneva. Distrutta così anche quella suggestione che emanava da quei resti affiorati dai muri, tra finestre e case, dalle svolte delle strade. Ora isolati così hanno l’arido della pomice cariata non c’è più l’humus della vita. (Voce fuori coro) In particolare, per realizzare via della Conciliazione fu demolita la “spina di Borgo”: un atroce 263 Giuseppe Cuccia, Urbanistica, edilizia, infrastrutture di Roma Capitale 1870-1990. Una Cronologia, Laterza, Bari 1991, p. 114. 264 A. Conti, Storia di una distruzione, in Liliana Barroero, Alessandro Conti, Anna Maria Racheli, Mario Serio, Via dei Fori Imperiali. La zona archeologica di Roma: urbanistica, beni artistici e politica culturale, Marsilio editore, Venezia 1983, pp. 40-42. 265 ACGV, Fondo Prato, Pm 6. 187 intervento che uccideva l’effetto sorpresa progettato da Bernini per piazza San Pietro e, contemporaneamente, ossequiava la Chiesa celebrando la stipula dei Patti Lateranensi. Notevoli gli articoli di Dolores Prato che ricordano questa distruzione: La via di tutti i popoli, in “La Via”, 15 novembre 1952, e La Spina, in “Paese Sera”, 23 gennaio 1960. Riportare integralmente il testo di quest’ultimo, che a Dolores valse anche il Premio Città di Roma, può essere utile per capire il grado di approfondimento storico e di senso critico che accompagnava la giornalista nei suoi appassionati pezzi su Roma. “Non c’è rosa senza spine”, si dice; difatti la rosa più sbocciata di Roma, la piazza S. Pietro, aveva la sua spina. Era come un lungo aculeo, come un sottile ed acuminato aculeo di fabbricati che si insinuava tra un folto di altri edifici risultandone due stridette come due corridoi che si facevano largo a fatica tra case e casucce, palazzi e palazzetti, chiese e cappelle, fontane ed edicole e tante tante botteghe, uno addosso all’altra con caparbietà di chi vuole assolutamente stare in quel posto e non in un altro. C’era per quelle due strade il brusio del paese e quello del mondo, giacché la gente di qualunque terra e di qualunque colore che veniva a Roma, percorreva quei lunghi corridoi per sfociare in una immensità circoscritta, che era una piazza, per trovarsi di fronte a una montagna di granito fatta di colonne, pilastri, porte, logge, trabeazioni, fregi e cupole tra cui emergeva, come una immanenza, “er cupolone”. Dapprima gli occhi tentavano di misurare l’immensità della piazza, poi era il tempo a misurarla; il tempo che ci voleva per arrivare, un passo avanti l’altro, sino alla scalinata che portava all’ingresso di un’altra immensità, al tempio. Erano proprio quelle due stradine strette e soffocate a preparare gli animi per meglio avvertire le due immensità. Si chiamavano “Borghi” così come erano detti i raggruppamenti di case fuori della città, lungo una strada o attorno a un castello. In quel luogo, un tempo arido e malsano, gli imperatori avevano costruito giardini, circhi, mausolei. La via Cornelia andava proprio nel senso di questi Borghi, in direzione del luogo ove era la Basilica che le fu costruita sopra per includervi il sepolcro di un uomo povero e condannato che in quella campagna brutta e scoscesa, seminata di sepolture plebee e di modesti mausolei, si diceva fosse stato in fretta sepolto e nascosto. Su quel sepolcro ci fu eretta prima una “memoria”, poi una basilica il cui baldacchino si alzò sopra la memoria, finché su tutto si gonfiò, profonda come un cielo, la cupola michelangiolesca. Intorno alla primitiva basilica si erano raggruppati oratori, cappelle, monasteri e case, separati da strade, straducce e sentieri, ma la principale via ebbe sempre il tracciato della Cornelia. Nel Medio Evo essa era una strada coperta da un portico che dal ponte S. Angelo andava 188 all’ingresso della basilica. I pellegrini, nella vicinanza del luogo sacro, non erano disturbati, né dal sole, né dalla pioggia; il portico li raccoglieva materialmente e spiritualmente. . Esso durò parecchi secoli, poi pian piano qua e là si scoperchiò, qua e là crollò; venne l’epoca in cui esso scomparve e la terra ridiventò campagna; ci si coltivarono gli orti; sorse tra essi qualche casolare e lentamente la vita riprese. Il primo anno santo, ottima trovata spirituale e turistica di Bonifacio VIII, dette il via a un più rapido impulso costruttivo. Il tracciato della via Cornelia, già coperto dal portico, fu fiancheggiato da povere casupole, bottegucce e locande, poi il tempo e gli uomini, come sempre fanno, continuarono a distruggere e costruire, a migliorare e cambiare. Si tracciarono strade, si fiancheggiarono di case che si serravano l’una all’altra per dar posto a tutte. Tra costruzioni e abbattimenti, nella direzione dell’antica Cornelia, della medioevale “Portica”, risultarono due strade divise da una fila di case, che si chiamarono successivamente: Via Recta, Carriera Santa, Carriera dei Martiri, Via Beata, Via Pontificum, Via Alessandrina, Borgo Vecchio, Borgo Nuovo, e le costruzioni che le dividevano costituirono “la Spina” fino ai nostri giorni, quando furono abbattute e si fece quell’enorme vuoto che strada non è, piazza nemmeno, ma si chiama via della Conciliazione. La Spina divideva l’afflusso ei pellegrini a S. Pietro e, se tra bei palazzi e discreti palazzetti, aveva anche case povere e forse brutte, il tempo le aveva colorate, patinate e rese amiche. Cadde con la Spina un apporto secolare di vita. Cadde (una tra le tante case suggestive che caddero) quella cappelletta chiusa da un cancello, dove dentro ardevano dei ceri e tra le sbarre c’erano sempre dei fiori intrecciati. Si diceva che un papa avesse chiuso con quella cappella lo sbocco di un violetto tra i due Borghi, corto come un nano, per ammenda a una Madonna contro cui erano state gettate scorze di melone. Si abbatterono i confini di quella piazza Scossacavalli che il gorgoglio di una fontana bastava per riempire, mentre certe finestre che vi si affacciavano, ripetevano con la scritta dei loro architravi: Soli Deo, Soli Deo, Soli Deo. Si raccontava che su quella piazzetta, nel punto preciso dove sorgeva una chiesa, i cavalli che portavano la pietra di Isacco, si erano fermati e non era stato possibile farli più proseguire. Per diverso tempo la chiesa chiamò S. Salvatore in Bordonia, per i bastoni dei pellegrini, poi prese altri nomi, ci fiorirono altre leggende, altre poesie e ora non c’è più nulla, nemmeno il nome. Si poteva sanare quell’agglomerato di costruzioni e invece si abbatté tutto e si fece il vuoto che è nulla. La Spina, obbligando a vedere la piazza solo quando si era giunti a una sua estremità, ne scopriva di colpo tutta l’enorme vastità, mentre ora, per il fatto che essa è concava, la lontananza la restringe. Erano due vie strette sì, ma la vita vi brulicava e ferveva e, come tutte le cose che sono esageratamente se stesse, se concentrate, erano straordinariamente vitali. Quelle due strade anguste concentravano la vita e l’afflusso dei viandanti accompagnandoli allo sbocco. 189 Dal fitto delle case si usciva in quella grandezza sonante di acque, di spazio, di vuoto; nell’insospettabile slargo la vita si diluiva e placava, restava sola l’immensa meraviglia. Con l’apertura del chiuso pare che gran parte di queste cose siano fuggite. Nello spazio risultante dalle demolizioni si poteva erigere qualcosa che conservasse un poco di quella immensa sorpresa emotiva. Invece la soluzione è quella che è già da tanti anni senza riuscire a convincere, senza riuscire a perdere nulla della sua muta freddezza: una processione di obelischetti con il lampione sulla testa, che in quell’enorme spazio rammentano i birilli, e tante panchine, utilissime per apparecchiarci sopra uno spuntino. Birilli e sedili, non c’è da illudersi, non diventeranno mai suggestivi. Ma in quel vuoto di cose e di emozioni, il sogno ha un teatro vastissimo per esercitarsi. Anche un sogno fatto per riposo e per divertimento, è capace di mettere idee in quel vuoto di idee. E il sogno rialza e distende l’antico Portico, gli dà la quadruplice berniniana fila di colossali colonne, lo allarga sullo spazio che era occupato dalla Spina. Invece di una sola spropositata strada, il sogno ne vede tre: due ai lati, scoperte, per i veicoli, una nel mezzo per i viandanti, folta di colonne e coperta di volte, oltre la quale sarebbe veramente l’ingresso alla piazza del Paradiso. E non potendo più vedere S. Pietro in lontananza, esso non ricorderebbe più un “souvenir”, ma tornerebbe ad essere quella montagna che è, sorgente da un cielo rovesciato in terra. Ma un sogno ha la forza di una piuma che voglia rimuovere la pietra: il sogno allora scompare. Resta la freddezza semivuota di quella strada che è nuda come i gambi delle rose ottenute scientificamente: alte, fredde, dure, senza odore e senza spine. A uccidere la stratificazione storica in nome della sola propaganda fu la realizzazione di piazza Augusto Imperatore (1927-29). Nel 1934, quando si iniziò a demolire per scoprire e isolare il mausoleo di Augusto, che dopo varie trasformazioni era divenuto, nel 1908, l’auditorium cittadino, le demolizioni raggiunsero un picco: per realizzare questo intervento furono abbattuti circa centoventi fabbricati in via dei Pontefici, via delle Colonnette, vicolo Soderini, via e vicolo degli Schiavoni e vicolo del Grottino. Il mausoleo restaurato, la cui resa scenografica risultava molto inferiore alle attese, fu inaugurato nel 1938, in concomitanza con la conclusione delle celebrazioni per il bimillenario di Augusto. E non è un caso, a questo punto, che insieme all’articolo sulla spina di Borgo, a far conquistare il Premio Città di Roma a Dolores Prato fosse proprio il pezzo Due millenni di storia sul sarcofago di Augusto (“Paese Sera, 30-31 gennaio 1960), che raccontava e ripercorreva la storia del mausoleo. Significativo il riferimento all’arrivo del “fatidico piccone, simbolo di un’epoca”. 190 Il sepolcro del primo imperatore era il solo magazzino capace di ospitare il cavallone del monumento all’ultimo primo re d’Italia; due decenni di umiliante vigilia e il magazzino diventa la più suggestiva sala di concerti che il mondo abbia conosciuto, prende trionfante il nome di Augusto e fu l’apoteosi! Il mausoleo aveva conosciuto preci e bestemmie guerresche, colpi di piccone e di zappa, vigneti e fiori, folle tumultuose e incendi favolosi, polvere e sole, conobbe allora la grande quiete devota, sotto una cupola gonfia di musica, con una folla religiosa e muta; fu davvero un tempio dell’arte e tutto il mondo ce lo invidiò. Ma arrivò anche l’ultimo concerto, giacché era stato deciso di sradicare tutta la vita che si era abbarbicata addosso al monumento, e di restituirlo alla morte. Vi fu un pieno inverosimile; la commozione che tramava in ogni cuore traboccava nell’aria, diventato tutt’uno con le ultime armonie: musica fatta commozione, commozione fatta musica e l’immensa sala ne fu colma. Alla fine del concerto non “scrosciò” l’applauso, fu un battimento lento, intenso, uguale, parve non dovesse finire più. Era un dolore che applaudiva per manifestarsi era la appassionata protesta per un delitto vicino al compimento. L’orchestra, che doveva essere l’applaudita, applaudiva anche essa e la gente non si staccava di lì; era in piedi, seria, triste, e batteva le mani. Pareva che qualcuno dovesse parlare, ma nessuno parlò; nessuno usciva da quelle porte, tra le quali erano soliti sgusciare frettolosi all’accenno degli ultimi accordi. Per i romani una cosa tanto amata, moriva; le si dava così un addio accorato. Il fatidico piccone, simbolo di un’epoca, cominciò presto l’opera sua: lunghi mesi di polverone, di terriccio, di pena e tutto intorno la grande opera fu compiuta. Apparve un torsolo nudo, brutto, inespressivo, quasi osceno come lo diventano, sotto la luce, le cose fatte per essere coperte. Si vide il sepolcro vuoto e repellente come una cassa da morto usata. Le mura sbrecciate e smozzicate furono pareggiate, perché le rovine dovevano presentarsi con l’uniforme in ordine; una rovina capricciosa non era permessa. Finita la sistemazione della zona, quel povero rudero gareggiò in miseria e bruttezza con l’antesignana di tutto lo scatolame nazionale, la scatola dell’Ara Pacis. Son passati tanti anni e quel mozzicone imperiale non rivive, resta sempre un sepolcro affossato, diventato lui stesso il morto. Sullo stesso monumento Dolores scrive, in Voce fuori coro, con la schiettezza tipica di quel pamphlet: Riprende, come all’epoca dell’annessione, la furia degli sventramenti di quel che di storico era rimasto nel centro della città. Si distrusse come allora, e mentre allora si costruiva borghese, ora 191 si costruisce littorio, grande, imponente, monumentale, rosso e bianco, e statue nerborute. Secondo Mussolini all’Augusteo “liberato” sarebbero arrivate tutte le genti d’Italia e tutti i popoli del mondo. Ebbe tempo anche lui per convincersi che se prima, visto e non visto, scoperto a pezzetti tra le case, desuntane l’immensità in quel cerchio altissimo dentro il quale risuonò la più bella musica del mondo, aveva ancora un fascino, ridotto a quel torsolo che è nessuno lo guarda più in faccia. Sulla ricostruzione delle demolizioni fasciste Dolores Prato è accurata anche in Voce fuori coro: Questi si facevano vanto di demolire senza pietà. Buttarono giù tra piazza Barberini e S. Bernardo, buttarono giù all’Argentina per isolare i templi, buttato giù a piazza dell’Ara coeli, così furono distrutti non solo gli edifici, ma anche la piazza. La via dell’Impero (ora dei fori imperiali) fu una distruzione di quanto i secoli vi avevano accumulato e di quanto, in una zona così ricca, veniva alla luce durante gli scavi. Se mantenere un monumento scoperto con gli scavi serviva alla sua demagogica esaltazione, tutto di guadagnato, ma sulla via dell’Impero era la via che importava per i prossimi trionfi, il passo dell’Oca non sopporta sassi nel suo cammino, sicché addosso anche ai vecchi monumenti se stavano nel percorso di quella fatidica strada. E ancora: All’epoca della liberazione del mausoleo d’Augusto, capato come si capa un torso di broccolo, e dell’incassettamento dell’Ara pacis….tra le altre cose fu demolita una casa che non aveva in sé nessun interesse tolto che il proprietario ci si era sbizzarrito a decorarla con formule chimiche perché l’aveva costruita con i soldi che aveva ricavato da una sua fortunata formula. Lì dov’era quella casa c’è un vuoto che gli altri non vedono, ma io sì perché salii un giorno sulla terrazza di casa. Spesso torno lassù; nulla mi sostiene, ma vedo quel che allora vidi come se qualche acido di quella formula avesse inciso la lastra della mia memoria. Distruzioni fasciste – argentina Era un piccolo cortile in una delle più piccole case in quel silenzio che dalla piazzetta di San Nicola di Cesarini si diluiva tuttintorno. C’erano delle colonne, si diceva che fossero del tempio d’Ercole, che di lì partivano i vaticini, che la colossale statua prima trafugata e poi ritrovata fosse stato il simulacro di quel tempio, nei muri del cortiletto era visibile un portico medioevale, in un angolo c’era un pesco. 192 Gli amanti delle antichità, i forestieri, giravano per quelle straducce alla ricerca del cortiletto, quando l’avevano trovato e le colonne “di Ercole” erano davanti agli occhi, era un tuffo di emozione specialmente se in un angolo del portichetto medioevale il pesco era in fiore. Ora a chi importano più quelle colonne nude, anche se hanno ritrovato il loro nome vero, lì all’aria aperta, come due scheletri? Non lesinava critiche pungenti: La gente a cui si demoliva la casa fu deportata fuori, in lontani agglomerati che non ebbero neppure il nome di Borgo, ma furono chiamate borgate. Isolata quella gente non trovava più lavoro, splendide dimore degne del grandissimo popolo italiano, risultarono peggiori in tutto di quelle da dove erano stati cacciati. E a quelle borgate affluirono gli abusivi, i non controllati, i “non sono nessuno”. Roma vide anche lo sconcio di quei motti, assiomi scritti /posti come fastigi Ma, oltre alle devastazioni urbanistiche e architettoniche, Dolores Prato è spietata nei confronti della retorica fascista, dei suoi riti e rituali “ridicoli”, segno di un imbarbarimento civico, civile e sociale. Lo vediamo, ad esempio, in Un Natale e una Pasqua quest’anno si sovrappongono (“Paese Sera”, 20-21 aprile 1957) Poi venne l’epoca della “Giovinezza” che viveva di riesumazioni e tra queste non poteva mancare il Natale di Roma. Rubandola al 1 maggio gli fu messa la casacca del lavoratore debitamente tinta in nero e il popolo, diviso a schiere a seconda dell’età, fu obbligato non a coronarsi di fiori, ma a marciare e a gridare. Adesso è una festa senza entusiasmo, ma anche senza ridicolo. La condanna al Fascismo, e alla sua pomposa retorica, è ancora più evidente in Voce fuori coro Distruzioni epoca fascista Li chiamavano “risanamenti”… Fascismo 193 I fascisti che morivano con cristiana e retorica rassegnazione dentro la camicia nera, portavano la stessa confusione e la stessa tetraggine nelle loro costruzioni. 1860 fascismo Garibaldi aveva tentato di abolire il titolo di eccellenza, Mussolini non lo abolì, ma lo raddrizzò come un fioretto puntato al cuore. Prima si diceva “sua eccellenza”, si girava al largo, quasi timorosi di accostarsi direttamente, Mussolini fece dire all’Italia l’Eccellenza, Noi Eccellenza. 1922 “Maestà io vi porto l’Italia di Vittorio Veneto”. Con questa frase entrò (oppure: questa frase fu la porta per la quale la colossale imperiale retorica ci rese tanto ridicoli). La pazzia fascista – capitalismo Che cosa non ha sofferto Roma in quel periodo? Basta ricordare il facciatone che si sovrappose alla facciata del palazzo delle esposizioni con quelle 4 enormi scuri che certo ebbero il vanto di essere allora e sempre per i secoli futuri le più colossali scuri sporgenti dai più colossali fasci littori. Oppure “Il mito imperiale romano è sempre ricomparso nelle epoche di servitù enfatica e barocca, nel XVII, nel fascismo. L’identificazione dell’Italia e della moderna Roma con Roma antica, il culto dei moderni, ha sempre gravato sull’anima italiana come un’istanza di senilità”. “Il Medioevo è come spazzato via dal vento, con tutto lo spirito storico del passato”. Così scriveva Gregorovius (I, IX) ritornato a Roma dopo che questa era stata annessa al Piemonte, dichiarava che Roma aveva perduto il suo incanto…se l’avesse vista nel fascismo, povero Lui! Il fascismo ci ha tolto tutto. Anche l’“est locanda” che aveva resistito alle immissioni barbariche 194 dei piemontesi, si trasformò nel banale “affittasi”. E sul Fascismo, e la sua influenza su Roma, chiudiamo con Dolores: Dal balconcino di Palazzo Venezia il 9 maggio 1936 Mussolini annunziò al mondo che era “riapparso l’impero sui colli fatali di Roma” così come si può riaprire un grande magazzino. 195 V – Anniversari, cinquantenari e un centenario: presagi di un antimito Sono quattro le date da osservare, se si vuol provare a vedere nelle celebrazioni degli anniversari di Roma capitale l’ombra di un mito più retorico che reale, e se si vogliono portare allo scoperto i segnali – forse nascosti – di un antimito, che Dolores Prato colse, mettendoli nero su bianco nei suoi articoli e nel progetto di Voce fuori coro. Nel 1895, 1911, 1920 e 1971 si rievocò solennemente la Roma italiana: il 1895 e il 1920 rappresentavano i venticinque e i cinquant’anni dal 20 settembre; il 1911 era il cinquantesimo dell’acclamazione di Roma capitale nel primo Parlamento del Regno; il 1971 era il centenario della proclamazione a capitale. Venticinque anni dopo l’Unità d’Italia, il desiderio di celebrazioni nasceva più che altro dalla volontà di contrastare un grigiore diffuso, una stagnazione, che attanagliava sia l’atmosfera della nazione in generale, sia la situazione economica di Roma, oppressa dalla crisi edilizia e dagli scandali finanziari. La “Gazzetta di Parma”, il 15 aprile 1895, commentava: “Morta l’industria, morto il commercio, rovinata l’agricoltura dalle malattie e dalle tasse, è naturale che anche la capitale, ed anzi specialmente la capitale, risenta di questa tristissima condizione di cose e molto più gravemente che le altre città”266. Proprio da questo languore scaturì il disegno di rianimare Roma con manifestazioni solenni, in concomitanza con il venticinquesimo dalla liberazione. A battersi più di ogni altro fu il ministro Guido Baccelli, alla guida della Società per il bene economico di Roma, a forte presenza massonica, che avrebbe voluto realizzare, fra il novembre 1895 e il giugno 1896, una grande esposizione nazionale dell’Italia industriale e produttiva. Il progetto, però, seppur approvato dal consiglio comunale, naufragò in Parlamento al momento della richiesta di un contributo finanziario. Ma la macchina organizzativa delle celebrazioni romane andava avanti, in particolare grazie al Comitato generale per solennizzare il XXV anniversario della liberazione di Roma, formato su iniziativa del sindaco Emanuele Ruspoli. Due i motivi di tanto movimento: Il primo è l'interesse del sindaco e degli amministratori capitolini, il ceto dirigente locale, ad assecondare - pur senza alterare gli equilibri politici locali condizionati dalla forte presenza cattolica in Campidoglio - l'iniziativa dei ceti economici e politici «progressisti» cittadini che nelle celebrazioni avrebbero voluta esaltata l'immagine di Roma capitale e centro propulsivo dello Stato nazionale, per il vantaggio che ne sarebbe derivato, in termini di consenso nazionale, ai temi della politica municipale, sempre ispirata alla necessità del sostegno finanziario dello Stato a favore dello sviluppo della Capitale. Il secondo è l'intendimento del governo, di suscitare una forte adesione di popolo, sottraendo terreno alle estreme, incanalando e disciplinando le 266 Cfr. A. Caracciolo, op. cit., p. 288. 196 manifestazioni «spontanee» di gruppi ed associazioni, il “paese reale”, nella grande festa nazional-popolare di sostegno alla monarchia: le celebrazioni negli intendimenti di Crispi in particolare sarebbero state un momento forte di rappresentazione della coesione del l'organismo statale postrisorgimentale, una dimostrazione del consenso di tutte le sue componenti sociali, nell'identificazione con la Monarchia, simbolo e garante della solidità e dello sviluppo dello Stato nazionale267. Il principe Ruspoli, per il suo comitato, voleva rappresentanti delle associazioni militari e dei reduci, degli istituti culturali e scientifici: i congressi di questi ultimi sarebbero dovuti essere centrali nelle manifestazioni del XXV°, rivitalizzando il vecchio mito di Roma italiana, capitale di arte e di cultura caro a Quintino Sella. Ma soprattutto, a far parte del comitato, furono chiamati tutti gli uomini delle istituzioni, dai consiglieri comunali ai sindaci delle maggiori città italiane, oltre che deputati e senatori, e anche i direttori dei maggiori quotidiani cittadini di area liberale, in rappresentanza del potere della stampa: lo scopo era quello di portare a Roma, per il venti settembre, il maggior numero di associazioni italiane, di qualunque natura, e per accrescere il “culto della Patria e la fede alle istituzioni”268. Ma se l’esposizione non andò in porto, molte altre furono le manifestazioni celebrative, soprattutto di natura politica, che provocarono contrasti fra i partiti e risentimenti nella cattolicità. Ad accendere il dibattito, nel luglio 1895, la proposta che il 20 settembre diventasse festività civile: a favore una larga maggioranza alla Camera (249 contro 26), fatta di radicali, repubblicani e gran parte dei liberali capeggiati da Crispi. Contrarie erano, invece, alcune società operaie, perché “Roma non è la capitale di un libero regno, ma l’asilo inviolato e sacro dei maestatori politici, dei loschi affaristi, dei banchieri, dei ministri corrotti e corruttori; è la Mecca della burocrazia pedante e assorbente; la cuccagna dei clienti e di tutti coloro che vivono aggrappati alla cassa dei fondi segreti”269. Il panorama era frastagliato: i socialisti volevano celebrare la ricorrenza del 20 settembre, principio, a loro avviso, di un’era nuova; la sacra Penitenzieria arrivò addirittura a vietare ai fedeli, salvo quelli costretti da incarichi pubblici, di prendere parte ai festeggiamenti; l’Estrema sinistra radicale voleva dare al tutto un tono di acceso anticlericalismo. Il Governo cercò di dare alle cerimonie un carattere puramente patriottico: si svolse una gara nazionale di tiro a segno, si formò un corteo a Porta Pia, di fronte ai reali, venne inaugurato sul Gianicolo il monumento a Garibaldi, con un discorso di Crispi ai sindaci di tutta Italia e al popolo. I partiti di sinistra e la massoneria organizzarono, in autonomia, conferenze e adunanze con accenti che volevano ferire il Papa. 267 L. Francescangeli, Il Comitato generale per solennizzare il XXV anniversario della liberazione di Roma ed il suo archivio, in “Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée”, T. 109, n°1, 1997, p. 187. 268 Ivi, p. 201. 269 Così in un articolo del “Corriere dell’Isola”, di Palermo, in A. M. Bonetti, Venticinque anni di Roma capitale d’Italia e suoi precedenti, Roma 1896, v. II, p. 395, cfr. A. Caracciolo, op. cit., p. 289. 197 Ma, tutto sommato, le celebrazioni del 1895 scorsero via senza grandi moti dell’animo, in un’atmosfera di ordine e di relativo entusiasmo, con “l’impressione che il 20 settembre oltre che una ricorrenza nazionale, fosse ancora, e soprattutto, un segno di contraddizione”270. Più maestoso il cinquantenario del Regno, nel 1911, il “Giubileo della Patria”. L’Italia era più moderna, più ricca e ambiziosa; Roma mostrò, ancora una volta, il suo ritardo: era sicuramente la capitale politica, sede degli organi dello Stato, ma non il centro economico, il cuore della nazione. Un’evidenza, lampante, se si guarda alle esposizioni internazionali, questa volta sì, allestite per le celebrazioni, a Roma e Torino. In precedenza, nello stesso anno, una minore fu organizzata anche a Firenze, in quanto ex-capitale. Le due esposizioni erano molto diverse tra loro, a partire dai temi: in Piemonte l’attenzione degli espositori era dedicata al lavoro e all’industria, primati del Nord; Roma era concentrata sull’arte, sulla storia patria e su una nuova emergente disciplina, l’etnografia. Torino, capitale del progresso italiano e snodo cruciale verso la Francia, ospitò l’Esposizione Internazionale dell’Industria e del Lavoro, con protagonisti il mito del progresso e l’elettricità. Roma, invece, fece da palcoscenico per le esposizioni di natura più umanistica: venne allestito il nucleo centrale di quello che sarebbe poi diventato il Museo del Risorgimento romano. Ma la natura “romana” dell’esposizione e l’impronta democratica e anticlericale voluta dalla giunta Nathan, anche per rimarcare il ruolo di nemico svolto dal Vaticano nel processo unitario, portarono a uno scarso successo della mostra. Di natura più “unitaria”, ma comunque con scarsi risultati di pubblico, le altre iniziative, come la Mostra internazionale di Arte, a Valle Giulia, l’inaugurazione del Museo medievale alla Mole Adriana e il Museo Romano alle Terme di Diocleziano. Più frequentata, invece, la Mostra etnografica che, sviluppandosi in decine di padiglioni d’arte e di folklore regionale, risultò maggiormente coinvolgente. Nei mesi di festeggiamenti furono molte le cerimonie, i discorsi, nei quali si esaltarono le glorie passate e future dell’Italia unita e di Roma capitale, e si inaugurò, alla presenza dei sindaci di ogni regione, il monumento a Vittorio Emanuele II. A ricordo permanente delle celebrazioni rimasero anche il ponte Risorgimento e il ponte Vittorio Emanuele, il quartiere poi intitolato a Mazzini (luogo dell’esposizione), lo stadio nazionale, il giardino zoologico, la Galleria nazionale d’arte moderna a Valle Giulia. E’ dunque l’apoteosi dell’“Italia del popolo”, della “terza Roma”, come il Nathan crede? Non si tratta di questo. E’ solo la rassegna orgogliosa, e forse un po’ pacchiana, di un’Italia liberale che sta vivendo gli ultimi tempi del suo progresso e del suo vigore. E che del nome e della tradizione di Roma vuol servirsi per apparire più maestosa e degna di rispetto271. 270 271 G. Arnaldi, Il Venti settembre 1895, in Studi romani, 1955, n. 5, p. 579, e cfr. A. Caracciolo, op. cit., p. 290. A. Caracciolo, op. cit., p. 292. 198 Sempre originali e interessanti sono le riflessioni di Prato sui più disparati argomenti e momenti relativi alle trasformazioni di Roma, e lo sono anche quelli relativi proprio alle esposizioni scritti per Voce fuori coro: dopo il 900 esposizione Restò galleria d’arte moderna coperta di ornati. Ogni tanto nelle ripuliture le hanno tolto qualche aggeggio ornamentale, ogni tanto un pezzetto di più di muro liscio. Ne aveva troppi, d’accordo, ma siccome brutto lo è, era meglio un brutto originale. Almeno segnava un’epoca. dal 70 al 900 - Esposizioni Che epoca curiosa, se non ci fosse stata la Prussia fagocitatrice (?) di fratelli e origini tedeschi, il dramma della Francia, la caduta del potere temporale dei papi, si sarebbe potuta distinguere come epoca delle esposizioni; si succedono in ogni parte del mondo, le grandi, pullulano le piccole in ogni città. Anche in Italia, a considerare quante ce n’erano si sarebbe detto che non aveva altri problemi. Invece per mangiare la gente partiva per l’estero coi fagotti di stracci e offriva braccia e intelligenza272. Il Giubileo della Patria, di fatto, mostrò due volti dell’Italia unita: il progresso e la tradizione. Per quanto riguarda il primo, di matrice più internazionale, lo scettro era in mano a Torino, industrializzata e con una posizione più favorevole rispetto agli stati dell’Europa continentale. In qualche modo, queste caratteristiche, nonostante che la volontà degli organizzatori fosse ben altra, fecero sì che l’ex capitale si mostrasse come il vero centro propulsore dell’immagine che l’Italia voleva trasmettere all’esterno: progredita, grande potenza, industrializzata e all’avanguardia. Roma, sfavorita dalla posizione e dalle tematiche più simbolico-culturali delle proprie esposizioni, finì per catalizzare meno l’attenzione dei visitatori internazionali, spesso industriali, chiudendo con poco più della metà dei visitatori di Torino. L’intonazione data ai festeggiamenti non riuscì a commuovere l’Italia del 1911. Non era ancora nata quella “terza Roma” cara a Mazzini. Le celebrazioni per il cinquantenario di Roma capitale, nel 1920, furono in linea con un Paese stremato dalla guerra, in grande difficoltà materiale. Il momento non era adatto a cerimonie: i partiti si stavano preparando alle elezioni amministrative con la forza richiesta da una delle battaglie decisive del dopoguerra; ovunque divampava una violenta lotta di classe. Gli operai romani 272 ACGV, Fondo Prato, Pm 3. 199 avevano stabilito i loro picchetti intorno alle fabbriche: l’Italia, per dirla con Gramsci273, si trovava alla vigilia della presa del potere politico da parte del proletariato, oppure di una tremenda reazione da parte della classe proprietaria. In pochi si accorsero delle celebrazioni del cinquantenario. Dei festeggiamenti si occuparono soltanto il Governo e quel che restava dell’apparato statale: tutto si risolse con l’istituzione delle Biennali Romane d’Arte (le cui uniche tre edizioni si svolsero dal 1921 al 1925), una seduta solenne in Campidoglio, un telegramma del sovrano, il tradizionale corteo con comizio a Porta Pia. Commemorazioni sbiadite, per un dissidio fra Stato e Chiesa che si era molto attenuato e, anzi, iniziava a trasformasi in convergenza. In cinquanta anni di capitale, colpiva il profondo divario fra l’esaltazione dell’idea di Roma e le concrete iniziative nei confronti della città da parte del ceto politico. L’avvenire di Roma, anzi, veniva determinato da convenienze e necessità contingenti: si era contro l’industrializzazione della città per timore di una futura concentrazione proletaria; con una consuetudine di omertà e ossequio, la burocrazia qui concentrata doveva essere docile e rispondere alle volontà di ministri, funzionari, governo; l’esaltazione del nome, del fascino, della tradizione di Roma, doveva servire a esaltare l’orgoglio nazionale e favorire l’unità formale del Paese, ma alla capitale non si concedeva nulla che potesse trasformarla in vero centro di gravità nazionale. Questo solco tra parole splendide pronunciate nelle grandi occasioni e condotta concreta dei governi diventò abissale con il fascismo. Roma, la romanità, i destini romani d’Italia, erano il leit-motiv della fraseologia mussoliniana: il Duce era alla ricerca di un mito. “Roma – diceva – è il nostro punto di partenza e di riferimento; è il nostro simbolo o, se si vuole, il nostro Mito”274. Ma, invece di progredire economicamente e culturalmente insieme al resto d’Italia, Roma si differenzia in modo sempre più accentuato: Milano era diventata l’effettivo capoluogo dell’Italia economica, Torino era la capitale industriale e proletaria, Roma rimaneva città che regna e non governa. Mentre si trasformava in popolosa metropoli, era sempre vivo il contrasto fra l’idea, l’immagine che di essa si cercava di rappresentare agli italiani, e la realtà che i suoi uomini e le sue donne incontravano ogni giorno. Un divario fra quello che Roma credeva di essere e quello che in realtà era. Per i cento anni di Roma capitale, nel 1970, si ripropose lo schema ufficiale di commemorazioni governative, senza più la forza della spinta anticlericale dei primi anni. Le celebrazioni portarono anche a coniare una moneta per l’occasione, le mille lire “Roma capitale”, con da un lato la pavimentazione progettata da Michelangelo per piazza del Campidoglio, e dall’altro il volto della Dea Concordia. Venne emesso un francobollo che raffigurava tre monumenti all’interno dello 273 274 A. Gramsci, L’Ordine nuovo, Einaudi, Torino 1954, p. 117. Passato e avvenire, in “Il Popolo d’Italia”, 21 aprile 1922, cfr. A. Caracciolo, op. cit., p. 297. 200 “stivale”, quelli di Roma, Torino e Firenze, con la scritta “Ho detto e affermo ancora una volta che Roma Roma sola deve essere la capitale d’Italia. Cavour”: un francobollo che, emblematicamente, rappresentava la storia, con le tre capitali, ma in cui, forse, si poteva ancora leggere la mancata centralità di Roma nello sviluppo e nell’economia del Paese, anche cento anni dopo la sua elezione a capitale. Numerosi, infine, furono gli eventi culturali pensati per l’occasione, e non mancò un fiorire di pubblicazioni, anche locali, con poesie, poemetti, racconti, memorie, per esaltare la memoria di Roma e la sua “eternità”. Come abbiamo avuto modo di approfondire nel terzo capitolo, anche Dolores Prato voleva con forza partecipare a queste celebrazioni. Ma voleva farlo a modo suo, in controtendenza con il pensiero ufficiale che esaltava il 20 settembre e la proclamazione di Roma capitale. Dolores scriveva apertamente, nell’abbozzo di Voce fuori coro: Ragione di questo libro è che un velo bugiardo è su tutte le commemorazioni. Noi altri facciamo un lamento perché noi pensiamo solo a Roma città costruita e città vivente275. E ancora, scritto su un ritaglio di giornale276: Ma è indubbio che se esiste occasione per dare agli avvenimenti storici una luce falsa, questa si presenta inevitabilmente nelle rievocazioni celebrative. Basterebbe, per rendersene conto, andarsi a rileggere molto di quello che è stato scritto qualche mese fa nel nostro Paese, in occasione del centenario di Porta Pia. Impietosa, nel suo schema di Voce fuori coro, Dolores appunta: Poi il discorso procede di celebrazione in celebrazione, cinquantenari, 75enni ecc. Ognuno è uno sguardo sugli ulteriori danni e sulle brutture. Le celebrazioni inoltre ospiteranno in maggiore quantità le buffonate retoriche277. 275 ACGV, Fondo Prato, Pm 1. ACGV, Fondo Prato, Pm 1. 277 ACGV, Fondo Prato, Pm 1. 276 201 Ma terminiamo questo capitolo sulla storia dell’Unità d’Italia, su Roma capitale e le celebrazioni che ne seguirono, con un articolo di Dolores Prato che tutto racchiude: la sua accurata ricerca storica, l’attenzione per i dettagli, la sua mirabile capacità descrittiva, l’acutezza delle considerazioni e delle intuizioni. Leggiamo, con chiarezza, la voce limpida di chi racconta l’antimito di Roma capitale, nel suo primo centenario, e queste parole possano anche servire di congedo alla multiforme personalità di una scrittrice del Novecento della quale abbiamo cercato – anche se il lavoro è solo agli inizi – di recuperare la voce troppo spesso messa a tacere, dagli eventi o da un’instancabile aspirazione alla perfezione. 1970 finestre278 Tre anni fa si celebrò il nefasto centenario di Roma capitale d’Italia. Intervennero anche i preti, non per celebrare le esequie di una città barbaramente distrutta, ma per assolverne la rovina. La ricorrenza bicentenaria della morte di Luigi Vanvitelli che concepì, disegnò, in parte attuò una capitale libera da condizionamenti ambientali, edilizi e storici, esistente di per sé, non appiccicata come una maschera sul volto di Roma che era la capitale del mondo, ravviva la pena per quello che poteva essere fatto e non fu fatto per salvarla. Bastava fare quello che già avevano fatto i Borboni: lasciando intatta la città, costruire, vicine ma staccate, quelle sedi rappresentative e burocratiche necessarie a una capitale. Perché questa condanna di diventare capitale toccasse proprio a Roma è un mistero che per spiegarlo non basta la sua millenaria grandezza e la necessità di far dispetto al Papa, dato che Roma aveva tutto il necessario per esserne esclusa. L’Italia è la terra delle tante splendide città, è una lunga chiesa illuminata da candelabri uno diverso dall’altro, ogni città grande o piccola, un candelabro prezioso; le più grandi erano tutte capitali, avevano tutte la reggia le nostre più grandi città, anche se si chiamavano palazzo Ducale o palazzo Pitti. C’era da scegliere. Scartando la millenaria fastosa città di Palermo troppo lontana per uno stato accentratore e pauroso, c’era Bologna che sta nell’Italia come il cuore nel petto degli uomini. C’era Milano che non sta “come” il cervello perché lo è e lo sarebbe stato nella formazione del nuovo stato che molto non ne aveva. C’era Torino piemontese e sabauda; restando lì la capitale avrebbe risparmiato la grande rovina di Firenze e la distruzione di Roma. C’era Napoli, soprattutto, lasciata in ultimo come nelle processioni solo alla fine sotto al baldacchino avanza il mistero sacro. Napoli era già capitale da otto secoli e per di più “regia”, quel regia che tanto inteneriva i Carignano. L’unità d’Italia in gran parte consistette in quell’aggettivo appiccicato a edifici, a istituzioni preesistenti da secoli, 278 probabilmente pubblicato su “Paese Sera” 202 alle rivendite dei tabacchi, al lotto che era un giochetto proprio da governo papalino. Napoli era una delle più splendide capitali d’Europa. I Savoia risparmiandosi l’umiliazione di strapparsi un alloggio con la forza, vi avrebbero trovato non una ma diverse regge, e tra le più belle al mondo. Ne aveva una aperta sul più bel panorama d’Italia, un’altra a Portici, più amena perché più piccola. Nel ‘700 dalla grandezza, dall’arte, dalla magnificenza, dalla ricchezza, dalla natura, era nato l’immenso stupore che è la reggia di Caserta. Carlo III pensava che la capitale sarebbe stata più libera e sicura all’interno, riparata dalla violenza di qualunque genere fosse, dell’acqua, dell’ambiente, della società. Ne parlò a Luigi Vanvitelli che sull’idea del Borbone innestò il suo miracolo. Alla proposta mastodontica Vanvitelli esplose come un fenomeno della natura. Era sangue nordico il suo nel quale il sole meridionale funzionava da esaltante energetico. […] In questa città di regge Carlo III ne volle una tanto grande che tutte le comprendesse, lontana dalla città, al riparo da turbamenti causati dalla violenza, di qualunque natura essa sia. Non s’ispirò a palazzo carignano, mirò a Versailles. Una Versailles in mezzo alle meraviglie della terra campana. Più di questa reggia ai Carignano importò più punzecchiare il papa occupando una sua casa con la forza come fanno qualche volta i baraccati, umiliando se stessi e condannando a morte Roma. La reggia c’era ed era una delle più belle del mondo se non la più bella perché cascate come quelle che il Vanvitelli costruì difficile trovarle. Una reggia fatta con mattoni, pietre, marmi, metalli, erba,alberi, acqua, popolata da statue di animali, di ninfe, di eroi, di apparizioni. Altro non sono che apparizioni certi scorci, certe lontananze, certe sorprese. Ha alleggerito mattoni, pietre e marmo creandosi ariosi labirinti di colonne, di gallerie che non si chiudono mai, dando l’illusione di un gioco di specchi come nella gloria di certi presepi che a forza di essere riflessa pare infinita. Introducendoci nella sua creazione ci introduce in una esplosione di sogni. Non è solo sogno, è canto. In questa vastissima opera paesistica si passa come in un poema dalle molteplici cantiche a tutti i toni del lirismo. Monumenti di pietra ed acqua, questo sono le fontane profuse da chi poteva contare sul suo inesauribile genio creativo. Acqua pigra, acqua rapida, acqua a cascate, ad archi, a zampilli, sgorga copiosa, gioca con l’erba, si nasconde sotto di essa, riappare per giocare con l’aria e balaustre, scogli, grotte per contrapporre il gioco raccolto a quelli affidati allo spazio e alla lontananza. La reggia di Caserta è appoggiata a un’opera della potenza di quelle romane, all’acquedotto carolino che percorre chilometri e chilometri, attraversa colline, valica le valli con superbi viadotti. Creatore, tecnico, artista, un uomo solo e tutto in pochi anni. E anche la città intorno alla reggia immaginò e disegnò, città che rimane a mezzo, la capitale solo capitale. Quello che avrebbero dovuto fare i Savoia se fossero stati all’altezza dei Borboni. La città progettata dal Vanvitelli aveva le caratteristiche che solo ora si cominciano a proporre come necessarie alla moderna urbanistica. I Borboni e questo popolo terrone bistrattati da una parte dell’Italia unita, pare che sapessero scegliere i loro architetti, pare che sapessero farli i loro sogni preveggenti. […] Quella superba reggia ebbe vicina una comunità basata sull’uguaglianza e sulla libertà, autonoma e 203 autosufficiente con diritto all’assistenza sanitaria e all’istruzione, poteva essere la prima di tante altre che avrebbero potuto fare della Campania la serra della libertà e del progresso. Ma i fermenti che preparavano l’unità italiana si sovrapposero provocando reazioni che tanto fecero comodo ai piemontesi. La Napoli che ha profuso la felicità della sua terra, il pensiero dei suoi uomini, la genialità del suo popolo e il suo saper soffrire, che prima dell’annessione al regno italiano aveva conosciuto splendori culturali a livello europeo, oggi tra cozze e ciminiere continua la sua via crucis. Può venire il dubbio che invece di opera unitaria si sia fatta della vivisezione. Ma la reggia creata da Vanvitelli resta, è un sogno realizzato come non lo fu quello di Francesco d’Assisi. Volandoci sopra, priva com’è delle 4 torri angolari e della cupola centrale progettate dal Vanvitelli, la reggia pare un’immensa finestra crociata appoggiata per terra. Una finestra coricata, traforata nel suo spessore da 1970 finestre. Inutile contarle, si ricomincia sempre daccapo. Tre anni fa quando si celebrò il centenario dell’unità raggiunta con l’annessione di Roma (che per concludere davvero ci vollero altre guerre), una unità che volle dare tinta unica a quello che era un fiorire di varietà, nel 1970 invece di quel disgraziato ricordo di Roma, sarebbe stato meglio celebrare le 1970 finestre di Caserta, una coincidenza che non si ripeterà mai più. 204 Appendice Raccolta degli articoli di Dolores Prato: editi, inediti e rari 205 A) EDITI E RARI, con foglio di giornale (ACGV, Pg 1-143; fondo Ferri-Ferrari) Il Quotidiano, 2 dicembre 1945 PEREGRINAZIONI ROMANE Da Cecilia a Lucina collocazione dattiloscritto: Pg 1-3. Catacombe: sepolcreti sotterranei, stretti, lunghi, tortuosi, umidi, bui, dove mai penetrò il sole, parrebbe dovessero accogliere tutto ciò che è negazione di luce e di vita, tutte le tenebre e tutte le morti di questo povero mondo. Invece, sulla faccia della terra, non c’è luogo da cui emani tanta luce come dal buio di quelle sotterranee gallerie mortuarie. Luce di vita; luce di martirio; luce di fede; luce di dottrina; luce di poesia, luce di sicure speranze; luce di miriadi di piccole lucerne; luce di nomi che illuminano ancora di vita quelle caverne, dove la morte non entrò neppure con un segno, con un grafito, con una parola, con un simbolo. “Lucina” è uno di questi nomi luminosi, forse il più luminoso: quello che ripetendosi con insistente uniformità attraverso i primi secoli cristiani, li costella di tanta luce, come se a ogni poco s’accendesse una lampada viva nell’ombra sotterranea delle catacombe. In quasi tutte le storie dei martiri incontriamo una matrona che li assiste, ne raccoglie il corpo e lo seppellisce in un suo possedimento. Questa ricca patrizia si chiama sempre “Lucina”. E’ un nome tipicamente cristiano. Il battesimo cacciava dalle tenebre dello spirito; gli iniziati entravano nella luce. Di una cristiana che si fosse distinta per opere di eccezionale pietà, veniva tramandata la memoria, ma senza preoccuparsi del suo nome gentilizio. Che fosse della gente “Cornella” o “Emilia”, o “Cecilia”, che importava? Essa era una “illuminata”; questa sì, valeva. E diventava “Lucina”, come quella, che della luce del battesimo, più ne prese; più ne portò; più ne diffuse. Una emanatrice di luce che è vita; di vita che è opera, di opra, che sola vale; che sola resta, oltre il nome di quaggiù, che non ha valore. Tante “Lucine”, dunque, che non si chiamavano “Lucina”: donne imprecisate, vere solo come fede e come azione; donne misteriose, che col loro nome simbolico illuminano, più delle lucerne, le oscure profondità sotterranee. Simbolico il nome; vere certamente le donne, che in esso venivano velate; vere e continue come la Carità, da che Cristo l’insegnò. Volete una donna più vera e più di quella “Lucina”, che nel II secolo offre alla comunità cristiana un suo campo sull’Appia che diventerà il Cemetero di Callisto, il più venerato e più ricco (la ricchezza di quei tempi 206 era la carità e il martirio); di quella donna che, secondo un’ipotesi, alla quale mi piace aderire, ha tanta autorità da consigliare il Pontefice Cornelio a togliere dalle malsicure sepolture pagane i corpi di SS. Pietro e Paolo; che ha tanta energia da attuare il trasferimento; che è così pietosa da raccogliere a decine i corpi dei fratelli martiri e religiosamente seppellirli, aiutata dalla notte e dai pochi fedeli? Eppure di questa “Lucina”, che darà solenne sepoltura anche al Papa Cornelio, nessuna memoria diretta nella sua catacomba. Invece, nello stesso Cemetro, distinta da un arcosolio, nella zona più sacra, proprio accanto alla Cripta dei Papi, ebbe la sua sepoltura una “Cecilia”, di cui nulla si sa con certezza, e che forse non patì neppure il martirio. Nella Cripta è dipinta la sua immagine; una donna aureolata e sorridente; riccamente vestita e ornata; con gli occhi grandi piene di luce; circondata da fiori; che allarga le braccia, levando in alto le mani in attitudine orante. Ma perché tanta distinzione per una donna della gente “Cecilia”, se nel secolo V, quando l’era dei martiri era chiusa da un pezzo, la Chiesa credette bene di lasciare che i cristiani manifestasserola loro crescente decozione per lei, conferendole il titolo di “martire”? E’ evidente che la sua vita dovette essere tale da renderla “testimonio” e “confessore” di Cristo per mezzo delle opere che uguagliarono in merito le testimonianze offerte col sangue. Se il periodo delle persecuzioni era chiuso, non per questo era cessata la lotta per il cristiano; sicché, dovette ben presto sorgere l’idea, che oltre al martirio del sangue, c’è un martirio della vita non meno doloroso, sempre più lungo. Se è così, S. Cecilia, anche se non martire fu la protomartire del nostro tipo di martirio. E, allora, si fa più vivo il desiderio di trarla dal suo secolare mistero, dal quale sta uscendo con una esplosione di luce, come solo dalle catacombe può erompere. La “Cecilia”, dormente nel Cemetero di Callisto, accanto alla Cripta dei Vescovi di Roma, potrebbe essere quella stessa matrona “Lucina” del III secolo: attiva, coraggiosa, pietosa, di cui si è accennato. Una donna, che, forse, non fu chiamata dagli altri col simbolico nome, ma che da sé potrebbe essersi nominata “Lucina”, a testimoniare la luce dalla quale fu assorbita all’atto del battesimo sulla scalia della nuova vita. Poteva averlo fatto anche per la ragione che, appartenendo alla gente “Cecilia” essa portava nel suo nome stesso il ricordo della “cecità” delle tenebre. “Cecilia”, ora che la luce di Dio l’ha illuminata? “Cecilia” quella che non vedeva, perché in tenebre non c’è più; ora c’è quella, che vede perché in luce c’è “Lucina”. Che in questa identificazione di “Cecilia” con “Lucina” cada la leggenda della sposa di Valeriano, non ha valore. Ciò che avrebbe ottenuto S. Cecilia dal suo sposo, infinite altre cristiane lo ottennero. Che cada la tradizione delle ferite che la lasciarono viva nel dolore per tre giorni; della testimonianza resa all’unità e trinità divina con le dita, non potendolo più con le parole, non conta. Che cada l’immagine di una “Cecilia”, traente dalla tastiera celesti armonie, non ha valore. Dalle catacombe prorompe sotto forma di luce, di acqua di fiori di simboli, un’esultanza tale di vita, da superare il più grandioso corale che abbia mai scosso la terra. 207 Questa “Cecilia-Lucina”, sarebbe assai più grande e più vera di quella, che la leggenda ci tramandò come “Cecilia martire”. Lucina viva solo per una formidabile forza operosa, acquista un volto nell’orante della Cripta di “Cecilia”; attenua la lucentezza del suo nome, perché noi vi possiamo scorgere attraverso la nobile figura di una donna dei “Cecili”. In questa nostra epoca devastata materialmente e spiritualmente, l’archeologo puro, che freddamente esamina muri e scavi; che matematicamente stabilisce misure, nomi e date, non trova più posto nelle nostre folle cieche ed affamate, che chiedono solo pane per il corpo e luce per l’anima. Ma un archeologo come il Belvedere, dalle cui parole e dai cui scritti io ho inteso attingere questa luce, che ho cercato di riflettere, in cui l’archeologia ha accentuato e approfondito il suo carattere sacerdotale, deve essere benedetto per la luce di vita, che trae da quegli oscuri sepolcreti, per offrirla alla nostra morta “cecità”. E nel suggerirci l’ipotesi della identità delle due donne, dà a noi il conforto di riallacciare la nostra fatica e il nostro patire quotidiani a quelli di “Cecilia-Lucina”, che, come noi, visse la sua vita, superata però da una carità, che noi non conosciamo più. 208 Paese Sera, 19 maggio 1950 I gatti insidiano l’eternità di Roma collocazione: Pg 4. Di qua e di là delle strade di Roma, che spesso si svolgono sopra quelle antiche, sorgono templi, s’ammucchiano case di poveri, si stendono palazzi di ricchi, come duemila anni fa e più. I templi hanno cambiato divinità, ma quando quello di oggi sorge sulle fondamenta di uno di allora, il nuovo titolare assume il cognome dell’antico come fa la donna entrando nella casa del marito. L’interno odora, sempre d’incenso, e il sacrificio di adesso è annunciato col suono del campanello come quello antico. Il capo dei sacerdoti conserva il nome di quello di allora: molte parole del rituale pagano sono passate nel nuovo. La fastosità delle antiche parate rivive nelle cerimonie d’oggi. Quelle imperiali si trasformano in quelle pontificali, così come all’università politica succede quella religiosa. La notte tra il 23 e il 24 giugno era a quei tempi una festa di chiasso, di letizia e di conviti; attraverso i secoli il chiasso di quella notte si è ripetuto e garofani e spighetta sono creature festeggiate anche adesso. Così per tutte le feste seminate lungo l’anno. Alcune, come quella della Purificazione in febbraio, sono rimaste quali colonne superstiti di un grande tempio distrutto. La grandezza e la solennità degli edifici antichi non è caduta con loro, è passata, tutt’altro che diminuita, sulle loro rovine. Se non ci fosse tanta scarsezza di abitazioni, sulle porte di oggi ci sarebbe ancora l’est locanda. I caratteri della vecchia Roma sopravvivono nella nuova con la longevità delle sue statue che, spezzate e mutilate, fanno ancora di esse una strana città abitata da gente viva e da gente di pietra. Eternità è dunque, in questo caso, sopravveste di continuità e, siccome la parola ha assunto anche qualcosa di superbo, di indifferente, di statuario, proprio del popolo romano, adoperiamola pure. Però questo blocco, fatto di continuità edilizia, religiosa, etnica, giuridica, linguistica, che diventa il mito della sua eternità, è incrinato dal gatto. Questo animale notturno è l’unico elemento nuovo di Roma. Nuovo per modo di dire, perché da un millennio ormai egli si è trasferito qui trovando confacente al suo carattere sacro quello grandioso dell’urbe. In una città che sotto tanti riguardi è sacra, il gatto, che si adagia su un cuscino come su un soffice trono, che si mette fra i piedi di una seggiola come all’ombra di un arco di trionfo, che nell’incedere conserva il ricordo atavico del baldacchino, che ha dell’idolo anche se malato e sperduto: questo animale sta bene a Roma. Tanto ci sta bene che si parla dei gatti romani come del Colosseo. Eppure il gatto a Roma è un immigrato, un invasore se si vuole, uno però che non è diventato Roma, ma che è stato pur sempre gatto e, sotto certi aspetti, antiromano. Ha cambiato faccia alla notte che, se non fosse per lui, sarebbe anch’essa, come le cerimonie, quella che era duemila anni fa, a parte le orge di alcuni patrizi come i sonnambulismi di alcuni da marosi di oggi. Ma adesso nella notte scappano fuori tutti i gatti e passeggiano, esplorano, bisticciano, amano, incontrano gli amici benestanti o randagi, filosofi o archeologi. 209 Roma antica ebbe il cane col solito collare, pappagalli e scimmie, ma non ebbe il gatto. Eppure il popolo romano venendo a contato con quello egizio, oltre alle piramidi conobbe certamente anche il gatto, ma forse ne ebbe paura come di un essere misterioso capace di scardinare il suo prestigio. Era accaduto che un cittadino romano – e come tale sacro quasi quanto il gatto in Egitto – fosse condannato a morte per averne ammazzato uno, senza che tutta l’autorità di Roma riuscisse a salvarlo. I romani si guardarono bene dal riportare gatti dall’Egitto come invece riportarono gli obelischi tanto più difficili a trasportare. Quel complesso di templi egiziani che si ergevano dove ora è via Piè di Marmo e adiacenze, era adorno di molte statue di gatti, che, rovinate coi templi, riaffiorano lungo i secoli insieme coi leoni e gli obelischi. Una non s’è allontanata da quei paraggi; sta sull’angolo di un cornicione a mezza altezza di un palazzo e la strada sotto si chiamò “della gatta”. Gli egizi portavano manifesti segni di lutto per la morte di un gatto, nel pericolo lo salvavano come gli altri popoli salvavano i loro idoli, come noi moderni salviamo la cassetta dei soldi e forse avranno fatto anche qui quei loro pellegrinaggi annuali portando in processione statuette e mummiette di gatti morti. Può darsi anche che la colonia abbia posseduto qualche gatto vivo, ma se questo accadde, non lo lasciarono certo bazzicare con un popolo profano. Roma, comunque, superò tutti i primi secoli dell’era volgare senza gatti e solamente dopo il mille essi assunsero la cittadinanza romana. Non scelsero un periodo buono. In quei secoli carichi di eretici, di demoni, di stregoni, furono ritenuti diabolici anche loro e come tali perseguitati, processati, farsi vivi. Un santo, a cui sua madre aveva raccontato di averlo sognato prima che nascesse come un cane bianco e nero a guardia di Dio, immaginò, addirittura il demonio con le sembianze di un gatto. Forse oggi i gatti randagi preferiscono adunarsi intorno al Pantheon per una specie di rivincita. Se ne stanno ora intorno al tempio come gente ritornata a casa propria ed è strano che, pur avendola lì a due passi, non si avvicinino mai alla Minerva. 210 Paese Sera, 20 maggio 1950 Una strada di Roma collocazione: Pg 5-8. A Roma si arriva, da Roma si può anche partire se non ci si resta, ma per Roma non si transita. Roma è una meta, non è una strada. Forse per questo ogni sua espressione, materiale o spirituale, simbolica o storica, assume il significato della strada. Ne deriva che le strade a Roma sono di tutti i generi e le genti che questo hanno capito, verso di lei, o contro di lei, hanno sempre camminato. Anticamente nel Foro era segnato il centro della città che rappresentava anche il centro ideale del mondo gravitante verso quel punto. Accanto c’era una colonna dove erano scritti in oro i nomi delle strade che simbolicamente partivano da quel centro, e la loro lunghezza in miglia. Forse apparve come il superstite rullo da cui s’erano svolte quelle strisce di pietra avanzanti a raggiera sino ai confini del mondo. E insieme con quelle strade procedevano quelle che era allora la civiltà di Roma, quella che era allora la sua lingua; regolarmente ne ritornavano oro, schiavitù, cultura. Il suo fiume prima di essere gonfio di leggenda e di storia prima ancora di essere dio, certo fu strada e strada rimase anche quando non fu più dio. Le acque che arrivano a Roma sono pellegrine fragorose camminanti sulle arcuate strade aeree, insinuantesi per quelle sotterranee grandi come criptoportici. Le cloache sono strade sepolte protette da un cielo di travertino, per l’andare nascosto di ciò che di sopra avanza alla vita. Il Diritto fu una strada aperta e battuta attraverso la foresta dell’arbitrio per un cammino meno storto della giustizia. Strada semovente fu il trionfo pagano prima, e la processione cristiana poi. Strada di purificazione il millenario pellegrinare dell’umanità a questa mèta. Strada d’interiore elevazione l’affluire qui dei grandi spiriti del mondo. Strada d’arte vitale quella degli ertisti che costituiscono un ininterrotto pellegrinaggio senza punte giubilari. I secoli hanno portato a Roma pellegrini di tutte le specie: della fede, della curiosità, dell’arte, del lavoro. Tutto questo pellegrinare del mondo verso Roma conferma la ricchezza intuita di strade d’ogni genere: della morale e del pensiero, dell’arte e della vita, del cuore e della fede, strade invisibili lanciate di qui all’assalto del cielo. A Roma ci sono una piazza a una via intitolate ai pellegrini; ma di vie ce n’è un’altra, per quanto non sia una strada comune perché sta dentro una chiesa. La chiesa si chiama Trinità dei Pellegrini ed ha accanto una casa dove quattro secoli fa, esattamente nel Giubileo del 1550, San Filippo Neri aperse un ospizio per quei pellegrini che, dopo essere arrivati qui attraverso le strade del mondo, non trovando posto altrove, rischiavano di pernottare nel proseguimento cittadino di quelle strade. A giubileo finito la casa continuò ad essere per i pellegrini, ma d’altro genere: per i reduci dalle prigioni che per anni e anni avevano percorso la 211 strada dura dell’espiazione; bisognava considerarli malati di stanchezza per il pesante viaggio, e quella diventò come una casa di convalescenza. La via dunque è dentro la chiesa, ma non c’è a tutte le ore. Appare intorno al mezzogiorno, quando il sole batte contro una finestra e con la forma di questa, entra nella chiesa, ne attraversa obliquamente la penombra e si schiaccia sul pavimento come una lastra di luce. Di questi raggi, aeree strade luminose, le chiese di Roma sono ricche. S. Pietro, dove non c’è ora di sole senza gloria di raggi, naturalmente, ne detiene il primato. Ma questo della Trinità dei Pellegrini è diverso; è un raggio più solido e non è solo il fumo dell’incenso, raccolto nella minore ampiezza dell’ambiente, a dargli maggiore consistenza; la consistenza ce l’ha in sé. Forse la scala del sogno di Giacobbe assomigliava a questo raggio meridiano perché ad andargli vicino, dove poggia in terra, pare di potercisi innalzare ed evadere. Di dove però se la finestra è, sì, altissima, ma chiusa? Comunque, quel raggio è sicuramente il segno luminoso della strada ; è la vera Via dei Pellegrini, non limitando il termine ai calmieri e ai romei, ma allargandolo sino alla comprensione di tutti i viandanti della vita. La strada unisce; e quella della Trinità dei Pellegrini è unita essa stessa, nella sua forma perfetta senza divergenze e sbavature, fatta solo di tremore di luce. Per la sua salita può andare il pensiero e anche il cuore che è più pesante, ma non lo potrebbe la divisione che va sempre armata e le armi, di qualunque genere, spirituale o materiale, precipitano, non salgono. Affondano nella terra, nella carne degli uomini, nella loro anima, scavano la buca immane di un inutile dolore. Inutile perché evitabile. Per questa strada solare attraversante la chiesa dei viandanti probabilmente passò l’anima di Mameli che morì nell’ospizio di Filippo Neri. E perché era poeta, forse quella strada inconsistente sopportò il ricordo della guerra, aiutandola a salire anche con quel peso. 212 Paese Sera, 3 giugno 1950 DA QUATTRO ANNI ABITA IN UN LUOGO RICCO DI SUGGESTIONI E DI STORIA La Repubblica sta sul Quirinale tra le antiche memorie e le bugie Il colle più alto di Roma e il più salubre – Un minestrone ad arco che illumina soltanto uno sgabuzzino da cui si affacciavano i papi e i re – Il panorama più bello della città minacciato dai palazzi che sorgono con troppa fretta e troppa ingordigia d’altezza collocazione: Pg 9-11. Per i bambini e i provinciali semplici, immaginare dove stia il Governo è difficile, mentre è facile sapere dove sta la Repubblica. Sta sul Quirinale, dove stava la Monarchia, e prima ancora, il Papa-re. Da quattro anni la Repubblica sta lassù anche se, per un po’ di tempo, si appartò a palazzo Giustiniani. Monte Cavallo è un colle un po’ difficile a capire anche lui, è contraddittorio, sotto alcuni aspetti persino equilibrista, ma nonostante tutto simpatico, per quella sua aria segregata, quasi separatista. Un colle che fu così paganamente savio nei tempi antichi che il nuovo paganesimo rinascimentale risbucò fuori di lì. Era il colle più alto di Roma, per conseguenza il più salubre, ma prese ugualmente le sue precauzioni nonostante l’immunità altimetrica, e provvide ad elevare un tempio alla Febbre nel suo punto più alto, perché al malanno dello stesso nome fu interdetto l’arrampicarsi lassù dove Venere, tra i tanti suoi appellativi, era onorata con quello più pratico ed universale di “felice”. Roma aveva già da un pezzo il suo tempio alla Pudicizia Patricia, quando, con un senso di simpatica equanimità o di calcolata prudenza, sul Quirinale fu elevato quello alla Pudicizia Plebeia. Nell’aristocratico colle pareva che avesse dovuto meglio trovar posto l’altro che invece era al Foro Boario. E anche uno dei massimi templi del colle, quello al dio Quirino, dalle cui rovine si preleveranno i marmi per la scalinata di Ara Coeli, presenta lo stesso dubbio per due piante di mirto che si coltivavano avanti al suo ingresso: una dedicata ai plebei, l’altra ai patrizi. Pare che le due piante prosperassero o intristissero ognuna d’accordo col montare o col decadere della rispettiva classe. Però della morte di quella patrizia, qualche ricordo c’è, dell’altra nulla si sa; forse fu trapiantata e visse, forse vive ancora. Tra templi simpatici e altri un poco ambigui, abitò gente simile. Tra quella simpatica emerge Marziale che, soffrendo per la sua condizione di cliente, viveva solo, al terzo piano di quella insula dove il frastuono dell’acqua che scrosciava lì presso, gli dava ai nervi, acuendogli il desiderio che almeno un poco ne salisse fino a casa sua. Ma essa serviva per usi aristocratici. In un certo senso assomigliava a Marziale, Pomponio Leto che abitò lassù tanti secoli dopo, quando il colle era già passato dallo splendore imperiale all’abbandono dell’alto Medio Evo; dal periodo in cui tra le sue rovine solitarie si nascondevano gli eremiti, a quello in cui i primi conventi avevano riportato un cenno di vita tra le boscaglie e i ruderi. 213 Pomponio Leto che sdegnò la sua ricca parentela, che restò per la vita il fedele innamorato di ogni sasso antico, di ogni parola antica, che raccoglieva le parole e le spiegava in quella sua scuola dove arrivava prima dell’alba con la lanterna in mano; che raccoglieva i sassi nella sua casa e nel suo giardino come facevano anche gli altri umanisti che s’erano isolati lassù dove le loro case e i loro giardini furono i primi musei dell’età nuova. Pomponio aveva certo sussultato quando scoperse che la sua casa sorgeva proprio sul luogo dove era stata quella di un altro Pomponio, l’Attico, il simpatico e geniale amico di Cicerone che viveva accanto al tempio della Salute. Per lui quei luoghi si ridestavano dal sonno dei secoli. Vicino a quella di Pomponio era la casa del Platina, intorno a loro si raccoglievano tutti gli amanti del passato. Pomponio coltivava un boschetto di lauri per incoronare i poeti dell’Accademia. In quel periodo il colle, coperto di orti scoscesi, carico di imponenti rovine, dove ancora le terme Costantiniane non erano state abbattute per far posto al palazzo Rospigliosi, fu veramente simpatico. Ma quei benedetti umanisti facevano tanto chiasso intorno al loro rinato paganesimo, che la curia, per quanto a malincuore, dovette vigilarli e quando Pomponio chiamò il Platina “Pater Sanctissimus”, trovò che c’era materia sufficiente per sospettarli eretici. Il sospetto diminuì la pace di quegli strani uomini, poveri e ricchi nello stesso tempo, che risuscitavano il passato per amore. Come mecenate aveva desiderato un po’ d’acqua, Pomponio aveva sognato di essere sepolto sull’Appia. Morì invece all’ospedale così povero che una povera sepoltura dovettero pagagliela gli amici. Gli umanisti s’erano insinuati al Quirinale tra i conventi e le vigne, nel luogo dove s’era già sgretolata una fortezza dei Crescenzi, poco prima che il colle cominciasse a subire la più grande delle sue trasformazioni; quando ville e palazzi principeschi se ne impossessarono, facendo delle antiche costruzioni ripiani e terrapieni per i loro giardini pensili che colonne e statue ornavano insieme con gli alberi e i fiori; quando le antichità che ostacolavano le nuove costruzioni venivano abbattute senza rimpianto. Ormai esse non erano altro che un complemento del fasto. Gli umanisti che alle rovine chiedevano testimonianza di una vita passata, erano morti e sulle loro case abbattute si costruirono le stalle per il palazzo che era già sorto, tanto grande da poter assumere addirittura il nome del colle. Dopo qualche tempo le stalle non si chiamarono più così, ma rimesse. Costituirono quel fabbricato basso che è tuttora di fronte al palazzo del Quirinale. Attraverso lente, ma continue trasformazioni, il colle è arrivato allo stato attuale con un carattere un poco bugiardo. La bugia più nota è quella scritta sul piedistallo dei due colossi che li indica come opera di Fidia e di Prassitele. Ma nel gruppo c’è una bugia che si potrebbe chiamare costituzionale: i due uomini risultano molto più grandi dei cavalli. E pensare che proprio su quelle due statue sorse la leggenda dei due giovani che si erano presentati completamente nudi a Tiberio che ne aveva chiesto il motivo. “Perché noi conosciamo la verità delle cose”, avevano risposto e gliene fornirono la prova. Si patteggiò allora tra l’imperatore e i due: questi avrebbero taciuto ciò che di lui sapevano, egli avrebbe innalzato a loto un monumento. E ora da secoli stanno piantati lì, nudi, sì, ma dritti proprio su una bugia. E anche la grande loggia sopra il portone del palazzo, alla quale guardano torcendo la testa agli Apostoli, è pure una bella bugia. Un minestrone ad arco, ampio, slanciato, aperto di fronte al sole nella vastità 214 dell’altezza, deve inondare di luce un salone immenso. Niente affatto. Dietro a quella loggia c’è un piccolo vano come uno spogliatoio. Lo sgabello che c’era una volta per conferire altezza e maestà alle persone che si sporgevano di lassù per l’ostensione delle loro facce, pareva quasi un mobile troppo grande per l’ambiente. Del resto quel palazzo espresse anche bugie psicologiche oltre alle architettoniche. Di lì, in un pomeriggio autunnale, dopo che i cardinali travestiti erano fuggiti, uscì anche Pio IX travestito da prete. Un uomo travestito è una bugia vivente. Bisogna tuttavia convenire che questa fu la più innocente che uscì di lì.. Scendendo per la via 24 Maggio, s’incontra una facciata alta con cinque finestre chiuse tra due portoni di cui uno solo è aperto. Questo muro con le sue inutili finestre non è che il paravento che nasconde un palazzo; tra i due c’è un vasto spazio dove si raccolgono irrequieti e stridenti tanti uccelli che non oltrepassano mai quel finto frontespizio tinto però del più schietto colore romano. Dio fronte c’è la porta e la facciata della chiesa di S. Silvestro che sono una grossa bugia. La porta, tinta in verde, è finta; non c’è neppure accennata la divisione dei battenti, non c’è serratura, non ci sono cardini; la facciata è finta perché dietro non ha la chiesa che invece le sta arrampicata sulle spalle, restata lassù dov’era quando la strada non era stata ingentilita dal livellamento. Ma lo strano è che questa bugia attuale sta sul luogo dove anticamente c’era il tempio a un dio nominato col suo aggettivo: Santo, e come santo per eccellenza, veniva anche chiamato Dius Fidius, dio della fede, della verità, della giustizia, della semplicità. Difatti lì dentro era venerata anche una statua muliebre in atto di filare. Da tutto questo che si può dedurre per la nostra Repubblica che risiede lassù, il luogo è fasto o nefasto? Forse l’espressione vera di questo colle la dette un suo tempio a una curiosa divinità, Euelpis, che era qualcosa più della Speranza e qualcosa meno della Fortuna. Librata così a mezz’aria potrebbe significare la volontà umana. Se fosse così ci sarebbe da sperare nonostante che su quel colle la bugia lentamente progredisca. Adesso è diventata anche visiva. Da quella splendida balconata che forma un lato della piazza, è fama che si veda una delle più suggestive inquadrature del panorama romano. Comincia ad essere una bugia. Subito al di là della balaustra, si sono lasciate fare delle sopraelevazioni che hanno sfacciatamente tamponato gran parte della visione. Se si continua così ci si affaccerà di lì per guardare giù, la discesa della Dataria, come si guarda un fosso. 215 Paese Sera, 2 agosto 1950 Terminata la “Festa de Noantri” Trastevere torna ai trasteverini I misteriosi caratteri del popolare rione scompaiono d’un colpo una volta l’anno quando il pubblico vi si riversa da ogni parte della città collocazione: Pg 12-14. Tratevere è un rione piuttosto misterioso, ma una volta all’anno, durante la Festa de Noantri, pare che il mistero s’allontani, rendendolo un luogo comune di festa. Dipende, forse, dal fatto che la festa non è più monopolio dei trasteverini, ma composta, impastata, cotta e sfornata da un collegio di organizzatori tanto distante dalla vecchia festa, come la processione di ora lo è da quella “delli Bucaletti”. Benché, a guardar bene, nonostante lo sforzo dei medesimi di farne una fiera standardizzata, la singolarità del popolo trasteverino, come l’olio sull’acqua, galleggia sulla banalità. Ma chiuso ieri il periodo feriale col ritorno della Madonna trasteverina alla sua chiesa abituale, le vecchie strade del rione tornano ad offrire al passeggero attento i misteriosi caratteri millenari della gente e della terra trasteverina. Ha cominciato la Madonna che, rientrata a casa, spenti i lumi, riappare quella Madonna misteriosa che, galleggiando sul mare, arrivò sino a Ostia dove i marinai la pescarono affidandola ai trasteverini, quasi che in mezzo a loro, viventi su una strana terra di dune color oro, la pellegrina marinara, potesse trovare un ricordo del mare. Salutata la Madonna anche i trasteverini ritorneranno trasteverini. Capire perché essi stanno singolari e inconfondibili, è difficile, forse impossibile. Si pensa agli Etruschi che nel Trastevere furono forti, che di lì alzarono orgogliosi la fronte contro l’altra sponda, che qualcosa dei loro caratteri e dei loro lineamenti certo lasciarono al popolo trasteverino. Ma su quei lineamenti si ritrova anche l’antica statuaria romana e non è raro incontrare lì il volto delle linee classiche complicate col sorriso dell’Apollo di Veio. Certo che il popolo trasteverino fu sempre una comunità distinta anche nel suo carattere romano che in lui ebbe il risalto di una scultura. Roma antica aveva due limiti cittadini: le Mura e il Pomerio. Quelle costituite da massicciate e torrioni, erano una barriera strategica; questo, segnato solo da cippi tanto distanziati da conservargli il suo carattere simbolico, era un limite religioso, puramente sacro; al di qua i templi, i tribunali, le case, la gente, al di là gli accampamenti militari e i sepolcri. I Trasteverini furono gente raccolta al di là e in mezzo a loro potevano sorgere i sepolcri. Quel monumento funebre e ricostruito dentro le Terme di Domiziano, era qui, accanto al fiume, dove il Pomerio non aveva incluso quella terra di plebei che vivevano insieme con gli Ebrei esercitando i mestieri meno graditi. Lì c’erano i conciatori, i vasai, pescivendoli, i barcaioli, gli scaricatori di porto, i lanaioli, i molinari gli 216 incettatori di roba usata e di stracci, gli antichi capostipiti dei robivecchi. Ebrei e lavoratori erano un popolo vivente in povertà dentro a casupole spesso di lego, privo di quel conforto igienico che cominciava ad abbondare al popolo al di là del Tevere. E privo continuò ad esserlo anche quando alcune famiglie patrizie cominciarono a frequentare i loro “prata” trasteverini; anche quando Cesare vi creò i suoi famosi giardini, attenuandosi solo un poco quando ville patrizie ed imperiali si distesero lungo i fianchi dei mmonti trasteverini. Però, per il dilagare delle ville la povera gente si ammassò sempre di più in confini sempre più limitati. La distribuzione edilizia è presso a poco quella che era. Sul pendio dei monti Gianicolense e Vaticano, ville e giardini freschi e riposant, nella pianura lungo il Tevere, povere, povere case, officine, agglomerato di gente che suda e lavora. Nelle incursioni barbariche il Trastevere fu di nuovo abbandonato, ma la povera gente continuò a vivere lì, mentre le ville rovinarono e i giardini diventarono orti. Anche di lì, lungo il corso dei secoli, la terra ha restituito molte statue che emigrarono un po’ dappertutto. Quando il Medio Evo svolgeva la corsa dei suoi secoli e delle sue lotte, il popolo trasteverino si tramandava imperturbabile quei suoi caratteri che lo rende angusto senza l’ausilio di paludamenti. Eppure, siccome era operaio e operaio di mestieri così detti bassi, fu escluso dalle alte cariche, nessun trasteverino poté mai essere senatore. E proprio il Medio Evo trovò in quei popolani tenuti in disparte i difensori di tutte le giustizie e di tutte le libertà. Restarono nei secoli battistrada nel progresso della giustizia, magari a costo di essere quasi sempre la spina dei governi, perché nelle loro strade si tumulava, nelle loro case si congiurava e si moriva. Trastevere è una terra di mistero per certe sue indeterminate promesse spesso chiuse in una parola come quella che sta dentro il nome delle carceri. Nell’antichità questo luogo invaso spesso dalle acque del fiume, era piuttosto malsano, perciò fu scelto per raccogliervi i prigionieri di guerra, per trasferirci la gente dai paesi vinti. In epoca moderna si ritornò all’antico: Trastevere luogo per i carcerati. Il reclusorio sorse sul luogo di uno strano convento a cui il popolo aveva dato il nome di “Regina Coeli” perché quelle suore ogni quattro ore suonavano la campana in tono festoso per annunciare che scendevano in chiesa a cantare l’antifona della letizia: “Regina Coeli laetare, alleluia!”. Invece di richiamare ogni tanto il pensiero del peccato o della morte, esse richiamavano quello della letizia. Gli abitanti del rione se entravano in chiesa facilmente erano accolti dall’alleluiare delle suore, che stavano in casa, li veniva a trovare il suono festoso della campana. Sono scomparse le religiose, scomparsi il convento e la chiesetta, ma resta un nome promettente letizia. 217 Paese Sera, 27 febbraio 1951 LA CERIMONIA AL LICEO “VISCONTI” Una bella funzione collocazione: Pg 15-17. C’è uno che dice di ricordare il giudizio universale come se fosse già avvenuto e racconta che, a operazione ultimata, dopo che giudici e giudicati avevano sgombrato il cosmico tribunale, quando le piante dei piedi delle ultime pattuglie dei beati sparivano tra le nuvole altissime e tutti i dannati erano già precipitati nelle tenebre dell’abisso, per lo spazio vuoto e spento passò un piccolo gruppo di ritardatari che se ne andavano chiacchierando, lenti e tranquilli, verso l’abisso che impazientemente aspettava di potersi richiudere per l’eternità. Ma quella gente non aveva né fretta, né paura e quando fu vicina a quello spettatore che ricorda ciò che sarà, uno della comitiva disse: - Tutto sommato, però, è stata una bella funzione! - Ho capito, sono romani – pensò lo spettatore. - Giacché è noto che essi, a forza di vedere spettacoli di tutti i generi, sono indifferenti a tutti e tutti li accomunano nel nome di quelli che sono più usuali. “E’ stata una gran bella funzione!” Si sentiva dire venerdì mattina tra la folla che usciva dal Liceo “Visconti” dopo la “solenne commemorazione del IV centenario della fondazione del Collegio Romano”. La differenza tra il Giudizio Universale e la cerimonia del “Visconti” stava nel fatto che per questo l’aggettivo era ironico, ma l’appellativo no. Bella, no, di certo, ma funzione, di sicuro! Doveva venire il Ministro Gonnella e, quasi per istintiva delega, tonache ecclesiastiche, fratesche e monacali riempirono l’Istituto. L’oratore ufficiale è stato il fratello di Padre Lombardi suscitando il sospetto che anche lui fosse un delegato, giacché dovendo la commemorazione consistere nell’esaltazione dell’opera dei gesuiti, non sarebbe stato di buon gusto che la medesima venisse snocciolata direttamente da un gesuita. Già il tono introduttivo del Preside Piersanti e del suo lungo latino, ci aveva posti in una aria di arcaica riesumazione, staccata da oggi. E l’oratore ci spinse subito indietro, nel cuore del ‘500, naturalmente in un solo limitato settore ecclesiastico del tempo, nel quale non trapela un cenno della vita di fuori. Egli non riesce a tirarci fuori da quell’aria stagnante neppure quando ci mette in evidenza che la fondazione dell’Istituto avveniva 60 dopo la scoperta dell’America! Nomi di Pontefici e di Cardinali, tanti! Benemerenze della Compagnia di Gesù, tante! E tutto questo sarebbe stato giusto se non fosse stato indubbio il tono di rivendicazione delle glorie clericali dimenticando tutte le altre. Nella parola di quell’oratore non era il passato che si trasfondeva nel presente, ma era il presente che veniva respinto nel passato e annullato. Quando pur dovette accostarsi ai tempi moderni, sorvolò sul “fatale” ’70 giustificandolo col 1929! 218 Nessun ricordo degli studenti che, usciti di lì in questa prima metà del secolo, hanno occupato con onore posti di altissima responsabilità; nessun ricordo di quelli che hanno raggiunto meritata fama nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze; nessun ricordo per i martiri della liberazione e delle Cave Ardeatine; anzi si avvertì una apprensione che qualcuno li ricordasse. Dalle parole dell’oratore parrebbe che in quel glorioso liceo nulla si sia fatto più da quando fuggì dalle mani dei Gesuiti, salvo che un po’ di comune esercitazione scolastica. Si parla del “Massimo” piuttosto e non potendo rimanere a lungo lì, si tornerebbe volentieri a parlare di Gesuiti, di Innocenza, di Gregari. Ma, per fortuna, anche nel suo periodo laico il Liceo “Visconti” offre qualcosa su cui il fratello di P. Lombardi si può trattenere. E’ il giovinetto Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII che frequentò l’Istituto. Giustissimo parlare di questo, gloriarsi di questo, ma allora deve anche essere ricordata l’anima santa di quel grande dotto che fu don Primo Vannutelli. Non perché fosse dotto (di dotti, di uomini di gran valore, di presidi emeriti dei quali non s’è fatto cenno, il Visconti ne ha avuti tanti!), ma perché don Primo Vannutelli è passato tra noi imitando Cristo. In conclusione questa cerimonia è servita per fare in una scuola laica l’esaltazione dell’insegnamento clericale. Tutto è stato disposto in funzione clericale , persino la banda dei carabinieri che ha aperto la celebrazione non con l’inno nazionale, come si suole, ma con una neutra sinfonia. Però alla fine, dopo che i prelati erano riusciti, è stato suonato l’inno di Mameli. Alla fine, invece che al principio, quando i pezzi grossi se ne erano andati e non quando entravano. Io mi sono divertita a guardare una donna che s’era messa sui capelli un fazzoletto da naso come si fa in chiesa quando non si ha altro copricapo, ma non ho capito se l’aveva fatto per ingenuità o per ironia. La conferenza del fratello di P. Lombardi si chiuse con una massima di S. Ignazio, e anche questo è stato giusto, come giusta e bella è stata la conclusione con il “Te Deum” cantato in S. Ignazio. E’ una delle chiese più romane di Roma e in quella sua meravigliosa chiarità silente, il canto della folla, larga e bassa sotto l’altezza tranquilla del tempio, pareva il sospiro dell’erba verso il sole. Ma non è stata giusta, né di buon gusto la distribuzione che è stata fatta di un opuscolo stampato nel ’40, con le rituali esaltazioni fasciste, i ridicoli saluti al re-imperatore e al duce, conclusi con la chiamata finale: “Camerati, evviva Pio XII!” 219 Paese Sera, 6 giugno 1951 La nuova chiesa di S. Eugenio collocazione: Pg 18-19. E’ stata costruita, consacrata ed aperta al pubblico una chiesa dedicata a S. Eugenio e offerta in dono al regnante Pontefice Pio XII che fu battezzato col nome di Eugenio. Succede spesso, quando si erige una chiesa in omaggio a un Papa, che la si dedichi proprio a quel santo il cui nome egli abbandonò nell’ascendere al Pontificato. Sarebbe una specie di risarcimento di danno. Così sorse S. Gioacchino, così è sorta S. Eugenio. S. Eugenio, chiede la gente, e chi lo conosce? Chi ha mai sentito il bisogno di pregare S. S. Eugenio? I santi del martirologio sono migliaia, ma quelli usuali non tanti; assai meno dei 365 che ogni lunario applica a ogni giornata. S. Eugenio è sì tra questi, ma tra gli sconosciuti. Quando cade quel nome lo sa solo chi ci si chiama e i suoi prossimi parenti ed amici, il resto della gente lo ignora. Per quanto un altro S. Eugenio che non si trova sui calendari, quello cartaginese, faccia più simpatia per la sua aspirazione all’unità e per aver consumata la vita per le strade tribolatissime degli esili, anche questo S. Eugenio, di cui il 2 giugno è il dies natalis, come la Chiesa chiama splendidamente il giorno della morte, non dispiace affatto. Forse perché fu romano di nascita e di sepoltura, forse perché s spera un poco nel suo aiuto per il raggiungimento d’una stabile pace nel mondo intero, dato che sopra alla porta di questo tempio che certo egli non s’aspettava c’è una sentenza: Opus justitiae pax. E’ bella ed è vera; sul suo significato siamo tutti d’accordo; però adesso si tratta di lasciare sul serio che la giustizia operi. S. Eugenio, che da noi comincia ora la sua carriera di santo officiato, potrebbe, con lo zelo che accompagna sempre l’assunzione di una carica, aiutarci davvero a stabilire la giustizia tra di noi. La chiesa proprio bella non è, anzi qualcuno dice senz’altro che è brutta. Ma brutta o bella che sia, porta almeno sui suoi muri e sugli edifici annessi, il colore di Roma. Oramai sono così rare le costruzioni nuove che ripetono quel nostro colore di terra arrossata cotta dal sole, che quando ne sorge qualcuna che non sia color pisellino o bianco-calce, ma di quella tinta calda, intensa, suggerita dal nostro orizzonte e dal nostro clima, si è disposti ad assolvere anche più di una stonatura architettonica. Se in S. Eugenio stonature ci sono, il colore le assolve, ma certo esso non arriva ad assolvere la cupola. Alla chiesa costruita nell’ambito dell’E 42, misero sopra qualche cosa che, data l’epoca in cui sorse, parve una specie di elmo chiodato. A questa, forse in omaggio all’Anno Santo, nel quale doveva essere dedicata. Anno Santo caratterizzato dai preti in basco, hanno messo sopra un qualche cosa che comincia come berretta e finisce come basco. Però l’interno è accogliente. Vista di dentro si capisce che è una chiesa dove si potrà pregare. E una chiesa solo così raggiunge il suo fine. Certo lo raggiungerebbe meglio se l’aiutasse il suono delle campane che invece perde di fervore meccanizzato com’è. 220 Intorno a questa chiesa, come a tutte le cose nuove, s’intreccia un mormorio di pareri contrastanti, c’è chi dice che la sua erezione sia stata opportuna e chi no. Questi sostengono che quando il Papa accettò il dono che il popolo cristiano chiedeva di potergli offrire, avrebbe fatto meglio a cambiarne la forma: invece che per una chiesa, devolvere gli stessi capitali per una borgatella intitolata a S. Eugenio dove avrebbe trovato un minimo di casa quella gente che, proprio in vista del tempo, vive nei buchi dei Monti Paioli. Il Santo sarebbe stato onorato lo stesso e il popolo lo avrebbe conosciuto sotto un aspetto più simpatic, trasferendo rigogliosa in Lui quella speranza che ora cresce stentata intorno ai nomi di Aldisio e di Fanfani. Gli uni dicono che il Papa deve pensare prima alla gloria di Dio e alla salute delle anime; gli altri ribattono che è giusto, ma che in quella zona non v’è penuria di chiese; oltre a S. Croce v’è la deliziosa chiesetta di S. Andrea, non lontana quella di piazza Euclide e del gruppo non indifferente del Popolo, 3 sulla piazza e 2 all’estremità del Corso dove chi ha fretta trova Messe tutti i quarti d’ora. Che la gente di questo quartiere sia eccezionalmente pigra? Ma se la si contenta troppo finirà col volere il servizio dei Sacramenti a domicilio, giacché la fretta che invade tutta la vita, non risparmia la religione, diventata per i più un dovere da sbrigare come con le bollette della luce e del gas. Questi scontenti per costituzione, per poter essere scontenti, non vogliono pensare che il Papa possa saper meglio di loro se e dove porre le sue chiese. D’altronde, dicono gli altri, prima di fare delle critiche in nome di una solidarietà, spesso retorica, per i cavernicoli, per i senzatetto, per gli accampati, bisognerebbe vedere quanti di loro affluiti qui, al paese d’origine invece di una grotta o di una baracca, potrebbero trovare una casa se non ce l’hanno già. E concludono che l’erezione di una nuova parrocchia era inderogabile. Tra gli infausti e i rancidi un rimandarsi di colpi come al gioco del tamburello, a base di “la merita”, “non la merita” e ognuno si fortilizza dietro un suo motivo che è poi il suo punto di vista. Vi è chi dice che non è adatta una chiesa a chi non rifiutò per la sua famiglia successivi graduali titoli nobiliari, per cui sarebbe stata più conforme l’offerta di un palazzo gentilizio. Vi è insomma chi vorrebbe i Pontefici, sotto certi aspetti, tutti simili a Pio X e a Benedetto XV. Questo gli rimprovera un peccato contro l’unità attribuendogli una certa frase intorno alla divisione del mondo. Quell’altro brontola perché, secondo lui, una volta avrebbe ringraziato il Signore di aver stabilito i ricchi. Tutti i mormorii a vuoto perché nel discorso di un Papa spesso c’è tutto; pare un dire poliedrico e ognuno vede la faccia che per il suo punto di vista è in luce. Non condivido queste critiche, però sono tra quelli che dicono come questa chiesa, per quanto mediocre, a Pio XII non si confacesse; ma il mio punto di vista è in un campo estetico-sentimentale e s’appunta proprio nel nome, in quel bellissimo nome di Eugenio. S. Santità si chiamava Eugenio quando fu eletto al Sommo Pontificato. Eugenio significa nato bene, c’è in quella parola un senso di nobiltà e di sanità. Egli nqcque un due marzo e si chiamò Eugenio. Sessantatre anni dopo, lo stesso giorno, uscì dal conclave Sommo Pontefice, qualcuno vociferò che fosse avvenuto anche alla stessa ora in cui era nato. E perché, data la meravigliosa coincidenza, per la quale quel nome veniva ad acquistare interamente e supremamente il suo significato, perché Egli non lo conservò? Sarebbe stato Papa Eugenio V. 221 Tutti e quattro i papi di quel nome sono stati eccezionalmente attaccati a Roma, due di essi furono romani. Egli sarebbe stato il terzo romano tra cinque Eugeni. Eugenio I, il santo, era stato deposto proprio nella basilica vaticana, forse c’è ancora e gli sarebbe stato vicino. Eugenio III, il beato abbellì, amò, vagheggiò la Basilica di S. Maria Maggiore dove Egli disse la sua prima Messa. Eugenio IV, il protettore del Colosseo, degli umanisti, delle università, degli artisti, il restauratore del Pantheon e del Laterano, il propugnatore della unità della Chiesa, ebbe la persona alta, macilenta, grave, ascetica, proprio come quella di Eugenio Pacelli. Perché non conservò quel bellissimo nome? Oggi la chiesa di S. Eugenio, invece di suggerire il senso di una riparazione, squillerebbe le note di un duplice trionfo. E anche la cristianità sarebbe stata rincorata da un nome nuovo. E’ un po’ stufa di quel “Pio” che, bello nel significato, ma brutto nel suono, pigola da troppo tempo nella sua vita. In appena un secolo e mezzo Pio VI, Pio VII, Pio VIII, Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII; si compiva sì la dozzina, ma oramai erano troppi. Un nome nuovo avrebbe anche data la speranza nuova a questa povera umanità che passa da un dolore nuovo all’altro. Avremmo visto, è vero, interrompere la consuetudine dell’assunzione di un altro nome nell’ascendere al Sommo Sacerdozio, ma l’interruzione di una consuetudine a volte è benefica, come per le medicine di cui ogni tanto si interrompe l’uso perché giovino meglio. E la cristianità che nel 1939 presentiva l’orrore di quel che poi successe, nel vedere alzarsi sull’alto trono papale l’alta figura di Eugenio V il Papa che non rinunziava al Suo nome perché il nome era bello, perché Cristo l’aveva chiamato a rappresentarlo sulla terra nel chiudersi esatto del cielo solare che conta gli anni della sua vita, confermando vero ciò che il nome significava, la cristianità avrebbe trovato in questo fatto uno dei tanti appigli a cui si aggrappa per non affogare. Ma se avvenisse che Egli diventasse ora tramite tra S. Eugenio e noi per darci la pace e l’unità, allora tutti troveremo che anche il nome di Pio non è brutto e che la Sua rinunzia ad Eugenio ha contribuito a preservarci dalla guerra. 222 223 Paese Sera, 1 settembre 1951 Trastevere: terra dove ogni leggenda è vera collocazione: Pg 20-22. “Ora incomincio il tuo inno di lode, o Trastevere!” Per lo spazio di un secondo, tanto da stendere la mano per prendere la penna, ho creduto che avrei scritto così. Una di quelle tante pulviscolari condizioni, brevi più di un respiro, che si avvertono come vere e nell’immediato finire sono già false. Sciogliere un inno di lode a Trastevere! E’ semplicemente ridicolo. Trastevere si dice. Nel dirlo qual è il suo massimo elogio, e nel riconoscere l’impossibilità di farlo compiutamente è la confessione della sua grandezza. Trastevere tutto fatto di terra color d’ora. Di terra color d’oro il monte, di terra color d’oro la pianura che si abbassa sotto l’acqua a reggere il passaggio del fiume che porta sciolto quel colore. Il S. Pietro trasteverino sta su un monte d’oro, “in montorio”. I santi Cosma e Damiano di Trastevere, riuniti per amore di brevità popolana in San Cosimato, sono detti “in mica aurea” e così altre chiese e anche un piccolo cimitero dove i morti dormono in mica aurea. Trastevere, estremo ramo di gente etrusca che si fermò sulla sponda destra del fiume a guardare la grandezza nascente della gente latina all’opposta sponda. Roma crescente lo fissava sospesa e non volle col Trastevere risoluto ponti duraturi; ne bastava uno solo e purché fosse di legno, materia soggetta all’ascia e al fuoco. Trastevere che è poi stato sempre un poco una piccola Etruria, che è tuttora una piccola Roma nella grossa Roma come il giallo di un fiore è il cuore di un fiore. Trastevere che di fronte alla Roma dei sette colli, fu e restò la Roma di un solo colle, ma del più alto, Trastevere è stato sempre temuto.; è troppo dignitoso e fiero. Trastevere, terra dove forse la leggenda è vera tanto essa è umana, e dove la verità è leggendaria tanto essa è bella. Bella come l’aspetto statuario della sua gente, di quella poca che ci resta veramente trasteverina. Trastevere, dove ha le fondamenta e i muri la casa Cecilia e dove aleggia la musica della sua storia. Storia che forse è confusa con la leggenda, ma dove c’è un dato così reale che si può toccare: l’atteggiamento squisitamente penoso della martire. Così come potrebbe non essere leggendaria la pietra su cui si inginocchiarono gli angioli avanti a S. Pietro morente, proprio perché è una pietra senza orme miracolose; l’orma sarebbe un falso perché gli angioli non ne lasciano. Trastevere, terra da cui scaturì la fonte pacifica dell’olio, “fons olei” c’è scritto nel punto dove sgorgò quando il re della pace stava per apparire sulla terra. Quel punto sta dentro S. Maria, una delle più belle chiese del mondo, proprio dalla parte del campanile che ostenta l’unica campana ribelle di tutta Roma, la sola che sia uscita fuori dalla sua cella. E’ una campana trasteverina, all’occasione sarebbe una specie di Giuditta Tafani Arcuati. 224 Trastevere che, come solleva oggi una campana al di sopra di un campanile, sollevò, tempo addietro, sulla sommità di una torre la grotta del Presepio. Era mezzo rovinata allora la torre degli Anguillara, non era pareggiata e lustrata come lo è oggi, ma proprio per questo poteva con più verità portare una grotta verso il cielo. E il cielo, i colli laziali, tutto il movimentato e largo panorama romano, facevano da ambiente vero alla grotta finta. Trastevere si fa amare anche per i nomi delle sue strade e per i miracoli che, sparsi per il rione, vi lasciarono nomi e monumenti. Per questo tra Merangoli, Polveraccio, Fienaroli, Botticella, Moro, Fico, troviamo Luce, Scala, Orto. Una casupola s’accese di luce come un sole per la impaurita preghiera di un cieco, ecco la Luce. Una ostinata e muta Madonna di un sottoscala, dovette rispondere alla trasteverina che la rimproverava seccata di aver chiesto invano: “Eppure se tu chiedessi a me un favore, io te lo farei subito!” e la Madonna per non essere da meno, le raddrizzò il figlio, cosa che era la sostanza del favore richiesto, e venne la Scala. In via di Monte Fiore, è il ricordo di tanti giardini fioriti sulle rovine della caserma romana e forse solo ora non si narrerà più della bella Frola (Flora) che stava in mezzo a quei giardini. Qualunque ne sia la ragione, è bello che Trastevere abbia una strada chiamata Roma Libera. Tutto il mondo è pieno di sepolcri e dappertutto ci sono tombe con un angelo o un genio nell’atto di spegnere la falce, simbolo della vita, capovolgendola contro terra, ma solo a Trastevere in una tomba così, fu scolpito: “Buona notte, mastro Jacopo”. Io sostengo che bisogna amare Trastevere anche per quel “buona notte”. Bisogna amare Trastevere per lo zelo con cui la sua farmacia, la seconda di tutta Roma, si occupò di diffondere farmaci per sedare gli isterismi femminili. Bisogna amare Trastevere che fu sempre in prevalenza terra di lavoratori, tanto che S. Benedetto di lì portò via il suo “prega e lavora”. Bisogna amare Trastevere perché S. Francesco lo scelse per sua dimora e per quella del suo primo convento romano; tutti sappiamo quali erano i suoi criteri di scelta. Dobbiamo amarlo perché il Petrarca fu incoronato poeta da un trasteverino; perché sul Granicolo trovò l’estremo rifugio il Tasso; perché qui Raffaello incontrò la gioia viva della sua vita. Capita di divagare così col pensiero, vagando per Trastevere; capita di pensare a queste e a tante altre cose perché la ricchezza del rione è inesauribile tanto che si possono anche incontrare frammenti di vita simili a pensieri. Può capitare, per esempio, di fermarsi in piazza S. Apollonia, dove s’alza la facciata di S. Margherita e di pensare che è giusto che la piazza si chiami così, perché S. Margherita c’è e ognuno la vede, ma S. Apollonia non c’è più e vive solo nel ricordo dove si rifugiò la Fornarina dopo la sua avventura semidivina. E può capitare che riaffiori d’aver sentito dire che da quelle parti doveva esserci murata una lapide a ricordo di un abbraccio. Sì, l’abbraccio di Garibaldi con quella gente che aveva votato per lui allora che vivo, come pare che continui a fare ora che è morto. Capita di guardare tutto intorno i muri delle case per ritrovare la lapide e nel vedere solo una scrostatura regolare sul rivestimento di un muro, di cadere subito nella colpa del giudizio temerario “l’hanno tolta!”. Capita di rivolgersi a un uomo che sta dritto sotto l’arco di una porta e di chiedergli: “Stava lì, è vero, la lapide dell’abbraccio di Garibaldi?” E di sentirsi rispondere che la lapide non 225 sta fuori, ma dentro casa, che non ci è stata portata, che è stata sempre dentro, perché il comizio dove avvenne l’incontro tra Garibaldi e il suo Trastevere, fu in un teatrino che ora è un magazzino, che la lapide c’è tuttora, ma non si vede più perché tutte le paret sono state scialbate. Capita di entrare col cortese informatore in un grande magazzino pieno di casse e di mastelletti di marmellata di disturbare un gruppo di uomini che stanno evidentemente discutendo di affari, per farsi dire dove è la lapide, di guardare fisso nel punto indicato e di non vedere nulla, altro che del muro come tutto l resto; il salire allora su di una seggiola e di ritrovare con i polpastrelli delle dita, come nella lettura della scrittura Braille, le lettere dell’iscrizione. Capita che gli uomini attirati dal nome di Garibaldi interrompano il loro lavoro, si avvicinino e leggano correntemente in criptografia, come se vedessero le parole, rendendo quasi inutile la proposta avanzata e caldeggiata di togliere lo scialbo e di ridare l’inchiostro alle lettere incise, perché è vero che la lapide è nascosta dall’intonaco, ma è vero anche che quegli uomini la sapevano tutti a memoria. Inutile dire, inutile fare, lo spirito di Trastevere fu e resta “naturaliter popularis”, naturalmente repubblicano. 226 La Via, 15 novembre 1952 La via di tutti i popoli collocazione: Pg 23-27. C’era una strada a Roma divisa in due nel senso della lunghezza da una fila di case che proprio per questo si chiamava “Spina”. Ne risultavano due stradine come due corridoi tra case, palazzi, chiese, fontane e tante botteghe strette una addosso all’altra perché ci volevano stare tutte. C’era per quelle strade il brusio del paese e quello del mondo perché la gente di qualunque terra e di qualunque colore veniva a Roma, andava lungo quei due corridoi per sfociare in una immensità che era una piazza, per trovarsi di fronte ad una montagna di granito fatta di colonne, di porte, di finestre, di logge, di trabeazioni, di fregi e di cupole tra cui troneggiava “er cupolone”. Prima gli occhi tentavano di misurare la immensità di quella piazza, poi era il tempo a misurarla, il tempo che ci voleva per arrivare, un piede avanti all’altro, sino alla scalinata che portava all’ingresso di un’altra immensità, al tempio. Erano proprio quelle due strade strette e soffocate a preparare gli animi per meglio avvertire quelle due immensità. Si chiamavano “Borghi” così come erano dette le case raggruppate attorno ai castelli. Le aveva tracciate la prima gente cristiana che s’era incamminata in quella direzione per arrivare sulla fossa di un uomo povero e condannato che sul declivio di una campagna brutta e scoscesa seminata di sepolture vere e di modesti mausolei, era stato in fretta sepolto e nascosto. Prima ci si eresse sopra una memoria simile ad un altare, poi una basilica il cui baldacchino s’alzò sopra la memoria, finché ci si gonfiò su tutto, grande come un cielo, la cupola michelangiolesca. Come intorno alla povera fossa s’erano accumulati i sepolcri per riposare il più possibile vicino a S. Pietro, così intorno alla basilica si aggrupparono oratori, monasteri, cappelle e case separati da strade, straducce, sentieri, ma la principale ebbe sempre su per giù il tracciato di quella via divisa in due. Nel Medio Evo fu una strada coperta da un portico che dal ponte sul fiume andava all’ingresso della basilica. I pellegrini nella vicinanza del luogo sacro non erano disturbati né dal sole, né dalla pioggia; il portico li raccoglieva e ne facilitava il raccoglimento. Poi venne l’epoca in cui il portico scomparve e la terra ridiventò campagna; ci si coltivarono gli orti fra i quali ogni tanto sorgeva un casolare e la vita riprese. Si tracciarono strade, si fiancheggiarono di case che gentilmente si stringevano per far posto alle altre. Ne risultarono le due strade divise da una fila di case e si chiamarono successivamente Carriera Santa, Carriera dei Martiri, Via Beata, Via Pontificum, Via Alessandrina, Borgo Vecchio, Borgo Nuovo e le costruzioni che le dividevano furono la Spina fino ai nostri giorni quando furono abbattute e si fece quell’enorme vuoto che strada non è, piazza nemmeno, ma si chiama via della Conciliazione. La Spina divideva l’afflusso dei pellegrini a S. Pietro e se tra bellissimi palazzi, discreti palazzetti aveva anche case povere e forse brutte, il tempo e il colore le avevano rese simpatiche. Cadde con la Spina un 227 apporto secolare di vita. Cadde quella cappelletta chiusa da un cancello, dove dentro ardevano sempre dei ceri e tra le sbarre c’erano sempre dei fiori intrecciati. Si diceva che un papa avesse chiuso con quella cappelletta lo sbocco di un vicolo per ammenda a una Madonna contro cui erano state gettate bucce di melone. Si abbatterono i confini di quella Piazza Scossacavalli che il gorgoglio di una fontana bastava per riempire mentre certe finestre che ci si affacciavano ripetevano: Soli Deo, soli deo, soli deo. Si racconta che in quel punto i cavalli che portavano la pietra di Isacco e quella della Circoncisione, si fermarono e non vollero più proseguire. Ci si fece una chiesa che a un certo punto si chiamò S. Salvatore in Bordonia per i bastoni dei pellegrini, poi prese altri nomi, ci crebbero altre memorie, altre leggende, altre poesie e or non c’è più nulla, nemmeno il nome. Si poteva sanare quell’agglomerato di costruzioni e invece si abbatté tutto e si fece il vuoto che è nulla. La Spina permettendo di vedere la piazza che è concava, solo quando si era giunti alla sua estremità più alta, ne scopriva di colpo tutta l’estensione mentre ora di lontano la parte più bassa affonda e la piazza pare larga solo per quanto emerge a livello della visuale. Erano vie strette sì, ma la vita vi brulicava e ferveva come tutte e cose sono esageratamente se stesse se concentrate. Quelle vie strette concentravano la vita e la portavano allo sbocco; dal fitto delle case si usciva in quella grandezza sonante di acque di spazio vuoto; nell’insospettabile slargo la vita si diluiva e si placava, restava solo l’immensa meraviglia. Con l’apertura del chiuso pare che gran parte di queste cose siano fuggite. Molti ritengono che lo scempio si sarebbe riparato solo costruendo nello stile del Bernini un portico lungo al posto della Spina. Invece la soluzione scelta è quella che è: una fila di portalampade e tante panchine che non servono per il riposo dei vinadanti ormai tutti motorizzati, ma solo per apparecchiarci sopra la colazione. Ecco perché mi parve ottima l’idea di un nostro amico che col suo gran cuore riesce ad avere visioni veramente cristiane, di nobilitare in qualche modo quella banale composizione, di mettere una idea in quel vuoto di idee, di mescolare un significato spirituale con quel monotono gioco di fredda pietra. Perché non innalzare al posto dei sedili le statue dei santi protettori di tutte le nazioni del mondo? Per quella strada i tedeschi incontrerebbero S. Bonifazio, i danesi S. Villibrando, gli irlandesi S. Patrizio, i boemi San Martino, i britanni S. Agostino, i moravi S, Cirillo, gli indiani S. Francesco Saverio, gli svedesi S. Ascanio, i bulgari San Metodo, gli ungheresi S. Stefano, i peruviani Santa Rosa, i francesi S. Remigio, S. Luigi e così ogni piccolo o grande popolo incontrerebbe qui il suo santo. Questa idea dell’amico Torquato pare un sogno capace di dissipare un incubo. Questi santi che hanno camminato dal centro alla periferia, che hanno percorso il mondo per strade che partono da Roma e che così tornerebbero a Roma fermandosi avanti a quel centro da cui partirono, aspettando ognuno i proprio pellegrini, testimonierebbero l’unità della famiglia umana. E ogni gente che viene a Roma ritroverebbe per questa strada il santo che parla la sua lingua. Senza dire che con questa teoria di santi automaticamente si cambierebbe nome a quella strada che convoglia una universalità verso un centro e che con la parola “conciliazione” richiama per forza una piccola bega di 228 famiglia, tiene presente una questione transeunte di un piccolo stato con una entità spirituale ed ecumenica. Umoristicamente poi quel nome pare lo sforzo fatto dai guastatori dopo aver abbattuta la Spina, di conciliare lo squarcio con l’armonia, lo stile di un palazzo con l’altro, lo sforzo di ridare con quell’accenno di interrompimento che deriva dalla processione degli obelischetti un po’ di prospettiva alla piazza, tutto uno sforzo conciliativo, anche le panchine. Con la processione dei santi di tutte le terre del mondo forse sboccerebbe naturale un altro nome, un nome che sia di tutti i popoli, un nome che ricordi l’Epifania, la manifestazione, la luce, l’universalità, magari più semplicemente un nome che sarebbe certo il nome più vero di quella via: Strada i tutti i popoli. 229 Paese Sera, 25 dicembre 1956 Le ghirlande collocazione: Pg 28-30. Intorno all’uomo che acquistava conoscenza di sé, il sole, l’acqua, il fulmine, tutto parve mistero perciò divino. Quando egli staccò dall’albero sacro un ramoscello e se lo girò intorno al capo, con quel gesto aveva creato la corona e il suo significato sacro e ornamentale. Crescendo la conoscenza della vita ne crescevano le paure e le speranze e anche la corona moltiplicò i suoi significati: fu offerta agli dei per impetrazione e ringraziamento, fu complemento di gioia e segno di lutto. Dal favoloso e misterioso oriente essa che era passata nel costume dei popoli mediterranei (l’Egitto che ci ha restituito corone intrecciate oltre duemila anni prima di Cristo), trovò il suo trionfo nel mondo pagano grecoromano che della vita ebbe un concetto meno deformato di tutte le altre civiltà. Ogni dio aveva la pianta a lui sacra dei cui rami si facevano corone per i suoi simulacri, per i sacerdoti e i fedeli. Negli ex voto le coroncine avevano la preponderanza sugli altri, come ora i cuori l’hanno su altri pezzi del corpo umano. Nei ludi, circensi o scenici, si offrivano corone ai vincitori come ora si offrono quei bicchieri metallici inchiodati su un piedistallo. Col tempo si diffuse l’uso di offrire la corona a magistrati e altri cittadini per speciali benemerenze e si passò a darle anche a corporazioni e città come ora si concedono medaglie. A Roma, per il grande uso che si faceva di corone, erano sorte industrie adeguate. Fiorai e fioraie, coronarii e rosarie, vendevano ghirlande di fiori freschi nella buona stagione, nella cattiva di fronde e di amaranto secco, che riprendeva i suoi colori bagnandolo. C’era l’industria delle corone d’oro, d’argento, di rame che, lucidato, pareva d’oro. Le corone militari, dalla graminea alla trionfale, erano esse stesse una legione, alcune più numerose delle nostre croci di guerra. Ma dove la corona diventò tripudio e mestizia, al di sopra del suo simbolismo sacro, politico e civile, fu nell’accompagnarsi agli scopi esuberanti della vita, esaltandoli, fu nel seguirne i mesti ripiegamenti verso la morte. I fiori, con la loro breve vita, facilmente ci allacciano all’idea della morte o al guizzo della giovinezza: ed ecco le danzatrici coronate di rose, in quelle famose feste dove ognuno, incoronato, tra musiche e libagioni tentava di gustare l’attimo fuggente della gioia. Ai morti invece che, per non essere più vivi, diventavano quasi eroi, gli offrivano corone d’oro che si chiudevano con loro nel sepolcro. In alcune feste annuali, specialmente nelle più licenziose, il popolo inghirlandava se stesso e tutto ciò che era intorno a lui. Ma venne il cristianesimo a soffocare quanto era possibile a soffocare di quella vita pagana, ad accettare quanto non lo era, svuotandolo però dei significati antichi per riempirlo con altri simiglianti. Le figure effigiate nelle catacombe offrono corone di oro gemme e smalti dei papi e degli imperatori, quelle metalliche che dondolavano nelle chiese attaccate a catenelle e quella diventava lampadario sospesa davanti agli altari. 230 La corona apparteneva solo ai santi del cielo e ai potenti della terra. Quando ricominciò a diffondersi era spesso confusa con l’elmo e il cappello: confusione che dovette restare nell’araldica ecclesiastica dove tuttora vediamo gli stemmi cardinalizi sormontati da un cappello invece che da una corona. Ma dopo il mille, in quel felice ritorno di umana vitalità, anche la corona ritornò elemento di vita: le donne ornarono i capelli di coroncine e diademi, sui vestiti si ricamavano ghirlandette, la grazia femminile assomigliava a quella del suo serto. Poi le araldiche si moltiplicarono soffocando le vere, quelle che pulsano con la nostra vita seguendone la caducità, caduche anch’esse. Ma proprio a Roma, dove le corone ufficiali erano le tre della tiara pontificia e quelle principesche create per i vari nipoti, proprio qui era sopravvissuta a tutte le vicende, la corona viva fatta con fiori e fronde. Perché questo era il miracolo di Roma: tener vive nella vita le espressioni che erano state sue nell’antichità classica e fare questo semplicemente la natura come fa la natura coi miracoli suoi. Ma questo miracolo romano che aveva resistito al tempo, ebbe il suo colpo fatale dall’annessione. La città che era stata per secoli un meraviglioso paese universale, ridotta a capitale di uno stato particolare, perdette pian piano ciò che dell’antichità classica era sopravvissuto per oltre due millenni. Da nord e da sud affluì su Roma gente che l’invase, ne distrusse le piccole e grandi tradizioni che erano il suo meraviglioso patrimonio, la sua attività, unica al mondo, la trasformò in città simile a tutte le altre. E così fu distrutta anche la ghirlanda che era sopravvissuta proprio per indicare il Natale. In quell’epoca favolosa in cui Roma era dei romani che vi abitavano e del mondo intero che vi passava, chi in questi giorni girava per le sue strade, ogni tanto vedeva una porta su cui era stata appesa una grossa corona di mortella. Era la trasposizione di un rito pagano: appendere alla porta una ghirlanda di mirto fu l’uso antico delle feste floreali, quando tutto doveva essere fiorito e inghirlandato, teste, vestiti, pozzi, archi, templi, case e porte di case, perché la festa di Flora coincideva col risveglio della natura. La corona di mortella durata fino ai tempi moderni era restata espressione di risveglio, anzi del risveglio assoluto, quello della nascita. Chi faceva il presepio, o perché presumesse che il suo fosse degno di essere visto, o perché animato da zelo religioso ed ospitale, su un battente del portoncino appendeva una corona lasciando socchiuso l’altro battente. Quella corona voleva dire al passante che nella casa c’era un presepio, che, se voleva, poteva salire a vederlo. Dive c’era una corona verde c’era una famiglia che ripeteva il gesto dei primi cristiani che aprivano le loro case, trasformate in oratori, a tutti i fedeli. Per il presepio con i fedeli salivano i pifferari che sin dall’avvento avevano cominciato a scendere a Roma (non fasulli come quelli di adesso), costellandolo di ninne nanne e di pastorali. La ghirlanda sulla porta era una specie di muto “venite ad oremus” e la gente saliva, pregava, ammirava, forse chiacchierava, avevano tutti gli stessi atavici gusti. Quell’unica corona viva che era rimasta attraverso i secoli, è scomparsa. Sono rimaste solo quelle politiche con le pallottole di stagnola e quelle funebri; ma queste, trasformate in un cavalletto triangolare di bastoni sostenente due agglomerati di fiori, come ancora si possono chiamare 231 corone? La corona è un’altra cosa e non c’è più. 232 Paese Sera, 29-30 gennaio 1957 Chi aveva ragione? collocazione: Pg 31-32. (Lo stesso articolo è stato pubblicato su “L’Osservatore romano”, l’11 agosto di un anno non noto, col titolo S. Francesco di Sales e Angelica Arnaud - collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari) Per fortuna i santi non vanno sempre d’accordo tra di loro; nel disaccordo, più che nell’armonia a tutti i costi, è visibile il fermento di vita e di libertà. Interessante per noi è quello sorto tra San Francesco di Sales, vescovo-principe di Ginevra e la santa baronessa di Chantal, a proposito di Angelica Arnauld, abbadessa di Port Royal. Si era nel 1619, il vescovo si trovava a Parigi, quando, come un turbine impetuoso, come un incendio indomato, entrò nella sua vita Angelica Arnauld. Angelica in realtà era Jacqueline, di quella famiglia Arnauld così celebre nella storia dei solitari di Port Royal e del giansenismo. A Port Royal, antichissima abbazia cistercense, di costumi rilassati, povera e malsana per la vicinanza di uno stagno da cui esalava la febbre perpetua, a otto anni fu rinchiusa Jacqueline destinata sin dalla nascita ad essere monaca. Quando ne ebbe undici, morì l’abbadessa. Avendo la bimba nomina di coadiutrice con diritto di successione, automaticamente diventò abbadessa. Ma per ottenere la conferma da Roma, precedentemente negata per la sua tenera età, si creò l’atto di nascita di una immaginaria suora diciassettenne di nome Angelica. Il giorno in cui prese possesso dell’abbadia prendendo nelle sue piccole mani il pastorale, fece anche la sua prima comunione. Ma quando ebbe veramente diciassette anni, dopo aver superato la tentazione di liberarsi da obblighi non liberamente assunti, dopo averli invece coscientemente accettati, pensò di riformare quella rilassatissima comunità. La sua riforma andò alle radici: cominciò con l’imporre la comunione dei beni, l’astinenza perpetua, la clausura. Rigida, ardente, forte, bramosa di sacrificio, aliena dalle mezze misure, si accinse a una lotta nella quale fu sola contro tutti. Il giorno che i suoi genitori e i fratelli, alleati delle monache, la sfidarono a proibire l’accesso al convento, essa ne sbarrò le porte e una drammatica discussione si svolse tra lei e la sua famiglia attraverso una finestrella chiusa da una grata. Fu la famosa “giornata dello sportello”. Dopo aver rimproverato ai suoi di averla messa in religione per forza e di adoperare ancora la forza per imporle di continuare in una vita rilassata, essa acdde svenuta. Quel giorno vinse la resistenza della famiglia e delle monache. Continuò a vincere nell’opera difficilissima della riforma, usando ogni rigore contro la sua natura indomita e 233 ogni bontà con le suore, di cui comprendeva l’insofferenza per essere state costrette alla rinunzia. Trasformato Port Royal, si accinse a una più difficile riforma, quella dell’abbazia di Maubisson a Parigi. Aveva 28 anni, era nel fulgore della giovinezza e a Parigi predicava Francesco di Sales. Angelica riuscì ad attirarlo a Maubisson e fu immediatamente soggiogata dal fascino che emanava da quell’uomo. Essa non vide in lui la dolcezza immensa, ma la forza inflessibile che piegava la sua altera volontà. In Francesco di Sales la forza non era certo inferiore alla soavità, ma Angelica vide uno solo dei due aspetti e, naturalmente, quello che rispondeva di più al suo temperamento. La forza, causa prima della dolcezza del Sales, fu quella che portò l’ardente abbadessa ad abbandonarsi interamente alla sua direzione. Due cose erano veramente profonde in lei: la religione e la libertà; ma questa le fu tolta imponendole quella. DI qui la sua tragedia intima che si placò nella illuminata serenità di Francesco dal quale imparò che la misura dell’amore è di amare senza misura, che lo spirito di libertà è da Dio e toglie timori, scrupoli, agitazioni. Ci volevano questi sconfinamenti per quell’anima esuberante ed inquieta a cui mancava la pace interna. Ma un giorno anche la pace apparve. La vide in quel povero convento della Visitazione fondato qualche anno prima dal vescovo di Ginevra e dalla baronessa di Chantal. Essa avrebbe abbandonato il grande sogno della riforma, avrebbe deposto il pastorale che sapeva maneggiare con tanta abilità e sarebbe entrata umile novizia in quel convento. Questa era la pace. Con la fermezza della decisione già presa, espose il suo pensiero al vescovo che ascoltò in silenzio e rispose con un sorriso. Nel sorriso c’era già il rifiuto. Angelica credendo di non essersi spiegata, scrisse, Francesco non rispose; insistette tanto finché arrivò una risposta evasiva: “La Visitazione è poca cosa”. Angelica allora cercò un’alleata nella eroica e forte Chantal che simpatizzò subito con lei. Erano due anime umanamente simili: la stessa grandezza, la stessa energia, le stesse impazienze, lo stesso bisogno degli estremi, solo che la Chantal, più anziana, aveva già affinato e smussato questa natura, Angelica aveva ancora tutte le asprezze della gioventù. La Chantal approvò il suo desiderio di umiltà, credette che un simile acquisto giovasse alla nascente Visitazione e che si potesse fare una grande donna. In questo senso parlò al vescovo, lo pregò, insistette, ma egli restò fermo nel suo rifiuto. Negli ultimi anni di sua vita, tra lui e la Chantal si eresse costantemente la figura di Angelica Arnauld chiedente di essere accolta tra le ultime delle visitandone. La baronessa, con la sua parola rude ed incisiva, ripeteva che sarebbe stato un bene per tutti accogliere la Arnauld e Francesco, spesso tacendo, affermava che sarebbe stato un male per tutti. Eppure nulla allora faceva sospettare l’errore in cui Angelica sarebbe caduta e il vescovo continuava con zelo ad assistere “quel cuore straordinario” al quale però non volle mai aprire le porte della sua umile Visitazione. Egli morì fermo nel suo rifiuto e la Chantal non ebbe certo l’ardire di aprire lei quella porta che lui aveva 234 voluta inesorabilmente chiusa per Angelica. Eppure il suo giudizio su lei non era cambiato; continuava a vederla e a scriverle. Un anno dopo la morte di Francesco di Sales, Angelica conobbe il Saint-Cyran; la rigidità di lei collimò perfettamente con quella di lui ed essa lo seguì fino alla morte. Ma dal momento in cui il Saint-Cyran entrò nella sua vita, Angelica riperdette la pace. Questa creatura nata per la libertà, in cui la libertà era stata offesa, finì per negare la libertà. Questa donna in cui l’amore era onnipotente, finì per avere paura di Dio. Quale di questi due santi che hanno qualcosa della nostra complicazione moderna, ebbe ragione in questo affare dell’Arnauld? Forse Francesco di Sales presentì l’errore in cui essa sarebbe caduta e volle salvare dall’eresia il chiuso del suo convento nascente. La Chantal invece credeva che una simile anima incanalata nella vita semplice della Visitazione, avrebbe dato frutti preziosi per se stessa e per l’ordine. Secondo lei non bisogna aver paura delle anime affocate, ma delle tiepide. E forse si sentì anche un poco responsabile dell’errore di Angelica Arnauld per averla lasciata indifesa dietro la porta. Si racconta che un giorno la Chantal, dopo una vana perorazione in favore di Angelica, chiedesse al Vescovo: - Monsignore, chi di noi due avrà ragione? E che Francesco di Sales rispondesse sorridendo: - Lo vedremo in paradiso. 235 Paese Sera, 19-20 marzo 1957 INCONTRO CON MARCHESI Ricordo collocazione: Pg 33-36. Nel pomeriggio ci sarebbe stata una solenne riunione dell’Accademia dei Lincei; in mattinata avevo tanta voglia di andarci e telefonai a Marchesi. - Ti lascio il biglietto di invito nella portineria dell’Accademia – mi disse. Era una giornata tutta sole; il fresco e il tepore primaverili sfioravano il volto senza mescolarsi. Nel pomeriggio non ebbi più voglia di andare a chiudermi in una sala con tanta gente uno che parla. Però mi dispiaceva che Marchesi ritrovasse in portineria la sua busta con l’invito calorosamente sollecitato. Se non lo avessi ritrovato lì giacente avrebbe creduto che io fossi andata e uscita come sovente accade, senza salutar nessuno. Dovevo arrivare alla Farnesina, prenderlo e tornarmene indietro. Questo semplice programma diventò fantastico come tutte le cose che si fanno col trepido senso vitale che ci coglie a primavera. Col passo riposante di chi non ha timore di far tardi, avrei goduto due ore di sole e di solitudine in compagnia del fiume che la concilia. Me ne andavo quasi sollevata da quell’aria nuova per il lungotevere di sinistra; ma a un ponte volli passare su quello di destra: la Farnesina è di là. Lo percorsi avendone a manca la spalletta , guardando in giù l’acqua bassa. All’estremità del ponte, nel momento che stavo voltando per riprendere a costeggiare il fiume, un formidabile scontro della mia spalla destra con la spalla di qualcuno che non avevo visto. In forza dell’urto ognuno fa mezzo giro su se stesso e siamo di fronte. Due facce indignate pronte a scambiarsi qualche improperio. Invece un simultaneo “Tu?” e una risata. Era Marchesi che dal lungotevere piegava sul ponte, guardando in alto alla sua sinistra. - Dove vai? – mi chiese. - Andavo a ritirare il biglietto che tu mi hai lasciato perché non ti accorgessi che non ero venuta. - Hai fatto bene a non venire. Io non ne potevo più e sono uscito. Giacché ci siamo scontrati, andiamocene un po’ in giro. Guidami in qualche parte della tua Roma. - Volentieri. Dove ti piacerebbe? - Nella Roma pontificia. Non eravamo lontani da San Pietro e dai suoi Borghi, ci dirigemmo da quella parte. Ci inoltravamo per strade e vicoli; ogni tanto di scorcio appariva qualcosa di immenso: la facciata, la piazza, la cupola, il colonnato. Io gli raccontavo le piccole storie che sapevo: ci fermavamo sotto un balconcino; bevemmo l’acqua di una 236 fontanella; sostammo avanti ai portoncini chiusi che lo commovevano; fiancheggiammo conventi che nei grossi muri riducevano al minimo l’apertura delle rare finestrelle; indugiammo non so più quanto tempo seduti sulle sbarre di ferro che, tra un pilastro e l’altro, chiudono la barriera intorno alla “guglia”. Chiamavamo così l’obelisco per sentirci più attinenti a quella Roma papale che io gli stavo raccontando e che egli tanto amava. Riprendemmo a camminare senza mète precise per le strade dell’altro borgo. Nel sole incominciava a insinuarsi la dolcezza del tramonto quando ci fermammo avanti a un arco cieco da cui sporgeva un piccolo edificio, che nella forma e nelle dimensioni ha dell’edicola e del confessionale. Coperto da una breve tettoia, è fatto per tenere una grata di ferro che ha nel mezzo uno spazio libero, rotondo, limitato da un cerchio, come un oblò. Dietro l’inferriata c’è una “ruota”, di quelle che nei conventi di clausura servono per introdurre le provviste senza aprire la porta e restando invisibili l’uno all’altro: chi mette e chi prende. Da una parte sporge il sostegno della campana. - Vedi, Marchesi, qui avanti si liberava in fretta il bambino dagli scialli e strettamente fasciato, come usava allora, lo si infilava attraverso il cerchio, deponendolo nella ruota; una spinta per farla girare verso l’interno; una strappata alla corda e via! Dall’altra parte, avvertito dalla campana, qualcuno correva; sapeva che cosa avrebbe trovato. E gli indicai la pietra lavorata e consunta dove si legge: “Elemosina per li poveri. Proietti”. - Proietti…qui venivano gettati! – disse lui sottovoce come si parla in chiesa. Rimanemmo in silenzio a guardare, poi lentamente ce ne ritornammo sul lungotevere, passando dall’altra parte, dove c’era ancora tutto l’oro del tramonto con le ombre lunghe lunghe. Anche noi due, per terra, eravamo alti come pinnacoli. Nella strada deserta vidi qualcosa che avanzava. - Guarda, guarda, Marchesi! Stava passando il più piccolo funerale che io abbia mai visto; c’era il cavallo, il carro nero con un suo traballante baldacchino, il cocchiere e un lumino acceso dentro uno dei fanali; l’altro forse era stato spento. Quel lumino era l’unica cosa che attestasse la presenza del morto nella cassa. Erano diretti al cimitero dei poveri, a Prima Porta. Senza neppure dire “andiamo”, Marchesi mi prese per mano e ci mettemmo dietro il carro. In pochi minuti avevamo congiunto due estremi della miseria: la ruota degli esposti e quel trasporto più simile a uno sgombero, che a un funerale. A un tratto il cocchiere, come se risovvenisse, di qualche cosa, frustò il cavallo, che prese un trotto leggero e allegro, lasciando noi due sempre più lontani. Ci fermammo, seguimmo con gli occhi quel carretto che portava al definitivo deposito un uomo che era stato vivo. Marchesi mi disse: - Io vorrei un funerale così. 237 ---- E’ appena un mese e una folla di bandiere e di gente seguiva il carro che portava lui al cimitero: bandiere sue e gente sua. Ma con questa tanta altra gente che, avanti a Marchesi, si piegò come bandiera che rende omaggio all’avversario. Gruppi che si affollavano negli sbocchi delle strade trasversali, sulle piazze, sui marciapiedi, guardavano muti e rispettosi l’interminabile sfilata di popolo: silenzio nell’una e nell’altra parte. Il funerale di Marchesi, fu l’opposto del piccolo funerale che desiderò quella sera. Quello che mancò proprio fu il sole. Io credevo che per un umanista come Marchesi, avrebbe dovuto farsi largo fra le nuvole, per salutarlo; anche perché egli stesso era solare. Quella sera del piccolo funerale egli non credette di turbare il viaggio di quel morto col seguirlo tenendo me per mano: eravamo unità, unità con la miseria di chi nasce e di chi muore; unità col sentimento e con la speranza della povera gente. Il giorno che Marchesi se ne andò a me pareva che buttasse a tutti una speranza e un invito all’unione e che la folla lo raccogliesse. Solo in apparenza, Marchesi, non ebbe il funerale che desiderava quella sera, perché quella folla che lo seguiva era anch’essa unità. 238 Paese Sera, 20-21 aprile 1957 UNA SINGOLARE CONGIUNZIONE DI FESTE Un Natale e una Pasqua quest’anno si sovrappongono Un incontro che avviene una volta ogni molti anni – Il significato delle pagane Palilie – Parabola del 21 aprile collocazione: Pg 37-38. Quest’anno un Natale e una Pasqua si sovrappongono nello stesso giorno: Natale di Roma, Pasqua di resurrezione. L’incontro tra queste due feste avviene una volta ogni tanti anni e tutte traggono aspetti rituali dalla congiunzione di altre celebrazioni. Il Natale di Roma si congiunse con le feste Palilie, così come le Parilie si erano congiunte con quelle. Tre celebrazioni che si cumulavano assurgendo insieme al trionfo della vita sulla morte, come poi lo sarà, in senso compiuto ed assoluto, la Pasqua. Le Palilie avevano carattere di purificazione e di propiziazione. I pastori purificavano con acque lustrali le stalle e il gregge; appuntavano un ramo di alloro alle porte; facevano fumigazioni bruciando erbe sabine, rosmarino, piante resinose insieme con lo zolfo. Era anche naturale disinfezione, come ora le pulizie di Pasqua. Spontaneamente alle Palilie si congiunsero le Parilie, feste del partorire, dell’apertura, della nascita. Romolo doveva aprire il solco per innalzare il muro della nuova città in un giorno fausto, nessuno più indicato di quello consacrato a Pale, dea della pastorizia. Ma coincise bene anche con le Parilie; nel solco c’è apertura della terra, un principio, un avvenire. Le feste propiziatorie per gli animali per i frutti della terra, per il nuovo ciclo annuale fecero tutt’uno con il Natale di Roma. Festa solennissima, in cui era fatto obbligo a ogni cittadino di coronarsi di fiori, festa che cominciava con la purificazione delle cose e continuava con preghiere per la remissione delle colpe commesse nell’anno. La bontà non è completa senza la comunione ed ecco tutta questa gente coronata di fiori che sfocia nelle campagne vicine per banchettare come una sola famiglia, consumando gli agnelli dell’olocausto, uniti tutti nel contatto con la nuda terra. L’usanza rimarrà nella pasqua cristiana, ma trasferendola al lunedì. Per secoli i romani celebrarono quella nascita come una cosa viva, vera, popolare. Ma il Natale di Roma era legato alla sua leggenda e alla sua prosperità. In epoche difficili la leggenda si addormenta, la prosperità cede il posto alla miseria. Senza sogno e senza benessere le feste non vivono. Nel secolo XV risorse perché tutto dell’antichità classica risorgeva con gli umanisti. Pompolio Leto con i suoi accademici la ripristinò, aprendola la mattina del 21 aprile 1483. 239 Quella festa che era abituata a vedere per tutta la giornata tutto il popolo coronato di fiori, certo non riconobbe se stessa. Nell’ottocento per opera della pontificia accademia di archeologia, la festa si rialzò, ma più ibrida di prima. Però a metà di questa sua esistenza dottocardinalizia ebbe un ritorno di vita come una esplosione tra due lunghi silenzi. Durante la breve gloriosa repubblica, capitò il 21 aprile 1849: il Natale di Roma fu celebrato con la commozione e l’esaltazione di chi sente in atto, con la propria liberazione, la sua rinascita. Nel Colosseo, dove si fecero illuminazioni fantastiche a bengala e a fiaccole, la gente cantava gli inni risorgimentali. Quattro giorni dopo a Civitavecchia sbarcava il generale Oudinot; a fine mese la battaglia del Granicolo. Con tante altre cose cadde anche quella festa che per una volta tanto era ritornata celebrazione di popolo. Vivacchiò ancora tra dotti e prelati, finché si riadagiò nel sepolcro. Poi venne l’epoca della “Giovinezza” che viveva di riesumazioni e tra queste non poteva mancare il Natale di Roma. Rubandola al 1 maggio gli fu messa la casacca del lavoratore debitamente tinta in nero e il popolo, diviso a schiere a seconda dell’età, fu obbligato non a coronarsi di fiori, ma a marciare e a gridare. Adesso è una festa senza entusiasmo, ma anche senza ridicolo. Però quest’anno essendo congiunta con la Pasqua se ne ravvivano colori e significati, risaltano quelle somiglianze di preci e di riti che legano queste feste pagane con la celebrazione pasquale ebraica e cristiana. 240 Paese Sera, 6-7 agosto 1957 Neve d’agosto collocazione: Pg 39-42. Nelle famiglie della vecchia Roma, quasi quanto quella di Cappuccetto Rosso, è nota la storia della neve caduta in piena estate sulla più alta vetta dell’Esquilino. In quella antichità che riusciva ancora a vedere le cose con l’amplificazione che poi restò solo all’infanzia, il colle era detto “super aves” a significare che si alzava tanto da superare il volo degli uccelli. E’ vero anche che i romani sono stati sempre particolarmente esagerati parlando dei loro colli che hanno costantemente chiamato “Monti”, così come chiamano monte ogni rialzo di terreno dovuto a edifici diroccati, o a terra di scarico. Ma il Monte Esquillino nei primi secoli di Roma era davvero più monte degli altri; assai più scosceso di quello che non lo sia ora, le sue cime erano ardue, le sue valli profonde, ma in alto, come adesso, s’allargava un vastissimo piano, quello che va da S. Maria Maggiore a Piazza Vittorio. Fu su questo pianoro che in una notte d’agosto nevicò tanto abbondantemente che la neve restò come resta su un buon campo da sci. Noi ormai abituati ai capricci e alle bizzarrie di una atmosfera innervosita per qualcosa che turba il suo quieto vivere, siamo meno disposti a meravigliarci di quella nevicata estiva. Ma i romani sono stati sempre così poco abituati alla neve che quando d’inevrno ne cadeva una spolverata come il formaggio sulla minestra, ne parlavano commossi agitati esaltati insospettiti come di un avvenimento eccezionale che proprio non sarebbe dovuto accadere. Figurarsi che cosa capitò quella mattina di agosto quando al luce del giorno rivelò l’alto monte coperto di spessa neve. La notizia si diramò, il popolo scese incredulo dagli altri colli, risalì le valli, si affollò lassù curioso e attonito. Si era nella seconda metà del secolo quarto quando, essendo ancora vicina l’epoca in cui il cristianesimo, con l’appoggio civile, era riuscito a superare e a fiaccare il contrastante paganesimo, i fedeli del nuovo credo vivevano nel loro periodo euforico. Tra questi c’era un patrizio che non sapeva come impiegare le sue ricchezze. Quella notte aveva sognato la Madonna che gli consigliava di impegnarle nella costruzione di un grande tempio a lei stessa dedicato; il luogo scelto era quello dove la mattina seguente si fosse trovata la neve. Il papa Liberio aveva sognato anche egli la Madonna che gli ordinava di erigerle una basilica sul terreno dove nella notte avesse nevicato. Tutti e due si ritrovarono lassù col popolo radunato. Il papa tracciò sulla neve la piana del tempio e il ricco patrizio fece voto di finanziare la costruzione. La chiesa sorse e, perché indicata dalla neve, si chiamò “ad nives”, ma siccome risultò pure la più bella di quelle dedicate alla Madonna, finì con l’essere chiamata Santa Maria Maggiore. Però, quando neppure un 241 secolo dopo Sisto III ricostruì il tempio, lo dedicò alla Plebe di Dio, “Xystus episcopus sanctae plebi Dei”. Le sue vicende furono complicatissime: storia e leggenda si intrecciano, si accavallano, si confondono, ma l’elemento umano vi domina sempre, come se quel tempo appartenesse veramente al popolo, che mescola i suoi errori con la sua sofferenza. Della leggendaria nevicata si continua a tramandare la memoria: il 5 agosto di ogni anno dentro il tempio cade dall’alto di una cupola simbolica neve formata da candidi fiori. Sono gelsomini che nel loro piccolo calice raccolgono il profumo della notte, sono petali carnosi di tuberose grasse di odore, sono rose sfogliate già stanche di essere vive, emananti il profumo del tramonto. Cade la neve molle e odorosa sui preti carichi di seta e di oro come idoli, sulla plebe di Dio che ignora di esserlo, che assiste allo spettacolo attratta e incuriosita dalla sua ingenua semplicità. La leggenda della neve e la cerimonia floreale che ogni anno la commemora hanno un antefatto che non è leggenda, ma storia, che non fu fenomeno passeggero, ma durò per secoli. Quel pianoro in vetta all’Esquilino dove prima dell’annessione di Roma all’Italia, la grande basilica s’alzava solitaria tra vigne, ville, e campi e dove i piemontesi precipitati quaggiù dopo il 1870, distruggendo secolari bellezze, costruirono il loro orribile quartiere, un casellario di caserme civili, quel campus esquilinus era un immenso sepolcreto per la gente povera e per le bestie. La plebe che non possedeva mausolei, né terra per farveli sorgere, dopo morte veniva portata lassù e buttata in fosse comuni. Mucchi di cadaveri e di carogne malamente coperti. A perdita d’occhio era un biancheggiare di ossa affioranti dalla terra come oggi a monte Testaccio affiorano i cocci delle anfore spezzate. Stuoli di corvi piovevano su quello spazio e torme di cani affamati lo frugavano e sconvolgevano. Le sentenze capitali spesso si eseguivano lassù risparmiando il trasporto del cadavere per la sepoltura, giacché il condannato arrivava coi suoi piedi sino alla fossa. E come ora si vedono ogni tanto sui muri della vecchia Roma, negli angoli delle piazzette o nella stretta rientranza di un edificio, quelle lapidi con le quali Monsignore proibiva “di fare mondezzaio” in quel luogo, così lassù, al limite dell’orrendo sepolcreto c’era una lapide con la proibizione di gettare roba immonda su quell’immondo carname. La proibizione è conferma di una abitudine acquisita, tuttavia quella fu l’unico riguardo che si richiese per il cimitero del popolaccio. E’ chiaro che un luogo colmo di rinnovata materia in processo di una putrefazione favorita dalla pioggia e dal sole, dovesse diffondere intorno miasmi insopportabili. Per contenerli un poco, per ostacolare alquanto il vento carico di quegli effluvi, il sepolcreto fu circondato con una fitta corona di alberi dei boschetti, alcuni dei quali diventarono sacri a divinità confacentesi al triste luogo, come Mefite e Libitinia, dee dell’aria corrotta e della morte. Dentro questo orrendo campo le streghe celebravano riti notturni, gente disperata ed illusa compiva sortilegi ripugnanti, maghi prezzolati procedevano ad evocazioni paurose. Com’era proibito l’apporto di sudicerie estranee al campo mortuario, così erano proibite queste cerimonie, deformazioni mostruose dello spirito e del sentimento. Ma nonostante i divieti e i sacri boschetti, il cimitero delle bestie della plebe e degli schiavi 242 continuò ad essere luogo sozzo e malfamato fino a che Mecenate non lo trasformò: i morti furono finalmente coperti da un’alta coltre di terra, su questa crebbero alberi, dilagarono fiori, scaturirono fontane, corsero ruscelli, scrosciarono cascate, si aprirono ninfei, sorsero ville, s’alzarono torri solo per reggere terrazzi da cui ammirare con uno sguardo tanta bellezza. La parte più abietta della città fu trasformata nella più deliziosa, e intorno alla villa di Mecenate affluirono i poeti. Altre ville si accostarono a quella, i patrizi risalirono la Suburra, i plebei li seguirono e tra villa e villa sorsero alte e stipate le case d’affitto, le Esquilie diventarono di colpo il luogo più delizioso e più popoloso di Roma. Tutto si trasformò lassù. La plebe che aveva avuto lì il suo ripugnante cimitero ebbe sullo stesso luogo il tempio a lei dedicato, tutto colore di mosaici e splendore d’oro; il biancheggiare arido delle ossa sconvolte si trasformò nel candore della neve; a quella bassa nuvola di miasmi, ragione vera per cui gli uccelli non volavano su quel monte, si contrappose la profumata pioggia di fiori. Persino le carogne degli animali, buttate a marcire in quel sepolcreto, pare abbiano avuto la loro rivincita. Lustrati e infiocchettati,cavalli, cani, gatti, uccelli salgono lassù in un giorno dell’anno, quando un prete esce dalla chiesa di S. Eusebio e, fermandosi sull’alta scalinata, stende il braccio a benedirli; unico giorno in cui la chiesa pare ricordarsi che tra le creature sofferenti del mondo ci sono anche le bestie. 243 Paese Sera, 28-29 giugno 1958 San Pietro pescatore collocazione: Pg 43-49. Per la solennità del 29 giugno in S. Pietro c’è qualche cosa che non è di tutti i giorni. La festa, che, come tutte le altre, liturgicamente si apre la vigilia al tramonto del sole per chiudersi al tramonto del giorno successivo, è limitata e contenuta da un canto singolare. E’ un inno che ricorda Orazio e il suo famoso Carmen Saeculare, nel quale il poeta latino si augurava che il sole non potesse mai vedere nulla più grande di Roma: nei primi e nei secondi vespri di questa festa l’aria della Basilica vibra per le note squillanti della musica di “o Roma felix...tu superi in bellezza tutte le città del mondo”. Ecco il voto di Orazio cantato come realtà, ma per cause ben diverse; non perché Roma aveva assoggettato il mondo, ma perché essa era stata bagnata dal sangue dei due Apostoli oggi celebrati. La chiesa non distrusse la civiltà pagana, ma la smontò, ne prese i pezzi che le servivanmo e, sostituendone nomi e significato, se li incorporò. Per questa festa la famosa statua bronzea di S. Pietro, che nei secoli passati si era sostituita nella funzione al classico Palladio, viene coperta col manto pontificale e incoronata con la tiara. Questa statua è l’unica cosa che in S. Pietro sia ferma, dura, senza atmosfera, mentre lì dentro tutto è movimento e aria: dai papi gesticolanti sui loro sepolcri alle fiammelle tremule della Confessione, dall’altezza celeste della cupola ai raggi di sole che la traversano come meridiane astrali. Quella sua espressione di ostentata autorità sotto i paramenti pomposi, è lì ormai da secoli a testimoniare una potenza che non è soltanto spirituale. La cosa veramente originale che si può vedere a S. Pietro in questa occasione è uno strano oggetto appeso all’entrata della Basilica: un grosso pallone ovoidale traforato come se fosse fatto di una rete a larghe maglie, coperto di rami di bosso. E’ una delle poche antichissime usanze, che ancora restano, tanto antica che se n’è smarrito il preciso significato; la gente per quel cesto s’è tramandato un nome, che a prima vista non pare gli sia appropriato: la rete del pescatore. Un frammento di pietra catacombale mostra scalfito tra gli altri segni pescatori anche un disegno di quell’oggetto. A me è sembrato sempre la forma del suono che nasce dalla vastità della Basilica e non si sa di che cosa sia fatto. A volte è come se venisse dal fluttuare della folla che lì dentro pare abbia perduto ogni possibilità di statica: va, viene, gira, torna, parte, non si sa di dove arriva, non si sa dove tornerà; folla quasi sempre dissipata, costretta a passare di lì per un perché, per tanti perché, per nessun perché. Ne viene un mormorio indistinto, 244 ma incessante, giacché quasi tutti parlano e pochi pregano; è uno scalpiccio, un brusio, uno strofinio che pare eterno come l’ansare del mare. E’ il rumore di tanti piedi che non ristanno, di tante voci che solo in questo tempio escono nel loro volume naturale, senza temperamento di tono. Il rumore di S. Pietro è simile all’altare cavernoso di un grosso incendio. Nel Medio Evo i pellegrini poggiavano lumi e candele sugli altari, sugli sporti, sulle mensole, sulle basi delle colonne, sui sarcofaghi, nell’atrio, nei portici, per le scale, sì che tutto il vecchio edificio ardeva di fiammelle. Tutte le fiamme che arsero per secoli nell’antica Basilica sembrano trasformate in suono nella nuova. Quel rumore è simile un poco a quello del mare, un poco a quello del vento tra le querce, però nessun rumore che non sia delle forze di natura gli assomiglia. S. Pietro è un’immensa conchiglia, dove il mormorio è perenne come lo scorrere del tempo. Se un moscerino penetra i una conchiglia, quel rumore di aria in cerchio, che noi avvertiamo solo accostandocela all’orecchio, deve essere per l’insetto uguale a quello che ci avvolge quando penetriamo in S. Pietro: un frusciare di suono, espressione di tempo fluente e di eterno presente. Quello strano oggetto che pende oggi all’ingresso della Basilica, è a forma di quel suono: suono senza angoli, senza rifrazioni, suono che gira come la terra, come il cielo, come l’aria dentro la conchiglia. Tutte sensazioni che si avvertono senza poterle definire. La definizione ci fa rientrare nella realtà: è la rete del pescatore. --- In un tratto del mare di Roma, oltre Ostia, oltre ogni segno di strada, dove l’acqua e il vento giocavano liberamente, formando quei monticellli di sabbia che moltiplicano la solitudine spezzandola, un giorno ritrovai quell’oggetto che ogni anno il 29 giugno pene all’ingreso di S. Pietro; era solo scheletro di vimini, abbandonato sul confine mobile dell’acqua e ondulava come cosa viva. Lo strano oggetto ornato di bosso doveva dunque ricordare di sicuro uno strumento piscatorio, giacché era lì, non quale simbolo, come sulla porta della Basilica e nella pietra catacombale, ma come realtà. A Roma è facile incontrarsi in questi anelli che legano tra loro i secoli e i millenni, dando quell’impressione di immanenza come la dà il suono che riempie S. Pietro. L’incontro con quel cesto ovale fu come una rivelazione che non spiega mai se stessa. Dune, acqua, solitudine e quello strano oggetto. Da dietro un monticello di sabbia uscì un uomo come un complemento della rivelazione. Parve lontano e non lo era. Io chiesi ed egli rispose. Sulle rive romane si adopera quell’arnese per conservare vivo nell’acqua il pesce catturato. 245 Paese Sera, 13 gennaio 1960 Vecchia Roma collocazione: Pg 50-51. La vera Roma è ridotta simile al corpo di un martire: spezzata, dispersa, esposta a frantumi sotto forma di reliquia. Ci sono ormai, dentro e fuori le mura, quartieri interi così significanti e standardizzati che potrebbero essere trasferiti in qualunque altra città, senza togliere nulla a Roma. Eppure a guardar bene qualche suo residuo si insinua tra quegli agglomerati di case e di casoni, perché il suo carattere è così prepotente che a volte basta un albero e qualche sasso a legittimare il bastardume dilagante. Il quartiere dei Parioli sta tra quelli che per il cattivo gusto edilizio e coloristico non hanno neppure l’attenuante della povertà, di cui si valgono gli orribili casamenti di certe zone periferiche. Eccone una strada: via Denza, che sale ondulando su per quelle aristocratiche alture; il suo movimento in ascesa è già Roma; è già Roma la luce che ne consegue; è già Roma la scorciatoia a scaletta che a un tratto sbuca dal fondo, in mezzo ai cipressi; certi alberi superstiti delle vecchie vigne, certi pini vasti come nuvole, benché prigionieri tra i muri, sono sensibilmente vecchia Roma; qualche muricciolo di cinta è tinteggiato con quello che fu il naturale colore della città; un superstite portale campagnolo, grande e semplice come un gigante si volge un poco di lato quasi vergognoso della sua mole, quasi pauroso d’esser notato, sta lì come un vecchio e decaduto proprietario, ospitato per forza di contratto dai nuovi compratori sempre in attesa di un appiglio che ne autorizzi lo sfratto. La strada sinuosa e lenta, sulla sommità dell’altura cambia nome e pendenza e prosegue su di un falso piano tra piccole ville che si affacciano presuntuose sulla strada, tra grandi ville che, superbiose, se ne allontanano, tra piccoli parchi che, stretti dai nuovi palazzi, lustri come servizi igienici, paiono immensi. Il tracciato della Salaria Vetus, che si divideva dalla Salaria Nova presso la cinta cittadina, creando l’enigma di due vie del sale che si erano scambiato l’aggettivo custodendone gelosamente il motivo, si svolge sotto a questa strada moderna percorsa da molte macchine e pedoni. Un giorno ci fu un po’ più di gente per quei marciapiedi e quella gente era popolo, voglio dire che c’erano uomini e donne, poveri e benestanti, lavoratori e preti; camminavano silenziosi, rapidi, in fila spezzata; forse per questo parevano avere nella loro andatura un qualche cosa di furtivo che suscitava un ricordo catacombale. Uno di quei massicci cancelli che stanno sempre chiusi, custodendo le ville che si coprono con gli alberi, era semiaperto; arrivata là, la gente entrava e scompariva. Oltre il cancello un viale fiancheggiato da mimose scendeva dolcemente, in fondo faceva un largo gomito e sfociava in un piazzale avanti alla villa che dal di fuori non si sarebbe supposta così grande. Intorno a un tavolino di ferro erano state piegate ed appoggiate delle seggiole a sdraio; un cameriere con la giacca a righino le vigilava. Ma quella gente non era curiosa del luogo, né mostrava di averne confidenza; andava dritta verso una porticina, aperta in un fianco rientrante 246 della villa, come le formiche: ognuna guidata da quella che la precedeva. La porticina era così sottile che faceva pensare a quella strettissima del purgatorio dantesco; ci passava una persona alla volta e non troppo comodamente. Oltre la soglia incominciava subito l’umido e il buio catacombale. Una minuscola scala a chiocciola s’inabissava sotto terra: pareva un trapano che stesse scavando. Sui gradini corrosi graffiti e lettere; sui muri rischiarati a macchia da rare candele, pezzi di marmo con epigrafi tronche e i noti segni cemeteriali pieni di vita e di speranza. La scala continuava monotona, insistente e s’avvertiva un lontanissimo canto corale salire dal profondo. I fosfori avevano ornato la terra umida scavata dalla spirale che scendeva, con rami di mortella e foglie di palme. Le candele si facevano più rare; pareva che la scala volesse arrivare al centro del mondo. Intanto il canto si spogliava sempre più di lontananza; fu appena velato da qualche cosa che poteva essere una parete o un gomito d’aria ed esplose in un poderoso Kyrie, mentre il chiarore sommato di tante candele non viste, rischiarò le tenebre e avanti alla strettoia dell’ultimo scalino si spalancò un’ampia altissima basilica sotterranea. Nulla di simile si può vedere nelle catacombe di prammatica turistica nelle quali le cappelle, in genere, sono formate dall’intersecarsi, o dal confluire di più gallerie; questa è una vera basilica in muratura con l’altissima volta e in fondo la grande abside nel mezzo della quale anticamente sedeva il vescovo. C’è ancora in essa l’incavo dove era infisso il trono marmoreo. Ed eccolo lì il vescovo moderno a lato dell’altare, ecco i celebranti, ecco il gruppo dei chierici cantori; indossano tutti i paramenti all’antica, morbidi e fluttuanti. Il giovane che dirige il coro è di spalle, ma le mani che si alzano e si abbassano, spiccano nere come l’ebano sul candore della cotta. In prima fila c’è un piccolissimo cinese con una voce così limpida che quando si espande sola dà l’impressione di luce, mentre dietro un negro gigantesco sprigiona una voce così cupa che pare il riflesso sonoro del suo colore. Quel complesso corale era un campionario umano che, sotto di Roma, cantava nella lingua di Roma. In piedi, nella penombra satura d’incenso stava la piccola folla che dalle strade asfaltate del soprassuolo era discesa nella profondità di quella invisibile basilica senza facciata, senza tetto, senza campanile, tutta scavata sotto terra. In fondo a un umido, stretto ambulacro, giuncato di fogli e di lauro, dove il canto ridiventava sotterraneo, nel centro di un basso arcsolio, un’epigrafe di due parole “Yacinthus Martyr”. Un vecchio fossore era lì e parlava di cose antichissime quasi ne fosse stato testimonio. “Quando si credeva che non ci fosse più nessun corpo di martire nelle catacombe, fu trovato quello di Giacinto. Erano poche ossa bruciate avvolte in un drappo intessuto con fili d’oro. I brandelli di quella stoffa emanavano ancora un sottile profumo”. Sotto una villa parolina, nel profondo della terra, un uomo, continuando nel mondo dello spirito l’antichissima figura del fossore, parlava così e il canto di un gruppo cosmopolita riempiva di voci latine le volte di una insospettata basilica. Pareva che Roma, perseguitata all’esterno dalla speculazione edilizia, anche monastica, si rifugiasse sotto terra come gli antichi cristiani. 247 Paese Sera, 23 gennaio 1960 UNA ROMA DIMENTICATA La Spina collocazione: Pg 52-54. “Non c’è rosa senza spine”, si dice; difatti la rosa più sbocciata di Roma, la piazza S. Pietro, aveva la sua spina. Era come un lungo aculeo, come un sottile ed acuminato aculeo di fabbricati che si insinuava tra un folto di altri edifici risultandone due stridette come due corridoi che si facevano largo a fatica tra case e casucce, palazzi e palazzetti, chiese e cappelle, fontane ed edicole e tante tante botteghe, uno addosso all’altra con caparbietà di chi vuole assolutamente stare in quel posto e non in un altro. C’era per quelle due strade il brusio del paese e quello del mondo, giacché la gente di qualunque terra e di qualunque colore che veniva a Roma, percorreva quei lunghi corridoi per sfociare in una immensità circoscritta, che era una piazza, per trovarsi di fronte a una montagna di granito fatta di colonne, pilastri, porte, logge, trabeazioni, fregi e cupole tra cui emergeva, come una immanenza, “er cupolone”. Dapprima gli occhi tentavano di misurare l’immensità della piazza, poi era il tempo a misurarla; il tempo che ci voleva per arrivare, un passo avanti l’altro, sino alla scalinata che portava all’ingresso di un’altra immensità, al tempio. Erano proprio quelle due stradine strette e soffocate a preparare gli animi per meglio avvertire le due immensità. Si chiamavano “Borghi” così come erano detti i raggruppamenti di case fuori della città, lungo una strada o attorno a un castello. In quel luogo, un tempo arido e malsano, gli imperatori avevano costruito giardini, circhi, mausolei. La via Cornelia andava proprio nel senso di questi Borghi, in direzione del luogo ove era la Basilica che le fu costruita sopra per includervi il sepolcro di un uomo povero e condannato che in quella campagna brutta e scoscesa, seminata di sepolture plebee e di modesti mausolei, si diceva fosse stato in fretta sepolto e nascosto. Su quel sepolcro ci fu eretta prima una “memoria”, poi una basilica il cui baldacchino si alzò sopra la memoria, finché su tutto si gonfiò, profonda come un cielo, la cupola michelangiolesca. Intorno alla primitiva basilica si erano raggruppati oratori, cappelle, monasteri e case, separati da strade, straducce e sentieri, ma la principale via ebbe sempre il tracciato della Cornelia. Nel Medio Evo essa era una strada coperta da un portico che dal ponte S. Angelo andava all’ingresso della basilica. I pellegrini, nella vicinanza del luogo sacro, non erano disturbati, né dal sole, né dalla pioggia; il portico li raccoglieva materialmente e spiritualmente. . Esso durò parecchi secoli, poi pian piano qua e là si scoperchiò, qua e là crollò; venne l’epoca in cui esso scomparve e la terra ridiventò campagna; ci si coltivarono gli orti; sorse tra essi qualche casolare e lentamente la vita riprese. 248 Il primo anno santo, ottima trovata spirituale e turistica di Bonifacio VIII, dette il via a un più rapido impulso costruttivo. Il tracciato della via Cornelia, già coperto dal portico, fu fiancheggiato da povere casupole, bottegucce e locande, poi il tempo e gli uomini, come sempre fanno, continuarono a distruggere e costruire, a migliorare e cambiare. Si tracciarono strade, si fiancheggiarono di case che si serravano l’una all’altra per dar posto a tutte. Tra costruzioni e abbattimenti, nella direzione dell’antica Cornelia, della medioevale “Portica”, risultarono due strade divise da una fila di case, che si chiamarono successivamente: Via Recta, Carriera Santa, Carriera dei Martiri, Via Beata, Via Pontificum, Via Alessandrina, Borgo Vecchio, Borgo Nuovo, e le costruzioni che le dividevano costituirono “la Spina” fino ai nostri giorni, quando furono abbattute e si fece quell’enorme vuoto che strada non è, piazza nemmeno, ma si chiama via della Conciliazione. La Spina divideva l’afflusso dei pellegrini a S. Pietro e, se tra bei palazzi e discreti palazzetti, aveva anche case povere e forse brutte, il tempo le aveva colorate, patinate e rese amiche. Cadde con la Spina un apporto secolare di vita. Cadde (una tra le tante case suggestive che caddero) quella cappelletta chiusa da un cancello, dove dentro ardevano dei ceri e tra le sbarre c’erano sempre dei fiori intrecciati. Si diceva che un papa avesse chiuso con quella cappella lo sbocco di un violetto tra i due Borghi, corto come un nano, per ammenda a una Madonna contro cui erano state gettate scorze di melone. Si abbatterono i confini di quella piazza Scossacavalli che il gorgoglio di una fontana bastava per riempire, mentre certe finestre che vi si affacciavano, ripetevano con la scritta dei loro architravi: Soli Deo, Soli Deo, Soli Deo. Si raccontava che su quella piazzetta, nel punto preciso dove sorgeva una chiesa, i cavalli che portavano la pietra di Isacco, si erano fermati e non era stato possibile farli più proseguire. Per diverso tempo la chiesa chiamò S. Salvatore in Bordonia, per i bastoni dei pellegrini, poi prese altri nomi, ci fiorirono altre leggende, altre poesie e ora non c’è più nulla, nemmeno il nome. Si poteva sanare quell’agglomerato di costruzioni e invece si abbatté tutto e si fece il vuoto che è nulla. La Spina, obbligando a vedere la piazza solo quando si era giunti a una sua estremità, ne scopriva di colpo tutta l’enorme vastità, mentre ora, per il fatto che essa è concava, la lontananza la restringe. Erano due vie strette sì, ma la vita vi brulicava e ferveva e, come tutte le cose che sono esageratamente se stesse, se concentrate, erano straordinariamente vitali. Quelle due strade anguste concentravano la vita e l’afflusso dei viandanti accompagnandoli allo sbocco. Dal fitto delle case si usciva in quella grandezza sonante di acque, di spazio, di vuoto; nell’insospettabile slargo la vita si diluiva e placava, restava sola l’immensa meraviglia. Con l’apertura del chiuso pare che gran parte di queste cose siano fuggite. Nello spazio risultante dalle demolizioni si poteva erigere qualcosa che conservasse un poco di quella immensa sorpresa emotiva. Invece la soluzione è quella che è già da tanti anni senza riuscire a convincere, senza riuscire a perdere nulla della sua muta freddezza: una processione di obelischetti con il lampione sulla testa, che in quell’enorme spazio rammentano i birilli, e tante panchine, utilissime per apparecchiarci sopra uno spuntino. Birilli e sedili, non c’è da illudersi, non diventeranno mai suggestivi. Ma in quel vuoto di cose e di emozioni, il sogno ha un 249 teatro vastissimo per esercitarsi. Anche un sogno fatto per riposo e per divertimento, è capace di mettere idee in quel vuoto di idee. E il sogno rialza e distende l’antico Portico, gli dà la quadruplice berniniana fila di colossali colonne, lo allarga sullo spazio che era occupato dalla Spina. Invece di una sola spropositata strada, il sogno ne vede tre: due ai lati, scoperte, per i veicoli, una nel mezzo per i viandanti, folta di colonne e coperta di volte, oltre la quale sarebbe veramente l’ingresso alla piazza del Paradiso. E non potendo più vedere S. Pietro in lontananza, esso non ricorderebbe più un “souvenir”, ma tornerebbe ad essere quella montagna che è, sorgente da un cielo rovesciato in terra. Ma un sogno ha la forza di una piuma che voglia rimuovere la pietra: il sogno allora scompare. Resta la freddezza semivuota di quella strada che è nuda come i gambi delle rose ottenute scientificamente: alte, fredde, dure, senza odore e senza spine. 250 Paese Sera, 30-31 gennaio 1960 IL FREGOLI DEGLI EDIFICI STORICI ROMANI Due millenni di storia sul sarcofago di Augusto Nacque tra due strade vitali, la Flaminia e il Tevere, e per parecchi secoli conobbe gli splendori pagani della vita e della morte, dominando il traffico terrestre e fluviale della capitale. Da sepolcro a fortezza collocazione: Pg 55-57. C’era a Roma un sepolcro, che in epoca non lontana, avrebbe potuto assurgere a simbolo della “itala gente dalle molte vite”, tante volte esso era risorto, tanti aspetti diversi aveva assunto, tanti svariati mestieri esercitati. Era il Fregoli degli edifici storici: sempre in scena, sempre diverso, sempre amato dalla folla. Di una trentina d’anni più anziano di Cristo, il mausoleo di Augusto nacque già col segno della vita, pur essendo destinato alla morte. Sorse tra due strade vitali, la Flaminia e il Tevere, a fianco di giardini tanto belli che una chiesetta, costruita di fronte a uno dei loro ingressi, si chiama tutt’ora “sancta Maria in Porta Paradisi”. Per parecchi secoli il mausoleo conobbe gli splendori pagani della vita e della morte. La statua di Augusto, altissima sul pilone centrale, dominava lì intorno il traffico terrestre e fluviale, i sontuosi edifici e gli ombrosi giardini, gli alti pioppi, che facevano bosco intorno. Poi le ondate barbariche si fransero anche contro il mausoleo, dove la ricchezza diminuiva il rispetto per la morte: devastazioni e trasformazioni cominciarono. Venne il silenzio del Medio Evo, che stese una coltre di terra sopra il gigantesco sepolcro, trasformandolo in uno dei tanti monti artificiali di Roma, il Mons Augustus. “In suo cacumine” sorse una chiesetta; tra le rovine delle vecchie costruzioni la gente rabberciò la sua dimora. Il Mons Augustus restò quieto nella paurosa attesa del misterioso anno mille, che passò come tutti gli altri; poi nel rozzo ritorno di vita si trasformò in una fortezza, “l’Agosta”. Dentro i signori, fuori il popolo, e attacchi, difese, espugnazioni su quel sepolcro, che era tanto grande perché più solenne fosse il sonno della morte. Anche la fortezza si sgretolò come il sepolcro, e la terra di nuovo ricoperse tutto e su tutto si piantò una vigna. Qua e là, addossate o vicine case e case, chiese e chiese, che tutte prendevano indicazioni da questa tomba: “…prope Mons Augustus; …non longe a monte qui Augustus dicitur…”. Intanto per l’azione delle piogge e della coltivazione affiorarono colonne e statue, metope e triglifi, i vecchi ambulacri diventati grotte danno urne, sarcofaghi, epigrafi. Il monte è una cava di marmi per alimentare le vicine calcare, che da essi trarranno la calce per tirar su catapecchie e case. Quel che restava del mausoleo di Augusto fu sconvolto e frugato finché parve esaurito. Il secolo d’oro, che stendeva giardini dove poteva, ne stese uno anche sul terrapieno del mausoleo; esso fu 251 tra i più affascinanti giardini all’italiana, allora di gran moda. Ma nel roboante secolo successivo il giardino scompare e al suo posto c’è una arena per giostre con bufale e vaccine. Gare di destrezza e tornei si alternano con fantastiche feste notturne, e fino alla metà dell’800 il sepolcro di Augusto fu incoronato da pazze girandole, da razzi che foravano il cielo, da portentose piogge d’oro, da soli roteanti, da effimere inesauribili costruzioni di fuoco. Intanto esso perdeva il suo nome, diventava il “Corea”, perché ridotto ad anfiteatro dagli ultimi proprietari, i Correa, che i romani pronunciavano “Corea” come ancora dicono “tera” invece di terra. Continuano però i circhi, le giostre, le notturne orge di giochi pirici e in più ci si danno rappresentazioni teatrali. Diventò per breve tempo, quasi profetico accenno, teatro stabile per musica popolare, finché, ricoperta l’arena con un lucernario, furono possibili anche le rappresentazioni serali. I più grandi artisti dell’epoca passarono per il Corea, che a un tratto diventò magazzino. Il sepolcro del primo imperatore era il solo magazzino capace di ospitare il cavallone del monumento all’ultimo primo re d’Italia; due decenni di umiliante vigilia e il magazzino diventa la più suggestiva sala di concerti che il mondo abbia conosciuto, prende trionfante il nome di Augusto e fu l’apoteosi! Il mausoleo aveva conosciuto preci e bestemmie guerresche, colpi di piccone e di zappa, vigneti e fiori, folle tumultuose e incendi favolosi, polvere e sole, conobbe allora la grande quiete devota, sotto una cupola gonfia di musica, con una folla religiosa e muta; fu davvero un tempio dell’arte e tutto il mondo ce lo invidiò. Ma arrivò anche l’ultimo concerto, giacché era stato deciso di sradicare tutta la vita che si era abbarbicata addosso al monumento, e di restituirlo alla morte. Vi fu un pieno inverosimile; la commozione che tramava in ogni cuore traboccava nell’aria, diventato tutt’uno con le ultime armonie: musica fatta commozione, commozione fatta musica e l’immensa sala ne fu colma. Alla fine del concerto non “scrosciò” l’applauso, fu un battimento lento, intenso, uguale, parve non dovesse finire più. Era un dolore che applaudiva per manifestarsi era la appassionata protesta per un delitto vicino al compimento. L’orchestra, che doveva essere l’applaudita, applaudiva anche essa e la gente non si staccava di lì; era in piedi, seria, triste, e batteva le mani. Pareva che qualcuno dovesse parlare, ma nessuno parlò; nessuno usciva da quelle porte, tra le quali erano soliti sgusciare frettolosi all’accenno degli ultimi accordi. Per i romani una cosa tanto amata, moriva; le si dava così un addio accorato. Il fatidico piccone, simbolo di un’epoca, cominciò presto l’opera sua: lunghi mesi di polverone, di terriccio, di pena e tutto intorno la grande opera fu compiuta. Apparve un torsolo nudo, brutto, inespressivo, quasi osceno come lo diventano, sotto la luce, le cose fatte per essere coperte. Si vide il sepolcro vuoto e repellente come una cassa da morto usata. Le mura sbrecciate e smozzicate furono pareggiate, perché le rovine dovevano presentarsi con l’uniforme in ordine; una rovina capricciosa non era permessa. Finita la sistemazione della zona, quel povero rudero gareggiò in miseria e bruttezza con l’antesignana di tutto lo scatolame nazionale, la scatola dell’Ara Pacis. Son passati tanti anni e quel mozzicone imperiale non rivive, resta sempre un sepolcro affossato, diventato 252 lui stesso il morto. In tutto questo tempo si è parlato di un auditorium, che sempre sarà e mai non è, quasi fosse trattenuto da un malocchio; forse quel sepolcro denudato agisce da Tutanchamen. Per placarlo rendiamogli la sua sana ed asciutta calotta al posto di quella di terriccio, umida e disgregatrice. Dalla distruzione ad oggi il tempo è punteggiato dalle proposte di ricostruire la sala lassù. Si potrebbe far qualcosa sul tipo del “Palazzetto dello Sport”; non nasconderebbe nulla e le rampe di sostegno potrebbero diventare scale per il rapido sfollamento. Riprenderebbe l’originale nome di Augusto; il mondo è pieno di “auditorium”; a Roma stessa ce n’è uno, se lo son fatto i preti e qualche volta, gentilmente ce lo prestano. E’ uno stanzone rettangolare, forse tecnicamente adatto, ma brutto. Il nostro avrebbe la forma perfetta del circolo e, alto, su quel centralissimo rudero, sarebbe almeno un poco pagano. Durante i concerti dell’Augusteo, a una certa ora, le campane di S. Rocco disturbavano l’attenzione coi loro rintocchi. Quelle campane erano le scocciatrici fisse, come le questuanti per beneficenza; nessuno le amava. Adesso però, se si trattasse davvero di riavere l’Augusteo, la gente farebbe festa anche alle campane di S. Rocco. 253 Paese Sera, 1 maggio 1960 S. GIUSTO TORNA OGNI QUATTRO ANNI Il santo bisestile Come nacque febbraio col suo giorno bisesto – Il Martirologio romano segue l’uso del calendario giuliano – Le regole del lunario – Duecento chiese dedicate alla Madonna e cinquanta al Salvatore collocazione: Pg 58-60. Febbraio col suo giorno bisesto è bello e finito. Ma prima di staccare e buttare il relativo foglio del lunario diamo un saluto a S.Giusto, per quattro anni non lo incontreremo più. Tre volte “febbraietto corto e maledetto” finirà con S. Romani, il giorno 28, poi tornerà ancora S. Giusto nell’anno bisestile, col giorno 29. Pare una congiura dei lunari popolari contro di lui. Il Martirologio romano, seguendo l’uso del calendario giuliano, negli anni bisestili ripete un giorno tra il 24 e il 25 febbraio, quello che nel computo romano, che come si sa andava a ritroso, era il “sexto kalendas martias” e che per venire annunziato due volte diventava “bis sexto kalendas martias”, da cui il nome “bisesto”. Passati poi ad indicare i giorni con un numero progressivo cominciando dalle calende, il 1°, cioè di ogni mese, negli anni bisestili febbraio risultò di 29 giorni, e il giorno appunto parve essere l’ultimo. I lunari attingono i loro santi dal Martirologio Romano, e se in questo la commemorazione di san Giusto cade tutti gli anni, o al 28, o al 29 febbraio, perché essi, tra i tanti santi del giorno, perché proprio a s. Giusto riservarono un ricordo così limitato? Ma la cosa più curiosa è che la stessa ingiustizia che i lunari hanno per S. Giusto, ce l’ha avuta anche Roma. Questa nostra città, capricciosa come le belle donne, è la città delle mille e mille chiese. Non si intende riferirsi alle chiese che ci sono oggi, ma a tutte quelle che nella sua non lunghissima vita cristiana, sorsero, durarono, caddero: a tutte quelle chiese che respirarono nella sua atmosfera, che spesso lasciarono un segno del loro passaggio, qualche volta con meno di niente, col ricordo di un nome estroso a una località, a un edificio. Se le chiese che Roma ha elevate, consumate e distrutte, potessero ad un tratto riapparire tutte, accanto a quelle esistenti, noi ci aggireremmo in una immensa città di santuari dai nomi più curiosi, le cui sorprese ci spingerebbero a una straordinaria esplorazione. In questo mondo mescolato di esistenze reali con esistenze evocate, noi troveremmo chiese dedicate ai Sette Santi Dormienti, ai Santi Caio, Portogallo, Zotico, Anigro, Passera, Macuto, Simmetrio, Stratonico, alle sante Degna e Emerita. C’è anche un allarmante S. Siluro, una Indola, “nome di santa sconosciuta” dice Carlo Cecchelli, il mago delle chiese che furono. Alla curiosità dei titoli corrisponde quella del numero delle chiese che lo stesso santo spesso possedeva. 254 Le chiese dedicate alla Madonna superano quelle dedicate al Salvatore, neppure cinquanta per lui, più di duecento per lei. I santi Giovanni, Lorenzo, Stefano, Nicolò, Andrea ne hanno chi poco meno chi poco più, una trentina ciascuno. Santi inesistenti perché il loro nome provenne da strani accoppiamenti o da corruzioni di parole, ne hanno più di una, come S. Abaciro che ne ha tre senza contare qualche oratorio in coabitazione con altri santi. Tra queste migliaia di chiese esistenti o esistite, se ne cercherebbe invano una dedicata a S. Giusto. Eppure tra una decina e più di santi Giusti che registra il martirologio romano, ce ne sono alcuni che avrebbero meritato di avere in Roma almeno una chiesetta. C’è quello che partì proprio di qui per andare ad evangelizzare l’Inghilterra: c’è il soldato che folgorato da una improvvisa conversione fece appena in tempo a distribuire ai poveri tutte le sue sostanze, che, calcatogli sul capo un elmo,infuocato, fu torturato, bruciato e finito con la spada, perché i martiri spesso resistevano al fuoco ma non resistevano mai alla spada. C’è il vescovo Giusto, dotato di spirito profetico, che rinunciò alla carica e se ne partì col suo “lettore” dove visse in vita “quasi evangelica”, dice il Martirologio e poi passò a ricevere “ la corona della giustizia”. Un piccolo oratorio per questo santo sarebbe stato un ottimo memorandum. C’ è un S. Giusto bambino che fu decapitato: neppure i teneri nostalgici dell’infanzia pensarono mai a costruirgli un’edicola. C’è uno studente di lettere che un giorno, col fratello, gettò nella scuola le tavolette e si presentò spontaneamente per ottenere il martirio. Tutti e due furono portati subito fuori porta e accontentati. , ma qui non fu eretta per loro neppure una memoria. Questa specie di congiura del silenzio di Roma e dei lunari intorno ad un nome, è certo dovuta al caso, ma a noi strappa un sorriso. Come se ad un tratto in essa noi scoprissimo quello che oggi sta affiorando: la stanchezza delle parole. Su fatto antico delle chiese, sul fatto vecchio dei lunari, si sovrappone il fatto nuovo, quello che è nostro. Noi ci siamo nutriti di grosse parole come: democrazia, libertà, giustizia. Abbiamo esagerato nel nutrimento e ne siamo intossicati. Quelle parole così difficilmente sane, così spesso gonfie e vuote, ci hanno fatto male, noi ne siamo ammalati. Ne siamo intontiti perché guerreggiamo con esse buttandocele scambievolmente contro la testa. Siamo arrestati nell’azione da queste parole idropiche che vogliono dir tutto e possono dire nulla. Ma c’è anche chi ne sta guarendo e ha per le parole grosse la nausea che resta per un cibo che ci fece male. Se proprio non vogliamo fare come Roma che escluse addirittura qualsiasi Giusto dalla congerie dei suoi santi, facciamo almeno come i lunari: una volta ogni tanto, ma non troppo spesso. 255 Paese Sera, 30-31 gennaio 1965 ITINERARI MISTERIOSI NEL TEMPO Il Pantheon: il più enigmatico monumento romano Non si è mai saputo di certo come, quando, perché sorse – La sorte di questo edificio segue molto da vicino quella del suo eterno abitatore: il gatto collocazione: Pg 64-66. Che cosa sia il Pantheon i dotti certo lo sanno, ma noi che leggiamo i dotti non ci capiamo nulla. Come sorse? Non lo sappiamo. Una cosa sola è certa che esso sorse sull’acqua. L’unico edificio dell’antichità classica restato intero concreto e stabile come un personaggio corpulento in una folla di fantasmi, il più sicuro nella sua forma, così solido nonostante il tempo, i terremoti, il fuoco i fulmini e gli uomini che ci si sono sempre arrampicati intorno per studiarlo, accomodarlo, sfruttarlo, vincolarlo, liberarlo, sgretolandolo come potevano, che sta lì potente quasi roccia naturale, nelle sue origini è incerto e fluttuante come un liquido che si adatta a tutti i recipienti. Rientra in ogni processo costruttivo e ne sfugge. Dubbio e mistero, questo è il Pantheon, ma che sorse dall’acqua è sicuro. L’acqua stagnava in quel basso da quando si formarono le colline sulle quali sarebbe sorta Roma. Per quanti millenni in quel punto furono soli l’acqua, la terra, la melma, la vegetazione lacustre? Poi l’uomo cominciò a passare da quelle parti perché le sue bestie ci trovavano qualcosa da brucare, poi, come uno scoppio, la città che sulle alture vicino era sorta e stava assoggettando il mondo, vuole sottomessa anche quella zona paludosa. “Io a settentrione, tu a meridione” – deve aver detto Augusto ad Agrippa. Incanalate le acque fino al Tevere, prosciugata e bonificata la zona, eccola coperta di giardini, mausolei, terme, portici, obelischi, templi; diventa la più bella di Roma. Vispanio Agrippa sanava e costruiva dove erano stati gli acquitrini, Mecenate faceva altrettanto su un fasto colle cimiteriale dove si buttavano le carogne degli animali e i cdaveri dei poveri. Allora il Pantheon è di Agrippa? Un po’ sì, un po’ no. Ma la dedica che tutt’ora si legge sul frontone? Non è la sua, è di uno che lealmente volle restituirgliela, ma poi di nuovo gli scappa di mano. E allora chi lo dedicò, chi lo restaurò, chi lo rifece, chi lo rimaneggiò, e chi soprattutto gli dette questa perfetta forma circolare? E il portico è stato fatto prima della rotonda? Dopo? Insieme? No, prima lui. No, prima lei. No, pari età. E poi ne sappiamo quanto ne sapevamo prima. Sì, ma la calotta però è ciò che era, la calotta è quella. Quella, d’accordo, ma di quando? Anche essa sorge dal mistero. Fu girata con sistema empirico, dice uno. No, assicura l’altro, essa è un prodigio di sapienza architettonica. E la cupola resta muta come un cielo immobile, gonfio di aria in penombra. Tutti gli imperatori più attivi in edilizia lo restaurarono, lo ritirarono su quando per vecchiezza cadeva e non avrebbe dovuto essere vecchio se le storie precedenti erano vere. L’età e il fuoco, le mutevoli usanze e i 256 capricci del gusto, tutto lavora per pasticciare quell’edificio che è il solo a scavalcare intero i secoli. Rutture e rabberci, demolizioni e ricostruzioni, forature e rattoppi, deturpato e restaurato, più volte soffocato da case e stambugi e più volte liberato, esso non ha mai svelato il mistero delle sue origini. Qualunque cosa sia venuta alla luce, ha complicato l’enigma. Si scopre un pavimento molto più basso di quello attuale? Potrebbe essere quello di Agrippa. Nossignori, è di molto dopo. Chi ci dirà mai che cosa fece veramente Agrippa? Il suo tempio era solo un pezzetto di questo odierno? Forse sì, forse no. Si scoprono mattoni con tanto di data impressa? Dunque, eccola la data del rifacimento. Adagio, potrebbe essere stato adoperato materiale scaduto, mattone non è medicina, è buono lo stesso! Domandare qualcosa di sicuro al Pantheon vuol dire snaturarlo, è simile a quelle creature umane che all’anagrafe sono segnate come figli di nessuno. Peggio esso ha oscuro anche il nome oltre il patronimico. Era definito così come al dire il tutto santo, il tutto divino?? O fu detto cosa divina, cosa celeste per la sua forma rotonda, per il suo immenso tolo emisferico come il cielo? Quella cupola era la forma del cielo sulla terra e il suo nome diceva questo? L’ipotesi già si faceva quando il tempio era nel suo massimo splendore e i cristiani erano conosciuti come una delle tante sette che sbarcavano a Roma da tutti i punti cardinali. O fu sacro alle sette divinità planetarie per le quali il cerchio è moto, essenza e forma? Oppure fu dedicato a tante divinità, prima fra tutte la coppia progenitrice della gente Giulia, Marte e Venere? Parrebbe così se si pensa ad Augusto, il discendente, che avrebbe rifiutato l’onore di porre il suo simulacro nell’interno del tempio, lasciandolo fuori dalla porta in una delle due nicchie laterali; nell’altra ci sarebbe stato Agrippa, parente d’acquisto della gente Giulia. Certo che quel nome facilmente lascia supporre un’accolta di statue di divinità, di tante, di tutte. E così mettendocele tutte siamo trasportati da un’idea piena di malìa e d’ironia. Se davvero ci fossero stati tutti gli dei, essendoci tutti, non ce n’era nessuno; c’era l’idea frantumata della divinità. Nella sua forma circolare, nei nicchioni ricavati simmetricamente, ognuno uguale all’altro, nelle edicole che si ripetono tutt’intorno, c’è l’impossibilità di dare a un dio un posto preminente. Un momento! Il tempio non è tutto uguale: c’è un grande arco che prospetta quello di ingresso; una simmetria architettonica, o un posto riservato, un trono, un tabernacolo? Se lì c’era un dio, quello era il maggiore. E allora potrebbe essere vero che il tempio fosse stato dedicato a Cibale e che il simulacro della gran madre fosse lì. Sul colle capitolino c’era un tempio dov’erano raccolte le statue delle province dell’impero. A ogni statua corrispondeva un campanello; se nella provincia, anche lontana quanto i confini del mondo, scoppiava una sedizione, il campanello suonava. Quello della Persia aveva squillato a lungo, si dette ad Agrippa l’incarico di domare l’insurrezione, ma Agrippa ne fu turbato. Ed ecco che una notte gli appare una donna alla quale egli confessa le sue preoccupazioni. Come tutte le madonne che appaiono, in cambio del suo aiuto chiese un tempio del quale aveva anche preparato il disegno e perché non si sbagliasse gli disse di essere Cibele e scomparve.. Mantennero la parola tutti e due e Agrippa innalzò il Pantheon. Siccome nei templi pagani trasformati in cristiani, c’è sempre una analogia tra il vecchio titolare pagano e quello nuovo sostituito dai cristiani, il fatto che la dedica cristiana fosse fatta alla Madonna e a tutti i martiri potrebbe essere una prova che quella pagana fu fatta alla Magna Madre di tutti gli dei. 257 Comunque se il Panteon veramente rappresentò sulla terra un olimpo, bisogna dire che proprio come un olimpo è misterioso, discusso sempre di fronte a un collegio arbitrale. L’epoca in cui questo misterioso olimpo sarebbe sorto coincide con quella in cui il gatto, animale sacro e misterioso, per la prima volta posò le sue zampe sul suolo romano e il suolo dove le posò è proprio lì; di fianco al Pantheon dove gli egiziani ebbero il loro quartiere. Assoggettato l’Egitto da Augusto proprio in quell’epoca, per quella specie di simbiosi politica che Roma attuava, una colonia romana si stabilì in Egitto, una colonia egizia si stabilì a Roma. Ogni colonia arrivava nel paese non suo con i propri bagagli culturali e religiosi. L’Egitto arrivò col gatto: Roma lo incontrò per la prima volta proprio in quei paraggi. Lo vide idolatrato da vivo e da morto; assisté attonita ai funerali della piccola mummia a quattro zampe; imparò a caro prezzo che il gatto non si tocca. E tra l’Iseo e il Perapeo, in quella foresta di sfingi di obelischi di fontane, certo c’erano anche statue di gatti se una sta ancora lassù, in pizzo alla prima cornice di palazzo Graziali. Pantheon e gatti sono contemporanei, apparvero insieme gli uni vicino all’altro e insieme sono rimasti e si assomigliano. Difficili da capire loro, difficile da capire lui. 258 Paese Sera, 31 gennaio 1965 (seconda parte: la prima era già stata pubblicata anche il 16 gennaio 1965) ITINERARI MISTERIOSI NEL TEMPO: IL PANTHEON Il primo tempio pagano che diventò basilica Un compromesso fra l’illegale imperatore bizantino Foca e il Senato di Roma – Un nome popolaresco e affettuoso Maria Rotonda collocazione: Pg 61-63. Ormai si conosceva tutto di Roma; chi andava vedeva, chi tornava raccontava o scriveva; chi restava ascoltava o leggeva. Del Pantheon non si sapeva solamente che era un tempio splendido come un Olimpo in terra, che gli si apriva davanti una piazza fiancheggiata dai portici, che alle spalle aveva terme lussuose dove bastava entrare per incontrarci mezzo mondo, ma si sapeva pure che aveva vicina l’“insula” più alta di tutta Roma, quell’insula che, se ci fosse stata la parola, sarebbe stato il grattacielo dell’impero. Nelle case d’affitto i poveri si ammucchiavano all’insù, verso il cielo, mentre i ricchi, con le loro “domus”, si distendevano in superficie. La gente che veniva dalle province frequentava quelle terme più delle altre proprio per la vicinanza di quel tempio che era un po’ di tutti. La religione di Roma, rituale propiziatorio o antropomorfismo, sempre identificata con lo Stato, aveva dovuto sostenere l’assalto dei misteri di Oriente e s’era difesa prima ostacolando, infine accogliendo. Purché non sia disturbato il culto statale Roma dà il diritto di cittadinanza a tutte le religioni. Forse esse simbolicamente vennero davvero accolte in quel tempio la cui architettura dice “unità”. Non ci sono linee spezzate, c’è il cerchio che raccoglie, unifica, concentra; non ci sono finestre che frazionano, ma un’unica sorgente di luce che scende dall’alto della cupola non conclusa e illumina ugualmente ogni punto del tempio. A tutte le religioni Roma poté restare indifferente, ma a quella cristiana no perché fondendo essa etrre e popoli in un’unica chiesa, era troppo simile al suo impero. Paura giustificata? So interroghiamo il Pantheon al solito esso ci risponde sì e no. Però essendo riuscita a imporre il suo “segno” al posto delle “signa militaria”, gli imperatori diventati cristiani emanarono gli editti di chiusura di tutti i templi pagani. La quasi inamovibile porta del Pantheon fu serrata e al di là restò abbandonato muto e impenetrabile quell’enorme spazio nel quale per due secoli nessun romano mise più piede. Se si pensa a quante generazioni occorrono per riempire due secoli, si resta sbalorditi a vederle passare per duecento anni avanti a una porta chiusa. Forse questo fu possibile perché sulla vecchiezza del popolo romano si stendeva lentamente un’età che, essendo un passaggio, era vecchia e infantile. I due estremi si raccontavano le favole tra di loro e quelle del medioevo, si sa, erano tutte confezionate con miracoli e demoni mescolati insieme. Il demonio, simile a Dio, era in ogni luogo, poteva nascondersi in ogni cosa o persona e pare che facesse proseliti dappertutto se è 259 vero che anche due papi si dedicarono al suo servizio. Nel secolare periodo in cui, per legge, i templi pagani restarono chiusi, tutti i demoni dislocati nella città eterna, si erano asserragliati nel Pantheon do dove ogni tanto uscivano per bastonare i cristiani che passavano di lì. Un tempio così ambiguo era campo connaturale per una lotta tra Dio e il demonio, il male e il bene, il paradiso e l’inferno. E la tenzone fu possibile per un compromesso tra il barbaro ed illegale imperatore bizantino Foca e il Senato Romano che ne accolse l’immagine. L’imperatore cedeva il tempio pagano al papa, il papa innalzava a lui nel foro una colonna onorifica. Scambio di omaggi, scambio di epoche. I due grandi battenti della porta si spalancano e, dopo gli esorcismi, allo squillo del “gloria!” che risvegliò l’eco sonora del tempio, tutti videro uno sciame di atterriti demoni che fuggirono “spertugiando” dall’apertura della cupola. Così, nel compimento del primo decennio del secolo VII, nel mese di maggio, proprio in quei giorni in cui l’antichità romana celebrava la festa della fioritura, toccava proprio a lui la sorte d’essere il primo tempio pagano trasformato in chiesa cristiana. Pochi anni dopo toccherà anche alla Curia, il palazzo Madama dell’antichità, ma la sua trasformazione riuscì bene, mentre il Pantheon, per quanto si cercasse di mascherarlo, restò sempre pagano. Pagano e sempre in piedi, così come mai completamente interrata restò la colonna onorifica per Foca. Emerse sempre da quel foro che diventerà il Campo Vaccino, così sola che il cavalier Vasi nella seconda metà del ‘700 scriveva che se ne stava appartata e nessuno poteva indovinare di dove fosse venuta. Era difficile indovinarlo; la sua carta d’identità, scolpita sulla base, era interrata con essa da secoli. Forse per analogia alla vecchia dedicazione pagana, Bonifacio IV lo dedicò alla Madonna e a tutti i martiri. Per questo furono trasportati 28 carri di ossa dei medesimi raccolti nei cimiteri cristiani. Non è vero perché allora le catacombe non si manomettevano, ma il passaggio da una folla di dei iracondi, arditi, gioiosi, vendicativi, ma sempre esprimenti vita, a questa ondata di trucidati, di rinunciatari alla vita, è melanconico lo stesso. Ma tra le due dedicazioni c’erano secoli, non decenni. Invece qualche decennio dopo l’imperatore Costante venne a Roma ne ammirò tutto, anche le tegole di bronzo dorato a forma di scaglie che brillavano al sole caduto sulla terra, ammirò e manomise la cupola portandosi le tegole in Oriente. Togliendo le tegole di bronzo dorato ruppe una unità che non fu ritrovata con tutte le diverse coperture e rabberciature di piombo che si fecero nei secoli. La rottura di quella unità preparò le crepe per i fichi che al posto dei lauri e dei cipressi incoronarono quell’edificio che poteva ora apparire come il mausoleo del paganesimo. La fantasia dell’epoca che appioppava origini miracolose a tutto quello che non capiva, ne dette una anche all’occhialone. Chi poteva aver fatto una cosa simile? Solo il miracolo e lo aveva fatto un papa che, prigioniero lì dentro, con quella porta fortemente serrata, sotto quella volta senza finestre, scampo non vedeva; fece un segno di croce e lassù s’aperse quel vuoto dal quale il papa “spertugiò”. Più tardi, non per miracolo, ma per complesso meccanico, un simulacro di Madonna s’innalzava tra nubi e angeli “spertugiando” di lassù per rappresentare la sua assunzione in cielo. Invece nella domenica “della Rosa” 260 durante la messa del papa, da quel vuoto si faceva cadere sul popolo una pioggia di rose. Intanto tra fantasie e cose vere, l’edificio cristiano aveva assunto un altro nome: Maria Rotonda. Per un millennio più qualche secolo fu il suo, finché col trasporto qui della capitale diventando tutti dotti e retorici, si perse l’affettuosa confidenza che avevamo con i nostri monumenti e restaurammo il Pantheon senza dimenticare l’acca. Maria Rotonda era tanto amata dai romani che il senatore, assumendo la carica, giurava di conservare al papa S. Pietro, caste S. Angelo, la città di Roma, aggiungendo “et Mariam Rotundam”. Era lui a pronunciare le parole, ma era il popolo a volere la cosa. Difatti Maria Rotonda fu rispettata anche quando toccò a lei pure di essere trasformata in fortilizio dai rivoluzionari di allora che ci si asserragliarono; per non attaccare Maria Rotonda si patteggiò con apparente disonore. Maria Rotonda diventò poi la Rotonda, o la Ritonna, a seconda del parlare più o meno civile. Anche i papi mostravano di prediligerla conservando in essa una delle più importanti reliquie, il Volto Santo. Era tenuta in una cassa con 13 serrature, le rispettive chiavi affidate a 13 ex caporioni del luogo; per rubarla ci sarebbe voluta l’unanimità. Se il Pantheon non fosse stato trasformato in chiesa, lo sarebbe stato il castello e allora ci rimarrebbero solo ruderi anche se poderosi. Ma restò sempre una chiesa incerta in cui il vecchio non moriva e il nuovo non attecchiva, restò senza dirci mai chiaro che cosa era. Aveva vicina la strada “ad duos amantes”, ma anche il tribunale della Inquisizione che lavorando non solo intorno a questioni di eresia, ma anche di magia, vi coinvolse i gatti aiutanti delle streghe. Dei gatti in tutto questo periodo poco sappiamo, ma che la loro condizione fosse terribilmente decaduta da quando nel tempio della dea Luna, occulta e misteriosa, vivevano incensati dai sacerdoti che da loro traevano auspici, questo è sicuro. Se il cristianesimo aveva esagerato chiamando demoni gli antichi idoli, anche l’Inquisizione esagerò. La gente accoppiò i gatti con le streghe, li perseguitò, li torturò, li impiccò, li bruciò vivi. Solo i gatti divisero con l’uomo la condanna al rogo. Il gatto, l’animale che non conobbe il sacrificio, ma il martirio. 261 Paese Sera, 9 marzo 1967 SANTA FRANCESCA ROMANA Oggi la festa della patrona degli automobilisti collocazione: Pg 67-68. Stamani, in occasione della festa di Santa Francesca Romana che fu proclamata da Pio XII patrona degli automobilisti, l’Amministrazione comunale, rinnovando un’antica tradizione, renderà omaggio alla “compatrona” di Roma nel tempio a lei dedicato sul Foro Romano. Alle 10, nel corso di una breve cerimonia, sarà deposto un cuscino di fiori intrecciato con nastri dai colori cittadini sulla tomba nella quale riposano le spoglie mortali della santa alla quale i romani, che familiarmente la chiamavano “Ceccolella” hanno sempre tributato affetto e venerazione. Questa la storia di “Ceccolella”. Tutti sappiamo che sul Campidoglio, in epoca romana, sorgevano con altri edifici, il Tabularium, il Tempio di Giunone Moneta, quello trino di Giove che, come una cattedrale, si ripeterà in tutte le città Romane. Ma nel medioevo quando il colle era ridotta ad una impervia altura dove si arrampicavano le capre, tanto che cambiò il vecchio glorioso nome con quello di Monte Caprino (il Foro sarà il Campo Vaccino), la fantasia calda di quei lunghi secoli di mezzo favoleggiava, come se fosse storia, delle grandezze antiche di quel luogo. Un muro altissimo rivestito di vetro, d’argento, d’oro ed ornato di intarsi preziosi, cingeva il colle. Dentro c’era un palazzo ornato d’oro e di pietre preziose: templi di pietre colorate e troni e archi e colonne e pergolati d’oro. Il Campidoglio era chiamato “aureo” perché splendeva sul mondo intero. E c’era una torre altissima che indirizzava i navigatori verso Roma, di giorno con lo scintillio dell’oro di cui era coperta, di notte con una poderosa lampada ardente: sulla torre c’era uno specchio magico dentro al quale si poteva vedere tutto quello che succedeva nelle più lontane province dell’impero e , in caso di sollevazioni, correre a sedarle. Si chiamava “la Torre degli specchi”. Poi la torre fu demolita ma restò il suo nome ad una strada stretta ai piedi del Campidoglio: quando la si allargò distruggendone un lato ,le si tolse il nome, e diventò Via del teatro di Marcello. A ricordarci questa leggenda c’è ancor oggi, attaccato al grande edificio che guarda la Rupe Tarpea, il monastero delle nobili Oblate di Tor de’ Specchi. Poche cose a Roma sono romane come questo monastero. Oramai le congregazioni religiose costituiscono catene come gli alberghi: la proliferazione è la loro gloria maggiore: questa congregazione invece è composta di quella casa sola che conserva il nome di Tor de’ Specchi e proprio nel non voler modificarsi, nel voler essere e restare solamente romana, la sua gloria più bella. Di famiglia romana la fondatrice. Francesca venne al mondo pochi anni dopo che Cola di Rienzo aveva fatto uno scavo di romanità nella coscienza addormentata del popolo, a Parione presso Piazza Navona: entrò sposa nella romanissima famiglia dei Ponziani, visse a Trastevere in quella piazza che si chiama ancora così:Raccolse a Campitelli, accanto alla torre che ancora era in piedi, la congregazione delle sue oblate. 262 Seguendo la vita di questa santa che non stava mai ferma si gira tutta Roma. Si ritrovano antiche vestigia, vecchie chiese, nobili palazzi con le loro virtù e le loro miserie, si va per i vicoli brulicanti di popolo con i suoi mestieri e la sua povertà. Scorrendo quella vita si è presi nel complesso aggrovigliato di quella storia politica e religiosa che per una donna dei Ponziani era quello che è per noi la cronaca, i fatti del giorno. Perché lei non si estraniava dagli avvenimenti pubblici ma ad esse dava la sua collaborazione. Essa si tuffava, per alleviarle, nelle miserie materiali e morali che erano tante in tutti i campi. La canonizzazione fissò il nome di Francesca, il popolo ci aggiunse Romana e fu Santa Francesca Romana: ma quella che oggi è chiamata così nella vita era “donna Ceccolella”. Sono circa 15 anni che questa romanissima santa è stata dichiarata patrona degli automobilisti, ma, a quanto pare, il campo della sua tutela è limitato a Roma. “Ceccolella” ebbe la vita travagliata dai demoni e difesa dagli angeli. I demoni la straziavano con ferro e fuoco, la flagellavano con i serpenti, la lasciavano tramortita per i maltrattamenti. Ma c’era l’angelo, un piccolo angelo bambino vestito da grande con camice bianco e tonacella da sudiacono che interveniva quando i monaci la torturavano: bastava che egli scotesse la testina e quelli scappavano. Il solo affiorare di quei riccioli d’oro metteva in fuga mezzo inferno. Il piccolo angelo che lei sola vedeva, qualche volta si nascondeva per avvertirla di un difetto che incrinava la sua azione. Ma altre volte l’avvertimento era più energico: la schiaffeggiava, la buttava a terra e la batteva. I presenti sentivano i colpi ma non vedevano chi li somministrava. Era bastonata da angeli e da demoni, dunque e lei distingueva benissimo chi era a dargliele. Pochi anni prima della sua morte Dio richiamò il piccolo angelo vestito da suddiacono e lo sostituì con un arcangelo vestito di luce molto più importante, più forte, più grande dell’altro: per mettere in fuga le forze infernali non occorreva neppure che scuotesse la testa, bastava un suo sguardo. Ceccolella sentì l’aumento del suo apporto anche nella parte “istruttiva”: la schiaffeggiava e la percuoteva più rapidamente. Quest’angelo si esprimeva coi fiori e con il lavoro: tesseva filava aggomitolava fili sottilissimi d’oro da interminabili matasse e ogni tanto offriva mazzi di rose rosse, di rose bianche, di violette. Quando mancavano 190 giorni alla morte di Ceccolella egli incominciò una nuova tela, le disse che sarebbe stata di 100 fili, poi ne avrebbe fatta una seconda di 60 e una terza di 30. Mentre “Ceccolella” agonizzava vide che si apprestava a finirla. Essa con la luce dell’angelo aveva potuto leggere di notte e girare nei grandi complicati edifici di allora senza lucerna. Anche i santi del paradiso le facevano avere mazzi di fiori perché li passasse al suo angioletto. Alle donne insegna prima i doveri della casa, poi quelli della pietà. “Prima di andare a messa, o donna, guarda se hai rifatto il letto”. A questa Santa, dunque, già Advocate Urbis, è stato affidato il compito di sorvegliare le automobili. Il simbolo di questa protezione calza. E’ come la compagnia dell’angelo che aveva due compiti: protezione e ammonizione. Che “Ceccolella” li protegga sì,ma che li ammonisca e, se necessario, li punisca come faceva l’angelo con lei. Quel che è necessario è una guida al cervello egli automobilisti. A questa figura spiccatamente medievale e decisamente moderna è stata commessa la protezione degli 263 automobilisti romani. E, dati i fatti abnormi che continuano a distruggere Roma coprendone le rovine con un ammasso informe che Roma non è, ma ne usurpa il bel nome, possiamo riprendere a favoleggiare e raccontare che da Tor de’ Specchi usciva una forza che piegava gli automobilisti al rispetto della strada. 264 L’Osservatore Romano, 1967 S. Francesco di Sales impaginazione: spalla destra; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. (lo stesso articolo, con il titolo Il nostro protettore, fu proposto a “Paese Sera” nel 1952 ma non fu pubblicato - collocazione: Pg 119) Si conclude il 4° centenario della nascita di Francesco di Sales Vescovo-principe di Ginevra, da diverso tempo protettore dei giornalisti. Anticamente la questione dei protettori era un fatto naturale: una santa accecata diventava patrona della vista, un santo ciabattino, patrono dei calzolai, ma quelli erano tempi semplici; in questa nostra èra stranamente composita, si dovette trovare un protettore per tante cose che prima non c’erano e ora ci sono. Fu una corsa nel campo agiografico alla scoperta di una analogia che giustificasse l’elezione di quel tale santo a protettore di quella tale cosa. In mancanza di santi si ricorse agli Arcangeli la cui biografia non è certo ricca. L’operazione non è ancora finita e ogni tanto capita lassù nel cielo che a un santo, immerso nella sua letificante beatitudine, arrivi dalla terra il conferimento di un protettorato. Veramente non è sempre chiara la relazione tra il santo e l’ufficio al quale lo si nomina. Ma quello conferito a Francesco di Sales vescovoprincipe di Ginevra è uno dei pochi pienamente giustificato; specialmente per noi italiani, che abbiamo con lui un legame goliardico: prima di farsi prete egli si era laureato in diritto; dove, alla Sorbonne? No, a Padova. A Parigi aveva studiato retorica e filosofia, ma per laurearsi in giurisprudenza scelse Padova, celebre in tutta Europa per il suo Studio. Aveva venti anni; nel 1591 gli fu solennemente conferita la corona e il berretto di dottore in utroque. La sua vita di studente universitario la passò tra di noi e nei suoi scritti la ricorda spesso come si ricorda il fervore e il sole della giovinezza. Si può anche supporre che la nomina a nostro protettore sia stata da lui accettata e ratificata con vera cordialità. Non sembrino irriverenti queste parole; proprio lui ammetteva che in paradiso si possa sorridere di noi, così come noi adulti sorridiamo dei bambini. E’ lecito anche arguire che, per quel che dipende da lui, la pratica non sarà archiviata, perché pare (almeno così ho sentito dire da chi se ne intende) che in paradiso si perfezioni, senza mutarlo, il temperamento che si ebbe sulla terra, e Francesco di Sales da carattere fermo, forte e soavissimo, fu uomo che amò gli uomini e s’interessò alla loro vita e ai loro problemi. Egli dette il suo tempo all’azione più che alle questioni dottrinarie; cercò gli uomini avvicinando chiunque, principi e plebei, cattolici ed eretici; conquistava con la forza dell’amore e legava con la concordia; riusciva quasi sempre; quando falliva, taceva, rispettoso della libertà e del travaglio dell’anima altrui. 265 In quest’uomo nulla di soprannaturale. La parola fu lo strumento della sua azione pacifica. Si era allora in piena lotta calvinista e grande era il turbamento delle coscienze; egli andava di città in città a predicare che le controversie si superano con la comprensione e la fraternità; che la pace si crea con la pace e non con la guerra, altrimenti si fa come quegli uscieri che urlano di far silenzio. La similitudine è sua. Era l’uomo dal parlare figurato, dalle immagini argute perchè egli non chiudeva gli occhi sulle bellezze della terra, non si straniava dalla vita; dalla osservazione delle piccole cose sgorgava la colorita poesia del suo dire. Dai particolari più minuti risaliva con naturalezza ai problemi universali. I fiori, i ruscelli, gli uccelli, la luce, gli oggetti che ci sono intorno, i nostri difetti e le nostre debolezze, tutto serviva a lui per dire agli uomini cose piane o difficili, in maniera accettabile. Egli volle farsi ascoltare e parlò tanto, in pubblico e in privato; riusciva a predicare anche tre volte il giorno. Ma la parola, più che pronunciata, la diffuse scritta. Scritta o detta egli fermamente credeva di dover dare alla parola un contenuto e una finalità. E scrisse senza sosta: scrisse libri, scrisse opuscoli, scrisse lettere. Arrivò a scrivere anche trenta lettere il giorno. Passò gran parte della vita con la penna in mano, come molti giornalisti quando non c’era la macchina da scrivere. Oggi avrebbe fatto lo stesso e avrebbe ripetuto che l’uomo deve operare per la giustizia, che la violenza, quella dell’azione o quella dello spirito, quella della parola e quella dell’immagine, non opera per la giustizia. Oggi continuerebbe a fare quello che faceva allora che prendeva quel tanto di spirito di libertà che il concilio di Trento lasciava sussistere, lo passava attraverso il suo cuore, restituendolo agli uomini nella sua interezza. E’ dunque uno di noi, può essere il nostro protettore. Questo uomo che conobbe in sé e negli altri l’esitazione e il dubbio della scelta, che da un pulpito di Parigi, con la forza dell’amore piegava l’anima ardente e torturata di Angelica Arnaud, che fondava un ordine religioso dove si insegnava che tutte le cose devono restare nella loro pace, che anche le porte vanno chiuse con dolcezza, quest’uomo, su qualunque sponda noi si sia, può essere nostro amico giacché egli volle essere ponte che supera e unisce. 266 Paese Sera, 19 marzo 1968 E’ OBBLIGATORIO SAPERE L’INGLESE? Italiana spaesata in Italia collocazione dattiloscritto: Pg 112; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. Dopo un articolo di Fausto Coen sul “linguaggio chiaro e oscuro in giornalismo” suggeritogli dal benemerito “Piccolo prontuario della lingua italiana” di Sergio Lepri, mi domandai come mai non sorga una protesta contro l’abuso di parole e frasi anglosassoni nei giornali. Io sono di origine ebraica e senza religione, all’infuori di uno stupefatto timore davanti al mistero che la scienza sposta, ma non spiega, però sono profondamente, orgogliosamente italiana. Come tale vorrei poter leggere i giornali che compero perché sono in lingua italiana, senza dover subire quegli arresti provocati da una seminagione di parole che non appartengono alla mia lingua. Perché devo essere costretta al vocabolario, o a lasciare una lacuna nella comprensione di ciò che stavo leggendo? E forse non sono la sola a ignorare la lingua inglese. Prima che ci americanizzassero, l’inglese di chi non l’aveva studiato si limitava ai nomi dei cani, Dick, Black, Blitz; al “Time” del di dietro le sveglie col suo fratello “Alarm”; al nome di un dolce, il “plum cake” che scherzosamente si pronunciava all’italiana; soprattutto a quel “Made in Italy” che faceva tanto inglese. Adesso l’inglesume dilaga, scritto, parlato, ostentato. I giornali sono pieni di stress, recital, cover-girl, party, team, breakfast, happening, strip tease, talent scouts, count-down, press agents, big, producers, shopping, tetra pak, full time, boss, inutili stupidi e servili esotismi che pronunciamo spesso in modo ridicolo. Ma perhé devo essere obbligata a sapere che cosa vogliono dire quei graffi fonetici? Perché devo essere costretta ad aggiungere “spray” ad ogni prodotto che compero sistemato in contenitori a spruzzo? Forse che uno schizzo è diverso se lo chiamo spray? Non vi piace né schizzo, né spruzzo? C’è il più spirituale vaporizzatore. Ora tutto è spray e allora cominciamo col dire che anche la vita è spray. Da tutte le parti scappano fuori show, show show, mi pare d’essere diventata una gallina. Non c’è proprio la possibilità di dire stress e il resto in italiano? E’ diventata così povera la nostra lingua? Lo steward, chi è costui? Mi chiedevo quando scappò fuori, poi capii, è una specie di cameriere viaggiante, volante, ad essere più precisi, ma come si pronuncia non lo imparerò mai e continuerò a chiamare accompagnatrici le hostess che infine sono delle eleganti cameriere. Il gioco dei birilli vecchio da quando l’uomo trovò sulla terra zeppi e sassi, ora diventa il bowling. Ti sforzi di leggere l’editoriale per capire qualcosa in quella politica dove non capisci nulla e ti può capitare di leggere frasi come questa: “per immergerci nel daily life, nella vie quotidienne o, se vogliamo, nella vita quotidiana”, ci siamo arrivati, ma che sforzo! “Sono sepolti vivi”, leggo; chi? “5 space men”; non me ne importa più. Stai leggendo una commossa rievocazione dell’assassinio di Kennedy e “questo senso di longing and loss” ti 267 ferma di colpo. Segui con interesse la descrizione di un carattere ed ecco certi happy few a crearti una fastidiosa soluzione di continuità. Un esame diagnostico è un “check up”, come se fosse una merce importata con un proprio nome intraducibile. Un articolo m’insegna come curare la pelle, ne ho bisogno, vediamo: “peeling, lifting”, basta, per sapere come curare la pelle devo studiare l’inglese. Fanno un’inchiesta su Roma che disturba i romanacci veri coinvolti in un giudizio che non appartiene a loro perché Roma non è più la loro e devono anche urtarsi contro il “commuting” laziale, con il “soft on communism”. Interessa sempre quella lontana rimozione di Krusciov, c’è un chiarimento e ti trovi il “background”, non sai che cosa è, ma lo senti, è un respingente che ha frenato il tuo slancio. Che “doping” abbondi nelle cronache sportive non meraviglia, lo sport è l’ibrido per forza, ma che all’Accademia dei Lincei manche un “public relation man”, infastidisce. Come il “designer” che avanza; in casa nostra c’è stato sempre il disegnatore industriale, è l’americanismo che avanza. I nostri bar sono tutti diventati “snack”; ti si para davanti un “cities service” e sulla bottega d’ogni guantaio spicca “gloves”. I nostri negozi parlano prima di tutto agli anglosassoni che nei loro paesi non si preoccupano di certo di piantare “guanti” dove vendono i gloves. Ci capita di vedere scritte alte un metro con una esse volante alla fine del nome che pare la piccola enne esponente dell’ennesima potenza. Ma torniamo ai giornali. Quello ci dice che hanno raggiunto il “point of no return”, quell’altro che è imminente lo “Showdown”, uno ci butta avanti “under statement”, l’altro “high lives”, invece di prendere il vocabolario preferisco buttarli. Ma li riprendo, sempre. “La festa sarà caratterizzata da un no stop dance; sentiremo la voce dei boss”. Passo a Purificato e mi dicono che la sua pittura ha come “background”, traducete, per favore. Invece raramente se ne dà con umiltà la traduzione. “La showmanship, l’arte di dare spettacolo di sé”, non era risparmio di tempo, di carta, d’inchiostro, dirlo in italiano? “Sposarlo o non sposarlo?”, chiede una. “That is the question”, risponde l’altra. E io mi domando: quando gli stranieri vedranno scritti come questi, è possibile che non ci disprezzino? Si dà il caso d’incontrare, in un pezzo solo, sixties, fifties, main streets, brain power, new left, get America moving again; è troppo per un giornale italiano; il giornalista scrive anche per chi non conosce l’americano. Ma l’assurdo diventa grottesco quando quelle stesse parole vengono sparse a piene ani nelle pagine letterarie come se lo scrittore italiano si sentisse un arretrato provinciale se non le adopera. E ci dicono che il “matter of fact” di Bontempelli è ancora valido, ma io non so che cosa è questo “matter” ancora valido. D’accordo che anche lo scrittore si sente coinvolto, spinto, trascinato dalla nuova realtà industriale, ma questa realtà parla tutte le lingue, perché allora invece di incontrarci solo con “l’high fidelity”, col “bull-doyer” non incontriamo anche parole francesi, tedesche, russe? Invece in quelle pagine letterarie poeti e scrittori usano “happy few”, “do it yourself”, “non fiction novel”, “action painting e action writing”, mentre noi eravamo interessati al loro discorso; critici che ci divcono come quel tale romanzo sia “work in progress”, mentre l’altro è “hold hat”. Meglio allora quella rivista che parlandoci di Joyce ci riporta frasi intere col suo linguaggio, così si butta prima. Lacune pozzanghere buche sono per me quelle frasi, sempre, ma nelle pagine letterarie mi offendono perché 268 proprio da chi sa che non lo è, la nostra lingua è trattata da deficiente. Quella lingua la cui purezza fu preziosa per i nostri vecchi scrittori. Pirandello offeso e scandalizzato per la mostra di un camiciaio con tanto di “Chemiserie”, la leggeva con disprezzo all’italiana: “che miserie!”. Siamo certi che avesse torto? 269 Paese Sera, 23 marzo 1970 NEL COLORE DI ROMA IL COLORE DEI TAXI Verdi mi piacciono di più collocazione dattiloscritto: Pg 121; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. Ce li avevano promessi, cominciano ad arrivare e ce li terremo i brutti taxi gialli. Milano, dicono, li ha gialli, Firenze pure. E con ciò? Per quale ragione li deve avere gialli anche Roma? In epoca di forzata massificazione è proprio obbligatorio massificarsi dove si può farne a meno? La gente che gira il mondo sarebbe così poco svelta da avere bisogno di un dato colore per distinguere le vetture pubbliche? Il colore giallo, freddo e stridente non combina con Roma. Si vedono meglio di notte, dicono. Ma per vederle nessuno guarda al colore. Se fosse così, le tante macchine private della stessa tinta riceverebbero continui segni di fermata. Di giorno e di notte basta quella crestina luminosa che le distingue come una volta la crestina bianca distingueva la persona di servizio, un segno di lavoro inalberato con grazia. E perché giallo proprio ora che i patiti dell’automobile seminano per tutte le corsie macchine di quel colore? Viste dall’alto, in mezzo alle altre, sembrano le scarpe gialle del tempo di Matilde Serao. Il giallo vernice metallica è un colore brutto, più brutto del bianco, perché se questo non dice nulla, quello dice marcio. Giallo è il colore dell’allontanamento. Con quel colore gli ebrei erano obbligati a distinguersi dai cristiani. L’itterizia, la febbre gialla, la morte sono intonazioni di quella tinta. Il girasole ha diritto di essere insieme giallo e bello. Il giallo è gradito in una sua luce naturale come nei fiori e nell’oro delle casseforti, che poi non è giallo, ma oro; dire giallo l’oro è improprio; l’oro ha una sua iride di colore fissata in luce per secoli. Nelle tavole dei primitivi, dove le figure stanno su fondo di oro, quella luce diventa suono che scoppia in sinfonia se ci batte il sole. Il giallo è bello nel canarino, che neppure lui è giallo, ma color canarino; nella mimosa, nei tulipani; nei bottoni d’oro che brillano sui prati, ma nella vernice automobilistica fa pensare ai pannolini dei neonati con disturbi intestinali. Diventa il giallo nel suo senso di dileggio; è tutt’altra cosa. Il colore deve correggere la bruttezza, non aumentarla. Anche i bruchi nascondono la propria bruttezza sotto bei colori; i pochi che sono gialli fanno più ribrezzo. Non bastavano i libri gialli, ci vogliono anche i taxi che stoneranno tanto con Roma. E’ vero che di questa stonatura se ne accorgeranno solo i compenetrati di Roma per i quali essa non è solo Circo Agonale, Trinità dei Monti, Colosseo, Cupolone, ma è anche aria, luce, colore e il colore di Roma, non c’è niente da fare, non s’accorda con il giallo. Il colore di Roma è quello rossiccio dei mattoni cotti da secoli di sole; è quello dei muri del Campidoglio, di Ostia all’ora del tramonto. E’ crosta di pane contadino cotto al forno; di travertino vecchio, di oro brunito dal tempo. Il colore di Roma è un colore che si fonde mirabilmente col sole che diventa romano anche per il colore della città. Il colore di Roma è quello che la sera, quando comincia l’ombra, resta aggrappato ai fastigi 270 delle chiese e dei palazzi. Il sole è impastato nel colore di Roma anche nelle giornate grigie. Il colore di Roma è quello necessario per il risalto di una città monumentale. Gli ordinatori di musei di scultura mettono i pezzi migliori su pareti tinte con quel colore. Ma da un secolo, da quando fu fatta diventare capitale d’Italia, Roma viene, non sistematicamente, ma rabbiosamente distrutta, in tutto, anche nel suo colore. Colore che resiste, sia pure a continuità spezzata, nel centro o in qualche superstite casolare della periferia: questo perché non interessa, quello perché è impossibile distruggerlo tutto. A sbiadirlo ci pensa l’illuminazione fluorescente. Ma nella grossa, informe terza Roma, il forte colore romano, sopravvivenza del pompeiano, ha ceduto del tutto alle svenevolezze dei teneri colorini. Verrà il sole a correggere, a cancellare, a brunire, a indorare, certo, ma a noi che importa? La sua azione è troppo lenta per una vita umana, che, corta com’è, non corre, precipita. Non è romanticismo gustare il valore lirico del colore negli immobili e anche nei mobili a quattro ruote; niente deve stonare con le quinte e i fondali di cui Roma offre una varietà ininterrotta di sorprese. Lo scenario romano non sopporta il giallo. Quando per i mezzi pubblici fu scelto quel colore che ancora possiamo vedere, gli immigrati o gli importati non se ne accorsero, come non si accorgeranno oggi del giallo, ma i romani dissero: “Meno male, tra tanto verde abbattuto, un po’ di verde circolante”. Quel verde si intona a Roma. Sotto il sole, su un ponte lontano, i nostri bus fanno colore, fanno paesaggio, fanno anche un po’ silenzio per l’anima perché il silenzio è verde; giallo è lo strillo; tra le vocali la “i” puntigliosa e pungente, è gialla. Un ammasso di giganteschi coleotteri di tutti i colori sono le automobili che distruggono le nostre piazze; in un cantuccio, come cetonie verdi i nostri taxi sono meno brutti. La cetonia sta bene con tutto, anche con i colori svenevoli, ma il giallo-taxì sta male con tutto, anche con se stesso. Però presto saranno tutti color marcio e invece della fettuccia dai colori capitolini, arancione e amaranto, che li consacra romani, avranno due file di quadratini. Perché? Per distinguerli? Ma se c’è quel pugno sugli occhi del colore, i quadratini, un segno così infantile, a che serve? Anche a Mosca i taxì hanno quel segno, ma almeno è una scacchiera così grossa che mette voglia di giocarci. In tanta distruzione coloristica questa dei taxi è certo una piccolezza, ma ogni cosa è fatta delle sue piccolezze. Lo paventavo, quel brutto colore, e proprio davanti a me venne a stazionare il primo, in uno di quei posteggi dove il Comune ha stabilito che debbano nascondersi i taxì in attesa di clienti. Prima quel colore aveva una sua bruttezza in potenza, ora l’aveva in atto: brutto senza condizionale. 271 Paese Sera, 10 gennaio 1972 1971, l’anno dei centenari collocazione manoscritto: Pg 72; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. Con titoli strillati sopra a testi che ripetevano cose sapute e risapute, la stampa italiana celebrò il “Centenario” per antonomasia, dicendo poco e titolando molto. Certo che se la confrontiamo con quella contemporanea agli avvenimenti la nostra sta all’altra come la girandola del Pincio può stare a un mortaretto. Nella stampa di allora la presa di Roma era spesso una notiziola in fondo, prima dei rebus e degli indovinelli. Del resto i contemporanei avevano poco da rallegrarsi: Roma, città originale e unica, stava decadendo a capitale del Regno Sabaudo. Con l’avvento della Repubblica, se l’avessero epurata, un centesimo di quel che era si sarebbe salvato, invece fu mantenuta nel suo ufficio riconoscendole anche gli anni di anzianità. Per questo il 1970 fu l’anno del “Centenario” e forse per reazione il 1971 è stato l’anno dei centenari. Ecco, Marcel Proust, raffinato e pietoso, grande artista, genio del pettegolezzo e, come tutti i chiacchieroni, qualche volta un po’ noioso, avrebbe ora cento anni. Paul Valery. Lo celebriamo, non lo celebriamo, marita, non merita, si, no, no, si. Logico, era una contraddizione lui stesso: padre francese, madre italiana, era nato già in bilico, ci restò. Ma intanto, fra esaltazioni e denigrazioni, abbiamo imparato che se fosse vivo oggi avrebbe cento anni. Grazia Deledda, anche lei avrebbe cento anni, cioè 96 perché 4 se li toglieva, ed è uno dei suoi aspetti più simpatici, se ne fosse tolti un po’ di più era meglio, perché quel misero 4 è tanto timido che dà fastidio, quasi quanto il suo modo di scrivere: una pagina al giorno, alla fine dell’anno 300 e più, il libro è fatto. Con lei, il Nobel premiò una brava donna e una bravissima artigiana. Come avranno celebrato il centenario di don Luigi Sturzo quelle care suore vestite color tabacco che non hanno avuto bisogno di rammodernarsi perché vestite già da vecchie signore di metà Ottocento? Laggiù nella piana fuori di porta S. Giovanni, nella loro anonima casa di quell’anonimo quartiere, aveva trovato il suo ultimo rifugio l’ottimo prete, l’acuto politico, il dilettante musicista, don Sturzo. Piccolo, nasuto, ai suoi tempi, così nuovo allora, era stato portato in trionfo per le strade di Roma; la celebrazione del suo centenario, seria e mondiale,pare avere fissato nella storia il suo trionfo. Luigi Albertini, il padre del giornale moderno, anche lui, un secolo avrebbe. Lo avrebbe anche quell’altissimo uomo, melanconico e pessimista che la gente credeva ridesse sempre, mentre invece era immerso nel sogno, o nella nostalgia. Quel che Proust faceva con la fiumana della Récherche, su la francese civiltà bene di allora, lo faceva lui, con minore curiosità e maggiore pena, sulla borghesoccia società della piccola Italia unitaria, con la sua spezzettata opera, lui, il nostro Trilussa, il prototipo degli scapoli. Ed è il centenario anche di un uomo che fu la sua voce e il sentimento della sua voce: Ruggero Ruggeri, attore senza radici. Gesto, trucco, teatro, erano superflui per lui, gli bastava quella sua voce eccezionale, una 272 voce di sogno che poteva anche struccare; schiavo della sua voce per forza ci finì, e diventò prezioso. Non so, può darsi che fosse più dicitore che artista. Di un altro è il centenario, artista autentico questo, che mai si ascoltò, mai ricercò se stesso, ma solo l’arte, il colore, la linea, il moto, la luce, il moto che diventa luce come l’elica. Egli dava; dava un quadro come se desse solo un fiore, ed era tanto povero di soldi. Dico di Giacomo Balla, nelle cui opere è il genio e nel sorriso l’innocenza della bontà. Personalissimo, sincero, lirico e reale, fortissimo e dolce, profondo nella ricerca e nella tecnica, audace distinto, inquieto, sensibile, ricevette sempre dolore e incomprensione. Adesso che non c’è, tutti lo sbandierano. Sinceramente? La mostra tuttora in atto lascia perplessi. Ed ecco un centenario che non lo è perché è compleanno, quello del poeta ticinese Francesco Chiesa, ha compiuto i cento anni con la gravità, l’armonia e la nobiltà della sua poesia. Chiesa ha consumato la serie degli anni a due cifre, ha cominciato quella di tre, ad multos! Nel 1871 fu fatto il primo censimento della popolazione italiana. Appena l’ebbero ammucchiata, vollero contarla. Quest’anno, forse, per celebrare il centenario di quel pastorizio avvenimento, si è ripetuta la conta. Con la differenza che i risultati del censimento di 100 anni fa furono regolarmente comunicati a fine anno; i risultati del nostro, affidati all’elettronica che deve essere cosa divina se ci legge nel cervello, non si sa quando arriveranno. Il 27 novembre scorso è stato celebrato il centenario del nostro Parlamento. Per la prima volta, in quel giorno, il Parlamento italiano si era riunito a Roma. Aveva titubato nella scelta del locale, poi decise per la Curia Innocenziana, l’odierno Montecitorio, e fece bene, il luogo è abituato alle lotterie. Anticamente l’impresa del gioco del lotto aveva sede accanto alla Curia, ma i numeri venivano tirati, letti e gridati dalla loggia sopra il portone del Parlamento. Quest’anno è stato il centenario della promulgazione della legge delle Guarentigie, ovverosia: concordato a una voce sola che diventerà duetto nel 1929, quando il Vaticano romperà il salvadanaio nel quale lo Stato aveva accumulato le quote stabilite nel suo solitario impegno. A Parigi un centenario che riguarda un po’ tutti, quello delle Folies-Bergères che per tanto tempo hanno eccitato fantasia e sensi del turismo mondiale con frenesie di tutù, di gambe, di lustrini di belle donne; lampeggiò allora quel nome che ancora balla e diverte. Però nel 1871 anche Roma ebbe la sua piccola Folies-Bergères, fu l’arrivo della regina Margherita, ancora principessa, ma già carica di perle a niagara, già ottima professionista del sorriso. In una città come Roma, dove al vertice per secoli e secoli non c’erano state che tonache, piviali e mozzette, quella donna fece colpo. Essa fu l’unica cosa accetta a molti, non a tutti naturalmente, perché la resistenza all’annessione si spense lentamente e anche ora, isolato e latente, qualche piccolo focolaio dura. L’apparizione a Roma di Margherita, grifagna nei lineamenti, mascherata però da uno splendido sorriso, compie anche essa i suoi 100 anni. Per la prima volta per le strade dell’Urbe, dove il Papa passava disegnando crocette nell’aria, passava ora una sovrana ingioiellata che piegando la testa di qua e di là accennava lievi saluti rubacuori. Tra tanti centenari ce n’è uno che tutti li amalgama e corona. Un secolo fa in Egitto, vicino al Nilo, trionfava 273 per la prima volta l’Aida di verdi. Se l’unità italiana era ancora fresca di vernice, e quella musica veniva da un filone dell’Italia particolare, non significa nulla. Tutto il mondo seppe il trionfo dell’opera di un italiano. Questo centenario, come quello di Francesco Chiesa, celebra una continuità di vita. Se Caracalla vuole aprire trionfalmente, apre con Aida. Le parole fanno ridere? Non significa nulla. E’ la musica che è immensa, una musica che è la voce del nostro Mediterraneo, voce nostra perché nel Mediterraneo noi ci stiamo immersi. 274 Il Globo, 29 giugno 1972 Il Tevere ex-biondo un amico che dobbiamo salvare Via di Ripetta e il Tevere, erano due strade a livello. E’ stato per secoli veicolo di traffici, luogo di svago e di bellezza. I muraglioni costruiti cento anni fa per difenderci dalle alluvioni lo hanno trasformato in un corso d’acqua fetido ed inutile collocazione: Pg 69-70. Se l’Egitto è un dono del Nilo, il Lazio non lo è del Tevere, neppure Roma: Roma se mai è un suo involontario prodotto. Involontario perché nel Tevere non c’è generosità. Le sue inondazioni non erano feconde come quelle del Nilo, ma distruttive come un moto tellurgico. La letteratura antica e moderna gli ha appiccicato l’aggettivo flavus, biondo Tevere che a volte era veramente biondo prima che fosse ridotto a fogna cittadina, biondo per la rena delle sue dune. San Pietro in Montorio (Monte d’oro), deve il nome a quella rena che in città si spargeva in uno spesso strato per le strade dove doveva svolgersi un pomposo corteo o un solenne funerale. Le ruote delle carrozze giravano silenziose sopra quel tappeto dorato, raffinata distinzione che Roma offriva rubandola al fiume. Nonostante che nell’alta antichità la navigazione del Tevere fosse piuttosto difficile, il fiume era la più diretta strada per merci e vettovaglie che dall’Etruria scendevano quaggiù. Dove la linea dei trasporti fluviali incrociava quella dei trasporti terrestri che dai colli albani, via terra, risaliva, dove le due strade s’incontravano non poteva non svilupparsi un mercato, l’isola tiberina pareva messa lì apposta E nel posto più atto a sfruttare economicamente le due strade sorse Roma. Attività commerciale sempre in aumento, fu necessaria Ostia, porta del fiume, porta di Roma, porte a delle terre fin dove poteva arrivare per via fluviale tutto quello che veniva dal mare. Poi si scavò il canale di Fiumicino: con due foci il turbolento fiume dette maggior pace e incremento al commercio. Poi Claudio costruì il porto e il commercio marittimo entrò decisamente nella sua splendida fase. Da Ostia e da Porto, all’altro capo del Tevere, tutto quello che poteva arrivare direttamente a Roma per acqua, arrivava all’Emporium, o Ripa. Arrivava grano, olio, legumi, legno, lana, avorio, piombo, datteri, stagno, rame, argento, oro, marmi, papiri, vetri, stoffe, incenso, spezie, coralli ed era l’Egitto, l’oriente, l’Arabia, la Spagna, l’Africa, la Gallia, la Grecia a mandare tutta questa roba. Con la caduta dell’impero romano molte cose decaddero, anche il meraviglioso commercio mondiale di questo piccolo fiume subì un declino, ma non cessò mai del tutto anche se la sua attività pareva quella di uno che non ce la fa più. Ma siccome morto non era e di pontefici illuminati ce n’erano, ogni tanti riprendeva vita finché alla fine del ‘600 ritornò allo splendore imperiale. Al porto di Ripagrande arrivavano bastimenti provenienti dal mare mentre a quello di Ripetta arrivavano barche, barconi, navicelli,che scendevano dall’Umbria, dalla sabina, uno scalo per merci che scendevano dal 275 nord come quello di Ripagrande lo era per quelle che venivano dal mare. Ripagrande era adesso la succursale di Civitavecchia; del porto vero aveva i caratteristici magazzini e le osterie. Santa Maria della Torre del Buon Viaggio raccoglieva gli umili voti dei naviganti che sono i migliori fornitori di ex voto. Siamo abituati noi posteri a pensare solo ai due porti di Ripagrande e di Ripetta perché i nomi sono rimasti, ma ce n’erano altri, quello della Traspontina, per esempio. Dove sbarcò tutto il travertino che diventerà il colonato di San Pietro. Era una strada d’acqua il Tevere, serviva molto bene e i papi aumentavano sempre questi porticcioli, l’ultimo nel 1827, il porto Leonino, di fronte all’abside di San Giovanni dei Fiorentini, aveva la sua piazzola, la sua fontana, le sue due rampe di strade fino all’approdo delle barche, era anche bello. Per secoli su questo fiume, ora morto, arrivavano, si fermavano, ripartivano come dice la leggenda di una stampa del ‘600: 2 navi di mercante, barche, tartane e altri vascelli et legni di mercanti e robbe commestibili navigate per mare per Tevere, condotte a Roma da tutte le parti”. Tor di Nona (corruzione d’Annona), stava lì sulla riva del Tevere perché sin dall’antichità romana le vettovaglie lì si accumulavano. Nella prima metà dell’ottocento vennero portate per fiume le colonne della ricostruendo basilica di S. Paolo e dall’Egitto i tronchi d’alabastro. Il nostro fiume, ormai solcato da bastimenti a vapore aveva la capacità di legarsi col Nilo. Quando arrivò il regio esercito per liberare Roma i piroscafi riempivano il porto di Ripagrande. Ma il governo che arrivò con lui, imprigionò, asfissiò, svilirizzò questo fiume che Plinio chiamava: “ Placidissimo mercante di tutte le cose che nascono al mondo”. Che cosa non fu buttato in questo fiume? Oro, argento, armi, viveri, documenti persone ed effigi di persone per una simbolica condanna, effigi di cortigiane soprattutto, le condannavano così perché era tanto belle lasciarle vivere. Da Ponte Sisto furono giustiziati i cappelli cardinalizi: tolti dalle botteghe di via Cappellari li buttarono a fiume. Nell’antichità vide giochi e feste che culminavano con fiere di mercanzie nell’isola. Vide gli spettacoli storici molto cari ai papi. Vide giochi e spettacoli fluviali che si protraevano fino a notte quando l’allegria poteva inasprirsi ai gridi di “Viva li Monti – viva Trastevere”. Vide corse di barchette, feste di cocomeri, regate e girandole. I vaporetti facevano gite di piacere, c’erano traghetti e barchette per passare sull’altra sponda, sui Prati di castello pieni di osterie e di giochi di bocce. Questo fiume ha convogliato storia e leggenda. Ancora nel ‘700 si poteva scrivere che le sue acque erano gialle per il grande oro che si trovava nel fondo: statue, monete, diademi, monili, tutte le ricchezze che i romani gettavano nel Tevere all’avvicinarsi dei barbari, galee naufragate cariche d’oro a cui si erano aggiunti il candelabro del Tempio e le chiavi di san Pietro buttate a fiume da Giulio II e il vasellame di oro che i Chigi gettavano in acqua dopo i banchetti. Piatti e anfore d’oro non ne ha restituiti, forse erano riportati su dalle reti del banchiere. 276 Il Tevere fu sempre capriccioso, girò qua e là coprendo e scoprendo: presso ponte Cavour coprì un pezzo di Roma, lì sotto ci sono strade e case, e nel 1575 perse addirittura la testa, cambiò percorso e si mangiò un pezzo di Ostia antica, che per causa sua non potrà più mai essere scoperta, a meno che non gli venga il capriccio di ritornare nel vecchio letto. Un rimedio per questi straripamenti era necessario, ma bisognava studiarne un altro, quello dei muraglioni è brutto senza discussione e più brutto è stato che per fare simile bruttura si sia mutilata la città in quel suo dolce scivolare verso l’acqua alla quale era unita per sempre. Case si specchiavano sull’acqua e terrazze e giardini sempre verdi e chiese e teatri e palazzi. Tra siepi di rose, arbusti d’aranci, spalliere di mortella e pergolati, s’affacciavano sul fiume osterie che magari si autoproclamavano “ orti Aureliani”. San Giovanni dei Fiorentini sorgeva dalle onde del fiume, di là dell’acqua, altri campanili, altre case, a fianco la fuga della via Giulia che andava a tuffarsi nel Tevere: Sull’altra sponda si alzava il Palazzo Salviati, poi cominciavano le case della Lungara, lungo il fiume, luminosa e vivace diventata ora un melanconico seminterrato. La campagna allora scorreva dentro la città insieme col fiume. Si mescolava ai giardini, alle rovine, cedeva il posto alle case, sosteneva le terrazze, piegava i suoi alberi nell’acqua come se volesse sciacquarceli. I muraglioni la seppellirono sotto uno strato di terra, di pietre, di mattoni. Erano strette le une alle altre le case che sorgevano sul muro della cinta aureliana che dal Popolo piegava sul fiume, dopo quel tratto, sorgevano sempre dall’acqua, ma più vicine o più lontane dalla riva. Senza margini la vita scivolava fino all’acqua; piccolo mercati di pesce intorno a una cesta; passarelle ad archi digradanti che portavano dentro il fiume; barche, colonne spezzate, e piccole spiaggette con gente stesa al sole.La Renella, la più grande, il nome è rimasto, era una confluenza di luce e di vita perché il popolo aveva lì anche il teatrino dell’Impero celeste, marionette meccaniche, maschere specialmente, delizia dei bambini, riposo dei grandi. Tutto distrutto. La passeggiata di Ripetta, o passeggiata del Tevere perché il fiume la sciacquettava e luccicava accanto un’assolata passeggiata ombreggiata dalle piante; sfiorata al tramonto dall’ombra delle vele che passavano sul fiume, si chiama ancora passeggiata ma ci si sguscia solo e a fatica, chi l’attraversa lo fa a suo rischio e pericolo. E quel casone lungo e desolato che ora tenta di guardare il fiume da un fosso, l’apostolico ospizio di San michele, cittadella della libertà del lavoro, era vivo e lieto con gli alberi davanti e poco più in là i velieri e i barconi che stavano in porto. E i due porti più grandi quello di Ripetta e di Ripagrande dove la gente si affacciava a guardare le navi ormai a vapore che scendevano da Nord o risalivano da Sud? Uno spettacolo caratteristicamente portuale che il Tevere non vedrà mai più. Via di Ripetta e il Tevere, erano due strade a livello , uno d’acqua l’altra di selci. Sulla distruzione dello splendido porto di Ripetta piangeva persino la stampa governativa. 277 Qualcosa che scaricasse il Tevere a monte quando ci fossero le piene, questo ci sarebbe voluto e il bel fiume continuerebbe ancora a scorrere tra le sorprese delle due sponde che erano inesauribili. I muraglioni dovevano superare l’altezza di quella piena che aveva battezzata Roma capitale d’Italia: In un certo senso voleva dire rendere stabile quella piena nel tratto cittadino. Nella piena il fiume s’annulla, in fondo ai muraglioni si nasconde. Quelle due sponde si rifecero con la più ottusa e brutale uniformità. Tanta varietà di bellezza sostituita da un monotono nulla. Gli ingegneri che li progettavano pur riconoscendo che non c’era fiume più navigabile del Tevere, lo resero malamente utile solo a convogliare le fogne. Quell’imprigionamento del fiume non andava a genio quasi a nessuno. La legge alla camera fu votata con 150 palle bianche e 108 nere e al Parlamento i romani erano ben pochi. L’appalto per l’inalveamento del fiume veniva ogni tanto ripetuto; ognuno traeva al suo profitto, i muraglioni alle prime piene cedevano. La caduta di un pezzo suggeriva i rimedi per tutto il resto; provando e riprovando costarono tanto che i governativi spiegavano ai romani che erano degi di Roma antica. Un’antichità si paga: Centocinque milioni di allora costò imprigionare quel fiume sovrano che ora si muove tra i muri come i carcerati che prendono aria. E ringraziamo il regio governo che non ci tolse l’isola Tiberina, il progetto di “ toglierla di mezzo2 c’era. La proposta fu bocciata perché ebbe paura delle “ opinioni volgari” e di quelle degli archeologi. Accenno di distruzioni, non elenco, per carità! Distrutti la chiesa di S. Giustino e Giovita, ospizio e ospedale annessi, l’arco dei Bresciani, Palazzo Gaetani, poi dei Cestini, palazzo Castellani il cui portico era uno dei più belli di Roma. Demolita la torre degli Stefaneschi e quella degli Albertazzi. Demolito l’ospedale dei Pazzarelli sopra l’Acqua Lanciana che finì di essere fontana di sorgente viva, ridotta ad un rubinetto uscente da un muro. Demolito il vecchio ospedale di Santo Spirito. Ponte Sisto pareva tenuto su da due braccia di Roma che si protendevano nell’acqua, isolato e tutto demolito intorno anche se erano costruzioni del ‘300, giù l’orologio, giù il fontanone, immagazzinati i pezzi, ricercati poi per ricostruirlo dall’altra parte, non tutti ritrovati, trasformato il ponte con l’aggiunta di due marciapiedi protetti da un’orribile balaustra in ghisa. Rovinati ponte e Catello Sant’Angelo. Due bastioni e lo splendido camminamento in pietra, “ empiamente distrutti”diceva la stampa contemporanea, affreschi, pietre diamantate, sculture, al magazzino: Demolite le due testate di ponte Sant’Angelo che avevano resistito 17 secoli, gli archi centrali lasciati soli in mezzo alla corrente stavano per crollare. Pio IX aveva costruito quel ponte sospeso di ferro, arioso e bello chiamato dei Fiorentini che, privo di arcate, non ostacolava il flutto del fiume. Era stato un lavoro di tale perfezione che il mondo lo considerò una gloria del suo pontificato. Egli ne aveva seguito i lavori, approvate le modifiche, accettati i miglioramenti ome un competente e un innamorato. Sopravvisse ai muraglioni funzionando a meraviglia: fu abbattuto lo stesso. 278 Demoliti il teatro Apollo, il primo costruito in Roma dopo gli antichi, il Politeama e l’Ahlambra. Altra irreparabile distruzione fu quella del palazzo Altoviti di fronte a Castello. Era una costruzione cinquecentesca: la loggia a colonne sul fiume, dipinta dal vasari, un quadro indimenticabile per chi una volta sola l’aveva vista. Roma, quella consenziente all’annessione e quella contraria, unite nella stessa pena, supplicava il ministero della Pubblica Istruzione di non fare atterrare il palazzo, di salvare le sue parti più interessanti per lo meno, per lo meno il portico a specchio del Tevere. Niente da fare. Atterrare, tutto! Il popolo e Pasquino parlavano di Re Piccone. Gli allagamenti cessarono dopo i muraglioni? Nella Roma bassa sì, ci fu miglioramento, lì ogni piccola piena allagava, ma se il Tevere cresce davvero una parte di Roma si allaga lo stesso. Quando le piene sono state di quelle grosse è capitato che un pezzo di muraglione sia caduto trascinando alberi e fanali. Nel 1915 per andare a San Pietro ci volle la barca. La piena del 1870, quella che battezzò l’annessione e portò il re, raggiunse i metri 17,22. Quella del 1938 che la superò di 33 centimetri, non fu molto disastrosa per il centro, per l’isola moltissimo, ma allagò tutto il nord di Roma facendone un lago. Circoli, ritrovi, tennis, ministeriali o sociali, hanno bloccato per loro solo quel pendio al fiume che avrebbe dovuto essere di tutti, ci tirano su costruzioni che coprono la vista dell’acqua, ma queste anche se lunghe ad un certo punto finiscono e si ritroverebbe quel paesaggio per il quale si va a spasso, invece ne occludono la vista con muri di siepi. Eppure il rispetto al paesaggio dovrebbe essere un paragrafo del rispetto del codice del cittadino. Il cittadino ha il diritto di godere di quel paesaggio, si può invocare la Costituzione per difendere un particolare panoramico. Ma chi si ribella. Forse qualche povero funzionario che cammina senza riuscire a vedere di là, l’altra sponda del fiume. Ci avevano tolto il fiume con i muraglioni,ce ne avevano resa difficile la vista arginando i lungotevere con muri invece di balaustre, come i ponti, muri non balaustre e spesso arrivati nel mezzo, di dove si amerebbe guardare giù perché parrebbe di essere sospesi sull’acqua, eccoti davanti una parete massiccia. Muri, muri, sempre muri, anche se ipocritamente sono fatti con innocenti alberelli. Il Tevere che è una realtà, ce l’hanno resa un sogno. Ma nessuno si ribella. E allora? E allora l’avvenire si presenta brutto perché manca l’amore. Chi non riscatta non ama. E’ anche vero però che non si può amare quello che non si conosce e che si è fatto del tutto perché i cittadini romani ignorino il loro fiume. Ci si può scaricare veleni e materia le indistruttibile, si può lasciare che i suoi pesci arrivino a una morìa crudele; nella tragedia ogni tanto risuona un grido d’allarme, e poi tutto continua come prima: Speriamo in qualche cosa che porti ad un ravvedimento,che non si finisca di avvelenare questo povero carcerato. Andiamo a vederlo a monte, lontano dai muraglioni, lo ameremo perché è bello. Se lo amiamo dobbiamo salvarlo. La speranza è il sogno di domani e l’ossigeno di oggi. 279 Nuova Repubblica, 17 dicembre 1972 NEL TRIGESIMO DELLA MORTE Rivivendo con Vinciguerra collocazione: Pg 113; collocazione foglio di giornale: fondo Ferri-Ferrari. Tra perseguitati e accantonati dal regime ci si cercava per sentirci meno soli. Veramente io non cercavo nessuno, la giovinezza mi impediva di accusare il colpo, erano quelli che si rendevano conto di tutto a rimandarmi dall’uno all’altro come una pallina di ping-pong ed io, leggera come quella, qualche volta mi divertivo a sbalzare qui o là. Da Milano venivo a Roma: Vincenzo cento, una ingiusta dimenticanza pesa su di lui, m’incaricò di andare da Adriano Tilgher. Da tanto tempo avevo abbandonato l’uso del cappello; tutte le donne lo portavano ancora, io facevo macchia, non me ne importava. Ma per andare da Tilgher me lo misi. Era un cappello larghissimo, sotto il suo immenso alone mi pareva di essere tanto bella, ma quando fui nel microscopico studiolo avvertii che era troppo ingombrante per quel luogo e mi pesò come certo pesano all’Italia le sue torri. Il campanello della porta suonò, Tilgher andò ad aprire. Nell’angusto ingressetto largo quanto la porta digià piccola, lungo quanto il battente ribaltato, uno scoppio di accoglienze festose. Abbracciati e sorridenti entrarono nello studiolo. Tilgher e Cecil Sprigg; presentazione come tra congiurati; clandestino era lo scopo di quella venuta. Apparentemente era venuto per questo e questo, cose importanti, culturali e politiche, che rotolavano avanti alla mia silenziosa ammirazione. Ma non era vero niente, aveva creato questi motivi per poter entrare in Italia, era venuto solo per sapere di Vinciguerra, voleva la conferma della sua liberazione. Aveva smosso forze diplomatiche e governative, italiane e inglesi, gliel’avevano assicurata, il duce aveva detto sì; veniva per riabbracciarlo. - Dov’è? - Sempre là, in prigione. Vedo ancora il gesto di rabbia di Sprigg. L’espressione di Tilgher che diceva senza parole “te lo dovevi immaginare”. Il silenzio durò a lungo. Mi sentivo a disagio in mezzo a quei due, anche per quel cappello che assumeva proporzioni cosmiche; feci per andarmene. - Resta, questo è un momento storico, devi esserne testimone. L’unico comando che io abbia avuto da Tilgher. Sprigg con uno sguardo, un sorriso, un cenno del capo e della mano, lo cambiò in preghiera. Se fossi stata proprio attenta a quel dialogo, se avessi avuto quella memoria che sin d’allora non avevo, se fossi stata meno anacronistica, avrei captato meglio quello che stava succedendo in quei cinque o sei metri 280 quadrati di superficie terrestre, e ora potrei dire quello che nessun altro sentì. Quel giorno cominciò la mia consuetudine con Tilgher che durò sino alla morte. *** Vinciguerra emerse per me dall’ombra di un carcere attraverso le parole di Tilgher, fatto d’ombra come un fantasma e intorno un alone di luce che crebbe quando lo conobbi di persona, che è diventato sole nel trapasso. Goethe morì chiedendo più luce, Mario Vinciguerra è morto nella luce, non l’ha detto, l’ha ripetuto. Sulla tomba è stato scritto: “Cercò sempre la verità – non indulse a miti – non ebbe paura di restar solo – ora possiede la verità”. Pare che dica tutto, eppure è al di sotto della verità, perciò verità più vera non ci potrebbe essere. *** Turbinio di guerra spaventosa che diventa turbinio di speranza appena sulla carta hanno scritto che la finivano. A un tratto seppi, vidi, sentii, come vi piace, che Vinciguerra era Presidente della Società Autori ed Editori. Chi me l’aveva detto? Nessuno. Dove l’avevo letto? Da nessuna parte, lo sapevo e basta; così scrissi subito ad Agostino. Agostino era Agostino Turla, un funzionario della società che si era ritirato per la guerra in una sua campagna e non voleva più tornare “a fare l’impiegato”. Stava tanto bene lassù col suo S. Paolo al quale lavorava, su quella piccola terra naturaliter repubblicana, “la Repubblica di Cospaia”. C’era stata, è vero, l’unificazione italiana e monarchica per di più, quelle zolle, però, quei sentieri, quegli alberi, quel campanile erano Repubblica di Cospaia, Agostino non voleva più muoversi di lì. Ma io scrissi di tornare subito perché il Presidente della ricostituenda società era Vinciguerra; con lui “l’impiegato” non esisteva, con lui c’era il partecipare a un grande lavoro affine, cugino se vuoi, del tuo S. Paolo, vieni, la società ora ha un’anima. E Agostino venne. Era lungo, si piegò su di me minaccioso come la Garisenda col cielo nuvoloso, “Ma dove te lo sei sognato che Vinciguerra è Presidente della Società? Non è vero manco per niente”. Che potevo sire? C’era un fossato nero avanti a me e nessun ponte levatoio per una scappatoia. “Non lo so, lo sapevo”. Agostino voleva ripartire, ma non fece in tempo. Alto sul cielo coperto, scoppiò il sole. “Agostino, lo vedi?” Mario Vinciguerra era Presidente della Siae. Tanti anni dopo, proprio per la dolorosa morte di Agostino, usufruii per l’unica volta della macchina che la Società metteva a disposizione del suo Presidente. Vinciguerra venne a prendermi quel giorno e insieme andammo ai funerali. E’ cosa notoria che Vinciguerra adoperava quella macchina solo per gli spostamenti strettamente legati al suo ufficio, una cosa che a me dava fastidio. Succedeva che se dalla Società veniva direttamente da me, adoperava quella macchina, ma la rimandava anche se sapeva di trattenersi poco e tornava con i mezzi pubblici. Era un’esagerazione e glielo dicevo. “Invece di andare a casa son venuto qui, ora basta!” E alzava 281 quella sua piccola mano inflessibile come lui. Esagerato nello scrupolo certo lo era. L’onestà portata a quella esasperazione poteva anche essere antipatica, quella rigidezza poteva anche essere scambiata per superbia, era invece una involontaria denuncia della sconfinata disonestà in cui viviamo. E’ questione d’equilibrio: se il braccio sinistro è tirato giù da un grosso peso, il destro si alza. E’ questione d’ottica: più il fondo è scuro, più bianco appare il bianco. Il candore di Vinciguerra era luminoso. E poi anche il santo è un esagerato; santità non è, se non è esagerazione. Vinciguerra era il prototipo d’una laica santità umana. *** Dalle trattorie dove qualche volta andavamo a cena, soli o no, con i resti che generosamente abbandonavamo sui piatti, ci facevamo fare due pacchettini, lui lo portava alla sua Sniff, io al mio Minou. Era la Sniff una gatta vanitosa, ebbe una collana che rimase per me un mistero. Eravamo in tempo di euforica ripresa, le stupidaggini che ci venivano dall’America ci parevano meraviglie, anche la collana della Sniff. Chicchi più grossi delle nocciole, di tutti i colori, si univano senza filo, la collana si chiudeva senza fermaglio: bastava accostare un chicco all’altro. Una volta che le fu messa al collo la difendeva a graffi, nessuno gliela poté più togliere, e quando s’aggirava tra i ruderi dei mercati di Traiano i gatti l’ammiravano, ma non potevano avvicinarla. Il mio Minou invece non sopportava nulla addosso, accettava solo il guinzaglio perché con quello poteva venire in giro per Roma con me. La gattofilia, non quella di moda, ma quella pensierosa avanti al mistero dell’animale, l’avevamo in comune. *** Ti ricordi, Vinci, quando accanto a me scoprivi certe cose di Roma che la tua partenopea laicità ignorava, cose davanti alle quali la tua profondità ammutoliva in una commozione più espressiva di qualunque parola? Ti ricordi, Vinci, la sera degli aspergilli? Tutto t’avevo raccontato sotto il sole: in nessuna parte del mondo si può fare questa funzione, solo a Roma e a Roma solo in S. Pietro; sentirai nell’aria del tempio l’odore del vino come in una mescita; se facciamo presto lo so io un posto dove possiamo salire quando la versano dalle grosse anfore sull’altare, lo bagna tutto, arriva sulla predella, a rivoletti scorre sui gradini, comincia la sfilata degli aspergilli, da quelli grossi dei cardinali a quelli minuscoli dei chierichetti, una sfilata che dura un’ora, ognuno sale e fa l’atto di asciugare la mensa con l’aspergillo che questa volta invece di aspergere ha la funzione di assorbire, ma è simbolica anche questa; poi giù di corsa a vedere la lotta del mondo turistico per appropriarsi di un aspergilo e poi…Al crepuscolo fummo in S. Pietro, il testo era finito, cominciava l’illustrazione. Quella sera S. Pietro era veramente immensa, conteneva in pace anche la tua laicità. *** 282 Con un sorrisetto e qualche smorzato squittio ridimensionava uomini e fatti, ma aveva la pazienza dell’ascolto. Ha perduto ore e ore a sentire i miei sfoghi durante certe crisi lunghe come quaresime d’altri tempi. Quando s’accorgeva che il mio fazzoletto era zuppo, mi passava il suo. In una di queste crisi mi morì il gatto, egli lasciò a mezzo una seduta e corse da me. Non so se adoperò la macchina della Società. Passò prima da un antiquario per una stampa che aveva già adocchiata: era di un luogo che io avevo interpretato a modo mio. Il gatto lo seppellimmo nella rupe delle catacombe di S. Valentino. Un santo canonizzabile mi avrebbe redarguita “vergogna! Piangere tanto per un gatto, è irragionevole!” Quest’altro santo laico parlava con le sue pazienti premure, mi diceva: “Che tu pianga per il gatto lo capisco, ne hai tutte le ragioni, ma per quell’altro no, smettila!” Poi ci fu una caduta nell’amicizia di Vinciguerra per me. Egli giudicava storto il mio soffrire per una persona, voleva che ne capissi l’assurdità. “Sgombrati la tua strada, l’hai tenuta sempre ingombra di persone sbagliate”. Verissimo, non ho fatto che inciampare e cadere, ma sgombrare non ho saputo. “Hai qualcosa di storto nella testa – finì per dirmi – ho fatto tanto per raddrizzarlo, non ci sono riuscito, sono vecchio, non posso più perdere il tempo a raddrizzare ciò che non si riaddrizza”. Quel marchingegno che non si riaddrizzava non era nella testa perché io ho sempre capito che Vinciguerra aveva ragione, che era assurdo patire per una persona che non lo meritava, non l’ho capito ora che è morto, lo capivo mentre me lo diceva. Ma un marchingegno puoi raddrizzarlo, un sentimento come lo riaddrizzi? Mica sta nel cervello; anche se la sua possibilità è lì, la sua obiettività lì non c’è proprio, lì è assente; un sentimento è in tutto il resto del corpo e finché non si esaurisce da sé non c’è niente da fare. E così se n’è andato inquieto con me senza che ne sapessi proprio il perché, non poteva essere solo quel marchingegno un po’ storto. Mi capita che qualcuno mi condanni senza che io sappia per quale colpa, passo la vita a domandarmene perché e non trovo. Anche questa volta è andata così, invece è stato peggio di così. Adesso un amico mi dice che non molto tempo fa gli aveva chiesto di me con la tristezza di chi si allontanava dalla vita “Non la sento più, non si fa più viva”. No, Mario, io ero sempre vicina a te con la tenerezza d’un affetto che niente poteva velare, facevo fatica a non scriverti “ho avuto torto, perdonami!”, mi trattenevo perché credevo che tu volessi questo. E invece appena hai rivisto quel comune amico che non vedevi da forse dodici anni, la prima parola che gli hai detto è stato il mio nome carico d’un intenso punto interrogativo. Ma perché quell’amico non corse a dirmelo? Perché doveva essere così affinché rientrasse nell’altra mia condanna: lasciar morire gli amici in un apparente abbandono, per pigrizia, per trascuratezza? Non lo so, per qualcosa che mi trattiene di dire il bene di cui sono carica, l’amico se ne va, io resto oppressa dal rimorso e dal rimpianto. Era meglio che avessi continuato a ignorare la cosa, avrei creduto che fosse la sua volontà a creare il silenzio, non la mia titubanza. Ma parliamo di altro. *** 283 Un tavolino mezzo incassato tra due sporgenze del muro stava in prigione con Vinciguerra. La gente non pensa alle cose, alla loro vita, al loro destino. Quel tavolino condannato a vivere in prigione fu però fortunato per tanti anni, quando visse con Vinciguerra che non strapazzava le cose, ma le amava. Su quel tavolino puntava i gomiti nelle sue letture, su quel tavolino scriveva, forse qualche volta ci piegò il capo nel pensiero o nella stanchezza, certo su quel tavolino giocò, questo lo so di sicuro. Chi è che non sa fare una barchetta di carta, una scatola, un cappello da carabiniere? Anche Vinciguerra in prigione li faceva appoggiando il foglio su quel tavolino per ben segnarlo nelle piegature: li faceva piccoli piccoli per non sprecare la carta e perché gli piacevano le cose minute. Forse cominciò col fare scatoline e barchette, ma progredì tanto che dalle sue dita uscirono cose che nessuno è mai riuscito a fare con la carta: capanne e casette, uccellini e fiori, organetti e farfalle, pipistrelli e stelle. Di stelle e a tutto volume, una varietà infinita. Me li rifece tutti i suoi giochetti della prigione; cominciò per insegnarmene qualcuno, continuò perché il ricordo lo aveva afferrato. In una scatola li posai uno sull’altro con la delicatezza con cui avrei posato una sull’altra tante farfalle che fossero morte con le ali alzate. Così io posi sull’altro quelle farfalle, quegli uccellini, quei fiori di carta, tutte quelle cosine inventate da una mente eccezionale nei momenti di sosta del pensiero, tanto per non impazzire. Questa parola è mia, mai Vinciguerra ha dato senso tragico alla sua prigionia. Moralmente profondo e robusto, fisicamente minuto e leggero come i suoi giochetti, ora ha conosciuto anche la pesantezza della morte. 284 B) (INEDITI e RARI) DA RINTRACCIARE Un sogno di Shakespeare realizzato da Reinhardt Collocazione: Pg 105. “Sogno di una notte di mezza estate” è un lavoro della giovinezza di Shakespeare, fresco, colorito, poetico, pieno di festività e di forza gioconda. Ci sono reminiscenze delle sue prime letture di Plutarco, dei poemi cavallereschi di Boiardo e dell’Ariosto, avvivate da una scapigliata fantasia. Il centro del dramma è la celebrazione delle nozze di Teseo duca d’Atene con Ippolita regina delle Amazzoni. Mentre Teseo informa la sposa delle feste che si preparano per lei, Egeo, padre di Ermia, chiede al duca che dia corso alla legge ateniese che punisce la figlia che non vuole sposare l’uomo scelto dal padre. Egli l’ha promessa a Demetrio che l'ama adesso come prima amava Elena che invece gli è rimasta fedele. Ma Ermia e Lisandro s’amano così follemente che quando il duca sentenzia che se la giovane persisterà nel rifiuto sarà chiusa come vestale del culto di Diana, essi decidono di fuggire in casa d’una parente partendo da un bosco vicino ad Atene dove si danno appuntamento. Ermia confida il disegno all’amica Elena la quale lo dice a Demetrio che, disperato, corre al bosco ed Elena lo segue per distornarlo da Ermia. Tra quegli alberi hanno preso stanza Oberon re dei geni e Titania regina delle fate sua moglie: anche fra loro vi è discordia per gelosia di un fanciullo che Oberon vuole a suo servizio e Titania gli rifiuta. Il re per vendetta chiama il suo fedel servo Puck e gli insegna a conoscere un misterioso fiore il cui succo spremuto sugli occhi di chi sta dormendo, al suo svegliarsi lo fa innamorare perdutamente della prima persona che vede. Puck trova il fiore e lo porta ad Oberon che comincia a bagnarne gli occhi di Titania per riempirle il cervello di strane visioni; poi ordina a Puck di scoprire dove sia Demetrio e che gli bagni gli occhi perché torni ad innamorarsi di Elena. Puck girando pel bosco trova qua e là dormenti sull’erba Ermia, Lisandro, Elena, Demetrio e, scambiando l’uno per l’altro, rovescia le sorti bagnando gli occhi di Lisandro che veduta Elena invece di Ermia s’innamora di lei. Così nasce una delle più stravaganti confusioni fra i quattro amanti imbizzarriti l’uno con l’altro, e anche anche la regina Titania s’incapriccia di un commediante a cui Puck ha messo una testa di ciuco. Finalmente Oberon, col succo di un altro fiore mette termine a questa frenesia, ognuno torna a essere quello che è e a vedere le cose come sono, allora l’azione riprende alle feste per le nozze di Teseo; gli artigianicommedianti che erano rimasti anche essi confusi nell’incantesimo del bosco, re citano la commedia di Piramo e Tisbe e le quattro coppie degli umani e dei geni, nell’affetto riconquistato e riordinato riacquistano pace e giocondità. Si potrebbe osservare che alla composizione, per quanto arricchita di episodi dal poeta, rimane sempre il carattere e vuoto del regno delle fiabe, che il suo contenuto passionale ha poco interesse, che gli artifizi di magia si ripetono troppo, che è irragionevole vedere la libera volontà umana sottomessa al capriccio di un 285 folletto malizioso che va spargendo a caso i suoi filtri, e sarebbero osservazioni giustissime, ma avremmo dimenticato che è una fiaba sognata, dunque due volte irreale. Del resto la realtà che trionfa sul sogno abbiamo vista quale sia. Ma quello che più conta in questo lavoro non è il pensiero, ma la sua rappresentazione cinematografica, è la realizzazione di questo sogno shakespeariano ottenuta da Max Reinhardt in modo tale che dopo averla vista possiamo supporre che il cinema trionferà ormai d’ogni più superba fantasia. Il grande regista ce ne ha data una prova. Il poema si svolge su tre piani diversi, quello umano, ignorante, grottesco, ma ingenuo, pieno di immaginazione (gli artieri che per l’occasione diventano attori), il piano della fantasia dove un nuvolo di fate, di elfi, di genietti sono così reali nella loro natura fantastica come quelli presi dal modello della vita. Tra i due piani estremi quello intermedio dell’umano nobile, eroico, colto. Questo è forse il meno riuscito, naturalmente a confronto degli altri due che sorpassano ognuno nel loro carattere, quei limiti oltre i quali si entra nel capolavoro. La parodia della compagnia dei commedianti è di un grottesco irraggiungibile. La fantasia delle fate e degli elfi al chiaro di luna nel bosco incantato sono così leggere e trasparenti che si dimentica assolutamente il volume corporeo di chi le eseguì. Il volo ritmico delle fate per la strada di luce che sale attorta a spirale su per il vecchio abete; il perdersi della fata nel cielo stellato assorbita lentamente dall’azzurro notturno; i voli di fate e di elfi più lievi di qualsiasi volo naturale, non sono solo miracoli di tecnica. Lì c’è il poeta che ha sentito il poeta. E Puck, lo spiritello stordito pieno di leggerezza e di malizia che ride di coloro che travia: “Signore! Come sono pazzi questi mortali!” potrà essere dimenticato? Il riso sgorga a fiotti dal piccolo indemoniato che è portato dal vento come il polline delle piante. Ma è riso di simpatia e di benevolenza perché benché egli si diverta a fare mille scherzi dispettosi, in fine è lui, quando “ogni vigna ha ritrovato il suo palo”, che dà il segnale alle fate e ai geni perché vengano a confermare nell’amore che durerà per tutta la vita le coppie dei mortali. E’ vero che questo lavoro ha per meta la bellezza, perché anche la virtù qui è intesa come grazia e come gioia. Tutto il sogno fiabesco nell’incantato bosco della fata Titania con le sue magie, coi suoi errori, è bello perché conduce al ristabilimento dell’ordine nel senso che tanto gli uomini, come gli esseri fantastici, disorientati nei loro affetti, ritrovano la retta via e in essa la pace e la felicità. 286 Il figliuol prodigo collocazione: Pg 106. Luis Trenker che noi ricordiamo nel film “La tragedia di Pizzo Palù”, scrittore, campione di sci, innamorato della montagna ci dà con questo “figliuol prodigo” un film che arriva alla nostra anima direttamente come il canto del poeta detto da lui stesso, perché Trenker ne è stato l’autore, il regista e l’attore. Tra il racconto e l’interpretazione non ci sono le interferenze dovute al regista e all’attore, tra l’opera dello scrittore e la sua realizzazione cinematografica. Questa maggiore individualità del lavoro è una delle cause, non ultima, del suo interesse. Che il fatto non sia originale, come qualcuno ha osservato, è una critica superficiale, che l’autore stesso già previene col titolo, scelto tra tanti altri che potevano essere ugualmente appropriati. Egli ha proprio voluto ripetere l’eterna storia del giovane che si sente soggiogatore della vita, e abbandona la sua terra, per seguire la magnifica illusione, che presto dileguerà cacciata dalla realtà, chiusa nell’angustia del binomio: famemiseria. Ma questa realtà lo purificherà, restituendolo semplice e buono alla sua terra! Nella parabola evangelica questo giovane, che è di tutti i tempi e di tutti i luoghi, trovò il suo nome e Trenker non ha voluto cambiarglielo, anche per conservare alla vicenda quella religiosità che è parte sostanziale del film. La prima visione è un Crocifisso di montagna che, poco a poco, appare tra le nubi; l’ultima è la Madonna che scompare lentamente nelle nuvole. Tra le due visioni, l’uomo che s’allontana dalla sua terra e dalla sua fede e, all’una e all’altra, provvidenzialmente ritornerà. Nel film ci sono due protagonisti: “il figliuol prodigo” e il paesaggio; la parola di ambedue è la musica, detta dal maestro Becce, in modo mirabile! Basta ricordare la sinfonia degli spaccalegna e quei canti religiosi che accompagnano il pianto dell’uomo e la sua gioia. Becce ha dato il suono a quei sentimenti ai quali Trenker ha dato un’espressione plastica, che non sarà superata facilmente. Tonio Fuersinger, tra gli altri contadini-marinari, è l’espressione più bella e più forte della terra comune; un villaggio che pare un altare, tra le candide guglie di una magnifica cerchia montana. Nel gruppo dei tagliatori d’alberi, sembra che da Tonio venga quel ritmo gonfio di forza e di lavoro. Quando in un ultimo scorcio della giornata egli ancora fresco di volontà e di energia, sostituisce il padre nell’aratura del campo, nel momento che con l’usato grido tratta i buoi e affonda il vomere nella terra è come se questa si piegasse sotto la sua forza. Una forza addolcita dall’amore per Maria, figlia di Oudauner, vecchio intagliatore in legno, e da un’interiore melanconia, che in lui prende il significato d’inappagato, come se il villaggio, le sue montagne, il suo lavoro e la sua gente costituissero una barriera alla sue aspirazioni! E non è che la melanconia di coloro a cui la natura ha dato un’anima diversa dalle comuni, che fatalmente li isola, facendone dei sognatori. Sono coloro che cadono nei più grandi errori dai quali, quasi sempre, ritornano col sogno stemperato dal pianto! Ma ritornano! Tonio cerca di calmare la sua insoddisfazione chiedendo al vecchio maestro notizie del mondo che non conosce. Il maestro insegna ed è pago di questo; invece nello 287 scolaro che ascolta la febbre di conquista si fa sempre più cocente. La forza e l’inesperienza, animata dal sogno, fanno parere tutto facile al giovane montanaro, guardando col maestro il globo terrestre, ne varca l’oceano col dito, mentre col sicuro sorriso proclama: “di qui e lì che cosa c’è? Appena questo spazio: ma qui la montagna è sempre la stessa, là, là c’è vita con le sue infinite possibilità!” Intanto egli vince una gara di sci, nella quale si disputa il premio offerto da un ricco americano, Mr. Williams che, viaggiando con la figlia Lilian, s’é fermato qualche tempo in paese. La giovane americana, la sera in cui si festeggia il vincitore, è presa dal fascino rude del montanaro e gli propone di accompagnarla in una ascensione. Tonio sceglie il Pizzo Bianco,non ancora raggiunto e parte con l’amico Giorgio e la giovane. E’ la notte in cui il villaggio elegge il “re del sole” che, nel prossimo solstizio d’inverno, nella “santa notte” sceglierà la sua sposa. Tonio è il prescelto e nella sua casa viene portata la maschera del sole, una vecchia maschera d’oro circondata da raggi della quale il maestro intagliatore ha fatto una copia per l’americano che se ne era invaghito; la festa ha una lontana tradizione pagana (nella notte misteriosa risorgono gli antichi geni della foresta, del fuoco, delle acque per solennizzare il riavvicinarsi del sole) alla quale s’è aggiunta, senza guastarla, quella cristiana dell’Epifania. La mitica terra e la nuova fede fanno tutt’uno. Nell’ascensione avviene un incidente nel quale Giorgio perde la vita. Ora la montagna pare una nemica a Tonio; se non gli avesse ucciso l’amico forse non sarebbe riuscito ad evadere. E parte con un biglietto che gli avevano dato i ricchi americani con l’indirizzo della loro residenza di New York. Quei piccoli inutili pezzetti di carta di cui si fornisce il povero come di bastoni sui quali puntarsi nel salto del pantano. Con quel biglietto e col suo sogno ingenuo e forte, Tonio lascia la buona terra madre, la buona semplice gente del suo villaggio, l’amore rustico della sua Maria e sbarca a New York. Picchia alla porta del milionario. “I signori sono in viaggio”. La prima porta si chiude sulla prima speranza e la prima ombra di delusione scende sul volto del montanaro. Poi è l’agenzia di collocamento con le sue metodiche fredde negazioni. La terra straniera non ha pane per l’emigrato. Poi è la vendita della valigetta con le sue poche robe. Sullo schermo continuano a vivere i due soli protagonisti del film: il figliuol prodigo e il paesaggio. Montagne di cemento armato ora diritte e levigate forate come un setaccio, nubi dense di fumo e binari aerei sui quali le macchine strisciano, fischiano ricordando pietosamente la grande corrente del suo fiume, il rumore degli spaccalegna e i tronchi striscianti sull’acqua spumosa. Tonio guarda e s’illude di credere in questa terra, ma non è vero. Nel paesaggio ritorna come un lamento la panchina dei giardini pubblici, la seggiola dei poveri, il letto dei senza casa. Con nessun altro elemento che la panchina sulla quale è seduto di sera, un po’ di nebbia intorno e lontano i rutilanti lumi della città, egli ha saputo creare intorno a se il silenzio isolato e disperato degli sperduti. Una mattina incontrerà nel giardino che si ridesta un disoccupato americano che lo aiuterà a trovare un po’ di 288 lavoro che durerà assai poco perché l’amico sarà imprigionato e lui licenziato. La seconda parte s’inizia con un simbolo, come la prima, ma non è più il Cristo dalle braccia aperte sul mondo, è la statua della libertà di New York. L’obbiettivo lentamente scorre giù per il colossale monumento lungo le pietre dell’enorme basamento, e si fissa ai piedi, in una panchina dove è seduto un uomo solo, finito dalla fame e dalla miseria. Da questo momento il film (che è sempre pochissimo parlato) diventa muto fino al ritorno dell’amico e quel silenzio è l’espressione profonda della smarrita solitudine dell’emigrante. Credo che la folla non si accorga molto di questo silenzio perché la maschera di Luis Trenker dice quello che non potrebbero mai dire le parole. Domina sempre il paesaggio ed è di una New York sporca, con negozi d’infimo ordine, con poveri stesi in terra lungo i vecchi casamenti agglomerati tra loro come gli innumerevoli cenci stesi alle finestre. Nessuno ci aveva fatto vedere sin’ora una New York così, l’avevamo sentita dire solamente dai nostri poveri emigrati. E comincia la via crucis avanti alle vetrine dei negozi di generi alimentari. Si è tentati di domandare a Trenker se egli le ha fatte davvero quelle affamate soste davanti ai buoni formaggi, ai prosciutti, a tutte le appetitose cose che torturano il desiderio dell’affamato; e se egli non ha sofferto quella tortura, è grande e buono come se l’avesse patita perché ha saputo sentirla riflessa in sé dagli altri mille che la patirono così. Quei leggeri movimenti di deglutizione della saliva, quell’occhio che ormai è tutto fame senz’altro sogno che di un po’ di pane e di una fetta di carne, non si dimenticheranno più. Lo sguardo vinto e avido insieme che fissa il colare del caffelatte dal bricco nella tazza, e la tazza che s’allontana dal suo desiderio senza vedersi la mano che la porta, è un tratto di passione così vera e intensa che basterebbe da solo a dar gloria a Luis Trenker. Come l’episodio del pane rubato e mangiato sotto il ponte. Come la fila degli affamati davanti alle donne dell’esercito della salute che cantando religiosamente distribuiscono una scodella di minestra, un cucchiaio, e una fetta di pane. Nella fila c’è anche l’illuso montanaro col viso scavato e l’anima spenta. Mentre la processione dei vinti avanza egli rivede la processione della sua terra: c’è la Madonna, ci sono le ragazze con la corona in testa, ci sono i montanari che rispondono in coro alle orazioni e Tonio piange. Anche Maria nella lontana Germania piange e i due volti si sovrappongono. Quel pianto non s’è visto mai sulla schermo; è un pianto inestetico, ma il pianto è così. Il parallelo tra la vita che il contadino ha lasciato e quella che trova nella città del suo sogno, sfugge da qualsiasi banalità nella quale poteva facilmente incappare. L’una è simile all’altra come due strofe d’uno stesso canto. Nella sua terra c’era il lavoro facile e libero, in terra straniera strappa a fatica brandelli di lavoro duro e controllato. Là c’erano parentesi d’allegria e d’amore, qua parentesi infinite di miseria e di fame. Nella piccola comunità del suo villaggio egli non era mai solo, e qui, nella più grande città del mondo, è solo come una bestia morente. Là c’era la buona zuppa di latte nella casa paterna, qui c’è un pane rubato. Là le giovanette della sua terra fresche, chiare e limpide come il loro cielo, qui le incuffiate fanatiche dell’esercito della salute. Là rompeva la terra, qua l’asfalto,là scalava le montagne, qua i grattacieli; là nelle ascensioni con la sua fune compieva 289 prodezze e salvataggi, ora con la fune solleva travi di ferro. Era giovane là, qui è vecchio, ma tornerà giovane appena ritroverà la sua terra. Ritorna intanto l’amico e con lui la possibilità di un po’ di lavoro. Fanno da inservienti in una società sportiva dove un pugno di Tonio che atterra il pugile lo porta di colpo al trionfo, alla notorietà, al guadagno. Tra gli spettatori c’è Lilian che lo ritrova e ora che può entrarci in abito da società la casa dell’americana è aperta. Una casa dove le statue mutilate, portate dal vecchio mondo, paiono poveri emigrati di pietra fuor di posto anche loro. Lilian è ripresa dal fascino dell’uomo e gli chiede di non lasciarla più e mentre egli si china a baciarla nella tacita adesione, i suoi occhi incontrano la maschera del sole. E’ il supremo grido della sua terra che lo richiama. E Tonio ritorna nella santa notte. Le feste notturne in cui escono i geni della foresta e del fiume, in cui il re del sole avrebbe dovuto scegliere la sua sposa. Avanzano anche i re magi dietro alla stella luminosa. E anche il re del sole è tornato per consolare il pianto della sua Maria. Tenendosi per mano i due sposi vanno sulla nave per assistere alla messa di notte, ma la porta della chiesetta è chiusa, Tonio la scuote inutilmente, potrà rientrarci, si, ma a processione finita, mescolandosi con la sua gente. Avanti all’altare Tonio e Maria sciolte le mani le piegano nel gesto della preghiera guardando la Madonna sull’altare velata da volubili nubi di incenso che pian piano s’infittiscono fino a nasconderla, si spezzano e mostrano il cielo. Ancora una sinfonia di nubi leggere e luminose tra le quali il canto del poeta, la preghiera del credente dileguano dolcemente. Ci si dilunga forse troppo nel parlare di questo film e pare poco perché non c’è nulla da scartare; sarebbe come togliere qua e là delle note da una musica, dei versi in un poema. Ci sono piccole cose comuni dalle quali Trenker trae significati profondi. Basta ricordare la maschera d’oro del sole portata a casa del vecchio Fuersinger ed appesa ad un chiodo sulla trave che puntella il soffitto; un gioco d’ombre e di luce riempie il vuoto degli occhi e della bocca sì che il dondolio della maschera appesa diventa movimento di vita quasi che il vecchio idolo cercasse l’assente per il quale è venuto. Ci sono dei gesti semplici sui quali indugia con un effetto significativo pienamente riuscito. Per esempio nel ballo che segue la gara di sci quando il protagonista non visto è presente negli occhi delle due donne Maria e l’americana, che diversamente lo desiderano. Altri gesti semplici appena accennati come quello della mano che passa e ripassa sul braccio nel brusco risveglio del giardino, è il movimento del povero che ha dormito scomodo e freddo. Si potrebbe osservare che abusa un poco della visione presa attraverso i vetri degli sportelli delle automobili, ma è pur vero che quell’abuso ci dà la sensazione del traffico che inceppa i nostri passi e la nostra vista specialmente quando vogliamo seguire qualcuno. Così nel film per seguire il protagonista che ha un movimento veramente felice quando svanito com’è sta per essere investito da una macchina. E’ così vero che ci si domanda se l’episodio non sia stato involontario. 290 Altri potrà trovare retorica certe figure secondarie,di facile effetto certi passi, forse sono coloro che hanno guardato il film alla superficie perché chi lo ha sentito in profondità non può non esserne commosso e ringraziare Trenker d’avercelo dato. Del resto questo “figliuol prodigo” è in certo senso superiore a quello evangelico perché quello ritorna alla sua terra spinto dalla miseria,questo rinunciando a un sicuro successo. Luis Trenker ci aiuta ad essere più buoni e a pregare. Quando sullo schermo non ci sono che due nubi tra le quali s’apre un ventaglio di luce che rischiara le cime bianche di monti,e la musica del maestro Becce prende un’andatura mistico-corale, chi non ha sentito che quel quadro era un atto di fede e la musica una preghiera? 291 Paese Sera, giugno 1958 Piccolo repubblicano collocazione: fondo Ferri-Ferrari. Le celebrazioni per i diversi fatti che costituirono la formazione e l’affermazione della nostra costituzione repubblicana, sono modeste, così timide che forse non stona la piccola celebrazione di un piccolo repubblicano di quel tempo in cui con tanta speranza si preparava la nostra Repubblica. Si chiamava Stefano, non aveva ancora cinque anni ed era il fratello di Mariolina. Adesso lui fa il ginnasio e la sorella il liceo; vivono con i genitori che confondono la loro giovinezza con quella dei figli. La loro casa pare sempre limpida e calda per la pace e la vitalità che la riempiono. Giochi, scherzi, allegrie, amarezze, dolori, difficoltà sono vissuti insieme da quei quattro con un tale calore affettivo da offrire l’esempio visibile della perfetta comunione. Entrando in casa loro si è accolti con tanta festosità da avere l’impressione che anche i mobili esultino. Dieci anni fa, dunque Stefano era il più piccolo repubblicano d’Italia e repubblicano lo era sempre stato. Si sarebbe potuto consacrare piccolo lama della repubblica, il suo sacerdote nato. Quando aveva tre anni sua madre aveva dovuto uscire in fretta da un ufficio perché il piccolo indirizzava a voce spiegata epiteti piuttosto insolenti a un ritratto reale che allora dominava ancora la parete. E quando gli capitò di scorgere un’altra effigie del genere sopra i disordinati scaffali del suo fruttarolo, si ribellò talmente da radunare la folla intorno a lui che pretendeva l’immediata detronizzazione del quadro. Fu in quell’epoca che io cominciai a chiamarlo “piccolo repubblicano” e lui mi rispondeva naturalmente come se questo fosse il suo nome. Nella casa di Stefano dove il luogo comune non entra né come forma di vita, né come espressione, i giocattoli dei ragazzi furono sempre costruiti dal babbo nelle poche ore lasciategli libere dal suo alto ufficio. Per la tirannia del tempo e l’urgenza dell’ispirazione avveniva che per la loro costruzione egli sfilasse le assi degli armadi, che staccasse le catenelle di sicurezza delle finestre, che togliesse le stecche degli ombrelli. Ma intanto Mariolina e Stefano avevano sempre giocattoli straordinari e unici al mondo, molto più spiritosi di quelli ispirati dalla caccia agli indiani. La mamma, che per la costruzione di Biancaneve e i sette nani aveva visto scomparire molti dei suoi indumenti, rideva con quella sua voce di festosa musicalità e offriva al marito ciò che egli non osava ancora sottrarre. L’anno in cui nacque la nostra costituzione repubblicana, il babbo aveva costruito ai ragazzi un presepio straordinario che dentro una meravigliosa notte lunare, raccoglieva tutto quello che di bello c’è nel mondo:cascate d’acqua luccicanti, zampilli che quasi raggiungevano gli angeli sospesi tra la terra e le stelle, strade che parevano percorse dal genere umano, colline con case dove non si dormiva perché le finestre erano illuminate, ruote di mulini che giravano vicino al fiume, palme, muschio, luci e pecore, galline, asini, anitre, piccioni tutti desti nella notte perché dentro alla grotta anche il Bambino era sveglio e stava con le 292 braccine aperte. Quel presepio era un sogno e Stefano viveva librato in una sua atmosfera di beatitudine. Veniva gente a vedere quello straordinario presepio ed egli silenzioso e sorridente si metteva di lato e i suoi occhi brillanti e immensi si colmavano di soddisfazione. Eccettuate le parentesi dei pasti e del sonno da Natale a Epifania Stefano era vissuto nel suo mondo fantastico. Per il giorno della befana non aveva chiesto né desiderato nulla, il presepio lo assorbiva. Eppure i doni arrivarono portati da una vecchia zia sempre sentita nominare e mai vista. Ero con loro quel giorno e ce ne stavamo in salotto noi donne e Stefano; il babbo si era chiuso nella stanza del presepio con Mariolina. Stefano stava appoggiato alla poltrona di quella zia meravigliosa che era arrivata carica di regali e di moine e la guardava tributandole con l’espressione affetto e ammirazione. La zia parlava. Che diceva? Discorreva di tutto. Dei parenti, dei vivi dei morti, della guerra dei partigiani, dei salti nel buio della repubblica, della monarchia, di quei poveretti esuli, di Dio e del demonio. Da tante chiacchiere non era difficile neppure per un bambino capire che essa dentro di sé portava un lutto stretto per la monarchia. Stefano cominciò con lo smorzare il suo abituale sorriso, poi, lentamente, si staccò dalla poltrona della zia, retrocesse fino a quella della mamma e puntando l’indice a braccio teso contro la zia gridò: - Mamma, mandala via, quella è monarchica. - Ma Stefano, che dici? Che fai? Il ragazzo raccoglieva i doni della zia e glieli buttava in grembo. In quel momento s’aperse la porta e il babbo disse: - Venite, sono arrivati i re Magi! Dalla stanza del presepio veniva un sommesso e lontano suono di zampogne e odore di incenso. Il babbo aveva messo il disco in modo che parevano proprio i zampognai di coccio a tirare fuori il suono dai loro otri. Pastori, pifferai, contadini, tutti si erano ritirati in disparte per far posto al corteo dei re magi coi cavalli i valletti e i doni. - Non dovevano arrivare per l’Epifania? Eccoli, sono arrivati! Stefano, guarda la stella che li ha guidati! Ma il piccolo non si muoveva stava in un angolo e piangeva. - Stefano, perché! Che cos’hai? Vieni a vedere. - No! Ci sono i re. Sarebbe stato facile capire che egli soffriva la prima tremenda delusione della vita, ma non lo avvertimmo, anzi lo facemmo soffrire di più con le nostre insistenti spiegazioni. Lo tenemmo lì fermo per dirgli che questi re non sono re come gli altri, che sono dei saggi, dei maghi; più che re sono sacerdoti della sapienza e ai loro tempi anche i sacerdoti portavano la corona. Glieli descrivemmo nel loro viaggio di andata e di ritorno; gliene raccontammo tante che finì col non piangere più, ma al presepio non si accostò. I re magi avevano distrutto una delle cose più meravigliose del mondo: l’incantesimo di un bambino per il presepio che gli aveva fatto il babbo. 293 Alla fine di quel giorno parve quietato, ma l’estasi interiore che appariva intorno a lui come un alone di luce era finito. Noi avevamo aiutato la monarchia a dissolverla. Quando me ne andai lo chiamai come sempre per salutarlo: - Piccolo repubblicano, dove sei? Vieni. Stefano si presentò freddo e compassato e mi disse: - Per favore, non mi chiamare più piccolo Repubblicano perché a me il re non piace neppure lì. - Come ti devo dire, allora? - Se mai dimmi “piccolo publicano”. Non aveva ancora cinque anni e nel viso tanto dolore. 294 1950-1960 Piccolo funerale collocazione: Pg 95; Roma cresce, eppure se ne va. Un pezzetto alla volta, ora grosso ora minuscolo, Roma scompare. Al posto di lei, singolare e superba, subentra una città qualunque che gareggia con innumerevoli città qualsiasi. Roma ha cominciato ad andarsene diventando capitale. Tutto e tutti hanno lavorato per sbriciolarla, eccetto il tempo che su Roma non ha eccessivo potere. Invece l’Italia affluita e affluente a Roma, si è affannata e si affanna per distruggerla. Tutta Italia manda a Roma la sua gente che ne dice male e poi ci resta. Restandoci, la slarga in malo modo, la modifica secondo i ricordi del proprio luogo di origine, ne cancella le vie, ne distrugge il verde, ne cambia il colore, ne nasconde i monumenti e i panorami e, quando capita, ripete che i romani sono gente impossibile! I romani, cari affluenti, sono una minoranza che non fa neppure l’opposizione. Guarda, sorride e tace, ma dentro soffre come soffrirebbe chiunque si fosse visto arrivare gente in casa propria e ce l’avesse lasciata stare come ospite rispettata ma intanto la vedesse demolirgli i mobili di casa e cambiarglieli con quelli fatti a serie. I romani assistono con apparente indifferenza a questa lenta, ma pertinace distruzione di Roma, alla sua lacrimevole camuffazione perché in loro c’è la sicurezza che per quanti sforzi si facciano, di Roma resterà sempre qualcosa di indistruttibile, non fosse altro che la porpora di certi suoi tramonti e l’ombra azzurra di Monte Cavo. Ma di queste cose immense o piccolissime che scompaiono (a volte è immenso un nome che si cancella perché con quel nome si butta alla spazzatura leggende e storia, memorie e tradizioni) faremo in seguito adeguati funerali o commemorazioni, come piacerà meglio. Oggi accompagniamo alla sepoltura le tabelle degli autobus con le ultime lettere. Addio ST, addio FL, addio NT, addio MP, addio CP, con voi muoiono tanti piccoli pezzetti di Roma. Non potete essere dei pezzi archeologici perché voi date nome ad itinerari di motori, ma per quanto recenti, eravate diventati pezzetti veri di Roma come lo diventa un gatto che prenda dimora al Pantheon, un pino che cresca solo al di fuori delle esedre arboree, il getto d’acqua d’una fontanella nuova. Forse tra coloro che avevano coronato gli autobus romani di quelle coppie di lettere, c’era qualcun o non romano. E’ possibile, perché di tanto in tanto, tra tutta l’Italia che affluisce qui, c’è qualcuno naturaliter romano ma questi lo diventa di diritto e non rovinerebbe mai Roma come non rovinerebbe la propria anima se avesse il dono di vederla. Ci tolgono quelle coppie di lettere in cima agli autobus e le sostituiscono coi numeri. Oltre alle solite ragioni tecniche, hanno addotto persino che non tutti conoscono le lettere dell’alfabeto. Per favore, non buttiamoci così giù. E poi è noto ad ognuno che ci furono dei vecchietti analfabeti che con gli autobus impararono almeno quelle lettere lì. Ma i numeri, dicono, si tengono meglio a mente. 295 Non è vero, per qualcuno, ragioniere o grande matematico che sia, può darsi che il numero acquisti una fisionomia più familiare della lettera, ma per i più non è così. Per i più la lettera, oltre al suono, ha una faccia, un nome un colore, un’antipatia o una simpatia, ma il numero ha solo il posto che gli è riserbato nella serie; a meno che non volessimo guardarlo sotto la smorfia del gioco del lotto. Allora però bisogna non superare il 90. In tutte le maggiori città del mondo, obiettano, gli autobus sono distinti quasi sempre con i numeri, di rado con le lettere, in questo caso con lettere isolate, non accoppiate. Qui vi volevamo! E se dappertutto o quasi, ci sono i numeri, a noi romani, scusate, che ce ne…importa? A noi ci importa che voi oggi ci togliete, con quelle tabelle, un pezzettino di Roma. Voi che difendete il banale conformismo dei numeri, non avete certo dimestichezza con Roma. Oh, si, ne conoscerete le strade una a una; conoscerete persino le porte di tutte le case,ma non ne conoscete lo spirito,non ne conoscete il silenzioso linguaggio, non siete stati assorbiti dal vortice della sua vita profonda. Intanto non avete mai spiegato ai forestieri, nostrani e stranieri, il significato di quelle lettere, perché allora vi sarebbe rimasta nel cuore la lieta meraviglia di coloro a cui sillabavate le misteriose sigle e ne avreste dedotto che anche quelle coppie di lettere erano una tessera dell’invisibile mosaico fatto di pietruzze grandi e piccole, preziose e no, dal quale emana il misterioso fascino di Roma. ST: Salario-Trastevere. C’è già qui uno spunto per sapere la meta dell’autobus; spunto che il numero non suggerisce. Ci sarà un settore entro il quale giocherà la prima decina, la seconda in un altro e così via; ci si familiarizzerà anche con queste finche numeriche, ma la fisionomia sarà distrutta, distrutto il colore che ci davano le coppie di lettere. Salario è il quartiere intorno alla Via Salaria, la via per la quale arrivava a Roma il sale. Trastevere è la cittadella della fierezza romana, dove troveremo S.Maria e le osterie, la più piccola campana di Roma e le centinate casette medioevali, il vecchio cantaro della basilica caeciliana e l’antica gente quirite. NT: Nomentano-Trastevere. Dalla via consolare di Nomentum alla mica aurea gianicolense, dall’Aniene alla riva destra del Tevere. FL: Dalla consolare Flaminia alla Ostiense,a quella via che arriverà al mare di Roma, al Lido. MP: dalla Porta Pretoria, dai Castra Praetoria che assunsero nell’epoca della controriforma il nome cinese di Macao, ai Prati, a quella banale zona della Roma nazionale, dove prima si stendevano i Prati di Castello. CP: dagli stessi Prati al Colosseo, dal mausoleo all’anfiteatro. Il defunto NB ci avvertiva che dal Nomentano arrivava a Borgo, la cittadella di S.Pietro. FR ci diceva che dal Flaminio potevamo andare a Ripa, al porto grande del Tevere, più a valle del porto piccolo, di Ripetta. E arrivati a Ripa eravamo a due passi dal monte dei Cocci e dalla piramide di Cestio. Gli occhi e il sorriso dei forestieri che sentivano queste storie qui accennate di sfuggita, si aprivano con simpatia e anche in quelle targhe di autobus, imparavano a scoprire Roma. E perché Roma non assomiglia che a se stessa, poteva ben permettersi il lusso di avere delle indicazioni autofilotranviarie diverse da quelle di Milano, di Berlino, di Parigi. 296 Paese Sera, settembre 1970 Una nonna tutta da scoprire Niente paura, si tratta della città di Cortona che, stando all’anagrafe leggendaria, sarebbe la Nonna di Roma. La cosa è chiarissima: Dardano partì da Cortona, sua patria, per andarsene a fondare Troia, da Troia partì Enea per venirsene nel Lazio a gettare i presupposti per la futura Roma. Dunque, essendo Roma figlia di Troia e Troia figlia di Cortona, Cortona, madre di Troia è nonna di Roma. Date queste sue mitiche origini, la sua ben visibile grandezza etrusca, la sceltissima ricchezza dei suoi musei, vien fatto di pensarla simile a un pregevole sepolcro antico. Inoltre c’è S. Margherita che contribuì ad ammantarla di cenere nella mente di chi non la conosce. S. Margherita, che non era neppure cortonese, andando lassù a compiere la sua spietata penitenza, le si affiancò in modo tale che oramai Cortona e lei sembrano una coppia di buoi sotto lo stesso giogo. Invece bisogna separarle: sono due soggetti completamente diversi ambedue interessanti. Cortona non è vecchia e non è polverosa, pur essendo antica. E’ simile a una bellissima donna, adorna di impareggiabili gioielli storici, serenamente protesa verso la vita. Si eleva come un trionfo in uno dei più suggestivi paesaggi del mondo ed è tutta da scoprire. Non è certo nei suoi ricordi etruschi, nella ricchezza delle sue opere d’arte, ma nel fascino delle sue strade, delle sue finestre, delle sue scale, dei suoi conventi. Cortona, città che si gusta in ogni angolo, in ogni prospettiva, che fonde in un inseparabile abbraccio arte e natura, allontana da sé il nome di nonna; ma se proprio lo è, allora bisogna riconoscere che è la Marlene Dietrich di città. 297 Paese Sera, ottobre-novembre 1973 1970 finestre collocazione: Pg 73-75. Tre anni fa si celebrò il nefasto centenario di Roma capitale d’Italia. Intervennero anche i preti, non per celebrare le esequie di una città barbaramente distrutta, ma per assolverne la rovina. La ricorrenza bicentenaria della morte di Luigi Vanvitelli che concepì, disegnò, in parte attuò una capitale libera da condizionamenti ambientali, edilizi e storici, esistente di per sé, non appiccicata come una maschera sul volto di Roma che era la capitale del mondo, ravviva la pena per quello che poteva essere fatto e non fu fatto per salvarla. Bastava fare quello che già avevano fatto i Borboni: lasciando intatta la città, costruire, vicine ma staccate, quelle sedi rappresentative e burocratiche necessarie a una capitale. Perché questa condanna di diventare capitale toccasse proprio a Roma è un mistero che per spiegarlo non basta la sua millenaria grandezza e la necessità di far dispetto al Papa, dato che Roma aveva tutto il necessario per esserne esclusa. L’Italia è la terra delle tante splendide città, è una lunga chiesa illuminata da candelabri uno diverso dall’altro, ogni città grande o piccola, un candelabro prezioso; le più grandi erano tutte capitali, avevano tutte la reggia le nostre più grandi città, anche se si chiamavano palazzo Ducale o palazzo Pitti. C’era da scegliere. Scartando la millenaria fastosa città di Palermo troppo lontana per uno stato accentratore e pauroso, c’era Bologna che sta nell’Italia come il cuore nel petto degli uomini. C’era Milano che non sta “come” il cervello perché lo è e lo sarebbe stato nella formazione del nuovo stato che molto non ne aveva. C’era Torino piemontese e sabauda; restando lì la capitale avrebbe risparmiato la grande rovina di Firenze e la distruzione di Roma. C’era Napoli, soprattutto, lasciata in ultimo come nelle processioni solo alla fine sotto al baldacchino avanza il mistero sacro. Napoli era già capitale da otto secoli e per di più “regia”, quel regia che tanto inteneriva i Carignano. L’unità d’Italia in gran parte consistette in quell’aggettivo appiccicato a edifici, a istituzioni preesistenti da secoli, alle rivendite dei tabacchi, al lotto che era un giochetto proprio da governo papalino. Napoli era una delle più splendide capitali d’Europa. I Savoia risparmiandosi l’umiliazione di strapparsi un alloggio con la forza, vi avrebbero trovato non una ma diverse regge, e tra le più belle al mondo. Ne aveva una aperta sul più bel panorama d’Italia, un’altra a Portici, più amena perché più piccola. Nel ‘700 dalla grandezza, dall’arte, dalla magnificenza, dalla ricchezza, dalla natura, era nato l’immenso stupore che è la reggia di Caserta. Carlo III pensava che la capitale sarebbe stata più libera e sicura all’interno, riparata dalla violenza di qualunque genere fosse, dell’acqua, dell’ambiente, della società. Ne parlò a Luigi Vanvitelli che sull’idea del Borbone innestò il suo miracolo. Alla proposta mastodontica Vanvitelli esplose come un fenomeno della natura. Era sangue nordico il suo nel quale il sole meridionale funzionava da esaltante 298 energetico. In suo padre, nato in Olanda, restò l’incantata ammirazione di questi nostri luoghi solari che ritraeva con infinito amore velando però i suoi quadri di grigioperla o di tenue lilla, un ricordo di melanconia. Nel figlio nato a Napoli non ci fu ammirazione, ci fu immedesimazione, la natura era lui, lui che conosce solo il trionfo della luce sia che lavori come architetto, come progettista, come tecnico. Forse dal suo maestro Juvara aveva colto la scintilla. Valendosi del terreno, dell’altezza, dell’aria, del panorama, Juvara aveva creato Superga dove non è la morte che viene celebrata, ma la vita serena nel riposo della bellezza, nella dolcezza del sonno anche se è senza risveglio. Una scintilla che l’allievo poteva non cogliere e conservare rispondente com’era alla sostanza della sua personalità: sentire terra acqua bosco cielo pietra come un mistero religioso, vederne la divina bellezza, fondere il suo genio con questa natura arcana, lavorarla da solo come fece Dio quando la creò. Si può dire che ebbe Roma in mano perché il papa tutto affidava a lui del consolidamento del Cupolone, all’erezione di chiese e monumenti nelle sue legazioni. L’arco clementino di Ancona, la chiesa del Gesù, la cappella di san Ciriaco. Dove non arrivava materialmente lui si elevavano palazzi e chiese con i suoi disegni. La deliziosa chiesetta della Misericordia a Macerata, ne è uno, in un breve spazio creò spazio a sorpresa col movimento delle colonne. Compì il campanile di Loreto innalzandolo. Di spazio aveva bisogno Vanvitelli, allargare, alzare, mai restringere. Col suo amico Salvi allungò la facciata di palazzo Odescalchi e qualcosa di lui ci sarà certo, come ispirazione, come esaltazione nella Fontana di Trevi. Il convento degli agostiniani è suo e non si può dire che sia un conventino. Ma gli toccarono anche lavori che non erano consoni al suo temperamento: manipolare il già fatto. La chiesa di s. Agostino non uscì migliorata dalle sue mani; quella di s. Maria degli Angeli meno ancora. Lo spazio qui ci sarebbe stato, quello spazio romano che Michelangelo voleva conservare, che i successori guastarono, che il Vanvitelli doveva completare. Lui avrebbe sfondato, riaperto, rimessa in efficienza tutta la grandiosità romana ma non si doveva; chiudere si doveva, restringere, coprire, falsare, far diventare lunghezza quel che era larghezza. Se la chiesa fu così stravolta non è certo colpa di Luigi Vanvitelli su cui aveva messo gli occhi uno dei più illuminati sovrani d’Europa, Carlo III di Borbone. Lo chiese al papa Lambertini che, bonario come sempre glielo concesse. Forse aveva anche intuito che Roma non dava abbastanza spazio a quel creatore. A Napoli innalzò subito con quello dei figli che riusciva a lavorare come il padre voleva, la chiesa dell’ Annunziata e a metà di via Toledo apre un trionfalistico emiciclo in onore di quel sovrano che gli dava ciò che quasi nessun uomo riesce ad avere: la possibilità di lavorare a modo suo. A Portici eccolo alle prese con gli scorci di mare, di luce, di piante, di colonne nella “residenza” che i Borboni si erano già costruita lì attirati dall’amenità del luogo, quasi una reggia in campagna. Napoli è città di regge; i secoli ce le hanno lasciate come le incrostazioni marine sulle colonne di Pozzuoli. Regge fortezze come Castel dell’Ovo, normanne come Castel Capuano; castelli rivoluzionari come quello dei Carpamazzi reali veri e propri; piccole regge muliebri come la Floridiana; regge per ospitare i capolavori d’arte come Capodimonte. Tante regge in mezzo ad uno dei popoli più ricchi della terra, ricco tanto che trasforma in vita anche la sua 299 indicibile miseria, tanto ricco e dignitoso che in ogni basso c’è lo spirito di una reggia. In questa città di regge Carlo III ne volle una tanto grande che tutte le comprendesse, lontana dalla città, al riparo da turbamenti causati dalla violenza, di qualunque natura essa sia. Non s’ispirò a palazzo Carignano, mirò a Versailles. Una Versailles in mezzo alle meraviglie della terra campana. Più di questa reggia ai Carignano importò più punzecchiare il papa occupando una sua casa con la forza come fanno qualche volta i baraccati, umiliando se stessi e condannando a morte Roma. La reggia c’era ed era una delle più belle del mondo se non la più bella perché cascate come quelle che il Vanvitelli costruì difficile trovarle. Una reggia fatta con mattoni, pietre, marmi, metalli, erba,alberi, acqua, popolata da statue di animali, di ninfe, di eroi, di apparizioni. Altro non sono che apparizioni certi scorci, certe lontananze, certe sorprese. Ha alleggerito mattoni, pietre e marmo creandosi ariosi labirinti di colonne, di gallerie che non si chiudono mai, dando l’illusione di un gioco di specchi come nella gloria di certi presepi che a forza di essere riflessa pare infinita. Introducendoci nella sua creazione ci introduce in una esplosione di sogni. Non è solo sogno, è canto. In questa vastissima opera paesistica si passa come in un poema dalle molteplici cantiche a tutti i toni del lirismo. Monumenti di pietra ed acqua, questo sono le fontane profuse da chi poteva contare sul suo inesauribile genio creativo. Acqua pigra, acqua rapida, acqua a cascate, ad archi, a zampilli, sgorga copiosa, gioca con l’erba, si nasconde sotto di essa, riappare per giocare con l’aria e balaustre, scogli, grotte per contrapporre il gioco raccolto a quelli affidati allo spazio e alla lontananza. La reggia di Caserta è appoggiata a un’opera della potenza di quelle romane, all’acquedotto carolino che percorre chilometri e chilometri, attraversa colline, valica le valli con superbi viadotti. Creatore, tecnico, artista, un uomo solo e tutto in pochi anni. E anche la città intorno alla reggia immaginò e disegnò, città che rimane a mezzo, la capitale solo capitale. Quello che avrebbero dovuto fare i Savoia se fossero stati all’altezza dei Borboni. La città progettata dal Vanvitelli aveva le caratteristiche che solo ora si cominciano a proporre come necessarie alla moderna urbanistica. I Borboni e questo popolo terrone bistrattati da una parte dell’Italia unita, pare che sapessero scegliere i loro architetti, pare che sapessero farli i loro sogni preveggenti. Gaetano Filangeri sublimava le leggi, il Borbone ne tentò la realizzazione e fu S. Leucio. Come nell’agro Patrimonio di s. Pietro si erano costituite le domus cultae, quelle libere comunità autosufficienti generate dalla necessità di raccogliersi e difendersi nella solitudine di quelle terre, Ferdinando di Borbone, con ben superiori intendimenti, volle provare. Quella superba reggia ebbe vicina una comunità basata sull’uguaglianza e sulla libertà, autonoma e autosufficiente con diritto all’assistenza sanitaria e all’istruzione, poteva essere la prima di tante altre che avrebbero potuto fare della Campania la serra della libertà e del progresso. Ma i fermenti che preparavano l’unità italiana si sovrapposero provocando reazioni che tanto fecero comodo ai piemontesi. La Napoli che ha profuso la felicità della sua terra, il pensiero dei suoi uomini, la genialità del suo popolo e il suo saper soffrire, che prima dell’annessione al regno italiano aveva conosciuto splendori culturali a livello europeo, oggi tra cozze e ciminiere continua la sua via crucis. Può venire il dubbio che invece di opera unitaria si sia fatta della vivisezione. Ma la reggia creata da Vanvitelli resta, è un sogno realizzato come non lo fu quello di Francesco d’Assisi. 300 Volandoci sopra, priva com’è delle 4 torri angolari e della cupola centrale progettate dal Vanvitelli, la reggia pare un’immensa finestra crociata appoggiata per terra. Una finestra coricata, traforata nel suo spessore da 1970 finestre. Inutile contarle, si ricomincia sempre daccapo. Tre anni fa quando si celebrò il centenario dell’unità raggiunta con l’annessione di Roma (che per concludere davvero ci vollero altre guerre), una unità che volle dare tinta unica a quello che era un fiorire di varietà, nel 1970 invece di quel disgraziato ricordo di Roma, sarebbe stato meglio celebrare le 1970 finestre di Caserta, una coincidenza che non si ripeterà mai più. 301 Il Globo, novembre 1973 Il lenzuolo piegato collocazione: Pg 102. “Il sepolcro è vuoto!” avevano gridato le donne che erano andate per imbalsamare Cristo. Pietro e Giovanni corsero; questo, più giovane, arrivò prima dell’altro, ma non entrò; però vide in terra le bende che avevano avvolto il cadavere. Pietro arrivò dopo, ma entro; vide i lini e anche il sudario da un’altra parte, piegato. Questo su per giù il racconto dei Vangeli. Il lenzuolo, piegato e messo da parte non si sa da chi, potrebbe essere la Sindone di Torino, un telo lungo più di due volte un corpo umano, tessuto a spina di pesce con filo di lino tratto da fibre grezze. Nel mezzo, la duplice tenuissima impronta di un corpo umano visto nel di fronte e nel dorso come succede quando tra due pagine di un libro si mette a seccare un fiore. Più visibili sono certe macchie che sarebbero il sangue delle ferite di Cristo. Più visibili ancora certe gore lasciate dall’acqua adoperata per spegnere i due incendi nei quali fu coinvolta. Più visibili ancora le bruciature del primo incendio, quello di Besançon. Visibilissimi i rappezzi che le monache sovrapposero alle bruciature del secondo incendio, quello di Chambéry e su tutto il passaggio opaco del tempo. Pare che il secondo incendio avvenisse nella cappella del papazzo dei Savoja quando la proprietà della Sindone era già passata a loro. Nella retorica che coperse la penisola dopo la rabberciata unità politica, ebbe un posto di prima fila quella sulle prodezze e le tenerezze della dinastia. Si disse allora che le principesse di casa Savoja avessero messe quelle pezze stando in ginocchio. Monache e principesse potrebbero avere agucchiato insieme intorno al lenzuolo di Gesù che è esso stesso un double-face. Ma il boom della Sindone scoppiò nel 1898 quando l’avvocato Pia, avuto il permesso da Umberto I di fotografarla, nello sviluppo della lastra s’accorse di avere ottenuto il positivo dell’incerta ombra umana che, solo allora lo capì, era il negativo di quell’immagine risultata positiva. Con alti e bassi si arrivò al 1931 quando Giuseppe Enrie, emerito studioso di fotografia, riprendendo con mezzi più perfezionati l’insieme e i dettagli del lenzuolo, ne scandagliò tutto ciò che l’obiettivo fotografico poteva allora scandagliare. Anche per Enrie, quando vide affiorare nello sviluppo della sua prima lastra, quel volto arcano e misterioso, l’emozione fu un sigillo che lo segnò con impronta indistruttibile. Da vecchio, quando ne parlava, faceva ancora il gesto di dondolare la bacinella dove l’acido stava rivelando un volto che poteva essere … quello di Cristo. Nonostante che lui credesse all’autenticità della reliquia, ne parlava e ne scrisse con l’obiettività dello scienziato come hanno continuato a fare gli studiosi di sindonologia italiani e stranieri, laici ed ecclesiastici; tra questi il dotto e infaticabile monsignor Giulio Ricci. Prima che la fotografia col suo positivo desse maggiore certezza a quell’incerta figura, la Sindone era stata creduta un miracolo, un trucco. Ma la fotografia svelò che pittura non è;né si poteva immaginare un negativo quando la camera oscura era ancora al di là dei secoli. Va bene; ma se sul telo ci sono macchie e colature di 302 sangue,vuol dire che nel sepolcro il sangue usciva ancora dal corpo di Cristo, che il suo cuore batteva ancora, che Egli era vivo. Se era vivo barcolla la Risurrezione su cui il cristianesimo poggia, non come dottrina, ma come religione, perché dal sepolcro poteva non essere uscito un corpo glorioso, ma un uomo riavutosi da profondo collasso. Era venerdì, il tramonto vicino, bisognava fare tutto in fretta: col crepuscolo cominciava la religiosa inattività del sabato che, per di più, quella era Parasceve. Forse si seppellì un vivo. Formidabile dubbio del quale, si disse, tempo fa, il Vaticano ha tanta paura che cerca di distruggere la Sindone. Era avvenuto che un insuperabile acrobata, per due volte, a rischio di rompersi il collo, per rovinose scalette, oramai dimenticate da sagrestani e custodi, scavate nello spessore dei muri, arrivasse alla Sindone per darle fuoco con uno straccetto imbevuto d’olio. Ignorava dunque che adesso per bruciare la Sindone non è più sufficiente la fiamma ossidrica. Il Vaticano che lo sapeva non stava tremando per quelle macchie; il suo prestigio poggia su basi uniche al mondo. Con le reliquie, con i miracoli, con certe espressioni superstiziose, si comporta come gli adulti con i ragazzini: purché non piangano li lasciano divertire con i giocarelli che si sono scelti. Riguardo alla Sindone non ha mai detto di credere o di non credere alla sua autenticità. L’agonia dei crocifissi era spaventosa: soffocavano, per respirare facevano sforzi orribili sollevandosi sui piedi, chiedendo aiuto alle mani. La rottura delle ossa dei ginocchi avveniva per togliere la possibilità di quei ultimi strazianti respiri; equivaleva al colpo di grazia. Lo sforzo che faceva Cristo nel sollevarsi per respirare era più spaventoso perché non era legato, ma inchiodato alla croce. A lui però non spezzarono le ossa perché era già morto, ma per maggiore sicurezza gli trafissero il cuore con la lancia. Le sofferenze avevano certo provocato in lui abbondante sudorazione con emanazione di vapori ammoniacali diffusi dall’urea del sangue. Quando fu messo nel sudario il sangue era coagulato di sicuro, ma con l’umidore ancora evaporante dal corpo appena morto e in fretta sepolto, aggiunto all’umidità del sepolcro, nuovo e scavato nella roccia, si sciolsero i coaguli e il telo li assorbì, una specie di soluzione della fibrina sanguigna. Il lenzuolo era imbevuto di aloe e di mirra; l’aloe in presenza di sostanze alcaline emesse dall’umidore cadaverico si altera assumendo quella tinta bruna che ha l’impronta della Sindone. Era morto, è provato, dicono questi. Non è affatto provato, rispondono gli altri. Argomenti tutti che coinvolgono storia, scienza e posizioni religiose e no, senza riuscire a sciogliere il mistero. Anche sull’altezza di Cristo si discute. S’era sempre detto che avesse avuto la statura media dei palestinesi: basso no, altissimo neppure. Adesso che la statura ad asparago fa tanto moderno, si vuol dedurre dalla Sindone che era altissimo. Le fibre di un tessuto tanto lungo con i loro 2000 anni di vita si sono certo rilassate;di un tessuto che con lo stare arrotolato intorno ad un asse, a volte per secoli, e che ne ha favorito l’allungamento,non possono dare l’altezza di Cristo che, del resto, non ha nessuna importanza. Ben più importante è l’espressione del volto. Stando arrotolata con le impronte all’interno, la seta rossa che la fodera nel retro, dovendo percorrere un 303 circuito più ampio, esercitava nel tessuto sottostante una pressione che, per rimettersi al passo con la fodera doveva ogni tanto aggrinzarsi. Ecco la causa di quelle pieghe sottilissime che risultano righe bianche nel negativo e nere nel positivo. Mettersi sulla strada dei pro e dei contro è interessante anche per i dubbi che camminano affiancati a loro. Sul dorso ci sono i segni della flagellazione. Possono i lividi lasciare la loro forma su una stoffa, o anche lì entra un processo di reazione chimica? Certo che intelligente e colto dovette essere il falsario se ci fu, perché quei lividi li fece col segno delle due pallottole terminali come era veramente il “flagellum” romano. Gli ebrei calavano sul volto del morto, prima del lenzuolo, un panno di lino. Se questo fu messo, come riuscirono i vapori del corpo a impressionare il lenzuolo? Dimenticato per la fretta. Se il lenzuolo fu tirato dalla nuca sul volto, l’impressione della testa doveva essere continuativa. Fu lasciata una piega del tessuto dietro? Ma i capelli che sembrano soffici e gonfi, potevano imprimere la tela come se fossero stati un rilievo solido?Si ipotizza che fossero stati sollevati da bende per incorniciare il volto. Ma se ci fu l’acconciatura da parrucchiere, dove va a finire la fretta per il Parasceve? Che indovinino quelli che per dissacrare dicono che nel lenzuolo fu posto un manichino preparato in modo da lasciare le sue impronte sulla tela? Ma un viso di quella potenza, poteva averlo un manichino? Perché avrebbero faticato a dargliela dato che non potevano supporre la scoperta della fotografia che lo avrebbe rivelato? Siamo abituati a vedere Cristo in croce disegnato, dipinto, scolpito, sempre con una fascia intorno ai fianchi, ma l’aveva veramente? Difficile supporre un riguardo per il pudore del condannato in gente che alla richiesta di acqua rispose comprimendogli sulla bocca una spugna imbevuta d’aceto. Se l’avesse avuta, data la fretta con cui bisognava seppellirlo, non avrebbero perso tempo a levargliela. L’impronta del Sudario è di un corpo perfettamente nudo; se è di Cristo egli stette sulla croce nudo com’era giusto che fosse per il nuovo Adamo. Pare confermato che il tessuto è di quell’epoca dal polline di certi fiori. Pare che gli scienziati ci diranno se le impronte della Sindone sono effetto delle radiazioni del corpo di Cristo. Si studierà, si analizzerà e la Sindone resterà chiusa nella bellezza del suo mistero. In tante ipotesi passate, presenti e future, il fatto meno ipotetico, anzi l’unico certo e che smentisce tutta l’iconografia cristiana, è il segno delle stimmate. Si chiamano così le ferite fatte dai chiodi nelle mani e nei piedi di Cristo e quella della lancia sul suo petto. In antecedenza lo stigma era un marchio, un segno, impresso nella carne viva con punture di ferro o di fuoco, a significare schiavitù, irreggimentazione, condanna, affiliazione a sette comunitarie o religiose. San Paolo adoperò per primo quella parola, ma in un senso che non ha niente a che vedere col senso che prese in seguito. Gli apostoli non erano cristiani così come noi l’intendiamo, erano ebrei che credevano nel Maestro scomparso, restando fedeli alla legge ebraica. Naturalmente anche i nuovi seguaci della dottrina predicata dai discepoli di Cristo,restavano ebrei osservanti di tutte le loro leggi cominciando dalla circoncisione, il segno sacro che li distingueva; si sarebbero sentiti ribelli a Dio senza quel segno che, assoggettandoli, a Lui li legava. Certo a loro apparve un poco blasfemo Paolo, quell’infatuato convertito, nell’insieme più gentile che ebreo, che sosteneva si dovesse tralasciare d’imporre quel segno perché superato. Fu proprio in una epistola su 304 questo argomento che apparve per la prima volta la parola stigmate, “io porto nel mio corpo le stigmate di Gesù”. San Paolo non dava alla parola il senso che le diamo noi; non ebbe mai nel corpo quei segni; non pensava neppure alle ferite di Cristo che in questo caso avrebbe detto “fixurae”; egli diceva di avere nello spirito il segno che gli altri avevano nel corpo. Fu dopo, molto dopo, che la parola significò le cicatrici della passione di Cristo e stimmate furono la riproduzione di quelle fixurae sul corpo dell’uomo. San Francesco fu stigmatizzato. Gli si presentò un serafino in croce, sei ali infocate, gli dardeggiò sul corpo i segni della passione di Cristo: le mani furono trafitte nel mezzo della palma. Dopo san Francesco ogni tanto è apparso qualcuno con le stimmate; di uomini in realtà pochi; di donne tante, ce ne furono, ce ne sono. Padre Pio le ebbe, ma fu tutto un grosso mistero italiano. Quel suo confessionale dove tra attese notturne, lagrime, improperi, seggiolate e urli del frate, si affollavano i più strani tipi del mondo; quel suo ambiente tra miracoli e affari, tra rozza semplicità e azioni inestricabili, sono tanti misteri uno dentro l’altro sino al sassolino ermetico delle stimmate. Prima le teneva scoperte, erano tra il medio e l’anulare, vicine alle dita, poi le nascose sotto i famosi mezzi guanti. Salvo che per san Francesco, la Chiesa non mostra simpatia per quei fenomeni; si direbbe che la disturbano se appaiono; il giudizio lo rimanda alle calende greche e se proprio deve pronunciarsi, lo fa con ambigua cautela. Ebbe più sopportazione per le statue semoventi delle vecchie campagne elettorali; forse perché il ciarlatano fa ridere, il patologico ripugna. Di qualunque natura esse siano, false lo sono sempre, lo dice la Sindone con l’impronta che ci lasciò un uomo sicuramente crocifisso con chiodi. Un corpo umano non può sostenersi appeso a due chiodi infilati nel metacarpo,vale a dire, tra le dita non ancora divise; la carne si straccerebbe, non ne reggerebbe il peso. Ebbene, in quel sudario la ferita della mano non è nel palmo, ma molto più vicino al polso, è tra le ossa del carpo. In quel punto sì, due chiodi potevano reggere quasi interamente il peso di un corpo abbandonato. Nella Sindone quel segno è al posto giusto secondo la fisica e secondo l’anatomia. Se è falsa, essa fu compilata tanti secoli fa da un mistificatore guidato dalla ragione, non dalla immaginazione. Perché invece gli stigmatizzati hanno tutti queste ferite della mani fuori posto? Il Crocifisso è stato sempre riprodotto da artisti e artigiani, col chiodo nel mezzo della mano. Gli innamorati del suo sangue fissano quelle immagini, meditano su quelle ferite, ci si chiudono, “intra vulnera tua asconde me”, su quei segni convergono tutte le loro forze affettive, mentali e nervose; se hanno una speciale natura adatta al fenomeno, essa fa il resto; la loro carne riproduce quel che, fissandolo, li esalta. Così si pensa noi profani; però piacerebbero assai le spiegazioni che possono darne studiosi competenti. Sapere perché anche il Serafino di San Francesco si sbagliò imprimendogli quelle fixurae dove Cristo non le ebbe. Che se in questi fenomeni ci fosse qualcosa che trascende la patologia umana, bisogna dire che con i nostri errori Iddio ci si diverte. 305 Paese Sera, fine 1974 Un po’ dei tanti centenari (addio al 1974) collocazione: Pg 79. Il 1974 si chiude su un numero straordinario di crisi, malefatte, tram e centenari: salutiamoci su quest’ultimo argomento. Venti volte cent’anni fa moriva Terenzio Varrone che tutto studiò, terrestre e trascendente, di tutto scrisse e col presente e il passato guardò il futuro rivelando molto all’umanità di se stesso. Degno perciò di rimanere seduto tra noi come sta nella sua Rieti, guardandoci in faccia e maneggiando carte. Dodicesimo centenario della calata di Carlo Magno in Italia. Sempre nefaste le calate per noi. S’erano strizzato l’occhio, papa e imperatore; questo calò e ne nacque il Sacro Romano Impero, un corpo fatto di due cose distinte. Settimo centenario della morte di san Tommaso d’Aquino a cui Cristo disse, parlandogli attraverso un crocifisso: “Bene scripsisti de me Thoma”, stroncata la contraddizione. Settimo centenario della morte di san Bonaventura da Bagnoregio; coetaneo di san Tommaso, morì pochi mesi dopo di lui. Dottore Angelico è chiamato Tommaso, inflessibile difensore della castità, Dottor Serafico Bonaventura abbandonato al trionfo del mistico amore. Genio della speculazione il primo, genio del mistero il secondo. Settimo centenario del Concilio ecumenico di Lione che in un certo senso uccise Tommaso e Bonaventura. Erano stati invitati tutti e due. Da Napoli Tommaso si mise in viaggio, uno di quei viaggi di allora fatti di lento procedere e di molto vedere; in una sosta all’Abbazia di Fossanova, lo raggiunse la morte e lo fermò lì. Bonaventura arrivò a Lione, ma due mesi dopo l’apertura del Concilio morì. Il Concilio fu come un corpo che invitandoli testimoniava di volere il trapianto in sé del diverso sapere dei due e nello stesso tempo fisicamente li rigettava. Parve che il domenicano Tommaso e il francescano Bonaventura, pari grandezza, assoluta diversità, sorgessero in un’epoca travagliata della chiesa perché essa facesse la sua scelta. Difatti prima assai del Concilio il Papa li aveva un giorno tutti e due davanti a sé, dovevano leggergli una composizione che separatamente aveva ordinato. Invitato a leggere per primo fu Tommaso, poi Bonaventura, ma questo non poteva più leggere: mentre ascoltava Tommaso aveva stracciato la sua composizione. Se il Papa avesse invitato prima Bonaventura, Tommaso avrebbe stracciato la sua? Sesto centenario della morte di Petrarca, l’incoronato poeta viaggiante che non libero ancora dei tormenti medievali sente in anticipo quelli nostri esistenziali. Il fuoco che a 23 anni lo accese d’amore per Laura duro tra esaltazione e repulsa, benedizioni e rimorsi, per tutta la sua vita, lo spense con un soffio la morte. Sesto centenario della nascita del pittore marchigiano Lorenzo Salimbeni unito nella vita e nell’arte a suo fratello Jacopo da non poter distinguere nelle tavole, firmate da tutti e due, quale la sua mano quale quella del fratello: fratelli siamesi nello spirito, erano indistinguibili. 306 Sesto centenario della nascita di Jacopo della Quercia, il prestigiatore che dette il respiro al petto della marmorea Ilaria del Carretto e il calore vitale del cane ai suoi piedi. Quinto centenario della nascita di Ludovico Ariosto, pratico, accorto, equilibrista, spaziò nella fantasia come folletto mai stanco di creare. Pensò anche di mandare qualcuno sulla luna, magazzino di tutto ciò che quaggiù si perde, per recuperare un po’ di senno necessario agli uomini. Operazione esattamente inversa deve essere avvenuta con l’andata reale dell’uomo sulla luna: invece di recuperare il senno umano ce lo hanno depositato, da allora ad oggi la pazzia nel mondo è in crescita. Quinto centenario della morte del musico integrale Guillaume Dufay che ogni parte della musica ebbe in suo potere, baccalaureato in utroque, cappellano, canonico e cantore. Quarto centenario della morte di Giorgio Vasari, ammirato e discusso come pittore e architetto, come biografo d’artisti interessante, piacevole, pettegolo. Quarto centenario della morte di Bartolomeo Eustachio, umanista, greco, arabo, ebraico, medicina, matematica, innovatore e scopritore nel campo anatomico, il suo nome tutti noi ce lo portiamo nell’orecchio; uno dei tanti geni che le Marche hanno regalato al mondo con la semplicità del contadino che offre un frutto della sua terra. Terzo centenario della morte di Giacomo Carissimi, celebre compositore di musica sacra, semplice e drammatico, un suo mottetto può ancora riempire di pathos la scettica folla moderna riunita dentro san Pietro. Terzo centenario della nascita del musicista Tommaso Albinoni; se non ci fosse stato lui le più sublimanti fughe di Bach non ci sarebbero. Secondo centenario della morte dell’irrequieto e illustre letterato inglese Oliver Goldsmith. Secondo centenario della Madonnina milanese, quel madonnone che è diventato simbolo e amore della città. Secondo centenario della nascita di Gaspare Spontini, il neoclassico musicista; uscito da un minuscolo centro marchigiano, genio e circostanza lo portarono in volo da una corte all’altra per tutta Europa finché tornò alla cuccia alla sua Majolati. Secondo centenario della benemerita Guardia di Finanza. I primi centenari non si contano, li ammucchio: primo centenario della morte del Rovani che tentò con un romanzo di darci cento anni di storia della vita lombarda – quella della prima mostra degli Impressionisti – della Costituzione – degli Ordini Forensi italiani – della Legione de Carabinieri di Roma – cento anni compie la Messa da requiem di Verdi – la Casa Editrice Sansoni testimonia se stessa per il suo centenario. Cent’anni fa moriva Niccolò Tommaseo; austero, liberale, credente, patriota, studioso, prolifico di scritti e di azioni, repubblicano convinto, inquieto e battagliero non si riposò neppure quando la completa cecità cercò di seppellirlo. Se fossero vivi avrebbero cent’anni: Guglielmo Marconi, genio della scienza, da tutti conosciuto nel mondo intero anche da chi non sa che cosa precisamente abbia scoperto; meno noto come altissimo esponente della gente bene che passando per la 307 Sacra Rota si rinnova. Luigi Barzini, scrittore e maestro di giornalismo. Churchill, condottiero, politico, statista, scrittore, pittore, tenerissimo amante di sua moglie. Luigi Einaudi da cui l’Italia avrebbe potuto imparare a condursi in modo da non dovere dire ora: Dio! Come sono caduta in basso! Il pittore e xilografo Adolfo De Carolis destinato a salire e scendere come le onde marine, ma la cui musicalità resterà sempre nell’aria. Antonio Graziadei. Dire il nome è rivedere una piccola immensa figura: guerra appena finita, ad un secondo piano di Piazza Fontanella borghese, lui tornava per farci comprendere il suo Marx; uno dei momenti più estatici dopo la distruzione, prima del disincanto. C’è Gaetano Salvemini. Paer, Farman, Meyerhold, Fiaccone, Arnold Shomberg, Somerset Maughan, e tanti altri, si dice sempre così per svignarsela. Ma per i romani c’è anche il centenario della loro bottega di carta, oggetti di cancelleria e piccola stamperia. Dietro i bersaglieri di Porta Pia scesero i piemontesi: “assumevano” tutto quello che toglievano; tra gli assunti anche le cartiere tanto più che erano “meridionali” quindi bisognose di luce nordica. Assunsero e si “stabilirono” con un vasto “negozio” in via Frattina. Ma cosa provinciale non può assorbire cosa universale; il senso dell’universale a Roma era anche nei robivecchi. Appena tre anni e il vasto negozio in mano ai Zampini fu romano. Lo scoppio del consumismo li sloggiò da Via Frattina, entrarono più a dentro, nel cuore della vecchia Roma. In quella cartoleria, la cui romanità nobilita anche le banali sacchette di plastica, si riflette quella che fu la sorte della città e del papato dopo l’annessione: sceso il Piemonte per distruggere e assorbire, fu assorbito e niente distrusse, neppure il potere temporale. 308 Divagando per Trastevere collocazione: Pg 94. “Ora incomincio il tuo inno di lode, o Trastevere!” Per lo spazio di un secondo, tanto da stendere la mano per prendere la penna, ho creduto che avrei scritto così. Una di quelle tante pulviscolari convinzioni, brevi più di un respiro, che si avvertono come vere e nell’immediato finire sono già false. Sciogliere un inno di lode a Trastevere! E’ semplicemente ridicolo. Trastevere si dice. Nel dirlo qual è, è il suo massimo elogio, e nel riconoscere l’impossibilità di farlo compiutamente è la confessione della sua grandezza. Trastevere tutto fatto di terra color d’oro. Di terra color d’oro il monte, di terra color d’oro la pianura che si abbassa sotto l’acqua a reggere il passaggio del fiume che porta sciolto quel colore. Il S.Pietro trasteverino sta su un monte d’oro, “in montorio”. I santi Cosma e Damiano di Trastevere, riuniti per amore di brevità popolana in san Cosimato, sono detti “in mica aurea” e così altre chiese e anche un piccolo cimitero dove i morti dormono in mica aurea. Trastevere, estremo ramo di gente etrusca che si fermò sulla sponda destra del fiume a guardare la grandezza nascente della gente latina all’opposta sponda. Roma crescente lo fissava sospesa e non volle col Trastevere risoluto ponti duraturi; ne bastava uno solo e purché fosse di legno, materia soggetta all’ascia e al fuoco. Trastevere che è poi stato sempre un poco una piccola Etruria, che è tuttora una piccola Roma nella grossa Roma come il giallo di un fiore è il cuore del fiore. Trastevere che di fronte alla Roma dei sette colli, fu e restò la Roma di un solo colle, ma del più alto, Trastevere è stato sempre temuto; è troppo dignitoso e fiero. Trastevere, terra dove forse la leggenda è vera tanto essa è umana, e dove la verità è leggendaria tanto essa è bella. Bella come l’aspetto statuario della sua gente, di quella poca che ci resta veramente trasteverina. Trastevere, dove ha le fondamenta e i muri la casa di Cecilio e dove aleggia la musica della sua storia. Storia che forse è confusa con la leggenda, ma dove c’è un dato così reale che si può toccare: l’atteggiamento squisitamente penoso della martire. Così come potrebbe non essere leggendaria la pietra su cui si inginocchiarono gli angeli avanti a S.Pietro morente, proprio perché è una pietra senza orme miracolose; l’orma sarebbe un falso perché gli angioli non ne lasciano. Trastevere, terra da cui scaturì la fonte pacifica dell’olio, “fons olei” c’è scritto nel punto dove sgorgò quando il Re della pace stava per apparire sulla terra. Quel punto sta dentro S.Maria, una delle più belle chiese del mondo, proprio dalla parte del campanile che ostenta l’unica campana ribelle di tutta Roma, la sola che sia uscita fuori della sua cella. E’ una campana trasteverina, all’occasione sarebbe una specie di Giuditta Tavani Arquati. Trastevere che, come solleva oggi una campana al di sopra di un campanile, sollevò, tempo addietro, sulla sommità di una torre la grotta del Presepio. Era mezzo rovinata allora la torre degli Anguillara, non era 309 pareggiata e lustrata come lo è oggi, ma proprio per questo poteva con più verità portare una grotta verso il cielo. E il cielo, i colli laziali, tutto il movimentato e largo panorama romano, facevano da ambiente vero alla grotta finta. Trastevere si fa amare anche per i nomi delle sue strade e per i miracoli che, sparsi per il rione, vi lasciarono nomi e monumenti. Per questo tra Merangoli, Polveraccio, Fienaroli, Botticella, Moro, Fico, troviamo Luce, Scala, Orto. Una casupola s’accese di luce come un sole per la impaurita preghiera di un cieco, ecco la Luce. Una ostinata e muta Madonna di un sottoscala, dovette rispondere alla trasteverina che la rimproverava seccata di aver chiesto invano: “Eppure se tu chiedessi a me un favore, io te lo farei subito!” e la Madonna per non essere da meno, le raddrizzò il figlio, cosa che era la sostanza del favore richiesto, e venne la Scala. In via di Monte Fiore, è il ricordo dei tanti giardini fioriti sulle rovine della caserma romana e forse solo ora non si narrerà più della Frola (Flora) che stava in mezzo a quei giardini. Qualunque ne sia la ragione, è bello che Trastevere abbia una strada chiamata Roma Libera. Tutto il mondo è pieno di sepolcri e dappertutto ci sono tombe con un angelo o un genio nell’atto di spegnere la face, simbolo della vita, capovolgendola contro terra, ma solo a Trastevere in una tomba così, fu scolpito: “Buona notte, mastro Jacopo”. Io sostengo che bisogna amare Trastevere anche per quel “buona notte”. Bisogna amare Trastevere per la sua festa. Anche oggi, nonostante gli orribili tubi fluorescenti e l’eccessivo sfarzo luminoso che abbaglia e nasconde gran parte del fascino locale, conserva lo spirito e il carattere di quando ornava strade e vicoli con cascate di catene e festoni di lanternini, gli uni e le altre di carta colorata. Bisogna amare Trastevere per lo zelo con cui la sua farmacia, la seconda di tutta Roma, si occupò di diffondere farmaci per sedare gli isterismi femminili. Bisogna amare Trastevere che fu sempre in prevalenza terra di lavoratori, tanto che S.Benedetto di lì portò via il suo “prega e lavora”. Bisogna amare Trastevere perché S. Francesco lo scelse per sua dimora e per quella del suo primo convento romano; tutti sappiamo quali erano i suoi criteri di scelta. Dobbiamo amarlo perché il Petrarca fu incoronato poeta da un trasteverino; perché sul Gianicolo trovò l’estremo rifugio il Tasso; perché qui Raffaello incontrò la gioia viva della sua vita. Capita di divagare così col pensiero, vagando per Trastevere; capita di pensare a queste e a tante altre cose perché la ricchezza del rione è inesauribile tanto che si possono anche incontrare frammenti di vita simili a pensieri. Può capitare, per esempio, di fermarsi in piazza S. Apollonia, dove s’ alza la facciata di S. Margherita e di pensare che è giusto che la piazza si chiami così, perché S. Margherita c’è e ognuno la vede, ma S. Apollonia non c’è più e vive solo nel ricordo di quel nome; non c’è più nemmeno il convento annesso alla chiesa dove si rifugiò la Fornarina dopo la sua avventura semidivina. E può capitare che riaffiori d’aver sentito dire che da quelle parti doveva esserci murata una lapide a ricordo di un abbraccio. Sì, l’abbraccio di Garibaldi con quella gente che aveva votato per lui allora che era vivo, come pare che continui a fare ora che è morto. Capita di guardare tutto intorno i muri della case per ritrovare la lapide e nel vedere solo una scrostatura 310 regolare sul rivestimento di un muro, di cadere subito nella colpa del giudizio temerario “l’hanno tolta!”. Capita di rivolgersi a un uomo che sta dritto sotto l’arco di una porta e di chiedergli: “Stava lì, è vero, la lapide dell’abbraccio di Garibaldi Garibaldi?” E di sentirsi rispondere che la lapide non sta fuori, ma dentro casa, che non ci è stata portata, che è stata sempre dentro, perché il comizio dove avvenne l’incontro tra Garibaldi e il suo Trastevere, fu in un teatrino che ora è un magazzino, che la lapide c’è tuttora, ma non si vede più perché tutte le pareti sono state scialbate. Capita di entrare col cortese informatore in un grande magazzino pieno di casse e di mastelletti di marmellata, di disturbare un gruppo di uomini che stanno evidentemente discutendo di affari, per farsi dire dove è la lapide, di guardare fisso nel punto indicato e di non vedere nulla, altro che del muro come tutto il resto; di salire allora su di una seggiola e di ritrovare con i polpastrelli delle dita, come nella lettura della scrittura Braille, le lettere dell’iscrizione. Capita che gli uomini attirati dal nome di Garibaldi interrompano il loro lavoro, si avvicinino e leggano correntemente in criptografia, come se vedessero le parole, rendendo quasi inutile la proposta avanzata e caldeggiata di togliere lo scialbo e di ridare l’inchiostro alle lettere incise, perché è vero che la lapide è nascosta dall’intonaco, ma è vero anche che quegli uomini la sapevano tutti a memoria. Inutile dire, inutile fare, lo spirito di Trastevere fu e resta naturaliter popularis, naturalmente repubblicano. 311 11 febbraio 1626 collocazione: Pg 111. Gli Etiopi che insieme con gli Ebrei furono i due soli popoli monoteisti dell’antichità, accettarono il Cristianesimo sin dai suoi primordi, ma la nuova fede non poteva rimanere pura e inalterata in una razza per la quale la superstizione fa parte della sua natura. Difatti Dioscoro, seguace di Eutiche, vi diffuse l’eresia monofisita che, mescolata a riti pagani propri del luogo. Costituì da allora a oggi la religione abissina,salvo una breve luminosa parentesi nel secolo XVII in cui il Negus Seltàn Sagàd volle riunirsi alla chiesa di Rum (Roma) “senza della quale non v’è luce”. Pochi anni avanti quando l’Etiopia era stata invasa dai Mussulmani, il Negus Claudios aveva chiesto aiuto ai Portoghesi giurando in compenso che tutto il paese, con lui a capo, sarebbe tornato alla fede cattolica. I Portoghesi risposero all’appello solo per riconquistare a Roma quel popolo imbevuto di errori. Ma dopo che il capitano Stefano da Gams coi suoi soldati lo ebbe liberato dall’invasione mussulmana, non volle più sapere del giuramento fatto e annunziò al Papa che non avrebbe ricevuto il Patriarca che Egli si preparava a inviare come suo legato. Iddio per castigo, dicevano allora i pochi fautori del cattolicesimo, aveva scatenato contro l’Abissinia i Galla. Il Negus Malàc Sagàd fu anch’egli fedifrago, mentre il figlio che gli succedette, il Negus Jacob, che si proponeva di mantenere fede al giuramento, fu esiliato, e per questo fu ucciso anche il suo successore. L’Impero era ridotto un caos di rovina quando la corona fu offerta a Seltàn Sagàd che si era ritirato in un convento dello Scioa. - Per voi, disse il Principe, è una necessità rompere i giuramenti fatti e uccidere i re, perciò lasciatemi in pace dove io sono. I messi giurarono chiamando su di loro, sui figli, sul popolo tutto le più orribili maledizioni se questa volta avessero mancato d’ubbidienza al sovrano che s’erano scelto. Seltàn Sagàd rispose: - Voi mi date un regno contro mia voglia, io l’accetto, ma sappiate che voi farete la mia volontà. E dopo aver ristabilito la pace interna si diede a studiare l’Haimanot-Abbau (il libro “della fede dei padri”) dal quale dedusse che solo riunendosi a Roma, l’Etiopia avrebbe ripreso il cammino della civiltà. Il Papa Urbano VIII rispose con paterna sollecitudine alla richiesta del Negus e inviò il Padre Mendez, gesuita, rivestito della dignità di Patriarca della chiesa Abissina perché ricevesse l’abiura degli errori, il giuramento di fedeltà e stipulasse con l’Imperatore un patto di amicizia. Lungo il disagevole viaggio il Legato con gli altri religiosi furono fatti segno a dimostrazioni fanatiche da parte della popolazione, ma gli onori culminarono nel ricevimento al palazzo del Negus. Il palazzo non era che tre grandi capanne circolari col tetto di paglia, internamente coperte di tappeti, prive quasi completamente di altre suppellettili. Il Negus aspettava il Patriarca nella zufan-biet o camera del trono o del letto che è la stessa cosa. Quando questi entrò rivestito dei sacri paramenti, l’Imperatore gli fece omaggio parlandogli “in due persone” vale a dire in plurale, com’era uso per persona di grande autorità. Il Negus per primo abiurò l’eresia e giurò fedeltà 312 alla chiesa di Roma, poi a uno a uno tutti i notabili che erano intervenuti in vestiti di gran gala, ripeterono il giuramento con la mano sul Vangelo che il Patriarca, seduto, teneva aperto sulle ginocchia. La ratifica di questo “concordato” fu quella che solamente poteva impressionare il popolo abissino: la minaccia di scomuniche, di anatemi contro chiunque avesse tentato di mancar fede al patto stabilito. Ma siccome laggiù pare più grave una maledizione detta insieme da diverse persone piuttosto che da una sola, il Mendez, in piedi, all’unisono con tutti gli altri preti del suo seguito proclamò la lunga serie delle maledizioni che avrebbe colpito i dissidenti. Però anche pronunziate in coro quelle minacce non fecero paura, perché morto Seltàn Sagàd, suo figlio stesso, uccisi i sacerdoti cattolici, ricondusse l’Abissinia agli antichi errori nei quali dura tuttora. Ma è forse vicino il giorno in cui si ridarà fede all’antico patto, l’Italia ne è garante. E una curiosa coincidenza pare confermarlo: quel giorno lontano del 1626, era l’11 febbraio! 313 Per favore! collocazione: Pg 114. Dopo i fatti di Roma e di Bologna, il più bravo gangster non potrà non riconoscere negli italiani i migliori allievi del mondo e ripeterà che, dopo tutto, il popolo italiano è veramente intelligente. Sì, signore, il popolo italiano è veramente intelligente: “America insegna”, si sente ripetere qua e là, tra la gente che commenta quel fatto inaudito. Perché se è vero che il più bravo gangster e seguaci, non sono tutta l’America, è ugualmente vero che quegli assassini di Roma e di Bologna, hanno nascita italiana e nome italiano, ma non sono allievi nostri. Non si vuol mica dire che da noi non ci siano assassini. Per carità! Di assassini ne abbiamo sempre avuti e tanti, ma erano assassini “made in Italy”. In genere qui si ammazzava per passione esasperata, per amore tradito, per vendetta familiare, per gelosia irragionevole, per follia irosa, per miseria inguaribile, qualche volta anche per rubare. Ma i nostri assassini occasionali, erano impulsivi; quelli premeditativi, con una scorta di sangue freddo presto esauribile. I delinquenti che hanno legato Roma e Bologna con due complicati nodi di assassini, sono nuovo per noi, nella realtà. Però quelle irruzioni in pieno giorno in locali aperti al pubblico, pistola in pugno e sciarpa tirata sul naso come nei giorni di tramontana; quelle colluttazioni selvagge; quelle fughe a piedi o in macchina; quello sfuggire agli agenti accoppandone almeno un paio; quel saltare su macchine di passaggio, da una all’altra; quell’abbattere il passante come chi per fretta gli darebbe una spinta; quella calma cinica davanti al cadavere di una vittima ed al pianto della madre di un’altra; tutti questi orrori, composti di fughe, di sparatorie, di rapidità, di gente falciata dal fuoco, di chiazze di sangue, di donne eleganti, bionde o brune, che appaiono e scompaiono tranquille ed equivoche, sono storie che noi vediamo sugli schermi da anni. Gli schermi sono nostri, ma le pellicole no. Ci vengono di fuori, forse ci sono anche imposte da una trafila di interessi e di pressioni il cui punto di avvio è lontano e ci sfugge. Ce ne sono venute tante di pellicole raccontanti questa storia che oramai ne siamo nauseati e ci basta vedere sui manifesti un campione di sparatoria, per girare al largo. E non da questi soli, ma anche da quelli di molte pellicole passionali nelle quali un lato del triangolo tradizionale è costituito dalla rivoltella: lui, lei, essa! La rivoltella è la diva che appare più spesso in quei manifesti, domina incontrastata in quelli di pellicole di avventure; tutti tipi di pellicole che ci vengono di fuori, ma che si proiettano sui nostri schermi. E anche tra il nostro popolo c’è una parte, che non ci fa certo onore, ma che si diletta di simili spettacoli. Che meraviglia se qualcuno, sviluppando il proprio temperamento ad una scuola, per lui anche divertente, riesca poi a rifare davvero ciò che gli attori hanno finto di fare davvero? L’italiano è un popolo intelligente, lo dicono tutti! E ora si vorrebbe fare una preghiera a quei paesi che ci mandano quelle pellicole: “Per favore, non mandatecele più”; “i nostri films e quelli di altri popoli sono più sani anche se più veri”. Vorremmo dire così, ma non lo diciamo perché tanto sarebbe inutile. Come sarebbe inutile se dicessimo: “Per favore, togliete 314 dalle porte delle nostre botteghe quei bolli rossi che richiamano la tristezza delle porte sigillate per sequestro; toglieteci quei paraventi colorati che ostruiscono tanti scorci delle nostre belle strade, toglieteci tutta quella esuberanza di sdolcinati manifesti che vorrebbero farci credere come un intruglio colorato sia capace di tutto, anche di vincere le corse”. Sarebbe inutile che le dicessimo, ormai la rete è così ampia che ritirarla sarebbe difficile. Però un favore vogliamo tentare di chiederlo: “Per cortesia, risparmiateci la diffusione che ci state promettendo, della vostra gloriosa storia, in fascicoli settimanali, sia pure sotto costo”. In democrazia anche i paesi coloniali hanno diritto di esprimere un loro desiderio, tanto più quelli che lo sono appena. E poi se l’esportare storia nel nostro paese è manifestazione di ignorante sicurezza di una parte, lo è pure di assurda acquiescenza da parte nostra. Perché se importare si deve, importiamo qualcosa che ci serva. Proprio di storia non sappiamo che farcene. Ce ne abbiamo tanta che, se fossimo anche noi bravi esportatori, potremmo riempire i mercati del mondo. 315 Il nome segreto collocazione: Pg 116. Chi è Roma, come si chiama, noi non lo sappiamo, né mai lo sapremo così come ignoreremo chi sia una persona che si tenesse ostinatamente la maschera sul volto. “Roma” è un nome-maschera, quello sovrapposto al vero, messo per essere visto, per essere detto e soprattutto per nascondere l’altro. Chi evocasse Roma lascerebbe in pace l’anima della Città perché il suo nome non è quello. Il nome, che per noi conserva solo un valore giuridico e burocratico, aveva un’importanza essenziale nell’epoca in cui nacque e fiorì la nostra città, la conserva ancora in alcuni luoghi della vecchissima civiltà orientale, è viva tuttora in certi settori dell’umanità con una civiltà ancora primitiva e naturale. Il nome era per noi allora, è per questi adesso un segno sacro, qualche cosa di così connesso con l’individuo che lo porta da esserne una sua parte integrante, una specie di altro se stesso, o addirittura la sua anima. Per questo tanto in Oriente come in America, presso alcune genti, si danno due nomi, uno segreto, l’altro palese, e gli sposi, se vogliono, dopo le nozze si rivelano a vicenda il loro vero nome. L’imposizione del nome era una delle più solenni tra le sacre cerimonie; il battesimo abbinando alla redenzione dell’anima l’imposizione del nome tramanda qualche cosa di quella cerimonia. Il nome è importante come la vita e se la vita cambia spesso cambia il nome. Così Saulo diventò Paolo,così chi entra in religione abbandona il vecchio nome accettandone uno nuovo,così in qualche antico sacerdozio l’individuo passava ad esso affogando nel mare il proprio nome. La potenza del verbo, quindi del nome, è al principio di tutte le cose divine ed umane. “La mia parola uscita dalla mia bocca non tornerà a me senza frutto” dice il Signore il cui verbo ha una potenza incontenibile. E l’uomo, sua pallidissima immagine, quando era, o si mantiene più vicino alle origini, avvertiva, o avverte la potenza del suo verbo. Una potenza ridotta, limitata, bisognosa di riti e di formule per sostenersi e difendersi; per lui il nome non ha solo un valore sacro, ma è l’anima delle cose, delle città, delle persone. Conoscere il nome di questa parte vitale, data la potenza che ha il verbo, è avere la possibilità di dominarla. Potente è il verbo, potente la voce, il verbo acquista la sua potenza convenientemente cantato. Chi conosce il nome segreto di un dio, di una città, di una persona e sappia declamarlo, evoca il corrispondente spirito, ne è quasi padrone. Di qui la necessità di tenere nascosto il vero nome affinché gli uomini o spiriti cattivi non ne approfittino; di qui la necessità di un nome falso che serva per la comune designazione. Come adesso imponendo il nome di un santo a un bambino intende metterlo sotto la sua protezione, così allora portare il nome di una divinità era stare sotto la sua tutela, quindi frequenti, specialmente per le città, il nome di un dio o di una dea. Il nome di una divinità è anche esso partecipe dell’essere stesso di Dio, sicché essi vengono invocati e portati scritti indosso come protezione contro nemici e disgrazie. 316 Anche per Roma fu dunque necessario tenere segreto il suo nome perché se i nemici fossero arrivati a conoscerlo ne avrebbero evocato la divinità protettrice conducendola in altro luogo; la città, priva di quella protezione, cadeva in arbitrio del nemico. Gli dei non erano né fedeli, né potentissimi, si lasciavano allettare e non potevano resistere alle evocazioni perfette nella forma e nel cerimoniale. Camillo vinse Vejo perché conobbe il nome segreto del nume tutelare, le promise un tempio più grande di quello che le aveva dedicato Vejo e la scongiurò di seguirlo a Roma. Quella volta non fu solo sensibile l’effetto dell’invocazione con l’indebolimento della resistenza e la caduta della città, ma ci fu anche la risposta esplicita della dea che affermò di volere migrare a Roma. Priva della sua anima Vejo s’afflosciò come un corpo morto. Il guaio era quando ignorando il nome bisognava per forza, per ragioni militari o politiche espugnare una città evocandone il nume di cui si ignorava anche il sesso. I pontefici custodivano le leggi che sancivano il rito col quale evocavano la divinità del luogo da espugnare e la segretezza del nome di Roma affinché nessun nemico potesse fare con essa ciò che essa faceva con gli altri. Essi soli e i capi dello stato conoscevano il nome di Roma che non è mai stato saputo dal popolo. Trasmettendosi il potere i capi dello stato se ne trasmettevano il segreto. Il pontefice solo ne pronunziava il nome sottovoce dinanzi all’altare del sacrificio in una cerimonia misteriosa a cui nessuno poteva assistere. In tutta la storia romana c’è un solo caso d’infrazione del segreto che poi non si sa neppure se fu tentato o compiuto: un tribuno della plebe, Valerio Sorano, pare che lo palesasse, ma la scontò duramente e certo è che se infrazione ci fu questa restò circoscritta, non superò i limiti dello spazio e del tempo. Naturalmente intorno al mistero fiorirono congetture e opinioni che nella loro varietà contribuirono a rendere più impenetrabile il segreto. Invano l’ara palatina al genio tutelare di Roma che sta là solitaria tra le rovine e le piante, porta scolpita ancora la sua invocazione “sia tu dio o dea”; e anche sullo scudo sacro era scritto “al genio della città di Roma sia maschio o femmina” il popolo doveva ignorare anche il sesso del suo nome. Difatti ci fu chi opinò per Giove e chi per la Luna, chi per Saturno e chi per Pale. Qualcuno credette che il nostro arcano fosse Bona per il mistero con cui si svolgeva il sacrificio di quella divinità. Lo accompagnava tutto un cerimoniale complicato svolto nella Regia della vestale massima che sacrificava accompagnata da donne immuni da recenti contatti che portavano in offerta fiori, primizie, piante e semi. Questo nome arcano, a cui sacrificava il sacerdote massimo e le invocazioni non erano fatte in piedi, ma piegati in modo da toccare il suolo di Roma. Qualcuno credette che Angerona, dea del silenzio, i cui simulacri avevano il dito sulla bocca e una fascia sulle labbra, fosse l’arcano nume tutelare; altri dissero che il suo era un culto espiatorio dopo la colpa di Valerio Sorano e una riaffermata volontà del segreto. Per il simbolo del risveglio primaverile, della fioritura feconda, si credette che Flora fosse il nome sacro di Roma. Per lo stesso simbolo della virtù creatrice anche Venere fu supposta nome e nume di Roma. Nello strano tempio binato che Adriano innalzò a Venere e a Roma, due templi le cui absidi opposte sono attaccate per la schiena come due fratelli siamesi, ma legati intorno da un porticato che ne faceva una cosa sola e dove gli incensi si bruciavano contemporaneamente sulle due are, si potrebbe vedere una manifestazione architettonica del nome segreto di Roma. Del resto Venere, prima di avere questo nome era invocata con 317 quello di Angerona, di Ope e nel culto segreto,con quello di Amor. E Amor potrebbe essere questo nome sacro e segreto. Dato che i preromani leggevano all’inverso, il nome volgare potrebbe derivare dalla stessa parola: Amor letto al rovescio dà Roma. A Pompei fu trovato questo grafito. Come la tomba di Romolo era nascosta e impenetrabile perché meglio se ne conservasse il carattere sacro, così nell’ombra di riti misteriosi veniva pronunciato il vero nome di Roma che noi non sapremo mai, che resterà sempre un mistero insolubile come quello del fascino di questa città. 318 Il rione di cui si parla oppure Trastevere misterioso Collocazione: Pg 120. Il Bambino e la Madonna tutti e due arrivarono a Roma per mare. Il Bambino più tardi e fu per naufragio; venne a Roma e salì il Campidoglio; ci sta tuttora prediletto dalla città su tutti gli altri bambini. La Madonna era arrivata un secolo e mezzo prima e più misteriosamente; galleggiando sul mare approdò a Ostia. Di dove? Nessuno lo seppe. Cosa certa era l’arrivo, cosa certa era che essa voleva arrivare a Roma e c’era arrivata. I marinai che la raccolsero, risalirono il fiume e la consegnarono al popolo di Trastevere che la predilige su tutte le altre Madonne. Madre e Figlio stanno quasi di fronte, una di qua uno di là dal fiume. La Madonna misteriosa nel rione più misterioso di Roma, il piccolo Re che domina i flutti, sul Campidoglio. Siano fatti veri o siano leggende, non importa; interessante è che questi due simulacri datici, metaforicamente o realmente, dal mare, uniscono con un ponte ideale le due opposte sponde. La Madonna marinara restò tra i trasteverini forse perché essi vivono su una strana terra di dune color d’oro e lei ci trovava un ricordo del suo mare. Ogni anno il popolo se la porta in processione per le sue strade, le fa e si fa festa per diversi giorni, e poi la riporta a casa, spegne pian piano le luminarie e ritorna quello che è:un popolo singolare vivente nel più suggestivo rione di Roma. Capire perché esso sia singolare e inconfondibile, è difficile, forse impossibile. Si pensa agli Etruschi che nel Trastevere furono forti, che di lì alzarono orgogliosi la fronte contro l’altra sponda. Qualcosa del loro carattere e dei loro lineamenti certo sussiste nel popolo trasteverino, ma su quei lineamenti si ritrova anche tutta l’antica statuaria romana, benché non sia raro di incontrare un volto dalle linee classiche complicate col sorriso dell’Apollo di Veio. Certo che il popolo trasteverino fu sempre una comunità distinta; distinta anche nel suo carattere romano che in lui ebbe il risalto della scultura. Roma antica aveva due limiti cittadini: le Mura e il Pomerio. Quelle, costituite da massicciate e torrioni, erano una barriera strategica; questo, segnato solo da cippi tanto distanziati da conservarne il suo carattere simbolico,era un limite religioso, solo per dare un carattere sacro alle case degli uomini; al di qua del Pomerio i templi, i tribunali, le case, la gente, al di là gli accampamenti militari e i sepolcri. I trasteverini agli inizi furono gente raccolta al di là e in mezzo a loro potevano sorgere i sepolcri. Quel monumento funebre ricostruito dentro le Terme di Diocleziano, era qui, accanto al fiume, perché il Pomerio non aveva incluso nel limite sacro quella terra di plebei e di Ebrei che esercitavano insieme i mestieri meno graditi. Lì c’erano i conciatori, i vasai, i pescivendoli, i barcaioli, gli scaricatori di porto, i lanaioli, i molinari, gli intercettatori di roba usata e di stracci, gli antichi capostipiti dei “robivecchi”. Ebrei e lavoratori erano un popolo vivente in povertà dentro a casupole speso di legno, prive di quel conforto igienico che il popolo al di qua del Tevere cominciava ad avere. E privo continuò ad esserlo anche quando alcune famiglie patrizie presero a frequentare i loro “prata” trasteverini; anche quando Cesare vi creò i suoi famosi giardini, 319 attenuandosi solo un poco quando ville patrizie ed imperiali si distesero lungo i fianchi delle alture trasteverine; però, per il dilagare delle ville, la povera gente si ammassò sempre di più in confini sempre più limitati. E’ vero che Cesare iniziò quel vezzo dei dittatori di regalare al popolo una parte di quella terra di cui prima si sono appropriati e “donò” (non usano mai il verbo restituire) al popolo romano i suoi giardini. I trasteverini però restarono agglomerati nel loro poco spazio; tanto poco che non ce ne era per dedicare templi alle diverse famiglie degli dei; può darsi però che neppure nell’anima degli abitanti ci fosse posto per quella roba. In Trastevere sorsero solo due templi: quello della Forte Fortuna e la Sinagoga. Questa, ripetendo il disegno del Tempio di Gerusalemme, parve, in seguito, il fantasma di un assassinato alle porte del suo uccisore. Per gli Ebrei dalla difficile vita, quel tempio era una necessità come per i trasteverini romani lo era quello della Forte Fortuna, l’unica divinità romana che avesse passato ponte per ché un re plebeo gliene eresse il tempio, giacché sapeva che i poveri si affidano spesso al caso e lo pregano o lo scongiurano a seconda del genere delle loro fedi. Per la ricorrenza annuale della Fors Fortuna che cadeva il 24 giugno, si faceva quella gazzarra notturna fatta di libagioni e di fracasso, ingentilita dai garofani e dalle erbe odorose, che poi si trasferì a S. Giovanni, essendo divenuto lui il titolare della vecchia festa. Però in difetto di templi quasi tutti gli antichi vicoli avevano il nome di altrettante edicole dedicate a divinità che non erano tuttavia quelle classiche dell’altra sponda e, più che divinità, erano idee religiose adatte per la vita dura. Nella Repubblica il Transtiberim, sorto come quartiere popolare, era escluso dalla pianta ufficiale della città come ora ne sono esclusi i mucchi di baracche. Con Augusto fu ufficialmente adottato quale parte della città. Ma oramai i diversi “prata” delle famiglie patrizie erano diventati ville e stringevano in spazi sempre più angusti le case dei poveri che col numero eccessivo di insule e di vici denunziava la loro strettezza. Ed è curioso che dall’antichità ad oggi lo spazio dei ricchi e quello dei poveri non si sia confuso; in genere dove ora sono le ville principesche, erano quelle patrizie, dove sono le case dei lavoratori, erano le insule dei lavoratori. La Farnesina sta sopra alla villa della bellissima Clodia, l’amante certa dell’acqua, fluviale o marina che fosse, la quasi sicura amante di Catullo. Villa grandiosa come le terme, ricca come i musei. Una parte delle sue pitture e dei suoi stucchi sono al museo delle Terme, ognuno può ammirarne la bellezza. La distribuzione edilizia è presso a poco quello che era; là giardini e ville freschi e riposanti, qui, povere case, officine, agglomerato di gente che suda. Nelle incursioni barbariche il Trastevere fu di nuovo abbandonato a se stesso, ma la povera gente che ci viveva continuò a viverci. Le ville invece rovinarono, i giardini diventarono orti e nel corso dei secoli colonne, capitelli, fregi, statue ritornarono alla luce come avveniva e avviene in ogni pezzo di terra dove sorse la Roma degli antichi. Le statue emigrarono un po’ dappertutto e una Venere che per il suo ardimento meriterebbe di’essere chiamata “trasteverina”, arrivò in Russia dove sta tuttora aspettando qualche cosa. Forse la continuazione di quella unità di cui essa conobbe appena il principio? Chissà? Quel che è certo è che le statue romane sono abituate all’attesa paziente e alla resurrezione. Mentre il Medio Evo si svolgeva nei suoi secoli e nelle sue lotte, il popolo trasteverino si tramandava 320 imperturbabile quei suoi caratteri che lo rendono augusto senza l’ausilio di paludamenti. Eppure siccome era operaio e operaio di mestieri bassi, fu escluso dalle alte cariche. Nessun trasteverino poté mai essere Senatore. E proprio il Medio Evo trovò in quei popolani tenuti in disparte i difensori di tutte le giustizie e di tutte le libertà. Tali restarono nei secoli a costo di essere quasi sempre la spina dei governi, perché nelle loro strade si tumultuava, nelle loro case si congiurava e si moriva. Sì, c’è del mistero nel carattere di questo popolo che passava ponte solo per necessità, che era orgoglioso se poteva dire di non averlo passato mai, che amava il suo rione con attaccamento feroce separandosi quasi dal resto del mondo, così come ora, nonostante l’indebolimento di quei caratteri, ne resta ancora singolarmente distinto. C’è del mistero in questa terra color d’oro, anche in tutte le sue leggende che non sono mai assurde. Una polla d’olio sarebbe scaturita dove poi sorgerà la prima chiesa dedicata a Maria, segno dell’avvento vicinissimo di Colui che avrebbe salutato gli uomini dando loro la pace. Corse il rivolo d’olio fino al Tevere, con lui arrivò al mare, col mare toccò tutte le terre. Forse non fu un olio dolce e vellutato come quello spremuto dall’olivo, ma un olio minerale perché diverse volte in diversi tempi, si constatò dalle parti di Trastevere la presenza del petrolio, ma questo no ha importanza, anzi proprio per questo la leggenda ha più sapore di verità; l’importante è che essa sia basata su una realtà e la realtà sia rivestita di significati spirituale. Il Trastevere non ha bisogno dell’assurdo per donare la sua fede. Se accoglierà una delle tante pietre venerabili, quella dove si erano inginocchiati gli angioli durante la morte di San Pietro, sarà una pietra senza alcuna impronta speciale, giacché è logico che gli angioli, anche se vi si piegarono lo fecero con più leggerezza dell’aria. A Trastevere balugina il mistero anche in certe sue indeterminate promesse spesso chiuse in un nome come in quello della luce, come in quello del luogo più tetro del rione, le carceri. Nell’antichità questa terra, invasa spesso dalle acque del fiume, era piuttosto malsana, perciò fu scelta per raccoglierci i prigionieri di guerra; ma fu un periodo relativamente breve. Poi per un millennio e mezzo, Trastevere non ospitò più gente coartata, ma gente libera nella sua povertà. I moderni riportarono i carcerati a Trastevere. Ma il reclusorio sorse sul posto di uno strano convento le cui suore ogni quattro ore sonavano a festa per annunziare che scendevano in chiesa a cantare l’antifona della letizia: “Regiona coeli laetare, alleluia” invece di richiamare ogni tanto il pensiero al peccato o alla morte, esse lo richiamavano alla letizia. Gli abitanti del rione avevano la giornata punteggiata da quell’allelujare e luogo, chiesa, convento, suore, era tutto chiamato “Regina coeli”. Scomparsi convento, chiesa, suore, resta un nome promettente o ricordante letizia. S. Benedetto dovette sentire l’attrattiva di questo rione, perché venne a trovare qui, in Piscinula, in una vecchia casa della sua gente il raccoglimento necessario per prepararsi alla sua grande vocazione e dalla terra dei lavoratori portò via una metà del suo programma: ora et labora. Come non è senza significato che S. Francesco, quando dovette chiedere un posto dove fermarsi a Roma, scelse Trastevere. Poteva chiederlo vicino a S. Pietro, cittadella di conventi, o vicino al Laterano, la chiesa 321 madre che proprio a lui Dio aveva rivelata cadente perché la restaurasse col suo amore, ma egli scelse Trastevere. Il mondo ha sempre guardato con simpatia o con timore a questo forte e leale rione che nell’evolversi della storia ha costantemente preceduto, mai seguito, come se il suo spirito avvertisse la realtà avanti al suo essere, come fece la polla d’olio che scaturì prima della nascita di Gesù. Per annunziarla perché era sicura, come fece la Madonna che precedette il Bambino, come fecero le monache di “Regina Coeli” che cantarono all’infinito quel “laetare” che tutto il mondo brama di poter presto ripetere in un necessario avvento di giustizia e di pace, perché proprio non ne può più! 322 Roma, non altro collocazione: Pg 122. Politica o religione, quella che ci rimette sempre è Roma, non quale entità amministrativa e presidenziale della Nazione, ma ROMA come entità a sé stante: le sue case, i suoi monumenti, le sue strade, i suoi alberi, la sua luce, la sua anima. Se non fosse per lei non si oserebbe neppure accennare all’Anno Santo. L’anno Santo è un “globo” tutto sfaccettato, può essere guardato da ogni punto di vista universale e nelle sue infinite facce presenta di tutto: religione e commercio, devozione e truffa, celeste e terrestre, angelico e demoniaco. L’Anno Santo di decisamente smorto ha questo nome che non era il suo. Il suo nome era Giubileo. Sette volte sette anni fanno 49, il cinquantesimo è il Giubileo, la remissione. Questo era nella legge ebraica. Giubileo è giubilo, nel giubilo è pace e allegria. Anche questa remissione, cambiandone la sostanza, il cristianesimo prese dagli ebrei. C’era un’espressione nella liturgia romana, tutt’altro che caritatevole verso di loro, fu cancellata adesso, da papa Giovanni. Perché dagli ebrei la chiesa prese, trasformando, svuotando o riempiendo a seconda del suo disegno, tutto quello che è religioso, da Cristo allo zucchetto, ma tenendoli lontani. Se per un caso assurdo dovesse scomparire dal mondo ogni monumento che testimoni il sorgere della Chiesa, basterebbe che restasse S. Sabina. Tutto cancellò dell’antico splendore musivo la controriforma, ma una parete è rimasta, la più breve, quella sopra la porta d’ingresso: è una fascia azzurra illuminata dalla luce selenitica delle impannate, dove corrono Tra le tante sfaccettature dei romano la forma delle sue chiese, l’espansionismo, la forma governativa, la pompa. Nel Giubileo questa doppia origine è più mescolata e più distinta nello stesso tempo. Proprio per questa sua origine, niente che non sia rispetto e simpatia per la Chiesa, in particolare per una cosa tanto suggestiva come lo è un Giubileo. La storia è punteggiata da giubilei, ma anche da giubilei rientrati, o indetti senza chiasso, sottovoce, se le circostanze lo richiedevano. Proprio un secolo fa Pio IX, data la recente annessione di Roma all’Italia e il turbamento che n’era derivato, concesse l’indulgenza senza manifestazioni esteriori, neppure l’apertura della Porta Santa; in certe condizioni pare opportuno fare così. Tanto più ora che con i mezzi moderni di trasporto è rovesciata la posizione del questuante l’indulgenza. Era la lunga, lunga fatica della strada che portava alla remissione dei peccati: Quella fatica per arrivare ora è cambiata in divertimento, un bel volo con le inerenti leccornie, comodi sonnellini, belle visuali, tante caramelle offerte da eleganti ostesse e siamo arrivati pellegrini a Roma. I “vaga mundi” di allora sono i volatori celesti di oggi. Tra le tante sfaccettature dei Giubilei ci fu anche quella che l’indulgenza non costasse fatica penitenziale, ma denaro. Però non fu solo l’appalto delle indulgenze che irritò Lutero, ci fu anche un subcosciente antiroma; era il barbaro vinto che prendeva la rivincita perché Roma proseguiva, spiritualizzandolo l’impero. La sfaccettatura nera che vide il tedesco è sopraffatta da miriadi di sfaccettature luminose. Però oggi, dato che il pellegrino non c’è più, anche la forma poteva adeguarsi alla sua assenza. 323 Bella subito, profetica poi, apparve l’innovazione di Paolo VI: ogni paese del mondo può lucrare l’indulgenza giubilare nell’anno precedente a quello santo, nella propria terra, senza venire a scombussolare questa povera città già tanto scombussolata. Scoppiò il petrolio. Quale occasione migliore per aggiungere “Amici, l’Anno Santo l’avete avuto in casa in anticipo ed abbondante anche, per voi basta così, risparmiamo il petrolio; il giubilare 1975 lasciamolo lucrare agli italiani che molta devozione non hanno e soldi anche meno. Di tempo per smacchiarvi l’anima con poca fatica e poca spesa ne avete avuto e chi non l’avesse fatto, può farlo ancora”. Invece arriveranno a Roma, alla città più che santa, avvilita. Tutto per l’Anno Santo, niente per lei. Pulluleranno centri d’informazione per i venienti. A noi per un certificato di morte ci mandano da un ufficio all’altro. Le Poste si organizzano per i turisti – pellegrini che non dovranno neppure faticare a cercare un ufficio postale, gireranno autobussetti per raccogliere lettere e cartoline. Le nostre vanno al macero e da anni la vita economica e affettiva è disturbata da questo disservizio. Ci saranno per loro mostre d’arte, gastronomiche e enologiche, spettacoli vari, opere musicali; la musica può disporre alla preghiera, ma quelli non musicali dove sgattaiolare è facile; un giubileo facile e divertente. Previdenze sanitarie che noi invochiamo da anni, in parte saranno attuate per l’Anno Santo. Si suggerisce di cominciare a ispezionare i nostri servizi igienici. Chi ispezionerà la gente in arrivo che può portarci infezioni più seriamente delle cozze di Napoli? Roma, lo vediamo, tiene sparsi per le strade gran parte dei suoi rifiuti, che sarà quando si aggiungeranno quelli di altri milioni di gente? A meno che, per acquistare l’indulgenza, gli uffici preposti alla “nettezza” urbana non decidano di funzionare e di far funzionare. Ai turisti – pellegrini consegneranno un opuscolo con le istruzioni per difendersi dalle malattie più comuni in Italia. Ne daranno uno a noi per difenderci dalle loro o ci indicheranno le cozze di Bari? Verranno anche i malati, come a Lourdes, consoliamoci. I giardini liberamente abbandonati e liberamente devastati, dovrebbero essere riassettati. Riguardo a Roma quella splendida fusione di arte arborea ed edilizia, può essere distrutta, ma, per carità, che non lo vedano i turisti – pellegrini. Il Turismo è sempre pacchiano perché servile, ed ecco che ci dicono anche “Mettetevi il vestito della festa, non quello di tutti i giorni, vengono i penitenti”. Spariscono prati, chiamiamoli praticelli (per chi non ha la lira il soldo è bono), per stenderci il tappeto d’asfalto necessario per le ruote gommate. Si costruisce dove era proibito, in forma provvisoria, dicono, per l’Anno Santo: che cosa è il provvisorio e quanto sia benedetto, ognuno lo sa. Si sventra, si sopraeleva, atei e religiosi allargano, modificano, sempre in vista dell’Anno Santo e Roma, un pezzetto alla volta sta finendo di andarsene. Cominciò a finire quando non fu più Roma, ma Capitale; da 105 anni la stanno distruggendo e l’Anno Santo le darà la sua scoppola; solo per questo duole. Il linguaggio vaticano è un velluto sempre soffice, anche le cose dure le dice con tono armonioso; a me piace, tempera la durezza della nostra società: Ma “le perplessità”, le “inquietudini” che esprime per l’occasione, tratte fuori dall’armonia, sono pretese logistiche belle e buone. Per difendere Roma dovrebbe ripetersi la Resistenza, una resistenza alle pretese dell’Anno Santo e 324 all’interessata collaborazione dei veri lucratori. Proprio un anno fa, c’era stato lo scoppio del petrolio. L’8 dicembre il Papa si recò, come sua consuetudine, a Piazza di Spagna per rendere omaggio alla Madonna. Per quello scoppio bisognava ridurre il consumo del petrolio; poco male per il settore automobilistico, tanta purificazione per l’aria e tanta salute per le gambe che sono le colonne della nostra vita. Anche il Papa entrò nel giro, lasciò in Vaticano la sua automobile e se ne andò con una carrozzella pubblica: leggermente teatrale poteva apparire la cosa, ma invece era un discorso ed ognuno l’intese come se lui l’avesse fatto a parole: “Il vostro vescovo è unito a voi, dividerà con voi rinunzie e sacrifici, come vi adattate voi, si adatterà lui”. L’applauso fu scrosciante. Ma ora come si fa a cacciare via il pensiero che poteva andare a Piazza di Spagna in automobile e risparmiare alla sua diocesi l’inquinamento di migliaia di autobus e quello di un improvviso aumento di viventi che espurgano peggio dei motori? L’inquinamento che ne deriverà velerà anche quella carrozzella di un anno fa e il dono, supremamente paterno che essa ci gettò. 325 Dal presepio al mondo collocazione: Pg 124. Quando Roma era solo dei romani che vi abitavano e del mondo intero che vi passava, voglio dire prima che, per sua disgrazia, accoppiasse al connaturale significato universale, quello stremato, nazionale, chi, in questi giorni, girava per le sue strade e per i suoi vicoli, ogni tanto vedeva una porta su cui era stata appesa una grossa corona di mortella. A Roma tutto è continuità, e i costumi, le usanze, le procedure rituali, conservano un segno, una formula, un gesto, che riallaccia, per similitudine e per trasposizione, il mondo cristiano e quello pagano. Appendere alla porta una ghirlanda di mirto,era l’uso antico nelle feste floreali, quando tutto doveva essere fiorito e inghirlandato: teste, vestiti, pozzi, archi, templi, case e porte di case, perché la festa di Flora coincideva col risveglio della natura. Ma la corona di mortella di cui noi si dice, pur essendo atavico ricordo di festa pagana, pur restando espressione di risveglio,anzi di risveglio assoluto quale è la Nascita, stava però a significare una cosa che non aveva nessun addentellato col paganesimo. La corona aveva assunto un linguaggio simbolico nuovo; diceva un invito nuovo: “Venite, adoremus!” E il passante poteva spingere la porta su cui era appesa la ghirlanda di mirto, entrare e dirigersi liberamente dove quel simbolo esposto sulla strada, chiamava. E lì trovava il presepio. La ghirlanda pagana serviva a un mistero nuovo,perché il presepio, nella celebrazione della povertà,non ricorda che Cristo. Il presepio è la festa di Natale, e questa festa è romana come è romano chi ci nasce, anche se poi gira per tutta la terra. Più esattamente ancora, essa è monticiana, perché nacque sull’Esquilino; il presepio sorse lassù, perché lassù era arrivata la mangiatoia ceduta dalle bestie al loro Creatore. Di lassù partì il presepio per il mondo e rifiorì, quasi nascendo, in diversi punti. Poi, a un tratto, come pellegrino che torna a casa, ritornò a Roma il presepio che s’era fermato qua e là per le borgate della terra, e tutta la città fu piena di presepi. In tutte le case ce n’era uno, o piccolo come il piano del comodino su cui trovava posto e trono, o grande come la tavola più larga della casa, su cui si stendeva da padrone nel tempo che correva dalla fine dell’Avvento alla Manifestazione. Presepi di famiglia intorno ai quali si radunavano a sera,quelli di casa e i parenti e gli amici che vi si trovavano in visita. Erano passati oltre mille anni che sulle porte delle case di Roma non si appendevano più corone di mortella, quando queste riapparvero qua e là. Dove c’era la ghirlanda verde, c’era un presepio che aveva delle ambizioni, che sapeva d’essere degno di essere visitato. Dove c’era la ghirlanda verde, c’era una famiglia che ripeteva il gesto dei primi cristiani, aprendo le loro case, trasformate in oratori, a tutti i fratelli. “Entrate”, diceva la corona i mortella, “qui c’è un presepio”. E il presepio che s’annunziava a quel modo, era sempre veramente eccezionale. Poteva avere le figure modellate da grandi artisti, e scoprire visuali inaspettate. Perché il presepio, a Roma, dove tutto si 326 allarga o si innalza,fu visto anche dall’alto di un tempio pagano diruto che serviva da podio, come se dall’alto di Gerusalemme si avesse sottocchio, in miniatura fedele, tutta la Palestina; il presepio fu visto sulle terrazze dei palazzi, dove la luce naturale e il cielo vero, erano complementi necessari della sacra rappresentazione. Roma sollevò la grotta verso il cielo e molte delle sue torri la mostrarono come fiaccola sul candelabro. Le case che permettevano a tutti la visita del proprio presepio, usavano anche impegnare in quei giorni, i pifferari che dal principio dell’Avvento cominciavano a scendere a Roma per costellarla di ninne – nanne e di pastorali. Intono al presepio i pifferari, pastori veri, modulavano le loro nenie, fondendo in un senso di dolcezza che ci è stato rubato, l’odore amarognolo del vellutello, la voce acerba dei bimbi che recitavano il sermone,la gloria luminosa degli angioli che stendevano il loro messaggio di pace. Cominciò, alla fine del 187°, la nuova regia polizia, a proibire ai pifferari di suonare per le strade, appena due mesi dopo il suo insediamento nella nostra città, proseguirono poi tante e svariate vicende che, lentamente, contribuirono a uccidere le nostre belle usanze. Ora, anche se qualche famiglia continua la dolce tradizione del presepio, le case però sono invase dagli alberi di Natale. L’albero non è romano, è germanico ed è nato come simbolo del Natale quando il presepio nostro aveva già diversi secoli di vita. L’albero che lassù si riallaccia ad antichi riti campestri, a Roma, non può ricordare altro che il legno con cui si farà la croce. Mentre il presepio, che ha al centro il mistero della nascita e intorno tutta la nostra povera, semplice, gaia e dolorosa vita, mescolata alla vita di tutte le creature, a quella dei polli, delle pecore, dei maiali, dei gatti, degli uccelli, dell’acqua, della vegetazione, degli angeli, degli astri, il presepio nostro, è lieto ed universale. In esso è raccolto tutto ciò che è vita e che alla vita serve; esso è vita all’aperto riscaldata dall’azione e dalla comunione, convergente nell’unità del Mistero. L’albero, con i ghiaccioli e il vento tra i rami, è freddo. Nell’albero c’è la solitudine della notte ghiacciata, non c’è la vita. L’albero è espressione singola del fantastico, il presepio è espressione collettiva di vita. All’albero si possono anche appendere come doni ai piccini, rivoltelle e sciabole, soldatini e cannoncini, a un presepio ciò non sarebbe mai possibile. L’albero è qualcosa che non si pronunzia, né per la pace, né per la guerra, il presepio è il più antico partigiano della Pace. In Trastevere, quello che era in cima della torre del palazzotto degli Anguillara, che aveva per suo cielo quello creato da Dio, per suo orizzonte, il cerchio dell’orizzonte naturale, quel presepio trasteverino, libero a tutti, anche ai ribelli di allora, che poi nella storia si chiamarono patrioti, quel presepio trasteverino, faceva vera e propria professione di pace. Con una lapide parlava al popolo invitandolo a salire lassù e gli diceva che quella torre, già fortezza di guerra e carcere di schiavitù, che impauriva di lontano il pellegrino, quella torre ora chiamava la gente di ogni paese perché entrasse lieta, dato che essa era diventata una culla del nascente Dio della Pace. Così diceva quel presepio che stava alto sulla torre, come alto, al disopra della torre campanaria è il simbolo di Trastevere dove oramai s’è raccolta Roma. Non è il suo stemma rionale, è un a campana ribelle che non ha sofferto il carcere della torre, e ne è scappata fuori, mostrandosi tutta qual è a tutte le luci del giorno e della notte; che sta lassù per guardare Roma e il mondo. La campana ribelle s’alza sul luogo dove scaturì la fonte 327 dell’alio il giorno della nascita di Cristo per confermare, col segno della pace, il suo messaggio di pace. Se si chiamerà a raccolta per la pace, qui a Roma, certo sarà prima a farlo quella campana di Trastevere. Ma sarebbe ancora più bello che si tornasse a rivedere le corone di mortella appese sulle porte delle case che nella pace si riaprono. Bisogna intrecciare una ghirlanda di mirto che abbracci il mondo e lo leghi con un nastro parlante come quello che tengono sospeso gli angeli nel mezzo dei presepi: “Pax in coelo – Pax in terra - Pax in omni populo!”. 328 Il mondo sottoterra collocazione: Pg 125. Il quartiere dei Parioli, uno dei più moderni, che passa per aristocratico per la gente ricca che l’abita, è uno dei più antipatici di tutta Roma. Un quartiere che potrebbe appartenere a qualsiasi città privo com’è di ogni carattere romano. Non ha neppure un rudero, neppure una colonna antica, neppure una facciata barocca, neppure il colore di Roma perché quassù le case sono di tutte le tinte esclusa quella tipica della città. Per ritrovare Roma in questo quartiere bisogna sforzarsi a pensare che una di queste strade banali, segue il tracciato della Salaria Vetus, ma è troppo poco; i vecchi poligoni di basalto, se ancora esistono, sono giù, sotto all’asfalto e da una cosa tanto profondamente sepolta, il ricordo non affiora a commuovere. Eppure è un’idea sbagliata che qui possa esserci un quartiere dove la Roma del passato sia assente. Pochi giorni fa passando per una di quelle strade dove le ville son più grandi e più folto il verde, dove i massicci cancelli stanno sempre chiusi, vidi gente silenziosa che infilava uno di quei cancelli semiaperto, si inoltrava per un viale, prendeva a sinistra un sentiero bordato di limoni che scendeva lentamente, voltava, scompariva. Non poteva certo andare tutta dai signori della villa anche perché quella gente era popolo. Voglio dire che c’erano giovani e vecchi, poveri e ricchi, operai e preti, gente che veniva da tutte le classi, da tutte le condizioni, da tutte le età. Sfilava silenziosa, rapida, sicura, entrava, procedeva, voltava, scompariva. Passai anch’io il cancello, percorsi il viale di mimose, scesi per il sentiero di limoni, voltai e mi ritrovai in un piazzale con una fontana nel mezzo, prospiciente la villa che dal di fuori non si immaginava così grande. Intorno a un tavolo di ferro c’erano delle seggiole a sdraio che erano state piegate e raccolte, vigilate tuttavia da un domestico. Ma quella gente non guardava intorno, andava dritta verso una porticina quasi nascosta nel fianco della villa, la varcava, ne era inghiottita. “Catacombe”, dissi tra me. Ed era curioso che la gente di oggi, avviata alle catacombe, avesse quell’andatura furtiva, rapida, silenziosa, come quella che attribuiamo ai primi cristiani quando nascostamente si riunivano laggiù dove seppellivano i loro martiri. Varcai la soglia della piccola porta ed ecco subito l’umido e il buio catacombale. Una scala a chiocciola s’inabissava sotto terra, i gradini corrosi mostravano grafiti e lettere; sui muri, rischiarati da candele, epigrafi tronche, pezzi di marmo coi noti segni cemeteriali. E la scala scendeva quanto non avrei supposto, pareva di dover arrivare al centro della terra. Un lontano canto corale cominciò a sentirsi, si avvicinò, il chiarore di candele non viste rischiarò le tenebre, un Kyrie poderoso esplose al termine della scaletta, ed io mi trovai in una ampia altissima basilica sotterranea. Un vescovo, dei celebranti, dei sacerdoti addetti al servizio, un gruppo di chierici cantori. Tutti indossavano i paramenti all’antica, morbidi, fluttuanti, cadenti, raccolti in ampie pieghe. Il calice, la pisside, il turibolo uguali a quelli che si usavano nei primi secoli. Il sacerdote che dirigeva il coro voltava le spalle, ma le mani che si alzavano e abbassavano, spiccavano brune dal bianco della cotta. Nel gruppo dei cantori erano 329 rappresentate tutte le razze. Un piccolissimo cinese dalla voce così limpida che quando si elevava sola dava più sensazione di luce che di suono. Un giovanissimo negro dal ciuffo crespo sulla fronte sprigionava una voce così cupa che pareva fosse il riflesso sonoro del suo colore. Due giapponesi con gli immancabili occhiali, un indiano alto e potente, un rhodesiano, due o tre sudanesi, tutta l’Africa, tutta l’Asia erano rappresentate in quel complesso corale, nonché l’Europa e l’America. Il celebrante era australiano, il diacono malese. Quando, leggendo il vangelo disse le parole: “Amen, amen, dico vobis” sentii quanto era bello questo ritorno di verità. La chiesa di Roma è andata per il mondo annunziando a tutti “In verità, in verità vi dico”, ed ecco che dalle più lontane regioni del mondo delle creature che hanno appresa da noi la buona novella, vengono e ce la ripetono, così come fanno i fratelli quando sono buoni, che fra di loro si ripetono i racconti che hanno imparato dai grandi. Un sacerdote nero come l’ebano fasciato da un ampio drappo di seta bianca, reggeva la mitria del vescovo. Coreografia, se volete, ma oltre a questa c’è un simbolo, oltre a questo c’è una sostanza, il mondo intero affratellato in un’idea che è partita da Roma, il mondo intero che nel rivolgersi a Dio prega e canta nella lingua di Roma. Quella folla che avevo visto sfilare silenziosa stava lì, ammassata, in piedi, raccolta, tuffata in una penombra satura di incenso. Un sacerdote italiano parlava Balilla, la dama romana che aveva ceduto il terreno ai compagni di fede per seppellirvi i loro morti, di Proto e di Giacinto di cui non si sa altro che erano giovani e morirono per la loro fede. Alla fine della funzione per gli stretti e bassi ambulacri partenti dall’altra basilica sotterranea sul terreno umido cosparse di foglie di lauro, mi avviai alla tomba dei due martiri. Di qua e di là gallerie non ancora esplorate. In una piccola cripta, sotto un rustico arcsolio, in mezzo a foglie di palma, la tomba con due parole sole: “Yacinthus Martyr”. Un sacerdote etiope in un italiano stentato ma comprensibile, raccontava il ritrovamento della tomba giusto cento anni fa. La gente si faceva sempre più rara, quella che s’attardava era interessata alle epigrafi e agli scavi. Un gruppo di preti neri come la loro veste stava lì e rispondeva alle domande. Mi parve proprio che parlassero italiano. Sì. Una donna chiese: - Proto e Giacinto erano fratelli? Un sacerdote nero, quello dal gran ciuffo sulla fronte, sorrise e rispose: - Fratelli?...Nel martirio, sì! 330 La Via Il mondo sottoterra collocazione: Pg 143. Capita solo a Roma d’incontrare sotto terra una rappresentanza del mondo universo. Me ne andavo per i “Parioli”, il più insignificante dei quartieri che passa per aristocratico perché lo abita molta gente ricca. Privo d’ogni carattere romano, potrebbe appartenere a qualsiasi città. Non si vede un rudero, una colonna antica, una facciata barocca, neppure il colore di Roma perché lassù le case sono di tutte le tinte esclusa quella romana. Per sentire Roma in questo quartiere bisogna pensare che forse una di queste vie comuni,segue il tracciato della Salaria Vetus, ma è troppo poco. I poligoni di basalto, se ancora esistono, sono giù, sotto l’asfalto e da una cosa tanto profondamente sepolta, il ricordo non affiora a commuovere. Pensavo così mentre andavo per una di quelle strade che hanno ville più grandi immerse tra alberi più folti, protette da cancelli più alti sempre chiusi. Ma uno, in fondo alla via, era socchiuso; me ne accorsi per la gente che vi spariva; una fila interrotta ogni tanto e subito ripresa. Quella gente non poteva andare tutta dai signori della villa perché era popolo, voglio dire che c’era di tutto: poveri e ricchi, operai e preti, giovani e vecchi, gente che veniva da tutte le classi, da tutte le condizioni, da tutte le età. Sfilava silenziosa, sicura, entrava, procedeva, voltava, scompariva. Aveva un’andatura furtiva, rapida come quella che dovette avere la cristianità delle persecuzioni quando nascostamente si riuniva dove seppellire i suoi martiri. Passai anche io il cancello,percorsi un viale di mimose, scesi per un sentiero di limoni, voltai e mi trovai in un piazzale con una fontana nel mezzo sul davanti della villa che dal di fuori non si immaginava così grande. Intorno a un tavolo di ferro erano state piegate e raccolte delle seggiole a sdraio. Un domestico vigilava girando largo. Ma quella gente non guardava intorno, andava diritta verso una porticina nascosta nella sporgenza di un fianco della villa, la varcava, ne era inghiottita. La seguii senza chiedere nulla. Ed ecco, subito dopo la porticina, l’umido e il buio catacombale. Una scala a chiocciola s’inabissava sotto terra, i gradini di pietra rotta e corrosa, mostravano grafiti e lettere; sui muri, rischiarati da candele, parte tinti nel colore caldo di Roma, parte in tufo scoperto, epigrafi tronche, pezzi di marmo coi noti segni cemeteriali. La scala scendeva quanto non avrei supposto, pareva di dover arrivare al centro della terra. E intanto un canto corale veniva di lontano e si avvicinava; il chiarore delle candele si fece più vivo, un Kyrie poderoso esplose quando,al termine della scaletta, mi trovai in un’ampia, altissima basilica sotterranea. Un Vescovo, i celebranti, sacerdoti addetti al servizio, un gruppo di chierici cantori. Tutti indossavano i paramenti all’antica, morbidi, fluttuanti, cadenti, raccolti in ampie pieghe. Di antica forma erano il calice, la 331 pisside,il turibolo. Il sacerdote che dirigeva il coro voltava le spalle, ma le mani che si alzavano e si abbassavano, uscivano nere sul bianco della cotta. Un piccolissimo cinese aveva una voce così limpida che quando si elevava sola dava più la sensazione di luce che di suono. Un giovane negro dal ciuffo crespo sulla fronte,sprigionava una voce così cupa che pareva il riflesso sonoro del suo colore. Due giapponesi con gli immancabili occhiali,un indiano alto e potente, un rhodesiano, due sudanesi,Africa, Asia,,Europa, America erano rappresentate in quel complesso corale. Il celebrante era australiano, malese il diacono. Quando, leggendo il Vangelo disse: “Amen, amen dico vobis”, parve un ritorno di verità attraverso le età e gli spazi del mondo. La chiesa di Roma l’ha percorso annunziando “amen, amen dico vobis”, ed ecco che dalle più lontane regioni vengono delle creature e ci ripetono la buona novella come fanno i fratelli quando sono buoni, che fra di loro si narrano i racconti che hanno imparato dai vecchi. Un sacerdote nero, fasciato da un ampio drappo di seta bianca, reggeva la mitria del Vescovo con l’immobilità di un idolo. Coreografia, certo, ma esprimente un simbolo che vela una sostanza, sostanza che diverrà vitale “i popoli uniranno la loro opera a quella di Dio”. Intanto quegli uomini che rappresentavano tutti i punti del mondo, pregavano e cantavano nella vecchia lingua di Roma. Intanto la folla che avevo vista sfilare silenziosa, stava lì, in piedi, unita, raccolta, tuffata nella stessa penombra satura d’incenso. Intanto io ero capitata vicino ad un operaio in tuta e a Sua Altezza Eminentissima il gran maestro del sovrano militare ordine di Malta. Me ne accorsi mentre un sacerdote italiano parlava di Basilla, la dama romana che aveva dato il terreno ai compagni di fede per seppellirvi i loro morti, di Proto e di Giacinto di cui non si dà altro che erano giovani e morirono per la fede comune. Con un inno in latino la cerimonia si spense mentre celebranti e folla si disperdevano lentamente. Sul terreno umido cosparso di foglie di lauro, per gli stretti e bassi ambulacri arrivai alla tomba dei due martiri. Di dove partono gallerie non ancora esplorate come la fraternità che dovremo ritrovare. Nella piccola cripta, sotto un rustico arcosolio inghirlandato da rami di palma, due parole sole su una pietra, “Yacinthus Martyr”. Passò un sacerdote etiope, che in italiano raccontava del loro ritrovamento. Poco dopo arrivò un gruppo di chierici tutti d’un colore, facce e vestiti, perché s’erano tolti i paramenti. Una donna chiese: - Proto e Giacinto erano fratelli? Il negro dal gran ciuffo sulla fronte, prima sorrise poi disse: - Fratelli? No Fratelli nella fede e nella morte, si! Lo disse così, nella lingua moderna di Roma. C) INEDITI 332 Come era Roma Collocazione Pg.117 Un sessantenne di oggi domandava spesso a suo nonno che gli raccontasse della breccia di porta Pia e del governo Subalpino dato che egli sapeva tante cose che i libri di scuola ignoravano. Prima di andare a scuola era la nonna a raccontare e cominciava sempre con “c’era una volta”; adesso era il nonno e incominciava sempre: “Quando gli italiani entrorno a Roma…” e un giorno non poté farne a meno, lo interruppe : - Scusa, sai, ma voialtri che eravate? Si drizzò il vecchio, parve raccogliersi in dignità e rispose come se incidesse una pietra: - Noantri erimo romani! Questi i romani, ma Roma che cosa era prima che dal nord le venisse appioppata la funzione di capitale d’Italia? Politicamente era il capoluogo della Comarca, ma questo nessuno lo sapeva. Essa per se stessa era una piccola città addormentata in un verde secolare con uno strano carattere di immensità. Piccola e immensa. Piccola nel raccolto del suo abitato: Piccola nel nucleo, diffusa nella continuità spaziosa delle sue ville, dei suoi orti, dei suoi giardini, delle sue vigne, delle sue rovine distese al sole tra alberi erba e cespugli in larghi spazi piani o scoscesi parlanti di immensità. I broccoli, l’insalata, i cavoli, i pomodori, il rosmarino insieme con le rose, i giaggioli e il glicine, crescevano fianco a fianco di rovine e monumenti noti in tutto il mondo. Roma era inimmaginabile per chi non l’aveva vista, superiore all’aspettativa per chi l’aveva sentita raccontare. Sfuggiva a qualunque schema, era Roma. Qualcuno dice che era un grosso paesotto fatto di basiliche, di chiese, di antichi monumenti, di palazzi, di conventi, di ville di rovine di giardini, di fontane, che nella sua campagna aveva chiese come san giovanni, santa Balbina, i santi Quattro san Pancrazio, nelle cui piazze periferiche, come la Barberini, potevano anche flettersi e riposare i buoi scesi dall’olmata dei Cappuccini, dove nelle casupole le porte delle botteghie si spalancavano all’esterno come persiane, una piazza rurale che aveva nel mezzo la fontana del Tritone, a un lato la fontanella delle api sulla conchiglia e dall’alto guardava in giù un palazzo superbo. Un grosso paesotto, ma fatto di sorprese uniche nel mondo a cominciare dalla gente. C’era già la stazione, lassù a Termini tra campi ville e solenni rovine; dentro le rovine una delle più belle chiese del mondo; di fronte all’esedra che faceva da facciata a questa chiesa, monsignor De Merode stava tracciando quella strada che sarà detta poi via Nazionale; una serie di sorprese e di meraviglie, di umili e umane armonie librate in quella sua inconfondibile immensità. Da che cosa era data quella sua immensità nella quale solo l’universale aveva diritto di cittadinanza?Dalla forma del suo spazio, certo, dalla sua luce, dal suo cielo, certissimo, ma ci doveva essere qualche altra cosa. Potrebbe essere forse la coincidenza di un particolare punto astrologico con uno magnetico ugualmente 333 particolare a fare di questa città che vi è germinata una città unica destinata ad essere sola come è solo chi sta sul trono o sulla croce. Una cosa misteriosa fu necessaria per formare una città misteriosa come Roma. Neppure il suo nome sappiamo. Come si chiama Roma non lo sappiamo, né lo sapremo mai. “Roma”, un nome–maschera sovrapposto al vero, messo per essere visto, per essere detto e soprattutto per nascondere l’altro. Il nome non aveva allora, come per noi ora, un valore solo familiare, giuridico e burocratico, ma anche un valore sacro; il nome era l’anima delle cose, era parte integrante dell’individuo che lo portava, dunque era necessario nasconderlo perché nessuno potesse pronunziandolo evocarne lo spirito per strapparglielo. La potenza del verbo era al principio di tutte le cose. Conoscere il nome di una città era conoscerne il nume e poterglielo rubare; tolto il nome è tolta la forza. Di qui la necessità di tenere nascosto il nome vero della città. I pontefici che lo pronunziavano solo nel segreto del sacrificio propiziatorio, se lo tramandavano l’un l’altro, ma non essendoci stato tradimento a un certo punto la catena fu spezzata e il nome perduto. Attraverso i secoli si è diffusa l’idea che Roma non sia altro che la parola Amor letta al rovescio, che il nome vero sarebbe quindi Amor. Ma il gioco delle due parole è troppo facile, perciò forse nulla di più di una fortunata coincidenza. Quel che è certo è che da questo punto della terra misteriosamente chiamato Roma, due civiltà si sono irradiate nel mondo intero, quella romana e quella cristiana, una continuità dell’altra, anche se per certi aspetti è superamento per altri retrocessione. Roma era stata fatta dal destino e dalla storia qualcosa di così grande che neanche il papa avrebbe potuto da altro luogo creare e mantenere il suo primato. Potrebbe esserci, in questo punto, una confluenza di influssi astrologici e di forze magnetiche in virtù della quale nacque una città che ebbe nei secoli un potere magico. Roma, motivo di contrasto, è essa stessa un contrasto dalle più grandi alle più piccole espressioni come quelle del clima. In qualche invernata può accadere di vedere arrivare la neve del nord, così come nelle estati capita d’essere avvolti dalla sabbia del deserto, o di vederla cadere con la pioggia in gocce grosse e rosse come se vi avessero stemperato la polvere di mattone. Roma è tutto un contrasto capriccioso. Meta dei nordici per il suo tepore, scatena una tramontana che penetra i corpi come i raggi X. Inutile coprirsi. Roma era tutta colorata, dai costumi delle donne a quelli degli uomini con le loro sgargianti fusciacche; dalle cerimonie religiose dove erano riuniti la porpora e l’oro dei secoli, dove la liturgia parlava anche con i colori, ai suoi mattoni e travertini patinati dal sole, al variare di toni del suo verde nel quale era affogata, ai fiori dei tanti giardini che la amalgamavano. Tutto l’anno le madonnelle erano fiorite, in maggio ne erano riboccanti. All’epoca dei cocomeri tutta Roma si ricopriva di castellucci e di carretti carichi di fette rosse. Capitava che la prima falce della luna quando stava per toccare Montemario che allora quasi dappertutto si vedeva, e scomparire, si arrossasse come una fetta di cocomero celeste. Le forme e i colori di Roma hanno ispirato gli artisti di tutti i secoli. Guardando quei quadri del sei, del 334 sette, del primo Ottocento, cadi in balia di una struggente meraviglia. Ma se davvero c’erano quelle cose, Roma era troppo bella. E allora si vorrebbe conoscere di più quell’altro genere di bellezza, quello dei secoli di mezzo, che la celebrarono miracolosa anche per la sua bellezza. Roma fu per quell’epoca la città miracolosa in cui avvengono i fenomeni più strani; città i cui edifici hanno migliaia di porte; città la cui folla è fatta di statue; città tutta di marmo e d’oro. Fantasie che provengono non da un popolo solo, ma da razze diverse, che perciò nascono dalla stupefatta meraviglia di chi la vide e la racconta. Queste fantasie provano la magnificenza di questa città e il culto che di lei restò anche nei secoli cosiddetti bui. Roma è stata sempre una città del mondo fuori del mondo. Questa sua strana unicità la fece un punto, un centro di attrazione. Nella prima metà dell’ottocento c’era in Roma una società cosmopolita meravigliosa: Dame che sanno di greco e di latino, di arte e di storia, di pittura e di musica, che cantano e suonano in scelti concerti e in gite campagnole con la chitarra. Spiritose e interessanti nella conversazione. Perché era il fior fiore dell’intelligenza internazionale che si riversava a Roma. Storici, archeologi, pittori, musicisti, filosofi, scultori ogni parte del mondo risiedevano a Roma e attendevano alle loro opere come nel proprio paese. A leggere le cronache di oggi e quelle di ieri, pare che allora i trasporti fossero supersonici e che adesso ci si muova con la posta a cavalli. Quell’andirivieni di re, regine, imperatori, imperatrici, regnanti o in esilio, quel correre qui di principi dinastici di ogni parte del mondo, e quella fiumana di duchi, di marchesi, di conti, che affluiva e defluiva, par gente che voli; mentre le rare visite di oggi sono concertate un ano prima, e il programma ci è noto sei mesi prima, e se ne viene uno quest’anno, passeranno forse altri anni prima che ne ritorni un altro. Per il clima, per lo spazio, per il temperamento della gente, per il fascino delle sue rovine, per quel governo unico al mondo in cui l’edito si mescolava al canto gregoriano e all’odor d’incenso, per quella melanconia dei funerali notturni e quegli scoppi trionfali della polifonia, Roma era soprattutto una città voluttuosa. Il “carpe diem” se non fosse nato qui forse non sarebbe nato altrove, perché Roma ti dà la bellezza delle sue luci e delle sue notti diffusa nel senso eterno del suo non essere. 335 Divagazioni tiberine collocazione: Pg 118. Se l’Egitto è dono del Nilo, il Lazio non lo è del Tevere, neppure Roma. Roma se mai è un suo involontario prodotto. Involontario perché nel Tevere non c’è generosità. Le sue inondazioni non erano feconde come quelle del Nilo, ma distruttive come un moto tellurico. Il Tevere era bellezza e comodità, due cose che a lui non costavano nulla, due cose di cui come un indifferente Iddio lasciava che la terra e gli uomini ne usufruissero. Un dio espresso dalla natura. Ma i romani se lo fabbricarono un dio fluviale con un paio di leggende diverse. La più diffusa che Tiberinus, re degli albani, morisse affogato nelle sue acque comunicandogli per osmosi nome e regalità che dopo morte divenne divinità. Tiberis, e Tibris, è il 2° fiume d’Italia, ma molto distanziato dal primo, come uno che in un concorso sia al 2° posto, ma solo perché tra lui e il primo in graduatoria ne mancano almeno altri quattro. La letteratura antica e moderna gli ha appiccicato l’aggettivo di flavus, il biondo Tevere che a volte lo era veramente biondo prima che fosse ridotto a fogna cittadina. Biondo per la rena delle sue dune. San Pietro in Montorio, Monte d’oro, deve il nome a quella rena che in città si spargeva per le strade dove doveva svolgersi un pomposo corteo o un solenne funerale. Le ruote delle carrozze giravano silenziose sopra quel tappeto dorato, raffinata distinzione che Roma offriva mutuandola dal fiume. Gli appiccicò anche i due gemellini soli e con la lupa che vive oramai nelle statue simboliche del fiume,fanno gruppo con lui e ne dicono il nome come la sfinge dice quello del Nilo. Del resto i gemelli li salvò lui prima di altri, invece di convogliare a mare la cesta con i ragazzini, la depositò su una secca perché Roma potesse essere. Così racconta il mito. Ma Roma fu solo per ragioni commerciali. Nonostante che nell’alta antichità la navigazione del Tevere fosse piuttosto difficile, esso era sempre la più diretta strada per merci e vettovaglie che dall’Etruria scendevano quaggiù. Dove la linea dei trasporti fluviali incrociava quella dei trasporti terrestri che risaliva per i colli Albani in quel punto d’incontro delle due strade non poteva non svilupparsi un mercato, l’isola Tiberina pareva messa lì apposta e lì nel posto più atto a sfruttare economicamente le due strade sorse Roma. In questa attività commerciale sempre in aumento fu necessaria Ostia, porta del fiume, porta di Roma, porta delle terre fin dove poteva arrivare per via fluviale tutto quello che veniva dal mare. Ma il fiume era appiccicoso, non dava sempre affidamento, come per i ragazzi turbolenti ci voleva una divagazione per questo si scavò il canale di Fiumicino, con due foci il turbolento fiume dette sfogo a se stesso e incremento agli scambi che col porto costruito da Claudio il commercio marittimo entrò direttamente nella sua splendida fase. Il fiume difese Roma, la nutrì, la provvide, l’uomo si sa deifica la provvidenza. Per noi che non deifichiamo più le forze della natura, la provvidenza è sinonimo di Dio. Nacque dunque la sacralità del fiume e del suo primo ponte, il Publicio. Lì il sacerdote accompagnava la vestale massima discinta in segno di lutto e 336 penitenza per buttare in acqua certi fantocci che avrebbero dovuto trascinare il male con loro liberandone la città. Il sacerdote addetto ai sacrifici sul ponte era il massimo e si chiamava Pontefice. Di mano in mano il nome è passato al capo della comunità cristiana occidentale, il nostro papa, Pontefice Massimo. Da Ostia e da Porto, all’altro capo del Tevere, tutto quello che poteva arrivare direttamente a Roma per acqua, arrivava all’Emporium, o Ripa. Arrivava grano, olio, legumi, legno, lana, avorio, piombo, datteri, stagno, rame, argento, oro, marmi, papiri, vetri, stoffe, incenso, spezie, perle, coralli, ed era l’Egitto, l’oriente l’Arabia, la Spagna, l’Africa, la Gallia, la Grecia a mandare tutta questa roba. Con la caduta dell’impero romano molte cose decaddero, anche il meraviglioso commercio mondiale di questo piccolo fiume subì un arresto ma non cessò mai del tutto anche se la sua attività pareva quella di uno che non ce la fa più. Ma siccome morto non era e di pontefici illuminati ce n’erano, ogni tanto riprendeva vita finché alla fine del ‘600 si ritornò allo splendore imperiale. Al porto di Ripa grande arrivavano bastimenti provenienti dal mare mentre a quello di Ripetta arrivavano barche, barconi, navicelli che scendevano dall’Umbria, dalla Sabina, uno scalo per le merci che scendevano dal nord, come quello di ripa grande lo era per quelle che venivano dal mare. Ripa grande era adesso la succursale di Civitavecchia, del porto vero aveva i caratteristici magazzini e le osterie. Santa Maria della Torre del Buon Viaggio raccoglieva gli umili voti dei naviganti che sono i migliori fornitori di ex voto. Già intorno al mille gli Arabi fantasticavano su questo fiume commerciante, dicevano che non è un fiume ma una striscia di mare che si insinua tra la città meravigliosa per servirla. Difatti le porta le navi cariche e gliele riporta via vuote. Prova questa che dopo lo sconvolgimento della caduta dell’impero, la vita commerciale del fiume non fu mai interrotta. Siamo abituati noi posteri a pensare solo ai due porti di Ripa grande e Ripetta perché i nomi sono rimasti, ma ce n’erano altri, quello della Traspontina, per esempio, in questo porticciolo sbarcò tutto il travertino che diventerà il colonnato di S. Pietro. Era una strada d’acqua il Tevere, serviva molto bene e i papi aumentavano sempre questi porticcioli, l’ultimo nel 1827, il porto Leonino, di fronte all’abside di S. Giovanni dei Fiorentini, aveva la sua piazzola, la sua fontana, le sue due rampe di scale fino all’approdo delle barche, era anche bello. Per secoli su questo fiume ora morto arrivavano, si fermavano, manovravano, ripartivano come dice la leggenda di una stampa del ‘600: “navi di mercanzie, barche, tartane, e altri vascelli et legni di mercanzie e robbe commestibili navigate per mare, per Tevere, condotte a Roma da tutte le parti”. Tor di Nona, corruzione d’Annona stava lì sulla riva del Tevere perché sin dall’antichità romana le vettovaglie lì si accumulavano. Sin dalla più remota antichità il fiume era stato pieno di ruote e pale che manovravano le mole di triturazione, sfarinatura, le macchine per muovere le seghe per il legno, le pietre, i metalli, la forza per sollevare i magli e gli aristi per battere rame e ferro, le mole, la maggior parte per macinare il grano ma 337 anche colori, maioliche ed altro, alcune erano fissate alle rive con catene, avanti a piccolissimi moli, la maggior parte con anelli e catene di ferro ai piloni dei ponti. Moltissimo all’isola e a S. Giovanni dei Fiorentini dove è rimasto il nome. Nella prima metà dell’800 vennero portate per fiume le colonne della ricostruendo basilica di S. Paolo e dall’Egitto i tronchi di alabastro. Il nostro fiume, oramai solcato da bastimenti a vapore aveva la capacità di legarsi col Nilo. Quando arrivò il regio esercito per liberare Roma i piroscafi riempivano il porto di Ripa grande. Ma il governo che arrivò con lui, imprigionò, asfissiò, svirilizzò questo fiume che Plinio chiamava: “placidissimo mercante di tutte le cose che nascono al mondo”. Lasciando da parte Ercole che si riposa sulle sue rive dopo la disfatta di Caco, Carmeta scarmigliata, Evandro e Tiberino, Turno che ci si lava le ferite, la Sibilla Tiburtina e Clelia che lo passa a nuoto, lasciando da parte cerimonie e illustrazioni che cosa non ha visto questo fiume? Saccheggi, imperi, rovine, papi, re, imperatori, fughe di questi e di quelli, feste sontuose, poeti, artisti, assassini e santi. Che cosa non fu buttato in questo fiume? Oro, argento, armi, viveri, documenti, persone, ed effigi di persone per una simbolica condanna, effigi di cortigiane sopra tutto, le condannavano così perché poi era così bello lasciarle vivere. Dopo le orge bacchiche gli iniziati correvano al Tevere agitando le fiaccole che spegnevano nell’acqua. Secondo la leggenda anche il candelabro a sette braccia del tempio di Gerusalemme, sarebbe finito in fondo al fiume. Massenzio, sconfitto, annegò nel Tevere. Anche un Borgia accolse questo fiume. Ci fu gettato a Ripetta, di fronte alla chiesa degli Schiavoni. Pare che in quell’epoca gettare di lì gente uccisa fosse un’abitudine. Le ceneri di Arnaldo da Brescia che risuscitava il ricordo dell’antica repubblica romana furono buttate al fiume. Disperse ma per una via solenne come un trionfo. Da Ponte Sisto furono giustiziati i cappelli cardinalizi: tolti dalle botteghe di via Cappellari e buttati al fiume. Invece da sé si giustiziò e per finirla con le sue angosce il padre dell’arditello Valodier argentiere, il papa gli commise una campana per S. Pietro. I fonditori ingelositi lo portarono a credere di avere fallito l’opera, disperato si buttò al fiume. Pioveva. Poco dopo da S. Pietro la sua campana spandeva un suono come se invece che col bronzo l’avesse fusa con l’argento a cui era abituato. E quante bestie ha visto il Tevere faticare lungo le sue rive quando traevano le barche, buttate a fiume per liberazione, e per godere del loro tormento. Quanti gemiti di cani per l’affogamento dei loro padroni. I mulinetti hanno risucchiato uomini in quantità e le ruote delle mole stritolati. Nell’antichità romana vide giochi e feste che culminavano con fiere di mercanzie nell’isola. Vide gli spettacoli storici molto cari ai papi “Orazio al ponte” era di prammatica, più spesso a Ripagrande perché il Sacro Sublicio era là. Vide giochi e spettacoli fluviali che si protraevano fino a notte quando l’allegria poteva inasprirsi ai gridi di “viva li Monti-Viva Trastevere”. Corse di barchette, feste di cocomeri, regate e girandole in acqua e poteva capitare che si costruisse una macchina rappresentante la nave degli 338 Argonauti alla conquista del vello d’oro. La letizia di Roma,si spense lentamente con l’annessione. Usava anche banchettare a mollo su tavole galleggianti che si dovevano seguire perché proprio ferme non ci stavano mai. I vaporetti facevano gite di piacere a ponte Mollo, all’Acqua Acetosa e i passeggeri sempre numerosi stornellavano. C’era un comodo battello per fare escursioni lungo il fiume e dall’acqua vedere la città. Questo allora era possibile. Ce n’era uno per traghettare la gente da Ripetta sui Prati di Castello pieni di osterie e di giochi di bocce. Traghetti o barchette di trapasso ce n’erano diversi perché la città scendeva al fiume e dall’altra parte ricominciava e con se stessa come a Trastevere, e con ville e con la campagna. Alle corse di Tor di Quinto ci andavano in vaporetto. Questo fiume che ha convogliato la storia è adorno di poche, ma durature leggende. Ancora nel 700 si poteva scrivere che le sue acque erano gialle per il grande oro che si trovava nel suo fondo: statue, monete, diademi, monili, tutte le ricchezze che i romani gettavano nel Tevere all’avvicinarsi dei barbari, galee naufragate cariche d’oro a cui si erano aggiunti le chiavi di S. Pietro buttate a fiume da Giulio II e il vasellame d’oro che i Chigi gettavano in acqua dopo i banchetti. Piatti e anfore d’oro non ne ha restituiti, forse erano riportati su dalle reti del banchiere. Però il Tevere, da secoli e secoli, basta stuzzicarlo un poco e qualche cosa restituisce. Da lui si possono estrarre pietre e rena come da tutti i fiumi, ma anche una testa di Afrodite bella come quella che sta alle Terme. Dalle sue sponde non venivano solo marmi, ma colonne e fregi. Venne fuori anche una enorme statua della dea Roma vestita di scuro con i capelli corvini e la faccia così pallida che le fecero una poltrona di legno dove tuttora riposa. Al principio del secolo dovendosi fare alcuni lavori di scavo nell’isola, ne vennero fuori tante colonne e tante statue quante non si sarebbe immaginato che potesse ospitarne. Poco prima dell’annessione, vicino a Ripagrande si scoperse una autentica cava di marmi tanti ve n’erano accumulati. Non per nulla sin dall’antichità il luogo si chiamava Marmorata perché lì si scaricavano. Vennero alla luce alabastri africani gialli antichi, serpentari, brecce, diaspri, neri, verdi, rossi antichi. Continuavano quei marmi a riapparire, ma arrivarono i muraglioni a inaridire quella fonte favolosa. A fine dell’800 quando sconvolsero tutto per costruirli si scopersero le due rampe terminali del ponte Elio, strade col noto selciato romano consumato dai pedoni e dai carri, fiancheggiate da due marciapiedi a doppio gradino. Tutto si guastava e si ricopriva. I lavori andavano a rilento, pareva che le draghe si divertissero a portare a superficie stucchi, bassorilievi, pitture, bronzi, elmi, monete, statue, colonne. Sulla Lungara, davanti alla Farnesina si scoprì una casa romana augustea con pareti dipinte e soffitti stuccati. Gli ebrei proposero ai papi di fare a loro spese certi lavori per facilitare il commercio fluviale, chiesero solo che passasse in loro proprietà le statue e i marmi che avrebbero trovato in fondo al fiume all’atto dello scavo. 339 I nuovi venuti che sconvolgevano la città scoprivano anche le ricchezze su cui essa siede come una favorita orientale sui suoi tappeti. Il Tevere è stato sempre capriccioso girò qua e là coprendo o scoprendo. Il cambio delle sue valute è segnato da secoli, da millenni. Presso ponte Cavour coprì un pezzo di Roma, più sotto c’è strade e case. Nel 1575 il fiume perse addirittura la testa, cambiò percorso e si mangiò quel pezzo di Ostia che si era stesa nell’ansa che quella piena apocalittica cancellava. Per colpa di questo tremendo piccolo fiume una parte di Ostia antica non potrà mai più essere scoperta,a meno che non gli venga il capriccio di ritornare nel vecchio letto. Il Tevere vuole qualche scadenza astrologica, qualche grossa occasione per straripare. Appena finiti i nove mesi di saccheggio di Carlo V, quando già Roma era tutta una rovina, straripò distruggendo centinaia di case già rovinate e, dicono, migliaia di persone. Cambiare corso e direzione gli è congeniale come uscire di senno con alluvioni disastrose, a capriccio, a volte pochi anni tra l’una e l’altra, a volte dei secoli. La prima dell’era cristiana fu una furia scatenata, ma Tiberio che era più saggio che pazzo ne riparò i guai con quella sollecitudine che noi desideriamo invano per i nostri guai. Rovinavano i ponti queste alluvioni, allagavano mezza Roma e oltre al solito deprimente deposito di ogni inondazione, lasciavano anche fame e peste. Improvvisa e veemente fu quella sul finire del secolo XV, così inaspettata e impetuosa che riempì di paura i cardinali che proprio in quel momento stavano uscendo dal conclave. Nella seguente una statua in legno di S. Maria Maddalena galleggiò in piedi sulle acque vorticose e andò da sola a piazzarsi sull’altare maggiore. Ora, sempre in piedi, sta in una cappella della chiesa della Maddalena. Quella di fine dicembre del 1870 parve una protesta per quello che a Roma stava avvenendo, una specie di presa in giro per quel re che non ce la faceva a venire per prendere possesso della città che gli avevano conquistata con la breccia di porta Pia. L’alluvione ce lo trascinò. Venne, non vide e ripartì. Un rimedio per queste alluvioni era necessario, ma si poteva rimediare in altra maniera, senza privare Roma di quella sua splendida parte fiumarola. Il rimedio dei muraglioni è brutto senza discussione, orribile è stato che per fare questa bruttura si sia distrutto, come i vandali mai fecero, case, alberi, palazzi, teatri, punti di vista sorprendenti, si è mutilata la città di quel suo dolce scivolare verso la sua acqua alla quale era unita da sempre. Vennero i nuovi padroni e lo divisero. Case e fiume erano parte viva della città come la gente che vi scendeva,il fiume era a livello della vita. I romani antiretorici e antiampollosi, che riducono tutto a nulla, indicarono sempre il Tevere col comunissimo er fiume, ma intimamente erano orgogliosi della loro storia, usavano la loro città quella canzonatura che usavano nell’amore. Dopo che glielo ebbero messo nella bara scoperta dei muraglioni, er fiume diventò er fosso. Case si specchiavano sull’acqua, terrazze e giardini sempre verdi e chiese e teatri e palazzi, immobili a volte, a volte con un tremore come se sull’acqua fosse distesa una seta dipinta così. Quel riflesso che durava da 340 millenni fu sepolto in una fogna scoperta. Tra siepi di rose, arbusti d’aranci, spalliere di mortella e pergolati, s’affacciavano sul fiume osterie che magari si autoproclamavano “Orti Aureliani”. Quella parte di Roma che s’affacciava sul fiume nasceva dall’acqua col miracolo fascinoso di Venezia, in qualche punto più incantevole di quello veneziano per il gran verde, per lo spazio enorme, per le svolte capricciose, ma sempre di gran respiro. San Giovanni dei Fiorentini sorgeva dalle onde del fiume, alle sue spalle, oltre l’acqua, altri campanili, altre case, di fronte la fuga della lunga valle Giulia a cui non era stata tolta la luce dell’acqua, che veniva a tuffarsi nel Tevere. Quell’abside sorgente dal fiume che nel sei, sette, ottocento fu l’ammirazione dei pittori di tutto il mondo, col terrapieno che ne seppellì mezza, danneggiarono irrimediabilmente la chiesa e le cose ammirevoli che vi erano raccolte. Il danno ognuno lo può immaginare solo passando sul lungotevere. Quella parte di abside che emerge è per metà bagnata d’umidità come un biscotto inzuppato nell’acqua. La campagna allora scorreva dentro la città insieme col fiume. Si mescolava ai giardini, alle rovine, cedeva il posto alle case, sosteneva le terrazze, piegava i suoi alberi nell’acqua come se volesse sciacquarceli. I muraglioni la seppellirono sotto uno strato di terra, di pietre, di mattoni. Dove la città diradava s’infittivano gli alberi sulle prode erbose e scoscese. Erano strette le une alle altre le case che sorgevano sul muro della cinta aureliana che dal Popolo piegava sul fiume. Dopo quel tratto sorgevano sempre dall’acqua, ma più accosto e più lontane dalla riva, erano intramezzate da piccolissime spiaggiole. Senza argini la vita scivolava sino all’acqua; piccoli mercati di pesce intorno a una cesta; passerelle ad archi digradanti che portavano dentro al fiume; piccole arene con gente stesa al sole. Barche, colonne spezzate, ma ancora dritte sul limite acqua-terra. Di dietro e dove è ora il ministero della giustizia una dolce stradina scendeva al Tevere fiancheggiata da alberi di melangoli, quegli alberi carichi di frutta color d’oro che non cadono mai. La città scendeva dolce verso l’acqua, nelle strade che vi sboccavano si avvertiva il chiarore dell’acqua assolata. Una bellezza irripetibile il Tevere alle falde dell’Aventino. L’Aventino s’immergeva nel Tevere e dal Tevere emergevano gli alberi. Case rare alte su rocce, rocce che scivolando si adagiavano nel fiume sino a scomparire sott’acqua, negli anfratti alberi, arbusti fiori, lontano il Tempio di Vesta. Tante spiaggette, s’è già detto, ma dopo Ponte Sisto c’era quella, la più grande lungo il corso del fiume è rimasto il nome a una viuzza. La Renella era una confluenza di luce e di vita perché il popolo viveva col suo fiume e lì aveva anche il teatrino dell’Impero Celeste, marionette meccaniche, maschere specialmente, delizia dei ragazzini, riposo dei grandi. Tutto distrutto. Via Giulia, la più bella strada di Roma accompagnava il corso d’acqua come un parallelo viale di palazzi. A uno di questi era fissata la fune per la barca che traghettava il fiume, in una casetta di fronte, sulla Lungara, era fissato l’altro capo. Ora via Giulia è una strada mezzo accecata, le hanno tolto la luce, le fronde, il 341 riflesso acquatico che le veniva dal fiume. L’hanno sepolta con un argine che le arriva a mezza vita. La passeggiata di Ripetta la chiamano anche passeggiata del Tevere perché gli alberi ombreggiavano sì, ma il fiume sciacquettava e luccicava lì accanto. Di fronte a san Giovanni dei Fiorentini sorgente dalle acque, sull’altra sponda, s’alzava il palazzo Salviati, poi cominciavano le case della Lungara, perché la Lungara era lungo il fiume, non era un seminterrato com’è ora. E quel cassone lungo e desolato che ora tenta di guardare il fiume da un fosso, l’apostolico Ospizio di San Michele, cittadella della libertà nel lavoro, era vivo e lieto con gli alberi davanti e poco più in là i velieri e i barconi che stavano al porto. Duemila anni e più erano corsi via con l’acqua lasciando sulle rive due cornici incomparabili che accompagnavano il fiume, Palazzi, case, ruderi, archi, scale, alberi e balconi e terrazze fiorite. Tutto giù. E i due porti più grandi quello di Ripetta e di Ripagrande dove la gente si affacciava a guardare le navi, ormai a vapore che scendevano da Nord o risalivano da Sud? Uno spettacolo caratteristicamente portuale che il Tevere non vedrà mai più. Due strade a livello, via di Ripetta e Tevere, la prima di selci, la seconda d’acqua e all’altra sponda le accompagnava un greto boscoso. La via di Ripetta, distesa lungo il suo fiume, aveva respiro e armonia in quell’aria luminosa. Sulla distruzione dello splendido porto di Ripetta piangeva persino la stampa governativa. Con scalini ondosi come il suono che scendeva all’attracco,viste dall’alto del parapetto quelle scale avevano la dolcezza sinuosa delle strigliature che vediamo su certi sarcofagi. Corde, barche, alberi, vaporetti e a notte la luce del faro. Due chiese stavano a guardia del porto di Ripetta. Una corsa di pochi passi e dall’acqua si stava in chiesa. Il palazzo Borghese guardava dalla sua altezza il discendente porto spingendosi verso il fiume con la tastiera del cembalo. Anche questa con davanti la gibbosità artificiale del lungotevere ha perduto la grandiosità che le dava il discendere del terreno e la luce e il respiro fluviale. Spremendo malignità di Roma tutto si sarebbe potuto dire, eccetto che era una città sepolta. Incassando il Tevere ci sono riusciti a seppellirla in parte. Lungo le sponde del fiume tutta la città è più bassa degli argini. Qualcosa che scaricasse il Tevere a monte quando ci fossero le piene, questo ci voleva. Il bel fiume continuerebbe a scorrere tra le sorprese delle sue sponde che erano inesauribili. La costruzione dei muraglioni, dicevano, avrebbe messo Roma nella condizione di tutte le città attraversate dai fiumi. Non lo è, ma se anche lo fosse, Roma non è una città come le altre. Essa anche se unica nella sua monumentalità, non era grande nello spazio, era grande nel tempo tanto che pareva averlo superato entrando nell’eternità. Roma eterna oggi fa ridere. I muraglioni dovevano superare l’altezza di quella piena che l’aveva battezzata capitale d’Italia. In un certo senso ciò voleva dire rendere stabile quella piena nel tratto cittadino. Nella piena, sformandosi, il fiume s’annulla, in fondo ai muraglioni si nasconde. Anche per un mattatoio, i papi chiamavano il nome di un architetto, per le dogane, per le prigioni, per le case di correzione, per gli ospizi sempre il valente architetto. Almeno questo potevano fare. 342 A una mente geniale quelle due sponde abbattute offrivano una quantità di spunti per dare a questi argini movimento e varietà. Invece si fecero con la più ottusa e brutale uniformità. Tanta varietà di bellezza da sostituita da un monotono nulla. Gli ingegneri che li progettavano riconoscevano che non c’era fiume più navigabile del Tevere e intanto studiavano i mezzi per renderlo utile solo a convogliare le fogne. I tempi erano maturi, come avevano portati i treni sui loro territori e la navigazione a vapore sul fiume, anche i papi avrebbero studiato il modo di evitarne gli straripamenti, ma così come volevano dagli architetti progetti artisticamente validi per magazzini e prigioni, avrebbero saputo far tutto con più eleganza e minori distruzioni. Intanto tra Stato e Comune la tensione e le inevitabili discussioni per chi doveva pagare la distruzione di Roma. Lo Stato pretendeva che il comune pagasse quasi tutta da sé l’opera di sventramento, come se chi viene sventrato avesse l’obbligo di pagarsi da sé i funerali. A Napoli perché si sventri su 100 milioni gliene dettero 50, ma a Roma solo una dozzina per rimangiarseli con la quota Tevere. Il governo, diceva, può imporre a Roma le tasse che vuole. Ogni tanto esigeva, ogni tanto esonerava. Il fatto è che quell’imprigionamento del fiume non andava a genio quasi a nessuno. La legge alla Camera fu votata con 150 palle bianche e 108 nere e al Parlamento i romani erano ben pochi. L’appalto per l’inalveamento del fiume veniva ogni tanto ripetuto, bastava un’offerta che diminuisse la percentuale di pochi centesimi. Ognuno traeva al suo profitto di modo che i muraglioni alle prime piene cadevano. La caduta di un tratto del muraglione suggeriva i rimedi per tutti, provando e riprovando costarono tanto che i governativi spiegavano ai romani che erano degni di Roma antica. Un’antichità si paga. Centocinque milioni di allora costò imprigionare quel fiume sovrano che ora si muove tra i muri come i carcerati che prendono l’aria. E ringraziamo il regio governo che non ci tolse l’isola Tiberina, il progetto di “toglierla di mezzo” c’era. La proposta fu bocciata perché essendo l’isola tanto collegata con la storia di Roma antica, avrebbe urtato “le opinioni volgari e quelle di tutti gli archeologi”. Il regio governo non era archeologo e non aveva niente a che fare con quelle “opinioni volgari” poteva benissimo spianare l’isola. Avrebbe forse ritrovato nel fondo il grano dei Tarquini che nella miseria in cui aveva buttato la città, avrebbe fatto comodo. Accenno di distruzioni, non elenco, per carità! Distrutta la chiesa di San Giustino e Giovita, ospizio o ospedale annessi; distrutto l’arco dei Bresciani. Palazzo Gaetani, poi dei Celestini,demolito. Demolito Palazzo Castellani il cui portico era uno dei più belli di Roma, demolita la torre degli Stefaneschi e quella degli Albertazzi. Demolito l’ospedale dei Pazzerelli sopra all’Acqua Lancisiana. Naturalmente questa finì di essere fontana di sorgente viva e si ridusse a un rubinetto uscente da un muro. Demolito il vecchio ospedale di S.Spirito. Ponte Sisto pareva tenuto su da due braccia di Roma che si protendevano nell’acqua, isolato tutto demolito intorno anche se erano costruzioni del ‘300, giù l’orologio, giù il fontanone, immagazzinati i pezzi, ricercati poi per ricostruirlo dall’altra parte,non tutti ritrovati. Trasformato il ponte con l’aggiunta di due marciapiedi 343 protetti da un’orribile balaustra in ghisa. Rovinati ponte e Castello Sant’Angelo. Due bastioni e lo splendido camminamento in pietra, “empiamenti distrutti” diceva la stampa contemporanea, affreschi,pietre diamantate, sculture, al magazzino. Demolite le due testate di ponte Sant’Angelo che avevano resistito 17 secoli, gli archi centrali lasciati soli in mezzo alla corrente stavano per crollare. La passeggiata di Ripetta che ora è un fosso di scorrimento per le automobili che vi si precipitano dall’argine, era un’assolata passeggiata ombreggiata dalle piante, sfiorata al tramonto dall’ombra delle vele che passavano sul fiume. Si chiama ancora “passeggiata”, ma ci si sguscia solo e a fatica, chi l’attraversa lo fa a suo rischio e pericolo. Pio IX aveva costruito quel ponte di ferro sospeso, arioso e bello chiamato dei Fiorentini che, non avendo arcate non ostacolava il flusso del fiume. Era stato un lavoro di tale perfezione che il mondo lo considerò una gloria del suo pontificato. Egli ne aveva seguito i lavori, approvate le modifiche, accettati i miglioramenti come un competente e un innamorato. Sopravvisse ai muraglioni funzionando a meraviglia, fu abbattuto lo stesso. Demolito il teatro Apollo, il primo costruito in Roma dopo gli antichi, il Politeama e l’Alhambra. Altra irreparabile distruzione fu quella del palazzo Altoviti di fronte a Castello. Era una costruzione cinquecentesca, la loggia a colonne sul fiume, dipinta dal vasari, un quadro indimenticabile per chi una volta sola l’aveva vista. Roma, quella consenziente all’annessione e quella contraria, unite nella stessa pena, supplicava il ministero della Pubblica Istruzione di non fare atterrare il palazzo, di salvare le sue parti più interessanti per lo meno, per lo meno il portico a specchio del Tevere. Niente da fare. Atterrare, tutto! Il popolo e Pasquino parlavano di Re Piccone. Giù tutti gli ospizi che i papi avevano costruito lungo il Tevere, anche se erano del Fontana, anche se il Regio governo non ne aveva costruiti altri per alloggiarci i ricoverati. Cancellato un affascinante elemento di varietà distruggendo il porto di Ripagrande. Ma quella folla di barconi e di piccoli piroscafi non era solo elemento di pittorica varietà, avvicinava il mare richiamandolo. Ponte rotto, ponte fratto, dicevano i romani, era stato costruito sotto Scipione l’Africano, le prime due arcate a destra erano le sue, mai crollate, 21 secoli avrebbero oggi se non le avessero barbaramente distrutte. E si che funzionavano, perché la metà crollata era stata sostituita da un ponte gettato in acciaio, senza piloni evitando così i facili crolli di quel punto. Un ponte che univa stranamente l’antichità più fonda e la modernità più avanzata, una curiosità perfettamente funzionante. Distrutto senza motivo. Distrutto senza ragione il faro di Ripagrande. I resti del ponte sacro di Roma, il Sublicio che da secoli affioravano nel mezzo del Tevere, che nessun fastidio davano al corso dell’acqua né alla navigazione, proprio ora che l’avevano annientata, fecero saltare con la dinamite quei resti, erano vecchi di 3.000 anni. Peggio ancora quando alla distruzione seguì la falsa ricostruzione un esempio per tutti. Il ponte Cestio con quella sua enorme iscrizione rimessa a posto, pare che sia l’antico. Neppure per sogno, demolito, rifatto diversamente, incastonate le colossali lettere epigrafiche: mancarono anche alla promessa di riutilizzare i massi di travertino che lo costruivano. Distrutta storia e memorie solo cancellando i nomi di 344 viuzze, piazzole, scalette scendenti nel fiume. Distrutti pittoreschi e sani costumi. I romani nuotavano nel fiume completamente nudi, un resto di paganesimo mai soffocato dalle foglie di fico. Il regio governo volle subito i braghettoni come per i nudi della Sistina. Dopo remate e nuotate i nostri fiumaroli che si stendevano sulla riva, parevano statue di bronzo. La riva non c’era più, dovettero fare i galleggianti per stendersi al sole. Roma non ha più la sua parte fiumarola, è una città divisa da un canale che potrebbe anche chiamarsi fogna scoperta, chiavicone a cielo aperto, a scelta. I muraglioni sono una specie di separazione legale tra il fiume e la sua città. Per essa cessano i bisticci, ma cessa anche l’unione che è comunione. E che dire delle costruzioni dopo le distruzioni che servono ad avvilire quel povero fiume “incatenato”? Un esempio solo anche per questo argomento. Ponte Mazzini, quello che sbocca, non davanti a una strada come tutti i ponti, ma davanti a un muro, e quel muro sono le carceri dal dolcissimo nome “Regina Coeli”. Lo costruirono per unire la via Giulia con la Lungara; due strade che seguivano la riva del fiume di qua e di là. Ma chi le vede quelle due fosse? Lì c’è solo un ponte che sbatte il muso contro un muro. I romani bofonchiando si domandavano: se i muraglioni ci salveranno dalle inondazioni, chi ci salverà dal diluvio delle tasse? Gli allagamenti cessarono davvero dopo i muraglioni? Nella Roma bassa sì, ci fu un miglioramento, lì ogni piccola piena allagava, ma se il Tevere cresce davvero una parte di Roma si allaga. Quando le piene sono state piuttosto grosse è capitato che un pezzo di muraglione sia caduto trascinando alberi e fanali. Nel 1915 per andare a san Pietro ci volle la barca. La piena del 1870, quella che battezzò l’annessione e portò il re, raggiunse i metri 17,22. Quella del 1938 che la superò di 33 centimetri, non fu molto disastrosa per il centro, per l’isola moltissimo, ma allagò tutto il nord di Roma facendone un lago. Al foro Mussolini galleggiavano migliaia di effigi del duce rubate dall’acqua agli uffici di propaganda. Fotografare non si poteva. Siccome l’ultima inondazione che superò i 17 metri prima di quella del 70, risale a 210 anni prima, se qualcuno dubita del collaudo dei muraglioni, ha la sua attenuante. Allo scempio fatto dagli uomini hanno un poco riparato le innocenti creature alberi, si sono piegati su quei muraglioni, cambiano colore con le stagioni, danno in ogni ora un senso di pace. La città si è estesa dove il muraglione cessa, ma si prolunga, declinando, gli argini, il terrapieno non è come il muro, pian piano diventa verde, passeggiandoci su il Tevere poteva vedersi ancora, in basso sì, ma ancora luminoso. Un destino assurdo lo proibisce. Società, circoli, tennis, ministeriali o sociali, hanno bloccato per loro soli quel pendio al fiume che avrebbe dovuto essere di tutti, ci tirano su costruzioni che coprono la vista dell’acqua, ma anche queste se lunghe a un certo punto finiscono e si ritroverebbe quel paesaggio per il quale si va a spasso, invece no, proseguono a occludercene la vista con muri di siepi e cipressetti fitti servono bene lo scopo che è quello di riservarsi non solo un pezzo di fiume, ma di proibirne la vista a chi non è socio. Eppure il rispetto al paesaggio dovrebbe essere un paragrafo del codice del rispetto del cittadino. Il cittadino ha diritto a godere di quel paesaggio, si può invocare la Costituzione per difendere un particolare 345 panoramico. Chi si ribella? Forse qualche povero pensionato che cammina e cammina senza riuscire a vedere di là, l’altra sponda del fiume. Ci avevano tolto il fiume con i muraglioni, ce ne avevano resa difficile la vita arginando il lungotevere non con balaustre, ma con muri, anche i ponti non li protessero con balaustre, ma con muri, e spesso quando ci si arriva nel mezzo, di dove si ama guardare giù perché lì pare d’essere sospeso sull’acqua, ti trovi davanti una parete massiccia. Muri, muri, muri sempre. 346 Distruzioni autorizzate collocazione: Pg 127. Ieri dalle pendici dei monti Parioli, a picco sul viale Tiziano, c’è stata una frana di tufo, sassi e arbusti che si è abbattuta sull’estremità di un distributore della Shell. Un giornale del mattino dice che si sta indagando per accertare le cause che hanno provocato lo smottamento. C’è poco da indagare, la causa è il lavoro di sterro fatto dalla Shell per allargare la sua piazza. Il fatto è doloso. Gli imputati sono due: la società Shell, in questo caso veramente scellerata, e chi l’autorizzò a crearsi una vasta insenatura in quella parte tufacea che era già stata ridotta a una parete verticale. La società Schell è nota; essa fa il suo interesse a spese del pubblico, suolo e uomini. Ma un permesso deve pure averlo avuto per scavare a livello stradale quella profonda e lunga insenatura alla base del monte. Chi ha dato quel permesso è il vero colpevole. Lo cercheranno? Lo troveranno? Ce lo indicheranno? E’ un piccolo guasto, si dirà. Non tanto perché quella chiazza gialla, dove prima c’era solo verde, verrà allargata per togliere le parti pericolanti, per essere in qualche modo puntellata e altri alberi, altri arbusti verranno sacrificati. Quella parte dei Monti Parioli, che ha valore storico ed artistico, ripidamente si, ma scendeva obliquamente al livello stradale, è stata manomessa da che il fuori porta non fece più paura ai romani non di Roma. Il fascismo non fece in tempo a coprirla con le sue muraglie come già fece a valle Giulia. Però siccome la strada risultava poco più della larghezza di un vicolo, Mussolini, in quattro e quattro otto la volle allargata e grande viale perché ci doveva passare Hitler. L’allora via dell’Impero risultò appestata da fiaccole accese su padelle di grassi fumiganti, tanto che Pasquino riesumò una sua vecchia battuta “Eccellenza, troppo olio per un cavolo” e il viale Tiziano, l’altra strada che doveva far colpo, un obbrobrio. Il monte era stato segato in modo che il suolo stradale risultasse di ampiezza strabiliante. Distrutto perciò tutto il verde che copriva la pendice, ne risultò una parte di tufo giallo senza senso. Il monte rapato a zero come un carcerato. Con quel taglio si scopersero a mezza altezza caverne che prima erano completamente interne o si affacciavano con brevi fessure, affiorarono, tronchi dalla mutilazione cunicoli terminali delle catacombe che serpeggiano All’interno del monte, uniche catacombe sopra al livello stradale. La guerra riempì di spostati quelle grotte. Per potersi arrampicare sin lassù si scavarono scale e scalette nel tufo. Neppure l’erba riusciva a macchiare di verde quella pendice che nel suo meridionale angolo roccioso era stato copiato d Raffaello per la sua Trasfigurazione. Il dopoguerra a fatica sgombrò quelle grotte dai loro inquilini, le aperture che la manomissione mussoliniana aveva allargate come fauci smisurate, furono chiuse. Quelle bocche murate sono rimaste chiazze aride nel verde che a fatica, con tanti anni, ha ricoperto il taglio fascista. La Shell aveva un suo distributore nello stesso posto, aveva appena sbancato un poco, sul terminale dello 347 sbancamento c’era murato il suo simbolo, un’enorme conchiglia; brutto come sono tutti brutti i distributori lo era, sempre adorno di gran pavesi di carta colorata come nelle fiere, ma il danno che aveva fatto era minimo, il peccato si riduceva a un peccato contro l’estetica. Volle allargarsi, qualcuno glielo permise, tolse la terra sotto i piedi del monte. Come faceva il monte a non franare? Questo lo doveva prevedere che dette il permesso alla Shell. La responsabilità è lì, altro che “indagare”. E ora? Ora bisognerebbe dare un po’ di pace a questo punto della città tra i più suggestivi, perché una parte collinosa coperta di verde a due passi dal centro, nessuna città ce l’ha. La riparazione intera sarebbe cacciare di lì la Shell, con lavoro di riporto sistemare la frana e rinverdirla senza aspettare che la terra fatichi da sé a farlo. Ma chi può toccare una società che certo ha pagato per fare quel disastro? Magari sarà lei a farsi pagare i danni. 348 Santi, beati e parenti di oggi, 25 giugno - inedito collocazione: Pg 76-78. - sant’Amando, eremita che per riuscire a vivere solo dovette sempre fuggire. - sant’Antido, con le tante leggende strabilianti che gli cucirono addosso,lo fecero parere più mago che santo. - san Biuha, che per rispetto all’Ostia consacrata mangiò un serpentello che ne aveva ingoiato un frammento, fu una sua comunione. - sant’Emiliano, costruito tardi su un mucchio di tombe misteriose che sarebbero pietre cadute dal cielo per seppellire un manipolo di cristiani morti combattendo contro i saraceni da lui guidati; nel 1872 un archeologo ritrovò la sua spada, un esemplare del XVII sec. Esattamente di un millennio più giovane, ma non fa nulla. - santa Eurosia, enigmatica martire uccisa da un moro in una caverna dove si era nascosta, un pastore avvertito da un angelo fece suonare tutte le campane. Gli spagnoli ne portarono il culto in Lombardia e qui rimase invocata contro le tempeste e i tuoni; la sua immagine è in atteggiamento di comandare al cielo l’allontanamento delle folgori. - santa Febronia, arrivò di Grecia a Patti, zona che sentì a lungo l’influsso della grecità, ma è un intruglio nel nome, nella leggenda, nelle ossa che intanto stanno in una cassa tutta d’argento cesellato. - san Gallicano, prediletto generale di Costantino che gli riserbava la figlia come sposa, ma dopo una strepitosa vittoria che lo portò al trionfo e al consolato, rinunziò alla carica e insieme a diventare genero dell’imperatore dedicandosi al servizio dei malati. Vive a Roma nell’ospedale per le malattie della pelle, il san Gallicano. - san Guglielmo da Vercelli, dimenticando che le bestie sono immuni dal peccato originale, la sua leggenda mette in risalto che quando egli dimorò solo su un’alta montagna, orsi e lupi non gli fecero alcun male. - san Guido, protegge dalla dissenteria perché ne morì, però si occupa anche delle stalle, delle scuderie, soprattutto delle bestie che tiravano l’aratro. - san Massimo, vescovo di Torino dove era usanza di emettere altissimi gridi in tempo di eclissi per aiutare la luna ad uscire dalla sua crisi. “Non ho potuto trattenere il riso - disse il mattino - ma fate bene a dare qualche aiuto alla divinità perché possa reggere il cielo”. - santi Pietro e Febronia, principi russi, coniugi finché entrarono in vecchiaia in due monasteri separati, ma la morte li riunì di nuovo nella tomba. - san Prospero d’Aquitania, battagliero difensore e interprete di sant’Agostino, ma arrivato a Roma, ambiente sedativo per eccellenza, da polemico si ridusse a divulgatore. - san Salomone, illuminato e crudele re di Bretagna dedito a guerre, invasioni e protezione delle arti; da vecchio si ritirò in un convento dal quale uscì per darsi in mano a coloro che aveva conculcato, perseguitato dai rimorsi per gli assassini che aveva compiuto, volle essere assassinato. --santa Tigre, pur dedicandosi ai pellegrini era attaccatissima a un suo pallino, voleva una reliquia di san 349 Giovanni Batista, andò ad Alessandria e dopo 3 anni importunò il santo nella sua tomba, finché qualcosa venne fuori, una tradizione dice che era un pollice (pollice verso), un’altra che erano tre dita (segno benedicente?) - due beati del secolo scorso tutti e due resi tali dai cinesi, Chien per la sua eroica difesa dell’immagine del Crocifisso, Henares, dopo mezzo secolo di missione finì chiuso in una gabbia. - beata Dorotea, mistica prussiana, stimmate visibili e ferite invisibili, estasi e penitenze raccapriccianti, amore languente e rinnovamento del cuore. Analfabeta scriveva ciò che Cristo le dettava, aveva imparato tutto da viaggiatori, predicatori e confessori, figli, in maturità stipulò un patto di continenza col marito, da vecchia si fece murare come reclusa nella cattedrale dove si macerava davanti alla gente che affluiva per guardare. - beata Isabella, sorella di Luigi IX, deluse il papa che la voleva nuora di Federico II, preferì pensare alle reliquie e ali crociati; da un monastero da lei fondato per giovani nobili come lei escluse la povertà. - da Corinto san Paolo scrive ai romani “vi salutano Lucio, Giasone e Sisipatro, miei parenti”. La festa di questo Sisipatro, parente di san Paolo, è oggi 25 giugno. 350 Una giornata di Dolores Prato – inedito 21 settembre 1978, San Matteo collocazione: Pg 80. Come sempre finalmente scendo dal letto e vado allo studio per levare il gancio della serranda, la prima cosa che faccio per paura di scordarmi, che se me ne scordo la fatica per riparare il guaio è mia. Sulla porta un sobbalzo, ho urtato col piede il bicchiere che ieri sera avevo capovolto sul pavimento. Ho tanta paura degli insetti e lì sul pavimento ce ne era uno, forse una scolopendra. Terrore. Ma stava ferma, dunque forse non lo era. Prendo il faro con quella luce, non vedo niente lo stesso, l’insetto è sempre lì. Allora col piede batto il pavimento, la scolopendra avanza, come un piccolo volo e si ferma subito. Batto col piede ancora una volta, l’insetto si sposta e si ferma. Allora decido lo copro con un bicchiere molto alto in modo che la mia mano sia lontana e rimando a domani: nel pomeriggio viene Angela, lei toglierà la bestia. Meglio se sotto il bicchiere non ci fosse stato nulla, ma vado a letto lo stesso. E adesso ho rovesciato il bicchiere la bestia è lì dentro, non esce; allora tiro su la serranda, entra il sole illumina il bicchiere, c’è dentro la piumetta di un uccello. Ma oggi avevo stabilito: volevo andare alla mostra fotografica della Galleria di Piazza Rondanini; una mostra che vorrebbe essere indicativa dell’anima e della sensibilità dei popoli meridionali; difatti accoglie tutte le regioni tagliando di traverso l’Italia sotto la Toscana e all’Emilia. E’ tanto che ci volevo andare, ma la mattina non ce la faccio, la sera col buio non posso più girare da sola e allora stabilito, fra due giorni si chiude, devo andare. Ma come avviene sempre il telefono che mai squilla questa mattina chiama a ripetizione. Son già le undici, non risponderò più e quando scendo sono le undici e mezza. Non guardo neppure la posta per far presto, ma la portiera grida “eccola eccola” davanti alla guardiola c’è lo stagnaro che ha fatto il lavoro in casa in questi ultimi giorni, c’è l’amministratore che mi assale. “Signora, bisogna dare novantamila lire, qui per quel lavoro”. - Ma come le chiede a me le deve dare Gaggero. - Sì, ma dovrei anticiparle io. - Altre volte lei non mi ha fatto questa questione. - Quest’uomo le esige, io dovrei anticiparle, le anticipi lei. E io che avverto la vigliaccheria della proposta che si avvale solo della mia decadenza fisica dico con una forza inaspettata anche da lui: “Metta una ipoteca sul fabbricato, a me non riguarda”. Solo lo stagnaro, alto, grosso col suo enorme nasone, mi guarda con simpatia e sorride. Me ne vado traballando esausta sconfortata cerco un taxì, non lo trovo, può tardare tanto da farmi arrivare all’ora di chiusura, salgo sul 95, sto scomoda ma intanto vado. Scendo a palazzo Chigi e prendo la strada: Montecitorio, piazza Capranica, piazza della Maddalena, e ci siamo. Ma quella strada col sole che mi acceca, con i sassi sporgenti che mi squilibrano, con le persone che mi affollano, strade senza marciapiedi, le 351 macchine fitte e strombazzanti, ci vuole proprio il mio desiderio di vedere le fotografie che riguarderanno le Marche per una conferma, forse per un suggerimento per questo lavoro che sto facendo da oltre due anni. E poi lo sapete dov’è la galleria? A Palazzo Rondanini, quel palazzo dove io ero a pensione da studentessa; quel palazzo che non è squadrato come un palazzo Farnese, ma è fatto di tanti edifici attaccati che si snodano per la piazzetta e per due altre strade con una punta sulla piazza del Pantheon su quella punta c’era un balconcino, quel balconcino apparteneva alla mia camera. Dove sarà la galleria? Attraversare piazza Rondanini è un inferno, un parcheggio disordinato dove si stanno lavando le macchine e l’acqua scivola giù, botti di qua clacson di là ma ecco finalmente il rilievo di piazza Pitti. Perché palazzo Rondanini ha avanti al portone una rotonda gonfia salitella come immensa è quella di Palazzo Pitti. Entro più che camminare guardo seguo le indicazioni per la galleria, salgo le scale, quelle che salivo, sono arrivata e la porta? E’ quella. Ma quella era la mia porta, la galleria è dove io ero. Arrivo presto al grande salone “affrescato dagli Zuccari” dicevamo noi allora, della scuola degli Zuccari, dicono adesso. Quel salone immenso tutto affrescato pareti e soffitto dove fu tenuto un conclave e sugli stipiti i segni del conclave di là una grande figura con le chiavi in mano. In quel salone tre gruppi di divani e poltrone lo lasciavano vuoto. Adesso è tutto coperto da tendaggi di velluto e tutto pieno di supporti pieni di fotografie tra i quali si gira come in un labirinto. E ancora per le altre stanze continuano supporti e fotografie. Devo cominciare la lotta estenuante del cambio degli occhiali per potervi leggere il nome di ognuno. Un giovane che gira lì mi guarda, io gli domando: - Lei è di qui? - Sì. - Allora mi può spiegare: le fotografie sono raccolte per argomenti, o per regioni? - In genere per argomenti, ma non si può neppur dire, girando e guardandole, si capisce. - Ma io ci vedo poco, m’interessano solo quelle marchigiane. - Allora venga qua, questo riquadro è solo marchigiano. L’uomo stava sorridendo come se fosse contento della mia richiesta. Fotografie bellissime: un grosso pagliaio avanti il quale passa una sposa vestita come la regina di Saba di Pier della Francesca, e poco più in là due rozzi contadini che l’aspettano, in primo piano giocano alle bocce. Fotografie interessanti, ma non mi servono. Questo reparto marchigiano sta in un vastissimo salone pieno anche questo di tanti supporti. Dico sotto voce come tra me: forse mangiavamo qui. E sento la necessità di spiegarmi con quest’uomo che è lì in attesa sorridente e dico: - Perché io da studentessa sono stata in pensione proprio in questo appartamento, avevo la camera che ha un balconcino su piazza del Pantheon e una finestra su via della Rosetta, dal ristorante di sotto venivano su tanti buoni odori. - La vorrebbe vedere la sua camera? Noi adesso ci teniamo una specie di ripostigli di carte, di cataloghi delle nostre mostre. 352 - Sarei felice di rivederla. Lui mi precede io lo seguo. Le porte hanno tutte quei bellissimi architravi in pietra; ecco quella di Lucia, povera Lucia quando ebbe il suo primo sbocco di sangue. S’apre una porta, la luce del balconcino entra fino a me, mi affaccio subito alla ringhiera e di lassù vedo quel che vedevo tanti anni fa. Luisa Ribechi che studiava tanto e veniva lì per lanciare al cielo i suoi trilli, quella Luisa che facendosi accompagnare dal fidanzato fino al portone del palazzo, dietro un battente si nascondevano per dirsi con le labbra ravvicinate “tu, tu, tu, tu” erano i loro baci. Negli anniversari della morte di Vittorio Emanuele II, di Umberto I solenni funerali al Pantheon, arrivavano i reali con i corazzieri nelle loro splendide berline, la piazza si riempiva di autorità, le finestre addobbate con drappi e coperte erano gremite di teste. Io sempre antimonarchica in segno di lutto, mio non loro, chiudevo le persiane del balcone e della finestra, quelle persiane chiuse, le uniche, doveva far pensare che lì c’era qualcuno che non voleva vedere. Io me ne andavo per paura che le compagne venissero dentro e aprissero per vedere, mi portavo via la chiave. - Ed ecco la cappella, dice il giovane. Non me la ricordavo, ma la riconosco, però c’era l’altare allora. E non ho detto che per la misura di quell’altare cominciò la lotta sorda della nuova longilinea superiora suor Guglielmina contro di me e di padre Goretto accomunati. Intanto l’uomo mi riaccompagna verso l’uscita e intanto mi domanda se sono marchigiana. - No, rispondo. Sono romana e mi dispiace molto che non si senta perché a me piace che ognuno abbia nella sua parola l’inflessione della sua terra, la cadenza è una radice benedetta della propria terra che ognuno dovrebbe conservare, ma io nata a Roma infanzia nelle Marche collegio Tosco-romagnolo, ho fatto una mescolanza. Eravamo arrivati nel suo ufficio cercava qualcosa da darmi come esempio della loro galleria e intanto diceva “perché io sono marchigiano”. - Di dove?, chiedo io - Della provincia maceratese. - Tò, dico io, l’infanzia la passai a Treja e ora ci sto facendo un lavoro. - E io sono di Penna San Giovanni, a venti Km da Treja. Si stabilisce una piccola conversazione facilmente immaginabile. Mi domanda se può venire a parlare un po’ di questo lavoro, dei miei ricordi marchigiani. Ma certo e gli do l’indirizzo. Via Fracassini, esclama lui. Ma io ci vengo sempre, ho lì mio fratello con un negozio di mobili. Quello vicino al fruttarolo, chiedo. Sì proprio quello. Ma quel negozietto che io intravedo è una cosa da poco, ma Angela nel pomeriggio mi dice: “Pare da poco perché è stretto nel principio ma entrando si allarga è lungo”. E allora io che mi aggrappo a tutto, senza che niente mi sostenga, ho pensato: chi lo sa che con questo mobiliere marchigiano non possa in qualche modo eliminare, rabberciandogli quei due insopportabili mobili di Ida. Ma tutto svanirà come sempre nel nulla. 353 Un falso miracoloso – inedito del 1970 collocazione: fondo Ferri-Ferrari. In mezzo alle trasmissioni TV sui “Misteri d’Italia”quella riferentesi ai prodigi di Padre Pio ha diritto massimo al titolo. La persona di Padre Pio, la sua opera, quel suo confessionale dove tra attese notturne, lagrime, improperi, esaltazioni, seggiolate e urli del frate, si affollavano i più strani tipi del mondo, quel suo ambiente tra miracoli e affari, tra semplicità rozza e azioni inestricabili, tra aspetti ascetici e ciarlataneschi, sono una serie interminabile di misteri. Credi di averne sciolto uno e vedi che sotto ce n’è un altro; uno dentro l’altro come le scatole cinesi, per arrivare a un sassolino ermetico, le stigmate. Che si chiamino così le ferite fatte dalla lancia sul petto di Cristo e dai chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi, anzi particolarmente queste e che si chiami così la riproduzione di quei segni in individui di particolare esaltata religiosità o di particolarissima anormalità, è ovvio. In antecedenza lo stigma era un marchio, un segno, impresso nella carne viva con punture di ferro o di fuoco, a significare schiavitù, irreggimentazione, condanna, affiliazione a sette comunitarie o religiose. San Paolo adoperò per primo quella parola, me in un senso che non ha niente a che vedere col senso che ebbe in seguito. Bisogna premettere che gli apostoli non erano cristiani così come noi l’intendiamo, erano ebrei che credevano nel Maestro scomparso restando fedeli alla legge ebraica. Naturalmente anche i nuovi seguaci della dottrina predicata dai discepoli di Cristo, restavano ebrei osservanti di tutte le loro leggi cominciando dalla circoncisione, il segno sacro che li distingueva. A questo segno tutti si votavano, si sarebbero sentiti ribelli a Dio senza quel segno che a lui, assoggettandoli, li legava. Un poco blasfemo certo apparve a loro Paolo, quell’infatuato convertito, nell’insieme più gentile che ebreo, perché sosteneva che quel segno fosse superato, che si doveva tralasciare d’imporlo. E fu proprio in una epistola su questo argomento che apparve per la prima volta la parola stigmate, “io porto nel mio corpo le stigmate di Gesù”. San Paolo non intendeva la parola nel senso che le diamo noi, egli non ebbe mai nel corpo le ferite di Cristo, non penava neppure alla sue ferite, in questo caso avrebbe detto fixurae; egli diceva di avere nello spirito Il segno che gli altri avevano nel corpo. Fu dopo, ma molto dopo, che la parola significò le cicatrici della passione di Cristo, particolarmente le fixurae fatte dai chiodi sulle mani e sui piedi. Le stimmate sola la riproduzione di quelle fixurae: San Francesco le ebbe, poi ogni tanto qualche altro. Veramente di uomini pochissimi, di donne invece si, ce ne furono, ce ne sono. Padre Pio le aveva, prima le teneva scoperte, erano in mezzo della mano, tra il medio e l’anulare, più vicine alle dita, poi le nascose sotto i famosi mezzi guanti. A me personalmente quelle lacerazioni sanguinolente danno fastidio, se le avessi davanti eviterei di guardarle come evito di guardare ciò che non mi fa simpatia. Neppure la Chiesa però mostra simpatia per quei fenomeni; salvo che per San Francesco, la sua posizione è di chi guarda senza pronunciarsi. Si direbbe che quel fenomeno la disturbi; non s’è mai rallegrata all’apparire di uno stigmatizzato; il giudizio l’ha sempre rimandato alle calende greche e se proprio ha dovuto pronunciarsi l’ha 354 fatto con una cautela che arriva ad essere irritante. Ha avuto più sopportazione per le statue semoventi delle vecchie campagne elettorali, forse perché il ciarlatano fa ridere, il patologico, se mai, ripugna. Che questo elemento non si possa facilmente escludere nel fenomeno delle stimmate, la chiesa ne è certa, di qui anche, la sua prudenza. Comunque esse siano, di natura morbosa o miracolosa, se le tiene lontane. Non fa male, perché, anche se miracolose, false però lo sono sempre. Un corpo umano non può sostenersi appeso a due chiodi infilati nel palmo delle mani. In quel punto le ossa, il metacarpo, non sono che la prosecuzione delle dita, unite invece che divise; la carne si sarebbe stracciata e il corpo sfuggito all’appiglio. Alla sacra Sindone di Torino la Chiesa presta fede, non ne fa un dogma d’infallibilità, me ne permette una così solenne venerazione da far credere di credere alla sua autenticità. Sia o no di Cristo quell’impronta, la Sindone è un documento estremamente interessante in ogni particolare. Ebbene, in quel lenzuolo dove il sangue e il vapore degli aromi impressero la forma del cadavere che accolse e ricoperse, il segno della ferita della mano non è nel palmo, ma molto più vicino al polso, è tra le ossa del carpo. In quel punto si, due chiodi potevano reggere quasi interamente il peso di un corpo abbandonato. Se la reliquia è vera, nel senso che abbia veramente accolto il cadavere insanguinato d’un crocifisso, come due pagine d’un libro accolgono un fiore che li lascia l’impronta, il segno del chiodo agli arti superiori è al posto giusto secondo la fisica e secondo l’anatomia. Se è falsa essa fu compilata tanti secoli fa da un mistificatore tale che per dare ogni apparenza di verità alla sua falsificazione, poneva il segno del chiodo dove non l’immaginazione, ma la ragione, doveva metterlo. Perché invece gli stigmatizzati hanno tutti queste ferite delle mani fuori posto? Il Crocifisso è stato sempre riprodotto dagli artisti come dagli artigiani col chiodo nel palmo della mano; gli innamorati del sangue fissano quelle immagini, meditano su quelle ferite, ci si chiudono, “intra vulnera tua asconde me”, su quei segni convergono tutte le loro forze affettive mentali e nervose, se hanno una speciale adatta natura, essa fa il resto; la loro carne riproduce quel che vedono, li esalta. Così si pensa noi profani, però ci piacerebbe tanto conoscere le spiegazioni che ne possono dare gli studiosi. Sapere perché anche padre Pio, benché difeso più dal mondo che dalla Chiesa, perché, se mistificatore non lo era, anche lui aveva quei segni dove non li ebbe Cristo? E se fosse vero che questi fenomeni possono anche trascendere la patologia umana, verrebbe da pensare che con l’errore ci si diverta anche Iddio. 355 Non ci sono più ghirlande per il Natale collocazione: Pg 107-108. Intorno all’uomo che acquistava conoscenza di sé, il sole, l’acqua, il fulmine, tutto pareva Mistero perciò divino. Quando egli staccò dall’albero sacro un ramoscello e se lo girò intorno al capo,con quel gesto aveva creato la corona e il suo significato sacro e ornamentale. Crescendo la conoscenza della vita ne crescevano le paure e le speranze e anche la corona moltiplicò i suoi significati: fu offerta agli dei per impetrazione e ringraziamento, fu complemento di gioia e segno di lutto. (La corona unì l’uomo al cielo perché diventò simbolo del potere regale, legato e confuso con quello celeste,perché distinse il sacerdote anche lui in rapporto diretto con la divinità). Dal favoloso e misterioso oriente essa che era passata nel costume dei popoli mediterranei (l’Egitto ci ha restituito corone intrecciate oltre duemila anni prima di Cristo), trovò il suo trionfo nel mondo pagano grecoromano che della vita ebbe un concetto meno deformato di tutte le altre civiltà. Ogni dio aveva la pianta a lui sacra dei cui rami si facevano corone per i suoi simulacri, per i sacerdoti e i fedeli. Negli ex voto le coroncine avevano la preponderanza sugli altri, come ora i cuori l’hanno su altri pezzi del corpo umano. Nei ludi, circensi o scenici, si offrivano corone ai vincitori come ora si offrono quei bicchieri metallici inchiodati su un piedistallo. Col tempo si diffuse l’uso di offrire la corona ai magistrati o altri cittadini per speciali benemerenze e si passò a darle anche a corporazioni e città come ora si concedono medaglie. A Roma, per il grande uso che si faceva di corone, erano sorte industrie adeguate. Fiorai e fioraie, coronarii e rosarie, vendevano ghirlande di fiori freschi nella buona stagione,nella cattiva di fronde e di amaranto secco che riprendeva i suoi colori bagnandolo. C’era l’industria delle corone d’oro d’argento, di rame che, lucidato, pareva d’oro. Le corone militari, dalla graminea alla trionfale, erano esse stesse una legione, alcune più numerose delle nostre croci di guerra. Ma dove la corona diventò tripudio o mestizia, al di sopra del suo simbolismo sacro, politico e civile, fu nell’accompagnarsi agli scoppi esuberanti della vita, esaltandoli, fu nel seguirne i mesti ripiegamenti verso la morte. I fiori, con la loro breve vita facilmente si allacciano all’idea della morte o al guizzo della giovinezza; ed ecco le danzatrici coronate di rose, in quelle famose feste dove ognuno, incoronato, tra musiche e libagioni tentava di gustare l’attimo fuggente della gioia. Ai morti invece che, per non essere più vivi diventavano quasi eroi, si offrivano corone d’oro che si chiudevano con loro nel sepolcro. In alcune feste annuali, specialmente nelle più licenziose, il popolo inghirlandava se stesso e tutto ciò che era intorno a lui. Ma venne il cristianesimo a soffocare quanto era possibile soffocare di quella vita pagana, ad accettare quanto non lo era, svuotandolo però dei significati antichi per riempirlo con altri somiglianti. Le figure effigiate nelle catacombe offrono corone al loro Dio come i pagani ai loro dei. 356 Nell’alto medio evo restavano solo le corone di oro gemme e smalti dei papi e degli imperatori,quelle metalliche che dondolavano nelle chiese attaccate a catenelle e quella diventata lampadario sospesa davanti agli altari. La corona apparteneva solo ai santi del cielo e ai potenti della terra. Quando ricominciò a diffondersi era spesso confusa con l’elmo e il cappello: confusione che dovette restare nell’araldica ecclesiastica dove tuttora vediamo gli stemmi cardinalizi sormontati da un cappello invece che da una corona. Ma dopo il mille,in quel felice ritorno di umana vitalità,anche la corona ritornò. Da elemento decorativo sulla pietra e sui musaici ritornò elemento di vita: le donne ornarono i capelli di coroncine e diademi, sui vestiti si ricamavano ghirlandette, la grazia femminile assomigliava a quella del suo serto. Poi le araldiche si moltiplicarono soffocando le vere,quelle che pulsano con la nostra vita seguendone la caducità,caduche anch’esse. Ma proprio a Roma, dove le corone ufficiali erano le tre della tiara pontificia e quelle principesche create per i vari nipoti, proprio qui era sopravvissuta a tutte le vicende la corona viva fatta con fiori e fronde. Perché questo era il miracolo di Roma: tener vive nella vita le espressioni che erano state sue nell’antichità classica e fare questo semplicemente come fa la natura coi miracoli suoi. Ma questo miracolo romano che aveva resistito al tempo, ebbe il suo colpo fatale dall’annessione. La città che era stata per secoli un meraviglioso paese universale, ridotta a capitale di uno stato particolare, perdette pian piano ciò che dall’antichità classica era sopravvissuto per oltre due millenni. Da nord e da sud affluì su Roma gente che l’invase, ne distrusse le piccole e grandi tradizioni che erano il suo meraviglioso patrimonio, la sua attrattiva unica al mondo, la trasformò in città simile a tutte le altre. E così fu distrutta anche la ghirlanda che era sopravvissuta proprio per indicare il Natale. In quell’epoca favolosa in cui Roma era dei romani che vi abitavano e del mondo intero che vi passava, chi in questi giorni girava per le sue strade, ogni tanto vedeva una porta su cui era stata appesa una grossa corona di mortella. Era la trasposizione di un rito pagano: appendere alla porta una ghirlanda di mirto fu l’uso antico delle feste floreali, quando tutto doveva essere fiorito e inghirlandato, teste, vestiti, pozzi, archi, templi, case e porte di case, perché la festa di Flora coincideva col risveglio della natura. La corona di mortella durata fino ai tempi moderni era restata espressione di risvegli anzi del risveglio assoluto, quello della nascita. Chi faceva il presepio, o perché presumesse che il suo fosse degno di essere visto, o perché animato da zelo religioso ed ospitale, su un battente del portoncino appendeva una corona lasciando socchiuso l’altro battente. Quella corona voleva dire al passante che nella casa c’era un presepio, che, se voleva, poteva salire a vederlo. Dove c’era una corona verde c’era una famiglia che ripeteva il gesto dei primi cristiani che aprivano le loro case, trasformate in oratori, a tutti i fedeli. Per il presepio con i fedeli salivano i pifferari che sin dall’avvento avevano cominciato a scendere a Roma 357 (non fasulli come quelli di adesso), costellandola di ninne nanne e di pastorali. La ghirlanda sulla porta era una specie di muto “venite ad oremus” e la gente saliva, pregava, ammirava, forse chiacchierava, avevano tutti gli stessi atavici gusti. Quell’unica corona viva che era rimasta attraverso i secoli, è scomparsa. Sono rimaste solo quelle politiche con le pallottole di stagnola e quelle funebri; ma queste trasformate in un cavalletto triangolare di bastoni sostenente due agglomerati di fiori, come ancora si possono chiamare corone? La corona è un’altra cosa e non c’è più. 358 Ringraziamento a Giovanni XXIII collocazione: Pg 109-110. Con papa Pacelli si è chiusa la dozzina dei papi autonominatisi Pii, e non sapremo mai se questo nome avrà rappresentato un proposito o una affermazione o una semplice imitazione affettiva. Pio è un nome brutto e freddo, è senza colore, senza passione, senza musicalità, è un nome monotono e tisico. In latino con quella S finale e l’accento che si adagia su due lettere è già tutt’altra cosa. Ma in italiano per non suonare male ha bisogno di un altro nome che lo preceda come se non fosse mai riuscito ad uscire dalla sfera degli aggettivi per entrare in quella dei sostantivi. Pio nudo e crudo è tutto il contrario di certi altri nomi che si potrebbero dire eroici, statuari, caldi, policromi, suonanti, per lo meno familiari. Il primo papa con questo nome comparve nel secondo secolo dell’era cristiana, in quell’epoca beata in cui i personaggi avevano tutti l’aureola, difatti anche Pio I è santo e la tradizione lo dice martire per quanto storicamente non sia certo. Da questo primo Pio al secondo passarono circa 1350 anni e per riavere un nome così religioso dobbiamo proprio arrivare al Rinascimento dell’antichità classica. E ad assumerlo fu proprio un uomo che viveva nella cultura pagana come un pittore vive con i suoi colori, Enea Silvio Piccolomini. Nel solo nome raccoglieva il mitico padre Enea e uno dei suoi figli quello che avrebbe continuata la stirpe decretata dall’Olimpo per la grandezza di Roma. Un uomo, già incoronato poeta, che non volle gli ordini sacri per non accettarne le rinunzie, che nel dissidio tra il concilio ed il pontificato, pur favorendo l’accordo fra le due parti per la pace che reclamavano i suoi studi, era però più propenso per il concilio, questo uomo che accettò gli ordini sacri e le loro conseguenti restrizioni solo quando la salute cominciò a difettare, quest’uomo eletto papa che nome poteva prendere che non lo dividesse dal suo Enea? L’aggettivo che è proprio di quell’eroe: Pius Aenea e così, dopo quasi un millennio e mezzo questo nome ritornò vestito di classicismo. Il 3° Pio, nipote del precedente, ebbe un pontificato brevissimo, 28 giorni, appena un mese lunare. Da quest’epoca ogni due secoli circa appare una coppia di Pii, vale a dire due papi consecutivi con lo stesso nome: la prima coppia è del secolo XVI, il primo dei due è Pio IV, quello che fece costruire Porta Pia, che sistemò la continuazione della Nomentana fino al Quirinale (l’attuale via XX settembre), sul tracciato dell’Alta semita degli antichi romani, che fece trasformare da Michelangelo il tepidarium delle terme di Diocleziano in S. Maria degli Angeli. Il secondo di questa prima coppia è santo anche lui, il terribile Pio V quello che fondò la congregazione dell’indice per i libri proibiti, quello che batté il record degli autodafé. Fu un santo pieno di uno speciale zelo, assomigliava a Pella perché non potendo ottenere la conversione dei ribelli ne desiderava la distruzione. Amò la guerra perché si chiamava crociata, morì confortato dalla previsione che questa fosse vicina. Passano due secoli senza Pii ed eccone una seconda coppia, Pio VI e Pio VII, il primo tormentato dall’ostilità di quasi tutti gli stati europei, primo tra tutti il francese con la sua rivoluzione prima e col suo Napoleone dopo. Il secondo seriamente “inguaiato” con Napoleone perché oltre a tutte le peripezie comuni al (col) suo 359 predecessore gli capitò quella sventuratissima del concordato. Dopo un altro Leone ecco un altro Pio, l’VIII. Poi un Gregorio quindi un altro Pio, il IX dal lunghissimo pontificato, quello a cui fu soffiata Roma. Segue Leone XIII e a lui succede Pio X. Dal 1914 al 1922 c’è Benedetto XV e dopo di lui fino al 1958 la terza coppia dei Pii, l’XI e il XII. 360 D) da INES FERRI – Sant’Angelo in Vado - INEDITI Una piantina di cicoria Mi sentivo distaccata, rara, adamantina, sublime, perché ero una renitente all’amore abilissima a scoraggiare chi voleva offrirmelo. La natura, dicono, aborre il vuoto, deve essere vero; forse era proprio per questo vuoto che mi creavo intorno che l’amore irrompeva su di me a ondate calde e veementi. Ma io, uno scoglio, lo scoglio non gira neppure la testa. Fare all’amore è facile, rifiutare è difficile. Io ero per le cose difficili. Poi come fu non lo so, ma certo è che quando mi si presentò nelle vesti di un giovane poeta, non lo respinsi, gli sorrisi e mi lasciai prendere per mano. Andammo per prati e per boschi; salimmo sulle cime dei monti e ne discendemmo volando, braccia, capelli riso all’aria; sedemmo sull’orlo dei ruscelli e buttammo fiori nella corrente; riposai la testa sul suo petto e lui baciò le dita con le quali gli avevo restituito un bacio posato sui capelli; salimmo sull’alto di una torre perché egli potesse insegnarmi il suo modo di pregare mentre il sole scompariva dietro i monti; fummo umili e buoni. Ero discesa dal piedistallo, mi sentivo dimessa e tanto felice. Un giorno che lui con un’immagine volle dirmi come doveva essere la sua vita di poeta, disegnò un cipresso alto e solo su una cima, puntato verso il cielo. Io dissi: - E se ai suoi piedi ci sarà una piantina di cicoria non gliene verrà alcun disturbo. Fece cenno di non aver capito. - Già, voi quassù non la conoscete; è una piantina minuscola delle nostre parti; si trova sui prati incolti e lungo i bordi delle strade di campagna. Le donne povere ne vanno in cerca e la raccolgono con la punta di un coltellino; stanno curve sulla terra ore e ore per portarne a casa una grembiulata. - Allora tu saresti la mia piantina di cicoria? Dissi di sì col capo. La sera andammo per la campagna sotto le stelle, indovinando appena il chiarore delle strade. A un tratto lui mi rivelò che intorno al viso avevo un alone di luce. Si fermò e mi si mise di fronte per vederne tutta la luminosità. Disse che era luce d’anima visibile agli occhi. Prese il mio volto tra le mani, ci affondò a lungo lo sguardo, poi tuffò il suo viso in quella luce e la bevve nella mia bocca. Non volli più proseguire, volli tornare indietro. Mi sentivo precipitata, frantumata. Bastò che lui dicesse “scusami” perché un fiotto improvviso di rimorso mai provato così grande, si risolvesse in parole, forse belle in sé, certo inopportune e gelide per lo stato d’animo dell’altro. Ci salutammo con un duplice, imbarazzato “a domani”, “a domani”. Domani, era già stabilito, saremmo andati a piedi a vedere il portico trecentesco di una vecchia pieve 361 abbandonata; c’era da star fuori tutto il pomeriggio. La mattina chiesi a un’amica se conosceva quel portico. Non lo conosceva. “Vieni con noi?”, le dissi. Lei venne. La mia amica era una ragazza a cui affiorava sempre un po’ di commozione nello sguardo; aveva la voce sommessa e leggermente velata come quella che ride dopo aver pianto; teneva il collo piegato in avanti come un fiore a cui pesi la corolla. Andavo; io stavo in mezzo. Il portico mi parve tanto lontano, forse era anche bello. A sera ci dividemmo; lui disse a me sempre “a domani”, ma io non risposi. A notte partii. Volevo ritornare quella che ero prima di scendere dal piedistallo. Quando fui lontana e sola, dissi: “E’ fatto! Non era fatto nulla. Non potevo fare nulla. Potevo solo disegnare cipressi, unica ombra melanconica di un incontro tanto radioso, ci facevo un puntino ai piedi di ognuno, li stracciavo e piangevo. Il dolore che dapprima giudicai lo scotto naturale dello strappo che avevo voluto, crebbe con i giorni, le settimane, i mesi, finché dalla sua stessa intensità scoppiò la forza incontenibile della riconquista. Non potevo perderlo. Ero così sicura che dovevo riunirmi a lui, come è sicuro che dopo la notte viene il giorno; così urgente era, come è urgente la plastica su un membro scarnificato. Scrissi a lui che volevo essere a ogni costo la piantina di cicoria ai piedi del grande cipresso, che mi aspettasse, ritornavo. La certezza che quell’abbandono disperato si sarebbe presto cambiato in abbandono beato, era già felicità. Che parola scialba! La mia era resurrezione. Laetare, alleluia, laetare, alleluia, non c’era altro intorno. Avevo appena raggiunta questa trionfante condizione, la lettera forse non gli era arrivata ancora che arrivò a me un telegramma dall’amica lungo quanto una lettera, era implorante come l’espressione del suo viso: chiedeva un incontro. Aveva certo adoperato la forma telegrafica per non darmi il tempo di discutere sulla sua opportunità. Del resto quando, già per la strada un’amica ti dice che domani ti aspetta nel tale posto, e se anche il motivo dell’incontro è taciuto, ma la sua gravità ne è proclamata in modo da far presentire una catastrofe, che fai? Parti. Tanto più che con la ritrovata gioia io ero nella migliore disposizione per essere buona. E poi c’era un’altra cosa. L’amica mi dava l’appuntamento in un santuario che era legato a me come le radici all’albero. Pare che da piccola io fossi incerta se vivere o morire; nell’angoscia di questa alternativa fui portata in quel santuario perché la Madonna che ne era la proprietaria, mi guarisse o mi riprendesse; la Madonna mi guarì. Ecco che dovevo andare proprio in quel santuario. Era uno strano santuario anfibio: davanti era chiesa con piazza e portici per folle e processioni; dietro era fortezza a picco sul mare, con torri e merli, terrapieni e camminamenti, feritoie e vedette. Una fortezza e una cupola, questo era il santuario visto dal mare. Ci arrivai, lei era ad attendermi col suo sguardo intenso. “Che è successo?”. Non rispose. C’era tanta gente; il brusio pareva infastidirla. Camminavamo sotto i portici. Pensavo che dopo forse le avrei detto il segreto, che mi aveva trovata per caso perché stavo per volare ai piedi dell’amore. “Che è successo? Me lo dici?” Non 362 rispondeva. Ma eccola decisa, vuole salire sulla torre campanaria. Interminabile chiocciola buia e a un tratto luce sole spazio mare. Si sedette sul parapetto estranea a tutte queste cose io restai con la faccia sul mare che era tutto un luccichio. Mi sembrava di essere io stessa alta come il campanile. - Ti devo fare una domanda – disse - ma tu prometti che mi risponderai solo se mi dirai il vero? - Certo. La sua voce si velò come per la celebrazione di un mistero; il volto più che piegato era proteso verso di me. - Tu ami… hai capito chi, tu lo ami, è vero? - Perché? - sentii che la bocca mi si storceva. - Tu prima devi dirmi se lo ami. - Sciocchezze. - Rispondimi, per pietà. - Perché? Lo ami tu? - Tanto! Quel “tanto” fu uno scoppio che frantumò tutto. Talmente ferita, stroncata ero che non m’accorsi subito del dolore. - Tanto! - riprese come raccogliendosi dopo lo scoppio - tanto che non so come potrei vivere senza di lui. Però non voglio la mia felicità al prezzo della tua. Se tu mi avessi detto che lo amavi… - Ma io non ti ho detto nulla. - Dunque e vero! - gridò soffocata come se le avessi fermato il cuore. Allora per tamponarlo dirsi forte staccando le sillabe. - Ma no, ma no! Non lo amo. - Davvero? E non l’hai mai amato? - Mai. - Allora a te non dispiace se l’amo io tanto! - No. Eravamo annegate tutte e due, lei come un beato, io come un dannato. Parlai per la prima: - Ma lui? Ti ama lui? - Credo di si. Un silenzio grande come la stupidità. Arrancai per tirarmene fuori. Dissi: - Hai pensato alla responsabilità che ti assumi immettendoti nella sua vita? Gli uomini come lui sono soli anche se noi ci accovacciamo ai loro piedi per tutta la vita. Chi entra nel loro giro deve rispettare quella solitudine, non essere più creatura viva, ma atmosfera: luce, od ombra, sorriso o riposo, secondo il loro bisogno e silenzio, silenzio soprattutto. Devi essere pronta a piangere da sola. - Si - disse lei e io dovetti certo cambiare voce e tono, perché dentro di me avvenne lo scatto di un cambiamento di marcia. - Non darmi ascolto. Si dicono stupidaggini a parlare di queste cose. L’amore è silenzio che brucia. Andiamo. 363 Imboccammo la chiocciola buia per la discesa. Non ero più alta di un coccio, non ero più consistente di un cencio. La grossa campana cominciò a muoversi, ondeggiò sempre più largo fino a che rintronò il primo tocco. “Tocco” dice chi lo sente di lontano. Ma lassù fu un crollo assordante, uno spavento che incalzava coi colpi successivi e io m’affrettavo per allontanarmi più presto possibile da quella sorgente devastante, da quel terribile suono che mi spingeva alle spalle come la voce di Dio quando cacciava dal paradiso i primi due disubbidienti. Per lei i colpi di quella spaventosa campana erano certo colpi d’ala che la lanciavano a chi volevo arrivare io solo cinque minuti prima. Essa partì, io restai. Vagai nel santuario e mi fermai avanti a quell’altare ai piedi del quale ero stata deposta bambina morente. Stavo lì senza dir nulla, una morta che si era depositata da sé. Dovettero insistere per farmi capire che la chiesa si chiude. Sulla mia distruzione rullò una notte interminabile senza speranza alcuna. Appena spuntò la luce me ne ritornai verso il santuario, ma non entrai, voltai a destra e discesi. Di lontano non si vedeva, ma tra il mare e i contrafforti del santuario, c’era una striscia di terra dove crescevano le erbacce, frammezzo poteva esserci anche qualche piantina di cicoria se qualcosa fosse stato vivo in me le avrei pestate. Niente parlava, tutto doleva. Mi sedetti e stetti muta avanti al mare come davanti all’altare della Madonna. 364 Il fiore dell’uomo Per l’impertinenza di un bottone che sfilò la testa dal cappio dell’asola, per il complice disordine della biancheria sottostante, mi si mostrò, da un pertugio, il fiore dell’uomo. Sbocciò alla mia vista come un colchico occhieggiante tra l’alba. Io non sapevo che il colchico è velenoso, tuttavia cercai di allontanare da lui gli occhi e il pensiero. Ma la sua presenza restava e nelle manovre per non guardarlo, spesso lo vedevo. Questa prima inconsapevole offerta, avvenne in un trenino che collegava due città lontane, dove passava il treno vero; un trenino capriccioso, ma bonario, tutto scosse e sussulti sempre pronto a compiacenti fermate. Io tornavo da una campagna che è il paradiso terrestre delle ciliegie. Me ne era stato regalato un cestino colmo. Mai prima, e mai dopo ebbi il dono di un cestino di ciliegie, solo quel giorno. Lo tenevo tra me e la mia compagna, brutta, pallida, secca. Sopra alle ciliegie avevano messo come copertura il loro fogliame, ma in più punti esse occhieggiavano. Il colchico era solo e impertinente, esse erano tante e curiose. A ogni poco io le sfioravo con le dita. L’uomo che mi sedeva di fronte e io ci si conosceva; egli aveva molta simpatia per me. Era ricco, giovane, intelligente, buono, un partito d’eccezione. “Se sapesse fare!” Mi si sussurrava intorno nel paese. Ma io non sapevo neppure che cosa avrei dovuto saper fare e poi ero anche timida. L’uomo era solo timido. Mi guardava quel giorno sorridendo più dolcemente di sempre. Era felice di starmi di fronte. Mi guardava senza spingere gli occhi con lo sguardo diffuso intorno al mio volto. Se fossero state mani invece che occhi, lo sguardo sarebbe stato una carezza dolcissima fatta più di gesto che di tocco. Mi guardava così e intanto i suoi calzoni gli avevano giocato quel tiro feroce. Per distrazione doveva aver infilato male un bottone nella sua asola, ma aveva anche trascurato di sovrapporre bene la biancheria intima. Come avvenne, non lo so; so che a un tratto, io che ero concentrata sul suo volto come lui sul mio, avevo visto occhieggiare turgido, roseo-violaceo, quel fiore. Guardai la mia compagna che mi contraccambiò uno sguardo ironico pieno di malizia. La sua anima sghignazzava. La mia no, aveva solo pena. E allora anche io fissai ostinatamente il volto di lui perché quando si fosse accorto di quel che stava facendo quel suo bricconcello, egli potesse ricordare che io avevo avuto sempre e solo guardato in alto. Puntavo i suoi occhi, sorridevo, ascoltavo, dicevo qualche parola e intanto avevo passato l’equatore, giacché i miei occhio terreni avevano intravisto quella cosa immortale dell’uomo. Mi si era offerta da sé (motu proprio) occhieggiando di tra i panni, come un croco tra l’erba. Io con la mano sfioravo le ciliegie e con le carezze scomponevo sempre di più le foglie di copertura. Faticavo a sostenere rigido il collo e alto lo sguardo, perché la volontà non riusciva a dominare quella 365 mescolanza di curiosità e di pena che frullavano confuse come i colori di una trottola in giro. Ma a un tratto il paesaggio fece per me quello che la mano fa per la clessidra, mi capovolse. Le case, gli alberi, le strade, mi dissero che era vicina la stazione di arrivo. Io non vidi più quello che prima vedevo intorno a me, non ricordo neppure come mi separai dalla mia eccitata compagna, non ricordo come salutai colui a cui era sbocciato quel fiore, io ero, come la polvere della clessidra, tutta conversa all’altro polo. Verso un uomo che mi aspettava alla stazione io ero tesa come una sbarra di ferro. In quei momenti di confusione per la discesa, forse quel poveretto si era accorto dell’insubordinazione e aveva ristabilito l’ordine nelle sue coperture. Non so. Io turbinavo sola nella confusione dell’ambiente, non vedevo nulla, sentivo solo la presenza di chi mi aspettava. Ed ecco che gli sono accanto, che egli mi tiene stretto sotto il braccio che reggeva il cestino di ciliegie, sollevandolo verso il suo cuore. La sua faccia, piegata verso la mia, è sorriso e respiro. Io prendo due ciliegie dal cestino; sono turgide e rosee, libere e unite forse leggermente calde, e gliele avvicino alle labbra. Egli le coglie come se aspirasse un bacio, socchiude gli occhio ne mi dice: - Come sto bene! Con queste ho cenato. Io portai con me i due peduncoli saldati all’estremità come si porta la prova di un miracolo. Mi coricai senza neppure ricordarmi di quella recente epifania pensavo solo alle due ciliegie, che egli aveva succhiate dalle mie dita, a quelle poche parole espresse con quella sua voce profonda come la vita, al sorridente silenzio estatico che ne era seguito come dopo la comunione. Io gli avevo amministrato il sacramento dell’amore; egli ora mi stringeva dentro di sé, sul cuore. 366 Un coltello Da Trastevere dove abita in uno dei più poveri agglomerati, una donna va a curarsi i denti in un ambulatorio a S.Giovanni. Di lì si avvia a piedi a piazza Vittorio, cammina preoccupata e assorta in se stessa. E’ povera, ha un marito onesto, 5 figli dai 16 in giù, non fa mercato nero, rispetta la roba altrui, lavora più che può, ma il lavoro onesto in questi tempi mantiene solo la povertà. Pensa che a piazza Vittorio i peperoni costano qualche lira meno che a Trastevere. E chi lo sa che non ci sia quella bancarella dove pochi giorni fa trovò del pesce a poco prezzo? La festa dei piccoli fu indescrivibile. Cammina senza guardarsi attorno, calcola in preventivo la spesa, pensa ai bimbi soli a casa. In una casa di piazza Vittorio intanto sono entrate due ragazze, 21 anni la grande, 17 la minore, sono amiche della padrona che è del loro paese. Sposata qui a un uomo che la ricolma d’ogni ben di Dio, è giovane, è bella, ha tre bimbi è felice. Le due sorelle sono venute per convincere l’amica a vendere due volpi argentate. Partendo per Roma hanno deciso che non torneranno a casa senza le due volpi, e, per ogni evenienza, si sono portate un bel coltello. In casa ne hanno tanti perché sono figlie di macellai. Provengono da un campo di concentramento e lì ne hanno sentite di tutti i colori. Sono ragazze già mature che sanno quel che vogliono. Ma l’amica non ha nessuna intenzione di vendere le volpi, inutile insistere, di denari non ha bisogno. Ma le due sorelle hanno invece bisogno delle volpi per le quali hanno ricevuto un acconto già speso e ora c’è la minaccia di denunzia per truffa. Perciò aprono la valigetta, tirano fuori il coltello, immobilizzano l’amica e la sgozzano. Lì c’è il bimbo piccino, due anni e mezzo, grida, piange, lo chiudono nel bagno mentre esse si puliscono dal sangue. Prendono le volpi, le mettono nella valigia e stanno per uscire quando pensano che il piccino le ha viste tante volte che può riconoscerle e poi, chiuso là dentro, urla come un ossesso. Tornano indietro, vanno nel bagno e sgozzano il bimbo con tale furia che si feriscono anche tra di loro. E poi giù per le scale. Il portiere le vede, le conosce, sono amiche della signora. A via Emanuele Filiberto, su un muricciolo limitante il giardino di una villetta, lasciano il coltello insanguinato. Per via Emanuele Filiberto cammina la donna pensando che a piazza Vittorio i peperoni costano meno che a Trastevere. Su un muricciolo vede un coltello. “Tò, un coltello a punta!” Da che è sposata non ha avuto mai un coltello a punta che in cucina è così utile; ne ha degli altri, ma senza punta, non ha potuto mai comperarselo perché le pareva superfluo, mentre per il palombo, quel pesce che costa poco, è necessario per spellarlo. Lei fatica tanto con quegli altri. E’ vero che questo coltello ha la punta accartocciata come se ci fosse stata aperta una scatola di latta ma essa lo drizzerà. E’ insanguinato il coltello, sicuramente è servito a qualcuno di quei macellari clandestini che l’ha dimenticato lì. Suo marito le direbbe: “Non lo toccare, non è tuo!” ma a lei farebbe tanto comodo! Lo prende per la punta accartocciata, lo mette nella borsa. A piazza Vittorio compera i peperoni, spalanca la borsa, il sole luccica sul coltello, la fruttarola ci rovescia sopra i peperoni. Il pesce a buon mercato oggi non c’è. Eppure oggi avrebbe il coltello per spellarlo. 367 Prende la circolare per tornare a casa. Pochi minuti dopo un brusio insolito parte da una casa della piazza;gente che corre, che urla, s’è scoperto il delitto orribile. Tutto il mercato è in subbuglio, l’orrore ha colto la folla. “Sì, saranno 10 minuti, non più!” La gente si guarda d’attorno, le assassine non debbono essere lontane, se le acciuffano le linciano! La donna coi peperoni arriva a casa stanca, rovescia la borsa sul tavolo, prende il coltello lo butta nell’acquaio e lo sciacqua. Quel sangue è fresco e va via subito, sicuramente ci hanno ammazzato dei conigli, chissà, forse degli abbacchi, saranno già andati a riprenderlo. Torna il marito, la donna gli chiede il favore di raddrizzare quella punta accartocciata. “Io non raddrizzo nulla, dice l’uomo, quel coltello non è tuo, non dovevi prenderlo. Tu devi riportarlo dove l’hai trovato. Un coltello insanguinato per la strada, ma chissà che cosa ci è stato fatto. Portalo via subito perché mi da fastidio”. La donna dice di sì, ma quando suo marito esce, raddrizza la punta da sé. A vederla così accartocciata aveva dedotto che il coltello fosse di qualità scadente, invece è durissimo, è buono. Fa una fatica indiavolata a rimetterlo a posto e che prima era accartocciato sulla punta si vede sempre. Ma come taglia bene. Oramai in cucina non adopera che questo. Ma nella notte suo marito sogna il coltello, è agitato, soffre. Si sveglia e dice: “Fammi il favore, riporta quel coltello dove l’hai trovato. Chissà a che è servito; lì c’è un mistero. Io ho sognato cose orribili; fammelo per favore toglilo di casa”. - Ma taglia tanto bene…! La donna vive in quel tristo agglomerato di casupole con tanta pena, e ci sta appartata, chiusa nella sua povera casetta. Non ha fatto nessuna amicizia con quell’altra gente sfrontata, sboccata. Ha paura che i suoi bimbi imparino le parolacce che dicono quegli altri che giocano nei cortili. Essa sta sola, sicché a lei non arriva la notizia del delitto. Suo marito compera un giornale a giorno a metà con un suo compagno di lavoro, uno lo legge la sera, uno la mattina dopo, fanno a turno, ora a lui tocca dopo. C’è di mezzo la domenica egli legge del delitto due giorni dopo. “Lo vedi che succede? Lo vedi?” dice alla moglie, “e tu vai raccattando coltelli insanguinati”. Due ragazze hanno ucciso, la più piccola ha l’età della loro grande. Arrestate, hanno confessato. Da quel momento l’uomo diventa un tormento. Quell’oggetto gli ha profanato la casa; la sua donna ha toccato una cosa immonda. Con quell’oggetto ha portato un mistero nella sua casa, povera sì, ma limpida. - Ma che mistero, dice la donna, quello era il coltello di un borsaro nero. Tre giorni dopo la questura dirama un comunicato: le assassine hanno precisato di aver abbandonato il coltello su un muricciolo di via Emanuele Filiberto; chi l’avesse trovato è pregato di consegnarlo. Ogni quindici giorni l’uomo ha una mattina libera e allora la moglie uscendo sbriga tutte le commissioni con 368 calma perché lui resta a casa coi bimbi. Quella mattina è libero. Prende il giornale già vecchio di un giorno e legge il comunicato della questura. Come un uomo colpito da una mazzata si piega nell’orrore diventato insopportabile. Dice solo: “Bimbi state buoni, per amor di Dio”. E fugge in questura. Racconta: “Mia moglie andava a piazza Vittorio per comperare i peperoni, vide su un muricciolo… - Sì sì, è quello dia pure. - Ma io non l’ho portato. Io non lo tocco; se lo volete venite voialtri a prenderlo. E con i carabinieri torna a casa, apre il cassetto del tavolo di cucina. - E’ quello lì, prendetelo pure, io non lo tocco. Con i carabinieri esce di casa il coltello0 maledetto. L’uomo fa un grande segno di croce. Torna la moglie con la borsa della spesa. Quando il suo uomo è a casa ne profitta per farsi aiutare a portarla su, lo chiama, egli scende… Quella mattina non scende, essa sale impensierita. Lo trova seduto con le braccia intorno ai tre più piccoli raccolti tra le sue ginocchia e il capo chino sulle loro testine. Pia da quel giorno in quella casa tanto povera la sera si prega per “l’anima benedetta” della povera uccisa. - E che non si parli più del delitto, dice il padre, che i nostri bimbi dimentichino che in casa nostra è entrato quel coltello maledetto. E la moglie pensando alle assassine guarda rabbrividendo la sua figlia più grande dagli occhi limpidi come la sua vita. Ho raccontato questo perché si veda che se in Italia succedono delitti tali da farci coprire di vergogna più di quello che non abbia fatto il passato regime questo non vuol dire che il popolo italiano abbia perduto tutto quanto la sua onestà. La dignitosa povertà di quella famiglia dove, per caso, entrò lo strumento dello delitto, direi che è superiore alla bassezza del delitto stesso. Questo, pur nel suo orrore, si spiega nelle sue origini con cause contingenti, con colpe nostre ed altrui, l’elevatezza di quella povera gente non ha cause, non è un’eccezione, è l’onestà innata di gran parte del popolo italiano. 369 Quel giorno e quella notte (25 luglio 1945) “Arieccolo!”dissi tra me appena sentii squillare il telefono. Tutte le domeniche a quell’ora mi chiamava supplicandomi di andare alla messa delle undici con lui, e tutte le domeniche gli rispondevo arrabbiata: “Lo sai che non ci vengo, non capisco perché tu insista così”. Lo capivo benissimo:nella sua mente c’era che se cominciavo ad andare a messa la domenica, cominciava anche la mia conversione. Era un mio amico magistrato impastato di religione curialesca. Come poteva capire me che stavo dolorosamente ferma avanti alla porta del mistero, una porta senza cardini, senza battenti, senza serrature, una porta che quaggiù non si aprirà mai? Ma quella mattina la sua voce non fu insinuante, non fu missionaria, non fu supplice, fu voce robusta, decisa, squillante: “Devi venire assolutamente a S. Maria del popolo, messa delle undici. Ti aspetto”. E riattaccò. Sentii che non mi invitava a messa, per ciò ci andai. Il divino sacrificio era già a metà, ma lui, sicuro che sarei arrivata in ritardo, mi aspettava in fondo alla chiesa, vicino alla porta. Mi sorrise appena e già tintinnava il campanello della consacrazione, inginocchiandosi ordinò: “Inginocchiati”, m’inginocchiai. Ma lui non congiunse le mani, non chinò il capo come era solito, continuava a sorridere a testa alta. Approfittando del raccoglimento generale, qualcuno cautamente s’avviò verso l’uscita, la luce della piazza di fuori batteva su quelle facce, razzo che esplose l’amico disse: “Guardali, guardali, domani neppure uno avrà più la cimice all’occhiello”. Dall’altare maggiore la scampanellata ultima col suo accento affrettato e allegro, rialzò tutti in piedi come prima li aveva genuflessi con la sua riverente cadenza. “Vedrai, vedrai, domani gli occhielli di tutte le giacche saranno ciechi”. Dopo l’audemus dicere pater noster, cominciò il movimento di tutti quelli che volevano uscire prima di essere imbottigliati nella calca finale. Il mio amico trionfava, venivano tutti verso di noi i distintivi P.N.F. illuminati dalla luce che la piazza riverberava nella penombra della chiesa ed egli se li rastrellava con gli occhi. Quando per la gente che si ammassava nella strettoia della porta dovettero tutti procedere più lentamente, fissava quelli che erano costretti a sostare un poco avanti a noi e ripeteva: “Domani non ce ne sarà neppure uno”. Non diceva più che cosa era la cosa che domani sarebbe scomparsa nel nulla. Aspettò che la chiesa fosse proprio vuota per dirmi: “Il fascismo è caduto, Mussolini è finito, la radio ne darà notizia alle 9 e mezza di stasera. Guai a te se lo dici a qualcuno”. La concitazione mal trattenuta di quelle parole provava che il fatto aspettato per tanto tempo e che la guerra stava avvicinando, era arrivato. Col cervello lo sappiamo che la morte c’è per tutto e per tutti, ma quando è tanto vicina che possiamo toccarla, allora non ci crediamo più. 370 “Possibile? Possibile?”, non sapevo dire altro. “Smettila col tuo possibile, sicuro è, sicurissimo, hai capito? Stasera alle nove e mezza tutta Italia lo saprà, il mondo intero lo saprà, tu lo sai ora, ma…con l’indice fece croce sulle labbra. “E tu come lo sai?” Al come non rispose, ma i fatti venuti e da venire me li disse. Ero un blocco di stupore scendendo le scale della chiesa. L’amico mi salutò con quelle parole dette e ridette: “Alle nove e mezza, sta lì pronta a sentire”. Nel pomeriggio della domenica diversi amici venivano a casa mia, si autodefinivano “i proci” perché il mio Ulisse era lontano, in viaggio, non per più conoscere, ma per più operare. I nostri discorsi erano interrogazioni, propositi, attesa, speranza, passione, angoscia, paura, mai disperazione. In quel pomeriggio dovetti apparire svagata ed irrequieta: era che facevo una fatica da morire a tenere dentro di me quel che sapevo,a non buttare quella splendida bomba in mezzo a loro che discutevano come sempre mentre il grande fatto stava accadendo, o era accaduto. “Sentite, una volta tanto invece di parlare vogliamo andare da qualche parte facendo una bella passeggiata?” Mi guardarono perplessi, “e dove si dovrebbe andare?” “Per il lungotevere piano piano andiamo da Astrid”. La cosa non dispiacque, tutti loro la conoscevano. Era una straniera bella e spiritosa, aveva un immenso giardino tropicale pensile, insospettabile dal basso, leggeva la mano o i tarocchi, offriva un tè insuperabile, la sua risata contagiava i più immusoniti, accanto a lei la noia non attecchiva. Per me era la salvezza: il moto avrebbe allentato la tensione prossima a spezzarsi, lassù poi, una mordacchia sarebbe stata la presenza della straniera, anche se amica. Così si fece. La girandola di Astrid vorticò, gli amici si divertivano, io non aveva pace. Mi licenziai prima degli altri; due di loro vollero accompagnarmi. Quando mi ci trovai braccio a braccio in mezzo, quante volte rallentai il passo per dirlo in segreto il mio segreto, almeno a quei due. Del resto il tempo in cui l’avrebbero saputo non era più molto. Quel silenzio mi cominciò a dolere come un tradimento che stessi facendo ad amici, ma non parlai. Affrettai il passo per congedarli il più presto possibile. Ed eccomi sola lassù nella mia grande casa alta come l’eden di Astrid, ma senza le sue piante tropicali, sola con l’avvenimento che s’avvicinava via via che il grigiore della sera si posava sulla città oscurata. Qualcuno bussa alla porta, sono due signore, madre e figlia, due fascistone, convinte che, ubbidendo all’ora legale, io avessi già cenato. Non erano mai venute, ci si salutava in ascensore e basta, per la prima volta, proprio allora. Nell’attesa di quella cosa che non lasciava posto ad altro, non avrei saputo dire se preferivo la solitudine o la compagnia. Le feci sprofondare in due poltrone, io me ne stetti in bilico sul bracciolo di un’altra. Del resto lo squillo del telefono mi chiamava spesso di là, era il magistrato che mi avvertiva successivi spostamenti d’ora della comunicazione radio, erano altri amici per altro; rispondere al telefono faceva da piccola vacanza nella fatica della visita; ma quando ritornavo ad appollaiarmi sul bracciolo, dovevo pure dialogare un po’ con loro che stavano parlando di quello di cui tutti parlavano: guerra e bombardamenti. La vecchia signora che aveva più volte stretto la mano alla regina togliendosi il guanto, disse: “La nostra salvezza è Mussolini, senza di lui saremmo già bell’e fritti”. 371 “Lo siamo, signora” - Mi subissò un duetto che, come in quelli dei melodrammi dove cantano in due dicendo cose diverse, io non capivo niente. Capivo però che era un esagitato peana al fascismo, dissi quasi con dolcezza: “Anche quello cadrà”. Un duplice urlo, una ripresa del confuso duetto dove la parola eternità forse non ci fu, ma perifrasi sinonime sì. Io sorridevo e quelle osannavano al duce, quando rimanemmo tutte e tre stroncate nel nostro rispettivo atteggiamento per un improvviso crescente baccano che veniva di fuori. Capii subito, la radio aveva parlato, il popolo rispondeva. Ci affacciammo: finestre spalancate e illuminate in barba all’oscuramento, gente che si protendeva da una all’altra, che si chiamava, che batteva le mani, da plurimi duetti si distinguevano bene gli abbasso e gli evviva. La vecchia signora era allibita; corsi al telefono, chiamava un amico che abitava a S. Emerenziana, la famiglia sfollata, stava preparandosi qualcosa per cena quando la radio gli disse quel che io sapevo, fece il mio numero per dire: “Vengo subito da te”. La signora giovane più allibita della madre, mi venne incontro: “Ma che succede, che succede?” “Ha visto bene quel che succede, è caduto il fascismo”. Stette qualche attimo perplessa come se dentro di sé si domandasse se era proprio vero, poi corse alla finestra, cominciò a sbracciarsi con tutta l’altra gente che si sbracciava e a gridare: “Abbasso Mussolini, abbasso!” C’era già abbasso: da una finestra avevano gettato un suo grande ritratto in cornice, pareva l’ingrandimento fotografico di un povero estinto maltrattato dai parenti diseredati. La vecchia signora disse: “Non l’avrei mai creduto”. Stavo per abbracciarla, ma il telefono squillava, gli amici chiamavano, alcuni annunziavano che sarebbero presto arrivati. Quando suonò il campanello della porta le due signore stavano di nuovo dentro le loro poltrone. Apersi, era quello di S.Emerenziana, dieci minuti non ce li aveva messi. “Come hai fatto così presto?” “Non ho preso per le strade, sono venuto in linea d’aria” - In linea d’aria significava saltare fossi, muretti, fili spinati e scavalcare la massicciata della Roma-Nord. Lui alto e robusto, io piccola e mingherlina, mi afferrò alla vita alzandomi in aria come si fa con i pupi, tenendomi così mi portò in giro per tutta casa canticchiando parole assurde di gioia; quando fu nella sala e, affondate nella poltrona vide le due signore, tacque paralizzato allargando le mani, caddi anch’io col fascismo, ma caddi in piedi. Intanto che altri amici arrivavano, le signore dissero che ci “levavano l’incomodo” per poco non dissi “grazie”. L’ultimo a presentarsi fu un esegeta cattolico, l’unico atteggiato a malinconia. Io il comunicato radio non l’avevo sentito, gli altri sì, la gioia però aveva schermato il colpo mancino che c’era dentro. Ma quando 372 l’esegeta cattolico sillabò a voce bassa: “La guerra continua”, quando, aperta la radio se ne sentiva ogni tanto la ripetizione, la pena entrò in tutti. Però poteva essere uno stratagemma; anche il silenzio sulla monarchia avrebbe potuto esserlo perché era logico, cadendo uno doveva cadere l’altra. Fu un agone tra pena e gioia, vinse la gioia. Tutta casa illuminata, tutte le finestre spalancate, respiravamo aria dell’anima. Dalla protesa loggia che offre quasi intero l’orizzonte di Roma, ci godevamo quella notte che poteva non aver più paura dei lumi. Infatti laggiù, a piazza Venezia ce ne dovevano essere tanti perché se ne elevava un chiarore diffuso come se da un enorme pozzo sorgesse l’alba. “Sono fiaccole” - dissero gli amici, ma fui io a dire: “Si sposta, si muovono”. “No, no” - dicevano loro. “Sì, sì” - dicevo io, finché lo videro anche loro che il chiarore si spostava”. “Salgono” - dissi. Difatti il chiarore saliva a sinistra della piazza. “Oddio, vanno al Quirinale” - gridai e le ali della vita mi si afflosciarono. Quando il chiarore fu fermo sull’alto del nostro Monte Cavallo, mentre forse si spalancava la loggia reale, la nostra si chiuse. Rientrammo abbacchiati. Fu quello di S.Emerenziana a riprendere tono: “Io ho fame, non ho mica cenato, dammi qualcosa”. Tutti ebbero fame e io avevo molto poco. “Uova ce n’hai?” “Sì” “Cipolle?” “Anche” “Andiamo, ti aiutiamo noi, facciamo una frittata con le cipolle”. In cucina chi piangeva tagliando le cipolle, chi cantava sbattendo le uova, chi riscaldava il pane duro per renderlo addentabile, chi scovava il vino. Alle quattro del mattino una vera tavola rotonda con in mezzo una frittata e intorno della brava gente affamata e un po’ delusa. Quando se ne furono andati, uscii sulla loggia. Albeggiava, l’orizzonte era cancellato da un anello di nebbia. Non ero stanca, non ero contenta. 373 Non siamo abbastanza antimonarchici Non siamo abbastanza antimonarchici perché anche i giornali che sono per la repubblica portarono senza nessun commento la notizia che essendo la moglie di Umberto Carignano (Maria José) a villeggiare a Castel Porziano, nell’incendio di parte di quel bosco, restò separata dai figli che erano a giocare sulla spiaggia finché i pompieri non glieli ebbero ricondotti. Una madre che soffre per i figli è sempre rispettabile, sia pur una Carignano, ma che la stampa italiana non abbia sentito che la notizia andava taciuta o commentata, è stata una mancanza d’intuito per il dolore del nostro popolo. Mentre i bimbi d’Italia (esclusi i figli dei ricchi e degli arricchiti che nella totalità sono un’esigua minoranza) non conoscono più villeggiature, né al mare, né al monte, né al piano, i figli di chi volle la guerra, togliendo così ai nostri bimbi non solo gli svaghi dei campi o dei mari, ma il pane e le vesti, passano da una villeggiatura ad un’altra, giocano sulla spiaggia “loro”, godono indisturbati i beni dell’Italia. Li hanno salvati, va bene, ma che non ce ne parlino per non farci sentire raddoppiato il cruccio per i nostri poveri bimbi vittime del padre, del nonno, del “cugino” del nonno, di tutti gli antenati di quei tre o quattro Carignano che giocano sulla spiaggia “loro”. (m’accorgo ora di non saper con sicurezza quanti siano i figli del luogotenente e…me ne rallegro!). 374 Bibliografia AA.VV., Matilde Serao tra giornalismo e letteratura, a cura di Gianni Infusino, Guida editori, Napoli 1981. AA.VV., Roma capitale d’Italia, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1971. AA. VV., Dizionario biografico degli Italiani, Edizioni dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1960-2012; varie voci. Aleramo Sibilla, Una donna, Feltrinelli, Milano 2003. Ead., Un amore insolito. Diario 1940-1944, Feltrinelli, Milano 1977. Ead., Andando e stando, a cura di Renata Guerricchio, Feltrinelli, Milano 1977. Ead., La donna e il femminismo. Scritti 1897-1910 (a cura di Bruna Conti), Editori Riuniti, Roma 1978. Ead., Amo dunque sono, Mondadori, Milano 1927. Allevi Febo, Liberty e Belle Epoque da un angolo visuale di provincia, dagli Atti del XXXI Convegno del Centro Studi Storici Maceratesi “Vita quotidiana e tradizioni popolari nel maceratese”, Abbadia di Fiastra 18-19 novembre 1995, Macerata 1997. Banti Anna, Serao, Utet, Torino 1965. Barroero Liliana, Conti Alessandro, Racheli Anna Maria, Serio Mario, Via dei Fori Imperiali. La zona archeologica di Roma: urbanistica, beni artistici e politica culturale, Marsilio, Venezia 1983. Boatti Giorgio, Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini, Einaudi, Torino 2001. Bonetti Antonmaria, Venticinque anni di Roma capitale d’Italia e suoi precedenti, Roma 1896. Brevini Franco, L’innamorata dei nomi. L’opera autobiografica di Dolores Prato, Città di Treia, Treia 1989. Bravo Anna, Pelaja Margherita, Pescarolo Alessandra, Scaraffia Lucetta, Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2001. Buonanno Milly, Visibilità senza potere. Le sorti progressive ma non magnifiche delle donne giornaliste italiane, Liguori Editore, Napoli 2005. Buttafuoco Annarita, Zancan Marina, Svelamento: una biografia intellettuale, Feltrinelli, Milano 1988. 375 Caracciolo Alberto, Roma Capitale, Editori Riuniti, Roma 1974. Id., I sindaci di Roma, Donzelli, Roma 1993. Casoni Giambattista, Roma e Parigi. Impressioni e memorie, Bologna 1862. Castronovo Valerio e Tranfaglia Nicola (a cura di), La stampa italiana nell’età liberale, Editori Laterza, Roma-Bari 1979. Id., La stampa italiana dalla Resistenza agli anni Sessanta, Editori Laterza, Roma-Bari 1980. Id., La stampa italiana nell’età della Tv. 1975-1994, Editori Laterza, Roma-Bari 1994. Cavalieri Pier Luigi, Sibilla Aleramo. Gli anni di Una donna. Porto Civitanova 1888-1902, Cattedrale, Ancona 2009. Cavour Camillo, Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour: raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei Deputati, 1863-1872, v. 11, in www.fondazionefeltrinelli.it. Cirilli Fiammetta, Per una lettura di “Giù la piazza non c’è nessuno” di Dolores Prato, 11 giugno 2011, in www.puntocritico.eu. Id., “Il ritorno degli italiani a Roma”. Aspetti di una polemica antisabauda nelle pagine di Dolores Prato, in Pre-sentimenti dell’Unità d’Italia dal Duecento all’Ottocento, Atti del Convegno di studi (Roma, Casa di Dante, 24-27 ottobre 2011), Salerno editrice, Roma (uscita prevista primo semestre 2012). Comune di Roma, Annuario statistico di Roma, Roma 1885. Conti Bruna (a cura di), Un viaggio chiamato amore. Lettere 1916-1918, Feltrinelli, Milano 2000. Conti Bruna, Morino Alba (a cura di), Sibilla Aleramo e il suo tempo. Vita raccontata e illustrata, Feltrinelli, Milano 1981. Contorbia Franco (a cura e con un saggio introduttivo di), Giornalismo italiano, Arnoldo Mondadori, Milano 2009. Crispino Anna Maria (a cura di), Oltrecanone. Per una cartografia della scrittura femminile, Manifestolibri, Roma 2003. Croce Benedetto, La letteratura della nuova Italia, vol. III, Laterza, Bari 1915. Cuccia Giuseppe, Urbanistica, edilizia, infrastrutture di Roma Capitale 1870-1990. Una Cronologia, Laterza, Bari 1991. Danesi Silvia e Patetta Luciano (a cura di), Il razionalismo e l’architettura in Italia durante il fascismo, Electa, Milano 1994. De Giorgio Michela, Le italiane dall’Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari 1992. 376 De Nunzio Schilardi Wanda, Matilde Serao giornalista (con antologia di scritti rari), Edizioni Micella, Lecce 1986. Farnetti Monica, Il centro della cattedrale. I ricordi d’infanzia nella scrittura femminile, Tre Lune Edizioni, Mantova 2002. Ferrero Guglielmo, L’Europa giovane. Studi e viaggi nei Paesi del Nord (nuova edizione), Garzanti, Milano 1946. Fetonte Aldo (a cura di), Centenario Romano 1870-1970, Edizioni Fema, Roma-Tolentino 1970. Fiorani Luigi, Prosperi Adriano (a cura di), Roma, la città del papa: vita civile e religiosa del giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla, Storia d’Italia, Annali n. 16, Einaudi, Torino 2000. Folli Anna, Penne leggère. Neera, Ada Negri, Sibilla Aleramo. Scritture femminili italiane fra Otto e Novecento, Guerini e Associati, Milano 2000. Forni Piera, Sibilla e Rina: l'Aleramo tra giornalismo e letteratura, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2006. Francesco di Sales e Giovanna di Chantal, Missione e spirito dell'Ordine della Visitazione di santa Maria, Città Nuova Editrice, Roma 2009. Franchini Silvia, Soldani Simonetta (a cura di), Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, FrancoAngeli, Milano 2004. Gentile Emilio, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1994. Giachery Paolini Noemi, Le mani tese di Dolores. I romanzi di Dolores Prato, Graphisoft, Roma 2008. Goetz Helmut, Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, La Nuova Italia, Firenze 2000. Gozzini Giovanni, Storia del giornalismo, Paravia Bruno Mondadori Editore, Milano 2000 Gramsci Antonio, Quaderni dal carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, III, Quaderno 19 (Risorgimento italiano) Id., L’Ordine nuovo, Einaudi, Torino 1954. Gregorovius Ferdinand, Diari romani, 1852-1874, a cura di A. M. Arpino, Avanzini e Torraca, Roma 1967. Grimm Herman, La distruzione di Roma, tradotta da C.V. Giusti, Loescher, Torino-Roma-Firenze 1886. Guarnieri Romana (a cura di), Don Giuseppe De Luca: tra cronaca e storia, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1991. 377 Guerricchio Rina, Storia di Sibilla, Nistri-Lischi, Pisa 1974. Insolera Italo, Roma fascista nelle fotografie dell’Istituto Luce, (con alcuni scritti di Antonio Cederna), Editori Riuniti-Istituto Luce, Roma 2001. Isnenghi Mario e Eva Cecchinato, Fare l’Italia: unità e disunità del Risorgimento, Utet, Torino 2007. Jannattoni Livio (a cura di), Roma sparita negli acquarelli di Ettore Roesler Franz, Newton Compton, Roma 1981. Lejeune Philippe, Il patto autobiografico, Il Mulino, Bologna 1986. Livi Grazia, Narrare è un destino: da Virginia Woolf a Karen Blixen, da Anna Banti a Dolores Prato, La Tartaruga Edizioni, Milano 2002. Livi Grazia, Lorenzini Niva, Mizzau Marina, Maraini Toni, Il timbro a fuoco della parola. Voci in dialogo con Dolores Prato, Città di Treia, Treia 2000. Lorenzetti Crepella, Architetture interiori: immagini domestiche nella letteratura femminile del Novecento italiano. Sibilla Aleramo, Natalia Ginzburg, Dolores Prato, Joyce Lussu, Franco Cesati Editore, Firenze 2008. Magnarelli Paola (a cura di), Donne tra Otto e Novecento: progetti culturali, emancipazione e partecipazione politica, eum, Macerata 2006. Mangoni Luisa, In partibus infidelium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del Novecento, Einaudi, Torino 1989. Mazzini Giuseppe, The Pope and the Italian Question, Londra, 1846-47, in Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini, Cooperativa Tipografico-Editrice Paolo Galeati, Imola 1906. Id., Discorso all’Assemblea costituente della Repubblica romana, 6 marzo 1849, in www.senato.it/documenti/repository/relazioni/biblioteca/scaffale_memoria/Mazzini_a_roma. Melosi Laura, Profili di donne dai fondi dell’Archivio Contemporaneo G. P. Vieusseux, Edizioni di Storia e Letteratura-Università degli studi di Firenze, Roma-Firenze 2001. Morino Alba (a cura di), Diario di una donna. Inediti 1945-1960, Feltrinelli, Milano 1978. Munoz A., Roma di Mussolini, Treves, Milano 1935. Murialdi Paolo, Storia del giornalismo italiano, Il Mulino, Bologna 2000. Id., La stampa italiana dalla Liberazione alla crisi di fine secolo, Editori Laterza, Roma-Bari 2003. Nathan Ernesto, La terza Roma, in “Nuova antologia”, 1 agosto 1916. Id., Scritti politici di Ernesto Nathan, a cura di Anna Maria Isastia, Bastogi, Foggia 1998. 378 Palombarini Augusta, Storie magistrali. Maestre marchigiane tra Otto e Novecento, eum, Macerata 2009. Ead., Lo scandalo dell’alfabeto. Educazione e istruzione femminile nelle Marche tra Otto e Novecento, Affinità Elettive Edizioni, Ancona 2004. Parpaglioni Edo, C’era una volta Paese sera. L’avventura di un giornale diverso, Editori Riuniti, Roma 1998. Pennacchi Antonio, Fascio e martello: viaggio per le città del duce, GLF Editori Laterza, Roma 2008. Pianciani Luigi, La Roma dei Papi, Edgardo Perino, Roma 1892. Pisano Laura (a cura di), Donne del giornalismo italiano. Da Eleonora Pimentel a Ilaria Alpi: dizionario bio-bibliografico secoli 18-20, Franco Angeli, Milano 2004. Prato Dolores, Giù la piazza non c’è nessuno, a cura di Giorgio Zampa, Quodlibet, Macerata 2009. Ead., Le Ore, a cura di Giorgio Zampa, Adelphi, Milano 1994. Ead., Le mura di Treia e altri frammenti, a cura di Giorgio Zampa, Edizioni Città di Treia, Treia 2000. Ead., Interno Esterno Interno, Edizioni Città di Treia, Treia 1996. Ead., Campane a Sangiocondo, a cura di Noemi Paolini Giachery, Avagliano Editore, Roma 2009. Ead., Scottature, Quodlibet, Macerata 1996. Ead., Sogni, a cura di Elena Frontaloni, Quodlibet, Macerata 2011. Scaramuzza Emma, La santa e la spudorata. Alessandrina Ravizza e Sibilla Aleramo. Amicizia, politica e scrittura, Liguori Editore, Napoli 2007. Serao Matilde, Il ventre di Napoli e altre storie, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2005. Stefanile Mario, Labirinto napoletano: studi e saggi letterari su scrittori di ieri e di oggi, ESI, Napoli 1958. Severi Stefania, L’essenza della solitudine. Vita di Dolores Prato, Sovera Editore, Roma 2002 Id., Dolores Prato. Voce fuori coro. Carteggi di una intellettuale del Novecento, il lavoro editoriale, Ancona 2007. Susmel Duilio, (a cura di), Opera omnia di B. Mussolini, La Fenice, Firenze 1951-1963. Vannelli Valter, Roma, architettura. Da città dei papi a capitale d’Italia, Edizioni Kappa, Roma 2001. Vidotto Vittorio, Roma contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2001. 379 Id., (a cura di), Roma capitale, Laterza, Roma-Bari 2002. Id., I luoghi del fascismo a Roma, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, n.2/2005. Willson Perry, Italiane. Biografia del Novecento, Editori Laterza, Roma-Bari 2011. Woolf Virginia, Le donne e la scrittura, a cura di Michèle Barrett, La Tartaruga edizioni, Milano 1990, (trad. it. di A. Bottini). Id., Momenti di essere. Scritti autobiografici, La Tartaruga edizioni, Milano 1977, (trad. it. di A. Bottini). Id., Ore in biblioteca e altri saggi, a cura di Paola Splendore, La Tartaruga edizioni, Milano 1991. Zambon Patrizia, Letteratura e stampa nel secondo Ottocento, Edizioni dell'Orso, Alessandria 1993. Zancan Marina, Il doppio itinerario della scrittura. La donna nella tradizione letteraria italiana, Einaudi, Torino 1998. Zanetti Daniela, Istantanee allo specchio. Bibliografia di Sibilla Aleramo giornalista, in «IG. Informazioni», II, n. 4, 1991. Zola Emile, Le ventre de Paris, Fasquelle, Parigi 1997. Fondi archivistici Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze, Archivio contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, Fondo Dolores Prato, serie Pg 1-143 (Articoli); Pm 1-41 (Roma capitale d’Italia). Fondo privato Ferri-Ferrari, Roma. Istituto Gramsci, Roma, Fondo Sibilla Aleramo. Comune di Treia, Accademia Georgica. 380
Scarica