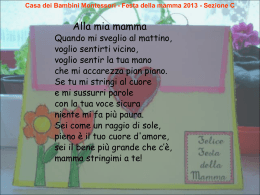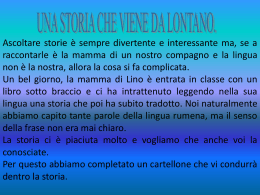FLAVIO PAGANI LAPSUS © I sognatori, Lecce ISBN 978-88-95068-04-6 Per contattare la casa editrice I sognatori, consultare il sito internet: www.casadeisognatori.com e il blog: casadeisognatori.splinder.com In copertina: disegno di Francesca Santamaria lapsus by casa editrice I sognatori is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License. Ogni riferimento puramente reale è meramente casuale Un particolare grazie a Giovanni Orelli, Alberto Panicucci, Maria Vispa, Francesca Zocchi e Anna Martelli. Dedicato a tutte le piccole donne e i piccoli uomini veri che varcano file, semafori e mari d’asfalto della realtà quotidiana, senza pugnalare alle spalle, armati solo della forza delle idee e degli ideali. INTRODUZIONE Anche in questo romanzaccio, come nel mondo, niente capita a casaccio, nemmeno un ago conficcato in una gomma. Neppure il chiodo fisso di una fantasia confitta in testa, neanche una gomma da masticare appiccicata sotto una suola o una pugnalata tra le scapole. Eppure, ogni dettaglio di questo libraccio ci permette di evadere dal caos. Persino dall’ingorgo tra Corso Buenos Aires e Via Leoncavallo delle cinque e mezza del pomeriggio. Per concentrarci meglio sugli indizi delle atrocità, o sulle tracce dei ritornelli, su cui é imbastita questa storia male… detta, ecco che devo chiederti di leggere tra le righe, esplorare cioè nel bianco che c’è tra una falsariga e l’altra. Prova quindi per un momento, breve come un tuffo nell’abisso, a lanciarti nel fondale vuoto di una pagina vuota. Aspetta che la macchi una stilla azzurra, vomitata da un calamaio, o una goccia scarlatta, sputata da un’arteria. Insomma, prima di rivelarti il volto dell’assassino protagonista di questa storia e i suoi errori, devo cercare, almeno per un paio di pagine, di condurti oltre via dei Fiori Chiari e la via Gluck. Al di là di quel candore, di quella purezza rifranta dal bianco. CAPITOLO 1 Ritrovamento delle modalità d’abuso del lapsus in fabula Tutte le storie iniziano da questo vuoto apparente, tinto di bianco, da questo spazio libero: Allora? Riesci a scorgerlo? È quello di un foglio, prima che lo macchi una goccia di nero fumo, di seppia, d’indaco… o di sugo al pomodoro, d’inchiostro carminio o di sangue. Se ti sei voltato a testa in giù per decifrare queste righe rivoltate, prima che siano pure rivoltanti, è meglio che torni a raddrizzare il libro e ad orientarti in una retta… prospettiva. Qui siamo a Sud delle Alpi, tra porta Lodovica e porta Garibaldi, e la prossimità con le spume del Mediterraneo ci porta a ravvisare — in un capoverso vuoto — una distesa bianca di sabbia. Se in questo fondale latteo scorgessimo una macchia rossa, potremmo ravvisarvi un’oasi di colore, un lago di fuoco visto dalla luna, una manciata di crepuscolo. Potremmo riconoscervi la pupilla di un demonio, una goccia distillata da un miocardio spremuto come un’arancia, uno zampillo di una ciliegia rubata dal giardino del re. Eppure, il bianco sembra chiudere ogni spiraglio di senso, a nulla vale sussurrare o urlare “apriti sesamo” e lo scenario si ostina a restare candido. Ora, il bianco di questo foglio sembra aprire un vuoto arido come il deserto, ma quando uno schizzo di cervello avrà macchiato la pagina, allora rimpiangerai il lindore di questo capoverso sgombro d’ideo… o di pittogrammi. Stai ancora sgranando gli occhi senza scorgere una goccia d’inchiostro simpatico o un pixel di senso? Se saprai gettare la tua pupilla, come una pallina da golf, al di là di via Anfiteatro, oltre questo scenario di carta apparentemente deserto, potrai vedere trasparire dalla filigrana alcune bollicine… bianche, ed inquadrare un coccio di senso. Potresti tastare, schiacciare la pagina e spremerne ebbrezza o liquore, come da un babà. Ma per il momento questo foglio non trasuda inchiostri di quelle verità che ci svelerà un mostro, forse più diabolico di quello che abitava al numero 3 di Corso di Porta Romana, ma la cellulosa lascia trapelare soltanto sudore e tralucere solo un bianco desolante. Lo stesso bianco che spargevano in questa città gli untori. No, non stropicciare, non esplorare questa pagina a tastoni, ma solo con i fari antinebbia del tuo sguar- do. Cattura il mistero di un tesoro bianco, celato da una manciata di sabbia candida o gli orrori nascosti in un pugno di candore arido come il sale, il sale di un mare misterioso che sommerge una polena scolpita nelle paronomasie, nell’ultima darsena di una città che ha scordato i contatti con l’Adriatico. Se il tuo occhio è caduto sul foglio, riprenditelo pure, prima che il bianco lo inghiotta con un morso. Scorgi una delle bollicine che intrappola l’aspirante protagonista? Non accostare troppo lo sguardo alla pagina e non sbuffare, perché il tuo respiro potrebbe far deflagrare una di queste bolle… rivelando già uno degli orrori su cui è intessuta la realtà e pure quella porzione di mondo che descrive questo romanzo di sgomenti. Facciamola breve, perché non hai tempo da perdere, perché hai magari l’auto parcheggiata in divieto in via Manzoni, o il numero del biglietto con cui ti sei posto in fila sta per essere chiamato: facciamo finta che abbia scorto davvero una bollicina e poi ancora un’altra, fino ad incorniciare un dedalo di schiuma. Aspetta, guarda bene la nube, anche se non l’hai inquadrata davvero, anche se il grigio di questa metropoli già la sta risucchiando. Dimentica il vigile che si avvicina alla tua vettura in doppia fila in via Garibaldi, armato di taccuino. Osserva attentamente questo nembo, come se vi si celasse un ufo e scoprirai quello che ancora manca a questa storia: delle mani, dei polsi, delle braccia, persino dei piedi. Finalmente, è apparso all’orizzonte il profilo di una specie riconoscibile: un corpo umano. No, non è un corpo mutilato, non è un cadavere: quello arriverà solo in seguito, con ferocie che ci faranno rimpiangere il lindore di una pagina vuota. Si tratta di un essere vivo. No, il volto del protagonista non traspare ancora, rimane celato dietro un velo, bianco, di candide bollicine. Ecco, finalmente hai rinvenuto dei cerchi. Questa storia, infatti, non segue le rette di un quadrato, ma le linee curve di un cerchio dove tutto, anche il più insignificante particolare, è destinato a tornare e a caricarsi di senso, persino un volto strappato e gettato nel pruneto di un parco o nella selva umana di un marciapiede. Se il tuo sguardo ha osato abbastanza, potrai discernere un cumulo di bianco, di candide bolle d’aria, di gas o di fantasia, da cui emergono due braccia. Ma come diavolo si può pretendere che qualcuno creda all’esistenza di una minuscola nuvola munita di braccia? Eppure, accidenti, questa storiaccia esordisce proprio così, con una piccola mostruosità. Devi solo aspettare un attimo che il velo bianco, che ammanta questo essere bizzarro, venga dissolto da un soffio di vento o da una zaffata di smog emessa da qualche aereo di passaggio. La piccola creatura, grazie a cui s’innesca questo racconto, nuotava in un’effervescenza di bollicine bianche, galleggiava ormai da tanto tempo che la punta delle dita si era raggrinzita. I suoi piedi erano minuscoli, eppure sommuovevano frangenti che sfioravano quel bordo di mondo denominato “orizzonte”. Il bambino ondeggiava su una spuma profumata come il sapone, chiudeva gli occhi e uno zefiro sospingeva la sua vela maestra oltre i cavalloni. Il fanciullo si librava su una schiuma candida come un cirro in un cielo azzurro. Ecco, con le sue braccine si era aggrappato ad una nuvola che volava al di sopra dei lampioni, oltre la torre del Filarete, l’Arco della Pace, oltre quel campanile dei Carmelitani che si elevò ad altezze astronomiche e fu il più alto della città, prima di essere abbattuto per far spazio a piazza Missori. Il fanciullo si alzò ancora, si elevò anche al di sopra della torre Velasca, del grattacielo Pirelli e del “fregacielo” elicoidale in costruzione, fino a rasentare la cima dei cipressi, dei platani, dei salici del parco… Il bimbo lambì un aquilone, un piccione, un corvo, una rondine, un enorme pallone aerostatico, uno stormo di barboni, di clochard che volavano, aggrappati ad una scopa di saggina. Trapassò una nube e raggiunse un paperotto gonfiabile di plastica issato dal vento, ma un angelo in carne ed ossa rimosse il tappo. Una donna premurosa svuotò la nube e la mongolfiera. La mamma sgonfiò tutto, persino il papero di plastica e il sogno… e ricondusse il fanciullo sulla superficie terrestre, dove regnavano le leggi della forza di gravità: <Forza amore, è ora di abbandonare la vasca! Dobbiamo uscire di casa! Oggi c’è il sole: non c’è nemmeno una nuvola!> La donna sollevò il tappo della vasca da bagno, avvolse il figlio in un morbido asciugamano bianco e liberò un soffio, uno sbuffo di vento caldo che asciugò i capelli. <Mamma non possiamo uscire di casa: ho ancora l’acqua in un orecchio!> La madre lo rassicurò: <Non fa niente: basta che tu tenga l’orecchio coperto con la tua bella cuffia di lana!> Allacciò l’ultimo bottone del cappotto del piccolo e gli sorrise: <Allora, sei pronto per uscire? Vero che non hai paura?> Non era facile camminare su uno stretto marciapiede brulicante di gomiti che corrono per raggiungere il lavoro… per una piccola donna che guidava un trabiccolo. Il fanciullo sussultò: <Guarda, guarda! Stanno calpestando una donna! Quel tizio con i pennelli in mano la sta soccorrendo, ma da solo non riesce a rianimarla!> La mamma rassicurò il bambino: <Tranquillo: la donna a terra è soltanto una madonna e il tipo che la sta curando è solo un pittore, un madonnaro che vuole infonderle colore!> Il figlioletto pretese comunque che il passeggino non calpestasse l’effigie della santa madre. La mamma con il passeggino si ostinò ad avanzare nel pruneto di braccia, piedi, gomiti. A volte, rapita da un raptus, avrebbe desiderato conquistarsi un passaggio nella ressa a colpi di scimitarra. In un arrembaggio, come Jolanda, la figlia del corsaro nero. Altre volte, quando la sua rabbia era più contenuta, avrebbe voluto pilotare un carro falcato e aprirsi un varco in quell’am-masso di carne. Non era semplice procedere, senza un carro armato, su un angusto marciapiede pullulante di braccia che sgomitavano per arrivare al lavoro. Era come seguire, senza salvagente, un torrente in piena, parallelo ad un altro che scorreva in senso contrario: insomma, due torrenti di decine di pedoni frettolosi… D’altra parte, è strano parlare di fiumi in una città che non ne ha. Tutti i borghi lontani dal mare, infatti, hanno almeno un ruscello che vi scorre in mezzo. Questa città, invece, si muove attorno a fiumi di gente che fluttuano in meno di due metri di asfalto, talvolta in un metro solo. Camminare sul marciapiede sarebbe potuto sembrare facile o persino banale, se a farlo non fosse stata una donna minuta con un bambino. Il piccolo avrebbe potuto benissimo procedere sulle sue gambine, ma col rischio di essere travolto o urtato dalla fiumana; sarebbe stato scaraventato oltre il marciapiede, sulla strada, dove sfrecciavano dei mostri metallici che avevano ormai risucchiato l’anima dei loro proprietari: viaggiatori che si erano fusi come i centauri in un essere, per metà auto e per metà uomo, che dai polmoni eruttava smog. La mamma dovette allora riporre la sua piccola creatura in un passeggino, occupare così quasi due corsie dell’affollato marciapiede e attirarsi gli sguardi inviperiti dei pedoni. Ogni giorno, su quel maledetto marciapiede, la donna con il passeggino si attirava i soliti rimproveri e improperi dei passanti. Avrebbe voluto balzare su una scopa e decollare, sfrecciare oltre i pinnacoli della cattedrale gotica, ma le magie si compiono solo negli spettacoli cinematografici o nelle fantasie epifaniche calzate da un bambino. Un pomeriggio, presso porta Venezia, un giovane con il cappello da basket smise di cincischiare con il “game” del suo cellulare e le brontolò addosso: <Accidenti, si- gnora, faccia largo, che noi dobbiamo andare a lavorare!> La donna osò rispondere: <Già, perché prendersi cura di un bambino non è anche quello un lavoro?> Un frettoloso signore con la coppola chiosò: <Ma lei non si occupa di suo figlio per soldi e quindi, se non è pagata, non svolge alcun lavoro!> La madre replicò: <Io e suo padre i soldi per pagare una colf o un asilo nido non li abbiamo!> Una donna con il foulard la rimproverò: <Insomma signora, non potrebbe farlo camminare questo bambino! > La mamma la fulminò con lo sguardo: <Sto appunto portando mio figlio al parco, proprio per farlo correre con le sue gambe!> A questo punto il piccolo avrebbe bramato cancellare tutto il marciapiede con una gomma e tornare proprio a quel bianco iniziale da cui eravamo partiti con tanta fatica. Il fanciullo avrebbe voluto stringere la colomba dei desideri, perdersi nelle sue piume nivee e chiudersi nel candore di quella nuvola da cui era decollato questo racconto. Ma no, il bimbo non intendeva ricadere nel bianco di una pagina vuota, ma solo tornare raggomitolato nella candida porcellana di una vasca da bagno, traboccante di bollicine nivee, riempirsi i polmoni di aria e gonfiare il suo paperotto. <Che fai piccolo? Sogni o dormi e basta?> Eppure la realtà lo riportò lì, in quel marciapiede dominato dalla forza di gravità; o solo dalla forza, o dalla gravità e basta. La mamma evitò una gomitata nello stomaco di un passante con la cravatta firmata, riparandosi con il manico della carrozzina. Un venditore ambulante le offrì un pacchetto di nivei fazzoletti: la madre li fissò e sperò di perdersi nel bianco, nel desolante, ma quieto vuoto di un quadratino di carta immacolato in attesa di una lacrima. Ma l’urto di un ragazzo con il gameboy la catapultò di nuovo nella realtà, su quel marciapiede brulicante di carne e gomiti. <Tenga signora — le disse il venditore dagli occhi a mandorla — tenga pure i fazzoletti: glieli regalo!> La mamma guardò stupita quel mercante gentile che si allontanava sommerso dalla marea umana, inforcò di nuovo la carrozzina e riprese la sua gimcana sul marciapiede asfaltato dall’affanno. Poi passò un vecchio che spingeva un carrello della spesa e si attirò tutti gli odi della folla, permettendo alla mamma con il suo trabiccolo di procedere indisturbata sul marciapiede. In quella desolazione di catrame e cemento si sarebbe aperta una chiazza di rosso che nessun fazzoletto avrebbe potuto prosciugare. No, non sarebbe stato un arabesco di sangue, non ancora: sarebbe stato un fiore amaranto smarrito in una macchia di verde, da cui la metropoli non sarebbe riuscita a pulirsi. Ma la madre non presagiva ancora nulla della macchia che l’attendeva, per cui lo sfondo, su cui si scriveva la sua storia, restava bianco, proprio come il fondale di questa pagina. Tutti i pomeriggi, la mamma con il passeggino arrivava in un’oasi di pace, dove si percepivano solo in lontananza vetture che urlavano e automobilisti che lanciavano versi simili a clacson. Giunta tra i pioppi, i platani e le aiuole, la madre poteva finalmente liberare i suoi pensieri e il figlio… sedersi sfinita su una panchina, sotto un cedro. Raccomandava sempre: <Non allontanarti troppo, rimani a portata di vista!> e intanto sfogliava una rivista, mentre il fanciullo esplorava le macchie… di verde. <Cosa fai, piccolo? Cosa cerchi per terra? Se cerchi la traccia di una favola, vieni qui che te ne racconto una io!> Il bimbo si girò e vide un anziano signore che lo invitava a sedersi accanto a lui sulla panchina. Che tizio strano: era vecchio, ma aveva un baffo nero ed uno biondo. Il suo aspetto era reso ancora più inquietante da una benda nera sull’occhio. La mamma gli aveva spiegato che il parco era infestato da barboni alcolizzati. Il piccolo restò a distanza e chiese: <Sei ubriaco?> Il vecchio si toccò il baffo biondo, sorrise e sussurrò: <E sì, mia moglie mi diceva sempre che le peggiori sono le sbronze d’inchiostro delle storie che racconto! Ma permettimi di rivelarti una favola.> Il bimbo gli si avvicinò, senza osare sedersi, lui si sistemò la benda sull’occhio e mormorò: <C’era una volta uno scrittore di nome Emilio Salgari, disprezzato dai critici letterari, che viveva in una città resa famosa dal racconto inventato da uno scrittore di farse che viveva sulla riva di un fiume del Nord.> Abbassò la voce e costrinse così il bambino, per sentirlo, ad avvicinarsi ancora di più a quello strano megafono sormontato da quei buffi mustacchi. L’anziano si toccò i baffi e bisbigliò: <E anche Salgari divenne celebre tra i ragazzi non per gli arcipelaghi che conquistò, ma per le pozzanghere d’inchiostro che navigò... restando a mani vuote: quando se ne rese conto gli crollò il mondo addosso> Il piccolo si sedette accanto al vecchio e lui continuò: <Ma a noi non è nota la sua triste storia, bensì la sua favola: “C’era una volta un pirata che voleva sposare una principessa e vivere isolato con lei sull’isola di Mompracem”> In lontananza si udì la madre che chiamava il figlio: <Caro, dove sei, che è un po’ che non ti vedo?> Il vecchio si accarezzò il baffo nero e si affrettò a narrare. Il racconto fu interrotto dalla madre: <Piccolo cosa fai? Parli con un estraneo? Mi scusi, ma con i tempi che corrono non posso permettere che il bimbo si intrattenga con uno sconosciuto!> Se la donna avesse soltanto lasciato aprire bocca al cantafavole avrebbe capito molte cose. Ma, sopraffatta dal timore, la madre prese il piccolo per mano e lo trascinò via: <Adesso, amore, torni vicino a me e non ti allontani oltre cinquanta metri!> La madre avrebbe voluto guidare il suo cucciolo in un parco recintato e vietato ai comuni mortali, come quello del conte Manomorta, o condurlo al sicuro in un prato interdetto ad anima viva, come quello dell’antico anfiteatro romano, ma si ricordò di essere comune, pure mortale e per giunta ancora dotata di un’anima, viva. Ogni volta, la mamma raccomandava al bimbo di non raccattare nulla e sempre, quando risalivano sull’autobus, il figlio recava sul passeggino pigne, margherite o quadrifogli che rimirava nella sua stanzetta come tesori, fino a quando le palpebre si facevano pesanti e si addormentava. Un pomeriggio il piccolo raccolse un brandello di un foglio molto strano. Era il frammento di un papiro. <Ce l’ho buttato io!> Il bimbo si voltò e rivide il vecchio con cui la madre gli aveva proibito di parlare. Il piccolo non poteva sbagliarsi: era proprio lo stesso strano tizio dell’altra volta: non vi erano in città molti altri individui con un baffo nero ed uno biondo e una benda sull’occhio! Il piccolo osservò: <Non si buttano carte per terra!> Il vegliardo si accarezzò i baffi e replicò: <Ho buttato apposta quella carta perché la raccogliessi tu!> Gli fece cenno di tacere e con un gesto lo invitò ad avvicinarsi. Il vecchio si lisciò il baffo nero e quello biondo e sussurrò: <Quel papiro riferiva di una favola che ti vorrei raccontare: “C’era una volta un principe che si lasciò guidare dal filo di una principessa, nel labirinto di un’isola, per uccidere un mostro, un essere semitaurino, o semiumano...” Ma poi la favola ha un rovescio della medaglia: “C’era una volta un’eroina che, dopo essere stata complice dell’uccisione del fratellastro e del tradimento del padre, venne piantata in Nasso dal suo eroe... finché non la prese con sé un dio, il dio della sbornia”.> Il bimbo camminava oltre aiuole di tulipani e di camelie, alla ricerca di un quadrifoglio o di un altro germoglio di fortuna, ma la madre lo sorvegliava senza posa, dall’ombra del suo cedro, con l’amorevole cura di un cerbero: <Cosa guardi per terra? Non mettere le mani nel prato che potresti pungerti con una siringa abbandonata! E non parlare con gli sconosciuti!> Un giorno il figlio, nonostante le raccomandazioni della madre, rinvenne tra le siepi di garofani qualcosa d’insolito: <Mamma, ho trovato un messaggio in una bottiglia!> <Amore, non toccare quella bottiglia che potresti tagliarti! Cosa fai? Tesoro, te l’ho detto mille volte che non devi raccogliere le cartacce da terra!> <Ma mamma, questa non è una cartaccia: è un messaggio, era dentro una bottiglia!> <Fammi vedere, piccolo mio! Ecco, visto? Sono le istruzioni e le modalità d’uso di uno psicofarmaco! Le avrà abbandonate qualche drogato!> <Ma mamma, perché erano in una bottiglia? Ti prego leggimele!> <Di solito i bambini chiedono alle madri di leggere favole!> obiettò lei, ma alla fine si accinse a decifrare quello strano messaggio: <In effetti c’è scritto qualcosa di strano…> Più volte interruppe la lettura, borbottando che si trattava di stupidaggini scritte da un pazzo, ma il bambino pretese che proseguisse fino alla fine. La madre stralunò gli occhi e borbottò: <“Istruzioni e modalità d’uso…” No, aspetta, c’è scritto “distruzioni”. Forse c’è un errore ortografico: manca un apostrofo.> DISTRUZIONI E MODALITÀ D’ABUSO DEL RAPTUS IN FABULA Attenzione, in questa storiaccia si mettono in scena mostruosità incredibili, tanto mostruose da essere indescrivibili. L’assunzione di questo romanzo è controindicato per chi ama narrazioni ricche di descrizioni e raffigurazioni doviziose di particolari: in questo brogliaccio luoghi e personaggi sono descritti in modo indefinito, per lasciare che sia il loro agire, o l’immaginazione dei lettori, a definirli. In questo brogliaccio, ricamato su errori orrendamente umani, siti ed anime sono rappresentati in modo tanto incerto, da lasciare indeterminato il loro nome: se quindi odiate una storia di anonimati, in cui sia un’innominata o un innominato a farla da padroni, evitate queste pagine equivoche. Questa miscela romanzesca è sconsigliata per coloro che non apprezzano la contaminazione delle favole con il fumetto o con il giallo, delle bellezze delle favole con l’horror del mondo reale, o l’innesto di code di pesce su donne bellissime, o di orchi e altri mostri nella realtà dei lettori. Insomma evitino questo libraccio coloro che non provano gusto a sviscerare i lupus, i lapsus e i raptus di fantasia che si celano nella realtà… La sperimentazione su cavie umane ne ha provato un effetto ipertensivo, ipotensivo, cardiotonico, con influssi positivi anche sul diaframma, sull’ipofisi, sulle ghiandole surrenali... L’assunzione di questo incastro di racconti è incompatibile con chi non crede nel potere della scrittura creativa, nella contaminazione delle grafie con le rime, nella confusione delle metafore con le consonanze, nella fusione delle raffigurazioni reali in quelle riflesse, o nelle immagini fantastiche, o negli echi del “C’era una volta”. Questo libretto è assolutamente controindicato per coloro che pretendono di viaggiare soltanto su aerei senza ritardi, su autostrade rettilinee senza rallentamenti, o su treni semivuoti con l’aria condizionata... insomma a coloro che non sanno adeguarsi agli imprevisti. Il canovaccio seguito dal romanzo s’inerpica, sprofonda e si contorce in cerchi di mostruosità, gorghi di delittuose grafie, gerghi, ghirigori di anagrammatiche consonanze, non su una linea retta. In questa contorsione, il filo del racconto si attorciglia spesso sul collo di più di una vittima, producendo raccapriccianti delitti, uccidendo innocenti, mostri, massacrando persino amanti dei gialli o delle favole, per cui si sconsiglia il libro ai deboli di cuore… e di stomaco. Si sconsiglia vivamente questo atipico romanzo a tutti coloro che non hanno mai creduto nell’esistenza dei draghi, di Medusa, di Giano, di Ecate, delle streghe, delle sirene, di Cappuccetto Rosso, di Heidi... di altri mostri di cattiveria, di bruttezza o di bontà e che rinnegano di avervi creduto. Si guardino da questo libraccio tutti coloro che credono che il paese delle favole sia un’isola a sé stante e non una metafora viva del mondo in cui viviamo. Se volete giocare un brutto tiro ad un individuo qualsiasi delle categorie per cui questo romanzo di favole è controindicato... allora rapitelo per un giorno, legatelo, imbavagliatelo e costringetelo a sfogliare questi gialli. E, se la vittima si chiude apposta gli occhi, allora leggete per lui... e continuate, senza pietà, nonostante le sue smorfie, a infliggergli queste favole! Il bimbo era incredibilmente incuriosito da quelle indicazioni: <Dai mamma, dobbiamo rintracciare le favole di cui parla questo messaggio… e poi catturiamo qualcuno di antipatico e gliele leggiamo! Posso andare a frugare dietro quei cespugli?> <No, non voglio che vada in posti nascosti!> <Mamma un giorno mi dovrai fare attraversare il bosco per portare una focaccia alla nonna!> <Tu non sei Cappuccetto Rosso!> <Appunto, mamma! E tra quei cespugli non ci sono i lupi! Insomma, cosa c’è di pericoloso in qualche pagina di favole?> <Tra le cartacce potresti trovare una siringa! No, caro, non insistere!> <Mamma, starò attento! Sono piccolo, ma non stupido!> <Ti ho detto di non intestardirti!> <Mamma voglio cercare queste favole!> <Piccolo mio, se vuoi leggere delle fiabe, andremo a comprarne in una libreria!> <Ma mamma, queste sono più originali, queste favole non si trovano in nessun negozio!> <Ecco, se insisti torniamo subito a casa!> Il bambino s’incaponì… e la mamma obbligò il figlio a rientrare in anticipo a casa. Il piccolo si avventurò in una fuga impossibile tra le aiuole. La mamma lo rincorse, imprecando per un collant impigliato tra le rose. Il bambino si issò su un faggio, ma la madre lo agguantò per un polpaccio: <Se continui così, non ti porterò mai più al parco!> La donna afferrò il figlio per la mano e lo trascinò verso casa. <Mamma, mi fai male!> Lo costrinse ad entrare su un tram gremito di gente: immaginatevi il disappunto dei passeggeri quando si avvidero che la madre aveva con sé un passeggino. La donna si fece scudo con il passeggino… e si conquistò un posto a sedere. Mentre il tram li riportava verso il loro quartiere, il bimbo teneva una mano in tasca. La mamma capì subito che celava qualcosa. <Amore, cosa hai in tasca? Non ci credo che non hai niente! Fammi vedere cosa hai nascosto! Ecco, lo sapevo, hai raccolto una cartaccia nel parco!> <No, mamma ti prego, non stracciarla! È solo un pezzo di carta! Dai, leggimelo! Se ci troverai qualcosa di brutto smetterai subito di leggere!> I passeggeri reagivano indispettiti ai capricci del piccolo. La donna provò a dirgli: <Zitto, che dai fastidio alla gente!> Ma il fanciullo si mise a schiamazzare, in modo sempre più acuto, tanto che la madre, per zittirlo, capitolò e si accinse, sbuffando, a bofonchiare un racconto. CAPITOLO 2 Il gigante dalla testa mostruosa La carrozza era stipata di gente, più gremita del Rocket o di una sala d’attesa del Fatebenefratelli, traboccante di una moltitudine che sembrava fondersi nell’unico corpo di un solo mostro da cui spuntavano tante teste, borse, valigette e persino delle baguette di chi aveva appena fatto la spesa. Quell’ammasso di carne umana aveva un aspetto quasi bestiale: da quell’intrico di gambe, nasi, occhi, orecchie, braccia, cellulari emergevano persino delle zampe e una coda. Il bimbo notò che un signore con la coppola portava in braccio un piccolo cane, un volpino. Salì sul vagone un violinista ambulante: provò ad inforcare il suo strumento e a liberare una melodia, ma l’angusto spazio lo costrinse ad urtare con l’archetto la testa di un giovane con il cappello da basket e sfiorò l’occhio di un signore con la cravatta firmata, che tentava di portare il cellulare all’orecchio, accanto ad un uomo in tuta blu che si affannava per vedere dal suo videotelefono, la telecronaca di una partita di calcio… Il violinista causò nella carrozza un tamponamento a catena che provocò la reazione stizzita dalla folla, che lo spintonò fuori alla prima fermata. Un ragazzo si affannava a giocare col gameboy incluso nel suo telefonino, ma era troppo stretto per muovere agevolmente i pulsanti; allora un anziano vicino lo aiutava ad azionare uno dei tasti e lo incitava ad affrettarsi: <Dai, sbrigati a finire questa maledetta partita, che stai esaurendo le batterie!> Il giovane uomo col berretto da basket ne approfittò per mordere indisturbato la baguette di una grassa signora con il foulard, a cui il signore con la coppola borbottò: <Con la sua mole, dovrebbe obliterare due biglietti!> La signora lo squadrò e mugugnò: <Anche il suo cane dovrebbe pagare la corsa!> Il bambino non voleva aspettare di attraccare a casa: <Dai mamma, leggimi la favola!> La madre esitava e rispose: <Ma ci sentiranno tutti!> Il figlio la incoraggiò: <Leggi sottovoce!> Poi il fanciullo s’interruppe per osservare qualcosa d’insolito che si stava compiendo nel tram. L’intrigo di teste e membra dei passeggeri era tale che un borseggiatore, mascherato sotto l’aria di un distinto signore in cravatta firmata, rubò un portafoglio e un cellulare. No, l’avvenimento insolito non era costituito da questo ennesimo furto, ma dal fatto che il ladro, confuso dalla calca, ripose per sbaglio la refurtiva nella tasca di un ignaro passeggero. Il piccolo provò a rivelarlo alla madre. <Mamma, quel signore in giacca e cravatta è un ladro!> La madre non poté credere che un signore così elegante fosse un borsaiolo e si sforzò di distrarre il figlio: <E va bene, ti leggerò la favola!> Impugnò il foglio, aggrottò le ciglia e si accinse a raccontare: <C’era una volta un gigante con una testa abnorme…> Ma la madre dovette interrompersi suo malgrado: <Guarda che io leggerei pure questa favola… ma il foglio è troppo sbiadito. L’inchiostro è stato rovinato dalla pioggia e in alcuni punti non riesco proprio a decifrare cosa ci sia scritto!> Il figlio scosse il capo: <Fa niente! Leggi lo stesso!> La madre incominciò a leggere… e, nelle parti in cui i suoi occhi non giungevano, procedette a naso colmando i buchi della storia con la sua immaginazione. Mentre narrava, tutti i telefonini tacevano: pareva che li avessero spenti apposta… Insomma, sembrava che tutti i passeggeri, compreso il cane, tendessero l’orecchio per ascoltarla. Persino il ragazzo col gameboy interruppe la sua partita, anche se forse aveva solo esaurito le batterie. LA FAVOLA DEL GIGANTE DALLA TESTA MOSTRUOSA <C’era una volta un gigante con una testa orrenda. Ciò che rendeva mostruoso quel cranio non era la sua enorme dimensione, che era proporzionata con il resto del corpo titanico, ma un particolare dello sguardo: aveva un occhio solo! Qualcuno riterrà che avesse perso l’altra pupilla in un incidente o che il colosso avesse preso parte a qualche guerra, magari con i pirati, dove era normale restare orbi, colpiti da un’archibugiata o da un fendente, soprattutto nelle risse ai semafori. In realtà, quel- l’omaccione non aveva mai avuto un secondo occhio: lo si poteva intuire ad esempio dall’assenza di un secondo sopracciglio… e da un altro particolare più inquietante. Quando varcava la frontiera, i doganieri rigiravano la sua carta d’identità più volte, prima di capire come e dove guardarla. L’unico globo oculare, di cui era stato provvisto sin dalla nascita, era incastonato in mezzo alla fronte, poco sopra il naso. Il ciclope viveva in una grotta buia senza mai uscire alla luce, nemmeno per fare shopping.> Il bambino chiese: <Perché non andava fuori? Non voleva vedere il mondo?> La madre abbozzò una spiegazione: <Forse non si esponeva al sole, perché aveva già visto il mondo. Ma io credo che volesse guardarlo unicamente nei suoi sogni! In ogni caso lui non aveva scelta, dato che era cieco! Il gigante non vedente viveva vendendo, in cambio di cibo, i racconti dei propri sogni ai pellegrini che si recavano nella sua spelonca.> Il fanciullo domandò ancora: <Ma perché era cieco?> La mamma cercò di esaudire la sua curiosità: <Quando nacque, Polifemo, cosi si chiamava il colosso, poteva percepire luci e colori… ma da un occhio solo!> Il bimbo opinò: <E allora? Che problema c’era? Uno può benissimo vedere da una sola pupilla!> e intanto si coprì un occhio con una manina. La madre tentò di chiarire il mistero <Ti sei mai chiesto perché siamo provvisti di due occhi quando ce ne potrebbe bastare uno? In realtà con ciascun occhio guardiamo le stesse cose, ma da un punto di vista diverso: attraverso una pupilla percepiamo il bene e attraverso l’altra il male.> Il fanciullo si stupì: <Ma allora il gigante poteva vedere solo il bene o solo il male!> La madre continuò: <L’omaccione scelse di scorgere solo il male e visse nutrendosi di prede umane! Divorava tutti gli uomini che incontrava! Che ci vuoi fare, era fatto così: era il suo modo di conoscere qualcuno senza separarsene. Non lo faceva per cattiveria, dato che non conosceva il bene e non era consapevole della contrapposizione con il male. Il gigante visse di cannibalismo, finché un giorno ospitò Ulisse, l’uomo più astuto del mondo. Dopo le presentazioni, il gigante volle approfondire la conoscenza e gli disse: “Ehi tu, piccolo, vieni qui che ti voglio divorare!” Ulisse, che non poteva contraddire la sua fama di furbo, fece finta di non sentire. “Ehi tu, nanerottolo: se sei ospite di qualcuno che ti ha invitato a pranzo, puoi anche rispondere quando ti si rivolge la parola!” Ulisse dovette dare una risposta: “Ah, stai dicendo a me? Scusa, ma pensavo che ti rivolgessi a qualcun altro!” Il colosso non si fece incantare: “E che, ti sembro strabico?” Ulisse fece il mortificato: “Potresti anche chiamarmi per nome!” Stavolta fu Polifemo a scusarsi: “Scusa ma… sai, questo nome, Nessuno, mi sembra strano!” Replicò Ulisse: “Certo che anche la tua dimora mi sembra bizzarra: come si può chiamare casa una grotta?!” Il ciclope si offese: “Che pignolo! Odio le persone che cercano le pagliuzze negli occhi!” Ulisse lo corresse: “Forse volevi dire che odi le persone che non vedono la trave nel proprio occhio?” Polifemo reagì sempre più irritato: “Volevo dire che non mi piacciono le persone che fanno di ogni pagliuzza una trave! E poi io non ho nessuna trave nell’occhio!” Ulisse, per il momento, preferì dargli ragione e, indovinando la sua antipatia, gli suggerì: “Se ti sono così indigesto potresti mangiarmi per ultimo”. Poi, però, quando il ciclope ebbe ingurgitato un paio dei suoi compagni, gli offrì un otre di vino. Sperava che così si addormentasse…> Un ragazzo con un cappello da basket interruppe il racconto della madre del bimbo: <Scusi se m’intrometto, ma non si può fare a meno di sentire! Posso chiedere che senso ha narrare una storia già nota a tutti? I giovani d’oggi hanno bisogno di storie nuove!> La madre rispose volentieri: <Io stavo proprio rivelando un aspetto nuovo di questa storia! Tutti sanno che Ulisse assalì Polifemo nel sonno e, con una trave, estirpò la sua unica pupilla! Ma non è noto a tutti che, proprio perché fu accecato mentre sognava, il gigante restò perennemente in contatto con il mondo dei sogni! Il titano perse la vista del mondo esterno, ma acquisì la capacità di scrutare i sogni degli altri! L’accecamento segnò profondamente la vita del ciclope regalandogli due benefici, o due malefici, secondo il punto di vista da cui si guarda. Da una parte il titano, privato di quell’occhio che gli permetteva di vedere solo il male, riuscì a percepire anche il bene… Dall’altro lato, avendo perso la vista durante un sogno, il gigante fu ancora in grado di guardare, ma solo attraverso le ciclopiche fotografie del sonno. Insomma, poté anche scorgere il bene, ma unicamente tramite i sogni!> <A questo punto, possiamo trarre un lieto fine dalla tragedia di un gigante accecato…> La mamma tossì, si schiarì la voce e procedette nei dedali della narrazione: <C’era una volta un gigante cieco che viveva in una spelonca buia senza mai uscire alla luce. Si dice che il colosso vedesse solo durante il sonno. Chi soffriva d’insonnia, si recava da lui, ascoltava i titanici racconti dei suoi fotogrammi onirici… e attraverso di essi recuperava la serenità necessaria per dormire.> Intervenne la signora con il foulard: <Scusate se m’impiccio dei vostri affari, ma non sono d’accordo! Secondo me, i sogni non aiutano solo a dormire… ma a vivere meglio anche quando siamo ad occhi aperti! Lo dicono persino in televisione!> Il ragazzo col berretto da basket si permise d’intromettersi: <Scusi se le faccio ancora una domanda, ma cosa raccontava di aver visto il colosso cieco?> La mamma allargò le braccia: <Guardi, a questo punto, la calligrafia diventa troppo vaga…> Un signore con la coppola volle dire la propria: <Ma, secondo me, se mi è consentito esprimere la mia opinione, il gigante diceva: “Ho visto un re!”> Ma un altro incredulo omuncolo con i baffi grigi insinuò: <Se la vist cus’è?! …> Iniziò tra i passeggeri, persino tra quelli che erano appena saliti sul tram, una gara per cogliere una fine della favola che piacesse di più al bambino. Il vegliardo con la coppola borbottò: <Manca una rima e un ritornello!> Quando giunsero verso il capolinea, l’anziano con la coppola enunciò la sua versione dell’ultimo racconto del gigante cieco: <La storia di Ulisse, il distruttore di Troia, prosegue con gli esuli della città data alle fiamme, fino a protrarsi in una nuova epopea: quella del gemello ucciso dal suo doppio, giustiziato dal fratello per aver varcato un confine!> Il bambino osservò puntiglioso: <Avevi promesso una rima e un ritornello!> Il vecchio si tolse la coppola, si grattò il capo e mormorò: <Trema Troia sulle torme in rima di un tormentato Omero. Trama Omero oltre il Mar di Marmara... Ammirando Omero, un ammiraglio rompe l’ormeggio e trae il suo timone al molo di Roma.> Ma il giovane con il berretto da basket non si lasciò incantare e obiettò: <Ma cosa diavolo ha visto o pretende di farci vedere? Queste cantilene sono solo delle ripetizioni di canzoni o ritornelli inventati da altri!> Il bardo ammise subito la sua colpa: <È vero! Io mi sono limitato a fare echeggiare miti passati! Ma in fin dei conti ogni narrare è solo un gioco di rimbalzi, di vuote immagini e d’echi! Totò diceva che “tutti sanno fare, pochi sanno copiare”! Io aggiungo che raccontare si basa sull’arte del duplicare, del giocare con il doppio, del copiare in modo creativo!> Poi la tenzone di racconti fu troncata da uno squillo. Per un attimo il ragazzo con il gameboy sperò che il suo aggeggio avesse ripreso a respirare. <E no! ― disse più dispiaciuto di lui l’anziano vicino che lo aveva aiutato a giocare ― è il solito telefonino che suona!> In effetti echeggiava un cellulare, ma si trattava di quello sbagliato. Era il telefonino che il borseggiatore aveva riposto, confuso dalla ressa, in una tasca non sua… Il derubato si accorse subito del furto, ma accusò la persona sbagliata. Il vero ladro finse di unirsi agli sguardi scandalizzati di tutti, sguardi che esponevano un innocente alla gogna. L’accusato, un signore con un vistoso riporto, si difese con la ferocia di chi é veramente privo di colpa. Gli onesti cittadini reagirono ancora più accanitamente: <Che faccia tosta! Come si può negare l’evidenza quando è stato colto con le mani nel sacco!> commentò ghignando il ragazzo con il cappello da basket: <D’altra parte, cosa vi aspettate che ammetta chi nega una calvizie così evidente?!> S’intromise il bambino: <Guardate che a rubare il cellulare è stato quell’uomo con la cravatta! Si è anche sgraffignato il portamonete!> L’uomo con la cravatta firmata si offese e pretese le scuse della madre. <Un momento ― suggerì la grassa signora con il foulard ― verifichiamo se il bimbo dice il vero: controlliamo che abbia il portafoglio!> La folla si divise tra chi accusava l’uno e chi accusava l’altro. Ne nacque un putiferio. Il signore con la coppola cominciò a ringhiare. No, era il suo cane, che giunse ad abbaiare. Il giovane con il cappello da basket ne approfittò per dare indisturbato altri morsi alla baguette della signora con il foulard. La madre si affrettò a trascinare il figlio fuori dal tram in subbuglio. <Ma mamma! Volevo sentire la fine della favola!> La donna accomodò il figlio nel passeggino sentenziando: <Ci può essere un fine, ma non esiste una vera fine della favola!> L’indomani il fanciullo scalpitò per tornare a tutti costi nel parco, anche se era nuvoloso e minacciava di piovere. Ecco, pensò la mamma, persino quegli uccelli neri dal lungo becco volano basso per paura della pioggia. La donna si sedette sulla panchina, sotto il gigantesco cedro, a sfogliare una rivista; intanto, con la coda dell’occhio sorvegliava il figlio. Il bambino giocava nel parco alla ricerca di altre favole… Improvvisamente, tornò di corsa dalla mamma. Di solito le recava una pigna, una foglia, una lumaca o un maggiolino, ma stavolta sembrava che avesse rinvenuto qualcosa di più particolare. Il piccolo era affannato, incuriosito e nel contempo allarmato: <Mamma, mamma, ho trovato tra i crisantemi una testa!> La madre era convinta che si trattasse di una statua decapitata da qualche vandalo: <Strano che ci siano dei crisantemi in un parco. Lascia stare quella testa, prima che diano la colpa a te!> <Ma mamma, non si deve avvisare la polizia?> <Se calpesti i crisantemi?> <No mamma, se si trova una testa mozzata!> <Lasciami finire di leggere l’articolo!> <Mamma! Ma la persona a cui è stata strappata la testa è morta?> <No, starà dormendo!> Il figlioletto tirò la madre per la manica: <Non dobbiamo svegliarla per dirle che ha perso la testa?> <E va bene, vammi a prendere la testa, che la metto nella borsa e andiamo a consegnarla alla polizia!> Il bimbo si allontanò, ma per pochissimo tempo, troppo poco perché la donna potesse finire l’articolo. Il piccolo molestatore tirò la madre per il gomito: <Mamma, non riesco più a trovare la testa mozzata! Non mi puoi aiutare a cercarla?> La madre si rassegnò a non poter leggiucchiare la sua rivista. I due frugarono tra le siepi e i cespugli. Il figlio disse: <Ecco i crisantemi!> La mamma osservò: <Ma questi non sono crisantemi, ma passiflore!> Il bambino osservò: <Pensavo che i crisantemi fossero i fiori dei morti!> La madre chiese: <Ma dov’è il piedistallo della statua decapitata?> Il figlio rispose con la pazienza di una maestrina: <Chi ha detto che si tratta di una statua? È una persona morta…> La madre fu presa dall’orrore e non si avvide di un particolare: quel cranio tranciato, sanguinante, aveva un baffo nero ed uno biondo. La mamma si lasciò rapire dall’emozione, perse la testa e lanciò un urlo, un grido acuto che fece scappare le torve creature appollaiate sugli alberi vicini… Un passante con lo zaino rosso, rosso come un fiore scarlatto irrorato dal rivolo che era sgorgato dalla testa mozzata, intravide degli uccelli neri dal lungo becco accovacciati su un cedro secolare: solo in un secondo momento riconobbe dei corvi. L’attenzione si concentrò sull’oggetto più insolito di questa storia: quella maledetta testa falciata. Abbandoniamo per il momento la donna e il suo bambino, ma non dimentichiamoli, perché niente è casuale, in questa storia apparentemente caotica. Tutto è destinato a celare e rivelare un importante significato, persino il più piccolo dettaglio o personaggio, incrociato da questi due personaggi uniti da un legame di sangue. Tutto e tutti sono destinati a tornare a galla in una pozza di eritrociti o a ritrovarsi uniti da vincoli di sangue. PRIMO ATTO In ogni favola che si rispetti, persino nel più lillipuziano dei semicantoni, non vi è solo un grand’uomo nella parte del protagonista. C’è pure un piccolo essere, che impersona il ruolo dell’antagonista. Talvolta è invisibile come una cimice, talora infido come un serpente, qualche volta speranzoso come un umano. In tutte le favole c’è sempre un mostro o almeno un mostriciattolo… che questa volta prese il sopravvento sull’eroe, facendogli perdere la faccia. Strappando, estirpando il suo volto con una lama più affilata di un pennino. Poco importa, legioni di scultori avrebbero sostituito quel capo dilaniato con miriadi di mezzi busti, che avrebbero riprodotto all’infinito e tramandato ai posteri quel viso vilipeso. CAPITOLO 3 Retroscena del primo delitto Anche quel venerdì, l’eco di manifesti, giornali, radio, televisioni e corni delle Alpi annunciava in ogni cantone che la favola si accingeva a emergere dal mondo astratto dell’ideale per materializzarsi nella realtà, alla portata di tutti. Un grand’uomo stava incantando la gente non con il “c’era una volta”, ma con un “adesso c’è, qui, ora, la vostra favola… e la potete acquistare in comode rate”. Quel personaggio così importante, quel signore così vincente, sorridente, elegante e convincente era capace di essere dalla parte di tutti: da quella dei tanti manager di successo come l’onorevole Saulo Cresonte, suo fratello, come pure dalla parte dei lavoratori precari, degli impiegati dei call center, degli alpigiani, dei disoccupati e dei pensionati… Il padre dell’antagonista di questa storia, aveva convertito i propri risparmi nelle azioni del Bingo Ambrosiano, ma in poco tempo tutti i suoi sogni furono trucidati o suicidati: le sue speranze perirono con capitani di un istituto di credito ritenuto inaffondabile come il Titanic: uno finì impiccato sotto un ponte di Londra, l’altro fu avvelenato da un caffé. In seguito al dissesto finanziario del padre, il figlio aveva dovuto abbandonare gli studi e precipitarsi a lavorare: divenne così marionettista. Riuscì a guadagnarsi da vivere e a racimolare un po’ di grana per sposarsi. Il nostro sfortunato agonista, che nel frattempo aveva avuto una figlia, decise di affidare i suoi denari alla più potente economia del mondo, gli Stati Uniti, nelle azioni di una promettente società petrolifera, la Enrun, ma, nonostante godesse anche dell’amicizia del presidente americano, anche questa società fallì. Il nostro antieroe investì i risparmi accantonati per la prole in un paese noto in tutto il mondo per affidabilità e sicurezza: il puparo puntò il suo denaro sulle azioni della compagnia di bandiera elvetica… Ma persino la Svizzair si schiantò al suolo con un rovinoso crack… finanziario. Si rassegnò a tornare in Italia e stavolta, per non perdere nuovamente tutto, cambiò settore, passò a quello alimentare e ipotecò tutti i beni di famiglia non in una sola società, ma in due: <Semmai dovesse fallire una società così solida e prestigiosa ― si disse toccando ferro ― potrò sempre puntare sull’altra!> Investì tutto nelle azioni della Pomidori e della Carmalot… e anche stavolta il marionettista perse tutto. Tuttavia, volle mostrare più fiducia di Giobbe e credere nella sua fortuna: comprò le azioni della squadra di hockey più blasonata del paese, ma in seguito alla corruzione di alcuni arbitri, fu retrocessa in serie C. Ecco, mi rinfaccerete voi, avevi promesso una favola e adesso ci stai raccontando una consueta, noiosa cronaca di una vicissitudine quotidiana condivisa, loro malgrado, da tanti, troppi, comuni mortali. Qui purtroppo, stava succedendo di peggio: la cronaca cedeva il passo al giallo. Un orrendo delitto avrebbe compromesso la favola, riportandoci nelle nefandezze della realtà. Sembrava che tutto fosse definitivamente rovinato da una disfatta più grave di quella di Marignano, ma il nostro antagonista aveva investito in politica su un protagonista di successo: <Se mi sono fatto fregare in finanza e in economia ― si disse lisciandosi nervosamente il pizzetto ― in politica per fortuna ho puntato su un cavallo vincente!> Il piccolo attore di questa storia aveva dato la sua fiducia a quel signore capace di realizzare il sogno di un paese in cui si sarebbero pagate meno tasse, ma ricevuto più lavori, più sussidi di disoccupazione, più borse di studio, più pensioni, con scuole, discoteche, ospedali, poste, tribunali, ferrovie ed aerei meno cari, ma più efficienti. L’anonimo interprete di questo romanzaccio aveva creduto in questo nobiluomo che scendeva dal suo elicottero per mischiarsi con la gente comune, prendere il carrello e fare la spesa, o fare la fila per andare allo stadio, gomito a gomito con gli altri tifosi ad incitare i Wolfs, gli eroi della squadra detentrice del titolo nazionale d’hockey su ghiaccio. Un giorno, il modesto agonista di questa storiaccia aveva consegnato al grande signore il voto grazie al quale era stato eletto in Consiglio Nazionale e poi in quello Federale. Quando era stato eletto, l’onorevole Saulo Cresonte, per ringraziarlo, gli aveva spedito un fermacarte in marmo che riproduceva la sua testa. Il piccolo antagonista di questa favola chiese udienza al venerato Cresonte. L’onorato gli concesse un appuntamento tre mesi dopo, ma l’annullò all’ultimo momento per un impegno con il Consiglio Federale. L’incontro fu ancora cancellato e poi rinviato per due anni. Quando approdarono alla fine del quadriennio della legislatura, il faccia a faccia non poté più essere procrastinato. Nel giorno del fatidico colloquio, il marionettista perse più tempo in bagno per radersi e ritoccare il suo pizzetto: tutto avrebbe dovuto essere perfetto. Era in procinto di uscire di casa, quando squillò il telefono. Era indeciso se rispondere. Finalmente alzò la cornetta: <Pronto è il direttore del teatro di marionette? Sono il conte Manomorta! Mi piacerebbe che allestisse uno spettacolo nel mio palazzo per…> Il marionettista non volle sentire il compenso che il Signore gli offriva: si diceva infatti che il principe arrecasse più sfortuna di un gatto nero. E poi doveva affrettarsi per recarsi all’appuntamento con Saulo Cresonte. Il puparo balbettò: <Adesso non ho tempo; la richiamerò presto!> Abbassò il ricevitore e fece le corna. Rallentò un attimo, colto da un dubbio e per risolvere quell’esitazione toccò ferro, ma poi, perseguitato ancora dalla nomea del conte, tastò pure i suoi gioielli. Il marionettista girovagò svariati quarti d’ora alla ricerca di un parcheggio: un normale automobilista si sarebbe snervato con un’ulcera, ma sapeva che quella era la prova imposta dall’alto per decidere se poteva essere degno di venire innalzato, sia pur per un attimo, sulla cima della società. Il manovratore di marionette si presentò all’ingresso del palazzo di Saulo Cresonte. Presto sarebbe asceso all’apice del grattacielo, all’ultimo piano e ricevuto da Sua Sommità. Superò un maggiore dei dragoni, un manipolo di alabardieri e un drappello di majorette di guardia. Fu perquisito da un eunuco ed introdotto in una sala d’aspetto. Attese un paio d’ore, sfogliando fardelli di riviste pubblicate da società dei Cresonte e poi, finalmente, una maggiorata, mora come la liquirizia, gli annunciò che il venerabile si degnava di riceverlo. Finalmente, il marionettista si trovò al cospetto di un personaggio che aveva fatto la storia del Bel Paese. Narrare ciò che gli comparve davanti è difficile, troppo arduo per una descrizione tradizionale. Eppure, il viso di Saulo Cresonte si presentava davvero così: Sì è vero, lo so, avevamo dichiarato che non avremmo fatto uso di una descrizione dettagliata e ne abbiamo addirittura abusato, procedendo al discutibile uso di una tecnica di rappresentazione del personaggio già utilizzata da Govoni. Tranquillizzatevi, perché questo è l’unico personaggio di questo romanzo che meriti una raffigurazione tale da bucare lo schermo come la pagina. L’onorevole Saulo si accarezzò la lunga chioma bionda, si aprì in un sorriso che illuminò tutta la stanza e guardò con iridi che in quel momento erano verdi come un semaforo. Fece accomodare il marionettista su una poltroncina in pelle e lo invitò ad aspettare: si stava facendo radere dal suo barbiere personale; il venerabile sopportava i peli sulla lingua, ma odiava avere peli sul viso, per cui si faceva fare la barba almeno due volte al giorno. Il venerabile Cresonte disse: <Mi piace perdere il pelo, ma non il vizio! Intanto che aspetta, ammiri il panorama con la vista sulle guglie del duomo, oppure, se è curioso, nella stanza accanto ho una Wunderkammer, tra cui conservo una collezione di Rolex e una di unicorni. Scusi se ne approfitto per ostentare un po’ di lusso!> Mentre ascoltava, il marionettista notò che sulla scrivania c’era un fermacarte identico a quello che gli era stato regalato, ma era in oro. L’onorabile proseguì: <Comunque, prima che ci addentriamo nel vivo della discussione, devo confessarle che non ho molto tempo! Infatti, devo partire: dovrei andare a Damasco, ma non ho nessuna intenzione di farlo, perché devo volare prima a Zugo. Mi ripetono che devo incamminarmi sulla via di Damasco, ma devo recarmi anche nel principato di Monaco e poi alle isole Cayman, per sbrigare faccende più importanti!> Saulo Cresonte si cosparse il volto di dopobarba. Si cambiò le lenti a contatto, esibì uno sguardo azzurro e porse la mano al marionettista. Il cantafavole gli strinse la mano avvertendo subito una sensazione di viscido, ma sembrava che l’onorevole Cresonte lo leggesse nel pensiero: <Ha la sensazione di sentire la mano unta? Dica la verità! Capita a tutti quelli che mi stringono la mano, o che me la baciano, ma è comprensibile, dato che sono stato unto con gli oli santi dall’alto: non per niente mi chiamano l’untuoso del Signore! Ma non perdiamoci in ciance! Allora, cosa posso fare per lei?> Il piccolo uomo esitò un attimo davanti al grande: <Guardi, Sua Untuosità, ho talmente tante cose da confessarle, tutte così urgenti, che non so da dove cominciare!> Il venerabile lo fermò: <Un momento, che faccio chiudere la porta!> L’onorabile fece uscire il barbiere, trasmise un ordine ad un citofono sulla scrivania e una fotomodella, bionda come il sole, venne a serrare lo studio. Saulo Cresonte non avrebbe più riaperto quell’uscio. Nessuno sarebbe più uscito da quella porta: non vivo, alme- no. Il gestore del piccolo teatro di pupazzi di cartapesta e fili si ritrovò finalmente di fronte all’onorevole Saulo Cresonte. Chi di loro era il vero favoliere? Chi di lavoro propinava favole irrealizzabili, e chi ― di professione ― smerciava favole da attuare veramente? Chi tra loro due era l’autentico marionettista: colui che tendeva le fila di pupazzi di cartapesta o chi, dal teatro della politica e dell’economia, tirava le fila di migliaia di piccoli uomini affamati di briciole di potere, fama o soldi? Il vero favoliere era chi coltivava le favole sul palco della fantasia o chi le realizzava dietro le quinte? In quello studio, attorno a quella scrivania, non vi era in discussione solo una diatriba di finanziamento, ma una questione esistenziale, su chi meritasse il titolo di favoliere. Cosa successe dentro lo studio, prima che una guardia vi facesse irruzione, non lo sappiamo, ma possiamo congetturarlo, sulla base degli importanti indizi rilevati attorno ad un lago di sangue. Sulla scrivania dell’onorevole, si sarebbe compiuto un disonorevole delitto, un orrore i cui effetti avrebbero definitivamente stravolto l’esistenza del colpevole e di chi gli stava appresso, scatenando un vortice di vendette che avrebbero pure sconvolto la vita di chi si sarebbe posto sulle tracce dell’assassino. CAPITOLO 4 In un capo senza filo Il giovedì, ventiquattr’ore prima del fatidico appuntamento con l’onorevole Saulo, il manovratore di personaggi di cartapesta si era insinuato in via Fortuna, via Belgioioso e via Desiderio ed era sgusciato in via Concordia e in via Costanza, per sboccare in via Gioia. Tali vie non erano contigue e il tragitto derivato da tale traiettoria era maledettamente lungo e contorto. Il nocchiero avrebbe potuto convincersi che quel percorso era stato compiuto per scansare le colonne di vetture. In realtà, in cuor suo sapeva che quell’itinerario era stato svolto per inseguire le emozioni suscitate da quei nomi. Eppure era consapevole che via della Fortuna non esisteva, che era solo una sua personale traduzione dal tedesco di “Gluck”. Era pure cosciente del fatto che non era “gioia” il vero nome di quella via, dato che era legata ad un certo Melchiorre, che non era nemmeno uno dei re magi. Ciò che contava non era il percorso reale, ma quello messo in atto dall’immaginazione. Appena un giorno prima del fatale venerdì in cui si sarebbe incontrato con l’onorato Saulo Cresonte, l’animatore delle creature di legno aveva decantato delle favole, senza sapere che quelle bizzarre storie anticipavano le avventure o le sventure che, di lì a poco, avrebbero sovvertito l’ordine della sua vita: <C’era una volta un tizio che non aveva fegato, non aveva cuore, non era in gamba, perché non aveva gambe e non aveva nemmeno stomaco, ma aveva testa, troppa testa. Costui ponderava sempre, pensava persino sotto una doccia scozzese e, ragionando, il suo capo si colmava di idee, riflessioni, giudizi. La sua testa si comprimeva di progetti, meditazioni, osservazioni, che non cessavano mai; restavano perpetuamente depositati nel suo capo, tanto che il suo cranio si dilatò sempre più per contenere tutti quei pensieri. La sua zucca divenne tanto ampia da non potere più varcare gli usci. Non riuscì più ad insinuarsi negli ascensori, nelle automobili o nei rifugi antiatomici. Caricato del fardello di tante elucubrazioni, la sua testa si fece tanto pesante da doverla perennemente appoggiare prima sui gomiti, poi sulla scrivania: per muoversi doveva posarla su un carrello. C’era una volta un uomo il cui cranio divenne tanto gigantesco da racchiudere il mondo intero.> <C’era una volta una testa sola, senza corpo, priva di mondo, sprovvista di sole, perché era l’unico pianeta della sua galassia.> <C’ERA UNA VOLTA UNA MARIONETTA che non ce la faceva ad individuare il capo del filo che lo dirigeva. C’era un regno con un marionettista, che un giorno decise di recidere le briglie di un suo pupazzo. Senza rivelargli niente, avrebbe concesso che se ne andasse per la sua strada. Il marionettista brandì una lama con la decisione di un boia, con la precisione di un chirurgo, con la maestria di un parrucchiere. Il puparo si armò di forbice e trinciò il cordone ombelicale della sua creatura. I fili mozzati si riversarono come capelli su un collo lungo e slanciato. Ammirò braccia e gambe che si muovevano da sole. Vacillò, ma solo per un istante e corse, salticchiò, piroettò, si librò per radure di fiordalisi, fiorini, fiori di campo elisi, danzò con il corpo e volteggiò con l’immaginazione, per prati di fiorranci, fioretti, capriole di api e fiorrancini, si smarrì allegramente tra laghetti di acqua Fiuggi, boschi intagliati, fuggi fuggi di caprioli e farfalle, saltellò fra barlumi stagliati in fiorentine, tigli, faggi e tartagli in fiore, lasciandosi condurre da una brezza, insieme alla sua lunga chioma... Ah già! ― non ve lo avevo detto? ― In realtà quell’essere era una femmina! Del resto, non è che prima di questo capoverso ciò avesse molta importanza, perché quella fanciulla, poc’anzi, era stata soltanto una marionetta. La ragazza girò per il mondo, girovagò per arcipelaghi, vagò per lagune blu di regni favolosi e laghi dorati di favole lontane. Le piacque talmente che smise di ricordare chi fosse stata un tempo e forse, addirittura, interruppe il suo pensare. Una sera, nella radura di un querceto, tra i daini, gli aironi e gli sciuridi spermofili, la fanciulla si imbatté in un uomo che le promise qualcosa di straordinario e le offrì delle spine fiorite. La giovane osservò: “Ma cosa c’è di straordinario in un atto così comune come quello di un uomo che dona una rosa canina?”. Lui osservò che, se avesse accettato il bocciolo, le avrebbe rivelato un segreto. La ragazza strinse lo stelo e l’osservò stupita, notando un lepidottero screziato che vi si era posato. Lo sconosciuto si avvicinò al suo timpano e le sussurrò una frase breve, ma penetrante come un dardo, che le trafisse il cuore e le fece girare il capo: “Io sono il manovratore delle marionette!”. Allora la fanciulla si rammentò di essere un pupazzo e perse l’equilibrio, perché un burattino non può restare eretto senza una mano che lo sostenga, perché una marionetta non può reggersi senza fili. E, risucchiata dalla forza di gravità, crollò al suolo, tra gli asfodeli e i gladioli, smarrendo i sensi. Quando la svegliarono, bofonchiò che non poteva alzarsi, perché era una marionetta senza fili. “Ma tu sei una donna!”, le rimproverano sbalorditi. Se lo ripeté ancora nel bagno, davanti ad un grande specchio. Per riprendersi si sciacquò la faccia con l’acqua fredda e poi, per ridestarsi completamente, si dette una lavata di capo. Già, si ridisse, mentre gingillava con l’asciugacapelli, non solo era una donna, ma una moglie e una madre. Intanto qualcuno, fuori, bussava sempre più insistentemente, chiedendo lo specchio e il lavandino liberi. Ma lei non avrebbe voluto essere lì... Avrebbe desiderato essere un palloncino giallo dal filo spezzato sospeso nel caldo soffio dell’aurora. C’era una volta una fanciulla che scoprì l’oceano nella vasca da bagno. Ma quello non era né lo scirocco né il fohn, non era un vento caldo del sud o del nord, ma il soffio dell’asciugacapelli e quella non era l’alba, bensì la luce al neon del bagno. Glielo ricordò il marito quando la implorò, mentre percuoteva la porta: “Ho bisogno dello specchio e della doccia! Per favore, devo andare a lavorare!”. La donna girò la chiave… e in quel giro vide roteare il mondo, l’orologio delle sue emozioni, la giostra dei suoi pensieri, il giradischi dei suoi sogni.> Il marionettista si grattò il pizzetto, afferrò la chiave e chiuse il teatro, a doppia mandata, senza sapere che la realtà avrebbe superato la fantasia, al punto da realizzare immaginazioni senza fine, senza un capo capace di sviscerarne il senso. CAPITOLO 5 Fuga dal primo delitto Il cantafavole cercò di eclissarsi, facendosi inghiottire da un mostro di metallo che si tuffò nelle viscere della terra, seguendo linee parallele come binari. Il serpente di ferro penetrò in una galleria e si arrestò alla prima stazione. Spalancò le sue paratie come fossero fauci e ingurgitò altri passeggeri. Mentre era nella metropolitana, il raccontafavole notò che una manica della camicia era macchiata di rosso e si cacciò la mano in tasca. Si sentiva come un bambino imbrattato di marmellata rubata. Si accorse che il collo della camicia era impiastricciato di sangue. Per nascondere quella compromettente macchia, si portò la mano alla nuca e finse di avere un torcicollo. Ma non era finita, perché aveva anche un calzino insudiciato dal sangue: lo nascose agli altri passeggeri, appoggiandovi davanti la borsa. In quel momento, gli parve che tutti i manifesti, i tabelloni e tutti gli schermi pubblicitari glorificassero il nitore; gli sembrò che demonizzassero le patacche più microscopiche, celebrando le qualità di detersivi più prodigiosi dell’acqua di Lourdes. Il marionettista aveva l’impressione che la chiazza fosse dotata di una forza motrice propria capace di spostarla, insinuarla nei posti più imbarazzanti. Per nascondersi allo sguardo altrui, avrebbe voluto sprofondare per terra. D’altra parte, quel treno lo stava conducendo sempre più sottoterra, ma gli pareva che lo stesse trascinando verso l’inferno. La guardia del corpo sapeva che non doveva assolutamente disturbare l’onorevole Saulo Cresonte, mentre era nel suo studio. Eppure, quell’uscio era sigillato da troppo tempo. Bussò e mormorò: <Mi scusi, venerato onorabile, la disturbo?> Dallo studio non si udì nulla. Il gorilla provò ad aprire la porta, ma era chiusa a chiave. La guardia bussò più energicamente e urlò: <Onorevoleee! Ha bisogno di qualcosa?> Prese a pugni la porta e poi decise di agire come i poliziotti dei film americani, abbattendola con un calcio. Si slogò la gamba, ma non riuscì a scalfire la soglia. Si decise a sciogliere il nodo gordiano che sbarrava quell’ingresso con la violenza: impugnò la rivoltella e sparò alla serratura. Il proiettile rimbalzò sul pomo della porta e lese la coscia della segretaria. Per un attimo la guardia del corpo si perse a contemplare quell’opera d’arte sfregiata: si sentì come un vandalo che aveva deturpato la Gioconda. Tornato in superficie, il marionettista camminava claudicante, tenendo la gamba tesa, per non scoprire il calzino con la patacca vermiglia. Mentre arrancava sul marciapiede, gli si appiccicò addosso un venditore di moccichini. <No, grazie non ho bisogno di fazzoletti!> Ma il mercante insistette: <Guardi che ne ha bisogno: le servono per pulirsi da quella macchia di rosso!> Pur di levarselo di dosso gli comprò un pacchetto di pezzuole di carta. Per fortuna la segretaria era stata colpita solo di striscio, ma il gorilla pensò che il padrone non gli avrebbe perdonato nemmeno una scalfittura di quel capolavoro di anatomia femminile. La guardia del corpo raddrizzò la mira e sparò un altro colpo contro la serratura. Finalmente l’uscio si spalancò e l’orrore si distese davanti al gorilla. Il corpo di Saulo Cresonte giaceva sulla scrivania, in una pozzanghera di sangue. L’unico volto che rimaneva dell’onorevole era quello delle foto e dei busti sulla scrivania; era stato decapitato e della testa mozzata non vi era in giro nemmeno un pezzo: neanche un bulbo oculare, il lobo di un orecchio o uno schizzo di cervello. La segretaria entrò nell’ufficio, vide quel corpo mutilato e lanciò un urlo: <Accidenti ― pensò l’impiegata ― come farò a pulire e rimettere tutto in ordine?> La finestra era spalancata: l’assassino doveva essere fuggito da lì e poi essersi calato per una grondaia e per una scala antincendio. Per le strade, le auto della polizia sfrecciavano a sirene spiegate, mentre gli elicotteri delle forze dell’ordine sorvolavano la città. La gente si guardava, chiedendosi cosa fosse successo. L’o- micida entrò in un centro commerciale per rifarsi un’identità e liberarsi delle macchie del suo passato. Andò in bagno e lavò una patacca di rosso che gli insudiciava il collo. Nonostante il sapone, quei grumi di sangue coagulato non volevano essere cacciati dalla scena. Il mostro doveva procurarsi degli abiti lindi, immacolati, rispettabili, capaci di celare le macchie della sua anima. Il sergente Colombo piombò sul luogo del delitto, appena in tempo per fermare l’opera devastante della segretaria; armata di straccio stava già pulendo tutto dicendo: <L’onorevole non ha mai sopportato il disordine!> Il fratello della vittima, il presidente Costantino Cresonte, si fece portare con un elicottero sul sito del misfatto. Ecco che un nuovo importante personaggio si stava affacciando, troppo importante per rappresentarlo in modo originale e degno di Lui. Descriverlo era tanto arduo quanto raffigurare Dio. Eppure, il volto di Costantino Cresonte si presentava veramente così: Sì, lo so, suo fratello, il defunto Saulo Cresonte, era già stato rappresentato nello stesso identico modo, ma i due, un po’ grazie a madre natura, un po’ in virtù di un demiurgo munito di bisturi, si assomigliavano tremendamente, proprio come i fratelli di Michael Jackson. Il sergente stava scattando foto e cercando qualche impronta digitale non ancora cancellata dalla furia ripulente della segretaria. Il presidente, Costantino Cresonte, si rivolse al poliziotto: <Ispettore, deve agguantare quel mostro a tutti i costi, ricorrendo a qualsiasi mezzo!> Colombo lo corresse: <Veramente, presidente, io non sono ispettore, ma sergente!> Costantino lo guardò in tralice: <Come sarebbe a dire? Del caso non si occupa un ispettore, ma solo un sergente?!> Colombo sudò freddo; avrebbe dovuto ammettere: <Del caso del capo assente si dovrebbe preoccupare un capo che per caso è assente!> ma si morse la lingua e si difese o protesse il superiore non presente: <Veramente del caso si occupa un investigatore validissimo, il commissario Bossettoni, che mi ha incaricato di venire qui, mentre lui coordinava dalla centrale le ricerche dell’assassino negli aeroporti e nelle stazioni!> Costantino Cresonte disse al sergente: <Chi ha commesso questo delitto non si rende conto del fio che dovrà pagare! Metterò una taglia milionaria sulla sua testa! Dica all’ispettore Bossettoni di farmi presto un rapporto sulle indagini!> Prima che la polizia emanasse il suo identikit, l’assassino acquistò una parrucca finta. Poi entrò da un ottico per procurarsi degli occhiali con una spessa montatura. Dal televisore di un negozio, sentì Tina Corrodi, la direttrice del telegiornale che, in un’edizione straordinaria, dava la linea al reporter Cuco Zucca che annunciava una clamorosa notizia: Saulo Cresonte, il fratello del premier, era stato orrendamente ucciso. Ritornò in bagno e si aggiustò gli abiti in modo da sembrare più corpulento di quello che era. Nella fretta, per poco non dimenticò la borsa con il cimelio trafugato. Mentre la televisione trasmetteva a tamburo battente la notizia del delitto, il favoliere prese un taxi. Il taxista chiese cortesemente: <Vuole mettere la borsa nel baule?> Il cantafavole rispose seccato: <No, per carità la tengo io!> Per essere sicuro di non essere pedinato, seguì un tragitto contorto. Varcò via Monte Titano, via Monte Nero e via Piave, valicò val di Fiemme, via Vesuvio, via Monte Nevoso e pure via Valtellina. Gli parve di salire con le sue gambe, veramente, per quei monti o per quelle valli, tanto che gli venne il fiatone. Il favoliere indirizzò il taxi lontano dal centro del ciclone, verso la periferia, nei bassifondi della metropoli. Si recò in uno scantinato e disse: <Per fuggire sono disposto a fare carte false!> Il contraffattore fece notare: <Tutti quelli che si rivolgono a me, mi chiedono di alterare la realtà! Non per niente sono un falsario!> e gli chiese: <Come vuole farsi chiamare?> L’assassino si accarezzò il pizzetto e pensò: <Voglio che il mio nuovo nome sia d’auspicio per la mia nuova esistenza…> L’omicida si tuffò nelle pozzanghere dell’immaginazione, pescò dalle reminescenze della sua infanzia e borbottò: <Yanez de Gomera!> Il falsario gli consigliò: <Il passaporto è pronto, ma manca una nuova foto. Vi dovrà comparire la figura di un volto nuovo, ma credibile. Che faccia vuole che abbia Yanez? Le concedo ancora una notte per pensarci.> Con la sua nuova identità, “Yanez de Gomera”, il mostro comprò un biglietto d’aereo per una località esotica che aveva conosciuto da ragazzo nei romanzi di Salgari. Poi il capitano delle marionette ricapitò a casa e il narratore decapitante volle recapitare ai familiari stille di affetti preziose come capitali. Dall’isola in cui sarebbe fuggito, il favoliere non avrebbe potuto fornire o esigere alcuna notizia, per non offrire tracce utili alla polizia. Sapeva che non avrebbe potuto fare come Mattia Pascal e tornare indietro. Il marionettista entrò in casa accolto festosamente dalla figlia. Ripose la borsa e l’abbracciò. La bimba chiese: <Papà, cosa hai nella borsa? Hai un regalo per me?> Il padre non poteva confessare cosa ci occultava, ma volle comunque concederle un obolo: <Il dono che ho per te, è una nuova favola! È una storia speciale che rivelerò solo a te!> Giocò con sua figlia, la accompagnò a letto e aprì un libro, per svelarle un’ultima avventura della fantasia. Chiuse le tende, come fossero le propaggini di un sipario e sfogliò una storia, ma senza leggere. In realtà non scandagliava i caratteri d’inchiostro che si delineavano sulle pagine, ma rovistava nella storia che era scritta dentro di sé, nel sangue. Frugò nelle iridi della bimba e disse: <Ecco, ti racconterò un’ultima favola, che ti accompagnerà in un sogno meraviglioso!> Il marionettista le rimboccò le coperte e aprì un varco nel sipario del fantastico con la lama del “C’era una volta”. Si accarezzò il pizzetto e sussurrò alla figlia: <C’era una volta un essere pensante che dimenticava di essere un uomo, credendo di essere solo una testa…>. Poi si avvicinò all’orecchio della bambina, le infilò il chicco di una fiaba sotto il cuscino e le bisbigliò in modo tanto basso che nessuno, tranne la piccola, poté sentire. L’indomani il favoliere non sarebbe fuggito subito, per non rendere troppo evidente la sua colpevolezza: i segugi sulle tracce dell’assassino di Saulo Cresonte avrebbero sicuramente controllato la lista dei passeggeri in partenza. Il marionettista avrebbe fatto finta di niente, rispettando i suoi impegni di lavoro ed allestendo i suoi spettacoli fino a sera. Poi sarebbe rientrato tardi a casa, con il cielo stellato, quando la sua figlioletta già dormiva, avrebbe passato un’ultima notte nel nido domestico e il giorno seguente, nella quiete dell’alba domenicale, quando i familiari ancora russavano, si sarebbe diretto all’aeroporto e sarebbe decollato… verso la clandestinità. CAPITOLO 6 Oltre cartine in fumo Il posacenere dell’ispettore era stracolmo di mozziconi. Nei film americani i detective sono quasi sempre fuori, in strada, nei bar, nelle bische, nei casini, nei casinò… Ma qui non eravamo né in America, né in un film. Qui la burocrazia non funzionava né come oltralpe né come oltreoceano e le formalità lo obbligavano a fuggire la vita reale per tuffarsi in un mare di formulari. Eravamo in una dura realtà tinta di grigio: il grigio della nebbia tralucente da un’anonima metropoli a Nord del Mediterraneo, il grigio dello smog trapelante da una città qualsiasi a Sud delle Alpi, il grigio della nicotina, cui il nostro protagonista si aggrappava per non lasciare che la propria vitalità andasse in fumo, per non farsi catturare dalla lenza del sonno, per non essere rapito dalla sonnolenza della routine. Nella realtà, il nostro eroe doveva svolgere gran parte della sua guerra contro il male tra le carte, affrontare l’idra della burocrazia, sfidare la noia di un ufficio, tra fogli intrappolati in computer infettati da virus, o in pagine incastrate in stampanti povere d’inchiostro, o in polverosi schedari fatti di carta che si erigevano in un enorme castello… di cellulosa. Nella realtà, la lotta del paladino del bene contro il male si compiva mentre inseguiva i cattivi attraverso le loro tracce cartacee: le ricevute fiscali, le fatture, gli scontrini, gli estratti conto, i bilanci di società finanziarie fantasma, che gli orchi avevano dimenticato dietro di loro tra un misfatto e l’altro. Ogni giorno, il vice commissario Bossettoni avrebbe voluto debellare l’ingiustizia, ma un turno di otto ore non bastava per vincere la guerra contro il male: rinviava sempre il ritorno a casa di qualche ora, ma si doveva rassegnare a staccare senza aver guadagnato nemmeno una scaramuccia. Stavolta, l’ispettore si preparava ad abbandonare l’ufficio giusto in tempo per approdare in orario al desco serale. <Aspetta ― si disse ― prima di uscire mi fumo un’ultima sigaretta!> Proprio quando si accingeva a varcare la soglia del commissariato, ecco che squillò il telefono. Dall’altro capo del filo, il sergente Colombo annunciò che era stata decapitata una testa eminente. Bossettoni non prese alla lettera le parole del suo sergente ed intese che era stato ucciso il capo di una banda molto importante. Pensava si trattasse del solito gangster. Il vice commissario implorò il sergente Colombo: <La prego, per favore, vada lei sul luogo del delitto, io non posso arrivare ancora in ritardo a casa, altrimenti scoppia un dramma familiare! Almeno stasera devo smettere di fare lo sbirro e devo tornare ad essere solo un padre di famiglia!> Poi Bossettoni rinfacciò precedenti favori, promise persino di regalare una scatola di Avana e poté, almeno fino al giorno seguente, scaricare il caso al collega. Mentre aspirava l’ennesima boccata di tabacco, tirò un sospiro di sollievo che liberò dai suoi polmoni uno sbuffo di fumo: quell’alito di nebbia si unì alle nuvolaglie di smog che incombevano sui santi accovacciati sopra le guglie del duomo. Il commissario poté tornare alla guida della sua vita: a bordo della sua vettura, gli era consentito riprendere ad essere una persona normale. Impugnò il volante, il cambio e una sigaretta, ardente di desiderio d’Itaca e si diresse verso il nido dove lo attendevano moglie e figlio. Un papà vagava come un Ulisse con la sua automobile, attorno alla sua casa, alla ricerca di un parcheggio. Un tir con un faro rotto, più sinistro di Polifemo, rischiò di travolgere la sua automobilina. Da un manifesto pubblicitario, una ninfa più seducente di Circe lo invitava ad evadere dalla sua vettura e a fuggire in un’isola pedonale. Proprio come Odisseo, proprio quando sembrava aver pescato nel mare d’asfalto un porto in cui ormeggiare il suo mezzo, ecco che il posteggio era carpito da automobilisti più aggressivi di un lestrigone o altri mostri omerici. <Ah ― pensò ― se fossi in Svizzera girerebbero solo biciclette e auto solari, guidate da nocchieri civili e persino gentili!> Ma la confederazione elvetica era allora lontana, più remota dell’Itaca che stava cercando in quel mare d’asfalto. Fu costretto ad avventurarsi in una doppia rotonda; nella frenesia del traffico, la sua utilitaria parve una zattera in un mare di catrame incandescente scosso dall’ira di Poseidone. Nel frattempo il sole era tramontato e le tenebre ormai calate. Più il nostro eroe annaspava per avvicinarsi al suo quartiere e più la minaccia di una multa, o un fuoristrada speronante, lo distanziava dalla sua Itaca. La sua Penelope telefonò seccata: <Allora, quando arrivi? Entro cinque minuti metto la cena in tavola!> Schivò le sirene più insidiose: quelle di un’autoambulanza che sbucava da un marciapiede e quella di un’auto della polizia lanciata in un inseguimento con l’accanimento di un cerbero e, finalmente, il nostro novello Odisseo si pose in salvo in un parcheggio per il carico e lo scarico. Proprio sopra il parcheggio, troneggiava da un manifesto una prorompente venere in bikini che sussurrava <Compra FILIPPOS e fammi perdere la testa…> Il messaggio si offriva a diverse interpretazioni: infatti “Filippos” era il marchio di un un’auto sportiva, di un profumo, di un orologio di lusso e di un pacchetto di sigarette. L’intera città era tappezzata di gigantografie della pubblicità, ma nessuna ritraeva la fotomodella per intero, perché l’inquadratura ingrandiva solo una parte del corpo. L’unica a non essere mai ripresa per intero era la testa, quasi che il fotografo avesse voluto decapitare la modella. Eppure in tutta la città nessuno si accorse di quel ghigliottinamento. Il papà si avviò verso il focolare domestico. Un uccello sinistro si frappose tra l’eroe e la sua meta e gli sbarrò il passo: no, non si trattava di un avvoltoio inviato dal signore dell’Ade, ma di un piccione che non voleva smuoversi; il padre non si avvide che il volatile era solo un’effige dipinta da un madonnaro sul marciapiede. Scantonò quel minuscolo mostro di guano, ma un altro ostacolo gli si parò davanti. Un venditore ambulante di accendini, torvo come Efesto, gli rammentò che era un fumatore: gli comprò una stilla di fuoco. Poi si ricordò di avere quasi esaurito la scorta di sigarette ed entrò nel bar sottocasa; il tabaccaio abbassò il tono della voce e gli bisbigliò: <Ha sentito, commissario, da questa settimana c’è un’offerta straordinaria: se riesce a fumare 500 mila sigarette, le regaliamo un polmone!> Bossettoni non credette alle sue orecchie: <Un che? Un polmone?> Il tabaccaio annuì: <Sì, ha capito bene: un polmone vero! Guardi che non è uno scherzo. Ecco vede, ne ho qui uno sottaceto, uno sottovuoto ed uno sottoghiaccio, ciascuno munito del certificato del ministero della sanità!> Il vicecommissario fece una smorfia di disappunto: <Peccato che, per fumare tutte queste sigarette, debba provocarmi un cancro ad entrambi i polmoni!> Il tabaccaio aveva già la risposta pronta: <Peccato che un tumore ai polmoni sia comunque destinato a tutti i cittadini di questa città! Se ci pensa, poi, vedrà che non si tratta di così tante sigarette!> Bossettoni non accettò ancora la sfida e si limitò ad acquistare due pacchetti. Prima di salire in ascensore si fumò un’ultima sigaretta. Scese dal lift, ma prima di varcare la soglia di casa, decise di consumarsi ancora una paglia, giurando che quella sarebbe stata davvero l’ultima. Aprì la porta di casa, ma dietro di essa non vi era nessuno ad attenderlo, nemmeno un cane cieco. Eppure dentro la sua dimora c’erano la moglie e due bambini: il figlio Pietro e un cuginetto più piccolo, in visita per un paio di giorni. I bimbi sembravano non riconoscerlo, non si capiva se perché i minuti persi dal padre alla ricerca del posteggio fossero stati lunghi come decenni… o semplicemente perché i fanciulli fossero ipnotizzati da una Circe dell’etere. <Allora? ― si lamentò ― Siete troppo occupati a vedere la televisione per venire un istante a salutarmi?> Uno dei bimbi, che si gustava un lecca-lecca alla fragola, lo implorò: <Per favore zio, lasciaci vedere l’ultimo minuto di questa sfida tra Pokemon!> Il figlio lo invitò: <Dai, papà vieni a guardare con noi la battaglia!> Il padre si accomodò sul divano, i bimbi gli si sedettero in grembo ed il più grande cercò di spiegargli le tecniche e le magie di combattimento dei Pokemon: <Allora papà, hai capito come devi rispondere ad un attacco del nemico?> Il padre tentennò, sperando che la moglie lo chiamasse a cena: <Ehm, non so, lo attacco con una doppia carta?> Il bimbo scosse la testa con la rassegnazione di un professore che getta perle di saggezza ad alunni stolti come porci: <No, te l’ho già detto, devi prima ricorrere ad una mossa da difesa!> Per fortuna la moglie entrò in salotto, dette un bacio al marito e impose a tutti di andare a tavola. L’attore di questa odissea si sedette al suo desco e commentò: <Ma avevi preparato pastasciutta anche ieri sera!> La sua Penelope osservò argutamente: <Ma ieri era al pomodoro, mentre oggi è in bianco!> Ulisse sospirò, si fece rapire dai banchetti di Calipso e di Circe, ma ritornò in fretta alla realtà e chiese: <Posso avere del parmigiano?> Dopo cena, la famiglia si sedette là dove un tempo vi era il focolare ed ognuno si contese il telecomando. Tra un canale e l’altro, i principi dell’informazione, capitanati da Tina Corrodi, annunciavano nuovi particolari sul delitto che aveva appena scosso la nazione. La madre avrebbe voluto vedere “Anna dei mille giorni”, un lungometraggio sull’amore di Anna Bolena, mentre il padre, ammiratore di Rita Hayworth, avrebbe voluto guardare “Salomè”. Il bambino più piccolo avrebbe desiderato sfidare la paura con il film “Il mistero di Sleepy Hollow”, mentre il più grande avrebbe voluto sintonizzarsi su “Storie incredibili” di Spielberg. I bimbi si fecero piagnucolosi, la voce della moglie isterica: <Devo sempre rinunciare io al film che mi piace!> Alla fine il padre propose un compromesso: <E se questa sera uscissimo di casa per fare qualcosa di diverso dal solito? Al supermercato mi hanno regalato dei biglietti per uno spettacolo di marionette…> La moglie sembrava d’accordo, ma i bambini non ne vollero sapere: <Che noia le marionette! Ormai non sono più di moda! Nessuno dei nostri compagni di classe le va a vedere!> La madre obiettò: <Non sei obbligato a raccontare ai tuoi amici cosa fai nel tempo libero!> I genitori avevano ormai deciso che l’intera famiglia sarebbe andata a teatro. Il bimbo più piccolo scoppiò in lacrime, mentre il più grande cercava di nascondere le chiavi dell’auto. <Non fa niente ― concluse il padre ― andremo tutti in metropolitana: così non ci sarà il problema del parcheggio!> Il bimbo più piccolo si disperò: <Ma la fermata è a dieci minuti di cammino da qui!> La madre sentenziò: <Camminare fa bene!> Il padre ritrovò le chiavi della vettura. Il cuginetto fu caricato a forza sulla macchina. Durante il viaggio il più grande protestò: <Ma ho già visto almeno tre volte questi spettacoli!> Il papà obiettò: <Ma si trattava di tre storie diverse!> Mentre guidava, il vicecommissario pensò alle sigarette che avrebbe dovuto bruciare per vincere il polmone messo in palio dal tabaccaio. Se aveva cominciato a fumare regolarmente dall’età di quindici anni, ciò significava che, svuotando ogni giorno un pacchetto di venti sigarette, ne avrebbe aspirate 600 al mese, 7200 all’anno, 72 mila ogni dieci anni e 360 mila in cinquant’anni. Ma se fosse sopravvissuto fino a 80 anni, in 65 anni di nicotinismo, ne avrebbe potute esaurire 468 mila. Vivendo fino a 85 anni avrebbe potuto incenerirne 504 mila. Difficilmente sarebbe giunto a quella veneranda età senza un tumore al torace, ma se avesse raddoppiato il consumo a due pacchetti quotidiani, accendendo una paglia ogni 24 minuti di veglia, avrebbe potuto, in 70 anni di tabagismo, respirare oltre un milione di sigarette ed aggiudicarsi così DUE polmoni nuovi! Quando si fermarono ad un semaforo deserto, il bambino più piccolo approfittò della sosta forzata per evadere dal finestrino. La donna lo afferrò per un piede, lo trascinò verso di sé e se lo mise in braccio. Il bambino più grande oppose resistenza, anche quando ormai erano in fila per ritirare i biglietti: <Questo spettacolo sa di vecchio! Come possono interessarmi dei pupazzi che non usano nemmeno un laser? Che pena: hanno manti di carta velina e usano spade di cartone! Come posso divertirmi con degli eroi fatti di cartapesta?> CAPITOLO 7 Tra mostruosità della carta Il commissario e sua moglie con ― loro malgrado ― nipote e figlio al seguito, presero posto in platea. Tra il pubblico non c’era gente in abito da sera, ma solo gente comune nei suoi consueti, dimessi abiti di tutti i giorni: c’era ad esempio un uomo con la tuta blu da lavoro e suo figlio o un signore con la coppola e il suo volpino; c’era ad esempio una massaia che dopo aver fatto la spesa era venuta direttamente in platea, lasciando che una baguette spuntasse da una delle borse. Una voce dal palcoscenico annunciò: <Scusate le mie parole, ma devo profondere un po’ di enfasi! Dobbiamo provare a fingere di trovarci alla Scala o al Piccolo Teatro. Tacciano i sudditi e suonino le campane, i gong e i citofoni: un re si accinge a parlare e la favola sta per aprirsi ad occhi indiscreti.> Il favoliere avrebbe voluto rivelare storie indimenticabili, che echeggiassero canzoni di gesta straordinarie, da tramandare di generazione in generazione. Purtroppo, il nostro bardo avrebbe dovuto imbarcare i suoi racconti su una penna, affidarli ai mari tempestosi dell’inchiostro e farli trasportare lontano da vele effimere, fabbricate con un materiale fragile come la carta. Perché trascrivere le sue storie su pagine destinate ad ingiallire, a decomporsi e ad essere spazzate via, entro pochi decenni, dal vento del tempo? Del resto, gli spettatori non pretendevano di leggere e ricordare, ma solo di divertirsi. Per questo, il contastorie non aveva voluto ricorrere all’inchiostro e si accontentava di raccontare, per il puro gusto di narrare, affidandosi ad eroi fragili, fatti di cartapesta, che si muovevano su scenari e fondali ritagliati nel cartone. Il favoliere si lambì la barba, aprì il sipario di carta crespa e si decise a dare voce alle marionette: <C’era una volta un monarca che regnava da un palazzo di sommità, loggiati, pinnacoli e giardini, ritagliati nelle pagine sottratte ad un romanzo astruso…> Con tali pezzi di carta il cantafavole ricavò aquiloni, deltaplani, aquile bicipiti… che condussero gli eroi della favola ― impersonati da marionette di cartapesta ― e gli spettatori verso lidi remoti… Finché la quiete fu scossa da una sirena. Che fosse il canto di un essere per metà donna e l’altra pesce? La moglie sferrò una delicata gomitata tra le costole del suo uomo: <Caro, temo che la sirena sia proprio quella dell’allarme antincendio!> Il marito avrebbe voluto dare poco peso all’allarme, ma lui non era un comune mortale, bensì un pubblico ufficiale. Il vicecommissario Bossettoni prese in mano la situazione <Hai ragione! Presto, dobbiamo evacuare il teatro! Fate passare avanti i bambini, poi le donne, dopo i vecchi e infine gli altri!> Il nipotino del commissario chiese: <Ma questa signora deve passare avanti tra le donne o passare dietro tra gli anziani?> La signora rispose stizzita: <Io non sono vecchia!>. Una dodicenne si offese perché la volevano fare evacuare tra le bambine e non tra le donne. Si precipitarono ordinatamente fuori, calpestando qualche borsetta caduta. Nell’affanno, una signora con il foulard perse dalla sporta della spesa una baguette, che fu raccattata con i denti dal volpino del signore con la coppola. Quando furono all’esterno, sul marciapiede, i signori Bassettoni si accorsero che mancava il figlio. La mamma ricordò: <Era andato in bagno!> Il padre lo scoprì davanti ad un gabinetto, in una nuvola di fumo provocata da una sigaretta accesa: <Disgraziato, dove hai comprato queste sigarette? Lo sai che è proibita la vendita ai minori?> Il poliziotto, che già presagiva la scoperta di oscuri traffici alla scuola elementare, ricevette un’ennesima delusione quando il figlio rivelò: <Le ho prese dalla tua giacca!> Bossettoni maledisse il giorno in cui aveva cominciato a fumare, e poi il figlio. <Sciagurato! Fumare alla tua età: sei solo un bambino!> Il piccolo cercò di negare l’evidenza: <No, avevo la sigaretta accesa, ma, credimi, non stavo fumando!> Il padre dovette riconoscere che era forse più sfacciato di tanti criminali che aveva colto in castagna: <Che faccia tosta! E allora cosa stavi combinando con la sigaretta in bocca?> Anche con le mani nel sacco, il figlio si difese con caponeria: <Non ho respirato il fumo nei polmoni! Volevo solo controllare se funzionava l’allarme antincendio!> Il padre lo afferrò per un orecchio e lo trascinò fuori dal bagno: <Se avessi uno stipendio più cospicuo ti manderei in collegio nel canton Svitto! Maledetto: volevi solo impedire lo spettacolo! Per pagarla assisterai alla replica del teatrino tutti i sabati, per un mese intero!> Bossettoni affidò la piccola canaglia alla madre e disse: <Non perderlo di vista, che io esco un attimo a controllare che non siano stati chiamati i pompieri!> In realtà, l’ispettore uscì alla chetichella per consumare una sigaretta: do- veva farlo di nascosto, perché aveva detto alla moglie che aveva smesso di fumare. Il pubblico riprese posto tra le sedie del teatro. Il signore con la coppola litigò con il suo cane, ma alla fine prevalse sul quadrupede e restituì la baguette alla signora con il foulard. Le luci della platea si spensero e si accesero i riflettori sul palcoscenico. Lo spettacolo ricominciò da dove era stato troncato… Il cantastorie si sfiorò il pizzetto e annunciò: <Si fermino gli unicorni, tacciano i corni dei messaggeri e le cornette dei cellulari! Tra una manciata di istanti, entrerà in scena l’eroe della nostra storia! È un cavaliere senza armatura che sventola sul suo vessillo un bianco candido come la neve, sventaglia un rosso scarlatto come l’alba, sbandiera un azzurro splendente come il cielo di mezzogiorno e un giallo fulgido come il sole allo zenit. Insomma, porta sulla sua insegna l’arcobaleno e aspetta che qualcuno lo chiami a sfidare il diluvio. Viveva in quel regno un povero cavaliere, dalle armi rudimentali e le vesti dimesse, la cui unica ricchezza era uno stemma policromo, forgiato di colori cangianti. Infilata sulla lancia, portava la sua bandiera come fosse una vela. Un tempo era stato il giullare di corte e poi era stato nominato cavaliere per aver salvato la testa del re: si tratta comunque di un’altra storia che vi racconteremo in seguito. Al cavaliere, infatti, non faceva piacere che si ricordasse che un tempo era stato un buffone. Eppure sapeva che, quando sarebbe stato troppo vecchio per stringere una spada, sarebbe tornato ad essere un giullare, un saltimbanco senza corte costretto a campare e a dare spettacolo ai margini di un Luna Park. Per il momento, però, accantoneremo questa vicenda che macchia il passato e il futuro del paladino…> Ancora una volta, lo spettacolo fu interrotto. Degli uomini in uniforme irruppero nel teatro: <Presto ― disse perentorio il loro capo ― dobbiamo sgombrare tutti!> Bossettoni si avvide che erano poliziotti: riconobbe che erano guidati da Colombo, il suo sergente. Il poliziotto spiegò: <Ci hanno telefonato per segnalare una bomba! Per precauzione, dobbiamo perquisire tutto il teatro! > I bambini erano spaventati, i ragazzi divertiti dalla novità, gli adulti scocciati da quell’ennesimo contrattempo. La famiglia Bossettoni raggiunse il figlioletto, che era già all’esterno. <Che strano ― osservò la mamma ― non sembra né spaventato né sorpreso da questo sgombero!> Osservò il padre: <A me pare persino divertito e compiaciuto! Qui, gatta ci cova! Allora? Come diavolo hai fatto a scatenare questo allarme bomba?> Il bimbo tratteggiò una difesa: <Come potevo telefonare senza nemmeno un cellulare o uno spicciolo?> Il padre lo mise con le spalle al muro: <Come fai a sapere che l’allarme è partito da una telefonata?> Il figlioletto fu costretto a confessare dalla minaccia di rivedere tutto lo spettacolo dall’inizio: <Ho fermato un passante, gli ho detto di essermi perso e gli ho chiesto il cellulare per telefonare al mio papà…> Intanto i poliziotti perquisivano tutto il teatro in cerca di congegni esplosivi nascosti. Il sergente Colombo rinvenne una borsa sul palco e si accinse ad aprirla. Il marionettista giunse in quel momento e urlò: <Fermo, non la apra! È mia quella borsa!> Al poliziotto parve che il raccontafavole fosse un po’ troppo allarmato, s’insospettì e si accinse a spalancare comunque la borsa: se l’avesse schiusa non vi avrebbe rinvenuto un ordigno, ma un macabro trofeo. Il favoliere gli fermò la mano e i due presero a tirare la sporta l’uno verso l’altro. Colombo gridò: <Questa è resistenza a pubblico ufficiale!> Il favoliere replicò: <Questa è una violazione della privacy!> Bossettoni arrivò giusto in tempo per mettere fine a quella contesa: <Sergente, si fermi: non c’è nessuna bomba nel teatro! Metta fine alla perquisizione e mandi via tutti gli agenti: me ne assumo io la responsabilità! Domani, in centrale, le spiegherò tutto. Adesso si scusi con il favoliere!> Il figlio fu trascinato da Bossettoni dentro il teatro, mentre si divincolava: <No, ti prego, papà, non voglio tornare a vedere quei mostri!> Chiese la madre preoccupata: <Hai paura?> Rispose il bimbo: <Macchè! Come potrebbero spaventare? Sono mostri troppo fasulli! Mi annoiano!> Bossettoni, intanto, pensava che nel paese di Rousseau, Pestalozzi, Piaget e Jung avrebbero sapu- to adeguatamente psicanalizzare ed educare un caso disperato come quello di suo figlio. Ma la Confederazione Pedagogica era lontana e non gli restava che ricorrere a metodi più spiccioli, ma più pratici ed economici. Per non correre rischi, il vicecommissario legò con le manette una caviglia del figlio ad una sedia. In questo modo lo spettacolo poté finalmente proseguire e il favoliere poté concludere una volta per tutte le avventure del cavaliere arlecchino con un “e vissero felici e contenti”. La famiglia Bossettoni uscì dal teatro. Il capofamiglia non trovava più l’auto. Fu assalito dal timore che l’avessero rubata, proprio a lui, ad un poliziotto. <Porca vacca ― imprecò ― con tutto il rispetto per i vaccini, ma in Svizzera queste cose non succedono!> Poi gli venne in mente di averla parcheggiata in un altro luogo, ma non ricordava dove. Per fortuna il figlioletto si rammentò che stava proprio dopo un viale di platani. Montarono in auto, il figlio salì in braccio alla madre, l’abbracciò e le sussurrò: <Mamma, mamma, ora so cosa chiedere a Gesù bambino per Natale! Voglio che nessuno mi porti mai più ad uno spettacolo di marionette!> CAPITOLO 8 Tuffandosi nella macchia Il favoliere si armò di rasoio e si scrutò un’ultima volta allo specchio. Quella era l’ultima volta in cui avrebbe riconosciuto, attraverso quel volto, la sua vecchia identità. Fissò l’attrezzo da barbiere, contemplò quella lama antica, ma ancora affilata e rilucente. Ecco, adesso avrebbe dato un taglio al suo essere. Il rasoio tremò e fu colto da un’esitazione, ma non aveva scelta: era con le spalle al muro… di una parete piastrellata. Si gettò in volto una manciata d’acqua, si spruzzò della schiuma e si rase il pizzetto. Risparmiò i baffi: quelli li avrebbe lasciati crescere. Gli sembra- va che dei lunghi mustacchi si adattassero bene alla sua nuova identità, quella di Yanez de Gomera: gli davano un’aria più vissuta, anche se non ancora abbastanza tenebrosa. Per avere un aspetto più virile si rase i capelli a zero. Così i baffi risaltavano di più, ma mancava ancora qualcosa. Avrebbe potuto aggiungere degli occhiali scuri da sole, ma erano troppo convenzionali. Sarebbe occorso qualcosa di più originale, di più forte per un personaggio trasgressivo come un pirata. Decise di mettersi una benda sull’occhio… Sul destro o sul sinistro? Avrebbe dovuto coprire l’occhio che percepiva il bene o il male? Poi, pensò di tingersi i baffi di biondo. Si tinse il baffo destro, ma esaurì l’acqua ossigenata, per cui l’altro mustacchio restava nero. Ormai non vi era tempo per riparare a quell’obbrobrio e radersi completamente: la polizia lo tallonava e un velivolo lo aspettava. Chiuse la porta del bagno dietro di sé, lasciando che lo sciacquone trasportasse, verso le fogne dell’oblio, le tracce dei suoi capelli, del suo pizzo e della sua vecchia identità. Il sole si affacciava in una timida aurora. Era tempo di darsi alla macchia, fuggendo lontano dalla giungla d’asfalto. Dette un ultimo bacio alla moglie e alla figlioletta addormentate. Quella mattina Yanez non prese l’automobile; temeva che la sua targa fosse già stata segnalata alla polizia, e di poter incappare così nei numerosi posti di blocco, che rendevano più chilometrici del solito i serpenti di auto che si attorcigliavano attorno agli incroci. Salì sul metrò: gli sembrò strano che il vagone non fosse gremito di pendolari ma, oltre ad essere presto, era domenica. Accanto a lui, una grassa signora con il foulard reggeva una borsa dalla quale spuntava una baguette, che un giovane ragazzo con un cappello da basket addentò. Tutti erano distratti da un piccolo cane, un volpino tenuto in braccio da un vecchio signore con la coppola, che digrignava i denti. Ringhiava contro Yanez. Per fortuna l’aeroporto era ormai vicino. Dagli schermi dei televisori dell’aeroporto, i tre cronisti del momento, Tina Corrodi, Cuco Zucca e Filippa De Marini, si passavano continuamente la linea, come una pallina da pingpong, per aggiornare spettatori e passeggeri sull’ultimo delitto che aveva sconvolto il Bel Paese. Yanez, si toccò il baffo nero e quello biondo e si immerse in un opuscolo turistico della Malesia. Yanez de Gomera planò su Singapore, e poi prese un battello che, il lunedì, lo sbarcò nella più grande isola dell’Indonesia. Ecco, finalmente era giunto il momento di tuffarsi nella macchia di verde, e lì, nella giungla tra il Sarawak e il Kalimantan, levarsi, lavarsi di dosso la terribile macchia, di sangue, che deturpava la sua anima. Teneva con sé solo una piccola borsa a mano e il passaporto. Essendo braccato, doveva essere il più leggero possibile. Non appena si addentrò nella giungla del Borneo, bruciò il passaporto: il nome che c’era stampato, Yanez de Gomera, era falso. Entrando in quella natura selvaggia voleva liberarsi dell’ultima falsità imposta dalla civiltà. Avrebbe chiesto ospitalità agli ultimi Dayachi che ancora vivevano nel cuore della giungla, resistendo alle orde di motoseghe e ruspe che volevano abbattere la loro casa: la foresta. Sapeva che quando li avrebbe raggiunti non sarebbe servito esibire il passaporto: per dimostrare quel che si è nella giungla basta il proprio valore. Facile a dirsi, e difficile a farsi, ora aveva varcato il mare, l’oceano che si frapponeva tra il dire e il fare, tra gli oltre quattromila metri del monte Kinabalu e le anse infinite del fiume Kapuas. Nel cuore del Borneo, perso nel mare di verde tra Balikpapan e Tawai, non riusciva nemmeno a capire in quale direzione cercare i dayachi, gli ultimi cacciatori di teste. Non poteva chiedere indicazioni in giro, perché erano in guerra con il governo e sarebbe stato arrestato come un fiancheggiatore dei ribelli. Per alcuni chilometri, si fece dare un passaggio su per il fiume da alcuni cercatori d’oro che vivevano su una giunca o su un prahos. Li salutò e si addentrò nella foresta tra acacie sovrastate da oranghi. Fatta eccezione dei buceri, dei gibboni, di qualche iguana, non s’imbatté in altra anima viva. Eppure aveva sempre la sensazione di essere spiato, dalla polizia, dai guerriglieri o dalle belve. Si addormentò sotto un teck, accanto alla sua borsa, sognando avventure. Mentre russava, un mostro gli si avvicinò con passo felino. Per fortuna, non era un hariman-bintang, la terribile pantera della Sonda, per cui poté proseguire i suoi sogni. Si trattava di una tigre che annusò la sua borsa, la divorò come antipasto e poi gli addentò un calcagno. Trasalì, urlò di dolore, scagliò una pietra contro la fiera, ma non riuscì a centrarla, perché teneva le palpebre abbassate. Quando la tigre gli strappò la gamba, riapri gli occhi e si accorse che quello era solo un incubo. Per lo spavento uno dei sopraccigli cambiò colore: divenne quasi bianco in confronto all’altro, che restò nero, ma osservandolo meglio era biondo. Forse l’incubo della tigre era un sogno, il desiderio di un’avventura che lo ridestasse da quella tremenda monotonia? Là, tra i banani, i teck, le piante di ananas, di caucciù o di sandalo, il cammino procedeva lentamente, senza il minimo sussulto, tanto piano che ad ogni sosta si assopiva. Nel dormiveglia gli parve di avvertire un fetore, forse l’esalazione di carne marcia: che il trofeo che celava nella borsa stesse per putrefarsi? Una mosca gli si posò addosso: la scacciò e l’insetto si depose su un fiore enorme. Per un attimo pensò che quella corolla paresse gigantesca al confronto delle piccole dimensioni dell’insetto; poi avvicinò una mano al fiore e si accorse che il bocciolo era veramente enorme: misurava quasi un metro. Spalancò gli occhi e si dette un pizzicotto: quella non era la percezione di un incubo, ma della realtà. I petali si richiusero e inghiottirono la mosca. Yanez si allontanò per paura che il fiore ingurgitasse anche lui. Settimane dopo, i penan gli spiegarono che si trattava della Rafflesia Arnoldi, il più grande fiore del mondo, che viveva nelle isole della Sonda. Fu presto ripreso dal tedio della lentezza, tanto che rimpianse pure un incubo che lo scuotesse da quella assenza di movimento. Provò a scrollarsi la noia di dosso mettendosi in cammino, cercando i cacciatori di teste, ma non capiva dove fossero. Sapeva che i dayachi vivevano nel cuore della foresta, ma gli era gravoso persino riconoscere la giungla. Nei film e nei romanzi la giungla è traboccante di piante e animali esotici. Nella realtà flora e fauna si nascondono e si disperdono in una zona intermedia, ibri- da, grigia, dove si mescono piantagioni, radure, orti, boscaglie, arbusti, acquitrini, mangrovie, cadaveri di foreste bruciate dai contadini o rase al suolo dai tagliaboschi. Gli unici esseri esotici di cui vi era abbondanza erano i ragni e i serpenti e, soprattutto, le zanzare. Ogni tanto, incontrava capanne popolate da gente locale, ma gli era difficile riconoscere tra loro gli antichi guerrieri: tutti avevano addosso segni di civiltà, come un cappellino da basket, una maglietta con lo slogan Scola Cola o un orologio, che contaminavano la realtà selvaggia, incontaminata, che Yanez bramava. Quella realtà che aveva letto nei romanzi di Salgari o di Kipling. Quei romanzi scritti due secoli addietro, prima che si diffondesse nel mondo la corrente elettrica: là dove vi era l’elettricità la gente non si radunava più davanti a un focolare per raccontare, ma attorno al televisore, muti, a contemplare sogni che lì, nella foresta, erano impossibili. Nella giungla il cammino non procedeva per avventure o grandi imprese a ritmo di rock, come scontri con il leone o i pitoni o guerrieri armati di kriss o di cerbottana. No. Lì, nelle profondità della foresta, la vita procedeva lenta, silente, immobile, nutrendosi di piccoli gesti come il taglio della legna, l’accensione di un fuoco e lunghe soste: ore ed ore ad attendere su un sampan che un tilapia abboccasse alla lenza o seduto sul suo macabro bagaglio, giorni ed intere notti ad aspettare che una preda si lasciasse trafiggere da una lancia o catturare da una trappola. Era scappato dall’Europa per evadere dalle attese nell’ingorgo stradale o in una fila al supermercato ed ora si ritrovava costretto ad attese ancora più lunghe. Dapprima quella soste forzate gli sembrarono tremende, profonde quanto l’oceano che aveva varcato. Yanez captava quasi ogni giorno gli strofinii, i fruscii, i brusii, persino gli sguardi di qualcuno che lo spiava. Poi imparò a combattere la noia o la paranoia senza restare con le mani in mano: intagliava ciotole, intrecciava cesti, aguzzava frecce, raccoglieva paku, ananas, miding e banane, ammazzava il tempo e qualche scorpione. Certo non era facile farlo con una borsa in mano, ma non poteva separarsene. Ad un certo punto, persino l’attesa con la lenza sulle sponde del Batang Rejang non divenne più un vuoto, ma un’attività che riempiva, arricchiva il suo tempo, gli dava la possibilità di trasecolare e di contemplare caimani, fenicotteri e altre curiose creature che popolavano il fiume nella giungla. Trovò il centro della foresta, grazie alla furia distruttiva che incalzava alla sua periferia. No, non era lo tsunami, ma una devastazione meno forte, ma alla lunga altrettanto rovinosa: era la forza delle ruspe e delle motoseghe che abbattevano gli alberi per venderne il legname. Fuggendo alla distruzione dei tagliaboschi giunse nel cuore della giungla dei dayachi. Attraversò le montagne del Pejunajan, le anse del Kapuas, del Mahhkanum e del Barito. Varcò la giungla del Kalimantan e giunse nella foresta del Sarawak, da cui gli oranghi, arroccati sui rami come fossero su bertesche, spiavano l’intruso dai bizzarri mustacchi. Non vedeva ancora i dayachi, ma gli pareva di udirne il respiro. Talvolta credeva di scorgerli con la coda dell’occhio, ma appena si voltava sentiva qualcuno che fuggiva tra le frasche. Che fossero quei mostri antropomorfi noti come “meia”, “mias” o “maias”? Se non mostrava di accorgersi di essere osservato, allora avvertiva che chi lo spiava si avvicinava. Fu così, facendo finta di nulla, che si ritrovò circondato dai dayachi. Appena rivolse loro la parola, i guerrieri si allontanarono. Stavolta, però, non scomparirono nella macchia. Yanez li inseguì, ma si accorse che non facevano nulla per dileguarsi. Lasciavano che il bianco li pedinasse. Che volessero attirarlo in una trappola? Lì seguì fino al loro villaggio di capanne abbarbicate tra gli alberi. <Buon giorno! Salve! Buon dì! Disturbo? Sono di troppo? Me ne devo andare?… Ehi, dico a voi!> Yanez s’introdusse nel villaggio, ma nessuno pareva accorgersi della sua presenza. Si spinse persino dentro una capanna, ma nessuno sembrava in grado di vederlo. Osservò i Dayachi mentre si tatuavano. Provò a fare “Marameo” a tutti i bambini della tribù, ma neppure loro parevano notarlo. Che fosse divenuto etereo o impercettibile? Ma, se fosse stato invisibile, non avrebbe potuto nemmeno lui vedere le sue mani, le sue braccia, il suo corpo. Si avvicinò ad un fuoco, dove degli uomini tatuati cucinavano della carne di bue dentro foglie di simpoh e disse sorridendo: <Salve! Posso aggiungermi alla tavola? Beh, si fa per dire! Posso assaggiare? Chi tace acconsente? Uhm, buono, squisito questo boccone. Sono di troppo? Me ne devo andare? Basta che facciate un cenno e me ne vado… Ehi, dico a voi!> Urlò saluti ad un gruppo di donne occupate a farsi un tatuaggio, ma nessuna lo guardò. Notò di avere meno peso delle mosche: quelle almeno erano cacciate dai dayachi. Che fosse diventato un fantasma? Oppure era lui ad essere capitato in un villaggio di spettri? Che fosse stato condannato anche lui, come Ulisse o Enea ad una spedizione nel regno delle ombre? O costretto, come Dante, ad affrontare un viaggio nel regno dei trapassati? Ma se quegli esseri erano ombre o morti, come era possibile che riuscisse a nutrirsi del loro cibo? Che fosse giunto come Astolfo sul pianeta dei folli… o delle anime perse? Sembrava che lui ― o il villaggio nella giungla ― non esistesse, eppure poteva mangiare, bere, scaldarsi al fuoco dei dayachi. Solo una cosa non riusciva a compiere: farsi un tatuaggio sulla schiena, per il quale avrebbe avuto bisogno dell’aiuto di qualcuno, che però ignorava completamente l’esistenza di Yanez. Insomma, lì non era nessuno, era proprio diventato l’incarnazione di nessuno, di un uomo fatto di nulla. O forse erano gli altri a non esistere? Chi era lui, nel mezzo di quella grande isola tra due oceani? Provò ancora a mettersi in contatto con i suoi simili: <Buon giorno, sono Yanez de Gomera. Disturbo? Sono di troppo? Me ne devo andare? Ehi, dico a voi!> Nessuno reagiva. O forse tutti non rispondevano a nessuno, perché lui era proprio il signor Nessuno. Insomma, come avrebbe potuto dimostrare di essere qualcuno? CAPITOLO 9 In un regno senza capo Il favoliere si chiese come sarebbe stato possibile essere riconosciuto con un nome, Yanez de Gomera, che non era il suo! Lì, sbattuto nella giungla, senza un vero documento, era arduo non solo dimostrare la propria identità, ma persino palesare la propria esistenza. Si appoggiò ad un grande albero di teck su cui erano appollaiate delle scimmie proboscidate: forse il loro enorme naso avrebbe percepito almeno l’odore di Yanez? L’ex marionettista si prese la testa fra le mani. Non disponeva nemmeno di uno specchio per provare la propria apparenza. Che fare per dimostrare che lui NON era il signor Nessuno? Chiuse gli occhi, accarezzò il baffo nero e quello biondo e si sforzò di tornare indietro, di ricordare quando era qualcuno, quando era un qualcuno che cominciava ad esistere proprio davanti ad uno specchio… Innanzi ai suoi occhi si stendeva il buio: Poi, in questo buio, oscuro come una macchia indistinta di inchiostro, s’intravide un pertugio, il barbaglio di un carattere scritto da un’esile luce, ma imperversavano ancora le tenebre. Da questa pagina cupa non trapelava un’oscurità qualsiasi, ma un grumo nero, che risucchiava tutto quanto c’era attorno: le stelle, ogni riflessione di luce e persino la sua identità. Stava per essere catturato da un buco nero. Poi il suono della sveglia gli fece capire che quel buio non esisteva veramente, ma era solo creato dalle tapparelle abbassate sulle sue pupille. Per dissolvere il buco nero nella normalità della notte, bastava riaprire gli occhi. Alle sei e trentacinque si svegliò. Alle sei e quaranta, con la stessa solennità del primo uomo sulla luna, pose il piede sulla terra, oltre quella che prima era un’astronave da sogno ed ora soltanto un letto. Alle sei e quarantacinque, con la stessa velocità di un astronauta su Marte, si avventurò verso uno specchio che dimostrasse che lui era un essere umano e non un marziano, ma la via era sbarrata. Una paratia si frapponeva fra lui e lo specchio. Il bagno era già occupato da un essere che, data l’ora, avrebbe potuto essere più estraneo di un marziano. Alle sei e cinquanta il marito conquistò l’ingresso del bagno. Compì tutte le operazioni che ancora oggi svolge un uomo all’alba, prima di recarsi al lavoro. Alle sette e dodici in punto si osservò davanti allo specchio, si chiese per un attimo chi fosse, si armò di una forbice, si spuntò il pizzetto, si pettinò. Alle sette e venticinque, con dieci minuti di anticipo, avviò l’auto. Quel giorno era martedì e quindi, oltre a far benzina, avrebbe dovuto controllare le gomme. Il marito era un uomo meticoloso, con la testa sulle spalle. Quel giorno era più assonnato del solito. Accese l’autoradio per svegliarsi; la cronista Filippa De Marini annunciava le consuete privatizzazioni realizzate quel giorno dal premier: <Comprando il Colosseo ― dichiarava il capo del governo ― vi ho fatto un favore: vi ho liberato da un monumento in rovina la cui manutenzione pesava troppo sulle casse dello Stato. In questo modo doterò la città della lupa di un nuovo stadio!> L’automobilista credette di trovarsi in un sogno e si fece cogliere da un colpo di sonno. Si accorse all’ultimo momento di un anziano signore con la coppola che portava al guinzaglio il cane… e dovette frenare bruscamente, facendo stridere le gomme, per non investirlo. <Ma chi ti ha dato la patente?> Il marito era un uomo meticoloso, con la testa sulle spalle, che ogni tanto si distraeva. Alle otto e trenta giunse sul posto di lavoro, timbrò con metodica precisione il cartellino, depositò la valigetta ventiquattrore… e inciampò in un volto mozzato. Orrore! Bellofronte era stato decapitato! L’uomo non si perse d’animo, raccolse i resti di quel corpo dilaniato e si accinse a medicare tutte le ferite dei pupazzi del suo teatrino. Il favoliere brandì uno straccio e cominciò a spolverare le marionette. Il sipario era tutto impolverato, per cui avrebbe dovuto essere portato in tintoria. Inoltre occorreva passare lo straccio sul pavimento, in una laboriosa gincana tra le sedie del pubblico. Almeno due poltroncine zoppe chiedevano supplicanti una gruccia. A tutte queste cose doveva pensare! Ma lui era un uomo con la testa sulle spalle, cosicché non poteva perdersi d’animo, per portare la pagnotta a casa. Versò sera, arrivò come sempre, più o meno numeroso, il pubblico. Alle venti e trenta, tra spettatori più o meno interessati, ebbe inizio lo spettacolo. Non sapeva ancora quale creatura avrebbe abboccato all’amo del suo “C’era una volta”. Gettò la lenza nel vuoto e aspettò che un personaggio, quella personalità che sarebbe divenuta la sua marionetta, vi si appigliasse. C’ERA UNA VOLTA UN UOMO INCORONATO SENZA TESTA Essere un re senza testa comportava molti problemi, almeno per degli uomini seri, con importanti responsabilità, come ad esempio quelle che gravano su un capo di Stato. Si ha poca memoria, si pensa poco, si parla con poco senno. Ma del resto, che razza di Stato è un regno con un capo senza capo? E poi, ammettendo che si potesse trovare un bravo e onesto ciambellano che facesse le veci del re, dove appoggiare la corona? Qualcuno, dotato di sbrigativo senso pratico risponderà: <Tenendosela in mano!> Ma in questo modo il poveruomo non aveva mai le mani libere, e non poteva sbrigare le sue mansioni, anche quelle pratiche come lavarsi i denti, farsi la barba o mettersi le dita nel naso. Il maniero della nostra favola aveva un’apparenza ingannevole, quasi quanto quella del mago Atlante. La rocca sembrava d’oro e d’argento. Sembrava: in effetti era avvolta da fogli di carta, perché tutto parte dalla carta, anche i castelli di queste favole. Si trattava però di carta speciale, particolarmente colorata e rilucente; quei fogli argentati e dorati celavano mura color ebano e torri color avorio… Ma non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Tra i bastioni di quel che non era ebano ma cacao, e le bertesche di quel che non era avorio ma cioccolato bianco, risuonarono le trombe che annunciavano solennemente l’arrivo del re nella grande sala del castello. Sulla scena apparve il monarca, sontuoso, maestoso, con lungo mantello, passo marziale, forse addirittura reale. Teneva in mano scettro e corona e si accingeva a suggellare con la propria penna un trattato di pace con un potente reame vicino. Quando si sedette sul trono, il ciambellano si rese conto di un insormontabile dilemma. Come liberare la real mano necessaria alla firma del trattato? Rimettendosi la corona in capo? Ma il re in questione non aveva testa. Affidando per un istante la corona alle mani del ciambellano o del principino? Ma il trattato, per essere valido, doveva essere segnato da un re incoronato, dotato cioè di corona. Che razza di re è un sovrano incapace di tenere una corona? Rimasero tutti imbarazzati, impietriti in un gelido silenzio. Tranne Arlecchino, il giullare, che rideva: <Certamente, per Sua Maestà è il colmo ritrovarsi un tale grattacapo!> Del resto la funzione del buffone era quella di darsi al riso. Intanto la pace con il potente regno vicino non ebbe seguito. Il giorno seguente il re convocò Arlecchino. Il giullare capì subito che avrebbe subìto una bella lavata di capo. Nella sala del trono era stato convocato un omone a torso nudo, con un cappuccio nero, che affilava un’enorme scure. Che fosse il boia? Il sovrano indicò il buffone con lo scettro e lo incaricò di partire da quel castello per andare a cercare la preziosa testa reale smarrita. Brandendo minaccioso lo scettro troneggiò: <Lo smarrimento del cranio del sovrano è una faccenda seria di cui non si può ridere! Per punizione cercherai la testa smarrita nell’unico luogo che nessuno ha mai osato esplorare!> Ma come? Come faceva a proferire parola un uomo senza testa? Scriveva i suoi ordini su una pergamena che veniva letta ad alta voce dal ciambellano! Il monarca, gesticolando più rabbiosamente, sentenziò: <Ti avventurerai nella valle del Bieco!> Il menestrello giunse le mani in segno di preghiera: <Vi prego, pietà vostra Sommità, abbiate pena, condannatemi ad un’altra pena!> Il re scosse lo scettro in segno di diniego. Il buffone si gettò in ginocchio e cominciò a piangere implorando clemenza: <Vi prego, o capo Supremo, infliggetemi qualsiasi castigo, ma non di varcare la valle del Bieco!> Tanto insistette che il re disse: <E va bene, non andrai nella valle del Bieco!> Arlecchino si lasciò scappare un osanna e un <Hip hip hurrà,> ma il sovrano gelò il suo sollievo con un’altra tremenda condanna. Il monarca puntò lo scettro verso Arlecchino ed emise una crudele sentenza: <Ti inoltrerai nelle pozze del fiume Breggia, e là ti destreggerai distruggendo il mostro fiammeggiante!> Il buffone di corte supplicò il monarca di affidargli impresa più facile: la conquista del vello d’oro, del dente dell’orco, o la denuncia di un concorso pubblico senza raccomandati, ma non una così ardua. Il re, appellandosi alla corona di cui comunque manteneva il possesso, insistette e gli intimò di eseguire il suo ordine, pena la decapitazione. Ad Arlecchino non restò che rassegnarsi all’obbedienza, giacché un sovrano senza testa resta sempre un monarca, mentre un giullare, un suddito, o un uomo senza cranio non è più nessuno. E, facendo un inchino, se ne partì da palazzo a capo chino. Il giullare raggirò la valle del Bieco e si avventurò nella vallata del mostro, tra verdeggianti valli che si stringevano in da urlo, si avvinghiavano nelle di vortici e si avviluppavano nella di un inferno verde. Arlecchino si tuffò tra i meandri dei monti e dragò i mulinelli del fiume alla ricerca del drago, ma non scorse nulla, nemmeno un magro mostriciattolo. Il menestrello penetrò nelle fauci della montagna finché la gola della valle venne scossa dall’ugola della famelica fiera. <Arg!> grugnì vorace il drago digrignando i denti in un ghigno feroce. <Mi sembra di arguire che ti si sia ingorgata la gola!> disse Arlecchino provocando il mostro, che riprese con un nuovo e più profondo <AAArrrg!> che percorse l’intera gola della valle. <Ergo mi pare che l’ingordigia abbia ingroppato le tue tonsille.> Il mostro riprese con un “Arg” di terrore, incalzato dal giullare che strillava: <Ti prendo da tergo e con una filastrocca infergo!> Ma che diavolo di arma è una filastrocca contro un mostro così terribile?! Eppure, già il primo dardo del giullare spaccone picchiò duramente la bestia verde. <Ti prego ― invocò il drago ― io non posso rivelarti chi tiene prigioniera la testa che cerchi!> Arlecchino scoccò allora una seconda filastrocca. Fiaccò il drago con fiocchi di versi finché il mostro si accasciò supplicando con voce fioca: <Abbi pietà di me, non sono io, ma il mago, a disporre della testa del re!> Quindi l’enorme bestia cercò di reagire eruttando una colonna di fuoco alta quanto cento guerrieri. Ma il saltimbanco non si perse d’animo, schioccando crudele un’altra tremenda filastrocca che fece scricchiolare il nemico spaccandogli le ossa. <Sarai tu ― disse al mostro ormai vinto ― a recarti dal mago per reclamare la testa reale!> Ma lo sciocco drago cercò di resistere. Fu allora che l’inesorabile Arlecchino finì il mostro gracchiando un’ultima filastrocca... Il mago Atlante attaccò ferocemente il menestrello. Con il suo bastone percosse la roccia aprendo enormi voragini che cercarono di inghiottire l’eroico giullare. Poi, con il suo corno chiamò dai più profondi abissi battaglioni di orchi con il muso da lupo che, ringhiando e ululando, presero d’assalto Arlecchino. Tuttavia, nessuno dei sortilegi del re dei sabba poté vincere le filastrocche del saltimbanco. Arlecchino tornò al palazzo reale con la testa del re. Il monarca lo accolse trionfalmente porgendogli, quale suprema ricompensa, la mano della principessa o la nomina a cavaliere. Il sovrano ordinò che si festeggiasse l’eroe con un grande torneo e un banchetto. Furono divorati cinghiali, faraone, piramidi di anatre farcite, faraonici cervi allo spiedo. Dopo il dessert, quando giunsero all’ammazzacaffé, qualcuno dei convitati chiese ad Arlecchino di rivelare il segreto delle sue filastrocche, offrendo di pagarlo a peso d’oro. Ma l’eroe rispose, con un inchino, che: <La bocca di Arlecchino non scocca né arrocca versi, non tira le fila, o ciocche di balocchi. Beve soltanto, strizzando l’occhio a Bacco, dalla brocca gracchiante della filastrocca.> Proferì il giullare, gingillando con il suo giallo liuto, che: <l’artista è di una pasta senz’arte né parte. Si appresta senza sosta per pista lesta, con cesta di gesti estrosi. Il suo giusto posto è ad un festino da re con pasto per poveri astanti privi di casta…> Il racconto del cantafavole echeggiò in uno spaventoso vuoto, nella voragine che la fame aveva aperto nel suo stomaco. Il favoliere riaprì gli occhi e smise di pensare al suo vecchio mestiere e alle storie che raccontava per campare. Aveva la pancia vuota e per sopravvivere nella giungla non gli sarebbe bastato narrare favole. CAPITOLO 10 Cercando un punto nella macchia Appollaiati tra i rami più alti dei bengkirai della foresta pluviale tra Labuan e Banjamsin, come se quelle cime fossero delle guglie, quella mattina gli oranghi assistevano divertiti allo scimmiesco tentativo di comunicazione di Yanez. Insomma, non era possibile che in quella selva nessuno si accorgesse di lui. Per l’ennesima volta, il favoliere si affannò per contattare il popolo della foresta, ma stavolta scandì meglio le parole: <Buon… giorno! So-no Ya-nez de Go-me-ra! Di-stur-bo?> Nonostante la totale indifferenza, si rivolse ad una matrona che cucinava del tilapia nelle foglie di tapioca e poi s’indirizzò ad un vecchio che tatuava un coccodrillo sul dorso di un ragazzo, ma stavolta accompagnò le parole con i gesti. <Sono di troppo? ― disse sbracciandosi sempre più energicamente ― Basta che facciate un cenno e me ne vado… Ehi, sto parlando con voi!> Nessuno lo degnava di uno sguardo. O forse tutti non potevano vedere nessuno, perché lui era davvero Nessuno. Si ridisse che lui era Yanez de Gomera, ma neppure lui se ne convinse: quel nome e cognome non erano suoi, né erano mai appartenuti ad un personaggio reale, ma solo ad una creazione della fantasia. Eppure non gli sarebbe bastato nemmeno affermare di essere James Brooke o il sultano del Brunei! Era pure lui, adesso, un personaggio immaginario? Per trovare una certezza sulla sua identità, non poteva nemmeno aggrapparsi al nome e al cognome del suo passato: li aveva bruciati assieme al passaporto, prima di darsi alla macchia. Colto da dubbi amletici, si sforzò di aggrapparsi all’unico elemento concreto ed assodato del suo passato: lo custodiva nella borsa. Accidenti! Perché un uomo con la testa sulle spalle come lui non ci aveva pensato prima? Nella sacca conservava l‘attestazione che lui un tempo era stato un uomo reale, capace di azioni vere, persino brutali. Preso dalla disperazione, l’ex favoliere aprì la sua borsa, afferrò il trofeo che conteneva e lo lanciò nella piazza, proprio nel centro attorno a cui si raccoglievano le capanne. Neanche stavolta qualcuno dei dayachi si accorse del sussulto del forestiero o di quella testa recisa che per loro avrebbe dovuto costituire un segno di distinzione. Yanez poi capì che quella che per lui era una piazza per i tagliatori di teste, che vivevano in casupole abbarbicate tra gli alberi, era solo l’ennesimo vuoto tra i rami. Lo straniero scese dal bengkirai, afferrò per i capelli il capo mozzato, rimontò su per un teck e corresse la mira lanciandolo nella capanna che fungeva da sala riunioni dei penan. Una testa rotolò ai piedi dei dayachi. Gli occhi dell’onorevole Saulo Cresonte parevano scandagliare perplessi tutta quella gente. Solo allora i penan si ricordarono di essere dei dayachi e accettarono di vedere Yanez, ravvisando in lui un cacciatore di teste. Un uomo di mezz’età, dal fisico vigoroso, con il corpo decorato da rughe, cicatrici e tatuaggi, che dal piumaggio pareva fosse il loro capo, chiese: <Cosa vuoi dalla nostra tribù? Cosa vuoi venderci?> Il favoliere era ancora irritato per essere stato ignorato per tanto tempo: <Ah, finalmente vi accorgete di me! Cosa vi impediva di vedermi prima? Non mi avete visto neppure quando ho mangiato con voi!> Il capo sorrise divertito: <Prima di entrare nelle nostre capanne sugli alberi, qui si usa dire “Siou Do Mohoing”, ma voi bianchi avete il brutto vizio di non dirlo!> Yanez chiese: <E cosa diavolo significa “Siudomoing”?> Un ragazzo dayaco lo corresse: <Si dice “Siou Do Mohoing”!> Il favoliere riconobbe seccato: <Scusa la mia pessima pronuncia!> Il capo spiegò: <Significa: “perdonaci di entrare”. Inoltre, se proprio vuoi mangiare con noi, dovresti usare solo le prime tre dita della mano destra!> Yanez tacque, abbassò lo sguardo e ammise: <Scusate, ma non avevo capito!> Il capo commentò: <Voi bianchi non capite molte cose del nostro modo di vivere, perché non sapete guardare nell’anima dell’altro!> L’avventuriero balbettò: <Eppure io vorrei vivere tra voi!> Il capo dei penan rise, seguito dalla risata di tutti i membri della tribù e da quella delle scimmie proboscidate a penzoloni sulle acacie vicine. Il capo chiese: <Come può un bianco nato nel paese più ricco dell’Occidente, vivere con dei guerrieri seminudi in guerra con la civiltà?> Yanez non demorse: <Non me ne importa nulla della civiltà. Il suo progresso sta distruggendo tutto, persino la vostra selva!> Il capo ridacchiò ancora: <Che ne sai tu della giungla, della guerriglia, del colera, dei dayachi? Tra Palangkaraya e Miri non ho mai conosciuto nessuno così presuntuoso! Ti sei addirittura portato la borsa con i vestiti: nella foresta sono solo d’impaccio!> Questa volta fu Yanez a sogghignare: <Questa borsa non contiene vestiti e la voglio subito buttare via! Non ho nulla da offrivi se non me stesso e questo trofeo che testimonia la mia voglia di combattere! > Il capo dayaco spiegò perplesso: <Se vorrai stare tra noi non dovrai solo accettare il nostro modo di vivere, ma dovrai adottarlo tu stesso, credendoci fino in fondo, vivendolo sulla tua pelle. Perché noi penan viviamo ogni metafora, ogni sogno, ogni canzone… sulla nostra pelle. Noi non lasciamo che i sogni diventino pensieri e pesino e marciscano nella testa: noi viviamo le nostre emozioni e la nostra umanità concretamente, in modo immediato. Se ad esempio, vogliamo conquistare l’anima di un nemico, noi non lo insultiamo, non lo compriamo, non lo umiliamo, ma lo decapitiamo. No, non lo uccidiamo per crudeltà, ma per conquistarne l’identità: la sua testa sarà conservata per sempre su un altare! Sei pronto a vivere come noi?> Yanez disse: <Anche nelle favole che raccontavo prima di venire qui le metafore e i sogni erano parte integrante della realtà> e indicò il cranio che aveva portato con sé. Fu così che la tribù dei cacciatori di teschi accettò di fare un tatuaggio sulla schiena di Yanez: raffigurava un drago che ingurgitava la testa di un bianco. Da allora, i penan accolsero lo straniero come un loro fratello. Da quel giorno, in tutta l’Indonesia e la Malesia, si mormorò di un guerriero bianco, con un occhio solo, che guidava i dayachi nella lotta contro i mostri di ferro che minacciavano la giungla. Le ruspe dovettero essere scortate dai soldati, anche di notte. Ma dalla macchia, soffiati dal respiro attraverso le cerbottane, giungevano dardi avvelenati che colpivano i militari. I fanti si difendevano a casaccio in quell’inferno verde, sferrando alla cieca raffiche di mitra, senza vedere l’aggressore. I soldati dovettero abbandonare le ruspe per dare la caccia ai guerriglieri arroccati sugli alberi come fossero torri di una reggia. Sulla testa di Yanez fu messa una taglia, ma lui riusciva sempre a dileguarsi protetto dal labirinto di tronchi. Per catturarlo avrebbero dovuto abbattere l’intera boscaglia. Il capo dei dayachi notò che quando combatteva contro i tagliaboschi, Yanez teneva scoperto l’occhio sinistro, mentre quando era al villaggio tra i dayachi mostrava l’occhio destro. <Insomma ― gli chiese ― a cosa diavolo ti serve quella benda?> Yanez cercò di spiegare: <Con un occhio vedo il bene e con l’altro il male!> Talvolta la lama dei dayachi si avventava sul collo dei nemici. Ma amputare una testa non era così semplice, come può sembrare in epici finali come quelli di Golia o di Macbeth: il più delle volte occorreva menare sul collo del malcapitato più di un fendente e a volta la lama s’impigliava fra le cervicali. Purtroppo, in quella guerra, i dayachi non potevano fermarsi a mozzare la testa del nemico ucciso, ma dovevano subito svanire nella giungla. L’unico trofeo che potevano esibire era il racconto delle loro battaglie contro le ruspe. Ogni sera, i combattenti narravano gli eroismi di quel giorno e poi i vecchi decantavano le gesta dei duelli, in cui si rendeva onore al nemico ucciso conservandone la testa. Fino a notte fonda, i bambini della tribù ascoltavano l’eco di quelle imprese che già conoscevano, come se le avessero udite per la prima volta. Tutti, a turno, raccontavano una favola, strappandola dal proprio passato. Anche Yanez fu chiamato a narrare, proprio mentre una tarantola si avvicinava alla sua mano. Era stato abituato fino ad allora a parlare attraverso le sue marionette, ma si ritrovava nudo, privo di effetti speciali, armato soltanto di parole, ricordi e fantasia. Yanez dovette subito rinunciare a raccontare Salgari, perché conoscevano quella realtà troppo bene, meglio dello scrittore veronese. Un bambino con la cravatta firmata, gli fece subito notare ridacchiando: <Nel Borneo non esistono tigri della Malesia: quelle c’erano semmai a Sumatra, o a Giava, mentre qui vi sono i leopardi!> Yanez lo guardò perplesso, proprio quando la taran- tola zampettava sulla sua mano e domandò al fanciullo: <Cosa ci fai nella giungla con una cravatta firmata?> Il bimbo sorrise: <L’ho rubata ad uno straniero, un turista!> De Gomera non trasalì, lasciò che la tarantola camminasse oltre la sua mano proseguendo il suo tragitto sul ramo di un albero di teck e si rammentò di essere un padre: <Non sta bene rubare le cose degli altri!> Il piccolo non si scompose: <Ma io non ho voluto rubargli la cravatta, ma la firma! In questa tribù, tutti sottraiamo agli altri la loro identità> De Gomera gli chiese: <Borseggerai anche me?> Il piccole scosse il capo: <Anche tu, come quello che ho depredato, sei straniero, ma non sei un turista e nemmeno un ladro! Il padrone della cravatta derubava persino i suoi compagni!> Armato di una torcia, lo straniero si prese in braccio il piccolo con la cravatta firmata e si accinse a favoleggiare realtà lontane da ogni bambino della tribù. Un coccodrillo si gettò poco oltre la riva dove Yanez raccontava, ma il contastorie con l’occhio bendato proseguì imperterrito: <Ecco, adesso ti voglio introdurre in un’isola. Giocando con le favole, ci saremmo dovuti approdare, o naufragare, prima o poi, perché le fiabe sono proprio isole: sono scogli nel mare, oasi nel deserto, bagni del mistero o radure nella giungla d’asfalto del mondo reale...> Nella selva si udì sibilare un pitone che interruppe per un attimo Yanez. Tra Samarinda e Pontianak non ne aveva mai visti di così grandi. Yanez dimenticò quel sibilo e riprese a sciorinare: <Sì, lo so, mi dirai, siamo nel Borneo, che è già un’isola. Del resto la foresta è la nostra vera isola. Bisogna sempre cercare un altro scoglio dove evadere.> Lontano si udì il ruggito di un leopardo, ma Yanez si accarezzò il baffo biondo e quello nero e si ostinò a sussurrare una favola ad un fanciullo con il cappello da basket… In lontananza si udiva passare un elicottero militare. Un pappagallo colorato come un arlecchino si accomodò su un ramo, vicino alla testa del contastorie, forse per trovare un rifugio dai predatori che infestavano la giungla, ma Yanez seguitò ad affabulare… Il pappagallo si appoggiò sulla spalla di Yanez, ma lui riprese a confabulare… Anche quando si sentivano degli spari lontani, Yanez non mancava mai di borbottare una fiaba ai bambini. Ma ogni fanciullo cresceva e non si accontentava più di storie fantastiche. La giungla a pochi chilometri bruciava, estinguendo gli ultimi elefanti e gli ultimi rinoceronti, ma Yanez persisteva nel suo raccontare, faccia a faccia, a ciascun bambino, accarezzandosi la benda sull’occhio. Tutti erano tanto concentrati ad ascoltare gli echi di quei racconti che non si accorsero di un bambino, con il cappello da basket, che rubava del pane dalla sacca di una grassa matrona con il foulard. I ragazzi esigevano che riferisse una favola più prossima alla sua vita… Il bambino con il cappello da basket, seduto su un’altalena di liane, lo incalzò: <Perché sei fuggito? Da dove vieni? Chi eri prima di venire qui?> Alla fine, Yanez si lisciò il baffo nero e quello biondo e si arrese: <E va bene, comincerò a rispondere ad una delle vostre domande, esponendovi in una favola chi ero prima di nascondermi qui. Da giovane sono stato dapprima contrabbandiere di fumo. Poi, mi sono guadagnato da vivere smerciando nelle piazze eroi di favole o spacciando eroine di sogni che violavano la frontiera tra l’ordine della realtà e il caos della fantasia…> CAPITOLO 11 Indimenticabile primo amore Quell’essere che si librava nella giungla tra Kota Kinabalu e Palangkaraya, proiettandosi da una liana all’altra, non era una scimmia, non un acrobata del circo, ma qualcosa di più. Inerpicatosi sull’albero più alto, lanciò un urlo simile all’ululato, allo yodel e al ruggito: lo sentirono i leopardi, i boscaioli, i dayachi e capirono che quello era Tarzan. Che diavolo ci fa il re della giungla africana nel Borneo? C’era giunto in missione per conto de- gli svizzeri. Stava girando una pubblicità per una caramella elvetica contro il mal di gola. Il re della foresta dichiarò: <La mia caramella può rinfrescare persino l’alito di una Rafflesia Arnoldi!> come se tutti conoscessero l’acre odore di carne marcia emesso del gigantesco fiore carnivoro delle isole della Sonda. Per consentire all’attore che impersonava Tarzan di recitare per un paio di giorni in santa pace, l’agenzia pubblicitaria aveva dovuto pagare i boscaioli, affinché sospendessero momentaneamente il loro selvaggio taglio. Yanez e i dayachi osservavano divertiti l’intermezzo alla guerra offerto dalla pubblicità. L’indomani i penan avrebbero ripigliato a combattere il taglio degli alberi, con la mietitura di qualche testa. Forse già nella notte, si sarebbero insinuati nelle tende dei boscaioli sorprendendoli nel sonno. L’ispettore Bossettoni, il più accanito fumatore della polizia, era sulle tracce del mostro che aveva decollato l’azienda dell’onorevole Saulo Cresonte, non solo in senso figurato. L’assassino non aveva scordato dietro di sé vere tracce, odori evidenti, ma solo dei fumi: i moventi di un lavoro andato in fumo ad esempio. Forse, per familiarizzare con le cortine fumogene che si estendevano attorno alla figura dell’ucciso e dell’ucci- sore, il vice commissario Bossettoni accese più frequentemente le sigarette. L’investigatore aveva abbandonato la pista del movente politico per quello economico, stilando una lista di sospettati tra i debitori dell’ucciso. Indagò tra i fornitori di passaporti falsi: gli fu facile rintracciare un informatore, offrendo molte sigarette e la taglia che il presidente Costantino Cresonte aveva posto sulla testa dell’assassino del fratello. Nonostante la nebbia stesa da tante stecche, il segugio scoprì che uno dei principali indiziati aveva richiesto un documento, intestato a Yanez de Gomera e con questo nominativo aveva acquistato un biglietto d’aereo per Singapore. <Porca vacca ― imprecò l’ispettore ― ma io questo tizio l’ho già visto a teatro!> Bossettoni comunicò la sua scoperta al diretto superiore, ma se ne pentì, perché il capo lo inviò subito sul posto. A nulla valse recarsi a Singapore e sopportare per 12 giorni quel caldo opprimente infestato dalle zanzare, che tentava di scacciare con le esalazioni del tabacco. L’ispettore emetteva fiotti di sudore anche sotto la doccia. A distanza di tre settimane il ventilatore della sua stanza d’albergo si ruppe, e dopo aver consumato invano i polmoni in decine di pacchetti di sigarette, il detective decise di sospendere l’indagine. Sbatté nelle valigie la biancheria sporca, l’ultimo pacchetto di paglie e gli ultimi dubbi, si avviò per l’aeroporto e, mentre aspettava l’aereo per Malpensa, si fumò l’ultima cicca e acquistò il giornale. In prima pagina campeggiava la foto di una ruspa e di un blindato schiantati in un burrone; il titolo diceva: “Nuova incursione del bianco che guida i ribelli penan”. Il sottotitolo spiegava che nella notte i guerriglieri dayachi avevano segato parti delle strutture del ponte, che era crollato al passaggio di un convoglio di ruspe scortato dai carri armati. A questo punto, quelle ore della sua infanzia rubate allo studio, per divorare i romanzi di Salgari, produssero finalmente dei frutti: l’investigatore ricordò che Yanez era il nome di uno dei personaggi dello scrittore veronese e che il Borneo era una della sue zone operative. Bossettoni ebbe allora un’illuminazione: e se fosse stato proprio questo misterioso bianco, lo Yanez che il poliziotto braccava? Il vice commissario partì subito per il Borneo, affittò un fuoristrada, si procurò una scorta di stecche di sigarette e si addentrò nella foresta vergine. La sera, spossato per il viaggio, fermò la jeep in un minuscolo villaggio di boscaioli, dove offerse qualche paglia. Le zanzare lo attaccavano a sciami: <Porca vacca, in Svizzera farebbero una bella bonifica con l’insetticida!> Un indigeno gli chiese: <Anche in Svizzera ci sono tutte queste zanzare? > Il vicecommissario respingeva gli attacchi delle anofele con una cortina fumogena sollevata dalle sue sigarette. Bossettoni affittò una camera, chiese un posacenere, calcolò quanti lustri gli mancassero per riscuotere il premio fedeltà che gli aveva promesso il suo tabaccaio e si addormentò all’istante con la sigaretta ancora accesa. Nella notte si sentirono i versi di un orso che russava… Ma gli orsi malesi dormivano piuttosto di giorno! No, si trattava di Bossettoni. Il poliziotto russava come un orso, in un sonno così letargico che non si accorse che un dayaco era penetrato nella sua baracca. Il cacciatore di teste con un occhio solo alzò la sua lama e vibrò un secco colpo sulle cervicali dell’in-vestigatore. Il detective si svegliò di soprassalto, si portò una mano alla nuca e si avvide che si trattava soltanto di un incubo. Tormentato dall’insonnia, l’ispettore si rassegnò a fumare l’ultima stecca. Il segugio della polizia comprese che era impossibile snidare Yanez de Gomera dalla giungla, nemmeno facendo apposta a far cadere un mozzicone acceso nella selva… per appiccarvi il fuoco. E allora, tra una boccata di fumo e l’altra, decise di escogitare un trabocchetto, ricorrendo ad un’esca. Fece circolare la voce che la donna di Yanez era stata minacciata di morte da parte di fratelli massoni dell’ucciso. Yanez raccolse quella voce come una sfida. Bossettoni si sentiva addosso l’occhio del cacciatore di teste. L’ispettore sapeva, sentiva che stava provocando la morte, proprio come quando, accendendo una sigaretta, sfidava il cancro ai polmoni. Non chiuse occhio per parecchie notti e prese l’abitudine di fumare anche nel buio. Le sigarette non bastavano più: lo sbirro, ormai, doveva ricorrere ai sigari. Una sera il vicecommissario tentò di tenersi sveglio aggrappandosi alla nicotina, finché fu sopraffatto da una spossatezza che faceva pesare le sue palpebre come saracinesche. L’investigatore si addormentò dopo aver ispezionato l’allerta delle sentinelle. I suoi scrupoli furono vani, perché Yanez si calò da un “durion”, accoltellò un paio di guardie, s’incuneò fin nella sua tenda, si avvicinò al suo collo e recise la sua colonna vertebrale. Un urlo di dolore si elevò dalle tenebre che avvolgevano la giungla: l’ululato del vice commissario ridestato dall’ennesimo incubo. Gridarono anche le guardie, strappando tutti dal sonno: qualcuno era penetrato nell’accampamento. Si udirono degli spari contro l’intruso che si tuffava nell’oscurità. L’investigatore riaccese una lanterna a petrolio e vide in faccia la Fine, con un sogghigno che stringeva cuore, polmoni, budella: la Morte gli sorrise e gli infilò un indice, una mano in bocca, in gola, nella trachea, fino a giungere agli alveoli, afferrare un polmone e strapparlo. No, la Fine non si manifestava sotto le mentite spoglie di una signora ammantata di nero e armata di falce, con un ghigno a trentadue denti perennemente stampato sul teschio. Si rivelava attraverso lo sguardo di un uomo comune, ma rispettabile, un tempo persino onorabile o venerabile. Guardando negli occhi la morte, Bossettoni si rese conto di quanto fosse attaccato alla vita e capì che non poteva più permettersi di sprecarne neppure un nanosecondo. Forse, fu la morte a scrutare nelle pupille del vicecommissario, a chiedergli di accendere un’altra sigaretta e di bruciare l’ennesimo brandello di alveoli. La soluzione più diretta, spicciola e meno ardua che riuscì a prendere fu quella di smettere di fumare. Quando il detective accese la sua lampada, si accorse che la visita di Yanez non era stata solo un incubo: accanto a lui, sul suo letto, giaceva un volto senza vita. L’ispettore guardò in faccia quell’essere: d’altra parte, oltre al viso, non vi era null’altro da osservare, anche se sembrava che quella testa troncata squadrasse Bossettoni. Quel viso senza collo sembrava quasi che sorridesse. Il vicecommissario raddrizzò il volto reciso afferrandolo per i capelli. Si domandò se quello potesse essere o meno l’onorevole Saulo Cresonte: avrebbe dovuto riconoscerlo dalla foto di un volto riportato in un passaporto, o attraverso delle impronte digitali inesistenti? Sembrava che quella testa mozzata esigesse di sussurrargli: <Ci sono o non ci sono? Ci sono ancora o non ci sono più?> Le palpebre del morto erano ancora alzate e pareva che le pupille si intestardissero a fissare il mondo. L’ispettore si chiese cosa gli frullasse in testa, ma forse sarebbe stato più corretto domandarsi cosa gli frollasse nel cranio, visti i numerosi vermi che dilaniavano il suo encefalo in putrefazione. Il vicecommissario non scaricò la tensione nervosa accendendo come di consueto una paglia. Abbassò quelle palpebre sbarrate, raccolse il viso dell’ucciso e, rassegnandosi a restare senza il volto dell’assassino, si preparò a rimpatriare. Se non altro, non avrebbero potuto accusarlo di essere tornato a mani vuote! All’aeroporto chiese il prezzo del biglietto e un’affascinante hostess di terra gli rispose: <1400 euro a testa!> Bossettoni volle fare una battuta, forse per impressionare la bella impiegata: <A testa?! Ma allora deve pagare anche lui?> Non l’avesse mai fatto, la hostess chiamò i superiori e pretesero che pagasse un secondo biglietto anche per il Cresonte! Sull’aereo, Bossettoni finì in un reparto non fumatori e non poté consumare nemmeno una cicca. Litigò con la hostess, perché si incaponì a lasciare la borsa con la testa del Cresonte sul sedile accanto: <Ha pagato anche lui e quindi deve stare qui seduto!> La hostess osservò che tutte le borse dovevano essere riposte nell’apposito portabagagli. <Non c’è problema ― disse prontamente l’ispettore ― tolgo il cranio dalla borsa!> Per non impressionare deboli di cuore e bambini, gli fu imposto di chiudere la testa mozzata nella sporta e quindi nel vano bagagli. Il commissario dovette arrendersi, ma pretese che gli servissero anche le bibite cui avrebbe avuto diritto il passeggero che giaceva nel bagagliaio. All’aeroporto vi era già ad attenderlo una folla di giornalisti, tra i quali svettavano Tina Corrodi, Filippa De Marini e Cuco Zucca. Il commissario cercò di aprirsi un varco in quel roveto di microfoni: <Non rilascio dichiarazioni, perché le indagini sono ancora in corso!> Tina Corrodi approfittò della calca per strusciarsi addosso all’ispettore: <Allora commissario? Neanche a me rila- scia un’intervista?> Cuco Zucca dette una gomitata nello stomaco di Tina e ne approfittò Filippa De Marini per farsi avanti con una procace scollatura: <Senta ispettore, posso offrirle una sigaretta?> Bossettoni la fulminò con lo sguardo: <Sono viceispettore e ci vuol ben altro per corrompermi! Comunque io non fumo più!> Filippa lo guardò stupita: <Ma come? Non fuma più? Questa è una notizia…> Il vice commissario salì su un’auto guidata dal fido sergente Colombo e si allontanò da quella folla così curiosa. Il nocchiero gli offrì un sigaro, ma il commissario rifiutò: <No grazie, veramente, non voglio fumare più!> Dopo essere stato sfiorato dalla morte così da vicino, l’ispettore si era sentito più che mai attaccato alla vita e aveva deciso di smettere di fumare: in effetti, non toccò più una sigaretta, ma da allora cominciò a consumare ogni giorno decine di gomme da masticare… e prese ad imprecare con più frequenza e più enfasi di prima. La notte stava calando e i predatori di teste si accingevano a proferire favole. Yanez si stropicciò il baffo nero e quello biondo, mescolò le sue favole come fossero i tasselli di un “mahjong” o gli ingredienti di una ricetta “Nionya” e farfugliò: <C’era una volta, in un bosco, un lupo che insidiava le bambine dal cappuccio amaranto…> Fu subito interrotto: <Cos’è un lupo?> Il narratore bendato era in difficoltà, perché in quell’isola non vi erano lupi. <Ecco ― cercò di spiegare ― si tratta del più tremendo predatore della foresta!> Il contastorie, che avrebbe voluto terrorizzarli, si ritrovò spiazzato, perché in quella selva i predatori non erano disprezzati come sulle Alpi, ma erano persino venerati. Yanez, per incutere timore nei suoi ascoltatori, decise di ricorrere ad una creatura fantastica; quindi estrasse dalla tasca segreta della sua immaginazione il più tremendo dei mostri: <C’era una volta un mostro verde che volava…> ma fu di nuovo fermato. <Per favore ― implorò con sguardo sardonico il capo dayaco ― se vuoi incantare i bambini del Borneo, non parlare più dei draghi. Queste creature impressionano i piccini del resto del mondo, perché hanno sembianze fuori della norma. Un rettile che vola esiste veramente nel Borneo, è chiamato “drago”, ma non spaventa, perché non supera la grandezza di una mano e non erutta fuoco!> E i due risero della mostruosità dei draghi. Prestando orecchio a quella favola molti si assopirono. Yanez si preparò a chiudere anche la pupilla che non era bendata per dormire, ma ogni dayaco pretendeva un ennesimo racconto tutto per sé. Il contastorie cedette alle loro insistenze, si grattò l’occhio coperto, rimestò sensazioni antiche e moderne, come nelle pietanze Nyonya e affabulò: <C’era una volta un arcipelago di terre emerse incantate: la caverna di Polifemo, gli scogli delle sirene, la spiaggia della ninfa Calipso, il lido del regno dei Feaci, il porto d’Itaca…> Stramazzarono tutti nel sonno, tranne il bimbo con la cravatta firmata ed un parrocchetto che si era posato su un ramo vicino a Yanez. Il fanciullo si divertiva a stringere e sciogliere il nodo della cravatta. Il contastorie lasciò che una tarantola gli zampettasse sul braccio e si allontanasse, si sistemò la benda sull’occhio e barbugliò: <C’era una volta un grigio menestrello dal cui volto rugoso si aprì una rima. Rema la rima oltre il muro amaro senza calore, oltre il mare color amaranto...> Yanez fece così perdere i sensi ai bambini più piccoli, persino agli ultimi oranghi svegli che ciondolavano da un teck, ma non il più grande, un ragazzino con il cappello da basket e suo fratello, un bimbo con la cravatta firmata. Chiesero i due fratelli, più curiosi di Pandora: <Raccontaci perché vuoi tornare da dove sei fuggito!> Il signor Gomera si decise infine a confessare: <Devo ritornare, per ritrovare la mia principessa.> I fanciulli però lo importunarono ancora: <Ma chi è? Su cosa governa la tua principessa?> Il contastorie con un occhio solo si rassegnò a rispondere: <Regna su parole in assonanza. Ecco, adesso vi parlerò della donna per la quale ho deciso di abbandonare quest’isola di felicità e tornare nella giungla d’asfalto.> CAPITOLO 12 Su un filo senza capo Eva, la moglie del favoliere, si rese conto che da troppi capitoli era ferma in bagno. Che la smettesse di specchiarsi, se non voleva che i lettori si scordassero di lei: era tempo che uscisse da quelle ceramiche linde come pagine vuote per tornare sulla scena, senza timore di imbrattarsi d’inchiostro o di smog. La donna chiuse i rubinetti della doccia, indossò l’accappatoio, abbandonò le calde pareti del bagno e poi, subito, con i capelli ancora umidi, neri e lucidi come l’inchiostro appena stampato, lasciò le mura di casa. La donna spinse la porta dietro di sé, con la stessa leggerezza con cui si volta pagina. Uscì in strada in accappatoio? No, era assonnata, aveva fretta, ma non fino al punto da essere così sbadata. Eva varcò la frontiera oltre cui la sua sete, o la sua carta di identità, a nulla sarebbero valse per elevarla al di sopra dell’anonima moltitudine, quella calca per la quale si riduceva a due gambe e due gomiti in ritardo, in corsa verso la metropolitana. Calpestò una donna adagiata sul marciapiede, senza accorgersi che era una madonna affrescata da un madonnaro. Oltrepassò il semaforo rosso scansando due auto, un camion e una bicicletta che non sapevano se frenare o travolgerla. Ma occorreva essere più arditi, il metrò non attendeva, non apprezzava quei tardivi tentativi di coraggio, ben sapendo che il vero eroe si dimostra tale affrontando la marea della ressa urbana. Si buttò oltre il ponte levatoio del vagone della metropolitana, eludendo per un nanosecondo le porte che si proponevano di stritolarla. Le paratie si chiusero implacabili, inghiottendo la protagonista nel gigantesco mostro metallico, la balena che si tuffò negli alienanti abissi della città, ma l’eroina continuò anelante a galleggiare nei sogni della sua vasca da bagno… finché parole che annunciavano orrore la scuoterono dal suo torpore: “Ritrovato corpo squartato”, “Il giallo della testa mozzata”, “Sul luogo del delitto gli inquirenti cercano ancora la testa della vittima”. Erano i brandelli di articoli dei giornali branditi dagli altri passeggeri. Notizie che lei afferrava solo a brani, nella calca del vagone, affannandosi di ricomporre quel macabro mosaico. Prima che avesse digerito quei titoli grondanti di sangue, il serpente delle viscere terrestri spalancò le sue fauci, espellendo tutti nella frenesia delle strade, dove il grigio dello smog sommerse il giallo annunciato quella mattina. La moglie del favoliere riemerse in superficie, tra marciapiedi brulicanti di tizi, caii e semproni che deambulavano frettolosi per raggiungere le postazioni di lavoro ed evitò per un soffio d’inabissarsi in un buco nero in cui era già precipitato un cosmonauta con la sua astronave ed un passante in giacca e cravatta: no, questa apertura verso lo spazio siderale non era vera, non era possibile in una metropoli così chiusa, ma era soltanto il dipinto ancora fresco di un madonnaro che raffigurava una madonna in uno scafandro. Eva scantonò un venditore di fiori, uno di fazzoletti, un altro di accendini e tre auto inferocite. Giunta appena in tempo, timbrò affannata il cartellino e si sedette trafelata al tavolo di lavoro. Un groviglio di fili si stendeva davanti a lei. Un roveto di intrichi, intrighi che lei avrebbe cercato di dipanare o ordinare con il suo modesto lavoro, districando un nodo delle corde vocali, liberando il sussurro legato ad ognuno di quegli intriganti intrecci. A volte, di fronte ad un compito così grande, si sentiva debole e minuta. A volte, presa dalla vertigine di quel vortice di parole, avrebbe voluto, proprio come faceva suo marito, stringere il capo della matassa e, tirandone il bandolo, avrebbe desiderato guidare come una marionettista tutte quelle voci. Ma nessuna di quelle vibrazioni delle corde vocali si sarebbe lasciata catturare e manovrare. Ognuna di quelle voci aveva una vita autonoma mossa da una forza libera come il vento e lei non era una regista, ma soltanto una telefonista. Eva si lasciò condurre dal vento, via, lontano dal call center, in un’impossibile fuga, lontano da tutti quei fili fugaci, quelle parole fuggenti, quei discorsi sfuggiti. Attraversò il paese dei draghi e dei maghi, finché fu proiettata sul letto della propria bimba, nel- l’atto di raccontarle una favola. <C’erano una volta ― disse alla figlia ― tre anziane sorelle, vecchie come il mondo, che insieme dipanavano, tessevano e tagliavano il filo della vita e della morte...> Ma la bimba la interruppe: <Mamma, questa é la storia delle tre Moire, me l’hai già raccontata!> Le pagine di questo libraccio volavano via, sospinte da fonemi senza senso, come aquiloni, rapaci di carta legati al filo dell’immaginazione, eppure la bambina s’intestardiva a non dormire, si ostinava a restare aggrappata alla coscienza. Allora la madre le cantò una filastrocca: <Tastando destro con gusto in lotta intestina, tesse senz’astio il desto artista imposture, oltre l’angusto. Frusta la mestizia ebbro di mosto e mestola testardo astruse sestine miste all’estro.> <Mamma, non ho capito niente> commentò la bimba, che cominciava ad avere una testa troppo ingombrante per le fiabe. La madre scorse uno scarafaggio tra le lenzuola, ma non si perse d’animo e, prima che venisse visto anche dalla sua bambina, lo scacciò con un colpo di mano; per non correre il rischio che turbasse i sogni e le favole della sua figlioletta, lo schiacciò sotto la ciabatta e proseguì il suo tentativo d’incanto: <Nelle favole, figlia mia, non bisogna capire nulla, non si può comprendere niente, o almeno qualcosa di sensato. Nelle favole non si può usare la testa. Non si deve pensare, perché pensando tutto si carica di un peso che sprofonda nella logica. Occorre perdere la testa, e seguire solo il vento dell’immaginazione. Bisogna dimenticare il capo e vagare, errare, vagabondare oltre ogni confine, anche a costo di cadere in errori, per lasciare parlare e diventare realtà parole e affinità strane e leggere> CAPITOLO 13 Alla ricerca del capo della favola E pensare che aveva accettato di abboccare a quella pubblicità per concedersi una lunga pausa e smetterla una buona volta di rimuginare, di caricare la sua testa di ponderazioni e pesi. Non c’era tempo di arrestarsi per riflettere: doveva correre e basta, a gambe in spalla. Avrebbe voluto fermarsi un attimo per fare pipì, ma dovette procedere, non tanto perché mancasse il bagno (era in una foresta), ma perché non c’era tempo. E pensare che aveva accettato di andare lì, per farsi una vacanza, catturato dall’invito di una pubblicità. “Ah, dannata reclame!” Inciampò in una liana, e si chiese ancora una volta perché diavolo si fosse incantato in uno spot. Correva nella macchia, di notte… No, il suo non era più un viaggio di piacere, non era più un turista. Dovette fermarsi un attimo per riprendere fiato. Ah, maledetta quella pubblicità da cui si era lasciato inseguire! Aveva un tremendo mal di testa, forse perché aveva perso la sua coppola e il sole gli aveva battuto per troppo tempo sulla testa. Forse aveva la febbre, ma doveva proseguire comunque. No, non si stava affrettando per arrivare senza ritardo ad un appuntamento. A dire il vero non aveva una meta: stava solo fuggendo, dato che era lui la meta degli inseguitori. Certo, se si fosse fermato qualcuno avrebbe messo drasticamente fine alla sua emicrania. Era tallonato dai dayachi, che erano a caccia proprio della sua testa. Forse, se fosse giunto fino al fiume, avrebbe fatto perdere le sue tracce, ma l’acqua era infestata dai coccodrilli! I guerrieri lo braccavano nel labirinto verde con le lame sguainate. La preda umana cercò di nascondersi ai cacciatori di teste, tappandosi tra le radici di un enorme “durion”. Tuttavia un guerriero scoprì per terra la coppola che aveva smarrito e recuperò le tracce lasciate dalle sue orme… fino a quando lo sentì ansimare. L’inseguito tentò di scostare il cacciatore distraendolo con un rumore: gettò una pietra lontano e l’inseguitore si diresse in quella direzione. La preda corse via e riuscì a distaccarsi dai cacciatori. Dovette rallentare, per attenuare il fiatone e quindi la probabilità che i suoi ansimi fossero uditi dagli inseguitori. Mentre scendeva un pendio, inciampò in una liana, appoggiò male un piede, si slogò una caviglia e fu costretto ad una tappa. Anche un mostro coperto di peli si aggirava per quella foresta. Era un orso. Che stesse braccando anch’esso il signore senza coppola? Un momento: l’orso era bianco, candido come la neve. Ma cosa diavolo ci faceva un orso polare nella giungla tra Samarinda e Pontianak? Con un piede zoppicante, l’inseguito non solo fu costretto a rallentare, ma ad abbandonare il passo felpato e rendersi più rumoroso, ansimante per il dolore. Per riprendere le forze, si rifugiò dietro un teck… e “toppete”, fu colpito sulla nuca, dal manico di un kriss in agguato. Il dayaco lo afferrò per i capelli e alzò la lama pronto a menare il suo fendente. <Per favore! Pietà!> gridò la vittima. Il guerriero cercò d’incoraggiarlo: <Non ti voglio fare male! Non avvertirai dolore e poi tutta la tribù canterà e ballerà in tuo onore! Quando morirai non sarai dimenticato, ma passerai ai posteri e sarai venerato sull’altare delle teste strappate!> Filippa de Marini chiese al truccatore di ritoccarle la cipria: <Sì, mettine pure anche lì, nella scollatura!> Filippa si aggiustò il reggiseno: <Allora? Cosa avete da guardare?> Controllò la scaletta del telegiornale e chiese: <Ma quando arriva questo servizio sull’orso polare nel Borneo? Come? Deve prima andare in onda il reportage sulla decapitazione?> Il dayaco vibrò un colpo deciso della lama sulle vertebre del malcapitato signore che aveva perso la coppola. La testa del disgraziato fu staccata dal corpo e sollevata dal vincitore trionfante. Il cranio fu mostrato a tutti durante il telegiornale: la cronista Filippa de Marini s’interruppe per concedere l’uso della favella a quell’orrenda immagine. Le palpebre del capo mozzato continuarono a sbattere. Sul viso della vittima si delineò un sorriso. La bocca della testa troncata si mosse e dichiarò: <Se non vuoi perdere la testa, combatti il mal di capo con la pillola “Emicracida”, composta da aromi naturali della giungla del Borneo ed eucaliptus dell’Engadina!> Filippa de Marini si riprese la parola e la linea: <Basta con queste fantasticherie senza capo né coda. E’ tempo d’interrompere questa cronaca dell’assurdo per tornare alla realtà.> La bella cronista si allacciò un bottone sulla procace scollatura, si meritò un primo piano delle telecamere e proseguì: <Nella normalità non si può perdere tempo in storie senza senso che non valgono un nichelino. Nella modernità tutto deve essere finalizzato a guadagnare tempo. E’ ora di rientrare nel mondo moderno con una vera interruzione pubblicitaria!> Un orso polare si aggirava per la giungla urlando: <Che caldo, che caldo!> Finalmente uno stregone gli portò il rimedio miracoloso: <Usa Diditì, la crema depilatoria che rade al suolo la più pertinace boscaglia di peli!> L’orso si cosparse con l’unguento magico e dai peli emerse una bellissima bionda, con i seni coperti unicamente dalle mani, che fu rapita da Tarzan. Impazzito per la conquista della procace pulzella, il re della foresta urlò di gioia, ma una raucedine stroncò il suo grido. Ecco però giungere la bionda, con un gonnellino di banane, ad offrirgli una caramella svizzera all’eucalipto. Sarebbe questa la normalità del mondo reale? Nascosti assieme ai macachi, ai leopardi e agli ultimi elefanti, i dayachi, abbarbicati su rami slanciati come pinnacoli, spiavano la troupe dell’agenzia pubblicitaria che riprendeva questo pietoso spot nella loro selva. No, questo era troppo. Quando videro la bionda con quel gonnellino, decisero d’intervenire. Circondarono la troupe e la assalirono. Stavano per sopraffare tutti, quando la scorta intervenne a raffiche di mitra. I cacciatori di teste dovettero ritirarsi, ma fuggendo s’impadronirono della bionda e la se- questrarono nel loro covo. Sentenziò allora il capo tribù, rivolgendosi alla venere tremante: <No, non volevamo prendere il tuo corpo! No, non volevamo nemmeno la tua testa, ma quella del regista! Non si può sopportare che si usi la nostra giungla per raccontare una storia così insulsa! Non possiamo tollerare che si faccia recitare ad una donna bella come te una parte così idiota! Rientra pure dalla tua gente e avvertili di non riprendere più simili scene nella nostra foresta!> Yanez si tolse per un momento la benda sull’occhio e spiò la bionda mentre si allontanava. Il capo tribù si accorse che l’occhio dell’amico era caduto sul sedere della bellissima e gli chiese: <Che vuoi fare? Vuoi seguirla e conquistarla?> Il guerriero bianco si grattò l’occhio coperto e scosse il capo: <No, non desidero lei, ma un’altra donna, che sta lontano da qui. Non bramo una donna qualsiasi, per bella che sia, ma voglio tornare dalla mia ragazza!> Il dayaco chiese: <Non ti bastano le nostre femmine, non sono abbastanza belle? Non sei contento in questa giungla?> Il cacciatore bianco si strofinò l’occhio bendato e cercò di spiegare: <Qui sono stato tanto felice da considerarmi un dayaco. Ma la felicità è un bene che fugge sempre. Persino Marco Polo, pur incontrando i favori di un imperatore, decise di tornare… pagando con la prigione. Continuerò ad essere un guerriero fino alla fine, ma devo cercare il mio appagamento altrove. E’ tempo che ritorni dalla donna da cui sono scappato, ma forse lei è solo un pretesto.> Rincasare per spiarla da lontano, o per riabbracciarla? Rimpatriando come clandestino avrebbe dovuto affrontare la ferocia della polizia degli stranieri. E in seguito? Yanez sapeva che attorno alla sua donna si celavano branchi d’agenti e cecchini di polizie pubbliche, semi-privatizzate e private, in agguato, pronte a scagliarsi su di lui. Il capo dayaco volle offrire a Yanez un kriss, una lama con cui aveva tagliato molte teste, che gli era stato regalata da un nemico in punto di morte. <Ti ringrazio ― disse Yanez ― ma non voglio più usare armi!> Il vecchio guerriero lo guardò stupito: <Rinunci a combattere?> Yanez accettò il dono, ma ad un patto: <Per tutta la vita seguiterò ad essere e fare il cacciatore di teste, ma userò come armi i racconti e le favole con le quali abbiamo affrontato tante notti.> Il capo della tribù lo abbracciò augurando: <Che la macchia sia sempre dentro di te, Yanez!> Si sfregò il baffo biondo e rise: <Una macchia verde come la foresta, o blu come l’inchiostro? Non importa, ma non chiamarmi Yanez, perché è soltanto un nome falso! Io non ho nome, perché non appartengo al mondo delle parole, ma a quello di un caos, tinto di verde, di blu, di giallo…> Il vecchio lo accompagnò fino ai margini del labirinto verde e gli chiese: <E allora, con quale nome dovremo ricordarti e raccontarti nelle nostre favole?> Rispose l’altro cacciatore di teste, stropicciandosi il baffo nero: <Nemmeno Frankenstein aveva imposto un nome al suo mostro. Ma io ho costruito da solo la mia mostruosità. Chiamatemi col nome di Nessuno, d’Innominabile, o con quello di Uomo Qualunque, o Uomo Comune, o Sempronio! Ecco ho trovato: chiamatemi Tizio!> Il capo dayaco gli chiese: <Hai visto il tatuaggio che ti abbiamo fatto sotto la scapola sinistra?> Il signor Nessuno osservò: <Come faccio a guardarmi la schiena? Qui nella giungla non ci sono specchi!> Il dayaco sorrise: <Appunto: adesso partirai per un paese dotato di specchi. Attraverso un’immagine riflessa potrai vedere ciò che ti sei lasciato alle spalle!> Il vecchio capo tribù ritornò nel cuore della giungla e raccontò ai suoi la favola di un signor Nessuno che si era avventurato oltre l’oceano, oltre l’immaginabile, per fare perdere la testa ad una principessa mozzando il capo del mostro più tremendo. Uno dei fanciulli chiese al capo: <Yanez aveva tatuato sotto la sua spalla un uomo bianco che stava per essere decapitato dal drago?> Il vecchio rispose: <Non è detto che quell’uomo sia divorato dal drago. Dipende da cosa dice al mostro. Se gli sa parlare in modo giusto, il drago apre le sue fauci e lascia che il viso pallido ne estragga una perla!> I bambini si lasciarono divorare dal sonno e là, nelle viscere di Morfeo, rincorsero i sogni raccontati dal vegliardo. CAPITOLO 14 Ritrovando un capo del filo Eva si specchiava nel bagno, mentre impugnava una spazzola. Ogni giorno lasciava annodare e sciogliere la sua chioma, come se fosse una tela. Avrebbe desiderato spazzolarsi all’infinito, sciogliendo tutti i nodi della vita, ma fuori qualcuno bussava. La donna del favoliere avrebbe voluto chiudere fuori dal bagno ogni preoccupazione, agganciare la sua chioma al lavandino e lasciare che vi si arrampicasse il suo Romeo oppure, aggrappandosi ai suoi capelli, calarsi nelle mille riflessioni moltiplicate da quello specchio, come se fosse una delle marionette che un tempo manovrava suo marito, prima che scomparisse. Ma dei colpi alla porta la richiamavano alla realtà, alla sua (pre)occupazione di lavoratrice, di adulta e di madre. Fuori la preoccupazione bussò ancora e disse: <Mamma esci! Devi preparare la colazione e portarmi a scuola!> Eva imburrò le fette biscottate e le cosparse di marmellata: poi preparò per sé del caffé e per la sua bambina del latte con un cucchiaio di cacao. Eva e sua figlia s’incamminarono sul marciapiede verso il treno sotterraneo. La figlia disse: <Guarda mamma! I piccioni stanno beccando gli occhi di quella signora!> Non si avvidero che si trattava solo di una madonna dipinta da un madonnaro, su cui stazionava un colombo urbano e la madre replicò: <Non impicciarti degli affari degli altri!> Salirono sulla metropolitana. Miracolosamente, la mamma compì un’impresa più ardua dell’apertura di un guado nel Mar Rosso: si aprì un varco nella folla che gremiva il vagone fino ad un posto seduto. La fortuna le offrì anche notizie gratis. Prese in grembo la figlia e spiò le pagine che sfogliava il vicino. I titoli del quotidiano evocavano tragedie tremende, ma consuete e lontane: gli Stati Uniti avevano bombardato un nuovo covo di terroristi, che per rappresaglia avevano scatenato un nuovo attentato, che aveva provocato per ritorsione un attacco nucleare mirato con precisione chirurgica. Una picco- la nota a piè di pagina segnalava che il covo era al centro di una metropoli. Mentre sbirciava dal giornale del vicino, un signore in giacca e cravatta ne approfittò per infilarle una mano in tasca. Eva sbottò: <Ci mancava il maniaco! Si vergogni! Davanti ad una bambina!> L’uomo in cravatta la guardò scandalizzato: <Lei ha frainteso! Volevo solo rubarle il portafoglio!> Il signore distinto, si stizzì distintamente e si tuffò alla prima fermata oltre le paratie. La moglie del favoliere accompagnò la figlia a scuola, le raccomandò di fare la brava e la baciò. Poi Eva si recò al lavoro, timbrò il cartellino, e si sedette al tavolo da cui dirigeva tutte quelle voci. Ogni voce era un fiume di sillabe soffiato dall’aria nel cielo, di cui lei, tramite le sue umili mansioni, stringeva il filo. Non poteva pensare che dietro ciascuno di quei gomitoli srotolati tra le nuvole ci fossero altri esseri umani come lei, inchiodati a terra o ad una sedia. Dietro tutti quei bandoli spiegati nel vento ci vedeva volare pappagalli, comete, cervi volanti, aquile... Ogni filo si librava su parole senza senso, termini assurdi se estrapolati, sganciati dalla lingua o dal discorso cui si allacciavano. In fin dei conti, così le pareva, forse ciascuna voce faceva parte di un unico discorso di cui lei, attraverso il telefono, cercava di ritrovare il filo. Così, ad esempio, parole come pappagallo, cometa o cervo volante, che da sole non dicono nulla, attaccate ad un filo, o a una lingua come il portoghese, lo spagnolo, o il francese, significano soltanto aquilone. E lei, trasportata dal vento dell’immaginazione, non era più una semplice telefonista, ma una piuma, un’aquila, un aquilotto, oppure un balocco di carta colorata che volteggiava in una brezza. Ogni giorno, Eva sognava non di dirigere i fili di un telefono, ma quelli di un aquilone o di una marionetta, presa dalla nostalgia per quell’isola o quell’angolo di paradiso della fantasia che aveva costruito il suo uomo. Quel pomeriggio, alla fine del turno di lavoro, decise di recarsi nel luogo dove un tempo sorgeva il teatro di suo marito. Per anni non vi aveva messo piede, ma non aveva osato venderlo, sperando che il suo uomo tornasse e ri- prendesse la guida delle marionette. Eva custodiva le chiavi del teatro sempre in tasca, assieme a quelle di casa. Attraversò la platea e il palco aspettando di trovarsi in un teatro di spettri sommersi dalla polvere e dalle ragnatele ma, inspiegabilmente, tutto (anche la marionetta del personaggio più oscuro, persino quella di Gano o di Giuda) era perfettamente pulito e ordinato, come se vi fosse stato tenuto uno spettacolo da poco. Eva chiese alla custode dello stabile se qualcuno fosse penetrato nel teatro. La portinaia la guardò perplessa e borbottò: <Da anni non vi ha messo piede nessuno! Da quando suo marito è scappato… no, volevo dire che scomparve!> Chi aveva pulito e ordinato il teatro? Che suo marito fosse ricomparso? Ma, allora, se il favoliere era tornato, perché non si faceva vivo? La madre continuò a comportarsi come di consueto: salì sul metrò, andò a prendere la figlia a scuola, le fece svolgere i compiti, le preparò la cena, guardò con lei la televisione, la accompagnò a letto, la accarezzò e le raccontò: <C’era una volta una galassia di terre emerse incantate: la grotta di Polifemo, i faraglioni delle sirene, il lido della ninfa Calipso, il porto del reame dei Feaci> La mamma fu fermata: <No ― disse la figlia scuotendo la testa ― questa storia me l’aveva già raccontata papà!> La narratrice non si scoraggiò: <Ma il mio scopo non è rivelarti qualcosa di assolutamente nuovo, ma di mescolare il passato con il presente e il futuro.> Ma la figlia non voleva dimenticare il padre: <Papà tornerà a raccontarmi favole?> La madre cercò di spiegare: <Tuo padre è dovuto partire in un’isola lontana, e questa cosa non è dipesa né da me, né da te! Attraverso la favola che ho appena finito di raccontarti, cercavo appunto di dirti che tuo padre come Ulisse riapproderà a casa nostra…> La bimba sorrise e fece per alzarsi: <Quando tornerà?> La madre la rifece sdraiare: <Non hai ascoltato bene l’Odissea. Ulisse poté rivedere suo figlio solo quando diventò grande. Anche tu, potrai riabbracciare il tuo papà quando sarai adulta!> La piccola disse stizzita: <Mamma, non giocare con le favole!> La madre la invitò a fissarla negli occhi: <Tuo padre potrà tornare, quando tu sarai gran- de! Così mi ha detto lui stesso prima di partire!> La figlia non parve consolarsi: <Ma quando sarò grande? Ti ha raccontato anche questo papà? L’ultima volta che mi aveva accompagnato a scuola, lui aveva forse cercato di spiegarmelo, ma non l’avevo capito.> La madre si mantenne tranquilla: <Per ogni problema del presente, c’è sempre una storia del passato in grado di indicarci la via per il futuro! Come Eva, la prima protagonista della storia umana, anche tu uscirai dal paradiso dell’infanzia e diventerai donna, quando monterai su una sommità vietata e mangerai con il tuo Adamo il frutto proibito!> La figlia non parve tranquillizzarsi: <Com’è il frutto proibito?> La mamma tentò di chiarire: <La domanda giusta non è com’è il frutto proibito, perché la sua forma cambia per ogni coppia. La domanda corretta è: come posso fare a riconoscerlo? Per riuscirci devi cantare le rime e i ritornelli in cui echeggia la vita…> Chiese alla figlioletta: <Ti ricordi il teatrino di marionette che teneva tuo padre?> La bimba annuì e la mamma annunciò: <Ecco, ho deciso di riaprirlo!> La figlia esultò: <Che bello! Torna papà?> Eva spiegò: <No, lui non torna. Ma sono sicura che sarebbe felice della nostra decisione! Sarai tu ad aiutarmi a condurre gli spettacoli!> La figlia era entusiasta: <E quali storie racconteremo?> La madre sussurrò: <Racconteremo le gesta di chi pesta la testa contro i bastioni del fantastico, anche se non basta dire “basta” per sfuggire a un destino senza fasti.> CAPITOLO 15 Ritorno apparente alla normalità L’ammaestratore di marionette controllò l’orologio: era tempo che si recasse a scuola dalla sua bambina anche a costo di attraversare mare e monti. Per essere sicuro di non essere seguito, percorse una rotta contorta. Varcò rapidamente via Mar nero e poi si perse in un’infinità di monti. Valicò via Monte Rosa, e poi le vie battezzate dal Monte Bianco, dal Monte Grappa, scavalcò via Val di Sole e via Monte Amiata. Forse per fuggire dalla noia di un orizzonte così chiuso, lineare, limitato solo dalla via percorsa, forse per evadere dal “piattume” della metropoli, ecco che a così tante vie erano stati affidati i toponimi di monti, passi montani e valli… Entro una manciata d’istanti sarebbe suonato il gong e sua figlia avrebbe concluso l’ultima lezione. Un muro di cemento sputò un uccello fatto di grigio che sfiorò il volto del favoliere: era un piccione che si era mimetizzato con il favore di uno sbuffo di smog. Quando giunse presso la scuola, il contafavole si mantenne a distanza… e lasciò che fosse la moglie ad andare a prendere la piccola. Ogni giorno, il favoliere si dava appuntamento lì non per mostrarsi alla moglie e alla figlia, ma per vederle. Non per spiarle, ma per accertarsi della loro esistenza ed incontrarle, abbracciarle almeno con lo sguardo. Era ancora ricercato da orde di agenti di polizie pubbliche e private, per cui doveva mantenersi nascosto, nella clandestinità, e rimanere Nessuno, un’anima senza nome e senza volto. Anni addietro, quando era fuggito nella giungla di un’isola della Sonda, era stato costretto a subire un dramma simile: era stato obbligato ad aggirarsi tra altri esseri viventi, i dayachi, senza essere riconosciuto o venendo identificato come il signor Nessuno. In quel frangente, il marionettista era costretto a rimanere sullo sfondo della scena dell’immensa metropoli, tra la folla di volti anonimi che scorrevano attorno a sua moglie Eva e a sua figlia, senza potere nemmeno rivolgere loro una parola. Già da alcuni giorni, la figlia aveva avuto il sentore di essere pedinata da qualcuno: nella notte le pareva di percepire il respiro di un essere che la spiava. Aveva rivolto domande alla madre sulla presenza del babau, del doppelgänger e di Belzebù, ma la mamma l’aveva rassicurata: lei era buona e quindi non aveva motivi di temere nessuno. Eppure, anche durante il giorno la figlia aveva la sensazione di essere braccata! Non poteva però trat- tarsi di un fantasma malefico: infatti, si accorse di essere seguita, proprio in occasione di piccoli eventi positivi non spiegabili; dei miracoli, insomma. La madre, ora che era più grande, pretendeva che lei facesse la polvere nella sua stanza: la ragazzina disobbediva, più per pigrizia che per spirito di contraddizione, ma ogni scaffale, ogni suppellettile, ogni bambola, continuava a restare immune della polvere: com’era possibile? Eva si complimentò con la figlia perché aveva preso l’iniziativa di annaffiare i fiori: ma non era stata lei a farlo. C’era qualcuno che aiutava di nascosto la bambina? La figlia chiese alla madre: <Quando devo gonfiare le gomme della bici?> La mamma rispose: <Almeno una volta al mese, ma vedo che tu le pompi regolarmente. Brava!> In effetti i pneumatici della sua bicicletta non si sgonfiavano mai: chi li pompava? Cominciò a pensare alla vicinanza di un angelo custode. La bambina non ebbe il coraggio di rivelare alla madre la presenza soprannaturale che la tallonava come un’ombra. Eppure, anche la mamma aveva la sensazione di essere seguita. Un mattino, Eva aveva persino smarrito il portafoglio, ma il giorno stesso era stato recapitato nella buca delle lettere, con tutti i soldi dentro. Un avvenimento fortunato, che divenne straordinario quando fu replicato alcuni anni dopo. Il cantafavole seguì moglie e figlia, per istanti, lunghi come mesi, stagioni, anni. Ogni volta che le vedeva, avrebbe desiderato rivolgere loro la parola. Ma era costretto a rimanere in silenzio, così vicino, ma così lontano. Avrebbe voluto almeno abbracciarle o accarezzarle, ma era obbligato a restare inabissato nell’anonimato dell’immensa folla di anime senza nome che popolava la metropoli. Un tempo, prima che l’effetto serra provocato dallo smog la sciogliesse, la nebbia avvolgeva l’intera città per mesi. Ora, sembrava che un’ultima nuvola di bruma avvolgesse il favoliere, soltanto lui, per proteggerlo dalle orde di segugi alla ricerca della taglia che pendeva sulla sua testa. Il cantastorie si recò ancora ad ammirare la sua figlioletta uscire di scuola. Ogni giorno la trovava più grande. Il contafavole si ac- carezzò il baffo nero e quello biondo e seguì con lo sguardo la sua donna e la sua bambina, ancora per un attimo che cercò di prolungare con la moviola, finché si dileguarono nella moltitudine che si tuffava nel metrò. Allora, il domatore di marionette si rassegnò a tornare a mansioni più umili, ma necessarie. Il favoliere si sistemò la benda sull’occhio, impugnò un carrello e si avventurò in un labirinto di scaffali. Racimolò provviste dal reparto delle verdure, dalla macelleria, dal panificio. Visitò anche il settore del bricolage per raccogliere utensili per il suo teatro. Poi si aggrappò alla coda di una catena umana, di un serpente dalle molte teste e s’incolonnò rassegnato davanti alla cassa, in una fila infinita. Erano proprio queste operazioni ― il lavoro manuale, le pulizie, la spesa e le colonne ― che distinguevano la gente comune dai nobili, dagli eroi, o dai privilegiati. Lì, in fila, nel super-big-ipermercato, il favoliere era di fronte al commissario Bossettoni. L’ispettore non riconobbe, sotto quelle spoglie così mortali, dimesse, il criminale che ricercava da tanto tempo. Il vicecommissario lo guardò e disse: <Fossimo in Svizzera questo non succederebbe! Lì si sanno organizzare: c’è una fila per chi ha venti articoli, per chi ne ha dieci e cinque, oltre ad una corsia preferenziale per anziani, donne incinte e invalidi. Così non si aspetta mai più di cinque minuti, nemmeno davanti allo skilift!> Al marionettista cadde dal carrello un rotolo di filo da pesca, lo stesso che usava per sorreggere le marionette, e una sega, la medesima che adoperava per ritagliare nuovi pupazzi. Il poliziotto in borghese li raccolse e li porse all’altro che ringraziò. SECONDO ATTO Dopo aver affrontato la sua piccola guerra e la sua odissea in battigie remote, ecco che il cantastorie era approdato nuovamente nel mare d’asfalto della sua Itaca: il favoliere era stato quindi costretto non solo a restare in incognito, come già aveva fatto Ulisse, ma aveva dovuto persino rinunciare a rivolgere la parola ai suoi cari. L’inventafavole era ricomparso su un marciapiede tra via Virgilio, via Ariosto e via Pirandello, ma, per descriverne il ritorno, ecco che dobbiamo ricorrere ad un reset e ricondurre il nastro del racconto al punto di partenza di questa maledetta storia.
Scarica



![Felaco_elaborato7[1]..](http://s2.diazilla.com/store/data/000084584_1-c0d32aa64ea920109a8a507124e0b22f-260x520.png)