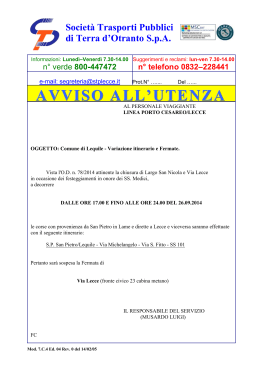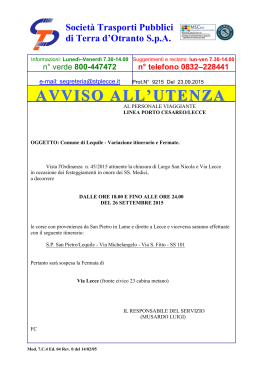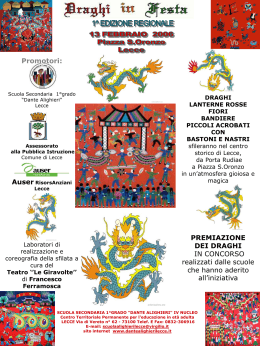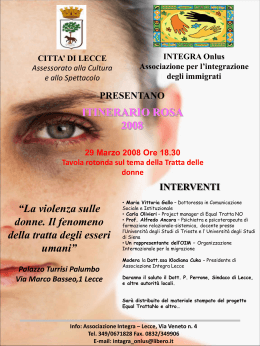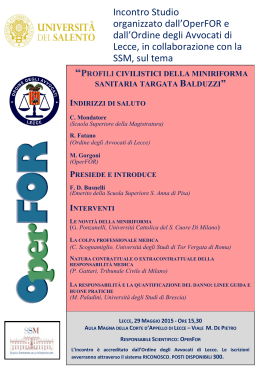LO BALZINO di Rcgeri de Pacientia POEMA INEDITO DEL SECOLO XV (continuazione dal n. 2) Nelle varie composizioni di tale genere influsse sia il Boccaccio che Ovidio, sebbene la Corti (43), più iche di influsso boccaccesco parli di mediazione boccaccesca tra il modello ovidiano delle Eroidi e le nuove composizioni. Non staremo qui ad esaminare la produzione poetica del Chariteo giacchè un tale esame esula dal fine propostoci, che è quello di determinare i caratteri della cultura aragonese. Diremo solo che tra i lirici volgari dell'età aragonese, occupa il primo posto, se non per il valore della sua Musa, certo per la ricchezza della sua vena poetica. A cavallo tra il XV e il XVI secolo sta l'opera di Jacopo Sannazzaro membro dell'Accademia pontaniana e assai fedele alla dinastia aragonese. La sua importanza letteraria non è certo legata alle sue farse né ai gliommeri. Le prime, ossia le farse, si ricollegano ad una produzione fiorita negli ultimi tempi del governo aragonese e sono composizioni di carattere popolare, sotto forma di endecasillabi; questo genere sarà poi continuato dalle farse cavaiole, la cui produzione fu assai ricca nel secolo XVI. Come dicevamo, il Sannazzaro non deve la sua fama né alle farse né ai gliommeri bensì all'Arcadia : « opera che, ponendosi sulla tradizione della letteratura bucolica, realizza quell'ideale della prosa umanistica applicata ad un contenuto di arte pura e di dilettazione » (44). Noi non stabiliremo i pregi e le limitazioni dell'opera del Sannazzaro, ciò che ci interessa notare è che egli assomma in sé i caratteri della nuova letteratura, di una nuova letteratura che, abbattute faticosamente le barriere regionali si appresta a diventare nazionale. Stabiliti i caratteri della cultura aragonese vediamo ora in quali rapporti stia detta cultura con l'ambiente culturale di Terra d'Otranto, patria di Rogeri de Pacientia. Terra d'Otranto non poteva mantenersi estranea al grande movimento umanistico, anche per le sue tradizioni. L'eco di Ennio, di Pacuvio, di Livio, nati qui non si era ancora spento e il lungo dominio dei greci non era stato solo un episodio; di quest'ultimo dominio, rimanevano quali testimonianze le celebri scuole di Nardò che, osserva il Gothein (45) « erano non solo il centro di cultura di questo angolo d'Italia, ma servivano di modello anche ai greci ». (43) MARIA CORTI, op. cit., p. 39. SAPEGNO, Storia della Lett. ital., GOTHEIN, op. cit., p. 123. (44) N. (45) vol. I, p. 372. 39 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce Anche oggi esiste nel Salento una piccola isola etnica e linguistica che Va sotto il nome di Grecia di. Terra d'Otranto che, col passare dei secoli, va sempre più limitandosi ma che nel secolo XV era molto più vasta. Da una relazione spedita dal vescovo di Nardò a Giovanni XXIII risulta che nel 1410-1415 c'erano in quella diocesi 14 paesi con colonie greche, dove veniva osservato il rito greco (46). Le scuole di Nardò fiorirono nella cittadina dalla quale presero nome; esse per un certo periodo costituirono l'Ateneo della regione e dettero nome alla città di piccola Atene. Primi insegnanti di queste scuole furono i Basiliani che dall'VIII all'XI secolo portarono, oltre al culto, lo studio delle lettere e delle lingue greche e orientali. Vennero poi i Benedettini i quali si occupavano in modo particolare di filosofia e di matematica, di teologia, di storia, ,di musica, di lingue classiche. Le scuole salentine erano quindi adatte a costruire il sostrato spirituale necessario alla formazione del perfetto umanista. Ci troviamo così di fronte ad un'ambiente culturale non stagnante, ma che, al contrario, ha in sé i germi di un più largo e più fecondo sviluppo. E se il Galateo, temendo per la sua sorte, a causa della sua fedeltà alla casa aragonese, venuti i francesi e portatosi da Napoli a Lecce, qui fondò l'Accademia Lupiensis, sul modello di quella pontaniana, è segno che non pochi erano gli uomini di cultura con i quali poteva agitare questioni culturali. Altra prova dell'esistenza di un clima culturale suscettibile di sempre più alte conquiste, è l'esistenza nel secolo XV di una ricchissima biblioteca posseduta da Angilberto del Balzo, duca di Nardò e conte di Ugento, incorporata nel 1464 nella biblioteca reale dei Re d'Aragona a Napoli e ai tempi di Carlo VIII in quella nazionale .di. Parigi; ricca tra l'altro di molti codici in volgare, tra cui i Trionfi del Petrarca, due esemplari della Teseide del Boccaccio, i volgarizzamenti del De Consolatione philosophiae, della Civitas di S. Agostino, dei libri dei Profeti e del trattato sui Peccati. Ma a più esplicita dimostrazione di quanto sopra affermato, sta il fatto che uomini come il Galateo e come Fra Roberto Caracciolo — per ricordare solo i maggiori - che comunemente vengono inseriti nel numero dei facenti parte dell'umanesimo napoletano, qui abbiano avuto i loro natali e, quel che più conta, presso le scuole salentine abbiano ricevuta la loro prima educazione. Se è vero dunque che, perchè si sviluppassero e dessero i loro frutti quelli che ancora erano solo elementi della loro formazione spirituale, ebbero bisogno di uscire dalle piccole città, in massima parte feudali del Salento, ed andare a Napoli, centro della cultura aragonese, è pur vero che a battesimo li tenne non l'Accademia Pontaniana, bensì la scuola greca di Nardò. La lingua del Poema L'affermazione dell'italiano letterario, fuori della Toscana, avvenne con una certa lentezza, preceduta da ibridismo linguistico che, presente in ogni parte d'Italia, comparve alla fine del 400. Nel. secolo XIV, come nelle altre regioni d'Italia, fiorì a Napoli una letteratura municipale che si era servita di un dialetto, reso aulico, da elementi latini e da qualche influsso toscano (47). Si intravede quindi, in Napoli, già dal 300, la premessa di una lingua letteraria, sebbene si possa parlare della sua penetrazione solo con l'avvento DE GIORGI, Bozzetti di viaggio, Lecce 1877. (47) G. FOLENA, La crisi linguistica del 400 e l'Arcadia di I. Sannazzaro, Olscki, Firenze 1952, p. 6. (46) C. 40 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura-di IMAGO - Lecce al trono della dinastia aragonese. Qui come altrove, col prevalere del volgare, per i bisogni di comunicazione determinati da ragioni amministrative, si forma una Koinè meridionale nella quale la nobilitazione del dialetto è operata dal latino. Non apparirà strano ciò quando si pensi che, al di fuori della cultura umanistica « l'abitudine al latino cancelleresco e chiesastico era viva e radicata » (48). Forme dialettali e forme latineggianti dunque costituiscono l'elemento caratteristico di questa Koinè meridionale. Nel 400 in genere, e quindi anche in quello Napoletano, abbiamo una ricca fioritura di opere in latino che l'umanesimo aveva esaltato di contro al volgare. Ciò però non esclude l'uso del volgare che tanta parte aveva avuto nella poesia popolare, per gran parte anonima e nella quale il dialetto si presentava privo di 'pretese e di imitazioni toscane, mentre, più elevato appare il dialetto dei volgarizzamenti (49). La lingua letteraria penetra in Napoli con l'influenza che, come in altro capitolo accennammo a proposito del De Jennaro, la triade dei trecentisti toscani esercitò sui poeti maggiori del tempo. Di questi, quello che più influenzò, oltre che il contenuto anche la lingua, fu il Petrarca, per cui il Folena parla di « lingua petrarchesca », il cui influsso, - anche se in misura assai minore, appare anche nella prosa. Si va maturando quindi un distacco sia pure assai lento dalla Koinè regionale. A comprova del più lento cammino della lingua letteraria nella prosa, rispetto alla poesia, osserva il Folena che: « Scrittori per alcuni lati pregevoli come il Carafa, il Del Tuppo scrivono stentatamente un italiano che ha come fondo non il dialetto vero e proprio ma un impasto di dialetto e di latino con vernice e struttura boccaccesca (50) ». Siamo così sulla strada che porta alla formazione della lingua letteraria « ché tendenza fondamentale delle lingue letterarie è appunto quella di obliterare i tratti locali, per . sentirsi il meno possibile contingenti e legate a situazioni particolari » (51). Vanno quindi determinandosi e maturandosi quelle premesse, linguistiche oltre che culturali, che non è qui il caso di considerare: tali premesse troveranno la loro più completa soluzione nell'Arcadia del Sannazzaro nella quale assoluta è la vittoria sulla tradizione locale contro l'affermazione della tradizione letteraria che muove dalla Toscana. Ma a questo punto, sorge spontanea una domanda: quale la situazione linguistica in terra d'Otranto nel quattrocento? Non altrimenti che altrove la produzione letteraria in latino predomina incontrastata, ed una tale predominanza della lingua di Roma, non si determina solo nel campo letterario, bensì anche nella vita civile e feudale. Ma le prime tracce di volgare appaiono a Lecce nelle formule giudiziali, come ad esempio nelle decisioni del « Concistorium Principis » che era stato istituito da Ramondello Orsini nel 1402. Siamo all'inizio del secolo e di una prevalenza del volgare, sia nei documenti che nelle composizioni letterarie, non si può parlare; è solo nella seconda metà del quattrocento che se ne potrà parlare. quando le mutate condizioni di vita, politiche e culturali, avranno portato al crollo del corrotto linguaggio che aveva informato, fino ad allora, tutti i documenti. (48) G. FOLENA, op. cit., p. 6. (49) A. ALTAMURA. Testi Napoletani del 400, Collezione Novantiqua, Napoli 1953, intr. FOI.ENA, op. cit., p. 9. (50) (51) Micuroamn e FOLENA, Testi non toscani del 400, Istituto di fu. rom., Modena 1953, pag. 16. Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce Le prime manifestazioni del volgare, in Terra d'Otranto, — quelle conosciute„ almeno sono le lettere di Maria d'Enghien, alle quali debbono aggiungersi ordinanze e statuti dalla stessa emanati. Ella apprese quel volgare presso la corte di Ladislao, re di Napoli, dove rimase fino al 1449 e dove il volgare era già in uso. Si spiega così come ella adoperasse, venuta a Lecce, nei suoi statuti, nei quali, come nota il prof. Mario D'Ella, studioso di problemi linguistici di Terra d'Otranto, « tradizione toscana, tradizione latina e dialetto salentino sono i principali filoni che confluiscono » (52). Anche nel Salento quindi ci troviamo di fronte ad un ibridismo linguistico. Le sorti della lingua napoletana non dovevano rimanere estranee a Terra d'Otranto, ché, una considerazione di carattere storico, mostrerà come anche qui si diffondesse l'uso di quella lingua che trovava il suo centro diramatore nella corte aragonese, con quei caratteri che più sopra abbiamo indicato. Quando nel 1463 Giovanni Antonio del Balzo morì, re Ferrante venne in Terra d'Otranto ad impossessarsi del feudo ereditato e, abolito il « Concistorium Principis », ad esso subentrarono la Regia Udienza e il Sacro Regio Consiglio Otrantino, di cui furono vicari e luogotenenti generali i figli di Ferrante, Alfonso, Cesare e Federico. Ora, è logico che questi Principi usassero nei loro scritti quel volgare che ormai era divenuto familiare presso la corte. Da una parte, quindi, l'esigenza ormai maturata e presente anche negli spiriti più colti di una nuova lingua, quale le nuove condizioni richiedevano, e dall'altra, l'esempio di una corte, su un mondo provinciale né retrivo né chiuso alle nuove aspirazioni culturali, come avemmo modo di notare in un precedente capitolo. Si giustifica così, nel Salento, nella seconda metà del 400, l'esistenza di una lingua comune a tutto il regno napoletano e quale appare dalle lettere del Pontano, dal « Novellino » del Guardati, dal « De Majestate » del Majo. Fu una lingua ricca di meridionalismi, di latinismi e neologismi, di voci e di modi dovuti alla influenza spagnola, di un forte colorito locale e che pure indulgeva ad influssi toscani. Si è parlato di influsso toscano, ma fino a che punto esso arrivi è difficile stabilire, giacchè mancano studi che illustrino la penetrazione della lingua letteraria nel Salento. Possiamo solo notare che uomini come il Galateo e il Caracciolo vissero nella stessa Napoli di un De Jennaro che già abbiamo avuto modo di notare in quale misura abbia sentito l'influenza del Petrarca e qui, — si badi bene —, intendiamo sottolineare l'influenza linguistica. Ma accanto a questa, diremo, opera di mediazione esercitata dai nostri accademici, sta l'azione diretta che la diffusione di opere in volgare (Trionfi del Petrarca nella biblioteca di Angilberto del Balzo) e dei numerosi volgarizzamenti (abbiamo notizia di un Guidone da Nardò e di Fra Nicola, amanuense in volgare il primo e volgarizzatore il secondo) dovette esercitare nella lingua del tempo. Non minore importanza, in tale senso, hanno le colonie mercantili, in special modo di fiorentini, che qui si erano stabilite. Si è parlato del Caracciolo e del Galateo e non sarà qui fuori luogo, notare come ambedue questi scrittori vagheggiassero, come gli altri accademici napoletani, un ideale di lingua letteraria che, se pure non riuscirono a raggiungere, pure il loro esempio unitamente a quello degli altri accademici, sarà di aiuto alla soluzione che al problema darà il Sannazzaro. (52) M. D'ELIA, Osservazioni sul volgare negli statuti di M. D'Enghien, dagli « Atti del Il Congresso Storico Pugliese e del Convegno Internaz. di Studi Salentini, 25-31 ott. 1952. 42 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce Da uno studio locale, diretto alla conoscenza dello sviluppo del volgare in Terra d'Otranto di Rodolfo Francioso (53), si ricava che il primo ,documento della lingua volgare, adoperata dallo scrittore con intendimenti letterari, risalga al 1448. Si tratta di un manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi (54). Ci proponiamo ora di stabilire i caratteri linguistici del poema in questione, che testimonia, a fine secolo, a quale livello il volgare, usato con intendimenti letterari, fosse giunto in Terra d'Otranto. Una rapida scorsa ci consente di individuare nel suo stile composito, quegli stessi orientamenti e quelle stesse correnti linguistico-culturali che caratterizzano le scritture meridionali del 400, di carattere letterario. Accanto a voci e forme, comuni ai testi letterari meridionali, e che si possono ricollegare ad una Koinè letteraria napoletana e meridionale, basata su forme dialettali meridionali, si rilevano forme aderenti al toscaneggiamento e al latineggiamento. Indichiamo qui alcuni particolari caratteri fonetici e lessicali del nostro documento, nonchè alcune sue particolari costruzioni, in aggiunta ai latinismi frequenti ed ai caratteri nati da riflessi particolari, di natura storica, religiosa, retorica etc.... Sono tutti motivi, diremo comuni all'epoca, che riaffiorano in altri documenti meridionali dei secoli XIV e XV, non solo di contenuto letterario, ma anche di tipo amministrativo (55). Receputa, ricevuta, c. lr. cfr. Maria Corti, De Jennaro, Gloss. s. v. Receputo id. Altamura, Testi napoletani XIII-XIV sec., Gloss. s. v. Recepere, ricevere. Applicato (in sua laude applicato), rivolto a sua lode, c. ir. cfr. Migliorini-Folena, Testi Quattrocento, 26, 20 ( a Palermo) Applicari a... assegnare. Monopoli ( L. R.) Capitula Catapanorum, p. 59 « ...incidat in penam tareni aurei unius applicandam utilitatibus universitatis predicte modo... ». RODOLFO FRANCIOSO, op. cit. (54) Trovasi nei man. Italiani, 455 Membranaceo di pag. 66: « Incomenza et librecto de pestilencia composto per messer Nicolò de Ingegno cavaliere et medico al suo glorioso signore Johanne Antonio de Baucio di Ursini principe di Taranto et cetera suo singolare .signore nelli anni del Signore 1448 del mese di marzo ». (55) Le abbreviature che usiamo per indicare i suddetti documenti, sono le seguenti: A. Altamura, Testi napoletani XIII-XIV sec. = ALTAMURA, Testi napoletani dei secoli XIII XVI, Napoli, editrice Viti, 1949. M. Catalano, Beata Eustochia da Messina = CATALANO MICHELE, La leggenda della Beata Eustochia da Messina, II ediz., Biblioteca di cultura contemporanea XXXIII, edit. D'Anna, Messina-Firenze 1950. CORTI MARIA, PIETRO JACOPO DE JENNARO, Rime e lettere a Cura M. Corti, J. De Jennaro di M. C., collezione di opere inedite e rare pubblicate per cura della Comm.ne per i Testi di Lingua, vol. 120, Bologna 1956. Folena, Angilu di Capua = FOLENA GIANFRANCO, La historia di Eneas vulgarizzata per Angilu di Capua, a cura di G. F., collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV diretta da E. Li Gotti, Palermo 1956. F. Gaeta, I. Majo GAETA FRANCO, Juniano Maio, De Maiestate, inedito del sec. XV, a cura di F. G., scelta di curiosità letterarie inedite e rare dal sec. XIII al XIX, Dispensa CCL, commissione per i Testi di Lingua, Bologna 1956. Lecce (S.M.d'E.) = Statuti di Maria d'Enghien (Lecce, anno 1473; manoscritto pergamenaceo nella Sezione di Archivio di Stato di Lecce; pubblicato da FRANCESCO CASOTTI in « Opuscoli di Archeologia, Storia e Arti Patrie », Firenze 1874, pp. LXXII-CXXI. Migliorini-Folena, Testi quattrocento = MIGLIORINI BRUNO - FOLENA GIANFRANCO, Testi non toscani del 400 a cura di M.B. e G.F., Istituto di Fil. Rom., Testi e, manuali n. 39, Modena 1953. Monopoli (L. R.) = Libro Rosso della città di Monopoli (XVI sec.) pubblicato a cura di FRANCESCO MUCIACCIA, commissione provinciale di Archeologia e Storia Patria, documenti e monografie, vol. IV, Bari 1906. (53) 43 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce Lecce (S. M. d'E.), XCIV « ... alla pena de unce quattro applicando alla corte del capitanio », da assegnarsi. Fatiga e. lv., lavoro, impegno dell'amanuense. cfr. Folena, Angilu di Capua, Gloss. s. v. fatiga, dolore, prova. Catalano, Beata Eustochia da Messina, Gloss. s. v. fatiga, fatica. Forno, furono, c. 2r. cfr. Catalano, Beata Eustachia ,da Messina, Gloss. s. v. forno. id. Maria Corti, J. De Jennaro, Introd., p. CLIX, forno, id. Satisfacto, soddisfatto, c. lr. cfr. Maria Corti, J. De Jennaro, Gloss. s. v. satisfare; satisfatto, id. Lecce (S. M. d'E.) XCV « et satisf ore allo patruno de lo danno... » id. Compie, Campi Salentina, c. 3r. cfr. Lecce (S. M. d'E.) C. Casale Campie. Como, come, c. 3v. cfr. Altamura, Testi napoletani XIII-XIV sec. Gloss. s. v. como id. Maria Corti, J. De Jennaro, Gloss. s. v. como id. Gaeta, I. Majo, Gloss, s. v. como, id. Posserse, potersi, c. 3r. cfr. Maria Corti, J. De Jennaro, Gloss. s. v. posser, potere. Et sia licito ad Monopoli, (L. R.) XXI, Capituli del Scannagio, p. 67 « quello che farà dieta carne possere vendere li mussi pedi et quello de intro... ». Lassando, lasciando, c. 3v. cfr. Maria Corti, J. De Jennaro, Gloss. s. v. lassare (più infinito semplice), cessare di Folena, Angilu di Capua, Gloss. s. v. lassari, lasciare. Maria Corti, J. De Jennaro LXXXIII. Sonno (sonno state ad visitarla), sono, c. 3v. cfr. Catalano, Beata Eustochia da Messina, Gloss. s. v. sonno, id. A cio che, acciochè, c. 34v. cfr. Monopoli (L. R.) XXI Capituli J:lel Scannagio, p. 71 « Et a cio eche li sopradicti non possa sorgire dubio o... » id. Biasmo, biasimo, c. 42r. cfr. Maria Corti, J. De Jennaro, biasmar (XXXIV, 12) biasimare. Tra le voci del nostro testo che trovano una corrispondenza nel lessico di dialetti salentini odierni e che possono essere presi in considerazione, per individuare il filone dialettale del nostro testo, possono essere prese in considerazione poche voci: masculi - maschi; fiate - volte ; canata - cognata ; size - mammelle ; menna - mammella ; macina - mattina. Va da sé che la larga diffusione delle voci sopradette in documenti a carattere letterario o amministrativo meridionale del 400, ci induce a pensare che, nella coscienza linguistica dell'autore, le stesse voci non rappresentavano tratti crudamente dialettali, ma voci già nobilitate dal precedente uso di carattere letterario e amministrativo. Tra i soliti tipi di grafie latineggianti notiamo i seguenti: affectionata, astrecto, satisfacto, tutta, honesta, laudare, dixe, exequir, exarso, substene,. orphani, subsidio, septe, seu, gotta, triunphale, exquisiti, hora. Non mancano nel poema francesismi e spagnolismi. Sono spagnolismi: verdatero, donairo, juro a Dio, posata, creato. Non considereremo qui quei caratteri comuni alle scritture del tempo quali : la riduzione di ti + vocale . in ci + vocale, la scempia al posto della doppia nell'italiano odierno, il plurale rappresentato oltre che da i, anche da j. 44 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce Conclusione Fino a questo momento abbiamo cercato di stabilire le caratteristiche dell'ambiente culturale in cui si colloca, sia pure spiritualmente, la nostra opera, e ancora, di esaminarne la lingua, seguendo — per la migliore interpretazione dei dati offerti — un metodo di semplice e serena logica, nella quale abbiamo fatto convergere i metodi di lettura tradizionali (critica storica, filologica, estetica, e stilistica), senza concessioni particolari ad alcuna di queste. Ci sembra ora giunto il momento di considerare il poema nella sua totalità, per esaminarne i caratteri. Da un esame condotto sulla fortuna e sulla critica del poema, ci è stato dato stabilire, come lo studio fatto dal Croce rappresenti l'unica vera critica che al poema sia stata fatta. Sarà ora opportuno richiamare alla mente un tale studio e, diremo, subito, come ci sembri che troppe siano le riserve e le limitazioni del critico; non già che noi consideriamo la composizione un capolavoro, ma ci sembra che maggiore indulgenza meritasse %neri de Pacientia. Infatti nel « Lo Balzino » gli affetti, i sentimenti e i pensieri si « scandiscono », si « versificano », trovano la loro giusta collocazione in una poesia che non ha pretese e che, appunto per questa dichiarata e voluta semplicità, piace. E' vero che la forma del poema è modellata sui poemi cavallereschi dei cantastorie, ma di essi non riproduce né la forma sciatta né l'argomento trito. Noi abbiamo l'impressione che si tratti di un volgarizzamento storico, dettato da una palese intenzione del poeta di narrare, ín forma piana, i casi della sventurata Isabella. L'opera non è appesantita da intenti moralistici, anche se non mancano osservazioni morali, né la sua composizione è legata a precisi scopi da raggiungere, se si eccettua quello — per noi evidente — di fare opera storica per un pubblico non iniziato a sottili ricerche, quale poteva essere quello di dame cortigiane cui è rivolta la composizione. « Trattato » non aulico quindi, non per altri motivi, se non per intenzione stessa dell'autore. E' evidente che l'impegno stilistico non abbia costituito una preoccupazione per il nostro autore. Egli stesso dichiara di voler usare uno stile « mediocre et bascio », ma questo vale quanto dire che non sapesse fare di meglio? Nomina tre fra i rimatori cortigiani famosi del tempo: Non son lo Chariteo, non son lo Antonio Né men el vostro docto Thimoteo Lassando a li predicti la eloquencia El terso et alto et glorioso stile. (56) Non sarà quindi arbitrario ammettere che conoscesse la migliore produzione letteraria coeva. « E' puerile nella forma » — nota il Croce — è vero, ma una forma aulica, giacchè non ci sembra di riscontrare una forma sciatta, non avrebbe costituito una stonatura con il carattere decisamente popolare della composizione? (56) Lo BALZINO, C. 146 v. 45 A questo proposito diremo come da una completa lettura, ci sembra che si possa affermare che lo stile della prosa sia ben più elevato di quello dei versi. Non staremo qui a stabilire se il nostro autore sia stato un letterato o no, anche perchè, come è ovvio, la inesistenza assoluta di notizie biografiche non ci faciliterebbe di certo il compito; non abbiamo di lui che un codice — e nulla di più — e questo non basta, .dato il carattere stesso dell'opera, a trarre conclusioni definitive sulla sua posizione di fronte all'ambiente culturale del tempo. Certo che la cultura aragonese non dovette essergli del tutto estranea, giacchè tornano nel suo poema diversi elementi che a quella lo ricollegano, non ultimo quel carattere cronachistico che tanto spiacque al Croce (57). Già, in altro capitolo, considerando i caratteri della cultura aragonese, avemmo modo di sottolineare come negli scrittori popolari fosse vivo il gusto della cronistoria mondana. Ora quale altro scrittore avrebbe potuto seguire con più giustificati motivi un tale atteggiamento se non il Pazienza, uomo di corte? Abbiamo detto atteggiamento, ma, certo, il termine non è esatto, ché, se a molti si addice, non tra questi rientra il nostro autore, nel quale, la cronistoria mondana era quasi una forma naturale quanto mai consona alle « sue occupacioni ». E non è questo il solo elemento che alla cultura napoletana lo riconduca, anche l'aneddoto relativo alla divisione che Beltrando del Balzo fece del tesoro di Manfredi; quale evidenza narrativa, da quei versi, traspare! Smontato el re al castello capuano li fo appresentato un gran thesoro de Re Maníredo: et quel signor soprano chiamo Beltran de Balzo in mezo al coro et dixeli e bilanze piglia in mano et pesa et sparti tutto questo tal oro Beltran respose che faro de bilanze ad spartir tanta moneta et tante zanze Et dicto questo salio sopra poi et con li piedi in tre parte el destina la una dixe sia del nostro Roj et l'altra de nostra damma la Rejna et l'altra se deuida fra gente soi cioe fra caualer che seco mina et si fo facto et quel se obseruao et ciascun la sua parte se pigliao (58) La scena è davanti ai nostri occhi nella sua realtà formale, oltre che sostanziale, con un cromatismo e con una compiutezza che colpisce, quasi più della stessa realtà. Abbiamo citato quest'esempio, ma. ancora, tanti se ne potrebbero citare, e forse più efficaci, nell'efficacia realistica della narrativa in esame. A parte l'efficacia particolare che il nostro autore raggiunge quando si indugia nel presentare una persona : è come la caratterizzasse con un felice pennello al quale riuscisse. come per miracolo creativo, in un tutt'uno: corpo (57) B. CROCE, Storie e leggende napoletane, p. 187. (58) Lo BALZINO, C. 8 v. 46 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce ed anima. Un esempio di tale felice caratterizzazione presenta la seguente descrizione della « bajla over nutriza » di Isabella « de bona ganga (ganga mola e non ganascia come traduce il Croce) (59) et tristo pede » una che de orane vitegno lo celebro tenea sempre inacquato • • • • • • • • • et molte uolte sopra de la nata congreue son spisso se adormea (60) La nota sull'efficacia narrativa del poema, ci ha portati molto lontani dalle considerazioni che stavamo facendo, volte a stabilire in quali rapporti il poema in questione sia legato a manifestazioni culturali, comuni, del tempo. Come sopra dicevamo, un esame del poema non rivela intenti morali così pressanti come nell'opera di un Guardati o di un Del Tuppo, nei quali tali intenti si è da più parti d'accordo di considerarli nèi anzichè elementi positivi. Il raffronto, anche sotto quest'ultimo profilo. ci è utile per dimostrare che al componimento del quale ci occupiamo spetta un posto, non preminente, ma neppure di ultimo piano, come espressione di un'epoca. Altra considerazione da fare in relazione a quanto sopra affermato è l'adesione del poeta all'ambiente storico in cui visse. La scelta dell'argomento costituisce senza dubbio un'altra documentazione a quanto affermiamo, giacchè, come la cronistoria mondana, risponde ad una naturale disposizione dell'uomo di corte, incline sempre a proiettare nelle sue opere la vita che egli vive. Una considerazione particolare, piuttosto, merita l'opera, tenendo conto che gli avvenimenti in essa narrati furono vissuti dal nostro autore, e in maniera molto diretta, per essere egli uomo di corte. La nuova indagine ci porta ad un primo risultato : quello di scoprire innanzitutto la perfetta fedeltà dell'autore alla casa aragonese e quindi la sua quasi familiare partecipazione alle venture e alle sventure della casa. La profonda devozione che egli ebbe per Casa d'Aragona e i maggiori avvenimenti ad essa legati sono evidenti nel poema, e, a parte ora considerazioni di carattere puramente estetico e letterario, diremo come la dovizia di notizie e la fedeltà assoluta con cui sono riportate, ci autorizzano ad affermare che, indipendentemente da ogni valore artistico, l'opera costituisce un documento storico di non disprezzabile valore. L'importanza storica del testo ed alcune notizie relative al costume del tempo, sono state sottolineate dal Croce, tanto da meritare una completa esposizione dell'opera : ma tale preminente importanza è forse stata anche il motivo che ha indotto il Croce a non interessarsi del lato letterario del componimento, se non marginalmente ed in maniera superficiale e poco indulgente. Certo che, se diverso fosse stato il « tono » del poeta, noi avremmo avuto un'opera storica di non scarso valore e degna di essere collocata tra le opere dei migliori storici del tempo. Valore storico. dunque, e non solo per l'aiuto che l'autore dà alla ricostruzione della storia, ma per i molteplici e diversi riflessi che alla storia sono legati e che interessano vita, costume e ambiente di una intera epoca. A questo proposito gioverà ricordare che già abbiamo rilevato, nell'opera in esame, motivi che interessano la storia del costume e che ci portarono a constatare l'usanza della conservazione degli abiti al pari dei gioielli. (59) B. CROCE, cc Arch. Stor. ,napol. », a. XXII, p. 654; Storie e leg. nap., p. 194. (60) Lo BALZINO, C. 11 r. 47 4 - LA ZAGAGLIA Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce Ci portò a questo primo dato di storia del costume, il dono che la regina Giovanna inviò ad Isabella, consistente nella gonnella di panno di oro. Confermano tale dato e lo arricchiscono altri motivi: la minuta descrizione del rito battesimale di un figlio di Giulia Paladini, cui Isabella fece da madrina e che si conclude con un bacio tra i compari (usanza tipicamente salentina), le descrizioni di feste e' di cerimonie che in onore di Isabella si tenevano, la presentazione di colorite scene di caccia che si accompagnavano ai vari festeggiamenti ,di corte e che offrivano motivo di composizione a tanti scrittori. Il carattere dell'opera, comunque, è tipicamente meridionale e traspare — direi — sempre dalle forti tinte con le quali l'autore ama presentare e tramandare il suo mondo. Ora è una devozione e un affetto esuberante che fa di Isabella la sua eroina, ora un sentimento religioso che ha quasi del fanatismo. C'è in lui grande venerazione per tutto ciò che è santo ed è manifestazione quasi tangibile della divinità. Indulge volentieri alla tentazione di descrivere le reliquie che da vescovi e prelati erano portate incontro ad Isabella, quando giungeva nelle varie città, e non tralascia occasione, per sottolineare il carattere religioso della sua « pia » eroina. Il sentimento predominante nel poema è, come abbiamo più volte notato, il suo incondizionato amore per la regina, ma, con questo amore reverenziale, è una gamma infinita di altri sentimenti affettivi che entrano, quale elemento costitutivo del poema, tra i quali, in primo piano, come si trattasse di luce siderea, l'amore tra Federico e Isabella. Quell'amore che tanta parte aveva avuto nella trattatistica quattrocentesca trova anche qui, come gli altri affetti, la sua giusta collocazione. E per finire, continuando nell'indagine spirituale, volta a scoprire ed a mettere in evidenza i vari temi sentimentali che sono l'anima del poema, non può sfuggirci il tema della Fortuna che costituisce poi il motivo conduttore delle vicende narrate. Tale motivo abbiamo lasciato deliberatamente per ultimo, perchè in esso è evidente il carattere tipicamente popolare che definisce il poema. Fortuna e virtù costituiscono un problema classico, al cui fascino nessuno -degli scrittori quattrocenteschi di tutta Italia — potremo forse dire — si è sottratto : dal Cavalcanti al Morelli, al Collenuccio, al Pontano, al Galateo; anche se non risolto in egual modo e con gli stessi risultati, fu un problema che tutti si posero. Nel nostro autore la Fortuna è debellata dal « core humano » di Isabella; virtù vince quindi Fortuna. Spesso la Fortuna acquista nel poema carattere di superstizione, ma questo non deve meravigliare, trattandosi di una composizione a carattere popolare, e, quel che più conta, composta da un meridionale. Lo Balzino rientra, secondo noi, nel numero di quelle opere che oggi, deve farci pensare a diversità di toni, intesi come caratterizzazione; non ci troviamo di fronte ad una poesia popolare che perde il suo carattere e non riesce nello stesso tempo a trovarne un altro, invece t naturale e facile riscontrare coerenza e fedeltà assoluta, dalla prima all'ultima parola, allo specifico carattere popolaresco : una continuità ammirevole che non sempre si riscontra in poemi del genere. La Balzino rientra, secondo noi, nel numero di quelle opere che oggi, dato il loro non rilevante valore artistico, hanno perduto quell'interesse che avevano nel tempo in cui nacquero, giacchè legate all'ambiente e alle esigenze di esso. Ciò non toglie però che lo Balzino, in particolare per quel suo innegabile — e più volte ripetuto — valore artistico, accompagnato ad una 48 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce non disprezzabile forma letteraria, meriterebbe giusta collocazione tra i primi tentativi di una formazione di prosa letteraria in terra d'Otranto. Una trascrizione completa dell'opera renderebbe più suasive queste nostre osser vazioni e varrebbe a dare prestigio alla letteratura del Salento, che troppo, è stata mortificata nella comune convinzione di provincialismo. RITA MOSCARDINO BIBLIOGRAFIA ALTAMURA ANTONIO - Testi napoletani dei sec. XIII e XIV - Editrice Viti, 1949, Napoli. ALTAMURA ANTONIO - « Testi napoletani del 400 » - Collezione Novantiqua, Napoli 1953. BACILE FILIPPO - « Scritti varii di arte e di storia » - S.T.E.B., Bari 1915. BEVERE RICCARDO - Archivio Storico napoletano, a. XXII, fase. II. BIGI E. - «Lorenzo Lirico » in « La rassegna della letteratura italiana » luglio-settembre 1953 n. 3, ristampato nel vol. « Dal Petrarca al Leopardi », Ricciardi Milano-Napoli, 1954.. statuti di M. D'Enghien » (Lecce a. 1473) pubblicati in « Opuscoli di Archeologia, storia ed arti patrie », Firenze 1874, pp. LXXIPCXXI. CATALANO MICHELE - « La Leggenda •della Beata Eustachia da Messina », 2' edizione, Biblioteca di cultura contemporanea XXXIII, Messina-Firenze 1950. CORTI MARIA - « Pietro Iacopo De Jennaro » Commissione per i Testi di Lingua, vol. 120,. Bologna 1956. CROCE BENEDETTO - « Poesia popolare e poesia d'Arte », Bari, Laterza 1957. CROCE BENEDETTO - « Storie e Leggende napoletane », 3 a ed., Bari, Laterza 1942. CROCE BENEDETTO - « Arch. Stor. per le prov. napol. », a. XXII fasc. IV, Napoli 1897. CROCE BENEDETTO - « Napoli nobilissima », vol. VII, fase. III, marzo 1898. D'ELIA MARIO - « Osservazioni sul volgare negli statuti di M. D'Enghien ». Dagli « Atti del Il Congresso Storico Pugliese e del Convegno Internazionale di Studi Salentini », ed. Cressati, Bari 1952. DE LINA - « La provincia di Lecce » (settimanale locale), 30 gennaio 1898. FLORA FRANCESCO - « Storia della lett. italiana », vol. 1°, Mondadori 1950. FOLENA GIANFRANCO - « La crisi linguistica del quattrocento e l'Arcadia di I. Sannazzaro, Biblioteca dello « Arch. Romanicum », ed. Olschki, Firenze 1952. FOLENA GIANFRANCO - « La historia di Eneas volgarizzata per Angilu di Capua », a cura di G. F., collez. di testi siciliani dei sec. XIV e XV diretta da E. Li Gotti, Palermo 1956. FOLENA-MIGLIORINI - « Testi non toscani del quattrocento », Ist. •di Fil. Rom., Modena 1953. FRANCIOSO RODOLFO - « Il volgare in terra "tranto nel sec. XV », nella Rivista Storica Salentina, Legge maggio-giugno 1907, n. 5 e 6. GAETA FRANCO - funiano Maio - De Maiestate - inedito del sec. XV, scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal sec. XIII al XIX( dispensa CCL Commissione per i Testi di Lingua, Bologna 1956. GOTHEIN EVERARDO - « Il Rinascimento nell'Italia Meridionale », trad. di T. Persico, Biblioteca Stor. del Rinascimento, Sansoni, Firenze 1915. MIGLIORINI-FOLENA - « Testi non toscani del quattrocento », Ist. Fil. Rom., Modena 1953 (op. cit.). MUCIACCIA FRANCESCO • « Libro rosso della Città di Monopoli » (sec. XVI) Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria, Documenti e Monografie, vol. IV. Bari 1906.. PERCOPO ERASMO - « Rassegna Critica della Letteratura italiana », a. II, fase. XI-XI1. PANAREO SALVATORE - « Isabella del Balzo in Terra d'Otranto secondo un poema inedito del tempo », ed. Vecchi, Trani, 1906. PETROCCHI GIORGIO - « Il Novellino », Sansoni, Firenze 1957; « Masuccio Guardati e la narrativa napoletana del 400 », Le Monnier, Firenze 1953. SAPEGNO NATALINO - « Storia della letteratura italiana », vol. I°, La Nuova Italia, Firenze 1950. TANZI « Il Chronicum Neritinum » nella Riv. Storica Salentina, Lecce ag.-sett. 1903, n. 4-5. VOLPICELLA - e Regis Ferdinandi primi Instmetionum Liber », Società Napoletana di Storia Patria, Pieno, Napoli 1916. CASOTTI FRANCESCO - « Gli FINE 49 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDIESSE (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce
Scarica