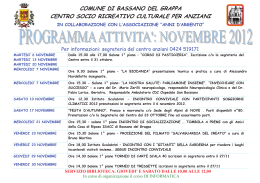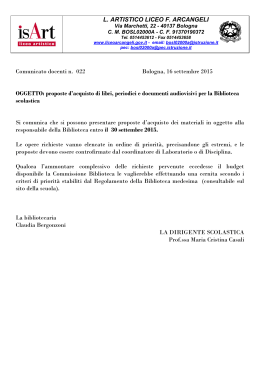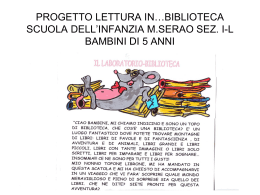A Luigi Mancino stimato collega LA CAPITANATA Rivista quadrimestrale della Biblioteca Provinciale di Foggia Direttore: Franco Mercurio Segretaria di redazione: Maria Adele La Torretta Redazione e amministrazione: «la Capitanata», viale Michelangelo 1, 71100 Foggia tel. 0881-791621; fax 0881-636881; e-mail: [email protected] «la Capitanata» è distribuita direttamente dalla Biblioteca Provinciale di Foggia. Per informazioni e per iscriversi alla lista delle persone e degli enti interessati rivolgersi a «la Capitanata», viale Michelangelo 1 71100 Foggia, tel. 0881-791621; fax 0881-636881; e-mail: [email protected] “LA MAGNA CAPITANA” BIBLIOTECA PROVINCIALE DI FOGGIA è un servizio della Provincia di Foggia Presidente: Carmine Stallone Responsabile Agenzia Prov.le per la Cultura: Rosaria Dicesare Direttore: Franco Mercurio, [email protected] Authority amministrativa: Adolfo Rosiello, [email protected] Authority catalografica: Gabriella Berardi, [email protected] Authority editoriale: Elena Infantini, [email protected] Authority logistica: Gino Vallario, [email protected] Authority informatica: Antonio Perrelli, [email protected] ilDock: Centri di documentazione: Enrica Fatigato, [email protected] Emeroteca: Franco Corbo, [email protected] Fondi antichi e speciali: Antonio Ventura, [email protected] Sala Narrativa: Annalisa Scillitani, scillitani @bibliotecaprovinciale.foggia.it Sala Consultazione: Maria Altobella, [email protected] Sala Ragazzi: Milena Tancredi, [email protected] Erba curvata dal vento (… grano, canneti della costa o delle zone paludose…) e il terso cielo stellato sono elementi simbolicamente connotativi del nostro territorio. La dicitura A.D. 2000, insieme alla scritta ex-libris mutuata da Michele Vocino, rappresentano la volontà di tenere sempre presente il collegamento tra passato, presente e futuro senza soluzione di continuità. Questo ex-libris che d’ora in poi caratterizzerà i documenti posseduti dalla Biblioteca Provinciale, è stato per noi elaborato da “Red Hot - laboratorio di idee e comunicazione d’impresa” e da loro gentilmente donato. Red Hot: Gianluca Fiano, Saverio Mazzone, Andrea Pacilli e Lorenzo Trigiani. Manfredonia, a.d. 2000. _______________ LA CAPITANATA RASSEGNA DI VITA E DI STUDI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA _______________ 16 _______________ Biblioteca _______________ Giugno 2004 4 Indice p. 9 L’ordine, il disordine e il mutante: a trent’anni dall’inaugurazione della nuova sede di Franco Mercurio 1. La V Legge 2. Trent’anni fa 3. Poi… 15 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città di Guido Pensato 1. Anniversari, ricorrenze (coincidenze, convergenze)? 2. Il “personale”, se non “politico”, può essere almeno “pubblico”? 3. “Quegli anni”: la Città, il Teatro Club, la Biblioteca /1 4. Intermezzo: Una città da amare (o da odiare?) 5. “Quegli anni”: la Città, il Teatro Club, la Biblioteca /2 6. Coincidenze, convergenze? /1 7. Breve inciso, “da bibliotecario ancora militante” 8. Coincidenze, convergenze? /2 9. Cap. N/Memo? 10. Due nuovi servizi 11. Breve storia di un collezionista. I manifesti cinematografici della Biblioteca Provinciale 12. L’Archivio della Cultura di Base, ovvero, la biblioteca si nega: due volte 13. (S)Conclusioni, (s)considerazioni quasi finali 14. Commiato/i 69 Apparato di consultazione generale. Aspetti strutturali e semantici di Maria Altobella 4. La Sala di Consultazione: definizione e riferimenti storico-bibliografici 5. Programmazione della fisionomia 6. Offerta documentaria 7. Innovazione 83 Il catalogo della Biblioteca Provinciale di Foggia tra passato, presente e futuro di Gabriella Berardi 89 Le registrazioni musicali: una prima ricognizione del fondo dei dischi in vinile di Grazia Carbonella 5 99 Il deposito librario: problemi e prospettive di Pasquale d’Addedda 105 La sezione “Immagini&Suoni” della Biblioteca Provinciale di Foggia di Enrichetta Fatigato 1. La mission 2. Profilo biografico e documentale 111 Il Fondo Antico dell’ex Biblioteca Comunale di Foggia nella Biblioteca Provinciale di oggi di Marianna Iafelice 119 Il web della biblioteca di Elena Infantini 123 Il ruolo della rete nella biblioteca di Antonio Perrelli 131 Sulla biblioteca a cura di Annalisa Scillitani 139 La biblioteca dei ragazzi di Milena Tancredi 147 I Fondi Speciali: le terre incognitae della Biblioteca Provinciale di Antonio Ventura 1. Introduzione 2. La nuova Sezione Locale 3. La Sezione Locale: centro di documentazione del territorio 4. Il Fondo Antico: memoria culturale della città e della provincia Presente come cultura 173 “Kirikù. Intercultura, biblioteca e mezzi di comunicazione” Foggia, Palazzo Dogana, 3 dicembre 2003 175 L’intercultura nella Biblioteca Provinciale di Foggia di Franco Mercurio 177 Kirikù a “ilDock”: la sezione intercultura della Biblioteca Provinciale di Foggia di Enrichetta Fatigato 6 185 L’esperienza della Biblioteca “Lazzerini” di Prato di Franco Neri 193 Intercultura e diritto alla differenza di Franca Pinto Minerva 1. L’emigrazione tra identità e alterità 2. Il nuovo concetto di cittadinanza 3. Pensiero nomade migrante 4. Il ruolo della scuola 199 Egnazia, ponte tra l’Italia e l’Albania di Angelo Sante Trisciuzzi 203 Immigrazione e integrazione di Carine Bizimana 205 Una premessa per le Linee Guida della Biblioteca Provinciale di Foggia di Franco Mercurio 209 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari de “la Magna Capitana” 1. Introduzione 2. Fisionomia e profilo culturale 3. La politica documentaria e lo sviluppo della raccolta 4. Criteri di gestione 5. Sintesi dei punti qualificanti del documento e degli indirizzi al direttore 247 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) 1. Introduzione 2. La descrizione degli indicatori 3. Gli indicatori 271 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia da parte della collettività (marzo 2004) 1. Introduzione 2. Profilo del lettore 3. Il bisogno della Biblioteca 4. La percezione della funzione della Biblioteca 5. I consumi culturali e di informazione dei lettori della Biblioteca 309 Gli autori 7 8 Franco Mercurio L’ordine, il disordine e il mutante: a trent’anni dall’inaugurazione della nuova sede di Franco Mercurio 1. La V Legge Per un bibliotecario un poco poco accorto la quinta di Shivali Ramamrita Ranganathan è una legge inesorabile. Come un novello memento mori sta a significare che in una biblioteca nulla è immutabile, perfino nei più rari fondi di conservazione chiusi nelle camere pressurizzate. Il raggiungimento faticoso dell’equilibrio più avanzato fra i tre fattori che costituiscono la biblioteca (libro, lettore, bibliotecario) diventa il principio di un’altra fase di instabilità volta al conseguimento di nuovi equilibri. Solo la consapevolezza di questa eterna lotta fra ordine biblioteconomico raggiunto e disordine biblioteconomico incipiente fa comprendere il senso profondo della V Legge, che recita: “la biblioteca è un organismo in evoluzione”. La biblioteca è una costola della sua comunità di riferimento, rispecchia la sua storia, interpreta i suoi bisogni, anticipa per quanto sia possibile le sue domande. La biblioteca muta con il mutare della società. E questo accade in tutti gli aspetti della biblioteca, anche in quelli che riteniamo meno condizionati dalla fugacità del tempo. Abbiamo appena classificato le nostre unità bibliografiche con la 21ª edizione della Dewey, che già si attende la pubblicazione della 22ª, che modificherà in modo più o meno inafferrabile alcuni descrittori nello forzo di intercettare e di descrivere nel modo più aderente al comune sentire i mutamenti dell’azione e del pensiero umano. Le certezze di ieri nell’indicizzazione diventano attesa oggi per trasformarsi in altre certezze domani. E, poiché la ricerca dell’ordine spesso crea la necessità di dover spiegare le ragioni di quell’ordine, noi abbiamo preso l’abitudine di dichiarare su ogni scheda, ogni record bibliografico che stiamo utilizzando la 21ª Dewey, così come abbiamo dichiarato nel passato che utilizzavamo la 20ª, la 19ª, e diremo domani che applichiamo i descrittori fissati nella 22ª edizione. Perché ogni volta che muta qualcosa avvertiamo per nostra natura professionale la necessità di testimoniarlo. Consapevolmente. Una metafora, che sarà il tormentone di questa introduzione, è possibile farla. La biblioteca è come un film che il lettore vede per intero o per sequenze; il bibliotecario non può fare a meno di vederlo per fotogrammi, dove ogni fotogramma è il nuovo equilibrio raggiunto fra ordine e disordine negli impercettibili movi9 L’ordine, il disordine e il mutante: a trent’anni dall’inaugurazione della nuova sede menti fra i diversi fotogrammi, che proviene da un ordine precedente e tende attraverso il disordine del presente ad un ordine futuro. Quanto più vi è consapevolezza del presente, tanto più è possibile comprendere le ragioni del passato, presagire il futuro. Siamo così presi della lettura dei singoli fotogrammi che a volte qualcuno di noi dimentica che quelli sono comunque fotogrammi che vanno lavorati singolarmente, ma hanno un senso compiuto solo se abbiamo consapevolezza che fanno parte di una pellicola; se abbiamo la capacità di leggere il film nella sua interezza. Il bibliotecario poco poco accorto vive in questo modo la sua biblioteca. Per questo la biblioteca, qualsiasi biblioteca, è qualcosa di speciale per chi vi lavora. Per questo il bibliotecario vive il suo lavoro in modo diverso da qualsiasi altro collega. Uso il termine “diverso” e non altri per spiegare l’intima natura dell’approccio al nostro mestiere, che non è né migliore né peggiore di altri del pubblico impiego; non è né più importante né meno. È semplicemente diverso perché agiamo in modo diacronico e sincronico ad un solo tempo. Siamo condannati a confrontarci ogni giorno con il vissuto della nostra comunità cercando di rispondere al presente e scrutare nelle nebbie le domande future. E mentre facciamo questo siamo condannati a confrontarci con le odierne biblioteche e gli odierni bibliotecari del resto del pianeta, perché abbiamo un solo codice comunicativo, univoco ed uniforme, a cui non possiamo sottrarci. Se lo facessimo saremmo responsabili della nuova Babele. Non saremmo più bravi bibliotecari, ma estrosi creativi, intellettuali, bibliofili, collezionisti, ligi funzionari, impiegati amministrativi, o quello che meglio vi pare pensare di noi; la biblioteca non sarebbe più un organismo ‘ranganathanamente’ parlando ma un deposito di beni mobili di proprietà pubblica che per un’atavica consuetudine civile si danno in uso temporaneo ai residenti; un po’ come gli inveterati jus civici di legnare o pascolare o usare i beni demaniali. 2. Trent’anni fa Trent’anni fa, dunque, veniva aperta al pubblico l’attuale sede di questa biblioteca. Era esattamente il 5 ottobre 1974. Accompagnata dal XXIV congresso nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche che inaugurava la fortunata stagione dell’auditorium, la Biblioteca Provinciale di Angelo Celuzza era l’inveramento della modernità biblioteconomica. Anche in Italia, anche nel Sud dell’Italia. In sé, nella sua stessa struttura fisica la “Provinciale” dichiarava la sua mission. La fisionomia della nuova biblioteca si delineava sulle suggestioni della public library di matrice anglosassone quale luogo di diffusione della cultura senza censure e, quindi, di presidio della democrazia. Quelle suggestioni bene si intonavano con l’azione meridionalistica rivolta ad estendere le biblioteche nel territorio e nelle aree rurali. Nasceva in tal modo una biblioteca in perfetto equilibro tra conservazione (che trovava nel grande deposito e nella sezione dei fondi speciali e locali i punti 10 Franco Mercurio più qualificanti) e innovazione (che trovava nelle quattro aree a scaffale aperto ragazzi, adulti, consultazione, periodici - i luoghi più immediatamente fruibili). Gli elementi più spinti di innovazione erano assicurati dalla fonoteca che copriva finalmente un’area - quella musicale e audio - scarsamente valorizzata in precedenza e dal progetto di automazione che introduceva i primi momenti di adeguamento tecnologico nella catalogazione. Non più solo biblioteca di studio, caratterizzata da un imponente deposito, ma una public library a scaffale aperto dove il cittadino poteva liberamente aggirarsi, superando quella “paura della soglia” che tanto intimidisce i nuovi lettori e tanto angustia i bibliotecari poco poco accorti. La Biblioteca Provinciale del 1974 si caratterizzava per i nuovi servizi destinati a rivoluzionare l’approccio di una comunità meridionale all’idea di biblioteca. Sala ragazzi, sala adulti, sala di consultazione, fonoteca, laboratorio linguistico, auditorium, bar e perfino un fumoir stavano a spiegare ai foggiani che la biblioteca davvero si apriva al territorio, voleva essere amichevole e mettere a proprio agio i cittadini interessati ad utilizzarla. E per realizzare questa apertura era necessario anche introdurre processi tecnologici innovativi: automazione catalografica, microfilmatura, posta pneumatica interna. Ma la biblioteca del 1974 non si fermava alla sua avveniristica struttura: una delle poche disegnata e progettata da ingegneri e architetti con la consulenza dei bibliotecari. Si proponeva come luogo di coordinamento, indirizzo, guida, promozione della lettura e delle biblioteche civiche perfino nelle più sperdute realtà della nostra provincia. Era il coronamento di oltre dieci anni di lavoro intorno a quel “Piano L”, un progetto ministeriale sperimentale della stagione della programmazione del primo centro-sinistra che nel 1963 considerava la lettura e la conoscenza come fondamentale valore aggiunto per il riscatto delle comunità più povere ed emarginate della nostra provincia. Si prospettava, dunque, una Biblioteca Provinciale di studio e di informazione con un’ampia sezione di conservazione, vocata attraverso il centro rete ad assumere la funzione di direzione e coordinamento delle public library civiche, caratterizzate da una rilevante presenza di opere generali. La cooperazione interbibliotecaria doveva essere la quintessenza del nuovo bibliotecario provinciale. Le funzioni di biblioteca di pubblica lettura svolte fino a quel momento dalla “Provinciale” dovevano passare progressivamente ad una rete civica foggiana di biblioteche decentrate, impiantate sempre sullo stesso modello delle civiche della provincia: una grande selezione di opere generali, community reference, attività di animazione culturale rivolte ad ampliare la promozione della lettura. La “Provinciale” doveva sempre più assumere i caratteri di una biblioteca che era consulente e guida di altre biblioteche. La missione della Biblioteca Provinciale definita nel 1974 è stata per l’ultimo quarto di secolo il punto di riferimento dell’azione dei bibliotecari foggiani. Il fuoco che ardeva nel petto dei giovani bibliotecari di quel tempo trovava, dunque, lenimento nei nuovi equilibri raggiungibili attraverso la nuova biblioteca, che del 11 L’ordine, il disordine e il mutante: a trent’anni dall’inaugurazione della nuova sede passato portava con sé il ricco patrimonio storico, una vocazione alla modernità, impostale da Francesco Barberi negli anni Quaranta, e una propensione alla cooperazione interbibliotecaria nel più ampio significato della parola, instillata da Angelo Celuzza durante la sua direzione. La V Legge dettava le sue condizioni. La biblioteca era un organismo che si doveva evolvere. Necessariamente si doveva evolvere in una società che passava dall’agricoltura all’industria (sebbene dovesse migrare in massa) e sostituiva la radio con la televisione, scopriva che poteva permettersi la “600”, cominciava ad andare al mare ed utilizzava l’italiano come lingua principale anche nelle comunicazioni informali. Era proprio Angelo Celuzza, il padre della nuova “Provinciale”, che ad un certo momento avvertì l’esigenza di richiamare quei bibliotecari che avevano una percezione di sé ancora “con la papalina e la mantellina sulle spalle, chiusi in un umbratile silenzio”. Per restare nella metafora cinematografica, si trattava dell’inizio di un altro tempo del film. Poi… 3. Poi… Poi è accaduto che la rete urbana delle biblioteche di quartiere non si è mai realizzata e la “Provinciale” ha dovuto mutare progressivamente di fisionomia, assumendo sempre più decisamente i caratteri di grande biblioteca civica a sostegno degli studenti. La sala adulti, pensata come sala di primo impatto, in grado di dare riposte immediate alle domande più disparate di aggiornamento personale, ha dovuto sopportare per anni il carico di tutta l’utenza, in attesa dell’apertura della grande sala di consultazione, riservata agli studiosi e agli universitari. Quando questa finalmente ha aperto con imperdonabile ritardo, l’imprinting alla sala adulti era ormai indelebile. La sua fisionomia originaria ne usciva compromessa, finiva per essere un clone venuto male della grande sala di studio: in una studiavano gli studenti, l’altra era riservata a studiosi e ricercatori. L’automazione non riusciva a decollare al punto che solo nel 2000 è stato possibile introdurre la catalogazione informatizzata; il laboratorio linguistico non fu mai utilizzato e in quello di microfilmatura non si riuscì a fotografare nemmeno una pagina. Nemmeno la posta pneumatica fu in grado di funzionare. La stessa rete provinciale, che era stato oggetto nazionale di studio e non poche volte oggetto di invidia professionale, cominciò un lento regresso fino a scomparire il giorno di un mese di un anno a tutti ignoto nell’indifferenza assoluta di tutti. Il bibliobus morì a Vico del Gargano dopo oltre 20 anni di esercizio e centinaia di migliaia di chilometri nel motore fra rivendicazioni salariali di improbabili cantonieri/autisti/bibliotecari e rimpianti generali di operatori turistici e amministratori. Ma nessuno poi mise mano al portafogli per un nuovo mezzo. Ricordo ancora che, fresco fresco di nomina, fui chiamato da Radio Rai 1 a dovermi giustificare per la liquidazione di quell’esperimento avvenuta anni prima nella distrazione quasi generale. 12 Franco Mercurio Per carità. Non voglio passare per quello che dice tutto il male possibile del passato, perché c’è una rilevante parte di quel passato di cui orgogliosamente si può solo parlare bene. Fra l’avvio del 1974 e la fine di quegli esprimenti che ho sintetizzato impietosamente in due righe vi sono stati tentativi e tentativi di adeguamenti, di sollecitazioni, di azioni. Oscuri silenzi di coloro che avevano le chiavi per decidere ai diversi livelli istituzionali ed una sorta di nostalgia del miglior passato da parte di tanti bibliotecari non hanno contribuito a fare avanzare quella pellicola. Molti di noi si erano soffermati sui fotogrammi più belli, pensando che il film proseguisse per una qualche propria intrinseca virtù. Eravamo troppo presi a ricordare il momento fondativo per sentire che il pubblico, rumoreggiante perché la pellicola si era inceppata da tempo nella macchina, in gran parte stava abbandonando la sala. Fuor di metafora devo dire che i molti problemi della “Provinciale” degli anni Ottanta e Novanta non erano solo il frutto di un attardamento sull’impostazione originaria, dovuta anche ad un serio ed aspro confronto ideologico e biblioteconomico fra i colleghi, che avvertivano senza averne consapevolezza che la mission della biblioteca era forse diventata inadeguata. Era la nostra società che stava cambiando tumultuosamente, contribuendo a confondere ulteriormente le prospettive. Fattori internazionali come la formazione politica dell’Europa e la fine del comunismo, la rivoluzione informatica e ancor più quella telematica, fattori interni come l’immigrazione, la crescita zero; fattori locali come la disoccupazione giovanile, la nascita dell’università e del Parco del Gargano, lo sviluppo del culto di Padre Pio; fattori sociali come lo sviluppo della rete di pub e di locali notturni, i mutati rapporti fra i sessi, la riappropriazione di spazi abbandonati, come i centri storici e via dicendo necessitavano di una riflessione più attenta da parte dei bibliotecari poco poco accorti. Quando lo abbiamo finalmente capito era passato troppo tempo per riannodare tutti i fili e riprendere la strada interrotta. Andava ridefinita e ricontrattata la mission della “Provinciale”. Andavano adeguati spazi, metodi e prospettive cercando di salvare tutto quello che ancora si poteva del bell’impianto concettuale del 1974. In parte ci siamo riusciti. In parte abbiamo dovuto rifunzionalizzare spazi e rimodulare le fisionomie dei singoli settori. In parte abbiamo dovuto individuare nuove frontiere per rispondere agli imperativi di Ranganathan. Di quanto abbiamo cominciato a fare, parte rilevante è raccontato nelle pagine di questo numero della rivista. Oggi cogliamo da questo anniversario l’occasione per riflettere insieme ai nostri lettori sul nostro presente e sul nostro futuro. Non è allora ovviamente un caso che questo numero de «la Capitanata» sia dedicato alla Biblioteca Provinciale, per spiegare meglio quale nuovo equilibrio stiamo cercando di costruire. Le trasformazioni in biblioteca a volte discrete a volte impetuose che state registrando nel corso di questi ultimi anni non hanno nulla di casuale. Si inseriscono all’interno di un complesso progetto di rimodulazione della nostra biblioteca, esaltando aspetti del suo passato, correggendone altri, aggiungendone dei nuovi. Dentro questo pro13 L’ordine, il disordine e il mutante: a trent’anni dall’inaugurazione della nuova sede getto non vi è creatività fine a sé stessa né furore iconoclastico né facili adesioni a mode passeggere; vi è semplicemente tutto l’anelito della V Legge. E già sappiamo che, appena avremo costruito questi nuovi equilibri, sarà necessario individuarne degli altri perché abbiamo consapevolezza di essere un organismo che, specchio fedele della sua comunità di appartenenza, per essere di qualche utilità deve mutare costantemente. 14 Guido Pensato Per fatto personale: di molti La Biblioteca, il Teatro Club, la Città* di Guido Pensato Me-ti vantava in Mi-en-leh la capacità di gettare carbone nel fuoco con le mani senza sporcarsi (B. Brecht, Me-ti. Libro delle svolte) 1. Anniversari, ricorrenze (coincidenze, convergenze?) Nel giro di qualche mese e in sequenza mi sono venute a scadenza due richieste di contributi scritti per eventi che ho finito col collegare e col rubricare sotto le voci “anniversario”, “decennale”; forse in maniera non del tutto arbitraria, sulla base di una motivazione e una chiave di lettura degli stessi fortemente (e non solo soggettivamente) unificanti. Se, infatti, l’ottobre 2004 consacra il trentennale della nuova sede della Biblioteca Provinciale di Foggia, tra 2004 e 2005 si collocano, rispettivamente, i quarantacinque anni del CUT (Centro Universitario Teatrale) di Bari e il quarantennale del Teatro Club, una fragorosa meteora della storia culturale foggiana. Attraverso il teatro. Cronache dal CUT Bari negli anni dell’innovazione * Mentre consegno in redazione queste pagine, giunge notizia di un convegno in cui si discute, tra l’altro, di un progetto di legge per la statizzazione della Biblioteca Comunale di Lucera. Trent’anni e più di dure battaglie dell’Associazione e di tutti i bibliotecari italiani, delle Regioni e degli Enti Locali, per liberare l’Italia dal triste e solitario primato di gestire decine di biblioteche “nazionali” (che sono storicamente e culturalmente “regionali”), oltre che due biblioteche nazionali…centrali, vengono minacciate da rigurgiti di retorico provincialismo e di specifica ignoranza della storia e della cultura bibliotecaria italiana e della storia culturale tout court. Se c’è in Puglia una biblioteca che incarna un rapporto strettissimo con la città, la sua storia, la sua cultura; la storia dei suoi uomini di ingegno, dei suoi intellettuali, della loro capacità di dialogare, dalla loro città e attraverso la sua biblioteca, con la cultura italiana: questa è la biblioteca di Lucera, che con la città si identifica. Ha senso rescindere questo legame, in epoca di controverso ma trasversale federalismo, in nome di un riconoscimento fasullo (o per un improbabile “pugno di dollari”?), che espropria la città della propria storia e del proprio passato? Un passato che, in questo momento, ne sono certo, si vergogna del presente, nella certezza che il futuro finirà, una volta per tutte, per seppellire sotto una sonora risata sortite che riescono ad insultare contemporaneamente tante storie, tante vicende, tante idee, tanti valori importanti. 15 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città (Modugno, Edizioni dal Sud, 2004), dedica una meticolosa analisi alla storia e all’attività del gruppo barese, nell’ambito di una, purtroppo insolita, attenzione ai protagonisti e ai destinatari, che privilegia il versante delle politiche e dell’organizzazione, e non solo quello testuale o registico. Eccellente quanto raro segnale in proposito (mi piace rilevarlo qui, in questo frangente e in apertura) è Il pubblico del teatro in Italia, curato da Fabiana Sciarelli e Walter Tortorella (Napoli, Electa Napoli, 2004). Il volume sul CUT reca tracce anche della vicenda che, in questo caso “attraverso il Teatro Club”, più direttamente ha riguardato la nostra città, lungo un breve ma intenso quinquennio, dal 1965 al 1970. Sarebbe, perciò, questo, tempo di anniversari, o di bilanci, e di bilanci? E quale tempo non lo è? Si può sfuggire agli anniversari? Sono più insopportabili, insostenibili i fatti o la loro memoria? I processi o le celebrazioni? Domande elise (eluse?), in questo caso, dalla coincidenza e dal collegamento; che non sono una forzatura, perché l’una e l’altra sono nei fatti, prima ancora che nelle date, nei tempi. E un fatto sono anche le persone, i soggetti coinvolti. Ed è per questo che ho scelto di non ignorare il sovrapporsi di date e di memorie, al di là delle differenze, soprattutto di scala, tra le vicende e gli oggetti di cui ho deciso di occuparmi. E proverò a farlo percorrendo una linea di confine, per di più né retta, né continua; e in modo, perciò, vagamente rapsodico, come si conviene a chi si affida ai ritmi fluttuanti e ondivaghi della memoria; e quasi esclusivamente a quelli. Non ho, perciò, consultato documenti, atti; solo qualche pagina tratta da libri che mi assediano da sempre (piacevolmente, perché in versi) o che mi hanno incuriosito di recente o che contengono qualche precedente riflessione (mia e no) sugli oggetti di questa nota. Una scelta che, per di più, mi consente di dedicare queste pagine esclusivamente agli anni della mia presenza in biblioteca - dal 1970 al 1994 -, salvo qualche irruzione nell’immediato passato e nel contesto generale di oggi. 2. Il “personale”, se non “politico”, può essere almeno “pubblico”? Lo avevo promesso, proprio dalle pagine di questa rivista: prima o poi avrei tracciato un bilancio della mia esperienza, dei miei cinque lustri all’interno della Biblioteca, o meglio, più in generale, dell’itinerario attraverso le biblioteche, l’Associazione, il Consiglio Nazionale dei Beni Culturali. È passato del tempo da quell’impegno. Sono qui per dire quel che ho da dire, ma non sarà quel che avevo in mente allora, quello che sarebbe forse giusto dire fare e aspettarsi. Ma, tant’è: “Durano sì certe amorose intese/quanto una vita e più./Io so un amore che ha durato un mese,/e vero amore fu”. (Saba) Certe altre, viceversa, coltivati magari per venticinque anni, finiscono, deperiscono. E non si ha più, mai più voglia di parlarne, qualunque cosa si dica o si sappia in materia di “elaborazione del lutto”. Oppure, se si decide di parlarne, si sceglie di farlo con modalità affatto particolari, che spesso riescono a dissimulare rimpianti, nostalgia, recriminazioni; ma rischiano di portarsi via perfino l’interesse 16 Guido Pensato per l’oggetto in sé, ammesso che e per quanto distante e astratto sia diventato. In questo senso, le pagine che seguono sono il mio modo di tenere fede a quell’impegno. E le modalità, i toni, la forma, i temi possono apparire insoliti, irregolarmente assemblati: sono, in ogni caso, gli unici di cui dispongo, che sono disposto a impiegare. Ma, al di là del chiedersi se sia legittimo provare a ricavare analisi partendo dal vissuto personale, da quello che residua, a questo livello di coscienza e di elaborazione psicologica e intellettuale, di vicende che hanno avuto un versante pubblico; al là di questo, non è affatto detto che siano, oltre che apparentemente arbitrari, anche inutilizzabili, inservibili le modalità e i toni evocati e scelti. È stato detto autorevolmente - e proprio in occasione di un precedente decennale che la storia delle istituzioni culturali è fatta anche di quella degli uomini che vi operano e delle loro vicende. Vanno, tuttavia, messi in conto, nelle ricostruzioni che, come in questo caso, da esse non prescindono, almeno sotto forma degli umori e “rumori di fondo” che conservano, non possono escludersi - ma corro l’alea - un po’ di rischi: da quello di offrire queste pagine come “reperto” e “sintomo”, a quelli di parzialità e miopia analitica, di una più o meno consapevole (e già ipotizzata) riluttanza ad analizzare quella che si è configurata come passione forte e delusa (ma è davvero completamente così? Non è, in fondo, diventata ancora più forte, perché riportata sul terreno della pura astrazione e costruzione intellettuale?); e, infine, quello di una sorta di cortina fumogena di parole, di sensazioni sollevata a coprire una sostanziale reticenza, un più o meno esplicito rifiuto. Ancora più comprensibile, perciò, sarà la disparità di trattamento riservata ad una vicenda piuttosto che ad un’altra, ad un settore della biblioteca rispetto ad altri, in un intervento, che è una ricostruzione (professionale, psicologica, culturale, emotiva) personale e soggettiva. La forma che emerge da queste pagine, il loro configurarsi non come un bilancio, ma solo come un repertorio di brandelli, di lacerti recuperati dalla memoria (anche in momenti in cui essa sembra assumere i caratteri di una nuova conoscenza e dell’esperienza ed abilitare, perciò, a tentativi di analisi), assegna un rilievo primario a quella individuale, per un deficit di memoria istituzionale collettiva pubblica, che normalmente rinvia a un presupposto di coscienza civile diffusa, che è lontano dall’essere patrimonio condiviso nella storia non solo recente delle nostre comunità; al di là di retoriche enunciazioni in nome di altrettanto sbandierati e improbabili problemi di identità, vista la confusione e l’approssimazione dei contesti evocati e delle finalità dichiarate e sottese. Eppure quello della memoria, anche di quella individuale, personale, all’interno delle istituzioni, soprattutto di quelle che della memoria si occupano, è un dovere, non solo formale ma sostanziale, “civico” e professionale, che dovrebbe assumere forme specifiche, al di là di quelle costituite dagli atti e dalla documentazione strettamente burocratico-amministrativa o della diaristica più o meno esplicitamente autocelebrativa. E spesso così non è stato, anche nel mio caso e in quello della storia della nostra biblioteca. Lungo il mio percorso professionale ho prodotto una discreta quantità di pagine, ufficiali e no, di relazioni, progetti, proposte, programmi, atti; mai, tuttavia, 17 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città quelle pagine hanno assunto il carattere di bilancio, di “formale consegna” amministrativa e culturale, nemmeno quando, conclusa l’esperienza della direzione della “Provinciale”, passai il testimone al mio successore; cosa che, d’altro canto, si era verificata pari pari in occasione della cessazione dall’incarico da parte del mio predecessore e si sarebbe ripetuta nei confronti dell’attuale direttore. Inconsapevole, reiterata trascuratezza? O sintomo esplicito ed esplicitamente esibito di un’ansia di distacco, di presa di distanza? È forse anche per questo e per altri dubbi che serpeggiano lungo il percorso che sto compiendo (- occorre dirlo? - in tranquillità e addirittura, talora, in allegra creatività), che mi spingo, sento di dovermi spingere a mettere in campo non solo un punto di vista soggettivo, ma soprattutto la riconduzione del tutto a questa sfera; quella che, molto probabilmente, mi ha consentito di praticare costantemente una sorta di parziale clandestinità non enunciata, se non nella sua parte più esterna, leggibile; la ricerca spasmodica di una via di fuga, di una sfera pubblico-privata, a metà strada tra il pubblico e il privato, per l’esercizio di una irregolarità impossibile, di una trasgressione vitale, di un livello di conciliazione improbabile tra antiistituzionale e creativo, tra pragmatismo d’obbligo e utopia, di una pratica esibizionistica e narcisistica insopprimibile e, se possibile, non azzardata. E infine, a rischio di enfatizzare il versante delle colpe, come ignorare un dubbio “conclusivo”: che la scelta di lasciare a cinquant’anni la direzione della Biblioteca - continuando a coltivare gli stessi convincimenti di fondo, gli stessi interessi e gli stessi impegni, intrecciandoli, come era già stato in passato, ma da privato cittadino ormai, “con le mani libere”, accanto ad altri, contigui o lontani - sia stato il frutto e la conferma di una sopraggiunta, ormai radicale, estraneità al compito: per colpa di una natura di onnivoro vorace, di famelico consumatore di esperienze e del precoce (ben più di quanto gli esiti del percorso e della decisione finale facciano intendere) deperimento di quella che è stata certamente la più duratura, la più professionalizzata e istituzionalizzata. 3. “Quegli anni”: la Città, il Teatro Club, la Biblioteca /1 Negli anni ’60 Foggia vive ancora una fase acuta delle vicende postbelliche e della ricostruzione di un tessuto abitativo e civile sconvolto; vicende che vengono arricchite e complicate dai fenomeni di un inurbamento innescato dalla crisi e dallo spopolamento delle campagne e delle aree interne del Gargano e dell’Appennino. Ma l’emergenza sembra finita. A quelli che si configurano ormai come dati strutturali della società locale: l’ “economia del mattone”, le pratiche dell’assistenzialismo e del “clientelismo a mezzo ente pubblico”, assurte, rispettivamente, a cultura imprenditoriale e modelli sociali diffusi, sembrano affiancarsi idee e bisogni nuovi, sul fronte delle domande e su quello delle risposte. Si intravedono i primi esiti - soprattutto in termini di psicologia e di progettualità individuale e collettiva - di una ripresa, di uno sviluppo in atto, che, peraltro, riguarda tutto il paese. Sul versante 18 Guido Pensato culturale la guerra aveva consegnato ai foggiani una città che a lungo era stata e ancora sarebbe stata quasi un deserto: un Teatro Comunale ridotto a “pidocchietto”, perché progressivamente trasformato in un equivoco locale di quart’ordine, dopo aver tentato di essere nell’Ottocento il labile segnacolo delle aspirazioni e della voglia di “autorappresentazione” di altrettanto precariamente emergenti ceti dirigenti cittadini e dopo aver tenuto a battesimo, all’inizio del XX secolo, il “cinematografo” a Foggia (Cristina Zagaria, Società e cinema in Capitanata, Foggia, Diomede, 2002); una Biblioteca Provinciale (la sola biblioteca pubblica della città) alle prese con i problemi (ma anche con le opportunità) della ricostruzione; un Museo di fatto inesistente, un Liceo Musicale e un Palazzetto dell’Arte che faticano a far emergere una consuetudine accettabile - e soprattutto orientata al nuovo - con le pratiche e le produzioni di propria rispettiva competenza. Poco altro: locali cinematografici e librerie relegati - come promotori e destinatari insieme - in un circolo vizioso domanda/offerta e qualità/consumo che annunciava ben altri ritardi e “perversioni” tipiche dell’industria culturale di massa; una “Società Dauna di Cultura”, alle prese - ma siamo già qualche anno più avanti - con le tematiche tradizionali della storia locale; i partiti, i sindacati, le organizzazioni cattoliche, che, sia pure in un clima di contrapposizione e di scontro ideologico, garantiscono finalmente i meccanismi della partecipazione, della crescita individuale e collettiva, la dimensione pubblica, politica della vita cittadina. È proprio nei primi anni ’60 che Foggia (in asse con Bari e con l’egemonia “morotea” nella politica pugliese) diviene laboratorio, se non dell’innovazione, certamente di un’idea di modernità e di sviluppo che, pur continuando a pagare un tributo pesante in termini di costruzioni e distruzioni, in eguale misura devastanti, non si limita al miraggio consumistico e non esclude dal proprio orizzonte la scuola, la formazione, la cultura, l’arte. Si mette mano ai lavori di restauro e riorganizzazione del Museo Civico e del Teatro “Giordano”, recuperato alla gestione pubblica, ma emblematicamente contrassegnata, questa, dalla “cancellazione” del grande dipinto del soffitto. La Biblioteca si accinge a divenire uno dei poli di sperimentazione del primo programma organico di diffusione della lettura nel nostro paese. Si avvia un contraddittorio dibattito (durerà vent’anni!) intorno a un’università dauna. Ce n’è abbastanza, in fin dei conti, per suscitare attenzioni diverse, nuove energie, per instaurare un circuito positivo e vivace. Anche tra i giovani. È in questo contesto e in questo clima che si costituisce il Teatro Club Foggia. I poli della sua azione vengono individuati rapidamente: la riapertura del Teatro Comunale - che rappresenta addirittura il “pretesto” per la sua nascita - e il dibattito sul “teatro pubblico”, che, dal “Piccolo” di Milano e da oltre un decennio ormai, coinvolge tutta la cultura italiana. Come era inevitabile in una realtà di inesistente associazionismo culturale “engagé”, “militante” - ché questo si avviò rapidamente ad essere il gruppo - la sfera di intervento si ampliò rapidamente e finì con il coincidere con tutto il sistema (che sistema non era ancora e non è tuttora) di quello che oggi chiameremmo “dell’organizzazione delle strutture e dei servizi culturali”, ma che allora non si riusciva se non ad intravedere come percorso e obiettivo. Le attivi19 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città tà si estesero, nell’arco di cinque anni, a tutto campo: dalla stampa (nessuna nostalgia per lo “sporco” e frustrante ciclostile!) di un bollettino di informazioni e discussione, alle battaglie per un cartellone e una gestione non colonialistica del “Giordano” da parte dell’Ente Teatrale Italiano (ETI) e per l’apertura festiva (tuttora una chimera) del Palazzetto dell’Arte e a quella, insieme al Cut Bari e ad altri organismi spontanei, per un teatro pubblico in Puglia; dai gruppi di studio su autori italiani e stranieri, alla produzione di spettacoli di “teatro politico” (quasi a ridosso dell’uscita del libro, si realizzò qui la prima messa in scena italiana di Lettera a una professoressa di don Milani e della Scuola di Barbiana), alle iniziative messe in campo in occasione dell’alluvione di Firenze, contro le dittature di Franco in Spagna e dei colonnelli in Grecia, contro la guerra del Vietnam e contro l’invasione della Cecoslovacchia, alla attiva solidarietà nei confronti del “movimento per il metano” del Subappennino Dauno. Per un quinquennio, un gruppo partito da uno specifico settore della vita culturale cittadina, da un’emergenza positiva, coglieva la centralità del tema generale della cultura, in una fase cruciale della transizione della città dai problemi e dal clima dominante il lungo dopoguerra a quelli di una società sulla strada della modernizzazione, di nuovi bisogni, di nuove domande, di crescenti spazi chiesti e offerti alla e dalla circolazione delle idee, del sapere, delle conoscenze, dell’arte. Questa capacità venne “riconosciuta” e divenne il terreno di incontro con le forze più avanzate della città e con i pochi operatori impegnati all’interno delle istituzioni e dell’organizzazione culturale e in grado di rivelarsi all’altezza dei compiti nuovi che quella fase richiedeva, di assumere un ruolo decisivo, da protagonisti, di quel momento. In primo piano vennero le convergenze con i gruppi di ispirazione cattolica (ampiamente maggioritari ed egemoni), impegnati in particolare, oltre che in un vivace dibattito interno ma aperto, anche sul versante della cultura cinematografica (è a partire da qui che si dischiuse pubblicamente la straordinaria e dialogante militanza civile e culturale di Peppino Normanno, la cui “assenza” si fa fatica, fatico tuttora ad accettare) e con i quali, di fatto, si individuava un’area comune di scambio e di elaborazione critica. Si trattava di un’esperienza del tutto nuova, extrapolitica, ma non separata o “a parte”; al contrario, di forte presa sulla realtà e sull’attualità: “del mondo” e “locale”, ma proprio per questo l’una e l’altra, rispettivamente, non “evasive” e non più semplicemente coincidenti con un hic et nunc angustamente localistico, “risorgimentale” e “patrio”. Il clima di fervore innovativo che si respirava veniva colto e riceveva conferme e segnali di risposta significativi e diversi: dal messaggio vergato e fatto pervenire ai “giovani del Teatro Club” da quello che, allievo di Mario Sansone, sarebbe divenuto docente di letteratura italiana nell’Università di Bari e che, grosso modo, suonava così: “grazie per darci una speranza…”; al numero di iscritti (diverse centinaia), incredibile per un gruppo culturale autonomo, non “affiliato”, che finì col veder rappresentati davvero tutti gli strati della popolazione: dai giovani studenti al mondo della scuola in generale, dagli impiegati ai tanti operatori, cultori e appassionati di teatro, di cinema, di arte, di musica; ad 20 Guido Pensato una, anche questa eccezionale, insolitamente forte presenza di donne. Insomma, come suggerisce il titolo già citato, sembra di poter dire che intorno al Teatro Club e “attraverso il teatro”, tematiche, persone e protagonisti sensibili e attenti ai contenuti e al ruolo della cultura e delle arti in una società in trasformazione si raccolsero intelligenze, energie, idee, azioni e si imposero come oggetti e soggetti di interesse generale. Era il versante attivo, partecipato, protagonista di una società di massa ormai in fase di strutturazione, anche per quel che riguardava la cultura e il livello locale. Di più: il Teatro Club fu fattore e soggetto attivo di una fase in cui si veniva delineando un proficuo rapporto critico tra istituzioni società e cittadini, fuori dai canali tradizionalmente praticati nell’ambito di una democrazia recente e di una storia sociale e civile fortemente contrassegnata dalla subordinazione, piuttosto che dalla partecipazione. Il gruppo accompagnò e visse nella realtà locale la fase nascente di quella che si sarebbe schematicamente e successivamente definita come “società civile”. Si delineava - e ne erano protagonisti su versanti diversi ma sullo stesso terreno - un circuito in cui individui istituzioni e cittadini organizzati, al di là dei luoghi e dei soggetti deputati - partiti e sindacati -, si proponevano e agivano come articolazioni di una comunità in profonda trasformazione, che viveva, forse come non mai prima, in presa diretta i mutamenti in corso, le idee, le contraddizioni, gli scontri generazionali presenti nel più ampio contesto nazionale e oltre. Una situazione che, come è ovvio, si andò (ma a partire dal Sessantotto), anche qui da noi, arricchendo e complicando con e attraverso la presenza - antiistituzionale, radicale e contestativa - di nuovi strumenti, nuove tematiche e nuovi soggetti organizzati, soprattutto giovanili; e che prenderanno il posto di quelli tradizionali, “forniti” dalla politica e dai livelli istituzionali, per esempio della Chiesa. Dal seno del Teatro Club si leggevano, d’altro canto, i segnali e non solo questi, ma anche le azioni esplicite, che partivano da quei settori della città che resistevano al cambiamento. Dire che questo continuerà ad essere fino ad oggi il tema centrale, la questione sempre aperta, equivale ad evocare una costante generale della dialettica interna ai gruppi sociali e alle comunità locali. Ma mai come in quegli anni ciò risultò visibile, evidente: e non poteva essere diversamente, dato il carattere radicale ed epocale del confronto in atto. Con sempre maggiore consapevolezza, l’azione e i protagonisti di quel gruppo si diressero contro questa parte della città, una parte che manifestava caratteri che oggi si chiamerebbero “trasversali”. Si trattava, infatti, di un establishment stanziato sui due versanti degli schieramenti politici e sociali e che andava dai vecchi e nuovi gruppi di potere che individuavano negli apparati pubblici il luogo privilegiato del loro insediamento strategico, ai gruppi dirigenti pervicacemente “bracciantili” e antiurbani dei partiti della sinistra, che resistevano, nonostante la visione diversa e lucida di alcuni, all’esigenza di “scafonizzare” il movimento politico-sindacale socialista e comunista locale (o quanto meno di renderlo capace di un dialogo più ricco, più diversificato, non monolitico, più aderente ad una realtà in trasformazione verso una complessità tipica dei centri urbani meridionali). Fu, quest’ultima, una visione costantemente minoritaria di fronte a quella, bracciantile appunto, di segno oggettivamente conservatore (rispetto al complessi21 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città vo contesto locale, anche se, viceversa, avanzato e spesso addirittura “esemplare” a livello nazionale, per quel che riguardava lo specifico contrattuale e di categoria), rinsaldata dalla trentennale posizione di forza mantenuta dal Partito Comunista in gran parte dei principali centri della Capitanata e agita, brandita come strumento di pressione sul capoluogo, sui e tra i gruppi dirigenti locali. Si trattava di una situazione che, a distanza di decenni, Enrico Berlinguer denunciò esplicitamente nel corso di un congresso provinciale del PCI (30 gennaio 1983), rilevandone la gravità e la persistenza: Giustamente si è parlato della permanenza nel Partito di una certa chiusura e di una certa scarsità di collegamenti e di iniziative verso tutte queste nuove realtà sociali tali che tengano conto e si avvalgano anche dei positivi sviluppi e mutamenti avvenuti nella coscienza e nelle aspirazioni, in particolare in quelle delle grandi masse femminili e giovanili. Anche nel lavoro del Partito nel capoluogo e nella provincia – e nell’atteggiamento verso la città capoluogo delle nostre organizzazioni insediate nei grossi Comuni - si riverberano, mi pare, queste chiusure e diffidenze. Per cui la vostra Federazione è in una certa misura ancora una costellazione di roccaforti con un carattere un po’ paesano e non una realtà fusa, operante, che riceve forza da questi capisaldi […] e la unisce, la proietta, la diffonde in tutta la provincia e nel capoluogo. (Enrico Berlinguer, Le costellazioni di roccaforti, in «Sudest», Numero Zero, ottobre 2004). A distanza di qualche anno, il crollo verticale di quei capisaldi sanciva il carattere di quello che si configurò e deflagrò, quando venne “pronunciato”, come un (sia pure irrimediabilmente tardivo) vero e proprio allarme. 4. Intermezzo: Una città da amare (o da odiare?) Come si può immaginare e come sa chi in quegli anni visse le vicende che qui provo a riassumere, le tematiche proposte dal Teatro Club e, in particolare, nella seconda parte di quella breve esperienza, tra il 1968 e il 1970, quelle che esploderanno grosso modo in sincrono e in sintonia (fatti salvi i fisiologici ritardi e la diversa scala) con “il movimento” mondiale, trovarono anche nella realtà della Capitanata, soprattutto nel capoluogo, interlocutori, “sponde” attive e reattive, protagonisti diretti, non solo tra i giovani, gli studenti e gli operai, ma perfino in settori del livello istituzionale (addirittura emblematiche e talora paradossali e un po’ parossistiche divennero le “rincorse” e gli scavalcamenti da parte di frange - la “sinistra di base” - della Democrazia Cristiana e del sindaco di allora, puntualmente presente a tutte le iniziative “contro”: i colonnelli greci, la guerra del Vietnam, ecc…). Personalmente inclino a collocare in quegli anni il pendolo del mio rapporto con la città in cui sono nato e vivo. Ma nemmeno in questo caso credo si tratti di una questione semplicemente privata, originale ed esclusiva. E tuttavia, proprio per questo, mi sembra di poter dire che non è un caso che quel tema mi si imponga 22 Guido Pensato nell’ambito di una più estesa riflessione su una fase in cui si costruisce e si struttura, con caratteri di dinamismo e di ambivalenza, quel rapporto; e che, per questo, è soprattutto riflettendo su quella fase della mia vita personale e pubblica che mi appare alternativamente chiaro e oscuro cosa si intenda per amare/odiare una città. In effetti cosa si ama, cosa si odia di una città? A cosa penso quando penso alla città, a questa città? Certo immediatamente alla sua fisicità, che, non potendo riferirsi a caratteri strettamente geografici, evoca il costruito, la stratificazione visibile (quando è visibile) attraverso il costruito. Ma il costruito è quello architettonico, edilizio (l’urbanistico è qui un risultato ottenuto per pura e brutale addizione/sottrazione/ giustapposizione); ma è anche lo storico, il comunitario, il sociale; e infine, il mentale, psicologico, emotivo, frutto di volontà di identificazione o avversione, in relazione o contrapposizione con un’idea, un’astrazione che si deposita in un nome, ma che si compone di pezzi concreti, di vicende e avvenimenti della cronaca e della storia individuale e collettiva, di eventi e soggetti, protagonisti e vittime. Ma anche di un “colore”, di suoni, di profumi e sapori rintracciati lungo le strade o nei percorsi della memoria, intorno alle tavole imbandite della cucina familiare. E tuttavia, il più delle volte, sono proprio i tratti materiali, visibili e tangibili, della città - edifici, strade, spazi, quartieri - a leggere, raccontare e farsi lente delle vicende e di noi stessi in queste e del tutto in uno spazio fisico. E quei tratti, al di là delle catastrofi e delle distruttive vicende storiche subite, rinviano al progressivo, inesorabile imbruttimento estetico e all’abbrutimento etico e sociale che corrono sul filo dello sviluppo edilizio della cità e convergono simbolicamente (e drammaticamente), tra XX e XXI secolo, nel “crollo di Viale Giotto” del 1999, con i suoi 67 morti; ma anche ad altro, in quanto segni e tracce delle caratteristiche culturali e sociali, politiche ed economiche e del ruolo svolto, nelle diverse epoche della storia, dai ceti e dai gruppi sociali, a cominciare da quelli egemoni. Quando perciò, dico che mi è difficile stabilire se amo la mia città, lamento di fatto di avere a disposizione un guazzabuglio, un coacervo indistinto di dati materiali, culturali e psicologici; e non un gruzzolo, una sequenza di fatti-eventi-processi-documenti-monumenti-figure in grado di assumere il carattere e il ruolo di miti/riti identitari da condividere; capaci, cioè, di essere memoria collettiva, riconosciuta e diffusa e di produrre oggi modelli non mitologici e fasulli, ma concreti, perché culturalmente radicati e agiti. Insomma, un ipotetico, sia pur generoso, mozartiano catalogo di “oggetti amorosi” sarebbe, nel mio caso e rispetto al mio rapporto con la città, ben striminzito; a meno di accontentarsi di dati di fatto preculturali, nel senso di possedere un minimum infinitesimale di razionalità sociale e un massimo di ancestralità psicologica individuale e collettiva, coincidente con il radicamento e con l’identificazione affettiva e sentimentale con i luoghi, le persone e le loro storie. Io credo di aver strutturato il mio rapporto con la città negli anni che sto raccontando, sulla base del conflitto che insorgeva e si disponeva ai miei occhi sulla coppia, apparentemente primordiale anch’essa, razionale-emotiva: “amore/odio”, nel tempo rafforzata dall’altra: “stare/andare”. E ciò avvenne in quegli anni perché fu allora che Foggia si fece fondale, scenario in cui si rappresentavano (e mi si svelavano con evidenza) le contraddizio23 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città ni, i ritardi culturali, le arretratezze sociali ed economiche dei gruppi dirigenti, delle istituzioni e degli apparati pubblici, della società locale nel suo complesso. Nei tratti fisici ho cominciato a vedere rispecchiato tutto questo: in quelli involontari e subiti dei bombardamenti e delle distruzioni belliche; in quelli voluti e scelti - sia pure “in stato di necessità” - della ricostruzione postbellica e delle distruzioni ulteriori collegate alle fasi successive di “ammodernamento” e di espansione; gli uni e gli altri frutto di una (in)cultura del vivere associato e della incapacità di coniugare la percezione primaria e il soddisfacimento di bisogni individuali e privati con una salda e non antagonistica percezione-assimilazione della dimensione collettiva e pubblica. Se, in conclusione, non esistono luoghi senza passato e senza storia e se il passato e la storia non sono “buoni” o “cattivi”, possono essere, tuttavia, tali da sedimentarsi in segni e tratti più o meno significativi ed esemplari, da far assumere a questa o quella città perfino i caratteri e il ruolo di metafora esistenziale, culturale e sociale, individuale e collettiva. Vi sono città che, afflitte da un deficit di immagine e di riconoscibilità grave, relegano i cittadini in una sorta di indigenza e finzione identitaria collettiva o di solipsismo relazionale, in grado di generare un pulviscolo di metafore ad uso e consumo degli individui, che si rivela non liberatorio, non creativo. Anche le città caratterizzate, viceversa, da una sorta di “opulenza identitaria”, producono una mole infinita di metafore: ma queste sono capaci di generare idee, energie, modelli collettivi, creatività. Niente di nuovo, evidentemente, e di straordinario, se non che tutto ciò avveniva in quegli anni, nei quali, contemporaneamente e tutto intorno, si realizzavano trasformazioni, contrasti e rivolgimenti ben più profondi e radicali, che sollecitavano e inducevano novità e cambiamenti anche nelle “periferie” e nello stesso tempo acuivano localmente (nelle angustie sociali e culturali - prossemiche? - date) le contraddizioni e gli esiti “conservativi”, depositandoli nelle coscienze e amplificandone la portata e la risonanza a livello individuale e “a futura memoria”, come vizio, male “oscuro” e inconsapevole, come intransigente inappagamento. 5. “Quegli anni”: la Città, il Teatro Club, la Biblioteca /2 Rispetto alle tematiche culturali e agli anni cui si riferiscono queste pagine, il punto meno appariscente ma certamente più rilevante di quello che si configurò come un convergere di pochi e diversi soggetti intorno a obiettivi e modalità di intervento comuni fu rappresentato dalle iniziative della Biblioteca Provinciale e del suo direttore, Angelo Celuzza. Fin dalla costituzione (la fase più “collaborativa” e istituzionalizzata, precedente quella contestativa e radicalizzata, sul piano culturale e su quello politico), il Teatro Club si impegnò sul versante della diffusione della conoscenza delle opere e degli autori collegati all’attività del rinato Teatro Comunale e a quella dell’attualità culturale in genere; e lo fece con atteggiamento non paludato, ma concreto e “di servizio”, producendo schede e articoli, frutto del lavoro di appositi gruppi di studio e di singoli soci. La risposta della 24 Guido Pensato biblioteca, che era diventata il luogo “naturale” di questa attività, fu immediata, contestuale: Mario Taronna, vecchio bibliotecario, giornalista, conoscitore e studioso della canzone e dello spettacolo napoletano e meridionale, fu applicato a compilare un catalogo speciale su schede dedicato al teatro, che comprendeva anche gli spogli delle riviste specializzate di settore. Quel catalogo fu uno strumento prezioso di conoscenza e di valorizzazione di una parte del patrimonio della biblioteca a disposizione di appassionati, operatori, ricercatori. Esso è ancora oggi un documento, non solo della storia recente della biblioteca, ma della fase iniziale di una nuova e più ampia storia, di una vicenda che non ha conclusione, perché allude alla vita stessa delle istituzioni culturali, alla loro specifica “missione”, perché le riguarda e le simboleggia. Mi riferisco al processo permanente e alle modalità corrette attraverso cui esse, interagendo con la società locale e la comunità degli utenti - reali e potenziali, individuali e collettivi, spontanei e organizzati -, mettono continuamente in gioco e in discussione struttura, funzioni, procedure, servizi e si propongono come “osservatorio pubblico permanente delle dinamiche culturali in atto”; laddove “culturali” ha un’accezione antropologica e sociologica amplissima e “osservatorio” è inteso come strumento di analisi e di conoscenza finalizzato alla produzione di risposte adeguate a domande e bisogni informativi, documentari, conoscitivi e culturali correttamente e precisamente individuati e riconosciuti. Il flusso di azioni, iniziative, interventi tra Biblioteca Provinciale e Teatro Club passava, come ovvio, attraverso persone fisiche concrete e finì con il coinvolgerle personalmente nelle vicende dell’uno e dell’altra, anzi, più precisamente, dall’uno all’altra. Al termine del quinquennio di vita del gruppo (non è senza significato che esso comprenda anni come il 1968 – “maggio francese” e “movimento studentesco” - e 1969 – “autunno caldo” - ), molti dei protagonisti furono attratti in quella che non fu mai, tuttavia, una banale deriva, ma una precisa scelta, un esito e un impegno politico diretto e consapevolmente perseguito. Tutti avevano comunque maturato una acuta e moderna sensibilità per la rilevanza “civile” e politica delle tematiche culturali, una sensibilità e una capacità perspicue di sguardo nei confronti della produzione, dei linguaggi e dei contenuti specifici e settoriali della cultura e delle arti. Sensibilità e capacità che diventarono “requisiti” e non passarono inosservati agli occhi di chi seppe guardare e vedere e furono valutati come una risorsa spendibile, da investire nei programmi in atto per l’ammodernamento delle strutture culturali cittadine. Il che avveniva sulla base di una concezione, tacitamente e largamente condivisa, della cultura e del suo ruolo, avvertiti come di fatto collocati agli antipodi rispetto a una pratica ancillare di essa nei confronti del potere e a una consuetudine di reciproca contiguità, subalternità: pratica e consuetudine ben note, oggi non meno di ieri e dell’altro ieri. Era questo il segnale forte di una sintonia che accomunava soggetti diversi, ma, sarebbe giusto aggiungere: che e perché era nei fatti, nelle nuove esigenze di una realtà in crescita, di nuovi protagonisti della scena, non solo locale. In tale contesto la Biblioteca Provinciale, nel quadro del programma mini25 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città steriale di istituzione e diffusione, prima sperimentale e attraverso progetti pilota la Capitanata era tra questi -, quindi ordinario, della lettura e dei “sistemi bibliotecari”, aveva promosso la nascita di biblioteche comunali in gran parte dei centri del Tavoliere, del Gargano e del Subappennino. A seguito di quello che era il primo concreto manifestarsi e attuarsi di una funzione territoriale ampia e tendenzialmente coincidente con le competenze istituzionali dell’ente di appartenenza, la “Provinciale”, in quanto “centro-rete” del sistema, si accingeva a disporre di una nuova moderna sede: stava per divenire concreta la prospettiva proposta fin dagli inizi degli anni ‘60. Si trattò di un processo a tappe insolitamente accelerate, che prevedeva, tra l’altro, il reclutamento e l’impiego di un gran numero di nuovi addetti, a diversi livelli di competenze e di funzioni. Si mise in moto un meccanismo, direi bidirezionale: la biblioteca (nelle persone che ne avevano la responsabilità, rispettivamente, culturale e politica) “scoprì” e “riconobbe” nei giovani impegnati nel Teatro Club, prima degli interlocutori e dei destinatari delle sue attività, delle iniziative e dei programmi, quindi dei possibili collaboratori diretti, dei protagonisti delle stesse. Lo fece con una modalità singolare, svelandosi cioè, non come il luogo in cui “abitano”, “si trovano” e “si leggono” i libri, ma come istituzione culturale viva, in cui si producono occasioni culturali e servizi per la cultura; in cui, insomma, “persone” fanno tutto questo “lavorando”. Una sorta di rivelazione, appunto: tra l’altro, tuttora non ancora compiutamente avvenuta, sia sul versante degli operatori, che su quello dei cittadini, in un paese come il nostro, solo di recente conquistato ad una cultura e ad una pratica bibliotecaria moderne. Quelle, intendo, quanto meno legate al concetto di public library, di biblioteca come servizio pubblico, certamente non in contraddizione con quelli di biblioteca come sistema culturale complesso e come parte di un sistema complesso: osservazione utile, io credo, a definire anche i limiti delle accuse di tecnicismo, empirismo ed ipocrita “neutralismo”, che allora venivano mosse, “da sinistra”, a quel concetto, soprattutto quando e se se ne enfatizzavano, isolandoli e promuovendoli a feticci, paranoie e solipsismi i più disparati, gli aspetti tecnico-catalografici. Il maieutico itinerario di disvelamento delle biblioteche come realtà e opportunità “lavorative” cui ho fatto cenno, si svolse anche attraverso tappe dirette quanto esplicite, come quella che mi coinvolse in prima persona. Fui invitato a partecipare, su suggerimento di Angelo Celuzza e in qualità di laureando (ma anche perché, ne sono certo, impegnato in un gruppo come il Teatro Club e perciò visibile e credibile rappresentante dei giovani cui l’iniziativa era diretta), a una tavola rotonda sulla “fuga dei cervelli” e sul conseguente impoverimento del Mezzogiorno: argomento, come ognuno può vedere, mai sopito, mai vecchio, oltre che costantemente, inutilmente premonitore e ammonitorio. Armato di dati e rapporti del Banco di Napoli, sostenni la inaccettabilità del “ricatto morale” insito nell’equazione “abbandono del Sud uguale tradimento”. Ma ero, nell’ultimo degli anni ’60, sulla strada del tradimento… della tesi lì con convinzione difesa. Agli inizi del 1970 ero il vicedirettore della Biblioteca Provinciale di Foggia. Il concorso era stato bandito nell’estate precedente. Sostenni le prove dopo qualche mese, 26 Guido Pensato di fronte a una commissione non “presieduta”, ma “affascinata” da uno straordinario e vitalissimo Mario Sansone. Era successo. Lavoravo in un luogo che frequentavo, da lettore, da oltre un decennio, dai tempi del ginnasio (lo conoscevo da tempo, avendo frequentato le medie nella vecchia “De Sanctis”, ospitato in Palazzo Dogana fino alla costruzione della nuova sede) e nel quale avevo maturato e visto crescere in concreto - ma per pochissimi - l’idea del ruolo della cultura e delle sue istituzioni per la città e per i cittadini. La mia scrivania era collocata in una sala della storica sede di Piazza XX Settembre, con una grande finestra sul Vico Palazzo, tra gli scaffali e i libri della sezione locale. Ma la “scoperta” delle biblioteche coinvolse altri, ormai “ex”, del Teatro Club. Nel giro di qualche mese, uno divenne bibliotecario dell’ “Universitaria” di Pisa e, di lì a qualche anno, due approdarono nelle biblioteche dei Centri Servizi Culturali del Formez e quattro ancora nella Biblioteca Provinciale di Foggia. È indubbio che queste non erano più solo vicende personali; che l’appeal delle biblioteche, uscite finalmente da una sorta di clandestinità, da una storica, secolare marginalità sociale e culturale, cominciò a diventare visibile e consistente in quegli anni, anche qui da noi. I progetti che nascevano intorno alla “Provinciale” la facevano crescere e rientrare anche nella progettualità di chi provava a immaginare un futuro nella propria terra e un lavoro non privo di suggestioni, di fascino: “lavorare tra i libri, con i libri!”, ma anche di incognite: “in cosa mai consisterà un lavoro di biblioteca?”; un lavoro da inventare forse, e proprio per questo, in grado di sollecitare le aspettative di chi aveva scelto (magari con qualche concessione a un’enfasi ideologica tipica di quegli anni) e aveva avuto la ventura di fare esperienza di sé e del rapporto con gli altri e con la realtà, attraverso e sul terreno della cultura. 6. Coincidenze, convergenze? /1 Bastano gli elementi fin qui disposti alla rinfusa a spiegare e giustificare, anche partendo da un’ottica soggettiva e personale, la scelta di proporre all’attenzione del lettore di queste pagine una riflessione in parallelo tra le vicende di un’istituzione con centosettant’anni di storia - per quanto travagliatissima fino agli anni ’60 del ’900 - e quelle di una sorta di meteora velocissima - per quanto “densa”, “scabra” e irrequieta - del panorama culturale cittadino? E ancora: dice qualcosa il “passaggio” di un gruppo del Teatro Club alle biblioteche, alla Biblioteca Provinciale di Foggia? Ma, più in generale, la coincidenza giustifica che venga anche segnalata? Al di là di una semplice percezione personale, c’era qualcosa, un terreno comune che rendeva, magari accidentalmente, vicini, contigui due soggetti così diversi e “inconfrontabili”: l’uno istituzionale e l’altro “spontaneo”, l’uno “storico” e con una storia da scrivere, l’altro “effimero”, destinato a bruciare in una breve stagione la propria esperienza? Ovviamente, credo di sì. A partire dal contesto geografico e sociale, economico politico e istituzionale: ma è scontato. E il dato temporale, quegli anni e il clima di quegli anni: ma è generico. Cosa 27 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città era quel clima, qui e allora? Era certamente l’insofferenza verso il vecchio, la voglia, il bisogno di nuovo, l’urgenza di superare il localismo; una visione condivisa della cultura, delle istituzioni culturali pubbliche, che uscivano allora e qui da una cronica marginalità, inutilità; una forte carica progettuale, inventiva. Questo terreno era stato scelto ed era iscritto nella genesi, nel patrimonio genetico del Teatro Club, gruppo “nato per questo”. Ma era una opzione culturale altrettanto radicale, di svolta, al di là della percezione di “eccezionale normalità” che se ne aveva, per la Biblioteca Provinciale e per Angelo Celuzza, l’uno e l’altra terminali quasi di un processo di ammodernamento, di radicale trasformazione di istituzioni ridotte, soprattutto al Sud (ma c’era mai stata qui una storia diversa?), a un’esistenza poco meno che simbolica e autoreferenziale, o fortemente, radicalmente élitarie e classiste (si intende ancora il senso di questa parola?). L’ancoraggio forte di quel progetto era rappresentato da un modello consolidato - la public library - misurato (sia pure parzialmente e con esiti più o meno positivi, come apparirà chiaro, io credo e a ben guardare, negli anni successivi), sulla concreta situazione italiana e meridionale. Ma c’era dell’altro, di segno opposto e ben oltre la dimensione locale: le biblioteche erano destinate all’estinzione, a sentire chi in quegli stessi anni questo vaticinava, sul versante di una fatale ineludibile palingenesi “macluhaniana” dell’universo informativo e culturale: la paperless society, una comunità planetaria “senza carta, senza libri, senza biblioteche”. Il che mostra quanto la scommessa allora messa in campo in Capitanata, fosse (o comunque apparisse e con fondamento) straordinariamente vincente; anche a distanza di tempo e visti, di contro, gli esiti complessivi e, lo si può dire oggi, finali di quel sinistro vaticinio, peraltro, occorre dirlo, sbrigativamente e catastroficamente semplificato e volgarizzato. A quei lontani anni risale certamente la mia speciale avversione per le retoriche intorno al libro, alla lettura e alle biblioteche: quelle di segno positivo, fondate su supponenti affermazioni tautologiche (ideologiche e antimoderne), circa la “superiorità” del libro; e quelle in negativo, costruite sull’annuncio della sua estinzione, al di fuori di una reale, concreta e “umile” (alla Escarpit, per intenderci) conoscenza dei meccanismi di funzionamento e delle motivazioni all’uso della straordinaria, complessa “macchina da leggere” e “del leggere” (anche queste ugualmente ideologiche, in quanto moderniste). A ben guardare, entrambe le posizioni mi sono sempre apparse prodotto di un più o meno consapevole pregiudizio elitaristico, di una più o meno intenzionale e cinica volontà di difesa di quello che viene, infine, percepito e gestito come un privilegio e un bene, un’opportunità “non per tutti, non da tutti”. Fu per questo che il catalogo speciale dedicato al teatro, cui si è fatto cenno, mi sembrò un segnale chiaro, era la esposizione lineare di un’idea, che non ho smesso di condividere, circa il ruolo delle biblioteche: istituzioni culturali pub28 Guido Pensato bliche di carattere primario, poste cioè a fondamento e a base della ricerca, dell’accesso e della pratica della cultura; non insomma ornamenti e decoro feticistico e superfluo di un’autoesaltazione civica e nazionale. Un ruolo che si traduce, viceversa, in funzioni specifiche, quale quella di garantire la raccolta, la conservazione e la circolazione delle informazioni, dei dati e delle conoscenze e che prescinde dalla natura dei supporti, perché dinamicamente, “evolutivamente” ne presuppone e ne prevede lo sviluppo, la trasformazione, anche radicale. È questo lo specifico modo di fare cultura delle biblioteche, è questa la cultura delle biblioteche: garantire le condizioni - dal punto di vista delle risorse materiali e professionali, delle procedure di descrizione, di organizzazione, di gestione, di accesso e di servizio - perché individui, gruppi organizzati e comunità nel loro articolato complesso, esercitino i propri diritti all’autoformazione, alla ricerca, al libero e consapevole impiego del tempo libero, alla libera espressione delle proprie capacità e della propria creatività: perché per strade liberamente e consapevolmente scelte, “usino” e producano cultura. È di questi giorni l’ennesima, come sempre e, verrebbe da dire, vanamente e sterilmente allarmata - visti i rimedi proposti e i risultati solitamente conseguiti - indagine sulla lettura, curata dall’Associazione Italiana Editori (Aie). Un’associazione che oggi rappresenta un settore dell’industria culturale, che per numerosi decenni - di fatto dall’Unità al Fascismo fino agli anni ’70 -, o ha ignorato le biblioteche, o le ha brutalmente strumentalizzate: si pensi all’Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche e alle leggi delle Regioni (soprattutto meridionali) sull’editoria: veri e propri strumenti di indiscriminato assistenzialismo e di “smaltimento dei rifiuti” del mercato, delle giacenze -; o le ha addirittura avversate, perché avvertite come concorrenziali (come si vede, niente di nuovo nelle “moderne” battaglie sulle fotocopie e sul prestito librario a pagamento, condotte anche con “ispezioni” nelle biblioteche). È indubbio che queste ricorrenti analisi dello stato delle cose sono ben lontane dal confermare le previsioni catastrofiche di qualche decennio fa, ma, semmai, il già noto: che, per esempio, i paesi tradizionalmente “forti lettori” continuano ad esserlo, così come i deboli - e tra questi, cronicamente, il Bel Paese (dove, tuttavia, è bene ricordarlo, la pratica della lettura, in un secolo o poco più, ha bruciato tappe inimmaginabili quando la percentuale degli analfabeti superava l’80%) - restano deboli, per un intreccio, nel nostro caso, di fattori strutturali: storici, politici - di (mancata e tuttora mancante) politica di settore - e culturali, che nulla hanno a che fare con i temi e i problemi posti dai “media elettrici ed elettronici”, che sembrano aggravare sì la nostra situazione, ma proprio per la compresenza di quelli. A ben guardare, a livello planetario (e quindi anche qui da noi), viceversa, non si sono mai stampati tanti titoli, testate e copie, quanti nell’era di Internet. Anche su e per Internet, argomento e strumento, nascono nuovi lettori abituali, più o meno settoriali. Proprio gli utilizzatori della “rete” diventano lettori o più forti lettori di libri (e periodici). Quelli deboli hanno qualche chance di rafforzarsi (anche se sono l’anello a rischio nella catena); gli abituali tendono a diventare forti e questi fortissimi. Il che 29 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città conferma un altro dato, noto e inoppugnabile, circa lo stato delle cose, sia nei paesi “avanzati” che in quelli afflitti da ritardi gravissimi sul piano economico e sociale, se solo si amplia lo spettro dell’analisi a comprendere, oltre che la lettura, le pratiche e i consumi culturali in genere: in linea di massima, gli uni e le altre si rafforzano reciprocamente, così come gli analfabetismi. Basti riflettere su un dato a conferma: negli stessi giorni dell’allarmata denuncia dell’Aie, a Mantova, nell’ambito di “Festivaletterature”, fino a quarantamila lettori paganti hanno frequentato incontri-evento con scrittori di tutto il mondo. Ma, al di là di un dato quantitativo che dice qualcosa e in positivo sul reale stato delle cose, elementi dello stesso tenore, vengono proposti da un clima generale, che, di fronte alle drammatiche pretese semplificatorie della politica dominante, ci racconta un paese, soprattutto giovane, desideroso di capire e ficcare occhi e intelligenza nella complessità del mondo: e lo fa nei libri e attraverso i libri, nelle cento occasioni che, anche le realtà periferiche, offrono e si offrono. Penso ai festival dedicati alla filosofia e alla storia, alle letterature e alla poesia, alle letture poetiche, alle contaminazioni tra cultura scritta, arti visive e sceniche e musica, ai “Presìdi del libro”. Non è, perciò, un piccolo segnale che si confermi e consolidi a Lucera un “Festival della letteratura mediterranea”, così come a Milano si discute partendo dal Teatro del Mediterraneo o che l’Università di Foggia dedichi attenzione, facendosi garante dell’alto livello qualitativo del confronto, alla “poesia neodialettale”. Perché si tratta di un complesso di dati e di eventi che mostrano, anche qui da noi, come non esistano battaglie culturali perse per sempre, né luoghi deputati della lettura, ma che quelli che lo sono istituzionalmente possono concorrere, “uscendo fuori di sé” (dal punto di vista delle rigide partizioni istituzionali e disciplinari), a migliorare il proprio ruolo e a garantire il raggiungimento degli obiettivi della diffusione della lettura e della partecipazione critica. Il che sarà tanto più possibile, soprattutto se si abbandonano intenti e modalità pedanti e “pedagogiche”, se si parte non dai feticci, ma dai soggetti e dagli oggetti vivi, dai libri, dagli autori, dai lettori, dal loro incontro, facendoli uscire da una condizione “muta” e solipsistica, cui non sono fatalmente e ab origine destinati; restituendo un ruolo anche alla parola detta, allo scambio, alla oralità, al calore di un mezzo - la parola appunto “raffreddato” da incrostazioni, mediazioni, lontananze e inaccessibilità ormai storiche, di natura intellettualistica, divistica, commerciale, consumistica, massmediatica. E tuttavia l’accesso alla lettura è tuttora, innegabilmente un privilegio: in troppi luoghi del mondo, non solo del “terzo” o del “quarto”, ma anche del “primo e del “secondo”, dove i proclami sul carattere (peraltro incontestabile, anche se costantemente minacciato) aperto e democratico della “rete” rischiano di assumere funzione democraticistica di copertura nei confronti delle esclusioni ed espulsioni (leggi “analfabetismi di ritorno”, generali e settoriali, in cui piombano troppi diplomati e laureati) dai prodotti, dai canali e dai servizi informativi e culturali più tradizionali e complessi (per struttura profonda e non per “organizzazione esterna e puramente tecnologica”). In ogni caso, al di là della battaglia delle cifre, della contraddittorietà 30 Guido Pensato dei dati forniti da questo o da quel soggetto interessato, resta incontestabile che tutto quello che si riuscirà a fare perché si legga di più non sarà mai troppo e lo si farà, lo si dovrà fare, comunque, anche attraverso e nelle biblioteche. Che si tratti di un imperativo tuttora decisivo per l’Italia lo si ricava dal clima di diffusa incultura che Tullio De Mauro coglie e documenta nel paese e, ancora una volta lucidamente e appassionatamente, ci trasmette dalle pagine del suo libro-intervista (curato da Francesco Erbani) La cultura degli italiani (Bari, Laterza, 2004). 8. Coincidenze, convergenze? /2 All’attuale, più massiccio impegno verso gli altri, deve corrispondere il più vivo ed elaborato contrappeso interno del nostro dibattito, così che abbia valore e significato di arricchimento collettivo di quel che noi “agli altri” diremo, e al tempo stesso, ci trovino meglio sensibilizzati a ricevere - e a rielaborare - gli stimoli e i suggerimenti che “dagli altri” riceveremo. In questo senso, siamo, come del resto sempre abbiamo saputo, una élite che si prepara la fossa. (Chi siamo, in «Bollettino del Teatro Club Foggia», II, (1968), n. 3, gennaio). Sarebbe ben più che una forzatura, forse un segno di delirante presunzione retrodatata, attribuire a queste parole, farne discendere una volontà di “donazione culturale di sé” in favore della città. Certo è che una lucida consapevolezza del carattere transitorio, “suicida” della connotazione d’avanguardia e contestativa del gruppo c’era; come del suo essere fisiologicamente legata al bisogno di radicale trasformazione, di sostituzione degli obiettivi, dei valori, delle finalità, del modo di proporsi della cultura e delle istituzioni, degli intellettuali, degli operatori rispetto al contesto, alla società, ai cittadini, agli utenti (che cominciano ad essere individuati come soggetti e non solo come destinatari di prodotti e servizi graziosamente elargiti, solitamente dalla parte più arroccata e inattingibile degli apparati pubblici: quella insediata, incistata nelle istituzioni culturali tradizionali, non a caso vissute e usate come “sine cura” o cosa propria). Così come diffusa tra i più era la convinzione che il destino di consolidamento e di sviluppo di quelle che apparivano come conquiste, quanto meno ideali, concettuali e di consapevolezza, era affidato alla loro assunzione da parte delle articolazioni rappresentative della società, delle istituzioni culturali e della loro generalizzazione e del loro radicamento nel tessuto della città. In sintesi: mi sembra non arbitrario scorgere nell’azione di quegli anni, della biblioteca e del gruppo, una condivisione non “stipulata”, ma fondata su pratiche concrete e sulla constatazione della inadeguatezza dei tradizionali modelli organizzativi, della ratio stessa, delle finalità poste a giustificare e orientare le scelte della cultura, delle istituzioni culturali, degli operatori. Tutto ciò è oggi evidente, anche se allora poteva risultare non immediatamente leggibile, perché si trattava, come già detto, di soggetti non omologabili, impegnati su percorsi diversi e che sembravano rinviare a visioni apparentemente divaricate, lontane, ma più per il carattere rituale 31 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città della terminologia, della lingua parlata e della liturgia praticata dal gruppo e di quelle ufficiali normalmente in uso nelle istituzioni. Al di là di queste differenze emergono in filigrana, soprattutto a distanza di tempo, lo sfondo pragmatico e la visione ideale insieme, che attribuivano una funzione attiva di democratizzazione della società alla cultura, a un accesso finalmente libero e generalizzato alla cultura. Una visione incarnata dalla definizione della biblioteca pubblica quale “istituto della democrazia”, che molto probabilmente “quelli del Teatro Club” non conoscevano, ma che ben si attagliava all’idea di cultura che praticavano. 9. Cap. N/Memo? a) Il contesto I pachidermi lasciano tracce profonde e durature; come i grandi uomini, le esistenze significative. L’Italia, questo paese di grandi ingombranti passati, di grandi uomini e grandi imprese, di grandi biblioteche storiche, ha faticato e fatica tuttora a dotarsi di grandi biblioteche (oggi mediateche, multimediateche?) moderne, da mettere in campo di fronte ai complessi problemi propri delle società contemporanee. Ma grandi bibliotecari sono nati e hanno operato proprio tra le difficoltà di una storia fatta di contraddizioni e ritardi. Qualcuno ne ho conosciuto. Con qualcuno ho lavorato, nella Biblioteca Provinciale di Foggia, nel Direttivo dell’Associazione, in giro per l’Italia e oltre: e sono, soprattutto, Franco Balboni, Angelo Celuzza, Angela Vinay, Luigi Crocetti, Luigi De Gregori, Luigi Balsamo, Mia L’Abbate Widmann. Sono quelli che mi hanno consentito di apprendere la professione, di amarla partendo dalla e costruendola sulla passione civile che, a lungo e a partire dagli anni ’60 e ’70, al di là delle difficoltà e delle contingenze, si concretizzò nell’obiettivo strategico della generalizzazione dell’accesso all’informazione, al sapere, alla ricerca, alla cultura, alle fonti e ai servizi, alla loro utilizzazione libera e non burocratica, autoritaria ed eterodiretta. Come bibliotecario considero di essere stato fortunato. Ho vissuto intensamente, “attraverso le biblioteche”, anni intensi e cruciali per l’organizzazione bibliotecaria italiana e in Capitanata. Si consolidava, qui e altrove, con successi e successivi ridimensionamenti e delusioni, l’esperienza dei “sistemi bibliotecari” e partiva l’era del decentramento regionale, che portò a una vera e propria esplosione dell’organizzazione bibliotecaria: centinaia di nuove biblioteche e grande dibattito sui nuovi compiti e le nuove funzioni. L’Associazione Italiana Biblioteche cessava di essere una costola ministeriale e assumeva un ruolo decisivo nella grande svolta di quegli anni. I bibliotecari degli enti locali uscivano dall’isolamento, si incontravano, scambiavano esperienze, descrivevano le situazioni, per lo più disastrose, ma lo facevano immaginando e progettando un futuro; come avevano fatto qualche anno prima, senza risultati, dando vita ad un’associazione “separatista”, contrapposta a un’A.I.B., che, fino alle soglie degli anni ’70, sareb32 Guido Pensato be stata tradizionale “portavoce” dei settori più retrivi e immobili del Ministero della Pubblica Istruzione e delle biblioteche statali. Cominciavano ad avere voce i responsabili delle biblioteche dei piccoli centri italiani: la stragrande maggioranza! “Bibliotecari campesinos” si autodefinirono in uno dei tanti infuocati congressi “di svolta”. Nel giro di poco più di un decennio, si innescarono processi e si realizzarono obiettivi inimmaginabili dopo più di un secolo - tra Unità e Fascismo - di disastrosa storia bibliotecaria, fatta di retorica esibizione e progressivo degrado, enfasi propagandistica e asservimento del prezioso patrimonio e delle istituzioni culturali nazionali; di progressiva incapacità di trasformare le gloriose ma inevitabilmente elitarie istituzioni degli Stati regionali preunitari in strutture della e per la “nuova Italia”, adeguandole ai cambiamenti, non solo politio-istituzionali, ma sociali ed economici di un paese che pretendeva di essere non solo unito, ma moderno. Tutto quello che si riuscì a fare fu di trasformare quelle biblioteche, indistintamente, in biblioteche “statali”, “nazionali”: caso unico al mondo e vezzo tardivo ancora oggi e qui da noi, di un provincialismo retorico e ignorante. Le biblioteche cessavano finalmente di essere oggetti oscuri e misteriosi, luoghi di pratiche “clandestine”, sconosciute e inaccessibili ai più e si imponevano addirittura come argomento giornalisticamente interessante, al Nord come al Sud. Un serrato dibattito teorico e politico su questioni cruciali, come la funzione e l’organizzazione, la “mission”, la strumentazione legislativa, intorno all’oggetto “biblioteche”, ma più in generale, al patrimonio e ai servizi culturali. Le Regioni divennero laboratori di concreta sperimentazione e pronta applicazione di analisi ed elaborazioni maturate nell’ambito del dibattito sul concetto di “bene culturale”, che, partito negli anni ’60 in seno alla “Commissione Franceschini”, avrebbe condotto, negli anni ’80, alla istituzione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Fu questa, in tutto il paese, per il settore delle biblioteche, una vera e propria fase costituente, nel senso che si ponevano le basi - incerte, contraddittorie, diseguali quanto si vuole, ma concrete, visibili e soprattutto progettuali, proiettate verso il futuro - di una moderna rete di servizi bibliotecari di base e diffusi. Così come si dibattevano e si progettavano e si proponevano - attraverso l’azione finalmente libera da condizionamenti e straordianariamente dinamica dell’A.I.B. - interventi in grado di ridefinire l’architettura generale del sistema, il ruolo e le funzioni delle strutture “nazionali”, la istituzione e l’articolazione di vecchi e nuovi servizi centrali. Di lì a qualche anno - sia pure, come era inevitabile, tra contrasti e interrogativi, all’interno dell’Associazione e nelle altre sedi “competenti” - avrebbe visto la luce SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale, ambizioso programma - il primo, il solo! - di messa in rete e di organizzazione in sistema delle risorse bibliografiche del paese: strutture, patrimoni, servizi. Le Regioni passavano, intanto, progressivamente alle leggi di seconda generazione in materia. La rivoluzione informatica si trasformava in un processo complesso, con il quale le biblioteche e i bibliotecari avrebbero imparato a fare i conti, trasformando radicalmente e arricchendo fortemente potenzialità e offerta: di strutture, patrimoni e servizi, appunto. Si deve alla “rivoluzione” di quegli anni, se gran 33 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città parte delle biblioteche italiane è oggi in grado di gestire e offrire Internet come lo strumento avanzatissimo - potenzialmente e tendenzialmente democratico e “senza limiti e confini” - di una prassi biblioteconomica collaudata, capace di presentare, a sua volta, la biblioteca come strumento e “luogo” maturo di analisi e di esercizio di un uso consapevole e critico di ogni tecnologia informativa da parte dei cittadini. b) Il sommerso, ma non tanto A proposito di grande storia bibliotecaria e di grandi storiche biblioteche; di piccoli o grandi, antichi o precoci pachidermi culturali: quanto (non) hanno pesato sul passato, quanto (non) pesano sul presente, soprattutto del Sud? E nel calcolo del peso di oggi rientra il passato, quanto conta il ricordo? Quanto pesavano, in quegli anni, l’uno e l’altro, quel mito, la conoscenza di quello straordinario passato e un ricordo non ancora maturo, quando non erano né l’uno né l’altro, ma presente, il mio presente nella biblioteca della mia città? Che peso, che risonanza hanno dentro di me oggi e che valore, che significato, che senso avevano allora per me le esperienze che facevo, le cose che si realizzavano e, tra queste, quelle che in qualche misura o di fatto erano riconducibili a me, al mio ruolo, indipendentemente dal fatto che fosse formalmente, ufficialmente riconosciuto o da me stesso “ritagliato”, all’interno di una gestione contemporaneamente centralizzata, frantumata e… “situazionista”? L’avvio di quella che sarebbe stata, all’interno della Biblioteca Provinciale di Foggia e attraverso essa, una vera e propria avventura professionale, culturale e umana - “a termine”, ma, almeno per un quindicennio, “di formazione”: lunga e ininterrotta, costantemente e appassionatamente assaporata - fu all’insegna, sì di un quasi incredulo entusiasmo, ma anche, oggettivamente, di una sia pur “eccitata” normalità. Ma essere dentro e armeggiare tra i penetrali della biblioteca - libri, scaffalature, sale di lettura, depositi, schedari riservati, cataloghi -: tutto questo era già l’avventura. Certo non l’esercizio scontato e di scarso interesse, niente affatto stimolante per chi non ha mai apprezzato l’ebbrezza di poteri formali, della cosiddetta funzione vicaria del direttore. Ma, al contrario: schedare il piccolo “Fondo Nardini”; curare il servizio e la rassegna stampa per un paio di presidenti della Provincia e fungere da loro ghostwriter; scoprire i caratteri, i pregi e le lacune delle collezioni; seguire e concorrere a curare la visita di Cesare Zavattini (memorabile la foto che lo ritrae, del tutto casualmente, in biblioteca, lui sceneggiatore di Ladri di biciclette, accanto a quella del vecchio commesso, pubblicata in un ormai introvabile opuscolo!); cominciare ad entrare nel più vasto mondo delle biblioteche, attraverso un corso riservato ai bibliotecari statali e, attraverso e nell’A.I.B., maturare contemporaneamente il convincimento che fosse giunto il tempo di fare entrare il mondo nelle biblioteche: ce n’era a sufficienza per suscitare entusiasmi ed energie. Al punto di non intravedere i limiti che avrebbero accompagnato, già nella fase della gestazione (complici anche vicende esterne impreviste), la transizione dalla vecchia alla 34 Guido Pensato nuova (sede della) biblioteca e la sua vita futura. Come accennato, nel giro di qualche anno, tra 1970 e 1973, l’ampliamento dell’organico aprì le porte, per la prima volta attraverso pubblici concorsi per tutti i diversi livelli - da vicedirettore ad “ordinatore” ad “applicato”-, a forze numerose e giovani, compreso il drappello di “reduci del Teatro Club”. Il Sistema Bibliotecario Provinciale era in pieno sviluppo, la nuova sede quasi pronta. L’ansia, il fervore dei protagonisti: direttore in testa, amministratori, dipendenti, gran parte dell’opinione pubblica cittadina, erano intensissimi. Classificazione Decimale Dewey e informatizzazione delle procedure catalografiche costituirono le porte di accesso e gli itinerari di iniziazione straordinariamente stimolanti e innovativi - alla teoria e alla prassi biblioteconomiche: ben al di là delle angustie tecnicistiche cui la fama - un po’ oscura e, tutto sommato, immeritata - della disciplina sembrava introdurre. Uno sciagurato allarme, non si sa quanto realistico o quanto addirittura artificiosamente lanciato: “Palazzo Dogana crolla!”, accelerò il trasferimento del patrimonio librario e documentario, degli uffici e del personale della biblioteca presso la nuova sede di Viale Michelangelo. E fu una eccellente controprova della antropologica vocazione degli italiani-meridionali-napoletani-pugliesi-dauni-foggiani (dentro questa “linea” sono sintetizzati i cinque sesti di quella ideale che orienta lo sviluppo delle collezioni di interesse locale della “Provinciale”!) alla gestione ottimizzata delle emergenze; nel corso della quale si distinse, insieme a tanti altri, Vincenzo Fidanza: certo per abnegazione e spirito di iniziativa, ma soprattutto per olimpica calma e ironico distacco; e per questo mi piace ricordarlo, quasi simbolo di quegli anni e di quanti a uno spirito analogo sono capaci di informare il proprio piccolo o grande impegno quotidiano. Ma il trasferimento materiale dei vecchi fondi della biblioteca coincideva con l’esigenza di arricchire e aggiornare le collezioni, di costituirne di nuove per nuovi servizi, di colmare lacune di carattere generale, per esempio sul versante delle scienze e delle nuove scienze, dei materiali periodici, fondamentali per dar conto della ricerca e dello stato degli studi sulle discipline “di confine” e sull’attualità sociale politica e culturale. Si trattò di un processo che si svolse in tempi brevi, con modalità governate dalla concitazione e dall’eccitazione intellettuale, in cui conoscenze e predilezioni personali si mescolavano ad analisi affrettate e presuntive delle esigenze di un futuro possibile pubblico della biblioteca. Era ancora fresco di stampa La scelta del libro (1972) di Rinaldo Lunati; di là da venire Gli acquisti in biblioteca (1989) e Costruzione e sviluppo delle raccolte (1997) di Carlo Carotti e Le raccolte delle biblioteche (1999) di Giovanni Solimine. E d’altra parte, chi mai si era avventurato prima in analisi del risicato universo di utenti (l’1% della popolazione?) delle strutture culturali locali? Era proprio questo che ci sembrava doversi fare: innescare un processo avanzato di sollecitazione (vellicamento?) della domanda, attraverso i materiali che documentavano la vivacità e la complessità del momento storico-culturale che stavamo vivendo. E infine, non c’erano pur sempre, ormai da tempo, nella città e in provincia centri culturali e di ricerca, luoghi moderni di applicazione e di esercizio della scienza e della cultura: Teatro, Conservatorio, Accademia 35 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città di Belle Arti, Laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri sperimentali per l’agricoltura, le foraggiere e la zootecnia, i complessi ospedalieri; lo zoccolo strutturale su cui, accanto alla stessa nuova biblioteca, cominciava a costruirsi la prospettiva dell’università foggiana (che, tra l’altro, proprio in biblioteca mosse i primi passi), tali e tanti da lasciar supporre l’esistenza di una domanda sommersa, latente? Ma il percorso per l’affermazione di un ruolo forte della biblioteca doveva essere (è tuttora) ben più arduo e non poteva esaurirsi nella definizione di un’offerta culturale (bibliografico-documentaria) accattivante e ricca. Fu così che la presenza sugli scaffali di materiali riguardanti la filosofia della scienza e le antropologie, le comunicazioni di massa e la linguistica; di quelli raccolti dai Lomax per la Library of Congress, delle bibliografie nazionali (italiana, inglese, francese, americana), dei repertori bibliografici speciali, dei classici nelle lingue originali, dei principali “Excerpta” di carattere medico, di settecento periodici correnti: tutto questo non bastò, si rivelò in gran parte esercizio illusorio in sé. Imparai a capire allora quello che da allora cominciai a tradurre nella formuletta: “la domanda di lettura non si crea in biblioteca e attraverso le tecniche descrittive e catalografiche”. Insomma: gli apprendisti bibliotecari si erano trasformati in apprendisti stregoni e avrebbero dovuto, da un canto imparare a fare i conti con il contesto, quello vero, non quello presunto, immaginato, sognato; dall’altro che, senza una solida struttura tecnicoprofessionale specifica della biblioteca nel suo complesso, il gap tra le potenzialità di essa e la reale capacità di farle valere “fuori di sé” rischiava di consolidarsi e di rendere sempre più concreta la prospettiva di un suo sostanziale isolamento, di vederla trasformata, al di là della forte, ormai solida e permanente visibilità, in una “cattedrale nel deserto”: fenomeno, d’altra parte, non estraneo ad altri versanti del panorama locale. Questi nodi sarebbero divenuti intricati e visibili più in là, soprattutto negli esiti riconducibili al ruolo dell’apparato politico-amministrativo. 10. Due nuovi servizi La Sala Ragazzi Intanto la nuova biblioteca prendeva forma, attraverso servizi del tutto nuovi o apparentemente tradizionali, ma che di fatto non avevano nulla in comune con quello che la vecchia struttura riusciva a garantire. Inconfrontabile con la situazione del passato, per non fare che un esempio, il destino che la nuova prestigiosa sede cominciò a garantire a compiti e fondi che più tradizionali e tipici non potrebbero essere in una biblioteca italiana: quelli destinati alla conservazione e alla valorizzazione dei materiali di interesse locale e di quelli rari e di pregio. Finalmente, attraverso l’allestimento o la partecipazione a mostre, l’attività editoriale, la pubblicazione di manoscritti facenti parte delle collezioni della “Provinciale”, la produzione di bibliografie e cataloghi a stampa o su scheda, i “tesori nascosti” divennero potenzialmente accessibili. Nuovo impulso ricevette «la Capitanata”», che, 36 Guido Pensato con i suoi oltre quarant’anni di vita, resta la rivista più longeva della storia culturale della provincia che le dà il nome. Per quel che mi riguarda, al di là dell’allestimento di sale come quella destinata agli adulti (in effetti sala di lettura a carattere generale) e quella “di consultazione”, cui concorsi partendo dal patrimonio esistente e attraverso una “campagna acquisti” che durò diversi anni, un particolare impegno fui chiamato a porre nella costituzione della “Sala ragazzi” e della “Discoteca”. A ragione, credo ancora oggi, i due nuovi settori furono individuati come simbolo e concreto strumento operativo dell’urgenza e della prospettiva, rispettivamente, di legare la nuova biblioteca proprio al luogo primario di formazione dell’abitudine alla lettura e della capacità critica di fronte ad essa e non solo; e di proiettarla in ambiti tendenzialmente sempre più forti e complessi del consumo culturale corrente, che personalmente consideravo non necessariamente e definitivamente terreno esclusivo ed elusivo di pratiche inconsapevoli ed eterodirette. Il carattere emblematico delle rispettive “storie”, fu confermato tutto, nel tempo, nel bene e nel male. Per questo mi sembra utile dirne, sia pure brevemente, anche perché nelle due vicende credo di aver speso e investito, insieme ai colleghi direttamente impegnati nei servizi, molte mie energie e le speranze di rapido radicamento della biblioteca nel tessuto culturale e formativo della città e della Capitanata. L’opuscolo che, distribuito in tutte le scuole, annunciava la nascita della “Sala Ragazzi”, nella forma adottata - agile e ironica - e negli argomenti utilizzati - “libertà di aggirarsi e di utilizzare i materiali”, “nessuna barriera tra utenti e servizi” tendeva a ribaltare quello che sapevamo essere un archetipo, saldamente e inconsapevolmente insediato, come immagine fortemente negativa e scostante e che tendeva a identificare su questo terreno aprioristicamente repulsivo scuola e biblioteca. La stessa costruzione del fondo librario fece i conti con questo sforzo, sganciandosi dall’orizzonte strettamente “scolastico” e “parascolastico” imposto da un’editoria di settore ancora carente, soprattutto sul piano della qualità e dell’autonomia e della specificità dei materiali destinati ai bambini e ai ragazzi, “al di là della scuola”. Problemi analoghi si posero perfino per gli arredi: scaffalature, tavoli, sedie, schedari, generalmente afflitti da una anonima e disarmante tristezza, come la produzione libraria, dove, tuttavia, non mancavano le eccezioni e le eccezionali novità (Munari e Rodari, per pochi, ma c’erano già), che esibivamo con insistenza. Su queste premesse, le iniziative della “Sala Ragazzi” si moltiplicarono, coinvolgendo decine di scuole, docenti e studenti. I terreni privilegiati furono quelli dell’attività teatrale appositamente ideata e realizzata (per e con i destinatari-protagonisti: docenti e studenti) e dei seminari di qualificazione e di aggiornamento; le tematiche quelle dei linguaggi e dei rapporti tra gli stessi e un forte radicamento con le realtà in cui operavano le scuole e vivevano i ragazzi: i piccoli centri, i quartieri e le borgate del capoluogo. I quaderni “Biblioteca Educazione” documentarono un complesso e sistematico programma realizzato dalla “Sala ragazzi” e indirizzato alla scuola, non agli insegnanti e agli studenti, ma alla scuola come istituzione. Le prime 37 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città pagine del primo quaderno, pubblicato nel 1979, ma costruito su esperienze avviate nel 1977 (che videro impegnati, con il gruppo “Giochiamo davvero” di Giuliano Parenti, due giovanissimi Susy Blady e Patrizio Roversi) esplicitano con chiarezza gli elementi utili alla comprensione della logica, delle motivazioni, degli obiettivi, delle metodologie e delle tecniche impiegate in iniziative protrattesi per alcuni anni e sistematicamente accompagnate da pubblicazioni e mostre, l’ultima delle quali - “La parte dell’occhio” - allestita nelle sale del Palazzetto dell’Arte. La definizione della linea di intervento della sala ragazzi nei confronti della scuola è necessariamente legata alle tensioni e alle contraddizioni che questa vive, viene condizionata dai limiti e dalle carenze che limitano questa istituzione, si scontra con la stessa arretratezza contro cui sono da tempo impegnati studenti e insegnanti. Questo legame scaturisce dalla scelta fatta di non considerare la biblioteca come ‘seconda scuola’ né, d’altra parte, come porto franco in cui evadere, ipotizzare e realizzare avanzate sperimentazioni culturali. La ‘terza strada’ adottata è quella di un confronto, pur nella specificità di intervento, tra i due istituti, partendo, per quanto riguarda la biblioteca, proprio dai limiti e dalle contraddizioni più grosse della scuola per svolgere opera di fruttuosa ‘provocazione’ e, in questo rapporto, trovare e ridefinire volta a volta il proprio ruolo. Questa convinzione ci ha indotto a considerare come interlocutore privilegiato nelle iniziative che si intraprendono non tanto i singoli insegnanti e studenti (anche se, nei fatti, è su questi che si fa perno), quanto l’istituzione nel suo complesso, chiamata a responsabilizzarsi e a cogestire direttamente le attività. […] (Liliana Di Ponte, Teatro animazione ricerca. Un’esperienza di animazione teatrale tra biblioteca, scuola e territorio, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1979). Su tali premesse si articolarono progetti che si ponevano obiettivi specifici: analizzare problematiche della città e delle altre realtà coinvolte; utilizzare consapevolmente e con abilità il libro, il giornale, la biblioteca; scoprire che la parola non è il solo mezzo di espressione; scoprire “un modo di ‘fare ricerca’ del tutto diverso (nel metodo, nei tempi di attuazione e negli strumenti utilizzati) da come comunemente lo si intende e lo si pratica nella scuola”. Nelle stesse pagine così vengono descritte le fasi di una iniziativa, esemplarmente significative del rifiuto dell’attività di animazione come pratica di evasione e di banalizzazione: lo spettacolo mobilita, attraverso linee prevalentemente emotive, una serie di interessi, richieste, interrogativi attorno ai problemi che tratteggia; - l’animazione immediatamente successiva, facendo leva su questa domanda, rende possibile e sollecita un’immediata presa di posizione di ognuno, espressa prevalentemente con la parola scritta, il disegno, il fumetto; - la riflessione collettiva sui materiali così prodotti conduce dalla emotività iniziale ai primi tentativi di sistemazione razionale. Dalle inevitabili contraddizioni scaturiscono più solide motivazioni alla ricerca; - la ricerca sul reale più prossimo, tramite interviste e indagini, dilata i primi risultati, li precisa, li contestualizza; - la ricerca su libri, giornali, docu38 Guido Pensato menti che affrontano quelle problematiche fa emergere altri termini della questione, riferendoli non solo ai confini della propria realtà ma a quelli relativi alla dimensione e alle implicazioni complessive del problema. (Ibid.) Mi appare tuttora chiaro come il complesso degli interventi progettati e realizzati dovesse tendere e fosse diretto a un obiettivo fondamentale, coerente, da una parte con la riconosciuta centralità del rapporto con la scuola e con il tema più generale della formazione degli utenti della biblioteca (non si dice, da sempre, che la scuola è il luogo della formazione dei cittadini; e non sono innanzitutto cittadini gli utenti dei servizi, compresi quelli culturali?) della biblioteca; dall’altra con la natura istituzionalmente propria della biblioteca, in quanto struttura al servizio di tutto il territorio provinciale e, perciò non servizio di base e di primo livello, ma di secondo livello, diretto, cioè, ai bibliotecari comunali e scolastici, ai docenti e agli operatori dell’educazione e della formazione in genere e, attraverso questi, agli utenti e ai potenziali utenti impegnati nella ricerca, nello studio, nell’impiego del tempo libero. Quello che mi sembrava doversi configurare era, insomma, un vero e proprio “dipartimento educativo”, che andasse ben al di là dell’idea della “sala destinata ai ragazzi” e, per di più, della sola area urbana e che fosse in grado di concorrere ad accrescere conoscenze e abilità specifiche, a partire dal terreno della “mediazione catalografica” (Serrai), per integrare quella della mediazione educativa e formativa e della comunicazione culturale e, infine, della scoperta e della pratica della creatività come risorsa della (auto)formazione, dell’affermazione di sé e della condivisione del sistema di valori su cui si fonda una democrazia tollerante e giusta. Sarebbe forse arduo graduare il peso rispettivo di ciascuna delle cause che hanno determinato la mancata realizzazione di una articolazione funzionale di una specifica “competenza” della biblioteca, che consideravo allora e considero tuttora strategica rispetto alla sua capacità di realizzare, attraverso la definizione di un proprio ambito formativo, gli obiettivi propri; i quali, arricchiti e complicati dalla complessità degli scenari sociali e culturali in cui vanno interpretati e perseguiti, tuttavia permangono, al di là della mutata natura degli “oggetti” di cui si occupa e della strumentazione che impiega. Nessun dubbio, viceversa, sul fatto che, spostando in avanti il riferimento a quelle più generali e strutturali, le cause specifiche, anche a distanza di anni, possano essere sommariamente così descritte: a) pressoché totale inesistenza, all’interno delle scuole, di un sia pur minimale (e reale, non apparente) servizio di biblioteca e, conseguentemente, di una pratica della lettura, della ricerca bibliografica e del rapporto con le istituzioni e le risorse informative documentarie e culturali del territorio, che non fosse frutto, in generale, di un avvilente routine minimalista. Una scuola ancora inchiodata a un rapporto esclusivo e totemico con il libro di testo e che trasformava in libro di testo ogni libro, faticava a relazionarsi in maniera attiva con la biblioteca e a configurare e formulare, dall’esterno della stessa, una diversa e più forte proiezione verso i potenziali utenti collettivi e organizzati. Resta da aggiungere almeno l’aberrante stra39 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città volgimento verso il basso della pratica delle “ricerche”: una grottesca e devastante prefigurazione “ante litteram” del “copia/incolla” informatico; b) enfatizzazione, all’interno della biblioteca, di pratiche forse troppo marcatamente (ma apparentemente, aggiungo) comprese sotto la generica formula di “attività culturali con la scuola”, a scapito di quelle tradizionali e convenzionali: produzione di cataloghi speciali e bibliografie mirate, specifiche e periodiche; programmi di “avviamento e invito alla lettura” e “lettura in comune e ad alta voce” e così via. Una deviazione per molti versi inevitabile, che e perché si spiega con il generale timore che percorreva allora il mondo bibliotecario italiano di fronte al deserto di consuetudine e di tradizioni nei confronti del servizio di pubblica lettura, oltre che della lettura stessa; con l’ansia di richiamare l’attenzione sul nuovo che nasceva e con il timore che il nuovo non fosse riconosciuto come tale perché storicamente arenato nelle paludi delle pratiche catalografiche e del “bricolage biblioteconomico” (Rino Pensato). Quella che qui segnalo si configurò come una carenza grave che rappresentò un alibi inconsapevolmente offerto alla scuola e fece venire meno, proprio nei confronti del soggetto collettivo e organizzato, dell’utente istituzionale più rilevante e strategico, quella strumentazione tecnico-culturale in grado di garantire l’assunzione di quel ruolo attivo e autonomo, perché tecnicamente attrezzato, di fronte alla biblioteca - quella della scuola e quelle del territorio -, alle sue risorse, ai suoi servizi; c) natura conflittuale che, al di là delle intenzioni, assunse la proposta di trasformare in “dipartimento educativo” la “Sala ragazzi”; una scelta che avrebbe consentito di correggere errori e deviazioni, da una parte, e ataviche passività e pigrizie, dall’altra. È questa l’occasione, tra l’altro, di rilevare come la dizione “Sala ragazzi” sostanzialmente confliggesse in maniera stridente e fin dall’inizio - dalla fase di progettazione della nuova sede e della definizione dei relativi servizi - con il ruolo complessivo della biblioteca, in quanto “provinciale” e in quanto “centro rete” e struttura di riferimento del Sistema Bibliotecario della Capitanata. Non trattandosi, infatti, di semplice leggerezza o approssimazione terminologica, non si vede e non si spiega - se non come un caso di strategia culturale non sufficientemente chiara o non coerentemente attuata - come le funzioni implicite nel suo ruolo istituzionale, politico-amministrativo e politico-culturale, potessero tollerare la prefigurazione di un servizio generale (di una funzione surrogatoria rispetto a quelli di base), indirizzato essenzialmente ai “ragazzi”, per di più solo a quelli del capoluogo e non imponessero, viceversa, proprio la configurazione che successivamente proposi. Prevalse, perché inserita, come era opportuno che fosse, nel più ampio contesto di una riorganizzazione complessiva dei servizi, il sospetto che la proposta fosse o potesse essere indirizzata a costruire posizioni di preminenza a favore di un addetto piuttosto che di un altro. Era una fase storica (giova ricordarlo e dichiararlo, finalmente, al di là di attardate e inestinguibili ipocrisie), in cui nella pubblica amministrazione imperava (un imperfetto fuori luogo?) la più completa “cogestione” tra i diversi livelli: politico-partitico, politico-amministrativo, politico-sindacale e 40 Guido Pensato degli apparati. Nessun atto che avesse, sia pur minime e lontane nel tempo, in una prospettiva breve media e lunga, capacità di incidere sul destino di un pubblico dipendente, quale che fosse la norma o la ratio politica, amministrativa e organizzativa da cui traeva origine - magari la più alta e impellente - poteva sottrarsi al vaglio, alle defatiganti trattative e ai conseguenti stravolgimenti in grado di piegarlo agli accordi raggiunti o da raggiungere a tutti i costi. La Discoteca La nascita della “Sala Ragazzi” rappresentava pur sempre, tra i servizi di nuova istituzione, la centralità di una scelta a favore della scuola e del suo rapporto con la biblioteca, tradizionalmente forte (o meglio, con forza e sistematicamente enunciata) perfino nel nostro paese (anche se rimasta lettera morta lungo tutto il periodo post-unitario, il Fascismo, fino al secondo dopoguerra e agli anni ’60), ma mai, comunque, elusa in ogni biblioteca moderna in ogni parte del mondo; particolarmente e soprattutto se e perché generalmente ispirata a quel concetto di public library affermatosi in area angloamericana, in stretta relazione, già nel XIX secolo, con i processi di scolarizzazione e di alfabetizzazione di massa. Anche la previsione e la costituzione della “Discoteca” (successivamente e più correttamente denominata “Fonoteca”), destinata alla cultura musicale, al materiale sonoro e alla produzione discografica e su nastro magnetico, vanno ricondotte alla stessa matrice di cultura bibliotecaria, lontana da una visione sacrale e sacralizzante delle istituzioni pubbliche, dei musei, delle biblioteche, degli archivi, destinati tutti, programmaticamente, alla conservazione e al trattamento di materiali rigorosamente ben individuati da una rigida e solida tradizione. Si pensi, viceversa, per stare a quello che qui ci interessa, allo straordinario, già citato, materiale raccolto sotto il nome dei Lomax presso la Library of Congress di Washington e alle analoghe iniziative rapidamente consolidate presso gran parte delle biblioteche pubbliche americane e inglesi. Nel panorama italiano degli anni ’70 la nascita della “Discoteca” foggiana rappresentava una sostanziale, radicale novità, anche per le dimensioni della nascente nuova biblioteca, per il carattere esemplare che si attribuiva al progetto, non a caso seguito passo dopo passo da Virginia Carini Dainotti, vestale del modello public library, consegnato a quel vero e proprio manifesto che fu il suo La biblioteca pubblica istituto della democrazia (Milano, Fabbri, 1964). Eppure, l’angustia degli spazi (quattro cabine individuali di 1m.x1m. e un’area scaffalature-ufficio di 10 mq. circa) destinati all’interno della nuova sede a questo servizio, insieme alla mancata previsione di un’area di ascolto comune (cui si rimediò successivamente), denunciavano più un frettoloso ricalco del modello, che non una preventiva, consapevole definizione dei presupposti e delle strategie culturali che la scelta implicava. Questa della discoteca fu per me un’importante esperienza, anche se e forse proprio perché si rivelò uno dei terreni sul quale si misurò il peso del contesto reale rispetto ai modelli e il destino di inefficacia degli stessi di fronte ai fatali 41 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città esiti di isolamento, di “fuga in avanti” e ridimensionamento, costantemente in agguato nel settore culturale, come in quelli sociali ed economici e sistematicamente ricorrenti nella storia recente del Sud (si pensi all’asse “intervento straordinario, Cassa del Mezzogiorno, intervento sul ‘fattore umano’, Formez, Centri Servizi Culturali”). La stessa preliminare costituzione del fondo discografico di base pose questioni di grande interesse perché imponeva di misurarsi con il panorama di un mercato affollatissimo di prodotti e articolatissimo; così come si rivelarono stimolanti e complesse quelle legate alla descrizione catalografica dei materiali, in un contesto nazionale in cui si muovevano i primi passi verso scelte comuni e coerenti con le regole e i repertori internazionali in materia di “non-book materials” e supporti sonori. Per quanto la stessa nascita della nuova biblioteca rendesse scontata e in linea di principio accettata la presenza di supporti “non cartacei”; e per quanto fosse rifiutata a priori - e pour cause - ogni ipotesi di “consacrazione” o di esclusione di questo o quel genere musicale, di specifici e singoli materiali sonori, con l’una e con l’altra si dovette successivamente fare i conti. E furono proprio la vastità della produzione, la complessità della cultura musicale e dell’universo sonoro e la necessità di misurarsi con le risorse finanziarie e con le capacità gestionali concretamente disponibili, a imporre scelte e percorsi culturali precisi, in qualche misura obbligati. Difficoltà vennero, come era inevitabile, dall’assenza in loco di fornitori in grado di far fronte ad ordini quantitativamente rilevanti e diversificati per generi. I laboriosi percorsi di acquisizione dei materiali toccarono Bari, Napoli, Roma, Bologna e Milano e dettero luogo, nel corso degli anni impiegati nella costituzione della dotazione di base, complicati dalle allora - così sembrava e si diceva - inevitabili lungaggini burocratiche, anche ad episodi ai limiti del grottesco: un importante rivenditore napoletano, sfiancato dall’attesa dei pagamenti, di fronte alla richiesta di una nuova fornitura, replicò di essere pronto a soddisfarla solo a fronte di un pagamento non “pronta cassa”, ma… “a cassa fulminante!”. Di ben altro tenore, fortunatamente, i confronti e le discussioni sui termini di volta in volta, di genere, cronologici, quantitativi - entro i quali definire gli acquisti e i tentativi posti in essere per produrre un circuito tra diverse istituzioni locali, partendo dai temi della cultura musicale. Autori ed esecutori (anche diversi per le opere più importanti), come ovvio, furono i riferimenti obbligati per la musica classico-sinfonica e operistica; e non fu trascurata quella contemporanea, salvo l’acuirsi dei problemi della scarsità e della difficile reperibilità delle incisioni. Altrettanto ovvia l’attenzione quasi esclusiva posta, nel caso del jazz, agli esecutori; in questo ambito si cercò, tra difficoltà già allora note, di valorizzare il ruolo del jazz italiano contemporaneo. Difficoltà di ben altra portata e di natura opposta, incontrammo nella compilazione di elenchi ideali e ipotesi e pacchetti di acquisto dedicati alla musica popolare e demoantropologica da una parte e a quella leggera-pop-rock dall’altra. Per quel che riguarda la prima, volendo restringere le scelte, come di fatto si decise di fare, all’ambito italiano, ben poco veniva offerto dal mercato discografico. E fu così che si cominciarono a stabilire rapporti con la Discoteca di Stato, che, per non fare che qualche esempio, ci fornì copia di registrazioni 42 Guido Pensato storiche, come quelle effettuate negli anni ’50 sul Gargano da Diego Carpitella e Alan Lomax e quelle riguardanti eventi e personaggi della storia italiana; e a cui offrimmo la possibilità di acquisire copia di esecuzioni storiche e rare in mio possesso e che depositai in copia (realizzata dalla stessa Discoteca di Stato) anche presso la nostra biblioteca: il “Trio n.1” di Schubert nella esecuzione di Cortot-Thibaud-Casals; “On l’appelle Manon”, nella interpretazione di Enrico Caruso; e incisioni di Chaliapine e Mc Cormack. Nonostante gli sforzi, credo che, fin da allora il settore dedicato alla musica popolare fosse particolarmente carente. Così come credo sia tuttora irrilevante la documentazione riguardante quella leggera-pop-rock; ma, come detto, per ragioni opposte. Di fronte, infatti, alla sterminata, quotidianamente incalzante e montante produzione nazionale e mondiale e alla conseguente impossibilità di definire un criterio e una strategia plausibili di formazione e, in prospettiva, di incremento della specifica raccolta, si adottò una decisione in radicale contrasto con la linea di “non consacrazione” preventivamente stabilita. Si decise, infatti, non so quanto salomonicamente, di acquisire quei materiali relativi a opere, autori, esecutori, gruppi, complessi… consacrati - evidentemente dal passare del tempo, dalla critica e dal mercato - nella definizione di “classici” della storia della musica rock, pop e leggera. Sono ancora qui in attesa di superare, da un canto le mille obiezioni possibili, dall’altra le altrettante difficoltà di una eventuale, possibile scelta alternativa (che non sia, oggi, quella, estremamente controversa, offerta dal libero accesso alla “rete”). Come sono ancora incerto circa le ragioni che impedirono la riuscita di una ipotesi di lavoro messa in campo già nella fase di costituzione della raccolta, che, mirata, come credo tuttora giusto, a un’utenza collettiva e organizzata, oltre che a quella spontanea, prevedeva il coinvolgimento del Conservatorio “Giordano”, docenti in prima istanza. Terreno prescelto di incontro fu il rapporto della musica, delle correnti, dei compositori, dei musicisti in genere, con i movimenti, gli autori, le correnti delle altre arti e delle diverse discipline del sapere e del pensiero nei diversi periodi storici. Un terreno fin troppo scontato, apparentemente banale, o fin troppo arduo? Fatto sta, che, dopo qualche incontro preparatorio, il tentativo si arenò e ripiegò su occasionali incontri e filoni tematici di ascolto comune. Si può ben dire, perciò, che, tra i servizi della biblioteca e rispetto alle potenzialità innovative, quello della “Discoteca” è stato il più… sottoutilizzato, se si fa eccezione per uno sparuto gruppo di docenti e di appassionati (per lo più giovani e addetti ai lavori). Quel che è certamente rimasto del “lavorio” di quegli anni è depositato tangibile testimonianza delle grandi difficoltà, ma anche del grande fascino culturale che suscita un lavoro all’interno delle istituzioni pubbliche, che cerchi di essere non di puro ricalco dei meccanismi prevalenti, dominanti del consumo - tra gli stigli della fonoteca: un (ormai) piccolo fondo di incisioni storiche rare e preziose; perché prestigiosi gli esecutori, perché ormai introvabili sul mercato corrente, perché su supporto, il vinile, desueto, eppure considerato “da melomani veri”: da quelle riguardanti jazzisti leggendari come Muggsy Spainer, “Jelly Roll” Morton, Fats Waller o i nostri Gianni Basso e Oscar Valdambrini, all’ormai introvabile Messa “Se la face ay pale” di Guillaume Dufay e ai “Mottetti e Madrigali” di Gesualdo da 43 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città Venosa; dai “Quattro Concerti per corno” di Mozart nell’esecuzione di Seifert al “Como una ola de fuerza y luz” di Nono; dalla “Donna Lombarda” ai “Maggi della Bismantova” e così via. Attraverso la fonoteca sperimentai un piccolo saggio di quello che si sarebbe potuto (dovuto) fare, anche su questo versante; di quello che ogni biblioteca, ogni istituto culturale pubblico locale, dovrebbe essere messo in condizione di fare, di tentare almeno, rispetto ai materiali e alle fonti, alla memoria, disseminata e nascosta, dispersa sul territorio. Mi accadde di visitare (grazie all’indimenticabile Ferrante) - e mi fu concesso di farlo in maniera abbastanza meticolosa - “casa Volpe” a Sant’Agata di Puglia: una piccola casa-museo familiare. Quella occasione produsse il recupero e la pubblicazione del prezioso archivio (a cura di Viviano Iazzetti) e l’acquisizione da parte della Biblioteca Provinciale di un piccolo fondo discografico su grafite, che comprendeva rare incisioni di “Bohème”, “Aida”, “Norma” e un altrettanto raro grammofono d’epoca. Infine: la storia della Fonoteca è stata accompagnata dalla progressiva acquisizione di un prezioso bagaglio di conoscenze in materia di descrizione dei materiali sonori, che non ha, tuttavia, potuto contare, all’interno della biblioteca, su una adeguata e altrettanto costante catena di trasmissione: un dato di fatto, che riconduce a limiti “storici” e “strutturali” delle vicende della Biblioteca Provinciale di Foggia (intorno alle quali queste pagine cercano di imbastire, nei limiti detti ed esplicitamente accettati di una lettura “molto personale”, una riflessione). 11. Breve storia di un collezionista. I manifesti cinematografici della Biblioteca Provinciale Franco Ferrarotti, titolare della prima cattedra italiana di Sociologia, ebbe modo di sostenere, con convinzione e argomentazioni, che tutto quello che si è capito e spiegato della società italiana del secondo dopoguerra, della ricostruzione, degli anni ’60 e del cosiddetto “boom economico”, lo si deve più al cinema che alla sociologia. E si riferiva, evidentemente, allo straordinario percorso dal “neorealismo” alla “commedia all’italiana”. Ma quel contributo di analisi il cinema - tra alti e bassi - non ha mai cessato di fornirlo, fino ad oggi e, ovviamente, in tante parti del mondo: non è un caso che venga considerata, per antonomasia, la musa (e lo specchio, più o meno deformante, poco importa) della contemporaneità. Spesso ha fatto di se stesso - del patrimonio di immagini, di suoni e miti, di personaggi, parole e storie sedimentato nella memoria e nell’immaginario di ciascuno - l’oggetto di nuovi racconti. Tralasciando la lunga teoria di grandi e meno grandi “registi cinefili” - dalle origini ad oggi, il cinema è un continuo “filmarsi addosso” -, Ettore Scola e Giuseppe Tornatore hanno raccontato, rispettivamente in Splendor e in Nuovo Cinema Paradiso, nello stesso anno - il 1988 - il ruolo del cinema, della distribuzione cinematografica nella costruzione del bagaglio di informazioni, di paesaggi - fisici e mentali - di comportamenti e di modelli, di visioni e sogni di un intero paese; di interi paesi, soprattutto di quelli della periferia italiana, di quella meridionale in 44 Guido Pensato particolare, deserta di luoghi e strumenti per l’informazione e la cultura, oltre che per la socialità (spesso per la stessa speranza). Parte da qui, da lontano, la storia dell’acquisizione della collezione di manifesti cinematografici oggi in possesso della Biblioteca Provinciale. Da molto lontano; e da una sorta di delirio, non dissimile da quello collettivo che accompagnava spesso l’apparizione sullo schermo, - o la sparizione e la cancellazione, per censura o per rottura della pellicola - di un personaggio, di una sequenza. Tutt’altro dai fanatici deliri che ci documenta la televisione e che vanno in scena lungo le passerelle della Croisette o del Lido veneziano. Perché precoce e furioso, individuale e segreto, solipsistico delirio di possesso fu quello che si impadronì di Matteo Soccio, intorno agli otto nove anni, tra il finire dei ‘40 e gli inizi dei ‘50. Fu allora che nella natia Pietra Montecorvino, piccolo centro dell’Appennino Dauno, vide il suo primo film, Il Cucciolo (1946), nel neonato Cinema Lembo (1948). Non era un film qualsiasi, anzi. Fiaba triste e struggente “che ha fatto piangere intere generazioni”, premio Oscar per la fotografia, sembrava fatto apposta - protagonisti una famiglia contadina, un giovane cerbiatto e un bambino; interprete Gregory Peck - per “impadronirsi” del piccolo Matteo e per conquistarlo ineluttabilmente alla “fabbrica dei sogni”. Se si pensa che il secondo film che vide (o quello di cui conserva, non a caso, ed è questo che conta, nitida memoria) fu Catene (1949) di Raffaello Matarazzo, uno straordinario melodramma, che combinava eros, dedizione e spirito di sacrificio, centralità della famiglia e… del divismo (Yvonne Sanson e Amedeo Nazzari), la sola cosa che meraviglia non è che Soccio uscisse dalla doppia esperienza completamente soggiogato dal cinema, ma la singolarità della forma che quella “possessione” assunse e la motivazione, la spiegazione che di quella modalità egli adduce. Al giovane, precoce cinefilo (definizione assolutamente riduttiva) sembrava assurdo e crudele che, riaccese le luci, tutto svanisse e, addirittura, che durante la proiezione le immagini non avessero consistenza, non lasciassero traccia sul telone (ancora oggi, nel rievocare quella sorta di “deprivazione”, si alza in piedi e compie il gesto di toccare… quelle ombre sfuggenti). Per fortuna vennero in soccorso le “locandine”, sintetiche evocatrici del sogno. Si può immaginare la storia - umana, psicologica, culturale e materiale -, che partì in quel lontano 1948/1949 e, soprattutto, la progressione alluvionale di “apporti”, che l’esperienza e l’audacia, giorno dopo giorno acquisite, e il montante delirio, alimentato dalle “conquiste”, investì, per decenni, casa Soccio, in Via Spalato, a Foggia, dove, a qualche anno di distanza da quelle iniziali folgorazioni, la famiglia d’origine si era trasferita. Il tutto (o quasi) mi fu raccontato, fresco della funzione di direttore, da Matteo: con un misto di orgoglio e di senso della ineluttabilità degli eventi; e da sua moglie Dora, che lasciava trasparire un orgoglio vicino alla tenerezza che si ha con i “folli”, insieme a una disperazione, che giunta, credetti di capire, alla soglia estrema di gesti irreparabili, per l’equilibrio della famiglia o l’incolumità del “collezionista”, si trasformava in speranza e sotto tale forma si aggrappava a me (alla biblioteca), ai miei cenni di meraviglia, di approvazione, di grande interesse. Un intreccio, un incrocio di occhiate, esclamazioni, sensazioni a tre, che si faceva denso, stringente, incalzante, via via che la signora, desolata e implorante compren45 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città sione e aiuto, apriva sportelli, cassetti, armadi, valige, ripostigli, scatoloni… e, infine, stremata, il forno: il tutto stipato fino all’inverosimile di locandine, manifesti, foto di scena, ritagli. Compreso il “dramma”, fui informato dell’intenzione di Soccio di cedere gran parte della collezione, “chiusa” in sé e di fatto tematica: quasi esclusivamente cinema italiano, e organizzata entro termini temporali abbastanza definiti e circoscritti: anni ’20/’60 (ma con esemplari fino agli anni ’80). Obiettivo della decisione era la non più segreta speranza di trasformare, scambiare i due sogni di una vita: il cinema e una casa di proprietà! (l’esclamativo è d’obbligo, per una storia che sembra venire fuori da quegli anni sì, ma raccontata dal cinema di qualche decennio prima; e che, si sussurra, potrebbe aver ispirato, viceversa, quella sulla quale Tornatore costruì il suo Nuovo Cinema Paradiso da Oscar). Non si affacciarono dubbi di sorta sulla utilità dell’acquisizione, anzi sulla straordinaria occasione che si presentava di documentare una vicenda personale non comune e, insieme, una serie altrettanto importante di implicazioni: un pezzo di storia culturale di una comunità attraverso la distribuzione cinematografica e la sua programmazione (tutta da indagare, al di là delle suggestioni provenienti… dal cinema); e quella, “interna” e specifica, della grafica applicata ai manifesti e, ovviamente, del cinema italiano del periodo rappresentato. Ma quante buone intenzioni e azioni si impantanano, per cause ben note o per ragioni (apparentemente) misteriose? (A proposito: la burocrazia, di cui si lamentano cittadini, operatori culturali, industriali, politologi, analisti sociali…, è un “mistero”, un alibi, o un unico grande, diffuso “ministero”; il “Grande Fratellastro” di una società perennemente in bilico tra lamento e scaricabarile?). Questo non fu il caso. Nel giro di qualche mese, col sostegno immediato e incondizionato dell’assessore del tempo, Leonardo De Luca, “appenninico” pragmatico e fidente, la trattativa era conclusa. Non si rivelò particolarmente complicata, anche perché non fu difficile battere la concorrenza, prestigiosa, ma debole nell’occasione, di Arturo Carlo Quintavalle e del suo Archivio dell’Immagine dell’Università di Parma: la sua offerta, infatti, - un’auto di lusso - non interessava minimamente i Soccio. Matteo, infatti, era impiegato presso una concessionaria Citroen ed entrambi… sognavano una loro casa, altro che una nuova macchina. La parte più impegnativa dell’operazione, ma anche più interessante, riguardò l’acquisizione di pareri culturali e tecnici di congruità; che furono forniti da Gianni Attolini, allora ricercatore presso la cattedra di Storia dello spettacolo dell’Università di Bari e da Luciana Zingarelli, storica dell’arte. Prima della fine del 1985 l’operazione era conclusa. Tra le poche, nel novero di quelle in qualche modo riconducibili al mio diretto impegno, che sento di sottoscrivere in pieno, perché completamente rispondente all’idea che sempre ho coltivato del ruolo di un’istituzione culturale pubblica: di attiva e dinamica conservazione/innovazione. L’indubbia rilevanza dell’acquisizione mise in moto l’imperativo di non chiudere i materiali nel cassetto. Cominciò il solito lavoro di indagine sulle norme e di messa a punto delle tecniche di descrizione (di questo e d’altro riferisce Antonio De Cosmo ne suo Rita Haywart e il suo doppio. Diario grafico graficocatalografico, apparso in «la Capitanata», nel n. 2 del 1994); sulle modalità di conser46 Guido Pensato vazione e, contestualmente, di riproposta. Dall’ansia di rendere immediatamente concreto quest’ultimo obiettivo, “in parallelo” e non “dopo” le procedure di descrizione, che furono realizzati un intensissimo incontro con Vincenzo Mollica, nascente e già brillante divulgatore-raccontatore di storie e personaggi legati al cinema, al fumetto, alla musica e una piccola mostra presso il Palazzetto dell’Arte, dedicata al duo Rota-Fellini e collegata ad un concerto dei Solisti Dauni su musiche del compositore milanese, tanto legato alla Puglia e all’ensemble foggiano, che aveva diretto tra il ’73 e il ’77 e per il quale scrisse espressamente nel 1977 il quinto tempo, “Presto”, del suo Nonetto, cui aveva lavorato già in due precedenti riprese, nel ’59 e nel ‘74. La collezione di manifesti della Biblioteca Provinciale - lo sta ampiamente dimostrando - è una fonte inesauribile di suggestioni e di iniziative, ma anche di ricerche trasversali e in profondità. Ma non va dimenticata la particolare storia che l’ha originata. Non sarebbe, perciò, disdicevole conservare, nell’intitolazione, il nome dell’avventuroso collezionista: Matteo Soccio. La memoria porta sempre il nome di uomini. 12. L’Archivio della Cultura di Base, ovvero, la biblioteca si nega: due volte All’atto del mio ingresso in Biblioteca Provinciale come vicedirettore, si verificò una sorta di tacita attribuzione di compiti, che mi destinava (fu davvero così, o mi sembrò che così fosse, o “decisi” che così dovesse essere; o, infine, mi sembra di poter ricostruire che questo si sia verificato?) ad avere un’attenzione particolare ai meccanismi, ai soggetti e ai percorsi considerati e di fatto non “ufficiali”, non tradizionali, non consueti rispetto a quelli delle istituzioni culturali pubbliche. Una “assegnazione” che, facendosi ruolo istituzionale, sembrò derivare da una dato generazionale (avevo ventisei anni) e da una storia personale e culturale (cui, peraltro, in queste pagine si è, direttamente e indirettamente, fatto cenno); fatto sta che il tutto assunse rapidamente anche le forme di una sorta di routine: un filo diretto con i giovani (l’informazione bibliografica e l’assistenza nella compilazione delle tesi di laurea restano tra le esperienze più interessanti, istruttive e “rivelatrici” tra quelle da me fatte nell’intero settore) e con le organizzazioni spontanee e le articolazioni culturali “non formali” presenti ed emergenti: dai Circoli del Cinema - le esperienze si inseguivano e moltiplicavano - al Cidi, dal Gruppo Speleologico Dauno ai Centri Servizi Culturali, all’Arci, alla Mathesis, ai Solisti Dauni, al Laboratorio Artivisive, ai gruppi che affiancavano, ora formalmente, attraverso i “comitati di gestione”, ora informalmente, le biblioteche comunali. Nei confronti di tale universo finivo spesso col rappresentare me stesso e la biblioteca, fino al punto di esservi coinvolto direttamente, personalmente, appunto, in qualche caso fin dall’atto della nascita dei gruppi. Le vicende dell’Archivio della Cultura di Base sono dentro tutto questo e ben più in là di tutto questo. Difficile, complessa da raccontare, da sintetizzare, se non affidandosi anche ad alcune brevi citazioni risalenti alle diverse fasi, vere e proprie epoche che quella storia ha subito, riemergendo con una prepotenza degna di 47 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città una riflessione ben più ampia (e forse distaccata, ammesso che questo ne garantisca l’attendibilità) di quella che queste righe riusciranno ad assicurare. Come vedremo, materia e soggetti in grado di garantire che ciò avvenga non mancano. E non è un caso che, in qualche misura, sia già avvenuto. La storia delle biblioteche italiane - delle biblioteche nel loro complesso, non quella delle singole strutture, né quella dell’ “organizzazione” o del “sistema” bibliotecario, tuttora inesistente - è una storia antichissima e nobilissima; recente e “miserabile”: eppure/oppure, se si vuole, “eroica”; recentissima e sulla strada di una rapidissima e “incredibile” “riabilitazione”, di un sostanziale riaccreditamento: non irreversibili, né generalizzati. Sinteticamente si potrebbe dire che i problemi appena passati o ancora attuali delle nostre biblioteche sono riconducibili a una incapacità storica dei ceti dirigenti - politici (in senso lato) e intellettuali (in senso lato) - di far germinare un presente e un futuro da uno straordinario passato, ridotto viceversa a peso retorico ingombrante e ingestibile e perciò spesso votato al degrado. Nemmeno nelle fasi cruciali di “modernizzazione” che hanno caratterizzato le vicende post-unitarie, quelle del Fascismo e quelle del secondo dopoguerra, le biblioteche, come altri luoghi nodali del rapporto società-formazione-cultura-economia, sono state individuate e sono riuscite ad imporsi come strumenti al servizio di un paese moderno. Non è un caso, a conferma della stretta connessione tra sviluppo della democrazia e affermazione del concetto di biblioteca pubblica, che questo venga a maturazione, qui da noi, solo a partire dagli anni ’70 del XX secolo, a cento anni dall’analogo processo verificatosi in paesi come l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Non sorprenderà, quindi, che un tale ritardo temporale se ne sia portati dietro di ulteriori sul piano tecnico, culturale, strutturale, gestionale e così via. Come quello, per non citarne che uno, che qui mi interessa in particolare segnalare e che si è concretizzato nella radicale separatezza, ripropostasi e riprodottasi fedelmente all’interno dei tradizionali istituti culturali, tra cultura “alta”, accademica, ufficiale e, in quanto tale, consacrabile (e non a caso consacrata esclusivamente nella scrittura in senso stretto e dalla pratica e dal riconoscimento delle élites che la producono e consumano) e cultura “popolare”, “bassa”, non accademica, destinata a circuiti “altri”, “esterni”, spontanei, subalterni, non riconosciuti, non consacrati, in quanto quasi sempre consegnati alla oralità. I materiali “minori”, “non librari”, i contenuti, le storie, i testi non organizzati in forme tradizionalmente riconosciute o non provenienti da soggetti individuali e collettivi non altrettanto tradizionalmente “abilitati” e riconosciuti, hanno faticato e faticano tuttora ad essere accettati in gran parte delle biblioteche italiane. Altrove, nei paesi di cultura bibliotecaria matura, essi rappresentano quasi sempre il nerbo, il nucleo centrale delle “collezioni locali” e delle sezioni di “cultura e tradizione orale”. Quando, a metà degli anni ’70, dall’incontro con due giovani ricercatori Giovanni Rinaldi e Paola Sobrero - prese l’avvio il progetto di costituzione nell’ambito della Biblioteca Provinciale, dell’Archivio della Cultura di Base, mi sembrava chiaro che di questo si trattasse: della preliminare negazione dello statuto tradizionale, della messa in discussione, non solo della “natura” apparentemente 48 Guido Pensato immutabile della biblioteca, ma della sua natura “incompleta”; della incompletezza, cioè delle sue funzioni, del suo ruolo istituzionale, esclusivo ed escludente, della conseguente incompletezza delle sue raccolte, delle sue tecniche di raccolta e di acquisizione, di trattamento e di descrizione dei materiali. La grande “fortuna” che per ragioni diverse - dalla maturazione delle tematiche del decentramento amministrativo e della più diretta e diffusa partecipazione democratica a tutti i livelli, fino all’attenzione e al ruolo nuovo che assumevano le “chiese locali” - si guadagnarono la cultura popolare e quella materiale, apriva, se non le porte di tutte le istituzioni culturali pubbliche, quanto meno ampi spiragli nel dibattito tra gli operatori, i quali ponevano con decisa problematicità la questione della costituzione di sezioni e dipartimenti programmaticamente dedicati alle espressioni e alle testimonianze di quelle culture. Quella che allora definivamo “indifferenza” (in pratica un’apertura problematica) rispetto alla localizzazione di tali sezioni presso biblioteche, musei, archivi-centri di documentazione (Guido e Rino Pensato, Storia locale, cultura popolare e biblioteca: il caso dell’Archivio della cultura di base, in La memoria che resta. Vissuto quotidiano, mito e storia dei braccianti del Basso Tavoliere, Foggia, Biblioteca Provinciale, 1981), non impediva (e non impedisce tuttora) che altrettanto chiaro apparisse a me, in quanto bibliotecario, e a loro, in quanto ricercatori demoantropologici, il perché dovesse essere e fosse proprio una biblioteca a sperimentare il percorso ipotizzato. Non era/è, infatti, la biblioteca pubblica moderna, il luogo e lo strumento della conservazione della memoria individuale e collettiva; in particolare di quella “locale” e di quella fortemente e precocemente deperibile; nel caso soprattutto, ed era/è il nostro, di una struttura a forte vocazione territoriale? Ma non è così, anche e soprattutto in questo caso, nel caso, cioè, della “cultura locale”, della produzione culturale locale “marginale”, e dell’istituzione culturale dichiaratamente, programmaticamente, decisamente orientata alla circolarità della azioni e degli interventi; schierata, cioè, sul versante dell’uso, della “restituzione” agli utenti delle risorse informative e documentarie, delle fonti? O almeno, non avrebbe dovuto, non dovrebbe essere tuttora questo? Le attività dell’Archivio suscitarono un indubbio interesse, ben oltre la dimensione locale e sui piani diversi su cui si realizzavano: da quello strettamente biblioteconomico (sia pure in un senso radicalmente e consapevolmente innovativo), a quello più ampiamente demoantropologico e storico-culturale. Basti pensare a un solo tema, esemplarmente cruciale e trasversale, particolarmente in quegli anni, ma che potrebbe essere riproposto (e forse si ripropone) oggi, in termini sostanzialmente analoghi. Mi riferisco al tentativo che, tra gli altri, l’Archivio pretendeva di rappresentare e realizzare: quello di contribuire a far uscire (protagonisti e interpreti di) quella parte rilevante, soprattutto in Capitanata, della storia locale e della storia generale del Paese che riguardava le cosiddette “classi subalterne” appunto, dal ghetto della marginalità in cui, nel suo complesso, si è sempre collocata e dibattuta, se e perché non “trattata” con gli strumenti, i metodi e le fonti della storiografia ufficiale; ma anche dalla apparentemente ineluttabile e permanente tendenza a scrivere e trasmettere acriticamente la mitografia individuale e collettiva di una 49 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città classe, o meglio: di un’avanguardia di una classe e di ceti popolari, in quanto militante e, soprattutto, in quanto “organizzata” in apparati e istituzioni. Si provava, inoltre, a proporre una lettura dei termini “avanguardia” e “militante” non necessariamente ed esclusivamente in senso strettamente politico, ma anche semplicemente perché agite sul terreno (politico) della cultura, delle proprie, originali, autonome forme e modalità di espressione, di “scrittura” in senso lato e comunicazione; forme e modalità fondate su una forte (perché politica e culturale) consapevolezza di sé come protagonisti e interpreti, ma anche in grado di proporsi come “oggetti” e questione storiografica non chiusa e di politica della cultura aperta all’investigazione e alle decisioni di istituzioni anche diverse: biblioteche, musei, archivi, centri di documentazione. Se queste furono le intenzioni, più o meno esplicitate, in ogni caso accompagnate da una forte consapevolezza e oggi altrettanto chiaramente ricostruibili, le azioni concrete riguardarono oggetti di interesse, metodologia e strumenti di indagine, di raccolta e di riproposta e, infine, risultati che si andarono progressivamente arricchendo e complicando. Testimonianze orali, individuali e collettive, raccolte in audio e in video, campagne fotografiche, videoregistrazioni e filmati sulla storia dei braccianti del Tavoliere, dei protagonisti delle lotte, sui testimoni e “narratori” delle stesse; sui grandi miti e i grandi riti collettivi, laici e religiosi - Di Vittorio, il 1° Maggio, il Carnevale, il teatro popolare dei “ditt” garganici, la Cavalcata degli Angeli dell’Incoronata -; tematiche, e relativi materiali raccolti, riproposti, innanzitutto nei luoghi e tra i protagonisti stessi della ricerca, ma anche altrove, dalla Puglia al Ferrarese, in spazi deputati e no, dalle scuole alle Camere del Lavoro, dalle biblioteche alle gallerie d’arte, attraverso mostre, proiezioni, dibattiti, convegni. Una mole ingentissima di documenti, in gran parte destinati alla sparizione, perché disconosciuti dai circuiti e dai meccanismi tradizionali e ufficiali della memoria, della storia e della cultura e soprattutto per questo (oltre che per le intrinseche caratteristiche degli strumenti e dei supporti impiegati per la trasmissione) “deperibili”, divenne oggetto e materiale per la ricostruzione di storia e di storie, per la discussione di temi e problemi presenti e la definizione di progetti. L’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici, reso possibile dall’intervento istituzionale, migliora la qualità delle rilevazioni ed estende il raggio d’azione della ricerca a tutti i paesi della Capitanata che, aderendo al Sistema Bibliotecario Provinciale, diventano dei veri e propri terminali dell’Archivio, creando una vasta rete di collaboratori, associazioni, ricercatori e storici locali. Il progetto stesso a questo punto si estende all’obiettivo di rappresentare attraverso tutte le fonti disponibili le specifiche caratteristiche della memoria popolare dei diversi territori indagati” (Giovanni Rinaldi, Braccianti. Il silenzio e la memoria, in «Il de Martino», n.14/2003). Ma è in particolare la ricerca sui braccianti (avviata da Rinaldi e Sobrero prima della costituzione dell’Archivio e proseguita nell’ambito e attraverso lo stesso), rifluita in gran parte in La memoria che resta, a rappresentare un modello, al quale 50 Guido Pensato tuttora si fa riferimento, se Cesare Bermani, nel presentare il fascicolo della rivista dell’Istituto Ernesto de Martino dedicato a “Oralità, classe operaia, ricerca sul campo” («Il de Martino», n.14/2003), la definisce la “più importante ricerca che sia stata fatta nel nostro paese su una zona di bracciantato agricolo, quella del Basso Tavoliere di Puglia”. Non sorprende, pertanto, che la stessa pubblicazione de La memoria che resta venga considerata da Sergio D’Amaro, in un articolo dal titolo Capitanata: culture e territorio, apparso su «La Grande Provincia» del 19 marzo 2003, una svolta nell’approccio alla microstoria. Non più solo era ‘interessante’ la grande storia o la storia degli altri, ma diventa ‘interessante’ la storia dei piccoli e la storia del ‘vicino’, grazie al documento parlante. Non era la museificazione del mondo contadino, né la sua esaltazione acritica. Ciò che prima era sembrato il ‘confine di Eboli’, la ‘porta dell’inferno’, l’ ‘altro mondo’, la ‘riserva indiana’, capace al massimo di fruizione folklorica, entrata invece come nuova frontiera nella piazza dei nuovi discorsi su ciò che era stato e voleva essere una parte del Mezzogiorno. Al di là dei riconoscimenti raccolti e dell’interesse suscitato, lentamente, progressivamente, inesorabilmente (ma non del tutto inspiegabilmente) gli spazi andarono via via restringendosi: dapprima attraverso l’impiego delle armi tradizionali e sostanzialmente occulte, non dichiarate, delle difficoltà “burocratiche e finanziarie”; quindi in maniera esplicita, “amministrativa” e “politica”. Il luogo istituzionale per la decisione, amministrativa e politica appunto, fu la Commissione Pubblica Istruzione e Cultura della Provincia. Alla massiccia illustrazione-proiezione-audizione-visione dei materiali raccolti e prodotti non seguì una discussione/messa in discussione né dell’attività dell’Archivio, né dei risultati conseguiti. Tutto si incanalò verso una pretestuosa messa in questione del ruolo dei ricercatori rispetto all’Amministrazione, che assunse i chiari connotati di un’operazione condotta in nome e per conto di settori interni all’apparato - dell’amministrazione e della biblioteca che avevano da sempre mal sopportato l’ “intrusione” e che avrebbe successivamente dato luogo a una sorta di “vertenza”, non formalizzata ma strumentalmente agitata, circa la titolarità giuridico-culturale dei materiali raccolti. Il gioco fu, insomma, condotto in modo esplicito e strisciante nello stesso tempo; in ogni caso “scoperto” e contemporaneamente reso più complicato e contraddittorio dalla posizione assunta dal rappresentante di uno delle forze politiche di opposizione, Michele Marinelli dell’ M.S.I. (la maggioranza che governava in quegli anni la Capitanata era di sinistra), il quale dichiarava il suo totale apprezzamento, nel merito scientifico e culturale, per il lavoro svolto, al di là della lettura che, sul versante dei contenuti, se ne dava. Detto della (malcelata) opposizione di natura sindacal-corporativa, si può provare a riassumere e spiegare, a memoria e per sommi capi, la singolare articolazione delle posizioni che si manifestarono in quella occasione nel modo seguente: 51 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città a) dato per scontato il carattere strumentale della “difesa Marinelli” di cui si è detto, non può tuttavia escludersi, anche per le caratteristiche e le qualità del protagonista, tutt’altro che “rozzo” o “incolto”, un ancoraggio culturale e politico della stessa. Non si dimentichi che Foggia e la Capitanata furono uno dei luoghi “privilegiati” di esercizio di una delle irriducibili ambiguità, delle doppiezze permanenti e consapevolmente irrisolte del Fascismo e di quegli anni. È qui, infatti, che le squadracce di mazzieri organizzati e capeggiati da Caradonna compirono le imprese più feroci nei confronti di braccianti e contadini e al fianco degli agrari; qui, come altrove, si sperimentava la retorica “ruralistica” e delle “tradizioni popolari”. Risalgono a quegli anni, per non fare che qualche esempio all’insegna di un solo nome, gli studi e le attività promozionali di Ester Lojodice (seguace degli insegnamenti di Nicola Zingarelli), le elezioni delle “reginette del grano” (in auge, peraltro, già agli inizi del secolo), la costituzione presso il museo del capoluogo di un’apposita sezione dedicata alle “tradizioni popolari”, appunto; b) la crescente insofferenza dell’Amministrazione, della maggioranza di sinistra che la governava in quegli anni (di quanti rappresentavano l’una e l’altra) nei confronti dell’Archivio, va messa in relazione al fatto che esso si muoveva sulla base di un progetto e un programma definiti dal punto di vista metodologico e delle strategie di indagine e di riproposta, ma pensato e gestito “programmaticamente” come strumento e per mezzo di strumenti, con modalità e attraverso percorsi - diretti spontanei non formalizzati né soprattutto mediati - che lo resero “sospetto”, nella misura in cui se ne verificava una capacità di suscitare adesioni, azioni, “parole” altrettanto non formalizzate, non controllate attraverso i consolidati canali e meccanismi della mediazione politica istituzionale. Si noti, infine, che in nessuna occasione venne meno da parte della Direzione della biblioteca (leggi Angelo Celuzza) l’apprezzamento positivo per la qualità che aveva caratterizzato i programmi e le attività dell’Archivio e per la mole e la natura dei risultati conseguiti; c) all’interno della storica patologia da cui sono affetti tutti gli apparati precocemente o lentamente consolidati in posizioni di presunto o reale potere politico, burocratico o culturale, va considerata pressoché nella norma (è accaduto anche nei confronti del tema e del processo di informatizzazione dell’amministrazione pubblica) la istantanea e pregiudiziale ostilità con cui fu accolta l’esperienza dell’Archivio all’interno della biblioteca: 1. perché considerata “esterna” ed “estranea”, appunto. Si trattava, in effetti, di una delle prime esperienze del genere, nell’ottica di considerare la biblioteca il naturale luogo di incrocio e di incontro di professionalità, abilità e ambiti disciplinari diversi, soprattutto in una fase in cui le biblioteche sembravano (mi sembravano, ci sembravano) non potersi sottrarre a una messa in discussione di uno statuto tecnico-culturale e di una strumentazione del tutto coerenti con una secolare e fallimentare tradizione e tanto più inadeguati rispetto alle domande e alle sollecitazioni culturali e professionali allora prevalenti; 2. perché in aperto conflitto con la storiografia localistica, ancillare e subalterna rispetto a quel52 Guido Pensato la ufficiale e accademica, della quale traduceva “in minore” un’eco di rifiuto ed estraneità rispetto agli strumenti, alle metodologie e al sistema delle fonti propri della “storia orale” e della sua statutaria propensione al “nomadismo disciplinare” e a un programmatico capovolgimento delle gerarchie degli “oggetti”, oltre che delle fonti. E si trattava di uno stato di cose solo marginalmente scalfito dall’ormai consolidata fortuna della “microstoria” e dalla generale attenzione - frutto di un preciso clima politico sociale e culturale - riservata proprio alla cultura orale e a quella materiale; 3. perché queste posizioni venivano oggettivamente incoraggiate dai limiti di settorializzazione, autoreferenzialità, scarsa collegialità e circolazione delle esperienze che affliggevano la biblioteca. Attendibile o tendenziosa che sia o appaia questa lettura “a posteriori” degli eventi, resta il dato storico che la voce relativa all’Archivio scomparve dai programmi dell’Ente, inducendo la biblioteca a “negarsi” per la seconda volta: in questo caso, nel segno di un rappel à l’ordre. Ma, come è noto, la memoria resiste. E infatti quella che sembrava una morte decretata, si rivelò semplicemente presunta e, col passare degli anni, invece di trasformarsi in una dichiarazione valida a tutti gli effetti giuridici e culturali, si confermò per quello che era e molti speravano che fosse: una morte apparente. La vita dell’Archivio riprendeva altrove. Già nel 1985 Sergio De Sandro Salvati aveva realizzato un documentario, Frammenti di memoria, basato, per la parte sonora, sulle registrazioni trascritte ne La memoria che resta. Da allora in poi, quelli che erano stati riconoscimenti e attestazioni - in vita e post mortem - hanno cominciato a dar luogo a sistematiche riesumazioni (mi si scusi l’insistita ma scaramantica metafora all’insegna della necrofilia) di quello che si è rivelato una sorta di vero e proprio “cadavre exquis”, ricco ancora di vitalità e suggestioni creative. Il rapido esaurirsi della tiratura iniziale de La memoria che resta, non aveva impedito una sua costante circolazione tra addetti ai lavori in senso stretto e, più in generale, tra operatori culturali e artisti. L’ultimo significativo effetto di questa “persistenza” è la stampa, a grande richiesta, di una nuova edizione (Lecce, Aramiré, 2004), riveduta e ampliata, con una piccola variazione nel sottotitolo Vita quotidiana, mito e storia dei braccianti nel Tavoliere di Puglia - e corredata di due cd che raccolgono i canti e i racconti registrati sul campo. Si tratta di un evento che si verifica mentre sono ormai disponibili in rete (www.progettobraccianti.it) la gran parte dei nastri magnetici originali e le immagini fotografiche; premessa, forse, di una auspicabile inversione di quel processo che Cesare Bermani, nella sua Introduzione alla storia orale (Roma, Odradek, 1999), lamentava aver colpito l’esperienza dell’Archivio: le cui testimonianze sono finite con filmati, fotografie e manoscritti in un armadio della Biblioteca Provinciale di Foggia. Altri materiali sono presso gli archivi personali dei ricercatori, presso quello di Roberto Leydi, presso l’Istituto Ernesto de Martino […] un caso tipico di smembramento di una ricerca importante. 53 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città In effetti - a conferma di una sorta di “effetto domino” che si produce intorno ad esperienze multidisciplinari e strutturate tra i poli della ricerca e della riproposta lo stesso lavoro che ha prodotto la nascita del sito, era finalizzato, in prima istanza, alla produzione di uno spettacolo teatrale (si noti, peraltro, che l’esperienza di Giovanni Rinaldi e Paola Sobrero proprio dal teatro era partita; aveva, infatti, preso le mosse, nel 1973-74, da quelle drammaturgiche realizzate, nell’ambito dell’appena nato Dams bolognese, intorno al Gorilla Quadrumàno di Giuliano Scabia e al “teatro di stalla”). Da oltre un anno un progetto, “teatrale e multimediale”, intitolato Braccianti. La memoria che resta, costruito intorno ai materiali dell’Archivio e realizzato dalla compagnia Armamaxa, viene rappresentato in varie località italiane, Capitanata compresa. Ma i frutti irriducibili e “squisiti” hanno assunto anche veste musicale. Un musicista e compositore di origine foggiana, Umberto Sangiovanni, così racconta la svolta imposta al suo lavoro artistico e a quello della sua DauniaOrchestra: Cercavo una chiave di racconto di me stesso, un elemento ispiratore forte: l’ho trovato tre anni fa su una spiaggia del Gargano, grazie a un amico che mi ha fatto leggere un libro, La memoria che resta: ho capito che dovevo partire dalla mia terra e da una sana nostalgia. (Intervista di Claudio Botta a Umberto Sangiovanni, in «Profili», II, 2004, febbraio). E infine: Fahreneit è un programma molto popolare di Radio Rai Tre, che, tra l’altro, ha diffuso in Italia la pratica del book crossing e che, all’interno del contenitore generale, mette a disposizione degli ascoltatori-lettori una rubrica di “caccia al libro introvabile”. Nella trasmissione del 31 maggio 2002, Alessandro Piva, regista di La Capagira (1999), “caso” cinematografico non solo italiano, lanciava un appello perché qualcuno gli procurasse una copia de La memoria che resta. Stava coltivando l’idea, infatti, di costruire un film dedicato ai braccianti pugliesi, partendo dalle storie e dalle vicende raccontate anche in quelle pagine. Quel progetto va avanti. Grazie anche a una biblioteca, quella di Lugo di Romagna, come si può leggere nell’appello lanciato da due bibliotecari, Sante Medri e Igino Poggiali, attraverso il sito del Comune e a firma dell’assessore Dante Ferrieri: Nel marzo del 1950, la città di Lugo fu protagonista di un particolare episodio di solidarietà. Ospitò per due anni bambini, figli di braccianti imprigionati in Puglia per aver lottato per i propri diritti. Ora il regista Alessandro Piva vuole trasformare questa storia in un film “Il treno della felicità” e sta cercando documenti, materiali, testimonianze per ricostruire la vicenda. E veniamo ai fatti. Per raccontarli riportiamo uno stralcio di un articolo pubblicato da «la Repubblica - Bari» del 23 marzo 2004. “I braccianti davanti ai carri armati. Il 23 marzo 1950 la lotta al grido di ‘pane e lavoro’ cambiò la vita a San Severo (Foggia). A fermare la rivolta arrivò l’esercito. Un morto, centinaia di feriti e 180 arrestati. Uomini e donne, in carcere per due anni. E, soprattutto, i loro bambini incustoditi, accolti nelle case di famiglie del Nord grazie a una catena di solidarietà. Il regista Alessandro Piva e lo storico Giovanni Rinaldi stanno cercando ora 54 Guido Pensato proprio quei piccoli che partirono un pomeriggio di primavera sui ‘treni della felicità’. La memoria ricostruita comporrà infatti la sceneggiatura di un film. Ma prima, conta restituire quei giorni a se stessi, riannodare i ricordi del 23 marzo 1950 e delle giornate durissime che seguirono”.[…] Con questo appello ci rivolgiamo a tutti coloro che ricordano o, meglio ancora, hanno conservato documenti, foto o addirittura sono tuttora in relazione con qualcuno di quei ragazzi. Vogliamo creare un archivio di tale documentazione e partecipare alla realizzazione di quel film. Questa potrebbe essere anche l’occasione per avviare la raccolta sistematica di documentazione sulla solidarietà della quale questa città in ogni tempo è stata capace. Per collaborare a questa ricerca occorre prendere contatto con la Biblioteca Trisi. Le biblioteche sono certamente e da sempre luoghi della memoria. La Biblioteca Provinciale di Foggia, attraverso l’Archivio della Cultura di Base, ha saputo farsi anche strumento e soggetto attivo di itinerari nella memoria, per la sua ricostruzione e la sua restituzione a quanti era stata occultata e a quanti era stata rubata. Poche istituzioni lo fecero in quegli stessi anni (il Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo istituì un centro con la stessa denominazione nel 1981). Non molte lo fanno oggi. Ed è vero: Per noi, a cui hanno portato via il sogno di continuare a mescolare le nostre vite e i nostri progetti a quelli della memoria, di individui e di collettività, per farne un tramite di conoscenza e di comunicazione, rimane, oltre al sentimento orgoglioso di aver vissuto comunque un’esperienza straordinaria, la soddisfazione di vederla farsi rappresentazione, musica immagine, di aver ispirato la mente e il cuore di chi è capace di trasformarla e restituirla come una esperienza universale di emozioni, appartenenze, passioni. (Giovanni Rinaldi-Paola Sobrero, La memoria che resta trent’anni dopo, in La memoria che resta…, 2004). È, infatti, indispensabile, a fronte di una memoria che resta e resiste, che resistano e tornino continuamente ad accendersi, da quella memoria, la speranza, il progetto, la creatività. Esattamente come è già stato. 13. (S)Conclusioni, (s)considerazioni quasi finali Al di là di quello che fin qui - tra memoria, racconto e riflessione (auto)critica - traspare e può comunque configurarsi come abbozzo di una valutazione complessiva, gli intenti che percorrono queste pagine non comprendono quello di costituire la base per una analisi critica oggettiva e rigorosa delle vicende narrate. Troppo intensa è stata la passione e troppo calda è tuttora la materia, perché alto fu il livello del coinvolgimento e degli investimenti professionali ed emotivi e perciò, troppo personali, anomale e irregolari le modalità della loro “riscrittura”. Se, quindi, non rinuncio a qualche annotazione (quasi) in chiusura, lo faccio, continuo a farlo al55 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città l’insegna della incongruità, di una in qualche misura ossessiva iterazione di concetti e idee (fisse) e dell’apparentemente casuale affastellarsi di associazioni, spinte e piani diversi, forse non tutti e non completamente “distanziati”. E tuttavia, una lettura di fatti e vicende individuali-collettive, pur non provenendo da uno storico o da un analista di fatti sociali, non è mai completamente arbitraria; soprattutto nel caso di un testimone-protagonista diretto. Quanto meno, ed è questo il caso, “l’interprete” fornisce elementi per un collegamento tra “lettura” e intenzioni, convincimenti, passati e attuali e sulla loro “persistenza” (ed è, ancora una volta, questo il caso). a) La biblioteca e il sistema. La biblioteca fuori del sistema La costituzione del Sistema Bibliotecario e la costruzione della nuova sede della biblioteca si verificarono nel contesto di una realtà, cittadina e provinciale, molto debole sul piano delle strutture e della pratica culturale diffusa. Una debolezza che si sostanziava nell’assenza totale di servizi bibliotecari e culturali di base in pressoché tutti i comuni, capoluogo compreso (se si accetta, come credo sia indispensabile fare, che la “Provinciale” non è, non può essere una “struttura di base”, in quanto struttura più complessa dal punto di vista territoriale e delle funzioni); in una conseguente estraneità, generalizzata e specifica (per esempio del mondo della scuola), rispetto alla cultura scritta e alla fruizione culturale in genere: libri acquistati e librerie presenti e parametri analoghi per cinema, teatro, musica offrivano indicatori quantitativi e qualitativi eloquenti; e offrono tuttora, come attestano, assegnando sistematicamente da anni a Foggia una delle ultime posizioni, le indagini sulla “qualità della vita” in Italia. La generalizzata - e in qualche modo anche esplicitata - fame di opportunità (nemmeno lontanamente appagata, se non attraverso i nuovi consumi “primari” indotti, da una nascente società di massa) creava, anche per le ragioni appena dette e negli anni di cui parlo, condizioni certamente favorevoli, forti aspettative, ma anche impegni e compiti ardui. Quello di coinvolgere centinaia di amministratori e dirigenti locali sui temi della biblioteca pubblica si mostrò e fu straordinario e dette risultati straordinari, se nel giro di qualche anno i comuni della Capitanata (salvo quello delle Isole Tremiti) che ne erano privi ne avevano istituita una. Le condizioni nelle quali versavano quelle preesistenti, dei centri più importanti - Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Torremaggiore, ecc. - si possono immaginare e rendono (e rendevano) del tutto misteriose le regioni che ne motivarono l’esclusione (l’autoesclusione) dal Sistema. Sistema che ha vissuto momenti e vicende di grande rilevanza per molte comunità locali. Per anni l’organizzazione centrale garantì i servizi di acquisto, catalogazione, circolazione e prestito dei materiali librari e un’attività di formazione degli addetti, sia pure, per quel che riguarda quest’ultimo aspetto, senza sistematicità e continuità e, quindi con risultati largamente insoddisfacenti (anche per i preliminari limiti oggettivi e soggettivi del meccanismo di reclutamento e selezione). I bibliotecari comunali poterono contare su un’assistenza costante, 56 Guido Pensato soprattutto sul terreno della costruzione di una immagine e di una concreta pratica della biblioteca pubblica, strettamente collegate alle specifiche realtà servite. Rapporti con il mondo della scuola, con i gruppi organizzati, costituzione dei “comitati di gestione”, attivazione di programmi culturali, di cicli di conferenze e dibattiti e di cineforum: il ventaglio delle iniziative fu ampio e sempre accompagnato dal consenso e dalla maturazione dell’idea che la biblioteca potesse essere il centro della vita delle comunità locali. A distanza di anni, considero le esperienze fatte nell’ambito del Sistema come la punta più alta di verifica della “necessità”, della insostituibilità di una rete diffusa di strutture culturali di base: ancora di più oggi, in presenza di eccezionali canali e strumenti per la circolazione e lo scambio di informazioni e conoscenze. Si trattò, allora, di esperienze fondate sulla paziente e attenta tessitura di rapporti umani e culturali, di “ascolto” e di attenzione alle esigenze, soprattutto inespresse, di giovani e adulti generalmente tagliati fuori dai circuiti, dai meccanismi e dalle opportunità di una comunicazione culturale e di una socialità ricche, aperte e dialoganti, capaci di valorizzare, nell’incontro e nello scambio, intelligenze, creatività, saperi mutilati dall’isolamento, dall’afasia. A distanza di anni, alcune situazioni nate o maturate in quell’ambito sono tuttora o ormai solide. Molte altre sono ripiombate nella tradizionale marginalità, altre sono letteralmente scomparse; e proprio nelle realtà che più ne avrebbero bisogno, perché minuscole e periferiche. Tentativi di arginare un processo di degrado che alla fine si rivelò inarrestabile furono compiuti, da molti bibliotecari comunali e da quelli che, all’interno della Biblioteca Provinciale, “si occupavano del Sistema”, prima e ben oltre il momento in cui segnali espliciti annunciavano che il suo destino era segnato. Ma quel che avvenne mi appare chiaro, oggi più di ieri, quando la voglia di non arrendersi induceva a fare, a tenere in piedi il minimo di contatti, di iniziative rese possibili da una situazione profondamente mutata, ma che ci sembrava, volevamo credere rimediabile, perché incomprensibile, ingiustificabile quello che stava accadendo. Vi fu, incontrovertibile e decisiva, una responsabilità politica e culturale “storica” della Regione, fin dall’epoca della sua istituzione, successiva a quella dei “sistemi bibliotecari”. Furono i prodromi di un nuovo centralismo - di apparati politici e burocratici - che, in Puglia più e più precocemente che altrove, faceva le prove in danno di un reale decentramento di funzioni e poteri decisionali e di gestione. Assistenzialismo e clientelismo, latitanza legislativa e programmatoria, latitanza e assenza tout court produssero, nel giro di qualche anno, dal momento del trasferimento delle competenze dallo Stato, un arretramento della situazione disastroso, perché fondato sull’esplicito lavoro di distruzione dell’idea stessa di cooperazione interbibliotecaria e di sistema di biblioteche. Perché un programma, una legge, la cooperazione mal si conciliavano con le pratiche - spartitorie e dissipatrici - che avrebbero per lustri dominato, nel settore delle biblioteche e della cultura in genere, la vita regionale. Eppure si trattò di un arretramento che si sarebbe forse potuto arginare - e per qualche anno lo si fece - se un analogo, progressivo e parallelo disimpegno dal sistema bibliotecario, dalle logiche che ne giustificavano e sostene57 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città vano la costituzione e l’esistenza, non fosse stato perseguito, con meticolosa sottovalutazione e costante disattenzione, dall’Amministrazione Provinciale di Foggia. Potrei fermarmi qui, perché sono convinto che la rescissione del legame Sistema Bibliotecario/Biblioteca Provinciale, la separazione delle rispettive sorti, la liquidazione del primo e, di conseguenza, il ridimensionamento - “territoriale e funzionale” - della seconda, siano dati di fatto ed eventi strettamente collegati. Ma ci fu (c’era già stato) altro, perché quei dati e quegli eventi erano già in germe negli stessi atti costitutivi di tutta la vicenda Sistema Bibliotecario/Nuova Biblioteca. Il Sistema Bibliotecario fu forse concepito, certamente fu, successivamente alla istituzione e nei fatti, gestito e vissuto dalla Biblioteca Provinciale, nell’ambito della stessa e rispetto alla stessa, come un suo servizio, come uno dei suoi servizi e non come il “sistema delle strutture e dei servizi territoriali” del quale anche essa era parte. Questo avrebbe dovuto essere il rapporto tra i due soggetti. Era stata infatti la prefigurazione di questo tipo di relazione che aveva portato alla istituzione del Sistema e alla costruzione di una nuova sede della biblioteca, “in quanto struttura centrale di riferimento” del sistema e quindi come insieme, a sua volta, di risorse, competenze, funzioni, procedure e servizi inseriti nell’ambito e a disposizione del sistema. Non essendosi proposto il rapporto Biblioteca Provinciale/Sistema Bibliotecario in termini corretti e coerenti rispetto alla stessa “logica di sistema”, nessuno dei settori della biblioteca è stato mai davvero, e al di là di singole sporadiche occasioni, fino in fondo, sistematicamente perché programmaticamente, al servizio di tutto il territorio provinciale; se non nel senso di subire i meccanismi spontanei che governano la formazione della domanda individuale (e talora collettiva) nei confronti delle istituzioni culturali in genere. A questi limiti va aggiunta la ricordata e (tuttora) perdurante assenza nel capoluogo di un sistema urbano di servizi bibliotecari di base, cui pure in quella fase si cercò di cominciare a porre rimedio, con risultati al limite del credibile: l’offerta della costruzione di una moderna biblioteca nel quartiere CEP di Foggia, formulata dall’Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche, che se ne accollava gli oneri, a fronte della messa a disposizione del suolo, fu lasciata cadere dal silente rifiuto del Comune. Il ridimensionamento prima e quindi la liquidazione del “sistema provinciale” produssero effetti negativi nelle singole realtà comunali e, come detto, sospinsero la nuova biblioteca verso una almeno parziale delusione delle stesse aspettative e del complesso di domande e di bisogni, soprattutto inespressi, suscitati e la costrinsero in un ruolo territorialmente circoscritto e indubitabilmente riduttivo, rispetto alle potenzialità e alle risorse, delle competenze e delle funzioni di una “Provinciale”. Un ruolo che appariva una sorta di damnatio, perché quasi iscritto nella sua stessa genesi, in quanto nata da una costola della vecchia “Comunale” e, per questo, quasi segnata da un destino “civico”. Quel processo si accentuò progressivamente, tra anni ’80 e ’90, indipendentemente e nonostante il consolidarsi a livello locale e nazionale dell’immagine della nuova biblioteca; un’immagine consacrata, fin dalla nascita, dalla celebrazione - tra 58 Guido Pensato Foggia e Pugnochiuso - del congresso nazionale dell’A.I.B., cui seguirono - accanto al proliferare di lasciti e donazioni, segnali inequivocabili dell’accreditamento di una biblioteca nei confronti della comunità - iniziative di grande rilievo, sul piano strettamente professionale e ampiamente culturale, di cui è fatto rapido cenno da Angelo Celuzza nel suo I venti anni della nuova Biblioteca Provinciale (in «la Capitanata», XXXI, 1994, 2) e che, fugati i dubbi e i pudori per le autocelebrazioni, una volta ricostruiti, “dalle origini ai nostri giorni”, riusciranno forse, tra l’altro, a lenire almeno parzialmente gli eccessi autocritici e di severità presenti soprattutto in queste mie note. È arduo (accade quando si cerca di individuare, accanto alle “cause prime” e scatenanti, le concause, soprattutto se queste appaiono e sono inestricabilmente collegate agli effetti e viceversa) “pesare” i fattori che hanno concorso, da una parte a non impedire lo smantellamento del Sistema Bibliotecario, dall’altra a ostacolare il completo dispiegamento delle potenzialità della nuova struttura. Mi riferisco sia alla fase di transizione e “costituente” (si passava da una decina di addetti alla Biblioteca Provinciale a sessanta; il che equivale a dire, da una accettabile conduzione “familiare” ad una ineludibile gestione manageriale: ma c’era già la parola?), sia a quella compresa tra gli anni ’80 e ’90. Provo, comunque, al di là di quelli segnalati fin qui, a mettere in fila quelli che mi appaiono oggi degni di essere raccolti in una sia pur sommaria elencazione, mi auguro in qualche modo utile: - la forte centralizzazione delle scelte riguardanti il Sistema, utile nella fase iniziale, in cui si trattava di raccogliere le adesioni dei singoli comuni, controproducente in quelle successive, nelle quali un organismo formale e collegiale di partecipazione avrebbe svolto una funzione di garanzia rispetto agli obiettivi di una maggiore e duratura responsabilizzazione, di una condivisione delle scelte, di continuità oltre le quotidiane vicende e pastoie amministrative; - i meccanismi di reclutamento e di “fidelizzazione” degli addetti alle biblioteche comunali estremamente deboli e precari: compenso scarso/impegno scarso; nonostante alcuni sporadici tentativi, formazione inadeguata, qualificazione e aggiornamento delegati esclusivamente al livello personale e individuale; - l’identica, per quel che riguarda questi temi, anzi, più grave situazione nella quale venne a trovarsi il personale della “Provinciale”, a causa della totale - tradizionale, storica per gli enti locali - assenza di una specifica politica, che si rivelò decisiva, in negativo, per un settore in forte potenziale espansione e investito da processi di intensa professionalizzazione e altrettanto rapida innovazione (definizione e diversificazione delle figure, unificazione e standardizzazione delle procedure, informatizzazione, ecc.). I livelli garantiti dall’autoformazione e da una gestione burocratico-amministrativa e/o genericamente “culturale” dei problemi del personale, si rivelarono del tutto inadeguati; 59 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città - la articolazione in sale e servizi della nuova biblioteca, non accompagnata da adeguati meccanismi e spazi di scambio e confronto, in grado di garantire livelli essenziali di collegialità, di identificazione e coinvolgimento nella programmazione generale dell’istituto. Si produsse, in conseguenza di ciò, un processo di parcellizzazione, superspecializzazione e autoreferenzialità “di settore”, aggravato dalla “estraneità” sostanziale rispetto alla organizzazione del Sistema e che non risultò intaccato dal tentativo (peraltro rapidamente accantonato) di darsi un “consiglio di istituto”, in analogia a quanto previsto per le strutture dello Stato dalla legge istitutiva del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Questi dati finirono con l’apparire via via sempre meno modificabili, perché fu sostenuto e aggravato dalla totale assenza di politiche della formazione e di una sistematica pratica del confronto e dello scambio professionale, che produsse, a sua volta, un consolidarsi, ai limiti della esclusività, di un rapporto già tradizionalmente forte nella pubblica amministrazione, soprattutto del Sud: quello, diretto esclusivo personale e fondamentalmente distorto, con gli apparati sindacali, burocratici e politici (leggi “politico di riferimento”); una fonte tradizionale di confusione, sovrapposizione, contiguità e scambio tra il livello tecnico-culturale (e professionale) e quello politico-amministrativo, che finivano con l’indebolire quello già di per sé debole - il primo - e la sua credibilità e autonomia. Anche questo versante della vicenda può essere ricondotto a un, allora gravissimo, deficit di moderna cultura dell’organizzazione e della gestione; in particolare, di cultura dell’organizzazione e della gestione delle istituzioni e dei sistemi territoriali complessi. Tutto quello che riguardava la sfera culturale e intellettuale e creativa sembrava doversi pregiudizialmente (e snobisticamente/provincialisticamente) sottrarre a logiche (per non parlate delle tecniche) sentite come “estranee”, “tecnocratiche”. E forse si trattava, più semplicemente, di coniugare professionalità, collegialità, partecipazione, responsabilizzazione; parole e concetti, tra l’altro, non estranei al clima dell’epoca, ma evidentemente, sempre particolarmente difficili da praticare. 14. Commiato/i a) Quattro direttori (di cui tre “ex”), ovvero: Il ceppo dauno della biblioteconomia può essere nocivo? Al di là della forzatura, che posso aver imposto a queste pagine, sottolineando ricorrenze plurime, coincidenze, convergenze, il caso ha voluto segnalare una ulteriore particolarità di questa “celebrazione”. Per quanto si possa dire che il caso, nella fattispecie, sono io, proprio perché sono io che mi sono messo sulla strada della ricerca di coincidenze e segnali, è un dato che essa celebrazione veda impegnati ben quattro direttori della Biblioteca Provinciale: tre “ex” e uno in servizio. Ha un ruolo così 60 Guido Pensato predominante il caso, da togliere qualsiasi significato a questo dato: che, infatti, non è una coincidenza. Ben tre “ex”, vivi e vegeti! E un quarto, in servizio, altrettanto vivo e vegeto. È un fatto che vorrà pur dire, da solo, qualcosa…al di là della benedetta e beneaugurante e auspicabilmente e ancora lungamente perdurante ed estensibile (da lui agli altri tre) longevità anagrafica e intellettuale del “Direttore” per antonomasia, Angelo Celuzza! Vorrà, cioè, pur dire qualcosa che in campo - stavo per dire (o sarebbe giusto dire) “sul campo”, “sul terreno” - vi siano un direttore in servizio e tre “ex”, dislocati, questi ultimi, per quel che riguarda l’epoca del pensionamento, in fasce di età comprese tra i 70 e i 50 anni. Che voglia significare, per esempio, qualcosa circa la “nocività” della funzione? Dei tre direttori “in quiescenza”, il primo, Angelo Celuzza, “temprato” da vent’anni di Fascismo, dalla guerra, dal dopoguerra, dalla ricostruzione della biblioteca, “compì l’impresa” di dotare la Capitanata di “una struttura bibliotecaria e culturale fondamentale per ogni ipotesi di costruzione di un sistema integrato di servizi dedicati alla documentazione e alla circolazione delle conoscenze” come amavamo dire e come di fatto è. Eppure non posso dimenticare il sollievo che gli si leggeva sul viso (a meno che non abbia “letto” male), nel lasciarmi il testimone e che si fece, via via che passavano i mesi, più intenso, assumendo i caratteri di una serena riconquistata gioia di vivere (“non riuscivo più a dormire, me li sognavo anche la notte”, si lasciò scappare in un fugace incontro, in una sosta delle sue amate passeggiate). Per quel che mi riguarda, lasciata a mia volta, nel settembre del ’94, la Biblioteca Provinciale, un mese dopo ero impegnato in una ricerca sulle tradizioni alimentari del Gargano, destinata alla Comunità Europea. Tuttora mi dedico con energia e allegria a intense scorribande tra biblioteche, gastronomia e mostre d’arte, vecchi e nuovi interessi, senza denunciare particolari sindromi da vedovanza. Il che mi sembra di poter dire anche di Mario Giorgio, direttore da quella data e fino al 1999. A pensarci bene, la domanda posta in testa al paragrafo può essere anche capovolta: “Foggia nuoce alla biblioteconomia, nelle persone dei bibliotecari, dei direttori di biblioteca?”. Mi auguro di no. Ma soprattutto, mi auguro che non nuoccia alle biblioteche. b) Autocitazione Chiudo il paragrafo su di me: ben sapendo che il percorso del disamore intreccia i rispettivi e reciproci processi di disconoscimento, ridimensionamento di ragioni pregi e meriti, di riconoscimento di torti difetti e limiti. Lo faccio ricorrendo a cose da me scritte per il numero 148-149 (marzo-aprile 1977) di «Italia Nostra», bollettino dell’omonima associazione; non perché siano particolarmente significative e nonostante che siano temporalmente “datate”, ma proprio perché risalenti a circa trent’anni fa (e scritte a tre anni dall’inaugurazione della nuova sede) possono apparire anche moderatamente significative. La nuova Biblioteca Provinciale di Foggia e il Sistema Bibliotecario su di essa imperniato sono due entità strettamente collegate, sorte intorno agli ultimi anni 61 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città sessanta nell’ambito di uno , e non tra i meno ambiziosi, dei rari tentativi di dare un ‘sistema bibliotecario nazionale’ al nostro Paese. Il progetto aveva complessivamente una credibilità notevole, anche perché contrastava con un passato in cui lo Stato non era riuscito ad esprimere nemmeno in via di ipotesi una visione unitaria del problema. Giocava a favore di quel tentativo la diffusa (e effimera) ebbrezza programmatoria e riformatrice di quegli anni. Il tutto, però, conteneva già germi pericolosi e contraddittori: - la pretesa di affrontare il problema della pubblica lettura (di una rete, cioè, di strutture bibliotecarie di base) prescindendo dalla situazione disastrosa in cui versavano i servizi e le biblioteche nazionali; - l’illusione di poter calare dall’alto una iniziativa che riservava al Ministero, quello stesso che non riusciva a svolgere le proprie funzioni di carattere generale, ogni potere decisionale; - la logica dei ‘poli di sviluppo’ che anche nel settore culturale presiedeva alla scelta delle aree in cui andava sperimentato il ‘sistema’; - la incapacità di sollecitare e coinvolgere le forze sociali e culturali, essendo tutto demandato ai livelli tecnici (vedi il boom dell’ideologia degli ‘standards’) o a quelli burocratico-amministrativi (l’Ente Locale come ‘ostacolo da superare’ e non da conquistare al discorso, proprio attraverso il coinvolgimento delle forze sociali); - lo scollegamento rispetto ad altri interventi che, proprio in quegli anni, partivano e investivano particolarmente il Sud e il settore della cultura: l’ “intervento straordinario sul fattore umano” della Cassa del Mezzogiorno e del Formez, che avrebbe finito col porsi su un piano obiettivamente concorrenziale rispetto al progetto del ‘Piano L’ prima e del ‘Servizio Nazionale di Lettura’ dopo. Gli elementi fin qui rilevati sono essenziali alla comprensione della realtà bibliotecaria di Foggia, che si presenta ormai come un ‘fenomeno’ a livello meridionale e nazionale. Dovremmo aggiungerne altri, concorrenti e non marginali e sono poi quelli che hanno impedito il crollo dell’iniziativa fin dalla fase di interregno tra la competenza dello Stato e quella delle Regioni -: la dedizione e la confluenza energie (professionali e politico-amministrative) individuali; la totale assenza in circa il 90% dei Comuni della Capitanata della sia pur minima struttura culturale di base, carenza suscettibile di trasformarsi immediatamente in domanda e disponibilità. Elementi, questi, che andrebbero, insieme ad altri, chiariti e approfonditi per comprendere fino in fondo il fatto certamente ‘anomalo’ della nascita in un’area meridionale di una struttura bibliotecaria d’avanguardia e di un sistema di base comprendente 53 biblioteche, tuttora vitale, pur tra mille difficoltà e contraddizioni.[…] Il tutto concorre a creare lo ‘scandalo’ di una biblioteca che smette di credere che il proprio interlocutore sia il libro e scopre - o quanto meno cerca – gli utenti, quelli attuali e soprattutto quelli possibili, che sono di gran lunga la maggioranza della popolazione della Capitanata. E gli utenti di una biblioteca non si inventano con una tautologia: ‘il libro è importante perché è il libro’ o con una finzione: ‘c’è un libro per tutti’, che sono sempre state, sia pure talora inconsapevolmente, alla base dell’attività delle biblioteche e dei bibliotecari. Gli interrogativi, i dubbi che caratterizzano positivamente l’azione della Biblioteca Provinciale di Foggia possono ridursi alla semplice questione: dato che la collettività non può permettersi di gestire ‘per pochi intimi’ (l’1% della 62 Guido Pensato popolazione?) strutture che costano centinaia di milioni; e dato che non è pensabile chiudere dette strutture - il regresso non è mai una soluzione -, l’unica strada possibile, anche sul piano strettamente economico, oltre che su quello, preminente, politico-culturale, è quella di moltiplicare enormemente l’utenza, di rendere le biblioteche davvero ‘strutture pubbliche aperte a tutti’. E questo non lo si fa soltanto ‘portando il libro al lettore’. È ora infatti che si dica con chiarezza non solo che le biblioteche funzionano male, ma anche: che la lettura è per molti nel nostro Paese un obiettivo da raggiungere; che la scuola non fa nulla per fornire ai giovani le capacità strumentali e critiche essenziali alla ‘pratica della lettura’; che la lettura non è il fine ma un mezzo; che il libro non né un ‘bisogno da indurre’, ma una risposta, una possibilità da dare in mano a molta più gente; che la complessiva concezione dei beni culturali ancora egemone è sostanzialmente quella per cui si attribuisce un valore, proprio perché dato e acquisito per sempre, soprattutto ai beni artistici, architettonici, monumentali e archivistico-documentari, mentre se ne attribuisce uno del tutto marginale ai beni librari (a meno che non siano ‘anche’ antichi), in quanto destinati ad essere ‘usati’, a ‘servire’. Se insomma è vero che il lettore non si costruisce come categoria sociologica ‘a termine’, ma come qualificazione critica aggiuntiva a quelle ‘normali’ (e non semplicemente sociologiche) di ‘lavoratore’, ‘impiegato’, ‘studente’, ecc., è necessario che la biblioteca esca fuori da se stessa e, almeno per una lunga fase di ‘consapevole emergenza’, aggredisca non tanto ‘il problema dei lettori’, quanto ‘i problemi del lettore (e del non-lettore). Il che può significare affrontare i problemi reali di tutta una comunità, del territorio, della loro identità storico-culturale e rispetto a questi verificare e ricostruire le capacità (vecchie e nuove) di risposta del libro, della biblioteca, dei bibliotecari. c) Breve autocritica (con breve autodifesa) Il mio rifiuto della conflittualità e la convinzione illusoria che sono le idee a fornire autorevolezza a chi ha potere/autorità, garantendomi sicuramente un percorso pendolare lungo l’asse “mitezza-indeterminatezza”, sono diventati (o li ho riconosciuti), a una lettura a distanza, come un crisma di “pratica inadeguatezza”. Quel rifiuto e quella convinzione furono consolidati dal primo lungo periodo trascorso in biblioteca col ruolo di vicedirettore, nel corso del quale ero di fatto “dispensato” da situazioni legate alla gestione del personale (salvo il citato episodio sala ragazzi-dipartimento educativo), fonte privilegiata e quasi esclusiva di conflittualità nella pubblica amministrazione. Avevo la sensazione di poter coltivare in tranquillità il mito di un’attività culturale affidata alla pura e semplice forza della ragione, delle idee e delle proposte. Ma oggi mi sembra di poter, tuttavia, scorgere uno sfondo di presunzione e di dirigismo, che si manifestava soprattutto in una (peraltro più generale) del tutto insufficiente comunicazione e messa in comune delle esperienze professionalmente forti e intense che facevo in quegli anni, all’interno del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e del Direttivo dell’A.I.B.. In breve: un che di solipsistico e messianico; una fiducia cieca nell’onnipotenza delle 63 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città idee che avevo (ed ho tuttora, mutatis mutandis, sostanzialmente intatte) sull’organizzazione delle biblioteche e della cultura in generale, mi resero forse addirittura snobisticamente disattento di fronte a situazioni che avrebbero richiesto forse non più che l’apertura di uno spazio di confronto e discussione e non i semplici insopportabili interventi di natura burocratico-amministrativa, che sembravano, apparivano (ed erano) come la permanente condanna della mia condizione. E continuai a lungo a non capacitarmi che la realtà fosse così “vile e meschina” rispetto al sogno e alla ragione e a pretendere che si piegasse spontaneamente all’una e all’altro. Tanto più che, a ben guardare, queste stesse note, pur così avventurosamente compilate attraverso i meandri di una memoria, di una natura e di una quotidianità fortemente concitate, mi sembrano ribadire esplicitamente, idee, intenzioni, convincimenti a lungo (costantemente e coerentemente) praticati. d) Qualche elemento in più Lo sguardo sul passato, la pervicace (ma tutta condotta, come detto, sul filo della pura speculazione e osservazione) attenzione che continuo a dedicare all’universo amplissimo di cui le biblioteche, mi ostino a credere, devono far parte e con cui, viceversa, molte riluttano a misurarsi; il vederle proficuamente, creativamente schierate (dilaniate!) sulla linea di confine: conservazione/innovazione/ servizio pubblico (al pubblico); il veder confermata oggi, nel panorama delle biblioteche italiane, nel dibattito teorico e nella loro prassi, la “ineluttabilità” e l’urgenza dell’interazione tra “competenze” e funzioni culturalmente ampie e connesse (e premesse) al ruolo proprio e solida definizione e accorto esercizio delle specifiche procedure biblioteconomiche; il verificare, rispetto a queste ultime, che qua e là non è stato bandito, ma riemerge il contestuale, se si vuole ansiogeno rifiuto dell’autoreclusione in esse, rassicuranti e asfissianti mura, tra confini disciplinari e politico-culturali definiti una volta per tutte e cristallizzati, fuori dal tempo e sotto qualunque cielo; ma soprattutto, la constatazione e il convincimento, saldi oggi come ieri, che vi sono troppe cose fuori delle biblioteche, troppi cittadini estranei ai loro “traffici culturali”, per non reclamare una sistematica, ricorrente messa in questione di tutte le rassicuranti certezze che, queste sì, ne minano ruolo, funzioni e futuro (esattamente quello che non è stato fatto per un lungo, marginale, soporifero, inutilmente “glorioso” passato): tutto questo vi è stato nell’esperienza e nella storia recente delle Biblioteca Provinciale e del Sistema Bibliotecario, con le contraddizioni e i problemi ampiamente detti. Ma le direzioni e le strade intraprese erano e sono ancora quelle giuste; come molte delle cose fatte, le idee praticate, i risultati conseguiti, i dubbi, le perplessità, le incertezze seminate: sottoscrivo tutto, perché sono esattamente quello di cui sono fatte parole come biblioteca, libro, cultura. Si può avere addirittura la sensazione che si sia “fatto troppo” in quegli anni e proprio a scapito delle specificità…biblioteconomiche della biblioteca. Riesco a 64 Guido Pensato fugare il sospetto pensando a come, per lunghi decenni, dall’Unità in poi, (anche) le grandi strutture nazionali e quelle delle grandi aree urbane avanzate del paese, pur essendo custodi di patrimoni ingenti e preziosi e (talora, non sempre) di raffinate e rigorose tecniche di descrizione e di catalogazione, non siano mai riuscite, sulla base della semplice ed esclusiva manipolazione di quelle tecniche, a definire ed assumere un benché minimo ruolo utile, “produttivo”, non autoreferenziale rispetto al contesto. Assolutamente superfluo osservare come nelle fasi storiche e nelle realtà economicamente, socialmente, culturalmente caratterizzate da ritardi e arretratezze, quelle esclusive pratiche assumessero i connotati di un’offensiva attività onanistica. Rendere giustizia, viceversa, alla funzione insostituibile di quelle procedure, significa fare i conti con le situazioni date in termini di usi, abitudini e consumi culturali; col numero dei libri venduti e letti, con il numero e la “qualità” delle librerie e dei lettori. Perché il tutto cresca adeguatamente, senza pensare mai che i risultati acquisiti siano definitivi. La “battaglia delle idee” è lunga e faticosa. E deve impiegare, anche in biblioteca e attraverso la biblioteca, strumenti, occasioni, proposte diverse, all’insegna di una seria creatività. Nei decenni dagli anni ’70 fino ad oggi per indicare una strada obbligata - aperta, vivace e “interventista” - alla biblioteca pubblica, si sono utilizzate parole anche equivoche: “promozione”, dal sapore vagamente burocratico-mercantile, oltre che inequivocabilmente paternalistico; “animazione”, leggiadramente sanitario, ospedaliero; “incremento” (culturale) - spesso utilizzato, tra i lazzi e gli sghignazzi di quelli del Teatro Club, dalla burocrazia comunale di Foggia, proprio negli anni da cui ha preso le mosse questo intervento - e la cui valenza “ippica” (di monta equina), ai foggiani ben nota (per aver la città ospitato a lungo un “istituto incremento ippico”, appunto) avrebbe dovuto sconsigliare l’impiego. Ma il lessico biblioteconomico inglese e americano contemplano una parola chiara, nitida, per indicare il compito, qua e là più o meno urgente, da parte delle biblioteche di “uscire fuori di sé”: “extension”, semplicemente “estensione”. Una parola e un concetto che fanno parte integrante dello statuto disciplinare e della pratica bibliotecaria e culturale di realtà avanzate di grande tradizione. Stabilire quali siano i confini e i limiti del suo raggio d’azione non può che spettare, nelle diverse, specifiche situazioni, ai bibliotecari, agli utenti individuali e organizzati, a coloro che sono in grado di rappresentare e dare voce al versante silente, assente e potenziale dell’utenza. Lo si ricorda spesso e a ragione: mentre era in costruzione la nuova sede della Biblioteca Provinciale, un regista, preparando un documentario sull’argomento, intervistò gli operai addetti ai lavori, chiedendo, in particolare a uno di loro, dopo avergli spiegato cosa fosse una biblioteca, cosa ne pensasse, se la considerasse una buona cosa. L’operaio accompagnò la scontatissima approvazione con un laconico, tagliente: “speriamo che non sarà la solita cosa per i figli dei massoni” (intendendo, come è ovvio, “per i soliti pochi privilegiati”). Che risposta daremmo oggi, non nel caso specifico, ma più in generale, qui e altrove, rispetto al tema cultura-cittadiniprivilegio-esclusione, a quel dubbio, a quel sospetto? Non so, infatti, se possono (o devono) definirsi privilegi, esclusioni oritardi, arretratezze, quelli che sono, tutto65 Per fatto personale: di molti. La Biblioteca, il Teatro Club, la Città ra, dati di fatto della situazione bibliotecaria italiana; che, comunque, inducono Tulio De Mauro alle “sorprendenti” riflessioni dedicate all’eargomento nel citato libro-intevista: solo poche persone sanno - non lo sa il Comune di Roma, non lo sa la Regione Lazio, non lo sa forse l’intera popolazione romana - che prima dei bombardamenti, in proporzione agli abitanti, la città di Baghdad offriva ai suoi residenti più luoghi di lettura pubblica che non la città di Roma […] A Roma nessuno sa di avere diritto, secondo gli standard internazionali, a trovare entro 600 metri da casa propria una biblioteca che gli metta a disposizione i libri appena usciti. E questo accade a New York o a Parigi, a Madrid o a Salamanca e a Barcellona. Allora, certamentre l’Italia vive una condizione di arretratezza, ma è un’arretratezza indotta. Se non ci sono biblioteche, non si sa che potrebbero e dovrebbero esserci. Non sapendo questo, nessuno spinge per avere biblioteche. E quindi si degenera in una situazione di arretratezza collettiva. […] Ma […] arretrati non si nasce. Autopoiesi Il tono e le intenzioni non sistematiche di questa mia partecipazione ai riti, tanto più graditi quanto più informali, per il trentennale della nuova sede della Biblioteca Provinciale, da una parte mi inducono a definirla, per così dire e ancora una volta, “tangenziale”, “eccentrica”, “a margine” rispetto a una riflessione “adeguata”, “matura”, che altri vorranno (finalmente e doverosamente) dedicare all’argomento; dall’altra, mi dispensano dall’apporre una chiusa purchessia, preferibilmente altrettanto ritualmente augurale (il che si dia, comunque, come fatto); e infine, mi autorizzano a proporne una che mi sembra, nonostante l’apparente suo carattere eterodosso, in sintonia con l’evento e con la mia disposizione nei confronti dello stesso. La pagina conclusiva pretende, infatti, di essere molte (come al solito, troppe) cose: - una delle mie esercitazioni (una citazione futurista o un gioco passatista? in ogni caso utile per risparmiare pagine) sui confini, tra il poetico e il tipo-grafico; - una certificazione e un riconoscimento del debito che ho nei confronti degli “anni di biblioteca”, per avermi consentito di consolidare la mia delirante passione per la parola e la scrittura, soprattutto su due versanti apparentemente lontani: il ludico-segnico e il civile-semantico, che, tutto sommato, forse è uno solo; - un piccolo rito conclusivo di appartenenza e di distacco; - un atto e un attestato di autoliberazione, come alternativa a un improbabile, improponibile, ingiustificato atto di contrizione. Ma un dubbio resta: si tratta dell’ explicit di un poeta precoce ma clandestino, che ha preteso di fare il bibliotecario - scegliendo il certo presente tra i libri e non l’incerto futuro nei libri - e si è accorto tardivamente di non essere tagliato per farlo (il bibliotecario); o di un irriducibile bibliotecario, tardivamente pentito, che si accorge di essere (stato da sempre, malgrado tutto, semplicemente, presuntuosamente) poeta o che ha costantemente la tentazione di “buttarla in poesia”? 66 Guido Pensato, Sparse (: frecce morbide), 2004 68 Maria Altobella Apparato di consultazione generale Aspetti strutturali e semantici di Maria Altobella 1. La Sala di Consultazione: definizione e riferimenti storico - bibliografici Una riflessione sul ruolo della “Sala di Consultazione” di una biblioteca pubblica non può non muoversi all’interno di un preciso quadro di riferimento. Nelle biblioteche pubbliche italiane per “Sala di Consultazione” si intende una speciale sala di lettura, diversa dalle sale comuni in quanto raccoglie e mette immediatamente a disposizione degli studiosi le opere che costituiscono i sussidi fondamentali per lo studio di qualsiasi argomento; sussidi che vengono definiti, con termine generico, opere di consultazione. Come istituzione, questa tipologia di sala risale alla seconda metà del secolo XIX quando, cioè, l’aumento della produzione libraria rese necessario separare i magazzini dal servizio pubblico portando a contatto degli studiosi non certo tutti i libri della biblioteca, bensì le cosiddette opere di consultazione. Di conseguenza le biblioteche si sono dovute arricchire di opere fondamentali e, per metterle a portata di mano, è stato necessario creare la sala di consultazione.1 In Italia la prima di queste sale venne istituita al piano terra della Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele” di Roma nel 1885 e, naturalmente, servì poi da modello teorico per altre biblioteche. Rimaneggiata più volte e riordinata radicalmente da Luigi De Gregori2 nel 1909, comprese cinque grandi sezioni fondamentali - Enciclopedie generali, Dizionari speciali, Dizionari e Repertori di araldica e famiglie celebri, Dizionari biografici speciali e Biografie generali nazionali ed opere essenziali relative a tutto lo scibile umano - Arte, Scienze tecnologiche e matematiche, Scienze naturali, Medicina e Veterinaria, Leggi e Giurisprudenza, Economia politica e Finanze, Filosofia, Lingue e Letterature, Antichità classiche, 1 Amalia VAGO, La sala di consultazione, Milano, Mondadori, 1941. Attraverso questa monografia l’autrice realizza una sistematizzazione teorica della problematica relativa alle sale di consultazione introducendo il principio di ordinamento per materia. 2 Luigi De Gregori, studioso e bibliotecario prima presso la Biblioteca Nazionale di Roma, poi, in qualità di direttore, presso la Biblioteca del Ministero della Pubblica Istruzione e la Casanatense, dopo aver riorganizzato la Biblioteca romana “Antonio Sarti” e la Casa di Dante, compì ogni sforzo per rendere le biblioteche efficienti e sicure modernizzandole e accrescendone il patrimonio e contribuì a diffondere l’idea di una biblioteca nuova, realmente aperta a tutti, difendendo il patrimonio librario pubblico. 69 Apparato di consultazione generale. Aspetti strutturali e semantici Filologia, Classici greci e latini, Testi e Dizionari classici e medioevali, Letterature e Dizionari, Storia italiana e di altre Nazioni, Storia della Chiesa. Nei primi anni del secolo XX altre ricche Sale di Consultazione vennero istituite sia presso la Biblioteca Vaticana che presso la Nazionale Marciana di Venezia, la Biblioteca Universitaria di Padova, la Nazionale di Torino, la Nazionale Braidense di Milano e la Nazionale Centrale di Firenze; quest’ultima, sotto la direzione di Domenico Fava,3 istituì 15 sezioni di consultazione completandole con i periodici.4 Ma anche importanti biblioteche in Europa - Germania, Francia, Austria e Inghilterra - mostrarono interesse per queste grandi sale di lettura, realizzandole. Le biblioteche americane, invece, si caratterizzarono per l’organizzazione della lettura pubblica e per la ricchezza dei relativi mezzi impiegati. Il tema della “Sala di Consultazione” è stato preso in esame da numerosi autori tra cui Giordani, Apollonj, Camerani, Santoro Fioroni, Pinto e Barberi.5 In tempi più vicini è stato trattato da Aghemo, Sisinni, Solimine, Bottasso, Maltese, Del Bono e Pensato.6 Quest’ultimo autore attribuisce al lavoro di consultazione una caratteristica dinamica collegandolo al servizio di informazione e proponendo una definizione binomica: servizi di informazione - consultazione. a) Le Opere di Consultazione L’attività di informazione necessariamente richiede strumenti specifici di lavoro. Una parte del materiale documentario posseduto dalle biblioteche - a causa di caratteristiche intrinseche - è strumento informativo per eccellenza ed è rappresen- 3 Domenico Fava, dopo una decennale permanenza alla Braidense di Milano, ha diretto la Biblioteca Estense di Modena ed in seguito la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze rivolgendo particolare attenzione agli studi bibliografici. 4 Joachim WIEDER, Le sale di studio nelle biblioteche italiane, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», XXV (1957), 1, pp. 28-38. 5 Per uno sguardo retrospettivo cfr. Igino GIORDANI, La sala di consultazione nella Biblioteca governativa di Lucca, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», IV (1930), 3, pp. 285-286; Ettore APOLLONJ, Guida alle biblioteche italiane, Milano, Mondadori, 1939; Vittorio CAMERANI, L’uso pubblico delle biblioteche, Milano, Mondadori, 1939; Enza SANTORO FIORONI, L’informazione nelle biblioteche, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», XXVI (1958), 45-6, pp. 400-406; Olga PINTO, Gli uffici d’informazione nelle biblioteche pubbliche, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», XXVI (1958), 3-4, pp.193-201; Francesco BARBERI, Servizi d’informazione nella biblioteca pubblica, in Francesco BARBERI, Biblioteca e bibliotecario, Bologna, Cappelli, 1967, pp. 95-107. 6 Tra gli interventi più significativi e relativamente recenti: Aurelio AGHEMO, Il servizio di consultazione fra realtà e immaginario: nuove prospettive per lo sviluppo di una funzione centrale nei servizi all’utenza, in «Biblioteche oggi», VI (1988), 5, pp.43-48; Francesco SISINNI, Diffusione della informazione bibliografica: problemi e prospettive, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», XLVIII (1980), 1, pp. 5-10; Giovanni SOLIMINE, L’informazione in biblioteca: introduzione ai problemi dell’informazione bibliografica, Milano, Editrice Bibliografica, 1985; Enzo BOTTASSO, Reperimento dell’informazione e sviluppo civile, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», (1982), 4-5, pp. 355-364; Diego MALTESE, Le sale di consultazione, in Diego MALTESE, La biblioteca come linguaggio e come sistema, Milano, Editrice Bibliografica, 1985, pp. 131-135; Gianna DEL BONO, Consultazione, Roma, A.I.B., 1992; Rino PENSATO, Il servizio di consultazione in Paola GERETTO (a cura di), Lineamenti di biblioteconomia, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 271-297. 70 Maria Altobella tato dalle opere di consultazione che, per tradizione, sono costituite da documenti di elevato contenuto scientifico e culturale. Si tratta, quindi, di collezioni di opere speciali il cui compito è quello di formare la base operativa per tutte le attività di informazione che ogni biblioteca deve fornire alla sua utenza.7 Molteplici sono le definizioni ricorrenti e formulate da diversi autori che hanno portato all’individuazione di vari raggruppamenti che possono essere così semplificati: opera fatta per essere consultata, opera che serve per una informazione o una risposta, opera che non si legge da cima a fondo, opera che serve per orientare, opera ausiliaria per una ricerca, opera non esportabile dalla biblioteca. Sono, queste, definizioni funzionali al concetto di opere quali strumenti di informazione. Cercando di individuarne i contenuti secondo la loro tipologia è possibile ricondurle ad alcuni gruppi e cioè: opere di tipo bibliografico, opere a testo discontinuo, opere a testo continuo, opere di tipo iconico ed opere di tipo tabellare e numerico. Tale suddivisione a volte è trasversale rispetto ad alcune opere; infatti, le enciclopedie possono presentare il loro contenuto in forma sia alfabetica e cioè a testo discontinuo, sia sistematica e quindi a testo continuo. Un’ulteriore distinzione riguarda le opere ad accesso diretto all’informazione quali enciclopedie, dizionari, annuari, repertori; e le opere ad accesso indiretto all’informazione quali cataloghi, bibliografie, indici.8 Le opere di consultazione, inoltre, quando sono di tipo bibliografico comprendono bibliografie, cataloghi di biblioteche, cataloghi commerciali ed editoriali, indici; quando sono a testo discontinuo comprendono enciclopedie, dizionari, concordanze, repertori biografici, cronologie, annuari; quando sono a testo continuo comprendono trattati, manuali, collezioni di testi, fonti, guide; le opere di tipo iconico, non reperibili cioè in un testo scritto, riguardano stemmi, blasoni, bandiere, raffigurazioni umane o di opere artistiche, panorami, fotografie. Le pubblicazioni in forma tabellare sono riconducibili a serie statistiche e a raccolte di dati numerici laddove l’informazione è rappresentata da grafici, elenchi, tabelle, tavole matematiche e logaritmiche oppure astronomiche, fisiche, biologiche e chimiche. Da non trascurare, infine, i periodici - riviste e pubblicazioni accademiche che rappresentano un vero e proprio mare magnum della cultura e costituiscono serie importantissime di studi. Inoltre, ai fini della ricerca, forniscono spesso indici propri, pubblicati ad intervalli più o meno regolari; molto diffusi sono gli indici annuali, ma si rivelano utili soprattutto gli indici cumulativi pluriennali. Se gli abstracts provvedono all’informazione corrente, l’indice pluriennale di un singolo periodico viene utilizzato soprattutto per le ricerche di tipo retrospettivo. 7 Aurelio AGHEMO, L’opera di consultazione: contributo alla definizione di una voce di un possibile glossario, in «Biblioteche oggi», VII (1989), 4, pp. 453-466. 8 Aurelio AGHEMO, Informare in biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica, 1992, pp. 41-91. 71 Apparato di consultazione generale. Aspetti strutturali e semantici 2. Programmazione della fisionomia Le motivazioni che spingono alla lettura pubblica e quindi alla consultazione di un testo all’interno di una struttura istituzionale sono chiaramente dovute all’opportunità di trovare informazioni su una quantità di opere che non è possibile o conveniente acquistare, alla possibilità di integrare la lettura e lo studio con la consultazione di altri testi e con l’accesso a vari servizi che supportano la ricerca; i bisogni che inducono a frequentare gli istituti culturali sono, di conseguenza, professionali o di studio, di svago o di formazione. Le biblioteche hanno quindi il compito di soddisfare i bisogni informativi, formativi, di lettura e di essere al servizio della comunità selezionando, filtrando e organizzando le informazioni.9 Un settore chiave di ogni biblioteca è costituito proprio dalle Sale di Consultazione, luoghi in cui il patrimonio documentario è disposto in modo sistematico dopo essere stato selezionato con cura, comprendendo opere non effimere e capaci di offrire una panoramica dello stato delle conoscenze. I criteri da seguire per la scelta delle opere di consultazione devono riguardare i bisogni informativi della comunità servita, il posseduto, l’utilizzo effettivo dei materiali bibliografici, i fondi disponibili ed, eventualmente, i programmi di cooperazione. Le raccolte, di conseguenza, dovranno rinnovarsi in modo costante per coprire con tempestività i nuovi campi del sapere e, data la rapida obsolescenza dei materiali destinati alla consultazione, sarà opportuno affiancare il formato on-line dei documenti. Infatti, i servizi on-line sono più veloci, più convenienti, più specifici ed aggiornati. La ricerca on-line, considerata inizialmente come estensione molto specializzata della sala di consultazione, attualmente è giudicata un utile complemento delle risorse esistenti.10 Se, quindi, in un primo tempo era ritenuto un servizio addizionale - solo una veloce alternativa al reference tradizionale - oggi è uno dei molti servizi a disposizione degli studiosi. 11 Un’onesta ricerca di pluralismo culturale, inoltre, deve garantire un giusto equilibrio tra diversi orientamenti ideologici e condurre a scelte differenziate, rappresentative di concezioni e metodologie diverse. Le collezioni devono, altresì, riflettere il rapporto che l’istituto bibliotecario ha con il contesto ambientale ed il tessuto socio - culturale; l’interazione con l’ambiente, infatti, costituisce uno dei principi fondamentali della politica di sviluppo 9 G. SOLIMINE, L’informazione in biblioteca…, cit. Carla LEONARDI, Il reference in biblioteca: guida ai servizi d’informazione, Milano, Editrice Bibliografica, 1995. 11 L’uso dei materiali on-line non deve, comunque, essere esclusivo perché tra la ‘memoria vegetale’ - fatta di carta - e la ‘memoria minerale’ - del computer - non sarà quella vegetale ad essere sconfitta; nel buio di probabili blackout, infatti, saranno i libri - immortali - a tenere compagnia e a parlare del mondo. Cfr. Umberto ECO, Memoria vegetale e memoria minerale: il futuro dei libri, vero e proprio inno al libro in occasione della conferenza tenuta nella nuova Biblioteca di Alessandria d’Egitto, in qualità di componente del consiglio di amministrazione, il 1° novembre 2003. 10 72 Maria Altobella delle raccolte; tuttavia, la coerenza della fisionomia documentaria darà, naturalmente, spazio all’universalità del sapere per fornire stimoli nuovi e garantire il pluralismo. L’apparato di consultazione deve, dunque, servire il proprio bacino di utenza, deve rispecchiare l’andamento della produzione corrente e deve rappresentare il patrimonio di conoscenze anche attraverso la consistenza pregressa dei documenti.12 Il valore di questo apparato si può misurare sotto vari aspetti: per le dimensioni, per la copertura bibliografica, per l’impegno costante e continuativo nell’aggiornamento e per la conseguente attività di promozione all’uso dei documenti. Particolare attenzione è da rivolgere all’organizzazione ed all’uso di riviste e periodici che - in un settore di carattere generale - rivestono un ruolo molto importante nella connotazione e nell’aggiornamento delle varie sezioni; i periodici specializzati, infatti, possono convivere con le monografie della medesima disciplina e fare parte della raccolta per quei principi di completezza delle notizie e delle informazioni. La tempestività di diffusione dei contenuti e la facile e veloce accessibilità alle conoscenze qualifica la pubblicazione periodica per cui ogni esigenza - culturale e professionale - trova una delle forme più congeniali di soddisfacimento. Inoltre, la duplicazione su audiovisivi di giornali e periodici ed il giornale elettronico, renderanno questi strumenti sempre più adeguati ed efficaci.13 3. Offerta documentaria La Sala di Consultazione della Biblioteca Provinciale di Foggia, settore costituito durante gli anni 1974-1978, si sviluppa su 700 mq, raccoglie e conserva circa 20.000 unità documentarie ordinate per materia a scaffale aperto e suddivise in dieci classi secondo la Classificazione Decimale Dewey; dispone di 180 posti di lavoro per la lettura in sede e, naturalmente, dei cataloghi - autori/titoli e soggetti - sia cartaceo retrospettivo che elettronico corrente. A stretto contatto con la Sala di Consultazione è ubicata - su 187 mq e 50 posti di lavoro - la Sala Periodici, con dotazione di 1755 testate di cui 800 correnti e 20 giornali - tra stranieri, nazionali e locali - 200 cd-rom, 100 floppy disk oltre a banche dati e risorse accessibili in rete. La sala di lettura, a scaffale aperto, offre l’accesso diretto alle annate in corso.14 12 Giovanni SOLIMINE, Le raccolte delle biblioteche: progetto e gestione, Milano, Editrice Bibliografica, 1999. 13 Carlo CAROTTI – Rita CARRARINI, I periodici nelle biblioteche pubbliche, Milano, Editrice Bibliografica, 1985. Cfr. anche Fabrizia BEVILACQUA, Usabilità e uso dei periodici elettronici: problemi e soluzioni, in «Biblioteche Oggi», XXI (2003), 3, pp. 5-13. 14 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, La Biblioteca Provinciale di Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1974. Opuscolo pubblicato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Provinciale. 73 Apparato di consultazione generale. Aspetti strutturali e semantici Un tradizionale banco di distribuzione - cerniera tra le due aree - collega le sale al deposito moderno - serbatoio di informazioni - saldando la ricerca documentaria con il ricco patrimonio storico. 15 Il patrimonio documentario, di elevata validità scientifica e culturale, è particolarmente ricco di repertori bibliografici. A titolo esemplificativo, sono da indicare importanti strumenti retrospettivi quali: Besterman Theodore, A world bibliography of bibliographies and of bibliographical catalogues, calendars, abstracts, digests, indexes and the like: 5 volumi editi a Losanna nel 1966 che elencano 117.000 bibliografie pubblicate sino al 1964 e distinte in 15.829 argomenti; Index traslationum, repertorio annuale di tutti i libri del mondo tradotti nella lingua originale in tre serie pubblicate tra il 1932 e il 1983 ed in 27 volumi; Catalogo Generale della Libreria Italiana 1847-1967 del Pagliaini, ristampa anastatica della classica bibliografia retrospettiva delle pubblicazioni italiane; Catalogo Cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane (CUBI), risultato della fusione in unica sequenza alfabetica delle circa 640.000 schede contenute nelle 72 annate del Bollettino; Catalogo dei Libri Italiani dell’Ottocento 1801-1900 (CLIO), organico strumento di consultazione per tutto il secolo comprendente 420.898 edizioni; British Museum, General Catalogue of Printed Books, Compact, to 1955: stampa fotomeccanica del catalogo di servizio del British Museum; Catalogue Générale Origines 1970 de la Bibliothèque de France, catalogo della Biblioteca Centrale di Francia che fa da pendant al catalogo del British Museum; National Union Catalog (NUC), pre-1956 imprints 1958-1982, comprende in microfiches le acquisizioni di biblioteche degli USA e del Canada; Library of Congress, Subject Catalog 1950-1982, indice delle accessioni della Library of Congress che, con la cumulazione del 1982, cessa le pubblicazioni ed è sostituito dall’edizione in microfiches del NUC. I repertori correnti più significativi, oltre agli aggiornamenti del NUC ed ai supplementi del British Museum, comprendono: la Bibliografia Nazionale Italiana (BNI) - bibliografia elaborata sugli esemplari d’obbligo che pervengono alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - ed il Bollettino delle Opere Moderne Straniere acquisite dalle biblioteche pubbliche statali italiane (BOMS): repertorio che registra opere straniere localizzando la loro presenza presso trentasette biblioteche italiane; Giornale della Libreria, organo ufficiale dell’Associazione Italiana Editori, che informa sistematicamente sulle novità e le nuove edizioni via via pubblicate in Italia; sono ancora da segnalare: British National Bibliography, bibliografia nazionale inglese ufficiale in corso; American Book Publishing Record Cumulative, cumulazione annuale dei libri in commercio negli Stati Uniti; Letteratura Italiana Aggiornamento Bibliografico (LIAB), pubblicazioni sulla letteratura italiana in Italia e all’estero; L’Année philologique, bibliografia critica ed analitica dell’antichità greco-latina; Dizionario delle Opere Classiche (DOC), bibliografia di letteratura clas- 15 Angelo CELUZZA, La nuova Biblioteca Provinciale, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1975. 74 Maria Altobella sica a cura di Vittorio Volpi; Repertorium fontium historiae Medii Aevi a cura del Potthast; International Bibliography: of Economics, of Antropology, of Political Science, of Sociology, of Historical Sciences. Tra le più importanti biografie generali: Dizionario biografico degli italiani, grande biografia nazionale ancora in corso edita dalla Treccani; Bibliotheca Sanctorum, dizionario agiografico monumentale; Dictionary of international biography, dizionario biografico internazionale. Completano l’assetto informativo enciclopedie generali: Treccani, Britannica, Larousse, Universal Ilustrada (Espana), Meyers Neues Lexicon, Einaudi, Garzanti; enciclopedie specializzate: Enciclopedia delle scienze sociali, Enciclopedia delle scienze fisiche, Enciclopedia cattolica, Enciclopedia medica italiana, Enciclopedia del diritto, Enciclopedia giuridica, Enciclopedia della scienza e della tecnica, Enciclopedia universale dell’arte, Enciclopedia agraria italiana, Enciclopedia dello spettacolo, Enciclopedia della stampa, Enciclopedia della Fisica, Enciclopedia dell’Ingegneria, Enciclopedia di Psicopedagogia; riviste:16 «Annales», «Annuario DEA delle Università e degli Istituti di Studio e Ricerca in Italia», «Archivio glottologico italiano», «Biblioteca teatrale», «Bollettino di archeologia», «Bollettino d’arte», «Bollettino di numismatica»; «Giornale d’Arte», «Giornale di Astronomia», «Giornale di Matematiche»; «Flash Art», «Lares», «Studi storici», «Civiltà cattolica», «Nuova Antologia», «Il Ponte», «Scrittura e Civiltà», «Polis», «Politica internazionale», «Quaderni storici», «Studi medievali», «Napoli nobilissima», «Physis», «Rivista di Agronomia», «Rivista Italiana di Musicologia», «Nature», «Sapere», «Sipario», «Il Foro Italiano», «Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane», «Annuario Statistico Italiano», «Informazioni Statistiche», «Rivista giuridica del Mezzogiorno», «Rivista giuridica dell’edilizia», «Rivista giuridica dell’ambiente», «Rivista giuridica della scuola», «Il Fisco», «The Economist», «Tecnology review», «Vetera Christianorum», Banca dati giuridica De Agostini, ecc...; repertori speciali: Corpus Nummorum Italicorum, Storia Economica Cambridge, Storia delle Scienze, diretta da Paolo Rossi, I Greci, Storia di Roma, Storia d’Italia, Storia d’Europa, Annali, Le Regioni (Einaudi); Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso (UTET), Grande Antologia Filosofica, Le radici del pensiero filosofico, Dizionario della lingua italiana a cura di Tommaseo e Bellini, Vocabolario Universale Italiano (Tramater), Vocabolario della lingua italiana (Treccani), Grande Dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia, Dizionario dell’uso di Tullio De Mauro, The new Grove Dictionary of Music and Musicians, The Dictionary of Art (Grove), Storia economica d’Europa diretta da Carlo M. Cipolla, La Pittura: in Europa, in Italia (Electa), Trattato di medicina interna di Introzzi, Atlante di Anatomia del Netter, Storia del teatro di Doglio. Da sottolineare, inoltre, tra le collezioni di testi: Patrologia greca e latina del 16 Carlo REVELLI, Osservatorio internazionale: ancora sui periodici, in «Biblioteche oggi», XXI (2003), 4, pp. 65-68. 75 Apparato di consultazione generale. Aspetti strutturali e semantici Migne, Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) del Mommsen, Lexicon totius Latinitatis di Forcellini, Enciclopedia storico-nobiliare italiana dello Spreti, Rerum Italicarum Scriptores del Muratori, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis, The Loeb Classical Library, Les Belles Lettres (serie greca e latina con traduzione francese), Biblioteca di scrittori italiani, Fondazione Valla, Classici latini, Classici greci; Classici della Filosofia, Classici della Politica, Classici dell’Economia, Classici della Pedagogia, Classici delle Religioni, Classici della Scienza; Scrittori d’Italia, Fonti per la storia d’Italia, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Monumenta Germaniae Historica, Alegmeins Kunstler Lexicon (Saur), Bibliothèque de la Pléiade, Biblioteca de Autores Espanoles, e così via. A questi fondamentali strumenti informativi si aggiungono le opere considerate ‘definitive’ per l’elevato livello scientifico e per la loro funzione di guida organica e rigorosa. Alcuni esempi: Trattato di grafologia di Moretti, Storia del costume in Italia di Levi Pisetzky, Storia e potere della scrittura di Martin, Il secolo breve di Hobsbawn, Il Medio Evo di Volpe, La civiltà dell’Occidente medievale di Le Goff, Storia del paesaggio agrario italiano di Sereni, Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea a cura di Bevilacqua, Storia dei Longobardi di Paolo Diacono, Storia della città di Benevolo, Storia dell’architettura moderna di Zevi, Storia dell’arte italiana di Argan, Storia dei partiti nell’Italia Repubblicana di Colarizi, Mafia, politica e affari di Tranfaglia, Biochimica di Lehninger, L’arte della cucina in Italia (Einaudi), Il giardino e la città di Cerami, Flora d’Italia di Pignatti, ecc... Numerose le opere sistematiche su singole discipline quali: agraria, antropologia, archeologia, architettura, arte, astronomia, biblioteconomia, botanica, chimica, cibernetica ed informatica, cinema, comunicazioni e mass media, diritto, economia e politica economica, filatelia, filologia, filosofia, fisica, folklore, fotografia, geografia, giochi, letterature, linguistica, matematica, medicina, musica, paesaggio, pedagogia, politica, psicologia, religioni, scienza e tecnica, scienze biologiche, scienze della terra, sociologia, sport, storia, teatro, turismo, urbanistica, veterinaria, zoologia. Questa, la panoramica dell’offerta documentaria dell’apparato di consultazione generale e, lectis rerum summis, la relativa fisionomia bibliografica.17 4. Innovazione Al fine di esaltare e potenziare il carattere di reference library del settore, è determinante tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze su determinati temi e delle tendenze innovative. L’organizzazione fisica dei documenti, oltre a produrre effetti sull’occupazione dello spazio, può condizionare l’uso degli stessi da parte degli studiosi. La 17 Giuliano VIGINI, Opere di consultazione per la biblioteca pubblica, Milano, Editrice Bibliografica,1983. 76 Maria Altobella rigida separazione in classi, osservata finora, è oggi al centro di interessanti dibattiti tesi ad affermare lo sviluppo di sistemi di classificazione/collocazione che, prescindendo dalle tradizionali suddivisioni disciplinari, parta dagli elementi di conoscenza per costruire raggruppamenti fondati oggettivamente sulle interrelazioni; si sostengono, cioè, sistemi di classificazione fondati sulla struttura ontologica del mondo reale.18 La riorganizzazione dell’area prevede una struttura basata su un unico spazio aperto, articolato in zone attraverso una particolare disposizione degli elementi di arredo, comunque finalizzata all’integrazione dei diversi ambienti da un punto di vista logico e fisico. Infatti, l’esigenza di relazione tra alcuni campi disciplinari ne suggerisce la collocazione in contiguità delineando unità funzionali a cui corrispondono unità spaziali.19 L’ordinamento delle opere seguirà un criterio di organizzazione per aree macrotematiche introducendo, cioè, aree di tipo dipartimentale con articolazioni sezionali. 20 Ogni macroarea sarà dotata dei classici, delle più autorevoli collezioni di testi, delle fonti, dei manuali e dei trattati, delle monografie fondamentali, dei rapporti di associazioni scientifiche oltre ad atti congressuali, principali riviste, audiovisivi e documenti elettronici.21 La nuova fisionomia documentaria verrà determinata dalla specificità di grandi campi disciplinari i cui aspetti, strutturali e semantici, saranno sempre legati all’ordinamento classificato ed al libero accesso agli scaffali da parte degli utenti. Una mappa concettuale orienterà i rapporti che uniscono i diversi campi del sapere. Nell’organizzare l’offerta delle diverse macroaree, lo sviluppo delle collezioni sarà progettato a cercare un punto di equilibrio tra la quantità di documenti pubblicati e disponibili in commercio per ciascuna disciplina e l’interesse che gli studiosi manifesteranno verso le sezioni tematiche proposte. Naturalmente verranno ancora coltivati i filoni già presenti nella fisionomia bibliografica dall’apparato ma, nello stesso tempo, si cercherà di servire gli utenti offrendo le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno, stimolando ulteriori esigenze. La collezione di consultazione generale, quindi, si svilupperà in rapporto alle necessità di studio e di ricerca richieste dal suo pubblico ed in relazione al supporto dei documenti, cioè libri, giornali, riviste, microfilm, microfiches, cd-rom, audiovisivi: elementi tutti 18 Claudio GNOLI, Mezzo o messaggio? Le classificazioni all’inseguimento delle conoscenze in evoluzione, in «Biblioteche oggi», XXI (2003), 1, pp. 17-20. 19 Patrizia LUPERI, Le case dell’apprendimento flessibile: ripensare lo spazio della biblioteca in funzione dei nuovi processi di comunicazione in «Biblioteche oggi», XXI(2003), 6, pp. 31-33. 20 Giovanni DI DOMENICO, Presentazione dell’offerta documentaria e ordinamento delle raccolte nella BEIC, in «Bollettino AIB: rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell’informazione», 2003, 1, pp. 45-62. 21 Enrico MARTELLINI, I periodici elettronici in biblioteca in «Bollettino AIB: rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell’informazione», 1998, 3, pp. 325-334. 77 Apparato di consultazione generale. Aspetti strutturali e semantici ‘significanti’ della raccolta che coprono ambiti e interessi di ogni disciplina documentando in profondità.22 Il rapporto tra libro e altri supporti rappresenta un nuovo passaggio nella storia e nella tradizione della pubblica lettura e richiede la coesistenza e lo sviluppo di media diversi tra loro che crescono e si affermano pur mantenendo la loro costitutiva differenza. In precedenza fonoteche e videoteche erano costituite in zone separate all’interno della stessa struttura bibliotecaria;23 oggi si tende a disseminare i diversi supporti in tutta la biblioteca con la conseguente, necessaria esigenza di riorganizzare spazi e servizi al fine di misurarsi con la rivoluzione culturale e antropologica indetta dalle nuove tecnologie della comunicazione.24 Le aree macrotematiche e le relative sezioni sono state così identificate: GENERALITÀ e BIBLIOTECONOMIA (classe 000) Sezioni: a) Opere di carattere generale: enciclopedie, bibliografie, cataloghi e repertori di carattere generale b) Biblioteconomia Le bibliografie e le enciclopedie speciali verranno inserite nelle relative discipline. SCIENZE UMANE (classi: 100, 200, 900) Sezioni: a) Filosofia b) Religioni c) Storia e Geografia storica: storia, archeologia, geografia storica e viaggi, biografie SCIENZE SOCIALI (classi 300, 640, 650) Sezioni: a) Società e Istituzioni: sociologia e antropologia, scienza politica, problemi e servizi sociali, educazione, usi e costumi b) Statistica c) Scienze giuridiche e Scienze dell’amministrazione: diritto, amministrazione pubblica e scienza militare, marketing d) Scienze economiche: economia, commercio, comunicazioni, trasporti, economia domestica, gestione e servizi ausiliari 22 Carlo CAROTTI, Costruzione e sviluppo delle raccolte, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 1997. Annie PISSARD, Dalla biblioteca alla mediateca: come le nuove tecnologie modificano i servizi al pubblico , in Massimo ACCARISI-Massimo BELOTTI (a cura di), La biblioteca e il suo pubblico: centralità dell’utente e servizi d’informazione, Milano, Editrice Bibliografica, 1994, pp. 121-125. 24 Cfr. Luca FERRIERI, Servizi multimediali in una biblioteca pubblica di base: l’esperienza di Cologno Monzese, in «Bollettino AIB: rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell’informazione», 1998, 4, pp. 441-455 e Michele SANTORO, Biblioteche domani: il mutamento delle prospettive bibliotecarie all’alba del terzo millennio, in Ibid., 3, pp. 303-322. 23 78 Maria Altobella LINGUE E LETTERATURE (classi: 400, 800) Sezioni: a) Lingue b) Letterature SCIENZE E TECNOLOGIE (classi: 004-010, 130, 150, 500, 600) Sezioni: a) Scienze di base: fisica, chimica, matematica b) Scienze della vita e della persona: psicologia, parapsicologia, psicanalisi, paleontologia, biologia, medicina, botanica, zoologia c) Scienze della terra e del cosmo: geografia fisica e geografia matematica, geologia, astronomia, oceanografia d) Tecnologie ed altre scienze applicate: informatica ed intelligenza artificiale, agricoltura, ingegneria, ingegneria chimica, lavorazione metalli/carta/legno, manifatture tessili ARTI E ATTIVITÀ CREATIVE (classe 700) Sezioni: a) Arti visive, Tecniche e Manufatti artistici b) Architettura e Urbanistica c) Musica e Spettacoli d) Giochi e Sport L’apparato strutturale della consultazione generale, dunque, è il risultato di un insieme di interventi diretti a realizzare il progetto culturale che si esprime nella fisionomia della raccolta; interventi che costituiscono risposte programmate - intelligibili ed utili rispetto alle esigenze dell’utenza - e che si configurano come servizio al pubblico. L’analisi semantica dei documenti sarà alla base di elaborazioni classificatorie per consentire l’organizzazione istituzionale della ricerca, semplificata anche dall’uso di schede-vedette.25 5. Strategie di servizio La configurazione e la ripartizione delle discipline sono state ripensate secondo una filosofia diversa da quella comunemente seguita nella Classificazione Dewey. Uno schema di classificazione non va considerato come una rigida camicia di forza da cui non ci si possa liberare, ma piuttosto come una proposta di percorso con possibili varianti sul tracciato indicato per renderlo più conforme all’ambiente socio - culturale in cui si colloca e al tipo di esigenze da soddisfare. 25 Paolo TRANIELLO, La biblioteca tra istituzione e sistema comunicativo, Milano, Editrice Bibliografica, 1986. 79 Apparato di consultazione generale. Aspetti strutturali e semantici Il raggruppamento risponde a criteri di sistemazione funzionale e si realizza all’interno di quattro nuclei fondamentali - oltre al settore chiave del servizio informativo, Generalità e Biblioteconomia - dai seguenti titoli unificanti: (Scienze Umane) L’uomo e la coscienza di sé; (Scienze Sociali) L’uomo che organizza i suoi rapporti col mondo; (Lingue e Letterature; Arti) L’uomo e le sue rappresentazioni; (Scienze e Tecnologie) L’uomo che agisce sul mondo. Alle suddette aree macrotematiche - sistemate sempre a scaffale aperto - corrisponderanno i relativi posti di lettura, l’agilità dei quali non interferirà con i percorsi. I diversi spazi operativi si articoleranno in varie zone facilmente identificabili tramite segnaletica:26 Zona della ricerca catalografica: sarà possibile consultare i cataloghi anche su microfiches mediante appositi lettori, ricercare informazioni bibliografiche, identificare fonti più ampie attraverso l’utilizzazione di terminali per la ricerca su catalogo computerizzato o su banche dati bibliografiche. Zona della distribuzione documentaria Sala di Consultazione / Deposito moderno: punto di servizio in cui il personale interagisce con il pubblico; verranno svolte tutte le attività concernenti il ricevimento delle richieste - libri, riviste cessate, periodici arretrati, cd-rom, ecc… - l’orientamento, le informazioni; rappresenta un piano di lavoro che, per la sua caratteristica di banco a doppia faccia di azione, svolge simultaneamente diverse funzioni. Tra queste deve essere prevista la sensibilizzazione e la desensibilizzazione dei materiali in entrata e uscita, in seguito al sistema automatico per il controllo dei furti. Zona di consultazione informale delle novità: spazio localizzato in adiacenza alla zona di controllo del personale con esposizione periodica delle ultime acquisizioni bibliografiche ed esposizione/distribuzione di materiale informativo, di diffusione e promozione della lettura (bibliografie speciali, esposizioni tematiche, spogli di periodici, indici e bollettini di abstracts, ecc…).27 Zona di consultazione asistematica: spazio complementare alle zone di lettura in cui saranno a disposizione strumenti di prima e rapida informazione quali dizionari linguistici e tecnici, codici e quotidiani. I metodi espositivi in questa zona dovranno essere di tipo informale e cioè materiali appoggiati sui tavoli, su espositori rotanti o su scaffali inclinati. Zona di consultazione sistematica: alla suddivisione concettuale delle aree macrotematiche - visivamente schermate - corrisponderà una distribuzione regolare dei tavoli per la lettura e dei materiali esposti attraverso gli scaffali aperti e, per 26 Paola VIDULLI, Progettare la biblioteca: guida alla pianificazione e progettazione della biblioteca pubblica , Milano, Editrice Bibliografica,1988. 27 Il periodico «La Rivisteria»: mensile di analisi e informazione sul mondo del libro, delle riviste e del video in Italia (www.rivisteria.it) pubblica in ogni fascicolo abstracts relativi a riviste e libri riguardanti vari temi con lo scopo di informare chi desideri approfondire determinati argomenti; si tratta di uno strumento che può trovare utile collocazione all’interno di questa zona. 80 Maria Altobella consentire la continuità di ricerca su supporti diversi, troveranno posto nello stesso spazio scaffali per i materiali speciali - le più importanti riviste di informazione disciplinare, atlanti, ecc... - e per i materiali non librari - cd-rom, programmi computerizzati, floppy disk - tranne nel caso in cui è richiesta una più diretta connessione con gli apparecchi e gli arredi previsti per la loro utilizzazione.28 La consultazione delle riviste proseguirà nello spazio autonomo - Emeroteca - costituita sia da espositori/contenitori dei numeri più recenti, sempre secondo l’aggregazione disciplinare articolata in aree macrotematiche, che dalla zona di consultazione asistematica per la lettura dei quotidiani. È opportuno che l’esposizione dei periodici conservi uno spazio separato - ma non isolato dalla zona libri - perché possa assolvere alla duplice funzione di richiamo nei confronti dell’utenza potenziale e di tramite verso gli altri strumenti informativi. Per le riviste «Archivio Storico per le province napoletane», «Japigia», «Archivio storico pugliese» e «la Capitanata», si suggerisce invece la ricollocazione presso il Fondo Locale in quanto documenti - per il loro carattere storico, culturale e bibliografico - legati all’area geografica di copertura della raccolta locale.29 L’evoluzione recente avvenuta nel settore delle biblioteche pubbliche30 e la tendenza alla permanenza in sede degli utenti della Biblioteca Provinciale ha richiesto una complessiva riorganizzazione. È giusto, pertanto, che l’apparato di consultazione generale metta a disposizione del pubblico una gamma articolata di posti di lettura, abbandonando la sistemazione che prevede i tavoli tutti uguali disposti in modo regolare ed in un unico spazio dall’aspetto quasi scolastico, per zone di piccole e medie dimensioni, con conseguente flessibilità di spazi attrezzati per la consultazione sistematica in sede e lo studio individuale con uno o più supporti.31 Il valore dell’apparato di consultazione generale potrà essere misurato dalle dimensioni quantitative, dalla copertura bibliografica in relazione alle aree disciplinari, dalla qualità intrinseca dei documenti, da periodiche revisioni a vantaggio del- 28 Paolo GALLUZZI, La Biblioteca Digitale “Ibrida”, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», 2001, 1-2; Fabio DI GIAMMARCO, La biblioteca ibrida: verso un sistema informativo integrato in «A.I.B. notizie», 2002, 4, pp. 9-10. Il dibattito sulla “biblioteca ibrida” (espressione entrata recentemente nel gergo tecnico dei bibliotecari) è ancora aperto in quanto il tema divide gli addetti ai lavori tra coloro che sostengono l’importanza della disponibilità di strumenti e tecnologie avanzate per potenziare la performance ed esaltare la missione civile e democratica della biblioteca, rinvigorendone il ruolo, e quanti invece si preoccupano per l’eventuale rischio che corre l’ “Icaro” elettronico: costi elevati, possibile selezione sbagliata del materiale, problemi di copyright e di conservazione, pericolo che la digitalizzazione possa trasformarsi in una freccia puntata verso la disintegrazione e la progressiva scomparsa della biblioteca fisica, costringendo alla rinuncia di vantaggi, piaceri e comodità della vecchia, amata carta. 29 Rino PENSATO, La raccolta locale: principi e gestione, Milano, Editrice Bibliografica, 2000. 30 Ornella FOGLIENI (a cura di), La qualità nel sistema biblioteca: innovazione tecnologica, nuovi criteri di gestione e nuovi standard di servizio, Milano, Editrice Bibliografica, 2001. 31 Michel MELOT, Strategie multimediali per una biblioteca pubblica in trasformazione, in Massimo CECCONI et al. (a cura di), La biblioteca efficace: tendenze e ipotesi di sviluppo della biblioteca pubblica negli anni ’90, Milano, Editrice Bibliografica, 1992, pp. 63-75. 81 Apparato di consultazione generale. Aspetti strutturali e semantici la freschezza delle raccolte e dall’impegno professionale continuo nel cercare di catalizzare e soddisfare i bisogni degli utenti. Nessuna biblioteca, tuttavia, è un’isola. La Biblioteca Provinciale e, dunque, il settore di consultazione generale, non può coltivare una propria politica delle collezioni ignorando il tessuto documentario del contesto sociale in cui opera. Pertanto, bisognerà adottare una strategia di cooperazione, cercando di realizzare, attraverso altre strutture bibliotecarie presenti nel territorio urbano e provinciale, un controllo bibliografico esauriente e collaborare in modo organico allo sviluppo delle relative raccolte al fine di una armonizzazione delle conoscenze.32 32 REGIONE SICILIA, Cultura organizzativa e pianificazione: ruolo e prospettive per le biblioteche nel mercato dell’informazione, Atti del 35° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana biblioteche (Cefalù 30 settembre-4 ottobre 1989), Palermo, Regione Sicilia, 1991. 82 Gabriella Berardi Il catalogo della Biblioteca Provinciale di Foggia tra passato, presente e futuro di Gabriella Berardi La biblioteca è per eccellenza il luogo dell’intermediazione, e strumento privilegiato per questa funzione è il catalogo. Se consideriamo la biblioteca come un sistema informativo composto dalle variabili documenti, utenti, sistemi di organizzazione, possiamo renderci conto di come l’anello di congiunzione tra offerta informativa e bisogni degli utenti sia costituito proprio dai sistemi di organizzazione allestiti da una biblioteca. E infatti “una raccolta di documenti, sia pure selezionati con criteri determinati, non costituisce una biblioteca in assenza di un linguaggio – il catalogo – che la metta in relazione con i lettori”.1 La natura sistemica delle biblioteche e la natura strumentale del catalogo, il cui scopo è quindi quello di mettere in relazione le informazioni e gli utenti, hanno come conseguenza la necessaria storicità del processo catalografico, “legato ai bisogni di chi lo usa da una parte, ai modi in cui si organizza e si manifesta il processo informativo dall’altra”.2 La verità di questa affermazione è riscontrabile anche nei cambiamenti del catalogo della Biblioteca Provinciale di Foggia. In un contesto di ibridazione delle collezioni e dei servizi3 possiamo tracciare una linea di sviluppo del catalogo de “la Magna Capitana” comune alla maggior parte delle biblioteche esistenti ed articolata in tre fasi: da una produzione di schede a stampa si è passati alla fase attuale caratterizzata dalla convivenza di OPAC e catalogo cartaceo per ipotizzare infine un terzo momento costituito solo dal catalogo elettronico. Fino al 2000 il catalogo della Biblioteca Provinciale era esclusivamente cartaceo, con uno schedario generale per autori ed un altro per soggetti. Ogni sala aveva inoltre un proprio catalogo contenente i duplicati delle schede relative ai documenti di propria pertinenza. Il registro d’ingresso, come di norma in un contesto non automatizzato, era aggiornato manualmente da un unico addetto che poi smistava i documenti verso i vari settori. Il passaggio ad una gestione automatizzata delle procedure catalografiche ha comportato una serie di mutamenti sia nelle pratiche di 1 Mauro GUERRINI-Alberto CHETI, Catalogazione e indicizzazione, Roma, Mediateca 2000, 1998, p. 11. Luigi CROCETTI-Rossella DINI, ISBD (M) : introduzione ed esercizi, terza ed., Milano, Editrice Bibliografica, 1995, p. 11. 3 A questo tema è stato dedicato il convegno “La biblioteca ibrida”, Milano 14-15 marzo 2002. 2 83 Il catalogo della Biblioteca Provinciale di Foggia tra passato, presente e futuro lavoro che nel servizio offerto agli utenti. Inizialmente, come per ogni cambiamento in qualche modo epocale, il primo passo è stato quello di vincere le resistenze dei bibliotecari abituati a consuetudini lavorative ormai consolidate nel tempo. Il passaggio all’automazione ha aperto senza dubbio nuove possibilità, ma nel contempo ha portato con sé non solo l’acquisizione di nuove competenze, ma la condivisione e soprattutto il confronto continuo. Spesso, e questa è una costante ogni volta che una nuova biblioteca entra nel sistema provinciale e viene formata sulle tematiche legate alla catalogazione automatizzata, i bibliotecari sono presi dalla sconforto dovuto alla smentita della loro convinzione che con il computer tutto sarebbe stato più semplice e il lavoro si sarebbe quasi fatto da sé. In realtà le macchine non ci forniscono “l’intelligenza, ma le occasioni per verificare la supposta conoscenza dei fenomeni e dei processi bibliotecari”.4 Per quanto riguarda il software da utilizzare la scelta è caduta sul Sebina, unico programma allora compatibile con il Servizio Bibliotecario Nazionale. La struttura modulare del software ha consentito di avviare un processo di informatizzazione graduale, partendo inizialmente dalle operazioni catalografiche per poi arrivare alla gestione degli utenti e del prestito sia locale che in prospettiva interbibliotecario. Nella fase di impostazione del lavoro si è posta la prima scelta cruciale, se optare per una conversione retrospettiva o per una catalogazione retrospettiva. Essendo il catalogo cartaceo della “Provinciale” risultato di un lavoro stratificato nel tempo, ed essendo nel contempo cambiate le standardizzazioni sia a livello descrittivo che in parte semantico, si è scelta la strada più impegnativa ma anche quella in grado di garantire una maggiore correttezza e attualità, quella della catalogazione retrospettiva. Questo significa procedere ad una attività di catalogazione informatizzata ‘libro in mano’ per un pregresso che si aggira intorno ai 250 mila volumi. Impegnare il personale in un lavoro del genere, però, avrebbe significato il blocco o un notevole ritardo nelle attività di catalogazione delle nuove accessioni, senza considerare che i catalogatori sono spesso impegnati anche in lavoro di sala. Si è optato quindi per l’esternalizzazione del recupero catalografico del pregresso affidato ad una società cooperativa nata dal progetto ministeriale “Mediateca 2000”. Tutte le nuove accessioni restano invece di pertinenza del personale interno. Il passaggio all’automazione è coinciso con l’aggiornamento degli strumenti di lavoro sia per quanto riguarda la descrizione bibliografica5 che la formulazione degli indici soprattutto semantici.6 Questo per garantire quell’uniformità che è condizione essenziale per la condivisione delle raccolte e per il recu4 Alfredo SERRAI, Manuale di biblioteconomia, Firenze, Sansoni, 1995, p. 62. Strumenti imprescindibili sono: ISTITUTO CENTALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE , Guida alla catalogazione in SBN. Pubblicazioni monografiche, pubblicazioni in serie, Roma, ICCU, 1995; ISTITUTO CENTALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE, Guida alla catalogazione in SBN. Libro antico, Roma, ICCU, 1995; nonché Giuliana SAPORI (a cura di), Manuale di regole di catalogazione in SBN consultabile all’indirizzo internet: http://www.cilea.it/Virtual_Library/bibliot/sapori/manuale.htm. 6 Per i soggetti: ISTITUTO CENTALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE, Soggettario, voci di soggetto dal 1925 al 1998, Roma, ICCU, 2001. Per le classi: Melvil D EWEY, Classificazione decimale Dewey, ventunesima ed., Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2000. 5 84 Gabriella Berardi pero delle informazioni da parte degli utenti. Sempre in quest’ottica la biblioteca ha avviato un intenso programma di formazione di base e specialistica. Per quanto possibile l’alfabetizzazione è stata portata avanti da personale interno, mentre l’aggiornamento sull’uso del software di catalogazione è stato effettuato dalla ditta produttrice. Inoltre la Biblioteca Provinciale, per tenere fede al suo ruolo di indirizzo e di riferimento a livello provinciale ha organizzato alcuni seminari di formazione tenuti da personalità del mondo delle biblioteche a livello nazionale. Per gli argomenti legati al catalogo non possiamo non ricordare il seminario di studio sul “Controllo di autorità nella mediazione catalografica” tenuto da Mauro Guerrini, introduttivo al Convegno internazionale svoltosi a Firenze.7 L’ampia partecipazione di pubblico ad un incontro così tecnico ha confermato l’interesse esistente intorno alle attività di biblioteca e soprattutto la necessità di promuovere periodicamente incontri del genere come momento non solo di formazione ma di confronto delle singole pratiche di lavoro quotidiano da parte delle biblioteche della provincia. Il passaggio all’automazione ha comportato non solo un mutamento della forma fisica del catalogo, ma anche un mutamento delle informazioni contenute. La possibilità di creare, oltre a quelli tradizionali per autore, soggetto e classe, accessi anche per titoli secondari, collane editoriali, luoghi di pubblicazione ed editori, oppure di affiancare alla descrizione un link multimediale (come nel caso dei manifesti cinematografici) o un abstract rappresenta un notevole incremento delle informazioni offerte e delle possibilità di ricerca, ampliate dall’eventuale uso di operatori logici.8 Inoltre l’uso del software ha consentito anche un notevole miglioramento della struttura sindetica del catalogo, in particolar modo per quanto riguarda gli indici semantici. Gestire legami normalmente usati in un thesaurus9 per i descrittori di soggetto oltre che, come avveniva anche nel cartaceo, per le stringhe, consente all’utente di navigare all’interno del catalogo alla ricerca del soggetto più pertinente alle proprie esigenze informative.10 Nell’OPAC confluiscono anche tutte le registrazioni bibliografiche delle biblioteche aderenti al sistema provinciale, consentendo ricerche in tutte le strutture contemporaneamente o soltanto in una di esse. Da febbraio 2003 la Biblioteca Provinciale è entrata ufficialmente nel Servizio Bibliotecario Nazionale come centro rete del “Polo SBN Foggia” costituito anche da altre biblioteche del territorio.11 Fanno parte del catalogo condiviso con 7 Questi i dati relativi ai due incontri: “Il controllo d’autorità nella mediazione catalografica”, Foggia 27-28 novembre 2002. “Authority control. Definizione ed esperienze internazionali”, Firenze 10-11 febbraio 2003. Di quest’ultimo sono stati pubblicati gli atti: Authority control. Definizioni ed esperienze internazionali, Atti del convegno internazionale, (Firenze 10-12 febbraio 2003), Firenze, Firenze University Press, 2003. 8 L’illustrazione delle possibilità di ricerca dell’OPAC della Biblioteca Provinciale è affidata all’aiuto in linea multilingue: italiano, inglese, francese, arabo. 9 BT (broader term), NT (narrower term), RT (related term), UF (used for). 10 Per un’esemplificazione di quanto detto è possibile nell’OPAC della Biblioteca inserire nel campo soggetto il termine “acquisto” e selezionare l’opzione “descrittori”. 11 L’elenco completo e aggiornato delle biblioteche che fanno parte del Polo SBN Foggia è consultabile all’indirizzo http://www.iccu.sbn.it/pofoggia.htm. 85 Il catalogo della Biblioteca Provinciale di Foggia tra passato, presente e futuro SBN le banche dati libro moderno e libro antico. Per quanto riguarda le altre tipologie documentarie, audiovisivi e grafica in primis, si è scelta la strada della gestione solo in banca dati locale, per esigenze legate ad una maggiore analicità descrittiva e semantica che i codici SBN allo stato attuale non consentono. Attualmente catalogano in Indice “la Magna Capitana” le biblioteche di Manfredonia, Lucera, S. Giovanni Rotondo e Trinitapoli. I bibliotecari di tutte le strutture aderenti hanno seguito un corso di formazione di un mese sulla catalogazione in SBN e sull’utilizzo del software Sebina, cui ha fatto seguito un periodo di lavoro in ambiente di prova. Come fase di formazione complementare le biblioteche hanno spedito via posta elettronica gli identificativi dei documenti catturati o creati al responsabile di polo per l’eventuale correzione. Per il momento la formazione ha avuto come oggetto il materiale monografico, ma una volta comprese e applicate con padronanza le procedure sono previste ulteriori fasi formative sulla catalogazione delle altre tipologie documentarie presenti nelle biblioteche, principalmente periodici, audiovisivi e risorse elettroniche. Il catalogo ibrido, dovuto alla temporanea compresenza del catalogo elettronico e di quello cartaceo, fa il paio con delle collezioni votate sempre più all’ibridazione. Questa situazione, congenita per “la Magna Capitana” nata con un patrimonio costituito da libri e periodici insieme a musica su vinile e manifesti cinematografici,12 si è accentuata con l’entrata in biblioteca di nuovi supporti e risorse informative multimediali e ipertestuali, che pongono questioni urgenti non solo in ambito catalografico ma anche gestionale ed organizzativo.13 Per questo tipo di documenti è necessaria anche la distinzione tra Risorse elettroniche ad accesso locale (REL) e Risorse elettroniche ad accesso remoto (RER), distinzione che introduce un argomento ormai classico per i bibliotecari, quello della contrapposizione tra possesso di queste risorse e accesso alle medesime.14 Indipendentemente dalla discussione professionale in atto, che tra l’altro segnala il superamento in ambito anglosassone del termine “accesso” verso un maggiore coordinamento delle funzioni relative alle acquisizioni indicato con l’acronimo RADAR,15 la Biblioteca Provinciale ha scelto di fornire un accesso unico e integrato a tutti materiali a stampa e digitali attraverso l’OPAC. Finora le risorse elettroniche presenti nel catalogo sono 12 Cfr. l’opuscolo sull’inaugurazione della struttura: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAPITANATA, Biblioteca Provinciale di Foggia, Foggia, L. Cappetta & F., 1974. 13 Per un esame esaustivo delle problematiche poste dalle risorse elettroniche in biblioteca, cfr. Rossana MORRIELLO, Gestire le raccolte elettroniche in biblioteca. Problemi e prospettive in «Bibliotime», V(2002), 3 (novembre), http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/num-v-3/morriell.htm. 14 Joel S. RUTSTEIN et al., Possesso contro accesso.Un cambiamento per le biblioteche, in «Biblioteche oggi», XIII (1995), 7 (settembre), pp. 40-52. 15 Cfr. Michele SANTORO, L’era dell’Acquario, in «Bibliotime», III (2000), 2 (luglio), http://www.spbo.unibo.it/ bibliotime/num-iii-2/editoria.htm. A proposito dell’accesso Santoro scrive: “nelle strutture bibliotecarie, e in particolar modo in quelle universitarie, si accresce l’importanza del coordinamento fra tutti i settori della biblioteca, a cominciare da quello davvero strategico delle acquisizioni: pertanto, al posto del termine “accesso”, viene ora impiegata un’espressione più articolata, sintetizzata nell’acronimo RADAR (Resources Access Detection Acquisition and Retrieval)”. 86 Gabriella Berardi però soltanto ad accesso locale, ma la volontà è quella di fornire un unico canale di ricerca anche per le risorse elettroniche remote, in particolare quelle presenti in Internet. Attualmente il catalogo elettronico della Biblioteca Provinciale contiene le seguenti tipologie di materiale: libro moderno, libro antico, grafica (manifesti cinematografici), audiovisivi (vhs, dvd, dischi in vinile), partiture musicali. Nella categoria libro moderno rientrano sia i documenti a stampa pubblicati dal 1831 in poi, sia le risorse elettroniche, gestite con il codice di genere x (archivio elettronico). Nel modulo libro antico sono descritti e indicizzati i documenti pubblicati prima del 1830. Gli audiovisivi, pur potendo rientrare nell’archivio libro moderno agendo con un codice di genere, sono trattati in un modulo specifico per esigenze di maggiore completezza catalografica. Ad esempio, nella formulazione degli indici per autore è possibile specificare la funzione di responsabilità invece che limitarsi all’indicazione di responsabilità principale o secondaria. Lo stesso dicasi per i manifesti cinematografici catalogati nel modulo grafica.16 In realtà, così come la biblioteca, citando la quinta legge della biblioteconomia di Ranganathan, è un organismo in crescita, quindi mai uguale a se stessa, così è anche per il catalogo. Le sollecitazioni introdotte dai Requisisti funzionali per i Record Bibliografici (FRBR) con il discorso su entità e relazioni, e la distinzione tra opera, espressione, manifestazione e item, sono talmente gravide di conseguenze da far prevedere una nuova logica alla base del lavoro catalografico. Un OPAC che riuscisse a far proprie e a rendere operative le potenzialità insite in FRBR offrirebbe la “possibilità da una parte di ricevere sempre la risposta del livello e della granularità appropriate, dall’altro di navigare la rete delle relazioni per cambiare di livello o di granularità nelle direzioni desiderate, disponendo sempre della massima informazione sui propri movimenti”.17 Se poi si vuole restare nel campo strettamente semantico, come non parlare della difficoltà di organizzare e indicizzare un sapere in continuo divenire, difficoltà che aumenta con la diffusione del sapere in formato elettronico, con “i meccanismi informativi e della comunicazione a un ritmo assai prossimo al potenziale del nostro cervello”.18 Le biblioteche non potranno non fare i conti con quella “convergenza al digitale”19 che porta non solo ad una progressiva smaterializzazione dell’informazione ma a nuove forme di organizzazione ed elaborazione del pensiero. Per una istituzione come “la Magna Capitana”, che sta vivendo un momento cruciale di riorganizzazione dei servizi e degli spazi, non è possibile ignorare le questioni fin qui poste, alla luce delle quali risulta con evidenza come la frontiera del catalogo della “Provinciale” risieda nel potenziamento della struttura sindetica del catalogo, della rete tra descrizioni e indici che dovrà consentire di dare contezza 16 Per il trattamento di questa tipologia di materiale da parte de “la Magna Capitana”, cfr. Gabriella BERARDI, La sezione “Immagini e suoni” della Biblioteca provinciale di Foggia. Questioni catalografiche , in «la Capitanata», XLI (2003), 14 (ottobre), pp. 217-223. 17 Serafina SPINELLI, Al centro di FRBR l’utente, in «Bibliotime», V (2002), 2 (luglio), http://www.spbo.unibo.it/ bibliotime/num-v-2/spinelli.htm 18 Michele SANTORO, Sulle spalle dei giganti in «Biblioteche oggi», XXI (2003), 1 (gen.-feb.), p. 24. 19 Ibid., p. 22. 87 Il catalogo della Biblioteca Provinciale di Foggia tra passato, presente e futuro di un sapere sempre più frammentato e granulare. Il tutto incentrato sulla conoscenza e analisi dei bisogni degli utenti da un lato, e sulla comprensione dei contenuti concettuali e delle caratteristiche bibliografiche dei documenti dall’altro, in modo che il catalogo non sia solo un contenitore di notizie, ma sia anche una “guida all’esplorazione delle diverse espressioni e manifestazioni del pensiero e della creatività umana”.20 20 Alberto PETRUCCIANI, Nuovi requisiti per nuovi cataloghi, in Seminario FRBR. Functional requirements for bibliographic records, Atti del convegno (Firenze 27-28 gennaio 2000), Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2000, p.150. 88 Grazia Carbonella I documenti sonori: prime considerazioni sulle registrazioni musicali di Grazia Carbonella Alla fine dell’Ottocento il pensiero europeo ha avviato una riflessione generale sui fenomeni musicali e sui loro presupposti che, congiuntamente al rapido sviluppo delle scienze, ha generato nuove discipline, nuove scoperte scientifiche e nuove applicazioni tecnologiche. Con l’avvento del fonografo, nel 1887, nasce infatti una nuova tecnologia capace di captare, fissare e riprodurre i suoni: la registrazione, uno degli eventi capitali nella storia della musica del XX secolo. “La registrazione ha fornito alla musica un supporto materiale per trascendere il tempo e ha abolito i confini spazio-temporali che la limitavano”,1 ha aperto la strada alla fondazione e allo sviluppo dell’etnomusicologia come scienza,2 ha influenzato l’ascolto,3 la composizione,4 l’apprendimento, la ricerca. La registrazione come documento5 quindi; per questo la Biblioteca Provinciale sin dal suo atto di nascita ha contemplato una sezione dedicata alla conservazione dei documenti sonori. La collezione comprende circa 6829 dischi, di cui 4689 1 Jacques HAINS, Dal rullo di cera al CD, in Jean-Jacques NATTIEZ (a cura di), Enciclopedia della musica, Torino, Einaudi, 2001, 3 voll.: I vol., Il Novecento, pp. 783. 2 “Prima dell’introduzione dei mezzi meccanici e poi elettrici e magnetici per la fissazione della parola e del suono e dei mezzi di fissazione visiva, gli etnologi e gli etnomusicologi erano, di fatto, non già operatori che cercavano, raccoglievano e interpretavano documenti preesistenti (come gli storici), ma ‘creatori’ delle loro stesse fonti documentarie. Infatti, osservavano sul campo i fenomeni e ne fissavano, con un’operazione inevitabilmente selettiva, i tratti per loro salienti e caratterizzanti in notazione grafica (scrittura o notazione musicale o disegno). Quando poi affrontavano lo studio del materiale raccolto e operavano (come gli storici) una scelta attingendo agli appunti presi sul campo, si trovavano di fronte a un duplice problema: quei documenti erano stati da loro stessi composti (non soltanto scelti), e quanto avessero scartato sarebbe stato perduto”; cfr. Roberto LEYDI, L’altra musica, Milano, Giunti-Ricordi, 1991, p. 25. 3 “Il concerto è un luogo d’incontro dove si celebra un rituale sociale e magico, dove l’ascoltatore partecipa ad un avvenimento […] in comunione con l’interprete e col resto del pubblico; mentre allorché appoggia un disco sul piatto attua un comportamento individuale, come quando legge un libro”; cfr. J. HAINS, Dal rullo di cera al CD…, cit., p. 816. 4 Pensiamo nel secondo dopoguerra alla musica sperimentale; cfr. Ugo DUSE, Per una storia della musica nel Novecento e altri saggi, Torino, EDT/Musica, 1981, pp. 100-107. 5 “Con il termine documento intendiamo ogni insieme di informazioni e di conoscenza fissato materialmente e suscettibile di essere utilizzato per la consultazione, per lo studio, oppure come prova di un fatto”; cfr. Nicola TANGARI, Standard e documenti musicali, Milano, Editrice Bibliografica, 2002, p. 53; la citazione riportata è di Édith WEBER, La recherche musicologique. Objet, méthodologie, normes de prèsentation, Paris, Beauchense, 1980, p. 47. 89 I documenti sonori: prime considerazioni sulle registrazioni musicali in vinile e 2140 CD. Tra i dischi in vinile è compreso anche il fondo Amilcare Volpe acquistato nel 1987 e costituito da 400 78 giri. Da ottobre 2002 è partito un progetto di catalogazione dei documenti sonori attraverso procedure informatiche: utilizzando standard internazionali sono stati inseriti nel catalogo generale della Biblioteca - consultabile attraverso il suo OPAC - i record relativi ai singoli dischi. Da una rapida ricognizione il fondo in vinile appare costituito da due nuclei principali: una collezione di 33 giri di musica classica e una di musica jazz. A questi due nuclei si aggiungono le incisioni di musica classica su 78 giri e, su 33 giri, un altro piccolo gruppo di musica etnica, di canti politici e della resistenza. Il lavoro di recupero è partito dai 33 giri di musica classica; a tutt’oggi sono stati catalogati mille dischi*. Poiché il lavoro di catalogazione è ancora in corso, non è possibile esprimere valutazioni definitive, ma dai documenti finora visionati è evidente una preminenza quantitativa della musica strumentale su quella vocale, del repertorio classicoromantico su quello barocco e rinascimentale. Di questo non c’è da stupirsi: sono spesso i cataloghi delle case discografiche a condizionare gli acquisti6 e, nel caso di questo fondo, per la sezione fin’ora analizzata, le incisioni più numerose appartengono all’etichetta Deutsche Grammophon e alla EMI. Si tratta di due colossi del panorama discografico internazionale, dalla storia lunga e finanziariamente travagliata. La EMI - Electrict and Musical Industries Ltd.- nasce nel 1931 dalla fusione intersocietaria della Gramophon Company- proprietaria della celebre etichetta His Master’s Voice - e della Columbia inglese.7 Il fondo in questione contiene 300 unità discografiche che afferiscono al gruppo EMI:8 la EMI Electrola (marchio della divisione tedesca), la EMI italiana e La voce del padrone, marchio italiano dell’inglese His Master’s Voice. Si tratta in gran parte di registrazioni storiche - Karajan che dirige Wagner per la EMI Electrola - e di collezioni celebri, come la “Seraphim” (nelle sue sezioni “Concerto”, “Musica da camera”, “Recital” e “Sinfonia”) e la * I dati riportati in questo studio sono relativi al mese di febbraio 2004. A riguardo sono interessanti le riflessioni di Paolo PRATO, La musica nell’era della globalizzazione, in «Musica/Realtà», 2002, 69 (novembre), pp. 127-134. 7 La Columbia Phonograph Company viene fondata negli Stati Uniti nel 1888 dall’imprenditore Jesse Lippincott, unitamente alla North American Phonograph Company. Le due società commercializzavano apparecchi realizzati con i brevetti acquisiti da Thomas Alva Edison e da Chichester Bell e Charles Sumner Tainter, le cosiddette talching machines. Delle due società solo la Columbia è sopravvissuta a lungo sfruttando quella che è stata l’idea vincente del suo fondatore: creare una rete commerciale su larga scala con una serie di compagnie locali licenziatarie della società madre. La National Gramophone Company nasce invece in Inghilterra nel 1897 dalle ceneri della Berliner Gramophon Company americana. Il suo fondatore, lo stesso Berliner, fu costretto da una serie di azioni legali intraprese contro di lui a ritirarsi dagli Stati Uniti confluendo nella Victor Talking Machines di Eldridge Johnson. Al momento della fusione il gruppo EMI acquisì il controllo del mercato europeo, poiché la Columbia aveva già assorbito nel 1925 la tedesca Lindström e nel 1928 la francese Pathè. Cfr. Luca CERCHIARI, Il disco. Musica, tecnologia mercato, Milano, Sansoni, 2001, pp. 19 e 36. 8 Dopo le prime esperienze pionieristiche e con lo sviluppo dell’impresa discografica è ormai sempre più diffusa la distinzione tra denominazione sociale della casa madre e marchi discografici (label); cfr. L. CERCHIARI, Il disco…, cit., p. 73. 6 90 Grazia Carbonella “Discoteca classica” (di cui si conservano incisioni di Arturo Benedetto Michelangeli, Sviatoslav Richter, Alirio Diaz, Yehudi Menuhin, Walter Gieseking, Artur Rubinstein). Un discorso a sé meritano le registrazioni de La voce del padrone, anche per la consistenza quantità dei dischi posseduti, pari a 258 documenti. Dal prestigioso catalogo della corrispondente etichetta inglese His Master’s Voice, passata alla storia per aver utilizzato come logo il cagnolino Nipper - fox terrier intento ad ascoltare i suoni da una tromba di un grammofono - sono state riproposte dalla EMI nella collezione “Historical Archives” numerose incisioni storiche. Si tratta di incisioni di celebri cantanti italiani: da Enrico Caruso a Beniamino Gigli, da Giacomo Lauri Volpi a Rosetta Pampanini, da Tancredi Pasero a Giulietta Simionato, per citarne solo alcuni. Il Teatro alla Scala di Milano era per l’Italia la principale sede d’incontro tra il mondo del melodramma e quello dell’industria discografica: nasceva in quegli anni il divismo canoro, di cui questi dischi sono testimonianza. Tra le incisioni di voci illustri non mancano anche quelle di Maria Callas e di Giuseppe Di Stefano con la direzione di Nicola Rescigno, Dino Olivieri e di Tullio Serafin. Accanto a queste registrazioni è interessante sottolineare la presenza nel fondo di una serie di incisioni dell’etichetta russa Melodiya10 acquisite ed edite in Italia dalla stessa EMI. Si tratta di registrazioni di autori nazionali - Glinka, Sostakovic, Prokof’ev - eseguite dall’Orchestra Sinfonica del Ministero diretta da Svetlanov e da Rozhdestvensky tra cui il Concerto per violino e orchestra in re minore di Kachaturian eseguito da David Oistrakh e dall’Orchestra Sinfonica della Radio di Mosca sotto la direzione dello stesso autore. A questo gruppo appartengono anche sei dischi contenenti canzoni classiche napoletane: si tratta di incisioni di Giuseppe Di Stefano, di Tito Schipa e di Beniamino Gigli. Le canzoni sono quelle della tradizione classica che tanta fortuna hanno avuto in Italia e all’estero: da Marchiare a Torna a Surriento, da Funesta che lucive a Funiculì, funiculà, per citarne solo alcune. Il secondo gruppo di dischi, quantitativamente rilevante, è quello della Deutsche Grammophon. La storica etichetta tedesca nasce come fabbrica per il pressaggio dei dischi le cui matrici venivano realizzate a Londra dalla consociata Grammophon di Emile Berliner. Diventata autonoma nel 1917, ha vissuto il perio- 9 Questa immagine fu realizzata dal pittore londinese Francis James Barraud, ex studente alla Royal Academy School inglese. Il dipinto, offerto in un primo momento e senza successo ad Edison, è stato poi acquistato da William Berry Owen, amministratore delegato della Grammophon - che chiese all’autore di sostituire il fonografo della prima versione con un grammofono - pagando 100 sterline per la cessione dei relativi diritti, acquisiti poi nel 1900 da Emile Berliner per gli Stati Uniti e per il Canada. L’immagine, trasferita poi alla Victor Talking Machine Company, ha fatto il giro del mondo, finendo per identificare un’epoca della storia del disco, relativa al formato 78 giri. Cfr. CERCHIARI, op. cit., p. 51. 10 L’etichetta nasce nel 1964 come società unica di produzione discografica, da un provvedimento del Ministero della Cultura. Inglobando diverse realtà presenti sul territorio la nuova label, ben presto tra le principali sei etichette discografiche del mondo, ha potuto incrementare la sua produzione, modernizzando i suoi impianti attraverso l’acquisto di attrezzature dai Paesi Occidentali. Il suo catalogo, grazie anche all’alta professionalità delle interpretazioni vocali e strumentali, è stato ben presto oggetto di esportazione. Cfr. ibid., p. 166. 91 I documenti sonori: prime considerazioni sulle registrazioni musicali do di maggiore crescita a partire dagli anni ‘50, e soprattutto ‘60.11 Per la celebre etichetta tedesca è stata centrale la figura di Herbert von Karajan, personaggio carismatico attorno al quale è nato un vero e proprio culto, alla cui attività, relativa al prestigioso Festival di Salisburgo, la casa discografica ha legato molte celebri incisioni.12 La Biblioteca Provinciale possiede 185 dischi della Deutsche Grammophon tra cui registrazioni di Karl Richter, Dieter Fischer-Dieskau, e tredici registrazioni di Wilhelm Kempff. Non mancano anche interpreti italiani tra cui Arturo Benedetti Michelangeli - che suona Debussy e Chopin - e Maurizio Pollini - che suona tra l’altro Stravinskij e Prokof’ev. Alcune tra le incisioni conservate appartengono alle collezioni “Préstige”, “Privilege”, “Resonance” e “Omaggio all’opera”.13 Della Deutsche Grammophon è anche Metropolitan opera gala honoring sir Rudolf Bing, disco registrato dal vivo al Metropolitan Opera Hause il 22 aprile del 1922.14 Alcune interessanti registrazioni DGG sono state riproposte sul mercato italiano anche dall’Istituto Geografico de Agostini con I grandi compositori: ascoltare e capire la loro musica, un progetto editoriale che ha previsto la pubblicazione in fascicoli di testi - per un totale di 5 monografie - e di 26 audiocassette15 a sostegno di un catalogo di 102 incisioni discografiche. Tra queste l’Eroica di Beethoven eseguita dalla Wiener Philharmoniker diretta Leonard Bernstein, la Pastorale diretta da Carl Böhm e la Quinta Sinfonia, sempre di Beethoven, eseguita dai Berliner Philharmoniker con la direzione di Wilhelm Furtwängler. Il piano dell’opera – interamente posseduto dalla Biblioteca - comprende anche una serie di registrazioni della Philips. Legata alla Deutsche Grammophon è l’etichetta Archiv Produktion, nata nel 1948 per documentare il repertorio rinascimentale e barocco.16 La Biblioteca possiede 11 dischi di questa etichetta. Si tratta di pubblicazioni estremamente curate in cui le registrazioni, che si avvalgono dell’uso di strumenti originali e si prefiggono esecuzioni filologicamente corrette, sono corredate di un ricco apparato esplicativo, con note storiche sul periodo delle composizioni nelle quattro lingue, italiano, francese, tedesco e inglese. Sono inoltre puntualmente indicate le fonti impiegate per le esecuzioni e, se manoscritte, dove sono conservate. Insomma un impianto 11 Il successo mondiale della Deutsche Grammophon è dovuto alla eccellente qualità della resa sonora delle sue incisioni, all’intransigente selezione degli interpreti e ad un’attenta scelta dei repertori del XIX e del XX secolo. Ma oltre a tutto questo il grande successo di questa etichetta è dovuto a una fedele presenza del pubblico tedesco, che più di ogni altro ha una forte inclinazione all’ascolto e al consumo della produzione musicale eurocolta, in particolare strumentale. Cfr. CERCHIARI, op.cit., p. 171. 12 La Biblioteca conserva 22 dischi che testimoniano questo connubio. 13 Di questa serie si conserva solo un disco - il n. 10 - che contiene un’incisione del Rigoletto di Verdi con Orchestra e Coro del Teatro alla Scala sotto la direzione di Kubelik, con Renata Scotto, Mirella Fiorentini, Carlo Bergonzi, Dietrich Fischer-Dieskau (phonogram 1964). 14 Si tratta di un memorabile concerto che coinvolse grandi interpreti tra cui Martina Arroyo, Montserrat Caballé, Birgit Nilsson, Leontyne Price, Franco Corelli con la Metropolitan Opera Orchestra diretta da Richard Bonynge, James Levine, Carl Böhm, Francesco Molinari-Pradelli, Kurt Adler. 15 Un’audioguida all’ascolto con testi di Carlo Delfrati, con la consulenza discografica di Gaetano Santangelo e con la voce di Giancarlo Dettori. 16 Si legge sui dischi: Musikhistorisches studio der Deutsche Grammophon Gesellschaft. 92 Grazia Carbonella informativo di taglio musicologico, chiaramente rivolto ad un pubblico specialistico. Ne è un esempio la registrazione del dramma allegorico Rappresentatione di Anima et di Corpo di Emilio de’ Cavalieri.17 Le note musicologiche sono di Claude V. Palisca, Theophil Antonicek, Suzanne Clercx, E.H. Hiss e sono relative alla musica italiana del Seicento e alla strumentazione del dramma, le cui indicazioni sono contenute nell’avvertimento Ai lettori, riproposto in versione fac-simile e nelle relative traduzioni. Dell’etichetta inglese Decca sono invece conservati 35 dischi. La Decca nasce su iniziativa dell’imprenditore inglese Edward Lewis nel 1929. Pochi anni più tardi, nel 1934, invertendo una tendenza largamente radicata, la casa inglese ha aperto una filiale negli Stati Uniti, destinata tra l’altro ad un maggior successo della casa madre.18 La politica da subito adottata è stata quella di contenimento dei prezzi, mettendo sul mercato dischi a prezzi economici, quasi la metà del costo dei dischi EMI.19 Tra gli esemplari conservati ci sono alcune riedizioni delle prime registrazioni effettuate dalla casa inglese e dedicate al direttore d’orchestra svizzero Ernest Ansermet alla testa de L’Orchestre de la Suisse Romande, e alcune incisioni appartenenti alla serie “Eclipse” e “Ace of Clubs” - tra cui alcune del Quartetto Italiano.20 Sono dedicate al repertorio strumentale invece le incisioni degli Études d’execution transcendante di Liszt eseguiti da Vladimir Ashkenazy, che con la Moscow Philharmonic Orchestra diretta da Kyrill Kondrashin esegue anche musiche di Rachmaninov. Di questa etichetta sono conservate anche due registrazioni di un giovanissimo Abbado che dirige la London Symphony Orchestra in musiche di Mendelsshon e Prokof’ev e di Luciano Pavarotti in una raccolta di arie con la Vienna State Opera Orchestra and Chorus e la New Philharmonia Orchestra and Chorus. Sono ancora Decca le Sonate di Galuppi e di Scarlatti eseguite da Arturo Benedetti Michelangeli e le Sinfonie di Mozart eseguite dalla New Philharmonia Orchestra con la direzione di Carlo Maria Giulini.21 17 Composto per “recitar cantando” e messo in scena ad opera dei padri filippini di Roma nel 1600, fu un grande evento mondano e rappresenta una tappa importante nella storia del melodramma, proponendo uno stile atto “a diversi affetti muovere gli spettatori”. In realtà sarà l’Euridice di Ottavio Rinuccini, messa in scena a Firenze nel 1600, il primo dramma interamente cantato di cui possediamo la partitura completa nelle due edizioni di Jacopo Peri e di Giulio Caccini. Cfr. Renato DI BENEDETTO, Poetiche e polemiche, in Lorenzo BIANCONI-Giorgio PESTELLI (a cura di), Storia dell’opera italiana, Torino, EDT/Musica, 1988, 6 voll.: vol. VI, Teorie e tecniche. Immagini e fantasmi, pp. 5-7 e Lorenzo BIANCONI, Il Seicento, Torino, EDT/Musica, 1991, p. 176. 18 Una larga fetta della produzione negli Stati Uniti era infatti destinata ai juke-box. Negli anni ‘30 il ‘fonografo meccanico’, comparso già nel 1889, era largamente diffuso in tutti i locali pubblici con il modello “Orchestrope” di Homer E. Capehart, funzionante con ben 56 selezioni. Nel 1939, 40 milioni di dischi prodotti dall’industria discografica erano assorbiti dai juke-box, di cui 19 della Decca. Dietro questa situazione c’erano ragioni d’ordine giuridico: il caso juke-box, infatti, non veniva riferito alla legge del 1909 sul copyright, per questo i locali dove si ascoltavano dischi non erano tenuti a pagare i relativi diritti d’autore. Cfr. CERCHIARI, op. cit., p. 101. 19 Ibid., p. 96. 20 La formazione comprendeva Paolo Borciani, Elisa Pegreffi, Piero Farulli, Franco Rossi. 21 Entrambi i dischi riportano il phonogram del 1965. 93 I documenti sonori: prime considerazioni sulle registrazioni musicali Novantatre sono invece i dischi della CBS - Columbia Broadcasting System - nata negli Stati Uniti come stazione radiofonica.22 Il fondo comprende incisioni storiche pubblicate nella serie “Odissea. Esecuzioni Leggendarie”, “Odissea. Musica del nostro tempo”, “International Masterworks”, “Classics”23 e “Grand interprètes”. Sono riproposte esecuzioni della Columbia Symphony Orchestra diretta da Bruno Walter, della Philadelphia Orchestra diretta da Eugene Ormandy, della Cleveland Orchestra diretta da George Szell. Accanto alla produzione americana sono conservate anche produzioni della CBS italiana. Al periodo compreso tra gli anni ’60 e ’70 rimandano i phonogram delle incisioni di E. P. Biggs, Isaac Stern e Glenn Gould (che esegue Schoenberg e le Variazioni Goldberg di Bach), ma anche del celebre concerto del 18 maggio 1976 alla Carnegie Hall allestito per festeggiare l’ottantacinquesimo anniversario della sua apertura. La CBS ha realizzato anche una serie di registrazioni di Igor Stravinskij dirette dall’autore stesso: la biblioteca possiede cinque dischi che contengono tra l’altro Petrushka - nella sua versione integrale del 1947 - il Monumentum pro Gesualdo, L’historire du suldat, l’Epitaphium per flauto, clarinetto e arpa. Di Stravinskij è anche la Firebird-suite eseguita, con Music for strings, percussion and celesta di Bartók, dalla BBC Sympony Orchestra sotto la direzione di Pierre Boulez. Tra le molte incisioni spiccano anche concerti tenuti alla Carnegie Hall nel 1966 da Horowitz24 e l’esecuzione del Concerto per due pianoforti, percussione e orchestra di Bartók diretto da Bernstein e inciso per la prima volta dalla CBS. Prima registrazione è anche il Concerto per violino e orchestra, opera postuma dello stesso Bartók, eseguito da Isaac Stern e dalla Philadelphia Orchestra con la direzione di E. Ormandy. Americana è anche l’echitetta RCA - Radio Corporation of America - che nasce negli Stati Uniti nel 1919 per intervento dello stesso Governo preoccupato di riportare ordine nello scenario di guerre incrociate tra le società promotrici della radio, all’indomani del suo avvento. Si trattava quindi di una corporazione delle principali emittenti radiofoniche,25 ma ben presto la forte concorrenza del sistema 22 L’avvento della radio, brevettata da Guglielmo Marconi nel 1895, ha minacciato profondamente l’industria discografica dei 78 giri: diversamente dal grammofono, infatti, offriva un servizio gratuito, compresa molta musica, e gli apparecchi radiofonici disponevano di altoparlanti e di una manopola di regolazione del volume, il che consentiva di sonorizzare un’intera stanza. L’industria discografica per ovviare alla temibile concorrenza ha risposto facendo propria la principale innovazione tecnologica introdotta dalla radio, cioè la dimensione elettrica. Sono nati così i radio-grammofoni che, utilizzando in una sola soluzione l’altoparlante e il sistema elettrico, collegato sia al giradischi che alla radio, hanno sancito il primo passo del processo di fusione tra produzione discografica e radiofonica destinato a svilupparsi ulteriormente negli anni a venire. Cfr. Ibid., pp. 85-87. 23 La busta che contiene il disco, all’interno della custodia rigida, è graziosamente decorata con motivi retrò e contiene l’elenco delle registrazioni della serie “Classics”, richiamando un po’ la veste grafica degli antichi 78 giri. 24 Dopo dodici anni di assenza dal palcoscenico, il maestro ritornò a suonare dal vivo alla Carnegie Hall nel 1965. Nel primo periodo della sua carriera artistica Horowitz aveva inciso sempre per la RCA e solo nel 1962 passò alla Columbia, così il suo ritorno alle scene fu felicemente accolto dalla casa discografica per rilanciare le sue incisioni. Cfr. Piero RATTALINO, dalle note di copertina del disco Vladimir Horowitz interpreta Chopin. 25 Cfr. CERCHIARI, op. cit., p. 84. 94 Grazia Carbonella spinse gli investitori a fondere la RCA con la Victor Talking Machines,26 dando vita alla RCA Victor Co. La Biblioteca possiede 11 dischi di questa etichetta. Si tratta di registrazioni realizzate dalla RCA italiana27 tra cui alcune relative alla serie “LineaTre” e pubblicate sotto il marchio RCA Victrola.28 A quest’ultimo gruppo appartengono due dischi che contengono incisioni della NBC Symphony Orchestra sotto la direzione di Arturo Toscanini.29 Si tratta di registrazioni appartenenti al periodo americano del grande direttore che diresse per ben diciassette anni la NBC Symphony Orchestra.30 Il fondo contiene anche un gruppo di dischi, per la precisione 112, pubblicati dalla Fabbri in un duplice progetto editoriale: “I grandi musicisti” e “I grandi interpreti della musica”. Le collane, entrambe dirette da Edoardo Rescigno, presentano un’analoga impostazione editoriale. I cofanetti, dalla veste grafica molto curata, si aprono a libro e contengono diverse pagine con lunghe note storiche relative ai brani e al periodo storico - per “I grandi musicisti” - e note biografiche - per “I grandi interpreti” - oltre ad un ricco impianto iconografico, con foto d’epoca, facsimili di pagine manoscritte e locandine di concerti. Segue una scheda musicale contenente gli incipit dei singoli movimenti, l’indicazione del periodo di composizione dei brani, la dedica, il luogo di conservazione del manoscritto autografo, l’anno della prima edizione e il titolo originale dell’opera. Chiude il cofanetto una discografia ragionata, curata da Renato Garavaglia, relativa al contenuto di ciascun disco con qualche suggerimento di ascolto. Le registrazioni sono tratte da diversi cataloghi e sono riproposte sotto concessione dalla Vox, MMG, Polyband, Vanguard Recording Society. Particolarmente interessanti sono i diciotto dischi di natura monografica della collana “I grandi interpreti” anche per la pregnanza delle note biografiche firmate da noti musicologici: tra questi Giuseppe Pugliese che firma Karajan, Luigi Fait per Gazzelloni, Rostropovic e Richter, Piero Rattalino per 26 La Victor nasce nel 1900 dalla filiazione della United State Gramophon Company di Berliner ad opera di Jesse Johnson. Per una serie di azioni legali, la Gramophon sarà costretta ben bresto a confluire nella Victor (che per questo motivo poté impiegare l’immagine del cagnolino Nipper). Cfr. ibid., p. 30 27 La multinazionale americana era sbarcata in Italia già nel 1953 interessata soprattutto a stabilire rapporti con il mondo della televisione e del cinema. Cfr. ibid., p. 161. 28 Il Victrola era un mobile grammofono realizzato dalla Victor nel laboratorio di Cadmen. Si distingueva per la linea elegante e l’altezza media, offrendo per la prima volta una spazio per riporre i dischi. Cfr. ibid., p. 103. 29 Si conservano registrazioni de I pini di Roma di Ottorino Respighi, di brani tratti da Psyche di Cesar Franck e da Iberia di Debussy. 30 Tutte le incisioni realizzate in questo periodo nello studio 8H sono conservate su dischi campione. “Si tratta di dischi di acetato di 16 e 17 pollici prodotti a 33 giri e 1/3, ma con un solco largo quanto quello dei dischi a 78 giri. Non destinati alla distribuzione commerciale, tali dischi avevano termini di frequenza e di gamma dinamica molto più ampie di quanto gli apparecchi per uso domestico non siano in grado di riprodurre. L’aspetto più importante è che, essendo i concerti del Maestro con la NBC ben conservati su dischi campione, abbiamo la documentazione relativa agli ultimi 17 anni della sua attività americana. Il lavoro di nessun altro direttore di questo periodo è così ben documentato”. Cfr. Mortimer H. FRANCK, Toscanini in esilio: gli anni americani, in Toscanini, Atti del Convegno “Bologna per Toscanini” (Bologna 14 maggio 1991), Bologna, Clueb, 1992, pp. 149-150. 95 I documenti sonori: prime considerazioni sulle registrazioni musicali Gieseking e Horowitz, Lorenzo Arruga per I Solisti Veneti, Romano Giacchetti per Stokowski, per citarne solo alcuni. La più giovane tra le etichette possedute è la Philips nata in Olanda nel 1929 come Philips Gloeilompenfrabrieken, originariamente compagnia elettrica. Il fondo contiene 190 unità discografiche distribuite nelle collane “Universo series”, “Trésor Classiques” e nel “Colin Davis Berlioz cycles”, registrazioni storiche queste ultime, dirette da Colin Davis in occasione del centenario della morte del celebre compositore. A questa etichetta appartengono incisioni di Claudio Arrau, del Quartetto Italiano, del Concertgebouw-Orchester Amsterdam con la direzione Bernard Haitink, che esegue le sinfonie di Mahler e di Bruckner, e dell’Academy of St. Martin-in-the-Fields con la direzione di Neville Marriner. Durante gli anni ‘60 la casa discografica ha avviato un progetto di registrazione del catalogo di Vivaldi e di Albinoni. Il successo è stato enorme, soprattutto per le Quattro stagioni eseguite da I Musici, tanto da favorire un vero recupero di tutto il repertorio barocco, trascurato a lungo dall’industria discografica.31 La Biblioteca conserva 28 dischi contenenti registrazioni di questo ensemble. Durante il lavoro di catalogazione è apparso subito evidente come nel corso degli anni gli acquisti siano stati fatti più per cataloghi editoriali che per aree tematiche o per periodi storici, ad eccezione di un gruppo di undici dischi di musica elettronica. Si tratta di registrazioni degli anni Sessanta, ma la sperimentazione musicale per la composizione di nuova musica era già partita dagli anni ’20 con l’allestimento dei primi laboratori.32 I dischi di musica elettronica conservati nel fondo sono pubblicazioni della Deutsche Grammophon, della TurnaboutVox e della Compagnia Generale del Disco - in collaborazione con le Edizioni Suvini Zerboni. Tra queste registrazioni si conservano Le voyage di Pierre Henry, 33 Gesang der Jünglinge di Karlheinz Stockhausen, Thema (Omaggio a Joyce) 31 Cfr. James CHATER, Philips, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, edited by Stansley Sadie, London, Macmillan, 2001, 20 voll.: vol. XIX, pp. 587-589. 32 Attraverso l’intervento diretto sulle onde sinusoidali, con l’acquisizione del rumore bianco e con l’applicazione dei filtri, il musicista non creava più con i suoni, ma ‘creava’ i suoni. Queste prospettive di ricerca sono state affrontate nell’ambito della musica elettronica, per l’appunto, e negli studi di fonologia di Colonia e di Parigi. Lo Studio di Fonologia della RAI di Milano , dove sono state realizzate le registrazioni di alcuni dischi contenuti nel fondo, nasce invece nel 1955 per volontà di Bruno Maderna e di Luciano Berio che, insieme ad Alfredo Lietti e Marino Zuccheri, hanno cercato di operare una sintesi tra le due opposte tendenze espresse dagli studi di Parigi e di Colonia: da un lato c’era la poetica della musique concrète, legata alle esperienze di Pierre Schaeffer, e dall’altro il principio della Klangerzeugnis, ovvero della produzione mediante la sintesi. L’orientamento che perseguì lo Studio di Fonologia di Milano fu proprio quello di utilizzare il mezzo elettronico per arricchire e trasformare le sonorità prodotte dalle voci e dagli strumenti. Cfr. U. DUSE, Per una storia della musica…, cit., p. 101 e Enzo RESTAGNO, Ritratto dell’artista da giovane, in Enzo RESTAGNO (a cura di), Berio, Torino, EDT/Musica, 1995, p. 11. 33 Pierre Henry nel 1951 ha collaborato con Pierre Schaffaer all’interno del “Groupe de recherches de musique concrète” (GRMC) presso lo Studio d’Essai della RTF (Radiodiffusion Télévision Française) per classificare i suoni. Cfr. Marc BATTIER, Laboratori, in J.J. NATTIEZ, Enciclopedia della musica..., cit., vol. I, p. 406. 96 Grazia Carbonella di Luciano Berio.34 Dell’etichetta Turnabout-Vox sono anche le registrazioni del Bolero35 di Maurice Ravel che dirige personalmente la Lamoureux Orchestra e della Sonata for two pianos and percussion36 di Béla Bartók che suona in compagnia di Ditta Pasztory Bartók. Per completare il panorama delle etichette presenti nel fondo fin’ora visionato non possiamo non citare la Cetra e la Fonit-Cetra. La Compagnia per Edizioni, Teatro, Registrazione e Affini, nasce nel 1932 come antagonista de La voce del padrone/Columbia connotandosi subito come ‘interfaccia’ discografica della radio pubblica EIAR e diventando lo sbocco naturale su 78 giri degli artisti legati alle orchestre della radio. Con l’inizio della seconda guerra mondiale si fonda con la Fonit, Fonodisco Italiano Trevisan fondata nel 1911: da questa fusione nasce la Fonit-Cetra.37 A questo gruppo di dischi appartengono soprattutto incisioni di repertori operistici, antologie di arie e di celebri cori del melodramma italiano. Piuttosto divulgativo anche il catalogo della casa discografica Fontana di cui si conservano una quarantina di dischi di natura per lo più antologica (melodie classicoleggere, celebri valzer, concerti di Natale) oltre ai Concerti grossi di Händel e al Clavicembalo ben temperato di Bach. Tra le etichette straniere si conservano anche 12 dischi dell’Hungaroton: sono registrazioni prevalentemente degli anni ’70 tra cui alcuni dischi dell’edizione integrale delle opere di Béla Bartók, e musiche di Bach dirette da Otto Klemperer. 34 Gesang der Jünglinge di Stockhausen, è il primo capolavoro in linea con quel processo di destrutturazione della parola, diffuso nel secondo dopoguerra, che ha portato i compositori ad indagare gli elementi fonologici della voce e a manipolarli per i propri progetti sonori. “[…] le parole, tratte dal testo biblico ‘Canto dei giovani alla fornace’, in parte cantate e in parte recitate dalla voce di un fanciullo, una volta registrate su nastro vengono poi trasformate magneticamente e mescolate con suoni prodotti dalla macchina fino a ottenere un continuum ordinato secondo ‘famiglie sonore’. Su analoghi principi due anni dopo Berio compone Thema (Omaggio a Joyce) avvalendosi esclusivamente della voce di Cathy Berberian e di un brano tratto da Ulysse di Joyce. Le parole, in sé fortemente onomatopeiche e musicali all’inizio, dove sembra che venga esposto, appunto, il tema su cui si svolgerà il pezzo, indi si dilatano e si trasformano allo scopo di raggiungere una “nuova possibilità d’incontro tra lettura di un testo poetico e la musica”. All’estremo limite dell’elaborazione elettronica la voce umana scompare ed è sostituita dalla sua riproduzione attraverso sintetizzatori e modulatori di frequenza”. Cfr. Rossana DALMONTE, Voci, in NATTIEZ, op. cit., p. 303. La citazione contenuta è di Luciano BERIO, Poesia e musica-un’esperienza, in «Incontri Musicali», 1959, 3, p. 99. 35 Il disco contiene anche La Vallée des cloches, da Miroirs, Chansons madécasses e Pavane pour une infante défunte. 36 Il disco contiene anche una scelta di brani da For Children, Evening in Transilvania, Bear’s dance. 37 Cfr, CERCHIARI, op. cit., p. 119 e Eliot B. LEVIN, Cetra, in The New Grove Dictionary…, cit., vol. V, p. 402. 97 98 Pasquale d’Addedda Il deposito librario: problemi e prospettive di Pasquale d’Addedda Il Deposito librario è organizzato a scaffale chiuso (il lettore deve rivolgersi al personale della biblioteca per ottenere un libro). I lettori sono esclusi dall’accesso a questo settore e tutte le informazioni necessarie per sapere se il libro è posseduto dalla biblioteca, e per chiederlo in lettura, devono essere fornite dai cataloghi. In questo settore il materiale è collocato per materia e per formato. Questo sistema consente di organizzare l’altezza dei ripiani in modo da sfruttare al massimo la capienza degli scaffali, mettendo uno accanto all’altro volumi della stessa altezza. Il Deposito librario ha il compito di organizzare i libri negli scaffali secondo i criteri adottati dalla biblioteca, segnalare eventuali saturazioni dei diversi segmenti, rilevare lo stato di consunzione del materiale per inviarlo, eventualmente, al rilegatore. Provvede, inoltre, a soddisfare le richieste degli utenti, inviando tramite un montacarichi il libro richiesto al distributore e a ricollocare il giorno dopo i libri consultati o, se il libro è stato prestato, a collocare al suo posto una copia del modulo di prestito incollata su una tavoletta. Provvede ad effettuare tutte le operazioni relative al prestito (4000 volumi nell’anno 2003). In questo settore sono conservati 123.000 volumi, il 42% dell’intera raccolta della biblioteca. In questi ultimi anni molti problemi sono stati risolti, voglio qui di seguito ricordarne alcuni: a) sono stati individuati, definiti, riuniti e riorganizzati, in un settore del magazzino, i libri provenienti da acquisti o donazioni di importanti biblioteche private; b) per i libri antichi e rari che venivano conservati in maniera indifferenziata con i moderni è stato costituito un “fondo antico” e uno “rari”; 7884 volumi sono entrati a far parte del fondo antico e per i rari la ricerca è ancora in corso; c) è stata attuata la trasformazione delle diverse collocazioni del magazzino nel sistema più adatto alle caratteristiche storiche e culturali delle collezioni, alla struttura degli ambienti, alle esigenze dei servizi: quello per materia e formato; d) tutti i vecchi contenitori di miscellanee ormai fatiscenti sono stati sostituiti; e) l’illuminazione e il condizionamento dell’aria sono stati recentemente rinnovati. 99 Il deposito librario: problemi e prospettive Molti problemi permangono tutt’oggi e quasi esclusivamente derivano da una costante sottovalutazione del magazzino librario e della sua organizzazione di lavoro. La mancanza di spazio, un problema già sentito da qualche anno, si è ora acuito notevolmente. L’attuale sede della “Provinciale”, in viale Michelangelo - 1, fu inaugurata il 5 ottobre 1974, esattamente 140 anni dopo l’inaugurazione della illustre biblioteca comunale, con sede in Palazzo Arpi in piazza Mercantile. La nuova sede, una struttura moderna corrispondente al momento della sua progettazione alle esigenze della città e della provincia, uno dei pochi esempi di biblioteca costruita appositamente senza ricorrere ad adattamenti di edifici preesistenti, comincia a mostrare dei limiti strutturali. Il Deposito progettato per contenere i libri e le riviste allora in dotazione, con spazi per un futuro sviluppo delle raccolte, per il continuo accrescimento del patrimonio librario è ormai vicino al collasso (sono stati scaffalati anche spazi destinati ad altri usi: ex rilegatoria e spazio antistante). Ma a chi importa? A cosa serve lo spazio in una biblioteca? C’entra qualcosa lo spazio per tenere ben ordinate e conservate le raccolte? Per svolgere il proprio lavoro in condizioni decenti di efficienza e sicurezza? La prospettiva più praticabile dopo aver sollecitato ancora una volta la direzione a trovare nuovi spazi - siano essi immobili scolastici non utilizzati, demanio militare dismesso, o altri, (l’ideale sarebbe una palazzina vicina geograficamente dove collocare il materiale della biblioteca di meno frequente consultazione) è di diventare “ricercatore di spazi per lo sviluppo delle raccolte”. È difficile prevedere che cosa il futuro abbia in serbo riguardo alla gestione delle collezioni per via del rapido evolversi delle tecnologie (forma dei documenti, natura dei supporti, modalità di comunicazione e accesso). La biblioteca del futuro richiederà minore spazio fisico e minore uso interno a vantaggio dell’uso remoto? Si parla sempre più spesso, erroneamente, in maniera indifferenziata di biblioteca elettronica, biblioteca ibrida, biblioteca come gateway, biblioteca complessa, biblioteca virtuale, biblioteca digitale. La logica della comunicazione digitale è da molto tempo praticata nelle biblioteche. Dal 1990, infatti, grazie al Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.), la cui prima ideazione è dovuta a Angela Vinay, i bibliotecari italiani, sono abituati ad interagire fra di loro, a mettere in comune il risultato del proprio lavoro, a condividere le risorse nell’individuazione dell’informazione. Nel panorama delle amministrazioni pubbliche italiane, il settore delle biblioteche è perciò sicuramente all’avanguardia dal punto di vista della cultura digitale. I bibliotecari hanno non solo grande confidenza con tastiera e computer, conoscono i nuovi strumenti della comunicazione software e hardware, collegamenti, reti interne ed esterne - possiedono il minimo vocabolario che rende nominate e nominabili, e quindi più vicine, le nuove tecnologie ma, fatto strutturale ben più importante, sono abituati a pensare in termini di economia digitale, cioè di interazione, di partecipazione, di integrazione, di instabilità, di de-localizzazione e di de-contestualizzazione del lavoro. I settori maggiormente beneficiati, attualmente, dalle nuove tecnologie sono periodici e libri antichi. 100 Pasquale d’Addedda Già da qualche anno è partito il progetto di Biblioteca Digitale Italiana. Uno studio di fattibilità fu già elaborato alla fine del 1999 ed è stato poi aggiornato ed ampliato nell’aprile 2003. Il Comitato Guida della BDI, presieduto dal prof. Tullio Gregory e composto da rappresentanti della realtà bibliotecaria statale e regionale, dei musei, dell’università e della ricerca avvierà immediatamente un programma coordinato di scansione, in formato immagine, dei cataloghi storici delle biblioteche pubbliche italiane. Gruppi di esperti definiranno le linee di realizzazione secondo le quali dovranno operare biblioteche, archivi e musei. La biblioteca diventerà un luogo dove la stampa, il materiale digitato e quello nato come digitale si possono presentare come parti complementari del tessuto della conoscenza. Insieme alla ricerca di nuovi spazi la nostra biblioteca deve comunque avviare una razionale gestione di quello disponibile: poiché è importante che il patrimonio librario non solo cresca ma si evolva, una funzione fondamentale viene assunta dallo scarto. Molti e concordi sono, in generale, i documenti, gli articoli di periodici ed i libri che assegnano allo scarto librario una funzione importante ed imprescindibile all’interno della biblioteca pubblica. Lo scarto librario, infatti, può essere considerato, rispetto agli acquisti e all’accettazione delle donazioni, l’altra faccia di una stessa medaglia. Si potrebbe affermare addirittura che già negli acquisti si opera un primo scarto, nello scegliere (e dunque nel decidere se acquistare o non acquistare, se accettare o meno in dono) solo i libri adatti alla nostra biblioteca, rispetto alla grande mole dei libri offerti annualmente dall’editoria. L’importante è che ciascuna biblioteca acquisti e scarti secondo la propria natura e le proprie esigenze, possibilmente inserite in un contesto più ampio di cooperazione prima di tutto con altre biblioteche della città e nell’ambito del nostro Sistema Bibliotecario, con l’aiuto del “Progetto Conspectus”, che permette la creazione di una mappa delle collezioni, per favorirne la condivisione. È importante ribadire la natura tecnica dello scarto per metterlo a riparo da indebite ingerenze: rientra infatti nella specifica ed esclusiva professionalità del bibliotecario, procedere allo scarto dei singoli volumi o delle partite di volumi. Determinanti sono non solo le peculiari caratteristiche del libro e le sue condizioni fisiche, ma anche altri fattori come la circolazione libraria, la documentazione bibliografica, l’esperienza del bibliotecario. Ogni volume va visto, pertanto, nell’insieme del patrimonio librario presente e futuro. Solo il bibliotecario conosce infatti la frequenza con cui un libro è richiesto, la sua utilizzazione all’interno del patrimonio librario (non c’è biblioteca se non c’è uso della biblioteca: books are for use ricorda Ranganathan), il suo ‘peso specifico’ rispetto agli altri libri, quella che viene definita la ‘coerenza’ del libro rispetto al resto del patrimonio librario e non ultima la capacità che il libro soddisfi le esigenze del suo utente. Ribadita la natura tecnica dello scarto è importante definirla come attività normale e periodica: perché, se da un lato si procede nello scarto man mano che si presenta il singolo problema (una donazione, un libro deteriorato, ecc...), è corretto 101 Il deposito librario: problemi e prospettive d’altro canto che almeno una volta ogni due anni si proceda ad una revisione sistematica delle diverse classi Dewey. Se riconosciamo che la nostra è una biblioteca di base non vincolata da obblighi di conservazione (se non per determinate sezioni: Locale, Antichi e Rari), una biblioteca che ha come suo pubblico naturale un’utenza composita e variegata e che per propria natura non deve essere specialistica, non sarà difficile cominciare a definire i criteri e le modalità dello scarto. Il principale criterio guida è lo svecchiamento delle raccolte: lo spazio in biblioteca non è illimitato e anche quando lo fosse, lo spazio comunque ha un costo iniziale ed un costo di manutenzione e di gestione. Anche il lavoro necessario a trattare un libro costa: pur nel caso in cui il libro sia stato donato, il gestirlo e l’immagazzinarlo ha sempre un costo. Per questo è necessario avere sugli scaffali solo libri utili, utilizzati o almeno utilizzabili. Anche la questione delle pulizie rimasta irrisolta per anni attende soluzioni immediate. Negli ultimi anni, polvere, residui dei lavori che sono stati realizzati in biblioteca ed altro si sono accumulati su libri e scaffali. Gli alti costi non devono far dimenticare la necessità impellente per la salute dei libri, di operatori e utenti, di compiere periodicamente questa importante operazione. Nel 1890 il famoso bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Brera, Giuseppe Fumagalli, in un manuale dal titolo Della collocazione dei libri nelle biblioteche pubbliche raccomandava “[…] la periodica spolveratura degli scaffali e libri contenutivi, da farsi nella buona stagione, quando l’aria ha perduto la sua umidità e le larve degli insetti sono usciti dalle uova. Questi specialmente, il più terribile dei nemici che abbiano le biblioteche, siano lo ptinus fur, o lo ptinus mollis, o l’anobium pertinax, o l’anobium eruditum o l’anobium paniceum, o l’oecophora, farebbero grandi devastazioni se non si muovesse loro guerra ad oltranza”. La pulizia dovrebbe, quindi, essere affidata ad una ditta specializzata e bisognerebbe prevedere nel capitolato d’appalto, la pulizia giornaliera a rotazione di un quantitativo di libri e scaffali da determinarsi, in modo tale che nell’arco di un anno tutti i libri e gli scaffali della biblioteca siano stati puliti. Con l’installazione di scaffali compatti la capienza potrebbe quasi raddoppiare e il problema della polvere sarebbe in parte risolto, ma sono poco funzionali e, a lungo andare, procurano qualche danno alle raccolte. Molto sentita è anche la mancanza di uno spazio per le attrezzature: cassettiere, scaffali, palchetti, vecchi computers, tutto ciò che non serve in altri settori viene scaricato in Deposito, ostacolando il lavoro degli operatori e occupando spazi riservati ai libri. Sarebbe importante, anche, valorizzare con iniziative di promozione alla lettura (corsi, mostre, convegni) parte di quell’interessantissimo patrimonio della biblioteca conservato in magazzino, come alcune collane dell’editore Firmin Didot: “L’univers pittoresque: histoire et description de touts les peuples”, dal 1838 al 1850, il testo descrittivo di questa interessante e non comune collana di guide turistiche è accompagnato da stampe; di Laterza: “Biblioteca di cultura moderna”, nata nel 1902, che riunisce titoli di politica, storia, filosofia, in una concezione viva e non 102 Pasquale d’Addedda formalistica della cultura; “Classici della filosofia moderna”, nata nel 1906, i cui curatori in gran parte non sono filosofi di professione ma letterati e politici, storici e saggisti; “I filosofi antichi e medievali”, dal 1915, diretta da Giovanni Gentile; “Libri del tempo”, nata nel 1950, con caratteristiche di impegno civile e di denuncia sociale; “Universale Laterza”, il primo volume è la Storia d’Italia di Denis Mack Smith che si rivelò subito un grande successo; di Formìggini, l’editore ebreo che si suicidò per restare italiano: “Classici del ridere” dal 1913 al 1938, 105 titoli, da Petronio a Sterne e Balzac, “la cosa più seria, com’ebbe a dire lui stesso, che sono riuscito a fare”; “Profili” (1909-1938), vivaci, sintetiche suggestive rievocazioni di figure attraenti e significative; di Carabba: “Cultura dell’anima”, dal 1919, diretta da Papini, il rapporto diretto è con filosofi veri e propri, da Pitagora a Kierkegaard; di Rizzoli: “Biblioteca Universale Rizzoli”, dal 1949, che costituisce la prima vera collana italiana di tascabili, sulla scorta della inglese Penguin o della tedesca Reclam o ancora della newyorchese Poket book. Non è un quadro idilliaco, quello che si prospetta. Nonostante gli enormi progressi compiuti negli ultimi anni, abbiamo visto che si deve fare di più e meglio. 103 104 Enrichetta Fatigato La sezione “Immagini” della Biblioteca Provinciale di Foggia di Enrichetta Fatigato 1. La mission La sezione “Immagini” della Biblioteca Provinciale di Foggia, trae le sue origini da un fondo storico di risorse documentarie rappresentato dalla collezione dei manifesti cinematografici, sedimentatasi a seguito di donazioni e acquisti realizzati nel corso degli anni. La ragguardevole consistenza fisica del fondo (circa 30.000 pezzi in gran parte digitalizzati e consultabili nel web della Biblioteca all’indirizzo http:// www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/portale/Portal/Search/), per il quale sono occorse operazioni di manutenzione e pulitura che lo preservassero dai danni del tempo, consente di pensare, oggi, alla possibilità di valorizzare appieno tutte le possibilità insite in un patrimonio documentario di così immediato e interessante valore comunicativo e culturale. L’ intento da perseguire è quello di: a) far ruotare attorno a questo nucleo documentario, opportunamente catalogato nell’OPAC della Biblioteca, tutta una sezione dedicata alla cultura cinematografica; b) organizzare la sezione specializzandola non solo nei formati di rappresentazione delle informazioni (supporti cartacei integrati a supporti informatici ed elettronici), ma nei livelli di copertura delle problematiche ruotanti attorno ai significati espressi dalla cultura che si rappresenta nel e attraverso il cinema; c) intercettare attraverso le selezioni e le disponibilità messe in campo, le attenzioni e gli interessi di quanti sono attratti da questa espressione artistica, favorendo sia i gradi di primo contatto, alfabetizzazione e orientamento alla cultura cinematografica, nei suoi aspetti tecnico-artistici, sia le ricerche e gli approfondimenti di studio avanzati; d) portare l’offerta di servizio ruotante attorno al nucleo documentario originario proposta al livello delle prestazioni degli standard medi nazionali attraverso un costante processo di verifica delle scelte al fabbisogno culturale latente o espresso, monitorando annualmente l’adeguatezza degli interventi in termini di budget utilizzato, risorse rese disponibili, risorse 105 La sezione “Immagini&Suoni” della Biblioteca Provinciale di Foggia utilizzate, risorse da incrementare o da abolire, target della comunità di utenti realmente raggiunto con azioni di servizi erogati o con relazioni di scambi e incontri che abbiano come obiettivo la conoscenza e diffusione della cultura cinematografica; e) veicolare con i sistemi della comunicazione attraverso il web della biblioteca attività, proposte, iniziative, risorse informative e collegamenti con altri centri di impianto omogeneo, al fine di inserire le azioni intraprese nell’opportuno e necessario universo delle informazioni che circolano attraverso l’etere. 2. Profilo bibliografico e documentale Questa definizione ha dovuto necessariamente prendere atto delle consistenze esistenti, della loro localizzazione, del loro grado di vetustà editoriale e fisica, a partire: a) dai record immessi nell’OPAC e classificati con i numeri indici a partire da 791.43 a 791.437 5 e loro ulteriori suddivisioni standard e notazioni specifiche, e dalle specificazioni della classe 016. che caratterizzassero questa sezione specifica; b) dal controllo dei documenti residui ancora presenti nel catalogo generale cartaceo della biblioteca, per operare scelte di utile e possibile integrazione nel costituendo nucleo bibliografico della sezione specializzata; c) dalla verifica nell’ OPAC della presenza di documenti non indicizzati ai numeri sopraindicati, ma che qualche collegamento semantico avessero con l’universo tematico individuato; d) dall’esame delle descrizioni inventariali preesistenti riguardanti il posseduto in manifesti cinematografici; e) dalla predisposizione di un progetto di sistemazione fisica del materiale nella sede dell’ex Liceo Scientifico “Marconi”, privilegiando una logistica degli ambienti, della distribuzione degli arredi e delle suppellettili a impostazione open space per uno spazio destinato ad un patrimonio documentario di circa 10.000 entità utili e alla conservazione e preservazione dei manifesti cinematografici ed all’esposizione possibile degli originali o alla proiezione delle copie digitalizzate. Il risultato della ricognizione, relativamente ai primi tre punti del presente paragrafo, ha permesso di avanzare alcune considerazioni di merito e altre di procedura e gestione rispetto al patrimonio complessivo della biblioteca dislocato e distribuito per sale al pubblico e deposito. Il profilo bibliografico e documentale della sezione “Immagini” si configura a partire dalla selezione dei materiali che entrano a far parte del fondo. La particolare natura speciale del fondo consente, immediatamente, di definirlo un sistema integrato di supporti per l’accesso all’informazione e studio. 106 Enrichetta Fatigato Il sistema integrato verso cui sono orientati tutti i moderni regimi bibliotecari, si avvale di documenti cartacei, di documenti visivi e sonori in formato elettronico e di documenti in formato digitale. Nella sezione “Immagini”, qualificabile a elevato impatto multimediale, l’integrazione dei supporti è condizione primaria e, assolutamente, imprescindibile. Rispetto a questo assunto di base occorre precisare che l’integrazione dei supporti non è solo una integrazione fisica; il profilo bibliografico e documentale di un sistema bibliotecario a struttura integrata si può dire sia stato ben tratteggiato, sì da consentire un successivo sviluppo fisionomico armonico, se l’integrazione avviene a partire dalla struttura semantica e indicizzatoria; questo particolare tipo di integrazione consente di mantenere la fisionomia del fondo coerente sia per la sua caratterizzazione interna, sia per le sue successive fasi di potenziamento, perché consente la verifica puntuale delle lacune tematiche, perché impone una coerenza nell’indicizzazione anche del materiale localizzato nelle altre sale e nei depositi della biblioteca e il possibile spostamento di materiale da sale, dove avrebbe scarsa caratterizzazione, al fondo specializzato. Operando questo tipo di impostazione metodologica nell’approccio alla definizione del profilo bibliografico e documentale si è reso necessario revisionare tutta l’impalcatura semantica e indicizzatoria esistente, per creare punti di accesso conoscitivi uniformi, biunivoci e coestesi con la natura dei documenti anche nelle diverse localizzazioni. Si è inteso, in tal modo: a) non disperdere le informazioni riguardanti i singoli documenti omogeneizzando i preesistenti indici che tendevano ad allontanare significativamente, oltre che fisicamente, documenti caratterizzanti unità bibliografiche definite; b) curare collocazioni omogenee per unità bibliografiche e documentarie e unità particolari, quali quelle riferite a registi, attori, sceneggiatori. Per questi documenti si è esclusa la segnatura a base Dewey, accorpandoli in collocazioni alfabetiche per nazionalità, per nome del personaggio cui si riferiva l’unità bibliografica e i singoli documenti con le loro responsabilità; c) assegnare un legame di classificazione Dewey che desse enfasi alle coordinate spazio-temporali degli autori di cinema; d) mantenere una indicizzazione biunivoca e costante fra indice numerico (classificazione Dewey) e indice di linguaggio culturale controllato (soggettario BNI e abstract); e) con questo tipo di indicizzazione consentire di integrare i singoli autori con gli apparati che li riguardano di reference, i saggi critici, le bibliografie, le filmografie e i relativi, possibili manifesti sia descritti nell’OPAC che digitalizzati nel Web e gli abstract che si riferiscono ai singoli film posseduti; f) favorire anche l’integrazione dei documenti dislocati in altre aree della Biblioteca Provinciale di Foggia. 107 La sezione “Immagini&Suoni” della Biblioteca Provinciale di Foggia Il profilo, così tratteggiato, consente ora di tracciare le linee del successivo incremento del patrimonio documentario, prefigurabile in 20.000 titoli e oltre 4.000 film, mantenendo salda un’impostazione compatta, omogenea e a supporti integrati, in un lasso di tempo di cinque anni. Solo il tempo, la disponibilità economica e la passione dei bibliotecari documentalisti per il cinema, in relazione ai suggerimenti e alle sollecitazioni degli utenti potranno tradurre questo profilo in un organismo saldo e al passo con le sollecitazioni che scaturiscono da un settore culturale ricco di stimoli e provocazioni positive. I primi tratti che qui si propongono, solo per comodità materiale di presentazione sono articolati in macroaree, al loro interno profondamente coese. A proposito di ogni autore (in particolare per quelli già presenti in qualche modo nella sezione) si è cercato di offrire lo spettro più aggiornato di documentazione, sia in termini di opere letterarie, di saggi critici e di recensioni alle sue produzioni filmiche che consentissero l’approdo ad una caratterizzazione, per quanto possibile, di una unità bibliografica. Non sono stati trascurati gli aspetti squisitamente tecnici e le relazioni che il cinema intesse con altre manifestazioni della vita e della cultura contemporanea. Un cenno particolare va fatto per la macroarea 18 “Collegamenti web”. Nell’ottica dello sviluppo integrato di accesso alle risorse informative e documentarie, nelle segnalazioni sono rappresentati siti di interesse selezionati in rapporto ad argomenti specifici quali, appunto, quelli delineati nelle 20 macroaree. Pertanto, gli accessi selezionati, che potrebbero trovare una loro configurazione tramite una pagina web della biblioteca, destinata al cinema, delineano trasversalmente tutta la qualificazione del profilo bibliografico e documentario. Nella pagina web, inoltre, sarebbe utile creare collegamenti indicativi con le programmazioni cinematografiche provinciali, con gli eventi (rassegne, festival, sperimentazioni scolastiche...) che territorialmente sono dedicati al cinema. Queste le macroaree che contraddistinguono le imminenti accessioni della sezione: • Opere di reference • Festival e sale cinematografiche, cineclub • Cinematografie per nazioni • Censura- Critica- Recensioni di film • Cinema e altri media (Internet, TV) e altre immagini (pittura, fotografia, manifesti) • Cinema negli aspetti estetico–linguistico–letterari • Cinema, costume e società • Cinema e musica • Cinema e fumetto • Sceneggiature, regie, interpreti • Cinema muto e generi particolari (western, porno...) • Cinema nei suoi aspetti tecnologici, industriali, per il restauro, per il doppiaggio e il marketing 108 Enrichetta Fatigato • Cinema in relazione con altri ambiti disciplinari (storia, educazione, formazione, religione, psichiatria, ambiente, urbanistica) • Cortometraggi, lungometraggi • Cinema indipendente • Filmografia in commercio • Manifesti cinematografici • Collegamenti web suddivisi per macroaree • Periodici sul cinema • Opere in lingua straniera suddivise secondo le macroaree Come già accennato, si tratta di un profilo appena delineato, perché per alcune aree non è possibile raggiungere un livello di copertura analitica approfondito, preferendo acquisire ex novo solo pubblicazioni di edizioni recenti e retrodatate non oltre la seconda metà degli anni ’90 del XX sec. quando le edizioni antecedenti a questa data non siano fonte di informazione primaria su un determinato autore o argomento e, pertanto, di necessaria acquisizione. La compilazione dell’elenco delle nuove proposte di acquisti è stata resa possibile dal confronto con il catalogo topografico della Biblioteca della Cineteca di Bologna, consultabile alla pagina http://www3.muspe.unibo.it:8080/biblio/catalog/ libri/cinema/navcin.htm e con il catalogo della Biblioteca del Circolo di Cultura cinematografica di Verbania, alla pagina http://space.tin.it/associazioni/lbjma/ccc/ e attraverso la consultazione e la selezione dei documenti presenti nel Catalogo dei libri in commercio /Associazione italiana editori.2002, nel Catalogo dei periodici in commercio e nei cataloghi editoriali, sia cartacei che virtuali, più specializzati o con sezioni molto articolate in tema di cinema, quali: • Altana: http://www.altana.net/ • Arcanfiction: http://www.arcanalibri.it/catalogo/catalogo.html • British counsil: http://www.britfilms.com/festivals/browse/? country=Italy • Cinemazero: http://www.cinemazero.pn.it/ • CinetecadelFriulihttp://cinetecadelfriuli.org/pubblicazioni/Libri/ publication_00_03frset_cdf.html • Cineteca di Bologna. http://www.cinetecadibologna.it/ • Dino Audino: http://www.audinoeditore.it/catalogo.php • Falsopiano: http: // space.virgilio.it/[email protected]/CATALOGO %20FALSOPIANO.html • Gramma Group: http://evora.omega.it/demos/faol/gamma/ publications.htm • Gremese: http://www.gremese.com/Argomenti.asp?Argomento=Cinema • Il Castoro: http://www.cinema.castoro-on-line.it/film.htm • Il pontevecchio: http://www.ilpontevecchio.com/TITOLI.HTM Ancora61390 • Le mani: http://www.lemanieditore.com/cinema.htm • Lindau: http://www.lindau.it/ita/cinema.html 109 La sezione “Immagini&Suoni” della Biblioteca Provinciale di Foggia • Lupetti: http://www.lupetti.com/cat092.htm • Minimum fax: http://www.minimumfax.com/listino.asp?pagina =collana&collanaID = 7 • Moretti&Vitali: http://www.morettievitali.it/catalogo/altre-proposte.html# • Pegacity: http://www.pegacity.it/utopia/cinema/ • Puntozero: http://www.puntozero.net/pmovies/pmovies.htm • Scuola nazionale di cinema: http://www.snc.it/other/editoria.asp • Terminalvideoitalia: http://www.terminalvideo.it/risultati-ricerca. asp?radSearchMode=INIZIA&cmbIn=1&hidInDescr= Titoli+e+nomi&cmbFormati = 26&hidFormatiDescr = Vhs&txtSearch 110 Marianna Iafelice Il Fondo Antico della ex Biblioteca Comunale di Foggia, nella Biblioteca Provinciale di oggi di Marianna Iafelice Quando ho cominciato la stesura della descrizione del fondo antico di questa biblioteca, a cui sto lavorando da anni, l’entusiasmo iniziale ha lasciato il posto a quel rammarico che accompagna chi è consapevole di dover tralasciare tanto, rispetto all’enorme ricchezza che il fondo offre. Se volessimo parlare di quest’ultimo usando i numeri, potremmo dire che dal luglio 2000, da quando cioè è cominciata la catalogazione informatizzata dei libri antichi, in OPAC sono presenti più di settemila volumi, tra seicentine, settecentine e opere del XIX secolo con data fino al 1830, quando cioè si conclude l’età antica del libro. Volendo essere ancora più dettagliati potremmo aggiungere che ben 2277 sono i titoli stampati a Napoli, 1289 quelli veneziani e solo 206 quelli romani; in quest’analisi geografica non vanno sottovalutate nemmeno altre città, sia italiane che europee, come Milano, Firenze, Parigi, Utrecht, Anversa e Losanna.* Ritengo però, che per descrivere un fondo antico le cifre sono sì utili, ma non esaustive, soprattutto se si tratta di un fondo come quello della Provinciale, che si è dimostrato molto complesso nella sua semplicità e omogeneo nelle sue diversità. Sono libri questi, provenienti nella quasi totalità dalla ex Biblioteca Comunale di Foggia, istituita il 19 giugno 1833 per rescriptum principis di Ferdinando II di Borbone, Re delle Due Sicilie,1 e inaugurata il 30 maggio 1834 con un patrimonio iniziale di soli 1913 volumi, a cui si aggiunsero in seguito, una lunga serie di donazioni di famiglie foggiane e di Capitanata, quali Celentano, Staffa, Tugini, Villani, Nigri, e Scillitani, oltre ai numerosi testi delle biblioteche dei conventi soppressi, primo fra tutti quello del Convento dei Cappuccini della chiesa Gesù e Maria di Foggia.2 Siffatto patrimonio subì un ulteriore incremento quando, nel 1871, alla Comunale, fu aggregata pure la biblioteca popolare fondata solo l’anno precedente.3 * Le cifre sono naturalmente destinate ad aumentare con il completamento delle procedure di catalogazione. Oreste DE BIASE, La biblioteca comunale di Foggia, in «Accademie e biblioteche d’Italia», V (1931),10, p. 279. 2 Carlo VILLANI, Cronistoria di Foggia, (1848-1870), Napoli, Officina Cromotipografica Aldina, 1913, p. 245. 3 O. DE BIASE, La biblioteca comunale di Foggia…, cit., p. 279. 1 111 Il Fondo Antico dell’ex Biblioteca Comunale di Foggia nella Biblioteca Provinciale di oggi Questa nutrita serie di ingressi, provenienti come abbiamo visto sia dal clero locale che da famiglie del luogo, hanno determinato un titolario assortito, e caratterizzato soprattutto da un’indole culturale di tipo generico. Il risultato che abbiamo oggi è quello di un fondo completo, perché scaturito proprio dalla fusione di librerie appartenute e donate da soggetti culturalmente attivi, siano essi stati canonici, giuristi, o medici che avendo avuto una identità ben precisa, acquistavano in base ad un criterio che, stabile nel tempo, seguiva il cammino della cultura. Una completezza, quella a cui abbiamo accennato, che scaturisce proprio dal fatto che tutti questi volumi hanno seguito le varie fasi di questo cammino culturale, con i suoi grandi sconvolgimenti storici, e di come la traccia di questi cambiamenti sia rimasta indelebile tra queste pagine. È un catalogo, quindi, frutto di una somma o per meglio dire di una stratificazione di personalità diverse, che svolgendo professioni diverse, avevano interessi personali coltivati diversamente e che hanno dato vita a raccolte diverse, le quali poi sicuramente nel corso degli anni hanno subito smembramenti, traslochi, vendite ed inevitabili perdite. Per questo accanto ai severi volumi di teologia, di diritto e di storia, troviamo anche trattati scientifici e medici, testi letterari latini e italiani, sussidi grammaticali, oltre ad altri svariati scritti d’erudizione. La sua completezza ideale rende possibili, inoltre, volendo, molteplici percorsi di analisi, che vanno dalla storia dell’editoria in generale, a quella napoletana in particolare, passando dalla più statica e frenata cultura del Seicento italiano a quella più disinvolta e vivace del Settecento, cultura che si innesta perfettamente nella nuova circolazione di idee a livello europeo, per andare a fermarsi poi alle replicate ristampe degli autori antichi che tanto frequenti furono agli inizi dell’Ottocento. Infatti si tratta di un fondo sorto grazie alla tendenza di conservare anche quei titoli che a seconda del giudizio storico del tempo potevano essere diventati ormai inutili, banali e superati. Ed è stata proprio questa tendenza conservativa, che ha garantito, fortunatamente, la sopravvivenza fino ai giorni nostri di certi libri, anche dopo che questi avevano ormai esaurito totalmente la loro attualità. L’analisi dei frontespizi, poi, corrobora la tesi che si tratti di volumi che sicuramente hanno fatto parte delle biblioteche di famiglia per più di una generazione, del resto basti pensare a quelli appartenuti ai Celentano, cui le date delle note di possesso manoscritte in elegante grafia, risalgono addirittura al XVIII secolo, o alle diverse note sui volumi che nel corso degli anni sono stati Applicati alla Libraria de’ Cappuccini di Foggia. Per questo, scorrendo il catalogo e tralasciando volutamente da queste analisi le cinquecentine, si può decidere di partire da un percorso più specificatamente ecclesiastico, e in questo caso ci rendiamo subito conto che grande importanza fu data all’ambito della predicazione per cui, se appare scontata e normale la presenza di geniali e forti personalità che sono il vanto dell’oratoria sacra francese quali Fenelon, Bourdalue e Bossuet, non mancano nemmeno nomi italiani di rilievo qua112 Marianna Iafelice li Cornelio Musso4 a cui aggiungiamo quello di Paolo Segneri con il noto Quaresimale,5 o le famose per l’epoca, Prediche quaresimali del cappuccino Emanuele Orchi,6 un predicatore che se molto successo ebbe nel breve giro di pochi anni, per il suo stile tipicamente barocco e secentistico, fu altrettanto velocemente dimenticato, tanto che dall’ultima edizione delle sue prediche uscita in latino a Magonza nel 1668, non verrà più ristampato. Dalle prediche spesso poco intime e poco profonde non sempre originali di alcuni di questi predicatori, si passa alle pagine dei più consolidati biblisti come Calmet, a quelle dei tomisti come Jacquier e Roselli, ma anche e soprattutto alla nutrita presenza di autori giansenisti, il che conferma ancora una volta se ce ne fosse bisogno, che in Italia il Giansenismo fu sempre limitato ai ceti colti e ristretto quasi sempre tra gli ecclesiastici secolari e regolari.7 La presenza inoltre di autori ammirati dal primo Giansenismo italiano, come Fleury che con la Justification des discours et de l’histoire ecclesiastique (1736) condanna l’eccesso di credulità ed esercita per tutto il Settecento una enorme influenza, o come Noel Alexandre che fu autore di una famosa storia ecclesiastica8 poco cara per alcuni contenuti alla Santa Sede, ci fa comprendere come tutti coloro che parteciparono a questo movimento, o che comunque gli si avvicinarono, erano accomunati da ben altro che la sola generica avversione ai Gesuiti. E questo è un elemento sintomatico di questo fondo, dove se molti sono gli autori facenti parte della Compagnia di Gesù, non sono pochi quelli che l’hanno fervidamente avversata, come il famosissimo teologo Antoine Arnauld, che “fu trascinato al giansenismo proprio dall’avversione antigesuitica”9 e che insieme con Pierre Nicole, fu coautore di una celeberrima Logica sive ars cogitandi,10 pubblicata anonima e conosciuta anche come La Logica di Port Royal nella quale approvano il Cartesianesimo e si definiscono interessati alla sua filosofia principalmente perché la considerarono come la rinascita del pensiero agostiniano ritenendo Cartesio un sostenitore della scienza, come loro. La presenza di ben quattro edizioni della Logica, sembra giustificare quasi naturalmente almeno una edizione delle Provinciali, che Pascal scrisse facendo satira degli oppositori gesuiti, forse con l’aiuto e la collaborazione proprio di Arnauld e di Nicole, satira che nell’edizione da noi conservata si evince pure per l’area relativa al luogo e alla responsabilità di pubblicazione 4 Cornelio MUSSO, Delle prediche quadragesimali del reuerendiss. mons. Cornelio Musso vescouo di Bitonto, Venezia, Giunti, 1603. 5 Paolo SEGNERI, Quaresimale di Paolo Segneri della Compagnia di Giesù, Venezia, Prodotti, 1690. 6 Emanuele ORCHI, Prediche quaresimali del padre f. Emmanuele Orchi da Como..., Venezia, Giunti e Hertz, 1651. 7 Arturo Carlo JEMOLO, Il Giansenismo in Italia prima della rivoluzione, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1928, p. 91. 8 Noel ALEXANDRE, Historia ecclesiastica Veteris Novique Testamenti ab orbe condito ad annum Domini 1600, Parigi, Silvani de Grasortis, 1730. 9 A.C. JEMOLO, Il Giansenismo in Italia prima della rivoluzione…, cit., p. 50. 10 Pierre NICOLE, Logica sive ars cogitandi, Lugduni Batavorum , Ex Officina Joannis du Vivie, 1694. 113 Il Fondo Antico dell’ex Biblioteca Comunale di Foggia nella Biblioteca Provinciale di oggi dove leggiamo: Venezia: nella Stamperia de’ PP. Gesuiti nel Foro Deretano, 1761. La presenza di questi autori quindi, e la quantitativa supremazia di stampatori ed editori napoletani, ma anche la presenza di non poche edizioni in francese, costituiscono per questo fondo un importante fattore di unità, un fattore quasi geograficamente scontato soprattutto se si considera che le vicende di questi libri, si intersecano direttamente con la storia politica, economica e sociale di Foggia, dove sicuramente arrivarono gli echi di quell’Illuminismo napoletano, alimentato dai filosofi civili del regno, e dove i frequenti contatti con Napoli, patria del Giannone e del Genovesi, attivissimo centro di opposizione alle pretese curiali gesuitiche, contribuivano alla diffusione di tali idee che ponevano la parte più viva della cultura napoletana in un intimo e proficuo contatto con la cultura europea in generale e con la vivacità di quella francese in particolare.11 A questo proposito quindi, non può e non deve assolutamente meravigliare la nutrita presenza di opere del Genovesi, con cui Saverio Celentano ebbe pure un breve scambio epistolare,12 molte delle quali sono prime edizioni, tutte pubblicate dalla stamperia Simoniana, ad eccezione della Storia del commercio della Gran Bretagna, di John Cary, pubblicata nel 1757 da Benedetto Gessari, ed annunciata l’anno precedente in un manifesto con il quale un libraio napoletano apriva la sottoscrizione per una Storia del commercio che fa al presente l’Inghilterra “corredata con note del signor Genovesi e tradotta dalla versione francese”, versione riscontrata con il testo inglese originale di un’edizione del 1745.13 Accanto al nome del Genovesi, in una sorta di congiungimento ideale, si pongono i nomi di Ferdinando Galiani, autore, tra l’altro, di un trattato Della moneta,14 che il Venturi definisce un “capolavoro uscito dalla discussione sulle monete a metà del secolo”, la cui composizione fu sollecitata proprio dalla crisi monetaria che aveva colpito il Regno di Napoli dopo la Pace di Aquisgrana, e che uscita anonima con data 1750 forse per timore come sostiene Diaz che “per la sua originalità e novità potesse in qualche modo spiacere alle autorità […]”, fu stampata nel 1751.15 Sempre in questo ambito citiamo i nomi degli studiosi calabresi che, non rimanendo indifferenti al Genovesi, avevano subito l’influsso innovativo del suo pensiero, tra cui Domenico Cavallari,16 che fu discepolo di quest’ultimo in filosofia ed in letteratura e di Pasquale Cirillo per la giurisprudenza, Domenico Grimaldi17 11 Michele FUIANO Aspetti della cultura e dell’editoria napoletana nel ’700 , in «Archivio Storico Province napoletane», XCI (1794), pp. 257-279. 12 Carlo VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni, e contemporanei, Trani, V. Vecchi, 1904, p. 235 13 Franco VENTURI (a cura di), Riformatori napoletani, in La letteratura italiana. Storia e testi, Illuministi italiani, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 1962, 7 voll.: vol. V, p. 122. 14 Ferdinando GALIANI, Della moneta libri cinque, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1750. 15 Silvio DE MAJO, Ferdinando Galiani, in Dizionario Biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. LI, p. 457. 16 Domenico CAVALLARI, Institutiones iuris canonici quibus vetus et nova ecclesiae disciplina enarratur in usum privati auditorii conscriptae, Napoli, Di Simone, 1777. 17 Domenico GRIMALDI, Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete nel regno di Napoli, Napoli, Giuseppe Maria Porcelli, 1780. 114 Marianna Iafelice o Francesco Saverio Salfi che con il Saggio di fenomeni antropologici relativi al tremuoto si inseriva in quell’acceso dibattito che imperversava in quegli anni sui danni causati dal terribile sisma del 1785, senza però dimenticare nemmeno Antonio Jerocades, meglio noto con l’appellativo di “abate massone”, grande traduttore di Pindaro ed Orazio, che fu autore anche di una raccolta di poesie, La lira focense,18 che composte nel corso di vari anni, sono in un certo senso un vero e proprio massimario espresso in rima, con statuti, riti e miti propri della massoneria. Un’altra opera che ben si inserisce nella controversia, attiva in quel periodo, tra governo napoletano e Santa Sede, sulla nomina del vescovi, è costituita dal primo scritto di Ottavio Maria Chiarizia, i Lamenti delle vedove ovvero rimostranze delle vacanti chiese del regno di Napoli, (Filadelfia, 1784), opera definita dall’allora inviato pontificio straordinario Lorenzo Caleppi “cosa molto rara nel tempo corrente” in quanto il Chiarizia ha avuto la grande singolarità di trascurare le ragioni giuridiche delle parti in causa e di soffermarsi principalmente sul danno religioso e quindi morale e sociale prodotto dalle sedi prive di vescovi.19 La presenza inoltre in questo fondo di autori illuministi come Voltaire, Rousseau o Montesquieau non stride assolutamente, ma convive armoniosamente anche con le pagine pagane di Ovidio, di Cicerone e di Livio, per citare solo alcuni classici, mentre i più attivi e rinomati stampatori ed editori napoletani del Settecento, quali Felice Mosca, Giovanni de Simone e Domenico Terres, sono tutti presenti in questo catalogo, con edizioni che non sempre possono essere definite delle belle edizioni, per la cattiva qualità della carta, degli inchiostri e per molti versi anche per la mancanza di gusto, che portava costoro sempre a volgere lo sguardo verso i prodotti tipografici della Serenissima, dove le officine davano ancora vita, nonostante la forte crisi del settore, a pagine di ottima qualità grafica, ben equilibrate e ben composte, con inchiostri immuni da alterazioni e molto spesso stampate su cartaforte, ben diversi insomma dai molti libri non perfetti che uscivano dalle officine tipografiche napoletane. Del resto gli stampatori della capitale del regno, non solo si contentavano di lavorare a prezzi bassissimi, ma soprattutto tendevano a ristampare edizioni veneziane, alleggerendosi così del peso economico della traduzione che trovavano già pagata da Venezia, che si impegnava a stampare le prime edizioni. Del resto Venezia in quegli anni, accanto alla stampa dei cosiddetti “rossi e neri”, così venivano comunemente denominati i libri liturgici, dà vita ad opere grandiose, quelle vere e proprie imprese che nel corso del Settecento hanno contribuito a scrivere le pagine della storia del libro illustrato, di cui la biblioteca possiede, La Gerusalemme liberata (1787), le Opere del Metastasio, (1781-1783), e soprattutto la ricercata ed elegante edizione delle 18 19 Volume privo di frontespizio la cui data 1724 è ricavabile dalla prefazione a p. 5. Giuseppe PIGNATELLI, Ottavio Maria Chiarizia, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. XXIV, p. 592. 115 Il Fondo Antico dell’ex Biblioteca Comunale di Foggia nella Biblioteca Provinciale di oggi Opere di Dante (1757-1758) tutte pubblicate da Antonio Zatta,20 che con l’Albrizzi e il Pasquali è considerato uno dei tre grandi esponenti proprio del libro illustrato veneziano. L’ambito della storia, in questo catalogo se si escludono la Storia universale21 di Jacques Benigne Bossuet, o quella del Rollin con la continuazione del Crevier, deve lasciare un posto ampio anche alla storiografia del Seicento, e più precisamente al primo dei due volumi delle Historie del mondo di Cesare Campana, stampata dai Giunti a Venezia nel 1607, dove il Campana allontanandosi dagli esempi umanistici, tenta di ritornare a quel carattere più prettamente universale che fu proprio della cronachistica medievale, e per il quale divenne un vero e proprio modello del genere, al contrario di quanto fa Girolamo Brusoni che nella Historia d’Italia di Girolamo Brusoni dall’anno 1627 fino al 166022 preferisce invece un ambito più limitatamente contemporaneo per quest’opera che nell’arco di venticinque anni subì ben sette rifacimenti, e che fece guadagnare all’autore l’incarico di storiografo della corte torinese, dopo essere stato obbligato a ‘rivedere’ alcuni passaggi, considerati evidentemente compromettenti per l’operato del Duca di Savoia.23 L’interesse preminente per il presente, sembra essere in questi storici, al contrario di quanto avveniva per quelli delle generazioni precedenti, un punto focale su cui concentrare la propria attenzione, e far partire le grandi polemiche verso l’antico, ma se questo nuovo interesse da un lato rappresentava l’aspetto più vivace di queste opere, al contempo ne costituiva pure il loro grande limite, soprattutto per la loro frequente superficialità, priva molto spesso sia di interesse storico che di effettivo valore stilistico. Compiendo un salto epocale, che ci conferma ancora una volta come questo catalogo sia diventato oggi l’interfaccia dei cambiamenti culturali che hanno scandito il nostro passato, arriviamo agli Annali d’Italia del Muratori, di cui possediamo la prima bella edizione, stampata a Venezia, ma uscita con falso luogo di stampa (Milano), dal 1744 al 1749 e pubblicata da Giambattista Pasquali, un tipografo colto e raffinato, che ebbe il grande merito di saper rinnovare l’editoria veneta del tempo, prediligendo scritti innovativi che stampava molto spesso con illustrazioni chiare ed efficaci, contro la tendenza dell’epoca quando, come abbiamo visto, si preferiva ristampare solo libri devozionali o classici della letteratura. 20 L’edizione delle Opere di Dante, è dedicata ad Elisabetta Petrowna, imperatrice di tutte le Russie con un sonetto racchiuso in cornice calcografica, preceduto sia da un ritratto della Petrowna, sia da un’antiporta raffigurante una “delle imbasciate di Dante alla Serenissima nostra repubblica, quando intorno agli anni di nostra salute 1320 spedito vene sovente a Vinegia da Guido da Polenta […]” (Prefazione del vol. 1, p. [3]). Ognuno dei cinque volumi è arricchito da splendide carte di tavola a cui hanno collaborato numerosi ed importanti maestri incisori, tra cui ricordiamo il Giampicoli, il Magnini, il Crivellari e Filippo Rizzi, i quali sicuramente hanno fornito pure il loro contributo per i tanti fregi e le iniziali che decorano finemente le pagine. 22 Girolamo BRUSONI, Historia d’Italia di Girolamo Brusoni dall’anno 1627 fino al 1660, Venezia, Francesco Storti, 1661. 23 Sandro PIANTANIDA et al.(a cura di), Autori italiani del ’600. Catalogo bibliografico, Roma, Multigrafica Editrice, 1986, 3 voll.: vol. I, pp. 132-133. 116 Marianna Iafelice Del Pasquali sono pure i sei volumi del Supplemento al Dizionario universale delle arti e delle scienze, del Chambers, volumi composti da George Lewis, che si inseriscono tra le tantissime opere presenti in catalogo di scienze fisiche, chimiche e mediche del Redi, del Pasta, di Cullen o di Percival Pott, per fare solo alcuni nomi. Come numerosissime sono quelle di diritto, tra cui citiamo solo per motivi di spazio, la bella edizione del Theatrum veritatis & justitiae, siue decisiui discursus per materias, seu titulos distincti & ad veritatem editi in forensibus controuersiis canonicis et ciuilibus del cardinale De Luca, stampata dai Baglioni nel 1716, opera scritta con il chiaro intento di offrire una vera e propria enciclopedia giuridica, dove gli interventi e le rielaborazioni sono facilmente ripercorribili attraverso i sommari, tanto che il Mazzacane la definisce “una delle migliori edizioni”.24 Tra le opere singolari di questo fondo vanno ricordate pure due seicentine, di Alessandro Salvio, un giocatore di scacchi, assiduo frequentatore delle accademie scacchistiche napoletane dell’epoca e cioè il Trattato dell’inuentione et arte liberale del gioco di scacchi25 e Il puttino altramente detto, il caualiero errante del Saluio, sopra il gioco de’ scacchi,26 in cui si danno numerose notizie, non sempre attendibili a dire il vero, sui giocatori napoletani del suo tempo. Se fino a questo momento abbiamo descritto questo fondo ponendo l’attenzione principalmente sul messaggio intellettuale del testo, prima di concludere quest’analisi, è doveroso dedicare un po’ di spazio alla tipologia delle legature, rappresentanti l’elemento materiale del libro e dare, quindi, uno sguardo allo stato di conservazione generale. La maggior parte delle legature è in pergamena rigida cartonata, con indicazioni dell’autore e del titolo abbreviate, siano esse impresse in oro o manoscritte, poste nella parte superiore del dorso, anche se non mancano però nemmeno coperte in pergamena floscia, soprattutto per le edizioni del Seicento, le cui indicazioni manoscritte sono localizzate a differenza delle prime, lungo tutto il dorso o quelle in mezza pergamena, i cui piatti sono rivestiti con carta marmorizzata. Lo stato fisico generale del fondo è abbastanza buono, mancano infatti se si escludono pochissimi esemplari, quasi totalmente danni causati da tipologie di insetti come i tarli, che grazie a microrganismi intestinali simbionti sono in grado di metabolizzare la cellulosa e che quando sono nella fase larvale scavano gallerie dal diametro variabile, poco visibili all’esterno, fino a praticare fori di sfarfallamento (visibili di solito sulle coperte) quando raggiungono la piena maturità. I libri maggiormente danneggiati presentano invece il distacco parziale o totale della coperta o del dorso, e/o rotture dei nervi o dei capitelli, rotture che di conseguenza indeboliscono anche le cuciture, mentre più frequente è la presenza di tracce di foxing sulle pagine dei volumi, ovvero macchioline rugginose la cui origi- 24 Alessandro MAZZACANE, De Luca Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli italiani…, vol. XXXVIII, pp. 342-343. 25 In Napoli, nella Stampa di Gio. Domenico Montanaro, 1634. 26 In Napoli, nella Stampa di Gio. Domenico Montanaro, 1634. 117 Il Fondo Antico dell’ex Biblioteca Comunale di Foggia nella Biblioteca Provinciale di oggi ne è ancora incerta, e che secondo alcuni studiosi è imputabile ad agenti microbici che si sviluppano sulla carta in presenza di ferro e di condizioni chimico fisiche particolari, secondo altri invece i microrganismi avrebbero solo una responsabilità indiretta, andando cioè solo a facilitare la creazione di zone maggiormente igroscopiche, nelle quali si andrebbero poi ad accumulare i prodotti di decomposizione della cellulosa. 118 Elena Infantini Il web della biblioteca di Elena Infantini Con l’avvento di Internet in biblioteca, superata l’iniziale preoccupazione sulla possibile scomparsa delle biblioteche e dei bibliotecari, si sono aperte nuove frontiere per la trasmissione delle conoscenze ed oggi la Rete è considerata strumento fondamentale non solo per l’accesso alle informazioni che viaggiano in tempo reale e senza limiti quantitavi, ma anche per la promozione della biblioteca e dei suoi servizi, quindi un’altra grande opportunità per ‘comunicare la biblioteca’. “Internet, infatti, è intervenuto a modificare fortemente l’intero panorama del settore della comunicazione e della cultura, del quale le biblioteche sono solo uno dei tanti attori. Rimanere immobili nella difesa di una nostra specificità senza confrontarsi con il cambiamento può rappresentare il rischio di un inutile e sterile ripiegamento sul passato”.1 Se proviamo a navigare nei meandri della Rete, verifichiamo che la maggior parte delle biblioteche estere e italiane, tranne poche eccezioni, ha allestito un proprio sito web, dichiarando all’utente remoto che le visita virtualmente, le proprie caratteristiche e finalità, la propria missione. Siamo però, ancora in una fase di “sperimentazione non sempre sorretta da orientamenti consolidati”,2 il web “incunabolo digitale”3 di cui parla Riccardo Ridi, e, mentre da una parte si è discusso ampiamente sui vantaggi che Internet ha portato all’evoluzione dei servizi delle biblioteche, il catalogo in linea, il reference a distanza e molto altro, dall’altra ancora pochi sono gli studi sulla valutazione dei siti web delle biblioteche di pubblica lettura. Non entrando nel merito degli elementi considerati nelle cosiddette griglie valutative dei siti bibliotecari, come la struttura, la velocità di caricamento o la quantità e la qualità delle informazioni, si rimanda alla bibliografia di riferimento; quello che emerge con insistenza dalle discussioni sull’argomento, è che necessariamente 1 Elena BORETTI, Comunicare con l’utente remoto. Il riposizionamento della biblioteca nel mercato dell’informazione, in «Biblioteche oggi», XIX (2001), 6 (luglio-agosto), p. 54. 2 Stefano PARISE, La qualità del web in un seminario a Rozzano. Tecniche e strategie per creazione e la gestione dei siti Internet bibliotecari, in «Biblioteche oggi», XX (2002), 8 (ottobre), p. 92. 3 Riccardo RIDI, Il web bibliotecario come incunabolo digitale, in Franz BERGER - Klaus KEMP (a cura di), Riforma universitaria e rivoluzione dei media: una sfida per le biblioteche universitarie , Atti del convegno internazionale (Bolzano 28-29 settembre 2000), Firenze, Canalini libri, 2001, pp. 59-72. 119 Il web della biblioteca un sito web debba presentare: chiarezza e omogeneità, considerando lo scopo principale che il sito di una biblioteca deve perseguire, quello di fornire informazioni in modo trasparente. È giusto che, da un punto di vista contenutistico, i siti delle biblioteche rispondano a determinati requisiti che mettano in luce la missione di ognuna, le caratteristiche che le accomunano e quelle che le differenziano, ma da un punto di vista formale, invece, sarebbe auspicabile che questi siti si uniformassero a tipologie comuni e parlassero un linguaggio omogeneo, perché espressione dell’attività d’istituzioni culturali affini le quali rientrano in primis tra i Soggetti Culturali Pubblici cui fa riferimento Minerva nel Manuale sulla qualità dei siti Web culturali.4 Minerva è un progetto finanziato dalla Commissione Europea e che ha riunito i Ministeri dei Paesi Membri dell’Unione Europea preposti alla cultura, con la finalità di favorire una comune visione europea nella creazione dei siti culturali, armonizzando allo stesso tempo le attività di digitalizzazione, da qui la pubblicazione del Manuale sulle buone pratiche nella digitalizzazione.5 È, in sostanza, un progetto nato per aiutare le Istituzioni Culturali a raggiungere un adeguato livello di qualità. Un altro punto, di cui si discute già da qualche tempo nella letteratura professionale, ma che è diventato di grande attualità da quando è stata pubblicata la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004,6 è la ‘accessibilità’ dei siti web. Non appena sarà pubblicato il regolamento, la Legge dovrà essere applicata e i siti delle amministrazioni pubbliche dovranno diventare conformi al WAI7 del W3C (World Wide Web Consortium). Quando si parla di ‘accessibilità’, si fa in relazione alle persone disabili: un sito è accessibile quando non esistano ostacoli alla navigazione per tutte quelle disabilità fisiche e/o cognitive; ma un sito accessibile, usabile e navigabile per un disabile, diventa inevitabilmente un sito molto più fruibile da parte di tutti gli utenti.8 “Si tratta dunque, in definitiva, dell’affermazione di un primato di democrazia su un mezzo di comunicazione e informazione destinato a divenire d’uso comune per tutti i cittadini nei prossimi anni. Ove l’accessibilità non venisse integralmente conquistata, si perpetuerebbe un discrimine sociale e culturale che finirebbe per ingrandire il fossato di disuguaglianza e disparità tra le persone”.9 Le Biblioteche che, per citare il Manifesto IFLA-Unesco sulle biblioteche pubbliche, “rendono prontamente disponibile per i loro utenti ogni genere di co4 MINERVA WORKING GROUP 5, Manuale sulla qualità dei siti Web culturali, in http://www.minerva.europe.org/ publications/qualitycriteria.htm. 5 MINERVA WORKING GROUP 5, Manuale sulle buone pratiche di digitalizzazione, in http://www.minerva.europe.org/ publications/goodhand.htm. 6 Legge 9 gennaio 2004 n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, in http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l4_04.html 7 W3C, Linee guida per l’accessibilità ai contenuti del web. Versione 1.0 (5 Maggio 1999). Traduzione italiana a cura del WAI-IT (gruppo di studio sull’uguaglianza d’accesso ai servizi delle biblioteche) in http://www.aib.it/ aib/cwai/cwai .htm. 8 Mario BARBUTO, L’accessibilità nel web: prima un dovere, poi un diritto!, in http://www.marciana.venezia.sbn.it/ CABI/barbuto.html. 9 Ibid. 120 Elena Infantini noscenza e informazione”, hanno l’obbligo di aderire ai principi del W3C, fornendo i propri servizi sulla base dell’uguaglianza dell’accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità e condizione sociale. Da questa esigenza nasce il CABI (Campagna per l’accessibilità delle biblioteche in rete)10 promossa dalla Biblioteca Marciana di concerto con il M.B.A.C., Direzione Generale per i Beni Librari e le Istituzioni culturali e a cui possono aderire anche le biblioteche i cui siti non sono ancora accessibili. Scopo del CABI è sensibilizzare il settore, fornendo allo stesso tempo indicazioni, strumenti e suggerimenti tecnici per raggiungere l’obiettivo: informare anche i più deboli, direzione in cui finora purtroppo, pochissime biblioteche si sono mosse; due prototipi di siti con la ‘tripla A’ sono quelli della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano realizzati da Brunella Longo ed in fase di implementazione. Perché si parla di ‘tripla A’? Bisogna scendere un po’ più nel particolare, e spiegare che le raccomandazioni del W3C, oltre a discutere i problemi di accessibilità, forniscono allo stesso tempo soluzioni e indicazioni pratiche per la progettazione dei siti; sono dirette sia agli sviluppatori di contenuti web, sia agli sviluppatori di strumenti di authoring, proponendo, secondo le diverse possibilità economiche, tre differenti livelli di accessibilità e sfatando l’idea che un sito accessibile non possa essere anche creativo ed accattivante, perché l’accessibilità non esclude il design. Esistono poi dei programmi che valutano la conformità delle pagine alle linee guida del WAI, uno di questi è Bobby,11 sviluppato dal Center for Applied Special Tecnology e che, in caso di conformità, rilascia un certificato di qualità con un logo e la dicitura “Bobby approved”. Per avere un’idea, è possibile visitare il sito delle biblioteche comunali di Pisa, approvato da Bobby, all’indirizzo http://www.comune.pisa.it/ doc/bibliopi/pro.htm. La strada che le biblioteche hanno intrapreso per raggiungere l’accessibilità dei propri siti è appena iniziata ed è in salita, ma è un impegno che non spaventa considerato il fine che si vuole raggiungere: l’accesso alle informazioni per tutti, ‘nessuno escluso’, mutuando un’espressione utilizzata dalla Biblioteca Civica di Cologno Monzese. Di queste biblioteche fa parte la Biblioteca Provinciale di Foggia “la Magna Capitana”, che per le ragioni spiegate fin ora, ha deciso di ristrutturare il proprio sito, pubblicato nel 2001 in fase sperimentale. A tal fine è stata condotta un’attenta analisi sia delle caratteristiche peculiari de “la Magna Capitana”, biblioteca di pubblica lettura nonché importante biblioteca di conservazione, sia dei propri servizi e delle esigenze dell’utenza, ed è stato chiesto, per redigere un progetto nel modo più serio e scientifico possibile, uno studio ad uno dei più importanti esperti del settore, Riccardo Ridi, al termine del quale sono nate le Linee guida per il sito web della Biblioteca Provinciale di Foggia. 10 11 CABI (Campagna per l’accessibilità delle biblioteche in rete): http://marciana.venezia.sbn.it/CABI/. Disponibile all’URL http://www.cast.org/bobby. 121 Il web della biblioteca Dopo gli sforzi fatti, nel seguire degli anni, con lo scopo di fornire servizi sempre più di qualità all’utenza, ora la Biblioteca Provinciale di Foggia, accoglie questa nuova sfida, nell’ottica di poter offrire un sito web coerente con tutti gli obiettivi che si è proposta, e aspirando ad arrivare prima o poi, perché no, alla ‘tripla A’. BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO Circolare Funzione pubblica 13 marzo 2001, n. 3/2001 http://www. governo.it/Presidenza/web/circ13mar2001_FP.html Circolare AIPA 6 Settembre 2001, n. AIPA/CR/32 http://www. governo.it/Presidenza/web/circ6set2001_AIPA.html Carla BASILI - Corrado PETTINATI, La biblioteca virtuale, Milano, Editrice Bibliografica, 1994. Valentina COMBA, Comunicare nell’era digitale, Milano, Editrice Bibliografica, 2000. Giovanni DI DOMENICO - Michele ROSCO, Comunicazione e marketing della biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica, 1998. Ornella FOGLIENI (a cura di), La biblioteca amichevole, Milano, Editrice Bibliografica, 2000. Ornella FOGLIENI (a cura di), Comunicare la biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica, 2002. Massimiliano MARCUCCI, I siti web delle biblioteche comunali toscane. Un’efficace griglia valutativa alla base di un’indagine sulle realtà di maggiore interesse formativo, in «Biblioteche oggi», XX (2002), 10 (dicembre), pp. 18-31. Fabio METITIERI, Biblioteche in rete: istruzioni per l’uso, Roma, Laterza, 2002. Maria Stella RASETTI, L’odalisca sul risciò. L’uso del sito web come strumento di management per valutare e dirigere i processi organizzativi in biblioteca, in «Biblioteche oggi», XVIII (2000), 9 (novembre), pp. 8-20. Riccardo RIDI, Censimento dei siti web delle biblioteche lombarde, in Multimedialità nelle biblioteche lombarde, Milano, Regione Lombardia, 1999, pp. 19-63. Arturo SANTORIO, Quanto valgono i siti web, in «Biblioteche oggi», XX (2002), 10 (dicembre), pp. 6-17. 122 Antonio Perrelli Il ruolo della rete nella biblioteca di Antonio Perrelli Attualmente la mondializzazione degli scambi, la globalizzazione delle tecnologie, l’avvento di una nuova società dell’informazione hanno aperto maggiori possibilità di accesso al sapere, anche tramite strumenti multimediali e interattivi. Per il pieno compimento della società dell’informazione, è fondamentale una maggiore diffusione delle nuove tecnologie, raggiungibile solo con lo sviluppo delle più avanzate infrastrutture tecnologiche distribuite capillarmente sul territorio e con un colossale sforzo per mettere tutti i cittadini in condizioni di avvalersi delle opportunità che tali tecnologie offrono. Tra queste, il personal computer rappresenta il fulcro di questa innovazione culturale. Esso è ormai oggi nelle nostre case e fa parte della nostra vita lavorativa e di divertimento. Se però si considera questo prodotto dell’evoluzione tecnologica come uno strumento isolato, si commette un grosso errore; la sua vera potenza sta nel fatto che può far parte di un mondo fatto di informazioni tutte disponibili e sparse per il pianeta. Esempio reale della sua espansione è individuabile nel mondo delle biblioteche che stanno vivendo una vera e propria rivoluzione. Il computer ne è ormai entrato a far parte integrante e il bibliotecario stesso ha acquisito competenze nel settore informatico, assumendo un ruolo di riferimento per il ricercatore e l’utente che si rivolgono alla biblioteca per ottenere testi, strumenti, informazioni. Per rendere la biblioteca ancora più aperta al pubblico e alle sue esigenze, non c’é nulla di meglio della rete, che, al contempo, collega lo spazio-biblioteca con l’abitazione e il luogo di lavoro dell’utente, facilitandone il contatto reciproco e soprattutto migliorando i tempi della ricerca. Il settore della documentazione, nonché in senso più lato la biblioteconomia si sta evolvendo rapidamente. Per sfruttare le potenzialità che la rete offre è, però, necessario conoscere bene il suo funzionamento, sapere come svolgere una ricerca mirata, conoscere le fonti e le possibilità che vengono offerte dalla struttura. Ma che cos’è una rete? In linea generale si può definire una rete come l’insieme di due o più calcolatori opportunamente collegati fra loro (attraverso un mezzo di connessione, un cavo coassiale o a fibre ottiche, un collegamento via satellite o una semplice linea telefonica) in grado di scambiarsi informazioni e mettere a disposizione l’uno le risorse dell’altro. Se nella rete sono presenti computers che mettono a disposizione risorse e 123 Il ruolo della rete nella biblioteca dati (server: danno servizi) ed altri che possono leggere questi dati (client: ricevono servizi) la rete diventa di tipo client/server. Ovviamente tale rete si può espandere aumentando il numero di client ed eventualmente di server, incrementando ogni volta i collegamenti in modo da formare una maglia (da qui la definizione di rete) che potrà avere forme geometriche di vario tipo anche dettate dalle tecnologie di collegamento. Oggi si tende a concentrare i collegamenti in apparati di convergenza dei dati (HUB) che poi li smistano ai vari computer. Esempio di rete noto a tutti è Internet, che connette milioni di computer in tutto il mondo. Grazie alla sua organizzazione decentrata e priva di controlli e alla facilità degli scambi informativi, Internet è dunque la “rete delle reti”; la più grande rete telematica e il più dinamico e innovativo sistema d’informazione e di comunicazione oggi esistente, che veicola una quantità sterminata di risorse, d’informazioni, di servizi. Internet coinvolge una molteplicità di interessi, di possibilità, di punti di vista; si discute molto, ad esempio, degli aspetti “sociologici” della rete, cioè di tutto quanto attiene alla comunicazione interattiva, ai gruppi di discussione, ai luoghi d’incontro telematici, alle comunità virtuali: insomma tutto il vasto universo che guarda alla rete come ad un vero e proprio mondo parallelo, che è ormai noto col termine di “ciberspazio”. Internet, quindi, ha un ruolo di immenso contenitore di conoscenze disponibili per la ricerca e il recupero in tutti i campi dello scibile. Infatti, malgrado il gran numero di attività commerciali e di elementi futili o inutili presenti su Internet, è indubbio che le informazioni valide a fini scientifici siano in costante aumento e che assumano una validità sempre maggiore nella comunità accademica internazionale. Con Internet infatti è possibile: a) recuperare informazioni ai fini di una ricerca informativa; b) consultare cataloghi on-line (OPAC) e banche dati; c) diffondere notizie in tempo reale ai diversi membri della comunità accademica internazionale; d) ottenere in anticipo informazioni su argomenti scientifici; e) avviare e proseguire discussioni su argomenti di comune interesse accademico. Tuttavia Internet non è soltanto un collegamento fisico tra un sempre crescente numero di calcolatori sparsi in tutto il mondo, ma è soprattutto un protocollo di comunicazione. La grande innovazione di Internet è quella di aver unificato il protocollo di comunicazione (TCP/IP: Transfert Control Protocol/Internet Protocol). Il TCP/IP permette di far parlare fra loro milioni di computer in tutto il mondo, ma anche di connettere efficientemente le poche macchine di una rete locale. Grazie alle sue caratteristiche di economicità e versatilità, infatti, molte aziende utilizzano ormai TCP/IP anche per le proprie reti interne. Queste reti, per lo più aziendali, vengono comunemente indicate con il nome di Intranet. Una rete Intranet, vista l’intrinseca necessità di sicurezza di una rete aziendale, è normalmente inaccessibile al comune utente Internet. Al contrario, da una Intranet si ha in genere la possibilità di navigare sulla rete delle reti (Internet). 124 Antonio Perrelli Diventa, perciò, sempre più pressante l’esigenza di possedere meccanismi sistematici e standardizzati per identificare, localizzare e descrivere le risorse informative di rete funzionali ad una data ricerca conoscitiva. Infatti il patrimonio informativo presente in rete è enorme ed in continuo incremento, a volte sovradimensionato rispetto alle esigenze dei ricercatori; tale sovrabbondanza, pur rappresentando una caratteristica fondamentale di Internet, può costituire un ostacolo alla ricerca e al recupero delle informazioni, in quanto il ricercatore non sempre conosce l’esistenza e la localizzazione di risorse che invece possono diventare delle preziose fonti conoscitive. Per ovviare a tali difficoltà, è dunque necessario individuare delle strategie che permettano al ricercatore non solo di orientarsi fra la miriade di informazioni disponibili, ma di padroneggiarle e renderle funzionali alle sue esigenze. Il reperimento e il recupero delle risorse informative, infatti, sono facilitati da una serie di strumenti e di meccanismi di ricerca presenti in rete, che permettono di accedere alle risorse desiderate in maniera semplice ed efficace. Basti pensare ai famosissimi motori di ricerca. Essi rappresentano la risorsa principale a disposizione dell’utente per la ricerca di informazioni presenti in rete attraverso l’ausilio di parole chiave. Si può dire, in generale, che sono dei grandi archivi di dati contenenti informazioni dettagliate su un gran numero di pagine web. Dalla ricerca possono risultare singoli file di testo, interi siti, immagini, suoni, file multimediali, ecc… Internet sta, quindi, divenendo uno strumento di lavoro e di ricerca di rilevanza sempre più marcata e soprattutto di mediazione dei flussi informativi. Internet ha senz’altro rivoluzionato anche il modo di lavorare di tante biblioteche. Inutile sottolineare la particolare sensibilità del mondo bibliotecario alle innovazioni tecnologiche: si tratta ormai di un dato acquisito e, già agli albori della Rete, i bibliotecari sono stati tra i primi a coglierne tutte le potenzialità. In primo luogo cambia il concetto di “risorsa bibliografica” ossia l’insieme di informazioni di natura puramente bibliografica tratte non solo da cataloghi cartacei di biblioteche, repertori, ecc…, ma anche da banche dati, cataloghi elettronici, siti web, ecc… indispensabili per l’individuazione e il reperimento di documenti presenti in biblioteche e centri di documentazione, per la compilazione di bibliografie. Di conseguenza il solo catalogo cartaceo non sembra bastare più: oggi grazie all’ipertestualità si assiste alla creazione di sistemi che consentono con un semplice clic di passare dall’informazione secondaria a quella primaria, dal dato bibliografico alla risorsa full text. Da qui la nascita dei cosiddetti e-book: strumenti delle dimensioni e del peso del tutto paragonabili a quelli di un normale libro a stampa ma capaci di consentire l’accesso a una libreria smisurata di testi, suoni e filmati, permettendone la lettura su uno schermo ad alta risoluzione più ampio e leggibile di quello di un communicator, ma più piccolo, leggero e resistente di un display da scrivania. Il catalogo, specchio fedele di ciò che la biblioteca possiede, cambia la sua concezione di ‘staticità’ in una più moderna e funzionale di ‘dinamicità’. Sempre di più si parla di accesso e non di possesso. Non solo, ma le biblioteche tendono a 125 Il ruolo della rete nella biblioteca condividere le proprie risorse economiche, umane e tecnologiche, unendosi in consorzi. Ed è proprio in questo ambito che la Rete rappresenta la risorsa più importante per le biblioteche del nuovo millennio. Infatti attraverso l’installazione di un software unico su un elaboratore centrale al quale vengono collegati un certo numero di personal computer che costituiscono le stazioni di lavoro in sede per lettori e bibliotecari, è possibile creare una rete locale (LAN: Local Area Network). Nel caso di sistemi composti da più biblioteche, è invece possibile utilizzare per il software, un elaboratore centrale più potente a cui vanno collegate, con linee telefoniche dedicate alla trasmissione dati (più veloci e sicure) oppure con linee telefoniche commutate (meno costose), le diverse reti locali costituendo una rete più estesa (WAN: Wide Area Network). Internet offre, quindi, oggi, una notevole quantità di servizi di tipo bibliotecario rivolti al pubblico generico, oltre ad alcuni servizi orientati maggiormente ad una utenza professionale. È possibile suddividere tale insieme di servizi nelle seguenti classi: a) servizi di informazione al pubblico basati sul Web relativi a singole biblioteche (information desk on-line); b) servizi di consultazione on-line dei cataloghi informatici di singole biblioteche o di gruppi di biblioteche (cataloghi individuali e collettivi); c) servizi di distribuzione selettiva di documenti (document delivery); d) servizi speciali di informazione e di supporto per i bibliotecari; e) servizi di biblioteca digitale. Si rende sempre più evidente, dunque, il ruolo attivo che dovrebbero assumere le biblioteche pubbliche, non solo come luoghi in cui è possibile accedere alla consultazione di Internet (ruolo sempre più scontato) ma come soggetti principali della rete in qualità di gestori dell’informazione. La tendenza deve essere quella di focalizzare l’attenzione sui criteri di gestione e costruzione dei siti web al fine di fornire un servizio utile, non solo perché questo aumenta la ‘presenza’ della biblioteca nel mondo della rete, ma anche perché se tempo fa si discuteva, magari con qualche ironia, di virtualità e assenza di pareti, oggi può succedere che l’esistenza stessa di una struttura possa coincidere proprio con l’essere in rete: si esiste solo se si ha un sito web. Il Web è lo strumento attraverso il quale con sempre maggior facilità la biblioteca può mettere a disposizione della sua utenza non solo informazioni, non solo il catalogo, ma anche servizi aggiuntivi. I nuovi siti web offrono al pubblico informazioni, a vario livello di dettaglio, sulla biblioteca stessa, sulla sua collocazione, sui regolamenti e gli orari di accesso, sulla qualità e consistenza delle collezioni. In alcuni casi è possibile trovare anche servizi avanzati come la prenotazione del prestito di un volume, o persino l’attivazione di procedure per il prestito interbibliotecario. In un certo qual modo il web della biblioteca è al tempo stesso un portale verso l’interno, il punto di partenza per una navigazione che consenta di scoprirne le ‘ricchezze interiori’, e dall’altro un portale verso l’ester126 Antonio Perrelli no per l’utente istituzionale che vuole servirsi della biblioteca come starting point per le sue ricerche. Naturalmente la disponibilità di questi strumenti è legata alla presenza sul sito bibliotecario di un sistema di consultazione on-line del catalogo. Tali sistemi, detti OPAC (acronimo di On-line Public Access Catalog), sono senza dubbio una delle più preziose risorse informative attualmente disponibili sulla rete. Un OPAC è costituito sostanzialmente da un database (dotato di un proprio motore di ricerca) e da una interfaccia di accesso ai dati in esso archiviati. Un database dal punto di vista logico è composto da una serie di schede (record). Ogni record contiene la descrizione, organizzata per aree prefissate (o campi), di un determinato oggetto. Nel caso dei database catalografici tali oggetti sono i documenti che fanno parte della collezione di una o più biblioteche. In un database la ricerca può avvenire in base a qualsiasi campo, o persino indipendentemente da un qualche campo. In generale tutti gli OPAC permettono di effettuare ricerche usando come chiavi le principali intestazioni presenti in una normale scheda catalografica: autore, titolo, soggetto. Alcuni forniscono anche altre chiavi o filtri di ricerca, quali data o luogo di pubblicazione, editore, classificazione (nei vari sistemi Dewey, CDU, LC, ecc…), codice ISBN. Con gli OPAC, quindi, è possibile, per i catalogatori, risparmiare tempo prezioso evitando di ricatalogare documenti già registrati nella base dati, per i lettori, disporre di un catalogo unico per tutte le biblioteche del sistema che permetta di effettuare una ricerca rapida e completa delle informazioni di cui ha bisogno individuando contemporaneamente quale biblioteca possieda il libro o il periodico che cerca, rimanendo comodamente seduti alla propria postazione elettronica. Tuttavia é con la diffusione della rete che davvero ci si è trovati di fronte a dei problemi di natura gestionale non indifferenti e alla necessità per tutti: per i bibliotecari, per gli editori e per i tanti attori del mercato dell’informazione, di valutare con rinnovato interesse l’impatto di queste risorse, cercando di trovare soluzioni valide alle richieste sempre più pressanti di un’utenza che, con il passare del tempo, ha acquistato familiarità con la rete ed è diventata sempre più esigente. La natura fortemente invasiva delle risorse elettroniche pone problemi nuovi: a) nella gestione delle raccolte, sia per quel che concerne l’aspetto della conservazione e dell’uso, sia per quel che concerne la politica delle acquisizioni; b) nella gestione del catalogo (o dell’OPAC), inteso come lo strumento che consente all’utente di conoscere l’effettiva disponibilità (sia essa intesa come possesso, sia essa intesa come accesso) delle risorse informative; c) nella gestione dei servizi, in primo luogo del reference, ma anche di tutte le transazioni di document delivery e di prestito interbibliotecario; d) nella formazione dei bibliotecari; e) nella formazione degli utenti; f) nel rapporto con la propria istituzione di appartenenza e nella armoniz127 Il ruolo della rete nella biblioteca zazione con le altre strutture bibliotecarie presenti, ad esempio, all’interno di un Ateneo; g) nella visibilità complessiva che la biblioteca può avere, sia nei confronti della sua utenza primaria, sia nei riguardi dell’utenza esterna. Tutto questo accade mentre la biblioteca, nella stragrande maggioranza dei casi, deve ancora garantire l’accessibilità e la fruizione del suo patrimonio tradizionale, sommando così, verrebbe da dire, nuovi e vecchi problemi, in un contesto particolare come è quello italiano. Uno dei principali ostacoli alla distribuzione di contenuti e servizi ad alto valore aggiunto attraverso Internet è stato proprio costituito dalla limitata capacità delle infrastrutture di trasmissione, soprattutto nel cosiddetto “ultimo miglio”, il tratto che giunge nelle case degli utenti. L’enorme espansione della rete ha stimolato l’offerta e la domanda di nuovi servizi e contenuti digitali, ma le infrastrutture tecnologiche esistenti non sono sufficientemente veloci per veicolare gli elevati quantitativi di informazione necessari. Se da una parte è apprezzata la libertà di poter leggere le informazioni sulla rete sia da casa che in ufficio che in biblioteca, senza essere soggetti a spostamenti e orari, poter cercare da soli qualsiasi tipo di documento, diventa, dall’altra parte, un limite la velocità della trasmissione, il costo delle connessioni e delle attrezzature private, l’imperfezione, l’instabilità e l’improvvisazione dell’informazione su Web. In questo quadro si collocano gli ingenti investimenti che istituzioni pubbliche e aziende private stanno facendo per rinnovare e potenziare gli apparati e i canali di trasmissione dati che costituiscono le infrastrutture fondamentali di Internet, e in generale di tutti gli strumenti di comunicazione digitali. Inoltre la tecnologia ha ampliato l’accesso alle risorse informative al di là delle mura della biblioteca, spesso producendo come effetto collaterale la perdita da parte della biblioteca e del bibliotecario del ruolo di mediazione informativa e la crescita del numero degli utenti dei servizi in remoto. Qual è allora il ruolo del bibliotecario nella biblioteca ibrida? Sostanzialmente lo stesso di sempre. Il bibliotecario cerca di mettere a disposizione dell’utenza un insieme ordinato di informazioni e aiuta quanti vengono in biblioteca a trovare soddisfazione ai propri bisogni informativi. Insomma le cinque leggi di Ranganathan sono sempre valide. Naturalmente si tratta di misurarsi con un mondo in continua trasformazione e anche con nuove generazioni che, ad esempio, crescono in un humus tecnologico in rapida evoluzione. Si presenta, però, il problema di apprendere l’uso di queste nuove tecnologie: dall’utilizzo della posta elettronica fino all’eventualità della gestione vera e propria di un sito web. Compiti questi che si aggiungono a quelli normalmente svolti, spesso grazie alla passione di qualche collega più bravo a ‘smanettare’ di altri, ma che non trovano nessun reale riconoscimento né in profili o qualifiche, né tanto meno vengono realmente incoraggiati dalle Amministrazioni di appartenenza. Dunque 128 Antonio Perrelli prevale, come spesso accade nel nostro contesto, l’autoformazione e naturalmente va dato il giusto riconoscimento a quelle Amministrazioni che si preoccupano di garantire ai loro dipendenti la possibilità di godere di quelle possibilità che vanno oggi sotto il nome di long-life learning, anche se va detto che per sfruttare appieno queste opportunità bisogna essere animati da curiosità intellettuale e voglia di apprendere, doti che, a volte, per tanti motivi, difettano in alcuni colleghi. Altro problema derivante dalla diffusione della Rete è caratterizzato dall’onnipresente pericolo rappresentato dai virus o dall’intrusione di pirati informatici nei sistemi informativi. Poco tempo fa il computer era soggetto a rischi ed attacchi, ma si poteva anche organizzarne la difesa attraverso l’uso di un buon antivirus e di un buon programma firewall. Con il progressivo sviluppo della Rete e l’uso sempre più frequente di strumenti differenziati di collegamento (dal computer da scrivania al communicator, dall’e-book all’impianto HC) è divenuto indispensabile utilizzare “depositi” in rete capaci di ospitare i dati e i moduli software in maniera indipendente dai singoli dispositivi utilizzati di volta in volta per accedervi. Un numero crescente di servizi (a cominciare dalla Virtual Library) dipende dalla capacità di conservazione di dati (profili utente, preferenze, moduli software) in dispositivi di memoria di massa dei quali sfugge perfino la collocazione geografica. In molti casi questo si traduce in un aumento e non in una diminuzione della sicurezza, dato che a gestire questi spazi sono di norma società altamente professionali, i cui spazi macchina sono protetti da solidi firewall e garantiti da periodici backup. Ma forse ancor più rilevante è l’altro aspetto del problema, rappresentato dal controllo dei dati e dalla protezione della privacy. Nonostante le tranquillizzanti assicurazioni ufficiali al riguardo, vi sono pochi dubbi sul fatto che spesso agenzie governative e servizi segreti, e talvolta anche i servizi informativi di alcune fra le maggiori multinazionali, abbiano accesso a dati che rivelano ormai davvero moltissimo sulla vita privata delle persone, sui gusti, sulle attività, ecc... In altri termini: non vi è solo chi cerca di distruggere i dati altrui; vi è anche chi tenta di conoscerli per controllarli meglio. Certo, i sistemi di criptatura associati ai sigilli elettronici personali costituiscono una difesa contro queste intrusioni. Ma si tratta di una difesa che – pur tecnicamente valida – si rivela in molti casi praticamente vulnerabile. Le enormi potenzialità della Rete come mezzo rapido, capillare ed economico per la diffusione di contributi “a testo pieno” non sembrano tuttavia ancora esser state completamente espresse. Il motivo di questo ritardo sta soprattutto nella diffidenza del mondo accademico nei confronti di un medium (Internet) che oggettivamente comporta ancora non pochi problemi in ordine alla disciplina dei diritti d’autore e alla eventuale validità concorsuale dei titoli pubblicati solamente attraverso di esso. Di fatto, navigando nella Rete ben presto ci si rende conto che la grande maggioranza dei materiali ha un’importanza decisamente marginale rispetto a ciò che si trova pubblicato nelle forme tradizionali. Il fatto è che la Rete, a differenza per esempio delle riviste scientifiche su carta, è aperta a tutti e registrarvi un articolo comporta spese spesso irrilevanti; la novità del mezzo ha poi allentato la tensione 129 Il ruolo della rete nella biblioteca sui contenuti e si è naturalmente portati a giudicare con maggiore indulgenza quello che giunge in modo tanto prodigioso (e il più delle volte gratuitamente) nei nostri computer. Il risultato è che molto spesso ci si trova davanti a contributi di qualità quantomeno discutibile, quando non addirittura sconcertante. La responsabilità non è ovviamente di Internet in sé, che può imporre al massimo una forma di espressione, non la qualità dell’espressione stessa, ma è di chi via Internet diffonde la propria produzione. Sono tanti i settori in cui le biblioteche potranno potenziare, grazie alla Rete, i propri servizi per gli utenti. Prima di tutto la progressiva digitalizzazione del patrimonio bibliografico cartaceo retrospettivo, e in parallelo l’incremento della conservazione, catalogazione e distribuzione del materiale che nasce direttamente in formato digitale, come ad esempio i periodici elettronici. Un altro settore strategico è quello dei cataloghi elettronici. Bisogna assolutamente che le biblioteche italiane, partite in ritardo, colmino il loro gap e completino il passaggio dai cataloghi a schede a quelli elettronici, sia introducendo ovunque la catalogazione elettronica dei nuovi libri e periodici man mano acquisiti, sia investendo massicciamente nella digitalizzazione retrospettiva delle vecchie schede. In un futuro forse non troppo remoto sarà infine possibile applicare alle biblioteche le tecnologie della realtà virtuale, adesso ancora in gran parte sperimentali. Gli utenti virtuali, senza muoversi da casa, potranno aggirarsi fra gli scaffali (sempre ordinati, senza volumi persi, in prestito o fuori posto e riorganizzabili all’istante in base a qualsiasi criterio desiderato) di biblioteche completamente digitalizzate, magari incontrandovi gli avatar, cioè le immagini dei bibliotecari e degli altri utenti, altrettanto virtuali, che potranno aiutarlo nella ricerca. Pertanto è necessario valutare ed analizzare bene tutti gli aspetti del futuro della Rete in modo da poter operare le scelte più adeguate alle proprie esigenze. 130 Annalisa Scillitani Sulla biblioteca a cura di Annalisa Scillitani Nel 1962, Ermete Cerza, presidente della commissione straordinaria per l’Amministrazione della Provincia di Foggia, saluta la nascita del «Bollettino d’informazione della Biblioteca». È il primo atto ufficiale che sancisce il riconoscimento da parte dell’amministrazione del ruolo fondamentale della biblioteca per la diffusione della cultura, e si accompagna all’incremento delle raccolte bibliografiche e al completamento dell’organico. Nella presentazione del «Bollettino» si esplicita la necessità di dotare l’istituzione di una nuova sede, ma ci vorranno ancora circa 15 anni perché il progetto venga realizzato, grazie alla dedizione e all’impegno del direttore Angelo Celuzza. Un anno dopo, nel 1963, il «Bollettino» amplia il suo intervento trasformandosi in «la Capitanata - Rassegna bimestrale di vita e studi della Provincia di Foggia». Da allora non è mai venuta meno al ruolo di ribalta del dibattito locale, prevalentemente storico-culturale, ma anche politico-economico-sociale, dedicando sempre al proprio interno uno spazio significativo alle attività della biblioteca, estendendo in questo caso il proprio intervento a livello nazionale. Ed è per questo che scorrendone gli indici possiamo ricostruire in modo significativo lo sviluppo dei servizi de “la Magna Capitana” inquadrandoli nell’evoluzione dei servizi bibliotecari in Italia. La bibliografia che segue, organizzata cronologicamente, non è esaustiva; segnala tappe e momenti significativi della vita della Biblioteca, a partire proprio dal 1962 l’anno in cui per la prima volta si auspica una nuova sede per la “Provinciale”. Nella prima parte i riferimenti bibliografici attengono proprio a «la Capitanata» ed in questo caso gli articoli segnalati, come del resto l’intera collezione della rivista, sono reperibili full-text sul sito internet della Biblioteca; la seconda parte, in vista del catalogo storico delle edizioni della biblioteca, riprendendo l’ordine cronologico, segnala semplici riferimenti, articoli e pubblicazioni che documentano attività emblematiche nella storia trentennale della nuova “Provinciale”. Alcune segnalazioni sono accompagnate da una breve nota esplicativa. 131 Sulla biblioteca Parte I «la Biblioteca provinciale di Foggia - Bollettino bimestrale d’informazione» Mario SIMONE, La “Provinciale” di Foggia, I (1962), 1-2, pp. 5-12. ANNALI DELLA BIBLIOTECA, 1 - Il primo decennio della ricostruzione 2 - I provvedimenti dell’Amministrazione straordinaria, I (1962), 1-2, pp. 13-20. ANNALI DELLA BIBLIOTECA, La Mostra storica della Casa editrice Laterza, I (1962), 3, pp. 61-63. «la Capitanata - Rassegna di vita e studi della Provincia di Foggia» Attilio FRAJESE, Il Piano “L”, I (1963), 3-4 parte seconda, pp. 65-68. Il Convegno di studio per la diffusione del libro, I (1963), 3-4 parte seconda, pp. 6975. Antonio CATERINO, La storia del libro e la sua influenza sulla cultura, I (1963), 3-4 parte seconda, pp. 76-85. Mattia DI TARANTO, La biblioteca e la sua evoluzione, I (1963), 3-4 parte seconda, pp. 86-90. Maria SOLA, Forme moderne per la valorizzazione del libro, I (1963), 3-4 parte seconda, pp. 91-99. Maria SOLA, Criteri generali per la scelta dei libri, I (1963), 3-4 parte seconda, pp. 100-108. Angelo CELUZZA, Realtà esigenze e prospettive della “Provinciale” di Foggia, II (1964), 1-6 parte seconda, pp. 1-14. Angelo CELUZZA, Il “Servizio nazionale di lettura”, V (1967),1-3 parte seconda, pp. 21-26. Antonio CATERINO, La biblioteca, centro di promozione culturale, VI (1968), 1-3 parte seconda, pp. 1-8. Angelo CELUZZA, Biblioteca in ogni comune, VI (1968), 1-3 parte seconda, pp. 9-18. Pietro ROSELLI, Le biblioteche nei comuni agricoli, VI (1968), 4-6 parte seconda, pp. 49-61. 132 Annalisa Scillitani Angelo CELUZZA, Il convegno dell’ Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche, VI (1968), 4-6 parte seconda, pp. 62-66. Angelo CELUZZA, Per la nostra nuova sede, VI (1968), 4-6 parte seconda, pp. 67-73. Virginia CARINI-DAINOTTI, La lettura pubblica in Italia a traverso gli interventi ministeriali, VII (1969), 1-6 parte seconda, pp. 1-16. Angelo CELUZZA, Aspetti e problemi della pubblica lettura, VIII (1970), 1-6 parte seconda, pp. 4-17. Mario SIMONE, Le biblioteche della Cassa, VIII (1970), 1-6 parte seconda, pp. 4-17. Marcello MAIOLI, Politica di piano e biblioteche pubbliche, IX (1971), 1-6 parte seconda, pp. 1-5. Angelo CELUZZA - Guido PENSATO, A proposito di una alternativa alla scuola. Il ruolo del bibliotecario, IX (1971), 1-6 parte seconda, pp. 6-15. Angelo CELUZZA, La nuova «Provinciale». Sistemazione dei fondi e distribuzione dei servizi, X (1972), 1-3 parte seconda, pp. 1-7. Guido PENSATO, La figura sociale del bibliotecario (Appunti per una ridefinizione del ruolo), X (1972), 1-3 parte seconda, pp. 9-25. Raffaele GIAMPIETRO, La biblioteca senza qualità, X (1972), 4-6 parte seconda, pp.123-140. Raffaele GIAMPIETRO, Biblioteca e società, XI-XII (1973-74), 1-4 parte prima, pp. 150-155. «la Capitanata - Rassegna di vita e studi della Provincia di Foggia», XI-XII (1973-74), 1-3 parte seconda. È un numero speciale. L’intero fascicolo è dedicato al XXIV Congresso dell’Associazione Italiana Biblioteche, che si svolse a Pugnochiuso (Fg) dal 5 al 10 ottobre 1974 in concomitanza con l’ inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Provinciale. Angelo CELUZZA - Guido PENSATO, La situazione delle biblioteche in Puglia, XIXII (1973-74), 4-6 parte seconda, pp. 65-82. Antonio DE COSMO, L’automazione in biblioteca, XI-XII (1973-74), 4-6 parte seconda, pp. 83-112. ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, Orientamenti per un servizio di biblioteca 133 Sulla biblioteca pubblica in Italia, XIII (1975), 1-6 parte seconda, pp. 1-15. Documento conclusivo presentato dal Gruppo di lavoro Biblioteca Pubblica al XXV Congresso dell’A.I.B., Alassio 5 - 10 maggio 1975. Raffaele GIAMPIETRO, Informazione e ideologie della “società post-industriale”, XIII (1975), 1-6 parte seconda, pp. 16-22. Royston BROWN, La biblioteca pubblica del sec. XX, XIII (1975), 1-6 parte seconda, pp. 23-47. Giovanni RINALDI - Paola SOBRERO, “Fogli Volanti”. Cultura di base in Capitanata. Ricerche e interventi del sistema bibliotecario, XIV (1976), 1-6 parte seconda, pp.1-54. Angelo CELUZZA - Guido PENSATO, L’A.I.B. per una politica delle biblioteche in Italia, XIV (1976), 1-6 parte seconda, pp. 76-191. Relazione presentata alla conferenza Nazionale dei Dipendenti del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Roma, 26 - 27 novembre 1976. Antonio DE COSMO, L’ordinatore e i cataloghi, XV (1977), 1-6 parte seconda, pp.128. Maria ALTOBELLA GALASSO - Antonio VENTURA, Foggia e la Capitanata, XV (1977), 1-6 parte seconda, pp. 29-81. Organizzazione bibliotecaria e pubblica lettura in Italia, XV (1977), 1-6 parte seconda, pp.123-155. Tavola rotonda tenuta presso l’Auditorium della Biblioteca Provinciale di Foggia in occasione della presentazione del volume Primo non leggere di Giulia Barone e Armando Petrucci. Guido PENSATO, La formazione professionale nel settore dei beni culturali: le biblioteche, XVI (1978-79), 1-6 parte seconda, pp. 55-62. Francesco Barberi e la Puglia, XVI (1978-79), 1-6 parte seconda, pp.63-81. Tavola rotonda tenuta a Foggia nell’Auditorium della Biblioteca Provinciale il 22 Ottobre 1977 - in occasione della presentazione del volume I manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia curato da Pasquale Di Cicco - con la partecipazione di Angela Vinay, Armando Petrucci e Francesco Barberi; contiene, tra gli altri, interventi di: Giorgio De Gregori, Franco Balboni, Angela Vinay, Armando Petrucci, Virginia Carini Dainotti. Lucia RINALDI, Catalogazione collettiva: una bibliografia, XVII-XVIII-XIX (198082), 1-6 parte seconda, pp. 1-36. Leonardo SELVAGGI, Le biblioteche nello spirito della nuova politica dei beni culturali, XVII-XVIII-XIX (1980-82), 1-6 parte seconda, pp. 46-51. 134 Annalisa Scillitani Maria ALTOBELLA GALASSO, Itinerario bibliografico per le tradizioni popolari di Capitanata. Testi della Biblioteca Provinciale di Foggia, XX (1983),1-6 parte seconda, pp. 1-66. Liliana DI PONTE, “Sala Ragazzi” anno 10, XX (1983), 1-6 parte seconda, pp. 113120. Maria ALTOBELLA GALASSO, I “Fondi Speciali” nelle biblioteche. Panorama di esperienze, XX (1985-85), 1-6 parte prima, pp.193-200. Luigi MANCINO, Animazione tra biblioteca e scuola, XXI-XXII (1984-85),1-6 parte seconda, pp. 215-223. Angelo CELUZZA, I vent’anni della nuova Biblioteca Provinciale di Foggia: 19741994, XXXI (1994), n.s., 2, pp. 253-272. Antonio DE COSMO, Rita Haywort e il suo “doppio”. Diario grafico-catalografico, XXXI (1994), n.s., pp. 273-304. Antonio VENTURA, A palazzo e in Biblioteca, XXXII-XXXIII (1995-96), n.s., 3-4, pp. 411-415. Antonio DE COSMO, “Cinecento” e . . . altro, XXXII-XXXIII (1995-96), n.s., 3-4, pp. 417-424. Franco MERCURIO, La Provinciale ed il Sistema Bibliotecario. Nuove tendenze e ipotesi di lavoro, XXXV-XXXVIII (1998-2001), 6-9, pp. 287-311. Enrichetta FATIGATO, IlDock: centri di Servizi e documentazione, XXXVIII (2001), 10, pp. 289-293. Marcella CARDILLI - Mariana IAFELICE, Il fondo D’Urso, XIL (2002), 11, pp. 267271. Maria ALTOBELLA, Area public library: fisionomia bibliografica, XIL (2002), 12, pp. 261-269. Marianna IAFELICE, Il ritratto inciso in alcune settecentine della Biblioteca provinciale di Foggia “la Magna Capitana”, XIL (2002), 12, pp. 309-326. Enrichetta FATIGATO, La comunicazione in biblioteca, XLI (2003), 13, pp. 271-307. Angelo CELUZZA, Gli incontri della vita, XLI (2003), 14, pp. 149-161. 135 Sulla biblioteca Gabriella BERARDI, La sezione “Immagini e suoni” della Biblioteca Provinciale di Foggia. Questioni catalografiche, XLI (2003),14, pp. 217-223. Parte II Giuseppe CASSIERI, Strumenti per il Sud, in Biblioteca Provinciale di Foggia, a cura di Antonio Lo Mele e Guido Pensato, Foggia, Amministrazione Provinciale, 1974. L’opuscolo, pubblicato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede, riporta l’intervento precedentemente apparso su «il Messaggero». Franco GALASSO, La nuova biblioteca valido strumento di elevazione culturale, in «la Gazzetta del Mezzogiorno», 10 ottobre 1974. Marco LARATRO, Inaugurata la Biblioteca Provinciale, in «Il Mattino», 12 ottobre 1974. Angelo CELUZZA, La Biblioteca Provinciale di Foggia, in «Bollettino d’Informazioni. Associazione italiana biblioteche», XV (1975), 3, pp. 177-192. Guido PENSATO, Alcune esperienze locali, in «Italia Nostra. Bollettino dell’Associazione nazionale Italia nostra», XIX (1977), 148/149, pp. 19-23. Nel 1976, Italia Nostra organizzò il convegno nazionale La formazione del personale per le biblioteche. L’intervento di Guido Pensato è inserito in quello più generale dal titolo Quale personale per quali servizi: la formazione del personale per le biblioteche. Guido PENSATO, Biblioteca Provinciale di Foggia: una proposta politica, in «Bollettino d’informazioni. Associazione italiana biblioteche», XVIII (1977), 3, pp. 205-215. Liliana DI PONTE, Per una ridefinizione delle funzioni della biblioteca per ragazzi, in «Bollettino d’informazioni. Associazione italiana biblioteche», XVIII (1978), 1, pp. 18-22. Liliana DI PONTE (a cura di), Teatro animazione ricerca: un’esperienza di animazione teatrale tra biblioteca, scuola e territorio, con la collaborazione del gruppo “Giochiamo davvero” di Mantova: Maurizia Giusti, Giuliano Parenti, Patrizio Roversi. Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1979. Giovanni RINALDI - Paola SOBRERO, (a cura di), La memoria che resta: vissuto quotidiano, mito e storia dei braccianti del basso tavoliere, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1981. Emma COEN PIRANI, Nuovo manuale del bibliotecario, Modena, S.T.E.M. Mucchi, 1981, pp. 53-54 e p.191. 136 Annalisa Scillitani Antonio DE COSMO, Il rapporto fra biblioteca pubblica e biblioteca scolastica: un’esperienza a Foggia, in ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, Ruolo e formazione del bibliotecario, Firenze, Giunta Regionale Toscana, 1981 pp. 251-253. Guido PENSATO, L’Archivio della Cultura di Base a Foggia in La memoria lunga, a cura di Paola Bertolucci e Rino Pensato, Milano, Editrice Bibliografica, 1985, pp. 135-146. Claudio DI BENEDETTO, Le Biblioteche in Italia in Lineamenti di biblioteconomia, a cura di Paola Geretto, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 31-32. Guido PENSATO (a cura di), A corpo libro: del leggere in spiaggia, Bologna, Clueb, 1993. A venti anni di distanza questo libro è un omaggio e indiretta testimonianza dell’allora pionieristico servizio di prestito sulla spiaggia, promosso dalla “Provinciale” e curato dalla Biblioteca Civica di Vico del Gargano. Guido PENSATO, Tra istituzione e cooperazione, in «Biblioteche oggi», XIII (1995),6, pp. 48-49. Antonio DE COSMO, Grafic: un’applicazione di CDS-ISIS alla catalogazione di manifesti cinematografici, in «Bollettino d’informazioni. Centro di ricerche informatiche per i beni culturali», VI (1996), 1, pp. 69-84. … la biblioteca nella città nella biblioteca nella città …, catalogo della mostra bibliografica a cura di Mario Giorgio, Foggia, Grenzi, 1998. Guido PENSATO, È ferma. Oppur si muove ? in «Biblioteche oggi», XVII (1999), 10, pp. 32-40. Guido PENSATO - Saverio RUSSO, La città apparente: la vita culturale a Foggia, Bari, Laterza, Edizioni della libreria, 2000, pp. 54-57. Enrichetta FATIGATO, ilDock nella Biblioteca provinciale di Foggia, in Biblioteche provinciali e biblioteche pubbliche di capoluogo: servizio sul territorio. Atti del V° Convegno nazionale (Pescara 27-28 settembre 2001), a cura di Dario D’Alessandro, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2002, pp. 59-63. Enrichetta FATIGATO, ilDock: uno snodo della comunicazione in Capitanata, in «Biblioteche oggi», XX (2002) 7, pp. 14-16. Enrichetta FATIGATO, A Foggia prima presentazione nazionale del libro di Michael Gorman, in «A.I.B. notizie newsletter dell’Associazione italiana biblioteche», XV (2003), 1, p.19. 137 138 Milena Tancredi La Biblioteca dei Ragazzi di Milena Tancredi 1. Introduzione “Un bambino che non è messo in condizione di apprendere e gestire il mondo di domani, in cui varranno regole presumibilmente diverse da quelle attuali e in cui la capacità di raggiungere un’informazione sarà molto più importante di una generica performance nozionistica, avrà minori possibilità di successo”. Fulvio Scapparo e Stefano Castelli così sintetizzano i rischi che un bambino corre se la sua formazione non inizia dalla tenera età.1 “La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e d’informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzioni di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale”.2 Attualmente la biblioteca pubblica di base rivolge particolare attenzione ai giovani attivando ovunque la sezione ragazzi. La sezione ragazzi (children’s department) all’interno di una biblioteca pubblica è una sezione apposita provvista di libri adatti al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi dei ragazzi e dotata di materiali e attrezzature utili a creare un ambiente di piacevole incontro con la lettura. La Biblioteca dei Ragazzi è un centro informativo che deve fornire strumenti organizzati e offerti con i necessari supporti didattici in grado di facilitare in tutti i modi l’accesso ai documenti e al loro utilizzo. Il suo ruolo è fondamentale perché è qui che l’utente cresce e si forma, ed è questo il motivo per cui, sulla scorta dell’esperienza ormai acquisita, creiamo le condizioni favorevoli perché questo avvenga. 1 Fulvio SCAPPARO – Stefano CASTELLI, Telematica con l’infanzia: dichiarazione di assunzione di responsabilità degli adulti, in http://www.onde.net/progetto/carta3.htm. 2 Cfr. il Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche, aggiornato alla sezione per le biblioteche pubbliche dell’IFLA. 139 La biblioteca dei ragazzi La nostra missione così si configura: a) biblioteca come spazio sociale; b) offerta di stimoli culturali ed educativi per un pieno sviluppo psicologico, intellettivo e sociale; c) formazione di una personalità attiva e creativa; d) biblioteca dove i genitori, accompagnando i loro bambini, si possono fermare, sfogliare a loro volta un libro o una rivista ed essere coinvolti anche nei laboratori; e) favorire il rapporto adulto/bambino attraverso un lavoro di informazione sui libri e sui materiali più appropriati anche attraverso la scoperta del piacere di leggere insieme una storia; f) offrire ai bambini e ragazzi un luogo in cui sia possibile intrecciare relazioni personali con coetanei; g) dare l’opportunità di conoscere e utilizzare i nuovi strumenti e le tecnologie multimediali; h) integrare i ragazzi stranieri tenendo conto della loro cultura; i) fare in modo che i più piccoli conservino dell’incontro un ricordo talmente felice da portarli ad associare ai libri una duratura idea di piacere, creando così l’abitudine all’uso della biblioteca; l) creare le condizioni favorevoli per incontri con autori e per partecipare ad attività di animazioni riferite al libro e alla lettura. 2. Riqualificazione delle collezioni L’acquisizione e lo sviluppo delle raccolte è garantita dall’offerta integrata di materiali diversi: a) stimoli culturali ed educativi per un pieno sviluppo psicologico, intellettivo e sociale; b) informazioni e conoscenze (in forma di testo, immagine o suono) che costituiscono il patrimonio sociale in cui si cresce tenendo conto anche delle abitudini culturali e sociale degli stranieri residenti; c) la formazione di una personalità attiva e creativa. Abbiamo così costituito una collezione tenendo conto della tipologia della nostra utenza e l’abbiamo collocata per fascia d’età. I lettori della fascia 0-6, in particolare i bambini da zero a tre anni, costituiscono la vera novità di quest’ultimo periodo. I bibliotecari americani distinguono i lapsit services (quando i bambini stanno seduti sulle ginocchia) dai toddlers services (quando cominciano a camminare). I bambini piccoli si sono rivelati clienti entusiasti ed esigenti: vogliono i loro libri, i loro spazi, sono curiosi, amano imitare l’adulto che legge, amano manipolare, sfogliare, annusare, addentare, riconoscersi nei piccoli personaggi. I bambini si muovono con grande disinvoltura prendendo i libri dagli scaffali, mescolandoli e trasferendoli da una parte all’altra. Per 140 Milena Tancredi questo motivo lo spazio è riempito di oggetti piacevoli e divertenti: un libro casetta dove nascondersi a leggere, grandi materassini colorati, arredi molto bassi. Il mercato dei libri per i bambini molto piccoli ha avuto uno sviluppo notevole, ma quantità non significa necessariamente qualità e occorre prestare attenzione ai libri che sviluppano la creatività. I Prelibri di Munari, i libri di Leo Lionni, di Eric Carle, di Jan Ormerod, di Helen Oxennburry, di Iela e Enzo Mari, di Tana Hoban rimangono all’avanguardia, per la loro carica di fantasia e di creatività, per la loro capacità di continuare a stimolare nei bambini esperienze e idee sempre nuove e piaceri duraturi. Di questi autori e illustratori abbiamo dei libri ormai importanti storicamente ed abbiamo allestito una vetrina permanente. La collezione per questa fascia d’età include libri, musica, video, primi libri di materiale e forma varia, dal legno alla plastica, libri gioco e videocassette. La raccolta di materiale è selezionata con il proposito specifico di: facilitare lo sviluppo dell’immaginazione e delle capacità linguistiche; sviluppare la curiosità e la conoscenza della realtà, attraverso i nuovi materiali di divulgazione per i più piccoli, presenti nel mercato da circa dieci anni; promuovere l’abitudine della lettura come momento di divertimento e di piacere; stimolare il gusto della ricerca personale; adottare libri per l’integrazione sociale degli stranieri; aiutare il bambino a orientarsi nella biblioteca come insieme organizzato di informazioni e documenti, da sfogliare e consultare, affinché si abitui ad una ricerca per argomenti e temi di interesse, secondo i propri desideri; selezionare testi significativi da leggere a voce alta a piccoli gruppi di utenti, mostrando le illustrazioni attraverso la proiezione delle immagini; far vivere ai genitori l’esperienza della lettura condivisa, fin dai primi mesi di vita. Il ragazzo che appartiene alla fascia di età 6-13 anni è un’utente piuttosto esigente che tende a passare molto tempo in biblioteca: vuole essere preso sul serio, richiede servizi di qualità, personale competente che conosca bene i libri e sia in grado di aiutarlo a trovare quello che cerca. È anche estremamente importante riuscire a creare un luogo in cui il ragazzo ami entrare e restare ed è fondamentale che percepisca la biblioteca come un terreno di avventure e di sogni, dove soddisfare il desiderio di evasione, ma anche il bisogno di sicurezza. La nostra Biblioteca dei Ragazzi è un luogo dove ci si può muovere liberamente: abbiamo bacheche dove facciamo mostra delle novità, dove presentiamo un illustratore o un particolare percorso di lettura, dove inserire anche segni affettuosi e messaggi tra utenti per incontrarsi in biblioteca. Tutti i libri di narrativa hanno un’indicazione di genere riportata nella collocazione, accompagnati da un’etichetta CELBIV: gialli, fantasy, storie di animali e della natura, storie fantastiche e storie di ragazzi e ragazze. In linea con tutte le biblioteche per ragazzi abbondiamo nelle descrizioni dei generi per rendere l’accesso al libro sempre più facilitato. La raccolta di narrativa si sviluppa con il proposito di: incoraggiare l’abitudine alla lettura come piacere e arricchire la fantasia; contribuire allo sviluppo dell’in141 La biblioteca dei ragazzi telligenza e all’equilibrio psicologico per il raggiungimento di una personalità autonoma e creativa; favorire le capacità di socializzazione; soddisfare i bisogni informativi ed educativi; sviluppare l’uso e la comprensione della lingua; aiutare a conoscere e a riflettere sulla propria cultura e su quelle appartenenti ad altri popoli presenti nel nostro territorio, proponendo libri in lingua originale; promuovere la capacità d’uso della biblioteca. I libri di divulgazione sono ordinati secondo la Classificazione Decimale Dewey: poniamo particolare attenzione all’arte, al turismo giovanile, alla musica, allo sport, all’informatica, alla geografia e al tempo libero e abbiamo vhs, dvd, cd audio, cd-rom e riviste che integrano il semplice materiale cartaceo. La selezione e l’acquisizione dei diversi materiali risponde a diverse esigenze: andare incontro ai bisogni formativi (curiosità individuali e ricerche scolastiche); aiutare a conoscere e a riflettere sulla propria e sulle altre eredità culturali; promuovere l’interesse al libro e quindi alla lettura nei ragazzi che non sono attratti dalla narrativa, sollecitando la curiosità su argomenti particolari, su esperienze vissute; offrire strumenti di studio, confronto e approfondimento alle classi e ai loro insegnanti; creare curiosità, desiderio di conoscere, approfondire, aprirsi a nuovi interessi; approfondire un tema a diversi livelli. Attenzione particolare poniamo alla collezione di documenti da destinare agli interessi informativi di genitori, insegnanti bibliotecari, studiosi. Rispondere ai bisogni dei genitori fa parte di ogni servizio ai ragazzi, esattamente come impostare i servizi per la scuola. Il lavoro con i genitori è fondamentale soprattutto nei primi mesi di vita del bambino: attraverso la biblioteca possono soprattutto capire l’importanza del libro che nel tempo deve diventare un oggetto familiare anche tra le pareti domestiche. I genitori amano molto svolgere attività con i figli: leggere, guardare un film, incontrare gli amici dei piccoli, ascoltare una storia. Condividono con i loro figli la scoperta dei libri, delle illustrazioni, il piacere di una bella storia amano luoghi accoglienti e apprezzano la presenza di personale gentile e competente capace di aiutarli a trovare il libro giusto. In realtà la presenza significativa di casalinghe, papà, nonni è dovuta proprio alla sala ragazzi. I genitori devono conoscere i servizi e le collezioni della sala; devono imparare l’importanza di leggere ad alta voce, di giocare e svolgere attività con i loro figli; la Biblioteca dei Ragazzi coinvolge i genitori, li fa partecipi di varie attività e li sostiene con documenti che riguardano il rapporto genitori-figli e le dinamiche psico-affettive di relazione. 3. Localizzazione dei supporti Tutti i materiali sono disponibili a scaffale aperto. La divulgazione è organizzata secondo la decimale Dewey, mentre la classe 800 viene sostituita dal CELBIV. La 800 si usa soltanto per quelle opere dell’editoria “adulta” (inserite come proposte di lettura per la particolare utenza di confine costituita dagli adolescenti) che hanno la seguente collocazione: ROMANZI ADO prime tre lettere dell’autore. 142 Milena Tancredi L’impianto della classificazione CELBIV è per generi letterari e gruppi di una certa consistenza che siano funzionali all’uso e agevolino l’approccio al libro: sono simboli visivi utili per presentare in modo più semplice e piacevole i generi e aiutano il bambino a trovare il libro che gli piace di più e a rendere la biblioteca “amichevole”. I generi sono: • Favole e fiabe • Miti e leggende • Viaggi e fantascienza • Gialli • Rosa • Fumetti • Comici • Horror • Libri game • Teatro • Poesia • Racconti prima fascia d’età RR1 • Racconti seconda fascia d’età RR2 • Primi libri e libri giocattolo suddivisi in Immagini e Storie a) PL IMMAGINI (età di riferimento 0-4 anni) Solo immagini, poche parole, senza una narrazione. Suddivisione necessaria soprattutto per i primissimi approcci, già verso gli 8/10 mesi, quando il bambino non sa ancora parlare, ma si diverte a riconoscere gli oggetti di uso quotidiano, o immagini di parti del corpo, indicandoli col dito alla richiesta del genitore; sono necessarie figure uniche e molto semplici su fondo chiaro uniforme, materiali robusti, leggeri, facilmente maneggevoli, poche pagine da imparare e sfogliare con sicurezza senza pericoli di punte e rotture (libri di legno, di stoffa morbida, plastiche atossiche lavabili); quando aumenta la capacità di imparare parole nuove ci sono anche testi più complessi di consultazione delle immagini per un’età dal nido alla scuola materna, con figure raggruppate per temi di ambiente quotidiano, con l’esplorazione minuta di particolari, per stimolare l’osservazione e la curiosità, sempre accompagnate però da poche parole descrittive. b) PL STORIE (età di riferimento 2-5 anni) Il bambino sa già parlare e può capire molte più parole di quanto possa pronunciare; sono i libri con una prima breve narrazione, sempre di poche pagine e pochi personaggi; spesso sono già di carta, più fragili; il bambino ricorda già la sequenza della narrazione dei testi preferiti e ci corregge se saltiamo o modifichia143 La biblioteca dei ragazzi mo delle parti. Qui sono presenti anche libri con storie per immagini senza testo, con cui incoraggiare il bambino a capire e ricostruire la storia. c) LIBRI GIOCO (2-5 anni) Libri nati perché i bambini imparino a giocare anche da soli con lo strumento libro, quindi assai robusti e maneggevoli, con formati e materiali particolari; in maggioranza cartonati, spiralati, sagomati; ideale da lasciare a disposizione di gruppi classe anche senza un particolare controllo; in questa sezione sono presenti numerosi libri con allegati pupazzi e libri giganti da leggere in gruppo. Così sono suddivise le zone in sala : Zona accoglienza e consultazione: l’ingresso della biblioteca ragazzi e il bancone reference sono in assoluto la spina dorsale della sala perché è qui che avviene lo snodo fondamentale ed è qui che costruiamo il famoso rapporto di empatia con l’utente, per cui l’utente bambino si appoggia comodamente, magari con i gomiti, sul bancone o si siede di fronte chiedendoci le ultime avventure dei personaggi dei libri che hanno appena consegnato o che stanno prendendo in prestito ed hanno a disposizione un computer per le ricerche in OPAC. Vetrina delle novità e consigli di lettura: cambiamo continuamente le vetrine allestendole con percorsi di lettura organizzati con il resto della biblioteca, perché il bambino/ragazzo utente è parte integrante di tutta la struttura. Non è mai troppo presto per leggere: giocando, sfogliando…, leggiamo con… l’autore, l’illustratore, l’attore, il cantafavole. 0 – 6 anni. Primi Libri: questo è il gruppo più ricco dove ogni libro è una sorpresa; libri grandi e libri piccoli che non entrano in una tasca, libri di gomma con i buchi pieni di simpatici personaggi come Pimpa, Spotty, Babar e strega Teodora; libri per chi ancora non sa leggere e libri facili per chi sta imparando a leggere. Spazio laboratori: tavoli lunghi dove si possono fare laboratori vari, costruzione del libro, libro tridimensionale, colori, origami ecc… Spazio multimediale: Spazio Bit, clicca, naviga, esplora, cd-rom. Sezione di fantasia/Celbiv: letture di carta 6 – 13 anni. Il piacere di leggere: romanzi, racconti, gialli, fumetti, poesia, comici, ecc… Sezione di divulgazione Dewey: arte, turismo giovanile, musica, sport, informatica, geografia, tempo libero, vhs, dvd, cd audio, cd-rom, riviste. Sezione professionale e genitori: libri, riviste, banche dati, cataloghi su letture, letteratura, biblioteche per ragazzi e per i genitori, arriva un bebè, puericultura, psicologia, casa, vacanze con la famiglia. Parte sostanziale di questi servizi è la disponibilità di una consulenza qualificata per l’orientamento nelle scelte di lettura, consultazione e prestito dei vari tipi di documenti, per l’istruzione all’uso delle diverse fonti, per l’individuazione e il reperimento di informazioni e la loro trasformazione in elementi di conoscenza. 144 Milena Tancredi Per il raggiungimento di questi obiettivi attuiamo iniziative di promozione dei servizi e dei materiali disponibili e della produzione editoriale e documentaria per ragazzi, rivolte a gruppi di utenza libera o organizzata. In questo ambito viene riservata particolare attenzione al mondo della scuola. Abbiamo intensificato le collaborazioni con le scuole dell’infanzia attraverso le letture nello spazio morbido e colorato introducendo percorsi di lettura per avvicinarli al meglio che l’editoria offre. Organizziamo una media di cinquanta visite guidate l’anno per le scuole materne, elementari e medie proponendo percorsi di lettura di divulgazione e narrativa. Il risultato è che i documenti proposti entrano subito nella classifica dei libri più richiesti in prestito. Questa è la Biblioteca dei Ragazzi di Foggia che ha parametri congrui con le indicazione che le Linee Guida dei servizi bibliotecari per ragazzi ci danno sulla promozione alla lettura: qui nasce l’idea di una valigia itinerante di libri per l’infanzia e per bambini fino ai 10 anni d’età con la sempre più sentita esigenza di far conoscere e quindi far fruire il patrimonio librario e il materiale esistente presso la Biblioteca dei Ragazzi. Questa ideale valigia è indirizzata anche a quei bambini della provincia che si presume abbiano maggiore difficoltà ad incontrare la biblioteca: sessanta bellissimi libri di narrativa per ragazzi di recente pubblicazione, opere di scrittori ed illustratori italiani e stranieri editi da oltre quaranta case editrici specializzate, fanno il paio con giocattoli, oggetti significativi, odori, profumi e stoffe, tutto materiale da usare come sollecitazione per bambini e ragazzi e in grado di suscitare la loro curiosità. Sarà possibile prendere in prestito tutto questo materiale e pensiamo di farli restituire proprio dai nostri giovani utenti, in modo da creare con loro un “ponte” e presentare loro tutta la biblioteca. Il fine ultimo è quello di creare una Biblioteca dei Ragazzi che sia un’efficiente struttura informativa, un luogo di promozione della lettura, uno spazio sociale, un micromondo dove le storie si incrociano e le fantasie si avverano, così diverso dai luoghi urbani seganti dall’anonimia spaziale in cui i giovani sono spesso costretti a muoversi. Un’isola felice, insomma, dove si celebra la “lentezza del pensiero, della narrazione, della riflessione e del civile confronto”. E mi piace concludere questo breve viaggio nella sala ragazzi pensando che il bibliotecario dei ragazzi deve avere una ‘competenza sentimentale’ che faciliti la comunicazione con bambini/ragazzi e agevoli il loro avvicinamento ai libri e al piacere della lettura. 145 146 Antonio Ventura I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale di Antonio Ventura 1. Introduzione Terrae incognitae era una delle espressioni letterarie ricorrenti nelle prime mappe per indicare quelle regioni sconosciute, di cui i cartografi avevano sentito favoleggiare meraviglie da viaggiatori e mercanti, senza tuttavia possedere informazioni precise. Alla pari di esse i Fondi Speciali, custoditi ed incrementati da generazioni di bibliotecari ma non del tutto esplorati, hanno rappresentato all’interno della Biblioteca Provinciale e, in parte, tuttora rappresentano,1 per restare in metafora, una sorta di terrae incognitae, dalle quali emergono in continuazione rarità documentarie e preziosi cimeli bibliografici e tipografici. Le raccolte conservate tra i loro scaffali provengono, infatti, dalla vecchia Biblioteca Comunale, dalle soppressioni francese e piemontese dei monasteri di Capitanata2 e da illustri protagonisti della cultura nazionale e locale:3 tutte, comunque, nonostante la diversità della provenienza sono riconducibili ai due settori fondamentali in cui si articolano i Fondi Speciali: il Locale e l’Antico, che per molti aspetti sono collegati tra loro. 1 È ancora in corso la catalogazione dei fondi moderni e di quello antico. Anna CLEMENTE - Giuseppe CLEMENTE, La soppressione degli ordini monastici in Capitanata nel decennio francese (1806-1815), Bari, Tipografica, 1993. 3 Romolo Caggese (Ascoli Satriano 1881-Milano 1938) professore universitario, storico medievalista; Nicola Zingarelli (Cerignola 1860-Milano 1935) professore universitario, dantista, filologo e Accademico della Crusca; Angelo Fraccacreta (San Severo 1882-Napoli 1950), meridionalista, rettore dell’Università di Bari nel 19431944; Alfredo Petrucci (S. Nicandro Garganico 1888-Roma 1969), direttore del Gabinetto delle stampe di Roma, ma anche raffinato incisore e scrittore; Luigi Tamburrano (San Giovanni Rotondo 1894-Foggia 1964), vice presidente dell’Amministrazione Provinciale di Capitanata presieduta dal senatore Allegato, e senatore nel primo Parlamento Repubblicano per il Collegio di Foggia; Michele Vocino (Peschici 1881-Roma 1965), giornalista e storico locale; Mario Domenico Simone (Caserta 1901-Manfredonia 1975), esponente del Partito d’Azione, editore, fondatore della Società Dauna di Cultura; Lorenzo Agnelli (Sant’Agata di Puglia 18301904), storico; Ignazio Bellucci (Troia 1804-Manfredonia 1887), vicario capitolare dell’Archidiocesi di Manfredonia, e Michele Bellucci (Manfredonia 1849-Roma 1944), musicologo e notaio; Ester Loiodice (Foggia 1893-Roma 1985), studiosa di tradizioni popolari; i bibliofili Luigi Rosario Saponaro (Foggia 1913-Foggia 1970); Giuseppe D’Urso (Solofra 1875-Rocchetta Sant’Antonio 1935), medico e meridionalista; Domenico Faiella (sec. XIX-XX), Antonio Nardini (sec. XIX-XX) e Raffaele Pagliara (sec. XIX-XX). 2 147 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale 2. La nuova Sezione Locale Di recente, questa sezione è andata assumendo, a Foggia come altrove, sempre più le caratteristiche di un centro di documentazione, per adeguarsi alla rinnovata importanza assunta dagli studi locali: la ricerca che sino alla prima metà del Novecento era in mano agli eruditi del luogo, quasi sempre professionisti o sacerdoti, dal dopoguerra, o meglio dagli anni Sessanta, è andata acquistando diversa fisionomia e nuovo impulso, mentre si facevano strada moderne concezioni storiografiche, si rinnovavano le strutture delle vecchie Deputazioni di Storia Patria e cresceva l’interesse didattico delle Università per questo genere di indagini. Dalle storie di tipo memorialistico su una località, condotte senza approfondita conoscenza e valutazione delle fonti, si è, così, passati a ricerche settoriali, nelle varie branche delle discipline storiche, per archi cronologici limitati e, di conseguenza, anche gli studiosi locali hanno acquisito un abito mentale differente rispetto al passato. Sono usciti dall’isolamento scientifico ed hanno appreso, con la partecipazione ad equipes coordinate da accademici, l’utilizzazione dei modelli metodologici e culturali riscontrabili nelle grandi imprese editoriali prodotte nel settore dell’indagine storico-sociale: la Storia d’Italia, con i volumi degli Annali e delle Regioni dall’Unità ad oggi, edita, a partire dal 1972, da Einaudi; la Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso (in tre sezioni, L’Italia medievale, Gli Stati italiani nell’età moderna, L’Italia contemporanea), pubblicata dalla UTET dal 1976; La Storia del Mezzogiorno, stampata in quindici volumi nel 1991. Alle antiche riviste nazionali, quali l’ «Archivio Storico Italiano», fondato dal Viesseux nel 1842, la «Rivista Storica Italiana» (dal 1888), la «Nuova Rivista Storica» (dal 1917), alle rassegne annuali delle Società di Storia Patria, come, ad esempio, l’ «Archivio Storico Pugliese» e l’ «Archivio Storico per le Province Napoletane», si è andato affiancando un cospicuo numero di pubblicazioni periodiche, dove ampio spazio è stato riservato alle nuove metodologie ed ai saggi di interesse locale: si possono citare «Studi Storici» (dal 1960), trimestrale dell’Istituto Gramsci (Roma, Editori Riuniti); «Quaderni Storici» (dal 1966), quadrimestrale monografico (Bologna, il Mulino); «Storia della città» (dal 1976), rivista internazionale di storia urbana e territoriale (Milano, Electa); «Società e Storia» (dal 1978), trimestrale di storia sociale ed economica (Milano, Angeli); «Quaderni Medievali» (dal 1976), semestrale (Bari, Dedalo); «Studi Storici Meridionali» (dal 1984, ora cessati), quadrimestrale (Lecce, Capone); «Lingua e Storia in Puglia» (dal 1975, ora cessata), semestrale (Siponto, Centro Residenziale di Studi Pugliesi). Il panorama degli studi locali, nei periodici, si è, dunque, assai dilatato; ma, sulla medesima linea si sono mossi anche gli editori, riservando a tale genere di pubblicazioni nuove collane: Einaudi, “Microstorie”; Guida, “Fonti e documenti per la storia del Mezzogiorno”; Edipuglia, “Mediterranea”; Editori Riuniti, “Biblioteca di Storia”; Capone, “Storie municipali” e “Scritture e Città”; Lacaita, “Mezzogiorno e Cultura Moderna”; Milella, “Biblioteca di Storia della Società Contemporanea”; Congedo, “Biblioteca di Cultura Pugliese”, imitati dagli Enti Pubblici, 148 Antonio Ventura patrocinatori di mostre e pubblicazioni varie, e dagli Istituti di Credito, finanziatori di libri strenna di elevato livello scientifico nel campo della storiografia locale. I motivi di una ripresa tanto rilevante sono stati individuati da Cinzio Violante, presidente della Società Storica Pisana soprattutto nelle seguenti quattro cause: l’influsso del lavoro delle Annales, il rinnovarsi della cultura, l’allargamento del concetto di fonte storica, l’ausilio di altre discipline di vari settori delle scienze umane e sociali.4 Pertanto, si assiste ad una continua crescita della quantità e della qualità degli studi locali, che, ormai, rispondono non solo ad un programma storiografico diverso da quello del passato, ma anche ad un bisogno della collettività: essi, infatti, non obbediscono più all’esigenza di soddisfare le necessità campanilistiche ed agiografiche dell’élite colta del luogo, ma sono richiesti da larghi strati del mondo della scuola, desideroso di verificare, sulle vicende comunali e provinciali, i fatti presentati sul libro di testo e di acquisire maggiori conoscenze, per meglio conservare l’ambiente ed il territorio.5 Va, quindi, scomparendo la storia globale ed universale, mentre il terreno del ricercatore appare suddiviso non soltanto dal punto di vista delle discipline e degli ambiti spaziali e temporali, ma addirittura nelle sue componenti sociologiche, antropologiche ed etnologiche; inoltre, le diverse realtà esaminate nelle loro relazioni, consentono la ricomposizione di un panorama unitario, dove lo storico locale, “architetto di un solo mattone”, fornisce la materia prima necessaria alla costruzione dell’edificio. Per questa storia ‘nuova’, creata, spesso, attraverso la revisione degli scritti precedenti ed assumendo come criteri di fondo i due principi dell’organicità e della comparazione, è fondamentale la collaborazione tra lo storico professionista e quello locale: il primo fornirà il quadro interpretativo, la metodologia, gli strumenti di indagine; il secondo, la conoscenza delle fonti riguardanti il territorio e dell’ambiente socio-culturale. Alla luce di tali orientamenti che rivalutano la funzione ed il livello degli studi su realtà territoriali circoscritte, un centro importante di riferimento è divenuta la Biblioteca e, in particolare, la sua Sezione Locale, destinata a fornire strumenti per lavori nei vari settori della storia (istituzionale, sociale, religiosa, artistica, economica) e della cultura (dialetto, letteratura popolare, folklore, civiltà contadina ed operaia, cultura materiale): secondo il dettato delle leggi regionali, infatti, rientra nelle funzioni della Biblioteca Pubblica, ai vari livelli - comunale, provinciale, comprensoriale - il compito di raccogliere documentazione di ogni genere relativamente al territorio ed all’ambiente nel cui ambito essa opera. 4 Cinzio VIOLANTE (a cura di), La storia locale in Italia. Temi, fonti e metodi della ricerca, Bologna, il Mulino, 1982, pp. 15-31. 5 Alfredo PAPALE, Storia locale e ricerca scolastica. Un ruolo e una prospettiva per la biblioteca pubblica, in «Biblioteche oggi», II (1984), 1, pp. 49-64. 149 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale 3. La Sezione Locale: centro di documentazione del territorio Le fonti bibliografiche della Sezione Locale sono quelle generali, a tutti note, e, accanto ad esse, le altre prodotte nel territorio, le quali sono assai meno conosciute e talvolta non compaiono nei circuiti della distribuzione editoriale nazionale, soprattutto se date alla luce in tiratura ridotta da piccoli stampatori e limitate, quindi, ad una diffusione soltanto provinciale, se non addirittura cittadina, oppure se promosse da iniziative culturali di Enti Pubblici, sempre difficilmente raggiungibili da parte dell’utenza interessata, a causa della mancanza di cataloghi o di altre forme pubblicitarie. È, però, opportuno segnalare, per quanto riguarda la Puglia, che, nel 1992 e nel 1999, la Regione ha provveduto a redigere due parziali elenchi delle proprie pubblicazioni negli inventari ragionati curati da Nicola Pergola,6 mentre, nel 1993, la Comunità Montana del Gargano ha affidato analogo incarico a Tommaso Nardella, Giuseppe Soccio e Mario Villani;7 la Provincia di Foggia, invece, commissiona all’editore Claudio Grenzi la stampa delle proprie collane. Anche questi contributi, talvolta introvabili, dedicati alla storia ed alla società regionale sono, comunque, reperibili nella Sezione Locale, perché, come si legge nei bollettini dell’Associazione Italiana Biblioteche, ad essa compete, insieme con l’Archivio, la funzione di custodire, tutelare e rendere fruibili i documenti del territorio: opinione pure condivisa, per le loro realtà, dai corrispondenti organi professionali inglese e francese - il Librarian’s glossary e Le Métier de bibliothècaire - che la definiscono “fondo di documenti relativi ad una specifica località o regione, utilizzabile da un pubblico di studiosi, studenti e cittadini, i quali vi trovano libri, collezioni di periodici, manifesti, e qualche volta pure dischi, diapositive, film e cdrom”.8 Costituisce, pertanto, un centro di documentazione e di informazioni, presso il quale ogni ricercatore avrà la possibilità di consultare raccolte aggiornate ed ordinate dei materiali più importanti per accedere alla conoscenza dell’ambiente: - Fonti documentarie inedite: memorie, cronache, diari, statuti, biografie ed epistolari, libri catastali e demografici. È a disposizione dell’utenza un autonomo indice descrittivo dei manoscritti,9 integrato da inventari a stampa o elettronici dei principali fondi archivistici laici ed ecclesiastici, pubblici e privati, relativi alle località, nel cui ambito opera la Biblioteca. 6 Nicola PERGOLA, Editoria pubblica pugliese. Dieci anni di intervento dei Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali, Cerignola, C.R.S.E.C., 1992; e Nicola PERGOLA, Libri di Puglia. La produzione editoriale dei Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali degli Assessorati alla Cultura e alla P.I. della Regione Puglia, Troia-Cerignola, C.R.S.E.C., 1999. 7 Tommaso NARDELLA et al., Per la storia del Gargano. Repertori bibliografici. Biblioteca di Tommaso Nardella-Biblioteca del Convento di San Matteo San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, Comunità Montana del Gargano, 1993. 8 Rino PENSATO - Valerio MONTANARI, Le fonti locali in biblioteca, Milano, Bibliografica, 1984, pp. 31-33; Rino PENSATO , La raccolta locale, Milano, Bibliografica, 2000, pp. 27-33. 9 Pasquale DI CICCO, I Manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1977. 150 Antonio Ventura - Fonti a stampa: opere locali e scritti di carattere generale, per i quali esiste un interesse specifico; costituiscono l’ossatura della Sezione e la presenza più costante rispetto a quella rara dei documenti autografi ed all’altra, in crescente aumento, dei materiali elettronici. Nella maggior parte dei casi trattano argomenti storici, araldici, genealogici e biografici, geografici e toponomastici, politici, amministrativi, sociali, urbanistici, economici e finanziari, religiosi, giuridici, statistici, naturalistici, folklorici, linguistici e dialettologici. Appartengono a questa categoria anche gli opuscoli, pubblicazioni monografiche o estratti di riviste, che hanno la forma esterna e l’organizzazione tipografica del libro, senza raggiungerne la consistenza, e il materiale minore a stampa, definito pure non book materials, perché comprende tutto quanto non si acquista in libreria, ma è costituito da letteratura grigia, volantini, ciclostilati, manifesti, giornali, dischi, microfilm.10 - Fonti iconografiche: stampe di genere documentario (avvenimenti storici, ritratti, luoghi e monumenti, usi e costumi), cartoline, lastre e negative, diapositive, libri illustrati, litografie ed altri tipi di incisioni, disegni e dipinti.11 - Fonti fotografiche: per la sua capacità di fissare e registrare la componente dinamica e quella statica della realtà, gli eventi e le situazioni, l’attività degli uomini e gli assetti della natura, la fotografia si può configurare, non tanto come supplemento alle fonti scritte, quanto come documento visivo indispensabile per la ricostruzione del passato e del presente di una regione. Nelle tre grandi classi degli eventi, degli oggetti e delle situazioni ambientali, la foto riproduce ogni aspetto e fenomeno della storia, della vita e della realtà territoriale: dall’insediamento delle autorità amministrative alla visita di personalità politiche e religiose alle manifestazioni politiche e sindacali a quelle sportive; dall’architettura agli oggetti d’uso; dal paesaggio alle tradizioni religiose; dalla vita quotidiana al marketing; dalle fiere ai trasporti. L’uso di questo documento ai fini della ricostruzione storica e socio-economica è stato bene illustrato nella Storia d’Italia. Annali 2. L’immagine fotografica 1845- 1945 (Torino, Einaudi, 1979).12 - Fonti geografiche: raccontano il territorio, in maniera altrimenti difficile da ricostruire, negli atlanti regionali, nelle mappe catastali, oppure nelle serie cartografiche riferite a precise località, come quelle curate dell’Istituto Geografico Militare; spesso, invece, fanno, da supporto a memorie, diari, lavori tecnici, pro- 10 Utili, per conoscere almeno in parte la letteratura d’interesse locale, alcuni repertori d’ambito regionale: Saverio RUSSO - Rita CAFORIO, Fonti a stampa per la storia delle campagne pugliesi fra XVIII e XX secolo, Bari, Edipuglia, 1990; Guido LUISI, Saggio di bibliografia geografica della Puglia, Bari, Grandolfo, 1979; Antonio VENTURA, La Puglia nei libri. Catalogo ragionato 1978-1988, Foggia, Edizioni del Rosone, 1990; Pasquale CARATÙ - Pasquale PIEMONTESE, Saggio di bibliografia linguistica per la Puglia, Siponto, s.n., 1980. 11 Molti reperibili nell’archivio iconografico di carattere musicale della famiglia “Bellucci” e in quello fotografico di natura artistico-monumentale di “Alfredo Petrucci”. Ambedue sono in corso di inventariazione 12 A livello locale, cfr.: Antonio GUERRIERI, La città spezzata. Foggia, quei giorni del ’42, Bari, Edipuglia, 1996; Maria Teresa ALTIERI, Il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese di Foggia, Foggia, Grenzi, 2002; Vincenza MORIZIO, I Cirillo Farrusi a Cerignola fra Belgio e Capitanata, Foggia, Grenzi, 2003; l’archivio d’interesse folclorico di “Ester Loiodice” e l’altro storico-politico di “Mario Simone”, in corso di inventariazione. 151 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale getti urbanistici, indagini territoriali, censimenti di beni culturali, studi economici.13 - Fonti orali: memorie e interviste, conservate in audiocassette o in trascrizioni, su fatti storici e sociali rilevanti, come guerre, catastrofi, sommosse, scioperi, visite di personaggi illustri, fiere annuali; oppure su tradizioni popolari e vita materiale: il vivere quotidiano, gli attrezzi, i mestieri, l’alimentazione, le credenze mediche, le case, le strade, i divertimenti.14 - Fonti Audiovisive: immagini di cerimonie pubbliche e tradizionali, di avvenimenti sportivi, oppure di tragici eventi bellici o naturali della storia regionale recente conservati su diapositive, videocassette, film, prodotti multimediali:15 supporti differenti, che richiedono, per poter essere consultati, tecnologie particolari, in modo da consentire anche la lettura dei recenti prodotti editoriali, come le enciclopedie elettroniche, gli ipertesti, i libri virtuali ed i cataloghi automatizzati. La maggior parte di questo materiale è stato recuperato dalla Sezione Locale grazie alla collaborazione delle più rappresentative organizzazioni pubbliche e private operanti sul territorio: - Enti Locali: Regioni, Province, Comuni e rispettivi dipartimenti. Fondamentale quanto prodotto nell’espletamento delle loro funzioni dai Consigli e dalle Giunte: i verbali delle loro sedute offrono un panorama ricchissimo di spunti sulla vita delle popolazioni amministrate. Ma interessanti sono anche i dati provenienti dalle Commissioni all’urbanistica e alla toponomastica, dagli Assessorati alla Cultura, ai Servizi Sociali, all’Agricoltura, ai Lavori Pubblici, dagli Uffici dell’Anagrafe, di Statistica e dell’Annona, dalle Aziende Municipalizzate, dalle Unità Sanitarie Locali.16 - Istituzioni culturali e scolastiche pubbliche: Università, Accademie, Scuole produttrici di lavori riguardanti il proprio funzionamento, come gli Annuari e gli Statuti, oppure l’attività scientifica, didattica e di ricerca, riscontrabile nelle indagini interdisciplinari condotte da docenti e studenti, nelle tesi e nei repertori delle 13 Cfr., ad esempio, il Piano Albertini, stampato dal Comune di Foggia, nel 1931, in Cinque anni di amministrazione fascista, oppure l’Atlante delle condizioni insediative industriali nelle province di Foggia e Bari, pubblicato, nel 1975, dalla Federazione Regionale degli Industriali della Puglia. Per la cartografia storica, cfr., invece, le pubblicazioni dell’editore Capone di Lecce, tra cui, l’Atlante storico della Puglia; le Immagini del Sud e le Immagini di Puglia. 14 Esempi sono forniti da Giovanni RINALDI - Paola SOBRERO (a cura di), La memoria che resta. Vissuto quotidiano, mito e storia dei braccianti del Basso Tavoliere, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1981; Giuseppe GIARRIZZO - Fosco MARIANI, Civiltà contadina. Immagini dal Mezzogiorno degli anni Cinquanta, a cura di Enzo Persichella, Bari, De Donato, 1980; Nicola PERGOLA, Cerignola. Quarant’anni di immagini, Cerignola, Centro di servizio e programmazione culturale regionale, 1986. 15 Cfr. il cd-rom Storia, tradizioni e percorsi della Capitanata, prodotto da Multimedia, per conto della Provincia di Foggia. 16 Per l’utilizzazione di questi materiali, cfr.: PROVINCIA DI FOGGIA, La Provincia a cinquant’anni dalla prima elezione a suffragio universale, mostra documentaria a cura di Franco Mercurio, Foggia, Grenzi, 2002. 152 Antonio Ventura pubblicazioni e delle attività seminariali stampati periodicamente dagli Atenei barese, foggiano e leccese. - Corpi politici e sociali: partiti e sindacati, interessati a diffondere, attraverso le relazioni dei congressi ed i programmi elettorali, le testimonianze dirette della propria attività, e, mediante i libri bianchi, gli atti di convegni, le tavole rotonde, le ricerche tematiche, i risultati delle indagini da loro condotte o commissionate sulla società locale. - Aziende industriali, Banche, Camere di Commercio, Agenzie turistiche: oltre a stampare periodici, bollettini e statistiche attinenti all’attività svolta, finanziano, spesso, inchieste originali sul territorio, come, ad esempio, quelli portati a termine dai Centri Studi delle Associazioni Provinciali degli Industriali17 e di alcuni Istituti Finanziari.18 - Uffici giudiziari: utili per conoscere il fenomeno della “devianza” attraverso le loro statistiche, il cui uso metodologico è stato ben illustrato in alcune recenti indagini sul disagio sociale in Capitanata e Puglia.19 - Chiese e gruppi religiosi: tradizionali e fecondi produttori di ricca e varia letteratura d’interesse locale,20 da quella di devozione, alla amministrativa-archivistica, alla liturgica, alla pedagogica (scuole e collegi), alla sociale-assistenziale (istituzioni di carità, ricoveri, ospedali). - Società Storiche: rilievo tutto particolare hanno queste istituzioni, protagoniste quasi esclusive, per lungo tempo, della ricerca locale e della edizione dei relativi strumenti di informazione. Importante a riguardo il catalogo dei lavori stampati dalla Società di Storia Patria per la Puglia e gli Indici dell’ “Archivio Storico Pugliese (1947-1987)”. - Istituzioni, associazioni e gruppi culturali, artistici, teatrali e musicali, ricreativi e sportivi, pubblici e privati: impegnati a promuovere e finanziare inchieste 17 Cfr., tra gli altri, i volumi editi a cura dell’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI CAPITANATA, Dossier su: Università e Mezzogiorno. Il caso di Foggia, Foggia, 1978; Il settore alimentare in provincia di Foggia, Foggia, 1979; Sviluppo economico e sistema del trasporto merci in Capitanata, Foggia, 1982; Foggia nel Mezzogiorno che cambia, Foggia, 1993. 18 La Banca Popolare Dauna ha stampato il volume: Maria Raffaella CAROSELLI, La Capitanata nelle luci e nelle ombre della sua storia economica e sociale, San Paolo di Civitate, 1982. 19 Maurizio FIASCO, Puglia. Il crimine scenari e strategie, Roma, Sapere, 1992; Nichi VENDOLA, La mafia levantina. Rapporto sulla criminalità organizzata in Puglia, Bari, Edipuglia, 1996; Michele GALANTE, Criminalità ed illegalità in Capitanata, Bari, Edizioni dal Sud, 1992. 20 Oltre alle pubblicazioni storiche e documentarie di Don Michele Di Gioia, particolare importanza assumono gli inventari archivistici; cfr., ad esempio: Michele DI GIOIA (a cura di), Archivio Storico del Capitolo di Foggia, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1981; Francesco CONTE (a cura di), Archivio Storico Diocesano di Foggia, Foggia, Arcidiocesi di Foggia, 2002 e Francesco CONTE (a cura di), Canonici e Mansionari ieri... ed oggi. Miscellanea, Foggia, Arcidiocesi di Foggia, 2002; ed i censimenti di monumenti sacri, cfr.: Storia e Arte nella Daunia Medioevale, Atti della Settimana sui Beni Storico-Artistici della Chiesa in Italia (Foggia 26-31 ottobre 1981), Foggia, Leone Editrice Apulia, 1985; e Maria Stella CALÒ MARIANI (a cura di), Insediamenti Benedettini in Puglia. Per una storia dell’arte dall’XI al XVIII secolo., Galatina, Congedo, 1981, 3 voll.: vol. II. 153 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale e indagini di grande interesse locale, ma destinate a divenire subito introvabili per la loro limitata tiratura.21 - Tipografie e case editrici a livello provinciale e regionale: la loro attività costituisce una fonte primaria di conoscenza delle iniziative industriali, artigianali, artistiche e culturali esistenti nel circondario in cui operano, mentre la letteratura da loro stampata e pubblicata ne consente l’approfondimento delle caratteristiche storiche, sociali, culturali. - Organi locali di informazione: giornali a diffusione cittadina, provinciale e regionale, e in particolare «Gazzetta del Mezzogiorno», «Corriere della Sera» e «la Repubblica» con i loro inserti locali; ma, soprattutto, le emittenti televisive pubbliche, come il Tg 3 Puglia, e private, quali Telenorba, Telepuglia, Teledue, Antenna Sud, per limitarsi a quelle dotate di un segnale più potente. I programmi d’interesse locale ed i telegiornali, la cui importanza ai fini delle ricerche sul territorio è stata bene illustrata dai lavori di Antonio Rossano22 e di Enrico Maria Brescia,23 sono reperibili presso la Mediateca Regionale, annessa all’Assessorato alla Cultura. Le emittenti, tuttavia, sono raggiungibili attraverso il Comitato Regionale Servizi Radiotelevisivi operante presso la Presidenza della Regione. Una fonte, infine, che merita particolare attenzione è costituita dalle opere degli scrittori locali, talvolta oggetto di un diffuso pregiudizio: è, invece, quanto mai errato sottovalutarne le benemerenze, perché, specialmente nei centri minori, per l’intera prima metà del Novecento, hanno rappresentato l’unica tradizione di cultura, contribuendo a conservare quella identità del luogo, che senza di loro sarebbe andata perduta. Non a caso i maggiori repertori retrospettivi della produzione bibliografica nazionale24 segnalano, tra le fonti per lo studio della storia pugliese durante gli anni Venti e Trenta del Novecento, i documenti ufficiali editi dagli organi centrali di governo, ma anche poco note storie paesane. Informazioni sociali ed economiche di fondamentale importanza ricorrono, infatti, nelle pubblicazioni sul Mezzogior- 21 Cfr. i censimenti sui beni artistici territoriali promossi dal Centro Studi “Territorio e Ambiente” di Ascoli Satriano: di Giuseppe D’ARCANGELO, Le chiese rurali nel territorio storico di Ascoli. Passato e presente, Ascoli Satriano, Centro Studi “Territorio e Ambiente”, 1987; e Il territorio e gli insediamenti rurali: alcune grandi masserie, Ascoli Satriano, Centro Studi “Territorio e Ambiente”, 1988; Viviano IAZZETTI, Il territorio di Ascoli e la Dogana delle Pecore di Foggia, Ascoli Satriano, Centro Studi “Territorio e Ambiente”, 1990. Oppure, per Cerignola, cfr. ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI DAUNIA SUD (a cura di), Cerignola Antica. I convegni 1977/1981, Cerignola, Centro di servizio e programmazione culturale regionale, 1985; CENTRO STUDI TORRE ALEMMANNA (a cura di), Processi lavorativi e vita sociale nel Basso Tavoliere. Introduzione al Museo Etnografico Cerignolano, Cerignola, Centro regionale di servizi educativi e regionali, 1989; CENACOLO CULTURALE CONTARDO FERRINI (a cura di), La guerra dal convento. La tragica estate del 1943 nelle cronistorie della Parrocchia e del Convento dei Cappuccini di Sant’Anna di Foggia, Foggia, Cenacolo Culturale Contardo Ferrini, 1993. 22 Antonio ROSSANO, La Gazzetta del Mezzogiorno. Da piazza Roma alla sala times, Bari, Edlico, 1980. 23 Enrico Maria BRESCIA, Dentro “l’onda selvaggia”. Comunicazione audiovisiva e Tv private in Puglia, Bari, Edizioni dal Sud, 1981. 24 Attilio PAGLIAINI, Catalogo generale della libreria italiana, Bologna, Forni, 1964-1967; e CUBI, Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto stampa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Nendeln, Kraus Reprint, 1968-1969. 154 Antonio Ventura no curate dal Parlamento e dai Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio e da quello del Lavoro del Regno,25 ma non inferiore valore documentario hanno i coevi contributi storiografici locali, dove gli anonimi dati numerici delle indagini governative diventano luoghi, persone e fatti concreti, come è possibile, ad esempio, riscontrare, per la Capitanata, in Carlo Gaetano Nicastro, Pasquale Rosario, Lorenzo Agnelli, Giovanni Battista Gifuni, Michele Papa, Carlo Villani; per la Terra di Bari, in Armando Perotti, Raffaele De Cesare, Gennaro Maria Monti, Antonio Lucarelli, Michele Gervasio, Giuseppe Gabrieli; per il Salento in Pietro Palumbo, Pietro Marti, Luigi De Simone. Tutti autori impegnati in ricerche di impegno civile e scientifico, il cui originale percorso è pure rintracciabile nelle maggiori riviste regionali della prima metà del secolo: la «Rassegna Pugliese di Scienze», «Lettere ed Arti» (Trani 1884-1913) e «Iapigia» (Bari, 1930-1946), i cui indici sono stati pubblicati, di recente, dagli editori baresi Lacaita e Cacucci,26 ed «Apulia. Rivista di filologia, storia, arte e scienze economico - sociali» (Martina Franca 1910-1916). A proposito, invece, delle più recenti vicende del Fascismo, del secondo conflitto e della ripresa democratica, anche gli autorevoli Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea (dal 1947) e Bollettino bibliografico per la storia del Mezzogiorno d’Italia (1961-1995), stampato dalla Società Napoletana di Storia Patria, non omettono di segnalare i lavori di numerosi autori locali, quali, Saverio La Sorsa, Antonio Matrella, Attilio Tibollo, Michele Magno, Michele Pistillo, Giuseppe Gramegna, Aldo Pedretti, Antonio Guerrieri, accanto a quelli degli storici professionisti Giuliano Procacci, Manlio Rossi Doria, Piero Bevilacqua, Simona Colarizi, Francesco Barbagallo, Luigi Masella, Vito Antonio Leuzzi ed alla documentazione fornita dai Comuni, dalle Province, dall’Opera Nazionale Combattenti, dai Consorzi di Bonifica, dall’Acquedotto Pugliese per proprie pubblicazioni tecnico-amministrative,27 oppure per opere celebrative del Regime, come, ad esempio, il numero speciale della rivista «Ospitalità Italiana» del 1931 finanziato, a scopo propagandistico, dall’Amministrazione Podestarile Foggiana, e Puglia in linea (Bari 1939). Contributi differenti tra loro per il contenuto, ma la cui importan- 25 Si possono ricordare le relazioni di Giuseppe Andrea Angeloni e di Errico Presutti nelle Inchieste sulle condizioni dei contadini del 1884 e del 1909; i Materiali per lo studio delle condizioni dei lavoratori della terra, Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1909; l’Annuario Statistico Italiano (1911-1939); le Notizie periodiche di statistica agraria (1911-1925); i Rapporti della Commissione Parlamentare sulla Disoccupazione, Roma, Camera dei Deputati, 1953, ed ancora i resoconti presentati dalle Commissioni Interministeriali, tra il 1905 ed il 1925, sugli scioperi in Italia, sul lavoro femminile e minorile nell’industria e nell’agricoltura, sui salari dei braccianti e degli operai, sulla migrazione interna… 26 Antonio IURILLI - Maria Teresa COLOTTI (a cura di), Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti. Indici (1884-1913), introduzione di Michele Dell’Aquila, Manduria, Lacaita, 1985; Michele DELL’AQUILA et. al. (a cura di), Iapigia (1930-1946). Indici e schede di spoglio, Bari, Cacucci, 1982. 27 PROVINCIA DI FOGGIA, La provincia di Foggia nel primo decennale del Regime Fascista (1923-1933), Foggia, Tipografia editrice Fiammata, 1933; Roberto CURATO (a cura di), Piano generale per la bonifica del Tavoliere, Roma, C. Colombo, 1933; e CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA E TRASFORMAZIONE FONDIARIA DELLA CAPITANATA, Progetto esecutivo del centro rurale di Incoronata in agro di Foggia, Bari, Società editrice tipografica, 1932. 155 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale za, come fonte storiografica, è stata sottolineata negli studi di Raffaele Colapietra, di Leandra D’Antone e di Franco Mercurio.28 Si è già accennato al fatto che la Sezione Locale può mettere a disposizione materiale non solo librario, ma anche di altra natura: presso quella foggiana, fonti importanti per ricerche sul territorio in età contemporanea sono i già menzionati archivi privati di Mario Simone, Pietro Celentani Ungaro, Ester Loiodice e Luigi Rosario Saponaro: personaggi pubblici, i primi tre, che hanno raccolto e conservato i documenti prodotti e ricevuti nello svolgimento delle loro funzioni; semplice cronista di fatti, il quarto, che si è limitato a registrare gli avvenimenti ed a conservarne le testimonianze più significative. Le carte di Mario Simone, militante del Partito Repubblicano, avvocato, esponente del Partito d’Azione, editore e fondatore della Società Dauna di Cultura, forniscono indicazioni di prima mano sugli eventi politici e culturali della regione dal 1920 sino al 1970. Materiali bibliografici e documentari si intrecciano e completano a formare un mosaico storico di grande interesse: lettere di esponenti della politica e della cultura locale; testimonianze pugliesi della spedizione dannunziana a Fiume del 1919; memorie legali in giudizi dibattuti dinanzi ai tribunali alleati del dopoguerra; minute di discorsi; giornali e ritagli di articoli; immagini di personalità locali e nazionali del Regno, del Fascismo e della Repubblica; cartoline illustrate di città pugliesi; foto di luoghi, di monumenti e di avvenimenti; diari sui bombardamenti anglo-americani; relazioni dei governatori militari alleati del 1943-1945; risultati dei processi delle commissioni di epurazione; bollettini della Prefettura per le elezioni nei Comuni e nelle Province dal 1948 al 1970; dibattiti tra le forze politiche locali nel corso delle varie campagne elettorali amministrative e politiche; volantini di propaganda; progetti di biblioteche popolari e di centri culturali; esposti presentati alle Sovrintendenze Bibliografiche ed Archivistiche; bozze di pubblicazioni; iniziative promosse d’intesa con l’Università di Bari e con la Società di Storia Patria della Puglia; menabò di riviste mai uscite, locandine di rappresentazioni teatrali, di conferenze e di convegni.29 Di natura diversa il fondo di Ester Loiodice, docente di Istituti Secondari, fiduciaria del P.N.F. per la Scuola, studiosa di folklore pugliese, fondatrice della Sezione demologica del Museo Civico di Foggia. Dalla documentazione, consistente in lettere di notabili del mondo accademico e scientifico italiano, in minute di relazioni al Ministero della Cultura Popolare ed al podestà del Comune di Foggia, in schede di lavoro sulle tradizioni civili e religiose e sui mestieri più diffusi nel territorio provinciale, vengono fuori i rapporti tra gli organi centrali e periferici del 28 Raffaele COLAPIETRA, La Capitanata nel periodo fascista (1926-1943), Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1978; Leandra D’ANTONE, Scienze e governo del territorio, Milano, Franco Angeli, 1990; Franco MERCURIO (a cura di), Le metafore dello sviluppo, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1993 e Franco MERCURIO, Le frontiere del Tavoliere, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1990. 29 Michele FERRI, Mario Simone nel centenario della nascita, Manfredonia, Edizioni del golfo, 2002; Michele FERRI, Mario Simone nel centenario della nascita. Atti del Convegno. Bibliografia di Mario Simone, Manfredonia, Edizioni del golfo, 2002. 156 Antonio Ventura regime ed il coinvolgimento degli intellettuali per l’organizzazione del consenso popolare, ma anche le numerose iniziative culturali, spesso di grande spessore scientifico, intraprese a livello regionale negli anni Venti e Trenta ed il tentativo di costituire in Capitanata, presso il Museo Civico, un centro di documentazione storica locale ante litteram. L’archivio di Pietro Celentani Ungaro, ingegnere dell’Acquedotto Pugliese negli anni della sua costruzione, è assai specifico, perché i resoconti dei sopralluoghi, i progetti e la cartografia tecnica forniscono soprattutto testimonianze, in termini tecnologici e finanziari, dell’impresa. Tuttavia, le opinioni da lui espresse nelle minute di risposta alle lettere di colleghi e collaboratori oppure alle circolari ministeriali forniscono spunti storici interessanti, per conoscere l’ambiente socio-economico delle province pugliesi ed i contrasti politici esistenti all’interno della locale dirigenza fascista nei confronti dei progetti avviati da Gabriele Canelli e da Gaetano Postiglione per trasformare e modernizzare il Tavoliere. Bibliografica, ma non per questo meno interessante, è la raccolta di Luigi Rosario Saponaro, commercialista, docente negli Istituti Tecnici, ma soprattutto acuto commentatore della realtà meridionale sulle pagine dei quotidiani e periodici che, come giornalista, diresse o ai quali collaborò dal 1935 al 1965: il «Giornale del Mezzogiorno», «Il Meridionale», «Sud», il «Popolo di Foggia», la «Voce di Foggia», il «Corriere di Foggia». Nel corso di tale attività raccolse tutto quanto veniva pubblicato su Capitanata e Puglia: libri, opuscoli, dattiloscritti, ciclostilati, stampa periodica, volantini, cataloghi di mostre, atti di convegni promossi da associazioni ed enti operanti sul territorio. In queste fonti, tra cui circa novantaquattro testate giornalistiche soprattutto regionali, si trovano alcuni argomenti fondamentali sulla storia della provincia in età contemporanea: la ricostruzione postbellica, gli aiuti statunitensi U.N.R.R.A. e del Piano Marshall, l’ascesa della classe dirigente democristiana, l’intervento della Cassa per il Mezzogiorno, la Riforma Agraria, il rinnovamento dell’agricoltura e della zootecnia, le vicende del metano in Capitanata, i problemi dell’industrializzazione, il rilancio delle attività turistiche. Fonti preziose da integrare, comunque, con quegli autentici contenitori di informazioni storiche, politiche, economiche, di vita sociale e di storia del costume che sono i periodici locali, un primo censimento dei quali, curato dalla Biblioteca Comunale di San Severo,30 fornisce, per ciascuno di essi, dettagliate schede bibliografiche, a partire dal liberale «Il Foglietto» (1897); ai primi organi politici delle leghe rosse: «Bandiera Socialista» (1903), «Azione Democratica» (1912), «Il Randello» (1906); ai periodici fascisti: «Fiammata» (1921) e «Il Popolo Nuovo» (1932); sino ai giornali dell’immediato dopoguerra: «Civiltà Proletaria» (P.C.I.), «Tre Frecce» (P.S.I.), «Civiltà Nostra» (D.C.); «Azione Democratica» (P.L I.). Accanto ad essi, ai quotidiani regionali ed agli inserti provinciali dei giornali a diffusione nazionale un contributo fondamentale all’indagine storica contempo- 30 Pietro VOCALE et al., Stampa periodica di San Severo e di Capitanata, San Severo, Dotoli, 1981. 157 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale ranea viene pure fornito dagli opuscoli d’interesse locale, brevi saggi a carattere monografico d’argomento storico, narrativo, bibliografico, scientifico, tecnico..., e dal materiale minore a stampa prodotto nel luogo, un tipo particolare di documentazione, assai deperibile ma essenziale per una visione dettagliata della società, espressa da organismi di vita associativa (partiti, sindacati, associazioni ricreative, sportive, religiose, assistenziali, organismi industriali, commerciali, finanziari), destinata ad un ambito circoscritto (persone o territorio), in uno spazio temporale limitato. Si tratta, in genere, di numeri unici per celebrare anniversari di istituzioni, pieghevoli di propaganda elettorale, manifesti di controversie politiche e sindacali, statuti delle più diverse associazioni, listini di prezzi, cataloghi e bibliografie, programmi di manifestazioni culturali e sportive: nella maggior parte dei casi sono prodotti tipograficamente poveri o addirittura stampati col ciclostile e non soggetti al diritto stampa, con il risultato che, a distanza di poche ore dalla produzione e distribuzione, non resta alcuna traccia di questi autentici lembi di storia del territorio. Per accedere alle fonti della Sezione Locale è messo a disposizione degli utenti il catalogo cartaceo per autore e, soprattutto, l’altro per argomento, estremamente analitico, integrato da spogli di riviste e periodici; bibliografie di istituzioni, di personaggi, monumenti ed eventi storici cittadini, provinciali e regionali; indici di manoscritti e di carte geografiche e topografiche. Si va, tuttavia, affermando l’altro elettronico dell’OPAC della Biblioteca Provinciale, che consente di creare delle guide di ricerca, basate sul collegamento tra le opere tradizionali di manualistica e saggistica specifica e quelle della nuova pubblicistica informatica. Ma la moderna tecnologia sta già predisponendo altri strumenti per la ricerca storica,31 che pure nella Sezione Locale di Foggia consentiranno, in tempi brevi, di affiancare ai mezzi bibliografici tradizionali, gli altri dell’ipertesto o del libro virtuale, messi in circolazione dalla odierna editoria,32 sempre più orientata ad integrare l’informazione su supporto cartaceo con quella su supporto elettronico. Si va, dunque, offuscando l’immagine dello studioso impegnato a passare ore in mezzo alla polvere per cercare qualche documento interessante: quello di oggi, anche se animato dalle medesime motivazioni, sempre meno tempo dovrà impiega- 31 Il Ministero per i Beni Culturali sta trasferendo su cd-rom il patrimonio documentario della Fototeca Nazionale relativo a centri urbani, eventi bellici, terremoti, consistente in 350.000 foto in bianco e nero, 13.000 a colori, 600 radiografie di centri storici e di singoli monumenti con la relativa documentazione di corredo, costituita da 3.750.000 schede bibliografiche; La Biblioteca Vaticana sta traducendo in formato elettronico il suo patrimonio documentario e librario consistente in 150.000 manoscritti, un milione e mezzo di libri, migliaia di carte geografiche; La Editrice Bibliografica mette a disposizione i cd Alice dei libri in commercio, con 460.000 titoli, i cd della Bibliografia Nazionale Italiana, con oltre 500.000 pubblicazioni, ed i cd Pico, con 650.000 riferimenti a 32 quotidiani e 102 periodici, italiani e stranieri, apparsi dal 1989 ad oggi. 32 Francesco SICILIA, Editoria elettronica e biblioteche, in «Biblioteche oggi», 1996, 4, pp. 52-63; Fausto COLOMBO, Media e industria culturale, Milano, Vita e pensiero, 1994; Marco CUPELLARO, La biblioteca senza pareti, in «Biblioteche oggi», 1990, 2, pp. 235-239; Biblioteche e prospettiva multimediale in «Biblioteche oggi», 1997, 5, pp. 54-59; Raffaele D E MAGISTRIS, Il libro e la lettura nella società multimediale, in «Biblioteche oggi», 1990, pp. 553-571; Giovanni GALLI, Iperloc. Una guida ipermediale alla documentazione locale, in «Biblioteche oggi», 1996, 2, pp. 54-59. 158 Antonio Ventura re presso i cataloghi, nella faticosa ricerca di libri e documenti, perché gli sarà sufficiente premere un tasto, per avere a disposizione intere bibliografie. 4. Il Fondo Antico: memoria culturale della città e della provincia Strettamente collegato con la Sezione Locale è il Fondo Antico, che, formato in origine dalle spontanee donazioni dei maggiorenti cittadini e incrementato dalle successive requisizioni statali a danno delle istituzioni religiose,33 costituisce la testimonianza della produzione editoriale circolante a Foggia in età moderna e conserva, quindi, nella Biblioteca Provinciale i segni tangibili dell’evoluzione culturale, politica e sociale vissuta, in passato, dal capoluogo e dalla sua rappresentanza politica, imprenditoriale e religiosa, come ebbero già modo di sottolineare, nel 1834, l’intendente Gaetano Lotti, durante la cerimonia di inaugurazione della Biblioteca, e Raffaele Liberatore, sulle pagine degli «Annali Civili».34 In effetti, come si apprende proprio da alcuni libri del Fondo Antico, la città, centro della vita economica e politica provinciale, era stata interessata, nel corso dei secoli XVII e XVIII, da un ininterrotto dinamismo demografico ed economico:35 “Foggia cresce di giorno in giorno di abitatori forestieri”,36 scriveva un cronista contemporaneo e faceva notare come costoro vi si trasferissero, abbandonando le circostanti terre baronali, perché attratti dalle sue libertà mercantili, dalle migliori opportunità di lavoro, dalla crescente richiesta di servizi, dal rimaneggiamento urbanistico imposto dal terremoto del 1731. 33 Giuseppe CLEMENTE, Libri e frati. Le biblioteche dei conventi della Capitanata soppressi nel decennio francese (1806-1815) in «la Capitanata», XXXIV (1997), 5, pp. 249-268. 34 In un passaggio del suo discorso così si espresse l’intendente Gaetano Lotti: «[...] Cittadini, a cui la gloria del proprio paese è cara, si affrettarono a donar quei libri che formavano la delizia delle loro famiglie. Giovani, a’ quali l’amor del sapere è vita, mi circondarono co’ loro desideri, mi animarono co’ loro talenti; e finalmente l’amministrazione comunale di questa città e colui che la dirige e che non conosce ostacoli quando si tratta di bene pubblico, mi coadiuvarono con tale efficace energia, che ormai posso annunziarvi, che in pochi mesi la biblioteca di Foggia, quantunque non ancora ricca di molti libri, è tale però da poter alimentare le discrete ricerche nelle varie ramificazioni delle umane conoscenze». Cfr.: Biblioteca pubblica a Foggia, in «Poligrafo della Capitanata», 1834, II, p. 14. Raffaele Liberatore, invece, a proposito della tradizionale vivacità culturale della città e della provincia, elencava alcuni dei suoi maggiori autori presenti negli scaffali: «Marcantonio Coda che nel secolo XVI scriveva di economia; Giambattista Vitale che prese a difendere il Tasso contro la Crusca; Monsignor Celestino Galiani e Giuseppe Rosati, uomini di chiarissima rinomanza; Salvatore Grana, altro insigne economista; i due Cimaglia, il poeta estemporaneo Massari, il matematico Del Muscio chierico regolare delle Scuole Pie, il primo che nel pubblico insegnamento di Napoli introdusse le lezioni del calcolo infinitesimale; l’altro Reale Accademico Fraticelli, e il poliglotta Padroni, e ‘l medico Sorge, e Niccolò Tortorelli, traduttore di Silio Italico, ed altri egregi che bene della patria loro e delle lettere meritarono [...]». Cfr.: Raffaele LIBERATORE, Pubblica biblioteca in Foggia in «Annali Civili del Regno delle Due Sicilie», 1834, p. 125. 35 Dalle «collettive di stati delle anime» si rileva che i residenti, malgrado le ricorrenti carestie ed epidemie, passarono dalle 4.500 unità del 1595, alle 8.000 del 1688, alle 13.560 del 1768, alle oltre 18.000 del 1794. Cfr.: Giovanna DA MOLIN, Lo sviluppo demografico di Foggia dal XVI al XIX secolo, in Saverio RUSSO (a cura di), Storia di Foggia in età moderna, Bari, Edipuglia, 1992, pp. 142-145. 36 Gerolamo CALVANESE, Memorie per la città di Foggia. Manoscritto esistente nella Biblioteca Comunale di Foggia illustrato da Benedetto Biagi, Foggia, Tipografia editrice Fiammata, 1931, pp. 84-85. 159 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale Il capoluogo, già sede della Dogana delle Pecore e del suo Tribunale,37 concentrava anche la quasi totalità delle attività secondarie e terziarie provinciali e, in particolare, provvedeva ad erogare beni e servizi sul territorio: “Foggia è una grande piazza di commercio”, scriveva nel ‘700 il Galanti, constatando come il mercato locale non registrasse le interruzioni stagionali riscontrabili altrove.38 E aggiungeva il Longano: “[...] è l’emporio di una industria che non ha pari del Regno [...]. Onde in essa calano e dagli Apruzzi, e dal Contado di Molise, dal Principato e dalla Basilicata stessa migliaia di persone a renderla la più florida, la più popolata, e la più ricca del Regno.”39 La singolare condizione di floridezza economica trovava riscontro anche nel fiorente artigianato e nell’intenso commercio di beni di lusso, segnalati dal Calvanese: “[...] si vedono in Foggia molte botteghe di mercanti che vendono panni, sete e drappi d’oro; quattro o cinque mercanti di cera e droghe; cinque o sei speziali di medicina, altrettanti orefici, calzolai infiniti, mercanti di fettuccie e tele di Persia, et altri d’infinite mercanzie, tutti benestanti e ricchi.”40 La vera fonte di ricchezza era, tuttavia, rappresentata dal commercio agrario: i grandi quantitativi di cereali conservati nelle numerose fosse granarie cittadine alimentavano un mercato incessante, “in ogni giorno - scriveva, ancora, il Calvanese - nel Piano della Croce si vedono mercanti che comprano e padroni che ricevono danaro de’ grani venduti”;41 d’altro canto, non meno fiorente risultava il commercio della lana immagazzinata negli innumerevoli fondaci di proprietà della Regia Corte, dell’Università, delle famiglie benestanti.42 Diffuso benessere confermato dai dati relativi alla condizione socio-finanziaria dei suoi abitanti, forniti dall’imposta personale istituita dai Francesi con decreto 29 settembre 1809,43 ma rilevabile, anche, dal grande numero di chiese e mo- 37 Pasquale DI CICCO, Una giurisdizione speciale nel Regno di Napoli: il tribunale delle pecore di Puglia (sec. XV-XIX), in «la Capitanata», XXIV (1987), 1-6, I, pp. 37-88. 38 Giuseppe Maria GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, a cura di Franca Assante e Domenico Demarco, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1969, 2 voll.: vol. II, p. 520. 39 Francesco LONGANO, Viaggio per la Capitanata, a cura di Renato Lalli, Campobasso, Editoriale Rufus, 1981, p. 63. 40 G. Calvanese, Memorie per la città di Foggia..., cit., pp. 84 -85. 41 Ibid. 42 John A. MARINO, La fiera di Foggia e la crisi del XVII secolo, in S. RUSSO (a cura di), Storia di Foggia in età moderna..., cit., pp. 57-78; Maria Carolina NARDELLA, Attività creditizie e commerciali a Foggia nella prima metà del XVII secolo, in Angelo MASSAFRA (a cura di), Produzione, mercato e classi sociali nella Capitanata moderna e contemporanea, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1984. 43 Sottoponeva a tassazione progressiva, nel Comune di residenza, i capifamiglia e tutti i titolari di censi superiori ai 120 ducati, ripartendoli in otto classi di reddito. Cfr.: Elio CERRITO, Strutture economiche e distribuzione del reddito in Capitanata nel decennio francese in ibid., pp. 137-140; ma cfr. anche: Giuseppe CEVA GRIMALDI, Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia di Terra d’Otranto nell’anno 1818, Napoli, Tipografia Porcelli, 1821, p. 16. 160 Antonio Ventura nasteri, tutti titolari di grandi risorse finanziarie ed estesi patrimoni immobiliari.44 L’importanza della piazza commerciale di Foggia determinò, come si evince dalla lettura del Libro Rosso,45 violenti contrasti politici all’interno dell’Università (Comune), per il controllo delle ingenti ricchezze riversate sul mercato locale dai proventi dell’agricoltura, della pastorizia e della Fiera. Nella seconda metà del ‘600, dopo la ribellione di Sabato Pastore,46 il Consiglio cittadino, controllato dalla maggioranza oligarchica latifondista, fu costretto ad accogliere alcuni rappresentanti riformatori della nuova classe mercantile cittadina: Alessandro Sacchetti, Giuseppe Saggese, Onofrio Sica, Giuseppe Cimaglia, i quali, alleandosi con il sempre più forte ceto dei massari e soprattutto con intellettuali come Francesco Onofri, autore di un famoso libello antioligarchico,47 si impegnarono per realizzare una svolta democratica,48 ottenendo, dopo varie vicissitudini, l’ingresso nel massimo consesso cittadino di Michele Gargani, Pietro della Posta, Francesco e Gaetano Cuoci, autorevoli esponenti dell’aristocrazia liberale, i quali, nel 1725, collaborarono con il doganiere Rullan alla riforma del Consiglio.49 Dopo la pausa imposta dal terremoto e dall’opera di ricostruzione, riprese lo scontro tra i conservatori ed i progressisti, rappresentati, questa volta, da illustri esponenti dell’intellighenzia cittadina, come Saverio Celentano, Luca Brencola, Niccolò Tortorelli, Francescantonio Ricciardi, i quali basarono la propria offensiva politica su tutta una serie di iniziative educativo-culturali a favore della società locale: sollecitarono i numerosi maestri residenti in Foggia a creare delle scuole, come 44 “È la città adornata di più conventi religiosi, come sono li Padri Predicatori, eremiti di S. Agostino, Chierici regolari -volgarmente Teatini - Minori Osservanti, Minori Conventuali, Padri Cappuccini, Padri di S. Pietro Alcantara, Padri dell’Ospedale di S. Giovanni di Dio, l’Ospizio de’ Padri Scalzi Agostiniani, l’Ospizio de’ Padri Scalzi Teresiani, l’Ospizio de’ Padri Camaldolesi, l’Ospizio dei Padri della Compagnia di Gesù del Collegio Romano, li quali tutti tengono case e chiese cospicue, et abitazioni copiose e molto nobili [...]”. Cfr.: CALVANESE, op. cit., pp. 88-89; ma cfr. anche: Mario SPEDICATO, Chiesa collegiata e istituzioni ecclesiastiche in età moderna, in RUSSO, op. cit., pp. 130-136. 45 Oltre alla copia dei “Capitoli e Statuti della città di Foggia” proveniente dalla Comunale e descritta in Pasquale DI CICCO, I manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia, Foggia, Ammistrazione Provinciale di Capitanata, 1977, pp. 50-51, ne esiste un’altra redatta nel 1738 in maniera più completa e fedele all’originale, distrutto dall’incendio appiccato all’archivio comunale nel 1898, che è stata recentemente acquistata dalla Biblioteca Provinciale, dopo essere stata ritrovata per caso sul mercato dell’antiquariato. Per informazioni sulle sue caratteristiche, cfr.: Pasquale DI CICCO, Il libro rosso della città di Foggia, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1965, pp. 9-10. 46 La Biblioteca possiede il manoscritto di Fra Gabriele da Cerignola sulla sommossa, cfr.: P. DI CICCO, I manoscritti della Biblioteca Provinciale..., cit., p. 76; ma cfr. anche: Raffaele PETROSILLO, La ribellione di Sabato Pastore in Foggia nell’anno 1648, Foggia, Tip. E. Ferreri, 1897; Oronzo MARANGELLI, Relazione della ribellione detta di Sabato Pastore in Foggia nell’anno 1648 del padre Fra Gabriele da Cerignola, Foggia, Tip. editrice Fiammata, 1932. 47 Francesco ONOFRI, Nota per li cittadini ed Università di Foggia, Napoli, s.n., 1710. Cfr.: Raffaele COLAPIETRA, Élite amministrativa e ceti dirigenti fra Seicento e Settecento, in RUSSO, op. cit., p. 111; Vittoria PILONE, Storia di Foggia dalla venuta di Carlo di Borbone al 1806, Foggia, Adriatica, 1971, pp. 59-76. 48 R. COLAPIETRA, Élite amministrativa..., cit., pp. 107-109. 49 P. DI CICCO, Il libro rosso..., cit., pp. 35-41. 161 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale quelle di Andrea Gaudiani50 e Giuseppe Rosati;51 proposero, nel 1742, ottenendola nel 1751, l’istituzione delle cattedre di Legge, Filosofia e Retorica e fondarono, accanto a quelle già esistenti,52 una nuova Accademia, la cui protezione venne offerta, con esito negativo, a Celestino Galiani. Mobilitarono, così, le migliori energie a realizzare un intenso programma di riscatto sociale, finalizzato a colpire il potere oligarchico proprio attraverso la formazione, nelle classi cittadine, e soprattutto nelle imprenditoriali e professioniste, di quella coscienza civile, che le avrebbe, poi, indotte a riappropriarsi del diritto di scegliersi i propri amministratori. Dalle biblioteche private di questi personaggi53 derivano buona parte delle edizioni del XV e del XVI secolo54 e del rimanente Fondo Antico che, nell’attuale sistemazione biblioteconomica, tuttora in corso, si è provveduto a ricostruire nella sua struttura primitiva, attraverso l’identificazione, là dove è stato possibile, della provenienza di ciascun volume, sulla base delle note autografe, dei timbri e dei sigilli apposti dagli originari proprietari sui frontespizi delle singole edizioni. Ripercorrendo velocemente i nomi degli autori ed i titoli delle pubblicazioni si riscontra subito l’attenzione prestata dagli ambienti culturali foggiani di fine ‘600 e ‘700 agli argomenti dibattuti dagli intellettuali napoletani all’interno delle loro Accademie. Lo confermano la presenza di autori illustri come Nicola Partenio Giannettasio, Francesco Verde e Alessio Simmaco Mazzocchi,55 accanto agli scritti 50 Andrea GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, a cura di Pasquale di Cicco, Foggia, Ed. Apulia, 1981, p. 9. 51 Alfredo PANERAI, Una eminente figura del Settecento pugliese: Giuseppe Rosati agronomo ed economista agrario, Foggia, Studio editoriale dauno, 1967. 52 Pasquale SORRENTI, Le accademie in Puglia dal XV al XVIII secolo, Bari, Laterza e Polo, 1965, pp. 45-46. 53 Per informazioni su alcune di queste famiglie, cfr. il volume coevo: Difesa per la città di Foggia e per le famiglie nobili della medesima, Napoli, s. n., 1728. 54 Gli stampatori ricorrenti sono tra i più importanti del Cinquecento: Aldo Manuzio (Venezia); Niccolò Bevilacqua (Trento); Gabriele Giolito Ferrari (Trino); Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio (Venezia); Giovanni Battista di Sessa (Milano); Sebastiano Griffo (Lione). Per le caratteristiche delle edizioni, cfr.: Maria ALTOBELLA GALASSO -Antonio VENTURA, Le cinquecentine della Biblioteca Provinciale di Foggia, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1988; e Giuseppe Maria PUGNO, Trattato di cultura generale nel campo della stampa. Torino, Società editrice internazionale, 1967, 5 voll.: vol. III, pp. 117-216. Un’eccezione è rappresentata dalle edizioni antiche pervenute alla Provinciale dal fondo bibliografico di Nicola Zingarelli, per il quale si rinvia a: Maria ALTOBELLA GALASSO, Catalogo del fondo dantesco-petrarchesco. Biblioteca “Nicola Zingarelli”, Foggia, Amministrazione Provinciale di Capitanata, 1977. 55 Tra i protagonisti dei dibattiti all’interno delle principali Accademie napoletane, quali Colonia Sebezia, degli Investiganti, degli Oscuri, degli Oziosi e degli Uniti, sono reperibili nel fondo antico autori importanti come, Nicola Partenio GIANNETTASIO, Universalis cosmographiae elementa in Collegio Neapolitano S. Iesu a viris nobilibus demonstrata, Napoli, ex officina typ. Jacobi Raillard, 1688; Francesco VERDE, Institutionum canonicarum libri quattuor, Napoli, Forastieri, 1735; e il più dotto ecclesiastico presente a Napoli agli inizi del ‘700, Alessio SIMMACO MAZZOCCHI, Ad amplissimum virum Bernardinum Tanuccium regis nostri a secretis epistola..., Neapoli, Excudit G. Musca, 1739. Per i caratteri della cultura napoletana del periodo, cfr.: Romeo DE MAIO, Società e vita religiosa a Napoli nell’età moderna (1656-1799), Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1971, pp. 74-100. 162 Antonio Ventura di respiro europeo di Voltaire, De Mably e Rousseau56 ed a quelli di buona parte della letteratura laicista e giurisdizionalista che, influenzata dalle idee del ceto civile e forense, ispirava la polemica antigesuita di Gianvincenzo Gravina57 e tutta la pubblicistica di contestazione contro i ‘diritti divini’ della Santa Sede all’investitura del Regno di Napoli, a cominciare dagli scritti di Niccolò Caravita58 e Costantino Grimaldi,59 le cui opere finirono all’Indice, sino alla produzione di Pietro Giannone e di Giambattista Vico e degli scrittori regalisti, come Niccolò Capasso, Placido Troyli, Francesco Peccheneda, Vincenzio Russo, Francescantonio Grimaldi, Domenico Forges Davanzati, Francesco Lo Monaco.60 Non meno significativa, accanto alle opere di costoro, la presenza delle principali edizioni influenzate, a partire dagli anni ’50 del 1700, dal nuovo corso culturale promosso, nel Regno di Napoli, dall’insegnamento di Antonio Genovesi, il quale non esitò a spezzare ogni legame con la tradizione, imperante nell’Università e nelle Accademie, del Giurisdizionalismo, del Platonismo e del Cartesianesimo, per accogliere le sollecitazioni riformistiche delle nuove dottrine economiche fiorite in Inghilterra, Francia ed Olanda, ma anche a Venezia ed in Toscana. La conoscenza di queste moderne correnti europee di pensiero si trasfusero, quando ottenne, nel 1754, la cattedra di Economia Politica nelle Lezioni di commercio, pubblicate tra il 1765 ed il 1767 e destinate a suscitare l’interesse e l’entusiasmo dei più evoluti ambienti culturali dell’epoca.61 Il Genovesi si servì, infatti, della docenza universitaria, modernamente intesa come strumento di educazione pubblica, per indicare i problemi da affrontare e risolvere62 ai governanti ed a quanti desideravano realizzare nel Mezzogiorno italiano lo sviluppo socio-economico già raggiunto da altri stati europei: la sua Scuola diffusasi, ben presto, per ogni città e provincia del Regno di Napoli, pose le basi di quel Movimento Illuministico, destinato a realizzare la secolarizzazione della società meridionale, la soppressione del Santo Officio e delle immunità locali, l’espulsione della Compagnia di Gesù dal Mezzogiorno ed il riscatto degli orientamenti culturali e politici napoletani dalla tradizionale influenza ecclesiastica. 56 Si possono citare per il primo, l’Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1770); per il secondo, Le droit public de l’Europe (1768); e per il terzo, Il deismo confutato da sé medesimo (1769). 57 Gian Vincenzo GRAVINA, Originum juris civilis..., Neapoli, ex typographia Felicis Mosca, 1722. 58 Niccolò CARAVITA, Nullum jus Pontificis Maximi in Regno Neapolitano dissertatio historico-juridica, Alithopoli [Napoli], s.n., 1707. 59 Costantino GRIMALDI, Discussioni istoriche, teologiche e filosofiche, Lucca, s. n., 1725. 60 Cfr. R. DE MAIO, Società e vita religiosa..., cit., pp. 320-332. 61 Franco VENTURI, Napoli capitale nel pensiero dei riformatori illuministi, in Storia di Napoli, Napoli, Società editrice Storia di Napoli, 1971, pp. 1-74; Raffaele SIRRI, La cultura a Napoli nel Settecento in ibid., pp. 165-310. 62 Maurizio TORRINI, Dagli Investiganti all’Illuminismo. Scienza e Società a Napoli nell’età moderna, in Giuseppe GALASSO-Rosario ROMEO (a cura di), Storia del Mezzogiorno, Napoli, Edizioni del sole, 1991, 15 voll.: vol. IX, Aspetti e problemi del Medioevo e dell’Età Moderna, tomo II, pp. 615-630; Eugenio GARIN, Antonio Genovesi storico della scienza, in «Physis», XI (1969), pp. 211-222; Eugenio D’ ACUNTI, L’anno di Genovesi. La vita e il pensiero, in «la Capitanata», VIII (1969), 1-2, pp. 1-18. 163 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale L’intellettualità meridionale del secondo ‘700, sollecitata dai suoi scritti La logica per gli giovanetti e il Discorso sopra il vero fine delle Lettere e delle Scienze, accettò il gravoso impegno di misurarsi con i temi dell’istruzione pubblica, dell’economia, della meccanica, dell’agricoltura, del commercio, dell’industria, ed apparvero, così, i primi contributi di analisi storico-ambientale del Mezzogiorno. Quasi tutti figurano nel Fondo Antico, tra i più significativi: il Saggio di economia campestre per la Calabria Ultra (Napoli, 1780) ed il Piano di riforma per la pubblica economia delle province del Regno di Napoli e per l’agricoltura delle Due Sicilie (Napoli, 1780) elaborati da Domenico Grimaldi dei marchesi di Messimeri, artefice di trasformazioni colturali nei propri possedimenti; il Viaggio per la Capitanata (Napoli, 1790) pubblicato da Francesco Longano ed incentrato sulle condizioni dell’agricoltura, dell’allevamento e del commercio; la Descrizione geografica e politica delle Sicilie (Napoli, 1794) realizzata da Giuseppe Maria Galanti sulla base dei medesimi interessi; le Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli (Napoli, 1788), nelle quali il marchese Giuseppe Palmieri, esponente della classe dei grandi proprietari di inclinazione capitalistica, trasferì la lunga esperienza maturata all’interno dei propri latifondi pugliesi; l’Annona, o sia piano economico di pubblica sussistenza (Palermo, 1783) scritta da Domenico Di Gennaro; le Riflessioni intorno al commercio antico e moderno del Regno di Napoli (Napoli, 1760) di Nicola Fortunato, e il trattato Della moneta (Napoli, 1780),63 nel quale Ferdinando Galiani mise sotto accusa l’arcaico ed antieconomico regime pastorale del Tavoliere, riassumendo in un passo ormai famoso le linee riformatrici dell’Illuminismo meridionale.64 Accanto a questa letteratura di stampo politico-economico, risulta assai consistente anche quella più spiccatamente erudita,65 come si può rilevare dalla presenza di diverse edizioni di una medesima opera: evidentemente all’ambiente culturale foggiano, vivacizzato, come si è già detto, da scuole e accademie, non era sconosciuta la pubblicistica italiana in genere e, in particolare, l’attività di alcuni coraggiosi ed illuminati editori napoletani, come Giovanni Gravier, Vincenzo Orsini, Giovanni di Simone, Vincenzo Flauto, e, in particolare, Antonio Bulifon,66 i quali, nel loro impegno a favore del rinnovamento politico ma anche della rinascita lette- 63 R. SIRRI, La cultura a Napoli..., cit., pp. 194-244; Augusto PLACANICA, Cultura e pensiero politico nel Mezzogiorno settecentesco in G. GALASSO-R. ROMEO, Storia del Mezzogiorno..., cit., vol. IX, tomo III, pp. 200-256. 64 Ferdinando GALIANI, Della moneta libri cinque di Ferdinando Galiani, seconda edizione, Napoli, Stamperia Simoniana, 1780, p. 414. Nel Fondo Locale è altresì reperibile buona parte della letteratura seicentesca e settecentesca sulla Dogana delle Pecore di Foggia, dalle raccolte di prammatiche e di leggi del Giustiniani, del Grimaldi e del De Sariis, ai trattati coevi del Coda, del Grana, del De Dominicis e del Di Stefano, all’intero dibattito illuministico contro la secolare istituzione pastorale, che vide protagonisti autori come Filangieri, Vivenzio, Cimaglia, Patini, Silla, Targioni, Rosati. 65 Nino CORTESE, Cultura e politica a Napoli dal Cinquecento al Settecento, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1965, pp. 221-274. 66 Ibid., pp. 185-220. 164 Antonio Ventura raria e filosofica del Regno, seguivano con attenzione la polemica tra giurisdizionalisti ed antigiurisdizionalisti e sul Tribunale del Sant’Officio, ma, nel contempo, non trascuravano l’opera di quegli studiosi che, attraverso la paziente ricerca di edizioni rare, di documenti biografici e di curiosità storiche, tentavano di ricostruire il complesso mosaico storico e letterario delle province meridionali. Si giunse, così, al tentativo fatto dal Signorelli67 di sintetizzare in più volumi la storia della cultura e del teatro napoletani; all’altro del Giustiniani68 di redigere una Biblioteca storica69 del Regno; o, ancora, alle indagini dello stesso sugli scrittori legali,70 affiancate da quelle sui magistrati del Grimaldi,71 sino ai vari Dizionari geografici72 ed alle ristampe di cronache, prima fra tutte quella del Gravier, che nella sua splendida Raccolta 73 pubblicò tutto ciò che di meglio era stato scritto sul Mezzogiorno d’Italia. Lo scenario editoriale sin qui analizzato cambia radicalmente, quando si passa a prendere in esame la parte ‘ecclesiastica’ del Fondo Antico: diventa, infatti, preponderante la presenza di volumi provenienti dalle biblioteche dei conventi e degli ‘studi’, soprattutto cappuccini, sparsi per la Capitanata, come si rileva dalle annotazioni manoscritte riportate sui frontespizi, cosicché risulta agevole conoscere quale genere di idee circolava al loro interno.74 Le edizioni del Cinquecento75 commentano, per lo più, gli argomenti filosofici e teologici ricorrenti nelle opere di Aristotele, Tommaso d’Aquino e Duns Scoto: ne sono un esempio gli studi di Agostino Nifo, ...In librum Averrois de substantia orbis... ; l’Aristotelis liber de mundo di Guillaume Budè; le edizioni curate da Joachim 67 Pietro NAPOLI SIGNORELLI, Vicende della coltura nelle Due Sicilie dalla venuta delle colonie straniere sino a’ giorni nostri, Napoli, Vincenzo Orsini, 1810-1811; e Pietro NAPOLI SIGNORELLI, Storia critica de’ teatri antichi e moderni divisa in dieci tomi, Napoli, Vincenzo Orsini, 1813. 68 Su di lui, cfr. N. CORTESE, Cultura e politica a Napoli..., cit., pp. 246-263. 69 Lorenzo GIUSTINIANI, La Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli, Napoli, Vincenzo Orsini, 1793. 70 Lorenzo GIUSTINIANI, La Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli, Napoli, Stamperia Simoniana, 1787-1788. 71 Gregorio GRIMALDI, Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli, Napoli, Stamperia di Giovanni di Simone, 1749-1752. 72 Lorenzo GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, Napoli, Manfredi, 17971805 e ibid., parte seconda, De’ fiumi, laghi, fonti, golfi, monti, promontorj, vulcanj, e boschi, Napoli, De Bonis, 1797-1805; Francesco SACCO, Dizionario geografico-istorico-fisico del Regno di Napoli, Napoli, Vincenzo Flauto, 1795-1796; Elia D’AMATO, Pantopologia calabra in qua celebriorum ejusdem provinciae locorum, virorumque, armis, pietate... monimenta expanduntur, Napoli, ex thypographia Felicis Mosca 1725. 73 Giovanni GRAVIER, Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell’istoria generale del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste Provincie hanno preso forma di Regno, Napoli, Gravier, 1769-1770. 74 Una tesi di laurea in Biblioteconomia, assegnata dalla prof.ssa Tavoni dell’Università di Bologna, un’altra per dottorato di ricerca presso l’Università di Napoli, condotta dal prof. Stefano Capone e la catalogazione della dott.ssa Marianna Iafelice hanno consentito di individuare un significativo nucleo di opere provenienti dai conventi cappuccini locali. 75 M. ALTOBELLA GALASSO-A. VENTURA, Le cinquecentine..., cit. 165 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale Perion di varie opere aristoteliche, come il De anima, il De caelo e il De natura; e le Expositiones quaestionum doctoris subtilis... di Duns Scoto. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di pubblicazioni che rivedono il dibattito sviluppatosi, durante i secoli XIII e XIV, nell’ambito della Filosofia Scolastica, impegnata a superare le diffidenze manifestatesi, presso gli ambienti culturali ed ecclesiastici, nei confronti dell’Aristotelismo e del Neoplatonismo diffusi dalle fonti arabe e greche, ed a cercare, suddividendosi nelle tre correnti dell’Agostinismo, dell’Averroismo e del Tomismo, un punto d’incontro con la Filosofia Cristiana, sui delicati problemi dell’origine del mondo, della Provvidenza, della forma sostanziale e dell’immortalità dell’anima. Le opere del secolo XVII registrano, invece, una consistente presenza di scritti curati dai Gesuiti e da loro stessi diffusi nel Regno di Napoli, dove, all’indomani del Concilio di Trento, si impegnarono in una intensa strategia missionaria, creando, lungo i versanti tirrenico ed adriatico, una serie di collegi nelle città di Nola, Castellammare, Massalubrense, Salerno, Benevento, Cosenza, Lecce, Bari, Barletta, Chieti, Atri, L’Aquila, Bovino. Da tali basi operative si muovevano per raggiungere quegli strati rurali della provincia meridionale, che condizioni di isolamento, di miseria e di disgregazione parrocchiale condannavano ad un pressoché totale abbandono da parte della Chiesa e delle sue istituzioni. In Puglia importanti erano le case di Lecce, Bari e Barletta, destinate a sostenere l’intervento della Compagnia nel cuore e nella parte meridionale della regione, mentre l’altra di Bovino, finanziata dalla munificenza del feudatario locale, il duca Inico di Guevara, rappresentava, dalle propaggini del Subappennino Dauno, l’estremità nord-occidentale della cerniera, indispensabile supporto agli interventi nella Capitanata e, di qui, sino al Beneventano. In questo modo, i Gesuiti, nel pieno della Controriforma, modellarono forme di pietà e di devozione destinate ad improntare, per lungo tempo, le labili realtà urbane e le estese strutture rurali della civiltà regnicola, ma anche a lasciare un’impronta significativa nell’editoria dell’epoca, rintracciabile in opere di carattere storico-teologico, tra cui: l’Historia del Concilio Tridentino di Paolo Sarpi76 e la Doctrina catholica, ex Sacro Concilio Tridentino, et Catechismo Romano... di Giovanni Bellarino.77 Per quanto riguarda, invece, la loro opera di evangelizzazione in Oriente e, in particolare, la politica di tolleranza religiosa nei confronti dei riti malabarici, argomento che, tra la fine del ‘600 ed i primi decenni del ‘700, era venuto ad occupare un posto di tutto rilievo nelle discussioni filosofiche, politiche e religiose degli ambienti laici ed ecclesiastici partenopei78, particolare importanza rivestono alcune 76 Paolo SARPI, Historia del Concilio Tridentino di Pietro Soave polano, Ginevra, Aubert, 1629. Giovanni BELLARINO, Doctrina cattolica, ex Sacro Concilio Tridentino, et Catechismo Romano..., Venezia, apud Joannem de Albertis et Georgium Valentinum, 1628. 78 Sergio ZOLI, Europa libertina tra Controriforma e Illuminismo. L’“Oriente” dei libertini e le origini dell’Illuminismo. Studi e ricerche, Bologna, Cappelli, 1989, pp. 206-224. 77 166 Antonio Ventura pubblicazioni, già all’epoca non facilmente reperibili e la cui presenza negli studi monastici foggiani ne conferma il prestigioso passato. Si tratta degli scritti di autori come i gesuiti Giovanni Antonio Gavazzi,79 Alvaro Semedo80 e Jean Baptiste Gabriel Grosier,81 e soprattutto del domenicano Alexandre Noel,82 che avevano sostenuto con fermezza il carattere civile e non idolatrico delle consuetudini funerarie cinesi. Consistente, quindi, anche la presenza di testi destinati ad aiutare i sacerdoti nell’esercizio del loro ministero: dal sacramento della confessione, esaminato nelle Resolutionum moralium..., di Antonino Diana83 e, soprattutto, nel Manuale de’ confessori, di Martino di Navarra84 e nel Missionario istruito di Filippo De Mura,85 che presentava, esposti in ordine alfabetico, argomenti fondamentali come la simonia, l’usura, l’autorità del Papa; al conforto dei moribondi, trattato nella Practica visitandi infirmos...;86 sino ai consigli per i religiosi, elencati con dovizia di particolari, nel Tractatio de monialibus..., di Francesco Pellizzari.87 Non meno interessanti le edizioni del secolo XVIII, e in particolare quelle successive al Concordato del 1741 tra la Corte Borbonica e la Santa Sede, che rappresentò una conquista memorabile per il mondo laico, ma anche per quello religioso, in quanto segnò l’inizio di una primavera di riforme, riguardanti, in particolare, i modi della collaborazione pastorale e l’aggiornamento del catechismo bellarminiano. Esse, però, solo in minima parte furono, poi, realizzate, nonostante l’impegno del cardinale Giuseppe Spinelli, coadiuvato da Sant’Alfonso de’ Liguori e da San Gennaro Sarnelli, le cui opere figurano nel Fondo Antico. Le ripercussioni delle polemiche ideologiche di quel lungo confronto dottrinario affiorano, comunque, in diverse opere, come: Della origine del dominio e della sovranità de’ papi..., di Giuseppe Agostino Orsi, autore, pure, Della istoria ecclesiastica... in 21 tomi,88 mentre continua a registrarsi la solita nutrita presenza di 79 Giovanni Antonio GAVAZZI, Istorica descrittione de’ tre regni Congo, Matamba et Angola situati nell’Etiopia inferiore occidentale, Milano, nelle stampe dell’Agnelli, 1690. 80 Alvaro SEMEDO, Historica relatione del gran regno della Cina divisa in due parti, Roma, Mascardi, 1653. 81 Jean Baptiste Gabriel GROSIER, Storia generale della Cina ovvero grandi annali cinesi tradotti dal TongKien-Kang-Mon dal padre Giuseppe Anna Maria de Moyriac de Mailla, Siena, Bindi, 1777-1781. 82 Alexandre NOEL, Apologia de’ padri Domenicani missionari della China, o pure risposta al libro del padre Le Tellier gesuita, intitolato difesa de nuovi cristiani, e dilucidazione di P. Le Gobien della stessa Compagnia, sopra gli honori che li Chinesi portano à Confucio ed a i morti, Colonia, appresso gli heredi di Cornelio d’Hegmond, 1699. 83 Antonino DIANA, Resolutionum moralium pars sexta. In qua selectiores casus conscientiae breuiter, dilucide, et ut plurimum benigne explicabuntur, Venezia, Francesco Baba, 1743. 84 Martino DI NAVARRA, Manuale de’ confessori..., Roma, s. n., 1647. 85 Filippo DE MURA, Il missionario istruito in tutte le regole, e precetti di comporre ogni esercizio di vangelica apostolica predicazione, che nelle sante missioni si fa, Napoli, Guerra, 1790. 86 Giacomo MANCINI, Practica visitandi infirmos..., Napoli, expensis Jo. Baptistae de Juorio, 1637. 87 Francesco PELLIZZARI, Tractatio de monialibus, Roma, ex typographia Generosi Salomoni, 1755. 88 Giuseppe Agostino ORSI, Della origine del dominio e della sovranità de’ papi, Roma, Gioacchino Puccinelli, 1788; Giuseppe Agostino ORSI, Della istoria ecclesiastica descritta da fr. Giuseppe Agostino Orsi, Roma, Paglierini, 1751-1756. 167 I Fondi Speciali: le terrae incognitae della Biblioteca Provinciale scritti a carattere divulgativo, che la pubblicistica sacra persiste a produrre per tutto il 1700: in particolare si diffondono i quaresimali, tra i quali sono da segnalare quelli, assai efficaci per gli esempi tratti dal Vangelo, di Alessandro Calamato, Fulvio Fontana, Vincenzo Giliberti e Paolo Segneri, ed i testi di letteratura devozionale. Accanto a queste opere di carattere religioso non mancavano testi di contenuto umanistico, scientifico, storico, geografico, giuridico che, utilizzati per l’aggiornamento culturale dei sacerdoti e la formazione dei novizi, erano, nella maggior parte dei casi, gli stessi che circolavano presso i professionisti e le istituzioni laiche di Foggia. La cultura classica è rappresentata soprattutto dagli autori latini, nettamente prevalenti sui greci: solo qualche opera, tuttavia, è pregiata, come le Commedie di Terenzio Afro, stampate a Venezia dagli eredi di Nicola Pezzana nel 1782, con il commento del gesuita Joseph Juvency e le Lettere familiari di Marco Tullio Cicerone, pubblicate a Napoli da Felice Mosca, nel 1735. Le altre non presentano particolari caratteri di rarità, con qualche eccezione per alcune prime edizioni ottocentesche: le Commedie di Plauto (1822), in cinque tomi; le Lettere di Plinio il Vecchio (1828), in due; ed i Libri ab Urbe condita di Tito Livio (1825) in quattordici. Per la storia letteraria italiana, soltanto il compendio di Girolamo Tiraboschi rientra tra i libri anteriori al 1830, perché messo in distribuzione a Napoli, da Giovanni Muccis, in dieci tomi, tra il 1777 ed il 1786, mentre le vicende artistiche nazionali sono descritte in prime edizione ottocentesche di grande pregio per l’autorevolezza degli autori e la raffinatezza dell’apparato iconografico, come si può rilevare dalle Opere di Johan Joachim Winckelmann e di Luigi Lanzi.89 Tra i libri di storia, a parte alcuni trattati generali poco comuni, come i venti volumi della Storia romana... del giansenista Charles Rollin,90 le edizioni di maggiore pregio provengono dalla produzione tipografica napoletana dei secoli XVII e XVIII e prendono in esame, attraverso il Summonte, il Troyli ed il Martuscelli, le vicende plurisecolari del Reame.91 Pure per la geografia, la rappresentazione dei piccoli spazi si alterna a quella degli estesi, così, accanto alle ricerche storico-geografiche seicentesche, ancora influenzate dagli studi umanistici di Leandro Alberti o di Flavio Biondo e, quindi, solo descrittive e non corredate da tavole cartografiche, come quelle di Enrico Bacco e di Ottavio Beltrano,92 si incontrano le opere monumentali ed enciclopediche di 89 Luigi LANZI, Storia pittorica dell’Italia dal risorgimento delle belle arti fin presso al fine del 18 ° secolo, Milano, Società tipografica de’ classici italiani, 1824-1825. 90 Charles ROLLIN, Storia romana sino alla battaglia di Azio, o sia sino al termine della Repubblica di Carlo Rollin tradotta dal francese., Roma, Poggioli, 1806. 91 Giovanni Antonio SUMMONTE, Historia della città e Regno di Napoli, Napoli, Stamperia Domenico Vivenzio, 1748; Placido TROYLI, Istoria generale del Regno di Napoli, Napoli, s. n., 1747-1754; Domenico MARTUSCELLI, Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli, Napoli, Nicola Gervasi, 1814-1822. 92 Enrico BACCO, Il Regno di Napoli diviso in dodici province, Napoli, Stamperia Scorriggio, 1615; Ottavio BELTRANO, Breve descrizione del Regno di Napoli, Napoli, per Ottavio Beltrano, 1648. 168 Antonio Ventura Claude Buffier,93 e di Attilio Zuccagni Orlandini,94 la cui caratteristica principale, determinata dalle novità scientifiche di fine ‘700 e primo ‘800, è la costante presenza di un vasto ed accurato apparato cartografico, reso possibile dall’evoluzione della tecnica tipografica di riproduzione delle incisioni. Un breve cenno, infine, alle opere scientifiche, che, a parte gli Elementa... di Nicola Fergola,95 la Storia naturale e particolare di George Louis Buffon, conte di Leclerc96 e il Delle cose rustiche... di Nicola Onorati, detto Columella97 sono quasi tutte di primo Ottocento e senza edizioni di rilievo, ma rivelano, nei numerosi titoli riguardanti la Geometria, la Storia Naturale, la Trigonometria, la Chimica, la Matematica, la Botanica, la Fisica, l’Astronomia..., l’attenzione prestata in ugual modo da laici e religiosi verso questo aspetto della cultura. In conclusione, quindi, la Sezione Locale ed il Fondo Antico, pur costituendo due elementi biblioteconomici distinti per le caratteristiche bibliografiche, concettualmente si fondono e completano, perché testimoniano aspetti e momenti differenti della comunità locale, urbana e provinciale: rappresentano un patrimonio di documenti, libri, testimonianze, idee, sentimenti, passioni che è sopravvissuto ai danni dei ‘tempi’ ed ai guasti delle ‘mode’ e che così si ha il dovere di tutelare, ordinare e consegnare a chi, in futuro, ha il diritto di trovarci i segni della propria tradizione civile e culturale. 93 Claudio BUFFIER, Geografia universale, Napoli, Migliaccio, 1796. Attilio ZUCCAGNI ORLANDINI, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia, Firenze, presso gli Editori, 1835-1845. 95 Nicola FERGOLA, Elementa phisicae experimentalis usui tironum, Napoli, Joseph de Hyppolito, 1791. 96 Gorge Louis BUFFON, Storia naturale e particolare per servire di seguito alla storia degli animali quadrupedi, Napoli, Raimondi, 1772. 97 Niccola ONORATI, Delle cose rustiche, Napoli, Giuseppe Maria Porcelli, 1791-1799. 94 169 170 Presente come cultura 172 “Kirikù. Intercultura, biblioteca e mezzi di comunicazione” Foggia, Palazzo Dogana, 3 dicembre 2003 174 Franco Mercurio L’intercultura nella Biblioteca Provinciale di Foggia di Franco Mercurio Per i ragazzi l’immigrazione è un fenomeno normale, che si è sviluppato insieme a loro. Diverso è per chi, come molti di noi, ha qualche anno in più. L’immigrazione nel nostro territorio resta ancora qualcosa di inconsueto perché ha assunto da meno di venti anni gli aspetti di massa che si riscontrano oggi. Il problema è balzato alla nostra attenzione quando è cominciato il grande esodo albanese dopo la caduta del comunismo di stato in quel paese. Oggi, dunque, per la prima volta la Biblioteca Provinciale si cimenta a riflettere sul fenomeno. Si tratta di un primo provvisorio punto di arrivo, che prende le mosse dalla domanda che la Provincia ci pose qualche anno fa: “come la biblioteca intende attrezzarsi di fronte a questo fenomeno inedito?”. La domanda in sé era perfino troppo semplice; ma ciò che sembra facile richiede quasi sempre risposte difficili da dare perché la nostra biblioteca, come grande parte della società, non era né sul piano culturale né su quello operativo, attrezzata ad affrontare l’impatto di un movimento immigratorio di massa. D’altra parte questa è sempre stata una terra di emigranti; si andava via alla ricerca di un lavoro, di una nuova dignità. All’improvviso abbiamo scoperto che non eravamo più noi ad andare via, ma vi erano altre persone che venivano qui con gli stessi identici bisogni, con la complicazione che derivava dalla diversa visione del mondo, dal diverso approccio culturale alle vicende della vita. Quando un italiano emigrava trovava quasi sempre una società che si richiamava ai valori cristiani, se non proprio cattolici. Qui da noi, invece, si è aggiunto all’ovvio disagio della lingua anche questa diversità di approccio culturale e religioso, che in talune circostanze tratteggia una vera e propria linea di demarcazione fra comunità locali ed immigrati. Avevamo, dunque, diverse risposte da poter dare. La più ovvia era quella tracciata dall’Unione Europea attraverso i suoi programmi comunitari. Vi erano alcuni programmi che riguardavano l’inclusione. In modo particolare erano rivolti a contrastare la xenofobia perché sembrava in un primo momento che il problema principale fosse quello di contrastare i fenomeni di razzismo nei confronti degli immigrati. Quasi subito ci siamo resi conto quanto questa scelta non fosse in grado di rispondere compitamente alla domanda. Potevamo, infatti, offrire gli strumenti di conoscenza, formazione e informazione, ma non avremmo affrontato l’altro corno del problema, che è rappresentato dalla necessità della biblioteca di entrare in contatto con gli universi paralleli dell’immigrazione. E ancor più ci sembrava importante non soltan175 L’intercultura nella Biblioteca Provinciale di Foggia to entrare in relazione con gli immigranti, ma soprattutto definire la gamma di servizi che noi potevamo offrire loro. Ovviamente il nostro compito non è quello di fare le politiche sociali o culturali. La nostra funzione è quella di attrezzare la biblioteca per dare il maggior numero di risposte a chi vuol capire il fenomeno e a chi vuole attuare le migliori forme di inclusione. Per tale ragione ci siamo guardati intorno e per un certo periodo abbiamo assunto come punto di riferimento un’esperienza importante, che non è europea, ma americana. Mi riferisco alla biblioteca di pubblica lettura di San Francisco. Gli Stati Uniti, pur essendo un paese tradizionalmente aperto alle immigrazioni, da qualche tempo sono interessati da flussi immigratori completamente diversi rispetto al passato. In realtà da una generazione a questa parte è l’intero mondo ricco occidentale ad essere sottoposto ad una forte pressione immigratoria da parte dei paesi poveri. È la stessa immigrazione che ha mutato qualità rispetto a quella otto-novecentesca, perché sono cambiate le condizioni interne dei paesi in cui si emigra. L’esperienza della lontana biblioteca di San Francisco ci è sembrata interessante perché ha cercato di dare risposte nuove a quel diverso livello di immigrazione, puntando sull’inclusione e l’integrazione. La biblioteca svolge anche una funzione di reference di comunità rivolgendosi direttamente agli immigrati, organizzando corsi di alfabetizzazione o di cultura locale. In altri termini attraverso la biblioteca l’immigrato comprende la cultura, le tradizioni, gli stili di vita del paese che li ospita. Oggi noi abbiamo la fortuna di aggiungere a queste esperienze che vengono da oltre oceano quelle maturate nella più vicina realtà di Prato, attraverso la testimonianza di Franco Neri, il direttore della biblioteca civica di quella città. La Biblioteca Provinciale è oggi dunque in grado di dare una prima risposta a quella domanda che ci fu posta tre anni fa dalla nostra Amministrazione. Noi riteniamo che si possa realizzare un’interazione fra coloro che vogliono capire il fenomeno dell’immigrazione e gli immigrati stessi. Uno dei punti di incontro è proprio la scuola. Ci sono ormai centinaia di ragazzi, figli di immigrati, che frequentano le nostre scuole, che sono cittadini italiani o che comunque vivono i nostri stessi stili di vita. Ma vi è anche un altro punto che dialoga direttamente con il futuro e che fa della biblioteca un centro di documentazione e di conservazione dei materiali. Venti anni fa la biblioteca fece una importante esperienza con l’istituzione dell’Archivio della cultura di base. Venti anni fa un gruppetto di ricercatori si mise a battere il territorio raccogliendo le testimonianze del lavoro bracciantile, ormai alle soglie del suo esaurimento. Quei dati raccolti allora, oggi sono di fondamentale importanza per chi studia o solo vuole conoscere il nostro passato. Oggi come allora abbiamo la pretesa di raccogliere i materiali sul fenomeno dell’immigrazione per lasciare una traccia e una memoria che resti ai loro figli che saranno italiani e probabilmente hanno la necessità di capire la propria origine, conoscere le proprie radici. Oggi le vogliamo intercettare per domani. Si conclude, dunque, una fase che è stata di riflessione e di definizione della fisionomia di questa parte della biblioteca che si interessa di intercultura e di immigrazione. Ed ovviamente se ne apre un’altra che passa necessariamente attraverso le verifiche che questo incontro reca con sé. Per questo motivo riflettere sugli esiti del progetto Kirikù che ha avuto una funzione sperimentale, confrontarsi con l’esperienza di Prato e conoscere le valutazioni dell’università sono i punti fondanti delle future fasi. 176 Enrichetta Fatigato Kirikù a “ilDock”: la sezione intercultura della Biblioteca Provinciale di Foggia di Enrichetta Fatigato È profondamente coerente con la fisionomia delle biblioteche rispondere agli stimoli provenienti dai confronti con le culture ‘altre’ . La storia della formazione delle biblioteche nei secoli dimostra l’attenzione riservata all’incontro e al confronto con le culture non proprio legate al territorio in cui si insedia la biblioteca. Mi piace sempre ricordare, ad esempio, le corrispondenze epistolari che intercorrevano fra Petrarca e gli intellettuali d’oltralpe dell’epoca e le ricerche del padre della moderna bibliografia, Conrad Gesner, per sottolineare che la costituzione delle grandi biblioteche private e pubbliche dell’Umanesimo e del primo Rinascimento furono dovute alle relazioni e alle corrispondenze che intellettuali di questa portata intessevano con uomini di altri territori per lo scambio di segnalazioni bibliografiche. Sono state queste corrispondenze ad introdurre nelle biblioteche dell’epoca le testimonianze scritte di una cultura non più solo latina, contribuendo all’affermarsi della lingua volgare, e ad aprire, in particolar modo ad opera di Conrad Gesner, il mondo delle biblioteche alla nascita e al confronto delle scienze positive e sperimentali. Ancora oggi, la realizzazione del suo opus magnum, la “Bibliotheca universalis” rappresenta, per le biblioteche, un mirabile esempio concreto di ricerca per sviluppo di nuovi incontri culturali e di nuovi saperi. La sua “Bibliotheca” ha consentito nel mondo occidentale la diffusione e l’affermazione delle scienze positive, della biologia, delle scienze naturali e sperimentali. E come non ricordare Federico II, la sua biblioteca itinerante contenuta nelle casse di libri che seguivano l’imperatore negli spostamenti fra le sedi dell’impero. Molto significativa per la nostra realtà attuale e il nostro territorio è la sua biblioteca ricca di libri che venivano dall’Oriente. I documenti contenuti erano, certo, testimonianza di espressioni linguistiche diverse, ma, soprattutto, trasferivano competenze, conoscenze, in un atteggiamento cosmopolita e multiculturale su cui occorre, oggi, soffermarsi a riflettere. La coerenza multiculturale delle biblioteche pubbliche contemporanee è riscontrabile non solo nelle dotazioni librarie, ma anche negli strumenti tecnici di cui dispone la moderna biblioteconomia. Questi sin dalla predisposizione e fino 177 Kirikù a “ilDock”: la sezione intercultura della Biblioteca Provinciale di Foggia alla reale applicazione, orientano alla rappresentazione e tutela dell’incontro con le culture e i saperi differenziati e con ogni entità intellettuale e documentale proveniente da paesi e da continenti i più diversi. Si pensi, solo per esempio, all’internazionalizzazione dei formati di scambio dei dati bibliografici, all’invito proposto agli stati nazionali negli anni ’60 e ‘70 dagli organismi di ricerca biblioteconomica per la redazione di codici per l’identificazione degli autori, ai regimi di classificazione in uso nelle biblioteche per dare valore paritetico ai documenti ovunque e da qualsivoglia soggetto prodotti e/o usati, al rispetto nelle descrizioni bibliografiche dei titoli originari delle opere e al dibattito sulle tavole di traslitterazione per redigere i cataloghi di biblioteca che prevedano la diffusione delle informazioni anche a gruppi etnici, linguistici e culturali diversi da quelli presenti nelle comunità di riferimento. Dalla seconda metà degli anni ‘90, metodologie e prassi consentono alle biblioteche di emergere dall’isolamento comunicativo, di aprirsi a confronti internazionali e interculturali più che nel passato. Le operazioni di selezione, acquisizione e allestimento delle raccolte bibliografiche e documentarie si qualificano come servizi diretti alla crescita culturale dei cittadini, al rispetto delle differenze. Volendo intensificare e potenziare la propria coerenza comunicativa le biblioteche pubbliche che, per gradi e forme diverse, decidono di approntare non solo collezioni, ma servizi rivolti alle minoranze etnico – culturali devono recepire l’esplicito intervento dell’International Federation of Library Associations (IFLA) che dettaglia attraverso le Linee Guida per le biblioteche multiculturali, (la cui seconda edizione è appena uscita nella traduzione italiana) criteri per la promozione di servizi orientati soprattutto all’imparzialità e all’equità. L’uso del servizio di biblioteca diretto alle minoranze etniche, linguistiche e culturali deve essere realizzato attraverso l’adozione di standard che siano paritetici a tutti gli altri adottati in ogni tipologia bibliotecaria moderna, sia di riferimento locale e nazionale che internazionale. In una’indagine pilota, condotta dal Gruppo di lavoro sulle biblioteche multiculturali della Commissione Nazionale biblioteche pubbliche dell’A.I.B., è risultato che il contesto italiano registra situazioni diverse nell’attivazione di servizi orientati a favorire la multiculturalità.1 Dappertutto in Italia, riferisce il rapporto A.I.B., i servizi bibliotecari multiculturali hanno non più di dieci anni e non esiste un aggiornamento specifico dei bibliotecari. Nel centro-nord dove il fenomeno immigratorio è diventato più residenziale e stabile, anche la risposta di servizi bibliotecari orientati diventa più evidente. Esistono esperienze diffuse di grandi interventi nel Sistema Bibliotecario Urbano di Torino, nella Biblioteca Comunale Centrale di Milano, a Perugia, Ravenna, Modena e Roma. 1 Cfr. http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/mc/cicdom01.htm. 178 Enrichetta Fatigato Molto significative sono le esperienze condotte dalla Biblioteca di “Sala Borsa” a Bologna, dalla “Delfini” di Modena e dalla “Lazzerini” di Prato. In queste, il percorso biblioteconomico si è esteso al controllo bibliografico, con costituzione di fondi multiculturali e multilingue, di cataloghi bilingue, bibliografie tematiche plurilingue e selezioni di siti web o di e-reference dedicati. Nel sud d’Italia ove il fenomeno dell’immigrazione negli aspetti più macroscopici è stato definito di primo impatto e di transito non si trova alcuna corrispondenza tra servizi bibliotecari attrezzati e fenomeno immigratorio. Il lavoro che stiamo conducendo nella Biblioteca Provinciale di Foggia, non trova comparazione nei tavoli di lavoro regionali pugliesi sul ruolo delle biblioteche in tema interculturale, con possibili altri interventi di merito. Siamo i primi in Puglia ad elaborare questi orientamenti. I risultati dell’indagine A.I.B. attribuiscono il diverso passo di crescita a sviluppi diseguali della biblioteca per tutti e di pubblica lettura, a congiunture poco favorevoli per servizi così specializzati in cui è necessario si adottino gli strumenti biblioteconomici dell’analisi di comunità, si predispongano servizi di reference mirato, ci sia cooperazione territoriale per la messa a punto di servizi rivolti alle minoranze e pratica delle lingue e degli alfabeti, sia per la comunicazione diretta che per le registrazioni bibliografiche. A ciò si aggiunga che nel costruire fondi multiculturali è diffusa a livello nazionale la difficoltà di reperire nell’editoria italiana prodotti nella lingua originale delle minoranze; mancano, per i bibliotecari addetti alle selezioni per gli acquisti, adeguate fonti informative dal mercato editoriale estero. Le segnalazioni editoriali che riguardano il multiculturalismo sono dirette, per lo più, al lettore autoctono, si rivolgono essenzialmente al pubblico dei minori attraverso il rapporto filtrato con le scuole, non riescono ancora a catturare l’adulto immigrato. Al di là di queste difficoltà, anche le biblioteche dei territori dell’immigrazione di transito o di prima generazione non possono e non devono dimenticare di riflettere sul fenomeno, favorendo la diffusione del confronto e scambio interculturale, interagendo con il territorio per la lettura dei bisogni informativi e culturali, in primo luogo con il mondo della scuola e di quanti operano nel sociale per favorire l’accoglienza e il rispetto delle differenze. La Biblioteca Provinciale di Foggia, contemporaneamente alla riorganizzazione dell’assetto strutturale dei servizi di pubblica lettura, a partire dal 2000, ha iniziato a porre attenzione al fenomeno immigratorio. L’orientamento assunto si richiama al Manifesto dell’Unesco e inquadra anche il regime della nostra biblioteca in un concetto di cultura allargato ed egualitario dove, se è difesa l’uguaglianza del valore di tutte le culture di tutta l’umanità, occorre tradurre questa convinzione in opportunità di scambi e confronti perché i servizi di biblioteca riproducano e rappresentino culture sempre meno etnocentriche. La cura di quella che, per ora, come un po’ nella media nazionale, è solo una ‘sezione’ dedicata all’intercultura è affidata Centro di documentazione “ilDock”. 179 Kirikù a “ilDock”: la sezione intercultura della Biblioteca Provinciale di Foggia Il Centro, per definizione di ruolo, collabora con le istituzioni scolastiche, con le biblioteche scolastiche, con i centri e le associazioni attive sul territorio, nell’intento di valorizzare, attraverso la selezione, l’acquisizione e la diffusione allargata di documentazioni, la riflessione sul senso e il significato che assumono le progettualità formative e culturali quando intendono contribuire a rendere il territorio non solo più attento alla propria memoria, ma, e soprattutto, più aperto al confronto sulle migliori prassi. “ilDock” propone la propria mission nella consapevolezza sia metodologica che procedurale di operare nell’ambito dei servizi tipici della public library, riflettendo su come rendere i servizi culturali di accesso alla ricerca e all’informazione bibliografica e documentale aderenti al modello di società multiculturale così come va esprimendosi, soprattutto localmente, anche tramite il confronto con le Istituzioni Scolastiche, l’Università e gli operatori sociali. Nel delineare il profilo bibliografico e documentale del nostro fondo interculturale si è inteso contribuire: • a fornire strumenti per la formazione di operatori sociali e scolastici impegnati nei processi di accoglienza e prima integrazione; • a svolgere un’azione problematica che attraversi trasversalmente tutti i diversi campi e le molteplici forme in cui si manifestano i saperi; • a collegarsi ai metodi di orientamento comune e di lavoro collettivo tipici della community education per lo sviluppo di strategie dirette alla crescita multiculturale del territorio; • a sostenere e condividere procedure che siano vie possibili alla pace, alla riappacificazione e collaborazione fra tutte le donne e gli uomini della terra; • a rifiutare approcci di accettazione paternalistica delle espressioni delle culture minoritarie in termini folcklorici ed esotici; • a spezzare i presupposti primati culturali di territori che nell’epoca della globalizzazione economica e sociale non consentano, innanzitutto, l’espressione dei diritti umani fondamentali e non siano disponibili all’accoglienza dei diversi gruppi etnoculturali nel villaggio globale composto da tante tribù di minoranze. Oltre alla recente configurazione del fondo interculturale presente nel Centro di documentazione “ilDock”, occorre riferire del patrimonio della biblioteca dei bambini e ragazzi con presenze di libri di narrativa e di divulgazione con testi originari a fronte e nelle lingue inglesi, tedesche e francesi, con prime, recenti acquisizioni di narrativa in cinese, scaturite dai contatti quotidiani che la sezione ragazzi intesse con le scuole; la dotazione multilingue e interdisciplinare del fondo dei periodici e la sezione della narrativa che se si propone ad impianto multiculturale. Oltre 900 titoli di narrativa in lingua originale proveniente da tutti i paesi del mondo sono il recente incremento del nucleo di base ad assetto linguistico occidentaleeuropeo. Nel fondo locale sono reperibili testimonianze delle minoranze linguistiche. 180 Enrichetta Fatigato Perché gli interventi verso le minoranze etnico-linguistiche, e le proposte interculturali rispondano a criteri di efficacia di servizi, le attività che nel Centro sono state intraprese presuppongono il giusto collocamento all’interno dei processi comunicativi diffusi sul territorio. Occorre riferirsi alla comunicazione diretta alle minoranze orientando e distinguendo nel variegato e multiforme complesso di fonti ed emittenti, distinguendo fra quelle legate agli stadi di dipendenza e precarietà e quelle che accompagnano la stabilità residenziale. Attraverso un’indagine a campione che stiamo avviando in questi giorni, vogliamo approfondire le conoscenze dei gradi e della qualità dei processi di integrazione degli adulti; tentare di capire la natura dei loro bisogni informativi e culturali, sia latenti che espressi. A partire dai dati statistici sull’immigrazione offerti dall’Osservatorio provinciale sulla qualità e le politiche sociali, è in corso un sondaggio da cui possa emergere il profilo delle comunità degli immigrati nella nostra provincia. Partecipiamo, per le nostre competenze, alle riunioni del Coordinamento provinciale per gli immigrati e i richiedenti asilo “Insieme per una società solidale” patrocinato dall’Assessorato Provinciale all’Immigrazione. Ne curiamo da meno di un mese la newsletter elettronica alla pagina web de “ilDock”.1 Lo snodo di notizie che si crea fra gli operatori dell’accoglienza e dell’integrazione, ci consente di vigilare che le nostre proposte comunicative, informative e culturali si adeguino progressivamente alle reali situazioni locali. Questa misura consente di testare periodicamente la complessa relazione di integrazione identificando: • le funzioni della comunicazione attraverso la selezione dei bisogni e l’accesso alle fonti documentarie scritte visive ed orali; • i contenuti del trasferimento di notizie; • i tempi, i modi e i gradi dell’offerta comunicativa; • la tipologia e il grado di sofisticazione degli strumenti con cui interveniamo. Da qualche settimana opera presso il nostro Centro una mediatrice culturale. Il suo servizio si svolge nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno” a titolarità del Ministero degli Interni in collaborazione con la Regione Puglia ed è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per promuovere attività nel settore dell’istruzione. Sappiamo di disporre di un’opportunità non sempre riconosciuta al mondo delle biblioteche. Con la nostra mediatrice stiamo già lavorando sul complesso sistema informativo che investe l’immigrazione. Le associazioni di volontariato quali quelle presenti nel Coordinamento provinciale ben rappresentano le risposte ai bisogni informativi e di orientamento tipici della fase di accoglienza. Gli immigrati nelle fasi di ingresso sono interessati a informazioni legate alla 1 http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/dock 181 Kirikù a “ilDock”: la sezione intercultura della Biblioteca Provinciale di Foggia propria sopravvivenza e alla tutela del proprio soggiorno e il circuito di notizie che li riguardano sono quelle circolanti nella comunità dei propri pari o nei centri di prima accoglienza e divulgate da operatori sociali e sanitari con volantini, opuscoli comunemente redatti nelle lingue occidentali e solo alcuni si spingono nell’uso dei linguaggi dei paesi d’origine. Il ruolo della Biblioteca diventa determinante già nella fase di primo inserimento quando le informazioni riguardano conoscenze più strutturate, ponte per una futura integrazione. Occorre emettere comunicazioni di iniziative formative destinate agli immigrati corredate da supporti didattici di diversa natura e nelle lingue più affini al loro patrimonio culturale. Un’attenzione particolare è data all’apprendimento delle lingue creando occasioni di mutuo e simmetrico scambio di occasioni formative, di abilità cognitive prassi e opportunità fra ospiti ed immigrati. Attraverso la newsletter elettronica diamo notizie su corsi di lingua per gli immigrati nella provincia di Foggia ma anche riservati ad operatori e formatori locali per facilitare lo scambio culturale. Le iniziative che stanno ruotando attorno alla costituzione del fondo interculturale de “ilDock”, consultabile nell’OPAC della Biblioteca Provinciale di Foggia2 e alla produzione di dossier bibliografici tematici prodotti nel Centro, hanno fatto incrementare il numero degli utenti insegnanti e operatori sociali e dei prestiti. Interessante l’iniziativa promossa dalla nostra mediatrice culturale dell’ora del racconto di fiabe etniche realizzate nella lingua d’origine da alcuni adulti immigrati in Sala Ragazzi. Finanziamenti dell’Unione Europea quali incentivi all’integrazione degli immigrati trovano nel punto Eurodesk, attivo presso il Centro foggiano, uno sportello di sostegno e orientamento. La fase della prima integrazione è legata anche in provincia di Foggia agli inserimenti scolastici e al 2002 registra 722 alunni non italiani, all’ingresso nel mondo del lavoro (badanti, ecc..) la relazione comunicativa si fa più complessa e articolata. Il fenomeno è molto recente e non allo stesso grado per ciascuna etnia. I dati dell’Osservatorio ci dicono che va riducendosi la presenza di alunni albanesi e compare la rappresentanza asiatica. Il cittadino del paese ospite si lascia permeare dalla cultura degli immigrati in quella che viene definita “moda dell’etnico” e contemporaneamente gli immigrati e le loro famiglie chiedono l’accesso a strumenti comunicativi che gli consentano il godimento del diritto di piena cittadinanza. È la fase degli scambi informativi reciproci su usi e costumi attraverso occasioni di incontri festosi. In occasione del Natale 2002 presso la saletta de “ilDock”, in collaborazione con il Centro interculturale “Jambo” della Cooperativa sociale onlus “Xenia” in 2 http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/h3/h3.exe/ase 182 Enrichetta Fatigato collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e numerose aziende private che hanno allestito le decorazioni degli spazi del Centro, è stata realizzata un’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Foggia e denominata “Per un Natale di Pace, auguri dal mondo”, ha permesso l’incontro delle varie comunità straniere (albanesi, brasiliani, algerini, tunisini, marocchini, russi, burundesi e polacchi) presenti nella città di Foggia. In questo filone di intervento si inseriscono i partenariati del Centro: • al progetto “La cultura araba per gli operatori del sociale” nell’ambito dell’iniziativa di Educazione permanente per gli adulti presentato dall’Istituto “Poerio” di Foggia; • al progetto “In viaggio” patrocinato dal Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli studi) della Provincia di Foggia; • alla ricerca-azione del progetto “Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani” patrocinato dal MIUR e destinato nella Regione Puglia anche a Foggia ad un gruppo di scuole di diversi ordini e gradi con capofila il Liceo Scientifico “A.Volta”; • all’iniziativa “Kirikù: intercultura, biblioteca e mezzi di comunicazione” in collaborazione con le cooperative “Xenia” e “Jumbo” rivolta alle scuole della provincia di Foggia. Avvertiamo la necessità di riprodurre nei servizi al pubblico corrispondenze pari all’entità dei flussi migratori, di perseverare in un lavoro collettivo e di sistema per evolvere dagli ‘scaffali per l’intercultura’ a ‘scaffali multiculturali’ diffusi ad ampio spettro in ogni sezioni disciplinare. Anche nella nostra provincia gli immigrati devono trovare nei servizi di reference, negli spazi fisici accoglienti, oltre che nelle raccolte, tutelato il rispetto di tutte le identità culturali e documentali, così noi contribuiremo al rispetto e alla crescita del diritto di cittadinanza, da questo confronto il nostro territorio verrà arricchito e giammai impoverito. 183 184 Franco Neri L’esperienza della Biblioteca “Lazzerini” di Prato 1 di Franco Neri La Provincia di Prato è la più piccola della Toscana: la sua ampiezza (365 kmq.) corrisponde a ca. il 2% della regione, ma la densità demografica è assai più accentuata: la popolazione costituisce il 6% di quella regionale. I residenti, secondo il censimento 2001, erano 227.886 (623,9/kmq.). Nel territorio del Comune di Prato,2 i residenti complessivi al 31/12/2003 sono 178.003; gli stranieri residenti, 13.127. Ma in realtà i processi demografici e sociali sono molto più intensi di quanto non rappresentino i dati ufficiali. Recenti ricerche del Centro Ricerche e Servizi per l’Immigrazione del Comune di Prato ipotizzano una presenza in città di ca. 28.000 cittadini di altre nazioni (includendo nel calcolo i minori e coloro che hanno presentato domanda di regolarizzazione), con un’incidenza di ca. il 16% sulla popolazione del territorio comunale, ed una diseguale distribuzione all’interno di esso. Le comunità numericamente più significative sono, in ordine decrescente, la cinese, l’albanese, la marocchina, la pakistana. Altrettanto significativi i dati sulla frequenza di alunni stranieri ai diversi gradi di scolarità. Nell’anno scolastico 2003-2004 vi sono complessivamente, fra scuole statali e paritarie, 2.386 alunni stranieri su 25.038 iscritti (9,52%), così distribuiti: 446 nella scuola dell’infanzia su 4.585 (9,73%); 864 alle scuole elementari su 7.051 (11,52%); 712 alle scuole medie inferiori su 4.965 (ca. il 14%); 364 alle scuole superiori su 8.437 (4,31%), con una tendenza ovunque generalizzata alla crescita rispetto agli anni precedenti, ed un riequilibrio della presenza cinese a favore di altri gruppi (albanesi, marocchini, pakistani). La rapidità dei processi migratori ha profondamente modificato l’assetto del territorio, l’organizzazione della città (la città “plurale”) e la percezione che di essa hanno i soggetti che vi vivono ed operano. Non a caso il Rapporto Caritas 2002 ha in più punti sottolineato come la politica migratoria consista nella gestione della complessità. 1 Rielaborazione e aggiornamento a giugno 2004. Si è cercato di mantenere, laddove possibile, il tono colloquiale del contributo. 2 Cfr.: CENTRO RICERCHE E SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE, La crescita della popolazione straniera a Prato: realtà attuale e proiezioni sul prossimo anno, commento e analisi dei dati di Anna Marsden, Prato, Comune di Prato, 2002, pp. 10-11 e CENTRO RICERCHE E SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE, I numeri della presenza straniera a Prato, commento e analisi dei dati di Anna Marsden, Prato, Comune di Prato, 2003, pp. 2-3. 185 L’esperienza della Biblioteca “Lazzerini” di Prato Le biblioteche, in particolare quelle pubbliche, non sono strutture neutre rispetto alla diseguale distribuzione delle opportunità culturali e di informazione. Quando si forma una raccolta libraria, non si forma né si sviluppa attraverso un ipotetico, asettico livello medio: una raccolta libraria ha sempre dei picchi, questi picchi sono i momenti alti del rapporto tra la biblioteca e il territorio. Cosa significa, ad esempio, che in un certo momento si vedono tanti nuovi libri che riguardano un determinato argomento? È il frutto di un’opera di “copertura” di vuoti bibliografici, compiuta dal bibliotecario, oppure (e soprattutto, ai fini di questa riflessione) esprime una capacità di attenzione a diversificati bisogni di lettura, di formazione, di sapere espressi da soggetti individuali e collettivi, e che si manifestano nella progettazione e nell’organizzazione di una raccolta documentaria? Non è utopistico pensare che pure gli utenti possano riconoscersi, anche nel loro temporaneo aggregarsi come portatori di richieste specifiche di documentazione e conoscenza (ad esempio, ad integrazione di percorsi di apprendimento, autonomi o di gruppo), come co-determinatori del dispiegarsi di una raccolta documentaria; in questa ipotesi tanto più è efficace una raccolta quanto più visibili sono le tracce di una relazione forte fra la biblioteca ed i suoi pubblici. Tutto questo significa guardare agli interessi ed alle domande di una collettività, ed è il segno di una reattività, di una capacità di “leggere” nelle culture di un territorio, nei tratti peculiari e dominanti e nelle differenze, che fa parte strutturale della mission della biblioteca. È indispensabile allora dotarsi di professionalità complesse, in grado di fare interagire competenza tecnica e capacità di ascolto e di operare in partnership, e di raffinati strumenti di lettura dei bisogni. In generale, ciò implica una abilità complessiva di costruire relazioni stabili, permanenti con saperi di diverso tipo, esterni alla struttura bibliotecaria: saperi individuali, certo, ed il riferimento spontaneo è alla intellettualità locale, a quella – spesso dispersa – rete di competenze che spesso è “allocata” in specialisti e operatori di vario genere: storici, sociologi, pedagogisti, operatori e mediatori culturali, insegnanti. Quella rete di alleanze culturali, di partnership individuali, che rende viva la percezione del ruolo della biblioteca nel circuito intellettuale di una città. Ma anche, assolutamente complementare, una capacità di costruire non solo relazioni stabili, ma tavoli di ascolto e confronto con i saperi delle aggregazioni sociali, delle istituzioni ed associazioni culturali, dell’associazionismo sociale. Oggi, in territori, in aree urbane abitate sempre più, a seguito dei recenti flussi migratori, da soggetti e culture diverse, come la biblioteca si pone davanti a un’identità sociale in trasformazione? Noi siamo partiti ormai otto anni fa, nel 1996, da un’ipotesi iniziale di scaffale multiculturale. I contributi di Vinicio Ongini, a partire da La biblioteca multietnica: libri, percorsi, proposte per un incontro fra culture diverse (Milano, Ed. Bibliografica, 1991), proponevano allora il livello più avanzato in Italia: rendere leggibili le differenze culturali di un territorio, dei soggetti, ma anche delle culture attraverso le raccolte delle biblioteche, individuando in questa scelta di fondo la necessità di una forte e naturale 186 Franco Neri collaborazione tra biblioteca e scuola. Di qui la ‘creazione’ dello scaffale multiculturale come tramite, attraverso le narrazioni, della varietà e ricchezza delle culture. Dovemmo andare presto oltre. Lo scaffale multiculturale si può benissimo realizzare anche in assenza di soggetti diversi, di cinesi, di pakistani, di senegalesi, di marocchini, o comunque in presenza di flussi migratori relativamente contenuti.3 Prato già allora rappresentava la seconda città della Toscana per numero di abitanti: nell’anno in cui sono stati aperti i servizi interculturali (aprile 1999), i residenti al 31.12.1999 erano 172.473, gli stranieri residenti 7.424. Ma i dati sui permessi di soggiorno, consultabili ed aggiornati periodicamente nel sito “Prato multietnica” (http://www.comune.prato.it/immigra), banca dati del Centro Ricerche e Servizi per l’immigrazione del Comune di Prato (Assessorato ai Servizi sociali), davano cifre che assai meglio si approssimavano alla realtà effettiva: in tutto il territorio provinciale 13.360 erano gli stranieri muniti, al 31.12.1999, di regolare permesso di soggiorno. Il passo ulteriore ha costituito l’integrazione ed il superamento, nella specifica realtà pratese, dell’orizzonte dello scaffale interculturale. Capimmo che dovevamo individuare i destinatari di questi servizi, cioè innanzitutto le comunità di recente immigrazione. La biblioteca pubblica, se vuole essere uno strumento di cittadinanza attiva, deve fare sì che il cittadino che proviene da altri territori vi possa trovare i testi nella sua lingua e vi trovi non soltanto i classici della letteratura, della filosofia, ma le pubblicazioni recenti della sua cultura e di quella europea tradotte nella sua lingua; quindi, per quanto riguarda la narrativa cinese, Acheng sicuramente, ma anche scrittori italiani ed europei, non solo i contemporanei, tradotti in cinese: anche Boccaccio in cinese, come classico della narrativa occidentale. Di questa scelta gli esiti sono: - la formazione di “microbiblioteche” in lingua (cinese, araba, albanese, urdu), per complessivi 2500 volumi (libri, riviste, corsi di lingua su cdrom e su cassetta), con nuclei oscillanti mediamente da 300 a 800 volumi; - la realizzazione di cataloghi specifici, in duplice versione per arabo e cinese (traslitterata e non); - la progettazione e costruzione di raccolte librarie, con il supporto di consulenti esterni, in modo da corrispondere alle differenziate esigenze delle comunità di riferimento; - servizi di informazione e mediazione culturale in modo da valorizzare le risorse ed i servizi della biblioteca e più in generale, nella sua funzione informativa e di orientamento alla città; 3 L’esperienza pratese è stata più volte, da allora, oggetto di confronto e discussione: al Congresso A.I.B. del 1999, da Franco Neri; al Seminario di Castelfiorentino. Cfr. Franco NERI – Lucia BASSANESE (a cura di), Biblioteche e intercultura, Atti del seminario (Castelfiorentino 26 novembre 1999), Firenze, Regione Toscana, 2001); in contributi della responsabile dei servizi interculturali, Lucia Bassanese, come La lettura per tutti, in “Percorsi di cittadinanza”, 2001, 11, pp. III e VIII, o nel recente volume collettaneo, curato dalla Commissione nazionale biblioteche pubbliche dell’Associazione Italiana Biblioteche Linee guida per i servizi multiculturali nelle biblioteche pubbliche, Roma,A.I.B., 2003. 187 L’esperienza della Biblioteca “Lazzerini” di Prato - attività formative e di alfabetizzazione informatica e linguistica; - la costruzione di un sito interculturale multilingue (italiano, arabo, cinese), “Babele: culture a Prato”. Per il “decollo” di tali servizi ed attività negli anni che vanno dall’apertura della Sezione multiculturale “Senghor” (1999) alle iniziative attuali (2004), la Biblioteca “A. Lazzerini” ha attivato molteplici processi di partnership, anche esterni al territorio: il progetto “Immigrati e territori” (Misura C4, F.S.E.), concluso alla fine del 2003, ha permesso di costruire il sito interculturale “Babele: culture a Prato”; di realizzare Circoli di studio di alfabetizzazione informatica (1° e 2° livello) per la comunità araba; di realizzare, con il Centro Ricerche e servizi per l’immigrazione e con la partnership del Liceo scientifico “F. Livi” di Prato, corsi di lingua per la comunità cinese ed una innovativa ricerca sui bisogni formativi, curata dalla sinologa Antonella Ceccagno, ora edita (Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora, Firenze, Giunti, 2003). Nella frequentazione dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzeriniana, nella molteplicità delle risorse rese fruibili, si è come rappresentato il processo di trasformazione della città: oggi ca. il 20% degli utenti della Biblioteca Lazzeriniana è costituito da cinesi, arabi, pakistani, albanesi, e le risorse documentarie ed informative, se rispondono innanzitutto ai bisogni delle comunità di recente immigrazione, “supportano” anche le necessità di docenti, operatori e mediatori e, più complessivamente, le domande di comprensione dei cittadini. La varietà dei supporti linguistici e culturali e delle forme di mediazione interculturale divengono fattori di “cittadinanza attiva” e la biblioteca uno degli strumenti di interazione reciproca fra la comunità locale e i nuovi soggetti. L’accreditamento della Biblioteca “A. Lazzerini” quale agenzia formativa si inserisce in questa linea di impegno: il sito interculturale in italiano, cinese, arabo; l’attività formativa; il catalogo in cinese ed arabo; il riconoscimento di Polo regionale di documentazione interculturale ne sono i più recenti prodotti. Tuttavia, quando una città cambia così profondamente, non basta lavorare soltanto sui servizi agli immigrati, bisogna lavorare anche su servizi che offrano a tutti i cittadini interessati l’opportunità di capire il cambiamento; la biblioteca diventa uno degli strumenti, sul piano culturale ed informativo, che la città ha per leggere e per leggersi dentro il cambiamento. In tal modo la biblioteca può essere un referente importante della pubblica amministrazione, delle aggregazioni sociali e culturali, degli operatori (insegnanti, mediatori culturali, facilitatori linguistici). Ho citato prima il Rapporto Caritas 2002, e la sua sottolineatura della complessità del fenomeno migratorio. A una realtà complessa deve corrispondere un modello complesso di servizi informativi e culturali. Complesso non vuol dire complicato: vuol dire articolato, capace di mettere in evidenza relazioni e nessi fra esperienze, guardando a più soggetti individuali e collettivi; vuol dire costruire un servizio percepito come utile e rispondente ai differenziati bisogni di lettura, sapere e comprensione delle comunità locali. Significa anche un modello: - trasversale rispetto all’organizzazione dei servizi della biblioteca: infor188 Franco Neri mativi, di orientamento, di prestito, formativi ed alle opportunità di relazione e scambio che questa offre, capace cioè di fare riflettere e crescere tutti gli operatori del servizio bibliotecari; - capace di interazione con altre strutture e servizi dell’Ente che, a diverso titolo, operano nell’area dei servizi alle comunità di recente immigrazione.4 Debbo anche riconoscere che qui si gioca la scommessa più difficile: la possibilità di una crescita integrata, attraverso processi formativi specifici, degli operatori. All’inizio degli anni ‘90 il Comune di Prato si è dotato di una struttura, il “Centro ricerche e servizi per l’immigrazione” che ha prodotto ricerche di notevole rilievo. Fra le ultime, entrambe edite da Franco Angeli, Migranti a Prato: il distretto tessile multietnico, a cura di Antonella Ceccagno (2003) e Giovani migranti cinesi: la seconda generazione a Prato (2004), della medesima autrice, ricerca sorta nell’ambito di un progetto biennale (“Migranti oltre la scuola dell’obbligo”) finanziato su risorse FSE, Misura C2 (Prevenzione della dispersione scolastica). In Migranti a Prato confluiscono le analisi degli esperti e ricercatori del Centro con il sapere e le riflessioni dei vari soggetti madrelingua, operatori e consulenti di sportello, integrata con l’esperienza complessiva del Centro nell’erogazione di servizi di consulenza, di formazione (corsi di lingua), di supporto (alle scuole), di orientamento. Le nostre raccolte sono nate con la collaborazione del “Centro ricerche e servizi per l’immigrazione”. Abbiamo un consulente straordinario di lingua araba, è un marocchino. Con noi ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con obiettivi diversificati: consulenza agli immigrati e mediazione culturale; consulenza allo sviluppo delle raccolte; catalogazione; promozione di circoli di studio e iniziative culturali e formative. La consulenza agli immigrati ha come finalità prevalente l’orientamento alle raccolte, ai servizi e alle risorse che complessivamente la biblioteca offre, e che non sono soltanto risorse documentarie, ma risorse ed opportunità per conoscere la città ed il territorio. Questa persona fa anche servizio di sportello per la comunità araba al “Centro ricerche e servizi per l’immigrazione”. Si tratta di unire, di far convivere, il momento dell’informazione e della formazione, che per noi è decisivo, con un più complessivo problema di orientamento alla città. 4 Sia concessa una autocitazione. Nella presentazione (p. 5-6) della citata ricerca di Antonella Ceccagno Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora ho avuto modo di scrivere:” Una lettura delle differenze è possibile solo attraverso un alto livello di integrazione e scambio fra i diversi soggetti coinvolti nell’area della comunicazione interculturale. Un esempio, fra i tanti. Quotidianamente ca. 80 migranti di diverse etnie, con larga prevalenza per quella cinese, araba e pakistana, frequentano la Biblioteca “A. Lazzerini”, ne utilizzano gli spazi, le risorse documentarie e informative, le opportunità culturali, di relazione e di formazione che offre. Vi è contiguità fra questi bisogni e quelli espressi altrove dai soggetti migranti, presso la FIL o il Centro Ricerche e Servizi per l’Immigrazione, il Centro territoriale permanente o il Centro per l’impiego? Quali bisogni di formazione, conoscenza, orientamento esprimono i migranti rispetto alle articolazioni sociali, culturali, economiche, educative del territorio? Quale confidenza hanno con tali strutture? Quali sono i punti di intersezione fra processi culturali, formativi e sociali? Per quanti sono coinvolti nella progettazione e gestione di percorsi formativi si apre un terreno enorme di cooperazione, in cui il capire e l’agire sono azioni da costruire sempre insieme”. 189 L’esperienza della Biblioteca “Lazzerini” di Prato La Biblioteca “Alessandro Lazzerini” non è più, dal 2001, soltanto servizio bibliotecario. Il servizio che dirigo si chiama “Sistema bibliotecario e delle Opportunità formative”, con il coordinamento dei progetti e delle azioni di Educazione degli adulti del Comune. Per la Biblioteca Lazzeriniana ciò ha voluto dire misurarsi con un orizzonte relativamente nuovo per le biblioteche pubbliche, con la formazione come momento strutturale del fare cultura. Notevole è stato l’impatto sul processo di crescita dei servizi interculturali. Abbiamo costruito e realizzato – come accennato precedentemente - un progetto, fra il 2001 ed il 2003, con la collaborazione del “Centro ricerche e servizi per l’immigrazione”, chiamato “Immigrati e Territorio“ articolato in tre nuclei fondamentali: a) corsi di Italiano L2 per la comunità cinese, in partnership con il Liceo scientifico”C. Livi” situato in un’area di forte concentrazione abitativa della comunità cinese. È da questo corso che è nata la ricerca di Antonella Ceccagno Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora; b) circoli di studio, all’interno della biblioteca, di Informatica (di base e avanzata) per la comunità araba; c) il sito interculturale multilingue “Babele: culture a Prato”. È con questo progetto che è stato fatto il salto di qualità e che i servizi hanno conosciuto una progressiva differenziazione. Circa il 20% dei nostri utenti sono immigrati. È un dato rilevante, che ha visto negli anni modificarsi la composizione dei gruppi che frequentano la biblioteca, con una più accentuata presenza di utenti arabi e pakistani. Tale dato tuttavia sale a quasi il 40% quando parliamo di utenti che utilizzano le postazioni Internet; la posta elettronica, per esempio, è uno dei servizi più utilizzati, così come la lettura dei quotidiani sulla rete o su supporto cartaceo. Il fondo urdu è di recentissima costituzione, per anni abbiamo incontrato difficoltà notevoli nell’acquisizione di libri in lingua urdu in Italia. Nonostante ciò, la stampa quotidiana da Internet del quotidiano in urdu «Daily Jang» ha permesso che si mantenesse, e anzi si sviluppasse un rapporto fra la biblioteca come luogo di lettura ed informazione, e la comunità pakistana. In tal modo la biblioteca, oltre che insieme di opportunità informative e culturali, è stata percepita come una delle risorse fondamentali per facilitare il rapporto con la città. Se la biblioteca viene vista come strumento accessibile in cui le richieste di informazione vengono accolte e valorizzate, può dispiegare la sua funzione di strumento di integrazione. La presenza di un nuovo pubblico ha reso necessario, in particolare negli ultimi due anni, l’organizzazione di corsi di aggiornamento del personale. Nell’ultimo trimestre del 2003 abbiamo promosso un corso di comunicazione interculturale trasversale ai diversi servizi dell’Ente coinvolti in attività di informazione agli immigrati (Biblioteca, Anagrafe, URP, Circoscrizioni, Servizi sociali) articolato in un primo nucleo comune, ed in uno successivo più direttamente rivolto ai bibliotecari, con l’intento duplice di favorire gli scambi (di conoscenze ed esperienze) e le relazioni fra operatori diversi, e di fornire ai bibliotecari strumenti 190 Franco Neri e metodologie per “ricollocare” i servizi interculturali in una nuova immagine della biblioteca pubblica. Il corso non è stato un successo. I tempi per una integrazione fra operatori diversi sono più lenti di quanto, illuministicamente, forse, non avessimo presunto: la condivisione degli obiettivi e delle azioni formative conseguenti deve essere sempre attentamente preparata, e resa preventivamente chiara negli intenti ai destinatari. Nella progettazione dei servizi, anche di quelli tecnici, è stata posta una particolare attenzione sia alla dimensione comunicativa che alla rispondenza e fruibilità degli strumenti rispetto al pubblico degli immigrati. Così è per il catalogo, il primo in Italia da dicembre 2002 a rendere possibile un duplice livello di “lettura” dei fondi in arabo e cinese: mediante la consultazione della notizia bibliografica traslitterata oppure in caratteri arabi e cinesi. L’OPAC, nella versione pratese del software EasyWeb, permette di disaggregare tutti i fondi della biblioteca, con la possibilità di vedere non solo tutto quello che la biblioteca ha, ma anche tutto quello che la biblioteca possiede in un fondo particolare. In tal modo le risorse documentarie interculturali possono essere lette e disaggregate nei contesti più vari e secondo le chiavi di ricerca prescelte (autore / titolo / titolo tradotto in italiano / classificazione …). L’altra grande iniziativa è stata la costruzione del sito multilingue (italiano, arabo, cinese) “Babele: culture a Prato”, che ci ha visti impegnati per oltre un anno e mezzo. Il sito (Babele.po-net.prato.it) è strutturato in cinque sezioni: 1) Città multietnica, con informazioni sulle cultura e comunità araba e cinese, e sulle tradizioni del territorio. La sottosezione dedicata alla cultura araba è tradotta anche in cinese, e viceversa; analogamente sono tradotte le parti relative alle tradizioni del territorio, al fine di favorire processi di interazione e conoscenza della storia e realtà locale. 2) Nella sezione Cultura e formazione è possibile vedere quali sono le opportunità di aggiornamento e di formazione rivolte agli immigrati, e segnalati alcuni progetti interculturali delle scuole. 3) La parte Diritti e doveri significativamente porta il sottotitolo “Soggetti immigrati e servizi locali”: intorno ad alcune voci tematiche (Bambini / Casa / Donne / Lavoro /Scuola e formazione), sperimentalmente, segnala e riaggrega informazioni di vario genere recuperabili sia nella rete Po-net che nel Web. 4) La quarta sezione, Biblioteca A. Lazzerini, ne descrive i servizi e le risorse, con una guida alla consultazione ed uso del catalogo. 5) La quinta sezione, Risorse rete, contiene, fra l’altro, due importanti sitografie ragionate (rispettivamente tradotte in arabo e cinese) sulla cultura araba e cinese. Complessivamente “Babele” è stato pensato come risorsa utilizzabile in contesti diversi: presso la biblioteca o dalle postazioni pubbliche collegate alla rete civica nelle scuole e in luoghi diversi della città sino ai corsi per adulti. Da poco meno di un anno la Biblioteca “Lazzerini” è diventata Polo regio191 L’esperienza della Biblioteca “Lazzerini” di Prato nale di documentazione interculturale. In questo, come si legge nella presentazione del progetto sul sito della Regione Toscana, “[…] la Biblioteca Comunale di Prato colloca in un contesto cooperativo, di ricerca di soluzioni e di strumenti condivisi, la propria maturata e adeguata esperienza in ambito interculturale”. La convenzione con la Regione Toscana (è in corso di definizione la convenzione triennale) ha definito gli ambiti di intervento: SVILUPPO DELLE RACCOLTE E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI Consulenza nella formazione delle raccolte, nell’organizzazione dei servizi, nell’acquisizione di testi, nelle procedure di catalogazione, per quanto riguarda la lingua araba e cinese. PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA Prestito interbibliotecario dei documenti appartenenti alla biblioteca specializzata del Polo (con forte presenza di testi e ricerche nelle principali lingue europee) nelle aree dell’analisi dei processi migratori, della didattica interculturale e apprendimento linguistico, della mediazione linguistica e culturale. SITO INTERCULTURALE “BABELE” “Babele” (http://babele.po-net.prato.it) è un sito multilingue (in italiano, arabo e cinese) dedicato alle diverse culture e tradizioni che si confrontano nel nostro territorio toscano. È anche un valido strumento per la circolazione della documentazione di esperienze, la segnalazione di letteratura grigia, l’ospitalità di recensioni FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Aggiornamento e formazione di bibliotecari nell’area dei servizi interculturali L’indagine sul fabbisogno di formazione e di servizi interculturali dei bibliotecari toscani, realizzata dalla Biblioteca Lazzeriniana fra dicembre 2003 e gennaio 2004, ha permesso di definire un corso di formazione di base per i bibliotecari che si svolgerà in autunno 2004. Come si vede, si tratta di un processo in rapida crescita. L’orizzonte del Polo regionale da un lato, l’esperienza maturata con i progetti comunitari ed una crescente attenzione alla rilevazione dei bisogni ed alla trasversalità dei servizi dall’altro, stanno modificando l’esperienza pratese. È cresciuto uno staff specifico, si sono consolidate relazioni e collaborazioni. In questo percorso di crescita molti devono essere ringraziati. Una innanzitutto, la responsabile dei servizi interculturali, Lucia Bassanese, che ha profuso passione, pazienza, intelligenza nella tessitura di relazioni e nell’approfondimento di innovative soluzioni tecniche. A lei e a tutti coloro che ci hanno accompagnato con partecipazione un grazie di cuore. 192 Franca Pinto Minerva Intercultura e diritto alla differenza di Franca Pinto Minerva 1. L’emigrazione: tra identità e alterità Il nomadismo dei popoli - ma anche di pensieri, di parole, di idee, di immagini, di sogni e di valori - contrassegna da sempre i percorsi della storia. Le migrazioni alla ricerca di migliori condizioni di vita - di terre più fertili, climi più miti, lavoro più sicuro - alla ricerca di accoglienza e ospitalità dopo la fuga da Paesi in guerra o da regimi autoritari e totalitari sono un evento connaturato alla storia dell’umanità che, tuttavia, si presenta oggi con i caratteri di una particolare emergenza. Viaggi, spostamenti, emigrazioni determinano un profondo rimescolamento fra le popolazioni. Ai colori, alle parole, alle forme, ai suoni familiari si aggiungono, intrecciandosi, i colori, le parole, le forme, i suoni diversi e inusuali delle culture altre. Le differenze si moltiplicano, rompono schemi consolidati e alimentano occasioni di confronto e di scambio. Emerge, in tal modo, un quadro complessivo e articolato in cui le molteplici identità etniche, culturali, religiose, politiche e linguistiche delineano configurazioni inedite, prezioso motivo di crescita e arricchimento culturale. Ospitanti e ospiti scoprono l’alterità: un’alterità che spesso conoscevano o intuivano, ma che era “lontana” e, pertanto, cognitivamente e emotivamente controllabile. Una “alterità” che spesso, vivendola così ravvicinata, determina vissuti di disagio e, talvolta, di aperto conflitto. Avviene così che paradossalmente la straordinaria ricchezza che gli intrecci di culture e lingue diverse sollecitano, possano produrre imprevedibili vissuti di ostilità che si traducono talvolta in forme inaccettabili di intolleranza e di discriminazione nei confronti di coloro che si discostano, per un verso, dai propri modi di vita e di pensiero. Si tratta di forme di rifiuto che chiamano in causa il rischio a cui sempre apre il rapporto con ciò che è “altro” rispetto al proprio bagaglio di esperienze, conoscenze, convinzioni, emozioni, relazioni. La quota di rischio che tale pensiero implica è tutta nelle incognite che sempre accompagnano il viaggio in territori sconosciuti. L’incontro con la differenza prevede sempre la scoperta di aspetti non conosciuti e, in parte, inconoscibili. Lontano dal proprio apparato conoscitivo, valoriale ed emozionale, infatti, si pongono da un parte, quegli insiemi di conoscenze, valori ed emozioni che non 193 La pedagogia dell’intercultura conosciamo né condividiamo ma che, tuttavia, appaiono suscettibili di conoscenza e di condivisione; dall’altra parte, quegli strumenti di conoscenze, valori ed emozioni che non conosciamo né condividiamo e che risultano inattingibili dalle nostre possibilità di conoscenza e condivisione, costituendo il limite intrinseco che ogni esperienza dell’altro da sé sempre presenta. Ambedue i tipi di “differenza” richiedono la capacità di tollerare l’ansia dell’ignoto, declinandola su diversi versanti di un alto impegno euristico (il primo tipo di differenza) di disposizione ermeneutica rispettosa dei propri limiti (il secondo). 2. Il nuovo concetto di cittadinanza Nel quadro appena tracciato, saper pensare – e costruire – le differenze significa saper “essere in transito”, essere disponibili a oltrepassare le frontiere, allontanarsi dalle sicurezze di percorsi noti e sperimentati per inoltrarsi in sentieri sconosciuti e, proprio per questo, ricchi di imprevedibili sorprese. Occorre ripensare, in forma rinnovata, il concetto di cittadinanza, che sappia valorizzare la positività delle differenze senza dimenticare l’importanza della costruzione di un senso di appartenenza comune. Occorre, pertanto potenziare e valorizzare la storia delle interazioni dei popoli costruendo il concetto di appartenenza proprio sulla logica degli scambi, degli innesti e dei rimescolamenti, agendo in tal modo sulla costruzione di un pensiero attento alle condivisioni, agli intrecci e ai pluralismi anziché alle separazioni e alle distanze. Per avviare questa vera e propria rivoluzione culturale occorre partire da un principio fondamentale solo apparentemente scontato: e cioè che l’altro è, comunque e sempre, uomo come noi e che nella reciproca diversità è possibile scoprire l’uguaglianza, riconoscendo se stesso nell’altro e l’altro da sé. L’affermazione che riconosce nella comune umanità il fondamento dell’uguaglianza degli uomini può rappresentare, in tale prospettiva, il punto di partenza per una pratica di colloquio e di dialogo in grado di osteggiare i contrapposti meccanismi di discriminazione e di assoggettamento di altri “uomini come noi”. Né, d’altro canto, va dimenticato che l’identità del singolo non è unicità, bensì – come già detto – ciascuna individualità deve fare i conti continuamente con l’alterità che è in essa, quella alterità che spesso è vissuta come “straniera”: la parte inconscia, la “dimensione sommersa”, identificabile con il magma non codificabile delle pulsioni di vita e di morte, di desideri inconsapevoli, di rimozioni e di ricordi. Rispetto a tale conflittuale presenza, all’io è affidata la complessa e problematica funzione di mettere dialetticamente e dinamicamente in contatto tra loro la parte cognitiva con quella emotiva, il conscio con l’inconscio, il razionale con il pulsionale, la logica e la fantasia, la mente e il cuore. L’autonomia e la ricchezza delle differenti “voci” dell’io sono nella sua possibilità di guardare e leggere la realtà a partire da ipotesi interpretative molteplici e diverse, di confrontare tali molteplici forme di lettura – cognitiva, etica ed estetica – 194 Franca Pinto Minerva e di accorgersi che “più sguardi” e “più voci” interpretative ci rimandano della realtà un’immagine molto più articolata e complessa, più inquietante ma, al tempo stesso, più avvincente e suggestiva. La difficile ma indispensabile mediazione tra il senso di appartenenza, di radicamento a un gruppo e a un territorio e l’apertura ad altri luoghi e ad altri soggetti trova, come già detto, nella revisione del concetto di cittadinanza proprio il suo snodo principale. Si tratta, allora, di elaborare il modello di una nuova cittadinanza sociale e politica, ma soprattutto, etica, in quanto capace di dare principio, forma ed attuazione ai valori del pluralismo e della democrazia. È, pertanto, indispensabile ripensare e rivedere dalle radici la teoria e la pratica della cittadinanza, utilizzando e potenziando il filo rosso che lega la dimensione dei principi (formalmente sanciti nelle Costituzioni dei vari Stati e delle Confederazioni di Stati, come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) con quella dei fatti concreti, a partire, ad esempio dalla diffusione di pratiche di inclusione agevolata degli immigrati piuttosto che della loro esclusione o criminalizzazione. Il ripensamento e la revisione del concetto di cittadinanza partono dalla necessità di mettere in crisi il concetto di cittadinanza identità chiusa, autocentrata e autoreferenziale, proponendo, anche per essa, il concetto di identità multipla. 3. Pensiero nomade e migrante L’incontro con l’alterità – l’incontro con altre storie, con altre logiche e con altre lingue – comporta la disponibilità – sulla base del confronto – a cambiare concetti, idee, opinioni, modi di pensare e di essere, ipotesi e versioni del mondo ritenute certe, sicure e infallibili e che, in quanto tali, rischiano di rinchiudere il pensiero nella gabbia dell’intolleranza e del pregiudizio. Nasce e si diffonde, in tal senso, l’idea di promuovere un decentramento cognitivo in grado di operare il passaggio da una prospettiva “multiculturale” ad una prospettiva “interculturale” in cui realizzare un’integrazione dinamica di culture disposte a incontrarsi e a confrontarsi, a scambiarsi punti di vista, a prestarsi vicendevolmente parole, ipotesi, fantasie, utopie, ad aggiungere ai propri simboli quelli di altri sistemi culturali. Se l’interculturalità consiste nella disponibilità ad “uscire” dai confini della propria cultura per “entrare” nei territori mentali di altre culture, un progetto di educazione interculturale comporta come obiettivo fondamentale, lo sviluppo di un pensiero aperto e flessibile, problematico e antiodogmatico. Un pensiero capace di allontanarsi dai propri riferimenti cognitivi e valoriali per dirigersi verso quelli di altre culture, per scoprire e comprendere le differenze e le connessioni, capace, inoltre, di “tornare” nella propria cultura arricchito dall’esperienza del confronto e, pertanto, in grado di riconoscere e valutare con maggiore consapevolezza critica la 195 La pedagogia dell’intercultura propria specificità nei suoi aspetti di positività e negatività. Essere portatori di intercultura, infatti, significa essere disponibili a far parte di più culture senza tradire la propria, anzi arricchendola e moltiplicandone – con il contatto e il confronto, con le interferenze e i prestiti – le potenzialità evolutive e creative. Significa avere chiara consapevolezza dei caratteri storici e dinamici della propria e dell’altrui cultura, degli elementi di ricorrenza e di trasformazione, degli aspetti di complessità, di processualità e di interazione che collegano culture diverse, le distanziano e le differenziano ma anche le unificano e le integrano. Tutto ciò significa imparare a usare quel potenziale creativo di cui il pensiero umano è sempre dotato (anche se in misura diversa da soggetto a soggetto) e che rischia di disperdersi e cristallizzarsi per il prevalere unidimensionale del pensiero convergente, lineare, chiuso e assiomatico. La creatività, infatti, legata all’azione del pensiero divergente, chiama in causa la capacità di generare processi di trasformazione e cambiamento, di uscire dalla monotonia del ripetitivo, di affrontare il disordine e dar vita a un nuovo ordine. In questa prospettiva, essere creativi significa essere in grado di errare tra le lingue, di usare parole, immagini, idee, pensieri, emozioni in forma inedita e originale, di elaborare il conflitto con l’alterità in modo produttivo, di scoprire – attraverso l’apporto della divergenza e della differenza – la possibilità di progettare mondi nuovi e diversi, di lasciar emergere e di saper accedere ad inindagate e originali prospettive interpretative della realtà, capaci di ristrutturare quelle esperienze di problematicità che caratterizzano la nostra esistenza. 4. Il ruolo della scuola L’educazione alla differenza e al pluralismo comporta un costante tirocinio percettivo, sensoriale, intellettuale, emotivo e relazionale, alla scoperta delle mille diversità che oggi arricchiscono le nostre città, le nostre scuole, i nostri luoghi di lavoro e dello svago. Un tirocinio che va sperimentato innanzitutto a scuola, luogo privilegiato e specializzato della formazione, anche quando non sono presenti bambini stranieri, proprio perché è la disponibilità, intellettuale ed emotiva a riconoscere e a rispettare le differenze in qualche modo più vicine a noi – differenze tra bambino e bambina, tra adulto e bambino, tra le persone, gli animali e le piante – che può significativamente estendersi a coloro che sono diversi da noi per il colore della pelle per il suono della lingua. La molteplicità di esperienze educative condotte a scuola consente di sperimentare situazioni e occasioni di educazione alla “diversità” , “con” la diversità e “attraverso” la diversità, divenendo un insostituibile “laboratorio” di ricerca sulle differenze, assunte come preziose risorse per ripensare il rapporto tra l’orizzonte unitario e comune della solidarietà planetaria e la pluralità dei modi di pensare e di abitare la terra. Alla scuola è affidato, in tal senso, il difficile compito di promuovere il passaggio da un pensiero autocentrato e monolitico a un pensiero nomade e migrante, 196 Franca Pinto Minerva con cui imparare a coniugare vicino e lontano, particolarità e universalità, a difendere l’autonomia intellettuale, a contrastare la dipendenza e l’uniformazione, a contribuire all’elaborazione di un progetto comune di superamento e di rimozione delle vecchie e nuove forme di intolleranza e di discriminazione. In una fase storica in cui le nostre coste e le nostre città sono diventate meta di intere popolazioni migranti, l’educazione interculturale realizzata a scuola si pone come irrinunciabile priorità per trasformare un evento carico di possibile conflittualità in un’irripetibile opportunità di analisi e riflessione sui limiti della monocultura e dell’etnocentrismo e per porre le basi di una storia comune e solidale. A tale scopo, essa si propone di esplorare i livelli di possibile distinzione e complementarietà, di interazione e di integrazione, tra lingue e culture considerate talora incompatibili, non confrontabili né coordinabili. Tra le culture, al contrario, esistono distinzioni che non implicano dissociazioni ma che anzi rimandano a connessioni, confronti e scambi. L’intercultura esprime dunque un concetto dinamico, in quanto presuppone la capacità e la volontà di promuovere situazioni di analisi e comparazioni di idee, valori, culture differenti alla ricerca di “intese” e di punti di incontro che non annullino le differenze ma, al contrario, le esaltino, attraverso un intreccio dialettico di scambi necessari per il reciproco riconoscimento. Tali scambi comportano, da parte dei popoli accoglienti e di quelli ospitanti, un duplice impegno. Il primo assume come obiettivo il superamento di ogni etnocentrismo, il confronto, la conoscenza reciproca e la comunicazione costante. Partendo dalla comprensione delle “uguaglianze” e delle “diversità” che accomunano e contraddistinguono le differenti culture, diventa, infatti, possibile comprendere la relatività dei propri punti di vista e, quindi, la necessità di decentrarsi. Il secondo impegno assume l’obiettivo di ampliare il raggio di profondità di tale processo di relativizzazione cognitiva, contro ogni pregiudizio sociale nei confronti di tutte le forma di diversità (cognitiva, sociale, comunicativa, affettiva ed esistenziale). Questo modello di educazione interculturale, ulteriormente elaborato e problematizzato in seguito all’ “emergenza immigrazione”, rappresenta oggi una straordinaria occasione per sperimentare l’intero processo educativo nei termini di formazione alla convivenza democratica, una sorta di traguardo “ermeneutico” da estendere all’intera dimensione educativa, intesa come formazione di persone e di personalità la cui identità si struttura e “si fa” attraverso la disponibilità alla relazione con l’altro nella sua complessità umana, culturale e storica. In tal senso, la dimensione interculturale si pone come obiettivo irrinunciabile della formazione, indipendentemente e al di là della presenza a scuola di bambini e ragazzi stranieri. Ancora, l’interculturalità può rappresentare il significativo compendio di una molteplicità di dimensioni formative che rinviano a valori comuni e condivisi come il riconoscimento dei diritti umani e l’educazione alla pace, il rispetto delle differenze e del pluralismo, l’educazione all’ascolto e alla cura dell’altro. 197 La pedagogia dell’intercultura RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Di Franca Pinto Minerva: Identità plurali: la sfida della formazione, in Interground. Guidare e studiare l’intercultura, IRRSAE PUGLIA, 1996. L’Intercultura, Laterza, Roma-Bari 2002 Educare al pensiero della differenza, in Franca PINTO MINERVA - Maria VINELLA (a cura di), Pensare la differenza scuola, Progedit, Bari 2003 198 Angelo Sante Trisciuzzi Egnazia, ponte tra l’Italia e l’Albania di Angelo Sante Triscuzzi Nel 2001 partecipai a Bari al seminario in materia di promozione della gestione delle biblioteche delle comunità del cosiddetto Corridoio 8 e intitolai il mio intervento come il dilemma di Don Abbondio nei Promessi Sposi: “Carneade: chi era costui?”. E così il mio breve contributo ebbe come oggetto Scanderbeg e Manzoni. Chi sono costoro? Per noi tutti Manzoni non ha bisogno di alcuna presentazione; parlare di Scanderbeg forse ai più risulterebbe meno facile. Per un qualsiasi albanese sarebbe la stessa cosa, basterebbe invertire i cognomi; per loro, infatti, Scanderbeg è il personaggio più famoso, il più amato di tutta l’Albania, è l’eroe nazionale, quasi più del nostro Garibaldi, del nostro Cavour, del nostro Vittorio Emanuele II. Nel 1998, nell’ambito del Congresso nazionale dell’A.I.B., coordinai una tavola rotonda dal titolo: “Mediterraneo: biblioteche senza confini”. Fu per me sorprendente apprendere dalla voce di un collega siciliano che a Mazara del Vallo, un comune marinaro dove gran parte della manodopera è tunisina, il quartiere più antico, quello prospiciente il porto e quasi del tutto abbandonato dai mazaresi, era stato occupato quasi totalmente dai tunisini che vi avevano instaurato una nuova Casba con nuove regole e dove la stessa polizia italiana poteva entrare con molta difficoltà. Quella parte antica di Mazara era diventata un piccolo paese nella grande città marinara e la stessa istruzione dei ragazzi, nei primi anni dell’immigrazione, non era stata effettuata dallo Stato italiano ma da quello tunisino che vi inviava un suo maestro ogni anno. Una comunità, in verità numerosa, che si era inserita in un’altra comunità senza adeguarsi né alle nuove regole, né agli usi locali. Questa notizia per me fu sorprendente perché nella nostra Puglia, terra di forte immigrazione per tanti albanesi arrivati dagli anni ’90 in poi, nulla di simile era capitato. D’altronde gli albanesi non avevano un governo che continuava a seguirli. Ma guardiamola questa comunità albanese, a noi così vicina e non solo in termini geografici: il popolo albanese discende dagli Illiri che sono presenti sul versante occidentale dei Balcani fin dall’Età del Bronzo, terzo millennio a.C.. I Romani chiamarono Illiricum l’intera regione anche se il nome faceva rife199 L’immigrazione nel bacino del Mediterraneo rimento all’antica Scodra, oggi Scutari; tra la fine dell’Età del Bronzo e l’inizio di quella del Ferro, gli Illiri sono presenti anche in Puglia con il nome di Iàpigi o Iàpidi da cui Iapudia, Apudia, Apulia, Apuliae e di questo ceppo fanno parte anche Dauni, Peucezi, Messapi. La loro presenza in Puglia determina un sostanziale cambiamento nella cultura locale, e ne è testimone la lingua messapica, che nel Salento deriva dall’antico illirico. Molte espressioni messapiche, contenenti nomi propri di persone e di luoghi, permettono di costruire ancora oggi parentele anche con l’albanese moderno che discende direttamente dall’antico illirico. Un esempio può essere il nome Brundisium, Brindisi, il porto che il geografo Strabone descrive come le corna di un cervo e che trae origine dal greco brendon, appunto, cervo; il termine è molto simile a quello albanese bri - ni, che significa, corno. Nell’Eneide Virgilio racconta una leggenda sulla nascita della città albanese di Butrinto, che sarebbe nata al tempo della distruzione di Troia. Butrinto infatti, quasi nuova città di Troia, sarebbe stata fondata da Eleno, figlio di Priamo che condotto schiavo in Epiro dal figlio di Achille, Pirro, dopo la morte del padrone sposò Andromaca, vedova di Ettore. Enea nel suo viaggio verso l’Italia, partito proprio da Butrinto salutò il suo re con queste parole: “ Se entrerò mai nel Tevere, nei campi che esso bagna e vedrò la città promessa alla mia gente, faremo si che l’una e l’altra Troia, l’italica e l’epiriota, Butrinto e Roma, congiunte da tanto tempo per sangue, discendenti da Dardano entrambe, siano una sola Troia nel più profondo del cuore: spetta ai nostri nipoti mantenere l’impegno”. Così raccontava Virgilio, ma quei nipoti della leggenda riportata da Virgilio, potremmo essere noi? Al tempo dei Romani l’Illiria, e quindi tutto il territorio albanese, venne da loro controllata e fu una dominazione che ha lasciato ampie tracce sul territorio e nella lingua. I Romani in quella terra vi costruirono anche la via Ignazia ed il nome è quello dell’importante città di Egniatia o Gnatia, vicino Fasano, la mia città, dove una derivazione della via Appia, la Traiana, tra Roma e Brindisi toccava quella città e perciò il mare. La via Egnazia, costruita in Albania, divenne a quel tempo la principale strada di comunicazione che univa Roma all’Oriente. I contatti tra l’Italia e l’Albania, perciò, sono stati sempre molto stretti, né finirono con i Romani, anzi si apprende con grande meraviglia che Carlo D’Angiò, molti secoli dopo, per restaurare il castrum di Durazzo, il castello, ricorre a quattro fabricatores che venivano da Monopoli. La storia più recente, in particolare quella della fine del Novecento, la richiamo solo per un dato generico: gli albanesi in Puglia, ma anche kossovari, macedoni, curdi, marocchini, algerini, senegalesi - e molte altre etnie- sono tantissimi, e quasi mai le strutture culturali e locali hanno fatto qualcosa per loro, per la loro lingua, per la loro cultura, per le loro tradizioni. Qualche incontro è avvenuto, ma quasi mai in maniera profonda e duratura. Non credo che sia mai nata alcuna associazione, per esempio, tra gli abitanti di Scutari e tutti gli scuteresi abitanti in Puglia o nel resto d’Italia. 200 Angelo Sante Trisciuzzi Un’associazione simile noi ce l’abbiamo nelle nostre terre, a Fasano: i fasanesi di Montana, in Svizzera, hanno costruito un’associazione; ma ci sono altri esempi. I polignanesi di San Paolo del Brasile hanno fatto la stessa cosa e sicuramente anche nel foggiano ne esisteranno altre. Negli ultimi tempi si è parlato molto dell’immigrazione e anche dell’integrazione culturale di queste popolazioni che hanno raggiunto le nostre terre, e molte biblioteche hanno realizzato corsi di lingua, hanno acquistato vocabolari per poter meglio tradurre parole straniere, sono nate sezioni specializzate con testi stranieri, ma tutto in maniera estemporanea e senza un progetto globale che coinvolgesse anche le Istituzioni. Il progetto Kirikù, che non conoscevo, sicuramente, entra in questa ottica e raggiunge i risultati prefissati; ma è importante considerare un altro dato che caratterizza la nostra Italia, che nell’immaginario collettivo è sempre stata terra di emigranti e che oggi è divenuta meta stabile e talvolta definitiva di molti immigrati. I dati ministeriali in materia di alunni di cittadinanza non italiana nelle scuole italiane di ogni ordine e grado: alla fine degli anni ‘80 davano una presenza di circa 16.000 studenti, alla fine degli anni ‘90 erano oltre 63.000 e la Puglia, con tutte le sue comunità, continua a ricevere stranieri provenienti dal mare, un mare che può essere portato all’antico concetto del mare nostrum, mare antico, mare amico. Cominciamo a guardare il nostro Adriatico come elemento che unisce e non che divide; per sentirci uniti dobbiamo conoscere, conoscerci, e per fare questo possiamo utilizzare il libro, un libro, un libro come unione o come conoscenza portando in ogni biblioteca dei paesi dell’Adriatico o del Mediterraneo gli elementi della nostra cultura, portare in ogni biblioteca della nostra Puglia gli elementi della cultura di quei popoli e tutto magari in lingua originale. Favorire la conoscenza di nuovi autori, offrire opportunità di sviluppo attraverso lo scambio culturale. E la biblioteca, anche attraverso le nuove tecnologie, deve tornare ad essere il luogo degli incontri, il luogo del dibattito, il luogo delle conoscenze. Possiamo cominciare con l’Albania, gemellando le biblioteche ed attraverso esse, scambiare le esperienze, scambiare i libri e le conoscenze, riprendere quel discorso annunciato da Virgilio di unire due popoli fratelli. E per noi bibliotecari questo è possibile, perché il nostro linguaggio si è sempre basato e si basa sui grandi valori della cultura, della pace, del progresso civile e del progresso sociale. 201 202 Carine Bizimana Immigrazione e integrazione di Carine Bizimana Sono un’operatrice sociale della cooperativa “Xenia”, una cooperativa nata tre anni fa dopo un progetto europeo dell’Amministrazione Provinciale di Foggia che faceva parte del programma “Integra” e nella quale lavorano i rappresentanti di cinque diverse nazionalità. In questo progetto un gruppo di italiani e stranieri hanno dato vita ad un centro di informazione e di consulenza agli immigrati. Ovviamente per noi stranieri non solo era innovativo ma era una grande occasione: per la prima volta ci vedevamo riconosciuti sul territorio foggiano, per la prima volta ci veniva data la possibilità di incontrarci, di confrontarci e di iniziare un cammino unico perché gli stranieri per la loro storia, per la loro esperienza si legano tra loro, portano con sé la propria cultura e la condividono con gli altri. Da straniera devo dire grazie alla città di Foggia perché siamo stati accolti in modo diverso. Se consideriamo la situazione italiana, Foggia è da poco impegnata in questo campo, anche se in passato era terra di emigrazione; oggi è chiamata a fronteggiare un’emergenza continua. Però grazie alla sensibilità, all’impegno delle parti politiche e soprattutto al mondo della scuola, si sta lavorando per cercare di preparare un terreno per i nostri figli. Si parlava di prima generazione di immigrazione di cui facciamo parte io e i colleghi della cooperativa; questi colleghi hanno dei figli, e siamo già alla seconda generazione. Si è parlato molto della realtà albanese, perché la comunità albanese è numerosa e più conosciuta, ma chi conosce i numeri dell’immigrazione, conosce molto bene la realtà marocchina che è stata la prima realtà presente a Foggia insieme alla realtà Rom. La cooperativa “Xenia” continua a lavorare e fa di tutto per migliorare; siamo riusciti a realizzare un sogno: mettere su un centro interculturale, creato e animato da persone che hanno un gran cuore. Non abbiamo una struttura tranne quella de “ilDock”, che ci ha aperto le porte e ci permette di lavorare, ma portiamo fuori le nostre conoscenze, la nostra metodologia. Purtroppo in Occidente siamo abituati a vedere l’immigrazione in un certo modo, legata al periodo della colonizzazione in cui bisognava civilizzare i popoli, all’immagine delle missioni che hanno portato aiuto nelle mie zone; e ora, quando si parla di immigrazione, la gente pensa alle persone che arrivano e non riesce ad andare al di là di questa idea, non riesce a vedere quello che lo straniero ha dentro di sé e dietro di sé. 203 Immigrazione e integrazione Perché lavoriamo con la scuola? Chi conosce un po’ meglio la cultura africana, sa quanto noi africani teniamo all’educazione del racconto. C’è, nel mio paese, il mito dell’albero, il mito del saggio, l’anziano della comunità, del villaggio che ogni sera racconta ai più piccoli una storia, una favola, una fiaba; ed è questa l’educazione della tradizione orale dei paesi che per tanti anni non hanno conosciuto la scrittura. Soltanto il racconto del nonno ha fatto crescere tante generazioni e ha educato alle tradizioni e alla storia di un popolo. Per questo, nel nostro centro di informazione partiamo proprio con l’informazione e la formazione, con la metodologia del racconto, una metodologia interattiva. Quando uno straniero arriva in un paese che non è il suo, è importante che venga riconosciuta e rispettata la sua dignità, la sua identità di straniero; è necessario accoglierlo e dargli la possibilità di esprimersi. È normale che la prima cosa di cui ha bisogno è un piatto caldo, un tetto. Ma se quegli stranieri, in quel momento, potessero essere accolti nella loro lingua, creando subito un rapporto di fiducia, ci sarebbe più comunicazione e meno paura. La Biblioteca Provinciale di Foggia nel momento in cui ha messo su il centro di documentazione multimediale, ha avuto bisogno di preparare delle bibliografie. Devo ammettere che in un primo momento come cooperativa abbiamo avuto delle difficoltà, perché vivevamo nell’emergenza quotidiana ed era difficile avere materiale pronto. Ad un certo punto io, non soddisfatta di comprare soltanto libri, ho avuto la possibilità, grazie alla dottoressa Fatigato, di leggere alcuni obiettivi dell’IFLA, la Federazione internazionale dei bibliotecari, in cui si parlava di rimuovere ogni barriera, di individuare delle comunità, di raccogliere, di offrire servizi, di favorire la partecipazione. La scuola è il primo luogo in cui i bambini stranieri riescono a sentirsi “bambini normali”; allora abbiamo cominciato a lavorare con un gruppo di circa cinquanta insegnanti che hanno partecipato alla prima fase del Progetto “Kirikù”, che prevedeva sette sessioni molto impegnative. Sette sessioni di formazione durante le quali abbiamo affrontato tutte le tematiche anche se in maniera un po’ superficiale, tutto quello che riguardava la comunicazione interculturale, l’approccio interculturale e i mezzi di comunicazione. 204 Franco Mercurio Una premessa per le Linee Guida della Biblioteca Provinciale di Foggia di Franco Mercurio Quando ai principi del 2000 cominciammo coralmente a riflettere sulla nostra biblioteca ci rendemmo conto che la spinta propulsiva degli anni Settanta si era affievolita anche perché il tentativo di Angelo Celuzza di sganciare la Provinciale dalle “tirannie” del territorio non era approdato a buon fine. La nuova Biblioteca Provinciale di Foggia aveva l’ambizione di diventare essenzialmente il centro ed il motore di una rete che aveva i suoi snodi nelle biblioteche civiche dei piccoli comuni e nelle biblioteche di quartiere della città capoluogo. Il sordo silenzio di Foggia sul progetto di un sistema bibliotecario urbano in grado di soddisfare la domanda di primo impatto sortì un risultato completamente inedito. La Biblioteca Provinciale si stava, anche contro la sua volontà, radicando ancora più fortemente al territorio urbano fino ad assumere nel breve volgere di un decennio la funzione di public library cittadina. Il “peso” dell’utenza urbana, insieme ad una sostanziale fine del primigenio Sistema Bibliotecario Provinciale, finirono naturalmente per sfigurare la fisionomia originari. Le Linee Guida, che giungono a maturazione nel 2002, sono il frutto di questa analisi e della conseguente riflessione del ruolo della Biblioteca di Foggia nel XXI secolo. Se è vero che ogni biblioteca è irripetibile, perché è il precipitato della comunità in cui si inserisce e con cui interagisce, a maggior ragione era giunto il momento di prendere atto che la Biblioteca Provinciale di Foggia era ciò che i foggiani avevano voluto che diventasse: la loro public library. Occorreva a quel punto riconsiderare la fisionomia, ricontrattare la mission, immaginare in sostanza il futuro di questo organismo che si evolve e si relaziona con il territorio. Non era una questione di facile soluzione. La storia della Biblioteca Provinciale di Foggia aveva restituito una ricca biblioteca di conservazione con una fantastica collezione locale, pugliese e meridionale. Lo sforzo degli anni Settanta aveva sedimentato a sua volta l’aspetto della public library attraverso l’aspetto più appariscente: lo scaffale aperto. Cinque generazioni di studenti si sono formate nelle sale a scaffale aperto della “Provinciale”. Una intera generazione di cittadini aveva interiorizzato anche questo aspetto della fisionomia della Biblioteca di Foggia. Era normale che fra noi bibliotecari si accendesse il dibattito su quale orientamento 205 Una premessa per le Linee Guida della Biblioteca Provinciale di Foggia dare alla mission. A complicare la questione erano intervenuti altri fattori: dalla telematica all’intercultura, dalla catalogazione in regime di condivisione alla ibridizzazione dei supporti. Non era davvero per nulla facile trovare un varco fra le tante Scilla e Cariddi che ci venivano incontro. Fu un caso che durante una navigazione notturna mi imbattei nel progetto della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC). Mano a mano che scorrevano le pagine web trovavo le risposte alle domande che ci stavamo ponendo. “Una grande biblioteca a scaffali aperti, con stretta integrazione tra libri e moduli informatici: oltre 500.000 opere in volume e/o integralmente digitalizzate, relative a tutti i rami del sapere, sistematicamente organizzate e selezionate, con i testi fondamentali in originale e in traduzione, le opere generali di base e di sintesi, le monografie più importanti, i periodici principali; nonché un vasto settore di deposito e spazi per biblioteche speciali”: sono queste le parole utilizzate per sintetizzare la fisionomia della BEIC. Sembravano, mutatis mutandis, proprio le parole che ci servivano per definire la nostra biblioteca. Da quel momento vi è stata una svolta. Le Linee Guida sono nate giorno dopo giorno nei nostri dibattiti al punto tale che, nel momento in cui dovevamo cominciare a scrivere, scoprimmo di aver interiorizzato così profondamente quanto previsto dai progettisti della BEIC, che non aveva senso usare parole diverse dalle loro per dire le stesse cose. Non si è trattato ovviamente di una copiatura. In alcuni casi è una rilettura (il sistema a tre livelli), in altri una adesione incondizionata (la carta delle collezioni, il Conspectus), in altri una diversificazione (la funzione del Web). Ma nella sostanza c’è la stessa anima, lo stesso spirito che fa dire a Massimo Belotti, Giovanni Solimine, Giorgio Montecchi, Laura Ricchina e Ornella Foglieni, i pilastri del progetto sotto il profilo biblioteconomico, che si sta parlando di “una biblioteca diversa dalle altre”. Credo che sia esattamente ciò che abbiamo avvertito nel momento in cui ci siamo messi a lavorare, una volta approvate le Linee Guida. Questa diversità non è alterità, ma evoluzione della biblioteca “all’italiana”, che conserva quel suo luogo di conservazione e contemporaneamente agenzia di informazioni, che sa mantenere i legami con la storia del territorio in cui opera, ma che bandisce la nostalgia per rispondere alle domande del presente, alle sfide del futuro. Quando il documento fu ultimato nella tarda estate del 2002 potevamo già operare. Ritenemmo, però, che fosse il caso che la parte politica prendesse consapevolezza dei mutamenti in atto e che le Linee Guida non fossero un mero strumento tecnico, ma un atto importante di indirizzo politico. Non nascondo che la decisione di sottoporre alla Giunta Provinciale le Linee Guida sotto forma di indirizzi al direttore, fu presa con qualche titubanza. Chiedere alla politica di interessarsi non solo delle risorse finanziarie e delle ricadute sulla collettività, ma perfino di entrare nel vivo della mission e della fisionomia di una biblioteca, poteva sembrare eccessivo. La discussione e l’esito che ne derivarono dimostrarono esattamente il con206 Franco Mercurio trario. Quando le ragioni di una scelta sono forti e vi sono interlocutori sensibili, è possibile conseguire traguardi impensabili. Dopo 65 anni la Provincia non si interessava di arredi, di personale, di immobili; tornava a riflettere sulla sua politica biblioteconomica. Lo aveva fatto nel 1937 quando coraggiosamente decideva di aprire la sua biblioteca, lo faceva consapevolmente nel 2002 quando condivideva un progetto ed un processo di lungo periodo e di ampio respiro. Desidero qui ringraziare Massimo Belotti, Ornella Foglieni, Giorgio Montecchi, Laura Ricchina e Giovanni Solimine che con il loro sforzo intellettuale non hanno solo definito il progetto di una grande biblioteca nazionale di carattere innovativo, ma hanno tracciato un percorso di riflessione di enorme portata per tutti noi. Le nostre Linee Guida sono la testimonianza che con il progetto BEIC è stato tracciato un modello applicabile ad altre biblioteche medio-grandi del nostro Paese. 207 208 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia 1. Introduzione Gli sviluppi vertiginosamente rapidi e profondi della società contemporanea impongono ai singoli e alle organizzazioni di potenziare i canali di accesso alle informazioni di ogni tipo e di ogni livello. I tre grandi processi in/formativi intercettati dalle più recenti politiche dell’Unione Europea (società dell’informazione; società dell’informatizzazione e longlife learning) hanno imposto una sostanziale modifica della vecchia concezione della biblioteca quale luogo eminentemente deputato allo studio. La riqualificazione del lavoro (che ha perduto molto i caratteri della serialità e della ripetitività), ma anche i luoghi ed i tempi oggi disponibili per le attività extralavorative, insieme con i tempi assai più lunghi dell’esistenza umana, rendono possibile investire, in ogni fase della vita, maggiori energie nella conoscenza. La biblioteca del XXI secolo non è più, dunque, esclusivamente una biblioteca per lo studio; essa sarà sempre più un luogo di informazione, di conoscenza, di svago, ed assumerà una funzione centrale nella selezione, raccolta e trasmissione delle informazioni di ogni tipo e di ogni livello. La biblioteca del XXI secolo sempre più assumerà le funzioni di presidio delle libertà di accesso alle fonti e, quindi, di difesa e di diffusione delle libertà e della democrazia, ma anche di contenitore culturale autoportante, in grado di proporre contemporaneamente offerte informative, culturali e sociali. Gli strumenti di attuazione di queste finalità, anche nella Biblioteca della Provincia di Foggia, non sono adeguati in modo diffuso e simultaneo. Sin d’ora, la prevista combinazione intelligente (tecnicamente definibile ibridazione dei servizi) di opere a stampa e di supporti elettronici, di pagine scritte e di mezzi multimediali e interattivi può contribuire a fornire a tutti ed a ciascuno gli strumenti per cercare e per reperire le informazioni, le opportunità formative, le vie per progredire nella conoscenza. Il modello che sembra rispondere meglio alla crescente domanda di informazione e di cultura in forme puntuali ed esaurienti rimane quello di una grande biblioteca a scaffale aperto, organizzata sulla base di una politica ragionata delle raccolte, sia di materiale cartaceo che di altro materiale (audiovisivo, informatico, digi209 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia tale, telematico), con efficienti servizi di reference, con una particolare attenzione ai servizi e alle risorse elettroniche on-line. Lo sviluppo grandioso dell’informatica, con le sue straordinarie potenzialità, pone sempre più l’esigenza di dar vita a strutture bibliotecarie, ove convivano e si integrino libri, periodici, CD, banche dati e connessioni in rete. L’immensa produzione di opere a stampa e la presenza di una smisurata quantità di informazioni renderà sempre più necessaria un’attività di consulenza e di selezione ragionata sulle fonti di informazione primarie e secondarie, sulle vie di ricerca in rete e sulle banche dati, condotta con metodo e continuità da bibliotecari professionalmente consapevoli e tecnicamente attrezzati. Sempre più il bibliotecario deve considerare le sue acquisite abilità teoriche e pratiche in tema catalografico e biblioteconomico semplicemente come una base avanzata di partenza per conseguire specializzazioni sempre più differenziate (dal bibliografia al marketing dei servizi; dal reference al library web design; dalle pubbliche relazioni alla promozione dei servizi fino al managing). Questa linea di tendenza europea ed internazionale è ormai in via di consolidamento nelle più grandi biblioteche e presso le agenzie nazionali ed internazionali ed ha ispirato le linee guida per la nascita o la conversione recente di alcune grandi biblioteche in Europa e negli Stati Uniti. In Italia biblioteche impostate secondo simili linee direttrici, pur con caratteri ovviamente diversi e specifici, sono (a titolo esemplificativo) la Biblioteca di Sala Borsa a Bologna e la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano (BEIC). Di quest’ultima, in particolare, se ne condividono a pieno titolo le metodologie e le pratiche attuative in corso al punto tale da essere stata assunta a modello da imitare, adattandola alle circostanze e al contesto. L’Italia, invero, nel confronto con le tendenze biblioteconomiche internazionali, degli anni Novanta, si è inserita privilegiando soprattutto le politiche di innovazione tecnologica degli impianti, affrontando solo molto recentemente i temi dell’integrazione delle risorse elettroniche, negli assetti preesistenti dei fondi documentari delle biblioteche dell’informatica applicata alle biblioteche e il conseguente dibattito scientifico e culturale. L’esempio in cantiere della grande Biblioteca Europea di Informazione e di Cultura di Milano (BEIC), ancora in una fase di impostazione e progettazione esecutiva, si fonda sulla più completa ibridazione di documenti a stampa, con documenti audiovisivi e documenti elettronici ed è l’espressione avanzata dei più recenti dibattiti in materia di servizi per la pubblica lettura. Secondo questa prospettiva, anche nella Biblioteca Provinciale di Foggia stanno trovando posto (in versione cartacea, digitale e telematica) tutti i testi fondamentali di tutti i rami del sapere. Saranno aggiornate, integrate ed ampliate le principali raccolte di documenti, gli strumenti bibliografici di base, le enciclopedie, i glossari, i manuali, i trattati, gli atlanti, le principali opere di sintesi, le biografie, le monografie e gli articoli essenziali, i periodici più importanti. 210 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia Alcune aree storicamente qualificanti il patrimonio della nostra biblioteca assumeranno caratteri speciali e di specializzazione (prima infanzia e ragazzi, storia locale meridionalistica e fondi speciali, musica, cinema, teatro). Queste aree speciali e di specializzazione saranno affiancate da alcuni centri di documentazione sempre più essenziali per il futuro del nostro territorio (didattica, ambiente, Unione Europea, fumetto, giovani adulti, interetnicità, cultura materiale delle classi subalterne). L’obiettivo è quello di raggiungere attraverso efficienti interlibrary loan e delivery service tutte le informazioni volute e tutte le opere esistenti in ogni parte del mondo. All’interno di una visione unitaria e coerente la politica delle collezioni della Biblioteca Provinciale, le raccolte e i servizi dovranno raffinare l’offerta informativa secondo scale diverse di esigenze, di cui sarà ogni volta il lettore a stabilire quali scegliere. La reperibilità delle informazioni più aggiornate è, in particolare, un’esigenza primaria nel mondo del lavoro e delle professioni dell’età attuale (longlife learning). Si tratta di un’esigenza nuova che richiede strutture apposite, circuiti informatici e telematici predisposti ad hoc, ricorso alla “letteratura grigia”, servizi efficienti di reference. Una particolare attenzione sarà rivolta alle fondamentali fonti letterarie e scientifiche attraverso una politica delle collezioni che dovrà continuare ad assicurare la presenza in biblioteca dell’opera nella sua completezza (in alcuni casi in lingua originale), in forma di volume ma anche con un’ampia produzione e selezione di digitalizzazioni. Il progetto, già in nuce nelle elaborazioni compiute fra gli anni Sessanta e Settanta presso la Biblioteca Provinciale, è dunque quello di dare identità più marcata ad una biblioteca necessariamente selettiva quanto alle opere accolte, ma costruita in modo da contenere un vastissimo insieme - organico, bilanciato, continuamente aggiornato mediante un’accorta politica degli acquisti - di testi fondamentali e di strumenti relativi a tutti i rami del sapere, in forma di volume e in forma digitale. Si tratta di definire una carta delle collezioni in grado di realizzare una biblioteca più completa e avanzata, rispetto a quella attuale. Resta chiaro che la fortuna di questo progetto risiede nella capacità della Biblioteca Provinciale di fare sistema e di attivare più incisive e allargate formule di cooperazione interbibliotecaria sia con le biblioteche locali che con sistemi bibliotecari nazionali ed internazionali. Fino ad oggi il Web è stato considerato una sorta di adeguamento tecnologico delle informazioni che la biblioteca già normalmente offre ai propri lettori. Le innovazioni informatiche hanno, ad esempio, consentito alle biblioteche di permettere senza limiti di tempo l’accesso in remoto ai propri cataloghi, anche quando la biblioteca è fisicamente chiusa. L’OPAC ha significato un evidente momento evolutivo. OPAC, virtual reference, opere digitalizzate, aree tematiche di divulgazione e approfondimento bibliografico interattivo, informazione, accesso a banche dati 211 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia definiscono gli elementi inscindibili della biblioteca del nuovo millennio che consente ai lettori di una più vasta platea di dimensione globale di accedere alle informazioni e ai testi digitali della biblioteca, che consente di offrire selezioni telematiche e di fornire e di riceve informazioni e servizi. La geografia distributiva di questi servizi non è dappertutto uguale e uniforme: esistono siti di biblioteche che offrono informazioni sui servizi prodotti e spesso si spingono in forme di assistenza/consulenza a distanza con il ricorso alla posta elettronica (reference on-line); altre biblioteche consentono l’accesso in remoto ad opere digitalizzate in proprio. L’evoluzione di questo tipo di web è comunque alle porte anche de “la Magna Capitana” in seguito agli adeguamenti strutturali e all’adeguamento delle risorse anche umane. Nella Biblioteca Provinciale il Web non è una sorta di adeguamento tecnologico, ma è evoluzione contemporanea del sistema comunicativo nel suo complesso organico e sostanziale, secondo i più recenti orientamenti nazionali ed internazionali. Per questa ragione il Web della biblioteca è destinato a diventare una nuova faccia della biblioteca con proprie autonome caratteristiche e con propria fisionomia biblioteconomica. La biblioteca che realizza servizi integrati, dunque, non solo manterrà ma vedrà ancora accresciuto il suo ruolo di mediazione delle conoscenze. Gli studi internazionali più recenti hanno dimostrato tra l’altro che il ricorso alla telematica e alle risorse elettroniche ha ovunque aumentato la richiesta di libri a stampa. È, dunque, evidente che una biblioteca del tipo descritto costituisce la struttura atta a soddisfare alcune ulteriori domande di consumo culturale destinate a crescere. Sarà di conseguenza sempre più necessario disporre di personale bibliotecario dotato di alta professionalità e cultura, in grado: a) di aiutare a reperire, mediante moderni servizi di reference, tutte le informazioni e tutte le opere richieste dal lettore; b) di scegliere - con la consulenza, ove necessario, di specialisti - e di porre a disposizione del pubblico le opere primarie e secondarie ritenute via via più significative nell’immensa produzione libraria attuale; c) in pari tempo provvedendo a recuperare tramite digitalizzazione il testo di opere fondamentali, a cominciare da quelle, strettamente legate al territorio e non più disponibili in commercio. In tale prospettiva di sviluppo, la Biblioteca Provinciale di Foggia assolverà alla sua tradizionale funzione di grande biblioteca pubblica al servizio del vasto bacino d’utenza (che va oltre gli stessi confini provinciali) in qualità di agenzia di informazione e di servizi, soprattutto sul fronte cruciale dei collegamenti interdisciplinari. L’istituzione di un settore d’ingresso e di accoglienza, il potenziamento dell’area di cultura generale, delle aree speciali e delle aree specializzate insieme alla creazione di una serie di strutture complementari contribuiranno a soddisfare le diverse esigenze di informazione e di cultura in forma modulare e integrata, attraverso le potenzialità offerte dal portale telematico della biblioteca. Sotto questo punto di vista la Biblioteca Provinciale di Foggia ha tutte le potenzialità per evolvere in “centro di eccellenza” a livello nazionale. 212 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia 2. Fisionomia e profilo culturale a) Gli obiettivi della Biblioteca Provinciale La biblioteca, presidio per la circolazione e la diffusione dei saperi, trasmessi attraverso le più svariate forme di presentazione, intende rivolgersi a quanti siano portatori di bisogni di informazione e cultura, predisponendo servizi di accesso agli usi (anche i più specialistici) e al passo con i tempi nel territorio della Capitanata e della Puglia, confermandosi presidio delle libertà civili e della democrazia, esercitati attraverso la libertà intellettuale, la libertà di leggere, la libertà di vedere e di ascoltare. A tal fine ha predisposto sin d’ora il quadro delle relazioni per una reale e sinergica cooperazione territoriale, con la giovane Università e ogni altra agenzia o istituzione culturale. Il passaggio da una biblioteca eminentemente di studio alla biblioteca pubblica del XXI ha una ulteriore speciale valenza per una realtà locale come la nostra che si colloca solitamente in fondo alle classifiche nazionali dei consumi culturali. La sfida della Biblioteca Provinciale è anche quella di promuovere l’uso della lettura e la frequenza delle biblioteche come consuetudine diffusa di vita. Sempre più, dunque, alla biblioteca dovrà ricorrere chiunque abbia una curiosità, un desiderio, un bisogno informativo: il giovane e il comune cittadino di qualsiasi età che sia mosso da una semplice curiosità o da un interesse legato all’attualità o alla sua vita quotidiana, ai suoi rapporti con la società civile e le istituzioni; lo studente che si avvii alla ricerca o che intenda coltivare alcuni settori di studio; lo studioso e il ricercatore che abbiano l’esigenza di ampliare lo spettro della propria ricerca oltre i rigidi schemi degli specialismi; gli intellettuali delle professioni (i professionisti, gli imprenditori, i funzionari, i quadri dirigenti) e quanti possano avere la necessità di documentarsi su un qualsiasi campo di attività o di aggiornare e approfondire le proprie conoscenze professionali. Così la biblioteca non si rivolge solo a chi studia, ma a tutti. In questi concetti si condensano gli assunti culturali e politici della missione de “la Magna Capitana”. Alcuni di questi bisogni informativi potranno essere soddisfatti direttamente dalla biblioteca, mentre in altri casi essa eserciterà una funzione di filtro e orientamento verso altre fonti (biblioteche, archivi e centri di documentazione; biblioteche storiche e di ricerca dotate di fondi specialistici; servizi e strutture nazionali e internazionali; raccolte fisiche e virtuali), grazie al potenziamento dei servizi e dei livelli di reference. La definizione degli obiettivi, l’articolazione dei servizi e la fisionomia bibliografica della biblioteca dovranno avere una reciproca intrinseca e rigorosa coerenza. Caratteristiche portanti dovranno essere la flessibilità, la permeabilità, la disponibilità a lasciarsi plasmare dall’evoluzione stessa del sapere e delle sue forme, oltre che dall’uso che gli utenti ne faranno. L’interazione della biblioteca con i pro213 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia cessi di produzione e circolazione del sapere, da un lato, e con i suoi utenti, dall’altro, daranno dinamicità al rapporto domanda/offerta. b) La fisionomia bibliografica La fisionomia bibliografica della biblioteca si configura a partire dalla storia che ha generato la formazione delle sue collezioni, la loro organizzazione spaziotemporale e dagli strumenti con cui ci si è adeguati al soddisfacimento dei bisogni culturali dei suoi frequentatori. Nella fase attuale si configura questa ossatura strutturale: • progressiva integrazione fra patrimonio storico e adeguamento moderno a forte integrazione di supporti; • allestimento di una strumentazione per la fornitura di informazioni che oltre al possesso intervengano sugli accessi; • trasformazione dell’utente da finale (destinatario di servizi), a utente protagonista (produttore di documentazione). La fisionomia della Biblioteca Provinciale sarà, pertanto “ibrida” perché in questa le tipologie di materiali documentari e le sezioni copriranno aree di interesse diverse e si rivolgeranno a fasce diverse di utenti, ma l’intero impianto sarà ricondotto ad unità dai servizi che la biblioteca impianterà. La garanzia di organicità può essere assicurata da una carta delle collezioni, da un sistema integrato di gestione delle informazioni e dall’allestimento di strumenti di mediazione centralizzati ed efficaci. Un’offerta ampia e variegata di documenti e servizi richiede un forte impegno e un’alta qualificazione nel personale addetto all’assistenza del pubblico; richiede uno sforzo di superamento degli angusti limiti autoreferenziali dell’attuale organizzazione per i tradizionali comparti autonomi e parcellizzati della biblioteca provinciale. c) Il modello a tre livelli applicato alla Biblioteca Provinciale di Foggia La biblioteca a tre livelli è un modello organizzativo dei servizi di biblioteca nato alla fine degli anni Settanta in Germania per le biblioteche di pubblica lettura. In questo modello la biblioteca è divisa da un punto di vista logistico e spaziale in settore d’ingresso (Nahbereich: significa settore vicino, in prossimità dell’utente), settore centrale a scaffale aperto (Mittelbereich: settore di mezzo), settore del deposito, o magazzino (Fernbereich: settore lontano). La denominazione di questi tre settori è definita dalla vicinanza, sia ideale che spaziale, all’utenza. L’obiettivo principale è la soddisfazione dell’utente, il quale determina i compiti e gli scopi della biblioteca. Questa concezione che applica le strategie di marketing ai servizi di biblioteca si fonda su alcune innovazioni: 214 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia a) il settore d’ingresso; b) un metodo di collocazione e presentazione del patrimonio basato sulla individuazione di aree tematiche alternativo ai sistemi di classificazione tradizionali; c) la rotazione del patrimonio tra i diversi settori della biblioteca; d) un sofisticato monitoraggio del patrimonio. Il settore d’ingresso realizza la vicinanza ideale e spaziale con l’utente. Esso funge da biglietto da visita della biblioteca per tutte le persone che vi accedono, e in particolare si rivolge a coloro che non hanno una richiesta specifica, ma sono alla ricerca di qualcosa di “interessante” di cui non hanno ancora un’idea precisa. L’obiettivo di questo settore è aiutare l’utente a superare la cosiddetta “paura della soglia”, l’imbarazzo e la soggezione che spesso ostacolano il rapporto tra la biblioteca e il cittadino. Infatti perché il cittadino possa riconoscersi nella biblioteca, deve poter trovare in biblioteca la risposta ad ogni sua specifica esigenza e ottenere ciò che cerca nel minor tempo possibile. Le modalità di collocazione del patrimonio in questo settore sono fondamentali. La collocazione avviene secondo criteri alternativi a quelli delle aree disciplinari dei sistemi di classificazione che risultano troppo rigidi e lontani dall’approccio dell’utenza. Il patrimonio viene presentato secondo le cosiddette aree d’interesse o temi che vengono formulati per essere il più possibile aderenti ai gusti più comuni e mutevoli dell’utenza. Essi vengono definiti in base ai prestiti, alle domande più frequenti dell’utenza, alle tendenze culturali; sono flessibili (cambiano con gli interessi dell’utenza); il linguaggio con cui vengono presentati è di uso comune. Il patrimonio esposto nell’area d’ingresso viene in parte acquistato appositamente per questo settore e in parte è costituito attraverso trasferimenti temporanei dalle altre sale a scaffale aperto o dai depositi. La biblioteca a tre livelli è un modello organizzativo basato su una concezione unitaria della biblioteca. L’unitarietà si realizza attraverso la circolazione del patrimonio all’interno della biblioteca. Infatti nessuna unità del patrimonio ha un posto fisso nella biblioteca. In base agli interessi e ai percorsi dei diversi gruppi d’utenza, parti del patrimonio possono essere spostate in altri settori. Ogni settore deve essere impostato secondo un elevato orientamento all’utenza a cui è destinato. Occorre perseguire una programmazione esplicita della differenziazione del patrimonio in base alla segmentazione dell’utenza. La collocazione del patrimonio deve essere integrata (multimediale): i diversi supporti (tradizionali e digitali) su cui viene proposto un argomento sono presentati insieme. Fondamentale è la flessibilità dell’organizzazione. Quindi nella concezione a tre livelli, le politiche di marketing determinano la scelta del patrimonio, il modo di presentarlo, le tipologie dei servizi offerti, la loro dislocazione. L’obiettivo è raggiungere la massima soddisfazione dell’utenza attraverso l’ottimizzazione del patrimonio. La fase preliminare imprescindibile per applicare questo approccio è l’analisi dell’utenza per adeguare il patrimonio e i servizi della biblioteca alle esigenze reali 215 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia dei cittadini. Essa consiste nell’analizzare le tipologie di utenza reale e potenziale presenti sul territorio, nel monitorare la presenza di associazioni e attività culturali, sociali, non profit, nell’analizzare il tessuto produttivo, nello studiare i percorsi e le abitudini di vita dei cittadini e la distribuzione dei servizi sul territorio per determinare, ad esempio, la dislocazione e gli orari della biblioteca. All’interno della biblioteca le strategie di marketing si basano su un attento monitoraggio del patrimonio, utilizzando diversi strumenti: statistiche sui prestiti, indice di circolazione (valuta il favore che un singolo libro ha ottenuto in base al numero di uscite), quota d’assenza (registra la percentuale dei libri in prestito sul totale della sezione, se supera un certo valore, il patrimonio di quella sezione è ritenuto insufficiente). Questo attento monitoraggio determina: la programmazione degli acquisti, la gestione degli scarti, la rotazione del patrimonio, l’organizzazione e la flessibilità del settore d’ingresso. La logica del marketing applicata all’organizzazione dei servizi di biblioteca parte quindi da un’analisi del territorio e delle esigenze dei cittadini, da cui derivano una serie di scelte sulle tipologie d’utenza a cui la biblioteca vuole prevalentemente indirizzare i propri servizi. A questa prima valutazione segue l’analisi dei prodotti/servizi da offrire e la loro combinazione quantitativa, ad esempio se puntare più o meno sulla promozione del libro piuttosto che sui servizi multimediali. L’obiettivo delle scelte strategiche è stabilire di quali cittadini la biblioteca vuole occuparsi e quali servizi vuole offrire. In base a queste scelte di fondo, individua gli strumenti per realizzarle: come progettare il servizio, come organizzarlo, come comunicarlo. Definire la strategia è fondamentale in quanto il fine istituzionale è sempre troppo ampio rispetto alle risorse. L’intuizione fondamentale della biblioteca a tre livelli è che l’accesso ai servizi non è neutro. La biblioteca, che presuntivamente si rivolge a tutti i cittadini, di fatto filtra l’utenza attraverso una serie di scelte di servizio (patrimonio, orari, arredi, organizzazione degli spazi, ecc…). d) I vincoli architettonici dell’attuale biblioteca L’articolazione dell’attuale sede centrale della Biblioteca Provinciale su quattro piani (sotterraneo, piano terra, primo e secondo piano) non consente di adattare completamente la costruzione logica della biblioteca a tre livelli all’attuale organizzazione degli spazi, se non ricorrendo in alcuni a casi a rilevanti modifiche della distribuzione degli spazi (ad esempio la trasformazione dell’atrio aperto in ingresso chiuso) ed in altri casi ad un maggiore sforzo organizzativo delle risorse umane, fisicamente dislocate su piani diversi, ma funzionalmente molto legate ed interdipendenti fra di loro nella formazione e nell’offerta dei prodotti/servizi (ad esempio l’integrazione fra gli addetti ai servizi di accoglienza, di reference di comunità, di reference avanzato e di consulenza specializzata). Non c’è dubbio che la dislocazione su tre plessi (sede centrale, ex “Marconi” ed ex “Pascal”) non consentiranno uno sviluppo equilibrato della biblioteca a tre 216 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia livelli, anche se le ipotesi di utilizzazione degli spazi che si prospettano permettono, comunque, di mantenere un rapporto organico fra le parti. Intanto sarà necessario procedere presso la sede centrale al recupero degli ampi spazi aperti al pubblico ed oggi inutilizzati, mentre dovranno essere valorizzati gli ampi spazi aperti dell’ex “Pascal” e dell’ex “Marconi” che consentono di sperimentare proposte inedite, come la lettura e lo studio all’aperto nella pinetina appena sistemata nell’area ex “Pascal” o come l’internet café nel palmeto dell’ex “Marconi”. Sulla base, dunque, del modello a tre livelli e delle cautele necessarie nell’applicazione per i vincoli architettonici dei plessi si può definire meglio il rapporto fra fisionomia bibliografica e organizzazione degli spazi. e) Settore d’ingresso Si dovrà dare una forte identità a quest’area che precede, fisicamente e funzionalmente, le sale di lettura e i magazzini ed ha lo scopo di aiutare l’utente a superare la “paura della soglia”. La distribuzione amichevole degli spazi e una segnaletica chiara e studiata in modo da attirare l’attenzione e mettere gli utenti a proprio agio sono i requisiti indispensabili per il successo di questa ipotesi progettuale. Questo spazio è il luogo nel quale i visitatori si guardano intorno, si arrestano per un attimo e poi, una volta individuata la direzione giusta, vi si recano, partendo verso una graduale scoperta dell’edificio e dei servizi che esso offre; è un crocevia, che separa e congiunge, che prepara e allontana, che isola e unisce i diversi spazi che vi convergono e che da esso si diramano. Non si tratterà di uno spazio vuoto, ma di un ambiente da cui si cominceranno a leggere le funzioni e lo stile della biblioteca, in cui manifesti, avvisi, bacheche multimediali, vetrine per piccole esposizioni temporanee e altro ancora introdurranno gli utenti all’uso della biblioteca. Anche negli orari in cui la biblioteca sarà chiusa ed in cui questo spazio sarà utilizzato solo per accedere all’auditorium per assistere ad un convegno o ad un concerto, il passaggio obbligato attraverso questo ambiente avrà lo scopo di far scoprire la biblioteca e di incuriosire quanti non ne sono utenti abituali. In questo spazio sarà dislocato un info-point, cui gli utenti ricorreranno per orientarsi e per essere assistiti nelle loro scelte. Qui, nella zona di cerniera fra quest’area e l’accesso alla biblioteca, saranno collocati anche il banco per le iscrizioni alla biblioteca, i servizi di informazione e di divulgazione. f) Accoglienza e area di divulgazione Troveremo ubicati in questo ambiente, cui si dovrà accedere nel modo più libero possibile, i servizi di accoglienza (guardaroba, bar, ecc...) e una parte del ma217 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia teriale documentario che funga da biglietto da visita della biblioteca. Da qui si accederà ai servizi di informazione e ai servizi di reference di comunità e, attraverso di questi, alle diverse sezioni della biblioteca, in modo che il percorso dell’utente consista in una graduale e progressiva scoperta della biblioteca e dei suoi servizi. In questa area troviamo i cataloghi cartacei che andranno in esaurimento, le postazioni per l’interrogazione del catalogo in linea e alcune bacheche multimediali per l’interrogazione di banche dati speciali (Reciproc@, rete civica, CD-Rom interattivi, informazioni di comunità, informagiovani, orari ferroviari e aerei, informazioni turistiche, ecc…). Scopo di un servizio di informazione di comunità è quello di soddisfare esigenze informative primarie della cittadinanza, concentrando e diffondendo le informazioni di varia natura prodotte dai soggetti, pubblici e privati, erogatori di servizi e prestazioni di utilità comune, riguardanti la casa, la scuola, il mercato del lavoro, il tempo libero, la tutela della salute e dell’ambiente ecc… Qualunque tipo di informazione pratica dovrà essere accessibile. Qui dovranno essere accessibili, quindi, anche quei materiali che consentono alla biblioteca di presentarsi come un servizio informativo a tutto tondo, non legato unicamente all’informazione bibliografica. In questo ambiente andranno sistemati opuscoli informativi e guide turistiche della città, depliant e locandine di manifestazioni artistiche e culturali, elenchi telefonici ed orari dei servizi pubblici e di trasporto, altri materiali informativi ecc… Ma in questo spazio dovrà trovare posto anche una prima esposizione del materiale librario: scaffali, vetrine e bacheche dedicate a presentare il materiale secondo aree di interesse il più possibile aderenti ai gusti più comuni e mutevoli dell’utenza. La scelta dei temi cui dedicare questi settori e il modo di allestirli possono variare di molto: gli scaffali sono variegati per formato e colore, e parte dei libri viene esposta di piatto; divanetti e altre sedute comode favoriscono un contatto diretto coi libri; vengono preparate piccolissime mostre tematiche di breve durata e continuamente rinnovate (“l’autore della settimana”, “il tema del mese”), che diano l’idea della vastità e della varietà dell’offerta; viene fatto ruotare il patrimonio solitamente collocato altrove e bisognoso di una promozione specifica, riproponendolo mediante un approccio alternativo a quello di tipo disciplinare (ad esempio, la Classificazione Decimale Dewey) . In questa area, che è tipica della biblioteca pubblica e che ospiterà un pubblico eterogeneo, conviene offrire almeno una prima possibilità di incontro con i documenti a partire dalle questioni che essi affrontano e non dalle discipline che se ne occupano. Le aree tematiche “fisse” individuate sono le seguenti: hobby, viaggi, casa, salute, concorsi, religioni, sport, musica, computer, libri da guardare. Sempre in questo settore di ingresso si dovrebbe presentare un’anteprima delle novità che riguardano le altre aree (audiovisivi, CD, DVD) e consentire la lettura dei quotidiani. Viene considerata area d’ingresso l’area comprendente l’atrio aperto e parte delle due sale laterali. Con uno specifico stanziamento di spesa si procederà a trasformare l’atrio da un ambiente all’aperto ad uno spazio interno, dove prenderanno posto la reception/informazione ed altri servizi. 218 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia La sezione attualità e le aree di divulgazione esporranno le novità editoriali (libri, giornali riviste, audiovisivi), documenti su temi ritenuti di attualità, raccolte tematiche di documenti (hobby, viaggi, casa, salute, concorsi, religioni, sport, musica, computer, libri da guardare). Comprenderà postazioni di lavoro normali e posti di consultazione “accoglienti” (divani, poltroncine) sia per la lettura sia per l’ascolto. Il materiale sarà esposto in gran parte di piatto. La sezione attualità e di divulgazione insieme ospiteranno circa 5.000 documenti e 50 posti utenti (dimensionamento: mq. 390; posti 50). Le esposizioni potranno riguardare materiale depositato nella biblioteca o in genere documenti correlati all’attività culturale della biblioteca. Potranno essere organizzate mostre tematiche o mostre di materiale iconografico. La sezione esposizioni può essere articolata in due spazi: uno spazio autonomo, destinato a mostre tematiche, ed uno spazio che può essere integrato con lo spazio d’ingresso ed il sistema di circolazione e che agli effetti del dimensionamento è compreso in questi spazi (dimensionamento: mq. 110). La configurazione complessiva dell’intero settore dovrà essere a metà tra il salotto in cui i cittadini (che non necessariamente diverranno utenti degli altri servizi della biblioteca) andranno ad affacciarsi per vedere “cosa si dice in biblioteca” o quali nuovi stimoli essa offre, e una introduzione al servizio bibliotecario vero e proprio (dimensionamento dell’intero settore: mq. 500). g) Informazione, reference di base e reference di comunità Da quest’area inizierà l’orientamento verso i servizi della biblioteca. Fondamentale – ai fini dell’immagine e dello stile di servizio della biblioteca, e quindi anche del suo impatto complessivo sugli utenti – sarà l’informazione che il personale addetto a questo settore saprà dare al pubblico, sia agli utenti più disorientati e sprovveduti, bisognosi di una guida all’uso delle fonti e dei documenti disponibili, sia agli studiosi portatori di esigenze più sofisticate, ma proprio per questo bisognosi di assistenza nelle loro ricerche. I servizi di reference di questo livello che saranno forniti all’utenza non riguarderanno una funzione consulenziale, come normalmente avviene nelle reference library. Si tratterà di fornire informazioni a tutto tondo e, nel caso, ad indirizzare il lettore ai servizi di reference generale o specialistici presenti. Non vi sarà, ovviamente, una netta separazione tra ambienti di servizio e ambienti di lavoro; il personale addetto a questo servizio sarà impiegato per gran parte del tempo nel settore di front-office. In quest’area troveranno spazio i calendari di congressi, mostre, fiere, spettacoli e altri avvenimenti, annuari, indirizzari, elenchi telefonici ed orari di treni, aerei, autobus. Essenziale sarà il virtual reference con elenchi di siti preferiti, collegamenti a banche dati (on-line o in intranet) e servizi automatizzati di informazione, che dovranno essere disponibili all’utenza e facilmente accessibili. 219 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia Il reference di base avrà una funzione quasi maieutica nei confronti degli utenti. La sua funzione principale è quella di rendere autonomo il lettore dalla mediazione bibliotecaria ridondante. Le funzioni essenziali sono quelle di consentire al lettore sprovveduto di essere in grado di utilizzare bene i cataloghi, l’OPAC e le risorse di rete; quelle di comprendere il livello di complessità delle richieste degli utenti in modo da produrre un reale immediato collegamento con il reference generale o con il reference specialistico o con il bibliografo responsabile dell’area; quello di proporre offerte informative alternative. Il servizio di reference generale (distinto da quello di reference di base), come meglio illustrato nei paragrafi successivi, si articolerà in un servizio di consultazione generale e in alcuni servizi di consulenza specializzata, rivolti a soddisfare particolari esigenze o particolari categorie di utenti. Quindi non potendo avere una dislocazione degli spazi tale che da consentire i servizi di reference in un’unica grande area, sarà necessario che tutti gli addetti ai diversi reference curino con particolare attenzione le relazioni interne fra di loro in modo da consentire una veloce individuazione del bibliotecario-bibliografo in grado di fornire l’orientamento e la consulenza a seconda dei livelli progressivi di complessità delle domande poste dagli utenti. L’area di reference di base disporrà anche di servizi di riproduzione self-service (non solo macchine fotocopiatrici, ma anche attrezzature per la scannerizzazione), accessibili attraverso carte pre-pagate. Per riproduzioni più sofisticate, la biblioteca si doterà anche di un centro di digitalizzazione che, fra le diverse responsabilità, eseguirà lavori onerosi per conto degli utenti. La complessità delle procedure connesse al maneggio del denaro e alla fatturazione diretta hanno consigliato il ricorso alla gestione delle entrate in outsourcing. Mentre per la riproduzione dei materiali collocati nelle sale si provvederà in loco con attrezzature self-service, la gestione dell’Interlibrary Loan (ILL) e del Document Delivery (DD) avverrà presso il reference di base. h) Sala di narrativa (ex Sala Adulti) L’attuale sala adulti perderà la fisionomia di sala di consultazione divulgativa per diventare una sala tematica a scaffale aperto dedicata alla narrativa mondiale. Saranno disponibili – alcune opere in originale – i classici e la narrativa mondiale contemporanea con attenzione ai classici pre-ottocenteschi. Sarà comunque consentito l’accesso alla lettura della narrativa conservata in magazzino, che non trova collocazione negli scaffali aperti, mediante un autonomo banco di distribuzione. La modularità della sala adulti sarà concepita in modo da consentire all’interno della stessa sala momenti di animazione e di lettura ad alta voce, anche attraverso l’utilizzazione intelligente ed oculata degli spazi aperti contigui alla sala (dimensionamento: mq. 264; posti 50). 220 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia 2.1 Biblioteca dei ragazzi Per “biblioteca per ragazzi” si intende, convenzionalmente, l’insieme dei servizi e degli spazi destinati all’utenza più giovane, compresa tra 0 e 13 anni. La tendenza ad abbassare l’età degli utenti fino a comprendere i piccolissimi è abbastanza recente e risente degli influssi che provengono soprattutto dall’esperienza bibliotecaria dei paesi scandinavi, ma anche di altri paesi europei e degli Stati Uniti. Va riconosciuto che anche per quanto riguarda le biblioteche pubbliche del nostro paese sono state prodotte significative e interessantissime esperienze e la stessa Biblioteca Provinciale ha avviato sperimentazioni al riguardo, attualmente degne di essere implementate negli usi e nelle relazioni. Hanno favorito, inoltre, questo trend lo sviluppo di una editoria di qualità destinata alla prima infanzia e le più moderne teorie pedagogiche, che riconoscono l’esistenza di una capacità di “leggere prima di leggere” che va stimolata e organizzata. Nonostante la presenza di neonati e di bambini piccolissimi, si continua ad adottare il termine generico “biblioteca per ragazzi” per individuare l’intera sezione 0-13 anni, alla quale viene riconosciuto un proprio statuto culturale. Questa sezione presenta, nel suo insieme, una sostanziale diversità quanto a dotazioni, arredi, abilità professionali rispetto al resto della biblioteca e una tendenziale omogeneità al suo interno, che accomuna le diverse fasce d’età. Al personale che lavora in questa sezione è richiesto di possedere, diversamente dagli altri bibliotecari, anche una formazione di tipo pedagogico e un’approfondita conoscenza, non solo di tipo bibliografico, della letteratura per l’infanzia, che può giungere fino alla conoscenza del contenuto stesso dei singoli libri, senza la quale è difficile impostare un lavoro di reference con i giovani lettori; e ancora, in questo settore sono massicciamente previste attività di laboratorio e di animazione per ogni fascia d’età (anche se ovviamente diversificate), che rimandano alla presenza di altre competenze professionali, in parte interne e in parte recuperabili all’esterno. Se è vero che la sezione per ragazzi non va considerata come un corpo separato della biblioteca, ma al contrario parte integrante di essa e partecipe delle sue risorse complessive ed introduttiva in maniera amichevole ai servizi bibliotecari degli adulti, questo è a tutti gli effetti l’unico comparto della biblioteca pubblica che ha una sua marcata fisionomia autonoma e un proprio “linguaggio” specifico. All’interno della biblioteca per ragazzi si individuano di solito due aree: quella dei più piccoli (0-5 anni) e quella dei bambini/ragazzi (6-13 anni), anche se i confini sono sfumati, a cominciare da quelli assai esili tra preadolescenza e adolescenza. Obiettivo particolare della biblioteca dei ragazzi sarà quella di evitare lo sviluppo di un concetto distorto che nell’immaginario dei ragazzi assegna al libro una funzione essenzialmente di studio e, di conseguenza, finisce per alimentare una visione stereotipata della biblioteca. In questo senso sarò necessario sviluppare un rapporto diretto ed equilibrato fra ragazzo e biblioteca attraverso un uso multipolare del libro e del documento. In questo senso il programma nazionale “Nati per leggere” diventerà a Foggia un’azione promozionale e sperimentale 221 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia affatto nuova e rivolta a creare un rapporto con i ragazzi che esce fuori dalla mediazione scolastica. Sarà opportuno prevedere all’interno della biblioteca per ragazzi uno specifico spazio per i genitori, con documentazione mirata all’approfondimento delle tematiche psico-affettive di relazione. La biblioteca per ragazzi con spazio per consultazione a scaffale aperto di libri e periodici (circa 10.000 volumi e 30 periodici); spazio per audiovisivi (con zone per l’ascolto di musica e zone per televisione); spazio d’attività (per lavori manuali), spazio di teatro e di lettura dei bambini, viene articolata in due sezioni: • una per i bambini più piccoli (0-5 anni), • una per bambini/ragazzi (6-13 anni). Per quanto riguarda gli adolescenti, invece, nella letteratura professionale e nelle esperienze più avanzate si fa sempre più strada l’idea di considerarli parte integrante della “biblioteca degli adulti”: da qui la volontà di organizzare una sezione giovani adulti all’interno de “ilDock”. Questa sarà per la Biblioteca Provinciale un modo per offrire agli adolescenti qualcosa in più e “di speciale” rispetto ad altri servizi che sono comunque a loro disposizione (come le sale per lo studio con i propri libri, le sezioni di attualità e tematiche, gli spazi di socializzazione, i laboratori didattici e tutto ciò che la biblioteca, nelle sue molte articolazioni, offre a qualunque cittadino). L’area giovani adulti dovrà cercare di venire incontro alla dimensione adolescenziale e di intercettare mode, bisogni, timori. Anche in questa sezione che, per assunto, si pone in continuità con tutti i servizi e le aree della Biblioteca, la formazione del bibliotecario sarà discriminante. Flessibilità, duttilità, capacità di permeare il mondo giovanile con proposte non stereotipate ma estremamente ricettive delle tendenze e degli atteggiamenti culturali, costituiranno le competenze ascrivibili agli addetti al servizio. La scommessa è riuscire a riportare in biblioteca una fascia di età che normalmente non la frequenta più. Il bibliotecario-orientatore curerà di guidare i giovani dai più immediati approcci ai servizi multimediali verso usi più confacenti ad una formazione completa e positiva. Poiché esiste ormai un’offerta editoriale di stampa periodica, specificamente dedicata a questa fascia d’età, si curerà di proporre anche l’uso di questi supporti informativi. La sezione giovani adulti, dedicata agli adolescenti, sarà fisicamente autonoma e indipendente dalla ragazzi e adulti ed assegnata a “ilDock” (dimensionamento: mq. 253; posti: 20). 2.2 Fondi speciali La biblioteca ha un ricchissimo patrimonio riguardante i fondi meridionalistici al punto da collocarla ai vertici nazionali per importanza dei documenti conservati. Per tali ragioni essa svilupperà al suo interno le proprie collezioni, sia attraverso la 222 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia ricomposizione di importanti biblioteche e fondi preesistenti, che risultano smembrati all’interno dell’attuale biblioteca, sia attraverso l’acquisizione di fondi privati che per diversi motivi vivono una vita precaria e non hanno altre e certe prospettive di sviluppo se non addirittura di sopravvivenza (alle quali si potrà offrire ospitalità, garantendone l’identità o l’autonomia anche funzionale, oppure acquisendole e inglobandole a pieno titolo). Particolare attenzione sarà data all’incremento in modo specialistico di quelle aree tematiche che corrispondano alla storia locale e ai fondi meridionalistici. Dovrà essere cantierizzata una ricognizione delle biblioteche private esistenti che potrebbero essere acquisite dalla Biblioteca Provinciale. Nei fondi “speciali” già è presente una specialità diffusa di materiali integrati, che dovrà essere potenziata come nelle restanti aree della Biblioteca (fondi di biblioteche private, manoscritti, fotografie, carte geografiche, manifesti, documenti d’archivio). Va, pertanto, riconosciuto a questo settore l’alto ruolo di biblioteca per la conservazione di materiale raro, antico e di pregio, dichiarato non scartabile e inalienabile (dimensionamento: mq. 475; posti: 50). 2.3 Consultazione e reference generale a) Reference generale Una più decisa caratterizzazione della fisionomia della biblioteca sarà quella di essere una biblioteca in cui vi è una forte integrazione fra risorse professionali (i bibliotecari), risorse informative (cataloghi, repertori bibliografici, banche dati on-line) e materiale documentario posseduto e l’utente accolto, orientato, messo in condizione di esprimere le sue domande in modo che possano essere soddisfatte nel modo migliore, utilizzando i documenti posseduti o ricorrendo a risorse remote. Per questo lavoro di interpretazione dei bisogni informativi è indispensabile che la biblioteca sviluppi un corpo di professionisti specializzati in questo tipo di servizi, i reference librarian, fase avanzata e imprescindibile della più tradizionale mediazione catalografica, con alcune competenze che confermino e ribadiscano il ruolo del bibliotecario in età moderna, ma consentano: • gli accessi virtuali alle fonti consentiti tramite il web della Biblioteca; • l’abilità all’uso dei descrittori per l’accesso a metadata tematici; • la dimestichezza all’uso degli strumenti di e-reference. A corredo del settore di reference, la biblioteca sarà dotata di un ricchissimo apparato di materiali di consultazione a carattere generale: enciclopedie, dizionari e vocabolari; glossari, lessici, annuari, cronologie; repertori, bibliografie correnti e retrospettive, repertori biografici, who’s who; indici, inventari, cataloghi; opere di tipo iconico; raccolte di fonti, di dati statistici e di informazione fattuale, pubblicazioni in forma tabellare; raccolte di norme legislative e tecniche, ecc.. Questo servizio, che pure dovrà contare su una notevole quantità di materia223 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia le cartaceo, si avvarrà di molti prodotti multimediali, che tendono sempre più spesso a sostituire le pubblicazioni a stampa con testo discontinuo. b) Consultazione La funzione e l’articolazione di questa area funzionale dovrà caratterizzare la biblioteca come una reference library, dotata di un ricchissimo apparato di materiali di consultazione (su supporto cartaceo e multimediale), direttamente disponibile per gli utenti. In questa stessa area saranno disponibili anche collegamenti telematici. Per favorire una visualizzazione del collegamento ideale e funzionale esistente tra la consultazione (che potremmo definire anche come settore di cultura generale) e le sezioni tematiche (che potremmo definire come settore di cultura specializzata), si può citare a questo punto il classico concetto di circolarità del sapere, che è alla base dello studio che Antonio Panizzi fece per il salone della vecchia biblioteca del British Museum. Possiamo dire che dalla consultazione l’offerta si dovrà “irradiare” nelle sezioni tematiche. I soli limiti saranno dati dalla disponibilità di risorse economiche e dagli spazi fisici disponibili. Questa impostazione, che è la sola compatibile con le ambizioni che il progetto intende coltivare, presenta le sfide dell’era delle reti e del mercato globale dell’informazione e l’obiettivo deve intendersi come un tentativo di rendere accessibili direttamente o indirettamente, tramite la biblioteca, tutte le fonti informative e documentarie ovunque dislocate. Va ricercato e raggiunto un punto di equilibrio tra la fisionomia della biblioteca di cultura generale e quella specializzata: l’obiettivo ovviamente non deve essere quello di acquistare tutto su tutto, né di inseguire la produzione scientifica nei vari ambiti di specializzazione, bensì quello di fare alta divulgazione assicurando la documentazione dello stato delle conoscenze in un determinato settore, fornendo poi gli strumenti telematici, bibliografici e di localizzazione per l’uso remoto delle risorse documentarie e per chi voglia condurre presso altre biblioteche ed agenzie di informazione le sue ricerche specialistiche. Essenziali, ai fini del raggiungimento di quest’ultimo obiettivo, saranno le strategie di cooperazione interbibliotecaria che la biblioteca riuscirà a mettere in campo. La biblioteca continuerà, dunque, a fondare il suo modello di servizio sulla sala di consultazione come la più completa area di cultura generale, ma introdurrà elementi di specializzazione in aree particolari sulle quali o vi è già una domanda abbastanza matura o prevediamo che possa maturare. La sala consultazione a scaffale aperto sarà dimensionata per 24.000 opere (alcune delle quali in più volumi) e 140 posti di consultazione e sarà divisa per sezioni (10 sezioni). Il numero dei documenti è stimato in rapporto alla superficie disponibile (15-18 mq. ogni 1.000 volumi). Per ciascuna sezione saranno disponibili (eventualmente anche in lingua originale) i classici, le più autorevoli collezioni di testi (nel caso, anche concordanze e altri sussidi). La sala sarà attrezzata con un’iso224 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia la informativa gestita dai bibliotecari, terminali per la consultazione dei cataloghi, posti di consultazione - parte dei quali attrezzati con postazioni informatiche e comunque attrezzati per uso di PC portatili e attrezzabili con postazioni informatiche - ; deposito dei documenti (sia cartacei sia elettronici); attrezzature per la riproduzione di documenti. La sala di consultazione dovrà essere collegata in modo sinergico e coordinato al deposito documenti a scaffale chiuso, in cui sono immagazzinati i volumi eccedenti meno consultati. È molto probabile che le limitate dimensioni della sala non consentano alla biblioteca di esibire a scaffale aperto a livello apprezzabile le collezioni di cultura generale, per cui è anche possibile pensare al deposito come momento suppletivo della sala (dimensionamento: mq. 630; posti: 140). c) Seriali Un problema su cui riflettere con particolare attenzione è quello dell’organizzazione e dell’uso di riviste e periodici, che, dato il carattere della biblioteca, rivestono un ruolo molto importante nella connotazione e nell’aggiornamento. Una parte dei periodici specializzati, ad esempio, dovranno convivere nelle sezioni tematiche con le monografie della medesima disciplina, mentre le riviste di cultura generale troveranno posto assieme ai giornali nell’emeroteca. Si tratta di dare una più marcata fisionomia di cultura generale all’attuale sala periodici che dovrà arricchire le sue collezioni di seriali divulgativi e di cultura generale, mentre quelli più specialistici afferenti alle sole sezioni tematiche specializzate saranno spostati nelle singole sezioni. Sul piano funzionale la sala periodici, che condivide con la sala di consultazione il banco di distribuzione dovrà sempre più integrarsi all’interno di questa area di consultazione e di cultura generale. Una particolare attenzione verrà rivolta alle politiche di cooperazione interbibliotecaria e alle pratiche di document delivery in grado di riempire le lacune e le carenze delle collezioni (dimensionamento: mq. 208; posti: 42). 2.4 Centri di documentazione e sezioni tematiche a scaffale aperto Accanto al servizio di consultazione generale si prevedono, dunque, alcuni servizi di consultazione e reference altamente specializzati, presso le sezioni tematiche, rivolti a soddisfare particolari esigenze o particolari categorie di utenti. I prodotti (bollettini di accessioni e novità, dossier informativi, dossier bibliografici, raccolte di normative, spogli di articoli, rassegne stampa, sintesi e bollettini di abstract, ricerche su commessa) che la biblioteca potrà offrire consentiranno di penetrare anche in ambienti che difficilmente verrebbero raggiunti tramite i tradizionali servizi bibliografici, rappresentando così un’efficace opera225 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia zione di marketing e creando un auspicabile indotto anche sugli altri servizi bibliotecari. Al di là della sua pratica utilità, infatti, tale servizio è importante per l’effetto che può provocare, trasformando notevolmente l’immagine della biblioteca agli occhi di quei cittadini che non conoscono le potenzialità dei servizi di pubblica lettura. Lo sviluppo della politica generale delle collezioni della biblioteca e l’articolazione dei settori in aree tematiche e/o di interesse confluiscono nel sistema informatico centrale ed unico della biblioteca. Questo sistema è a forte impianto integrato fra: • livelli delle dotazioni patrimoniali; • livelli dei sistemi di identificazione delle informazioni; • livelli analitici e sistematici di trasmissione delle conoscenze. Si traduce nella confluenza fra OPAC e Web e il loro integrarsi nelle cooperazioni nazionali ed internazionali. Questa parte della biblioteca che definiremo settore tematico troverà la propria sede definitiva presso la palazzina dell’ex “Marconi” che offre una disponibilità al coperto di oltre 900 mq. ed uno spazio all’aperto di circa 600 mq. Anche per l’utilizzazione di questa palazzina si applicheranno i principi della biblioteca a tre livelli. Il settore di ingresso coincide con il palmeto ed una parte del piano rialzato. Il lettore entrerà in biblioteca attraverso il palmeto e troverà di fronte il vecchio corridoio trasformato in porticato. La segnaletica indicherà l’internet café di fronte e a destra l’ingresso alla biblioteca vera e propria. L’internet café, la cui gestione commerciale sarà esternalizzata, svolgerà sul piano propriamente culturale le funzioni del vecchio caffè letterario con un’area dedicata all’esibizioni culturali serali (martedì letterario, mercoledì musicale, giovedì cinematografico, ecc…). L’ambiente funzionerà da hall con i servizi di accoglienza, di reference e le novità in vetrina dell’intero settore. Sarà disponibile un’area per esposizioni a tema. Nell’ingresso e in diversi punti del sistema di circolazione vi saranno postazioni telematiche in piedi. a) Centri di documentazione La biblioteca dilata le proprie funzioni con alcune aree di documentazione multimediale già definite con l’istituzione de “ilDock”. Le azioni previste riguarderanno certamente la conservazione territoriale della documentazione selezionata e raccolta presso il Centro a seguito di relazioni di snodo e scambio di relazioni progettuali fra quanti, Enti e organizzazioni, ne siano produttori. La sezione didattica, ad esempio, non si configura assolutamente come biblioteca specializzata; la proposta è riuscire ad essere raccordo fra i sistemi territoriali che si occupano di istruzione e formazione per favorire l’integrazione, e risoluzioni di svantaggio e l’orientamento; per questa sezione sono strategiche le rela226 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia zioni territoriali con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Provveditorato di Foggia e le Scuole della Provincia. Oltre alla didattica le sezioni tematiche previste sono: ambiente, integrazione europea, giovani adulti, intercultura e interetnicità, fumetto, cultura materiale. Alcune biblioteche americane (quella di San Francisco, ad esempio) ospitano spazi per l’istruzione della popolazione immigrata e per lo svolgimento delle attività culturali di ciascun gruppo (centro interculturale). L’istruzione mira a facilitare l’inserimento nel tessuto sociale (apprendimento della lingua, delle norme di vita associata, dei mestieri); lo svolgimento di attività culturali mira a conservare identità e tradizioni dei gruppi etnici in un quadro di integrazione. Questo modello, sviluppato in una nazione che ha tratto dall’immigrazione la sua linfa vitale, può essere imitato anche a Foggia, a servizio di una provincia che sarà sempre più interessata da fenomeni migratori. I centri di documentazione de “ilDock” comprendono spazi per riunioni di gruppo, spazi per la conservazione di documenti, spazi per la lettura, con postazioni informatiche o televisive per l’apprendimento della lingua e dei mestieri e delle abilità (modello utilizzato anche nel Centre Pompidou a Parigi). I centri di documentazione de ”ilDock” da un verso saranno i luoghi di raccolta, selezione, conservazione e divulgazione della produzione culturale relativa a queste aree tematiche. Dall’altro verso diventeranno il centro di coordinamento di attività svolte prevalentemente nelle biblioteche decentrate o nelle scuole. È in corso una ricognizione delle strutture esistenti sul territorio che potrebbero entrare in relazione interattiva con “ilDock” e fungere anche da indicatori e verificatori delle informazioni fornite. Quindi “ilDock”, in quanto momento di sintesi dei centri di documentazione e delle aree tematiche “speciali”, non sarà tale solo perché ospiterà materiali “speciali” (letteratura grigia, fotografie, carte geografiche, manifesti, documenti d’archivio; anche se non si esclude che possano esistere parti dedicate a particolari categorie di documenti), ma perché si tratta di una struttura con una sua autonoma fisionomia e organizzazione. b) Sezione “Immagini&Suoni” La Biblioteca Provinciale sarà articolata (come, ad esempio, la Biblioteca dell’Aia) per sezioni, disciplinari o problematiche, non per supporti. In ogni sezione saranno disponibili sia supporti cartacei (libri e riviste) che supporti informatici. Nelle sezioni tematiche non appare, infatti, utile e funzionale una separazione dei materiali per tipologia. Tutte le tipologie di documenti che potranno utilmente e congiuntamente essere consultate per rispondere ad un unico bisogno informativo, riconducibile ad una disciplina, dovranno essere collocate nella stessa sezione. La sezione “Immagini&Suoni” (che si distingue dalle altre sezioni per modi e mezzi prevalenti di consultazione) ospiterà prevalentemente documenti relativi al 227 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia cinema, alla musica, allo spettacolo, all’informazione radiotelevisiva: sia audiovisivi (documenti sonori, videocassette, videodischi, pellicole) che cartacei (libri e documenti sul cinema e sulla televisione, libri di musica e spartiti musicali). Sarà l’equivalente in sedicesimo della sezione “Musica e film” della Biblioteca dell’Aia o della sezione “Immagine e suono” della nuova Biblioteca di Francia. Oltre a spazi per la consultazione individuale comprenderà spazi per la consultazione di gruppo e stazioni multimediali. Queste sezioni tematiche nascono dall’evoluzione di situazioni preesistenti e che risultano attualmente prive di una forte identità e, soprattutto, sovrapposte e non fuse nella missione della biblioteca. Si tratta dell’area dei manifesti cinematografici che evolverà in una biblioteca specializzata sul cinema con particolare riferimento alla grafica cinematografica e dell’area della fonoteca che si svilupperà in una biblioteca specializzata sulla musica con particolare riferimento ad alcuni generi che saranno oggetto di analisi più approfondita della domanda e delle potenzialità. Vi è una terza area che si sviluppa intorno al teatro e agli spogli di riviste effettuati negli anni Sessanta dal maestro Taronna. Questa area si evolverà in una sezione specializzata nel teatro classico e moderno pugliese. Dovranno essere previste, oltre alle normali postazioni di lavoro della biblioteca, postazioni “comode”. Per ciascuna sezione tematica saranno disponibili (eventualmente anche in lingua originale) i classici, le più autorevoli collezioni di testi (nel caso, anche concordanze e altri sussidi), le fonti, i manuali e i trattati, le monografie fondamentali, le opere che meglio documentano la storia delle singole discipline, gli atti dei principali congressi scientifici, bollettini di abstracts, bollettini delle ricerche in corso, annate correnti delle principali riviste specializzate, rapporti recenti di organizzazioni e associazioni professionali, atti e calendari di congressi e manifestazioni espositive, rassegne stampa tematiche, e ogni altro genere di documenti (pubblicazioni a stampa, letteratura grigia, audiovisivi, documenti elettronici, ecc…) che siano atti ad offrire un panorama il più possibile completo dell’evoluzione delle conoscenze su un determinato tema, dello stato dell’arte, delle tendenze più innovative delle ricerche sull’argomento. Le bibliografie specializzate e altri repertori specifici faranno parte della collezione generale di reference. In ogni caso si opterà per le versioni digitali delle bibliografie specializzate che saranno inserite nella intranet e, quindi, consultabili da qualsiasi computer attivo in biblioteca. Ognuna di queste sezioni avrà una propria articolazione interna. Ciò sia per quanto riguarda il materiale documentario (volumi a stampa, periodici specializzati, documenti su sopporto digitale, collegamenti on-line), sia per quanto riguarda le attività che vi si svolgeranno, che per gli ambienti di lavoro (ci sarà del personale assegnato a una determinata sezione, o a sezioni che presentino una certa affinità dal punto di vista disciplinare; i bibliotecari-bibliografi addetti alle sezioni svolgeranno anche servizio di reference avanzato e/o selettivo. La disponibilità di un immobile dedicato a questo settore (l’ex Liceo 228 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia “Marconi”), sebbene non sia stato progettato per essere una biblioteca, consente di immaginare le sezioni tematiche come un qualcosa di unitario. Le sezioni tematiche saranno comunque organizzate a scaffale aperto e saranno ad accesso libero da parte degli utenti, ma, anche per non occupare troppo spazio, andranno sottoposte ad un costante lavoro di svecchiamento: infatti, tranne alcune tipologie di documenti (classici, fonti, monografie fondamentali, ecc…), che rimarranno sempre in sala, tutto il materiale che abbia perso di attualità o che possa essere sostituito da edizioni più aggiornate verrà periodicamente sostituito e trasferito nel magazzino. Ciò vuol dire che esisterà un settore di magazzino corrispondente a ciascuna sezione tematica, gestito dal personale della sezione. La sezione multimediale farà riferimento al centro di digitalizzazione per la produzione e riproduzione di documenti. La sezione multimediale sarà dimensionata per 20 posti di consultazione, 20.000 documenti audiovisivi, 8.000 libri o spartiti, oltre ai 30.000 manifesti cinematografici già in nostro possesso. 2.5 Magazzino Lo spazio dei magazzini dovrebbe essere sufficiente ad ospitare circa 500.000 volumi. Purtroppo l’unico magazzino attualmente in funzione ha quasi raggiunto il limite di saturazione. L’individuazione all’interno dell’ex “Pascal” di un’area in grado di soddisfare al fabbisogno dei prossimi anni consentirà alla biblioteca di risolvere il problema per altri dieci anni. L’utilizzazione da suo canto di un piccolo magazzino presso l’ex “Marconi” consentirà al settore tematico di poter operare in tranquillità almeno per cinque anni. Sarebbe necessario dar vita ad una sala di lettura a servizio dei volumi collocati nel magazzino. Finora questa funzione è stata svolta dalla sala adulti, che però perderà questa funzione. L’idea che è maturata è quella di porre in una visione unitaria il magazzino in diretta relazione con la principale e più completa sala di lettura della biblioteca (la sala di consultazione) che sarà così in grado di fornire i servizi di lettura in una duplice forma: a scaffale aperto e in magazzino. Il deposito comprende il magazzino dello scaffale aperto (documenti trasferiti a magazzino perché non più attuali da parte della sala di consultazione e della sala periodici) e il magazzino dei documenti provenienti dal diritto di stampa, doni e scambi. Il deposito è dimensionato complessivamente per 500.000 volumi, è attualmente saturo per la grande mole di seriali che nel corso dell’ultimo quarto di secolo hanno superato di gran lunga le stime iniziali. È in fase di definizione la sistemazione del piano terra dell’ex “Pascal” dove verranno sistemati i documenti meno utilizzati del deposito corrente (periodici cessati), liberando di conseguenza un’area in grado di ospitare circa 200.000 volumi. Il deposito è collegato alle sale lettura con montalibri. 229 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia 2.6 Spazi per lo studio e la lettura La città di Foggia, come tutte le sedi di università, soffre di una grave carenza di spazi per la lettura da mettere a disposizione degli studenti. La Biblioteca Provinciale, oltre alle sale di lettura e consultazione per l’utilizzo del materiale librario e documentario della biblioteca, disporrà presso l’ex “Pascal” di ampie sale di lettura “dedicate”, cui potranno accedere universitari per poter studiare in ambienti confortevoli. Lo scopo di questo servizio non sarà solo quello di dare ospitalità a chi desidera studiare sui propri materiali, ma di far svolgere questa attività in un contesto di più ampio respiro: la biblioteca pubblica è un luogo in cui lo studio e la ricerca, anche se a livello specialistico, non avvengono in modo parcellizzato come di solito accade nelle biblioteche universitarie. Gli studenti dovranno essere invitati ad accedere alle risorse documentarie di carattere multidisciplinare e interdisciplinare di cui la biblioteca disporrà. Al di là di questi spazi dedicati a tale specifico servizio, la Biblioteca Provinciale si propone di essere un luogo in cui sarà piacevole trattenersi per leggere, studiare, informarsi, conversare. Oltre ai consueti tavoli a 4 o 6 posti nelle sale a scaffale aperto, saranno anche disponibili molte postazioni di lettura informali (poltrone, divanetti, puff, ecc...) e si cercherà di allestire alcuni di posti di lettura nell’ampio cortile alberato dell’ex “Pascal”. Al riguardo si è già proceduto ad una sistemazione dell’area verde. 2.7 L’area telematica Come si è già fatto cenno in precedenza, l’introduzione dell’informatica e della telematica in biblioteca non può più essere intesa come una mera innovazione tecnologica, simile a quella che ha caratterizzato il passaggio alla catalogazione automatizzata dei decenni scorsi. La telematica ha introdotto qualcosa di profondamente diverso nei tradizionali approcci biblioteconomici al punto da diventare un’altra espressione della fisionomia culturale della biblioteca. L’evoluzione di questi ultimi anni ha già prodotto diverse generazioni di librarian web, che da semplici messe in rete dei cataloghi e dalla diffusione di informazioni statiche sui servizi e le funzioni della biblioteca si sono evoluti in portali bibliografici, che forniscono informazioni e servizi. Il modello prospettato per la Biblioteca Provinciale di Foggia tende a superare perfino questa ultima generazione di web. I cardini della biblioteca a tre livelli possono, infatti, essere applicati all’organizzazione del web per produrre una reale integrazione dei servizi. Il coordinamento a diversi livelli tra i servizi bibliotecari reali e quelli digitali e la diversificazione dei servizi fra reali, digitali on e off line, sono una possibile risposta adeguata ad un’utenza non rigidamente vincolata al ristretto ambito di copertura territoriale. In questo modo il compito immane della 230 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia biblioteca che è quello di rispondere ai bisogni di cultura e informazione di ogni cittadino è facilitato dalle risorse di rete. Quello che avviene a livello di singola biblioteca nel modello a tre livelli può essere trasposto nel portale. La determinazione del patrimonio e dei servizi in base alle fasce d’utenza a cui esplicitamente la singola biblioteca sceglie di indirizzarsi, nel Web si traducono nella scelta di evitare di privilegiare la sua funzione generalista a favore della gradualità della specializzazione delle sue funzioni. Il portale offrirà certamente i servizi telematici generali più noti (catalogo, informazioni statiche e dinamiche sui servizi e le attività della biblioteca, servizi dinamici come il reference on-line), ma sarà un luogo di incontro (con bacheche elettroniche, gruppi di discussione, ecc…) e offrirà funzioni di reference con e senza mediazione bibliotecaria anche in ambiti specialistici, in modo completamente diversi dai servizi bibliotecari tradizionali. In particolare la questione che si vuole affrontare con questo progetto riguarda uno dei servizi più avanzati di quel complesso di attività e di assistenza ai lettori che viene definito reference che, rafforzato dalle potenzialità delle telematica odierna, consentono ad una biblioteca di levatura interregionale, quale è “la Magna Capitana”, di presentarsi nel panorama nazionale con una proposta innovativa sul piano biblioteconomico e, contemporaneamente, valida sul piano della ricerca documentale e della valorizzazione delle risorse locali. Ogni parte del nostro pianeta è, infatti, caratterizzata da specificità ambientali, territoriali, economiche, sociali e culturali che spesso hanno assunto valenze di carattere generale, assurgendo perfino a momenti emblematici della civiltà di un intero Paese. La telematica consente alla biblioteca, quale agenzia di informazioni, di assumere, nell’ambito della costruzione e della gestione delle risorse elettroniche in rete, una funzione in forma selettiva di costruttore di risorse elettroniche integrate. A partire proprio dalle caratteristiche del territorio di appartenenza. Si tratta in sostanza di realizzare risorse elettroniche tematizzate, rigorosamente ed esclusivamente in rete, in grado di fornire puntuali informazioni generali, bibliografiche, audiovisive, ecc... secondo un processo di aggiornamento costante delle fonti di informazioni, facendo ricorso peraltro all’essenziale interattività che esiste fra ricerca in rete, fornitura di informazioni e aggiornamento dei dati. L’obiettivo principale è quello di diventare, per particolari temi legati al territorio di appartenenza, luogo privilegiato di raccolta e di fornitura di informazioni bibliografiche in senso lato, sia di documenti posseduti localmente, sia di fonti di qualsiasi altra origine non presenti in loco. Si tratta, indubbiamente, di un progetto ambizioso che dovrà richiedere diversi anni per la sua completa costruzione e dovrà vedere impegnati ricercatori, bibliotecari ed informatici sia interni che esterni alla biblioteca nella costruzione, ricerca e aggiornamento dei siti che si propongono. Il collegamento e l’interazione tra le diverse sezioni, attraverso la circolazione del patrimonio, realizzano l’unità della biblioteca a tre livelli. L’interazione fra 231 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia OPAC, informazioni, servizi on-line, risorse digitalizzate e le diverse sezioni della biblioteca fisica realizzano l’unità della biblioteca ibrida. Sarà, inoltre, importante sviluppare una politica di digitalizzazione del meglio del patrimonio antico, raro e speciale in possesso della biblioteca (meridionalistica, fondi locali, manoscritti, manifesti, reperti audio e video), da mettere in rete e consentire l’accesso alla lettura e il download in chiaro o con password. In tal senso “la Magna Capitana” parteciperà al progetto nazionale della Biblioteca Digitale Italiana. Il Web a tre livelli si snoderà, dunque, attraverso una progressiva penetrazione fra le informazioni generali, le informazioni di comunità, l’OPAC, le informazioni interattive, i servizi on-line, i siti monotematici fino ai download delle risorse digitalizzate. 2.8 Auditorium e sale È in fase di completamento la ristrutturazione dell’auditorium, destinato ad ospitare conferenze e convegni, utilizzabile anche come sala multimediale. La capienza è di 160 posti. Nei pressi dell’auditorium devono essere localizzate alcune salette riunioni, utilizzabili anche come aule per attività di istruzione. Si tratta di spazi flessibili, frazionabili od accorpabili secondo necessità. Il dimensionamento tiene conto unicamente della dotazione minima considerata necessaria per la biblioteca: auditorium di 306 mq. per 180 posti, 1 aula seminario da 40 posti (presso l’ex “Marconi”), 2 aule seminari da 25 e 30 posti presso la sede centrale (dimensionamento: mq. 500). 2.9 Ambienti di lavoro Le postazioni per la consultazione dell’OPAC e delle altre banche dati disponibili, attraverso le quali si potrà interagire con i diversi servizi della biblioteca, saranno diffuse in tutti gli ambienti accessibili al pubblico e negli uffici. Tutti i posti a sedere “tradizionali” (tavoli grandi e piccoli), compatibilmente con l’architettura delle sale, saranno corredati di attacchi per chi si recherà in biblioteca col proprio notebook. Solo una minima quota di bibliotecari e aiuto bibliotecari lavorerà in “uffici” inaccessibili al pubblico, in quanto gran parte dei bibliotecari saranno addetti, o si alterneranno, ai lavori di consulenza e assistenza. Comunque, i loro ambienti di lavoro dovranno essere il più possibile contigui agli spazi per il pubblico, in base al principio che il servizio bibliotecario nasce nel momento in cui viene erogato e quindi l’offerta va allestita là dove nasce e si esprime la domanda. Come è ovvio, sono da prevedersi alcune eccezioni, essenzialmente per le fasi iniziali del trattamento dei documenti e per le funzioni di direzione e management. Gli spazi destinati all’amministrazione comprenderanno spazi per: 232 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia • servizi amministrativi (direzione, segreteria, personale, contabilità, ricevimento e spedizione di pacchi); • servizi scientifici (sviluppo collezioni, ordine e ricevimento libri, registrazione, classificazione, catalogazione e indicizzazione, gestione amministrativa periodici, ecc...); • servizi tecnici (informatizzazione, rilegatura ed etichettatura, conservazione, stampa, ecc…). Parte dei servizi si svolgerà a diretto contatto col pubblico (in particolare nelle isole informative presenti in tutti i settori della biblioteca). La biblioteca dovrebbe riuscire a mettere a disposizione complessivamente non meno di 500.000 volumi, consultabili mediante circa 500 di posti di lettura. Tutto il materiale, e in primo luogo quello collocato a scaffale aperto, dovrà essere protetto da un sistema antitaccheggio. 3. La politica documentaria e lo sviluppo delle raccolte La fisionomia bibliografica che è stata appena tracciata può essere perseguita solo attraverso una accurata politica di selezione condotta da bibliotecari-bibliografi e da consulenti esterni che venga attentamente discussa, giungendo anche ad una formalizzazione in un protocollo e nella definizione di un vero e proprio progetto di collection development. Il budget annuo per lo sviluppo delle collezioni, fissato attualmente di 200.000 euro, sarà definitivamente tarato sul livello effettivo di copertura che scaturirà dalla redazione della carta delle collezioni. La politica documentaria della biblioteca si dovrà inserire pienamente nel ciclo gestionale, in quanto tocca la fase della definizione degli obiettivi, quella della scelta del materiale da acquisire, quella del suo trattamento fisico e catalografico, quella della valutazione dell’utilizzo delle collezioni da parte degli utenti. Quindi il problema non è solo di crescita quantitativa delle raccolte, ma di costruzione e valutazione complessiva della loro funzionalità. In effetti, il procedimento di selezione e acquisizione dei documenti è solo uno dei momenti attraverso il quale si realizza la gestione della collezione documentaria di una biblioteca, collezione che non necessariamente deve svilupparsi attraverso una linea di crescita quantitativa continua. Parte integrante del processo di gestione delle collezioni è, infatti, il lavoro di revisione periodica del posseduto. Esiste una dimensione qualitativa della crescita che non è detto corrisponda solo ad un aumento del numero delle unità bibliografiche possedute. Una volta che la biblioteca abbia raggiunto quello che si riterrà il suo dimensionamento ottimale nelle singole aree, per un totale di 500.000 documenti, si potrà procedere nella ricerca di un equilibrio tra scarti e acquisizioni che mantenga ed elevi la qualità della raccolta senza appesantirne la gestione. Non per questo il mancato aumento delle 233 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia dimensioni fisiche vorrà dire che la biblioteca non starà “crescendo” e non sarà egualmente un organismo in sviluppo, sia perché l’aggiornamento è crescita, sia perché la biblioteca sarà inserita in un sistema cooperativo di circolazione dell’informazione e dei documenti che garantirà comunque la sua vitalità. La crescita reale della biblioteca, quindi, sarà il risultato della incisività con cui essa saprà inserirsi in un più ampio sistema di circolazione delle conoscenze, rappresentando ai propri utenti i prodotti dell’industria editoriale e offrendo loro le informazioni sui documenti disponibili e sulla loro localizzazione. 3.1 Politica degli acquisti Per dare organicità e dignità alla politica documentaria della biblioteca occorrerà formalizzare la carta delle collezioni in un documento programmatico o dichiarazione scritta di intenti, in cui esplicitare – a tutto lo staff, agli utenti, agli amministratori e finanziatori della struttura, alle altre biblioteche con cui si intrattengono rapporti di cooperazione – gli obiettivi di tale politica, correlandoli alle finalità generali della struttura. Nella carta delle collezioni si dovranno esporre i parametri di riferimento prescelti (riferiti al contesto in cui la biblioteca è incardinata e al bacino d’utenza cui si rivolge), le priorità che si intendono perseguire, il livello di approfondimento nelle varie aree tematiche che si ritiene di dover garantire, i criteri che si intendono adottare per la selezione del materiale, e così via: la stesura di tale documento è una importante occasione per riflettere sull’identità della biblioteca, così come esso potrà divenire in seguito uno strumento per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della coerenza con cui essi sono stati perseguiti. Sarà questo il primo compito del direttore, anche se non si può pensare che una sola persona possa sostenere l’onere di questo lavoro. La formalizzazione sistematica della politica documentaria è affidata essenzialmente alla elaborazione di due documenti: la carta delle collezioni e il piano di sviluppo delle collezioni. 3.2. La carta delle collezioni La carta delle collezioni è lo strumento di programmazione che propone gli obiettivi generali della politica documentaria della biblioteca e i principi cui essa si ispira: essa sarà il risultato di una elaborazione collettiva, concertata con l’Amministrazione Provinciale e sottoposta alla sua approvazione, e infine portata a conoscenza del pubblico e delle strutture con cui la biblioteca interagisce, affinché l’utenza reale e potenziale sia in grado di valutare fino a che punto si riconosce negli obiettivi della biblioteca. Come già si è detto parlando della fisionomia bibliografica del nuovo istitu234 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia to, l’elaborazione della politica documentaria sarà affidata ad una équipe selezionata di bibliotecari-bibliografi, eventualmente integrata da consulenti esterni, che, specie nella prima fase attuativa, dovrà discutere attentamente sulle finalità della biblioteca, traducendo i risultati di tale discussione nell’individuazione delle materie prime da cui partire per progettare i servizi. La carta delle collezioni – che andrà rivista e aggiornata periodicamente, preferibilmente con cadenza quinquennale, anche alla luce di una valutazione del grado di soddisfacimento degli utenti – conterrà informazioni piuttosto dettagliate in merito ai diversi punti in cui si concretizza la politica documentaria: a) analisi strategica del territorio che forma in bacino di utenza della biblioteca con particolare attenzione alle variabili sociali, economiche e culturali, alla dimensione della domanda e dell’offerta culturale, all’analisi dei lettori reali, all’analisi della domanda potenziale e della domanda inespressa, alla definizione degli scenari di medio termine e all’anticipazione della domanda futura; b) posizionamento della biblioteca rispetto alla comunità da servire e suoi obiettivi generali, con l’indicazione delle coperture che si intendono realizzare, sia dal punto di vista delle aree disciplinari che della tipologia di bisogni (ricerca, istruzione, divulgazione, informazione di base, ecc...) che si propone di soddisfare; c) prima traduzione delle finalità esposte al punto precedente nella specificazione dei grandi settori in cui la biblioteca intende muoversi e conseguentemente dei propri fondi documentari. Pur assumendo ad unità il posseduto dell’intera biblioteca, saranno esplicitate le caratteristiche delle diverse sezioni (di consultazione generale, speciali, specialistiche, ecc…), con una indicazione del taglio che si intende dare alle raccolte nei diversi settori. Si specificherà il livello di copertura bibliografica (da 0 a 5) delle 24 aree tematiche previste dalla metodologia; si preciserà la consistenza prevista per la raccolta e il livello di copertura desiderato. La qualificazione della copertura bibliografica va integrata con la valutazione della copertura per aree linguistiche e geografiche, periodi cronologici, tipologie di materiale – ad esempio monografie, periodici, giornali, microforme, manoscritti, pubblicazioni ufficiali, audiovisivi, ecc... L’ultima parte del documento prevede la definizione delle priorità con cui le risorse disponibili verranno impiegate per il soddisfacimento dei diversi bisogni; in questa parte della carta tali aspetti verranno affrontati ad un livello generale, mentre molte questioni specifiche saranno oggetto di una più dettagliata trattazione nei diversi punti in cui il documento si articola. d) elencazione dei supporti documentari che saranno oggetto delle acquisizioni, anche in riferimento ai diversi settori e alle tipologie d’utilizzo. Ad esempio per i materiali di reference bibliografici si farà ampio uso di banche dati in linea o su CD-Rom, mentre per alcune collezioni di classici si farà riferimento alla digitalizzazione o ad altre forme di riproduzione; 235 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia verranno, invece, impiegati i microfilm come sostituto dei quotidiani a fini di conservazione, al fine di ridurre gli spazi occupati nel magazzino; e) per alcuni ambiti particolarmente problematici o per quelli su cui la biblioteca vuole esercitare un’azione privilegiata, andrà specificata la politica che si intende perseguire e i criteri di scelta che verranno adottati (dichiarando cosa si farà, ad esempio, per la manualistica, o come ci si comporterà per quanto riguarda le registrazioni sonore e televisive); parimenti verranno indicate priorità e limitazioni che governeranno la politica degli acquisti per determinati ambiti (inclusione o esclusione di particolari forme di documenti e supporti, di lingue o aree geografiche, estremi cronologici, ecc...); f) vanno anche precisati i limiti entro i quali si terrà conto dei desiderata degli utenti; (chiarendo se essi verranno sempre accolti, entro i limiti consentiti dal budget, oppure se verrà effettuata anche una valutazione di merito per garantire la coerenza delle acquisizioni); g) va dichiarato anche l’atteggiamento della biblioteca in riferimento a delicate questioni di carattere deontologico; h) un’altra indicazione che la carta dovrà contenere riguarda l’atteggiamento della biblioteca nei confronti di doni e scambi e i criteri in base ai quali essi verranno accettati o rifiutati; i) va anche resa esplicita la politica di revisione periodica delle collezioni che la biblioteca adotterà e la volontà o meno di procedere ad uno scarto del materiale obsoleto o deteriorato; j) un’altra importante indicazione riguarda le fonti attraverso le quali avverrà l’approvvigionamento (librerie, editori, mercato antiquario, acquisti diretti all’estero, ecc...); k) una forma complementare all’acquisto in sede locale è l’utilizzazione delle reti di biblioteche come risorsa cui attingere per rendere accessibile ciò che non si possiede ed è opportuno quindi che la carta indichi i criteri e le forme attraverso cui si intende eventualmente coordinare con altre biblioteche la politica degli acquisti e le scelte che verranno attuate per l’attivazione di servizi di prestito interbibliotecario e di fornitura di documenti; il documento fornirà il quadro di riferimento territoriale e il quadro delle risorse complessivamente impiegate in una politica di sviluppo e utilizzo cooperativo delle raccolte; l) vanno anche indicati i criteri e la periodicità con cui si procederà alla revisione dei risultati dell’analisi del contesto e dell’utenza e alla definizione dei principi ispiratori della politica documentaria, per individuare i cambiamenti intervenuti negli obiettivi generali, nei bisogni degli utenti, nelle priorità, ecc…; m) il documento conterrà, infine, l’indicazione delle figure responsabili degli acquisti e della composizione dei comitati di esperti (bibliotecari-bibliografi 236 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia addetti ai vari settori e consulenti esterni) che parteciperanno alla selezione del materiale da acquistare. 3.3. Il piano di sviluppo delle collezioni Il piano di sviluppo delle collezioni, determina anno per anno gli obiettivi con cui viene applicata la carta delle collezioni e le modalità per l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Si tratterà di un documento interno riconducibile essenzialmente alla responsabilità del direttore della biblioteca, ma discusso e concordato tra le diverse sezioni con l’intento di conciliarne le esigenze. Nella sua forma più sintetica esso può consistere in una ripartizione del budget annuo, anche sotto forma di tabella, mentre nella sua stesura completa il piano sarà esposto in un documento molto più elaborato, che tenga conto degli obiettivi e dei risultati dei piani di sviluppo degli anni precedenti e che talvolta può anche introdurre qualche elemento innovativo riguardo alla carta delle collezioni in attesa di una sua revisione. Ciascun piano annuale va immaginato come il segmento intermedio di un più generale percorso di sviluppo, che si inquadra negli obiettivi di medio termine della biblioteca e che tiene conto dello stato delle collezioni e del loro utilizzo. È un utilissimo strumento di lavoro per i responsabili delle varie sezioni e per i bibliotecari-bibliografi addetti alle acquisizioni, che possono guardare in termini complessivi al bilancio e alla collezione, collocando le scelte per il proprio particolare settore in una strategia di più ampio respiro. I risultati di questa riflessione collettiva e delle decisioni finali saranno: a) la presentazione degli obiettivi prioritari per l’anno cui il piano si riferisce, in funzione di quanto previsto dalla carta delle collezioni e dei risultati del piano di sviluppo dell’anno precedente; b) la traduzione di questi obiettivi in quantità di documenti che ci si propone di acquistare per ciascun settore, sia in relazione alle novità correnti che allo scopo di colmare le lacune riscontrate e di operare un certo riequilibrio; c) la ripartizione del budget per i diversi settori (calcolata, quindi, in base al costo medio dei diversi generi di pubblicazioni e delle pubblicazioni delle diverse aree disciplinari), considerando tutte le somme disponibili (eventuali residui degli esercizi precedenti, dotazione corrente, eventuali assestamenti di bilancio in corso d’anno, ecc...); d) una valutazione dei risultati che questa ipotesi di sviluppo produrrà nella composizione della collezione, in relazione sia ai diversi settori d’uso (aree di divulgazione, narrativa, consultazione, sezioni speciali e specialistiche, collezione di reference, ecc...), sia alle diverse aree disciplinari (agricoltura, antropologia, arte e architettura, biologia, economia, informatica, pedagogia, ingegneria e tecnologia, geografia e geologia, storia, lingua e letteratura, diritto, biblioteconomia, matematica, medicina, filosofia e religione, sport e 237 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia tempo libero, fisica, scienze politiche, psicologia, sociologia), sia alle diverse tipologie di documenti e ai diversi generi (opere di consultazione, giornali e riviste, narrativa, saggistica, supporti multimediali, risorse elettroniche, letteratura grigia, ecc...); e) l’indicazione delle somme riservate alla soddisfazione dei desiderata degli utenti e dei vincoli di coerenza col piano di sviluppo che verranno applicati nel valutare tali richieste; f) l’enunciazione dell’atteggiamento che si intende tenere rispetto a questioni particolari, come l’acquisto di più esemplari delle edizioni maggiormente richieste, la scelta del materiale rilegato con copertine rigide in confronto di quelle in brossura, la scelta di versioni digitali da inserire nella intranet invece di più copie cartacee della stessa opera; g) l’individuazione di una soluzione per problemi verificatisi negli anni precedenti e che potrebbero presentarsi nuovamente (decisioni non coerenti con il piano prestabilito, acquisto di doppioni indesiderati, sovrapposizioni o conflitti di competenze fra settori, ecc...); h) l’indicazione dei criteri che verranno adottati per lo svecchiamento e lo scarto. La redazione di questo documento offrirà anche l’occasione per una verifica annuale delle scelte di fondo compiute dalla biblioteca e dell’adeguatezza o meno delle risorse e degli strumenti rispetto agli obiettivi che sono stati fissati. Il piano di sviluppo delle collezioni avrà bisogno in molti casi anche di essere rivisto e modificato nel corso dell’anno, in modo che si possa tener conto degli imprevisti e introdurre i necessari aggiustamenti. 3.4. Politica di revisione Un naturale complemento dell’attività di acquisizione è costituito dalla periodica revisione delle collezioni, che quindi non va concepita come un’incombenza occasionale e marginale. La revisione delle collezioni è da intendere principalmente come un’azione di ricollocazione dei documenti all’interno degli spazi della biblioteca, anche se non è da escludere una vera e propria azione di eliminazione. La pratica della revisione della collezione è piuttosto complessa e richiede un lavoro assai rigoroso. Infatti, come la politica delle acquisizioni non è il frutto casuale di singoli atti, finalizzati ciascuno all’acquisizione di un singolo documento, ma il risultato di un disegno, di un progetto, di una strategia, di una programmazione sviluppata nel tempo, così anche il lavoro di revisione non si esaurisce nella episodica eliminazione di qualche volume usurato da una circolazione particolarmente intensa o superato da edizioni più aggiornate. La programmazione della revisione è affidata solitamente ad una analisi della collezione che tiene conto: a) dell’età del volume (la data del copyright indica solitamente l’età delle 238 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia informazioni che il volume contiene); b) del tempo trascorso dall’ultimo utilizzo (ricavando l’informazione dalle statistiche sulla circolazione); c) dalla presenza di uno o più fattori negativi (il volume contiene informazioni scorrette; il volume è da considerarsi superficiale o mediocre; il volume è deteriorato o sporco, privo di alcune pagine, non più rilegabile; il contenuto è sorpassato; il volume è inadeguato e non coerente con la collezione); d) maturazione del dibattito culturale e scientifico. In base a questi parametri è possibile indicare per ciascuna classe C.D.D. la soglia oltre la quale un’edizione è candidata alla ricollocazione. Per ciascun ambito, inoltre, si può tener conto di particolari annotazioni, che suggeriscono di derogare ai parametri di tempo in alcuni casi particolari o di fare eccezioni per alcune tematiche (il materiale cronachistico o polemico va eliminato quando cala l’attenzione rispetto alle questioni trattate) o tipologie di documenti (i manuali tecnici vanno conservati fino a quando sono ancora in circolazione i prodotti a cui si riferiscono). Anche per la politica di revisione andrà prevista – come già si è detto per la carta delle collezioni e per il piano annuale di sviluppo delle collezioni – la redazione di un documento che formalizzi i principi cui ispirarsi e le tappe da rispettare. I passaggi in cui materialmente articolare il lavoro nei magazzini e sugli scaffali sono i seguenti: a) riesaminare la programmazione della politica documentaria e introdurre i necessari emendamenti che esplicitino i principi cui è ispirata la politica di revisione; b) definire un calendario annuale che evidenzi le priorità e consenta possibilmente di revisionare l’intera collezione; c) delimitare e sistemare (facendo rientrare i prestiti e riordinando gli scaffali) i diversi settori di cui si compone la raccolta e sui quali si intende intervenire; d) raccogliere il materiale necessario per il lavoro (il catalogo topografico; repertori bibliografici su cui controllare se un titolo è ancora in commercio, l’esistenza di edizioni più recenti di un determinato volume, se il suo autore è ancora attivo ecc…; una scheda del libro su cui appuntare lo stato del volume, della legatura e le operazioni da effettuare); e) confrontare, pezzo per pezzo, il materiale esistente sugli scaffali con l’inventario alla mano; f) verificare su altri repertori e fonti bibliografiche l’opportunità di eliminare un volume; g) suddividere i volumi a seconda della tipologia degli interventi da effettuare, riponendoli in contenitori separati; h) effettuare gli interventi decisi (eseguire i lavori di restauro per i volumi che si decide di conservare, sostituire i volumi deteriorati acquistando nuovi esemplari identici o quelli superati acquistando esemplari di nuove edi239 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia zioni, procedere all’eliminazione dei volumi scartati e che non si intende sostituire, apportare le correzioni a inventari e cataloghi); i) valorizzare i fondi che risultano sottoutilizzati, ma che si è deciso di mantenere ugualmente. Ma questi criteri, che fondano le scelte solo sul livello di aggiornamento e sullo stato di conservazione del materiale, non esauriscono l’intera gamma di questioni di cui tenere conto. I dati sull’uso delle collezioni offrono anch’essi importanti elementi di valutazione: le statistiche sulla circolazione consentono di monitorare regolarmente l’andamento dell’uso dei documenti e di elaborare gli indicatori che ci possono segnalare il declino del tasso di circolazione di un documento, che corrisponde probabilmente ad una sua oggettiva obsolescenza o a un mutamento negli interessi del pubblico. L’operazione dovrebbe essere particolarmente agevole, in quanto le procedure di circolazione saranno automatizzate e si prevede l’implementazione di un modulo software per la produzione di statistiche. Dall’insieme di questi elementi di valutazione scaturisce una griglia di indicazioni che la biblioteca può adottare come bussola per lasciarsi guidare nella revisione. Ovviamente, gli effetti della revisione potranno essere diversi: a) una parte del materiale potrebbe essere trasferito dal magazzino o dalla consultazione alle sezioni tematiche, o viceversa, perché dalla revisione potrebbe risultare che la sua utilizzabilità è maggiore in un settore diverso e che esso ha assunto funzioni differenti; b) volumi, inizialmente collocati a scaffale aperto, e che dovessero risultare obsoleti, potranno essere trasferiti nel magazzino; c) quando anche il magazzino dovesse risultare saturato, parte del materiale potrebbe essere spostato in un magazzino decentrato; d) infine, ci sarà una parte del materiale che si potrà decidere di eliminare del tutto. 3.5. Dimensionamento delle collezioni Occorrerà inoltre procedere ad un’ipotesi di dimensionamento delle collezioni. Per il momento, ed a titolo puramente esemplificativo, si può ipotizzare che a regime la biblioteca dovrà attestarsi intorno ai 500.000 volumi. Se la previsione è di raggiungere queste dimensioni entro dieci anni, in dipendenza delle risorse disponibili, si possono formulare alcune proposte di ripartizione per le diverse aree tematiche. Prendendo a riferimento le articolazioni della Classificazione Decimale Dewey o di quella della Library of Congress, è possibile ipotizzare – sulla base delle scelte strategiche e dei settori che si deciderà di privilegiare – per ciascuna area disciplinare quella che dovrà essere in percentuale la consistenza documentaria. Una prima sgrossatura potrà essere effettuata tenendo conto delle dimensioni della produzio240 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia ne nei vari settori, del numero di classici che bisognerà assolutamente possedere come dotazione fissa, della presenza o meno di altre biblioteche che coprono quegli stessi settori disciplinari. Per una definizione del livello di approfondimento, si propone l’utilizzo contestuale del metodo Conspectus. 3.6. Metodologia per la definizione del grado di copertura bibliografica Il progetto Conspectus parte nel 1978 negli Stati Uniti per iniziativa del Research Library Group, allo scopo di creare una mappa delle collezioni delle principali biblioteche di ricerca, per favorirne la condivisione e lo sviluppo coordinato. Ai nostri fini è interessante la codifica che la metodologia Conspectus ha messo a punto per descrivere il livello di copertura bibliografica di una determinata area disciplinare (a partire dalla classificazione della Library of Congress sono state individuate 24 suddivisioni, articolate in 500 categorie e 4000 soggetti). Per ciascuna di queste partizioni va indicato un codice standard di tipo numerico, sia per la consistenza della collezione (ECS: Existing Collection Strenght), che per l’impegno messo nelle acquisizioni correnti (CCI: Current Collecting Intensity). Sulla base dell’universo delle pubblicazioni disponibili su qualsiasi supporto (nel nostro caso si utilizzeranno bibliografie di riferimento, bibliografie nazionali, cataloghi di grandi biblioteche, ecc…), si determinano i livelli di copertura che una biblioteca intende garantire: • il livello 0 viene assegnato quando l’argomento è fuori dagli ambiti di interesse della biblioteca, che quindi non acquista materiale in quel settore; • il livello 1 corrisponde alla presenza di pochi testi di base; • il livello 2 alla disponibilità di materiale di orientamento e di consultazione generale sufficiente ad introdurre alla conoscenza di un argomento; • il livello 3 viene assegnato nel caso in cui la raccolta sia sufficiente per un sostegno all’istruzione universitaria e superiore; • il livello 4 corrisponde alla presenza di fonti e sussidi necessari a condurre una ricerca autonoma nel campo; • il livello 5 viene assegnato quando una biblioteca acquista tutto il materiale significativo sull’argomento, puntando a formare una raccolta esaustiva. Accanto a questa classificazione della consistenza, è prevista un’altra codifica, relativa alla copertura linguistica e con la quale si indicano le priorità ed i limiti della politica degli acquisti: • il codice E indica la presenza predominante e quasi esclusiva di materiale in inglese; • il codice F indica che al materiale in inglese si affianca una scelta di materiale pubblicato in altre lingue; • il codice W corrisponde ad una assenza di limitazioni e alla presenza di 241 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia materiale in tutte le lingue; • il codice Y indica la prevalenza di una lingua straniera rispetto all’inglese, con particolare riferimento a quelle lingue in cui si esprime in maggioranza la letteratura scientifica sull’argomento. Con le opportune personalizzazioni e modifiche della metodologia Conspectus, la biblioteca deciderà gli obiettivi di copertura bibliografica per i diversi settori, dando così concretezza alle indicazioni di metodo fornite illustrando la Carta delle collezioni. La biblioteca dimensionerà gli obiettivi di acquisto e di budget per ciascuna area di soggetto. Per effettuare tali lavori si farà ricorso, oltre a strumenti repertoriali, anche dati statistici sulla produzione e sui prezzi medi di copertina. 4. Criteri di gestione delle relazioni pubbliche 4.1. Politiche di servizio Le politiche di servizio devono avere il massimo di flessibilità e adattabilità al mutare della domanda: andrà ricercato un equilibrio dinamico tra domanda e offerta, tenendo conto del fatto che in una realtà culturalmente debole, come la Capitanata, è l’offerta a creare la domanda. La Biblioteca Provinciale dovrà dotarsi di una “carta dei servizi”, che indichi quali sono gli standard di servizio che la biblioteca si impegna a rispettare, che fissi in modo chiaro e verificabile quali sono i diritti ed i doveri degli utenti, che segnali i responsabili ai quali l’utente si può rivolgere per qualsiasi esigenza, e nella quali si possa leggere qual è il “patto chiaro” che la biblioteca stringe con i cittadini che intendono usarla. In tal senso la biblioteca adeguerà sia la regolamentazione che la carta dei servizi alle raccomandazioni A.I.B. in materia. La Biblioteca Provinciale dovrà puntare a “fidelizzare” i propri utenti, attraendoli e consolidando il loro rapporto con la biblioteca. Pur senza voler porre vincoli e limiti all’utilizzo della struttura e dei suoi servizi collaterali, si deve considerare la Bibliocard, appena varata, come una “tessera” che dia agli utenti il senso dell’appartenenza, che sia collegata a facilitazioni nell’accesso e nell’uso delle attività commerciali, che consenta all’utente di pagare con questa carta le riproduzioni, il download dei dati, le tariffe dei servizi a pagamento. Sul modello della card adottata dalla Deutsche Bibliothek di Francoforte si sta già sperimentando la dotazione agli utenti di tessere a scalare ricaricabili. Con deliberazione dello scorso 2001 il Consiglio Provinciale ha definito i servizi bibliotecari gratuiti e quelli a pagamento. Il principio generale della gratuità del servizio è stato salvaguardato, soprattutto per quei servizi che riguardano l’accesso all’informazione e non comportano l’uso esclusivo di attrezzature e documenti per un periodo prolungato di tempo. Sono stati invece sottoposti a tariffazione i seguenti servizi a valore aggiunto fortemente personalizzati: duplicazione di documenti, ricerche su banche dati one242 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia rose, prestito interbibliotecario, document delivery, bibliografie personalizzate, riproduzione con scanner, riproduzione fotografica, accesso ad Internet, nolo auditorium. 4.2 Politiche di cooperazione interbibliotecaria Occorre prefigurare la rete di relazioni che essa dovrà stabilire con il territorio, con le biblioteche locali, con altre agenzie culturali. Anche se la biblioteca non è organicamente collegata ad altre strutture e si presenta al proprio pubblico come un servizio che, proprio per la sua storia, opera in parte isolatamente, è evidente che essa non potrà non stabilire rapporti di cooperazione con altre biblioteche locali, nazionali e straniere. La recente decisione dell’Amministrazione di istituire il Sistema Bibliotecario Provinciale è il primo passo per ricostruire quei processi di interazione fra le biblioteche locali che si era stabilizzato agli inizi degli anni Settanta. Il Sistema Bibliotecario Provinciale pone “la Magna Capitana” al vertice del sistema come biblioteca capofila che sostanzialmente dà alle biblioteche civiche molto più di quanto riceva in un’ottica di coordinamento e di promozione della lettura e con l’idea di realizzare il catalogo unico provinciale. Sarà fondamentale nei prossimi anni avviare altri rapporti di cooperazione interbibliotecaria con strutture di dimensioni simili a quelle de “la Magna Capitana” in un quadro più stabile e coordinato di scambi di servizi incrociati. In questa prospettiva la Biblioteca Provinciale, ad esempio, comincerà a breve a “vedersi” con il Servizio Bibliotecario Nazionale e con altre reti di biblioteche, rispetto alle quali dovrà assumere una funzione di “corrispondente”, diffondendone i servizi e divenendo loro interlocutore privilegiato e, non appena sarà in grado di farlo, fornitore di informazioni e documenti. Si è più volte ribadito che la biblioteca, pur puntando molto sulle proprie collezioni e su ciò che sarà in grado di fornire direttamente al suo pubblico, dovrà erogare anche servizi bibliotecari virtuali. È molto probabile che tra i suoi servizi si debba prevedere un sistema di accesso ai documenti posseduti da altri, il che comporta la necessità di accordi con i principali fornitori di documenti (British Library Document Supply Center, Inside, OCLC, Inist, ecc…). Ma la cooperazione non riguarda solo i servizi bibliotecari. Se la biblioteca vorrà diventare in tempi brevi un punto di riferimento obbligato essa dovrà stabilire rapporti con i circoli scientifici e culturali più avanzati (pur nella diversità di situazioni e finalità, si pensi al ruolo che l’Istituto italiano di studi filosofici ha avuto nella rinascita di una città come Napoli); con il mondo dell’editoria (in questo caso si possono portare ad esempio gli effetti prodotti dalla presenza dello stand della Biblioteca Provinciale al Salone del Libro di Torino) e dell’informazione; con quanti intendono organizzare manifestazioni ed eventi culturali di grande richiamo. A questo scopo potrà essere funzionale la nascita di una “Associazione di 243 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia amici della Biblioteca”, che potrebbero sostenerla, vigilare sulla sua crescita, godere di particolari vantaggi nella fruizione dei suoi servizi e dei suoi spazi. 4.3. Comunicazione istituzionale Si impone la creazione di un metalinguaggio istituzionale in grado di assicurare la permanenza dei “segni” della biblioteca in modo univoco ed universale in tutte le forme di comunicazione istituzionale (dalla segnaletica interna alle informazioni scritte e telematiche) in grado di definire un’immagine nitida e lineare dei messaggi istituzionali. Di conseguenza la biblioteca dovrà dotarsi di un layout flessibile in grado di adattarsi a tutti i supporti comunicativi. La comunicazione istituzionale dovrà assumere particolare rilevanza all’interno delle strategie comunicative della biblioteca rivolte a promuovere le forme di espressione culturale locali e ad ampliare e diffondere le pratiche di lettura. In questo senso la Biblioteca attraverso e le sue collane editoriali e attraverso la rivista «la Capitanata» privilegerà la promozione della ricerca e degli studi nei diversi ambiti del sapere, mentre attraverso iniziative estemporanee a carattere culturale contribuirà allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e dei saperi. In modo particolare occorrerà sedimentare e stabilizzare una serie di iniziative che dovranno avere una stabilità ed una continuità (premio video indagine, premio letterario per studenti, ecc..., nati per leggere, serate letterarie, musicali, cinematografiche, premi scientifici, ecc...), occorrerà sviluppare la convegnistica di qualità, l’animazione culturale e la formazione bibliotecaria d’eccellenza. Tali attività dovranno essere realizzate in proprio o in regime di cooperazione con altre biblioteche o istituti ed associazioni culturali e di ricerca. Non saranno tralasciati interventi volti ad espandere la consapevolezza dei diritti universali dell’uomo, della donna e del fanciullo, il diritto alla lettura, all’esercizio delle libertà e della democrazia. 5. Sintesi dei punti qualificanti del documento e degli indirizzi al direttore Indirizzo politico Il presente documento descrive gli indirizzi politici dell’Amministrazione in materia di servizi bibliotecari. Volontà politiche L’Amministrazione Provinciale di Foggia ribadisce il ruolo strategico della Biblioteca Provinciale a livello provinciale e regionale (va ricordato che la Biblioteca Provinciale di Foggia è la più importante “provinciale” italiana, è la più rilevante biblioteca pubblica pugliese ed è una delle più importanti biblioteche meridionali). Obiettivo Riconfermare la funzione di grande struttura bibliotecaria pugliese a scaffale aperto, introducendo una nuova stretta integrazione tra libri, risorse elettroniche, materiale “grigio”, documenti audiovisivi e Internet. Si prevede di arriva244 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia re a 500.000 opere fra versioni cartacee e digitali, relative a tutti i rami del sapere, sistematicamente organizzate e selezionate con i criteri alla metodologia Conspectus modificata, con i testi fondamentali di alcune aree anche in lingua originale, le opere generali di base e di sintesi, le monografie più importanti, i periodici principali; nonché due vaste aree di conservazione (fondi locali e deposito) e spazi per aree specializzate e centri di documentazione. Interventi sulla struttura Conclusa la complessa fase di consolidamento e di adeguamento della struttura, gli interventi riguarderanno l’ottimizzazione delle aree interne per adeguare la struttura alle nuove funzioni. Le procedure per la progettazione e l’arredamento degli spazi interni (sale, architettura informatica, collegamenti, comunicazione istituzionale) si debbono accompagnare con la contestuale selezione, acquisizione e catalogazione del patrimonio bibliografico (libri e digitalizzazioni). Saranno da istituire due distinti gruppi di lavoro - comitato tecnico-organizzativo, comitato scientifico-biblioteconomico - entrambi composti da bibliotecari ed informatici facenti capo alla direzione della biblioteca che coordinerà i gruppi di lavoro in modo sinergico. Strutture integrative Si dovrà procedere in tempi ragionevolmente brevi al recupero dell’area dell’ex “Pascal”, già individuata ed assegnata alla biblioteca con una triplice funzione: 1) assicurare un nuovo ampio spazio per il deposito di volumi e di periodici (il deposito attuale è saturo); 2) assicurare un nuovo spazio per costituire la sala di studio per gli studenti universitari che utilizzano in prevalenza propri testi; 3) reperire una sede per la digitalizzazione dei testi, suoni ed immagini e per la catalogazione elettronica dei testi, le cui procedure di appalto si sono concluse recentemente. Si dovrà procedere all’arredamento degli spazi necessari al funzionamento dei centri di documentazione (“ilDock”) e dell’area multimediale (videoteca, cineteca) connesse con la biblioteca principale, che saranno allogati presso l’ex “Marconi”. Rete Collegamento in rete con le biblioteche pubbliche e private della provincia di Foggia ed adesione al Sistema Bibliotecario Nazionale, con le banche dati bibliografici italiane e internazionali, con alcune biblioteche italiane e straniere attraverso circuiti agevolati. Sperimentazione di una politica di coordinamento e di cooperazione interbibliotecaria soprattutto con le biblioteche provinciali che aderiscono al patto delle 4 province (Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia). Evoluzione del web della biblioteca in una internet public library che consenta quattro ambiti fondamentali di azioni: consultabilità anche da postazioni remote dei cataloghi della biblioteca e del sistema; consultabilità anche in remoto dei testi digitalizzati e indicizzati delle banche dati; fornitura di servizi on-line; reference services; produzione di selezionati percorsi tematici in rete (a due livelli: specialistico e divulgativo) di rilievo nazionale ed internazionale. Eccellenza Il progetto intende esaltare le ricche collezioni della biblioteca, collocandola pienamente nell’ambito culturale e scientifico da cui hanno preso forma le più recenti realizzazioni italiane ed europee sia per il livello qualitativo e quantitativo delle collezioni presenti, sia per le ragioni culturali e biblioteconomiche che sottendono all’uso delle risorse informatiche. L’idea che è presente al fondo della proposta 245 Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari della Biblioteca Provinciale di Foggia progettuale è quella di definire ambiti di eccellenza anche nel Mezzogiorno e in settori, quale l’informazione biblioteconomica, ad alto potenziale culturale. Qualità totale Qualità progettuale, qualità architettonica dell’edificio e degli interni (sale), qualità culturale del patrimonio di opere (carta delle collezioni), qualità dei servizi (reference), qualità della manutenzione, consentiranno alla biblioteca di redigere i propri regolamenti di funzionamento e la propria carta dei servizi con la prospettiva di sottoporsi alla certificazione ISO. Finanziamento Il progetto di sviluppo deve essere predisposto in forma modulare, in modo da consentire la realizzazione per stati di avanzamento autonomi ed autosufficienti. Le fonti di finanziamento saranno quelle ordinarie di bilancio, nel senso che molti moduli progettuali dovranno essere realizzati senza alcun intervento finanziario aggiuntivo da parte della Provincia, ma soltanto basandosi su una razionalizzazione delle spese correnti attuali. La parte restante del programma potrà essere realizzato in dipendenza di specifiche fonti di finanziamento regionale (fondi ordinari e POR), di finanziamento nazionali (PON, Ministero dei Beni Culturali) ed europei. Le presenti Linee Guida sono finalizzate alla realizzazione di servizi bibliotecari più efficaci ed efficienti. Indirizzi al direttore Per conseguire questi obiettivi la biblioteca dovrà procedere preliminarmente: a) ad una mappatura dei servizi bibliotecari in Capitanata b) un’analisi dell’utenza c) un’analisi della domanda potenziale d) alla misurazione dei servizi secondo le Linee Guida A.I.B. Sulla scorta delle analisi sopra indicate la biblioteca procederà a: 1) riorganizzare gli spazi aperti al pubblico della sede centrale, della sede ex “Marconi” e della sede ex “Pascal” con la descrizione dettagliata degli arredi necessari; 2) definire gli scenari per il prossimo quinquennio, individuando i nodi per sviluppare la domanda potenziale e quella inespressa; 3) definire esattamente le aree tematiche divulgative “fisse”; 4) definire esattamente le dimensioni dell’area tematica sulla narrativa, indicando ambiti cronologici, ambiti geografici e genere; 5) dimensionare sulla base della classificazione Dewey i range entro cui opereranno le sezioni specializzate de “ilDock” e della sezione multimediale; 6) redigere la bozza degli indirizzi dello sviluppo delle collezioni e di selezione dei materiali della biblioteca (carta delle collezioni) da sottoporre all’approvazione della Giunta; 7) redigere la bozza di regolamento della biblioteca con annessi tecnici e speciali per questioni di particolare sensibilità (uso di Internet, accesso alle banche dati, servizi a pagamento, ecc…) da sottoporre all’approvazione della Giunta; 8) redigere la bozza della carta dei servizi della biblioteca da sottoporre all’approvazione della Giunta. 246 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) Valutazione dei servizi (anno 2003) 1. Introduzione In questi ultimi mesi si sono affacciati sullo scenario nazionale del mondo delle biblioteche due eventi di straordinaria portata. Il primo si riferisce al II Rapporto sulle biblioteche italiane che viene redatto a quattro mani dall’A.I.B. e dall’ISTAT. Si tratta di rilevazione di dati, ancora in gran parte in forma sperimentale, che riguarda il panorama nazionale e regionale delle biblioteche di pubblica lettura, universitarie e nazionali. Rispetto al primo rapporto del 2001 sono stati compiuti rilevanti passi avanti nella raccolta, lettura e soprattutto comparazione del dati. Le prospettive del Rapporto sono evidenti: cercare di diventare uno strumento di analisi della realtà biblioteconomica italiana in grado di fornire elementi di innovazione nell’azione concreta delle singole biblioteche. Questo dato di novità si coniuga con l’Accordo del gennaio 2004 fra ANCI, UPI e Regioni che reca il titolo “Linee di politica bibliotecaria per le autonomie”. Si tratta di un documento di principi per la prima volta dopo anni foriero di grandi novità per le biblioteche di enti locali. Ma se nel Rapporto si tende a trovare fra le diverse opzioni misure di comparazione a livello nazionale e regionale, nel secondo documento si dettano principi che fanno capo direttamente alla misurazione dei servizi predisposto dall’IFLA, il nostro organismo internazionale più autorevole, ed adottato dall’A.I.B. nel 2000. Il richiamo esplicito nel documento ANCI-UPI-Regioni alle Linee Guida per la valutazione dei servizi bibliotecari dell’A.I.B. si incontra con una rinnovata attenzione della Puglia alla questione delle biblioteche. Infatti nell’Accordo di programma quadro in materie di beni ed attività culturali per il territorio della Regione Puglia, stipulato a Roma in 22 dicembre 2003 quale “Intesa istituzione di programma tra il Governo Italiano e la Regione Puglia”, una piccola parte finanziaria, ma politicamente rilevante, è destinata allo sviluppo del sistema bibliotecario delle autonomie pugliesi. Questi tre elementi di novità nazionale e regionale si sovrappongono mirabilmente sulle Linee Guida per l’aggiornamento dei servizi bibliotecari de “la Magna Capitana”, votate nel 2002 e destinate a modificare il volto della Biblioteca Provinciale nei prossimi anni, per essere in sintonia con le mutate esigenze della nostra utenza bibliotecaria. Uno dei primi atti previsti dalle Linee Guida era appunto la valutazione annuale dei servizi della biblioteca che oggi viene riproposto per il secondo anno. 247 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) Se la valutazione dei servizi del 2002 ci consentiva di porre basi statistiche certe, misurabili e comparabili, la valutazione del 2003 ci consente di avviare la fase vera e propria di monitoraggio dei servizi. Ed è con questo spirito e con le speranze indotte dai documenti nazionali e regionali citati, che ci apprestiamo a licenziare il secondo rapporto annuale sulla valutazione dei nostri servizi. La valutazione dei servizi di una biblioteca è un elemento centrale dello sviluppo dei servizi bibliotecari ed è un aspetto fondamentale per una biblioteca che intende puntare sulla qualità dei fattori. La Biblioteca Provinciale di Foggia sta costruendo un percorso di sviluppo che tende al conseguimento di obiettivi di qualità di rilievo regionale. L’approvazione delle Linee Guida per lo sviluppo dei servizi bibliotecari del novembre 2002 pone alla biblioteca scadenze, obiettivi e traguardi di rilevante importanza non solo per la comunità locale. Per tale ragione la valutazione 2002 ex ante dei servizi è stata essenziale per costruire una misura di confronto e di verifica degli interventi che sono stati effettuati nel 2003 sulle collezioni, sulle strategie di comunicazione e sull’ampliamento della platea degli utenti. La valutazione della Biblioteca Provinciale di Foggia è stata condotta sulla base delle linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane, rese pubbliche nel 2000 dall’Associazione Italiana Biblioteche (A.I.B.).1 Questo ha consentito di procedere a comparazioni e confronti con le misurazioni di altre biblioteche di pubblica lettura. Si sono consentite alcune variazioni suggerite da Douglas Zweizig e Eleanor Jo Rodger nel loro manuale di procedure standardizzate per la misurazione dei servizi delle biblioteche pubbliche.2 In conclusione va detto che per sua tradizione “la Magna Capitana” non può essere considerata una public library in senso stretto. La presenza di un imponente settore di conservazione e di un grandioso deposito fanno de “la Magna Capitana” una biblioteca di pubblica lettura ibrida sia sul piano della diversità di supporti del materiale posseduto sia sul piano dell’imponenza dell’area di conservazione. Questo dato ineludibile, tuttavia, non esime la Biblioteca dalla valutazione dei propri servizi offerti, né dalla comparazione con le biblioteche italiane che hanno una fisionomia di public library. Poiché gli indicatori di valutazione sono stati predisposti per misurare essenzialmente le biblioteche di pubblica lettura dotate essenzialmente di “materiale moderno”, alcuni dati risulteranno oggettivamente alterati perché non è stato possibile epurare dall’analisi il “peso” del settore di conservazione, che è rilevante, come si evince dalla seguente tabella: 1 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, Linee Guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche, Roma, A.I.B., 2000. 2 Douglas ZWEIZIG, La misurazione dei servizi delle biblioteche pubbliche, Roma, A.I.B., 1987. 248 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) 249 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) 2. La descrizione degli indicatori a) Acquisti Con il termine acquisti si intende correntemente l’insieme di volumi a stampa, degli audiovisivi e dei documenti elettronici aventi natura di monografie o rientranti in grandi opere (“opere in continuazione”) acquistati durante il 2003. Sono stati esclusi i doni, i periodici, i documenti “miscellanei” e “misti”, la letteratura grigia e le opere d’antiquariato o comunque con un’anzianità di pubblicazione ultraventennale. La tab. 2 indica gli acquisti effettuati nel 2003. Va anticipato che il dato del 2002 è da considerarsi anomalo in quanto gli acquisti sono stati ridotti in vista della definizione della carta delle collezioni. Gli obiettivi che la valutazione del 2002 poneva erano quelli di incrementare il patrimonio librario al fine di migliorare il quinto indicatore, di cui si dirà più avanti. 250 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) b) Area dei servizi al pubblico Si definiscono con questa espressione tutti gli spazi destinati al pubblico per la fruizione e la fornitura dei servizi bibliotecari propriamente detti. Sono stati inclusi gli spazi che prevedono espressamente o meno la compresenza di pubblico e personale, le sale per attività di laboratorio e di animazione, i depositi librari. Sono escluse le aree adibite ad attività non strettamente bibliotecarie, quale l’auditorium e gli spazi riservati esclusivamente al personale (uffici). Rispetto all’anno precedente non è mutato nulla, anche se si aspettava di entrare in possesso della terza palazzina dell’ex “Marconi” per allogarvi le sezioni specializzazione ed i centri di documentazione, così come previsto dalle Linee Guida. Il temporaneo “fermo” dell’Amministrazione non ha consentito di migliorare i dati di questa tabella. 3 251 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) c) Dotazione documentaria Con l’espressione dotazione documentaria le linee guida A.I.B. identificano la sola “collezione moderna” ovvero l’insieme di monografie, di opere in continuazione a stampa, di audiovisivi, di risorse elettroniche, ecc… che al momento del rilevamento siano di fatto disponibili alla fruizione e non risultino obsoleti. Sono inclusi i volumi (monografie, repertori e grandi opere), gli audiovisivi (monografie, repertori e grandi opere) e i multimediali (monografie, repertori e grandi opere). Queste opere devono avere, per convenzione, meno di vent’anni di vita. Sono esclusi i periodici, la letteratura grigia, i documenti miscellanei (fotografie, dipinti, stampe, manifesti, ecc...), gli scarti. Occorre dire che la rilevazione è da considerarsi provvisoria ed assume, ai fini di questa rilevazione, un valore indicativo e di massima, in quanto la dotazione documentale non consente di definire con precisione gli acquisti annuali effettuati dal 1983 al 2002. La rilevazione diventerà definitiva nel momento in cui si sarà in grado di procedere ad una ricognizione del posseduto sulla base della totalità dei dati immessi nel data base della biblioteca. La rilevazione è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite a seguito di perizia da parte dei responsabili delle diverse aree. 4 d) Iscritti al prestito Si considerano iscritti al prestito tutte – e solamente – le persone che hanno preso in prestito almeno un documento durante l’anno del rilevamento. Nei confronti del 2002 si è registrato un incremento di 544 unità, pari al 27,35%. Vi è da rilevare che la trasformazione della vecchia “sala adulti” in due sezioni “area d’ingresso” e “sala narrativa” prospetta un futuro interessante al riguardo. Le difficoltà di rilevazione del 2002 avevano consigliato di raggruppare i dati in una sola voce, “altri”, che oggi scompare per essere più correttamente disaggregata per le rispettive aree della biblioteca. 252 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) e) Orario di apertura Si definisce orario di apertura settimanale il totale delle ore in cui, nell’arco della settimana, è consentito l’accesso al pubblico per la fruizione di tutti, di una parte o anche di uno solo dei servizi di natura biblioteconomica previsti dalla biblioteca. Rimane lo stesso orario dello scorso anno e quindi non vi è mutamento alcuno. 6 f) Periodici correnti Sono considerati tutti i periodici di cui è attivo l’abbonamento (se in acquisto) o in corso l’arrivo (se in dono) durante il 2003. Rispetto all’anno precedente si è riscontrato un decremento dovuto alla cessazione di alcuni periodici. Il dato è mitigato dall’incremento dei periodici in dono o scambio, dovuto allo scambio posto in essere con la nostra rivista «la Capitanata». 253 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) g) Personale Rientra nella voce personale ogni unità lavorativa non solo in organico alla struttura, ma anche a qualsiasi titolo e con qualsiasi qualifica e forma di contratto, anche a termine, ha prestato di fatto la propria opera in biblioteca a tempo pieno o part-time, purché con una certa continuità, nell’arco dell’anno solare oggetto della rilevazione. È incluso tutto il personale di ruolo e non di ruolo della biblioteca; tutto il personale in forza mediante appalti e agenzie, incarichi a cooperative, convenzioni, ecc…, purché il rapporto di lavoro sia regolato da un contatto almeno annuale. Sono esclusi tutti coloro che offrono forme sporadiche di collaborazione (volontari, ecc…). Ai fini di una misurazione omogenea il personale è stato convertito in FTE (full time equivalent), con ogni singolo FTE uguale a 36 ore lavorative settimanali. Rispetto al 2002 il personale è aumentato di 4 unità necessarie a fronteggiare il fabbisogno di presidio nelle sale. Va anche detto che sono state conteggiate anche le dipendenti che sono rientrate dal periodo di astensione obbligatorie per maternità. La tabella registra, infine, il passaggio dei dipendenti ex LPU in servizio part time da un contratto di 24 ore settimanali ad un contratto di 30 ore settimanali. h) Popolazione Viene assunta la totalità delle persone residenti nel Comune di Foggia nel 2001. Nelle procedure di monitoraggio e valutazione la popolazione del Comune si 254 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) assume come bacino del servizio, per cui si può considerare sinonimo di utenza servita o da servire (potenziale). La rilevazione ha previsto una suddivisione in classi di età per consentire una migliore lettura dell’utenza potenziale della biblioteca. 9 i) Prestiti Per prestiti si intende il numero totale di documenti concessi durante l’anno della rilevazione agli utenti affinché possano consultarli fuori dalla biblioteca per un periodo di tempo determinato. Sono inclusi i prestiti interbibliotecari, mentre sono stati esclusi i documenti che escono per assolvere a funzioni o attività estranee a quelle tipiche del servizio (per esempio prestiti per mostre); sono stati esclusi anche i rinnovi. I prestiti sono passati da 5.346 del 2002 a 10.885 del 2003 con un incremento del 103,61%. Il dato può sembrare clamoroso se rapportato a se stesso, resta in realtà ancora un punto debolissimo della biblioteca che non riesce a compararsi con gli standard nazionale. La politica adottata del rinnovo del patrimonio librario e di un rapporto più amichevole e confidenziale con l’utenza sta comunque aiutando la biblioteca ad uscire da una visione solipsistica che la caratterizzava negli ultimi anni. 255 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) l) Spesa Si definisce spesa per la biblioteca il totale delle spese in conto corrente sostenute durante l’anno allo scopo di mantenere attivo o incrementare il servizio. Sono state incluse le spese per il personale, comprendendovi il pagamento delle prestazioni lavorative ed ogni altro connesso alla sua attività; le spese per l’acquisto di materiali documentari (libri, periodici, risorse elettroniche, ecc…); le spese di gestione corrente (energia, riscaldamento, telefono, pulizie, cancelleria, manutenzione di attrezzature, ecc...); le spese per attività di promozione della biblioteca e della lettura. Sono state escluse le spese per iniziative culturali, le spese in conto capitale o straordinarie per il rinnovo massiccio di arredi e di attrezzature tradizionali o informatiche. Rispetto al 2002 vi è stata una contrazione delle spese di gestione di euro 148.670, pari al 13,6%. L’aumento di spesa di registra per il personale dovuto ai miglioramenti contrattuali e all’arrivo di nuove risorse umane. m) Transazioni informative È definita transazione informativa ogni richiesta di informazione fatta di persona, per posta, per telefono, ecc… da parte di un ragazzo o di un adulto, che deter256 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) mini l’intervento del personale della biblioteca e comporti da parte sua la conoscenza, l’uso, l’interpretazione o l’istruzione dell’uso di una o più fonti di informazione. Una transazione informativa si dice completata quando il bibliotecario giudica che l’utente abbia ricevuto l’informazione richiesta. Si dice riorientata quando il bibliotecario fornisce notizie esatte e fondate su dove l’utente può trovare risposta alla sua richiesta. Si dice non completata quando per motivi vari (materiale non posseduto, indisponibilità di personale, fretta dell’utente, ecc.) l’utente non riceve l’informazione richiesta. Una transazione si dice di tipo direzionale quando è limitata ad informazioni sull’organizzazione della struttura e dei servizi. Ai fini della valutazione si è tenuto conto sono delle transazioni informative di persona. Si è considerata una percentuale del 20% in incremento per le transazioni telefoniche, postali e telematiche. Si è proceduto a campionare una settimana (15-20 dicembre) e a procedere successivamente ad una proiezione su scala annuale. Rispetto al 2002 le transazioni informative sono cresciute del 15%. n) Visite Per visita si definisce la totalità degli “ingressi” registrati nella biblioteca durante l’anno per l’utilizzazione di uno qualsiasi dei servizi erogati. È inclusa ogni persona che si reca in biblioteca con l’intenzione di utilizzare un suo specifico servizio, conteggiandola tutte le volte che vi entra, anche in una stessa giornata. Sono escluse le presenze registrate in occasione di visite guidate e di attività di promozione o genericamente culturali (mostre, convegni, ecc…). La scoperta di un “buco” nel sistema di rilevazione dovuto ad un uso eccessivo e anomalo di carte provvisorie di ingresso ha consigliato di procedere a stime campionarie sulla base di una rilevazione settimanale nelle ore di maggiore affluenza (ore 11.00 ed ore 17.30), da cui si ricava la seguente tabella. La non comparabilità dei dati rispetto alla rilevazione dello scorso anno condotta esclusivamente sui dati informatici di ingresso non consente di raffrontare i dati. 257 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) o) Uso dei materiali in biblioteca Questa misura, non prevista dalla metodologia A.I.B., è indicata da Zweizig e Rodger ed è costituita dalla stima del numero di materiali usati in un anno in biblioteca dagli utenti. L’A.I.B. ha per tradizione considerato come misura dell’efficacia dei servizi bibliotecari il numero totale dei prestiti annui, mentre l’uso dei materiali in biblioteca non è un tipo di misura molto generalizzato, anche se si riconosce che si tratta di un aspetto fondamentale dei servizi della biblioteca. La misura qui definita comprende tutti i tipi di materiali utilizzati in biblioteca dai lettori. Si è proceduto al riguardo ad una rilevazione settimanale (15-20 dicembre) da cui si è ottenuta la seguente proiezione annuale. Dal raffronto emerge un incremento del 23,85% rispetto all’anno precedente. In particolare si nota un incremento dell’uso di “altri materiali” connessi allo sviluppo dei centri di documentazione. 258 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) 3. Gli indicatori a) Premessa La misurazione delle risorse e dei servizi della biblioteca produce dati utili alla gestione del sistema sia nella sua organizzazione interna che nei rapporti con l’esterno. Il corretto utilizzo dei dati numerici consente di superare uno stile di lavoro essenzialmente empirico e non finalizzato al conseguimento degli obiettivi prefissati dalle linee guida. La metodologia A.I.B. sottolinea, tuttavia, che una valutazione corretta delle risorse e dei risultati deve tenere conto non solo dei valori quantitativi assoluti, ma anche della loro adeguatezza rispetto alla realtà specifica in cui la biblioteca opera e in particolare rispetto alla comunità locali alla quale la biblioteca ha l’obbligo di fornire servizi di informazione e di lettura. Questa relativizzazione si ottiene con la relativizzazione di indicatori che, mettendo in relazione le risorse e le prestazioni con l’utenza potenziale e tra di loro, ne forniscono il vero valore e l’adeguatezza rispetto alla missione della biblioteca. La metodologia A.I.B. prevede la costruzione e l’analisi di 15 indicatori. Alcuni di questi si riferiscono agli input, alle risorse di cui la biblioteca dispone e alla loro adeguatezza rispetto alla popolazione, ossia all’utenza potenziale che la biblioteca è chiamata a servire: • Indice si superficie • Indice di apertura • Indice della dotazione di personale • Indice di spesa • Indice della dotazione di periodici • Indice della dotazione documentaria Gli altri otto indicatori esprimono, invece, gli output, il risultato delle prestazioni, e testimoniano l’orientamento al servizio della biblioteca, l’efficacia della sua azione e l’efficienza di gestione: • Indice di impatto • Indice di prestito • Indice di circolazione • Indice di fidelizzazione • Indice di frequentazione • Indice di affollamento • Indice quantitativo dei reference • Indice di costo dei servizi b) Indice di superficie L’indice di superficie mette in relazione la superficie dell’area dei servizi al 259 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) pubblico con la popolazione; serve a verificare l’adeguatezza della sede della biblioteca a contenere documenti, servizi e spazi per gli utenti proporzionati all’utenza potenziale. Il calcolo dell’indice è espresso dalla seguente formula: area dei servizi al pubblico 10 popolazione Nel nostro caso si è tenuto conto delle aree dei servizi al pubblico, comprendendo anche le aree escluse dall’accesso al pubblico, ma strettamente funzionali al servizio (depositi). L’indice che scaturisce è 0,34, che colloca la nostra biblioteca nella media nazionale delle biblioteche pubbliche in comuni superiori a 10.000 abitanti che è stimata in 0,35. Il mancato ampliamento della biblioteca con l’aggiunta dell’ex “Pascal” e dell’ex “Marconi” non ha consentito di incrementare l’indice superando la media nazionale. c) Indice di apertura L’indice di apertura rileva in modo ponderato quante ore in una settimana la biblioteca è aperta in fasce orarie più accessibili al pubblico. Serve a verificare l’accessibilità effettiva della biblioteca. Il calcolo dell’indice è espresso dalla seguente formula: ore di apertura mattutina (escluso il sabato) 3 + ore di apertura pomeridiana + serale + sabato L’indice che scaturisce è di 46,00 che pone la Biblioteca Provinciale di Foggia al vertice, considerando che l’indice massimo riscontrato dalla rilevazione A.I.B. in Italia è 40. Questo obiettivo è stato conseguito grazie alla scelta opportuna di introdurre l’orario unico continuato e chiudendo la biblioteca per riposo estivo le prime tre settimane di agosto. Non occorre intervenire ulteriormente su questo indicatore. d) Indice della dotazione di personale L’indice della dotazione di personale mette in relazione il personale, ossia il numero di unità lavorative addette alla biblioteca calcolato in FTE, con la popola260 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) zione. Serve a verificare l’adeguatezza della dotazione di personale della biblioteca rispetto all’utenza potenziale. Il calcolo dell’indice è espresso dalla seguente formula: FTE 2000 popolazione L’indice si conforma allo standard a suo tempo proposto dall’IFLA di un addetto ogni 2.000 abitanti. Anche in questo caso l’indice che scaturisce di 1,08 pone la biblioteca al vertice, considerando che l’indice massimo riscontrato dalla rilevazione A.I.B. in Italia è di 0,96. Occorre dire che ha contribuito al conseguimento di tale indice l’esternalizzazione dei servizi di recupero catalografico del retrospettivo, affidato a seguito di gara europea ad una ditta specializzata. Poiché il calcolo degli FTE viene effettuato tenendo presente anche il personale in servizio non dipendente, è da ipotizzare che l’indice tenderà ad abbassarsi, ma senza vistosi scostamenti dall’attuale, quando scadrà nel 2004 il contratto. Va rilevato, tuttavia, che la complessità della struttura della biblioteca, pensata come grandi open spaces comporta la necessità di un incremento di personale esecutivo addetto alle sale, attualmente deficitario nella copertura dei turni. e) Indice di spesa L’indice di spesa mette in relazione la spesa per la biblioteca con la popolazione. Verifica l’adeguatezza delle risorse economiche per la gestione corrente della biblioteca rispetto alle esigenze dell’utenza potenziale. Il calcolo dell’indice è stato effettuato sulla base della seguente formula: spesa popolazione Anche in questo caso l’indice pone la biblioteca al vertice della scala nazionale con un indice di 15,89, che si avvicina al massimo riscontrato dalla rilevazione A.I.B. di 16,91. Secondo l’A.I.B. un indicatore alto è da considerarsi positivo perché sta a significare che la biblioteca dispone di risorse economiche per espletare in modo adeguato i suoi compiti. L’indicatore esprime lo sforzo e l’impegno ordinario che la Provincia ha compiuto nei confronti della biblioteca. L’A.I.B. al riguardo sottolinea come le eventuali riserve, dovute al timore che un indice di spesa consistente corrisponda ad un deficit di efficienza della biblioteca, possono essere formulate solo a seguito di una valutazione quali/ quantitativa della gamma dei servizi offerti a fronte di un indice di costo dei servizi molto alto. 261 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) f) Indice della dotazione documentaria L’indice della dotazione documentaria mette in relazione la dotazione documentaria posseduta dalla biblioteca con la popolazione. Serve a verificare l’adeguatezza della collezione moderna della biblioteca in rapporto all’utenza. Il calcolo dell’indice viene effettuato sulla base della seguente formula: dotazione documentaria popolazione A fronte di un indice medio nazionale di 1,69 l’indice della dotazione documentaria della Biblioteca Provinciale si colloca ai minimi con 0,41, di poco superiore al minimo riscontrato di 0,27. In generale un valore alto dell’indicatore è da interpretarsi positivamente in quanto denota che un patrimonio è ricco e l’offerta è adeguata. Anche se va notato che non necessariamente un gran numero di documenti implica un loro maggiore uso oppure un’alta soddisfazione degli utenti. Tuttavia l’indice estremamente basso, riscontrato preso la Biblioteca Provinciale di Foggia pone problemi di fondo molto importanti, che riguardano la dotazione patrimoniale della collezione moderna. Ai fini di questo indicatore (i documenti non devono avere più di vent’anni di vita) la dotazione di soli 51.000 documenti “moderni” è assolutamente insufficiente a rispondere alla domanda attuale, per non parlare di quella potenziale. Per portare l’indice della dotazione documentaria nella media nazionale, che è stimata in 1,69, occorrerebbe procedere ad un incremento straordinario di 210.000 nuovi documenti. Questi nuovi accessi, insieme al ricco patrimonio antico e di pregio, porterebbero il patrimonio librario della biblioteca a 500.000 documenti, così come è previsto dalle Linee Guida approvate lo scorso 2002. Ai valori attuali occorrerebbe una spesa di euro 6.300.000, assumendo il costo medio di un’opera in euro 30,00. Si tratta, ovviamente, di una spesa insostenibile per la Provincia. Tuttavia il dato ci informa che occorrerà potenziare al massimo la dotazione libraria con una politica degli acquisti più consistente e più costante. Nel 2003 le risorse finanziarie hanno consentito di acquistare poco più di 10.000 nuove opere. I tagli effettuali nella proposta di bilancio 2004 consentiranno di incrementare la dotazione solo di 1.066 opere, allontanando il conseguimento dell’obiettivo di recuperare il gap in 20 anni, fissato nel 2003 quando si pensava di assicurare l’acquisto medio di 10.000 volumi all’anno. La drastica riduzione dei fondi non consente più nemmeno di ipotizzare una possibile data per colmare il gap riscontrato. 262 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) g) Indice della dotazione di periodici L’indice della dotazione di periodici mette in relazione il numero dei periodici correnti con la popolazione; serve a verificare l’adeguatezza del patrimonio dei periodici “vivi” messi a disposizione della biblioteca rispetto all’utenza potenziale. Il calcolo dell’indice viene svolto sulla base della seguente formula, che si conforma allo standard IFLA: dotazione documentaria 1000 popolazione L’indice ricavato di 4,76 è quasi in linea con la media nazionale, che è di 5,42. Per raggiungere il dato medio nazionale si procederà ad una valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, verificando quali sono le richieste più frequenti. In tal modo si procederà ad un rinnovo ponderato dei seriali, incrementando quantitativamente di 100 testate la dotazione attuale. La spesa a prevedersi dovrebbe essere molto contenuta perché si procederà progressivamente a dimettere gli abbonamenti dei seriali più costosi che non risultano consultati almeno da tre anni. h) Indice di incremento della dotazione documentaria L’indice di incremento della dotazione documentaria mette in relazione gli acquisti della biblioteca con la popolazione. Serve a verificare l’impegno profuso dalla biblioteca per aumentare l’offerta documentaria e per mantenerla aggiornata. La formula, secondo gli standard IFLA e qui applicata per calcolare l’indice è la seguente: acquisti 1000 popolazione L’indice di incremento della dotazione documentaria della Biblioteca Provinciale per il 2003 è stato di 74,22, collocando al di sotto della media nazionale che è di 103,84. Questo indice, strettamente correlato all’indicatore n. 5 (indice della dotazione documentaria), riveste un’importanza primaria perché esprime la politica di incremento delle collezioni, che allo stato attuale è sostanzialmente inesistente. Le Linee Guida del 2002 hanno posto una particolare attenzione alla carta delle collezioni che dovrà assumere la principale funzione strategica nella determinazione dell’efficacia dei servizi della biblioteca. D’altra parte è provato che si registra un vero e proprio rapporto di causa-effetto fra l’aumento dell’indice di incremento della dotazione documentaria con quello dei prestiti che analizzeremo più avanti. Per portare l’indice nella media nazionale occorrerebbe acquistare almeno 14.500 opere all’anno per una spesa che si aggira intorno ad euro 435.000. La riduzione di spesa per il 2004 che consentirà l’acquisto di 1.066 opere comporterà il conseguimento di un indice del 9,00, che è al di fuori di ogni parametro di valutazione. Infatti il 263 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) valore minimo riscontrato a livello nazionale è di 18,47, mentre la media nazionale che si colloca a 103,84. Di conseguenza le risorse finanziarie attualmente non consentono di mantenere questo livello appena ipotizzato. i) Indice di impatto L’indice di impatto definisce la percentuale degli iscritti al prestito sul totale della popolazione; serve a verificare l’impatto della biblioteca sui suoi utenti potenziali. In altre parole serve a verificare il radicamento nel territorio di riferimento. L’indice viene calcolato secondo la seguente formula: iscritti al prestito 100 popolazione L’indice di impatto è di 1,64, di poco superiore al minimo rilevato in Italia (1,00) e di gran lunga distante dalla media nazionale di 13,00. In generale un basso indice di impatto viene imputato a numerosi fattori che fanno capo alle disponibilità di risorse (valori troppo bassi di accessioni, dotazione documentaria insufficiente, orario di apertura, spese ridotte, personale non preparato) o a un non sufficiente orientamento della biblioteca all’uso pubblico (orario non funzionale, norme interne che inibiscono il prestito, collezioni prevalentemente collocate in deposito, politica degli acquisti ridotte oppure orientate su utenze di nicchia). Gli indicatori fin qui analizzati sembrano indicare alcuni punti di debolezza al riguardo nella disattenta politica delle collezioni, in norme interne che inibiscono il prestito, in una dislocazione non felice delle collezioni, nel personale a volte poco disponibile. Dall’analisi dei prestiti e delle letture in sede effettuati durante il 2003 emergono dati interessanti che vale la pena leggere attentamente. Occorre precisare che la rilevazione riguarda esclusivamente le aree della biblioteca riservate agli adulti. Tab. 14 - Indice di gradimento per classi 264 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) Intanto la tab. 14 indica immediatamente come il prestito locale, che è uno dei perni dei servizi bibliotecari, ricopre una rilevante quota delle transazioni analizzate. Un altro dato significativo è il ricorso a diverse forme di materiali speciali in disponibilità ad “Immagini&Suoni” e a “ilDock”. Vi è ancora una rilevante presenza di lettura in sala dei documenti presenti in deposito, che è indice di affaticamento della sala di consultazione, in quanto per una biblioteca che punta essenzialmente sulle sale “a scaffale aperto” il ricorso al materiale in deposito dovrebbe essere ridotto ai soli studiosi interessati ad analizzare materiale ultraventennale per ragioni di studio e di ricerca comparata. I dati sembrano, dunque, confermare la necessità di un rinnovo sostanzioso delle collezioni in modo da offrire materiale nuovo ed aggiornato in grado di soddisfare i bisogni dell’utenza attuale e di stimolare l’utenza potenziale, che indica come sia necessario procedere ad uno svecchiamento dei materiali “a scaffale aperto”. Resta confermata la centralità della sala di consultazione sia per i materiali utilizzati in loco, che per i prestiti locali. È interessante notare che una parte fondamentale viene coperta dalla classe 800 (letteratura) che copre da sola il 33,33% della domanda, seguita dalla classe 900 (storia, geografia e biografie) con un 25,65% e dalla 300 (scienze sociali) con il 17,88%. Queste informazioni, ancorché molto aggregate, forniscono indicazioni molto interessanti ai fini della modificazione dell’indice in analisi. In particolare si tratta di valorizzare e potenziare il patrimonio con gli opportuni adattamenti della struttura e dell’organizzazione per mettere in evidenza la dotazione patrimoniale esistente e quella che andrà ad integrare l’attuale. Una carta delle collezioni più sensibile a queste tendenze ed una migliore strategia comunicativa devono diventare l’elemento strategico per ampliare il numero di iscritti al prestito. Per portare l’indice nella media nazionale occorrerebbe, dunque, passare dagli attuali 10.000 primi prestiti a 20.000 prestiti effettuati almeno una volta nell’anno. Ovviamente si tratta di considerare questo obiettivo come una linea di tendenza a cui giungere progressivamente nel tempo, sulla base di tre variabili fondamentali: materiali nuovi ed interessanti, strategie di promozione delle raccolte, strategie di comunicazione. l) Indice di prestito L’indice di prestito rileva il numero dei prestiti annuali rispetto alla popolazione. Serve a valutate l’efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere l’uso delle raccolte. Viene calcolato in base alla seguente formula: prestiti popolazione 265 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) Ovviamente la conseguenza di un numero limitati di prestiti, che ha inciso negativamente sull’indice di impatto, non poteva non incidere negativamente anche sull’indice di prestito. La Biblioteca Provinciale ha un indice di prestito al di sotto di tutti i parametri considerati. Il suo indice rilevato nel 2002 dello 0,03 si colloca nettamente al si sotto dell’indice minimo riscontrato nella rilevazione nazionale che è dello 0,08, mentre l’indice medio nazionale è dello 0,98. Un valore così basso deve essere interpretato in modo estremamente negativo e può essere determinato da numerosi fattori: esiguità degli acquisti, raccolte non corrispondenti ai bisogni dell’utenza, personale non professionalizzato. Lo sforzo compiuto nello scorso 2003 ha comunque consentito di elevare l’indice allo 0,07, di poco al di sotto della soglia minima nazionale. Per raggiungere, tuttavia, l’indice medio nazionale occorrerebbe portare gli attuali 10.000 prestiti annui ad un numero ottimale di 150.000 prestiti. Anche in questo caso questo dato deve essere considerato come un obiettivo a cui tendere progressivamente, attuando strategie comunicative sul posseduto e sulle nuove collezioni. m) Indice di circolazione L’indice di circolazione mette in relazione il numero totale dei prestiti con la dotazione documentaria della biblioteca; serve a verificare il tasso d’uso della collezione e la qualità delle raccolte. L’indice viene calcolato in base alla seguente formula: prestiti dotazione documentaria L’indice di circolazione della biblioteca del 2002 (0,10) si collocava poco al di sopra dell’indice minimo riscontrato, ma ben lontano dall’indice medio nazionale (0,61). L’indice basso di circolazione è segnale di un uso limitato del materiale e di scarsa disponibilità di materiali nuovi. È un segnale preoccupante che mette in luce la scarsa efficacia di una parte considerevole del sistema biblioteca, che produce pochi prestiti, per arrivare a valutazioni più specifiche circa le raccolte documentarie. Non corrispondono in parte ai bisogni dell’utenza perché obsolete, con scarsi acquisti, non coerenti con le domande dell’utenza. Una delle ragioni riscontrate di questo basso indice risiede nella scarsa diffusione della revisione delle raccolte, le quali, non essendo state mai veramente sottoposte alla verifica circa i prestiti effettuati negli ultimi anni e circa la validità e freschezza dei contenuti, non sono mai state effettivamente oggetto di scarti e quindi contengono buona parte di “patrimonio morto”. I recenti acquisti nel 2003 hanno comunque consentito di elevare l’indice a 0,17. Occorre comunque pensare ad una duplice funzione: arricchire il patrimonio, adeguandolo alle esigenze dell’utenza ed incentivare il prestito attraverso poli266 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) tiche di valorizzazione del patrimonio librario della biblioteca. n) Indice di fidelizzazione L’indice di fidelizzazione mette in relazione il numero dei prestiti con il numero degli iscritti al prestito della biblioteca e verifica le frequenze di lettura e quindi il grado di “fedeltà” degli utenti alla biblioteca. L’indice è calcolato sulla base della seguente formula: prestiti iscritti al prestito L’indice di fidelizzazione della biblioteca è salito da 2,69 del 2002 a 4,30, anche se resta al di sotto della media nazionale. Un indice alto di norma è da interpretare positivamente perché denota che gli iscritti al prestito sono soddisfatti di come la biblioteca organizza e gestisce il servizio. L’indice basso è determinato essenzialmente da due fattori negativi. Il primo afferisce all’organizzazione del servizio ancora farraginoso e limitativo, il secondo è strettamente dipendente dalla qualità delle collezioni. Anche in questo caso occorre un’accorta politica di promozione da un verso e di comunicazione e di disponibilità del personale nei confronti dell’utenza. o) Indice di frequentazione L’indice di frequentazione rileva il numero totale delle visite annuali in biblioteca rapportato alla popolazione; è utile a verificare l’attrattiva che la biblioteca nel suo insieme esercita sui cittadini. Il calcolo è bastato sulla seguente formula: visite popolazione La presenza di circa 90.000 visite all’anno ha consentito di portare nel 2003 l’indice di frequentazione da 0,26 a 0,58, superando la soglia minima nazionale di 0,35. La biblioteca resta, comunque, distante dalla media nazionale di 1,99. Va detto che l’indice appena indicato è da ritenere dato per difetto perché non sempre è stato possibile verificare correttamente l’afflusso degli utenti. Tuttavia non si può negare che esso deve essere interpretato come un ulteriore segnale di scarsa vitalità della biblioteca sul piano dell’offerta informativa e documentaria, nonché della comunicazione. L’idea della biblioteca come luogo eminentemente di studio diventa un ele267 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) mento negativo per l’apertura della biblioteca ad altre fasce sociali e culturali, finora poco sensibili alla funzione della biblioteca, e finora non intercettate dalla struttura. In questo senso un’opportuna strategia di comunicazione, insieme ad una politica delle collezioni più vicina alla domanda dell’utenza dovrebbe consentire alla biblioteca di migliorare l’indice di frequentazione. Per raggiungere la media nazionale si dovrebbe registrare una presenza media di mille utenti al giorno, che è difficilmente raggiungibile e che comporterebbe complessi problemi logistici, a partire dalla disponibilità di posti a sedere, che attualmente sono 256. Le Linee Guida hanno posto al riguardo come obiettivo la realizzazione di 400 posti per 500 presenze medie giornaliere. In tal modo l’indice di frequentazione dovrebbe gradualmente salire dall’attuale 0,58 a 0,95. p) Indice di affollamento L’indice di affollamento mette in relazione la media settimanale delle visite alla biblioteca con le ore di apertura settimanale; serve a verificare da un lato l’intensità della frequentazione della biblioteca, dall’altro l’affollamento della stessa. Il calcolo dell’indice viene effettuato sulla base della seguente formula: media settimanale visite orario di apertura settimanale Da questo punto di vista la Biblioteca Provinciale offre con un 27,74 un indice superiore alla media nazionale, che è di 16,47. È evidente che la tendenza ad incrementare l’afflusso in biblioteca, fissando in 500 utenze giornaliere la media ottimale, comporterà un incremento dell’indice di affollamento al 61,32 che potrebbe comportare l’insorgenza di problemi logistici in quando si possono produrre indisponibilità di posti a sedere, confusione, impossibilità di ospitare adeguatamente gli utenti. Tuttavia il dato che si prospetta rimane all’interno del range nazionale considerato, visto che il valore massimo riscontrato è di 106,48. q) Indice quantitativo del servizio di reference L’indice quantitativo del servizio di reference mette in relazione il numero complessivo di transazioni informative con la popolazione: serve a valutare l’intensità d’uso del servizio di reference, cioè l’entità del flusso informativo che passa attraverso il personale. Il calcolo dell’indice è effettuato in base alla seguente formula: transazioni popolazione 268 Valutazione dei servizi de “la Magna Capitana” (anno 2003) L’indice della Biblioteca Provinciale è di 0,66, al di sopra dalla media nazionale di 0,43. Si è trattato di incrementare la presenza in biblioteca, che ha comportato un aumento di transazioni. r) Indice del costo dei servizi L’indice di costo dei servizi mette in relazione la spesa per la biblioteca con i servizi forniti; serve a verificare l’efficienza della biblioteca e quindi il rendimento della spesa in termini di servizio erogato. La formula utilizzata per calcolare l’indice è la seguente: spesa transazioni + uso quantitativo dei materiali Diversamente dalla metodologia A.I.B. che suggerisce la comparazione con i soli prestiti, si è ritenuto più aderente alla valutazione complessiva dei servizi bibliotecari raffrontare la spesa con la totalità dei servizi erogati che rientrano nelle transazioni informative (che includono anche prestiti) e nell’uso in sede dei materiali documentari. L’indice di 13,09, pur rimanendo nel range di valutazione dell’A.I.B., è lontano dalla media nazionale che si colloca a 3,91. Ma è da ipotizzare che le politiche rivolte ad incrementare i prestiti ed aumentare l’utenza consentiranno di allineare progressivamente il dato di Foggia a quello nazionale. 0,33 0,41 1,29 1,64 0,10 0,17 4,30 0,57 13,50 0,66 13,09 269 0,08 12,50 0,11 1,49 0,27 0,00 18,47 1,00 0,08 0,00 3,65 0,35 1,69 0,06 15,12 270 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 1. Introduzione Nel mese di novembre 2002 l’Amministrazione Provinciale di Foggia, da cui dipende la Biblioteca Provinciale, ha approvato le prime Linee Guida. Si è trattato di un atto di fondamentale importanza che accompagnerà l’evoluzione della biblioteca per i prossimi anni. Fra gli indirizzi dettati al direttore vi era la redazione di un’analisi puntuale dell’utenza quale chiave di volta per le successive carta delle collezioni e carta dei servizi. Fra il mese di ottobre e di novembre 2002 si è proceduto ad una rilevazione dei dati sulla scorta dei seguenti strumenti di indagine: a) una scheda censuaria limitata ai soli possessori della bibliocard, cioè dei lettori che si sono iscritti o reiscritti alla biblioteca a partire dal 2001; b) un questionario, rigorosamente anonimo, somministrato per posta; c) un sondaggio telefonico. Le schede ed i questionari sono stati predisposti e realizzati in economia direttamente dal management della biblioteca. I questionari somministrati per posta e quelli utilizzati per il sondaggio sono identici. Il campione relativo al questionario somministrato per posta è stato scelto casualmente per i possessori della bibliocard residenti a Foggia nel numero di 2000. I questionari restituiti sono stati 702, pari al 35,1%. Il sondaggio è stato effettuato casualmente fra i numeri di telefono che compaiono fra gli abbonati telefonici alla Telecom per l’anno 2002 nel numero di 95. L’elaborazione dei dati relativi al questionario e al sondaggio si è conclusa nell’autunno 2003. Sebbene nelle tabelle che si riportano in questo rapporto i dati relativi al questionario e quelli relativi al sondaggio siano graficamente affiancati, si è ritenuto di considerare i due universi in esame non comparabili, per gli elevati scarti riscontrati. I dati censuari relativi ai possessori della bibliocard hanno svolto la funzione di fornire informazioni relative alla professione, alla classe d’età e alla provenienza. I dati campionari, invece, hanno svolto la funzione di indicare il livello di percezione e di soddisfacimento dei servizi bibliotecari, ma hanno consentito anche di fornire informazioni utili relative ai consumi culturali, alla credibilità delle principali sorgenti di informazione e ai bisogni informativi. 271 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Il presente rapporto viene, infine, integrato, da alcuni dati derivanti dalla valutazione dei servizi della biblioteca relativa agli anni 2002 e 2003, redatta in base alle Linee Guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche in Italia dell’A.I.B. e delle raccomandazioni dell’IFLA, che hanno fornito ulteriori elementi di conoscenza quantitativa e qualitativa, basandosi su 15 indicatori. In questo rapporto saranno utilizzati solo alcuni di tali dati, ritenuti necessari per contestualizzare meglio le informazioni. 2. Profilo del lettore Dall’analisi delle proiezioni sulle rilevazioni delle visite effettuate nella terza settimana del mese di gennaio del 2004 in 8 punti di stazionamento in biblioteca nelle ore di picco (11,00 e 17,30) si rileva una media di visite annue stimata in 89.719 presenze (tab. 1). Nei confronti della precedente rilevazione relativa al 2002 si nota un deciso trend ascendente, anche se occorre avvisare che soltanto nel 2005 si giungerà alla maturità del dato sulle visite, perché la biblioteca è uscita da un lungo periodo di interruzioni di servizi dovuti alla ristrutturazione dell’immobile e all’adeguamento degli impianti. Occorre, infatti, sottolineare che al momento attuale non sono ancora aperte al pubblico la Sala Narrativa, l’Area Divulgativa, la sezione “Immagini&Suoni” e l’Auditorium, mentre “ilDock” vive ancora una fase di incertezza dovuta al recente trasferimento presso la sua sede definitiva, ancora in fase di allestmento. È al riguardo interessante notare l’andamento mensile delle visite nel 2002 e nel 2003 (tab. 2), da cui si rileva una sostanziale omogeneità di comportamento dei nostri lettori. Va tenuto presente che nel mese di agosto la biblioteca osserva tre settimane di chiusura. 272 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia -A Può risultare interessante valutare anche le presenze registrate presso il sito web della biblioteca, che sempre più è destinato a svolgere una funzione essenziale nella fornitura di servizi e di informazioni bibliotecarie. Si è effettuata una rilevazione settimanale degli accessi che ha fornito i seguenti dati: • accessi settimanali dall’interno n. 10.506; • accessi settimanali dall’esterno n. 5.257. Per accessi interni si intendono gli accesi di servizio alla Intranet e gli accessi degli utenti in loco al catalogo elettronico. Gli accessi complessivi annui sono stimati in 788.158. Pur volendo escludere dal calcolo gli accessi al web dall’interno, considerandoli esclusivamente accesi di servizio, si ha un dato annuo pari a 273.364 visite, che sommate alle visite annue di cui alla precedente tab. 1, assommano a 363.083 visite. Va precisato che i dati riferiti alle tabelle riportate in questo paragrafo riguardano i lettori che sono entrati in possesso della bibliocard nel biennio 2001-2002. I possessori della bibliocard sono prevalentemente studenti (74.5%), seguiti di gran lunga dai docenti (5,24%), professionisti (4,74%) e impiegati (4,27%). Questo dato mostra ancora una sostanziale monofunzione della Biblioteca Provinciale di supporto all’istruzione e di surrogato alle carenze di istituzioni bibliotecarie scolastiche e universitarie (tab. 3). Sono note le carenze delle prime, su cui sarà necessario intervenire anche come biblioteca provinciale per stimolare ed allargare la consapevolezza del ruolo della biblioteca scolastica. Sono sull’altro versante giustificabili le carenze delle biblioteche universitarie per la giovane età dell’Ateneo foggiano e per gli ovvi tempi lunghi perché le collezioni delle biblioteche universitarie possano giungere a maturità. È, tuttavia, innegabile che si dovrà intervenire su altre fasce sociali, diverse da quelle studentesche, per ampliare la platea degli utenti con un’offerta variegata e più rispondente alle esigenze e ai gusti dei futuri utenti. 273 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia s d p i p d r a c o m b t i d c a r a Nella successiva tab. 4 si riporta invece la stratificazione per professione delle persone che hanno risposto al questionario e al sondaggio, mostrando sostanzialmente due aspetti. Il primo relativo ai frequentanti che vede una minore partecipazione degli studenti, il secondo relativo al sondaggio che riflette un universo del tutto diverso dove ovviamente le casalinghe ed i pensionati assumono un peso rilevante, senza dimenticare comunque il peso sempre importante ricoperto dagli studenti. 274 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Conferma il dato della prevalenza studentesca anche la tab. 5 relativa alla suddivisione per classi d’età. Il lettore della Biblioteca Provinciale si colloca principalmente fra gli 11 e i 25 anni (50,94%); importante è la fascia che ha lasciato gli studi da pochi anni fra i 26 e 40 anni con un 30,09%; interessante ma ancora debole è il dato riguardante i ragazzi dell’istruzione primaria (6-10 anni) con un 6,25%. Di scarso peso quantitativo, ma significativo sul piano qualitativo, è il dato prescolare (0-5 anni) che compare per la prima volta in questo ultimo biennio. Raffrontando i dati degli utenti con quelli della popolazione residente a Foggia (tab. 6), pur nella differenza di scala si nota come la percentuale degli utenti fra 0 e 18 anni copra il 32,81% a fronte del 23,24% della popolazione foggiana compresa fra 0 e 19 anni. Il dato è oltremodo significativo in quanto dimostra un particolare appeal della biblioteca nei confronti dell’utenza giovanile, che certamente dovrà essere ulteriormente stimolato. Allo stesso modo gli utenti che si collocano fra i 19 ed i 40 anni risultano coprire il 54,90%, a fronte di un 31,37% coperto dalla popolazione di Foggia compresa fra 20 e 39 anni. Lo scarto evidente riscontrato su queste fasce d’età tende a ribaltarsi con l’aumento di età. Gli utenti di età compresa fra i 41 e i 60 anni rappresentano il 9,20% mentre la popolazione residente a Foggia di età compresa fra i 40 e i 59 anni copre il 25,50% dei residenti. 275 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Ovviamente la prevalenza giovanile e della fascia che si colloca fra i 20 ed i 35 anni è confermata anche dal questionario, mentre l’età tende ad aumentare nel sondaggio (tab. 7), che conferma di rappresentare un universo a parte non comparabile con i dati relativi all’utenza. Sotto l’aspetto della provenienza la Biblioteca Provinciale risulta decisamente al servizio della città di Foggia (76,79%), con qualche apertura alla provincia (15,95%). Interessante il dato extraprovinciale, che denota, almeno per quanto riguarda la messa a disposizione di fondi di conservazione di particolare interesse sovraregionale (tab. 8). 276 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 3. Il bisogno di biblioteca Dei 702 lettori che hanno compilato il questionario ben 518 (73,79%) dichiarano di utilizzare la Biblioteca Provinciale da diversi anni. Dichiarano di frequentare la biblioteca da un anno e da meno di 6 mesi rispettivamente il 9,54% e il 9,26%. Si rileva, dunque, un trend di crescita di nuovi iscritti situabile intorno al 9% annuo (tab. 10). Interessante è il dato fornito dal sondaggio, che sebbene sia squilibrato verso professioni e classi di età tradizionalmente poco inclini a recarsi in biblioteca, mostra un 25,32% della popolazione che ha utilizzato la biblioteca in questi anni. 277 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia La successiva tab. 11 che riguarda i livelli di frequenza presenta un’utenza che usa occasionalmente i servizi bibliotecari (68,52%). Questo dato riscontrato fra gli iscritti in biblioteca viene confermato anche da un analogo picco (23,16%) rilevato dal sondaggio. La tab. 12 sembra confermare una utilizzazione “di base” della biblioteca da parte dell’utenza, che evidentemente non trova ancora i giusti stimoli per trattenersi in sede per ragioni diverse da quelle dettate dall’uso tradizionale della struttura. Il 36,18% dichiara di trattenersi in biblioteca al massimo un’ora ed il 49,57% fino a 3 ore. Le principali motivazioni che hanno mosso un utente a recarsi in biblioteca sono sintetizzate dalla tab. 13 da cui si rileva sia dal questionario che dal sondaggio che il servizio maggiormente utilizzato è quello della consultazione delle gazzette ufficiali con un 13,92% e un 16,18%. Seguono, occupando il maggior peso, tutte le funzioni connesse in qualche modo allo studio e agli studenti (studio, ricerca, tesi di laurea, prestito). Soltanto il 4,78% dei questionari e l’1,47% delle interviste telefoniche dichiara di recarsi in biblioteca per il piacere di leggere un libro. Sono attestate comunque le altre funzioni della biblioteca (leggere un quotidiano, leggere un settimanale, partecipare ad una iniziativa culturale, ascoltare musica). La tab. 14, utilizzata come verifica, conferma una biblioteca utilizzata e percepita essenzialmente come luogo di studio e di ricerca. 278 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 279 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Tab. 14 - Le principali ragioni di utilizzazione della biblioteca Nella successiva tab. 15 abbiamo provato a valutare il livello di affollamento degli spazi fisici della biblioteca, chiedendo al campione di indicarci con un voto il luogo che frequenta di più in biblioteca. Emerge una utilizzazione tradizionale della biblioteca (le sale di studio), una scarsa conoscenza delle nuove aree e delle nuove funzioni. Tab. 15 - Livello di utilizzazione degli spazi fisici della biblioteca area area 280 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 4. I servizi della Biblioteca 4.1 Uno sguardo d’insieme Una utilizzazione di base e tradizionale della biblioteca è confermata dalla tab. 16 relativa agli indici di utilizzazione dei servizi bibliotecari. Sia dal campione che dal sondaggio si evidenza nella fotocopiatura il servizio più utilizzato, seguito immediatamente dalla consultazione degli atti ufficiali di Governo. Segue il servizio di orientamento bibliografico ed il prestito locale. Diventa netta la cesura fra i servizi tradizionali appena elencati e quelli a valore culturale aggiunto (report specialistici, bibliografie per tesi di laurea, consigli nella lettura), quelli che coinvolgono la cooperazione interbibliotecaria (prestito interbibliotecario, document delivery) o quelli innovativi (accesso a banche dati, e-governance, digitalizzazione). 281 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Ad una analisi più di qualità (tab. 17) dei servizi e degli spazi si conferma da parte del campione l’idea che la biblioteca sia un lungo confortevole e ben dotato di strumenti tradizionali. Il campione non coglie giustamente la presenza della discoteca mai aperta completamente, mentre percepisce e valuta positivamente l’emeroteca e, in tempi brevissimi dalla sua istituzione, coglie e percepisce il sito web della biblioteca. Molto più attardata sulla tradizione sembra essere la valutazione emersa dai dati del sondaggio, che evidentemente ha intercettato utenti che si sono perduti nel tempo, ricordano il confort delle sale, la segnaletica, il vasto patrimonio librario posseduto, ma ignorano l’esistenza del sito web, del catalogo elettronico, della discoteca o la possibilità di ricorrere al document delivery. Nonostante la percezione, forse troppo attardata su un’idea tradizionale di biblioteca, sia il campione che l’esito del sondaggio esprimono sostanzialmente un giudizio positivo sulla varietà dei servizi offerti, riconoscendo la presenza di una gamma ampia di servizi ottenibili in biblioteca. Circa il 16% del campione non esprime giudizio o esprime un giudizio negativo sulla varietà dei servizi proposti. Il giudizio negativo o non espresso sale al 23,81% nel sondaggio. La soddisfazione è tale che circa il 13% degli utenti che rispondono al questionario esprime un giudizio di eccellenza (tab. 18). Il giudizio migliore sui servizi sia del questionario che del sondaggio si colloca fra 7 e 8 rispettivamente con un 47,86% e 66,67%. 282 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Scendendo nel dettaglio dei servizi il 76,78% degli intervistati dichiara di essere entrato in relazione con i servizi di reference. La percentuale si abbassa leggermente nel sondaggio, restando tuttavia a livelli molto alti, pari al 61,90%. Tab. 19 - Utilizzazione dei servizi di reference Le risposte riguardanti le principali transazioni informative da parte degli utenti sono state raggruppate in 9 grandi categorie (tab. 20). Prevale la domanda sui punti di accesso alle informazioni con un 49,19% (orientamento nell’uso dei cataloghi e modalità di accesso ai documenti). Rilevante è la percentuale che si riferisce alla consulenza bibliografica (25,66%); importante la quota riservata alle domande riguardanti i servizi offerti (11,42%). I dati del sondaggio confermano in rilevante parte i tipi di domande più frequentemente rivolte ai bibliotecari, anche se colpisce la totale assenza di interesse nei confronti dei cataloghi. 283 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Il livello di soddisfacimento dei servizi di reference nella loro complessità è accettabile. Solo il 25% circa degli utenti non si esprime o esprime un giudizio negativo. Il sondaggio conferma il giudizio positivo appena intercettato (tab. 21). 4.2 L’orientamento bibliografico I lettori della Biblioteca Provinciale usano molto il servizio di orientamento bibliografico (l’82,91%). La percentuale scende al 61,9% secondo il sondaggio, confermando da un lato l’importanza del servizio offerto, mentre dall’altro mette in evidenza come il mancato incontro con il bibliotecario tende, soprattutto negli utenti occasionali e quelli che arrivano per la prima volta in biblioteca, ad allontanare il potenziale utente (tab. 22). Sul piano del soddisfacimento il 70,45% dichiara di essersi sentito soddisfatto dalla funzione di intermediazione svolta dal bibliotecario (tab. 23). Il dato è confermato dall’indice di gradimento di cui alla tab. 24. 284 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Tab. 22 - Uso dei servizi di orientamento (questionario) 4.3. I cataloghi della biblioteca Le tab. 25 mette in luce come il ricorso al catalogo cartaceo sia una delle attività centrali della biblioteca, anche se sconta la sua obsolescenza che discende da tempo immemorabile. In ogni caso il 65,24% dei lettori fa ricorso al catalogo generale della biblioteca. 285 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia La tab. 26 indica in un 30,48% gli utenti che ricorrono al catalogo elettronico. Si tratta di un dato positivo, tenendo conto che il catalogo elettronico è stato istituito nel mese di giugno 2001 ed è in lenta fase di implementazione con il recupero, libro alla mano, delle informazioni bibliografiche del pregresso. 4.3. Il patrimonio librario 4.3.1. Livello di utilizzazione in sede del patrimonio librario e documentale Il 32,77% dei lettori non dichiara o dichiara di non utilizzare unità bibliografiche in possesso della biblioteca. 286 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 4.3.2. Prestito locale Il 58,83% dei lettori dichiara di fare ricorso al prestito locale; la percentuale sale al 66,67% nel sondaggio (tab. 28). È interessante notare come il giudizio sul livello di soddisfacimento del servizio di prestito locale sia prevalentemente positivo o molto positivo sia fra gli utenti che nel sondaggio (tab. 29). voto Tab. 30 - Livello di utilizzazione del servizio di prestito locale 287 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 4.3.3. ILL – prestito interbibliotecario Il ricorso al servizio di prestito interbibliotecario è sostanzialmente ridotto. Sia nel sondaggio che nei lettori che hanno risposto al questionario il prestito interbibliotecario è stato praticato da una frangia di utenti che si colloca al di sotto del 10% dei frequentatori della biblioteca (tab. 31). Resta anche in questo caso confermato un sostanziale parere positivo sul servizio assicurato (tab. 32) con oltre un 75% dei giudizi positivi. 4.4. Servizi di riproduzione 4.4.1. Fotocopie Il servizio fotocopie, che attualmente è in parte esternalizzato e in parte in regime di self service, si conferma essere il servizio più utilizzato dagli utenti. Sia per coloro a cui è stato somministrato il questionario che per coloro che si sono sottoposti al sondaggio telefonico si raggiungono percentuali molto elevate con un 288 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 74,50% ed un 71,43% rispettivamente di risposte positive (tab. 33). Anche in questo caso i giudizi sono sostanzialmente positivi (tab. 34). 4.4.2. Digitalizzazione Il servizio di digitalizzazione è stato attivato in forma sperimentale e ridotta contemporaneamente alla somministrazione del questionario. Per questa ragione si riscontrano dati negativi molto vistosi (tab. 35). 289 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 4.5. Internet Il servizio di accesso ad Internet non era attivo al momento della somministrazione del questionario. La domanda fu posta come momento di verifica della “sincerità” delle risposte. Va detto, comunque, che l’accesso all’OPAC dall’interno della biblioteca avveniva al tempo della somministrazione del questionario attraverso Internet. Per tale ragione ad un utente un po’ più smaliziato non sfuggì l’opportunità di “aggirare” le protezioni per accedere alla rete. 4.6. Document delivery Il servizio di document delivery fu attivato in forma sperimentale in contemporanea alla somministrazione del questionario. La presenza, dunque, di un 5,27% di utenti che ha fatto ricorso al servizio è sicuramente da rafforzare, ma anche da leggere in una prospettiva di rapida crescita del servizio. 4.7. Desiderata Il servizio dei desiderata è da considerare un’offerta consolidata della biblioteca, anche se il dato del 14,25% sottolinea che i lettori difficilmente vi fanno ricorso (tab. 38). Le ragioni di questo scarso utilizzo risiedono quasi sicuramente nella scarsa accoglienza da parte della biblioteca delle richieste degli utenti, come la tab. 39 conferma. Infatti il 67% degli utenti che ha formulato desiderata riferisce di un esito negativo della domanda. 290 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 4.8. Attività di promozione Le attività di promozione della lettura poste in essere dalla biblioteca interessano positivamente il 35,75% degli utenti a cui è stato somministrato il questionario, mentre il dato scende al 9,52% nel sondaggio. Il dato evidenzia certamente una poco efficace circolazione delle informazioni all’esterno della biblioteca, su cui occorrerà riflettere per individuare strategie comunicative in grado di raggiungere in modo più capillare la popolazione. 4.9 Web La stessa esigenza di definire strategie informative riguarda l’uso del sito web. Il 16,38% dei questionari ed il 23,81% del sondaggio dichiara di farvi ricorso (tab. 41). Occorre ricordare che si tratta di dati riferiti al 2002, quando il sito 291 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia era stato da poco reso pubblico. Infatti dalla rilevazione dei servizi per il 2003 si evince una media annua di frequentatori del sito, esterni alla biblioteca di 273.364 visite. Questo dato rende il sito web il “luogo” più frequentato della biblioteca. (tab. 42). 4.10. «la Capitanata» La rivista della biblioteca, che si stampa senza soluzione di continuità dal 1962 è conosciuta dal 39,32% dei lettori a cui è stato somministrato il questionario e dal 42,86% di coloro che hanno risposto al sondaggio (tab. 43). Di coloro che hanno detto di conoscere la rivista il 42,03% dichiara di averla letta (tab. 44), tenendo conto che la rivista stampata in un numero variabile di copie (da 500 a 900) ha una circolazione nazionale e quindi non è in grado di circolare diffusamente fra i lettori. La scelta compiuta di digitalizzare tutta la collezione e di metterla in chiaro in rete consentirà sicuramente un accesso più ampio. 292 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 4.11. Le aree specializzate L’istituzione nel 2001 de “ilDock” con i suoi centri di documentazione e la riconversione nel 2002 della fonoteca in sezione “Immagini&Suoni” consentono alla biblioteca di fornire per la prima volta un completo pacchetto di servizi bibliotecari specializzati che si aggiungono alla più nota e dotata sezione dei fondi speciali. La domanda di cui alla tab. 45 è stata posta con la consapevolezza di ottenere un indice di utilizzazione non elevato, per la giovane età dei servizi proposti. È servita, però, a riflettere dopo due anni di attivazione sperimentale sui possibili punti di forza. In questo senso si è rilevata una attenzione maggiore alla sezione dei giovani adulti e della didattica a dimostrazione che si tratta di due segmenti sociali ormai maturi ed in grado di alimentare una domanda speciale e specialistica. 293 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 4.5. Giudizi sulla professionalità dei bibliotecari 4.5.1. La cortesia Le due tabelle che seguono servono a comprendere il giudizio che gli utenti esprimono sulla qualità dell’azione dei bibliotecari. In particolare si è deciso di chiedere un giudizio su due aspetti professionali attinenti alla sfera relazionale (la cortesia e la tempestività) tenendo conto che nelle precedenti tabelle si era già provveduto a valutare gli aspetti più attinenti alla fisionomia della professione del bibliotecario (reference, orientamento bibliotecario, prestito, ecc…). Il giudizio comparato fra queste due qualità mette in evidenza un sincero esercizio critico degli utenti. Se il 20,67% degli intervistati esprime un giudizio negativo sul livello di cortesia dei bibliotecari (tab. 46), il dato negativo sale al 30,06% quando di parla di tempestività (tab. 47). Il 18,66% esprime un giudizio appena sufficiente per quanto riguarda la cortesia e un 22,65% per quanto riguarda la tempestività. Sostanzialmente simile è il risultato che emerge dal sondaggio. Le punte di eccellenza sono del 14,39% per la cortesia e del 9,69% per quanto riguarda la tempestività. 294 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 4.5.2. La tempestività 4.6. Il giudizio globale In questo paragrafo si affronta il giudizio globale sulla biblioteca, sui suoi servizi e i suoi bibliotecari. Si è deciso di procedere con due insidiose domande a risposta aperta per valutare i punti di maggiore debolezza e forza, chiedendo all’utente di individuare il peggior difetto e il maggior pregio. Le risposte sono state successivamente elaborate e raggruppate in risposte omogenee ed assimilabili. Intanto i maggiori rilievi vengono mossi a due aspetti fondanti della biblioteca (il bibliotecario e il patrimonio librario), seguono poi i giudizi negativi sui servizi. Il 17% lamenta una scarsa professionalità del personale, a cui si aggiunge un 1,28% che lamenta apertamente la maleducazione del personale. Sul piano dell’offerta documentale e libraria i nostri utenti lamentano per il 15,17% la presenza di libri inadeguati, che significa una critica severa alla politica delle collezioni finora seguita dai bibliotecari, probabilmente racchiusa in una visione olistica delle scelte di acquisto. A questa si aggiunge un 11,70% che lamenta il mancato aggiornamento bibliografico che rappresenta l’altro aspetto della politica delle collezioni. Questo dato negativo è ulteriormente rimarcato dal sondaggio che per il 33,33% lamenta un aggiornamento bibliografico inadeguato. Sul piano della rappresentazione di sé e della comunicazione della biblioteca con gli utenti esprimono un giudizio negativo per un complessivo 13,19% (4,94% non comunica con gli utenti, 4,39% è burocratica, 1,46% lascia gli utenti abbandonati a se stessi, 1,28% è dispersiva, 1,10% è poco confortevole). Per quanto riguarda la fornitura dei servizi gli utenti lamenta295 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia no per un 8,44% l’orario non rispondente (riferito al precedente orario spezzato) e per uno 0,73% la chiusura estiva, per un 4,75% affermano che genericamente alcuni servizi essenziali non funzionano, per un 2,19% trovano la biblioteca tecnologicamente ed informaticamente arretrata, per un altro 2,19% riscontrano un servizio di orientamento e di consulenza non adeguato e poi a seguire lamentano una complessiva cattiva organizzazione del servizi (1,65%), un catalogo inefficiente (1,65%), una lentezza eccessiva per ottenere i materiali (1,46%); un 1,28% accusa la biblioteca di non offrire molti stimoli culturali. Un 5,67% esprime un giudizio negativo sull’edificio non ritenuto più adeguato alle nuove esigenze, mentre un 2,19% esprime un giudizio negativo su se stesso quando individua come peggior difetto della biblioteca il suo essere luogo di ritrovo per perditempo. Vi è un giudizio negativo esortativo per l’1,46% che chiede alla biblioteca di pubblicizzarsi meglio all’esterno, mentre vi è un 4.39% che non riesce a trovare alcun aspetto negativo, a fronte di uno 0,37% che dipinge la biblioteca come luogo assolutamente negativo. 296 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Gli stessi aspetti fondanti della biblioteca (personale e patrimonio librario) su cui venivano espressi giudizi negativi assumono carattere positivo nella valutazione dei pregi. Il 19,81% considera la Biblioteca Provinciale ben fornita (il 21,05% nel sondaggio), mentre il 10,85% attribuisce alle qualità professionali il maggior pregio della biblioteca (5,90% personale preparato, 4,95% personale cortese, che sale a 21,05% nel sondaggio). La struttura fisica e l’organizzazione degli spazi della biblioteca continuano ad essere considerati tratti qualificanti della biblioteca: il 10,86% enfatizza la sua architettura e l’ubicazione e il 4,38% ne sottolinea gli spazi. Sul piano dei servizi offerti il 7,81% si dichiara soddisfatto dei servizi bibliotecari, il 5,71% considera il servizio di orientamento il maggior pregio della biblioteca, lo 0,76% esprime un giudizio estremamente positivo sui cataloghi; il 4,19% trova l’orario continuato il pregio più importante della biblioteca. Per quanto riguarda la rappresentazione di sé e la capacità di porsi in relazione con l’utenza vengono segnalati come maggior pregio la sua accoglienza (6,48%), la silenziosità (6,10%), la sua voglia di adeguarsi ai bisogni dell’utenza (4,57%), la sua capacità di essere un riferimento culturale (1,90%) o un luogo di aggregazione (1,14%). Infine c’è un 2,67% che non sa trovare alcun pregio, mentre un 2,29% sicuramente non ne ha trovato nessuno a fronte di un 3,62% che considera la biblioteca nella sua interezza un luogo “non plus ultra”. 297 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Dalla valutazione dei pregi e dei difetti della biblioteca consegue la richiesta di esprimere in un giudizio sintetico la valutazione sulla funzionalità complessiva della biblioteca (tab. 50). Al riguardo non viene espresso alcun giudizio o viene espresso un giudizio negativo dal 22,8% di coloro che hanno risposto al questionario e dal 19.04% del sondaggio. Un giudizio sufficiente viene espresso dal 23,22% del questionario e dal 9,52% del sondaggio. Danno una valutazione globale positiva o molto positiva il 79,01% di coloro a cui è stato somministrato il questionario e il 71,43% del sondaggio. 5. La percezione della funzione della Biblioteca La tab. 51 è di complessa lettura e corrisponde ad una domanda molto strutturata rivolta a collocare la biblioteca in una scala di percezione e di utilizzazione fra diverse sorgenti di informazioni in relazione ad alcuni gruppi omogenei di informazioni che normalmente la biblioteca è in grado di fornire. I gruppi di informazione individuati sono: la storia di Foggia, le fonti per tesi di laurea, notizie sull’istruzione, i romanzi, informazioni per i concorsi, la lettura dei giornali, l’aggiornamento professionale, notizie sull’Unione Europea, consultazione di statistiche ufficiali, informazioni sull’ambiente e l’inquinamento, informazioni ed aggiornamento per gli insegnanti, manuali per la cucina, il giardinaggio, il fai da te e l’hobbystica, notizie politiche ed elettorali, informazioni di carattere religioso, il codice della strada, informazioni sulla salute, testi e audiovisivi teatrali musicali e cinematrografici, dati ed informazioni sulla protezione civile, informazioni per viaggi e vacanze, informazioni sulle automobili, leggi e regolamenti condominiali, pratiche sportive. Si tratta di informazioni su diversi supporti che la biblioteca possiede e mette a disposizione dell’utenza. 298 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Si è chiesto agli utenti e al sondaggio di esprimere con un voto da 0 a 10 il livello di affidabilità delle informazioni (per completezza, tempestività e aggiornamento), comparando la biblioteca con altre 8 sorgenti di informazioni (Internet, professionista, edicola/libreria, amico/parente, negozio specializzato, TV/radio, scuola/università, associazione). Questa domanda ci serviva per comprendere il livello di percezione della biblioteca quale fornitore di informazioni non necessariamente legate alla funzione di studio. Il dato globale è allarmante. La biblioteca si colloca al settimo posto ed è preceduto non solo dai concorrenti più noti ed agguerriti (Internet, TV, edicola e libreria), ma anche dai professionisti e dai negozi specializzati e perfino dai consigli degli amici e dei parenti. Il dato si incupisce ulteriormente nel sondaggio, dove per credibilità complessiva la biblioteca si colloca al penultimo posto, precedendo solo le associazioni. La ragione di questo piazzamento risiede sostanzialmente nell’ampiezza della forbice tra l’argomento ritenuto più vicino alla funzione della biblioteca (notizie sulla storia di Foggia) a quello ritenuto più lontano (informazioni sulle automobili). Lo stesso andamento si riscontra per la scuola e l’università sottolineando in tal modo nell’idea degli utenti una sorta di separatezza fra materie oggetto di studio e materie oggetto di non-studio. Il fatto che la biblioteca segua lo stesso andamento della scuola e dell’università conferma la percezione di una struttura sostanzialmente chiusa sulle funzioni di studio e di ricerca e non aperta a funzioni informative, alimentando quella già nota “paura della soglia”. Scendendo nel dettaglio la biblioteca riesce a sostenere il confronto in quelle aree che sono tradizionalmente contigue allo studio, alla ricerca e alla tradizionale funzione di conservazione (storia di Foggia, tesi di laurea, notizie sull’istruzione, romanzi), mentre perde clamorosamente per quanto riguarda la fornitura di informazioni che potremmo definire di comunità, estendendo in modo improprio la categoria (codice stradale, protezione civile, condomino, elezioni, sport, cucina, automobili) e per quanto riguarda aree la cui copertura era assicurata dalla “sala adulti” ora smobilitata (hobby e fai da te, religione, salute, teatro, musica, cinema, giardinaggio, viaggi). Mantiene invece una propria credibilità quale agente di informazione per quanto riguarda i concorsi, i giornali, l’aggiornamento professionale, l’Unione Europea, l’ambiente e la didattica (queste ultime tre aree sono da un paio di anni particolare oggetto di attenzione da parte della biblioteca). Complessivamente l’utenza nei confronti della Biblioteca Provinciale, intesa come agenzia di informazioni, si comporta in modo tradizionale, tornando a sottolineare implicitamente la scarsa credibilità della biblioteca a mostrarsi capace di fornire informazioni recenti. Emerge una biblioteca, dunque, ancora di studio e di conservazione, che ha difficoltà a fornire informazioni su argomenti di attualità e di interesse collettivo locale. Questa percezione di una biblioteca “di base” è rafforzata dai dati che emergono dal sondaggio telefonico in cui si evidenza una sostanziale inesistenza di appeal della biblioteca, che è praticamente sostituita dall’edicola e dalla libreria nelle forme tradizionali e da Internet in quelle innovative e più avanzate. 299 q = questionario s = sondaggio Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 300 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 6. I consumi culturali e di informazione dei lettori della biblioteca L’indagine che abbiamo condotto sulla biblioteca ci ha consentito di ampliare l’inchiesta sui consumi culturali a Foggia, quale elemento di conoscenza per definire nuove strategie comunicative della biblioteca in relazione all’ampliamento dei servizi bibliotecari stessi. Le domande che seguono vertono su alcuni consumi e bisogni culturali urbani di fondamentale importanza che possono offrire indicazioni importanti per lo sviluppo delle collezioni della biblioteca. In particolare si è cercato di conoscere l’attenzione che i foggiani rivolgono ai quotidiani, ai libri, alla musica, al cinema, al teatro e al tempo libero. Emerge un quadro interessante foriero di importanti sviluppi per una biblioteca che sta ampliandosi da un luogo di studio ad un luogo di studio, cultura e informazione. Le tabelle che seguono si riferiscono a domande identiche somministrate sia ai lettori per posta che alle persone intervistate telefonicamente. Va infine ricordato che le stime che seguono si riferiscono ad un’indagine di carattere sperimentale che non ha possibilità per ora di essere misurata e confrontata con dati omogenei precedenti. I dati, dunque, dovranno essere considerati provvisori e base per misurazioni omogenee e compatibili successive. 6.1. I Quotidiani 6.1.1. Stima mensile di lettura di un quotidiano Coloro che non si esprimono o dichiarano di non leggere mai un quotidiano rappresentano una esigua minoranza sia fra i lettori della biblioteca (9,83%) che fra le persone intervistate telefonicamente (12,63%). Rispettivamente il 42,16% e il 35,79% dichiara di leggere un quotidiano fra 1 e 10 volte al mese. Leggono praticamente ogni giorno un quotidiano il 48% degli utenti della biblioteca ed il 51,58% degli intervistati telefonicamente (tab. 52). Il dato che è appena emerso indurrebbe a pensare che in città vi sia una sostenuta vendita di quotidiani, che contrasta con i dati degli editori sulla diffusione e la vendita dei quotidiani in città. Molto probabilmente il dato è da collegarsi alla lettura occasionale che avviene in luoghi di aggregazione (bar, pub, associazioni, ecc…). Non è un caso che alla successiva domanda riferita al quotidiano preferito il 31,71% dei lettori ed il 23,16% degli intervistati che hanno dichiarato di leggere un quotidiano affermano di non avere un quotidiano preferito. Per quanto riguarda il livello di fedeltà a quotidiani a copertura nazionale si colloca al primo posto il «Corriere della Sera» rispettivamente con il 19,14% ed il 20%, seguito da «la Repubblica» con il 18% ed il 16,84%. Seguono di gran lunga staccati «Il Manifesto» (1,57%), «Il Giornale» (1,14%), l’«Avvenire» (0,71%), «La Stampa» (0,57%). Per quanto riguarda i quotidiani locali «La Gazzetta del Mezzo301 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia giorno» occupa una quota del 15,57% fra gli utenti della biblioteca per salire al 25,26% degli intervistati telefonicamente. Seguono di gran lunga staccati «Il Quotidiano di Foggia», «La Grande Provincia», «Foggia&Foggia» (quest’ultimo è un settimanale di annunci commerciali a diffusione gratuita). Per quanto riguarda i grandi quotidiani sportivi nazionali «La Gazzetta dello Sport» è il quotidiano preferito per il 2,71% degli utenti della biblioteca e «Il Corriere dello Sport» per lo 0,57%. Per quanto riguarda i quotidiani politici «L’Unità» è preferito dall’1,86%, seguito dal «Secolo d’Italia» per uno 0,14% (tab. 53). 6.1.2. Il quotidiano preferito 302 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 6.2. I libri 6.2.1. Stima annua di lettura L’8,55% dei questionari e il 14,74% del sondaggio non indica o dichiara di non aver mai letto un libro nell’ultimo anno. Dichiarano di leggere almeno un libro il 35,9% degli intervistati e il 26,32% del sondaggio. La percentuale dei lettori di libri si eleva al 47,3% degli utenti e al 25,27% del sondaggio per giungere rispettivamente ad un 8,26% e ad un 33,68% di coloro che leggono oltre venti libri l’anno (tab. 54). Per comprendere la natura e i generi dei libri preferiti abbiamo chiesto ai nostri intervistati di indicarci da 1 a 3 autori o libri preferiti. Emerge una predilezione per il romanzo o comunque per la fiction, non senza attenzioni alla saggistica. Emerge un quadro dinamico, molto poco legato alla circolazione scolastica che consente di immaginare una platea di lettori attenta, sensibile ed esigente. 6.3. Cinema e teatro 6.3.1. Stima annua Per quanto riguarda i consumi culturali legati al cinema e al teatro emerge un quadro contrastato. Intanto il 15,52% degli utenti ed il 40% del sondaggio dichiara di non recarsi mai al cinema. Il dato negativo è enfatizzato da coloro che vi accedono raramente in un anno: rispettivamente il 28,77% ed il 33,68%. Oltre le 10 volte l’anno vanno al cinema a Foggia il 28,77% degli utenti e solo l’8,43% del sondaggio (tab. 56), evidenziando ancora una volta la crisi che sta vivendo la sala cinematografica. 303 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia Ancora più sconfortanti sono le percentuali che riguardano il teatro. Il 43,87% degli utenti ed il 66,32% del sondaggio non indicano o dichiarano di non essere mai andati a teatro. Oltre 10 rappresentazioni all’anno sono state seguite dal 4,7% degli iscritti e da nessuno del sondaggio. Tab. 57 - Quante rappresentazioni teatrali all’anno 6.3.2. I generi preferiti In occasione della somministrazione delle interviste abbiamo ritenuto di informarci anche sul genere preferito, indipendentemente dalla manifestazione (libro, cinema, tv, ecc…). Il dato che emerge è significativo. Fra gli iscritti alla biblioteca ottengono elevati indici di gradimento l’attualità, il genere scientifico, i viaggi, gli argomenti di storia e di avventura. L’attualità e l’avventura sono molto graditi anche al sondaggio, che non disdegna il genere sentimentale e quello a contenuto religioso. Sembrano non ottenere il gradimento dei foggiani l’horror, il genere fantascientifico, parapsicologico e militare. Colpisce il penultimo posto nell’indice di gradimento fra i lettori della biblioteca assegnato al femminismo (tab. 58). 304 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 6.4. La musica 6.4.1. Stima annua Anche i consumi musicali sembrano seguire lo stesso trend del cinema e del teatro. Il 27,05% degli utenti ed il 45,26% del sondaggio dichiara di non essere mai andato ad un concerto, anche se rispettivamente il 54,27% ed il 50,53% dichiara di esservi andato almeno una volta. I cultori restano pochissimi. Il 7,12% degli utenti e solo l’1,05% del sondaggio dichiara di andare oltre 10 volte all’anno ad un concerto (tab. 59). Tab. 59 - Quanti concerti all’anno 305 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 6.4.2. I generi musicali preferiti Per quanto riguarda i generi musicali sia fra i lettori che nel sondaggio conquistano le prime tre posizioni il rock, il melodico e la musica classica, anche se fra i due universi si nota un ordine di piazzamento diverso, dovuto sicuramente alla prevalenza della fascia giovanile fra gli utenti (tab. 60). 6.4.3. Il musicista preferito La tendenza viene confermata anche dalla risposta aperta che aveva per argomento il musicista preferito. La varietà è ampia e si riscontra la presenza di cantanti rock e di cantanti melodici. Fra i classici Mozart sembra prevalere per poche posizioni di Beethoven. 6.5. Il tempo libero 6.5.1. Stima annua dei week-end Il 20,8% degli utenti dichiara di non prendersi mai un week-end; il 33,9% dichiara di viaggiare almeno una volta all’anno; il 23,79% sostiene di viaggiare oltre le 10 volte (tab. 62). Interessante è il dato della successiva tab. 63 da cui emerge che oltre la metà degli utenti e la metà esatta del sondaggio dichiara di viaggiare all’estero per proprio piacere. 306 Primo rapporto sulla percezione della Biblioteca Provinciale di Foggia 6.5.2. Viaggi all’estero 6.6. Computer Infine, il dato relativo all’uso dello strumento informatico. Ormai solo 13,25% degli utenti non si esprime o dichiara di non aver mai usato il computer. Anche coloro che sono stati raggiunti telefonicamente in prevalenza usano il computer, anche se la percentuale di quanti non sanno o vogliono prenderlo in considerazione copre ancora il 48,1%. 307 308 Gli autori Gli autori Maria Altobella, bibliotecaria dal 1973, è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con la tesi Beni culturali e biblioteche: attività legislativa dallo Stato unitario alle Regioni. Ha conseguito, inoltre, il Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Bari. In qualità di Funzionario Culturale Bibliotecario, è coordinatore dell’Area Public Library della Biblioteca Provinciale di Foggia oltre che referente della Sala Consultazione. Ha curato la pubblicazione di cataloghi bibliografici, bibliografie speciali, dossier tematici e collaborato a riviste specializzate. Ha svolto attività di docenza in corsi di formazione professionale tra cui, nel 1998, quella relativa a “Mediateca 2000. Progetto d’azione organizzato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali”. Gabriella Berardi, laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Bari, presta servizio, con la qualifica di Funzionario culturale, presso la Biblioteca Provinciale di Foggia. In questa veste è la responsabile del Polo SBN di Foggia e si occupa di formazione e normalizzazione delle procedure catalografiche del Sistema Bibliotecario Provinciale. È giornalista pubblicista. Carine Bizimana, nata in Burundi, vive a Foggia da sei anni. Fa parte della cooperativa “Xenia” che cura i rapporti con gli immigrati. Collabora attivamente con l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Foggia e cura una rubrica di approfondimento sociale per l’emittente televisiva “Teleradioerre”. Grazia Carbonella nasce a S. Giovanni Rotondo il 25 maggio 1974. Dopo la maturità classica, consegue il diploma di chitarra presso il Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia. Nel 1997 si laurea in Storia della musica presso al facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la tesi L’uso del basso ostinato nella musica italiana del Seicento, relatore il prof. Pierluigi Petrobelli. Nel 1999 frequenta il corso di perfezionamento in “Filologia musicale” organizzato dalla Fondazione Rossini di Pesaro e nel 2000 il corso di “Iconografia musicale” organizzato dalla Fondazione Italiana per la Musica Antica di Urbino. Nel 2001 segue il corso regionale “Esperto in tecnologie di sistemi multimediali” presso la KnowK. di Foggia. Dal 2002 collabora con la cooperativa “Mediateca2000” per la catalogazione dei documenti sonori della Biblioteca Provinciale di Foggia. È giornalista pubblicista. Pasquale d’Addedda è stato assunto il 9 aprile 1973 presso la Biblioteca Provinciale di Foggia attraverso pubblico concorso. Nei primi anni si è dedicato, dopo un corso tenuto presso l’IBM di Bari sulla programmazione in RPGII, quasi esclusivamente all’opera di introduzione delle nuove tecnologie digitali e telematiche a supporto della catalogazione, acquisendo notevole professionalità sull’argomento e ha partecipato ad alcuni progetti interni. A diversi livelli ha continuato ad interessarsi della catalogazione in quasi tutti i settori della Biblioteca. In questo ambito ha provveduto ad unificare, sia fisicamente che biblioteconomicamente i due cataloghi per autori esistenti: uno su schede Staderini e l’altro su schede internazionali. 309 Gli autori Ha collaborato nel 1998 alla catalogazione ed elaborazione dei dati per la pubblicazione del catalogo della mostra bibliografica “… la biblioteca (nel)la città la città (nel)la biblioteca”. Dal 21 marzo 2000 si occupa, su incarico conferitogli dal dirigente, della trasformazione del magazzino librario da deposito in struttura biblioteconomicamente funzionale alle nuove esigenze della Biblioteca. Partecipa alla catalogazione elettronica del patrimonio librario. Sul n. 10 del 2001 della rivista «la Capitanata» è stato pubblicato un suo articolo col titolo Il nuovo magazzino librario della Biblioteca Provinciale di Foggia. Enrichetta Fatigato, nata e residente a Foggia, laureata in Filosofia ha coltivato, a partire dalla tesi di laurea sull’urbanizzazione terziaria di Foggia pubblicata in saggio su «la Capitanata», interessi per gli studi psicologici. Presta attualmente servizio presso la Biblioteca Provinciale di Foggia in qualità di Funzionario culturale bibliotecario. Esperta di biblioteconomia, bibliografia e tecnica dei cataloghi e docente in corsi di formazione e aggiornamento per bibliotecari, ha curato per il Distretto Scolastico di Foggia la pubblicazione “Rapporto sulle biblioteche scolastiche del Distretto di Foggia”. È stata dal 1990 al 2000 responsabile della Biblioteca centrale delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza di Foggia. È attualmente responsabile de “ilDock” Centro servizi e documentazioni multimediali istituito presso la Biblioteca Provinciale di Foggia avendone ideato e progettato l’impianto. Marianna Iafelice è nata a San Severo nel 1971, si è laureata in Conservazione dei Beni Culturali, Indirizzo dei Beni Archivistici Librari presso l’Università degli Studi di Udine, per poi specializzarsi a Bari nella catalogazione informatizzata del libro antico. Di recente ha conseguito il Diploma della Scuola biennale di Archivistica, Paleografica e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Bari. Ha contribuito alla schedatura degli incunaboli e delle cinquecentine della Biblioteca Comunale di San Severo, finalizzata alla realizzazione di un catalogo su cd-rom dal titolo “Gli incunaboli e le cinquecentine della Biblioteca Comunale A. Minuziano di San Severo.” Nel 2000 le è stata affidata dalla COMES ATP, la redazione di una ricerca storico-libraria-archivistica da allegare al progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell’immobile di pregio che ospita l’Istituto Talassografico Sperimentale “A. Cerreti” del CNR di Taranto. Ha pubblicato sulle riviste «Carte di Puglia», «la Capitanata», «Il Provinciale». Attualmente sta effettuando la catalogazione informatizzata del fondo antico della Biblioteca Provinciale di Foggia. Elena Infantini, nata a Foggia nel 1971, si è laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Bologna. Dopo aver conseguito il Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Bari, ha prestato servizio di volontariato presso l’Archivio di Stato di Foggia ed ha lavorato, per conto di una società privata, alla fase iniziale del riordino dell’archivio appartenente alla ASL FG3, occupandosi delle operazioni di scarto. Attualmente è Funzionario culturale presso la Biblioteca Provinciale di Foggia dove ricopre l’incarico di responsabile del Web e della Comunicazione. Franco Mercurio è laureato in Filosofia con specializzazioni post-laurea in ambito storico e amministrativo. Direttore della Biblioteca Provinciale di Foggia, è responsabile del coordinamento interprovinciale delle quattro province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia. Ha svolto numerose attività di docenza fra cui, ultima, dal 1997 al 2002, presso l’Istituto universitario di Architettura di Venezia, Laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, corso di 310 Gli autori “Storia delle città e del territorio”. È autore e curatore di numerose pubblicazioni fra cui La frontiera del Tavoliere. Agricoltura, bonifiche e società nel processo di modernizzazione del Mezzogiorno tra ‘800 e ‘900 (Foggia, 1990); Classi dirigenti o ceti dominanti? Breve storia di Foggia in età contemporanea (Foggia, 2001). Franco Neri è nato a Prato il 23 marzo 1950. Ha diretto dal 1980 al maggio 1994 la Biblioteca comunale “R. Fucini” di Empoli. Dal 1 giugno 1994 dirige la Biblioteca comunale “A. Lazzerini” di Prato (“Sistema bibliotecario urbano e delle opportunità formative”) e coordina dal 2001 il Sistema bibliotecario provinciale pratese, del quale ha curato la progettazione per conto della Provincia di Prato. Ha inoltre curato e progettato a partire dal 1995 l’OPAC delle risorse documentarie della provincia di Prato e la personalizzazione del nuovo software catalografico EASYCAT. È responsabile anche del settore di Educazione degli Adulti del Comune di Prato. Coordina in tale veste (la Biblioteca “A. Lazzerini” è in corso di accreditamento quale agenzia formativa) progetti su bandi misura C4, risorse F.S.E. In questi anni si è occupato di temi di cooperazione bibliotecaria, biblioteche e reti civiche, reti bibliotecarie interistituzionali. Guido Pensato è stato vicedirettore prima e quindi direttore della Biblioteca Provinciale di Foggia, nonché componente del primo Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e del Direttivo dell’Associazione Italiana Biblioteche. Si occupa anche di cultura alimentare e di arte contemporanea. Sugli argomenti oggetto dei suoi interessi pubblica articoli e saggi. Antonio Perrelli è l’Authority Informatica della Biblioteca Provinciale di Foggia. Franca Pinto Minerva è professore di Pedagogia generale e preside della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Foggia. Si occupa da anni di educazione interculturale e di fenomeni migratori ed è stata coordinatore scientifico del progetto CE-MPI-IRRSAE “I curricoli dell’intercultura: educazione linguistica, educazione scientifica, mass media, matematica, storia, religioni, musica per la scuola dell’obbligo”. Tra le sue pubblicazioni sul tema dell’intercultura ricordiamo Le parole dell’Intercultura (Adda, Bari, 1996). Annalisa Scillitani nata a Foggia nel 1956, lavora in biblioteca dal 1980. Si è occupata di biblioteche per ragazzi. Attualmente è responsabile della Sala Narrativa e della Divulgazione. Filomena Tancredi, nata a Foggia nel 1965, è bibliotecaria. In qualità di Istruttore direttivo culturale è responsabile della Sala Ragazzi della Biblioteca Provinciale di Foggia e referente regionale A.I.B. Puglia delle biblioteche per ragazzi. Attualmente frequenta presso l’Università Roma Tre il Master “Pedagogia della lettura e biblioteconomia per ragazzi”. Angelo Sante Trisciuzzi è direttore della Biblioteca Comunale “Ignazio Ciaia” di Fasano, sua città; è iscritto all’Associazione Italiana Biblioteche dal 1974 ed è attualmente presidente regionale dopo essere stato componente del Comitato Esecutivo Nazionale. Dirige la collana “Studi e ricerche della Biblioteca I. Ciaia, ricca di 10 titoli, ha curato la pubblicazione di numerosi volumi, è autore di due monografie e di vari articoli pubblicati su riviste e periodici. Antonio Ventura, nato a Foggia il 30 luglio 1946, presta servizio, con la qualifica di Funzionario culturale bibliotecario, presso la Biblioteca Provinciale di Foggia, dove è il responsabile del Settore di Conservazione e di Storia Locale, “Fondi Speciali”. Giornalista pubblicista, è autore di saggi sulla storia dell’Italia Meridionale, della Puglia e della Capitanata e di pubblicazioni di Cartografia Storica, di Biblioteconomia e di Paleografia. 311 Finito di stampare nel mese di novembre 2004 presso il Centro Grafico Francescano 1a trav. Via Manfredonia - 71100 Foggia tel. 0881/777338 • fax 0881/722719 www.centrograficofrancescano.it
Scarica