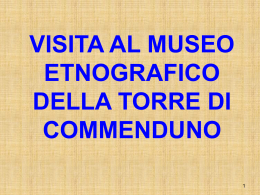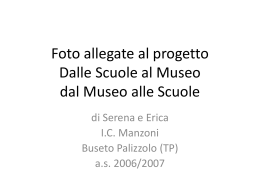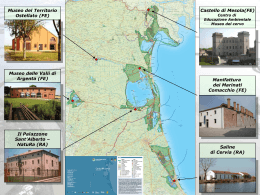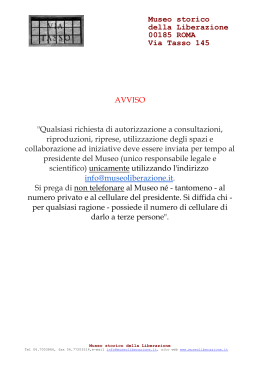26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 26 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO D I E L E N A MU S C I I segni del territorio: il patrimonio in gioco I l laboratorio proposto ha l’obiettivo di re n d e re interessante agli occhi dei bambini il contesto in cui vivono, di renderli curiosi rispetto ai segni della Storia sul territorio, di riempire di s i g n i ficato i luoghi, gli edifici e gli elementi artistici in cui sono immersi senza averne consapevolezza. Il gioco, come strumento didattico, permette di costru i re la conoscenza e di trasmetterla agli altri con l’entusiasmo di una propria scoperta; nello stesso tempo, aiuta ad acquisire un atteggiamento consapevole nei c o n f ronti del patrimonio storico-artistico. Identikit del laboratorio obiettivi • Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione esistenti tra loro (classi I e II). • Avviare la costruzione di alcuni dei concetti fondamentali della Storia: famiglia, gruppo, regole, ambiente (classi I e II). • Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, famigliare e della comunità di appartenenza (tutte le classi). • Ricavare da fonti diverse conoscenze su momenti del passato, locali e non (classi III, IV e V). • Ricavare e produrre informazioni da tabelle, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso (classi III, IV e V). • Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa...) (classe V). • Conoscere e usare termini specifici del linguaggio disciplinare (tutte le classi). raccordi Geografia: utilizzare la piantina di un edificio per orientarsi e collocare reperti. Art e e immagine: leggere, comprendere e descrivere le immagini e le opere d’arte, i beni culturali e il patrimonio artistico. Educazione alla cittadinanza: sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative. organizzazione: lavori in piccoli gruppi e collettivi. Escursioni sul territorio. materiali: grandi fogli quadrettati, nastro adesivo, colla, matite, pennarelli, forbici (classi I e II); fotocopie del materiale proposto (classi III e IV); fotografie, piantine della città o del museo visitato (classi IV e V). tempi: variano a seconda dell’attività. Si tratta comunque di attività che richiedono almeno tre ore e che possono essere sviluppate su più giorni. 26 LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 27 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO classe 1 a Il “museo della classe” fase 1 la scatola dei tesori fase 2 piccoli detective 1. Diciamo ai bambini che stiamo per fare un gioco per 1. Prendiamo una scatola a caso e mettiamola sulla cattedra. Il gioco consiste nello scoprire a chi appartiene (raccomandiamo al proprietario di non far capire che gli oggetti sono i suoi). Apriamo la scatola con cura, creando aspettativa. • Chissà di chi sarà? Di un bambino o di una bambina? Che cosa ci sarà dentro? Scopriamolo subito! scoprire la nostra storia, le persone e i luoghi che ci sono cari. Raccoglieremo gli oggetti, le testimonianze e tutto ciò che per noi è importante e trasformeremo un angolo dell’aula nel “museo della classe”. 2. Invitiamo i bambini a portare da casa alcuni oggetti: • fotografie dei parenti e/o di persone care (genitori, fratelli, nonni, amici ecc.), con scritti sul retro i nomi delle persone rappresentate, la data e il luogo in cui sono state scattate; • il loro gioco o giocattolo preferito (o una parte di esso, per esempio il vestito di una bambola); • oggetti di parenti e/o persone care, possibilmente di quando erano piccoli o giovani; • un loro documento personale (il certificato di nascita, di battesimo, il libretto delle vaccinazioni ecc.); • un oggetto, una fotografia o un documento scritto per loro importante (per esempio una conchiglia, la fotografia delle vacanze, un biglietto d’invito...). Ognuno deve mettere il proprio materiale in una scatola da scarpe. Ricordiamoci sempre di fare attenzione alle diverse situazioni familiari (per esempio bambini adottati); se in classe ci sono bambini stranieri, raccomandiamo di portare anche immagini od oggetti che parlino del loro Paese d’origine. 2. Tiriamone fuori gli oggetti e facciamoli girare fra i bambini chiedendo di fare ipotesi sul proprietario. • Come possiamo capire se è un bambino o una bam bina? Che cosa gli piace? Dopo che i bambini hanno espresso le loro ipotesi chiediamo al proprietario della scatola di rivelare chi è. Avevamo indovinato la sua identità? 3. Formiamo delle coppie e consegniamo a ognuna una scatola. Poi invitiamo i bambini a osservare gli oggetti che vi sono contenuti e a fare ipotesi sul compagno “misterioso”. Per guidare l’attività, scriviamo alla lavagna in stampato maiuscolo e leggiamo ai bambini queste domande. IL COMPAGNO MISTERIOSO IL TUO COMPAGNO È UN BAMBINO O UNA BAMBINA? DOVE È NATO/A? GLI PIACCIONO GLI ANIMALI? È SEMPRE VISSUTO/A IN ITALIA? COME SI CHIAMA LA SUA MAMMA? COME SI CHIAMA IL SUO PAPÀ? HA UNA FAMIGLIA NUMEROSA? QUAL È IL SUO GIOCO O GIOCATTO LO PREFERITO? LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 27 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 28 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 4. A turno, i bambini di ogni coppia raccontano a tutti quello che hanno scoperto del compagno misterioso attraverso i suoi oggetti. Di volta in volta, gli interessati c o n f e rmano o smentiscono le ipotesi fatte. fase 3 allestiamo il “museo” 1. Disponiamo tutti gli oggetti nell’angolo destinato a diventare il “museo della classe”. Attacchiamo le fotog r a fie e i documenti scritti con del nastro adesivo attacca-stacca su fogli di carta da pacchi (un foglio per ogni bambino) da appendere alla parete. Disponiamo anche gli oggetti nell’angolo, ai piedi delle immagini, con dei cartellini che indicano il nome del proprietario. classe 2 a Classificazioni per il “museo” Con i bambini di classe seconda possiamo proseguire l’attività in vari modi. fase 1 riordiniamo i reperti 1. Chiediamo a ciascun bambino di portare la fotografia di un luogo importante della propria storia personale: l’ospedale in cui è nato, la scuola dell’infanzia, il parco, il luogo di culto, la casa di un amico ecc. Con l’aiuto dei bambini, incolliamo anche queste foto sui cartelloni del “museo”. Ricordiamo che ogni fotografia deve avere scritti sul retro la data, il luogo e i nomi delle persone eventualmente raffigurate. Spieghiamo che gli oggetti che fanno parte del nostro “museo” sono testimonianze del passato e possiamo interrogarli per farli diventare “fonti” per la ricostruzione della nostra storia. 2. R i flettiamo insieme ai bambini sul fatto che ci possono essere vari modi per organizzare gli oggetti del nostro museo. Sperimentiamone alcuni con un gioco. ANDREA 3. Chiediamo a ogni alunno di rimettere i propri oggetti e fotografie nella sua scatola. Noi intanto prepariamo dei bigliettini con indicazioni per organizzare i reperti, come in questi tre esempi. 4. Dividiamo la classe in piccoli gruppi (di tre o quattro LAURA 2. Infine, riflettiamo sul metodo che abbiamo seguito per “far parlare gli oggetti”: • ci si pone una domanda; • si osservano gli oggetti per cercare la risposta; • si discute se l’ipotesi fatta è corretta oppure no. 28 LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 bambini) e consegniamo a ognuno di essi le scatole dei compagni, in modo da distribuirle tutte. Per esempio se la classe è costituita da ventuno bambini, formiamo sette gruppi e diamo a ogni gruppo le scatole di altri tre compagni. 5. Invitiamo ogni gruppo a pescare uno dei bigliettini e a provare a organizzare il materiale secondo le indicazioni, creando una sezione del “museo” sul banco. 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 29 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 6. Chiediamo di scrivere su un cartoncino l’elenco dei reperti suddivisi in base al criterio di selezione indicato nel bigliettino. Per esempio: • GIOCATTOLI Bambolotto e bambola di pezza di Elena Videogioco e Game Boy di Marco Fischietto e aquilone di Li Li • TESTI SCRITTI Certificato di nascita di Elena Libretto delle vaccinazioni di Marco Certificato di nascita di Li Li • FOTOGRAFIE Nonna di Elena (Bari, 1948) e foto di gruppo con i fratellini e gli zii (Bari, 2007). Marco con il papà e la mamma (Dolomiti, 2006) e Marco al mare con il fratello (San Vincenzo, 2007) Li Li con l’aquilone (Shanghai, Cina 2005) e foto dei cinque cuginetti (Shanghai, Cina 2006) Immagine PostScript bambina cinese Li Li con l’aquilone. fase 2 visita al “museo” Quando i bambini hanno terminato il lavoro, visitiamo le varie sezioni del “museo”. Invitiamo i compagni a fare domande sui vari reperti; gli “allestitori” devono rispondere e dare spiegazioni come se fossero delle guide turistiche. fase 3 riflessione dopo il gioco Riflettiamo sul fatto che nel nostro “museo” possiamo usare criteri diversi per organizzare i documenti e che ogni criterio ha dei vantaggi e ci aiuta a capire meglio alcuni aspetti. Chiediamo a ciascun gruppo: • di scrivere un riepilogo con il criterio di divisione e le informazioni ricavate dai reperti della propria sezione; • di creare con l’elaborato un vero e proprio cartellone esplicativo, da arricchire con piantine della città o carte geografiche che mostrino i luoghi di cui parlano i documenti (come nell’esempio in basso). IL CARTELLONE ESPLICATIVO Qui abita la nonna di Elena. Criterio di divisione dei reperti Nella nostra sezione i re p e rti sono divisi tra fotografie, giocattoli e testi scritti. Informazioni ricavate dai reperti Le fotografie ci fanno capire che la famiglia di Ma rco è poco Immagine PostScript numerosa, mentre Elena ha due fratellini e molti zii. Anche bari.eps la famiglia di Li Li è molto numerosa, ma molti suoi parenti vivono in Cina. I giocattoli ci fanno capire che Li Li ama giocare all’aria aperta, infatti uno dei suoi giocattoli preferiti è l’aquilone, mentre Marco preferisce giocare a casa con i videogiochi. A Elena invece piacciono molto le bambole. I documenti scritti ci raccontano quando sono nate Elena e Li Li e quante volte Ma rco è stato va ccinato... LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 29 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 30 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO classi 3 a e4 a Santi ed eroi 1. Con i bambini di classe terza e quarta facciamo un percorso per imparare a leggere immagini e monumenti storici che troviamo nelle chiese e nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città. In classe terza, proponiamo attività di ricerca e di gioco su alcune immagini dei santi che fanno parte della nostra tradizione culturale; in quarta, sui monumenti di alcuni eroi del Risorgimento. Attraverso esplorazioni sul territorio e fonti di documentazione diversa, andiamo alla scoperta di alcuni personaggi che sono stati importanti per la nostra cultura e che hanno rivestito un ruolo significativo nella storia della nostra comunità. 2. Riconoscere chi è rappresentato nei monumenti, o nei dipinti che vediamo nei musei o nelle edicole che si trovano agli angoli delle strade, ci aiuta a capire qualcosa di più su coloro che hanno abitato il nostro territorio tanto tempo fa. Leggere i segni della storia sul territorio non è semplice, perché bisogna imparare a interpretare il significato di simboli ricchi e complessi, ma nello stesso tempo molto affascinanti. fase 1 vite e immagini dei santi 1. Proponiamo un’attività che ha come obiettivo quello di far conoscere ai bambini alcuni santi della tradizione cristiana che vediamo raffigurati in statue e dipinti delle chiese o dei musei. L’esempio che facciamo riguarL’idea in più disegna il simbolo del compagno Alla fine dell’attività chiediamo ai gruppi di disegnare un compagno con alcuni simboli che rappresentano le sue passioni o caratteristiche principali. Gli altri devono indovinare chi è stato disegnato e che cosa indicano gli elementi scelti. da quattri santi molto presenti nel nostro territorio: santa Lucia, san Martino di Tours, santa Caterina d’Alessandria, san Giorgio. In relazione alla specifica storia della nostra comunità, possiamo sceglierne altri. 2. Cerchiamo notizie sulla vita dei santi scelti, sul periodo storico in cui sono vissuti; procuriamoci alcuni dipinti che li raffigurano e poi andiamo alla scoperta dei simboli con cui sono stati rappresentati. Ogni santo, infatti, ha elementi simbolici che ci narrano la sua storia e ci permettono di riconoscerlo. Per esempio la palma nel mondo antico era simbolo di vittoria. Molti fra i primi cristiani sono morti per non rinnegare la propria fede; sono coloro che la Chiesa onora come martiri. Essi sono stati premiati con la santità; se vediamo un santo con la palma, vuol dire che ha subìto il martirio. 3. Con le notizie e le immagini raccolte costruiamo alcune schede relative ai santi scelti. Alcune conterranno i testi con le biografie, altre le riproduzione, prive però del nome del personaggio rappresentato (sull’esempio dei modelli del box 1); costituiranno i materiali per il nostro gioco. 30 LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 31 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO Box 1 – Le carte Santa Lucia Secondo la tradizione, visse a Siracusa verso la fine del III secolo. Un uomo che vo l e va sposarla, dopo essere stato respinto, disse che era cristiana. Per questo motivo Lucia venne torturata e uccisa. È la protettrice della vista. Secondo la leggenda per non sentire più il suo pretendente lodare i suoi occhi, se li cavò e glieli mandò su un piattino. Un’altra leggenda dice che le furono tolti durante la tortura, ma le ricre bbero miracolosamente. In fine, una tradizione racconta che è la protettrice della vista perché il suo nome, in latino, significa luce. San Martino di Tours Secondo la tradizione era un cava l i e re romano vissuto nel IV secolo. Un giorno molto freddo, avendo con sé solo gli indumenti militari, dimostrò la sua carità e il suo amore per il prossimo tagliando in due il proprio mantello e donandone metà a un pove ro. Si conve rtì al cristianesimo e fondò un monastero. Venne poi eletto vescovo di Tours e diffuse il cristianesimo in tutta la Gallia occidentale. Santa Caterina d’Alessandria Secondo la tradizione, Caterina era una giovane nobile (forse una regina) molto sapiente, vissuta verso la fine del III secolo. In occasione dell’insediamento ad Alessandria d’Egitto del gove r n a t o re romano, si presentò durante i festeggiamenti e invitò il gove r n a t o re a conve rtirsi a Cristo. Questi non volle e chiese a lei di rinnegare la sua fede. Caterina rifiutò e per questo fu condannata a morire su una ruota dentata. La ruota, però, si ruppe. Il gove r n a t o re ordinò allora che fosse decapitata. San Giorgio La sua vita è avvolta nel mistero e ricca di storie leggendarie. Secondo la tradizione, visse in Palestina nel III secolo. I suoi nemici cerc a rono di ucciderlo in diversi modi ma, prima di morire, egli riuscì a conve rt i re molte persone. Era un soldato cristiano che non volle rinunciare alla sua religione. La tradizione popolare lo raffigura come il cava l i e re che affronta e uccide il drago con una lancia e salva la figlia del re che dove va essere sacrificata al drago, cioè al diavo l o. Il suo cavallo è bianco perché questo colore indica la purezza. fase 2 cerchiamo i simboli 1. Dividiamo la classe in piccoli gruppi e consegniamo a ogni gruppo le schede con le biografie dei santi. Facciamole leggere e commentiamole insieme. 2. Quali possono essere i simboli di questi santi? Scriviamoli, mescolandoli, alla lavagna e chiediamo ai bambini di riconoscere a chi appartengono: due occhi, la palma (santa Lucia); una ruota dentata, vestiti eleganti, la palma, una spada (santa Caterina); un’armatura, una lancia, un drago, un cavallo bianco (san Giorgio); un cavallo, l’armatura, un mantello tagliato in due, un povero, gli abiti da vescovo (san Martino di Tours). 3. Distribuiamo a ogni gruppo le immagini e chiediamo di abbinarle alle schede. Vince il gruppo che riesce a fare il maggior numero di abbinamenti corretti. 4. Se possibile, portiamo i bambini in un museo o in una chiesa della città con l’obiettivo di cercare ritratti o statue dei santi che abbiamo imparato a riconoscere. LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 31 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 32 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO fase 3 eroi del risorgimento 1. Andiamo alla scoperta dei monumenti delle nostre piazze e strade. In quasi tutti i Comuni d’Italia ci sono sculture o lapidi dedicate a Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele II o ad altri protagonisti della storia d’Italia del XIX secolo. Sono elementi che fanno parte del paesaggio urbano di grandi e piccoli centri; spesso i bambini li guardano, incuriositi dalle pose, dall’abbigliamento, dalle iscrizioni sotto alle sculture. Proponiamo di conoscerli più da vicino e di capire perché hanno meritato un monumento. 2. Cerchiamo brevi notizie e reffigurazioni di questi protagonisti della storia della nostra nazione. Realizziamo alcune schede con notizie e immagini relative alla loro vita sul modello di quelle del box 2. Facciamo leggere con attenzione i testi e commentiamoli insieme. Box 2 – Le schede Giuseppe Garibaldi (1807-82) È stato generale e condottiero. Ha avuto una vita molto avve n t u rosa e ha combattuto non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo come Brasile e Perù. Ha guidato molte battaglie importanti per la formazione dell’Unità d’Italia. La sua imp resa più famosa è stata la “spedizione dei Mi l l e”, in cui ha guidato molti volontari, chiamati garibaldini o “camicie rosse”, alla conquista del meridione, in nome dell’Italia unita. Giuseppe Mazzini (1805-72) È stato uomo politico e scrittore. Fu perseguitato e costretto all’esilio perché nei suoi scritti propagandava un’Italia unita, indipendente, libera e repubblicana. Non fu un condottiero, ma le sue idee furono importanti per la nascita dell’Italia unita p e rché ispirarono combattenti e uomini politici. Vittorio Emanuele II (1820-78) Nel 1861 è stato proclamato il primo Re dell’Italia unita e per questo motivo è stato chiamato “Pa d re della Patria”. È r a p p resentato come un condottiero a c a vallo, capace di guidare popoli, prima divisi, verso l’unità e port a re la nuova nazione verso la grandez z a . 32 LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 3. Sull’esempio del laboratorio sui santi, chiediamo ai bambini che simboli userebbero per rappresentare questi personaggi. Possiamo anche chiedere loro di sceglierne uno e disegnarlo con i simboli individuati, come se si trattasse di un dipinto o del progetto di un monumento. fase 4 a caccia di monumenti 1. Organizziamo un’uscita per andare a riconoscere nelle piazze e nelle vie monumenti e lapidi relative ai personaggi delle schede. Muniamoci di macchina fotografica. Dividiamo i bambini in piccoli gruppi di tre o quattro e diamo a ognuno le schede con i personaggi da riconoscere. Solitamente Garibaldi è rappresentato come un condottiero o un combattente, sempre con la tipica camicia dei garibaldini (nei ritratti o quadri è ovviamente rossa). Mazzini è raffigurato come un pensatore, spesso è seduto, mentre Vittorio Emanuele II è rappresentato quasi sempre a cavallo, con la spada sguainata, come un condottiero. 2. Arrivati davanti a ciascun monumento fermiamoci a osservarlo con attenzione. Diamo ai bambini il tempo di controllare le schede confrontandole con i particolari della statua. Verifichiamo quali squadre hanno riconosciuto il personaggio rappresentato. Chiediamo quali sono stati gli indizi utili e cosa ci raccontano. Insieme leggiamo lapidi o iscrizioni e cerchiamo di decifrarle. Fotografiamo il monumento. 3. Nel nostro giro di perlustrazione incontriamo solo monumenti o lapidi di patrioti risorgimentali, oppure ci sono anche altri personaggi? Che ruolo hanno: locale, nazionale, internazionale? Si tratta di scrittori, pittori, musicisti, politici? Fotografiamoli e annotiamo nomi e dati presenti. Potremo lavorarci in un secondo tempo. 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 33 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO fase 5 il memory della comunità 1. In classe discutiamo e rielaboriamo l’esperienza. Stampiamo le foto dei monumenti, attacchiamole su cartoncini; su altri cartoncini scriviamo le didascalie con il nome del personaggio. Possiamo anche aggiungere carte con le immagini dei santi che abbiamo trovato sul nostro territorio. Con queste carte organizziamo un gioco tipo memory, disponendole rovesciate su un tavolo centrale su più colonne, mettendo da un lato le fotografie e dall’altro le didascalie. 2. Formiamo le squadre; a turno ogni squadra scopre prima una carta con una fotografia e poi una carta con una didascalia e la legge a voce alta. Se la squadra di turno scopre la fotografia e la didascalia corrispondenti, prende le carte, guadagna un punto e scopre altre due carte. Altrimenti le ripone (sempre coperte) nella stessa posizione. Vince la squadra che totalizza più punti. fase 6 per concludere 1. Riprendiamo in mano tutte le carte. Che cosa ci raccontano della storia del nostro Paese e della nostra comunità? I monumenti ci danno indicazioni su come si evolve una comunità nel tempo e sui fatti che sono successi? Facciamo scrivere un testo partendo dalle note che abbiamo preso sui vari monumenti cittadini. 2. Possiamo arricchire l’attività facendo una ricerca sui principali edifici cittadini e individuando il loro diverso ruolo nei secoli: dalla casa del signore rinascimentale all’attuale sede del Comune ecc. Anche per questi edifici possiamo realizzare le carte con le immagini e quelle con le didascalie e completare il nostro memory. Infin e , possiamo procurarci una piantina del paese, ingrandirla, e collocarvi sopra, con i bambini, le foto dei monumenti e degli edifici, indicandone le date significative. In questo modo potremo visualizzare lo sviluppo della città. LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 33 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 34 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO classe 5 a Visita al museo fase 1 i preparativi 1. Con i bambini di classe quinta organizziamo una visita a un museo. Molte città e paesi ospitano musei anche di piccole dimensioni ben organizzati. Possiamo scegliere un museo di tipo storico o archeologico: i reperti di epoca preistorica e dell’età antica (etruschi, delle antiche società italiche, greci e romani) affascinano molto i bambini. Soprattutto cerchiamo un museo che abbia supporti grafici e testuali accurati (didascalie complete e leggibili, pannelli illustrativi chiari, eventualmente un catalogo…). 2. Prepariamo la visita con cura, informiamoci se nel museo si organizzano visite guidate per le scuole (vedi box 3): potremo eventualmente chiedere alla guida di integrare le informazioni sul museo trascurate dalla nostra attività. Cerchiamo depliant e materiali illustrativi; se ci sono, scarichiamo dati e informazioni dal sito internet del museo. Quindi scegliamo il percorso che vogliamo proporre, selezionando sale e reperti. Affinché la visita non sia dispersiva, il percorso deve es- Piatto commemorativo delle campagne di Pirro (Roma, Museo di Villa Giulia) sere semplice (ma non banale), le sale da visitare poche, come pure il numero dei reperti. 3. Chiediamo ai bambini se sanno che cos'è un museo e se ci sono già stati con i genitori. Ricordiamo le regole che si devono osservare nella visita ai musei: non correre, non parlare a voce alta, ascoltare la guida o l’insegnante, lasciare a tutti il modo di avvicinarsi alle vetrine... Box 3 – Musei e scuole Molti musei offrono non solo la competenza professionale delle proprie guide, ma anche opuscoli e materiali che l’insegnante può acquistare per realizzare attività didattiche in tutta autonomia. La maggior parte di questi materiali contiene anche contenuti utili per approfondire in classe i temi del museo. Eccone alcuni esempi: • S. Gurdrun, Contadini, fabbri, tessitori… Vita e mestieri di una volta. Materiali didattici del Museo Etnografico Pro vinciale di Teodone (BZ) (materiali: schede di lavoro, giochi da costruire, Puzzle, Poker, Memory, Il piccolo dizionario, lucidi a colore); • AA. VV., Castel Ti rolo visto da vicino. Materiali didattici per alunni e insegnanti, Arte Grafica, Verona 2005 (materiali: due fascicoli per l’insegnante di carattere metodologico e informativo, e fascicoli tematici da distribuire ai ragazzi per permettere loro di esplorare autonomamente il museo); • M. G. Bonfiglioli, M. T. Ganzerla, Bologna nell’età napoleonica, Bologna 2002, 3° edizione (materiale che propone un percorso completo da svolgersi prima, durante e dopo aver visitato il museo); • A. Fontemaggi, O. Piolanti, L. Ponti, M. G. Testoni, Agenzia investigativa del passato. Schede per un viaggio nel tempo, “L’arco di Augusto”, Musei comunali, Rimini 1998-99 (materiali: schede di approfondimento e riflessione da proporre in classe); • A. Ciancio, C. Iacobone (a cura di), Storie nell’antica città senza nome. Come esplorare l’area archeologica di Monte Sannace, Laterza, Bari 2000 (materiali: un fascicolo per l’insegnante e schede per realizzare un’attività ludico-didattica autonoma di escursione); • AA. VV., Schede didattiche del Parco archeologico e Museo all’aperto della terr a m a re di Montale, Modena (materiale: opuscolo informativo e schede didattiche. Schede propedeutiche alla visita sono scaricabili gratuitamente all’indirizzo: www.parcomontale.it). 34 LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 35 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO fase 2 i materiali 1. Definito il percorso e le sale da visitare organizziamo un gioco, una sorta di caccia al tesoro. Prepariamo una mappa del museo, con l'indicazione del numero delle sale che viImmagine PostScript siteremo (vedi l’esempio nella figura 1). 2. Se i bambini non hanno mai fatto esperienze di orientamento con una piantina, pos- piantina.eps siamo realizzare un’attività preparatoria alla visita al museo: riproduciamo la pianta con un disegno, andiamo in palestra e simuliamola disponendo nello spazio panche, cerchi, birilli, materassini; proviamo a “visitare” e a entrare e uscire dalle diverse “sale”. Ragioniamo con i bambini su come collocare sulla piantina alcuni oggetti che abbiamo posato nel nostro “museo virtuale” e facciamo alcune prove. Figura 1 3. Scegliamo i reperti che vogliamo siano oggetto di studio e prepariamo alcune schede da completare (almeno una ventina). Ciascuna scheda contiene una sorta di identikit del reperto che i bambini dovranno riconoscere durante la visita: uno spazio per il disegno, il nome, la descrizione di forma e decorazioni, il materiale, l'uso, l'epoca a cui risale, il luogo in cui è stato trovato (vedi box 4). 4. Creiamo anche un piccolo glossario come quello del box 5, che potremo modificare o arricchire a seconda del percorso e dei reperti che andremo a visitare. Realizziamo le voci fornendo le informazioni che possono aiutare i bambini a capire com’è fatto il reperto che devono cercare. Box 4 – Le schede per giocare Per realizzare le schede scegliamo oggetti facilmente identificabili, per esempio vasi e piatti di diverse forme e dimensioni, oggetti di uso quotidiano, giocattoli, gioielli, statuette votive, elmi e scudi. Secondo le informazioni contenute nei pannelli esplicativi del museo e nelle didascalie, scegliamo gli elementi che i bambini dovranno ricercare: per esempio la data o il luogo di provenienza del reperto. Lasciamo uno spazio per due disegni: uno da realizzare prima dell’inizio della caccia al tesoro (“come immagini questo reperto?”) e uno per la copia dal vivo. Alla fine del gioco potremo ragionare sulla differenza fra le ipotesi espresse dai disegni e la forma reale degli oggetti. E proviamo a fare alcune ipotesi: da che cosa dipende questa differenza? Scheda di catalogazione Nome del reperto: Dolio Come immagini il dolio? Leggi il glossario e disegnalo. Disegnalo qui, ora che l’hai trovato... Come immagini il dolio? Leggi il glossario e disegnalo. Disegnalo qui, ora che l’hai trovato... Materiale/i: Funzione d’uso: conservazione di sostanza alimentari solide come i cereali Decorazione: sull’orlo presenta una decorazione a impressione. Sulla superficie ci sono rosette d’argilla applicate Scavo/luogo di provenienza: Datazione: eneolitico Scheda di catalogazione Nome del reperto: Dolio Materiale/i: argilla grossolana Funzione d’uso: conservazione di sostanza alimentari solide come i cereali Decorazione: sull’orlo presenta una decorazione a impressione. Sulla superficie ci sono rosette d’argilla applicate Scavo/luogo di provenienza: Datazione: fossato di Conelle eneolitico LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 35 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 36 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO Box 5 – Glossario Anfora Vaso a due anse che serve per il trasporto e la conservazione di liquidi e cibo. Ansa Sinonimo di manico. Può servire per prendere il vaso o può essere una decorazione. Può essere di forme differenti. Astragali Ossa del piede. Anticamente quelli di capre e montoni erano usati come dadi da gioco. Armilla Bracciale rigido per i polsi o per le braccia realizzato in materiali più o meno preziosi (oro, argento, bronzo, vetro). Dolio Contenitore simile alla olla, ma più grande. Kyathos Anforetta con anse verticali. Olla Vaso d’uso comune, per lo più in terracotta o pietra, con corpo profondo tondeggiante e imboccatura poco larga. A volte usato per cuocere o conservare cibi. fase 3 caccia ai reperti 1. Quando riteniamo che i bambini siano pronti per la visita, dividiamo la classe in squadre di tre o quattro componenti e forniamo a ciascuna squadra una fotocopia della mappa del museo. 2. Mettiamo tutte le schede-tessera in un sacchetto e facciamone estrarre quattro o cinque da ciascuna squadra. Ogni squadra deve andare alla ricerca dei reperti, identificarli nel più breve tempo possibile, collocarli sulla piantina del museo e completare le schede correttamente. Vince la squadra che per prima consegna tutte le schede e la piantina con le indicazioni esatte. 3. Con le schede preparate possiamo fare anche altre attività: riordinarle in base alla funzione dei reperti (tutti gli utensili della vita quotidiana, tutti quelli per il culto, le armi e gli strumenti di difesa); in base al materiale (terracottta, bronzo, ferro, vetro...); possiamo disporle in ordine cronologico o raggrupparle per area geografica. 36 LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 26-37.qxd 21-01-2008 17:57 Pagina 37 STORIA ED EDUCAZIONE AL PATRIMONIO fase 4 che cosa abbiamo imparato? Bibliografia e siti internet 4 R. Andreassi, Santi, uomini e… pecore, in R. Andreassi, M. Federico, Il cammino dell’uomo at traverso i segni. Lettura storico-didattica dei per corsi della transumanza, Campobasso: IRRE Molise 2005 (per l’attività sui santi). 1. Riperc o rriamo con i bambini il gioco cercando even4 A. Brusa, Come evitare le visite guidate e go tuali difficoltà e loro cause: testi difficili, mancata conodersi una testimonianza storica, in Atti del conscenza dell’ambiente museale… vegno sul tema “La valenza dei beni culturali”, Ravenna 1999. Chiediamo se ora che conoscono il museo e il modo in 4 L. Bresil, A. Brusa, Il tesoretto, in Laboratorio, cui è strutturato sarebbe più facile vincere e perché. vol. I, Bruno Mondadori, Milano 1994 (per l’attività “Il museo della classe”). 2. Aiutiamoli a riflettere sui diversi aspetti con cui abbia4 E. Musci, Il laboratorio con i giochi didattici, in mo giocato: le caratteristiche museografiche (la funzioInsegnare Storia. Guida alla didattica del labora ne delle didascalie e dei pannelli illustrativi, i criteri con torio storico, a cura di P. Bernardi, UTET Università, pp. 226-239, Torino 2006. cui sono disposti i reperti), ma anche i contenuti storico4 E. Nardi, B. Vertecchi, Come riconoscere i san artistico-ambientali. ti, gli dei e gli eroi, Comune di Modena, Galleria Estense (per l’attività sui santi e sugli eroi del Ri3. Stimoliamoli a ragionare circa il contesto d’uso degli sorgimento). oggetti che abbiamo osservato e sul rapporto fra l’uo4 E. Musci, La didattica ludica e l’educazione al mo e l’ambiente e sulla cultura che ne scaturisce. patrimonio: un cantiere aperto, in S. Rabuiti, C. Santini, L. Santopaolo (a cura di), Intrecci di sto rie. Patrimonio, storia, musica, Progetto Chirone, 4. Riprendiamo in mano i disegni e riflettiamo sui moFaenza 2006 [per l’attività “Il museo in gioco” tivi che hanno portato a immaginare gli oggetti in un Immagine PostScript gli esempi si riferiscono al museo archeologico di certo modo. Che rapporto c’è tra la loro funzione d’uArcevia (AN)]. mouse-scont.eps so e la forma? 5. Se abbiamo scelto un museo relativo alle civiltà antiche, come quella della Magna Grecia o di Roma, possiamo organizzare le informazioni apprese in un quadro di civiltà arricchendolo con quanto eventualmente proposto dal libro di testo. tiriamo le somme Nelle prime due classi abbiamo realizzato attività propedeutiche alla comprensione della funzione del museo, della sua struttura organizzativa e della conservazione del patrimonio storico-artistico. Abbiamo iniziato ad affrontare il tema del rapporto dell’uomo con l’ambiente e il concetto di documento, di fonte e di ricostruzione del racconto storico. In classe terza abbiamo stimolato le abilità relative all’analisi iconologica delle immagini, cioè quell’analisi che indaga il valore simbolico, in quella data società, del tema rappresentato. In classe quarta abbiamo giocato con i monumenti e con la città. In quinta abbiamo portato a maturazione le conoscenze e le competenze apprese sia rispetto all’istituzione museale che allo studio e alla rappresentazione del rapporto dell’uomo con l’ambiente contestualizzando, dove concesso dalla realtà locale, lo studio di una società antica nel nostro territorio. LA VITA SCOLASTICA n° 11 • 2008 / Dossier Laboratori 2 37
Scarica