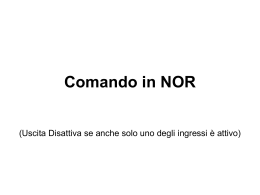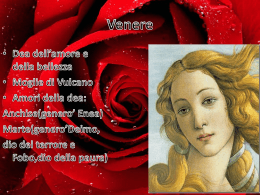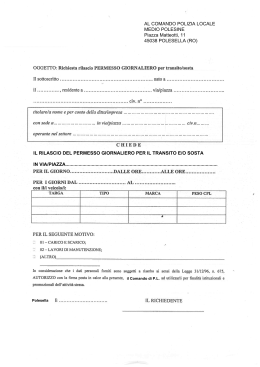11 I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea Del Boca Ghirardini Mattioli Cavagnini Fiammetti Valabrega Soave Benevelli Clodomiro Paracchini Fontana Omodeo Zorini Begozzi Romandini Tenconi giugno 2010 EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO I Sentieri della Ricerca è una pubblicazione del Centro Studi Piero Ginocchi, Crodo. Direttore Angelo Del Boca Condirettori Giorgio Rochat, Nicola Labanca Redattrice Severina Fontana Comitato scientifico Marina Addis Saba, Aldo Agosti, Mauro Begozzi, Shiferaw Bekele, Gian Mario Bravo, Marco Buttino, Giampaolo Calchi Novati, Vanni Clodomiro, Basil Davidson, Jacques Delarue, Mirco Dondi, Angelo d’Orsi, Nuruddin Farah, Edgardo Ferrari, Mimmo Franzinelli, Sandro Gerbi, Francesco Germinario, Mario Giovana, Claudio Gorlier, Mario Isnenghi, Lutz Klinkhammer, Nicola Labanca, Vittorio Lanternari, Marco Lenci, Aram Mattioli, Gilbert Meynier, Pierre Milza, Renato Monteleone, Marco Mozzati, Richard Pankhurst, Giorgio Rochat, Massimo Romandini, Alain Rouaud, Gerhard Schreiber, Francesco Surdich, Nicola Tranfaglia, Jean Luc Vellut, Bahru Zewde La rivista esce in fascicoli semestrali Direttore Angelo Del Boca Editrice: Centro Studi Piero Ginocchi Via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB) Stampa: Tipolitografia Saccardo Carlo & Figli Via Jenghi, 10 - 28877 Ornavasso (VB) e-mail: [email protected] N. 11 - 1° Sem. 2010 Numero di registrazione presso il Tribunale di Verbania: 8, in data 9 giugno 2005 Poste italiane spa Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1 Prezzo di copertina � 20,00 Abbonamento annuale � 30,00 Abbonamento sostenitore � 100,00 C.C.P. n. 14099287 intestato al Centro Studi Piero Ginocchi via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB) causale abbonamento: ISDR Questo volume esce grazie anche al contributo dell’avvocato Anwar Fekini, che con Angelo Del Boca ha fondato in Crodo il Centro di documentazione Arabo-Africano presso il Centro Studi Piero Ginocchi. Provincia del Verbano Cusio Ossola Comune di Crodo Sommario 7 Dall’aggressione a Berlusconi alla beatificazione di Bettino Craxi di Angelo Del Boca vivere la Resistenza 13 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle di Gian Paolo Ghirardini storia nazionale 61 Le picconate di Berlusconi ai tabù della memoria storica di Aram Mattioli 75 Il mito dell’eroe crociato: padre Reginaldo Giuliani «soldato di Cristo e della Patria» di Giovanni Cavagnini 99 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi nel Novarese durante la Grande guerra di Renzo Fiammetti l’Africa e il resto del mondo 115 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53. L’esperienza di un giovane socialista sionista ricostruita attraverso le sue carte di Paolo Valabrega 147 Un caso di mancato attacco preventivo: gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) di Paolo Soave 179 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? I casi della Somalia e della Libia di Luigi Benevelli 207 Il programma coloniale della Germania nel 1915 di Vanni Clodomiro internet e storia 237 I sentieri della Rete di Andrea Paracchini rassegna bibliografica 253 Criminali di guerra in libertà di Francesco Omodeo Zorini 270 Schede 287 vita della rivista 295 notizie sugli autori di questo numero Dall’aggressione a Berlusconi alla beatificazione di Bettino Craxi di Angelo Del Boca 1. Ancora una volta, dal 6 ottobre al 13 dicembre 2009, Silvio Berlusconi ha dominato la scena politica italiana con i suoi guai giudiziari, le sue discolpe, le sue accuse, i suoi pronostici, le sue minacce e, infine, con il suo volto insanguinato. Ancora una volta, per un periodo lunghissimo e difficile da vivere, ha invaso le prime pagine dei quotidiani e non soltanto nazionali. Si comincia con le motivazioni sulla sentenza del Lodo Mondadori. Il Cavaliere viene definito «corresponsabile di corruzione» nella vicenda che consentì alla Fininvest di assumere il controllo della casa editrice Mondadori e viene condannato a risarcire con 750 milioni di euro la CIR di Carlo De Benedetti. A poche ore di distanza, mentre la maggioranza di governo strepita e parla di «eversione» e di «enormità giuridica», la Corte Costituzionale boccia il Lodo Alfano con una sentenza che comporta automaticamente la riapertura dei processi a carico del presidente del Consiglio. Per tutta risposta, Berlusconi sferra un feroce attacco alla Consulta e al Quirinale («si sa da che parte sta»)1. Nei giorni successivi sfoga la sua ira con dichiarazioni sempre più violente e farneticanti: «Gli italiani vedranno di che pasta sono fatto»2. «Non mi fermerà nessuno, alla democrazia ghe pensi mi»3. «Anche se mi condannano non mi dimetto»4. Anche se sono quindici anni che Berlusconi è avvezzo ad affrontare l’opinione pubblica con atteggiamenti sconcertanti e, a volte, deliranti, le ultime sue uscite provocano, specie all’estero, commenti fortemente critici. Scrive il «Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «L’Italia è sull’orlo dell’abisso. Berlusconi peggiorerà ancora»5. «Il mago Houdini della politica italiana può trasformarsi in un’anatra zoppa», titola un editoriale del «Times»6. E «The Guardian» precisa: «Ora che è stato stabilito che Berlusconi non è al di sopra della legge, è importante che le ruote della giustizia comincino a girare [...]. I processi devono andare avanti. Ogni 7 Angelo Del Boca altro corso di eventi spingerebbe ancor di più l’Italia lontano dal suo presente democratico e indietro verso il suo passato fascista»7. Scende in campo, per la prima volta, anche il prestigioso «New York Times»: «Mercoledì scorso è stato un brutto giorno per Berlusconi, un bel giorno per la democrazia italiana [...]. L’era Berlusconi è durata troppo a lungo, con troppi pochi risultati positivi»8. E per finire il settimanale americano «Newsweek» invoca le dimissioni del Cavaliere: «L’Italia non può più sopportare le buffonate del suo playboy in capo»9. Più meditati e articolati i commenti della stampa italiana. Scrive Giuseppe D’Avanzo: «Berlusconi vuol poter dire, in un monologo senza interlocutori e ogni volta che lo ritiene necessario per le sue sorti, che ha salvato il mondo dal Male e l’Italia da ogni male [...]. Berlusconi affida il suo successo e il suo potere a questa ‘macchina fascinatoria’ che si alimenta di mitologie, retorica, menzogne, passione, stupidità; che abolisce ogni pensiero critico»10. Nel suo editoriale della domenica, su «la Repubblica», Eugenio Scalfari scrive: «Berlusconi pensa che lo smottamento della sua popolarità non ci sarà oppure sarà di modeste proporzioni e quindi va avanti, disposto se necessario ad appellarsi al popolo e voglioso di trasformare lo Stato repubblicano in un regime autoritario senza più ostacoli nè controlli che tarpino le ali ai suoi desideri»11. Molto severo il giudizio dell’ex capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro: «C’è una presunzione di godere della fiducia del popolo contrapponendola a qualunque norma costituzionale. Ricordo quando Berlusconi dichiarò che il popolo sapeva delle sue vicende giudiziarie e però lo aveva votato. Dissi allora e lo ripeto oggi: il voto non è un detersivo»12. Ancora più inflessibile nelle sue dichiarazioni un altro ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi: «Viviamo un tempo triste. Negli anni finali della mia vita non immaginavo davvero di dover assistere ad un simile imbarbarimento dell’azione politica, ad una aggressione così brutale e sistematica delle istituzioni e dei valori nei quali ho creduto [...]. È in corso un vero e proprio degrado dei valori collettivi, si percepisce un senso di continua manipolazione delle regole, una perdita inesorabile di quelli che sono i punti cardinali del nostro vivere civile»13. Ma il commento più lucido, approfondito, è quello dello storico Massimo L. Salvadori: «Abbiamo a che fare non con un sistema in cui potere frena potere, ma con un accumulo di poteri di stampo illiberale il quale altera gli equilibri; con una deriva di tipo plebiscitario che punta in maniera 8 Dall’aggressione a Berlusconi alla beatificazione di Bettino Craxi ormai sistematica alla delegittimazione del potere giudiziario, della Corte costituzionale, del ruolo di garanzia rappresentato dal Presidente della Repubblica; con la teoria che l’unico potere ad essere legittimato è quello del capo del potere esecutivo in quanto il solo a costituire l’espressione diretta della vox populi: un potere che ora mira apertamente a cambiare la Costituzione così da acquisire il completo primato. Locke, Montesquieu, Mill, Weber: tutti messi in soffitta»14. La situazione di progressiva confusione e tensione nel Paese, che investe maggioranza ed opposizione e che è ulteriormente aggravata dalla crisi economica, tutt’altro che superata, e dall’aumento della disoccupazione, alimenta, com’era da prevedere, quel ribellismo che si sperava fosse tramontato per sempre. Con lettere minatorie a Berlusconi, Fini e Bossi, si fanno infatti vive l’8 ottobre 2009 le «Brigate rivoluzionarie per il comunismo combattente». Un mese dopo i «Nuclei di azione territoriale» inviano a RAI, Mediaset, «l’Unità» e «Il Giornale» un documento, condiviso da cinque nuclei attivi (Milano, Torino, Bergamo, Lecco e Bologna), che è una sorta di chiamata alle armi, rivolta ai lavoratori, ai migranti, a tutti i soggetti deboli. La conclusione è perentoria: «i politici razzisti e fascisti non devono più dormire sonni tranquilli». Il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, ha così commentato il documento: «Ci sono dei segnali seri. Ci sono delle forti analogie con il sistema delle BR, ma anche delle differenze importanti, che ci fanno però ritenere non sia frutto della mente di un matto». Maroni non esclude che possano avere rapporti con l’integralismo islamico15. Si aggiunga che, sul finire del 2009, il presidente del Consiglio appare sempre di più sull’orlo di una crisi di nervi, tanto da approfittare del vertice a Bonn del Partito popolare europeo per lasciarsi andare ad un lungo sfogo sulle sue disavventure giudiziarie, nel corso del quale non ha risparmiato il Capo dello Stato e gli organi di garanzia, dalla Corte costituzionale alla magistratura. Attacchi feroci che ripete, in piazza del Duomo a Milano, domenica 13 dicembre. Alle 18.33, un personaggio sconosciuto, Massimo Tartaglia, assale Berlusconi mentre si gode un bagno di folla e gli stampa sul viso, col massimo vigore, una statuetta del Duomo di Milano che lo inonda di sangue. Mentre l’immagine del Cavaliere, con il volto sfigurato, fa il giro del mondo, il centro-destra accusa le «toghe» di aver fomentato la violenza e più precisamente Antonio Di Pietro, Rosy Bindi, Michele Santoro e Gian9 Angelo Del Boca franco Fini. Si invocano leggi speciali, la chiusura dei siti internet che inneggiano alla violenza, la punizione dei «mandanti morali». Ricoverato in ospedale, Berlusconi scompare dalla scena per una ventina di giorni e quando riappare non è cambiato, tutto preso com’è ad elaborare con i suoi avvocati (pagati da noi in quanto parlamentari) un pacchetto di leggi salvapremier, in vista dei processi Mills e Mediaset. Ad invelenire maggiormente l’atmosfera del Paese avviene, tra squilli di tromba, la beatificazione della «vittima sacrificale»16, cioè di Bettino Craxi, nel decennale della sua scomparsa. Fortunatamente non tutti hanno partecipato a questa indecente operazione, tesa a legittimare Berlusconi e la Seconda Repubblica. Scrive, ad esempio, Pietro Ingrao: «Sinceramente io di luci non ne vedo, perché nel corso di quegli anni molto aspri per le vicende politico-sociali del nostro Paese, Craxi si è schierato con la parte più conservatrice della DC, con Forlani e Andreotti e non certo con Zaccagnini. [...]. Era distante anni luce da un socialista come Riccardo Lombardi, lui sì di sinistra insieme ad altri nel PSI. Craxi era un’altra cosa, e francamente non vedo proprio dove abbia innovato, semmai ha usato della sua spregiudicatezza per crearsi spazio nel quadro politico. Ma allora entriamo in un’altra categoria, quella dei politicanti...»17. Se qualcuno sperava che, con l’anno nuovo, il Paese sarebbe entrato in un clima di moderata tranquillità, restava deluso. In febbraio, infatti, scoppiava lo scandalo della protezione civile e Berlusconi si affrettava a difendere Bertolaso con il quale vanta di aver compiuto miracoli. In marzo la Procura di Trani accusava Berlusconi di concussione e minacce, dopo aver intercettato le sue telefonate a dirigenti della RAI e dell’Agcom, che avevano il solo scopo di impedire a Santoro di programmare «Annozero», notoriamente critico nei confronti del Governo. Il 22 marzo, nel tentativo di riprendere quota dopo l’ondata di accuse, il presidente del Consiglio radunava il suo popolo a Roma e, tra le fallaci promesse, annunciava che in tre anni avrebbe debellato il cancro in Italia. In qualsiasi altro paese del mondo, un personaggio screditato come Berlusconi sarebbe da anni scomparso dalla scena politica. Ma non in Italia, dove il 30 marzo è riuscito ancora una volta a prevalere nelle elezioni regionali, seppure con l’appoggio determinante della Lega. Che cosa accade, allora, nel nostro Paese? La risposta ce la fornisce Jacqueline Risset, su «Le Monde»: «Il Paese è arrivato all’anestesia totale, alla sonnolenza collettiva, alla narcosi». Ma come rovesciare questa letale tendenza? Suggerisce Guido 10 Dall’aggressione a Berlusconi alla beatificazione di Bettino Craxi Crainz: «Il centrosinistra non può pensare di vincere e neppure di sopravvivere, senza mettere in campo un “valore aggiunto” capace di parlare alla accresciuta area di cittadini segnati dalla sfiducia, e anche a quelli spesso al confine fra rassegnazione e adeguamento»18. 2. Con questo numero riprendiamo la cadenza di pubblicazione semestrale. Per due anni, come avete potuto constatare, siamo stati costretti a fare dei numeri doppi per operare dei notevoli risparmi. Del resto siamo stati nell’impossibilità assoluta di fare due numeri all’anno perché gli abbonamenti sono fermi a 250 (dovremmo almeno raggiungere i 500) e i sussidi da parte degli enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) si sono ridotti a zero. La sola istituzione che ha risposto favorevolmente alle nostre richieste è stato il Ministero dei Beni e Attività Culturali. In data 20 febbraio 2009, prot. n. 1307, ci assicurava, per l’anno 2007, un contributo di 1.000 euro. Con il quale, purtroppo, non paghiamo neppure le spese postali. A questo punto, mentre già disperavamo di salvare la rivista e mi accingevo a scrivere con tristezza il commiato dai lettori, ci è giunto un insperato aiuto. L’avvocato Anwar Fekini, che con me ha fondato il Centro di Documentazione Arabo-Africano, con sede a Crodo, si è offerto di sostenere anche le spese della rivista riportandola alla cadenza semestrale. E subito, con una donazione di 16 mila euro, ha saldato i conti pregressi. Un altro segno della generosità di questo nipote di Mohamed Fekini, il patriota libico che per venti anni ha condotto una spietata guerriglia contro l’Italia di Giolitti e di Mussolini19, è l’impegno con il quale sta portando avanti la raccolta di testi in lingua araba per il Centro di Documentazione Arabo-Africano. Ad oggi sono più di 500 i volumi raccolti negli scaffali del Centro Studi di Crodo, ciascuno con la traduzione in italiano del titolo e un breve abstract del testo, a cura dell’islamologo torinese Luca Aldo Patrizi. Ma l’obiettivo di Anwar Fekini è molto più ambizioso. Avvalendosi della consulenza del dottor Patrizi, ha frequentato, in gennaio e febbraio, le due più importanti fiere del libro del mondo arabo, al Cairo e a Casablanca, con l’intento di acquistare alcune migliaia di volumi, tanto da assegnare al nostro CDAA il primo posto in Italia. Obiettivo del nostro Centro, come già scrivemmo su queste pagine, è la progettazione e creazione di un fondo di testi in lingua araba sui paesi del Nordafrica e del Vicino Oriente, consacrato in maniera particolare alle problematiche del colonialismo, del postcolonialismo e della resistenza al colonialismo. 11 Angelo Del Boca Note al testo 1 «la Repubblica», 8 ottobre 2009. 2 «Il Manifesto», 9 ottobre 2009. 3 «la Repubblica», 13 ottobre 2009. 4 «Il Fatto quotidiano», 1° novembre 2009. 5 Cit. in «la Repubblica», 10 ottobre 2009. 6 Ivi. 7 Ivi. 8 Ivi. 9 «la Repubblica», 12 ottobre 2009. 10 Ivi, 11 agosto 2009. Titolo dell’articolo: Ossessione permanente. 11 Ivi, 15 novembre 2009. Titolo: Silvio c’è, ma lavora solo per sè. 12 «l’Unità», 17 ottobre 2009. Titolo : Scassano le istituzioni. L’indifferenza è pericolosa. 13 «la Repubblica», 23 novembre 2009. Titolo: Basta con le leggi ad personam. Berlusconi delegittima le istituzioni. 14 «la Repubblica», 11 novembre 2009. Titolo: Il pensiero liberale e il potere berlusconiano. 15 Dalla stampa quotidiana, 17 novembre 2009. 16 Così lo ha definito il presidente del Senato, Renato Schifani, a Palazzo Madama, nella giornata di commemorazione del leader socialista. 17 «La Stampa», 19 gennaio 2010. 18 «la Repubblica», 1° aprile 2010. Dall’articolo di Guido Crainz La società incivile. 19 Si veda: Angelo Del Boca, A un passo dalla forca. Atrocità e infamie della occupazione italiana della Libia nelle memorie di Mohamed Fekini, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2007. 12 vivere la Resistenza Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle di Gian Paolo Ghirardini Le origini del movimento garibaldino in bassa valle Il 10 giugno 1944 la Delegazione per la Lombardia del Comando generale delle brigate d’assalto Garibaldi inviava al Comando generale un rapporto in cui esponeva l’attività svolta nei due mesi precedenti. A fine aprile «i risultati – si legge nel rapporto – furono scarsi, né poteva essere altrimenti, […] in quanto perdurava ancora nelle differenti federazioni una incomprensione ed una sottovalutazione del lavoro militare che ostacolava e rendeva difficile non solo lo sviluppo del lavoro stesso, ma anche la presa di collegamento con le forze esistenti»1. Nei centri lombardi le forze gappiste erano quasi inesistenti e le poche formazioni partigiane in attività erano disperse e isolate nelle province. La relazione arieggiava un testo assai più duro scritto in quegli stessi giorni dalla sezione organizzazione ed effettivi del Comando generale e forse mai spedito. In esso si legge che «in Lombardia esiste una sola brigata Garibaldi, 3ª Lombardia, ma praticamente inesistente perché è stata disorganizzata dai colpi della polizia […]. Cosa volete che sia una brigata inesistente di fronte alle nove del Piemonte, sei dell’Emilia, quattro del Veneto e quattro delle Marche? Come vedete la vostra regione è alla coda del movimento partigiano in Italia e questo ritardo è tanto più grave se si considera la forza organizzativa del Partito nella regione […], la combattività della classe operaia dimostrata in vari scioperi generali, l’odio antitedesco e antifascista della popolazione e questa constatazione è un disonore per voi. Dovete al più presto mettere fine a questo stato di cose […]. In ognuna delle vostre vallate: Brescia, Sondrio, Pavia, dove avete già dei distaccamenti organizzati, nel Bergamasco, nel Varesotto, dove certamente ci sono dei distaccamenti partigiani di cui voi non sapete nemmeno l’esistenza, in ognuna di queste valli dovete organizzare una brigata Garibaldi»2. Difficile essere più chiari, ma la durezza del tono 13 Gian Paolo Ghirardini era dettata dall’urgenza del momento: Roma era appena stata liberata e le truppe di Eisenhower avevano messo piede in Francia, col grandioso e terribile sbarco in Normandia; a est l’esercito sovietico si stava concentrando per lanciare un’offensiva che stringerà in una morsa le truppe tedesche. La liberazione sembrava ottimisticamente vicina e il movimento partigiano non poteva farsi trovare impreparato. «Ogni vallata, ogni montagna, ogni città e villaggio deve avere il suo gruppo armato di patrioti che disturbi con attacchi continui il nemico»3. Insufficienza del movimento partigiano e urgenza di mobilitarsi sono dunque le linee guida dei massimi comandi garibaldini lombardi nella tarda primavera del 1944. Dai maggiori centri della Lombardia i veterani dell’esercito popolare con la stella rossa furono inviati in provincia col preciso ordine di prendere contatto con le bande partigiane disperse sulle montagne e di inquadrarle in brigate e divisioni garibaldine. Valdo Aldrovandi, ex ufficiale di complemento, in contatto a Milano col circolo antifascista di Antonio Banfi, vicino alle posizioni comuniste anche se non iscritto al partito, venne mandato dal comando regionale nel Lecchese. Con lui era una giovane donna, Maria Luisa Manfredi, che egli aveva conosciuto a Milano in casa Banfi e che aveva già operato come partigiana in provincia di Bergamo, col nome di Manuela. «Il compito di Al è di organizzare e coordinare le bande di tutta la zona per conto del comando militare regionale: Al provvede a portare soldi, direttive, organizza l’arrivo in montagna dei nuovi partigiani»4. Viaggiando in bicicletta o in treno, Aldrovandi aveva battuto la Valsassina e la bassa Valtellina, senza una meta precisa, fermandosi nelle case e nelle osterie, parlando con la gente, cercando contatti coi partigiani locali. Portava le direttive del CLN di Milano e i soldi della Falck, ottenuti tramite l’avvocato Sternai, legale della famiglia Falck, anche lui del gruppo milanese di Banfi5. Nelle sue peregrinazioni, Al era giunto sino a Morbegno, dove aveva preso contatto col CLN locale, ma la sua presenza in Valtellina era stata sporadica. A fine primavera del 1944 la valle dell’Adda mancava ancora di una guida che organizzasse i ribelli rifugiatisi in montagna. Fu Luisa Manfredi ad indicare ad Al il nome dell’uomo che avrebbe diretto il movimento partigiano in bassa Valtellina: Dionisio Gambaruto, nomi di battaglia Diego e Nicola6. Gambaruto, la Manuela lo conosceva bene, anche se non lo aveva mai incontrato di persona. Col fratello di Luisa, Gabriele, ancor prima della caduta del fascismo aveva organizzato una 14 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle Partigiani valtellinesi con il vescovo di Como Alessandro Macchi cellula antifascista nella caserma di Anzio dove stava frequentando un corso di contraerea. Scoperto, fu arrestato, ma riuscì ad evadere dal carcere. Dopo l’8 settembre, trovandosi nel Varesotto, guidò alcuni uomini al confine svizzero per sbarrare la strada ai soldati in fuga. Presso Cantello, organizzò un gruppo di trenta persone, che si volatilizzò in una notte. Ma Nicola non era tipo da scoraggiarsi. Raggiunse Varese e da lì Milano, dove si arruolò nei Gap. Fece alcune azioni con la «squadra recuperi», finché una spiata non lo costrinse di nuovo a spostarsi a Torino. In Piemonte non rimase molto: il tempo di riprendere i contatti col vecchio amico Gabriele Manfredi e poi il ritorno a Milano. A marzo, Pietro Vergani, comandante generale delle brigate Garibaldi della Lombardia, gli ordinò di dirigersi verso Lecco. Nicola incontrò Manuela a Bellano e Al a Verginate, in Valsassina. Il comandante Aldrovandi gli disse di andare in Valtellina e gli assegnò la zona che da Colico arriva sino a Sondrio. Un giorno di fine aprile, Nicola scese alla stazione di S. Pietro Berbenno, a pochi chilometri dal capoluogo valtellinese7. 15 Gian Paolo Ghirardini Ad attendere Nicola c’era un giovanotto milanese, Ambrogio Confalonieri, detto il Biondo, che lo accompagnò sino al Gaggio di Maroggia, sulle alpi Retiche tra Morbegno e Sondrio. Ciò che Nicola vide una volta giunto a destinazione dovette ricordargli il gruppetto di partigiani che al confine svizzero gli si era dissolto fra le mani, nel giro di una notte: al Gaggio c’erano quindici uomini raminghi armati di due pistole Glisenti e tre vecchi fucili 91, che alla prima azione a Pedemonte si diedero quasi tutti alla fuga. Nicola, però, sapeva il fatto suo: rimpannucciati i ranghi con uomini provenienti da Lecco e da Milano, riuscì ad impossessarsi di una mitragliatrice e costituì una banda sullo Scermedone. In poco tempo fissò i turni di guardia, organizzò l’approvvigionamento di viveri e realizzò dei depositi8. Mentre Nicola era impegnato sullo Scermedone, la federazione milanese del Partito comunista inviò in Valtellina due compagni col compito di ispezionare alcune zone montane. Mario Abbiezzi (Ario e poi Maio) e Domenico Tomat (Silvio) giunsero in bassa valle nel maggio del 1944. Erano stati gappisti a Milano, al comando della 1ª brigata Garibaldi, ma ragioni di sicurezza li avevano convinti a lasciare il capoluogo. Ario e Silvio trovarono subito il gruppettino di Nicola e dopo dodici giorni di ricerca e una bella camminata di dieci ore in zona Premana – Valsassina – incontrarono un altro gruppo di partigiani, una trentina di uomini agli ordini del comandante comunista Spartaco Cavallini. Spartaco era un sottoposto, ma non troppo, di Aldrovandi e nel marzo del 1944 aveva fondato il distaccamento Carlo Marx9. Dai tempi di Milano era ben conosciuto dai due ispettori del Partito comunista, che non si meravigliarono del suo carattere anarcoide e accentratore. Ario, Silvio, Nicola e Al furono dunque i primi dirigenti garibaldini del movimento partigiano da Bellano a Sondrio. Partendo dalle piccole formazioni di Nicola e Spartaco, in tutto una cinquantina di uomini, i quattro comandanti diedero vita a un movimento che in pochi mesi contava quasi mille effettivi e il modo in cui lo fecero, lo spirito che in esso insufflarono ebbe conseguenze notevoli sul periodo che è l’oggetto della nostra ricerca. L’organizzazione militare I due pungoli dei comandi garibaldini lombardi furono dunque il senso della inadeguatezza del movimento partigiano in Lombardia e la necessi16 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle tà di prepararsi per la liberazione, che non doveva essere lontana. «Il 6 giugno, ricorda Nicola, gli alleati erano sbarcati in Normandia e noi della Resistenza avevamo ricevuto l’ordine di entrare in azione dappertutto per allargare il più possibile il conflitto e per disturbare la marcia delle truppe fasciste e tedesche»10. I partigiani garibaldini si fecero subito comandanti di distaccamento e si diedero ad organizzare le formazioni partigiane dall’interno. Era il lavoro militare, la mancanza del quale aveva pregiudicato i successi della Resistenza lombarda nella passata primavera. A luglio, nella loro relazione per la federazione e il comando militare, Ario e Silvio ricordarono che «furono scelti i migliori elementi e preparati per coprire posti di comando […]. Il distaccamento fu così organizzato: nucleo di sei uomini compreso il capo nucleo; squadra su due nuclei, più il caposquadra; distaccamento su due squadre, più il comandante, il commissario, il vicecomandante più alcuni elementi per servizi vari»11. Furono costituite sei basi di appoggio, che dovevano servire da magazzino e da recapito e furono imbastiti i collegamenti con la federazione, il comando militare, il Fronte della Gioventù, il comando unico. I partigiani disponevano poi di due uffici di intendenza collegati con Milano, di un ufficio informazioni e di un medico per il servizio sanitario12. Il 25 maggio, in risposta al bando di Mussolini per l’arruolamento nell’esercito di Salò, fu costituita la 40ª brigata Matteotti, divisa in due zone: il Fronte nord, sul lato destro della Valtellina fino a Sondrio, e il Fronte sud, dalla val Gerola all’alta Valsassina. A capo del primo fu posto Nicola, il secondo fu affidato ad Aldrovandi. Da questi due tronchi nasceranno, nel luglio del 1944, le due brigate Garibaldi della Valtellina: la 40ª Matteotti e la 55ª Rosselli. Gli effettivi al 10 luglio ammontavano già a cinquecento uomini, per lo più giovani mandati dal Fronte della Gioventù e provenienti da Lecco e da Milano. Ma la loro preparazione lasciava molto a desiderare. Scrivevano Ario e Silvio: «Non andiamo per nulla bene […]. Il 90 per cento dei giovani del F.d.G. inviati o si sono sbandati o sono ritornati a casa e molti sono stati arrestati perché destavano sospetto in gruppo o hanno parlato lungo il viaggio della loro meta. La maggioranza sono arrivati scalzi e credevano di trovare l’Eden. Il compito principale del F.d.G. è di prepararli a sopportare le dure fatiche della montagna e di tutto il nostro lavoro. Bisogna che prima di partire sappiano che il cibo è scarsissimo che le armi non sono a disposizione come in una caserma, ma che si devono prendere al nemico e che un fucile è già un’arma preziosa per il partigiano»13. 17 Gian Paolo Ghirardini Il carattere dell’attività garibaldina in Valtellina è essenzialmente militante: il suo obiettivo è il potenziamento del movimento partigiano dall’interno, la sua espansione e lo sviluppo dell’organizzazione. Ma il momento dell’organizzazione è congiunto all’azione bellica e ne è per così dire il prolungamento: «la migliore organizzazione militare sorge e si tempra alla prova del fuoco», scrivono Ario e Silvio in maiuscolo nella loro relazione e sono parole che torneranno nelle carte dei comandi partigiani14. A fine agosto Ario, diventato nel frattempo comandante in pectore del raggruppamento della 40ª, 55ª e 52ª, le tre brigate attive tra la Valsassina e Sondrio, scriverà alle compagne partigiane parole inequivocabili: «Alludiamo alla necessità, in questo momento, di bolscevizzare la nostra azione mediante una lotta serrata aperta finale. Nessuna esitazione, nessuna giustificazione, tutte le nostre forze devono essere in linea di combattimento, dobbiamo imitare i gloriosi compagni e compagne dell’Unione Sovietica che hanno saputo dare alla guerra sostenuta dall’esercito rosso un’impronta bolscevica, unica e vera ragione per cui gli eserciti nazifascisti sono ripetutamente battuti […]. Avanti dunque con coraggio, organizzate squadre di gappiste, di sappiste, organizzate distaccamenti completi femminili che agiranno al nostro fianco valorosamente»15. Dalla lotta nascono i quadri: «non fatemi più sapere (perché purtroppo lo so già) che vi mancano i compagni capaci – così Ario ai compagni della brigata – I compagni capaci siete voi, poiché altri non ve ne sono e non ve ne saranno, dato il grandioso compito del Partito nella società democratica immediatamente futura. Sdoppiatevi, moltiplicatevi e mettete avanti negli sforzi con coraggio giovani e poi giovani compagni che, dietro la vostra guida, daranno certamente buoni risultati. Non sono capaci? Diventeranno capaci in misura degli aiuti che voi saprete apportare loro. E solo voi sarete responsabili se non funzioneranno. Così l’avanzamento tra i migliori patrioti. La nostra lotta è la nostra Università e i quadri devono uscire da questo consesso patriottico così come in tutte le rivoluzioni sociali i quadri escono dal popolo»16. Coraggio dunque: fare e organizzare, lottare e nella lotta forgiare le formazioni. Certo, il lavoro organizzativo non diede proprio i risultati che i dirigenti di Lecco e di Milano desideravano. Dal giugno al novembre del 1944 uno stillicidio di comunicazioni della Delegazione del Comando generale per la Lombardia al comando della 40ª brigata Matteotti e della 55ª Rosselli – cioè a Nicola e Al – e poi al Comando di raggruppamento delle brigate operanti in Valtellina, lamentava l’evanescenza del comando di brigata, 18 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle l’insufficienza dei collegamenti interni, la necessità di costituire, nel mese di agosto, un comando di divisione, la disorganizzazione della 55ª brigata e la mancanza, ovunque, di commissari politici17. Il 14 agosto 1944, Nicola rispose piccato in una lettera alla Delegazione: «Questo comando vorrebbe sapere quali elementi specifici di organizzazione ci rimproverate. Sono sempre stati nostri criteri impedire la burocratizzazione dei comandi per tenersi il più possibile vicino agli uomini e spingerli continuamente sulla via dell’azione. Quando è stato possibile non abbiamo esitato a lasciare le circolari per adoperare il mitra»18 e spiegò che il lavoro delle varie sezioni Operazioni, Intendenza e Sanità poteva essere svolto anche solo da un capo-sezione, con l’ausilio tutt’al più di un vice. «Tenete però conto di vari elementi – proseguiva Nicola – che i capaci e in fede sono pochi; che non essendo molto numerosa la brigata, alcuni servizi possono essere assunti dallo stesso individuo senza tema di accumulazione dannosa di lavoro; che abbiamo cercato di snellire i servizi per portare tutti gli elementi idonei alla lotta viva e reale contro l’odiato nemico»19. Insomma, per riprendere il filo della nostra argomentazione, le deficienze organizzative del movimento garibaldino non ne inficiarono l’ispirazione di fondo: quella a svilupparsi dall’interno e ad accrescersi per mezzo di un’incessante attività di combattimento. L’organizzazione interna non veniva prima dell’azione, ma dopo: la parola d’ordine era «bolscevizzare», lasciare le circolari per il mitra. L’organizzazione politica Accanto al lavoro militare, i comandanti garibaldini comunisti erano consapevoli della necessità di un alacre lavoro politico. «Non essendoci a disposizione un numero di compagni sufficiente, pensammo di reclutare tra i simpatizzanti migliori alcuni elementi per farli entrare nel Partito» così Ario e Silvio, che organizzarono i nuclei di partito nei distaccamenti della 40ª brigata. «Molte riunioni furono fatte per spiegare o comunque chiarire i compiti militari e politici dei Distaccamenti e sviluppammo tutto il programma del CLN. Furono fatte riunioni dei nuclei di partito e spiegammo i loro compiti e le funzioni dei compagni nelle formazioni. Segnalammo alla federazione l’urgente necessità di avere la nostra stampa nelle formazioni»20. In un documento senza data, ma collocabile tra il giugno e il luglio del 1944, il vicecommissario di brigata Gino esponeva ai commissari di distaccamento il punto di vista del comando partigiano in tema di 19 Gian Paolo Ghirardini propaganda politica. «La propaganda, che dovrebbe dare una coscienza politica al combattente per la libertà, è stata un po’ trascurata finora in quanto gli avvenimenti hanno impedito la propulsione di essa. Da oggi i Commissari politici incaricati a detta mansione, dovranno svolgere un’intensa azione di propaganda al fine di rendere comprensibile a tutti i combattenti il movente della nostra lotta contro l’invasore tedesco e il traditore fascista». Parlando del CLN, che Gino definisce il nuovo governo degli italiani, il vice commissario si raccomanda: «i combattenti devono anche conoscerlo in tutti i suoi atti e in tutto il suo valore affinché essi vedano sempre che il loro interesse e l’interesse dei lavoratori è salvaguardato ed è il movente principale della lotta di liberazione nazionale»21. Tuttavia, il lavoro politico incontrò grosse difficoltà dovute soprattutto alla cronica mancanza di agit prop: «questo comando non è tanto contento in quanto, mancando dei compagni capaci, il lavoro dei nuclei non rende come dovrebbe; anche i commissari non sono all’altezza dei loro compiti. Pur tuttavia, ora si inizierà una serie di circolari che si crede colmeranno queste lacune, poiché stiamo allestendo una segreteria della brigata. Si sta preparando il giornale della Brigata e si è certi che se ne trarranno buoni profitti»22. Nei mesi estivi, comunque, i progressi sul fronte politico furono di scarso rilievo e in autunno si dovette ricominciare daccapo. Il 14 ottobre 1944, in una riunione dei compagni del comando di divisione fu stigmatizzata la poca coscienza politica dei nuovi partigiani, ma in ottemperanza alle direttive del Partito comunista si decise di reclutare tutti i simpatizzanti, escludendo solo gli elementi di moralità molto dubbia23. Furono nominati i responsabili di partito per ogni distaccamento, battaglione e brigata; fu deciso che i compagni dei distaccamenti si sarebbero riuniti due volte alla settimana, che con la stessa frequenza i responsabili dei distaccamenti avrebbero incontrato i loro omologhi dei battaglioni e che una volta alla settimana si sarebbero riuniti tutti i compagni della brigata24. Nei mesi di ottobre e novembre, la propaganda politica cominciò a dare i suoi frutti: «In questa brigata si è dato impulso al lavoro politico con riunioni e conferenze fatte ai Patrioti. I commissari svolgono bene il loro lavoro. […] le riunioni politiche sono state oggi esplicate dai commissari nei distaccamenti IV e X discutendo: in uno della disciplina nelle formazioni partigiane e nell’altro leggendo e commentando il fascicolo La nostra lotta». Particolare attenzione fu dedicata ai più giovani: «A Cataeggio sono stati adunati tutti i giovani del Paese dai 16 anni in avanti ed è stata loro spiegata l’organizzazione del Fronte 20 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle della Gioventù. Alla richiesta fatta loro di organizzarsi tutti hanno aderito» e alle donne: «è stato formato a Cataeggio un Gruppo di difesa della donna composto da 35 donne. Anche a Filorera 15 donne si sono organizzate. A queste donne è stata tenuta una conferenza dove veniva loro spiegata l’utilità e la necessità di questa organizzazione»25. Malgrado le precauzioni prese26, l’opera di propaganda politica fece sorgere in alcuni partigiani non iscritti al PCI l’impressione che taluni combattenti fossero più uguali degli altri: «la propaganda politica era attiva – ricorda l’allora comandante di distaccamento Germano Bodo – per merito soprattutto del Partito comunista che inviava alle formazioni pubblicazioni e giornali del Fronte della Gioventù, dell’Unione delle donne italiane. Ne guadagnava il dibattito e il confronto politico, diretto soprattutto da Maio (alias Mario Abbiezzi, anche soprannominato Ario, N.d.A.), un compagno molto preparato, vicino con il suo insegnamento ai partigiani. Certo non mancarono in me e nei miei amici non comunisti momenti di grande perplessità quando, in qualche occasione, fummo esclusi dalle riunioni dei comandi: ci sentimmo in quelle ore emarginati, fuori gioco, appartenenti ad una categoria quasi inferiore»27. Nel 1967 Giulio Spini, già comandante garibaldino e dirigente locale della DC, in un incontro dei capi e commissari garibaldini con lo storico Franco Catalano confermò l’isolamento dei non comunisti testimoniato da Germano Bodo: «questo gruppo (i.e. il gruppo comunista, N.d.A.) era portato ad arroccarsi e ricordo che un certo choc mi veniva dal sapere per esempio che alcune decisioni erano prese ad altissimo livello, a livello riservatissimo ad esclusione di altri, i quali nella fase esecutiva o anche nella fase delle materie di carattere materiale erano ammessi, ma erano evidentemente esclusi dalla grande strategia»28. Giuseppe Giumelli, che si scontrò fortemente col comando di divisione, riferisce questo arroccamento dei capi comunisti soprattutto alle decisioni relative ad esecuzioni di fascisti e spie: «Se si trattava di fare una azione ci si andava tutti, ma ‘questo qui deve essere fatto fuori o quell’altro lo dobbiamo andare a prendere’ era una cosa di cui si vedevano gli effetti immediati e non l’inizio e la causa»29. In effetti, il Partito comunista cercava di mantenere uno stretto controllo sulle formazioni partigiane: «Vi era però dall’interno una specie di formazione di partito, un tribunale di partito […]. Vi erano anche degli Ispettori di Partito evidentemente»30. Anche Giuseppe Giumelli sottolinea la regia politica del movimento garibaldino: «Durante l’estate, riesplosero 21 Gian Paolo Ghirardini fra me e Nicola motivi di dissenso in relazione ad imprese che lasciavano spazio a forti critiche. Seppi che i partiti avevano lanciato un attacco politico notevole e che le azioni recavano un po’ quel marchio. Giunsero fra di noi opuscoli di propaganda e arrivarono da Milano persone del tutto ignare di tecnica di guerriglia. Gente che nulla aveva a che fare coi partigiani»31. Nella testimonianza di Cesare Parravicini, comandante di distaccamento a Postalesio, vicino a Sondrio, la distinzione fra partigiani comunisti e non comunisti assume tratti radicali. «La maggior parte di quelli che sono stati con me e che poi sono aumentati lo hanno scelto per un motivo prettamente ideale. Cioè pensavano che liberarsi da una dittatura fosse lo scopo principale […] Invece ho avuto la netta impressione che la formazione garibaldina, come poi praticamente si è visto e si rivede ancora adesso, fosse l’unica formazione in mano ai comunisti i quali avevano […] una direzione nettamente politica, con tendenza ad impadronirsi del potere e usavano dei mezzi che a me non andavano; a me il terrorismo assolutamente non andava»32. D’altra parte, il comando di divisione garibaldino promuoveva la presenza di non comunisti nei quadri partigiani. In Valtellina i quadri non comunisti ebbero sostanzialmente due origini: una autoctona, da cui i comandanti Giuseppe Giumelli, Clorindo Fiora e Cesare Parravicini e una derivante dal gruppo del colonnello Carlo Croce che nell’autunno del 1943 dopo essere stato sconfitto dai tedeschi nella battaglia di S. Martino nel Varesotto aveva dovuto riparare in Svizzera. Il programma di Croce era di tornare in Valtellina, dove aveva vissuto, portando con sé un numero di ufficiali reduci dalla battaglia di S. Martino per unificare sotto di sé l’intero movimento partigiano. Croce fu intercettato e ucciso dai tedeschi nel luglio del 1944 poco dopo aver varcato la frontiera italiana, ma alcuni suoi ufficiali si inserirono nel movimento garibaldino come comandanti di distaccamento e fra questi Germano Bodo, Vieri Vanni e Carlo Baruffi33. Dunque, dicevamo, non pochi furono i partigiani estranei al PCI che il comando di divisione mise al comando di distaccamenti. Ad essi però impedì ogni attività politica e richiese sempre il rispetto del vincolo di lealtà nei confronti del comandante: «l’importante era che non ci fosse attività politica […] dai non comunisti; che ci fosse solo del lealismo verso il comandante»34. Nei distaccamenti, l’attività politica si risolse talvolta nella propaganda di partito. Il 25 ottobre 1944, nella relazione sul secondo viaggio in Valtel22 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle lina, Neri, vicecomandante del raggruppamento delle divisioni garibaldine lombarde, riportò le riserve di Giulio Spini: «[Spini] lamenta anche che nelle formazioni si sia fatta propaganda politica di un solo partito, afferma che si è fatto il reclutamento del PC, che l’Ispettrice sanitaria Angela, credendolo comunista senza l’aggettivo cattolico, gli abbia confidato […] che sarebbero presto cominciate le nostre infiltrazioni nella 90ª per conquistarla completamente»35. I commissari politici erano per Cesare Parravicini la quinta colonna del Partito comunista: «Nicola per ogni battaglione che c’era, erano magari così: venticinque trenta uomini, ci metteva il suo commissarietto che non faceva nient’altro che il ruffianetto per andare a riferire, come si pensava più che altro»36. Non si pensi ad una mera nota di colore: la posizione di Parravicini era condivisa da altri comandanti partigiani in bassa e alta valle. Come abbiamo visto, l’attività dei commissari politici a partire dall’ottobre 1944 fu nel complesso diversa da come la dipinge Parravicini: attività di informazione e formazione politica sui temi della lotta partigiana, ma il punto di vista del comandante di Postalesio, pur essendo parziale, non fu senza conseguenze sul modo in cui i partigiani non comunisti giudicarono il lavoro politico del comando di divisione. Quando la propaganda politica si tinse troppo di rosso, il Comando di raggruppamento intervenne per rimproverare i commissari politici e riportarli sulla via maestra della politica di unità nazionale: «I commissari politici in generale – scrisse l’ispettore Riccardo alla Delegazione lombarda del Comando generale – non conoscono il loro mestiere. Essendo dei comunisti confondono la vita di partito con la linea politica di Fronte Nazionale. I nuclei di partito come organizzazione non esistono. A questo proposito mi sono intrattenuto con la compagna Elsa, attualmente vicecommissario politico di brigata circa l’organizzazione dei nuclei»37. In effetti gli alti comandi garibaldini non si stancarono mai di istruire i comandanti partigiani sui compiti dei commissari politici e sulla necessità di distinguere l’attività politica dalla propaganda di partito. In un documento senza data, ma probabilmente della prima estate 1944 il Comando generale per l’Italia occupata inviava a tutti i comandi regionali e alle formazioni un documento sulle funzioni del commissario politico in cui si leggeva: «va chiarito innanzitutto che il commissario politico presso le formazioni partigiane a qualunque partito appartenga non è mai membro del comando in funzione di rappresentante di un partito politico, bensì in funzione di rappresentante del CLN». Seguiva un elenco delle funzioni del commissario: 23 Gian Paolo Ghirardini è responsabile della disciplina degli uomini e della loro educazione politica e morale, secondo le direttive del CLN; tiene informati i partigiani degli avvenimenti più importanti; organizza riunioni in cui vengono discussi i problemi inerenti la vita e l’organizzazione delle formazioni; controlla i rapporti tra partigiani e famiglie; è responsabile dei rapporti fra la formazione e la popolazione locale38. L’8 agosto 1944 il Comando generale delle brigate Garibaldi emanava una nuova circolare a tutte le formazioni in cui ribadiva i concetti sopra illustrati: «richiamiamo la vostra attenzione sulla necessità di controllare da vicino l’attività di ogni formazione, di ogni comando, di ogni singolo garibaldino perché sia effettivamente applicata la linea politica nazionale e unitaria che più volte abbiamo illustrata nelle nostre direttive […]. È necessario controbattere con i fatti la propaganda di certi avversari che le formazioni garibaldine siano unità di partito e che la vita vi sia impossibile o difficile per i non comunisti». E sui commissari politici: «la linea deve essere quella del CLN. Non si deve attaccare nessun partito e nessun partito deve essere esaltato. Il commissario è il commissario di tutti e rappresenta il CLN nel suo complesso»39. Erano parole abbastanza chiare che ritroviamo nelle istruzioni ai commissari che il Comando di raggruppamento inviò a tutte le formazioni: «Il commissario politico è delegato dal CLN […] il commissario politico rappresenta gli interessi di tutti i patrioti di qualsiasi idea politica e religione»40. Anche la direzione del Partito comunista fece sentire la sua opinione in tema di propaganda politica. Fra le carte del Comando di raggruppamento, conservate nel Fondo Resistenza dell’archivio dei Musei Civici di Lecco, si trova un dattiloscritto intitolato Istruzioni per tutti i compagni e le formazioni di partito e firmato Ercoli. In otto punti, Palmiro Togliatti riassumeva la linea politica del PCI nella Resistenza. Tra questi si legge: «2. Il partito realizza questa linea [l’insurrezione generale del popolo per la liberazione da tedeschi e fascisti, nda] sulla base dell’unità di tutte le forze popolari, antifasciste e nazionali […] già organizzate nei Comitati di Liberazione. L’insurrezione che noi vogliamo deve essere non di un partito o di una parte sola del fronte, ma di tutto il popolo, di tutta la nazione. 3. Ricordarsi sempre che l’insurrezione che noi vogliamo non ha lo scopo di imporre trasformazioni sociali o politiche in senso socialista o comunista, ma ha come scopo la liberazione nazionale e la distruzione del fascismo. Tutti gli altri problemi verranno risolti dal popolo domani una volta liberata tutta l’Italia, attraverso una libera consultazione popolare e l’elezione di un’as24 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle semblea Costituente»41. Era l’enunciazione della politica di unità nazionale, che Togliatti aveva concordato con Stalin prima del suo ritorno in Italia. In verità, i fatti, i documenti e le testimonianze delle divisioni e delle brigate Garibaldi ci fanno credere che presso i comandi garibaldini inferiori lo scopo della attività politica all’interno del movimento partigiano fosse diverso sia dalla mera propaganda di partito sia dalla politica di unità nazionale. Il suo scopo era infatti di accreditare il movimento garibaldino come l’unico movimento partigiano in grado di combattere radicalmente il nemico nazifascista, senza esitazioni e senza infingimenti e di porre da subito, con i mezzi della lotta partigiana, le basi della nuova Italia antifascista. Si trattava di fondare politicamente la superiorità del movimento garibaldino su ogni altra organizzazione antifascista e partigiana. L’istanza di rinnovamento era presente anche nel movimento partigiano non garibaldino dell’alta Valtellina, ad est di Sondrio. Ma per i dirigenti dell’alta valle il rinnovamento si basava su una rete di istituzioni politiche ed economiche che si organizzano paritariamente per cospirare e costituire dopo la liberazione la spina dorsale del nuovo ordine politico, mentre per i dirigenti garibaldini il rinnovamento nasceva dal ferro e dal fuoco della lotta partigiana e dalla progressiva espansione del movimento garibaldino stesso. Homines novi, dovettero credersi gli uomini del comando garibaldino e forse lo erano davvero. Certo per loro la politica non era solo propaganda comunista, ma lo strumento indispensabile per la liberazione del Paese. I garibaldini e le formazioni non garibaldine Da questo senso di superiorità del movimento garibaldino nacque la tendenza a negare l’autonomia politica ai distaccamenti e a ridurre le formazioni di diverso colore alla propria influenza, se non alle proprie dipendenze. Da qui numerosi contrasti e motivi di dissenso, che vogliamo ora esaminare. Tra il luglio e il settembre del 1944 il Comitato Militare di Milano e il CLN di Morbegno ricevettero tre rapporti firmati Onit Nass e Pino Retico. La prima firma era l’anagramma di un certo Sandro Costantino di Roncaglia, che era e sarebbe rimasto un Carneade, l’altra apparteneva a Clorindo Fiora, quarantaquattro anni, originario di Civo, antifascista di lungo corso che aveva passato la sua giovinezza in Francia, Inghilterra, Germania e Unione Sovietica, a contatto con i fuoriusciti italiani. Intellet25 Gian Paolo Ghirardini tuale cattolico, Fiora era anche soprannominato il Professore e aveva organizzato nella zona di Civo un gruppo di una sessantina di giovani, refrattari all’integrazione nel movimento garibaldino42. Pino Retico accusava il comando di brigata della 40ª Matteotti di incapacità militare e i partigiani garibaldini di imprudenza e ruberie43. Altre accuse riguardavano i rapporti fra il comando e il gruppo di Retico. Fiora lamentava che il comando volesse mantenere il suo gruppo in posizione ausiliaria e subordinata: «si è radicata l’impressione che detto comando voglia considerare questo gruppo come costituito da truppe mercenarie e da impiegare per i servizi ausiliari e per le imprese rischiose a suo profitto»; che non collaborasse con l’invio di armi: «nessuna promessa, neanche in misura infinitesimale, è stata mantenuta e ciò ha prodotto forte diffidenza circa l’assegnamento che si può fare sull’assistenza esterna»44. Nel Rapporto n. 2, Pino Retico accusava il comando di aver ordinato al suo gruppo di muoversi verso lo Scermedone, dove risiedeva il comando di brigata, allo scopo di ritirare armi che poi non sarebbero risultate disponibili: «Ogni uomo ha avuto invincibile impressione che per motivi di gelosia nel timore che sorgano a fianco dei corpi più numerosi ed efficienti, il reiterato comando ha compiuto consapevolmente questa turlupinatura allo scopo di disintegrare per contraccolpo e quindi sciogliere e diffamare l’organizzazione locale per poterla assorbire e dominare». Retico non aveva dubbi su chi fosse il responsabile di ciò: «Qui non si esita ad identificare il principale operatore di questo tentativo nella persona di un detto [Nicola, N.d.A.], che non esita ad assumersi le più gravi responsabilità. Egli infatti ha dichiarato che per conto suo non ci avrebbe appoggiati per il rifornimento di armi e che la passeggiata era destinata soltanto ad eseguire un ordine del Comitato e cioè non si trattava [che] di una obbedienza simulata mirante a turlupinare simultaneamente tanto il comitato quanto questo gruppo. […] Attualmente – concludeva Retico – questo gruppo ha rotto ogni rapporto con quel comando»45. Già Ario e Silvio, nella Relazione per la Federazione e il Comando Militare, avevano espresso l’intenzione di annettersi il gruppo di Pino Retico: «L’ostilità e il sabotaggio del Prof. non ci hanno ancora permesso di inquadrare queste forze nel nostro comando, pur tuttavia la nostra influenza tra questi giovani è tale per cui fin da ora possiamo ritenerle forze nostre»46. La risposta che il 14 luglio il comando della 40ª inviò a Retico, via Onit Nass, fu tuttavia la più esplicita formulazione dell’intendimento dei dirigenti garibaldini di ricondurre il gruppo di Civo sotto l’orbita d’influenza del co26 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle mando dello Scermedone. Così scrivevano Nicola e Primo: «la vostra inesperienza e ignoranza nel campo della lotta partigiana vi fa dire assurdità tali che potrebbero provocare la necessità, da parte di questo comando, di spiccare un regolare mandato di cattura per mettervi davanti alle vostre responsabilità». Secondo un tropo che ritroveremo, Retico veniva accusato di cesarismo filofascista: «qualsiasi ostilità diretta o indiretta della popolazione verso i nostri combattenti […] sarà ritenuta da questo comando una bassa vostra manovra per soddisfare le vostre personali ambizioni filofasciste di comando assoluto» e gli veniva intimato di sottomettersi al comando di brigata: «dal momento che nell’Italia invasa si è costituito il comando unico di tutte le forze combattenti e quindi non si può ammettere l’esistenza di una qualsiasi organizzazione Patriottica che operi non secondo il piano unico di lotta, dovete decidervi o a lottare dietro le direttive del Comando generale delle brigate o ad abbandonare la lotta prima di impugnare le armi. […] scegliendo la continuazione della lotta isolata sarete trattati o come banditi o come sabotatori della Libertà e come tali smascherati politicamente e colpiti dalle disposizioni militari che prevedono in questi casi la pena di morte». Dopo il bastone di una ventilata condanna a morte, la carota di una proposta di collaborazione: «il vostro gruppetto non è una formazione partigiana. Esso ha tutte le caratteristiche specifiche dei GAP […]. Sarete considerato il comandante dei GAP della Valtellina. I vostri uomini resteranno nelle loro abitazioni e lavoreranno normalmente»47. La lettera del comando di brigata non dovette impressionare Retico più di tanto, se nel Rapporto n. 3, inviato al Comitato centrale di Milano e al CLN di Morbegno e recante la data «dal 2 settembre», il comandante di Civo ripetè le accuse già mosse e rilevò l’ingerenza di Nicola nell’organizzazione dei suoi distaccamenti: «il comando di brigata ha investito il comando gruppo di Nicola di ogni facoltà di ingerirsi in tutti i fatti della organizzazione locale, facendo e disfacendo senza consultazione e senza discriminazione nell’intento di assorbirsi uomini e mezzi e di assicurarsi le maggiori comodità a danno della sicurezza», concludendo con: «si prega il Comitato Militare di volere al più presto provvedere per l’allontanamento da questo mandamento della banda Nicola»48. Era davvero troppo. Nicola istituì un tribunale partigiano e mandò a Civo il compagno Rosa, un vecchio comunista che divenne una specie di ambasciatore della 40ª Matteotti. Rosa ebbe alcuni colloqui con Retico e stese una breve relazione in cui si legge: «il compagno Rosa riferisce che in un ultimo colloquio avuto un 27 Gian Paolo Ghirardini tentativo di collaborazione pacifica fatto a scopo di prova è fallito. L’imputato negava ogni collaborazione e non riconosceva il Comandante Nicola, non voleva essere suo subordinato, non riconosceva il comando di brigata […] tutte queste manovre miravano al nostro allontanamento dalla zona per salvare le sue ambizioni egocentriche [parola incomprensibile] su tutti i paesi della zona stessa. Altra ragione di ostilità verso i Comandi derivava dal fatto di vedere scompigliato il suo piano di comodo attesismo e inattività dal nostro intervento»49. Chiamati a deporre presso il tribunale, Clorindo Fiora e due suoi collaboratori, Franco e Pino, in parte ridimensionavano e in parte ritrattavano le accuse50. Retico firmò una supina accettazione dei comandi garibaldini: «In seguito alla comunicazione dell’esistenza del comando di brigata regolarmente costituito e riconosciuto dal Comitato il sottoscritto riconosce l’esistente e l’autorità di detto comando. Il sottoscritto si pone a completa disposizione di questo comando di brigata […] con preferenza di essere assegnato al servizio ausiliario. Il sottoscritto dichiara di non avere prevenzioni verso i comandi e i comandanti che gli organi centrali hanno designato o designeranno»51. Una vera palinodia, a cui Nicola non credette: «Il Tribunale […] fa le seguenti dichiarazioni: In base alle deposizioni dei due aiutanti [di Fiora] (Pino e Franco) a quelle del compagno Rosa e a quelle del Fiora si accerta la malafede dell’imputato e perciò non sincere le sue dichiarazioni fatte nell’allegato 2 bis […] Tutto l’allegato n. 2 è impostato su un tentativo sofistico e ingenuo di attenuare e mascherare la gravità delle dichiarazioni del rapporto n. 3»52. Malgrado la condanna, a Pino Retico fu concesso di tornare a Civo, dove ricominciò la sua attività, ma in sordina, senza suscitare le polemiche dell’estate appena passata. Altro di lui non sappiamo, fino al 23 febbraio 1945, quando Pietro Vergani, il compagno Fabio, il numero uno del movimento partigiano lombardo gli scrisse una lettera dal tono conciliante e dal contenuto deciso. «Cosa vuoi intendere per autonomia? - gli chiedeva il comandante garibaldino – Intendi forse mettere una barriera tra i valtellinesi e i non valtellinesi? Se è così, sei su un terreno fascista. Non vi è peggiore politica, peggiore azione di quella di dividere un italiano da un altro»53. Di nuovo dunque la critica di una attività partigiana svincolata dall’organizzazione garibaldina, che fra i suoi effettivi contava moltissimi giovani provenienti dai centri urbani lombardi. E di nuovo l’assimilazione del non garibaldino al fascista. Fabio stigmatizzò poi la pretesa, che fu quasi una costante nella corrispondenza di Retico54, di attendere i finan28 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle ziamenti e i lanci di armi ed equipaggiamento, prima di attaccare il nemico: «Condizione essenziale per incominciare la lotta con quei giovani che ti stanno al fianco, tu pretendi che vengano fatti copiosi lanci di materiale bellico e che ti vengano inviate grosse somme di denaro». All’attendismo di Retico Fabio contrappose il motto dell’attivismo garibaldino: «Il nostro non è un esercito regolare, ma un esercito partigiano, il quale ha come insegna principale sulla sua bandiera di lotta queste parole: La lotta partigiana alimenta la lotta partigiana», scritto ancora in maiuscolo, come nella relazione di Ario e Silvio. Fabio concludeva la lettera con un appello a Fiora, perché si unisse una buona volta al movimento garibaldino: «Tu devi dare l’esempio, tu devi mobilitare questi giovani, che devi portare nelle file Garibaldine, sotto la bandiera dell’Eroe dei Due Mondi, perché solo così sarà possibile la nostra giusta e vera redenzione di italiani»55. Questa lettera è un piccolo manifesto che raccoglie tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto del movimento garibaldino con le altre formazioni: negazione dell’autonomia politica, assimilazione dei movimenti non garibaldini al fascismo, subordinazione del momento della organizzazione a quello della lotta e superiorità del movimento garibaldino come unica opzione democratica e rinnovatrice per il Paese. Clorindo Fiora rispose solo il 21 marzo 1945, con una lettera al comando provinciale del CVL. In essa scrisse che la diffidenza e il contegno dei garibaldini nei suoi confronti lo costringevano a sciogliere la sua formazione, certo che da loro non sarebbe arrivato alcun aiuto materiale56. Invece, secondo la testimonianza della nipote Maria Fiora, pochi giorni dopo Retico fu invitato a ritirare delle armi presso un distaccamento della II divisione Garibaldi, comandata da un partigiano di nome Federico Giordano, detto Gek. Il professore non fece più ritorno: fu fucilato per ordine dello stesso Gek il 3 aprile 194557. Assai diverso negli esiti, il caso di Ettore Mascheroni rivela lo stesso atteggiamento del comando garibaldino nei confronti delle altre formazioni partigiane. Prima di arrivare in Valtellina, su consiglio dell’avvocato Carlo Elmo che era in contatto con gli ambienti della Resistenza milanese, Ettore aveva già svolto attività partigiana in Piemonte, a Milano e nel suo paese d’origine S. Angelo Lodigiano, dove era stato arrestato nel maggio del 1944. Giunto a Talamona alla fine di giugno, aveva organizzato un gruppo di ribelli provenienti dalla 40ª Matteotti, da cui si erano allontanati do29 Gian Paolo Ghirardini po la battaglia di Buglio in Monte in polemica col comandante Nicola58. Nicola non poteva certo apprezzare che Ettore costituisse una formazione partigiana autonoma con elementi della sua brigata, tanto più che la posizione del gruppo di Mascheroni, poco sopra l’importante centro di Morbegno e nel punto di incontro tra la 40ª Matteotti e la 55ª Rosselli, era notevole dal punto di vista strategico: «Crediamo che la posizione orografica del IV distaccamento – tale era formalmente il gruppo di Ettore – sia eccellente per cui non vorremmo farlo trasferire fra il I e il II distaccamento. Per lasciarlo nella stessa posizione è assolutamente indispensabile che ci sia un comandante e un commissario della massima fiducia di codesto comando, che rendano giornalmente conto dell’attività e del morale del Distaccamento in parola. Bisogna che ci sia un collegamento diretto col comando Fronte Nord (i.e. Nicola, N.d.A.) e uno che colleghi col I distaccamento»59. Il 6 agosto Nicola incontrò Ettore a Talamona, nella casa di Nicodemo Luzzi. Il colloquio prese una brutta piega e, secondo la testimonianza di Nicola, a un certo punto Ettore si allontanò con un pretesto e si dileguò. «Ad ogni modo – scrisse Nicola nella sua relazione al comando di divisione – gli elementi affiorati dal colloquio sono: a) Il suddetto Ettore si rifiuta categoricamente di accettare nella sua formazione alcun commissario politico […]. b) Avendogli io chiarito che la funzione di commissario politico è riconosciuta e ordinata dal CLN, l’Ettore dichiarava di non riconoscere alcuna autorità al CLN in proposito. c) Avendogli io esposto il dovere di tutte le formazioni patriottiche della subordinazione al comando unico del CVL, affermava poter esistere benissimo la sua formazione sul piano di collaborazione ma non di subordinazione ai comandi superiori»60. Dunque, Ettore non solo perseguiva l’autonomia dal movimento garibaldino, ma si riteneva svincolato anche dal CVL e dal CLNAI e rifiutava di accogliere nella propria formazione i commissari politici, che, come abbiamo visto, erano visti da alcuni come gli occhi e le orecchie del PCI nei distaccamenti. Il 9 agosto il Comando di raggruppamento della 40ª e 55ª brigata decretò l’ostracismo nei confronti di Ettore: «Questo comando vi conferma che qualsiasi contatto con T[alamona] deve essere bruscamente interrotto […] Il Comandante del IV distaccamento di T[alamona] è un reazionario, insubordinato al CVL e al CLN. Esso non riconosce nessun comando e fa il filofascista»61. Come da copione, l’estraneità di Ettore al CVL e la sua refrattarietà al movimento garibaldino lo mettevano fuori dalla comunità antifascista. 30 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle Ma non bastava. Dopo essere stato arrestato dai fascisti alla fine di luglio e dopo una rocambolesca fuga dal treno che lo portava in Germania, Ettore era andato in val Brembana a cercare contatti con altri dissidenti62. Sfortunatamente, la valle bergamasca era un territorio di estremo interesse per il di raggruppamento della 40ª e 55ª, che proprio in quel periodo stava progettando di collegare le due brigate valtellinesi con le formazioni bergamasche e costituire così una divisione63. Come aveva mandato il compagno Rosa a trattare con Pino Retico, questa volta Nicola mandò da Ettore Alfonso Vinci, il partigiano Bill, originario di Talamona, che aveva guidato una formazione partigiana nel paese natio e in val Gerola e si era poi unito ai garibaldini intorno alla metà di giugno. Bill aveva già conosciuto Ettore al comando militare del CLN di Milano, quando questi faceva la spola tra S. Angelo Lodigiano e il capoluogo lombardo per consegnare le copie clandestine del «Risorgimento liberale» che faceva stampare sotto casa64. Questa volta il colloquio ebbe esito positivo: «Alla fine egli ha accettato illimitatamente di collaborare con la brigata, senza nessuna riserva, vale a dire ha fatto atto di resipiscenza»65. Pochi giorni dopo al comando della 40ª Matteotti giunse una lettera di Ettore in cui il comandante lodigiano accettava tutti i punti risultati controversi nelle settimane precedenti: riconosceva l’importanza del CVL e del CLN; riconosceva la necessità di un commissario politico in un gruppo di distaccamenti, ma precisava che in ciascun distaccamento le funzioni del commissario potevano essere svolte dal comandante; spiegava di essere stato inviato dalla Delegazione lombarda del comando regionale per collaborare col movimento garibaldino e che non aveva mai avuto alcuna intenzione di creare una organizzazione autonoma66. «Non metto in dubbio – aggiungeva significativamente – che nella vostra organizzazione di brigata vi siano ufficiali di partiti diversi e che attualmente non considerano la loro idea politica, bensì la lotta per il raggiungimento della libertà nazionale»67. Come dobbiamo valutare la totale resipiscenza di Ettore? Fu forse il timore di una condanna a morte, che Bill dovette avergli ventilato nella riunione a Talamona, a fargli cambiare idea68? O Vinci riuscì davvero a convincere il comandante lodigiano? Vero è che la testimonianza di Mascheroni è molto reticente sul suo dissidio con Nicola e che nei mesi successivi Ettore si segnalò come un ottimo comandante garibaldino, ottenendo dal comando di divisione incarichi molto importanti: come elemento moderato fu mandato assieme a Bill a parlamentare con le formazioni parti31 Gian Paolo Ghirardini giane in alta valle, ottenne il comando di un distaccamento a Postalesio, che divenne in seguito il I battaglione della 40ª Matteotti e nel marzo del 1945 ottenne il comando della brigata Rinaldi, costituita con i distaccamenti della 40ª sopravvissuti al grande rastrellamento dell’autunno-inverno 194469. Il che conferma anche quanto testimoniato da Giulio Spini, cioè che i comandi del movimento garibaldino sapevano valorizzare i partigiani non comunisti purché essi rinunciassero al proselitismo politico e si mantenessero leali verso i loro comandanti. Il caso di Carlo Baruffi si differenzia dai precedenti per la sua specificità locale. A quanto sembra dai documenti, il coinvolgimento nella vicenda del Comando di raggruppamento e della Delegazione lombarda del Comando generale fu minimo e avvenne quando ormai tutte le decisioni erano state prese. Carlo Baruffi era un ufficiale dell’esercito che aveva combattuto col colonnello Carlo Croce a S. Martino, era con lui riparato in Svizzera e nel luglio del 1944 era tornato in Italia per preparare il rientro del colonnello in Valtellina. Quando Croce fu catturato e ucciso dai tedeschi, Baruffi ed altri suoi ufficiali organizzarono un gruppo di partigiani nella zona di Torre Santa Maria con l’aiuto di Attilio Ponti, antifascista e dirigente partigiano in alta valle. Dopo poco, avevano deciso di spostarsi in bassa valle, dove il movimento partigiano era più organizzato, si erano presentati al comando della 40ª ed erano stati assegnati a varie formazioni70. Carlo fu mandato a Postalesio, pochi chilometri sotto Sondrio, a comandare un minuscolo distaccamento di sette o otto uomini. Non sembra che al comando di questo distaccamento Carlo abbia mai compiuto azioni belliche di rilievo, né che il suo gruppo sia mai stato attaccato durante i rastrellamenti. Insospettito da questa inattività, Nicola decise di mandare qualcuno a controllare la situazione e scelse Luisa Manfredi, che era già stata collaboratrice di Al nel Lecchese e che col nome di Manuela aveva operato come commissario politico nella 40ª Matteotti. In una lunga testimonianza sulla sua attività partigiana, Manuela parla diffusamente della sua ispezione a Postalesio: «Scoprii che Carlo tutti i giorni a pomeriggio inoltrato andava a Sondrio a prendere l’aperitivo al caffè sulla piazza principale. Questo mi turbò perché a Sondrio c’era e ci fu fino alla fine un enorme concentramento di brigate nere e di forze tedesche»71. Al sospetto che Carlo se la intendesse coi fascisti seguì la conferma della filosofia attendista di Baruffi e del suo entourage. Carlo fissò a Manuela un appuntamen32 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle to con un sedicente membro del CLNAI. L’incontro, che doveva avvenire a Sondrio, fu spostato a Postalesio per la diffidenza dell’ispettrice di Nicola. «Sentii solo rampogne – ricorda Manuela – e aspri rimproveri per il comportamento pazzesco, assurdo, insensato della nostra divisione, troppe azioni, troppo disturbo, a che cosa miravamo, qual era il nostro fine e che dovevamo aspettare il momento buono»72. Manuela scrisse dunque un rapporto riservatissimo per Nicola e lo affidò ad una staffetta, ma Carlo la intercettò e con una scusa si fece consegnare lo scritto. Da ciò insospettita, Manuela anticipò di alcune ore il suo rientro al comando della 40ª. «In quanto al mio rapporto per Nicola – conclude – a Liberazione avvenuta seppi da dei partigiani della nostra divisione che era stato trovato a Sondrio, in Prefettura, in un cassetto della scrivania del prefetto fascista»73. I sospetti di collegamento con tedeschi e fascisti erano in realtà la conseguenza e non la causa dei dissapori tra Carlo e il comando garibaldino. Parravicini testimonia che Carlo non condivideva i metodi terroristici di Nicola e stava progettando di separarsi dalla divisione garibaldina: «questo ragazzo che faceva parte del comando di Nicola (i.e. Baruffi, N.d.A.) pensava di voler scindersi dalla sua formazione perché anche lui come me non condivideva affatto le… il modo di azione, il modo di agire di Nicola»74. In effetti, Carlo ricevette soldi e armi dal comando della divisione GL in alta valle e riuscì a formare un gruppo di alcune decine di partigiani che si ritenevano autonomi dal comando della divisione Garibaldi75. Per i comandanti garibaldini questi contatti con l’alta valle equivalevano ad un tradimento: «ad un certo momento – ricorda Luigi Grassi, allora commissario politico della I divisione Garibaldi – quando nella Divisione troviamo due comandanti di distaccamento (i.e. Baruffi e Parravicini, N.d.A.) e prendono due distaccamenti e fanno di tutto per portarli in un’altra formazione, sguarnendo una parte sulla quale contavamo, questo per noi è tradimento»76. Da questo momento, sul capo di Carlo cominciarono a piovere accuse di intesa coi fascisti: «diversi partigiani confermarono questa voce, questa accusa che lui fosse entrato in contatto con ufficiali fascisti per una specie di modus vivendi. Questa era l’accusa e d’altra parte però c’era stata un’accusa che si ritorceva contro Nicola e cioè che egli avesse aggravato l’accusa molto risentito dal fatto che gli esponenti dell’Alta Valtellina stessero invadendo un po’ la zona che faceva parte della sua influenza»77. Queste parole di Giulio Spini sono confermate da Plinio Corti, uno dei capi della resistenza in alta valle: «nel frattempo emissari della brigata Matteotti 33 Gian Paolo Ghirardini cominciavano sott’acqua tra i gregari la solita opera di calunnia, di disgregazione: furono fatte circolare voci che Carlo era un traditore e un venduto ai fascisti e alla polizia, che rubava i denari destinati alle bande, che noi eravamo dei fascisti ecc. ecc.»78. Come abbiamo visto, l’accusa di filofascismo o di tradimento a favore dei fascisti fu lanciata contro tutti coloro che tralignavano dalla strada maestra del movimento garibaldino. Nel caso di Baruffi, le accuse si basarono su alcuni documenti che sarebbero stati trovati in tasca a Carlo al momento del suo arresto. Tuttavia, queste carte erano probabilmente delle tessere in tedesco emesse dalla Todt, l’organizzazione tedesca preposta allo sfruttamento del legno della Valtellina, che una giovane partigiana Rachele Brenna, inquadrata nelle formazioni in alta valle e impiegata presso il municipio di Sondrio, era riuscita a sottrarre. A quanto pare, Carlo avrebbe distribuito queste tessere ai suoi compagni, perché potessero passare senza problemi attraverso i posti di blocco tedeschi79. Per porre fine al dissidio, Plinio Corti ordinò a Carlo di spostarsi in alta valle, ma commise l’ingenuità di mandare copia dell’ordine a Nicola, per conoscenza80. Nicola non aspettava altro. Inviò subito un gruppo di uomini a Postalesio per arrestare Baruffi. Il commando, dalla val Tartano, allora sede del comando di divisione, scese al piano, filtrò tra i soldati tedeschi che pattugliavano la zona e puntò su Colorina. Gli uomini di Nicola attraversarono la pianura e si fermarono poco prima di Postalesio: bisognava trovare il momento giusto per entrare in paese senza essere visti dalle sentinelle di Carlo. Al momento opportuno i partigiani garibaldini sfilarono non visti sotto gli occhi delle sentinelle e disarmarono gli uomini di Baruffi. Carlo riuscì a fuggire verso Castione: in quella zona c’era il distaccamento comandato da Ettore, il cui commissario politico era Germano Bodo, compagno di Carlo nella formazione del colonnello Croce. Avvertito da Cupido, un uomo di Parravicini, Germano incontrò Carlo nella chiesa di Castione. Baruffi protestò la sua innocenza e Bodo non poté fare altro che consigliare all’amico di scappare. Ma non c’era più tempo: il commando di Nicola aveva seguito le tracce di Carlo fino a Castione. Baruffi provò a nascondersi nella cappa del camino della casa parrocchiale, ma fu subito scoperto. Arrestato assieme al povero Cupido, fu portato quella stessa notte a Cosaggio, in val Tartano, dove Nicola aveva già convocato il Tribunale partigiano. A sostenere l’accusa fu chiamato Primo, al secolo Luigi Grassi, commissario della divisione Garibaldi; la difesa fu presa da Germano Bo34 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle do e da suo fratello, con l’intervento di Cesare Parravicini; Nicola presiedeva il tribunale. I difensori si batterono a lungo in favore dei due imputati. Cupido ebbe salva la vita, ma per Carlo Baruffi non ci fu nulla da fare: fu fucilato poco sopra Cosaggio, la notte seguente81. Il caso Baruffi fu gestito all’interno del raggruppamento della I e II divisione Garibaldi. Il Comando di raggruppamento, che era nelle mani di Ario, riferì alla Delegazione lombarda del Comando generale solo a fatto compiuto e con diversi giorni di ritardo. Il 25 settembre la Delegazione scrisse al raggruppamento, alle due divisioni e alle rispettive brigate: «Da oltre dieci giorni noi non riceviamo notizie dell’attività del Comando di raggruppamento e quando le riceviamo sono vecchie che quasi non servono più»82. Quelle poche informazioni che Ario fece avere ai suoi superiori originarono qualche dubbio: «Ci avete inviato dei documenti riguardanti il processo dell’ufficiale Carlo, ma non ci avete fatto un sia pur breve rapportino che ci serva di guida chiarificatrice nello studio del documento stesso. Ci avete comunicato che l’ufficiale Carlo è stato fucilato per aver trattato col nemico tedesco, ma dal verbale del processo non risulta affatto che egli abbia patteggiato con i tedeschi. Perciò noi siamo molto all’oscuro su di un fatto di grande importanza come la fucilazione di un ufficiale. Vi domandiamo pertanto delle delucidazioni sul processo Carlo e compagni e vi preghiamo di essere più precisi in avvenire in tutti i problemi che ci portate a conoscenza»83. Qualcuno, negli alti comandi garibaldini, cominciava ad avere dei dubbi su Nicola e i suoi metodi draconiani che rischiavano di spaccare il movimento partigiano in bassa valle, inimicare la popolazione e mettere così a rischio lo straordinario lavoro organizzativo finora compiuto. Per il momento, a Lecco e a Milano nessuno si mosse. Ma tra poco le ripercussioni della vertenza più grave di tutta la Resistenza in provincia di Sondrio, cioè il caso Giumelli di cui scriveremo sotto, spingeranno i superiori comandi garibaldini ad una presa di posizione che nessuno si sarebbe aspettato. Il caso Baruffi scosse il movimento partigiano in bassa valle. Un senso di disagio si diffuse fra molti garibaldini, un sentimento di incertezza e di sospetto che cominciò ad estendersi alla popolazione. Ciò era anche dovuto alla fucilazione nei paesi della valle di fascisti o presunti tali, accusati di atti di spionaggio le cui responsabilità non sempre erano accertate e all’intensificarsi delle requisizioni84. L’atteggiamento di Nicola si inseriva in una azione di stretto controllo delle formazioni che egli andava per35 Gian Paolo Ghirardini seguendo già dal luglio 1944 e di cui abbiamo parlato sopra85. Tale azione comportava l’epurazione interna alle formazioni degli elementi meno sicuri e la soppressione esterna dei fascisti e delle spie. Le ragioni di tale atteggiamento erano più di una. Innanzitutto, e non ci stancheremo di ripeterlo, il carattere militante del movimento garibaldino, tutto teso a compattarsi, ad espandersi dall’interno attraverso la condivisione del proprio modus operandi da parte di tutte le sue membra. E ciò, sia detto di nuovo, non per calcolo di partito, ma per un forte senso di superiorità democratica e antifascista, che non consentiva ai comandanti garibaldini di accettare facilmente l’autonomia di altre formazioni partigiane. In secondo luogo, il giro di vite sull’autonomia dei distaccamenti in media valle fu una reazione all’opera di proselitismo che Plinio Corti, dopo un fallito tentativo di collaborazione con la 40ª Matteotti, stava svolgendo proprio in quel periodo, allo scopo di condurre i distaccamenti garibaldini intorno a Sondrio nell’orbita della I divisione alpina GL operante in alta valle86. Infine, la terza ragione fu una certa psicosi delle spie e dei traditori che si impadronì dei comandanti partigiani e li spinse all’intransigenza nei confronti dei sottoposti. «In quei mesi – ricorda Giulio Spini – Nicola era molto sotto l’emozione dei possibili traditori e anche perché era per natura sua molto diffidente e poi per la individuazione e soppressione delle spie»87. Il caso che più fece rumore in bassa valle fu quello di Giuseppe Giumelli. Giumelli era nato nel 1917 a Traona, un paese posto alla base delle alpi Retiche di fronte a Morbegno e aveva svolto propaganda antifascista a Milano al tempo in cui frequentava la facoltà di medicina. Dopo essersi laureato ed essere stato imprigionato per attività antifascista a S. Vittore e a Regina Coeli, tornò in Valtellina, dove lavorò come medico condotto ad Ardenno, poco sopra Morbegno. Come medico fu chiamato a curare alcuni partigiani feriti in montagna ed entrò così in contatto col movimento garibaldino in bassa valle. Nella primavera del 1944 Giumelli notò che due forestieri avevano cominciato a frequentare la trattoria dove lui stesso pranzava, sempre accomodati al tavolo di fronte al suo. Erano due agenti della Questura di Sondrio. Poco dopo, ricevette la cartolina che lo richiamava alle armi. Giumelli non dovette pensarci su molto: salutati i genitori a Traona e affidata la motocicletta ad un amico, partì per la montagna88. Giumelli partecipò a tutte le azioni del fronte nord della brigata Matteotti e presto ne divenne uno dei leader, anche in ragione della sua posi36 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle zione di medico dell’intera brigata. Ma egli aveva una sensibilità del tutto diversa dal comandante Nicola e non passò molto tempo prima che si trovasse con lui in disaccordo. Il primo dissidio avvenne dopo la battaglia di Buglio, il paese sopra Ardenno che l’11 giugno era stato occupato dai partigiani, i quali lo avevano tenuto per cinque giorni, prima che le truppe naziste e fasciste lo mettessero a ferro e fuoco, bruciando 36 abitazioni e 12 cascinali. Secondo Giumelli, «occupare un paese, pretendendo di dare le libertà democratiche, distribuire la lana alla popolazione come è stato fatto, destituire il podestà e nominare il sindaco, rappresentò un cumulo di sbagli»89. Per Giumelli, l’occupazione di Buglio era stata decisa per ragioni di natura politica: «una disfatta che ha delle giustificazioni in ciò che pensano i partiti in un senso politico tattico ed anche strumentale e demagogico», ragioni che contrastavano con elementari principi di prudenza: «in una guerra partigiana non si occupa un paese, non ci si fa contare, si salta di qua e di là con opportuni colpi di mano, si fa guerriglia e non si occupano paesi. Soprattutto quando non si hanno i mezzi per resistere»90. Gli studi sulla battaglia di Buglio, che fu l’avvenimento maggiore della Resistenza in Valtellina, e sulle sue conseguenze sul movimento partigiano pongono in luce la differente origine di Giumelli e Nicola: valtellinese il primo e quindi più sensibile alle ricadute che le azioni partigiane potevano avere sulla popolazione, «milanese» il secondo e quindi meno sentimentalmente coinvolto nelle rappresaglie91. Tuttavia, occorre notare che il quieta non movere non ricorre mai nella testimonianza di Giumelli, che ritenne al contrario che le azioni partigiane col passare del tempo avessero perso troppo mordente92. Ciò che appare è invece la critica continua alla politicità delle decisioni di certi comandanti garibaldini, devoti al Partito comunista. Diciamo subito che Giumelli sbagliava nel ritenere che i partigiani comunisti facessero del movimento garibaldino un feudo del PCI, da gestire a suo tornaconto. Tuttavia, in una valle del tutto priva di un ceto politico attivo, Giumelli rappresentò con pochissimi altri la parte anticomunista della Resistenza e tenne sempre a sottolineare la differenza fra i partigiani milanesi comunisti e quelli valtellinesi anticomunisti. Subito dopo la battaglia di Buglio, Giumelli ebbe un aspro scontro verbale con Nicola e decise di abbandonare la formazione. Con pochi uomini, si accampò sulle montagne sopra Traona. Dopo quindici giorni Nicola invitò Giumelli ad un incontro in cui gli propose di riunire i loro gruppi e di lavorare come medico della nuova formazione. Giumelli accettò, con37 Gian Paolo Ghirardini vinto che la nuova banda nascesse su criteri diversi da quelli del passato93. Nessuno più pensò ad azioni in grande stile come quella di Buglio, ma le speranze di Giumelli furono presto deluse: «durante l’estate le azioni partigiane sono diventate imprese che lasciavano luogo a delle critiche; so che i partiti sferrarono un attacco politico notevole e le azioni recarono un po’ quel marchio: arrivarono opuscoli di propaganda ed inviava [sic] anche gente da Milano e dintorni completamente ignara di quel che poteva essere una battaglia, la guerra in montagna eccetera. Così sono giunti purtroppo elementi che non erano partigiani, erano su come partigiani, ma in pratica tutt’altro. C’era gente che scendeva, accoppava vacche, non mangiava la testa che piantava lì a marcire, rubava; gente in scarpette da tennis che appena vedevano i fascisti bruciare le case tagliavano la corda […] Accaddero anche degli omicidi e delle rapine del tutto ingiustificate: a Morbegno accopparono per esempio una vecchia di ottant’anni che anzi era la madre di un antifascista. La tensione aumentava e tra me e Nicola si creò uno stato di assoluta incomunicabilità. Lui, ormai, aveva preso il potere, perché aveva alle spalle il Partito comunista che gli mandava armi, istruzioni, uomini e direttive»94. Di nuovo, Giumelli insiste sulla spregiudicatezza dei partigiani di Milano e sul carattere politico della loro attività. E qui appare la divisione fra valtellinesi e milanesi: «A questo punto si verificò la nascita di un certo malumore fra la popolazione dei paesi valtellinesi. E si era venuto a creare un certo dissapore fra i partigiani valtellinesi e quelli venuti da fuori in quell’estate»95. Ma tale dicotomia è sempre riferita alle azioni insensate di certi partigiani e alla loro differente inclinazione politica, non già ad una diversa percezione emotiva del pericolo di rappresaglie, che se indubbiamente serve come discrimine fra partigiani di alta e bassa valle, non si applica però al caso di Giumelli. La seconda crisi tra Nicola e Giumelli scoppiò dopo la battaglia di Mello, combattuta il primo giorno di ottobre 1944. La battaglia costò alle formazioni partigiane alcuni morti e causò rovine e distruzioni a danno della popolazione. «I miei rapporti con Nicola si inasprirono ancora di più. Anche gli uomini protestarono mentre i valligiani di Mello insorsero vedendo portar via il formaggio e il bestiame. L’entusiasmo di un tempo stava spegnendosi e si incrinava l’antica solidarietà. La popolazione era stanca di pagare e di non essere difesa»96. Mentre il malcontento nei confronti di Nicola montava, Giumelli fu contattato dai dirigenti della Resistenza in alta valle. Il primo di agosto del 38 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle 1944 era stata costituita la Divisione Giustizia e Libertà che inquadrava tutte le formazioni partigiane dopo Sondrio. Il comandante della divisione era il capitano in s.p.e. Giuseppe Motta, detto Camillo, e il commissario politico era Plinio Corti, un valtellinese che lavorava a Milano come legale della Edison. Camillo cercò subito di allacciare rapporti col movimento garibaldino e incaricò Ercole Valenti, maresciallo dei carabinieri in forza al distretto militare di Sondrio e partigiano in incognito, di organizzare un incontro con i due capi garibaldini più in vista, Nicola e Giumelli, per discutere della unificazione dei comandi partigiani. Valenti non riuscì a fissare un incontro con Nicola, ma vide Giumelli più volte fra l’estate e l’autunno 1944. Dal primo incontro, Valenti trasse l’impressione che Giumelli, pur volendo essere leale verso Nicola, non approvasse i metodi del suo capo97. Quando poi, nell’agosto del 1944, Nicola mandò in alta valle i suoi ambasciatori Bill e Rosa per convincere le formazioni là dislocate a passare agli ordini del comando garibaldino, Camillo si convinse dell’inutilità di una collaborazione col comandante della I divisione Garibaldi e incaricò Valenti di trattare col solo Giumelli. «Giumelli alla testa delle formazioni partigiane della bassa Valtellina – scrive Valenti – e in stretto collegamento con quelle dell’alta valle, formanti tutte un blocco bene amalgamato e alle dirette dipendenze di un unico capo, che avrebbe potuto essere appunto Camillo perché riuniva in sé, a mio parere, tutte le doti necessarie per esserlo. Questo sarebbe stato veramente l’ideale auspicabile»98. Tra i comandanti dell’alta valle cominciava a farsi strada l’idea di provocare un terremoto fra le file garibaldine per eliminare gli ostacoli che si frapponevano alla unificazione dei comandi sotto la loro guida. Dopo che Giumelli aveva accettato di incontrare Camillo, questi gli fece avere nel settembre 1944 un promemoria in cui delineava il programma della sua divisione. Il promemoria si apriva con una dura critica a Nicola per il suo rifiuto di collaborare e per l’ostilità verso le formazioni non comuniste – il riferimento era al caso Baruffi e alla citata missione di Bill e Rosa in alta valle – e si chiudeva con l’enunciazione del programma di Camillo: difendere le dighe e le centrali da eventuali attacchi, evitare azioni inutili e precipitose e prepararsi per la battaglia finale contro i tedeschi99. Nell’ottobre del 1944, ci fu una riunione in casa Ponti, a cui parteciparono oltre al padrone di casa Attilio, i notabili sondriesi Mario Buzzi e Plinio Corti, che sostituiva Camillo costretto a lasciare Sondrio, Ercole Valenti e il fondatore del CLN di Chiavenna Febo Zanon. Fu deciso che se si fosse convinto Giumelli ad 39 Gian Paolo Ghirardini assumere il comando delle forze partigiane in bassa valle, i partigiani della val Chiavenna già inquadrati con le forze dell’alta valle si sarebbero tenuti pronti ad accorrere in suo aiuto, qualora Nicola avesse deciso di reagire100. Insomma i dirigenti dell’alta valle stavano preparando un putsch in piena regola. Poco dopo, a Campovico Valenti incontrò ancora Giumelli, che era accompagnato dal suo stretto collaboratore Franco Ghislanzoni, detto Athos. Facendo leva sull’avversione di Giumelli per i metodi violenti di Nicola, Valenti espose a Giumelli il progetto dei comandanti dell’alta valle: «rappresentai l’opportunità che Nicola venisse decisamente eliminato e che Giumelli assumesse il comando delle formazioni e si mettesse subito in contatto con le formazioni dell’alta valle onde giungere al più presto possibile al tanto desiderato comando unico»101. Dopo aver riflettuto da solo per alcuni minuti, Giumelli disse a Valenti: «potete riferire a Camillo e a Ricci (alias Plinio Corti, N.d.A.) che da questo momento partono gli ordini per la scissione. Noi ci distacchiamo da Nicola e attendiamo ordini dal comandante delle formazioni dell’alta valle alle dipendenze del quale passiamo»102. Due giorni dopo Giumelli ricevette da Corti il denaro necessario a finanziare la nuova formazione103. L’ammutinamento di Giumelli avvenne nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 1944. Egli era formalmente inquadrato nel I battaglione della 90ª brigata Zampiero, che dal ponte del Baffo in Valmasino si allungava verso ovest, comprendendo Mello e Poira, fino al Pian di Spagna e alla val Chiavenna. Il comandante della brigata era un certo Nino e il commissario politico si faceva chiamare Dan; erano entrambi tra gli uomini più fidati di Nicola. Durante la notte, Giumelli aiutato da Athos e da un gruppo di partigiani tutti valtellinesi disarmò l’intero primo battaglione e portò via undici mitragliatrici. Il giorno dopo si spostò al Piz di Mastroj, sede del V distaccamento della brigata Zampiero, dove fu accolto trionfalmente. Il gruppo di Giumelli e gli uomini del V distaccamento si unirono dando vita ad una formazione autonoma104. A questo punto, Nicola prese l’iniziativa: «dispongo tutte le misure di sicurezza in caso che i rivoltosi mirassero al comando di divisione. Mando staffette alla 40ª brigata avvisando di tenersi a disposizione in stato di allarme; ai distaccamenti del III battaglione preavvisandoli delle manovre di Giumelli; al comando di brigata per chiedere notizie. Le notizie dal comando di brigata arrivano scarse e sconclusionate tanto da far temere che il comando fosse prigioniero e le lettere venissero imposte con la minaccia delle armi»105. Giumelli aveva occupato un ma40 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle gazzino viveri e disponeva di molte armi. Secondo la relazione di Nicola al Comando Delegazione e al raggruppamento, gli uomini del dottore avrebbero messo in atto un’operazione di pulizia politica: «Tutti gli elementi dei paesi favorevoli al comando di brigata vengono arrestati. Pattuglie di rivoltosi percorrono continuamente i paesi; si minaccia un’azione diretta sul comando di divisione. La sera del giorno prima due elementi locali che avevano sempre lavorato con passione per il comando sono presi a fucilate»106. Il 17 ottobre, il Comando di raggruppamento mandò una circolare a Giumelli condannandone l’operato e invitandolo ad aprire delle trattative: «[Il Comando di raggruppamento] invita il responsabile scissionista dottor Giumelli a voler desistere immediatamente dal provocare disordine, sabotaggio, disfattismo e di volersi presentare coi suoi collaboratori al Comando della I divisione per appianare i dissensi che noi riteniamo del tutto personali. Al comando della I divisione trovasi un nostro delegato, dottor Rossi (alias Tiberio Panzeri, N.d.A.) che assumerà la carica di presidente della riunione conciliatrice che dovrà appianare i dissidi»107. Il CLN di Milano mandò suoi rappresentanti a parlamentare con Giumelli e persino i repubblichini si fecero vivi con proposte che Giumelli rifiutò108. Il giorno stesso della circolare del raggruppamento, Nicola mandò Bill, il valtellinese Alfonso Vinci, a trattare con Giumelli. A Cevo, Bill fu intercettato dagli uomini di Giumelli che gli sequestrarono la pistola e lo lasciarono proseguire sotto scorta. Quando incontrò Giumelli, questi gli comunicò subito l’impossibilità di una intesa: «mi disse che era in netto disaccordo con i milanesi e che non approvava i loro metodi». Intanto Nicola aveva mandato una decina di uomini dietro Bill. A Roncaglia essi incontrarono i partigiani di Giumelli che lo avevano arrestato e, trovata nelle loro mani la pistola del Capo di Stato Maggiore garibaldino, ne fucilarono seduta stante due109. «Quando fui informato dell’episodio – racconta Giumelli – dichiarai che non potevamo accettare supinamente, che avremmo vendicato i caduti»110. Giumelli lasciò Poira, sede del comando della nuova formazione, e si diresse verso la val Masino. Coi suoi uomini circondò il comando garibaldino di stanza presso l’albergo dei Bagni di Masino. Poco mancò che il dissidio fra le due fazioni partigiane non finisse in un bagno di sangue111. Pare che ci siano stati degli scontri tra gli uomini di Giumelli e quelli di Nicola e anche qualche vittima112. Il blocco della val Masino durò un paio di giorni, poi il dottor Rossi, vicecommissario del Comando di raggruppamento, intervenne per avviare trattative di pace. Al dottor Rossi si asso41 Gian Paolo Ghirardini ciò un uomo della delegazione lombarda del Comando generale, il commissario Lino. L’incontro fra le due parti avvenne il 20 ottobre nella piana di Poira in un’atmosfera da Ok Corall: «Ci vedemmo su un prato – ricorda Giumelli – con cinque uomini armati da una parte e cinque dall’altra. Io avevo una colt e Nicola una bomba a mano. Con me c’era Athos e le rispettive bande erano in attesa nei boschi»113. Alla fine l’accordo fu raggiunto su questi punti: Giumelli si impegnò a rientrare nella 90ª Zampiero e ad agire con lealtà e cameratismo; egli ottenne per sé il comando del I battaglione e per Athos, al quale non fu concesso tanto, il ruolo di intendente della brigata; Giulio Spini, valtellinese e su posizioni critiche nei confronti di Nicola, divenne commissario politico di Giumelli; Nino e Dan, comandante e commissario della 90ª invisi a Giumelli furono sostituiti da Bill ed Elio; le armi vennero suddivise fra i tre battaglioni della brigata e parte degli uomini di Giumelli dovette passare al II battaglione. Furono inoltre decise la liberazione dei prigionieri fatti da Giumelli e la restituzione di armi e viveri114. La crisi sembrava definitivamente risolta: «dal giorno 20/10 si torna alla normalità. Il comando della 90ª si insedia a Ledino. I reparti della 90ª ritornano alle loro sedi. Solo il distaccamento d’assalto rimane in zona a disposizione del comando di divisione. Si riformano i tre battaglioni della 90ª, i quadri sono già al completo»115. Ma qualcuno al Comando di raggruppamento notò subito che l’accordo poggiava su basi malferme. Il problema era la concessione a Giumelli del comando del I battaglione, che in realtà fu decisa in un secondo momento contro le istruzioni date a Lino e Rossi e per intervento dell’ispettore della delegazione lombarda del Comando generale, Giorgio116. «Il fatto stesso di fare altre concessioni dopo gli accordi e di dare completamente ragione alla tesi di Giumelli non fece che avvalorare e ritenere legali i rivoltosi»117. Dello stesso parere il vicecomandante del raggruppamento Neri: «Formalmente ogni cosa risulta appianata, ma è evidente che lasciandogli il comando di una frazione di uomini (degli stessi elementi locali malcontenti) è sempre latente il pericolo del rinascere di dissidi, disegni ambiziosi da parte del capo»118. Erano parole profetiche. Subito dopo gli accordi di Poira, due battaglioni della 55ª brigata Rosselli, facente capo alla II divisione Lombardia, sfuggendo ai rastrellamenti in Valsassina e al Legnone erano entrati in bassa Valtellina119. Li comandava Leopoldo Scalcini, detto Mina. Mina provava un certo risentimento per quello Spartaco Cavallini che abbiamo visto al comando del distaccamen42 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle to Carlo Marx nella preistoria della Resistenza in Valtellina e che da allora aveva fatto una discreta carriera, essendo stato nominato comandante della 55ª brigata. S’intende che Mina avrebbe voluto quel posto per sé e che riteneva Spartaco inadatto al ruolo. Oltre a ciò, Mina sentiva di essere stato abbandonato dai comandi superiori da quando in Valsassina si era scatenato il rastrellamento di ottobre. Dal 4 del mese non aveva più comunicazioni dal comando di divisione e dal raggruppamento e i suoi uomini erano stati lasciati soli al freddo, alle intemperie e alla reazione fascista120. In bassa Valtellina, Mina entrò in contatto con Giumelli che vide in lui un garibaldino assai diverso da quelli della I divisione: «allora, io ho avuto contatti con Mina con Al e con gli altri capi della Rosselli che, pur comunisti, avevano uno spirito diverso, erano più evoluti. Al era comunista, Ges era comunista e la formazione pur sempre garibaldina, tuttavia con loro si poteva ragionare»121. In breve, avvenne ciò che il Comando di raggruppamento aveva previsto. Rimasto al comando dei suoi uomini, alla prima occasione Giumelli secessionò nuovamente e si unì agli uomini di Mina. Insieme, i due comandanti costituirono una divisione su due brigate, autonoma dalla I e dalla II divisione Garibaldi, ma riconobbero l’autorità del raggruppamento. Fu subito steso l’organigramma della nuova formazione: «Comandante di divisione sarebbe Mina, vice Giumelli, capo di S.M. Bill, commissario Lino, intendente Athos, comandante una brigata Ettore, commissario Spini, comandante altra brigata Gabri, commissario Piero, vicecommissario Oreste – capi di S. M. delle due brigate: Vanni e Torre»122. La velleità del progetto di Mina e Giumelli balza evidente da questo organigramma, che mette insieme aspri critici del movimento garibaldino (Giumelli, Mina e Athos), dissidenti moderati (Spini ed Ettore) e uomini di indiscussa fede garibaldina (Bill, Oreste, Piero e Lino), alcuni dei quali, sottolinea Neri nella sua relazione, erano all’oscuro di tutto, perché in missione in zone lontane. L’elenco dei quadri, in realtà, tradisce l’intenzione di rendersi autonomi dalle due divisioni Garibaldi, senza giungere ad uno scontro con esse, anzi integrandone alcuni degli uomini più in vista, a mo’ di garanzia di lealtà futura. In ogni caso, il Comando di raggruppamento prese molto sul serio la questione e mise in campo tre pesi massimi: il vicecomandante Neri, il commissario politico Ario e il capo di Stato Maggiore Odo. Neri era già in Valtellina per delle ispezioni a Talamona. Mentre col comando della I divisione stava discutendo intorno agli accordi di Poi43 Gian Paolo Ghirardini ra, venne informato della costituzione della nuova divisione. Fra gli uomini del comando «prevale l’opinione che si tratti di una manovra tendente, dopo questo primo atto, a staccare le formazioni dal movimento garibaldino per aggregarle alle formazioni Giustizia e Libertà dell’alta Valtellina: il timore sarebbe provocato da vari indizi fra i quali: la direttrice di marcia (nord-ovest), l’intenzione di Giustizia e Libertà di appoggiare e fare perno sul campanilismo delle popolazioni locali per fare della Valtellina una zona di influenza esclusivamente sua»123. I comandanti della I divisione erano tutti per una soluzione di forza: «prevale sempre l’opinione che si debbano attuare misure militari, chiamando reparti della 52ª nella zona e così pure quanto rimane della 55ª», ma Neri espresse un’opinione diversa: «richiesto lo scrivente di quale sarà presumibilmente l’atteggiamento dei comandi superiori nella circostanza, risponde: conciliazione a qualunque costo»124. Prima di partire Neri espose agli uomini della I divisione il suo programma per affrontare la crisi: dire a Mina e ad altri scissionisti che il raggruppamento aveva già deciso di promuoverli ad incarichi più importanti, ciò che non era stato possibile comunicare per la rottura dei collegamenti durante il rastrellamento; ottenere l’appoggio del Comando di raggruppamento e della delegazione; inviare viveri, equipaggiamento ed armi per venire incontro alle necessità dei dissidenti; intensificare l’attività politica al piano, con la fondazione di CLN e sezioni di partito per migliorare il clima politico locale125. Neri incontrò dunque i partigiani coinvolti nella scissione ed ebbe modo di farsi un’idea dei problemi che avevano condotto ad essa. Dalla sua relazione emergono elementi che meritano una riflessione. Innanzitutto, a differenza del putsch del 15 ottobre, questa volta la scissione non fu sobillata dai comandi partigiani dell’alta valle. In realtà il malcontento all’origine della scissione ebbe nei suoi protagonisti ragioni distinte, che prescindono tutte dai rapporti con le formazioni di Giustizia e Libertà. Per Athos Giumelli, Spini e Bill furono, con gradi diversi, l’intransigenza estrema dei comandanti garibaldini e la propaganda politica da essi attuata. Per Mina e Piero furono la inettitudine del comandante di brigata Spartaco e l’abbandono delle formazioni della 55ª, costrette ad affrontare un terribile rastrellamento senza viveri e senza equipaggiamento. Prendendo le misure di quanto era accaduto, Neri riconobbe che il problema andava ridimensionato: «salvo le sorprese che possono derivare dai primi elencati [i e. Giumelli e Athos, N.d.A.], non si tratta di una vera e propria defezione. Tutti si erano stretti intorno al sottoscritto perché facesse presente la 44 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle necessità di fare giustizia senza mettere in dubbio minimamente che il comando superiore fosse il Comando di raggruppamento, che le formazioni fossero garibaldine»126. Neri consigliava quindi di assecondare le ambizioni dei meritevoli e prendere provvedimenti contro le lagnanze a carico dei comandi della 55ª e della I divisione. Avallando una interpretazione prevalentemente tecnica, non politica, della vertenza Neri concludeva: «Ma soprattutto giustizia per i garibaldini vuol dire invio di viveri, di scarpe, di indumenti, di mezzi adeguati per la lotta, vuol dire assistenza continua efficace da parte di ogni ente o persona preposta ai vari servizi»127. In seguito Neri si diresse al Comando di raggruppamento dove giunse il 29 ottobre e informò subito i suoi colleghi di quanto stava succedendo in Valtellina. Ario e Odo decisero di partire alla volta dei Bagni di Masino, sede del comando della I divisione, dove giunsero la mattina del 30. Una staffetta fu subito mandata a convocare i partigiani dissidenti, che fecero sapere di poter raggiungere la val Masino il giorno successivo. Il pomeriggio del 30 fu dedicato ai capi della I divisione: «In varie riunioni – ricorda Ario – criticai aspramente l’atteggiamento bellicoso di tutti i compagni i quali non vedono altro che una soluzione di forza e vorrebbero sempre decidere con le armi. In una particolare riunione con Diego [alias Nicola, N.d.A.] e Primo spiegai loro che avevano fatto tanto lavoro ma senza quella diplomazia che il partito insegna. Per le fucilazioni e le requisizioni devono sempre sentire il parere dei CLN e delle Giunte Popolari Comunali o quanto meno farli partecipare alla responsabilità»128. Durante questi incontri, fu deciso di separare la questione in due problemi distinti: «1) Il problema Mina: che a Mina venga riconosciuto un comando superiore (essendo già negli intendimenti di questo raggruppamento), ma che la Rosselli rientri nei quadri della II divisione. La sostituzione di Spa[rtaco], dimostratosi troppe volte inetto, con Gabri. 2) Il problema Giumelli: che il Giumelli possa entrare a far parte del comando della I divisione come vicecomandante, anche contro il parere di Diego e del commissario Primo» e anche dei compagni Rossi e Lino, artefici degli accordi di Poira129. Il giorno dopo fu la volta dei dissidenti, ascoltati a Cataeggio presso l’albergo Rossi. Prima di cominciare le audizioni, i partigiani comunisti della 55ª, guidati da Oreste, chiesero di conferire con Ario. Al commissario del raggruppamento essi espressero delle critiche sull’operato di Spartaco, ritenuto inadatto al comando di una brigata, ma soprattutto avvisarono Ario sulle possibili conseguenze che la scissione avrebbe avuto sulle sorti del partito: «ag45 Gian Paolo Ghirardini giungono che la situazione è particolarmente grave in quanto il partito in caso di scissione non potrebbe contare che su una trentina di elementi poiché i valligiani sono tutti con Mina e Giumelli»130. L’impressione che Neri aveva avuto, di un sommovimento che avesse ragioni più tecniche che politiche, più legate alle difficoltà della vita partigiana che all’opinione politica dei comandanti, dovette essere in parte corretta. Oreste fece balenare nella mente di Ario il timore che Giumelli, lontano da qualsiasi partito politico, ma convinto nello stigmatizzare il comunismo dei comandanti garibaldini catalizzasse le forze valtellinesi tradizionalmente aliene da tutto ciò che andava oltre una sinistra genericamente radicale ed emarginasse il PCI. Si imponeva più che mai una composizione della vertenza: «rispondo di star tranquilli perché sono certo di una buona riuscita delle trattative nell’interesse del partito»131. Al termine delle consultazioni, Ario e Odo proposero una soluzione che incontrò l’approvazione generale. A Mina venne dato il posto di vicecomandante della II divisione. Spartaco, sostituito da Gabri, venne messo a disposizione del raggruppamento, che gli conferì incarichi politici. Giumelli, constatata l’impossibilità di un suo rientro in seno alla I divisione, ottenne di trasferirsi con i suoi uomini alla brigata Rosselli132. Rispetto agli accordi di Poira, che erano stati decisi in ultima istanza dalla Delegazione del Comando generale, quelli di Cataeggio videro emergere il Comando di raggruppamento come l’istituzione che godeva del maggior credito fra i partigiani garibaldini e la sua politica di meditata composizione dei dissidi come la più efficace per garantire al movimento partigiano l’appoggio popolare. «I compagni della Delegazione – scriveva Ario – i compagni Lino e Rossi e della I divisione devono arrendersi davanti al fatto che il Comando di raggruppamento ha ormai acquisito un prestigio sui patrioti. Io spero che tanti errori di psicologia e diplomazia non siano più commessi dai compagni i quali devono imparare in questo momento ad utilizzare la diplomazia del partito come esso insegna. Basta il saper fare il comunista solo coi comunisti, un vero comunista in questo momento deve saper dirigere le masse, prendere delle decisioni e farle approvare dalle masse stesse»133. Il trasferimento degli uomini di Giumelli alla 55ª Rosselli causò notevoli difficoltà alla I divisione in Valtellina. La 40ª Matteotti aveva già perso dei distaccamenti, passati alle dipendenze dell’alta valle. Ora la 90ª Zampiero era stata quasi completamente spiumata. Il I battaglione, quello di Giumelli, si era trasferito in Valsassina, del II battaglione rimanevano solo 46 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle il comandante e il commissario, attivi presso il comando di divisione dei Bagni e il III contava appena due distaccamenti, insediati a S. Martino val Masino con effettivi ridottissimi134. Scarsi erano pure l’armamento, l’equipaggiamento e i viveri, molti dei quali portati via dagli uomini di Giumelli. I collegamenti andavano ricostruiti135. Il morale tuttavia sembrava buono: «tendenza generale in tutti a prendere con senso di umorismo e allegria la presente situazione»136. I comandanti della I divisione si adoperarono per riallacciare buoni rapporti con la popolazione. Come riconosce Giumelli: «Nicola dopo questi fatti si era molto ammansito, le cose erano cambiate. Ecatombe di buoi e ruberie non ne sono più successe. Perlomeno, le grane hanno provocato una riaffermazione dei principi»137. Il comando della I divisione scaricò le colpe dei cattivi rapporti con la popolazione sull’ex comandante della 90ª: «Il comandante della 90ª brigata, Nino, attualmente comandante della 52ª brigata ha letteralmente sconquassata la zona occupata dalla 90ª brigata». Furono organizzate conferenze a Cevo, Caspano e Roncaglia sul CLN, sul CVL e sugli incidenti appena passati138. Secondo le indicazioni di Neri, furono costituite nuove giunte popolari, nuovi gruppi di difesa della donna e i giovani furono inquadrati nel FdG139. «I rapporti con la popolazione sono più buoni e migliorano sempre più. Si riacquista poco a poco quella fiducia che era venuta a mancare e con la nostra buona volontà contiamo di portare la popolazione su un piano di collaborazione che sia ottimo»140. Ma era ormai troppo tardi. Il 15 novembre 1944 la Delegazione del Comando generale inviò una comunicazione al Comando di raggruppamento in cui elencava le mancanze all’origine delle crisi di ottobre. Innanzitutto, secondo la delegazione i comandanti erano troppo lontani dagli uomini. Si dava il caso di partigiani che pur essendo inquadrati in una brigata da tre mesi non avevano ancora visto il loro comandante. Poi la mancanza di un lavoro di integrazione da parte dei commissari politici, che avrebbe causato la separazione degli uomini a seconda delle loro idee politiche e religiose. In terzo luogo, le requisizioni fatte indiscriminatamente, senza tener conto delle reali condizioni economiche della popolazione e delle loro possibilità. Infine la condanna a morte di elementi la cui collaborazione col nemico non era stata sufficientemente provata141. Lo stesso giorno, un’altra comunicazione della Delegazione al raggruppamento riaffermava il problema dell’allontanamento della popolazione dai partigiani e prospettava una soluzio47 Gian Paolo Ghirardini ne: «a questa situazione bisogna porre rimedio al più presto possibile per ritornare ad avere i necessari rapporti di reciproco aiuto tra la popolazione e i patrioti. Tra le misure che la Delegazione vi propone vi sarebbe quella di spostare alcuni quadri comandanti almeno temporaneamente […] È notorio che attorno al comandante Nicola, che tanto valore ha già profuso in quelle contrade, si è andata accumulando una serie di lamentele che per la maggior parte sono infondate e quasi sempre a sfondo personalistico […] Come misura per risolvere questo fatto vi proponiamo di chiamare al Comando di raggruppamento in veste di vicecomandante del raggruppamento il comandante Nicola e di inviare al comando della I divisione l’attuale vicecomandante di raggruppamento Neri»142. Il Comando di raggruppamento non fu colto di sorpresa. In verità, lo stesso capo di S.M. del raggruppamento, Odo, nella sua relazione sulla vicenda Giumelli – Mina aveva già suggerito di rimuovere Nicola: «ascoltati gli uni e gli altri, udito l’umore della popolazione e in specie la deposizione del patriota Giovanni, comandante un battaglione della 40ª (rimasta fedele alla I divisione), reputo necessario che siano presi questi provvedimenti: lo spostamento di Diego [i.e. Nicola, N.d.A.] e Primo dal comando della I divisione. Essi si sono resi colpevoli, almeno con vizi di forma, di essersi inimicate le popolazioni delle Vallate e dei paesi viciniori; di avere adottati sistemi di requisizione piuttosto terroristici; di non aver capito che la nostra lotta di liberazione è una lotta a cui devono concorrere tutte le forze unite del popolo e che nelle formazioni partigiane il motto ‘in guerra tutto è permesso’ non è di possibile applicazione. I valligiani e la popolazione non aiuteranno mai le nostre formazioni fino a che il terrore ingenerato non sarà cancellato col cambiamento dei comandanti»143. Oltre alla necessità di recuperare il rapporto con la popolazione, il Comando di raggruppamento vedeva nella sostituzione di Nicola un passo necessario per migliorare i rapporti con i comandi Giustizia e Libertà in alta valle: «in sede di questo Comando di raggruppamento i rappresentanti di GL posero come premessa di accordo il cambiamento del comandante della I divisione ed infine i vari CLN locali ci hanno fatto pervenire uguali desideri»144. Il 16 novembre dal raggruppamento partirono due lettere destinate a Nicola e a Neri. A Neri veniva dato l’incarico di ristabilire l’ordine garibaldino e creare le condizioni per l’unificazione con GL145. Nella lettera a Nicola si legge: «Ti alleghiamo copia della lettera della Delegazione. Leggi con calma e riflessione. Finora abbiamo perso tempo per vedere se le co48 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle se si potevano superare ma poiché la Delegazione desidera questo trasferimento qui al Comando di raggruppamento abbiamo deciso di accettare detta proposta e di dare corso alla trasformazione dei Comandi interessati […] Pensiamo che al raggruppamento sarai prezioso perché certamente saprai infondere a tutte le divisioni a tutte le brigate lo spirito combattivo che ti anima e ti distingue»146. Contemporaneamente al messaggio ufficiale del raggruppamento, il commissario politico Ario, firmandosi Maio, inviava a Nicola una lettera personale: «La delegazione e il raggruppamento si trovano davanti a delle necessità di forza maggiore. Dobbiamo dare un po’ alla popolazione, la quale carica le responsabilità di Nino, Manuela, Orfeo, Dan e tutti gli errori commessi dai compagni sulle tue spalle. Dobbiamo arrivare a degli accordi importantissimi con Giustizia e Libertà e il caso Carlo [Baruffi, N.d.A.] è a tuo carico. Dobbiamo risolvere la questione di Neri che ha creato un po’ di malcontento al raggruppamento. Neri si è innamorato di una collegatrice [Gianna, cioè Giuseppina Tuissi, N.d.A.] e finisce con il trascurare il lavoro e crea ragioni di malcontento tra i compagni. Per queste ragioni siamo arrivati alla determinazione di cambiarvi il posto. Abbiamo ritardato l’inchiesta per vedere se il tempo era in grado di accomodare tutto senza sostituzioni. Ma il caso Neri si impone come misura immediata. Il tuo valore e il tuo spirito combattivo e le tue capacità militari hanno indotto tutti noi a ritenerti il migliore e degno sostituto di Neri. […] Il comandante e il capo di S.M. hanno una profonda ammirazione per te. Sono certissimo che ti troverai bene e avrai grandi soddisfazioni»147. Al principio, Nicola esitò ad accettare: preferiva un posto di combattimento a funzioni organizzative, sia pure presso un alto comando garibaldino. Tuttavia, presto vide nel suo trasferimento un’occasione per modificare la disposizione geostrategica delle forze garibaldine. Nicola pensò di poter lavorare al riposizionamento verso nord della II divisione e al rafforzamento dei collegamenti con la I, superando così gli accordi di Cataeggio che avevano rigorosamente separato le due divisioni e aumentandone la forza e la sicurezza. Di conseguenza, immaginò di poter ampliare la testa di ponte della val Masino ed aprire nuovi passaggi in Svizzera. Infine, si ripromise di sviluppare il movimento garibaldino in val Chiavenna148. Incoraggiato da questi nuovi impegni, Nicola accettò il trasferimento: «non vedo ora alcuna difficoltà al mio trasferimento perché spero lavorando alacremente di dare un buon rendimento»149. Era il 26 novembre 1944. Tre giorni dopo i nazifascisti scatenarono in Valtellina il più grande rastrella49 Gian Paolo Ghirardini mento mai visto dall’inizio della Resistenza, un rastrellamento che per tre mesi cancellò il movimento partigiano in bassa valle. I piani degli alti comandi garibaldini furono ancora una volta scombinati. Il carattere militante del movimento partigiano in bassa valle Il carattere del movimento garibaldino in Valtellina è essenzialmente militante. A differenza dei dirigenti partigiani in alta valle, i quali svilupparono il loro movimento intessendo relazioni alla pari con altre istituzioni politiche ed economiche della Resistenza e con gli alleati, i comandanti in bassa valle mirarono al potenziamento del movimento garibaldino dall’interno, conferendogli una struttura organica e complessa e allargandone gradualmente la zona di competenza. Di qui l’intenso lavoro organizzativo, militare e politico, svolto tra maggio e ottobre del 1944. Di qui anche il modo in cui si rapportarono con le formazioni autonome in bassa valle e la caparbietà con cui vollero ridurle alle loro dipendenze. Il carattere militante del movimento era sostenuto da un forte sentimento di superiorità democratica e antifascista. Per i comandanti in bassa valle il movimento garibaldino non era un’opzione antifascista fra le altre, che assieme alle altre contribuisse alla costituzione della nuova Italia del dopoguerra. Per essi il movimento era già in sé l’intera opzione democratica e antifascista, la più vera, l’unica che potesse condurre al rinnovamento radicale del Paese. E ciò proprio in virtù del suo carattere militante, del suo non lasciarsi impastoiare in rapporti paritari con altri movimenti, meno democraticamente qualificati. Questo senso di superiorità antifascista e democratica fu la cultura politica del movimento. Una cultura spontanea e immediata, che solo in alcuni casi era sottoposta ad un approfondimento critico e il più delle volte era semplicemente acquisita, respirata. Una cultura che non era fatta solo di antifascismo e democrazia, ma implicava appunto la superiorità del movimento garibaldino come l’unico strumento adatto per attuarli. In questo contesto, il comunismo ebbe la sua parte. L’attività dei commissari fu spesso propaganda comunista, il PCI manteneva un certo controllo sulle formazioni attraverso i nuclei di partito, i comunisti godevano di uno status privilegiato. Tuttavia occorre specificare meglio il senso di questo comunismo. Una indicazione la troviamo nel già citato Incontro dei capi e dei commissari della 40ª. In quell’occasione il commissario politico della I divisio50 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle ne, Primo, disse: «per me il comunismo, per me era una divisione dei beni, ma forse non sapevo neanche bene come. […] Io facevo il tornitore in quel momento lì. Perciò capivo benissimo […] che quello che prendevo era appena sufficiente per mangiare. Non avevo altre cose. Non ho mai studiato, non ho mai potuto studiare. Niente potevo fare. Perché il fascismo aveva detto che, sembra di essere nel Medioevo, no? Tu fai il tornitore e farai sempre il tornitore, no? Perciò io non avevo altra alternativa e non avevo altro da perdere»150. Questa idea di comunismo come mera rivendicazione, dopo vent’anni di fascismo e decenni di emarginazione politica e sociale poteva ben identificarsi con l’antifascismo e la democrazia tout court. Per i partigiani comunisti antifascismo, democrazia, comunismo e movimento garibaldino potevano fondersi in una unità virtualmente indistinta. Per essi il riconoscimento dell’esistenza di forze democratiche e antifasciste, ma non garibaldine e non comuniste poteva essere alquanto problematico. Di qui la tendenza a tacciare di filofascismo tutti coloro che non si allineavano alle direttive dei comandi garibaldini. Perché fosse possibile concepire l’esistenza di forze autenticamente democratiche ma non comuniste e la necessità di collaborare con loro nella politica di unità nazionale, era necessaria una cultura politica assai più critica e matura. Tale cultura era certamente presente nel Comando di raggruppamento di Lecco. Uomini come Ario, Odo e Neri lavorarono indefessamente per infondere nel movimento garibaldino in bassa valle la logica della mediazione dei conflitti e della collaborazione con tutte le forze antifasciste. Ma la posizione del raggruppamento faticò a farsi strada. Ci vollero le crisi di ottobre e la paura che il PCI venisse completamente marginalizzato nella Resistenza valtellinese per convincere i comandanti garibaldini dell’autorità del raggruppamento e della giustezza del suo punto di vista. La natura militante del loro impegno nel movimento e il senso di superiorità democratica dovettero essere all’origine dell’astrattezza del comportamento dei comandanti garibaldini nei rapporti con la popolazione, forse più che la loro provenienza dai centri urbani lombardi. Essi cioè prescindevano da una valutazione concreta delle condizioni della popolazione, dalle loro effettive possibilità economiche, dalla capacità di sopportare il peso delle requisizioni e delle rappresaglie. «Basta fare il comunista solo coi comunisti […] un vero comunista deve saper dirigere le masse»151, scrisse Ario in un documento citato e centrò il bersaglio: fu la convinzione 51 Gian Paolo Ghirardini di appartenere ad una cerchia di uomini moralmente superiori – i comunisti tra i comunisti – investiti di un compito speciale, più che la mancanza di relazioni affettive col luogo, a spingere alcuni garibaldini a richiedere dalla popolazione assai più di quanto potesse dare e con metodi meno che commendevoli. A ciò si aggiunse la mancanza in bassa valle di un ceto politico antifascista che potesse mediare tra la popolazione e i partigiani152. Se si eccettua il caso del CLN di Morbegno, non ci fu tra Colico e Sondrio un solo organismo politico clandestino in grado di farsi portavoce delle istanze della popolazione taglieggiata e presentarle ai comandi garibaldini. I CLN e le Giunte Popolari Comunali furono costituite solo tra l’ottobre e il novembre del 1944 appunto per cercare di recuperare il rapporto ormai deteriorato con la popolazione e non sembra che abbiano funzionato molto. In realtà l’unica zona in cui le GPC ebbero un ruolo significativo fu tra Castione e Postalesio nel febbraio-marzo del 1945. Queste GPC funzionarono perché costituite e sostenute da Ennio Pillitteri capo del servizio informazioni e intendenza della brigata Rinaldi e servirono a mantenere buoni rapporti fra partigiani e popolazione. Quando invece lo stesso movimento garibaldino non si preoccupò di sostenere tali organi popolari, il rapporto tra comandi partigiani e popolazione fu senza mediazioni e la popolazione si trovò alla mercé dei taglieggiatori. In questo vuoto politico si colloca l’opera di Giumelli. Egli fu e rimase sempre nella sua vita estraneo alla politica e ad ogni partito. Ma la sua insistenza nel criticare la natura politica delle decisioni dei comandi garibaldini per poco non ne fece l’eroe della Resistenza anticomunista. Probabilmente egli non se ne avvide e certamente tale ruolo non gli sarebbe andato a genio. Tuttavia, il pericolo fu chiaramente percepito dai partigiani comunisti della 55ª che rivolsero ad Ario la preghiera di ricomporre la scissione di fine ottobre, perché in caso contrario al partito non sarebbero rimasti più di trenta uomini. Anche in questa occasione la politica di collaborazione antifascista del raggruppamento salvò il movimento garibaldino dalle conseguenze della sua cultura politica militante. Il particolare carattere del movimento garibaldino conferì una speciale funzione agli organigrammi delle formazioni. La ripartizione delle forze partigiane in divisioni, brigate, battaglioni e distaccamenti e la composizione dei relativi quadri dirigenti non ebbe in effetti una notevole funzione operativa. Le denominazioni, gli incarichi, le suddivisioni cambiavano talmente in fretta da rendere assai dubbia la loro funzione militare. Chi spi52 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle golasse tra i documenti delle brigate Garibaldi, si accorgerebbe che le formazioni vengono chiamate con un vecchio nome anche dopo la loro trasformazione in unità operative diverse. I fronti nord e sud tornano dopo la costituzione delle brigate Matteotti e Rosselli, le brigate vengono fatte e disfatte con una facilità impressionante. A volte gli stessi comandi garibaldini rimanevano confusi ed erano costretti a chiedere spiegazioni: «pregasi compiacersi comunicare quale sia il numero distintivo della brigata Hissel […] La richiesta di precisazione è motivata dal fatto che in precedenza fu designata col numero 53, in prosieguo di tempo fu designata col numero 86»153. In realtà nella maggior parte dei casi le azioni militari venivano decise autonomamente dai vari distaccamenti e l’opera di coordinamento dei comandi superiori era alquanto debole. Lo stato dei collegamenti fu sempre pessimo e l’assenteismo dei comandanti superiori presso i distaccamenti notevolissimo. In realtà, questi organigrammi non avevano funzioni operative, ma gestionali, organizzative: erano il mezzo con cui si esprimeva il carattere militante del movimento, con cui il movimento si rinsaldava e garantiva la sua organicità. Svolgevano una funzione di potenziamento interno, non di proiezione all’esterno della forza di attacco delle divisioni. In bassa valle, infatti, i comandanti furono sempre più vicini ai loro superiori che ai loro uomini. Le eccezioni, come Baruffi, Ettore e Giumelli furono perseguite e combattute, perché minavano l’unità del movimento che proprio dagli organigrammi era garantita. Note al testo 1 Le brigate Garibaldi nella Resistenza: documenti, Feltrinelli, Milano 1979, vol. II, p. 23. 2 Ivi, p. 30. 3 Ivi, p. 28 4 Silvio Puccio, Una Resistenza. Antifascismo e lotta di liberazione a Lecco e nel Lecchese 10221945, Nuova Europa, Milano 1965, p. 76. 5 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga. Lotta partigiana e difesa degli impianti idroelettrici in Valtellina: 1943-1945, Sugarco, Milano 1984, v. I, p. 70-72. 6 Ivi, v. II, p. 75. 7 Ivi, v. I, pp. 93-94, e v. II, pp. 55 e 75. 53 Gian Paolo Ghirardini 8 Ivi, v. I, p. 94, e v. II, p. 55. 9 Cfr. Silvio Puccio, Una Resistenza cit., pp. 71 ss. ., v. II, p. 56. Istituto sondriese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ( d’ora innanzi Issrec), Fondo Gramsci, b.1, f. 6, Relazione. 10 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, p. 56. 11 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f. 6, Relazione per la F. e il CM di Ario e Silvio del 10 luglio 1944. 12 Ivi. 13 Ivi 14 Ivi. 15 Le Brigate Garibaldi cit., v. II, pp. 279-280. 16 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.6, Il Comando della 40ª Brigata d’assalto Garibaldi Matteotti ai compagni della brigata, firmato Ario, 21 luglio 1944. 17 Vedasi al riguardo Issrec, Fondo Cvl Insmli. 18 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Il Comando della 40ª Brigata d’assalto Matteotti alla Delegazione, firmato Nicola, 14 agosto 1944. 19 Ivi. 20 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f. 6, Relazione per la F. e il CM di Ario e Silvio cit. 21 Issrec, Fondo Cvl Insmli, b.1 f.5, 40ª Brigata d’assalto Matteotti ai commissari di distaccamento, Oggetto: Lavoro di propaganda politica da svolgere, firmato Gino, s.d., Fondo Cvl Insmli, L’intestazione reca tra parentesi la scritta «Comando Fronte nord». Il 23 luglio 1944 i due fronti della 40ª Matteotti si trasformarono reciprocamente nella 40ª Brigata Matteotti e nella 55ª Brigata Rosselli. Da qui la nostra datazione del testo al giugno-luglio del 1944. 22 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.6. Il giornale della 40ª Matteotti. Comando della 40ª Brigata d’assalto Garibaldi Matteotti per la Delegazione Comando e il Comando regionale unificato Lombardo, 20/7. 23 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.5, Il nucleo di partito del Comando di divisione alla Federazione del PCI, 14 ottobre 1944. 24 Ivi. 25 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.5. Relazione politica al commissario di raggruppamento, firmato Nicola e Primo, 24 novembre 1944. 26 «Facemmo togliere immediatamente tutte le stelle rosse e qualsiasi altra manifestazione che poteva ostacolare e compromettere lo sviluppo del lavoro di massa in questo Comando Militare», Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f. 6, Relazione per la F. e il CM di Ario e Silvio cit. 27 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, p. 39. 28 Issrec, Fondo Anpi, b.4, f.13, Incontro dei capi e commissari della 40ª Matteotti, 24 settembre 1967. 29 Ivi 30 Ivi. 31 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, p. 62. 54 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle 32 Issrec, Fondo Anpi, b.2, f.18, Intervista a Cesarino Parravicini, s.d. 33 Per l’attività del colonnello Croce in Valtellina vedasi Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., pp. 86-90; Giorgio Gianoncelli Corvi, Uomini e donne nella Resistenza più lunga, Edizioni Polaris, Sondrio 1998, pp. 29-42. 34 Issrec, Fondo Anpi, b.2, f.18. Intervista fatta a Giulio Spini. 35 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.3, Relazione secondo viaggio in Valtellina: 25 ottobre 1944, firmato Neri. 36 Ivi. 37 Musei Civici di Lecco, Fondo Resistenza, b. 6, Relazione sulla mia ispezione in Valtellina, 4 ottobre 1944, firmata da Riccardo. 38 Musei Civici di Lecco, Fondo Resistenza, b. 5, Carte Brigate Rosselli, Fronte Nord, Matteotti. Comando generale per l’Italia occupata ai comandi regionali a tutte le formazioni, s. d. 39 Musei Civici di Lecco, Fondo Resistenza, b. 6. Comando generale dei distaccamenti e delle Brigate d’assalto alle delegazioni comando a tutte le formazioni, 8 agosto 1944. 40 Musei Civici di Lecco, Fondo Resistenza, b. 5, Carte Brigate Rosselli, Fronte Nord, Matteotti. Raggruppamento divisioni d’assalto garibaldine lombarde ai commissari di Divisione, di Brigata ecc., 26 settembre 1944. 41 Musei Civici di Lecco, Fondo Resistenza, b.6. Istruzioni per tutti i compagni e le formazioni di partito, firmato Ercoli. 42 Per la vicenda di Clorindo Fiora Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v . I, pp. 112-117. Per il gruppo di partigiani organizzati da Fiora cfr. Relazione per la F. e il CM di Ario e Silvio del 10 luglio 1944, cit. 43 Cfr Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Rapporto n. 1, n. 2, n. 3 di Pino Retico e Onit Nass, s. d. Una lettera del Comando della 40ª Brigata Matteotti che cita i primi due rapporti e è datata 14 luglio, cfr. Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Il Comando della 40ª Brigata Matteotti per il Signor Onit Nass, 14 luglio, Il Rapporto n. 3 reca la data «dal 2 settembre». 44 Rapporto n. 1 cit. 45 Rapporto n. 2 cit. 46 Relazione per la F. e il CM di Ario e Silvio del 10 luglio 1944 cit. 47 Il Comando della 40ª Brigata Matteotti per il Signor Onit Nass cit. 48 Rapporto n. 3 cit. 49 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.6, Processo Fiora. Allegato n. 1: Relazione Rosa, firmato Rosa, s.d. 50 Processo Fiora. Allegato n. 2: Deposizioni dell’accusato, firmato Pino Retico, s.d. e Processo Fiora. Allegato n. 3: Deposizioni degli imputati, firmato Franco e Pino, s.d., entrambi in Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6. 51 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6. Processo Fiora. Allegato 2 bis, firma illeggibile (Pino Retico), s. d. L’attribuzione a Clorindo Fiora si evince da Processo Fiora, s.d., firmato Diego (alias Nicola) et al. in Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6. 52 Ivi. 53 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.6, Lettera di Fabio a Pino Retico, 23 febbraio 1945. 55 Gian Paolo Ghirardini 54 Rapporto n. 1 cit. 55 Lettera di Fabio a Pino Retico cit. 56 Lettera di Pino Retico al Comando provinciale del CVL, 21 marzo 1945, Issrec, Fondo Gola, b.1, f. 6. 57 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. I, pp. 116-117 e la lettera di Gek a Tiberio, datata 3 aprile 1945, conservata in Issrec, Fondo Porchera, b.1, f.5. 58 Issrec, Fondo Anpi, b.4 f.14, Intervista fatta a Ettore Mascheroni. 59 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f .6. Il Comando della 40ª Brigata d’Assalto Garibaldi Matteotti al Comando Fronte Nord, 25 luglio, firmato Ario. 60 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Il Comando 40ª Brigata d’assalto Matteotti al Comando 1ª Divisione Lombarda, 7/8/44, firmato Diego e Gino. 61 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.4, Il Comando raggruppamento brigate 40ª Matteotti 55ª Rosselli al Comitato di Liberazione, 9 agosto 1944, firmato «Il Comandante» (i.e. Ario, N.d.A.). 62 Issrec, Fondo Anpi, b.4, f.14, Intervista fatta a Ettore Mascheroni. 63 Relazione sulla mia ispezione in Valtellina, 4 agosto 1944 cit. 64 Issrec, Fondo Anpi, b. 4, f.14, Intervista fatta a Ettore Mascheroni. 65 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f. 6, Al Comando di divisione, 13 agosto 1944, firmato Bill, 66 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.6. Il Comando della 40ª brigata d’assalto Matteotti al Comando della I divisione lombarda, 16 agosto 1944, firmato Diego e Gino. 67 Ivi. 68 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, p. 113. 69 Issrec, Fondo Anpi, b.4, f. 14, Intervista a Ettore Mascheroni e Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, pp. 82-3 e pp. 193-4. 70 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6. Il Comando della 40ª brigata Matteotti al Comando della I divisione Lombardia, 3 agosto 1944, firmato Diego. 71 Issrec, Testimonianza di Manuela. 72 Ivi. 73 Ivi. 74 Intervista fatta a Cesarino Parravicini, cit. 75 Appunto di Plinio Corti sulla costituzione della 1ª Divisione Alpina Valtellina, in Marco Fini - Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II p. 165. 76 Issrec, Fondo Anpi, b.4, f.13, Incontro dei capi e commissari della 40ª Matteotti cit. 77 Intervista fatta a Giulio Spini cit. 78 Appunto di Plinio Corti cit. 79 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. I, nota 34, p. 168. 80 Appunto di Plinio Corti cit. 81 Per la cattura e il processo di Carlo si vedano le interviste già citate a Giulio Spini e a Cesarino Parravicini oltre che gli accenni di Primo in Issrec, Fondo Anpi, b.4, f.13, Incontro dei capi e commissari della 40ª Matteotti cit. Sempre in proposito Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga, v. II, pp. 37-8. 56 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle 82 Issrec, Fondo CVL INSMLI, b.1, f.1, Delegazione del Comando per la Lombardia al Comando del raggruppamento, 25 settembre 1944. 83 Ivi. 84 Intervista fatta a Giulio Spini cit. 85 Intervista fatta a Giulio Spini cit. 86 Per i rapporti di Corti col comando della 40ª e i suoi distaccamenti vedasi l’Appunto di Plinio Corti, l’intervista a Giulio Spini e l’intervista a Cesarino Parravicini già citati; Marco FiniFranco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II p. 37, v. I, pp. 125-7 e passim; per la reazione di Nicola alle proposte di collaborazione di Corti Issrec, Fondo CVL INSMLI, b.1 f. 2, Il Comando della 40ª brigata Matteotti al Comando della I divisione Garibaldi, 2 agosto 1944, firmato Nicola. 87 Intervista fatta a Giulio Spini cit. 88 Issrec, Fondo Anpi, b.4 f.18, Intervista a Giuseppe Giumelli. 89 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga, v. II, p. 61. 90 Intervista fatta a Giuseppe Giumelli cit. 91 Per la battaglia di Buglio e le polemiche che ne seguirono cfr: Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit.; Dante Sosio, Buglio in monte: un Comune di antiche origini nella storia del Terziere inferiore, Comune di Buglio in Monte 2000; Ferruccio Scala, Buglio a trenta anni dalla battaglia, in «Il lavoratore Valtellinese», 24 aprile 1974; Giuseppe Giumelli, La battaglia di Buglio, «Il lavoratore Valtellinese», 4 luglio 1964. 92 Issrec, Fondo Anpi, b.4, f.13, Incontro dei capi e commissari della 40ª Matteotti cit. 93 Intervista fatta a Giuseppe Giumelli cit. 94 Ivi. 95 Ivi. 96 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, p. 62. 97 Ivi, p. 134. 98 Ivi, p 140. 99 Ivi, p. 152. 100 Ivi, p. 158. 101 Ivi, p. 170. 102 Ivi, p. 171. 103 Ivi, pp 171-2. 104 Intervista fatta a Giuseppe Giumelli cit. Issrec, Fondo Anpi, fascicolo «Vertenza Giumelli», Il Comando della I divisione alla Delegazione Comando e al Comando del raggruppamento delle divisioni garibaldine lombarde, 24 ottobre 1944, firmato Diego (alias Nicola, N.d.A.). 105 106 Ivi. Ibidem, Il Comando del raggruppamento a Giumelli e al CLN di Morbegno, 17 ottobre 1944. 107 108 Intervista fatta a Giuseppe Giumelli cit. 57 Gian Paolo Ghirardini 109 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, p. 113. 110 Ibidem, pp. 62-63. Cfr. le testimonianze di Giumelli, Germano Bodo e Giovanni Pola riportate nel medesimo volume di Fini e Giannantoni. Alle pp. 63, 38 e 92. È significativo che nella sua relazione al raggruppamento Nicola ometta completamente questa parte della vicenda. 111 La maggior parte delle testimonianze non riferisce di scontri armati. Ne parla però Ercole Valenti, in sue memorie. In una intervista concessa da. Mario Songini, all’epoca ragazzo e abitante in val Masino, accenna a baruffe nei pressi di Cataeggio. 112 Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, p. 63. Secondo Giumelli, questo incontro avvenne a Cataeggio. Bill e Iseo Vola dicono invece che si svolse a Poira, Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. II, pp. 114 e 116. Così anche Nicola, in Issrec, Fondo Anpi, fascicolo «Vertenza Giumelli», Il Comando della I divisione alla Delegazione Comando e al Comando del raggruppamento delle divisioni garibaldine lombarde, 24 ottobre 1944, cit. Fini e Giannantoni per parte loro sposano la ricostruzione di Nicola, Bill e Vola, Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. I, p. 195. 113 Issrec, Fondo Anpi, fascicolo «Vertenza Giumelli», Il Comando della I divisione alla Delegazione Comando e al Comando del raggruppamento delle divisioni garibaldine lombarde, 24 ottobre 1944, cit. 114 115 Ivi. Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Relazione alla Delegazione Comando, 4 novembre1944, senza firma ma attribuibile ad Ario. 116 117 Ivi. Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.3, Relazione secondo viaggio in Valtellina, 25 ottobre 1944, firmato Neri. 118 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.5, Relazione sui fatti avvenuti alla I divisione, s.d., firmato Odo. 119 120 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.3, Relazione secondo viaggio in Valtellina, 25 ottobre 1944 cit.. 121 Intervista fatta a Giumelli cit. 122 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.3, Relazione secondo viaggio in Valtellina, 25 ottobre 1944 cit. 123 Ivi. 124 Ivi. 125 Ivi. 126 Ivi. 127 Ivi. 128 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Relazione alla Delegazione Comando, 4 novembre1944 cit. 129 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.5, Relazione sui fatti avvenuti alla I divisione cit. 130 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Relazione alla Delegazione Comando, 4 novembre1944 cit. 131 Ivi. Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Relazione alla Delegazione Comando, 4 novembre1944 cit.; Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.5, Relazione sui fatti avvenuti alla I divisione cit.; per altri dettagli 132 58 Valtellina, il movimento partigiano in bassa valle inerenti agli accordi si veda invece Issrec, Fondo Anpi, fascicolo «Vertenza Giumelli», 30-31ottobre 1944, manoscritto recante le firme di Ario, Odo, Mina, Giumelli et al. 133 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Relazione alla Delegazione Comando, 4 novembre1944 cit. Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.5, Il Comando della I divisione alla Delegazione Comando delle brigate Garibaldi, 15 novembre 1944, firmato Primo. 134 Issrec, Fondo Anpi, fascicolo «Vertenza Giumelli», Il Comando I divisione Lombardia al Comando di raggruppamento, 4 novembre 1944, firmato Nicola e Primo. 135 Issrec, Fondo Gramsci, b.1 f.5, Il Comando della I divisione alla Delegazione Comando delle brigate Garibaldi, 15 novembre 1944 cit. 136 137 Intervista fatta a Giumelli cit. Issrec, Fondo Anpi, fascicolo «Vertenza Giumelli», Il Comando della I divisione al Comando di raggruppamento, 12 novembre 1944, firmato Primo e Nicola. 138 Ibidem, Il Comando della I divisione al Comando di raggruppamento, 24 novembre 1944, firmato Nicola e Primo. 139 140 Ivi. Issrec, Fondo CVL INSMLI, b.1, f.1, La Delegazione per la Lombardia del Comando generale delle brigate Garibaldi al Comando raggruppamento I e II divisione d’Assalto Garibaldi, 15 novembre 1944. 141 142 Ivi. 143 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.5, Relazione sui fatti avvenuti alla I divisione cit. Lettera del Comando di raggruppamento divisioni Garibaldi alla Delegazione Comando, 28 novembre 1944, cit. in Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. I, p. 212. 144 Musei Civici di Lecco, Fondo Resistenza, b. 5, Il Comando raggruppamento al vicecomandante di raggruppamento Neri, 16 novembre 1944. 145 Musei Civici di Lecco, Fondo Resistenza, b. 5, Il Comando raggruppamento al comandante della I divisione Diego, 16 novembre 1944. 146 Lettera di Maio a Diego, 16 novembre1944, cit. in Marco Fini-Franco Giannantoni, La Resistenza più lunga cit., v. I, p. 214. 147 148 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.3, Lettera di Nicola a Maio, 26 novembre 1944. 149 Ivi. 150 Issrec, Fondo Anpi, b.4, f.13, Incontro dei capi e commissari della 40ª Matteotti cit. 151 Issrec, Fondo Gramsci, b.1, f.6, Relazione alla Delegazione Comando, 4 novembre1944 cit. È una osservazione di Giulio Spini ini Issrec, Fondo Anpi, b.4, f.13, Incontro dei capi e commissari della 40ª Matteotti cit. 152 Musei Civici di Lecco, Fondo Resistenza, b. 5, Il Comando raggruppamento al Comando regionale e al Comando II divisione Garibaldi, 18 settembre 1944. 153 59 storia nazionale Le picconate di Berlusconi ai tabù della memoria storica di Aram Mattioli Da anni gli esponenti della coalizione di destra oggi al governo in Italia muovono a giornalisti, giudici e procuratori – che altro non fanno se non il proprio lavoro – accuse prive di ogni fondamento, conducendo una vera e propria campagna denigratoria e infamante. Chi si prova a riportare fatti scomodi o pone interrogativi critici in merito allo stile di governo sempre più illiberale di Silvio Berlusconi, viene intimidito o querelato – come è già avvenuto a due quotidiani, l’«Unità» e «La Repubblica». L’impressione che se ne ha è che si tratti di una sistematica strategia che ha per obiettivo di ridurre definitivamente al silenzio oppositori e critici. Perfino scrittori di grande prestigio internazionale come Claudio Magris e Antonio Tabucchi vengono tacciati di essere antitaliani e di sputare nel piatto da cui pur mangiano, quando esprimono perplessità e preoccupazione sul berlusconismo e i pericoli che vi sono insiti. Recentemente è toccato anche alle scienze storiche di finire sotto il tiro incrociato di velenose polemiche. Il 28 e 29 settembre alla Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento si è tenuto un convegno internazionale sul tema La politica di Berlusconi 1994-2009. I governi del centrodestra in un confronto europeo. La manifestazione era organizzata dalla FBK Studi storici italo-germanici e dall’autorevole Institut für Zeitgeschichte di Monaco di Baviera, con la partecipazione di una dozzina di storici e politologi provenienti da Germania, Svizzera e Italia, che relazionavano su diversi settori come la politica estera, la politica della famiglia, quella del mercato del lavoro, la politica interna e anche la politica della memoria. Già solo l’annuncio del convegno spinse «Il Giornale» – un quotidiano di pura propaganda – a un attacco frontale: la Fondazione Bruno Kessler – che riceve anche sovvenzioni pubbliche – stava organizzando un convegno antiberlusconi, all’unico scopo di screditare l’attuale presidente del Consiglio, ecco quanto sostenuto in un articolo platealmente disinformato. Subito dopo il capogruppo del Popolo della Libertà si scatenava in parlamento regionale, prote61 Aram Mattioli stando ufficialmente contro la manifestazione, da lui sprezzantemente ridotta a mera polemica politica sotto mentita veste di evento scientifico. La pressione artificiosamente costruita induceva un membro del consiglio d’amministrazione della Fondazione a chiedere che l’iniziativa venisse annullata, cosa questa alla quale il presidente della fondazione stessa opponeva un pronto rifiuto, pur esternando un certo scetticismo. Quando infine la manifestazione ebbe inizio, il pomeriggio del 28 settembre, il pubblico – comunque accorso in buon numero – e i relatori stessi furono costretti a farsi strada in mezzo a una dimostrazione del Popolo della Libertà, cui partecipava anche il senatore Cristiano de Eccher. La Fondazione veniva accusata nei volantini di scialacquare i soldi delle tasse per fare propaganda di sinistra mentre le équipes di due emittenti televisive e numerosi cronisti e fotografi riuscirono a dare all’evento un aspetto distorto e inverosimile. Nel discorso d’apertura il politologo torinese Gian Enrico Rusconi si vide obbligato a far presente un fatto addirittura ovvio: «La storia e la scienza politica hanno il diritto e il dovere di occuparsi a livello scientifico dei fenomeni contemporanei, come facciamo in questo caso esercitando il nostro mestiere […] Non possiamo non occuparci del berlusconismo che da vent’anni caratterizza l’Italia». In seguito, riferendo del convegno, la «Süddeutsche Zeitung» pose il quesito se in Italia – dove già la libertà di stampa non sembra più essere così scontata come dovrebbe essere in una democrazia parlamentare – viene adesso messa in forse anche quella della ricerca scientifica. Dove ha luogo una sistematica intimidazione, alla lunga la cultura democratica del dibattito non può che venire soffocata fino all’estinzione. Quanto avvenuto è un segnale d’allarme. Qui di seguito pubblichiamo la conferenza che lo storico svizzero Aram Mattioli ha tenuto il 29 settembre al «convegno delle polemiche». Il suo contributo affronta la questione delle responsabilità politiche del Cavaliere nel revisionismo storico di destra, inserendolo nel suo contesto sociale. La monografia che Mattioli, docente all’Università di Lucerna, pubblicherà nel 2010 – corredata di un più ampio spettro di fonti – mostrerà come la coalizione di destra che Berlusconi guida dal 1994 vada percorrendo un cammino allarmante anche nella politica della memoria storica, un cammino impensabile per ogni altro paese dell’ Europa occidentale. L’ascesa di Silvio Berlusconi a uomo più potente d’Italia a partire dalla metà degli anni ottanta venne resa possibile da una «controrivoluzione silenziosa»1. Una rivoluzione che si manifestò con un clima di crescente vol62 Le picconate di Berlusconi ai tabù della memoria storica garità e intolleranza, ma anche con un preoccupante stile di intimidazioni e calunnie e con la deliberata infrazione di consolidati tabù2. Il nuovo populismo del gran mogol milanese dei media trasformò poco alla volta il paese in una democrazia senza vera democrazia. Sulla scia di questo sviluppo non solo la società scivolò nettamente verso destra, ma i temi della destra ottennero nei pubblici dibattiti uno spazio fino ad allora a malapena ritenuto possibile: uno spazio accordato adesso anche alla politica della storiografia portata avanti dalla destra berlusconiana. Oggi l’apologia del fascismo e l’ammirazione per il Duce sono ormai approdati al centro della società. Diversamente che in altri paesi europei, in Italia non sono solo gli estremisti di destra e i nostalgici irriducibili a sostenere tesi revisioniste (nel senso – va da sé – di rivedere quelle antifasciste), ma anche pubbliche personalità. Politici di spicco che riconoscono alla dittatura di Mussolini pagine positive, strade intitolate a «eroi» del regime o «fascisti buoni» protagonisti di anestetizzanti sceneggiati televisivi sono a partire dal 1994 parte della vita quotidiana della Seconda Repubblica, come anche le proposte di legge per equiparare i collaborazionisti di Salò e i «guerrieri» dell’ultima leva di Mussolini ai combattenti della Resistenza3. Già nel 2005 Oscar Luigi Scalfaro, ex-presidente della Repubblica, democristiano e magistrato, traeva questa inquietante conclusione: «Vediamo oggi che in Italia viene portata avanti una politica della storiografia che sotto il segno della riconciliazione nazionale mira invece alla revisione della storia e alla rivalutazione del fascismo»4. In effetti l’Italia ha vissuto a partire dal 1994, anno in cui Berlusconi è sceso nell’arena politica, una vera e propria «guerra della memoria». Per decenni le istanze di legittimazione e la politica della repubblica nata nel 1946 in Italia avevano poggiato sulla salda convinzione che gli italiani avevano battuto il fascismo con le proprie forze e liberato con le armi in pugno il paese dai tedeschi che lo avevano occupato nell’autunno 1943. Una simpatica menzogna, che aveva però contribuito a installare in Italia una duratura democrazia dopo oltre vent’anni di dittatura. In ogni caso la costituzione entrata in vigore nel 1948 fu – ed è – vincolata allo spirito antifascista e repubblicano. Il 25 aprile di ogni anno i vertici dello Stato hanno diligentemente messo in scena l’epos eroico della resistenza armata al nazifascismo5. Il culto della Resistenza toccò il suo apice tra il 1978 e il 1985 con l’ex-partigiano Sandro Pertini eletto alla massima carica dello stato. La fine della Guerra fredda e quella della Prima Repubblica, provoca63 Aram Mattioli ta dalla corruzione, spinse sulla difensiva la vecchia cultura politica pervasa di antifascismo mentre storici e pubblicisti orientati a destra mettevano sempre più in dubbio la lettura antifascista della storia recente. Con le vittorie elettorali nel 1994, 2001 e 2008 alla coalizione di destra guidata da Berlusconi si offrì il destro – dalla vantaggiosa posizione di governo – di trasformare la politica della memoria nella direzione da essa voluta e questo sia a livello di amministrazione centrale che a quello locale di comuni e province. Questo particolare settore della politica finì con il divenire un importante spazio di confronto sociale. La politica storiografica parla sì di quel che è stato, ma intende sempre quel che è e in fin dei conti guarda a quel che sarà. Insomma non si tratta mai solo del passato, ma di supremazia culturale nella sua interpretazione e di autorappresentazione nazionale e quindi indirettamente anche delle future maggioranze. I disinvolti contatti di Berlusconi con la destra «Non ci sono fascisti nel mio governo»6, così si esprimeva Berlusconi nel giugno 1994, poche settimane dopo avere per la prima volta chiamato nel suo governo i neofascisti di Fini e i separatisti della Lega Nord di Bossi. In questa reazione del nuovo premier già si manifestava quel modello comportamentale di base che rimase tipico del suo rapporto con scottanti questioni della cultura della memoria. La critica di democratici preoccupati che con la sua coalizione di destra Berlusconi avesse per la prima volta spezzato il consenso antifascista di base nell’ Europa del dopoguerra, venne rigettata con noncuranza come infondata. Berlusconi comunque non svolse mai un ruolo trainante nel dibattito sulla memoria, mirato a un rovesciamento revisionista della storia. Questo ruolo se lo assunsero per lo più i membri di Alleanza Nazionale, il partito nato dal disciolto neofascista Movimento Sociale Italiano, spesso e volentieri vigorosamente assecondati da esponenti di Forza Italia. Ma data la sua qualità di presidente del consiglio – l’istanza superiore che rendeva possibile una simile re-interpretazione – il ruolo del Cavaliere fu assolutamente determinante. Berlusconi non solo lasciò campo libero ai revisionisti mentre avrebbe dovuto porre loro dei freni, ma si mostrò addirittura adulatorio verso le loro opinioni, o quantomeno si avvolse nel silenzio, quando invece avrebbe dovuto prendere le distanze in maniera netta e ben udibile. Agì insomma senza scrupolo alcuno anche in questo settore della politica, solo perché anche que64 Le picconate di Berlusconi ai tabù della memoria storica sto non era del tutto irrilevante, dapprima per la sua scalata al potere e in seguito per mantenerlo7. Una disamina scientifica delle responsabilità politiche di Berlusconi nel campo della politica della memoria passa non solo attraverso l’analisi di quanto da lui pubblicamente affermato in merito alla dittatura fascista, ma anche – e in modo ben più significativo – per il fatto che lui – il più potente uomo di Italia – non abbia mai mostrato nessun timore o remora nel tenersi in stretto contatto con gli eredi del mussolinismo, dando invece sempre l’impressione che per lui costoro altro non fossero che normalissimi politici con vedute del tutto ragionevoli, anche e soprattutto per quanto concerne la loro interpretazione del fascismo. Già negli anni settanta l’ambizioso imprenditore era stato membro della loggia segreta P2, al cui vertice si trovava Licio Gelli, fascista notorio ed ex-appartenente alle SS. I fratelli della loggia erano infiltrati in politica, economia, media e burocrazia, collaborando con mafia, generali, servizi segreti e terroristi di destra che tramavano colpi di stato. Loro intento era di immettere il paese in una deriva di autoritarismo8. Comunque, nel 1982 la P2 venne sciolta come «organizzazione eversiva». Non del tutto senza fondamento alcuni buoni conoscitori del paese presumono che Berlusconi stia perseguendo ancor oggi lo stesso obiettivo, adesso però tramite una modifica costituzionale che dovrebbe conferirgli maggiori poteri come futuro presidente della repubblica9. L’assenza di qualsivoglia scrupolo nei confronti della destra estrema caratterizza l’intero percorso della carriera di Berlusconi, non solo i suoi inizi, quando riuscì a rendere accetti in società sia la Lega Nord che il MSI – pur sempre il maggior partito neofascista d’Europa. Dopo la sua seconda vittoria elettorale nel 2001 si adoperò costantemente per avere buoni rapporti anche con i gruppi di estrema destra fuoriusciti da AN e da anni intrattiene una relazione amichevole con Alessandra Mussolini, rappresentante del nocciolo duro della destra estrema, che dopo il viaggio di Fini in Israele ha dato vita ad Alternativa Sociale, una scheggia di ultradestra. Dando prova di una assoluta carenza di sensibilità storica, all’inizio del 2005 Berlusconi si informò in tutta serietà se la Mussolini avesse interesse per la presidenza della Regione Campania, che contava di potere strappare alla sinistra tramite quest’abbraccio con una formazione di destra estrema10: una mossa inaudita perfino per l’Italia. Per pura avidità di potere Berlusconi era pronto ad accettare al vertice di una grande coalizione di destra perfino una fa65 Aram Mattioli scista dichiarata e praticante – in netta contrapposizione con i suoi partner Gianfranco Fini e il democristiano Pier Ferdinando Casini. Alessandra Mussolini dimostrò di apprezzare le avances politiche del premier, plaudendo a lui come a un «vero leader»11. Oggi la nipote del dittatore è membro del composito partito del «Popolo della libertà». Durante le elezioni del 2006 avvenne che in alcune piazze, come per esempio Napoli12, Berlusconi venisse salutato dagli spettatori entusiasti con il grido «Duce, Duce» e il saluto a braccio teso. Significativo è che Berlusconi non abbia mai obiettato a un simile comportamento, non vedendovi problema di sorta. Come non fosse abbastanza, il capo della coalizione di destra «Casa delle libertà», per guadagnare un paio di punti in più, non esitò addirittura a stringere alleanze con partiti neofascisti border-line: non solo con «Alternativa Sociale» di Alessandra Mussolini («Meglio fascista che frocio!») ma anche con il MSI-Fiamma Tricolore di Luca Romagnoli («Semplicemente, non si può sostenere che il fascismo sia stato un male assoluto»)13. Che un eminente politico conservatore in un paese dell’Europa Occidentale venga a patti con movimenti di estrema destra è un fatto peculiare ed eccezionale. Per esempio, i gollisti francesi hanno sempre rifiutato un’alleanza elettorale con il Fronte Nazionale di Le Pen. Impensabile è poi che nella Repubblica Federale Tedesca un capo di governo democristiano scenda a trattative con i neonazisti dell’NPD (Nazionaldemokratische Partei) e della DVU (Deutsche Volksunion), anche solo a livello di governo regionale. Fin dalla sua discesa in politica Berlusconi cancellò sistematicamente i confini tra destra borghese-conservatrice e destra neofascista. Non solo egli stesso era pronto e disposto a infrangere qualunque tabù, ma anche a tollerare in benevolo silenzio che altri lo facesse. Come leader dell’opposizione onorò della propria presenza il congresso di fondazione del partito neofascista La Destra, che si teneva in un ambiente fortemente simbolico, il palazzo dell’ EUR, il quartiere che Mussolini aveva voluto per glorificare l’Impero. Non solo Berlusconi accettò di buon grado i saluti romani e le grida di «Duce» con cui lo accolsero festosamente i delegati, ma gridò loro: «Il mio cuore è con voi!». Nemmeno quando Francesco Storace, il presidente della Destra chiarì che per questo nuovo partito non si poneva proprio la questione di condannare il fascismo l’illustre ospite si mostrò minimamente irritato, anzi invitò i neofascisti a entrare nella sua coalizione prima delle imminenti elezioni14. Anche questa volta trovò superfluo pren66 Le picconate di Berlusconi ai tabù della memoria storica dere le distanze dalle dichiarazioni di fede fascista dei politici presenti. Nelle elezioni parlamentari della primavera 2008 alcuni dichiarati ammiratori del fascismo si candidarono per la coalizione di destra (il Popolo della Libertà) retta da Berlusconi: Alessandra Mussolini per la Camera dei Deputati – come sopra ricordato – e l’editore Giuseppe Ciarrapico per il Senato. Ovviamente e tipicamente per il personaggio, Berlusconi si guardò bene dal chiedere loro di ritirare le proprie candidature, una volta rese note. Il caso di Ciarrapico era particolarmente scottante, dato che non si candidava per un partito di destra esterno, ma per la stessa FI. In un’intervista al «Corriere della Sera» Berlusconi si limitò a osservare a proposito del suo amico di partito: «Siamo nel mezzo della lotta elettorale e abbiamo il dovere di vincere. L’editore Ciarrapico è proprietario di giornali che non ci sono contrari. È di estrema importanza che questo non cambi, visto che tutti gli altri grandi giornali sono contro di noi»15. Nonostante l’indignazione dovuta al fatto che Berlusconi ancora una volta andasse a caccia di voti fascisti, Ciarrapico venne eletto al Senato e la Mussolini alla Camera. Come se non bastasse, Berlusconi – risultato vincitore alle elezioni e affaccendato con la formazione del suo quarto governo – si astenne dal presenziare alla cerimonia ufficiale per il 25 aprile, anniversario della Liberazione, come del resto ha sempre fatto da quando è entrato in politica16. Proprio in questa ricorrenza, con un gesto di grande forza simbolica ha invece preferito ricevere per un colloquio il senatore Ciarrapico17. L’uomo forte d’Italia non si è comunque mostrato scorretto solo in occasione delle sue frequentazioni dell’estrema destra, ma è anche incorso in frequenti scivoloni sullo sdrucciolevole terreno del giudizio e del confronto con il recente passato nazionale, esprimendo pubblicamente le proprie opinioni – chiaramente da profano, ma sempre in sintonia con il sentimento popolare – sulla storia del secolo passato. La visione storica del Cavaliere Nella visione storica revisionista di Berlusconi è centrale l’affermazione che non sia stato il nazionalsocialismo, bensì il comunismo, l’«impresa più disumana della storia»18. Non particolarmente versato nella storia, l’uomo da decenni sostiene una cruda variante della teoria dei totalitarismi che sembra uscita direttamente dal deposito dei cimeli della guerra fredda. Come «anticomunista senza complessi» – così si è definito una volta – Ber67 Aram Mattioli lusconi considera suo preciso dovere morale prima e sopra ogni altra cosa di mantenere viva la memoria dei crimini dei regimi comunisti, tutti dediti a megastermini di massa19. Il 27 gennaio 2006, giorno della memoria della Shoah, Berlusconi definì il genocidio perpetrato sugli ebrei d’Europa una «follia», ma sottolineando che oltre a quello nazista ci fu anche un totalitarismo comunista, che avrebbe sulla coscienza molte più vittime della Germania di Hitler20, creando così l’impressione che il «genocidio di razza» del regime nazionalsocialista sia stato meno grave del «genocidio di classe» comunista. E questa non fu una estemporanea ed isolata esternazione: il grande semplificatore ritiene invece che il comunismo sia di gran lunga la maggiore tragedia del 20° secolo21. In questa valutazione Berlusconi si sente pienamente confortato dal Libro nero del comunismo, pubblicato in Francia nel 1997 dallo storico Stéphane Courtois. Per lui quest’opera controversa e discussa, nella cui prefazione viene tracciato un nuovo bilancio dei crimini del ventesimo secolo – abbattendo la Shoah dal «piedestallo della singolarità negativa»22 – è in assoluto tra le pubblicazioni di maggior importanza del presente, cui spetterebbe il posto d’onore nella libreria di ogni italiano, accanto alla Bibbia. È evidente che Berlusconi considera suo dovere propagare tra i suoi concittadini i fatti esposti nel Libro nero, dato che per lui l’Italia sarebbe uno degli ultimi residui baluardi della sinistra estrema. Con grande rapidità la casa editrice Mondadori, che fa parte del suo impero mediatico, tradusse e stampò l’opera in grande tiratura. Ben presto circolò tra gli iscritti a Forza Italia. Senza esserne richiesto, Berlusconi ne fece omaggio ai 5.000 delegati del congresso di AN a Verona, supponendo che condividessero con lui una cultura anticomunista. Peraltro, il dono non colpì particolarmente i suoi più fedeli alleati: non ha senso – spiegò con distacco Gianfranco Fini – giocare la carta dell’anticomunismo contro un nemico che nemmeno più esiste23. Che nella sua crociata anticomunista stia in realtà combattendo contro una fata morgana non tocca affatto Berlusconi: da quando è sceso nell’arena politica, ha sempre martellato nella testa dei suoi concittadini che il pericolo di una presa del potere comunista non è affatto scomparso in Italia24. Un ritorno della sinistra al governo, affermò nel gennaio 2005 in una grottesca profezia, avrebbe significato «miseria, terrore e morte», come in tutti i posti in cui il comunismo ha governato25. Altro non era che un tentativo di seminare il panico, senza tenere nel benché minimo conto il fatto che l’Italia non ha mai conosciuto una dittatura comunista, né prima né 68 Le picconate di Berlusconi ai tabù della memoria storica durante la Guerra Fredda. Per anni il leader di FI si è mostrato addirittura ossessionato dalla convinzione che tra i suoi avversari – o meglio, nemici – brulichino comunisti, dichiarati o sotto mentite spoglie, sia che si tratti di politici, intellettuali, giornalisti della stampa o commentatori televisivi, comici o di «toghe rosse». Dando prova di un’assoluta mancanza di scrupoli e di ogni freno ha tacciato anche democristiani come il suo annoso avversario Romano Prodi, di essere dei «leader cattocomunisti», tanto ingenui e malaccorti da lasciarsi manovrare a piacimento dall’estrema sinistra26. Insomma, chi non è per lui e con lui, non può essere altro che un comunista o un «compagno di viaggio». Ben saldo sul cavallo della battaglia anticomunista, Berlusconi ha suddiviso l’Italia della Seconda Repubblica in buoni e cattivi, rilasciando serenamente alla destra postfascista un certificato di irreprensibile buona condotta. In fin dei conti destra e FI sono apparentate da una comune «cultura anticomunista» (Gianfranco Fini) e dal ribrezzo verso il mito fondativo antifascista della repubblica nata nel dopoguerra. Come altri politici, pubblicisti e storici anche il Cavaliere assimila la lotta armata contro il fascismo a un tentativo di presa del potere da parte dei comunisti. Il modello rivoluzionario che avrebbe ispirato i comunisti italiani durante la Resistenza, sarebbe stato un primo passo verso una «rivoluzione bolscevica» di stampo sovietico. Pertanto, una moderna nazione democratica si potrebbe definire veramente antitotalitaria solo quando si senta vincolata contemporaneamente a valori antifascisti e anticomunisti – così un giornale internet di FI rielabora efficacemente per i suoi lettori il revisionismo di Berlusconi27. Nonostante le sue professioni di antitotalitarismo, Berlusconi non considera l’esperimento sociale – totalitario - di Mussolini una dittatura da condannare senza ma e senza se: alla domanda del Washington Post, nel maggio 1994, su che cosa pensasse delle esternazioni apologetiche del suo giovane partner Gianfranco Fini, rispose: «per un certo tempo Mussolini ha fatto delle buone cose in Italia – è una realtà storicamente provata»28. Certo il risultato finale della dittatura fascista alla fine sarebbe stato negativo, perché avrebbe rapinato all’Italia la libertà e l’avrebbe precipitata nella seconda guerra mondiale29. Parole che per i revisionisti italiani furono un dolce balsamo: Berlusconi dava a intendere che il fascismo di Mussolini avrebbe deviato dalla giusta rotta solo quando finì sotto l’influenza nefasta della Germania nazionalsocialista. Un pregiudizio largamente diffuso e già da tempo contraddetto e invalidato dalla ricerca storica, ma di cui Berlu69 Aram Mattioli sconi ha fatto ripetuto uso durante gli anni del suo governo. Nella tarda estate 2003 il primo ministro d’Italia ha addirittura definito «bonaria» la dittatura fascista e ha sostenuto, contro ogni evidenza storica, che il Duce e i suoi sgherri non avrebbero mai ucciso nessuno, limitandosi a «mandare in vacanza» gli antifascisti su isole amene come Ponza e Ventotene30. Davanti all’ondata di indignazione dell’opposizione nazionale e all’estero, Berlusconi si difese sostenendo che, da buon «patriota» italiano, aveva solo voluto salvaguardare Mussolini da un improprio paragone con uno sterminatore di massa come Saddam Hussein31. Che però non si sia trattato di uno scivolone una volta tanto, il re delle gaffes lo dimostrò nel dicembre 2005, pochi mesi prima della scadenza della legislatura: durante una conferenza stampa, davanti a un buon numero di giornalisti, Berlusconi non si peritò di affermare che «il fascismo non fu mai criminale». «Ci furono le spaventose leggi razziali perché si voleva vincere la guerra insieme a Hitler. Il fascismo in Italia ha alcune macchie, ma niente di paragonabile al nazismo o al comunismo»32. Interpellato in analoga occasione da un giornalista su Paolo di Canio, capitano della Lazio, che pochi giorni prima aveva entusiasmato i tifosi di estrema destra facendo il saluto romano (per la terza volta nello stesso anno) durante una partita con la Juventus, Berlusconi contesto che questo inequivocabile avesse una qualche significato. «Di Canio è un bravo ragazzo, non un fascista», così lo difese, «Lo fa solo per i tifosi, non per cattiveria». Insomma, un ragazzo a posto, solo «un po’ esibizionista»33. L’affermazione del premier risultò tanto più di difficile comprensione per il fatto che Di Canio è notoriamente uno sfegatato veneratore di Mussolini, che porta «DUX» tatuato sull’avambraccio destro34. Val la pena di ricordare che in molte altre democrazie europee un presidente del consiglio sarebbe stato costretto a dimettersi dopo queste scandalose affermazioni. La nuova cultura della memoria anti-antifascista Dopo il collasso della Prima Repubblica, Silvio Berlusconi spalancò le porte all’apologia del fascismo e questo portò a un aspro clima di contrapposizione e inconciliabilità nel dibattito italiano sulla memoria. Già nel 1994 la coalizione di destra reputò «inopportuna» la proposta avanzata da 100 deputati dell’opposizione di una cerimonia commemorativa del 70° anniversario della morte del parlamentare antifascista Giacomo Matteotti, 70 Le picconate di Berlusconi ai tabù della memoria storica assassinato da sicari fascisti35. Una manifestazione condotta in comune tra maggioranza e opposizione avrebbe allora potuto essere un atto concreto di «pacificazione nazionale» ma il disprezzo per la cultura antifascista è sempre stata una costante nella carriera politica di Berlusconi, che non si è fermato nemmeno dinanzi alla Costituzione, in vigore dal 1° gennaio 1948, che per lui presenta «un’impronta sovietica»36. La politica della storia portata avanti da Berlusconi ha provocato una confusione babelica, tanto che oggi gli antifascisti si sentono in obbligo di giustificare la propria posizione, ormai in odore di comunismo37. Con sempre maggiore evidenza si va delineando il profilo di una cultura della memoria anti-antifascista, in cui si ricordano senza pudore le sedicenti realizzazioni positive della dittatura mussoliniana e la collaborazione con la Germania nazionalsocialista38. Con la riabilitazione, per ora ancora parziale, del fascismo l’Italia – sola in Europa – ha imboccato una strada tutta sua. E questo non è rimasto senza conseguenze per la cultura politica. «Mi spiace – così si è espressa nel 2006 la democristiana Tina Anselmi, che in gioventù aderì attivamente alla Resistenza – che oggi in Italia ci si possa nuovamente dire fascisti senza che nessuno se ne senta disturbato». Traduzione di Massimo Tirotti Note al testo 1 Alexander Stille, Citizen Berlusconi, Monaco d. B. 2006. Vedi anche Paul Ginsborg, Berlusconi. Politisches Modell der Zukunft oder italienischer Sonderweg?, Berlino 2005; David Lane, Berlusconi’s Shadow. Crime, justice and the pursuit of the power, Londra 2005; Marc Lazar, L’Italie à la derive. Le moment Berlusconi, Parigi 2006 e Massimo Giannini, Lo statista. Il ventennio berlusconiano tra fascismo e populismo, Milano 2009. 2 Cfr Claudio Magris, Der düstere Traum von einem Leben ohne Gesetz. Danksrede für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, in «Süddeutsche Zeitung», 19 ottobre 2009. Con pari pessimismo sull’attuale situazione del paese si è recentemente espresso Antonio Tabucchi, Erkennst Du mich, Luft?, in «Süddeutsche Zeitung», 22 ottobre 2009. Tabucchi parla di un clima di decadenza culturale di difficile arresto. Cfr anche Franz Haas, Die Wüste wächst im Lande Italien, in «Neue Zürcher Zeitung», 26 ottobre 2009. 3 Il revisionismo di destra intrapreso dalla destra berlusconiana viene adesso analizzato nei suoi diversi modi di manifestarsi e come fenomeno sociale globale in Aram Mattioli, «Viva Mussolini». Die Aufwertung des Faschismus im Italien Berlusconis, Padeborn-Monaco d. B. 2010. Più focalizzato sul dibattito storico e scientifico è invece l’importante libro curato da Angelo Del Boca, La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico, Vicenza 2009. 71 Aram Mattioli Die «Achse» im Krieg. Protokoll einer Podiumdiskussion zur Erinnerungskultur und Geschischtspolitik in Italien und Deutschland, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblioteken 86 (2006), pp. 656 ss. 4 Filippo Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Roma-Bari 2005 e Aram Mattioli, «Die Resistenza ist tot, es lebe Onkel Mussolini !» Vom Umdeuten der Geschichte im Italien Berlusconis, in «Mittelweg» 36 17 (2008), pp. 75-93. 6 Hansjakob Stehle, Nettes über den Duce, in «Die Zeit», 3 giugno 1994. 5 7 A. Stille, Citizen Berlusconi cit., p. 68. 8 Friederike Hausmann, Kleine Geschichte Italiens von 1945 bis Berlusconi, Berlino 2002, pp. 118-123; Christian Jansen, Italien seit 1945, Göttingen 2007, pp. 185 ss.; A. Stille, Citizen Berlusconi cit., pp. 74 ss. 9 Friederike Hausmann, Italien, Monaco i. B. 2009, p. 214. 10 Berlusconi für Mussolini, in «Neue Zürcher Zeitung», 30 gennaio 2005. 11 Aldo Cazzullo, Mussolini: Silvio un vero leader, Fini è come Badoglio, in «Corriere della Sera», 17 febbraio 2005. 12 Angelo Carotenuto, Il Cavaliere affacciato al Balcone, dalla strada un coro. «Duce. Duce», in «la Repubblica», 8 aprile 2006. Cfr anche il filmato su Youtube: Al comizio di Berlusconi la gente fa il saluto romano e grida «Duce, duce», 2006. 13 Birgit Schönau, Rechte Freunde, in «Die Zeit», 23 marzo 2006. 14 Julius Müller-Meiningen, «Mein Herz schlägt für euch», in «Süddeutsche Zeitung», 15 novembre 2007; Kordula Doerfler, Berlusconi verliert Schlacht, in «Tages-Anzeiger», 17 novembre 2007. 15 Berlusconi stützt Faschisten, in «Süddeutsche Zeitung», 11 marzo 2008. Cfr. anche BerlusconiParteifreund bekennt sich zum Faschismus, in «Spiegel-Online», 11 marzo 2008. 16 Gianluca Luzi, 25 aprile, ci sarà anche Berlusconi, in «La Repubblica», 22 aprile 2009. La tradizione di non presenza è stata interrotta da Berlusconi per la prima volta nel 2009, quando ha partecipato alla cerimonia tenutasi a Onna, una frazione dell’Aquila, nell’Abruzzo terremotato. Qui l’11 giugno 1944 17 civili innocenti vennero massacrati da soldati tedeschi. In precedenza il ministro della Difesa Ignazio La Russa lo aveva pubblicamente invitato a non intervenire. Berlusconi motivò il suo passo con la necessità di non lasciare più il 25 aprile alla sola sinistra, che aveva trasformato una festività nazionale in una festa di partito. Difficile ravvisare in questa sua prima presenza un reale riconoscimento della Resistenza e della sua importanza per lo sviluppo della democrazia nell’Italia del dopoguerra. 17 John Hooper, Cries of «Duce! Duce!» salute Rome’s new mayor, in www. guardian. co. uk /world /2008/ apr/30/italy/print. 18 Nazismo una follia, ma il comunismo …, in «la Repubblica», 27 gennaio 2006. 19 Silvio Berlusconi, Azzurra, la nave della libertà, Da Una storia italiana (2000), in www. forzaitalia.it/silvio berlusconi/10_azzurra.htm. Cfr anche Silvio Berlusconi, L’anticomunismo è un dovere morale della memoria (Rimini, 24 agosto 2000), in Id., La forza di un sogno. Introduzione di Sandro Bondi, Milano 2004, pp. 33-64, in part. p. 38. 20 Nazismo una follia, ma il comunismo …, in «la Repubblica», 27 gennaio 2006. 21 Il libro nero del comunismo. Recensione di Stefano Doroni, 11 settembre 2006, in www.ragionpolitica.it/testo.3867. 72 Le picconate di Berlusconi ai tabù della memoria storica 22 Heinrich August Winkler, Der Stoss kommt von links, in «Die Zeit», 21 novembre 1997. 23 Giovanni Valentini, L’autogol del Cavaliere, in «la Repubblica», 2 marzo 1998. 24 Roberto Zuccolini, E l’autore del «Libro nero» dà torto a Berlusconi, in «Corriere della Sera», 6 marzo 1998. Barbara Jerkov, Se vince la sinistra miseria, terrore e morte, in «la Repubblica», 17 gennaio 2005. 26 Marco Galluzzo, Berlusconi: il leader Pd è un cattocomunista, in «Corriere della Sera», 13marzo 2009. 25 27 Stefano Doroni, Quale storia per gli italiani?, 14 ottobre 2005, in www.ragionpolitica.it/ testo.3985. 28 Vincenzo Nigro, Berlusconi: Non ho ministri fascisti, in «la Repubblica», 28 maggio1994. 29 Ivi 30 Cfr «Mussolini non uccise»: bufera su Berlusconi, in «Corriere della Sera», 12 settembre 2003: Oliver Meiler, Berlusconi wertet Mussolini auf, in. «Tages-Anzeiger», 12 settembre 2003: Wirbel um eine Äusserung Berlusconis über Mussolini, in «Neue Zürcher Zeitung», 12 settembre 2003; Berlusconi und die Opfer des Faschismus. Von einer peinlichen Äusserung zur nächsten, in «Neue Zürcher Zeitung», 13-14 settembre 2003. 31 Mussolini non è Saddam, non ha ucciso nessuno, in «Corriere della Sera», 12 settembre 2003. 32 Maurizio Caprara, Berlusconi: il fascismo? Non fu criminale, in «Corriere della Sera», 21 dicembre 2005. 33 Ivi. 34 Birgit Schönau, Tore für den Duce, in «Die Zeit», 17 febbraio 2005, p. 61. Dopo il primo episodio Paolo Di Canio venne condannato dalla FGCI a una multa di 10.000 euro. L’attaccante non ammise di essersi comportato scorrettamente, ripetendo il saluto romano nelle partite contro il Livorno e la Juventus l’11 e il 17 dicembre 2005. Venne nuovamente multato per lo stesso importo e squalificato. Il club di tifosi di estrema destra della Lazio, gli «Irriducibili» organizzò una dimostrazione di protesta davanti alla sede della Federazione. In segno di solidarietà con Di Canio, tre club di tifosi della Lazio avviarono una colletta per raccogliere la somma della multa comminata al loro idolo. 35 Hansjakob Stehle, Nettes über den Duce, in «Die Zeit», 3 giugno 1994. 36 Gianluca Luzi, Un’impronta sovietica nella nostra Costituzione, in «la Repubblica», 13 aprile 2003. 37 B. Schönau, Dschungelcamp Italien, in «Die Zeit», 12 marzo 2009. 38 B. Schönau, Rechte Freunde, in «Die Zeit», 23 marzo 2006. 73 Il mito dell’eroe crociato: padre Reginaldo Giuliani «soldato di Cristo e della Patria» di Giovanni Cavagnini Ad oltre sessant’anni dal sanguinoso epilogo della dittatura mussoliniana, gli studi sul ventennio fascista hanno ormai raggiunto una mole considerevole, toccando ambiti variegati quali il ruolo delle donne, la ritualità politica o l’evoluzione delle forze armate; per determinati aspetti il panorama delle nostre conoscenze permane tuttavia lacunoso, come dimostra tra le altre cose la scarsa attenzione riservata alle convergenze tra autorità politica e chiesa cattolica. Nonostante frequenti scivolamenti nell’apologia o nella tesi banalizzante di una reciproca strumentalizzazione tra i due poteri, la storiografia non ha mancato in alcune occasioni di soffermarsi con profitto sui protagonisti dell’avvicinamento ecclesiastico al regime, quali il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, o il francescano Agostino Gemelli, rettore dell’Università del Sacro Cuore. A fronte di tali contributi occorre rilevare come il silenzio continui ad avvolgere altre, ancorché significative, figure, ad esempio il domenicano Reginaldo Giuliani, cappellano militare delle camicie nere caduto nel corso della campagna etiopica e celebrato quale esemplare «soldato di Cristo e della Patria». Prendendo le mosse da tale lacuna, ciò che in questa sede vorrei tentare è una ricostruzione della fortuna postuma del religioso torinese nel periodo compreso tra la guerra africana ed i giorni nostri. Sebbene non esaustivo, tale lavoro costituisce una prima ricognizione da cui partire per una più approfondita analisi di materiali utili non solo alla decifrazione del mito dell’«eroe crociato» ma, più ampiamente, alla comprensione del nazionalismo cattolico e del complesso rapporto tra Italia repubblicana, memoria del fascismo ed eredità coloniale1. La biografia Andrea Giuliani nacque a Torino nel 1887. La sua formazione ebbe im75 Giovanni Cavagnini pronta marcatamente confessionale: dopo aver frequentato le scuole elementari presso l’istituto Federico Sclopis, gestito dai Fratelli delle scuole cristiane, divenne allievo dei salesiani presso il ginnasio di Valdocco per poi entrare, nel 1904, nel noviziato domenicano di Chieri. Ordinato sacerdote, fu assegnato nel 1913 al convento di Trino Vercellese, dove la sua attività di fiero predicatore antisocialista fu interrotta dalla chiamata alle armi. Di sentimenti accesamente nazionalisti, tra il 1916 ed il 1918 il tenente cappellano Giuliani ebbe modo di guadagnarsi tre medaglie al valore al seguito del 55° Reggimento Fanteria Marche (Carso, Tonale) e poi degli Arditi della Terza Armata (Piave); terminate le ostilità, seguitò a servire nell’esercito come ufficiale P. e all’indomani del congedo partecipò all’occupazione di Fiume da parte dei legionari dannunziani, finché il suo coinvolgimento nella celebre benedizione del pugnale donato dalle donne fiumane al comandante nella chiesa di San Vito indusse i superiori a richiamarlo a Trino. Qui padre Reginaldo riprese la sua attività di oratore, battendosi contro i «sovversivi» e partecipando attivamente a numerose cerimonie nazional-patriottiche (inaugurazioni di monumenti ai caduti, rievocazioni della Vittoria, ecc.); trasferito a Torino, vide con favore l’ascesa del fascismo, restauratore dell’ordine e geloso custode della memoria della Grande Guerra. Con il trascorrere degli anni e specialmente con la Conciliazione, il suo appoggio al regime divenne entusiastico, portandolo alla decisione di partecipare, volontario quarantottenne, al conflitto contro il Negus. Sbarcato a Massaua nel maggio 1935, Giuliani prese servizio come centurione cappellano del Primo Gruppo Battaglioni Camicie Nere d’Eritrea, agli ordini del generale Filippo Diamanti. Le lettere inviate ad amici e confratelli nonché le corrispondenze per il quotidiano torinese «La Gazzetta del Popolo» testimoniano una cieca fiducia nel duce e nel successo dell’impresa, unita ad una altrettanto ferma volontà di martirio in nome della religione e della patria2. La ferrea determinazione lo aiutò a resistere a marce, privazioni ed umiliazioni impostegli da ufficiali spesso refrattari ai precetti della religione cattolica; coinvolto infine nel duro scontro di Mai Beles-Passo Uarieu e deciso a non abbandonare i moribondi alla loro sorte, fu raggiunto e ucciso dal nemico (gennaio 1936). Conclusasi la prima battaglia del Tembien con la sconfitta delle truppe etiopiche, i suoi resti furono raccolti e inumati nel cimitero militare di Passo Uarieu. 76 Il mito dell’eroe crociato Il mito in età fascista La grande stagione del mito di padre Giuliani abbraccia gli anni compresi tra la guerra etiopica ed il tramonto della Repubblica sociale italiana, articolandosi in tre fasi: una prima, limitata in sostanza ai mesi iniziali del 1936, in cui il ruolo dell’autorità politica centrale giocò un ruolo importante ma niente affatto esclusivo nella promozione dell’immagine del sacerdote-soldato; una seconda, più ampia (1936-43), di piena ed ordinata istituzionalizzazione della stessa da parte della propaganda ufficiale; una terza, coincidente con il periodo della guerra civile (1943-45), di fruizione circoscritta ai settori più oltranzisti del clero militarizzato saloino. Tutto ebbe inizio con la comunicazione della morte, recata a Torino il 31 gennaio da un telegramma del duca di Pistoia e del duca di Bergamo a padre Carlo Grosso, priore del convento di San Domenico. La figura di Giuliani era molto nota nella città sabauda, ove la notizia si diffuse rapidamente e la stampa d’informazione si affrettò a pubblicare più o meno romanzate commemorazioni dell’ecclesiastico, ritoccandone la già patriottica biografia: «La Stampa» alimentò ad esempio la falsa notizia della partecipazione alla marcia su Roma («durante le azioni che precedettero ed accompagnarono la marcia su Roma, padre Giuliani fu sempre a fianco delle squadre di azione e nel corteo che mosse, nell’ottobre 1922, da piazza Statuto attraverso la città, egli marciava in testa con le sue decorazioni, tra i gagliardetti gloriosi»), mentre «La Gazzetta del Popolo» non esitò a prolungare il soggiorno fiumano fino al tragico epilogo dell’impresa («cappellano dei Reparti di Arditi, egli vive e combatte, durante il Natale di sangue, a fianco degli eroici soldati»)3. Tali voci furono prontamente riprese ed amplificate dai maggiori quotidiani nazionali: «Il Corriere della Sera» ripropose l’introduzione di Renato Simoni a Gli Arditi, prima e più fortunata opera del defunto, mentre l’autorevole «Popolo d’Italia» sfruttò la vicenda dell’«italiano purissimo» e del suo «martirio» per rinfocolare l’astio nei confronti di sanzionisti ginevrini e «barbari» etiopici4. Anche per effetto di questi pubblici riconoscimenti, militari, religiosi, politici, artisti, parenti, amici, conoscenti o semplici sconosciuti ansiosi di testimoniare la propria ammirazione nei confronti dello scomparso inviarono da tutta la penisola decine di lettere, biglietti e telegrammi al convento di San Domenico: tra i molti, il generale Guido Paoletti invitava i confratelli a promuovere la beatificazione dell’eroico caduto ed il vescovo castrense, mons. Angelo Barto77 Giovanni Cavagnini lomasi, parlava di un «cappellano militare magnifico: forse il migliore dei cappellani di questa guerra coloniale»5. In questa prima e caotica fase, i più attivi nelle celebrazioni furono i domenicani torinesi e in particolare padre Enrico Ibertis, provinciale di Piemonte e Liguria che, informati i subordinati del «glorioso sacrificio» compiuto «per la causa della civiltà cristiana», fece riservare i due successivi numeri de «La Stella di San Domenico», organo ufficiale della provincia di San Pietro Martire, interamente al cappellano, rappresentato come «eroica figura» capace di unire in sé le caratteristiche del religioso integerrimo, del soldato valoroso e del martire della fede cattolica. Contemporaneamente, un ufficioso necrologio comparve sulla prestigiosa tribuna di «Memorie Domenicane», tacciando di «esecrabile crudeltà» le «orde feroci» assassine di chi, inerme, si batteva «perché il nome sacro di Roma, nome di fede, di civiltà, di cristianesimo imperasse in quelle terre barbare»6. Nei giorni che seguirono l’annuncio dell’«olocausto», i predicatori si dedicarono insomma attraverso la pubblicistica e l’oratoria ad una massiccia opera di santificazione del confratello, presentato come mirabile sintesi di virtù religiose e militari, con una prevalenza delle prime sulle seconde. Il loro sforzo dovette tuttavia misurarsi presto con la ben più capillare propaganda statale, interessata a glorificare in padre Giuliani non tanto il pio figlio del santo guzmano quanto il perfetto milite fascista, obbediente, spartano, fideisticamente convinto della bontà e del successo della causa nazionale. Sintomatica, a questo proposito, la motivazione che accompagnava il conferimento della medaglia d’oro al v.m.. In base ad essa, «di fronte all’incalzare del nemico» il centurione avrebbe alimentato «con la parola e con l’esempio l’ardore delle camicie nere gridando: “Dobbiamo vincere, il duce vuole così”»7: forzatura evidente, volta a fascistizzare la morte del frate trasformandola in oleografia da martirologio littorio. Non a caso, il capo del governo in persona appuntò la decorazione sul petto di un entusiasta confratello ed amico di Giuliani, padre Filippo Robotti, il 31 maggio 1936 presso l’aeroporto di Centocelle (Roma)8. La solenne cerimonia ebbe l’effetto di rimuovere qualsiasi ostacolo alla sfrenata celebrazione del caduto: se in precedenza numerose erano state le esternazioni in favore del «crociato» torinese da parte di laici ed ecclesiastici, da questo momento il coro di omaggi assunse dimensioni davvero ampie, incontrando il pieno appoggio ed anzi l’incoraggiamento dell’autorità politica. Entrato «di diritto», come ha scritto Angelo Del Boca, «nel pantheon 78 Il mito dell’eroe crociato dei caduti della rivoluzione fascista»9, il nome di padre Reginaldo conobbe nella penisola una popolarità che nemmeno la Grande Guerra e un quindicennio di intensa attività predicatoria itinerante gli avevano conferito. Fu così che alla nuova gloria dell’Italia mussoliniana venne dedicata una quantità di strade, piazze, scuole, lapidi, biografie, conferenze e via dicendo, nel tentativo di additare ai connazionali un fulgido esempio di obbedienza, disciplina e sacrificio, delle qualità proprie cioè del popolo guerriero che avrebbe dovuto realizzare i disegni espansionistici del duce. Per avere un’idea della vastità del processo in atto, si può richiamare qualche elemento particolarmente indicativo. Il palazzo de «La Gazzetta del Popolo» a Torino ospitò per tre settimane (agosto-settembre 1936) la mostra dei cimeli, raccogliendo non solo pubblicazioni, autografi e fotografie, ma anche effetti personali e reliquie inviate dall’Africa Orientale Italiana da Mario Giai Merlera, segretario del duca di Bergamo e amico di Giuliani (il portafoglio, una manciata di terra presa sul luogo della morte e soprattutto la scimitarra che avrebbe abbattuto il domenicano, ancora sporca del suo sangue)10. L’iniziativa ebbe successo: varie personalità politiche la visitarono, i marinaretti dell’Opera Nazionale Balilla prestarono la guardia d’onore, la Centuria Reginaldo Giuliani della Coorte motorizzata 18 Novembre «si schierò davanti all’edificio del […] giornale e prima di iniziare la visita, come omaggio alla memoria dell’eroico cappellano, presentò le armi […]. Terminata la visita la centuria si schierò nuovamente di fronte al […] palazzo sui due viali del corso presentando le armi»11. La considerevole affluenza indusse i confratelli a trasformare quella che doveva essere un’esposizione temporanea in un piccolo museo permanente, con sede nella chiesa di Santa Maria delle Rose, eretta al principio degli anni trenta in corso Stupinigi (l’attuale corso Unione Sovietica) per volontà dello stesso Giuliani12. In quei mesi gli editori più accorti non si lasciarono sfuggire un argomento di grido e diedero alle stampe numerose opere, tra le quali ricordiamo Fede ed eroismo di Olga Ginesi, Eroe crociato di Lorenzo Tealdy, Padre Giuliani, ardito di Carlo Gennero, Il cappellano degli arditi e delle camicie nere di Arrigo Pozzi13. Significativamente, un importante contributo al mito guerresco di padre Reginaldo fu offerto dagli stessi domenicani, non sempre attenti a privilegiare in maniera sistematica ed inequivocabile la dimensione spirituale; più accorti, i gesuiti de «La Civiltà cattolica» si premurarono, recensendo un paio di libri a lui dedicati, non solo di rende79 Giovanni Cavagnini re omaggio al «valoroso cappellano» dal «carattere ardente e generoso», ma anche di ricordare come «sopra tutto» egli fosse «un pio religioso»14. Questa precisazione si perdette però nel clamore della grande sinfonia propagandistica che accompagnò e seguì la fondazione dell’impero, di cui Giuliani divenne tosto uno dei numi tutelari, rievocato con continuità anche negli anni successivi al 1936. La vicenda del sacerdote-soldato si rivelò infatti quanto mai adatta al clima di guerra permanente che caratterizzò l’Italia tra l’apertura delle ostilità nel Corno d’Africa e l’ingresso a fianco della Germania hitleriana nel secondo conflitto mondiale (campagna di Spagna, conquista dell’Albania, lotta contro i partigiani etiopici): chi meglio di padre Giuliani avrebbe potuto incarnare l’italiano forte e bellicoso, atto a realizzare gli obiettivi della sempre più ambiziosa politica estera mussoliniana? Numerose testimonianze confermano la perdurante fama del cappellano. Solo nel 1937 apparvero un’antologia dei suoi scritti con l’eloquente titolo di Croce e spada e le corrispondenze dall’Africa; il celebre giornalista Mario Appelius ne parlò ne Il crollo dell’impero del Negus; l’ex commilitone Mario Peruzzo rievocò i momenti passati al suo fianco nella Grande Guerra; a lui fu riservata «La Fiorita», annuale pubblicazione dei novizi domenicani piemontesi; il mensile «Realtà politica e sindacale del fascismo» pubblicò una spavalda fotografia del religioso, ritratto in divisa, con lo sguardo deciso e le mani sul cinturone15. A Roma il duce ricevette in udienza padre Martin Gillet, maestro generale dei predicatori, parlandogli «amorevolmente» dell’«eroica fine del grande cappellano»; a Firenze i domenicani accolsero un contingente di militari di ritorno dall’Etiopia esponendo in piazza San Marco «un grande ritratto dell’eroico padre Reginaldo Giuliani, circondato da una corona brillante di lampadine. Sotto l’effigie del valoroso cappellano era la seguente scritta: “Nel nome di Cristo e di Roma, perenne eroe crociato”»; dall’Etiopia il tenente Carlo Dozzo scrisse «delle immagini di padre Reginaldo che ho distribuite (quante ce ne vorrebbero per darle a tutti quelli che le desiderano!) ai soldati della 110ª Infermeria quadrupedi di Dessiè dove sono stato trasferito, che conoscevano e conservano un culto di ardente ammirazione per padre Reginaldo»16. Grazie soprattutto alla toponomastica il Nostro invase gli spazi pubblici dell’Italia fascista, guadagnandosi il diritto di figurare nella prestigiosa Enciclopedia Italiana, che ne faceva uno squadrista della prima ora, e dando il proprio nome ad un sommergibile varato nel dicembre 1939 nelle acque di Taranto17. Nemmeno il mondo delle arti rimase estraneo al processo di esaltazione 80 Il mito dell’eroe crociato 1. 2. 3. 4. 1. P. R. Giuliani, Il Vangelo della domenica spiegato ai miei soldati, Stella di S. Domenico, Torino 1936. 2. A. Pozzi, Il cappellano degli Arditi e delle Camicie Nere (P. Reginaldo Giuliani O.P.), Pinciana, Roma 1936. 3. P. Reginaldo Giuliani domenicano. Conferenza commemorativa del p. Filippo Robotti O.P., Amministrazione Stella di S. Domenico, Torino 1936. 4. ACSD, FRG, cartolina commemorativa, s.d. 81 Giovanni Cavagnini 5. 6. 7. 8. 5. A. Mecherini, La bandiera di Cristo e della Patria, in «Memorie Domenicane», a. LVI, maggio-giugno 1939. 6. Labaro della Terza Legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale Reginaldo Giuliani (immagine reperibile alla pagina web http://digilander.libero.it/lacorsainfinita/guerra2/personaggi/giuliani.htm). 7. O. Ginesi, Fede e eroismo. P. Reginaldo Giuliani, Carroccio, Milano 1936. 8. Disegno di V. Pisani, in «La tribuna illustrata», a. XLIV, 16 febbraio 1936, p. 1. 82 Il mito dell’eroe crociato del caduto, associandovisi anzi a più riprese. Già nel 1936 Carlo Trabucco, direttore del settimanale diocesano torinese di Azione cattolica «L’Aurora», aveva pubblicato Il cappellano delle fiamme nere, opera teatrale in due versioni, una per le rappresentazioni parrocchiali con interpreti esclusivamente maschili e l’altra messa in scena dall’Opera Nazionale Dopolavoro con attori di entrambi i sessi, mentre il celebre disegnatore Vittorio Pisani rappresentava sulla «Tribuna illustrata» gli ultimi momenti del «martire», attorniato da «abissini inferociti» in procinto di trucidarlo «barbaramente»18. Nel secondo anniversario della morte fu inaugurata nella chiesa di Santa Maria delle Rose una lapide dello scultore Emilio Musso tutta incentrata sulla dimensione marziale del personaggio, rappresentato a testa alta e di profilo come il Federico da Montefeltro di Piero della Francesca, con le decorazioni bene in vista; successivamente, in occasione della 21ª Mostra Internazionale di Venezia Armando Baldinelli espose «nel salone d’onore» un affresco raffigurante il «sacrificio eroico», incontrando la viva approvazione di Mussolini19. La testimonianza forse più significativa è fornita dalla pittrice Amelia Mecherini, che nella Galleria d’arte di via Cavour a Firenze espose la Vita eroica del padre Giuliani, ciclo pittorico formato da dodici tele così articolate: 1) La bandiera di Cristo e la bandiera della Patria; 2) Ascensioni di sangue; 3) Verso il dovere, oltre il dovere; 4) Sacro Piave; 5) La serena immolazione; 6) Tregua, per il dolorante corteo; 7) Martiri della barbarie; 8) Luce sull’amba; 9) L’immacolato altare della Fede e della Patria; 10) Il miracolo della carità; 11) Il supremo olocausto; 12) L’apoteosi della morte. Tra le più originali va certamente annoverata la prima, in cui «padre Reginaldo Giuliani, vestito della tonaca bianco-nera dell’ordine domenicano, ma coperto il capo di elmetto, a significare lo strenuo combattente, sale al cielo al di sopra di una nuvola fitta di stendardi e di gagliardetti dove sono visibilissimi i simboli di Roma e della nuova Italia fascista ed imperiale. L’eroe alza con la destra la sua crocetta fatta di luce e stringe nella sinistra il tricolore. Dio e Patria. Tutta l’azione, tutto l’amore, tutto il sacrificio del Grande sono contenuti in questi due poli di inequivocabile nobilissimo significato»20. Nell’ultima, quattro legionari immobili e silenti tenevano le insegne abbassate sul corpo del caduto, la cui spalla sinistra appariva straziata dal colpo di scimitarra; dal cadavere del santo (giacché in tale veste l’artista lo presentava) emanava un chiarore soprannaturale, che illuminava la notte africana e proiettava verso il cielo stellato la sagoma della chiesa di Adi Cajeh, da Giuliani eretta al confine eritreo alla vigilia dell’invasio83 Giovanni Cavagnini ne. Italianità, civilizzazione, sacrificio, trasfigurazione costituivano i pilastri del quadro e dell’intero ciclo, che dopo le cruente scene di battaglia poneva la quiete dell’eterno riposo in paradiso o meglio nel walhalla fascista a suggello di un iter esemplare, da ammirare ma anche da percorrere21. Giunta nel giugno 1940 l’ora delle «decisioni irrevocabili», la figura del «domenicano ardito» venne ancora una volta elevata a luminoso esempio di coraggio leonino per i combattenti e di incrollabile patriottismo per i civili, in breve a simbolo della nazione in armi. Se presto le magre figure rimediate sui diversi scenari bellici rivelarono in tutta la sua drammaticità il contrasto tra l’impreparazione delle nostre forze armate ed i travolgenti successi dell’alleato germanico, non per questo il glorioso «eroe del Tembien» finì prontamente nell’oblio; al contrario, fino a tutto il 1941 la propaganda continuò ad insistere su padre Giuliani, caduto in nome della patria littoria battendosi contro soverchianti forze nemiche. Nel gennaio 1941, mentre il regio esercito riusciva a malapena ad arginare la controffensiva greca e doveva subire il ritorno inglese in Africa settentrionale e orientale, mons. Bartolomasi rivolse alle truppe un discorso radiofonico per commemorare il quinto anniversario della morte del subordinato. Con operazione alquanto trasparente, l’ordinario militare riprese una frase del grande mutilato Carlo Delcroix, secondo cui «l’onorare i sacrifici compiuti prepara gli animi a quelli da compiere», quindi delineò a rapide pennellate la personalità del defunto, dotato dell’«animo intrepido di Santa Caterina da Siena, domenicana che soleva dire: “se la religione comanderà suggelleremo la fede nostra col sangue”» e del temperamento «del Duce che proclamò: “chi non è pronto a morire per la sua fede, non è degno di professarla”»22. Mentre il vescovo di campo spronava i soldati all’accettazione di nuove e più dure prove per tenere «alto l’onore della Patria», nel tempio torinese di San Domenico i padri Ibertis e Robotti officiavano l’annuale funzione di suffragio, davanti ad una platea composta da autorità politiche, associazioni combattentistiche, cappellani militari e studenti; un mese dopo, a Monfalcone venne varata la motonave Reginaldo Giuliani del Lloyd Triestino; ancora, a Marmorito (Asti) gli furono dedicate una strada e la scuola, a Calizzano (Savona) si ebbe invece l’inaugurazione di un ritratto; infine, l’Istituto magistrale del Divin Cuore a Torino celebrò la ricorrenza del 4 novembre con una messa e l’appello ai caduti, senza dimenticare il Nostro23. Neppure le pubblicazioni si interruppero, come dimostrano Il cappellano degli arditi di Silvio Riva, il completamento de Il Vangelo ai miei 84 Il mito dell’eroe crociato soldati ad opera di don Silvio Solero e la comparsa di un’inedita conferenza del domenicano24. Il 1942 segnò, con le decisive sconfitte dell’Asse a Stalingrado, El Alamein e Midway, una svolta nella storia della guerra: con un’avanzata lenta ma inarrestabile, gli Alleati avviarono un’offensiva che si sarebbe chiusa nel 1945 con la capitolazione del nemico. Non a caso, questo fu l’anno che fece registrare una certa flessione nella fortuna postuma di padre Giuliani, ancora rievocato da politici ed ecclesiastici, ma in misura minore rispetto agli anni precedenti. Scomparso l’impero che egli aveva contribuito a fondare, sconfitti gli eserciti italo-tedeschi in Africa settentrionale, bombardato e minacciato di invasione il suolo nazionale, del crociato torinese nessuno praticamente parlava più: l’uscita, nel giugno 1943, de L’uomo dalla croce, ultimo capitolo della trilogia bellica rosselliniana che, ispirandosi alla vicenda di padre Reginaldo, narrava le vicissitudini di un cappellano militare italiano caduto sul fronte ucraino nel generoso tentativo di soccorrere un carrista sovietico, parve quasi il canto del cigno del mito25; invece i fatti del 25 luglio, la «morte della patria», l’invasione tedesca e la guerra civile si rivelarono condizioni propizie alla rinascita (nell’Italia controllata dai nazi-fascisti, non nel Regno del sud) dell’epos. Principale artefice e veicolo di questo inatteso cambiamento fu il settimanale «Crociata Italica», stampato nella Cremona di Roberto Farinacci a partire dal gennaio 1944. Il periodico, diretto da don Tullio Calcagno, si fece «paladino di una concezione integralista del cristianesimo coniugata ad un irriducibile dogmatismo fascista», trovando adepti e simpatizzanti «specialmente nell’ambiente dei cappellani militari»26: sebbene una semplice scorsa riveli che «il nome di padre Reginaldo Giuliani è quello che ricorre con maggior frequenza»27, due sono gli articoli d’interesse. Il primo, del 24 gennaio 1944, riportava il testo della commemorazione radiofonica tenuta dal torinese don Edmondo De Amicis, successore di padre Reginaldo tra le camicie nere di Passo Uarieu. Amare le considerazioni del saloino, che dopo aver sottolineato il contrasto tra gli allori imperiali del 1936 ed il «cielo oscurato dalla vergogna di un re fuggiasco», contro la «strapotenza dell’oro giudaico», «il bolscevismo alle porte dell’Europa» e «l’Italia in due campi divisa» invocò il ritorno della medaglia d’oro: P. Giuliani, la tua figura bianco vermiglia ritorni sull’orizzonte della storia. La tua voce suoni e ridesti i sonnolenti, gli apatici, i corrotti, i vili, gli incerti, imperi ancora una 85 Giovanni Cavagnini volta. Siamo qui in attesa, noi che già rinserriamo i ranghi dei rinnovellati battaglioni della riscossa. I tuoi morti chiamano con te, e una voce sola risuona per dire che non tutto è perduto, che contro le mire di una congregazione politica, contro la congiura occulta, contro la potenza internazionale dell’oro più vale la potenza di quella fede che crede nella giustizia infinita di Dio e non può lasciare perire i poveri popoli onesti che credono nella potenza della preghiera delle madri e nel valore del sangue innocente dei bimbi macerati dalla barbarie nemica; che crede nel valore dei suoi soldati ritornati alla lotta dopo lo smarrimento di un’ora; che crede al destino di questa Italia favorita da Dio, faro di luce e di civiltà sul mondo egoista e pagano. P. Giuliani, ritorna con noi e guidaci alla lotta e alla vittoria!28. Simili aneliti accompagnarono le speranze di quanti confidarono prima nel trionfo, poi nel riscatto della Repubblica sociale, ma nemmeno la certezza della sconfitta indusse il clero più nazionalista ad abbandonare l’icona del sacerdote-soldato. Dieci mesi dopo l’intervento di De Amicis, ormai disperata la situazione dei fascisti, «Crociata Italica» ospitò un lungo scritto di don Fermo Fidenzi, nel quale si immaginava che «l’eroico frate domenicano, già cappellano delle camicie nere, padre Reginaldo Giuliani, medaglia d’oro, salito al cielo dalle gloriose ambe africane di Passo Uarieu il 21 gennaio 1936, angustiato dall’inaudito tradimento settembrino e dalla defezione di parte del suo popolo italiano dalle vie dell’onore, ottenne di poter tornare in pio pellegrinaggio sulla terra e di ripercorrere le vie dei suoi travagli e delle sue glorie». Il Nostro rivedeva così «l’istituto salesiano di Valdocco…pure esso rovinato da quei massacratori che certi beotissimi italianucci osano ancora chiamare liberatori» e si chiedeva «perché mai oggi, a tanti miei confratelli, sembra sporcarsi la bocca a parlare dei doveri verso la Patria», «perché ora i preti non escono a parlare al popolo». Giunto a Roma, rimaneva esterrefatto di fronte a «un re fuggito e traditore; un governo di larve; stranieri imperanti; un sindaco americano; truppe occupanti e provocanti; negri scompiscianti i sacri ricordi»; non diverso lo spettacolo offerto dall’Ordinariato Militare («anche colà tutto silenzio […] tutto “addomesticamento” e tradimento ignobile») e dal Vaticano, frequentato da «capi stranieri e vescovi anglicani e generali massacratori. Vi fa la spola una eminenza grigia, americana anche essa: mons. Spellmann! Onde Cristo […] è diventato americano!»). Avvilito, Giuliani ritornava infine in cielo, concludendo il suo «triste pellegrinaggio nell’Italietta del 1944, non più imperiale»29. Una rabbiosa impotenza trasudava dall’articolo, indicativa espressione di un gruppo che percepiva il rapido, inesorabile avvicinarsi 86 Il mito dell’eroe crociato della disfatta: né l’indignazione del defunto cappellano né le armi tedesche impedirono infatti il tracollo dell’Asse e della grande Italia che padre Giuliani tanto aveva celebrato. Terminata la guerra con un’ignominiosa sconfitta, si prospettarono per l’ex gloria nazionale anni molto difficili, caratterizzati da un imbarazzato silenzio. Il mito in età repubblicana Con l’avvento della democrazia, nell’impossibilità di varcare i confini degli ambienti combattentistici e nostalgici, l’icona di padre Giuliani subì un drastico ridimensionamento, a dispetto del quale il periodo repubblicano può essere suddiviso in varie fasi: una prima (1945-55), di assenza quasi totale dallo scenario pubblico; una seconda (1956-68), di rinascita; una terza, di profonda crisi (1968-80); una quarta (1980-2000), di ripresa via via più sfumata della figura, con progressiva accentuazione dei tratti apostolici rispetto a quelli politici. Incurante del frangente scarsamente propizio, già pochi mesi dopo la liberazione qualcuno si batté per una riabilitazione. Nel 1946 padre Robotti affrontò di petto la questione con un opuscoletto intitolato Fu p. Giuliani fascista?, in cui si premurò di distinguere tra patriottismo e fascismo, minimizzò l’episodio fiumano della benedizione del pugnale, smentì la «leggenda» di un padre Reginaldo animatore dello squadrismo torinese, in prima fila nella marcia su Roma, e descrisse come ostile l’atteggiamento di Mussolini («anticlericale fegatoso») nei confronti del «valoroso domenicano». Il religioso diceva probabilmente il vero affermando che il confratello «vedeva soprattutto nel fascismo un movimento patriottico tendente a valorizzare e a far più grande l’Italia», ma finiva per incappare in evidenti eccessi apologetici che male si accordavano con la sua passata attività di conferenziere o la realtà documentaria, arrivando a dichiarare: «se p. Giuliani fosse stato ancora in vita…è probabilissimo che avrebbe chiesto ai suoi superiori di fare il cappellano dei partigiani, perché, mentre aborriva i tedeschi, era un fervido ammiratore degli Stati Uniti, ove fu due anni come missionario»30. Se alcuni ingaggiarono una disperata battaglia difensiva, altri non parvero nemmeno percepire il problema. Scrivendo ad un cappellano militare in pensione intenzionato a «raccogliere pagine di storia e di valore italiano nella guerra mondiale degli anni 1915-18», mons. Bartolomasi menzionò tra i sacerdoti «degni di memoria» «il p. Giuliani, domenicano, 87 Giovanni Cavagnini l’ardito Cappellano degli Arditi, che si guadagnò una medaglia d’argento, due di bronzo, e poi quando cadde in Africa Orientale Italiana la medaglia d’oro»31: né i legami con il passato regime, né il trauma della guerra civile inducevano l’ex ordinario militare a tacere o ad avanzare riserve su una figura tanto compromessa. Tentativi siffatti, parte di un più ampio coro di apologisti, erano destinati al fallimento nell’Italia dell’immediato dopoguerra: mentre i monarchici venivano sconfitti al referendum del 2 giugno 1946 e i neofascisti andavano tra mille difficoltà riordinando le proprie fila32, il nome di Giuliani fu rimosso (sebbene in maniera non sistematica) da vie, piazze, scuole, a cominciare dalla natia Torino. Per un decennio calò pressoché completo il silenzio su uno dei cappellani più decorati della storia d’Italia; la memoria dell’«eroe crociato», tuttavia, non si era persa, semplicemente attendeva momenti più idonei per riaffiorare. La congiuntura favorevole fu determinata dalle dinamiche della guerra fredda: i clamori celebrativi del regime impedirono un’immediata ripresa del culto nell’Italia parlamentare, ma la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, la minacciosa forza del partito comunista e la definitiva riorganizzazione dell’area neofascista fecero sì che, alla metà degli anni cinquanta, le sorti del domenicano cominciassero a mutare. L’occasione fu offerta dal ventennale della morte e della fondazione dell’impero, allorché gli estimatori, abbandonato ogni riserbo, ricorsero alla «glorificazione della sua memoria e della sua fine per ricordare la guerra delle camicie nere», divenuta «indicibile»33. Vale la pena di riportare per esteso le provocatorie parole de «Il Secolo d’Italia», quotidiano di estrema destra vicino al Msi: Perché il Secolo d’Italia pubblica una pagina, nell’anniversario della morte di p. Reginaldo Giuliani, dedicata alle sue idee, alla sua carità, allo spirito combattivo da cui era animato, alla sua fine eroica? E perché a fianco di un discorso che l’intrepido domenicano pronunciò alla radio subito dopo la Conciliazione, riportiamo, in uno scarno diario, le tre giornate della battaglia di Passo Uarieu, in cui cadde il padre, meritandosi la medaglia d’oro al v. m.? Ma perché questi sacerdoti e questi caduti e questi fatti non si debbono dimenticare. Perché la via che essi tracciarono con la loro fede e con il loro sangue, risplende ancora davanti ai nostri occhi come una via luminosa, come una via da percorrere. Chiesa e Patria, cattolicesimo e Italia, aveva lasciato scritto p. Reginaldo Giuliani. Egli veramente intendeva la sua missione come quella di un apostolo della civiltà cristiana di Roma, e non come quella di un zelante alfiere di quella di Mosca, come troppo spesso ostenta, per farsi bello verso le sinistre, il «cattolico»…La Pira, e 88 Il mito dell’eroe crociato tanti altri come lui. Riconciliazione tra Chiesa e Stato, vita vissuta degnamente, per la Chiesa e per l’Italia, in servizio di Cristo, perché trionfi il primato civile di Roma. Ecco a quali ideali sacrificò la sua vita p. Reginaldo Giuliani, ed ecco per quale ideale si sacrificarono i combattenti di Passo Uarieu. Oggi, in cui tanti idolatri della Croce e insieme della falce e martello sputano su quei caduti, e ci trascinano davanti ai tribunali perché non abbiamo vergogna di essere quelli che siamo, e di chiamarci col nostro nome, è bello e confortante rientrare in questa cappelletta, disegnata da p. Giuliani, costruita dai legionari d’Africa. Ci si respira un’aria sana, non contaminata. Ci si ritrova ancora veramente fratelli, sotto quelle alte insegne, per cui è meritevole vivere, ed è desiderabile morire: la Croce ed il Tricolore. Ecco la via, ed ecco il retaggio, che ci lasciano i caduti, cui oggi il Secolo dedica commosso e riverente la sua terza pagina34. Con tutto questo, il centro della rinascita del culto del Nostro rimase naturalmente la città natale. La chiesa di San Domenico ospitò quella che mi risulta essere la prima funzione di suffragio dai tempi della seconda guerra mondiale. Il rito fu coronato da un discorso di don Solero, secondo cui la memoria del defunto continuava a vivere «nel cuore dei migliori italiani» e «l’Italia, nell’ora immancabile della sua vera, antica e ricuperata grandezza (presto o tardi che sia per arrivare quest’ora) risaluterà anche ufficialmente la figura eroica di Reginaldo Giuliani nella schiera dei santi tutelari della Patria»35. Contemporaneamente, padre Ibertis inaugurava la sua attività di pubblicista e massimo sacerdote del culto di Giuliani nel periodo repubblicano con i Ricordi agli italiani ed un articolo volto a dissipare una volta per tutte le ombre della famigerata «messa del pugnale»36. Soprattutto, l’attivissimo religioso riuscì a ottenere il rimpatrio dei resti dell’amico: riesumati dalla chiesa di Adi-Cajeh (Eritrea), essi giunsero a Torino il 30 ottobre 1956 per essere tumulati con grande solennità nel tempio di San Domenico il giorno successivo, alla presenza di una folto pubblico di commilitoni tra i quali spiccava la figura del generale Diamanti. Officiante fu il vicario militare mons. Carlo Rusticoni, mentre il discorso funebre fu tenuto dall’ex cappellano mons. José Cottino, prefetto della basilica di Superga, che tra le altre cose disse: «L’apostolo che ama le anime a queste mira, queste cerca di convertire, queste di illuminare, ed è disposto perciò, secondo una coraggiosa e paradossale frase attribuita a Pio XI, a fare patti anche con il diavolo. I piccoli uomini forse non lo capiranno mai e non potranno vedere lo splendore dell’anima apostolica di padre Reginaldo Giuliani, che dimessa l’amata candida tonaca domenicana rivestì il grigio-verde soltanto per amore delle anime e soltanto per amore delle ani89 Giovanni Cavagnini me accettò ogni divisa e ogni destinazione, facendosi tutto a tutti per tutti guadagnare a Cristo»37. Da quel momento non fu insolito vedere drappelli di reduci della Grande Guerra, delle campagne etiopica e spagnola o del 1940-45 recarsi in pellegrinaggio a Torino per onorare il sepolcro del caduto, calorosamente accolti da religiosi più che mai determinati a seguire la strada dell’apologia riguardo a padre Reginaldo ed ai rapporti con il regime: indicativa, a questo proposito, la principale biografia, pubblicata nel 1960 dall’infaticabile Ibertis e prefata da una paginetta dell’ordinario militare mons. Arrigo Pintonello, che esaltava «al di là di ogni polemica» le «mirabili gesta», la «mirabile avventura», la «tomba gloriosa»38. Tutto sembrava indurre a ritenere definitivamente chiusa la parentesi del dopoguerra, ma l’evoluzione del contesto socio-politico nazionale venne ancora una volta a scompaginare ogni ottimistica previsione. Il clima di accesa contestazione studentesca e di scontro sindacale che caratterizzò l’Italia tra la fine degli anni sessanta ed il decennio successivo rese assai problematica la prosecuzione del culto dell’«eroe del Tembien», che infatti accusò un deciso arresto: se ancora nel 1966 «Il Secolo d’Italia» aveva ricordato con toni degni del 1936 il «sublime sacrificio»39, nel volgere di pochi anni la situazione cambiò profondamente. Lo testimonia bene un discorso tenuto il 24 gennaio 1971 a Torino dal generale Diamanti. Il luogo prescelto non fu il consueto «bel San Domenico» dove frate Reginaldo aveva tante volte predicato, ma «una sala di trattoria», per di più sotterranea. Le parole dell’oratore erano piene di risentimento contro «le difficoltà frapposte da chi ha timore che la nostra voce sia comunque contrastante con quella oggi dominante, dei negatori di ogni virtù, di ogni spirito, di ogni fede; con quella di coloro che sono riusciti a distruggere i sacri principi dell’amore di patria, i principi che predispongono alla sopportazione di qualsiasi sacrificio fosse imposto dall’interesse della collettività o dalle ricorrenti necessità della vita del nostro popolo». Insulto supremo al defunto eroe, la recente visita dell’imperatore etiope a Torino: «Io voglio sperare che due mesi or sono, nello scorso novembre del 1970, il Suo sonno non sia stato turbato dal clamore di quanti nella Sua città di Torino fecero ala osannanti a chi fu capo di quell’esercito nemico che noi combattevamo, e di cui un barbaro soldato vibrò il colpo di scimitarra che chiuse la sua vita terrena di apostolo per dare inizio a quella di un martire». Ripercorrendo le tappe della vita di Giuliani, l’ex generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale si soffermò sul periodo 1919-22, dominato a 90 Il mito dell’eroe crociato suo avviso da «un clima che vagamente assomiglia a quello ancora più grave che stiamo attraversando», di denigrazione dei valori patriottici, e sulle missioni americane del Nostro, che portò agli emigrati «il ricordo della Patria allora realmente grande». Al rigetto completo dell’indegno presente si univa l’esatta ripetizione dei temi della propaganda mussoliniana: «noi non avevamo mire di conquista, ma tendevamo a difendere strenuamente quanto era nostro, e quanto ci serviva per dare pane e vita ai tanti e tanti italiani che non trovavano allora ed ancora meno trovano oggi possibilità di sfamarsi nella loro terra natia»; «fummo civilizzatori, non conquistatori, in ogni circostanza, in ogni manifestazione della nostra attività, in ogni occasione»40. La figura di Diamanti, reduce della campagna di Russia e della Repubblica sociale, condannato a quindici anni di prigione alla fine della guerra41, è emblematica. Fredda collera e viscerale attaccamento alle certezze della propaganda imperiale svelano l’amarezza di quanti vedevano denigrati i valori simboleggiati dal cappellano: svanito il senso della disciplina, dell’obbedienza e della gerarchia tra i banchi della scuola e nelle fabbriche (è della Torino industriale che parliamo), il futuro doveva apparire poco roseo a queste persone. Il richiamo al primo dopoguerra sembrava lasciare aperta la possibilità di un secondo squadrismo rigeneratore, ma le riunioni clandestine, l’età dei convenuti e la povertà simbolica dei luoghi prescelti per gli incontri non contribuivano ad alimentare grandi speranze. Il pessimismo che pervadeva le orgogliose parole del vecchio generale era ben giustificato: per tutti gli anni settanta, la figura di Giuliani tornò nell’ombra, aspettando un mutamento della temperie politica e culturale che le consentisse di riemergere dal prudente silenzio che la ammantava. Con il «ritorno all’ordine» sancito dalla fine delle grandi lotte operaie e dall’attenuarsi del terrorismo si presentarono le condizioni per la riapparizione di padre Reginaldo nel discorso pubblico. Preceduta da alcune timide anticipazioni, la svolta si ebbe nel 1986, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, allorché i domenicani decisero, dopo un’interruzione di tre lustri, di celebrare in San Domenico un’altra funzione di suffragio, incentrata stavolta sulla carità e lo zelo pastorale dello scomparso, nell’intento di prevenire eventuali accuse di clerico-fascismo. Questa cautela trovò conferma nel numero monografico della «Stella» con cui i torinesi affermarono di aver «voluto ricordare la sua figura intrepida di religioso domenicano, di predicatore e [solo in ultimo] di cappellano militare». Mezzo secolo dopo i fatti di Passo Uarieu, una visione meno acriti91 Giovanni Cavagnini ca degli eventi cominciava a prendere piede tra i confratelli, ma il processo permaneva lento e difficoltoso, come indicava la permanente elevazione di eroismo e sacrificio al rango di categorie ermeneutiche. Padre Enrico di Rovasenda, ex presidente del circolo fucino Cesare Balbo, avverso al GUF, fu l’unico a parlare esplicitamente di «significativo appoggio al regime», finendo però per riaffermare al di là delle divergenze politiche l’ammirazione nei confronti del maestro («I cattolici, ecclesiastici e laici, erano divisi nei riguardi del fascismo, ma quel nostro contrasto politico giovanile non intaccò la stima e l’affetto per il sacerdote e religioso, ministro della parola di Dio, apostolo di innumerevoli conversioni alla vita cristiana ottenute con la predicazione dai maggiori pulpiti d’Italia»)42. Questa prima, tormentata e incerta presa di distanza dal mito fascista si riscontrava alle stesse date anche nelle pubblicazioni ufficiali dell’Ordinariato Militare, non scevre da una robusta dose d’imbarazzo: «Nel 1935 i cappellani militari furono messi alla prima prova del fuoco con la conquista dell’impero. Difficile a descriversi, questo periodo, perché nel nostro paese la storia è troppo spesso faziosa. Ragion per cui non sarà male rammentare, per esempio, il domenicano padre Reginaldo Giuliani. Possibilmente senza vergognarsene»43. Da parte sua, l’esercito italiano rese con il generale Oreste Bovio «reverente e commosso omaggio» alla «nobile testimonianza di sacerdote e di soldato». Dopo aver ricordato le parole di Karol Wojtyla sulla compatibilità tra «vocazione cristiana» e servizio militare, l’autore venne al punto: se «indubbiamente il regime fascista cercò di utilizzare per i suoi fini propagandistici l’eroico domenicano», in lui «la fede più profonda e il patriottismo più sincero convissero in modo del tutto armonico e spontaneo»; l’«entusiastico appoggio» al fascismo e la «devozione alla persona di Mussolini, da lui ingenuamente ma sinceramente ritenuto l’Uomo della Provvidenza» erano, secondo Bovio, spiegabili alla luce della Conciliazione, «sogno tanto a lungo perseguito con l’azione e con la predicazione, il suggello autorevole del suo comportamento di sempre». Colui che in vita aveva sempre considerato i soldati alla stregua di bambini veniva qui fatto oggetto della paternalistica considerazione di un alto ufficiale, che tentava di illustrarne i comportamenti ricorrendo a sua volta alla caratteristica dell’ingenuità. Il generale concludeva il discorso con la benevola assoluzione dell’ex martire fascista: «e se è lecito dubitare che padre Giuliani incitasse al combattimento i suoi soldati con il grido “il Duce vuole così”, è legittimo credere che sia caduto levando in alto la Croce, simbolo della sua 92 Il mito dell’eroe crociato fede profondamente sentita e vissuta»44. Insomma, l’impressione complessiva è che tra i pochi cultori della memoria del cappellano prevalesse negli anni a cavallo dell’implosione del blocco orientale la tendenza a tacere della questione politica, dilungandosi viceversa sulla dimensione strettamente religiosa per plasmare ex novo una identità accettabile ai parametri della società democratica. Questa operazione risultava però, dati i trascorsi del personaggio in questione, tutt’altro che agevole, costringendo i pur volonterosi apologeti a vistosi funambolismi argomentativi e pesanti omissioni: ad esempio, nel 2000 Maria Grazia Gobbi prese spunto dalle parole di Giovanni Paolo II sui «testimoni della fede» del ventesimo secolo e dal racconto di un’anziana torinese per rievocare nel domenicano «un martire del Novecento», non riconosciuto ufficialmente come tale dalla Chiesa cattolica. Il «soldato di Cristo e della Patria», perduta ogni connotazione nazionalistica, veniva qui presentato in una luce più intima, di ricordo familiare, di santini ingialliti conservati con affetto. La giornalista ipotizzava che il mancato avvio di un processo di beatificazione andasse addebitato a «piccoli uomini dalle vedute corte», che «a suo tempo lo hanno voluto presentare come uomo di parte, ancora ad un sistema o ad un regime», e sosteneva con mons. Solero: «la figura di questo monaco-soldato, soverchiando smisuratamente le nubi dei piccoli e miserevoli rancori del fuggevole tempo, grandeggerà sempre più fino a splendere in cielo». Come aveva dichiarato il pontefice nell’incontro ecumenico del 7 maggio 2000, «il credente che abbia presa in seria considerazione la propria vocazione cristiana, per la quale il martirio è una possibilità annunciata già nella Rivelazione, non può escludere questa prospettiva dal proprio orizzonte di vita»; per la Gobbi, questa era «una prospettiva che certamente padre Reginaldo Giuliani ha coniugato ogni giorno della sua breve ma valorosa vita»45. L’autrice non faceva che riproporre uno schema usuale, per cui all’attualizzazione della figura non corrispondeva una valutazione critica della vicenda: significativo, in questo senso, il richiamo a don Solero, le cui memorie, risalenti al secondo dopoguerra, sono state pubblicate nel 2001. Ripercorrendo la propria vita, l’ecclesiastico si riferiva più volte al «fraterno amico» dal «nome eroico», «novello Savonarola» asceso al cielo con «morte gloriosa», e confessava: «quante volte ho desiderato e invocato che tornasse in questa nostra povera Patria divisa e straziata un altro padre Giuliani! Ché solo gli uomini come lui possono dire nelle ore torbide cupe la parola che ridesta, che ravviva, che rasserena e addita le vie della risurrezione ad 93 Giovanni Cavagnini un popolo sprofondato nell’abisso della morte civile»46. Il sogno di Solero e degli altri estimatori non si è concretizzato: ignoto al di fuori di una ristretta cerchia di confratelli, nostalgici e studiosi, oggi il cappellano e la sua memoria sopravvivono principalmente nella toponomastica, senza prendere corpo in rituali collettivi riconducibili a precisi complessi identitari e politici47. Nondimeno, la vicenda qui analizzata permette di cogliere, attraverso le alterne fortune degli ambienti neofascisti e neocoloniali nell’Italia repubblicana, la permanenza fino ai giorni nostri di vecchi clichés nazional-coloniali, manifestazioni di quello spregiudicato uso pubblico della storia nello smascheramento e nel rifiuto del quale risiede il valore civile della pratica storiografica48. Note al testo 1 Per una rassegna, cfr. Bibliografia ragionata del fascismo, sotto la direzione di R. De Felice, Bonacci, Roma 1991, e il più recente Dizionario del fascismo, a cura di V. De Grazia e S. Luzzatto, 2 voll., Einaudi, Torino 2002-03. In particolare, si vedano le opportune osservazioni di G. Miccoli, Fra mito della cristianità e secolarizzazione: studi sul rapporto Chiesa-società nell’età contemporanea, Marietti, Casale Monferrato 1985, pp. 112-30, e di M. Franzinelli, Il clero fascista, in Il regime fascista. Storia e storiografia, a cura di A. Del Boca, M. Legnani, M. G. Rossi, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 182-202. Su padre Giuliani cfr. M. Franzinelli, Stellette, croce e fascio littorio. L’assistenza religiosa a militari, balilla e camicie nere (1919-39), Franco Angeli, Milano 1995, pp. 249-57 ed il mio Un apostolo per «la più grande Italia». P. Reginaldo Giuliani tra mito e storia, rel. prof. M. Battini, Università di Pisa, a.a. 2007/2008, di cui qui riprendo alcuni elementi. Per il nazionalismo cattolico il riferimento rimane L. Ganapini, Il nazionalismo cattolico: i cattolici e la politica estera in Italia dal 1870 al 1914, Laterza, Bari 1970; per la mancata elaborazione in senso critico della memoria coloniale, v. A. Triulzi, Ritorni di memoria nell’Italia postcoloniale, in L’impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-41), a cura di R. Bottoni, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 573-95. 2 Cfr. P. R. Giuliani, Per Cristo e per la Patria. Ultimi scritti dall’Africa, Salani, Firenze 1937. 3 La figura e l’opera di Padre Giuliani, «La Stampa della Sera», 1 febbraio 1936; P. Giuliani è morto eroicamente in Africa Orientale, «La Gazzetta del Popolo», 1° febbraio 1936. 4 P. R. Giuliani, Gli Arditi. Breve storia dei Reparti d’assalto della Terza Armata, Fratelli Treves, Milano 1919. Cfr. Padre Reginaldo Giuliani, «Il Corriere della Sera», 2 febbraio 1936; si veda anche E. Bricchetto, La verità della propaganda. Il “Corriere della sera” e la guerra d’Etiopia, Unicopli, Milano 2004, p. 132; Padre Reginaldo Giuliani, «Il Popolo d’Italia», 2 febbraio 1936. 5 Archivio del convento di S. Domenico, Torino, Fondo Reginaldo Giuliani (d’ora in poi ACSD, FRG), lettera del generale G. Paoletti a p. C. Grosso, 2 febbraio 1936; ibid., lettera di mons. A. Bartolomasi, vescovo castrense, 2 febbraio 1936. 94 Il mito dell’eroe crociato 6 ACSD, FRG, lettera del p. E. Ibertis, provinciale, 1° febbraio 1936; «La Stella di San Domenico» (d’ora in poi «SSD»), a. XXXII, nn.2-3, febbraio-marzo 1936; L’eroica morte del p. Giuliani, «Memorie Domenicane» (d’ora in pi «MD»), a. LIII, gennaio-febbraio 1936, pp. 58-60. 7 Archivio dell’Ordinariato militare per l’Italia, Fascicolo personale del cappellano Reginaldo Giuliani, Stato di servizio. 8 P. F. Robotti, L’apoteosi del Padre Giuliani nella gloria di Roma, «SSD», a. XXXII, giugno 1936, pp. 145-48. 9 A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale. II. La conquista dell’impero, Laterza, Roma-Bari 1979, p. 537. 10 Preziosi cimeli di Padre Giuliani portati a Torino da Sua Altezza Reale il Duca di Bergamo, «MD», a. LIII, luglio-agosto 1936, pp. 260-61. 11 Si è chiusa ieri la mostra dei cimeli di Padre Giuliani, «La Gazzetta del Popolo», 14 settembre 1936. 12 Cfr. Archivio provinciale dell’Ordine dei predicatori, Torino, Albo dei visitatori della mostra dei cimeli di p. Reginaldo Giuliani medaglia d’oro – Torino. Il documento indica che le visite, iniziate nel gennaio 1937, si protrassero con regolarità fino all’estate 1943, per un totale di circa 2.300 ingressi. 13 O. Ginesi, Fede ed eroismo: p. Reginaldo Giuliani, Carroccio di G. E. R. Boschi, Milano 1936; L. Tealdy, Eroe crociato: p. Reginaldo Giuliani, 1936; C. Gennero, P. Giuliani, ardito, Mattalia, Torino 1936; A. Pozzi, Il cappellano degli arditi e delle camicie nere (p. Reginaldo Giuliani O. P.), Pinciana, Roma 1936 (2ª ed. Gasparini, Milano 1939). 14 «Civiltà cattolica», a. LXXXVII (1936), vol. 3, pp. 494-95. 15 P. R. Giuliani, Croce e spada. Alcune delle sue pagine più belle, Fedetto, Torino 1937; M. Appelius, Il crollo dell’impero del Negus, Mondatori, Milano 1937, pp. 202-03; M. Peruzzo, Dal Piave all’Isonzo con p. Giuliani, Tipografia Antoniana, Padova 1937 (2ª ed. 1938); «La Fiorita», 1937; «Realtà politica e sindacale del fascismo», a. XXI, febbraio 1937. 16 Cfr. «SSD», a. XXXIII, febbraio 1937, pp. 55 e 58; ACSD, FRG, lettera del tenente C. Dozzo, febbraio 1937. 17 Cfr. la voce Giuliani, Reginaldo, in Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Appendice I, Rizzoli, Milano 1938, pp. 676-77; Il sommergibile «Reginaldo Giuliani» varato a Taranto, «SSD», a. XXXVI, gennaio 1940, p. 17. 18 C. Trabucco, Il cappellano delle fiamme nere, Ancora, Milano 1936; «La Tribuna Illustrata», a. XLIV, 16 febbraio 1936, p. 1. 19 «SSD», a. XXXIV, febbraio 1938, p. 33; ibid., ottobre 1938, p. 285, dove si afferma che «il Duce stesso si è compiaciuto di disporre per l’acquisto del medesimo [affresco] per donarlo poi ad una scuola di Venezia, dove verrà murato». La ricerca non ha confermato questa indicazione. 20 A. Pozzi, La «Vita eroica» di p. Reginaldo Giuliani esaltata in dodici quadri di Amelia Mecherini, «MD», a. LVI, maggio-giugno 1939, pp. 154-61. 21 Il tentativo di rintracciare la collocazione fisica del ciclo pittorico non ha purtroppo dato esito positivo: unica fonte per lo studio del medesimo rimangono dunque al momento le pagine di «MD», che riproducono le composizioni nn. 1, 7, 9, 11 e 12 (a. LVI, nn. di marzo-aprile e maggio-giugno 1939). 22 Nel quinto anniversario della morte gloriosa del p. Reginaldo Giuliani medaglia d’oro, «SSD», a. XXXVII, febbraio 1941, pp. 37-40. 95 Giovanni Cavagnini 23 Cfr. «SSD», a. XXXVII, febbraio, aprile, settembre, novembre e dicembre 1941. 24 S. Riva, Il cappellano degli arditi (p. Reginaldo Giuliani), Salani, Firenze 1941; P. R. Giuliani, Il Vangelo spiegato ai miei soldati, L.I.C.E., 1941 (ed. or. Stella di San Domenico, Torino 1936); Eroi obliati. Conferenza religiosa del p. Reginaldo Giuliani, Stella di San Domenico, Torino 1941. 25 Sul film, che ebbe tepida accoglienza da parte sia del pubblico sia della critica, cfr. G. Rondolino, Roberto Rossellini, UTET, Torino 1989, pp. 59-63. 26 M. Franzinelli, Il riarmo dello spirito. I cappellani militari nella seconda guerra mondiale, Pagus Edizioni, Paese 1991 , pp. 225-26. 27 Cfr. A. Dordoni, «Crociata italica». Fascismo e religione nella Repubblica di Salò, gennaio 1944 – aprile 1945, SugarCo, Milano 1976, p. 77. 28 P. Reginaldo Giuliani sacerdote di Cristo e combattente d’Italia, «Crociata Italica», 24 gennaio 1944, p. 4. 29 F. Fidenzi, Dal cielo scende il centurione crociato, «Crociata Italica», 20 novembre 1944, p. 1. 30 P. F. Robotti, Fu Padre Giuliani fascista?, Edizione Stella di San Domenico, Torino 1946; Id., Padre Reginaldo Giuliani domenicano: conferenza commemorativa, Edizioni Stella di San Domenico, Torino 1936. 31 Archivio del Centro Culturale Diocesano di Susa, Fondo Angelo Bartolomasi, faldone 15, fascicolo 232, lettera di mons. Angelo Bartolomasi al can. Angelo Tannzella, primo gennaio 1946. 32 G. Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943-48, Il Mulino, Bologna 2006. 33 N. Labanca, Una guerra per l’impero. Memorie della campagna d’Etiopia, Il Mulino, Bologna 2005, p. 190. 34 «Il Secolo d’Italia», 22 gennaio 1956, p. 3. 35 Cfr. l’opuscolo Padre Reginaldo Giuliani medaglia d’oro nel ventennio della sua morte gloriosa, 1936-56, Tipografia A. Vinciguerra e figli, Torino 1956. 36 P. R. Giuliani, Ricordi agli italiani, a cura di p. E. Ibertis, Astesano, Chieri 1956; p. E. Ibertis, Padre Reginaldo Giuliani O.P. al bivio nella «gesta fiumana», «MD», a. LXXIII, aprile-giugno 1956, pp. 76-89. 37 P. Giuliani è ritornato in Italia, «MD», a. LXXIV, aprile-giugno 1957, pp. 97-101. 38 P. E. Ibertis, La medaglia d’oro p. Reginaldo Giuliani, soldato di Cristo e della Patria, SEI, Torino 1960. Cfr. anche Testimonianze su p. Reginaldo Giuliani O. P. medaglia d’oro, Edizioni La Stella di San Domenico, Torino 1957 e P. Reginaldo Giuliani O. P. medaglia d’oro tra i giovani, Tipografia A. Vinciguerra, Torino 1963, entrambi curati dallo stesso padre Ibertis; p. F. Robotti, Un colpo di scimitarra nemica chiudeva la vita di un apostolo, dando inizio a quella di un martire!, in Cappellani militari d’Italia 1918 – 4 novembre – 1958, pp. 27-28. 39 R. Carniello, P. Reginaldo Giuliani caduto a Passo Uarieu, «Il Secolo d’Italia», 23 gennaio 1966. 40 ACSD, FRG. Sulla visita di Haile Selassie a Torino, cfr. A. Del Boca, Il Negus. Vita e morte dell’ultimo re dei re, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 304. 41 A. Del Boca, Gli italiani in Africa orientale. IV. Nostalgia delle colonie, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 16. 96 Il mito dell’eroe crociato 42 Cfr. i cenni biografici distribuiti in occasione della funzione del 1986 in ACSD, FRG, e «SSD», a. LXXXII, dicembre 1986. 43 Ordinariato Militare per l’Italia, In pace e in guerra sempre e solo pastori, Roma 1986, p. 69. 44 O. Bovio, Sacerdoti di Marte, USSME, Roma 1993, pp. 383-90. 45 M. G. Gobbi, P. Reginaldo Giuliani, «Il Corriere di Saluzzo», 22 settembre 2000. 46 S. Solero, Ricordi di un prete soldato. Appunti e memorie autobiografiche, a cura di don G. Tuninetti, Società storica delle valli di Lanzo, Lanzo Torinese 2001, pp. 227-30. 47 Una ricognizione sistematica dello stradario nazionale ha dimostrato che delle moltissime vie e piazze intitolategli all’indomani della conquista dell’impero rimane uno sparuto drappello, formato da un paio di piazze e da una trentina di strade, concentrate perlopiù in Lombardia (dodici, delle quali sette in provincia di Milano) e nel settentrione, che vanta la grande maggioranza (oltre due terzi) delle ricorrenze. Identica sorte ha colpito il mondo della scuola, un altro dei pilastri del culto del «soldato di Cristo e della Patria»: un controllo condotto con gli stessi criteri ha rilevato che solamente otto istituti scolastici del Nord continuano a portare il nome del crociato torinese. 48 D. Menozzi, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione dei conflitti religiosi, Il Mulino, Bologna 2008, p. 13. Sulla retorica impiegata in Italia all’indomani della strage di Nassiriya (novembre 2003), si veda M. Nani, Il lutto, la nazione, la storia, in «Novecento», 10/XIII(2004), pp. 165-75. 97 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi nel Novarese durante la Grande guerra di Renzo Fiammetti Premessa Recentemente, a livello nazionale, si è acceso l’interesse sulla vicenda della prigionia di guerra in Italia durante la prima guerra mondiale, grazie al saggio di Alessandro Tortato1 che colma una lacuna tutta italiana su un tema che in altri paesi ha trovato sin dal primo dopoguerra un preciso interesse storiografico2. Nelle considerazioni che seguono si proverà a dare una prima sistemazione a questa complessa materia per quanto riguarda il Novarese, nella estensione che la provincia aveva nella prima guerra mondiale (comprendendo quindi il Vercellese, il Biellese, e il VCO) tenendo presenti le difficoltà di ricostruzione di queste vicende3. Al lavoro, fra timori e urgenza di manodopera L’impiego lavorativo di prigionieri di guerra ha un percorso complesso e tormentato, caratterizzato da una sostanziale diffidenza nell’impiego di questa manodopera, diffidenza che diviene aperto timore di pericolose collusioni e influenze dei prigionieri nemici sui contadini e che porta dopo Caporetto alla decisione di ritirare i prigionieri dal lavoro nei campi, temendo la negativa propaganda che i prigionieri – resi baldanzosi dallo sfondamento delle linee italiane – potevano esercitare sulla popolazione civile4. Nell’estate 1916, il prefetto di Novara scrive al presidente della Camera di commercio per una valutazione in merito all’impiego dei prigionieri nei lavori agricoli. L’orientamento assunto dal presidente dell’Ente camerale non è positivo, soprattutto per i problemi di sorveglianza. Esito negativo anche da una riunione in Municipio con le organizzazioni agricole5. Pochi giorni dopo arrivano a Novara i primi prigionieri nemici - diciotto soldati 99 Renzo Fiammetti austriaci feriti e catturati dagli Alpini italiani in Trentino – subito internati all’ospedale militare della città6. Sulla stampa locale compaiono i primi dettagli, frutto di una stupita curiosità verso questi uomini: la loro giovane età – «Sono giovanissimi, uno del 1897, parecchi del 1896»7 – il fatto che comprendano o meno l’italiano, con indicazioni contraddittorie – «non parlano né intendono l’italiano e non essendo famigliari agli interpreti i loro idiomi non si hanno ancora notizie sui casi loro»8, «parecchi sanno qualche cosa di italiano e riescono a farsi comprendere e a capire ciò che loro viene detto dagli altri nostri soldati»9. Un particolare colpisce i giornalisti novaresi: «Sono tutti ben vestiti e hanno dietro il berretto una pezzuola bianca che scende sul collo e che serve per farli riconoscere da lontano alle loro artiglierie per evitare che il tiro troppo corto debba colpirli confondendoli colle nostre truppe10. Una nota riguardante la loro cattura ci informa che: «Di questi diciotto uno ha ancora commesso un atto di barbarie quando era già fatto prigioniero e cioè ha lanciato una bomba contro un nostro alpino che lo aveva catturato, riuscendo a ucciderlo»11. Non abbiamo altre notizie di arrivi di prigionieri nelle settimane e nei mesi successivi. I diciotto soldati arrivati nell’estate del 1916 non dovrebbero (almeno non tutti) fermarsi nel Novarese se, all’inizio dell’anno 1917, secondo una relazione ufficiale dell’Esercito italiano, a Novara sono presenti due soli prigionieri12.Un numero che cambia quasi subito: nel marzo avviene l’assegnazione al Novarese di prigionieri destinati a lavorare nelle campagne di «Cameri, Caltignaga, Cressa, San Pietro Mosezzo, Casalbeltrame, Biandrate, Solarolo, Vespolate, ecc. Detti prigionieri han un aspetto florido e si dimostrano soddisfatti della nuova loro vita e del guadagno che loro è dato»13. E ancora: «In questi giorni dietro domande di numerosi agricoltori è giunto dal campo di concentramento del forte di Gavi un discreto numero di prigionieri austriaci che vennero adibiti ai lavori agricoli nelle nostre campagne. Ai prigionieri viene assegnato dai proprietari il vitto che è su per giù quello dei soldati e dei nostri contadini ed una paga giornaliera in ragione di centesimi venticinque all’ora»14. All’inizio di marzo 1917 arrivano anche a Vercelli i primi prigionieri destinati ai lavori agricoli: «Sono cinquanta tutti ungheresi e vengono dal Deposito della testa di ponte di Casale. Sono stati mandati nella vasta tenuta di Montoneo di proprietà dell’Ordine Mauriziano e affittato a Maggiorino Savio. Hanno uno speciale quartiere, mangiano il rancio dei soldati e percepiscono un soprasoldo. Dei cinquanta prigionieri tre caporali parlano un poco d’italia100 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi no. Vestono ancora le loro uniformi. Tutti si dimostrano contenti di essere stati destinati al lavoro che rompe la monotonia e procura loro qualche agio»15. Questa assegnazione potrebbe essere un episodio sporadico perché, ancora nelle settimane successive, vi sono le «rinnovate insistenze» del presidente dell’Associazione degli agricoltori, conte di Gattinara, per la concessione di prigionieri per i lavori in campagna16. Con il passare delle settimane, prigionieri di guerra, organizzati in Distaccamenti17 sono assegnati nelle seguenti località della provincia di Novara: Armeno, Andorno Micca, Bellinzago Novarese, Biandrate, Bianzé, Biella, Bioglio, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casalgiate (frazione di Novara), Casalino, Castellazzo Novarese, Cervarolo, Costanzana, Cressa, Fontanetto Po, Formigliana, Granozzo, Grignasco, Lamporo, Livorno Ferraris (allora Livorno Vercellese), Miagliano, Nonio, Novara, Oleggio, Palazzolo, Pertenengo, Ponzana, Ronsecco, San Pietro Mosezzo, Sali Vercellese, Salussola, San Germano Vercellese, Santhià, Solarolo, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Tricerro, Trino Vercellese, Tronzano Vercellese, Vicolungo, Vercelli e Vespolate18. Impiegati soprattutto in lavori agricoli, i prigionieri sono rinchiusi in locali nelle cascine, sotto sorveglianza militare: a Casalbeltrame alla cascina Bosco; a Biandrate alla cascina del Conte; a Caltignaga nella cascina Boscale, nei magazzini posti sopra alle case dei contadini italiani19; a Bellinzago alla Badia di Dulzago; a Trino alle cascine Ramezzana, Lucedio e Leri. A Livorno Ferraris nella cascina Spinola; alla regione Brianco a Salussola; alla cascina Stroppei a Tronzano; a Vicolungo probabilmente alla tenuta Gargarengo; alla cascina Rovellina a Tornaco. A Cameri nel marzo 1917 arriva un primo gruppo di 25 prigionieri, assegnati alla tenuta Bonacossa all’Argine per essere «occupati nei lavori agricoli»20; e segue poi un altro gruppo più consistente – 40 uomini – alloggiato, almeno in un primo momento, addirittura nel Municipio del paese. Nell’estate 1919 vengono raccolti alla cascina Montimperiale «circa 200 prigionieri ungheresi che si trovavano qua e là per lavorare nelle campagne»21 e che ora vengono ritirati per lasciare il posto «ai nostri contadini disoccupati». «Quantunque trattati meglio dei nostri soldati sono tristi e demoralizzati perché essendo obbligati a far nulla non sanno come passare la giornata. Sospirano perciò il momento che, conclusa la pace, possano tornare nella loro patria! Noi auguriamo che presto il loro desiderio venga soddisfatto». A luglio i prigionieri sono trasferiti alla Mandria, tenuta agricola vicino Torino: «Essi, che continuamente chiedevano se la pace 101 Renzo Fiammetti coll’Austria fosse firmata, sperano di presto rivedere la propria famiglia: il che noi loro auguriamo cordialmente»22. Alla data del 19 aprile 1918 sono presenti nel Novarese 2.630 prigionieri di guerra, assegnati a lavori agricoli23, numero certamente da aumentare per arrivi successivi, come ad esempio quello di oltre mille prigionieri che in novembre, a guerra finita da poche ore, arrivano a Vercelli; e perché l’impiego nei lavori agricoli non è esclusivo. Non sono destinati a lavori agricoli i cinquanta prigionieri inviati a Biella, nel giugno 1917 «accasermati nella palestra di via Arnulfo, (e che) saranno collocati negli stabilimenti industriali, dietro richiesta»24. Nel gennaio 1919 la Commissione provinciale di agricoltura propone «all’autorità competente il ritiro dei prigionieri per assicurare occupazione alla manodopera locale, ritiro che avviene gradualmente onde evitare perturbazioni nelle aziende e sarà iniziato nei Comuni dove già si verificano casi di disoccupazione»25. L’impiego dei prigionieri causa acute polemiche sindacali. Tra l’estate del 1917 e la primavera del 1918 i socialisti vercellesi denunciano un impiego disinvolto della manodopera dei prigionieri nemici, invece di manodopera locale. Prigionieri usati anche come arma di ricatto sindacale da parte dei padroni: «Anche dove non apparirà la disoccupazione la presenza di troppi prigionieri servirà magnificamente ai padroni per deludere le richieste di quegli aumenti di paga che nei tempi in cui viviamo sono addirittura indispensabili»26. Denunce che sono riprese anche al Congresso dei lavoratori della terra, che si tiene a Milano dall’8 al 10 ottobre 1917, quando si evidenzia che i prigionieri sono richiesti dagli agricoltori non perché «mancanti di altra manodopera ma per far ribassare la paga ai lavoratori locali»27. Denunce che coinvolgono, nell’autunno 1918, anche i socialisti novaresi che definiscono la manodopera dei prigionieri come una sorta di calmiere «della paga non certo rispondente agli aumentati bisogni e al reale aumento del costo della vita»28. Storia di un soldato Le vicende biografiche dei singoli prigionieri internati nel Novarese sono di difficile ricostruzione e non strettamente funzionali al presente lavoro. Ma, anche solo a titolo di esempio, una vicenda esemplare possiamo narrarla: quella del caporale Simon Dank. 102 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi Simon Dank nasce nel 1892 nel villaggio ungherese di Kozsa, nella provincia di Hunyand. Figlio di Simon e di Marie, è di professione contadino e non è sposato. Arruolato, diviene caporale del 64° reggimento. Impiegato sul fronte italiano, il 24 maggio 1917 è catturato dagli Italiani a Medeazza, durante la decima battaglia dell’Isonzo29. Internato nel campo di concentramento di Avezzano (L’Aquila) è trasferito – forse transitando dal forte di Gavi o da Casale Monferrato - a Casalbeltrame e inquadrato nel Distaccamento omonimo alla cascina Bosco. All’alba del 31 dicembre 1918 Simon Dank muore – probabilmente di spagnola – e viene sepolto nel cimitero del paese, dove si trova ancora oggi; accanto a lui riposa il commilitone Paul Zabulotny, un anziano soldato di 43 anni, vedovo, originario della Galizia e deceduto a Casalbeltrame il 28 luglio 191930. Ma la vicenda del caporale ungherese Dank non si arresta qui: quando nel 1943 si procede a un censimento dei caduti austroungarici in Italia, per il Novarese, alla voce «Casalbeltrame» si annotano due caduti, un ukraino (Zabulotny) e un romeno (Dank). Era accaduto che dopo la guerra il villaggio di Kozsa (anche conosciuto con il nome tedesco di Koseln) si ritrovasse in territorio romeno, assumendo il nome di Coaja mentre la provincia diventava Honedoara. Oggi Coaja, piccolo villaggio di meno di 150 persone, è parte del Comune di Vorta31. Prigionieri, comunità e uso pubblico della storia L’attenzione che la stampa novarese dedica ai prigionieri di guerra inizia con una sorta di interesse curioso, per poi trasformarsi quasi in una normale cronaca e divenire – soprattutto durante e dopo i giorni drammatici di Caporetto – sospettosa e ostile. Una evoluzione che trova motivazione con il protrarsi della guerra, con l’aumento dello sforzo militare e umano italiano, con le notizie che iniziano a giungere – spesso drammatiche – dei prigionieri italiani internati in Austria o in Germania e che – quasi inevitabilmente – si riflettono sull’attenzione che hanno – in Italia – i prigionieri nemici. Chiaro è l’invito che viene rivolto alla popolazione novarese dopo Caporetto su come considerare i prigionieri nemici: «Non bisogna creder loro e tantomeno trattarli con confidenza. Sono anch’essi nemici nostri implacabili appartenenti a stati violatori di ogni principio di onestà e giustizia, in guerra quasi con tutto il mondo e da quasi tutto il mondo odiati ed esecrati [. . .]. Essi maltrattano iniquamente i nostri poveri fratelli ca103 Renzo Fiammetti duti nelle loro mani e lasciati senza cibo e ricovero sufficiente mentre qui i loro prigionieri sono trattati come noi e meglio di noi [. . .]. Non prestate adunque orecchio agli inganni dei tedeschi che non hanno mai fatto nulla di buono per noi e molto male sempre [. . .]. Attenti dunque, state bene in guardia contro i prigionieri che non potendo più fare la guerra con le armi, la continuano a fare con ogni sorta di raggiri e inganni [. . .]. Perché quando, finita la guerra, ritorneranno alle loro case diranno, ridendo alle vostre spalle, di non aver trovato gente più credenzona e balorda dei contadini italiani. State dunque in guardia»32. Ma cosa accadeva, dunque, di così pericoloso? «Ci si dice, e stentiamo a crederlo, che in qualche posto si siano organizzate fra i prigionieri e le nostre forosette delle allegre danze che sarebbero una atroce offesa al sentimento di dignità del nostro popolo»33. E ancora: «Si era giunti a questo che qualche contadino aveva imparato a cantare – naturalmente senza capirlo – l’inno tedesco Deutschland über aller! L’inno della superbia tedesca che aspira ad assoggettare il mondo ponendo la Germania sopra tutto»34. Che fraternizzasse o meno, la popolazione civile non sembra particolarmente ostile ai prigionieri nemici. Probabilmente riconosce in quei soldati ciò che anche loro sono, cioè povera gente dedita al duro lavoro della terra. Una accondiscendenza che viene criticata dalla stampa borghese, che – soprattutto dopo Caporetto – teme la presenza nelle campagne di così tanti prigionieri nemici a contatto con l’«ingenua coscienza popolare»35. Una stampa che si affretta a denunciare addirittura «la curiosità morbosa» o la «malintesa pietà» che spinge le donne («brave donnette» ironizza la «Sentinella novarese»36) a usare «riguardi» ai prigionieri. Più inclini a vedere nei prigionieri degli uomini, dei contadini più che dei nemici è la stampa socialista, che – ad esempio – stigmatizza, nel dicembre 1918, la morte in solitudine del soldato Gregor Samilo, avvenuta a Sali Vercellese37. Ancora un esempio di pietà umana dei civili verso i prigionieri è dato dall’arrivo a Vercelli, nel novembre 1918, di 1.208 prigionieri di guerra «destinati alle nostra campagne»38. Hanno un «aspetto pietoso: pallidi, magri, disfatti dalla mancanza di alimenti e dalle fatiche, con l’occhio smarrito, cadenti, sudici e con le uniformi a brandelli, parecchi senza camicia». Alloggiati alla caserma Umberto I e alla Cavallerizza, sono «rifocillati con una minestra di riso e molti confessavano che non ricordavano da quando ne avessero mangiato … Il loro stato mosse a pietà molta gente che dava loro, al passaggio, pane e qualche soldo. È il cuore del nostro popolo così diverso da 104 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi quello dei nostri nemici». La permanenza a Vercelli di questo grosso contingente di prigionieri dura solo una notte, alla mattina successiva il loro arrivo lasciano la città «diretti ai vari paesi ed a tenute del nostro circondario, salvo un centinaio mandati a Salussola39, dove saranno adibiti a lavori di bonifica della baraggia». Un accenno alla vicenda dei prigionieri nemici a Granozzo si trova nelle pagine di Dante Graziosi. «I prigionieri ungheresi erano brava gente che simpatizzava coi paesani»40, mentre a Trino Vercellese nasce addirittura una canzone popolare41; un canto composto da alcune mondine che hanno udito – alla cascina Ramezzana – i lamenti di un prigioniero malato e – come tale – incapace di lavorare, e per questo maltrattato da un ufficiale italiano. Senza comprendere il significato delle implorazioni del prigioniero, non conoscendone la lingua, le donne gli attribuiscono sentimenti universali di attaccamento alla madre e alla terra natìa, con un canto «carico di una pietà antimilitarista e internazionalista»42. Riportando la testimonianza di una delle mondine di Trino, Carolina Zorni, il testo di Castelli, Jona e Lovatto specifica che «questi prigionieri assegnati ai lavori agricoli non avessero sovente di che sfamarsi e come spesso le mondine facessero finta di niente e gli gettassero del pane e riuscissero a fargli avere altri cibi»43. Fuga È connaturata alla condizione di prigioniero il tentare di fuggire. Così tentano la fuga i prigionieri internati nel Novarese, ma non solo: nella provincia sono catturati prigionieri evasi da campi situati anche in altre regioni d’Italia. I primi casi documentati sulla stampa novarese sono del 1917. Il primo riguarda la fuga di Marco Iskovic, soldato catturato dagli italiani a Plava il 26 giugno 1915. La sera del 24 maggio abbandona Salussola «ove era impegnato nei lavori agricoli» ma è arrestato alla Colma di Civiasco da due Guardie di Finanza e dal Messo del Comune44. Di pochi giorni successivi è la fuga da Cozzo, località della Lomellina in provincia di Pavia, del sergente Francesco Bohner, di Vienna, e del soldato Giuseppe Ichnida, galiziano. Fuggono insieme indossando divise italiane, e insieme sono ripresi a Cravagliana, nel mandamento di Varallo. Fermati da due civili, sono rifocillati, poi consegnati ai carabinieri e da questi condotti al Distretto militare di Alessandria45. Sempre in giugno si verifica la fuga, quasi grottesca per l’esito, di tre soldati – il caporale Lajos Tots e gli appuntati Joinos Pill 105 Renzo Fiammetti e Laizlo Oeres – fuggiti da Grignasco dove lavorano alla cava di pietrisco Negri, insieme ad altri 27 prigionieri. Scoperta la fuga «i carabinieri si son dati alla ricerca per tutta notte su per il Fenera perché così opinione pensava che l’unica strada della fuga potrebbe essere la via un po’ nascosta dei boschi. Invece i tre poveri diavoli vennero arrestati verso le ore 3 di martedì nei pressi del Rondò di Bornate dal brigadiere Bossi e da due carabinieri, tutti inzuppati d’acqua e pieni di freddo [. . .] e di alto stupore perché avendo guadato il Sesia così come è alto ora, credevano proprio di aver attraversato l’Isonzo e di trovarsi in Austria!»46. Nell’agosto dello stesso anno, vengono ripresi tre prigionieri di guerra evasi dalla tenuta Leone a Balocco. Due di loro sono catturati al passo del monte Moro, a pochi metri dal confine con la Svizzera, a Macugnaga; uno in località Cuarazza, sempre a Macugnaga47. Ancora nelle valli ossolane, a Formazza, nello stesso periodo è catturato, in abiti borghesi, un disertore boemo48, mentre alcuni giorni dopo, a Ceppomorelli, i carabinieri di Bannio Anzino catturano tre sergenti e un caporale evasi insieme da un campo a Pavia49. Più avventurosa appare la vicenda del cadetto Giovanni Dengl e del tenente Stefano Bernald e di un terzo ufficiale di cui non conosciamo il nome, evasi dal campo di concentramento di Pélago, vicino Firenze e ripresi il primo a Cannobio, il secondo a Trarego mentre non sembra certa la cattura del terzo, anche se probabile50. In ottobre sono il caporale Jonas Zolmai e il soldato Giorgio Gorgio a essere catturati a Cuzzago dai carabinieri di Ornavasso. Sono evasi da Cervarolo dove si trovano internati e impegnati «pel taglio dei boschi»51. Da Vigevano fugge invece Carlo Pollach, che viene bloccato da un civile a Vagna – in Ossola – mentre cerca di raggiungere il confine svizzero, e consegnato poi ai carabinieri che lo riportano a Vigevano52. Nel 1918 gli ultimi casi di fuga dei quali siamo a conoscenza. Nel marzo sei prigionieri appartenenti ad un gruppo «comandato ai lavori agricoli» si allontanano dalla cascina Cortenuova al Torrion Quartara sobborgo di Novara, «ma per breve tempo rimasero liberi, poiché vennero riacciuffati nei pressi di Vercelli»53. Poi la vicenda del soldato ungherese Billo Boio che, in una mattina di agosto dello stesso anno, è sorpreso a vagare alla stazione di Arona in cerca di un treno per la Svizzera, dopo la fuga da una cascina di Bellinzago (probabilmente la Badia di Dulzago) dove è addetto ai lavori agricoli54. Infine, la fuga di quattro prigionieri occupati nella ditta Poma di Miagliano, nel circondario di Biella. Tre sono arrestati, del quarto non abbiamo notizia55. 106 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi Morte Allo stato attuale della ricerca, risultano deceduti in provincia di Novara, dalla primavera 1917 all’inizio del 1920, 151 prigionieri di guerra, quasi tutti appartenenti all’esercito austro-ungarico. La morte dei prigionieri di guerra si lega indissolubilmente con la devastante epidemia di influenza spagnola, che colpisce il Novarese come il resto del territorio italiano, e il mondo, tra la fine dell’estate 1918 e l’inizio della primavera 1919: infatti, tra l’ottobre 1918 e il marzo 1919, si colloca il 76 per cento del totale dei decessi di prigionieri nel Novarese56. Per un approfondimento, si veda l’elenco – parziale – dei soldati deceduti in prigionia, riportato di seguito in appendice, raggruppati per Comune. Si riportano anche le annotazioni relative ai documenti rinvenuti a Vienna e quelli che si è potuto reperire nei singoli comuni, evidenziando le concordanze e le dissonanze fra le due fonti. Appendice Armeno (di questi nominativi si è trovata traccia all’Osterreichisches Staatsarchiv di Vienna, non risultando riscontri al Registro dei morti del Comune di Armeno e neppure nei Registri parrocchiali. Per Imre Birkas, nei documenti austriaci, si fa riferimento al decesso avvenuto all’ospedale da campo 74): Kyrylo Vazar (1876-1919), Karl Kerber (1896-1919), Josef Freisthube (1889-1919), Imre Birkas (1893-1919), Emil Aspeck (1875-1919), Mijo Antolovic (1881-1919). Bellinzago Novarese (non risultano documenti a Vienna; vedi iscrizioni al Registro dei morti del Comune): Eduard Benisch (1897-1918), Gyorgy Brynzas (1879-1918). Biandrate (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Danilo Danyluk (1886-1918). Bianzé (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Imric Modilka (1891-1918), Johan Oberauer (1897-1918), Nikolas Schanen (1892-1918). Biella (concordanza fra i documenti austriaci e quelli del Comune di Biella, conservati all’Archivio di Stato della città): Alessandro Nagy (1893-1918), Nicola Pisanjc (1878-1919), Velicko Miscevic (1898-1919), Mita Jovanof (1895-1919), Vlada Zsivanov (1877-1919), Stefans Franzio (1900-1919), Franz Sterle(1880-919), Osvald Max Lohor (1884-1920). Bioglio: (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Tragott Tschurtschentaller (1894-1919). Casalbeltrame (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Simon Dank (1892-1918), Paul Zabulotny (1876-1919). Casalino, frazione Cameriano (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Josef Storch (1895-1918). Casalino, frazione Ponzana (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei 107 Renzo Fiammetti morti del Comune): Josef Pichler (1890-1918). Costanzana (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Teodoro Gall (1889–1918), Mathias Novak (1895-1918). Castellazzo Novarese (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Carlo Lamb (1887-1919). Fontanetto Po (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Johann Findeis (1890-1918), Josef Blaha (1884-1918). Granozzo con Monticello (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Franz Ihuschha (1895-1918). Lamporo: (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune) Marton Kotka (1883-1918). Livorno Ferraris (non risultano documenti a Vienna, dati ripresi dal Registro dei morti del Comune): Peter Benedik (1897-1918), Franz Srebe (1895-1918), Matheas Walder (1894-1918). Nonio (di questo nominativo si è trovata traccia all’Osterreichisches Staatsarchiv di Vienna, non risultando riscontro al Registro dei morti del Comune di Nonio. Il documento austriaco fa riferimento al decesso avvenuto all’ospedale da campo 94): Leopold Amon (1883-1919). Novara (i documenti austriaci attestano, in modo errato, 53 decessi invece di 76, come indicano i documenti dell’Archivio storico del Comune di Novara, conservati all’Archivio di Stato di Novara): Michael Petricevich (morto nel 1917), Nikolas Herlea (1896-1917), Momin Loic (1896-1917); Albrecht Binder (1897-1917), Josef Finster (1898-1918), Johann Zsurka (18861918), Stefan K. Kovcs (1885-1918), Johann Szakal (1878-1918), Wilhelm Berndt (18731918); Aron Miklos (1889-1918); Ludvig Eisler (1873-1918), Mathias Lovretic (1890-1918), Franz Kovacic (1886-1918), Dimitrio Ikluk (1894-1918), Stefano Laukoski (1897-1918), Johan Olbrycht (1886-1918), Frovid Favid (1892-1918), Michael Gruber (1895-1918), Peter Flavig (1891-1918), Joseph Polak (1889–1918), Anton Posch (1880-1918), Martin Chujel (1893-1918), Istvan Csordaz (1890-1918), Johann Zalmai (1891-1918), Stefano Zakarecz (1893-1918), Iosef Kostal (1892-1918), Johan Mayerhofer (1891-1918), Florian Pichler (1891-1918), Georg Dmitrak (1881-1918), Tomas Ofner (morto nel 1918), Iures Restovri (1882-1918), Franz Herdely (1885-1918), Rudolf Appelt (1897-1918), Franz Kakusci (18951918), Herman Schattltustuer (1890-1918), Martin Chermerl (1892-1918), Josep Stiblachier (1882-1918), Osvald Klamminger (1881-1918), Joseph Barzylak (1891-1918), Joseph Hipeszsuk (1889-1918), Gregor Aldrian (1894-1918), Joseph Ladik (1895-1918), Franz Pravec (1882-1918), Joseph Wild (1894-1918), Karl Berut (1898-1918), Joseph Gloss (1896-1918), Joseph Charner (1883-1918), Michael Cril (1895-1918), Stefano Kolmar (1894-1918), Janos Meszaros (1883-1918), Istvan Kafin (1893-1918), Johan Kosak (1886-1918), Franz Vitik (1883-1918), Gottfried Albrecht (1896-1918), Jusup Dellemustafic (1898-1918), Joseph Turner (1894-1919), Demeter Butkovan (1894-1919), Josef Ignatic (1875-1919), Jvan Semenec (1881-1919), Michal Stantediecz (1883-1919), Onofry Burtak (1873-1919), Laslo Eipurs (1892-1919), Johann Vukota (1888-1919), Stefan Romanof (1889-1919), Georg Zapotognii (1885-1919), Mikal Holongrega (1877-1919), Peter Prohopjnk (1899-1919), Dimetro Bojeziuk (1889-1919), Procop Makara (1884-1919), Ivan Koval (1882-1919), Wilhelm Prasse (1899-1919), Georg Kinaz (1881-1919), Petro Serdanovic (1890-1919), Jurko Gjarchi (18891919), Paolo Codul (1897-1919), Nickola Butta (1889-1919). Oleggio (non risultano documenti a Vienna; vedi iscrizioni al Registro dei morti del Comune): Giovanni Dabnischki (1883-1919). Sali Vercellese (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Johann Boiczuk (1891-1918), Johann Czajkz (1883-1918), Gregor Samilo (18931918). Salussola (non risultano documenti a Vienna ; vedi iscrizioni al Registro dei morti del Comune): Ivan Martinovic (1882-1919), Paolo Milic (1879-1919), Wlata Rodavanaio (1884-1918). San Germano Vercellese (non vi è concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Regi- 108 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi stro dei morti del Comune. Secondo i documenti rinvenuti a Vienna il soldato risulta sepolto al «2 recinto, quadro 2 del Cimitero nuovo»): Bela Ney (1885-1918). Santhià: (tale nominativo appare nei documenti austriaci): Casem Gerbovelka (morto nel 1919). San Pietro Mosezzo (tale nominativo appare nei documenti austriaci nulla risultando al Registro dei morti del Comune. Il soldato Tagas, secondo Vienna, è sepolto nel cimitero della frazione Mosezzo «distinto con una lapide in marmo con sopra le generalità sopraindicate»): Jacob Tagas (morto nel 1918). Trecate (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune, cambia solo il nome: per il Comune Sandor, per Vienna Alex) Alex Lukacs (1876-1919). Trino Vercellese (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune, ad eccezione del nominativo di Wasul Nyegru rinvenuto solo nel registro dei morti del Comune): Wasul Nyegru (1884-1918), Peter Gaina (1881-1918), Georg Ercussin (18791918), Azente Florea (1898–1918), Peter Ivanutz (1890–1918), Laszlo Pascha (1888-1918), Vassilie Fogisch (1879-1918), Giovanni Faratz (1877–1919). Tornaco (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Janos Vaina (1895 – 1918). Tronzano Vercellese (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Johann Krubert (1892- 1918). Vercelli (concordanza fra i documenti austriaci e l’iscrizione al Registro dei morti del Comune): Johann Mittermayer (1894-1918), Jon Marika (1888-1918), Martin Paprotzky (1890 – 1918), Alfred Jaksck (1893-1918), Josef Gaiger (1894-1918), Michal Prystajko (1898-1918), Josef Muller (1896-1918), Luka Kraisnik (1875-1918), Jan Novotny (1895-1918), Janos Kiovrig (1894-1918), Mata Bosanchic (1891-1919), Antonio Iachsie (1891-1919), Karl Brandl (1889- 1917), Peter Perchtold (1894- 1918), Otto Wranovscky (1893- 1918), Borisav Sargnac (1898-1919), Simon Vreco (1880–1918). Vicolungo: (nulla risulta al Registro dei morti del Comune, indicazione solo nei documenti conservati a Vienna): Michele Melnicky (1886-1918). Note al testo 1 Alessandro Tortato, La prigionia di guerra in Italia 1915-1919, Mursia, Milano 2004. Il saggio di Tortato è quanto di più sistematico e scientificamente fondato su una solida base documentale esista in Italia, ad oggi, sul tema, e vi faremo ampio ricorso per le note che seguono. Un testo, quello di Tortato, che si affianca al saggio di Giovanna Procacci (Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra. Con una raccolta di lettere inedite, Bollati Boringhieri, Torino 2000) sulle vicende dei prigionieri italiani in Austria e Germania. Successivamente al saggio di Tortato, è apparso lo studio di Giovanni Re (Prigionieri dimenticati. Cellelager 1917-1918. Mursia, Milano 2008) tratto dalle memorie di un ufficiale italiano – Niccolò Nicchiarelli – internato nel Gefangenenlager di Celle, nei pressi di Hannover. A questi studi fanno da corollario contributi locali (ricordati nel testo di Tortato e apparsi anche in anni meno recenti) che hanno il merito contestualizzare il tema della prigionia tedesca e austro-ungarica in Italia nelle singole comunità. È il caso del saggio di Pierangelo Petronio (Caduti e dispersi di Riva Ligure 19151918, prigionieri di guerra Austro- Ungarici deceduti nel Circondario e profughi di guerra veneti accolti nel nostro Comune, Riva Ligure 2000) che affronta anche il tema dei profughi dal Veneto invaso; mentre si deve ricordare il saggio di Giuseppe Agnelli (L’ecatombe dell’isola dell’Asinara, Biancardi, Lodi 1961) come una sorta di antesignano delle ricerche sul tema della prigionia in 109 Renzo Fiammetti Italia durante la Grande guerra, anche per aver affrontato il tema dell’internamento dei prigionieri austriaci all’Asinara, che ebbe esiti drammatici. Va citato inoltre Giorgio Migliavacca (Prigionieri di guerra in territori italiani durante la prima guerra mondiale, Pavia 1982) così come il successivo contributo di Enzo Maccalini e Lucio Losardo (Prigionieri di guerra ad Avezzano, a cura dell’Archeoclub d’Italia, sezione della Marsica, Avezzano 1996). Non va dimenticato – infine – quanto si è pubblicato sul prigioniero di guerra più famoso che l’Italia ospita, il filosofo Ludwig Wittgenstein, prigioniero a Cassino, come recita il titolo omonimo del libro di Franz Parak (Wittgenstein prigioniero a Cassino, Armando, Roma 1978). 2 Sul versante francese e tedesco, la saggistica sul tema data da più tempo, come ricorda Tortato, con Georges Cahen Salvador (Les prisonniers de guerre: 1914-1919, Payot, Paris, 1929) Wenzel Wosecek (Kriegsegefangen und entflohen. Erlebnisse in italienischer und franzosischer Gefangenschaft nacherzahlt von Erich neugebauer, Jasper, Wien 1918.) e Hans Weiland (In Feindeshand, Wien, 1931); più recente è il saggio di Joel Kotek e Pierre Rigoulot (Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio: 1900-2000, Mondadori, Milano 2001) che legge l’universo concentrazionario come una sorta di denominatore comune della storia del Novecento. 3 Una fonte, inaspettata, riguardo la vicenda dei prigionieri di guerra austro-ungarici e tedeschi nel Novarese è la stampa locale, abbastanza ricca di notizie su questa vicenda, in particolare con articoli e annotazioni alle Rubriche di Stato civile. Altra fonte i Registri di morte dei Comuni in cui morirono prigionieri là internati: a tale riguardo va segnalata la difficoltà di accesso a questi riscontri, non sempre agevole per sofismi burocratici e anche perché non si dispone preventivamente di un elenco completo delle località di internamento, dovendo quindi procedere per tentativi successivi; in molti casi le istanze alle amministrazioni comunali hanno dovuto attendere mesi per essere evase e in qualche caso non sono state evase per nulla; anche per resistenze a fornire i dati richiesti (assolutamente pubblici per legge). A Vienna si sono consultati i documenti conservati all’Osterreichisches Staatsarchiv, in merito ai prigionieri deceduti nel Novarese (e Vercellese, essendo i documenti risalenti al 1943 ed esistendo a quella data la nuova provincia di Vercelli), riscontrando significative lacune. Nulla riguardo ai prigionieri tedeschi nel Novarese risulta al Bundesarchiv di Friburgo, ma va ricordato che durante la seconda guerra mondiale l’archivio dell’esercito tedesco, allora collocato a Potsdam, fu distrutto da un bombardamento aereo alleato nel 1945. Rispetto ai nominativi di soldati tedeschi sono in corso verifiche negli archivi berlinesi. Indichiamo qui anche una prima nota di sintesi sulla storiografia più generale sulla prima guerra mondiale. È di recente pubblicazione La prima guerra mondiale, a cura di Stéphane Audoin- Rouzerau e Jean Jacques Becker, 2 voll., Einaudi Torino, 2007, (ed. italiana a cura di Antonio Gibelli). È stato riproposto anche lo studio di Mario Insenghi e Giorgio Rochat, La Grande guerra, 1914-18, Il Mulino, Bologna, 2008, mentre del solo Isnenghi continua a essere ripubblicato Il mito della Grande guerra, Il Mulino, Bologna, VI ed., 2007. Di recente proposta, è invece il saggio di Emilio Gentile, L’apocalisse della modernità. La Grande guerra per l’uomo nuovo, Mondadori, Milano 2008. Non recenti ma importanti per i temi trattati: Antonio Gibelli, L’officina della guerra. La Grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Bollati Boringhieri, Torino 1991; Enzo Forcella, Alberto Monticone, Plotone d’esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Laterza, Bari 1968 (nuova edizione riveduta 1998). Di Antonio Gibelli ricordiamo anche La Grande guerra degli italiani 1915- 1918, Rizzoli, Milano, 1998. Mentre, per parte austriaca, citiamo la ripubblicazione delle cronache della giornalista Alice Schalck, prima donna inviata di guerra (Isonzofront, Libreria editrice goriziana, Gorizia 2003). 4 Se la questione si pone già nell’estate del 1915, è soltanto quasi un anno dopo – nel maggio 1916 – che vengono diramate le prime norme per l’impiego dei prigionieri di guerra in lavori agricoli e industriali, prevedendo l’impiego degli stessi in gruppi non inferiori alle cento unità, con scorta di un ufficiale e ventiquattro soldati. A chiedere per primi i prigionieri di guerra 110 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi sono i proprietari terrieri per i lavori di mietitura; si formano così le prime 32 compagnie composte, ciascuna, da duecento prigionieri . Le domande di impiego di associazioni di agrari o singoli imprenditori vengono vagliate dalle Commissioni provinciali di agricoltura e poi giungono alla Commissione per i prigionieri di guerra. Con l’inizio del 1917 aumentano, in tutto il Paese, le domande di impiego dei prigionieri, la cui forza lavoro impiegata ammonta a duemila distaccamenti per complessivi 80mila uomini. Per queste considerazioni generali cfr. Alessandro Tortato, La prigionia di guerra in Italia cit., pp.100-1; Giovanna Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra cit., p. 223. 5 «L’Azione novarese», n. 50, 20 giugno 1916. 6 «Gazzetta di Novara», n. 1.922, 15-16 luglio 1916. 7 «Corriere di Novara», n. 56, 15 luglio 1916. 8 «Gazzetta di Novara», n. 1.922, 15-16 luglio 1916. 9 «L’Azione Novarese», n. 57,14 luglio 1916. 10 «Corriere di Novara», n. 56, 15 luglio 1916. 11 «L’Azione Novarese», n. 57, 14 luglio 1916. 12 Alessandro Tortato, La prigionia di guerra in Italia cit., p. 30. La relazione, pubblicata nel saggio di Tortato, è datata 3 gennaio 1917 e viene redatta dalla Commissione prigionieri di guerra, presieduta dal generale Spingardi. Complessivamente, secondo tale relazione, alla data del primo gennaio 1917 in Italia sono internati 79.978 prigionieri, così distinti: 1.633 ufficiali, 332 aspiranti e cadetti, 78.013 uomini di truppa. I due prigionieri presenti a Novara sono uomini di truppa. Secondo quanto indicato da Tortato (p.33) la cifra – detratti 16mila prigionieri consegnati ai francesi e 7mila deceduti all’ Asinara – corrisponde all’effettivo numero dei prigionieri catturati dall’esercito italiano nel periodo 24 maggio 1915 - 31dicembre 1916. 13 «Gazzetta di Novara», n. 1993, 31 marzo - 1° aprile 1917. 14 Gazzetta di Novara», n. 1996 , 11-12 aprile 1917. Secondo la Raccolta delle disposizioni di carattere permanente relative ai prigionieri di guerra e ai disertori del nemico dell’agosto 1918 (pubblicata in appendice a Alessandro Tortato, La prigionia di guerra in Italia cit., p. 204 e seguenti) la paga giornaliera del prigioniero in caso di lavori per amministrazioni pubbliche è fissata in centesimi 5, nel caso di lavori per conto di privati «la mercede di ogni ora di lavoro dovrà essere stabilita in misura corrispondente a quella degli operai liberi, per le stesse quantità e qualità di lavoro, tenendo però debito conto dei diversi elementi negativi che tendono a diminuire l’effettivo rendimento dell’opera dei prigionieri, quali sarebbero le limitazioni dipendenti dalla necessità di sorveglianza, il minore spirito di collaborazione e, soprattutto, la mancanza nei prigionieri dello stimolo dell’interesse, atto ad eccitare la produzione». 15 «La Sesia», n. 29, 10-11 marzo 1917. Il nome corretto della tenuta è Montonero e non Montoneo. 16 «La Sesia», n. 47, 24 aprile 1917. 17 A livello nazionale, proprio con l’inizio del 1917 come abbiamo visto, si assiste a un aumento delle domande per l’impiego dei prigionieri di guerra nelle mansioni più diverse, non solo agricole, e vengono organizzati duemila distaccamenti con complessivamente 80mila prigionieri impiegati nei campi, nelle miniere, nelle fabbriche, in lavori pubblici. Anche in mansioni attinenti – indirettamente – le operazioni militari, come lavori nelle immediate retrovie del fronte. L’articolazione dei distaccamenti di regola prevede – come già visto – cento prigionieri per ogni reparto, numero riducibile a un minimo di trenta se funzionali a particolari esigenze agricole. Cfr. Alessandro Tortato, La prigionia di guerra in Italia cit., pp. 103-4. 111 Renzo Fiammetti 18 Si conferma che si tratta di un elenco probabilmente incompleto. 19 Questa indicazione è stata fornita dall’impiegato comunale di Caltignaga, signor Brustia che ricorda racconti che gli facevano la nonna e la zia, ragazze del 1899 e del 1900 che, negli anni della guerra, abitavano nella cascina Boscale. 20 «Il Camerese», n. 12, 25 marzo 1917. 21 «Il Camerese», n. 17, 26 aprile 1919. Per come viene data la notizia, ipotizziamo che a Cameri si raccolgano non soltanto i prigionieri del paese ma anche quelli di località vicine. È ipotizzabile che, ad esempio, vi si raccolgano i prigionieri internati a Bellinzago. 22 «Il Camerese», n. 31, 2 agosto 1919. 23 Lettera del ministro dell’Agricoltura al presidente della Deputazione provinciale di Novara del 19 marzo 1918 in: Archivio di Stato di Novara, Fondo Provincia di Novara, busta 2003. A livello nazionale, alla data del 6 aprile 1918, sono 130mila i prigionieri impiegati in lavoro in Italia, di cui 60mila in agricoltura. Cfr. Alessandro Tortato, La prigionia di guerra in Italia cit., p. 108. 24 «Il Biellese», n. 49, 28 giugno 1917. 25 «Gazzetta di Novara», n. 3, 11-12 gennaio 1919. Questo dovrebbe essere l’ultimo atto della presenza dei prigionieri di guerra nel Novarese, comunque la permanenza degli stessi in provincia si protrae ancora per mesi. Infatti il rimpatrio – a guerra terminata – dei prigionieri è lungo e complesso. Basti ricordare che l’Ufficio prigionieri di guerra dell’Esercito italiano (la nuova denominazione assunta dalla Commissione prigionieri di guerra) viene soppresso solo il 20 agosto 1920 «avendo ormai ultimato il grosso del suo lavoro» e che le operazioni di rimpatrio sono organizzate tenendo conto della nazionalità dei prigionieri, prima – ad esempio – i dalmati italiani; poi serbi, croati e sloveni. Solo nel luglio 1919 sono rimpatriati austriaci e tedeschi e al dicembre dello stesso anno ancora attendono il rimpatrio gli jugoslavi. Cfr. in generale Alessandro Tortato, La prigionia di guerra in Italia cit., pp. 151-60. 26 «La Risaia», n. 29, 21 luglio 1917. In questo numero si afferma che i prigionieri «sparsi per il Vercellese» sono «centinaia e centinaia». 27 «La Risaia», n. 41, 20 ottobre 1917. 28 «Il Lavoratore», n. 45, 23 novembre 1918. 29 Sulla decima battaglia dell’Isonzo cfr. Mario Silvestri, Isonzo1917, Einaudi,Torino 1965, pp. 120 ss. Come si nota dal saggio di Silvestri ( p. 173) il primo diretto attacco contro quota 175 sul monte Hermada (cioè l’abitato di Medeazza) è scatenato dagli Italiani il 25 maggio, senza che il borgo fosse conquistato. Il caporale Simon Dank è catturato il giorno prima, probabilmente in scontri di pattuglie, e non durante la battaglia vera e propria. La decima battaglia dell’Isonzo - «glorioso macello» la definisce Silvestri (p. 182) – si conclude con enormi perdite italiane e austroungariche: 210mila soldati italiani, di cui 54mila morti, 129mila feriti e 27mila prigionieri; 100mila soldati austroungarici, di cui 25mila prigionieri. Cfr. Mario Silvestri, Isonzo1917 cit., pp. 181-2. Più recentemente vedi: Gianni Baj - Macario, Anton von Pitreich, Prima di Caporetto. La decima e l’undicesima battaglia dell’Isonzo, Libreria Editrice, Goriziana, Gorizia, 2007. 30 Cfr. su Simon Dank: Comune di Casalbeltrame, Registro dei morti, dall’anno 1916 all’anno 1926, anno 1919, n. 1. Osterrechisches Staatsarchiv – Wien, ad nomen. Su Paul Zabulotny: Comune di Casalbeltrame, Registro dei morti, dall’anno 1916 all’anno 1926, anno 1919, n. 13. 31 Osterrechisches Staatsarchiv – Wien, ad nomen e al Karton 60. www.cjhunedoara.ro. 32 «Gazzetta di Novara», n. 2061, 1-2 dicembre 1917. 112 Primi appunti per una storia dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi 33 «La Sesia», n. 134, 16 novembre 1917. 34 «La Sesia», n. 135, 17- 18 novembre 1917. Aller è ovviamente un errore del giornale, va inteso Alles. 35 Così si esprime «La Sesia», n. 134, 16 novembre 1917. 36 «La Sentinella novarese», n. 9, 15 giugno 1918. 37 «La Risaia», n. 49, 7 dicembre 1918. Il giornale socialista vercellese denuncia la morte in solitudine del prigioniero, così come era toccato a due suoi compagni nei giorni precedenti, probabilmente colpiti da spagnola. Alla «Risaia» risponde il giornale «La Sesia», rimarcando come il soldato fu curato per quanto possibile e non morì solo come «un cane austriaco» (come aveva titolato il suo articolo «La Risaia»). Cfr. «La Sesia», n. 101, 17 dicembre 1918. 38 Per la cronaca di questo fatto cfr. «La Sesia», n. 94, 22 novembre 1918. 39 A Salussola la presenza di prigionieri di guerra destinati a lavori agricoli è documentata dal 1917. 40 Dante Graziosi, La terra degli aironi, Interlinea, Novara 1997, pp. 29 ss. Dante Graziosi racconta la vicenda della morte del soldato Franz Juschla, deceduto di spagnola il primo novembre 1918. Secondo quanto rinvenuto nel Registro delle morti del Comune di Granozzo con Monticello – al numero 18 – il soldato si chiama Franz Ihuschha ed è deceduto non il 1° novembre bensì il 5 «nella casa posta in via Casalino al numero 5». Oggi in occasione di cerimonie ufficiali, si portano ancora fiori alla tomba del soldato Ihuschha. 41 Domenico Massa, Renzo Palazzi, Secondo Vittone, Risèri dal me coeur, ed. SM, Vercelli, 1981, pp. 164- 5. Il testo della canzone (intitolata Il prigioniero)– riportato in questo volume – dice: Sentite, buona gente, un fatto di dolore/di un povero prigioniero che vi commuove il cuore!/Il prigioniero malato, la visita chiamò/ed il tenente ingrato il bastone adoperò./«il prigioniero malato, non è riconosciuto»/ed il tenente ingrato, invece lo ha battuto./E mentre lo batteva, gridava ad alta voce:/«Nell’Austria più non andrai; ti voglio ammazzar»./Il prigioniero invece gridava in camerata: «Non ti vedrò mai più, o madre desolata»./Vigliacco di un tenente! Hai il cuore di un leone/meriteresti il fronte o la fucilazione!A tutti voi tenenti e tutti comandanti:/«Cercate di trattar bene i poveri soldati»/Lor lasciano la moglie ed i bambini ancor/ e voi non comprendete lo strazio ed il dolor. Diverso il testo riportato invece in Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto, Senti le rane che cantano, Donzelli, Roma 2005, p. 412, che chiude con una durissima strofa: Vigliacchi preti e frati/che han voluto la guerra/volevan far morire/ la gioventù più bella. Viene inoltre riportata una ulteriore versione del canto che, priva della citata strofa anticlericale, conclude invece così: Vigliacco di un tenente/che non hai detto il vero/che stava per morire/ il povero prigioniero. Ancora una versione ulteriore viene ripresa da una registrazione di Cesare Bermani, e non presenta varianti di rilievo, eccezion fatta per la strofa finale, che diventa Mentr’io in branda a tribolare/tu vai a divertire/ perché tu sei un vigliacco/ ti piace far soffrire. Nel cd allegato al volume è presente una incisione del brano. On line al sito www.ildeposito.org (dove è possibile anche scaricare un file musicale del brano) il canto viene indicato con il titolo Sentite, buona gente e appare meno articolato delle versioni precedentemente indicate, e comunque privo della strofa anticlericale. Altra incisione del brano si può ascoltare dal gruppo Ciar ’dla Valara di Trino Vercellese, nell’audiocassetta Canti delle risaie, Prince, sl, sd. 42 Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto, Senti le rane che cantano cit., p. 66. 43 Ibidem, p. 414. 44 «Corriere Valsesiano», n. 22, 2 giugno 1917. 45 «Gazzetta di Novara», n. 2019, 4-5 luglio 1917. Per quanto riguarda la grafia dei nomi dei prigionieri riportiamo qui quella indicata nei giornali dell’epoca, che italianizza quasi sempre il 113 Renzo Fiammetti nome di battesimo e può essere impreciso sulla grafia dei cognomi (ad esempio, nel caso indicato, il cognome del soldato Ichnida viene anche scritto Jchnida dal «Corriere Valsesiano» che nel numero 26 del 30 giugno 1917 riporta la notizia della cattura dei due fuggiaschi). 46 «Corriere Valsesiano», n. 24, 16 giugno 1917. 47 «Gazzetta di Novara», n. 2037, 7-8 settembre 1917. Il giornale non riporta i nomi dei tre prigionieri. 48 «Gazzetta di Novara», n. 2037, 7- 8 settembre 1917. Anche in questo caso non viene pubblicato il nome del disertore. 49 «Gazzetta di Novara», n. 2041, 22-23 settembre 1917. 50 «Gazzetta di Novara», n. 2042, 26-27 settembre 1917. 51 «Gazzetta di Novara», n. 2048, 17-18 ottobre 1917. 52 «Gazzetta di Novara» n. 2055, 10-11 novembre 1917. 53 «Gazzetta di Novara», n. 24, 23-24 marzo 1918. 54 «Gazzetta di Novara», n. 68, 31 agosto - 1° settembre 1918. 55 «Corriere Biellese», n. 64, 13 agosto 1918. 56 La bibliografia sull’influenza spagnola è ampia. In generale si può fare riferimento ai saggi di Gina Kolata, Storia della grande influenza del 1918 e della ricerca di un virus mortale, Mondadori, Milano 2000; e di Eugenia Tognotti, La «spagnola» in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919), Franco Angeli, Milano 2002. Meno recente è Giuseppe Mortara, La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra, Laterza, Bari 1925. 114 l’Africa e il resto del mondo Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53. L’esperienza di un giovane socialista sionista ricostruita attraverso le sue carte di Paolo Valabrega Le pagine che seguono sono tratte da una tesi di laurea (Gadi. Ascesa e caduta di un giovane socialista sionista, relatrice la professoressa Elvira Cantarella), che è stata per me l’occasione di metter mano ad uno scatolone di vecchie carte e ricostruire la storia – fino ad allora piuttosto sconosciuta – degli anni giovanili di mio padre, Guido Valabrega1. Sfuggito fortunosamente alle persecuzioni antisemite, mio padre appena quattordicenne si trovò a partecipare con il nome ebraico di Gadi alle prime organizzazioni giovanili sorte ad opera dei soldati palestinesi della cosiddetta Brigata Ebraica, nella Torino dell’immediato dopoguerra. Dai giochi dei primi doposcuola, passando per le attività dei boy scouts Zofim (Esploratori), lo studio della lingua ebraica e l’assimilazione via via di tutto il bagaglio teorico e ideologico necessario, per arrivare infine alla militanza completa nel movimento Hechaluz (Il Pioniere): Guido Valabrega sperimentò in prima persona il processo formativo dell’«uomo nuovo» sionista e socialista e visse per circa tre anni in Israele, quale membro del kibbuz Ruchama. Qualcosa però andò storto, per Gadi e anche per l’ideale socialista sionista. Guido Valabrega, che fu espulso da Ruchama e rientrò in Italia disertando dall’esercito israeliano, diventò con gli anni uno dei principali storici italiani delle vicende palestinesi e israeliane, schierandosi apertamente dalla parte del popolo palestinese. Le carte che ho consultato sono raccolte nel Fondo Guido Valabrega, curato da Gabriella Solaro presso l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia Ferruccio Parri, a Milano. Il database dell’Archivio è accessibile dal sito dell’Istituto, all’URL «www.italia-liberazione.it». 115 Paolo Valabrega Rendere conto dei tre anni dal dicembre 1950 al novembre 1953, il periodo della permanenza di Gadi in Israele, non è cosa facile. Per cercare di capire qualcosa si dovranno moltiplicare i piani e i punti di vista, e passare spesso dal microcosmo della vita nel kibbuz, con le sue complicate valenze personali e politiche, alla realtà circostante di Israele e alle più vaste relazioni internazionali, che pure avranno una diretta influenza sui destini individuali. Il kibbuz, sia chiaro subito, è però centrale. Come mi ha raccontato Corrado Vivanti: «A noi il sionismo per stare in Israele non interessava per niente. Noi andavamo in Israele per andare nei kibbuz». Il kibbuz doveva essere la cellula fondamentale di un grande organismo socialista. La scintilla di una grande rivoluzione individuale e collettiva. Un luogo già liberato nei rapporti umani, nella vita materiale e spirituale dei suoi abitanti. Queste promesse saranno nel corso di pochi anni drasticamente ridimensionate e, nella sostanza, deluse. Sarà così anche inevitabile interrogarsi un poco sulla parabola politica del socialismo sionista, e cercare di capire in quale misura la vicenda individuale di Gadi possa essere considerata in qualche modo significativa di quell’altra vicenda collettiva. Di certo, in quei primi anni cinquanta, diventava ogni giorno più difficile tenere insieme da una parte le istanze del sionismo colonizzatore, dall’altra i principi del socialismo – solidarietà di classe, giustizia sociale, fratellanza dei popoli – e soprattutto i legami ideali e politici con i paesi del socialismo realizzato, guidati dall’Unione Sovietica. Il kibbuz, intanto. Ruchama, ai lembi del deserto del Neghev, circa un centinaio di chilometri a sud-est di Gaza, per quanto fondato appena nel 1944, è già considerato un kibbuz ‘vecchio’. La massima aspirazione di molti chaluzim – pionieri, per l’appunto – sarebbe invece di fondare un nuovo insediamento, o comunque inserirsi nell’impresa di un kibbuz ancora in formazione. Un primo gruppo di italiani è però insediato a Ruchama dalla fine del 1949, una scelta che già era stata frutto di un intenso dibattito, e che aveva poi suscitato molte ulteriori discussioni con i compagni in Italia a proposito appunto dell’opportunità o meno di indirizzarsi ancora a Ruchama o verso un nuovo kibbuz. Gli ultimi accordi prevedevano che il nuovo gruppo, di cui faceva parte Gadi, avrebbe raggiunto gli altri a Ruchama, e insieme poi avrebbero deciso se spostarsi insieme a Carmia, un kibbuz ‘giovane’. 116 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 Il nuovo gruppo con Gadi raggiunge dunque i sei italiani di Ruchama ai primi di dicembre del 1950. Tra le carte è conservato il resoconto non ufficiale di Gadi della prima riunione del garin, gruppo. [...] visti i pericoli di incomprensione reciproca che sarebbero stati maggiori con due gruppi invece che con uno solo, visto che diversi chaverim dei due gruppi sono legati già attualmente da vincoli molto stretti che in pratica avrebbero sempre formato un legame abbastanza stretto tra i due gruppi, nonostante vi fosse il parere di soprassedere per qualche tempo fino a che i nuovi arrivati non avessero una maggior conoscenza di vita kibbuzistica e israeliana, all’unanimità si è deciso di creare un garin unico con maskirut [direttivo] unica. Esaurito questo primo punto dell’ordine del giorno si è passati alla creazione di una maskirut che si è deciso fosse così composta sul tipo che regge ogni garin: Merakes Hamaskirut (con funzioni di vaadat hachaverim e contatti con gli organismi centrali dello Shomer Hazair) = Israel Sadran ‘Avodà = Izchak Ghisbar = Laura Vaadat Hatarbut [commissione cultura]= Gadi, Uri, Ilana […]. L’inserimento nella nuova vita non sarà semplice né veloce. Gadi lo ripeterà spesso, dopo: ci vogliono degli anni solo per capire dove si è arrivati. D’altra parte lo spirito del kibbuz non è certo quello dell’hachasciarà e della sua permanente e febbrile militanza. Qui la tensione è rivolta soprattutto al lavoro, meno alla costruzione dell’Uomo nuovo. Corrado Israel De Benedetti lo scriveva sul giornale «Hechaluz» l’anno prima, appena arrivato a Ruchama: Specialmente nei primi tempi, quando non si conoscono le persone e la vita del meschek [azienda agricola], l’aria di famiglia che si respira un po’ da per tutto, la vita individuale che qui trova molto più respiro, il ritmo regolato dal lavoro ecc. ti fanno sembrare l’atmosfera statica, come se mancasse ogni spirito giovanile, rivoluzionario. E il chaver che è arrivato da poco vede la gente lavorare, mangiare e poi tornare alla proprie camere per sentire la radio, per chiacchierare con gli amici, per giocare a scacchi e ci resta male. [...] Allora si pensa che è tutta colpa del kibbuz già formato, che bisogna uscirne ed andare in hitiashvut [«colonizzazione», insediamento di un nuovo kibbuz]. [...] Senza tener conto che ogni uomo, perfino ciascuno di noi, tende naturalmente a crearsi il suo angolino di vita, che sia questo un libro o la fisarmonica, lo studio o le chiacchiere poco importa. Ed è questa tendenza, umana e quindi naturalissima, che porta ad abbassare la tensione apparente [...]. Naturalmente il primo stadio di insoddisfazione non è eterno. Basta aprire gli occhi, e col tempo si arriva a cogliere tensione continua sul lavoro, o nelle discussioni cui tutti i chaverim sono sottoposti. Naturalmente è una tensione diversa da quella in hachsciarà. Naturalmente ci sono anche delle esigenze da parte degli individui. Perché 117 Paolo Valabrega non si dovrebbe richiedere con la stessa urgenza la messa a coltivazione di nuove terre e il miglioramento di vita dei chaverim, in qualche particolare? Il punto è che abbiamo davanti a noi della gente che non guarda ai contadini degli altri paesi (come noi si guardava a S. Marco) come un punto massimo di paragone, ma come una base minima che si deve assolutamente superare per quanto riguarda rendimento sul lavoro, razionalizzazione, e nello stesso tempo per tutto quanto riguarda la funzione di lavoratori coscienti della lotta di classe. Sono degli operai, non dei dilettanti all’inizio del loro mestiere. [...] La collettività è data qui non tanto da particolari secondari, come potrebbero essere il divieto di kumsiz [baldoria; falò, dove si canta, si balla ecc.] o un solo tavolo in chadar ha-ochel [sala da pranzo], quanto dall’armonia creativa in ogni campo, economico, politico e culturale, che lega gli uomini gli uni con gli altri. [...] Per sentirsi parte di questa armonia, bisogna potersi sentire legati, radicati, attraverso gli uomini, al meschek [azienda agricola], in tutte le sue differenziazioni. [...]2. Le lettere da casa, scritte sempre principalmente dalla madre Jolanda si susseguono regolari e compongono un notevole mosaico di vita quotidiana in quei primi anni cinquanta, dai temi più spiccioli della meteorologia fino ai commenti degli eventi politici nazionali ed internazionali, passando per la salute di tutti i parenti, gli affari e il tran-tran del negozio, le serate al cinema e al varietà, le imprese alpinistiche del giovane Sergio e quelle automobilistiche a bordo delle prime vetture familiari. Ma dalla metà del 1951 sono conservate anche le lettere di Gadi alla famiglia. L’insieme completo di questa corrispondenza, che conta più di trecento lettere, all’incirca una ogni settimana o dieci giorni, mi pare raggiunga dunque un certo valore di testimonianza storica, e meriterebbe ben più attenzione di quanta qui per ragioni di sintesi vi si potrà dedicare. Da una parte e dall’altra, genitori e figlio lontano alimentano nella scrittura il legame degli affetti e trovano in questa presenza a distanza un sostegno fondamentale. Anche per questo, per i bisogni profondi a cui queste lettere rispondono, sarà opportuno fare di esse una lettura non superficiale. Ad esempio, Gadi manterrà a lungo sulla nuova vita un tono positivo, se non entusiasta, a dispetto delle insoddisfazioni che presto cominciano ad affiorare. È d’altronde comprensibile, nella sua posizione, una certa tendenza ad addolcire i racconti, a nascondere le insoddisfazioni, e anche a tacere alcune situazioni di difficoltà o pericolo. Dei primi mesi di Gadi in Israele si trovano solo indicazioni sparse tra le righe delle lettere dall’Italia. 118 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 Gadi in posa sul trattore a Ruchama Lettera del fratello Gherscion, 13 dicembre 1950: La mamma è rimasta molto addolorata dal fatto che tu non abbia mai espresso una parola di rimpianto o di affetto nelle tue lettere; ammetto che questo può essere un po’ una reazione alla tua sopravvenuta libertà di agire, ma credo che dovresti riprendere l’equilibrio nel considerare queste cose; se non altro fallo per lei e anche per me perché la mia situazione è abbastanza critica e ogni volta che arriva una tua lettera in famiglia è una giornata meno serena delle altre. Con questo mi raccomando scrivi lo stesso, solo metti un po’ più di tua partecipazione personale nelle tue lettere, non dare solo un resoconto dei fatti che avvengono. Specialmente nelle lettere che scrivi a me raccontami delle tue impressioni, dei tuoi stati d’animo, oltre che ai fatti naturalmente. Lettera dalla mamma n. 7, 8 gennaio 1951: Mi pare di capire dalle tue lettere che le prime impressioni su Israel sono buone e ne sono molto contenta; vorrei ancora sapere se ti è passato un po’ l’orgasmo e se ti sei calmato e non ti arrabbi per ogni piccola contrarietà. Il padre Vittorio, 23 febbraio 1951, in una delle sue aggiunte alle lettere materne: Siamo molto contenti di ricevere tue lettere così spesso. Le leggiamo e le rileggiamo con molto affetto. Perciò non desistere. Io, solito tran tran; solita vita; solita noia; quasi quasi, e anche senza quasi ti invidio per la tua esistenza tutt’altro che annoiante, a stare a quel che scrivi. 119 Paolo Valabrega Vittorio Valabrega, che nelle lettere si limita quasi sempre ad aggiungere qualche riga di saluto, si assume invece subito un altro compito fondamentale nel mantenimento dei rapporti con il figlio: è lui infatti che cura tutte le spedizioni dei pacchi postali. Queste spedizioni conterranno quasi esclusivamente giornali italiani («L’Unità», «Rinascita», ma anche «La Settimana enigmistica»), e libri, unici beni di conforto richiesti in dono da Gadi. Ecco finalmente una delle prime lettere rimaste di Gadi da Ruchama, 17 luglio 1951: Carissimi ho ricevuto la vostra N.32 del 4.7. Anzitutto tanti ringraziamenti per i prezzi dei colori e affini al babbo anche da parte del tizio che li ha richiesti. In questo periodo sono capitate un mucchio di cose belle. Primo, gita al mare in un altro posto, anche questa volta è stato molto bello. In questi punti di costa c’è una spiaggia meravigliosa con sabbia finissima con dune e palme alla De Mille (il regista americano). Poi c’è stata la messiba del garin Ashalim che prima di entrare nel nahal3 è stato accettato in kibbuz. Abbiamo mangiato una quantità enorme di dolci, birra ecc. Hanno poi ballato un balletto molto in gamba. Dopo di ciò v’è stata la chiusura delle scuole con esposizione di opere dei bambini (disegni, plastici, fotografie, costruzioni) molto di buon gusto e una loro rappresentazione veramente buona. Hanno prima recitato «il Principe ed il povero», poi hanno cantato con un coro a tre voci e dopo hanno fatto esercizi ginnici. Ma la cosa più bella che abbiamo fatto è stata la gita a Negba con il camion. Negba è il kibbuz che con la sua eroica resistenza agli egiziani ha impedito la loro ulteriore avanzata, e ivi una settimana fa si è celebrato l’anniversario di questa resistenza. Erano presenti Meir Jaari, Israel Galili, Izchak Grinen, Emma Levin che sono tutti pezzi molto grossi del nostro partito. Qualcosa come Togliatti e Nenni in Italia. Erano convenuti chaverim da tutti i kibbuzzim, vi erano anche molti soldati ed operai. Il più bello di queste cerimonie, come anche quella di Jad Mordechai, è l’atmosfera che c’è nel pubblico, quando veramente ci si trova in mezzo a migliaia di chaluzim. E non ti puoi immaginare il numero di conoscenti che si trovano. Anche noi, che pure siamo nuovi nel paese, ne abbiamo trovati parecchi: da Erdely a Luciano Forti, da Jochanan d’Ancona a un tale che abbiamo conosciuto ad Avigliana, ed una tale che abbiamo conosciuto al campeggio in Svizzera. L’organizzazione del kibbuz era impeccabile, con distribuzione gratuita di panini e acqua zuccherata. I discorsi erano inframmezzati dalle canzoni del coro più in gamba del movimento, il cui nome è «Monti di Efraim», da pezzi al pianoforte ecc. Infine i bambini hanno danzato un ottimo balletto in onore dell’epopea di Negba. Stasera ho ricevuto la lettera di Sergio alla quale risponderò presto. 120 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 La sala da pranzo comunitaria al kibbuz Ruchama Il lavoro procede bene. Ho imparato un mucchio di nuovi lavori a macchina, incomincio per esempio ad imparare a guidare il trattore, che qui è alle volte utile come la bicicletta in Italia, a lavorare con la macchina per tirare fuori le patate ecc. ecc. Scusatemi se vi scrivo tante cose così ammucchiate, varrebbe la pena di soffermarsi di più su ognuna di esse, ma le notizie oggi sono tante e devono stare tutte su questo foglio che è piccolo. Bacioni a tuttissimi e tre. E un’altra di qualche giorno dopo, 29 luglio 1951. In questa settimana siamo stati due volte in gita fino a Tel-Aviv. La prima volta è stato mercoledì, allorché abbiamo ricevuto vacanza e tutti noi italiani e il nostro madrich Mielo abbiamo fatto un bel viaggetto. Prima siamo stati a Rechovot a visitare l’Istituto Weizman per le ricerche scientifiche in campo agricolo. È un posto bellissimo con edifici lussuosi sommersi in un bel parco verdeggiante; naturalmente non si sarebbe potuto entrare poiché non era il giorno prescritto per le visite se l’onnipotente Mielo per prezzo delle sue arti da romeno, kibbuznik e shomer non avesse addirittura trovato modo di farci ricevere da un divertito professore. Poi siamo stati a Rishon Le Zion dove siamo riusciti a visitare una enorme fabbrica di birra. 121 Paolo Valabrega Manifestazione kibbuzistica Infine giunti a Tel-Aviv abbiamo mangiato un riva al fiume Jarkon quello che ci eravamo portati da casa. Poi siamo stati a visitare lo zoo che è abbastanza grande con tanto di elefanti, giraffe, orsi, pantere ecc. ecc. Anche qui Mielo, come abitanti del Neghev ci ha fatto fare uno sconto per l’entrata. E così pure ha fatto per la mostra di pitture di Chagall che abbiamo successivamente visitato. L’ultima attività di questa intensissima giornata è stata alla sera dopo cena, quando siamo andati a teatro a vedere «Il nemico del popolo» di Ibsen. Ne abbiamo fatte di cose in un giorno no? La seconda volta che siamo andati a Tel-Aviv è stata ieri sabato. Siamo stati lì in occasione di una grande manifestazione per le elezioni che si terranno questa stessa settimana. Su camion tutti addobbati di scritte, bandiere, manifesti, nelle tre grandi città Gerusalemme, Chaifa e Tel-Aviv si sono radunati per sentire comizi e fare cortei gli uomini dei kibbuzim e gli operai. Noi siamo giunti a Tel-Aviv in una delle tre colonne di camion che convergevano su di essa, colonne composte per lo meno di trenta camion stracarichi di gente. È stato uno spettacolo meraviglioso, organizzato fin nei più piccoli particolari. Certo che l’atmosfera nella città era accesissima perché è stata una manifestazione poderosa nel pieno di una campagna elettorale intensa, in una città seppellita da manifestini, urla di altoparlanti ecc. ecc. Vi assicuro che quando ci mettemmo a gridare scandendo in coro: «MA-PAM, MAPAM, MA-PAM» veramente faceva l’impressione di uno scoppio di bomba a mano. Non mi dilungo in particolari che credo ne scriverò a Sergio o magari ne salterà fuori un articolo per Hechaluz. Comunque la voce di mezza Ruchama oggi è in cantina. [...] 122 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 Il MAPAM, che – dopo il partito di governo di Ben Gurion MAPAI – è il secondo partito israeliano con oltre un quinto dei voti a queste elezioni del 1951, si era appena riunito nel suo secondo congresso. Il giornale «Hechaluz» ne pubblica un resoconto, piuttosto significativo della non semplice composizione tra le sue diverse anime: Dopo il saluto della sezione di Chaifa al Congresso, Jussuf Tamis porta al Congresso le parole della Sezione Araba. Dopo aver sottolineato le difficoltà della loro lotta in seno alla popolazione araba del paese, tra cui la propaganda del MAKI (Partito Comunista) ha molta influenza, egli espone le decisioni prese dal Congresso della Sezione tenutosi antecedentemente al Congresso del partito. Tali decisioni, che sono state distribuite sotto forma di lettera aperta a tutti i delegati, rappresentano una specie di piattaforma di partito, concisa e chiara nella sua forma. In essa sono sottolineati i compiti del partito: avanguardia del proletariato ebraico ed arabo in Israele, guidato dalla versione del mondo marxista-leninista e ispirato dalla dottrina di Borochov, per quanto riguarda il fenomeno del concentramento nazionale ebraico. Il partito deve sapere indirizzare la lotta dell’operaio ebreo che ritorna alla sua terra, e dell’operaio arabo che vi è nato. Deve combattere per il ritorno della integrità nazionale, attraverso un accordo di popoli, sulle due rive del Giordano, per il ritorno dei profughi arabi alle loro case e ai loro campi, per la scomparsa di ogni differenziazione sociale e politica tra i due popoli. Alla luce di questi postulati, la Sezione Araba si augura che il Congresso si renda consapevole della necessità del proletariato arabo di essere organizzato in un medesimo partito con quello ebraico, e si augura che questo sia l’ultimo congresso del MAPAM, cui gli arabi partecipino in qualità di ospiti. Le parole di Jussuf tradotte da Weiz, sono salutate da applausi generali, e veramente si ha l’impressione di assistere a un avvenimento decisivo per la storia del proletariato d’Israele. Un arabo porta il saluto agli operai ebrei, tende loro la mano, per iniziare assieme una medesima strada di lotta per il rinnovamento sociale e politico della medesima patria. [...] Sneh mette a fuoco la situazione rovinosa cui la politica del MAPAI ha condotto il paese: «nella nostra condizione, non esiste presa di posizione di alcun partito che non sia: o un passo verso il mondo operaio, o un tradimento nei suoi confronti... Se accettiamo la definizione di marxismo-leninismo, dobbiamo dimostrare la nostra coerenza accettando la territorialità del partito, e il diritto degli arabi alla autodecisione». Benni Marsciak (della Mazkirut del Kibbuz Hammeuchad) afferma invece che l’entrata degli arabi nel partito costituirebbe in mutamento della sua struttura, cosa che egli non si sente in nessun modo di accettare. [...] Tabenkin porta finalmente la parola tanto attesa di colui che può ben considerarsi il padre spirituale dell’Achdut Haavodà. Parla lungamente, un discorso di una lingua purissima, con spunti di ritorno al vecchio spirito chaluzistico dei vecchi tempi, e, nello stesso tempo, un discorso duro [...]: «La nostra strada la scriviamo noi tutti, operai di Israele, col nostro sangue e il nostro sudore; la nostra strada non è scritta in nessun libro, neppure su quelli di Lenin», egli afferma, e di qui egli entra in polemica con quel123 Paolo Valabrega la ch’egli chiama la tendenza «asionistica» in seno al partito, ossia con il «Fronte», che, secondo lui, tende a far passare in seconda linea tutti i problemi connessi con il Kibbuz Galuiot4. Pure sul problema arabo, egli, riconfermando la sua stima personale a tutti i chaverim arabi che lavorano nella Sezione, dichiara risolutamente che non è ancora giunto il momento di trasformare il partito in partito territoriale. A Tabenkin rispondono successivamente Meir Jaari e Ben Tov, i quali sostengono risolutamente che la direzione che il «Fronte»5 vuole imprimere al partito è una soluzione sionistica e socialista, e, precisamente, sionistica in quanto socialista. Essi dichiarano assolutamente infondate le accuse di «asionismo». Infine, [...] in una notte di lavori ininterrotti un migliaio di delegati assiste alla nascita dello statuto del MAPAM, statuto finalmente completo, piattaforma politica precisa nei suoi particolari e chiaro strumento di lotta verso nuove conquiste. Riesaminando praticamente il nuovo testo (che tra l’altro non è stato ancora pubblicato nella sua forma definitiva), queste ne sono le innovazioni particolarmente decisive, nei confronti del precedente statuto: a) il partito è stato definito come «il partito del Socialismo rivoluzionario, il partito rivoluzionario della classe operaia in Erez Israel, il partito chaluzistico in Israele e tra il popolo ebraico». Il partito si basa sul borochovismo, come spiegazione del fenomeno della rinascita nazionale ebraica alla luce del Marxismo e sulle «teorie marxiste-leniniste, come visione del mondo, e come via della lotta politica del mondo operaio rivoluzionario». b) Il partito ha chiarito la sua posizione nei confronti del ritorno alla integrità del paese, riconoscendo il diritto degli arabi alla autodecisione, una volta raggiunta l’integrità attraverso accordi di popoli e per vie di pace. c) Il partito dichiara la sua volontà di trasformarsi in partito territoriale, ma la questione dell’ammissione immediata degli arabi della Sezione Araba del partito negli organi dirigenti viene rinviata in considerazione dell’opposizione di principio della minoranza. d) Si afferma la struttura unitaria del partito, che non riconosce ad alcuna corrente nel suo seno di organizzarsi separatamente. Disciplina di partito unica, che impegna ogni membro singolarmente6. La trasformazione politica in corso in Israele, con il condizionamento dei partiti religiosi, le nuove masse di manovra appena immigrate dai paesi arabi, il lento scivolamento nella sfera di influenza americana e la insufficiente prova della sinistra socialista sono colti in pieno invece da Corrado Vivanti, che è giunto con Gadi a Ruchama, e così scrive su «Hechaluz» in un lungo articolo a commento delle manifestazioni del Primo Maggio 1951: Strano paese davvero questo, a metà del tutto rivoluzionario, a metà legato alle forme 124 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 più viete del passato! Per le vie sfilava già da qualche ora il corteo dei lavoratori. Passava aprendo nel vento una marea di bandiere rosse, e si snodava per le strade centrali sin davanti al palco delle autorità su cui sedevano Sprinzak, Presidente della Knesset e Sciarett, in rappresentanza del Governo. Eppure il Primo Maggio in questo paese non è festa nazionale, anche se il corteo era organizzato in modo che quasi sospettavi che la Rivoluzione Socialista fosse già stata attuata fra noi. Ma bastava guardarti intorno e capivi subito che non era così. Non solo nelle vie fuori dal centro la vita aveva il ritmo di tutti i giorni, consueto e normale, e per nulla alterato dalle migliaia di persone che sfilavano a pochi passi di distanza, ma, nelle stesse vie in cui il corteo passava, vedevi gente che se ne andava per le proprie occupazioni, maledettamente seccata dal contrattempo che faceva perdere un poco dei loro preziosi minuti. Le scritte inneggiavano al socialismo, all’eguaglianza, alla giustizia, ma sui marciapiedi mendicanti chiedevano l’elemosina, bambini cenciosi arrampicati sui tetti delle edicole e sugli alberi lanciavano fischi e improperi all’indirizzo dei giovani dei movimenti più di sinistra che passavano nel rosso corteo, e nei negozi affollati, i padroni troneggiavano dietro i banchi, più che mai consci della loro potenza, che, dopo tanta babele rivoluzionaria, le prossime elezioni avrebbero dato loro ragione. «Gridate pure, cantate a perdifiato – pareva dicesse tutta questa gente – ma chi comanda oggi siamo noi». Dal palco delle autorità si alzava lento il canto dell’«Internazionale». Anche il microfono pareva venuto alla reazione, amplificando al massimo le stonature di tutte quelle personalità. Solo Sciarett se ne stava composto in silenzio, nel gran coro. Forse il suo scetticismo di diplomatico gli faceva dubitare delle belle utopie di quest’inno. Forse, più semplicemente, pensava al viaggio a Washington, che Ben Gurion avrebbe intrapreso l’indomani. Strano paese davvero questo, che vuol vivere in una presunta indipendenza dal conflitto delle due parti, e che pure non può riuscirvi ed è costretto ogni giorno di più a pencolare da un lato, e d’altra parte vede il conflitto di classi avverse regnare per le sue strade anche e proprio nel giorno del Primo Maggio. Avevi nettissima la sensazione in quel momento che il corteo facesse una rassegna delle grandi energie del passato. Histadrut, Kibbuz, Palmach (e questo, la cosa è abbastanza significativa, è già solo un glorioso ricordo!) erano il simbolo della costruzione di questo paese, quando veramente, anche qui, c’era tutto «un popolo alla macchia». Ma l’oggi era rappresentato da quelli che ci lanciavano sguardi indifferenti o ostili. La nuova alià si impone con le sue masse a Erez Israel, che ha avuto un passato così radioso e un presente che si presenta grigio, nebuloso e opprimente per il sorgente imperio della borghesia. E allora pensi che è meglio cessare l’inganno: che nonostante tanto bello sia il passato, e così prossimo, che quasi ti dà l’impressione di esistere ancora, sia bene affrontare decisamente la realtà dell’oggi. È meglio rifare un corteo e una dimostrazione che effettivamente e più violentemente suoni alla lotta contro le forze che solo oggi giunte nel paese da altri costruito, già cercano di imporsi con gli usi e la mentalità abbietta che 125 Paolo Valabrega noi vogliamo e dobbiamo combattere. Hai quasi paura che senza un continuo appello alla continuità della nostra lotta l’attenzione dei lavoratori si lasci distogliere e distrarre da queste manifestazioni ottimamente organizzate; hai paura che anche al nostro slancio rivoluzionario capiti la sorte dei sogni ebraici. [...] Nessun Messia calerà dal cielo a portarci la Rivoluzione! E allora è bene che sia nostro simbolo quel verso dell’«Internazionale», che ieri valse per noi e ci permise di giungere sino a questo punto, e che oggi deve valere per il paese: «Nulla è lo ieri, domani è tutto!».7 Una prima nota di personale disillusione, a sei mesi dall’inizio della nuova vita in Israele, compare in uno scritto di Gadi dell’estate 1951, di cui sono conservate diverse versioni. Quella che segue dovrebbe essere una delle ultime stesure. Vent’anni di shmirà [guardia]. Mia cara amica, sono da sei mesi in kibbuz, e sono di nuovo di shmirà. È molto difficile in piena luce ritornare nella caratteristica atmosfera degli shomirim, «cristo, che bella notte per andare in giro con una bachurà [amante] – sì, accidenti, chi vuoi che voglia cercare di rubare con un chiaro di luna simile, per la madonna», mi sforzerò di farlo, tuttavia, perché è arduo parlare al chiarore del giorno delle cose oscure e dubbiose in cui ci si aggira nelle tenebre. L’ultima notte ho pensato molto a te. E se ripenso a tutti quei problemi interiori di cui tu sei un poco stata lo spunto e che ora mi occupano, capisco che è questo il momento in cui anche te, come tutto il resto del mondo, devo ridefinire, riscoprire. Il kibbuz è tutto ombre nere. Più grandi, più piccole, enormi come quella dei silos. Fra le ombre nelle ombre si aggirano gli shomirim. Vedi, il fatto è che mi accorgo che adesso forse vado proprio uscendo da un’età ed entrando in una nuova epoca. Naturalmente le cose vanno per gradi, dialetticamente, e se rifaccio con il pensiero il mio progressivo sviluppo biologico-spirituale potrei, per esempio, dire addirittura il giorno e l’ora in cui, dopo una serie non breve di spazi di tempo, minuto dopo minuto, sono stato giovane. Si sta lì accucciati nella paglia con strani, insoliti vestiti, sciarpa legata alla vita, maglione rossiccio, ciuffo ribelle che fiorisce sotto il berretto, a pensare ed a raccontarsi storie che non racconteremo alla luce del giorno. Laggiù nella pozzanghera d’agata lunare s’abbeverano gli sciacalli. Giovane completamente, assolutamente, senza sottintesi: è stato un istante brevissimo, l’istante della presa del potere, in cui prima si era oppressi e non si è ancora oppressori, istante subito dopo il quale hanno cominciato a sorgere in me le forze novelle che prepareranno nella mia vita l’avvento di un’altra epoca, che ancora non conosco, né so definire, ma che vedo chiaramente sempre più diversificarsi dalla precedente. «Taghid, Meir, che ne pensi di Lea?» «E cavolo, quella si cavalca più facilmente di Armoni, te lo dico io.» 126 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 Così nella notte tranquilli e sboccati parlano gli shomirim. È passata l’età dell’illusione, questo è indubbio. È di questi brandelli di illusione che fuggono lontano incalzati dal vento aspro che debbo parlarti. Giacché ancora non mi so decidere ad abbandonarli e non so se la strada che vado intraprendendo è giusta; o forse giusta o errata la via che si deve imboccare la imboccherò, per quanti salti e bizzarrie faccia. Amica, amica cara, hai mai guardato il viso del tuo amante quando lo baci? Hai mai visto il suo naso come si torce, la pelle come si tira? Oppure chiudi gli occhi, se non altro quelli razionali? Hai mai voluto proprio in quel supremo momento uscire da te stessa e osservare scientificamente te e di fronte a te? Questo è quello che vado facendo or ora. Come ben capirai l’esercizio è complicato e non si può reggere a lungo. È possibile passare continuamente dal sogno alla realtà? Una mucca nel hazer s’alza sulla groppa di un’altra. (!hi!) Non è molto diverso dall’incertezza e dalla lotta che ho combattuto dentro di me prima di essere in achsciarà: città o achsciarà? E avrei voluto andare di continuo avanti e indietro e avanti per confrontare e confrontare. L’universo tutto è per me sottosopra: ciò che credevo ieri vale ancora oggi? O da che parte, da che cosa, inizia la revisione? Lavoro strano e affascinante e deprimente nello stesso tempo quello dello shomer. Affascinante per quel che c’è di romantico nel vedersi la luna ruotare da qua a là e tramontare e sorgere, per quel luccicare e sbiadire e risplendere di stelle, per i cavalli bianchi sfumati cui porti da mangiare e che nervosi ti aspettano e con il muso ti urtano il secchio della biada che versi nella loro mangiatoia, per il senso che provi di essere tu l’unico responsabile del buon andamento delle cose in kibbuz – chiudere l’acqua della innaffiatura, accendere le luci nel pollaio, caricare il latte, svegliare i chaverim. Deprimente perché ti tocca stare con un tale e sviscerartelo per sei sere di fila, e hai sempre la testa pesante per quel sonno che non hai mai né a sufficienza, né ad ore giuste, per l’isolamento in cui in fin dei conti vivi gran parte della tua giornata. Ho detto l’universo tutto, ma non è esatto, si tratta di alcune delle sterminate attività che interessano l’uomo ad essere in discussione; e finora filosofia e politica stanno solide e ferme, forse perché non ho ancora dato loro modo di deludermi? Che fai mucca sfuggita al pastore che ancora t’aggiri inquieta tra le stalle, ti trovavi forse meglio prigioniera, ma presso la mangiatoia? Questo è il punto fondamentale: credevo in una cristiana essenziale bontà ed onestà degli uomini, nella purezza, nella donna angelicata, nell’entusiasmo; e da diverso tempo i fatti, la realtà mi danno torto: mi disilluderò, non crederò più? I miei peccati si rivelano così piccoli da farmi essere infinitamente migliore di come mi credevo? Che mondo sarà quello che sorgerà nuovo da queste fondamenta? (o rovine) Quand’ero più ingenuo ed ignorante e perciò seguivo più supinamente e completamente ciò che mi dettava il mio carattere estremamente politico, ero più nel giusto? In principio ti fermi a sentire il tramestio del kumsiz [baldoria] che fanno i sud-ame- 127 Paolo Valabrega ricani per la visita di due tizie. «Sai dove dormono?» «No» «Cretino, che occasione perduta!» Partiranno al mattino un’ora dopo che hai incominciato a dormire. Ed è sempre così. Non immaginatevi grandi scandali. (Poi ti avvii, e lentamente la notte avvolgerà del tutto i due shomirim) Intorno all’estate del 1951, arriva il momento di decidere se restare o no a Ruchama. Ricorda Corrado Israel De Benedetti: Dal movimento ci propongono di andare a vedere un kibbuz appena fondato – Carmia – per unirci ai compagni in gran parte tunisini. Partiamo un giorno in tre appena finito il lavoro e siamo accolti la sera con grandi feste. Il kibbuz è quasi in riva al mare, vicino a Zikim [...] : anche qui un recinto di filo spinato tra una distesa di siepi di fichi d’India malamente illuminate da un fanale solitario. Ci fanno entrare in una vecchia casa araba dalle pareti scrostate dove hanno riunito l’assemblea in nostro onore. Questi compagni ci tengono moltissimo alla nostra venuta e ci offrono incarichi di dirigenza (noi ci sentiamo molto vatikim [vecchi] : siamo arrivati un anno prima di loro), però alle nostre domande sulle condizioni di vita le risposte sono vaghe e poco soddisfacenti. Non hanno ancora bambini, quindi mancano le strutture adatte, per cui Nomi dovrebbe andare a stare in un kibbuz vicino, si abita tutti in tenda e le prime baracche saranno disponibili tra un anno. In compenso sono tutti molto attivi politicamente e ci parlano delle dimostrazioni cui hanno già preso parte nel paese. Torniamo a Ruchama con la testa confusa: gli scapoli tra di noi sono entusiasti all’idea del kibbuz giovane e nuovo, le coppie lo sono meno (siamo già imborghesiti e pensiamo alle nostre piccole prime proprietà?!). Viene indetta una riunione straordinaria del garin (senza i nostri madrikhim – non vogliamo essere influenzati da quelli di Ruchama che non ci vogliono mollare, naturalmente). Ci raduniamo nel wadi sotto le stalle: i nostri ex zofim hanno preparato un fuoco di campo e noi tutti attorno, mezzi affumicati dal fumo, a discutere con toni violenti i pro e i contro. Non ce ne rendiamo conto ma stiamo decidendo della nostra vita futura, una decisione che ci porteremo dietro per anni e anni. Jair e Lina, la coppia più anziana, non sono neppure venuti: hanno detto che noi possiamo decidere quello che vogliamo, loro restano comunque a Ruchama! Alla fine si vota: 12 contro 11 si decide di restare, e in onore di una vera democrazia tutti rispettano la decisione presa: se in futuro qualcuno se ne andrà (e sono pochissimi) lo farà per motivi diversi. Carmia continuerà senza di noi... riceverà in cambio qualche anno più tardi un gruppo di giovani israeliani.8 Le lettere di Gadi alla famiglia segnano le tappe del progressivo radicamento nella vita del kibbuz. Qui di seguito alcuni brani, appena esemplificativi del periodo 1951-1952. 128 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 3 ottobre 1951 Noi continuiamo un’attività culturale febbrile addirittura. Ogni sera è occupata senza fallo. O ci si prepara per la grande rappresentazione. O c’è lezione di ebraico, o ci sono i circoli culturali o c’è l’assemblea del kibbuz, o conferenza o cinema, o seduta di qualche commissione. Insomma è una cosa meravigliosa essere sempre occupati. Perché il tempo libero naturalmente serve a me per esempio in questo momento particolarmente a leggere economia politica. La quale cosa è veramente interessantissima e devo dire grazie di cuore a Adam il nostro madrich che nel giorno di studio ce ne ha riempito talmente la testa che mi sono vergognato di non poterlo alle volte capire in tutti i ragionamenti, e mi sono messo così a seguirla, e ne vale la pena. [...] 9 ottobre 1951 Il nostro movimento ha deciso che ogni appartenente deve andare almeno una volta ogni quattro anni a frequentare qualcuno degli innumerevoli corsi che si tengono nella «Università» nostra, a Ghivat Chaviva. [...] Inoltre si viene inviati assai spesso ai corsi di specializzazione tecnica più vari, da quello per direttori d’azienda a quello di ortolano, o trattorista, o cassiere ecc. ecc. [...] All’interno del kibbuz vi sono poi molti tipi di attività culturali e vi accennerò solo la più importante: il circolo di studi politico-ideologici. Anche noi all’interno del garin abbiamo due circoli di studi, uno di letteratura (sul realismo nell’arte) e uno di marxismo (sulla storia del P.C.(b.)R.). Come forse già saprete riceviamo anche come garin 5 ore di studio alla settimana. Oltre al madrich. Questi molto ma molto in breve alcuni schiarimenti che dovevano essere fatti. L’eterna questione: come potere essere maggiormente completi?, esiste. [...] 14 ottobre 1951 Questa settimana sono di guardia e in realtà ne ho piacere perché ci si riposa un poco. Fatto sta che di giorno leggo un mucchio di roba. Siccome partecipo attivamente al circolo di letteratura che si occupa del realismo russo ho letto parecchi libri di Tolstoi, Dostoevskij ecc. ecc. Insomma viene fuori uno studio collettivo molto interessante. Un altro aspetto piacevole della smirà è che si mangia di notte un pranzo meraviglioso con due o tre uova a testa, pollo, zucchero ed olio a volontà, latte, torte e dolci. [...] 23 ottobre 1951 Ieri sera siamo stati accettati solennemente a far parte del kibbuz; diventiamo quindi anche noi padroni di tutto quello che c’è qua, trattori, case, macchine ecc. ecc. 13 novenbre 1951 Non so ve lo avevo accennato, comunque vi racconterò di nuovo che allorché siamo stati accettati in kibbuz diversi di noi sono entrati a far parte di alcune delle più importanti commissioni, come per esempio la commissione del lavoro, dell’azienda, 129 Paolo Valabrega Gruppo di Chaluzim dell’educazione, della cultura. Io sono stato chiamato a collaborare con quest’ultima commissione. Che è un incarico abbastanza impegnativo perché ci si deve occupare di una infinità di cose dall’attività politica, per la pace, all’inviare gente ai corsi di perfezionamento, all’organizzazione di balli, commedie, mostre ecc. Per questo a ognuno dei membri sono stati affidati vari incarichi. Chi l’organizzazione della sala di lettura, chi la biblioteca ecc. ecc. A me è toccato di occuparmi specialmente dei films, dell’attività pittorica e dell’ornamentazione [sic]. Vedremo se me la riuscirò a cavare. Comunque il far parte di queste commissioni è una cosa utilissima perché si possono conoscere meglio nuovi chaverim e si può entrare ancora più a fondo nella vita del kibbuz in generale. [...] Vi sono anche novità in campo lavoro. Sono ritornato a lavorare in orto e si incomincia a prepararci per la edificazione del nuovo grande orto industriale. La questione della costituzione di tale nuovo orto era stata addirittura portata all’approvazione dell’assemblea, perché non sarà per nulla una cosa semplice. Data la relativa distanza da casa (4 km.), la scarsità di braccia lavorative ecc. Io comunque sono molto favorevole a questa opera. Speriamo di cavarne qualcosa di buono. Fatto sta che oggi ho già preparato 35 tubi per rubinetti occorrenti all’innaffiatura dei nuovi campi. Non so se lo sapete, in orto lavora anche Zvi, fratello di Eldad. Molto si spera dalla meccanizzazione: oggi, per esempio, abbiamo fatto una semina a macchina, di carote. Vi abbiamo messo un’ora invece di sei e si può ancora ridurre. [...] 130 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 8 dicembre 1951 Ieri sera abbiamo fatto un «onegh-shabbat» [festa del sabato] sulla pace e oggi andremo a Beer Sheva a raccogliere firme per l’incontro fra i 5 grandi. Durante l’onegh-shabbat abbiamo rappresentato una specie di ginnastica ritmica con fucili, una specie di pantomima pacifista. Anche io vi ho preso parte. Eravamo tutti in camicia bianca e calzoni blu. È venuta fuori una cosa abbastanza bella, non solo a giudizio mio che vi partecipavo, ma anche degli spettatori, con cambiamenti di luce ecc. Per la prossima settimana è annunciato un concerto pionieristico e la visita di due scrittori israeliani che ci intratterranno sui loro libri. Oltre a ciò vi sarà come al solito il circolo politico-ideologico, le prove della nostra commedia, le lezioni di ebraico ecc. ecc. [...] 31 gennaio 1952 Circa il vostro «terrore» per i regali vi dirò questo: che qui non ho bisogno di nessuna cosa, ma se proprio volete farmi avere qualche cosa speditemi libri. Così come quando ero piccolo al mio compleanno mi facevo regalare solo libri, la mania non è cambiata neanche ora, sebbene il tempo per leggerli sia diminuito e le esigenze di dati generi di libri e autori si siano accresciute e complicate. Se quando cambierò casa avrò bisogno di qualche cosa ve lo scriverò. Comunque perché incominci a voler mettere tendine alle finestre, portafiori e portaombrelli a destra e a manca, paralumi e anfore in giro sui letti e i tavoli devono veramente accadere grosse cose. Tutti questi non sono che imbrogli inutili. [...] 6 marzo 1952 Anzitutto vi dirò che sono stato fatto abile, non è indicato per quale arma perché è stata solo una prima visita. E spero di non doverne fare più altre perché pare che si sia scoperta o inventata o fabbricata una legge per cui i facenti parte dei kibbuzim nella posizione come Ruchama, se staranno almeno 4 anni in kibbuz, non faranno il servizio militare. Se eventualmente non sarà così dovremo andare sotto leva per 2 (non tre) anni in 5 o 6 italiani almeno. Ma ci sono buone possibilità di scamparsela. [...] 12 marzo 1952 Anche quest’anno è stata organizzata dalla nostra casa editrice e dal kibbuz la vendita quasi gratuita di libri. Essa è organizzata ogni anno con il motto «Un libro per ogni chaver». Io ho acquistato per 10 grush 2 libri del valore complessivo di 160. Essi sono «Per la lunga strada», scritti del nostro capo Meir Jari e «Arte e vita sociale» di Plekanov. Forse tradurrò per il giornale di Sergio qualche pezzo adatto del primo libro. [...] 10 aprile 1952 [...] anzitutto vi annunzio che ho finalmente cambiato casa. Non è come si diceva un 131 Paolo Valabrega tempo quella dove avrei dovuto andare a stare, ma una più modesta. Tuttavia i vantaggi sono parecchi sia perché più adatta perché più piccola a noi due Moshe ed io, unici rimasti dei 4 che agli inizi eravamo nell’altra, sia perché più vicina alle camere degli altri chaverim. Così anche noi per Pesach abbiamo cominciato con pulizie e traslochi. Ma tutto è andato molto bene sia perché la distanza è stata piuttosto piccola (50 metri!), sia perché con l’ausilio del nostro trattore abbiamo trasportato tutto molto facilmente. Ieri sera c’è stato il seder [lett. «ordine», rituale della Pasqua] molto ben riuscito anche per la grandiosa mangiata fatta che si è prolungata anche tutt’oggi con enorme abbondanza di vini e dolciumi. Nelle camere è stato inoltre distribuito cioccolato, biscotti, una torta, zucchero, una bottiglia di vino, un bel piatto di vetro e una scatola di marmellata. E sono anche state date calze nuove, un fazzoletto e un paio di calzoni corti. La parte culturale si presenta poi vastissima, come già vi avevo accennato, e si prevede che si dovrà andare a letto tardi per tutta l’intera settimana. Stasera ad esempio vi sarà un’attrice ed un pianista. In orto le cose vanno assai bene. Le nostre patate promettono un raccolto assai buono. E date le cure che abbiamo nel tirarle su ce lo meritiamo proprio che vengano su come si deve. [...] 6 maggio 1952 A proposito di roba da mangiare. Continuiamo quando siamo a lavorare fuori a mangiare particolarmente bene. Ecco il pranzo di stamattina: minestra, pastasciutta, pesce, frittata, due contorni, budino e aranci. Mica male, no? Il lavoro continua però intenso. Il raccolto del fieno è stato molto buono e si fanno delle «spedizioni straordinarie» per portarlo a casa. Certi giorni tre camion per tutta la giornata non fanno altro che la spola avanti e indietro dai campi ai magazzini per raccoglierlo. [...] 23 maggio 1952, dopo aver ricevuto notizia della morte dello zio, Mario Zargani Alle volte non posso non provare un poco di desiderio di tornare in Italia a Torino a rivedervi tutti, ma a così breve tempo da quando sono partito le cose mi sembrano già così cambiate che questo desiderio si allontana subito, perché tutto è già così mutato che pensare all’Italia, se non fosse per voi tre, non farebbe altro che immalinconirmi. [...] Sono certo che se anche voi vedeste un poco tutti questi campi immensi gialli-oro per il grano che matura, le macchine grandiose che avanzano rombando, i compagni che alla sera volontariamente dopo la fine della loro giornata lavorativa se ne partono a caricare i sacchi di frumento che non si è fatto in tempo a raccogliere durante il giorno, vi sentireste un poco tranquillati [sic]. E credo riuscireste a vedere in quei genitori che se ne vanno al tramonto a raccogliere gli ultimi sacchi della giornata, accompagnati dalle nidiate dei loro figli, come un simbolo della vitalità umana che non si fer132 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 ma mai e si trapassa senza tregua di generazione in generazione. [...] 4 giugno 1952 Due giorni fa abbiamo solennemente festeggiato «Hag habicunim», «La festa delle primizie». Anche quest’anno v’è stata una bellissima sfilata dei rami agricoli che successivamente portavano sul palco le loro primizie destinate al Keren Kaiemet9. V’è stata naturalmente anche una giuria che destinava premi ai rami che si fossero particolarmente distinti sia nel lavoro dei mesi precedenti sia nella loro partecipazione alla manifestazione. E quest’anno il primo premio (una gita a teatro) ce lo siamo proprio presi noi dell’orto. E in verità ce lo siamo meritato. Siamo comparsi con una specie di treno formato dal trattore, dalla seminatrice e da un rimorchio sul quale erano disposti in bell’ordine sacchi e cassette delle nostre verdure ed inoltre ci stavamo anche noi solidamente piantati con un tubo per l’innaffiatura sulle spalle al quale erano appesi grappoli formati da verdure intrecciate. Insomma abbiamo fatto colpo. Questo almeno è stato il parere della giuria. [...] 18 giugno 1952 La cosa principale che ci occupa adesso è il lavoro. Ogni giorno escono da qui due o tre camion carichi di prodotti o grano o miele o verdure o frutta o polli ecc. ecc. E perciò si è sempre occupatissimi. Ma l’importante è che le cose filano seppure con qualche ora di lavoro in più e con qualche alzata al mattino presto. [...] 10 luglio 1952 Sono arrivati per un mese come «campo di lavoro» una trentina di baldi giovani della sezione di Tel-Aviv. Sono veramente un grande aiuto e li facciamo sgobbare ben bene. È finito il raccolto del grano e i lavoratori di questo ramo hanno fatto una poderosa bevuta e mangiata in loro onore. Se lo sono meritato. Il valore della giornata lavorativa è arrivato in questi mesi sulle 17 lire israeliane. Se pensate che 3 lire è la giornata lavorativa media vedrete che hanno sgobbato bene. [...] 1° agosto 1952 Carissimi, stavolta vi scrivo a matita perché come voi siete ad Alassio a godervela, anche io mi faccio vivo dalla nostra stazione balneare. Mi trovo cioè nei campi a sorvegliare l’innaffiatura e vi assicuro che si sta abbastanza... freschi. Mi trovo più precisamente nel famoso campo delle ex patate che stiamo preparando per le prossime colture. La prima innaffiatura è particolarmente intensa e non vi sono molti spostamenti di tubi da fare e perciò è sufficiente una persona sola che apre i rubinetti e guarda come vanno le cose. E per fortuna le cose vanno con calma, l’acqua esce regolarmente da dove deve uscire e rimane dentro dove deve stare dentro (e non viceversa come capita alle volte) cosicché ho trovato persino il tempo per scrivervi. [...] 133 Paolo Valabrega 4 settembre 1952 Noi ci troviamo attualmente al centro delle grandi manovre annuali. Tutta la regione è invasa da automezzi carichi di soldati. Ci stiamo preparando a sostenere un attacco da parte dei «verdi» che si prevede per dopodomani sera. Nel complesso è una cosa abbastanza divertente anche perché possiamo andare a comprare ottimi gelati da uno speciale veicolo che li trasporta per i soldati. [...] A proposito degli scontri di pattuglie non è assolutamente il caso che vi impressioniate. Adesso vi dirò in un orecchio di che si tratta, ma è un’informazione piuttosto delicata che vi do perché non stiate in pensiero. Il fatto è che come in ogni paese del mondo anche qui vi sono corsi per ufficiali, specialisti ecc. ecc. Nel corso di tali corsi si fanno esercitazioni «vere» e cioè incursioni esplorative oltre frontiera, se si incontrano nemici si fa fuoco naturalmente, e così ci scappa il morto da una parte e dell’altra. Se poi pensate che anche gli arabi come logico faranno simili «studi» è pressoché inevitabile un continuo susseguirsi di incidenti. Questa è la spiegazione piuttosto schifosa invero, almeno secondo me, ma non escludo che vi siano anche altre questioni. 25 settembre 1952 Noi abbiamo passato capo d’anno molto bene, festeggiandolo a tre riprese: la prima fra noi italiani, poi con i lavoratori dell’orto ed infine con tutto il kibbuz. E la terza volta è stata la più bella perché inaspettata. Si era in stanza da pranzo per la riunione settimanale, ma poiché era Rosh-Ashanà naturalmente la gente nicchiava a venire. Allora tanto per scaldare l’atmosfera abbiamo cominciato a cantare e così poco a poco ci si è messi sempre più in allegria, la gente entrava tutta stupita a vedere il segretario seduto dietro al suo tavolo che faceva il direttore del coro, alla fine si è mandato al diavolo l’ordine del giorno, in un istante sono stati tolti di mezzo tavoli, sedie e panche e si è cominciato a ballare. È comparsa una fisarmonica, sono venuti i ragazzini, insomma una cosa da vedersi, impossibile a descriversi. Sul giornale «Hechaluz» compaiono in questi anni diversi articoli di Gadi. Alcuni non mancano di suscitare cori di proteste nel movimento; altri sono invece più narrativi. Uno dei principali bersagli polemici continua ad essere quella mentalità piccolo-borghese che Gadi vede mettere radici anche all’interno della società kibbuzistica. Nel maggio 1951 esce a questo proposito un lungo articolo a titolo La «POSTA»: Si sa che la forte maggioranza dei chaluzim proviene dalla piccola borghesia, e che attraverso una rivoluzione personale essi si trasformano, si fanno operai, contadini, classi sane, semplici. [...] Il giovane uscito dalla piccola borghesia con tutte le ansie, la superficialità, abbranca la 134 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 nuova idea, trova ciò che per tanto tempo ha cercato, i compagni che ha sempre aspettato, si disperdono nel nulla i sogni stolti di una comoda «bella vita» borghese, si imparano nuove concezioni più semplici, più sane, più reali. Si è detto «con entusiasmo», ma questo può per un certo periodo di tempo essere sufficiente per la vita di snif [sezione] o di hachasciarà, non è più così in kibbuz. Allora succede che dopo aver sopportato in hachsciarà un periodo di traversie spirituali, intorno alla soluzione delle quali ci si è molto affaticati, ma a cui si è sempre data una spiegazione affermando che era una vita momentanea, imperfetta e che quella del kibbuz sarebbe stata ben diversa, ci si ritrova in kibbuz nelle medesime condizioni di indecisione spirituale, di mancanza di coerenza interna. Giacché in kibbuz le cose sono fondamentalmente assai poco dissimili dall’hachsciarà e quindi i termini dei problemi non mutano, bensì si approfondiscono, si precisano, diventano più complessi. Il piccolo borghese in kibbuz si agita di continuo su certi suoi motivi caratteristici, ne fa il centro della vita e, giunto all’estremo della sua crisi personale, inizia una critica a fondo del kibbuz. Dopo tanta strada, dopo tanti entusiasmi, dopo tante sofferenze, egli si ripropone le medesime domande che si era fatto in principio, agli inizi. Ma allora non sapeva niente, oggi sa (o crede si sapere) e vede (o crede di vedere) come si svolgono le cose. E succede che ci si dichiara incapaci con le proprie forze a darsi una risposta e quindi si cercano aiuti in chaverim più preparati, o nello studio assiduo e metodico, ed allora si potrà ancora pervenire ad un vero chaluzismo; oppure se questa persona è già riuscita a darsi una spiegazione negativa del kibbuz, ebbene, costui se ne andrà per un’altra strada. [...] Poiché chi arriva al kibbuz senza aver cambiato radicalmente modo di vivere, di ragionare ecc. non ha capito i termini del fatto stesso oppure non ha saputo giudicare fino a qual punto, dove e in che cosa doveva cambiare per entrare a far parte della società senza classi del kibbuz. [...] Nei riguardi del lavoro vari possono essere i suoi atteggiamenti. Anzitutto può considerare il lavoro semplicemente come un dovere ineliminabile. E quindi finite le proprie otto ore quotidiane, ogni dovere è compiuto: se si lavora in più si è senz’altro sfruttati o truffati. Si lavora passivamente, senza guardare al di là della propria fatica. Non esiste slancio realizzatore stakanovista, non vi è legame profondo di amicizia con i compagni di lavoro. [...] Alle volte, invece, ci si getta ciecamente nello sforzo per riuscire ad esaurirsi in esso, per sfiancarsi, per non pensare. Ma è chiaro che una tale situazione non è sostenibile a lungo. Basterà un cambiamento di stato d’animo, dovuto a cause magari quasi impercettibili, per essere gettati in un’altra crisi. Così pure la cultura, così com’è intesa collettivamente, può apparirgli come una cosa noiosa e insulsa, e lo strano è che può probabilmente apparire tale anche a chi ne possiede già una certa dose (egli allora dirà che ne è «nauseato»). [...] Pure di fronte alla chevrà queste persone assumono atteggiamenti quali nessun altro. Anzitutto nei confronti delle autorità costituite provano sempre una invincibile e anar- 135 Paolo Valabrega chica antipatia. E così nella loro immaginazione mazkirut [direttivo], vaadot [commissioni], assefot [assemblee] ecc. diventano inutili organismi burocratici. Si assiste alle volte a veri complessi di inferiorità del chaver piccolo-boghese. Non si trova il coraggio di parlare nelle assefot e si balbetta e si arrossisce, oppure si cade nell’eccesso opposto e si urla senza ugualmente riuscire ad esprimersi. E sempre vi è una qualche questione da regolare con qualche vaadà; sempre, senza saper bene il motivo, si esce dalla regola, oppure non si hanno mai da porre questioni di principio e ci si lascia trascinare dal parere altrui come se non si sapesse usare la propria ragione. [...] Ma il caso più triste si ha quando il chaver si accorge di non saper addirittura concepire i rapporti di chevrà. Egli li confonde con amicizie poco chiare derivanti a volte da oscuri complessi sessuali, oppure con... i primitivi legami di membri di tribù. Che risponderemo al piccolo-borghese? Come controbatteremo le accuse, e come spiegheremo le incomprensioni? [...] Non ci rimane che un unico tentativo da fare. Prenderlo, cioè, per mano e condurlo, la sera, a spasso per il kibbuz. Non c’è mica poi tanto da vedere, né tanto meno di eccezionale: c’è solo da osservare quel ritardatario mezzo nudo che corre in doccia, questo che se ne va a casa con il figlio a cavalluccio, quest’altro che si affretta verso il chadar ochel [sala da pranzo]. E sai come questa tranquillità sia vera, sia forse una delle pochissime paci vere in questo mondo teoricamente tutto in pace. E sai tutti i paragoni che si usano fare, con gli operai delle città che non hanno di che nutrirsi, con i contadini che lavorano ancora con metodi feudali, con lo studio nelle università ben lontano ancora dalle libertà illuministiche nell’ambito delle quali dovrebbe fiorire il sapere. [...] Osserviamo dunque per un momento ancora dall’alto della torre dell’acqua il fiammeggiante tramonto sugli zrifim [baracche] e sui binianim [case] del kibbuz. (Come sono belle le tue tende, Giacobbe, i tuoi padiglioni, Israele). Questa è la «posta» in gioco!10 Sul tema della composizione di classe del movimento, e sul difficile tentativo in Italia di indirizzare al chaluzismo i giovani sottoproletari dei ghetti di Roma e Livorno, esce l’articolo Opinioni di chaverim, del luglio 1951. All’articolo è anteposta una nota redazionale: Pubblichiamo il seguente articolo di Gadi, di cui però non condividiamo le idee. [...] Noi crediamo che la hachsciarà debba essere aperta a tutti e che chiunque, da qualsiasi classe venga, possa abbracciare la nostra causa, lavorare, studiare e lottare con noi; noi vogliamo solo degli uomini, non degli intellettuali o degli «idealisti»: a S. Marco diventeranno dei lavoratori coscienti. In questo momento ci rivolgiamo in particolare agli ambienti ebraici più popolari, cui finora non è mai giunta la nostra voce, e cerchiamo di portarli sulla nostra strada, at- 136 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 tività questa di carattere oltre che sionistico puro e semplice anche di grande interesse sociale e umano, poiché solo una vita di lavoro in Erez Israel può rappresentare una soluzione a una vita di miseria e disoccupazione in Italia. Il compito è difficile, le forze a nostra disposizione deboli, ma la soluzione a questo problema non deve essere lasciata ad altri, perché oggi siamo i soli a poter agire in questo senso. Questa invece la tesi di Gadi: Da quale classe sociale provengono i chaluzim, coloro che cioè dai tempi delle prime aliot hanno creato via via kvuzà [collettivo] e kibbuz, histadrut e palmach? È logico comprendere che questo quesito sorga ora nel movimento Hechaluz italiano, quando la scarsità dei membri della tnuà [movimento] si fa sempre più sentire. Secondo dati sicuri si sa che la piccola e media borghesia ebraica sono le classi donde provengono più del 90 per cento dei chavrei-hechaluz di tutti i paesi della golà; è evidente quindi, almeno secondo me, che per quanto il movimento Hechaluz d’Italia si trovi in difficoltà per la mancanza di elementi, prima di decidere che in Italia «le cose non vanno come negli altri paesi» (ed allora in ogni campo è facile passare a comportarsi in maniera particolare e però pericolosa e audace) occorre esaminare e studiare i fatti alla luce delle dottrine che seguiamo e delle nostre esperienze. [...] Secondo me è impossibile affrontare il dibattito senza che ci si sia spiegati e messi d’accordo su alcuni termini fondamentali quali sottoproletari, proletari, piccola e media borghesia, poiché l’equivoco su certe parole, come ben si comprende, può portare a incomprensioni assai più seccanti di concetti ed idee. Ed allora chi sono questi proletari? Proletari sono coloro che come unica ricchezza quale mezzo per la loro esistenza, possiedono la forza delle loro braccia. Siamo dunque tanto sicuri che in Italia vi siano, in quantità «industrialmente» sfruttabile, ebrei braccianti agricoli, operai o tranvieri o muratori? Qui si impongono due obiezioni fondamentali. Primo, i proletari sono la classe spiritualmente e materialmente più lontana dallo spirito di rivoluzione borghese che ancora circola per le vene del movimento Hechaluz Italchi e, secondo, che non mi pare moralmente simpatico né utile per gli idealistici chaluzim il tentativo, invero troppo machiavellico, di distogliere, se pure per la santa causa, dalle file del proletariato italiano questi molto problematici proletari ebrei, basandosi esclusivamente sul fatto che le schiere della rivoluzione italiana si trovano in questo momento in difficoltà. Che forza avrebbero degli individui venuti a noi solo perché sperano di trovare la via più facile? E che direbbero quando si accorgessero che in verità in Israele il proletariato è forse molto più lontano dalla conquista del potere che in Italia? [...] Il desiderio di popolare la hachsciarà di sottoproletari (o secondo Marx Lumpenproletarier) spero non venga udito da qualche astuto borghese in vena di piantar grane, perché forse questa volta sarei costretto a dar ragione ai suoi scandolezzamenti, se addirittura Lenin diffidava di questi sottoproletari, che sono sì esseri umani perfettamente correggibili, ma per mezzo di quei sacrosanti campi di lavoro forzato istituiti 137 Paolo Valabrega nell’URSS appositamente per questi esseri asociali, ladri, prostitute, delinquenti ecc. ecc. E se si vorrà trasformare la hachsciarà in un pio istituto di rieducazione alla moda sovietica la cosa sarà quanto mai utile e meritoria (non si sono visti cambiamenti miracolosi in questi uomini che la società capitalistica ha gettato ai margini della vita?), ma allora però la hachsciarà non vi sarà più, almeno così come la intendo io. Studiamo ora brevemente questa piccola e media borghesia ebraica, croce e delizia del chaluzismo. Croce, perché i più grandi difetti dell’ebraismo del galut sono imputabili a lei, delizia perché proprio da questi vizi, da questa sua abiezione, è scaturita infine quella forza disperata di adattamento e al lager e allo sforzo di ricostruzione nazionale, al kibbuz. Praticamente è impossibile sradicare il proletario dalla sua classe senza svigorirlo ed eliminarne le doti, praticamente impossibile è rieducare in grande stile i sottoproletari, possibile è solo trarre le nostre forze da quella piccola e media borghesia dalla quale se mi volgo intorno vedo tutti proveniamo11. Ancora pieno di ideali - e di evidenti riferimenti personali - è l’articolo dell’ottobre 1951 La fuga da casa, dedicato «ai giovani che devono venire in hachsciarà quest’anno». Che sono poi molti degli stessi zofim a cui Gadi già si era rivolto ai tempi del seminario di Bardonecchia, l’anno precedente. Questa è la verità, chaverim, sempre quando si viene in hachsciarà si scappa. (Scappare in questo caso significa volgersi rapidamente alla direzione opposta a quella cui si era diretti e correre per una strada nuova come se si avesse timore che qualche cosa ci volesse fermare). Si scappa o in maniera clamorosa e poliziesca (quando il questurino ti rincorre su e giù per il pisano) o in maniera machiavellica e silenziosa, o addirittura col permesso delle varie autorità famigliari. Il fatto tuttavia rimane sempre evidente nella sua essenza: si taglia con il passato violentemente, si passa dalla teoria alla pratica, si agisce, volontà intelligenza e sentimento si compongono meravigliosamente in un tutto unico per respingere quello che è stato ed essere solo avvenire. Si scappa da casa, si va in hachsciarà coscienti quindi, come abbiamo sempre saputo da un mucchio di tempo, che si abbandonano gli studi, gli amici, gli usi. [...] Mettiamoci dunque l’animo in pace: la fuga da casa è una cosa per noi logica, coronamento evidente di una lunga attività precedente e preludio a questi atti. Si deve uscire di casa, si deve iniziare una vita diversa, è inutile giocare con le parole e non è nemmeno onesto: si rompe violentemente col passato. [...] So bene che questi discorsi sono forse un poco inutili perché se c’è qualcuno che fa il sordo e non vuol capire, non sarà la mia misera voce a ridonargli l’udito, ma qualche cosa desidero ancora dire a quegli indecisi dalle idee decisissime di progresso, di rivolta ed altre cose belle. 138 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 Il mondo è fatto di fatti. Di americani a Livorno, di razzismo, di fabbriche di armi, di scioperi, di percosse, di ribellioni, di milioni di operai e di rivolte contadine, di montagne di libri; pure il nostro animo di rivoluzionari conseguenti deve vivere all’unisono con il palpito di questo mondo, - e se non in prima fila, dove? -, e la nostra prima linea passa per le dune del Neghev ed i monti rocciosi del Galil, per i kibbuzzim in lotta con il capitalismo ebraico nascente. Son parole troppo grosse forse? Può darsi, ma a me è difficile, anzi impossibile non inquadrare la questione in questi termini. A noi la possibilità di «fare qualche cosa» è data. È meravigliosamente possibile uscire di casa sulle vie del mondo, ribellarci, vibrare un colpo a quella borghesia in agguato, come un diavolo per farci fermare, farci cadere. È possibile venire in hachsciarà, in Israele, con i chaverim, fare parte di un Movimento, sentirsi motore e mosso nello stesso tempo. Autunno: l’hachsciarà minaccia di chiudersi, ma noi ce ne ridiamo. Anche quest’anno verranno i chaverim a rinnovare il miracolo della moltiplicazione dei chavrei-Tel Broshim, un po’ alla spicciolata, un po’ con il contagocce, ma verranno. Si fuggirà ancora da casa. L’hachsciarà rimarrà ancora aperta12. Del marzo 1952 è l’articolo Giornata di ghius, che dovrebbe essere l’ultimo scritto firmato da Gadi pubblicato su «Hechaluz» in questo biennio 1951-1952. Un piccolo bozzetto di vita di kibbuz: Ieri ho partecipato a ghius per le madrechot. Mi spiego. Esiste a Ruchama una decisione dei chaverim per cui i marciapiedi «salvafango» vengono costruiti dai chaverim stessi che fanno per questo a turno ciascuno una giornata lavorativa all’anno. Dunque questa settimana è toccato a me che vi ho partecipato per la prima volta. E ci si è trovati in buon numero di mattino, presto, in una limpida e fredda giornata. Già tutto era stato preparato il giorno prima dai lavoratori del binian affinché la produttività del lavoro fosse massima: le due macchine per preparare l’impasto di cemento erano perfettamente oliate, i mucchi di sabbia, di ghiaia, di sacchi erano ben disposti e a fianco a loro pale, turle, arnesi. E via, si incomincia a lavorare. Avevamo da fare una «iezikà», una gettata di cemento, per un vasto marciapiedi, con alcuni allacciamenti, questo il piano di lavoro. Getto le prime palate di sabbia nel ventre della mia mescolatrice, si aggiunge ghiaia e cemento, si versa nella prima carriola. I lavoratori del binian dirigono i lavori, sono presenti nei punti nevralgici. Ma in verità anche fra i vatikim si rivela l’esperto muratore che ha sì cambiato il mestiere, ma la mano l’ha ancora buona, e come! E l’opera prosegue le braccia dolgono per il lavoro inconsueto, ma via avanti avanti. E chi è che non vorrebbe rallentare il ritmo? Ma è la macchina che noi guidiamo che 139 Paolo Valabrega ce lo impone, da cui ce lo facciamo imporre! Il complesso lavoro è ben presto organizzato e si sente solo più il rumore delle macchine che ruotano e le grida di incoraggiamento e di guida: la confusione è solo apparente, giacché tutto procede con regolarità, ognuno intento alla sua opera. Brevi istanti per intravvedere i compagni di lavoro. Ecco Benzion, il madrich, il dolce educatore, specialista linguistico del kibbuz, trasformarsi nel mio «capo» diretto che guida l’impastatrice con mano ferma e impartisce direttive, incita, corregge, con la forza e il vigore degli anni in cui lavorò al porto. Ecco Uriel, direttore della fabbrica di spazzole, erculeo, alto, grosso, che da solo guida il carrello pieno di cemento. Questo è per lui già il terzo anno di ghius, ché vi partecipò dal principio. Ecco Alex ed Israel due trattoristi della haslamà che si cimentano con turla e pala invece che con freni e leve. E qui c’è Daniel e Mielo, i maestri, Salec del garage, Zvi anche lui della fabbrica, Mordi il vignaiuolo. Ma malgrado le molteplici provenienze la chevrà s’è già ben fusa insieme, come il cemento con la sabbia. Il sole ascende in alto, ma il vento fresco ne attenua i raggi, fa anzi quasi freddo. Intorno c’è un pulviscolo grigio e i capelli si infarinano un poco, uno schizzo prepotente t’arriva sui calzoni. Dopo colazione cominciano le visite. Lavoriamo infatti nel centro del kibbuz e son pochi quelli che non vengono a vedere come procedono i lavori. Arrivano le mogli con i figli, vengono i chaverim che guidano in visita i loro bambini, passano scapoli dalle gambe lunghe, si fermano e lanciano un’occhiata e un frizzo, è pieno di ragazzini che giocano con la sabbia fino all’istante in cui viene presa e gettata nella macchina. Via, via il lavoro procede, si completano gli scomparti in cui è diviso il marciapiedi, si congiungono, si dà la lisciata finale, un trattore porta sbuffando una platforma [sic] carica di sabbia, riparte, ne porta una seconda, la macchina di destra ha un guasto presto risolto e subito riprende a sbuffare e ruotare. Le carriuole [sic] continuano ad andare avanti e indietro. Ma i muscoli si sono abituati allo sforzo e l’opera procede ergonometricamente esatta. Una chaverà passa, si ferma, dà uno sguardo in giro, poi afferra una turla e si mette a lavorare di lena per un quarto d’ora, poi si rassetta con un colpo i capelli, si raddrizza e va per i fatti suoi. Pranzo, le due, le due e mezza, le tre. Ci si approssima alla fine, il lavoro diviene un poco convulso, rapido: ecco qui è finito, lì quasi, presto presto, liscia in quell’angolo, la cazzuola, svelti con la carriola, adagio, su con la ruota, ghiaia, sabbia, cemento, acqua, avanti, avanti. La «iezikà» è finita, il tuo giorno di «ghius» è passato, un’occhiata al lavoro compiuto e, svelti, in doccia. Quest’inverno il fango darà meno fastidio.13 Verso la fine del 1952 l’orizzonte politico si fa plumbeo, e la tempesta 140 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 si avvicina veloce: nel volgere di pochi mesi le contraddizioni in seno alla sinistra socialista esploderanno clamorose. Da una lettera di Gadi alla famiglia, 15 novembre 1952: Qui in questi giorni siamo tutti sotto l’impressione del processo di Praga, in cui come saprete è implicato anche Mordechai Oren, dirigente del nostro partito, e capo dell’Agenzia Ebraica di Praga qualche anno fa. Le discussioni ed i commenti sono vivissimi in ogni angolo, dalla doccia alla stanza da pranzo, nelle camere ecc. ecc. Purtroppo fra le nostre file v’è una certa qual confusione e incapacità a chiarire le varie posizioni. Anche nella direzione del Partito si sono manifestati pareri discordi. Ieri sera Sharett (ministro degli esteri) ha fatto alla Camera dei deputati una dichiarazione sulla questione, tale che se lo pescassero in Cecoslovacchia lo fucilerebbero addirittura senza processo! E in Italia che se ne dice? Cosa ne pensano i comunisti italiani di questo processo, avendo alcuni di loro aiutato i Sionisti nel 1947-48 proprio come Slanski e soci? E, infine, da una lettera a Gadi di Carlo Ottino della fine di dicembre 1952, che precorre molti degli avvenimenti di lì a breve: Ho letto con molta attenzione ciò che mi scrivi dei problemi kibbuzistici [...]. Mi sembra che si vada accentuando la posizione contraddittoria in cui si dibatte lo Stato d’Israele, sistematicamente asservito dalla cricca socialdemocratica di Ben Gurion all’imperialismo americano (anche la posizione rispetto al preteso «antisemitismo» comunista dopo il processo al traditore Slanski mi pare significativa): mi pare quindi che i problemi di vita del Kibbuz – sabotati dalle autorità governative e dalla maggioranza dell’Histadruth, e del resto non autosufficienti nella struttura capitalistica e semicoloniale del paese – rischino di diventare in talune circostanze quasi accademici (nel mare delle difficoltà!), se non riusciranno ad inserirsi fondamentalmente nella lotta dei Partiti operai (unità dei lavoratori ebrei ed arabi, alleanza fra città e campagne chaluziste) per lo sviluppo democratico e indipendente d’Israele. - La tesi è appena accennata: scrivimi, con particolari riferimenti al Kibbuz Arzì ed alle tue personali esperienze. Nel corso del 1953 i processi in Cecoslovacchia e in Unione Sovietica contro funzionari ebrei accusati di alto tradimento producono una crisi profonda all’interno della sinistra israeliana, mentre il governo laburista ormai apertamente si orienta verso la sfera di influenza occidentale. Nel partito MAPAM si apre una spaccatura, con la scissione della corrente filo-sovietica guidata da Moshe Sneh, Chativat Smoll [Frazione di Sinistra], che spinge ad un più forte impegno rivoluzionario nelle città, abbandonando il modello rurale del kibbuz, e si impegna finalmente per l’unione dei proletari ebrei ed arabi. Un’ondata di epurazioni attraversa tutte le strutture del partito, e an141 Paolo Valabrega che Guido Valabrega – che non aveva mai nascosto il suo dissenso politico e nel frattempo era stato obbligato al servizio militare - viene espulso dal kibbuz Ruchama a causa di un articolo fortemente critico pubblicato in Italia su «Hechaluz». Nell’estate la vicenda volge ad un drammatico epilogo: Sergio, unico fratello di Guido Valabrega, viene colpito da una forma di poliomelite. Rientrato in Italia con un permesso straordinario per gravi motivi familiari, Guido Valabrega non farà mai più ritorno in Israele. Per dare un’idea delle sue posizioni, riporto un’ultima lettera, indirizzata il 1° ottobre 1953 al compagno Giuseppe Tedesco: Caro Josef, proprio in questi giorni m’è capitato di rileggere sull’Hechaluz n. 11 del 30 luglio il tuo breve ma vibrante articolo in memoria dei Rosenberg. Ed è proprio ricordando i due martiri ebrei americani che mi sono sentito spinto a scriverti, a mettermi in contatto con te che sempre ti sei mostrato sensibile di fronte alle sofferenze degli oppressi ed alle persecuzioni che vengono inferte ad esseri umani per la loro razza, la loro religione, la loro nazionalità. Lo sdegno del mondo tutto per l’assassinio americano è ben comprensibile, tanto più logico lo sdegno ebraico per la sorte dolorosa imposta ai due correligionari. Ma permetti che aggiunga che non ci si deve fermare qui. Specialmente gli ebrei che si considerano socialisti hanno il dovere di continuare in nome dei Rosenberg la lotta contro quel tipo di persecuzioni cui accennavo più sopra. Per questo, di fronte al selvaggio «antiarabismo» che si va formando nello Stato di Israele attualmente, ho sentito il dovere di richiamare la tua attenzione e per quanto sarà possibile il tuo aiuto concreto. Io credo che la nostra concezione della questione nazionale sia piuttosto simile, si possa insomma compendiare nella frase di Marx che «non può essere libero, un popolo che opprime altri popoli»; per tal motivo sono anche convinto che vorrai interessarti al problema arabo, alla situazione dei 150.000 cittadini arabi dello stato d’Israele. Più o meno conoscerai i termini generali della questione, l’obbligo ai cittadini arabi a risiedere in date zone, impedimenti alla possibilità di spostarsi, regime militare, e quindi disinteressamento particolare dell’autorità per quanto riguarda l’educazione pubblica, i diritti sindacali, la sanità ecc. ecc., ma il «nuovo» che s’è in questi ultimi tempi aggiunto sono vari singoli episodi cui voglio accennare, episodi che purtroppo alle volte dimostrano come pure vasti strati di ambienti operai, che si autodefiniscono socialisti, di socialista per lo meno nei confronti della questione araba non hanno che un’etichetta e male appiccicata. Pensa dunque che è successo, e non in un solo caso, che madri di famiglia arabe, fuggite ai tempi della guerra di liberazione antinglese in Transgiordania, rientrate da due o tre anni in Israele, pur avendo a lungo richiesto la cittadinanza israeliana, sono state in questi giorni strappate con la forza dalle loro famiglie, e sono state trasportate fuori dai confini dello Stato. 142 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 Di nuovo Gadi al lavoro a Ruchama 143 Paolo Valabrega È capitato che un gruppo di lavoratori arabi del Galil, che non avendo ottenuto permessi di viaggio per recarsi sul posto di lavoro vi si recavano clandestinamente a condizioni salariali naturalmente da fame, è stato sorpreso e punito con pene elevatissime; pensa gli arabi sono stati puniti, non il datore di lavoro! Ugualmente tragica è la situazione delle tribù nomadi di beduini del Neghev, che sempre con la scusa di ragioni militari si sono viste scacciare dai luoghi di pascolo su cui vagavano da centinaia di anni e al posto dei terreni coltivabili di cui finora hanno usufruito hanno ricevuto territori assolutamente incoltivabili e privi di pozzi. E infine permetti che termini questa incompletissima rassegna dei nostri vergognosi atti citando i furti di terre arabe compiuti dai kibbuzim dell’Hashomer Hazair14 Sassa, Kfar Masarik e Bar Am; i chaverim di tali colonie per impedire che i contadini arabi si rinsediassero nella loro zona originaria, dalla quale erano stati scacciati per ragioni militari, hanno distrutto a colpi di dinamite il villaggio arabo di Bir Am. Ed ora nel migliore dei casi danno in affitto agli arabi le terre che essi hanno rubato a questi stessi arabi! Tale episodio lo posso solo paragonare al furto di bestiame compiuto qualche anno fa dal kibbuz Zikim ai danni degli arabi della zona, ricettatori del qual furto furono Ruchama e, se non sbaglio, Jad Mordechai. Di fronte a tale situazione si è costretti a domandarsi: valeva la pena di faticare come s’è faticato per giungere a ciò? È questo il risultato da noi desiderato? Questo, Josef, sentivo il dovere di comunicarti alla vigilia della vostra alià: che il lamento di tanti miseri venga da voi ascoltato. So che questa forma di saluto non è l’usuale ormai stereotipata che si usa fare, ma ho la certezza che non verrà disprezzata. Che il vostro garin fra tutti i vari compiti che deve assumersi non dimentichi mai quello di lottare per la difesa delle minoranze oppresse! Gadi Note al testo 1 Questo articolo è pubblicato sotto licenza «Creative Commons Attribuzione-Non commerciale 2.5 Italia». È consentito riprodurre, distribuire, comunicare, esporre, rappresentare, eseguire o recitare quest’opera o parti di quest’opera, a condizione di attribuirne correttamente la fonte. Non è consentito alcun uso commerciale. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/ 2 Israel [Corrado Israel De Benedetti], Hachsciarà e kibbuz, in «Hechaluz. Giornale per la gioventù ebraica», Anno V, n. 9, 25 gennaio 1950, p. 2. 3 Acronimo di Noar Haluzì Lohem, Gioventù Pioniera Combattente, corpo giovanile che unisce compiti militari al lavoro in un kibbuz o moshav [azienda agricola cooperativa]. 4 La «riunione delle diaspore» in Israele, più che obiettivo, ragione d’essere del movimento sionista. 144 Guido Valabrega «Gadi» pioniere del kibbuz Ruchama, 1951-53 5 Il «Fronte per il consolidamento del partito» è la corrente pilotata dall’Hashomer Hazair. 6 C.D. [Corrado Israel De Benedetti], Impressioni dal Congresso del «Mapam», in «Hechaluz. Giornale per la gioventù ebraica», Anno VI, n. 13, 20 luglio 1951, pp. 3-4. 7 Uri Chaim [Corrado Vivanti], La festa del lavoro ieri e oggi, in «Hechaluz. Giornale per la gioventù ebraica», Anno VI, n. 11, 28 maggio 1951, pp. 7 e 8. 8 Corrado Israel De Benedetti, I sogni non passano in eredità. Cinquant’anni di vita in kibbuz, Firenze, Giuntina, 2001, pp. 31-32. 9 Fondo Permanente per Israele, la principale organizzazione finanziaria sionista, sorta all’inizio del Novecento con la finalità di acquistare terre in Palestina. 10 Gadi [Guido Valabrega], La «POSTA», in «Hechaluz. Giornale per la gioventù ebraica», Anno VI, n. 11, 28 maggio 1951, pp. 2 e 8. 11 Gadi [Guido Valabrega], Opinioni di chaverim, in «Hechaluz. Giornale per la gioventù ebraica», Anno VI, n. 13, 20 luglio 1951, p. 2. 12 Gadi [Guido Valabrega], La fuga da casa, in «Hechaluz. Giornale per la gioventù ebraica», Anno VI, n. 15, 4 ottobre 1951, p. 3. 13 Gad [Guido Valabrega], Giornata di ghius, in «Hechaluz. Giornale per la gioventù ebraica», Anno VII, n. 4, 7 marzo 1952, p. 2. 14 La memoria di questi fatti ritrova parole di indignazione ancora trentacinque anni dopo tra gli scritti di Guido Valabrega: «Nei pressi del kibbuz Ruchama esistono tuttora le rovine di un villaggio arabo fatto saltare con la dinamite. Esso è chiamato dai membri del kibbuz, con tono spregiativo, Jamama [...]. Certo i sionisti-socialisti di Ruchama non hanno avuto tanto ribrezzo delle terre palestinesi delle quali si sono impadroniti nel 1948: i vecchi kibbuznikim vogliono dimenticare, i giovani rifiutano di sapere» (Gruppo di ricerca sul Medio Oriente contemporaneo – Milano, Nakba. L’espulsione dei palestinesi dalla loro terra, Ripostes, Salerno - Roma, 1988, p. 36). 145 Un caso di mancato attacco preventivo: gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) di Paolo Soave Il programma nucleare cinese: dalla dipendenza all’autonomia dall’URSS Fra il 1949 e il 1968 si consumò quella che è stata definita la fase “rivoluzionaria” della politica estera della Cina popolare. Raccolta un’eredità di asservimento alle grandi potenze, Mao Tse-tung intese affermare la natura ideologico-nazionale del regime contro quel sistema bipolare che tendeva a cristallizzare i rapporti di forza e, quindi, a frustrare gli sforzi di emancipazione dei paesi più arretrati. La rivoluzione maoista elevata a politica estera, d’altra parte, pur potendo far leva su una certa solidarietà internazionale, non poteva eludere la difficile realtà interna del mancato sviluppo. Continui furono i compromessi fra la purezza dottrinaria, che imponeva un ruolo internazionale rigidamente antisistemico, e la necessità di inserirsi fra le altre potenze per sostenere la modernizzazione della Cina. L’elemento rivoluzionario, pertanto, si ridimensionò nel tempo alla tutela del maoismo senza ostacolare, sul piano empirico, il conseguimento del preteso status di potenza autonoma e emergente1. Il programma nucleare cinese, varato da Mao il 15 gennaio 1955 denominato in codice “02”2, fu una delle manifestazioni più convincenti della controversa condizione internazionale del paese. Esso costituì una delle variabili indipendenti che maggiormente condizionarono, dalla seconda metà degli anni cinquanta al primo test atomico del 1964, l’evoluzione dei rapporti sino-sovietici e la politica di sicurezza americana. Sul piano strategico Pechino si proponeva di acquisire nei confronti degli Stati Uniti, percepiti come concreta minaccia anche per la crescente influenza da essi esercitata nel settore asiatico, una capacità di deterrenza autonoma da quella fornita dall’alleato sovietico, da far valere soprattutto come strumento di pressione sul regime nazionalista di Taiwan, la cui sopravvivenza era garan147 Paolo Soave tita proprio da Washington. L’obiettivo ideologico, quello più legato alla natura del regime comunista, sarebbe invece emerso nel tempo, con il passaggio dalla cooperazione alla rottura con Mosca. I tenaci sforzi sostenuti dai cinesi tesero in sostanza a spezzare la stretta morsa bipolare imposta da entrambe le superpotenze, l’una, quella americana, percepita come ostile e strategicamente minacciosa, l’altra, quella sovietica, come egemonica in quel campo economico ed ideologico nel quale la Cina popolare maggiormente intendeva affrancarsi3. La questione atomica, chiave di lettura non marginale dei rapporti fra Mosca e Pechino, consente di evidenziare alcune discontinuità e contraddizioni nella politica estera del Cremlino. I termini delle relazioni fra i due paesi furono originariamente impostati con rigoroso realismo da Stalin che, dopo aver preso atto dell’affermazione di Mao, decise nel 1950 di estendere l’ombrello atomico dell’URSS alla Cina popolare. Essa, guardata con un certo sospetto per le peculiarità del suo processo rivoluzionario rispetto al modello sovietico, avrebbe fatalmente assunto il ruolo di nuovo satellite all’interno dell’orbita moscovita4. Il conflitto coreano tuttavia promosse rapidamente Pechino al rango di partner politico-strategico del Cremlino5. Scomparso Stalin caddero molte delle riserve nutrite dalla dirigenza sovietica per l’esperimento rivoluzionario cinese e, fino al 1958, vi fu spazio per una intensa collaborazione fra i due paesi6. Fra il gennaio e l’aprile 1955, contestualmente al varo del programma nucleare cinese, l’URSS assunse una serie di impegni volti a incoraggiare e sostenere materialmente i progetti di Pechino, con forniture di uranio e plutonio, la cessione di un reattore e di un ciclotrone e l’invio di numerosi esperti per la formazione degli scienziati locali7. Il 15 ottobre 1957 Mosca si spinse al passo decisivo: avrebbe messo a disposizione dell’alleato un prototipo di bomba atomica entro tre anni8. Kruscev comprese ben presto di aver commesso una leggerezza: nonostante l’avvio della destalinizzazione, egli intendeva preservare una leadership sull’intero campo comunista che soprattutto in ambito nucleare doveva essere monolitica9. Mentre il Cremlino aveva inteso favorire lo sviluppo interno cinese, anche per bilanciare l’influenza che, attraverso il Giappone, gli Stati Uniti esercitavano dalla fine del secondo conflitto mondiale nel settore asiatico, Mao perseguiva il rilancio della contrapposizione bipolare attraverso un’escalation che andava nella direzione contraria a quella della politica estera sovietica. Le scelte di campo del Cremlino costituivano un freno alle spregiudicate e potenzial148 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) mente destabilizzanti rivendicazioni cinesi, in particolare riguardo al destino di Formosa, che non poteva essere forzato senza evitare un catastrofico scontro con gli Stati Uniti, e nella crisi di confine con l’India, che vide l’URSS assumere una posizione equidistante per non compromettere le relazioni con il fronte dei non allineati10. Nel corso della grande diatriba comunista maturata sul finire degli anni cinquanta, i programmi nucleari cinesi si trasformarono da una delle cause originarie nella conseguenza strategica della frattura. Essi acquisirono una duplice legittimazione: militare, come strumento con cui provvedere su basi nazionali alla difesa del paese, non più garantita dall’ex alleato, e politica, come guanto di sfida lanciato contro la non più inattaccabile leadership sovietica. Nel corso del XXI congresso del PCUS Kruscev propose la costituzione di un’ampia zona denuclearizzata compresa fra l’Estremo Oriente e il Pacifico, con cui avrebbe potuto pretendere un analogo impegno da parte americana riguardo alla Germania occidentale e, allo stesso tempo, prevenire l’autonomia atomica cinese. L’argomento tendeva a consolidare proprio quello spirito di distensione fra superpotenze che Mao, anche attraverso la bomba, voleva piuttosto minare. Né ebbe miglior esito, quando la rottura fu ormai consumata, l’accusa del Cremlino secondo la quale la dirigenza cinese, anziché affidarsi alla difesa offerta dall’URSS, preferiva sostenere gli alti costi di un programma nucleare nazionale non compatibili con lo stato dell’economia cinese11. A Pechino i militari si erano divisi tra chi riteneva prioritaria la modernizzazione dell’apparato difensivo garantita dall’URSS e chi, al contrario, in ossequio alla concezione ideologica della rivoluzione permanente, preferiva affidarsi all’esercito di massa, costituito dalla forza d’urto di tre milioni di uomini armati che, all’occorrenza, secondo Mao, potevano diventare addirittura cento. Alla vigilia del viaggio a Mosca dell’agosto 1958 Mao sintetizzò efficacemente questo scontro interno, che vide prevalere gli ideologi sui modernizzatori, con lo slogan secondo il quale l’atomica altro non era che una “tigre di carta”. Il “grande timoniere” certo non intendeva rinunciare ai suoi programmi nucleari quanto, piuttosto, enfatizzare la sua concezione ideologica della bomba in contrapposizione a quella strategica coltivata dalle altre potenze12. Probabilmente in nessun altro contesto quanto in quello strategico-diplomatico si manifestava chiaramente il paradosso della politica estera di un paese che, pur rivoluzionario, ambiva a uno sviluppo che ne favorisse il riconoscimento internazionale. La dirigenza comunista poteva così rivendicare il diritto all’atomica, contribuen149 Paolo Soave do alla proliferazione, e allo stesso tempo schierarsi in favore della pace e del disarmo. In fondo, come sosteneva Mao, la Cina non avrebbe dovuto temere la guerra nucleare quanto USA e URSS: una volta dissoltasi la nube atomica sarebbe sopravvissuta la forza rivoluzionaria del suo vasto popolo. Pertanto, tatticamente Mao avrebbe tenuto conto di tutte le potenze, che tuttavia rimanevano, strategicamente, in una prospettiva di lungo periodo, destinate a soccombere in quanto dotate della sola arma atomica e, per questo, mere “tigri di carta”13. Il 20 giugno 1959 il Cremlino denunciò gli impegni assunti con Pechino e l’anno seguente richiamò i propri esperti, anche in vista delle trattative avviate con gli americani per giungere alla messa al bando degli esperimenti atomici14. Privato del sostegno sovietico, il programma nucleare cinese potè proseguire solo attraverso la valorizzazione delle risorse locali. Doveva rivelarsi cruciale, in tal senso, l’apporto degli scienziati formatisi all’estero. Il capo del progetto missilistico, Tsian Hsue-shen15, si era perfezionato nel 1935 al MIT, per poi lavorare al Caltech, in California, al tempo il più prestigioso istituto d’aereonautica del mondo. Coinvolto nella ricerca al servizio dell’aviazione statunitense durante la seconda guerra mondiale, mise a punto il primo missile d’alta quota americano. Nel 1955 in clima di “caccia alle streghe” e a seguito della guerra di Corea, Tsian e gli altri tecnici cinesi furono espulsi dagli Stati Uniti. Accolto al ritorno in patria come una delle massime autorità mondiali nel campo della propulsione a reazione, Tsian divenne responsabile del nascente programma missilistico grazie al quale la bomba atomica cinese sarebbe divenuta, nel tempo, una concreta minaccia per il territorio americano. Da parte sua il fisico Tsien San-chiang16, direttore dell’Istituto di energia atomica, aveva avviato al termine del secondo conflitto mondiale una stretta collaborazione con i premi Nobel Frédéric e Irène Joliot-Curie, padri della bomba francese che, fermamente convinti della necessità di infrangere il monopolio atomico degli Stati Uniti, incoraggiarono i programmi cinesi e fornirono da Parigi il proprio appoggio17. La Cina riuscì, in tal modo, a superare gli ostacoli di natura tecnica relativi ai processi di fissione (per l’atomica) e di fusione (per l’ordigno all’idrogeno), mentre maggiori difficoltà furono incontrate nel reperimento delle scorte di materiale fissile. Nel 1958, anno del dispiegamento degli ordigni atomici americani a Formosa, venne istituita la cosiddetta “Nona Accademia”, l’ente cinese preposto alla ricerca nell’ambito degli armamenti nucleari, e fu avviato l’allestimento dei primi laborato150 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) ri a Baoutou e a Lanzhou per la produzione di uranio arricchito. Nel 1960 venne avviata anche la costruzione di un reattore per la produzione di plutonio, a Jiuqhuan, e di un sito per gli esperimenti atomici a Lop Nur18. Kennedy e l’incubo cinese Quella rappresentata dalle “due Cine” fu una delle eredità dell’amministrazione Eisenhower più sgradite per Kennedy, che pur intuendo la crescente influenza che Pechino avrebbe nel tempo esercitato, in particolare in Asia, intendeva subordinare l’interpretazione del complesso enigma cinese alle esigenze del prioritario rapporto bipolare con l’URSS. Curare l’intesa con Kruscev doveva apparire al presidente non solo più importante, ma anche più semplice che trattare direttamente con Mao. Non sfuggiva inoltre all’amministrazione americana che la crisi sino-sovietica poteva costituire un argomento su cui far leva per ammorbidire la linea del Cremlino sui grandi temi19. Nel settembre 1959 gli americani raccolsero le prime prove fotografiche del programma atomico di Pechino, e a partire dall’agosto 1960 furono disponibili anche le prime immagini satellitari20. La reazione fu di viva apprensione, pur in presenza di un’agenda che, in tema di politica estera, presentava priorità ben più concrete quali quelle legate a Cuba e a Berlino. Nel corso di quello che fu il passaggio più delicato della guerra fredda l’avvento di un terzo incomodo nucleare, irriducibilmente ostile agli Stati Uniti e fuori dall’orbita di controllo sovietico, suonava come l’elemento in grado di far crollare l’intero “castello bipolare”, oltre che di contrastare la crescente influenza della Casa Bianca nel settore asiatico. L’eventualità di un test nucleare cinese divenne per Kennedy un vero e proprio incubo, addirittura «the most significant and worst event of the 1960s»21. Anche il monitoraggio dei progressi nel campo della ricerca atomica, affidato all’intelligence, risultando lacunoso e frammentario, contribuì a rendere plausibili gli scenari più diversi, compresi quelli più preoccupanti. La stessa stima dell’aiuto fornito dai sovietici costituì un dilemma dall’incerta soluzione. Per la CIA il primo test nucleare cinese avrebbe dovuto tenersi nel 196322, ma secondo un più allarmistico rapporto dello Stato Maggiore dell’Aviazione esso sarebbe potuto avvenire già nel 196123. Inoltre, entro il 1965 la Cina popolare avrebbero disposto di un certo numero di bombardieri e dopo il 1970 avrebbe conseguito la capacità di raggiungere il ter151 Paolo Soave ritorio americano con missili intercontinentali. Le risposte americane dovevano essere necessariamente flessibili: all’indomani del primo, simbolico test, la Casa Bianca avrebbe dovuto rassicurare i propri partner asiatici con progetti di difesa integrata resi credibili dalla presenza di nuove basi militari, previste anche in Australia e Alaska. Anche la promozione di una potenza atomica asiatica, se necessario, avrebbe favorito il ripristino dell’equilibrio strategico regionale. Nel momento in cui la Cina popolare avesse conseguito un’effettiva capacità atomica, comprovata dall’esistenza di un arsenale, gli Stati Uniti sarebbero passati alla dislocazione nei paesi amici, in particolare in Giappone, dei propri missili. Infine, quando Pechino fosse stata in grado di minacciare lo stesso continente americano, l’integrazione strategica asiatica e la presenza americana si sarebbero perfezionate secondo il modello difensivo già applicato in Europa occidentale. La Cina popolare, analogamente all’URSS, sarebbe stata cinta da un anello di sicurezza costituito dalle basi strategiche disseminate in Giappone, Taiwan, India e Filippine, in grado di monitorare il territorio cinese e dissuadere un eventuale attacco24. Certo tali contromisure, come sottolineavano le analisi provenienti dagli ambienti militari, non avrebbero potuto scongiurare il rischio della proliferazione: quello cinese poteva diventare un modello di successo per altri paesi emergenti tale da compromettere la sicurezza internazionale che, considerata in epoca atomica un gioco a somma zero, poteva venir annullata da qualsiasi attore25. Vi era inoltre una certa tendenza, in queste valutazioni, a enfatizzare l’impatto politico della bomba cinese sugli equilibri asiatici e, quindi, sulla stessa capacità americana di tenere le posizioni nella regione, in particolare nei riguardi dei partner più esposti alla nuova minaccia26. Alla Casa Bianca maturò nel tempo la convinzione che la prospettiva di un futuro approdo all’atomica da parte di Germania e Cina popolare dovesse costituire per Kruscev un duplice incubo, tale da rendere il leader sovietico disponibile a collaborare, su tali temi, con gli Stati Uniti o, in alternativa, a non opporsi a un’eventuale azione di forza unilaterale volta a prevenire la realizzazione dei programmi di Mao27. Kennan e Harriman, consumati “sovietologi” dell’amministrazione democratica, suggerivano di sondare e sfruttare la presunta debolezza di Kruscev, ad esempio lasciando trapelare un possibile linkage fra la questione tedesca e quella cinese. L’occasione individuata alla scopo fu quella del vertice programmato a Vienna per il giugno 196128. In Austria tuttavia Kennedy constatò come Kruscev 152 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) tendesse ancora a dissimulare la questione cinese. Il segretario del PCUS, confidando nella possibilità di recuperare ancora il rapporto con Pechino, intendeva porsi al riparo dall’accusa di accondiscendenza ai voleri del campo “imperialista” mossa proprio da Mao29. Quando il presidente americano prospettò la messa al bando degli esperimenti atomici quale antidoto a un’incontrollata proliferazione di potenze nucleari, portò allo scoperto la posizione sovietica sulla Cina. L’idea, la cui paternità spettava all’amministrazione Eisenhower, aveva già prodotto nel 1958 una prima moratoria accettata anche dalla Gran Bretagna30. Mosca e Washington erano accomunate dall’esigenza di difendere il loro monopolio strategico all’interno delle rispettive sfere d’influenza: all’anomalia francese rappresentata dalla force de frappe corrispondeva, almeno potenzialmente, quella ben più destabilizzante della Cina popolare. Intrapresa la via autonoma all’atomica, la dirigenza di Pechino sarebbe tornata sui propri passi solo in caso di una messa al bando della bomba, tale da imporre il disarmo generalizzato. Quanto alla proliferazione, come detto, essa non rappresentava per i cinesi un fattore in assoluto negativo: avrebbe piuttosto rafforzato la posizione dei paesi intenzionati a affrancarsi dal duopolio delle superpotenze31. Il trattato, d’altra parte, avrebbe permesso agli Stati Uniti di ampliare il fossato fra sovietici e cinesi, spingendo forse i primi a collaborare per prevenire i programmi nucleari dei secondi che, a loro volta, si sarebbero trovati isolati, anche economicamente, in ambito internazionale32. Nell’aprile 1962 la CIA, sulla base di nuovi elementi, procrastinò i tempi dell’esperimento cinese oltre il 1963, «perhaps by as much as several years» 33. Veniva invece confermato che la produzione di uranio, attraverso l’aiuto sovietico, era finalizzata all’ottenimento di plutonio, ritenuto l’elemento base del programma nucleare di Pechino. Le prove fotografiche raccolte evidenziavano come i siti missilistici, simili a quelli dell’URSS, fossero orientati verso Occidente. I vettori presenti a Shuang Cheng Tzu, nel nord del paese, con un raggio di 1100 chilometri, avrebbero potuto raggiungere le regioni meridionali dell’URSS e, se dislocati altrove, l’India, l’Indonesia, le Filippine e il Giappone. Nonostante i rallentamenti dovuti al ritiro dei tecnici sovietici, in particolare nei settori dei missili a lunga gittata e dei sottomarini, i cinesi erano ormai in grado di procedere su basi nazionali. Mao poteva così rivendicare con orgoglio le ricadute positive che il programma nucleare aveva prodotto sull’industria pesante, anche se l’elevato costo che il paese stava sostenendo aveva imposto un drastico ta153 Paolo Soave glio al budget dell’esercito popolare. La soluzione che George McGhee, direttore del Policy Planning Council del Dipartimento di Stato propose al segretario di Stato Rusk dovette sembrare un azzardato rilancio della posta atomica in Asia: incoraggiare gli sforzi dell’India in campo nucleare e spingere Nuova Delhi a precedere il temuto test cinese al fine di controbilanciarne la portata, non solo in ambito strategico, ma anche in quello politico. L’ipotesi di un bipolarismo asiatico, seppur indotto dalla Casa Bianca, non raccolse alcun favore in seno al Dipartimento di Stato, data la comprovata intransigenza di Rusk sul tema della proliferazione. Piuttosto il segretario di Stato accolse una successiva proposta di McGhee, nel settembre 1962, per una campagna propagandistica da affidarsi in parte alle covert operations gestite dalla CIA, volta a contenere l’inquietudine che il previsto esperimento cinese avrebbe prodotto soprattutto nell’opinione pubblica34. Si trattava, in pratica, di ribadire con l’enfasi del caso la schiacciante superiorità degli Stati Uniti in ambito nucleare, al cospetto della quale i modesti progetti cinesi, sconfessati dagli stessi sovietici, non apparivano certo in grado di minare le garanzie fornite dalla Casa Bianca ai partner asiatici. Le implicazioni dell’ascesa di Pechino dovevano essere contrastate soprattutto in ambito politico-diplomatico: al fine di evitare che la Cina popolare potesse trovar credito alle Nazioni Unite sarebbe stato necessario isolarla, quale potenza destabilizzante, e rinsaldare il fronte pacifista dei paesi interessati a negoziare un trattato per la messa al bando dei test nucleari. Nel corso di una riunione del National Security Council, del gennaio 1963, Kennedy illustrò quella che poteva ormai ritenersi la prima opzione per gestire la questione cinese. Le trattative con i sovietici per la messa al bando degli esperimenti nucleari avrebbero dovuto fruttare la collaborazione di Mosca per attuare una contrapposizione comune ai programmi di quella che, in prospettiva, era destinata per il presidente a divenire la maggiore antagonista degli Stati Uniti. L’incubo si sarebbe così trasformato in profezia35. I militari, al contrario, non riponevano molte speranze nella collaborazione sovietica. Una nota riservata di Curtis LeMay, capo di Stato Maggiore, prospettava una vasta gamma di possibili azioni militari preventive, quali infiltrazioni in territorio comunista, sabotaggi, offensive condotte dalla Cina nazionalista, blocchi navali, attacco della Corea del Sud ai danni di quella del Nord come strumento di pressione ai confini di Pechino, operazioni aeree convenzionali su siti nucleari e, extre154 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) ma ratio, il ricorso a ordigni atomici tattici su obiettivi selezionati. Qualora l’URSS avesse collaborato fattivamente, o non si fosse apertamente opposta, le misure adottate si sarebbero rivelate più incisive e le conseguenze indesiderate meno destabilizzanti. Anche LeMay, significativamente, individuava nell’atteggiamento del Cremlino l’elemento discriminante nella delicata scelta della condotta da seguire. Verosimilmente Kruscev non avrebbe potuto tollerare simili “acts of war” sferrati dal campo occidentale contro l’emisfero comunista. D’altra parte la speranza che tramite Mosca, in virtù della sua supposta «better position to exercise the leverage on Communist China» sarebbe stato possibile ottenere l’adesione di Pechino al trattato sui test, appariva del tutto illusoria. Il generale concludeva sconsigliando un’azione unilaterale preventiva, che non avrebbe potuto contare su alcun consenso internazionale e che, soprattutto, avrebbe innescato una temibile escalation militare, con possibili implicazioni atomiche, senza peraltro costringere Mao a sottoscrivere l’accordo36. D’altra parte un rapporto del Policy Planning Council concludeva che la bomba avrebbe costituito per Mao solo una «political weapon to earn respect, to promote neutralism, to encourage revolutionaries»37. A metà maggio McGeorge Bundy38, consigliere alla sicurezza nazionale, tentò un approccio sulla questione cinese con l’ambasciatore sovietico Dobrynin, la cui reazione, tutt’altro che incoraggiante, fu alquanto significativa. Egli si scagliò contro la proposta americana di costituzione di una forza multilaterale (MLF)39 e il conseguente coinvolgimento tedesco nella gestione nucleare in seno alla NATO, lasciando intuire che essi rappresentavano per il Cremlino degli ostacoli che si frapponevano a una costruttiva discussione del problema cinese. A nulla valse l’assicurazione di Bundy secondo cui la MLF intendeva proprio rafforzare il controllo sulla Germania, anche nell’interesse sovietico. Alla possibilità di sacrificare tale progetto pur di ottenere la collaborazione dell’URSS si oppose Rusk, che ricordò come il rapporto con gli alleati occidentali, al cui rafforzamento era volto il programma di forza multilaterale, non fosse negoziabile per la Casa Bianca. Il timore cinese di Kennedy, d’altra parte, non smosse neppure De Gaulle40. Tuttavia, quando alle Nazioni Unite, nel corso del 1963, Gromyko respinse l’accusa di Rusk secondo la quale l’URSS molto aveva contribuito a alimentare l’insorgente minaccia cinese, dimostrò buona volontà precisando che, almeno per il Cremlino, non sussistevano ostacoli al negoziato che avrebbe dovuto condurre al trattato per la messa al bando de155 Paolo Soave gli esperimenti e che avrebbe finito per isolare proprio Pechino. Non era in effetti nell’interesse delle superpotenze sacrificare la lotta comune contro la proliferazione per una divergenza di valutazioni sul particolare, rappresentato dalle ambizioni atomiche di Pechino41. Accolta da Kruscev la proposta formulata dal premier inglese Macmillan per una conferenza fra Stati Uniti, Gran Bretagna e URSS, Kennedy inviò in missione a Mosca il “veterano” Harriman, al quale affidò il difficile compito di far emergere i timori del leader sovietico per i programmi cinesi al fine di ottenerne la disponibilità «either to take Soviet action or to accept US actioned» per prevenire l’approdo di Pechino all’atomica42. La risposta del segretario del PCUS avrebbe costituito l’elemento discriminante nel processo decisionale in corso alla Casa Bianca, in quanto la collaborazione fra superpotenze poteva realmente rendere incisive le misure volte a isolare la Cina. L’unico intervento unilaterale praticabile dagli Stati Uniti sarebbe stato quello del ricorso alla forza, ma esso avrebbe prodotto gravi conseguenze nei rapporti con l’URSS. Si trattava dell’ultima risorsa disponibile per tentare di arrestare la proliferazione atomica, individuata da McNamara come la vera minaccia alla supremazia internazionale degli Stati Uniti43. A Mosca Harriman sondò l’esatto limite della disponibilità sovietica: il Cremlino confermava l’interesse all’accordo, ma non intendeva spingersi oltre, rifiutandosi di offrire una collaborazione che potesse rendere coercitiva la messa al bando degli esperimenti per i paesi non firmatari. Ulteriormente sollecitato dal presidente, Harriman tentò di mettere alle strette Kruscev chiedendogli come avrebbe reagito nel caso in cui la Cina popolare avesse puntato i propri missili contro il territorio sovietico. Il segretario del PCUS replicò accusando gli americani di non aver a loro volta controllato e prevenuto i programmi nucleari francesi. A questo punto l’inviato statunitense rilanciò con un’ulteriore provocazione: qualora gli Stati Uniti avessero convinto De Gaulle a firmare il trattato di non proliferazione, l’URSS si sarebbe impegnata a ottenere un analogo impegno da parte di Mao? Kruscev si sottrasse al memorabile scambio di battute concludendo che come potenza nucleare la Cina sarebbe stata paradossalmente meno pericolosa e più giudiziosa, una considerazione peraltro condivisa anche da alcuni analisti americani44. In realtà i sovietici erano più preoccupati di quanto non lasciassero trapelare, come dimostrano le pressioni esercitate sui cinesi, fino a pochi giorni prima della firma del trattato, per appianare le divergenze fra Mosca e Pechino45. Di fronte a simili resistenze Kennedy promosse la questione cinese 156 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) a minaccia alla sicurezza nazionale e su richiesta di William Bundy lo Stato Maggiore fu incaricato di predisporre un piano di intervento convenzionale per ritardare lo sviluppo dei siti nucleari di Pechino46. La via diplomatica non aveva potuto ottenere niente più che la firma di Kruscev al trattato del 5 agosto 1963 che metteva al bando gli esperimenti nucleari in superficie e nell’atmosfera47. La speranza che il leader sovietico potesse spingersi oltre ignorando le voci che in seno al Politburo si erano già levate a difesa di quello che restava pur sempre un paese comunista, era risultata avventata. L’accordo, che dopo la crisi di Cuba accomunava le due superpotenze nello sforzo di esercitare un più stretto controllo sugli ordigni nucleari in uno spirito di distensione, fece precipitare i rapporti sino-sovietici al minimo storico e, secondo la concezione di Mao, rafforzò la legittimità stessa del programma nucleare cinese48. Il confronto alla Casa Bianca, più che mai aperto data anche l’insoddisfazione di Kennedy, conobbe un punto di svolta nel successivo mese di settembre, quando Chiang Ching-kuo, figlio di Chiang Kai-shek, si recò in visita a Washington nella speranza di convincere l’alleato a agire prontamente per prevenire l’incombente minaccia e evitare che essa potesse divenire «a problem more difficult to handle»49. Intrattenendosi con il presidente egli suggerì l’invio di un commando nazionalista composto da 300500 uomini per colpire le infrastrutture nucleari, un tipo di operazione che aveva già ricevuto l’assenso della CIA. Kennedy, sostenuto dal consigliere Bundy, non voleva rischiare un’escalation ben più temibile della prospettiva di una Cina popolare potenza atomica, inoltre mentre l’esito del raid si presentava altamente incerto una delle conseguenze indesiderate più probabili sarebbe stata quella del riallineamento fra Pechino e Mosca. Bundy in particolare sembrava nutrire forti dubbi sull’efficacia di interventi affidati alle limitate forze nazionaliste. Un’azione congiunta sarebbe stata preferibile, ma gli americani non si sarebbero mossi se non in presenza di un quadro più nitido dell’effettivo potenziale comunista e non prima di aver prudentemente soppesato ogni possibile ricaduta. Per il regime nazionalista, d’altra parte, la pressione da sostenere era ben superiore a quella avvertita a Washington: l’atomica nelle mani di Mao avrebbe segnato il definitivo tramonto della residua speranza di sovvertire l’ordine politico a Pechino e, soprattutto, posto una minaccia mortale alla sopravvivenza di Taiwan. Tuttavia quando la Casa Bianca rigettò la formula proposta del now or never negando il proprio avallo a una missione nazionalista, a Chiang 157 Paolo Soave non restò che rimettersi alla volontà dell’alleato e accontentarsi della costituzione di un gruppo di studio che avrebbe dovuto pianificare l’eventuale attacco di forze nazionaliste contro i siti nucleari comunisti. Solo in caso di approvazione congiunta da parte delle massime autorità dei due paesi l’operazione avrebbe avuto seguito50. Di fatto la Casa Bianca aveva scelto, escludendo l’intervento preventivo. Le ragioni di tale orientamento trovarono conferma nelle analisi misurate che giunsero dal Political Planning Council, ad opera del suo direttore Walt Rostow e, soprattutto, da parte di Robert Johnson. Per quest’ultimo il presupposto di partenza era che la capacità di cui Pechino era sul punto di disporre, lungi dal costituire una minaccia per gli Stati Uniti e i suoi interessi in Asia, avrebbe paradossalmente imposto alla Cina popolare i rischi connessi alla condizione di potenza nucleare, ma non ancora i vantaggi, esponendola a un attacco atomico ma non offrendo ancora la possibilità di colpire. Pertanto era ragionevole supporre un atteggiamento più prudente nei confronti della schiacciante superiorità strategica degli Stati Uniti. L’unico immediato vantaggio fornito ai cinesi dalla bomba sarebbe stato quello di una più credibile capacità di deterrenza verso le eventuali minacce convenzionali regionali51. Maggiori difficoltà avrebbe forse sofferto l’URSS, se la bomba avesse incoraggiato Pechino a sostenere posizioni particolarmente provocatorie in seno al blocco comunista. Pertanto «Soviet cooperation with the U.S. in containing Communist China is more likely to be tacit than explicit». La proposta di Robert Johnson era quella di non cavalcare la tigre atomica con la Cina popolare, di evitare significativi riposizionamenti di forze in Asia in risposta al previsto test e di enfatizzare piuttosto la palese capacità di immediata e devastante reazione convenzionale che gli Stati Uniti erano in grado di attuare. A rassicurare gli alleati regionali sarebbero bastati degli accordi bilaterali e l’impegno da parte americana di garantire la deterrenza nucleare in funzione anti-cinese, con un’analoga assunzione di responsabilità britannica a difesa di India e Pakistan. Johnson inoltre non sembrava attribuire credito all’ipotesi che la prima deflagrazione cinese potesse riaprire la questione della rappresentanza in seno alle Nazioni Unite indebolendo Taiwan. In ogni caso Washington non avrebbe dovuto rivedere la propria posizione al riguardo, rimanendo ancorata al principio di favorire una ricomposizione pacifica fra i due regimi cinesi. Le considerazioni rassicuranti di Johnson, che non imponevano un cambiamento di rotta nella politica asiatica de158 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) gli Stati Uniti, erano ormai acquisite da Kennedy e Rusk, ma c’era ancora spazio per le perplessità provenienti dal Pentagono. I militari concentravano le loro critiche soprattutto sul trattato sottoscritto a Mosca. Esso avrebbe potuto costituire il presupposto legittimante di un eventuale preemptive attack contro le infrastrutture nucleari cinesi, che seppur improbabile non poteva essere escluso a priori per non indebolire l’efficacia della deterrenza americana? Il generale LeMay nutriva dubbi sull’effettiva incisività dell’accordo, mentre Maxwell Taylor lo riteneva perfino inopportuno per gli Stati Uniti, pur offrendo il vantaggio politico di un ampliamento della spaccatura fra cinesi e sovietici52. Essi erano incoraggiati in parte dallo stesso presidente, che insoddisfatto di quanto ottenuto dai sovietici voleva mantenere praticabili tutte le ipotesi prese in esame, in parte dal timore che egli stesso si lasciasse condizionare dal corso dei rapporti fra superpotenze. Se “né con Mosca, né senza Mosca, né contro Mosca” era possibile neutralizzare la minaccia cinese, gli Stati Uniti si sarebbero trovati ridotti all’impotenza. Da tali presupposti scaturì, quattro giorni prima dell’eccidio di Dallas, l’“Unconventional Warfare Program BRAVO”53 predisposto dal generale Taylor, in pratica la prima pianificazione di intervento contro le infrastrutture nucleari cinesi attraverso l’impiego di mezzi convenzionali affidati a un team di un centinaio di sabotatori nazionalisti. La necessità di condurre un attacco multiplo per colpire tutti i siti esistenti sembrava addirittura imporre un attacco atomico, che peraltro venne immediatamente accantonato. BRAVO e le altre operazioni militari volte a prevenire la bomba avrebbero peraltro richiesto, attraverso le ricognizioni degli U2, il reperimento di informazioni accurate che gli americani non riuscirono mai a ottenere. Lyndon Johnson e la convivenza con l’atomica cinese Pur dissimulando ufficialmente l’esistenza di una minaccia cinese, Lyndon Johnson riprese in considerazione tutte le opzioni precedentemente esaminate rilanciando il confronto fra le posizioni contrapposte. Il principio della coesistenza con le “due Cine” restava ancora valido a tutti gli effetti e privo di alternative credibili54. Fra le contromisure soft l“Educative Program” adottato nel 1962 e avviato con la diffusione di materiale propagandistico si estese sino a coinvolgere la struttura della NATO, ideale strumento di propagazione di una campagna d’informazione internazionale. 159 Paolo Soave Il 7 maggio 1964, in una riunione tenutasi a Londra presso il Foreign Office, i rappresentanti dei paesi membri dell’Alleanza Atlantica esposti alla minaccia cinese, Canada, Australia e Nuova Zelanda, coordinarono i loro compiti55. Fra l’aprile e il giugno 1964 Robert Johnson illustrò in una serie di rapporti quello che poteva essere considerato il punto di vista delle “colombe” sui possibili interventi preventivi contro le infrastrutture cinesi56. Egli sostenne che, nella migliore delle ipotesi, il ricorso alla forza avrebbe potuto ritardare di qualche tempo l’approdo di Pechino alla bomba, ma non il definitivo fallimento del suo programma nucleare. Quest’ultimo, considerato il migliore dei risultati possibili, anche perché avrebbe dissuaso paesi come India e Giappone dall’alimentare a loro volta la proliferazione nucleare in Asia, veniva ritenuto altamente improbabile. Tra le opzioni praticabili Johnson prendeva in esame un attacco aereo convenzionale da parte degli Stati Uniti o della Cina nazionalista, una covert operation terrestre condotta da agenti infiltrati e un’incursione aerea ad opera di sabotatori provenienti da Formosa. L’elevato numero di obiettivi sensibili da cogliere, in larga parte ancora da identificare, e gli scarsi mezzi a disposizione del regime nazionalista, sembravano sconsigliare simili soluzioni. Non valeva la pena, soprattutto, di correre il rischio di un’escalation solo per guadagnare un po’ di tempo. La prevedibile rappresaglia cinese si sarebbe abbattuta su Taiwan e sulle basi americane in Asia orientale; ancor più grave sarebbe stata la reazione sovietica a tutela dell’integrità dell’emisfero comunista. I fantasmi della guerra fredda, scacciati altrove, sarebbero riapparsi in Estremo Oriente. Solo come risposta a un’aggressione cinese diretta contro un partner asiatico degli Stati Uniti il ricorso alla forza sarebbe stato legittimato da un certo grado di consenso internazionale, mai come azione preventiva, data anche l’asimmetria strategica fra le parti in causa. Se nonostante tali considerazioni l’amministrazione avesse comunque inteso tutelarsi in via preventiva, Robert Johnson raccomandava una covert operation che sottraesse la Casa Bianca al peso di responsabilità palesi. Più ampio risultava invece il ventaglio delle misure politiche, definite “unorthodox” dallo stesso Johnson, che comprendeva il già suggerito impegno formale alla rappresaglia in caso di aggressione, una dichiarazione congiunta con il Cremlino per negare qualsiasi assistenza ai paesi intenzionati a procurarsi la bomba, perfino la costituzione di una zona asiatica denuclearizzata, a partire dagli Urali, peraltro di scarsa praticabilità per lo scontato rifiuto di Pechino 160 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) e per gli alti costi che avrebbe imposto agli americani per il mantenimento della sicurezza regionale. Tramite Rusk, tali considerazioni giunsero sulla scrivania di Lyndon Johnson, segnando un punto in favore delle “colombe”57. Per gli uomini della National Security Agency, invece, ancora una volta era stato sottovalutato il pericolo cinese e le sue implicazioni politiche58. Gli elementi oggettivi su cui avrebbe dovuto consumarsi il confronto fra “falchi” e “colombe” furono nuovamente alterati dalla CIA, costretta a rettificare che, causa la scarsità di materiale fissile, il primo test nucleare cinese sarebbe probabilmente slittato al 1965, a meno che Pechino non avesse ottenuto scorte aggiuntive da paesi come l’URSS o la Francia. Per il sinologo Whiting la possibile data dell’esperimento era quella dell’1 agosto 196459. Il 15 settembre Lyndon Johnson e i suoi più stretti collaboratori determinarono una volta per tutte la linea di condotta escludendo l’ipotesi di un’azione unilaterale non provocata. La Casa Bianca avrebbe atteso l’esperimento nucleare cinese non più come un incubo, quanto piuttosto come una “fastidiosa” ma non drammatica fatalità. Naturalmente gli Stati Uniti si riservavano la possibilità di un intervento incondizionato nel caso in cui lo stato di tensione con Pechino fosse degenerato in vera e propria crisi60. L’orientamento emerso, apparentemente indefinito e analogo a quello maturato nel corso della presidenza Kennedy, tracciò più nettamente il limite da non valicare. Per la prima volta da quando i programmi nucleari di Pechino erano divenuti oggetto di attenzione, la Casa Bianca aveva superato quel particolare tabù, psicologico oltre che strategico, legato all’esperimento, capace di intimorire molti, a partire dallo stesso Kennedy, più ancora della minaccia rappresentata a lungo termine dalla nascita di un’autentica potenza atomica cinese. Questa fu la vittoria delle “colombe”, di chi come Roger Hilsman e Robert Johnson per anni avevano ripetuto che la bomba non avrebbe turbato gli equilibri asiatici, né avrebbe reso più minacciosa la politica estera della Cina popolare che, al di là della retorica aggressiva di Mao, restava nella sostanza prudente61. La prudenza, d’altra parte, si imponeva anche nei toni della campagna elettorale in cui era al tempo impegnato il presidente Johnson, per il quale, al contrario del suo predecessore, i programmi di Pechino non costituivano una minaccia per la sicurezza nazionale62. La svolta non rappresentava per i “falchi” la migliore delle soluzioni possibili. Nel corso della riunione decisiva il segretario di Stato aveva assunto l’impegno di sondare la posizione sovietica, e il 25 settembre McGeorge 161 Paolo Soave Bundy ebbe un colloquio con Dobrynin. Il rappresentante sovietico, pur ammettendo la gravità senza precedenti della frattura fra Mosca e Pechino, respinse anche in questa circostanza la prospettiva di una collaborazione fra superpotenze contro la Cina popolare ribadendo l’argomento, già di Kruscev, secondo il quale Pechino non avrebbe in nessun caso posto una minaccia diretta contro Mosca e Washington, né alterato gli equilibri asiatici63. Le ragioni addotte dai sovietici per negare il loro sostegno, curiosamente, erano analoghe a quelle risultate vincenti nel corso della decisiva riunione dei consiglieri di Lyndon Johnson. Le due superpotenze avrebbero tollerato l’esperimento atomico cinese pur constatando l’inutilità degli impegni solenni assunti contro il rischio della proliferazione. Lo spirito di distensione, d’altra parte, aveva già esaurito la fase di maggior slancio. Quando Dobrynin rivelò agli americani che, contrariamente alle previsioni della CIA, il test era imminente, la Casa Bianca decise di contenerne gli effetti con una dichiarazione ufficiale, del 29 settembre, in cui si annunciava che l’esplosione sarebbe potuta avvenire “at any time”, non mancando di aggiungere che Pechino difettava ancora dei necessari sistemi di lancio per le testate64. L’attesa fu comunque febbrile, almeno al Dipartimento della Difesa, dove fu prodotto un rapporto allarmante in cui si richiamava l’attenzione sul vero obiettivo di lungo periodo della Cina popolare, che dopo aver favorito la proliferazione atomica fra i vicini comunisti, eliminando l’influenza degli Stati Uniti in Asia, avrebbe puntato a acquisire, probabilmente entro gli anni ottanta, la capacità di colpire le metropoli americane con vettori intercontinentali65. Il test nucleare cinese e la reazione americana: dal rapporto Rathjens alla commissione Gilpatric Ottenuto l’uranio arricchito e simulata con successo la deflagrazione in “scala”, i cinesi avevano ultimato i preparativi in vista dell’esperimento entro la prima metà del 196466. Durante una visita in Mali, Zhou Enlai aveva così potuto preannunciare a Mobido Keiita il test per ottobre67. La prima atomica cinese esplose il 16 ottobre 196468. Il non casuale tempismo dell’esperimento, Kruscev era stato destituito da appena ventiquattro ore, volle solennizzare l’ingresso della Cina popolare nell’esclusivo “club atomico” proprio nel momento più acuto della crisi politica che aveva investito i vertici della potenza capofila del comunismo internazionale, quell’URSS 162 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) che aveva sostenuto e poi tradito le aspettative di Pechino69. Quello che per Mosca costituiva uno “schiaffo”, per Washington avrebbe dovuto teoricamente rappresentare una minaccia. In realtà la Cina popolare, in grado di produrre non più di un paio di ordigni all’anno, restava una potenza atomica virtuale. Il giorno stesso del test Pechino si affrettò a lanciare una campagna propagandistica volta a rassicurare la comunità internazionale e a salvaguardare la percezione esterna del paese. Violato il duopolio atomico delle superpotenze la Cina si impegnava a non ricorrere per prima all’impiego di ordigni nucleari e rilanciava la proposta di smantellamento di tutti gli arsenali esistenti. Ottenuta la bomba, i perenni equilibrismi di Mao fra rivoluzione contro il sistema bipolare e prudenza per ottenere un riconoscimento internazionale divennero ancor più delicati. C’era in effetti il fondato rischio che la Cina popolare venisse percepita, non solo al Pentagono, come una nuova minaccia strategica, mentre il fine politico cui anche i programmi nucleari erano asserviti era, al contrario, quello di guadagnare l’inserimento fra le potenze. Le dichiarazioni rilasciate da Mao alla stampa francese esprimevano tutto l’orgoglio nazionale per la capacità del paese di smentire le fosche previsioni di Kruscev sulle ricadute che il programma nucleare avrebbe avuto sull’economia nazionale, e ribadivano la volontà di pace della Cina70. Il test atomico, in sostanza, sembrava costituire più un punto di arrivo che di partenza, tanto che parevano schiudersi scenari insperati, vagamente intuiti dagli analisti americani più moderati, quali quelli relativi a un impegno di Pechino in funzione di un vasto piano di disarmo internazionale71. La deflagrazione fu puntualmente rilevata dai punti di osservazione americani, che registrarono alle 15,00 del 16 ottobre un’esplosione pari a 20 kilotoni nel deserto dello Xinjiang72. L’indomani il National Security Council discusse un ordine del giorno la cui più alta priorità era costituita dalla notizia della rimozione di Kruscev73. Solo il 20 ottobre, dopo aver esaminato i dati raccolti, gli analisti americani si resero conto, con viva sorpresa, che il test non aveva avuto il plutonio come elemento base ma, piuttosto, l’uranio 235. Fu, come ammise William Bundy, “quite an accomplishment”, che sconfessava clamorosamente anni di speculazioni della CIA e confermava come l’intelligence non fosse mai riuscita a penetrare i segreti del programma nucleare cinese. Da dove proveniva l’uranio impiegato? Neppure un massiccio aiuto sovietico, peraltro negato, avrebbe potuto offrire una spiegazione plausibile. Il mistero fu svelato in dicembre, quando 163 Paolo Soave le ricognizioni degli U2 evidenziarono che il reattore di Lanzhou, contrariamente a quanto creduto, era attivo. Soprattutto, l’impiego di uranio arricchito imponeva una rettifica allarmistica di tutte le stime dei successivi sviluppi. La Cina sarebbe divenuta una potenza nucleare di tutto rispetto ben prima di quanto fin lì supposto74. La reazione ufficiale della Casa Bianca, al di là della rinnovata preoccupazione per la proliferazione, che anche Lyndon Johnson riconosceva richiedere ora un approccio condiviso con l’URSS, fu nel complesso misurata, all’insegna dello slogan “Free World Nuclear Strength”, riecheggiante nei toni la stessa dichiarazione ufficiale di Pechino. Il presidente ribadì che non era il caso di sovrastimare la portata dell’esperimento e curiosamente, come aveva già sostenuto Kruscev, aggiunse che i costi del programma nucleare avrebbero avuto drammatiche ricadute economiche sul popolo cinese75. La speranza che l’avvenuto test potesse in qualche modo favorire l’insperato avvio del dialogo fra Washington e Pechino cadde immediatamente. Alla provocatoria proposta cinese di un vertice atomico per discutere di disarmo generale accompagnata dalla rinuncia al first use nucleare, Washington replicò chiedendo in cambio l’adesione di Pechino alla messa al bando degli esperimenti decretata a Mosca nel 1963, contropartita respinta da Mao76. Come previsto e suggerito dagli analisti più moderati gli Stati Uniti ribadirono il loro impegno a difesa dell’Asia e minimizzarono la rilevanza dell’esplosione, negando che da Oriente fosse sorta una nuova minaccia. L’avvento della “bomba gialla” fu piuttosto rivendicato con un certo orgoglio dai paesi non allineati, presso i quali il prestigio cinese crebbe considerevolmente77. A Taiwan, più ancora che in Giappone e in India, la reazione fu meno serena. Per Chiang Kai-shek l’atomica cinese poneva fine a qualsiasi velleità di restaurazione su terraferma, e esponeva il regime insediatosi a Formosa a una minaccia incombente e distruttiva, tale da rendere la sopravvivenza politica del regime totalmente dipendente dalla volontà degli Stati Uniti. Il leader nazionalista sollecitò un intervento americano volto a ripristinare l’alterato equilibrio strategico fra le “due Cine” e, soprattutto, chiese nuove concrete garanzie di prevenzione di un attacco atomico comunista che, seppur limitato, avrebbe cancellato Formosa. Egli confidò all’inviato della CIA Ray Cline di non avere interesse alcuno alla eventuale rappresaglia degli Stati Uniti contro Pechino, che non non sarebbe stata sufficiente a dissuadere Mao dalla tentazione di sacrificare qualche milione 164 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) di cinesi pur di annientare il regime nazionalista. Chiang riteneva di potersi a buon diritto accreditare più che mai, presso Washington, come campione dell’anticomunismo asiatico, nel momento in cui l’atomica rendeva nuovamente invasiva la propaganda maoista. Nel momento in cui intuiva come l’impegno assunto dalla Casa Bianca a difesa del suo regime potesse venire relativizzato da superiori ragioni di equilibrio internazionale legate all’emergere di un nuovo antagonista degli Stati Uniti, il leader nazionalista rilanciò il progetto di un raid contro i siti nucleari cinesi materialmente sostenuto dagli americani78. Tuttavia Rusk potè disimpegnarsi dalla richiesta enfatizzando la natura prudente della nuova potenza atomica. In definitiva, qualsiasi interrogativo sollevato dal test cinese sembrava poter essere sciolto, come concluse McNamara, riconoscendo che esso non imponeva mutamenti strategici di rilievo per gli Stati Uniti79. Il superamento del “tabù” rappresentato dal test atomico cinese non pose fine al confronto fra “falchi” e “colombe”, che si spostò sul più generale tema delle contromisure da adottare per fronteggiare la proliferazione nucleare. George Rathiens, membro della Arms Control and Disarmament Agency, contestò gli assunti di Robert Johnson, in particolare la supposta irrilevanza, nel breve e medio termine, dell’atomica cinese per gli equilibri asiatici, e l’assenza di una minaccia diretta contro gli Stati Uniti. Per Rathjens alcune delle maggiori città americane avrebbero potuto realmente essere distrutte in caso di attacco, mentre un’analoga perdita sarebbe risultata tollerabile per Mao. La bomba cinese, inoltre, inibiva di fatto il potenziale ricorso statunitense a ordigni nucleari tattici in Asia. Un intervento militare contro la Cina popolare, da condurre con l’eventuale appoggio sovietico, tornava a essere un’opzione attuale80. Per analizzare approfonditamente il tema della proliferazione Lyndon Johnson dette vita a un panel di “wise men”, ex esponenti del governo, chiamati a compiti di monitoraggio, sotto la guida di Roswell Gilpatric, già membro della Commissione parlamentare della Difesa. Nel rapporto finale81 si sottolineava come la proliferazione, riconosciuta minaccia all’interesse nazionale americano, potesse finire fuori controllo se quello cinese fosse divenuto un modello di successo per i paesi in via di sviluppo. L’eventuale bilanciamento strategico che un simile “effetto domino” avrebbe potuto produrre in Asia con l’avvento dell’atomica anche in Giappone e in India, non avrebbe certo compensato i rischi legati a una “chain reaction” estesa anche a altri continenti, inclusa l’Europa, dove era degno di attenzione il caso tedesco. Pertan165 Paolo Soave to si suggeriva agli Stati Uniti di dare il “buon esempio” assumendo il ruolo di potenza capofila nella lotta contro la proliferazione, da condursi con un approccio necessariamente multilaterale. La collaborazione sovietica, in tal senso, doveva essere acquisita per prima dalla Casa Bianca, anche se entrambe le superpotenze avrebbero dovuto impegnarsi seriamente per apparire credibili, come le critiche di Francia e Cina dimostravano. La commissione Gilpatric in concreto suggerì degli accordi che includessero tanto gli alleati degli Stati Uniti che quelli dell’URSS, il bando dei test atomici rafforzato da ispezioni internazionali, la costituzione di una Nuclear Free Zone comprensiva di America Latina e Africa, l’adozione di politiche volte a disincentivare la proliferazione attraverso la concessione di garanzie di sicurezza e, se necessario, il ricorso a restrizioni economiche, in particolare nei riguardi dei paesi sospetti di perseguire la bomba come India, Giappone, Israele e Repubblica Araba Unita. Tali misure rischiavano d’altra parte di portare alla luce alcune incoerenze presenti soprattutto nel campo occidentale: la pretesa autonomia atomica francese, ad esempio, minava la credibilità dell’impegno americano e doveva essere ridotta anche attraverso misure coercitive, mentre per l’arsenale nucleare britannico sarebbe stato sufficiente l’inglobamento in un unico sistema difensivo occidentale. Esso poteva essere costituito, a giudizio della commissione Gilpatric, dalla MLF che, lungi dal rappresentare una minaccia per il campo comunista, avrebbe potuto garantire il contenimento della proliferazione in Occidente riconducendo sotto un comando integrato più dispositivi strategici nazionali. Anche il problema tedesco avrebbe potuto essere risolto nello stesso modo. Ben più difficile si presentava il recupero della Cina popolare al comune sforzo contro la proliferazione internazionale. La Casa Bianca avrebbe dovuto prendere in considerazione un approccio più flessibile nei confronti di Pechino, il cui isolamento ostacolava qualsiasi compartecipazione agli accordi di disarmo. Nel pronunciarsi su un possibile intervento militare come misura estrema da adottare contro quei paesi che avessero inteso contraddire lo sforzo congiunto contro la proliferazione, la commissione rilevò che il ricorso alla forza avrebbe accentuato l’incoerenza delle potenze nucleari impegnate nel preservare il loro esclusivo status82. Implicitamente anche i lavori presieduti da Gilpatric confermarono la validità, insuperata anche dopo il test cinese, dell’approccio soft di Robert Johnson, pur in un contesto in cui andava aggravandosi il rischio di proliferazione. A ben vedere, il suggerimento più rilevante rivolto alla Casa Bianca fu 166 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) quello di tentare un’apertura con Pechino, una sorta di distensione asiatica che, partendo dall’implicito riconoscimento del nuovo status di potenza atomica, avrebbe potuto coinvolgere anche la Cina popolare nei negoziati per il disarmo e nella lotta contro la proliferazione83. Johnson non accolse con favore le considerazioni della commissione Gilpatric, che ipotizzando un approccio inedito e particolarmente coraggioso coglievano i limiti e le contraddizioni dell’impegno dell’amministrazione nella lotta contro la diffusione dell’atomica e suggerivano perfino un’apertura nei confronti di Pechino, ritenuta oltremodo prematura. Anche Rusk, del resto, restava persuaso che gli Stati Uniti dovessero mantenere un profilo imperiale e promuovere unilateralmente soluzioni quali, ad esempio, quella volta a costituire una sorta di «nuclear weapons bank», attraverso la quale mettere a disposizione di paesi ritenuti amici la bomba per bilanciare la Cina, in alternativa allo sviluppo di programmi nucleari autonomi84. La questione cinese non fu totalmente assorbita dalla lotta contro la proliferazione nucleare. Rusk riteneva in merito che l’eventuale riconoscimento del regime maoista avrebbe legittimato e incoraggiato la sua influenza ideologica e strategica sul continente asiatico, indebolendo la posizione americana. L’eventuale rappresentanza di Pechino in seno alle Nazioni Unite sarebbe stata interpretata dalla comunità internazionale come un riconoscimento dello status di grande potenza e quindi un premio alla proliferazione. La Casa Bianca si impegnò piuttosto, assieme ai suoi alleati, a interdire alla Cina popolare l’accesso ai prodotti a elevato contenuto tecnologico, per ostacolare gli ulteriori sviluppi del suo programma nucleare. Nel 1965 gli americani ipotizzarono che entro pochi anni i cinesi si sarebbero dotati di sottomarini in grado di sferrare un attacco contro il territorio americano lanciando missili dal Pacifico (SLBM). L’intelligence alimentò in tal modo il fantasioso timore della cosiddetta catalytic war, in base al quale Pechino avrebbe camuffato come sovietica l’eventuale aggressione agli Stati Uniti, la cui rappresaglia si sarebbe per errore abbattuta su Mosca. Paul Nitze, al tempo segretario della Marina, prese talmente sul serio tale scenario da sostenere l’opportunità di affondare preventivamente il primo sottomarino cinese che si fosse avvicinato alle Hawaii. Simili paure, che non tenevano in alcun conto la vera natura della politica estera cinese, di fatto immutata dopo il conseguimento della bomba, dovevano rivelarsi irragionevoli almeno sino agli anni ottanta, quando Pechino realmente mise a punto il sistema di lancio da sottomarino85. Esse tuttavia testimo167 Paolo Soave niavano come la Casa Bianca, che apparentemente aveva inteso esorcizzare la portata del test atomico del 1964, fosse ricaduta nell’incubo cinese di kennedyana memoria86. Il presidente che aveva elevato la Cina popolare, in qualità di nuova potenza atomica ostile, a minaccia per la sicurezza nazionale americana, aveva lasciato in eredità alla politica estera e di difesa statunitense un incubo e una profezia. Il primo era rappresentato dall’atteso test atomico di Pechino, la seconda dalla percezione che la Cina avrebbe assunto nel tempo il ruolo di grande antagonista internazionale degli Stati Uniti. Di fronte a tali prospettive egli mantenne in vita ogni possibile opzione, compresa quella di un attacco preventivo, ma seguì pragmaticamente la via più prudente non permettendo che la questione cinese potesse compromettere il rapporto bipolare fra superpotenze. Kennedy, prevedendo l’ascesa internazionale di Pechino, intuiva che prima o poi si sarebbe imposta per gli Stati Uniti l’esigenza di una revisione del sistema delle “due Cine”, ma l’incubo era al tempo troppo vicino e la profezia ancora troppo lontana per una così coraggiosa apertura nei confronti di una potenza ostile. Lyndon Johnson, meno profetico, non era altrettanto disposto a ammettere, riconoscendo l’esistenza di una nuova minaccia, l’avvento di una terza grande potenza, pertanto qualsiasi cambiamento di rotta nella politica di Washington nei confronti di Pechino fu escluso in partenza e l’approccio alla questione cinese rimase rigido. Fu nel più generale contesto della lotta contro la proliferazione nucleare che i “falchi”, favorevoli a un attacco preventivo, tentarono di influenzare la Casa Bianca. Come ipotesi di studio esso, di fatto, non tramontò mai, neppure dopo il test atomico del 1964. D’altra parte entrambi i presidenti finirono per optare per la convivenza critica con la nuova potenza nucleare, nei cui confronti un ricorso alla forza avrebbe destituito di ogni credibilità l’impegno multilaterale assunto da Washington nella lotta contro la proliferazione, così come un riconoscimento del profilo internazionale del regime comunista, vero obiettivo perseguito da Mao con la bomba, avrebbe incoraggiato altri paesi a seguirne l’esempio, e messo in crisi Taiwan. A questa situazione apparentemente bloccata Kennedy e Johnson cercarono di reagire diversamente: il primo tentando con una certa tenacia di coinvolgere Mosca nella gestione del pericolo cinese oltre i limiti del trattato che bandì i test nel 1963, il secondo soprattutto rafforzando la presenza militare americana nel settore asiatico attraverso l’escalation vietnamita. Nell’incessante confronto fra “falchi” e “co168 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) lombe”, innescato da Kennedy e alimentato anche dalle incerte stime della CIA, le analisi più equilibrate furono quelle provenienti dai consiglieri del Policy Planning Council, in particolare Robert Johnson, i cui inviti all’assunzione di contromisure moderate, politiche più che strategiche, traevano fondamento dall’intuizione delle vere intenzioni di Mao e della particolare concezione ideologica, antibipolare, “prestigiosa”, della bomba, in definitiva non destabilizzante. Mao, in sostanza, nonostante la sua avversione per il sistema internazionale e i suoi equilibri, non era un “Hitler con la bomba atomica”, ma piuttosto il leader di un paese impegnato nel complesso compito di conciliare il dogma con la crescita del profilo internazionale della Cina87. Le ragioni dei “falchi”, d’altra parte, non furono mai corroborate dalla percezione di una minaccia tangibile e immediata. Paradossalmente nella stima del pericolo essi furono più misurati di Kennedy, ma si spinsero oltre nel suggerire soluzioni ispirate da una visione angusta del problema, incompatibili con il mantenimento dei rapporti bipolari e che non contribuivano ad alimentare il consenso internazionale nella lotta contro la proliferazione. Riguardo ai programmi nucleari cinesi fu pertanto sperimentata la difficoltà di combinare l’eventuale intervento preventivo con una soluzione generale, necessariamente politica, valida per tutti i casi di presunta proliferazione, a causa dell’insanabile difetto di legittimazione internazionale. Apparivano soddisfacenti, in tal senso, solo adeguate politiche di sicurezza, inevitabilmente multilaterali, come aveva intuito, oltre allo stesso Robert Johnson, la commissione Gilpatric. L’esperimento del 16 ottobre 1964 costituì più un punto di arrivo che di partenza, e proprio per questo elevò l’esempio cinese a modello da seguire, inducendo più paesi a ritenere legittimo, dopo tale data, perseguire la costruzione della bomba per mere ragioni di prestigio politico e di deterrenza strategica, con l’impegno, al cospetto della comunità internazionale, ad escludere il first use e addirittura a contribuire con maggiore disponibilità al possibile disarmo, esattamente come dichiarato dalla dirigenza di Pechino l’indomani del test atomico88. Solo un processo particolarmente graduale, probabilmente innescato proprio il 16 ottobre 1964 e maturato con il superamento del conflitto vietnamita, consentì alla Casa Bianca, sotto l’amministrazione Nixon, di accogliere la visione kissingeriana di un ordine virtualmente multipolare, che andava concretizzandosi anche con l’avvento del nuovo pilastro cinese, e nel quale divenne più naturale convivere con un certo grado, fisiolo169 Paolo Soave gico, di proliferazione. Non appare pertanto casuale che, mentre Washington superava l’incubo kennedyano, fosse proprio l’URSS a minacciare un attacco preventivo contro i siti nucleari cinesi nel corso della grave crisi di confine del 1969, anche per opporsi al temuto mutamento degli equilibri internazionali89. Note al testo 1 Per una periodizzazione della politica estera cinese si veda J. Camilleri, Chinese Foreign Policy. The Maoist Era and its Aftermath, Oxford 1980, pp. 20 ss. 2 La decisione venne presa nel corso della crisi che contrappose Cina popolare e Stati Uniti per il controllo delle isole Quemoy e Matsu, nella stretto di Formosa. Ad essa seguì un poderoso incremento dei fondi destinati alla ricerca scientifica, passati da 15 milioni di dollari nel 1955 a 100 nel 1956, J.W. Lewis-X. Litai, China Builds the Bomb, Stanford 1988, pp. 38-42. 3 Uno degli argomenti più convincenti con cui Pechino rivendicò il proprio diritto all’atomica fu quello del precedente sovietico: al termine del secondo conflitto mondiale l’URSS, potenza rivoluzionaria in ascesa, aveva tratto grande beneficio, non solo strategico, ma anche politico ed economico, dallo sfidare il monopolio nucleare americano. Non c’era quindi ragione per negare lo stesso diritto a un paese affine che si trovava in condizioni analoghe. Inoltre, nonostante l’opposizione dei paesi neutrali alla proliferazione nucleare, i dirigenti cinesi riuscirono almeno in parte a legittimare i propri programmi teorizzando l’“atomica del Terzo Mondo”, come fattore di contrapposizione allo strapotere delle due superpotenze, F. Fejtö, Cina-URSS: il conflitto. Lo sviluppo del grande scisma comunista 1958-1968, Milano 1968, p. 439. 4 Zhou Enlai e Vyshinskii sottoscrissero a Mosca il 14 febbraio 1950 l’accordo di alleanza. A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica, Milano 1970, p. 707, fa risalire addirittura alla sofferta firma del trattato del 1949 la fine dell’“epoca dell’indiscusso predominio dell’Unione Sovietica” all’interno del blocco comunista. 5 In proposito osserva A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., p. 755: «Se, come era possibile, gli Stati Uniti intendevano reagire a un massiccio intervento cino-comunista trasferendo la lotta sul territorio cinese, con un attacco atomico, oppure “scatenando” Chiang Kaishek, come si disse più tardi, cosa avrebbero fatto i russi? È molto probabile che non avrebbero fatto niente». 6 Questa fase prese avvio con il trattato commerciale e di assistenza economica firmato il 26 marzo 1953, R. Medvedev, China and the Superpowers, Oxford 1986, pp. 5-65. 7 A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., p. 351. Accordi di cooperazione nell’ambito dello sfruttamento civile dell’energia atomica furono conclusi dall’URSS con Cina popolare, Polonia, Cecoslovacchia, Romania e Repubblica democratica tedesca, «Relazioni Internazionali», n. 6, 5 febbraio 1955, p. 171; n. 21, 21 maggio 1955, p. 567. 170 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) 8 M.C. Bergere, La Repubblica Popolare Cinese, Bologna 1994, pp. 129-130. A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., pp. 794-798, ritiene che l’accondiscendenza sovietica verso la Cina popolare fosse dovuta al desiderio di tenere unito il campo comunista in un momento in cui le divisioni fra gli eredi di Stalin stavano condizionando gli equilibri interni del Cremlino, e dalla volontà di preservare un certo grado di controllo sullo sviluppo interno cinese, in particolare creando un rapporto di clientela con l’esercito, concepito come contrappeso a Mao. Tanta generosità doveva in qualche misura anche ricompensare i cinesi per l’appoggio caloroso fornito l’indomani dell’intervento dell’Armata Rossa a Budapest, A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., pp. 859-860. 9 D. Holloway, Stalin and the Bomb, London 1994, p. 355. 10 K.S. Karol, La Cina di Mao, Verona 1967, pp. 463-479. J. Gittings, Il contrasto russo-cinese, in 20° secolo. Storia del mondo contemporaneo, a cura di B. Vigezzi, Verona 1976, vol. VI, p. 407: «Di fronte alla possibilità di una guerra tra Cina e Stati Uniti, Chrušcëv agì con cautela ed evitò di impegnare i sovietici a dare un appoggio nucleare ai compagni cinesi che così si sentirono autorizzati a pensare che, quando si veniva al dunque, non c’era da fare affidamento sulla “garanzia nucleare” sovietica. I russi, dal canto loro, conclusero che Pechino era un alleato bellicoso e poco attendibile. Un anno dopo Chrušcëv si recò a Pechino e ammonì apertamente i cinesi che non dovevano mettere alla prova con la forza la stabilità del sistema capitalista». Sulle ragioni del dissidio sino-sovietico, ha concluso M.C. Bergere, La Repubblica Popolare Cinese cit., pp. 123: «Nelle sue diverse espressioni – ideologica, politica, militare – questo conflitto manifesta la difficoltà di collocare la Cina in rapporto all’Unione Sovietica. Nazione-continente, troppo vasta, troppo pesante per essere un semplice satellite, troppo povera, troppo debole, arrivata troppo tardi alla rivoluzione per essere riconosciuta come partner di eguale rango». 11 A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., pp. 890-893. 12 Alla rottura fra Mosca e Pechino corrispose, nel 1959, l’avvicendamento alla guida del ministero della Difesa cinese: Peng Teh-huai, che aveva sostenuto l’esigenza di una solidarietà atomica con l’URSS, fu rimpiazzato da Lin Piao, N. Dombey, Una politica nucleare, in 20° secolo cit., vol. VI, p. 401. Sul primato dell’arma ideologica rispetto a quella atomica nel pensiero cinese, dovuto anche alla consapevolezza di non poter competere con gli Stati Uniti in campo tecnologico, K.S. Karol, La Cina di Mao cit., pp. XI ss. 13 j. J. Camilleri, Chinese Foreign Policy cit., pp. 24-25. 14 W.E. Griffith, The Sino-Soviet Rift, Cambridge 1964, p. 351. E. Crankshaw, La nuova guerra fredda. Mosca contro Pechino, Rocca San Casciano 1965, p. 194 evidenzia i timori di Kruscev per una Cina potenza nucleare, giustificati non solo dal rischio di una maggiore instabilità nei rapporti con l’Occidente, ma anche dalla presenza di un vicino troppo influente. Russi e cinesi si confrontarono in occasione della visita di Kruscev a Pechino dal 30 settembre al 4 ottobre 1959, A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., p. 899. I cinesi denunciarono il mancato rispetto dell’accordo che prevedeva la consegna nelle loro mani da parte sovietica di un esemplare di bomba atomica nell’articolo Le origini e lo sviluppo delle divergenze tra i dirigenti del PCUS e noi, pubblicato in «Bandiera rossa» e sul «Quotidiano del popolo» del 6 settembre 1963, il cui testo è riportato in Coesistenza e rivoluzione. Documenti della disputa cino-sovietica, a cura di P. Calzini-E. Collotti Pischel, Torino 1964, p. 466. 15 N. Dombey, Una politica nucleare, in 20° secolo cit., vol. VI, p. 402. 16 F. Fejtö, Cina-URSS cit., p. 438. 17 J.W. Lewis-X. Litai, China Builds the Bomb cit., p. 36. 18 Ibidem, pp. 177-178. 171 Paolo Soave 19 Dulles, già nell’ottobre 1958, aveva ipotizzato il riconoscimento di entrambi i regimi cinesi. A tale scopo aveva cercato di ottenere da Chiang Kai-shek l’impegno a non ricorrere all’uso della forza contro la Cina continentale. Mao peraltro non si fidò di tali aperture: la presenza a Formosa di atomiche tattiche costituiva per il leader comunista la prova inconfutabile della volontà americana di congelare l’esistenza dei due regimi, W.I. Cohen, America’s Response to China. A History of Sino-American Relations, New York 2000, pp.186 ss.; cfr. A.M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy, Milano 1994, pp. 456-509. Nelle sue memorie Andrej Gromyko ricorda che un primo approccio americano con l’URSS riguardo all’emergente questione cinese si ebbe nel corso dell’incontro dei ministri degli Esteri del maggio 1959 a Ginevra, in occasione del quale Neil McElroy, segretario alla Difesa, parlò del «pericolo giallo» di fronte al quale le due superpotenze avrebbero dovuto unirsi. Gromyko preferì riportare l’attenzione sui problemi europei e sullo stato dei rapporti fra Washington e Mosca, A. Gromyko, Memorie, Milano 1989, pp. 179-180. 20 A partire dal 1961 vennero condotte ricognizioni con U2 dalle basi di Taiwan, ma data l’ampiezza del territorio da controllare fu soprattutto sul programma satellitare Corona che confidò l’intelligence per la raccolta delle prime informazioni sul sito di Lop Nur, W. Burr-J.T. Richelson, Whether to «strangle the baby in the cradle»: the United States and the Chinese Nuclear program, 1960-64, in «International Security», n. 3, vol. 25, 2001, p. 63. 21 Citato da W. Burr-J.T. Richelson, Whether to «strangle the baby in the cradle» cit., p. 61; A. M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 898-899, che conferma la ricorrente preoccupazione di Kennedy per la Cina popolare. In particolare il presidente e Rusk erano i più convinti assertori del pericolo cinese come maggiore minaccia comunista all’orizzonte. Per il segretario di Stato l’immagine di un miliardo di cinesi in possesso della bomba appariva apocalittica, una sorta di minaccia all’ordine internazionale precostituito analoga a quella portata da Hitler. Nel 1961 Kennedy si impegnò con Chiang Kai-shek a cooperare nel campo della sicurezza con covert operations e a porre il veto all’ingresso di Pechino all’ONU. Altri esponenti dell’amministrazione, quali Bowles, Stevenson, McGeorge Bundy, la cosiddetta «lobby cinese», cercarono di favorire un approccio più flessibile con Pechino. 22 Foreign Relations of the United States (d’ora in poi FRUS), 1958-1960, vol. 19, The Chinese Communist Atomic Energy Program: Summary and Conclusions, Director of Central Intelligence Agency, National Intelligence Estimate 13-2-60, December 13, 1960, pp. 744-747. 23 Long-Range Threat of Communist China, Memorandum from Lt. General John K. Gerhart, Deputy of Staff, Plans and Programs, U.S. Air Force to Air Force Chief of Staff Thomas White, February 8, 1961. Questo e i successivi documenti che verranno indicati con la sigla NSAEBB (National Security Archive Electronic Briefing Books), sono consultabili in rete al sito web del National Security Archive (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB), un ente di ricerca che raccoglie e rende fruibili documenti delle maggiori istituzioni politiche, archivi e biblioteche statunitensi. 24 NSAEBB, National Intelligence Estimate on Implications of Chinese Nuclear Capability, Memorandum from John. M. Steeves, Bureau of Far Eastern Affairs, to Roger Hilsman, Director, Bureau of Intelligence and Research, April 12, 1961. 25 FRUS, 1961-63, vol. 8, Estimate of the World Situation, January 17, 1961, p. 8. 26 FRUS, 1961-63, vol. 22, A Strategic Analysis of the Impact of the Acquisition by Communist China of a Nuclear Capability, Memorandum from Joint Chiefs of Staff, June 26, 1961, pp. 84-85. 27 Per i timori atomici dei sovietici, F. Fejtö, Cina-URSS cit., pp. 331-332. Esisteva, come osserva A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., pp. 874-875, una cruciale asimmetria 172 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) fra i due campi: l’URSS non avrebbe mai potuto tollerare una potenza nucleare autonoma all’interno della propria orbita. In occasione del XX congresso del PCUS, del febbraio 1956, Kruscev illustrò la dottrina della coesistenza pacifica con il blocco occidentale con cui intendeva chiudere l’era della concezione «zdanoviana» della contrapposizione totale. Mentre per i sovietici la convivenza poteva divenire definitiva, per i cinesi poteva costituire solo un compromesso temporaneo di carattere tattico, come confermava anche la divergenza con l’URSS relativa all’eventualità di un conflitto termonucleare: per il Cremlino la questione principale in campo internazionale era quella della cooperazione, per Pechino il tema della guerra e della pace restava insuperato, Coesistenza e rivoluzione cit., pp. 11-124. 28 G.H. Chang, JFK, China and the Bomb, «The Journal of American History», n. 4, vol. 74, March 1988, pp. 1288-1289; A. M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., p. 343. 29 M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 410-416, rileva che nel corso dell’incontro Kruscev liquidò la questione precisando di conoscere bene i cinesi e accusò gli Stati Uniti di opporsi all’ingresso di Pechino alle Nazioni Unite. Egli riteneva particolarmente moderato Mao, al posto del quale avrebbe attaccato Formosa. 30 r.a. divine, Blowing on the Wind: The Nuclear Test Ban Debate, 1954-1962, New York 1978. Kennedy, già nel corso della campagna elettorale, aveva preso apertamente posizione in favore della messa al bando degli esperimenti. Dalle tribune dell’ONU rilanciò il tema con un vibrante discorso all’insegna dello slogan «imponiamo una tregua al terrore», ma successivamente anche gli Stati Uniti, in risposta all’URSS, ripresero i test nell’atmosfera, A.M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 456-509; G. Giordano, La politica estera degli Stati Uniti. Da Truman a Bush (1945-1992), Milano 1999, pp. 142-143. 31 J. Camilleri, Chinese Foreign Policy cit., p. 24. 32 G.H. Chang, JFK, China and the Bomb cit., pp. 1294-1295. 33 NSAEBB, Chinese Communist Advanced Weapons Capabilities, National Intelligence Estimate 13-2-62, April 25, 1962, in cui si ribadiva che «We cannot reach firm conclusions on these matters, or predict the year in which deployment of a complete weapons system will probably begin». 34 NSAEBB, Program to Influence World Opinion with Respect to a Chicom Nuclear Detonation, Undersecretary of State for Political Affairs George McGhee to Assistant Secretary of State for Public Affairs Robert Manning, September 24, 1962. 35 FRUS, 1961-63, vol. 8, Remarks of President Kennedy to the National Security Council Meeting of January 22, 1963, p. 462; NSAEBB, Averell Harriman Papers, Under Secretary of State for Political Affairs W. Averell Harriman to President John F. Kennedy, January 23, 1963. 36 NSAEBB, Study of Chinese Communist Vulnerability, General Curtis LeMay, Acting Chairman, Joint Chiefs of Staff, to Secretary of Defense, April 29, 1963. 37 NSAEBB, Probable Consequences of a Chinese Communist Nuclear Detonation, May 6, 1963. 38 NSAEBB, McGeorge Bundy Correspondence, Memorandum of Conversation with Ambassador Dobrynin, May 17, 1963. 39 La Multilateral Force prevedeva una flotta di venticinque unità con equipaggi multinazionali, armati di missili Polaris, per il cui impiego l’ultima parola sarebbe spettata agli Stati Uniti. Anche per tale ragione il progetto riscosse scarso successo in Europa e fu lasciato cadere da Lyndon Johnson, C. Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov. Storia delle relazioni fra Stati Uniti e Unione Sovietica nel dopoguerra, Firenze 1990, p. 104; cfr G. Giordano, La politica estera degli Stati Uniti cit., p. 141; cfr. A.M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 173 Paolo Soave 842-848. Sui timori sovietici relativi alla MLF, A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., p. 974. 40 Sull’incontro di Parigi fra Kennedy e il generale, A.M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 393-403. 41 NSAEBB, World Reaction to Test Ban Treaty, September 28, 1963. 42 FRUS, 1961-63, vol. 7, John F. Kennedy to A. Harriman, July 12, 1963, pp. 719-722; John F. Kennedy to U.S. Embassy in Moscow, July 15, 1963, p. 801; U.S. Embassy in Moscow to U.S. Department of State, July 27, 1963, p. 860. 43 G.H. Chang, JFK, China and the Bomb cit., p. 1301. In vista della missione di Harriman a Mosca l’Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) aveva predisposto un rapporto in cui l’esempio della Cina popolare, non particolarmente sviluppata, veniva assunto come paradigmatico del successo che avrebbe potuto coronare gli sforzi di qualsiasi paese determinato a dotarsi di armi atomiche, rendendo più pressante il tema della proliferazione, NSAEBB, Summary and Appraisal of Latest Evidence on Chinese Communist Advanced Weapon Capability, Arms Control and Disarmament Agency, July 10, 1963. 44 FRUS, 1961-63, vol. 7, U.S. Embassy in Moscow to U.S. Department of State, July 27, 1963, p. 860. Per A.M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 903-904, proprio Mao, involontariamente, aveva contribuito a far firmare il trattato. 45 A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., p. 961-962, 975, ritiene che le possibilità di una più vasta collaborazione fra Mosca e Washington vennero vanificate dalla volontà del Cremlino di non «rendere pubblici i propri problemi e le proprie difficoltà» con la Cina popolare, da cui gli americani avrebbero potuto trarre vantaggio assumendo una posizione ancor più rigida sulla Germania. 46 FRUS, 1964-68, vol. 30, The President’s News Conference of August 1, 1963, p. 24. 47 L’accordo, che vincolava le potenze atomiche firmatarie a non cedere armi e tecnologie nucleari e gli altri paesi aderenti a non fabbricare e a non cercare di procurarsi tali ordigni, non proibiva i test sotterranei, G. Giordano, La politica estera degli Stati Uniti cit., pp. 142-143. Nel gennaio 1964 Francia e Cina popolare, che si opponevano al trattato, ripristinarono le loro relazioni diplomatiche, M.C. Bergere, La Repubblica Popolare Cinese cit., p. 334. 48 C. Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov cit., pp. 105-106, ritiene che la stipula del trattato si giustificasse da parte americana con il superamento delle rigidità della fase più acuta della guerra fredda e da parte sovietica proprio con l’aggravarsi della tensione con Pechino. Per la condanna cinese e il rilancio della proposta di smantellamento di tutti gli arsenali nucleari, «Relazioni Internazionali», n. 35, 31 agosto 1963, p. 1211. L’URSS aveva notificato il 25 agosto 1962 alla Cina la propria accettazione del trattato. Pechino rispose con tre memorandum in cui auspicava che il Cremlino non assumesse impegni che avrebbero potuto attentare alla sovranità cinese. A.B.Ulam, Storia della politica estera sovietica cit., pp. 876 e 897 osserva che la tesi cinese secondo cui l’URSS aveva sacrificato la lotta contro l’imperialismo e la solidarietà verso un paese fratello alla convivenza con gli USA sembrava avere una certa fondatezza. 49 NSAEBB, Meeting of General Chiang Ching-kuo with the President, Memorandum for McGeorge Bundy, September 10, 1963. 50 NSAEBB, The President’s Meeting with the Chinese Minister of Defense Chiang Ching-kuo, September 23, 1963, September 18, 1965; Deputy Assistant Secretary of State Edward Rice to Ambassador Ting-Fu Tsiang, October 14, 1963; «Visit of General Chiang Ching-kuo», CIA Far East Division Chief William E. Colby to McGeorge Bundy, September 19, 1963. 51 NSAEBB, A Chinese Communist Nuclear Detonation and Nuclear Capability, Robert H. John- 174 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) son, October 15, 1963. 52 G.H. Chang, JFK, China and the Bomb cit., p. 1306. Il generale Taylor fu uno dei principali assertori della dottrina della «guerra limitata», cui dedicò nel 1960 il volume The Uncertain Trumpet, A.M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 348-349, 907-908. 53 NSAEBB, Chinese Nuclear Development, Memorandum, General Maxwell D. Taylor, Chairman, Joint Chiefs of Staff, to General LeMay, General Wheeler, Admiral McDonald, General Shoup, November 18, 1963, che non include il programma; j. wilson, Greatest Secrets of the Cold War (http://popularmechanics.com/science/military/1984/4/secretsofcoldwar). Già durante la crisi laotiana, nel 1961, il Pentagono aveva ipotizzato il bombardamento di Pechino, A.M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 380-381. 54 Lo sosteneva in particolare Roger Hilsman, consigliere per l’Estremo Oriente. In realtà il vero problema sembrava essere quello di far accettare una simile tesi, più che a Chiang, a Mao, W.I. Cohen, America’s Response to China cit., p. 191. 55 NSAEBB, Status of Program to Influence World Opinion with Respect to a Chinese Communist Nuclear Detonation, Department of State to U.S. Embassy in Thailand et al., July 20, 1964. 56 FRUS, 1964-68, vol. 30, An Exploration of the Possible Bases for Action Against the Chinese Communist Nuclear Facilities, Robert H. Johnson, April 14, 1964, pp. 39-40; NSAEBB, Implications of a Chinese Communist Nuclear Capability, Robert Johnson, State Department Policy Planning Staff, April 17, 1964; NSAEBB, The Chinese Communist Nuclear Capability and Some “Unorthodox” Approaches to the Problem of Nuclear Proliferation, June 1, 1964. 57 NSAEBB, The Implications of a Chinese Communist Nuclear Capability, Memorandum from Secretary of State Rusk to President Johnson enclosing W.W. Rostow, Chairman, Policy Planning Council to the President, May 1, 1964. 58 FRUS, 1964-68, vol. 30, Memorandum by William Y. Smith, Daily White House Staff Meeting, April 30, 1964, pp. 56-57. 59 NSAEBB, The Chances of an Imminent Communist Chinese Nuclear Explosion, Special National Intelligence Estimate, August 26, 1964; Thursday Planning Group Discussion of Communist China and Nuclear Proliferation, Memorandum, Robert H. Johnson, Policy Planning Council, to Henry Owen, September 2, 1964. Da tempo gli americani sospettavano che l’URSS avesse ceduto del materiale fissile alla Cina, French-Soviet and French-Chinese Cooperation in the Atomic Energy Field, Department of State, August 15, 1963. 60 All’incontro tenutosi al Dipartimento di Stato parteciparono Rusk, McCone, McNamara e McGeorge Bundy. Le loro conclusioni furono accolte il giorno stesso dal presidente, NSAEBB, McGeorge Bundy, Memos to the President, September 15, 1964; G.H. Chang, JFK, China and the Bomb cit., p. 1308. 61 G.H. Chang, JFK, China and the Bomb cit., p. 1309. 62 La Casa Bianca respinse anche le ultime proposte della CIA per un attacco preventivo, NSAEBB, Robert W. Komer, National Security Council, to Bundy, September 18, 1964. Anche quando il conflitto in Vietnam coinvolse più direttamente gli Stati Uniti l’amministrazione Johnson si guardò bene dal rischiare un ampliamento del fronte tale da coinvolgere Pechino, nonostante l’occasione paresse propizia a McNamara per liquidare la capacità nucleare cinese, W. Burr-J.T. Richelson, Whether to «strangle the baby in the cradle» cit., pp. 88-89. 63 NSAEBB, Memcon, September 25, 1963. 64 W. Burr-J.T. Richelson, Whether to «strangle the baby in the cradle» cit., p. 90. Il vero timore fu chiaramente espresso da Giorgio Sansa sul «Corriere della Sera» dell’11 ottobre 1964, p. 20, 175 Paolo Soave nell’articolo Il terzo mondo minato da infiltrazioni comuniste cinesi, in cui lo scrittore americano osservava che il test avrebbe prodotto un profondo effetto sui paesi arretrati, e che anche la Cina, al pari della Francia, ambiva a detenere la bomba «per sole ragioni di prestigio». 65 NSAEBB, China as a Nuclear Power, Office of International Security Affairs, Department of Defense, October 7, 1964. 66 J.W. Lewis-X. Litai, China Builds the Bomb cit., pp. 135-136, 167-169. 67 W. Burr-J.T. Richelson, Whether to «strangle the baby in the cradle» cit., p. 84; NSAEBB, U.S. Department of State to U.S. Embassy in Paris, October 9, 1964. 68 N. Dombey, Una politica nucleare, in 20° secolo cit., vol. VI, p. 401. Il 17 ottobre 1964 il «Corriere della Sera», stabilendo un ordine di priorità, titolava a tutta prima pagina Scoppiata l’atomica cinese. Il mondo in ansia per la crisi sovietica; cfr. «Relazioni Internazionali», La bomba atomica cinese, n. 43, 24 ottobre 1964, p. 1345. 69 F. Fejtö, Cina-URSS cit., pp. 315, 437. A proposito della «simbologia atomica» della Cina popolare ha osservato G. Melis, La Cina di Mao 1949-1969. Sullo sfondo della Cina di sempre, Milano 1971, p. 548: «Non ci si poteva aspettare di meno dal maoismo militarizzato. Oltre a costituire un punto d’arrivo militare molto ambito, era una controprova della validità del loro regime. La prova nucleare poteva servire da “portento naturale” per attestarne la legittimità: al tempo degli imperatori, i confuciani si erano serviti dei “prodigi naturali”, grandi perturbazioni atmosferiche o “mostri”, per sostenere od osteggiare i loro sovrani». 70 Quando il 17 giugno 1967 i cinesi detonarono la loro prima bomba all’idrogeno il leader comunista rivendicò la rapidità con cui il programma varato a metà degli anni ’50 aveva conseguito il successo, rispetto ai tempi impiegati dalle altre potenze atomiche. Considerando lo sforzo che i cinesi avevano dovuto sostenere per supplire al ritiro dei tecnici sovietici, Mao ironicamente propose una medaglia a Kruscev, N. Dombey, Una politica nucleare, in 20° secolo cit., vol. VI, p. 402. 71 W. Burr-J.T. Richelson, Whether to «strangle the baby in the cradle» cit., p. 92. Sul «Corriere della Sera» del 17 ottobre 1964, p. 1, Seymour Topping coglieva l’essenza di un comunicato cinese titolando Il governo di Mao afferma che la bomba è un contributo alla difesa della pace; cfr. «Relazioni Internazionali», n. 43, 24 ottobre 1964, p. 1354, che riporta la nota ufficiale del governo di Pechino, in cui si precisava che il test era stato tenuto nell’interesse della difesa nazionale e della pace mondiale. Quanto alla reazione di De Gaulle, sul cui plauso Mao faceva affidamento, occorre osservare che, con fredda formalità, egli dichiarò che la Francia ribadiva il proprio impegno in favore del disarmo, «Relazioni Internazionali», n. 45, 7 novembre 1964, p. 1403. 72 J.W. Lewis-X. Litai, China Builds the Bomb cit., pp. 171-189. 73 Tuttavia Rusk richiamò l’attenzione anche sulle implicazioni del test cinese, NSAEBB, Diary Entry for October 17, 1964, Journals of Glenn Seaborg, vol. 9, Glenn T. Seaborg, Chairman, Atomic Energy Commission. 74 NSAEBB, Diary Entry for 20 and 21 October 1964, Journals of Glenn Seaborg, vol. 9, Glenn. T. Seaborg, Chairman, Atomic Energy Commission; W. Burr-J.T. Richelson, Whether to «strangle the baby in the cradle» cit., pp. 91-92. 75 C. Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov cit., pp. 133-134; Pacata analisi di Johnson, in «Relazioni Internazionali», n. 43, 24 ottobre 1964, p. 1345. 76 F. Fejtö, Cina-URSS cit., p. 481. 77 NSAEBB, Effect of Chicom Nuclear Explosion, December 8, 1964. Sul «Corriere della Sera» 176 Gli Stati Uniti di fronte al programma nucleare cinese (1962-1964) del 20 ottobre 1964, p. 5, Dino Frescobaldi scriveva L’atomica di Mao faro del terzo mondo; F. Fejtö, Cina-URSS cit., pp. 439-441, che evidenzia l’orgoglio asiatico provato da Sukarno, il principe Sihanuk, Ho Ci-min, Kim Il Sun, contrapposto all’ostentato disinteresse sovietico. Nel giugno 1965 il fronte afro-asiatico rigettò alle Nazioni Unite una mozione di condanna dell’esperimento cinese. 78 NSAEBB, U.S. Embassy, Taipei, to Department of State, October 24, 1964. 79 Lo scoppio della bomba cinese non esige mutamenti nella strategia, «Relazioni Internazionali», n. 44, 31 ottobre 1964, pp. 1378-1379. 80 NSAEBB, Destruction of Chinese Nuclear Weapons Capabilities, George Rathjens, Arms Control and Disarmament Agency (ACDA), December 14, 1964. 81 NSAEBB, Gilpatric Report, Committee on Nuclear Proliferation, January 21, 1965. 82 NSAEBB, Comments on Non-Proliferation Paper of December 12, 1964, December 31, 1964. 83 FRUS, 1964-68, vol. 11, A Report to the President by the Committee on Nuclear Proliferation, Committee on Nuclear Proliferation, January 21, 1965, pp. 173-182. 84 W. Burr-J.T. Richelson, Whether to «strangle the baby in the cradle» cit., p. 94. 85 NSAEBB, The ChiCom ’G’ Class (Missile-Launching) Submarine, Gathright Walt Rostow, May 4, 1965; cfr w.f. buckley, Should We Bomb Red China’s Bomb?, in «National Review», January 12, 1965, pp. 8-9. 86 Il vero limite delle due amministrazioni democratiche nell’approccio alla questione cinese andrebbe ricercato, a giudizio di W.I. Cohen, America’s Response to China cit., p. 192, nell’assunzione del Vietnam come «linea del Rubiconde» in Asia. Washington sarebbe pertanto caduta nella trappola della lotta di liberazione, mentre la partita della guerra fredda nel continente asiatico avrebbe richiesto altre soluzioni. Kennedy, prendendo in considerazione l’intervento preventivo, finì con l’accentuare la tensione con Pechino. Anche G.H. Chang, JFK, China and the Bomb cit., p. 1310, è dello stesso avviso. In senso contrario A.M. Schlesinger jr, I mille giorni di John F. Kennedy cit., pp. 456-509, per il quale il presidente dimostrò particolare flessibilità nel trattare la questione cinese. 87 Contrariamente a quanto sostenuto da Georges Pompidou, secondo il quale la posizione cinese nel mondo era immediatamente cambiata a seguito del test atomico e l’ingresso di Pechino alle Nazioni Unite appariva come imminente, la Cina popolare dovette attendere fino all’ottobre 1971 per occupare all’ONU il seggio di Taiwan, «Le Monde», 5 novembre 1964, citato in F. Fejtö, Cina-URSS cit., pp. 440-441. 88 Anche le due successive deflagrazioni del 14 maggio 1965 e del 9 maggio 1966 andavano interpretate alla luce del pensiero di Mao, secondo il quale «l’elemento uomo rimaneva decisivo», F. Fejtö, Cina-URSS cit., p. 440. 89 R. Garthoff, Detente and Confrontation: American–Soviet Relations from Nixon to Reagan, Washington, 1994, pp. 236-237. Nel febbraio 1972 Nixon e Chou En-lai sottoscrissero lo storico accordo che normalizzava i rapporti fra Stati Uniti e Cina popolare e impegnava i due paesi a non perseguire l’egemonia nel settore asiatico-pacifico, A. Iryie, The Cold War in Asia, Englewood Cliffs 1974, pp. 1 ss.; C. Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov cit., pp. 222-268. 177 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? I casi della Somalia e della Libia di Luigi Benevelli Alla fine della seconda guerra mondiale, l’articolo 23 del trattato di pace firmato il 10 febbraio 1947 imponeva il ritiro dell’Italia dall’Africa. Ciononostante, il governo italiano continuò a battersi per tornare e rimanere in Africa1. A livello internazionale fu deciso di nominare una commissione quadripartita che avrebbe visitato le ex colonie italiane per assumere informazioni e contattare rappresentanti delle opinioni pubbliche, dei notabili e dei partiti locali. La commissione espletò il proprio compito fra il novembre 1947 e il giugno 1948, presentando dei rapporti finali ad una sessione che si tenne dal 21 al 27 luglio 1948. Le ipotesi in discussione erano diverse: estromissione totale dell’Italia ex fascista dall’Africa e indipendenza immediata delle ex colonie, concessione all’Italia di uno o più mandati di «amministrazione fiduciaria» (cioè di amministrazione che doveva preparare l’indipendenza di quei territori), ritorno dell’Italia su una o più colonie. La Commissione si orientò verso la concessione dell’indipendenza a tutte le ex colonie. Ciononostante, per le insistenze italiane e perché il tema era ritenuto tutto sommato secondario, la riunione dei ministri degli Esteri delle quattro grandi potenze tenutasi a Parigi nel settembre 1948 non arrivò ad una soluzione concorde. E tutto fu deferito all’Assemblea delle Nazioni Unite. A quel momento, dal punto di vista internazionale, si era ormai in piena guerra fredda, il piano Marshall aveva ulteriormente diviso l’Europa, da molti mesi si stavano definendo i particolari di quello che poi sarebbe stato il Patto Atlantico. Da lì a poco la guerra di Corea avrebbe ulteriormente approfondito il solco fra le due superpotenze e le rispettive sfere d’influenza. L’India aveva già ottenuto la sua indipendenza, sia pure a prezzo della secessione del Pakistan, e quasi tutti i movimenti nazionalisti anticoloniali erano in agitazione nei territori governati dalle potenze europee. In questo 179 Luigi Benevelli grandioso, anche se drammatico scenario, il governo italiano cercava di ottenere qualche lembo d’Africa. Se le richieste del 1945-1947 potevano essere comprensibili, nell’ottica dei governi d’unità nazionale e dei timori di rigurgiti nazionalisti o addirittura fascisti legati all’immediato dopoguerra, le insistite richieste del 19471950 si presentavano invece come sostanzialmente diverse, e non solo perché era cambiata la maggioranza di governo. Roma continuò ad illudersi che la stabilizzazione democristiana e i buoni servigi resi come fedele alleato degli Stati Uniti (visita di De Gasperi nel gennaio 1947, governo centrista nel maggio, vittoria elettorale del 18 aprile 1948, propensione all’ingresso nella Ueo nell’ottobre 1948, accettazione del piano Marshall, firma d’adesione alla Nato nell’aprile 1949) potessero fruttare qualcosa. Per la verità durante la sessione della primavera del 1949 all’Onu, Roma riuscì a strappare un compromesso con Londra basato sull’idea di differenziare le sorti di Libia ed Eritrea. Ma il compromesso Bevin-Sforza del 5-6 maggio durò lo spazio di qualche giorno. Dopo aver scontentato molti (i colonialisti in Italia, i rappresentanti delle élite locali nelle ex colonie) e dopo aver presentato la giovane democrazia italiana disposta alle spartizioni più spregiudicate al pari delle vecchie potenze coloniali, il 17 maggio 1949 quel compromesso venne rigettato dall’Assemblea (per un voto). La questione rimaneva formalmente ancora aperta: ma le speranze di un ritorno in Libia, o almeno in Tripolitania, vennero fugate; per la sorte dell’Eritrea, anche se fu nominata una ulteriore Commissione che avrebbe terminato i suoi lavori in piena guerra di Corea, l’ipotesi più probabile si delineava ormai quella della provincia (federata) dell’Etiopia. Per i tardivi sogni italiani rimaneva solo la povera Somalia: gli ultimi sforzi di Roma si sarebbero concentrati su questa. Nel 1949-1950 la querelle venne finalmente risolta, e in un senso non favorevole all’Italia. Fra il settembre, quando fu riesaminata tutta la questione, e il 21 novembre 1949, quando fu votata la risoluzione 289 dell’Assemblea dell’Onu, furono decise le sorti della Libia e dell’Eritrea. L’anno successivo - dopo ennesimi incontri, interim committee e commissioni – l’Assemblea generale votò il 2 dicembre 1950 la destinazione della Somalia all’Italia come amministrazione fiduciaria. La fine formale del dominio coloniale italiano può essere fatta risalire alla perdita delle ex colonie e alla concessione della Somalia in amministrazione fiduciaria, ma la fine sostanziale del dominio, per la verità, era già maturata fra 1941 e 1943. La fasci180 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? nazione imperiale dell’opinione pubblica nazionale sotto il fascismo era stata intensa, ma non aveva messo radici tenaci. Purtroppo proprio l’aver assolto i capi fece mancare all’opinione pubblica e al Paese in generale l’avvio di quel dibattito ampio e profondo sul passato coloniale che in altri paesi la decolonizzazione avrebbe portato con sé. Abbastanza presto gli italiani tolsero dalla propria agenda le colonie, e forse l’Africa: ma non lo fecero sulla base di una critica e di un’autocritica delle passate fascinazioni. Più semplicemente si autoassolsero, ricorrendo alla retorica della «brava gente»: mancò loro una seria e vera «decolonizzazione» della memoria. Più a lungo durò, ovviamente, il colonialismo per le comunità coloniali rimaste in Africa. Le statistiche sono imprecise, ma gli ordini di grandezza sono chiari. Nella sterminata Etiopia alla fine della guerra erano rimaste tre, quattro migliaia di italiani (ma alcuni dati parlano di diecimila). In Somalia erano forse quattro-cinquemila (nemmeno tremila nel 1950). Le due comunità più rilevanti rimanevano quella dell’Eritrea (circa 37.000 nel 1945, 20.000 nel 1950) e della Libia, o più esattamente della Tripolitania (forse 45.000 nel 1945, la metà venti anni più tardi). Si trattava di comunità, soprattutto le ultime due, consistenti ma dalla storia alquanto diversa: di maggior durata e radicamento quella libica, e frutto in particolare della rapida crescita del periodo «d’oro» della preparazione dell’aggressione all’Etiopia quella eritrea. Per esse il colonialismo non finì con la fine del dominio italiano. Molti dei loro componenti cercarono di prolungare quell’esperienza, anche senza l’aiuto della madrepatria. Però si trattava di comunità di sconfitti. Sconfitto l’impero, esse tornavano ad avere dimensioni paragonabili alle altre comunità italiane dell’Africa mediterranea (insediate in Egitto, in Tunisia, in Algeria e persino in Marocco), che solo negli anni trenta esse avevano superato dal punto di vista quantitativo. Nel frattempo anche altri italiani stavano cercando vanamente di mettere in quei primi anni del secondo dopoguerra la parola fine al loro colonialismo. Erano i «profughi d’Africa». Si trattava di quei «coloni» sorpresi dalla sconfitta del fascismo all’Oltremare o di quelli che, pur rientrati in Italia già fra il 1941 e il 1943, non sempre erano ancora riusciti ad integrarsi nella società della madrepatria. Il loro numero era consistente. Alla fine degli anni quaranta ne sarebbero stati computati circa 90.000 dalla Libia, più di 50.000 dall’Etiopia, un poco meno dall’Eritrea e più di 10.000 dalla Somalia. Sommati assieme, questi profughi erano di gran lunga più numerosi dei residui «italiani d’Africa» rimasti all’Oltremare. 181 Luigi Benevelli L’esperienza dell’Università nazionale somala2 Come abbiamo visto, la presenza italiana in Somalia continuò fino al termine del mandato e ancora successivamente con programmi di aiuto e di supporto alla costruzione e alla gestione delle strutture dello Stato. Fra questi, per il nostro discorso, rientra l’esperienza dell’Università nazionale somala, della facoltà di Medicina e Chirurgia e dei corsi di psichiatria che dal 1978 al 1988 furono tenuti da Antonino Jaria. Del 1982 sono le Considerazioni preliminari ad un programma di salute mentale in Somalia. Si tratta di un dattiloscritto nel quale sono affermati l’impegno e l’auspicio a che dal corso di psichiatria possa nascere un programma nazionale per la salute mentale. Jaria parte dalla constatazione che in Somalia il grosso delle risposte e dei trattamenti psichiatrici continua a essere dato da operatori della medicina tradizionale. Di qui l’opportunità che il loro lavoro fosse riconosciuto. Inoltre, anche in accordo cogli orientamenti del rapporto del comitato di esperti Oms 1974 sulla Organizzazione di servizi di salute mentale nei paesi in via di sviluppo, orientamenti confermati nella conferenza di Alma Ata del 1978, l’assistenza psichiatrica avrebbe dovuto rientrare nella organizzazione della medicina di base o primaria. La nota esponeva un programma di salute mentale di base che fosse parte integrante della politica nazionale della salute. Gli aspetti più importanti erano il rapporto con la medicina tradizionale e una ricerca epidemiologica dei fenomeni psicopatologici che proseguisse nell’indagine avviata nel 1982 sui ricoveri nel reparto psichiatrico dell’ospedale Forlanini3 di Mogadiscio della quale si riconoscevano i limiti (la valutazione della epidemiologia dei disturbi mentali era evidentemente approssimativa), ma anche l’utilità. Del 1984 sono l’intervento di Jaria al convegno Malattia mentale e medicina tradizionale in Somalia: incontro multidisciplinare tenutosi a Roma il 14 giugno4 e l’articolo Considerazioni sul problema della malattia mentale e della medicina tradizionale in Somalia5. La medicina scientifica e la medicina tradizionale in Somalia Premesso che è in corso un incessante dibattito, a vari livelli, sulla condizione della salute in Africa, caratterizzata dalla simultanea presenza della medicina scientifica europea e della medicina tradizionale, Jaria nel lavoro 182 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? menzionato afferma che «tutte le culture riconoscono le malattie e posseggono dei metodi per curarle. Le credenze a proposito della eziologia, della diagnosi, prognosi e terapie opportune, costituiscono un tutto integrato che si viene ad inserire nel sistema culturale globale. I sistemi tradizionali africani hanno subito l’impatto e la sovrapposizione della ideologia medica europea, chiusa e diffidente verso le pratiche dei guaritori, che sembravano frutto di superstizione ed ignoranza. Magari in forma latente e privata, la medicina tradizionale ha tuttavia continuato tenacemente ad esistere, godendo dell’ubiquitario consenso delle popolazioni indigene». Si auspica che il rinnovato interesse degli studiosi europei e la nuova considerazione nei confronti dei sistemi tradizionali di credenze, «riusciranno forse a creare le premesse per il superamento dell’attuale situazione di separazione e non comunicazione, in vista di una qualche forma di collaborazione ed interscambio tra gli operatori delle due “medicine”». Nell’ambito dei fenomeni psicopatologici si presentano problemi particolarmente spinosi. I modelli esplicativi dei disturbi mentali strutturati dalle diverse popolazioni africane si conciliano solo parzialmente con gli schemi della nosografia psichiatrica. Lo stesso concetto di malattia «mentale» è poco significativo per culture che non contemplano l’esistenza di una separazione mente/corpo e per le quali l’evento patogeno colpisce l’individuo nella sua interezza, alterando il suo equilibrio psicofisico e sconvolgendo le complesse trame di relazioni che lo connettono al mondo naturale, soprannaturale, sociale. L’insorgenza dei disturbi viene ricondotta ad una molteplicità di cause: uno spirito ha preso possesso del corpo del malato, un corpo estraneo gli è entrato dentro, una stregoneria o una «fattura» lo hanno colpito; il malato ha trasgredito un tabù ed è stato colpito dalla punizione soprannaturale, il malato ha perduto la propria «anima», ecc. Molte popolazioni africane hanno sviluppato dei sistemi di interpretazione delle malattie mentali estremamente complessi e minuziosi. Il terapeuta tradizionale è il depositario e l’esperto dei concetti «nosologici» tramandati dagli avi. Attraverso le fasi del suo iter iniziatico, egli ha imparato a padroneggiare i procedimenti diagnostici e le pratiche terapeutiche, approfondendo al contempo la conoscenza del substrato di credenze e di simboli su cui si fonda la legittimità del sistema medico tradizionale. I riti terapeutici che il guaritore africano organizza e presiede hanno generalmente carattere pubblico e collettivo arrivando a coinvolgere l’intero gruppo sociale. Si ritiene che un paziente migliorerà solo quando le «col183 Luigi Benevelli pe» e l’aggressività sua e/o del suo gruppo saranno eliminate attraverso il trattamento rituale, che ha la funzione di ristabilire l’equilibrio comunitario alterato e di scongiurare l’ostilità e gli attacchi degli spiriti ristabilendo con loro dei buoni rapporti. Il guaritore tradizionale si dimostra in genere dotato di una buona intuizione e conoscenza delle dinamiche psicologiche individuali e di gruppo. Durante le cerimonie terapeutiche egli cerca di individuare i nuclei conflittuali patogeni, operando per favorire l’emergenza catartica delle tensioni represse. Alla fine il malato può venire reintegrato nella sua rete di relazioni. La psichiatria transculturale Jaria svolge alcune considerazioni che riguardano «il nostro modo di intendere il lavoro nel campo della “psichiatria transculturale”», intendendo «psichiatria transculturale» una locuzione con valore descrittivo per circoscrivere un ambito di ricerca. Premesso che la trasposizione «sic et simpliciter» delle categorie e degli strumenti della psichiatria e della psicoanalisi in un contesto africano non è sufficiente ad esaurire la poliedrica realtà delle malattie mentali, osserva che alla psichiatria si impone una riflessione critica sui modi attraverso i quali ogni singola cultura o società tratta i fenomeni psicopatologici. La follia costituisce un problema di cui non si può ignorare l’esistenza. La collettività struttura dei sistemi di rappresentazioni simboliche attraverso i quali la parte «folle» che è in ogni essere umano possa esprimersi e trovare, per così dire un contenimento. I modelli culturali organizzano le differenti patologie individuali, nella prospettiva di una maggior prevedibilità e controllo delle stesse. Nel momento dello scompenso psicopatologico, l’individuo si trova ad utilizzare, in maniera inconsapevole, i materiali culturali a sua disposizione, veicolandoli all’interno di particolari canali espressivo-comunicativi anch’essi, in genere, culturalmente determinati. Per lo psichiatra è opportuno ricostruire il quadro culturale complessivo che dà significato alla condotta e ai vissuti interiori dei malati con cui viene a contatto: egli deve sforzarsi di penetrare all’interno della fitta rete di significanti simbolici che il soggetto deriva dalla propria cultura, metabolizzandoli ed elaborandoli in maniera personale. L’approccio psichiatrico tradizionale europeo privilegia la dimensione intrapsichica e sottolinea le differenze individuali, ma lo psichiatra che opera in un contesto africano ha la necessità di allargare il proprio angolo visuale, impe184 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? gnandosi nella ricerca ed investigazione dei motivi-guida culturali che sottendono le problematiche psicopatologiche dei singoli. L’indagine culturale passa attraverso i pazienti, incentrandosi sulla cultura come esperienza vissuta. Strumento cardine dell’analisi rimane il rapporto terapeutico, che si viene a declinare come collisione e collusione (nel senso letterale) di due mondi fantasmatici rispecchianti due differenti universi culturali. La riflessione dello psichiatra su questi temi si deve sviluppare nel (oppure «accompagnare al ») costante confronto con gli altri studiosi (l’antropologo culturale, l’etnologo, lo psicologo, il sociologo, ecc.) nel rispetto delle diverse competenze ed avendo cura di evitare pericolose ed affrettate contaminazioni delle rispettive metodologie ed aree di interesse. La crisi della psichiatria europea e l’impatto con la medicina tradizionale somala Come conseguenza della evoluzione delle società occidentali e, nello stesso tempo, per l’impulso di correnti di pensiero quali la psicanalisi, la fenomenologia, la sociologia, la teoria generale dei sistemi, ecc. nella psichiatria europea si è venuta a determinare una crisi profonda e lacerante. Si denuncia l’astrattezza e la rigidità delle categorie nosologiche, il rapporto oggettivante tra lo psichiatra ed il paziente, la gestione custodialistica e repressiva della devianza; lo stesso concetto di «malattia mentale» è stato messo in questione e criticato in molti modi. La nosografia classica non è sufficiente a rendere comprensibi1i le realtà cliniche complesse che si osservano sul terreno della ricerca. Per lo psichiatra che opera in un paese africano e, nella fattispecie, in Somalia, si aggiungono difficoltà derivanti dalla discrepanza tra il suo modo di considerare la malattia mentale e quello proprio della tradizione culturale indigena. In Somalia la concezione della malattia e la cura della stessa divergono largamente dalle concezioni occidentali e per ciò che riguarda le pratiche terapeutiche e le categorie interpretative utilizzate dai medici tradizionali, bisogna tener conto del vasto ed articolato substrato mitologico, cosmologico, religioso, che si è venuto sedimentando nel corso dei secoli, come frutto di una elaborazione originale e dell’influsso di altre culture, africane e non africane, con cui i somali sono venuti a contatto Tali contatti hanno arricchito e diversificato la medicina tradizionale: mentre alcune credenze e concetti sono presenti in tutta la Somalia, altri si trovano solo in particolari regioni, in virtù anche, del185 Luigi Benevelli lo specifico tipo di cultura ivi esistente (nomado-pastorizia, agricola, ecc.). Nella medicina somala possiamo riscontrare la esistenza di due «strati» culturali: ad un fondo di carattere naturalistico tradizionale si è venuta a sovrapporre la tradizione religiosa e culturale islamica, che ha assorbito, trasformandole o lasciandole immutate molte delle credenze preesistenti. Particolarmente interessanti, per il discorso sulla salute mentale, sono le terapie di carattere religioso coranico, i culti di possessione come il Minghis, il Numbi, il Borane ed altri, che costituiscono, anche in considerazione della arretratezza e cattiva organizzazione dell’assistenza psichiatrica, la principale fonte di aiuto per chi soffre di disturbi psichici. Questi riti rappresentano la risposta per il malato che cerca una spiegazione ed un rimedio alla sua condizione e trova nel proprio patrimonio culturale una serie di categorie interpretative connesse a metodiche di cura e a figure di guaritori specifiche e distinte. Tali categorie non sono comunque precisate e tendono a sconfinare l’una nell’altra, sicché la prima sommaria «diagnosi» circa il disturbo e la conseguente scelta del terapeuta al quale affidarsi, risentono grandemente delle credenze culturali del gruppo cui il malato appartiene. I fenomeni psicopatologici che si riscontrano in Somalia non si possono astrattamente descrivere e categorizzare secondo l’approccio medicopsichiatrico europeo. In questo errore cadrebbe chiunque volesse operare secondo un’ottica etnocentrica, riduttiva ed astratta. Dopo aver analizzato gli aspetti positivi e negativi della medicina scientifica e della medicina tradizionale, sarebbe forse utile assoldare i guaritori tradizionali ai servizi sanitari per sperimentare la possibilità di una conoscenza e di un confronto tra gli operatori delle due medicine. La formazione dei quadri sanitari somali Altre situazioni da sottolineare sono la mancanza quasi totale di fonti bibliografiche e casistiche cliniche riguardanti gli studi psichiatrici in Somalia, nonché le difficoltà di tipo operativo emergenti dal particolare tipo di preparazione che gli operatori psichiatrici hanno ricevuto: essi o sono stranieri e quindi hanno una esperienza limitata o superficiale della realtà somala, o sono somali e, avendo studiato nelle università di altri paesi o anche nella facoltà medica di Mogadiscio, sono orientati esclusivamente in senso medico-scientifico. La facoltà di Mogadiscio fu realizzata nel 1973 per far fronte alle gravi necessità igienico-sanitarie del Paese. Particolare 186 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? enfasi venne attribuita all’addestramento teorico-pratico nei campi della patologia di particolare gravità e frequenza; l’insegnamento fu impartito per obiettivi secondo una indicazione dell’Oms, nella quale si sosteneva che la patologia da combattere era rappresentata prevalentemente da tubercolosi, malaria, schistosomiasi e che la mortalità infantile costituiva un grave problema. È evidente che in quella fase non si poteva ancora pensare ad una politica della salute mentale: solamente in seguito si cominciò a sentire anche questa necessità. Dallo studio della situazione complessiva risulta chiaro che per un corretto approccio alla malattia mentale c’è bisogno di un nuovo tipo di medico la cui formazione deve necessariamente partire dall’università. Nel realizzare questa formazione, occorrerebbe un maggior distacco dall’impostazione europeo-occidentale e si dovrebbero perseguire prima di tutto tre obiettivi: - fornire gli strumenti conoscitivi per poter individuare i problemi sanitari più gravi e urgenti che interessano la comunità; - fornire le conoscenze necessarie per intervenire efficacemente nei confronti di questi problemi; - far acquisire la sensibilità e l’attitudine per il lavoro di gruppo, anche a carattere interdisciplinare, assolutamente necessario quando si intenda realizzare un’attività di medicina di comunità intendendosi con questo termine «quella forma dell’intervento medico che tende, oltre che a curare i singoli fatti morbosi, ad affrontare le cause della patologia più grave e rilevante all’interno delle comunità nelle quali queste cause si manifestano e agiscono. In conclusione, mentre nel 1974 secondo l’Oms l’indirizzo era quello di assicurare «le cure elementari di salute mentale da parte di operatori di salute primaria reclutati a livello del villaggio», oggi, essendosi modificato l’intero quadro socio-culturale, è necessaria un’alleanza nuova, per la salute mentale, fra le due medicine, di natura nello stesso tempo pratica, teorica e culturale. La ricerca dovrebbe puntare su tre obiettivi principali: conoscenza della realtà culturale; ipotesi di utilizzo e integrazione di persone, procedimenti e prodotti della medicina locale; definizione degli interventi da effettuare come assistenza sanitaria, assistenza preventiva, medicina di comunità. 187 Luigi Benevelli Gli ultimi sforzi Nel 1986 Mayeh Abu Omar6 e Antonino Jaria presentarono il loro intervento su Integrated Mental Health Services in Somalia7. In questo lavoro sono prima evidenziati i problemi e le difficoltà della psichiatria somala (365 letti psichiatrici in tre centri, mancanza di trattamenti assistenziali differenziati, sovraffollamento e inadeguatezza degli arredi, regime di tipo carcerario, scarsità del personale, scarsa disponibilità di psicofarmaci, pessimo stato degli edifici). Segue la trattazione del ruolo della medicina tradizionale e l’affermazione dell’impegno alla sua valorizzazione. Per rispondere in modo più adeguato alla situazione si prevede e si propone, in alternativa all’allestimento di posti letto, di concentrare gli investimenti nelle risorse umane e professionali di squadre di operatori collocati nell’organizzazione della medicina di comunità. È proposta l’istituzione di un villaggio psichiatrico sul modello di quello di T. A. Lambo in Nigeria nel quale la psichiatria tradizionale e quella occidentale cooperino garantendo le funzioni di day hospital, di cura usando tutte le risorse terapeutiche disponibili, di opportunità di terapie occupazionali, da fruire nelle ore pomeridiane, di ospitalità nelle case gestite dallo staff del villaggio stesso. È prevista l’accoglienza anche dei familiari dei pazienti che possono coadiuvare nella preparazione dei cibi, nei lavori di pulizia ecc. e partecipare alla vita quotidiana del villaggio. Lo staff del personale curante (medici, infermieri, operatori sociali), in collaborazione con i guaritori tradizionali dovrebbe organizzare i trattamenti di gruppo e i programmi occupazionali, basati sull’uso delle tecniche della tradizione artigianale; ha la responsabilità della gestione amministrativa e delle prestazioni sanitarie. Quanto agli ospedali psichiatrici, sono previsti interventi di recupero edilizio e adeguamento funzionale, nonché la differenziazione dei trattamenti fra pazienti con deficit intellettivi, pazienti psichiatrici propriamente detti e pazienti autori di reato. Inoltre si affermava l’indicazione di allargare e diffondere in tutta la Somalia l’offerta di servizi di assistenza psichiatrica presso i servizi di medicina di base o primaria e i centri di medicina di comunità. Ma il grosso dell’investimento doveva essere diretto alla formazione dei quadri (medici, infermieri, operatori sociali) sia in paesi esteri che in Somalia: questo comportava la revisione dei percorsi e dei curriculum e la presenza dei leader religiosi e dei guaritori tradizionali in un sistema nel quale, appunto, trattamenti biomedici moderni e culture sanitarie locali si 188 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? integravano. Erano previste anche indagini e ricerche a sostegno della progettazione più particolare dei servizi. Nella relazione sul corso di psichiatria del 19868 cominciano infine a farsi sentire la fatica del lavoro e la progressiva perdita di energia del progetto dell’Uns. Il corso di psichiatria (che secondo il curriculum di studi del 1965 avrebbe dovuto essere trimestrale con un totale di 60 ore) si era ridotto quest’anno per vari motivi a meno di 50 giorni con un totale di 50 ore. Tuttavia con la collaborazione del preside, del coordinatore, dei colleghi e degli studenti si era riusciti a dare alcune nozioni fondamentali perché i futuri medici potessero conoscere «il funzionamento e la patologia di quell’importante strumento umano che è la mente nei suoi riflessi, tra l’altro e non meno importanti, individuali, culturali, sociali di un paese in rapido sviluppo come è la Somalia» . Come già previsto da molti anni, infatti, la psicopatologia di transizione tipica dei paesi africani era di anno in anno in tumultuoso aumento come d’altra parte l’inurbazione e urgeva quindi uno studio della situazione per programmare pochi interventi ormai improcrastinabili. Al primo National Congress on Health Research (Mogadiscio 27-29 gennaio 1986), era stato presentato un rapporto; si erano avuti incontri anche con il ministro della Sanità,con il vice ministro Rakja e con il responsabile dell’Ufficio programma salute mentale, Maye, con il quale si era concordato un progetto di salute mentale e si era prospettata la necessità di una attività di consulenza continua della facoltà di Medicina. Per affrontare il problema della salute mentale si erano avute sollecitazioni e incarichi a Roma anche da parte del WHO di Ginevra. Si erano iniziate e impostate le ricerche per due tesi di laurea di studenti del settimo anno, la prima riguardante uno Studio comparativo fra medicina occidentale e medicina tradizionale da svolgersi sulla popolazione del reparto e ambulatorio psichiatrico del Forlanini. Il relatore che assieme al sottoscritto avrebbe guidato l’indagine era Abdullahi Rita, docente di medicina tradizionale e antropologia. La seconda, curata dallo stesso Jaria e da Mohamed Abdi Yusuf si riferiva ad una ricerca e tesi su L’incidenza e importanza sociale della nevrosi in Somalia. Si erano svolte esercitazioni pratiche con gli studenti al reparto Forlanini, la cui situazione assistenziale e terapeutica era drammaticamente carente e necessitava di urgenti provvedimenti già proposti nella relazione di Maye al ministero della Sanità. Sul versante culturale (dovendo essere la psichiatria dei paesi in via di sviluppo necessariamente transculturale) 189 Luigi Benevelli si erano presi contatti per continuare i programmi di ricerca sulla Medicina tradizionale col ministro della Pubblica Istruzione e con il vice presidente dell’Accademia somala di Scienze e Arti e svolgendo lezioni assieme a Abdullahi Rita. Per quanto riguarda i rapporti con le altre faco1tà si era continuata la collaborazione con la facoltà di Legge con un seminario svolto agli studenti sulla responsabilità e sulla capacità di intendere e di volere. Assieme a Fucci, docente di medicina legale e a Gure era stato presentato il progetto di un corso di aggiornamento in diritto penale, psichiatria forense e medicina legale. Per allargare e approfondire la conoscenza dei problemi che riguardavano la salute mentale, si proponeva di inserire nella fase propedeutica un breve programma sul funzionamento della mente in accordo anche coi linguisti e con l’insegnamento della fisiologia; portare l’insegnamento della medicina tradizionale al semestre della psichiatria per svolgere assieme dei seminari e ricerche abbinate; trasferire la psichiatria dal Dipartimento di medicina a quello di medicina di comunità; questo avrebbe consentito di dare una connotazione ed un indirizzo alla psichiatria che si proietta sul territorio e avrebbe tenuto impegnati gli assistenti per dodici mesi invece che per due; inserire poche ore di insegnamento oppure semplicemente seminari di psicosomatica e salute mentale nei corsi di specializzazione di medicina, chirurgia, pediatria e ginecologia; La salute mentale, la prevenzione e la profilassi dei disturbi psichici dovevano costituire elemento fondamentale del curriculum della scuola di specializzazione in Sanità Pubblica e Medicina comunitaria (la psichiatria fa parte degli interventi comunitari e della Primary Health Care) e non poteva essere confinata a poche ore sulle malattie degenerative. Si allegavano le relazioni del 1978 e 79 ad esempio che stesse considerazioni scritte si erano già prospettate in quegli anni e non avevano purtroppo dato i frutti sperati. Il reparto neuropsichiatrico dell’ospedale coloniale di Tripoli e l’ospedale psichiatrico di Fesclum9 In Libia, l’esperienza dell’assistenza psichiatrica nel reparto neuropsichiatrico dell’ospedale principale di Tripoli e nell’ospedale di Gargaresc proseguì sotto la direzione di Mario Felici, fino all’espulsione degli italiani nel 1970 da parte del colonnello Gheddafi. Dopo la sconfitta degli eserciti dell’Asse, la Libia fu occupata dai bri190 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? tannici e l’amministrazione della cosa pubblica fu assunta dalla British Administration Tripolitania (BAT). Nel nuovo contesto continuò l’opera degli psichiatri italiani che si succedettero ad Angelo Bravi morto il 9 febbraio 1943. Mario Felici10 era un neuropsichiatra formatosi alla scuola romana di Cerletti e Bini. Ferdinando Accornero11 ricostruisce episodi e protagonisti delle ricerche che portarono alla sperimentazione e alla messa a punto dell’elettroshock e cita ripetutamente Mario Felici, assistente della Clinica delle malattie nervose e mentali dell’Università di Roma. Questi era presente la mattina dell’aprile 1938 quando per la prima volta il trattamento fu applicato su un uomo, un paziente ricoverato nel reparto psichiatria, «uno schizofrenico condotto dalla questura che lo aveva raccolto vagante per le vie di Roma. Nessuno lo aveva cercato, nessuno si era curato di lui»12. I lavori e le relazioni a firma di Mario Felici sono pubblicate sul «Bollettino Sanitario della Tripolitania», un foglio periodico a cura dell’Ispettorato centrale della Sanità Pubblica sotto il controllo della Direzione di Sanità della BAT. La terapia convulsivante con elettroshock13. Il lavoro dà conto dei trattamenti di 31 pazienti, «sia nazionali che musulmani»; per ogni paziente le somministrazioni settimanali erano state due per un totale che era andato mediamente da 8 a 12 applicazioni. Gli stati depressivi erano 11, 3 le sindromi amenziali, 2 gli stati di eccitamento psicomotorio, 7 i casi di schizofrenia, 6 di eccitamento, 2 gli stati di ansia. Gli esiti erano stati largamente positivi. In Stato depressivo guarito in seguito a tentativo di suicidio per impiccagione14, Felici ipotizza che l’anossiemia cerebrale conseguente al tentativo di impiccagione avesse contribuito alla guarigione del paziente da una depressione patologica, analogicamente a quanto si pensa accada a seguito di trattamenti di shock. In Aspetto clinico-statistico della sifilide nervosa nell’arabo libico15, Mario Felici dà conto dei ricoveri per sifilide nervosa avvenuti nel quinquennio 1943-1947 nell’ospedale principale di Tripoli: dei 506 pazienti (di cui 162 donne) ricoverati nel quinquennio, le diagnosi di sifilide nervosa erano state 2116 con una frequenza del 2,30 per cento circa, co191 Luigi Benevelli munque non rara e significativa anche a fronte dei dati europei che davano un attendibile 5 per cento. Le seguenti notazioni di commento di Mario Felici interessano ai fini del discorso su una possibile discontinuità col pensiero e la pratica coloniale: il quadro psichico morboso è rapportato alla diversa evoluzione mentale degli individui: «la maggioranza psichicamente non evoluta non presentò che forme apatiche con rapido scadimento della personalità». Felici suggerisce «che evidentemente il processo anatomo-patologico della paralisi progressiva qualora non trovi ostacolo in un ricco simbolismo di una corteccia filogeneticamente matura non dia quei quadri caratteristici (euforia, idee di grandezza) nei quali si è soliti considerarla. In altre parole l’aspetto semplice della forma dell’arabo libico sarebbe dovuto alla qualità dei soggetti quasi sempre a mentalità primitiva e non evoluta». In Furore omicida in soggetto ansioso sottotitolato «nota di psichiatria comparata per la conoscenza delle sindromi affettive nell’arabo libico»17 Mario Felici afferma che, per la omogeneità e unità psichica di fondo degli uomini18, non esiste una psichiatria «coloniale» e che c’è un grande bisogno di revisionare il patrimonio delle conoscenze psichiatriche costruito dagli europei nelle nazioni europee «tanto più sentito oggi che particolari condizioni di vita hanno posto ad intimo contatto gli esseri umani più lontani e più disparati tra loro, che eventi eccezionali hanno sottoposto l’umanità ad una usura terribile della vita psichica». Si tratta di riflessioni emerse nel corso, pare evidente, di una perizia psichiatrica che si conclude con la definizione dei caratteri propri della figura psichica dell’ansioso a mentalità primordiale non evoluta. Nello svolgere le proprie argomentazioni sulla vicenda che aveva avuto protagonista un contadino arabo di 24 anni, Felici infila una serie di affermazioni del tipo: «l’ambiente (il contesto sociale in cui viveva il “fellah”) è pervaso dal senso del soprannaturale […]; se ancora oggi si ricorre al marabutto, si accetta poi l’opera del medico […]; né si osservano con facilità gli aspetti isterici che dominano le razze negre […]; le poche osservazioni sopra gli uomini di colore sono concordi nell’ammettere che la psicosi periodica si manifesta, nel primitivo, con gli stessi caratteri coi quali si manifesta nel bambino […]; esiste un diverso aspetto dello stato ansioso a seconda che esso si verifichi in un individuo evoluto psichicamente oppure in un individuo a psichismo primordiale». 192 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? In Le sindromi affettive nell’arabo libico19, si dà conto dei 932 ricoveri (645 uomini e 287 donne) avvenuti nei sei anni dal 1944 al 1949 nel reparto psichiatrico di 120 letti dell’ospedale principale di Tripoli20. Mario Felici descrive vivacemente le difficoltà del lavoro clinico fra le quali la maggiore per la semeiotica psichiatrica è rappresentata dalla mancanza, quasi costante ed assoluta, di una qualsiasi psicoanamnesi. Infatti o ci si trova di fronte al deserto concettuale più assoluto, sia nel soggetto che nei familiari, per cui gli interrogati rispondono con un non so » oppure non rispondono affatto, o s’incontra la generica affermazione religiosa che tutto è avvenuto per volontà di Dio, quando non è addirittura l’elemento magico e superstizioso che fa riferire l’inizio della malattia ad uno «spavento», ad una «fattura» (più rara). Impossibile stabilire con precisione una data d’inizio: «forse un mese», «forse più», «forse meno», queste in genere le risposte che si ottengono. Tale imprecisione vale anche per gli arabi dei grossi centri abitati sebbene per questi riesca più agevole stabilire l’inizio dei sintomi. In genere. bisogna adoperare l’unico materiale anamnestico efficiente e cioè cercare di stabilire – sempre con approssimazione – l’inizio del disturbo esteriore e cioè il manifestarsi palese del disturbo della condotta. Tenendo però presente che per la massima parte si tratta di soggetti agricoltori o pastori che vivono sotto la tenda è opportuno cercare di dare risalto, nell’indagine anamnestica, ai disturbi a carico della vita vegetativa i quali con facilità colpiscono l’osservazione dell’ambiente circostante. In siffatta maniera i precedenti anamnestici si riducono in genere a pochi giorni d’insonnia e di agitazione. Quando compare quest’ultima, in genere a spese del vasellame domestico, i familiari si decidono quasi sempre a ricorrere all’opera del medico condotto che provvede al ricovero. Pertanto il primo elemento clinico generico – perchè proprio di tutta la nosografia locale – è presentato dalla mancanza di elementi anamnestici, condizione che porta lo psichiatra a lavorare ed osservare in condizioni particolarmente difficili al fini della valutazione prognostica. Quando si riesce a stabilire con certezza un elemento anamnestico, questi è quasi sempre la dichiarazione fatta dal paziente – a guarigione avvenuta – di essere da qualche giorno in preda a senso di malessere imprecisato. Il che, per la verità, non è molto. Forse l’indagine anamnestica riesce di miglior aiuto nei casi di «ansia», casi che esplodono improvvisamente nelle ore precedenti al ricovero e che perciò sono 193 Luigi Benevelli ancora freschi di ricordi nell’ambiente ed affatto scoloriti. In genere si tratta di operai «spaventatisi» sul lavoro; di contadini « impauriti» per la presenza di ladri nell’orto; si tratta di giovani vagabondi «atterriti» perché arrestati dalla polizia in quanto sospettati di furto o di molestia. Per le donne è in genere una lite con le vicine o con la suocera; è bene tener presente il particolare aspetto della casa araba, la convivenza di numerose donne in spazio ristretto, per comprendere la relativa frequenza di tale causa per l’insorgenza di S.A. Impossibile accertare l’eventuale familiarità di elementi psicopatici. Impossibile accertare la periodicità di un quadro di S. A. poichè nel mondo capitato alla nostra osservazione quando uno «sta bene» non si discute nemmeno l’eventuale ipotesi che si possa anche non star bene del tutto, ed in questo senso la risposta negativa «ilah» è veramente assoluta. In genere tanto il quadro ansioso che quello di depressione o di eccitamento sono caratterizzati dalla breve durata e questo permette di differenziarli dalle vere forme di depressione o di eccitamento della psicosi maniaco-depressiva le quali persistono oltre i 90 giorni e sono specialmente caratterizzate dalla periodicità e quindi in tutto simili al quadro nosografico classico. Come si è detto esse sono estremamente rare e in esse si verificano i tentativi di suicidio oppure si riscontra la marcata, ben nota, esaltazione della sfera percettivo-ideativa. Sono ammalati che cantano, scherzano, assumono a comando grottesche e comiche posizioni; individui che sottraggono il cibo agli altri ricoverati, che li molestano o che si fanno beffe di loro. In genere è in questa forma che si riscontra il tipo che circondato da ragazzi e da sfaccendati fa «fantasia», per le strade o nel mezzo della cabila, e che viene considerato « marabutto», cioè investito da un riflesso della divinità e capace quindi di far miracoli. Data l’estrema facilità alla esaltazione vuoi singola che collettiva – come gli arabi libici dimostrano nelle «hadre» – tali forme maniacali si dovrebbero ricoverare con frequenza assai maggiore ma le ragioni per le quali questo non si verifica ci sembra che debbano essere: 1. che tali individui vengono considerati benevolmente dai concabilani e quindi assistiti e protetti; 2. che preferibilmente si conduce il folle ad altro riconosciuto marabutto che dopo avergli praticato una «shmala» col ferro rovente provvederà a calarlo nel pozzo acciocchè lo spirito maligno sia costretto ad andarsene; 3. la scarsa efficienza del simbolismo e perciò della ideazione che toglie a questi quadri di eccitamento i principali caratteri della varietà e ricchezza as194 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? sociativa, per cui essi sono difficilmente identificabili con la ciclofrenia vera e propria. Questa terza ragione è la spiegazione più plausibile della assoluta amorfa generica di questi quadri di eccitamento, sia ansiosi che maniacali, espressione quindi di uno psichismo quanto mai elementare e povero. Ricapitolando quindi le risultanze della osservazione si conclude che il quadro delle S. A. nell’arabo libico è quanto mai generico e poco differenziato. Negli anni del secondo dopoguerra, le condizioni in cui si svolge l’assistenza ai malati di mente restano molto difficili, come emerge dal «Corriere di Tripoli», quotidiano della Tripolitania, del 22 giugno 1954, che informava con grande evidenza della visita del governatore al servizio neuropsichiatrico condotto da Mario Felici e Cesare Felici21. Il manicomio di Fesclum era stato costruito dove una volta era una caserma di ascari. Allora ospitava 200 pazienti e vi operavano due infermieri libici diplomati, un infermiere ed un’infermiera italiani diplomati, 2 assistenti e 3 infermieri libici non diplomati, le suore e vari inservienti addetti ai servizi di portineria, cucina, guardia ecc. I reparti di ricovero erano 3, 2 per gli uomini e 1 per le donne. Un fabbricato ospitava gli uffici del direttore, del medico assistente, gli uffici amministrativi e tecnici, un ambulatorio dotato di apparecchio per l’elettroshock applicato gratuitamente e in regime ambulatoriale. I fabbricati erano circondati da recinti e giardini. Prima di quel 22 giugno 1954 l’ospedale non era mai stato visitato da alcuna autorità e non «aveva goduto di alcuna riforma né di miglioramenti sensibili sia nelle sua attrezzature, che nei suoi fabbricati, che nei servizi complementari». Nel corso della visita il governatore disponeva il miglioramento della qualità e della quantità dei cibi (le vivande erano cucinate nell’ospedale principale e da lì trasportate al manicomio dove erano distribuite), il miglioramento dlla pulizia e della disponibilità di capi di vestiario, che si costruisse una nuova cucina con relativa dispensa, rapidamente si desse inizio ai lavori di riparazione e tinteggiatura dei muri, delle porte e delle finestre, al «miglioramento del servizio elettrico», alla riparazione delle condutture e degli scarichi, alla sistemazione dei giardini abbandonati all’incuria. Inoltre donava due apparecchi radio e disponeva l’erogazione di somme mensili che servissero «esclusivamente per la ricreazione dei pazienti e per l’acquisto di rinfreschi, dolciumi, sigarette ecc». Terminata la visita, il professor Mario Felici dichiarava la propria soddisfazione per il 195 Luigi Benevelli In questa e alle pagine seguenti documentazione fotografica dell’ospedale psichiatrico di Fesclum (Tripoli), fornita all’autore da Antonietta Sammartano, vedova del medico Cesare Felici (1923-2005), che vi lavorò dal 1951 al 1957. 196 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? 197 Luigi Benevelli 198 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? 199 Luigi Benevelli 200 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? 201 Luigi Benevelli 202 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? 203 Luigi Benevelli riconoscimento e le garanzie ricevute, manifestava la volontà di «non solo continuare, ma anche di intensificare ed incrementare la nostra opera». Pochi dati sulla situazione in Etiopia Giel Robert22 psichiatra olandese racconta che negli anni sessanta il ministero della Sanità etiopico riferiva dell’esistenza di un ospedale psichiatrico in Asmara diretto da uno psichiatra italiano, in precedenza medico militare con l’assistenza di suore cattoliche. Ad Harar c’era un asilo per pazienti cronici e ad Addis Abeba l’ospedale psichiatrico di Hamanuel (390 letti), nascosto dietro un lungo muro di cinta fra la Chiesa di Sant Hamanuel e l’affollato mercato del grano. La sistemazione risaliva alla fine degli anni trenta. Giel visita l’ospedale nel 1965 e trova una situazione da «fossa dei serpenti»: pazienti in numero superiore ai letti, molti pazienti nudi e in catene, sessioni di elettroshock due volte la settimana in una stanza affollata al piano terra dell’edificio. Pavicevic, unico psichiatra jugoslavo, si dava da fare per migliorare la situazione. L’Etiopia aveva e continua ad avere abbondanza di guaritori e luoghi dedicati: acque sante, chiese copte, riti di possessione, sheik ed erboristi. Note al testo 1 Nicola Labanca, Oltremare, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 427-470 passim. 2 Devo questa ricostruzione alla generosa collaborazione del professor Antonino Jaria, mio primo direttore che incontrai nel 1968 quando iniziai a lavorare presso l’ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere. 3 (Jaria, Buho,Abikarim) nel corso del 1982 erano stati registrati 383 ingressi e 19 reingressi riguardanti solo le psicosi schizofreniche (79,6 per cento).Atri gruppi diagnostici più rilevanti: psicosi organiche 4,9 per cento, 7,14 per cento epilessia, 1,5 per cento psicosi senili. 4 v. Atti e memorie della Accademia di storia dell’arte sanitaria, 1985, n. 3. Relatori oltre a Jaria furono: A. Antoniotto, docente di antropologia e medicina tradizionale a Mogadiscio, Una terapia tradizionale in Somalia: ill Minghis. Aspetti socio-culturali di un culto di possessione; G. Berdini, psicologo, Approccio psicologico al trattamento dei disturbi mentali nella medicina tradizionale; B. Bernardi, etnologo dell’università di Roma, Il contesto culturale della trance. 5 A. Jaria, A. Foltieri, G. Berdini, Considerazioni sul problema della «malattia mentale» e della medicina tradizionale in Somalia, «Africa», n. 3, pp. 459-469. 204 Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale italiana? 6 Capo della sezione coordinamento e rapporti internazionali sulla salute; direttore del programma per lo sviluppo della salute mentale del ministero della Sanità del governo somalo. 7 Relazione al III International Congress of Somali Studies, Roma 26-30 maggio. 8 Dattiloscritto in data 5 marzo 1986. 9 La stesura di queste note è stata consentita dalla opportunità ad accedere a documenti e pubblicazioni del professor Mario Felici, concessami dal figlio Francesco e dalla cortesia della signora Antonietta Sammartano, vedova del dottor Cesare Felici, che ha messo a disposizione documentazione fotografica dell’ospedale psichiatrico di Fesclum (Tripoli di Libia). 10 Mario Felici nasce a Napoli l’ 8 giugno 1908; muore a Roma il 15 febbraio 1989. Nel 1934 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e nel 1938 si specializza in Clinica delle malattie nervose e mentali. Dal 1934 al 1941 è assistente volontario alla Clinica delle malattie nervose e mentali di Roma, diretta da Ugo Cerletti. In questo periodo Mario Felici partecipa attivamente alle ricerche sulla terapia elettroconvulsivante del gruppo coordinato da Cerletti e di cui fanno parte tra gli altri Lucio Bini e Ferdinando Accornero. Felici si occupa delle analisi sulla composizione del liquor dopo elettroshock. Nel 1941, sottotenente medico di Cpl. Divisione Trieste è assegnato al fronte nordafricano. Decorato nello stesso anno di medaglia d’argento al valor militare, fronte di El Alamein. Nel 1943 a Tripoli, in Libia, viene fatto prigioniero di guerra dall’esercito inglese e deportato in un campo di prigionia sul canale di Suez (El Qantara) dove fino al 1947 ha modo di fare esperienza di medico secondo l’organizazzione anglosassone. Dal 1948 al 1964, al termine della prigionia, anche a seguito di sue vicende personali, Felici si stabilisce a Tripoli in Libia, dove fonda e dirige un reparto di clinica neuropsichiatrica. Successivamente viene incaricato dal governo libico di dirigere un ospedale psichiatrico in zona Feschlum capace di qualche centinaio di posti letto e di questa struttura diviene il direttore. Nel 1952 gli è conferita la libera docenza in Clinica delle malattie nervose e mentali dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza. All’inizio del 1963 l’ospedale psichiatrico si trasferisce a Gargaresh in una nuova struttura capace di circa 2000 posti letto. Nel 1964, a seguito del progressivo intensificarsi degli episodi di intolleranza verso la comunità italiana, Felici decide di interrompere l’esperienza libica dopo 22 anni, e rimpatria a Roma con la famiglia dove continua la sua opera di medico sino al momento della morte. Mario Felici è l’unico psichiatra italiano citato nel Trattato di psichiatria di Bini e Bazzi del 1967 nel capitolo dedicato agli Abnormi psichici secondo i gruppi etnici. Nevrosi dei primitivi. Egli è citato insieme a Aubin-Alliez e Carothers: la tendenza a scariche aggressive e violente sia in relazione a stimoli esterni sia come acting out in seguito a conflitti endopsichici o come reazione a disturbi ansioso-disforici sarebbe più spiccata nei cosiddetti «primitivi», negri africani, malesi, arabi, ecc. (vol. III, p 57). 11 F. Accornero, Testimonianza oculare sulla scoperta dell’elettroshock, in Pagine di Storia della Medicina, Università di Roma, Roma 1970, anno XIV, 2, marzo-aprile, pp. 38-52. 12 «Bini e Felici stavano presso l’apparecchio, Cerletti ed io presso il paziente. […] tutto era pronto. Bini volse uno sguardo interrogativo al Maestro e questi fece un cenno d’assenso». 13 M. Felici, La terapia convulsivante con elettroshock, «Bollettino Sanitario della Tripolitania, marzo 1944. 14 M. Felici, Stato depressivo guarito in seguito a tentativo di suicidio per impiccagione (nota clinica), «Bollettino Sanitario della Tripolitania», maggio-giugno 1944. 15 M. Felici, Aspetto clinico-statistico della sifilide nervosa nell’arabo libico, «Bollettino Sanitario della Tripolitania», gennaio-giugno 1947. 16 Paralisi progressiva 6, tabe paralisi 2, lues cerebri 5, di cui una donna, psicosi in soggetto luetico 8, di cui una donna. 205 Luigi Benevelli 17 M. Felici, Furore omicida in soggetto ansioso, «Bollettino Sanitario della Tripolitania», novembre 1949. 18 Ivi: «i diversi elementi della vita psichica dell’uomo vengono a modificarsi a secondo dell’individuo e delle necessità ambientali così come una qualsiasi funzione si adatta e si trasforma nelle diverse specie, pur rimanendo sempre la stessa rispetto alla propria finalità». 19 M. Felici, Le sindromi affettive dell’arabo libico, «Bollettino Sanitario della Tripolitania», fasc.1-2, 1950. 20 Le diagnosi di «sindromi affettive» furono 175 (119 uomini e 56 donne), vale a dire il 18.77 per cento del totale. La maggior parte dei ricoveri non superò mai i 15-30 giorni, solo 23 superarono i 6 mesi e 2 furono ricoverati in manicomio. 21 Cesare Felici (La Maddalena 8 novembre1923 - Roma 14 novembre 2005), si laurea all’Università di Roma in Medicina e chirurgia nel 1950, dopo essere stato negli anni dal 1943 al 1945 in guerra prima e poi prigioniero in Iugoslavia. Nel 1951, chiamato dal prof. Mario Felici, direttore dell’ospedale psichiatrico di Tripoli (Libia) assume la carica di assistente presso l’ospedale psichiatrico di Fesclum. Svolge questa attività ininterrottamente per sei anni a tempo pieno, vive e lavora infatti nell’oasi di Fesclum dove si trova l’ospedale, fino al gennaio 1957, quando, infine, rientra in Italia. Sia pure in anni diversi e per un periodo più breve, Felici vive la stessa esperienza di Mario Tobino, anche lui tutt’uno con l’ospedale, a contatto, come affermava Tobino, con «la follia pura», non condizionata da psicofarmaci, e affrontata con un impegno quotidiano totale. Il lungo soggiorno a Fesclum costituisce dunque una fondamentale esperienza per Felici, che, anche nella sua attività di medico a Roma, porta con sé gli esiti del rapporto avuto con la malattia mentale manifestata da popolazioni ancora lontane dalla cultura e dagli stilemi di una società più evoluta, anche se non mancarono pazienti della locale comunità europea, italiani ed inglesi soprattutto. Di questo rapporto Felici conserva l’idea di un manicomio «aperto», dove i pazienti, esclusi i casi più gravi, sono autorizzati a circolare liberamente fra i piccoli caseggiati e magari…. a salire come scimmie su una palma altissima, spingendolo a doversi arrampicare lui stesso per riportarli a terra. Si instaura certamente un rapporto quasi familiare, come dimostrano le lettere che alcuni, più acculturati, gli scrivono dopo il suo ritorno in Italia. L’attività quotidiana nell’ospedale lascia poco spazio per altre attività mediche, anche se da un certo momento Felici apre uno studio privato nella città vecchia di Tripoli. Durante un periodo di ferie in Italia frequenta il laboratorio di Elettroencefalografia della Clinica delle malattie nervose e mentali diretta dal professor M. Gozzano. I rapporti con la Nazira of Interior Tripolitania sono corretti, ma improntati a un carattere piuttosto poliziesco, come attestato dai pochissimi permessi di licenza concessi, dalla necessità di un permesso per il coprifuoco, dalla difficile cessazione del rapporto di lavoro. Rientrato in Italia Felici si reinserisce nell’attività sanitaria scontando l’inevitabile gap dovuto alla lunga assenza dall’Italia (diventa medico di famiglia e medico funzionario presso l’ENPAS) e soltanto nel 1980 la sua collocazione di medico funzionario lo porta a lavorare presso l’ospedale psichiatrio di S. Maria della Pietà, nel momento del discrimine fra l’assetto preesistente e l’applicazione della legge Basaglia. In questa veste collaterale di medico funzionario, Felici realizza un progetto che aveva sperimentato già in Libia, utilizzando terapeuticamente i burattini con un gruppo di malati psicotici, lungo degenti presso l’ospedale. L’utilizzo delle tecniche relative al teatro di figura (burattini e marionette) secondo principi metodologici sperimentati specialmente in campo internazionale (Marionnette et thérapie è l’associazione francese che più si è impegnata in questo campo) può essere messo in atto da Felici anche grazie alla sua conoscenza delle tecniche del teatro di figura di cui è un esperto. Felici ricopre infatti la carica di presidente del Centro UNIMA Italia, parte dell’associazione internazionale UNIMA (Union internationale de la Marionnette). 22 R. Giel, The prehistory of psychiatry in Ethiopia, «Acta Psychiatr. Scand.» 1999, 100, pp. 2-4. 206 Il programma coloniale della Germania nel 1915 di Vanni Clodomiro Il documento di cui riportiamo il contenuto si trova in Germania, presso l’Archivio Centrale dello Stato, nelle Carte Solf 1, e rappresenta, in sostanza, il programma tedesco di rivendicazioni coloniali, così come fu concepito nell’ottobre del 1915, allorché la Germania, invaso ormai da un anno il Belgio, aveva conseguito la vittoria di Gorlice contro i russi e occupato l’intera Polonia assieme alle province baltiche occidentali (maggio 1915); pertanto, la situazione in Europa era tale da consentire alla Germania di coltivare quei sogni di grandezza che poi sarebbero svaniti con l’evoluzione degli eventi bellici. E, in effetti, la relazione del ministro Solf costituiva, come lui stesso affermò chiaramente alla conclusione della relazione, un programma «in grande stile»2. Solf redasse quella relazione confidenziale, anche sulla base di ciò che sul problema coloniale avevano espresso per iscritto le federazioni degli industriali e degli agricoltori e la Società coloniale tedesca. Ma teneva nel dovuto conto il fatto che, mentre le federazioni rappresentavano in effetti tutta l’agricoltura e tutta l’industria della Germania, non si poteva affermare che nella stessa misura la Società coloniale tedesca rappresentasse realmente tutti gli interessi coloniali della Germania. Ci sembra opportuno soffermarci brevemente su un aspetto particolare della relazione di Solf, da cui risulta evidente che i motivi dell’ingresso in guerra della Germania dovrebbero essere riconducibili più o meno esclusivamente alle esigenze coloniali e commerciali. Infatti, tutto il programma si pone come fine quello del beneficio economico eventualmente derivato alla nazione da un più ampio e razionale sfruttamento delle terre africane. Solo pochi accenni iniziali sono dedicati al territorio europeo. Subito dopo, si distendono l’esposizione minuta e l’analisi puntualissima delle possibilità della Germania di operare, in pratica, una sistematica rapina di colonie a danno degli altri stati europei. Ciò sembra dare ragione a chi vuol in207 Vanni Clodomiro terpretare la decisione della Germania di scatenare la guerra come la logica conseguenza della necessità di creare nuovi mercati di sbocco, indispensabili per la sua abbondante produzione industriale e per la sua superpopolazione. All’epoca, anche il ministro italiano per le Colonie, Colosimo, sosteneva che la Germania aveva «impostato i suoi scopi di guerra e di pace sulla questione coloniale […] per ottenere, insieme con la libertà dei mari, la propria indipendenza economica mediante la disponibilità delle materie prime in territori di suo diretto dominio»3. Bisogna riconoscere che Colosimo aveva una visione, per così dire, coloniale dei rapporti politici europei e quindi una preoccupazione quasi esclusiva per le colonie; anche Solf manifestava un’analoga inclinazione, ponendo però una particolare attenzione agli effetti che un grande «regno coloniale» avrebbe avuto sull’economia tedesca. Ma con qualche differenza: anzitutto, Colosimo non fece programmi, per così dire, in grande stile; in secondo luogo, Solf non si curava affatto di ciò che invece sembra stesse a cuore a Colosimo, e cioè del dovere che questi sembrava avvertire, almeno nelle affermazioni di principio (alle quali sinceramente siamo poco inclini a credere) di svolgere anche opera di «civilizzazione» delle popolazioni indigene africane. Comunque, sono un fatto i rapporti di cordialità che, a un certo punto, l’Italia instaurò con Sajed el Idriss, capo libico della Confraternita religiosa dei Senussiti. Anzi, aggiungiamo che il programma di Solf aveva il fine precipuo di fornire alla Germania «eccellenti lavoratori», come nel caso delle isole britanniche di Zanzibar e Pemba, la cui popolazione era vista dal ministro tedesco solo come «uomini di fatica per il trasporto di pesi». Una visione coloniale tout court degli interessi economici del suo paese rimase un carattere costante del pensiero politico di Solf, se è vero, come è, che, ancora nel 1918, cioè appena un mese prima dell’armistizio di Compiègne, che avrebbe sancito il crollo definitivo dell’impero tedesco, egli si preoccupava, quasi a dispetto della difficile situazione interna della Germania, di puntualizzare e rivendicare i suoi diritti in politica estera4, e in particolare nelle colonie africane. La «Depêche Coloniale et Maritime» del 4 ottobre aveva pubblicato una corrispondenza da Amsterdam, dove Solf aveva tenuto, il primo ottobre5, una conferenza sulla guerra e le colonie, a cui aveva assistito il re di Baviera, e in cui, tra l’altro, diceva: Recuperare le nostre colonie è compito di importanza nazionale che non può essere 208 Il programma coloniale della Germania nel 1915 nascosto da nessun altro. Prima della guerra, i paesi tropicali e subtropicali fornivano il 50% delle materie prime da cui dipendevano le nostre industrie. Gli attuali surrogati non possono essere sufficienti in tempi di pace. Senza colonie, dovremo rimanere in una condizione di dipendenza e alla discrezione dei paesi stranieri. Quando scoppiò la guerra, le nostre colonie facevano buoni progressi: noi eravamo in grado di resistere all’assalto del monopolio degli altri Stati. I trattati commerciali non offrono garanzie; nelle colonie francesi, la parità di trattamento non esisteva che sulla carta. Il governo imperiale mantiene ferma la sua richiesta: il ritorno delle colonie africane e di quelle dei mari meridionali esige, inoltre, una nuova ripartizione dell’Africa, tale da consolidare i nostri possedimenti sparsi. Il Belgio, il Portogallo e la Francia possiedono grandi ed eccessive distese territoriali. Noi non pretendiamo la parte del leone. Se non pretendeva la parte del leone, Solf era però certamente determinato nelle insistenti e plateali rivendicazioni, allo scopo di creare un movimento d’opinione da utilizzare, eventualmente, come elemento di pressione in sede di trattative di pace con le altre potenze europee. La sua visione coloniale dell’assetto europeo durava ostinatamente ben oltre gli anni della guerra. Tuttavia, le mutate condizioni della Germania comportarono un mutamento nel tono delle sue affermazioni: nel 1926, in una lettera all’amico Schnee6, affermava tra l’altro: «Vorrei perciò dire soltanto che sono sempre affezionato alle cose coloniali, che ritengo però necessari altri metodi che quelli attuati dai nostri amici in Germania, se vogliamo raggiungere obiettivi per noi vantaggiosi»7. Nel resto della lettera, Solf non specificò quali dovessero essere gli altri metodi, ma l’affermazione degli obiettivi parla da sé. E nel 1933, in un’altra lettera8 allo stesso Schnee, contestava Hitler, in relazione al suo rifiuto, nel Mein Kampf, di una politica coloniale: Brani che fanno riferimento alla politica coloniale tedesca di prima, che lui decisamente condanna, si trovano alle pagine 689, 691, 730 e 753. Per il futuro rifiuta una politica coloniale tedesca9. Metà ottobre 1915 In un memoriale confidenziale stampato come manoscritto10 ed indirizzato nel maggio 1915 al cancelliere del Reich ed ai ministeri dei singoli stati federali, le federazioni unite dell’agricoltura e dell’industria affermavano tra l’altro l’esigenza di un regno coloniale in grado di soddisfa209 Vanni Clodomiro re pienamente i molteplici interessi economici della Germania, la necessità della garanzia del suo futuro politico-doganale e politico-commerciale e del raggiungimento di un sufficiente risarcimento dei danni di guerra concesso in forma appropriata; vedevano inoltre lo scopo principale della battaglia nell’assicurarsi e nel migliorare le basi europee su cui si fondava l’esistenza del Deutschen Reich. Seguivano poi ampie, dettagliatamente motivate pretese di una estensione territoriale in Europa basata sul massimo successo militare: significativa crescita nell’Est, annessione del Belgio, presa di possesso della costa del Canale fino alla Somme e della cinta francese di opere di fortificazione Verdun-Belfort. Le esigenze di tipo politico-coloniale e politico-commerciale non venivano spiegate nei dettagli, ma si riteneva dovesse essere riservato alle parti interessate alle colonie esprimere e motivare i loro desideri a tale riguardo. Di tali rivendicazioni di pace riguardanti il settore coloniale si era occupata, in una seduta del 22 settembre a Berlino, la commissione allargata della Società coloniale tedesca; le risoluzioni approvate in quell’occasione erano state pubblicate sulla «Deutschen Kolonialzeitung» dell’8 ottobre. Riguardo alle rivendicazioni di pace, le risoluzioni avevano il seguente contenuto: La Società Coloniale Tedesca riconosce l’importanza degli sforzi di dare al Deutschen Reich in Europa frontiere militari ed economiche più favorevoli di quelle esistenti. Come supplemento a queste rivendicazioni, ritiene però assolutamente indispensabile che siano assicurati al Deutschen Reich un possedimento coloniale ed un commercio d’oltremare corrispondenti alla sua forza popolare, al suo potenziale finanziario, alle sue esigenze economiche ed ai suoi obblighi culturali. In particolare richiede: 1) Restituzione dei possedimenti coloniali tedeschi occupati dai nemici e concessione di una espiazione, comprensibile anche agli indigeni, per le offese recate al popolo tedesco. 2) Ingrandimento ed organizzazione dei possedimenti coloniali tedeschi secondo di punti di vista geografici, economici, militari e finanziari. 3) Libertà dei mari, protezione delle colonie tedesche e del commercio mondiale tedesco tramite il potenziamento della nostra flotta e la costruzione di basi per la flotta e di stazioni radio. 4) Determinazione del principio della porta aperta per le colonie delle potenze europee. La Società Coloniale Tedesca ritiene indispensabile per motivi economici e politicocoloniali — e lo ritiene inoltre un obbligo d’onore del Deutschen Reich — concedere ai Tedeschi che lavorano nelle nostre colonie un pieno e sollecito indennizzo per i danni subiti a causa della guerra, e cioè per principio e nella stessa misura come succede in 210 Il programma coloniale della Germania nel 1915 altre regioni tedesche, specialmente nella Prussia dell’Est. Nello stesso momento fa presente che il commercio d’oltremare, indispensabile per la crescita economica della Germania, può soltanto ottenere nuovamente la sua antica importanza se gli venga concesso un sufficiente risarcimento per le perdite subite nelle colonie nemiche e per mare. A differenza del manifesto molto più approfondito ed esteso dell’agricoltura e dell’industria, riguardante la futura conformazione del Deutschen Reich in Europa, le risoluzioni della Società coloniale erano soltanto di tipo generico. Solf sottolineava che le federazioni agricole ed industriali, che si erano rivolte con il loro memoriale al cancelliere, rappresentavano in effetti tutta l’agricoltura e tutta l’industria della Germania, mentre non si poteva affermare che nella stessa misura la Società coloniale tedesca fosse l’autorizzata rappresentante di tutte le parti interessate alle colonie. Scopo della relazione era circoscrivere e spiegare più da vicino le rivendicazioni di pace, specialmente per l’Africa, riferendosi possibilmente sia ai principi scelti dall’agricoltura e dall’industria nel loro memoriale, sia alle risoluzioni approvate dalla Società coloniale. Si trattava qui di una espressione d’opinione puramente personale di Solf, che non pretendeva di corrispondere in ogni punto ai desideri della maggioranza delle parti interessate alle colonie. Era naturale che anche nei circoli coloniali si facesse spesso quel campanilismo che voleva vedere le rivendicazioni di pace dettate esclusivamente dalla loro influenza sulle proprie faccende. A seconda del tipo di posizione o di iniziativa che si intendeva intraprendere, venivano manifestati desideri che questo o quel paese rimanesse o diventasse tedesco anche in futuro (e fino a che punto), oppure non rimanesse o non diventasse tedesco. Nonostante ciò, soltanto i desideri pronunciati pro domo corrispondevano probabilmente abbastanza spesso in piena misura agli interessi generali. Non avrebbero dovuto apparire certamente come integrazioni appropriate e degne d’attenzione dei desideri generali, visto che nella maggioranza dei casi si basavano su esperienze profonde in un campo specifico comunemente poco conosciuto. La base delle rivendicazioni di pace formulate dall’agricoltura e dall’industria era la realizzazione della formula che a questa guerra dovrebbe seguire una pace onorevole, che corrisponda ai sacrifici fatti e che porti in sé la garanzia della sua stabilità. 211 Vanni Clodomiro Si faceva notare inoltre che i nemici proclamavano continuamente che la Germania fosse da distruggere e da eliminare dal novero delle grandi potenze, e si esprimeva l’opinione che non si trovasse protezione alle aspirazioni tedesche in trattati che al momento opportuno sarebbero stati nuovamente calpestati, ma soltanto nel forte indebolimento economico e militare dei nemici: con ciò, la pace sarebbe stata garantita per un tempo prevedibile. Dopo le rivendicazioni di espansione territoriale, si diceva che quelle si basavano ovviamente sulla condizione della loro fattibilità militare. Ma dopo ciò che si era raggiunto fino ad allora, si aveva piena fiducia nell’esercito e nei suoi vertici che sarebbe stata conquistata una vittoria capace di garantire il raggiungimento di quegli scopi. La stessa fiducia doveva essere anche alla base delle rivendicazioni coloniali di pace. Nelle rivendicazioni europee di pace l’agricoltura e l’industria esigevano significativi ingrandimenti territoriali a spese della Russia, del Belgio e della Francia. Si era certi che il raggiungimento di quelle pretese avrebbe distrutto il Belgio e indebolito la Francia quanto bastava per mettere la Germania per oltre una generazione al sicuro da eventuali attacchi. Anche contro la Russia si sarebbe potuta raggiungere una maggiore sicurezza del Deutschen Reich con la sottrazione di alcuni (imprecisati, N.d.A.) territori. Dopo la guerra, la situazione interna della Russia sarebbe stata tale da impedirle una rapida ripresa. Ma come si trovava l’Inghilterra? Le rivendicazioni nei suoi confronti dovevano consistere nel risarcimento dei danni di guerra, in significative ed appropriate espansioni del regno coloniale tedesco e nella soddisfazione delle esigenze politico-doganali e politicocommerciali11. Si diceva che per la provocazione dell’incendio mondiale l’Inghilterra sarebbe stata punita abbastanza ed in modo assai gravoso con l’annessione, da parte della Germania, del Belgio e dell’eventuale possesso di Dunkerque, Calais e Boulogne. Certamente l’Inghilterra, che sembrava fosse entrata in guerra per la neutralità del Belgio, avrebbe forse perduto pesantemente di prestigio, qualora non lo avesse avuto in restituzione. La sua perdita significava per l’Inghilterra la perdita di un’importante base continentale contro la Germania e con il possesso tedesco della Costa del Canale quest’ultima avrebbe ottenuto una base capace di rappresentare una continua minaccia per l’Inghilterra, mentre la menomazione della Francia avrebbe indebolito il più potente alleato dell’Inghilterra. Perciò, un nuovo attacco militare dell’Inghilterra contro la Germania sarebbe stato sicuramente molto più difficile; ma l’Inghilterra si sarebbe rapida212 Il programma coloniale della Germania nel 1915 mente consolata. Con il Belgio in possesso tedesco, ben presto i diplomatici inglesi avrebbero saputo spiegare al mondo che il Belgio come Stato autonomo sarebbe stato di grandissimo valore per l’Inghilterra e per tutto il mondo culturale, ma che in possesso tedesco avrebbe significato soltanto un indebolimento e un danno incalcolabile per la Germania. Del resto, la perdita del Belgio e della Costa del Canale francese, pur costituendo una base sgradevole e minacciosa, non avrebbe colpito direttamente l’Inghilterra, ma i suoi alleati; l’Inghilterra avrebbe comunque potuto contrastare con ogni mezzo, leale e non, il commercio estero tedesco, senza il quale nel corso del tempo la Germania si sarebbe impoverita. L’Anti-German-League, fondata in Inghilterra, era una prova di ciò che essa avrebbe voluto e saputo fare per combattere il commercio tedesco. In ogni caso, c’era da aspettarsi da parte degli inglesi una sistematica lotta contro il commercio tedesco, anche in caso di una pace favorevole alla Germania. Il successo di tale lotta sarebbe dipeso comunque in gran parte dalle condizioni di pace. Sarebbe stato di massima importanza «il peso di piombo dei miliardi», menzionato dal Segretario di Stato Helfferich, che l’Inghilterra si sarebbe trascinato nel tempo, in caso di vittoria tedesca. Del resto, importante sarebbe stato fino a che punto ed in che modo alla Germania sarebbe stata garantita, per il commercio e la navigazione, la parità dei diritti con l’Inghilterra. In ogni caso, Solf riteneva che, a prescindere da una possibile, sfavorevole influenza dell’Inghilterra sugli stati neutrali, essa ed i suoi amici avrebbero escluso la Germania dai mercati d’oltremare, usando una sorta di «differenziamento doganale». In Australia, nel Sud Africa Britannico e nelle colonie francesi e portoghesi già prima dell’inizio della guerra il commercio tedesco era molto difficile ed era escluso completamente da molti settori, per via delle dogane differenziate. Sarebbe stato facile per l’Inghilterra aumentare tali dogane e introdurre un differenziamento simile per l’esportazione di prodotti in tutte le proprietà inglesi ed anglofile, il che avrebbe significato un disastroso scoglio per il commercio tedesco d’oltremare. Anche se le dogane differenziate fossero rimaste così come erano, e nei paesi dove c’erano già, ciò avrebbe comunque significato una sostanziale diminuzione dell’esportazione tedesca, vista quella che Solf diceva essere una accresciuta tendenza antitedesca nelle colonie inglesi. Soltanto se in futuro la navigazione e il commercio tedeschi fossero stati messi alla pari in tutte le colonie con il commercio nazionale e con la navigazione nazionale, sarebbe stato possibile per la Germania conquistare 213 Vanni Clodomiro nuovamente e ampliare – anche sui mercati dominanti – la posizione che aveva prima della guerra: il che era ritenuto di massima importanza per il benessere durevole della Nazione. Per il futuro sviluppo della Germania la più importante rivendicazione di pace era (oltre che la protezione militare delle frontiere europee) non solo il massimo favore, ma anche una incondizionata parità dei diritti del commercio e della navigazione tedeschi, in tutto il traffico d’oltremare, con le colonie inglesi. Altro problema era l’espansione dei possedimenti coloniali tedeschi, ad esclusione del Marocco e dell’Egitto che avrebbero dovuto far parte della sfera d’interesse dei alleati della Germania. Solf diceva che la Germania, se avesse dovuto applicare lo stesso principio che auspicavano agricoltura e industria nelle loro rivendicazioni di pace per l’espansione territoriale europea, avrebbe dovuto esigere oltre alla restituzione di tutta la proprietà tedesca avuta sino a quest’ora, nell’Africa dell’Ovest circa dal Marocco fino all’Africa sud-ovest tedesca, nell’Africa dell’Est dal paese dei Somali fino alla Baia di Delagoa tutte le proprietà inglesi, francesi, belghe e portoghesi con le isole Madeira, Sao Thomé, Principe, Zanzibar, Pemba e Madagascar. È ovvio che così accontenteremmo ogni parte tedesca interessata all’Africa. Solf avanzava dunque, per la Germania, due ordini di rivendicazioni: quelle europee e le aspirazioni indicate per l’Africa. Per l’Europa pensava in linea di massima a ciò che già si era occupato o che si sarebbe probabilmente conquistato, mentre per l’Africa la Germania non aveva occupato neanche una delle colonie nemiche; e delle tedesche soltanto una parte. Era quindi chiaro come in tali condizioni la base per le rivendicazioni europee e quelle africane fosse completamente diversa, anche se organi competenti avevano espresso più volte il parere che il destino delle colonie si sarebbe deciso sul teatro di guerra. Tuttavia sarebbe stato necessario per l’attuazione del programma, non soltanto la completa disfatta del Belgio e della Francia, ma anche, e soprattutto, un considerevole colpo alla potenza inglese. Si sarebbe dovuto strappare agli inglesi almeno il Canale di Suez con l’Egitto e in più poter minacciare seriamente l’India. Ma questo era tutto da vedere. In ogni caso, al momento, nessuno sarebbe stato disposto a dare senz’altro una risposta affermativa a quella domanda, salvo che la guerra dovesse continuare ancora per molto tempo. Ma in che modo, ove la Germania non fosse riuscita a strappare il Canale di Suez all’In214 Il programma coloniale della Germania nel 1915 ghilterra e questa fosse rimasta ferma su solide basi? La Società coloniale aveva avanzato come prima rivendicazione «la restituzione del possesso coloniale tedesco occupato dai nemici». Al possesso est-asiatico Solf non voleva si facesse cenno e si domandava piuttosto se fosse proprio indispensabile, anche per l’Africa, la restituzione di tutto il territorio coloniale tedesco occupato dal nemico, e se tale rivendicazione meritasse veramente di essere messa in primo piano. Certamente corrispondeva in genere al sentimento del popolo tedesco, e in tal senso si era pronunciato anche il Segretario di Stato dell’Ufficio Coloniale del Reich. Ma il ministro delle Colonie si chiedeva se la rivendicazione tout court dei possedimenti coloniali fosse il segno di una buona politica sentimentale o una questione di principio, nel senso che una eventuale – sia pure parziale – rinuncia della Germania avrebbe potuto significare una notevole perdita di prestigio internazionale. Ma, realisticamente, sarebbe stato un buon risultato anche la rinuncia ad una minima parte di territorio tedesco, ove ciò fosse stato ricompensato con una soluzione capace di avvantaggiare la Germania dal punto di vista militare ed economico. In tal caso, si sarebbe ottenuto un certo equilibrio tra la questione di prestigio e d’onore da un lato e il sentimento popolare dall’altro. Dunque, le soluzioni potevano essere due: restituzione del possesso coloniale tedesco occupato dal nemico, oppure cessione alla Germania di un territorio coloniale da essa riconosciuto come compenso del tutto soddisfacente. Solo così si sarebbe tenuto conto dell’opinione pubblica, avviando nel contempo una via più ampia per le trattative di pace, ed eventualmente offrendo all’Inghilterra qualche facilitazione in cambio dell’accoglimento delle richieste tedesche. In caso invece di difficoltà dell’Inghilterra a cedere qualcuno dei territori, la Germania avrebbe potuto trarre vantaggio da una tale difficoltà, scegliendo un compenso ritenuto comunque sufficiente. Per Solf, la Germania aveva bisogno di un possesso coloniale il più vasto possibile (e questo conferma la tesi di Colosimo): 1) che ci fornisca il maggior numero possibile di prodotti grezzi e ci renda così più indipendenti dall’estero; 2) che ci offra il mercato più vasto possibile per l’industria del nostro paese; 3) che ci consenta, se possibile, anche l’accrescimento di una sana terra di colonizzazione; 4) che militarmente sia da proteggere senza costi fissi troppo alti e che abbia possibilmente una posizione tale da offrirci solide basi per garantire in misura adeguata una concreta soluzione del problema della libertà dei mari. 215 Vanni Clodomiro A questo punto, il ministro si volgeva a considerare la situazione dell’Africa sud-ovest tedesca. Ricordava che la colonia non era stata conquistata dall’Inghilterra, bensì dall’Unione Sudafricana, cui ormai era aggregata. Egli non dubitava che l’Unione così non aveva svolto una politica puramente inglese, ma che aveva tenuto conto principalmente degli interessi sudafricani e che avrebbe fatto ciò anche in futuro: era difficile intuire le intenzioni di Botha. Questi era stato accusato più volte di corruzione, cosa non rara tra i boeri, e si diceva che l’ex-generale dei boeri fosse ormai più inglese degli inglesi. Il partito degli africani di pelle bianca conduceva una spietata campagna elettorale contro di lui, il risultato della quale non si lasciava ancora prevedere. Gli africani di pelle bianca gli rimproveravano il tradimento della causa dei boeri. E tutto ciò, non senza giusti sospetti: Botha non avrebbe gettato polvere negli occhi degli inglesi e non avrebbe pensato nel suo intimo soltanto ad un Sudafrica più esteso che prima o poi sarebbe divenuto autonomo? In Inghilterra si era acclamato Botha quando annunciava la campagna militare contro l’Africa sud-ovest tedesca. Tuttavia, già allora si affermava energicamente che, nel caso di una conquista di quel territorio, l’Inghilterra avrebbe riservato esclusivamente a sé il diritto di disporne. Dopo l’avvenuta conquista, però, il quadro era essenzialmente mutato. Anche allora si acclamava Botha e, in un primo momento, si era dato alla colonia conquistata il nome di Terra di Botha e si festeggiava la conquista dell’Africa sud-ovest tedesca come il primo successo importante della guerra. Eppure Solf non aveva dubbi che il modo della consegna del Sud-ovest tedesco e il fatto di aver concesso ai difensori tedeschi senza troppo spargimento di sangue condizioni onorevoli avessero contrariato molto l’Inghilterra; tanto più che, dopo la consegna, il governo dell’Unione si dimostrava ovviamente il più compiacente possibile con i tedeschi del Sud-ovest. Inoltre, Botha aveva affermato, e più volte in pubblico, che mai e poi mai si sarebbe potuto pensare ad una cessione del Sud-ovest e che il diritto di disporne era esclusivamente del Sudafrica e non dell’Inghilterra. In tali circostanze, sarebbe stato possibile per l’Inghilterra restituire la colonia alla Germania? In ogni caso, l’Unione Sudafricana avrebbe preteso compensi molto alti, impossibili per l’Inghilterra, che si sarebbero conclusi con la richiesta d’indipendenza, semmai l’Unione avesse accettato una cessione, senza pressione armata. 216 Il programma coloniale della Germania nel 1915 Se l’Inghilterra, in seguito alla guerra, fosse stata capace di un’azione armata, coronata da successo, contro l’Unione, rimaneva da vedere, viste le esperienze nella guerra dei boeri. Vero era che la Germania avrebbe potuto riconquistare l’Africa sud-ovest tedesca, mandando una spedizione; ma, ad una tale spedizione, l’Inghilterra non avrebbe acconsentito facilmente, potendola impedire. Per conseguenza, la Germania poteva pensare ad una riconquista dell’Africa sud-ovest tedesca in termini reali soltanto nel momento in cui l’Inghilterra fosse stata inferiore per mare. Era possibile ottenere ciò nel corso della guerra? In realtà non sarebbe andata a finire così, cioè che già prima si raggiungesse una pace accettabile per via di trattative? Anche con l’eventuale perdita del Canale di Suez da parte dell’Inghilterra, nulla ancora sarebbe cambiato per l’Africa sud-ovest tedesca. Si sarebbe andati verso una nuova guerra, ove se ne fosse pretesa ad ogni costo la restituzione. Sempre secondo Solf, nell’Unione non ci sarebbero stati dubbi che l’Africa sud-ovest tedesca, in mano tedesca, avrebbe avuto in futuro una potenza militare considerevolmente più grande di prima e che avrebbe costituito perciò un pericolo continuo per l’Unione. Infatti, quel territorio, nuovamente in possesso tedesco, avrebbe significato, per l’Unione, una minaccia ancora più grande di quanto potesse esserlo il possesso tedesco della Costa del Canale per l’Inghilterra. Quale sarebbe stato il futuro, in Sudafrica, se l’Africa sud-ovest tedesca fosse stata annessa all’Unione Sudafricana? A piena parità tra la popolazione tedesca e quella inglese e sudafricana, i tedeschi e gli africani di pelle bianca avrebbero avuto, dopo pochi anni, la prevalenza sugli inglesi, e una piena separazione dell’Unione dalla terra natìa avrebbe costituito lo sviluppo naturale delle cose: sarebbe stata solo una questione di tempo. Nell’Africa sud-ovest tedesca, le parti tedesche interessate avrebbero dovuto ottenere un risarcimento particolarmente abbondante per i danni subiti nella guerra, e, anche dopo la conclusione della pace, avrebbero dovuto trovare, tramite un lavoro programmato di rappresentanti idonei del Deutschen Reich, almeno nel primo periodo successivo alla guerra, tanto sostegno, da consentire che l’elemento tedesco non si lasciasse scacciare dal paese. Anzi, avrebbe dovuto avere interesse a rendere innocui gli sforzi antitedeschi – che inizialmente sarebbero stati in gran misura attuati dagli inglesi – e a non continuare solamente le attività esistenti, ma ad estenderle tramite l’annessione all’Unione, la quale avrebbe offerto senza dubbio anche nuove possibilità di sviluppo per il Sud-ovest. Tuttavia, la pre217 Vanni Clodomiro messa di ciò era che i tedeschi potessero usufruire, sotto ogni rispetto ed in tutta l’Unione, della parità dei diritti con gli inglesi, e che fosse impossibile vessarli e metterli al muro con dogane differenziate, o altre disposizioni legislative. Difficilmente si sarebbe dubitato della buona volontà della maggioranza degli africani di pelle bianca di collaborare con i coloni tedeschi, con il secondo fine di un Sudafrica autonomo. All’inizio della guerra, si era creduto spesso che l’Unione non si sarebbe lasciata sfuggire l’opportunità – mentre l’Inghilterra affogava nelle faccende europee – di staccarsi da essa. Ma quelle speranze non tenevano conto del potere del capitale inglese, che occupava nell’Unione un ruolo importantissimo e determinante. Tuttavia, anche sotto questo profilo, le cose avrebbero potuto cambiare con l’annessione dell’Africa sud-ovest tedesca. La crescita considerevole di popolazione tedesca avrebbe portato con sé, per forza di cose, anche una partecipazione considerevolmente maggiore di capitale tedesco, che sarebbe aumentato ben presto attraverso il sufficiente sostegno da parte del governo e delle banche, fornendo così un contrappeso, in continuo aumento nel corso del tempo, al capitale inglese, dal quale così l’Unione si sarebbe liberata ben presto. Nel caso invece in cui la Germania avesse voluto, anche se a malincuore, rinunciare alla restituzione dell’Africa sud-ovest tedesca, avrebbe potuto, da una parte, raggiungere lo scopo di fare vacillare in tempi non lunghi uno dei pilastri portanti del regno coloniale inglese; dall’altra, avrebbe avuto però l’obbligo di insistere proprio nelle trattative di pace in modo ostinato sulla restituzione della colonia, cioè fino a che non le fosse garantita la parità di diritti nell’Unione e una soddisfacente risposta ai desideri speciali degli africani tedeschi del Sud-ovest. Non solo, ma anche fino a che non le fosse offerta una riparazione per l’Africa sud-ovest, il cui valore indiscutibilmente alto l’avrebbe compensata della rinuncia e, fino a un certo punto, della definitiva perdita di prestigio: non sarebbe stato possibile creare una compensazione tramite una riparazione a spese degli alleati degli inglesi. Ciò che si sarebbe tolto a questi ultimi non erano gli affari dell’Inghilterra: essa si sarebbe volentieri adoperata per soddisfare le richieste tedesche cedendo le colonie altrui. Far perdere in tal modo l’Africa sud-ovest tedesca all’Unione Sudafricana Britannica e non far pagare il risarcimento all’Inghilterra di propria tasca avrebbe significato una vittoria dell’Inghilterra sulla Germania, pur essendo grandi le perdite degli alleati degli inglesi. Come risarcimento da fornire dall’Inghilterra per l’Africa sud-ovest era218 Il programma coloniale della Germania nel 1915 no da considerare in primo luogo i seguenti domini inglesi-africani: la Nigeria, la colonia della Costa d’Oro, Sierra Leone, il Gambia, l’Africa Britannica dell’Est, Zanzibar, Pemba ed il paese di Nyassa. Oggettivamente, tra questi, erano infinitamente più preziose le regioni dell’Africa ovest che quelli dell’Africa est. Le cifre di importazione ed esportazione secondo la statistica del 1912 davano il seguente quadro: Domini inglesi nell’Africa dell’Ovest Nigeria Costa d’Oro Sierra Leone Gambia totale esportazioni (in milioni di marchi) 120 86 30 15 251 importazioni (in milioni di marchi) 128 80 28 15 150 Africa dell’Est esportazioni Britannica (in milioni di marchi) East African Protectorate 33 e Uganda Zanzibar e Pemba 20,5 Paese di Nyassa 3,5 totale 57 importazioni (in milioni di marchi) 51,5 20,5 4,5 76,5 Anche se le cifre d’importazione e di esportazione della statistica non potevano pretendere in alcun modo di fornire una misura veramente adeguata al valore di un territorio, davano comunque un quadro approssimativo della ricchezza e della capacità di assorbimento dei vari territori. In tal modo, si potevano però confrontare sempre soltanto colonie tropiche con altre colonie tropiche. Volendo invece paragonare nello stesso modo le colonie tropiche con quelle subtropiche, il risultato sarebbe stato un quadro assai errato. Nel 1912, l’Africa sud-ovest tedesca aveva una importazione di circa 45 milioni soltanto, ed una esportazione di circa 28,5 milioni. Era però impossibile trarre da ciò la conclusione che, per esempio, la Nigeria avesse un valore quasi triplo o quadruplo di quello dell’Africa sudovest tedesca, che era, secondo Solf, un paese per europei: la popolazione 219 Vanni Clodomiro indigena ammontava soltanto a poche centinaia di migliaia di abitanti. La Nigeria, al contrario, era una colonia di «negri» con circa 17 milioni di indigeni. Dopo tutto, l’Africa sud-ovest tedesca, come paese degli europei, offriva per natura possibilità sensibilmente maggiori per il futuro, rispetto alle regioni tropiche dell’Africa Est Britannica, il cui clima sfavorevole avrebbe sempre limitato la permanenza di europei. Se dunque la Germania avesse ottenuto, in cambio della cessione dell’Africa sud-ovest tedesca, anche tutti i domini britannici dell’Africa Ovest (Nigeria, colonia della Costa D’Oro, Sierra Leone e Gambia), si sarebbe ritenuta pienamente soddisfatta dal punto di vista economico. Ma le sarebbe mancato ancora un compenso di territorio da colonizzare. Tale compenso avrebbe potuto trovare nella zona d’interessi dell’Unione Sudafricana, e cioè nella Rhodesia del Nord, che rappresentava un’ottima terra di colonizzazione difficilmente superabile nella qualità dei suoi pascoli. Per la cessione alla Germania sarebbe stata adatta sopra tutto la parte settentrionale, a nord del fiume Zambesi. Quel possesso rurale aveva tuttavia lo svantaggio non indifferente, rispetto all’Africa sud-ovest tedesca, di trovarsi situato all’interno dell’Africa e non sulla costa o nelle vicinanze della costa. Perciò, la perdita non avrebbe avuto un’importanza così grande per l’Unione, mentre per la Germania proprio il territorio della Rhodesia del Nord avrebbe acquistato importanza per il collegamento dei possessi africani dell’ovest con quelli dell’est, e per l’accerchiamento e l’arrotondamento dell’allora Katanga Belga. Quanto alla cessione della Rhodesia del nord, c’era da mettere anche in particolare rilievo che quel paese sano e ricco era stato fino ad allora sottoposto a poca coltura. Visto che l’Inghilterra aveva già investito enormi capitali nella Rhodesia del sud, e in quella del nord in misura molto ridotta, avrebbe potuto consolarsi più facilmente di quella perdita e non avrebbe trovato neanche grossa resistenza da parte dell’Unione. La Rhodesia del Nord confinava con il paese di Nyassa (Africa Centrale Britannica), che era stretto appunto tra la Rhodesia del Nord e l’Africa est tedesca e portoghese, e che aveva accesso alla costa soltanto attraverso il territorio portoghese. Se la zona costiera portoghese fosse passata alla Germania, questa avrebbe avuto anche le chiavi per il paese di Nyassa; e quest’ultimo, come zona interamente circondata da proprietà tedesca nel cuore dell’Africa, avrebbe perduto il suo diritto d’esistenza come colonia inglese e sarebbe anch’esso passato in mano tedesca. Del resto, si sarebbe offerta per la Rhodesia e per il paese di Nyassa una buona possibilità di ri220 Il programma coloniale della Germania nel 1915 sarcimento a spese del Portogallo, e ciò sarebbe stato discusso in seguito con la questione delle colonie portoghesi. La successiva ed ultima questione relativa alle colonie britanniche era il futuro del protettorato dell’Africa Est Britannica e l’Uganda, oltre a Zanzibar e Pemba. Anche se i dati statistici dell’importazione e dell’esportazione di quelle regioni rimanevano molto indietro rispetto a quelli dell’Africa Ovest Britannica, si doveva comunque ipotizzare come punto fermo che l’Inghilterra si sarebbe decisa molto più facilmente alla cessione di possedimenti dell’Africa Est, per motivi puramente militari, anche se ogni possesso tedesco nell’Africa Est era considerato dall’Inghilterra come una minaccia all’India, che costituiva notoriamente il nucleo vitale più importante del regno britannico. L’Inghilterra aveva sempre cercato di dominare la costa dell’Oceano Indiano, e da quel punto di vista già l’Africa Est tedesca era per gli inglesi un pugno nell’occhio, e per la sua eliminazione non avrebbero badato a spese: si sarebbero opposti in ogni caso e con tutte le sue forze alla cessione del possesso est-africano, e naturalmente tutto sarebbe dipeso dalla posizione di forza della Germania al momento della conclusione della pace, se – e fino a che punto – i tedeschi fossero stati in grado di mettere mano sul quel possesso. Era fuori discussione che proprio quel possesso sarebbe stato di particolare importanza per la Germania, anche se forse non così prezioso come l’Africa Ovest britannica. Le isole antistanti alla colonia dell’Africa Est tedesca, pur non offrendo più grandi possibilità di sviluppo, avrebbero sempre avuto il loro valore per l’economia, in particolare perché fornivano copra e garofani. Importante era anche la loro popolazione, ovunque conosciuta come popolo di eccellenti lavoratori, che mancavano nell’Africa Est tedesca e che trovavano, per esempio, già da anni utilizzazione come uomini di fatica per il trasporto di pesi, sulla maggior parte dei piroscafi che servivano la costa est-africana: ciò non soltanto nel porto di Zanzibar, ma lungo tutta la costa. A differenza di Zanzibar e Pemba, l’Uganda e l’East African Protectorate offrivano ancora grandi possibilità di sviluppo e avevano davanti a sé, senz’altro, ancora un grande futuro. Ad ogni modo, l’acquisizione dei domini britannici nell’Africa est era di massima importanza non soltanto per motivi economici, ma anche politici. Tale importanza consisteva nell’arrotondamento del territorio tedesco e nell’evitare aree d’attrito al confine con i possedimenti inglesi12. Quindi, Solf volgeva l’attenzione al possesso africano della Francia. Si 221 Vanni Clodomiro trattava, da una parte, dell’Africa Ovest francese, (comprendente il Senegal, La Guinea Francese, la Costa d’Avorio, Dahome, il Gabon ed il Congo francese); dall’altra, del Madagascar: tutte regioni ricche e desiderabili. Il ministro non aveva dubbi che la Germania avrebbe avuto il potere di togliere alla Francia le colonie africane dell’est e dell’ovest. Sotto la pressione delle baionette tedesche, la Francia, stretta dal bisogno, si sarebbe dichiarata d’accordo con tutto; l’Inghilterra si sarebbe battuta certamente per le cose francesi, ma di sicuro non con la stessa ostinazione, che per i possedimenti inglesi. Bisognava tener presenti per il momento le cifre d’importazione e d’esportazione delle colonie francesi, per avere un’idea approssimativa del loro valore economico. Le statistiche ufficiali francesi del 1912 mostravano per il commercio tra la Francia e le colonie francesi per l’Africa Ovest un’esportazione di 95 milioni di franchi ed un’importazione di 70 milioni, per il Madagascar un’esportazione di 47 milioni di franchi e un’importazione di 41 milioni. Bisognava tener conto che quelle cifre si riferivano esclusivamente al commercio delle colonie con la «madrepatria». Il commercio con altri Paesi non era di grande importanza, per effetto della legislazione doganale francese, sopra tutto non per l’Africa Ovest francese, mentre la percentuale del commercio con Paesi non francesi saliva considerevolmente per il Madagascar. Del resto, bisognava tener presente, guardando le cifre, la cattiva amministrazione francese. Sotto regime tedesco, le regioni francesi avrebbero fornito risultati sicuramente più alti. Sopra tutto il Madagascar era stato completamente trascurato, e il suo sviluppo naturale era stato addirittura bloccato. Nel Madagascar giacevano ancora immense ed eccellenti risorse minerarie, quasi per nulla sfruttate, anche se conosciute. Il Madagascar possedeva una grande ricchezza di bestiame, e il clima era in genere salutare, specialmente sugli ampi altipiani. Terra e popolazione dimostravano ancora in misura molto spiccata l’impronta dell’economia francese, e ci potevano essere delle difficoltà da superare, per far diventare il Madagascar un «paese tedesco». Tali difficoltà erano da valutare certamente di più nel Madagascar che in altri territori, perché colà esisteva un regno completamente chiuso; per cui influenze esterne erano più difficili che altrove, cioè in regioni circondate da colonie straniere. Nonostante ciò, però, una serie di prestigiose ditte tedesche registrava in Madagascar eccellenti successi. Il commercio era fortemente legato agli interessi tedeschi, nonostante tutte le «angherie» francesi. Una vol222 Il programma coloniale della Germania nel 1915 ta attaccato con forza dalla Germania, anche nel Madagascar sarebbe sparito ben presto l’elemento francese, e un Madagascar tedesco avrebbe avuto possibilità di sviluppo veramente eccellenti, con un futuro difficilmente paragonabile a quello di un qualsiasi altro paese dell’Africa. Oltre al valore economico, era di grande importanza anche il valore militare, specialmente per le colonie francesi. Proprio l’aspetto militare meritava colà, più che in qualsiasi altra colonia, di essere posto in primo piano. A parte l’arrotondamento necessario del regno coloniale africano tedesco, che si poteva difendere molto meglio e più facilmente come complesso intero che come insieme di singoli territori sparsi qua e là, bisognava dare rilievo al valore militare veramente eccezionale sopra tutto del Senegal, che allora esso aveva per la Francia e che avrebbe avuto in misura ancora maggiore nel futuro. Il «negro» del Senegal riusciva un ottimo soldato. Questo era già stato sperimentato nella guerra: circa 100.000 senegalesi avrebbero combattuto contro la Germania nelle file dei francesi e certamente non erano avversari da sottovalutare. La razza era forte e guerriera, e la popolazione estremamente numerosa. Già allora correva voce che, dopo la guerra, sarebbe stato compito della Francia introdurre nel Senegal il servizio militare obbligatorio. Non si poteva negare – e in ogni caso meritava molta attenzione – il fatto che la Francia sarebbe riuscita a mettere in piedi alcuni milioni di valenti soldati senegalesi, anche se la realizzazione di tali progetti non era certamente priva di difficoltà pratiche. In ogni caso, in futuro, la Francia avrebbe fatto ricorso al Senegal in misura molto maggiore di quanto non avesse già fatto per i suoi bisogni militari, e avrebbe avuto colà senz’altro una ricca fonte cui attingere materiale umano molto utile alla sua forza militare. Fino a quando la Francia avesse avuto tale possibilità, il pensiero della vendetta contro la Germania avrebbe sempre trovato nuovo nutrimento e minacciato la pace. Sottrarre definitivamente alla Francia quella possibilità sarebbe stato un compito importante, la cui possibile sottovalutazione durante le trattative di pace avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Debilitando assai la Francia militarmente, togliendole le sue colonie dell’Africa Ovest, e specialmente con l’acquisizione del Senegal, la Germania avrebbe creato nello stesso momento un’eccellente truppa coloniale di protezione. La Francia avrebbe potuto mobilitare bene un’armata nel Senegal, ma altrettanto bene ed anche meglio avrebbe potuto fare la Germania: ciò, non con l’idea di utilizzare i guerrieri sui teatri di guerra europei, ma di 223 Vanni Clodomiro proteggere il regno coloniale africano e rendere impossibili, nelle colonie, attacchi o sorprese sgradevoli, come si era verificato durante la guerra. Solf non dubitava che i senegalesi avrebbero prestato servizio militare per la Germania altrettanto volentieri che per la Francia, se non addirittura di più; quella convinzione si fondava sul fatto che si trattava in linea di massima di una popolazione mussulmana. Con una forte armata di indigeni nell’ombra, l’Africa Ovest avrebbe assunto un valore inestimabile, offrendo, eventualmente, delle basi alla flotta tedesca, non soltanto per la sicurezza delle navi, ma anche per la possibilità di estendere considerevolmente l’influenza oltre oceano. Una forte Africa Ovest, che si difendesse da sé, nelle mani tedesche avrebbe avuto effetto anche sul Sudamerica, offrendo una forte base all’estensione degli interessi tedeschi. L’Africa Ovest, come base, sarebbe stata di grandissima importanza militare e marittima nell’Oceano Atlantico, come il Madagascar nell’Oceano Indiano. Il Madagascar era costituito da un territorio chiuso, che si difendeva da sé, e il porto di Diego Suarez all’estremo punto nord est era senz’altro idoneo come base per la flotta. Bisognava comunque prevedere, in caso di un’eventuale acquisizione del Madagascar, una resistenza dell’Inghilterra molto maggiore che nel caso di qualsiasi acquisizione nell’Africa Ovest. Un Madagascar tedesco sarebbe stato sempre inteso da parte degli inglesi come una pesante minaccia per l’India. Valeva lì ciò che valeva per ogni cessione di possesso britannico nell’Africa Est. Fino a quando l’Inghilterra poteva disporre del Canale di Suez, tenendo così in mano la chiave per l’Oceano Indiano, si sarebbe opposta con tutte le forze ai progetti tedeschi che avessero per obiettivo una qualsiasi estensione territoriale vicino all’Oceano Indiano. Un’altra questione era quella delle proprietà belghe e portoghesi in Africa. Certamente sarebbe esistito ancora un Portogallo europeo dopo la fine della guerra, mentre sembrava almeno messa in dubbio l’esistenza di un Belgio europeo. Ma si riteneva con sicurezza che né il Belgio, né il Portogallo sarebbero stati in grado di mantenere le loro colonie con le proprie forze. Se l’esistenza di queste ultime fosse continuata, in realtà sarebbero stati nient’altro che colonie inglesi, e bisognava ostacolare in ogni caso un tale sviluppo. Nessuno voleva che l’Inghilterra raccogliesse i frutti della guerra tutti per sé. Le cifre d’importazione e d’esportazione del Congo Belga indicate per il 1912 ammontavano a circa 47 milioni di marchi per l’esportazione ed a circa 43 milioni di marchi per l’importazione. Ci224 Il programma coloniale della Germania nel 1915 fre che sarebbero cambiate di molto a causa dello sviluppo del Katanga, che soltanto da pochi anni avanzava rapidamente. Nell’ultimo anno prima dell’inizio della guerra, il Katanga aveva portato la sua esportazione di rame, iniziata soltanto da poco, a circa 7000 tonnellate, ed allora si contava di portare quella cifra, già negli anni successivi, ad un quantitativo annuo di 36.000 tonnellate di rame. Secondo Solf, per le colonie portoghesi ci sarebbero state difficilmente statistiche nuove ed affidabili. Per il 1910 si indicavano le seguenti cifre: Colonie portoghesi esportazioni nell’Africa dell’Est (in milioni di marchi) Guinea portoghese 2 Sao Thomé e Principe 13 Angola e Cabinda 14 totale 29 importazioni (in milioni di marchi) 3,5 10,5 23,5 37,5 Per l’Africa Est Portoghese si indicava per il 1910 un’esportazione complessiva di 120 milioni di marchi. Tali cifre dovevano però contenere in buona parte anche il traffico di passaggio da e per regioni non portoghesi, e perciò non davano un quadro corretto. Non si riteneva quindi necessario motivare ancora l’opportunità e la necessità dell’annessione del Congo Belga. Ci sarebbe stata certamente la possibilità di disporre del Congo alla conclusione della pace. In caso contrario, difficilmente si sarebbe immaginata per la Germania una pace onorevole e corrispondente in certo qual modo alle esigenze economiche del Deutschen Reich. Il Congo Belga avrebbe dovuto formare in futuro il centro del regno coloniale tedesco e rappresentare l’anello di congiunzione tra i possessi dell’est e dell’ovest. La ricchezza, le possibilità di sviluppo ed il futuro del Congo si ritenevano sicuramente enormi; eppure non bisognava farsi idea sbagliata del tempo di uno sfruttamento e di uno sviluppo più consistenti. Anche nel Congo – con eccezione del Katanga, alle cui immense risorse minerarie, che permettevano uno sfruttamento immediato in grande stile, erano già poste mani – l’ulteriore apertura e sviluppo sarebbero stati sì, sicuri e continui, ma comunque lenti e graduali rispetto ad altre parti del mondo. C’era bisogno di molto lavoro duro e dell’investimento di grandi capitali, di cui si sarebbero visti i ricchi frutti in tem225 Vanni Clodomiro pi non brevi. Era quella una caratteristica dell’Africa, che faceva perdere a molti l’interesse e la giusta comprensione, nonché il pieno apprezzamento del suo valore. Un sollecito ed assicurato rendimento di capitale già all’inizio era generalmente una rarità in Africa, anche se naturalmente c’erano, oltre al Katanga, altre eccezioni. Ma chi avesse previsto lauti guadagni già dal primo anno avrebbe avuto sicure delusioni. Chi, invece, avesse avuto tempo e pazienza, volendo creare ed eseguire un lavoro efficace, avrebbe trovato quasi ovunque in Africa ampie possibilità di lavoro, ricco e sicuro per il futuro, la cui cura e continuità prometteva infatti altissimi profitti, di grandissima importanza soprattutto per l’industria tedesca, per effetto della fornitura, sicuramente in continuo aumento, delle materie prime più necessarie. La solidità, la tenacia e la perseveranza erano spiccate qualità del carattere tedesco, e perciò si affermava che proprio l’Africa fosse un campo di lavoro congeniale e che nessun’altra nazione fosse in grado di lavorare o di sfruttare l’Africa con lo stesso successo o con risultati simili. Come si vede, nessuna forma d’ipocrisia traspariva dalle affermazioni della classe politica tedesca, che non esitava a parlare a chiare lettere dell’Africa – e della sua popolazione – come di un fertile terreno di puro sfruttamento. La possibilità in genere relativamente lenta di sviluppo dell’Africa era dovuta maggiormente – a parte le sorprese inevitabili causate dalle condizioni climatiche – alla popolazione spesso molto scarsa, che si abituava solo gradualmente ad un lavoro regolare, oltre che, spesso, e specialmente nel Congo Belga, alle enormi difficoltà di trasporto nell’interno. Il Congo Belga copriva un’area quattro volte quella del Deutschen Reich e aveva una popolazione di appena 15 milioni di abitanti. Tali condizioni comportavano naturalmente il fatto che il problema della mano d’opera acquistasse un’importanza determinante, e che l’avvicinamento degli indigeni al lavoro e l’aumento delle loro esigenze andassero di pari passo con l’incremento della capacità produttiva. Era perciò anche fuori dubbio che i paesi più sfruttabili fossero quelli che disponevano della popolazione più numerosa: era il caso sopra tutto dei territori dalla Nigeria fino al Senegal, per cui quelle colonie sarebbero diventate le più desiderabili e ancora più sfruttabili che altri possessi situati più ad est e sud, in genere scarsamente popolati. Per la questione delle colonie portoghesi era dunque importante il fatto che non si fosse in guerra con il Portogallo. Se questo si fosse schierato con 226 Il programma coloniale della Germania nel 1915 gli alleati, restava da vedere (tanto non sarebbe cambiato di molto il giudizio sulla sua posizione): esso aveva infranto altre volte le neutralità a sfavore della Germania e dunque non meritava, per Solf, alcun riguardo sentimentale, alla conclusione della pace. Sembrava comunque che il popolo e l’esercito portoghesi si opponessero con successo agli sforzi del governo – che era al soldo dell’Inghilterra – di coinvolgere il Paese nella guerra europea, ma in Africa gli inglesi avevano trovato spesso il sostegno portoghese, inconciliabile con la neutralità; perciò bisognava considerarsi in ogni caso in stato di guerra con le colonie portoghesi, e non avere nessuno scrupolo sulla loro annessione, in quanto sarebbero state altrimenti lasciate in completa balìa dell’influenza inglese. La Madeira portoghese non era alla pari con le colonie: era considerata dal Portogallo come parte della patria natìa. Madeira sarebbe stata di gran valore per la Germania come base di flotta e stazione di rifornimento di carbone, e in quanto tale sarebbe stata anche un pugno nell’occhio degli inglesi. Tuttavia, la questione della Madeira meritava forse un riguardo speciale: la futura posizione nella guerra mondiale, specialmente del Portogallo europeo, avrebbe determinato la decisione se porre le mani su Madeira. Già prima della guerra, l’Inghilterra aveva acconsentito, a certe condizioni, ad una spartizione delle colonie portoghesi, e su ciò si era stipulata la convenzione anglo-tedesca, molto discussa dall’opinione pubblica, ma mai ratificata. Pertanto, in linea di massima, l’Inghilterra non avrebbe sollevato serie obiezioni sul fatto che il Portogallo perdesse le sue colonie; specialmente se anche l’Inghilterra ne avesse ottenuto una parte. Quella parte doveva essere comunque più piccola di quanto originariamente previsto dalla convenzione anglo-tedesca, e si sarebbe dovuta limitare al territorio sudest, situato tra l’Africa Sud Britannica e Beira. Con ciò la Baia di Delagoa sarebbe dovuta cadere all’Unione Sudafricana, e questo corrispondeva, per così dire, allo sviluppo naturale delle cose. Quella baia aveva un valore preciso soltanto come porto d’entrata per il Transvaal, e non avrebbe mai potuto avere un valore simile come possesso portoghese o tedesco. Per fare concorrenza alla Baia di Delagoa il traffico inglese di transito per e dal Transvaal, in gran parte, si poteva condurre senza grandi difficoltà per la via del Durban Britannico, anche se quest’ultima era considerevolmente più costosa. Il possesso della Baia di Delagoa avrebbe dato all’Unione sudafricana, 227 Vanni Clodomiro oltre che il naturale arrotondamento del suo territorio e la conquista del miglior porto sudafricano, sopra tutto la possibilità di grandissimi risparmi nel traffico con il Transvaal. D’altra parte, quella Baia, come porto naturale del Transvaal, in mano tedesca avrebbe creato una situazione insostenibile per l’Unione, rendendo del tutto impossibile buone relazioni di vicinato con essa. La convenzione anglo-tedesca prevedeva il fiume Zambesi come confine tra le colonie tedesche e quelle inglesi. Bisognava però cercare, in ogni caso, di collocare il confine un poco più verso sud e di far diventare confine il fiume Pungwe, alla cui riva nord c’era la città di Beira, porto d’ingresso per la Rhodesia. Lo Zambesi come confine sarebbe stato per la Germania inadatto e quanto mai sfavorevole. Quel fiume era la strada d’ingresso per la terra del Nyassa, ancora inglese. Lungo il suo corso si era sviluppata un’industria di zucchero non indifferente. Tre ditte inglesi di zucchero fornivano un’esportazione annua che andava dalle 30 alle 40.000 tonnellate, che trovavano la maggior parte del mercato nell’Unione Sudafricana. Il commercio lungo lo Zambesi era in gran parte in mano tedesca, ma l’industria inglese aveva messo mano sul distretto più ricco di mano d’opera e, in sostanza, dominava quel fiume. Fino a pochi anni prima, la non indifferente navigazione fluviale era stata in parte in mano tedesca, in parte in mano inglese, ma era dominata dai trasporti delle ditte inglesi di zucchero, e qualche anno prima si era raggiunto un accordo tra le parti interessate, secondo cui, pur essendo sotto bandiera inglese anche il materiale tedesco di navigazione, si dava in sostanza ai Tedeschi il controllo delle imprese di trasporto. Quella soluzione aveva funzionato in modo vantaggioso per le parti interessate fino all’inizio della guerra. Poco dopo, però, il direttore inglese e principale azionista delle fabbriche di zucchero, ignorando ogni accordo, aveva escluso ogni elemento tedesco, così che tutta la navigazione dello Zambesi si trovò in mano inglese. Ove lo Zambesi fosse stato, dopo la guerra, il confine tra il possesso tedesco e quello inglese, il fiume sarebbe stato comunque inglese, dando origine a continue beghe; anche la terra del Nyassa si sarebbe tenuta una strada inglese di congiunzione con l’Oceano e in ogni caso il suo diritto come colonia inglese. L’elemento tedesco – in tempo di guerra levato di mezzo e distrutto – difficilmente si sarebbe potuto risollevare, per effetto della pressione degli inglesi. Nemmeno una nuova e forte navigazione fluviale in mano tedesca avrebbe potuto costituire un qualche mutamento, perché il movimento di 228 Il programma coloniale della Germania nel 1915 merci si svolgeva per il porto di Chinde, portoghese e accessibile soltanto a veicoli a scafo molto piatto. Bisognava quindi portare tutto il carico con veicoli costieri a scafo piatto da Chinde al porto portoghese di Beira, a circa 150 miglia marittime più a sud, per essere di là caricato sui piroscafi in rotta verso l’Europa. Tutta la merce destinata al territorio dello Zambesi ed al paese di Nyassa doveva fare la stessa strada Beira-Chinde. Prima dell’inizio della guerra si era progettata una linea ferroviaria diretta tra Beira ed il distretto industriale dello Zambesi, rendendo così superflua la maggior parte della navigazione e creando contemporaneamente un collegamento diretto con il paese di Nyassa. La linea ferroviaria Beira-Zambesi si sarebbe dovuta costruire già prima, con un consorzio prevalentemente belga, ed il progetto era prossimo alla sua realizzazione. Se poi lo Zambesi fosse diventato il fiume di confine tra territorio tedesco e territorio inglese, niente sarebbe stato più facile per gli inglesi che ritornare al vecchio progetto belga e costruire una ferrovia da Beira allo Zambesi, capace di offrire definitivamente agli inglesi la chiave per l’intero territorio dello Zambesi e per il paese di Nyassa. Era inoltre importante che il porto di Beira non fosse soltanto di transito per Chinde, ma anche per il distretto di Quelimane, situato più a nord. Tra Beira e il Mozambico non esisteva neanche un porto accessibile per piroscafi più grandi. Soltanto Beira si poteva considerare porto di transito per il distretto di Zambesi e di Quelimane, e, qualora fosse divenuta inglese, l’Inghilterra avrebbe avuto in mano non soltanto la chiave per lo Zambesi, ma anche per tutto il ricco distretto di Quelimane, situato al nord dello Zambesi: un porto di transito inglese in territorio tedesco sarebbe stato per forza di cose una ricca fonte di spiacevoli differenze, per effetto di una dipendenza del tutto indesiderabile dall’Inghilterra. Per Solf, un confine naturale, che tenesse conto anche delle esigenze tedesche, non doveva essere lo Zambesi, bensì il fiume Pungwe, alla cui riva nord era situata la città di Beira, porto naturale d’ingresso per la Rhodesia. E quest’ultima non poteva fare a meno di quel porto. La foce del Pungwe offriva intanto una possibilità eccellente di due bacini portuali completamente separati tra loro, dei quali l’uno, situato alla riva nord, sarebbe potuto diventare tedesco, mentre l’altro, alla riva sud, inglese. Da Beira, la ferrovia conduceva nella Rhodesia: costeggiava all’inizio la riva del Pungwe, che attraversava però dopo poche miglia verso l’interno, all’altezza di Fontesville, per tenersi poi del tutto sul lato sud del Pungwe. Se il Pungwe fosse divenuto in futuro il fiume di confine tra il territorio tedesco e quel229 Vanni Clodomiro lo inglese, sarebbe toccata alla Germania Beira, con la linea ferroviaria, anche se corta, Beira-Fontesville. L’Inghilterra si sarebbe mantenuta sulla riva sud, organizzando fin lì le colonie portoghesi, situate a pochi km. verso l’interno del paese; avrebbe dovuto costruire sulla riva sud del Pungwe una nuova linea ferroviaria fino a Fontesville, che avrebbe poi costituito l’ingresso per la Rhodesia. Era stato, quello, un progetto più volte preso in considerazione già in tempo di pace. Fino all’ultimazione della ferrovia dalla riva sud del Pungwe a Fontesville, conveniva trovare temporaneamente un modus vivendi per l’uso inglese del tratto corrispondente sulla riva nord, che toccasse, insieme a Beira, alla Germania. Il tratto ferroviario Beira-Fontesville avrebbe offerto più tardi alla Germania la possibilità di un prolungamento fino allo Zambesi. Così, il confine sud del territorio tedesco avrebbe percorso la riva del Pungwe fino al confine rhodesiano, di là lungo il confine portoghese-rhodesiano; lo Zambesi superiore, a mala pena navigabile, sarebbe stato, all’interno, il confine sud della Rodhesia del nord, allora inglese, in futuro tedesca, e avrebbe fatto da confine fino al punto dove raggiungeva il confine nord del lembo di Caprivi. In tal modo, si sarebbe creato un confine capace di consentire relazioni estremamente favorevoli di buon vicinato con l’Unione. Si sarebbe ottenuto che anche tutto il territorio dello Zambesi, oltre al paese di Nyassa e al distretto di Quelimane, diventasse tedesco e quindi indipendente, sotto ogni aspetto, dai territori inglesi situati più a sud. Solf trattava la questione del confine sudest-africano così dettagliatamente, per il preciso motivo che sarebbe stato, secondo lui, naturale tornare alla convenzione, pur non ratificata, presa in considerazione prima dello scoppio della guerra; la realizzazione di quel progetto avrebbe però di fatto sottoposto all’influenza inglese territori importanti, pur spettando questi ultimi alla Germania, secondo la lettera della convenzione stessa. Il ministro tedesco riteneva che spettasse alla Germania tutta l’Africa Ovest Portoghese, incluse le isole di Sao Thomé e Principe, ottenendo anche nell’Angola, con i suoi altipiani salubri e fertili, un territorio di grandi possibilità di sviluppo, per molti versi simile all’Africa sud-ovest tedesca. Si sarebbe lasciata all’Inghilterra mano libera per il possesso portoghese-asiatico, prezioso per l’Inghilterra, ma difficilmente in questione per la Germania. Bisognava accennare ancora alla questione delle colonie spagnole nell’Africa ovest, nella Liberia e a quelle situate tra l’Africa Est Britannica e l’Egitto. 230 Il programma coloniale della Germania nel 1915 Se la Spagna attribuiva grande importanza al mantenimento del suo possesso est-africano con la mutata situazione, o se preferiva rinunciarvi in favore della Germania contro un ricco risarcimento nel Marocco, sarebbe stata una questione di trattative e restava comunque da vedere. Per la Liberia, circondata dai possedimenti tedeschi, prima o poi si sarebbe trovata la via per una annessione appropriata. La Somalia italiana non appariva desiderabile per la Germania: aveva ha una popolazione molto difficile, la sottomissione della quale poteva costare grandi sacrifici, difficilmente remunerativi. Rendere accessibile il paese, che non possedeva nemmeno un porto in certo qual modo soddisfacente, avrebbe comportato l’impiego di grossi capitali, peraltro senza qualche concreta utilità. Tuttavia, Solf pensava che sarebbe stato forse opportuno strappare all’Italia la Somalia e l’Eritrea: era un problema legato strettamente alla questione egiziana, e tutta la zona costiera situata a nord dell’Africa Est Britannica sarebbe apparsa sopra tutto adatta come zona d’interesse prevalentemente turco13 . Riassumendo, emergeva da quell’esposizione una richiesta – ovviamente dipendente dalla dimensione della forza militare tedesca – di un grande, congiunto regno coloniale tedesco-africano con i seguenti confini: Confine Nord: dall’Oceano Atlantico circa all’altezza del 20° grado latitudine nord fino al confine egiziano-sudanese, fatto continuare questo confine fino all’Oceano Indiano lungo il confine nord dell’Africa Est britannica (Uganda ed East African Protectorate). Confine Sud: confine odierno del sud ed est dell’Africa sud-ovest tedesca, dal lembo di Caprivi lungo lo Zambesi fino al confine portoghese-rhodesiano, mantenendo tale confine dallo Zambesi verso sud fino al fiume Pungwe, e percorrendo la riva nord del Pungwe, fino all’Oceano Indiano. Confine Ovest: l’Oceano Atlantico e, nell’Oceano Atlantico, le isole Sao Thomé, Principe, e secondo il futuro comportamento del Portogallo anche Madeira, e sulla via di uno scambio probabilmente Fernando Po (l’attuale Bioko, N.d.A.). Confine Est: L’Oceano Indiano e, nell’Oceano Indiano, le isole Madagascar, Zanzibar e Pemba. Se alla conclusione della pace non fosse bastata la posizione di forza della Germania per pretendere il gigantesco regno ipotizzato, si sarebbe dovuto rinunciare, secondo le esigenze emerse, ai seguenti territori, e cioè eventualmente nell’ordine seguente: 231 Vanni Clodomiro 1) Zanzibar, Pemba e l’Africa Est Britannica 2) Madagascar 3) L’Africa sud-ovest tedesca Questo sarebbe stato il programma minimo per le colonie africane. Dopo, si era pensato di rinunciare all’Africa Est tedesca, per rendere l’Inghilterra più disponibile nell’Africa ovest. Solf sperava che il potere tedesco bastasse anche di fronte all’Inghilterra per proteggere la Germania dalla rinuncia alla colonia meglio difesa, cioè l’Africa Est tedesca, in favore di possessi nell’Africa ovest. Non si voleva certamente negare che una rinuncia tedesca a qualsiasi possesso confinante con l’Oceano Indiano avrebbe indotto l’Inghilterra ad una larga disponibilità nell’Africa Ovest. Ma, nonostante ciò, questo sarebbe stato difficilmente possibile senza un notevole indebolimento del predominio tedesco nell’Africa. C’era differenza tra la rinuncia all’Africa sud-ovest e quella all’Africa Est. L’Africa sud-ovest tedesca sarebbe spettata all’Unione, che prima o poi, specialmente con l’annessione di quel territorio, avrebbe raggiunto l’indipendenza, ed inoltre era forse impossibile per l’Inghilterra la restituzione di quella parte dell’Africa. L’Africa Est tedesca, al contrario, era sempre possesso tedesco, e probabilmente tale sarebbe rimasta in futuro. Ove invece fosse stata persa, sia nella guerra, sia alla conclusione della pace, sarebbe andata all’Inghilterra e – al contrario dell’Africa sud-ovest tedesca in possesso dell’Unione – sarebbe diventata territorio inglese, rafforzando considerevolmente la posizione dell’Inghilterra nell’Oceano Indiano a spese della Germania. Al momento dell’assegnazione dei territori coloniali, compito molto importante era la creazione di zone d’interesse il più possibile geograficamente compatte, evitando anche eventuali aree di attrito. Era naturale che la soluzione più favorevole all’Inghilterra nell’Oceano Indiano sarebbe stata la rinuncia tedesca ad ogni possesso, e non si negava che una divisione così netta avrebbe potuto dare garanzia di stabilità, ma sarebbe comunque stata una soluzione sfavorevole alla Germania. La soluzione in favore della Germania ed a spese dell’Inghilterra – secondo la quale l’Africa Est Britannica, Zanzibar, Pemba e Madagascar, ed il territorio portoghese, Beira inclusa, sarebbero stati assegnati alla Germania – avrebbe comportato una divisione altrettanto netta, dato che la costa est dell’Oceano Indiano sarebbe divenuta essenzialmente possesso tedesco. In Africa sarebbero state così eliminate, per quanto possibile, le aree d’attrito; il territorio tedesco avrebbe toccato a sud il confine dell’Unio232 Il programma coloniale della Germania nel 1915 ne Sudafricana (e perciò territorio non puramente inglese), e a nord gli interessi turchi. Se si fosse invece rinunciato all’Africa Est Britannica, Zanzibar, Pemba, e Madagascar, tenendo l’Africa Est tedesca ed il confinante territorio portoghese, Beira inclusa, sarebbe stato quello un compromesso probabilmente inevitabile, che, pur non tenendo conto di tutti i desideri tedeschi, in ogni caso non avrebbe preteso dei sacrifici da parte della Germania in favore di un rafforzamento del predominio inglese nell’Oceano Indiano. A quel punto, Solf si domandava se la Germania non si stesse impegnando troppo nella realizzazione completa del programma coloniale descritto, e se una tale espansione del regno coloniale non significasse una politica di conquista difficilmente giustificabile. A tali domande bisognava dare in ogni caso, sempre secondo Solf, una risposta decisamente negativa. Giudicando quelle domande, bisognava anzitutto tener presente l’odio che, anche dopo la guerra, sarebbe durato ancora per molto tempo in misura non minore specialmente tra inglesi e tedeschi. C’era da immaginarsi che in molti ambienti l’odio tedesco verso gli inglesi sarebbe aumentato ancora dopo la guerra, una volta venute alla luce tutte le infamie e tutte le offese recate ai tedeschi in terra inglese. Anche da parte inglese, una volta conquistato il posto al sole, non sarebbe diminuito l’odio verso i tedeschi. Tuttavia, Solf riteneva che, dopo una pace sfavorevole all’Inghilterra, essa avrebbe ritrovato ben presto, apparentemente, le maniere gentili verso il suo concorrente. Non avrebbe però perso altrettanto facilmente l’odio di fondo, e, laddove fosse stato possibile, avrebbe danneggiato e perseguitato i tedeschi, anche se spesso «in segreto». L’Inghilterra non si sarebbe lasciata sfuggire ogni occasione per rendere amara la vita ai tedeschi in terra britannica, ed anche nelle zone inglesi d’oltremare avrebbe tentato di irritare e spingere fuori l’elemento tedesco. Tanto più quindi, secondo Solf, sarebbe stato importante possedere grandi sfere d’interessi oltremare, dove i tedeschi avrebbero potuto trovare un ricco campo di lavoro e dove, vedendosi scacciati dai paesi britannici, avrebbero forse trovato un’ottima ricompensa, con la possibilità di svolgere sotto la protezione del loro Paese un lavoro benefico ed importantissimo per la sua vita economica. Un grande regno coloniale tedesco-africano secondo il programma indicato dal ministro avrebbe offerto all’industria tedesca enormi possibilità di mercato ed una compensazione per la perdita nel commercio con gli in233 Vanni Clodomiro glesi, e sarebbe stato di grande importanza sopra tutto anche per il rifornimento di materie prime. Anzitutto, avrebbe offerto solide basi per l’Oceano Atlantico e quello Indiano, e garantito in zone molto vaste la libertà dei mari. Proprio in quel tempo era stata avanzata spesso l’idea che la linea Helgoland-Basra, come sfera d’interessi tedesca, fosse lo scopo più importante per lo sviluppo economico, e non si dubitava che, nella realizzazione di tali progetti, ci fossero effettivamente immense possibilità. Ma si riteneva pericoloso trascurare con ciò i progetti africani e mettere in dubbio la necessità di una energica politica in Africa. Non si voleva in alcun modo sminuire l’importanza e le prospettive di una sfera d’interessi Helgoland-Basra, ma non doveva rimanere senza accenno che nel programma Helgoland-Basra ci sarebbe stato continuamente bisogno di buoni rapporti con gli alleati della Germania, e che d’un colpo la posta sarebbe diventata troppo alta, se nel corso del tempo, per causa di giochi politici, fosse venuto a mancare un qualsiasi anello nella catena Helgoland-Basra, rendendosi in tal modo vulnerabile all’adescamento inglese o di qualsiasi altra potenza. Anche se ciò non era assolutamente prevedibile, c’era la lucida consapevolezza che la costellazione delle potenze nel mondo fosse facilmente sottoposta ad oscillazioni, ed anche in futuro tali rischi sarebbero rimasti una concreta possibilità. Non bisognava dunque ignorare che il solo perseguimento dello scopo Helgoland-Basra non avrebbe comportato neanche un passo avanti verso la libertà dei mari, e perciò trovava il supplemento necessario tramite un programma africano in grande stile. La speranza, dunque, era in una forte politica tedesca nell’Africa, entro le linee generali indicate. Concludendo, ci sembra di poter dire che tali e consimili considerazioni del ministro tedesco fossero dettate, come abbiamo avuto modo di accennare più sopra, da una pressante esigenza propagandistica all’interno della Germania, piuttosto che da reali e concrete sensazioni, fondate sull’esperienza politica. Solf, evidentemente, aveva tutto l’interesse di far apparire come sentimento di odio quella particolare altezzosità, che era una inveterata attitudine delle popolazioni britanniche, dovuta, in parte, al carattere tipico degli isolani, e in parte all’austera consapevolezza di appartenere ad uno Stato forte e da secoli aduso al dominio e al comando. 234 Il programma coloniale della Germania nel 1915 Note al testo 1 Wilhelm Solf, nato a Berlino il 5 ottobre 1862, intraprese la carriera giudiziaria, ma già nel 1894 entrò nell’ufficio coloniale del Ministero degli Esteri. Dal 1899 al 1911 fu governatore di Samoa. Dal 1911 al 1918 fu Segretario di Stato per le Colonie. Durante la guerra mondiale, fondò la Deutsche Gesellschaft (1914). Nell’agosto 1918 si dichiarò favorevole ad una pace d’accordi, sicché, quando il 3 ottobre Max de Baden costituì il primo e ultimo gabinetto parlamentare dell’impero, col compito di intavolare trattative di pace con le potenze dell’Intesa, volle il Solf al ministero degli Esteri. Il gabinetto iniziò le trattative con Wilson e aggiunse, all’accettazione dei 14 punti, la richiesta di un armistizio immediato. Rimase al suo posto, come ministro tecnico, anche durante la rivoluzione del novembre, ma fu costretto ad abbandonarlo nel gennaio successivo. Era stato candidato democratico alle elezioni per l’Assemblea nazionale. Dal 1920 al 1928 fu incaricato d’affari e poi ambasciatore a Tokio. Ritiratosi nel 1928, divenne presidente dell’Aysland-Institut di Stoccarda. Morì a Berlino nel 1936. Tra i suoi scritti, ricordiamo: Rede zur Gründung d. deutschen Gesellschaft 1914, Berlino 1915; Die Lehren d. Weltkrieges für unsere Kolonialpolitik, Stoccarda 1916; Die Missionen in d. deutschen Schutzgebieten, Berlino 1918; Germany’s right to recover her colonies, ivi 1919; Kolonialpolitik. Mein polit. Vermächtnis, ivi 1919; Africa für Europa. Der koloniale Gedancke d. 20 Jahrh., Neumünster 1920; Japanische Farbenholzschnitte aus der Sammulung W. H. Solf (Catalogo), Gottinga 1930. 2 Koblenz, BundesArchiv, Nachlaß Solf, Aktenband 48. Il fondo, praticamente tutto inedito, consiste di 156 buste, con documenti che riguardano, nel complesso, gli anni 1901-1934. Solo 14 buste (ma sono più che sufficienti) rivestono un notevole interesse, relativamente alla politica coloniale tedesca. La busta nr. 156 contiene le Carte della signora Hanna Dotti, moglie di Solf, la quale si lasciò coinvolgere dagli avvenimenti politici nel periodo nazista. Hanna Solf, ormai vedova del ministro, da tempo teneva a Berlino un salotto antinazista. Ad uno dei suoi noti “tè”, il 10 settembre del 1943, partecipò un certo dottor Reckse, che purtroppo era un agente della Gestapo, alla quale trasmise lettere incriminanti sulla signora Solf, che, in seguito, fu internata nel campo di concentramento di Ravensbruck, insieme con la figlia, contessa di Ballestrem. Le due donne sfuggirono alla morte per miracolo (per ulteriori elementi, cfr.: W.L. Shirer, Storia del terzo Reich, Torino 1962, pp.1553-1555). Le Carte Solf meritano di essere portate alla luce – come speriamo gradatamente di fare – anche allo scopo di individuare eventuali analogie e differenze tra l’impostazione tedesca della politica coloniale e quella italiana, nella stessa epoca. 3 Archivio di Stato di Catanzaro, Carte Colosimo, b. 8, f. IV, anno 1918 (lettera di Colosimo ad Orlando del 3 giugno 1918). 4 Per ulteriori elementi, cfr. V. Clodomiro, Il ministro delle Colonie Colosimo e la conferenza di Versailles, in «Storia contemporanea», dicembre 1985, pp. 1010-1011; poi in Libia ed Etiopia nella politica coloniale italiana (1918-1919), Catanzaro, 1986, pp. 26-29. 5 Si rammenti che due giorni dopo sarebbe divenuto ministro degli Esteri. 6 Il dr. Heinrich Schnee, ultimo governatore dell’Africa Orientale Tedesca, aveva scritto un libro, apparso nel 1924 in lingua tedesca col titolo Die koloniale Schuldlüge (La menzogna della colpa coloniale [tedesca]), e dopo, proprio nel 1926 – data della prima lettera a lui diretta da Solf – in lingua inglese, col titolo German Colonization Past and future. Per inciso, diciamo che un’eloquente dedica deve far riflettere sulla posizione (che andrebbe approfondita in altra sede) di alcuni intellettuali tedeschi del tempo: A Benito Mussolini, duce e fondatore dell’Impero, l’autore con ammirazione e deferenza dedica questo libro. 235 Vanni Clodomiro 7 Koblenz, BundesArchiv, Nachlaß Solf, Aktenband 131. 8 Ibidem. 9 Si riferisce ai brani, in cui Hitler afferma: «Confesso apertamente che già nel periodo prebellico avrei ritenuto più giusto se la Germania, in alleanza con l’Inghilterra, si fosse messa contro la Russia rinunciando alla insensata politica coloniale e rinunciando alla flotta commerciale e militare, e se fosse passata così da una debole politica comune ad una decisa politica europea d’acquisizione di suolo continentale. E più avanti: «Perché non dobbiamo vedere la soluzione di questo problema nell’acquisto coloniale, ma esclusivamente nella conquista di un territorio di colonizzazione, che aumenti la superficie della patria stessa e che non solo mantenga così i nuovi coloni in stretta unione con la patria natìa, ma che assicuri all’intero territorio quei vantaggi che stanno nella sua unita vastità». 10 L’espressione vuol dire semplicemente che il memoriale non era destinato alla pubblicazione. Dopo aver preso visione del memoriale, Solf stese la relazione da sottoporre al Cancelliere. 11 Anche questa strana affermazione degli ambienti dell’agricoltura e dell’industria sulla responsabilità inglese nello scoppio della guerra appare chiaramente propagandistica. Infatti, bisogna ricordare che il contrasto anglo-tedesco era alimentato dal progresso dell’industria germanica che, nel campo della metallurgia, della meccanica e della chimica, minacciava o superava il primato inglese fino allora indiscusso. Il volume complessivo delle esportazioni industriali britanniche, fortissimo nel settore dei tessili, teneva ancora la testa, ma le distanze si accorciavano rapidamente, e nel primo decennio del secolo, mentre le esportazioni tedesche crescevano del 93,2 per cento, quelle inglesi aumentavano solo del 62,3 per cento. L’Inghilterra, d’altra parte, era fortemente interessata a conservare in Europa una situazione di equilibrio che le permettesse di continuare quella politica della «mano libera» grazie alla quale essa poteva far fronte ai suoi impegni di potenza mondiale; e la preponderanza germanica sul continente violava tale equilibrio. Infine, il programma tedesco della «grande flotta», promosso dall’ammiraglio Tirpitz, aveva costretto l’Inghilterra ad affrontare spese quasi insostenibili per conservare l’egemonia marittima. 12 Più avanti, la relazione di Solf esaminerà questo particolare aspetto del problema coloniale in modo più dettagliato. 13 Con decreto del 22 agosto 1915, l’Italia, mentre garantiva in Libia la più ampia libertà religiosa, abrogava tutte quelle norme che riconoscevano colà la rappresentanza del Sultano come Califfo (cfr., in proposito, R. Ciasca, Storia coloniale dell’Italia contemporanea, Milano 1938, pp. 360 ss.). La Libia antiitaliana, aiutata dalla Turchia e dalla Germania, approfittò dell’occupazione italiana del retroterra per reagire violentemente (reazione arabo-turco-senussita). Nel momento in cui Solf elaborava il suo programma coloniale, esisteva già un progetto turcotedesco per la conquista del delta nilotico e per il canale di Suez, cioè per un territorio abbastanza distante dalla Somalia: essendo la linea tedesca, in sostanza, anche antiitaliana, Solf non avrebbe certo esitato, in una contingenza bellica particolarmente fortunata della Germania, a danneggiare l’Italia, pure in una zona di non grande interesse per i tedeschi. 236 internet e storia I sentieri della Rete1 di Andrea Paracchini L’interesse del web per lo storico Nell’immediato futuro, i sentieri della ricerca dovranno avventurarsi nelle acque agitate del world wide web, lo sterminato ipertesto nato e cresciuto sullo scheletro di internet. Non sarà una necessità costante ed ineludibile per ogni tipo di ricerca, ma, specie per chi si occupa di storia contemporanea, ignorare il potenziale informativo della rete potrebbe costituire un serio handicap conoscitivo o, quanto meno, un’occasione mancata. Basta prendere l’ultimo dei tanti annunciati sviluppi della rete per rendersene conto: alla fine del settembre 2005 Viviane Reding, commissaria europea per l’Information Society e i Media, ha presentato un progetto (ispirato ad analoghe iniziative di alcuni grandi motori di ricerca statunitensi) per la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo con il dichiarato obbiettivo di rendere accessibile tramite internet ai cittadini del continente migliaia di testi, filmati e immagini di ogni epoca. Questa è solo l’ultima tappa di un percorso, non privo di ambiguità e passi falsi, che negli ultimi dieci anni ha visto crescere ed evolvere il ruolo della rete nella vita delle persone. Cogliere ed analizzare le tendenze di questo processo – mantenendosi a distanza di sicurezza tanto dalle posizioni degli «apocalittici» quanto da quelle degli «integrati» – è un proposito importante per qualunque cittadino che aspiri a vivere consapevolmente nel suo tempo, ma diventa quasi una necessità per chi ha come oggetto di studio l’uomo, la società e la loro storia. L’importanza non solo pratica ma anche teorica della rete come strumento di attuazione della libertà di espressione appare evidente se leggiamo le potenzialità del mezzo usando come chiave interpretativa l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948). Esso recita: 237 Andrea Paracchini Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere, diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Rileggendo oggi questo articolo si direbbe quasi che gli estensori della carta abbiano dettato le linee guida per la realizzazione di un progetto, il world wide web, che avrebbe visto la luce quasi cinquant’anni dopo. Se confrontiamo infatti le tre funzioni principali del web individuate da Roger Fidler2 con la triplice accezione del diritto di espressione contenuta nell’art.19 non si può non riconoscere un profondo accordo: il web è allo stesso tempo un medium di diffusione (broadcasting uno-molti) e uno strumento di comunicazione interpersonale ma è anche un «documento», un ambiente senza frontiere apparenti all’interno del quale cercare informazioni. È probabilmente quest’ultimo aspetto quello che desta il maggiore interesse da parte di uno storico: la possibilità di accedere ad una sterminata biblioteca, ad un archivio definitivo, rapidamente, a basso costo e senza doversi spostare dalla propria scrivania non è priva di appeal. Su questo aspetto, e sulle problematiche spesso ignorate che lo circondano, torneremo più avanti. Prima è utile mettere in luce la rilevanza storica anche degli altri due aspetti. Come sosteneva Edward Carr nella prima delle Sei lezioni sulla storia3 «i fatti storici non ci giungono mai in forma pura […] essi ci giungono sempre riflessi nella mente di chi li registra». Ecco che allora possono diventare prezioso oggetto di analisi per lo studioso di storia contemporanea la cronaca, la narrazione, il confronto fra interpretazioni che si dipanano anche in rete (in alcuni casi sotto forma di dialogo) come parte sempre più fondamentale del processo di costruzione di senso che circonda ogni evento. Un campo di applicazione privilegiato per questo tipo di prospettiva è senza dubbio oggi il fenomeno del «terrorismo internazionale», ormai costantemente al primo posto nell’agenda politica di molti paesi del mondo. La portata mediatica della ferita simbolica inferta con l’attentato dell’11 settembre 2001 ha segnato un punto di svolta nello studio del rapporto fra terrorismo e media, internet incluso. Puntando le loro telecamere sulle torri in fiamme e riproducendo all’infinito le immagini del loro crollo, le televisioni e i giornali di ogni parte della terra si sono resi strumento, oltre che testimone, della «messa in scena», dal vivo e in diretta, di un attentato ideato e confezionato ad uso e consumo dei media. Per questo moti238 I sentieri della Rete vo l’11 settembre è da molti ritenuto la prova di una rinnovata e moderna capacità di sfruttare i mezzi di comunicazione da parte di quella galassia di organizzazioni terroristiche che sempre più spesso oggi si affacciano sullo scenario internazionale. La componente mediatica del terrorismo, intesa come uso e sfruttamento dei media come strumento per diffondere e amplificare gli effetti dei singoli atti terroristici, si è dimostrata in molti casi determinante per l’efficacia delle azioni messe in atto. Casi emblematici, ancor più dello stesso attentato alle Torri Gemelle, sono da considerarsi i numerosi sequestri a danno di civili occidentali avvenuti in Iraq dopo la presa di Baghdad. La stagione dei sequestri (che non è ancora chiaro se possa dirsi conclusa) è stata contrassegnata dall’inedito utilizzo del web come mezzo di diffusione di messaggi ed ultimatum scritti o filmati, mostrando, nello stesso momento, sia le potenzialità del web, sia l’intrinseca ambivalenza di internet. Dall’interazione fra media «vecchi e «nuovi» è emersa inoltre la necessità di una maggiore consapevolezza sia da parte degli operatori dell’informazione che da parte dei cittadini del precario equilibrio cui devono faticosamente tendere i mezzi di comunicazione di fronte alla tematica del terrorismo. Il successo delle azioni terroristiche si misura infatti sulla capacità di generare panico e paura nei destinatari del messaggio. Il caso del sequestro delle due cooperanti italiane Simona Pari e Simona Torretta mostra in modo emblematico il senso di quanto affermato. In quindici giorni, nel settembre 2004, venne data notizia di otto messaggi o ultimatum via internet riguardanti la sorte delle due donne. In tutti i casi si trattava di messaggi lasciati su chat room, forum o webblog, in sostanza «bacheche» aperte cui può accedere chiunque, anche in forma anonima o sotto mentite spoglie, per «postare» un messaggio. Il fatto che la stragrande maggioranza dei media italiani abbia per lungo tempo ignorato o non sufficientemente approfondito le implicazioni screditanti sulla credibilità ed attendibilità rappresentate da queste caratteristiche ha trasformato i media stessi in megafono di un processo di «manutenzione della paura». Consapevolmente o meno, gli autori dei messaggi si sono giovati dei meccanismi della «macchina dell’informazione» occidentale – pressata dall’urgenza e spesso schiava dei processi imitativi innescati della concorrenza – riuscendo a lanciare le più grandi offensive sul fronte della psycological warfare. In assenza della logica «senza filtro» applicata dai media italiani, i messaggi in arabo collocati in siti pressoché sconosciuti e difficilmente raggiungibili dal grande pubblico 239 Andrea Paracchini avrebbero avuto lo stesso effetto e la stessa visibilità offerta da un tg di prima serata o dal titolo «strillato» di un quotidiano nazionale? Entrando ancora più a fondo nel terreno minato che vede i media internazionali in bilico fra l’autocensura e il rischio di diventare potenti portavoce del messaggio terroristico, un tentativo di interpretazione della «pulizia asettica» delle immagini di BBC durante gli attentati a Londra del luglio 2005 perderebbe di profondità se non tenesse conto del tormentato dibattito pubblico avvenuto nei media inglesi durante e dopo i sequestri di Margaret Hassan e Kenneth Bigley nell’autunno 2004. Di fronte ad immagini crude e violente i responsabili dell’informazione delle varie testate si chiesero come tutelare il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini ad essere informati senza però divenire strumento nelle mani dei terroristi. Le soluzioni proposte furono diverse, ognuno optò per quella che riteneva più efficace. È evidente che in epoca di globalizzazione e comunicazioni transfrontaliere l’opzione «oscuramento totale» è destinata a fallire: le immagini di Florence Aubenas in catene furono bandite da tutti i media francesi ma erano disponibili in anteprima per tutti gli utenti della rete sul sito di SkyNews 24. Il dibattito deontologico raggiunse livelli ancor più sofisticati fra i responsabili di testate on line, ma non è il caso di approfondire qui. Una prima conclusione che piuttosto potrebbe essere delineata è che, come si è cercato di mostrare, lo scenario è cambiato, nuove voci si sono aggiunte (anche se purtroppo non sempre «nuovo» è sinonimo di «diverso») ed è necessario tenere conto anche del loro racconto (sebbene questo sia ancora ascoltato meno rispetto a quello di altri «oratori» più affermati). Le risorse utili non mancano e, manco a dirlo, i contributi più stimolanti sono molto spesso proprio quelli che si possono trovare in rete, dove l’agilità del formato consente un approccio alle questioni più diretto e concreto (anche se a volte impulsivo e non sufficientemente meditato). Basta cercare. I problemi legati all’accesso dei contenuti sul Web Cercare, appunto. È difficile poter pensare di avventurarsi nel terreno in costante crescita e ancora ampiamente inesplorato del web senza l’adeguato bagaglio di strumenti e competenze per orientarsi. Un approccio del tipo «prove-ed-errori» è comunque uno dei modi più efficaci per familiarizzare con morfologia, toponomastica e segnaletica del web. Quello che qui si vorrebbe affrontare sono invece alcune delle problematiche legate 240 I sentieri della Rete all’accesso al contenuto sul Web nella sua accezione «documentale» facendo anche attenzione alle modalità d’uso della rete da parte degli utilizzatori. La trattazione non può che concentrarsi sull’analisi dei motori di ricerca: le indagini statistiche mostrano infatti come i motori di ricerca costituiscano oggi il principale punto di partenza per la ricerca di informazioni in rete e quindi per l’accesso ai contenuti del web. Se la stragrande maggioranza degli utenti del web è assolutamente familiare con la semplice interfaccia di Google o con il ricco portale di Yahoo!, in pochi però si soffermano a riflettere sui principali condizionamenti – diretti e indiretti, voluti o involontari, interni o esterni – cui gli indici a cui questi motori attingono sono sottoposti e che influenzano, in molti casi in maniera determinante, il servizio fornito e, di conseguenza, la rappresentazione del web che offrono agli utenti. Già questo dovrebbe suggerire che oltre ai condizionamenti strutturali è lo stesso approccio degli utenti col motore di ricerca a comportare il primo condizionamento di importanza non trascurabile nell’accesso ai contenuti. Conviene però procedere con ordine, inquadrando anzitutto la realtà dei motori di ricerca. In rete esistono infatti migliaia di motori di ricerca ma il dato più rilevante è che il 96 per cento delle risposte alle interrogazioni di utenti è fornito da solo tre di loro: Google, Msn Search (Microsoft), Yahoo!. Il volume di pagine indicizzate varia a seconda del motore: Google ne dichiarava oltre 8 miliardi a metà del 2005, ma recentemente, dopo che Yahoo! aveva dichiarato di aver raggiunto i 16 miliardi di pagine, ha scelto provocatoriamente di rimuovere dalla sua home page il totale delle pagine indicizzate e di sfidare i suoi utenti ad indovinarne il numero esatto. Oltre alle pagine web recentemente stanno aumentando anche le tipologie di oggetti indicizzati: prima le immagini, poi le news, ora i video (Yahoo!), il contenuto dei testi e, in futuro, intere biblioteche (Google). La maggior parte degli utenti considera il funzionamento dei motori assolutamente oggettivo e trasparente ed accetta con fiducia la gerarchia di risultati che il motore restituisce in risposta alle loro ricerche. Tuttavia sono molti i condizionamenti cui sono sottoposti i motori di ricerca nell’elaborazione dei risultati. Pochi di questi sono noti, e molto spesso vengono ignorati dagli utenti, altri sono del tutto sconosciuti. 241 Andrea Paracchini Condizionamenti legati all’elaborazione dei risultati I principali motori di ricerca offrono due forme di catalogazione dei contenuti. Una prima forma di indicizzazione prevede la catalogazione (eseguita da un operatore) delle home page in Directory e Sub-directory per argomento ed è quindi consultabile come una sorta di indice per argomenti4. L’indicizzazione più sfruttata dagli utenti è però quella «spider» che consiste nella ricerca delle parole chiave immessa dall’utente all’interno del contenuto di tutte le pagine web indicizzate per mezzo di sofisticati e segreti algoritmi5. Questi algoritmi rilevano essenzialmente la frequenza e la «centralità» della parola chiave immessa nelle pagine da loro indicizzate e forniscono un elenco gerarchico di risultati. Google, imitato in vario modo anche da altri concorrenti, ha associato a questo criterio una variabile ulteriore6 che attribuisce valore ai link reciproci fra le pagine attribuendo alle pagine maggiormente interconnesse maggiore rilevanza. Non è qui il caso di approfondire il preciso funzionamento degli algoritmi impiegati dai motori di ricerca, basterà tenere conto che questo è il primo e più determinante intervento che il motore di ricerca compie sulla rappresentazione del web7. Condizionamenti per incompletezza di indicizzazione Per quanto sofisticati, gli strumenti a disposizione dei gestori dei motori di ricerca non consentono l’indicizzazione completa di tutte le pagine presenti sul web. Uno studio del 20008 stimava che un singolo motore di ricerca non è in grado di indicizzare più del 16 per cento del web. Anche sommando tutti i motori di ricerca non si supererebbe comunque il 42 per cento. Questo accade non tanto per volontà di censura, quanto piuttosto per la vastità, mutevolezza e articolazione del web che comporta grandi difficoltà tecniche di localizzazione delle nuove pagine (che diventano visibili sono quando sono connesse ad una pagina che il motore già conosce) ed elevati costi legati alle procedure di indicizzazione. A questo si aggiunge l’immane lavoro di filtraggio di tutto lo spam e il materiale spazzatura presente nel web che a volte può escludere anche contenuti legittimi9. Inoltre esistono una grandissima quantità di pagine web che vengono generate dinamicamente ossia sulla base di richieste e opzioni fornite direttamente dall’utente a maschere di interrogazione di database o generato242 I sentieri della Rete ri di pagine. Raramente i motori di ricerca sono in grado di interagire con questo tipo di interfacce. L’inclusione di documenti in formato differente dall’HTML poi ha solo da poco visto un’accelerazione. Condizionamenti economici Il paragrafo più consistente per quanto riguarda i condizionamenti cui sono soggetti i motori di ricerca è sicuramente quello riguardante gli aspetti economici. La gestione di un motore è un’attività molto costosa: richiede un’infrastruttura complessa, che va manutenuta con assiduità per poter garantire il servizio con continuità e che occupa diverse professionalità specializzate (nonostante gran parte del lavoro visibile all’utente sia svolto dai sofisticati e tutelati algoritmi matematici). Tutto questo per offrire un servizio che è sempre gratuito. Anche in presenza di utili finanziari (la quotazione in borsa di Google è stata una mossa audace ma efficace) o di un solido gruppo alle spalle (Msn è emanazione di Microsoft) tutti i motori di ricerca perseguono dei ricavati. I due modelli di business più diffusi sono il paid placement e il paid inclusion ed entrambi prevedono che il sito che viene indicizzato versi al motore un prezzo in cambio della visibilità, con alcune differenze che non è qui il caso di approfondire. Nel 2002 la Federal Trade Commission statunitense, pur non ravvisando alcuna irregolarità in queste procedure, ha tuttavia chiesto che la loro applicazione fosse resa più trasparente ed evidente agli utenti10, fornendo anche alcune indicazioni pratiche11. I vari motori di ricerca hanno recepito l’invito ma hanno compiuto solo pochi adeguamenti formali al punto che la FTC ha emanato un Consumer Alert12 per sensibilizzare gli utenti. Intanto i links commerciali proliferano ai primi posti nelle pagine dei risultati dei principali motori di ricerca. La società comScore Networks13 ha riportato che il 40-45 per cento dei risultati di ricerche includono link sponsorizzati dal momento che, anche se non in tutti i casi la stringa ricercata viene immessa con l’intento di ottenere un risultato commerciale, facilmente la gran parte dei termini usati può costituire un appiglio per un link commerciale. La soluzione più semplicistica – proporre un abbonamento ai servizi di motori di ricerca ripuliti dai link sponsorizzati – se da un lato non offre reali garanzie contro i condizionamenti economici, dall’altro incontrerebbe con ogni probabilità la forte ostilità degli utenti che da tempo hanno dimostrato di ritenere la filosofia del «tutto gratis» una delle colon243 Andrea Paracchini ne portanti del web. Al punto da fare della richiesta di pagamento un fattore pesante di condizionamento: l’esistenza di siti a pagamento a fianco di altri gratuiti è di per sé un incentivo implicito a preferire questi ultimi (anche considerando che le transazioni on line, specie per quel che riguarda i contenuti informativi, persistono con l’essere poco flessibili, non semplicissime, ansiogene e soprattutto poco popolari) e in alcuni casi persino un disincentivo ad intraprendere la ricerca14. Condizionamenti legati alla privacy Si tratta di condizionamenti legati all’effetto che determinati interventi politici di regolamentazione possono avere sull’accessibilità dei contenuti on line. Come singolo esempio della vastità di possibili azioni volte alla limitazione, non necessariamente illegittima, del diritto di accesso alle informazioni sul web in funzione della tutela della privacy è sufficiente fare riferimento ad un recente intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. Per tutelare dalla «gogna» elettronica cittadini incappati in sanzioni, è stato disposto che trascorso un congruo periodo di tempo, per effetto del diritto all’oblio, le pagine riportanti condanne o sanzioni imputate siano relegate in sezioni del sito accessibili solo tramite motore interno ma non visibili ai generici motori di ricerca15. Condizionamenti per politiche repressive Come ogni altro mezzo di informazione e di espressione del libero pensiero, anche il web è sottoposto in più parti del mondo a dure pressioni da parte del potere politico. La natura anarchica e libertaria che ha indotto a parlare del web come di un’«agorà elettronica» risulta particolarmente minacciosa per ogni regime che si senta minacciato dalla libera circolazione delle informazioni e del dissenso. D’altra parte, questa stessa natura costituisce una valida forma di resistenza a molte delle misure repressive. Non mancano però i tentativi riusciti da parte del potere politico di controllare il web, proprio a partire dai suoi punti di accesso privilegiati: i motori di ricerca. Il regime cinese, ad esempio, dispone probabilmente del sistema di controllo della rete più sofisticato del mondo (costruito in gran parte con le migliori tecnologie occidentali, fornite da ditte quali Cisco Systems) che gli consente di controllare i risultati delle ricerche in Google senza che 244 I sentieri della Rete questi possa opporsi. La completa chiusura di Google era stata tentata nel 2002 ma si era rivelata problematica dal momento che, come già detto, i motori sono oramai considerati intrinseci al funzionamento della rete. Attualmente quindi la Cina riesce a bloccare parzialmente i risultati delle ricerche su materie controverse bloccando la connessione dell’utente o non restituendo alcun risultato. Una forma più subdola di intervento agisce sui Domain Name Server (DNS) e consente, sfruttando comunque l’autorevolezza del motore di ricerca, di re-direzionare gli utenti verso siti specchio «depurati» dal governo. I severi censori cinesi però non sempre devono ricorrere ad espedienti tecnologici: in alcuni casi sono gli stessi gestori dei motori di ricerca ad offrire la loro collaborazione. È il caso questo di Yahoo! che si è conformata alle richieste del governo cinese e del servizio Google News, che in Cina è offerto in versione limitata, con l’accurata soppressione di alcune fonti di informazione invise al regime16. Condizionamenti per pressioni esterne La documentazione a questo proposito è decisamente scarsa perché basata essenzialmente su pochi episodi venuti alla luce sulla stampa. Inoltre le società di gestione dei motori di ricerca prevedibilmente hanno opposto resistenza alla pubblicizzazione delle liste di siti filtrati. Il Berkman Center for Internet & Society presso la Harvard Law School ha così avviato un programma d i monitoraggio e ricerca per portare alla luce l’oscuramento da parte dei motori di ricerca di alcune pagine web. Oltre ad alcuni casi in cui la violazione del diritto d’autore sancito dal Digital Millenium Copyright Act ha permesso a terze parti di richiedere il filtraggio di determinati siti, il centro ha documentato ed elencato fino ad oggi 113 siti che sono stati banditi da Google.fr (Francia), Google.de (Germania) e Google. ch (Svizzera)17. Condizionamenti culturali Un aspetto decisamente più complesso e sottile, e che meriterebbe un’analisi specifica sulla base di apposite rilevazioni empiriche, è quello della questione culturale. Tutti i quattro maggiori motori di ricerca sono gestiti e posseduti da compagnie statunitensi e, quando sono nati, erano disponibili solo con un’interfaccia in inglese, anche se i contenuti cataloga245 Andrea Paracchini ti erano multilingua e transnazionali. Oggi questi motori, in primis Google, offrono un’interfaccia tradotta in decine di idiomi, ma questo, se da un lato ha tolto un ostacolo concreto all’accesso per molti utenti, dall’altro ha introdotto un condizionamento molto sottile alla presentazione dei risultati. Considerando l’esempio di Google, tramite il riconoscimento della lingua impostata come preferita nel browser, l’utente viene reindirizzato automaticamente verso l’interfaccia di Google in quella lingua. Qui può scegliere di effettuare la ricerca su tutti i siti web indicizzati dal motore oppure solo su quelli nella lingua dell’interfaccia o, recentemente, sui siti ospitati su server che si trovano nel paese di quella lingua. In questo modo Google produce una segmentazione dei risultati che è carica di implicazioni, intanto perché il numero dei risultati varia, in certi casi significativamente, a seconda della diffusione nel mondo e soprattutto sul web della lingua in questione, poi perché contribuisce a riprodurre anche sul web quei confini e quelle frontiere nazionali che si supponeva internet dovesse mettere in discussione18. D’altro canto bisogna pur tenere conto dell’assoluta predominanza nel web di siti nazionali. Predominanza che ha dato adito a timori di una «egemonia culturale» americana sul web. Allarmato dal faraonico progetto di digitalizzare l’intero patrimonio librario di diverse biblioteche americane annunciato da Google a fine 2004, il presidente francese Jacques Chirac ha concordato con il ministro della Cultura Renaud Donnedieu de Vabres e il direttore della Bibliothèque Nationale de France Jean-Noël Jeanneney uno studio di fattibilità su un analogo progetto di digitalizzazione, accessibile però da un motore interamente francese19. Come ricordavamo in apertura, la Commissione Europea ha già rilanciato l’iniziativa a livello più ampio. La scelta del motore di ricerca Si è già accennato alla grande rilevanza che i motori di ricerca hanno per spiegare il rapporto fra utenti ed internet. L’attenzione è una risorsa scarsa, specialmente in internet, e i Content Provider possono raggiungere grandi pubblici solo se i motori, svolgendo la loro funzione di gatekeeping, incanalano gli utenti verso di loro20. Una ricerca piuttosto datata considerando i tempi di evoluzione del web mostrava come i motori di ricerca contribuissero ad attuare anche per quanto riguarda la distribuzione dell’attenzione in rete la cosiddetta regola degli 80/20 elaborata dall’eco246 I sentieri della Rete nomista Vilfredo Pareto: nel web l’80 per cento delle visite sarebbe diretta al 5 per cento dei siti web21. Dati aggiornati hanno consentito al Pew Internet & American Life Project di calcolare che in media un utente visita quasi 2 (1,9) pagine a ricerca22. Questa stima è però poco significativa perché nulla autorizza a dire, in assenza di dettagli sul tipo di ricerca effettuata, se effettivamente la risposta più corretta non sia in ogni caso contenuta nei primi due risultati. Lo stesso PIP ha però approfondito l’argomento23: il 92 per cento degli utilizzatori di motori di ricerca ha fiducia nelle proprie capacità di «cercatore», oltre la metà di questi è addirittura molto fiduciosa. Il dato si riflette anche sul senso di soddisfazione associato all’uso di un motore dal momento che l’87 per cento dei cercatori dice di portare quasi sempre a termine con successo le sue ricerche. Si crea anzi una spirale positiva fra sicurezza nella ricerca, propensione a fare ricerche e soddisfazione derivante che può anche avere effetti perversi: utenti fiduciosi delle proprie capacità e convinti che cercare sul web sia un’attività facile e felice negli esiti si impegnano in ricerche sempre più brevi e superficiali trascurando anche le più elementari procedure di ricerca. L’aspetto più problematico è che il 68 per cento degli considera i motori di ricerca una fonte di informazioni onesta e non manipolata. In particolare chi più si fida è anche chi meno di frequente cerca. Per giunta il 62 per cento di chi si rivolge ad un motore non sa distinguere tra link sponsorizzati e non sponsorizzati (i pochi che ci riescono sono i meno fiduciosi nei confronti dei motori, anche se molti degli utenti in generale nemmeno considerano un problema la presenza di link sponsorizzati). Volendo approfondire le basi di quello che potrebbe essere chiamato il «contratto di lettura» fra l’utente e i motori di ricerca non contrasta con l’esperienza comune il dato che quasi la metà degli utenti ricorre ad un solo motore di ricerca, sempre lo stesso (meno di un utente su dieci si rivolge a più di due motori di ricerca). L’attaccamento è così radicato che la società di marketing per motori di ricerca iProspect ha potuto osservare che il 92 per cento degli utenti, di fronte a risultati insoddisfacenti, è più propenso a ritentare variando la query piuttosto che andare a provare su un altro motore24. La causa di questo attaccamento può risultare più chiara se viene messo in correlazione al coinvolgimento dell’utente nella ricerca. Appare così che chi usa più motori di ricerca lo fa perché accorda la preferenza all’uno o all’altro motore in funzione dello scopo della ricerca e delle peculiarità che attribuisce ad ogni motore. Al contrario, chi si affida ad un unico motore è di solito chi cerca me247 Andrea Paracchini no di frequente e per trovare informazioni che reputa poco rilevanti. Può quindi essere plausibile imputare l’attaccamento non tanto alla fiducia o alla lealtà (come potrebbe essere per un quotidiano o un telegiornale) quanto più all’abitudine e alla pigrizia. Il ruolo giocato dall’abitudine, o quanto meno dalla familiarità, induce a guardare con più attenzione verso la fascia di utenti di età compresa fra i 15 e i 25 anni, ossia quella generazione che è cresciuta insieme ad internet. Un piccolo studio25 condotto presso il College femminile di Wellesley, Massachussets, ha indagato la disposizione degli studenti verso internet come fonte di informazione mettendo in evidenza tra l’altro il ruolo fondamentale assolto dai motori di ricerca come porta di accesso al web. La ricerca è consistita nel sottoporre una serie di compiti di documentazione a 180 iscritte al corso di computer science nell’anno 2000-01 senza precisare a quali fonti dovessero fare riferimento. L’aspetto più significativo che l’analisi dei report prodotti dalle studentesse ha fatto emergere è la grande fiducia nelle proprie abilità di ricerca ma anche la sostanziale acriticità nei confronti dei motori e dei contenuti che presentano. La facilità con cui è possibile ottenere molti risultati paradossalmente sembra infatti indurre non solo a prendere per buono il primo risultato trovato ma anche a trascurare le più basilari regole di fact-checking come la «triangolazione delle fonti». Non solo, la ricerca constata che un atteggiamento più critico nei confronti del web è associato alla competenza riguardo ad internet piuttosto che alla consuetudine a intraprendere ricerche, evidenziando però anche come poche studentesse mostrassero un’adeguata conoscenza dei meccanismi di ricerca e presentazione dei risultati impiegati dai motori di ricerca. L’ignoranza di aspetti quali i link sponsorizzati e l’«invisibile-web», unita alla spiccata propensione a privilegiare un solo motore di ricerca, contribuisce a spiegare la difficoltà mostrata dalle studentesse nel documentare alcuni degli argomenti proposti, specie quelli più controversi. Questo studio non è certamente esente da limiti, primo fra tutti la ristrettezza e la non rappresentatività del campione. Tuttavia un simile approccio consente di indagare con precisione le dinamiche interne ad una specifica attività di ricerca e ha il pregio di mettere in luce le insidie in cui, anche inconsapevolmente, può cadere chi ha come oggetto la storia, magari nelle sue pagine più controverse. 248 I sentieri della Rete Conclusioni Com’è evidente con questo articolo si è cercato soltanto di illustrare il più ampio numero possibile di aspetti e problematiche legate all’uso dei motori di ricerca da parte degli utenti di internet. In conclusione quindi riportiamo soltanto due brevi considerazioni. La prima, ispirata da ricerche come quella del Wellesley College, è un umile richiamo all’importanza dello sviluppo di programmi di formazione per accrescere la competenza nella ricerca e nella consultazione di materiale sul web. Le guide messe a disposizione dagli stessi motori di ricerca26 infatti soddisfano solo in parte questa necessità e si mostrano spesso omertose sugli aspetti più controversi. Come pure non sembrano una risposta adeguata e operativamente proficua le liste di siti certificati come attendibili da scuole o istituzioni di formazione. La seconda considerazione vuole soltanto ridimensionare un’impressione di strapotere sul web dei motori di ricerca che può essere sorta dalla lettura di queste pagine. Non bisogna dimenticare infatti che molti utenti, a seconda delle circostanze, preferiscono infatti cercare informazioni in internet percorrendo una fra le diverse possibili strade alternative rappresentate, ad esempio, dai portali specializzati conosciuti, dai bookmarks personali, dagli URL noti o segnalati da fonti terze, dai link incontrati occasionalmente navigando. Non si intende dire che queste strade siano a priori migliori dell’altra: per quanto riguarda i portali, molte delle considerazioni fatte a proposito dei motori di ricerca possono utilmente essere applicate anche a questo tipo di siti mentre il ricorso ad un elenco di siti «preferiti» o segnalati, se da un lato è interessante perché rimette in gioco le capacità di valutazione umana, dall’altro rischia di portare alla fossilizzazione o all’istituzionalizzazione di certe fonti pregiudicando in ultimo il cosiddetto effetto serendipity. Questo vorrebbe dire sacrificare quello che è forse il più grande valore aggiunto del web e che soltanto la «navigazione a vista», di link in link, consente di apprezzare a pieno. In fondo, anche sui sentieri della rete occorre saper correre qualche rischio. 249 Andrea Paracchini Note al testo 1 Il presente articolo è frutto della rielaborazione della lezione «Ho letto su internet» tenuta dall’autore nell’aprile 2005 in tre istituti superiori della città di Novara con il patrocinio dell’Istituto storico della Resistenza Piero Fornara. 2 R. Fidler, Mediamorfosi, Guerrini, Milano 2002. 3 E. Carr, Sei lezioni sulla storia, Einaudi, Torino 1961. 4 Questo tipo di selezione del contenuto è per molti versi simile a quello che si opera davanti ad un edicola, in libreria o fra i canali della tv satellitare. Ci si trova infatti di fronte ad un bouquet ripartito e organizzato, comprendente un certo numero di contenuti tra cui scegliere. 5 La distinzione operata qui è sommaria: quasi tutti i motori di ricerca forniscono pagine di spiegazione del loro funzionamento e la rete abbonda di guide simili. 6 La tecnologia PageRank™. 7 Un accurato confronto fra Google e Yahoo! è stato realizzato all’interno del Teaching Library Internet Workshop dell’Università della California, Berkeley. http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html 8 L. Introna - H. Nissembaum, Defining the Web: The politics of search engines, IEEE Computer, v. 33(1), pp.54–62. 9 G. Price – C. Sherman, The invisible-web: uncovering information sources search engine can’t see, Independent Publisher Group, Chicago 2001, http://www.invisible-web.net/. 10 H. Hippsley, Federal Trade Commission, 27 giugno 2002. http://www.ftc.gov/os/closings/staff/commercialalertletter.htm 11 Ivi. 12 Federal Trade Commission, Being Frank about Search Engine Rank, settembre 2002. http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/alerts/searchalrt.pdf 13 comScore qSearch Q2 2004, citato in D. Fallows, Search Engine Users: internet searchers are confident, satisfied and trusting – but they are also unaware and naïve, Pew Internet & American Life Project, 2005. 14 http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Search_Engine_Data.pdf D. Fallows, Search Engine Users cit. 15 Internet: motori di ricerca e diritto all’oblio, Newsletter n. 249, 21 marzo 2005. http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1113806 16 China, Google News and source inclusion, Google Blog, 27 settembre 2004. http://www.google.com/googleblog/2004/09/china-google-news-and-source-inclusion.html 17 J. Zittrain - B. Edelman, Documentation of Internet Filtering Worldwide, Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School, 2005. http://cyber.law.harvard.edu/filtering/google/ 18 A. Halavais, National borders on the world wide web, New Media & Society, 2000, v. 2(1), pp. 7-28. 19 Nonostante già oggi il 74 per cento degli utenti internet francesi ricorra a Google per le sue ricerche, il direttore della BNF ha dichiarato «Non credo che l’unico modo per accedere alla nostra cultura debba essere la classificazione automatica per popolarità che sta dietro al succes- 250 I sentieri della Rete so di Google», Google à la française, «The Economist», 31 marzo 2005. 20 P. Di Maggio, E. Hargittai, W.R. Neuman, J.P Robinson, Social implication of the internet, «Annual Review of Sociology», 2001, v. 27, pp. 307-336. 21 J. Waxman, The old 80/20 rule take on the jaw. Internet trends report 1999 Review, Alexa Res, San Francisco 2000. 22 È doveroso precisare però che questa apparente superficialità in alcuni casi può essere giustificata dal fatto che molti utenti fanno uso dei motore di ricerca come una sorta di pagine gialle del web. 23 Informazioni sulla ricerca anche nel Data Memo: The popularity and importance of search engines, Pew Internet & American Life Project, agosto 2004. http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Data_Memo_Searchengines.pdf. 24 Search Engine Marketing Firm iProspect Survey Confirms Search Engine Loyalty Exists, «iProspect Press Release», 14 aprile 2004. http://www.iprospect.com/media/press2004_04_14.htm 25 L. Graham, P.T. Metaxas, «Of course it’s true; I saw it on the internet» Critical Thinking in the Internet Era, «Communications of the ACM», 2003, v. 46(5). http://www.wellesley.edu/CS/pmetaxas/CriticalThinking.pdf 26 Il motore francese seekport.fr mette in evidenza nell’home page l’opuscolo «Cerchez – trouvez!» realizzato per illustrare agli utenti potenzialità e funzionamento di un motore di ricerca. È un esempio interessante, soprattutto perché viene da un piccolo motore poco frequentato, http://www.seekport.fr/brochure/brochure.pdf 251 rassegna bibliografica Criminali di guerra in libertà di Francesco Omodeo Zorini Chi avesse ancora delle perplessità, ma sincere, sulla validità della tesi della continuità dello Stato tra fascismo e post-fascismo, cara, mi sovviene, al nostro maestro Guido Quazza, (che poi è la tesi affacciata da Lutz Klinkhammer, responsabile dell’area disciplinare di «storia del XIX e XX secolo» presso l’Istituto Storico Germanico di Roma e autore di Stragi naziste in Italia 1943/44, tra Reich e Germania federale), è servito. Un «accordo segreto» tra Italia e Germania consentì la scarcerazione dei criminali di guerra tedeschi. Una storiaccia. Fanno breccia sentimenti e pensieri difficili a vestire di parole. Una politica malata fa ammalare la lingua e viceversa. Il patto scellerato – ennesima conferma di un’evidenza da cavare gli occhi della mancata defascistizzazione dell’Italia dopo il 25 aprile – cui allude nel titolo il recente volume di Focardi Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-55, edito da Carocci con la prefazione di Lutz Klinkhammer, non è in effetti una novità storiografica. Lo rese noto lo studioso stesso nel 2003 in un convincente saggio su «Italia Contemporanea», in cui, tra le altre cose, denunciava la questione del fondo H-8, sui crimini di guerra, presso l’archivio dell’Ufficio storico dello stato maggiore dell’esercito, in permanente riordino da circa quattro anni, sottraendo di fatto le carte agli studiosi dopo l’uscita del volume di Costantino Di Sante, Italiani senza onore. In sostanza nel novembre 1950 Heinric Höfler, Kamerad und Freund compagno di partito e amico personale del cancelliere Adenauer, s´accordò in veste di suo emissario con il conte Vittorio Zoppi, segretario generale del ministero degli Esteri, per il proscioglimento dei criminali di guerra tedeschi condannati con sentenza definitiva. Nel volgere di alcuni mesi, con provvedimenti di grazia firmati dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi e controfirmati dal ministro della Difesa Randolfo Pacciardi (ex volontario antifascista nella guerra di Spagna), costoro furono rimpatriati 253 Francesco Omodeo Zorini in Germania in gran segreto. Tra loro, gli ufficiali del cosiddetto Gruppo di Rodi. In testa il Generalmajor Otto Wagener, il capitano Helmut Meeske, i maggiori Johann Koch e Herbert Nicklas, responsabili dell’uccisione sull’isola greca di migliaia di prigionieri di guerra italiani. Ieri come oggi nazisti e fascisti in libera uscita. Il dossier straordinariamente accurato si concentra con meticolosa acribia sulla clamorosa vicenda. La certifica. Ne ricostruisce passo a passo le modalità di attuazione in cui giocò un ruolo primario la complicità del Vaticano. E ciò soprattutto per mezzo dell’azione – avallata in alto loco pur nello sconcerto del Segretario di Stato Montini – del vescovo austriaco rettore del Collegio teutonico di Santa Maria dell’Anima in Roma, Alois Hudal. Ordinato da Pacelli all’epoca della nunziatura apostolica nel Reich, era stato fin da allora fautore fanatico di un «nazionalsocialismo cristiano» incarnato da Hitler «Sigfrido della grandezza tedesca», e poi quinta colonna dell’organizzazione Odessa per l’esfiltrazione dei criminali nazisti in America Latina, tanto da essere implicato, parrebbe, addirittura nella fuga di Eichman (indefessa fu anche l’opera prodigata in favore dei nazisti da parte del sacerdote cattolico J. W. Jurowsky). L’A. si avvale di documentazione di prima mano, proveniente dall’Archivio del Tribunale militare territoriale di Roma, da quello storico-diplomatico del ministero degli esteri, dall’Archivio centrale dello Stato, da quello federale tedesco di Coblenza e da quello politico del ministero degli esteri di Berlino. Per di più in appendice allega una silloge della repertazione probatoria riproducendo 26 scottanti documenti: appunti, lettere, sentenze, decreti, rapporti, tutti del periodo 1946-54, tra i quali compare in chiaro persino la firma di Konrad Adenauer. Nelle carceri italiane erano così rimasti soltanto Kappler e Reder, a far da specchietto per le allodole, nell’inveterata ambiguità italiana, alla negata giustizia contro i criminali, a molti dei quali era stato dato come escamotage il tempo e fornita l’occasione di scappare, per così dire a risarcimento dell’emanazione dei mandati di cattura. Una mano lava l’altra. Non si dice così nel cinismo amorale del potere di casa nostra? Sul tema degli eccidi occultati e dell’impunità ai responsabili era già uscito nel 2002 per Mondadori l’ampio minuzioso saggio di Mimmo Franzinelli, Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001 (che esplora a fondo tra l’altro il percorso di vessazioni torture patimenti a catena, umiliazioni, prove 254 Criminali di guerra in libertà disumane, atroci supplizi, connesso ai lager italiani di Fossoli e Bolzano, qui l’ucraino Michael Seifert elimina di propria mano 12 dei cinquanta prigionieri uccisi, poi scappa in Canada). Ma forse è stato cinque anni fa Franco Giustolisi, giornalista emerito dell’Espresso, ad attirare l’attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche di una buona fetta di opinione pubblica sulla spinosa questione, col libro L’armadio della vergogna (edito a Roma da Nutrimenti). Testimonianza e rappresentazione del capitolo più infame dell’Italia postfascista e, insieme, il più ignorato, l’«amnistia per omissione e occultamento» nei confronti dei criminali di guerra tedeschi e dei criminali collaborazionisti italiani. Un tarlato mobile tinta testa-di-moro, al fondo di un corridoio defilato della Procura generale militare, andito seminascosto del cinquecentesco Palazzo Cesi, via Acquasparta, Roma – protetto da un cancello munito di lucchetto, le ante serrate a chiave, voltate verso il muro – ha imboscato per mezzo secolo, come un pozzo oscuro, un registro di protocollo di 2.274 notizie di reato e 709 faldoni di istruttorie, dei quali 415 con nomi e cognomi, e tanto di grado e reparto di appartenenza dei responsabili, che avevano massacrato migliaia di civili, ebrei e partigiani alle Fosse Ardeatine, a Piazzale Loreto, Porta San Paolo, Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto, Duomo di San Miniato, Farneta, Barletta, Benedicta, Turchino, Matera, Pietransieri, Falzano di Cortona, Conca della Campania, Niccioleta, La Storta, Sarnano, Scarpanto, Leonessa, Valdobbiadene, Capistrello, Gubbio, Godenzo, Fivizzano, Sant’Angelo di Godigo, Biagioni, la strage della famiglia Einstein, Borgo Ticino… e di militari italiani a Cefalonia, Corfù (già storicamente «chiave d’Italia»), Coo, Korica, Lero, Santi Quaranta, Spalato, Rodi… presumibilmente attorno alle cinquantamila persone complessivamente. Giustamente l’Anpi nazionale chiede se ne faccia con precisione la macabra conta. Se ci sarà bisogno ci si potrà rivolgere all’Equipo de Antropologia Forense argentina, la più professionale forse al mondo, dopo l’improbo esercizio sui trentamila desaparecidos, provocato dal delirio «occidentale cristiano» dei militari tra il 1976 e 1983. Tant’è che l’hanno chiamato in Spagna per aiutare a riconoscere i resti dei morti nelle fosse comuni della vendetta franchista alla fine della guerra civile. Nelle brume del silenzio apparente, cimiteri riempiti dall’odio e dalla violenza. Il Procuratore Intelisano nel forziere di cartari ingialliti slabbrati, macchie violette di salnitro, polvere, pesciolini d’argento noti col nome lepisma saccarina, vi incespica quasi casualmente nel 1994, nel corso del procedi255 Francesco Omodeo Zorini mento di estradizione dall’Argentina di Erich Priebke, il boia delle Ardeatine. Molti nemmeno tradotti dal tedesco o dall’inglese; tali e quali erano arrivati dal comando dei servizi segreti britannici. Tre anni ci vogliono di instancabili, pressanti e reiterate sollecitazioni per arrivare alla desecretazione dei documenti. Per farla breve, in quella santabarbara del dimenticatoio, anzi dell’assassinio, era sepolta la catasta di incartamenti residui dei pochi processi celebrati all’epoca del governi Parri e del primo governo De Gasperi contro criminali nazifascisti, tenuto altresì conto dell’«amnistiaamnesia» Togliatti del 1946 che aveva inopinatamente svuotato le galere della peggior feccia repubblichina, e al proposito si vada a vedere l’esemplare lavoro di Franzinelli, edito per Mondadori nel 2006. C’è un passo in Antigone di Maria Zambrano che si impone alla nostra meditazione mentre affrontiamo una materia talmente grave nel senso latino di gravitas: «Il tempo può esaurirsi e il sangue non scorrere più, se però sangue c’è stato ed è scorso, la storia continua a trattenere il tempo, ad aggrovigliarlo, a condannarlo». Le cose che ci buttiamo alle spalle spesso ci inseguono come fantasmi senza pace. Né possiamo arrenderci sogghignando insieme al Mefistofele di Faust: «ed è come se non fosse successo nulla». Se l´Italia è stata in grado di comminare tre ergastoli in tutto (Kappler, Reder e Niedermayer), di cui uno in contumacia, due sole condanne a più di 15 anni di reclusione (Wagener e Mair), ben dodici assoluzioni su un totale di ventisei inquisiti, la piccola Danimarca – dove l´occupazione tedesca è stata sicuramente meno cruenta – condusse in porto tra il 1948 e il 1950 settantasette processi, con settantuno condanne. Le cifre prodotte da Focardi sono impressionanti. In Belgio i processi espletati furono trentuno contro una novantina di criminali, e pene molto pesanti tra cui ventuno condanne a morte. Nella gentile Olanda i criminali di guerra processati furono nientemeno che duecentotrentuno, con diciotto condanne a morte. Non diversamente in Francia dove i processi furono centinaia e circa cinquanta i giustiziati. Né provvidero i tedeschi a riscattare le vittime italiane. Tutti i fascicoli aperti in Germania alla metà degli anni Sessanta si conclusero con l’immancabile «non luogo a procedere». Ad eccezione di Caiazzo, nessuna strage di civili italiani ha mai avuto un processo. Niente colpevoli per l’inflessibile giustizia germanica. Un timbro del 14 gennaio 1960 di «archiviazione provvisoria», istituto sconosciuto in qualsiasi sistema giuridico democratico del pianeta, fatto apporre dal P. G. Santacroce aveva sancito l’ignobile occultamento. Sem256 Criminali di guerra in libertà plicistico tuttavia far rimprovero e accollare l’esclusiva responsabilità ai tre Procuratori in stellette, Borsari (di nomina governativa fino al sottentrare negli anni ottanta dell’organo di autogoverno della magistratura militare, e magistrato che tra le altre cose in un primo momento aveva agito con lealtà e correttezza), Mirabella e Santacroce, avvicendatisi nel periodo in esame. L’ordine fu politico e non amministrativo. Di sicuro non un’operetta d’antan. Ragion di stato della granitica nazione liberatasi dalla dittatura e magnificamente incamminata sulla strada maestra della democrazia! Da queste considerazioni, fatte proprie dalla storiografia contemporanea più aggiornata (Baldissara, Battini, Brunelli, Di Sante, Frei, Gentile, Goni, Klee, Klinkhammer, Oliva, Palla, Pellegrini, Pezzino, Ricci, Rivello, Schreiber, Sanfilippo, Staron, Tognarini), prende l’avvio e tiene il punto fino in fondo il lavoro di Focardi, documentando come le ragioni della negata giustizia contro i criminali tedeschi risiedano in precise intenzionali deliberazioni di ordine politico piuttosto che in presunte carenze della magistratura in divisa. La mossa dell’affossamento fu – con quella certezza mai assodata e sempre nebulosa che avvolge i più mostruosi misfatti dell’intero arco della parabola repubblicana – dei ministri Gaetano Martino e Paolo Emilio Taviani (il partigiano cattolico presidente dell’Associazione volontari della libertà) del primo governo Segni, il futuro presidente della Repubblica «dimissionato» dopo la scoperta del Piano eversivo «Solo», il disegno di colpo di stato del generale dei carabinieri De Lorenzo, denunciato nel 1964 dai giornalisti Scalfari e Jannuzzi. Ma diuturna incombe sulla scena della «notte della verità della Repubblica», così come per tutte le vicende di fiancheggiamento alle alte sfere decisionali tra mafia e politica, di strategia della tensione e stragismo terroristico fino al delitto Moro e oltre, e ancora delle milizie segrete parallele di Gladio etc., l’ombra s-bieca del lotofago Andreotti, smemorato detentore di laticlavio a vita, nel caso di specie guarda caso sottosegretario alla Presidenza del Consiglio all’epoca dell’accordo bilaterale italo-tedesco, di cui trattasi, e ministro della Difesa all’epoca della «secretazione» delle carte processuali. In particolare riferendosi alla corrispondenza tra Martino e Taviani, che bloccarono l’inchiesta sugli assassini di Cefalonia (fascicolo 1188 dell’armadio della vergogna), sollecitata dal «cacciatore di nazisti» Simon Wiesenthal, il «divo» Giulio – «andante con anima e con qualche licenza» – si è lasciato andare alla sfrontatezza beffarda di buttar lì che, dopotutto, si trattava di carteggio «privato». 257 Francesco Omodeo Zorini L’A. individua almeno quattro nuclei di motivazioni che concorsero a perpetrare lo scandaloso vulnus al popolo italiano, alla Resistenza e alla Costituzione in fieri. Anzitutto l’oggettiva imprecisione e incompletezza di parte delle carte degli atti processuali raccolti che, per consuetudine, è causa prevalente dell’annullamento delle cause per vizio di forma. Secondo, quello che maggiormente pesò, la reticenza del governo italiano ad istruire i processi – salvo quelli contro ignoti – per non legittimare il boomerang delle richieste di estradizione di criminali di guerra italiani, reclamate – in base alle clausole del cosiddetto «lungo armistizio» – dai paesi aggrediti dall’Italia fascista: in particolare la Jugoslavia e la Grecia, ma anche Etiopia, Francia, Albania e Unione Sovietica. E, sia detto di passata, a proposito delle guerre coloniali esiste lo sterminato lavoro di scavo di Angelo Del Boca che ha fatto da battistrada per una folta «scuola» di studiosi, inizialmente contestato con pervicacia fino alla resa davanti all’inoppugnabilità. Ma, per quanto concerne gli estradandi, ecco due nomi per tutti: Roatta e Bastianini (quest’ultimo assurto da cosegretario del Pnf e governatore fascista della Dalmazia a segretario di stato agli esteri della Repubblica!). Tanto più se si considera che il nostro paese, alla faccia dell’epurazione, aveva preso in carico nelle istituzioni, Parlamento in primis, intruppati nel Movimento Sociale e nei partiti monarchici ma anche nel maggioritario partito cattolico democristiano, una folta schiera di fascisti riciclati nei primi anni del dopoguerra. Terzo, il precipitare della «guerra fredda» con il disegno anglo-americano di riarmo della Germania federale quale baluardo strategico nei confronti dell’URSS e, dalla metà del ’47, l’avvio del piano Marshall in Europa, e a casa nostra la contestuale estromissione delle sinistre dal governo del paese. Il nemico di prima diventa ora l’amico e, viceversa. Macabro gioco a «guardia e ladri» che rappresenta una costante nella storia del paese di Pulcinella. Infine la creazione nel 1949 della Bundesrepublick è contrassegnata fin dal sorgere da stretti legami politici tra Italia e Germania federale e da una vision pienamente condivisa dei principali partiti moderati dei due paesi, fattori che consentono la spregiudicata offensiva diplomatica di Adenauer, questa volta servendosi del barone Von Planitz, contro la debole volontà punitiva italiana dalle frecce puntate a rovescio. Il saggio di Focardi, attraverso una rigorosa disamina storiografica in certo senso circoscritta, irradia un fascio di luce su una tematica fondante di snodo del secolo ventesimo e dalla gittata policentrica di dimensione 258 Criminali di guerra in libertà europea. Dalla stiva delle questioni ne porta alla ribalta almeno altre due dall’attualità pregnante. Primo: l’importanza del nesso tra storia e politica e del loro serrato dialogo, per cui l’una può e deve avvalersi degli apporti dell’altra nel suo agire nel presente, cosa che invece è stata vergognosamente disattesa dalla relazione conclusiva approvata a maggioranza dalla Commissione parlamentare sulle stragi nazifasciste, presidente Enzo Raisi, AN. Si è ben guardata infatti dal tener conto delle inconfutabili acquisizioni storiografiche, ha fatto scaricabarile impugnando la ragion di stato, ha posto sotto accusa di ogni responsabilità l’odiata magistratura e ha speculato senza pudore appellandosi all’antititismo e tirando in ballo, proprio come i cavoli a merenda, il consunto leitmotiv delle foibe. Secondo: la necessità che l’ordine giudiziario rimanga indipendente dal potere esecutivo, principio costituzionale oggi messo permanentemente in discussione dai governi di centro-destra. Al proposito va sottolineato ad esempio come Le stragi nascoste di Franzinelli, abbia avuto, a detta dell’autore, quale retroterra il prezioso encomiabile lavoro esplicato da giudici con le stellette, onesti e coraggiosi come Bartolomeo Costantini (procura militare di Verona), Sergio Dini (Padova), Antonino Intelisano (Roma) e Pier Paolo Rivello (Torino), i quali hanno messo a sua disposizione la loro esperienza professionale e il materiale depositato – ovviamente a chiusura delle indagini – negli archivi dei tribunali militari dei rispettivi territori di competenza. E come dire poi grazie, da semplici cittadini italiani, al diligente e coraggioso procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis che riesce a condurre in porto col massimo rigore, centinaia di testi escussi e udienze quotidiane, il processo per la carneficina di Sant’Anna di Stazzema? e quelle di Marzabotto e di Falzano? Perché mai il Procuratore generale presso la Corte militare d’appello Fabrizio Fabretti deve ridursi a lamentare che le sentenze non vengano eseguite? perché il giudice Agostino Quistelli dopo la sentenza per la strage di Fivizzano è costretto ad augurarsi che la sentenza venga eseguita? Giustolisi ha amaramente fatto notare come il numero uno della magistratura, il Presidente Napolitano, che è intervenuto per l’estradizione del terrorista rosso Cesare Battisti, non abbia mai fatto sentire da par suo un monito severo sulla mancata applicazione delle sentenze contro i crimini nazifascisti. È decisivo soffermarsi inoltre su alcuni aspetti di natura tecnico-giuridica che hanno improntato l’azione penale di quel periodo storico e che hanno mantenuto riflessi fino a oggi. Sgombrato il campo dal fallace mito 259 Francesco Omodeo Zorini della Wermacht «pulita», sfatato peraltro in modo indelebile dalle ricerche di studiosi tedeschi come Schminck-Gustavus, Schreiber e Klinkhammer, nonostante la cavillosa distinzione, vischiosa come la tunica del bulbillo d’aglio, tra crimini nazisti di regime, ideologicamente motivati, e crimini individuali (si badi bene, mai di un intero apparato militare!) attuati in circostanze di guerra. Prevalse comunque la logica della legittimità della «guerra ai civili» all’interno di una lotta senza quartiere contro i movimenti partigiani. Occorre poi osservare come nei procedimenti si sia fatto abuso del principio in dubio pro reo ossia della clemenza verso il colpevole nei casi non incontrovertibilmente comprovati, così come nel processo penale tedesco si distingua il Täter autore materiale (di delitti) dall’Haupt-Täter responsabile gerarchico in alto, e dal Gehilfen complice dell’esecutore, e come gli imputati abbiano sistematicamente fatto ricorso all’arcinoto principio della Befehlsnotstand ossia dell’impossibilità di disubbidire ad un ordine superiore. E ancora come si faccia distinzione tra Mord omicidio volontario aggravato e Totschlag omicidio colposo semplice, alla cui fattispecie venivano ascritti gli omicidi perpetrati su ordine superiore. Di questa capziosa tassonomia classificatoria ne sa molto, ahinoi, Marcella De Negri, figlia del capitano Francesco De Negri, trucidato a Cefalonia alla Casetta Rossa, la quale, essendosi con quel coraggio civile ormai sbianchettato nel nostro paese, costituita – a proprie esclusive forze – parte civile nel processo in Germania contro l’ultimo sopravvissuto fucilatore del padre, il sottotenente Otmar Muehlhauser, si è venuta a scontrare attraverso gli avvocati con la congiura del silenzio e dell’insabbiamento, fino alla sentenza di non luogo a procedere. Il tutto nell’indifferenza delle istituzioni e del paese tra paura, imbarazzo e fastidio. E pensare che l’imputato era, come il suo camerata Johan Dehm (deceduto nel 2005), reoconfesso dal lontano 1967 quando affermò: «Tra gli ufficiali si parlava della divisione italiana solo come traditori... Al tradimento vi è una sola risposta: l’esecuzione». Il Procuratore capo di Monaco, August Stern, nella sua ordinanza di archiviazione del 27 luglio 2006 proscioglieva in istruttoria Muehlhauser, scrivendo che i soldati italiani di Cefalonia erano traditori e pertanto passibili di fucilazione al pari dei disertori tedeschi. Mattanza autorizzata quella della divisione Acqui. D’altronde le spoglie dell’amato cancelliere Willy Brandt non hanno a tuttoggi potuto essere traslate in Germania in quanto «disertore», ist Verboten! poiché collaboratore della Resistenza svedese. 260 Criminali di guerra in libertà A differenza della magistratura tedesca, in Italia si sarebbe dimostrato, è convinzione di De Negri (e in un primo momento anche del dottor Intelisano), che a Cefalonia proprio di omicidio plurimo aggravato si era trattato e, quindi, di crimine contro l’umanità non soggetto a prescrizione. Tuttavia nel 1996 Intelisano non ha ancora dato seguito alla scoperta da lui fatta due anni addietro del fascicolo di Cefalonia, nemmeno disponendo un supplemento d’indagine in Germania. Si trincera dietro la giustificazione che la sentenza del 14 giugno 1960 del giudice istruttore militare Carlo Del Prato aveva ormai prosciolto, per non aver commesso il fatto, il general Hubert Lanz, Hans Speidel e camerati. E l’obbligatorietà dell’azione penale? Non solo. C’è di più. La sentenza Del Prato è anche la ragione per cui Marcella De Negri perde la causa intentata contro il Ministero della difesa per ottenere un risarcimento, in virtù della legge Pinto, sulla ragionevole durata del processo: dalla Procura militare si comunica all’Avvocatura dello Stato che nulla ha da pretendere la ricorrente poiché il caso Cefalonia è stato definitivamente risolto nel 1960. De Negri dice che no, Costituzione alla mano, no. Senza secondi fini, dietrologie, tantomeno convenienze partitiche o tentazioni elettorali, ma anche senza cedere di un palmo, di un sol millimetro, sempre sola, a proprie spese le traduzioni asseverate e autenticate dall’autorità consolare di Monaco, delle interrogazioni rese davanti ai giudici di Dortmund da Muehlhauser. Carte problematiche da acquisire non essendo colà parte in causa e dovute soltanto alla disponibilità del Procuratore capo Maass. Con Paola Fioretti, figlia del Capo di stato maggiore della Acqui, anch’egli fucilato alla Casetta Rossa, decide quindi di presentare un esposto al Procuratore Intelisano, affinché apra finalmente presso il Tribunale militare di Roma, un procedimento per la fucilazione degli ufficiali alla Casetta Rossa il 24 settembre 1943, crimine di guerra per cui era stato indagato e poi prosciolto in Germania il Muehlhauser. Seguono l’articolo del «Manifesto» dell’11 agosto 2007 Una pietra sulla strage di Cefalonia, e la «lettera aperta» al Presidente della Repubblica e al Ministro della Difesa del 22 agosto a incutere alquanta preoccupazione nella Magistratura militare di Roma. Eterna commedia delle parti, delle contraddizioni, ricatti, prese di distanza, fraintendimenti della stampa, giri di parole, smentite, qui pro quo, annunci. Un colpo al cerchio e uno alla botte, nel novembre dello stesso anno Intelisano in conferenza stampa annuncia di aver aperto il procedimento per Cefalonia, che, meglio tardi che mai, con la richiesta di rinvio 261 Francesco Omodeo Zorini a giudizio del P. M. Tornatore del 2 gennaio e l’udienza preliminare del 5 maggio 2009 si concretizza (ma che la causa di un temping così dilatato sia il sovraccarico di lavoro dell’Ufficio? ci risulta abbia dato più di una risposta il servizio di Gabanelli in «Report»). Tutti i precedenti procedimenti per Cefalonia si sono sempre risolti in Italia con proscioglimenti in istruttoria. Ma che significa la boutade del funzionario togato dinnanzi ai giornalisti «...noi magistrati, a differenza degli storici, non possiamo processare i morti». E allora non sarebbe opportuno, proprio per questo fondatissimo motivo, tentare di processare Muehlhauser finch’è in vita? Prima o poi morirà, basta agire con lentezza. Morirà nel suo letto, indisturbato, come si conviene ad un ufficiale della Wehrmacht, col suo onore di assassino incontaminato. La morte estingue il reato. L’esito del procedimento, per quanto puramente simbolico, è c. v. d. vanificato col decesso dell’inquisito nel luglio 2009. Essì, spesso la tempistica giudiziaria mal si concilia con l’elaborazione del lutto. Suggestioni horror? Doveroso astenersi da commenti, signorimiei. Ci informa infine Giustolisi che a palazzo Cesi esiste un secondo armadio della vergogna. La scoperta la si deve al procuratore militare di Padova Dini, che il 18 marzo 2008, ha scritto al Cmm, di cui è componente, che si accerti, con riferimento ai crimini di guerra italiani: «a. se nel corso del dopoguerra siano stati celebrati processi o comunque intraprese indagini sulle vicende in discorso; b. nel caso che ciò non risulti (come in effetti consta allo scrivente), per quali ragioni ciò non sia mai avvenuto nonostante la inequivoca esistenza di vere e proprie notizie di reato al riguardo risalenti già alla seconda metà degli anni quaranta; c. per quali ragioni non abbiano avuto esiti processuali le risultanze della commissione di inchiesta nominata con D.M. 6 maggio 1946 (cosiddetta Commissione Gasparotto) che pure aveva individuato una serie di elementi e di nominativi sui quali si sarebbe ben potuta instaurare proficua attività processuale. Ciò anche al fine di individuare possibili profili di responsabilità in capo ad appartenenti all’ordine giudiziario militare, o di chiarire l’esistenza di eventuali ragioni (estranee alla responsabilità della Magistratura Militare) in ordine a questo macroscopico caso di denegata giustizia». È del tutto destituita di fondamento la leggenda degli «italiani brava gente». Basterebbe richiamare – nota Giustolisi – le circolari del generale Roatta, nei Balcani, che ordinava di ripagare «testa per dente», e del generale Geloso che in Grecia imponeva di dare fuoco ai villaggi da cui 262 Criminali di guerra in libertà partivano gli attentati e di fucilare senza tanti complimenti gli ostaggi che capitavano a tiro. In fondo, tanto per riequilibrare i fatti e dare, come si dice, «a Cesare quel che è di Cesare», le disposizioni che imponevano ai nazisti la fucilazione di dieci ostaggi per ogni tedesco ucciso, impartite dal Feldmarschall Albert Kesserling, comandante supremo per il Mediterraneo, in nome del Furher, erano state formulate nel 1943. Vergeltunsmaßnahme rappresaglia ritorsione. Si visioni il film omonimo diretto nel 1973 dal regista Gorge P. Cosmatos, che ricostruisce attraverso il libro Morte a Roma di Robert Katz, che ha contribuito alla sceneggiatura, gli eventi riguardanti l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Quindi, constata il procuratore Dini, tali aberranti disposizioni erano assai successive rispetto a quelle dei suoi colleghi italiani, che si erano ammantati del diritto di vita e di morte sin dal 1941. All’Italia spettano almeno altri quattro primi posti nel Guinness dei primati: l’impiego di aeroplani in guerra in Libia nel 1911; l’invenzione del fascismo; l’aver fatto da battistrada nelle leggi razziste alla Germania stessa; l’aver dato per prima il via alle rappresaglie sui civili in Etiopia e poi ancora in Spagna. Il Fascismo è stato guerra ininterrotta per dieci anni dal 1935 al 1945: Libia, Etiopia, Spagna, Albania, Francia, Grecia, Jugoslavia, Russia. A liberazione avvenuta, il governo Parri, da subito nel 1945, fa iniziare le inchieste per accertare le carneficine che nazisti e fascisti hanno compiuto. In questo ambito c’è anche la necessità di accertare quel che gli invasori italiani hanno commesso nei teatri di guerra aperti dal regime fascista. Per capire e valutare con coscienza e scienza giuridica le accuse che vengono rivolte ai militari italiani, i «nostri ragazzi», – c’è una lista di oltre ottocento nominativi di cui viene richiesta l’estradizione – viene insediata una commissione d’inchiesta. A presiederla è chiamato Luigi Gasparotto, già ministro della guerra in epoca prefascista, esponente della democrazia del Lavoro, successivamente, dopo la caduta del fascismo, più volte ministro. Gasparotto, il cui figlio Leopoldo era stato assassinato il 22 giugno 1944 (altri 67 poveri cristi il 12 luglio) da fascisti e nazisti nel lager di Fossoli, presso Carpi, si mette al lavoro, interroga, indaga, verifica, acquisisce documentazione, fa raffronti e confronti. Oltre a Roatta e Geloso deve esaminare il comportamento del generale Robotti, quello che sbraitava con i suoi uomini «qui se ne uccidono troppo pochi»; del generale Gambara che spiegava ai sottoposti «campo di concentramento non significa campo di ingrassamento»; del generale Pirzio 263 Francesco Omodeo Zorini Biroli che in Etiopia, come ricorda Alessandra Kersevan, nel suo libro sui lager italiani, faceva buttare nel lago Tana i capi tribù con una pietra legata al collo. E ancora, altri generali: Magaldi, Caruso, Sorrentino, Piazzoni, Baistrocchi... Ma anche molti ufficiali di grado inferiore che andavano proclamando che tutta quella sottoumanità che fossero sloveni, greci, albanesi, eccetera, andavano «uccisi senza pietà». C’erano, poi, gli alti funzionari civili, non meno abietti dei loro colleghi in divisa, come Bastianini, Giunta, Grazioli... Intorno alla fine del 1947 e ai primi mesi dell’anno successivo la Commissione Gasparotto termina il suo lavoro. Dei tanti casi che ha esaminato risulta che in poco meno di un’ottantina le accuse risultano provate. Si pensi ai fratelli Rosselli uccisi in Normandia dagli incappucciati Cagoulard, una sorta di Ku Klux Klan, mandante il genero del duce Costanzo Ciano Ministro degli esteri, nella catena di comando attraverso Filippo Anfuso, capo di gabinetto, ambasciatore Rsi a Berlino, condannato a morte in contumacia con sentenza definitiva dall’Alta Corte di Giustizia, fuggito in Francia, ospitato dal Caudillo, incomprensibilmente prosciolto dal Tribunale di Perugia nel 1949, parlamentare MSI dal 1953 al 1963. Intanto il governo ha cambiato fisionomia: c’è sempre De Gasperi, con al fianco il fido Andreotti, ma comunisti e socialisti non sono più nella maggioranza. Quindi la destra, come accade oggi, ha tutti i poteri e così nasconde le stragi commesse in Italia dai nazifascisti e quelle perpetrate da Roatta e camerati sui campi insanguinati d’Europa e d’Africa. È l’ora dunque di domandarsi – domanda delle domande – se, putacaso, nei sottoscala e scantinati di palazzo Cesi sia già iniziata la caccia al tesoro dell’«armadio della vergogna 2». 264 Novara Millenovecentoventidue: un film, un libro 16 luglio 1922: un battaglione di ciclisti fascisti (25-30) del Gruppo Pavese tenta l’assalto alla piccola frazione di Novara, Lumellogno, (sono le 15,30), ma viene respinto. Da Novara dopo qualche ora tornano con molti rinforzi (due o tre auto e una corriera). Lo scontro è violentissimo, partecipano anche le donne, i fascisti sparano. Muoiono tre contadini (Giovanni Merlotti, Angelo De Giorgi, Pietro Castelli), altri tre moriranno in seguito alle ferite riportate (Gaudenzio Mazzetta, Giuseppe Galli, Carlo Cardani) e sette saranno i feriti (Battista Scarenzi, Pietro Faccenda, Angela Colli Vignarelli, Giovanni Lombardi, Gaudenzio Bigliani, Pietro Ciocca, Giuseppe Colombara). Muore un fascista (Luigi De Michelis) e quattro rimangono feriti (Giovanni Manzuetti, Giuseppe Portalupi, Adolfo Alessandri, Antonio Ferraroli). Vengono però nuovamente respinti. Il Circolo operaio agricolo, appena trasformatosi in Casa del Popolo, è salvo. È l’episodio saliente della cosiddetta «battaglia di Novara» del luglio 1922. Dire «battaglia di Novara» porta alla mente il 23 marzo 1849, lo scontro della Bicocca tra l’esercito austriaco comandato dal maresciallo Radetzky e i soldati del Regno sardo guidati da re Carlo Alberto, dal generale Chrzanowski e da Alessandro La Marmora, la sconfitta, la fine della Prima guerra d’indipendenza, l’abdicazione dello stesso Carlo Alberto a favore del figlio Vittorio Emanuele II e il conseguente armistizio di Vignale. Insomma, «la fatal Novara» della storiografia e dell’iconografia risorgimentale. Ma, come detto, vi è stata un’altra «battaglia di Novara», altrettanto «fatale» per la nostra storia, ed è quella che si combatté nelle strade della città e in tutto il circondario dal 9 al 23 luglio 1922. Certo meno nota o meno ricordata o, ancora, volutamente dimenticata, quella sconfitta delle organizzazioni e dei partiti operai e contadini ad opera del fascismo squadrista, 265 Novara Millenovecentoventidue: un film, un libro segnò la fine del primo dopoguerra, la fine delle speranze della costruzione di un’Italia democratica in cui anche le cosiddette classi subalterne, che tanto avevano pagato e sofferto nelle trincee della Prima guerra mondiale, potessero trovare il loro posto nella società italiana. Novara fu allora crocevia di una «guerra civile» ben più ampia (in Lombardia come nella Marche, in Liguria come in Emilia Romagna, in Piemonte come nelle Puglie) e dimostrò ad un fascismo che proprio in quei mesi estivi del 1922 si sentiva isolato nell’opinione pubblica, la quale cominciava a criticare le violenze sistematiche degli squadristi, che occorreva dare il colpo di grazia alle istituzioni democratiche attraverso una ancor più violenta mobilitazione. Novara si rivelò zona strategica, «provincia rossa» nel cuore del triangolo industriale, e qui fu dato corso ad uno scontro, pochi mesi prima della 266 Novara Millenovecentoventidue: un film, un libro cosiddetta «marcia su Roma», che si rivelò decisivo. Gli storici si sono spesso posti la domanda se in quella calda estate i partiti antifascisti avrebbero ancora fatto in tempo a fermare l’avanzata del fascismo, ovunque protetto e spalleggiato dalle forze di polizia e dall’esercito, senza però addivenire ad una risposta esaustiva. Di certo, la fragilità, l’immaturità e la divisione degli stessi portò a far sì che gli scioperi locali di protesta (come quello novarese) si esaurissero o restassero senza sbocchi e senza un ampio movimento di resistenza nazionale che li coordinasse. Lo sciopero legalitario antifascista dichiarato il 31 luglio, com’ebbe a dire Angelo Tasca, fu proclamato dieci giorni troppo tardi. Oggi, come detto, pochi sanno o ricordano cosa successe in quei quindici giorni di battaglia nel Novarese, pochi ricordano i nomi dei protagonisti, dei caduti e dei feriti, la scia di distruzione e di sangue che lasciò. De267 Novara Millenovecentoventidue: un film, un libro rubricata a piccolo anche se cruento episodio locale e non già, come detto, crocevia di una vera e propria guerra civile dalle conseguenze drammatiche per la storia italiana (vent’anni di dittatura fascista), ebbe al centro degli avvenimenti quanto successe nella frazione di Lumellogno il 16 luglio 1922 dove il bilancio dell’assalto fu pesantissimo, ma al contempo assai significativo. Perché a Lumellogno, i contadini e gli operai, uniti e consapevoli, ebbero la meglio e scacciarono gli assalitori. Per questo, dieci anni dopo, durante la mostra della rivoluzione fascista ove vennero fatte sfilare come trofei le bandiere dei partiti, delle leghe, delle Case del popolo, dei circoli e delle organizzazioni operaie e contadine «conquistate», la piccola frazione fu definita dai fascisti stessi «paese non italiano». Ripercorrendo la cronologia di quei giorni, la gravità degli episodi, l’accavallarsi delle situazioni e il drammatico bilancio finale (50 sedi di associazioni operaie e contadine distrutte; 40 comuni assaltati; case di privati incendiate; 8 morti e 25 feriti tra gli antifascisti; 3 morti e 15 feriti tra i fascisti), ci si rende conto di quanto pesanti siano state le conseguenze, di come le ferite aperte in quel luglio 1922 dalla violenza sistematica non si sarebbero chiuse tanto presto, tanto meno con la «normalizzazione» della dittatura, che terminò solo dopo una serie infinita di guerre, di lutti e distruzioni, attraverso una nuova resistenza, diversa certo, ma comunque figlia di quel primo anelito di libertà. Trascorsi quasi novant’anni, tra oblio e scarso interesse, nel 2007, grazie al lumellognese Carlo Migliavacca e alla sua determinazione, per quella resistenza popolare e antifascista il Presidente della Repubblica ha concesso la Medaglia d’Oro la Valor Civile alla città di Novara: una medaglia doppiamente significativa, per contenuto e per tempistica, visto il clima di deriva morale e culturale che caratterizza questo inizio di nuovo secolo. Un nuovo interesse si è così creato attorno alla crisi dello stato democratico italiano nell’immediato primo dopoguerra e una delle realizzazioni più significative e, anche innovative (dal punto di vista della comunicazione storica), è stato il recente film Novara Millenovecentoventidue del regista novarese Vanni Vallino, girato nelle campagne attorno al piccolo villaggio di Pisnengo nell’estate del 2009. Prodotto dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel VCO Piero Fornara e da Immagina, in collaborazione con il Comitato di quartiere di Lumellogno, il film (sarebbe meglio forse definirlo il «corto», vista la breve durata di 27 minuti) ha avuto il 268 Novara Millenovecentoventidue: un film, un libro contributo della Film Commission Torino Piemonte e la collaborazione di: ATL Novara, Raffineria Sarpom Trecate, Unione Comuni Basso Novarese Granozzo con Monticello e Casalino, Clementoni Magis, nonché il patrocinio della Prefettura e della Provincia di Novara. Prodotto a bassissimo costo, grazie alla partecipazione disinteressata di tantissime persone (in larga parte giovani e giovanissimi) si è avvalso della bravura artistica di alcuni noti attori (Nino Castelnuovo, Marco Morellini, Bruna Vero, Maria Cristina Di Nicola, Sergio Danzi, Ileana Spalla) e l’altrettanto spontanea bravura di altri attori non professionisti (i gruppi teatrali Laribalta di Novara e Arcoscenico di Asti, la piccola Viola Donderi, vera star del film, Linda Bigliani, figlia di uno dei protagonisti della vicenda, nonché Enrico Massara, scomparso qualche mese dopo il termine del girato, ma che non ha voluto mancare, lui che ricordava, bambino, l’incendio della Camera de lavoro di Novara a pochi passi da casa sua). Il film, che ha riscosso nelle prime uscite un grande successo di pubblico, sviluppa il racconto su tre piani temporali (l’oggi, la vigilia delle elezioni per il referendum istituzionale del 1946 e il luglio 1922) ed ha al centro la piccola Viola, vestita non casualmente di bianco, di rosso e di verde: l’Italia ancora bambina, che fatica a crescere e a ricordare. È anche accompagnato da un libro, curato da Vanni Vallino e Mauro Begozzi (sceneggiatori del film stesso), edizione Immagina e Italgrafica, Novara 2009. Arricchito dalle fotografie di Paolo Migliavacca e Paolo Zanforlin, oltre ad alcune immagini d’epoca, il volume racconta «il progetto e la conseguente realizzazione» di Novara Millenoventoventidue. 269 Le schede Le schede «Pount». Cahiers d’études Corne de l’Afrique – Arabie du Sud, 2009, Numéro 3/Étranger (I), pp. 171 Si tratta del terzo numero della rivista fondata da Alain Rouaud per Les Éthiopisants Associés e riservata all’Eritrea, all’Etiopia, a Gibuti, all’Oman, alla Somalia e allo Yemen con ampi contributi riguardanti l’archeologia, l’arte, l’etnologia, la geografia, la storia, la linguistica, la letteratura, le religione di quest’ampia area geografica, ancora meritevole di approfondimenti. Il numero in questione è dedicato allo studioso Berhanou Abebe, scomparso nel giugno 2008, autore tra l’altro di alcune traduzioni di testi di Rimbaud, uno dei quali, il noto Le Bateau ivre, è riportato in amarico e francese alle pp. 10-17 della rivista. L’intero numero si segnala per il gran numero di contributi interessanti. Tra questi possiamo segnalare, in primo luogo, Le ras Makonnen sous l’œil occidental di Benjiamin Volff; Aperçus sur le franc270 maçonnerie française en Éthiopie de 1909 á 1924 di Lukian Prijac e Laurent Depui, le Lawrence d’Arabie français? di Édith Mailhac Raggini. Interessanti anche le due testimonianze di René Clément e Pier Paolo Pasolini nell’articolo di Franck Mermier intitolato Deux cinéastes au Yémen. Impressioni di viaggio nello Yemen sono contenute nel contributo di Alain Rouaud su Homo turisticus per Felicem Arabiam, mentre la traduzione dall’arabo, ad opera di Pierre Boquien, di un racconto di Muhammad ‘Ahmad ‘Abd al-Walī, Sur la route d’Asmara, riporta il lettore a visioni e sensazioni della capitale dell’Eritrea indipendente che ben conosce chi ha potuto visitare quella straordinaria città dell’altopiano. Il numero 3 di Pount è completato da una ricerca sull’etnia Akhdam dello Yemen a cura delle studiose Th. Arnaud e A. Vayssiére e da alcune recensioni di volumi sui Paesi dell’area africana-orientale, editi tutti nel 2008 (Massimo Romandini). Le schede Le note del commissario (Teobaldo Folchi e i Cenni storico-amministrativi sul commissariato di Massaua, 1898), a cura di Massimo Zaccaria, Franco Angeli, Milano 2009, pp.351 (Collana storica del Centro Studi per i Popoli extraeuropei Cesare Bonaccossa dell’Università di Pavia) Quelli che Teobaldo Folchi, militare e funzionario coloniale nell’Eritrea a cavallo della prima guerra d’Africa, definisce in una lettera all’amico Pecori Giraldi «un cumulo di dati […] buttati giù con poco nesso e con uno stile barbaro», sono tutt’altro che un lavoro di secondo piano. Infatti, i Cenni storico amministrativi sul Commissariato di Massaua, elaborati dal Folchi nel 1898 (ne fa cenno, per la prima volta, in un rapporto al governatore Ferdinando Martini il 25 dicembre di quell’anno) costituiscono un documento su cui impostare più di una riflessione e la testimonianza dell’impegno ben oltre il professionale di alcuni personaggi coloniali dell’epoca che potrebbero, a ragione, definirsi «etnografi per caso». Le «note» sono costituite da 553 pagine manoscritte, 85 tabelle riassuntive, 27 alberi genealogici: una mole di lavoro non indifferente che certamente costituisce per lo studioso dell’Eritrea di fine Ottocen- to una miniera di informazioni: «un’occasione preziosa (come sottolinea Massimo Zaccaria nella prima pagina della sua attenta introduzione) per ripercorrere i meccanismi e le modalità attraverso cui il colonialismo italiano costruì la conoscenza sulle popolazioni amministrate». Sotto questo profilo il funzionario Folchi entra di diritto nell’interessante elenco di quei personaggi che svolsero un ruolo specifico nell’Eritrea tra Ottocento e Novecento (residenti, commissari, direttori coloniali), segnalandosi per capacità culturali oltreché professionali. Teobaldo Folchi aveva messo piede in Africa nell’aprile del 1887 (aveva anche partecipato alla terza guerra d’indipendenza), poi comandato il presidio di Adi Ugri, partecipato all’occupazione di Kassala nel luglio 1894 guadagnandosi una medaglia d’argento, combattuto contro il «ribelle» Bahta Agos, preso parte alla battaglia di Halay guadagnandosi questa volta il cavalierato dell’Ordine Militare di Savoia, partecipato ancora alla battaglia di Coatit (1316 gennaio 1895). Dopo un breve ritorno in Italia, era passato al presidio di Agordat che aveva organizzato contro il pericolo mahdista; era poi passato (febbraio 1898) al settore di Keren, ma il Martini nel giugno dello stesso anno gli aveva 271 Le schede affidato la missione di costituire il Commissariato Regionale di Massawa dove il Folchi si era trattenuto sei mesi (scrivendo i suoi Cenni poi inviati al governatore), per passare quindi le consegne a Giuseppe Mantia e insediarsi da reggente nel commissariato regionale di Keren. Come si vede e come sa chi si occupa dell’Eritrea italiana di fine Ottocento, una storia – quella di Folchi – segnata da avvenimenti militari ben noti agli studiosi. Ma dopo l’ultimo incarico l’attenzione deve concentrarsi piuttosto sull’insoddisfazione che si impossessa del funzionario coloniale con tanti anni di servizio sulle spalle. Deluso per non essere andato oltre il grado di maggiore nonostante le tante benemerenze militari, deluso per le facili promozioni di alcuni suoi colleghi, amareggiato per non aver potuto partecipare ad alcuni importanti avvenimenti del dopo Adua e soprattutto per il suo collocamento in posizione ausiliaria dal giugno 1899, Folchi regge (come detto) dal giugno 1899 il commissariato di Keren a seguito della proposta del governatore Martini che voleva inserirlo nella schiera dei funzionari civili, poi (in settembre) chiede di ritornare per qualche tempo in Italia, rifiutando di conseguenza gli inviti del governo coloniale a ritardare tale partenza. Co272 mincia così l’inesorabile declino di Folchi che non riesce a rientrare più in Eritrea, nonostante i ripetuti contatti con le autorità coloniali e con la stesso Martini che, a suo dire, lo menerebbe «pel naso». Un ricorso di Folchi al Ministero degli Esteri non sortisce effetto alcuno, come ricorda Zaccaria. Qui la storia del «commissario», strettamente legata alla sua Eritrea, può considerarsi chiusa. Folchi non tornerà più in Affrica, come avrebbe scritto il Martini. L’uomo, che poteva vantare un’ottima conoscenza di uomini e cose eritree, non godeva però della simpatia del «Regio Commissario Civile» arrivato in Eritrea dopo l’infausta giornata di Adua. Il deputato di Monsummano non stimava i militari «vecchi della colonia» (come allora si diceva) a cui addebitava molte responsabilità. Era venuto in colonia per «ricomporre e stringere» e traghettare l’Eritrea, disfatta dalla guerra con l’Etiopia, verso il governo civile. Era questo il diffuso sentimento di insofferenza che il Martini nutriva, in quel particolare momento, anche nei riguardi di Folchi che aveva, peraltro, visto all’opera due volte durante il suo comando a Keren non ricevendone, sotto il profilo amministrativo, la migliore impressione. Dice infatti di lui in un’annotazione del Diario Eri- Le schede treo segnata dall’inconfondibile stile dello scrittore: «(Folchi) è dispotico e invadente. Non tollera divisione di potere: fa, strafa, qualche volta mal fa a furia di strafare». Certo, le parole del Martini accantonano quello che Zaccaria definisce, con gioco di parole, il «dilettantismo molto professionale» del militare che aveva saputo comunque accompagnare la monotona vita di guarnigione con attente ricerche sulle popolazioni e sulla geo- grafia del luogo. Sotto questo aspetto Folchi e gli altri che, al pari di lui, studiarono l’Eritrea, provenendo dai ruoli militari o da quelli civili, meritano ogni rispetto e alcuni di loro, se fosse ancora possibile, qualche approfondimento. Gli scritti sono di notevole valore e ben ha fatto Zaccaria a dedicare a questi personaggi alcune interessanti pagine dell’introduzione del volume (pp. 52-65) (Massimo Romandini). Gianni d’Angelo, La strana morte del Tenente Generale Alberto Pollio Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 1° luglio 1914, Gino Rossato Editore, Novale 2009 ni novanta dell’Ottocento, aveva poi sposato una baronessa austriaca ebrea di vent’anni più giovane, che gli aveva imposto la coabitazione con un suo fratello, un ufficiale della riserva della Landwehren e con un’altra sorella. Alla luce delle idee e dei legami familiari di Pollio, la sua morte cadeva quanto mai opportuna nei giorni in cui gli ambienti vicini ai Savoia e in particolare al filofrancese duca Emanuele Filiberto d’Aosta e gli ambienti politici si andavano smarcando dalla vecchia alleanza militare e aprendo segretamente a Francia e Gran Bretagna. Risultato ne era stato l’isolamento del generale prima e il silenzio seguito alla sua morte poi. I difficili rapporti personali con quello che era dal 1913 uno dei quattro comandanti d’armata, Cadorna, Tre giorni prima si sono consumati gli assassinii di Serajevo per mano dello studente bosniaco Gavrilo Princip, che avrebbero fatto precipitare le tensioni sottese ai rapporti fra gli stati della vecchia Europa nel momento in cui stavano implodendo i vecchi imperi, quando moriva in un albergo torinese Alberto Pollio, dal 1908 capo dello Stato Maggiore italiano, fedele alleato di Vienna, la cui lealtà alla Triplice, di fronte all’inasprirsi delle tensioni fra Francia e Germania, era ben conosciuta. Addetto militare a Vienna negli an- 273 Le schede dovettero facilitare il superamento del trauma ai vertici dell’esercito italiano. Diverse sono state le ragioni che hanno spinto l’autore ad occuparsi del fatto. Il ricordo di riferimenti allusivi all’episodio nelle conversazioni familiari; il ritrovamento di una memoria su quella morte scritta nel 1919, dopo la destituzione di Cadorna e la sua sostituzione con Diaz, dal nonno materno, il generale Vincenzo Traniello, che aveva accompagnato Pollio nel suo ultimo e fatale viaggio a Torino; l’uscita nel 1985 di un libro di Gianni Rocca su Cadorna in cui si parla di Pollio. Da allora una ricerca durata tredi- ci anni negli archivi militari e civili e nelle raccolte di carte delle personalità politiche dell’epoca ha corredato un’attenta e minuziosa analisi delle relazioni stese dai comprimari del dramma, per vagliarne criticamente dichiarazioni e silenzi, al fine di ricostruire i fatti di quella notte così come si sono svolti. Quello che ne esce è uno spaccato del nostro paese alla vigilia della grande guerra che getta luce sui rapporti fra ambienti militari e governativi e ben integra il quadro consueto nel quale siamo abituati a collocare il nostro ingresso nel conflitto fra neutralisti e interventisti (Severina Fontana). Morire a vent’anni. Le lettere dal fronte di Giuseppe Piccolini di Momo, a cura di Fernando Andoardi e Lucio Fabi, Fogliano Redipuglia (Go), I / Sentieri di Pace, 2009, pp. 79, € 10.00 cidersi gli uni con gli altri «vestiti da Macellai di carne umana», scrive Piccolini, freddo, fame da morire, pidocchi, la posta che non funziona, il morso dell’affetto per i nipotini che lo «chiamano sovente», mesi di insonnia, «disagi d’ogni colore» «granate… al selz, cacciate lontano colle mani» «dopo 22 giorni di trincea di prima linea… se sono ancora al mondo è per miracolo. Ieri due ore prima di lasciare la trincea, uno sraplnels scoppiava all’entrata della galleria che mi trovavo dentro uccidendone 4 e ferendone una decina, e lasciandomi incolume» «devo lavorare dalle 5 di mattina alle «Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita», incipit perentorio del romanzo Aden Arabia (1931) del comunista francese Paul Nizan. Non stato appagante, bensì passaggio della vita in cui il dolore ti sta addosso come morso di cavezza, come un basto, e pesa di più. Di più quando si è mandati a uc274 Le schede 7 di sera». «Presto vi leverò d’impiccio» «al mondo non mi resta che una morte liberatrice» «non so se avrò salva la pelle in quell’operazione» «addio. Arrivederci in paradiso» «ciò che mi raccapriccia il cuore è che qualche proiettile nemico mi colga in pieno petto e allora addio genitori, addio fratelli, addio vent’anni!» 28 lettere, 28 dei 4 miliardi di lettere dalle trincee, le più non scritte di pugno dagli oltre 4 milioni di soldati italiani semianalfabeti nel primo conflitto mondiale, unico modo di uscire da lì, stretti tra fango, sangue, escrementi urinosi, se non camminando su cataste di contubernali uccisi. Ancora un epistolario di guerra. Esiguo cammeo illuminato da scrittura proletaria felicissima: «Tu dici [sorella] di voler bene ai superiori, faresti tu carezze alla vipera che si volta per avvelenarti? Vorresti tu bene all’aguzzino che seguita a martoriarti a più non posso». Comanda la compagnia un capitano novarese, «l’anima l’ha di bruto» scrive Piccolini, e «giù legnate a destra e manca», tuttavia «andremo a batterci e versare fino all’ultima stilla di sangue. O Italia! O patria di ricchi!» «Mi si è presa una febbre nelle ossa che mi dà molta pena, pure colla febbre, devo andare all’istruzione lo stesso, perché se marco visita e non sono ri- conosciuto son guai» «Non credevo che la carne umana fosse calcolata così pocho… il pane è nerissimo e di quella farina che si dà ai maiali (ravese)» «168 cartucce per soldato, due scatolette di carne, sei gallette», «non piangete ne mamma? Se so che piangete vado dai tedeschi e non vengo più a casa», ove andare dagli austroungarici voleva dire consegnarsi al nemico, un modo di disertare, infatti «non ci lasciano mai sortire dal quartiere, e siamo come i prigionieri, perché han paura che scappiamo» «Ci hanno dato un berretto di acciaio (ferro) con due ali, una di dietro e una davanti, e una maschera che è contro i gas asfissianti» «vedeste che figura faccio col cappello di ferro e la maschera che ci han dati, assomiglio a un brigante di Calabria». 28 lettere a matita, prima di morire a vent’anni, tutto quello che è rimasto di lui. Classe 1897, coetaneo della momese Rina Del Ponte (colei che incarnerà la pietas cristiana nella lotta partigiana nel Novarese), con la quale sarà stato in zoccoli, grembiule nero e crapa pelata sui banchi delle elementari, dal maestro Mariani. Maestro che seppe insegnare loro a scrivere come oggi non si sa più, nominando le cose secondo la «tribù a cui si appartiene» (per dirla con Sanguineti): «… maledetto il Carso in cui mi trovo 275 Le schede Vorrei scriverne tante ma la censura…» «non si può scrivere ciò che si vuole, con questa maledetta censura» «io sono quello che scrive a casa per tutta la compagnia: ci sono molti vecchietti che non sanno scrivere, e io volentieri scrivo a casa per loro. Ci son molti calabresi o siciliani o napoletani i quali quando devono scrivere alla fidanzata dicono a me: ‘Dì, Peppì, un me la scrivi u letterì a u ffidanzà?’»…«E poi i piemotesi dicono che i napoletani adoperano il coltello, che i calabresi son terre da briganti ecc…, invece io dico che sono più brava gente quelli che i piemontesi, perché io sto più bene fra quei taroni di calabresi e napoletani e toscani che quando ero a Sanfré tra i piemontesi». Fante zappatore «ché si lavora a fortificarsi, facendo trincee di rincalzo, gallerie, bocche di lupo», quindi sarto di battaglione e poi di reggimento «Le mani mi son venute come quelle di puttana, così gentili che guai se le sporco di terra», e infine, per non essere sceso a compromessi «colla politica sporca», invece di «caporale furriere», promosso portaordini, consapevole del rischio nell’ultima 18 maggio 1917: «Spero di camparmela ancora, ché sono portaordini, ma non c’è che dire vada come Dio vuole». Peppì portaordini, uncinato e disintegrato da una granata. Preso in 276 mezzo nell’avanzata alla baionetta per lo «sbalzo» al Monte Santo, sul lembo di terra di nessuno, dove staziona Gorgone. Nel corso della decima offensiva dell’Isonzo, per cui lasciarono la giovinezza 160.000 italiani e 100.000 austroungarici. Mai ritrovato il suo corpo insepolto, come altri 60.000 «militi ignoti» nell’amusìa delle nudità carsiche. Eppure ogni morto ha bisogno d’un punto di sepoltura per rientrare nel continuum tra vivi e morti. Il pronipote Fernando Andoardi, al quale sono state tramandate nel divallare di generazioni, le ha raccolte e trascritte queste lettere, per un debito con le proprie origini, e pubblicandole (anche in anastatica) mostrare il «valore morale di questo ventenne, semplice contadino». Onorarne la memoria facendo di esse opera postuma e «capolavoro» involontario di una letteratura degli ultimi, lingua abitabile per un paese abitabile. Il postumo sa di estinzione, revenant che, dal caveau di morte, reclama di tornare alla luce e sottrarsi al destino di un doppio annientamento. Il volume inaugura il progetto editoriale «Sentieri di Pace» della Pro Loco di Fogliano Redipuglia e il commento introduttivo, sensibile e impeccabile, è affidato allo storico specialista Lucio Fabi. Alla presentazione del libro a Mo- Le schede mo, Giampietro Morreale ha fatto notare come sulla prima guerra abbiamo una storia scritta da ufficiali (come il memoriale del novarese Zucconi pubblicato dal nostro Istituto) e pochissime testimonianze di soldati semplici, al tempo metà analfabeti. È sbagliato identificarci oggi nella narrazione dei graduati soltanto perché, ormai imborghesiti, stiamo un po’ meglio, quando in realtà siamo perlopiù discendenti dei soldati contadini. 8 milioni di morti nella «grande» guerra ma oltre 30 per la «spagnola» diffusasi nel 1918, che in effetti la fece troncare in anticipo, mentre le potenze alleate contavano di far arrendere gli imperi centrali a metà 1919. L’amico Uglietti ha ragguagliato sui 400 momesi delle classi dal 1875 al 1900 chiamati al fronte, 61 dei quali morirono e ha accennato alla storia dell’edificazione dei monumenti ai caduti nel primo dopoguerra (che meriterebbe approfondimento per il duro scontro ideologico che la caratterizzò, specie nella nostra terra). Pure di Momo fu il fante Giovanni Squarini (18861963) del quale il «Bollettino storico della provincia di Novara» ha pubblicato il Notiziario della guerra 1915-18 (a. XCIX – 2008, n. 1, pp. 157-172). Intanto «Pace forza organante del mondo e conservativa», sentenziava Corradini. «Guerra madre di tutte le cose» primo mobile della storia e dell’esistenza umana, per Junger di Tempeste d’acciaio e Sangue e fuoco, il quale avrà tuttavia la preveggenza che quella guerra «non rappresenta, come molti pensano, la fine, bensì l’inizio della violenza». E Gramsci: «La guerra non ha plasmato né coscienza mondiale, né coscienza europea, né coscienza italiana, né coscienza individuale. Appostato ad ogni angolo da un gendarme, da una spia, da un ardito del fronte interno, il dolore si è rincantucciato nel tondo delle anime, come un gatto idrofobo rinchiuso in un sacco, ha morso il cuore, ha straziato senza creare, ha distrutto, lasciando un mucchietto di sterco e di putredine. Invece della disciplina sociale, spontaneo fiore della libera riflessione sui doveri comuni, dal ribollire schiumoso delle passioni sono esalati tutti gli istinti antisociali, tutta la barbarie, tutta la ferocia, tutta la slealtà che secoli di servaggio politico, di gesuitismo e di attività settaria avevano accumulato nell’animo degli italiani. La vernice di civiltà si è sfaldata, lasciando nuovamente apparire, nella sua nudità schifosa, l’irresponsabile poltroneria, l’animalesca sete di godimento, lo spirito di sopraffazione, che sono i caratteri più vistosi della tradizione sociale italiana» (Francesco Omodeo Zorini). 277 Le schede Andrew Hilton, The ethiopian patriot. Forgotten voices of the Italo Abyssinian War 1935-1941, SpellmountLimited, Uk 2007 Andrew Hilton è un archeologo che ha lavorato a lungo in Africa in qualità di consulente per le attività economiche e di sviluppo. In occasione di un soggiorno in Etiopia è nato il suo studio the ethiopian patriots; il lavoro di Hilton, basato su poco più di una decina di testimonianze orali, è certamente significativo dal punto di vista del recupero e della preservazione della memoria di un’esperienza che, altrimenti, sarebbe destinata a non lasciare traccia di sé. Le quattordici testimonianze, tredici memorie di uomini e una di una donna, sono precedute da una breve introduzione di Richard Pankhurst che, in maniera sintetica, illustra le diverse fasi attraversate dal movimento partigiano etiopico nella sua pluriennale lotta contro l’invasore fascista. Una vicenda, sottolinea lo stesso storico, mai raccontata adeguatamente fino ad ora: «The story of the ethioStefano Fabei, Operazione Barbarossa 22 giugno 1941, Mursia Editore, Milano, 2010, pp.75 È questo il secondo volumetto sto278 pian patriots who fought almost alone against the Italian Fascist occupation of their country in the late 1930, has never been adequatelytold and i today largely forgotten» (Introduzione, p. 33). Le testimonianze raccolte e pubblicate da Andrew Hilton, non sono certamente tali da chiudere l’argomento, questi racconti orali dei partigiani etiopici oltre ad essere un testamento ed un manifesto del loro coraggio e della loro determinazione nell’affrontare un nemico di gran lunga superiore per uomini e mezzi costituiscono anche un importante ed essenziale tassello per chiunque intenda occuparsi e sviluppare questa affascinante tematica. Nell’insieme, tuttavia, mi pare anche necessario evidenziare che la semplice trascrizione delle testimonianze orali senza un’adeguata presentazione dei singoli testimoni e l’assenza di una più robusta e analitica presentazione del movimento partigiano abissino non permettono a mio avviso una piena valorizzazione delle stesse memorie raccolte (Massimiliano Tenconi). rico della Collana I Picci One ideata dall’editore Mursia. Altri volumetti, altrettanto agili, sono dedicati a vari capolavori della letteratura mondiale. Le schede A leggere il sito web della nota casa editrice milanese, la Collana intende offrire in formato tascabile «al prezzo di un cappuccino e brioche» i classici della letteratura di sempre e testi storici di autori affermati per avvicinare il grande pubblico alla lettura. Un’operazione non nuova nella storia delle edizioni economiche delle nostre case editrici. Stefano Fabei, docente a Perugia, è noto per una serie di lavori sul periodo fascista. Tra i suoi saggi più noti, da noi recensiti anche sul «Corriere», ricordiamo (sempre con Mursia) Il fascio, la svastica e la mezzaluna (2002), Una vita per la Palestina (2003), Mussolini e la resistenza palestinese (2005), La legione straniera di Mussolini (2008). Questa pubblicazione, nella sua fresca essenzialità, si legge d’un fiato e offre spazio a qualche riflessione fuori dei margini soliti della Storia. È il 22 giugno 1941 quando l’armata hitleriana attacca l’Unione Sovietica precedendo analoghe intenzioni di Stalin verso l’odiato nemico tedesco. Qui si racchiude l’originalità del breve saggio: Stalin sarebbe stato anticipato nelle mire aggressive coltivate da tempo dall’audace e travolgente mossa di Hitler che lo avrebbe semplicemente battuto sul tempo. Fabei ricorda che questa la tesi era stata già sostenuta dallo storico rus- so Suvorov la cui opera, Stalin, Hitler: la rivoluzione bolscevica mondiale, era uscita anche in traduzione italiana nel 2000. L’attacco tedesco potrebbe definirsi «un’estrema reazione per prevenire l’imminente invasione dell’Europa da parte di Stalin, ragione per cui l’opposizione di quest’ultimo al Terzo Reich sarebbe stata soltanto strumentale: la premessa di uno scontro più vasto con le democrazie occidentali». Il maresciallo Zukov il 15 maggio 1941 aveva preparato un piano di attacco alla Germania in ossequio al principio staliniano di «diffusione del regime comunista in tutto il mondo, pena la disintegrazione dell’Unione Sovietica». La tesi di Suvotov, come fa rilevare Fabei, «comportava un vero e proprio sconvolgimento della storiografia novecentesca, che ritiene l’opposizione dell’Unione Sovietica e, in genere, la lotta antifascista della sinistra come il nodo cruciale del XX secolo». Stando ai documenti di archivio Stalin avrebbe dovuto attaccare la Germania il 6 luglio 1941 ma, scoperto il progetto nemico, il Führer lo precedette di due settimane. L’incapacità dei russi di difendersi in casa loro sarebbe stata determinata dall’impreparazione alla guerra difensiva imposta dal Terzo Reich. Si ricordi che, il 23 agosto 1939, Hitler aveva sottoscritto con 279 Le schede Stalin un accordo di non aggressione, tre mesi dopo il Patto d’acciaio siglato da Ciano e von Ribbentrop per l’alleanza italo-germanica. L’Operazione Barbarossa costò a Hitler molti affanni che confessò a Martin Bormann negli ultimi giorni nel bunker della Cancelleria a Berlino: una decisione non facile per un uomo pur spregiudicato negli attacchi militari. Alle 3,15 del 22 giugno 1941, 600.000 veicoli a motore, 3580 carri armati, 7184 pezzi di artiglieria e 2740 aerei attaccavano l’Unione Sovietica con l’aiuto di forze supplementari rumene, finlandesi, ungheresi, slovacche e italiane. Si trattava della più grande forza militare raccolta su un unico teatro bellico dell’intera Storia (Massimo Romandini). Gian Luigi e Julia Banfi, Amore e speranza. Corrispondenza tra Julia e Giangio dal campo di Fossoli aprileluglio 1944, a cura di Susanna Sala Massari, prefazione di Vittorio Gregotti, postfazione di Maria Vittoria Capitanucci, Milano, Archinto, 2009, pp. 205, € 18.00. corso tra i suoi genitori, Julia Bertolotti e Giangio. Corrispondenza, seppur in senso letterale, mai come in questo caso «d’amorosi sensi» e, insieme pathos di speranza, allorché quest’ultimo si trovava internato a San Vittore e poi al campo di concentramento di Fossoli, nel lasso temporale che, per esattezza, va dal 9 aprile al 4 agosto 1944. Il percorso di morte di Giangio si consumerà nelle tappe della traduzione a Bolzano e definitivamente a Mauthausen, nel cui sottocampo di Gusen II si spegnerà all’alba della liberazione il 10 aprile 1945. Un epistolario di 87 messaggi: Toi et moi. Bigliettini fitti fitti di microscopica grafia filiforme, ripiegati a strisce sottili come appunti proibiti di studenti per il compito in classe. Pizzini clandestini scambiati in manciate di attimi tra ansia e sgomento, negli intermittenti contat- Mi è presente la sera alla Triennale di Milano quando nell’aula gremita all’inverosimile, stretto tra due autentici «giganti» di un parterre intellettuale di prim’ordine quali Vincenzo Consolo e il mio concittadino Vittorio Gregotti, ascoltavo Giuliano Banfi presentare con pudore e commozione questo piccolo grande libro. Vinto l’incomprimibile impulso affettivo di rimozione, senza dribblare i sentimenti, annunciava d’essersi risoluto a dare alle stampe il carteggio di intima e trepidante tenerezza, inter280 Le schede ti strappati al destino. Epistolario di straordinaria completezza giacché, al momento della spedizione in Germania, a premonizione forse del definitivo congedo, Giangio ha la prontezza di mettere in salvo, facendoli scivolare tra le mani di quell’adorata moglie di superiore intelligenza e bergmaniano charme, tanto amata fin dall’acerbezza adolescenziale, quelli da lei ricevuti. Se l’averli conservati si deve al culto di risarcimento dell’assenza, dapprima di Julia e poi della famiglia, ora il renderli pubblici è merito della consapevolezza civile di tradurli in testimonianza da condividere per farne vero riconoscimento e renderne vera riconoscenza a chi ha sofferto l’atrocità estrema per la libertà di noi tutti, in un tempo ormai lontano e mai passato. La morte non è non essere più, ma essere ancora, nella memoria e nella considerazione degli altri. Operazione di conoscenza, preziosa e necessaria, che ci sottopone uno spaccato inusuale della cospirazione antifascista, della tragedia della deportazione e dei suoi protagonisti dall’esistenza sinistrata e perigliosa nella Milano occupata dai tedeschi. Quando ci volevano cinquecentomila euri odierni per riscattare la vita di un antifascista destinato all’eliminazione. Missive d’amore intenso, di passione accesa e di delicata vicendevo- le cura che, pur nella fuggevole apprensività della penna e nella forzosa cripticità, sono anche d’inestimabile valore culturale e tangenzialmente politico, e non soltanto morale ed affettivo, perché riflettono la comunione d’intenti e di progettualità di due lucidi intellettuali travolti dalla guerra. L’architetto Gian Luigi Banfi, fratello di Arialdo, è un brillante intellettuale trentaquattrenne affermato professionista, «spavaldo e colto» nel pieno delle facoltà creative. Nel 1932 ha fondato con Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers lo storico studio di architettura urbanistica BBPR. Nel 1942 stringe legami con il partito d’azione e si dedica intensamente all’attività cospirativa nel movimento «Giustizia e Libertà» dei federalisti europei Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, di Riccardo Lombardi, Leopoldo Gasparotto, Brenno Cavallari, Arturo Martinelli, Peppino Pugliesi. Il 21 marzo 1944 è arrestato con Lodo Belgiojoso, l’amico di sempre. Vengono condannati senza processo alla deportazione per spionaggio e distribuzione di stampa clandestina. Lodo, smistato a Gusen I, avrà la fortuna di far ritorno e di darci testimonianza, specie in Notte, nebbia e Frammenti di una vita, insieme ad Aldo Carpi 281 Le schede in Diario di Gusen, delle ultime stazioni del calvario di Giangio. Mi sia consentito, a proposito di Belgiojoso, notare come la rivista del nostro Istituto«Ieri Novara oggi» (5/1981) si sia potuta fregiare, a corredo del Diario da un lager di Enrico Piccaluga e Otello Vecchio, dei clichés di suoi disegni originali dal campo di Gusen, della serie di quelli raffigurati in questo libro. Julia si è laureata in lettere con un taglio estetico figurativo, allieva di Rogers, Antonio Banfi ed Enzo Paci. È entrata nell’entourage di Gillo Dorfles, Raffaele De Grada, Gio Ponti e Vittorio Sereni. Ha lavorato a «Domus» occupandosi di design, grafica, architettura. Sposatisi nel 1939, l’anno successivo ha messo al mondo Giuliano. La sua poliedrica formazione la porta ad interagire con ottica autonoma in dialettica complementare con Giangio. Un sodalizio di vita e di lavoro traumaticamente interrotto. Da quando Giangio è stato razziato per la Germania ella tiene un diario fino al marzo 1945, in cui ce la mette tutta per tenere la barra a dritta, che è qui pubblicato in appendice alle lettere. Grazie alla «puntigliosa sollecitazione di Susanna Sala Massari che ha compiuto un difficile lavoro, non solo di decrittazione, lettura, trascrizione, datazione, ma anche 282 di identificazione di tutte le persone che sono citate in modo assai prudente per il pericolo di intercettazioni« nelle postille alle lettere è ospitata la folta galleria dei personaggi dell’intelligentia, dell’imprenditoria e dell’antifascismo dei ceti emergenti quando Milano era a pieno titolo «capitale della Resistenza». Dal parergo di Maria Vittoria Capitanucci si evince infine una puntuale sistematizzazione del contesto specialistico in cui operano i protagonisti. Caratterizzato dalla dimensione civile che si stanno dando questi architetti, dall’apporto collegiale come principio metodologico, dalla matrice razionalistica proiettata alla libertà innovativa fondata sull’analisi del territorio per la pianificazione urbanistica guardando a Le Corbusier, dall’autonomia espressiva tesa al superamento dei vincoli più schematici delle strettoie della scuola di provenienza alimentata dalla modernità di regime, dal tema pervasivo dell’abitare in cui ci si imbatte nella personalità eclettica di Adriano Olivetti. Avamposti culturali che hanno cementano l’antifascismo nel pensiero e nell’azione. Ma per fare ancora un po’ di quella malvoluta memoria storica, della quale oggi par bellamente si voglia con ostinazione fare a meno, un nome ancora dei sodali di Julissa e Giangio, deside- Le schede ro spendere. Quello dell’architetto Giuseppe Pagano, passato da Villa Triste della Banda Koch di sadici tossici come Valenti e Ferida, anche lui a Fossoli e poi a Mauthausen, dove lascia la vita sotto il bastone di un guardiano il 22 aprile 1945 (FrancescoOmodeo Zorini). Virginia Paravati, Quello che siamo state. Storia e memoria di donne in fabbrica. Lo iutificio di Villadossola (1900-1950), Provincia VCO, 2009, pp. 250 tinuità tematica con la precedente apprezzata prova dell’A.: Aspettando la luna nuova. Dialoghi sul sapere delle donne a Ornavasso nella prima metà del Novecento (Verbania, Alberti, 2007). Scientificità ancor più validata dalla molteplicità delle fonti archivistiche, bibliografiche e orali compulsate, così come dal peso del tutor che ha avuto negli studi Virginia Paravati: il professor Claudio Dellavalle, una delle massime autorità accademiche in materia, docente di storia contemporanea all’Università di Torino e Presidente del confratello Istituto della Resistenza piemontese nonché Vicepresidente dell’Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia. L’A. ripercorre sinteticamente le coordinate del processo d’industrializzazione in Ossola nel volgere di due secoli, restringendo via via l’obiettivo su quell’unicum – in un distretto di metallurgia (Sisma e Ceretti) e chimica (Set, poi Montecatini, e Distillerie Italiane) – costituito dalla saccheria per tele d’imballaggi, teloni, cordami, sacchi e tappeti, che fu la Sasa. Si L’edizione è assai opportunamente e meritoriamente promossa dalla consigliera di Parità e dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola. L’Autrice, ampliando l’elaborato della propria tesi di laurea, ricostruisce mezzo secolo della Sasa, acronimo di Società Anonima Saccherie Agricole. ‘l fabricùn, tetti a dente di sega, per due terzi maestranze al femminile, supererà le 500 unità all’indomani della Liberazione, rappresentando un decimo della popolazione operaia della «piccola Manchester» della val d’Ossola: Villadossola (di appena diecimila abitanti), «primo fuoco che si accese» alla guerriglia antifascista e antinazista del nostro Paese con la cruenta insurrezione popolare, operaia e partigiana del 7 novembre 1943. D’un fiato s’è inquadrato l’oggetto e lo scenario del saggio, la cui garanzia di qualità è data dalla con- 283 Le schede concentra con efficacia sulle cardatrici addette alla scarpinatura della juta, sulle filatrici, tessitrici, scaricatrici, bobinatrici, aspatrici, sulle cops addette alle spole, sulle mezzanti dal basso profilo di mestiere. Ascolta i loro affanni, aspirazioni e le loro conquiste. L’attenzione si focalizza quindi sull’ultimo decennio di funzionamento della fabbrica, coincidente con il periodo della seconda guerra mondiale e il lustro successivo, soffermandosi con acutezza infine sul tormentato ultimo anno di aspre battaglie sindacali e di definitiva irreparabile capitolazione, sancita nel clima di riflusso postresistenziale. Arrivano congiunture, ahinoi, nel rotolio dei tempi, nelle quali si collassa fino a regressioni in cui si assiste allo scambio del governo con il comando, del comando con il potere, del potere con il dominio. Più che per forza altrui per incapacità nostra. È una memoria celata quella che l’A. va a disvelare. Interrogando il silenzio par di vederle affiorare dal buio fondale di una negazione irriducibile, riapparse, per il solo momento della parola viva (come la centoduenne Giacomina Toni), dall’opacità del recinto domestico: una turba di operaie-montanare autoctone e immigrate (trenta sono le deposizioni testimoniali), il cui legame con la Storia segue un andamen284 to carsico di infossamenti e risalite tra privato e pubblico. Ed in paritempo emerge il nondetto soffocato represso. Come annegate gonfie di annullamento, vengono a noi dall’alveo di gelo notturno dell’Ovesca, murate nella loro icastica diversità, un’identità lavica con tracciati esistenziali di sacrificio e riscatto, pericolo e autonomia, e, da un limo profondo, sembrano mandarci il messaggio che la Storia stessa non è tutto. Perché «la differenza femminile – ha notato Wanda Tommasi – eccede anche, in parte, la storicità, e allude a una trascendenza del femminile, all’apertura di quest’ultimo verso possibilità inesplorate e non previste dalla prospettiva androcentrica». La specificità della donna, delle donne, di queste donne operaie, ci sta dicendo l’A., non è riducibile al genere, né alla condizione sociale ed economica, né all’insieme di valori qualità ruoli che si sono storicamente in loro sedimentati, quando afferma che obiettivo della ricerca è mantenere viva la memoria e mettere in luce il travaglio individuale e collettivo in cui esse hanno abitato, per dar forma e moto al cammino di trasformazione della comunità. Vicende che s’innestano al sommitale dell’albero grande della Resistenza e dell’antifascismo. È il noi che vince, non la singola gra- Le schede ma vita della persona. Donne che, dopo aver retto l’home front il fronte casalingo di ben due guerre mondiali, vengono umiliate nel 1950 con lo smantellamento della fabbrica (ma è pur storia del presente) dopo sette mesi di lotta e occupazione, documentati nel libro con eloquenti fotografie d’epoca, e relegate all’angolo del focolare. In tal modo si disperde irrimediabilmente un patrimonio comune di socialità e cittadinanza politica, di itinerari di emancipazione dal girone dei dannati, che costituisce l’essenza della democrazia, dell’etica pubblica, dell’educazione a tuttotondo. Di qui l’amara riflessione in esergo di Maria che dà il titolo al volume: «Mi dispiace di una cosa. Noi non siamo state capaci di trasmettere quello che abbiamo fatto, quello che siamo state». Sconfitta che brucia, per chi è stato titolare del proprio io desiderante. Muro che sbarra la vista. Impedisce il pas- saggio di testimone tra generazioni. E questo potrebbe bastare. Tuttavia per contrasto, è dovere osservare, come la nobiltà di queste proletarie che misero a investimento la grande forza segreta delle loro anime e dei loro corpi logorati fin dall’età infantile dalla polvere del telaio, da malnutrizione e spossamento, da broncopolmoniti, asme e tisi, dai cosiddetti «aborti spontanei», risalta maggiormente oggi, in un panorama da regime mascherato, dominato dalla scontornata galassia del mercimonio, tanto sfavillante quanto impudente, della femminilità. Panorama ributtante, nel quale, persino baldracche in tenuta da combattimento sono abilitate a posare sugli scranni della rappresentanza democratica il loro più cospicuo e ambito tesoretto, quello perineale. No, non si dovrebbero mai mescolare gli stracci con le salviette, raccomandavano i vecchi delle nostre parti (FrancescoOmodeo Zorini). Daniela Del Boca - Alessandro Rosina, Famiglie sole. Sopravvivere con un welfare inefficiente, Il Mulino, Bologna 2009 serirsi nel mercato del lavoro e di conseguire un’autonomia economica che consenta loro di mettere al mondo e mantenere figli, l’instabilità coniugale e da ultimo gli effetti dei flussi migratori investono in tutto il mondo occidentale l’istituto familiare. In Italia tuttavia non si può ignorare che con la famiglia I mutamenti demografici in atto, che si traducono nel generale invecchiamento della popolazione, nella difficoltà dei giovani di in- 285 Le schede si tocca una delle peculiarità culturali su cui poggia la nostra identità nazionale. Il libro di Daniela Del Boca e Alessandro Rosina parte da questa consapevolezza per avviare una riflessione sulla debolezza storica del nostro sistema di welfare in materia, che contraddice la vocazione storica del paese, sempre ribadita e rafforzata dalla contiguità fra le istituzioni centrali dello Stato nazionale e quelle della chiesa cattolica. Il risultato è che «siamo uno dei paesi occidentali nei quali le donne lavorano di meno, le coppie fanno meno figli e la scelta di averne di più accresce il rischio di povertà» (p.11). In Europa l’Italia è il paese che ha il tasso di occupazione femminile più basso, inferiore a quello della Grecia, e la forbice fra Italia da un lato e Norvegia, Danimarca e Svezia dall’altro – i paesi dove tale valore è il più alto – è pari all’incirca a 30 punti percentuali. Altri dati evidenziano la difficoltà di conciliazione per le donne fra lavoro e famiglia (p.61). Ai ritardi nei servizi si sommano la resistenza che oppone al cambiamento la secolare misoginia che nel mondo cattolico ha re- 286 legato le donne al ruolo riproduttivo e ai lavori di cura dentro la famiglia, radicata nella cultura maschile e nelle regioni meridionali. Analogamente il nostro è il paese in cui più che altrove la flessibilizzazione del mercato del lavoro rischia di trasformarsi in una trappola e, in mancanza di un sistema di protezione per i giovani quando passano da un’occupazione ad un’altra, la flessibilità diventa precarietà costringendoli a procrastinare il tempo in cui formare una famiglia propria e a restare presso la famiglia di provenienza (p.44). Per sociologi e politologi il grido d’allarme è forte, riguardo al futuro del paese, per gli storici interessante è la tendenza evidenziata nel libro da parte dei governi che si sono succeduti nella storia della repubblica, in contrasto con la centralità assegnata ideologicamente all’istituto familiare, a trascurare le politiche di welfare a sostegno della famiglia per utilizzarla di fatto come ammortizzatore sociale a detrimento dello sviluppo economico nelle aree depresse del Sud e delle ragioni di donne e giovani in tutto il paese (Severina Fontana). vita della rivista In memoria di Mario Giovana Caro Mario, in questi giorni ti avrei telefonato per chiederti di scrivere, così come ho fatto altre decine di volte, un editoriale per la nostra rivista, «I sentieri della ricerca». Da quindici anni viviamo in un clima di confusione e di sfacelo, ma da qualche tempo, dopo i violenti attacchi alla magistratura, alla Costituzione e al suo garante, si respira aria di regime. Per questo motivo ti avrei pregato di elaborare una di quelle tue analisi lucide, graffianti, che lasciano il segno. Forse non hai tenuto il conto, ma per «Studi Piacentini» e poi per «I sentieri della ricerca» hai scritto non meno di una ventina di editoriali, tanti da farne un libro. Ci siamo conosciuti nell’immediato dopoguerra. Tu lavoravi all’«Avanti!», io alla «Gazzetta del Popolo». Ci unì, subito, la comune appartenenza al movimento di liberazione nazionale e ancor più il fatto di aver militato entrambi in formazioni di «Giustizia e libertà», tu a Paralup, nel Cuneese, io nel Piacentino. Ci unì anche l’adesione convinta, entusiasta agli ideali del Partito Socialista Italiano, nell’ambito del quale sei stato consigliere regionale e, per sette anni, membro del Comitato Centrale. Quando il partito, in modo particolare Pietro Nenni, ci chiese di fare dei sacrifici, alcuni dei quali comportavano il rischio della vita, non abbiamo mai avuto dubbi o tentennamenti: tu penetrasti nell’Algeria insorta per una «missione informativa e tecnica», io in Spagna per riallacciare i legami con gli antifascisti del PSOE clandestino. Tu, in Spagna, ci andasti anche portando armi, le micidiali matite esplosive. E insieme, in piena autonomia, all’insaputa del PSI, che avrebbe sicuramente bocciato il nostro progetto, cercammo di attrarre l’attenzione del mondo sui crimini del franchismo, sulle torture praticate nel carcere madrileno di Carabanchel, organizzando il sequestro dell’ambasciatore spagnolo a Bruxelles. Sequestro 287 che fallì per la pavidità dei due spagnoli incaricati della bisogna. I nostri «sten», pazientemente lubrificati, finirono nelle acque del lago di Como. Il nostro sodalizio era tale – ricordi Mario – che gli amici, scherzosamente, ci chiamavano «le sorelle Kessler». Abbiamo persino scritto un libro insieme, I figli del sole. Mezzo secolo di nazi-fascismo nel mondo, il cui miglior capitolo, quello dedicato al neo-fascismo italiano, lo scrivesti tu. Ma tu, a quella data, avevi già al tuo attivo altri libri importanti Algeria, anno settimo, una sintesi della tua straordinaria avventura nel maquis algerino; Storia del CLN piemontese e, soprattutto, Storia di una formazione partigiana, pubblicato da Einaudi. Ci unì anche il tragico destino delle nostre mogli: la tua scomparve il 10 novembre 1978, la mia un anno dopo, il 14 novembre 1979. Due donne straordinarie, già a noi legate dai giorni della Resistenza. Tu non riuscivi a sopportare questa perdita, tanto che decidesti di lasciare Torino per non rivedere i luoghi dove insieme eravate stati felici. Ti rifugiasti a Cuneo, a due passi da Paralup, forse nella speranza di ritrovare nella culla della lotta di liberazione un clima accogliente. Ma non andò così. In quegli anni imperava a Cuneo la figura di un altro illustre resistente ed intellettuale, Nuto Revelli. Con il tuo carattere schivo, incapace di operare compromessi, in un certo senso ti autoesiliasti nella tua casa di corso IV Novembre. Ti fu solo di conforto di trovare in Anna Stefanelli una compagna fedele ed amorevole. Nel 1988 hai scritto forse il tuo libro più bello e importante: Guerriglia e mondo contadino, che io non esito a porre accanto a Una guerra civile. Saggio sulla moralità della Resistenza di Claudio Pavone e alla Storia della Resistenza italiana di Roberto Battaglia. Il nostro rapporto con le popolazioni contadine non fu mai facile, ma era comunque essenziale per la nostra stessa sopravvivenza, e tu spieghi con eccezionale bravura questo rapporto variegato, non limitandoti a parlare genericamente di «zona grigia», come ha fatto De Felice. Ogni tanto, quando il clima di Cuneo e del paese ti diventava insopportabile, ti rifugiavi a Ceva, dalle tue amatissime figlie, oppure andavi a Nizza, dove sei nato, e a Parigi, dove incontravi esponenti di un mondo meno provinciale del nostro. Tornavi arricchito e riprendevi a lavorare anche se i tuoi occhi perdevano ogni anno vitalità, sino a sfiorare la cecità. Penso agli sforzi tremendi che hai dovuto fare per scrivere le cinquecento pagine del tuo ultimo libro, Giustizia e Libertà in Italia. Storia di una 288 Mario Giovana, sulla destra, con Pietro Nenni 289 cospirazione antifascista apparso da Bollati Boringhieri nel 2005. Ma hai continuato a scrivere sino all’ultimo, collaborando alle mie riviste con un’assiduità straordinaria, e completando libri, rimasti inediti, e che spero verranno ora pubblicati. Perdona questa chiacchierata che ho fatto in tuo onore. Semplice e spoglia. Ma tu non avresti voluto neppure questo modesto ricordo. Soltanto il silenzio al momento del distacco. Diciamo allora che ho pronunciato queste parole per i parenti e gli amici, che stanno qui intorno a te e che ti vogliono bene. Ti abbraccio Mario, splendida medaglia d’argento della lotta di liberazione. Angelo Del Boca 290 Enrico Massara e la «sua» Novara di Mauro Begozzi Il 7 settembre 2009 si è spento nella sua Novara, nella sua casa di Sant’Andrea, dove aveva vissuto ininterrottamente i suoi bellissimi novant’anni (quasi novantuno), Enrico Massara. Il resistente, il socialista, l’antifascista, il cattolico, il novarese Enrico Massara. A chi volesse saperne di più su di lui conviene leggere o rileggere la lunga, appassionata e appassionate intervista che rilasciò in occasione dei suoi 85 anni (e del 60° anniversario della Liberazione) e che fu raccolta nel prezioso volumetto Mon vieux capitaine, pubblicato a cura dell’Istituto storico P. Fornara. 291 Ora, però, per chi come me ha condiviso con Enrico, spesso gomito a gomito, un non breve tratto di strada nel tentativo di dare alla città e alla comunità novarese un centro di ricerca e di cultura storica vivo e vitale, un luogo di conservazione della memoria e al contempo un laboratorio di idee e opportunità (soprattutto per i giovani studiosi), prevale il bisogno di una riflessione diversa, più personale, una riflessione che ha a che fare con il senso della perdita, del distacco ormai quasi definitivo da una generazione che è stata a lungo dentro alla nostra storia (e alla nostra vita): nell’antifascismo, nella Resistenza, nella ricostruzione morale e materiale del paese, nelle dure battaglie politiche. Con uno sguardo, che era poi volontà e impegno, concretezza, oggi smarrito: lo sguardo della responsabilità, dell’ideale che si fa progetto, della coerenza. Con Massara, forse ultimo testimone «consapevole» di quella generazione dei «padri», scorrono i volti e le voci di tutti gli altri: amici, compagni, avversari politici. Uomini e donne di diversa estrazione, di diverso ideale, accomunati però da uno straordinario senso del dovere, scoperto spesso sui diversi fronti di guerra e, più consapevolmente, in montagna, tra i partigiani, quando si fece chiaro l’inganno del fascismo e si pensò, si sognò, si lavorò per un paese diverso e migliore. Massara per tutta la vita restò legato a quella straordinaria esperienza vissuta in prima persona e rappresentata dalla Resistenza, a quei venti mesi in cui l’Italia sembrò cambiata, rinata, a un sogno di libertà e pulizia. Per quello, nel ricordare i difficili anni del dopoguerra della sua Novara, ebbe a scrivere: «Pur non avendo conosciuto le distruzioni di altre città, anche delle sue dimensioni, Novara necessitava di un futuro nuovo, tutto da inventare, tutto da costruire. C’era bisogno di idee, c’era bisogno sopra ogni altra cosa di lavoro e di solidarietà. Uomini e donne straordinari si rimboccarono le maniche e ricominciarono. Lo spirito di laboriosità e sobrietà dei novaresi divenne modello per molti, che cominciarono a giungere in città in cerca di una vita migliore. Non furono anni facili, ma furono anni di slanci e progetti, di voglia di vivere. È difficile da spiegare, ma in quei momenti difficili assieme con i problemi emergevano le qualità dei singoli, fossero essi operai, impiegati, artigiani, industriali, amministratori o politici. Sono orgoglioso d’aver vissuto quel periodo e aver potuto dare il mio contributo». C’era, in quelle parole, tutto il senso vero e profondo della resistenza, di quella vera e veramente vissuta, non quella celebrata e ingessata del poi, 292 c’era non un «gigante» della politica o della cultura, ma un uomo vero, mite, il socialista unitario e umanitario della tradizione, il cattolico praticante. Contraddizione? Inesistente. C’era il costruttore, paziente e tenace. Fondò con Fornara, Gastone, Menotti, Calletti, Del Ponte, Moscatelli e tanti altri l’Istituto intitolato al pediatra, prefetto della Liberazione e ci spese tutte le sue energie. A 80 anni ci guardò negli occhi e decise di lasciare la presidenza: «tocca ad altri, tocca ai più giovani». Credeva nella cultura, meno in certi intellettuali, nella cultura che è partecipazione, è elaborazione di idee, è formazione delle nuove generazioni. Credeva nei «vecchi», che portano sulle spalle il peso della vita e dell’esperienza, purché sappiano dare il dovuto spazio e la meritata fiducia ai nuovi, ai giovani. Perché le nuove idee hanno gambe solo se si fondano sulla conoscenza e sulla tradizione, perché non c’è scienza senza filosofia e umanità, non c’è futuro senza storia, non c’è politica senza un ideale, un’utopia, un sogno. Più che «capitano», cavaliere, grande ufficiale (in pochi sapevano di tutto questo) si sentiva «maestro» e ci teneva molto ad essere chiamato così: maestro, con la «m» minuscola, che ogni giorno reca il suo granello di sabbia, che ha una parola per tutti, tra via Maestra (e non è un gioco di parole), l’edicola di Corso della Vittoria, il caffè davanti all’Istituto in Corso Cavour. Una parola e un sorriso, paziente, con tutti. Il suo ultimo scritto, apparso postumo su «Nuova Resistenza Unita» è stato, come sempre, come aveva fatto per tutta la vita, un ricordo di un amico, di un compagno di lotta, di un socialista come lui, Terenzio Leone. Maestro elementare, Enrico Massara nel 1941 è richiamato alle armi nel 4° reggimento carristi di stanza a Vercelli dove incontra Alfredo Di Dio suo capo istruttore. Trasferito prima a Roma e poi ad Abano Terme, viene destinato nel 1943 a Casale Monferrato come sottotenente di complemento. Qui lo coglie l’8 settembre. Fugge dalla caserma e nei giorni successivi raggiunge a Quarna il capitano Filippo Maria Beltrami diventando ben presto comandante di distaccamento della gloriosa Brigata Patrioti Valstrona. Partecipa alle principali azioni del gruppo ed è coinvolto il 13 febbraio 1943 nella battaglia di Megolo in cui cadono Beltrami, Antonio Di Dio, Gaspare Pajetta e altri nove partigiani. Arrestato, picchiato, riesce a fuggire. Torna in montagna ed è tra i fondatori, con Antonio Di Dio, del gruppo Patrioti Ossola, divenuto in seguito divisione Valtoce. Ufficiale di collegamento, partecipa alla liberazione dell’Ossola nel settembre 1944. Durante i famosi «quaranta giorni di libertà» è comandante del presidio di Domodossola. Nell’ottobre è costretto a seguire 293 partigiani e popolazione in Svizzera dove è internato in diversi campi. Nonostante ripetuti tentativi di fuga rientra in Italia solo a liberazione avvenuta. Tra il 1945 e il 1948 è capitano di Pubblica Sicurezza a Novara. Aderisce al Partito socialista nel 1945 e ne diviene segretario della federazione provinciale: in quel periodo è anche segretario provinciale dell’Anpi. Esponente di spicco del movimento cooperativo, tra il 1961 e il 1970 è assessore comunale a Novara, poi presidente dell’Istituto autonomo case popolari (1970-74), componente il collegio sindacale della Cariplo, del fondo pensioni e infine del Finafrica (1975-1998). Convinto assertore dell’unità della Resistenza è tra i fondatori nel 1968 del Raggruppamento unitario di Novara (Anpi-Fiap-Fivl) e dell’Istituto di cui è ininterrottamente consigliere fin che non ne diviene nel 1975 vicepresidente e nel 1986 presidente. La sua presidenza, dal 1986 al 1996, è caratterizzata da una forte crescita dell’Istituto e dalla razionalizzazione del Consorzio di gestione. In seguito sarà presidente onorario dell’Anpi interprovinciale e presidente onorario dell’Associazione Casa della Resistenza di Fondotoce, di quella splendida realtà culturale di cui è stato uno dei più accaniti fautori e primo presidente. Dal 1967 è Cavaliere dell’Ordine al Merito della repubblica italiana e, dal 1995, Grande Ufficiale. Nel 1998 la sua Città, lo ha insignito del titolo di Novarese dell’anno. Tra le sue opere sono: Crimini dei nazifascisti in provincia di Novara, La Foresta Rossa, Novara 1956; Novara, 24 ottobre 1944. Rappresaglia, Grafica Novarese, Novara 1980; Antologia dell’antifascismo e della resistenza novarese, Grafica Novarese, Novara 1984; Mon viuex capitaine (a cura di Mauro Begozzi), Tipografia San Gaudenzio, Novara 2004. Suoi articoli sono apparsi numerosi in «Resistenza unita», «Il Lavoratore»; «Stella Alpina»; «Resistance unie». 294 notizie sugli autori di questo numero Mauro Begozzi - Direttore scientifico dell’Istituto storico «P. Fornara» di Novara. Si occupa di storia contemporanea sia come autore di saggi che come organizzatore e mediatore culturale. Tra i suoi libri Il signore dei ribelli (1991) e Non preoccuparti che muoio...innocente (1995), tra le sue realizzazioni la Sala storica di Domodossola e la Galleria della memoria di Verbania-Fondotoce. Luigi Benevelli - Medico psichiatra, parlamentare del Partito comunista nella IX e X legislatura, attualmente è vicepresidente dell’Istituto di storia contemporanea di Mantova e socio della Società italiana di antropologia medica. Giovanni Cavagnini - Attualmente perfezionando presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, sta svolgendo ricerche su esponenti del nazionalismo cattolico nella Grande Guerra. Vanni Clodomiro - Presidente dell’Istituto di studi storici di Catanzaro e collaboratore di diverse riviste storiche, ha condotto studi sulle figure di Benedetto Croce e Gaspare Colosimo. Angelo Del Boca - Da quarant’anni si occupa di storia del colonialismo e dei problemi dell’Africa d’oggi. Fra i suoi libri recenti: Gheddafi. Una sfida dal deserto, Laterza, 2010; Un testimone scomodo, Grossi, 2000; La disfatta di Gars bu Hàdi, Mondadori, 2004; Italiani, brava gente? Neri Pozza, 2005. Da poco è uscito, per i tipi della Baldini Castoldi Dalai A un passo dalla forca, con il quale ricostruisce la vicenda di uno dei protagonisti della resistenza libica all’occupazione italiana, Mohamed Fekini. Renzo Fiammetti - Collaboratore dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea del Novarese e del Verbano Cusio Ossola, ha scritto numerosi libri su temi diversi di storia locale. Severina Fontana - Insegnante di storia e filosofia al Liceo classico Melchiorre Gioia di Piacenza, si è occupata di storia delle borghesie nell’Ottocento italiano, di associazionismo economico fra Otto e Novecento e ha toccato tematiche di storia di genere. Ha scritto su riviste italiane e straniere come «Quaderni storici» e «Histoire Économie et Société». Tra le altre pubblicazioni ha curato La Federconsorzi fra Stato liberale e fascismo, Laterza, Roma-Bari 1995 e Donne luoghi lavoro, Mazzotta, Milano 2003. 295 Gian Paolo Ghirardini - Laureato a Bologna, attualmente collabora con l’Istituto sondriese per lo studio della Resistenza e dell’età contemporanea occupandosi dell’organizzazione del movimento partigiano e del rapporto fra società e Resistenza. Aram Mattioli - Ordinario all’Università di Lucerna, si è occupato di temi inerenti la costruzione di un’identità nazionale in Svizzera. In proposito insieme a Guy P. Marchal ha scritto Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität, Zürich 1992. Tra i principali suoi interessi di studio sono anche le ideologie totalitarie, l’antisemitismo e il colonialismo. Con Olaf Blaschke ha curato Katholischer Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Ursachen und Traditionen im internationalen Vergleich, Zürich 2000. In più occasioni ha trattato aspetti del colonialismo italiano. Recenti sono i suoi saggi Terra promessa. Italien und Libyen 1911-1943, in Sahara. Text- und Bildessays, a cura di Christian Reder e Elfie Semotan, Wien, New York 2004 e E salva l’Italia nel Duce. Die katholische Kirche im faschistischen Italien 1922-1938, in Katholizismus in Geschichte und Gegenwart, a cura di Richard Faber, Würzburg 2005. Francesco Omodeo Zorini - Dirigente scolastico, dal 1998 presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola «P. Fornara». Ha pubblicato tra l’altro: Conoscere la Resistenza novarese. Bibliografia ragionata, prefazione di A. Jacometti, Novara 1978; La formazione del partigiano. Politica, cultura, educazione nelle brigate Garibaldi, prefazione di Guido Quazza, Borgosesia 1990; Una scrittura morale. Antologia di giornali della Resistenza del Piemonte orientale, Borgosesia 1996; Piero Fornara il pediatra delle libertà, Novara 2005. Andrea Paracchini - Giovane novarese, ha conseguito di recente a Bologna una laurea specialistica in Comunicazione pubblica, sociale e politica con una tesi su Uso pubblico della storia e rappresentazioni sociali della Resistenza. Paolo Soave - Dottore di ricerca in Storia dell’Africa presso l’Università degli Studi di Siena. Fra i suoi lavori Fezzan: il deserto conteso (1842-1921), Giuffré, Milano 2001; La rivoluzione mediterranea nel Mediterraneo: prove di politica di potenza e declino delle Reggenze Barbaresche (1785-1816), Giuffré, Milano 2004; Le minacce globali alla sicurezza e all’ordine internazionale, Cemiss, Roma 2005. Massimo Romandini - Dirigente scolastico, dal 1969 al 1975 ha insegnato in Etiopia alle dipendenze del ministero degli Esteri. Si occupa di storia del colonialismo italiano in Africa Orientale. Paolo Valabrega - Milanese, lavora come bibliotecario in una biblioteca pubblica di quartiere. 296 ISSN 1826-7920 11 I SENTIERI DELLA RICERCA � 20,00 11 I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea Del Boca Ghirardini Mattioli Cavagnini Fiammetti Valabrega Soave Benevelli Clodomiro Paracchini Fontana Omodeo Zorini Begozzi Romandini Tenconi giugno 2010 EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO
Scaricare