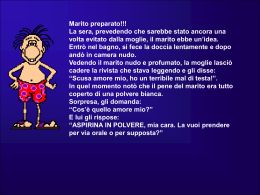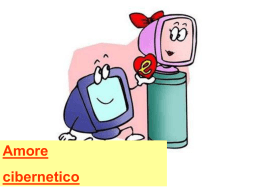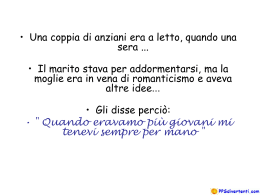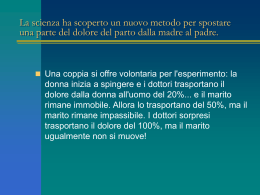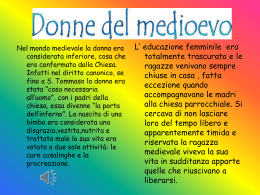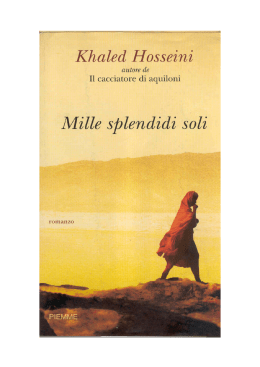dinaw mengestu leggere il vento Traduzione di Isabella Vaj Titolo originale: How to Read the Air © 2010 by Dinaw Mengestu All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form. Per esergo: Rainer Maria Rilke, Elegie duinesi, trad. di Franco Rella, BUR 1994, p. 43. Redazione: Edistudio, Milano I Edizione 2011 © 2011 - EDIZIONI PIEMME Spa 20145 Milano - Via Tiziano, 32 [email protected] - www.edizpiemme.it 1 C’erano trecentodue chilometri e mezzo dalla casa dei miei genitori a Peoria, in Illinois, fino a Nashville, in Tennessee, distanza che una Monte Carlo rossa di sette anni, ai novanta all’ora circa, avrebbe potuto coprire in un tempo variabile tra le otto e le dodici ore, a seconda del numero di cartelli stradali che avrebbero proposto deviazioni verso siti storici, e di quante volte mia madre, Mariam, sarebbe andata in bagno. Avevano dato al viaggio il nome di vacanza solo perché l’espressione “luna di miele” li metteva a disagio: l’associazione di due parole distinte, delle quali i miei genitori capivano il rispettivo significato, sembrava alludere a un dono troppo grande che nessuno dei due era disposto ad accettare. Non erano novelli sposi, ma i tre anni di separazione li avevano resi estranei. Si parlavano sussurrando, mezzo in amarico, mezzo in inglese, come se una parola pronunciata ad alta voce potesse rivelare a entrambi che in realtà non si erano mai capiti, non avevano mai saputo chi fosse veramente l’altro. In fondo, imparare una nuova lingua non era diverso dall’imparare a innamorarsi del proprio marito una seconda volta, pensava Mariam. In piedi davanti allo 11 specchio, la mattina presto, spesso diceva a se stessa, in quella che credeva una pronuncia perfetta: «Gli uomini possono essere strani. Noi siamo diverse». Era una frase che aveva sentito da una signora della chiesa battista che lei e il marito avevano incominciato a frequentare. Finito il sermone, un gruppo di signore si era fermato al parcheggio e una di loro si era rivolta a Mariam dicendo: «Gli uomini possono essere così strani. Noi siamo semplicemente diverse». In quel momento si era limitata a ripetere le parole alla lettera: «Sì, è vero. Gli uomini possono essere strani» solo così era sicura che tutti avrebbero capito cosa diceva. Quello che avrebbe voluto dire era molto più complesso e implicava una lista di differenze piuttosto rilevanti che secondo qualsiasi altro metro sarebbero state considerate inconciliabili. Da quando era arrivata in America sei mesi prima, si era sforzata di imparare nuove cose sul marito, per esempio perché parlava da solo quando credeva che nessuno lo guardasse, e perché certi giorni, tornato dal lavoro, rimaneva seduto per dieci o venti minuti nella macchina parcheggiata sul vialetto, mentre lei lo osservava da dietro le tende del soggiorno. A volte di notte si svegliava e usciva dalla camera, attento a non disturbarla, ma senza mai riuscirci, perché Mariam non dormiva quasi per niente. Si stendeva nudo sul divano del soggiorno e dal letto lei sentiva che, alla fine, emetteva un breve mugolio seguito da un grugnito, per poi tornare a letto e dormire profondamente sino al mattino. Mia madre scopriva queste cose e le archiviava in un angolo della mente che riteneva riservato espressamente ai fatti che riguardavano suo marito. E nello stesso modo si sforzava di dire parole nuove e formare nuove frasi in 12 inglese, perché se c’era uno spazio riservato al marito, ce n’era uno per l’inglese, uno per i cibi stranieri e un altro per i nomi delle strade vicine a casa. Imparò a dire: «Piacere di conoscerla» e singole parole, come “sparpagliato”, “diligente” e “sarcastico”. Imparò l’imperfetto. Per esempio: «Ieri ero stanca» invece di «Ieri sono stanca» o «Ieri stanca io sono». Imparò che Russell Street porta a Garfield Street, che a sua volta arriva a Main Street, che si immette nella I-74, strada da cui puoi andare ovunque tu voglia, a est o a ovest. Alla fine tutto avrebbe acquistato un senso. I verbi sarebbero stati collocati al posto giusto, il sarcasmo sarebbe risultato divertente, la città sarebbe diventata familiare: avrebbe potuto capire passato, presente, futuro e marito se vi si fosse dedicata con sufficiente pazienza. A quel punto del loro matrimonio avevano passato più tempo separati che assieme. Sommò i giorni facendo cifra tonda dei mesi, alcuni per eccesso, altri per difetto. Per ogni giorno che avevano passato assieme, ne avevano trascorsi 3,18 separati. Per lei questo significava un debito che doveva essere ripagato, benché non fosse chiaro chi dei due fosse il debitore. Chi soffre di più? Chi è abbandonato o chi viene spedito solo nel mondo per guadagnarsi da vivere e costruirsi una nuova vita? Aveva sempre odiato i numeri, ma poiché l’inglese in gran parte ancora le sfuggiva, trovava conforto nelle cifre e andava alla ricerca di cose da sommare. Al supermercato calcolava il costo di ogni articolo prima di arrivare alla cassa: una lattina di piselli, settantotto centesimi; un pacchetto di sale, quarantanove centesimi; un sacchetto di cipolle, quaranta centesimi. Con il viso sorridente le cassiere le offrivano sempre alcune parole 13 prima di annunciare il totale. Con lei erano sprecate, ma che differenza faceva se non sapeva come accogliere un complimento, una battuta, o capire cosa significava il “due per uno”? Alla fine sapeva la cifra, e quella cifra, dal momento che non aveva bisogno di traduzione, era potere, e il fatto che la conoscesse prima di arrivare alla cassa le dava soddisfazione e la riempiva d’orgoglio come nient’altro di ciò che aveva imparato da quando era arrivata. E questo, silenziosamente, la faceva sentire per un attimo una donna di cui tenere conto, una donna che gli altri prima o poi avrebbero finito per invidiare. Non seppe mai ciò che suo marito aveva passato in quei tre anni di separazione, né aveva mai cercato veramente di immaginarlo. Ripeti la parola “America” innumerevoli volte, cerca di figurartela innumerevoli volte e ti troverai qualche grattacielo in mezzo a un campo di grano con migliaia di automobili che gli girano attorno. Aveva ricevuto una sola fotografia di suo marito in quei tre anni: Yosef seduto al posto di guida di una grossa macchina, la portiera aperta, il corpo metà dentro, metà fuori. Teneva un braccio sul volante, l’altro appoggiato a una gamba. Era bello, con un’aria dignitosa, i baffi spuntati con cura, i folti capelli crespi scolpiti in modo da formare una palla perfetta, che metteva in risalto la strana somiglianza della sua testa col mappamondo che il padre di Mariam teneva sul cassettone. Quando vide la foto non credette che la macchina fosse del marito. Pensò che l’avesse trovata parcheggiata sul ciglio della strada e avesse colto l’occasione per darsi arie, il che in effetti era proprio ciò che lui aveva fatto. Tuttavia, questo non le impedì di mostrare la foto alla madre, alle sorelle e alle amiche e di scrivere sul retro, 14 in inglese, Yosef car. Si aspettava di ricevere altre fotografie, prima o poi. Foto di Yosef davanti a una grande casa con giardino; foto in cui indossava un completo e teneva in mano una cartella; e poi, con il passare dei giorni, delle settimane e dei mesi, quando i due anni stavano ormai diventando rapidamente tre, incominciò ad attendere la foto di lui abbracciato a un’altra donna, con due ragazzini al fianco. In cuor suo temeva che questo sarebbe accaduto sin dal primo giorno che era partito, perché quando mai si era sentito di un uomo che aspettava la moglie? Il mondo non funzionava così. Gli uomini entravano nella tua vita e ci rimanevano fintanto che eri capace di trattenerli. Aveva persino scelto un nome per i figli del marito: Adam per il maschio e Sarah per la femmina, nomi che non avrebbe mai dato ai propri, perché banali e comuni; i suoi figli, quando fossero venuti, sarebbero stati speciali. Poiché quelle foto non erano arrivate, avrebbe voluto scrivergli di inviargliene una al centro di qualcosa – una piazza, un parco urbano – un’immagine nella quale lui avesse un piccolo ruolo secondario. «Mandami una foto in cui stai facendo qualcosa» avrebbe voluto scrivergli, ma non era esattamente quello che voleva. Ciò che desiderava era una foto che lo mostrasse nel pieno della sua vita, in cui respirava, camminava, rideva, viveva senza di lei. La mattina in cui partirono per Nashville, mia madre mise in una piccola valigia la biancheria per due settimane, tre maglioni di lana che aveva comprato a una vendita di seconda mano per due dollari l’uno, più calzoni e camicette per l’estate, l’autunno e l’inverno, 15 anche se era la prima settimana di settembre e sino allora le giornate erano state tiepide, assolate e a volte troppo calde persino per le canottiere che aveva visto indossare alle altre donne per le corsie del supermercato, nei centri commerciali e lungo la deserta Main Street. Le donne non erano né magre né graziose. Erano bruttine, pallide e ordinarie e ai suoi occhi del tutto indistinguibili le une dalle altre, il che era esattamente ciò che più la irritava. Il viaggio doveva durare quattro notti e cinque giorni, ma mentre riempiva la valigia al massimo, decise che era meglio essere preparati all’imprevisto, un guasto della macchina, una strada sbagliata, una lunga camminata notturna che per qualche ragione non sarebbe terminata mai. Aveva messo in valigia tutta la sua vita già una volta, e ora, a distanza di sei mesi, aveva imparato che poteva cavarsela con molto meno. Se l’avesse voluto, sarebbe potuta partire quasi con niente. Suo marito, Yosef, la stava già aspettando in strada nella Monte Carlo rossa; per acquistarla aveva tirato la cinghia e risparmiato per oltre un anno e ora poteva a malapena permettersela. Non era la stessa automobile della foto. Mariam non sapeva come e perché, ma le sembrava meno elegante, forse più piccola, e anche se l’immagine era in bianco e nero, pensava che la Monte Carlo in cui il marito l’aspettava era di un rosso più smorto di quello che si era immaginata. Il clacson della macchina suonò due volte per lei: due brevi suoni acuti che avrebbero potuto passare inosservati, ma così non fu, perché in parte li aspettava, in parte li desiderava. Quando li sentì immaginò un uccello – una colomba o qualcosa di simile – che veniva liberato, l’aria smossa dal rapido frullo delle ali. Se avesse conosciuto 16 più parole in inglese avrebbe detto che il suono perforava il silenzio, “perforare” era il verbo efficace in questo caso, perché suggeriva che si fosse verificato qualcosa di violento. Se suona ancora una volta, si disse mia madre con convinzione, mi rifiuterò di partire. Era una questione di principio, o almeno qualcosa che vi si avvicinava al punto che, benché si trattasse soltanto di orgoglio e rabbia mascherati, era disposta a lottare e a distruggere la casa pur di rimanervi fedele. Dopotutto l’aveva aspettato per anni – una vedova virtuale, ma senza il cadavere e il cordoglio altrui. Si sentiva in credito di tempo. Tempo per fare la valigia, allacciare i nastri del vestito e fare un elenco di tutto ciò che avrebbe potuto dimenticare e di cui forse avrebbe avuto bisogno. Se suona ancora, si disse, disfo la valigia, chiudo a chiave la porta della camera da letto e aspetto che parta senza di me. Era così che iniziava la maggior parte dei litigi dei miei genitori, se non tutti. Con un’insignificante, quasi invisibile trasgressione cui ciascuno dei due si aggrappava, come se stessero litigando non perché lui le faceva fretta o perché aveva lasciato accese troppe luci, ma per il loro diritto a esistere, a vivere e a respirare l’aria pura di Dio. Da bambino ho imparato presto che c’era sempre un litigio pronto a scoppiare, e talvolta lo immaginavo come una presenza fisica, reale, acquattata nell’ombra dello spazio che i miei genitori si trovavano a occupare in quel momento – un negozio di alimentari, una macchina, un ristorante. Mi figuravo il litigio seduto accanto a noi sul divano di fronte alla televisione, una figura solenne, nera, che indossava l’abito del boia, una caricatura della 17 morte e della tragedia chiaramente mutuata da libri e film, ma non per questo meno reale. I fantasmi sono presenti nella vita di tutti i bambini: i miei avevano semplicemente l’abitudine di venire a cena da noi molto più spesso della maggior parte degli altri. L’ultimo litigio prima di quella mattina aveva lasciato un grosso livido nero e violetto sul braccio destro di mia madre, proprio sotto la spalla. Aveva il colore di una prugna marcia ed era così che lei lo pensava, una prugna marcia schiacciata dentro la pelle con tale rapidità e violenza che la buccia si era spaccata e la polpa era penetrata nella carne. Mia madre trovava la cosa quasi bella. Che il corpo potesse assumere tanti colori diversi la stupiva, la induceva a pensare che sotto l’epidermide non si nascondesse soltanto un insieme di sangue e tessuti. Con una mano sulla valigia aspettava che la macchina suonasse ancora. Cercava di non pensarci, ma le tornava comunque il desiderio egoistico, quasi incrollabile, di sentire esplodere anche accidentalmente, il lamento del clacson. Una sola volta ancora, pensò. Suona ancora una volta. Trattenne il respiro. Chiuse la valigia nel silenzio più assoluto. Vi premette sopra una mano e tirò metà della cerniera. Fece capolino un piccolo frammento di tessuto azzurro di un paio di pantofole imbottite, comprate due settimane prima. Lo spinse dentro con un dito, consentendo alla lampo di chiudersi e con quel gesto riconobbe che stavolta aveva vinto il marito. Aveva resistito quanto bastava per darle il tempo di completare quell’unica piccola incombenza che si frapponeva tra lei e la partenza, e nonostante tutti i suoi sforzi, era così che mia madre vedeva la cosa, lui aveva riportato una 18 vittoria e inflitto una sconfitta. Sarebbe partita. Anche se ora avesse premuto sul clacson con tutte le sue forze lei sarebbe dovuta partire, avrebbe dovuto scendere le scale e scusarsi per averci impiegato tanto tempo, perché le aveva fatto fretta, ma senza esagerare. Talvolta Mariam sospettava che mio padre fosse consapevole delle invisibili linee di demarcazione che lei tracciava costantemente. C’erano decine di linee disseminate ovunque nel loro bilocale, simili a micce che, una volta innescate, decretavano l’inizio di una nuova battaglia. C’era una linea attorno al numero di piatti che potevano essere lasciati nell’acquaio, un’altra attorno alle scarpe che si potevano indossare in casa, e altre che avevano a che fare con sguardi e contatti fisici, con il modo in cui lui entrava in una stanza, si spogliava, o la baciava sulla guancia. Una volta, dopo una notte di sonno particolarmente inquieto, sentì l’alito di suo marito sulla nuca. Era caldo e le arrivava con gli sbuffi sonori e regolari di un uomo profondamente addormentato. Non sapeva cosa odiava di più, l’uomo che respirava o i suoi respiri. Alla fine si costruì un muro di guanciali alle spalle, un muro di cui al mattino avrebbe negato l’esistenza. Le quattro grandi querce che fiancheggiavano il vialetto erano le ultime sopravvissute. La più grande e più vecchia del gruppo si ergeva solo a pochi metri dalla bifamiliare a due piani che i miei genitori condividevano con una donna anziana, fragile e gobba, gli occhi di un azzurro lattiginoso, che brontolava sottovoce ogni volta che, entrando o uscendo di casa, incrociava mia madre. Le querce rinfrescavano il soggiorno d’estate, permettendo alla luce pomeridiana di filtrare attraverso le im19 mense fronde che, secondo Mariam, tenevano fuori di proposito la luce più accecante lasciando penetrare solo i raggi più dolci e miti. Ora che era settembre e che la calura estiva più feroce era passata, mentre si apprestava a lasciare la casa, notò che le foglie più prossime alla sommità degli alberi avevano iniziato a cambiare colore e che alla base dell’albero ne era già caduto un mucchietto. Cadevano le foglie, dunque questo era l’autunno. Poche settimane prima una donna della chiesa battista le aveva detto: «Oh, aspetta che cadano le foglie. Vedrai, l’autunno ti piacerà tantissimo». Si chiamava Agnes e portava una parrucca di riccioli neri per nascondere le chiazze calve sulla testa. Mariam scrisse a-g-n-e-s dietro l’opuscolo della chiesa che si dilungava sui minimi particolari dell’agonia di Cristo, il che, dopo il loro primo incontro, l’aveva indotta ad aggiungere a-g-o-n-y e accanto Agnes is in agony, una frase semplice, con un soggetto e un verbo che formavano una proposizione enunciativa, che aveva, a giudizio di Mariam, molte più possibilità di essere vera che falsa. A quel tempo mia madre aveva pensato: “Non potrei mai amare qualcosa in cui si verifica una ‘caduta’”. C’era caduta e “caduta”. Cadere era crollare, sprofondare. Quando mia madre aveva dieci anni, suo nonno era uscito dalla camera da letto sul retro della casa con addosso soltanto una vestaglia aperta. Era sordo e mezzo cieco da sempre, per quanto lei ricordava; arrivato in mezzo al soggiorno, circondato dai suoi familiari, era caduto, non sulle ginocchia, ma in avanti, come un albero abbattuto, la tempia squarciata sul bordo della mensola del caminetto, spruzzando di sangue la parete e il divano. Era così che si poteva cadere. 20 Si poteva anche cadere da una rampa di scale, come nella frase: «Una mattina tuo marito è caduto dalle scale mentre usciva per andare al lavoro». Le veniva questo pensiero almeno una, ma spesso anche tre volte alla settimana. Se lo figurava che inciampava e cadeva a gambe all’aria, come i personaggi dei cartoni animati, la sua droga tra l’una e le quattro del pomeriggio. In quei filmati tutti i personaggi si riprendevano dalla caduta in pochi secondi, rimettendo a posto un braccio qui e raddrizzando una caviglia là. I cartoni animati la facevano ridere e le tornavano in mente quando pensava al marito che cadeva dai gradini, il corpo alto e magro, perfettamente adatto a rotolare giù dalle scale coperte da una passatoia consunta, magari fermandosi per un attimo sulla curva prima della rampa finale. Quando i corpi reali cadevano, Mariam lo sapeva benissimo, non si rialzavano. Non rimbalzavano in piedi riprendendo la loro forma. Si accartocciavano e dovevano essere soccorsi. Nonostante mia madre si sforzasse in ogni modo di resistere alla caduta autunnale, si sentiva sempre più catturata dalla nuova stagione. Il sole tramontava prima, e ben presto si rese conto che al giorno veniva sottratta un’intera ora di luce, cosa che talvolta desiderava fosse ripetuta finché del vecchio giorno non fosse rimasta che una versione in miniatura. Le notti si facevano leggermente ma sensibilmente più fresche. Le foglie cambiavano colore e i bambini, che durante l’estate avevano tiranneggiato il quartiere, erano di nuovo ordinati in gruppi di due o tre, costretti ogni mattina (almeno così pensava Mariam) a sottomettersi dalle regole della stagione che cambiava. Nel giorno che andava accorciandosi c’era ancora spazio per credere che il mondo non 21 fosse del tutto insensibile al dolore e alla nostalgia, e che reagisse come aveva fatto lei quando si era convinta che il tempo fosse stato regolato in modo sbagliato, rendendo la perdita quotidiana di un altro minuto un conforto gradito. Mia madre non avrebbe mai potuto dire che amava l’autunno, ma mentre scendeva i gradini con la valigia in mano, avvicinandosi alla Monte Carlo rossa dove suo marito l’aspettava da quasi un’ora, avrebbe potuto dire di rispettare il ruolo di mediazione che la stagione svolgeva tra due estremi. L’autunno arrivava e se ne andava, l’inverno era tollerato mentre l’estate era riverita. L’autunno era il riposo che rendeva entrambi possibili e sopportabili, e ora eccola accanto al marito, che si immergeva in un pomeriggio di primo autunno con solo un’idea vaghissima di chi stessero per diventare e di cosa sarebbe successo dopo. 22 2 Sei mesi prima che lasciassi mia moglie Angela e che ricostruissi la rotta dei miei genitori attraverso il Midwest, mio padre passò a miglior vita nell’ospizio dove aveva vissuto negli ultimi dieci anni. Allora avevo disinvoltamente messo la sua morte nell’angolo privato in cui per moltissimo tempo avevo sepolto tutto ciò che consideravo troppo inquietante – una categoria in costante crescita e che a quel punto comprendeva anche torti irrilevanti, come insulti e sguardi malevoli da parte di estranei. Erano passati tre anni da quando avevo parlato a mio padre per l’ultima volta e molti di più da quando avevamo smesso di incontrarci regolarmente, un fatto che avevo tenuto a comunicare ad Angela quando mi aveva chiesto, diversi giorni dopo aver ricevuto la notizia della sua morte, perché mi comportavo come se la cosa non mi avesse minimamente toccato. «Ci risiamo, Jonas» aveva detto. «Tiri avanti come se nulla fosse successo. Non sopporto quando fai così.» Ricordo che quella conversazione ebbe luogo un sabato pomeriggio mentre eravamo seduti sull’elegante divano verde sbiadito del soggiorno che fungeva anche da sala da pranzo. Era verso la fine di luglio e mi appre23 stavo a lavorare al programma di letteratura inglese per gli studenti del primo anno di una scuola privata dell’Upper West Side di Manhattan, dove allora insegnavo. Angela indossava un vestito azzurro e, come faceva da qualche tempo, aveva raccolto le spesse trecce nere in una crocchia che le dava un’aria seria e solenne poco adatta a lei, come se, con i suoi enormi occhi neri da cerbiatto e le gote leggermente paffute, stesse recitando il ruolo di un avvocato molto impegnato, che lavorava anche il fine settimana, per una produzione provinciale in cui lei era la star. «In realtà non siamo mai stati molto vicini» le avevo detto «e poi me l’aspettavo. Che altro vuoi che ti dica?» A quel tempo molte delle conversazioni con Angela finivano per ricalcare le stesse linee difensive. Eravamo sposati da tre anni, ma negli ultimi sei mesi quasi non ci eravamo rivolti la parola se non per attaccarci con reciproca cattiveria. Era normale che Angela mi accusasse di non provare nessun sentimento, così come era normale che passasse parecchio tempo, di giorno e di notte, lontano da me e dall’appartamentino nel seminterrato che condividevamo. Era avvocato in uno studio legale di medie dimensioni nel centro di Manhattan, i cui clienti, proprietari di aziende di second’ordine, non avevano la disponibilità finanziaria per avvalersi di uno dei prestigiosi studi legali che occupavano i piani alti del grattacielo dove lavorava. Odiava quello che faceva e la maggior parte delle persone con cui lavorava, ma era molto orgogliosa del posto che occupava, essendo cresciuta povera e sradicata in una dozzina di città del Sud e del Midwest, dal Tennessee al Missouri all’estremo Nord dell’Ohio. Una volta mi raccontò che ancora ricordava la sensazione 24 provata la prima volta che si era guardata nello specchio e aveva detto a se stessa che era un avvocato. «Era strano. L’ho dovuto ripetere tre volte prima di poterci credere veramente.» Era stata lei a trovarmi il posto d’insegnante attraverso uno dei soci del suo studio. Prima lavoravo a Manhattan nel un centro di assistenza per rifugiati dove Angela e io ci eravamo conosciuti. Il centro era vicino all’incrocio di Canal Street con la Bowery e godeva di una vista dal quinto piano sull’East River e sui ponti di Manhattan e Brooklyn. Ai clienti piaceva fermarsi per parecchi minuti davanti alle finestre prima del colloquio con uno degli avvocati, come se sapessero già che, con le leggi e l’indirizzo politico del momento, avrebbe potuto essere la loro unica occasione per godersi un tale panorama. Era il sesto lavoro che cambiavo in due anni, cosa che faceva parte della sfilza di cambiamenti che comprendevano nuovi appartamenti, sempre più piccoli, da condividere con estranei i quali, per tutto il tempo della nostra vita in comune, rimanevano perfetti sconosciuti, come il giorno in cui ci eravamo incontrati. Avevo avuto un paio di lavori semifissi, ma nessuno che potesse rappresentare o preparare a una carriera. Finita l’università, avevo vagamente pensato di conseguire un dottorato in letteratura inglese, specializzato in poesia moderna americana, cosa che dicevo alle conoscenze occasionali o alle ragazze per impressionarle su ciò che facevo a New York, anche se per lo più non facevo assolutamente niente. Una decina d’anni dopo essermi laureato, però, non avevo ancora fatto nessun serio tentativo in quella direzione se non richiedere ogni anno il catalogo delle cinque o sei università che – così affermavo – sognavo 25 di frequentare. Avevo fatto il cameriere in due caffè, piccoli ma alla moda, in belle strade fiancheggiate da alberi nelle vicinanze del West Village, tutti e due fieri delle loro marmellate e del loro pane fatti in casa e delle verdure di produzione locale, i cui prezzi riflettevano quanto i frequentatori erano disposti a pagare per quei prodotti. I nostri clienti erano per lo più ricchi, a volte anche famosi, ma non venivano adocchiati con particolare curiosità. Per servire in fretta un caffè o dei bagel caldi con marmellata mi pagavano il doppio di quanto guadagnavo in mance e un paio di volte mi erano stati offerti consigli finanziari non richiesti e non necessari, tale era l’aria vagamente surreale in cui erano immersi quei locali. A parte i miei molteplici impieghi come cameriere, avevo lavorato temporaneamente anche in modeste società di mediazione che occupavano meno di un quarto di piano in uno squallido e fatiscente edificio su una strada anonima del centro. Almeno una aveva elaborato un sofisticato piano di evasione fiscale per i ricconi ormai finiti della città, le altre erano solo attività imprenditoriali appena avviate che faticavano ad affermarsi, ancora troppo povere per assumere a tempo pieno più di una manciata d’impiegati, e che, nella disperata ricerca di clienti, o avventori, spesso mi sembravano poco più di chioschi di bibite intorno ai quali sedeva una dozzina di uomini e donne in attesa che squillasse il telefono. I miei unici compiti, indipendentemente dall’attività della compagnia e dal suo successo, erano: parlare poco, mangiare in fretta e registrare diverse centinaia di numeri l’ora, tutte cose che facevo sempre bene e per le quali in due occasioni, almeno per qualche tempo, ero stato molto apprezzato. 26 Senza rendermene conto, ero diventato uno di quegli uomini che passano sempre più sere da soli, né disperati né depressi, semplicemente estranei alle trame sociali in cui gli altri sono coinvolti. Finita l’intimità forzata dell’infanzia, scoprii di avere problemi a stare con gli altri. I pochi amici che mi ero fatto all’università alla fine avevano tutti trovato la loro strada senza di me. Senza bisogno di andarsene si erano costruiti una vita migliore nella stessa città, dove si scambiavano con disinvoltura aperitivi e regali di compleanno, ma anche sesso e intimità. Angela e io diventammo amici poco dopo che avevamo iniziato a lavorare al centro per immigrati. Lei era una dei tanti volontari, tirocinanti estivi e impiegati temporanei che annualmente transitavano per gli uffici. A differenza degli altri che arrivavano e se ne andavano senza che neppure sapessi come si chiamavano di cognome, Angela e io trovammo subito degli interessi comuni. Eravamo i soli neri che lavoravano al centro – tutte le altre persone di colore presenti in ufficio erano con ogni probabilità clienti pregressi, attuali o futuri – un fatto di cui Angela mi chiese ragione pochi giorni dopo aver preso servizio. «È una cosa che ti disturba, visto che questo è il tuo lavoro a tempo pieno?» «Non ci penso quasi mai» le dissi. «E a te?» «No» rispose. «Ma a volte mi chiedo se non dovrebbe.» Da quel momento scoprimmo che avevamo altri obblighi sociali e razziali di cui avremmo potuto preoccuparci se ne avessimo avuto voglia. «E a proposito degli africani che vengono al centro,» 27 mi chiese alcuni giorni dopo «ti piacciono più o meno degli altri? Sii sincero.» «Dipende» dissi. «Da cosa?» «Da che parte dell’Africa vengono. Se vengono dalla costa occidentale, allora, per essere sincero, non me ne frega granché. La costa orientale, invece, è un’altra storia.» «Allora qui c’è un problema» disse. «Essendo di discendenza afroamericana e…» «Capisco dove vuoi arrivare. Lealtà…» «Alla costa occidentale, sempre» disse. Incominciammo a pranzare insieme a Chinatown quasi ogni giorno. Era stata Angela a proporlo anche se sosteneva di non sopportare la vista delle anatre appese per il collo nelle vetrine dei ristoranti che sarebbero state arrostite. «Sono in parte vegetariana» disse. «Il che è un po’ come dire che sono in parte bianca, perché mio nonno era irlandese. In realtà non conta e nessuno tranne me ci crede veramente.» Dopo aver condiviso diverse ciotole di spaghetti, incominciammo a spartirci i clienti a seconda che fossero originari della costa orientale o di quella occidentale. Separammo per primi gli africani, perché era più facile. Benin, Togo, tutta la costa occidentale giù sino alla Namibia, e persino ampie porzioni di Africa settentrionale e centrale, dal Congo a occidente, andarono ad Angela, il che era perfetto, dissi, perché io avevo la Somalia, «e con questi non c’è troppo da scherzare». Finito con l’Africa passammo all’Asia meridionale, che dividemmo a metà con un taglio netto, cosa completamente inutile dal 28 momento che, tanto per cominciare, tutti i nostri clienti originari di quella regione erano pachistani. L’America centrale venne poi suddivisa a seconda della vicinanza di ciascuno stato al Golfo del Messico, e poi restavano le piccole sacche del mondo che sistemammo caso per caso. Un uomo delle Figi andò ad Angela perché sosteneva che assomigliasse a un suo zio che viveva a Boston; io mi presi un’intera famiglia del Turkmenistan, perché il loro cognome quasi faceva rima con il mio. Quando, più o meno una settimana dopo, terminammo la nostra suddivisione Angela possedeva il suo immaginario equipaggio occidentale e io il mio orientale. Se a qualcuno della mia sponda veniva concesso un colloquio per la richiesta di asilo politico era una vittoria per tutta la mia squadra. Bastava che le dicessi «costa orientale» e capiva cosa volevo dire. Angela faceva la stessa cosa, non solo con me, ma anche con gli altri avvocati e tirocinanti del centro, che la fissavano allibiti quando diceva con un sorriso: «Nuova vittoria della costa occidentale». In ufficio nessuno, tranne noi, parlava così. Quando l’argomento della conversazione erano i nostri clienti, il tono generale era di compassione, rafforzata da affermazioni apparentemente sincere e sentite come: «Non posso credere che abbiano dovuto vederne tante». Angela non avrebbe mai parlato così, e questa era una delle ragioni per cui l’ammiravo. A differenza di quasi tutti gli impiegati e volontari del centro lei era felice del proprio lavoro. «I rifugiati?» diceva. «Com’è possibile non amarli? Tra le persone che conosci chi se la passa peggio?» Durante i dodici mesi in cui avevo lavorato al centro prima che arrivasse lei, una decina di volontari e di avvocati erano venuti e se ne erano andati; quasi tutti 29 disertavano per ragioni personali o familiari come avrebbero poi spiegato in e-mail collettive, mentre la verità era nota a chi passava almeno un breve periodo della sua vita al centro. Venivamo sempre sconfitti, se non ogni giorno certamente ogni settimana: i clienti sparivano all’improvviso, molti di quelli che rimanevano erano destinati al rimpatrio, e noi eravamo impotenti con gli uni e con gli altri. Un giorno un honduregno fuggiva, un altro una famiglia di quattro liberiani, la cui domanda di asilo doveva essere riesaminata, svaniva in un angolo del Bronx. Come tutti coloro che si rivolgevano a noi, sapevano che le possibilità di farcela erano scarse, nonostante le rassicurazioni dei quattro avvocati che lavoravano a tempo pieno. Un pronostico più che favorevole non era mai sufficiente – soltanto la sicurezza assoluta avrebbe potuto permettere che coloro che avevano rischiato la vita o avevano perso i loro beni per arrivare qui se ne stessero seduti tranquilli mentre qualcun altro decideva del loro destino. Angela era la sola persona, oltre a Bill – l’avvocato anziano e direttore del centro, un uomo calvo che invecchiava rapidamente – che sapeva come temperare la delusione della sconfitta con una visione oggettiva della realtà. Bill spesso scherzava dicendo che la vera ragione dell’esistenza del centro era offrire alla gente il tempo sufficiente per imparare il funzionamento del sistema prima di sparire. «E quei bastardi» diceva «non ci ringraziano neppure.» La maggior parte delle vittorie che potevamo vantare erano scontate; ogni mese Bill sceglieva alcuni casi il cui esito poteva quasi sempre essere previsto – l’ex medico 30 o avvocato cubano, il dissidente politico cinese, o le recenti vittime di una guerra africana particolarmente feroce che aveva brevemente occupato i titoli dei giornali e aveva attirato l’attenzione di un senatore o di un membro del Congresso. In genere sapevamo di poter contare su costoro per stendere un convincente rapporto di fine anno nel quale registravamo vittorie e sconfitte prima di manipolare l’esito finale per essere sicuri che il bilancio fosse positivo. 31
Scaricare