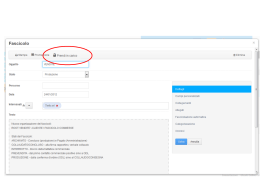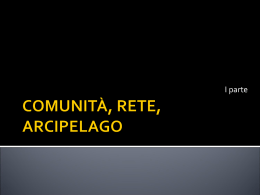Poste Italiane S.p.A. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n.46, art.1, comma 1, AUT. CNS/CBPA/CENTRO1 val. dal 13/10/06 Kenya: giochi pericolosi ANNO XIX / n. 01 gennaio 2008 / € 4,00 06 Vinicio Albanesi: il welfare del 2008 15 Bangladesh: piove sul bagnato 22 Immigrazione: quei morti alle porte dell’Europa SSIER O D 1 3 ce, la pa tica, li la po iazione d la me solidarietà internazionale anno xIX / n. 01 gennaio 2008 / € 4,00 foto di copertina: Kenya, Nairobi (17 gennaio 2008). ©Reuters/Noor Khamis Rivista mensile del CIPSI Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale Dir., Amm. e Segr. di Redazione: Via Colossi, 53 - 00146 Roma Tel. 06.54.15.730 Fax 06.59.60.05.33 Email [email protected] Web www.soint.it Abbonamenti: individuale € 20; estero € 30 Email [email protected] Direttore Responsabile: Guido Barbera Direttore: Eugenio Melandri Gruppo di lavoro redazionale: Nicola Perrone (caporedattore), Francesca Giovannetti (segreteria di redazione), Paola Bizzarri, Patrizia Caiffa, Cristiano Colombi, Tiziana Miglino, Francesca Quartieri, Stefano Trasatti, Graziano Zoni. Collaboratori: Vinicio Albanesi, Gianni Caligaris, Giancarla Codrignani, Mirta Da Pra Pocchiesa, Giuseppe Florio, Andrea Folloni (ricerca fotografica), Tonio Dell’Olio, Giulio Marcon, Giuliana Martirani, Antonio Nanni, Niccolò Rinaldi, Michele Sorice, Valeria Viola, Michele Zanzucchi. Progetto grafico/impaginazione: sezioneaurea.com Foto: Cipsi, Ag. Fot. Contrasto, Corbis, Reuters Pictures. Stampa: 21/01/2008 presso la tipografia Litograf s.r.l., Zona Industriale Pian di Porto, Loc. Bodoglie 148/7/T/1, 06059 Todi (PG) Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 347 dell’08/06/1988 Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa n. 11977 del 28/02/2001. IVA assolta dall’editore art. 74 comma 1 lett. c DPR 633/72. Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 21/03/2007 n.46) art.1, comma 1 AUT. CNS/CBPA/CENTRO1 valida dal 13/10/2006. Organismi associati: A.I.S. SEGUIMI Associazione di Iniziative Sociali, Roma, Tel. 06.6277806 AMISTRADA Rete di Amicizia con le Ragazze e i Ragazzi di Strada Onlus, Roma, Tel. 06.55285543 A.M.U. Associazione per un Mondo Unito, onlus Rocca di Papa (Roma), Tel. 06.94792170 Associazione Onlus Funima International, Sant’ Elpidio a Mare (AP), Tel. 0734.858840 Ass. BAMBINI VITTIME (ADERENTE), Genova, tel. 010.2518277 C.C.M. Comitato di Collaborazione Medica, Torino, Tel. 011.6602793 CE.SVI.TE.M. Centro Sviluppo Terzo Mondo - onlus Mirano (VE), Tel. 041.5700843 CE.V.I. Centro di Volontariato Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo - Onlus, Udine, Tel. 0432.548886 C.I.A.I. Centro italiano aiuti all’infanzia Onlus, Milano, Tel. 02.540041 C.I.C.a. Comunità Internazionale di Capodarco, Roma, Tel. 06.7180570 D.P.U. Associazione dalla Parte degli Ultimi, Campobasso, Tel. 0874.698571 FDU Fratelli dell’Uomo Onlus, Milano, Tel. 02.69900210 FERRARA TERZO MONDO Associazione Gruppo Ferrara Terzo Mondo Onlus, Ferrara, Tel. 0532.205472 GRUPPO MISSIONI ASMARA Gruppo Missioni Asmara Onlus, Montagnana (PD), Tel. 0429.800830 INCONTRO FRA I POPOLI Incontro fra i Popoli Onlus, Cittadella (PD), Tel. 049.5975338 ISI, I SANT’INNOCENTI Onlus, Reggio Emilia, Tel. 0522.408795 MANO AMICA Mano Amica Onlus, Camposampiero (PD), Tel. 049.5790798 NAAA Infanzia. Cooperazione. Sviluppo. Ciriè (TO), Tel. 011.9222178 N.A.D.I.A. ONLUS Nuova Associazione di genitori insieme per l’adozione, Verona, Tel. 045.8403328 PROGETTO CONTINENTI Progetto Continenti Onlus, Roma, Tel. 06.59600319 SOLIDARMONDO Associazione per La Cooperazione Internazionale, Roma, Tel. 06.6147047 S.O.S. MISSIONARIO S. Benedetto del Tronto (AP), Tel. 0735.585037 U.P.D. Una Proposta Diversa Onlus, Cittadella (PD), Tel. 049.9400748 Cel. 338.4981981 VISES Volontari Iniziative di Sviluppo Economico e Sociale Roma, Tel. 06.44070272 VOGLIO VIVERE Membro Unione Internazionale Raoul Follereau Onlus, Biella, Tel. 015.352777. Rete amici: Gruppo “Amici degli Ultimi del Mondo”, Paternò (CT), tel. 095.846009 Casa Famiglia Rosetta Associazione “Casa Famiglia Rosetta” Caltanissetta, Tel. 0934.508311 Chiama l’Africa Roma, Tel. 06.5414894 C.I.N.S. Cooperazione Italiana Nord Sud, Roma, Tel. 06.3202373 Cooperativa sociale Polo Oasi Roccabascerana (AV), Tel/fax 0825/993520 Di tutti i colori S. Maria di Occhiobello (Rovigo), Tel. 340.0589269 Eco Himal Varese, Tel. 0332.227245 Emmaus Italia Firenze, Tel. 055.6503458 Fondazione Brownsea Milano, Tel. 02 58.314760 Geologi nel Mondo Vergato (Bo), Tel. 329.7766699 GSI Italia Perugia, Tel. 0743.49987 L’Africa chiama, Fano (PU) Tel/Fax 0721.865159 Movimento Apostolico Ciechi Roma, Tel. 06.6861977 Ass. Inter. “Noi Ragazzi del Mondo” AINRAM, Roma, tel. 06.71289053 Nuovi Segni Torino, Tel. 011.8121426 O.S. Operazione Sviluppo, Roma Tel. 06.36001480 Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi Onlus San Giorgio del Sannio (BN), Tel./ fax 0824.58027 S.A.L. Solidarietà con l’America Latina Onlus Roma, Tel. 06.87248124 S.P.S. Solidarietà Pace e Sviluppo Aosta, Tel. 0165.42427. Gli articoli possono essere riprodotti citando la fonte; riflettono le opinioni degli autori e non rappresentano necessariamente il punto di vista dell’editore. Questa rivista è stampata su carta Fedrigoni Freelife Cento ecologica certificata ECOLABEL e FSC. Questa rivista è stata realizzata anche con il contributo della direzione generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri - progetto: “Rivista solidarietà internazionale: iniziative per favorire la conoscenza dei problemi e delle attività di solidarietà e cooperazione del sud e del nord del mondo nei luoghi/simbolo più significativi - AID 8561”. sommario senza firma 17 Il Tigri sbarrato di L. Manes 01 Il campo della speranza 18 La Malesia compie i 50 rubriche 20 Sempre in movimento di G. Caligaris agnelli e lupi 22 Quei morti alle porte dell’Europa di E. Asciutti 02 Pagine di diario 04 La casa mediterranea di P. Bizzarri di G. Del Grande di T. Dell’Olio le facce della luna 04 Benazir e il potere di G. Codrignani parole per dire 05 Miraggio Europa di C. A. Dioma la città conviviale 05 Le migrazioni fanno bene all’economia di A. Nanni l’opinione 06 Il welfare del 2008 di V. Albanesi 24 La via dolorosa di N. Rinaldi 26 La sovranità pubblica di R. Petrella 28 Quando il dissenso è reato di F. Giovannetti e N. Perrone dossier 31 La pace, la politica, la mediazione XXI secolo 30 Partecipazione: il potere diffuso di G. Barbera storie musulmane 44 Taip, l’agricoltore di M. Zanzucchi copertina 07 Kenya: giochi pericolosi di R. Kizito Sesana cose 11 Esisto, quindi ho diritto di esistere di G. Zoni 13 Il coraggio di cambiare di C. Colombi 15 Piove sul bagnato di P. Caiffa 32 Alex Zanotelli: il mondo della pace sta a guardare 33 Lidia Menapace: così si fa cadere il governo 34 Enrico Peyretti: l’autocritica paziente della non-violenza 34 Lorenzo Scaramellini: non sono d’accordo 36 Renzo Craighero: una indignazione motivata 36 Angelo Gandolfi: se questa è sinistra 38 Gianni Alioti: perché sono d’accordo con Alex intervista 39 Incontri: Emilio Molinari Ci restano cinquant’anni a cura di E. Melandri bacheca 42 La bacheca a cura di T. Miglino senza firma | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | Il campo della speranza N on nasce sotto i migliori auspici questo 2008. Ai problemi di sempre - quelli strutturali di un mondo che vede sempre più esaurirsi le risorse e che domanda un’inversione totale di tendenza - si aggiungono questioni nuove. Nel nostro paese l’emergenza dei rifiuti a Napoli ci regala lo spaccato non soltanto dell’inefficienza della politica e della pubblica amministrazione, ma anche di un mondo che rischia di diventare un’enorme discarica a cielo aperto. Per accogliere i rifiuti di una società che si basa sul consumo ad ogni costo. Il petrolio vola a prezzi spaventosi e ci dice che stiamo raschiando il fondo del barile. L’acqua diventa un bene sempre più raro e ricercato. Per ottenerla si fanno dighe e si deviano fiumi, con conseguenze sociali che neanche riusciamo ad immaginare. I paesi che possiedono le sorgenti cercano di tenere tutta l’acqua per i loro consumi, preparando conflitti con i paesi che stanno a valle. Le falde acquifere sono sempre più inquinate, mentre ogni giorno, alle foci del Rio delle Amazzoni, petroliere cinesi fanno il pieno di acqua da portare in Cina. Intanto il clima sociale si sta avvelenando. Gli scontri tra diversi integralismi stanno diventando normali, non soltanto a grandi livelli, ma anche ai livelli minimi, nelle relazioni quotidiane. Ci si parla e ci si intende solo con quelli della propria parrocchia, del proprio gruppo sociale, della propria idea religiosa o politica. Gli altri sono avversari da combattere. La vicenda di Papa Benedetto XVI alla Sapienza è in proposito molto significativa. La competizione, come motore della crescita, non solo economica, sta dando i suoi frutti. Siamo tutti in competizione. Per essere i primi, per avere di più, per accaparrarci quel po’ di risorse che restano, per salvaguardare le conquiste raggiunte. Sparisce la solidarietà come pratica della convivenza e ci si rifugia in forme di solidarietà corporative in cui si cerca di difendere solo i propri interessi, anche se a scapito degli altri. Aumentano in progressione geometrica gli squilibri sociali. Tutto in nome delle leggi di mercato che tendono a quantizzare ogni cosa, senza tener conto dei diritti fondamentali delle persone. Mentre un gruppo sempre più consistente di persone non sa come spendere i soldi, a Roma, la notte del primo gennaio due persone muoiono di freddo. Nel disinteresse generale. E non è possibile, di fronte all’aumento dei fenomeni di esclusione sociale ed economica, fare appello all’assistenza. Occorrono soluzioni politiche strutturali. Siamo in pieno dentro a quello che Bush e i suoi adepti chiamano capitalismo compassionevole. Dove i più deboli devono accontentarsi delle briciole che cascano dal tavolo dei ricchi assisi al banchetto. Quest’anno ricorrono due anniversari importanti: 60 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana che disegna uno Stato, fondato sul lavoro, solidale e attento ai diritti di tutti. E 60 anni dalla proclamazione della carta universale dei diritti umani. Ratificata e sbandierata ad ogni piè sospinto, ma non praticata fin nei suoi aspetti più materiali, come il diritto a vivere e ad esistere. È tempo di rimboccarsi le maniche. Il 2008 che è appena cominciato lancia una sfida alla nostra capacità non solo di agire, ma anche di sperare. “La speranza - scrive Roger Garaudy – è la decisione militante di vivere con la certezza che non abbiamo esaurito tutti i possibili fino a quando non tentiamo l’impossibile”. All’inizio di un nuovo anno dobbiamo avere il coraggio di “decidere” di sperare. Durante l’esilio a Babilonia, quando Gerusalemme era disabitata e distrutta, Dio chiamò Geremia e gli ordinò di comprare un campo nella città santa. Dal punto di vista economico, un cattivissimo investimento. Geremia comprò quel campo che diventò il segno concreto della speranza che un giorno il popolo in esilio avrebbe smesso di appendere le cetre ai salici piangenti e avrebbe potuto tornare a cantare nella città. A Sion. All’inizio di questo nuovo anno, forse è chiesto anche e noi di comprare un campo nella desolazione di questo deserto, sapendo che domani anche il deserto, se ce la mettiamo tutta e se non smettiamo di sperare, potrà rifiorire. Auguri | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | pagine di diario Gianni Caligaris ©ALBERTO CRISTOFARI/A3/CONTRASTO Morti sul lavoro I l mio bisnonno era un operaio piemontese, della provincia di Vercelli, compaesano e forse parente di quel Caligaris che passò alla storia come terzino della Juve e della Nazionale (Combi, Rosetta, Caligaris). Verso fine ‘800 fu “inviato”, con una cinquantina di coetanei, tutti celibi, a Terni, dove nel 1884 furono aperte “Le Acciaierie”. Morì giovane lasciando una vedova e tre figli fra cui mio nonno, il maggiore, che andò apprendista (gratis) a quattordici anni alle Acciaierie per imparare il mestiere. Era bravo, diventò operaio specializzato, passò alla Fabbrica d’Armi (lo so, non è carino, ma erano altri tempi) diventò capo operaio, poi capo armaiolo. Ho ancora un suo compasso da metallo con inciso il suo nome. Mantenne i fratelli finché non si resero autonomi, dopo la Grande Guerra mise su famiglia, ebbe due figli che fece studiare, assicurò ai suoi una vita decorosa, mia nonna non ebbe bisogno di andare a 2 lavorare. E voi direte: cosa ci interessa della tua saga familiare? Ne parlo perché oggi “Le Acciaierie” sono della ThyssenKrupp, quella dei morti di Torino. All’epoca dei miei avi la fabbrica non era un bel posto. Ci si moriva e ci si storpiava sicuramente più e peggio di adesso. Ma era un luogo di promozione sociale. Semi analfabeti che abbandonavano il bracciantato a giornata o la vita di espedienti per una professionalità. E intorno alla fabbrica nasceva la socialità. Nei quartieri operai si rigenerava la solidarietà interfamiliare tipica delle comunità rurali. Sorgevano le prime cooperative di mutualità o di consumo fra operai (mio nonno fu tra i fondatori di una di esse, che garantì cibo a credito alle famiglie degli operai durante gli scioperi dei primi anni del ‘900). Nasceva una coscienza di classe, che sarà poi una delle spine dorsali dell’antifascismo prima, delle lotte operaie dopo. La fabbrica era un luogo durissimo, ma al minimo dava da vivere, al suo meglio era un trampolino di mobilità sociale: mio nonno passò da proletario a piccolo borghese. E oggi? Oggi la fabbrica è un ghetto, come si legge nello straziante servizio di Ezio Mauro apparso su La Repubblica nei giorni in cui sto scrivendo. Un agghiacciante racconto di un sopravvissuto che alterna le immagini da Armageddon del disastro, allucinanti flash-back dei corpi ustionati e scarnificati, con considerazioni di bassa quotidianità ed alta sociologia (o viceversa?): in discoteca è meglio se dici che fai il rappresentante. La classe operaia non è mai andata in paradiso, meno che mai sembra possa andarci adesso, invisibile, riserva indiana, minoranza indispensabile ma oscena (ob scenam, ciò che non può essere mostrato). E ieri Epifani ha detto che il sindacato deve tornare in fabbrica? Welcome in the real world, Neo (“Benvenuto nel mondo reale, Neo”, da Matrix). solidarietà internazionale 01/2008 Bush: bombardare! A un certo punto Bush si è soffermato davanti a una cartina aerea di Auschwitz e, rivoltosi a Condoleezza Rice, le ha chiesto perché gli americani non bombardarono il campo di concentramento nazista. Gli americani, ha spiegato la Rice, non pensavano che ciò avrebbe fermato lo sterminio degli ebrei. Bush si è fermato a pensare, e poi ha detto: “Avremmo dovuto bombardarlo”. L’interessante scambio è accaduto i giorni scorsi a Gerusalemme, al Museo della Shoa. A parte l’approssimazione della risposta di Condi, le poche battute fanno capire una volta per tutte l’individuo. Lui risolve bombardando, lui avrebbe bombardato. A costo di ammazzare Primo Levi o Eli Wiesel, che da Auschwitz sopravvissero, a costo di far fuori cento internati per ogni SS o kapò. Bombe al fosforo, come quelle usate su Colonia, al posto dei forni crematori, cosa importa come bruci? La bomba igiene del mondo, come in Iraq, come in Afghanistan. Primo Levi sarebbe potuto essere una danno collaterale, ci stiamo abituando. La filosofia della “tabula rasa”: pialliamo il mondo per renderlo levigato, condoglianze agli innocenti che diventano trucioli. | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | ©REUTERS/Jeff Mitchell US solidarietà internazionale 01/2008 famiglia, di mettere al mondo dei figli e di vederli crescere, di invecchiare fra l’affetto dei propri cari, ad una questione di “eros e sesso”. Mi colpisce anche l’affermazione apodittica sull’amore della “gente”. Significa che i pastori protestanti non sono amati dalle loro comunità? Mi sconcerta anche l’evidente distacco dalla realtà. Perché Sua Eminenza, che probabilmente non bazzica parrocchie da tempo, non promuove un sondaggio tra i cattolici praticanti per sapere cosa ne pensano, soprattutto nelle fasce di età meno anziane, quelle che costituiscono il futuro della Chiesa? Forse avrebbe qualche sorpresa. Il sacerdozio dei preti G razie al cardinale Etchegaray, preceduto qualche mese fa dal collega Hummes, si sta riaprendo il dibattito sul sacerdozio dei presbiteri all’interno della Chiesa Cattolica Romana (visto che in quella Cattolica di Rito Orientale il problema non esiste). Io spero che si sviluppi ed anche velocemente. Nel farlo registro con dispiacere il commento di un alto prelato, membro dell’Opus Dei, intellettuale e giurista: “Certo, una cosa sono i dogmi e un’altra le leggi. Le norme possono anche essere modificate, ma ciò non significa che sia opportuno o conveniente farlo. L’abolizione del celibato impoverirebbe tremendamente la vita della Chiesa. La gente ama di più un sacerdote che ha fatto della sua vita una donazione completa. Il mondo non è tutto eros e sesso”. Mi impressiona il fatto che un porporato di indubbia esperienza e, data l’età, di auspicabile saggezza, riduca la tensione verso un amore corrisposto e verso la possibilità di creare una ©STEFANO G. PAVESI/CONTRASTO I bambini immigrati hanno diritto alla scuola “P er difendere le categorie più deboli bisogna combattere l’immigrazione irregolare e clandestina, che non paga le tasse e che può finire per essere contigua alla microcriminalità. Ma non è certo escludendo i figli degli immigrati dalle scuole che si riuscirà in questa battaglia. Al contrario, si rischia solo di fomentare la marginalità e la criminalità. Per combattere in modo efficace l’immigrazione clandestina c’è solo una strada da percorrere: intensificare i controlli sui posti di lavoro, dove gli immigrati irregolari si recano tutti i giorni. Perché allora i sindaci, che dicono di voler combattere la piaga dell’immigrazione illegale, non rivolgono le loro attenzioni agli ispettorati del lavoro, spingendoli a intensificare i controlli sui posti di lavoro nel loro comune, perché non chiedono ai loro concittadini di aiutarli nel segnalare il lavoro irregolare degli immigrati? (…) Un sospetto ce l’abbiamo: forse tra i loro grandi elettori ci sono anche coloro che assumono illegalmente manodopera immigrata e vogliono pochi controlli sui posti di lavoro per non pagare i contributi sociali e tenere basso il costo del lavoro. C’è solo un modo per convincerci del contrario: ci dimostrino coi fatti che non è vero.” Così Tito Boeri su “La Stampa”. Nello stesso articolo ricorda che mentre tutta l’Europa si sforza per mandare a scuola i figli degli immigrati, come punto essenziale delle politiche di integrazione e di inclusione, l’Italia si appresta a diventare il primo paese che va in direzione contraria. Per fortuna le reazioni dello Stato sembrano essere all’altezza; su direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione è stato intimato al comune di Milano di ripristinare le regole sull’iscrizione alle scuole dell’infanzia dei bimbi extracomunitari. In caso contrario, l’Ufficio scolastico regionale sospenderà la parità concessa e l’erogazione di ogni contributo statale. Il ministro Fioroni ha ricordato che “il diritto all’istruzione è uno dei diritti fondamentali dell’uomo. Impedirne la fruizione significa ledere la dignità della persona umana. Non possono esistere deroghe a questa fruizione né per le colpe dei padri né per lo stato di povertà. L’intero assetto legislativo, fino a oggi e a prescindere dai colori politici dei governi, non ha mai messo in discussione il fatto che un bambino che vive sul nostro territorio abbia diritto a essere istruito e curato e questo indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche della famiglia”. Finalmente uno scatto d’orgoglio in una stagione politica bigia ed intristita, in cui pare che non esistano più punti fermi, in cui tutto è negoziabile, in cui le identità sfumano come i contorni dei filari al crepuscolo, come il profilo dei monti quando sale la bruma. Il Carnevale “V iene Febbraio, e il mondo è a capo chino, ma nei convitti e in piazza lascia i dolori e vesti da Arlecchino, il Carnevale impazza, il Carnevale impazza... L’inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza nei primi giorni di malato sole la primavera danza, la primavera danza”. Questo vate molto padano ma, fortunatamente, poco celtico, ci accompagna verso i nuovi germogli. Non ho mai amato il Carnevale, forse a causa di una mia indecifrabile e gioconda malinconia, ma la danza della Primavera è tutta un’altra cosa, tutta un’altra cosa. ([email protected]) ▪ 3 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 agnelli e lupi Tonio Dell’Olio La casa mediterranea M EDLINK – intrecci mediterranei si avvia a diventare un punto di riferimento importante e originale tra gli appuntamenti dei movimenti di base e della società civile. Un incontro annuale tra soggetti rappresentativi di quello “sguardo dal basso e sguardo da dentro” che sindacati, associazioni, movimenti e gruppi locali riescono ad avere delle società in cui vivono. Un vero peccato che a essere ascoltati sulle politiche e sui travagli culturali siano in genere soltanto i rappresentanti delle istituzioni o gli esponenti della cultura ufficiale che si celebra Benazir Bhutto. ©Archivio Palma/A3/Contrasto Benazir e il potere A sessant’anni dalla sanguinosa determinazione che separò gli islamici dagli induisti, il Pakistan è ancora governato dai militari, detiene testate nucleari, “gode” del sostegno degli americani e offre rifugio ai talebani del confinante Afghanistan se non, probabilmente, a Bin Laden. Il partito del popolo - pur discusso e discutibile, ma unico serio oppositore al regime di Musharraf - ha perduto tragicamente la sua leader. Le preoccupazioni visibilmente non sono diminuite, le elezioni spostate hanno prodotto gli esiti previsti, il potere si è rimescolato, il vedovo Zardari resta screditato. Tuttavia, l’opinione mondiale oggi dovrebbe sentirsi più informata sul Pakistan, dopo le tante paginate sul tremendo assassinio. I delitti importanti galvanizzano sempre i media, ma le immagini di Benazir sono state particolarmente suggestive: raffiguravano la morte di una donna, di una donna bella, che faceva parte di una famiglia di rango e portava l’investitura paterna davanti a sé; già eletta due volte alla Presidenza del suo paese, aveva sperimentato il carcere e l’esilio e prometteva la democrazia. Una strategia da uomo agita da un corpo di donna. Solo uomini hanno accompagnato la sua bara. Voleva “cambiare il destino” del suo paese. Questo significa, anche per una donna, rafforzare il partito del clan, mantenere 4 nelle aule universitarie! C’è un fermento interessante, ricco e variegato tra i movimenti, le associazioni, i sindacati e le fedi anche nel bacino del Mediterraneo. L’edizione 2007 di Medlink (www. medlinknet.org/) che ha visto la partecipazione di circa 60 persone provenienti da tutte le aree del Mediterraneo, ha posto al centro della riflessione il dato della crisi di civiltà per poterlo rileggere dal basso, ovvero con l’esperienza, le competenze, le fatiche e, a volte, le ferite della gente organizzata che vive nei paesi che si affacciano su un mare che solo l’ignoranza potrebbe ancora definire nostrum. È avvenuto così che i rappresentanti di organizzazioni del Maghreb e dell’Europa mediterranea si sono incontrati dal 14 al 16 dicembre le facce della luna scorsi a Roma per riflettere Giancarla Codrignani su “Oltre la crisi di civiltà. Cultura, politica e religioni per costruire alternative nel Mediterraneo”. Difficile operare una sintesi del dibattito l’appoggio degli Usa, barcamenarsi tra la cortanto ricco, ma si può cerruzione, il potere dell’esercito, gli attacchi dei tamente dire che l’accordo militari alla magistratura, la crisi di un paese ad nel superare la visione dello alto tasso di analfabetismo, ma immerso nella scontro di civiltà è stato unamodernità. Problemi “neutri”, propri di un capo. nime perché proprio essa In questo caso un capo che conosceva i limiti costituisce la visione ideolodell’esser donna, dall’obbligo di avere un marito gica di fondo per la teoria (e e dei figli per essere riconosciuta socialmente, alla la pratica!) della guerra perscelta che l’ha candidata, anche nel 1989, perché manente. Anche sul piano i maschi del partito non superavano le contrapdel dialogo interreligioso si posizioni interne. Le pakistane si riconoscevano è osato di più fino a sostenella donna che era riuscita ad emergere politinere piuttosto la proposta camente in un paese in cui non mancano donne di incontro e di “intrecci” tra evolute e ottime professioniste, ma in cui la strale espressioni delle diverse grande maggioranza non conosce autonomia? fedi che intendono liberare Avrebbe potuto Benazir sostenere gli interessi le potenzialità dei rispettivi delle donne e cambiare davvero il paese? Nelle credi e patrimoni di valore interviste assicurava di sì, ma la mole dei probleche provocano ebrei, mumi di governo l’avrebbe obbligata a differire gli sulmani e cristiani a percorsi impegni “di genere”, politicamente scomodi in concreti di liberazione tanto tutti i paesi. È il rischio delle donne-leader: brave all’interno delle proprie co“come un uomo” debbono risolvere i problemi munità che come servizio del governare per un genere solo. Se una di loro alle società del Mediterraci muore, restano sui muri, per la storia e per la neo. ([email protected]) ▪ consolazione delle altre donne, i manifesti di un bel viso e gli slogan di speranza. Intanto tornano a primeggiare sugli antichi guai i capi tradizionali. Che non cambiano. ([email protected]) ▪ solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | parole per dire Cleophas Adrien Dioma Miraggio Europa Ringraziamo Cleophas Adrien Dioma del Burkina Faso, poeta, giornalista, fotografo, video documentarista, che inizia da questo numero la sua collaborazione con Solidarietà internazionale, curando una rubrica mensile. V enire in Europa era il mio sogno. Volevo vivere la verità. Non mi piaceva più quella finta solidarietà africana. Nelle grandi città la gente aveva cambiato tutto; i valori e le cose belle del villaggio erano ormai diventati motivo di orgoglio e strumento per farsi valere. Chi ti apriva la porta, non lo faceva perché ti voleva bene, ma perché sperava sempre che tu ne parlassi dopo. E avreste dovuto vedere le case come erano fatte! Erano ville super sofisticate, con giardini... Tutto in stile occidentale. Per molto tempo è stata una cosa normale, anche se dentro di me c’era qualcosa che rifiutava tutto questo. Vedere le cose da molto lontano mi porta adesso a farmi delle domande, cerco il vero senso di tutto questo. Quando per la prima volta sono tornato a casa, mi sono vestito con un paio di jeans, una maglietta e sono uscito a salutare i miei amici. Mia madre vedendomi dalla finestra mi disse “Vestiti da europeo!” ed io le ho chiesto “Ma mamma come si vestono gli europei?”. Era comunque difficile spiegare a mia madre che essere europeo non voleva dire vestirsi con lo smoking e avere le scarpe di Valentino. Quando sono rientrato in Africa per le vacanze non credo di esser riuscito a spiegare a tutti che non ero cambiato, che la mia situazione in Italia non era tanto bella, ma forse neanche brutta. Che avevo lavorato nei campi di pomodoro. Che avevo vissuto a Napoli in un appartamento con altre quattordici persone. Che la prima frase che ho imparato in italiano era “Cerco lavoro”. Che andavamo in giro, di casa in casa, a bussare e dire alla gente “Cerco lavoro” e ad avere GRUPPO DI IMMIGRATI R U M E N I N E L L A LO R O CASA. ©ELIGIO PAONI/ CONTRASTO come risposta “Hai fame? Hai freddo? Vuoi qualcosa?”. E noi che rispondevamo sempre “Cerco lavoro” perché non capivamo niente. Che nei campi di arance-mandarini in Calabria dormivamo in case abbandonate senza finestre e senza porte. Che una notte ci hanno sparato due colpi di fucile. Non sapevo come spiegare loro cosa voleva dire essere clandestino. Il non avere diritti, il non essere, la non esistenza. Come spiegare quando andavamo in piazza a metterci come schiavi ad aspettare che qualcuno venisse a prenderci per fare il muratore, il giardiniere o per portare dei sacchi di cemento per cinque o sei piani? Non ho mai avuto il coraggio di spiegare le cose. E poi… chi mi avrebbe creduto? ▪ la città conviviale Antonio Nanni Le migrazioni fanno bene all’economia C hi maledice la presenza degli stranieri in Italia come fattore di impoverimento e di declino, non possiede l’alfabeto dell’economia. Tutti i centri di ricerca e i Rapporti internazionali confermano che i flussi migratori rappresentano un motore formidabile per lo sviluppo, per la crescita e per la redistribuzione globale dell’economia. Ad esempio, il Dossier 2007 di CaritasMigrantes ci informa che il contributo degli stranieri all’economia italiana è stato consistente perché il 6,1 per cento del Pil è stato realizzato dagli immigrati. I lavoratori stranieri pagano in Italia quasi 1,9 miliardi di euro di tasse. È bene non dimenticarlo. Tra i lavoratori stranieri, secondo l’archivio di Unioncamere, ci sarebbero ben 141.393 imprenditori, per il 70 per cento operanti nel commercio e nelle costruzioni. Va poi considerato che il lavoro degli immigrati copre un tipo di domanda “scomoda”, che evidentemente gli italiani preferiscono lasciare ad altri: più di un quarto degli occupati stranieri lavora infatti in orari disagiati (il 19 per cento la sera, dalle 20 alle 23, il 12 per cento la notte, dopo le 23, il 15 per cento la domenica). Bisogna inoltre considerare che gli stranieri rappresentano anche un fattore di redistribuzione della ricchezza a livello planetario. Nel mondo infatti le rimesse superano i 300 miliardi di dollari all’anno e valgono tre volte gli aiuti allo sviluppo. Nel 2006 le rimesse spedite dagli immigrati presenti in Italia verso i loro paesi di provenienza hanno raggiunto la soglia dei 4,5 miliardi di euro. Secondo la “mappatura globale” realizzata dall’Ifad, agenzia Onu per la riduzione della povertà rurale, sono 150 milioni gli emigranti che mandano a casa parte del proprio stipendio. La situazione italiana è stata monitorata da una ricerca realizzata dalla Fondazione Cariplo. Dallo studio emerge che un lavoratore straniero invia dall’Italia al paese di origine il 47 per cento del proprio reddito e che questi fondi sono utilizzati soprattutto per consumo ed educazione. Resta un nodo centrale, quello del costo dei trasferimenti, che in alcuni casi rappresentano il 20-25 per cento della somma inviata. ([email protected]) ▪ 5 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 l’opinione Il welfare del 2008 N Vinicio Albanesi Don Vinicio Albanesi. ©AUGUSTO CASASOLI/A3/ CONTRASTO 6 emmeno con la fantasia è possibile prevedere per il 2008 soluzioni alle questioni irrisolte del welfare. Una serie di fattori “negativi” impediscono programmazione e interventi significativi sul benessere sociale. Il primo elemento negativo è la spinta alla sopravvivenza. Nel paese è oramai forte l’appello al rilancio dell’economia e del benessere. Da tutte le parti si sente il ritornello: “I salari sono insufficienti” e non permettono tranquillità. Per chi sta sotto la linea della “normalità”, per motivi personali e/o familiari, le difficoltà si raddoppiano. Soffre dei limiti di tutti, più quelli della solitudine, della mancanza di salute e di risorse. Inoltre, il mondo della “politica” è tutto concentrato sugli “assetti istituzionali”. La mobilità dei quadri di riferimento non interrompono le difficoltà, anzi le aggravano. L’attenzione è sul quadro generale della “governance”: i problemi concreti e quelli più gravi rimangono in sospeso. Ciò che esiste stenta a sopravvivere: nemmeno si parla delle situazioni più pesanti da affrontare. Infine, l’esasperazione del federalismo ha prodotto se non 20 Italie, poco meno. I territori si differenziano. La legge 328, pensata per dare autonomia e quindi territorialità ed efficienza ai servizi, è inevasa o comunque realizzata a macchie. Territori ricchi di risposte e di progetti: poco più in là deserti impensabili. Pur in quadri di riferimento locali, non sono stati sciolti i nodi dell’integrazione sanitario-sociale. Un palleggio pericolosissimo si è innescato tra le competenze: vengono “volentieri” affidate. Non per generosità, ma per sgravarsi di problemi, date le scarse risorse. Non resta dunque che segnalare per il 2008 “i nodi” evidenti e seri del welfare: senza nemmeno la speranza che verranno risolti; probabilmente nemmeno affrontati. Il primo è la cosiddetta “autosufficienza”: una prospettiva che può abbracciare molti aspetti del sociale, ma anche essere limitata a scarse e insufficienti risposte. Se infatti per autosufficienza si intende l’offerta di strumenti per dare a chi è in difficoltà (disabile, anziano, povero, disagiato) soluzioni di vivibilità, tale prospettiva, senza una profonda rivisitazione di tutto il sistema di welfare, non è nemmeno pensabile. Si riduce a qualche ora al giorno di assistenza da offrire ai vari soggetti bisognosi. Su questo versante addirittura la riflessione è in ritardo. Un altro grande nodo del welfare è tutto l’universo giovanile. Invocato in circostanze drammatiche (incidenti, alcolismo, tossicodipendenza, bullismo…), in verità nella nostra Italia non è mai esistita una politica giovanile. Non esistono reti, agenzie, occasioni capaci di intercettare disagi e disfunzioni dei giovani. Il carico di ogni forma di educazione e di accompagnamento è affidato alla famiglia, comunque essa sia. Sia forte e capace, che incerta e problematica. Non è difficile immaginare le conseguenze del disagio in famiglie fragili: le problematiche si moltiplicano con sbocchi drammatici di disordine e sofferenza. Infine, è lontana ogni politica dei territori. Eppure è una prospettiva interessante perché, se esistono problemi sociali in ogni parte d’Italia, la loro gravità e ingestibilità dipende anche dai contesti ambientali e sociali molto diversi nel territorio. Gli esempi sono molti: gli stessi problemi sono diversamente risolvibili in una grande città o in un piccolo paese; in aree ad alto rischio o in aree più tranquille. Certamente i trend virtuosi si innescano per una serie di circostanze positive. La semplice elencazione di macro aree dimostra quanta buona volontà (politica) creativa sarebbe necessaria, pur tenendo presenti le scarse risorse economiche del paese. Una stagnazione pesante sembra incombere sul paese. Un piccolo trotto a garantire specchietti di soluzioni. Lo sforzo tutto concentrato a non perdere quel poco terreno conquistato in servizi e in risposte. Da qui l’invito almeno a riflettere, a ripensare il welfare in maniera complessiva ed efficace: ritornare alla creatività tenendo conto delle nuove forme di disagio, dei contesti modificati e soprattutto della programmazione delle risorse. Il minimo che possiamo augurarci in tempi difficili. ([email protected]) ▪ solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | Kenya: giochi pericolosi Gravi disordini politici e tribali dopo le elezioni Kenya, Mombasa. ©REUTERS/Joseph Okanga Renato Kizito Sesana C iò che è avvenuto nelle scorse settimane in Kenya, al di là della tragedia rappresentata dalle centinaia di vittime rimaste sul campo, pone seri interrogativi non sul sistema democratico in se stesso (fino ad ora non siamo riusciti ad individuarne uno migliore), ma sulle forme della democrazia quando essa viene declinata in contesti culturali diversi dal nostro. Un dato è certo: chi in Africa viene chiamato, anche attraverso elezioni democratiche, a gestire il potere, difficilmente lo abbandona. Ki-Zerbo, il quale, oltre che storico è stato anche un leader politico, era solito dire che in Africa non conviene fare opposizione, perché si perde sempre. Chi ha il potere troppo spesso infatti lo gestisce a uso e consumo di se stesso e della propria etnia e non lascia spazio all’opposizione. Il Kenya dopo essersi liberato democraticamente dalla dittatura più che ventennale del dittatore Moi, era ritenuto un paese sicuro. Dopo queste ultime elezioni è caduto in una spirale pericolosissima che rischia di innescare un conflitto che ha contorni sia politici che etnici. Di seguito pubblichiamo un’analisi di Padre Kizito e l’appello lanciato dal Premio Nobel per la pace nel 2004, la kenyana Wangari Maathai. Per capire l’attuale contesto politico keniano bisognerebbe risalire almeno al 1982, quando, dopo un tentativo di colpo di Stato, l’allora Presidente Moi Si accusano reciprocamente i due contendenti alle elezioni presidenziali. Il presidente uscente, dichiarato vincitore, giura in fretta nella residenza presidenziale. Il suo rivale e gran parte degli osservatori internazionali denunciano brogli. Centinaia di vittime. Senza dialogo il paese rischia di essere ingovernabile. ha trasformato il paese in una dittatura brutale, pur mantenendo alcuni elementi formali e di facciata per spacciare il proprio regime come democrazia. Il tutto, è bene notarlo, sempre restando fedele alleato della Gran Bretagna e degli USA. Amico e protetto dall’Occidente. Sarebbe troppo lungo seguire dall’82 ad oggi la carriera politica dei due principali protagonisti della crisi odierna, Mwai Kibaki e Raila Odinga. Basti dire che da allora ad oggi entrambi sono stati alleati e avversari di Moi, alleati con tutti e avversari di tutti, anche tra di loro. Per entrambi non si può parlare di una posizione ideologica diversa o di programmi politici alternativi, ma sempre e solo di alleanze per arrivare al potere. Entrambi hanno una considerevole fortuna personale, che non hanno paura di ostentare. È famosa la Hummer di Raila, un fuoristrada che costa diverse decine di migliaia di euro e che fa due kilometri con un litro. Raila l’ha usata per visitare Kibera, il più grande slum di Nairobi, che fa parte del suo collegio elettorale. Per entrambi, credere che siano motivati dal desiderio di servire il paese o che siano paladini delle democrazie e dei poveri, è cadere vittima di una pericolosa illusione. Il loro atteggiamento è descritto bene nell’editoriale del 1° gennaio del “The Nation”: “Né il Party of National Unity (NPU) né l’Orange Democratic Movement (ODM) durante le campagne (elettorali) hanno dimostrato particolare controllo o rispetto per la 7 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | stabilità del paese. Il mantra sembra essere stato: o lo governiamo o lo bruciamo”. L’incontrollata sete di potere, e di proteggere col potere le ricchezze più o meno legalmente acquisite, sono il motore dell’attività politica di questi partiti. Detto questo, bisogna fare delle distinzioni. Mwai Kibaki, quando è andato al potere cinque anni fa ha fatto delle riforme importanti: ha disposto l’educazione gratuita per gli otto anni di Kenya, Nairobi. ©REUTERS/Antony Njuguna scuola elementare e garantito la libertà di espressione e di stampa. Per cinque anni non abbiamo avuto prigionieri politici e tanto meno assassini politici come avveniva con Moi, e mai in Kenya una campagna elettorale è stata libera come quella dello scorso mese. Ha preso una serie di provvedimenti economici che hanno fatto ripartire l’economia del paese, che negli ultimi anni di Moi aveva una crescita negativa e che invece dal 2004 è cresciuta di oltre il 5% all’anno. Due, invece, sono i grandi fallimenti di Kibaki. La corruzione pervasiva, ereditata dai 24 anni di malgoverno di Moi, non è stata combattuta con l’efficacia e la determinazione che il cittadino comune avrebbe voluto. È stata sì ridotta di molto, ma resta un cancro che pervade tutta la società keniana. Inoltre, la nuova costituzione promessa da Kibaki appena eletto non è stata ancora approvata e la conseguente promessa di decentralizzazione del potere non è stata onorata. La questione etnica Dal canto suo Raila Odinga, andato al governo come membro della coalizione di Kibaki cinque anni fa, è poi passato all’opposizione sulla questione della nuova costituzione, ed é riuscito a far bocciare la costituzione proposta da Kibaki con il referendum di due anni fa. L’ODM è nato dallo slancio di questa bocciatura popolare, e da allora Raila ha 8 solidarietà internazionale 01/2008 accentrato il potere del movimento ed ha esasperato la questione tribale. Da oltre un anno ormai la parola d’ordine fra i Luo, - l’etnia di Raila che ha un peso preponderante nell’ODM, come invece i kikuyo sono l’etnia di Kibaki con un peso preponderante nel PNU, - è stata: “È arrivato il nostro turno di governare il paese” per poi trasformarsi più recentemente in: “Se perdiamo le elezioni vuol dire che ci sono stati brogli”. Raila poi, durante la campagna elettorale, ha giocato due carte pericolose. Ha promesso di implementare il “majimboism”, una specie di regionalismo che era stato negli anni novanta proposto da Moi e rifiutato da Raila, senza specificare che contenuti avesse questo majinboism. Lasciando così temere, anche tenendo conto della storia personale di Raila, che si trattasse concretamente di una specie di rigido regionalismo che avrebbe frazionato il Paese. Successivamente ha firmato con i notabili della comunità musulmana un Memorandum of Understanding – un patto di intesa - i cui contenuti non sono mai stati divulgati con chiarezza. I suoi avversari, e molti cristiani fra loro, hanno giudicato questo accordo come un errore, perché fa una distinzione fra i cittadini keniani, basandosi sull’appartenenza religiosa, e questo è già contro la costituzione in vigore, così come contro il progetto di costituzione dell’ODM. Kibaki e il suo gruppo non hanno reagito a questa campagna, alzando steccati e lasciandosi imprigionare nella trappola degli stereotipi etnici. Una responsabilità, quella dell’etnicizzazione del conflitto, che è tutta di questi leader politici. Per citare ancora l’editoriale del Nation, indirizzandosi a Kibaki e Raila, af ferma: “Non c’è mai stata tanta animosità fra gente che ha vissuto insieme per molti anni come buoni vicini. Il caos che stiamo vivendo è il prodotto dell’élite tribale, economica e politica che si identifica con voi”. Che l’aspetto etnico sia diventato centrale non lo si può negare. Inutile girare intorno al problema. Odinga in primo luogo, ma anche Kibaki e il suo partito, negli ultimi tre anni, per ragioni di opportunità politica personale, hanno fatto tutta una serie di passi, e a volte magari solo passi sbagliati, che hanno alimentato l’animosità etnica. Entrambi i partiti usano saltuariamente, soprattutto nei momenti critici, l’appoggio dei “mungiki” e delle squadre organizzate e pagate di giovani disoccupati e disperati. I mungiki sono nati all’inizio degli anni novanta come una comunità di kikuyo che voleva tornare alla religione ancestrale: la venerazione di Ngai (Dio) rappresentato dal monte Kenya. Lentamente questo gruppo è degenerato in una specie di piccola mafia che, ad esempio, a Nairobi ha controllato alcune delle linee di trasporto, e che riesce a mobilitare gli adepti anche per azioni violente e criminali. In questo gruppo ci sono ora anche non-kikuyo, ma tendenzialmente si identificano con la difesa delle comunità e degli interessi kikuyo. A questa setta parareligiosa si contrappongono le squadre di giovani disoccupati di Kibera controllate da Raila Odinga, e delle quali Raila si è sempre servito per provocare disordini di piazza. Anche alzando il livello dello scontro fino a voler cercare di provocare vittime da poter poi usare per i propri scopi. Sono i due volti peggiori dello scontro in atto. A Nairobi la maggioranza delle vittime di questi ultimi giorni non sono state uccise negli scontri con la polizia, ma da azioni organizzate da questi due gruppi. Così a Kawangware, dove i kikuyo sono prevalenti, hanno attaccato case e piccole attività artigianali dei Luo, e l’opposto è avvenuto a Kibera. Purtroppo poi, come sempre capita, a farne le spese sono le persone inermi e innocenti. Il mattino del 31 dicembre, dopo la notte di peggiori violenze che siano finora avvenute a Kibera, Kamba, u n a m ico, m i Odinga in primo luogo e Kibaki, hanno alimentato l’animosità etnica. La corruzione pervasiva non è stata combattuta, ma resta un cancro che pervade tutta la società keniana. solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | KENYA, NAIROBI. ©REUTERS/Antony Njuguna Ci si dimostra grandi in tempi come questi Da un appello lanciato dal Pre- alla presenza di pochi ospiti e mio Nobel per la Pace Wangari ministri, inclusi molti che aveMaathai vano perso il loro seggio parlamentare. La cerimonia del giuattuale situazione nel mio ramento è stata così frettolosa paese, il Kenya, è scioccan- che ci si è dimenticati anche te e pericolosa. Dobbiamo l’inno nazionale. Una fretta che agire ora per far cessare le vio- è servita soltanto ad aumentare lenze e le uccisioni senza senso. ampiamente i sospetti di brogli Abbiamo visto tutti con orrore elettorali, denunciati anche dae profonda tristezza gli eventi gli osservatori internazionali. devastanti svoltisi nelle ultime Per questo l’ODM e il suo leader settimane. La situazione proble- Raila Odinga hanno protestato, matica continua a crescere e tut- affermando che era stata loro ti i kenyani di buona coscienza rubata la vittoria. Hanno chiesto devono continuare a esortare i le dimissioni del presidente, il nostri due leader, il Presidente quale, però, dopo il giuramento Mwai Kibaki e Hon Raila Odinga, si considera regolarmente eleta impegnarsi nel dialogo e a far- to e insediato. Di qui la rabbia la finita con questo conflitto che che si è riversata sulle strade e provoca disagio sociale , uccisio- sulle piazze e l’entrata in campo ni e distruzione della proprietà. delle divisioni etniche, dato che i Tutto è nato con l’annuncio da due contendenti appartengono parte della Commissione Elet- a due grandi etnie del paese. torale del Kenya (ECK) che pro- Centinaia di persone sono state clamava vincitore delle elezioni uccise. Migliaia hanno dovuto il Presidente Kibaki. C’era, però, abbandonare le loro case. Case in precedenza un malcontento e proprietà sono state distrutte. di vecchia data e una sfiducia Come uscire da questa situaziotra alcune comunità etniche, ne? Io propongo 4 approcci. alimentate lungo gli anni da È necessario trovare vie di ricongenerazioni di politici. ciliazione. So che c’è frustrazioPoco dopo l’annuncio della ne e dolore tra l’ODM e i suoi socommissione elettorale, il Pre- stenitori specialmente perché sidente eletto ha prestato giura- credono che sia stata loro rubamento nella casa presidenziale, ta la vittoria. C’è grande divisio- L’ raccontava terrorizzato di aver visto a poche decine di metri dalla sua baracca di Kibera i corpi di 4 suoi vicini e conoscenti, kikuyo, che erano stati sgozzati con un coltello da cucina. Questa crisi l’abbiamo vista arrivare, ma nessuno ne aveva capito la potenziale distruttività e la carica di tribalismo che stava prendendo. I sondaggi che sono stati pubblicati dai media kenyani negli ultimi mesi facevano vedere come la gente continuasse ad avere una sostanziale fiducia nel presidente e sempre meno fiducia nel suo partito. Mentre molti, favorevoli ai cambiamenti promessi dall’ODM, erano meno entusiasti verso Raila, percepito come un uomo politico con tendenze dittatoriali. Così oggi i risultati delle elezioni, prendendo come autentici quelli ufficiali, rendono il paese ingovernabile. Con un presidente nel quale sono accentrati molti poteri, ma che è in minoranza in parlamento, e quindi non può governare, e con una rivalità tribale che è sfuggita probabilmente anche al controllo di chi l’ha scatenata. ne e questa può essere risolta solo attraverso grande sincerità e riconciliazione. Aspettarsi che i kenioti accettino i risultati ottenuti illegalmente sarebbe scorretto e non democratico. Per questo è necessario che vengano riconteggiati i voti. Un passo altrettanto importante sarebbe quello di promuovere il dialogo tra i 2 leader o direttamente o coadiuvati da un mediatore. Chiediamo a entrambe le parti di guidare questa nazione verso la pace, la guarigione e la riconciliazione; e chiediamo rispetto e umiltà. Un’altra via potrebbe essere quella di creare una coalizione tra i due partiti. Per eliminare qualsiasi tipo di paura questo approccio dovrebbe poter essere tutelato a livello costituzionale e discusso in parlamento per superare qualsiasi tipo di disaccordo. Mentre i politici si impegnano nel fare il proprio dovere, i cittadini dovrebbero evitare di trovarsi coinvolti in atti di violenza e distruzione. Tutte le 42 comunità che compongono il paese hanno un legame storico e geografico e sono chiamate a vivere insieme nello stesso paese. Come vicine. Uccidendo, distruggendo proprietà e costringendo i nostri fratelli e le nostre sorelle ad abbandonare le loro case, si crea un circuito di odio che peserà sui nostri figli e sui figli dei nostri figli per tanti anni. Rompiamo, per favore, questo circolo vizioso dell’odio. Torniamo a vivere gli uni vicino agli altri, senza farci accecare da pregiudizi etnici. È di fondamentale importanza che tutti i kenyani si battano per ottenere giustizia. L’ingiustizia nei confronti di uno solo di noi deve essere percepita come un’ingiustizia effettuata nei confronti di tutti quanti. In un momento come questo, vorrei ricordare le parole del Pastore Martin Neimoller, che, ricordando il periodo del nazismo in Germania dice: “Sono arrivati prima per i comunisti, e io non ho parlato perché non ero comunista. Poi per gli Ebrei, e io non ho parlato perché non ero ebreo. Poi per i sindacalisti, e io non ho parlato perché non ero un sindacalista. Poi sono venuti per me, ma a quel punto non c’era più nessuno che potesse parlare”. ▪ Wangara Maathai, Premio Nobel Pace 2004 9 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 rispettando la legge, la costituzione vigente, rinunciando entrambi alle manifestazioni di piazza che inevitabilmente provocherebbero morti e feriti. E servirebbero solo ad inasprire le divisioni e creare un piedistallo per i due leader: i miei morti sono più dei tuoi. Il parlamento, così come composto dai risultati elettorali annunciati, deve essere convocato e la giustizia deve lavorare indipendentemente per esaminare le reciproche accuse di brogli. Ma non basta. Kibaki deve accettare una seria revisione delle elezioni e la riconta dei voti, con la presenza di un monitoraggio internazionale. Non c’è altra alternativa se vuole garantire la sua legittimità. Ma la cosa più importante è che Kibaki e Raila dialoghino. Kibaki finora ha reagito con la repressione, Raila punta sulle manifestazioni di piazza. Ma è una strada di confronto che non può portare lontano e che rischia di bloccare il paese in un conflitto irrisolvibile. La diplomazia internazionale deve aiutare il Kenya; Gran Bretagna e USA devono aiutare ad avviare il dialogo. L’Unione europea può avere un’influenza importante. L’Unione africana potrebbe aiutare a prender tempo. Tutte le possibili pressioni devono essere fatte su queste due persone e i partiti che rappresentano perché accettino il fatto che il Kenya è più importante di loro, e che devono collaborare. Ma in ultima analisi la pace non può venire dal di fuori, deve nascere dal di dentro, per poter superare definitivamente le difficoltà e gli odi seminati negli ultimi mesi e nelle ultime settimane. Un’ipotesi possibile sarebbe quella di recuperare il “terzo uomo”, Kalozo Musyoka, che ha partecipato alle elezioni ottenendo quasi mezzo milione di voti. Appartiene ad un’etnia minoritaria, non ha mai usato né pubblicamente né privatamente, da quanto si sa, il linguaggio dell’odio tribale. Ha competenza e conoscenza della situazione politica del paese. Potrebbe diventare il mediatore interno ideale, capace di far muovere avanti un processo di riconciliazione che non può essere imposto dal di fuori. Il dialogo fra le due parti deve cominciare al più presto. Non si può aspettare. Bisogna evitare ulteriori manifestazioni di piazza. Se tutto invece continua così, non ci sono dubbi che nel paese si scatenerà un nuovo ciclo di violenza e morte che renderà ancora più difficile la possibilità di una riconciliazione. ([email protected]) ▪ INTANTO A MALINDI I risultati delle elezioni, al di là dei possibili brogli, rendono il paese ingovernabile. N onostante questo, la festa di fine anno di Colajanni (ex parlamentare europeo ed ex responsabile esteri dei DS) e di altri italiani famosi «in trasferta» a Malindi è filata liscia. «Francamente... ce ne siamo fregati. Eravamo io con mia moglie, Chicco Testa e famiglia, Giovanni Minoli e la moglie Matilde Bernabei, Pietro Calabrese e pochi altri. Cena a casa mia sulla spiaggia a lume di candela». Solite aragoste a due euro l’una? «No, no, non impazzisco per il pesce. Abbiamo mangiato invece un’ottima pasta e poi l’insalata russa, che adoro. L’unica cosa, ogni tanto scherzando qualcuno brindava dicendo: “Buon Capodanno... se non ci tagliano la gola”. (Dal Corriere della sera) KENYA, NAIROBI. ©REUTERS/Thomas Mukoya Il dialogo come unica soluzione E le due parti sembrano ormai fisse su posizioni che non ammettono il dialogo. Un amico giornalista kikuyo mi pare possa rappresentare la mentalità comune: “Io ho votato nel mio collegio elettorale per un parlamentare dell’ODM, perché credo che l’ODM possa avere in parlamento una funzione importante di controllo su un possibile strapotere del presidente, ma non accetterei mai Railia come presidente. Con lui al potere fra cinque anni non avremmo elezioni truccate. Non avremmo elezioni, punto e basta”. Come sbloccare la situazione? Innanzitutto è importante che Kibaki e Raila accettino di muoversi nella legalità, KENYA, NAIROBI. ©REUTERS/Radu Sigheti 10 solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | Riflessione in margine ad una nuova tragedia della miseria Il diritto di esistere Graziano Zoni Il primo gennaio 2008 due persone muoiono di freddo a Roma. Finito il tempo delle parole e delle statistiche è tempo di agire concretamente. Se esisto, ho il diritto di esistere. Un reddito minimo di “esistenza” per tutti. Bari. Carmela, 86 anni. ©Fabio Cuttica/Contrasto N on ne posso più di statistiche, di studi e ricerche. Di numeri e di statistiche. Certo, anche quelle sono importanti. Sapere che in Italia ci sono alcuni milioni di poveri, che in Europa sono decine di milioni e che nel mondo oltre due miliardi di persone non sanno come sopravvivere non può non preoccupare. I numeri sono importanti perché ci danno la misura del dramma. Ma sono freddi. Non suscitano emozioni. Non raccontano che dietro loro ci sono storie di vita, donne, uomini e bambini in carne ed ossa. In più servono a coltivare quel vezzo tipico della nostra cultura che crede di aver risolto un problema quando lo ha analizzato. Invece occorre trovare e in fretta, risposte concrete. Mi hanno sempre insegnato che nel mondo “o c’è pane per tutti o non ce n’è per nessuno”. Ho pensato a questo quando ho saputo che il primo gennaio di quest’anno a Roma due persone sono morte di freddo. Due persone vere, in carne ed ossa. Con le loro storie, i loro sogni e le loro aspirazioni. Non due numeri di una fredda statistica! Casa, sanità, scuola per tutti La stampa, a metà dicembre scorso, ha riportato un intervento del premier Romano Prodi alla Commissione d’indagine sull’esclusione sociale. “Noi - dice Prodi - ci attendiamo non solo l’indicazione delle anomalie, ma anche provvedimenti che entrino nel dibattito sul reddito minimo di cit- tadinanza. Un dibattito che un Paese democratico non può non considerare”. Se posso, da ruspante della strada, vorrei completare l’affermazione del premier. Un Paese democratico, con un Governo di sinistra sostenuto da tanti cattolici, non solo “non può non considerare”, ma deve, assolutamente deve, e quindi, avrebbe dovuto già, realizzare e rispettare questo diritto primario che spetta ad ogni persona: di possedere un reddito minimo garantito, un’abitazione degna di un essere umano, una sanità ed una scuola gratuite. È un diritto questo che gli è dovuto in quanto esiste, è nel mondo. Ogni persona, nel momento in cui viene al mondo, porta stampato in sé, nel suo certificato di nascita questo diritto primario. L’Abbé Pierre nell’inverno del 1954, particolarmente gelido nella regione parigina,di fronte ai tanti senza tetto che rischiavano di morire assiderati, con i suoi “stracciaioli di Emmaus” decise di costruire “case illegali”. E diceva: “Se la polizia verrà a chiedermi il permesso di costruire, mostrerò loro ed alla stampa il certificato di nascita di queste persone”. Esisto, quindi devo esistere, quindi ho diritto di esistere! Attorno a questo concetto, già dal 1989 l’economista Henry Guitton fondò l’Associazione Aire (Associazione per l’Istituzione di un Reddito di Esistenza). Questa associazione conf luì poi nella rete Bien (“Basic incombe European Network”) che raggruppa più di duecento (sì, avete letto bene, duecento) ricercatori occidentali di moltissimi settori (economia, sociologia, filosofia, politica ed amministrazione). Come sempre, in questi network mancano i diretti interessati: i senza tetto, i senza fissa dimora, i senza tutto. Devo riconoscere che negli ultimi anni la Commissione europea ha cominciato a riunire sui problemi sociali anche i diretti interessati. Guido e Michele della Comunità Emmaus di Roma, che hanno partecipato agli incontri a Bruxelles, ne sono tornati abbastanza soddisfatti, ma stanchi, sfibrati dalle troppe parole. Ad Emmaus sono abi11 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | tuati a fare. E il problema resta sempre questo: come passare dalle parole ai fatti concreti? D a l l ’a n a l i s i e dallo studio della miseria ad azioni concrete che possano portare ad una soluzione vera? Un reddito minimo garantito Attorno alla richiesta del “reddito di esistenza” ci sono varie interpretazioni. Chi lo vede legato ad un’attività sociale, chi in vista di un inserimento nel mondo del lavoro, chi lo ritiene un diritto legato semplicemente al fatto di “esistere”. In Francia per esempio esiste da anni il “Rmi” (Reddito Minimo d’Inserimento). Nel 1998 il Governo italiano decise come esperimento per due anni, un istituto analogo coinvolgendo direttamente i comuni che dovevano farsi carico del 10 per cento delle allora 500.000 lire (258,23 euro) che venivano erogate. Lo stanziamento previsto avrebbe potuto interessare circa centomila famiglie. Alla soddisfazione di molti non mancò all’epoca qualche cautela. Ad esempio Mons. Nervo, presidente della Fondazione Zancan, riconobbe la validità del provvedimento, ma ne evidenziò anche i rischi: l’attuazione assai complicata richiedeva molta attenzione per garantirne l’efficacia, affinché fosse realmente uno strumento per uscire dalla miseria, senza alcuna strumentalizzazione. Oggi, il Presidente Prodi parla di “reddito minimo di cittadinanza”. Conoscendo gli equivoci possibili cui la parola “cittadinanza” si presta, specialmente oggi, avrei preferito e preferisco la denominazione di “reddito minimo di esistenza”. La trovo più chiara e forse afferma e riconosce meglio il diritto non finalizzato al “per esistere”, ma al semplice fatto che “esisto”. La differenza non è di poco conto. Va ben oltre il gusto della disquisizione semantica, e ci aiuta ad intenderci meglio. A proposito, mi resta sempre l’incubo della parola “incapiente” che da un po’ di tempo ricorre nel nostro lessico politico-sociale. Non l’ho trovata 12 Sapere che in Italia sono alcuni milioni di poveri, che in Europa sono decine di milioni, e che nel mondo oltre due miliardi di persone non sanno come sopravvivere non può non preoccupare. nemmeno sul vocabolario, quindi deve essere fresca di conio. Mi ha aperto un po’ la mente un articolo di Francesco Marsico sull’ultimo “Italia Caritas” del 2007. Marsico esamina il pacchetto “sociale” della Finanziaria e, ad un certo punto, parlando dei 1.900 milioni di euro provenienti dal cosiddetto “tesoretto”, scrive che dovrebbero essere destinati ai contribuenti a basso reddito, detti “incapienti”. E qui ripongo, insieme a Marsico e spero a tanti altri, la domanda per la quale occorre una chiara risposta del nostro sedicente Governo di sinistra: «E coloro che non sono nemmeno incapienti?». D’accordo pensare e preoccuparsi dei titolari di pensione sociale, d’accordo sostenere i cortei e le lotte dei precari, d’accordo impegnarsi a difendere il potere d’acquisto dei salari. Ma a coloro, e sono una moltitudine!, che vivono in estrema miseria, che non sono nemmeno iscritti all’anagrafe fiscale (e qualcuno magari nemmeno all’anagra- solidarietà internazionale 01/2008 fe civile), che non hanno sindacati se non le nostre associazioni che tentano di dare loro una risposta ai loro diritti, a costoro chi ci pensa? Contro chi devono dichiarare sciopero? E sciopero di “che”, della fame? Esistono, quindi hanno diritto di BARI. La signora Corsi vivere. osserva il figlio che dorme , all‘ interno La mia rif lesdella loro abitazione in cui vivono nove persione non vuole sone. ©Fabio Cuttica/ Contrasto essere polemica od offensiva. Ma ritengo che oggi sia dovere primario delle organizzazioni sindacali richiedere al governo efficaci interventi anche per questa fascia sempre più larga di persone, pur non iscritte nelle liste delle proprie organizzazioni. E dal governo mi aspetto, finalmente, un gesto che vada oltre i calcoli politici, un gesto umano di giustizia. L’istituzione fissa del “salario di esistenza” potrebbe essere il primo passo verso efficaci ed urgenti riforme sociali importanti, almeno quanto le grandi riforme su cui le forze politiche, di sinistra e di destra e di centro, stanno litigando da tempo, senza concludere nulla. E non mi si parli di risorse. Se si trattasse di spese militari, dirette o indirette che siano, o di investimenti per tenere “alto” il nome dell’Italia nel mondo, le risorse fiorirebbero dalla sera alla mattina. Perché mancano sempre “risorse” quando si tratta di rispettare la dignità, il diritto di tante persone, (e per non essere frainteso specifico, italiane e non), che condanniamo a sopravvivere nella disperazione? Per carità, non escludiamo gli esclusi anche nel cosiddetto welfare! La società civile italiana, nelle sue varie forme ed organizzazioni, continuerà a fare la sua parte, ma guai se lo Stato, il Governo, il Parlamento non sono decisi a fare il proprio dovere. E guai se, società civile e istituzioni, non cominceremo con forza, decisione e perché no?, anche con qualche collera d’amore, a mettere in primo piano, al centro, la persona. La persona, non il calcolo di parte. La persona, non le astuzie del potere. La persona, non le mosse egemoniche. La persona, non il prestigio delle fazioni. Non a parole, ma coi fatti. (italia@ emmaus.it) ▪ solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | America latina, un anno difficile Il coraggio di Cristiano Colombi cambiare Dopo le ‘rivoluzioni elettorali’ degli ultimi due anni, i popoli latinoamericani hanno l’opportunità storica di cambiare. Non possono fallire la prova, ma chi si oppone minaccia di alzare il tiro… I fatti che hanno interessato l’America latina nel corso del 2007 hanno messo in luce come nel ‘continente della speranza’ sia necessario ancora molto coraggio per realizzare cose che dovrebbero essere normali, come rispettare i risultati delle elezioni, accettare sconfitte referendarie, chiedere il rispetto di diritti riconosciuti a livello internazionale. Intendiamoci, non si tratta di mancanza di democrazia: da una parte la maratona elettorale degli ultimi due anni, che per la prima volta ha portato forze di sinistra al potere nella maggioranza degli Stati del Sud America, e dall’altra la grande capacità di partecipazione diretta delle forze sociali sono grandi prove di democrazia. Il problema è la reazione delle élite di fronte alla sola possibilità di realizzare le riforme richieste dalla popolazione, che riporta alla mente gli scenari più inquietanti del recente passato. Eppure dopo 500 anni i popoli dell’America latina hanno l’opportunità storica di cambiare, di demolire le strutture dello sfruttamento e di ricostruire una società democratica e autonoma, un’occasione che non possono permettersi di fallire. Con tutte le differenze che percorrono il continente, il tentativo di dare un nuovo volto all’America latina merita di essere analizzato a tre livelli: nei rapporti tra paesi, nella riforma degli Stati e nella lotta della società civile al di fuori delle istituzioni. Il sogno dell’unione latinoamericana La congiuntura favorevole di avere una maggioranza di governi riformisti ha permesso di compiere in un anno due passi importanti verso un grande traguardo politico, la realizzazione di una comunità degli Stati dell’America del Sud. Abbandonando i modelli superati di un accordo tutto economico come il Mercosur, o tutto politico come la Bolivia, La Paz. ©REUTERS/David Mercado Comunità andina, si è scelta una strada più pragmatica, quella di dare vita ad istituzioni multilaterali su aspetti strategici. Un percorso che ricorda quello europeo, iniziato proprio con la CECA, la Comunità del Carbone e dell’Acciaio. Così il 16 e 17 aprile 2007 il Primo Vertice Sudamericano sull’Energia ha battezzato l’Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR) e dato vita ad una segreteria di coordinamento sulle politiche energetiche dei vari Stati, primo passo per definire un modello economico autonomo e nuove iniziative comuni. Sei mesi più tardi, il 10 dicembre, Brasile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Paraguay e Bolivia hanno lanciato la Banca del Sud, strumento per finanziare i progetti infrastrutturali di sviluppo e di utilità sociale in autonomia rispetto al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale. Significative le sedi di questi atti ufficiali, il Venezuela del petrolio e l’Argentina dell’ultima crisi finanziaria. Dietro non è difficile scorgere il ruolo da promotore del presidente venezuelano Chavez, ma occorre riconoscere che i termini finali degli accordi hanno largamente superato le proposte iniziali del caudillo, rispecchiando le posizioni degli altri paesi ed in particolare del Brasile, vera ‘locomotiva’ dell’economia latinoamericana. Anche a costo di forti mediazioni, come la rinuncia al ruolo di prestatore di ultima istanza della Banca del Sud che l’avrebbe avvicinata al modello più coraggioso di un’autentica banca centrale sudamericana. 13 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | SANTIAGO DEL CILE. MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DEGLI INDIOS MAPUCHES. ©wREUTERS/Ivan Alvarado Il potere non si tocca Se da una parte la ritrovata unità di intenti dei governi ha dimostrato di poter avviare un nuovo processo di integrazione sudamericana, dall’altra i tentativi di riforma più profondi fanno emergere contraddizioni e conflitti anche violenti. Il cambiamento promesso dalla sinistra latinoamericana, infatti, prevedeva la strada di un nuovo processo costituente, capace di modernizzare le istituzioni e al tempo stesso di avvicinarle ai problemi sociali. Ma le vicende in Bolivia, Ecuador e Venezuela sono state molto diverse. Il caso della Bolivia è il più inquietante, al punto che, dopo due anni dalla sua storica elezione, il presidente indio Morales si vede ora costretto ad accettare la sfida di un referendum sulla sua possibile destituzione. Dopo un primo anno in cui l’élite del paese ha fomentato la richiesta di indipendenza della ricca provincia di Santa Cruz, nel 2007 gli stessi gruppi di potere hanno soffiato sul fuoco della disputa tra Sucre e La Paz per il ruolo di capitale nella nuova Costituzione. A fine novembre, a Sucre, il giorno in cui l’Assemblea Costituente (a schiacciante maggioranza del partito di Morales) avrebbe dovuto votare il testo finale, la tensione è salita alle stelle. Mentre cordoni di contadini e indigeni cercavano invano di proteggere i lavori, gruppi di manifestanti affrontavano le forze di polizia e costringevano alla fuga i deputati. Il bilancio insanguinato di quattro morti portava la Costituente a sciogliersi. La decisione di Morales di ridare la parola al voto popolare è un estremo tentativo di fermare una deriva violenta che sembra costruita a tavolino. Diverso il caso dell’Ecuador in cui l’elezione di ottobre dell’Assemblea Costituente ha quasi rappresentato un rovesciamento dei poteri. Sciolto il Parlamento alla prima riunione, la 14 solidarietà internazionale 01/2008 In lotta per i diritti Il difficile percorso per la costruzione di una nuova America latina riguarda anche e soprattutto la società civile. Occorre ricordare le crescenti tensioni sociali in Messico e Centro America, le preoccupanti manifestazioni dei sostenitori di Fujimori in Perù in occasione della storica estradizione dell’ex presidente, ma soprattutto i conflitti che riguardano ancora una volta i popoli originari, proprio nell’anno dell’approvazione all’Onu della ‘Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni’, un risultato atteso da venti anni. Assumono toni ormai drammatici i fatti che riguardano le comunità Mapuche in Cile, contro le quali si applica ancora le Legge Antiterrorista della dittatura: lo sciopero della fame di oltre novanta giorni di Patricia Troncoso, prigioniera politica, l’uccisione di un ragazzo ad inizio 2008, la presenza asfissiante della polizia nelle comunità. In Brasile i popoli indigeni continuano ad affrontare numerosi conf litti ambientali, come per le acque del Rio S. Francisco: un nuovo sciopero della fame di mons. Cappio nulla ha potuto contro la decisione del Supremo Tribunale Federale di non interrompere i progetti di sfruttamento. Ed infine i dieci anni senza giustizia dalla strage di Acteal in Chiapas, Messico, ricordano come sia ancora lunga ed in salita la strada per l’affermazione dei diritti in America latina. Il processo di cambiamento in America latina, dunque, avrà bisogno ancora di molto coraggio per affrontare il conflitto con i vecchi apparati, con i loro patrocinatori internazionali. Ma un risultato è il fatto che, per la prima volta, l’ago della bilancia sarà la partecipazione popolare, l’impegno di una società civile che non può smettere di elaborare le nuove forme possibili di una convivenza più degna. ([email protected]) ▪ In Cile si continuano ad applicare contro le comunità Mapuche le leggi antiterrorismo dei tempi della dittatura. Costituente è l’istituzione più potente, tanto da spingere alcuni osservatori a considerare il suo presidente, Alberto Acosta, professore universitario e solo pochi mesi prima ‘scomodo’ ministro dell’Energia, più influente dello stesso Rafael Correa. Un personaggio, Acosta, con il coraggio di assumere posizioni controcorrente, come quella di smarcarsi da Chavez e dichiarare di volere un ‘Socialismo del XXI secolo’ diverso, costruito dai cittadini, che non insegua il mito ‘sviluppista’. Ed è stato proprio il ‘Socialismo del XXI secolo’ a giocare un brutto tiro al presidente venezuelano che il 2 dicembre scorso ha perso per un soffio il referendum sulla nuova Costituzione. L’astensionismo dei suoi elettori non militanti, più indipendenti, ha agito da freno alle fughe in avanti e riportato Chavez a più miti consigli. L’immediato riconoscimento della sconfitta ed il rimpasto di governo di inizio 2008, con la sostituzione dei ministri più radicali e contestati, ne sono una dimostrazione. Ma anche in questo caso non mancano i segnali inquietanti, come il modo con cui l’opposizione conservatrice ha fatto propaganda, forte del quasi monopolio dei mezzi d’informazione, spostando l’attenzione sulla norma che abolisce il limite di rieleggibilità del presidente (ma come in tante ‘democrazie occidentali’), a spese delle altre riforme, soprattutto economiche. A due anni dalla sua elezione, il presidente boliviano Morales si vede costretto ad accettare la sfida di un referendum sulla sua possibile sostituzione. solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | Piove sul bagnato Nel Bangladesh dopo il ciclone Patrizia Caiffa I cambiamenti climatici rendono ancora più drammatici i ricorrenti cicloni. Da sei stagioni si è passati a due. Dopo l’ultimo ciclone inizia l’ennesima ricostruzione. È la terra dei fiumi e delle alluvioni. Qui il Gange si incontra con il Brahmaputra e si perde in mare con il suo delta gigantesco. La zona dove i fiumi sono sacri agli dei è però dimenticata dagli umani. E rischia di rimanere sommersa, prima o poi. A causa dell’incrocio tra le correnti del Golfo del Bengala e i venti freddi dall’Himalaya, con i cambiamenti climatici e il BANGLADESH. ©Patrizia Caiffa BANGLADESH. ©Patrizia Caiffa riscaldamento globale, quest’angolo di Asia è diventato ancora più vulnerabile alle catastrofi naturali. Anche stavolta il Bangladesh prova a riemergere, attraverso la ricostruzione, dall’ennesima tragedia che l’ha colpito il 15 novembre scorso, il ciclone chiamato “Sidr” (significa proprio “occhio del ciclone”) che in una notte ha spazzato via dalle sue coste del Bangladesh, con raffiche di vento a 220/240 km orari, tutto ciò che trovava sul suo percorso: uomini, case, animali, alberi. Le cifre ufficiali confermano oggi 3.300 morti e 863 scomparsi (ma potrebbero essere molti di più perché tanti, soprattutto i bambini, non hanno documenti). Almeno 2 milioni i senza tetto; in totale, più di 8 milioni e mezzo di persone in 30 distretti del Paese sono stati coinvolti, riportando danni fisici o materiali. A distanza di un mese le persone colpite vivono ancora in alloggi di fortuna, a pochi metri dal fiume o dal mare. Gli uomini lavorano a giornata nei campi o guidano risciò e barche. Le donne portano cesti di argilla sulla testa, per poi riversarla ai lati scoscesi delle strade di terra. I resti di case in lamiera e gli alberi divelti giacciono abbandonati lungo le strade o i fiumi. Il governo ha decretato il 15 dicembre 2007 la fine degli aiuti d’emergenza, cantando vittoria per come, insieme alle Ong e agli aiuti dei governi stranieri, è riuscito a gestire la situazione, tenuta sotto controllo senza rischio di epidemie, come era stato invece preannunciato. “In Bangladesh prima avevamo sei stagioni, ora solo caldo e freddo - dice mons. Paulinus Costa, arcivescovo di Dhaka, alla guida di una piccola comunità di 30.000 cattolici in una città di 17 milioni di abitanti musulmani-. Quando dovrebbe piovere c’è il sole e viceversa. Abbiamo paura delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Se nessuno ci ascolta rischiamo di essere presto sommersi”. Di recente, afferma mons. Costa, avvolto nel tipico scialle di lana che ripara i bengalesi dal freddo del mattino, “il nostro Paese si è lamentato all’Onu perché non fa niente per aiutarci a contrastare i cambiamenti climatici. Qui ogni anno succede una alluvione o un ciclone, il governo è corrotto e la gente è poverissima, con pochissime speranze di ripresa. Ci sentiamo dimenticati dalla comunità internazionale”. La ricostruzione Intanto nelle zone colpite sono iniziati i primi passi della ricostruzione: lavori saltuari stipendiati dal governo o dalle organizzazioni non governative per permettere alle persone colpite di rendersi indipendenti dalla distribuzione degli aiuti e ricominciare una vita autonoma. Caritas Bangladesh lo chiama “cash for work”, ossia “soldi contanti in cambio di lavoro”. “Avevo una casa e un piccolo negozio di drogheria - racconta Mohammed Alam Gazi, 35 anni, moglie e tre figlie - ma ho perso tutto in una sola notte. All’inizio ero totalmente dipendente dagli aiuti della Caritas e di altre Ong; però due giorni fa ho iniziato a lavorare pagato dal governo e ora posso comprare ciò di cui abbiamo bisogno”. Mariyam Begam lavora invece insieme alle altre vedove nella ricostruzione della strada che collega alla scuola, finanziata dalla Caritas. Anche lei ha perso la casa e deve sfamare 4 figli, che le fanno compagnia gironzolando insieme agli altri bambini durante il lavoro. “Per noi è una benedizione - dice - poter lavorare e guadagnarci da vivere in autonomia”. Le vittime I poveri sari colorati che indossano le donne sono gli stessi della notte della tragedia. Tutte hanno perso quasi tutto. Una di loro veste invece il suo velo islamico nero e ha perso anche una figlia di 8 anni. Khadiza, 30 anni, appena sentito il segnale di allarme che avvisava dell’arrivo del ciclone, ha preso in braccio Romi e l’ha legata al sari, correndo disperatamente accanto al fiume Andarmanik verso la vicina scuola, utilizzata nelle emergenze come rifugio. Ma mentre fuggiva si è resa conto che la stoffa del sari stringeva troppo forte la bambina, rischiando di strozzarla. “Ho allentato 15 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | “Prima avevamo sei stagioni, ora solo caldo e freddo. Quando dovrebbe piovere c’è il sole e viceversa. Abbiamo paura delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Se nessuno ci ascolta rischiamo di essere presto sommersi”. (mons. Paulinus Costa) un po’ la presa, ma la corrente del fiume me l’ha strappata via”, racconta Khadiza, guardando davanti a sé nel suo lontano vuoto. Secondo studi locali, nelle scorse catastrofi naturali il 60% delle vittime erano donne, bambine, adulte o anziane. Diverse le ragioni. “Prima di tutto - spiega Pintu William Gomez del dipartimento emer- BANGLADESH. ©Patrizia Caiffa 16 genze di Caritas Bangladesh - per problemi pratici: indossando il sari i loro movimenti, nella fuga, sono ridotti e impacciati. Anche i capelli lunghi sono un ostacolo. Poi ci sono motivi culturali: spesso i mariti, soprattutto nelle regioni più conservatrici, non davano il permesso alle donne di raggiungere i rifugi per la promiscuità che si veniva a creare con gli altri uomini. Oppure loro stesse sceglievano di non andare”. Per questo Caritas ha lavorato molto sulla sensibilizzazione e ora “la situazione sembra essere migliorata, anche rispetto al numero delle vittime in generale”. Il Bangladesh, infatti, in meno di quarant’anni ha visto abbattersi sulle sue terre ben tre cicloni, oltre ad una dose annuale di una o due alluvioni che mietono sempre vite umane e creano senza tetto. Il primo nel 1970 ha provocato 500.000 morti, il secondo nel 1991 circa 140.000, quest’ultimo “solo” 3.300. I rifugi anticiclone Uno dei modi per sottrarsi agli effetti delle calamità naturali sono i rifugi anticiclone, costruzioni a un piano sopraelevato in cemento armato, a forma di cuneo per smorzare l’impatto del vento. Nei locali interni, in situazioni di emergenza possono stare in piedi circa 1.500/2.000 persone. In Bangladesh ne sono stati costruiti 2.000 ma il governo ne chiede altri 1.000. La rete Caritas ne ha realizzati 222 negli anni, di cui 66 finanziati da Caritas italiana. Ora la rete internazionale vorrebbe costruirne altri 50. Caritas Bangladesh, spiega il direttore Benedict Alo Di Rosario, oltre alla distribuzione di aiuti e alla ripresa delle attività lavorative, sta anche studiando programmi di abitazioni low cost, con solidarietà internazionale 01/2008 BANGLADESH ©Patrizia Caiffa “base in cemento, pilastri in acciaio e telaio rigido, con almeno un metro in muratura per ripararsi dalle alluvioni”. Per il momento è prevista la ricostruzione di 9.100 case. La distribuzione degli aiuti È nel cortile della scuola di formazione professionale di Barisal, città di 2 milioni di abitanti a Sud della capitale Dhaka, che incontriamo una delle tante lunghe file di donne, alcune completamente velate di nero, altre con i sari colorati, destinatarie degli aiuti (riso, lenticchie, coperte, lenzuola, piatti, bicchieri, ecc.). Arrivano al tavolo della distribuzione e firmano timorose con l’impronta digitale (l’indice di analfabetismo è al 40% tra gli uomini, ancora di più tra le donne). Si illuminano con un sorriso al ricevere le voluminose mercanzie colorate, poi si dileguano con circospezione tra la folla custodendo il geloso dono. E non è raro trovare volontari musulmani che lavorano insieme alla Caritas per ricostruire la loro terra distrutta dal ciclone. Sayed Mi Faruk, 25 anni, insegnante di religione nella vicina madrassa, la scuola coranica utilizzata come rifugio il 15 novembre scorso, dice di avere “buone relazioni sia con i cristiani sia con gli indù. Durante le festività ci facciamo gli auguri a vicenda”. Accade nel villaggio sul mare di Kuawa Kata, nella Sea belt, dove il vento ha creato onde devastanti che hanno inondato le terre circostanti, portando via le abitazioni e le barche dei pescatori, circa 2.000 persone che vivono pescando ed essiccando il pesce. Ora sulla spiaggia c’è solo ciò che rimane delle case in foglie di palma secche. Mentre gli uomini lavorano gli anziani passeggiano, i bambini corrono e le donne cucinano. La vita continua a scorrere tra le insolite macerie frondose. Nonostante tutto e ancora. ([email protected]) ▪ solidarietà internazionale 01/2008 N egli ultimi mesi del 2001 in Turchia, ma anche nel resto del pianeta, furono in tanti a tirare un bel sospiro di sollievo, allorché il progetto della diga di Ilisu sul fiume Tigri, in pieno Kurdistan turco, sembrò tramontare in maniera definitiva. Le agenzie di credito di Italia (la Sace) e Regno Unito (ECGD), infatti, non se la sentirono di dare il loro appoggio politico e finanziario ad un’opera dai molteplici impatti negativi – tanto che la Banca mondiale fin da principio si era guardata bene dall’avere qualsiasi tipo di implicazione – e di conseguenza il consorzio costruttore, tra le cui fila c’era anche l’Impregilo, cessò rapidamente di esistere. Ora Ilisu è tornato prepotentemente di attualità. Le agenzie di credito all’export di Austria, Germania e Svizzera hanno deciso di sostenere il manipolo di imprese interessate a ricevere laute ricompense dal governo turco per la realizzazione della diga. Ma non solo, come sempre accade per questo tipo di progetti, forte è anche il coinvolgimento di un gruppo di banche private pronte a erogare prestiti di milioni di euro. Nella lista di istituti di credito spicca la Austria Bank Creditanstalt, controllata dall’italiana Unicredit. Proprio l’Unicredit è attualmente oggetto di una campagna, da parte di una serie di organizzazioni, tra cui il coordinamento AcquaSuAv, affinché si ritiri dal previsto finanziamento di 280 milioni di euro. Unicredit Group ritiene che la diga di Ilisu sia ben monitorata e in linea con gli standard internazionali, ma non tiene in considerazione che le conseguenze della costruzione della diga saranno incalcolabili e irreversibili. Numerose e di grande rilievo le questioni in ballo. In assenza di accordi internazionali sull’utilizzo dell’acqua del Tigri, l’impianto di Ilisu potrebbe essere utilizzato come strumento di ricatto nei confronti dei paesi confinanti, in particolare Siria e Iraq – i cui confini sono a meno di 100 chilometri dal sito interessato dalla costruzione dell’opera. Una sensibile riduzione dei flussi d’acqua ed un peggioramento della sua qualità avrebbero ripercussioni gravi sui territori dei due stati asiatici, aumentando la tensione in uno spicchio del mondo dove i problemi sono già tanti. Ma non è finita qui. La storica città di Hasankeyf e centinaia di altri beni culturali nella valle del Tigri con oltre 12mila anni di storia, verrebbero sommersi e quindi perduti per sempre. Hasankeyf è stata una delle capitali degli antichi regni dell’Anatolia ed un magnifico esempio di pacifica convivenza tra religioni diverse. La città, come la maggior parte dei luoghi che saranno impattati negativamente dal progetto, rappresenta | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | TURCHIA: RITORNA L’INCUBO DELLA DIGA DI ILISU Il Tigri sbarrato Luca Manes Appoggio e complicità di banche austriache, svizzere e tedesche. Sparirà la città storica di Hasankeyf. I fiumi d’acqua gestiti in funzione politica anti-siriana e anti-irachena. TURCHIA, HASANKEYF. ©REUTERS/Umit Bektas 17 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | un luogo culturalmente importante per l’etnia Kurda, stanziata nella regione Sud-orientale della Turchia. Secondo gli storici, 10mila anni fa proprio ad Hasankeyf si stabilirono i primi insediamenti dell’antica Mesopotamia. Vista la posizione strategica sul fiume Tigri, nel corso dei secoli si sono susseguite diverse civiltà nel controllo della città, dove sono state realizzate numerose opere di estremo valore artistico e culturale. Le caverne scavate nelle pareti di roccia che costeggiano il fiume furono abitate fino agli anni ’60, quando le autorità le evacuarono con la forza, in previsione dei futuri progetti di dighe. Qualche grotta è ancora abitata e ciò rappresenta l’aspetto più peculiare dell’antica città per il singolare modello di vita che tali abitazioni permettono. Anche queste sarebbero spazzate via dall’acqua, così come gran parte dei monumenti storici che caratterizzano la città. Tra questi chiese, moschee, tombe islamiche – ad Hasankeyf è sepolto il sultano Suleymano, discendente diretto di Maometto e profondamente venerato in tutto il paese - che rappresentano l’enorme complessità dell’eredità culturale e religiosa lasciata da numerose civiltà, tra cui i bizantini, i romani, i sassanidi, gli abbassidi, i merwanidi, i selgiukidi, gli eubiani, e più di recente gli ottomani. Altra nota dolente è quella degli impatti sulle popolazioni locali. Oltre 55mila persone – secondo la stima più conservativa – saranno costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. In realtà alcuni villaggi sono già stati sfollati, usando maniere a dir poco spicce, come ha potuto appurare di persona Christine Eberlein, esponente di spicco della Ong svizzera Berne Declaration, durante la sua missione sul campo tenutasi nell’ottobre 2007. La Eberlein è riuscita a raccogliere numerose testimonianze di famiglie cacciate dalle loro case a fronte di compensazioni irrisorie ed inique e nella latente violazione degli accordi presi tra le tre agenzie di credito all’esportazione coinvolte nel progetto e le autorità turche – tanto che per la concessione delle garanzie i governi di Austria, Germania e Svizzera avevano imposto circa 150 clausole. Secondo Yilmaz Orkan, presidente del Centro culturale Ararat di Roma, “gli espropri sono eseguiti sulla base di una legge turca sulle emergenze, quindi al di fuori del quadro legale previsto dalle linee guida internazionali, senza possibilità di verifica dell’effettiva erogazione del compenso previsto né della sua adeguatezza”. I gruppi kurdi sparsi per l’Europa si stanno mobilitando in massa, nel tentativo di fermare ancora una volta la costruzione della diga di Ilisu. Ma il tempo stringe ed Hasankeyf è sempre più a rischio. ([email protected]) ▪ 18 solidarietà internazionale 01/2008 GRANDI CELEBRAZIONI PER L’ANNIVERSARIO La Malesia compie i 50 Elena Asciutti Mezzo secolo di stabilità e sviluppo ha trasformato una nazione povera e disgregata in un paese economicamente forte. Un paese islamico e laico. Sottotraccia il pericolo di divisioni. I l 31 agosto 2007 la Malesia ha festeggiato il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza dal Regno Unito. Le strade e gli edifici di Kuala Lumpur erano decorati con bandiere e striscioni, sui quali spiccava “Merdeka”, parola in lingua bahasa che significa sia libertà sia indipendenza. Le celebrazioni sono state intense e sentite dalla popolazione che, durante gli alzabandiera e le parate, ha espresso tutto l’orgoglio malese. Durante quasi cinque secoli la Malesia è stata divisa in una serie di sultanati e regni spesso in competizione fra loro, per poi passare sotto il controllo portoghese prima, poi olandese e infine britannico, diventando indipendente nel 1957 e Stato unitario soltanto nel 1963. La vocazione commerciale della penisola malese e il controllo coloniale inglese contribuirono alla formazione di un complesso assetto demografico e religioso. Nei secoli, mercanti arabi, indiani, cinesi si installarono nei porti principali della Malesia. Successivamente gli Inglesi favorirono l’importazione massiccia di manodopera dall’odierno Sri Lanka, dall’India meridionale e dal Sud della Cina. La popolazione malese è pertanto composta da quasi 25 milioni di abitanti, di cui il 58% è “malay”, o “bumiputra” (figli della terra), il 30% è cinese e il 10% indiano; il resto è classificato nell’imprecisa categoria di “altri”. La maggior parte della popolazione è di fede musulmana, molti tra i cinesi e gli indiani sono però buddisti, induisti e anglicani. Nel 1957, ottenuta l’indipendenza, il compito principale per i leader politici malesi fu immaginare una nazione unitaria nella quale credere e far credere, gestendo la ricca eredità etnica e religiosa. L’elemento unificante fu perciò rintracciato nell’Islam. Questa scelta condusse però a praticare una “politica razziale”, volta a proteggere i bisogni, veri o presunti, di un determinato gruppo etnico, anche a scapito di altri. Lo scopo era di raddrizzare la bilancia a favore della maggioranza “malay” che aveva subito decenni di discriminazioni da parte del potere coloniale. Legalmente per essere “malay” bisogna soddisfare tre requisiti: essere musulmani, parlare “bahasa malaysia”, la lingua nazionale, e “seguire le abitudini malay” – concetto, quest’ultimo, piuttosto vago. La conseguenza è stata che i tre gruppi etnici (“malay”, indiani e cinesi) si sono ritrovati a vivere separati. Dal 1957, i cinque Primi ministri, succedutisi nel governo della Malesia, hanno contribuito al processo di formazione e di consolidamento della Malesia come Stato unitario: Tunku Abdul Rahman, il «Padre dell’Indipendenza» (1957 – 1970); Abdul Razak, il «Padre dello Sviluppo» (1970 – 1976); Hussein Onn, il «Padre dell’Unità» (1976 – 1981); Mahathir Mohamad, il «Padre della Malesia moderna» (1981 – 2003); e Abdullah Ahmad Badawi. Il «Padre della Malesia moderna» è sicuramente il premier che ha più segnato il futuro della Malesia durante i 22 anni passati alla guida del governo, tanto da far parlare di “mahathirismo”, dottrina politica articolata in cinque elementi: nazionalismo, capitalismo, Islam, populismo e autoritarismo. Mahathir è stato capa- solidarietà internazionale 01/2008 ce di esercitare un’influenza pervasiva sulle scelte politiche e sulle istituzioni pubbliche, mettendo in pratica una forma personalizzata di egemonia, basata sull’abilità di proiettare un’immagine ambiziosa della società malese, al fine di allineare il livello di vita della Malesia a quello occidentale, trasformandola in un paese pienamente sviluppato non solo sul piano economico, ma anche a livello politico, sociale e spirituale. Dopo il ritiro di Mahathir nel 2003, è avvenuta l’ascesa politica del “Parti Islam Se-Malesia” (Partito Islamico Panmalese - Pas), legato all’Islam politico dei Fratelli Musulmani. Il Pas ha rappresentato un’alternativa per coloro che, contrari al programma nazionalista di stampo capitalista, proponevano la creazione di uno Stato islamico, amministrato attraverso la legge coranica. Con l’arrivo | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | a livello statale, dopo esser state stabilite dai sultani a capo degli Stati della Federazione, limitatamente al diritto di famiglia, ai riti religiosi e alle cerimonie. Pertanto, convivono due sistemi paralleli di giustizia: uno secolare basato sulle leggi approvate dal Parlamento; e l’altro fondato sulla legge islamica avente giurisdizione sulle persone che si dichiarano di fede musulmana. Tra laicità e religione La Malesia è uno Stato laico, così come definito dalla Costituzione. L’articolo 11 tutela poi la libertà di religione. Ma la realtà è diversa. Innanzitutto, per i “malay” è impossibile convertirsi a religioni diverse dall’Islam. Spesso si è anche sollevata la questione se fosse possibile per un “malay” credere in altre scuole musulmane e non solo in quella sunnita. Per le altre etnie aderenti ad altre fedi non ci sono restrizioni. Manca una sfera pubblica che permetta diverse esperienze religiose attraverso cui impegnarsi per il bene comune. L’immagine che emerge non è rosea. Sul piano delle relazioni internazionali, dopo l’11 settembre 2001, anche uno Stato moderato come la Malesia è rimasto intrappolata nel confronto tra Islam e non-Islam. A livello nazionale, nonostante i traguardi raggiunti in 50 anni di indipendenza, su Il nuovo Primo ministro spende una parte dei profitti del petrolio per costruire moschee e centri islamici. del nuovo Primo ministro, Abdullah Ahmad Badawi, devoto musulmano, il programma “Islam Hadhari” (Civiltà islamica moderna) è stato avviato al fine di coniugare la pratica dell’Islam con il rispetto della legge secolare, la modernizzazione e lo sviluppo del paese, e di impegnare la Malesia a spendere una parte dei profitti del petrolio per costruire moschee e centri islamici. Considerata da molti studiosi presuntuosa per la pretesa di avere riscoperto un tipo d’Islam dimenticato da secoli, la ricetta Badawi è però piaciuta agli elettori che nel 2004 lo premiano con il 64,4% dei voti, ridimensionando così l’ascesa politica del Pas. Tuttavia, le regole della sharia sono applicate in Malesia Malesia. ©REUTERS/Bazuki Muhammad (MALAYSIA) certe questioni ciò che divide i cittadini malesi è più enfatizzato rispetto a quello che li unisce. E quando queste questioni riguardano la fede, le controversie diventano ancora più forti. A questo proposito, Raja Nazrin, importante intellettuale malese, dichiara: «Cinquant’anni fa la nostra diversità etnica e religiosa era considerata un vantaggio unico. Oggi, siamo preoccupati da come mantenere l’unità del paese. La Malesia dovrebbe evitare la polarizzazione e la competizione lungo le linee dell’appartenenza etnica e religiosa. La Costituzione è la legge suprema, capace di garantire le libertà fondamentali a ogni cittadino. Lo strumento legale deve però essere accompagnato anche dal perseguimento della giustizia sociale ed economica della popolazione, per cui oltre all’attività politica è necessaria una vivace società civile». Mezzo secolo di stabilità e sviluppo ha trasformato una nazione povera e disgregata in un paese economicamente forte. Le celebrazioni per i cinquant’anni della nascita della nazione hanno rappresentato un momento per non dimenticare che l’unità della Malesia esiste, ma è un’opera non del tutto compiuta. Il 2008 sarà un anno importante in cui nuove elezioni nazionali dovrebbero essere indette dal Primo Ministro Badawi, nei primi mesi dell’anno. La speranza è che il paese riesca a darsi un’impronta di nazione tollerante e ricca della diversità razziale tipica dell’Asia. (asciuttie@ hotmail.com) ▪ Malesia. ©REUTERS/Bazuki Muhammad 19 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 Incontro con Gianluca e Massimiliano De Serio Sempre in movimento Paola Bizzarri Vincitori della categoria “Italiana.doc” del Festival di Torino. La macchina da presa racconta il cambiamento. Le storie vere di donne e minori, migranti e trafficanti. A lways on the move. Sempre in movimento. Questo lo slogan che campeggiava ovunque nella città di Torino durante le fasi antecedenti lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali nel 2006. Sono in molti ad affermare che la capitale italiana dell’auto, città industriale per antonomasia, stia cambiando. Torino, da metropoli operaia, negli ultimi anni sta lentamente indossando i panni di centro propulsivo di iniziative culturali, spettacoli, eventi e mostre di forte interesse. Nel bene o nel male è vero. È così. E in ogni cambiamento esistono protagonisti e spettatori. Vi sono persone che questo cambiamento lo raccontano con lo sguardo degli spettatori più deboli e meno coinvolti da questi nuovi processi: immigrati, donne, bambini. Divenendone così protagonisti. Costoro sono Gianluca e Massimiliano De Serio, due filmakers torinesi, gemelli, classe 1978, vincitori nella categoria “Italiana.doc” dell’ultimo Torino Film Festival diretto per la prima volta da Nanni Moretti. Massimiliano è dottorando in estetica e tecnologia dell’arte a Parigi, Gianluca è laureato in storia del cinema. Dal 1999 realizzano cortometraggi e documentari tra cui «Il giorno del santo» (2002), «Maria Jesus» (2003), «Mio fratello Yang» (2004), «Lezioni di arabo» (2005), «Zakaria» (2005), «Ensi e Shade», «Rew e Shade» e «Raige e Shade» (2006) presentati ai maggiori festival internazionali, dove hanno ricevuto numerosi riconoscimenti. Dal 2007 lavorano come artisti alla galleria torinese Guido Costa Projects. Durante l’ultima edizione del 20 FOTO DI PAOLA BIZZARRI. ©ARCHIVIO CIPSI. Torino Film Festival hanno vinto il Premio speciale della giuria con «L’esame di Xhodi» (documentario) per “aver saputo raccontare con inconsueta padronanza dei mezzi espressivi la straordinaria, quotidiana esperienza della creazione artistica”. Teatro della storia un’Albania pronta ad accogliere il presidente degli Stati Uniti d’America in visita ufficiale. Ma proprio quel giorno all’Accademia d’arte e al Conservatorio della città è il momento degli esami… Cambiamenti, passaggi, migrazioni e soprattutto storie di esseri umani. Ne abbiamo parlato con loro. Provenite da un quartiere operaio di Torino, “Barriera di Milano”, oggi connotato da una forte incidenza di stranieri. Qual è il vostro sguardo su questa parte di città? Barriera di Milano è un punto di vista privilegiato nei confronti della vita della città, una fonte di ricchezza e ispirazione. La nostra fortuna risiede proprio nella provenienza da questa zona ricca di contraddizioni e difficoltà, ma anche di bellezza. Un quartiere che, come altre periferie, bene rappresenta l’essenza della Torino accogliente, prima in relazione all’immigrazione meridionale, oggi a quella straniera. Noi stessi arriviamo da una famiglia del Sud, emigrata negli anni ’50, che ancora vive in questa periferia. Tutti i nostri lavori partono da incontri e sguardi su questa realtà. «Maria Jesus» nasce da un incontro avvenuto in Barriera con una ragazza a cui abbiamo chiesto di solidarietà internazionale 01/2008 raccontare la sua storia d’immigrazione dal Sud America all’Italia, a Barriera di Milano. Il corto è stato girato negli stessi luoghi. Lo stesso discorso vale per «Mio fratello Yang», la storia di Bing, arrivata clandestinamente a Torino dalla Cina. L’immigrazione è un punto centrale dei vostri lavori. Prevalente è la figura della donna. Abbiamo iniziato con «Il giorno del Santo» nel 2002, dove si racconta di una ragazza FOTO DI PAOLA BIZZARRI. ©ARCHIVIO CIPSI. FOTO DI PAOLA BIZZARRI. ©ARCHIVIO CIPSI. curdo-irachena che perde il lavoro e il diritto a vivere nella nostra comunità, proprio all’indomani dell’approvazione della legge Bossi-Fini. Nel film la troviamo sola, impegnata a scrivere una lettera ad un “tu” impersonale che, a ben guardare, siamo tutti noi. In «Maria Jesus» la protagonista non è sola, ma assieme ad una trafficante di immigrati con cui instaura un conflitto. In «Mio fratello Yang», la ragazza è ospitata dal suo nuovo fratello Yang, che l’aiuta ad imparare i prezzi e i nomi della mercanzia venduta al mercato. Le tre storie formano un corpus incentrato su donne clandestine in Italia, a Torino. Per noi raccontare queste storie al femminile rappresenta una sfida. Vogliamo presentare dei ritratti, o meglio ritrarre il bello e conturbante di ciò che racchiude | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | insieme la paura della vita e il coraggio di affrontarla. E il volto femminile ben raccoglie questa ambivalenza. Il volto di Maria mentre attende l’arrivo dei trafficanti di immigrati che l’abbandoneranno a se stessa, racchiude questi due aspetti. Inoltre, l’universo femminile meglio si presta a rappresentare il volto di tutta una comunità straniera, presente a Torino, ma comprensiva di figli e genitori lontani, nei paesi d’origine. Infine c’è un’altra ragione. Girare un film è sempre un processo invasivo e aggressivo. Lavorando con protagoniste donne abbiamo imparato a essere discreti. Loro stesse ci hanno permesso di apprendere un utilizzo delicato e rispettoso della macchina da presa. Lo stesso con i lavori incentrati su ragazzini come «Zakaria» e «Ensi e Shade». Infatti, gli altri protagonisti dei vostri film sono i minori. Come è nato questo interesse? Abbiamo iniziato a lavorare con gli adolescenti a partire da «Zakaria». In quel momento, eravamo interessati ad effettuare un percorso sull’apprendimento. Per antonomasia, colui che apprende è il bambino, attraverso l’attuazione di passaggi rivolti al divenire adulto. Zakaria è un adolescente che impara da una maestra, ma anche da un coetaneo che, scopriremo, chiamarsi con lo stesso nome. Sono seguiti «Ensi e Shade», «Rew e Shade» e «Raige e Shade», l’anno dopo, nel 2006. Una trilogia in cui Shade, un diciottenne, combatte e cresce a colpi di freestyle, rap improvvisato, contro il suo maestro, dialoga con il suo migliore amico e si confronta con il suo idolo: tre momenti sull’apprendimento, attraverso temi come la vita, la politica, la religione, l’amore. Sempre l’insegnamento di giovani è al centro del vostro ultimo successo: «L’esame di Xhodi». Si tratta di un documentario sull’insegnamento, sull’accademia delle Belle Arti e sul conservatorio di Tirana e si compone di una serie di ritratti di questi giovani alle prese con gli esami. «L’esame di Xhodi» muove da un approccio legato alla figura di Don Milani, all’insegnamento collettivo senza gerarchie. Ogni ragazzo ha un suo maestro, che ha i suoi allievi, che a loro volta aiutano altre persone fino ad arrivare alla sorellina, cui insegnano a suonare il piano, per esempio. Queste persone trasmettono saperi legati all’arte, alla musica, alla pittura ma, in questa provvisorietà legata all’apprendimento, è racchiusa tutta la forza di queste vite in formazione. All’inizio si parte con un vecchio professore dell’Accademia, per finire alla piccola Xhodi, impegnata a imparare a suonare il piano e a superare il suo esame. Da un lato si tratta di ritratti di studenti alle prese con se stessi, allo stesso tempo si dipingono i contorni del ritratto di una nazione, di questa giovane Albania piena di contraddizioni dopo gli anni di dittatura. Non a caso tutto il film si svolge durante la visita ufficiale di G. W. Bush. La presenza, pur incombente, di elicotteri, bandiere, parate militari e decoro è volutamente rimasta nello sfondo e al centro c’è l’Accademia, una bolla di vetro in cui si svolge la vera vita. Ma si sente come l’esterno penetri questo mondo. A proposito di minori, «Dentro il silenzio», «L’uomo più forte del mondo», «Jacopo» e «Senza respiro» sono quattro cortometraggi relativi a storie di bimbi con gravi malattie genetiche. Volete raccontare questa esperienza? Un’esperienza nata un po’ per caso. Siamo stati contattati quattro anni fa per compiere una serie di cortometraggi per la maratona Telethon, sulla Rai. Non ci abbiamo pensato due volte: l’obiettivo era raccogliere fondi per la ricerca. «Nell’uomo più forte del mondo» raccontiamo la storia di un bambino che ha salvato la vita al fratellino donandogli il midollo osseo e permettendone la guarigione, quasi ne fosse l’angelo custode. Purtroppo non tutti i casi filmati oggi presentano una conclusione positiva. Per noi resta essenziale l’opera di sensibilizzazione su temi di solidarietà rivolti ai minori. Oltre a «L’esame di Xhodi», da non perdere assolutamente «Spara», un video clip antimilitarista realizzato per la band piemontese degli Endura. Girato alle Fonti del Clitunno, in Umbria, racchiude ed esprime in modo efficace alcuni dei temi trattati dai Fratelli De Serio: l’insegnamento, la pericolosità delle gerarchie, la violenza sui minori, il dramma dei bambini costretti alla guerra e all’uso delle armi. Scaricabile da Youtube. ([email protected]) ▪ 21 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | N on si ferma la strage di migranti e rifugiati alle porte della Fortezza Europa. 243 morti a dicembre, 1.861 in tutto il 2007. Almeno 11.750 le vittime dal 1988. I dati sono contenuti nell’ultimo rapporto dell’osservatorio “Fortress Europe” (http://fortresseurope. blogspot.com). Quello di dicembre è stato uno dei mesi con più vittime. Un mese iniziato col summit euro-africano di Lisbona, e proseguito con l’allargamento a Est dell’Area Schengen e con la firma dell’accordo italo-libico per il pattugliamento congiunto. Un mese finito con 243 vittime tra migranti e rifugiati, dei quali 120 nel mar Egeo, 96 sulle rotte per le Canarie, 17 lungo le coste algerine, e 10 al largo dell’isola francese di Mayotte, nell’Oceano Indiano. Un tragico bilancio, che chiude un anno, il 2007, che si lascia alle spalle almeno 1.861 morti. Erano stati 2.088 nel 2006. Difficile confrontare i dati, visto che si basano esclusivamente sulle notizie riportate dalla stampa e quindi non costituiscono cifre esaustive. Ma esaminando solo il numero delle vittime in mare, l’ultima tappa dei viaggi, i morti del 2007 sono 1.684, contro i 1.625 dello scorso anno. Il che indica un netto aumento delle vittime, dato che gli arrivi sono sensibilmente diminuiti in tutta la frontiera Sud - con l’eccezione di Malta, Cipro e Grecia – a causa delle migliaia di respingimenti in mare operati dall’agenzia comunitaria Frontex, e dalle decine di migliaia di arresti operati in tutto il Nord Africa. I morti al largo delle Canarie sono passati dai 1.035 del 2006 ai 745 del 2007, ma a fronte di un calo degli arrivi del 75%. Nel Canale di Sicilia le vittime censite da Fortress Europe sono 551 contro le 302 dello scorso anno e con una diminuzione degli arrivi del 20%. Disastrosa la situazione dell’Egeo: 257 morti censiti, contro i 73 del 2006, anche con un raddoppio del numero di migranti sbarcati sulle coste della Grecia. Ad ogni modo, attraverso le rotte di tutto il Mediterraneo e dell’Atlantico, nel corso del 2007 sono arrivate in Europa meno di 50.000 persone, ovvero meno di un terzo dei 170.000 immigrati che solo il Governo italiano ha richiesto per soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera straniera con il decreto flussi del 2007, attraverso i recenti click days. Turchia-Grecia: non poteva finire peggio Sulla frontiera Turchia-Grecia, l’anno non poteva finire peggio. Nella sola notte del 10 dicembre, un naufragio al largo delle coste di Seferihisar, nella provincia di Izmir, ha fatto più morti che non durante tutto il 2006. Erano partiti in una notte di tempesta per evitare i con22 solidarietà internazionale 01/2008 Quei morti alle porte dell’Europa IL RAPPORTO DI FORTRESS EUROPE Gabriele del Grande Non si ferma la strage sulle rotte dell’immigrazione clandestina: 243 vittime a dicembre, tra Grecia e Spagna. I migranti morti alle porte dell’Ue nel 2007 sono almeno 1.861. Le vittime del Mediterraneo in forte aumento. E l’Unione europea prepara una missione anti-clandestini per i Campionati europei di calcio. trolli, ma la nave si è rovesciata in mare con tutti gli 85 passeggeri. Soltanto 6 i superstiti. Tra i 51 cadaveri ripescati nelle ore successive, quelli di 10 egiziani, 17 siriani e 10 palestinesi. Segno che la Turchia si conferma una rotta tanto più frequentata quanto più si restringono le altre, ad esempio quella libica. Nelle due settimane successive altri due naufragi causano 8 morti a Bodrum e 32 a Lesvos. È l’anno nero dell’Egeo. Almeno 257 vittime, contro le 73 del 2006. Almeno 885 annegati dal 1994. Ma ad aumentare sono stati anche gli arrivi. Dati ufficiali parlano di 10.000 persone sbarcate contro le 4.000 del 2006 e le 3.000 circa degli anni precedenti. Il 17 dicembre scorso si è aperta la rotta LAMPEDUSA. IMMIGRATI CLANDESTINI. ©FRANCESCO COCCO/CONTRASTO SICILIA, PORTO DI LICATA. IMMIGRATI CLANDESTINI. ©REUTERS/Antonio Parrinello solidarietà internazionale 01/2008 portoghese. 23 cittadini marocchini sono sbarcati a Olhao, nel Sud del Portogallo. Mentre più a Est, si è ormai affermata la rotta algerina per le isole Baleari, parallela a quella della Sardegna. Nel 2007 gli arrivi sono impennati del 7.000%, passando dagli 8 del 2006 ai 577 dei primi undici mesi di quest’anno. L’aumento degli sbarchi corrisponde a un maggior numero di arresti in Algeria: 1.500 quest’anno, dei quali 1.485 algerini. E anche i morti aumentano. La guardia costiera algerina ha ripescato 83 cadaveri quest’anno. Lo scorso anno erano stati 73, e nel 2005 soltanto 29. | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | Canale di Sicilia sono morte almeno 2.481 persone, lungo le rotte che vanno dalla Libia (da Zuwarah, Tripoli e Misratah) e dalla Tunisia (da Sousse, Chebba e Mahdia) all’isola di Malta, alle isole di Pantelleria e Lampedusa e alla costa Sud della Sicilia, ma anche dall’Egitto e dalla Turchia alla Calabria. Più della metà (1.522) sono disperse. Altri 64 giovani sono annegati navigando dall’Algeria (Annaba) alla Sardegna. Nel 2006 lo stesso osservatorio aveva censito la morte di 302 persone nel Canale di Sicilia. Difficile confrontare i dati tra il 2006 e il 2007, dal momento che si tratta di numeri non esaustivi, perché basati soltanto sulle notizie rinvenute dalla stampa. Eppure il trend è chiaramente di un aumento dei morti. Non soltanto infatti le vittime censite sono passate da 302 a 551 e il numero dei corpi recuperati da 96 a 144, ma nel frattempo gli sbarchi sono diminuiti del 20-30%. I morti nel Canale di Sicilia Sono stati almeno 551 i migranti e rifugiati che hanno perso la vita tentando di attraversare il Canale di Sicilia nel 2007. Di questi, almeno 144 cadaveri sono stati recuperati, mentre 407 persone risultano disperse in mare. Dal 1994, nel ‘’Africani state alla larga’’. Dagli Europei Dal 1994 nel Canale di Sicilia sono morte almeno 2.481 persone provenienti da Libia, Tunisia, Egitto e Turchia. Dall’inizio dell’anno fino al 17 settembre, i migranti arrivati sulle coste italiane sono stati 14.968, contro i 16.093 dello stesso periodo nel 2006, secondo dati del Viminale. Inoltre 1.396 persone avevano come meta la Sardegna e un migliaio la Calabria. Le vittime stanno aumentando perché si arriva su barche più piccole e quindi meno sicure (41 persone a bordo in media, secondo i dati del ministero dell’Interno, contro i 101 del 2005). Quelle stesse barche sono poi affidate alla guida dei passeggeri, che spesso non hanno esperienza di mare. Inoltre sono sempre più frequenti, stando alle testimonianze raccolte tra gli sbarcati, i casi di omissione di soccorso da parte di pescherecci e mercantili. L’8 agosto 2007, sette pescatori tunisini vennero arrestati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver sbarcato a Lampedusa 44 naufraghi a cui avevano salvato la vita. Dopo un mese di carcere sono stati rimessi in libertà. Le barche sono ancora sotto sequestro. Il processo va avanti e i sette rischiano da 1 a 15 anni di carcere. La voce si è sparsa e molti pescatori decidono di non prendere rischi. (gabriele_delgrande@ yahoo.it - www.redattoresociale.it) ▪ E intanto l’Unione europea sta preparando una missione anti-clandestini per i Campionati europei di calcio che si terranno in Svizzera e Austria dal 7 al 29 giugno 2008. Se ne occupa l’agenzia comunitaria per il controllo delle frontiere esterne, Frontex, che già nel 2006 organizzò la missione “Fifa 2006” in Germania, in occasione dei Mondiali. La notizia è contenuta in un esclusivo documento ufficiale dell’agenzia, pubblicato on line sul sito Fortress Europe. Il nome in codice dell’operazione è “Euro Cup 2008”. Nel 2007 Frontex ha svolto 22 missioni di pattugliamento e controllo lungo le frontiere marittime, terrestri ed aeree dell’Unione europea. Missioni che hanno portato all’arresto di 19.295 migranti, di cui 11.476 in mare, 4.522 a terra, e 3.297 negli aeroporti. Mentre nel 2006 il bilancio dell’agenzia di Varsavia si chiudeva con 32.016 arresti. Oltre alle più note missioni Nautilus nel Canale di Sicilia, Hera nell’Atlantico, Indalo nello Stretto di Gibilterra e Poseidon nell’Egeo, ve ne sono decine di meno note, messe in opera grazie ai mezzi dispiegati dagli Stati Membri. Nell’elenco figurano le missioni nei seguenti posti: nei porti andalusi, tra la Sardegna e le Baleari, dirimpetto all’Algeria, nei porti tedeschi, tra la Germania e i Paesi Scandinavi contro l’immigrazione cinese. E ancora tra Germania e Polonia, tra Romania, Slovacchia e Ungheria; e poi in Ungheria e in Slovenia, in Romania, Slovacchia, Ungheria e Polonia. Senza parlare delle missioni negli aeroporti di mezza Europa. Per non parlare dei programmi di formazione, che vanno dai progetti di rimpatrio congiunto, alla ricerca di auto rubate e perfino all’addestramento di cani. E per il 2008 si potrà fare di meglio, dato che il budget di Frontex è stato raddoppiato a 30 milioni di euro. 23 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 © R E U T E R S / S antiago Ferrero La via dolorosa Storie d’acqua e d’immigrati Niccolò Rinaldi Davanti a un quadro di Leandro Da Bassano. È la storia di un naufragio e di un santo che salva i naufraghi. Intanto nel mare di Malta e Lampedusa, al largo della Canarie e nell’Egeo... V enezia - Nella navata destra della basilica veneziana di San Giovanni e Paolo (San Zanipòlo in uso locale), si apre la cappella della Madonna della Pace, che raccoglie un’antica icona bizantina, credo di provenienza siriana. Seppure di epoca ben più tarda, la leggenda racconta che quest’icona fu venerata da San Giovanni Damasceno, che al suo cospetto ebbe riattaccata una mano che gli era stata tagliata, secondo le canoniche disavventure in cui capitavano i martiri cristiani. Come tutte le icone, entrati nella cappella, lo sguardo della madonna inchioda chi la osserva e, grazie alla magia matematica dei colori e delle proporzioni, tutta l’attenzione ne viene catalizzata. Così, per molti anni, non avevo fatto 24 caso a un grande quadro esposto su una delle pareti laterali e quasi illuminato di luce riflessa dal severo sguardo della Madonna della Pace. Si tratta di una tela di Leandro da Bassano, diversa da ogni altro quadro che conosco, per soggetto e per pathos. È notte, o quasi notte, e sulla sinistra si stende una città che si presenta solida, potente, con torri, castelli, palazzi alti. È una città in parte fortificata, protetta da mura. Accanto alle costruzioni dell’uomo, s’apre uno specchio d’acqua che prende spazio nel resto della tela. Non si vede, sulla destra, l’altra sponda, potrebbe essere un mare, un oceano. Ecco, i protagonisti del quadro sono questa acqua, queste onde, acqua scura e onde minacciose. La città, dotata anche di un porto, pare affidare i suoi traffici e il suo benessere a questa acqua, ma anche se ne difende. Davanti a questi due mondi - la città degli uomini, la potenza dell’acqua - Leandro da Bassano dipinge in primo piano un dramma concitato: una folla di persone abbigliate con agio, dunque si presume cittadini abbienti, si accalca intorno a due naufraghi: un uomo e un bambino. Entrambi esausti, coi vestiti stracci. Non se ne vede il volto, riversi per terra come sono, ma la loro posa plastica ci dice della loro fatica, della pena sofferta più di quanto capiremmo guardandoli in faccia. Tengono le gambe piegate, e con questo accorgimento il pittore pare tranquillizzarci sussurrando che sono ancora vivi, che ce l’hanno fatta, mentre i cittadini apportano soccorso. In mezzo a loro, affranti sulla riva, si erge la figura modesta di un domenicano, accompagnato da un seguace, con testa alta e volto luminoso. Solo osservando con attenzione vedo che questo personaggio non è approdato a terra, ma è ancora in acqua, anzi, cammina sull’acqua. Se l’uomo e il bambino sono ancora vivi, lo si deve, si capisce, al suo intervento. Il solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | C’è ha una somiglianza straordinaria con quanto vediamo sulle rive del nostro Mediterraneo, terra di salvezza e di morte, acqua di speranza e di dannazione. giovani e i padri di famiglia a caccia di un futuro migliore. L’acqua come “altro mondo”, sfera a parte che isola chi vi si avventura da ogni civiltà (nei barconi dei clandestini si muore anche di bastonate da parte degli scafisti); l’acqua che salva per il sorso d’acqua dolce del fondo della borraccia, e quella che fa crepare perché c’è solo acqua salata e nessuno allunga la bottiglia. DIPINTO “SAN GIACINTO AT TR AVERSA IL FIUME DNIEPER”. miracoloso personaggio è annunciato dal titolo del quadro, che conduce lontano dai canonici percorsi orientali di Venezia, e recita: “San Giacinto attraversa il fiume Dnieper”. L’avventura sul fiume Inutilmente ho cercato di saperne di più sull’avventura di questo santo domenicano sul grande fiume ucraino che sfocia nel Mar Nero, a più riprese allargandosi nel suo corso fino a creare dei vasti e tumultuosi laghi. Ma il predicatore che tra il XII e il XIII secolo evangelizza i prussiani e la Russia, deve intrattenere un rapporto speciale con l’acqua, tanto che in altre due occasioni doma la corrente della Vistola, una delle quali con una levitazione che gli permette di camminare sulle onde grazie alla sua cappa distesa portando con sé tre compagni. Anche sul Dnieper Giacinto sfodera poteri miracolosi, traendo in salvo l’uomo e il bimbo (forse anche altri miracolati non raffigurati nel quadro?) di cui niente sappiamo, ma di cui immaginiamo senza troppi giri di parole le peripezie, i bisogni, il legame che li unisce. Perché, seppure sprovvisti di rendiconti precisi, il quadro di Leandro da Bassano (il cui nome completo, questione di destino acquatico, è Leandro Da Ponte da Bassano) è abbastanza eloquente e anche noi ci commuoviamo al pari della folla accorsa. Ciò che ci illustra quasi fotograficamente ha una somiglianza straordinaria con quanto tocca vedere I protagonisti del quadro sono la città degli uomini, la potenza dell’acqua. sulle rive del nostro Mediterraneo, terra di salvezza e di morte, acqua di speranza e di dannazione. La città mercantile e l’acqua fonte di vita C’è la città prospera e sicura, ma anche prepotente e chiusa, che guarda l’acqua tanto con spirito mercantile quanto con senso di minaccia; c’è l’accorrere della folla curiosa e ansimante, ma diversa, consapevole del suo destino di diversità, rispetto ai naufraghi, che per ventura o per bisogno sono incappati nella sciagura, e che come tutti i sopravvissuti, hanno visto la morte in faccia. E soprattutto c’è l’acqua, fonte di vita, bisogno vitale, moneta di scambio, merce di arricchimento, benedizione divina, ma anche, come a largo di Lampedusa e di Malta, come a largo delle Canarie e nell’Egeo, come per i boat people vietnamiti e i fuggiaschi cubani, contraddittoria sostanza. Mobile quanto basta ad aprire lo spiraglio del passaggio verso la salvezza e la speranza di libertà, infida per richiudersi e uccidere - uccidere le donne avvistate dagli aeroplani mentre tengono stretti i loro bimbi poco prima dell’affogamento, uccidere i San Giovanni Damasceno e il custode del cimitero di Lampedusa Ma quello che Leandro da Bassano dipinge e che noi non possiamo fotografare oggidì, è il santo salvatore, ché non è più tempo di eroi, figuriamoci di santi miracolosi. Gli stessi domenicani anziché salvare naufraghi si sono dati anche ad altri sollazzi (nella stessa chiesa di San Giovanni e Paolo un altro quadro celebra il rogo dei libri nel massacro degli albigesi, e si conserva affettuosamente il corpo di San Vincenzo Ferrer, santo per aver perseguitato gli ebrei di Spagna) e oggi non resta che affidarci ad altri personaggi, a loro modo tutti belli. Come certi militari che non chiudono occhio tutta la notte nelle loro ricognizioni; come i volontari che prestano servizio e suppliscono alle carenze non dello Stato, ma di tutti noi; come l’anziano custode del piccolo cimitero di Lampedusa, che alle salme ignote dà degna sepoltura, provvedendo una croce di legno a ciascuno, perché questo, spiega, non sarà il simbolo del loro Dio, ma il solo che lui può dargli per vegliare sulla loro anima. Sfiorando il fiume col suo amore, Giacinto prova i poteri della levitazione, ovvero della cautela e della cura con cui si deve affrontare l’acqua, rispettandola e solo così domandola. È una lezione di inizio anno, un viatico al 2008, e che l’acqua esige sempre da noi, come risorsa idrica e come mare aperto. Quanto può suggerire un quadro veneziano, città propizia alla riflessione marina. Grazie alla sua leggerezza Giacinto ha salvato sul Dnieper un uomo e un bimbo. Noi cerchiamo di salvare gli altri, che sono tanti, tutti in balia del mistero dell’acqua, nuova via dolorosa. (niccolo.rinaldi@ europarl.europa.eu) ▪ 25 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 N BANGL ADESH, DACC A . © R E U T E R S / R afiqur Rahman LA POLITICA DEI BENI COMUNI La sovranità Riccardo Petrella pubblica L’acqua è un diritto, è un bene comune. Va governata pubblicamente. Esce nei prossimi giorni il libro di Rosario Lembo sull’uso virtuoso dell’acqua: ecco la prefazione in anteprima. 26 on è una nozione astratta quella dei beni comuni. È un modo diverso ed “eversivo” di fare politica. Mettendo al centro le persone e non i mercati. Per questo l’acqua ci lancia tre grandi sfide. La prima sfida è quella di concretizzare il diritto all’acqua potabile e sana per tutti gli abitanti del Pianeta, non fra 50-100 anni, ma entro una generazione (al più tardi entro il 2025). La tendenza invece è quella di considerare che, in ragione anche degli effetti devastatori dei cambiamenti climatici, non sarà possibile realizzare il diritto all’acqua per tutti. Ci saranno sempre in futuro, si ammette con rassegnazione, centinaia di milioni di essere umani “poveri d’acqua” (cioè privati dell’accesso alla vita). La seconda sfida concerne la ridefinizione dell’acqua come bene comune pubblico, da salvaguardare e promuovere come eco-patrimonio dell’umanità e di tutte le specie viventi. Il pensiero e l’azione prevalenti dei gruppi dominanti – si pensi alle politiche dell’Unione Europea e a quelle della Banca Mondiale, del WTO - vanno invece nella direzione di considerare l’acqua come un bene economico territoriale competitivo - risorsa in via di rarefazione avente, quindi, un valore di mercato sempre più alto ed attraente per i detentori di capitale da investire - da gestire secondo le regole dell’economia capitalista di mercato. La terza sfida consiste nel realizzare un governo pubblico dell’acqua fondato sulla reale partecipazione dei cittadini, sulla co-responsabilità delle comunità “locali” e sulla fraternità fra le popolazioni. Le classi dirigenti, invece, non credono più alla democrazia rappresentativa, figuriamoci se credono alla democrazia partecipata, al di là del costante riferimento che fanno alla demo-crazia e al coinvolgimento dei cittadini. Esse credono unicamente nel dominio. Lo stesso dicasi sulla co-responsabilità delle comunità “locali”: l’acqua è vista come una risorsa strategica su cui mantenere forte e chiara la propria sovranità patrimoniale (nazionale, regionale...; l’acqua è definita “l’oro blu”) per assicurare la propria sopravvivenza, sicurezza economica e competitività internazionale. Per quanto riguarda la fraternità, il pensiero dominante parla piuttosto di “guerre dell’acqua” che, secondo i poteri forti, saranno le guerre del XXI secolo, come il petrolio è stato all’origine di tante “guerre” del XX secolo. Come si vede, le sfide sono enormi. Se uno fosse in vena di superlativi, direbbe che siamo di fronte a sfide “epocali”. Le tre sfide sono, è evidente, strettamente legate fra loro. Non è pensabile tentare di abbordare e risolvere l’una solidarietà internazionale 01/2008 nell’assenza delle altre. In questo senso, e considerato lo stato attuale delle cose sul piano delle “politiche dell’acqua” in Italia, in Europa e nel mondo, mi sembra non solo suggestivo, ma soprattutto opportuno, proporre di considerare la seconda sfida come la sfida su cui centrare – e ri-iniziare - il lavoro di sensibilizzazione civica e di mobilitazione politica delle popolazioni, affinché un cambiamento “radicale” - per il lungo termine - possa essere operato tale, giustamente, da permettere di risolvere le sfide “epocali”. Il riconoscimento dell’acqua Propongo che la sfida a cui collegare le altre due sia l’obiettivo di giungere – a livello locale, nazionale, continentale e mondiale - al riconoscimento istituzionale dell’acqua come bene comune pubblico, eco-patrimonio dell’umanità e di tutte le specie viventi. Per tre ragioni. Primo: la cultura dei gruppi dominanti è riuscita a scardinare ed a far svanire dal bagaglio culturale delle società occidentali – estendendo il processo al resto del mondo – l’idea stessa di beni comuni (i beni individuali privati sono quelli che contano), e di beni (e servizi) pubblici | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | Concretizzare il diritto all’acqua potabile e sana per tutti gli abitanti del Pianeta entro una generazione. all’acqua (che resta il punto cardine della “militanza per l’acqua”). Secondo: la pratica politica e sociale che si è imposta nel corso degli ultimi trenta anni ha fatto saltare non solo la nozione di Stato, di Stato “sociale”, di Stato del welfare (il che è già una rottura radicale), ma anche quella di sovranità del popolo e di sovranità dell’umanità (in quanto insieme degli esseri umani). Il vero e principale soggetto di sovranità oggi riconosciuto è “il portatore d’interessi” (lo “stakeholder”) che può essere uno Stato, un sindacato, un gruppo di pensionati, un’impresa multinazionale, una “Chiesa”. Non v’è più la sovranità pubblica. Impera la sovranità privata. Una comunità umana è, invece, società “Chiediamo il riconoscimento istituzionale dell’acqua come bene comune pubblico, eco-patrimonio dell’umanità e di tutte le specie viventi”. (ridotti ad una nozione molto labile quale quella di beni/servizi di interesse generale e di non rilevanza economica. Come se la prima rilevanza che conta, a cui fa riferimento, fosse la rilevanza economica, per cui da una parte, ed in primis, ci sono i beni economici e poi ci sarebbero quelli non-economici!). Questa trasformazione culturale è alla base della mercificazione dell’acqua, cioè del trasferimento al consumatore della copertura dei costi di accesso all’acqua potabile nella qualità e quantità necessaria per la vita, anziché la loro copertura da parte della collettività in quanto diritto umano universale. Essa è altresì alla base della privatizzazione della gestione dei servizi idrici e del finanziamento degli investimenti (che poi, in realtà, in un’economia capitalista di mercato, sono finanziati dal consumatore. In effetti, in Italia, è stato sancito per legge che il finanziamento dei costi e degli investimenti dei servizi idrici è coperto dalla tariffa al m³ d’acqua pagata dall’utente). Re-inventare il bene comune pubblico acqua è strategicamente determinante anche per il riconoscimento del diritto quando questa si esprime attraverso una soggettività politica collettiva sovrana, rappresentante dell’insieme dei membri della comunità, al servizio dei loro diritti e doveri. La sovranità pubblica è impossibile senza beni comuni pubblici. Terzo: i risultati (relativamente) positivi raggiunti finora – come dimostra l’importante mobilitazione cittadina attorno alle problematiche dell’acqua intervenuta in questi ultimi anni in Italia – sono stati ottenuti meno sull’asse del riconoscimento del diritto all’acqua per tutti quanto, invece, sull’asse della gestione dell’acqua come bene comune pubblico. Il tema del bene comune pubblico è evocatore di tanti principi e modi di vivere che sono alla base della civiltà occidentale (uguaglianza, giustizia, solidarietà, benessere collettivo, fraternità, libertà di tutti, rispetto del patrimonio comune...). Per noi italiani, le battaglie attorno alla decrescita cui le classi dirigenti oppongono lo “sviluppo durevole” (il che finora ha significato principalmente “rinverdire il capitalismo di mercato”), così come quelle attorno alla ricchezza (dei pochi) ed alla povertà (dei molti) - rispetto alle quali i gruppi dominanti danno la priorità alla crescita della ricchezza dei pochi (vedi, per tutti, il presidente della Francia) - diventeranno di centrale pregnanza nei prossimi tre-cinque anni a livello europeo. La mobilitazione per il bene comune pubblico, ed in particolare per l’acqua, per riuscire deve diventare forte a livello dell’Unione europea. ([email protected]) ▪ INDIA, BANGALORE. ©REUTERS/Jagadeesh Nv 27 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 AGENTE DI POLIZIA NEL SUD-EST ASIATICO. ©REUTERS/David Gray A bbiamo incontrato nella nostra sede di Roma una persona che desidera mantenere l’anonimato poiché teme per la propria incolumità personale. Lo chiameremo con un nome di fantasia: Hu Jia. Lavora con l’associazione “Voglio Vivere” in un paese del Sud-Est asiatico. Non possiamo dire nemmeno il paese. Perché coloro che osano denunciare le innumerevoli violazioni dei diritti umani perpetrate nel paese vengono arrestati. Hu Jia ci racconta il suo lavoro con i malati di lebbra. E la situazione dei “dissidenti” oppressi e perseguitati dalle autorità. Hu Jia, come mai qui in Italia? Vengo da un paese del Sud-Est Asiatico di cui non posso dire il nome per paura di essere poi perseguitato. Sono qui perchè invitato dagli amici di “Voglio vivere” che mi danno una mano nella mia attività. Svolgo un’attività di tipo sociale per sostenere le persone ammalate di lebbra, il morbo di Hansen, e le persone che sono sopravvissute a questa malattia infettiva. Desidero informare su come viviamo: a fine dicembre anche alcuni giornalisti sono finiti in prigione. E prima dell’arresto gli agenti di polizia hanno bloccato tutte le linee telefoniche e la connessione internet del giornalista. Certo , deve essere difficile lavorare in queste condizioni. Quando in un paese esistono regimi 28 Diritti umani violati nel Sud-Est asiatico Quando il dissenso è reato Francesca Giovannetti e Nicola Perrone La vita in un paese con un regime totalitario al governo: la polizia controlla internet, le linee telefoniche, i cellulari. Senza libertà religiosa. La dissidenza perseguitata e imprigionata. Il lavoro con i malati di lebbra. totalitari la partecipazione è regolamentata in maniera molto rigida sia nei rapporti sia nelle informazioni. Ciò significa: “Ti permetto di partecipare nella misura in cui la tua partecipazione sostiene il regime che è al potere”. È questo che vale come legge fondamentale, ma anche come legge di investimento. Il dramma è che la dissidenza viene controllata severamente dallo Stato. La dissidenza comunica attraverso sistemi moderni, attuali, come internet. In questo modo i grandi network come Google, Yahoo, ecc. sono costretti a consegnare codici criptati alle spie della polizia in modo da poter eseguire dei filtri e capire chi è dissidente. Google e Yahoo hanno dovuto dare tutti i codici richiesti, per continuare la loro opera solidarietà internazionale 01/2008 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA NEL SUD-EST ASIATICO. ©REUTERS/Chaiwat Subprasom nel paese. Chi ha provato a opporsi al regime usando il proprio blog su uno di questi grandi network è andato in prigione. Comunque, qui il mezzo più diffuso e comune per controllare la dissidenza rimane quello delle intercettazioni telefoniche. Io stesso sono intercettato. Quindi niente libertà di espressione e di stampa? Vi racconto un altro fatto. Guai a cercare di documentare la realtà. Un uomo è stato ucciso a bastonate dagli agenti della polizia municipale per averli filmati con il suo cellulare mentre costoro stavano reprimendo una protesta popolare contro una discarica in un villaggio. Ventiquattro persone sono state arrestate per queste nuove violenze della polizia. L’uomo stava filmando con il suo telefono cellulare una cinquantina di poliziotti nel centro di una città, inviati a reprimere la rivolta degli abitanti di un villaggio che tentavano di impedire ai camion di immondizia di accedere alla discarica vicino alle loro case. I poliziotti si sono scagliati contro a quest’uomo prendendolo a bastonate. È morto subito dopo il trasporto in ospedale. Siete controllati anche nelle espressioni di fede e religione? Qui c’è la Chiesa ufficiale, che non può avere un rapporto diretto con il Vaticano. È ufficiale nel senso che è controllata dal governo. Il problema più grande è quello di assicurare alcuni cardini della fede cattolica, come ad esempio la successione apostolica. Non mancano alcuni fedeli cristiani che si radunano per conto proprio attraverso incontri privati, dato che non intendono entrare a far parte della Chiesa ufficiale governativa, proprio per questa sua | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | mancanza di un contatto diretto con il Vaticano. Quindi da ciò risulta evidente che esiste sempre il timore di un controllo e, quindi, di una repressione da parte dello Stato. Io stesso se voglio partecipare a una messa di un sacerdote “collegato al Vaticano” quando parlo al telefono cellulare chiedo se sono previste “cioccolate”, intendendo messa… Il paese in cui vivi si è industrializzato velocemente. Direi in modo esorbitante. Oggi c’è gente con il telefonino, con la parabola, ecc., ma vive nelle baracche. C’è il contadino che ara ancora a mano con il bue davanti, però nei pantaloni ha il telefonino. Ci sono cose stridenti e contraddittorie. Attualmente, come effetto dell’industrializzazione, si ha il 10% della popolazione che si è arricchita in modo esponenziale, con possibilità e capacità di acquisto che in Italia ci sogniamo. Mentre il restante 90% usufruisce solo di alcune briciole. Con il passar del tempo, ci si accorge che questo divario aumenta, invece di diminuire. È frustrante. La paga media di un operaio non supera mai settanta euro al mese, non c’è assistenza sanitaria, né previdenza né pensione. Nella maggior parte dei casi, lavorando sette giorni su sette, si hanno due giorni al mese di riposo, spesso non esiste la domenica. Come vivono gli operai? Se fossimo in Italia sarebbero chiamate “condizioni da schiavitù”. Però nell’area del Sud-Est asiatico sono legittime, perché non c’è al riguardo una legislazione vigente che tuteli e rispetti i diritti umani. Perciò un industriale viene qui ed approfitta della legislazione assente e, soprattutto, utilizza tale mancanza per trarre il suo profitto. Un operaio lavora dieci ore al giorno, ma si può arrivare anche a sedici ore di lavoro. Spesso all’interno della fabbrica l’operaio ha anche il suo posto per dormire. Non esiste una vita fuori dal lavoro. Un altro problema è il fatto che le fabbriche inquinano molto l’ambiente circostante. Nella zona in cui mi trovo, ci sono stati alcuni giornalisti che hanno annunciato che l’80% delle acque è praticamente inquinato. Le esportazioni del pesce allevato nelle vasche sono state bloccate ai confini del paese perché hanno trovato grosse quantità di mercurio. L’acqua che si beve non è pulita e allora si beve l’acqua imbottigliata anche se costa molto e si spera che sia purificata. Tra alcuni anni non si riuscirà più a vivere in questa zona. Raccontaci del tuo lavoro con i malati di lebbra. Sostengo socialmente le persone ammalate di lebbra, il morbo di Hansen, e gli ex-ammalati. A livello locale esiste una collaborazione con una struttura governativa, un “Centro di riabilitazione” molto simile a un antico lebbrosario. Il Centro è costituito da diversi villaggi dislocati abbastanza lontani dai centri abitati, in cui vivono solo gli “ex ammalati” di lebbra. Dico “ex ammalati” perché la maggior parte di questa gente ha già fatto la chemioterapia, ma non ha avuto tutte le cure mediche successive alla chemioterapia. Inoltre quando hanno problemi fisici difficilmente trovano accesso alle strutture sanitarie pubbliche. Sono trascorsi sette anni da quando vivo all’interno del Centro. Una volta sono andato a prendere l’autobus con tre ammalati di lebbra. L’autista mi ha detto: “Tu puoi salire. Loro no”. Oggi non solo tutti saliamo sull’autobus, ma sanno già chi siamo. La gente può andare al mercato a fare le spese normalmente, insomma le persone sono accettate dalla popolazione. Per me una delle cose più importanti è stata quella di poter andare a mangiare insieme ai malati di lebbra (o ex ammalati) in ristoranti pubblici. Con il sostegno dell’associazione italiana “Voglio Vivere” abbiamo iniziato a realizzare un programma di sostegno alle persone malate di lebbra grazie a un ospedale, dove il direttore è molto sensibile al nostro stile di lavoro e ha aperto le porte a questa gente. Hu Jia, svelaci qualche episodio che ti ha particolarmente toccato. Un giorno mi ricordo che un uomo, morto poi a casa, mi ha chiesto: “Perché vuoi spendere soldi per una persona malata e che sicuramente morirà?”. Gli ho risposto che lui è una persona come tutte le altre, che ha una dignità. La cosa più importante è dare una qualità anche alla morte di ogni individuo, affinché non sia la semplice fine di un’esistenza. Il fatto poi di aver continuato a spendere soldi per lui ha fatto crescere anche la coscienza dei medici stessi, apprezzare il valore della persona. ([email protected] - ufficiostampa@ cipsi.it) ▪ 29 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 XXI secolo Guido Barbera Partecipazione: il potere diffuso L a comprensione che la gente ha del mondo si forma e si consolida nelle relazioni interpersonali, all’interno dei piccoli gruppi sociali in cui viviamo la nostra quotidianità. La famiglia, la strada, la scuola, il quartiere, il villaggio… sono i luoghi comuni per tante di queste relazioni. Luoghi che assumono, allo stesso tempo, una potenziale funzione politica, perchè possono ottenere vantaggi sociali impossibili al singolo individuo. Al di fuori di questi ambiti ci accorgiamo però che il mondo è organizzato in maniera molto differente e ci troviamo ad accettare passivamente tante decisioni calate dall’alto, da una politica sempre più staccata dal cittadino. Ci troviamo di fatto sempre più esclusi, con meno possibilità di partecipare sia nei servizi sociali, che nei mercati, che nella vita politica e sociale. Conseguenza della globalizzazione, ma anche dell’apatia e del disinteresse sociale crescente. In parte, il problema è semplicemente una conseguenza pratica: molti aspetti della nostra vita attuale non sono più circoscrivibili all’ambito della sola casa o del quartiere. La complessità dei problemi, come la quantità stessa delle persone coinvolte, riducono di fatto la possibilità di relazioni interpersonali. Oggi, inoltre, con lo spirito del libero mercato, nella nostra società tutto sembra dover essere acquistato, e poco può essere ancora realizzato con quella collaborazione partecipativa e solidale all’interno della comunità, che per decenni ci ha animato e che ora forse troviamo solo in qualche sperduto villaggio africano. La partecipazione è un elemento essenziale della crescita sociale e della convivenza comune. Una partecipazione dove le persone sono coinvolte direttamente e concretamente in profondità nei processi economici, sociali, culturali e politici che determinano le condizioni della loro vita. Una partecipazione che è anche potere. Non semplice ed insignificante consultazione, come troppo spesso siamo abituati oggi a vedere nei processi avviati dalla cosiddetta democrazia partecipativa europea. Nella vita economica: come produttore o consumatore, imprenditore o salariato. Nella vita sociale: come parte di una famiglia, di un’associazione o di un 30 gruppo etnico. Nella vita politica: come elettore, come membro di un partito politico o aderente ad un movimento o ad un gruppo di opinione. Tante possibilità, vari ruoli, che si sovrappongono anche trasversalmente, offrendoci vari modelli e possibilità di presenza attiva che spesso si rafforzano uno con l’altro. I fatti recenti e sempre più ripetuti di tensioni sociali legati a momenti elettorali, vedi il Pakistan ed il Kenya in queste ultime settimane, ci sottolineano come sia tutt’altro che facile raggiungere maturità e stabilità in democrazia. È necessario avere garanzia dei diritti umani per tutti, inclusa la libertà di parola e di associazione anche politica; certezza del diritto; un sistema multi partitico; elezioni libere, imparziali, tenute ad intervalli regolari e con pari diritti garantiti a tutti i partecipanti; cambiamenti non traumatici; rappresentanti eletti che rispondano pienamente del loro mandato ai loro elettori. La democrazia non si conquista in un giorno. La si può perdere in un giorno! Quando si approvano leggi che derubano i cittadini dei loro diritti e della loro libertà di scelta. Le consultazioni elettorali sono una condizione importante per la democrazia, ma non sufficienti da sole. La partecipazione politica non è solamente recarsi alle urne. È una pratica di vita. Una pratica da recuperare in tutto il mondo, anche in Italia, dove la legge elettorale in vigore, di fatto ci priva della libertà di scelta dei nostri rappresentanti e di controllo sul loro mandato. La base della democrazia La partecipazione, base della democrazia, è un fiore che fa sempre più fatica a sbocciare. Come le primule, sta spingendo sotto i potenti interessi, guidati dall’avidità di pochi, che alzano ostacoli sempre più grandi al potere politico ed economico della gente: cattiva distribuzione della ricchezza; norme sociali inadeguate; sistemi legislativi corrotti; intrallazzi e procedure burocratiche. In questo contesto la cooperazione internazionale oggi costituisce la sede privilegiata delle relazioni a livello internazionale. Relazioni che promuovono partecipazione per costruire democrazia, non solo locale, ma internazionale, globale. Le oramai storiche Ong, che hanno segnato i decenni passati con la loro presenza ed azione nel mondo, specialmente in quelle situazioni molto spesso irraggiungibili per le istituzioni, oggi non possono più essere delle Organizzazioni Non Governative, ma piuttosto devono divenire Organizzazioni Popolari Democratiche, che rappresentano gli interessi della popolazione che in loro si ritrova, discute dei loro problemi, individua obiettivi, percorsi, azioni. Persone che si conoscono, che condividono un’esperienza. Persone impegnate a costruire il loro futuro, la loro esistenza, che non dipende da iniziative o da finanziamenti esterni, ma è radicata nella dignità e nei diritti di ogni essere umano. Non è l’opera di queste organizzazioni che può determinare la totale eliminazione della miseria dal mondo. L’apporto significativo che esse possono offrire si trova proprio nella loro capacità di offrire modelli ed esempi concreti di partecipazione popolare. Dimostrare che la miseria si può vincere, piuttosto che cercare di affrontarla da soli direttamente con grandi progetti. Incoraggiare e promuovere relazioni interpersonali locali ed internazionali per costruire partecipazione, significa rispondere con sensibilità alle esigenze delle persone e delle comunità, senza l’ambizione di assumersi direttamente il controllo della situazione. È necessario evitare il rischio di impegnarci troppo a distribuire beni e servizi, trascurando invece di incoraggiare e promuovere la partecipazione. La crescita notevole di organizzazioni, associazioni, movimenti, gruppi negli ultimi anni, in ogni paese del mondo, è un segnale forte e chiaro che la gente in tutto il mondo vuole partecipare più direttamente e concretamente alla vita sociale. Un movimento democratico che difficilmente si può fermare. Persone con maggiore cultura, maggiori redditi e maggiori possibilità, potranno chiedere con più forza la partecipazione ad ogni processo che coinvolge la loro vita. Pretendere che le istituzioni, il mercato, i politici, diano risposte alle loro esigenze. La partecipazione, oggi, è una condizione per la sopravvivenza. (presidenza@ cipsi.it) ▪ solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | La pace, la politica, la mediazione T utto è partito, ancora una volta, da una lettera aperta di P. Alex Zanotelli. Una lettera che mette bene a fuoco il disagio di tanti che si aspettavano da questo governo una svolta su alcuni temi, fra i quali quello della pace e della riduzione delle spese militari. Un disagio che ha radici lontane e che rischia di relegare l’impegno per la pace e la nonviolenza a un ruolo di semplice testimonianza, irrilevante nelle scelte politiche. È vero, il governo Prodi, poco dopo il suo insediamento, ha mantenuto – anche se in forme molto morbide – l’impegno elettorale di ritirare il contingente militare in Iraq. Ma poi tutto si è bloccato. Si è andati in Libano. Non si è fatta una seria riflessione sulla nostra presenza in Afghanistan – che pure era stata auspicata dallo stesso Ministro degli Esteri - e in più sono aumentate a dismisura le spese militari. Non soltanto per finanziare le nostre “spedizioni” all’estero, ma anche per dotare il nostro esercito (che nel frattempo è divenuto professionale) di nuovi, sofisticati e costosissimi armamenti. Ad accrescere la delusione è poi venuto quello che viene chiamato “editto bulgaro”, quando da Sofia, il Presidente Prodi, ha di fatto avvallato la costruzione della nuova base militare americana a Vicenza. Senza nessuna consultazione della popolazione, senza tener conto della contrarietà di gran parte della gente di Vicenza. Ma il dibattito è partito anche all’interno del mondo dell’associazionismo impegnato per la pace, il disarmo e la nonviolenza. Perché dietro questa decisa presa di posizione si celano interrogativi profondi che toccano non soltanto il tema della pace, del disarmo e della nonviolenza, ma mettono l’interrogativo sul senso stesso dell’impegno politico. Perché dietro questa denuncia si cela la domanda sul ruolo e il limite della mediazione politica. Fino a che punto deve arrivare la mediazione e il compromesso? È possibile accettare scelte, contro le quali si è sempre combattuto, per ottenere altro? Detto in altri termini e più concretamente: dobbiamo rassegnarci al meno peggio, oppure dobbiamo cercare in tutti i modi di raggiungere il meglio? E come? E ancora: saremo sempre costretti a votare chiudendoci gli occhi e tappandoci il naso? È giusto che, pur di non far cadere un governo e rischiare di averne uno peggiore, si debbano accettare scelte repellenti perfino per la propria coscienza e per l’impegno che si è sempre profuso per la pace? Lidia Menapace cita nella sua risposta una lettera ricevuta da Domenico Jervolino: «Se ci contentiamo di salvarci l’anima di votare contro (e tutto resta come prima, anzi peggio), allora Alex ha ragione. Se invece la politica è un lavoro paziente e faticoso per spostare in avanti gli equilibri nella situazione data (etica della responsabilità), credo che difficilmente si potrebbe fare meglio di quanto stanno facendo oggi i compagni al Senato». Sono interrogativi che raggiungono l’essenza stessa della politica e dell’impegno nelle istituzioni, ma che, come viene giustamente messo in evidenza nel dibattito che pubblichiamo in seguito, pongono degli interrogativi radicali anche al movimento ©REUTERS/Atef Hassan dossier per la pace. Quando, poco prima della marcia Perugia–Assisi, il comitato promotore ha incontrato il Presidente Prodi, di fronte alla domanda di una politica che limitasse le spese per il militare, si è sentito rispondere – papale papale – che rappresentava una minoranza. Che non era capace di coinvolgere la gente e che, quindi, non era in grado di pesare politicamente. Una risposta che non può non far riflettere e che domanda una seria riflessione da parte di chi vorrebbe un mondo diverso e nonviolento: quanto siamo capaci di organizzarci? (ricordiamoci che Gandhi per primo affermava che la nonviolenza necessita di organizzazione). Quanto siamo in grado di raccogliere consenso? Quanto riusciamo a coinvolgere la gente, il popolo nelle nostre iniziative? Oppure siamo sempre “i soliti noti” chiusi in una sorta di ghetto autoreferenziale che rischia soltanto di parlarsi addosso? Non rischiamo noi stessi di rendere il pacifismo una sorta di movimento elitario, fatto di brava gente incapace però di coinvolgere la gente? Come si vede, il dibattito va molto oltre lo specifico caso del finanziamento di missioni militari e dell’aumento delle spese per la difesa. Anche se il tema in se stesso merita particolare attenzione. Perché stiamo correndo il rischio di avallare con il nostro silenzio e il nostro ritorno ad una sorta di testimonianza personale e privata, scelte che portano alla costruzione di un mondo comandato e gestito dai più forti e dai più ricchi, che usano lo strumento militare a loro esclusivo vantaggio. Un mondo pieno di armi che solo i forti possono avere, e riempito di armi più piccole (ma che ammazzano sul serio) perché i poveracci si combattano tra di loro. Un mondo dove perfino la democrazia viaggia sulle ogive dei missili e viene esportata dalla guerra. Pubblichiamo di seguito alcune reazioni alla lettera di Padre Alex. Il dibattito è aperto e noi invitiamo i nostri lettori a parteciparvi in modo creativo. ▪ 31 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 Per gli Eurofighters sono stati stanziati 318 milioni di euro per il 2008, 468 per il 2009, 918 milioni per il 2010, 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012! il mondo della pace sta a guardare R imango esterrefatto che la Sinistra Radicale (la cosiddetta Cosa Rossa) abbia votato, il 12 novembre con il Pd e tutta la destra, per finanziare i CPT, le missioni militari e il riarmo del nostro paese. Questo nel silenzio generale di tutta la stampa e i media, ma anche nel quasi totale silenzio del “mondo della pace”. Ero venuto a conoscenza di tutto questo poche ore prima del voto. Ho lanciato subito un appello in internet: era già troppo tardi. La “frittata” era già fatta. Ne sono rimasto talmente male da non avere neanche voglia di riprendere la penna. Oggi sento che devo esternare la mia delusione, la mia rabbia. Delusione profonda verso la Sinistra Critica che in piazza chiede la chiusura dei “lager per gli immigrati”, parla contro le guerre e l’imperialismo e poi vota con la destra per rifinanziarli. E sono fior di quattrini! Non ne troviamo per la scuola, per i servizi sociali, ma per le armi Sì! E tanti!! Infatti, la Difesa per il 2008 avrà 32 ©TANIA/A3/CONTRASTO Alex Zanotelli: a disposizione 23,5 miliardi di euro: un aumento di risorse dell’11% rispetto alla finanziaria del 2007, che già aveva aumentato il bilancio militare del 12%. Il governo Prodi in due anni ha già aumentato le spese militari del 23%!! Ancora più grave per me è il fatto dei soldi investiti in armi pesanti. Due esempi sono gli F35 e le fregate FREMM. Gli F35 (i cosiddetti Joint Strike Fighter). Sono i nuovi aerei da combattimento (costano circa 110 milioni di euro cadauno). Il sottosegretario alla Difesa Forcieri ne aveva sottoscritto, lo scorso febbraio a Washington, il protocollo di intesa. In Senato, alcuni (solo 33) hanno votato a favore dell’emendamento Turigliatto contro il finanziamento degli Eurofighters, ma subito dopo hanno tutti votato a favore dell’articolo 31 che prevede anche il finanziamento ai satelliti spia militari e le fregate da combattimento FREMM. Per gli Eurofighters sono stati stanziati 318 milioni di euro per il 2008, 468 per il 2009, 918 milioni per il 2010, 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012! Altrettanto è avvenuto per le fregate FREMM e per i satelliti spia. È grave che la Sinistra, anche la Critica, abbia votato massicciamente per tutto questo, con la sola eccezione di Turigliatto e Rossi, e altri due astenuti o favorevoli. Purtroppo il voto non è stato registrato nominativamente! Noi vogliamo sapere come ogni senatore vota! Il silenzio del movimento per la pace significa la morte di milioni di persone e dello stesso pianeta. Tutto questo è di una gravità estrema! Il nostro paese entra così nella grande corsa al riarmo che ci porterà dritti all’attacco all’Iran e alla guerra atomica. Trovo gravissimo il silenzio della stampa su tutto questo: una stampa sempre più appiattita! Ma ancora più grave è il nostro silenzio: il mondo della pace che dorme sonni tranquilli. È questo silenzio assordante che mi fa male. Dobbiamo reagire, protestare, urlare! Il nostro silenzio, il silenzio del movimento per la pace significa la morte di milioni di persone e dello stesso pianeta. La nostra è follia collettiva, pazzia eretta a Sistema. È il trionfo di “'O Sistema”. Dobbiamo riunire i nostri fili per legare il Gigante, l’Impero del denaro. Come cittadini attivi non violenti dobbiamo formare la nuova rete per dire No a questo Sistema di Morte e un Sì perché vinca la Vita. Alex Zanotelli solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | Lidia Menapace: C aro Zanotelli, la questione non è - di volta in volta - rimanere esterrefatti perché la Tavola per la pace proprio quest’anno ha tolto la pace dalla piattaforma della marcia Perugia-Assisi, o perché la Finanziaria viene votata nel testo concordato in maggioranza, e che è già il frutto di un lavoro tenacissimo dei compagni e delle compagne che hanno lavorato nelle Commissioni: la questione è se ci si debba considerare legati al patto di sostenere questo governo, o se invece si viene formalmente sollecitati a farlo cadere. E la stessa cosa mi sentirei di dire ai compagni de Il Manifesto quando ci attaccano a sproposito su quanto ha giustamente detto Napolitano dei rumeni, accusandoci di silenzio colpevole perché staremmo cedendo sul decreto sicurezza. Che non è vero e che è la Sinistra a battersi per ridurre il danno al minimo, lo sanno anche i sassi. Perché fate finta di non ©Antonio Scattolon/A3/Contrasto così si fa cadere il governo saperlo voi? Ho già detto che mi considero legata al patto con gli elettori, ma sono aperta al dibattito su questo tema, purché sia indicato così: bisogna buttare giù questo governo e indicare quali vantaggi ne seguirebbero. Il nodo delle spese militari non è di oggi né di ieri. Abbiamo ereditato una situazione pressappoco così fatta: le fabbriche d’armi si chiamano «industrie della difesa», si trovano nel bilancio dello Stato tra le spese produttive, e le stesse fabbriche d’armi si considerano orgogliosamente la colonna portante del bilancio dello stato. Tutto ciò è conseguenza di una «interpretazione» dell’articolo 11 proposta anni fa dal generale Jean, secondo la quale la difesa deve intendersi non più come difesa del «territorio» nazionale, bensì degli «interessi» nazionali ovunque nel mondo, anche con forze di intervento rapide. Contro questa interpretazione si batté invano Raniero La Valle, il quale aveva proposto di definire meglio l’articolo 11 con legge ordinaria per riportarlo al suo significato autentico. Oggi (ma bisognerebbe interpellare dei costituzionalisti esperti) bisognerebbe forse aprire una controversia attraverso la Corte costituzionale. Di questo tipo mi pare potrebbero essere azioni di movimento, visto che appelli generici, anche se generosi, non ottengono nulla. Infatti, e questa è la seconda grave questione, si è largamente diffusa, e ha messo anche radici, una cultura che considera la guerra come una ratio nemmeno tanto extrema. Non è infatti un mistero che la destra fornirebbe voti in quantità sulle spese militari: in quantità, ma non gratuitamente e se il governo si fosse trovato in minoranza su quei capitoli, la sua caduta sarebbe stata molto probabile. Come si vede tutto ci rimanda alla questione fondamentale: chi giudica negative, immorali, vergognose le nostre posizioni, ci chiede di far cadere il governo? E allora lo dica chiaro e ci spieghi anche che tipo di appoggio ci darebbe e con quali argomenti in seguito. La situazione è serissima: personalmente credo che dobbiamo volere che il governo resista più a lungo di Bush, che consolidi rapporti in Europa per il rientro (ad esempio) dall’Afghanistan. Una volta raggiunti questi «obiettivi intermedi» si può discutere di modifiche del governo. E intanto si sarà visto quale sia la reale forza dei due grandi partiti virtuali che occupano un dilatatissimo «centro» tutto democratico, tutto moderato, tutto riformista. Se non siamo capaci di vedere lo spazio culturale, sociale, politico che resta a sinistra e non mettiamo in opera tutte le nostre capacità compositive e di raccordo, può capitarci - meritatamente - di scomparire dalla storia. Lidia Menapace 33 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 Enrico Peyretti: V edo, come tanti altri, questa lettera di Alex Zanotelli. Sento tutto il problema. Gli siamo grati di tormentarci con la profezia. So che a sinistra si spiega che l’aumento delle spese militari non è tutto un vero aumento, perché con Berlusconi quelle spese erano nascoste sotto altre voci. Mi sfuggono tante cose complicate. Ma vedo bene che certi armamenti non sono affatto difensivi, ma per loro aggressivi, offensivi, perciò anticostituzionali, come tutto il Nuovo Modello di Difesa (vedi allegato) che, dal 1991, tutti i governi successivi mandano in attuazione. So anche - come diceva un amico, importante amministratore comunale - che “in politica, come in famiglia, bisogna volere anche cose che non si vogliono”. È vero. Il “tengo famiglia” non è sempre solo una scusa ipocrita. Non sempre la coscienza di una persona è libera: abbiamo doveri verso la verità e la giustizia e 34 non sono d’accordo ©Tania/A3/Contrasto l’autocritica paziente della nonviolenza LORENZO SCARAMELLINI: altrettanto verso il prossimo e la sua situazione di fatto. Possono esserci conflitti assai faticosi, tormentosi. Bisognerebbe però che si confessasse questa fatica. Bisogna che un governo che ha la pace nel programma confessi e spieghi perché non può fare una migliore politica di pace. Bisogna che Prodi dica, o faccia dire, o lasci capire perché sul raddoppio della base Usa di Vicenza ha le mani legate; faccia capire se e come è ricattato. Oppure se crede che sia bene e giusto permettere agli Usa questo abuso. Bisogna anche - ma l’informazione ci dice tutto sui dibattiti parlamentari? - che i parlamentari dicano tutta la verità anche se poi, nel votare, devono fare il migliore possibile. Allora posso capire che il possibile non è sempre la verità, ma non per questo è una falsità. Lidia Menapace più di una volta, nelle sue lettere dal palazzo, ha parlato chiaro e ha spiegato questa differenza. Posso sostenere un governo e la sua politica che non approvo in tutto, perché vedo bene che abbattere quel governo non porterebbe a maggiore verità e giustizia, ma a maggiore falsità e ingiustizia. È il dibattito che ci affatica dal 2006. Non possiamo evitarlo. Se la nonviolenza non fosse anche critica, autocritica, paziente (cioè che soffre di non riuscire), specie quando entra nelle strettoie della politica, rimarrebbe retorica. Enrico Peyretti C aro Alex, non sono d’accordo. Il mio disaccordo, mi pare superfluo precisarlo, non è ovviamente nel merito: è chiaro, infatti, che aumentare le spese militari è un atto che contrasta frontalmente con l’esigenza di attivare politiche di pace. A mio parere, sbagli semplicemente obiettivo e destinatari. Il tuo appello prescinde infatti dal contesto ed è una semplificazione sbagliata di cui (tu come altre persone/organizzazioni del Movimento) non potete non rendervi conto. Il contesto qual è? È quello di un governo di coalizione, nato più che traballante e costante ostaggio di ogni singolo senatore. In una parola, a me pare che questo parlamento sia l’unico luogo in cui non si può fare politica, nel senso che non si possono assumere decisioni Politiche (con la P maiuscola), frutto di orientamenti ideali definiti e capaci di dare un’impronta politicamente definita al futuro. Si possono prendere solo decisioni politiche (con la p minuscola), amministrando l’esistente senza scontentare troppo nessuno, o comunque condizionate in modo decisivo da un timore/certezza: se questo governo (decisamente grigio, brutto, debolissimo) cade, torna la destra. E se torna, temo, non sarà per qualche mese, ma per molti anni perché il cittadino medio dirà: “Quelli, almeno, per 5 anni hanno governato, mentre questi non sono stati capaci neanche di andare d’accordo tra loro”. Mi sembra talmente evidente, tutto questo, che (davvero) non riesco a capire come se ne possa prescindere. Detto questo, a me pare altrettanto evidente che i parlamentari della Sinistra Radicale (ma non solo) non si siano “bevuti il cervello” o “venduti alla lobby della guerra”: ma ti pare possibile che persone come Lidia Menapace, Tiziana Valpiana, Giovanni Russo Spena, Francesco Martone, Paolo Cento, Sabina Siniscalchi, Haidi Giuliani, Anna Donati, Silvana Pisa, Elettra Deiana, Pietro Folena, un ministro come Paolo Ferrero o la vice ministra Patrizia Sentinelli... siano d’accordo con l’aumento delle spese militari e con la politica militare (ma non solo) di questo governo? E ti sembra il caso, invece, di riconoscere capacità di rappresentanza del Movimento a due persone come Rossi e Turigliatto? Con tutto il ri- | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | A QUANDO GLI INTERVENTI NONVIOLENTI? ©REUTERS/Jagadeesh Nv solidarietà internazionale 01/2008 Enrico Peyretti N el movimento per la pace italiano, di fronte alle vicende politiche sull’Afghanistan e sul Libano, si sono determinate due posizioni: intransigenti e “politici”. I primi, in nome di pacifismo e nonviolenza assoluti, vedono gli interventi come partecipazione alla guerra unica dell’Occidente in Asia. I secondi cercano anche vie politiche per il superamento della regola nefasta della guerra infinita, e valorizzano l’intervento Onu in Libano (diverso dai precedenti, accettato dalle parti, per la prima volta da Israele) come sostitutivo dell’azione unilaterale illegale di Usa e soci, platealmente e sanguinosamente fallita. La missione italiana in Afghanistan non era di pace ma di sostegno alla guerra Usa. Molti pacifisti hanno sperato che il rinnovo significasse riduzione. Le opinioni più serie dicono che oggi quella nostra presenza è inutile e pericolosa. Per dicembre deve finire. Opporsi fino a far cadere il governo? In parete, anche nella massima difficoltà, non puoi lasciare un appiglio se non ne hai uno migliore. Non si poteva rischiare una ricaduta nel governo precedente, assolutamente peggiore, in tutto. Certo, i militari hanno oggi un ruolo, non i civili: il volontariato internazionale è meritorio, ma in numero ovviamente insufficiente. Il militare, per cultura, formazione, strumentazione, non è mediatore di pace; al massimo si interpone. La mediazione deve disporre di Corpi Civili di Pace, riconosciuti, istituiti, finanziati, addestrati come un bene pubblico, in numero consistente, con fondi distolti dalle spese militari. Nel futuro che vogliamo, sostituiranno gli eserciti. La legislazione italiana (legge 230/98) offre già punti d’appoggio, se si capisce e si vuole. L’azione civile è meno costosa, più dignitosa, più efficace dell’azione militare e non compie i danni che il militare produce nell’animo profondo dei popoli, per generazioni. Proposte sapienti di soluzioni giuste, che la diplomazia deve raccogliere, vengono dalla cultura scientifica e morale di pace, come i progetti precisi di Galtung e di Samir Khalil Samir. Quando si parla di intervento nonviolento si vedono molti scuotere la testa convinti della inutilità di una proposta di questo tipo, in momenti di conflitto aspro. Certo, l’incendio va evitato, prima che spento. La maggiore azione è la pace preventiva. Perché si confida nelle armi? Per ignoranza pandemica, per educazione perversa (spettacoli violenti, videogiochi corruttori di bambini), per maledetti interessi a vendere morte… La cultura corrente è più violenta della natura umana. Ma in fondo le persone sensate sanno che la guerra aggrava ogni male. Il “no alla guerra” è abbastanza popolare, ma è da diffondere la storia delle lotte nonviolente e da organizzare la volontà politica dei metodi di pace. Le intermediazioni nonviolente hanno avuto anche i loro martiri. Martire non vuol dire vittima, ma testimone. Il soldato che viene ucciso perché non ha ucciso per primo fa pena, ma non testimonia nulla di nuovo, non è un martire. Chi cade vittima in un’azione giusta, di pace nonviolenta, di soccorso e riconciliazione, è testimone di una possibilità nuova, che deve realizzarsi come regola. Perciò la nonviolenza è sempre efficace, anche quando sembra sconfitta: ci lascia un lavoro avviato. C’è sempre chi non può o non vuole capire. Ma tutti possiamo capire chi annega per salvare uno che annega. Lo scopo è la vita di entrambi. Anche se e uno o l’altro, e persino entrambi, non si salvano, l’umanità è salva perché tutti davanti a quel gesto diventiamo più umani. ▪ spetto per loro, credo proprio che il Movimento meriti qualcosa di più, no? Secondo me, è mancato/manca ben altro. Come ho avuto occasione di dire a Lidia Menapace, nel corso di un recente incontro pubblico, proprio perché dentro questo governo e dentro questo Parlamento le ragioni della Pace e della nonviolenza non hanno alcuna possibilità di ascolto, andava/andrebbe creato un canale di comunicazione tra il Movimento e i parlamentari che si riconoscono nelle sue ragioni con due obiettivi ugualmente importanti: 1) evitare malintesi e aspettative Un canale di comunicazione tra il Movimento e i parlamentari. fuori luogo, rispetto all’attività e alle decisioni parlamentari (blindatissime, per i motivi che dicevo e che mi sembrano ovvi); 2) elaborare insieme un percorso politico che, nell’immediato “FUORI DAL PARLAMENTO” e nella prossima legislatura - mi auguro - “ANCHE DENTRO AL PARLAMENTO”, consenta alle ragioni della Pace e della nonviolenza di ottenere lo spazio che meritano, traducendosi in precisi atti politici supportati da forti campagne di base, da promuovere sul territorio. Un’alleanza, insomma, da ribadire e da rafforzare per costruire insieme quel futuro che tutti (Movimento e molti parlamentari, sicuramente!) vogliamo realizzare! Lorenzo Scaramellini 35 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | RENZO CRAIGHERO: Secondo me i “nostri” parlamentari dovrebbero, soprattutto in questi momenti, intensificare i rapporti con l’arcipelago pacifista e argomentare e motivare, molto di più di quanto facciano, le loro talora sofferte decisioni. Per questo sono d’accordo con l’osservazione conclusiva di Lorenzo di cercare di creare e rafforzare un canale di comunicazione tra il Movimento e i parlamentari di riferimento. Ma Zanotelli critica giustamente anche noi. Perché se una parte di responsabilità ce l’hanno gli eletti, noi non siamo esenti da colpe. Proprio in fase di manovra finanziaria dovremmo coordinare e moltiplicare le nostre iniziative verso i parlamentari “vicini” e verso la società civile. Purtroppo non è così: vedo per esempio quanto poco e faticosamente diamo voce e sostegno alla Campagna “Sbilanciamoci!” che tecnicamente e politicamente è lo strumento più prezioso che abbiamo per far valere le nostre critiche e le nostre proposte in quella fase. Peraltro è lo stesso opuscolo prodotto annualmente dal Tavolo degli esperti della campagna a fornirci informazioni utili sulla struttura e inefficienza delle nostre forze armate (poi da qui a farne elemento di richiamo per l’opinione pubblica e i media ne corre un po’...). Purtroppo, in materia di difesa, scontiamo tutti (movimenti e partiti) una difficoltà: che per la gran parte delle persone questo non è un tema oggetto di interesse, non viene percepito come un fattore incidente sulla propria vita. È un tema rimosso e su questo terreno la delega agli eletti è pressoché totale (e gran parte degli eletti condivide gli argomenti e le richieste dei vertici militari). Detto questo, considero l’intervento di Zanotelli “politicamente” opportuno? Forse per una parte di noi sì, per altri no, ma non mi sento di giudicare Zanotelli sulla base di un metro di “opportunità” politica: è uno che si spende, che sta dalla parte degli ultimi, lasciamolo parlare, invitiamolo a parlare. Auguri a tutti per un anno migliore. ANGELO GANDOLFI: se questa è sinistra ©ALBERTO CONTI/CONTRASTO una indignazione motivata solidarietà internazionale 01/2008 L’ appello di Zanotelli, come talora mi capita con i messaggi carichi di “radicalità” e “idealità”, mi ha lasciato senza parole, in una situazione di stallo di giudizio. Da una parte comprendendo il suo scoramento e rabbia (conseguenza forse delle stesse aspettative alimentate dai rapporti avuti con alcuni parlamentari), dall’altra sapendo il percorso in bilico al quale è costretta, con questo Governo, soprattutto la sinistra. Ecco allora che la sua indignazione verso i partiti della sinistra (e i relativi eletti) schierati col movimento pacifista mi è sembrata almeno in parte motivata, se non altro per una ragione: la scarsa trasparenza. Mentre infatti si vive una fase pre-finanziaria di (relativamente) positiva interazione fra partiti e movimenti, quando si entra nel percorso parlamentare di discussione e votazione sulla manovra poco si sa, o si viene a sapere, su ciò che capita per esempio in materia di “difesa” e spese militari. 36 C aro Lorenzo, purtroppo non sono in grado di seguirTi. Tu scrivi: se cade questo governo, torna la destra. Perché, questa è sinistra? Ma parliamo di argomenti politici. Il problema non mi pare tanto quello di “strategie” sul breve e medio termine. Penso alle nuove generazioni, al mondo che gli lasceremo, a cominciare dalla triste consuetudine di dare alla guerra il nome di “pace”, di considerare la parola “pacifista” come qualcosa di vergognoso, che sa di mancanza di valori quali la Patria, Dio e la famiglia e tutto quel che segue. Tu scrivi “torna la destra”. Ma come consideri l’opportunismo come regola dominante della politica? La guerra contro i poveri cristi? Come consideri il cinismo di chi lo stesso giorno che quattro lavoratori vengono bruciati vivi sul luogo di lavoro, dopo essersene andato alla prima dell’opera lirica alla Scala, se ne va a far bisboccia con altri 800 invitati ad un “pranzo di gala” | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | ©Augusto Casasoli/A3/Contrasto solidarietà internazionale 01/2008 forse pagato dai cittadini di Milano, o magari addebitato come spese per l’allestimento dello spettacolo? Avendo giurato fedeltà alla Costituzione della Repubblica democratica fondata sul lavoro. E due giorni dopo se ne va a rassicurare l’imperatore che lo spostamento di fronti di guerra ci sarà alla facciaccia dei cittadini teoricamente sovrani, sempre stando a quella Costituzione a cui ha giurato fedeltà? Come consideri il cinismo di un latifondista che ha frequentato per 13 anni un luogo di lavoro e maturato una lauta pensione che fa la battaglia in Parlamento sulla questione dei lavori usuranti, vale a dire sulla pelle di coloro che ce la rimettono sul lavoro? E che da questa posizione riesce a “ricattare “ un Prodi con tutta probabilità ben lieto di essere “ricattato”, dovendo rispondere a chi lo sostiene? O ad un governo che applica una sorta di “par condicio” prendendo i voti dai lavoratori e gli ordini dai padroni? Caro Lorenzo, qui non siamo di fronte a delle semplici “mele marce”, il cesto è incominciato a marcire da tempo, e sarebbe bene che ce ne rendessimo conto. Come giudichi un partito costruito nel modo più totalitario possibile che, sfruttando “l’antipolitica”, riduce il numero dei parlamentari in modo da rendere l’opposizione inesistente o comunque innocua? Qui quello che è in crisi e che è la vera vittima è la coscienza. Vogliamo, per “tattica”, “strategia”, chiamala un po’ come Ti pare, essere complici del suo massacro o piuttosto non dobbiamo cercare strade diverse? Vogliamo stare dalla parte di chi è potente e difende i propri privilegi, o dall’altra? Non credo che ci sia più possibilità di mediazione. E ormai il governo Prodi e la “maggioranza” sono il potere. E lo esercitano nel modo più “bieco” possibile specialmente nei confronti dei loro oppositori, una cospicua parte dei quali li ha anche votati ed è stata determinante per la loro ascesa. Ogni mediazione oggi non si chiama più così, con questa gente, ma il suo nome vero è “compromesso”. Credo proprio che altri due anni e mezzo di governo Prodi in queste condizioni ci porterebbero in una situazione ben peggiore che quella in cui ci ha conciati la gestione del potere da parte di Berlusconi e dei suoi accoliti. E temo che ogni giorno in cui si va avanti, aumenti di qualche misura la percentuale di successo della destra e nemmeno del centrodestra. E che alla fine saremo complici anche di questo, se non poniamo in qualche modo dei paletti. A me non pare proprio che Alex sbagli, come sostieni Tu, mi pare invece che, se non siamo noi a tenere alta la coscienza e a cercare di fare in modo che gli eletti siano “politici” e non “politicanti da McDonald’s”, non ci sia altro da fare che levare voci autorevoli come la sua. Che mondo vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi? E tutti quei poveri cristi che sono morti nella lotta di liberazione dove li lasciamo? Sono morti per i “pacchetti Treu”? O perché su un povero cristo che ti telefona per proporti un contratto telefonico ci mangino i responsabili di due agenzie che non fanno un tubo dalla mattina alla sera, anzi speculano sulla disoccupazione altrui? E i miei nonni e tutti coloro che si sono sacrificati perché questo paese avesse una rete di servizi, dall’erogazione della luce elettrica ai collegamenti ferroviari, dalle comunicazioni telefoniche all’informazione televisiva davano allo Stato una parte dei loro risparmi perché tutto questo venisse messo in mano con finte vendite alle banche e a speculatori che non hanno mai fatto nulla nella loro vita se non i playboys o i velisti e si fanno chiamare “industriali” o “imprenditori”? Certo i miei nonni ne ricavavano anche degli “interessi”, ma forse lo spirito con cui l’hanno fatto non era soltanto per tirare su qualche soldo per integrare la pensione. E a tutti questi come rispondiamo? Con la penosa risposta di Lidia Menapace ad Alex su “Il Manifesto” che ci è toccato leggere? Quei poveri cristi che si sono sacrificati, lo hanno fatto perché questo paese andasse in mano alle banche? Da qualche anno dico che in questo paese siamo al fascismo, ma non sembra che ce ne stiamo accorgendo. Basta vedere come procede la costruzione totalitaria di un partito, che si definisce “democratico”. Perfino l’enfasi rispetto al grande risultato sulla moratoria circa la pena di morte sa di strumentale, come la difesa dell’embrione da parte della gerarchia cattolica. Difendiamo quella vita che non ha nulla di scomodo, mentre non si muove un dito per tutelare quella vera, anzi si discrimina a più non posso, in nome dell’“amore di Dio”, tanto “misericordioso” sarà lui, se esiste. Forse quello che scrivi, caro Lorenzo, poteva essere ancora accettato nel primo anno di governo. Oggi mi pare fuori tempo massimo. Se crediamo nella coscienza e nel futuro di questo pianeta oggi dobbiamo scegliere da che parte stare, e non è certo quella del potere, anche se questo si fa chiamare “democratico”. L’opposizione è un dovere, lo scriveva diversi anni fa con altre parole don Lorenzo Milani, ma pare che ce ne stiamo dimenticando. A presto. Angelo 37 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 perchè sono d’accordo con Alex M i ero ripromesso, leggendo la tua lettera inviata ad Alex, di scriverti per dare voce ad una discussione che rischia di interrompersi sin dall’inizio. Personalmente non ci conosciamo, ma abbiamo - seppure “a distanza” - camminato insieme e ci ritroviamo in uno spazio comune, plurale ma unitario, com’è la Rete Italiana Disarmo. Dell’appello di Alex Zanotelli ho condiviso toni e sostanza, pur essendo consapevole del contesto politico-istituzionale di cui parli. Contesto che non giustifica affatto quei politici che, pur considerandosi ferventi pacifisti, non hanno fatto nulla di serio sia in ambito di Governo, sia sul piano parlamentare, per far passare due o tre cose inerenti la politica di difesa e le spese militari, a cui tutte le “persone di buona volontà” - compresi liberali e conservatori onesti – non avrebbero potuto dire di no. 38 ©REUTERS/Ahmad Masood GIANNI ALIOTI: Basta analizzare il numero e la qualità degli emendamenti presentati (che in quanto tali non fan cadere alcun Governo) e le numerose dichiarazioni pubbliche rilasciate dai leader della “sinistra radicale”, per capire che il potere di condizionamento e/o d’interdizione sulla finanziaria 2008 è stato giocato tutto su altri piani. La riduzione delle spese militari e il tema della riconversione non sono mai entrate tra i primi dieci (forse venti) punti dell’agenda politica di verdi, sinistra democratica, comunisti italiani e rifondazione. I pochi parlamentari che hanno cercato con coerenza e determinazione di fare quanto era nelle loro possibilità (cito fra tutte/i Francesco Martone e Silvana Pisa), non hanno raccolto nulla perché le priorità dei loro gruppi politici erano altre e perché, tutto sommato, anche a sinistra si è sempre creduto nelle “virtù keynesiane” delle spese militari e nel ruolo economico dello Stato attraverso la controllata Finmeccanica. Giustificare, quindi, le scelte politiche compiute per spirito di sacrificio a difesa della coalizione di Governo, mi sembra del tutto privo di fondamento. Su alcuni punti sostenuti da tempo dai portavoce della RID (vedi intervento di Francesco Vignarca al convegno “Armi da taglio” promosso dalla SD) o dalla campagna “Sbilanciamoci!”, bastava essere meno “autoreferenziali” e “radicali”, appoggiando il “rigore economicista” iniziale di Padoa Schioppa con il sostegno dei settori liberali al Governo, per portare a casa dei risultati concreti, senza mettere in crisi Prodi e la coalizione. Oppure bastava essere più trasversali per ottenere i consensi necessari a far passare alcune modifiche, agendo concretamente nelle Commissioni Bilancio e Attività Produttive, piuttosto che lasciare alcuni rispettabili parlamentari a lottare contro i mulini a vento nelle Commissioni Difesa, luogo tradizionale dove si concentra la lobby politica a sostegno del complesso militare-industriale. Perché non si è nemmeno tentato di percorrere queste strade? Si può ragionevolmente pensare che avrebbero messo in crisi il Governo? Significa (parafrasando la tua domanda) che Prodi o D’Alema si sono “bevuti il cervello” o “venduti alla lobby della guerra”? Se la risposta è sì, perché strapparci le vesti sull’eventuale crisi di Governo? Se la risposta è no, bisogna che - dopo due finanziarie generose verso l’appetito crescente del complesso militare-industriale italiano - ciascuno si assuma le sue responsabilità proporzionalmente al suo dichiarato “pacifismo”, senza ipocrisie e giustificazioni poco credibili. Su una cosa posso essere d’accordo con te: non mi sembra il caso di riconoscere capacità di rappresentanza politica a nome nostro (cioè di associazioni e movimenti) a Rossi e Turigliatto che, al di là di salvarsi l’anima votando contro, non mi sembra si siano mossi in sintonia con noi e con altri parlamentari su obiettivi concreti e realizzabili. Al contrario non condivido quando affermi che “andava (andrebbe) creato un canale di comunicazione tra il Movimento e i parlamentari che si riconoscono nelle sue ragioni”, come se non ci fossero stati - in questi due anni - momenti di confronto, riflessioni comuni e proposte condivise. Altro che “malintesi e aspettative fuori luogo”. Le associazioni ed i movimenti impegnati per il disarmo non hanno “chiesto l’impossibile”, pertanto non hanno nulla da rimproverarsi. La finanziaria 2008 non solo non ha portato alcun risultato sul versante della riduzione delle spese militari, della loro trasparenza e di una coerente relazione tra investimenti in nuovi sistemi d’arma, politica della difesa e politica estera, ma ha peggiorato le cose. Sono quindi altri che devono rendere conto dei loro atti di Governo e delle loro azioni parlamentari, dimostrando che il tema del disarmo è tra le priorità della loro agenda politica, cosa che ad oggi non hanno fatto. Gianni Alioti solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | Incontri: EMILIO MOLINARI Ci restano cinquant’anni Eugenio Melandri N on usa mezzi termini nel descrivere la situazione di crisi in cui versa il pianeta. Stiamo raschiando il fondo del barile e non siamo pronti a gestire la scarsità delle risorse. Una scarsità che ha effetti non solo ambientali, ma soprattutto sociali. Saranno i più poveri, infatti, a soffrirne di più. Il percorso umano e politico di Emilio Molinari, uno dei leader storici della nuova sinistra, è sempre stato caratterizzato dall’attenzione ai cambiamenti, e alle nuove sfide che questi cambiamenti ponevano alla sinistra, troppo schiava della sua stessa ideologia. Facendo spesso anche scelte di rottura, che soltanto in seguito diversi suoi compagni di strada hanno potuto capire. Parlare con lui è piacevole e stimolante, perché attraverso la sua storia si ripercorrono i sogni e le conquiste, ma anche le frustrazioni e i fallimenti di una generazione che avrebbe voluto cambiare il mondo. Oggi, dopo aver coperto diversi ruoli politici, consigliere comunale e regionale, Deputato europeo e senatore, è Presidente del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua. “ Emilio, non è facile oggi essere di sinistra. Anche perché si fa fatica a capire cosa significhi veramente. Ciò che significa lo dobbiamo scoprire. Anche mettendo in crisi alcuni miti sui quali ci siamo formati. La mia è la storia di una persona che da sempre si è impegnata nella sinistra. Sono nato nel 1939. Negli anni ‘50 ho cominciato a lavorare in fabbrica e ci sono rimasto per 22 anni. Provengo, quindi, dal mondo operaio e dalla militanza comunista. Ho partecipato al movimento sindacale. Ho fatto il ‘68 e contribuito alla nascita della nuova sinistra. In sintesi, posso dire che la mia formazione è stata di matrice operaia, comunista, marxista. La mia cultura politica si è sviluppata, quindi, nei luoghi classici della sinistra. Una sinistra, quella del ‘900 che ha rappresentato, certo, una grande epopea nella conquista dei diritti, da parte soprattutto dei lavoratori. È innegabile che essa abbia contribuito a cambiare la società, a difendere la giustizia. A costruire un pensiero democratico e a mettere le basi dello stato sociale. Ma una sinistra che ha anche coltivato miti di cui è rimasta essa stessa vittima. Pensa solo al mito della centralità della classe operaia, come classe che trasforma il mondo, e del potere, da prendere ad ogni costo. Oppure alla convinzione, che ha percorso gran parte del secolo scorso, dell’inesauribilità delle risorse. Al mito dello sviluppo, o della crescita come bene assoluto. Miti, questi, presenti non soltanto nel capitalismo, ma anche nel pensiero e nella prassi della sinistra. Lo stesso si può dire anche di un altro mito, quello della centralità del lavoro, presa in termini totalizzanti. Esso ci ha condizionato pesantemente. Contribuendo così a creare dei veri e propri mostri. “ Quando hai cominciato a capire che qualcosa doveva cambiare? Alla fine degli anni ‘80, un infarto mi ha costretto a fermare la mia attività e a passare diverso tempo in ospedale. Forse proprio questa condizione mi ha portato a riflettere e anche a mettere in crisi la mia militanza. Intendiamoci, non ho messo in crisi i valori di fondo che mi hanno sempre accompagnato: la lotta per l’uguaglianza, la giustizia e la libertà, contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. La lotta per una società più giusta dove a tutti sia garantito il diritto di vivere dignitosamente. Ma trovarmi in ospedale con gente normale, con l’idea che l’infarto che mi aveva colpito avrebbe potuto limitare definitivamente la mia attività, mi ha fatto capire che forse vivevo in modo astratto questi valori. Lontano dalla vita comune della gente. Sai, chi si impegna in politica in modo quasi totalizzante corre il pericolo di parlare solo con chi usa lo stesso genere di linguaggio. Le sofferenze vere ti sfuggono e rischi di perdere il contatto con quelli che dici di voler difendere. In più, proprio in quegli anni cominciavano a emergere prepotentemente alcune nuove questioni. “ Quali? Innanzitutto la questione ambientale. C’era stata la prima conferenza delle Nazioni Unite a Stoccolma nel 1972, e proprio nello stesso anno era stata pubblicata la ricerca del M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) che denunciava i limiti dello sviluppo e proponeva la crescita zero. Non ce ne eravamo accorti. Ma poi i fatti ci hanno portato a capire che l’emergenza ambientale aveva una grossa rilevanza sociale. Ho cominciato a interessarmene in modo assiduo. Penso di essere stato ai tempi il primo politico che ha cominciato a girare le discariche. Abbiamo scoperto così che i rifiuti tossici del Nord d’Italia finivano in Campania o peggio nel Sud del mondo, in Africa, fra i Saharawi, in Venezuela, in Somalia. Una partita, questa, a cui la sinistra pareva completamente indifferente. Poi, siamo a metà degli anni ‘80, fu il tempo della denuncia della corruzione politica 39 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | cominciava a delinearsi tangentopoli. Una realtà che non i compagni sembravano non capire, credendo che fosse un fenomeno solo interno alle istituzioni, senza riflessi sociali. Eppure si trattava di un vero e proprio sistema, che coinvolgeva sia il governo che l’opposizione. Ho cominciato allora a capire che qualcosa non funzionava nella sinistra storica. Nel marxismo stesso. Che dovevamo rivedere e correggere i nostri parametri. “ Per cui…? Ho lasciato Democrazia Proletaria, avvicinandomi al mondo “verde”. Poi nel ‘94 ho lasciato anche i verdi, poiché anche nel mondo politico ambientalista non avevo trovato punti e stimoli per una nuova narrazione, ma soltanto una sommatoria di piccole storie e di piccoli interessi, anche personali. Per me, te lo assicuro, si è trattato di scelte traumatiche e difficili. Nel ‘94 ho incontrato l’esperienza del Chiapas di Marcos e ho cominciato a seguirla e poi ciò che succedeva in Bosnia e nella ex Jugoslavia. Due situazioni diverse che mi hanno fatto scoprire realtà nuove e drammatiche. Poi, dopo un incontro organizzato qui a Milano da Mani Tese e da Punto Rosso, mi sono avvicinato al movimento dell’acqua, con Petrella. Mi è sembrato allora di capire che non si trattava di una semplice battaglia politica, anche importante, ma di un nuovo modo di fare politica a partire dai beni comuni. Poco tempo dopo abbiamo dato vita al Comitato Italiano dell’Acqua. Da allora mi sono impegnato fino in fondo in questa partita. “ Torniamo un attimo indietro. Sono passati 40 anni dal ‘68. A tanti anni di distanza, quali sono state le luci e le ombre di questo evento? Il ‘68 è stato una cosa molto complessa e contraddittoria. La tendenza oggi, a quarant’anni dagli accadimenti, è quella di demolirne la memoria, presentarla alle giovani generazioni come la madre di tutti i mali. Credo tuttavia si possa dire che si è trattato di una rivoluzione mancata che, però, ha gettato i semi di nuove narrazioni, assolutamente riprendere se vogliamo uscire dalla crisi di civiltà che ci ha consegnato il ‘900. Il ‘68, infatti, ha segnato la rottura con alcuni elementi tipici del potere. Tutto è nato all’insegna di alcuni fenomeni internazionali, che a quei tempi abbiamo letto in termini classici, ma che portavano dentro di loro i germi di un futuro. Abbiamo capito che se ce la potevano fare i contadini vietnamiti, se ce la potevano fare a Cuba, potevamo farcela anche noi. Il potere, 40 solidarietà internazionale 01/2008 malgrado abbia la bomba atomica e i servizi segreti, può avere i piedi d’argilla. Può essere sfidato se prendiamo in mano il nostro destino: “Non deleghiamo!”, si disse allora. Ma la cultura con cui abbiamo affrontato questi temi era ancora quella del passato. Ricca, certo, ma non in grado di leggere le nuove realtà. Non siamo riusciti a collocare questi nuovi scenari dentro al territorio dove vivevamo. Non siamo stati capaci di cogliere che si stava costruendo una società angosciante, stretta nel morso dell’industrializzazione. C’erano già i segnali di una crisi ambientale. Ma non siamo stati in grado di valutarne la sua portata, presi, come eravamo, dai nostri miti. La centralità della fabbrica, ad esempio. La fabbrica non è un valore, è un incubo. Che costruisce al suo proprio interno modelli gerarchici e di dominio. Non siamo stati capaci di fare davvero i conti con le questioni legate al potere e alla sua gestione, perché dentro di noi avevamo stampati gli stessi modelli di potere. L’idea della violenza come levatrice di nuove relazioni. La creazione di partiti, piccoli eserciti strutturati per prendere il palazzo. In più, senza quei legami di massa che avevano caratterizzato le lotte dei nostri padri. In una sorta di nuova aristocrazia di sinistra. È innegabile tuttavia, che nonostante queste contraddizioni, il ‘68 abbia rappresentato un grande momento di modernizzazione di questo paese e di un grande processo di acquisizione di diritti. quanto sia attuale. Siamo ad un punto di non ritorno. I cambiamenti climatici e la scarsità delle risorse (acqua e petrolio in primo luogo) ci impongono di frenare la crescita. Di cominciare a decrescere. Ma se vogliamo decrescere dobbiamo abbandonare l’idea di produrre sempre di più. “ “ Ma poi, alla fine, sembra che tutto sia rientrato. Forse proprio perché non eravamo attrezzati culturalmente a cogliere la portata del grande cambiamento per cui ci stavamo battendo. Ti faccio un esempio che ritengo molto significativo e che mette in evidenza il significato, anche culturale, di alcune conquiste che abbiamo fatto. Dal ‘66 al ‘69 i metalmeccanici abbattono otto ore di lavoro settimanale. Passano da 48 a 40 ore. Ottengono questo diritto, con la convinzione che ci siano altre cose importanti: il tempo libero, il sabato per stare con la famiglia, andare con la morosa. Oppure per leggere, andare al cinema o a teatro. C’è dietro una nuova concezione della vita e del lavoro. Non si vuole più legare il salario alla produzione. Nasce la battaglia contro il cottimo, che in pochi anni scomparirà definitivamente. Il salario, dicevamo, non deve essere legato alla produzione, ma ai rapporti che si stabiliscono con la contrattazione tra gli operai e gli imprenditori. Se leggiamo oggi questa conquista, ci accorgiamo di “ Senti, Emilio, mi pare di sognare. Mentre diciamo queste cose, oggi i sindacati per primi propongono di legare i salari alla produzione. È questa la sfida. Se non siamo capaci di mettere insieme in fretta gli spezzoni di un nuovo pensiero politico su scala mondiale, non riusciremo a cavarcela. La sfera della politica tradizionale va infatti da tutt’altra parte. Anche i sindacati. Per questo sono importanti i movimenti come il Social Forum o i Movimenti dell’acqua. Anche la sinistra sta dentro all’involucro della crescita. Non si ha il coraggio di dire che siamo arrivati al limite. Che il modello precedente non regge più. Dobbiamo ridurre i consumi e rimodellare la nostra vita. Per cui dobbiamo anche ridurre e ridistribuire il lavoro. Siamo arrivati al capolinea del petrolio e non sappiamo che fare. E tutto questo ha implicanze sociali enormi, i cui costi cadranno sui più fragili. La carenza di risorse e i costi degli interventi pubblici stanno espellendo i più deboli dal diritto alla vita. Il venire meno delle risorse non fa altro che selezionare chi le usa. Noi occidentali responsabili del disastro abbiamo il diritto di chiedere agli altri paesi comportamenti diversi? È vero. Paradossalmente, però, questi paesi devono capire bene verso che tipo di sviluppo stanno andando. La Cina in questo momento ha il 12% di crescita del Pil, sta invadendo i mercati, sta avendo un peso indiscutibile nel mondo, finalmente multipolare. Ma lo sta facendo in termini capitalistici. Lo stesso sta avvenendo in India e in Brasile. Il Brasile, ad esempio, sta mettendo sul mercato l’Amazzonia. Ma la gente non regge questo sforzo. La Cina non ha più risorse idriche. Deve fare dighe per mantenere tutta l’acqua. E questo la mette in conflitto con il SudEst asiatico. I livelli di inquinamento sono spaventosi. Le falde diminuiscono di tre metri all’anno, i costi di recupero dell’acqua sono enormi. Se continuerà in questo modo sarà costretta a fare una selezione spaventosa nell’accesso ai consumi e si determineranno divisioni e spaccature sociali di rilevanza enorme. L’India è nella stessa situazione. E solidarietà internazionale 01/2008 intanto si stanno raschiando i barili. La strada dei bioconbustibili è impercorribile, perche ci sono centinaia di milioni di persone che devono mangiare. Cina e India non se lo possono permettere. L’unico paese che può farlo è il Brasile. E sta tentando di giocare fino in fondo questa carta. La gioca bene perché lo fa in nome dell’autonomia del Sud America. Ma cosa avverrà nei rapporti sociali complessivi? Sta bruciando l’Amazzonia, ma rischia di creare un disastro mondiale. Sbilancia il mercato dell’alimentazione, con conseguenze che non riusciamo a immaginare. Devia i fiumi, come il Rio San Francisco. Ma quali devastazioni umane sta creando? Alle foci del Rio delle Amazzoni ci sono in continuazione petroliere cinesi che vengono a prelevare acqua e la portano via. Il che significa che sono ormai davvero con l’acqua alla gola. Da Gasprom arriveremo a Idroprom? Dobbiamo capire che l’idea del progresso e della modernità come l’abbiamo concepita fino adesso è arrivata al capolinea. “ Uno scenario non certo incoraggiante. Non temi l’accusa di catastrofismo? Io credo che i problemi debbano essere guardati in faccia. E sono sicuro che ormai abbiamo poco tempo a disposizione per trovare la strada. Paradossalmente mi pare che stiano nascendo alcuni importanti anticorpi proprio al centro dell’impero. La posizione di Al Gore, ad esempio, pur con tutte le contraddizioni che porta, è da questo punto di vista molto interessante. Per il resto non si vede molto all’orizzonte. Anche perché lo stesso movimento troppo spesso soffre di autoreferenzialità, e rischia di riprodurre al proprio interno le contraddizioni e i vizi dei partiti politici. Va costruito con tenacia un modello diverso. “ Facile dirlo, ma come? Vedi, non è un caso che ormai tutti, anche i mass media, riconoscono che questo è il problema, senza però riconoscere i soggetti sociali che cercano di individuare nuove strade. Eppure i Movimenti dell’acqua e della terra stanno cominciando ad ottenere qualcosa. I Movimenti dell’acqua hanno vinto in Bolivia, in Uruguay, in Ecuador. Stanno condizionando le scelte in Italia. Lo stesso si può dire dei movimenti per la terra. Di nuovo siamo sfidati dalla terra, dall’acqua e dal fuoco (energia). Io penso che se tutto questo è vero, se acqua, terra e fuoco stanno esaurendosi, non passiamo più ragionare nei termini | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | del novecento. O anche di prima. Abbiamo sempre pensato al futuro con l’idea che l’età dell’oro stia davanti a noi. Oggi bisogna pensare a una politica che non ha tempi indefiniti. Abbiamo poco tempo. Dobbiamo risolvere questi problemi nei prossimi cinquant’anni e innescare processi di cambiamento capaci di rimodellare i principi produttivi, gli stili di vita e i consumi. Anche la sinistra, attorno a questi grandi temi essenziali, deve abbandonare il mito dell’avvenire. “ Prova a spiegare, come? Occorre ridare alla politica una missione e delle priorità. All’inizio del novecento le reti pubbliche, idrica, ferroviaria ed elettrica, furono costruite insieme dalla destra e dalla sinistra. Come una conquista sociale a cui tutti erano interessati. È necessario allora che regoliamo l’agenda su queste priorità. Una sinistra che mette tutto sullo stesso piano rischia di diventare demenziale. Occorre definire le priorità. Tu sai quanto sia stato sempre attento ai diritti civili. Ma mi pare che oggi i veri problemi siano altri e che non sia intelligente cadere dentro la trappola dell’anticlericalismo inseguendo o precedendo il Papa su temi che sono sì rilevanti, ma non “ultimativi” come questo. Ma sono davvero queste le priorità dell’umanità? A me sembra che ci sia una sinistra impazzita. Che si porta dentro la memoria dei propri passati personali e si muove partendo da questi, dal proprio personale, erigendoli a linea politica generale. È importante il femminismo, certo. Sono importanti i diritti degli omosessuali. Ma non è questa la dimensione dei problemi del mondo. Il mondo è attraversato dalla crisi delle risorse. Tre quarti di questo mondo vivono altri problemi. E noi scambiamo i nostri desideri per diritti e i desideri della nostra memoria o della nostra esperienza personale per politica generale. Guarda ciò che è successo col Papa alla Sapienza. Se questo è vero, i nostri parametri della politica sono andati a pallino. Ci sono ancora persone che hanno fatto parte dei comitati antifascisti militanti degli anni ‘70 e continuano così, come se niente fosse cambiato. Anzi, vedono il pericolo fascista oggi con gli occhi del passato. Invece abbiamo pochi anni per costruire una politica capace di dare risposte nuove. Ecco la centralità dell’acqua e dei beni comuni, che non possono non interessare sia la destra che la sinistra. Sui beni comuni non possiamo dividerci come popolo, come cittadini. “ Emilio, riprendiamo da dove eravamo partiti. Ha ancora senso allora, essere di sinistra? E che significato ha? Certo che ha senso. La sinistra è per me la lotta al privilegio dei potenti e la riscossa dei deboli. Da sempre ho conosciuto questa divisione sociale: da una parte i “sciuri” e dall’altra i poveri. È ciò che ha accompagnato le lotte della fine dell’ottocento e del novecento. Non per invidia. Per senso di giustizia. Questa per me è ancora la sinistra. Le sovrastrutture arrivano dopo. La sinistra deve ripartire da qui, e con una visione mondiale. Prima erano i poveri del tuo paese, della tua nazione. Al massimo era il proletariato internazionale, dove però i poveri africani, ad esempio, non avevano spazio. Oggi, se vogliamo ricostruire davvero la sinistra, dobbiamo ritrovare questa dimensione mondiale di lotta al privilegio. Dobbiamo metterci al fianco di chi è davvero “proletario”, cioè ricco soltanto della propria prole. “ Un’ultima domanda. La sinistra ha sempre voluto cambiare il mondo. In che relazione sono cambiamento del mondo e cambiamento personale? È possibile cambiare il mondo, senza cambiare se stessi? Faccio parte di una generazione che ha vissuto il periodo del boom economico. In quegli anni, forse noi giovani di allora abbiamo avuto a disposizione più possibilità di quelle dei ragazzi di oggi. Potevamo andare al cinema, anche alle “prime visioni”. Andare in vacanza. Stare fuori nei weekend. Posso dire che la mia è stata una generazione molto felice. Ma il cappotto mi durava vent’anni e non mi vergognavo se non era nuovo e mi veniva passato da un altro della famiglia. Non avevamo l’orgia dei vestiti, della macchina nuova, del telefonino da cambiare ogni anno. Eppure eravamo felici. Forse dobbiamo andare alle origini vere della felicità. Non facendo del pauperismo, ma ritornando all’essenziale. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo anche cambiare noi stessi. Dopo di che non so se siamo in grado di farcela. Dobbiamo cambiare i nostri modelli personali. Le modalità già ci sono: il consumo critico, il commercio equo e solidale, il turismo responsabile. Tutte cose e comportamenti che dobbiamo certo riempire di contenuti politici. Ma che sono indispensabili per rendere vere, credibili ed efficaci le proposte di radicale cambiamento che sono necessarie per far sopravvivere il mondo. Cambiare se stessi non è sufficiente, ma è certo necessario per cambiare il mondo. (eugenio. [email protected]) ▪ 41 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | a cura di T. Miglino co r s i e n o n s o lo Scuola della nonviolenza Addio alle armi - Anno scolastico 2007/08 Proseguono gli incontri, organizzati da Ferrara Terzo Mondo, il Movimento Nonviolento e la Regione Emilia Romagna, sulla scuola della nonviolenza. Gli incontri si tengono presso la sede AIAS, g.c., via Cassoli 25/i – Ferrara, e per il mese di gennaio prevedono i seguenti appuntamenti: venerdì 11 gennaio ore 21: L’antimilitarismo preso sul serio - con Mao Valpiana, Direttore di Azione Nonviolenta; venerdì 18 gennaio ore 21: Difendersi dalle armi - con Massimiliano Pilati, Rete italiana per il disarmo; venerdì 25 gennaio ore 21: Il diritto contro la guerra - con Cristiana Fioravanti, Università di Ferrara. solidarietà internazionale 01/2008 co r s i e n o n s o lo Master internazionale in Microfinanza (terza edizione) Lunedì 21 gennaio 2008 alle ore 10.30, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo, prende il via la terza edizione del master internazionale in microfinanza, per cittadini extracomunitari. Partecipano 25 persone dei seguenti paesi: Argentina, Camerun, R.D. Congo, Etiopia, Ghana, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia. Il 30% sono donne. Il Master è organizzato dal CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale - e dall’Università degli Studi di Bergamo. Sviluppa un itinerario di formazione e di specializzazione per operatori e quadri provenienti dal mondo degli intermediari finanziari, delle Ong locali, delle istituzioni impegnate nel settore della cooperazione e della solidarietà internazionale o per persone che in tali ambiti desiderano trovare una collocazione lavorativa. Può partecipare al Master - a pagamento - anche un ridotto numero di italiani. L’obiettivo strategico del Master è quello di rafforzare le competenze professionali di chi si occupa di promozione di intermediari finanziari nei paesi impoveriti e della loro capacità di rispondere ai bisogni delle popolazioni marginalizzate dal sistema finanziario, con particolare attenzione ai paesi del Sud del mondo. co r s i e n o n s o lo XIII Corso di Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli La Fondazione Basso - Sezione internazionale - e la Scuola di giornalismo, dando seguito alla tradizione ormai consolidata dei Corsi di Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli, promuovono per il 2008 una serie di incontri sul tema: le conseguenze della guerra sulla salute delle popolazioni. Il corso del 2008 non sarà solo una serie di conferenze su alcuni temi che riguardano la guerra, ma sarà in se stesso una ricerca: intere zone del pianeta sono divenute luogo di sperimentazione di armi che producono effetti tragici sulle popolazioni locali. Tonnellate di sostanze tossiche nocive sono state utilizzate nei bombardamenti nella prima e nella seconda guerra del Golfo, nei conflitti in Kosovo, in Libano e in Afghanistan. Sono stati programmati sette incontri che avranno come oggetto: la situazione in Afghanistan (laboratorio Afghanistan), in Libano (laboratorio Libano) e in Iraq (laboratorio Iraq), in seguito alla sperimentazione di “nuove armi” nei recenti conflitti; le menzogne che circondano l’utilizzo dell’uranio impoverito, le ragioni della sua segretezza e le potenzialità del suo uso pacifico; la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione delle “nuove armi; la dipendenza della ricerca scientifica da fondi legati a politiche belliche e sulla necessità di garantirne l’indipendenza. A conclusione del corso, si terrà un seminario finale che analizzerà la situazione complessiva tra presente e prospettive future. Per tutte le informazioni sul corso e sulle modalità d’iscrizione contattare la Segreteria della Fondazione Basso - Sezione internazionale: via della Dogana Vecchia, 5 - 00186 Roma. INFO Tel. e Fax: 066877774 E-mail: [email protected] Web: http://www.internazionaleleliobasso.it 42 solidarietà internazionale 01/2008 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | a ppu n ta m e n t i Il futuro di Gandhi A sessant’anni dalla scomparsa Il Centro per la Pace del Comune di Bolzano apre una riflessione interculturale sulla lezione di uno dei personaggi simbolo del nostro tempo. Sono infatti passati sessant’anni dalla morte del profeta della nonviolenza. Poche ore prima di venire colpito da una pallottola Gandhi disse: «Se anche ora venissi colpito da una pallottola e nel morire pronunciassi solamente il nome di Dio senza offendere nessuno, allora significa che la mia pretesa è stata raggiunta». La pretesa di Gandhi era quella di rendere l’umanità nonviolenta, ossia capace di risolvere le controversie non attraverso l’uso della forza, ma attraverso la forza insopprimibile della ragione e del buon senso. Ora, dopo sessant’anni ci si accorge che Gandhi è stato un uomo del futuro. La sua azione si spalanca nell’avvenire. L’appuntamento è per mercoledì 30 gennaio 2008 alle ore 20.30 presso la sala di Rappresentanza del Comune, Vicolo Gumer, 7 a Bolzano. INFO Centro per la Pace Palazzo Altmann, Piazza Gries 18 - 39100 Bolzano E-mail: [email protected] n ot i z i e La Banca del Sud Nasce la Banca del Sud, la risposta latinoamericana a Fondo monetario e Banca mondiale Il Sud America fa un passo deciso verso l’autonomia finanziaria e l’integrazione economica regionale. Il 10 dicembre, a Buenos Aires, è nata la Banca del Sud (Bds), che si propone come alternativa locale alle grandi organizzazioni finanziarie internazionali. Banca mondiale (Bm), Fondo monetario internazionale (Fmi) e Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) per decenni hanno dominato incontrastate nella regione, imponendo, sotto il ricatto dei finanziamenti, politiche economiche spesso fallimentari. La Bds dovrebbe essere operativa già a marzo 2008. La Bds concederà prestiti per lo sviluppo, cercando di favorire l’integrazione regionale (il Bid, rivolto esclusivamente all’America latina, destina a tale scopo solo il 2 per cento dei suoi prestiti). A differenza di Fmi e Bm, a tutti i soci sarà assicurata la parità di voto, a prescindere dall’apporto di capitale. La sede principale della banca sarà a Caracas, in Venezuela, ma sono previste delle filiali anche a Buenos Aires (Argentina) e La Paz (Bolivia). libri Conoscere e raccontare i mondi “sconosciuti” 780 pagine 15 grandi capitoli (Carcere, Infanzia e adolescenza, Famiglia, Anziani, Disagio abitativo, Lavoro, Salute, Emarginazione e povertà, Disabilità, Droghe e dipendenze, Sicurezza criminalità e tutela dei diritti, Economia e finanza etica, Ambiente, Volontariato e terzo settore, Immigrazione) 225 tabelle statistiche 921 siti web 264 segnalazioni bibliografiche Decine di riferimenti legislativi e box di approfondimento. Migliaia di dati e notizie sui temi oggi al centro delle politiche per il welfare. Siamo convinti che conoscere i mondi spesso “sconosciuti” del sociale aiuti a interpretare la realtà non solo sulla quantità dei fenomeni, ma anche sulle loro caratteristiche. Questa edizione della Guida non solo si aggiorna nelle cifre, ma si “muove” in segmenti nuovi, come d’altra parte si muovono i costumi della società italiana. Come la precedente del 2006 segue l’impostazione e il linguaggio dell’agenzia giornalistica quotidiana che, con il suo Centro documentazione, l’ha realizzata. Una Guida scientifica, scevra da giudizi che spettano a chi fa la legge e la interpreta, ma che vuole essere utile strumento per chi incontra e scrive sugli avvenimenti sociali. 43 | rubriche | copertina | cose | dossier | intervista | bacheca | solidarietà internazionale 01/2008 storie musulmane Michele Zanzucchi Taip, l’agricoltore 1999 in Albania, durante la guerra del Kosovo. Tra Milot e Rubik, sulla strada maledetta (per via dei banditi che la infestano) e benedetta (per la salvezza di tanti) proveniente da Kukës, si erge un monumento nazionale, il ponte di Zog, ad arcate in cemen- Gjader, Missione Cattolica di Don Antonio Sciarra. Fedeli all'uscita dalla messa. © E L I G I O PAO N I / CONTRASTO 44 to, che attraversa il letto del fiume Mat. Albert, il mio accompagnatore, originario proprio di queste parti, mi spiega come risalga all’epoca − rimpianta, oh come rimpianta! − dell’occupazione italiana, che diede al Paese quella rete di infrastrutture che ancor oggi sostiene la nazione: ferrovie, strade e acquedotti. Due anni fa il ponte era stato chiuso perché pericolante: nel giro di qualche settimana le ringhiere di ferro erano sparite. Ora, nell’emergenza, è stato riaperto spontaneamente dalla gente: attraversarlo dà i brividi, per via dei pilastri di cemento armato scarnificati e delle paurose voragini nelle campate. Milot è passaggio obbligato per chi vuole scendere da Kukës verso la capitale. Su questa strada passa la lunga teoria, che parte dal Kosovo in fiamme, composta da carri, carretti, automobili e furgoni senza targhe, trattori, convogli militari, asini, potenti Mercedes che trasportano giornalisti e gigantesche jeep delle organizzazioni umanitarie. In uno dei primi giorni della tragedia, pioveva e tirava vento, un carro perse una ruota. Gli occupanti furono costretti a scendere, perché il danno era irreparabile dopo tanti chilometri di stenti. Si fermarono proprio dinanzi alla casa della famiglia K., papà musulmano e mamma cattolica: il figlio ha scelto la religione della madre. Il padre, Taip, non ha esitato più di tanto e se li è presi in casa, trasferendosi addirittura con i suoi in un locale molto più modesto, poco più di una porcilaia, nel cortile dietro l’abitazione, tra galline e un grosso maiale. «Loro erano in tredici, noi solo in tre»: Taip giustifica solo con queste lapidarie parole il suo gesto, come fosse la cosa più naturale al mondo. Mi conduce dapprima a visitare il suo appartamento, quello dato ai nuovi ospiti, costruito in decenni di lavoro mattutino nei campi sassosi, ma soprattutto nei piccoli lavori fatti nel pomeriggio in giro per la valle che porta a Kukës, preda troppo spesso delle bande di ladroni che infestano la regione. Poi scendiamo nel nuovo alloggio, che evidentemente la moglie è riuscito a rendere abitabile, nonostante l’umidità e l’assenza di un pavimento di cemento: la terra battuta tiene. «Bisogna sapersi adattare alle alterne vicende della vita», mi dice Taip, scacciando con la mano un grosso ragno che passeggia tranquillamente sul suo letto. Parlo con la famiglia accolta da Taip. Come tanti nuclei provenienti dal Kosovo, ha una struttura matriarcale. È la nonna, la più anziana, che mi racconta l’ennesimo calvario, da Dečani fino a Milot: «I soldati ci sparavano all’impazzata appena dieci centimetri sopra la testa. C’erano morti e feriti sul ciglio della strada, e le granate scoppiavano al nostro passaggio. Davanti a Žur due case bruciavano: i miliziani serbi vi avevano rinchiuso gli abitanti musulmani, gli uomini, sprangando porte e finestre prima di appiccare il fuoco. Ho ancora l’odore di carne bruciata nelle mie narici, carne animale e umana». Ma l’anziana donna kosovara mi racconta anche un commovente gesto del vicino serbo: «Quel brav’uomo, un timorato di Dio, ci aveva dato il suo carro per fuggire. Ma dei miliziani vagavano nei paraggi. Così ci ha nascosto nel suo fienile, mentre i soldati devastavano la nostra abitazione. Una volta che se ne furono andati, ci ha fatti uscire e scappare». Marie, la moglie di Taip, è contagiosamente ottimista. Cerco di capire cosa l’abbia spinta a ospitare gente sconosciuta. «Perché parli di gente sconosciuta? Sono come i miei figli, sono ormai della mia famiglia, non li dimenticherò più. Cosa avresti fatto al mio posto?». Non posso continuare la conversazione, Taip mi costringe ad accettare un invito a pranzo. È un fiume in piena: «Ieri ho accompagnato una signora fino al mare, a Durazzo: avevo saputo che il figlio di 21 anni era stato ucciso… Tratto i bambini della famiglia accolta a casa mia come miei figli… Io? Sono cresciuto senza una vera casa, perché mio zio era fuggito in Italia e i miei contestavano Hoxa e il suo modo di fare, per cui il governo ci aveva tolto la casa. Vivevamo in una baracca, proprio dove oggi c’è il nostro “secondo appartamento”. So bene cosa voglia dire rimanere senza nulla… Sì, c’è gente che si fa pagare per ospitare i kosovari, anche in questo paese di Milot. Potrei farti nomi e cognomi. Ma che vuole, la povertà qui è tanta, e si può capire anche questo cinismo. Io no, assolutamente, ho accolto la famiglia gratis… Questa gente resterà con noi finché non potrà tornare in Kosovo: gliel’ho promesso. Se troveranno la loro casa distrutta, cercheremo di fare in modo di ricostruirla… Certi amici e colleghi mi prendono in giro perché ho dato la mia casa ai kosovari. È vero, ora non ho più la doccia e mi devo lavare nell’orto. Ma sono più contento così». Verrò poi a sapere che Taip, nella sua Milot, con altri amici ha attrezzato una camionetta da cucina da campo e, all’ora dei pasti, offre gratis ai profughi un pasto caldo e un bicchiere di bibita. Si sono istallati vicino al gabbiotto della polizia, sia per evitare assalti da malintenzionati, sia perché così la polizia stessa può inviare loro i casi più bisognosi. Rivedo così Taip che ferma le auto con un sorriso grande come le sue mani di indefesso lavoratore. ([email protected]) ▪ 15.02.2008 DAL 16 febbraio 2008 www.soint.it
Scarica