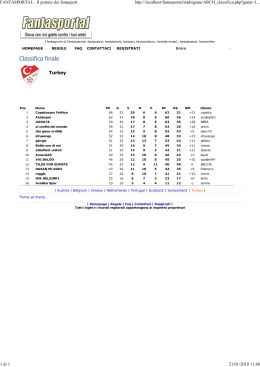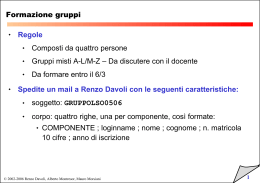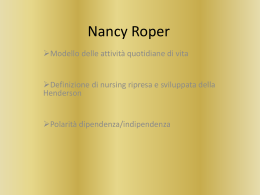Renzo Baldo Interventi su BresciaOggi 1976 – 1977 Quest'opera di Renzo Baldo è concessa sotto la Licenza Creative Commons Attribuzione: Non commerciale - Non opere derivate INDICE 1976..................................................................................................................... 5 Ucciso dalla violenza che combatteva.............................................................6 La folgorante nascita di una poesia civile....................................................... 7 Gli intellettuali e la guerra.............................................................................. 8 Malraux “politico”......................................................................................... 10 La “provincia” e lo scoccare dei diciotto anni................................................11 La pluralità dei significati…........................................................................... 12 Tra sogno e realtà.......................................................................................... 13 Una frattura storica....................................................................................... 14 La bomba di Piazzale Arnaldo....................................................................... 16 Walter Rathenau e l’autocritica del capitalismo........................................... 17 Piazzale Arnaldo: in fretta, non alla cieca..................................................... 19 1977.................................................................................................................. 20 Hanno detto… Parise, Ginzburg.................................................................... 21 Anche la Spagna nel mondo occidentale...................................................... 22 Un’apertura significativa...............................................................................23 Solo il tempo di farsi amare.......................................................................... 24 Si continua a morire...................................................................................... 25 L’affare Lockheed.......................................................................................... 26 Al bivio........................................................................................................... 27 Legalità e valori civili.................................................................................... 28 Primo Maggio................................................................................................ 29 Ripristinare garanzie credibili...................................................................... 30 L’ombra di Keynes?....................................................................................... 31 Una fuga simbolica........................................................................................ 32 Trent’anni di braccio di ferro........................................................................ 33 “8 Settembre”: una data da non archiviare.................................................. 34 La critica delle armi....................................................................................... 35 Cristianesimo e rivoluzione.......................................................................... 36 Tra antico e nuovo, una mediazione difficile............................................... 38 Nell’aula di Catanzaro...................................................................................40 L’abisso tragico del terrorismo politico........................................................ 41 I titoli dei giornali su Berlinguer e il vescovo............................................... 42 I servi dello Stato?......................................................................................... 43 Il rispetto per la vita...................................................................................... 44 Un episodio preoccupante............................................................................ 45 4 1976 RENZO BALDO La morte di Pier Paolo Pasolini Ucciso dalla violenza che combatteva A Brescia, una decina di anni or sono, una sera Pier Paolo Pasolini non riuscì ad entrare nel salone Da Cemmo, dove doveva parlare sul tema “Marxismo e cristianesimo”, tale era il rigurgito di folla, ammiratori. curiosi, amici e nemici, che si agitavano sulle scale e nei corridoi, bloccandone l’accesso. Quell’episodio rivelava forse l’aspetto più affascinante di Pasolini, che, in tempi nei quali i poeti quasi esclusivamente scrivono per lettori professionali, forse unico in Italia ha riproposto l’idea dello scrittore come specchio di problemi collettivi, con tale ventata di passione, da coinvolgervi di forza amici e nemici, guardandoli tutti con il suo occhio pieno di innocenza disarmante e di tagliente energia critica. Questo risultato Pasolini conseguiva, annullando totalmente ogni residuo mito superomistico, portando a compimento un processo, che era in corso da mezzo secolo, ma che solo in lui ha trovato così piena realizzazione. Da questo punto di vista non vi è dubbio che scompare tra noi lo scrittore probabilmente più significativo del nostro tempo. Egli scompare vittima di un episodio oscuro di violenza, che la banalità della cronaca si affretta a definire in termini di vita privata. alzando un’inquietante cortina, per ora leggibile soltanto in chiave di simbolo. Raramente è dato di morire in una chiave così dolorosamente simbolica. È stato distrutto dalla violenza chi come nessun altro ha avuto orrore della violenza e l’ha rappresentata e perseguita scoprendone, al di là di ogni facile esistenzialismo, le radici storiche e sociali, soffrendone la presenza negli strati sottoproletari, denunciandone con straordinaria lucidità. le origini più profonde, che si annidano nel tessuto più profondo di quello “sviluppo” consumistico, che a Pasolini appariva come la matrice del male odierno del mondo. E – particolare di cronaca non privo di dolorosa suggestione – a questo male, nei suoi aspetti, che costellano tragicamente la nostra vita quotidiana, erano esplicitamente dedicati gli ultimi suoi scritti, recentemente apparsi sulla stampa italiana. Ma non sarà ozioso congetturare, almeno sotto l’urgenza dell’emozione che ci prende ad una notizia così piena di angoscia, che forse davvero Pasolini era preordinato a sparire come vittima della violenza, e non perché frequentava ambienti dove la violenza è costume di vita, ma perché da sempre egli è stato oggetto di odi e di profondi rancori, come nessun altro, proprio perché lucida, intransigente e coraggiosa era la sua denuncia, irremovibile la sua aspirazione a far vincere le aspirazioni dell’uomo contro tutte quelle forze che hanno interesse a che la ragione non trionfi. Come nessun altro, e soprattutto nel mondo della cultura, dove più esplicitamente oggi si esige chiarezza e coraggio. La commozione per questa morte è dettata dallo sparire di un uomo, che tanto ha detto di noi e del nostro tempo, aiutandoci a chiarirne pieghe conturbanti e a scoprirne realtà di grande rilievo, è dettata dal venire meno di una voce coraggiosa e attenta, come è stato detto, alla “sostanza civile delle cose “, ma si fa più intensa e tragica, se si avverte che essa è senza dubbio un anello di una catena, che si snoda orribile sotto i nostri occhi, una catena che è stata montata accuratamente un po’ dappertutto in Italia e fuori. 4 Novembre 1975 BresciaOggi 1976 6 RENZO BALDO Tra caos sottoproletario e disumanizzazione neocapitalistica La folgorante nascita di una poesia civile Nell’arco della letteratura del nostro secolo la lirica di Pasolini conquista un nuovo linguaggio poetico Ha avuto largo spazio – da quando si è avvertita la sua presenza di scrittore – la nozione di Pasolini come poeta di una urgenza autobiografica appassionata ed irruente, carica di risvolti complessi, ma in ultima analisi, anche negli esiti migliori, sorretta da una sensibilità decadente, tra narcisismo e vitalismo. Una poesia che cerca di approdare alla “ragione”, ma che si concretizza in un linguaggio, che porta i segni di un non mai vinto irrazionalismo. Non, dunque, come Pasolini ambiva, un “ poeta civile “, ma un poeta nel quale, proprio perché affonda le sue radici nel cuore del “decadentismo”, questa ambizione rimane aspirazione intellettualistica e la scrittura si muove nel messaggio inquieto di un intellettuale piccolo borghese, che comunica la sua tumultuosa angoscia di “ritardatario” non capace di una piena coscienza storico-culturale “moderna”. Smontare questa immagine potrà e dovrà essere il compito della critica più avveduta. Qui basti, a minimo supporto di una opinione radicalmente diversa, ricordare che sicuramente Le Ceneri di Gramsci, La religione del mio tempo, Poesia in forma di rosa sono giunte – per usare una parola cara a Pasolini – come una “folgorazione”. Cadevano, in chi leggeva quelle pagine, le immagini della poesia e del poeta a cui ci aveva abituato una ormai lunga e non vinta tradizione. Si delineava, attraverso la scoperta del “caos” sottoproletario non ancora giunto alla storia e della “corruzione” neocapitalistica matrice di una storia disumana, una ricchezza di contenuti e una bruciante e lucida novità di linguaggio, nelle quali i “vizi” e le “malattie” di almeno mezzo secolo di letteratura trovavano il loro superamento. i ripiegamenti e le ambiguità, i superomismi nelle loro più varie forme dall’aggressivo al crepuscolare, la solitudine ermetica vi apparivano lasciati ormai alle spalle, distanziati in un taglio di discorso che assumeva tutto il significato di un evento “storico” assieme atteso e inaspettato.. Questo spiega anche perché un poeta colto e raffinato, per nulla disponibile ad essere “facile”, realizzava il miracolo di non essere letto soltanto dai critici professionali o dai consorti della repubblica delle lettere, di diventare davvero una voce nella quale ci si poteva ampiamente riconoscere, nella quale la realtà si illuminava, rivelando le sue forme e le sue contraddizioni. Ciò che è, nonostante tutte le raffinate incertezze che in proposto si agitano, il compito della poesia e il segreto della sua significanza. Se teniamo ben ferma la scoperta della “novità” della poesia di Pasolini, i competenti possono anche aiutarci a rintracciare le ascendenze e a scoprire i complessi canali da cui discende o a cui si collega la sua esperienza. Nessun poeta nasce sul vuoto. L’importante è verificare quanto nella sua “parola” si condensi di realtà, quanto la sua voce si carichi di sensibilità “storica”. Possiamo dire, quasi con commozione, che i segni di queste presenze, che qualificano e caratterizzano la grande poesia, sono, nei testi pasoliniani, numerosi e rilevanti, sì da farne veramente un protagonista. 5 Novembre 1976 BresciaOggi 1976 7 RENZO BALDO La drammatica crisi di coscienza Gli intellettuali e la guerra L’inquietante disagio della cultura di fronte al tragico evento mette a nudo un problema di pressante attualità Pochi mesi prima dell’inizio della prima guerra mondiale compariva a Firenze, nelle edizioni de La Voce, un opuscolo intitolato Discorsi militari. L’autore non era un militare, ma un giovane studioso, Giovanni Boine, aperto a interessi di ordine filosofico e religioso (aveva collaborato ad una rivista dei modernisti) e che si era fatto notare soprattutto come acuto critico letterario. Il tema di fondo dell’opuscolo lo si racchiudeva nella aspirazione a militarizzare la vita civile, nella convinzione che solo l’imposizione, la disciplina, lo spirito gregario possono garantire il superamento degli egoismi, dell’individualismo corrosivo, dell’assenza di ideali e realizzare una società solida, sana, rigenerata. Forse nessun altro libro e nessun altro discorso possono assurgere a un significato così tragicamente “esemplare” della dimensione psicologica e culturale, in cui si muovevano gli intellettuali italiani nei primi anni del secolo, fino alle soglie della guerra, e poi dentro a suo baratro, intellettuali inquieti, irritati dalla “banalità” giolittiana, confusamente in attesa di una palingenesi che non riusciva mai a uscire dai contorni ambigui dell’approssimazione: vittime da una parte del mito che l’intelligenza e la cultura possano costituire “partito”, travolti, dall’altra, per complesse ragioni storiche, dalla oggettiva difficoltà di afferrare le dimensioni reali del gigantesco processo di trasformazione, sotto la spinta dell’ormai avanzato stadio di sviluppo capitalistico, della società italiana ed europea. Alla distanza ormai illuminante di oltre mezzo secolo. la condizione dell’intellettuale italiano di fronte a quella guerra appare, sul fondo, nonostante la grande varietà degli atteggiamenti (se ne può vedere un’ottima analisi ne Il mito della grande guerra di M. Isnenghi, editore Laterza), singolarmente omogenea: la radicale incapacità, soggettiva e oggettiva, di collocarsi di fronte agli eventi con strumenti adeguati a coglierne le componenti reali, a pronunciare un giudizio severamente razionale, a ricavarne le conseguenze in una chiave di responsabilità “collettiva”. Individuare questa grande e drammatica “crisi” degli intellettuali non significa dunque soltanto rispondere alla, per quanto stimolante, curiosità di sapere che cosa essi abbiano pensato della guerra e come essi si siano comportati di fronte e dentro alla guerra, ma mettere a fuoco il problema del nesso tra cultura e azione, il problema della collocazione dell’intellettuale nell’ambito della società.. Sono ben note le giustificazioni della guerra alla luce dei valori risorgimentali e “democratici”, che ben presto agli occhi stessi dei loro appassionati sostenitori si rivelarono inconsistenti o, comunque, travolti da ben altre realtà. Così come assi noti sono i rigurgiti di darwinismo becero dei Papini o l’oracolismo narcisistico dei D’Annunzio, il delirio verbale dei Lacerbiani e la gaudiosa allegria dei Marinetti. Il dramma della guerra, ma forse soprattutto le successive tragedie, che ne sono nate in una catastrofica catena, ci hanno forse abbastanza vaccinato da poter far pensare che il nostro corpo sociale sia, nel suo insieme, abbastanza capace di rigetto nei confronti di questa sorta di perversioni. Più importanti, più dolorosamente ancora aperti alla nostra partecipazione e riflessione sono altri atteggiamenti, forse meno noti, forse anche in relazione alla loro minore appariscenza e alla loro maggiore serietà. B. Croce, in polemica col mare montante dell’attivismo irrazionalistico degli interventisti, ripiega anch’egli nel fatalismo: “che la guerra scoppi o no, è tanto poco morale o immorale quanto un terremoto o altro fenomeno di assestamento tellurico”. Non rimare che il dovere di rassegnatamente accettare il cataclisma. Padre A. Gemelli, studiando la psicologia del soldato, trova, contro i retori, che non ha senso parlare di patria, di libertà e dia altre simili cose, perché quel che garantisce l’accettazione della guerra è una generale apatia che determina una sorta di consenso meccanico e involontario. P. Jahier, che muove da posizioni di interventismo democratico salveminiano, sbocca verso un esistenzialismo populista, per cui la guerra perde ogni motivazione, ma viene BresciaOggi 1976 8 RENZO BALDO accettata come occasione per un incontro con gli umili e i diseredati: “Altri morirà per la storia d’Italia volentieri / e forse qualcuno per risolvere in qualche modo la vita./ Ma io per far compagnia a questo popolo digiuno / che non sa perché va a morire” Gianni Stuparich, triestino, irredentista e interventista, due fratelli caduti, cieco di guerra, autore di pagine tra le più belle e intense, perviene ad una dimensione valutativa, che molto bene Isnenghi ha definito di “logoramento delle razionalizzazioni politiche”. Non gli rimane che un doloroso approdo metastorico: “non può essere, no, non può essere che nel mondo sia stato vano tanto dolore”. È una amara, sofferta disfatta, che cerca di trovare conforto in una speranza che non riesce a definirsi in nessun contenuto.. Un altro interventista, Borgese, analizza la multiforme scala dei moventi della guerra per constatare la loro inconsistenza e trovare che la guerra è stata “una sfrontata e inconcludente sfida”, vissuta da ciascuno nelle chiavi più diverse, ma sempre con motivazioni, esplicite o latenti, totalmente soggettive, mai in grado di ricomporsi in una visione organica, “etica” nel senso più pieno della parola. Insomma, siamo proprio al trionfo di quell’individualismo che Boine aveva deprecato e per il superamento del quale egli e tutti gli interventisti più seri si erano pronunciati La rassegna potrebbe continuare, ma non si cambierebbe per nulla il filo interpretativo. che in essa inesorabilmente e chiaramente si legge. L’ansia morale di Boine, l’esigenza di disciplina, di socialità, di dedizione a ideali collettivi, che il miglior interventismo esprimeva, non poteva trovare alcuna risposta in una vicenda, le cui ragioni profonde, le cui strutture oggettive avevano ben altro significato, quello di decidere con le armi, e col totale disprezzo delle esigenze sociali e collettive, una gara di potenza determinata dai conflitti tipici di una determinata organizzazione economica. Il che, in altre parole, significa che gli intellettuali italiani furono, quasi totalmente, senza accorgersene, al servizio di quella organizzazione e di quella spinta. Per uscire da quella dolorosa e tragica contraddizione mancava loro, in gran parte, la presa di coscienza che la disciplina, lo spirito di sacrificio, la dedizione non sono sufficienti, se non ci si domanda da che parte stanno e al servizio di chi e di che cosa si mettono. 4 Novembre 1961 BresciaOggi 1976 9 RENZO BALDO Significato di una biografia Malraux “politico” Le scelte “eroiche” dell’intellettuale alla ricerca della risposta alle lacerazioni della “condizione umana” Per capire Malraux è opportuno individuare alcuni dati biografici esemplari. Tra il 1926 e il 1928 si reca in Cina accompagnandosi a Borodine, delegato sovietico del Komintern presso i rivoluzionari cinesi e segue le vicende, soprattutto a Canton e a Shangai, della guerra civile. Nel 1933 entra a far parte della lega internazionale contro l’antisemitismo e del Comitato mondiale antifascista. Come membro di questo organismo presiede il Comitato per la liberazione di Dimitrov, il rivoluzionario comunista bulgaro, che il nazismo si apprestava a condannare sotto la falsa accusa di aver incendiato il Reichstag, ed è incaricato di presentare a Hitler la protesta per il processo contro i pretesi incendiari. Nel ‘36 partecipa alla guerra di Spagna, è incaricato di organizzare l’aviazione della repubblica, è ferito in combattimento, va negli Usa per raccogliere fondi per la lotta antifranchista, rientra in Spagna e condivide i rischi e le fatiche spossanti della ritirata. Nel 1940, chiamato alle armi, è ferito in combattimento e fatto prigioniero. Evade ed entra nella Resistenza. Arrestato, fortunosamente liberato da un gruppo partigiano, assume il comando della brigata AlsaziaLorena. Allla fine della guerra esprime clamorosamente la sua simpatia per De Gaulle, lo aiuta come ministro, gli è vicino in modo decisivo nel maggio del ‘68. Nel ‘71 (a settant’anni) difende il dirottatore di un aereo che voleva un carico di medicinali per il Pakistan. Subito dopo si dichiara pronto a entrare volontario tra le forze militari che combattevano per l’autonomia del Bangladesh. Quale logica ha presieduto a queste scelte? Quale dimensione umana e politica ha rappresentato Malraux “uomo d’azione”? Si è detto che Malraux fu, soprattutto, pronto a combattere contro qualcosa piuttosto che a combattere per qualcosa. Si è visto in lui l’uomo che antepone “L’avventura” alla scelta ideologica coerente e organica. Si è visto in lui – giustamente – una sorta di esistenzialismo, vissuto con un vigore intellettuale e una intensità, che ha fatto della sua vita e della sua opera un punto di riferimento tra i più affascinanti per almeno trent’anni. Sicuramente molti, giovani e meno giovani (in Italia con qualche ritardo dovuto alle date di traduzione delle sue opere, sicché il fenomeno si è collocato principalmente negli ultimi anni quaranta e negli anni cinquanta) lo hanno sentito come un protagonista, come una voce di ampia a ricca risonanza. Probabilmente, se l’impressione non è troppo riduttiva, si è sentito in lui una felice fusione della carica vitalistica di un Hemingwuay – a livelli assai più alti, ovviamente – e della profondità di penetrazione di un Proust. Ma forse il significato più vero di Malraux è tutto racchiuso – pur coinvolgendo le prospettive e le angolature sopra riferite – nel personaggio protagonista de “I conquistatori”, quel Grine, disertore della legione straniera, guidato da una smisurata volontà di azione e di potenza, dal desiderio “puro” della grandezza, che sente nella rivoluzione non il trionfo di un ideale, un mutamento del mondo, ma una protesta contro l’assurdo della condizione umana. Malraux, dunque, nonostante tutto (tutta la sua dignità, tutta la forza della sua meditazione sulla vita e sulla morte, tutta la calda intuizione delle inquietudini del suo e nostro tempo) ancora dentro nell’individualismo e nelle pieghe dell’irrazionalismo, che furono le matrici di tanta letteratura europea del nostro secolo: nel bene e nel male, un protagonista del dramma dell’intellettuale, che deve prendere posizione sulle contraddizioni di fondo che segnano il ritmo della nostra storia, e dalle quali è così dilacerato da dover ripiegare su scelte eroiche, dove la “condizione umana“ si esalta in una prospettiva di “gran teatro del mondo”, sul quale le ideologie e la politica agiscono in funzione della loro capacità di risposta al tormento esistenziale. 24 Novembre 1976 BresciaOggi 1976 10 RENZO BALDO Le realtà che stanno dietro l’angolo La “provincia” e lo scoccare dei diciotto anni Basta dare un’occhiata al programma previsto dal Cineforum di Vobarno per capire che gli organizzatori sono stati mossi da seri intendimenti culturali. Certo, lo sappiamo: la norma di legge prevede, per la frequentazione degli spettacoli gestiti dai cineclub, l’età di 18 anni Ma, guarda caso, della norma ci si ricorda quando si tratta di un film che tocca tematiche, diciamo così, non gradite a chi è arroccato nella difesa ad oltranza dei modi più arretrati di concepire la società, la cultura, i centri di potere. In questi casi, dare una risposta soltanto formale (“la legge non lo consente…”) è come sfondare una porta aperta, è nascondersi dietro il classico dito, che non riesce a nascondere nulla. Dietro al dito ci sono alcune realtà, sulle quali è bene non chiudere gli occhi. C’è, ad esempio, il costante riproporsi della sorda ostilità ad ogni iniziativa culturale che smuova la morta gora della provincia. In questi ultimi anni gli enti locali sono riusciti a far cadere, nel grigiore diffuso che domina con la sua pesante monocromia intere e vaste zone, qualche goccia vitalizzante. Subito all’intorno si sono messe in agitazione le forze che da sempre sono impegnate a costruire siepi e a mantenere paludi. Le biblioteche comunali, che dovrebbero costituire un punto di riferimento per l’animazione culturale della provincia, subiscono costantemente questo impatto, che tende a cloroformizzarle e a ridurle inerti presenze, a larve inconsistenti e improduttive. Se una larva dà qualche segno di vitalità, bisogna subito scoraggiarla, ridurla al “buon senso”, in altre parole, ridurla in uno stato permanente di inutilità. Le biblioteche comunali, insomma, possono anche fare da fiore all’occhiello, ma si guardino bene dal diventare strumenti reali di informazione e di dibattito E c’è, anche, il problema dei giovani, di quei giovani che, sull’onda del ‘68, sono stati dichiarati maggiorenni all’età di 18 anni. Una conquista, non c’è dubbio. Ma il problema. della formazione e della aggregazione dei giovani, il problema della loro introduzione ad intendere le strutture, le forme, i contenuti della realtà non può avere, evidentemente, risposte meramente formali.. Nemmeno il più arretrato tra i pedagogisti più codini sarebbe disposto a sostenere che la formazione dei giovani, il loro contatto con le realtà locali, il contatto con quel minimo di cultura, che si esprime nell’ambiente nel quale vivono, debba iniziare allo scoccare del 18° anno. Con questi metodi – oltretutto in piena contraddizione con il fiume di lai, che quotidianamente vengono versati sulla condizione giovanile, su questi giovani che bisogna recuperare, che bisogna educare, che bisogna aiutare a entrare consapevolmente nella società civile, etc. etc. – si instaura il più squallido dei programmi da loro proporre: qui dentro non entrate, o minorenni, andate altrove, andate sui rampanti motori che allietano le nostre serate e le nostre domeniche, andate nelle discoteche e nelle balere, nei locali dove si proietta al 98% il fior fiore del pattume cinematografico (date un rapido sguardo ai programmi, se non ci credete), andate insomma dove volete, ma non qui, dove si fa qualche tentativo per pensare, per capire qualcosa, discutere, incontrarsi a livelli un po’ meno piattamente disutili, perché non avete diciotto anni. Il legislatore, infatti, ha previsto tutto: anche l’età in cui è lecito incontrarsi per pensare, capire qualcosa, etc. Di questo passo non c’è tanto il rischio che il tutore della legge entri nei recinti della famiglia (pare che siano sacri), ma certamente in tutti i recinti che non siano strettamente “privati”. Perché, per esempio, non entrare nelle scuole, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, per farne uscire i minori di 18 anni, quando vi si legga o spieghi qualcosa che puzzi di scarso rispetto per i “valori" così come i codini tradizionalmente li intendono? (Ahimè, se i codini, oltreché andare qualche volta al cinema, prendessero anche l’abitudine di leggere, chissà che sorprese avrebbero e, di conseguenza, ci darebbero!) Che sarebbe, non c’è dubbio, un risultato interessante nella lunga via verso la “riforma” della scuola. 28 Novembre 1976 BresciaOggi 1976 11 RENZO BALDO “Anarchico” La pluralità dei significati… In una lettera dai toni assai risentiti, il direttore responsabile del giornale Seme anarchico, se la prende con un nostro collaboratore, reo di aver usato il termine “anarco” in senso spregiativo. Definiva, ad esempio, “anarco-misticheggianti” certi atteggiamenti di Prezzolini. Il nostro interlocutore ritiene inaccettabile e offensivo che una parola a lui cara, perché in essa si riassumono ideali e valori nei quali fermamente crede, venga distorta ad un uso che non le compete. Possiamo, in astratto, dargli anche ragione. In concreto, però, non vediamo come potergli dare ascolto. Ci sembra anzi un po’ strano che una questione puramente linguistica venga convertita in una battaglia etico-politica. Da che mondo è mondo le parole si son sempre caricate di molti significati, senza che per questo ci si debba offendere. E perché mai dovremmo dubitare della capacità dell’ascoltatore di capire in quale accezione stiamo usando una parola? Su tutti i vocabolari è registrato il doppio uso della parola “anarchia”, con i suoi derivati. C’è anche chi, volonterosamente, tende a distinguere tra anarchia (la teoria politica dell’abolizione del potere costituito per realizzare un totale decentramento dove i lavoratori organizzino direttamente le forme della produzione e di tutti i rapporti sociali) e anarchismo (situazione di caos e sregolato individualismo), un po’, per fare un esempio analogico, come usano gli studiosi del ‘600 quando distinguono tra barocco e barocchismo. Ma – diciamo, se vogliamo, purtroppo – nell’uso i due termini tendono sistematicamente a confondersi. E si tratta di un uso che, ci informano i competenti, iniziato già nel XVII secolo, è rimasto costante fino ai giorni nostri, nella nostra come in tutte le lingue. Che possiamo farci? Dobbiamo chiedere ai nostri collaboratori un ascetico impegno per evitare le ambiguità linguistiche? O che mettano tra parentesi, ogni volta che usano un termine, il senso che in quell’occasione gli attribuiscono? Confidiamo che nessuno ci chieda metodi di scrittura così faticosi. Il nostro interlocutore potrebbe, a questo punto, obiettare che, di fatto, nel caso che a lui sta a cuore, troppa gente non ha alcuna consapevolezza della ambiguità e considera la teoria politica degli anarchici come un assoluto sinonimo di confusione e disordine. È probabile che sia vero. Ma, anche qui, possiamo farci poco. Come giornale non possiamo istituire corsi di aggiornamento, dobbiamo sempre dar credito al lettore e confidare che ci capisca. 30 Novembre 1976 BresciaOggi 1976 12 RENZO BALDO Un libro di racconti Tra sogno e realtà Un giovane bresciano alle prese con la propria adolescenza ci offre un documento, nel quale si legge una situazione esistenziale oggi assai diffusa Sogno e realtà sono i due poli intorno ai quali si muovono le pagine di Io uomo di Pier Marco Rossini, giovane scrittore bresciano che già si è fatto conoscere con precedenti poesie e racconti. “Il mio mondo è il sogno… da rendere reale ad un solo battito di ciglia”. “… il quieto porto ove cullare i transatlantici carichi dei miei sogni”. In queste immagini emerge una disponibilità a dar voce ad un nucleo lirico, che è probabilmente, almeno per ora, l’anima più vera di questo giovane scrittore, come testimoniano anche i versi, vivi ed omogenei, che aprono, a guisa di chiave di lettura, il libro. Pier Marco Rossini, invece, in questa raccolta (Editrice Letteraria Italiana) sperimenta arditamente il “discorso sciolto”, insomma cede volentieri al richiamo del “racconto”. Ritiene, probabilmente, di avere avuto un impatto con la realtà, che gli permetta di costruire una propria dimensione discorsiva. Soprattutto la pagina conclusiva del libro enuncia questa convinzione di avere costruito una esperienza del mondo da sottoporre al proprio ed altrui giudizio, come è proprio della letteratura di solido stampo autobiografico. L’autobiografismo, invece, gli si traduce costantemente, se vogliamo usare una categoria crociana, in una vera e propria scrittura “effusiva”. In altre parole, l’impatto con la realtà mantiene tutte le caratteristiche della immediatezza, il discorso si diluisce nella confessione, nello sfogo, qua e là tinto di qualche spunto di vaga ascendenza cattolica (il “peccato”, qualche sussulto moralistico, una inconscia sessuofobia, che affiora tra l’affollarsi delle esperienze erotiche, qualche pizzico di pessimismo religioso banalizzato nella povertà dell’io deluso), ma, in sostanza, il tutto conchiuso in quella “innocenza “, ben nota a chi ha conoscenza di questi tipici modi d’essere dell’adolescenza, che candidamente propone come originale scoperta del mondo l’incontro con la ovvietà del vivere quotidiano. Il progetto di farci assistere alla nascita dell’ “io uomo” si esaurisce così in una rappresentazione dell‘”io adolescente”, che non riesce a mediare sogno e realtà: il sogno muore e la realtà si dilegua, scompare in una generale assenza di significati. Si tratta di un fenomeno che, tradizionalmente (e banalmente) trova la sua ideologia in quell’atteggiamento generico – un po’ stanco, un po’ desolato, un po’ elegiaco – cui di solito si dà il nome di pessimismo. Pessimismo, che, contrariamente a quello che si suggerisce nella prefazione, non ha nulla a che fare con Pavese e ha, semmai, i suoi incunaboli in talune zone tardoromantiche. Dell’ambizione di darci una vicenda da “anni di apprendistat0”, da “educazione sentimentale”, (le ombre di Goethe e di Flaubert ci perdonino questa evocazione) non resta che una cronaca spicciola, che ha come modello inconscio prevalente il gusto che oggi si potrebbe chiamare del “fotoromanzo”, da intendersi, qui, come un particolare “genere”, nel quale la pretesa di rappresentare il reale nella sua corposità è accompagnato da una radicale inadeguatezza a darcene il senso “vero”. In questa angolatura e con questi limiti evidenti, il libro, a suo modo, risulta esemplare, perfino “tipico”. Un documento, una testimonianza, soprattutto a livello sociologico, di realtà umane, di “io”, sui quali (ci sia concesso di dirlo con qualche pomposità) non passa nemmeno l’ombra della storia, se non quella del sussulto biologico, intinto di qualche inchiostro di sapore letterario. E la letteratura, ahimè, è una dea maliziosa, che offre volentieri e con abbondanza clichés di cui saporosamente nutrirsi. E mentre si consuma il pasto, essa si allontana sorridendo e scompare. Accorgersene, è segno di uscita dall’adolescenza e di nascita dell’“uomo”. P. M. Rossini, che è giovane ricco di sensibilità, di letture e di ingegno, certamente se ne accorgerà presto. 30 Novembre 1976 BresciaOggi 1976 13 RENZO BALDO Piero Gobetti cinquant’anni dopo Una frattura storica A cinquant’anni dalla morte è legittimo domandarsi quali siano le motivazioni che sono sottese al costante rinverdirsi dell’interesse per Piero Gobetti. Esso non è dovuto soltanto alla esigenza storiografica di sempre meglio inquadrare e approfondire un capitolo, rilevante, delle vicende culturali e politiche degli anni immediatamente seguenti alla prima guerra mondiale. Nemmeno può spiegarsi soltanto col fascino che emana da quella prodigiosa figura di arcangelo adolescente (Felice Casorati nel celebre ritratto ne ha colto.. l’intreccio magico di limpidezza morale e di forza, di tenerezza e di penetrante energia intellettuale), che come una meteora traccia un solco di luce in quegli anni grevi e torbidi. Certamente esercita il suo peso, nel determinare quei motivi di interesse, anche l’esemplarità di una vita segnata da un coraggioso antifascismo, conclusosi tragicamente a 25 anni in una morte dovuta alla violenza bestiale dello squadrismo. Ma se, al di là di tutti questi pur ben validi motivi si vuol cercare una attualità di Gobetti, essa va individuata nel significato di frattura storica, che il suo pensiero e la sua attività hanno determinato nelle file della intellighenzia borghese. Quando si sottolinea, giustamente, l’eccezionale portata di rottura nei confronti del sostanziale conservatorismo della tradizione liberale (anche nei suoi aspetti migliori e più avanzati) del liberalismo “aperto” di Gobetti, si rileva che questa apertura significava, di fatto, l’incontro col movimento operaio, con l’esperienza dell’Ordine nuovo di Gramsci. Ciò è vero e altamente significativo Ma ci sembra sia importante osservare che questo non deve travolgerci, indebitamente, a vedere nel pensiero politico di Gobetti la matrice di un pensiero orientato a “rovesciare” il sistema, quanto piuttosto a farlo fermentare dal di dentro con l’apporto di forze nuove eticamente vitali e quindi socialmente capaci di porsi come protagoniste. Aveva ragione Luigi Einaudi quando, subito dopo la morte di Gobetti, nel rievocarne la figura sul “Baretti”, affermava che “egli voleva nel mondo operaio formare i germi di una società nuova, a cui i teorizzatori del tempo davano il nome di comunista o socialista, ma che in realtà era tutt’altra cosa”. Non, dunque, in quella direzione, per significativa che sia stata, va trovato il nerbo della rilevanza storica di Gobetti, sì bene nella eccezionale presa di coscienza della necessità, per l’intellettuale borghese, di slegarsi dalla tradizionale tendenza a porsi come “organico”, come disponibile alle scelte di fondo che di volta in volta il “trasformismo” del sistema borghese gli suggerisce (l’“apotismo” di Prezzolini, la “rinuncia” della Ronda, il dandismo narcisistico, l’accettazione scettica dello stato di fatto). Come nessun altro ai suoi tempi, Gobetti intravide il problema della formazione dell’intellettuale e della battaglia per renderlo adeguato alla realtà storica all’interno della quale si trova a vivere. Per questo, forse, l’aspetto più rilevante della personalità di Gobetti fu quello che già Gramsci con ammirazione gli riconosceva di “grande organizzatore della cultura”. Per questo azzarderemmo dire che l’ultima sua rivista, il “Baretti”, che Gobetti probabilmente sentì come un forzato ripiegamento dovuto alla durezza della situazione imposta dal fascismo vincitore, fu in realtà il momento più creativo e organico della sua instancabile attività. Dal “Baretti”, infatti, uscirono delle direttrici di cultura che operarono a lungo e positivamente nel tessuto della nostra società, raccolte intorno all’esigenza di superare il “provincialismo”, di raggiungere una “dimensione europea”, di porre sempre in primo piano l’incontro serio con le cose. Sul “Baretti”, in nome di un rinato illuminismo (non a caso il primo articolo di Gobetti sul primo numero della rivista è così intitolato) si combatte una vigorosa battaglia, che continuerà anche dopo la morte del fondatore, per liquidare quanto di avventuroso, di fumoso, di misticheggiante, di approssimativo viveva – e dominava – nella cultura italiana ( talvolta anche per opera di nomi illustri) e sostituirlo con la serietà, il rigore, la “dignità” che rifiuta la “genialità” (per dirla con termini gobettiani). Per questa via, l’intellettuale borghese giunge, inevitabilmente, a determinare la frattura di cui sopra si diceva, a mettere veramente in crisi la sua tradizione di sostanziale “disponibilità”, a rifiutare quella che assi bene Luti chiama “l’imposizione romantica di una BresciaOggi 1976 14 RENZO BALDO civiltà borghese idealizzata.” (che – per esempio – era stata propria anche dei momenti migliori de “La voce”. Sotto l’impulso di Gobetti il “Baretti” sottopone sistematicamente a revisione la cultura italiana, “riconduce ogni voce alla sua effettiva dimensione”, mette a fuoco i sintomi del disagio borghese e i suoi equivoci, compie un lavoro proteso a conquistare una “nuova cultura”, costruendo una piattaforma culturale e politica, che fu l’avamposto dei processi che si svolsero successivamente fino ai nostri giorni, una piattaforma con la quale ancora oggi l’intellettuale borghese deve confrontarsi, se vuol dare risposta ai problemi che lo travagliano e misurarsi adeguatamente con la realtà. 8 Dicembre 1976 BresciaOggi 1976 15 RENZO BALDO La bomba di Piazzale Arnaldo La violenza sanguinaria, il terrorismo più infame si è scatenato ancora una volta nella nostra città. Questa volta non una manifestazione operaia ne è stato il bersaglio, ma, indiscriminatamente, la gente, coloro che casualmente transitavano in un luogo frequentatissimo (se pur senza dimenticare che a pochi metri di distanza dal luogo dell’esplosione ci sono sedi di partiti e di organizzazioni politiche della sinistra e che ancora forte è l’eco della bomba che ha distrutto la sede della sezione “Gheda” del Pci). Se in piazza della Loggia il significato politico del gesto fascista era chiaro, non per questo meno indicativa è la scelta criminale del nuovo attentato alla pacifica convivenza cittadina: – seminare il terrore, diffondere l’impressione che l’Italia è ingovernabile, che gli istituti democratici sono fragili, inetti, incapaci di garantire la sicurezza e che, per di più, le forze dell’eversione sono implacabili, decise. Ancora una volta, ne siamo certi, il Paese darà, compatto, la sua risposta. Dimostrerà di non aver paura, di mantenere salda la sua capacità di risposta di massa alla ignobile provocazione. Ancora una volta, però, va rilevato che la recrudescenza della strategia della tensione ampiamente dà la misura della mancata soluzione dei problemi di fondo che essa coinvolge. Da piazza Fontana ad oggi, alla netta risposta di massa, che si è espressa in mille modi, non ha corrisposto un’adeguata, reale risposta delle istituzioni. Qui non si vuole proporre il linciaggio morale o politico di nessuno. Sappiamo che è più facile deplorare che fare, individuare le magagne che curarle. Ma la bomba di piazza Arnaldo, e le altre che hanno costellato gli anni dal ‘69 ad oggi, esplode, ce lo si lasci dire, anche come naturale conseguenza dei silenzi, della omertà, delle tergiversazioni, delle complicità, delle lentezze, delle distorsioni, che tutti conosciamo, che da anni sono intuibili, segnalate, perfino documentate, e che non hanno ancora trovato la netta e adeguata risposta politica, con la conseguente linea di chiarificazione e di azione che da essa ci si aspetta. In tanto lutto e in tanta amarezza, il dato positivo che sicuramente rimane è la crescita di consapevolezza nei confronti del problema, la consapevolezza, che va filtrando e diffondendosi nei più veri settori, che solo nella coraggiosa ed energica scelta democratica c’è salvezza per il Paese. Ed è sintomatico che così spesso, tra inermi cittadini, colpiti siano dei tutori dell’ordine, che sono e restano i tutori dell’ordine democratico, come energicamente essi hanno affermato anche nelle manifestazioni di ieri in piazza Loggia a Brescia, a Roma e Milano. 17 Dicembre 1976 BresciaOggi 1976 16 RENZO BALDO Controllo pretoriano o controllo proletario? Walter Rathenau e l’autocritica del capitalismo La riflessione critica di un grande industriale tedesco nei primi decenni del secolo si apre verso una problematica di pressante attualità La figura di Walter Rathenau è poco nota in Italia. Industriale, editore, uomo politico, presidente, nel 1915, della potentissima AEG, Rathenau è stato uno degli uomini di maggior rilievo della Germania dei primi due decenni del secolo. La sua riflessione politica, influenzata in particolar modo dal pensiero filosofico e sociale di Simmel, merita certamente attenzione. Ce lo ricorda, in una stimolante nota apparsa sul numero uno di quest’anno della rivista Studi Storici, lo storico Lucio Villari. Rathenau si colloca come momento di punta di quella che si potrebbe chiamare “L’autocritica borghese”. È possibile alla borghesia (la borghesia in senso marxiano, la ristrettissima classe dei grandi detentori del potere economico) sottoporre a critica il sistema di produzione di cui essa è portatrice? Una critica che non sia soltanto orientata ad una razionalizzazione del sistema e quindi, in sostanza, ad un suo potenziamento? Chi ha scorso le pagine de La distruzione della ragione di Lukacs, l’opera nella quale il filosofo ungherese compie una serrata analisi dell’irrazionalismo europeo, avrà notato che al nome di Rathenau si fa spesso, anche se brevemente, riferimento, per assumerlo quasi a simbolo di un atteggiamento intellettuale e morale di scoperta della “negatività” del capitalismo, senza tuttavia mai riuscire a sottrarsi alla sensazione della sua “fatalità”. Si ha l’impressione che Lucio Villari voglia approfondire l’argomento, ricavando, dalla rilettura degli scritti e dall’esame degli atteggiamenti politici di Rathenau, la individuazione di una problematica da valutarsi meno schematicamente, anche se sostanzialmente sempre carica di incertezze e di ambiguità. Sollecitatovi dalla evidenza della “degradazione” ch’esso implica, Rathenau tenta una critica non marxista del capitalismo. Le sue analisi sboccano, nel 1918, quando pubblica Die neue Wirtschaft (la nuova scienza) nella prospettiva di un’economia regolata (nazionalizzazionei, organizzazione centralizzata dell’industria, etc.), capace, a suo vedere, di superare al tempo stesso il capitalismo e il socialismo. L’ipotesi può dare il sospetto di una prefigurazione di una società “nazista”, di una sorta di capitalismo di stato controllato e governato, fuori di ogni capacità di risposta, alle esigenze popolari e democratiche, da minoranze implacabilmente tecnocratiche e verticistiche, il sogno, tutto sommato, del peggior capitalismo. Eppure affiorano, negli scritti di Rathenau, alcuni spunti tutt’altro che privi di interesse e che possono smentire questa interpretazione. La prova ne potrebbe essere anche la costante attenzione che Lenin e Gramsci portarono all’opera di Rthenau. Va tenuto presente che Rathenau giunge alla sua riflessione in un momento nel quale in Germania si è realizzato un gigantesco processo di crescita degli apparati industriali, con risultati che investivano, dando luogo a nuove e inquietanti dimensioni, la vita degli individui e delle masse, i rapporti sociali, le istituzioni. In questo quadro si pone a Rathenau il problema se sia possibile razionalizzare lo sviluppo, rigenerarlo dall’interno affrancandolo dalla spietata legge della “lotta dell’uomo con l’altro uomo”, superare il meccanismo del profitto, della speculazione, del parassitismo, in vista dell’interesse collettivo..L’obiettivo, secondo Rathenau, andava perseguito applicando a tutti gli apparati produttivi della nazione l’esperienza tecnica della grandi imprese e, simultaneamente, affidando allo stato il controllo dello sviluppo. Nell’agosto del ‘14 Rathenau, preposto alla direzione del KRA ( uffico materie prime di guerra) ebbe modo di realizzare in buona parte il suo progetto, pianificando organizzò la prima economia moderna pianificata nella Germania della prima guerra mondiale, anticipò Lenin, il cui orientamento verso il problema della pianificazione della Russia sovietica si basò l’economia tedesca secondo quel modello di “capitalismo di stato”, sul quale esplicitamente Lenin costruì l’organizzazione economica della Russia immediatamente dopo la Rivoluzione d’ottobre. BresciaOggi 1976 17 RENZO BALDO Rathenau lucidamente si rese conto che la sua esperienza poteva portare ad una “rivoluzione sociale”. E nel marzo 1919 poté scrivere che la società capitalistica andava “verso la dittatura, quella proletaria o quella pretoriana”. Tutto ciò spiega la costante attenzione che i teorici del socialismo, compresi Lenin e Gramsci, portarono al discorso teorico e all’opera politica di Rathenau, il quale, partendo dal versante opposto, finiva coll’incontrarsi, per la forza delle cose e per la disincantata lucidità delle sue analisi e della sua esperienza, con gli “avversari”. Commenta E. Carr, in La rivoluzione bolscevica: “Rathenau, che consapevolmente sul modello tedesco”, sicchè, come ebbe ad esprimersi Lenin, si poteva dire, in forma paradossale, che il socialismo era già stato realizzato per metà nella Germania di Rathenau. Una sorta di svolgimento “obbligato” “verso” il socialismo. Mancava l’altra metà. Stabilire a chi spetta il “controllo” della centralizzazione. e della razionalizzazione. Commentava Lenin: “Siamo favorevoli alla centralizzazione e al piano, ma alla centralizzazione e al piano dello stato proletario, alla disciplina proletaria della produzione e della distribuzione. Di quanto fosse “aperta” la riflessione e l’autocritica di Rathenau si accorsero i fautori della rivoluzione “pretoriana”, i quali, divenuto Rthenau esponente di primo piano della repubblica di Weimar, nel gennaio del 1922 lo fecero assassinare da sicari nazionalisti. Un episodio sulla strada del mantenimento del capitale – come sottolineava Gramsci in una nota proprio dedicata a Rathenau, comparsa pochi mesi prima sull’Ordine nuovo – come “brigantaggio” per “accrescere il male generale” pur di fare il vantaggio di qualcuno. 17 Dicembre 1976 BresciaOggi 1976 18 RENZO BALDO Piazzale Arnaldo: in fretta, non alla cieca Immediatamente dopo l’attentato di Piazzale Arnaldo abbiamo assistito al brutto spettacolo di un’opinione pubblica frastornata da gran parte della stampa e dalla Tv, che, sul fondamento di alcune affermazioni giunte da uno dei settori a cui è affidata l’inchiesta, le davano l’illusione di una rapida individuazione dei responsabili, coll’aggiunta, quasi romanzesca, di un contorno “politico”, in cui il rosso e il nero sembravano fondersi, in una mescolanza tanto più sconcertante quanto più sembrava consentire il rilancio, in chiave deteriorata e svilita, della teoria degli opposti estremismi, ridotti quasi a perdere ogni rilievo ideologico e a diventare l’indice di una piatta e balorda confusione di menti disordinate, sulla quale non si può pronunciare alcun giudizio di valore. Nel giro di pochi giorni il tutto si è rivelato una bolla di sapone, che si è dileguata lasciando, accanto al vuoto, una sgradevole sensazione di faciloneria e di leggerezza. Leggerezza è, infatti, dare, senza la necessaria doverosa riservatezza, notizie su un’inchiesta, certamente non facile, ma certamente non ancora giunta ad alcuna certezza. Faciloneria è ricavarne, addirittura, una prospettiva di fondo offerta in modo da poter suggerire una interpretazione generale, superficiale e frettolosa, della tensione in atto da anni nel Paese. Ma, al di là delle dimensioni dell’episodio, la bolla di sapone, che così malamente è stata lanciata e così malamente si è dissolta, offre l’occasione per alcune riflessioni. È probabile che abbia largamente inciso, per determinare questo lancio disinvolto, una sorta di psicosi, per cui si ritiene che all’opinione pubblica occorra dare subito, in fretta, la sensazione che le istituzioni operano e sanno dare risposta alla criminalità che sconvolge il paese. Che ci sia bisogno di questa “sicurezza” non v’è dubbio, ma una fretta così superficiale ed avventata, di “sicurezza” non ne dà affatto e, per di più, provoca molte perplessità, destinate a crescere quando si rilevi che la superficialità porta oggettivamente acqua al mulino della confusione. Che è quello col quale da troppo tempo si cerca di macinare una realtà, che avrebbe bisogno di tutt’altri ingranaggi per essere macinata e digerita. Fuor di metafora: avrebbe bisogno di chiarezza, di precisione, di serietà. E a Brescia in particolar modo, se si pensa che fra poco nella nostra città avrà luogo il processo del Mar e, forse, quello di piazza della Loggia, vicende sulle quali già più volte si è tentato di gettare confusione, da più parti. Ci si aspetterebbe la massima attenzione, da parte dei responsabili, a qualunque livello, in qualunque settore operino, ad evitare la benché minima faciloneria, il benché minimo polverone. Dobbiamo forse dar ragione a coloro che ancora temono e sospettano che di un organismo così importante, ai fini del chiarimento, come la Questura di Brescia, si debba non dimenticare che due funzionari, dopo piazza Loggia, sono stati allontanati per via amministrativa (notoriamente per non aver fatto quanto dovuto per prevenire la strage) e uno, il dott. Purificato, è incriminato per favoreggiamento dei Mar? Ci si domanda, quindi, se per caso anche queste ultime vicende non rivelino chiaramente una probabile assenza di direttive, politiche e tecniche, organiche, precise, funzionali e, insieme, la dannosità della separatezza, sempre in atto, fra i corpi che istituzionalmente sono preposti alle indagini, con tutte le conseguenze ch'essa inevitabilmente comporta. Il che ci porta anche a non tacere l’impressione che l’episodio rilevi, con nuova forza e costante riproporsi del fenomeno, uno dei mali maggiori che presiedono al nostro sistema 28 Dicembre 1976 BresciaOggi 1976 19 1977 RENZO BALDO Hanno detto… Parise, Ginzburg La decisione presa – in conformità al principio di autodeterminazione della donna – dalla Commissione Giustizia e Sanità del Senato di consentire l’aborto sotto i 16 anni, previo il consenso dei genitori o del giudice titolare, è stata commentata da Goffredo Parise, sul Corriere della Sera, con una forte sottolineatura drammatica. In sostanza, dice Parise, siamo di fronte al tramonto dell’“umanesimo”. La nuova cultura è inesorabilmente “tecnologica” La persona umana vi è coinvolta totalmente. Di essa si decide in base a valutazioni “selettive”, che si impongono in base a criteri realistici, di opportunità. Inutile opporsi a questa ormai fatale necessità storica. È davvero la fine di ogni ipotesi e speranza “umanistica”? Natalia Ginsburg sembra voler recuperare questa speranza, sottolineando che tra coloro che definiscono l’aborto come crimine e coloro che rozzamente o ingenuamente lo celebrano come un atto di “libertà” dimenticandone la natura dolorosa e probabilmente incancellabile di trauma, occorre aprire sempre più lo spazio alla consapevolezza che la scelta, nella sua libertà, deve essere fondata su valutazioni serie e ben ponderate non su facile e “allegra” spregiudicatezza. Giusta la legge, ma fondamentale, “umanistica” l’educazione ad affrontare tale scelta con meditata responsabilità. BresciaOggi 1977 21 RENZO BALDO Anche la Spagna nel mondo occidentale Nessuno certamente si aspettava che il processo di democratizzazione della Spagna postfranchista fosse indolore. Con un po’ di cauto ottimismo si poteva, però, forse, immaginare che una certa dose di buon senso, di ragionevolezza e di coscienza “storica” avrebbe potuto ridurre lo scontro, tra gli interessi arroccati nel privilegio instaurato da quarant’anni di dittatura e la volontà di trasformazione che emerge dal Paese, entro limiti definibili, se non altro col metro dell’esperienza di una nazione, che già ha conosciuto la terribilità della guerra civile. Gli avvenimenti di questi giorni sembrano togliere ogni illusione. Le “due Spagne” tendono ormai a fronteggiarsi in termini di implacabile antagonismo. L’imporsi drammatico di questa realtà può però generare un equivoco: la tendenza a pensare l’urto come una sorta di eredità, che affonda le sue radici in un contesto “nazionale” di lunga e irrimediabile tradizione, quasi si trattasse di una faida, che coinvolge il Paese con connotati spiegabili entro orizzonti “locali”. La questione delle “due Spagne” va invece immediatamente agganciata ad un discorso ben più vasto. La Spagna sta tragicamente rivelando di essere anch’essa all’interno di un dramma storico, che coinvolge tutto il cosiddetto mondo occidentale. Un mondo nel quale è in corso un processo che occorre saper senza esitazione riconoscere nei suoi contorni reali e incombenti: un processo determinato dalla scelta tra democrazia (reale) e fascismo. Gli attentati e le stragi in Spagna si imparentano e si identificano con quanto avviene in Italia. La misura storica nella quale essi vanno collocati è la stessa con la quale dobbiamo capire quel che ci turba e ci travaglia da anni. Ed è la stessa con la quale dobbiamo capire l’Argentina ed il Cile, il Guatemala e l’Uraguay, e molte altre terribili realtà di siffatto stampo. Non diremo che sia determinante, per capire quello che avviene in Spagna, la notizia, trasmessa da un’agenzia spagnola, che armi impiegate nella strage degli avvocati di Calle oca sono di fabbricazione nordamericana, impiegate unicamente da determinati servizi e da organismi di sicurezza di certi Paesi, e in Spagna praticamente sconosciute. Potrebbe essere un punto di domanda da non trascurarsi. Lo stesso punto di domanda che, in Italia, ci fa risalire in base ad elementi ben più gravi ed importanti della nazionalità di fabbricazione delle armi, dalle bombe della strategia della tensione, al Sid, ai servizi segreti, a personaggi di alte responsabilità, che anche in questi giorni occupano gli spazi della cronaca, in modo inquietante e significativo, a legami internazionali. Anche in Spagna ci sono i manovali e i loro mandanti. E forse non sarà fuor di luogo ricordare che molti di questi manovali (e forse anche qualcuno di grado più alto) ha trovato, dopo le sue imprese criminose in Italia, facile ricetto in terra di Spagna. BresciaOggi 1977 22 RENZO BALDO Un’apertura significativa L’improvvisa notizia della legalizzazione del partito comunista spagnolo assume, nel quadro politico che stiamo vivendo, un rilievo che va sottolineato. Non occorre essere comunisti o simpatizzanti per le linee e le scelte che attualmente in Europa questi partiti esprimono per cogliere la positività di una decisione nata nel contesto di un Paese, che si sta avviando da breve tempo verso il terreno della democrazia. Chiunque sinceramente e autenticamente creda in un’Europa capace di uscire dalle minacce, che ancora su di essa incombono, di involuzioni reazionarie, non può che rallegrarsi di questo importante gradino conquistato dalle forze popolari della Spagna e con la lampante dimostrazione che i risultati si ottengono quando c’è la volontà politica di ottenerli, volontà, evidentemente, che non è mancata al governo di Suarez. Questa conquista avviene in un Paese che non più di un anno fa era chiuso nell’involucro, che sembrava difficilissimo rompere, di una istituzionalizzazione tra le più ferreamente arroccate nel rifiutare ogni spiraglio di democrazia. L’ombra tragica di un’infame guerra civile provocata dalle destre spagnole sembrava precludere ogni apertura e ogni mutamento e mantenere in Europa una delle più inquietanti contraddizioni, un ostacolo, fra i tanti, frapposto al faticoso cammino verso forme politiche che escludano discriminazioni e consentano quei processi di avanzamento, che, nonostante il peso drammatico di eventi a stillicidio – che spesso mettono in crisi ogni speranza – rimangono la meta da cui non staccare mai gli occhi, una meta che non si consegue senza l’apporto di tutte le forze popolari. Senza quell’unità antifascista che spiace ai De Corlis di turno, occupatissimi a trovare ogni occasione per romperla o per snaturarla. BresciaOggi 1977 23 RENZO BALDO Solo il tempo di farsi amare All’orgia di retorica e al profluvio di parole, con le quali radiotelevisione e giornali hanno investito la morte di Paolo VI, il successivo Conclave e l’elezione di Luciani, si è contrapposto lo stile di semplicità e di pastorale bonomia del neoeletto. La sua improvvisa scomparsa, dopo soli 33 giorni, è giunta a definire in un ritratto ormai immutabile questa immagine di schiettezza e di candore Quest’uomo, non curiale, non diplomatico, rimarrà nella memoria come il simbolo di un’autorità capace di cordialmente piegarsi all’incontro con la gente, di saper dare risposta misurata e non demagogica, equilibrata e non equivocamente strumentale, al diffuso bisogno “popolare” di sentirsi rassicurati da una immagine, nella quale si legga schietta e affettuosa comprensione per gli uomini nella loro esistenza quotidiana, nella loro elementare esigenza di conforto e di sicurezza. Un prelato ha commentato: “Ha avuto solo il tempo di farsi amare”. Un commento, certamente, esistenzialmente amaro e perfino pungente, ma anche, in risvolto, carico di una verità confortante: talvolta la morte sembra davvero giungere a dare vita ad una immagine positiva, certa e imperitura Luciani non ha fatto in tempo a compiere gli atti più solenni e impegnativi. di un pontificato: encicliche, iniziative diplomatiche, messaggi; non ha fatto in tempo a sottoporsi alla corrosiva critica e agli scontri che inevitabilmente. questi impegni e queste scelte comportano; ha fatto invece in tempo a destare, in anni truci, in questi tempi da basso impero, una simpatia immediata, ingenua se si vuole, per la sua sorridente benevolenza, e a porla in modo indelebile come un richiamo alle virtù della gentilezza e dell’amore. Che non è poca cosa BresciaOggi 1977 24 RENZO BALDO Si continua a morire Di fronte al gravissimo episodio di Bologna, nel quale ancora una volta una vita umana viene stroncata, e va ad aggiungersi alla lunga serie di lutti che macchiano la nostra vita civile, costernazione e sgomento non devono apparire parole abusate. In caso contrario, vorrebbe dire che siamo disposti a rassegnarci all’idea che oggi, in Italia, si può anche morire così, dolercene, poco o tanto, a seconda della nostra soggettiva sensibilità, ed aspettare che la violenza del fatto si attenui, nel breve giro del tempo, nella nebbia indistinta delle cose che ci lasciamo alle spalle. La morte assurda e tragica dello studente Lo Russo va invece proiettata in avanti sull’onda di una commozione e di uno sdegno, che devono farsi valutazione politica e proposito perché a simili eventi non sia lasciato alcun margine di realizzabilità. Quanto è avvenuto a Bologna si colloca in un quadro inquietante, che risulta da un groviglio di dati e di elementi, su cui in molti sono chiamati a responsabilmente riflettere. Non si tratta di fare il processo alle forze di polizia in quanto tali, ma, questo sì, di domandarsi, ancora una volta, quali direttive esse ricevano e se sia accettabile che si spari ad altezza d’uomo, per uccidere. Non si tratta di sapere quanto di torto o di ragione ci sia nell’attuale agitazione delle università, ma di domandarsi cosa effettivamente si stia facendo, perché a questo nuovo e così diverso ‘68 vengano date risposte serie, risolutive, capaci di riassorbirne la carica drammatica e disperata. Il movimento del ‘68 aveva una sua logica, che con compattezza unitaria gli permetteva di assumere, al di là dei tratti esterni che lo caratterizzavano, una forte carica di positività e di speranza, e di cercare, quindi, degli interlocutori. Oggi il movimento ha assunto un rilievo, che è fortemente condizionato da una crisi economica e di disgregazione sociale che uccide ogni prospettiva, nonché caratterizzato da spaccature e isolamenti, che producono esasperazioni ribellistiche e un processo che va verso gli scontri frontali Le risposte che ci si attende dalle istituzioni e dalle forze politiche responsabili – al governo o all’opposizione che esse siano – non possono essere di pura scelta repressive, pena l’insorgenza di una situazione dai contorni inafferrabili e gravida di rischi drammatici. Non si dimentica che pesa, per fare un esempio, sull’episodio di ieri a Bologna, l’ombra del processo Panzieri, nel quale così esplicitamente si è sentenziato in una chiave di condanna politica mutuata da codici fascisti.Se il Paese vuole essere un paese realmente civile, l’appello ai giovani, che pur va fatto con energia, perché misurino il peso delle proprie scelte e avvertano la necessità di contenere la spinta di rivolta entro confini che evitino lo scontro e la provocazione – comunque essa si configuri e da qualunque parte venga – deve essere accompagnato dall’appello a tutti perché a livello di scelte e di direttive che coinvolgono responsabilità politiche e sociali, ideologiche ed esecutive, si abbia ben chiaro che un paese democratico regge se sa dare risposta vera e concreta alle inquietudini e ai bisogni di tutti. 12 Marzo 1977 BresciaOggi 1977 25 RENZO BALDO Desolazione e speranze L’affare Lockheed A molte altre vicende si può far riferimento, negli anni di questa nostra Repubblica nata sotto il segno di una speranza di riscatto civile della nazione, per trovare il triste segno di una gestione della cosa pubblica dominata da una pervicace attrazione verso l’intrigo, il sottogoverno, l’interesse clientelare e privato, ma forse nessuna come l’affare Lockheed ne costituisce un termometro così avvilente e preoccupante. A questo punto la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, che pur ancora legittimamente sarebbe doveroso attendersi, rischia perfino di diventare obiettivo secondario rispetto alla cornice complessiva che si è determinata. Una cornice nella quale si inquadrano due immagini desolanti.. Da un lato, nei settori di vertice della classe dirigente, la continuità – stratificata, diventata norma costante – ad adoperare le posizioni di potere per fini a con mezzi suggeriti da logiche di profonda depravazione civile: e quando le cose affiorano, dal pozzo delle manovre occulte, ad una possibile chiarificazione, il serratissimo impegno ad alzare siepi e a scavare trappole per far ripiombare tutto nel buio del pressappoco o dell’impenetrabile. Dall’altro la constatazione che, davanti a questa situazione, il Paese, tutto sommato, ne può ricevere un’impressione, che, fondendo insieme scoramento, scetticismo, indifferenza, genera una diffusa sensazione di “fatalità”, che ripropone l’immagine di un’Italia secolarmente avvilita ad accettare i fatti non come risultato di responsabilità, individuali e collettive, da definirsi e chiarirsi con esattezza in chiave personale e politica, ma come un magma oscuro, frutto di una realtà immodificabile, che colorisce di sé la nostra storia, passata, recente e presente Questo quadro – val la pena di affermarlo con energia – con le sue immagini desolanti, non esaurisce certamente il panorama del “paesaggio" italiano. Gli italiani non sono solo disonesti o rassegnati. Nel Paese fermentano forse e realtà che correggono quelle immagini e ne sono spesso decisamente antagonistiche. Ma di fronte ad una vicenda come quella della Lockheed è il caso di domandarsi se non sia il momento, per chi non intende rassegnarsi o passivamente aggregarsi, di chiarirsi con rigoroso esame di coscienza, dove, per quali canali “reali” – e non soltanto per i comodi canali della deplorazione e dello sdegno “interiore” – si possa trovare il modo di eliminare tutti quegli elementi portanti, che hanno fatto, di una Repubblica democratica, una Repubblica dove sembra riuscire impossibile il controllo democratico. Conforta, a tener vivo un barlume di speranza ad immaginare e ad attendere una possibile Italia “diversa”, il clamoroso episodio della protesta di ampi settori di base. Forse è la prima volta che con forza una base popolare esprime il suo dissenso, esplicita il suo rifiuto di accettare il buio e chiama i vertici a giustificarsi e a spiegare. L’episodio è senza dubbio rilevante. E può forse aiutare tutti coloro che, dovunque siano politicamente collocati, vedono il peso che la vicenda assume nel determinare il “tono” della vita del Paese, ad uscire da “interiori” amarezze e a rifiutare la prassi delle siepi e delle trappole, a rifiutare la logica del “far quadrato”, quella logica che trasforma la “cosa pubblica” in mafiosa “cosa nostra”. 3 Marzo 1977 BresciaOggi 1977 26 RENZO BALDO Al bivio La cosiddetta “storia patria” è stata sistematicamente trasferita, nel momento nel quale si decideva il suo “uso” di massa, in cornici celebrative accuratamente lucidate in colori retorici e smaglianti, che nascondevano abilmente rozzezza ideologica e mistificazione.. Protagonisti trasformati in santoni oleografici, sentimenti volgarizzati nella piattezza della genericità, problemi aperti e aporie irrisolte sistematicamente ignorati con una precisa scelta “pedagogica”. Cose serie e drammatiche come il Risorgimento o la prima guerra mondiale sono diventate brutti monumenti, corone, discorsi enfatici, campane di Rovereto, rituali senz’anima. Non sarà mai male ricordare che questa tradizione, con tutta la sua negatività, ha prevalso sulla buona volontà e lo sforzo di chi non era disposto ad accettare questa gestione corruttrice delle più profonde esigenze di educazione civile di massa. Le nostre classi dirigenti si sono quasi sempre date da fare per costruire e mantenere questa brutta gestione della “storia” e per la sua traduzione in un “costume” diffuso. Si può averne un’idea dando un’occhiata, per esempio, a decenni di “libri di lettura” della scuola, non solo elementare. Anche la Resistenza ha corso e corre questo rischio. Intorno ad essa, però, il processo di imbalsamazione e il tentativo di assorbimento all’interno di una tradizione di enfasi e di verbosa celebrazione ha urtato contro una realtà di “pudore”, che la generazione protagonista di quegli eventi ha istintivamente opposto, abituandoci a una discrezione e ad una misura, che è, senza dubbio, un indice della “eticità” che promana da quella esperienza storica. Questo “pudore” è stato alimentato, tra l’altro, dalla interna e sofferta consapevolezza (non certo di tutti, ma di molti sicuramente) che non si trattava di un’esperienza conchiusa, bensì aperta, proiettata verso il futuro “verso una città che deve ancora essere costruita”. Quest’anno il 25 aprile è caduto in un momento nel quale quel “pudore” e quell’“attesa”, solida e paziente, fanno i conti con una realtà inquietante, che, pur affondando le sue radici in una cronaca che si prolunga da anni, sembra aver raggiunto un punto di torbidità e di incertezza senza eguali e comunque tale da dare la sensazione di aver davvero portato il Paese al bivio. La stampa italiana in questi ultimi due giorni ha registrato istintivamente questa sensazione. La ricorrenza del 25 aprile è stata ricordata, generalmente, con una sobrietà e una assenza di toni celebrativi, che a qualcuno potrebbe dare la sensazione di distacco guardingo e perfino di indifferenza. Recensioni di libri, qualche rara discussione a livello storiografico, qualche documento e qualche prosa di memorie. Eppure a guardar bene tra le righe, a cogliere il senso che si cela tra quelle pagine, appare un diffuso e maturo assorbimento del significato profondo del “pudore” e dell’“attesa”, che hanno sempre caratterizzato il modo più vero e autentico con il quale la Resistenza si presenta a noi oggi. L’assenza quasi totale dei toni celebrativi non significa emarginazione della Resistenza, ma rifiuto di assimilarla nella grigia e fredda monumentalità della istituzionalizzazione ufficiale, per recepirla come segno di tensione e di “scandalo”. Lo “scandalo” della costante vitalità di una “dura speranza”, sulla quale si gioca il futuro del paese. “Siamo un po’ tutti col fiato sospeso”, ha commentato Italo Calvino in un editoriale intitolato al “miracolo che ritarda”. È il fiato sospeso di chi si sente a l bivio Davanti al bivio è la classe politica, che mai come oggi, specie nel settore della “maggioranza che governa”, viene chiamata a superare il metodo dell’accantonamento delle responsabilità. Davanti al bivio siamo tutti: verso un Paese civile, dove la partecipazione popolare – la grande anima della Resistenza – sia attiva e reale, o verso il precipizio della involuzione, dove la Resistenza rimanga soltanto dolorosa memoria esistenziale? 26 Aprile 1977 BresciaOggi 1977 27 RENZO BALDO Legalità e valori civili “Si poteva evitare”, “si doveva evitare” è il commento che corre più frequente sul nuovo episodio luttuoso di Roma. Ma nell’impegno rivolto a giudicare quanto è avvenuto e a definirlo nei suoi contorni e nella sua portata – come anche è emerso nel dibattito alla Camera – si delinea una contrapposizione drammatica di valutazioni, sulle quali è opportuno riflettere. Vi è, da un lato, una posizione “legalitaria”, che è tradizionale dell’animus con il quale taluni settori politici e d’opinione guardano a simili fatti: c’è il divieto di manifestazione, quindi chi contrasta a questo divieto ha torto. Alla intransigente secchezza di questa convinzione si affianca, più sfumata e guardinga, la posizione che definiremo come “legalitaria con riserva”: il divieto è assurdo, gli va detto un no chiaro e netto, ma è comunque indice di grave irresponsabilità, nell’attuale situazione del paese, concorrere a creare situazioni di scontro, che si prestano facilmente a provocazioni e a disordini, come in effetti è avvenuto. Dobbiamo dire che, se non ci piace affatto la comoda “astrattezza” della prima posizione, non ci persuade molto nemmeno la seconda, nonostante la comprensibile matrice di responsabilità politica che la detta. Non pare, infatti, che ci si posa sbrigare facilmente del significato “civile” che assume il gesto di chi intende sottolineare, con la sua presenza pacifica, la irrinunciabilità a dei valori, che non ci si deve abituare a lasciar mettere in forse e a lasciare emarginare con l’appello a discutibili stati di necessità. Sarà magari sessantottesco, ma è una scelta che è indice di positiva partecipazione, il segno di una attenzione – minoritaria, illuministica, “borghese”, tutto quel che si vuole, ma non da reprimere – ad alcuni modi essenziali della vita civile. Proprio per questo, discutibile, anzi deplorevole, appare un intervento repressivo, che si è manifestato con alcune caratteristiche che non possono non turbare: 1) un incredibile dispiegamento di energia contro un sit-in!, contro gente notoriamente pacifica ed aliena dalla violenza – e per di più in occasione di un anniversario che ha un suo preciso significato nella storia recente del Paese – da parte di uno Stato, che energia dovrebbe usare in ben altre occasioni; 2) il pervicace impegno – smentito dal Ministero degli Interni, ma in realtà, a quanto sembra, ampiamente testimoniato – di agenti armati in borghese, con tutta la provocatoria pericolosità di un metodo, che già altre volte ha dato sanguinosi risultati. L’uno e l’altro dato, di fatto, ripropongono gravi ed ormai consueti dubbi: come mai le disposizioni che vengono dai vertici dello Stato sono così poco duttili da trasformarsi tanto facilmente in fonte di tragedia e in causa concomitante della crescita della tensione? Davvero dobbiamo credere che il disegno eversivo, che indubbiamente grava sul paese, lo si fermi vietando le manifestazioni e impedendo i sit-in di poca gente pacifica? 14 Maggio 1977 BresciaOggi 1977 28 RENZO BALDO Primo Maggio Senza retorica Molta acqua è passata sotto i ponti da quando il Primo Maggio è entrato nel calendario come “festa dei lavoratori”, assumendo un rilievo simbolico che nessuna retorica è riuscita a scalfire. Molta acqua, e molte tempeste, tra le quali il mondo del lavoro ha portato avanti la sua battaglia, con sconfitte, che ha dovuto dolorosamente registrare e sbalzi in avanti, che ne hanno sottolineato il “ruolo storico”. Ma non sarebbe serio ricordare questa data senza sottolineare che la battaglia più importante non l’ha ancora vinta. La Resistenza ha potuto far scrivere, in un articolo della nostra Costituzione, che la repubblica italiana è fondata sul lavoro.. Ma non v’è dubbio che il processo in atto per tradurre questa affermazione nella concretezza dei fatti ha bisogno ancora di molte spinte Per vincere quella battaglia occorre fare molta strada. Nessuna repubblica, nessuna convivenza umana è “fondata sul lavoro”, finché il lavoro debba fare i conti con realtà che lo subordinano ai propri fini, finché, in altre parole, il lavoro non sia liberato dalla alienazione che inesorabilmente lo investe in una società dove la “sovranità” è appannaggio d’altre forze. Se questa è la meta “utopica”, ma imprescindibile, diremo che da essa è bene non distogliere lo sguardo, se non volgiamo intonare le trombe della retorica e accontentarci della loro eco consolatoria. E a non distogliere gli occhi ci spingono anche alcuni dato eloquenti, che ci riguardano molto da vicino, e che aiutano a capire la durezza della battaglia che il “lavoro” –cioè i lavoratori – devono condurre. I disoccupati in Italia hanno largamente superato il milione e si avviano probabilmente a crescere: la sottooccupazione continua ad essere fenomeno endemico; mezzo milione di giovani è in attesa della prima occupazione; il lavoro nero prolifica, il peso tributario grava per percentuali altissime sul lavoro subordinato; i capitali sono emigrati in misura gigantesca; con la loro emigrazione non ha sosta la collaterale emigrazione della forza-lavoro. Parlare di Repubblica fondata sul lavoro può –di fronte a questi dati – perfino suonare come invito a inventare delle barzellette. Ma siccome le barzellette servono a poco, sarà opportuno lasciarle da parte, e considerare il Primo Maggio un’occasione per meditare sulla situazione con spirito realistico. Con quel realismo che non va confuso col cedimento alle cose. Realismo significa capacità di prendere in esame le cose per quello che sono e modificarle. Forse mai come oggi, da trent’anni e oltre in qua, nelle ben gravi difficoltà in cui il Paese versa, il movimento dei lavoratori e le organizzazioni che lo esprimono hanno avuto così evidente e pressante responsabilità nella vita del Paese. 1 Maggio 1977 BresciaOggi 1977 29 RENZO BALDO Se si spara ai giornalisti Ripristinare garanzie credibili Quando hanno rapito Guido De Martino, abbiamo scritto che c’era da aspettarselo: prima o poi sarebbe toccato anche ai politici. Ma non era una previsione difficile. Potevamo anche scrivere: toccherà a tutti, a tutti coloro che poco o tanto possono fare da cassa di risonanza, perché investiti in qualche modo di funzioni rappresentative all’interno di questa nostra repubblica (ne abbiamo ricordato ieri la nascita, ma c’è chi ne vedrebbe volentieri la morte) La logica che presiede a quest’ultima fase della strategia della tensione è perfino più chiara di quella che ha retto le fasi precedenti: colpire in tutte le direzioni, diffondere un clima generale di insicurezza, screditare le istituzioni democratiche, far capire che “nessuno” si può sottrarre alla violenza ed al ricatto.La tattica prescelta, una tattica che ha tutte le peggiori caratteristiche di una “mafiosità” diventata norma e sistema, e gestita ad alti e sofisticati livelli di organizzazione e di finalizzazione, funziona inesorabilmente, come una macchina, che nessuno riesce a fermare. È ora la volta dei giornalisti. Anche il giornale, evidentemente, è un buon bersaglio, carico di risonanza. I giornali, bene o male, rappresentano qualcosa; se non proprio il mitico “quarto potere”, sono almeno l’espressione, per quanto imperfetta, di un principio che sta alla base della moderna convivenza civile: garantire che il Paese abbia dei canali attraverso, i quali realizzare l’informazione e lo scambio delle idee. Ebbene, il primo lampante significato degli attentati a Montanelli e a Bruno è proprio questo: nulla e nessuno in Italia deve sentirsi garantito nella propria libertà, protetto nelle proprie funzioni. Questi attentati hanno probabilmente anche un carattere intimidatorio, punitivo: tu scrivi, e io ti sparo. Da questo punto di vista, non si spenderanno mai abbastanza parole di sdegno per deprecare quanto è avvenuto. Ma non si tratta soltanto di questo: gli attentatori e i loro mandanti sanno benissimo che i giornali non cambiano la loro funzione o la loro linea sparando sui giornalisti. Sanno, invece, che simili episodi danno spazio al malessere che da tempo investe il paese, accrescono la sensazione di disgregazione, danno l’impressione che il Paese è ingovernabile. Occorre una svolta, un sussulto democratico che coinvolga, con le forze politiche, i cittadini tutti. La battaglia, più il tempo passa, diventa sempre più ardua. Occorre stringere i tempi, ammettere finalmente, e comportarsi di conseguenza, che siamo già oltre l’emergenza. È con questi sentimenti che BresciaOggi esprime alle nuove vittime della tragica sparatoria solidarietà convinta. 3 Giugno 1977 BresciaOggi 1977 30 RENZO BALDO L’ombra di Keynes? Lo slancio utopico del ‘68 centrò un bersaglio esplosivo quando propose all’opinione pubblica dell’intero paese la fondamentalità della scuola per tutti La classe politica ritenne di non potersi sottrarsi alla sollecitazione e risolse il problema con un tratto di penna: libero accesso alle università. Da quel momento, con un crescendo pauroso, ci si è trovati di fronte a una ondata di scolarizzazione che ha condotto le strutture scolastiche, e soprattutto quelle universitarie, al limite della disgregazione. Come uscirne? È chiaro che la soluzione non può trovare soltanto a livello di efficienza delle infrastrutture. È, questa, una visione ingenua del problema. Il potenziamento delle università, che pur va, ovviamente, perseguito, non risolve, di per sé, il problema, non annulla il cardine portante di tutta la complessa questione, che è quello del rapporto tra scuola e società, del collegamento col mondo del lavoro, della soluzione al dramma del mancato sbocco occupazionale. Tra le righe delle dichiarazioni fatte da Achille Occhetto a “Le Monde” si legge dunque, noi crediamo, non la falsa alternativa tra “libertà” e “restrizione”, come se, di fronte all’alluvione, si vogliano ricostruire i vecchi argini e riproporre una scuola selettiva nel vecchio, abusato, selettivo senso della parola, si voglia tornare indietro, perché si è commesso un errore, e quindi “ragionevolmente”(?) riportarsi sulla vecchia via, visto che la nuova via si è rivelata rovinosa, un pantano impraticabile. Vi si legge, invece, ci sembra, il richiamo ad una proposta di intervento globalmente programmato. È, insomma, il dito puntato sul nodo di fondo di una società, la nostra, dove non diciamo Marx, ma nemmeno Keynes hanno contato qualcosa. È possibile oggi, in Italia, immaginare una capacità e una volontà di programmazione, dove le libertà individuali né siano lasciate allo sbaraglio e al disordine né siano coartate dalla prepotenza di una rozza, brutale, “privatistica” selettività? Siano, cioè, incanalate entro un sistema sorretto dalla pubblica, razionale responsabilità? In un quadro globale dove essere “selezionati” non significa essere emarginati, respinti in condizioni di subalternità sociale? 26 Giugno 1977 BresciaOggi 1977 31 RENZO BALDO Una fuga simbolica Vista con occhio distaccato e un tantino cinico, la fuga di Kappler può apparire un caso da romanzo giallo, con molti degli ingredienti che si convengono al genere “evasione clamorosa”. In realtà si tratta di un caso dove il color nero, il nero sporco, prevale. Quel nero sporco che da qualche tempo è una tinta diffusa a piene mani nel sistema carcerario italiano e su molte realtà che gli stanno dietro o di fianco. Possiamo comprendere l’ansia coniugale della signora Wenger di portarsi a casa il marito. Ma al di là delle ragioni della affettività privata, non possiamo dimenticare che in Germania esiste una Associazione – di schietto stampo nazista – degli “amici di Kappler”, che non è mai stata reticente sul significato “simbolico” della liberazione del responsabile della strage delle Ardeatine. Non, dunque, ragioni affettive e nemmeno ragioni umanitarie (dopo ventotto anni, si sostiene da qualcuno, si può anche liberare un prigioniero gravemente ammalato) costituiscono il vero motore di questa vicenda. Ci aiutano a capirlo le dichiarazioni dell’avv. Franco Cuttica, che fu il difensore dell’ez colonnello delle SS, il quale ha testualmente affermato: “Due giorni fa mi sono incontrato con Kappler, le cui condizioni di salute erano molto gravi. Mi ha confermato la sua perfetta linearità morale nel comportamento verso le autorità italiane. Non penso che chiunque avesse a cuore la sua salute abbia potuto fargli intraprendere un lungo viaggio, le cui conseguenze potrebbero essergli letali”. Perfino volendo ammettere che Kappler mentisse, quando parlava con Cuttica, permane il fatto che la pervicace insistenza a cercarne la “libertà” fino a realizzare la fuga, è legata a ragioni ben diverse da quelle di solito addotte, a ragioni, cioè, largamente politiche. Si è cercato, in sostanza, di dare una dimostrazione di rifiuto di una sentenza, che è nata come espressione della Resistenza, una sentenza che ha in sé un preciso significato, quale è affiorato anche nelle reazioni del Novembre scorso di fronte alla proposta di grazia: le “strutture morali” del nazifascismo, quelle che hanno permesso la inenarrabile violenza che ha sconvolto l’Europa, non possono essere oggetto di “grazia”; la degenerazione che il nazifascismo ha rappresentato ed è ancora oggi in grado di rappresentare, non può essere ammessa dalla coscienza civile. Kappler, uno dei pochissimi – fra i moltissimi – che la giustizia è riuscita a raggiungere con precisione di prove e capacità di condanna, non può essere liberato, perché è assurto a simbolo. I simboli, si sa, ognuno se li può leggere come vuole. La coscienza civile e democratica li legge esattamente in senso contrario alla lettura che ne fa la struttura mentale nazifascista. Per questo va detto esplicitamente che il colore nero sporco, di cui abbiamo detto sopra, non va sottaciuto. Tanto più che è una macchia di nero dai contorni abbastanza dilatati. Nessuno, infatti, potrà mai credere che, complice il clima afoso-festaiolo del Ferragosto, il piano di fuga si sia realizzato senza connivenze o, quanto meno, senza gravissime leggerezze e l’imperdonabile presenza di vere e proprie gravi, irresponsabilità. 17 Luglio 1977 BresciaOggi 1977 32 RENZO BALDO Le dimissioni dell’on. Zamberletti Trent’anni di braccio di ferro Siamo certi che è giusta la preoccupazione che l’on. Zamberletti esprime nella sua lettera di dimissioni, quando afferma che episodi di malcostume non devono gettare ombra sui molti – funzionari, militari, pubblici amministratori – che con correttezza e spesso con dura fatica e sacrificio personale hanno dato il loro contributo all’avvio della ricostruzione del Friuli. Non è accettabile, infatti, che alla corruzione e alla sfacciata improntitudine di alcuni – pochi o meno pochi che siano – venga concesso di spandere il colore del sudiciume su tutto il Paese. Non possiamo però dimenticare che lo sciagurato episodio del Friuli non giunge, purtroppo, con le caratteristiche della mosca bianca. Esso viene avvertito dell’opinione pubblica non come un fatto eccezionale sul quale manifestare stupore e sdegno, ma come l’implacabile rivelarsi di una consuetudine; un fatto che sicuramente moltissimi italiani hanno commentato con uno scettico e amaro: “c’era da aspettarselo”. Questo scetticismo e questa amarezza non hanno le loro radici soltanto nel secolare fatalismo di una nazione che ne ha viste di tutti i colori e che ha nel bagaglio della sua sconsolata “saggezza” l’“arma” della sfiducia in tutto ciò che appartiene alla dimensione del “pubblico”, ma ben al di qua di questo qualunquismo “storico”, nella lucida convinzione che si stia giocando, oggi, un braccio di ferro tra strutture profondamente tarate da anni di arrogante sopraffazione – che ha fatto della corruzione quasi un sistema di governo, anche se abilmente distribuito nei sotterranei del sottogoverno – e una volontà politica, che il paese largamente esprime, di rifiuto di tale rovinoso sistema, che ci inquina e perfino ci ridicolizza. Di questo braccio di ferro non si vede ancora lo sbocco. Mille episodi dimostrano che il gioco è assai duro. E gli episodi del Friuli entrano in questa dimensione. Sono il sintomo di abitudini, di costumi, di comportamenti, che sono stati ampiamente avallati, ai livelli più diversi. E di dimissioni non se ne sono mai viste. Per questo la decisione dell’on. Zamberletti ci appare esemplare, se pur doverosa. Purchè non le si dia il significato ristretto, anche se pienamente comprensibile, di disponibilità personale a dimostrare la correttezza del proprio operato, ma quello di precisa scelta politica nel rifiutare un certo modo di intendere l’amministrazione pubblica. 2 Agosto 1977 BresciaOggi 1977 33 RENZO BALDO “8 Settembre”: una data da non archiviare Ci si potrebbe chiedere, se valga ancora la pena, oggi, di ricordare l’“8 Settembre”, se questa data non sia ridotta ormai al rango di pretesto per qualche evocazione, un po’ pigra, un po’ fabulosa, di “memorie”, alle quali non va nessun reale e costruttivo interesse. Effettivamente, dopo momenti di accese polemiche, che interessarono un orizzonte ampio di opinione pubblica e stimolarono la ricostruzione e la valutazione di quei fatti, che sconvolsero il paese, l’“8 settembre” ha, per così dire, subito un sensibile emarginamento. Si è trattato, ovviamente, di un processo naturale di “slontanamento”. Precisati, analiticamente, i fatti, ricostruite le responsabilità, chiariti i termini complessivi della vicenda, superati, soprattutto, gli anni, in cui quegli avvenimenti bruciavano come una piaga, che aveva personalmente toccato tutti gli italiani l’“8 Settembre” è stato in qualche modo incasellato, inscaffalato e riposto con tutti i crismi della “pratica evasa”. Eppure, già questa singolarità, rara, di un evento, che tocca, perfino fisicamente, tutti gli italiani, dovrebbe rendere guardinghi su questa frettolosa operazione di archiviazione. Una data, nella quale in modo così fulmineo, concentrato nel breve giro di poche ore, si svolge una tragedia collettiva, non può non avere un significato esemplare e simbolico, da cacciarsi bene nella testa e da non lasciar cadere tanto facilmente nel dimenticatoio. Un esercito che viene lasciato senza ordini o con ordini così ambigui da consentire il massimo della confusione e del disordine; un esercito che si sfascia quasi senza combattere, se non per singole, sporadiche coraggiose iniziative di pochi; una classe dirigente che butta un paese allo sbaraglio con una mescolanza – non c’è alcun dubbio in proposito – di egoismo, di paura, di incompetenza, in incuria, non sono cose da poco L’“8 Settembre” non è stato un “caso”, e nemmeno il risultato di una somma sfortunata e fatale di “casi”, la scelta disperata e inevitabile del “si salvi chi può”, perché ormai non c’è più niente da fare; ma, esattamente al contrario, il momento “rivelatore”, il frutto di scelte prolungate, sistematiche, consapevoli, il termine ultimo di un strada percorsa con cinica convinzione. Che cosa ha rivelato? Che un’intera classe dirigente, responsabile di tutto quello che era avvenuto (il fascismo, lo svuotamento della Costituzione, la velleitaria corsa imperialistica, la guerra, l’impreparazione, “la recitazione sostituita all’azione”, come molto bene uno storico ha definito gran parte delle decisioni militari italiane, (con un giudizio che si può tranquillamente trasferire anche alle scelte politiche e diplomatiche contemporanee e precedenti gli avvenimenti militari) non poteva e non voleva fare altra scelta che quella di salvare se stessa, confermando la brutta, tradizionale e sostanziale frattura tra essa e il paese. E compiva questa scelta non soltanto, come si potrebbe essere indotti a pensare, per salvare la propria integrità fisica. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che i Vittorio Emanuele ed i Badoglio, che scappano verso Pescara e verso Brindisi, non salvano solo se stessi come persone fisiche. Per vili, inetti, cinici ch’essi fossero la loro scelta implicava anche un sottile ed attento calcolo politico: salvare la “continuità”, garantire la possibilità di ridare fiato, corpo, vita, presenza, potere a quelle forze, a quei settori del paese, ch’essi avevano rappresentato e che avrebbero continuato a rappresentare. Per ottenere questo intento si poteva anche non lasciare direttive, lanciare quel capolavoro di ambiguità che fu il messaggio radio di Badoglio delle ore 19,45 (reagire “contro eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza”), lasciare deportare mezzo milione di soldati italiani. 8 Settembre 1977 BresciaOggi 1977 34 RENZO BALDO La critica delle armi Quella che ormai per consuetudine si chiama la strategia della tensione continua ad assumere forme tentacolari, la cui ambiguità o la cui maschera non riesce mai a nascondere la sostanza delle cose. Adesso è Torino la città dove si scatena, a provocare ed offendere, a tentar di creare la confusione. Le esplosioni alla Fiat, la bomba al palazzetto dello sport, l’attentato ad un giornalista dell’Unità vorrebbero mostrare il volto di una “critica delle armi”, che propone la violenza come segno esplicito di rifiuto e di condanna di tutto ciò che si affianca alla “legalità” e alle istituzioni o se ne lascia “integrare”. In realtà questi episodi riconfermano proprio la mancanza dell’aspetto fondamentale, che possa permettere di interpretarli come espressione di una volontà politica, che non accetti la “legalità” e, con essa, quello Stato che il “rivoluzionario” intende rovesciare: il volto chiaro di chi ritiene di dover far propria questa linea. È dal ‘69 che questi “rivoluzionari” tutto rivelano tranne che questa necessaria e imprescindibile “chiarezza”. L’ambiguità, l’oscurità, il paravento delle sigle non sono le caratteristiche di volontà “rivoluzionaria”, ma esattamente del suo contrario: la contro-rivoluzione, cioè il fascismo. Gli strateghi della tensione sono, fin dall’inizio, e con una continuità che non conosce correzioni e modifiche, dei consapevoli manovratori per un “rovesciamento”, che si chiama fascismo. I loro esecutori, quando non siano semplicemente dei sicari prezzolati, sono di fatto personaggi della stessa pasta e magari, in qualche caso, i portatori di una confusione soggettiva, che li degrada a strumenti inconsapevoli e rovinosi La difesa della “legalità”, quindi, si trasforma non in una ottusa o arrendevole difesa delle forme di uno Stato e di una società con i suoi limiti e il carico delle sue inadeguatezze, ma nella difesa di una realtà storica e istituzionale, dalla quale non si può prescindere, proprio perché essa è, oggi, strumento e piattaforma essenziale per consentire il “movimento” in avanti delle masse popolari, la risposta piena ai loro bisogni. . 22 Settembre 1977 BresciaOggi 1977 35 RENZO BALDO Cristianesimo e rivoluzione Vivo e stimolante il dibattito religioso offerto dalla Francia dopo il 1789 A chi è stato educato in ambienti cattolici, sarà certamente accaduto di sentir parlare della Rivoluzione Francese come di un luogo tipico della persecuzione religiosa: preti costretti alla clandestinità, suore buttate fuori dai conventi, altari profanati dalla Dea Ragione, i beni della chiesa oggetto di rapaci appropriazioni, chiese trasformate in caserme o in luoghi di ludibrio. Gli ambienti di laicismo intemerato coltivano specularmente – inevitabile contrapposizione – l’immagine di un mondo cattolico sordo ad ogni progresso, irrimediabilmente legato al carrozzone monarchico-feudale e ai propri privilegi, istigatore di rivolte ciecamente oscurantiste Questo schematismo interpretativo, provocato da un modo pesantemente ideologico di far storia, porta su di sé, come tutti gli schemi così costruiti, i segni di quella pigrizia mentale, propria di chi si addormenta nell’ideologia, che impedisce la ricerca e annulla la possibilità di vedere davvero come sono andate le cose, nella ricchezza di pieghe e di sfumature, che, sole, consentono di afferrare il senso totale degli avvenimenti. L’immagine della rivoluzione come cospirazione anticristiana ha avuto la sua prima definizione nei Mémoires pour servir l’histoire du Jacobinisme dell’abate A.Barruel, comparsi nel 1798. “Sotto lo sciagurato nome di Giacobini, una setta apparve nei primi giorni della Rivoluzione Francese, insegnando che gli uomini sono tutti uguali e liberi; nel nome di questa uguaglianza, di questa libertà disgregante, ha calpestato gli altari e i troni; nel nome di questa stessa eguaglianza, di questa stessa libertà ha chiamato tutti i popoli ai disastri della ribellione e agli orrori dell’anarchia”. È di estrema evidenza, in queste affermazioni perentorie, il taglio ideologico (che è altra cosa dalla soggettività, cioè dalla assunzione di soggettiva responsabilità nel giudizio storico), che determina il privilegiamento della linea di fatti che consentono di dar forza alla propria tesi precostituita. Se è pur vero che lo storico deve sempre “scegliere” nella congerie dei fatti, qui la scelta sarà inesorabilmente tranciante, cieca, fino a lasciar fuori larghi spazi di realtà. A Barruel, che scriveva alla fine del ‘700, si può concedere l’attenuante della passionalità con cui si vivono i fatti nella loro immediatezza, (l’immediatezza è cattiva consigliera: a Roma negli anni tra il 1791 e il 1794 la “Costituzione civile del clero” decretata dall’Assemblea nazionale fu tradotta in italiano in modo tale da realizzare una vera e propria falsificazione). Un po’ meno tollerabile è che questi tagli interpretativi continuino a vivere (o a vivacchiare): È, appunto, la pigrizia. Per fortuna oggi si assiste a una certa alacrità, che aiuta a ridurre le larghe zone di ignoranza in cui la pigrizia ci ha attardato. Una più avvertita coscienza storiografica ha consentito di occupare quegli spazi e di mettere a fuoco i problemi e le vicende della storia religiosa di quel periodo. Il clima determinato dal Vaticano II vi ha certo contribuito. Il riesame della storiografia, l’approccio alle fonti, la ricostruzione della teologia politica del cattolicesimo (quello francese in particolare) hanno ricevuto sicuramente forte sollecitazione verso la scoperta che, in quei frangenti, nel mondo cattolico si manifestarono tensioni largamente cariche di analogie con quelle attuali, se non, talora, addirittura identiche, o quasi, nei contenuti. Questa è certamente l’impressione che si ricava dalla lettura di un agile e attraente libretto edito dalla Queriniana di Brescia (Daniele Menozzi, Cristianesimo e rivoluzione francese). L’autore – un giovane studioso che insegna all’università di Bologna – ha raccolto, per la prima volta in Italia, una antologia, che permette di vedere il quadro della coscienza religiosa nel momento del suo confronto con il nuovo modello di Stato, che stava uscendo dalla Rivoluzione Francese. Si scopre, con questa lettera, un panorama, che probabilmente a molti risulterà inaspettato Accanto ai Barruel, fermentava, nei confronti della Rivoluzione e dello stesso giacobinismo, una ben più complessa e articolata riflessione del mondo cattolico. La rivoluzione, sommuovendo profondamente le strutture della società francese, aveva determinato nella chiesa gallicana conflitti, che se, da un lato, erano il frutto di problemi e di BresciaOggi 1977 36 RENZO BALDO scelte connesse all’ordinamento sociale, si proiettavano, dall’altro, sul terreno teologicoculturale. Il quadro risulta così ben diverso dal cliché tradizionale. Accanto alla strumentalizzazione sanfedista delle masse contadine, il discorso di Claude Fauchet – un prete che, pur investito della carica di “predicatore del re”, partecipò alla presa della Bastiglia – si apre alla’affermazione che le nuove forme politiche e sociali sono più consone al dettato evangelico. Ma Il panorama è ricco e vario. Nell’introduzione alla scelta antologica Menozzi offre una stimolante guida, che consente di percorrere quel tumultuoso grande angolo di storia afferrandone molti significati, scoprendone risvolti e pieghe di grande interesse. Nei Cahiers de doléances elaborati dalle parrocchie accanto alla protesta contro l’enorme ricchezza dell’alto clero si introduce il tema della effettiva partecipazione del clero alla vita della comunità, considerata possibile soltanto col depuramento da ogni privilegio. Claude Fauchet presenta agli Stati Generali una relazione, data anche alle stampe, che esamina nell'ottica del vangelo tutta la tematica religiosa e sociale che la rivoluzione (e la cultura dei lumi da cui essa nasceva) investiva. L’'espropriazione dei beni ecclesiastici. viene giudicata da A. Lamourette come uno strumento per il ritorno alla povertà. Compare, per la prima volta, nel suo scritto sull’argomento, l’espressione “prete operaio”. Nel groviglio drammatico, nello scontro ideologico e di classe di quegli anni cruciali si profilava anche la tendenza a ridurre la chiesa a una funzione dello stato. I vescovi “costituzionali”, capeggiati da H. Gregoire, condussero una coraggiosa battaglia, in nome della libertà religiosa per tutti, su due fronti: contro le tendenze reazionarie, nemiche della nuova Francia, e contro la linea intollerante di taluni settori dei “patrioti”. Era, in sostanza, una battaglia per la “separazione” di chiesa e stato, sentita come lo strumento più capace di garantire l’autenticità della coscienza religiosa. In questa prospettiva di costruire un’immagine rinnovata della Chiesa rientra l’attività infaticabile di due italiani, G. Ranza e il frate minore Riccardo Bartoli, dei quali l’antologia dà un po’ poco rispetto al peso effettivo dei loro scritti e della loro opera (e ci si potrebbe augurare una nuova fatica di Menozzi, che ce li faccia meglio conoscere). Su tutti quei fermenti calerà, nel giro di brevi anni, il Concordato tra Napoleone e la Chiesa. L’antologia chiude con i documenti relativi a questa vicenda “terminale”. Nel Catechismo ad uso di tutte le chiese dell’impero francese, ispirato al Concordato, si può leggere:” I cristiani sono tenuti a prestare ai principi che li governano e in particolare a Napoleone I, nostro imperatore, amore, rispetto, obbedienza, fedeltà, il servizio militare, le tasse ordinate per la conservazione e la difesa del trono”. “ Dio, che crea gli imperi e li distribuisce secondo il suo volere, ricolmando il nostro imperatore di doni, tanto in pace quanto in guerra, lo ha costituito nostro sovrano, lo ha reso ministro della sua potenza e sua immagine sopra la terra. Onorare e servire il nostro imperatore è dunque onorare e servire Dio stesso”. Napoleone “è diventato l’unto del Signore per la consacrazione che ha avuto dal sommo pontefice, capo della chiesa universale”. “Che cosa ci è proibito del quarto comandamento? Ci è proibito di essere disobbedienti ai nostri superiori, di nuocere loro e di dirne male”. Con queste perle si apriva l’“era del Concordato”. 14 Settembre 1977 BresciaOggi 1977 37 RENZO BALDO L’ottantesimo compleanno di Paolo VI Tra antico e nuovo, una mediazione difficile Non è facile, per un giornale che si definisce “laico”, delineare il profilo di un uomo assurto a così alta responsabilità e offrire ai lettori, sia pure in modo schematico – quale necessariamente si addice ad una ricorrenza che, per la sua occasionalità, ha tutte le caratteristiche della festa in famiglia – il quadro di quattordici anni di pontificato. E, in sostanza, tentar di navigare in un arcipelago, dove affiorano le isole della banalità agiografica mescolata al trionfalismo o della aridità informativa o, forse più insidiose, delle facili tentazioni laicistiche. È giusto, però, cogliere l’occasione offerta da questa data per dare qualche spunto di riflessione. È abbastanza sorprendente constatare che, nel delineare la figura di papa Montini, su un punto sembrano accordarsi tutti, d qualunque parte prenda l’avvio l’analisi e la valutazione della sua personalità e del suo pontificato: una sorta di perplessità, se non proprio amletica, certo costante e fortemente caratterizzante. Citiamo, a caso. Uno storico gesuita, Giacomo Martina, in un notissimo libro pubblicato da una editrice cattolica, così inizia il capitolo dedicato alla chiesa post-conciliare: “A un papa semplice, estroverso e coraggioso, succedeva, appena iniziato il Concilio, un pontefice di temperamento opposto, ansioso, introverso e meno deciso del suo predecessore”. Su Critica marxista in un saggio dedicato a La chiesa cattolica e il mondo contemporaneo, Alceste Santini, dopo aver definito Paolo VI introverso e problematico di carattere, ripetutamente riporta espressioni del Pontefice nelle quali affiorano l’inquietudine, il dubbio, la titubanza, perfino l’angoscia. Questa individuazione del personaggio – per la quale offre un approfondito contributo M. Rossi nel capitolo “Incontri con Montini prosegretario di stato” nel suo saggio I giorni della onnipotenza, edito da Coines – con tutta la carica della sua probabile esattezza, non deve però, crediamo, essere assunta a modulo per una interpretazione puramente psicologica di un personaggio su cui hanno pesato e pesano enormi responsabilità storiche. A parte il fatto che non sono mancati momenti di energia e di decisioni positive nella complessa serie di anni vissuti da G. B. Montini e prima e durante il Pontificato (basterebbe citare, a livello di cronaca spicciola, ma non per questo meno significativa, l’episodio, poco noto, della sua partecipazione a una riunione contro i comitati civici diretti da Gedda e protetti da Pio XII) ci sembra, in un caso come questo, importante che si eviti di dare subconsciamente per buono il criterio del pur grande Guicciardini che vedeva le vicende d’Italia determinate dal carattere dei suoi principi. Come ogni principe, anche questo principe della Chiesa, al di là del suo carattere e al di là dello stesso singolare destino – che sottilmente G. Martina, nel saggio sopra citato, individua come elemento portante della storia personale di G.B.Montini di essere costretto, in tutte le fasi della sua vita, a fare da mediatore fra esigenze opposte – esprime una realtà storica, in tutta la sua complessità e drammaticità. Questa realtà storica è la Chiesa cattolica di oggi, di questi anni post-conciliari. Diciamo meglio: è la Chiesa cattolica che deve fare i conti con una vastissima esigenza di promozione umana, quale si esprime, a livello mondiale, nella lotta, teorica e pratica, per una società diversa; quella promozione umana, che il Concilio Vaticano II ha individuato lucidamente come punto di riferimento imprescindibile. C’è, nelle scelte del pontificato di Paolo VI, tutta una serie di risposte positive a questa problematica: nel 1964 l’enciclica Ecclesiam suam, che insiste sul tema del dialogo e dell’incontro col pensiero moderno e contemporaneo; sempre nel 1064 il discorso alla nobiltà romana (“noi non siamo più per voi quelli di ieri”); il discorso all’Onu, i viaggi in Palestina, India, ecc., che, se pur a qualcuno sono potuti sembrare gesti un po’ teatrali, non eran certo privi di significato in quel loro proporsi come simbolo di una volontà di incontro; gli accenni al Concordato nel discorso in Campidoglio del ‘66; nel ‘67 la Populorum progressio, che, dando continuità alla forza traente di alcuni temi delle encicliche giovannee, è stata il punto BresciaOggi 1977 38 RENZO BALDO di partenza della cosiddetta reologia della liberazione; il tema della riconciliazione posto a base dell’anno santo 1975. Né va sottaciuto che la riflessione teologica e gli studi biblici hanno conosciuto in Italia un contatto con la cultura moderna prima del tutto inimmaginabili. Se la storia procedesse sotto la spinta delle dichiarazioni e delle enunciazioni, se il destino degli uomini fosse il risultato dei momenti più alti e consapevoli dell’intelletto, ci sarebbero, in questi dati e in questi fatti, elementi sufficienti per avere quel “modo nuovo” di affrontare la realtà, cui Paolo VI medesimo alludeva in una allocuzione del gennaio 1966. Ma la storia procede diversamente. Lo spessore di stratificazioni secolari, l’irrigidimento delle abitudini, dei comportamenti, delle forme mentali, lo scontro degli interessi costituiscono dimensioni gigantesche, per la cui modificazione occorre un intervento operativo, che produce tensioni, fa affiorare nostalgie per il passato, genera contraddizioni, implica lotte. Paolo VI, dopo l’indicazione di rotta tracciata dal Concilio, si è trovato al centro di questa corposa, massiccia realtà. La realtà di una chiesa, che, dai suoi vertici alle masse variamente articolate dei suoi fedeli, non è (o non è ancora) conciliare. Lo sforzo di mediazione intrapreso spiega la sua angoscia, la sua solitudine, come qualcuno l’ha chiamata, perché no?, la sua tragedia. La mediazione non sempre riesce, soprattutto quando forse si tratta di voltar pagina. In tal caso, le enunciazioni rischiano di rimanere tali, quanto meno di far molta fatica a diventare operative e addirittura di essere cintraddette da operazioni di segno diverso. Ad esempio la riconciliazione enunciata e rimasta senza alcun reale seguito; la sostanziale diversità di metodo usata nei confronti delle due contestazioni, da destra e da sinistra. Non è dunque soltanto un carattere che si è rivelato o che si è riconfermato, con le sue inquietudini e le sue titubanze, ma piuttosto il dramma che nasce quando ci si accorge che le cose hanno una pesantezza tale da rendere estremamente difficile le mediazioni, sicché la dialettica tra passato e presente, tra antico e nuovo, tra tradizione e rinnovamento può venire meno e il panorama trasformarsi in un drammatico scontro di realtà irriducibili nella loro contrapposizione. Quando questo si verifica, può sembrare che il diavolo metta la sua coda nella storia. 25 Settembre 1977 BresciaOggi 1977 39 RENZO BALDO Non c’ero, se c’ero dormivo Nell’aula di Catanzaro Abbiamo sempre pensato alla drammaticità di quei momenti, nei quali, in un’aula di tribunale, l’onesto cittadino, coinvolto in qualche vicenda di cronaca spicciola, deve fare appello alle sue meningi per non incappare nel reato di falsa testimonianza o reticenza, quando si sente sollecitato a ricordare fatti o persone, minuti particolari o tratti di linee somatiche, che deve fare affiorare alla memoria dalla distanza nebbiosa di anni lontani. Titubanze, incertezze, annebbiamenti comprensibili, legati come sono, spesso, alla banalità del vivere quotidiano, al transito dell’effimero. Ma non avremmo mai immaginato che nelle categorie del banale, dell’effimero, delle cose senza peso rientrassero fatti che coinvolgono una classe dirigente, incontri e decisioni che toccano scelte morali e politiche su cui si accentra l’attenzione e l’interesse di una intera nazione. Questo, invece, è lo spettacolo che ci viene offerto nell’aula di Catanzaro. Personaggi investiti delle massime responsabilità, ridotti alla penosa trincea della dimenticanza. Un po’ come nella vecchia battuta della mala: non c’ero, se c’ero dormivo. In più, però, anche la sorprendente rivelazione: che i ministri non leggono i giornali. Se, poi, fosse vero che davvero non c’erano, che davvero non ne sapevano niente, che altri hanno fatto e deciso, lo spettacolo diventa ancora più squallido e al tempo stesso terrificante: i massimi rettori delle sorti della nazione non fanno e non decidono. Chi fa, e chi decide? 18 Settembre 1977 BresciaOggi 1977 40 RENZO BALDO Non c’è proprio da rallegrarsi L’abisso tragico del terrorismo politico Non ci sono dubbi sul fatto che, comunque vadano i dirottamenti e le altre imprese cui si affida il terrorismo politico, l’opinione pubblica, nella sua stragrande maggioranza, sente con orrore queste vicende. Sul terrorismo politico – qualunque giustificazione ne sia alle radici – è sempre pesata questa condanna, che gli ha innalzato attorno le condizioni irrimediabili dell’isolamento. L’apprensione, l’ansia, con le quali vengono seguite le imprese terroristiche e la condanna che le accompagna, non trovano la loro spiegazione soltanto nell’oscura esigenza di ordine che l’individuo medio coltiva in sé, ma anche in una diffusa, elementare coscienza morale, che non rende facilmente tollerabile il gesto, che colpisce indiscriminatamente e trascina nella tragedia anche gli innocenti. I dirottatori del folle volo fino a Mogadiscio non si sono sottratti a questa regola, che ha governato, con palese ovvietà, i commenti e le informazioni, sui teleschermi e sulla stampa. Ma, pronunciate le giuste parole d’orrore e di sgomento, forse non è inopportuno sottolineare che quanto in questi giorni è avvenuto non è riportabile soltanto alla follia o, come altri preferisce, al fanatismo. Con i termini di fanatismo e di follia troppo facilmente si tende ad esaurire le spiegazioni in un orizzonte mistico-psichiatrico, che non è l’ultimo e più vero orizzonte entro il quale esse vanno cercate. Per questa via si arriva, anche sui giornali rispettabili e autenticamente democratici, a perdere un poco la testa e a dichiarare che di fronte a simili fatti non bisogna fare alcuno sforzo per comprendere, ma che bisogna soltanto punire. Pensiamo sia importante non rinunciare mai alla necessità di comprendere. Il che non significa premiare, e nemmeno ammettere che certe cose avvengano a possano avvenire. Ma si tratta, sempre, di capire perché avvengano, di riportare i fatti, anche se non sono accettabili, anche se condannabili, anche se orribili, al necessario orizzonte di spiegazione, se vogliamo davvero che essi non si ripetano e se davvero crediamo e ci vantiamo di appartenere ad una società democratica, fondata sulla non violenza, e che non può quindi credere, anche se per caso nella violenza c’è stata tirata per i capelli, di aver risolto tutto solo perché di fronte ai violenti si è dimostrata così efficiente e addestrata da rintuzzare la violenza con la violenza. La follia e l’orrore sono sintomi di realtà che vanno curate alle radici, rimuovendo le cause che le determinano. Nel caso specifico di questo ultimo episodio, e di tutta la vicenda del gruppo Baader-Meinhof, la conoscenza delle biografie dei protagonisti è illuminante. Si tratta di intellettuali, di gente uscita dal deterioramento delle grandi speranze del ‘68. Da quel processo di decomposizione è nata una linea tipicamente individualistica, propria dell’intellettuale separato dalle masse, tragicamente innalzato in una sfera di allucinato rifiuto della norma, della legge, per il disperato convincimento che la legge è inesorabilmente ingiusta, disumana e disumanizzante. Non si può certamente sempre dire che dietro alle loro scelte, del tutto condannabili, senza scampo improduttive, politicamente sbagliate, stia una realtà così pura, così nobile, così sicuramente avviata a dare risposta agli interrogativi che su di essa i protagonisti di queste allucinanti vicende si erano posti. Ma nel momento nel quale essi muoiono, di fronte alla conclusione sanguinosa che esce come risultante di un abisso tragico di contraddizioni e di errori, non dimentichiamo che il paese che ha espresso la loro sgomentante rivolta è un paese che ha alle sue spalle una storia demoniaca di sopraffazione e di violenza e che, nonostante tutti i giusti riconoscimenti che vanno al suo recupero democratico, mantiene, anzi accentua, ad ogni anno che passa, alcuni inquietanti interrogativi, che non dobbiamo nasconderci, e che riguardano proprio il suo destino democratico. E anche il nostro. Né, d’altra parte, la conclusione della vicenda offre alcun elemento di soddisfazione e di speranza. Una liberazione di innocenti, su cui sovrasta non soltanto la morte dei dirottatori, eliminati da una efficienza e da una determinazione, che, per quanto comprensibili, non si svestono di una fosca implacabilità, e, terrificante, un suicidio collettivo, che nulla ha di chiaro, tranne una sua cupa collocazione in una scena da basso impero. 1977 BresciaOggi 1977 41 RENZO BALDO I titoli dei giornali su Berlinguer e il vescovo È sempre un esercizio utile di lettura quello di verificare come una notizia giunga ai lettori dalle titolazioni dei giornali. (Titolazioni che talora non rispondono alla sostanza degli articoli, sicché, addirittura, si possono costruire, come è ben noto a coloro che sono esperti in questo sondaggio, due immagini di un giornale: quella offerta dalla rilevanza “spettacolare “ dei titolo e dei sommari e quella che risulta dai “contenuti” e dalla trama interna del discorso, che ad essi è sotteso. Ce ne offre un esempio interessante il modo con il quale la stampa di ieri ha dato notizia della lettera di Berlinguer al vescovo di Ivrea mons. Bettazzi. Si legge su La Repubblica: “Il Pci non è più ateo”. Che è come dire che prima lo era, e adesso, non si capisce bene se per calcolo astuto o per modificazione di principi teorici, non lo è più. Più esplicito Il Giornale di Brescia: “Berlinguer vuole dissipare le preoccupazioni dei cattolici”. Interpretazione coerentemente sulla linea di chi non si fisa del Pci, e preferisce attenersi alla radicatissima convinzione, che da quelle parti non ci possono essere, sull’argomento, che mosse tattiche con fini politici immediati. Perentorio e paradossale fino alle soglie della bugia Il Giorno: “Berlinguer: siamo contro l’ateismo”. Come dire che da oggi gli atei avranno vita difficile nel Pci e bisognerà magari fare qualche professione teistica per aggirarsi nei suoi paraggi. Sul Corriere della sera, riduzione dell’episodio ad un fatto di costume saporosamente inquadrabile in un umorismo alla Guareschi: “Caro Berlinguer, caro Monsignore: Chiesa e Pci si scrivono”. Onestamente cronachistica la Stampa: “Berlinguer al vescovo su i comunisti e la religione”, con un supporto, nel sommario, che individua il nocciolo del discorso: “il Pci è un partito laico e democratico, che rispetta l’idea e la pratica religiosa”. Ottobre 1977 BresciaOggi 1977 42 RENZO BALDO I servi dello Stato? Esaminiamo il linguaggio usato dalle sedicenti Brigate Rose a spiegazione dell’efferato attentato al vicedirettore del la Stampa. La vittima, secondo questi feroci gestori del crimine politico, è stata “giustiziata”. Non solo: “giustizia” è stata fatta nei confronti di un “servo dello Stato”. Si aggiunge anche che. come soltanto adesso si è saputo, alla redazione del giornale torinese sono giunte, nei giorni scorsi, telefonate anonime, che annunciavano la “condanna a morte” di quattro giornalisti scelti col criterio della “estrazione a sorte”. Ce n’è abbastanza – ammesso che ci fosse ancora bisogno di conferme – per comprendere l’orizzonte entro il quale si muove questo terrorismo. Un terrorismo di totale assoluto sradicamento non solo da un qualunque “movimento” – per quanto emarginato, caotico, violento e magari irresponsabile – in cui si esprimano realtà concrete, magari ridotte alla disperazione e alla rabbia, ma da una qualunque logica, che non sia quella della più pura e cinica provocazione, organizzata con sistematica freddezza non a far saltare lo “Stato borghese”, ma a creare le condizioni perché si determini una società a livello di barbarie. Queste condizioni le ha già conosciute la Germania degli anni di Weimar, le hanno sofferte, con i risultati che tutti conoscono, paesi come il Cile e l’Argentina. In questa prospettiva possiamo senza alcun dubbio vedere nelle attuali scelte del terrorismo la precisa continuità con le scelte che l’hanno caratterizzato nelle fasi precedenti, a partire da piazza Fontana Il terrorismo ha soltanto cambiato i mezzi e gli obiettivi immediati. Le bombe nelle banche, nelle piazze, sotto i treni non hanno dato risultati che i mandanti e gli esecutori (ammesso che talvolta gli esecutori non siano soltanto prezzolati e sappiano pensare) si aspettavano. Colpivano in modo casuale, indifferenziato, generico. Da qualche tempo in qua si spara invece sulle persone, ben scelte e ben individuare: giudici, giornalisti, esponenti politici, etc. etc.. Tutti “servi dello Stato”. Il fatto è che, nella gigantesca e articolata piramide della società, nella infinita serie delle forme e dei modi in cui lo Stato la controlla e la organizza, se ne serve e si fa servire, la condizione di “servitù” è universalmente diffusa. Non dovremo dunque meravigliarci se domani si continuerà a sparare scegliendo altrove, visto che dappertutto ci sono servi. Magari sugli operai della Fiat, quando escono di cancelli dei reparti dove “servono” lo Stato borghese lasciandosi sfruttare a livello di plusvalore. BresciaOggi 1977 43 RENZO BALDO Il rispetto per la vita Viviamo in tempi sanguinosi, nei quali sussulta un’antica ferocia non vinta, che ci fa guardare con sgomento a questo prolungarsi di una condizione di “preistoria”, di cui non si riesce ad intravedere la fine. Giunge, oggi, la notizia della morte di un giornalista, che con dignità professionale e limpidezza di ingegno portava, su un giornale di nobili tradizioni, il suo contributo allo svolgimento di quella civile battaglia di idee, che, sola, può garantire alla nostra democrazia un futuro di sicura e autentica crescita umana Una vita spenta da una delle tante ciniche esplosioni di un terrorismo, che, celando il suo volto dietro maschere equivoche o folli, costituisce da anni il segno efferato di una diffusa degenerazione della lotta politica, la cui matrice ha le sue radici nel terreno torbido di una incomposta volontà eversiva, che ribolle nel Paese, rimestata e coltivata da oscure trame, intessute, ahimè, in modo troppo abile e sorrette da troppa forza e sicurezza, per non risultare, sul fondo, manovrate da una mano che di “liberatorio” o di “rivoluzionario” ha assai poco. Giunge, da Bari, la notizia di uno sgomentante episodio di bieca violenza, che ancora una volta ripropone manifestamente il tema della intolleranza omicida, che fermenta come costume, come norma, come segno distintivo e come prassi quotidiana in chi ritiene che le espressioni di lotta politica debbano tradursi nella eliminazione fisica dell’avversario. Il “rispetto della vita” di schweitzeriana memoria sembra un’ombra patetica perduta in lontananze inaccessibili senza senso. Ma non è proprio possibile riconquistare questo valore umanissimo, senza peccare di ingenuità e far sorridere i tanti, che pensano ad una sostanziale ed irrimediabile degenerazione come marchio del nostro tempo? Forse in troppi abbiamo peccato di facile e verboso “umanismo”. Certamente in molti hanno creduto che fosse sufficiente predicare i valori dell’uomo e hanno sistematicamente trascurato l’operare per l’uomo. Quell’operare che si traduce nell’impegno a togliere di mezzo tutto ciò che quotidianamente ci offende, a tutti i livelli, per la sua inadeguatezza a delineare un’immagine “umana” della società in cui viviamo, a modificare le cose che ad essa si oppongono e ne sono la negazione. Soltanto in questo caso ci sarà fondata speranza che non si armino più mani omicide. 30 Novembre 1977 BresciaOggi 1977 44 RENZO BALDO Un episodio preoccupante Diciamolo pure senza troppi infingimenti: i fatti che hanno condotto il prof. Giorgio Coda davanti ai tribunali – e per i quali era stato condannato – si possono definire, eufemisticamente, sconcertanti; e le procedure per le quali l’“illustre” primario di ospedale psichiatrico poteva ancora tranquillamente circolare da libero cittadino, nonostante la condanna, citate significativamente come esempio di “come” può funzionare la giustizia in Italia. Ma è certo un indice gravissimo dei tempi che stiamo vivendo questo episodio di giustizia sommaria, questo sgomentante riproporsi di un metodo di “giustizia”, che ci fa ripiombare indietro di secoli e forse di millenni verso forme che dissolvono ie strutture portanti del vivere civile. Accanto a questa condanna, che deve essere categorica, di un simile ritorno alla barbarie, dobbiamo però registrare anche un’altra e collaterale preoccupazione. Questi episodi offrono esca ad una delle forme più pericolose di insidia alla libertà e alla democrazia, quella per cui si chiede il silenzio sulle verità che possono “turbare”. È uscito recentemente un libro di una nota casa editrice, che ricostruisce in tutta la sua gravità le vicende di cui il prof. Coda è stato protagonista. C’è forse pronto qualcuno a individuare nel libro e nell’editore i “mandanti morali”? Abbiamo qui in redazione, giunto da qualche giorno, un articolo di un nostro collaboratore su quel libro e su quelle vicende. Se per caso l’avessimo già pubblicato, potremmo essere da qualcuno elencati tra quei “mandanti”? 3 Dicembre 1977 BresciaOggi 1977 45
Scaricare