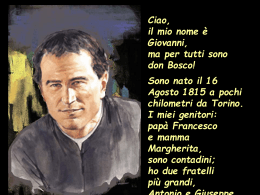in capo al mondo, dietro l’angolo, dentro l’anima In sintonia con il tema, che invitava a mettersi “In Viaggio”, quest’anno il Premio ha raggiunto ogni angolo d’Italia. Autori di ogni età e provenienza hanno esplorato l’idea del viaggio in tutte le sue sfaccettature, letterali e metaforiche, accompagnandoci in regioni remote del mondo o nella lontananza caliginosa del mito, nel futuro o nella storia, nella memoria, nell’immaginazione, nelle pieghe più riposte dell’animo umano. È forse in questo che risiede il maggior fascino di questa edizione 2013: nella ricca, e talvolta inaspettata, varietà di significati che il viaggio assume agli occhi dell’uomo. Di tanta molteplicità quest’antologia presenta necessariamente uno spaccato – e la scelta non è stata facile. Per mesi abbiamo letto e vagliato, confrontandoci con la quantità d’interpretazioni, stili e approcci. Il risultato è raccolto in questo volumetto, a rappresentare una piccola fenomenologia del viaggio per iscritto – in capo al mondo, dietro l’angolo, dentro l’anima. Roncoferraro - novembre 2013 La Commissione Giudicatrice editing a cura di Chiara Prezzavento grafica a cura di Paolo Dugoni 1 Mauro Barbetti Itaca, quanto sei bella. profili rocciosi che scendono a mare e più in alto campi in una contorsione di ulivi e viti. Finalmente torno, ma senza l’alone della fama o un segno tangibile degli Dei. torno, diventerò re al posto suo e questo basta. Gli sono stato fedele, tra amore e senso dell’onore, gli sono stato fedele, per lui ho viaggiato in cerca di alleanze, ho schivato imboscate e tradimenti, ho sostenuto una madre sul punto di mollare, gli ho combattuto al fianco, infine, per riprendersi il trono. Oggi torno e ciò che fu suo, passerà a me, suo figlio. Ma so che non sarò mai lui, nel bene e nel male. È a causa sua che sono partito, per ciò che è stato, per la sua invadente presenza. Il grande eroe. Quello sempre presente nei pensieri degli Dei, fossero essi di stima e favore o di contrarietà e ira. Mi confessò un giorno che in fondo era stato un loro dono, quel viaggio, che era grato persino al padre delle acque, persino a Eolo e ai suoi venti, per tutti gli anni di lotta e avventure, di amori sconvolgenti e conoscenza. Non c’era stato mortale sulla terra che avesse visto, toccato con mano, conosciuto nel profondo, ciò che a lui era stato dato in sorte. Ma anche a questo ci si abitua e ci si stanca. Dieci anni sono tanti, troppi per non avere voglia di casa, specie se il tempo passa, le ossa scricchiolano e i muscoli perdono progressivamente il loro tono. Anche in questo era stato fortunato. Era tornato in tempo, prima che le forze lo abbandonassero, prima che la sua fama e il timore che essa incuteva, svanissero. I Proci erano morti più per la paura che per la sua forza e la sua scaltrezza, si erano già arresi al loro destino, schiacciati dalla sua sola presenza. I loro occhi non si erano ingannati, era solo un vecchio, un mendicante malandato, prima di sapere il suo nome. Ma quel nome aveva il potere di evocare forza, autorità e mito. Se solo avessero saputo quanto le sue ossa erano ormai vecchie e piene di reumatismi, quanto la sua mente fosse sconvolta da fantasmi e presenze oscure. Presto, però, compresi quanto mio padre fosse egoista, pieno di arroganza e sicurezza, nutrite lautamente attraverso le battaglie vinte e il lungo esercizio del potere. Una volta ripreso il trono, io scomparii piano di fronte alla sua capacità di muovere tutti nei fili delle sue trame. E ho visto ciò che era, ciò che era veramente. A me che non l’avevo conosciuto se non nelle parole innamorate di mia madre, si è rivelato in tutta la sua nudità. L’ho visto amoreggiare con stupide pecoraie o con nobili annoiate. Tradire colei che gli era stata fedele, che l’aveva aspettato in tutti quegli anni di incosciente lontananza. Cosa sarebbe stato il suo ritorno senza di lei? In chi avrebbe potuto confidare e trovare sostegno? Avrebbe avuto la forza di combattere se lei non gli fosse stata accanto, o avrebbe ripreso mestamente la via del mare? L’ho visto organizzare l’eliminazione di chiunque gli fosse scomodo, con lucida e sapiente 2 crudeltà, senza il minimo rimorso. Dicono che questa sia la cifra di un vero re, ma io non sarò mai come lui, nel bene e nel male. Perciò sono partito, e per il suo stesso desiderio di acqua e lontananza, di vento nelle vele e vita dentro le vene, per sfidare sorte e Dei, per il bisogno di trovare me stesso lontano da lui e da tutti i confronti possibili. Lui l’aveva solo intuita, io l’avrei trovata, la terra estrema, l’ultimo baluardo, la fine del mondo, là dove la dimora degli umani finisce e si apre l’immenso, il non definibile, il luogo degli dei o dei mostri. Ma io non sono lui e gli Dei non mi sono accanto. Né mi sono ostili. Semplicemente non mi vedono, per loro non esisto. Sono partito per il fascino dei suoi racconti e non ho trovato niente. Solo giorni uguali, mare su mare, onde su onde e terre di nebbia in cui la Storia non era passata. Terre abitate da gente ignorante e volgare, o porti stranieri in cui l’unica logica era il denaro. Un universo senza nobiltà e bellezza. Quali mostri potevano essere più paurosi di questo? I mostri si combattono, li affronti, affronti in loro il destino che ti attende. Questo genere umano ti si appiccica addosso, ti conduce verso il fondo. Cosa sono le sirene a confronto? O Scilla e Cariddi? O Polifemo dietro il suo unico occhio? Fu in uno di questi porti che mi giunse la notizia della sua morte. I marinai l’accolsero con il lutto di facciata e la gioia nei cuori. Poi mi acclamarono re, mi festeggiarono, ma era il ritorno a casa che festeggiavano e la fine di quell’incubo di mare. Tornare alla pesca o ai campi coltivati, alla moglie e ai figli, questo era tutto quello che il loro cuore desiderava. Loro un ruolo ce l’avevano, un’identità precisa, netta, inscritta nel confine delle mura di casa. E questo bastava. Sto tornando, Itaca, riconosco via via le cale e le rocce, ricordo i nomi di tutti i gruppi di case sparse sui pendii, di tutte le fonti e i boschi, vedo le braccia del porto che si avvicinano per cingerci, vedo la folla che si assiepa sulle banchine, il frastuono e la festa. Itaca. Forse la mia vera vita comincerà adesso. Fu un attimo. Passare dall’apice alla polvere. Passare da ali di gente festante ad un urlo di folla sgomenta. Salivo verso la reggia illuminato a luce piena, traslavo dal piano cobalto del mare a quello turchino del cielo, salivo e non immaginavo che fosse sul mio altare sacrificale. Fu un attimo, quando sentii il morso improvviso nella carne e mi voltai incredulo. Vidi occhi scuri e un viso ritornare nella folla. Lo conoscevo bene perché aveva più o meno la mia stessa età, il figlio di Antinoo. Insieme avevamo diviso giochi al tempo della guerra di Troia, insieme eravamo cresciuti negli agi della corte. Avevo nutrito un affetto sincero nei suoi confronti, prima che la vita e un destino diverso ci allontanassero. Lui non partecipò all’oltraggio a mia madre, né alla congiura di suo padre. Per questo fu risparmiato e dimenticato. Neanche lui era come suo padre, ma spesso siamo coinvolti in destini più grandi di noi. Il suo era la vendetta, il mio l’espiazione. Pago per te, padre, per il tuo nome e per la tua crudeltà. L’ho trovata, la fine del mondo, il lembo di terra in cui tutto sfuma e diventa nebbia, grigiore e oblio. Era dietro l’angolo, era dietro la porta di casa, era il rovescio della mia terra amata. A me, Telemaco, alla fine non resta nulla. Non il ricordo, non la bellezza, non il favore degli Dei. Né la vita. 3 Veronica Acquaviva Il pullman sembra avanzare per inerzia in questo scenario lunare, l’egemonia del bianco, la neve a coprire come un sudario alberi, case, moschee, campi, congelando la vita. Gli unici segni esterni si limitano a qualche panno steso, o a un flebile filo di fumo che si alza da una baracca. In questo tratto di strada cielo e terra si stringono in un pallido abbraccio, indistinguibili i confini tra l’uno e l’altra. Quel riferimento spaziale così familiare - l’orizzonte svanisce. Sanab sorride quando il velo le lascia sfuggire una ciocca di capelli: pazientemente riporta l’ordine sul suo capo, poggia le mani sul ventre arrotondato, come a proteggere quanto di più prezioso ha, e torna a socchiudere gli occhi, la testa abbandonata inerme sulla mia spalla. La Turchia è un corpo trafitto da migliaia di bandiere e minareti, che si alzano orgogliosi verso il cielo: nazionalismo e religione, armi potenti, diffuse a perdita d’occhio, perché il controllo delle coscienze sia quanto più capillare possibile. E dove questo non è sufficiente, spuntano intere colline utilizzate come spazi pubblicitari: piccole e innocue pietre bianche compongono citazioni di Ataturk. Ne mutly turkum diyene, “Sono felice di definirmi turco”, sale sulle ferite del popolo curdo. Sbircio i volti degli altri passeggeri, per lo più Curdi, ma non leggo nei loro occhi alcuna reazione. Qualcuno scuote il capo, quando il pullman è costretto nuovamente a fermarsi, per l’ennesimo posto di blocco dell’esercito. Il freddo pungente rende insostenibile la lunga attesa. Sento gli occhi del militare che presidia questo frammento di nulla, attraversarmi. Suscito curiosità e interrogativi pesanti. Almeno quanto te, mio giovane amico, gli anfibi sprofondati nella neve, il viso ormai ridotto ad una insensibile maschera, mentre picchietti le dita sulla canna del tuo mitra. Di sicuro vieni da lontano: il governo deliberatamente allontana i giovani del servizio di leva dalla loro città natale. Forse la tua famiglia ha maledetto la tua sorte, un figlio perso in questo fottuto freezer, infestato di Curdi per di più, povero caro ragazzo… Io, verso quell’Est insidioso e non raccomandabile, sto spingendo i miei passi, per concedermi di stringere tra le dita un pezzetto di felicità, così simile ad un frammento di vetro che affiora sul bagnasciuga. Liscio e levigato dal mare, puoi accarezzarlo sapendo che non potrà ferirti, eppure sa produrre un bagliore di luce autentico, forse non duraturo, certo non surrogato. Quel frammento di vetro si chiama Erkan, un dono della strada prezioso e inatteso, e ora desiderato e cercato. Nella penombra, cullata dal motore, ripercorro il passato come fosse un album di fotografie. Tre amici in viaggio, Dogubayazit, surreale cittadina curda a una manciata di chilometri dal confine iraniano, un alberghetto a conduzione familiare, un’amicizia inattesa con il giovane figlio del proprietario. Sorrido ripensando ai tanti çai bevuti, galleggiando tra progetti, sogni, politica, interessi… Mesi dopo, un nuovo incontro. Labbra che si cercano timidamente, la Moschea Blu di Istanbul silenziosa spettatrice di una notte indimenticabile… Per queste istantanee preziose, sono nuovamente sulla strada. La strada… Quando si percepisce davvero di essere sulla strada? Quando il viaggio entra in circolo, annullando cautele e abitudini radicate nella vita quotidiana? In genere il primo segnale di questo grande miracolo – la partenza – è la preparazione dello zaino, inserire disordinatamente qualcosa che con tutta probabilità non servirà davvero, togliendo il posto a qualcos’altro che si rileverà indispensabile, e che per definizione giacerà nell’oblio di casa. 4 Questa volta è diverso, galleggio da settimane nell’attesa. Percepisco la strada, vagando sola per le strade di Istanbul, che ci hanno visti insieme; percepisco la strada sul dannato sedile di questo pullman, sul quale passerò ventiquattro lunghe e buie ore. E quando, esausta, metto piede a Dogubayazit, la strada fa parte di me, con le sue salite, le sue discese, il passo ora sicuro, ora incerto. Erkan è strada, a volte incanta con la bellezza del suo paesaggio, altre stanca per la fatica di far seguire un passo a un altro, altre ancora spaventa per il precipizio accanto al quale passeggia incurante. Gli occhi di Erkan sono strada, una distesa infinita da percorrere prima di riuscire a trovare un rifugio per la notte, disperata richiesta di un sostegno, così spesso inattesa, richiamo enigmatico e incomprensibile. È strada gioire della scoperta di sé, godere della vita che dolcemente ci si scambia, galleggiare nei frammenti del suo passato, che timidamente lascia scivolare lungo il cammino. Come uno strano Pollicino, li raccolgo, perché catalogano un dolore ancestrale, di cui ho paura, e perché mi mostrano la strada per arrivare a lui, alla violenza, alla disillusione, all’apatia, a una vita congelata in un istante, fatta di non scelte, un sentiero che non prevede bivi, ma solo distratta attesa della prossima frana. È un esercizio al dolore continuo. Se nulla attendi dal tuo camminare, non trovare nulla ti sembrerà fisiologico come appoggiare prima il tallone e poi la punta… In questo luogo speranza, ottimismo, sogni sono sotto una pesante coltre di neve, in letargo forse, perduti per sempre più probabilmente. Erkan fa fatica a camminare con me, esponente critico e illuminato di quella che resta una cultura del silenzio: le parole qui costano care, è indispensabile farne un buon uso. E così, quando dopo l’ennesima curva mi tende la mano, apre una nuova pista dentro di sé, lo seguo docilmente, grata del suo sforzo assoluto. La strada è scivolosa talvolta. Io le chiamo differenze culturali, che giustificano reazioni e paure, innate eppure così poco scontate. Lui sorride: “Non c’è un muro tra noi, solo Paesi e Paesi.” E forse è così, altra strada a separarci, troppa per essere percorsa in una vita. E allora questa distanza va accolta, perché non c’è nulla che io possa fare per ignorarla. Non posso ignorare di essere un alpinista high-tech ben equipaggiato, che può attraversare il mondo con gli occhi spalancati e il passo sicuro, né che questo uomo, che perde i suoi occhi miei, proceda solo, senza bussola, a piedi scalzi nella neve… C’è giustizia in questo? Non credo: la mia mano, che calma il suo respiro indugiando tra i suoi capelli, non restituisce nulla, non colma quel baratro, solo lo rende più dolce. Per me, instancabile Occidentale che può varcare nuove frontiere, è strada anche questo piatto fumante di zuppa, questa città sepolta sotto due metri di neve, l’aria che passa come carta vetrata sui miei bronchi, il passo incerto sul ghiaccio, il riverbero che mi costringe a fissare i miei scarponi. È viaggio persino circondarmi di questa rumorosa combriccola di giovani professori, involontarie vittime di Dogubayazit, inviate dal Governo in questa ghiacciaia, svogliati e inesperti responsabili del peggior livello di istruzione del Paese. È strada rispondere al loro inglese approssimativo, ignorare l’invidiosa supponenza con cui trattano Erkan, reo di essere uno qualunque, un non professore, e di avere una giovane italiana che sorride dolcemente. È strada anche l’attesa, e questo sembra in fondo ovvio: in quante stazioni, aeroporti, seduta su quanti gradini ho atteso qualcosa, vedendo il mondo passare e gioendo di ciò? Qui è un’attesa più intima, e allo stesso tempo meno metaforica, attendo che sia accanto a me, attendo di perdermi nei suoi occhi, o di impazzire al contatto della sua barba con la mia schiena. Attendo di non farmi capire, di ripetere, di fingermi stufa e arrabbiata, di ricominciare da capo. Attendo si svegli, mentre esausto riposa nella casa di sua madre, che 5 mi sorride. È strada il piede di quella donna malata, che accarezza il mio, sembra dirmi “È il mio amore, abbi cura di lui”. È strada vederlo scivolare fuori dal mio letto alle cinque del mattino per evitare scandali, porgermi una spalla con discrezione quando il ghiaccio si fa insidioso, scegliere il cibo proteggendomi dalla carne di montone che può nascondersi persino in un’ innocente melanzana. È strada scoprire che l’autocontrollo qui è d’obbligo, anche nel sesso, mai considerare qualcosa indispensabile, o la vita qui può rivelarsi una lunga immersione: accorgersi del suo orgasmo appena, come se qualcosa sfuggisse alla sua griglia fitta di anestesia e risalisse in superficie per un istante appena. Come vivere così? Forse la vera domanda è “come vivere senza”. Come sopravvivere senza questa autodisciplina, in un luogo in cui la natura imprigiona, spesso al buio per i continui black out, di sicuro al freddo, in un luogo in cui non c’è terra fertile per i sogni, che resteranno semi abbandonati in un cassetto, in un luogo in cui altri scelgono come disporre della tua vita e in fondo nessuno sembra stupirsi di ciò? Una mansueta accettazione della violenza, della transitorietà, dei propri diritti negati… Ecco un frammento di tutto ciò: lo posso vedere Erkan, poco più di dieci anni, guardare eccitato i bagliori nel cielo nero, eco degli scontri tra PKK ed esercito. Attende il mattino, per correre nella neve in cerca di bossoli. Non quel giorno, quel giorno un blindato dell’esercito carica i ragazzini per disperderli. Le scarpe, quelle scarpe sulla neve non hanno presa, cade e vede i cingoli del blindato a un passo da lui. Un cancello si apre, il braccio robusto di un uomo lo afferra e lo sottrae a quel destino, che evidentemente non gli apparteneva. Lo vedo ora Erkan, un uomo dagli occhi vibranti, un sollievo di lacrime negli occhi, la voce spezzata, mentre a ventotto anni racconta a chi viene da lontano le radici del suo dolore. È strada fare strada nel suo passato, drammi personali intrecciati all’epopea di un popolo senza futuro, un passato dimenticato, un presente sistematicamente calpestato. È strada capire cosa mi ha spinto qui, definito finora sete di felicità, anestesia emozionale, con l’arroganza di chi crede che il proprio passato sia di per sé giustificazione. È strada capire che nessun istante della mia vita è stato anestesia emozionale, piuttosto prosciugata felicità, ma posso io lamentarmi di ciò? Posso rimproverare alla vita scarsa generosità? Stare qui fa soffiare un vento nuovo,che riporta ogni frammento impolverato al suo colore originario, e mi manca il respiro nel vedere che magnifico caleidoscopio di colori è la mia vita. Dunque è necessario abituare la vista al grigio, o meglio all’omologazione del bianco, per ritrovare gratitudine e determinazione? Mi sentirei una ladra, se così fosse, un avvoltoio che depreda ulteriormente questa terra dura e i suoi rassegnati abitanti. Mi sentirei al centro di un egoistico viaggio new age di riscoperta di sé, fatto a spese del mio caro Erkan. Non credo sia così. Gli attimi vissuti possono permeare la nostra essenza, arrivare a perfezionare la nostra identità. E se avessi ora una lente di ingrandimento, vedrei un piccolo seme, che trema, ma vuole salvarsi. È un dono prezioso ricevuto senza merito, che va salvaguardato. Ho forse seminato io in questa neve implacabile, in questo cuore stanco, in questi occhi disillusi? Credo di sì, per un attimo questo dolce uomo, forte e fragile, indifeso eppure protetto da impenetrabili barricate, ha visto se stesso riflesso negli occhi di un altro, in modo gratuito, libero, entusiasta. Forse restano gli interrogativi, l’amarezza della separazione, ma per un attimo si è considerato degno di ricevere un dono dalla vita, senza interessi da pagare, un dono al quale lasciarsi andare, un dono da assaporare, sforzandosi di viverlo appieno, un dono infine del quale liberarsi, per tornare libero, per tornare alla vita, dura e implacabile, dimenticando che si può essere fragili e vulnerabili senza essere per questo colpiti violentemente. Ormai questo tempo non ci appartiene più. E come ho visto fare altre volte, ti vedo, dolce 6 arkadash, rivestirti della tua corazza, circondarti del tuo inaccessibile silenzio, come se io non fossi più qui ormai. C’è la vita da affrontare, e devi essere pronto. Vedo una luce in fondo ai tuoi occhi, che non mi riflette più; il tuo corpo tra le mie braccia non mi appartiene più, sei lontano ormai. Vorrei dirti “credi nel potere dei sogni, tutto si sistemerà, sii felice”, ma avrei potuto dire queste banalità prima di sprofondare nel tuo abisso, prima di vederti annegare nella mancanza di progettualità, nella rassegnazione dolorosa. Sono scesa con te laggiù, nel buio del tuo cuore, e ora che mi congedo da te, la luce fa male agli occhi. Fa male allontanarmi dal tuo buio, sapendo che presto sarà poco più di un ricordo… Mi rivesto. Ormai sono poco più di un’estranea. E so che i tuoi occhi, in quella stazione, si poseranno appena su di me, un fremito d’ali, un battito di ciglia, e i nostri mondi saranno lontani. E io sarò di nuovo sulla strada, uno zaino più pesante, pieno di ciò che mi hai insegnato… Torno alla luce, o forse al buio? Il tuo respiro spezzato accende un fuoco indomabile. Le sue ceneri spazzerò domani, facendo entrare l’aria fresca del mattino. Impenetrabile rifugio del mio presente, sarai fortezza invalicabile per il mio domani, impermeabile alla voce di donna che sibila nel vento, rispondile mio amato, non sono io a invocare le labbra tue, è la vita. Ripongo questo quaderno malconcio in borsa, la penna smette di scivolare sinuosa sulla carta. Il lungo viaggio di ritorno si sta esaurendo, inizio a scorgere i sobborghi di Istanbul. Socchiudo gli occhi, e quasi la voce del muezzin che vibra greve nell’aria mi culla, una ninnananna per lenire il mio dolore. 7 Bruno Bianco Oggi ho compiuto ottant’anni e questa mattina mi sono alzato prima del solito. Al paese, quando uno compie ottant’anni se ne ricordano tutti e ti fermano per strada ogni volta che ti incontrano. Chi ti fa gli auguri di festeggiare i cento, chi ti fa i complimenti per come porti gli anni che hai e chi ti prende in giro sul fatto che ormai sei vecchio davvero e non vai bene a far niente. Però adesso io non sto più al paese; non ci sto dal novembre dell’anno scorso, da quando mia figlia mi ha convinto, o forse sarebbe meglio dire “obbligato”, a venire a Torino. Certo è stata gentile, così come mio genero, e mi hanno trovato un alloggetto proprio di fronte al loro. Io ho ancora la mia indipendenza, ma mia figlia è tranquilla che se ho bisogno di qualcosa posso avere subito l’aiuto che serve. Che poi non posso dire di stare male qui a Torino. Ringraziando il cielo, a parte gli acciacchi dell’età, sono ancora in discreta salute, posso uscire tutti i giorni a prendere “La Stampa “ e a farmi la spesa da solo, con i negozianti della zona che sono sempre gentili con me. “Ecco il suo giornale, signor Rodolfo.” “Vuole che le porti a casa la borsa, signor Rodolfo?” “Mi saluti sua figlia, signor Rodolfo.” In paese non mi hanno mai chiamato signor Rodolfo. Per tutti sono sempre stato Dulfu, senza nessun signore davanti, e mi manca di sentirmi chiamare con il nome in dialetto. Un po’ per questo, un po’ perché è il mio compleanno, ma soprattutto perché oggi, come ogni ultima domenica di settembre, al paese c’è la festa delle associazioni di volontariato, ne avevo parlato per tempo con mia figlia: avevo chiesto se potevamo fare tutti una gita al paese per vedere la festa, andare a pranzo sotto il tendone e fare anche un giro nella vecchia casa prima che arrivi l’inverno. Mia figlia era davvero dispiaciuta, perché nello stesso giorno il mio nipote più piccolo aveva un torneo di scherma fuori provincia e non poteva proprio mancare. Che poi devo ancora capire qual è il senso di portarlo a fare scherma. Non dico di mandarlo a imparare il tamburello o la pallapugno, che erano i giochi di quando ero piccolo io, ma almeno il calcio o la pallacanestro. Per non parlare poi del nipote più grande, che lo mandano a fare judo che io non so nemmeno cosa sia. Ai tempi di oggi però sono questi gli sport moderni e so che devo adeguarmi. Io mi adeguo, ma la festa delle associazioni non la perdo per niente al mondo. Una settimana fa, con la scusa di farmi insegnare dal nipote grande come funziona questo internet che usano tutti, mi sono fatto guardare gli orari dei treni verso Asti e per il paese. Il giorno dopo sono subito andato a prendere un biglietto di andata e ritorno per la domenica dopo. Così questa mattina mia figlia, mio genero e i miei due nipoti sono partiti presto per la gara di scherma e si sono anche raccomandati che tenessi acceso tutto il giorno quell’aggeggio di un telefonino che mi obbligano a portare quando loro sono via di casa. Stavolta l’ho acceso sul serio, mentre dal finestrino guardavo allontanarsi la stazione di Porta Nuova, e se mia figlia mi telefonava avrei detto che ero appena uscito a prendere il giornale. Il treno è arrivato in perfetto orario ad Asti e ho preso subito la coincidenza con l’accelerato che partiva per il paese. Quel quarto d’ora di viaggio l’ho fatto tutto al finestrino, che se lo sanno mia figlia e il mio medico mi uccidono. Ma io non potevo rinunciare a sentire il profumo della mia terra. Che poi in questa stagione non c’è più l’odore forte del fieno, della meliga o del grano. Adesso ci sono i trattori nelle vigne, con i vendemmiatori tra i filari e le bottiglie di vino all’ombra sotto un albero. Così il profumo della mia terra diventa odore di mosto e aroma di frutta, come a trovarsi in un’enorme cantina a cielo aperto. E mentre annuso l’aria che entra dal finestrino, mi torna alla mente il treno che tornava dalla 8 Russia, insieme a quei pochi fortunati che come me ce l’avevano fatta a tornare. Mi ricordo ancora la promessa che avevo fatto a me stesso: la chiamata alle armi sarebbe stata l’ultimo gesto obbligatorio per la mia terra. Da lì in avanti avrei fatto la mia parte solo per scelta volontaria. E ho sempre mantenuto la promessa. L’ho mantenuta quando pochi mesi dopo ho scelto di andare con i partigiani delle Langhe, o ancora quando, dopo la liberazione, insieme agli amici di una vita ho messo il vigore della giovinezza a servizio della mia gente. Negli anni abbiamo rimesso a posto la scuola elementare e la chiesa con il campanile, abbiamo fatto la cantina sociale e il consorzio agrario per i contadini, l’acquedotto per portare l’acqua nelle nostre case e il foro boario per il mercato delle vacche. Con la Pro Loco abbiamo organizzato la festa patronale senza mai mancare nemmeno un anno, che venivano anche da fuori provincia nel nostro ballo a palchetto. E poi ho scelto di fare il consigliere comunale, perché i tempi stavano cambiando e avevo capito che bisognava sapersi districare nella burocrazia se si voleva fare qualcosa. Adesso il paese ha la Casa di Riposo per gli anziani, il campo di calcio per i ragazzi, la bocciofila per i grandi e addirittura la sezione della Croce Rossa con il pronto intervento, dove per più di trent’anni ho fatto il volontario a guidare le ambulanze. Il megafono della stazione spezza il filo dei miei ricordi. Scendo dal treno sull’unico binario, e non mi stupisco che alle nove della domenica mattina non ci siano altri passeggeri oltre a me. Il programma ce l’ho ben scritto in mente. Esco dalla stazione e salgo la strada verso il paese alto. La prima tappa sarà nella casa dove sono nato, cresciuto e vissuto per una vita. Aprirò il portoncino di legno e accenderò la luce per superare subito il primo impatto. Sarà come entrare nell’acqua fredda di fiume con un tuffo, senza prima bagnarsi nemmeno le braccia per abituarsi un po’. Poi uscirò ad aprire le persiane per far entrare la luce del sole, farò un giro fuori a vedere quello che resta dell’orto, il recinto dove hanno vissuto tutti i cani che ho avuto negli anni e il portico dove tenevo la fresa e il trattore. Ritornerò in casa e andrò al piano di sopra, aprirò le finestre e respirerò forte per sentire da dentro casa il profumo della mia terra. Quando sarò entrato in tutte le stanze mi sposterò al vicino cimitero. Voglio farlo per incontrare quella testona di mia moglie che, come in vita, anche in morte ha sempre fatto ogni cosa prima che la facessi io. Così passeggerò un po’ tra loculi e cappelle per salutare tutti gli amici che qui hanno già trovato ricovero, e mi servirà anche per prendere confidenza con quella che sarà la casa del mio futuro. Dopo ricomincerò a salire la strada per arrivare nella piazza del paese alto, dove ci sarà la messa al campo con tutte le associazioni del paese, ognuna con il suo stendardo e i volontari in divisa. Ascolterò il discorso del sindaco, la banda suonerà qualche pezzo allegro e la Pro Loco offrirà l’aperitivo a tutti i presenti. Ci sarà giusto il tempo di mangiare due salatini, prima di andare sotto il tendone per il pranzo dell’amicizia, con la carne cruda, gli agnolotti al plin e l’arrosto della vena. Prima di arrivare al pranzo sotto al tendone, devo ancora finire la salita verso casa e fa proprio un gran caldo per essere a fine settembre. Ma io non patisco né il sudore né la fatica. Sento soltanto il profumo della mia terra e ripercorro con la mente tutto quello che abbiamo fatto anche per gente fuori dal nostro paesino. Con la sezione degli Alpini siamo andati all’alluvione di Firenze, al terremoto del Friuli e a quello dell’Irpinia. Quando poi tornavamo al paese, organizzavamo raccolte di offerte e riuscivamo sempre a spedire delle cifre non da poco. Però mentre mi godo il ricordo nostalgico dei miei anni migliori, devo essere sincero con me stesso, perche se non lo sono adesso che ho ottant’anni non so quando potrei esserlo. Ero convinto che la mia attività, la mia presenza e addirittura la mia persona fossero indispensabili per tutto quello che è stato fatto. Invece mi ritrovo a ottant’anni senza poter più dare un contributo e con la coscienza che tutto va avanti anche senza di me, e magari va anche meglio. Ricordo bene quando a trent’anni pensavo che con la mia giovinezza potevo occupare un mio spazio, senza che nessuno potesse mai togliermelo. E quando a cinquanta mi ero convinto che la maturità dell’età adulta mi desse una forza illimitata. Adesso che sono arrivato agli ottanta, nessuno si accorge che 9 non ho più né il mio spazio né la mia forza, e per ricordare quello che ero devo cercare con fatica il profumo della mia terra. Come un cane da tartufi malato, che ha perso quel fiuto che lo aveva fatto diventare così importante per tutti quelli che gli erano vicini. Sono davvero un vecchio rimbambito, se con i miei ragionamenti stupidi sono riuscito a rovinarmi l’umore in un giorno come questo. Per fortuna sono arrivato nel mio cortile, e la sola vista della vecchia casa scaccia qualunque pensiero. Prima di entrare mi devo fermare un momento – un po’ per riprendere fiato, ma soprattutto per ricacciarmi dentro un groppo che mi si è bloccato in mezzo alla gola. Faccio fatica a infilare la chiave nel portoncino. C’è un po’ di ruggine nella serratura e non ho gli occhiali sul naso, ma la verità è che la mano mi trema come una foglia. Finalmente riesco a entrare e accendere la luce con l’interruttore che sta sulla destra, subito dopo la porta della cucina... “Tanti auguri, nonno!” Se non mi è venuto l’infarto adesso, vuol dire che non mi verrà mai più. All’altro capo della stanza, di fianco al caminetto, ci sono mia figlia, mio genero e i miei nipoti, che mi corrono incontro come solo i ragazzini sanno fare. “Io non avevo mica tanta voglia di andare a fare la gara di scherma!” grida il nipote più piccolo. “Quando abbiamo guardato su internet gli orari dei treni, io gliel’ho subito detto alla mamma,” mi prende in giro il nipote più grande. “Spero che mia moglie non diventi testarda come suo padre, altrimenti sarà dura tenerla a bada quando sarà avanti negli anni,” dice mio genero. “Guarda che non sei mai riuscito a fregarmi quando eri giovane, e non pensare di poterlo fare adesso,” borbotta mia figlia mentre mi abbraccia. Mentre mi sforzo di tenere dentro agli occhi quelle due lacrime che sono lì lì per uscire, mi rendo conto che non mi interessa più andare a vedere l’orto, il porticato e il recinto del cane, e nemmeno salire di sopra a guardare quelle stanze che ormai mi sono già lasciato alle spalle. Già che ci sono, non faccio nemmeno più il giro al cimitero, e con la mia famiglia al completo andiamo direttamente alla festa delle associazioni. Prendiamo la messa, ci gustiamo l’aperitivo e poi andiamo al pranzo sotto il tendone. Staremo insieme a tutti quelli che negli anni passati si sono impegnati con me e a chi si sta impegnando adesso con la stessa passione che avevo io, e non mi rattristerà più pensare che un tempo sono stato come loro, mentre adesso sono solo un attempato signore che ha dovuto scappare dal proprio paesino per garantirsi una vecchiaia assistita. Perché oggi ho capito che non sta scritto da nessuna parte che devi crescere dove sei nato e morire dove sei cresciuto. La vita può farti restare ottant’anni nello stesso posto o spostarti ottanta volte in tutta la tua esistenza. Questo però non cambia niente, perché il profumo della terra, se mai esiste, non è nell’aria che ti circonda, ma è dentro le narici del tuo naso. Lo puoi sentire parlando con le persone care che ti stanno intorno, guardando indietro a quello che hai fatto per gli altri e pensando a quello che gli altri continueranno a fare senza di te. Oggi ho compiuto ottant’anni, e questa mattina mi sono alzato prima del solito. Credo che, quando rientreremo a casa, andrò a dormire presto. Prima di coricarmi aprirò la finestra e farò un lungo respiro. Non vedrò le mie colline di campagna, ma un trafficato corso di città. Però so che nel naso c’è il profumo della mia terra, e niente potrà farlo sparire – anche se adesso ho ottant’anni e la Pro Loco, la Croce Rossa e la bocciofila vanno avanti senza di me che sto a cinquanta chilometri di distanza. Ma ora lo so bene qual è il profumo della terra: è sapere che c’e qualcuno che porta avanti l’opera di chi lo ha preceduto. Magari con mezzi, modi e soluzioni diverse, ma con la stesso cuore e passione che hai avuto tu e quelli che c’erano prima di te. È come passarsi un’eredità che attraversa le generazioni senza mai consumarsi, diventando più intensa e vivace ad ogni passaggio. È questo il profumo che ho dentro al naso. È questo il profumo della mia terra. 10 Giulia Parri Bardo Greco era professore e giocatore. Giocatore di scacchi e professore di letteratura. Era nato in una casa di periferia, aveva conosciuto la povertà e la violenza. Aveva lottato nella strada – ma in quei quartieri tutti lo facevano – con le parole e col coltello. Poi aveva scelto di essere quello che era. Quello che era diventato. Il professor Greco. Aveva rinunciato alla gioventù della strada e della balera, e si era consumato nello studio e nel rigore della disciplina. La sua intelligenza era straordinaria, inferiore forse solo alla sua bellezza. Ma intelligenza e bellezza non bastano per cambiare la vita di chi nasce tra le case di una borgata, segnato dal tanfo di miseria che resta addosso come un tatuaggio. Per sempre. Bardo aveva di più. Una forza di volontà capace di travolgere ogni ostacolo, capace – l’ha scritto Quasimodo – di cambiare persino i segni della propria mano, quelli dove le zingare leggono il destino. Lavorò per pagarsi gli studi. Cameriere nei sabato sera, raccoglitore nei campi di luglio, guardaspiaggia d’agosto, guardiano di cantieri la notte. Non ebbe altro tempo che per imparare il gioco degli scacchi e leggere la raccolta de L’Ordine Nuovo di Gramsci. Si laureò a ventiquattro anni con una tesi sulla Divina Commedia, e la sera della laurea la passò a preparare coni e cialde alla gelateria del Parco Aurora. Fu Matteo Repetto, un anziano docente che lo stimava, a proporgli l’ingresso all’università. Bardo partecipò al concorso da ricercatore e lo vinse. Più tardi vinse quello per docente di seconda fascia, e in ultimo quello per professore ordinario. Cattedra di letteratura medievale. Un’autorità internazionale per tutto ciò che riguardava Dante Alighieri. Le sue idee legate al socialismo reale gli negarono la presidenza. Non se ne fece mai un cruccio. Da anni si dedicava alla scrittura di un’opera di proporzioni innaturali dal titolo – peraltro provvisorio – I codici segreti delle similitudini dantesche. Quando gli dissero che a Toledo viveva un barbone che si vantava di conoscere quei codici, si mise a ridere. Più tardi l’ansia lo raggiunse e la paura iniziò il suo cammino. Quando si rese conto che ormai gli bastava addormentarsi per sognare un clochard sdentato e con gli occhi bianchi che rideva di lui, acquistò il biglietto di un volo per Madrid e si imbarcò la mattina del 6 aprile del 1981. Un lunedì di pioggia. Quando giunse a Toledo lo accolsero la violenza del vento e la pietra bruna dell’Alcázar. Inutilmente cercò nel paesaggio le pennellate di Theotocopulos che il mondo aveva conosciuto con il suo stesso nome. Le numerose domande lo guidarono oltre il Tago, fino a una piccola chiesa dai muri grigi. Seduto – forse accasciato – a lato della porta, un uomo di barba candida e occhi ancora infuocati di nero. Nessuno aveva saputo dire il suo nome. Tutti lo chiamavano el catedrático. Bardo vide che posati per terra l’uomo teneva una bottiglia di vino rosso, un sottovaso dove lasciava che cadessero i centesimi, una scatola di legno e un volume che riconobbe facilmente per la COMEDIA DANTIS ALDIGHERII POETAE FLORENTINI, nell’edizione del 1930 dei Fratelli Stianti. Un’edizione che riproduce fedelmente un manoscritto del Trecento, il Codice Caetani. Bardo Greco conosceva lo Spagnolo, e si rivolse al vecchio in un ostentato Castigliano. “Sono venuto dall’Italia per parlarle. Si dice di lei che conosca il codice segreto delle similitudini di Dante. Io credo che questa cosa sia una falsità e che lei sia un millantatore.” L’altro sollevò un viso consumato da inverni dormiti al riparo di un cartone e da estati di caldo impietoso. Lo guardò senza irritazione. “Un Italiano. Che tu sia il benvenuto. Mi scuserai se, al momento, non posso farti accomodare in una poltrona. Ma se ti siedi dietro alla colonna sarai riparato dal vento.” Bardo misurò la sporcizia della pietra e scelse di accettare l’invito. Non sarebbero stati dei pantaloni macchiati a fermarlo. Si presentò. Spiegò chi era e a quale opera lavorava da oltre vent’anni. Alla fine 11 chiese il permesso di sfogliare il libro. Era la centotrentanovesima delle trecento copie numerate uscite dai tipi dei Fratelli Stianti a San Casciano Val di Pesa. “Lei riesce a leggere l’Italiano?” L’altro sorrise. Rispose in un Italiano quasi perfetto, con un dondolante accento che lasciava intuire lunghe frequentazioni della Toscana. “Per alcuni anni ho studiato a Firenze ed ho visitato il suo paese decine di volte. Potrei dire che non c’è città che non abbia conosciuto.” Tutto questo alimentava sempre di più il desiderio di Bardo. “Vorrei chiederle come è finito sulla strada. Non mi sentirò offeso se preferirà tacere.” “E perché dovrei tacere?” Forse in omaggio ad una qualche consuetudine il barbone, prima di indugiare nei piaceri della memoria, tracannò un lungo sorso di vino. Si scusò di non poterlo offrire all’altro per la mancanza di un bicchiere e infine, con voce adatta, raccontò la sua storia. “Il mio nome è Manuel Santiago de Segura. Sono nato in una famiglia nobile. In un palazzo sontuoso, popolato di servi e di giardinieri. Mio padre è stato un aristocratico del vecchio stile. Un cortigiano, come diceva lui. I miei fratelli e le mie sorelle, quelli ancora in vita, godono dei favori della casa reale. Ho studiato in un collegio di Salamanca, e fin da giovane ho intrapreso la carriera dell’insegnamento. Sono stato professore di letteratura spagnola all’università di Madrid e ho dedicato il mio tempo all’inutilità della ricerca. La comprensione del misterioso Dante è stata la mia unica vanità. Ho cercato per anni il codice nascosto nelle similitudini e, quando ormai stavo per cedere alla rinuncia, l’ho trovato. È stato in quel momento che la vita, quella vita di accademia e di illusorio prestigio, mi è apparsa inutile. Ho lasciato l’università e mi sono ritirato in una casa che la mia famiglia possiede lungo le sabbie del Mediterraneo. Col tempo e la riflessione ho compreso che una casa è un luogo di abitudini e di memorie. Ho scelto di distruggere entrambi. Una notte d’estate sono uscito chiudendo la porta, ma senza la chiave per riaprirla. Avevo in tasca tante pesetas quante ne avrebbero consumate sei mesi o sei anni. L’ultima la lasciai cadere nel sottovaso di un mendicante, qui, dove siamo adesso. Giocai con lui a scacchi. La posta fu questa colonna. Sono rimasto qui e ci resterò finché qualcuno non mi sfiderà ancora e mi batterà.” Bardo aggiunse. “ Come un rex nemorensis.” “ Già, e magari lei è lo schiavo.” Da sotto una coperta, che Bardo Greco giudicò infetta, sfilò una scacchiera di stoffa e la distese sulle pietre della chiesa. Tolse uno ad uno i pezzi di bosso dalla scatola di legno e li distribuì sulle case con gesti di rigorosa geometria. Per sé tenne il nero. “Chi le assicura che io sappia giocare?” Il barbone lo guardò sollevando appena le spalle. “Ho sentito molto parlare di un professore italiano che da anni cerca i codici delle similitudini. Ho sentito dire che è di fede comunista e di consumata abilità agli scacchi.” La partita iniziò subito dopo. Bardo spinse il pedone in e4 e l’altro rispose in e5. Poi f4 bianco e nero in presa ef. La terza mossa fu Ac4 per il bianco e f5 per il nero. Bardo Greco riconobbe un controgambetto di re vecchio di quattrocento anni. Una trovata ambigua inventata da Ruy Lopez de Segura, un prete spagnolo del Sedicesimo secolo, forse il primo teorico del gioco degli scacchi. Non riconobbe nel nome del barbone il nome del sacerdote. La considerò una mossa debole. Sapeva lo scopo di quella scelta. Spalancare la quarta traversa al vantaggio del nero. Soppesò le varianti. Si chiese quale veramente fosse il livello del suo avversario, e alla fine scelse di assecondarlo. Si sentiva imbattibile. Accettò la presa in f5. Aspettò la risposta dettata dalla logica e dalla tradizione – la donna nera in h4, ma l’altro lo stupì con il movimento di un cavallo. Greco giudicò l’avversario poco più di un modesto dilettante e immaginò la scena grottesca della partita con cui aveva vinto il posto di barbone. Decise di farla finita in fretta. Non 12 disdegnò l’umiliazione. Lui, che aveva lottato tutta la vita per affrancarsi dalla miseria, per conquistare un pezzetto di prestigio in un mondo che lo aveva fatto nascere emarginato, era irritato all’idea che un rampollo nobile, viziato e con ogni porta pronta ad aprirsi, avesse scelto di percorrere la sua stessa strada, ma al contrario. Era andato incontro alla miseria, a quella miseria da cui lui era fuggito. Muoveva i pezzi velocemente. Voleva dimostrare a quel barbone che Bardo Greco non aveva tempo da perdere per pensare. Che poteva batterlo senza nessun impegno. Quando Manuel Santiago disse “scacco matto”, Greco non si era nemmeno reso conto di avere il re imprigionato tra i suoi stessi pezzi. “Mi dispiace, dovrà continuare a insegnare letteratura nella sua università, e io continuerò a occupare questo posto.” “Potrei dimettermi e cercarmi un posto di barbone accanto alla porta di una chiesa italiana. Non c’è solo questo posto nel mondo.” “Ma non può farlo. Ho dimenticato di dirle che nella posta c’era anche il codice di Dante. Lei poteva averlo insieme al posto, adesso dovrà continuare a cercarlo.” Bardo Greco sentì la terra aprirsi e credette di vedere le volute della chiesa che si ripiegavano su di lui. Il codice. Se avesse vinto. Una partita segnata da un errore enorme del suo avversario. Una partita che avrebbe vinto anche un principiante. E lui aveva perso. “La sfido ancora!” “No, professore. Non posso accettare, ma si prenda il libro e lo legga.” “Conosco a memoria ogni terzina. Ed ho letto anche il Codice Caetani. Non mi serve il suo libro. Possiedo le edizioni più rare della Commedia.” “Anche il controgambetto di Lopez conosce bene e immagino avrà letto i migliori lavori sul gioco degli scacchi, ma ha perduto. Prenda il libro, professore, e non dimentichi di leggerlo.” Iniziò a sfogliarlo mentre l’aereo dell’Iberia correva immobile sul Mediterraneo. Lo lesse con la distrazione dovuta all’eccessiva conoscenza. Fu tentato di saltare da una cantica all’altra, poi fu vinto dalla noia e lo chiuse. All’aeroporto si accorse di aver dimenticato il libro sul sedile, ma non se ne preoccupò. Al di là dei cinque o seicento euro del suo valore, non c’era ragione per possederlo. Si divertì pensando che forse la centotrentanovesima copia sarebbe finita al macero in una rumorosa ricicleria. Dopo sei mesi incontrò sui gradini d’ingresso della facoltà Mansueto Spano, un collega, professore associato che sapeva appassionato di Dante. Si salutarono. “Come va il tuo saggio?” “Va. Un po’ a rilento, devo dire.” “Devo raccontarti una cosa che ti lascerà basito. Tempo fa mia figlia ha scoperto in una cassa della ricicleria un’edizione della Divina Commedia. La conosci bene, la copia del Codice Caetani del ’30. Quella dei Fratelli Stianti. Anche se ne ignorava il valore, l’ha presa pensando alla mia passione per Dante. Difatti me ne ha fatto dono. Qui viene il bello. Verso la fine ho trovato delle note manoscritte. Non saprei da chi. Sono scritte in Spagnolo, e in poche frasi rivelano il codice delle similitudini. Straordinario, non trovi? Chiaro che nessuno può affermare che ci sia del vero. Forse è solo uno scherzo, ma comunque ho trovato il fatto piuttosto affascinante. Insomma, sono quattro o cinque mesi che aspettavo di incontrarti per dirtelo. Magari ti potrebbe interessare per il tuo saggio.” “Il numero. Dimmi il numero della copia.” “Credo sia la centotrentanovesima delle trecento stampate. Se vuoi te la posso prestare.” “Grazie, sei tanto gentile, ma non mi serve.” Il 15 di ottobre del 1981 Bardo Greco consegnò la busta con le sue dimissioni al Rettore dell’università. Il giorno successivo scelse la chiesa di San Paolo alla Ripa, si mise seduto con le spalle appoggiate alla pietra grigia, posò per terra un sottovaso, una scacchiera e una bottiglia di vino e sorrise. Si domandò se lo avrebbero chiamato “il cattedratico” e poi, forse in omaggio a una qualche consuetudine, tracannò un lungo sorso di vino. 13 Franca Viti La salita che porta a Cerbaiola è sempre la stessa, ma i campi sono incolti. La affronto pedalando veloce, a metà la fatica mi indurisce i polpacci. Scendo e continuo a piedi. Sono passati cinquant’anni e la voglia di tornare si è accampata nella mente, scalzando la fatica di vivere che riempie giorni e pensieri. In una giornata ottobrina di luce acida mi sono decisa. Non ho preso l’auto, sono tornata in bicicletta. L’unica scelta possibile. Come il vento che va lontano, ma prima o poi ritorna, io torno a casa. Su questo poggio trascorrevo le vacanze nella casa dei nonni. Era l’estate del Cinquantanove. Avevo sette anni e pedalavo veloce sulla piccola bici rossa, la gonna gonfia di vento. Il nonno mi intimò di rallentare, ma io non lo ascoltai e imboccai il viottolo che, a destra, tagliava verso l’alto. S’inerpicava in un tunnel ombroso. Sassi, muschio, rotaie parallele di barrocci e il profumo di schiacciata della nonna che mi prendeva per mano già all’inizio della salita. Pedalavo veloce verso le porte dell’estate. Sono in cima alla salita. La casa dei nonni è stata demolita, al suo posto una villa moderna che stona pesantemente con l’ambiente. Allora due colonne scortecciate e un`aia di mattoni con un fico al centro. Sulla porta della casa nonna Gina, il grembiule sbiancato di farina, i capelli raccolti in una treccia severa avvolta a cipolla, gli occhi attenti nel volto grinzoso. Mi scrutava. Ero l’unica nipote, figlia di una madre vedova che cuciva impermeabili a domicilio, lavorando duramente per pagare una casa popolare a riscatto. La tragica morte di mio padre, di ventisette anni, aveva esasperato le difficoltà familiari. Le tribolazioni materne avevano già disegnato in me cicatrici: tatuaggi nell’anima. La nonna si preoccupava per questa nipote guardinga di sentimenti, infiacchita dalla timidezza, seria e silenziosa, il dolore per la perdita del padre fermo lì, come un coltello affondato nel cervello. Il suo volto si apriva in un piccolo sorriso, prima che mi soffocasse in un abbraccio caldo. Iniziava così la lunga estate di libertà. Giorni pieni di niente. E di tutto. I pomeriggi sonnolenti in valletta, dove i contadini falciavano il grano. Il mare di spighe e papaveri lasciava il posto alle stoppie che mi graffiavano i piedi. Gli incontri con Miretta, il volto da elfo, gli occhi ridenti, le lunghe trecce nere che frustavano l’aria. Viveva un quotidiano, allegro disordine. Spericolata, istintiva, indomabile. Io, invece, mi muovevo goffa sul palcoscenico della vita: una mosca in volo dietro una farfalla leggiadra. Certi giorni improvvisamente uno strano fermento nell’aria. Era in arrivo un forestiero in quel crocevia del mondo. Qualcosa di nuovo che allentava la sonnolenza di giorni troppo uguali. L’estate che annodava storie e figure: i seggiolai, un frate questuante, un pescivendolo…. A giugno arrivò anche una straniera, o meglio “quella”, come la chiamavano tutti, srotolando la parola con un tono aspro, da insulto. Eppure la donna aveva un nome: si chiamava Licia. Lo rivelò un’anziana, assunta per le pulizie della villa in cui abitava. Ne parlò sottovoce, scuotendo la testa, quasi con fare infastidito. 14 La signora Nilde, Maria Soave…. rispetto e ossequi verso le villeggianti. Lei, invece, era “quella”. Non capivo e, se ponevo domande, mi veniva detto che non potevo comprendere. Ma cosa? Di lei sussurravano a mezza voce gli uomini la sera, seduti sul muretto dell’aia, voltando la schiena alla luna. Le donne abbassavano gli occhi e li ammonivano di tacere: c’erano i bambini. E una domenica il prete dal pulpito tuonò contro le donne perdute. Parlò di lussuria e di lascivia (che c’entrava la lisciva con la messa?). Ansimava, il volto acceso. Detergeva il sudore della fronte con un fazzoletto bianco, e si spostava tirandosi dietro la gamba rigida in uno svolazzare di tonaca. Poi snocciolò una raffica di frasi in Latino verso le donne che, a capo chino sui messali, i volti celati dai veli neri, ascoltavano senza capire nulla. Io arricciavo il naso, il profumo intenso dell’incenso stimolava starnuti che cercavo di reprimere. Il Latino aveva un potere quasi magico e spaventoso. All’uscita chiesi alla nonna: “Perché nessuno va a cercare le donne perdute nel bosco?” Lei mi trascinò lungo il sentiero di cipressi, intimandomi di tacere: ero troppo piccola per capire. Ma quando arrivava il tempo in cui i bambini potevano capire tutto? La donna perduta era la forestiera ed abitava nel villino di caccia, una villa cinquecentesca dalle linee solide ed armoniose. Anni più tardi qualcuno mi svelò il grande arcano: era l’amante di un industriale genovese. L’uomo arrivava a bordo di un bolide rombante, la guida spericolata tra buche, fosse, codazzi polverosi e galline starnazzanti che svolazzavano in cerca di salvezza. Lui atletico, elegante negli abiti di lino bianco. Lei bionda, eterea come una ninfa. Della coppia si bisbigliava molto. E questo mi incuriosiva. Avvertivo qualcosa di contrariato e patetico che mi attirava misteriosamente. Un giorno andai alla villa e rimasi folgorata. Lei era così diversa dalle contadine, donne tozze, indurite dal lavoro, le schiene curve, il sorriso scontroso sui denti gialli. Nella fantasia di bambina che si trastullava con le fiabe, assunse le sembianze di una fata. Le offrii il cuore in pegno di nulla. Con la bici pedalavo nei prati increspati di vento, fino al cancello della villa. Passeggiava nel giardino, riparandosi con un lezioso parasole, l’ombra rotonda le copriva le spalle. Guardava lontano. Mi spostavo nella traiettoria del suo sguardo. Un’occhiata fugace, un cenno della testa. Il cancello chiuso un muro di silenzio. Spesso usciva accompagnata dall’autista. Seguivo l’auto che acquistava velocità, spariva alla curva. Allora correvo a perdifiato fino al pescheto, la vedevo riapparire sulla strada per Empoli e perdersi oltre il cimitero. Agitavo la mano in un saluto solitario. Viaggiavo con lei, seduta sul sedile posteriore odoroso di pelle, i corpi che scivolavano vicini quando l’auto sobbalzava sulle buche. Viaggi in luoghi improbabili. Ogni giorno i contadini rifornivano la cucina della villa. Mio nonno portava le verdure, e io gli avevo chiesto di condurmi con lui, ma inutilmente. Alla villa non dovevo andare, mai. Divieti senza spiegazioni, ribaditi dalla nonna con parole dure e senza un perché. Una mattina Miretta arrivò di corsa sull’aia. “Dov’è la tu` nonna?” “A far l’erba per i conigli.” “Allora vieni con me.” “Indove?” 15 “A prende’ l’acqua al pozzo.” E in un sussurro, “Si va da quella.” Gran battere del cuore. La guardai titubante. Miretta sbuffò strafottente: “Sei la solita rammollita!” La sfida le ballava negli occhi come una bufera di vento, energia di luce, di slanci, di forze. Io, invece, vivevo un`età contorta. Scrivevo i silenzi di sogni e desideri, ma avevo un rapporto difficoltoso con le persone e con le parole. Eppure dentro di me si coloravano, si ammatassavano pensieri e voglie. Fuori di me dubbi, paure, abissi di insicurezza. Sparì oltre il cancello, rifece capolino, dondolando tra le dita un paniere. “Deciditi, coniglio. ‘Un ci si fa mi’a vede’ dalla tu` nonna!” Provocazioni lanciate come sassi. Non mi mossi. Se ne andó. L`infelicità aveva il rumore dei passi che si allontanavano. “Vengo!” Il grido si perse nell`aria calda. “Non mi ha sentita,” pensai – un sapore aspro che dilagava in gola. Invece la vidi riapparire tra i cipressi. Sorrideva maliziosa. Arrivo al villino di caccia. Le finestre sono chiuse, ma il giardino è ben curato. La villa è armoniosa, ma le manca il fascino del proibito e la presenza di lei che si aggirava leggiadra come una ninfa dei boschi . La osservo con un senso di distacco. Ripenso alla stagione in cui la fiaba illudeva di felicità. Allora sfarfallava l’estate e tutto pareva possibile. Ora il posto mi sembra vuoto. Innamorata di un sogno, sono giunta a una meta che sa di delusione. Tagliammo per i campi, l`erba calda e grassa che intrappolava le caviglie. Suonammo la campanella del cancello. Lungo il viale apparve un cameriere. Ci guardò con riprovazione, come se avessimo violato le regole del galateo solo sfiorando gli arabeschi del cancello, ma ci fece entrare. “Attendete qui,” ci ordinò. “Ora arriva la cuoca.” Opulenza e soggezione. Una porta si aprì. Non era la cuoca. Dalla penombra apparve lei, avvolta in una sottoveste di seta nera. Nella mano un fazzolettino con cui tergeva il sudore tra i seni. Camminò scalza, aprì una porta e ci invitò ad entrare in un salottino. Si abbandonò su una poltrona, sollevando la massa di capelli biondi sulla nuca. Profumo dolciastro di violette. Mi scrutò con occhi curiosi. “E così tu sei Franca.” Fissai i sandali, le dita strette intorno alle pieghe della gonna. Ero a disagio in quella villa così diversa dalla semplice abitazione dei nonni. Le scale odorose di stalla, il focolare annerito, la piattaia tinta di verde con i piatti scompagnati, la madia odorosa di pane, le macchie di umidità sui muri. Mi guardò. Grandi occhi chiari, iridati intorno alle pupille. “Non temere, sono solo cose. Oggetti costosi e belli di una prigione comoda.” Movimenti leggeri delle mani come voli di farfalla. Una voce bassa, l’arrotondamento strascicato delle erre. Come poteva essere quella una prigione? E se era imprigionata, dov’era il mago cattivo? Quante domande, l’alone fiabesco ben strutturato in testa. Non capivo che la perfezione estetica nascondeva sofferenze e lontananza, lutto di sentimenti. 16 “Sei la nipote di Beppe, la figlia della vedova. So molte cose di te.” Il movimento rotatorio della gamba accavallata. Le unghie del piede rosse, lucide, curate. Così diverse da quelle scheggiate, orlate di nero delle contadine dai calcagni callosi, nelle ciabatte incrostate di terra. Con un movimento sinuoso ci porse un vassoio di caramelle. Miretta riempì la tasca con uno strillo gioioso. Io scossi la testa. Ma il mio cuore capriolava. Sapeva chi ero. Allora aveva percepito l`offerta silenziosa della mia amicizia? Sfiorò i miei capelli. “Che belli,” disse, lasciandoli scivolare tra le dita. Avevo la gola secca, il silenzio incollato alle labbra. Miretta mi dette un piccolo colpo nel braccio col gomito, come se bussasse a una porta che non voleva aprirsi. Scossi la testa. “Non sono belli, sono troppo lisci, pareggiati a forbiciate dalla nonna.” “Ma no, hanno un colore raro. Tiziano. Mi suggeriscono i fuoco che è dentro di te, ma non sai tirarlo fuori.” Sul davanti avevo una striatura rossa che odiavo. Li avrei voluti neri, ricciuti e vivi come quelli di Miretta, e tiravo indietro il ciuffo, fermandolo stretto con una molletta. “E i tuoi occhi brillano di sogni.” L`emozione si liberò come una palla che rimbalza. Senso di calore, avvolta nel suo sorriso. Arrivò una cameriera per accompagnarci fuori. La fata mi prese una mano e sussurrò: “Torna!” Uscimmo dalla villa. Il cancello si richiuse. Frinire ossessivo di cicale, la mano restia, ancorata sul ferro arabescato. Ore affocate nella foschia estiva. Uno sbuffo di vento caldo rovesciò le cime dei cipressi, poi tutto tornò immobile. Mi stesi nell`erba, le mani unite sulla testa dove lei aveva posato le sue. Bevevo la luce del cielo. Attimi di pienezza, il tempo concentrato in me. “Allora?” ridacchió Miretta. “Vedi, il mondo è uguale a prima.” Non era vero. Il mio mondo si era capovolto. Tornai a casa. La nonna era curva su un paio di pantaloni, li rammendava con gesti nervosi. Mi osservò, un punto buio in fondo agli occhi. “Dove se’ stata?” “Da Miretta.” Scosse la testa, un`espressione di condanna sul volto severo. Sapeva. Silenzio. Un silenzio di colpa, un rossore traditore che saliva su per la pelle. La nonna riprese il rammendo, le spalle curve, i movimenti dell’ago quasi violenti. “So dove se’ stata. ‘Un ci devi torna’ mai più, capito? Mai più!” Mai più. Un sibilo della voce priva di risonanze. Mai più. Un tempo molto lungo per una bambina. Assentii, ma non avrei obbedito. Un piccolo gesto sovversivo, il primo. La rividi tante volte in quella lunga estate di attese avide di incontri. E ogni volta una rete di bugie tessuta con l’uncinetto della ribellione e con un gomitolo di desueta caparbietà. Ci incontravamo nelle prime ore del pomeriggio, quando la campagna era assorta sotto la calura e in giro non c’era nessuno. Entravo in giardino da una porticina nascosta nel fogliame di un salice piangente. Attirata da catene invisibili. Aspettava seduta su una panchina nascosta dentro un labirinto di bosso. M’invitava a 17 ripassare il sillabario. Tra un dettato e un pensierino, intrecciava ghirlande di margherite con cui ornava i nostri capelli. Le azioni scolastiche più semplici assumevano un significato nuovo. Le nostre infelicità si riconoscevano, si annusavano, si sceglievano. Certe volte usciva dal suo riserbo e parlava della famiglia, un non detto negli occhi, il tono piatto di sofferenza. Aveva scritto alla sorella, madre di una bambina della mia età, ma lei non le aveva risposto. I doni per la nipotina, spediti al suo domicilio di Genova, erano stati respinti al mittente. In certe notti piene di niente, telefonava alla madre. “Pronto…” la voce lontana, stridula. “Pronto… chi è?” La rabbia del padre. “Riattacca, non è nessuno.” Le parole morivano in un sussurro. “Non mi perdonano.” Una piccola ferita sul labbro che continuava a mordersi, premendosi le tempie con le dita, come se volesse scacciare dalla mente cavalli bizzosi. Come facevano a non perdonarla? L’abbracciavo, esistevamo solo noi in quel labirinto. Era una sensazione di rifugio sicuro, una polvere magica incollata alle palpebre. Arrivò ottobre, riaprivano le scuole, andavo in seconda, dovevo tornare a casa. Quell’ultimo pomeriggio scendeva un’acquerugiola lieve che si attaccava ai capelli in piccole perle liquide. Mi prese le mani, me le baciò. “Non mi dimenticare.” Parole senza fronzoli per un addio. Fu un lungo inverno noioso, ma nel cuore custodivo una luce. La covavo in un bozzolo segreto, aspettando che l’estate tornasse. Ma a giugno la villa era vuota, le imposte sprangate. “Quella”, mi dicevano, si era trasferita. Indagai, ma nessuno volle dirmi dove. Cercavo ovunque il suo sorriso. In cambio della mia insistenza, ricevevo mezze parole, sguardi sfuggenti. “È in un posto dove nessuno può farle del male,” mi disse qualcuno. Dov’era questo posto così perfetto dove non vivevano persone malvagie? Arrivarono certe sere stanche, piene di mancanze. Notti caldissime, investita da una tempesta di gelo, un buco nero che occupava il fondo del mio cuore L’estate si riempì di inedia, come se qualcuno avesse tolto il sonoro, i giorni un guscio vuoto. Ore che si moltiplicavano, sommando domande e sottraendo risposte, l’insoddisfazione che cresceva e guastava anche l’amicizia. Vivevo la fatica di arrivare alla fine della giornata senza litigare con Miretta. A settembre i nonni abbandonarono il podere. In pieno boom economico, lo zio aveva deciso il grande salto verso un nuovo modello di vita, avviando una moleria tutta sua. L’esodo. Un furgone caricò i poveri mobili e stoviglie partì verso la valletta, il paraurti che strisciava sui sassi, una tempesta di sbuffi di fumo nero. Con la bici in mano, ci avviammo verso la discesa. Sul cancello nonna Gina si fermò a guardare la casa in cui era arrivata giovane sposa. Improvvisamente quella donna silenziosa, risoluta e instancabile crollò sotto il peso di un dolore che dilagava come una marea tempestosa negli occhi rossi. Il nonno l’abbracciò e la spinse lungo il viottolo. Scendemmo a passi lenti, inseguiti dal chioccolio di una merla che ci spiava. Una piuma grigia volteggiò sulla mia spalla. Era un addio o un arrivederci? Mi voltai tante volte a guardare la casa, solida, squadrata. La cercai fino a quando scomparve 18 nascosta dagli alberi, ingoiata dal silenzio del tempo. Mi riscuoto. Ho sbagliato a tornare. I ricordi urlano nella mente, facendosi grancassa nell’anima, ma niente più mi lega a questi luoghi. Salgo sulla bicicletta e mi avvio per la discesa, svolto a sinistra sulla strada per Empoli. Dopo la curva, ecco il camposanto. Un piccolo cimitero di campagna in penoso abbandono. Il cancello cigola lugubre, tra due cipressi. Cammino tra lapidi sbilenche. Leggo nomi antichi, osservo volti di contadini, gli occhi dallo sguardo serio, di donne dai sorrisi timidi. Vite povere e concrete, consumate nella fatica. I loro occhi mi seguono mentre mi sposto tra le tombe. Si domandano se li ho riconosciuti? Il bisbigliare del vento, echi del passato e di lontani legami. Sto per andarmene. In un angolo vedo una croce striata di ruggine: Licia. Un sospiro affannato, l’aria mi strozza la gola, le lacrime pungono negli occhi. La data: 21 marzo 1960. Mi guarda dritta negli occhi. L’ho ritrovata. Il tempo pare pietrificarsi, fermo in un attimo gravido di attesa. Le tessere del mosaico trovano improvvisamente una loro giusta collocazione. Pulisco col fazzoletto l’immagine, ma sento sotto le dita la sua pelle diafana. Percepisco il profumo di violetta. Negli occhi limpidi il riflesso di un’anima sincera, lacerata dalla colpa. Figlia ripudiata e donna perduta. La voglia di cercarsi femmina, esplorando un amore scandaloso. “Allora non sei mai andata via?” Lei mi guarda, sembra annuire. Sospiro. È passato tanto tempo, ma i sentimenti sono ancora lì, forti, fieri. Anche quella lontana bambina è ancora lì. “Ti ho rinchiusa tra le pareti oppressive della memoria, poi ho finto di dimenticare.” Verità e amicizia sono la stessa cosa. Ma in quell’estate di sogni, non ero in grado di capire la verità e lei non trovò le parole giuste per raccontarmela. “Non ti ho mai giudicata, ti ho solo rimpianta, sempre.” È sempre stata in un luogo sedimentato dentro di me, dove nessuno poteva ferirla, deriderla, sdegnarla. L’ultima carezza sulla foto, un contatto che sa di presente, perché la morte rende invisibili ma non assenti. I ricordi si integrano in un cerchio perfetto. La bambina sognatrice che ero e la donna disillusa che sono conoscono l’ultima verità. Il viaggio in un mondo lontano, ma quasi dietro l’angolo, è concluso. 19 Cecilia Spaziani Mannheim, 5 Agosto 1888 Sono preoccupato per questo viaggio. Non sarà un viaggio ordinario, perciò ho deciso che appunterò su questi fogli tutto quel che ci capita. Mi chiamo Richard e ho 13 anni, mio fratello maggiore si chiama Eugene e ha 15 anni. È appena giorno e io, la mamma e Eugene stiamo per partire a bordo dell’ultima invenzione del babbo. Lui non vuole che la si tocchi e in famiglia chiamiamo questo aggeggio Diletta, proprio perché di tutte le sue creature è quella a cui tiene di più. Il babbo sta ancora dormendo e si sveglierà solo tra un paio d’ore, quando saremo troppo lontani perché possa raggiungerci. Meno male che è così abitudinario! Diletta è molto leggera, sicché l’abbiamo fatta scivolare fuori dal laboratorio pian pianino e poi l’abbiamo spinta lontano da casa per essere sicuri di non svegliare il babbo avviandola, perché è assai rumorosa. Questo è il primo viaggio per Diletta, e siamo tutti molto emozionati. La mamma è alla guida con le mani sulla leva centrale e io sono seduto al mio posto, davanti. Il mio sedile è come quello della cassetta del cocchiere, solo montato alla rovescia, sicché do la schiena alla strada. La cosa non mi piace molto, ma questo posto tocca a me perché sono il più piccolo. Eugene sta girando il volano orizzontale con foga, ma Diletta, non ne vuol sapere di avviarsi, quindi posso seguitare a scrivere. Devo chiarire che se stiamo per fare questo viaggio è anche per colpa mia. Quando è finita la scuola, la mamma mi ha chiesto cosa desiderassi come premio per i miei bei voti e io le ho risposto che mi sarebbe piaciuto fare un giro sulla nuova invenzione del babbo. Iersera la mamma è entrata in camera mia e mi ha detto con un grande sorriso: “Richard caro, domani andremo dalla nonna e tu piloterai Diletta come ti avevo promesso.” “Ma la nonna abita a Pforzheim, sono più di 100 chilometri da qui,” ho obiettato. “Shhhh abbassa la voce!” la mamma si è portata l’indice alle labbra. “Per questo partiremo all’alba e andremo solo io, te e Eugene, senza il babbo. Lui non ci lascerebbe mai usare Diletta.” Aveva due occhi luminosi che parevano stelle. “Vedrai sarà una meravigliosa avventura!” Fare le cose segretamente mi mette a disagio, ma è vero: il babbo non ci darebbe mai il permesso di partire. E poi ieri l’altro ho sentito una brutta discussione tra lui e la mamma. C’era ancora un’ora prima di andare a desinare, e stavano lavorando insieme al motore di Diletta. Io giocavo sul piazzale davanti al laboratorio con Silber, il nostro cane. Ad un tratto ho udito il babbo gridare: “Lo vuoi capire che non è pronta? Ci vuole ancora moltissimo lavoro perché possa fare un piccolo giro per le strade di Mannheim.” “La tua creatura è pronta, sei tu che non sei pronto a lasciarla andare! Può fare molto più di uno stupido percorso di pochi metri!” 20 “Guai a te se provi a mettere ancora le mani sul motore! Esci dalla mia officina e deciditi a fare quello che fanno tutte le altre donne, una buona volta!” La mamma è uscita di gran passo, aveva il viso arrossato e sporco di fumo, i suoi occhi erano lucidi. “Stupido perfezionista inconcludente, ha solo paura di fallire!” ha detto a bassa voce, mentre si asciugava le lacrime con il dorso della mano. Aveva le dita nere di grasso e gli abiti da lavoro unti, e dalla tasca della gonna spuntava una chiave a cricchetto. Sinceramente non credo che la mamma riuscirà mai a restare lontana dal laboratorio. Ama troppo gli ingranaggi, i bulloni e il vapore. Anche il babbo dice che ha un vero talento e che, se fosse stata un uomo, all’università sarebbe stata tra gli studenti più brillanti. Però è una donna e deve accontentarsi di lavorare accanto a lui in laboratorio, e deve stare alle sue regole. Questo la mamma lo sa bene, ma temo che sia ancora in collera e che abbia deciso di fuggire di casa rubando Diletta. Certo non spariremo nel nulla, abbiamo anche lasciato un biglietto: “Andiamo a trovare la nonna”. Penso che il babbo si aspetti che la mamma vada a sbollire la rabbia dalla nonna, ma non riesco a immaginare la faccia che farà quando si accorgerà che non siamo andati in treno. Chissà se ci permetterà mai di rimettere piede in questa casa. Ecco! Eugene è riuscito ad avviare il motore, si parte! Mi sento un gran rimescolìo nel sangue... Il mio animo presagisce una grossa avventura. Quasi a Wiesloch (percorsi circa 30 chilometri) Siamo fermi per rifornire di acqua il serbatoio di Diletta. Il motore si raffredda usando l’evaporazione dell’acqua, sicché siamo costretti a fermarci spesso. Per fortuna abbiamo incontrato molti ruscelli lungo la strada. Stavolta, però, io e Eugene abbiamo preso l’acqua dal pozzo di questo villaggio. La mamma intanto controlla che tutto sia a posto, e tra pochi minuti ripartiremo. Confesso che durante queste soste mi mancano un po’ i cavalli. È sempre bello accarezzarli e incoraggiarli quando ci si ferma per farli riposare. Ne approfitterò per scrivere del nostro viaggio. Presagivo una grande avventura e per la verità, la mia aspettazione non è stata punto delusa. Dopo un paio di bivi la mamma ci ha detto: “Non credo di sapere bene la strada, percorreremo le vie che conosciamo anche se il viaggio così sarà più lungo. Andremo verso Weinheim e poi a Wiesloch, e speriamo che il carburante ci basti.” Dopo un po’ di strada, Diletta ha preso bene il via. Si camminava che era una bellezza, e la mamma mi ha anche permesso di pilotarla. Su nessuna carrozza mi sono mai divertito tanto. Diletta ha solo tre ruote, ma è stabile e sulla strada buona può andare anche più veloce di una carrozza. E poi era da morir dal ridere vedere tutta la gente sgambettar di qua e di là per scansarsi, guardandoci spaventata quando passavamo con il nostro veicolo strambo e puzzolente. Anche se mi diverto, ammetto che sono sopraffatto dal pensiero del resto del viaggio. Come andrà? Langenbrücken (percorsi circa 40 chilometri) Ho fretta d’andare a pranzo, ma prima voglio raccontar qui come sono andate le cose. Nonostante tutto andasse per il meglio, la mamma perdeva man mano il suo buon umore 21 e si accigliava sempre più. Era divenuta piuttosto impaziente, e quando siamo arrivati a Wiesloch era tesissima. “Non pensavo che Diletta consumasse così tanto carburante,” ha detto. “Dobbiamo assolutamente trovare una farmacia.” “Vuoi comprare la ligroina in farmacia?” Eugene era incredulo. “Non ne avranno che poche bottigliette.” “Lo so. E siccome è usata come liquido smacchiante, costerà pure un mucchio di quattrini, ma non abbiamo scelta.” Così abbiamo trovato la farmacia. Mi viene ancora da ridere se penso alla smorfia che ha fatto il farmacista quando Diletta si è fermata davanti al suo negozio. Abbiamo comprato tutta la scorta che aveva, che però era solo mezzo gallone. E pensare che il nostro serbatoio conterrebbe ben 4 galloni e mezzo! Quando siamo ripartiti, Diletta ha fatto putupum! due o tre volte, e via di gran carriera. E la gente intorno a scappare e gridare spaventata. “Tutta colpa dei giornali! ” ha sbuffato la mamma. “A forza di insistere che le carrozze a motore sono inaffidabili e pericolose, hanno convinto persino vostro padre. Ma dopo questo viaggio cambieranno idea, vedrete!” Ora siamo a Langenbrücken per mangiare qualcosa, e ho proprio voglia di una fetta di torta di ciliegie. Abbiamo anche comprato altra ligroina ma anche qui la farmacia non ne ha che poche bottigliette, ci toccherà fermarci ancora a Bruchsal. Comincio a sentire un po’ di stanchezza, ma per fortuna dalla locanda arriva un odorino di stracotto che mi rallegra un po’ lo spirito. Bruchsal (percorsi circa 50chilometri) Eccoci a Bruchsal, e non solo per la ligroina. Stavolta ci è successo un affare serio. Poco dopo aver lasciato Langenbrücken con la pancia piena, abbiamo cominciato a sentire un brutto rumore di ferraglia. Ci siamo fermati e la mamma ha controllato Diletta. Confesso che quello è stato un brutto momento per me. Già ci vedevo alla ricerca affannosa di un telegrafo per chiedere al babbo di venirci a salvare, ma la mamma ci ha detto: “Ecco cos’è successo! Avrei dovuto pensarci subito.” Che genio che è la mamma! Prevede tutto e sa sempre rispondere a tutto. “D’ora in avanti Diletta deve procedere lentamente evitando le buche. Dobbiamo trovare un fabbro alla svelta.” Abbiamo puntato verso Bruchsal. Quando siamo arrivati nella cittadina, era l’ora del passeggio ed era un bel colpo d’occhio il vedere tutte quelle persone che formicolavano nei viali. Come avevamo stabilito, siamo andati difilato dal fabbro che ha riparato una catena che si era allentata e non afferrava più con precisione i denti degli ingranaggi. Nel frattempo Eugene è andato a cercare altra ligroina e stavolta ne ha trovati ben quattro galloni. Stavamo per ripartire quando un uomo vestito di tutto punto ci si è piantato dinanzi con atteggiamento minaccioso. “Invero, signora, trovo che un sì stravagante veicolo non si addica a una donna,” ci ha detto. “Mi sentirei molto più sicuro a guidare dei cavalli che a usare quella leva che avete davanti ai vostri piedi. I cavalli, poi si sa, sono bestie nobili.” La mamma lo ha guardato dritto negli occhi e ha risposto arditamente: 22 “Vedo, signore, che avete un debole per i cavalli come l’imperatore, ma vi ricrederete.” Poi gli ha sorriso e ha aggiunto: “Niente è più adatto a una donna di questa carrozza a motore. È molto semplice pilotarla, basta saper girare il manubrio e stare attenti alle voltate. Anche un ragazzo la sa manovrare.” Allora lui ha cominciato a rivolgerle delle interrogazioni su dove fosse l’inventore del buffo veicolo, e la mamma ha creduto bene che quello fosse il momento buono per congedarsi e gli ha detto che doveva inviare un telegramma. Non mi aspettavo che la mamma avrebbe mandato nostre notizie al babbo. Lei dice di avergli scritto che il viaggio sta procedendo bene, ma io temo che invece gli abbia mandato un telegramma scritto col pepe e col sale. E ancora una volta non riesco a immaginare la reazione che avrà il babbo quando leggerà il dispaccio. Di certo questo viaggio non era quello che aveva in mente quando le ha ordinato di stare alla larga dal laboratorio. Dintorni di Durlach (percorsi circa 70 chilometri) Finalmente ci siamo fermati! Stavolta ce la siamo vista brutta. Eugene è bianco come un cencio lavato, io tremo tutto e a stento riesco a scrivere. Anche la mamma è bianca da far paura. Sta seduta su un masso con la testa tra le mani e continua a ripetere: “Ragazzi perdonatemi… Sono una pessima madre… Vi ho messo seriamente in pericolo... Perdonatemi!” Dio mio, che spavento! Passato Durlach, abbiamo abbandonato la Valle del Reno e siamo partiti alla volta delle colline. Ogni volta che c’è una salita troppo ripida, scendiamo tutti e tre e spingiamo Diletta fino in cima, perché il suo motore a due cavalli e mezzo non ce la fa ad affrontare grandi pendenze. E poi via a precipizio giù per la strada! Diletta si slancia piacevolmente attraverso la campagna, ripagandoci dell’enorme fatica. Ma in quest’ultima discesa le cose sono andate diversamente. Abbiamo cominciato a scendere, e la mamma teneva stretta come sempre la leva laterale che rallenta le due ruote posteriori. A un tratto ha capito che non riusciva più a regolare Diletta in nessuna maniera – né a frenarla, né a fermarla. “Ragazzi, reggetevi forte!” ci ha gridato. Stringeva saldamente la leva del freno con una mano e con l’altra tentava di guidare. Siamo arrivati alla fine della discesa lanciati come una palla di schioppo, e via per la campagna con una velocità vertiginosa, tanto che non riuscivo a respirare. Solamente a ripensarci, mi sento rizzare i capelli sulla testa. Fortunatamente la strada era larga e diritta, e io vedevo come in sogno sfuggirmi dinanzi agli occhi gli alberi e i campi intorno. Ricordo benissimo che un contadino che badava ai buoi, vedendoci passare come una saetta, ha urlato: “Sangue d’un drago! Questa è opera di Satana!” Per fortuna a un certo punto abbiamo visto sorgere dinanzi a noi un’enorme collina, e lungo la salita Diletta ha rallentato fino a fermarsi. Ora la mamma sta esaminando il meccanismo dei freni. Ha lo sguardo acceso e sembra aver ritrovato la determinazione di sempre. 23 “Ho promesso che vi porterò dalla nonna, e ci arriveremo!” Si asciuga la fronte imperlata di sudore. “Il problema è che le ganasce dei freni si consumano in fretta,” dice. “Da ora in avanti bisogna adoperare una grande prudenza.” Confesso che l’idea di spingere Diletta fin su e poi di percorrere un’altra discesa mi mette la tremarella. Ma non lo dirò alla mamma. Aperta campagna È proprio vero! Le disgrazie arrivano a due a due come le ciliegie! Dopo l’enorme spavento per via dei freni consumati, a un tratto il motore si è spento senza motivo. Stavolta la mamma non si è scoraggiata, ma proprio non riusciva a trovare il bandolo dell’arruffata matassa. Con il viso sporco che pareva uno spazzacamino, ha studiato per un pezzo la natura dello strano rumore all’avviamento del motore. Alla fine si è convinta che doveva essere colpa del tubo del carburatore. Ha controllato un paio di volte gli attrezzi da meccanico e ha sbuffato: “Ho la soluzione, ma mi ci vorrebbe un ferro appuntito per metterla in esecuzione e noi non l’abbiamo!” Ha riflettuto ancora un attimo e poi, con un gesto disinvolto, ha sfilato dal suo cappello alla moda uno spillone assai pregiato e lo ha usato per pulire il tubo del carburatore che si era otturato. Che ingegno ha la mamma! E io che ho sempre creduto che i gingilli preziosi delle donne fossero inutili! Dintorni di Wilferdingen (percorsi circa 90 chilometri) Siamo sfiniti! Ho perso il conto di quante salite abbiamo affrontato. Anche Diletta non ce la fa più e non vuole più accendersi. E pensare che siamo sulla cima dell’ultima collina, e finalmente dopo ci aspetta la pianura. Quando abbiamo fatto la sosta per rifornire di acqua il sistema di raffreddamento, la mamma ha deciso di chiedere aiuto per spingere Diletta su per questa salita. È impossibile descrivere la contentezza prodotta in me e Eugene da una sì grata e inaspettata notizia. Ha trovato due giovanotti molto robusti dalle braccia forti, però che facce spaurite avevano! Temevano che Diletta esplodesse, e non volevano nemmeno toccarla, figurarsi spingerla su. Alla fine Eugene è riuscito a convincerli. Per fortuna siamo quasi alla fine del viaggio. Anche se d’ora in avanti non ci sarà più da spingere, sono angustiato all’idea di stare ancora a sedere per via di tutte le buche che hanno martoriato la mia povera schiena. Ma oltre al dolore c’è anche la preoccupazione per il fatto che il motore proprio non si avvia. Ecco finalmente si è riacceso! Allora si va, ma io non son punto tranquillo, perché da che abbiamo iniziato il viaggio non aveva mai fatto tante bizze per avviarsi. Che Dio ce la mandi buona e senza vento! Aperta campagna Siamo di nuovo fermi, tanto per cambiare! Stavolta, quando ha messo mano al motore, la mamma aveva il viso segnato da rughe di stanchezza. 24 Per quanto ragionasse e manipolasse i vari pezzi, non riusciva proprio a capire. Si è seduta a riflettere e a riconsiderare ad alta voce tutti i componenti di Diletta. È stato in quel momento che l’animo della mamma è stato vinto da quella cupa disperazione che in certe avventure provano anche gli eroi più coraggiosi, come Parsifal, Ulisse e tanti altri. “Aveva ragione vostro padre. Diletta non era pronta per un viaggio così lungo. Sono una stupida testarda!” Aveva il viso infocato e le tremava la voce. “Ho sempre pensato che è giusto che chi ha più cuore e più coraggio si sacrifichi per il bene comune, ma sono stata sconsiderata e ho messo in pericolo anche le vostre vite!” A sentirla parlare così mi si stringeva il cuore. “Come vorrei che vostro padre fosse qui!” “Per carità, mamma! Chissà quante ce ne direbbe se fosse qui!” ha detto Eugene alzando gli occhi al cielo. “Sai come si lamenterebbe?” ho aggiunto io. “Già...si lamenterebbe...” ha detto la mamma pensierosa. “E di cosa si lamenterebbe?” Tutto a un tratto è tornata in sé ed è andata al motore con fare deciso. “Maledizione, ecco cos’è! Il materiale di isolamento del cavo di accensione si è completamente eroso in un punto. Vostro padre si lamenta sempre di questo materiale isolante!” Credo che allora l’idea che le è venuta quasi l’abbia spaventata per la sua arditezza, ma era l’unica che in quel frangente avesse la virtù di farci riprendere il viaggio. Si è infilata le mani ancora sporche di olio sotto la gonna e ha tirato via la giarrettiera dalla coscia. Poi con quella ha isolato il cavo. E ha funzionato! Ecco che si riparte, e stavolta dalla nonna ci si arriva per davvero! Pforzheim, 5 Agosto 1888 (percorsi circa 120chilometri) Siamo giunti dalla nonna all’imbrunire. La mamma ha telegrafato al babbo che siamo arrivati sani e salvi, e che faremo ritorno tra qualche giorno. Anche io credo che sarà bene riposarci e studiare attentamente la strada prima di ripartire. E poi sulla via del ritorno ci toccherà sostituire la pelle sul ceppo del freno. Ecco il messaggio che il babbo ci ha telegrafato in risposta: “Mia Bertha, torna presto. Dobbiamo preparare Diletta per la Mostra che si terrà a Monaco di Baviera, voglio mostrarla al mondo intero. Tu e i ragazzi mi mancate infinitamente. Tuo Karl Benz” Un po’ deluso ho detto: “Sta a vedere che sarà il babbo a prendersi tutti gli applausi.” “Vergognati!” ha detto la mamma, ma l’ha detto ridendo. Poi ha aggiunto: “Cosa importa se il mondo ignora chi ha avuto il coraggio di fare per primo un viaggio in automobile? Abbiamo fatto qualcosa che cambierà per sempre la storia dei trasporti… ed è stato anche infinitamente divertente.” 25 Dalì Antonia Ciampa Scendendo dall’auto, ringraziai il tassista e gli chiesi di aspettare. Scrutai i numeri civici delle abitazioni dall’altro lato della strada fino a quando non trovai il ventisette alla mia destra, accanto a un piccolo cancello rosso. Feci un respiro profondo e mi avvicinai. La casa era una villetta molto graziosa: aveva un giardino con uno stretto vialetto che conduceva a un portone marrone scuro. I piani erano due: sopra c’era un lungo balcone con molte piante e sotto due finestre. Mi ricordava in modo assurdo le classiche case dei film e contemporaneamente la sentivo mia, ma molto probabilmente solo perché sapevo. Forse camminando in quella strada come una passante qualunque avrei solo pensato che fosse una casa davvero carina, o addirittura non l’avrei neanche notata. Sulla porta c’era una parola in un elegante corsivo, probabilmente un nome, ma non il mio come sarebbe dovuto essere. Mi feci coraggio, presi la macchinetta fotografica e scattai qualche foto. Mi concentrai poi su ogni particolare, per ricordare alla perfezione la scena, e mi allontanai incerta, voltandomi ogni due passi. In taxi andai dal fotografo più vicino a stampare le foto, e poi chiesi di tornare. Sapevo che ci sarebbe voluta più di mezz’ora, nonostante il campo di Aida distasse pochi chilometri da Betlemme, perché avremmo incontrato vari check-point. Ovviamente, come all’andata, li avremmo superati velocemente grazie ai miei documenti americani. Più che altro avremmo superato le lunghe code di targhe verdi in attesa. Le targhe verdi, segnali inconfondibili che quasi urlavano: “Io sono palestinese.” Anch’io, ma il taxi e la macchina noleggiata all’aeroporto di Gerusalemme avevano la targa gialla come gli Israeliani e come gli stranieri – e, come questi, avevo il passaporto rosso. Ai posti di blocco mi avevano perfino chiesto “Come va? Ah, Americana?” Io non mi sentivo americana, o straniera. Per la prima volta mi sentivo completamente a casa, in patria: due parole che per me erano sempre state un po’ un tabù. Nonostante non conoscessi quelle strade e quei paesaggi, appena arrivata, avevo sentito la stessa sensazione che si prova tornando a casa dopo una brutta giornata, avevo quasi sentito l’abbraccio consolatorio di una madre. E avevo pensato a mia nonna. Mia nonna materna aveva il mio stesso nome, Mariam, e viveva lì, in Palestina. Non se n’era mai andata. Non era venuta con noi quando, dopo la mia nascita, i miei genitori Nadi e Khadija avevano deciso che restare era diventato troppo pericoloso e mi avevano portata in California. Ora eravamo tornati per starle vicino nella sua malattia. L’ultima volta che l’avevo vista avevo dieci anni: ne erano passati tredici. Poche ore prima eravamo atterrati all’aeroporto di Gerusalemme e l’avevamo raggiunta a casa sua, nel campo profughi di Aida, fuori Betlemme. In realtà lei non riusciva ancora a chiamarla casa, così come accadeva a me con l’America. Appena arrivati, c’erano stati inizialmente alcuni minuti di abbracci, racconti, lacrime e sorrisi, ma dopo poco la nonna mi aveva messo in mano un indirizzo e mi aveva chiesto di scattare una foto per lei. Inizialmente non avevo capito. Ero appena arrivata, e già mi mandava a fare qualche assurda Commissione… Ma quella era casa nostra, era casa sua, prima che la mandassero via senza ragione. Schiacciai il naso contro il vetro, osservando il meccanico sfrecciare del paesaggio fuori dal finestrino: metri e metri di cemento grigio si susseguivano davanti al mio sguardo da ormai dieci minuti. Era la terza volta che mi trovavo costretta a guardarlo, e già credevo di averne abbastanza: il muro della vergogna, tanto alto da far girare la testa e bloccare lo stomaco. 26 L’ennesimo check-point comparve poco dopo: oltre questo si trovava il campo. Ingiustamente sorpassammo di nuovo le altre auto, che mi sforzai di non guardare chiudendo gli occhi. Li riaprii solo quando l’auto si fermò. Ringraziai, pagai e mi diressi verso l’enorme arco che segnava l’ingresso ad Aida: nonostante le dimensioni, passava inosservato in confronto alla chiave, altrettanto grande, che vi era adagiata sopra in orizzontale. Passando pensai alle parole di mio padre quando eravamo arrivati: “Aida vuol dire ritorno.” Entrai e raggiunsi la casa di mia nonna in una delle tante stradine. La porta era aperta, così entrai. La stanza era semi illuminata dalla luce che entrava dalla tapparella socchiusa sulla sinistra. In fondo alla stanza si trovava il letto. Mi avvicinai alla finestra, pensando che la nonna dormisse. Sullo sfondo, oltre le case si stagliava imponente il muro. Era assurdo come quella barriera riuscisse a comparire da qualunque punto si guardasse, opprimente e spaventosa, prima del cielo. La recinzione di una prigione all’aperto. A quei pensieri sospirai e subito sentii un sussurro alle mie spalle: “Mariam, sei tornata!” Mi voltai e scorsi il volto di mia nonna emergere dalle coperte. Mi avvicinai lentamente e sedetti su una poltrona accanto a lei. Mi fissava con uno sguardo di sollievo e felicità nei suoi occhi scuri, quasi neri, come i miei. Il suo volto era coperto da innumerevoli rughe, che contemporaneamente l’addolcivano e le conferivano saggezza. I suoi capelli, bianchi e lisci, un tempo erano stati scuri come i suoi occhi, diversi dai miei folti ricci castano chiaro. Tra quelle coperte sembrava eccessivamente piccola e debole. Le sorrisi ma non dissi niente, non sapendo come sarebbe stata la mia voce. Mi limitai a porgerle le foto. Lei si sporse ad accendere la luce e poi si concentrò sulle immagini. Dopo poco scorsi una lacrima rigarle il viso e distolsi lo sguardo, anche se già piangevo anch’io. “Qui, sulla destra del giardino, prima c’era un bellissimo melo. L’aveva piantato mio padre, il tuo bisnonno, e passavo ogni pomeriggio sotto i suoi rami a giocare o a leggere. Sulla porta invece avevo inciso il mio nome con un legnetto. Mia madre si arrabbiò così tanto!” Sorrise nostalgica a quei ricordi, e continuò a guardare attentamente le foto. Io mi mordevo con forza il labbro inferiore per trattenere le lacrime. Anche lei aveva la voce rotta dall’emozione e parlava molto piano. “Non ci sono più tornata. Con il mio visto potevo uscire solo per lavorare e avevo troppa paura dei ricordi che avrei risvegliato: di quelli belli, ma soprattutto di quelli brutti. Cerco di non pensare mai a quegli ultimi giorni: Betlemme sotto assedio e noi che vivevamo con l’angoscia di vederli entrare da un momento all’altro. E così fu, ma pensavamo di tornare presto: non mi fermai neanche a pensare a tutto quello che lasciavo, alla casa, al melo…” Non sapevo cosa dire, ma volevo sentirla raccontare ancora: “Cosa hai fatto per tutto questo tempo? Perché non sei venuta con noi?” Sorrise amaramente. “Perché il mio posto era qui. Non sono mai riuscita ad immaginare di andare via, neanche per un breve viaggio. Ma a dire la verità, restando ho affrontato il viaggio più grande e soprattutto il più difficile: perché non c’è una meta e non c’è mai stata. Non è il luogo d’arrivo il nostro obiettivo, ma il luogo di partenza. In fondo che cos’è un viaggio? È la destinazione o il percorso? È stata la strada che mi sono lasciata alle spalle, e non il luogo in cui sono arrivata finora, a rendermi la persona che sono, ad insegnarmi il segreto dell’attesa. Anche se, voltandomi, i metri percorsi sono pochi, so che devo usare un’altra misura: il tempo. Il luogo in cui ero sessant’anni fa è lontano anni luce da questo campo, anche se ci separano pochi chilometri. Questa è una delle tante cose che ho imparato: alcuni viaggi si misurano in base alla loro durata. Sai, ci pensavo proprio questa mattina: sto viaggiando da 64 anni 7 mesi e 12 giorni.” Fece una pausa, come a riprendere fiato, e rivolse di nuovo lo sguardo alle foto. Da ogni sua parola traspariva un grande dolore. Sentendola avevo automaticamente ripensato al tragitto in auto verso il campo, prima dall’aeroporto, e poi dalla vecchia casa: ogni piccola distanza che c’era da percorrere in quel luogo veniva dilatata fino a diventare un viaggio lunghissimo. 27 Il tempo e le lunghezze sembravano deformate da quell’angoscia nell’aria, schiacciate da quel muro troppo imponente. La nonna continuò: “Un tempo tutti erano più abituati a questi viaggi dell’anima, ora non più: si vuole tutto e subito, e non si è capaci di aspettare e desiderare. La modernità e la velocità continuano ad assecondarci. Con le nuove tecnologie è tutto più comodo: possiamo attraversare il mondo in poche ore, scrivere e ricevere notizie istantaneamente, vedere persone dall’altra parte del globo. Ma le nostre emozioni si arricchiscono come il nostro mondo materiale? La velocità non si sta prendendo qualcosa in cambio? Aspettare da così tanto tempo non mi rende felice, ma so che è necessario e ormai mi sono adattata, perché da queste parti sembra funzionare tutto al contrario e l’attesa invade sempre più prepotentemente le nostre vite. Non prendiamo l’aereo, ma aspettiamo mesi che chi può venga da noi. Non abbiamo il computer e la nostra posta è controllata e limitata. Per rivederti ho dovuto aspettare dieci anni, per uscire ogni mattina aspettavo ore, e dopo più di sessant’anni sto ancora aspettando di tornare a casa – o almeno di poter avere qualcosa da chiamare casa, patria a tutti gli effetti. Siamo diventati un popolo nomade, sia letteralmente sia in senso figurato: non abbiamo una casa, e intraprendiamo continui viaggi senza un arrivo.” Si piegò sul comodino e aprì il primo cassetto, cercò un po’ e poi ne estrasse un foglio e qualcosa che sembrava un mazzo di chiavi. “Quando andammo via, tutti noi pensavamo di tornare presto. Non avremmo mai immaginato tutto ciò che poi è successo. Eppure quel giorno nelle borse che avevamo pronte per le emergenze, mettemmo anche i documenti di proprietà della casa, come se in fondo sapessimo qualcosa.” Mi porse il foglio e notai che la sua mano tremava leggermente. “Li ho tenuti, insieme alle chiavi. Come faremo altrimenti a dimostrare che è nostra, quando ci faranno tornare? Come faremo ad entrare?” L’ultima parola fu spezzata da un violento singhiozzo. Mi chinai su di lei e la abbracciai, ma continuò a parlare: “Conserva tutto con cura, io non ce la faccio più. Sono stanca, ma non mi sto arrendendo.” Lo diceva come se si scusasse. “Accetterai questo viaggio al posto mio, Mariam?” Annuii freneticamente, continuando ad abbracciarla. Restammo così per alcuni minuti, tanto che credetti si fosse addormentata. Poi però sussurrò: “Purtroppo è tutto ciò che ho da lasciarti…” La strinsi più forte, fino a quando non sentii dei passi e i miei genitori varcarono la soglia. Si avvicinarono al letto con un’aria stranamente soddisfatta, quasi felice. “Mama, abbiamo una notizia bellissima!”. La nonna si mosse inquieta tra le lenzuola. “Eravamo al bar. L’hanno appena annunciato alla radio: da oggi la Palestina esiste. È entrata nell’ONU come Stato osservatore.” Sentii al mio fianco un suono strozzato, di pura gioia, e una stretta forte alla mano - e contemporaneamente avvertii una grande soddisfazione. Quasi nello stesso momento, però, vidi i miei genitori precipitarsi sconvolti accanto al letto. Mi voltai a guardare mia nonna: la sua testa era innaturalmente piegata in avanti sul collo. Sulle gambe aveva ancora le foto. Strinsi con forza la chiave che avevo in una mano, mentre con l’altra accarezzavo la ruvida pelle, incapace di fare altro. La nonna morì quello stesso giorno, dopo poche ore di coma. Sapevo però che aveva sentito le parole di mio padre. Aveva viaggiato tutta la vita, in ogni modo possibile, ma la sua attesa non era stata vana. E io avevo sentito bene le sue, di parole. E avevo accettato quel difficile viaggio che lei era quasi riuscita a compiere. Avevo accettato quello strano percorso che fisicamente non mi avrebbe portata da nessuna parte, ma che in realtà comportava cambiamenti più grandi di quelli dei voli più lunghi. Avrei appettato lì al suo posto, non m’importava quanto tempo. 28 Daniele Ardigò Così ti ho trovata, ieri, accoccolata nel silenzio d’una finestra, in quella stanza estranea e bianca con il tuo sguardo fisso nel vuoto infinito, ora come allora, gentile e fragile. Così ti ho ritrovata, all’alba, a consumarti lungo i cunicoli della mente come una viandante nella notte, che vaga tra nebbie d’assenza a cercare i pensieri, ad inseguire i gesti perduti. Così ti ho trovata, questa sera, seduta accanto alla tua solitudine, lontana, come rondine abbandonata dallo stormo, ed estranea a te stessa, come sonno che erra sui ghiacciai del nulla. Così verrò a svegliarti, anche domani, ti parlerò ancora di noi, dei nostri sentimenti, ti porterò una rosa dai giardini del mio cuore, ma la tua anima malata d’Alzheimer, nonna, si ricorderà del mio viaggio con te? 29 Annamaria Sacchi Quel che resta del mio viaggio con te è la calma. Sono uno specchio d’acqua senz’onde in cui si è immerso tutto il cielo, il tepore sulla pelle, sussurri nell’aria, un lento e armonico muoversi nel mondo. Al ritorno a casa resta il sangue liscio, lo sguardo troppo dolce, l’aria trasognata mentre vago sul tappeto di foglie. E ti penso. Quel che ho amato del viaggio con te è la sera. L’imbrunire nella valle tra i monti, a Tret, dove il fumo di legna si alza dai camini e ricade sugli orti, profumando l’aria di buono, di pulito, di brace, di antico bucato. Lì c’è la pace silenziosa che porta la notte e i focolari ardenti nelle case nere. Torna l’autunno languido e vivo, dai sensi caldi e calmi. Non è più tempo di viaggiare. Quando la vite dona i suoi grappoli e l’ulivo le sue bacche nere, vino e olio e conserve e caldarroste e marmellate ci rendono ricchi e soddisfatti e sicuri del futuro, allora matura il mio amore, prepara un nido di foglie rosse per l’inverno. Tra le nebbie abita il tabarro nero del nonno, la sua giacca di fustagno morbido e caldo e una grossa arancia per me nella tasca. L’ultimo viaggio è con te, è il nostro tempo breve e difficile, il tempo del nostro incontro nello spazio affollato delle nostre vite. Canto del cigno, dono inatteso, eppure è amore sorprendente e struggente e sarà così breve, così breve… 30 Maria Angela Pantani Sembra avvolta da ruvido cartone sgualcito, indefinibile il colore. A più giri legata con vigore da un consunto, arido cordone. Difficili quei nodi son da sciogliere che a ogni tentativo di effrazione si serrano più stretti a protezione. L’involucro che tu stai per dischiudere duro qual gretto cuoio era sembrato. Poi resti ad ammirarne il contenuto, che con orgoglio adesso ti ha mostrato, un po’ incantato e, per stupore, muto. I pensieri, i ricordi, una passione, fragili come bolle di sapone, brillanti come sfere di cristallo, se ne stanno riposti nell’imballo protetti da una nube d’emozione: di tanto tempo prima una canzone… scatoline a custodia di confetti… nido d’ape di certi camicini per rivestire rosei pargoletti dai ricci d’oro come cherubini… posta ingiallita da molto lontano con la firma incerta di un soldato in terra straniera deportato, ed aspettato troppi anni invano… nel bell’ abito grigio la sua sposa, i capelli ondulati, guance rosa… e poi…la cara mamma! il suo sorriso, la lunga sottana, il fiero petto, quell’odore di latte, il suo bel viso e l’immutato senso del rispetto… Frammenti di un’unica esistenza colma di innumerevoli emozioni, spesa tra sogni, gioie, delusioni; fanno dell’esser uomo una potenza dandogli onore, vita, tanta forza e infinita dolcezza oltre la scorza. 31 Carla De Falco ecco, mi siedo tra due lune: voglio osservare i sogni che tu insegui senza temere di perdermi nel sole o di sentire troppo gli aghi degli spini. evito i rovi, assaggio i pampini e seguo, seguo tuoi ricordi antichi fatti ora troppo lievi e vinti al crudo odore del vento d’inverno. piccola ed invisibile annego nella terra nera e dura ma poi saprò riemergere in una luce grande. così scorro, lenta e inesorabile scivolando via a fatica nella vita che porta sempre dentro nuovi tuffi. scorro. e vivo. nel dubbio, scrivo. scrivo parole d’acqua, a volte amare. ma non ho tempo per dolermi o stare. il mio solco è tutto nel passare e all’orizzonte già lo vedo: il mare 32 Erica De Zotti Un battito d’ali. Un giro di vento. sperduta nel buio di un respiro bramo ad ogni passo le luci sui pali ricerco la mia storia: un piccolo frammento. E mi dedico al ritorno. Non mi giro. Poi la vedo lontana nella mente... è la luce di casa, di mamma, l’odore di un soffice abbraccio. Un treno passato. Presente. Nel blu intenso s’accende una fiamma. Arrivata. Non c’è più bisogno di avere coraggio. 33 Federica Lancellotti Era una tiepida mattina di fine aprile del 1951, e a Jean quel venticello che gli accarezzava il viso sulla strada per la scuola aveva fatto passare la voglia di sentire la solita ramanzina del professor Godard che con voce monotona gli ricordava i doveri dello studente modello. Così, invece di fare il percorso quotidiano, imboccò a tutta velocità la prima via traversa e, rischiando di investire un malcapitato pedone, pedalò con tutta la forza che poteva, a testa bassa, ebbro di felicità. Ben presto si ritrovò in un quartiere che non conosceva: le case erano molto simili alla sua, ma particolarmente linde e curate. Anche i giardini avevano qualcosa fuori dall’ordinario: c’erano erba, fiori e piante, ma i loro colori, la disposizione nelle aiuole, la forma delle chiome erano così netti e definiti da sembrare dipinti. Inoltre, cosa ancor più strana, non emanavano alcun profumo. All’improvviso lo sguardo di Jean fu attirato da un piccolo edificio più scuro degli altri, in fondo alla via. Sopra la porta d’entrata pendeva un’insegna finemente decorata e scritta in caratteri dorati. Diceva “Bibliothèque des rêves”. Jean frenò bruscamente, mise in equilibrio la bicicletta accostando un pedale al marciapiede, prese la borsa dal portapacchi, ma quando stava per afferrare la maniglia di lucido ottone la porta si aprì di colpo, accompagnata da un piacevole concerto di campane tubolari. Dal fondo del locale una vocina squillante e familiare lo salutò con grande cortesia e lo invitò ad entrare. Jean diede una rapida occhiata intorno: le pareti della stanza erano completamente occupate da scaffalature di legno dai colori pastello, su cui erano disposti in file ordinate volumi di dimensioni differenti. Le copertine sgargianti, abbinate con grande attenzione agli accostamenti di colore, tradivano il criterio adottato dal bibliotecario che evidentemente non le aveva disposte per generi o per ordine alfabetico, ma aveva seguito un istinto puramente artistico. Uno solo dei libri pareva stonare in quel tripudio, un piccolo volume dal dorso un po’ sbiadito, che proprio per il suo contrasto attirò subito l’attenzione del ragazzo. Mentre allungava la mano per prenderlo, lo sguardo di Jean si posò sull’orologio da polso che segnava mezzogiorno passato. Doveva ritornare immediatamente a casa, la mamma si sarebbe preoccupata terribilmente se fosse arrivato in ritardo! Senza nemmeno leggere il titolo, si precipitò alla cassa, pagò, inforcò la bicicletta e in men che non si dica si ritrovò davanti al cancello di casa. Sul tavolo lo stava aspettando il solito pranzo precotto e riscaldato: da quando i genitori di Jean avevano deciso di separarsi, la mamma, che era una cuoca eccezionale, aveva perso qualsiasi interesse alla gastronomia. Jean ingurgitò di malavoglia la sbobba, alternandola a risposte vaghe sulla giornata trascorsa a scuola. Poi si rifugiò come sempre nella sua camera, l’unica stanza della casa che non veniva raggiunta dalle urla dei litigi sempre più frequenti dei suoi. Si buttò sul letto con la borsa ancora a tracolla, e con curiosità febbrile estrasse l’opuscolo che lo aveva incuriosito. La copertina era consumata, sembrava che fosse un libro di seconda mano: forse il suo acquisto non era stato molto oculato… “Vie écrite par lui-même”: il titolo assomigliava a quello di un’opera di Alfieri, un autore italiano che aveva appena studiato a scuola. L’interesse di Jean stava precipitando: quello scrittore era davvero noiosissimo. Tuttavia, prima di lanciarlo nel cesto delle cose da buttare lo sfogliò distrattamente e, cosa veramente molto strana, le pagine erano bianche! Sfogliava, sfogliava 34 ma niente, nemmeno una parola era stata stampata. Si stropicciò gli occhi per controllare la vista. Quella era a posto. Al primo stupore subentrò un senso di rabbia: era stato truffato, gli avevano venduto un quaderno al prezzo di un libro! Non poteva arrendersi all’idea di avere sprecato così la paghetta settimanale. Corse fuori di casa, prese la bici con la ferma intenzione di riportarlo indietro e di farsi restituire i soldi, ma dopo aver percorso vari chilometri fra vie e vicoli sconosciuti della città, dovette arrendersi: non riusciva a ritrovare quel negozio, né il quartiere così lindo e ordinato della mattina. Sconsolato, Jean tornò nel viale di casa dove, come temeva, lo attendevano alcuni suoi ex amici, che da qualche tempo lo avevano destinato ad essere la vittima preferita dei loro scherzi sadici e delle prese in giro più feroci. Si beccò qualche insulto e schivò per miracolo una sassata. Guadagnò la porta di casa e fu salvo. La sua vita da qualche mese aveva preso davvero una brutta piega: oltre ai litigi casalinghi e agli sberleffi dei coetanei, anche i voti erano un disastro. Jean si precipitò in camera, affondò la testa nel cuscino e si addormentò singhiozzando. Era ormai notte fonda quando fu svegliato dallo sbattere delle imposte: si era levato un forte vento, e un brutto temporale minacciava di scatenarsi da un momento all’altro. La mamma non lo aveva chiamato per la cena: forse aveva pensato che fosse meglio continuasse a riposare. Jean accese la luce della scrivania e vide che lo strano libercolo stava lì, aperto alla prima pagina: non ricordava di averlo lasciato in quel posto. Lo prese in mano e pensò che dopo tutto sarebbe stato più interessante scrivere una storia invece che leggerla. Quasi non fece in tempo a prendere in mano una penna che le parole cominciarono a scorrere sulla carta più veloci che mai, fuori controllo, come se una forza a cui non sapeva, o non voleva opporsi le stesse generando. Continuò a scrivere così, febbrilmente, per ore. Le uniche pause erano dedicate a tracciare degli schizzi che si trasformavano sotto i suoi occhi in bellissimi disegni dai colori smaglianti. Quando arrivò, esausto, all’ultima pagina, era l’alba. Di lì a poco la mamma lo avrebbe chiamato per far colazione, e poi un’altra grigia giornata a scuola lo stava attendendo. Ma c’era ancora qualche minuto… Jean sentiva le palpebre farsi sempre più pesanti. Appoggiò il capo sul libro ma ciò che successe non lo avrebbe potuto immaginare nemmeno nella più ardita delle sue fantasticherie: la voce della mamma lo stava chiamando non dal piano di sotto, ma dalla pagina su cui si era appoggiato! Con uno scatto fulmineo Jean alzò la testa, tese gli orecchi… ma fu ancor più esterrefatto quando si accorse che le figure dipinte sul libro non solo pronunciavano parole, ma si muovevano come se fossero state riprese in un film. Quella che più si agitava per attirare la sua attenzione assomigliava straordinariamente alla mamma… era la mamma! Vicino a lei c’era il papà: non sembrava lo stesso uomo dal volto triste e accigliato che ormai Jean era abituato a vedere. Aveva uno splendido sorriso, quello stesso che Jean ricordava di aver visto per l’ultima volta durante una vacanza a Nizza. Dopo quell’estate indimenticabile erano cominciati i bronci e le incomprensioni che avevano portato i suoi genitori sull’orlo del divorzio. Jean cominciò a sfogliare il libro e si accorse che le parole e le immagini raccontavano tutta la sua vita passata felice, e la narrazione si era fermata proprio quando avevano avuto inizio i dispiaceri. Prese di nuovo in mano la penna e cominciò a riscrivere la storia degli ultimi mesi, cancellando dalla memoria tutti i brutti ricordi, correggendo e aggiungendo particolari piacevoli e gioiosi. Era arrivato all’ultima pagina, al racconto di quella mattina di aprile in cui aveva deciso di marinare la scuola e di tuffarsi in un mondo sconosciuto, affascinante e colorato: il mondo della fantasia. Con un rapido schizzo tracciò la sua figurina che sfrecciava sulla bicicletta e in un baleno fu risucchiato in quel mondo meraviglioso. E lì per sempre restò. 35 Emma Pasetto Amo viaggiare! Amo ogni tipo di viaggio! Solo stando seduta in cucina posso viaggiare. Solo aprendo un libro posso immergermi in mondi sconosciuti. Anche solo studiando, riesco a gironzolare per l’universo. Così, in questi anni di scuola, ho potuto viaggiare per mondi metafisici, nell’Inferno di Dante, nell’infinito del pensiero di Leopardi, nell’immensità della luce di Ungaretti, ma anche in mondi reali: ho accompagnato Enayatollah Akbari nel suo viaggio, nella sua odissea dall’Afghanistan all’Italia attraverso un “ mare di coccodrilli”, provando le sue stesse emozioni, perché viaggiare è condividere esperienze. Ho viaggiato sullo stesso treno di Boris Pahor e al campo di concentramento dello Struthof in Alsazia, assieme ai miei compagni di classe, ho patito con lui lo strazio di quel luogo della memoria, ho raggiunto l’India per combattere la lotta non violenta di Gandhi e poi sono volata in America ad assistere al commovente discorso di Martin Luther King, perché viaggiare è condividere ideali. Studiando la storia, ho viaggiato nel tempo, ho scoperto l’America con Cristoforo Colombo, ho fatto il giro del mondo con Magellano, ho firmato, con i grandi personaggi della storia, i trattati di pace e la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, ho partecipato alle Rivoluzioni, conversato con Voltaire, cavalcato con i pellerossa, perché viaggiare è conoscere chi è lontano da noi. Finito di studiare, chiudo i libri e il mio viaggio ha termine. Torno alla realtà. È piuttosto facile, come prendere un aereo che mentre neanche te ne accorgi, decolla ed atterra, pronto a ripartire ogniqualvolta la curiosità del viaggiatore lo porta ad esplorare nuovi mondi. Più difficile è tornare da quei viaggi che aspetti da mesi – certi li sogni anche da anni. Quei viaggi Che, a lungo predisponi, non importa se la meta non è ancora quella che vorresti: ci sono tanti anni davanti per realizzarli! Quei viaggi che risultano sempre migliori delle aspettative, perché se è bello progettarli, realizzarli è ancora più soddisfacente. Quei viaggi da cui non vuoi tornare. Così è stata per me la gita in terza, con i miei compagni di classe. Quattro giorni in Alsazia, un viaggio a lungo desiderato, progettato, preparato, un viaggio che non avrei voluto terminasse mai. Ma poi, quando è stato il momento di tornare, mi sono resa conto che non ero troppo triste, perché è bello partire, ma anche avere un posto dove poter sempre fare ritorno, dove poter conservare i ricordi più importanti della tua vita, dove trovare persone che ti accolgono felici e che ti accettano sempre e comunque. Di questi posti, lo capisci meglio quando sei in viaggio, ne esiste uno solo in tutto l’universo. È l’unico posto che puoi chiamare “casa”. 36 Lorenzo Talassi 21 maggio 2013, ore 21 e 21 È sera, e come sempre sono qui in camera mia a giocare a KingsAge col PC anziché a ripassare le lezioni per domani, come credono i miei. Ho già costruito 25 villaggi e preparato gli eserciti e mi manca poco per attaccare la fortezza nemica….ma cosa succede? C’è uno strano messaggio che lampeggia sulla destra dello schermo. Sarà una delle solite pubblicità, o peggio un virus che tenta di rovinarmi la partita! Resisto, non clicco, non guardo neanche… Uffa, è ancora lì. Adesso ha anche cominciato a suonare un jingle che conosco… possibile? Ma sì, è “Back in black” degli ACDC, la mia canzone preferita! Che coincidenza! Resisto, resisto, resisto…no, non ce la faccio più, sono troppo curioso. Costi quel che costi, io clicco. Be’? Tutto qui? Tanta paura per niente! Colpa di tutte le prediche dei prof e di quella maledetta lezione della polizia postale: mi ha messo addosso una fifa terribile, sono davvero in paranoia! È apparsa a tutto schermo la scritta “Complimenti! Sei il 100000° utente del giorno 21 e ti sei connesso alle ore 21 e 21. Hai vinto un viaggio per tre persone in Brasile. Clicca su OK per scaricare il regolamento e il biglietto per Rio” Wow!!! Un viaggio in Sud America – cosa dico? Un super- megaviaggio in Brasile, a Rio de Janeiro, la città del carnevale, del Cristo Redentore, delle spiagge di Ipanema e Copacabana… Una terra fantastica, ricca di contrasti – il mio sogno a portata di mano, o meglio di dito! OK, cliccato! 8 giugno 2013 È finita la scuola!!! Domani parto! Come “per dove”? Ma sei rincitrullito, diario? Vado a Rio! As cidades do mundo come dicono i brasileiros. Bermuda? Ci sono! Crema solare? Presente! Occhiali a specchio? Assenti… ma dove sono finiti? Accidenti, parlo come le prof, devo fare al più presto una cura disintossicante… 10 giugno ore 9,05 Il viaggio è stato MASSACRANTE!!! 16 ORE DICO 16 ORE di volo… o la prof di geo, quando ci ha spiegato i fusi orari, ha saltato qualche meridiano, o il pilota ha fatto una rotta alternativa, o il pilota era fatto… ad un certo punto mi è parso di vedere la banchisa dell’Antartide! Non avrei mai pensato che un viaggio potesse superare nel noiosometro le lezioni di francese… Il letto non ha attutito la stanchezza, anzi, direi che ho la schiena a pezzi. Ma si sa, quando si cambia materasso non si dorme bene! C’erano anche di puntini neri sulle lenzuola, e si spostavano se cercavo di toccarli… Boh. 10 giugno ore 10 Una colazione degna delle migliori favelas! Ma dove mi hanno portato? I miei parents sono giù di testa, dicono di voler tornare subito all’aeroporto e prendere il primo volo per Milano. Esagerati! Cosa pensavano di trovare, un hotel a cinque stelle? Mio nonno dice sempre che “a caval donato non si guarda in bocca”. Forse, però, avrei fatto bene a dare una sbirciatina… 37 10 giugno ore 10.30 Finalmente in spiaggia! Guarda che mare, che sabbia, che gn… Fantastica! Occhi azzurri, capelli nerissimi e ricci, corpo da fata, un vero incanto. Vedo se riesco ad avere un incontro ravvicinato del terzo tipo con l’aliena… 11 giugno L’aliena non era quello che mi aspettavo, cmq è simpaticissimo: è il figlio dell’allenatore del Botafogo, e mi invitato stasera a vedere con lui la partita nel mitico stadio Maracanà… da paura!!! 12 giugno ore 5 Esperienza a dir poco ALLUCINANTE. Mio padre, quando ha saputo del meeting, ha tirato fuori così tante scuse che ce lo siamo dovuti sorbire per tutta la serata. Lui che odia il calcio, pur di non lasciarmi andare solo in una città che non conosco, si è improvvisato tifoso scatenato, al punto tale da scatenare la furia di un branco di ultras che lo ha scazzottato a sangue. Sono ancora qui al pronto soccorso in attesa che venga medicato. Alla mamma abbiamo detto di aver perso l’ultimo metrò. 13 giugno ore 13 Siamo all’ambasciata italiana di Rio. La mamma, quando ha saputo dell’accaduto, ha deciso di farsi /farci rimpatriare come rifugiati politici. Ho rubato delle salviette profumate dal bagno, spero di non essere beccato dall’Interpol. 14 giugno ore 21 e 21 Casa, dolce casa. Credo di aver imparato a non fare gesti avventati e sconsiderati con un dito. Mai fidarsi delle apparenze… Accidenti! Stanno attaccando il mio villaggio! Presto, devo inviare subito un esercito… aspetta! Cos’è che lampeggia sulla destra dello schermo…? 38 Vittoria Ambrosi Avete mai pensato a un viaggio lontano, dove per arrivare non serve un aeroplano, neanche una nave, neanche dei treni, dove per l’immaginazione non ci sono freni? Nel nostro mondo possiamo volare nel cielo infinito o toccare la luna con un solo dito, avremo l’occasione di realizzare i nostri desideri quelli più profondi e veri. Il nostro mondo immaginario è un’equazione di gran difficoltà che anche il più grande matematico risolvere non saprà. È il più difficile progetto che si possa inventare, più difficile che un ingegnere non possa immaginare. È un pianeta lontano che non potrà mai vedere l’astronomia, perché serve solamente un pizzico di fantasia. 39 Sara Gualtieri Non so, ma… inspiegabilmente mi trovai catapultata in un luogo bellissimo, fantastico, lontano, forse… in capo al mondo. Non cercai di capire se stavo sognando o se si era avverato il mio desiderio che in questo momento era diventato ancora più impellente. Viaggiare è sempre stato uno degli obbiettivi per il mio futuro, ma qualcosa di sinistro minava la mia serenità e la mia normale vita quotidiana, e trovarmi altrove in quel momento era la realizzazione anticipata del mio sogno. Decisi quindi di approfittare della situazione in cerca della pace perduta e del desiderio raggiunto. Ero nel cosiddetto “paradiso terrestre”. Mi abituai presto alla mia nuova vita. Stando all’ombra di una palma da cocco ammiravo incantata il mare cristallino e profumato di sale. I gabbiani volavano in alto nel cielo e i pesci guizzavano fuori dall’acqua con gioia e passione. La sabbia era candida, ma bollente sotto il sole . Su tutta la spiaggia i granchi alternavano il gioco del fuggi-fuggi con bagni ristoratori nel mare turchese. Mi gustavo questo fantastico paesaggio bevendo una limonata ghiacciata. Al tramonto mi recavo nella mia dimora: una capanna costruita con rami e foglie e arredata con oggetti abbandonati ritrovati in un rifugio distrutto. Avevo imparato anche ad accendere il fuoco. Utilizzavo gusci di noci di cocco come piatti e bicchieri. Nella mini-dispensa conservavo tantissimi vasi colmi dell’acqua che andavo a prendere in un ruscello. In cucina facevo colazione, pranzavo, cenavo. Dormivo su un giaciglio di frasche. Qualche volta, di notte, uscivo dalla capanna per avvistare le tartarughe che deponevano le uova annaspando nella sabbia. Poi, nel pomeriggio, mi arrampicavo su un albero, strappavo un ramo, legavo ad esso un filo con un’esca all’estremità e provavo a pescare. Ogni giorno mangiavo pesce, pesce e ancora pesce: pesce a colazione, pesce a pranzo e pesce a cena. Col passare del tempo iniziai ad annoiarmi, perché tutte le mie giornate trascorrevano sempre nello stesso modo. Sentivo la mancanza degli amici e dei cari. Le mie compagne erano la monotonia e la solitudine. La gioia di essere in quest’isola si era trasformata in tristezza. Cominciava a maturare in me il desiderio di ritornare a casa, ed ero decisa a riconquistare la tranquillità anche se il luogo in cui abitavo non era sicuramente il paradiso… Apro gli occhi e mi accorgo che tutto era frutto del mio proposito di trovarmi il più lontano possibile da quel terremoto che tanto mi spaventava. Quelle scosse mi terrorizzavano, suscitando un senso di smarrimento, sconforto e incredulità che un fenomeno naturale potesse provocare la distruzione del mio paese e l’inagibilità di molte abitazioni. Il tutto in pochi secondi che sembravano interminabili… Sui visi delle persone era disegnato il terrore. Ad ogni grande scossa si sentivano echeggiare nell’aria le sirene delle ambulanze che correvano a soccorrere chi si sentiva male, sfinito dal ripetersi continuo della situazione. Poi tutti insieme si è intrapreso un delicato cammino per superare il trauma e per riprendere la normale vita quotidiana. Con la famiglia mi sono lentamente rimpossessata della mia casa. Con gli amici trascorrevo gran parte della giornata fuori all’aperto, giocando, scherzando, alternando giornate in piscina o al campo estivo. Il nostro punto di forza era quello di non nominare la parola “terremoto”. Giorno dopo giorno ho imparato a convivere con rassegnazione anche con le crepe lasciate sugli edifici, come fossero un segno indelebile rimasto nella mia vita. Quindi non c’è posto in capo al mondo che valga di più degli affetti e del luogo in cui si è nati: la famiglia, la propria casa e gli amici sono insostituibili. Dietro l’angolo, vicino a casa, si trova sempre la forza di andare avanti con l’appoggio di amici e famigliari che permettono di trovare dentro l’anima il coraggio di affrontare qualsiasi situazione, bella o brutta che sia. 40 Fabio Pattarini “Do you speak English?”. Ecco, a questa domanda, io invariabilmente, rispondevo: “Of course.” Insomma, non sono certo un erudito o un poliglotta, ma almeno una lingua straniera, la più diffusa sul pianeta peraltro, la conosco. Tutto questo accadeva prima che io partissi per il mio primo viaggio negli Stati Uniti. Mi ero posto un obiettivo piuttosto ambizioso, quantomeno per le mie modeste capacità di viaggiatore dilettante: volo per New York con noleggio auto, qualche giorno a Manhattan e poi via, verso il grande Sud, terra di piantagioni di cotone e tabacco, blues e rock’n’roll, con itinerario ellissoidale che mi avrebbe infine riportato al John Fitzgerald Kennedy, per un mesto rientro a casa. Le prime avvisaglie che le cose non sarebbero state così semplici come pensavo le ebbi appena sbarcato. Ancora dentro al terminal, infatti, individuai una fila di telefoni contrassegnati dal logo delle diverse compagnie di autonoleggio. Individuai quella di mia competenza, sollevai la relativa cornetta e attesi che un operatore mi desse indicazioni su come raggiungere la mia auto. Dopo una decina di minuti senza cavare un ragno dal buco, l’operatore, esasperato, chiamò un collega all’apparecchio. Da quel momento in poi la conversazione proseguì con un tale di nome Nino, che parlava con spiccato accento campano, e con il quale rifeci in Italiano la conversazione che avevo tentato di sostenere fino a poco prima in Inglese. In sostanza lui mi disse di alzare lo sguardo e guardare di fronte a me, oltre la vetrata. Eseguii l’ordine e intravidi un tizio che mi faceva ampi cenni con la mano. In breve, gli uffici della compagnia erano proprio di fronte all’uscita. In effetti, non sembrava propriamente un’indicazione impossibile da comprendere in Inglese, ma decisi di non preoccuparmi per il momento: probabilmente ero stanco per il viaggio, e il telefono poi emanava un suono gracchiante che rendeva impossibile per chiunque comprendere le parole. Nei giorni seguenti non parlai pressoché con nessuno, se si eccettua un breve episodio in cui fui costretto a chiedere indicazioni per raggiungere il Dakota Building. Mi trovavo a Central Park e decisi di scandagliare accuratamente la variopinta popolazione presente. Finalmente individuai l’esemplare adatto: un’ottuagenaria dall’aria sveglia e simpatica che se ne stava tranquilla su una panchina a guardare il panorama. Mi avvicinai speranzoso e chiesi indicazioni. La vecchiaccia dapprima non capì niente. Poi, dopo aver ripetuto più volte le parole “Dakota Building”, accompagnate da gesti più o meno vaghi nell’aria, la nonnina sembrò cogliere il senso della mia presenza di fronte a lei e nel mondo. Spiegò quindi con poche brevi frasi dove dovevo andare – indicazioni che seguii pedissequamente. Bene: il Dakota Building non saprò mai com’è fatto, ma in compenso potei ammirare a lungo il Guggenheim Museum. Pensai non fosse comunque il caso di scoraggiarsi per così poco: probabilmente la vecchia era una povera scema, forse una ritardata – chissà cos’aveva capito. Poi andava pur messo in conto che portava la dentiera e aveva chiare difficoltà con la favella: era chiaro che neanche un Newyorchese di quarta generazione ci avrebbe capito niente. Tra l’altro, riflettevo con insolito ottimismo, non tutti i mali vengono per nuocere: al Guggenheim avrei comunque dovuto andarci. Esaurita la fase newyorchese, partii con l’auto a noleggio. Dall’Italia avevo prenotato 41 un’auto di classe medio piccola. Negli Stati Uniti scoprii che questo significava una Buick dotata di un motore a sei cilindri a “V” di 3.800 cc di cilindrata. A benzina. Del resto mi sarei presto abituato al nuovo senso delle proporzioni che gli Stati Uniti imponevano al visitatore europeo. Larghezza, lunghezza, altezza, peso, volume, temperatura: tutto andava collocato entro nuove categorie di riferimento. I marciapiedi erano larghi otto metri, una Coca media era circa un litro, per un cappuccino, invece, ne bastava mezzo. La temperatura nei locali, in piena estate, non doveva essere superiore ai dodici gradi (e immagino che, per compensazione, in inverno non dovesse essere inferiore ai trenta). Le distanze misurate in miglia, i rifornimenti dell’auto in galloni. Una passeggiata da Battery Park alla 68° strada, dove avevo l’hotel, che sulla cartina sembrava non solo fattibile ma un piacevole diversivo, richiese tutto il pomeriggio e mi ridusse in uno stato di semiparalisi temporanea che non mi consentì di alzarmi dal letto, quella sera, per uscire a cena. A parte questi piccoli disguidi, ad ogni modo, in auto andava tutto bene e se c’è una cosa semplice, ebbene, quella è proprio orientarsi sulle strade americane: le principali hanno un andamento tendenzialmente ortogonale, e sulla segnaletica sono anche indicati i punti cardinali. Se aggiungiamo che sull’auto c’era persino la bussola, perdersi era praticamente impossibile. Andava insomma proprio tutto bene, finché non attraversai il confine con la Virginia. Da questo punto in poi, divenne subito evidente che negli Stati Uniti non si parla più Inglese, ma una sorta di linguaggio primitivo fatto quasi esclusivamente di vocali, una specie di terrificante lallazione che, quando promana da adulti mediamente di un metro e novanta di statura e centocinquanta chili di peso, assume un che di sinistro e vagamente inquietante. Comunque non mi davo per vinto: in fondo qualche parola la capivo ancora, il senso generale dei discorsi più o meno lo coglievo. È vero che i discorsi consistevano perlopiù in indicazioni sullo svoltare a destra o a sinistra o alla quantificazione di conti da pagare al ristorante o alla stazione di servizio ma, insomma, più o meno me la stavo cavando. Questa granitica certezza mi sorresse fino all’arrivo in Georgia. Qui mi capitò di dover affrontare una prova che al lettore potrà apparire di tutta semplicità ma che, in realtà, fu terribile. Giunsi in una cittadina di provincia di cui ho rimosso il nome. Era piuttosto tardi, poiché durante il giorno avevo sbagliato strada più volte e alla fine mi ero perso. Dovevo ancora cenare ma, data l’ora tarda, un breve giro in centro mi rivelò che ormai tutti i ristoranti erano chiusi. Tutti tranne il locale McDonald’s. In realtà, anche quello era chiuso, ma era ancora possibile, come rivelavano alcune macchine in coda, servirsi tramite il McDrive. Decisi dunque di mettermi in fila con la mia piccola Buick, e di guardare come facevano gli altri avventori. Una strana sensazione, una sorta di cattivo presagio, cominciò a farsi strada dentro di me, sotto forma di leggero avvitamento dello stomaco. Vidi che i guidatori arrivavano nei pressi di una colonnina, si sporgevano dal finestrino, blateravano qualche parola all’affare e poi ripartivano, facendo il giro del locale e accostandosi al muro dal lato opposto. Non sembrava difficile, ma quella strana sensazione non se ne voleva andare. Decisi di abbassare il finestrino, nel tentativo di sentire cosa dicessero a quell’aggeggio infernale quelli che mi stavano davanti. Niente da fare: già era difficile capire le persone quando ti parlavano di fronte e potevi leggergli il labiale, figuriamoci in un frangente simile. Ad ogni modo le operazioni proseguivano con inquietante velocità e il mio turno si stava ormai avvicinando. Uno strano istinto di autoconservazione mi suggerì improvvisamente di ingranare la retro e levarmi di torno, ma ormai non era più possibile: dietro di me si erano già accodate altre auto. Alla fine fu chiaro che fra me e il cupo monolite non si frapponeva più alcun ostacolo. Ingranai la marcia e avanzai con una lentezza che somigliava a quella del condannato a morte che sale i gradini del patibolo. Era giunto il mio momento. 42 Ora, descrivere il dialogo che seguì va decisamente al di là delle mie povere capacità. Tenterò tuttavia di riportarlo esattamente come accadde, o perlomeno, come confusamente oggi ricordo che accadde. A prendere l’iniziativa, una volta giunto nei suoi pressi, fu quella specie di stramaledetto citofono che spuntava dall’asfalto: “Uohahaewei?” “Ehm… good evening.” “…’Haewei?” “Big Mac. One Big Mac.” “Maionee o kezah?” “Ehm… a Big Mac.” “Coh, sprah, enielsh…?” Porca troia, pensai, ma sempre domande? Ma dammi quel cazzo che ti pare. Che senso hanno tutte queste domande? “Coh, sprah, enielsh…?” “…Aahh, everything is good for me. Everything is ok. Everything you want. Thank you.” “Cah-fou.” “Ehm… I am sorry I don’t…” Non finii la frase, non sapevo più come proseguire. Decisi di attendere un po’, ma dal citofono non proveniva più alcun suono. La conversazione era finita? Chi poteva dirlo? Avrebbero potuto mettere una specie di semaforo, maledizione, una piccola spia, qualcosa: si accende il verde e tu parti. Invece niente. Dovevo partire? O di là si aspettavano che proseguissi con l’ordinazione? Che fare? Questi dubbi amletici, che mi avevano ridotto in uno stato di prostrazione estrema, vennero bruscamente interrotti da un concerto di clacson che aveva nel frattempo preso il via alle mie spalle. Chissà da quanto era cominciato. Ingranai di nuovo la marcia e mi avviai verso il muro sul lato opposto, sempre a una velocità rigorosamente inferiore a quella di un bambino di tre anni a passeggio con la mamma. Alla fine giunsi nei pressi di una finestra che si aprì all’improvviso, ancor prima che fermassi l’auto. Dietro c’era Serena Williams. Chissà che ci faceva lì, considerato quel che guadagna col tennis e tutto il resto. Comunque era lei, non c’erano dubbi. Dall’interno estrasse un contenitore di cartone delle dimensioni simili alla valigia che avevo nel bagagliaio. Probabilmente avevo ordinato l’intero menù offerto dal locale. Ma ormai non importava, l’importante era togliersi finalmente di lì. Afferrai il bagaglio e feci per partire, ma non era ancora finita: “Uenifà-zodi.” “Ehm…” “Uenifà-zodì!” “…” Allargai le braccia, guardando dal basso in alto in modo implorante. Vi prego, pensavo, lasciatemi andare. Non è questa la terra dell’habeas corpus? Lasciatemi andare, vi dico. E poi ho diritto ad un avvocato. E a una telefonata. Serenona nel frattempo mostrava segni evidenti di impazienza e mi stava lanciando uno sguardo come quello che riserva di solito alle avversarie quando osano ribattere il suo servizio e portarsi sul 30-40. Poi decise di rompere gli indugi e voltò il display del registratore di cassa verso di me, in modo che potessi leggerlo anch’io. Recava la cifra di 25,30 dollari. Ah, ecco cosa stava cercando di dirmi: il conto! Tirai fuori il grano e pagai senza ulteriore indugio. Stavo già per scatenare tutta la potenza del motore Buick quando Serenona, con spietato sadismo, mi rivolse ancora la parola: “Strohh?” “Ma cosa c’è ancora, porca puttana?!” 43 “Strohh?” “…” Niente da fare, proprio non capivo. Serenona, forse intenerita dalla vista di un cerebroleso alla guida, tutto solo e sudato nella notte americana, fece un gesto che, rabbrividendo, mi resi conto mimava proprio una fellatio. Oddio, che significava? Oddio, che voleva? Serena Williams s’era fatta delle idee su di me? Cosa dovevo fare adesso? L’unica era mettere la prima e sgommare via senza pietà, allontanandosi a tutta velocità. Ma Serenona, nel frattempo, si era allungata fuori dalla finestra e mi porgeva qualcosa. Cos’era quell’affare? Ah, una cannuccia. Una cannuccia! Ecco cosa stava dicendo: ‘straw’, cannuccia. Un’innocua cannuccia. L’afferrai al volo e ripartii senza guardarmi indietro. Più tardi, scovato un motel, mi rinchiusi in ghiacciaia e cercai di mangiare tutto quello che avevo ordinato. Non ci riuscii. Poi pensai che forse 25,30 dollari al McDonald’s costituiva una sorta di record mondiale. Non credo che nessuno ci fosse mai riuscito prima. Né dopo, probabilmente. E se oggi mi chiedete: “Do you speak English”, ebbene, la risposta è “NO!” 44 Livio Ghelli Venturini sentì un trapestio leggero dietro la porta di casa e si disse: Devo aver chiuso fuori la gatta… Aprì la porta, ma con la coda dell’occhio si accorse che la gatta era sempre lì, sul cuscino sfondato della sua sedia in cucina – sua della gatta, naturalmente – e lo guardava con occhi tondi. Dietro la porta c’era un tizio tra i trenta e i quaranta, con gli occhiali, una faccetta rosea e morbidina alla Enrico Mentana giovane, un giubbotto bègio e i capelli ricci bagnati dagli umidi vapori e dalle pioggerelline che nei pomeriggi d’inverno ristagnano sulla stagnante palude di Paperino. Alle cinque e mezzo già era buio, non era più l’ora dei volantini, né dei Testimoni di Geova e neppure dei propagandisti delle diverse Società Elettriche o del Gas – però in questi tempi di precariato non si può mai dire, meno alternative hai, più te ne propongono di inutili. Educatamente Venturini si fece da parte: “Entri se vuole, però non compro, non faccio contratti e non mi converto.” “Grazie,” fece Mentana giovane entrando in casa. “Sa, sono la sua morte e sono venuto a prenderla.” Ecco, si preoccupò Venturini. Finisce l’ora dei volantini e inizia quella degli squilibrati. Questo poi sembra tutto perbenino, con un’aria fintamente docile… Sono i peggiori… E io scemo che l’ho fatto entrare. Bisognava rivolgersi al pazzo con gentilezza. “Ma certo, naturalmente, io l’attendevo non dico con impazienza – questo no, ma con una certa curiosità,” cinguettò Venturini. “Tutte le mattine mi lavo i denti, e nel frattempo mi domando: ma quando verrà questa morte? Mica mi avrà dimenticato? Forse le hanno dato un indirizzo sbagliato… E invece eccola qua, puntuale come dicono! Posso offrirle una tazza di tè? Con questa pioggia a star fuori si prendono dei gran raffreddori e occorre scaldarsi…” “Ha proprio ragione,” disse la morte. “Un tè caldo mi ci vuole proprio. Sa, non sembra, ma il mio è un lavoraccio: sempre in giro a tutte le ore, senza turni, senza assicurazione, senza recupero straordinari… A volte ti mandano in certi posti! E poi la gente è così poco cordiale, ammutolisce o dà in escandescenze – mica come lei che è così gentile e capisce la situazione.” La gatta intanto scendeva precipitosamente dalla sedia e andava a nascondersi sotto il letto. Un brivido trascorse lungo il collo e la schiena di Venturini. Bisogna alzare il riscaldamento, si disse, mettendo a scaldare l’acqua per il tè. Va bene il risparmio ma adesso fa proprio freddo… Il pazzo seguitava a parlare, stiracchiandosi e allungando le gambe. “Indovini quanti prelievi mi sono toccati oggi? Cinquantasei! Poi dicono che non ci si stanca. Ho iniziato alle quattro e venti del mattino e adesso, alle sei di sera, mi siedo per la prima volta. E i miei colleghi non se la passano meglio, sa? Se un giorno te la cavi con quaranta prelievi, è una data da ricordare! Per fortuna lei è l’ultimo prelievo della giornata: la prendo in carico, la lascio al Centro di Smistamento e corro subito a nanna.” “E la gatta?” chiese Venturini. “Non la posso mica lasciare sola.” “Non è assolutamente possibile portarla con noi,” disse la morte. “Al Centro sono molto fiscali riguardo alle date.” Consultò rapidamente un minicomputer. “La capisco, ma… Come si chiama la gatta? Ah, ecco, ho trovato: morirà tra nove anni, sei mesi e due giorni, causa 45 ingestione – no indigestione di lampredotto – bisogna che cambi gli occhiali. Come vede, non la posso accontentare.” Da sotto il letto venne un miagolio lungo e lamentoso. “No, no piccolina,” trillò la morte, facendo una voce da gatti. “Tu non puoi venire con noi, no. Rimani qui buona buona quando andiamo via.” La gatta si zittò immediatamente. “Ecco, come tutti i gatti anche questa non mi può vedere,” disse la morte. “Non ho mai trovato un gatto che mi venisse in collo da sé, e invece i gatti mi piacerebbero. Sono così magici ed eleganti.” “Quando ci si mettono sono dei bei rompicoglioni,” disse Venturini. “Bisogna prenderli come sono,” disse la morte con indulgenza. Poi sorseggia il tè assieme a Venturini. Pausa di un minuto. “Ecco,” rifletté ad alta voce Venturini, “ma la morte non doveva averci il mantello nero e la falce fienaia, e viaggiare con un cavallo scheletrico?” “Siamo nel ventunesimo secolo, ci sono le mietitrebbiatrici e gli autobus. A mantenere un cavallo scheletrico, gli animalisti ti denunciano, i mantelli neri sono carissimi, e poi devi lavarli a mano sennò si ritirano,” disse la morte. “Si sta bene qui e lei è proprio una persona simpatica. Un ultimo desiderio prima di andare?” “Direi… inviare una raccomandata al padrone di casa che è anche un mio amico. Sa, per via dell’affitto e del resto. Me la può spedire lei? L’ufficio postale chiude alle 19 e 30.” “Molto volentieri,” disse la morte consultando l’orologio. “Scriva tutto quel che deve, poi io faccio un salto alla posta, le spedisco la raccomandata e torno a prenderla.” “Lei è davvero una brava morte,” disse Venturini. “Mio dovere,” disse la morte. Venturini prende carta e penna e scrive: Caro Giulio, per cause indipendenti dalla mia volontà devo lasciare la casa all’improvviso e per sempre. Nel libro Il cuoco in casa, sulla mensola alta della cucina, ho nascosto settecento euro. Prendili per l’affitto. Prendi tutte le cose mie che trovi in casa e fanne quello che vuoi. La lavatrice come sai è quasi nuova. Alla gatta ho lasciato da mangiare e da bere per un giorno o due. Ti sarei molto grato se la tenessi tu, che vuoi bene agli animali. Grazie per tutto quello che fai. Ciao. Venturini Poi chiude la busta, scrive in stampatello l’indirizzo e consegna il tutto alla morte. La morte esce e va all’ufficio postale, lasciando Venturini seduto in cucina, alquanto pensieroso. Erano diversi anni che la morte non metteva piede in un ufficio postale. Sì, ricorda molto tempo prima un anziano in coda per la pensione, colto da un infarto e rapidamente prelevato, e un’altra volta una maldestra rapina, con il ladro che sembrava Mandrake che si sparava su un piede e una signora che era morta di paura. L’ufficio postale dove mette piede adesso è diversissimo da quelli che ricordava: è una cosa strana, una mescolanza di luoghi, un insieme di supermercato, sala d’aspetto e sala del bingo. Ci sono macchine che distribuiscono lettere e numeri a seconda di quello che devi fare – una raccomandata, un versamento o qualcosa d’altro. La gente prende i numerini e guarda ansiosamente i tabelloni luminosi dove un bel giorno apparirà anche il loro numerino, e così sapranno a quale sportello dirigersi. La morte è stupita che ci siano tessere di gratta-e-vinci in vendita agli sportelli, e ancora di più che ci siano dei disperati in coda per comprarle. Le persone stanno pigiate perché gran parte dello spazio è occupato da espositori e banchi dove si offrono in vendita martelligiocattolo e seghetti da traforo, libri di cucina, manuali per raggiungere successi in vari campi, grattugie per il parmigiano, videocassette di Antonella Clerici, zainetti, post-it e il Libro dei Segreti di Fatima. I prezzi sono carissimi. C’è anche una motoretta, nuova fiammante, in 46 equilibrio precario sul cavalletto, e tutti si muovono con precauzione per non urtarla. La signora direttrice dell’ufficio deve aver immaginato che uno, passando alla posta per pagare la bolletta del gas, veda la motoretta e, colto da inarrestabile desiderio, se la compri. Dietro gli sportelli gli impiegati hanno movenze da bradipo. Alla posta si muore poco, pensa la morte, osservando un’impiegata immobilizzata da oltre sette minuti fingendo di guardare il computer. Ecco perché gli impiegati sono così lenti: ibernano la vita per ritardare la morte. Passano minuti, quarti d’ora, mezz’ore. La morte, istintivamente disciplinata e puntuale, diventa sempre più impaziente, preoccupata di non poter arrivare in tempo con Venturini e quell’altro signore, e di rischiare un cazziatone. “Cialtroni e nullafacenti… bisognerebbe frustarli tutti sul sedere come nel Medioevo,” borbotta la morte tra sé. “Macché frustate, io li ammazzerei tutti,” interloquisce una donna. “E la direttrice fatta fuori per prima. Una bella strage! Lei è troppo buono, si vede. Io però la conosco, non è quello della televisione?” “Veramente io non…” “Ma sì, lei è sempre lì, sulla 7, con codesto faccino rosa e gli occhiali. Alla mia mamma garba tanto, tutte le volte che c’è il suo telegiornale vuole accesa la televisione. Io la lascio fare perché perde colpi, ha più di novant’anni, ma per guardare il telegiornale io ci rimetto la mia telenovela. Comunque non ce l’ho con lei, dottor Minoli, perché mi rende lo stesso un bel servizio!” La morte (involontariamente somigliante a Enrico Mentana giovane) comincia a pensare che una bella strage tipo La maschera della Morte Rossa di Edgar Allan Poe sarebbe cosa buona e giusta in quell’accidente di bazar postale – coinvolgendo ovviamente, oltre agli impiegati, gli utenti come la signora, il ministro delle poste o comunque si chiami il ministero a ciò preposto, con tutto il seguito di portaborse e sottosegretari. Quasi quasi faccio un bel prelievo di massa e svuoto le poste italiane, pensa la morte, però sa di non poterlo fare. Le morti hanno protocolli rigidi, devono seguire la lista del giorno, render conto ai superiori, non possono permettersi stragi tanto per fare. Quando venne il suo turno, l’ufficio stava chiudendo – appena in tempo per consegnare la raccomandata a un’impiegata lunatica. “Questa scrittura è quasi illeggibile,” disse l’impiegata. “Dovrei farle ricompilare il modulo, sa? Ma io sono buona.” “Mi dispiace,” disse la morte. “La prossima volta cercherò di scrivere un po’ più chiaro.” “Senta, lei è quello della televisione, quello col nome che incomincia con M,” affermò l’impiegata. “No, non sono quello della televisione,” ribattè stancamente la morte. Pagò e s’involò nella sera. Non tornò da Venturini perché aveva fatto tardi e voleva prima prelevare e consegnare quell’altro. Arrivò al Centro di Smistamento mentre cambiavano i turni. Il giorno dopo fu una giornataccia, c’era un sacco di lavoro e la morte si dimenticò, semplicemente, di tornare a prendere Venturini. Da allora sono passati trent’anni e neanche il capufficio della morte si è accorto di questo piccolo disguido. Venturini conduce la vita di sempre. 47
Scaricare