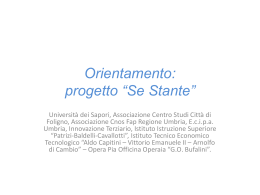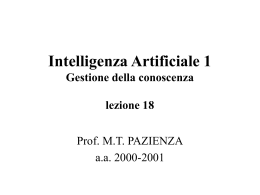RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XVI NUOVA SERIE - N. 47 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2002 Manni Manni Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma. Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Lecce, e dello stesso Dipartimento. 2 Direttore responsabile: Giovanni Invitto Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce), Antonio Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno), Antonio Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce). Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Daniela De Leo, Lucia De Pascalis, Alessandra Lezzi. Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel. (0832) 336627/8; fax (0832) 3366626. Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Nino Bixio, 11/b - 73100 Lecce - Tel. e Fax. 0832/387057. Iscritto al n. 389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo: Italia t 25, Estero t 35, c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata. Un fascicolo t 10, degli anni precedenti il doppio. Stampato presso Tiemme - Manduria nel novembre 2002 - per conto di Piero Manni s.r.l. SOMMARIO 5 R. Raggiunti GLI ATTI LINGUISTICI NEI LORO ASPETTI, SEMANTICO E PRAGMATICO 17 M. Fortuna RELIGIONE CRISTIANA E RELIGIONE APERTA. UN CONFRONTO CON ALDO CAPITINI 40 C. Fersini GENIO E DIMENSIONE ESTETICA IN SCHOPENHAUER. UNA PROPOSTA DI LETTURA 62 C. Stella DALLA CITTÀ ALLA COSMOPOLI UN CAMMINO POSSIBILE 67 P. Miccoli I “LUOGHI DELL’ANIMA” DI MARIA ZAMBRANO 70 G. De Liguori PER G. MUCCIARELLI. POSITIVISMO PSICOLOGIA E STORIA 75 S. Ciurlia I LINGUAGGI DELLA RICERCA STORICA: I VOCABOLARI DI BRAUDEL 85 M. Spadavecchia IL DOPPIO VOLTO DELLA MENZOGNA. LA DIMENSIONE SOLIDALE DEL MENTIRE 95 Recensioni 3 NOTE PER GLI AUTORI I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipartimento di Filosofia – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà restituito. Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle. Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, previa comunicazione e approvazione dell’Autore. Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro. 4 GLI ATTI LINGUISTICI NEI LORO DISTINTI ASPETTI, SEMANTICO E PRAGMATICO Una prima definizione della pragmatica, perfettamente valida, la troviamo in Charles Morris, nei suoi Foundations of the Theory of signs1. In tale opera Morris definisce la pragmatica come il rapporto dei segni con gli interpreti. Tale definizione rimane, a mio avviso, un punto fermo dal quale non ci possiamo allontanare, se vogliamo stabilire un criterio univoco e coerente, che ci permetta di delimitare la sfera della pragmatica e di distinguerla dalla sfera semantica. Sulla base di tale criterio, dobbiamo considerare l’atto linguistico, non tanto in relazione a ciò che viene detto, quanto in relazione alla partecipazione degli interpreti, parlante e ascoltatore. Non dobbiamo dimenticare che parlante e ascoltatore, nella loro partecipazione a ciò che viene detto, assumono due posizioni diverse, due ruoli diversi. In ciò consiste il carattere pragmatico dell’atto linguistico. Austin, fra i filosofi del linguaggio, è forse quello che ha posto in evidenza nella maniera più incisiva, il carattere pragmatico degli atti linguistici, in special modo in relazione alla differente partecipazione del parlante e dell’ascoltatore. Basti pensare alla sua analisi degli “enunciati performativi”, nei quali l’atto linguistico si configura come un’operazione pratica, che riguarda il parlante in maniera diversa dall’ascoltatore, che partecipa anch’esso a questa operazione pratica ma con una “parte” diversa rispetto a quella del parlante. Sulla base dello stesso concetto di “performance”, Austin ha sottoposto alla stessa analisi tutti i tipi di atti linguistici, ai quali ha attribuito una stessa rilevanza pragmatica, definendoli “atti illocutori”. La teoria degli “atti illocutori” è stata poi accolta da Searle, il quale distingue, entro l’atto illocutorio, due elementi ugualmente necessari per il compimento dell’atto stesso: quella parte dell’enunciato che egli denomina “indicatore della forza illocutiva” e la parte dell’enunciato che denomina “contenuto proposizionale”. Ad esempio, nell’enunciato “io prometto che partirò”, l’indicatore della forza illocutiva è rappresentato dal sintagma “io prometto che”, mentre il contenuto proposizionale è costituito dalla proposizione “io partirò”. Già si delinea una distinzione di un aspetto semantico e di un aspetto pragmatico dello stesso atto linguistico, ma questi due aspetti non vengono distinti dallo studioso americano. Egli stabilisce semplicemente e soltanto le regole che riguardano i caratteri pragmatici dell’operazione che stabilisce un certo rapporto fra il parlante e l’ascoltatore. A questo riguardo, potrei citare la regola (denominata da Searle di sincerità), che stabilisce che il parlante vuole compiere l’azione che ha promesso (partire), oppure la regola secondo la quale “l’ascoltatore dovrebbe preferire che il parlante compia piuttosto che non compia quella determinata azione, e il par- SAGGI di Renzo Raggiunti 5 6 lante ritiene che l’ascoltatore dovrebbe preferire il suo compiere quell’azione al suo non compierla”2. Viene posta soltanto in evidenza la differente partecipazione operativa dell’uno e dell’altro. Ebbene Searle definisce queste regole come regole semantiche, dimostrando chiaramente che egli non ritiene di poter e dovere distinguere una semantica da una pragmatica degli atti linguistici. Ha reso così più difficile l’impostazione e la soluzione dei problemi della semantica e della pragmatica degli atti linguistici. In una posizione, per certi aspetti, analoga, si trova Umberto Eco, il quale nel suo volume Semiotica e filosofia del linguaggio mostra di far propria la tesi di Bar-Hillel affermando: “La pragmatica è lo studio della dipendenza essenziale della comunicazione, nel linguaggio naturale, dal parlante e dall’ascoltatore, dal contesto linguistico e dal contesto extra-linguistico e dalla ‘disponibilità’ delle conoscenze di fondo, e dalla buona volontà dei partecipanti nell’atto comunicativo”3. È evidente che qui, Eco, quando parla di “regole di significazione” contenute in una lingua L, egli intende regole semantiche e include nell’ambito delle regole semantiche anche le regole propriamente pragmatiche, e, perciò, come Searle, non distingue la semantica dalla pragmatica, e include la pragmatica nella semantica degli atti linguistici. Rinuncia, così, a una impostazione rigorosa del problema della semantica e della pragmatica degli atti linguistici. Non si è compreso che l’atto di comunicazione può costituire un solido fondamento per definire e distinguere rigorosamente semantica e pragmatica degli atti linguistici. Il problema della comunicazione è stato trascurato da molti studiosi. Austin e Searle, che hanno maggiormente contribuito a porre in evidenza l’aspetto pragmatico dell’atto linguistico, non si sono posti, in realtà, il problema della comunicazione, anche se considerano la comunicazione come una condizione necessaria del realizzarsi dell’atto illocutorio. Austin non va oltre l’affermazione che la “sicurezza della comprensione” costituisce una delle condizioni del realizzarsi dell’atto illocutorio. La posizione di Searle è, per molti aspetti, simile a quella di Austin rispetto al problema della comunicazione. Per Searle ogni atto illocutorio deve avere anche la caratteristica di produrre sull’ascoltatore la comprensione dell’enunciato del parlante. Searle ammette che la comprensione di un enunciato letterale avviene in virtù di certe regole concernenti gli elementi della frase enunciata, regole della lingua ugualmente conosciuta dal parlante e dall’ascoltatore, ma non dice come esse rendano possibile la comunicazione. Nell’opera Intentionality che esce nel 1983 la sua posizione non è cambiata in relazione al problema della comunicazione. La semantica, come disciplina filosofica, deve rispondere a questo quesito: “[…] che cosa aggiunge l’intenzione del parlante a quell’evento fisico [l’enunciazione], che rende quell’evento fisico un caso in cui il parlante esprime un qualche significato per suo tramite?”4. Rispetto a tale problema, che, per Searle, si identifica con il problema del “significato”, assume un valore secondario l’interrogativo che viene posto dalla seguente domanda: “che conoscenza deve avere un parlante perché si possa SAGGI dire che conosce una lingua, come il francese o l’inglese?”. Tale questione non avrebbe, a suo avviso, “nessuna connessione con il problema del significato”. Eppure su tale “conoscenza”, che è la conoscenza propriamente linguistica, è fondata la possibilità stessa dell’atto di comunicazione. Searle distingue i due aspetti delle intenzioni significanti, l’intenzione di rappresentare e l’intenzione di comunicare, e sostiene che non sia consentito, in sede di teoria degli atti illocutori, quelli che si determinano nell’area del cosiddetto discorso ordinario, separare il rappresentare dal comunicare. Perciò, nell’analisi del discorso ordinario, è poco credibile la sua tesi che una teoria del linguaggio deve essere in grado di spiegare come “una persona possa fare un’affermazione ed essere del tutto indifferente rispetto al fatto che il suo pubblico le creda oppure no, o addirittura che il suo pubblico la comprenda”5. Dobbiamo domandarci come potremmo, in relazione ad un ordine o ad una promessa, ad esempio, affermare che sia possibile il rappresentare senza il comunicare. È certo che il problema della comunicazione è considerato, da Searle, soltanto come un problema secondario, rispetto al problema “semantico”, che si identifica, a suo avviso con il problema dell’Intenzionalità degli atti linguistici. Nell’ultima opera di Searle, scritta in collaborazione con Daniel Vanderveken, Foundations of illocutionary Logic, è espressa una posizione analoga, riguardo all’esigenza di definire i caratteri e i meccanismi dell’atto di comunicazione. Qui l’autore afferma che fra le condizioni che determinano la corretta comprensione di un’espressione vi è quella che “il parlante deve usare la stessa lingua dell’ascoltatore”. Non si preoccupa di spiegare che cosa significhi “usare la stessa lingua dell’ascoltatore”, quale differenza possa esserci fra la lingua, come strumento, e il suo uso; e neppure si preoccupa di spiegare come e per quali meccanismi l’uso della stessa lingua permetta ai parlanti di comunicare fra loro. E infine afferma che “[…] queste condizioni che sono alla base della comprensione sono di scarso interesse teoretico in un teoria degli atti linguistici […] e noi concentreremo la nostra attenzione sul parlante e su come la sua enunciazione soddisfa le altre condizioni per una esecuzione riuscita e non difettosa”6. Riprendiamo ora il tema della proposta di un criterio di distinzione della semantica e della pragmatica degli atti linguistici; penso che tale distinzione possa essere fondata, in maniera rigorosa, sul concetto di comunicazione che ci permette di individuare i contenuti propriamente semantici. La questione può essere affrontata opportunamente prendendo, anzitutto, in esame la struttura dell’atto illocutorio, teorizzato da Austin e successivamente da Searle, due studiosi che, pur distinguendosi l’uno dall’altro nei criteri di impostazione e soluzione del problema dell’atto illocutorio, hanno, entrambi, contribuito a porre in evidenza lo spessore pragmatico dell’atto linguistico. L’espressione “azione linguistica”, un’azione che si compie a mezzo delle parole ed è inseparabile dalle parole, indica chiaramente la sfera pragmatica dell’atto linguistico, i cui contenuti possono definirsi, in senso specifico, contenuti pragmatici dell’atto linguistico. La promessa, ad esempio, rappresenta un tipo di atto illocutorio. Se il par- 7 8 lante, rivolto ad un ascoltatore pronuncia la frase “Io prometto che partirò” egli compie un’azione linguistica diversa da quella che egli compie se pronuncia la frase “Pietro è partito”. L’aspetto pragmatico dell’atto linguistico ci si rivela soltanto, se si considera l’atto linguistico, accogliendo il suggerimento di Morris, in rapporto alle differenti posizioni del parlante e dell’ascoltatore. Se il parlante, a mezzo delle parole, compie l’azione del promettere, che consiste nell’assumersi l’obbligo di fare una certa cosa, nei confronti dell’ascoltatore, –tale azione la compie il parlante e non l’ascoltatore–. Il ruolo pragmatico dell’ascoltatore è nettamente distinto da quello del parlante: una cosa è fare una promessa, altra cosa è pretendere che sia mantenuta. Questo differenziarsi degli atteggiamenti pratici del parlante e dell’ascoltatore –in relazione al suddetto atto illocutorio, come a qualsiasi altro tipo di atto illocutorio–, ci dimostrano chiaramente che l’atto linguistico, nel suo aspetto pragmatico, si realizza sotto il segno della asimmetria dei ruoli e delle operazioni pratiche del parlante e dell’ascoltatore. Consideriamo ora l’aspetto semantico dell’atto linguistico, di qualsiasi atto linguistico, in quanto atto di comunicazione, che coinvolge, allo stesso modo, il parlante e l’ascoltatore, determinando una situazione di perfetto equilibrio, di simmetria dei ruoli del parlante e dell’ascoltatore. Nell’atto di comunicazione, i contenuti semantici debbono presentarsi identicamente al parlante e all’ascoltatore, ma è necessario precisare che non vi è nulla che privilegi certi contenuti come semantici, contrapponendoli ad altri contenuti non semantici. Si deve dire che la semantica del linguaggio naturale, nel discorso cosiddetto ordinario, non ha contenuti privilegiati, quali potrebbero essere, ad esempio, i contenuti apofantici, delle asserzioni vere o false, descrivibili in base a concetti logici. Alcuni studiosi come Gazdar e Kempson7 si trovano, erroneamente, in questa posizione e definiscono in questo modo la semantica, e assumono questo unico criterio per distinguerla dalla pragmatica. Non vi è alcuna valida ragione per affermare che soltanto i contenuti apofantici, delle asserzioni vere o false, debbano essere considerati come contenuti semantici. La semantica del linguaggio ordinario, che si è posta su questa strada, applicando un criterio rigidamente vero-funzionale, è indotta a definire pragmatiche differenze che hanno, invece, un carattere squisitamente semantico: l’enunciato “Maria è cagionevole di salute, ma è intelligente” avrebbe lo stesso significato semantico dell’enunciato “Maria è cagionevole di salute ed è intelligente”, e soltanto un differente significato pragmatico. Si ha ragione di porre questa tesi che nega che i contenuti apofantici possano avere essi soli il privilegio della semanticità. In contrasto con una illustre tradizione logico-linguistica si ha ragione di affermare, da un diverso punto di vista, che non vi è motivo alcuno, in sede di indagine sui contenuti del linguaggio ordinario, di limitare la nozione di “significato” al contenuto delle asserzioni, entro i limiti della nozione vero-funzionale. D’altra parte, anche la terminologia, quella delle origini, quella di Aristotele, sembra conferire validità alla tesi che la nozione di significato è più generale rispetto a quel significato specifico che è attribuibile al discorso assertivo: infatti lo stesso Aristotele distingue la semanticità del discorso dalla sua eventuale apofanticità, e, in tal SAGGI modo, dimostra chiaramente che attribuisce un significato anche al discorso non assertivo. Un altro tentativo di privilegiare e di distinguere, entro la sfera del significato in senso lato, determinati contenuti o significati è quello di coloro che8, distinguendo, in sede di linguistica teorica, competence e performance, langue e parole, identificano i contenuti semantici con i significati della lingua e quelli pragmatici con i contenuti o sensi degli atti di parole. Questa tesi, ovviamente, è da respingere senza esitazione; e non per il fatto che la definizione del concetto di lingua, come entità distinta dall’atto linguistico concreto, comporti delle difficoltà. Se si coglie la distinzione di lingua, langue nella terminologia di De Saussure, competence in quella di Chomsky, e si ammette che si possa dare una definizione consistente e rigorosa di lingua, è proprio la stessa definizione di lingua a fornirci le più valide argomentazioni contro la tesi, che si rivela, così, assurda, secondo la quale i contenuti semantici sarebbero i significati della lingua e quelli pragmatici i contenuti o sensi degli atti di parola. La lingua contiene, soltanto virtualmente, tutte le frasi possibili. Ma la lingua è soltanto uno strumento, usando il quale si possono produrre tutti i significati possibili: sarebbe opportuno precisare che si tratta propriamente di sensi o significazioni, che si producono mediante i singoli atti linguistici, mediante la parole. Virtualmente tutto appartiene alla lingua, i singoli termini come le frasi, le quali richiedono determinate regole sintattiche. Ma se consideriamo le entità linguistiche, termini e regole sintattiche, nella loro concreta realizzazione, niente appartiene alla lingua, neppure i singoli termini, che si realizzano nell’atto stesso in cui si realizzano le frasi. Ma prendiamo, ora, in considerazione una significativa distinzione, quella di enunciato e contesto di enunciazione. Possiamo affermare che non esistono enunciati privi di un contesto di enunciazione; è possibile solo distinguere fra enunciati il cui significato non è determinato o modificato dal contesto di enunciazione. Sulla base di questa distinzione, si è affermato che la semantica tratterebbe solo dei significati degli enunciati che non sono determinati dal contesto di enunciazione, mentre la pragmatica tratterebbe tutti e soli i significati che sono dipendenti dal contesto9. Ma non vi è alcuna valida ragione per escludere dalla semantica i significati degli enunciati che vengono determinati dal contesto di enunciazione. E, ugualmente, non è accettabile la tesi, affermata da alcuni studiosi di semantica di indirizzo propriamente logico, che è di competenza della semantica solo ciò che ha un rapporto diretto con la verità o la falsità, e perciò esclusivamente il campo delle asserzioni. Abbiamo, dunque, accertato che hanno tutte le caratteristiche necessarie per essere oggetto di considerazione e teorizzazione semantica anche i significati degli enunciati il cui contenuto è determinato, in qualche maniera, dal contesto enunciativo. Ma il contesto di enunciazione riguarda anche il campo più esteso degli enunciati non assertivi. Anche i significati di questi ultimi possono acquisire il loro contenuto pieno e compiuto, il loro senso determinato e 9 10 particolare, attraverso il contesto di enunciazione. Il senso preciso di enunciati come un ordine, una domanda, una minaccia, una promessa, e di tutti gli altri tipi di atti illocutori, si determina attraverso il contesto di enunciazione, nella mente del parlante come in quella dell’ascoltatore. Ma il senso di questi enunciati, anche se è determinato dal contesto di enunciazione, non ha nessuna caratteristica che lo escluda a priori dalla sfera dei contenuti della semantica; e neppure che lo includa a priori nella sfera dei contenuti propri della pragmatica. Appare fin da ora evidente che la determinazione del senso di un atto linguistico, effettuata mediante il contesto di enunciazione, è fenomeno che riguarda esclusivamente la semantica. Una volta stabilita la premessa che la semantica del linguaggio ordinario non ha contenuti privilegiati, e che il criterio per stabilire i contenuti semantici di ogni atto linguistico è il concetto di comunicazione, riprendiamo in esame, da questo punto di vista, gli atti illocutori della promessa e dell’asserzione, per porre finalmente in luce l’aspetto semantico di tali atti linguistici e individuarne i rispettivi contenuti. Mentre l’atto linguistico, nel suo aspetto pragmatico, si compie sotto il segno della asimmetria dei ruoli, del parlante e dell’ascoltatore, l’atto linguistico, nel suo aspetto comunicativo e strettamente semantico, si compie, al contrario, sotto il segno della simmetria dei ruoli, della reciprocità delle funzioni, del parlante e dell’ascoltatore. Per farsi comprendere, il parlante deve porsi anche nella posizione dell’ascoltatore; e l’ascoltatore, per comprendere, deve porsi anche nella posizione del parlante. Vediamo l’atto linguistico della promessa come atto di comunicazione. Il parlante, che compie l’azione del promettere, è in grado di prevedere –ponendosi nella posizione dell’ascoltatore–, come l’ascoltatore intenda le sue parole, attraverso la frase con cui denuncia il suo impegno di fare una certa cosa. In ciò consiste il “carattere semantico dell’atto linguistico come atto di comunicazione”. L’ascoltatore, come attore dell’atto di comunicazione, può, da parte sua, comprendere il significato dell’atto linguistico della promessa di cui è il destinatario, solo in quanto sa che cosa significa quella espressione, tanto meglio lo comprende, quanto più riesce a porsi nella situazione del parlante. Il concetto di contenuto semantico appare, così, fondato unicamente sul concetto di comunicazione. Consideriamo ora l’atto illocutorio dell’asserzione nel suo aspetto puramente semantico, e, perciò, dal punto di vista della comunicazione. Nell’enunciazione della frase “Pietro è partito”, nella quale un parlante si rivolge ad un ascoltatore, ciò che costituisce il contenuto propriamente pragmatico è la differenza dei ruoli, del parlante e dell’ascoltatore. Sappiamo che il ruolo del parlante consiste nel fatto che egli, ed egli soltanto, si assume la responsabilità di ciò che asserisce, della sua veridicità. Se invece consideriamo la stessa asserzione dal punto di vista della comunicazione, allora abbiamo il contenuto semantico dell’atto linguistico, che, per la simmetria e reciprocità dei ruoli, si prefigura come identico nel parlante e nell’ascoltatore. Il contenuto dell’asserzione è un’informazione che riguarda il fatto che Pietro è partito: tale contenuto, nella prospettiva della comunicazione, non ha alcuna relazione con la responsabilità dell’asserente e del parlante, che riguarda unica- SAGGI mente il carattere pragmatico dell’atto linguistico. Il contenuto della comunicazione, il contenuto propriamente semantico, è il puro “dictum” senza la paternità dell’asserente. Ma vi è da considerare un altro aspetto dell’atto di comunicazione, che riguarda la responsabilità del parlante che compie un atto di comunicazione. Il parlante può informare l’ascoltatore semplicemente del fatto che Pietro è partito, oppure può informare l’ascoltatore del fatto che Pietro è partito e insieme del fatto che egli si assume la responsabilità della veridicità dell’informazione. In entrambi i casi si tratta di contenuti che appartengono alla sfera semantica, e che hanno, o debbono avere, lo stesso significato per il parlante e per l’ascoltatore. Ciò che appartiene alla sfera pragmatica è semplicemente il fatto che il parlante –e soltanto il parlante– si assume la responsabilità della veridicità della sua asserzione. Indipendente dal puro contenuto semantico della comunicazione può essere considerato il fatto che il parlante, ponendo la sua asserzione, abbia l’intenzione di produrre determinati effetti sull’ascoltatore, come, ad esempio, tranquillizzarlo, spaventarlo, minacciarlo etc. Questi effetti, che sono stati denominati “perlocutori” e richiedono una definizione univoca e rigorosa che, fino ad oggi, è mancata, rientrano anch’essi nella sfera propriamente pragmatica. Ed ora, prendiamo in esame alcuni tipi di atti illocutori, per chiarire ulteriormente il criterio di distinzione della semantica e della pragmatica degli atti linguistici. Consideriamo un enunciato imperativo come, ad esempio, “Chiudi la finestra”, nel suo aspetto puramente comunicativo. Il suo contenuto, che è il puro significato dell’enunciato, per la simmetria e reciprocità dei ruoli, presentandosi identicamente per il parlante e per l’ascoltatore, è il contenuto semantico dell’atto linguistico. Lo stesso atto linguistico, nel suo aspetto pragmatico, ci mostra altrettanto chiaramente la asimmetria dei ruoli. L’azione che compie il parlante è quella di indurre una certa persona, l’ascoltatore, a fare una certa cosa. Mentre si vuole una certa cosa, si comunica che si vuole una certa cosa, ma le due operazioni rimangono distinte. L’ordine, che è dato dal parlante, cambia, in qualche modo, il rapporto sociale del parlante e dell’ascoltatore. La funzione pratica di chi dà gli ordini è diversa dalla funzione pratica di chi li riceve. Un altro tipo di atto illocutorio, che ci viene presentato e descritto da Austin, “sì, prendo questa donna come mia legittima sposa”, e che egli dapprima denomina “performativo”, e colloca nella classe degli enunciati “contrattuali”, stabilisce, come è noto, le condizioni necessarie alla sua completa realizzazione. Tutte le condizioni di felicità dell’enunciato, così descritte, si riferiscono ai caratteri pragmatici dell’atto linguistico, del “sì” celebrativo del matrimonio. Ma, fra le condizioni di “felicità” dell’enunciato ve n’è una, che riguarda soltanto “la comprensione del significato e del valore dell’enunciato” e che egli denomina “la sicurezza della comprensione”. Se consideriamo il “sì”, pronunciato dallo sposo nel suo puro contenuto semantico, vale a dire come un puro atto di comunicazione, il significato di esso, per la reciprocità dei ruoli, del parlante e dell’ascoltatore, sarà identico per il parlante e per l’ascoltatore. 11 12 Riguardo al contenuto semantico dell’ordine, dell’enunciato imperativo, possiamo dire che anch’esso costituisce, a suo modo, un’informazione. Nell’ambito di ciò che denominiamo informazione, possiamo distinguere l’ informazione in senso stretto, l’asserzione, vera o falsa, e l’informazione in senso lato, quella che non è trasmessa da un’asserzione, ma, bensì, da un ordine, oppure dall’espressione della volontà di stipulare un contratto matrimoniale, che si realizza mediante una certa formula. Nel rapporto che, a livello del discorso ordinario, si stabilisce fra un parlante e un ascoltatore, la linea di discriminazione fra la semantica e la pragmatica è determinata dal carattere di questo rapporto. Se si determina la asimmetria del rapporto parlante-ascoltatore, se i ruoli del primo e del secondo risultano differenziati, si ha, come sappiamo, una differente partecipazione operativa del parlante e dell’ascoltatore, nel compimento dell’atto linguistico. Se, come sostiene Morris, la pragmatica deve studiare la relazione dei segni con gli interpreti parlante e ascoltatore, occorreva definire il senso ed il carattere di questa relazione: per Austin, come per Searle, la relazione consiste in una operazione pratica, in un’azione che parlante e ascoltatore compiono a mezzo delle parole. Ma, come abbiamo più volte precisato, in tale operazione pratica, parlante e ascoltatore hanno ruoli e parti diverse. Se, ad esempio, il parlante dà un ordine all’ascoltatore, e, perciò, compie l’azione rispettiva, l’ascoltatore si sentirà in qualche modo obbligato o condizionato. I due ruoli diversi, del parlante e dell’ascoltatore, nel rapporto che si stabilisce fra essi mediante l’atto linguistico, danno luogo a ciò che io ho denominato l’asimmetria dell’atto linguistico, nel suo aspetto pragmatico, che è l’oggetto di studio di un settore ben determinato della filosofia del linguaggio. L’altro settore è costituito dalla semantica, i cui limiti racchiudono uno spazio molto più ampio, che è stato definito sulla base del concetto della comunicazione linguistica. A differenza della sfera pragmatica, la sfera semantica si manifesta sotto il segno della simmetria e della reciprocità dei ruoli. Ciò che ci determina a parlare di simmetria dei ruoli, del parlante e dell’ascoltatore, è il fatto che il contenuto della comunicazione trasmesso dal parlante e ricevuto dall’ascoltatore –se la comunicazione riesce– è identico per il parlante e per l’ascoltatore. La comunicazione non si realizza quando quello che sa il parlante e che vuole comunicare all’ascoltatore è diverso da quello che viene a sapere l’ascoltatore, e ciò si verifica a causa della conoscenza del parlante e dell’ignoranza dell’ascoltatore. In tal caso, non si verifica quella situazione ideale in cui il parlante è perfettamente in grado di comunicare e l’ascoltatore è perfettamente in grado di ricevere e comprendere la comunicazione. Ed ora consideriamo l’altro aspetto, distinto, dell’atto di comunicazione, quello della reciprocità o scambio dei ruoli, del parlante e dell’ascoltatore. L’ascoltatore tanto più è in grado di cogliere l’intenzione del parlante, ciò che vuole o desidera o sa, quanto più egli riesce a porsi nella prospettiva del parlante, nel suo punto di vista, oltre che nel proprio. La comunicazione fallisce tanto se l’ascoltatore non sa comprendere il punto di vista del parlante, quanto se il parlante non sa comprendere la mentalità, il punto di vista dell’ascoltatore. Sulla base di queste nozioni di simmetria e reciprocità dei ruoli del parlan- SAGGI te e dell’ascoltatore, possiamo stabilire che qualsiasi contenuto, in quanto si determina come identico per il parlante e per l’ascoltatore, deve essere considerato come oggetto di studio della semantica, invece l’oggetto di studio della pragmatica è costituito dalle operazioni compiute, a mezzo delle parole, dal parlante e dall’ascoltatore, in maniera differenziata; essa è fondata sul concetto della asimmetria dei ruoli. Non si ha ragione di escludere dalla sfera semantica alcuni contenuti dell’atto di comunicazione. Perciò appartengono alla sfera semantica non solo i contenuti apofantici, vale a dire i significati delle asserzioni, vere o false, definibili mediante concetti logici, ma anche gli altri contenuti, vale a dire i significati delle domande, degli ordini, delle promesse, degli avvertimenti, eccetera. E poiché l’atto di comunicazione è atto di parole, è performance, sono oggetto di studio della semantica tutti i contenuti che si realizzano nell’atto di parole in quanto atto di comunicazione. Perciò è da respingere la tesi che identifica i contenuti, che sono oggetto di studio della semantica, con i significati della langue, e assegna alla sfera pragmatica tutti i contenuti della parole. La lingua, la langue, a rigore, non contiene in sé nessun enunciato, nessun significato. La lingua è soltanto uno strumento, e dall’uso di tale strumento hanno origine i significati, che appartengono alla sfera della parole, e sono i contenuti che si realizzano nell’atto di parole come atto di comunicazione. Questa conclusione è in antitesi con un’altra esclusione, quella che eliminerebbe dalla sfera semantica tutti i contenuti che sono dipendenti dal contesto di enunciazione e li assegnerebbe alla sfera pragmatica. Perciò non si ha alcuna fondata ragione di escludere dalla sfera semantica i significati degli enunciati che sono determinati dal contesto di enunciazione. Dobbiamo anche respingere una tesi di Grice, che assegna alla sfera pragmatica i contenuti o significati che egli definisce come “implicitati non convenzionalmente”. Se accogliamo la distinzione di Grice, fra ciò che è detto, ciò che è implicitato convenzionalmente e ciò che è implicitato non convenzionalmente, dobbiamo collocare ugualmente nella sfera semantica tanto i significati di ciò che è detto e di ciò che è implicitato convenzionalmente, quanto i significati di ciò che è implicitato non convenzionalmente. Debbo osservare, ora, che il fatto di aver assegnato alla sfera semantica un insieme così ampio di significati non aumenta le difficoltà per la delimitazione e definizione dei problemi propriamente semantici. Austin, nell’opera How to do things with words e precisamente nella Lezione quinta, mentre sta saggiando la possibilità di scoprire un criterio grammaticale che permetta di riconoscere un enunciato performativo, ipotizza che tale criterio possa essere “la prima persona singolare del presente indicativo attivo”. Ebbene, Austin osserva che, in relazione a tale uso del presente indicativo attivo, “si deve notare l’asimmetria costante che si rivela fra questa prima persona e questi tempi e le altre persone e gli altri tempi dello stesso verbo” (p. 63). Si tratta della stessa asimmetria che si osserva tra la prima persona del presente indicativo del verbo promettere, ad esempio, e la prima persona del presente indicativo del verbo correre. C’è un’analoga differenza fra “io pro- 13 14 metto…” e “tu prometti…” o fra “io prometto…” e “io promisi…” e fra “io prometto” e “io corro”. Solo se dico”io prometto…” io sto compiendo l’azione del promettere. Invece se dico “tu prometti…” o “ io corro” io sto compiendo l’atto illocutorio dell’asserzione. Ciò che determina la asimmetria fra “io prometto…” e “tu prometti…” è il valore pragmatico dell’atto illocutorio, ma la asimmetria sussiste fra due atti illocutori diversi. Invece la asimmetria che io ho posto a fondamento del carattere pragmatico dell’atto linguistico è interna a una singola enunciazione, ad un singolo atto illocutorio, e riguarda esclusivamente il rapporto che si determina tra parlante e ascoltatore del singolo atto illocutorio. C’è una asimmetria tra i due distinti ruoli, del parlante e dell’ascoltatore, all’interno di uno stesso atto illocutorio. La asimmetria considerata da Austin fra l’io e il tu, in due enunciazioni diverse, deve essere posta fra il parlante e l’ascoltatore all’interno di un’unica enunciazione. Non dobbiamo dimenticare che qualsiasi tipo di atto illocutorio, oltre ad essere un’azione compiuta a mezzo delle parole, è anche un atto di comunicazione. Se noi astraiamo, ad esempio, dall’atto del promettere, nella sua interezza, l’atto con cui si comunica che si sta promettendo: da questo punto di vista, che è quello dell’atto di comunicazione, la asimmetria che sussiste, al livello pragmatico, fra “io prometto…” e “tu prometti…”, scompare per il necessario istaurarsi della simmetria dei ruoli, che caratterizza il concetto di comunicazione. Quando il parlante dice “io prometto…”, ciò che egli comunica non è l’azione del promettere: le azioni non si comunicano, si compiono e soltanto interagiscono con altre azioni; ciò che il parlante comunica è il significato dell’azione che compie, che, se la comunicazione riesce, deve risultare identico per il parlante e per l’ascoltatore. Se invece consideriamo l’atto del promettere nel suo carattere pragmatico, come un’azione compiuta a mezzo delle parole, dovremo collocare questa azione linguistica sull’asse della asimmetria dei ruoli, del parlante e dell’ascoltatore, e allora il pronome “io” presente in alcuni tipi di enunciati performativi espliciti assumerà tutto il suo spessore pragmatico, e caratterizzerà l’operazione del parlante, nella sua contrapposizione a quella dell’ascoltatore. Un altro problema, che può essere trattato dal nostro punto di vista della simmetria e asimmetria dei ruoli, è quello delle presupposizioni. Vediamo anzitutto l’aspetto semantico delle presupposizioni. Supponiamo che il parlante pronunci i seguenti enunciati, in direzione dell’ascoltatore: a: i figli di Giovanni sono ammalati. b: Pietro è ritornato dagli Stati Uniti. In questi enunciati vi è qualcosa di esplicito e qualcosa di implicito (presupposto). Il contenuto implicito del primo enunciato, a , la sua “presupposizione”, è che “Giovanni ha dei figli”; il contenuto implicito del secondo enunciato, b , è che “Pietro è partito per gli Stati Uniti dal luogo in cui si trovano il parlante e l’ascoltatore”. Supponiamo che questi enunciati siano detti da un parlante che vuole soltanto informare l’ascoltatore di certi fatti. Le presupposizioni dei due enuncia- SAGGI ti, a e b, che “Giovanni ha dei figli”, e che “Pietro è partito per gli Stati Uniti”, hanno, dunque, un carattere essenzialmente semantico. È evidente che non troviamo delle presupposizioni di carattere semantico anche in enunciati diversi dalle asserzioni, come, ad esempio, le interrogazioni. Ma vediamo, ora, il carattere pragmatico delle presupposizioni. Consideriamo ancora l’atto illocutorio della promessa. Quando si compie una promessa si presuppongono due cose, che il parlante abbia veramente l’intenzione di fare ciò che promette e che l’ascoltatore lo desideri. Questi due fatti o”presupposizioni”, che riguardano distintamente il parlante e l’ascoltatore, sono stati definiti da Searle come due delle condizioni necessarie per la perfetta realizzazione dell’atto illocutorio della promessa. Tali presupposizioni rivelano chiaramente il loro carattere pragmatico perché sono fondate sulla asimmetria del rapporto parlante –ascoltatore. Su questo piano propriamente pragmatico, non dipende certamente dall’ascoltatore che il parlante abbia veramente l’intenzione di fare ciò che promette, come non dipende dal parlante che l’ascoltatore desideri quella certa cosa che il parlante promette di fare. Quando, nell’atto linguistico del promettere, anche una sola di queste presupposizioni non viene soddisfatta, l’atto linguistico risulta fuori della norma. Adoperato il termine condizione usato da Searle possiamo dire che la presupposizione è la condizione implicita dell’atto del promettere. Se il parlante dice “prometto che partirò”, sono condizioni implicite di questo atto illocutorio sia che il parlante voglia partire, sia il fatto che l’ascoltatore desideri che il parlante parta. C’è un esplicito e un implicito. Si hanno due impliciti di origine diversa, uno riguarda il parlante, e l’altro riguarda l’ascoltatore, e si determinano sull’asse della asimmetria dei ruoli. Un altro esempio di questa asimmetria, legata al carattere pragmatico delle presupposizioni, si determina altrettanto chiaramente nell’atto illocutorio dell’ordine. Alla differenza e asimmetria dei ruoli, di chi impartisce l’ordine e di chi lo riceve, è correlativa una differenza e una asimmetria di presupposizioni. La presupposizione che riguarda l’atto compiuto dal parlante è distinta e diversa da quella che riguarda l’ascoltatore. La presupposizione che riguarda l’atto compiuto dal parlante è il fatto che egli si senta autorizzato a compiere l’atto in virtù della superiorità della sua posizione sociale rispetto all’ascoltatore, la presupposizione che riguarda l’ascoltatore è il fatto che egli si sente obbligato, nella sua partecipazione all’atto illocutorio dell’ordine, a causa della inferiorità della sua posizione sociale rispetto al parlante. Da un lato, quello del parlante, l’implicito è il fatto di sentirsi autorizzato, dall’altro lato, quello dell’ascoltatore, è il fatto di sentirsi obbligato. Tali presupposizioni sono parti integranti dell’atto illocutorio dell’ordine nel suo carattere di normalità. In questo senso l’implicito è parte integrante dell’esplicito. Se si esce dalla normalità, le presupposizioni possono venire a mancare. In teoria un soldato semplice, che non si sente autorizzato, può dare un ordine ad un capitano che non si sente obbligato. Prima di terminare, vorrei accennare soltanto agli usi linguistici dei pronomi io e tu, per porre in evidenza i due aspetti, pragmatico e semantico, di tali usi. Consideriamo gli atti illocutori, ormai familiari, dell’ordine e della promessa: 15 Io ti ordino di… Io ti prometto di… In questi atti illocutori, io e tu impersonano ruoli differenti, che caratterizzano l’aspetto pragmatico dei rispettivi usi. Io significa solo ciò che può fare il parlante, tu significa solo ciò che può fare l’ascoltatore, la sua partecipazione pratica nell’atto illocutorio. Io e tu sono collocati in un asse asimmetrico, in quanto rappresentano i due ruoli differenti del parlante e dell’ascoltatore e le rispettive presupposizioni. Ed ora prendiamo in esame l’altro aspetto, quello propriamente simmetrico, dell’uso di io e di tu. Gli stessi enunciati, “io ti ordino di…”, “io ti prometto di…”, considerati semplicemente come atti di comunicazione, come atti mediante i quali il parlante vuol soltanto far sapere qualcosa all’ascoltatore, e l’ascoltatore vuole solo comprendere ciò che gli dice il parlante. Sappiamo che, ormai, nell’atto di comunicazione vige il principio della simmetria e della reciprocità dei ruoli. L’io è pensato nello stesso modo dal parlante e dall’ascoltatore, esattamente come il tu. Il significato di “io” e il significato di “tu”, divengono identici, nell’atto di comunicazione, per il parlante e per l’ascoltatore10. 16 1 C. MORRIS, Foundations of the Theory of Signs, in Writings in the General Theory of Signs, Mouton, L’Aja 1971. 2 J.R. SEARLE, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, Rodon 1970, p. 63. 3 U. ECO, Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino 1984, pp. 68, 69. 4 J. R. SEARLE, Dell’Intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, tr. it., Bompiani, Milano 1985, pp. 166, 167. 5 Ivi, pp. 173, 174. 6 J.R. SEARLE, D. VANDERVEKEN, Foundations of illocutionary Logic, Cambridge 1985, p. 21. 7 G. GAZDAR, Pragmatics, Presupposition, and Logical Form, Academic Press, New York 1979; R.R. KEMPSON, Presupposition and the Delimitation of Semantics, Cambridge University Press, London 1975. 8 G. LEECH, Principles of Pragmatics, Longman, London 1983; R. KEMPSON, Presupposition and the Delimitation of Semantics, Longman, London 1975. 9 Questa posizione viene assunta, ad esempio, da J.J. KATZ e D.T. LANGENDOEN nell’articolo Pragmatics and presuppositions, “Language” 1, 1978. 10 A questo concetto della reciprocità, che caratterizza i pronomi “io” e “tu”, nel loro carattere semantico, sembra alludere Oswald Ducrot, che cita una definizione del linguista Benveniste; ma tanto Benveniste quanto Ducrot non pongono in luce l’aspetto più importante della reciprocità, quello che, presupponendo la rigorosa distinzione dei caratteri semantico e pragmatico dell’atto linguistico, rivela quel senso della reciprocità che è fondato sul concetto di comunicazione. Ducrot esprime la sua tesi con questa affermazione: “Ciò che è determinante nel pronome io, non è tanto il fatto che esso costituisce un mezzo abbreviato per parlare di sé, quanto, piuttosto, che esso obbliga colui che parla a designarsi con la stessa parola che il suo interlocutore utilizzerà a sua volta per designare se stesso. L’uso di io (lo stesso vale per il tu) costituisce dunque un apprendimento e un esercizio permanente della reciprocità [… ] Benveniste riassume questa tesi dicendo che i pronomi personali marcano la presenza dell’intersoggettività all’interno della lingua stessa”. (Dire et ne pas dire, Paris 1972. p. 3). RELIGIONE CRISTIANA E RELIGIONE APERTA: LINEE DI UN CONFRONTO L’opera e la figura di Aldo Capitini nella cultura italiana del Novecento non posseggono, a tutt’oggi, che nebulosi contorni. Basti pensare, ad esempio, a quanto sia limitato il numero di persone che riconosce in lui l’ideatore della Marcia della pace Perugia-Assisi. Non che Capitini non goda di una lusinghiera bibliografia quanto a numero di titoli. Ma il valore di questi testi, tranne alcune, anche recentissime, lodevoli eccezioni, è complessivamente modesto. E se una lacuna più di altre può distinguersi, questa attiene alla dimensione filosofico-religiosa del suo pensiero. Troppo spesso a quanti si interessano di nonviolenza la sua palese inclinazione religiosa si direbbe apparire come una superflua, quando non imbarazzante, appendice. E, naturalmente, questo non è che un modo, il più evidente forse, di tradire l’indiscutibile complessità del suo patrimonio intellettuale. Il rispetto per un pensatore comincia innanzi tutto dalla volontà di prenderlo in parola; è sufficiente dare una rapidissima scorsa ai titoli dei libri di Capitini e vedere quante volte le parole “religione”, “religioso” e “religiosa” ritornano per rendersi conto che una simile insistenza non solo non può essere casuale, ma testimonia un’opzione fondamentale e decisiva, sminuire la quale è un azzardo che chiunque intenda soffermarsi su di lui con una qualche meditata attenzione non può certo commettere. Lo scritto che segue trova la propria ragion d’essere nel tentativo di analizzare alcuni nodi fondamentali –sebbene altri se ne possano trovare– della prospettiva religiosa di Capitini, da lui stesso sintetizzata nella formula “religione aperta”. In essa s’intersecano mondi culturali diversi e la struttura concettuale che la contraddistingue si chiarisce in un ampio confronto fra svariati motivi, appartenenti tanto al pensiero laico e filosofico quanto alla tradizione strettamente religiosa. Mi pare si possa comunque dire che i componenti prioritari di questo intreccio sono: l’eredità cristiana, essenzialmente nel richiamo alla sua fonte evangelica, il criticismo kantiano, l’idealismo (tanto Hegel quanto Croce e Gentile), l’analisi marxiana, alcuni temi delle filosofie dell’esistenza e la spiritualità gandhiana. Analizzare con precisione critica il diverso apporto dato alla religione di Capitini da queste differenti fonti, ricostruire il contesto intellettuale della loro apparizione nel pensiero capitiniano, cogliere le reciproche influenze e ripercorrere le affinità tra questi molteplici “strati”, confrontarne gli esiti con alcune delle maggiori correnti filosofiche e religiose costituirebbe il, non agevole, compito di un intero libro. E si tratterebbe di un lavoro assolutamente meritorio, poiché al momento un libro siffatto non esiste. Questo articolo dal canto suo si propone, in modo assai più semplice, di SAGGI di Massimiliano Fortuna 17 18 ravvisare l’importanza che la religione cristiana possiede nell’opera capitiniana, e nel far questo coglie, come detto, l’occasione per tentare di fornire un contributo alla comprensione della religione aperta. Lo scritto è suddiviso in tre paragrafi, il primo dei quali cerca di mettere in luce i più significativi punti di tangenza che possono riscontrarsi tra cristianesimo e religione capitiniana, il secondo, all’opposto, ne evidenzia le maggiori differenze, e il terzo tenta di abbozzare qualche considerazione generale, sottolineando innanzi tutto il posto centrale che l’escatologia occupa nelle pagine di questo autore. Chi scrive è guidato infatti dalla convinzione che la cristiana idea di salvezza costituisca l’eredità di maggior rilievo nella delineazione del nucleo più profondo della religione di Capitini, e che il serrato corpo a corpo ingaggiato da quest’ultimo nei confronti dell’istituzione cattolica possa, al limite, leggersi come il tentativo di presentare se stesso come un erede del cristianesimo originario più autentico della Chiesa Romana, quasi, per adoperare parole sue, “il ricercatore e il costitutore di una vita religiosa, in contrasto con quella tradizionale, leggendaria, istituzionale, autoritaria”1. Alla base delle pagine che seguono è sottesa l’idea che l’apparato filosoficoreligioso capitiniano possegga un rigore concettuale e linguistico indiscutibile, la cui decifrazione non può che essere il risultato di pazienti e scrupolose ricerche; la sua “persuasione” religiosa non corrisponde in alcun modo ad un generico rispetto per la vita umana o ad una abborracciata e semplicistica silloge ecumenica, ma ad una precisa prospettiva a cui occorre avvicinarsi facendo uso delle più adeguate categorie ermeneutiche che l’analisi critica ci fornisce. Un terreno comune Dico dunque: io ho, insieme con tutti gli esseri esistenti. E per un eguale moto dico: io sono, insieme con tutti gli esseri presenti (intendendo per presenza l’essere apparsi, anche un istante solo che è infinito, nella storia). Al mio operare secondo i valori sono intrinsecamente presenti anche quelli che sembrano non operare più. Come l’avere i beni economici mi lega a tutti gli esistenti, così l’operare per i valori mi unisce a tutti gli esseri che ne sono o furono capaci, anche se morti, perché essi, solo che siano nati, hanno portato nel loro intimo un valore, ed il valore non muore: vivono con esso. Per la persuasione etica sociale voglio che tutti gli esistenti fruiscano dei beni economici esistenti; per la persuasione religiosa sento che alla creazione continua dei valori spirituali tutti sono infinitamente presenti, anche chi sembra non essere più2. Questa distinzione tra etica e religione non trova molti altri riscontri nelle pagine di Capitini: non mi pare venga mai formulata esplicitamente prima di tale passo e raramente lo sarà in seguito. Tuttavia per intendere la centralità e l’imprescindibilità del religioso in Capitini non si può partire che da qui: dalla consapevolezza, cioè, che se esiste un tentativo di chiarificazione concettuale, attinente a categorie classiche di pensiero, in grado di riepilogare la tensione che con maggior vitalità sorregge la sua pagina, questo non è altro che il tentativo di “distinguere il momento religioso dal momento morale, con cui generalmente, e i migliori, lo confondono”3. SAGGI Una cosa emerge da subito come la più evidente: lo “sguardo” della religione punta verso una direzione che l’etica non contempla: quella dei morti, di coloro il cui esistere sociale è venuto meno. Il discrimine tra etica e religione risiede innanzi tutto in una diversa valutazione in merito all’“altro” a cui rivolgere la propria attenzione. Capitini chiarisce che la responsabilità che l’uomo religioso avverte non resta circoscritta ad una dimensione che comprenda unicamente le creature viventi; la prospettiva che lo contraddistingue è all’insegna di un ampliamento, o più correttamente di un’aggiunta. Si tratta di transitare da una realtà parziale, quella dei vivi (gli esistenti), ad una realtà assoluta, volta ad incorporare anche coloro che hanno cessato di vivere (i presenti). La persuasione etica sociale, come Capitini la definisce, si ferma alla prima realtà, la religione raggiunge la seconda; e nel raggiungerla entra in possesso di una radicale verità entro la quale tutto il reale si incardina: i morti non muoiono, la morte non è che un inganno della vitalità, un tranello biologico nel quale il religioso (vero persuaso) evita di restare impigliato e che ha il compito di palesare a tutti, indicando –profeticamente, se si vuole– l’aggiungersi della vita dietro l’apparenza della morte. Afferrare senza esitazioni e con immediatezza l’esigenza di questa aggiunta significa aver posto l’orecchio sul battito vitale che sorregge l’intero pensiero capitiniano, poiché è sull’asse vita-morte che il seguente pensiero si gioca e solo in modo derivato su quello, di gran lunga più noto e indagato, nonviolenza-violenza: questa seconda antitesi, per quanto assolutamente centrale in Capitini, non costituisce che una specificazione della prima. Nel dire etico-sociale Capitini definisce uno spazio che è il medesimo della politica; valori etici e valori politici non si situano per lui in una scala gerarchica, né stanno fra loro in opposizione, né occupano ambiti autonomi e reciprocamente distinti: semplicemente costituiscono un’identità; la politica autenticamente intesa risponde ad esigenze etiche e l’etica non può evitare di trovare il proprio sbocco nell’azione politica e sociale. Ma nemmeno tra sfera etico-politica e sfera religiosa si dà una qualche contrapposizione, anzi una continuità profonda le attraversa: tutto il discorso di Capitini lascia facilmente intendere –anzi esplicitamente sottolinea– che il vero impegno politico è quello capace di dotarsi di uno sguardo religioso. Essere un riformatore religioso era infatti il ruolo che, con tutta probabilità, rivendicava prioritariamente per se stesso: e nella riforma religiosa dovevano conseguentemente rinvenirsi le condizioni di una nuova socialità (nuova anche perché non più solo strettamente politica); non è certo casuale che queste due espressioni si trovino accostate nel titolo di uno dei suoi libri più chiarificatori del vicendevole implicarsi di politica e religione. Ci si potrebbe innanzi tutto chiedere se l’uso della parola “riforma”, non costituisca di per sé la spia di una solidarietà essenziale tra religione cristiana e religione aperta. La volontà di riformare dovrebbe presupporre infatti un nucleo, già esistente, di idee religiose al quale si intende conferire una “nuova forma”. E questo nucleo, più che in qualsiasi altro movimento religioso, sembra proprio rinvenirsi nel cristianesimo: è il cristianesimo, pur non trascurando, nella sua mai circoscritta passione spirituale, altri patrimoni culturali, la religione che Capitini intende “aprire”. Ma sviluppare in pienezza e libertà le potenzialità di apertura interne ad esso significa inesorabilmente porsi in una condi- 19 20 zione di critica e di rifiuto nei riguardi della tradizione cattolica, vale a dire di una “versione” della religione cristiana che ne ha stravolto, o al limite visibilmente usurato, l’originaria forza d’urto nei confronti della società e delle “chiusure” che la perpetuano –non si presti dunque un’attenzione marginale al fatto che nella religione di Capitini, come, più o meno larvatamente, in ogni posizione che risenta vivamente della suggestione del cristianesimo evangelico, traluce un’immediatezza politica. Alla distinzione tra etica e religione se ne sovrappone una seconda, che Capitini mostra di avere ben chiara sin da quegli Elementi di un’esperienza religiosa che segnano il suo esordio saggistico: quella tra libertà e liberazione. La libertà, come si può intuire, corrisponde al supremo obiettivo di chi agisce circoscrivendosi in un terreno solo etico-politico, la liberazione costituisce lo sbocco finale di un’esigenza religiosa. Se ci immaginiamo, come Capitini stesso suggerisce, la libertà collocata su di un piano posto orizzontalmente e la liberazione su di un piano verticale, abbiamo una figura in grado di ricapitolare simbolicamente la distinzione tra le due dimensioni, ma anche il nesso capace di unirle. La libertà sociale, per trovare realizzazione, ha bisogno di radicarsi in un riconoscimento reciproco; ognuno è realmente libero nella misura in cui permette anche all’altro di considerarsi tale: una società giusta non può che essere quella in cui a ciascuno viene riconosciuta la propria “porzione” di libertà è una linea a cui si direbbe fatale l’irrigidirsi nello spazio asettico del diritto; e il mondo del diritto per Capitini, pur nell’inevitabile rispetto dovutogli, fonda un modo di esistere basato sulla separazione e come tale insufficiente. Se la libertà è all’insegna di un distanziarsi, l’agire nel quale la liberazione condensa il proprio senso originario mira ad un avvicinamento: donare senza pretendere nulla in cambio, senza voler ricevere in misura proporzionata a quel che si dà –è questa la direzione che la religione persegue allo scopo di colmare ciò che al diritto fa difetto. Pervenire ad un’unione sostanziale (intima) e non semplicemente formale (esteriore), non risponde ad altro la motivazione del persuaso: poiché unicamente da “questa liberazione intima sorge l’esigenza della libertà sociale, non come un diritto (come se qualcuno ce la dovesse dare), ma come un dovere: come è dovere l’esercitarla in sé cercando strenuamente il meglio”4. Se si rimane nell’ambito della vita (in quanto entità biologica), come la politica fa, non si può che aspirare a rimedi parziali: il diritto è uno strumento utile unicamente a disciplinare5, migliorandolo in direzione di un valore, ciò che vive e che, in quanto vivo, mantiene una inevitabile correlazione con la morte, ha un termine. Ma la persuasione religiosa pretende di cogliere, dietro questo tempo parziale del vivere, quel che non ha termine e non muore: l’eternità della presenza; e nell’estendere questa ad ogni creatura che è stata viva giunge ad intenderla come presenza di tutti, come compresenza. Alla parzialità della politica la religione risponde arrogandosi un compito assoluto: liberare definitivamente la vita dalla provvisorietà che la contrasta, permettere alla compresenza di emergere. Se la libertà si arresta alla direzione presente-futuro, nella liberazione SAGGI anche il passato converge nella sua interezza. Credere che la società, e con essa l’intera realtà, possa divenire non soltanto libera, ma totalmente liberata dal dolore e dal morire sarà dunque l’aspirazione di chi, come Capitini, è guidato dalla convinzione che il piano orizzontale della politica e quello verticale della religione non vadano disgiunti e che si debba diventar capaci di “vedere la liberazione sociale entro la liberazione religiosa”6. Individuata la matrice religiosa in un impulso alla liberazione, resta da chiedersi in quali precise forme Capitini prospetti questa liberazione. Una polarità di fondo difficilmente eludibile, e sufficiente ad impostare un discorso introduttivo, emerge con relativa facilità: quella che può rinvenirsi nella distinzione tra una liberazione acosmica ed una liberazione storica. La prima intende il liberarsi come un liberarsi da qualcosa: dal mondo, dalla storia, dalla realtà umana, dal tempo, dalla materia. Nella seconda la liberazione avviene con qualcosa: con il mondo e così via. Salvarsi acosmicamente vuol dire essenzialmente evadere da una realtà (storica) degradata: fuggendo da quel che appare reale, senza esserlo, in direzione di quanto è pienamente reale, transitando da un livello inferiore ad uno superiore, trasferendosi in un altro luogo, passando al di là. Salvarsi storicamente, al contrario, indica la necessità di attuare la redenzione attraverso la storia, ed anche per mezzo di essa, nel presupposto che il compito non sia, in concisione estrema, liberarsi dalla realtà in cui ci si trova ma renderla libera. Il cristianesimo e le altre religioni abramiche prefigurano, in modo inedito rispetto al restante panorama religioso (eccezion fatta per il mazdeismo), quest’ultimo tipo di salvezza7. Se ci si domanda quale di queste due biforcazioni imbocchi l’esigenza della liberazione avvertita da Capitini, la risposta non può che pendere verso una liberazione intesa storicamente. La salvezza tanto invocata nelle sue pagine non ha nulla a che vedere con una via di redenzione individuale: quella di Capitini non è una soteriologia, un salvarsi da soli dopo aver negato il mondo, ma un’escatologia, un salvarsi insieme, con gli altri, mutando il mondo ma conservandolo al medesimo tempo. Non sembra facile negare che la Novella al centro dei Vangeli testimonia di una redenzione che investirà e rinnoverà la creazione, senza disconoscerla nella sua concretezza: la salvezza rivestirà questo mondo, liberandolo per sempre dal dolore e dalla morte, ma sarà appunto questo mondo ad essere trasfigurato, essendo la vittoria sul peccato soltanto la vittoria su ciò che lo limita e non sulla sua intera consistenza reale. Analogamente, in Capitini la liberazione non è “emigrazione dalla terra” attraverso cui approdare “a luogo migliore”, ma “la liberazione è trasformazione qui della natura”8. Date queste premesse si direbbe innanzi tutto agevole intuire quel che Capitini non è. Un mistico, per prima cosa. I suoi interpreti più avvertiti non hanno faticato ad accorgersene, dal momento che a sottolinearlo è lui stesso: “Non è difficile vedere che alla concezione della migrazione verso altra terra sono simili le concezioni mistico-spaziali, per cui l’individuo si salva spostandosi spazialmente verso il Tutto, il Valore, la Realtà assoluta, la Beatitudine”9. Ma misticismo è parola ambigua, al cui interno si sono sedimentati nel tempo significati molteplici ed eterogenei, ricondurre i quali ad una qualche unità dotata di 21 22 senso ed uniformità non pare impresa possibile. All’interno della tradizione cristiana, ad esempio, sembra doveroso distinguere perlomeno tra due forme di misticismo. La prima è una mistica di derivazione neoplatonica, della quale è capostipite lo Pseudo-Dionigi, improntata su di un processo di ascesa e di innalzamento verso una realtà superiore, culminante nella riunione con una Trascendenza per la quale la dimensione terrena costituisce una distante appendice: è un misticismo che viene definito dell’immagine, ruotante attorno all’idea di identità, un misticismo estatico (o ancor meglio instatico), volto al raggiungimento di una salus individuale. Ma, soprattutto a partire dalla riscoperta francescana dell’integrale divinità del cosmo e della centralità della tenerezza nel Cristo evangelico, non manca una mistica dell’amore, incentrata sulla somiglianza degli esseri creati e sul loro reciproco corrispondersi, che, con l’occhio volto innanzi tutto al mistero dell’incarnazione, si sostiene sulla consapevolezza che “la presenza di Dio” si trova “nella creazione più che al di là della creazione”10 –è la mistica di Ildegarda di Bingen, Caterina da Siena, Teresa d’Avila. Il non misticismo di Capitini si chiarisce se posto a confronto con il primo tipo di mistica, non certo con il secondo11 –basti considerare il risalto di Francesco d’Assisi nelle sue pagine. Ma, soprattutto, approfondendo il senso di questa distinzione è possibile giungere in prossimità di uno dei perni concettuali attorno a cui la fenomenologia religiosa di Capitini incessantemente ruota. Misticismo dell’immagine e misticismo dell’amore sono sostanzialmente inconciliabili, perché fanno riferimento a due matrici culturali che non è possibile assimilare, se non a prezzo di un aperto sincretismo. In sintesi: se l’immagine si trova in rapporto con una visione, l’amore è a contatto con un’azione. Nel primo caso si fa capo alla categoria greca del vedere, nell’altro si è immersi nella centralità neotestamentaria, e più generalmente biblica, del fare. Qualsiasi pagina di Capitini si apra, sarà questa centralità a venirci incontro: anche per lui Dio non si svela in ciò che è visto ma in quel che viene compiuto; la ricerca non ha termine in un Essere da contemplare ed in cui eventualmente annullarsi misticamente (quale mistica si è detto), ma in un atto da svolgere. Non è l’affinarsi delle potenzialità visive, la teoresi, a condurre al cuore del divino e della verità, ma la capacità di realizzare qualcosa, la prassi, a permetterlo. Riuscire a scorgere cosa possa differenziare l’amore evangelico dalla prassi capitiniana non è impresa troppo semplice; la nonviolenza assomiglia molto ad una solidificazione pratica dell’originaria agape cristiana, per sua essenza attiva e creatrice di vincoli comunitari, e per nulla all’eros greco, radicato nel desiderio dell’anima di attingere il mondo sovrasensibile12. La predilezione di Angela da Foligno per il Dio che si dà rispetto al Dio che dà può bene indicare, meglio forse di qualsiasi altra sintesi più nutrita, l’amore a cui Capitini rivolge la sua attenzione13. A muoverlo è una sorta di istinto, di dedizione fiduciosa e incrollabile: la certezza, ma si potrebbe dire fede, che il mondo, nel suo nucleo inscalfibile, risponde ad un atto d’amore, un atto che, nelle nervature che egli cerca di far emergere nella loro elementare chiarezza, ha come dimensioni essenziali la coralità e la sovrabbondanza. Nessun essere vivente è immeritevole d’amore e nessun limite interno può realmente impedire a questa assolutezza d’amore di estinguersi o arenarsi –la sua stessa scrittura sembra conti- SAGGI gua ad essa ed incapace di sottrarvisi: un’equilibrata fusione di entusiasmo e serenità è la cifra ricorrente anche delle pagine più cupe di Capitini. L’amore come forza che anima un Dio di consolazione, l’incondizionata vicinanza alle creature, non abbandonate in balìa della morte e non lasciate a disperdersi nella loro naturale fragilità, sono l’innegabile collante che tiene unite divinità cristiana e compresenza; quando Capitini si rivolge a questa ritraendola nel seguente modo, non sembra quanto mai prossimo al Dio neotestamentario: “sa profondamente ciò che è ciascuno di noi, ci giudica e ci aiuta e sorregge continuamente, collabora nei valori, si aggiunge, perdonando, all’essere individuo”?14 Non amore senza meta, né universalismo umanitario: scrutare volti presenti e curare miserie concrete segnano in Capitini i prodromi indispensabili di ogni vero agire15; gli abbandoni mistici a cui non poteva impedirsi di guardare con sospetto gli dovevano sembrare, nell’ebbrezza dell’annichilirsi in Dio, una sorta di esaltazione di un amore astratto e fine soprattutto a se stesso: in questo amore per l’amore scorgeva probabilmente un possibile capostipite, seppure di stoffa nobilissima, di quell’azione per l’azione di cui i fascismi del ventesimo secolo si sono nutriti. Il male di Capitini è il male biblico; il dolore nella sua agghiacciante consistenza fisica e la concretezza innegabile del morire sono le due colonne d’Ercole che il suo pensiero riconosce in tutta la loro spaventosa imponenza: se si decide ad oltrepassarle è unicamente in nome di quella radicale escatologia che lo contraddistingue, non certo di un irenismo di maniera o di una facile teodicea. Non c’è dubbio sul fatto che Capitini abbia saputo tenersi a distanza di sicurezza da qualsivoglia tentazione di spiritualizzare la sofferenza, vero e proprio buco nero attorno al quale gli idealismi di ogni sorta gravitano sino ad esserne immancabilmente risucchiati. L’attenzione alla carne, in Capitini come nel cristianesimo evangelico, testimonia un’ulteriore tangenza tra i due, che sfocia in una reale prossimità antropologica. Di comune si ritrova innanzitutto, ed è, se si vuole, l’aspetto più generico, un’indomita attenzione agli ultimi; l’occhio di Capitini non sospende mai di vigilare su ogni forma di emarginazione: la tenerezza che egli profonde verso i deboli, il desiderio di non veder sopraffatti gli inermi, la costante vicinanza ai socialmente reietti ed ai limitati fisicamente non consentono paragoni, se non con pochissimi autori del Novecento: e i nomi, quando si rinvengano, fanno molto più probabilmente parte dell’ambito letterario che di quello rigidamente filosofico. E, già s’è visto, la reazione a questo dolore tanto intensamente avvertito non si arresta ad una condivisione della pena di vivere, Capitini non si limita a compatire coloro che soffrono il peso di un male diffuso e universale ma attende che sopraggiunga, più rapida possibile, una redenzione: svellere il dolore una volta per sempre è il gesto, ancora evangelico, che occupa integralmente il suo orizzonte. Ma la corrispondenza che deve forse venir sottolineata con maggiore risalto è quella che intercorre tra la cristiana resurrezione dei corpi e il modo d’essere nel quale la compresenza finirà per manifestarsi in una realtà liberata. Capitini riserva ben più che semplici accenni all’idea di un rinascere rivestiti di una corporeità nuova e trasfigurata: 23 La vita religiosa è aperta alla trasformazione del corpo e dell’universo, che è corpo di tutti, e si appassiona per la realtà di tutti che comprende anche chi ha il corpo malato e difettoso […]. L’appassionamento religioso per la realtà di tutti non è perché essa resti una cosa separata, ma perché cresca con un nuovo corpo e un nuovo universo adatti ad una realtà liberata16. 24 In Capitini la natura è l’ostacolo alla liberazione che la compresenza deve investire con la sua spiritualità e trasformare, come lo Spirito cristiano coinvolge il cosmo creato in una rinascita a nuova vita. Certo, la natura ed il corpo naturale sono abissale mancanza tanto in Capitini che nel cristianesimo, ma una volta depurati da questa mancanza e, per così dire, riplasmati, non si trovano esclusi dalla salvezza. Capitini sembra vicino ad intendere l’uomo quale unità non scindibile di esteriorità e interiorità, con un reciso rifiuto dell’irrimediabile dualismo platonico tra anima e corpo, in cui l’immortalità è riservata alla prima soltanto: ma questo rifiuto lo pone sulla linea di quel protocristianesimo che, ancora prossimo alla sua progenitura ebraica, non guardava all’anima e al corpo come a dimensioni irriducibili, ma come a due parti di una medesima unità che lo Spirito di Dio ha il potere di tener viva in eterno. La dedizione di Capitini alla carnalità umana e alle altissime sofferenze che la coinvolgono, sembra rientrare di conseguenza in una pienezza escatologica che non scorge nel corpo un’imbarazzante appendice che la liberazione conclusiva può tralasciare; non si dimentichi del resto che l’immagine capitiniana della festa come prefigurazione e anticipazione della realtà liberata si direbbe assai vicina ai banchetti vetero e neotestamentari, piuttosto che a rarefazioni nirvaniche (per quanto diverse e composite possano esser le versioni che del nirvana si sono date). Non manca, glossa a quanto si è appena scritto, un’ultima acuta convergenza con il cristianesimo: il convincimento, che deve restar sotteso ad ogni nostra azione, che l’atto all’origine del vivere debba venire inteso in primo e decisivo luogo come dono. La gioia di trovarsi nella vita, per quanto bisognosa di redenzione possa essere, e non nel nulla scava uno iato incolmabile rispetto a quell’aspirazione a non essere mai nati che è stata uno degli alimenti principali a cui la vena tragica della grecità si è nutrita e che costituisce, ad esempio, anche lo sfondo uniforme di quel Michelstaedter che Capitini amava. Divergenze “Non si dice cristiano; tuttavia gli sta sommamente a cuore l’avvenire del cristianesimo”17. Se si fosse costretti a compendiare in una riga soltanto tutto quel che in Capitini ruota attorno al problema religioso, queste parole di Fabrizio Truini si presenterebbero alla stregua di una formula quasi rituale. Difficile non avvertire del tutto come il non dirsi cristiano si stagli costantemente, e si direbbe con inevitabile consapevolezza, sullo sfondo di un terreno religioso fecondato dalle più profonde aspirazioni cristiane. Potrebbe un autore le cui pagine sono ripetutamente attraversate da espressioni come Provvidenza, Grazia, Resurrezione, Regno di Dio, pentimento, confessarsi, A me sembra che la piena realizzazione del principio sommo dell’unità amore per tutti, e dell’apertura ad una realtà liberata che finalmente comprenda tutti, sia attraversato, impedito, frustrato da quegli elementi tradizionali che Don Mazzolari conserva, e che gli fanno porre dei dilemmi religiosamente ormai inaccettabili, perché risultanti da residui di religioni primitive, crudeli, esclusivistiche. Come si può dire che “se Cristo è il Risorto, il suo Vangelo tiene, con neanche uno jota fuori; se non è il Risorto, tutto cade e diviene folle?”18 La tensione religiosa di un cristiano è però basata proprio sulla convinzione che la resurrezione di Gesù costituisca la primizia di un evento che, nel suo punto terminale, finirà per coinvolgere anche il resto dell’umanità: sottratta questa primizia, tutta la fede che ne segue vacilla e, se è certamente indubbio che la lezione dell’amore permane intatta nella sua validità, la redenzione attorno a cui i Vangeli ruotano inevitabilmente si dissolve. Per Capitini, semplicemente, la salvezza dell’umanità non si trova in balìa di alcuna primizia escatologica, non essendo Gesù di Nazareth un uomo differente dagli altri e, nello specifico, perché quella resurrezione attestata dai Vangeli non è mai avvenuta. L’atteggiamento tenuto nei riguardi della figura del Cristo neotestamentario richiama quella scuola interpretativa che viene definita critica o storicista, scuola che ha avuto in Loisy un maestro riconosciuto e in Buonaiuti e Martinetti i più noti esponenti italiani: nomi che nelle pagine di Capitini non è difatti raro incontrare. Il Gesù evangelico corrisponde ad un uomo storicamente esistito, uomo che si è reso protagonista per Capitini di una straordinaria, forse senza uguale, apertura religiosa: ma di un uomo si tratta e non di Dio. Posto questo ne risultano sfrondati non solo, e non tanto, i corollari miracolosi che la tradizione ha attribuito alla nascita e alla vita di Gesù, ma soprattutto l’idea che la salvezza si strutturi seguendo lo svolgersi di eventi storici dei SAGGI paradiso, perdono, incarnazione, considerarsi avulso dal sentire cristiano, estraneo alle speranze che al cristianesimo hanno permesso di radicarsi e diffondersi? Meglio, potrebbe un autore nel quale alla speranza è concesso un ruolo di rilievo, essere privo di relazioni proprio con il movimento spirituale che ha introdotto in Occidente l’orizzonte stesso della speranza? Evidentemente no, e fino ad ora il tentativo è stato precisamente quello di mostrare i risvolti più consistenti di questo legame. Ma accanto ad essi non si può naturalmente mancare di evidenziare anche ciò che separa. Per Capitini è innanzi tutto non credibile quel che per un cristiano costituisce il mattone a partire dal quale il resto del suo credo trova fondamento: l’accettazione della messianicità di Gesù di Nazareth. Nell’indicare la salvezza come luogo in cui il mondo pone fine al suo perpetuarsi nell’orizzonte della morte e del soffrire, Capitini non si avvale di un mediatore privilegiato. L’ipotesi che un uomo soltanto possa esser ritenuto il collante della redenzione universale, ai suoi occhi è destituita di qualsiasi plausibilità: sorge su di una linea di chiusura non di apertura. Ipotesi che pare rigettata quasi nel rifiuto di intenderla nella sua radicalità: ad esempio quando rivolto a Don Mazzolari in toni che, considerati in proporzione alla sua abituale estrema pacatezza, possono dirsi addirittura aspri Capitini sottolinea: 25 26 quali l’Antico e il Nuovo Testamento sarebbero i custodi e che l’incarnazione attraverso la quale Dio si rivela compiutamente costituisca un unicum assoluto: centro attorno a cui tutta la storia umana converge per rinvenire la propria fonte di senso. Sono appunto queste le conclusioni che Capitini trae. Se l’incarnazione non può dirsi un unicum, nemmeno la rivelazione lo può. “Moltiplicare” Cristo per il numero complessivo degli esseri viventi non è che un modo più suggestivo di definire la compresenza: tutto quel che vive si deve ritenere, al medesimo titolo, discesa nella morte e potenziale contributo alla sua disfatta. E qualsiasi uomo conserva in se stesso la possibilità di pervenire a questa fondamentale verità, senza dover ricorrere ad una voce soprannaturale. Così la storia della salvezza, se in Capitini è possibile rinvenirne una, ed a me pare la si possa rinvenire, non si svelerà in tappe storiche annunciate e graduali o, per quanto concerne le versioni secolarizzate, in “schemi” entro cui gli eventi si dispongono seguendo deduzioni conseguenti, ma si direbbe affidata all’estro di improvvise e successive “aperture” che, per quanto imparentate l’una con l’altra e sottese da un reciproco corrispondersi, non si lasciano ordinare secondo una qualche genealogia storica. Circoscrivendo per un momento l’attenzione al rapporto con il solo cattolicesimo, non dovrebbe a questo punto essere arduo comprendere che il casus belli all’origine del contrasto con la Chiesa cattolica, si deve precisamente al fatto di avere a che fare con una comunità che si dichiara Chiesa, che dichiara cioè se stessa passaggio obbligato attraverso cui pervenire alla redenzione, o, ancor più nettamente, luogo di una redenzione già in atto. Non accolta la mediazione unica di Gesù, diviene a maggior ragione impossibile accogliere l’opera di una istituzione che di questa mediazione si pretende erede, più ancora che privilegiata esclusiva. L’arco di volta, i cui contorni dovranno man mano tracciarsi con maggiore risalto, di tutta l’estesa e dettagliata –ma, occorre dire, quasi mai avventata e mai ostruita da una qualche farragine– polemica con cui Capitini investe la tradizione cattolica si incastona per intero proprio in questa lapidaria contrapposizione: se l’istituzione è tale in quanto propone se medesima come tramite della salvezza, l’instancabile e reiterato attestare l’urgenza della salvezza da parte di Capitini testimonia la superfluità di qualsiasi istituzione che intenda proporsi come tramite. Ne consegue che il primo, in ordine quantomeno ideale, atto che occorre rivolgere contro questa indebita pretesa ecclesiastica dovrà condensarsi nel rifiuto di quel segno di appartenenza che lega un nato in ambito cattolico alla sua comunità, ovverosia il segno del battesimo. È questo il senso essenziale da attribuire alle dimissioni da cattolico rese da Capitini in una lettera, rimasta priva di risposta, all’arcivescovo della natale Perugia: il principale resoconto delle quali, speculativo e biografico, si può leggere in Battezzati non credenti. Respingere l’istituzione cattolica significa, in altri termini, respingere quella cristallizzazione del divenire religioso entro la quale affondano le sue radici. È, all’esatto contrario, nella libertà concessa a questo divenire che Capitini scorge la possibilità di accelerare l’avvento della realtà liberata ed è nell’atto di voler circoscrivere la Grazia, che egli rinviene il travisamento d’origine nei confronti del Cristo evangelico: partito da questo travisamento il cattolicesimo non pote- SAGGI va che avviarsi irreversibilmente su di una linea di insufficienza religiosa, tanto più stridente e paradossale se costretta a sostenersi sull’idea che per ritornare a Cristo non si debba far altro che “riconoscere nella Chiesa lo stesso Cristo”19. Per Capitini Gesù di Nazareth non può essere ritenuto il Figlio di Dio che scende a redimere gli uomini da una colpa originaria, per il fatto che non si dà alcuna colpa originaria in forza della quale l’uomo insinua nella realtà un’imperfezione prima inesistente. Il tentativo di rendere conto di Dio nel mondo si snoda in Capitini senza perdere mai di vista la seguente convinzione. E le concezioni, che con la dovuta cautela possono definirsi teologiche, da lui svolte allo scopo di tratteggiare –per se stesso prima che per gli altri, come in ogni religiosità genuina– con maggior nettezza la sua idea del divino sembrano quasi disporsi a raggiera attorno a questo centro. L’assunto cardinale che in primo luogo ne deriva consiste nel vedere Dio e l’umanità implicati in un medesimo processo di liberazione; principio che sottende anche il rifiuto dell’idea che unicamente nella fugacità della dimensione terrena si possa giocare il destino eterno dell’uomo. Non si può dunque dare qualche cosa di paragonabile a quella creazione dal nulla attraverso la quale, secondo la prospettiva ebraico-cristiana, Dio concede all’umanità un’esistenza che in origine è lui solo a possedere. Colmare questa sperequazione tra Creatore e creatura mi pare sia il principale atto di riscrittura teologica perseguito da Capitini; tentativo che, se ripercorso con chiarezza, contribuisce certo ad illuminare anche quello che potrebbe ritenersi il sorgere aurorale (o uno fra i più decisivi quantomeno) delle analisi sulla nonviolenza, se è vero che una delle fonti concettuali al cui interno la violenza può annidarsi con maggior facilità a Capitini sembra proprio risiedere nell’atto con cui questa distanza tra Dio e mondo viene posta. La trascendenza del Dio cristiano che la tradizione ha perpetuato20 –anche se è d’obbligo tenere conto che l’incarnazione aveva manifestato, come mai era accaduto, il senso di una vicinanza assoluta tra l’umanità e il divino– conteneva in sé le potenzialità, concretizzatesi, di introdurre un vasto spazio vuoto tra cielo e terra che l’uomo poteva essere indotto a riempire facendo uso di un potere autoritario o attribuendo al Padre di bontà tratti autoritari. Nello sforzo di erodere questo dualismo tra Dio e mondo Capitini giunge nella compresenza ad una “soluzione” dal sapore indubbiamente panteistico. Non panteismo nel senso più elementare di perfetta coincidenza empirica di ogni cosa particolare con Dio, ma in quello di un monismo divino nel quale trova spazio ogni realtà vivente. Anche se con maggiore proprietà bisognerebbe forse ricorrere al termine panenteismo, per sottolineare con maggiore acutezza l’irriducibilità della compresenza al mondo della vitalità naturale: ogni vita si dà nella compresenza ed è la compresenza ad avvolgere il visibile, non il visibile a contenere la compresenza, perché “il valore è più del mondo e ingloba i fatti”21. Una qualsivoglia contiguità fra Dio e natura, del resto, è proprio quel che Capitini non si stanca di avversare ed escludere, finendo per rimproverare agli stessi pontefici romani di pensare, poco cristianamente, a Dio come ad un semplice “imitatore della natura”22. E se, giunti a questo punto, non si riuscisse a resistere al fascino tentatore della 27 28 definizione, gli si potrebbe cedere facendo ricorso ad un’espressione come panenteismo escatologico, meno suggestiva certamente ma forse più appropriata di quella di “monoteismo aperto” coniata da Capitini stesso23. Ma è un terreno minato, questo delle definizioni, che credo sia più lungimirante abbandonare subito. Una volta avviatosi sulla strada che conduce ad anestetizzare il dualismo tra Dio e mondo, Capitini non poteva evitare di incontrare Hegel. Deve infatti ammettere, e nel farlo parrebbe quasi palesare un leggero stupore, una non trascurabile attrazione nei confronti della filosofia hegeliana, dettata, con indiscutibile conseguenza rispetto a tutto il suo discorso del resto, dal movimento con il quale questa si propone “di calare gli elementi ideali nella realtà”24. Ed in effetti, pur con i proficui ed indispensabili confronti che si debbono fare con quel Kant che costituisce il suo principale filosofo di riferimento, non è possibile mettere in ordine tutti i tasselli del pensiero di Capitini, senza aver prima compreso adeguatamente questo “calare” e senza guardare alla nozione hegeliana dello Spirito come continua autoproduzione e della realtà umana intesa quale “atto di autocreazione progressiva temporale”, e non quale “dato eternamente identico a sé”25. Il Dio di Capitini non è l’Assoluto greco: sostanza immobile originariamente compiuta, da sempre data e da sempre identica a se stessa, ma il motore interno della realtà, l’intimo dinamismo che le permette di trovare svolgimento e che assieme ad essa si svolge; insomma, il Dio-compresenza non resta statico ma, come lo Spirito hegeliano, diviene; ed in quanto divenire, aperto al futuro, è storia. Sottolineare la centralità di questa dinamicità è una delle preoccupazioni costanti di Capitini, che in più di un caso designa la compresenza alla stregua di una Trinità dinamica contrapposta a quella immobile della tradizione26; non tenendo, d’altra parte, forse adeguatamente conto del fatto che la stessa Trinità cristiana sembrerebbe suggerire, sotto gli appesantimenti teologici, l’idea di una mobilità interna alla vita divina. “Eterno perché crescente” è la formula nella quale Capitini stesso compendia questo dinamismo: e il quadro di riferimento generale parrebbe delineare un’eternità che sin dall’origine coinvolge il mondo nel suo crescere –eternità che sembra però poter crescere, secondo un procedere hegeliano quanto fichtiano, solo nella misura in cui, nel suo punto d’avvio, l’esistere biologico le si pone di fronte come ostacolo da oltrepassare e correggere: “la compresenza è idealmente anteriore alla storia”27. Lo Spirito si incarna per realizzare il valore e assieme a questo realizzare se stesso, non come nel cristianesimo per mettere riparo ad una caduta, per ricomporre una lacerazione insinuatasi in una iniziale armonia. È forse questa la parte più sfuggente e meno circostanziata del pensiero di Capitini, quella su cui le sue pagine sembrano non volersi mai soffermare con l’assiduità dovuta: ma qualche barbaglio pare talvolta riservare chiarimenti improvvisi: E perché mi sono incarnato? Perché sono sceso in un mondo di limiti, incontro al dolore, alle avversità, alla morte? Potrei dare semplicemente la risposta che lo Spirito ha sempre dato nell’intimo di ogni uomo: per attuare il valore. Ma io posso dare un’altra risposta, in cui c’è un’aggiunta religiosa: “per attuare la realtà di tutti”28. SAGGI Ne segue, almeno così mi pare, che l’eternità non è, biblicamente, un dono di Dio all’uomo, risultato di un nuovo atto di creazione per mezzo del quale la morte arriva a capovolgersi nel suo contrario, ma tutta l’umanità, in quanto parte della compresenza, è di per sé (al modo greco più che a quello cristiano) un principio spirituale eterno, e la morte congiunta all’incarnarsi, per quanto esperienza abissale, sembra spesso in Capitini ontologicamente funzionale al compiersi di questo eterno29, tanto che da alcuni passaggi si potrebbe persino essere indotti a scorgere in lui una sorta di theologia gloriae della compresenza. Di conseguenza la pienezza, l’infinità del valore, in Capitini non si situa all’origine, come nel neoplatonismo o nell’induismo, né all’origine quanto alla fine, come nel cristianesimo (non è però l’unica prospettiva), ma soltanto alla fine, come in Hegel o Marx, con la grandissima differenza del resto che in lui questa pienezza non è il semplice inverarsi di un mondo storico ma una sua decisiva apertura, un ribaltamento a cui faranno seguito successive e potenzialmente infinite, oltre che non determinabili, aperture e tramutazioni all’interno di una realtà e di un’umanità ormai redente e sciolte dalla morte. C’è ancora spazio per accennare ad un dilemma, forse più terminologico che sostanziale, che può vedere impegnati, difficile dire quanto proficuamente, i lettori di Capitini: quello che verte sulla questione se la sua opera, in ultima analisi, si collochi più sul versante della filosofia o più su quello della religione. Affidandosi ad una sorta di deduzione empirica si potrebbe ritenere che, dato l’intrecciarsi di temi hegeliani e kantiani che attraversa con assiduità le sue pagine, i “panni” che meglio gli si addicono siano più quelli del filosofo che quelli del religioso, e, dal momento che Capitini fa sicuramente un considerevole impiego di strumenti filosofici, definirlo un filosofo non può certo considerarsi un grave errore concettuale. Si potrebbe, d’altra parte, essere indotti ad annacquare la sua religiosità e tentare di relegarla ad una sfera genericamente intimistica, facendo leva sull’uso di classiche espressioni capitiniane come “esperienza religiosa” o “persuasione religiosa”; ma se questo richiamo alla soggettività in lui è essenziale presupposto che intende indicare, con massima forza, nella religione un coinvolgimento assoluto e personale, senza il quale non si può essere propriamente religiosi, è altresì indiscutibile che la sua religione mira a proporsi come religione universale, valida sempre e sotto ogni latitudine. Verrebbe allora automatico dire semplicemente che quella di Capitini, non per nulla kantiano, è una religione nei limiti della sola ragione, o affidarsi alla distinzione classica tra religione naturale e religione rivelata. Ma non è meno giusto ricordare che molti riterrebbero questa distinzione impropria, dal momento che in ogni forma di religione si dà comunque sempre un momento rivelativo e che in una religione naturale questo momento rivelativo è semplicemente interno alla ragione stessa. Precisando meglio bisogna allora dire che Capitini non riconosce alcuna rivelazione storica incentrata su di una promessa divina (cosa che, evidentemente, un cristiano fa), ma attesta una rivelazione naturale. Ma per tornare al dunque: religione o filosofia? Mi pare che da una definizione precisa e convincente come la seguente possa giungere una schiarita: 29 L’elemento ricorrente in quasi tutte le forme religiose è la credenza in una Realtà che si distingue o trascende o impregna di un valore più alto la realtà empirica e percepibile […]; talora la credenza attesta un Divino o Assoluto (di solito immanente, senza tratti personali: monismo, panteismo…). A differenza delle filosofie, la prima questione non riguarda l’esistenza di questa entità bensì il rapporto da stabilirsi con essa, e questo è religione30. In Capitini questo “rapporto” si trova al centro, rende centro di vita chi lo sperimenta con pienezza; tale pienezza, è l’altro punto chiave, induce ad una non accettazione, si impernia su di un’ansia profonda di rivolta, ispira il dissenso quale culmine ideale di ogni agire: La religione è dissenso con il mondo com’esso è. La vita religiosa perde il suo senso essenziale se accetta l’umanità, la società, la realtà come esse sono31. Non credo sia sviante insistere sul fatto, troppo spesso relegato ai margini da chi ama insistere sulla sua laicità32, che, al di là di qualsiasi itinerario speculativo, ciò che più conta per Capitini è rendere testimonianza e dare impulso all’avvento di un nuovo mondo, di un altro modo di esistere: senza più dolore, né morte. Salvezza contro istituzione 30 L’autoproclamarsi post-cristiano da parte di Capitini è stato sovente messo in rilievo; quasi mai ci si è però voluti soffermare con il dovuto piglio critico sui non rari passi nei quali il medesimo Capitini sembra prossimo ad intendere la sua religiosità alla stregua di un realizzarsi del cristianesimo stesso, eccone uno fra i più conseguenti: Il fatto è che i princípi di cui parlo, lavorando per una riforma religiosa, sono nuovi appunto perché il mondo cristiano ha abbandonato quelli originari cristiani a cui, in parti essenziali, questi della riforma di cui parlo sono tanto vicini, e senza dubbio più vicini che a quelli che tanto mondo cattolico e protestante ha accolto in sé33. D’altra parte, anche il termine post-cristianesimo sembra contribuire a risvegliare questa vicinanza: nel momento in cui Capitini intende porsi oltre le religioni istituzionali, il fatto di assumere come riferimento linguistico proprio la religione cristiana lascia affiorare una sorta di cordone ombelicale forse più vitale dello stesso atto teso a reciderlo. Ma in effetti, come la citazione precedente pare dimostrare, recidere questo cordone non si direbbe nemmeno essere un’intenzione cosciente. In un interrogatorio rilasciato alla Questura di Perugia nel febbraio del 1942 concisamente dichiara: “Nei riguardi religiosi io sono per un rinnovamento evangelico, cioè secondo lo spirito cristiano”34. Ritengo pienamente conseguente sostenere che questo pretendersi post possa illuminarsi di senso soprattutto se messo in relazione ad un proto, se, non dico ricongiunto, ma certamente collocato in parallelo ad un’origine nella quale era radicalmente prioritario quel che il seguito ha provveduto a rimuo- SAGGI vere il più possibile: l’attesa impaziente di un mondo salvato. Una volta ancora, è lo stesso Capitini ad attestarlo nei toni più chiari: “non è questo postcristianesimo, pur privo della lettera e delle strutture storiche istituzionali, attuazione del cristianesimo?”35 La redenzione corrisponde in Capitini al significato ultimo che decifra la realtà e che permette di leggerla come una storia di salvezza, di intenderla realmente solo nella luce di un éschaton che la conclude in quanto luogo di sofferenza. Il tempo non è qui, come nei sistemi religiosi induisti, un insieme di istanti omogenei senza inizio e senza fine: intreccio illusorio che per salvarsi occorre squarciare; ma è ciò attraverso cui la liberazione si manifesta, il latore del senso supremo dell’esistere. Dire che questo senso si snoda attraverso il tempo significa prendere atto che per Capitini la relazione salvifica a fondamento del suo agire si colloca, temporalmente, tra un prima e un dopo, e non, spazialmente, tra un alto e un basso. È precisamente l’imminenza di un “dopo” a trovarsi al centro anche della pagina evangelica. Il non cristianesimo di Capitini acquista lineamenti concettuali meno vaghi, innanzi tutto se inteso quale critica ad una tradizione cristiana di maggioranza che, non marginalmente sedotta da categorie filosofiche elleniche, ha operato una sorta di congelamento di questo dopo (che i Vangeli mostravano di attendere entro scadenze limitate e sulla terra), sostituito da una salvezza già pienamente costituitasi in una dimensione spaziale altra, in un sopramondo –un cielo– rivestito dei caratteri di eternità e pienezza dell’Essere, separato ed in posizione dominante rispetto ad un mondo sottostante e contingente. La relazione pervasa dal dinamismo tra un tempo, ancora irredento, che si trova prima ed un tempo, redento, che arriverà in seguito viene evidentemente convertita ed immobilizzata in quella tra un eterno, come tale compiuto e perfetto, posto sopra ed un tempo, incompiuto e imperfetto, relegato in basso: sopra è la Verità sotto la distanza dalla Verità, sopra il cielo sotto la terra. A questa contrapposizione tempo-eternità fanno capo due prese di distanza già ricordate: il rifiuto di una salvezza mistico-spaziale e quello, più impetuoso e ribadito, di una istituzione ecclesiastica che, volendosi specchio di questa eternità celeste, occulta la redenzione come evento a venire e futuro: e “presentando sé come Regno di Dio”36 confonde manifestazione del divino e trionfo temporale della Chiesa. Capitini sembra leggere il cristianesimo nella prospettiva di una, pressoché immediata, rarefazione della tensione escatologica iniziale, sigillata dall’abbraccio mortale della metafisica greca: qualcosa di molto simile a quella “spiritualizzazione” nella quale un suo attento lettore come Sergio Quinzio ha scorto una sorta di vastissimo sentiero apocrifo interno alla fede cristiana. Quanto più Capitini si allontana da questa religione cristiana ellenizzata, tanto più sembra approssimarsi, s’è detto, ad un cristianesimo germinale; se è vero infatti che “per influenza del pensiero greco grava sul cristianesimo il concetto di un Dio totalmente perfetto, senza incremento”37, questo stride in primo luogo con “l’attesa pressante di una realtà diversa, liberata (o regno di Dio), cioè di una trasformazione della realtà e società attuali, come doveva essere, agli occhi di Gesù, il ‘regno di Dio’, cioè un cielo in terra, nuovo cielo 31 32 e nuova terra (regno dei ‘cieli’ sta nei Vangeli per non dire di ‘Dio’, cioè per non fare troppo spesso il nome di Dio)”38. Anche per Capitini, come molti altri prima e dopo di lui hanno notato, l’attesa impaziente della conclusione di questa realtà corrispondeva alla lingua franca del protocristianesimo. Il quadro di riferimento può completarsi con l’aiuto del filtro interpretativo di Oscar Cullmann, che ha saputo dare a mio avviso la lettura più conseguente e convincente della storia salvifica neotestamentaria39. È da rilevare in primo luogo che l’opposizione fra tempo ed eternità non trova riscontro nella letteratura neotestamentaria e che il “cristianesimo primitivo non conosce un Dio fuori del tempo” e “non vuole affermare che Dio è fuori del tempo, ma che il tempo di Dio è infinito”40. La critica capitiniana ad un Dio abitante di un mondo superiore disancorato dall’uomo –trascendente, immobile ed onnipotente– è rivolta ad una ibridazione successiva alla spiritualità neotestamentaria, nella quale, al contrario, Dio è piuttosto colui che affranca la realtà temporale dall’interno stesso del tempo, e quest’ultimo di conseguenza non risulta qualche cosa “di contrapposto a Dio, che vada quindi superato”41. D’altra parte si può anche puntualizzare sia che il termine biblico ‘olam, che riferito a Dio viene sovente tradotto con “eterno” nel significato greco di atemporale, sembra debba con maggior precisione venir inteso come “tempo molto lontano”, sia che la stessa parola “onnipotenza” non è propriamente di matrice biblica. Il Dio cristiano a cui Capitini con la sua compresenza si contrappone non si direbbe davvero avere molti tratti in comune con quel liberatore che i Vangeli attendono, nella speranza di vedere presto ricomposta la dolorosa imperfezione del mondo, e Capitini stesso dimostra in più di un caso di avere ben presente questo punto di tangenza entro la comune radice escatologica: non è al Sommo Bene che egli aspira ma al Regno. La storia della salvezza cristiana, Cullmann lo ha sottolineato, si dipana tra un “già” e un “non ancora”: al “già” corrisponde l’unicità dell’evento messianico di Gesù di Nazareth, Dio incarnato, al “non ancora” l’avvento definitivo del Regno di Dio. Non è difficile riscontare in Capitini un analogo ed al medesimo tempo assai differente rapporto tra “già” e “non ancora”. Il suo “già” non è Cristo ma la persuasione della compresenza, la percezione pratica di un’unità spirituale che regge il mondo e che preme sulla manchevolezza della realtà al fine di liberarla, il “non ancora” è questa stessa realtà liberata. È certamente vero che talvolta Capitini sembra dare risalto unicamente al primo elemento, ed è significativo notare che nelle occasioni in cui lo fa finisce per relegare ai margini il ruolo della speranza, oscurata dalla presenza dell’atto religioso d’amore, dal suo essere già qui; ma è altrettanto indubbio che la tensione tra il presente di questo atto e il “non ancora” della futura realtà liberata costella letteralmente la pagina capitiniana e risponde all’intima sostanza che sottende per intero la sua esperienza religiosa42. Una lettura di Capitini amputata dello spazio imprescindibile di questo “non ancora” è una lettura che ne tralascia, o ne sottovaluta in modo pregiudiziale, l’aspetto essenziale, ovvero quel punto terminale a cui tutti i suoi sforzi pratici si direbbero tendere; più concisamente: è una lettura solo etica, una lettura che, a dispetto dei non pochi libri nei quali Capitini tenta, talora certo anche disordinatamente, di erigere a fondamento SAGGI del suo pensiero una dimensione religiosa, riduce, con non lieve azzardo, questa dimensione religiosa a dimensione morale. Se si crede che la compresenza si esaurisca in una semplice partecipazione intima della presenza di tutti nella sofferenza come nella gioia, se la si riduce unicamente ad una solidarietà spirituale, ad una sorta di memoria sovraindividuale che in qualche modo misterioso il tempo non sovrasta o la si confina nella regione inevitabilmente imprecisa di un limite ideale, si oscura una persuasione che Capitini, perlomeno in quel La compresenza dei morti e dei viventi che costituisce il suo sforzo speculativo più denso, non lascia passare in secondo piano: l’attesa di una tramutazione “strutturale” della nostra realtà, il convincimento che “la natura ha il tempo contato”43. Allo stesso modo, se non si scorge che l’impegno politico di Capitini è volto a porre fine alla politica comunemente intesa, che la politica compiuta è quella che giunge anche al proprio compimento (che non risiede in una vita civile perfettamente funzionante ma in una vita redenta), che le sue proposte sociali hanno di mira l’orizzonte ultimo di una liberazione non classificabile semplicemente come sociale, allora quell’ampiezza profetica che intesse le sue pagine si sottrae progressivamente allo sguardo. Un’altra tensione, non estranea, innanzi tutto linguisticamente, al cristianesimo, affianca quella tra “già” e “non ancora”: il rapporto tra la libertà dell’uomo e l’aspetto provvidenziale della compresenza. In Capitini risalta, con una complessiva nettezza, che la trasfigurazione escatologica della realtà non si disegna solamente come eventualità, ma come sicuro possesso futuro44. Tanto sollecita è la sua preoccupazione di salvaguardare l’uomo da un determinismo che lo privi di ogni reale possibilità di scelta, quanto salda la fiducia nella certezza di una direzione: “Vi dirò che trovo sempre molto bello e profondo questo parlare di ‘piani di Dio’, di infinita capacità dello Spirito di provvedere, da par suo, ad ogni punto del suo manifestarsi: ciò che l’individuo deve sapere è che egli non è estraneo a un ordine, a una ragione. Cioè egli ha la libertà non in quanto è staccato da tutto […], ma per stabilire un rapporto con un piano nel quale egli rientri”45. Nell’agire religioso ogni uomo compie una decisiva apertura che accelera l’avverarsi della realtà liberata, la cui venuta si direbbe comunque iscritta da sempre nella compresenza: cosa che “può farci dire che ci vuole l’aiuto di Dio per giungere ad una realtà liberata”46. Naturalmente, anche questo doppio movimento in cui s’intersecano decisione umana e piano divino attecchisce entro un humus che si trova nei cromosomi dell’Occidente a causa del cristianesimo: vera e propria cera molle nel cui impasto ogni filosofia della storia ha modellato in seguito le proprie variazioni; non è facile, ad esempio, intendere lo storicismo hegeliano alla stregua di una monumentale e grandiosa trascrizione concettuale di tale doppio movimento? Se il Regno come certezza che si sottrae ad ogni forse costituisce poi la demarcazione essenziale che si interpone tra la salvezza cristiana e quella ebraica, occorre dire che entro questa prospettiva il “cristianesimo” di Capitini ne esce rinvigorito: l’angelo della storia dell’“ebreo” Benjamin guarda al passato attraversato dall’oscura angoscia che il suo dolore rimanga irredento e il Regno non si manifesti, la compresenza del “cristiano” Capitini sembra pervasa dall’intima sicurezza che la redenzione è più forte di qual- 33 34 siasi abisso di sofferenza e che ogni frammento disperso del passato finirà per ritrovare il proprio posto. “Il principio fondamentale della religione aperta è che ci salviamo tutti”47. In questa affermazione si avverte in primo luogo l’eco persistente di una presa di distanza da quell’idea di una salvezza circoscritta che la religione cattolica ha profondamente inglobato in sé. Nulla suona forse a Capitini più estraneo di una simile delimitazione, il prendersi a cuore la sorte di ragni, gatti, usignoli fa nella sua pagina da ripetuto contrappunto alla dedizione riservata alla vita umana: nella compresenza nessuna creatura vivente, nemmeno la muta manifestazione del mondo minerale, soggiace ad un definitivo annichilirsi. Indubbio che per rinvenire l’impronta di una simile globalità occorra guardare più all’Oriente che all’Occidente. Ma altrettanto indubbio, senza voler protrarre più di tanto un discorso virtualmente amplissimo, che anche all’interno dei secoli cristiani si possano rintracciare esempi, certamente piuttosto infrequenti, di illuminata partecipazione alla vita animale –Francesco d’Assisi è il primo ovvio nome a venire alla mente. E, più in generale, non si può certo non vedere che, nonostante i numerosi passi evangelici che disegnano la realtà di una punizione eterna, l’idea di una salvezza riservata al cosmo nella sua interezza non è aliena allo spirito cristiano: dal mirabile squarcio paolino in cui si coglie che “tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto” (Rm 8, 22), alla reintegrazione assoluta dell’apocatastasi di Origene, che lo stesso Capitini in più di un’occasione rammenta, fino alle variazioni origeniste di von Balthasar o alle rincuoranti pagine di Maurice Bellet e Adriana Zarri nel secolo appena concluso. Quel che di religioso si trova in Capitini è all’insegna di sovrapposizioni che possono turbare gli amanti delle delimitazioni rigorose; è del tutto comprensibile che sia di prammatica riservargli l’etichetta di pensatore confuso, inutilmente rapsodico, responsabile di accostare autori che i canoni della cultura ufficiale pretendono inavvicinabili; la stessa difficoltà ad inquadrarlo senza ambagi nel pensiero laico o in quello religioso è sintomo di un certo disagio speculativo che la sua figura contribuisce ad evocare. Ma la “confusione” che la pagina di Capitini solleva è più sovente frutto di una volontà di classificazione di chi se ne fa interprete. Se Capitini si distingue per essere uno dei pensatori italiani peggio studiati, lo si deve principalmente al fatto che la sua esperienza intellettuale è, in assoluto, una fra le meno scolastiche che si possano immaginare. Proprio il rapporto con la religione cristiana mi pare ne costituisca un esempio fra i più illuminanti. Il cristianesimo nelle sue mani da un lato, disancorato dalla sua consistenza storica, si volatilizza: Gesù non è più l’immagine di Dio, ma tutto lo è in misura uguale a lui, la mediazione non è Cristo ma la compresenza; dall’altro se ne coglie, con precisione ignota a numerose menti cristiane, il capovolgimento rivoluzionario, facendone brillare la purezza del nucleo escatologico e la conseguente insopprimibile protesta contro quel che di cieco ed impietoso si annida entro le pieghe del potere terreno. Capitini recepisce in pieno un germe religioso introdotto dalla coscienza cristiana: l’abbattimento del limite. Il venire della salvezza spazza via ogni ritaglio gerarchico, ogni spazio circoscritto: questo è il principale asse di collisione tra SAGGI cristianesimo e società classica. Ne deriva l’annullarsi del sacro inteso quale luogo o fatto delimitato, al cui interno una forza divina manifesta l’incombere della propria potenza ad un mondo che tale potenza non possiede. Questa divaricazione tra sacro e profano rispecchia quella tra eternità e tempo, alla base è una medesima sperequazione tra un dominante e un dominato. È questa sperequazione che Capitini vuole recidere, tagliando alla radice ogni forma di sapere aristocratico, ricomponendo qualsiasi spaccatura (produttrice per lui di violenza, sostenuta dalla violenza) che sottrae all’uomo la possibilità di entrare liberamente in contatto con la pienezza di senso che lo costituisce. Ma nel designarsi Chiesa del cristianesimo Capitini ravvisa l’immediato risorgere del limite: alla Chiesa soltanto spetta d’essere quel luogo circoscritto che contiene un rinvio all’ulteriorità; e il sacro di cui si fa immagine rimane ancora il sacro cosmico, precristiano, segnato dall’attributo di una potenza schiacciante: ne è sintomo quella “monarchicizzazione” di Gesù che replica e moltiplica la divisione terrena fra sovrano e sudditi, così come la potenza soprannaturale del sacro non rimanda che ad un accrescimento di quella naturale. Se Capitini ascrive a merito della filosofia moderna quella linea che “da Cartesio a Hegel è lo sviluppo della familiarità col sacro”48, non lo fa per espellere dall’esistenza la dimensione sacrale, ma per estendere il sacro ad ogni aspetto della realtà. Il sacro che apre autenticamente alla percezione di Dio, che “sporge” verso Dio, non si trova in contatto con quanto dispone della forza ma con quel che della forza è privo, riluce nell’impossibilità di agire non nell’impresa coronata dal successo, nella prostrazione, non nel trionfo. Il “sacro di apertura”, come lo chiama Capitini, rimanda ad uno spazio allargato: può manifestarsi ovunque, questo il nocciolo del ribaltamento49, perché ogni cosa va soggetta alla debolezza. Il rischio di un simile allargamento, che la vocazione ad annullare i limiti alimenta, è però tutto fuorché esiguo. L’istituzione Chiesa, nei suoi intenti più nobili ed acuti, ha rappresentato la percezione distinta di questo rischio supremo, di quanto di insostenibile emerga in una radicale passione salvifica: il suo pericoloso inclinare verso l’indistricabile, il caos, il disordine sottratto ad ogni regolazione. Ma il terrore, del tutto legittimo e comprensibile, di un disordine da cui potrebbe germinare un male più vasto e distruttivo di quello che l’ordine comprime nella rigidità dei meccanismi che presiedono al suo funzionamento, è il terrore che sopraggiunge, inevitabile, in chi nella salvezza non ha fiducia. Il limite che il sacro incorpora in sé sta in luogo di una redenzione assente: la Chiesa, come tale, si fonda sull’oscuro presentimento che il Regno non verrà, o quantomeno si trovi ben lontano dall’essere prossimo. Anche Capitini costeggia a volte la spirale senza uscita a cui l’assillo dell’integrità della liberazione può condurre: “come cogliere questa condizione pura se non negando tutto e tutti, con il pericolo di ritrovarsi nell’arbitrario, nietzscheano od estetico, perché tale purezza deve respingere per conquistare se stessa, anche gli esseri individuati e i valori?”. Ma Capitini crede nella salvezza, e subito dopo si limita a ricordare che è sufficiente “connettere questo stato puro con la compresenza, aperta alle conseguenti liberazioni”50. Forse per figurarsi il crinale, esilissimo, su cui questa persuasione si direbbe procedere possono 35 36 bastare due versi di Hölderlin, molto noti: “Ma dove è il pericolo, cresce / anche ciò che salva”; Ernst Bloch li ha ribaltati in un’inversione che non ne intacca il senso: dove cresce ciò che salva, cresce anche il pericolo. La via alla redenzione tracciata da Capitini è una via arituale, intenzionalmente costruita sull’espunzione di qualsiasi elemento riconducibile allo spazio del rito, del solidificarsi della ripetizione: nessun vago ricorso al potere salvifico di simboli, formule liturgiche, dettami dogmatici, potrà esservi rinvenuto. Possono invece riscontrarsi con chiarezza alcuni tratti ascetici di rinuncia: l’esigenza di una riduzione dei beni materiali fino ad una sfera prossima all’indispensabile, l’inclinazione ad astenersi dalla pratica sessuale. Ma, soprattutto, la salvezza in Capitini si lega all’esercizio della virtù, si attua in un costante sforzo di adeguazione agli obblighi morali che la ragione pratica ci rivela. Il nome unico con cui può dirsi lecito sintetizzare tale virtù è certamente quello di “nonviolenza”. Quest’ultima rappresenta, in un mondo non ancora salvato, un’unità inscindibile di metodo e contenuto. La nonviolenza è metodo nella misura in cui si presenta come odós, come strada attraverso la quale un fine può dirsi raggiungibile: la realtà liberata costituisce l’aspirazione cardine del nonviolento poiché la realtà liberata corrisponde al fine supremo a cui la nonviolenza tende. Ma, d’altro canto, la nonviolenza non è di meno un contenuto, un valore in sé, autonomo; anzi, si potrebbe addirittura notare che la sua valenza metodica equivale al segno stesso dell’imperfezione della realtà presente: in una realtà liberata, presumibilmente, questa qualità di metodo cederebbe per intero il proprio posto alla pienezza del contenuto. Impossibile, come vuole Capitini, raffigurarsi in tratti definibili una realtà siffatta, anche se tutto nelle sue allusioni lascia credere che a quel punto la nonviolenza, divenuta possesso ordinario, perderà la forza, che attualmente la caratterizza, di impatto rivoluzionario, e non solleciterà più la speranza di una tramutazione del reale, perché sarà il reale. 1 A. CAPITINI, Attraverso due terzi del secolo, in Scritti sulla nonviolenza, a c. di L. Schippa, Protagon, Perugia 1992, p. 4. 2 ID., Vita religiosa, in Scritti filosofici e religiosi, a c. di M. Martini, Protagon, Perugia 1994, p. 108 (d’ora in poi abbreviato in Scritti). Se è vero che proprio all’inizio di Nuova socialità e riforma religiosa (Einaudi, Torino 1950, p. 11) Capitini fa riferimento al “campo economico-politico opposto a quello etico-religioso”, non credo tuttavia che sia possibile ravvisare qui una reale contraddizione rispetto al passo citato nel testo: parrebbe trattarsi più semplicemente di una sorta di oscillazione linguistica –oscillazione che a proposito di questo tema si manifesta non poche volte nelle sue pagine; risulta infatti più opportuno e più appropriato distinguere (e non opporre) in Capitini una sfera etico-politica da una sfera etico-religiosa, in cui l’etica assume quasi le sembianze di una sorta di copula in grado di gettare un ponte tra religione e politica: la dimensione etica può rinchiudersi nel solo ambito politico o aprirsi all’esperienza religiosa. È lecito figurarsi la politica, l’etica e la religione accostate su di una linea continua nella quale è l’ultimo termine che dà pienamente senso ai primi due, ma i primi due sono in grado di fornire all’ultimo contenuti vitali e spazi di applicazione. 3 ID., Educazione aperta, vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1967, p. 313. 4 ID., Elementi di un’esperienza religiosa (rist. anast. dell’ed. Laterza, Bari 1947), Cappelli, Bologna 1990, p. 28. Capitini, lettore appassionato di Michelstaedter (citato, tra l’altro, sin dagli SAGGI Elementi), avvertiva certamente gli echi delle pagine di questo in cui la purezza dell’agire trova identificazione con un “beneficio” svincolato da qualsiasi rimunerazione sociale: “Poiché prendi parte alla violenza di tutte le cose, è nel tuo debito verso la giustizia tutta questa violenza. A toglier questa dalle radici deve andar tutta la tua attività: –tutto dare e niente chiedere: questo è il dovere– dove sono i doveri e i diritti io non so”, C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, a c. di S. Campailla, Adelphi, Milano 1995, pp. 41-42. 5 Se si è fatto uso di questo verbo è anche per non dare adito ad un’eventuale confusione: l’idea, cioè, che il piano della vita naturale e dell’etica costituiscano qualcosa di indistinto, quando si tratta di ambiti ben differenti. È Capitini stesso a palesarlo nel miglior modo possibile: “Vedendo ogni essere, io posso scorgere in lui tre aspetti: quello naturale biologico (un essere vivente); quello spirituale (un essere che ha la coscienza di diritti o doveri, personalità); quello religioso (un essere che va oltre i limiti di questa realtà imperfetta, dove c’è il male e la morte)”, dal che si può dedurre che l’aspetto spirituale –termine adoperato da Capitini talora con ambiguità– è quello che coincide con la dimensione etico-politica, cfr. A. Capitini, Religione aperta, in Scritti, cit., p. 563. 6 Ivi, p. 593. 7 Se l’acosmismo germoglia, letteralmente, all’insegna di una negazione –sottrarsi al mondo (non essere vinti dalla sua forza annichilente) è la parola d’ordine–, l’annuncio di Cristo che dichiara di avere vinto il mondo sottende ed alimenta l’irruzione salvifica del cristianesimo. 8 A. CAPITINI, La compresenza dei morti e dei viventi, in Scritti, cit., p. 396. 9 Ibidem. Nelle rarissime occasioni in cui Capitini inquadra la propria posizione ricorrendo al termine “misticismo”, non manca di porgli accanto l’aggettivo “pratico” (ad esempio Educazione aperta, vol. I, cit., p. 9): il perché si cerca di spiegarlo in quel che segue. 10 L. DUPRÉ, Misticismo, in MIRCEA ELIADE, a c. di, Enciclopedia delle religioni, vol. III, Jaca Book, Milano 1996, p. 397; all’interno di questa voce si veda la spiegazione più dettagliata dei due filoni mistici ai quali si è fatto cenno. 11 Se poi si vuole pensare al Corpo Mistico paolino, asserendo che la compresenza intende essere una sorta di estensione di questo ad ogni realtà esistente e non ai soli fedeli in Cristo, l’osservazione resta in linea con le osservazioni di Capitini stesso, cfr. ad esempio Battezzati non credenti, Parenti, Firenze 1961, pp. 100-1. 12 Si può seguire l’intrecciarsi di queste due dimensioni dell’amore nella tradizione cristiana nel classico, ma anche assai contestato, studio di A. NYGREN, Eros e agape, trad. it., Il Mulino, Bologna 1971. Non credo si possa trovare una parola di introduzione alla compresenza capitiniana più appropriata di quella che Maurice Bellet indirettamente ci fornisce, quando parlando del cristianesimo sostiene che “se c’è una verità fondamentale del Vangelo è che ciò che è primo non è l’io, il soggetto, il solo che cerca eventualmente altre persone, ma la comunione: noi umani insieme, con qualcosa ‘tra noi’ che non possiamo afferrare e che permette a ciascuno di risorgere alla propria esistenza.”, M. BELLET, M. CACCIARI, C. MOLARI, Il cristianesimo sta morendo?, l’altrapagina, Città di Castello 2001, p. 11. 13 Ritorna più volte in Capitini questa distinzione di Angela da Foligno, cfr. ad esempio Severità religiosa per il Concilio, De Donato, Bari 1966, p. 71; Nuova socialità…, cit., p. 184; Teismo e compresenza, p. 367 (v. nota seguente). 14 A. CAPITINI, Teismo e compresenza, in M. SOCCIO, a c. di, Tre scritti inediti di A. Capitini, “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia”, Serie III, V, 1 (1975), p. 372. Questo breve testo, che riproduce la relazione presentata al “Secondo Convegno su Teismo e Ateismo”, tenutosi al C.O.R. di Perugia il 15 gennaio 1967, rappresenta forse quanto di più limpido Capitini abbia mai scritto su alcuni nodi cruciali del suo sentire religioso. 15 Non ci si lasci sviare da un’espressione come “Dio anonimo”, della quale Capitini si serve allo scopo di definire il suo assoluto religioso. Nel Dio anonimo di Capitini non risaltano minimamente i tratti di una divinità sconosciuta ed abissale, quale è l’Ungrund di alcuni mistici. L’anonimità non corrisponde qui ad una mancanza di nome ma, gandhianamente, al privilegio di possederli tutti, con la conseguente prossimità a chiunque (cioè ogni creatura) si qualifichi come detentore di un nome. 16 A. CAPITINI, Religione aperta, cit., p. 484; cfr. anche La compresenza dei morti e dei viventi, cit., pp. 361, 376, 435-40; Il fanciullo nella liberazione dell’uomo, Nistri-Lischi, Pisa 1953, pp. 79, 189, 218, 255; L’atto di educare, La Nuova Italia, Firenze 1951, p. 91; Educazione aperta, vol. II, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 22. 37 F. TRUINI, Aldo Capitini, Cultura della Pace, S. Domenico di Fiesole 1989, p. 126. A. CAPITINI, Religione aperta, cit., p. 627. 19 ID., Discuto la religione di Pio XII, Parenti, Firenze 1957, p. 54. 20 Una ricostruzione essenziale, ma convincente e piuttosto esauriente, di questo processo, che chiama ovviamente in causa, come più avanti avverrà anche qui, la metafisica greca, si può trovare in M. RUGGENINI, Il Dio assente. La filosofia e l’esperienza del divino, Bruno Mondadori, Milano 1997, pp. 41-61. 21 A. CAPITINI, La realtà di tutti, in Scritti, cit., p. 186. 22 ID, Discuto la religione di Pio XII, cit., p. 26. 23 Cfr. ID., Il fanciullo nella liberazione dell’uomo, cit., p. 131. 24 ID., Attraverso due terzi del secolo, cit., p. 13. 25 A. KOJÈVE, La dialettica e l’idea della morte in Hegel, 2ª ed. (1ª ed. 1948), Einaudi, Torino 1991, p. 149. A dire meglio si tratta semplicemente di notare con attenzione la linea di continuità, quand’anche eretica, che si snoda tra Kant e Hegel: anche Kant è un filosofo dello spirito, e pure Capitini lo è. 26 Cfr. ad esempio A. CAPITINI, Lettere di religione, in Il potere di tutti, La Nuova Italia, Firenze 1969, p. 199 o Battezzati non credenti, cit., p. 177. 27 ID., La compresenza dei morti e dei viventi, cit., p. 391. 28 ID., La realtà di tutti, cit., pp. 199-200. 29 La tensione tra questo abisso e questa funzionalità sembra rispecchiata da passi come il seguente: “La nascita come essere vitale, l’essere una vita, una forza, una sensibilità, una corporeità, una realtà in una immensa realtà nello spazio e nel tempo, era ed è un mezzo nei riguardi della compresenza; e invece diventa innumerevoli volte un ostacolo; e perciò ogni essere è anche un Cristo che ne soffre, in tante occasioni e infine nella morte che ogni essere incontra, dove l’individualità come potenza è sconfitta, e si fa più evidente l’individualità nella compresenza.” (A. CAPITINI, La compresenza dei morti e dei viventi, op. cit., p. 316). Capitini non accetta l’idea paolina che uomo e natura siano colpa e di conseguenza respinge la necessità di un sacrificio riconciliatore tra Dio e mondo. Ma anche per lui il mondo in quanto natura, in quanto divenire secondo vitalità e potenza, non è rivestito da alcuna nietzscheana innocenza: la fine di questo divenire è il fuoco secondo cui il suo sguardo si regola, agire religiosamente è redimere (verbo che lo stesso Capitini impiega). E dal momento che la redenzione non è una “pezza” che Dio è costretto ad applicare ad un cosmo prima intatto poi lacerato, se si cerca di andare al fondo del suo discorso, nonostante la partecipe coscienza della tragica insufficienza della natura, su questa stessa insufficienza pare spesso ruotare una sorta di redenzione interna al divino, qualcosa di molto simile ad un processo teogonico, per mezzo del quale Dio diviene pienamente Dio o, per così dire, aumenta la propria estensione. 30 O. AIME, M. OPERTI, Religione e religioni. Guida allo studio del fenomeno religioso, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, pp. 249-50. 31 A. CAPITINI, Lettere di religione, cit., p. 262. 32 Proprio Capitini ha segnalato l’insufficienza del laicismo nel suo accettare “che la realtà si realizzi così come ora; che nel mondo ci sia il male e la morte; e, pur col programma umanistico e prometeico di umanizzare il mondo, la realizzazione è puramente scientifica e politica, dichiarando che l’uomo non può cercare altro”, Religione aperta, cit., p. 566. Si pensi solo a quanto sia riduzionistica la lettura di coloro che guardano a Capitini essenzialmente come l’autore di Le tecniche della nonviolenza, relegandolo, di fatto, al ruolo di precursore ed antesignano di quanti dopo di lui, come ad esempio Gene Sharp, hanno indagato in modo assai più capillare le dinamiche dell’agire nonviolento. 33 A. CAPITINI, Lettere di religione, cit., p. 223. 34 C. CUTINI, a c. di, Uno schedato politico: Aldo Capitini, Editoriale Umbra, Perugia 1988, p. 70. 35 A. CAPITINI, Nuova socialità…, cit., p. 220. 36 ID., Aggiunta religiosa all’opposizione, Parenti, Firenze 1958, p. 168. 37 ID., La compresenza dei morti e dei viventi, cit., p. 451. 38 ID., Battezzati non credenti, cit., p. 147. 39 Il rimando prioritario è a Cristo e il tempo e a Il mistero della redenzione nella storia, tr. it. Il Mulino, Bologna 1965, 1966. 40 O. CULLMANN, Cristo e il tempo, cit., pp. 87 e 94. 17 18 38 Ivi, p. 73, n. 25. Basti questo esempio: “apertura ad una realtà di tutti, liberata dalla finitezza, il cui superamento è, sì, già nella coscienza appassionata della finitezza stessa, ma procede e sbocca escatologicamente in una realtà di tutti”, A. CAPITINI, Educazione aperta, vol. I, cit., p. 10. 43 ID., La compresenza dei morti e dei viventi, cit., p. 408. 44 Fra i non pochi passi che si possono citare a questo proposito si veda Religione aperta, cit., p. 521, La compresenza dei morti e dei viventi, cit., pp. 262, 343, 438. 45 ID., Educazione aperta, vol. II, cit., p. 146; due sono infatti gli aspetti che si intrecciano: “che esiste una libertà di autodeterminarsi; che la religione ha un suo progresso, sopra ai cicli storici”, ivi, p. 149. Si può anche accennare qui, argomento che se ben evidenziato richiederebbe certo più pagine, al saldarsi in Capitini di due differenti modi di manifestazione del divino presenti nella tradizione ebraico-cristiana: quello della progressiva rivelazione di Dio e quello di una rottura radicale ed improvvisa; si è in precedenza tentato di rendere questa duplicità facendo ricorso ad un’espressione come “successive aperture”, dove a “successive” corrisponde l’elemento della continuità e ad “aperture” quello della rottura –a Gesù, Francesco d’Assisi e Gandhi si devono ad esempio alcune fra queste aperture, nessuna delle quali si è però rivelata definitiva. 46 ID., La compresenza dei morti e dei viventi, cit., p. 266. 47 ID., Religione aperta, cit., p. 476. 48 ID., Educazione aperta, vol. II, cit., p. 144. 49 È però lecito domandarsi se a questo punto sia ancora corretto far uso del termine “sacro”, dal momento che in tutte e tre le lingue cardine dell’Occidente (ebraica, greca, romana) esso rimanda proprio al significato di “separato”, e cioè costituito in opposizione ad un ambito “profano”, o non sia preferibile parlare di passaggio, come direbbe Lévinas, dal sacro al santo. 50 A. CAPITINI, La compresenza dei morti e dei viventi, cit., p. 443. 41 SAGGI 42 39 GENIO E DIMENSIONE ESTETICA IN SCHOPENHAUER. UNA PROPOSTA DI LETTURA di Cosima Fersini 40 Questo intervento vuole essere solo una rilettura di alcuni nodi concettuali, relativi alla nozione di “genialità” e il suo riferimento è alla produzione artistica e alla condizione estetica, nell’opera maggiore di Arthur Schopenhauer. L’interesse per l’arte matura, in Schopenhauer, nel periodo tra il 1814 e il 1818 quando, ritiratosi a Dresda, si accosta con convinta adesione alla filosofia di Kant, al buddismo e, nello stesso tempo, ha l’opportunità di conoscere artisti e critici d’arte che condizionano e convogliano la sua attenzione verso l’universo estetico. Così l’arte diventa, nella sua teorizzazione, la prima via di liberazione dal dolore esistenziale. Molti studiosi hanno dedicato le loro riflessioni alla teoria dell’arte di Schopenhauer. Tra questi, pensiamo a Elisa Oberti che ha tradotto l’intera sezione dell’opera principale del filosofo tedesco, quella che contiene il tema dell’arte1. Infatti, come è noto, il terzo libro de Il mondo come volontà e rappresentazione è interamente dedicato all’arte, a ciò che rappresenta, a come si estrinseca e al suo fine ultimo. Il tema estetico, in Schopenhauer, è il parto di un’esigenza profonda del suo sistema. Potremmo dire che così è stato pure per alcuni suoi predecessori tra i quali, ad esempio, Kant. Quest’ultimo si è accostato al problema dell’arte principalmente per conciliare le esigenze dell’uomo-soggetto di conoscenza e quelle dell’uomo-soggetto di moralità attraverso il giudizio riflettente che, libero dalle condizioni fenomeniche del giudizio determinante, guida verso l’in-sé. Hegel, dal suo canto, ha incastonato anch’egli il momento dell’arte nel proprio pensiero ma solo come gradino propedeutico alla filosofia, nella sintesi della quale trova soluzione. Tutto ciò è presente tanto nella Enciclopedia delle scienze filosofiche quanto nelle lezioni di Estetica2. Il panlogismo hegeliano3 si esprime nel fascino della sua imponente unità e della monumentale costruzione sistematica della sua filosofia. In questa costruzione è, senza dubbio, insito anche ciò che riesce a soddisfare la domanda estetica; e proprio questo svolge un ruolo decisivo a favore di Hegel rispetto a Fichte ed Herbart. Per Schelling il discorso è diverso. Anzitutto perché è determinante la sua avversione radicale per la filosofia di Hegel e la propensione per quella di Kant. Scrisse André Cresson: “Qui bene amat bene castigat. Questa formula classica caratterizza fortemente l’atteggiamento che Schopenhauer ha creduto di dover prendere nei confronti di Kant. Quando tratta di Fiche di Hanswurst di Kant (vale a dire Guignol), quando non parla mai di Hegel se non lo qualifica ‘pesante pedante imbecille’, quando ha parole così carine per quasi tutti i filosofi illustri, suoi contemporanei, Schopenhauer fa una eccezione per Kant. Dichiara di agganciarsi direttamente a lui. Lo dà per suo maestro”4. NOTE Tornando alla filosofia schopenhaueriana in rapporto a Hegel, non troveremo mai, però, il senso ottimistico del divenire e dello sviluppo che è l’essenza della dottrina hegeliana, né la fiducia nella forza della Ragione, con cui Hegel elude le attestazioni di Schopenhauer sulle miserie del mondo. Il problema della trasformazione dell’infelicità in felicità è la sorgente comune della Filosofia della religione, della Filosofia della storia, della Logica e dell’Estetica, appunto. Schopenhauer ha sradicato l’Idealismo hegeliano, propriamente logico ed ottimistico, impiantando il suo sistema in cui è centrale il dolor perennis che deriva dal conflitto tra soggettività e mondo della Volontà. Quella di Schopenhauer è la “filosofia par excellence degli artisti”; così giudica Thomas Mann5, soggiungendo che essa è tale anche, ma non solo, per il posto cospicuo che vi occupa la teoria dell’arte. Stefano Zecchi, allievo di Enzo Paci e filosofo interno all’area della Fenomenologia, ha dedicato il saggio apparso su Estetica 1994 a Eros e decadenza nell’estetica di Schopenhauer. Il titolo del saggio racchiude in sé il significato concettuale del romanzo. Schopenhauer è colui che ha portato la filosofia orientale nel nostro sistema; colui che, dopo Pascal, ma contemporaneamente allo stordimento logistico hegeliano, ha mostrato l’altra via del romanticismo: la via dell’arte, dell’intuizione corporea. Il tema dell’arte è introdotto e sostenuto dalla dottrina delle idee, una delle sezioni più importanti del sistema schopenhaueriano, ripresa dalla teoria platonica delle idee. Questa dottrina assecondava la Weltanschauung dell’epoca e la visione romantica. In Schopenhauer l’idea platonica rappresenta la forma che assume l’immediatezza romantica, cioè il rifiuto dell’intermediazione tra finito e infinito6. Questo rifiuto porta a cercare l’evanescenza del corpo e, siccome per Schopenhauer esso dipende dalle forme del principio di ragione, la trasparenza assoluta del corpo la si ottiene eliminando tali forme. Tutto questo avviene nell’arte. Nella contemplazione estetica si ha quel “piacere senza interesse” di cui aveva già parlato Kant nella Critica del Giudizio e che in Schopenhauer diventa liberazione dall’individuazione della volontà. Schopenhauer condivide la definizione di idea data da Platone, e da questa definizione fa scaturire, poi, il nesso tra idea e volontà, poiché, per il filosofo tedesco, le idee costituiscono i gradi di oggettivazione della volontà, che trova la sua più alta espressione nell’uomo. In particolare, per conoscere le “forme essenziali”, che chiama “idee”, seguendo la dottrina platonica, è necessaria, per lui, la contemplazione estetica, segno della capacità umana di sottrarsi al dominio della volontà7. “Con idea intenderemo indicare ogni grado determinato e costante di oggettivazione della volontà come cosa in sé, quindi come estranea alla pluralità; in relazione con gli oggetti particolari questi gradi sono forme eterne, o modelli”, conferma Schopenhauer8. La volontà, dunque, si oggettiva attraverso l’uomo e attraverso le idee. Queste ultime si manifestano in un’infinità di esistenze particolari che costituiscono nient’altro che copie di esse: ciò significa che tra l’idea e il fenomeno esiste un rapporto da modello a copia. “Ogni forza naturale generale ed originaria non è dunque altro, nella sua intima essenza, che un’oggettivazione della volontà in un grado inferiore; ciascuno di questi gradi è un’idea eterna nel senso di Platone. La legge di natura sarebbe la relazione tra l’idea e la forma del suo fenome- 41 42 no. Questa forma è il tempo, lo spazio e la causalità, legati tra loro da connessioni e relazioni necessarie e indissolubili. Mediante il tempo e lo spazio l’idea si moltiplica in innumerevoli manifestazioni: l’ordine poi, secondo cui tali manifestazioni si producono nelle forme della molteplicità, è rigorosamente determinato dalla legge di causalità: la quale segna in qualche modo il limite fra le manifestazioni delle differenti idee, ripartendo tra loro il tempo, lo spazio e la materia. Questa legge ha quindi una relazione necessaria con l’identità di tutta la materia data, costituente il substratum comune dei diversi fenomeni”9. Vecchiotti, uno dei principali rappresentanti della critica schopenhaueriana italiana, ripropone il pensiero del filosofo tedesco a questo proposito, affermando che le idee si presentano nei gradi più bassi come forze generali della natura; esse appaiono senza eccezione “in ogni materia, come peso, impermeabilità e in parte si distribuiscono senza ordine in tutta la materia esistente, così che alcune dominano su questa materia, altre su quella, che ne è appunto per questo specificata”10: a questo gruppo “appartengono la solidità, la fluidità, l’elasticità, l’elettricità, il magnetismo, le proprietà chimiche e le qualità di ogni tipo”11. Queste idee non sono cause o effetti, ma condizioni di tutte le cause e di tutti gli effetti. Ora, siccome spazio, tempo e causalità appartengono ai fenomeni dell’idea e non alla volontà, l’idea si manifesterà allo stesso modo in tutti i fenomeni di una tra le forze naturali: questa costanza nell’apparire, quando si presenta una serie di circostanze, si chiama legge naturale12. Possiamo, in tal modo, riconoscere una visione dinamica della vita della natura in Schopenhauer, visione che scaturisce in larga misura dall’evoluzionismo filosofico della scuola di Schelling e da quello empirico delle scuole naturalistiche delle quali lo Schopenhauer vuole riprendere e superare il momento meccanicistico13. La concezione di idea dello Schopenhauer e quella di Platone sono, dunque, abbastanza vicine. Platone considerava l’oggettità reale come doxa, cioè opinione, semplice copia dell’eidos, cioè dell’insieme di idee perfette che avevano un loro mondo. Anche Schopenhauer vede la “rappresentazione” come semplice copia di idee perfette che però sono per lui gradi di oggettivazione della volontà. Noi conosciamo, quindi, quello che ci appare, quello che percepiamo con i nostri organi di senso e che cogliamo con la ragione individuale. E le idee? È possibile conoscerle in qualche modo? La risposta che dà Schopenhauer è affermativa e radicale: “La conditio sine qua non affinché le idee divengano oggetto di conoscenza, è la soppressione dell’individualità del soggetto conoscente”14. L’unico modo per conoscere le idee è, dunque, quello di abbandonare il principio di ragione e, nella contemplazione degli oggetti, fare in modo che percipiente e percepito divengano una cosa sola senza relazione alcuna, per raggiungere un unico scopo: l’annientamento dell’individuo nella contemplazione e la sua nascita come soggetto conoscente puro che è al di là dal dolore, dalla volontà e dal tempo15. Quando l’uomo, lasciata la conoscenza dominata dal principio di ragione s’innalza con la concezione delle idee oltre il principium individuationis, la NOTE volontà, come realtà in sé, manifesta la propria libertà mettendo il fenomeno in contraddizione con se stesso. Questo fatto, chiamato dallo Schopenhauer abnegazione16, può spingersi fino alla vera e propria soppressione dell’essenza in sé del nostro essere; è l’unico e vero modo con cui la libertà della volontà come cosa in sé può insinuarsi nel campo del fenomeno. Solo allora il mondo come rappresentazione appare puro, intero; e si realizza la perfetta oggettivazione della volontà, proprio perché l’idea è la sua unica, adeguata oggettità. L’idea include in sé, contemporaneamente, soggetto e oggetto perfettamente in equilibrio tra loro come costituenti la sua forma unica. Questa coscienza, che ci permette, poi, di comprendere l’insieme delle idee, costituisce, in senso vero e proprio, tutto il mondo come rappresentazione17. Da questo consegue che il soggetto conoscente puro, conoscendo l’oggetto conosce se stesso, in quanto la volontà dell’oggetto e quella del soggetto costituiscono un unicum. Da queste premesse, ci si chiede quale sarà la specie di conoscenza in cui si potranno contemplare le idee. Schopenhauer giunge alla conclusione che questa speciale conoscenza sia l’arte, l’opera del genio. Ciò per due motivi: prima di tutto, perché ciò che noi vediamo nel quadro o nella poesia sta fuori da ogni possibile rapporto col nostro volere; poi, perché ciò non esiste già in sé che per la conoscenza e si volge immediatamente soltanto ad essa18. L’arte concepisce con la pura contemplazione riproducendo, di conseguenza, le idee eterne, cioè questi archetipi essenziali e permanenti presenti in tutti i fenomeni del mondo. A seconda, poi, della materia usata per questa riproduzione, prende il nome di arte figurativa (o plastica), di poesia o di musica. L’arte nasce, dunque, dal rapporto con le idee ed ha come unico fine la comunicazione di questo19. Schopenhauer contrappone questo tipo di relazione uomo-idee alla conoscenza razionale, conseguente al principio di ragione20, che ha valore ed utilità solo nella vita pratica e nella scienza: “L’arte si attiene dunque all’oggetto singolo, considerato a sé stante; ferma la ruota dei tempi; svanite le relazioni, l’essenziale, l’idea, formano il suo unico oggetto. La conoscenza che è in grado di fare astrazione dal principio di ragione è la contemplazione del genio, ed ha valore ed utilità soltanto nell’arte. La conoscenza razionale è simile alle gocce innumerevoli di una cascata, che cadono con violenza, assumono mille forme svariate, senza un attimo di riposo; l’arte è l’arcobaleno che si stende tranquillo sopra questo tumulto infernale”21. Il filosofo tedesco sostiene che il momento estetico permette all’artista di dimenticare le sofferenze della vita e, al tempo stesso, gli permette di ricompensarsi del dolore che, in qualità di genio, sente in maniera molto forte. Questo avviene perché, nel momento della produzione artistica, l’in sé della vita, la volontà, l’esistenza stessa è libera da ogni sofferenza e appare all’uomo di genio in tutto il suo splendore. Egli è in grado di giungere a questa conoscenza pura e di riprodurla artisticamente compiendo così un sacrificio perché: più pura è la conoscenza e più il soggetto conoscente puro soffre22. Schopenhauer sostiene che l’uomo che “vuole” è un uomo privo di qual- 43 44 cosa. Da ciò la sofferenza e il bisogno, la volontà di appropriarsi dell’oggetto mancante. Una volta raggiunto la sofferenza cessa, ma solo per pochi istanti, perché molti altri desideri prendono il posto di quello soddisfatto, in un processo infinito: l’appagamento è, quindi, solo apparente23. “Nessun voto realizzato può dare una soddisfazione duratura e inalterabile; è come l’elemosina che si getta a un mendicante, che gli salva la vita oggi per prolungare i suoi tormenti sino all’indomani”24. Emblematici, a tal proposito, gli esempi portati dal filosofo tedesco che assimila il soggetto della volontà ad Issione, sempre attaccato alla sua ruota che gira; alle Danaidi, che attingono sempre per riempire il vaglio; a Tantalo, eternamente assetato. Tutto questo, e perfino la felicità duratura e il riposo, sono gli effetti della nostra sottomissione alla volontà. Quando, però, interviene un motivo esterno o una causa interna che ci libera dalla schiavitù della volontà, allora avremo una conoscenza libera e concepiremo le cose in modo puramente oggettivo, senza relazioni alcune: solo così saremo felici25. Questi momenti di liberazione ci fanno entrare in una dimensione altra, in cui viviamo il benessere, la pace spirituale e la calma dell’animo, situazione simile all’atarassia di cui parlava Epicuro26. Questo è lo stato di contemplazione del genio. Basta uno sguardo sulla natura a liberarci, anche solo per un attimo, dai dolori e dalle pene che affliggono la volontà; infatti, se riusciamo a liberarci dal giogo della volontà e ci eleviamo alla conoscenza pura, non abbiamo più privazioni e, quindi, bisogni, desideri e tantomeno sofferenze27. La felicità, dunque, è ad un passo da noi, ma ci sfugge come le particelle di mercurio ci sfuggono dalle mani. Schopenhauer, come Leopardi, richiama l’attenzione sulla nostra esperienza del dolore28. I dolori della vita, infatti, sono di gran lunga maggiori rispetto ai piaceri e rispetto a quello stato di tranquillità che per Schopenhauer è il piacere vero e per Epicuro è, come accennato prima, l’atarassia. Non appena riacquistiamo la coscienza di una sola relazione tra un oggetto contemplato e la nostra volontà, infatti, la magia scompare, per cui torniamo ad essere semplici individui, anelli di una catena di cui fanno parte anche gli oggetti, non più come idee ma come cose. L’uomo comune, a differenza dell’uomo di genio, non è in grado di elevarsi al disopra della volontà, per cui si serve di una conoscenza logica, razionale29. Ciò che allevia il dolore all’uomo è, dunque, la beatitudine della contemplazione esente da volontà, così che attraverso la memoria del passato ci ritornano in mente solo gli oggetti e non il soggetto sottomesso a volontà, con le sue miserie30: per questo motivo, quando siamo angustiati dal dolore, le immagini del passato che ci balenano nella mente, ci danno l’impressione di un paradiso perduto31. Leggiamo in Schopenhauer: “Possiamo, per mezzo degli oggetti presenti, come per mezzo di quelli lontani, sottrarci a tutte le pene: basta che ci eleviamo alla loro contemplazione pura e oggettiva in modo da crearci l’illusione che se questi oggetti sono presenti a noi, noi non siamo presenti a loro; allora, sgravati dal nostro misero io, e divenuti soggetti puri di conoscenza, facciamo tutt’uno con tali oggetti, e la nostra miseria diviene allora tanto estranea a noi, NOTE quanto è estranea agli oggetti. Non resta più che il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà è svanito”32. Qui si pone il problema cruciale di ogni ermeneutica schopenhaueriana: la volontà, allora, è una quidditas negativa? Sicuramente, dopo l’analisi della teoria del dolore, risulta chiara la sua negatività, proprio perché la causa prima per la quale l’individuo soffre è il conflitto tra volontà universale e ragione individuale: è la loro coesistenza che provoca dolore. La conditio sine qua non per vivere senza soffrire è l’eliminazione della soggettività razionale o della volontà. Ma quale è possibile? L’uomo rappresenta il più alto grado di oggettivazione della volontà, ma proprio per questo sottostà, come abbiamo detto, al predominio di essa, di cui è costituito e dai cui promana. Contemporaneamente, è imprigionato nei principi razionali ed intellettivi della sua mente: quindi, non è comunque libero. Solo un uomo particolare è in grado di raggiungere una libertà che gli permette di entrare nella pura contemplazione, assorta per intero nel suo oggetto e di innalzarsi alla concezione delle idee. Quest’uomo particolare è il genio33. L’essenza del genio consiste proprio in un’attitudine, che supera la normalità, ad una simile contemplazione, ad entrare cioè nell’intuizione pura e a perdersi in essa, a liberare la conoscenza dalla schiavitù della volontà, trasformandosi da individuo a soggetto conoscente puro per un tempo abbastanza lungo da “riprodurre le proprie concezioni con i mezzi ben meditati dell’arte e per fissare in pensieri eterni ciò che fluttua nell’onda dei fenomeni”34. La conditio sine qua non che permette la manifestazione del genio nell’individuo è una somma di potenza intellettuale di gran lunga superiore a quella richiesta per il servizio di una volontà individuale35; il surplus di conoscenza che rimane, viene a costituire il soggetto libero da volontà, in preda ad un oblio completo della propria personalità e delle sue relazioni. In questo modo si spiega anche la vivacità, così spiccata negli uomini di genio, che rasenta la turbolenza. Inoltre essi appaiono sempre alla ricerca di oggetti nuovi e più degni di considerazione; così come anche di esseri simili a loro, cosa quasi sempre vana36. Mentre l’uomo comune dunque, è pago del presente, di ciò che lo circonda e della serenità della propria famiglia, al genio tutto questo benessere è negato37. La fantasia è stata considerata, da Schopenhauer, compagna del genio, un elemento indispensabile alla sua manifestazione. L’oggetto di conoscenza del genio è l’idea, che egli attinge intuitivamente. Sarebbe, però, una conoscenza sterile e dipendente dalle circostanze in cui tali oggetti si mostrano, se non intervenisse la fantasia ad allargare lo spettro di tale conoscenza38. Il genio si serve, dunque, della fantasia per vedere nelle cose ciò che la natura avrebbe dovuto realizzare, ma che non ha potuto a causa del conflitto reciproco fra le sue forme39. La fantasia, quindi, è un elemento che rende il genio tale. Come mai?, verrebbe da chiedersi; eppure essa può essere presente anche negli uomini comuni. Schopenhauer scioglie questo dubbio utilizzando quello che, secondo noi, è il filo rosso che guida e lega tutto il suo modo di pensare: il dualismo40. Come il mondo è volontà e rappresentazione; come l’oggetto è idea e oggetto materiale, così la fantasia può essere un mezzo per arrivare all’idea, 45 46 la cui comunicazione sarà l’opera d’arte ed è da questo punto di vista che il genio se ne serve. Oppure la fantasia può essere banalmente un mezzo per costruire castelli in aria, che servono al sognatore per appagare i propri desideri ma che, essendo semplici illusioni, sistematicamente crolleranno41. Schopenhauer contrappone spesso l’uomo comune all’uomo di genio, proprio per sottolineare l’antiteticità soprattutto per quanto riguarda il genere di conoscenza cui rispettivamente approdano. “La conoscenza, mentre per l’uomo volgare è la lanterna che illumina la via, per l’uomo di genio è invece il sole che rivela il mondo”, scrive Schopenhauer42. Questo perché, mentre l’uomo volgare resta un individuo che arriva a conoscere ciò che lo circonda entro il principio di ragione, il principium individuationis, la causalità, il tutto sotto lo stretto controllo della volontà, di cui il soggetto è succube, l’uomo di genio si trasforma in soggetto conoscente puro, che non conosce tramite la semplice astrazione, ma con l’intuizione giunge alla contemplazione delle idee e, quindi, alla pura realtà in cui la contemplazione, e non la volontà, è padrona43. A questo punto si impongono alcune constatazioni. Schopenhauer indica lo stato di contemplazione, che si raggiunge con l’arte grazie all’individuo che, elevandosi al disopra del principium individuationis, diventa soggetto puro di conoscenza, come prerogativa di un limitato numero di uomini che come abbiamo visto, nel campo dell’arte sono uomini di genio. Per essi il velo di Maya si squarcia liberandosi, finalmente, dalle sofferenze dello stato fenomenico e arrivando, così, a cogliere la vera essenza. Da questo punto di vista la filosofia di Schopenhauer sembra alquanto élitaria. È vero, infatti, che egli crea questa filosofia aristocratica, in cui solo un’élite etico-intellettuale alquanto ristretta di uomini è in grado di arrivare alla pura conoscenza e, nello stesso tempo, di liberarsi dal giogo della volontà liberandosi provvisoriamente anche dai dolori e dalle sofferenze che l’attrito volontà-individualità provoca. Nello stesso tempo, però, egli afferma anche che questi uomini geniali soffrono più degli altri, sviluppano maggiore sensibilità nei riguardi delle pene, delle sofferenze dell’umanità intera proprio perché hanno il dono di vedere oltre l’illusione. Occorre notare, quindi, che la condizione di sofferenza accomuna il soggetto puro di conoscenza e il semplice individuo. In poche parole, si soffre sempre e comunque, ciò che cambia è la causa di tale sofferenza, fino a che non annulliamo completamente la nostra individualità empirica. Ma c’è qualcosa di più. Sergio Givone ha scritto che non è, in Schopenhauer, alcuna differenza tra l’artista e l’uomo di genio: “Se così non fosse, non sarebbe neppure possibile all’uomo comune contemplare le opere dell’artista e riprodurre nella sua anima l’emozione, anzi, l’intuizione che le ha suscitate. Invece, l’esperienza estetica per l’artista e per l’uomo comune è nella sostanza identica: sia l’uno sia l’altro ‘conoscono nelle cose l’essenziale, al di fuori di ogni relazione’ e, quindi, mentre raggiungono l’in sé della volontà, si sottraggono al suo dominio”44. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare di primo acchito, l’uomo di genio non è perfetto; pecca, infatti, di conoscenza razionale e, con essa, di prudenza, saggezza pratica e avversione alle scienze, particolarmente alla matematica45. Da ciò consegue un’altra particolarità. Siccome ciò che costitui- NOTE sce l’intelligenza è un’esatta comprensione di ogni genere di relazioni, fondata sulle leggi di causalità e di motivazione, e poiché la conoscenza del genio non si preoccupa di relazione alcuna, ne deriva che un uomo “intelligente”, nei momenti in cui è tale manca di genio e, viceversa, un uomo di genio, nei momenti in cui è tale, non può essere un uomo “intelligente”46. L’uomo di genio, inoltre, è spesso in preda ad affezioni violente e a passioni insensate, conseguenza, in parte, di una straordinaria energia del fenomeno di volontà che costituisce l’uomo di genio; in parte, del predominio della conoscenza intuitiva su quella astratta47. L’impressione del presente è, quindi, molto forte nel genio e lo trascina verso un comportamento irragionevole, illogico, passionale. A proposito della conoscenza pura, che sembra risultare la causa del dolore di questa élite etico-intellettuale, vorremmo aprire una parentesi per dire che anche Leopardi e, più tardi Nietzsche in particolare, toccheranno e condivideranno la considerazione di Schopenhauer nei riguardi di tale conoscenza: ossia, che essa è simile alla follia. Il Leopardi, a onor del vero, è da sempre stato accomunato a Schopenhauer. Il De Sanctis ha scritto a tal proposito: “Leopardi e Schopenhauer sono una cosa. Quasi nello stesso tempo l’uno creava la metafisica e l’altro la poesia del dolore. Leopardi vedeva il mondo così, e non sapeva il perché. Arcano è tutto/ Fuorché il nostro dolor. Il perché l’ha trovato Schopenhauer con la scoperta del Wille”48. In una nota leopardiana del gennaio 1820, troviamo elencate tre maniere di vedere le cose. La prima è quella che riguarda proprio gli uomini di genio, che vedono nelle cose più spirito che corpo; la seconda, più comune, è quella degli “uomini volgari” per i quali le cose hanno molto corpo e poco spirito. Infine abbiamo “la sola funesta e miserabile e tuttavia la sola vera” maniera, quella dei filosofi per i quali le cose non hanno né corpo né spirito perché sono vane49. Tra l’altro, per Leopardi genio non si nasce, ma si diventa: “In natura, cioè non esiste (se non forse come singolarità) nessuna persona le cui facoltà intellettuali siano per se stesse strabocchevolmente maggiori degli altri. Le circostanze e le assuefazioni col diversissimo sviluppo di facoltà non molto diverse, producono la differenza degli ingegni”50. Tornando al concetto di genio presente in Schopenhauer, egli afferma che la genialtà non è sempre presente nell’uomo, ma si manifesta in determinati momenti e per un certo periodo di tempo, come per l’homo religiosus di Kierkegaard, Abramo. L’opera d’arte viene concepita in particolari momenti e, proprio per questo, viene considerata un’ispirazione, parto di un essere sovrumano. Schopenhauer afferma che tutti gli uomini di genio, gli artisti, vivono il loro essere dicotomico separatamente: da un lato il loro essere uomini e dall’altro il loro essere artisti, sopra ogni altro, l’artista sommo. Nella sua opera, Enten Eller, Kierkegaard sostiene che il genio è nell’attimo di una grandezza soprannaturale e in essa vi sprofonda con tutta la sua anima; realizza il suo scopo ma interrompe anche la coesione della sua vita. È solo un attimo che lo costringe a ricominciare da capo. L’artista, dunque, esiste come uomo dello hiatum irrationale kierkegaardiano e fichtiano51: l’attimo dell’ispirazione rappresenta il suo culmine vitale e l’ascesi il suo obiettivo ultimo. L’opera d’arte è una liberazione immediata dell’artista, mediatamente per il pubblico, fruitore dell’opera. Sappiamo, però, che Schopenhauer considera questa 47 48 liberazione momentanea e inadeguata a farlo uscire dalla vita: è solo un conforto alla vita stessa. L’arte nasce dalla negazione della natura, dalla fuga dell’artista dalla rappresentazione, ossia dall’oggettivazione di cui la volontà si serve per raggiungere i suoi fini: l’iter che l’artista segue per creare l’opera d’arte dipende ancora dalla volontà, è egli stesso volontà che si oggettiva attraverso la sua opera52. “L’istintiva necessità” che è il fondamento dell’opera lo rende estraneo al mondo e chiuso nella vita stessa. Schopenhauer si accosta e condivide il pensiero di Goethe riguardo all’attività geniale che, per ambedue, si oppone alla dispersione del tempo storico ed al suo impedire ogni unitarietà formale, proprio perché l’intelletto è la facoltà dell’analisi e della scissione. L’uomo di genio è astorico53 sia perché la sua intuizione è libera dalla volontà e quindi dal fenomeno, sia perché manca di una buona coesione dell’identità personale che lo avvicina molto alla follia e allo stato mentale infantile. A causa della conoscenza intuitiva, infatti, si manifesta nel genio un comportamento irrazionale, idiosincratico, simile a quello del folle54. Schopenhauer, in un passo de Il mondo come volontà e rappresentazione,55 ci racconta di aver conosciuto persone di una superiorità intellettuale molto pronunciata che presentavano, nello stesso tempo, una leggera traccia di follia: egli giunge, quindi, alla conclusione che ogni superiorità intellettuale oltrepassante la media comune debba venir considerata come un’anormalità predisponente alla follia. “Il folle ha un’esatta percezione del presente e di alcuni elementi frammentari del passato; ma disconosce la loro connessione, le loro relazioni; sicché erra e divaga. E questo è precisamente il punto di contatto con l’uomo di genio”, dice Schopenhauer56. Ed ancora: “in ogni cosa, egli non vede che gli estremi, e perciò anche la sua condotta cade negli estremi, manca di moderazione, conosce benissimo le idee, ma non gli individui”57. Per meglio comprendere l’arte, tappa fondamentale del pensiero schopenhaueriano, nonché prima via attraverso la quale l’uomo può superare il suo stato di dolore, si rende necessario il chiarimento di un argomento di sostegno qual è quello del sentimento del sublime58. Kant tratta la nozione di “sublime” nella Critica del Giudizio. Dopo aver toccato molti temi cari all’estetica settecentesca, il filosofo di Königsberg espone la propria teoria riguardo al concetto di “sublime”, affermando che esso è l’espressione di ciò che è privo di forma, che è inadeguato e violento nei confronti dell’immaginazione. Per Schopenhauer, il sublime risulta affine al sentimento del bello nella sua condizione principale, cioè nella contemplazione pura, libera dalla volontà, come nella conoscenza delle idee che ne deriva necessariamente e come nello stare al di fuori di tutte le relazioni determinate dal principio di ragione. Se ne discosta, invece, quando si eleva al disopra della relazione ostile alla volontà di sé come individuo, riconosciuta nell’oggetto. È proprio grazie a questa seconda fase che l’uomo sarà pervaso dal sentimento del sublime, portato ad uno stato di elevazione per il quale si dà il nome di sublime all’oggetto che provoca un tale stato59. Si possono distinguere due tipi di sublime. Il primo è il sublime dinamico che produce nell’uomo l’impressione di sentirsi infinitamente piccolo di fronte all’infinitamente grande del cielo o dell’universo, ad esempio60. Nello stesso NOTE tempo, però, prendiamo coscienza del fatto che tutte queste immensità esistono solo perché noi ce le rappresentiamo e, più specificamente, è il soggetto della conoscenza pura che lo crea. Siccome noi ci riconosciamo tali, quando dimentichiamo la nostra individualità, ci rendiamo conto di essere la conditio sine qua non di tutto ciò che in un primo tempo ci turbava. In concreto, l’immensità ci risolleva perché avvertiamo di essere parte del mondo: quest’elevazione al disopra della propria individualità è il sentimento del sublime61. Il secondo tipo, è il sublime matematico. Esso nasce quando guardiamo uno spazio piccolo che ci consente di percepire le tre dimensioni che lo delimitano riducendoci ad atomi rispetto alla sua grandezza, la quale però esiste solo come nostra rappresentazione e grazie al nostro sostegno. Si tratta, quindi, di un contrasto tra la nullità e la dipendenza del nostro io come individuo soggetto puro di conoscenza62. Questa teoria del sublime spazia anche in campo morale, permettendo, così, di delineare ciò che si chiama “carattere sublime”63. Esso è caratterizzato dal rimanere impotenti contro la volontà degli oggetti facendo anche qui prevalere la conoscenza: ne risulta un uomo che considera gli altri uomini dal punto di vista puramente oggettivo, senza che entrino in relazione con la sua volontà; in questo modo egli non soffre, come di fatto puntualizza lo stesso Schopenhauer: “Poiché nel corso della propria esistenza e nelle sue sventure, egli vedrà meno il suo destino individuale che quello dell’umanità in genere, la sua vita sarà quindi per lui un oggetto di studio, più che una causa di sofferenza”64. L’apparenza inganna, si sa. Così anche per l’eccitante65, che in un primo momento potrebbe sembrare simile al sublime, ma in realtà è ad esso contrario. Infatti, il sentimento del sublime nasce quando qualcosa di contrario alla volontà viene contemplato e questa contemplazione continua grazie ad un distacco completo dalla volontà, nonché ad un’elevazione al di sopra di ogni interesse; l’eccitante, invece, fa decadere il soggetto puro di conoscenza a semplice oggetto di volontà perché lo distoglie dalla contemplazione pura con degli oggetti che danno soddisfazione e appagamento alla volontà stessa66. La teoria di Schopenhauer sull’eccitante è duplice, perché esso col suo aspetto positivo stuzzica e con quello negativo ripugna alla volontà; quindi, mira sempre e comunque a stimolare la causa prima delle nostre sofferenze e della nostra bassezza, facendo decadere così anche lo scopo ideale dell’arte. Tutto quanto è stato detto finora sull’arte, fa parte del suo lato soggettivo ed è, quindi, un’analisi compiuta solo a metà. Nell’ambito di una trattazione sull’arte, è necessario conoscere i vari nuclei che hanno vita in essa e che ne costituiscono, appunto, la parte oggettiva. Prima di procedere, però, sono necessarie alcune ulteriori premesse. Sappiamo che la volontà trova la propria oggettivazione nelle idee, le quali, a loro volta, sono rappresentate nella realtà che ci circonda. La materia, però, non può essere la rappresentazione di un’idea e questo per due motivi. Il primo consiste nel fatto che la materia è causalità, ossia una forma del principio di ragione, mentre l’idea non ha niente in comune con tale principio. Il secondo è dato dall’esser la materia base, comune denominatore di tutti i fenomeni particolari delle idee e, quindi, anche trait d’union tra l’idea e il suo 49 50 fenomeno67. Inoltre, la materia presuppone un concetto astratto e non invece una rappresentazione intuitiva, la quale può avere come oggetto solo le forme e le qualità che si manifestano nelle idee ed hanno come substrato la materia. Dunque, non la materia, ma le sue qualità sono oggetto di contemplazione estetica68. Se prendiamo in esame l’architettura, possiamo dire innanzitutto che essa è un’arte bella e che è il mezzo attraverso il quale possiamo intuire le idee che si celano dietro le qualità “più basse” della materia, ossia la rigidità, la coesione e la durezza69. Anche se ci troviamo nei gradi inferiori di oggettivazione della volontà possiamo notare l’essenza di essa che si manifesta nella lotta tra il peso e la rigidità; ed è proprio questa lotta che costituisce precipuamente l’unico tema estetico dell’arte in architettura. Scopo di quest’arte è, dunque, quello di mettere in risalto tale lotta. In che modo? Frenando il peso, che qui rappresenta proprio la manifestazione della volontà; e la rigidità, in modo che la loro lotta si prolunghi all’infinito manifestandosi in svariate forme70. Quindi la bellezza di una qualsiasi opera architettonica consisterà nell’adattamento finale di ogni parte al tutto, nel senso che ogni elemento della costruzione dovrà essere legato necessariamente a tutti gli altri in modo tale che se uno solo di questi elementi venisse a mancare, crollerebbe l’intera costruzione71. Di notevole importanza è poi la luce nelle opere architettoniche: infatti, qualsiasi edificio immerso nella luce dà un effetto sicuramente diverso da quello che produce il buio; la luce conferisce un secondo motivo di bellezza “poiché la luce è la più gioconda di tutte le cose, in quanto è la condizione e il correlato oggettivo del modo più perfetto di conoscenza intuitiva”72. La contemplazione estetica che si innesca e di conseguenza il piacere che deriva dalla visione di un edificio ben illuminato, quindi, non dipende solo dalla conoscenza dei materiali, dalla lotta tra peso e rigidità e dalla luce, ma anche dal soggetto. Infatti, essendo l’architettura un’arte che riguarda i gradi inferiori di oggettivazione della volontà, ci dà un piacere estetico minimo in quanto a oggetto, che però diventa notevole se l’individuo si trasforma in soggetto puro di conoscenza libero dal giogo della volontà e del principio di ragione73. Ciò che contraddistingue l’architettura rispetto alle arti figurative e alla poesia è rappresentato dal fatto che, mentre queste ultime riproducono l’idea conosciuta, per esempio, in un quadro, che ha un significato nascosto, l’architettura offre allo spettatore direttamente l’oggetto da cui si può facilmente derivare l’idea, “portando l’oggetto reale e individuale alla chiara e completa espressione della sua essenza”74. Un altro particolare che contraddistingue l’architettura è la sua duplice funzione: mentre, infatti, le altre arti hanno fini puramente estetici, l’architettura unisce a questi i fini utilitari. Sta proprio in questo la grandezza dell’architetto: infatti, per ogni elemento dell’opera egli deve valutare il lato estetico e l’esigenza utilitaria75. Questi due elementi, tra l’altro, sono inversamente proporzionali perché più il clima richiede una maggiore utilità pratica, meno l’artista è in grado di conferire senso estetico. Come nell’architettura e nell’idraulica artistica, così in altre situazioni estetiche, quali ad esempio quelle che possono scaturire dal vedere un paesaggio NOTE o un giardino rigoglioso, prevale il lato soggettivo su quello oggettivo. Questo avviene perché, trovandosi di fronte ai gradi inferiori di oggettivazione della volontà, il piacere estetico deriva soprattutto dal soggetto conoscente puro che è svincolato dalla volontà e da qualsiasi altra relazione con l’individualità76. Sia contemplando uno spettacolo naturale, sia contemplando quadri che riproducono la natura, la realtà è sempre il soggetto che dà il maggior contributo al piacere estetico77. Procedendo per questo excursus di arti belle si ha l’impressione di salire i gradini di una scala, per cui dai gradi più bassi di oggettivazione della volontà si arriva ai superiori. Dopo l’architettura, che riguarda la materia inorganica e dopo la natura e la pittura di paesaggio, che hanno a che fare con la vita organica ma pur sempre vegetale, è interessante considerare la scultura e la pittura di animali dalle quali nasce una contemplazione estetica che trova il suo fondamento più nell’oggetto che nel soggetto: “Ci vediamo dinanzi quella medesima volontà in cui consiste anche la nostra essenza; ma la vediamo incarnata in esseri nei quali la sua manifestazione non è, come in noi, dominata e mitigata dalla riflessione, bensì accentuata nei tratti più intensi, ed esplicata in maniera così franca, da rasentare il grottesco e il mostruoso; e, in compenso, sbrigliata, nella piena luce del giorno, sempre ingenua, sempre schietta, senza la minima dissimulazione. Questa è la ragione vera per cui noi proviamo tanto interesse agli animali”78. Guardando gli animali, più che le piante, afferma Schopenhauer79, non si può fare a meno di notare la ricchezza delle forme e dei comportamenti che lasciano trasparire la volontà celata in essi; e c’è una particolare frase che egli adotta dai libri sacri degli Indù per definire l’essenza intima di questi esseri: “Tat Twam asi” (“questa cosa vivente sei tu”)80. Scopo della pittura storica e della scultura è quello di “rappresentare in maniera immediata e intuitiva le idee in cui la volontà raggiunge il grado più elevato della sua oggettivazione”, afferma Schopenhauer81. In questi ambiti il lato oggettivo supera quello soggettivo, perché ci troviamo di fronte a gradi di oggettivazione della volontà superiori rispetto a quelli dell’architettura e della pittura di paesaggio. Bisogna inoltre precisare un altro particolare di rilievo. Schopenhauer distingue nell’uomo due caratteri: uno generico, che è quello che riguarda la specie ed è il carattere che si trova oggettivamente in tutto il genere umano e si chiama bellezza in senso interamente oggettivo, appunto. Il secondo è il carattere intellettuale e si chiama propriamente “carattere” o “espressione”82. Paolo Vincieri puntualizza il pensiero di Schopenhauer a riguardo e sostiene che ognuno di noi ha una sua natura, un “carattere intelligibile” che si manifesta come una costante nel tempo83. Il filosofo tedesco, inoltre, spiega la perenne sofferenza legata alla vita come l’espiazione di una colpa originaria: quella del peccato originale, che determinerebbe anche il bellum omnium contra omnes. Questa lotta è proprio l’espressione dell’egoismo di un uomo che deve scontare una pena perché colpevole di esistere: tutto ciò determina un rapporto inseparabile tra colpa originaria e natura umana immutabile. Horkheimer, uno dei filosofi più significativi, condivide il principio schopenhaueriano della colpa originaria, ma non è d’accordo sulla natura umana immutabile. Egli sostiene che il carattere degli 51 52 uomini sia determinato dalle circostanze e che sicuramente la vita è contrassegnata dal dolore anche se è diverso il modo in cui viene vissuto. In Crepuscolo, Horkheimer afferma che diverso è il modo di soffrire del borghese e del proletario e diverso è il modo in cui si instaura, nel corso della storia, il rapporto degli uomini tra loro e con la natura. La bellezza umana è, dunque, un’espressione oggettiva che designa il più alto grado di oggettivazione della volontà, ossia l’idea dell’uomo84. Insieme a questo aspetto oggettivo, però, altrettanto importante è l’aspetto soggettivo. Infatti, per Schopenhauer, non esiste nella realtà alcun oggetto che colpisca subito come il volto umano; e questo succede perché nell’altrui figura riconosciamo subito l’essenza intima di noi stessi, ossia la volontà nel suo più alto grado di espressione; e anche perché questa bellezza che noi percepiamo è il mezzo più veloce per innalzarci al disopra del principium individuationis e raggiungere così quella conoscenza pura che ci permette di contemplare85. Qui il filosofo cita le parole di Goethe: “Colui che contempla la bellezza umana, si sente immune da ogni soffio di male; si sente in pieno accordo con se stesso e col mondo”86. Secondo Schopenhauer, la bellezza è il trionfo della volontà su tutti gli ostacoli oppostili dalle forze dei gradi inferiori della sua oggettivazione. Sappiamo, infatti, che la volontà lotta con se stessa per accaparrarsi la materia e, proprio dalla vittoria su queste battaglie, scaturisce la bellezza umana. Prova delle lotte, cui tutti i gradi di oggettivazione della volontà devono far fronte, è la conformazione stessa. Il corpo umano, per esempio, è un sistema di organi, fibre, muscoli ecc. che hanno ciascuno il proprio compito e tutti contribuiscono a mantenere in vita l’uomo87. Per quanto riguarda l’arte, era stato più volte affermato da illustri teorici che essa imita la natura. Ma Schopenhauer non è d’accordo su questo, perché è convinto che l’idea del bello non scaturisca a posteriori, ma che si fondi su una nozione a priori, non esattamente come i modi del principio di ragione, ma pur sempre a priori88. Questa certezza nasce, nel filosofo tedesco, dalla constatazione che in natura è quasi impossibile trovare delle forme perfette, ideali, che invece l’artista di genio sa creare proprio perché intuisce a priori la vera bellezza. Questo gli è possibile e gli permette di oggettivare in forme perfette la volontà che analizza, perché si tratta della nostra stessa volontà, della nostra stessa sostanza. “L’artista di genio, infatti, crea la bellezza perfetta nel più duro dei marmi e la mette poi a confronto con la natura quasi dicendo: ‘ecco quello che tu volevi dire’. ‘Si, proprio questo’, risponde una voce vibrante dall’intima coscienza dello spettatore”89. È questo il processo che ha luogo negli artisti quando creano le loro opere scultoree90. La bellezza umana è stata, dunque, definita dal filosofo di Danzica come “l’oggettivazione più alta della volontà nel grado supremo della sua conoscibilità”91. Essa si esprime nella forma, che a sua volta dipende dallo spazio e non necessariamente dal tempo; quindi “la bellezza in senso oggettivo non è altro che l’oggettivazione adeguata della volontà mediante un fenomeno puramente spaziale”92. L’uomo, però, non esiste solo nello spazio ma anche nel tempo; e l’oggettivazione della volontà nel tempo è l’azione, il movimento, che si può NOTE esprimere in due modi: o manifesta in modo puro l’atto volontario o no; nel primo modo abbiamo la grazia e nel secondo essa è assente93. Il connubio di grazia e bellezza dà come risultato la manifestazione più alta della volontà nel grado più alto della sua oggettivazione. Abbiamo visto che la bellezza è il carattere generico, quello della specie, mentre l’espressione è il carattere individuale. Scopo delle arti sarà, quindi, quello di rappresentare sia l’uno sia l’altro. Il carattere individuale, però, non deve essere considerato dal punto di vista empirico, di rappresentazione, ma bensì come un frammento dell’idea di umanità e come tale deve, quindi, essere visto in senso ideale. Questo carattere idealizzato si manifesta, tramite l’intelligenza e la volontà, attraverso i movimenti e il viso. “Così l’artista, quando si propone di rappresentare la bellezza, oggetto specialmente proprio della scultura, deve pur sempre modificare in qualcosa la bellezza medesima mediante il carattere individuale, mettendone in viva luce un lato particolare”94. L’approfondimento di concetti ideali, come quelli di grazia e bellezza, si è reso necessario dal momento che essi costituiscono i principi su cui si basa la scultura. Per questi motivi tale arte ha come oggetto il nudo o, quanto meno, i panneggi trasparenti che hanno il compito di far intuire allo spettatore le forme della rappresentazione dell’idea95. La pittura storica è un’altra arte bella che ha in comune con la scultura i due oggetti principali: la bellezza e la grazia. Oltre a tali caratteristiche peculiari la pittura è contraddistinta da un altro oggetto, ossia il carattere, considerato da Schopenhauer come “la rappresentazione della volontà nel più alto grado della sua oggettivazione”96, cioè quella parte dell’idea di umanità che contraddistingue ciascun uomo: il comportamento e le azioni sono le manifestazioni di tale carattere. La complessità dell’idea di umanità può essere colta solo attraverso le varie circostanze in cui l’uomo si viene a trovare: ed è proprio questo che la pittura ha il compito di rappresentare; ogni gesto, ogni avvenimento della vita di un uomo ha la sua importanza. Schopenhauer sostiene che bisogna distinguere tra il significato esteriore di un’azione e il significato interiore97: il primo è rappresentato dall’importanza che le conseguenze di un’azione possono avere per e nel mondo reale; quindi, è regolato dal principio di ragione. Il secondo, ossia il significato interiore, mette in risalto gli aspetti migliori dell’idea di umanità tramite individualità spiccate, dando loro la possibilità di esprimere le loro caratteristiche98. È quest’ultimo aspetto che diviene oggetto della pittura, mentre il primo è quello di cui si serve la storia. Questi due significati, inoltre, possono esistere separati ma anche trovarsi insieme in un’unica azione. Un’altra distinzione è importante considerare: in un quadro, sostiene Schopenhauer99, bisogna distinguere il significato nominale dal significato vero: anche qui, similmente ai significati di un’azione, il primo è esterno, mentre il secondo consiste in un aspetto particolare dell’idea di umanità rivelata mediante l’immagine all’intuizione. Nelle opere dei grandi artisti, “nelle loro fisionomie, specialmente negli occhi, vediamo l’espressione, il riflesso della conoscenza più completa; non di quella che mira alle cose particolari, ma di quella che abbraccia con visione 53 54 grandiosa le idee, quindi, l’essenza intera del mondo e della vita; una tale conoscenza reagisce anche sulla volontà; ma, anziché somministrarle dei motivi, come fa la conoscenza volgare, opera come un quietivo, e ne procede quella perfetta rassegnazione che costituisce ad un tempo lo spirito intimo del Cristianesimo e della saggezza indiana: la rinunzia e il sacrificio di ogni desiderio, la soppressione di ogni volontà e, quindi, anche di tutta l’essenza di questo mondo: e, cioè, in ultimo, la salvezza. Ecco l’alta saggezza che quegl’immortali maestri dell’arte espressero nelle loro opere”. Afferma Schopenhauer: “Ecco il vertice supremo dell’arte stessa: dopo aver seguito la volontà sulla scala ascendente di tutte le sue oggettivazioni adeguate che sono le idee, percorrendo successivamente i vari gradi in cui il suo essere si sviluppa, cioè gli inferiori, in cui obbedisce alle cause, gli altri in cui segue le eccitazioni, gli ultimi infine, in cui sottostà all’impero dei motivi, l’arte assurge finalmente alla rappresentazione della volontà in atto di libera autoespressione, dovuto a quel grande ‘quietivo’ che è la perfetta conoscenza del suo proprio essere”100. Fine dell’arte è, dunque, la comunicazione dell’idea e l’artista rappresenta lo strumento, la conditio sine qua non attraverso la quale essa viene isolata, purificata da elementi estranei e “consegnata” anche agli uomini comuni. “L’allegoria è un’opera d’arte che vuol significare una cosa diversa da quella che rappresenta”, scrive Schopenhauer101. Essa rappresenta un elemento degno di considerazione nel campo dell’arte, quasi paradossalmente, perché l’opera d’arte che rappresenta l’idea, è oggetto di intuizione e si esprime da sola; mentre l’allegoria, basandosi su concetti astratti, devia la conoscenza dello spettatore sul vero significato dell’opera, il quale deve sforzarsi di riconoscerlo. Anche in base all’allegoria l’opera d’arte ha due significati: uno nominale, che equivale al senso allegorico stesso; e uno reale, che è quello effettivamente rappresentato. Questi due significati sono, per così dire, in lotta perché l’allegoria oscura la conoscenza intuitiva dell’opera d’arte102. Quando poi l’allegoria si sposa con un oggetto nasce l’allegoria simbolica come, per esempio, l’alloro, simbolo di gloria o la colomba, simbolo di pace103. Se nelle arti plastiche l’allegoria ha un valore negativo, nella poesia accade il contrario. In quest’ambito, infatti, il dato immediato è il concetto astratto e il poeta ha il compito di condurre dal concetto astratto all’immagine intuitiva, fine dell’arte104. Fra le arti non si può non menzionare la poesia. Ad essa Schopenhauer dedica una parte del terzo libro de Il mondo come volontà e rappresentazione105. Anche il fine della poesia, come quello delle altre arti è di rappresentare le idee, ossia i gradi di oggettivazione della volontà; tali idee sono di natura intuitiva e, sebbene la poesia si risolva in una seria di parole e, quindi, di concetti astratti, essi concetti hanno proprio il compito di illuminare il lettore circa le idee106. Per raggiungere questo scopo, però, bisogna scuotere l’immaginazione del lettore e questo creando due condizioni: come prima cosa i concetti astratti devono intrecciarsi tra loro in modo tale che venga eliminata ogni loro astratta generalità; in secondo luogo è necessario che l’immagine intuitiva prenda il posto del concetto astratto nell’immaginazione e che la parola del poeta trasformi tale immagine perché si adatti a quello che vuole esprimere107. Elementi indispensabili della poesia sono il ritmo e la rima108 che hanno il NOTE grande potere di attirare la nostra attenzione e di predisporci ciecamente alla poesia. Perché si sprigiona questo potere quasi ipnotico? Schopenhauer risponde dicendo che la nostra facoltà di rappresentazione, legata principalmente al tempo, si sente trasportata da questi intervalli regolari nei quali si ripete il suono, per cui, la nostra attenzione si culla, per così dire, al suono della poesia109. Essa, inoltre, è un’arte che ha a disposizione una materia sconfinata per esprimere le idee e, secondo la natura del soggetto, adotta ora la forma descrittiva, ora quella narrativa, ora ancora, quella drammatica110. Oggetto della poesia è l’uomo, come grado più alto di oggettivazione della volontà che si manifesta progressivamente nei suoi atti, pensieri e comportamenti: dipingerlo nei suoi versi è il suo fine111. Schopenhauer richiama l’attenzione del lettore sul fatto che anche lo storico come il poeta si occupa dell’uomo: ma, mentre il primo adotta una Weltanschauung empirica, fenomenica, legata all’hic et nunc e al principium individuationis, il poeta ha una missione diversa: rivelare l’idea di umanità, la noumenicità del grado più alto di oggettivazione. Le parole del nostro ci confermano: “Il poeta abbraccia l’idea dell’umanità nel senso determinato in cui vuol rappresentarla; è la natura del suo proprio io quella che egli oggettiva dinanzi a sé nell’idea umana; la sua conoscenza, come si è detto in occasione della scultura è in parte a priori; il suo modello è sempre di fronte al suo spirito, fermo, distinto, luminoso, e non gli si offusca un momento. Ci mostra in tal modo, nello specchio del suo spirito, l’idea pura e limpida, e le sue pitture sono, fin nei minimi particolari, vere come è vera la vita stessa”112. Anche nella poesia, come nella pittura di paesaggio, “il genio è come lo specchio limpido e terso che raccoglie e riflette in viva luce tutto ciò che è essenziale ed importante, sopprimendo gli elementi accidentali ed eterogenei”113. Tenendo presente che il fine del poeta è la rappresentazione dell’idea di umanità, Schopenhauer114 dice che questo può avvenire in due modi: uno è quello in cui il poeta prende come oggetto se stesso e particolarmente descrive l’intuizione dei suoi stati d’animo: da qui nasce la poesia lirica, la canzone. Un altro modo è, invece, quello in cui il poeta prende ad oggetto un personaggio diverso col quale si eclissa fino a scomparire del tutto. Prendendo in esame la canzone scaturisce che in essa il soggetto della volontà occupa la coscienza del poeta in due modi possibili: o come volere libero e contento, che quindi è gioia; oppure sovente come volere contrastato, che è tristezza e comunque sempre come passione, sentimento. Insieme a questo stato d’animo c’è la contemplazione della realtà che circonda e fa prendere coscienza, al poeta, di essere un soggetto puro di conoscenza: da questa considerazione nasce una calma assoluta di spirito che picchia contro la violenza della volontà perennemente insoddisfatta; tale contrasto è il nucleo centrale da cui ha vita la canzone e l’ispirazione lirica in genere115. In questo stato d’ispirazione il genio è soggetto puro di conoscenza e libero dalla volontà; ma questa contemplazione dura poco perché la volontà è già pronta con i suoi artigli a farlo tornare alla sua mercé. Per questo nella canzone e nell’ispirazione lirica questi due stati sono ben percepibili e coesistono alternativamente. L’elemento più importante di tutti, nella poesia come nelle altre arti è, 55 56 comunque, la verità, infatti “all’arte si domanda che sia uno specchio fedele della vita, dell’umanità e del mondo”, afferma Schopenhauer116. Essa funge, quindi, da vocabolario perché ci aiuta a tradurre in oggetti o concetti comprensibili ciò che è oscuro. È da rilevare che la tragedia è considerata il genere poetico più elevato per la potenza dell’effetto e per la difficoltà dell’esecuzione. Scopo di tale genere è quello di mostrare il lato peggiore della vita, quindi “la lotta spaventosa della volontà con se stessa; lotta che, in questo grado supremo di oggettivazione, si spiega nell’ambito più vasto e completo”117. Sappiamo che la volontà, nella visione schopenhaueriana, è unica e si manifesta in tutti gli individui, i quali lottano costantemente tra loro spinti dall’egoismo; ci sono però alcuni individui che riescono a sollevarsi al disopra del principium individuationis e conoscono l’essenza perfetta del mondo; tale conoscenza agisce come quietivo della volontà e produce rassegnazione, rinuncia alla vita e alla stessa volontà di vivere. Tutto questo si ripropone nella tragedia, in cui, dopo lunghi sforzi e sofferenze, le creature più nobili rinunziano per sempre alle miserie della vita e si liberano della volontà, negandola. Esempi illustri ci sono offerti da Amleto, da Margherita di Faust, da Giovanna d’Arco, la Pulzella di Orléans, “tutti personaggi che muoiono purificati dal dolore, quando in loro è già morta la volontà di vivere”118. È d’obbligo, dopo questa nomenclatura delle belle arti, parlare della musica nel modo in cui era considerata da Schopenhauer. È una differenza sostanziale quella che separa la musica da tutte le rimanenti arti che abbiamo sondato: il nostro filosofo la individua nel fatto che dall’architettura alla tragedia, tutte si servono di mezzi, come un edificio, un quadro, una poesia, e di una conseguente modificazione della conoscenza dello spettatore per trasmettere le idee, loro scopo supremo. Tali arti, quindi, oggettivano la volontà mediatamente, ossia per mezzo delle idee. La musica, invece, è essa stessa un’oggettivazione immediata della volontà proprio come il mondo fenomenico e le idee119. Ne deriva che come fra le idee e il mondo fenomenico c’è una relazione di copia a modello, così, fra la musica e tale mondo fenomenico esiste la stessa analogia. Ciò significa che il basso, fondamentale nell’armonia, corrisponderà alla materia inorganica del mondo fenomenico e, man mano che si sale la scala del suono, si percorrono i vari gradi di oggettivazione della volontà, come fenomeni, fino a raggiungere la melodia che corrisponderebbe alla vita, alle aspirazioni coscienti dell’uomo120. Per questo motivo inventare una melodia, rivelare per suo mezzo i più profondi segreti della volontà e del sentimento umano è lo scopo, il fine supremo del genio. Questo avviene nella più completa ispirazione, tanto da poter parlare di sdoppiamento della personalità: infatti, quando il genio crea la melodia in questo stato di contemplazione, è come se si trovasse in una dimensione altra; per cui, una volta venutone fuori, non ricorda nulla di tale evento121. È necessario precisare una cosa. La musica ha, con le nostre analogie, solo una relazione indiretta: infatti, essa non esprime il fenomeno ma solo la volontà. Ecco perché la nostra immaginazione viene così facilmente eccitata dalla musica: è come se cercassimo di capire quel quid, ciò che per noi è sconosciuto, attraverso il trasporto delle note; “la musica non esprime, della vita e dei suoi avvenimenti, se non la quintessenza, e tale universalità è appunto NOTE il carattere che le conferisce un così alto valore, che ne fa la panacea di tutti i nostri mali”, sentenzia Schopenhauer122, “e quindi”, continua il filosofo, “esprime l’elemento metafisico del mondo fisico, l’in sé di ogni fenomeno: il mondo si potrebbe, in conseguenza, chiamare un’incarnazione della musica, non meno che della volontà”123. La musica va oltre le idee ed è indipendente dal mondo fenomenico, anzi, potrebbe, in certo qual modo, sussistere anche se il mondo non esistesse, a differenza delle altre arti. Con la musica si completa anche il lato oggettivo dell’arte. Abbiamo visto che lo stato di contemplazione permette all’artista di svincolarsi dai dolori e dalle sofferenze per creare la manifestazione delle idee eterne, anche se per brevi istanti. La volontà, infatti, è pronta a smembrare il genio dall’individuo, facendo ripiombare quest’ultimo nel baratro del dolore. L’arte rimane, dunque, per Schopenhauer, un rimedio solo parziale al dolore esistenziale. Dopo quanto è stato detto sulla musica il filosofo di Danzica giunge alla considerazione finale, cioè: se si riuscisse a rendere esplicito il significato intrinseco, ossia a tradurre in concetti ciò che la musica esprime, riusciremmo anche a trovare la spiegazione del mondo per mezzo di essi, il che equivarrebbe alla vera filosofia. Siccome poi, guardata dal punto di vista empirico, la musica è un mezzo per affermare in concreto dei grandi numeri e delle complicate relazioni numeriche (comprensibili solo per via dell’astrazione), si potrebbe concepire la possibilità di una filosofia dei numeri, come quella di Pitagora o dei Cinesi nell’Y-King124. I pitagorici avevano dato molta importanza alla musica e Platone non è stato da meno. Nel Fedone, il filosofo greco afferma che la musica ha il compito di formare la ragione: si tratta, nel senso più comune, del ritmo dorico, perché dotato di particolare serietà e gravità; nel senso più teorico, la musica viene considerata come ritmo regolato dal numero e come armonia che ha il numero per sua essenza specifica. Abbiamo già visto che la critica italiana rivela un’importanza molto concreta che si realizza anche in rappresentanti come Martinetti125 e Varisco126, per menzionarne alcuni. Vecchiotti, uno degli ultimi critici, richiama l’attenzione su un problema riguardante proprio il settore dell’arte127: la possibilità di conciliare il pessimismo complessivo con la filosofia della musica e con l’estetica schopenhaueriana. Più si conosce più si soffre, ma non si avverte la caducità del piacere quando si sa che nel mondo estetico non c’è dolore. Cosa comporta questo concetto? Di certo ottimismo e non già pessimismo come vuole Schopenhauer. L’arte ha, infatti, il compito di liberarci dalla volontà ma, in questo modo, insieme al dolore si elimina anche il piacere; Schopenhauer sostiene, invece, che l’arte porta alla liberazione dal dolore e, quindi, al piacere. Riconda richiama l’attenzione sulla grande capacità di sofferenza che esiste nel secolo che va da Goethe a Nietzsche. Schopenhauer si pone fra l’uno e l’altro, è l’anello di congiunzione tra Goethe, a differenza del quale è più classico, più tragico, più pessimista, insomma, e Nietzsche, in confronto al quale è più imponente, deciso e forte. Già Georg Simmel, nel 1907, aveva collegato l’idea goethiana di un Essere che incessantemente produce forme alle teorie di Nietzsche e Schopenhauer128. La specificità di quest’ultimo pensatore è nell’impronta pessimistica della 57 58 sua dottrina, dovuta al tentativo di negare il mondo e di creare un ideale ascetico, di strappare l’uomo alla rappresentazione e di elevarlo a redentore di tutte le creature. “La sua spirituale sensualità, la sua dottrina, sgorgata dalla vita, che ci insegna esser conoscenza, pensiero, filosofia, non solo un affare del cervello ma di tutto l’uomo, col cuore e coi sensi, col corpo e con l’anima […] in una parola la sua arte, appartiene ad un’umanità ugualmente lontana dall’aridità della ragione e dall’idolatria dell’istinto, e può forse favorirne la nascita. L’arte, infatti, con l’accompagnare l’uomo nel faticoso cammino verso se stesso, già ha conseguito sempre il suo specifico fine”129. Nonostante tutte le critiche che gli sono state mosse o che gli si potrebbero muovere, non si deve dimenticare perciò né la denuncia che Schopenhauer ha fatto della realtà del dolore né la portata demistificatrice del suo filosofare né, infine, la profondità di molte sue analisi, coincidenti, almeno a livello di “fenomenologia della condizione umana”, con le voci alte della sapienza, non solo occidentale, dell’età moderna e contemporanea. Del resto, la ricchezza di motivi del suo pensiero, anche per la parte estetica, al di là della cornice sistematica, è confermata dall’ampia serie di influssi esercitati sulla cultura successiva130. Possiamo fare nostra la conclusione posta da Simmel, alle analisi sull’arte di Schopenhauer: “L’insufficiente della liberazione per mezzo dell’arte è proprio in ciò stesso che questa liberazione riesce a fare: che essa si allontana soltanto dalla volontà, da cui noi invece abbiamo bisogno di essere liberati; al contrario, la liberazione reale, non revocata in ogni istante, deve impadronirsi della volontà stessa. E questo riesce nelle azioni dell’eticità e dell’ascesi, alle quali ci rivolgiamo come la soluzione pratica dell’oscura problematica in cui la riflessione di Schopenhauer ha finora calato la vita”131. Cfr. A. SCHOPENHAUER, Il problema dell’arte, trad. it., a c. di E. Oberti, Brescia 1959. Cfr. G. W. F. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a c. di B. Croce, (1907) Bari 1967; e ID., Estetica, trad. it., a c. di N. Merker e N. Vaccaro, Milano 1963. 3 Su questo è ancora valida l’impostazione metodologica presentata a suo tempo da V. VERRA, Hegel, in Questioni di storiografia filosofica, vol. III, a c. di V. Mathieu, Brescia 1974, p. 322. 4 A. CRESSON, Schopenhauer, Paris 1962, p. 2. 5 Cfr. T. MANN, Introduzione ad A. Schopenhauer, in Schopenhauer, Nietzsche, Freud, trad. it., Milano 1980, p. 5. 6 Cfr. G. RICONDA, Schopenhauer, in Questioni di storiografia filosofica, cit., pp. 375-376. 7 Cfr. S. ZECCHI-E. FRANZINI, Storia dell’estetica, v. II, Bologna 1995, p. 598. 8 Cfr. A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it., a c. di G. Riconda, Milano 1985, p. 168. 9 Ivi, p. 172. 10 Cfr. I. VECCHIOTTI, Introduzione a Schopenhauer, Bari 1986, p. 46. 11 Ibidem. 12 Cfr. ibidem. 13 Cfr. Ivi, pp. 47-48. 14 Cfr. A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 207. 1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Cfr. Ivi, p. 217. Cfr. Ivi, p. 343. Cfr. Ivi, p. 218. Cfr. Ivi, p. 223. Cfr. Ibidem. Cfr. Ibidem. Ivi, pp. 223-224. Ivi, pp. 309-310. Cfr. Ivi, pp. 234-235. Ibidem. Cfr. Ibidem. Cfr. Ibidem. Cfr. Ibidem. Cfr. G. RICONDA, op. cit., p. 377. Cfr. A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e come rappresentazione, cit., p. 237. Cfr. Ibidem. Cfr. Ibidem. Ivi, p. 238. Cfr. Ivi, p. 224. Ibidem. Cfr. Ibidem. Cfr. Ibidem. Cfr. Ivi, p. 225. Cfr. Ibidem. Cfr. Ibidem. Cfr. Ibidem. Cfr. Ivi, pp. 225-226. Ivi, p. 226 Cfr. Ivi, p. 227. S. GIVONE, Storia dell’estetica, Roma-Bari 1991, p. 91. Cfr. Ibidem. Cfr. Ivi, p. 228. Cfr. Ivi, 228-229. Cfr. F. DE SANCTIS, Schopenhauer e Leopardi, in Opere, vol. XIII, Einaudi, Torino 1969, p. 444. 49 Cfr. G. LEOPARDI, nota 103 (20 gennaio 1820), in Zibaldone di pensieri, ed. critica e annotata a c. di G. Pacella, v. I, Milano 1991, pp. 116-117. 50 Ivi, p. 966; la nota 1647 è del 7 settembre 1821. Cfr. G. INVITTO, “Varia filosofia e bella letteratura”. L’uso del termine “filosofia” nello Zibaldone, in Narrare fatti e concetti, Lecce 1999, p. 33. Vedi pure: A. PRETE, Schopenhauer e Leopardi (sull’origine del parallelo), in Schopenhauer ieri e oggi, Atti del Convegno Internazionale svoltosi dal 22 al 25 settembre 1986 a Gargnano del Garda, a c. di A. Marini, Genova 1991, pp. 439-444. 51 Cfr. S. A. KIERKEGAARD, Aut Aut, trad. it., Milano (1956) 1977. 52 Cfr. F. GALLO, Esistenza, arte, genialità. (Un itinerario schopenhaueriano), in Schopenhauer ieri e oggi, cit., pp. 242-243. 53 Cfr. Ivi, p. 243. 54 Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà…, cit., p. 229. 55 Cfr. Ivi, p. 230. 56 Ivi, p. 232. 57 Ivi, p. 233. 58 Cfr. Ivi, p. 241. 59 Cfr. Ivi, p. 242. 60 Cfr. Ivi, p. 244. 61 Cfr. Ivi, p. 245. 62 Cfr. Ibidem. 63 Cfr. Ivi, p. 246. NOTE 15 59 Ibidem. Cfr. Ivi, p. 247. 66 Cfr. Ivi, p. 248. 67 Cfr. Ivi, p. 252. 68 Cfr. Ivi, p. 253. 69 Cfr. Ibidem. 70 Cfr. Ivi, p. 254. 71 Ibidem. “Bisogna che ogni parte sostenga un peso esattamente proporzionato alla sua resistenza, e venga essa stessa sostenuta né più né meno del necessario: questa è, infatti, la condizione indispensabile per metter bene in luce quel conflitto tra la rigidità e il peso, in cui si manifesta la vita, l’estrinsecazione della volontà nella pietra, e che manifesta con chiarezza ed evidenza questi infimi gradi dell’oggettità della volontà stessa”. 72 Ivi, p. 256. 73 Cfr. Ibidem. 74 Ibidem. 75 Cfr. Ivi, p. 257. 76 Cfr. Ivi, p. 258. 77 Ibidem. “Infatti, non appena ci sforziamo di contemplare tali oggetti con gli occhi dell’artista che li ha dipinti, gioiamo subito, come per eco simpatica di sentimento, della serenità profonda di spirito dovuta al silenzio completo della volontà, i quali elementi si resero necessari affinché l’artista potesse effondere la sua conoscenza in oggetti così privi di vita, e concepirli con tanto amore, con oggettità perfetta”. 78 Ivi, p. 259. 79 Cfr. Ibidem. 80 Ivi, p. 260. 81 Ibidem. 82 Cfr. Ibidem. 83 Cfr. P. VINCIERI, Discordia e destino in Schopenhauer, Genova 1993, p. 140. 84 Cfr. M. HORKHEIMER, Crepuscolo, trad. it. a c. di G. Backaus, Torino 1977, pp. 35-36. 85 Cfr. A SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 260. 86 Ivi, p. 261. 87 Cfr. Ibidem. 88 Cfr. Ibidem. 89 Ivi, p. 262. 90 Ibidem. “Nell’anticipazione consiste l’ideale: l’idea, in quanto, almeno in parte, riconosciuta a priori, e in quanto, associandosi con i dati a posteriori della natura, e completandoli, entra nella pratica dell’arte. La possibilità, per l’artista, di concepire il bello a priori, e per l’osservatore di constatarlo a posteriori, deriva dal fatto che, tanto l’artista, quanto l’osservatore, sono essi stessi l’in sé della natura, e la loro essenza coincide con la volontà che si oggettiva”. 91 Ivi, p. 263. 92 Ibidem. 93 Cfr. Ivi, p. 264. 94 Ivi, p. 265. 95 Cfr. Ivi, p. 269. 96 Ivi, p. 270. 97 Cfr. Ibidem. 98 Cfr. Ivi, p. 271. 99 Cfr. Ivi, pp. 271-272. 100 Ivi, pp. 273-274. 101 Ivi, p. 277. 102 Cfr. Ivi, p. 278. 103 Cfr. Ivi, pp. 279-280. 104 Cfr. Ivi, p. 281. 105 Cfr. Ivi, p. 283. 106 Cfr. Ivi, p. 284. 107 Cfr. Ibidem. 64 65 60 Cfr. Ivi, p. 285. Cfr. Ibidem. 110 Cfr. Ibidem. 111 Cfr. Ibidem. 112 Ivi, p. 287. 113 Ivi, p. 290. 114 Cfr. Ibidem. 115 Cfr. Ivi, p. 292. 116 Ivi, p. 294. 117 Ivi, p. 295. 118 Ibidem. 119 Cfr. Ivi, p. 298. 120 Cfr. Ivi, p. 300. 121 Cfr. Ivi, p. 302. 122 Ivi, p. 304. 123 Ivi, p. 305. 124 Cfr. Ivi, p. 307. 125 Cfr. P. MARTINETTI, Antologia, Bologna 1971. 126 Cfr. B. VARISCO, I massimi problemi. Brani scelti e coordinati a c. di G. Albiney, Firenze 1941. 127 Cfr. I. VECCHIOTTI, op. cit., pp. 138-139. 128 Cfr. G. SIMMEL, Schopenhauer & Nietzsche, a c. di A. Olivieri, Firenze 1995. 129 Cfr. G. RICONDA, op. cit., pp. 387-388. 130 Per una ricostruzione complessiva della fortuna dell’estetica di Schopenhauer, cfr. S. GIVONE, op. cit., pp. 238-241 e S. ZECCHI-E. FRANZINI, op. cit., pp. 1077-1978. Si ricordano alcuni contributi specifici: F. VISCIDI, Il problema della musica nella filosofia di Schopenhauer, Padova 1959; C. ROSSET, L’esthétique de Schopenhauer, Paris 1969; A. PHILONENKO, Schopenhauer. Une philosophie de la tragédie, Paris 1980; S. ZECCHI, Eros e decadenza nell’estetica di Schopenhauer, in S. ZECCHI, a c. di, Estetica 1994. Scritture sull’Eros, Bologna 1995. 131 G. SIMMEL, op. cit., p. 154. 108 NOTE 109 61 DALLA CITTÀ ALLA COSMOPOLI, UN CAMMINO POSSIBILE di Carmela Stella 62 La discussione politico-culturale dell’ipotesi federalista e della sua singolare portata storica –di un’istanza progettuale di grande attualità ed interesse– costituisce uno dei temi, o meglio dei problemi, affrontati da Mario Schiattone in un suo recentissimo scritto, Città Federazione Cosmopoli in Carlo Cattaneo, edito da Name (Genova, 2002). Essa non poteva non proporsi, nell’impostazione argomentativa dell’autore, come riflessione critico-teoretica sul significato della storia, sulla sua affermazione nell’Ottocento (il secolo, come ebbe a dire Nietzsche, affetto dalla “malattia storica”, per il quale invocava l’oblio) come scienza indagativa, interpretativa di eventi e fatti, ma chiusa nelle grandi costruzioni e idealizzazioni, il concetto di nazione di Fichte, l’eticità dello Spirito oggettivato, come Stato, fondamento ontologico dell’uomo, nella teorizzazione hegeliana; una storia prefigurata da una ragione immanente, da principi direttivi, solo nel Novecento aperta a nuova rielaborazione. Come sottolinea Schiattone, con Mannheim ed, in particolare, con Bloch si comprende che la condizione prima della sua fattualità, non più definibile secondo precostituiti modelli evolutivi e di sviluppo, è una linearità progettuale, costantemente in relazione con le istanze che maturano dal suo svolgimento e di cui è possibile specificare la natura in quanto scaturienti dai fini che l’umanità persegue. Si tratta di un concetto di non immediata acquisizione perché prelude all’individuazione nella storia di una continuità di svolgimento di “istanze utopiche”, della presenza in essa di un progetto implicito che partendo da lontano –secondo alcune ricostruzioni già dal mito aureo– si è andato sempre più chiarendo e manifestando lungo l’idea guida della giustizia. In questa direzione procede Cattaneo: con il suo apporto “la storia italiana riconquista la sua linearità”, in anni già per se stessi densi di progetti, vivi per la forza propositiva del dibattito risorgimentale che doveva portare a maturazione l’idea dell’indipendenza dallo straniero, dell’unità nazionale in Mazzini e dell’istanza federativa in Ferrari e nello stesso Cattaneo (Mario Schiattone ha scritto, tra l’altro, un volume monografico su Ferrari dal titolo Alle origini del federalismo italiano. Giuseppe Ferrari ). Tenace animatore delle giornate insurrezionali del marzo 1848, Cattaneo avversò risolutamente i tentativi fusionisti dei fiduciari piemontesi in Lombardia, attento ai possibili sviluppi storico-politici del Risorgimento che, a suo avviso, dovevano porsi in naturale continuità con la storia italiana, una storia dominata dai particolarismi locali, elementi imprescindibili di un fecondo policentrismo; per essa, per la sua evoluzione sin dalla fase rinascimentale, non poteva risultare consono un programma unitario. Un filo sottile, ma NOTE chiaramente percettibile, lega Cattaneo alla progettazione utopica, nonostante egli abbia espresso nei riguardi dell’utopia un giudizio non positivo, vedendo in essa una sorta di volontarismo o una scarsa attenzione, se non proprio disaffezione, per le concrete questioni economiche. Ed interessante è il percorso –abilmente ricostruito da Schiattone– attraverso il quale vi perviene, definendo e chiarendo, nel contempo, la sua tesi sul federalismo: la relazione liberalismo-transazione e ancora liberalismo-utopia. Infatti al federalismo Cattaneo perviene attraverso il liberalismo, un liberalismo maturo che ha fatto proprie alcune istanze sociali consentendo una lettura della storia in termini progettuali. Fondamentale in esso è l’idea di progresso, fattore portante della storia umana, “deliberato e perpetuo”, indefinito nel suo sviluppo e nella sua natura, determinata di volta in volta dalle conquiste della scienza. Su tale idea, Cattaneo, come già Romagnosi, fonda la diretta e specifica responsabilità dell’uomo nella costruzione della sua storia, scevra da interventi sovrannaturali, giustificazioni metastoriche e pretesti provvidenziali. In questo assunto si rintracciano le radici culturali di Cattaneo, romagnosiane e vichiane da un lato e positiviste dall’altro, le premesse da cui dedurre un pensiero coerente: le tesi empiriste, baconiana e lockiana, confluenti nell’affermazione della connessione tra senso e ragione come criterio di reciproca verificabilità, l’attacco alla metafisica (proprio del positivismo, ma non solo, si pensi alle riserve kantiane) e la conseguente negazione dell’innatismo, nella sua pretesa di porre l’idea a fondamento della realtà, di porre principi universali a fondamento della storia, presupposti dogmatici ad una scienza considerata valida nel suo deduttivismo aprioristico. L’idea di progresso rappresenta, per Cattaneo, una conquista significativa, la radicale messa in discussione dei limiti prefissati e predefiniti all’emancipazione umana; su di essa egli imposta il principio di uguaglianza, il diritto di opportunità, consistente nell’offrire a tutti gli stessi mezzi, poiché solo così inteso il progresso può essere per tutti e assumere un significato universale. Sono ancora prime intuizioni, ma le basi per una matura riflessione sono già poste. Il liberalismo, cui egli fa riferimento, è propositivo, nella sua impostazione originaria, di istanze di grande forza epocale: la libertà, suo presupposto etico, il principio di rappresentanza, suo fondamento politico, la nozione di diritto, conquista-simbolo della demolizione del privilegio feudale-aristocratico; ma Cattaneo non ne coglie il vizio strutturale, l’ambiguità intrinseca. Come sottolinea Schiattone, il liberalismo “ha in sé l’ambiguità del rapporto individuo-società, attribuisce all’individuo un primato sulla società; ripone nell’iniziativa individuale il presupposto dell’organizzazione sociale, riconoscendo alla storia individua la componente del disegno sopraindividuale della storia”. Esso è espressione della borghesia, ceto egemone economicamente e politicamente, che ha introdotto la “democrazia liberale”, ma per perpetuare il potere e renderlo inattaccabile, ha introdotto il principio di popolo per sancire, attraverso l’istituzione della delega di potere, il diritto di “espropriazione della sua sovranità”. Cattaneo è, comunque, consapevole che la borghesia non può proporsi come unico ceto interprete dei bisogni della società e individua nella transazione la volontà di pervenire ad una interrelazione con gli 63 64 altri ceti, di equilibrare bisogni e aspettative, interessi e necessità; un principio che può apparire “velleitario perché l’equilibrio tra le forze di potere risulta sempre inadeguato”, ma sicuramente rispondente all’intento propositivo. Cattaneo, infatti, crede di poter “immettere”, attraverso la transazione, “un principio di ragione nella storia” che induca a guardare oltre gli inevitabili conflitti, a non vedere nella rivoluzione il loro momento risolutivo, anzi l’opposto, a riconsiderare intese e accordi, sempre possibili, tra le parti in causa; che consenta di comprendere le ragioni delle controversie, di risolverle all’interno della realtà sociale, favorendo nei contendenti la maturazione della coscienza individuale e sociale. Un sistema transattivo è un sistema che si apre alle nuove istanze, che si autoprogetta ed evolve. Altro non vede Cattaneo; e tuttavia egli rappresenta l’unico teorico che ha considerato la transazione come la possibile via del liberalismo verso l’utopia moderna. Non ha altro con cui esprimersi il liberalismo, se non una vaga nozione di decentramento, non sempre chiarificatrice della natura e delle mansioni delle autonomie che genera. Ma Cattaneo affronta questo tema, trasferisce la riflessione dal piano giuridico al piano politico, definisce le linee di un progetto di stato che costituisca per il cittadino l’espressione più alta della democrazia. Giunge così a prefigurare una federazione di stati, a precisarne le categorie costitutive, libertà e autonomia: la libertà diritto primo ed inalienabile della persona comporta l’autonomia, “cioè l’incondizionato riconoscimento della capacità di autogoverno in ciascuna persona in ciascun popolo”, come è affermato in un significativo inciso di Schiattone. Esplicita in tale definizione è, come egli sottolinea, la relazione individuo-società, la quale riporta a dimensioni sociali il volere del singolo che, in ragione del “valore sociale”, raccorda la propria volontà all’altrui volontà, non intravedendo in questo un ridimensionamento della propria persona ma un’opportunità di espansione della propria autonomia e libertà, in un contesto espressione, già di per sé, di tutte le potenzialità sociali e politiche, riassumibili nelle associazioni, nei movimenti, nei partiti, nelle federazioni delle arti e dei mestieri, nelle federazioni dell’industria; in tutte le possibili istanze e aspettative popolari. È l’idea di “pluralismo”, che in Cattaneo si carica di un forte significato utopico in quanto, così inteso, esso oltre che legittimare la pluralità delle prospettive sociali e politiche e ad esprimerne, nel comune senso della reciprocità e corresponsabilità, l’ampio concorso risolvendo l’emarginazione e la differenziazione tra ceti, rende possibile l’universale rappresentanza delle forze sociali. Solo allora risulta comprensibile il processo che fa sì che la società diventi stato, che la società concreta, luogo espansivo della propria libertà e autonomia, si dia un governo ed un’amministrazione rispondenti ai suoi bisogni. Una precisazione questa necessaria per comprendere l’avversione di Cattaneo per un sistema centralistico-autoritario e per l’ideologia unitaristica del Risorgimento, lesivi, a suo avviso, della sovranità popolare, correttamente esprimibile invece solo nella federazione, il cui fondamento, sul piano politico, è l’autogoverno, la capacità di “autorganizzarsi e autoamministrarsi, di autorappresentarsi”; sul piano economico, l’autogestione. Il rifiuto di ogni forma di omologazione, pericolosamente avvertita da Cattaneo (e Ferrari) anche nel progetto federalista di NOTE Pisacane, che prevedeva per gli Stati italiani la guida dello stato sabaudo, riporta l’attenzione sul problema di come sia comune ed ovvio rapportare la società allo stato, ritenere una società tale solo nella forma statuale e “investire lo stato di una ragione sovrindividuale contrapposta alla ragione dei singoli e dei popoli”. Per Cattaneo, la società diventa stato se sceglie di autodeterminarsi, di porre a proprio fondamento l’uguaglianza e la coesistenza pacifica, se realizza politicamente la sua autonomia, quale grado di consapevolezza della propria libertà, se si riappropria del potere come diritto della sovranità del proprio popolo e della singola persona costitutiva di quel popolo. In questo, il singolo membro della comunità deve avvertire il senso etico della responsabilità personale che impone “una prassi virtuosa”, cioè un formarsi consapevole alla libertà e all’autonomia, un educarsi alla cosa pubblica, alla sua difficile gestione, al suo governo che è poi il governo del popolo, un cementare in sé lo spirito comunitario, nella cooperazione e nel confronto. Il popolo rappresenta dunque il corpo dello stato, una comunità di eguali, sulla base del diritto e della dignità della persona. Solo un governo pienamente popolare porta alla concorde unione di entità statali, autonome nello spirito e nel valore della nazione. È la federazione il naturale esito delle insurrezioni popolari contro l’Austria. L’insurrezione, e non la rivoluzione, per Cattaneo come per Ferrari, rappresenta il momento in cui il popolo, cosciente della propria potenzialità “matura la rivolta, il ripudio dell’oppressione: in un sol tratto si emancipa”. Ma perché il diritto rientri nella prassi quotidiana e la partecipazione alla vita pubblica sia pienamente consapevole, Cattaneo ritiene necessaria quella che egli chiama “prossimità” o vicinanza fisica del cittadino alle istituzioni, vale a dire: il controllo diretto delle istituzioni, perché agevole è l’accostamento ad esse del cittadino, la valutazione diretta dell’operato dei governanti, con i quali immediato e rigoroso è il rapporto, il ritiro o la conferma del mandato di governo, il ripristino della sovranità ad ogni sua negazione. La prossimità, nota Cattaneo, richiede che lo stato sia piccolo, pienamente identificato con la comunità che lo costituisce, con il popolo che, in una tale realtà politica, rappresenta in forma democratica, semplicemente e pienamente se stesso; uno stato dalle dimensioni di una città e del suo circondario. Si arriva al punto centrale del discorso di Cattaneo, il ruolo storico della città, chiaramente delineato nel suo celebre saggio La città considerata come principio ideale delle storie italiane, ma anche in altri suoi scritti. Egli ricostruisce storicamente la genesi della città –seguendo il modello ateniese, quello dei comuni medievali e delle repubbliche– constata la sua forza aggregativa, il dinamismo produttivo e mercantile, la capacità di autoregolamentarsi, il costituirsi in essa dell’autonomia legislativa, vale a dire della democrazia (sia pure nei limiti imposti dal momento storico); essa rappresenta dunque il nucleo originario dello stato democratico. Cattaneo dimostra che, nella polis greca, lucido modello di comparazione, la gestione diretta dello stato ha il suo punto d’inizio nell’autonomia della città, nel livello di autogoverno che vi si afferma, nelle iniziative decisionali e deliberative delle assemblee e dei consigli. Pertanto, la società giusta –secondo l’accezione tipica– per Cattaneo è realizzabile nella città. Una funzione dunque feconda, prosegue Schiattone, 65 66 ma non considerata, nel suo giusto valore, dagli storici che hanno visto sempre le città come emanazione degli stati, degli imperi, mentre esse ne hanno costituito le basi. Cattaneo, su uno spunto offerto da Ferrari, capovolge il processo: lo stato promana dalle città e non viceversa. La città, ancora, è il luogo della socialità, espressione di tutti gli elementi dell’agire umano, dell’emotività, come della spinta solidale, che realizza l’armonia e la coesione tra i cittadini; la socialità è “disvelamento continuo dell’umanità dell’uomo”. Ma, continua Schiattone, l’espressione più alta della umanità dell’uomo è data dal valore che egli potrà attribuire alla libertà, per sé e per gli altri, poiché, nella libertà degli altri vi è “la certezza”della propria libertà. Questo costituisce il punto più alto ma anche più problematico della proposta cattaneana in quanto prerogativa di tutti gli uomini e di tutti i popoli diviene il diritto alla libertà e all’autonomia che postula il principio di universalizzazione della libertà, nella coscienza di ognuno; un principio di ragione che Cattaneo individua nella “dignità –diritto della persona, nella dignità– diritto dei popoli”, reso così efficacemente dall’espressione di Schiattone. In questo, il punto autenticamente utopico della riflessione cattaneana: la libertà, quale diritto universale, si contrappone agli abusi, alle prevaricazioni egemoniche e all’affermazione della potenza di uno stato sull’altro; con essa si ha il superamento della discriminazione e l’apertura verso la cosmopoli, verso una cittadinanza senza confini. Forte è nei popoli, come la storia attesta, un’ineludibile volontà di pace, che emerge con forza dopo ogni guerra, in ogni trattato, in ogni armistizio; il trattato è per Schiattone, riprendendo Cattaneo, “una conquista della coscienza, un atto di solenne giustizia che fa ringiovanire le istituzioni”, così come “la storia è un continuo dibattito sulla libertà e la giustizia, una continua petizione”. Nel diritto alla libertà si ritrova il principio di uguaglianza, nell’aspirazione verso la giustizia il riconoscimento nell’altro della dignità d’essere. Per questo è necessario superare ogni limite e chiusura, abbattere le frontiere, i confini, intesi da Cattaneo, come linee di contenimento delle diverse entità dei popoli, ma anche, con un’immagine pregnante, linee “sulle quali tutti i popoli confluiscono, scambiano comunicazioni e merci”, tracciando una cosmografia in cui tutti i popoli convivono nella loro “armoniosa varietà”; così ognuno è cittadino del mondo, ma nella singolarità della sua identità etnicoculturale. Questo il senso del cosmopolitismo di Cattaneo: il “cosmopolita ha bisogno di solide radici su cui fondare il proprio spirito di appartenenza mentre si aggetta sul mondo”. L’istanza straordinaria è il principio etico della cosmopoli che insiste nel riconoscimento della universale dignità umana, riassunta nei principi guida delle rivoluzioni, libertà uguaglianza e fraternità, non ancora pienamente inverati. Ancora altre e profonde sono le riflessioni di Schiattone, ma non è più possibile addentrarsi. Il rigore critico e analitico, l’essenzialità e insieme compiutezza delle trattazioni, la ricchezza degli spunti, delle riflessioni, dei riferimenti costituiscono il carattere saliente del suo apporto. Gli interrogativi, come egli afferma, rimangono: traspaiono nuove categorie, l’intersoggettività di Habermas, si affievoliscono i principi democratici, si avverte la necessità di un superamento delle federazioni storiche verso un federalismo più umano ed emancipato. I “LUOGHI DELL’ANIMA” DI MARIA ZAMBRANO Maria Zambiano (1904-1991) rappresenta una voce significativa del pensiero al femminile nel Novecento. Voce della hispanidad che si è fatta sentire in varie parti dell’Europa e del Nuovo Continente (Parigi, L’Avana, New York, Roma) a motivo del lungo esilio dal 1939 al 1984. Personalità di spicco, ella ha fatto tesoro del pensiero filosofico del suo maestro Ortega y Gasset e del magistero di Xavier Zubiri senza peraltro pregiudicare l’intimo sentire poetico che pervade i suoi saggi a metà strada tra letteratura e meditazione metafisica. Occasione del ritorno alla lettura della Zambrano è la recente traduzione italiana del volume L’uomo e il divino, ed. Lavoro, Roma 2001, opera di densa intelaiatura filosofica, che dialettizza il destino della civiltà europea secolarizzata, diagnosticandola tra il Sacro perduto e una forma di surrogata divinità antropocentrica, di cui si è appropriato l’uomo dell’Otto-Novecento in cerca di significati per poter sopravvivere. La lettura dell’opera in sé complessa è agevolata da una puntuale introduzione di Vincenzo Vitiello sulla filosofia della storia espressa dalla Zambrano e da una postfazione di Giovanni Ferraro che rivisita il percorso mistico della parola poetica dell’autrice. Riteniamo non superfluo un richiamo ad altri scritti della Zambrano allo scopo di agevolare i lettori che la conoscono meno. Leggendola, veniamo a contatto con una scrittura costantemente sollecitata dalla “conoscenza poetica”: un “logos embrionario” che si alimenta di umori viscerali e tende alla “conoscenza pura”, cioè al “dialogo dell’anima con se stessa” che cerca di essere ancora parola, la parola unica, la parola indicibile, la parola liberata dal linguaggio” (Chiari del bosco, trad. it. 1991). Vita e scrittura della Zambrano sono contrassegnate dalla cifra dell’esilio. I “claros” sono stazionamenti provvisori di tappe esistenziali raggiunte e subito abbandonate in vista di ulteriori viaggi dell’anima in cerca di luce che, tuttavia, si offre solo in episodiche radure spirituali grazie a folgorazioni improvvise che lasciano nostalgia nell’intimo. C’è, nella confessione talora orante di Maria Zambrano, il carisma dell’anima eletta che risponde a una misteriosa chiamata e pone la sua ‘vocazione’ sotto l’egida della parola poetica che impera sulla pagina e si fa eco di una carità assoluta nei confronti del popolo spagnolo e dell’intera umanità travagliati e storditi dagli eventi bellici della prima metà del Novecento. Una prosa tersa, sebbene ellittica, mette il lettore sull’avviso di non prendere troppo sul serio certe incandescenze nicciane o heideggeriane o marxiste, come pure di saper ridimensionare un misticismo locutivo sui generis che NOTE di Paolo Miccoli 67 68 a volte sembra apparentarsi col linguaggio di Eckhart, di s. Giovanni della Croce e persino con la lettura del Vangelo. Certo, i “chiari del bosco” richiamano, per assonanza, la ‘radura’ di Heidegger quale condizione di corrispondenza dell’uomo alla voce dell’essere. Ma nella sensibilità della Zambrano l’essere neutro di Heidegger è già avvistato e trasposto in presenza originaria dell’Amore preveniente e trasfigurante in senso di effettiva redenzione cristiana. L’uomo esiliato, che riesce a sottrarsi alle lusinghe e agli abbracci degli idoli terrestri, dispone la sua esistenziale indigenza alle pure invadenze “dell’amore che ci concerne e ci guarda, “che guarda verso di noi”, convocandoci all’ appello di un “sentire originale” «soltanto in qualche ‘claros’, aperti tra cielo e terra nel seno dell’iniziale vegetazione». Ogni creatura che vive di attitudine poetica è imparentata ai ‘Beati’: «vede o indovina la chiarezza nascosta nell’oscurità». Si appropria proletticamente dell’invisibile nel visibile proprio perché è in grado di sintetizzare fede e ragione, mistica amorosa e ricerca riflessiva nel vissuto quotidiano. Il “bienaventurado” è simultaneamente abitante del nostro mondo e insieme di un altro. Nel volume Los Bienaventurados (1990) si tratteggia l’identità del beato: essere di silenzio, fasciato, ritirato nella parola, distinto dal ‘santo’ che “patisce e arde per essere beato”, giacché mira ad approdare all’identità con se stesso. Il ‘beato’ è ‘ostaggio’ nel mondo, un trattenuto nell’esilio, un sofferente eppure riconciliato con la vita “a partire dalla raggiunta identità”. Questi richiami ci raggiungono come rimbalzo di luce che si sprigiona dai vari libri della Zambrano e consentono di avvicinare la riflessione filosofica più densa delle pagine di L’uomo e il divino, dove si dispiega una visione della storia che prende le mosse dal Sacro eclissato e da un equivoco modo di trasporre il Divino nell’uomo ad opera del razionalismo idealistico, poi fatto esplodere dal nichilismo nicciano che ha riservato al Superuomo i miseri onori dell’utopia illusoria. Gli elementi cardini del discorso possono essere ravvisati nella progressione depotenziata di tre idee: anima, coscienza, spirito. Eccone lo schema argomentativo. Il ‘luogo’ arcaico di sentire dell’uomo è l ‘anima, intesa come elemento turgido della vita, come “viscere” (entranas) di memoria orfico-pitagorica ed empedoclea, come ethos e pathos dell’essere che sta nella vibrazione originaria dell’Aurora. L’uomo panico si riflette nell’orizzonte del Sacro, inteso quale cifra totalizzante di delirio, di sogno, di estasi festiva. Un ‘sacro’ che può essere avvertito anche in forma dionisiaca e tragica, ma che trova le sue più congrue modalità esperienziali nella realtà femminile, la cui alta cifra simbolica è rappresentata dall’Antigone di Sofocle. Suggestiva la riflessione della Zambrano su La tomba di Antigone (ed. originale 1967). L’umanità, rivisitata archetipicamente affonda le radici nella ingens sylva del caos preistorico, da cui emergono troppo tardi gli ardimenti della tragedia greca. Dunque un Sacro pagano, più che biblico, quello della scrittrice spagnola. Un sacro naturalistico che troverà volto composto solo nella rivelazione cristiana. L’uomo moderno sta, invece, sotto il segno della coscienza razionalistica che ha già trasposto il delirio panico in certezza psicologica col cogito cartesiano. La ragione cogitante pensa il divino cioè l’idea di infinito, e ne tira le con- NOTE seguenze, deducendo e calcolando persino la divina geometria del mondo, del migliore dei mondi possibili. Trasposto in chiave filosofica, il divino si presenta come traccia illanguidita del Sacro archetipico. Il delirio di onnipotenza della coscienza riflessiva ha infine raggiunto il parossismo logico-dialettico con l’idealismo hegeliano che ha trascendentalizzato lo spirito (Geist ). Uomo, mondo e storia vengono ormai identificati in un’avventura dialettica inarrestabile all’insegna del protagonismo storico-etico della Libertà del genere umano. Che cosa ha guadagnato l’umanità con l’esplodere luciferino dell’orgogliosa conoscenza onnicomprensiva? Il dolente privilegio di un “occhio di troppo” e la deplorevole “nudità’” del “re mendico” in cerca della propria identità. L’uomo della trasgressione si ritrova nella condizione di Edipo accecato, che ha bisogno di guida. Siamo nel cuore della modernità che ha obliato le Origini e si sforza di infrenare “l’invidia” nell’inferno terrestre. La via della redenzione additata dalla Zambrano nel suo stimolante saggio di filosofia della storia e della cultura passa attraverso una forma peculiare di riappropriazione della Vita (vitalismo orteghiano) all’insegna della pietas che ci consenta non tanto di conoscere ma di patire le cose come dolce carezza e non come algidi fantasmi. Riappropriarci delle cose con larica sollecitudine chiama a raccolta fede e ragione nella direzione operativa dischiusa dal cristianesimo, che dispiega l’insegnamento sapienziale più alto nella rivelazione dell’amore quale pedagogia del “saper trattare l’altro”. Alla luce dell’amore evangelico la theorìa greca, sapienza umana troppo umana, va integrata con la dimensione mistica e poetica del sentire la Vita quale energia trasfigurante e additamento di destino umano che trova l’ultima e intrascendibile risorsa di senso nella misteriosa realtà del Dio-Amore. Si spiega così anche la legittimazione mistica dell’angoscia e del sacrificio in seno alla religione della Vita che è vittoria luminosa di Gesù Cristo sulla morte. 69 PER GIUSEPPE MUCCIARELLI POSITIVISMO PSICOLOGIA E STORIA di Girolamo De Liguori 70 Due convegni, promossi rispettivamente dalla Facoltà di Psicologia, sede di Cesena, e dal Dipartimento di Psicologia della Università di Bologna, hanno inteso ricordare in modo costruttivo l’attività di ricerca, di organizzatore editoriale e di coordinatore di studi del compianto Giuseppe Mucciarelli, psicologo profondamente impegnato nella ricerca sia metodologica che storiografica della sua disciplina. Il primo, dedicato specificamente a “Le biografie tra psicologia e storia”, si è tenuto a Cesena il 30 novembre 2001. Si è discusso di biografia e autobiografia, di biografia e storiografia, dell’essere e del farsi uomini nell’Ottocento, di autobiografia e teorie psicologiche, di false autobiografie e meccanismi dissociativi, di memorie individuali e collettive e finanche di storie di vita, di uomini e donne fra guerra e resistenza. In definitiva, si è voluto portare l’attenzione sul tema, particolarmente caro allo studioso scomparso, della continua intersezione tra psicologia e storia e sviluppare, in chiave operativa piuttosto che sterilmente commemorativa, l’impegno interrotto di Mucciarelli, psicologo e storico, attento alle frequenti connessioni disciplinari nel vasto campo della ricerca sul comportamento e le interrelazioni. Il secondo convegno, tenutosi il 24 maggio 2002 a Bologna, è stato dedicato a “Problemi di storiografia e di epistemologia della Psicologia” ed ha avuto relatori Renzo Canestrari, Riccardo Luccio, Guido Cimino, Luciano Mecacci, Nino Dazzi, Sergio Cesare Masin, concludendosi con una tavola rotonda condotta da Marco W. Battacchi sulla identità metodologica della psicologia. Dei rapporti tra Etologia e psicologia avrebbe dovuto riferire Stefano Parmigiani che per ragioni di forza maggiore ha dovuto disertrare l’incontro. Dopo un breve profilo dello scomparso, tracciato con viva intensità, il prof. Canestrari ha ricordato le sue doti di impareggiabile ricercatore, meticoloso e aperto nelle scelte di campo; di docente sempre disponibile nella sollecitazione e nel dialogo con gli studenti, ma anche la sua instancabile attività nell’edizione di testi poco noti, nella ricostruzione delle origini della psicologia italiana, tanto da farne un polo di costante riferimento per gli storici non soltanto della disciplina quanto anche della filosofia, della scienza, della antropologia e della critica letteraria. Sono quindi seguite le relazioni su quattro fondamentali momenti concernenti la storia della psicologia, connessa al problema epistemologico della propria legittimazione metodologica. Riccardo Luccio si è soffermato in modo particolare sui problemi di storiografia psicologica, mettendo in evidenza metodi errati e strade da evitare nel campo della ricostruzione storica. Una pars destruens, la sua, di particolare NOTE finezza argomentativa e di acutezza filologica che ha messo l’accento sulla necessità dell’inedito, degli epistolari e dei carteggi, esemplificando e non mancando di avvertire le difficoltà che si incontrano nel complicato percorso ricostruttivo sia di profili intellettuali di psicologi che di tematiche specifiche riguardanti teorie e tecniche diagnostiche. Ha, tra l’altro, avuto il merito di richiamare il nome di Felice Tocco, pur non lesinando critiche alla Nadia Urbinati che, nel 1984, ne avrebbe riesumato un Manuale scolastico “con un commento –dice testualmente il Luccio– acritico e colmo di franche corbellerie”. Le critiche non vengono lesinate neppure al testo del Tocco, definito “banale, bisognoso di molte correzioni che Tocco stesso ritenne di non pubblicare”; operazione che, francamente, avrebbe fatto torto allo stesso autore, del resto uno dei maggiori, se non il maggiore, storico della filosofia che l’Italia abbia avuto tra Ottocento e Novecento. Senza volere entrare nelle convinzioni del relatore, va osservato che il manoscritto, reso noto dalla Urbinati, era non più che la bozza di letture di psicologi, in particolare tedeschi, e che il suo valore sta tutto nel fatto che documenta la buona informazione e la considerevole attenzione di un filosofo italiano di quegli anni ai più avanzati sviluppi della psicologia sperimentale e non nella originalità sua di teorico della psicologia. Soprattutto se si tiene presente quanto, di lì a qualche anno, tali studi sarebbero stati avversati e sconsiderati dal trionfante neoidealismo; tanto che lo stesso Tocco avrebbe espresso il suo dissenso da Croce in termini che resta comunque merito della Urbinati avere ricordato: “il Croce ed io, parlanti due lingue diverse, non potremmo intenderci neanche a segni. Egli disdegna altamente la psicologia empirica, io, per l’opposto credo che una filosofia dello spirito senza una larga esperienza e psichica e storica non possa essere se non una bolla di sapone” (Cfr. N. Urbinati, Un manuale inedito di F. Tocco, Atti e memorie dell’Accad. toscana di scienze e lettere “La Colombaria”, Firenze, 1984, pp. 193-225). Guido Cimino ha presentato una sorta di carrellata sulla storia della storiografia in Italia negli ultimi trent’anni, relativamente alla psicologia nelle sue connessioni con la storia della scienza, ricordando il ruolo giocato dal Mucciarelli in questo campo di studi e leggendone la posizione raggiunta come un superamento ed un arricchimento di prospettiva rispetto a precendenti inchieste storiografiche della disciplina in Italia dalle quali emergeva una immagine sostanzialmente negativa se non del tutto fallimentare –almeno se ci si ferma al 1981, anno della diagnosi di Sadi Maharaba nel noto volume, Lineamenti di storia della psicologia italiana. L’esigenza del resto di quella che viene chiamata storia esterna della psicologia (in realtà la leggittima istanza di riportare la psicologia alla sua stessa storia che fu quella di relazioni con altre discpline, anzi di faticosa gestazione all’interno di statuti disciplinari che la tennero a battesimo, per così dire, dalla filosofia all’antropologia, dalla medicina alla neurologia, ecc.) era stata sentita dagli stessi padri fondatori della psicologia in Italia, da Giuseppe Sergi ad Ardigò, da Enrico Morselli a Bonaventura a Ferrari a De Sarlo, autori in cui fu evidente il travaglio di trovare il terreno sul quale dichiarare l’autonomia della discplina dalle sue matrici storiche. 71 72 Mecacci, in un intervento del tutto originale, ha trattato dell’idea di mente come spazio: contro l’abusata prospettiva dualistica di uno spazio tutto esteso e di una mente (pensiero) inestesa, secondo l’archetipo cartesiano di res extensa e res cogitans. In realtà, quella di Cartesio, era una metafora: la metafora della mente come spazio; e la sua eterogenità rispetto al corpo, come puro spazio, era data soltanto dalla sua indivisibilità di contro alla divisibilità della corporeità. La mente, in definitiva, era un modo per indicare una complessità di funzioni e, implicitamente, una sua scomponibilità non disgiunta dal luogo dove pur dovevasi collocare. L’assoluta contrapposizione tra spazialità e mente, infatti, non resse a lungo nella tradizione del pensiero moderno. Già Leibniz escogitò il modello del mulino per raffigurarla: una sorta di macchina che, pur non spiegando come avvenga la percezione, ne mostrerebbe almeno gli ingranaggi. Del resto, tale immagine era stata preceduta da quella del teatro cartesiano: un grande scenario interno, complesso e variegato, che è un po’ l’antefatto dell’interno della coscienza freudiana: un conscio e inconscio che sono come due vani di un unico appartamento. Essa non ha un suo luogo ben determinato: non è costituita di neuroni; perciò le teorie della localizzazione cerebrale le restano estranee, come un ramo secco della evoluzione del concetto stesso di mente. Ha tuttavia una sua spazialità costituita da molti spazi: una sorta di scatola nera della esistenza, non fuori dello spazio ma connessa alla fisiologia del corpo, tanto da far dire a Freud che “la mente è estesa ma non lo sa”. Il Masin ha tracciato una storia molto tecnica della psicofisica, da Fechner e dalla legge di Weber ai nostri giorni, suscitando interventi e consentendo un serrato incontro con alcuni studiosi convenuti tale da arricchire la tematica proposta. Nino Dazzi, dal canto suo, ha offerto, da storico della psicologia, una interessante trattazione delle somiglianze ma soprattutto delle differenze tra due cospicui protagonisti della psicologia tra Otto e Novecento, William James (1852-1910) e Karl Stumpf (1848-1936). Il raffronto gli ha offerto, in pari tempo, l’agio di ricordare la posizione che Giuseppe Mucciarelli aveva conquistato anche tra gli storici della psicologia italiana; e su tale questione vorrei riportare una mia più personale esperienza –della quale un rapido cenno avevo fatto, come testimonianza d’affetto e di stima, al convegno di cui si discute. “Il contributo offerto dai pensatori del positivismo in Italia alla affermazione della psicologia come scienza autonoma”. Questo il tema che con l’autore avevo personalmente discusso e progettato di portare avanti, con sondaggi storico-critici circostanziati, tra gli anni 1986 e 1988. Ne sono testimonianza alcune sue lettere che conservo e alcuni spunti che trapelano da suoi interventi di presentazione dei fascicoli della rivista da lui diretta e voluta, “Teorie e Modelli”. Il progetto, per quel che riguardava la mia collaborazione, si arrestò a due contributi sulla polemica intorno alle teorie del parallelismo in Italia, usciti su “Teorie e modelli”, nell’ ’86 e nell’ ’87. Ma, dopo una lunga interruzione durata più di un decennio, il nostro dialogo era ripreso; tanto che lo stesso direttore, nel presentare il numero doppio 1-2 del 2000, dichiarava con la chiarezza che gli era consueta, di voler “dedicare spazio in modo sistematico alla pubblicazione di lavori che riprendano argomenti “classici” della storia della psicologia in Italia ed allo studio di pensatori e di movimenti che sono stati tra- NOTE scurati e sottovalutati”. E, introducendo il mio nuovo articolo su Tito Vignoli, esplicitamente prometteva di “pubblicare in un prossimo numero materiale inedito del Vignoli […] con l’obbiettivo di ripubblicare alcune sue opere nella Collana Classici della Psicologia Italiana edita da Pitagora Editrice e che rappresenta una sorta di prolungamento dell’attività scientifica della rivista” (cfr. Premessa, in “Teorie e Modelli”, V, 1-2, 2000). Una serie di circostanze, tra le quali, più pesante e irrimediabile, la morte del nostro amico e, in più, del nipote di Tito Vignoli il dottor Antonio Cipollini, mi impedirono di portare avanti il disegno di completare definitivamente i miei studi sulla figura e l’opera di questo positivista, con la pubblicazione di lettere inedite di suoi corrispondenti e la ristampa con introduzione e note delle sue due opere maggiori, interessanti la psicologia. Se ben ricordo, del resto, il mio interesse specifico per Vignoli era nato proprio dalle nostre prime conversazioni, durante una pausa estiva nelle campagne pugliesi, nelle quali egli mi aveva confidato di volere riproporne alcuni saggi come Mito e scienza e La legge fondamentale dell’intelligenza nel mondo animale, testi che io avevo incontrato in quegli anni in cui andavo facendo indigestione di postivisti italiani di varia estrazione. Trascurati del tutto in Italia, li avevo trovati citati nell’opera di Ernst Cassirer e nella biografia di Warburg scritta da Gombrich, nonché negli interventi censori del padre Previti e di “Civiltà Cattolica”, negli anni Ottanta del secolo XIX. L’ipotesi storiografica che premettevo a tale ripresa del lavoro, era che quanti in Italia, tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX, si ponevano la complessa questione della fondazione dello statuto della psicologia collegavano sempre questa all’antropologia. Quanti sostenevano, contro vecchie preclusioni metafisiche o pregiudizi religiosi, l’autonomia della psicologia come scienza –sovente contro i gesuiti che, guarda caso, individuarono prontamente in Tito Vignoli un nemico della recta ratio, accusato di invocare autori stranieri e di indicare nella sperimentazione la risoluzione di problemi che soltanto religione e filosofia, assieme coordinate, potevano impostare e correttamente provarsi a risolvere– tutti indistintamente, ritenevano che una corretta fondazione della psicologia dovesse sottendere una nuova antropologia. Su tale terreno della stretta connessione tra psicologia e antropologia si impegnarono medici, fisiologi, neurofisologi, filosofi, antropologi: da Mantegazza a Lombroso, da Sergi a Vignoli, da Ardigò a Morselli, da Canestrini a Livi, a Tamburini, a Luciani, a Mosso, a Golgi, a tutto il fronte variegato e tormentato della cultura scientifica di ispirazione positivistica dei primi decenni del secolo. Quello che si chiamò o si individuò polemicamente come “positivismo” non fu perciò una scuola di filosofia; ma più semplicemente (se non soprattutto) un non sempre concorde schieramento di studiosi che, tra errori e tentativi frettolosi di sintesi, cadute scientistiche e appiattimenti meccanicistici, tenne una frontiera, contro le fughe idealistiche, in favore delle scienze dell’uomo, come scienze sperimentali. Grazie a Buccola, De Sarlo, Moleschott, Adolfo Faggi, e i già ricordati Sergi, Ardigò, Morselli fino a Piero Martinetti (filosofo, si badi, metafisico!) i nomi di Darwin, di Spencer, di Helmoltz, di Lotze, di Fechner, di Wundt, di Mach, non furono richiami retorici; e i problemi della percezione, del 73 74 rapporto mente-corpo, connessi alle questioni di neurologia, della scoperta della cellula prima e del neurone poi, cessarono di costituire campo chiuso degli anatomo-patologi da un canto e dei metafisici dall’altro, per diventare aspetti osservativi sistematici di una nuova metodologia di ricerca e analisi che avrebbe portato alla fondazione della psicologia scientifica. Certamente la connessione tra le due discipline comportava dei rischi, primo tra tutti quello, subito individuato e combattuto in Sergi, ad es., Morselli, Lombroso e compagni, del riduzionismo materialistico; ma per buona parte dei nostri positivisti tale legame significava mantenere la nuova disciplina dei comportamenti al riparo dalle prevaricazioni della metafisica spiritualistica che intendeva riportare l’origine del pensiero e dei fatti psichici nonché dei comportamenti in generale sotto la tutela della teodicea. L’antropologia significava una nuova concezione dell’uomo, evoluzionistica, progressiva, non antropocentrica, che legava l’essere umano agli animali e quindi all’universo in una scala ascendente senza soluzioni di continuità. Essa consentiva di leggere i fenomeni psichici come espressione complessa delle funzioni naturali e non come manifestazioni di forze soprannaturali, spirituali o divine. Antropologia era anche, di volta in volta, filosofia della natura e fisiologia; anatomia patologica e fisiologica; era costruzione teorica di una immagine di essere umano basata sui progressi della neurologia, sulle osservazioni degli esploratori, sui diari e i dagherottipi riportati dai viaggiatori in Asia, in Africa, in Oceania, in Brasile; sulle prime incerte conclusioni comparative di tratti somatici e comportamenti di popolazioni da poco avvicinate e osservate; e, infine, sui turbamenti, sia pure, o, talvolta, l’agnosticismo che prendeva i ricercatori che provavano ad avventurarsi in quei campi ancora oscuri degli organi di senso e del cervello in particolare che avrebbero costituito, tra non molto. il terreno di coltura delle future neuroscienze. Chi vorrà riprendere quest’ordine di ricerche storiche, del resto sempre fondamentali per ogni nuovo impegno teorico nel campo della psicologia come della storia della scienza, dovrà ricominciare da dove a Giuseppe Mucciarelli non è stato più consentito di procedere oltre. I LINGUAGGI DELLA RICERCA STORICA: I VOCABOLARI DI BRAUDEL* I. Il nome di Braudel è soprattutto legato alla proposta di una storiografia resa in grado d’indagare i “processi di lunga durata”, svincolata dai rigidi criteri di ricerca della tradizionale indagine storica di tipo evenemenziale. “Il tempo è come l’oceano”, ha dichiarato una volta lo storico francese: in superficie scorrono i fatti che caratterizzano lo sfuggente moto ondoso della cronaca; in profondità sfilano le correnti responsabili degli equilibri di “lunga durata”. La storiografia di Braudel si è sempre mossa tra questi due estremi, nel tentativo d’individuare i compositi ordini di configurazione dei fenomeni storici. Quella braudeliana non è solo, però, una rivoluzione metodologica in storiografia. È anche un’incessante ricerca volta a combinare metodi e linguaggi. Aggredire i fatti, disporsi a far luce sui processi storici significa dotarsi di un linguaggio teso ad isolare il singolo evento, immergendolo nel contesto di cui è espressione. Come può lo storico con il suo linguaggio attraversare il tempo, perimetrare un’epoca, fare i conti con i vari livelli di profondità dell’oceano della storia? A tale interrogativo tenta di offrire una risposta Giovanni Mari in questo volume dedicato all’opera del massimo esponente della storiografia annalistica e, in particolare, allo studio dei livelli linguistici della sua monumentale monografia, pubblicata nel 1949, dal titolo La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Mari si propone, sin dalle prime battute, sia d’introdursi nel “laboratorio lessicale” dello storico transalpino, sia di penetrare la sua concezione filosofica della storia. Tutto ciò nel tentativo di ricavare un piú ampio significato culturale dalla rivoluzione storiografica degli annalisti. Il punto di partenza dello studio è l’analisi della Prefazione braudeliana a La Méditerranée, dove Braudel spiega come il libro si articoli in “tre parti”, ciascuna delle quali costituisce un “tentativo di spiegazione a sé” (p. 15). Il primo tipo di spiegazione a cui si allude è quello relativo ad “una storia quasi immobile, quella dell’uomo nei suoi rapporti con l’ambiente”; il secondo si riferisce ad una “storia lentamente ritmata […], quella dei gruppi e degli aggruppamenti”; il terzo si lega alla tradizionale “storia événementielle”. Il risultato piú immediato di tali distinzioni consiste nell’aver scomposto il * A proposito di G. MARI, I vocabolari di Braudel. Lo spazio come verità della storia, Luciano Editore, Napoli 2001, pp. 184. Le pagine delle citazioni tratte da questo libro sono indicate, nel corpo del testo, in parentesi tonde. NOTE di Sandro Ciurlia 75 76 “tempo della storia” in “un tempo geografico, un tempo sociale, un tempo individuale” (Ib.). In questo modo si scinde “l’uomo in un corteo di personaggi”. Le esigenze di ricerca e la progressiva analisi delle questioni potranno portare –avverte Braudel–, “strada facendo”, a “passare dall’uno all’altro” di questi piani della spiegazione storica. Ne discenderà “una storia vivente e necessariamente una”. Questo tipo di storia configura, in realtà, non tanto un superiore piano ontologico, sintesi dialettica dei precedenti, quanto un orizzonte, un ideale regolativo di tipo metodologico per comprendere le tante dimensioni dell’azione umana immersa nel tempo, per far interagire i singoli nuclei di senso perseguiti da ciascun tipo di spiegazione: difesa ad oltranza, dunque, dell’unità della storia e del pluralismo storiografico. In verità, ogni piano della ricerca si compone di brevi, ed altrettanto complesse, “storie trasversali” (p. 19), che tocca allo storico legare, combinare, cogliendo nessi ed analogie tra gli eventi, allo scopo di ricostruire e di descrivere l’identità dei fatti e la policromìa degli sfondi. In questo senso l’unità della storia costituisce, per Braudel, “la totalità delle connessioni comprese” (Ib.) e si individua nello spazio che le ha rese possibili, nella fattispecie in quel crogiolo di civiltà qual è stato il mondo mediterraneo. Ora, se i tre modelli di storia sono stati presentati come “spiegazioni a sé” in qual modo dev’essere inteso il suddetto piano della “storia vivente e necessariamente una”? (p. 17). Come si può osservare, i problemi raccolti in quest’impostazione sono molti e fa bene Mari a giustificare il proprio libro come un lungo “commento” (Ib.) della Prefazione metodologica dell’opera braudeliana. Da essa emergono sia una dichiarazione di principio, sia un’evidente filosofia della storia protesa a ridefinire la natura dei rapporti tra le categorie storiche di spazio e di tempo. A giudizio di Mari, per gettare luce sulla stratigrafia dell’opera di Braudel è necessario, dunque, far luce sui suoi linguaggi. A tale scopo, l’autore non esita a prodursi in un approccio “analitico” al problema al fine di consentire al significato nascosto tra le righe della suindicata Prefazione braudeliana di esprimersi. Mari utilizza, anzitutto, la nozione wittgensteiniana di “gioco linguistico”, secondo la quale “il significato di una parola è nel suo uso linguistico”, essendo ciascun gioco “una forma di vita”, un mondo a sé. Cosí, dichiara Wittgenstein, “quando comprendiamo il significato di una parola […] lo afferriamo di colpo”1. Ne conseguono due risultati: è possibile considerare sia le tre “spiegazioni a sé” cui allude Braudel come altrettanti “giochi linguistici”, sia la “storia vivente e necessariamente una” come il momento della “comprensione” e dell’esplicitazione di una certa visione del mondo. Ciascuna delle dette “spiegazioni” –s’è detto– è legata ad un vocabolario. Parafrasando Rorty2, Mari intende per vocabolario “i giochi linguistici come totalità” (p. 26). Quella di Braudel è stata un’autentica rivoluzione linguistica in storiografia grazie all’uso continuo di tropi tesi ad investire di senso quelle spiegazioni “strada facendo” che possono risultare tanto illuminanti nel corso della ricerca. La metafora non appartenendo, nel suo uso letterale, ad alcun vocabolario, forza il consueto assetto semantico del linguaggio e gioca con i giochi linguistici: distorce ed amplia, cosí, significati consueti e condivisi; spesso “irrompe in un vuoto”, fino a proiettarsi sul “teoreticamente impossibile”3, NOTE rendendolo logico e coerente. La conseguenza piú diretta consiste, comunque, nell’ampliamento dell’area semantica di un dato termine. Secondo lo stesso schema, Braudel utilizza ed interseca i propri vocabolari, legati alle dette “spiegazioni a sé”, mentre l’uso ingente della metafora occorre a penetrare, attraverso il linguaggio, i tanti coni d’ombra del passato, cambiando registro, modulando toni, recingendo di nuovo senso gli spazi, ridefinendo la rettilineità del tempo in relazione a quel piccolo universo qual è l’area mediterranea ai tempi di Filippo II. In tal modo, si pone assieme una storiografia finalizzata a contemperare le tante anime di un’epoca con l’unità del suo senso; un’unità sintesi del molteplice, che non si riduce dialetticamente all’Uno, ma che vive della sua stessa varietà in seno ad un impianto unitario, conseguito mediante l’apporto dei risultati delle ricerche di varie discipline limitrofe alla storia. In questa maniera, il mondo mediterraneo esprime tutta la sua ricchezza di forme e si dimostra un nucleo di civiltà in cui si sono codificati equilibri compositi, tali da condizionare in modo duraturo i futuri assetti dell’intera Europa. Rimane in piedi un punto di enorme rilievo: nell’opera di Braudel, la ricerca di un significato complessivo della storia non compromette il valore dell’indagine evenemenziale perché convivono, nella sua produzione, i momenti della comprensione e della spiegazione. Pertanto, l’evidente presenza di una filosofia della storia non preclude la possibilità di immergersi nelle abissali profondità dell’oceano del passato, vagliandone le increspature superficiali e le forti correnti che ne alimentano il moto nel profondo. L’utilizzo di vari vocabolari, cioè di termini significanti legati da sostanziali “somiglianze di famiglia”4, garantisce un adeguato scandaglio della superficie nascosta di quello spazio. Nel caso dell’opera braudeliana del 1949, i “tre piani” dell’indagine si legano ad altrettanti approcci linguistici, ciascuno sorretto da un vocabolario: quello dell’“ambiente”, quello dei “destini collettivi” e quello degli “avvenimenti”, a cui Mari dedica i tre capitoli centrali del libro. Nella prima parte di La Méditerranée, Braudel significativamente pone l’accento sull’ambiente geografico. Trova qui applicazione la teoria della metafora prima evocata. Il vocabolario ambientale braudeliano opera una sorta di continua trasmigrazione linguistica dalla geografia alla storia: utilizza, infatti, termini designanti la morfologia fisica del territorio per disegnare nuovi sentieri di ricerca. Un esempio è costituito dall’utilizzo traslato del termine “istmo”. Quest’ultimo, nel linguaggio ordinario, indica una lingua di terra che mette in comunicazione ampi territori. Questi luoghi, in Braudel, divengono ponti di passaggio di civiltà, “attori” della storia, strumenti attivi di trasmissione di tradizioni, di significati, di cultura. L’istmo diviene, cosí, “un fattore di unità, di comprensione unitaria di mari, popoli, azioni e terre” (p. 44): ciò accade in relazione agli istmi russo, polacco e tedesco. Un simile utilizzo metaforico del vocabolario della geografia permette di cogliere il sorgere delle civiltà nelle loro relazioni “durature” con l’ambiente, il quale diviene, a sua volta, un “attore” di “irradiamento” delle culture dei popoli, condizionandone gli spostamenti, gli scambi commerciali, l’economia. La civiltà, in tal modo, letta nella “lunga durata” del suo manifestarsi, fa i conti con 77 78 l’ambiente, rende flessibili i suoi confini, li lega allo spazio e non solo allo scorrere del tempo. Lo stesso discorso vale per la trattazione braudeliana delle nozioni di “montagna” (per traslato da intendersi come una forma di ‘rifugio’), di “deserto” (la cui implacabilità richiama la ferrea fedeltà al dogma religioso tipica del mondo islamico), di “isola” (da leggersi come un luogo chiuso e senza confini dove si concentrano vita e storia) o di “mare” (inteso come lo spazio in cui sorge la civiltà mediterranea). La nozione di Mediterraneo costituisce, inoltre, un’unità umana, un punto d’“incontro” tra varie linee di forza; un mondo che finisce col diventare il mondo lungo cui si snodano e si esprimono i destini della modernità. In questa maniera, si assiste alla creazione di un “vocabolario “geostorico”” (p. 66), volto a descrivere il rapporto tra evento ed ambiente. Quella ambientale rappresenta, dunque, una delle citate “spiegazioni a sé”. A sua volta, la tropizzazione del linguaggio geografico conduce a costituire una prima forma, ancorché provvisoria, di unità della storia, colta attraverso la costituzione di un vocabolario fatto di strumenti linguistici che “permettono di parlare di cose di cui precedentemente non si riusciva a parlare nello stesso modo […] e soprattutto congiuntamente” (p. 68). Diviene possibile realizzare, cosí, quei passaggi di piano volti a compiere quelle “spiegazioni” trasversali resesi disponibili “strada facendo”, alle quali Braudel si era riferito nella Prefazione alla sua opera maggiore. Ma che tipo di relazione sussiste tra la prospettiva della spiegazione storica e l’utilizzo delle unità linguistiche dei vari vocabolari di senso? Chiarisce Mari: “La spiegazione è guidata dalle metafore, non le spiega […]. La spiegazione interviene dopo che la metaforizzazione ha già predisposto l’unità di senso e si sofferma solo su alcuni aspetti di questa” (p. 69). In altri termini, la metafora sollecita il linguaggio a configurare orizzonti unitari a tutto vantaggio del momento della spiegazione, il quale, invece, “illustra il significato della metafora” (Ib.) e ne utilizza l’avanzamento di senso nel frattempo conseguito per risolvere certi quesiti e porne altri. Se, viceversa, il momento logico della spiegazione fosse a fondamento dell’uso metaforico dei vocabolari si perderebbe di vista l’attività storiografica di illustrazione della testimonianza e del documento appartenenti ad un altro presente. La capacità, insita nella categoria della spiegazione, di far uso delle varie risorse del linguaggio rende la ricerca storica un’impresa critica. II. Oltre al vocabolario dell’“ambiente”, Braudel propone un altro tipo di “spiegazione a sé”, quella relativa al vocabolario dei “destini collettivi”. Si tratta di una sezione della ricerca di Le Méditerranée che si occupa dell’analisi dei processi socio-economici posti a determinare gli assetti di una civiltà complessa qual è quella mediterranea del Seicento. “È chiaro –sottolinea Mari– che [qui Braudel] crea un vocabolario dai confini lessicali meno precisi e uniformi di quelli del vocabolario dell’ambiente, ma in compenso in grado di parlare e di riportare sullo stesso piano una maggiore varietà di accadimenti” (p. 74). In questo modo, si persegue la costituzione di un vocabolario finalizzato a descrivere i caratteri di un’intera epoca senza che, con ciò, esso assuma i crismi di una sorta di meta-vocabolario finalizzato a descrivere la “globalità” NOTE degli eventi. Si rende possibile cogliere, cosí, “la misura del secolo” dai grandi spostamenti finanziari, dallo studio dei traffici di spezie e di metalli preziosi. In quest’aspetto “non vi è alcun segno di una considerazione fondativa dei fatti economici” (p. 82), ma solo l’applicazione di quel programma storiografico di ricerca volto a rintracciare i fattori che determinano l’evolversi dei processi complessi. L’economia è tra questi. Infatti, non si tratta solo di tenere conto delle dinamiche finanziarie tardo rinascimentali, quanto di osservare come lo spazio storico definisca il proprio assetto attraverso la valutazione del fattore economico. L’economia regge le sorti di un’epoca come fattore coagulante e come “misura” di un tempo, non configurandosi alla maniera di una “categoria strutturale” della storia: in questo consiste l’elemento metodologico di differenziazione tra l’approccio braudeliano e quello di un qualunque storico marxista. L’economia, dunque, come parte integrante del “vocabolario dei destini collettivi”. Lo stesso si può dire per la politica, l’etnografia, l’analisi sociale e la storia delle battaglie. In relazione al primo aspetto, Braudel tratta la vicenda della formazione dei grandi “colossi politici”. La loro “lunga evoluzione” conduce alla costituzione degli imperi, quelli turco e spagnolo. Quando parla di civiltà, invece, Braudel intreccia i propri percorsi di ricerca con quelli dell’etnologia, secondo un piano programmatico teso ad intersecare l’ordine dell’indagine storiografica con quello della descrizione delle condizioni complessive della vita civile. Si costituisce, in tal modo, la nozione di “spazio lavorato”, vale a dire riccamente tramato di senso in quanto luogo di convivenza civile e culturale tra gli uomini. Calato in quest’ottica, lo storico si mette nelle condizioni di osservare “permanenze” ed epifenomeni, seguendo i “piani” delle sue indagini. Nella Parte terza di La Mèditerranée, Braudel discute gli sviluppi degli eventi relativi al periodo del regno di Filippo II e mette a punto un terzo tipo di “spiegazione a sé”, legato alla costituzione di un “vocabolario degli avvenimenti”. Lo scorrere degli eventi è dominato dalla complessità dei meccanismi di lunga durata e dalle singole azioni degli individui: che rapporto c’è tra questi due poli? Ad un simile interrogativo Braudel offre una risposta nella conclusione dell’opera. A suo giudizio, isolare uno dei due aspetti è deleterio. La storia non è fatta né solo dagli “uomini”, né solo da “forze massicce”. Ciononostante, la libertà individuale, la sagacia e la prontezza dell’intuizione hanno il loro peso nel condizionare, in seno a certi processi, l’apertura delle “pesanti porte” della storia. Al riguardo, Braudel pensa a personaggi quali don Giovanni d’Austria e Pio V. Mari suggerisce di denominare tali figure “individui super-evenemenziali” (p. 136), perché collocati ““oltre” il tempo degli avvenimenti”, capaci di “forzare il corso degli eventi” (p. 137). Ben oltre lo stesso Filippo II, Solimano o Dragut, alla volontà dei due detti protagonisti si deve l’aver forzato l’ordinato circuito degli avvenimenti: sono, questi, alcuni degli elementi “trasversali” che lo storico può analizzare “strada facendo”. L’individuo super-evenemenziale è spesso legato ad un fenomeno di ‘rottura’, frutto della sua prorompente personalità. Vi sono anche, però, personaggi o avvenimenti per cosí dire di contesto, la cui caratura storica come capacità d’incidere sugli eventi tocca allo storico stabilire, e che assumono un 79 valore per lo piú contingente. In questo scontro tra “profondità” e “superficie” si gioca la dialettica della storia. Secondo Mari, Braudel pare assumere un atteggiamento “doppio” (p. 151): per un verso preferisce privilegiare lo spazio entro cui gli uomini agiscono e le cose accadono; per l’altro s’avvede di come “la storia [sia] l’immagine della vita in tutte le sue forme”, ridando tono, in questa maniera, all’evenemenziale. La storia, infatti, è una sorta di “gioco di specchi” (p. 153) tra la volontà individuale che contribuisce a determinare il profilo dell’evento ed i processi entro cui quest’ultimo si specifica in una continua lotta per il “riconoscimento” della propria identità. Entro questa prospettiva finalizzata a legare l’accadimento e l’azione dell’individuo alla lunga durata della storia tende a configurarsi un’idea complessiva di storia in grado di combinare i due aspetti (gli “uomini” e le “forze” della storia), senza arrivare a far leva su un télos, come accadeva nelle grandi prospettive storicistiche della tradizione. Torna qui il tema dell’unità della storia e dello spazio come sua unica verità. 80 III. La Méditerranée –s’è detto– è un’opera nella quale confluiscono resoconti, approcci trasversali, passaggi di piano “strada facendo”, verso una “storia vivente e necessariamente una” che ha come protagonista uno spazio, il mondo mediterraneo, lungo cui si snoda una civiltà complessa e dai tanti volti, quella dell’età di Filippo II. Secondo il ragionamento induttivo di Mari, si può concludere che, nello studio di Braudel, “una certa idea [di spazio] è la verità della storia” (p. 161). Per chiarire la questione, Mari cita il giudizio su Braudel elaborato da Paul Ricoeur in Temps et récit. Quest’ultimo aveva colto l’unità dell’intreccio di storie di cui si compone l’opera braudeliana in una certa concezione della temporalità responsabile di tale “sintesi dell’eterogeneo”5. Mari interpreta la proposta di Braudel, viceversa, come un invito a liberarsi dall’ossessione del tempo. Già Hegel, parlando del Mediterraneo come dell’“asse della storia universale”, aveva riscattato lo spazio dalla sua connotazione meramente geografica, anche se la disposizione degli eventi era sempre da collocarsi in seno alla Weltgeschichte6. Superare il fondamento temporale significa tornare a fare i conti con la categoria storica di spazio. L’unità dello spazio, cosí, contrassegna l’unità della storia. “In Braudel l’unità è un ulteriore significato che la pluralità acquisisce” (p. 173): quando Braudel parla di unità della storia non allude al culmine di un percorso teleologico, ma al modo in cui si combinano le tante storie che si raccolgono in un dato spazio. In questo senso la ricerca dell’unità coincide con la piena esaltazione della molteplicità tanto dei punti di vista narrativi, quanto degli approcci metodologici. Una storia senza télos, dunque, capace di valorizzare le “spiegazioni” e di sottrarsi a qualsivoglia neostoricismo speculativo. Importante questione, questa, secondo Mari, da proporsi nell’età della globalizzazione, nella quale il primato del tempo sancisce l’oblio dello spazio verso forme sempre piú astratte ed impersonali di dominio e di concentrazione di potere. In questo punto si concentra il significato culturale della rivoluzione storiografica braudeliana. L’immagine complessiva di Braudel che emerge dallo studio di Mari è quella di uno storico attento a combinare tante nicchie di significati da cui attinge- NOTE re l’unità della storia, detronizzando la “storia evenemenziale” per focalizzare l’attenzione sulla “storia lentamente ritmata”. L’approccio di Mari, inoltre, risulta assai suggestivo in relazione soprattutto alla definizione dei tre vocabolari in quanto “spiegazioni a sé” di cui si serve Braudel. In tale prospettiva è risultata assai utile la “lettura […] analitica” (p. 11) messa a punto da Mari per descrivere l’impianto de La Mèditerranée. Discutere i concetti di spiegazione, metafora, forma linguistica al fine di ritornare ad illuminare le traiettorie storiografiche braudeliane si è dimostrato un modo efficace per gettare nuova luce sull’imponente opera dello storico francese, in un momento in cui sono maturate, forse, le condizioni per stendere un severo bilancio critico dell’esperienza annalistica. Distinguere le tre forme di vocabolario allo scopo di rendere ragione di una simile forma di storiografia pluralistica suscita, però, qualche osservazione. Nell’enfasi ‘analitica’ di Mari tesa a giustificare i piani braudeliani del linguaggio appare, in verità, troppo netta la distinzione tra i vocabolari, proprio alla luce delle fluidificazioni “strada facendo” sulla cui necessità lo stesso Braudel non esita spesso ad indugiare. I confini tra i vocabolari sono davvero cosí netti da poter essere riconosciuti? Ed ancora, quella data trattazione che si erige sul loro confine di quale vocabolario fa uso visto che partecipa di piú d’uno? È un vocabolario questo tipo di vocabolario? In altri termini, nel momento vivo della ricerca la complessità dei problemi, al di là delle dichiarazioni di principio, non richiama spesso l’ausilio di piú vocabolari, passando da un piano all’altro per rispondere alla necessità di contestualizzare il dato storico e, nel contempo, all’esigenza di esprimere la compiuta fisionomia dell’evento? I tre vocabolari esprimono rispettivamente gli orizzonti dell’“unità”, dell’“universalità” e della “globalità” degli avvenimenti. Ciascuno, a suo modo, avendo citato Wittgenstein, configura un “gioco linguistico”, una “forma di vita” o una prospettiva narrativa nel nostro caso. Ora, esiste un Vocabolario dei vocabolari, un Gioco attraverso cui si determinano e si esprimono morfo-sintatticamente i singoli giochi? Le stesse difficoltà, queste, dell’impostazione wittgensteiniana. Il riferimento di Mari all’opera del filosofo austro-britannico nel mentre guida a comprendere la complessità dei piani su cui si fonda l’attività storiografica braudeliana si accompagna a tutti i problemi legati alle condizioni di autodicibilità dei vocabolari che, in Braudel, condividono la stessa sintassi e la stessa semantica, pur possedendo una diversa capacità euristica di aggredire le dinamiche storiche. Dunque, il fatto che tali vocabolari abbiano un’estensione parallela, richiamandosi in una sorta di dialettica corrispondenza di reciprocità ed indipendenza, rappresenta il loro punto di forza e, insieme, il loro limite. Braudel, in realtà, li usa nelle tre sezioni del libro, ma li interseca per affrontare molti passaggi problematici o per scardinare numerose stereotipie evenemenziali. Risulta, pertanto, difficile continuare a tenerli distinti e, soprattutto, ritenere di poterli riconoscere e definire data la loro frastagliata e problematicissima superficie di estensione. Non va trascurato, inoltre, il fatto che una visibile filosofia della storia s’insinua nelle maglie delle indagini braudeliane con inevitabili costi di opacità storiografica. L’idea dell’unità della storia, la tesi della presenza di figure emble- 81 82 matiche poste a guidarne gli sviluppi, il programma di descrizione della planimetria complessiva dei processi depongono a favore della costituzione, in Braudel, di una concezione della storia stessa come Weltanschauung, probabilmente frutto di suggestioni tratte dall’opera di Kojéve7. È proprio quest’aspetto, però, ad impensierire. Certo, nessuna operazione storiografica è mai neutra; pensare, tuttavia, ad un certo percorso unitario della storia rende la questione alquanto piú problematica. Braudel propone il proprio punto di vista con chiarezza: ciò gli consente di sfuggire alle angustie delle indagini evenemenziali e di cogliere i processi di lunga durata. Ma gli permette anche di concepire un adeguato concetto di comprensione tale da rendere la ricerca storica un procedimento ermeneutico, una combinazione di elementi alla volta della penetrazione delle oscurità del passato, in un processo continuo di interpretazione dei dati a disposizione. Braudel ha dichiarato a conclusione de La Méditerranée: “In storia non esiste un libro perfetto […] che non si riscriverà mai piú. Al contrario, la storia è un’interrogazione-interpretazione sempre differente del passato, perché deve seguire i bisogni e talvolta le angosce dell’ora presente. Si presenta a noi come un mezzo per la conoscenza dell’uomo, non come fine a se stessa”. In questa dialettica presente-passato riecheggiano le parole di Febvre, il quale aveva esortato lo storico a non scindersi, a non volgere un occhio al passato ed uno al presente, ma a “mescolarsi alla vita”, perché “fra pensiero e azione non c’è separazione”8. Una simile forma di neostoricismo, pur con tutti i suoi limiti, assimila la storia ad un’impresa critica e la rende sia un modo per partecipare al dibattito del presente, sia una maniera di fare domande al passato per capire da dove veniamo e per elaborare ragionevoli congetture su dove andiamo. Un tratto comune, questo, a tutta la scuola degli annalisti: si pensi ancora a Febvre ed a Bloch9. Una simile suggestiva impostazione, tuttavia, contrae un debito da pagare, quello di una storia dei lunghi processi che pecca, però, di tanto in tanto, di un eccesso di qualitativismo. Bernard Baylin, nel 1951, parlò dello studio di Braudel come di un “saggio enorme e sconnesso […] che ha l’ambizione di parlare di tutto […] procedendo per classificazioni, separazioni, compartizioni”10. La frequente genericità dei riferimenti, la larga estensione dell’oggetto e la rigidità delle divisioni sarebbero, dunque, responsabili di non aver sollevato “buone questioni storiche”11. Giudizio, questo, in buona parte condiviso in quegli anni, ma che spesso trascura di fare i conti con gli autentici motivi della rivoluzione metodologica della storiografia braudeliana. La richiesta di un vero pluralismo storiografico era, per Braudel, una forma di riconoscimento dell’irriducibile complessità del passato e rappresentava la pianificazione di un rigoroso piano metodologico per mettersi nelle condizioni di “fare” storia. Detto altrimenti, non bastano il solitario sguardo e la sagacia dello storico per intendere il fitto intrico di eventi del passato. Un’indagine storiograficamente avveduta, infatti, deve sapersi sintonizzare sulla stessa lunghezza d’onda delle altre scienze dell’antichità, sapendo penetrare metodologicamente in esse allo scopo di riuscire a tenere conto dei risultati delle loro ricerche. Una storiografia metodologicamente NOTE duttile, perciò, consapevole del fatto che studiare il passato dev’essere un’impresa collettiva e che per raggiungere tale scopo vanno combinati assetti e statuti disciplinari, creando addentellati e linguaggi comuni, pur nel rispetto della loro specificità. Una lezione di metodo, quella di Braudel, ed una lucida esortazione a dotarsi di una cultura all’altezza sia del passato, sia del vorticoso evolversi del presente. Mari insiste a lungo sui tre vocabolari di La Méditerranée. In verità, appare assai poco condivisibile il suo entusiasmo per l’ultimo di questi. In particolare, la teoria dei protagonisti “super-evenemenziali” della storia ricorda molto da vicino la teoria hegeliana degli “individui cosmico-storici” di cui si serve “con astuzia” la “Ragione” per realizzare i suoi piani terreni12. Quest’attenzione verso le figure emblematiche di un’epoca costituisce, forse, la piú limpida testimonianza della dimensione speculativa che agita il gesto storiografico di Braudel e, forse, uno dei segni della sua debolezza. Infatti, anche Pio V e don Giovanni d’Austria vanno inseriti nel contesto delle relazioni socio-politico-culturali di cui sono espressione. Enfatizzare la loro volontà d’azione (e di potenza) significa isolarne le figure come se avessero acquisito una dimensione di autonomia rispetto al loro tempo. Tutto ciò può avere un senso nel sistema hegeliano dell’Assoluto, ma lascia perplessi quando si tratta di studiare l’articolata planimetria degli equilibri europei del Seicento. Altra questione altamente problematica è la distinzione braudeliana tra “grandi avvenimenti” ed accadimenti ordinari, tra fenomeni profondi e di superficie, anche perché le correnti marine –per ritornare alla metafora dell’oceano– possono avere un andamento ondivago, insieme ascensionale e discensionale, per cui, ad un tratto, la superficie può diventare profondità e viceversa. Si nota, ancora, un malcelato hegelismo anche dietro la teoria del “riconoscimento”, secondo la quale la storia configura il teatro dello scontro (magari senza sintesi) di determinazioni che si fronteggiano. Del resto, la tradizione dell’hegelismo francese di cui sono pervasi Braudel ed un gran numero di intellettuali d’oltralpe degli anni Quaranta e Cinquanta è stata a lungo scandagliata. Quanto qui, tuttavia, importa rimarcare non sono i limiti –accanto ai suoi indubitabili meriti– dell’impostazione di Braudel, su cui si discute da decenni. Interessa, piuttosto, evidenziare come alle sue spalle occhieggi una robusta filosofia della storia. Lo studio di Mari, nel complesso, orienta l’attenzione sul tema del linguaggio dell’indagine storiografica e costituisce una sicura guida in quel vortice di storie e di personaggi qual è La Méditerranée. Mari isola le unità lessicali e narrative, scandisce i rilievi e gli sfondi, percorre i sentieri ora distesi ora interrotti della ricerca di Braudel. L’approccio analitico gli permette di cogliere il senso della distinzione braudeliana dei piani narrativi e di offrire lo stimolo per un rinnovato approccio ad un’esperienza storiografica che ha fatto della molteplicità dei punti di vista e della capacità di coordinare metodi e piani dell’indagine storica il suo vero punto di forza; una metodologia storiografica, quella di Braudel, capace ancora oggi di offrire il suo contributo in quel confronto impari ma affascinante tra i tanti volti del passato e la limitata estensione dell’orizzonte di ricerca dello storico. 83 1 L.WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, ed. it., a c. di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1974, § 138, p. 74. 2 Cfr. R. RORTY, La filosofia dopo la filosofia: contingenza, ironia e solidarietà, tr. it., a c. di G. Boringhieri, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 12. Per un’analisi dei rapporti tra la concezione rortyana della storia e la sua posizione in seno alla filosofia analitica contemporanea cfr. G. MARI, Postmoderno, democrazia, storia, ETS, Pisa 1998. 3 H.BLUMENBERG, Paradigmi per una metaforologia, tr. it., a c. di M.V. Serra Hansberg, Il Mulino, Bologna 1969, p. 183. 4 L’espressione ricorre in L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., § 67, p. 47. 5 Cfr. P.RICOEUR, Tempo e racconto, voll. 3, tr. it., a c. di G. Grampa, Jaka Book, Milano 19861988, vol. I, p. 110. Com’è noto, Ricoeur articola la propria posizione in costante dialogo critico e polemico con le proposte di P.VEYNE elaborate in Comment on écrit l’histoire, Èditions du Seuil, Paris 1971. 6 Cfr. G.W.F.HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, voll. 4, tr. it., a c. di G. Calogero e C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze 1941, vol. I, p. 235. 7 Dell’A. KOJÉVE studioso di Hegel e della sua filosofia della storia cfr. soprattutto Introduzione alla lettura di Hegel, ed. it., a c. di G.F. Frigo, Adelphi, Milano 1996. Il testo raccoglie i seminari di Kojéve tenuti dal 1933 al 1939 presso l’École des Hautes-Études di Parigi, raccolti e pubblicati da Raymond Queneau nel 1947. 8 L. FEBVRE, Problemi di metodo storico, tr. it., a c. di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1976, p. 152. 9 Cfr. M. BLOCH, Apologie pour l’histoire ou métier de l’historien, Colin, Paris 1949. 10 B. BAYLIN, La géohistoire de Braudel: une relecture critique, in AA.VV., Fernand Braudel et l’histoire, a c. di J. Revel, Hachette, Paris 1999, p. 79. Il saggio di Baylin, per la prima volta, apparve nel 1951. 11 Ibid. 12 Cfr. G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, cit., vol. I, pp. 98 e sgg. 84 IL DOPPIO VOLTO DELLA MENZOGNA. LA DIMENSIONE SOLIDALE DEL MENTIRE* Che il mentire sia un evento quotidiano è noto da secoli, ma che sia inteso come uno degli strumenti di comunicazione solidale tra gli esseri umani è stato in particolar modo messo in evidenza di recente da alcune pubblicazioni sul tema. In queste pagine si vogliono analizzare i percorsi tracciati da tre scritti, quelli di Maria Bettetini (Breve storia della bugia. Da Ulisse a Pinocchio) e di Andrea Tagliapietra (Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale), pubblicati nel 2001, e quello di Vladimir Jankélévitch (La menzogna e il malinteso), la cui traduzione italiana è avvenuta nel 2000 benché i due saggi, che compongono il testo, siano stati scritti dal filosofo nel 1940. Tutti e tre i testi hanno come comune denominatore la menzogna intesa come una delle più importanti e diffuse manifestazioni del quotidiano esistere dell’uomo. Il lavoro di Tagliapietra, che si snoda temporalmente tra le “figure della menzogna” del pensiero occidentale, prende avvio dalla mitologia greca attraversando la Genesi, la nascita del pensiero filosofico occidentale, da Socrate a Tommaso, da Cartesio a Kant fino a Jaspers e Derrida. Filosofia della bugia nasce dall’arduo tentativo dell’autore, peraltro ben riuscito, di mettere insieme in maniera sapiente interrogativi e riflessioni non solo appartenenti ad epoche storiche diverse ma anche legate ad ambiti disciplinari diversi. E così Tagliapietra attinge da una variegata produzione: dai classici greci ai testi di religione, filosofia e letteratura, dal teatro alle opere d’arte. Divertente e di agile lettura, pur nel rigore dell’analisi, è il lavoro della Bettetini che elabora una attenta ricognizione dell’alterna fortuna della bugia analizzando il pensiero di alcuni tra i più grandi filosofi, quali Platone, Aristotele, Agostino, Spinoza, Kant, e scrittori politici come Machiavelli, e le favole letterarie di Boccaccio, Swift, Collodi, Carrol, Rodari fino al moderno mito di Dylan Dog. Decantazioni e condanne del mentire si avvicendano nello scritto che segue le tracce dei differenti contesti storici e che ci porta a comprendere che non basta dire tutta la verità per essere autenticamente sinceri. E una fenomenologia del quotidiano sono le pagine del testo di Jankélévitch, scritte di getto mentre si trovava presso l’Ospedale complemen- * A proposito di A. TAGLIAPIETRA, Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale, Bruno Mondadori, Milano 2001; M. BETTETINI, Breve storia della bugia. Da Ulisse a Pinocchio, Raffaello Cortina, Milano 2001; V. JANKÉLÉVITCH, Du mensonge, Flammarion, Paris 1998, trad. it. a c di M. MOTTO, La menzogna e il malinteso, Raffaello Cortina, Milano 2000. NOTE di Mariella Spadavecchia 85 86 tare di Marmande, nel giugno-agosto 1940. Il filosofo, fatto oggetto di recente di notevole attenzione presso il pubblico italiano, aveva già da tempo rilevato l’importanza di un fenomeno così difficilmente eliminabile dal nostro esistere, visto che la menzogna e il malinteso costituiscono il fulcro dell’agire quotidiano dell’essere umano. Questo scritto riflette in pieno la riflessione filosofica jankélévitchiana denunciando un aspetto drammatico dell’essere umano: il suo barcamenarsi nel difficile equilibrio degli opposti. L’uomo è un essere intermedio che non può essere analizzato o giudicato se non nel suo essere nel mondo. E nel difficile equilibrio delle convenzioni quotidiane si sviluppa la meditazione del filosofo. Legge universale o vita concreta? Sincerità assoluta o intermediarietà dell’essere umano? È sulle tracce di questo interrogativo che si può condurre una ricerca sul significato e sul ruolo della bugia nel pensiero occidentale. Chi ha detto, dunque, la prima bugia? Con questa domanda si introduce il lavoro molto complesso di Tagliapietra che, in un cammino ampio e articolato, certamente interessante ma allo stesso tempo impegnativo, segue i cambiamenti storici, sociali e culturali di circa venticinque secoli. Un elogio della bugia e non un inno alla verità: è questo l’aspetto sorprendente di uno scritto che non vuole perorare la causa della sincerità e infliggere nuove condanne morali alla menzogna bensì vuole recuperare l’uso pratico e la valenza autenticamente umana del mentire. Anche la menzogna richiede la virtù del coraggio; se infatti per dire la verità bisogna avere coraggio, anche per mentire bisogna averne. Così l’Introduzione del lavoro di Tagliapietra è affidata a due personaggi: Socrate, padre della tradizione critica della filosofia, e Jakob il bugiardo, dell’omonimo romanzo di Becker, personaggi accomunati dallo stesso tragico destino di morte inflitto loro dai propri simili. Entrambi, il primo attraverso la verità, il secondo attraverso la menzogna, vogliono esprimersi, vogliono ribellarsi contro un comune destino di sopraffazione, di violenza. Socrate difende quella verità critica con la quale si impegna a negare il mondo esistente, quello stesso mondo che viene negato da Jakob attraverso la sua bugia con cui vuole creare un mondo nuovo. Socrate non dice mai il falso perché il ruolo del filosofo è quello di dire la verità anche a scapito della propria vita. È la verità critica di Socrate, la coerenza tra il dire e il fare, esercizio ed esempio di sincerità. Questa verità è sine cera, senza impurità. Così Socrate mette in gioco tutto se stesso, la sua intera esistenza per testimoniare la verità di cui si fa portavoce perché questo è il vero compito del filosofo. Lui si batte per la dignità dell’essere umano ma lo stesso fa Jakob, in modo diverso, con la sua bugia coraggiosa. Chiunque sia stato il primo a mentire, scrive Wilde ne La decadenza della menzogna, è stato sicuramente il fondatore delle relazioni sociali. La menzogna infatti nasce e si sviluppa in relazione all’altro, chiunque sia quest’altro, anche quell’altro che siamo noi stessi. La bugia ha un carattere relazionale, ha bisogno dell’altro per prendere forma, ha bisogno di quel dialogo di cui può invece fare a meno chi dice la verità. Chi mente deve innanzitutto penetrare nella mente dell’altro, operazione che può esimersi dal fare chi dice il vero, deve immedesimarsi nel suo interlocutore tanto da comprenderne le aspettati- NOTE ve e anticiparne i desideri. Il bugiardo mente in quanto è capace di immedesimazione e questo perché ha la capacità di sdoppiarsi. La coscienza allora nasce dallo sdoppiamento del proprio io che, come in una finzione scenica, ci consente di guardarci dal di fuori; lo sdoppiamento e l’immedesimazione sono alla base dell’inganno. Mente l’uomo che occulta la verità, mente quello che ne inventa una sua. L’intelligenza si esprime anche attraverso l’immaginazione; mentire, scrive Tagliapietra ricordando le parole della Arendt, vuol dire infatti creare dal nulla e quindi iniziare qualcosa che prima non c’era. La menzogna è dunque “metafora del nulla, è reazione alla cavità del mondo” (p.48) che ci permette di riempirlo e di inventarne nuovi. Senza tale capacità creativa forse non sarebbe neanche nata quella cosa che noi chiamiamo cultura umana. Così l’arte, il teatro, la letteratura mettono in scena storie non vere grazie alla capacità della coscienza di sdoppiarsi. La menzogna fonda la cultura, la menzogna fonda le relazioni sociali. Diverse possono essere le circostanze che portano a mentire. Mente il sopraffattore ma mente anche il debole. Si nasconde l’uomo come l’animale, mente l’uomo di fronte al nemico. La menzogna è anche gioco d’astuzia e di intelligenza. Si comprende di essere più deboli e si ricorre all’inganno al fine di salvarsi. La menzogna è dunque uno strumento, un gioco d’intelligenza che permette alla preda di sfuggire al suo cacciatore. La menzogna non è solo tecnica di sopravvivenza, è un terreno sfumato fatto di astuzia, caso, necessità, dovere. Sin dalle prime movenze, la bugia sembra essere, in questo lavoro, riabilitata dalla sua condanna etica per diversi motivi. Essa infatti non viene esaminata esclusivamente dal punto di vista morale, anzi le viene riconosciuta quella valenza positiva che spesso le è stata negata. La bugia del protobugiardo è una menzogna strumentale, simile a quella dell’animale e del bambino. Anche gli animali attuano delle tecniche di sopravvivenza, tuttavia queste bugie non vengono mantenute nel tempo: sono inganni strumentali, quegli stessi inganni che si raffineranno e diventeranno sempre più complessi nel passaggio dall’Iliade all’Odissea, testo quest’ultimo in cui si avverte la formazione della coscienza. La coscienza, infatti, consente di “narratizzare” il tempo, di estendere l’inganno in una progettualità temporale. È stata proprio tale capacità a permettere all’uomo di sopravvivere vista la sua scarsa dotazione fisica, a fronte di una forte capacità intellettiva. Menzogna e verità si intrecciano nelle relazioni con gli altri ma anche nel rapporto con se stessi nella forma della maschera, della doppiezza, dell’autoinganno. Riflettendo sulla storia della bugia, si nota che tante sono le sfumature del mentire. È complesso e difficoltoso delinearne un quadro univoco. Mentire è occultare la verità o inventarne una propria? La bugia non è identificabile con la metafora; allora quanto l’intenzionalità pesa sulla responsabilità del mentire? La menzogna è forse una violenza invisibile? Che senso ha quella bugia gratuita che il protobugiardo di Wilde racconta al ritorno dei propri compagni cacciatori mentre lui resta nella caverna? L’autore cerca di districarsi nei diversi interrogativi che si pongono. Varia è la casistica della menzogna. C’è chi considera poco importante una bugia riferita al di fuori dell’ambito giudiziario e tuttavia gravissima se lo fosse creando conseguenze negative per gli altri; basti pensare ai raggiri, alle trappole, ai plagi, allo spergiuro. Ma 87 88 ci sono anche bugie di cortesia, dette per consolare o per pacifica convivenza; o la menzogna come scelta tattica dell’uomo di potere detta per necessità o interesse. E ancora la menzogna raccontata per semplice piacere estetico. C’è chi mente agli amici e chi ai nemici; per ingannare o per sedurre o semplicemente per millanteria. È possibile ancora seguire il percorso della sincerità tracciato dai diversi autori, da Diogene di Sinope agli Epicurei e la scholé accademica, da Epitteto a Seneca. Passando così in rassegna circa venticinque secoli, emerge come il mentire sia presente nella storia dell’uomo sin dalle sue origini. È nella Genesi che fa il primo ingresso la menzogna con Adamo ed Eva. Mentivano gli dei dell’Olimpo, mentono nel paradiso terrestre Dio e il serpente così come mentono Abramo, sua moglie Sara, Lot, Raab e Giobbe. Eppure la dottrina della Chiesa ha ottusamente difeso la verità perché chi vive seguendola, vive in conformità con Dio, laddove la menzogna è la “fonte ontologica” di tutti i mali. Numeroso è l’elenco dei teologi che non condannano nettamente la bugia giustificando quella necessaria: da Clemente Alessandrino a Origene, da Cassiano a Girolamo e tanti altri ancora. Lunga è la tradizione dei filosofi che si sono divisi ed interrogati sulla menzogna, da Montaigne a Cartesio, da Rousseau a Kant, da Kierkegaard a Sartre ed altri ancora compreso lo stesso Nietzsche. Un cenno va fatto alle osservazioni che l’autore, spesso con tono critico, riferisce prendendo in esame la grande bugia dell’età contemporanea: il mito del progresso. Gli uomini, esseri dotati di grande intelligenza, hanno nei secoli raggiunto un dominio sul mondo circostante che è ormai da tempo sottoposto ad una aspra critica. Sotto accusa, adesso più che mai, sono la scienza e la tecnica il cui sviluppo non ha solo contribuito a trovare soluzioni a problemi esistenti ma si è spinto oltre, avanzando senza una meta precisa e creando sempre nuovi squilibri e nuovi bisogni. La tecnica è il più ambiguo di tutti i doni ed è proprio leggendo il mito di Prometeo che si evince il legame esistente tra dòlos e téchne. Nelle favole di Esopo, Igino e Fedro, si delinea il legame tra “l’originaria dotazione antropologica fornita da Prometeo all’uomo e la sua “naturale” predisposizione all’inganno e la menzogna” (p.54). Esopo infatti narra che a Momo, dio della critica e dello scherno, venne dato il compito di giudicare le opere di Zeus, Prometeo ed Atena. Zeus realizzò un toro, Prometeo creò l’uomo, Atena una casa. Nel giudicare il lavoro di Prometeo, il dio Momo rilevò un limite nella sua creazione ossia quello di non aver riportato il cuore dell’uomo all’esterno bensì all’interno del corpo, in modo tale che le sue intenzioni potessero rimanere nascoste. La tecnica si identifica con quel voler avere di più che, nella tradizione classica occidentale, trova la sua rappresentazione nella figura di Ulisse. Ulisse interpreta “un tipo d’uomo e un modello d’umanità che è già il nostro” (p.126). Ma perché parlare di Ulisse in un lavoro sulla menzogna? Perché “chi volesse scrivere una tipologia del bugiardo nella cultura occidentale non avrebbe dubbi nel trovarne l’archetipo più eminente e antico nell’eroico protagonista dell’Odissea” (p.89). La menzogna a cui ricorre Ulisse sembra, secondo alcune tradizioni, incarnare quel “piacere insano” che ha trovato manifestazione nei suoi innumerevoli travestimenti e nelle sue diverse rappresentazioni. NOTE Ulisse ha una naturale ed indomabile propensione per l’inganno, ha una volontà acquisitiva. Dunque, Ulisse rappresenta il desiderio che non si appaga mai, Ulisse mente perché vuole sempre di più. Il testo di Tagliapietra è ricco di particolari ed utile per chi volesse seguire le tracce di antichi racconti mitologici, dalla vicenda del Re d’Ausonia alla storia della Regina di Lab delle Mille e una Notte. Di Odisseo spesso sono state messe in evidenza con diversi epiteti l’astuzia, la furbizia, ma non tutte le letture del personaggio concordano nel dare una valutazione negativa al suo atteggiamento. Ulisse è anche l’emblema della razionalità e dell’ingegno. Egli adotta un movimento curvilineo, a spirale, diverso dal procedere rettilineo dei personaggi dell’Iliade. Ulisse non si pone in maniera diretta di fronte alla realtà ma obliqua, in quanto è convinto che sia possibile sconfiggere il nemico anche per via indiretta. Prudenza o furberia? Ulisse non è solo ciò che appare. Nella sua figura emerge la caratteristica di fondo del mentire ossia la separazione radicale tra esteriorità ed interiorità. Spesso la bugia assume la stessa forma della verità ma non per questo coincide con essa. La bugia per essere credibile deve aderire perfettamente alla realtà, apparire perfetta nella sua esteriorità, addirittura più perfetta della stessa realtà in cui a volte l’interiorità emerge attraverso lapsus e lacune. Ulisse ha mille volti, realizza il proprio inganno attraverso il corpo, la parola, il tono di voce; ogni cosa può essere utile alla menzogna, come gli strumenti della tecnica che ingannano sulle reali capacità di un individuo. Ulisse è l’astuzia gratuita e sovrabbondante del voler avere di più, è un simulatore, polymetis, polyméchanos, polytropos; è la menzogna prudente, è la gloria e la vendetta, è attore, è Nessuno. Tanti sono i volti della menzogna. Ma la menzogna di Ulisse ha una finalità anche difensiva: egli è dunque colui la cui bugia è necessaria per la propria e altrui sopravvivenza. La pubblica utilità o la sopravvivenza personale giustificano la necessità della menzogna. In alcuni contesti come quello di Ulisse il primo valore seguito non è quello della verità bensì quello della solidarietà. Se in effetti si volessero tracciare i confini etici del mentire si potrebbe sicuramente affermare che la verità, come legge universale, non può imporsi come un dovere oggettivo senza considerazione della concretezza dell’essere umano. L’uomo vive con gli altri ed è lecito mentire per salvare la loro vita. Il valore dell’ospitalità vale una menzogna. L’episodio biblico di Lot è il prototipo di quella menzogna necessaria che, pur negando i legami di stirpe, lo fa in nome della difesa del valore dell’ospitalità. È lecito mentire e quindi non rispettare la legge se così si rispetta la physis, il naturale rapporto tra l’io e l’altro. Dopo il sacrificio estremo di Gesù, si interrompe quella ritualità sacrificale presente nella Bibbia, inaugurando un’epoca post-sacrificale in cui si afferma l’etica dell’ospitalità assoluta: non si chiede a nessuno di sacrificarsi al proprio posto ma ci si assume la responsabilità dell’altro. Forse ancora troppo poco ospitale, ancora troppo sacrificale, annota Tagliapietra, è la nostra società globalizzata. E alle manifestazioni del mentire nella società contemporanea dedica attenzione la Bettetini sottolineando come la menzogna riguardi oggi il nostro modo di essere. Mentire nella civiltà tecnologica vuol dire disfare la propria identità, ricostruirsene una totalmente nuova e correre il rischio di smarrirsi e 89 90 non trovarsi più. È questo ciò che accade nel circuito virtuale, è questo ciò che accade nel tubo catodico dove le persone vengono risucchiate, decostruite e reimpostate. Siamo ingannati e ci lasciamo sottomettere all’inganno dal nostro tipo di società che ci insegna a non interrogarci più, che ci fa assorbire tutto ciò che ci propone. Quella della Bettetini è una polemica nei confronti del nostro nuovo mondo, quello dei mass media, della pubblicità, di Internet in cui il confine tra verità e menzogna si è ridotto sino a scomparire. La verità si è trasformata in fatto. Siamo costretti a vedere ogni giorno in televisione la cruda realtà, quella di popoli che soffrono, di situazioni di disagio a volte così tanto rappresentate nelle fiction televisive da non consentirci più di distinguere tra verità e menzogna; “quale tragica situazione di popolo terremotato o quale drammatica scena di film potrà pretendere il mio coinvolgimento dopo l’interruzione che ha invitato a perdere chili nei punti critici, a provare il nuovo cioccolato che ricopre il nuovo conturbante gelatone, a concedersi un’auto che sembra proprio come quelle dei veri ricchi?” (p. X). L’aspetto rilevante del lavoro consiste nell’aver sottolineato lo stretto legame esistente tra verità, linguaggio e potere. Il linguaggio è frutto di un accordo naturale tra gli uomini. Nel tempo si è affermata l’idea che esistesse un rapporto di diretta corrispondenza tra linguaggio e verità. Così molti pensatori moderni, tra cui Grozio, Montaigne e Swift, hanno condannato ad oltranza la menzogna in quanto lesiva del diritto di ognuno alla conoscenza. Ma il linguaggio è una convenzione e spesso la verità dipende dall’opinione diffusa. Così dimostra la novella di Pirandello intitolata La Patente che la Bettetini ricorda nel suo testo: “viene ritenuto vero ciò che vien ripetuto con convinzione” (p.109). La richiesta paradossale del protagonista della novella, Rosario Chiàrchiaro, di ottenere dal giudice la patente di iettatore fa emergere “un dato di fatto: l’opinione pubblica ritiene vero ciò che è detto, ripetuto, creduto tale, indipendentemente dall’assurdità di ciò che è sostenuto” (p.111). Oggi, di sovente, la comunicazione passa attraverso lo strumento dell’informazione e la verità viene identificata con il “fatto” grazie ai reality-show e alle inchiesteverità. Sennonché, in questo modo, si corre il rischio di smarrire il confine tra verità e menzogna, di perdere il senso della realtà visto che, di fronte allo scorrere delle immagini, nulla sembra più avere il peso della verità. Non è detto che sia necessario mentire per ingannare gli altri. Infatti, ammonisce nella prefazione al testo la Bettetini, “da sempre si è mentito molto meglio e molto più crudelmente senza dire bugie” (p.XI). Così nell’Otello di Shakespeare Iago trama un inganno senza quasi proferir menzogna. La forza di Hitler, in fondo, è consistita proprio in questo; è la lucida sincerità che inganna, la più perversa come sosteneva lo storico della scienza Alexandre Koyré ricordando che tutti coloro che sono stati a capo di governi totalitari hanno annunciato il loro programma proprio perché sapevano che non sarebbero stati creduti. Verità e menzogna hanno in ogni caso avuto un peso decisivo nello svolgersi degli eventi. Chi difatti può negare il peso che nella storia hanno avuto documenti ritenuti veri e rivelatisi in seguito falsi? Come dimenticare che queste false informazioni hanno modificato il corso della storia, basti pensare alla scoperta dell’America e alla serie di invenzioni casuali che hanno modificato la nostra esistenza. È questa la NOTE “serendipità”, “il ritrovamento di qualcosa di prezioso rinvenuto mentre non lo si stava cercando, anzi mentre si era occupati in altro” (p.112). Il grande merito di questo testo è sicuramente quello di aver risvegliato in noi la consapevolezza che ciò che comunemente riteniamo vero è solo il frutto delle costruzioni sociali e del comune assenso; le verità vengono costruite quotidianamente sui giornali, in televisione o in rete. In realtà bugia e verità possono essere decifrate soltanto guardando all’intenzione di chi agisce. Il vero o il falso infatti non vanno visti e giudicati in sé, bensì guardando all’intenzione che chi parla vuole dare al suo discorso. Non a caso, il “tema della bugia”, scrive l’autrice, “è l’inganno, ossia il “voler far credere” vero o falso ciò che vero o falso non si ritiene, indipendentemente dal fatto che lo sia davvero” (p.3). Scrive la Bettetini, ricordando il messaggio di Agostino di Ippona che la menzogna “dipende dall’intenzione dell’animo e non dalla verità o falsità delle cose” (p.11); è la direzione che si dà ad un atto che ne stabilisce la bontà. Esiste infatti un’unica eccezione al mentire: la generosità del cuore. È lecito chiedersi se sia giusto che il paziente debba conoscere sempre tutta la verità sul suo stato di salute. Il problema del rapporto medico paziente è un problema delicato e complesso allo stesso tempo. Al medico si vuol credere perché nelle sue mani è la nostra vita, pur tuttavia ci sono delle situazioni difficili da gestire. Come potrà un medico comunicare lo stato di salute al malato considerando ad esempio la situazione di solitudine in cui è possibile che si trovi, parlare con uomini soli “perché vivono soli, soli perché lo sono di fatto o soli per scelta, per proteggere dalla loro malattia i cari, per orgoglio, per vergogna, insomma per precisa determinazione” (p.100). Non è forse giusto mentire al malato sul letto di morte per regalargli un’ultima speranza? Si può in nome di un principio universale, quello della sincerità, sacrificare l’altro, le sue emozioni? Di certo no. È quello che sostiene Jankélévitch, nei cui due saggi, che compongono La menzogna e il malinteso, non tralascia di tracciare le due facce del mentire. Quelle di Jankélévitch sono pagine che invitano a recuperare un autentico rapporto con l’altro, inquinato troppo spesso da mascheramenti, doppi sensi e menzogne. Menzogna e malinteso sono così presenti nell’agire comune da essere diventati delle vere e proprie convenzioni che, è inutile negarlo, servirebbero a rendere più accettabile la quotidianità dell’incontro con l’altro altrimenti reso impossibile dallo scontro di due identità che si pongono in maniera assoluta l’una di fronte all’altra. Ma la riflessione di Jankélévitch è molto sottile; il filosofo non vuole affermare a tutti i costi la validità di un valore come la sincerità, cosa assolutamente improbabile per un filosofo così attento alla complessità dell’esperienza umana. Jankélévitch infatti osserva l’uomo nel suo agire in rapporto agli altri perché è nell’ambito della concreta esperienza umana che l’uomo può e deve essere giudicato. Non deve stupire la quotidianità delle argomentazioni del filosofo poiché proprio ciò che appare assolutamente banale è in realtà difficilmente esprimibile o addirittura comprensibile. E ciò che di banale c’è in questa riflessione è l’esperienza umana vista nella sua quotidianità. Il filosofare di Jankélévitch si rivela come la negazione totale di ogni intellettualismo grettamente razionalista e rivalutazione del piano dell’esistenza, con un’attenzione dunque all’uomo in quanto essere morale ma anche alla fragilità stes- 91 92 sa di questo suo essere morale. È un pensiero concentrato sul vissuto umano, sulla durata del tempo umano, un pensiero che si fonda proprio sulla capacità stessa del filosofo di cogliere ogni trasalimento dell’animo umano in quanto lui stesso essere umano come gli altri. Jankélévitch si insinua dunque nel difficile intreccio delle questioni umane, nei dilemmi costanti dell’esistenza morale dell’uomo, nelle infinite contaminazioni del suo agire. Guardando il volto negativo della menzogna il filosofo può così dire che la bugia non va assecondata in quanto fonda delle relazioni false e superficiali tra gli uomini basate sulla misconoscenza e determina l’impossibilità della comprensione autentica. La menzogna non è certo un evento indifferente nella vita di ognuno, anzi, è proprio la prima menzogna, quella innocente del bambino, che costituisce “la prima ruga sulla fronte ben liscia dell’innocenza, la prima complicazione annunciatrice di doppiezza” (p.11). Non è la bugia in se stessa che preoccupa quanto l’intenzione che si fa strada grazie alla comparsa della coscienza e della volontà e, di conseguenza, la consapevolezza di avere uno strumento di potere nelle nostre mani. La doppiezza è una caratteristica dell’essere umano, propria della sua struttura; l’uomo è un essere anfibio, duplice, scisso. Analizzando la genesi quotidiana del mentire, Jankélévitch spiega che l’uomo ha avvertito tale necessità in quanto il proprio io isolato si è imposto all’altro con il suo egoismo. “La menzogna trova la sua ragion d’essere in un mondo di creature parziali, opache, incomunicabili e segrete l’una per l’altra” (p.22); non c’è spazio per tutti in questo mondo. Ma la menzogna mostra sì, l’intelligenza, ma anche la debolezza dell’essere umano; ha un carattere sociale e antisociale. È vero infatti che aiuta la coesione sociale, ma si tratta di una coesione apparente, basata semplicemente sulla conciliazione provvisoria dei reciproci interessi. La menzogna è infatti la soluzione facile che l’egoismo trova per risolvere i suoi problemi. È quell’astuzia che permette a breve termine di superare gli ostacoli. “La menzogna costituisce il modello archetipo della difficoltà facile e della profondità superficiale” (p. 25), è l’“oppio del minimo sforzo”. Allo stesso modo il malinteso permette l’accordo che è, sì, preferibile alla discordia, ma si tratta di un accordo debole. “Il malinteso, come nel suo genere la gaffe, appartiene alla specie di quegli errori ben fondati che diventano possibili mediante il commercio scabroso delle coscienze, non semplice confusione, ma caratteristico falso-calcolo, falso-senso rivelatore, interessato e passionale” (p.51). La possibilità del malinteso è data dall’orientamento dei nostri desideri che ci portano a dar credito ad una cosa piuttosto che ad un’altra mettendo in atto una “falsa magia” in quanto il desiderio di qualcosa, non implica necessariamente che essa sia vera; “ecco in cosa consiste tutto lo sbaglio. Si crede ciò che si desidera e si intende ciò che si crede” (p.52). Chi si arrende o approfitta del malinteso non si pone seriamente di fronte alla vita. Così col malinteso si crea un dialogo di solitudini che comunicano solo apparentemente. Il malinteso distrugge la comunione tra sé e l’ciurliaaltro. Anche Jankélévitch, diversi anni prima della Bettetini, accusa la società di essere la responsabile dei malintesi in quanto “sbrigativa” e “frettolosa”, si interessa a ciò che si fa piuttosto che alle ragioni per cui lo si fa; “che la riuscita sia meritata o fortuita, il successo, si dice, è pur sempre il successo. La nozione di Merito, al contrario, sposta l’accento dal fine al come, su NOTE questo elemento invisibile della vittoria sulle difficoltà, che scava le rughe, incurva le schiene, lascia dappertutto dietro di sé la pensosa patina dell’infelicità” (p.62). Occorre il coraggio di sopportare un’esistenza complessa e difficile. Contro la durezza della realtà bisogna resistere, anche se la sincerità ha un costo. Viviamo con addosso delle maschere e ciò per colpa dell’aridità del nostro cuore che domina la nostra vita, laddove basterebbe essere ispirati da un po’ di simpatia e di serietà per incontrarsi in maniera autentica. Basta la semplicità del gaffeur per far crollare, con un gesto scandaloso, il nostro castello di carta. Ed è proprio tale semplice serietà che deve ispirare il nostro agire. Così che senso ha quella verità che viene detta per uccidere? Ciò che conta è l’intenzionalità del cuore, la sua purezza. Bisogna cercare dentro se stessi quella verità che ci permette di instaurare un’autentica relazione con l’altro e soprattutto una relazione d’amore. Al di là della denuncia dei diversi ed innumerevoli malintesi, al di là dell’invito a togliersi la maschera che si indossa ogni giorno, Jankélévitch difende il buon uso che della menzogna si può fare quando la questione è vitale. Ogni uomo ha peccato di ascolto, di generosità dove invece soltanto lo slancio fino al quasi-niente dell’amore poteva rendere autentica la nostra esistenza. Ciò che conta, ammonisce Jankélévitch, è la maniera: è questa che “fonda il valore dei nostri atti, così come fonda il pregio delle nostre opere” (p.60); è la maniera che fa la differenza, è il frutto doloroso della mediazione. Le difficoltà dell’agire morale non devono scoraggiare l’uomo che, al contrario, deve incessantemente impegnarsi a rinnovare il proprio impegno etico. La lacerazione che si produce nell’essere umano deriva proprio dalla consapevolezza della sua natura limitata e dall’aspirazione ad un’esistenza continuamente e autenticamente morale. L’uomo non è né angelo né bestia ma una creatura mediana che oscilla tra due estremi: l’amore di sé e lo slancio verso l’altro. Compito dell’uomo etico deve essere il suo impegno costante contro le sue istanze “egotropiche” perché la morale è, secondo Jankélévitch, un costante appello ad amare, a rispettare l’altro, alla tolleranza, alla generosità e alla giustizia. L’“odissea morale” corrisponde a questo infaticabile agire sempre pronto a ricominciare e sempre così vicino al proprio annichilimento, un agire tutto proteso alla realizzazione dell’amore. In questo complesso cammino è stato possibile constatare come la menzogna sia strettamente legata alla quotidianità dell’agire umano e come essa, nella sua dimensione vitale, cerchi di difendere valori quali la dignità umana, l’ascolto, la generosità che scavalcano ogni principio di verità. La menzogna rende possibile l’accoglienza e l’ospitalità. Ciò a cui ogni uomo deve ispirarsi è semplicemente la sincerità del cuore piuttosto che l’adesione a vuoti e astratti principi che si scontrano con il bene di quella stessa umanità di cui noi facciamo parte. Occorre accettare che, al di là della ricerca della verità che ogni uomo deve porsi come scopo, esiste una contaminazione menzognera nel suo agire necessaria ed umana. 93 O. DE BERTOLIS, Il diritto in San Tommaso d’Aquino. Un’indagine filosofica, Giappichelli, Torino 2000, pp. 107. 94 L’A. mira in questo libro a fornire elementi decisivi alla ricostruzione del pensiero giuridico di Tommaso d’Aquino, nella convinzione che le sue istanze di fondo siano ancora valide e capaci di dare un orientamento sicuro nella soluzione dei gravi problemi che oggi dobbiamo affrontare. Il problema giuridico in Tommaso, nella prospettiva dell’ A., non è posto nei soli termini della lex, cioè nell’ambito della scienza deduttivo-sillogistica, ma può essere colto in modo adeguato solo avendo ben presente il suo referente metafisico, l’ ens e la conoscenza ad esso propria. Il quadro di riferimento è quindi quello del realismo metafisico e giuridico. “Come per spiegare una scienza devo risalire all’ente, così, parallelamente, per spiegare la scienza giuridica devo risalire all’ente (sensibile) giuridico, al ius, la singola cosa giusta, in via resolutionis. Il diritto (cioè: la giustizia, in quanto ciò che è giusto) viene dunque prima della legge, e quest’ultima ne articola, ne svolge le esigenze: la legge costituisce come i gangli linfatici, i vasi sanguigni, nei quali fluisce il diritto, innervando tutto il sistema” (p. 31). Il giusnaturalismo che ne deriva non rende tuttavia superflue le leggi positive, ma addirittura le esige, perché per Tommaso, come per Aristotele, la legge, senza esaurire il giusto, ne costituisce tuttavia un’espressione privilegiata, “riuscendo così ad assurgere di volta in volta a tutte le possibili determinazioni concrete” (p. 39). Questo tipo di giusnaturalismo, a differenza di quello moderno (di Hobbes, Locke, Pufendorf, Thomasius, Wolff e Leibniz e i loro epigoni), non mira all’elaborazione di codici di diritti naturali, pure proiezioni delle idee del nostro spirito all’interno del reale, ma è un approccio che “privilegia l’effettività”, non “la validità formale” (p. 41). Per Tommaso la legge naturale è a sua volta partecipazione della legge eterna di Dio, così come l’essere della creatura è partecipazione all’essere di Dio e la ragione è lume partecipato dell’intelletto divino. Perciò “il problema delle scienze pratiche è costruire le regole dell’ agire libero secondo le esigenze ed i fini iscritti in natura” (p. 57). La legge naturale non è altro che l’ordine divino manifestato dagli impulsi, dalle tendenze fondamentali, dalle esigenze prime della natura umana razionale” (p. 59). Di modo che il diritto naturale e la legge positiva hanno il i loro fondamento ontologico in Dio stesso. In questo senso, la ragione, sebbene costitutiva della legge, non è autonoma, nell’ accezione moderna del termine, perché non trova in sé l’ordine dei valori, ma si fa interprete di essi “quali emergono nella logica fluida del reale” (p. 75). La derivazione della legge umana dalla legge naturale avviene in due modi, come una conclusione o come una determinazione. La legge umana non può avere l’infallibilità che hanno le conclusioni delle scienze speculative. In quanto, tuttavia, essa fa riferimento alla natura e quindi alla legge divina, “obbliga in coscienza” (p. 83). In definitiva, per l’A., nell’ambito giuridico la preminenza assoluta spetta al ius, che è il primo referente della lex, la sua anima, il suo baricentro. “La legge quindi è proiezione, nel campo dell’agire, di un procedere razionale inteso ad un fine, ad un effetto qualificato, il bene comune, fine che ha ragio- RECENSIONI ne di bene” (p. 92). Il giusnaturalismo di Tommaso esige le leggi positive, ma dà loro consistenza ontologica. La conclusione cui perviene l’A. è la seguente: “La giustizia non si dà senza la legge, la legge senza la giustizia è corpo senza anima: nel loro fondersi reciproco, nel loro continuo reciproco implicarsi ed esaltarsi sta l’autonomia della scienza (giuridica) ed il valore imprescindibile della filosofia (giuridica)” (p. 93). Questo volume raggiunge certamente i propri obiettivi, che non sono certamente quelli di proporre prospettive originali e nuove, ma di presentare le linee fondamentali della filosofia del diritto di Tommaso d’ Aquino, nella convinzione della sua attualità e della sua capacità di concorrere a “creare una cultura politica e giuridica più conforme a verità” (p. 3). Albino Babolin P. PONZIO, Tommaso Campanella. Filosofia della natura e teoria della scienza, Levante ed., Bari 2001, pp.330. Questa monografia si impone all’attenzione del lettore per il tracciato tematico e costituisce un valido contributo alla chiarificazione del pensiero filosofico e scientifico di Campanella, o, meglio, della sua philosophia naturalis. L’analisi attenta delle fonti e il confronto con l’aggiornata letteratura critica consentono di focalizzare l’originalità e l’ardimentosa coerenza del pensatore rinascimentale che mette a frutto la lezione del corregionale Bernardino Telesio nel fronteggiare lo studio della natura iuxta propria principia, discutendone le conseguenze in un serrato dibattito su questioni scottanti quale, ad esempio, la teoria copernicana sposata da Galilei, nei confronti della quale sa anche avanzare limiti e riserve, come è dato leggere in Apologia pro Galileo (1622). Osservatore attento del mondo a partire dall’autorità dei sensi e da ragionamenti deduttivi, ma altresì metafisico di razza che si muove a suo agio nel rivendicare la fondatività ontologica della realtà cosmica sia pur in chiave antiaristotelica, Campanella ha scritto numerose opere di filosofia della natura. Rispetto a Galileo che dilata ad artem l’osservazione dei cieli restando pur sempre vincolato ai calcoli matematici, e, quindi ai limiti delle “sensate esperienze” e delle “necessarie dimostrazioni”, il filosofo calabrese, accomunato al confratello domenicano Giordano Bruno dall’eros platonico di voler ‘vedere’ speculativamente l’unitotalità del mondo, o “de li infiniti mondi”, aguzza l’ingegno fantastico (talora fantasioso!), sporgendosi al di là delle barriere del sapere verificabile in un ardimento temerario che lo rende eretico di Chiesa. Né poteva essere diversamente per un entusiasta vessillifero del sapere enciclopedico che coniuga disinvoltamente teologia, metafisica e scienza. Campanella può rivendicare a sé il grande merito di aver aperto alla dimensione storica del sapere scientifico, incrinando non poco le presunzioni dogmatiche degli ecclesiastici suoi contemporanei in fatto di cosmologia. Ha avuto buon destro l’autore di questo ragguardevole volume a fronteg- 95 giare “la nozione di scienza in quanto historia e la ripartizione del sapere umano”: ambedue ritenute giustamente come i “modi più rilevanti della filosofia campanelliana” (p. 23). Sono pagine lucide ben documentate sugli scritti scientifici dello Stilota che si leggono con profitto storico e rendono ragione del destino di colui che si sentiva “nato a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia”, pagando di persona. Era convinto che “senza scienza nemmeno chi è santo può giudicare rettamente”. Paolo Miccoli R. RUSSO, Ragione e ascolto. L’ermeneutica di John Locke, Guida, Napoli 2001, pp.267 96 La tesi fondamentale del libro è che la problematica ermeneutica si impose a Locke lentamente, ma progressivamente, “fino a diventare il centro di tutta la sua riflessione” (p. 8). All’evoluzione intellettuale di Locke corrisponde “una progressiva insoddisfazione” nei confronti del lavoro esegetico. “Locke ebbe il merito di rendersi conto della necessità di affrontare il problema alla radice, e quindi di stabilire un criterio in base al quale interpretare il testo sacro: il problema ermeneutico si pose così come problema di metodo” (p. 9). La teoria dell’interpretazione di Locke è un’estensione al campo biblico “di quelle stesse esigenze di rigore, chiarezza e distinzione che erano proprie della sua impostazione teoretica” (p. 10). Parallelamente a questa tesi svolge un ruolo centrale nel libro di Russo la convinzione che vi sia una sostanziale continuità nel pensiero lockiano, un pensiero che, “pur orientato fin dall’inizio in senso religioso, e pur riconoscendo i limiti della ragione, non ha mai abdicato alle sue esigenze” (p. 20). Il punto di partenza della ricerca di Russo è l’esame del lavoro esegetico svolto da Locke anzitutto nel First Tract on Government, in polemica con Edward Bagshaw, e nel First Treatise of Government, in contrasto con Robert Filmer. A proposito del primo opuscolo, l’A. osserva che Locke, fin dall’inizio del suo percorso, si avvale di un metodo che mira a un’interpretazione contestuale e storicizzante del testo sacro e nell’applicazione di questo metodo presuppone una distinzione fra nucleo essenziale della fede e cose indifferenti (secondo un modulo interpretativo che sarà poi ripreso, trentacinque anni dopo, nella Reasonableness of Christianity, in un contesto ideologico radicalmente diverso). Naturalmente l’A. prende in considerazione tutti i testi rilevanti, comprese le Questions concerning the Law of Nature (che costituiscono una naturale prosecuzione dei due giovanili Tracts, e l’Essay on lnfallibility ad essi coevo). Quanto al Patriarcha di Filmer, l’A. osserva che “sarà proprio la parte esegetica, apparentemente meno ‘a rischio’, quella su cui si abbatterà con più forza dissolvente la critica sistematica del First Treatise di Locke” (p. 59). L’accusa fondamentale che Locke muove a Filmer è la mancanza di una RECENSIONI coerente derivazione delle sue posizioni da quella Scrittura su cui pretendevano fondarsi. Con spirito analitico e spesso mordace Locke dimostra che le deduzioni che Filmer trae dai numerosi riferimenti biblici sono “insostenibili” (p. 62). Nel suo lavoro esegetico Locke continua a dare per scontata la congruenza di ragione e rivelazione e mira a mostrare come ci siano clamorose discrepanze tra l’uso che Filmer fa di un testo citato e il significato di quel testo nel contesto generale. Uno dei presupposti fondamentali del metodo esegetico lockiano nel First Treatise of Government è la coerenza razionale della parola di Dio, che si rivolge agli uomini in maniera adeguata alla loro comprensione, e rispettosa delle regole del loro linguaggio. Per Locke condizione essenziale di questa convergenza fra il lume della ragione e la verità biblica (convergenza che egli condivide con molti suoi contemporanei, tra cui soprattutto il platonico di Cambridge e latitudinario Benjamin Whichcote) è “non sovrapporre al dettato biblico arbitrarie interpolazioni umane, spesso interessate, che ne distorcono la coerenza e ragionevolezza”, un principio regolatore dell’esegesi biblica, che “aprirà poi la strada ad una scelta ermeneutica che avrà un grande sviluppo nelle future riflessioni di Locke: quella secondo cui nell’interpretazione di ogni passo biblico controverso ‘la Scrittura è la migliore interprete di se stessa’”, e sarà proprio questo “il principio guida delle successive opere ermeneutiche di Locke” (pp. 65-66). Occorreva a Locke definire la specificità e i limiti del compito ermeneutico e approntare gli strumenti per giungere a definire incontrovertibilmente il nucleo essenziale della parola di Dio, un criterio che permettesse di discriminare, tra le interpretazionì della Scrittura, quelle aperte a un effettivo ascolto della lettera del testo. L’A. mette in evidenza quali siano per l’Essay concerning Human Understanding le difficoltà e i limiti del compito ermeneutico: soprattutto la forza dei pregiudizi, particolarmente rilevanti nell’ambito della religione e della morale, le difficoltà che nascono dalla strutturale imperfezione del linguaggio, l’antichità e l’oscurità dei testi sacri. Infine individua con precisione il ruolo svolto dalla ragione. Essa deve “fornire gli strumenti e le procedure che permettono di misurare l’attendibilità delle ‘credenziali’ di tutte le proposizioni che ambiscono al titolo di rivelazione divina ed anche di intenderle” (p. 116). La ragione non è uno strumento di scoperta di verità religiose, ma è, in questo campo, uno “strumento di regolazione dell’assenso”. L’A. mostra quindi analiticamente come, dopo aver identificato, con l’Essay, l’oggetto e i limiti del compito ermeneutico, Locke si risolve a verificare le riflessioni metodologiche sul campo dell’interpretazione vera e propria, attraverso l’interpretazione biblica fornita nella Reasonableness of Christianity e poi nella Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul. Per quanto concerne la Reasonabless, l’A. affronta anche i contenuti dottrinali dell’opera: la fede nella messianicità di Gesù, necessaria per dirsi cristiani, la necessità delle opere per la salvezza, l’insufficienza della ragione per rinvenire un sistema di regole morali capaci di orientare sulla via della salvezza e la conseguente necessaria integrazione offerta dalla rivelazione. In particolare tuttavia l’A. si sofferma sul tema della congruenza fra messaggio evangelico e ragione, sull’impossibilità che la parte ispirata della Scrittura presenti contraddizioni, e quindi sul tema della “concor- 97 98 danza evangelica”, sul tipo di erudizione religiosa volta alla “ricostruzione dell’armonia tra le varie parti della Scrittura, condotta in modo da ricavarne un corpus di verità coerenti” (p. 145). La posizione di Locke è ben determinata dall’A. in rapporto alla tradizione latitudinaria e all’arminianesimo di Limborch, alle tesi contrastanti di Richard Simon e Jean Le Clerc. La strategia ermeneutica di Locke mira a escludere ogni precomprensione dottrinale e filosofica, nel senso che il signìficato del testo non dev’essere cercato in una dottrina estranea alla Scrittura, ma nella Strittura stessa collazionata con se stessa. Russo osserva acutamente che di qui nasce un problema di difficile soluzione per Locke. Locke ha impiegato un’esegesi di tipo storico della Scrittura, in base all’idea che il linguaggio usato nella Scrittura avesse, per l’appunto, un carattere storico, e lo ha fatto per spiegare alcune difficoltà che il lettore moderno incontra nel leggere il testo sacro. Ma Locke sapeva bene, in quanto esperto di cronologia biblica e di concordanza evangelica, che i testi sacri appartengono a epoche storiche diversissime e gli scrittori sacri usarono le parole “secondo il linguaggio del tempo e del paese in cui vissero”. “Come si può, dunque, applicare il principio di comparazione per spiegare i passi più oscuri, se deve valere anche il principio storico?” (p. 159). I principi generali del metodo ermeneutico, le cui premesse erano state elaborate nell’Essay e riprese nella Conduct of Understanding, rimangono saldi in Locke, ma si rivelano insufficienti a dare forma organica e soddisfacente al lavoro di interpretazione applicato alle epistole di S. Paolo. Di qui l’impresa lockiana della Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul. “Lo scopo di Locke nell’intraprendere il suo nuovo lavoro ermeneutico era quindi quello di rendere accessibili a tutti le epistole di Paolo nel loro autentico significato” (p. 206). Rimane il ricorso alla ragione, che in Paraphrase and Notes risulta lo strumento più adatto “per la comunicazione di un contenuto altro –un contenuto che la trascende” (p. 216). Russo mette in evidenza come, seguendo in particolare le indicazioni metodologiche fornite da Robert Boyle in Considerations Touching the Style of the Holy Scriptures, Locke si impegni nel ricostruire la linea argomentativa delle epistole punto per punto, “ritrovandone tutti i nessi, gli snodi e le digressioni, per mostrare come tutto il testo sia coerentemente organizzato, in rapporto al fine che ciascuna epistola si propone” (p. 216). Risulta alla fine che lo scopo principale della lettura lockiana delle epistole di Paolo è quello di fondare su base scritturistica e paolina l’importanza della vita morale per la salvezza. “Ancora una volta –osserva acutamente Russo–, giunto ormai alla fine delta sua carriera intellettuà1e e della sua vita di studioso, Locke affronta la questione decisiva, quella intorno a cui aveva ruotato l’intero suo percorso. Lo fa, ancora una volta, da una prospettiva nuova, scegliendo il terreno apparentemente più sfavorevole: appunto quelle epistole di Paolo che erano l’arsenale preferito dei predestinazionisti, ovvero i testi biblici, che più apertamente svalutavano l’importanza delle opere per il conseguimento della salvezza eterna” (p. 219). Dal punto di vista dottrinale Russo sottolinea ancora una volta la sostanziale continuità dell’interpretazione lockiana di Paolo con l’impostazione di fondo dell’Essay e della Reasonableness: “‘Salvare le opere’ è in effetti l’obiettivo primario dell’erme- RECENSIONI neutica di Locke, che aveva fatto ricorso alla rivelazione proprio per fondare su basi il più possibile sicure il dovere morale di ciascuno, e attraverso quello il dovere politico” (p. 250). Il volume ha il pregio di affrontare direttamente il tema specifico dell’esegesi e dell’ermeneutica, tra i più trascurati nella vasta letteratura critica su Locke, collocandosi peraltro nel solco dei contributi critici più recenti che sottolineano la centralità del pensiero religioso nello sviluppo della filosofia lockiana. Russo dimostra una sicura padronanza delle fonti lockiane edite e inedite, del contento intellettuale e della letteratura secondaria. Attraverso lo studio critico dell’ermeneutica lockiana viene offerta una riconsiderazione complessiva del pensiero di Locke e del suo sviluppo storico. Mario Micheletti M. SCHOEPFLIN, Maurice Blondel, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, pp. 96. Tra i primi volumi di una intelligente collana (“Scrittori di Dio”) pubblicata d’intesa con il Progetto culturale della Chiesa italiana è giunto in libreria quello dedicato a Maurice Blondel (1861-1949) e che è stato curato da Maurizio Schoepflin. L’agile volumetto si articola in una breve, ma densa introduzione ed un’ampia antologia di testi blondeliani tra i più significativi. “Cattolico convinto e praticante –scrive Schoepflin–, cresciuto in una famiglia profondamente religiosa, lettore attento e partecipe, fin dalla giovinezza, di autori caratterizzati da una forte tensione spirituale, Maurice Blondel, che fu e si sentì per tutta la vita un professore di filosofia, avvertì con una sensibilità particolarmente spiccata un problema che è risultato costantemente presente e vivo all’interno del pensiero di ispirazione cristiana fin dalle origini: ovvero quello concernente il rapporto che può e deve intercorrere tra la fede e la speculazione filosofica”. Blondel studiò nella celebre Scuola Normale Superiore di Parigi, dove ebbe per maestri Léon Ollé-Laprune ed Emile Boutroux. Nel 1893 discusse la tesi di dottorato L’azione e nel 1895 iniziò la carriera universitaria. Egli è stato il più prestigioso rappresentante della filosofia dell’azione, una filosofia che è stata strettamente interconnessa con il movimento modernista. “L’azione –egli scrisse– nella mia vita è un fatto il più generale e costante di tutti”. Nell’azione l’uomo esprime la sua volontà, il suo essere. E la vita è una dialettica della volontà e non già come pensava Hegel della ragione. È una dialettica tra la volontà volente e la volontà voluta (cioè il risultato realmente ottenuto). E in questa dialettica l’uomo sperimenta la sproporzione esistente tra i due tipi di volontà or ora ricordati e si apre così alla trascendenza e al soprannaturale. L’uomo, per Blondel, è un essere finito che tende “naturalmente” all’Assoluto. L’uomo, infatti, si accorge che non può bastare a se stesso e “sente fino all’an- 99 goscia di non essere il proprio autore e il proprio padrone”. L’idea di Dio, egli afferma, “si sappia o no, è l’inevitabile compimento dell’azione umana, ma l’azione umana ha inoltre l’inevitabile ambizione di raggiungere ed adoperare, di definire e realizzare in sé questa idea della perfezione. Non possiamo conoscere Dio senza voler diventare Dio in qualche modo”. Il metodo dell’immanenza fatto proprio da Blondel fu condannato nel 1907 dal Sant’Uffizio insieme al modernismo. Tuttavia, in tempi a noi recenti, non pochi studiosi hanno dichiarato di poter considerare Blondel tra gli ispiratori del Concilio Vaticano II ed altri, tra cui Giovanni Ferretti, hanno visto in lui uno dei padri della cosiddetta “svolta antropologica” che ha condotto la teologia e la filosofia cattoliche “dalla considerazione primaria, se non esclusiva del piano religioso oggettuale e concettuale, alla considerazione primaria, anche se non esclusiva, del piano esistenziale personale del soggetto che effettivamente vive la religione”. Massimo Baldini E.AFFINATI, Un teologo contro Hitler. Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer, Mondadori, Milano 2002, pp. 172. 100 Per l’orientamento del pensiero filosofico e teologico, Bonhoeffer si inscrive nel filone della teologia liberale (Liberalitat) del Novecento, alla quale hanno prestato attenzione speciale studiosi insigni quali Jaspers, Gogarten, Bethge, Mancini, Caracciolo, Moretto. Nella realtà esistenziale la biografia del grande teologo evangelico è contrassegnata dall’appartenenza alla Chiesa confessante che ha fatto sentire la sua voce di condanna per i crimini commessi da Hitler e dal nazismo. Bonhoeffer ha incarnato nella sua vicenda esistenziale la tipologia del cristiano eroico che testimonia gli ideali del Vangelo senza cedimenti e senza compromessi con ideologie politiche. Egli ha vissuto la sua breve ma intensa vita nella doppia tensione di fedeltà a Cristo e ai fratelli di peregrinazione missionaria. L’eroica coerenza di vita cristiana ha condotto Bonhoeffer a morire impiccato nel campo di concentramento di Flossenburg, nell’aprile del 1945, con l’accusa di aver cospirato alla vita del Führer. Per incondizionata fedeltà a Cristo il giovane pastore d’anime ha rinunciato alla carriera dell’insegnamento, ha sacrificato nobilmente l’amore della fidanzata, ha fatto sentire la sua voce per la conquista della libertà personale, educando gli uomini della sua generazione, con scritti provocatori, a superare la psicologia dell’uomo diviso in se stesso (aner dìpsychos) in direzione di marcia etica e religiosa verso la ritrovata unità spirituale del credente (anthropos teleios). Assiduo lettore e interprete della Bibbia, Bonhoeffer ha vissuto sulla propria pelle la tragedia degli ebrei perseguitati ed ha scosso il torpore dei cristiani acquiescenti della Chiesa luterana, come del resto ha fatto anche Karl Barth, alla vigilia della seconda guerra mondiale. Paolo Miccoli RECENSIONI Lo scrittore Eraldo Affinati traccia, nella presente biografia, un ritratto esaltante dell’autore di Ethica, rivisitando, sulle tracce della memoria, i luoghi della vita e della morte del rinomato pastore e raccogliendo preziose testimonianze di persone che lo hanno conosciuto, fra le quali Dante Curcio. Una biografia che si legge con viva emozione e che può essere compendiata in questa riflessione di Bonhoeffer: “Essere libero significa essere-libero-per-l’altro perché l’altro mi ha legato a sé. Solo in rapporto all’altro sono libero”. F. BIANCO, G. MATTEUCCI, E. MATASSI, Dilthey e l’esperienza della poesia, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo 2001, pp.65. Il volume comprende tre saggi: Franco Bianco tratta Del profetico e della follia. Note sulla lettura diltheyana di Hölderlin; Giovanni Matteucci scrive Sull’idea diltheyana della poesia; Elio Matassi affronta il seguente tema: Walter Benjamin e l’esperienza vissuta: una ricezione controversa. In appendice è offerta una traduzione italiana (a cura di Giovanni Matteucci) del saggio di Dilthey del 1867: Hölderlin e le cause della sua follia. Il tema del saggio di Dilthey pubblicato in appendice, è presente nel primo contributo, quello di Franco Bianco, che mette in evidenza le considerazioni che inducono Dilthey a veder culminare l’evoluzione poetica di Hölderlin nelle liriche nate al limite della follia. “In esse giungeva infine ad una totale liberazione il ritmo interiore del sentimento, che prendeva congedo da ogni forma di chiusura esercitata fino ad allora” (p. 14). Per il Matteucci, se l’idea diltheyana di poesia si riassume nello stabilire un rapporto di reciprocità organica tra forma e vissuto, sembra giustificato sottolineare che “tale rapporto vale come principio di comprensione, in quanto designa una relazione a geometria variabile, plastica, aperta a contesti imprevedibili” (p. 27). L’idea di poesia che ha Dilthey è indice di uno schema d’esperienza alieno da intenti prescrittivi e inefficace sul piano delle definizioni. Il Matassi rende conto nel suo saggio della lettura radicalmente critica del paradigma diltheyano di Das Erlebnis und die Dichtung fornita da Walter Benjamin. “L’accusa alla Lebensphilosophie ed al Dilthey epigonale –osserva il Matassi– di far sfumare nell’indeterminatezza del mito la vita dell’artista, rendendola inqualificabile dal punto di vista morale, rappresenta il nucleo teoreticamente centrale di una teoria della critica, declinata essenzialmente sulla questione della verità” (p. 41). Naturalmente, la stessa traduzione italiana del saggio di Dilthey su Hölderlin e le cause della sua follia è un contributo significativo. Il volumetto, in definitiva, presenta alcune prospettive interessanti sull’estetica di Dilthey, con particolare riguardo alla figura di Hölderlin. Albino Babolin 101 AA. VV., Filosofia - dialogo - amicizia. Studi in memoria di Dario Faucci, a c. di A. Scivoletto, FrancoAngeli, Milano 1998, pp. 361. 102 Il filo che lega i contributi piuttosto eterogenei di questo volume è l’affettuoso ricordo di Dario Faucci, lo studioso, già docente all’Università di Parma, alla cui memoria questi saggi sono dedicati. La terza parte è espressamente dedicata a testimonianze relative alla personalità di Faucci e al suo tempo. C’è anche un’interessante intervista a Faucci, già pubblicata nel 1991, a cura di Pietro Leandro Di Giorgi. Il percorso filosofico, culturale e umano di Faucci è invece ricostruito nel contributo iniziale di Angelo Scivoletto. Mi limito qui a ricordare i principali contributi di carattere filosofico. Alberto Siclari tratta il seguente argomento: La fede e il mondo per Soren Kierkegaard. Il Siclari nota che, per il pensatore danese, in quanto costituisce l’unico rapporto esistenziale con l’eterno dell’uomo, la fede è il necessario fondamento di tutto il suo essere e di tutto il suo mondo: quando manca la fede, la realtà si trasforma, anche nella sua dimensione socio-politica, in un vortice dove ogni cosa è travolta e dissolta. “Questa funzione della fede, che Kierkegaard ribadisce sino nel suo ultimo scritto, rimasto inedito, non deve però far dimenticare che per il cristianesimo l’impegno negli affari del mondo ha un valore soltanto strumentale. È un punto sul quale, con il passare degli anni, Kierkegaard ha insistito con sempre maggiore decisione” (p. 193). Kierkegaard ha voluto riaffermare con assoluta chiarezza che la rinuncia al mondo è un’ esigenza reale e indeclinabile del cristianesimo. “Richiamando l’uomo al dovere dell’onestà intellettuale ed esistenziale, stimolando nel credente la coscienza del peccato e un’ adeguata consapevolezza del valore della grazia, ha cercato di restituire al cristianesimo la sua serietà e la sua dignità di fede difficile” (p. 198). Il saggio di Ferrucio Andolfi Attualità di una polemica ottocentesca su frammentazione e ordine sociale è imperniato sulla figura di Stirner e sulle critiche a lui rivolte da Marx. Andolfi sottolinea l’attualità di quella polemica, anche in rapporto al problema-religioso. Egli nota che la risacralizzazione del soggetto, resa necessaria dal fallimento stirneriano di una totale abolizione del ‘sacro’, può essere tentata secondo vie del tutto opposte. “Così Nietzsche allarga i confini dell’io, mettendolo in relazione con l’intero divenire cosmico, ma l’operazione finisce pur sempre da ultimo per inglobare il mondo nell’io, che viene perciò stesso reso ipertrofico. La filosofia umanistica e sociale di Feuerbach e Marx suggerisce al contrario una ‘trasformazione del sacro’ consistente nel riconoscimento dell’appartenenza e della dipendenza dai propri simili e dall’intero universo. Per questa via la grandezza dell’io non è esclusa ma ricercata attraverso la sua ‘deflazione’” (p. 207). Angelo Marchesi si sofferma invece sulla figura di Del Noce, considerando in particolare le sue riflessioni sull’ attualismo gentiliano, sul modernismo e sulla metafisica classica. Appare piuttosto discutibile il fatto che il pensiero di Del Noce sia studiato prevalentemente attraverso il filtro dell’ interpretazione di Rocco Buttiglione, peraltro aspramente criticata dal Marchesi. L’A. in particolare rivendica, specialmente nei confronti della interpretazione dell’attualismo RECENSIONI gentiliano, la prospettiva filosofica e metafisica bontadiniana, trascurata da Del Noce. Alla fine si mette in discussione che la frequentazione da parte di Del Noce di idealismo, tomismo e modernismo sia e rimanga “criticamente valida e apprezzabile o, addirittura imprescindibile, per riuscire a capirli” (p. 311). Vorrei concludere, ricordando la frase finale dell’intervento di Angelo Scivoletto, che sintetizza il suo approccio commosso alla figura e al pensiero di Faucci: “Dal dialogos al Logos: mi è caro riassumere in questo binomio la pensosa esistenza, solerte e tenera, di Dario Faucci, filosofo del dialogo e dell’amicizia” (p. 17). Albino Babolin A. G. MANNO, Quis est homo? Ricerche scientifiche, storiche e teoretiche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002, pp. 568. Questo ultimo volume di Ambrogio Giacomo Manno, dal sottotitolo Un cammino pensante tra scienza, filosofia, religione alla ricerca delle radici divine, spirituali e umane dell’uomo, è una vera enciclopedia del sapere divino e del sapere antropologico, inteso, quest’ultimo, a livello psicologico, epistemologico, etico, sociologico, storico, comunitario. È impensabile, sotto tutti gli aspetti, una separazione tra Dio e uomo, tra trascendenza e immanenza, tra rivelazione e scienza, tra Creatore e creato, tra Infinito radicato nel cuore dell’uomo e fìnitudine dello stesso uomo. C’è una voce della ragione, c’è una voce del cuore, c’è ancora una voce dell’anima, e c’è anche una voce della natura, della scienza, della storia dell’uomo, dalle origini fino ad oggi, che parlano di Dio e dell’itinerario spirituale e umano dell’uomo verso Dio. Cosa sarebbe, si chiede Manno, “un mondo senza Dio” e “un uomo senza Dio”? (p. 489) . Non si comprenderebbe il perché dell’esistenza di un mondo. “Tutto sarebbe senza un perché, come afferma l’ateo Sartre. E chi avrebbe potuto dare origine al mondo, alla sua intelligibilità, alle meraviglie delle specie vegetali e animali? Soppresso Dio resterebbero le tenebre, l’assurdo, il non senso di tutto il reale; anzi niente di tutto questo: resterebbe solo il Nulla. Soppresso Dio, l’uomo sarebbe un essere mostruoso e incomprensibile: bramoso di Dio, diretto a Dio, esigente Dio, sarebbe vittima di un ideale inconsistente, non si sa perché e da chi ispirato” (p. 489). L’attenzione particolare che emerge da questa estesa e profonda ricerca, dall’introduzione alla prima parte dedicata al Mondo ambiente e alcuni modelli storici (pp. 15-434), e alla seconda parte dedicata alle Linee di antropologia teoretica (pp. 437-555), è quella di porre alla riflessione di chi studia o legge queste pagine il nesso ontologico, logico, divino e umano tra Dio e l’uomo, e poi tra mondo, uomo e Dio. Manno studia, attraverso le ultime ipotesi sull’origine e sul tempo dell’universo, la storia del cosmo secondo le conoscenze attuali, i problemi epistemologici e filosofici riguardanti l’origine delle specie, l’origine dell’uomo e l’antropologia dei Veda delle Upanishad, il cammino di Dio nella storia 103 104 del mondo e, quindi, dell’uomo, e come tale cammino è stato visto dall’uomo comune e dagli studiosi. A conclusione della sua indagine sulla spiritualità dei Veda egli afferma: “Nella Bagavad-Gita, una delle ultime opere della grande tradizione brahmanica, si esprime la gratitudine alla Persona Suprema per il ritorno nella Patria; e nelle Upanishad, in generale, l’elevazione a Brahman, anche in vita, è considerata una sua grazia, un suo dono. Riportiamo in fase conclusiva la sentenza della Gita: “Colui che è libero dall’illusione, dall’orgoglio e dalle false relazioni, che comprende l’eterno, che è libero dalla lussuria e dalla dualità della gioia e del dolore, e sa come sottomettersi alla Persona Suprema, raggiunge questo regno eterno” (p.172). L’immortalità viene data a chi raggiunge la forma suprema di conoscenza, innalzandosi al “mondo soprasensibile”. Vi è quindi una discesa divina nella storia degli uomini, cui corrisponde una ascesi degli uomini verso il divino. “Ed è impressionante, scrive Manno, come questa spiritualità, non illuminata dalla luce del pensiero cristiano, ne abbia precorso molti aspetti” (p.167). Manno, dopo questa ricerca sulla spiritualità non cristiana e sui problemi epistemologici riguardanti le ipotesi sull’ origine del mondo e dell’uomo, rivolge la sua attenzione all’uomo inteso come persona che, creata da Dio con un’anima immortale, vive intensamente questa armonia di discesa di Dio nella sua storia e in quella dei suoi fratelli di fede e la forte tensione ascensionale verso Dio. A questa tematica è dedicata la maggior parte dell’opera, dalla Concezione dell’anima in S. Agostino all’uomo “come tempio della Trinità”, alla Charitas come “via di acceso a Dio”, all’eternità della verità e all’immortalità dell’anima (cap. 6-15). La centralità dell’uomo come persona è uno dei punti più caratteristici e originali di questa ricerca, sia attraverso l’indagine agostiniana, sia attraverso lo studio delle opere di Bonaventura da Bagnoregio. Certi temi, come l’umanesimo cristiano di Bonaventura, la facoltà dell’anima e l’ascesi a Dio come itinerario della mente, la dottrina dell’illuminazione, le ali della ragione e della fede per salire verso Dio, e tre vie della perfezione cristiana, purgativa, illuminativa, unitiva, che provocano “l’incendio amoroso” dell’anima, sono tutti in funzione della centralità della persona (cap.16-23). Il valore dell’uomo come persona sta proprio in questo itinerario ascensionale e in questo incontro con Dio che si è fatto uomo, croce, storia umana, Maestro “più vicino all’uomo e insieme più comunicativo” (p. 284). La persona umana, con la sua anima, con la ricchezza della sua intelligenza e con la bellezza della sua corporeità, pur restando “sempre nell’abissale distanza ontologica tra il creatore e la creatura” comprende allora “la grandezza infinita del suo Autore e l’immensità dell’amore che ha per lei” (p. 295), ma anche, nello stesso tempo, la dignità della propria persona e la sua nobiltà, oltre che la sua grandezza divina e antropologica. Il cammino della e sulla centralità della persona attraversa così il Tracciato antropologico nel pensiero moderno (cap.24), da Malebranche all’esistenzialismo ateo e teistico, per fermarsi ad approfondire il personalismo di Rosmini (pp. 325-358), il quale su questo tema, in pieno Ottocento, deve ritenersi un maestro di spiccata originalità e di elevata attualità per i nostri giorni. Manno riprende il suo itinerario presentando il personalismo di Mounier, di Maritain, di RECENSIONI La Pira, parlando del “personalismo comunitario” che si basa “sulla dottrina della persona come valore in sé, e come ‘valor assoluto’, ma, nello stesso tempo, comunicante intersoggettivamente” (p.361), e che rifiuta il liberalismo agnostico e individualistico, incapace di avere un respiro europeo e mondiale. Accanto a questi maestri della persona Manno colloca giustamente il pensiero di Michele Federico Sciacca che, seguendo la linea filosofica, pedagogica e giuridica di Rosmini, vede l’uomo-persona in tutte le sue dimensioni. Nella “charitas”, L’uomo, questo squilibrato della società moderna, può ritrovare la pienezza dell’essere e gustare l’Infinito (p. 391). L’uomo-persona può ritrovare il gusto della libertà e può uscire dalle strettoie di un pessimismo esistenziale passando dalla strada dei filosofi, cioè dal Dio dei filosofi, al Dio della Rivelazione biblica. E in questo passaggio Luigi Pareyson, con il suo personalismo, è maestro e guida di alto valore (pp. 413-434). Gli ultimi capitoli (29-36) sono dedicati al rapporto tra anima e corpo alla luce delle nuove frontiere della neurologia, alla volontà libera e responsabile, all’immortalità dell’anima. Il volume termina con una voce di speranza: “Nelle tenebre che avvolgono tante coscienze nell’ attuale momento culturale, Cristo Via, Verità e Vita, appare come la grande luce che possa guidare e illuminare l’umanità nel suo cammino” (p. 555). Pietro Addante 105 G. STRUMMIELLO, Il logos violato. La violenza nella filosofia, Dedalo, Bari 2001, pp. 416. Il volume mette in luce il rapporto tra il logos, inteso come il discorso ragionevole, e la violenza, intesa come ciò che, in apparenza, è altro dalla ragione, dal logos appunto, e che pertanto gli si opporrebbe. In quella che sembrerebbe un’esclusione reciproca si palesano i termini di una coappartenenza: la violenza è tratto caratterizzante dell’uomo almeno quanto la razionalità, difatti “solo l’animale razionale, così come recita la sua classica definizione filosofica, può essere violento, e quasi invariabilmente lo è” (p. 6). L’ampia e puntuale trattazione della Strummiello colloca al centro della riflessione il proprio dell’esercizio della filosofia come logos e permette, attraverso le analisi svolte, di riconoscere la violenza come il portato che permane sempre al fondo della razionalità filosofica. Questo nesso viene sviluppato ed indagato attraverso quattro sezioni che l’Autrice organizza come un percorso volto ad una graduale ed ampia decostruzione di ogni suo aspetto. La prima sezione, intitolata “Logos e violenza”, definisce non solo i termini della questione ma sonda già l’ambiguità intera del rapporto: la posizione del problema è quella hegeliana, l’assunzione della negatività come momento interno del processo dialettico che fa della filosofia un sapere (dell’) Assoluto. Il negativo –l’alterità, l’esterno– svolge nella dialettica hegeliana un ruolo fon- 106 damentale: esso rappresenta per Hegel il finito, l’immediato, il contingente, e quindi ciò che ha parvenza di esteriorità rispetto all’affermarsi dell’universale, dell’Assoluto, che regna nella storia. Il suo addomesticamento, il suo superamento, la sua ricostituzione nel movimento dialettico serve dunque a togliere questa parvenza e a liberare l’universale in esso dissimulato, a riconoscere l’identità dell’Assoluto con se stesso. L’alterità non è altro dunque che un momento dell’identico. Viene qui però messa in rilievo l’ambiguità essenziale di questo gesto: convergendo nell’affermazione dell’universale, inverandosi, il negativo lungi dall’essere destituito, viene, per così dire, elevato a potenza: “Si può così dire che Hegel non solo allestisce effettivamente lo scenario, ma definisce l’esatta posta in gioco del rapporto tra filosofia e violenza: la filosofia (il corso storico e teorico del logos) è sì una risposta al negativo e alla violenza (nella misura in cui si serve di essi per ricomporre una superiore conciliazione), ma solo in quanto essa stessa si fa portatrice di negatività e di violenza –una violenza di secondo grado, una metaviolenza nei confronti di ciò che è semplicemente dato e dev’essere tolto” (p. 35). A questa posizione Giusi Strummiello affianca quella di Eric Weil. Nella sua Logica della filosofia, Weil sostituisce la concezione classica dell’uomo come animal rationale con quella di animal rationabile e, come Hegel, fa della negazione, dell’affrancamento, il tratto costitutivo dell’uomo. La negazione è infatti l’attività con la quale l’uomo si affranca dalla sua condizione animale naturale per fare della ragione –la ragionevolezza– il proprio compito: essere ragionevole è per Weil il modo di liberarsi dallo scontento, dall’insoddisfazione, e maturare così la propria libertà. La violenza diviene quindi la controparte del divenire esseri ragionevoli, diventa l’irragionevole. La ragionevolezza si costituisce quindi come lo sforzo di una graduale armonia tra gli uomini, come dialogo, e rappresenta la libertà stessa come tratto proprio dell’uomo poiché è essa stessa scelta libera. A questo fa appello l’ideale weiliano del “discorso assolutamente coerente”, ad un ideale di logos come ragione realizzata tale da non contrastare più la possibilità della violenza ma piuttosto ricomprenderla in positivo. Ed ecco che l’Autrice mostra ancora la circolarità di questa ulteriore posizione del problema, circolarità in qualche modo strutturale: con le parole di Weil, “il risultato paradossale è dunque che la violenza non ha senso che per la filosofia, la quale è rifiuto della violenza” (cfr. p. 72); nelle parole della Strummiello, “senza la violenza […] la filosofia non sarebbe concepibile, non potrebbe darsi neppure come possibilità” (p. 73); “perché ci sia scelta consapevole del discorso filosofico […] ci si deve rappresentare la violenza” (p. 80). La seconda sezione, intitolata “Metafisica e violenza”, pone una domanda ben più radicale: questo “inizio” violento che genera la filosofia non porta invece a concepire il logos come già permeato di violenza, attraversato cioè, per la sua stessa pretesa di organizzare un senso, da un imprescindibile vena violenta? Fondamentale per l’Autrice si rivela qui quella riflessione radicale ancora in atto sull’inizio stesso, sul gesto originario del pensiero che inaugura la metafisica e la conseguente esigenza di pensare la possibilità di un superamento RECENSIONI della metafisica stessa, in particolare attraverso le riflessioni di Heidegger, Adorno, Lévinas e Derrida. La filosofia trova al fondo della propria urgenza la percezione di qualcosa di inquietante, di qualcosa di terribile che si situa più in là del thaumázein, e che Heidegger ritrova nel primo coro dell’Antigone di Sofocle: “Di molte specie è l’inquietante, nulla tuttavia/di più inquietante dell’uomo s’aderge” (p. 91). Nel 1935 Heidegger considera l’uomo come essenzialmente violento in quanto corrisponde all’apparire dell’essere che è un imporsi, un vigere nel mezzo dell’essente, esponendosi così alla percezione dell’inquietante, dello spaesamento, della perdita di ciò che è familiare: “L’uomo fa violenza dominando […] la violenza del predominante” (p. 96). L’uomo è violento in senso ontologico perché l’evento dell’essere è un imporsi violento. La cifra della violenza di questo corrispondimento tra uomo ed essere è il logos pensato come légein, come un raccogliere l’essere nel suo insieme con la lotta, esercitando la violenza che tiene aperto, nel seno dell’essente, il varco per la manifestazione dell’essere. Il logos originario sta dunque, per Heidegger, nella decisione di corrispondere all’imporsi dell’essere e nella lotta volta a mantenere questa apertura. Platone e Aristotele avrebbero in seguito tradotto/tradito questa verità del logos pensandola come ambito della rappresentazione degli enti. Ma già con Heidegger è raggiunto un importante risultato ai fini di questa ricerca: anche nel suo darsi aurorale, il logos si dà nella lotta, nella violenza, è percorso trasversalmente dalla conflittualità. Questo significa, con l’Autrice, che anche posizioni fortemente avverse alla tradizione metafisica della filosofia, avverse ad Heidegger stesso, devono fare i conti con una negatività insita nello stesso statuto del logos: Adorno oppone un rifiuto netto alla metafisica considerata come la matrice teorica della tragedia nazista, pur mantenendo il semplice senso in essa presente di apertura sull’alterità assoluta ma svuotando questa promessa di ogni contenuto concettuale, come una promessa che sottrae sempre il proprio dovuto. Anche in Lévinas l’alterità più radicale da appello morale diviene fondamento puro che ci si impone come un comandamento, e che si impone senza possibilità ulteriori, nel silenzio. È allora con Derrida che l’Autrice giunge a considerare che non si dà logos puro, esso è sempre insieme violato e violento: la filosofia allora non può che essere quella scelta unica e radicale di riconoscere questa compromissione e di optare per la minore violenza possibile: essa è l’ambito esclusivo in cui si rende possibile una economia della violenza. Nella terza sezione, intitolata “Cristianesimo e violenza”, viene analizzata l’altra matrice fondamentale dell’Occidente, e cioè quella giudaico-cristiana, e il suo rapporto con la violenza. Non si può a tal proposito non ricordare la sentenza nietzscheana di condanna del cristianesimo, ma ad essa l’Autrice contrappone la lettura in chiave antropologica che Girard fa delle Scritture, interpretandole come custodi di una teoria dell’uomo e come un epocale smascheramento della violenza quale fondamento della costituzione delle comunità e del sacro. La secolarizzazione del cristianesimo sta dunque nella tradu- 107 108 zione in termini storico-antropologici della colpa umana che sta al fondo di ogni comunità, quella con la quale si esorcizza il negativo attraverso il sacrificio umano. Il cristianesimo, con la figura del Cristo, ha additato per primo l’innocenza della vittima sacrificale, minando così la possibilità di allontanare la colpa o di occultarla nel culto del sacro. Altro concetto fondamentale della tradizione cristiana è la creazione ex nihilo che l’Autrice rivisita attraverso le tesi di María Zambrano. Per la Zambrano la violenza che scuote l’Europa nel Novecento deriva da lontano, fin dalla dottrina cristiana della creazione dal nulla considerata come un atto assoluto, una violenza che squarcia la notte dei tempi generando le cose, un atto violento esso stesso ma di una violenza positiva poiché propria della divinità. Il creazionismo rappresenta l’elemento di originalità che il cristianesimo e l’ebraismo introducono rispetto alla tradizione greca: esso è dunque “ciò che costituisce la matrice dell’Europa, poiché è l’adorazione del suo Dio che giustifica nell’uomo europeo la sua attività creatrice” (p. 257). La capacità creatrice è dunque motivo autentico di una intimità dell’uomo con Dio ed ha pertanto una valenza positiva come, secondo la Zambrano, pensava anche Agostino. Ora, l’attività umana si è piuttosto sviluppata nella più completa distanza da quel suo essere originaria prosecuzione dell’attività creatrice divina, avanzando la pretesa di sostituirsi ad essa in tutto, divenendone dunque una “variante perversa” (p. 260). Il cristianesimo è quindi portatore di una originaria consapevolezza della condizione di incompiutezza e contingenza dell’uomo ed in essa radica il senso autentico della capacità creatrice umana intesa come compito di progettarsi: esso insegna all’uomo a vivere nel fallimento della propria presunzione di assolutezza. Un’ultima sezione analizza i modi di concepire le forme storiche concrete di violenza. Vengono qui percorse in modo particolareggiato le principali tesi che interpretano la violenza nel suo darsi storico: come strumento ai fini degli equilibri economici (Engels), mezzo pedagogico (Sorel), fondamento del diritto (Benjamin), tratto attuale e fondamentale dell’apertura all’altro in sede di ontologia trascendentale (Sartre), controparte nella definizione del potere (Arendt). Ma l’Autrice si sofferma, sulla scorta di quanto fin’ora guadagnato, soprattutto sulla concezione di Foucault: con essa infatti scompare l’immagine monolitica del potere –e quindi della violenza– che diventa il dato di rapporti discontinui, mutevoli, locali, diviene cioè parte della trama di rapporti in cui sempre siamo. In questi rapporti, la violenza rappresenta un mezzo, e per di più non necessario: ritorniamo così alla filosofia come sede di una concezione economica della violenza sostenuta da un lavoro di ricerca genealogica e locale dei rapporti di cui la violenza stessa si compone. Ed è nella storia che il logos, compromesso con il negativo, incontra il logos del testimone, del sopravvissuto, e la sua soggettità destituita. Siamo, con la testimonianza, davanti ad un linguaggio che non appartiene ad un soggetto, e la violenza che lo anima è sempre tale da tenere in scacco il pensiero, il senso. L’Autrice sottolinea che sebbene la testimonianza sia sempre necessaria (il silenzio non è che il perpetuarsi eterno e a-storico dell’orrore subito) non possiamo però rendere il testimone un puro “portatore di storia”, nella misura in Roberto Ferrario RECENSIONI cui si rischia non solo la spettacolarizzazione della testimonianza, ma anche il suo inglobamento in una “dimensione industriale” (p. 376). La pratica filosofica esce, dall’indagine di Giusi Strummiello, sezionata nel suo legame con la violenza e smascherata nelle sue pretese assolute, richiamata ad una consapevolezza fatta di un paziente ed accurato lavoro di decostruzione delle interpretazioni conflittuali e della sua comunanza con questa stessa conflittualità. Proprio tale consapevolezza permette di evidenziare uno dei tratti più rilevanti del discorso dell’Autrice: sull’importanza e sull’urgenza di considerare un legame diretto tra filosofia e violenza, come si dice fin dalle prime battute del volume, regna la luce sinistra dei drammi storici e umani del secolo scorso e la consapevolezza che proprio il rigore di una organizzazione razionale dei mezzi ne ha reso possibile il compimento. Questo imporrebbe il dovere di imputare una certa responsabilità proprio al fallimento della “ragionevolezza” della filosofia di fronte a simili tragedie. Dice dunque l’Autrice a questo proposito: “Questo è forse il vero circolo in cui la filosofia si dibatte: il dolore, l’ingiustizia, la violenza richiedono risposte forti che la filosofia non può e non deve, in tutta onestà, dare” (pp. 390-391). Questo significherebbe infatti tradire una volta di più ciò che è davvero da pensare: il tentativo della Strummiello di sottrarre la violenza al monopolio di una riflessione etico-morale o di una considerazione “destinale” se da un lato permette di rilevare la profondità e difficoltà della questione, dall’altro attribuisce al pensiero un compito gravoso. Se di responsabilità della filosofia si deve parlare essa non può che consistere nel misconoscere il suo legame con la violenza, e per il logos dissimulare la consapevolezza che il proprio statuto si fonda sulla possibilità stessa della violenza. Esso dovrà allora progettarsi, crearsi su questa misura e senza alcuna garanzia di successo. In breve: dovrà prendere consapevolezza della propria radicale finitudine. Arginare meticolosamente la possibilità della violenza: questo il proprio del pensiero e la dimensione della sua autentica finitudine. Ed in questo sta allora anche la impossibilità di un superamento della metafisica, “perché questa è l’unica storia che abbiamo” (p. 121): se ogni discorso non solo è compromesso statutariamente con la violenza, è esso stesso apertura del violento, e partecipa sempre delle manifestazioni storiche della violenza e della sua rete locale di equilibri e discontinuità, dobbiamo, insieme all’Autrice, pensare che “alcune forme di violenza rimangono, con tutte le cautele che si vogliono, preferibili ad altre. Questo è il senso dell’espressione, che abbiamo mutuato da Derrida e a cui abbiamo più volte fatto riferimento nelle pagine precedenti, ‘economia della violenza’: non si può uscire fuori da questo regime (così come non si può saltare tout court fuori dal testo della metafisica), ma si può e anzi si deve optare per la violenza minore, per quella che non solo cerca di evitare, ma si impegna a combattere le forme più distruttive di violenza” (p. 384). 109 Vincenzo Consolo Oratorio Due testi teatrali novità pp. 64 - t 8,00 In questi due testi teatrali l’autore porta fino alle conseguenze estreme l’andatura della sua prosa che si compatta in un narrato contratto, sintetico, molto ritmico, giungendo fino alla forma poetica. In Catarsi è messo in scena il suicidio di un Empedocle contemporaneo. Il momento estremo prima della morte in un luogo anch’esso estremo, l’Etna. Ape Iblea è un’elegia per Noto dove si canta del terremoto, della ricostruzione e del degrado ambientale. Appare, in filigrana ma ben evidente, l’impegno civile sotteso a tutta l’opera di Consolo. 110 Alda Merini Il maglio del poeta novità pp. 64 - t 8,00 Il libro raccoglie l’ultimissima produzione di Alda Merini; è articolato in tre sezioni: nella prima (“Dediche”) si ricostruiscono le relazioni intellettuali ed umane della poetessa; la seconda (“Canzoniere d’amore”) è dedicata a d un tema dominante della poesia della Merini: la ricerca dell’amore in tutte le sue accezioni, da quella religiosa a quella sensuale, che in Alda si coniugano, in quanto la sensualità è insieme spiritualità; la terza sezione, che dà il titolo alla raccolta, è una riflessione sul mestiere del poeta, sul senso della poesia. PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA «SEGNI E COMPRENSIONE» (oltre quelle recensite nella rivista) Volumi: F. DAL BO, Società e discorso, con inedito di J. Derrida, Mimesis, Milano 2002, pp. 218. P. DALLA VIGNA, A partire da Merleau-Ponty, Mimesis, Milano 2002, pp. 232. D. FELICE, a cura di, Dispotismo. Genesi e sviluppo di un concetto filosoficopolitico, voll. 2, Liguori, Napoli 2001, pp. 702. F. LEONI e M. MALDONATO, a cura di, Al limite del mondo. Filosofia, estetica, psicopatologia, Dedalo, Bari 2002, pp. 240. E. LISCIANI PETRINI, La passione del mondo. Saggio su Merleau-Ponty, E. S. I., Napoli 2002, pp. 292. A. MONTANO, Il prisma a specchio della realtà. Percorsi di filosofia italiana tra Ottocento e Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 268. A. NAPOLI, Thomas Hobbes e gli italiani. 1981-2000. Bibliografia recensioni, Cuen, Napoli 2002, pp. 372. S. DE SIENA, La sfida globale di E. Morin, Besa, Nardò 2002, pp. 272. L. VALENTINO, Il saluto dell’errante. Tra poesia e pensiero in Heidegger, Sugarco, Milano 2002, pp. 170. S. VUSKOVIC ROJO, Allende en el mundo, Colectivo Itinerante, Valparaiso s. d. (2002). Periodici: Antologia Vieusseux, n. 22, gennaio-aprile 2002. Aquinas, n. 1, a. XLV, 2002. E. FRANZINI, Il teatro, la festa e la rivoluzione. Su Rousseau e gli enciclopedisti, Aesthetica Preprint, Centro internazionale Studi di Estetica, n.65, 2002, pp.104. Idee, n.49, 2002. L’incantiere, n. 58, a. XV, maggio 2002. Máthesis. Revista de Educaçao, v. I, n. 1, jan.-jun. 2000; v. 1, n. 2, jul.-dez. 2000; v. 2, n. 1, jan.-jul. 2001. G. MORPURGO-TAGLIABUE, Il Gusto nell’estetica del Settecento, a c. di L. Russo e G. Sertoli, Aesthetica Preprint-Supplementa, Centro internazionale Studi di Estetica, n.11, 2002, pp. 254. Proyección, teologia y mundo actual, n. 204, a. XLIX, enero-marzo 2002. Studia patavina, a.XLIX, n.2, maggio-agosto 2002. Uomini e idee, n. 11, 2002. 111 Bianca Gelli Voci di donne Discorsi sul genere novità pp. 256 - t 15,00 La rivoluzione culturale al femminile in un saggio critico interdisciplinare. Questo volume offre una riflessione critica su genere, identità, teoria e pratica della differenza: dalla filosofia, alla psicanalisi, alla pedagogia, alla sociologia e alla psicologia di comunità. Egidio Zacheo Il secolo della democrazia Politica e società nel Novecento novità pp. 200 - t 16,00 112 Il secolo della democrazia, del suffragio universale, delle dichiarazioni dei diritti, delle conquiste sociali. Carlo Alberto Augieri La letteratura e le forme dell’oltrepassamento novità pp. 184 - t 15,00 La capacità del testo letterario di andare oltre il contesto nel quale è prodotto. Saggi su Bachtin, Jakobs, Lotman e De Martino. I saggi qui raccolti focalizzano, all’interno del rapporto tra letteratura e significazione, un problema che interessa lo specifico della parola letteraria: il suo essere discorso dal senso oltrepassante (non solo aperto, dunque) rispetto al significare determinato, necessario, chiuso entro il codice tipologico della cultura che lo emette. 113 SAGGI 114 115 SAGGI
Scaricare