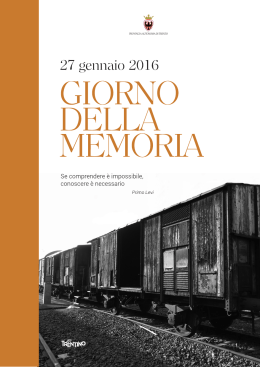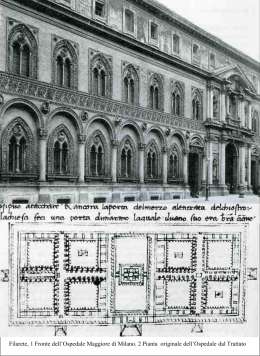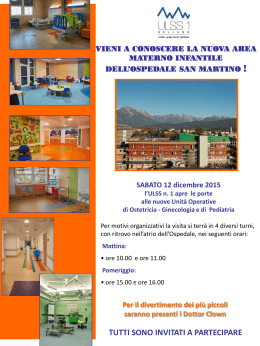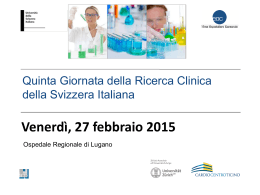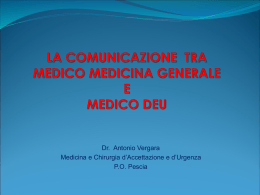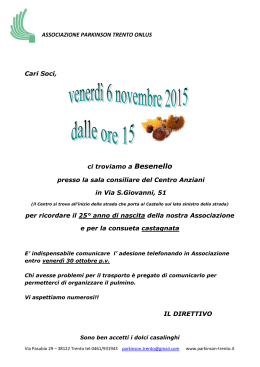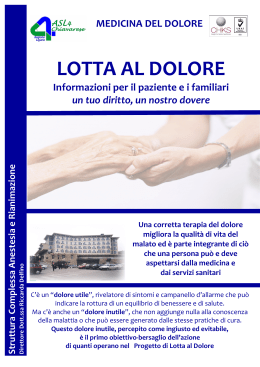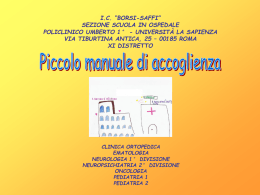Documenti per la Salute 19 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Nuova governance in una rete di comunicazione Atti 8a Conferenza Nazionale degli Ospedali per la Salute Riva del Garda, 24-25 settembre 2004 A CURA DI: PAOLO DE PIERI LORELLA MOLTENI AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI EDIZIONI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA SALUTE Trento 2004 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 © copyright Giunta della Provincia Autonoma di Trento, 2004 Collana Documenti per la Salute - 19 Assessorato alle Politiche per la Salute Servizio Innovazione e formazione per la salute Via Gilli, 4 – 38100 Trento tel. 0461 494037, fax 0461 494073 e-mail: [email protected] www.trentinosalute.net Nuova governance in una rete di comunicazione Atti 8a Conferenza Nazionale degli Ospedali per la Salute Riva del Garda, 24-25 settembre 2004 A cura di: Paolo De Pieri, Lorella Molterni Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento Coordinamento editoriale: Vittorio Curzel Conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute, 8., Riva del Garda, 2004 Nuova governance in una rete di comunicazione : atti 8° conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute : Riva del Garda, 24-25 settembre 2004 / a cura di: Paolo De Pieri, Lorella Molteni. – Trento : Provincia autonoma di Trento. Assesso rato alle politiche per la salute, 2004. – 320 p. : 24 cm. - (Documenti per la salute ; 19) ISBN: 88-7702-092-X 1. Ospedali – Organizzazione – Congressi – Riva del Garda – 2004 2. Assistenza ospedaliera - – Congressi – Riva del Garda – 2004 I. Tit. II. De Pieri, Paolo III. Molteni, Lorella 362.1106 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Presentazione La sfida forse più importante dei processi di riforma sanitaria nazionale e provinciale che si sono susseguiti dal 1978 ad oggi, quella che delinea la for ma, l’organizzazione e l’operatività del Servizio sanitario nazionale e provin ciale, ha riguardato e riguarda la “territorializzazione dei servizi”. Considerare e affermare nei servizi territoriali il punto cardine del sistema sanitario, significa da una parte costruire una rete che consente alle varie articolazioni organizzative di operare sinergicamente in un sistema unitario, dall’altra instaurare un nuovo e qualificante rapporto con i cittadini, per quan to concerne la loro principale dimensione vitale, quella della salute. È sempre più diffusa la certezza che la comunicazione sia un settore strate gico della Pubblica Amministrazione. Non soltanto per l’accresciuta consape volezza dei cittadini che sempre più richiedono di essere adeguatamente in formati e per l’emanazione di specifiche norme che cosiderano l’informazio ne come un diritto degli utenti e un dovere per gli Enti pubblici, ma anche per il ruolo rilevante che la comunicazione può avere rispetto all’esigenza di razionalizzare l’azione pubblica, ridurne le inefficienze e migliorare i servizi. Ancor più evidente ci pare il fatto che la comunicazione sia un settore stra tegico nel campo delle politiche per la salute e della gestione dei servizi sanitari. Nell’ambito di un approccio globale ai problemi della salute, comprenden te non solo il momento terapeutico e riabilitativo, ma anche la promozione, l’educazione sanitaria e la prevenzione delle malattie, un’efficace comunica zione migliora il rapporto fra i produttori e gli utenti del servizio, elevando il grado di consapevolezza, di partecipazione e di soddisfazione dei fruitori, contribuisce all’attività di prevenzione delle malattie, influenzando positiva mente gli stili di vita della popolazione, coopera a garantire l’equità di accesso e a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei trattamenti attraverso una chiara, corretta e completa informazione circa i servizi offerti e la loro dislocazione sul territorio. Inoltre il buon funzionamento dei processi comunicativi inerni costituisce la condizione di base per lo sviluppo del Servizio Sanitario e per la razionaliz zazione degli interventi, assicurando l’ottimale interazione fra le varie struttu re, la condivisione di obiettivi e strategie e la complementarietà fra le azioni intraprese, nella prospettiva di un approccio integrato e interdisciplinare ai singoli problemi e di un utile interscambio di competenze ed esperienze pro fessionali. La particolare attenzione tradizionalmente rivolta dai cittadini e dagli orga ni di informazione ai temi della salute e dell’assistenza sanitaria ci dice che il buon funzionamento di un servizio sanitario è spesso considerato il punto cruciale di un sistema territoriale. Attraverso la capacità di rispondere con ef ficacia ed efficienza alla domanda di salute della popolazione si misura capa Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 cità di una Amministrazione pubblica di promuovere un modello avanzato di società civile. Anche per questa ragione dobbiamo tenere costantemente al miglioramen to e rivolgere un’attenzione continua ai problemi dell’evoluzione del Servizio Sanitario, includendovi la comunicazione come strumento di governance. L’Assessorato provinciale alle Politiche per la Salute considera dunque di grande interesse ed utilità l’ottava Conferenza nazionale della Rete Italiana degli Ospedali per la promozione della Salute (HPH) e volentieri contribuisce alla sua realizzazione, accogliendo la richiesta dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di editarne gli atti, in una delle proprie collane. Con l’augurio di un buon lavoro ai molti partecipanti che converranno a Riva del Garda e con la consapevolezza che le conoscenze e le riflessioni, le buone pratiche e i modelli interpretativi e organizzativi, le esperienze e i valo ri che nell’incontro saranno comunicati e discussi, potranno contribuire a mi gliorare gli ospedali italiani e integrarli sempre più in una rete di operatori e strutture, capace di produrre buona assistenza e buona salute. Remo Andreolli Assessore provinciale alle Politiche per la Salute Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Indice 13 Carlo Favaretti: Presentazione della Conferenza Parte I: Sessioni Plenarie Cap 1 Nuova governance in una rete di comunicazione 19 20 24 25 1.1. GARY COOK, Foundation Trusts and clinical governance: an opportunity for supporting health promotion within hospitals 1.2. FRANCESCA ODELLA, Reti sociali: una metafora per la società complessa 1.3. NICOLA ZANARDI, Reti fisiche e luoghi virtuali. La comunica zione trasparente 1.4. OLIVER GRÖNE, New Governance in European Hospitals Cap. 2 Le esperienze delle Reti regionali HPH in Italia 27 29 32 35 36 38 39 41 43 45 2.1. SIMONE TASSO, Rete veneta HPH: principali attività 2003-2004 2.2. PIERO ZAINA, Attività della Rete HPH piemontese 2.3. CARLO ALBERTO TERSALVI, L’esperienza della Rete lombarda HPH 2.4. MARIELLA MARTINI, KYRIAKOULA PETROPULACOS, Il contributo della Rete “Health Promoting Hospitals” alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna 2.5. FABRIZIO SIMONELLI, PAOLO MORELLO MARCHESE, MARIA JOSÉ CALDES PINILLA, KATALIN MAJER, Lo sviluppo della Rete HPH Toscana 2.6. ROBERTO PREDONZANI, RITA GAGNO, L’esperienza della Rete HPH ligure 2.7. ENRICO NAVA, PAOLO DE PIERI, LORELLA MOLTENI, ROBERTO PANELATTI, Il contesto della promozione della salute e la rete trentina HPH 2.8. GIORGIO GALLI, La Rete HPH valdostana: dal progetto di salute al modello comunicativo 2.9. CRISTINA AGUZZOLI, MARIA TERESA PADOVAN, ADRIANA MONZANI, DANILO SPAZZAPAN, CLAUDIO RIEPPI, DANIELE PITTIONI, GIANNI CAVALLINI, La Rete HPH in Friuli Venezia Giulia 2.10. SARA DIAMARE, La Rete HPH della Campania: difficoltà e pro spettive Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Cap. 3 Gli ospedali per la promozione della salute nel contesto multiculturale 47 48 51 3.1. ANTONIO CHIARENZA, Gli ospedali per la promozione della sa lute nel contesto multiculturale: il progetto europeo Migrant friendly hospitals ed altre iniziative della Rete HPH 3.2. ROSARIA AVISANI, Ospedale interculturale: dall’esperienza alle Raccomandazioni 3.3. MARIA CATERINA DE MARCO, MAURIZIA BORDIN, Ospedale e terri torio interculturale. L’esperienza del gruppo veneto Parte II: Sessioni parallele Cap. 4 Gli standard e le strategie del movimento HPH 57 59 4.1. IRENA MISEVICIENE, Quality improvement of hospital care through self-assessment of standards and indicators for health promotion 4.2. JÜRGEN M. PELIKAN, Strategies for Health Promoting Hospitals and their implementation Cap. 5 Informazione, ascolto, comunicazione 61 63 65 66 68 70 5.1. FRANCESCA NOVACO, LAURA ALDROVANDI, VIOLA DAMEN, Rischio cli nico: il vissuto di professionisti e cittadini 5.2. LORENA FRANCHINI et al., Sperimentazione gestionale verso un nuovo modello di governance: l’esperienza del nuovo ospe dale di Sassuolo 5.3. ANNA ZAPPULLA, FABRIZIO SIMONELLI, CARLO BARBURINI, DOMENICA ARONNE, Il vissuto del ricovero ospedaliero nella rielaborazio ne del bambino 5.4. PAOLA GORETTI, MARCO BOSIO, ENRICO CRISTOFORI, ALBERTO ZOLI, PIETRO CALTAGIRONE, Carta dei servizi sanitari e sistema quali tà secondo la Vision 2000 5.5. ROSANNA CERRI, FRANCO RIPA, LIA DI MARCO, Le segnalazioni del cittadino: un modo di comunicare con l’azienda per un ospe dale centrato sulla persona 5.6. MARCELLA FILIERI, SERGIO ARDIS, ANTONELLA VINCENTI, GIUSEPPE REMEDI, La progettazione partecipata come metodologia di lavoro per l’umanizzazione degli ospedali in Toscana Cap. 6 L’Ospedale senza barriere culturali 73 6.1. PATRIZIA SIRONI, SIMONETTA BIANCHI, NABIHA ARIF, La comunica zione transculturale Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 74 76 78 80 83 6.2. GIOVANNA VITTORIA DALLARI, STEFANIA RICCI, Come l’ospedale interculturale promuove la salute dei cittadini stranieri im migrati a Bologna 6.3. VALERIA MANICARDI, EZIO BOSI, ZANICHELLI PIETRO, BODECCHI SIMONA, “Diabete per capirsi” 6.4. ALESSANDRA PEDONE, RINA TORRIOLI, LUCIO COLONNA, MONICA CA LAMAI, Il progetto HPH “Intercultura” e l’integrazione nel territorio: l’esperienza di Arezzo 6.5. VALENTINO LEMBO, RAFFAELLA BIONDI, ROBERTA PRANDI, MARIA CRI STINA CERATI, STEFANIA ZORZAN, Donne e minori di altri mon di e di altre frontiere 6.6. SIMONETTA FERRETTI, La Mediazione culturale al Policlinico di Modena Cap. 7 L’ospedale senza dolore 87 88 89 91 94 96 7.1. DONATELLA GIANNUNZIO, LEONARDO GALLI, ORNELLA BARDELLI, MARISA BONVINI, SIMONETTA BIANCHI, Diffusione progetto ospe dale senza dolore dall’azienda ospedale al territorio 7.2. SIMONA CAPRILLI, MARIANNA SCOLLO ABETI, CATERINA TEODORI, “Uso delle tecniche non farmacologiche in oncoematologia pediatrica: l’esperienza del Servizio Terapia del Dolore del l’ospedale Meyer 7.3. FERDINANDO CADREGARI, ROBERTO BELLINI, GIANPIERO PATRUCCO, FRANCESCO RICAGNI, Progetto ospedale senza dolore – ASL 21. Valutazione dei primi risultati 7.4. ANDREA VENEZIANI, ANTONIO MOLISSO, LUISA GAROFOLINI, BRUNELLA LIBRANDI, La formazione degli operatori nel progetto ospe dale senza dolore 7.5. MARIA GRAZIA ALLEGRETTI, MICHELINA MONTEROSSO, GIOVANNI MARIA GUARRERA, PAOLO ROMITI, DINO PEDROTTI, BENEDETTO PARODI, BIANCA BORTOLAMEOTTI, FRANCA DALLAPÈ, CRISTINA PONTALTI, ELISABETTA FONZI, ENRICO BALDANTONI, Indagine co noscitiva sull’utilizzo di farmaci analgesici nelle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della provincia autonoma di Trento 7.6. SIMONE TASSO, MARCO VISENTIN, RENATA FERRARI, LEONARDO TRENTIN, Il progetto “Ospedale e territorio contro il dolo re” della rete veneta HPH Cap. 8 L’ospedale senza fumo 101 102 8.1. SIMONE TASSO, Il progetto anti-tabagismo nelle reti HPH italiane attraverso l’utilizzo del questionario ENSH 8.2. MARINA BONFANTI, LUIGI MACCHI, VITTORIO CARCERI, Grado di aderenza agli standard europei per il controllo del fumo delle Aziende Sanitarie della Lombardia Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 105 107 8.3. GIORGIO GALLI, Verso un ospedale libero dal fumo 8.4. SARA DIAMARE, RENATO MONTELLA, ALFREDO SAVARESE, ANGELO MONTEMARANO, “ASL NA1 Libera dal fumo”: un progetto di rete “Ospedali per la promozione della salute” HPH Cap. 9 L’empowerment dei pazienti, del personale e della comunità 111 113 116 118 120 122 124 125 9.1. ROSARIA AVISANI, ALFONSO CASTELLANI, SABINA GALLERI, NADIA GUERCÈ, M. DORIS MARCHETTI, LUCIO MASTROMATTEO, ANNARITA MONTEVERDI, SERGIO PAGHERA, PAOLO PEZZOTTI, ADALGISE PRICOCO, BENEDETTA VENTURELLI, Effe Elle Esse: come conciliare tempo famiglia lavoro salute 9.2. VANDA LAURO, MAURO CONTER, VITTORINO CALESTANI, SIMONETTA BIANCHI, Dietoterapia in gravidanza: la consulenza nelle gestanti sovrappeso/obese 9.3. TERESITA GROTTOLO, LORETTA BORTOLAMEOTTI, SANDRO CARPINETA, Il Centro di Alcologia: promozione della salute dall’ospeda le al territorio 9.4. FABRIZIO ARTIOLI, KATIA CAGASSI, MARIA GRAZIA RUSSOMANNO, STE FANO CONCETTI, ANNE MARIE PIETRANTONIO, ANGELA RIGHI, Un mo dello assistenziale a supporto dei bisogni globali del paziente oncologico 9.5. LIVIANA TAVANTI, GIANNA ALDINUCCI, IDA DI PAOLA, GIULIANO GIOR NI, DONATELLA NARDI, PAOLO GHEZZI, GIOVANNI CINTI, LUCIO CO LONNA, MONICA CALAMAI, Strategie globali e pratiche riflessive: la promozione della salute degli operatori nella manipola zione dei farmaci antiblastici 9.6. SAURO FRANCESCHINI, SERGIO ARDIS, MORENO MARCUCCI, GRAZIELLA DI QUIRICO, LUCIA PULITI, MAURO GIRALDI, Umanizziamo la mor te encefalica 9.7. LUISA SPIANI, ADRIANA DALPONTE, ROBERTA PIFFER, La presa in cura del paziente fragile nel Dipartimento di Medicina interna dell’Ospedale di Trento 9.8. CARLA STEFANIA RICCARDI, Salute, sport e stili di vita: “Chi si ferma è perduto! 2” Cap. 10 La continuità assistenziale 127 129 130 131 10.1. CLEMENTE PONZETTI, MASSIMO LEPORATI, ANGELO PENNA, CHIARA GALOTTO, Integrazione Ospedale e Territorio: il progetto della Rete HPH Piemonte - Valle D’Aosta 10.2. MARIA JOSÉ CALDÉS PINILLA, FABRIZIO SIMONELLI, Il progetto HPH della ASL n. 3 di Pistoia come strategia per lo sviluppo della promozione della salute nell’ottica della complessità 10.3. ANNA GRAZIA GIULIANELLI, Un Dipartimento per l’integrazione sociosanitaria 10.4. DANILO ORLANDINI, FRANCO PRANDI, ROSANNA CARBOGNANI, CRISTI NA PEDRONI, ANTONIO CARBOGNANI, GIAMPAOLO GAMBARATI, ELENA CASADEI TURRONI, PIERANTONIO MAGNANI, DANIELE GOVI, La pro Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 133 135 gettazione multiprofessionale dei percorsi del paziente per la garanzia di continuità assistenziale 10.5. ANNAMARIA GIAMPIETRI, Dimissioni protette nell’unità opera tiva malattie infettive 10.6. MARCELLA FILIERI, SERGIO CORTOPASSI, ROBERTO CAPIFERRI, GIU SEPPE MARTINI, MAIDA PERCO, RENZO PIZ, L’umanizzazione del percorso assistenziale diabetico: il metodo delle “catego rie assistenziali” e il rapporto con gli standard internazio nali HPH Cap. 11 La promozione della salute per i bambini e gli adolescen ti in ospedale 139 141 143 144 148 150 152 155 11.1. FABRIZIO SIMONELLI, MARIA JOSÉ CALDÉS PINILLA, KATALIN MAJER, PAOLO MORELLO MARCHESE, Il progetto OMS “Promozione del la salute per bambini ed adolescenti in ospedale” 11.2. SEBASTIANO GUARNACCIA, DANIELA MANFREDI, EMANUELE D’AGATA, BENEDETTA VENTURELLI, ROSARIA AVISANI, ENRICO COMBERTI, GIO VANNA FERRETTI, LUIGI DANIELE NOTARANGELO, RAFFAELE SPIAZZI, Il Laboratorio Clinico Pedagogico per ottimizzare l’assi stenza pediatrica 11.3. FULVIA NEGRO, GEMMA ISAIA, ANNA PELOSO, ALGA BEVILACQUA, IDA BERTOTTI, ROSALINDA GEMELLO, CARLA BAIETTO, FRANCESCO ASTORINO, LUCIA CIRAMI, LAURA DE MICHELIS, CRISTINA ODDONE, SILVIA MURDOCCA, Un’esperienza di lavoro multidisciplinare sull’abuso e maltrattamento all’infanzia in un ospedale pediatrico 11.4. EDVIGE GOMBACH, GIULIO ANDREA ZANAZZO, STEFANO RUSSIAN, Assistenza domiciliare integrata nel bambino oncologico 11.5. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NEUROPSICHIATRIA INFANZIA ADOLESCENZA, U. O. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE OSPEDALE “G. SALESI”, “Ri-sco prirsi naturalmente”. Laboratorio multisensoriale per disabili neuropsichici 11.6. RAFFAELE PIUMELLI, NICCOLÒ NASSI, LUCA LANDINI, ROSA GINI, ADA MACCHIARINI, PAOLO MARCHESE MORELLO, La campagna regio nale di riduzione del rischio di morte improvvisa del lat tante (SIDS) in Toscana: rilevazione epidemiologica dei fattori di rischio. 11.7. GUARESE OLGA, MADDONNI M. LUISA, STAFFIERI SIMONA, GROTTOLO DONATELLA, L’allattamento al seno: ruolo degli operatori sanitari 11.8. VINSANI NICOLETTA, MARIA CLAUDIA MENOZZI, AVE LUPI, PAOLA CRISTOFORI, FAGANDINI PIERGIUSEPPINA, La “narrazione” dei sen timenti degli operatori come strumento professionale nel lavoro sanitario in neonatologia e pediatria Parte III: Sommario dei Poster Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 12 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Presentazione della conferenza Le Conferenze Nazionali della Rete Italiana degli Ospedali per la Promozio ne della Salute (HPH) sono ormai diventate un importante appuntamento fis so. A partire dal 1997, le Reti regionali HPH si sono impegnate a sviluppare questi momenti di incontro per sensibilizzare gli operatori sanitari, le istituzio ni e i soggetti sociali di riferimento sul tema della promozione della salute in ospedale, per mettere a confronto progetti ed esperienze concrete, per accre scere il livello scientifico e metodologico delle iniziative sviluppate e per for nire un contributo al movimento internazionale impegnato nella promozione della salute. Nel 2004 l’onere e l’onore di organizzare la Conferenza è toccato alla Rete Trentina degli Ospedali per la Promozione della Salute ed è quindi con gran de piacere che presento questa 8° Conferenza Nazionale HPH che si svolge a Riva del Garda il 24 e 25 settembre sul tema “Nuova governance in una rete di comunicazione”. Il primo obiettivo della Conferenza è sintetizzato nel titolo: approfondire la riflessione sui nuovi strumenti oggi necessari a governare i flussi organizzati vi, relazionali e comunicativi che esistono tra i diversi soggetti coinvolti nella costruzione del sistema-salute e che creano una rete di interconnessioni mol to articolata. Pazienti, operatori, comunità servite, associazioni di volontariato, istituzioni, mass media sono portatori ciascuno di una propria “cultura” della salute: i comportamenti, le conoscenze, le credenze, i linguaggi, le norme e i valori, i modelli interpretativi e organizzativi, le definizioni e i sistemi di clas sificazione, le ipotesi di soluzione sono diversi tra tutti questi soggetti e ciò definisce prospettive e punti di vista differenti, a volte difficilmente sovrapponibili e conciliabili tra di loro. La necessità (e anche l’urgenza) di favorire una convergenza è ormai sotto gli occhi di tutti. Sia le conoscenze maturate in ambito teorico (per esempio, i sistemi complessi, la governance, le reti), sia quelle derivate dalla trincea del quotidiano (per esempio, la gestione ordinaria dei pazienti cronici, il passag gio delle informazioni tra i diversi ambiti assistenziali, la disponibilità delle risorse) sono ormai concordi nell’indicare che il miglioramento dell’assisten za e della salute può derivare solo da un approccio globale che “costringa” i diversi soggetti a mettersi in relazione. Ciò non significa che bisogna solo mediare i diversi interessi e le diverse culture, ma che ciascuno deve diventa re anche più competente, autonomo e responsabile nel suo ruolo di “co-pro duttore” dell’assistenza e della salute. 13 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Tale scenario è coerente con quanto discusso a Mosca nei mesi scorsi in occasione della 12° Conferenza Internazionale degli Ospedali per la Promo zione della Salute, nel corso della quale si è discusso di come il Progetto HPH può contribuire allo sviluppo complessivo dei sistemi sanitari. Il problema quindi non è solo quello prefigurato agli inizi del movimento, e cioè di mi gliorare l’ospedale e trasformarlo in un “setting” che promuove la salute, ma sta via via diventando quello di integrare sempre più l’ospedale nella catena (chain / network / healthy alliances) che produce il valore di una buona assi stenza e di una buona salute, cioè il guadagno di salute prodotto da un setting di cui l’ospedale è solo una parte. Il secondo obiettivo dell’8° Conferenza è di favorire occasioni di incontro tra quanti in Italia si stanno adoperando per facilitare questa transizione cultu rale e gestionale. Nel 2004 la famiglia italiana delle Reti regionali HPH formal mente riconosciute dall’OMS è ulteriormente cresciuta: la Rete della Campania si è aggiunta a quelle di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Ligu ria, Toscana, Trentino, Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Al di là delle occasioni di incontro personale tra i professionisti, un intero pomeriggio della Conferenza è dedicato alla presentazione della attività con cretamente svolte dalle Reti e dagli ospedali aderenti (una sessione plenaria, 8 sessioni parallele di comunicazioni tematiche e la presentazione di quasi cen to poster). I contributi pervenuti al vaglio del Comitato scientifico per la pre sentazione di comunicazioni e poster sono stati numerosi e sempre più orien tati a documentare risultati ottenuti piuttosto che descrivere attività svolte o presentare iniziative ancora da realizzare. Il confronto avverrà sui temi della gestione del dolore, degli stili di vita, dell’empowerment di pazienti e operatori, della multiculturalità, della conti nuità assistenziale. È interessante notare come anche dagli abstract presentati si possano cogliere chiari tentativi di sviluppo di approcci globali che metto no in relazione l’ospedale con il resto della comunità ed è una tendenza senza dubbio molto positiva che mostra come sia possibile dare forma concreta alla rete di relazioni intrecciate dai diversi stakeholder. Nel confronto però dovremo essere molto realisti e affrontare con serenità due domande impegnative: a) le singole iniziative realizzate, quand’anche ben sviluppate, sono frutto di una trasformazione complessiva dell’ospedale oppure sono il risultato occasionale dell’impegno di pochi? b) l’interesse del l’ospedale per l’esterno è la naturale espansione di quanto viene fatto all’in terno oppure maschera di fatto una incapacità di incidere sulla sua organizza zione? 14 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Le premesse per un buon lavoro ci sono tutte: la voglia di fare da parte di moltissimi operatori, il ricco contenuto scientifico da approfondire, l’ospitali tà di una zona del Trentino che, all’inizio dell’autunno, è in grado di offrire occasioni di serenità dopo la formazione in aula. Mi auguro che questa 8° Conferenza, al pari delle altre che l’hanno preceduta, lasci un piccolo segno nella storia del movimento HPH italiano. Carlo Favaretti Coordinatore della Rete italiana HPH e della Rete trentina HPH 15 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Parte I Sessioni Plenarie Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 18 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 Nuova governance in una rete di comunicazione 1.1. Foundation Trusts and clinical governance: an opportunity for supporting health promotion within hospitals GARY COOK - Consultant in Public Health, Stockport NHS Foundation Trust Stockport NHS Foundation Trust or Stepping Hill Hospital (SHH) is a large 830 bedded District General Hospital providing a typical range of acute care for children and adults. It lies in the southern part of the Greater Manchester conurbation in North West England and serves a catchment population of almost 300,000. Its SMR is close to the National average but it has an ageing population. It is one of the first wave Foundation hospitals and can decide locally on how to meet its obligations, as opposed to being directed by Whitehall, and its policies and output are accountable to the community [1]. Wanless (2004) describes an optimal scenario that would result in improvements in population health, in turn reducing the future demand for health care services: “full engagement”[2]. The fully engaged scenario is predicted to produce life expectancy increases beyond current forecasts, a dramatic improvement in health status and public confidence in the health system, and a demand for high quality care. The scenario shows that the responsibility to improve the population’s health is not just the onus of the NHS, it can only be achieved through the combined efforts of a range of services. How is the fully engaged scenario to be achieved? One of the NHS’ responsibilities is to enable patients to make this informed choice by providing accurate and accessible health promotion advice and interventions at all levels of healthcare including secondary care. The World Health Organisation (WHO) in their “Health Promoting Hospitals” project aims to move secondary care away from a predominantly “sickness service” to a service which focuses on the factors causing disease (i.e. a “health driven” service) [3]. This and national policy emphasise the importance of secondary care implementing programmes which will promote health within NHS staff and patients. The issue addressed in this paper is how can SHH, best contribute to the national public health agenda in light of its newly gained status as a Foundation Trust? Steps have already been implemented at SHH to promote health in staff and patients through the 19 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 “Healthy Hospitals Project”. This project involves a series of initiatives to improve the hospital environment, address the health education needs of patients and their families, promote staff health at work, and develop links with other agencies and groups in joint health planning and disease prevention. However, in order to justify the resources required to continue this project it is paramount that the effectiveness of the initiatives is investigated (in terms of the relationship between financial cost and the benefits in increases in health and ensuing reductions in health care costs). A series of research is proposed as a first step towards examining the provision of health promotion at SHH and a step towards exploring how SHH might implement the WHO standards utilising its Foundation status. I wish to acknowledge the support and contribution to this work from Dr Charlotte Haynes PhD CVD Register Co-ordinator Stockport NHS Foundation Trust. References 1. DEPARTMENT OF HEALTH, The health and personal social services programmes, “Departmental report (Summary report)”, 2004, http://www.dh.gov.uk/assetRoot/ 04/08/40/09/04084009.pdf. 2. PRICE, M., Healthy Hospitals Project Action Plan 2004/5 (Available on request from Stockport NHS Trust). 3. WANLESS, D., Securing Good Health for the Whole Population. Final Report, 2004. 4. WHO E UROPE , Standards for Health Promotion in Hospitals, 2004, http:// www.euro.who.int/document/e82490.pdf. 1.2. Reti sociali: una metafora per la società complessa FRANCESCA ODELLA - Docente presso la facoltà di Sociologia dell’Università di Trento e presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste Il concetto di rete, e nello specifico di rete sociale, si afferma nel corso degli anni ’90 come metafora di forme di relazione, stati e condizioni tipici della so cietà nostra contemporanea [Mutti, 1996]. Se nel passato la società è stata conce pita attraverso la metafora dell’organismo, del sistema e del meccanismo, l’im magine della rete come rappresentazione della realtà sociale è diventata domi nante quando si parla di fenomeni sociali legati ai processi di creazione e diffu sione della conoscenza così come di produzione e circolazione di risorse eco nomiche e sociali. Perché di questo successo e da dove l’utilità del concetto? In primo luogo perché l’idea della rete è semplice, immediata dal punto di vista cognitivo, ma al tempo stesso consente di raffigurare aspetti complessi 20 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 ed interdipendenze fra elementi che possono – ma non necessariamente de vono – condividere specifiche caratteristiche. Come simbolo la rete si presta a dare rappresentazione dell’intreccio fra dimensioni formali ed informali nella vita sociale (la “rete” di conoscenze), della dimensione “locale” ed al tempo stesso globalizzata del potere decentrato (la rete no-global, ma anche la “tra ma occulta” delle lobbies), per diventare, infine, strumento di intervento ed azione nel sociale attraverso le relazioni sociali (la “rete”degli operatori, fare “rete” intorno alle figure del disagio). La dimensione di significato a cui fanno riferimento questi utilizzi del con cetto di rete sono però ancora prive di una vera riflessione su cosa implichi per un soggetto, un individuo piuttosto che un’organizzazione essere “nodo” o “maglia” di una rete. La seconda motivazione alla scelta del concetto di rete, ed una risposta alla nostra domanda, la possiamo cogliere invece prestando attenzione alle riflessioni che il sociologo G. Simmel ancora ai primi del Nove cento, fece sulla progressiva modificazione delle relazioni sociali nella società moderna. Simmel identificò una rilevante componente della condizione moderna nella compresenza di complessità e particolarismo, per cui un individuo partecipa a reti (o cerchiè, nella terminologia originale) di relazioni sociali che lo vedo no “connesso” come soggetto unico, dotato di caratteristiche di specificità, e al tempo stesso come soggetto indifferenziato perché parte di una collettività strutturata (dall’appartenenza professionale, associativa ma anche dall’origi ne sociale e geografica). Questa partecipazione, tuttavia, va vista come un processo, in continua evoluzione. Egli afferma, in particolare, che “dapprima il singolo si vede in un ambiente che, relativamente indifferente verso la sua individualità, lo incatena al proprio destino e gli impone una stretta coesistenza con coloro accanto ai quali lo ha posto il caso della nascita; questo dapprima significa tuttavia solo lo stato iniziale di uno sviluppo sia filogenetico sia ontogenetico”. Il percorso di ogni individuo, dunque, parte dalle cerchie familiari e locali, non liberamente scelte per portare a quelle associative ed alle relazioni con altre personalità con cui sente o ha oggettivamente un vincolo di comunanza, di interesse, di finalità nell’agire (terminus a quo). È importante sottolineare che per Simmel sono le associazioni ad essere considerate il luogo principale in cui si dispiega il processo di sviluppo dell’individuo, ma non è difficile pensare ad altri contesti sociali in cui l’individuo ha l’opportunità di condivi dere interessi, perseguire finalità comuni e attraverso queste sviluppare rela zioni sociali. L’immagine della rete consente appunto di rappresentare questa posizione dell’individuo, situato all’intreccio fra appartenenze multiple a scelta e impo ste dalla struttura sociale, dalla cultura, dalla logica del gruppo. In particolare, 21 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 porta la nostra attenzione sulle dinamiche della dipendenza e dell’inter dipendenza e quindi sulle possibilità che l’individuo e le organizzazioni han no di modificare la loro “rete”, di introdurre innovazioni e di iniziare a tessere nuove reti. Grazie a questa potenzialità euristica il concetto di rete e le specifiche metodologie di indagine e di analisi hanno progressivamente conquistato ter reno nell’ambito delle scienze sociali, dalla sociologia, alla psicologia fino all’economia e questo interesse è andato di pari passo con lo sviluppo di teo rie e modelli interpretativi di molti fenomeni sociali che si basano sull’idea di rete. In campo sociologico, per fare un esempio di rilievo, J. Coleman ha ela borato una teoria sulla diffusione di informazioni in campo medico fra due diversi gruppi di medici: i medici ospedalieri e quelli che esercitano in ambito ambulatoriale [Coleman, Katz e Menzel, 1957]. La sua analisi mo stra come lo scambio di informazioni sull’introduzione di nuovi farmaci (indicazioni terapeutiche, trattamento) sia collegato alla struttura delle re lazioni sociali che si intrattengono fra colleghi, ed in particolare alla rete dei contatti che ciascun medico mantiene con assiduità ed all’affidabilità che viene attribuita alla valutazione dei colleghi membri del gruppo di appartenenza. Un’altra indagine citata fra i “classici” nel campo dell’analisi delle reti sociali è quella svolta da M. Granovetter su un campione di professionisti nell’area urbana di Los Angeles (1974). In questa indagine le reti sociali si rivelano uno dei possibili strumenti attraverso cui le persone ricercano lavoro; in alcuni casi questa modalità, osserva Granovetter, risulta essere la migliore in quanto consente alle persone di cambiare ambiente e di trovare la posizione lavorativa conforme alle aspettative, oppure di accelerare i tempi di ricerca del lavo ro. Questa osservazione può sembrare scontata per chi appartiene ad un con testo culturale come quello italiano in cui le relazioni sociali ed i contatti so ciali “contano”, ma non lo è per il contesto anglosassone in cui la ricerca di lavoro segue molto più spesso i canali formali (annunci, agenzie di colloca mento private). Il lavoro di Granovetter, nello specifico, ebbe rilievo perché per primo por tò in evidenza che non erano i legami “forti” ovvero l’appartenenza a cerchie sociali primarie nella terminologia di Simmel (relazioni parentali), che aiuta vano di più a trovare lavoro bensì i legami cosiddetti deboli, quelli che sono appunto liberamente scelti dagli individui sulla base di affinità culturali, frequentazioni associative e reti amicali. I due esempi ci indicano che le forme di interazione che si possono instau rare in una rete, in questo senso, sono il prodotto della combinazione dell’ap porto che ogni individuo o organizzazione dà alla relazione sociale ed è attra verso la modifica di queste che cambia la struttura della rete, secondo un 22 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 principio di interdipendenza. Identificare, interpretare e adottare le informa zioni provenienti dai membri di una rete significa, quindi, non solo socializzare le informazioni, bensì combinare le informazioni che sono state socializzate a volte con esito innovativo, a volte semplicemente replicando la struttura pre sente. Va inoltre tenuto presente che ogni individuo che aderisce ad una rete è libero e nello stesso tempo obbligato, in quanto l’adesione ad una rete è basa ta sull’impegno, sul riconoscimento di una specifica appartenenza – come già ha fatto notare Simmel - ed identità sociale. Vista in termini complessivi, la logica delle reti è quindi modulare, additiva e contiene in sé le possibilità di cambiamento e di variazione; per l’individuo come per le organizzazioni che lo contengono e lo connettono ad altre reti. La metafora della rete consente in questo senso di visualizzare quei proces si di innovazione epistemologica che possono scaturire solo da processi di relazione sociale consapevoli, in quanto ogni soggetto che aderisce ad una rete, sia esso singolo individuo o organizzazione, acconsente – con diversi livelli di libertà - a condividere uno spazio di progettualità, e di mantenimento di relazioni sociali. Da una rete di contatti può nascere un’organizzazione (un’al tra rete) e le organizzazioni fra di loro possono scegliere di mettersi in rete per condividere esperienze, risolvere problemi, trovare soluzioni e scambiare ri sorse. Perché ciò sia effettivo, tuttavia, è rilevante la presenza di pratiche demo cratiche, interculturali, aperte all’apporto di diverse forme di comunicazione ed alla formulazione di conoscenze nuove. Se il vincolo di esistenza della rete è fondato, infatti, sul riconoscimento di identità è anche vero che perché l’in novazione sociale sia effettiva dovrebbe essere contemplata la possibilità di appartenenze e di identità multiple, in cui l’individuo realizzi il proprio pro getto di evoluzione personale e sociale. Riferimenti bibliografici 1. CHIESI, A., Attori e relazioni fra attori mediante l’analisi di reticoli multi pli, “Rassegna Italiana di Sociologia”, n. 1, 1996. 2. COLEMAN, J., KATZ, E. e METZEL, H., The diffusion of information among Physicians, “Sociometry”, n. 20, 1957. 3. GRANOVETTER, M., The Strenght of Weak Ties, “American Journal of Sociology”, n. 83, 1973. 4. MUTTI, A., Reti sociali: tra metafore e programmi teorici, “Rassegna Italiana di Sociologia”, n. 1, 1996. 5. SIMMEL, G., L’intersecazione di cerchie sociali, in ALFERJ, P., RUTIGLIANO, E., a cura di, Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici, Bollati Boringhieri 2003. 23 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 1.3. Reti fisiche e luoghi virtuali. La comunicazione trasparente NICOLA ZANARDI - Partner, Presidente e Direttore Creativo di XYZ Reply “Apparire attraverso”. Il latino medievale sanciva il senso della parola tra sparente. Ciò che non è esplicito, che lascia facilmente intendere la sua natu ra, il suo significato. Oppure che appare come è. In questi anni, nei quali la comunicazione ha assunto via via un ruolo sem pre più importante nelle funzioni di qualsiasi azienda, pubblica o privata che fosse, il concetto di qualità ha attraversato più volte il suo significato. Una qualità che, di volta in volta, doveva stupire, assecondare, convincere. Qual che volta, solo qualche volta informare. La comunicazione da sempre è in simbiosi con il marketing, parliamo di informatori scientifici solo in ambito medico. Ma anche qui cambiano i mezzi, cambiano i parametri, cambiano gli obiettivi. Il marketing non è più (solo) marketing di prodotto, è quasi sempre servizio a valore aggiunto. La comunicazione non è più above o below the line ma anche è soprattutto canali e profili digitali. Il target non è più un obiettivo generico e generalista ma si trasforma in tante comunità con cui confrontarsi. Comunità che fanno parte a loro volta di reti percepibili fisicamente o solo virtuali. Come impatta questo scenario sulla comunicazione? Che cosa succede quan do noi applichiamo delle regole in un contesto come quello della salute, in un Paese occidentale e maturo demograficamente? Che vuol dire una popolazio ne anziana con grandi prospettive di vita, un afflusso e un apporto alla società di popolazioni usi a regole, costumi, credi religiosi, ecc... diversi, una cronicizzazione delle malattie come tendenza legata alla demografia di tutti i Paesi occidentali. È un cambiamento epocale per le strutture ospedaliere, fino ad ora luoghi fisici identificati e identificabili, radicati sul territorio e in grado di offrire tutti i servizi a chi è in grado di raggiungerli. La logica territoriale dell’ospedale come casa della malattia, come proprietà assoluta e indiscutibile degli strumenti e della competenza per utilizzarli, la scia spazio a una struttura sempre radicata sul territorio, forse anche di più, che risponde, però, alle regole di un condominio per la salute. Tanti inquilini, tutti specialisti che interagiscono tra di loro in una logica di condivisione e di confronto, nodi di una rete che si apre al territorio, monitorando continua mente i flussi di dati di una cronicizzazione di casi che aumentano in maniera proporzionale all’aumentare dell’età media. L’episodio di cura come anello di una catena assistenziale ha nell’ospedale un hub, attorno al quale la rete territoriale assume una fisionomia che trova nella residenza abituale del paziente un pezzo della sua esistenza e forza. Su 24 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 questi layer si configura un rinnovato sistema di relazioni tra i vari nodi, tra le varie reti e soprattutto con il paziente che trova nell’ospedale condominio della salute, il palinsesto dei suoi atti e dei monitoraggi, ma vede nella sua residenzialità la normalità di una patologia con la quale deve convivere. Le reti fisiche ospedaliere vengono a innervare il territorio e i suoi punti di snodo, mentre l’assistenza domiciliare diventa l’incubatore di un ospedale vir tuale, dove la prestazione di qualità rimane e deve rimanere dentro le infra strutture fisiche. È indiscutibilmente prestazione di qualità anche la relazione che viene instaurata che deve vedere i due luoghi (o non luoghi), casa e ospe dale, come un unicum di un percorso dove il paziente non è solo spettatore passivo, ma anche e soprattutto attore protagonista e consapevole del mante nimento del suo stato di equilibrio di convivente sereno con una o più malat tie croniche. Discendono da questo scenario alcune domande. La cronicizzazione della malattia in che rapporto si configura con una tendenza alla cronicizzazione della professione? La promozione della salute coincide con la una maggiore consapevolezza del paziente? Nodi (ospedali), reti (terri torio) e contesto (relazione tra le parti), a loro volta fanno parte di altre reti? Se sì, come possiamo connetterle non soltanto virtualmente? La comunicazione trasparente (e puntuale) può essere uno strumento uti lissimo per costruire un nuovo sistema che agisca sempre di più su tutte le comunità che fanno parte del sistema e che in quanto comunità, per definizio ne, al loro interno tendono a confrontarsi in maniera continuativa. 1.4. New Governance in European Hospitals OLIVER GRÖNE - Technical Office Health Services, World Health Organization (WHO) European Office for Integrated Health Care Services, Barcelona, Spain The concept of Governance relates to the interaction between formal institutions and those in civil society and refers to a process whereby elements in society exercise power, authority and influence and enact policies and decisions concerning public life. It entails a complex relationship between professionalism and managerialism, the state and the market and individual autonomy and social solidarity. Governance is not a new concept in health care - it is a new perspective on the way health care should be governed and can best be understood through a historical perspective on health systems evolution. The Organization for Economic Development and Cooperation (OECD) has defined governance in terms of three main characteristics: a focus on equity, 25 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 1 the value of participation and an orientation toward a new ecology of cooperation. A focus on these characteristics is not only justified by movements in civil society (political-science perspective), but also by the limited effectiveness of health care (public health perspective): the health gap between income groups in society is widening, unused resources to involve patients and citizens in health care limit the appropriateness and clinical effectiveness of care and the current fragmentation of health care delivery results in quality deficiencies and economic inefficiencies. The presentation will briefly address the evolution of health systems and what the concept of governance means in this context, but put a major emphasis on its practical meaning from a public health perspective: Why do we need to think about Governance in health care? How can we achieve good Governance? And why is the concept taken up so slowly? It is the aim of the presentation to clarify these questions and address further challenges regarding the achievement of Good Governance in hospitals in Europe. 26 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 Le esperienze delle Reti HPH regionali in Italia 2.1. Rete veneta HPH: principali attività 2003-2004 SIMONE TASSO - Coordinatore Rete Veneta HPH, Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto L’attività regionale della Rete Veneta HPH nell’intervallo di tempo compre so tra la Conferenza Nazionale di Torino del novembre 2003 e quello attuale di Riva del Garda si è concentrata soprattutto sui Progetti “Ospedale e Territo rio contro il Dolore”, “Interculturale” ed “Anti-tabagismo”. Per quanto riguarda il Progetto sul dolore alla fine del 2003 si è conclusa la prima fase del Progetto rappresentata da uno studio policentrico (campione di 1.325 pazienti) sulla prevalenza del dolore nei ricoverati e sui corretti atteg giamenti e conoscenze del personale sanitario (campione di oltre 1.500 ope ratori sanitari) relativamente alla tematica dolore di cui si parla nello specifico abstract in altra parte di questo volume. Nel 2004 l’attività si è concentrata in particolare nella formazione del personale sulla corretta misurazione del do lore. Un primo tipo di formazione era già stato realizzato nel 2003 sul perso nale sanitario che ha svolto l’intervento di rilevazione dello studio policentrico. Tuttavia si era trattato di una formazione parziale che aveva come principale obiettivo quello di insegnare il corretto uso della scala Numerical Analogic Scale (NRS) agli operatori sanitari. Non c’è stata una specifica formazione sul la comunicazione con il paziente. I risultati del suddetto studio hanno messo in evidenza, tra l’altro, l’importanza di questo tipo di formazione sulla comu nicazione. Infatti è risultata una bassa concordanza tra dolore percepito dal paziente e dolore riconosciuto dall’operatore sanitario. In altri termini lo stu dio policentrico ha messo in evidenza uno dei punti più delicati sulla rilevazione del dolore: da una parte l’operatore sanitario non può registrare passivamente il livello numerico del dolore riferito dal paziente (il quale, peraltro, spesso chiede chiarimenti), dall’altra parte lo stesso operatore non può registrare un livello di dolore dalla sola osservazione del paziente, senza entrare in comu nicazione con lui. Di qui l’importanza di sviluppare una parte del Progetto specificatamente rivolta alla comunicazione. Per questo il Gruppo di Lavoro HPH interaziendale ha prodotto una videocassetta che contiene sia una parte teorica con lezioni “classiche” sulla misurazione del dolore sia una parte pra 27 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 tica con scene recitate da attori nel ruolo di pazienti, medici, infermieri su cui aprire una discussione. Per facilitare il lavoro del formatore la videocassetta è corredata da un manuale contenente i testi delle scene e schede didattiche da dare ai discenti nel corso della lezione. Videocassetta e manuale sono stati distribuiti ai formatori aziendali di cia scuna ULSS in un incontro appositamente organizzato. Il passaggio successi vo sarà la formazione di medici ed infermieri a livello locale che dovrebbe concludersi entro febbraio 2005. Attualmente il punto più delicato per la prosecuzione del Progetto appare la realizzazione di linee guida operative tra i diversi specialisti. Infatti ogni branca specialistica ha proprie linee guida cliniche che non sem pre coincidono. Tuttavia il paziente con dolore non raramente viene seguito da più specialisti. Ad esempio un paziente neoplastico che segue un protocol lo oncologico non raramente è sottoposto a intervento chirurgico e seguito da un anestesista nell’immediato post-operatorio e successivamente dal chirurgo generale per ritornare, infine, dall’oncologo. Di qui l’importanza delle linee guida operativa per una gestione coordinata e condivisa del paziente tra i diversi specialistici. Il Progetto “interculturale” veneto, dopo un inizio autonomo, ha avuto un ulteriore sviluppo grazie alla collaborazione con la Rete HPH Emiliano Romagnola che è stata importante punto di riferimento per gli incontri orga nizzati sull’argomento con le varie Reti Nazionali. Inoltre importante è stato il contributo di tale Rete per la realizzazione in Veneto di una giornata formativa sull’argomento alla quale hanno partecipato in qualità di relatori, alcuni responsabili scientifici ed operativi del Progetto Internazionale “Migrant Friendly Hospitals”. La giornata formativa interculturale è risultata un importante momento per fare conoscere l’attività della rete HPH su questa tematica e stringere alleanze con la Regione e con il territorio. È risultata la base di partenza per realizzare, in alcune realtà aziendali, workshops con i Comuni, con agenzie esterne (dei mediatori culturali) e con gli operatori ULSS dei diversi uffici. Al di là di questi aspetti positivi è anche doveroso segnalare la presenza di alcuni principali punti critici che possono essere così classificati: 1) aspetti normativi (difficoltà legate alla conoscenza della legislazione anche per lo stesso operatore sanita rio); 2) aspetti relazionali (per difficoltà/impossibilità di traduzione sia per scarsa/assenza conoscenza della cultura degli immigrati); 3) aspetti organiz zativi (difficoltà di realizzare procedure efficaci e possibilmente semplici, va lide sia per l’operatore che per i cittadini immigrati). Su questi punti critici si dovrà lavorare in futuro. Infine, si segnala l’importante contributo della Rete HPH Lombarda per la produzione di un poster multilingue sul triage del Pronto Soccorso. 28 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 Il Progetto antitabagismo ha visto il coordinamento della rilevazione nazio nale utilizzando il questionario (versione 2004) degli ENSH (European Network Smoke Free Hospitals). Sulla base del codice europeo degli ENSH si stanno definendo azioni per giungere all’ospedale libero dal fumo. In particolare con il fine di facilitare il raggiungimento dell’obiettivo finale (di un ospedale completamente libero dal fumo) si ritiene utile attivare una azione graduale, proponendo alle singo le Unità Operative di acquisire il titolo di “Unità Operativa libera dal Fumo” sulla base della rispondenza di determinati requisiti che tengono conto in particolare dell’empowerment del personale, dei pazienti tra cui: 1) sottoscri zione di documento di informazione ed adesione alla iniziativa da parte del personale; 2) affissione in U.O. del Codice Europeo da affiggere in U.O.; 3) accettazione di periodici da parte di una commissione esterna. Infine anche per il 2004-2005 è prevista la realizzazione del Concorso “Chi non fuma...VINCE!”. 2.2. Attività della Rete HPH piemontese PIERO ZAINA - Coordinatore Rete HPH piemontese Anche nel 2° quinquennio dell’attività della Rete HPH piemontese abbiamo ottenuto l’adesione di tutte le Aziende della Regione: 34 tra ASO, ASL, Presidi Ospedalieri convenzionati. Nella 7° Conferenza Nazionale HPH di Torino ab biamo presentato l’attività quinquennale di 4 Progetti regionali in rete, a cui abbiamo aggiunto 2 Progetti iniziati a livello aziendale, ma che hanno assunto ormai rilevanza di rete regionale. Nel gennaio 2004 abbiamo dato l’avvio ad un nuovo Progetto in rete regionale “l’Ospedale senza dolore” avendolo già scelto come progetto aziendale 8 Aziende (compresa la ASL Valle d’Aosta). Linee di sviluppo dei 7 Progetti regionali in Rete: 1) Progetto “Integrazione Ospedale- Territorio” Aderenti 19 Aziende (compresa la ASL Valle d’Aosta). La progettazione dell’attività del gruppo è iniziata con l’analisi dell’espe rienza acquisita nel precedente quinquennio, mediante il monitoraggio di progetti aziendali che hanno realizzato, anche se parzialmente, attraverso indicatori specifici l’integrazione Ospedale-Territorio, documentando i ri sultati ottenuti (attivazione dei servizi, ambulatori, numeri verdi ecc...), gli strumenti utilizzati (opuscoli informativi, rete di comunicazione, ecc...), l’im patto sul paziente (riduzione ricoveri ripetuti, dimissioni protette ecc...). Le evidenze derivate dai progetti sperimentati in vari contesti permetteranno di avviare strategie adattate alle singole realtà, quindi vari modelli di Ospe dale integrato, avendo concordato per la valutazione i seguenti parametri: 29 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 Riproducibilità, Fattibilità, Interesse aziendale. La complessità del Progetto ed il numero delle Aziende hanno reso necessaria la suddivisione del lavo ro in 3 sotto progetti ed altrettanti gruppi di lavoro: A) Comunicazione, Informazione: Internet, Telemedicina, numeri verdi e call-center per MMG, opuscoli per pazienti ecc... B) Linee guida e percorsi assistenziali: miglioramento dell’assistenza nelle patologie ad elevata esigenza di integrazione quali vasculopatie cardiocerebrali, diabete, patologie ortopediche ecc... C) Modelli organizzativi per la dimissione: lettera di dimissione, dimissione protetta, ADI, RSA, lungo degenza ecc. Per ciascun sottogruppo è stato identificato un coordinatore. 2) Progetto “Ospedali liberi dal fumo” Continua l’attività delle 15 Aziende aderenti al Progetto (compresa la ASL Valle d’Aosta). Il gruppo ha aderito all’iniziativa di creare un “Progetto internazionale contro il fumo” che finora ha coinvolto 87 Aziende delle varie Reti regionali. Dal Centro di coordinamento interregionale è stato inviato un questionario di autovalutazione per le Aziende Sanitarie sul grado di aderenza agli standards europei per il controllo del fumo: della nostra Rete hanno risposto 5 Azien de i cui dati saranno uniti a quelli delle altre reti per valutare lo stato della lotta al tabagismo nella Rete HPH italiana. Il gruppo piemontese ha iniziato la sperimentazione di introdurre nelle cartelle cliniche il Test di Fagestrom e di attivare il counselling minimo attraverso al tecnologia dei percorsi as sistenziali. 3) Progetto “Miglioramento dell’accoglienza alla persona straniera afferente ai Servizi Sanitari” È la delimitazione del precedente Progetto “Umanizzazione dei Servizi Sa nitari”, essendo divenuto emergente il problema della interculturalità e a cui sono sensibili parecchie Aziende della Rete (15), che hanno aderito, su iniziativa dell’Ufficio Europeo dell’OMS, al Progetto interregionale “Ospe dale e Servizi Socio-Sanitari interculturali”: il flusso migratorio in Europa è in continuo aumento, per cui in una società multietnica gli ospedali devo no adattarsi alla nuova situazione modificando il loro modo di comunica re, di organizzare le attività di cura e servizi eguali per tutti i pazienti, rico noscendo la centralità della persona, superando le barriere esistenti tra etnie diverse, specie la comunicazione. Il gruppo piemontese ha predisposto e somministrato un questionario per operatori sanitari ed amministrativi in previsione di un Corso di formazione centrato sia sulla parte normativa sia sulla parte socio culturale ed in attesa del finanziamento da parte del Fon do Generale Europeo. 4) Progetto “Fasce deboli. Abuso e violenza sulle donne e sui minori” Il Centro “Soccorso Violenza Sessuale” (SVS) dell’ASO S. Anna di Torino ha 30 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 avuto avvio nel maggio del 2003 come Centro integrato e multidisciplinare per fornire appropriata assistenza nei casi di violenza sessuale nei con fronti delle donne. Il Centro fornisce: - servizio di Pronto Intervento; - servizio telefonico di informazioni ed appuntamenti; - il follow-up medico-ginecologico; - consulenze medico legali; - consulenza psicologica di prima valutazione; - assistenza iniziale con il coinvolgimento interdisciplinare di varie figure professionali. Dal maggio 2003 al 31/12/2003 sono stati presi in carico 44 casi di violenza. Tale modello organizzativo è trasferibile in altre strutture sanitarie: è avvia to un collegamento in rete con l’Ospedale Maria Vittoria di Torino (ASL 3). Analoga struttura organizzativa è stata costituita presso l’ASO-OIRM di To rino con un gruppo di lavoro interdisciplinare (NPI, Pediatra, Psicologo, Chirurghi pediatrici, Infermieri professionali, Assistenti sociali) per la pre sa in carico dei casi di abuso e maltrattamento su minori. Dal gennaio 2003 all’aprile 2004 sono afferiti all’ambulatorio 63 bambini (130 visite totali) inviati dall’interno dell’Ospedale (DEA, Ambulatori, Re parti) e dai Servizi esterni. 5) Progetto “La Malnutrizione degli anziani residenti in RSA” Sette Aziende partecipano al Progetto quale estensione di una esperienza maturata da parecchi anni a livello ospedaliero rivolta specificamente a strutture residenziali per anziani, le cui patologie prevalenti hanno un no tevole impatto metabolico e nutrizionale. Si prevede di valutare i risultati di un modello di diagnosi precoce e di intervento mediante l’elaborazione dei risultati di un questionario rivolto al personale RSA, mirato alla malnu trizione, al riconoscimento della disfagia ed alla sua corretta gestione nutrizionale, alla adeguatezza di strumenti già in atto per la prevenzione – diagnosi precoce – trattamento della malnutrizione stessa. 6) Progetto “Salute e Sicurezza degli operatori sanitari” Aderenti 8 Aziende (compresa la ASL Valle d’Aosta). Obiettivi: - migliorare le condizioni di salute e sicurezza degli operatori sanitari; - migliorare le relazioni tra operatori sanitari e pazienti; - prevenire i rischi lavorativi correlati all’organizzazione delle strutture sa nitarie; - favorire il disegno ergonomico delle strutture ospedaliere; - promuovere la cultura della sicurezza tra gli operatori sanitari; - migliorare le attività di Medicina preventiva in ambito ospedaliero. Di pressante attualità la “Prevenzione del Burn-out negli operatori sanitari”: studi recenti hanno dimostrato che per circa il 58% dei dipendenti il disagio 31 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 lavorativo, lo stress emotivo, specie in alcuni reparti ad alta intensità lavora tiva, provocano stati di ansia e depressione con tendenza all’isolamento e con evidenti ripercussioni sull’efficienza lavorativa e sulla qualità della rela zione con i pazienti e i loro familiari. Un intervento preventivo e di sostegno di tipo psicologico (incontri quindicinali di gruppi di lavoro nei reparti più a rischio) presso l’ASO di Alessandria ha dato esito positivo, dimostrato dalla nessuna nuova richiesta di part-time o di trasferimento per l’aumento della attività di ricovero e dalla bassa frequenza di congedi per malattie. 7) Progetto “Ospedale senza dolore” Di recente acquisizione da parte della nostra Rete, abbiamo aderito al coordi namento interregionale del Progetto. Alcune Aziende del gruppo (8 Aziende compresa la ASL Valle d’Aosta) stanno già sviluppando specifici progetti sul tema della consapevolezza del dolore da parte dei vari attori in campo, valido riferimento per la definizione del Progetto regionale HPH, i cui principi ispiratori sono la centralità della persona ed il rapporto di rete tra le varie Aziende. L’obiettivo del Progetto è di modificare le attitudini ed il comportamento degli operatori sanitari ed anche dei pazienti, mediante la sensibilizzazione ed il coinvolgimento al “problema dolore” di tutto il personale sanitario, l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento, la valutazione ed il monitoraggio del dolore percepito dal paziente, la valorizzazione del paziente stesso attraverso il consenso informato quale metodo per creare l’alleanza per la salute tra operatori, pazienti e familiari. 2.3. L’esperienza della Rete lombarda HPH CARLO ALBERTO TERSALVI - Dirigente Medico della Struttura Comunicazione e Re lazioni internazionali della Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia La rete lombarda HPH è giunta al suo quinquennio di attività, essendosi costituita nel 1999, in occasione della 3° Conferenza Nazionale HPH, organiz zata a Milano dalla Regione Lombardia. A differenza delle altre reti regionali italiane, la rete lombarda HPH ha il suo centro di coordinamento presso la D.G. Sanità della Giunta Regionale. Que sto input regionale ha visto un iniziale entusiasmo nei primi anni, con un’ade sione di ben 62 strutture ospedaliere lombarde (tra quelle pubbliche e private accreditate) su un totale di 115 (pari al 54%) e con l’avvio di un’enorme quan tità di progetti, spesso non in linea con i principi HPH e/o con una carenza metodologica. A quel tempo era stato, comunque, raggiunto l’obiettivo regio nale: cioè quello di catturare l’attenzione degli operatori su cui avviare una informativa diretta ad un cambiamento culturale dell’ospedale che ricomprendesse, oltre alla “cura” anche la “promozione della salute” all’inter 32 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 no della struttura ospedaliera. Ora le strutture aderenti sono 58. Tale riduzio ne è dovuta allo scorporo dei presidi ospedalieri dalle ASL. Tra gli interventi regionali più importanti si ricorda: - Nell’anno 2002, inserimento, all’interno del P.S.S.R., tra i progetti innovati vi, di una serie di azioni miranti allo sviluppo della funzione trasversale della educazione alla salute e promozione alla salute negli ospedali, volte a favorire lo sviluppo di sinergie tra le varie strutture esistenti sul territorio, sia pubbliche che private (ospedaliere e non). La Regione Lombardia ha avviato le strutture verso un cambiamento culturale che è stato favorito, sia dall’affermarsi del principio di sussidiarietà riconosciuto nell’attuazione della devolution, sia dalle oggettive difficoltà economico-finanziarie non più sostenibili dal solo ente pubblico. - Nel giugno 2003 la giunta regionale (con proprio provvedimento) ha volu to estendere la rete lombarda HPH anche alle strutture socio-sanitarie, tra i propri soggetti attivi, dopo aver ottenuto l’assenso del Coordinatore Euro peo. Con questa iniziativa anche le RSA (Residenze sanitario-assistenziali) e le RSD (Residenze Sanitario-Assistenziali per persone con Disabilità) hanno la possibilità di realizzare, sia direttamente che in collaborazione con le strutture ospedaliere, progetti di promozione della salute agli anziani e ai disabili (fasce sociali più deboli). Inoltre, con questo provvedimento sono state assegnati alla rete lombarda HPH 360.000,00 Euro (per il triennio 2003-2006), quale fondo di incen tivazione per la realizzazione di progetti HPH da parte delle strutture sani tarie e socio-sanitarie. - Nell’anno 2004 con il supporto della nuova “Direzione Scientifica” (com prendente esperti delle due aree “sanità” e “socio-sanitaria”), la Regione ha: individuato le seguenti aree prioritarie, nel cui ambito avviare i progetti HPH, sia delle strutture sanitarie che socio-sanitarie: a) ospedale e territorio; b) uso corretto dei farmaci e dei presidi; c) promozione di stili di vita (in cui sono ricomprese tutte le tematiche inerenti il comportamento corretto della persona, ivi compreso anche l’ospedale senza fumo); d) ospedale senza dolore; e) ospedale interculturale. La Regione non ha escluso altre aree, purché in attuazione al PSSR 2002 2004; ha organizzato un corso di formazione per la “progettazione e gestione di progetti HPH” agli operatori sanitari (già realizzato a giugno) e socio-sanitari; ha predisposto uno strumento unico (scheda) per la rilevazione dei progetti HPH. Obiettivo generale regionale: migliorare la qualità delle prestazioni ai citta dini. 33 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 Obiettivi specifici regionali: implementare il numero dei progetti HPH delle strutture sanitarie e socio-sanitarie attraverso l’incentivazione di premi; costi tuire un database regionale dei progetti HPH. Sintesi progetti regionali Tra le tematiche prioritarie sono ricomprese quelle relative ai 3 progetti regionali avviati (Ospedale senza dolore, ospedale senza fumo e ospedale interculturale): - Ospedale senza dolore: n. 17 strutture sanitarie coinvolte. Obiettivo generale: fornire alla D.G. Sanità gli strumenti per programmare un sistema a rete finalizzato a combattere il dolore inutile delle persone ricoverate o che afferiscono alle Strutture di ricovero regionali. Obiettivi specifici: creare una rete sperimentale tra le esperienze di eccel lenza presenti in regione; elaborare un manuale applicativo regionale sugli aspetti principali dell’OSD (strumenti di misura, formazione, informazione, linee diagnostico terapeutiche) a disposizione delle Strutture Sanitarie che hanno istituito o istituiranno i COSD; creare un file delle esperienze in cor so, sul sito web regionale; fornire alla D.G. Sanità le basi per lo sviluppo della rete regionale per l’OSD; confrontarsi con le esperienze in corso pres so altre regioni (in primis quelle partecipanti alla rete HPH). Azioni e risultati: terminata la stesura del manuale regionale per l’OSD che costituirà lo strumento operativo per il recepimento delle Linee guida nazio nali. Esso è strutturato nei suoi capitoli principali: 1) normative nazionali e regionali; 2) esperienze in corso; 3) strumenti di rilevazione e misura consi gliati; 4) indicazioni generali terapeutiche; 5) strategie formative; 6) strate gie informative; 7) bibliografia. - Ospedale senza fumo: n. 17 strutture sanitarie coinvolte. Obiettivo: valutare il grado di aderenza agli standard europei per il controllo del fumo delle Aziende Sanitarie pubbliche e private della rete Lombarda HPH a distanza di tre anni dallo sviluppo dei primi progetti HPH “Ospedali liberi dal fumo”. Per la sintesi sulle azioni e risultati si rimanda ad apposito abstract regionale inviato. - Ospedale interculturale: 16 strutture coinvolte. Obiettivo generale: facilitare l’accesso e l’accoglienza del cittadino immigra to ai servizi ospedalieri e la comunicazione degli stessi con gli operatori dell’ospedale, attraverso una metodologia di lavoro di rete nell’area interculturale. Per la sintesi sulle azioni e risultati si rimanda ad apposito abstract regionale inviato. 34 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 2.4. Il contributo della Rete “Health Promoting Hospitals” alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna MARIELLA MARTINI - Direttore Generale AUSL di Reggio Emilia, Coordinatrice Rete HPH Emilia Romagna KYRIAKOULA PETROPULACOS - Responsabile dei Servizi ospedalieri della Regione Emilia Romagna, Assessorato Sanità dell’Emilia Romagna La promozione della salute è parte integrante della strategia complessiva individuata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ultimo Piano sanitario, che ri prende ed integra i principi essenziali del Piano Sanitario Nazionale, in parti colare: la centralità della persona, l’uguaglianza e la solidarietà, l’attenzione ai bisogni di salute, le alleanze per la salute, l’orientamento ai risultati, la globalità dell’offerta e della presa in cura, la modernizzazione e miglioramento dei ser vizi. L’intento è, da una parte, di migliorare la qualità dell’offerta e di garantire l’equità dell’accesso mediante lo sviluppo di reti integrate di servizi e dall’al tra, di allargare lo sguardo oltre l’orizzonte dei servizi sanitari per ricercare il coinvolgimento e distribuire le responsabilità attorno a un “Patto di solidarie tà per la salute” fra enti locali, aziende sanitarie, organizzazioni sociali ed indi vidui della comunità. Sono scelte pienamente coerenti con la filosofia e le politiche di promozio ne della salute sostenute dall’OMS e fanno si che il sistema dei servizi sanitari della Regione Emilia Romagna sia un sistema che assume la promozione della salute come fulcro delle azioni di pianificazione e sviluppo dei servizi che il piano annuale degli obiettivi traduce in indicazioni operative cogenti. L’ade sione da parte di tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna alla Rete degli Health Promoting Hospitals ha questo scenario di contesto come punto di forza e contemporaneamente richiede di declinare i progetti che dovrebbero essere sviluppati, per essere parte della rete degli HPH, secondo le linee della pianificazione regionale. In altri termini, si assume la coinciden za tra i progetti HPH e i progetti da sviluppare in attuazione del piano degli obiettivi assegnato dalla Regione alle Aziende Sanitarie. L’obiettivo di questa comunicazione è di presentare e discutere come gli ospe dali della rete HPH dell’ER hanno attivato una strategia complessiva che da una parte, si fonda su un insieme di progetti volti a migliorare la qualità dei servizi sanitari e delle attività di promozione della salute negli ospedali, e dall’altra, sulla ricerca di partnership volte a sviluppare forme di partecipazione e di co produzione degli interventi di salute coi diversi attori della comunità, intesi come pazienti, cittadini, organizzazioni sociali. In questo scenario la Rete degli ospe dali per la promozione della salute (HPH) costituisce una concretizzazione 35 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 progettuale che deriva il proprio mandato dagli indirizzi generali dell’O.M.S. relativi al ri-orientamento degli Ospedali verso la promozione della salute, ma anche dalle politiche regionali che ne inquadrano l’azione in un sistema locale orientato a produrre guadagni in salute nella popolazione. 2.5. Lo sviluppo della Rete HPH Toscana FABRIZIO SIMONELLI, PAOLO MORELLO MARCHESE, MARIA JOSÉ CALDES PINILLA, KATALIN M AJER - Centro di coordinamento della Rete HPH Toscana, Azienda Ospedaliero-Universitaria A. Meyer (Firenze) Fin dalla sua costituzione, la Rete Toscana HPH è stata intesa dai suoi attori come elemento dinamico nei rapporti con il sistema regionale per la salute, con le altre Reti HPH italiane e con il Network HPH internazionale, assumen do una impostazione tesa da un lato ad importare orientamenti internazionali e dall’altro a contribuire allo sviluppo generale del movimento per la promo zione della salute. Questo tipo di approccio consente di prospettare ruoli differenziati e rile vanti per la Rete HPH: - quello istituzionale, di ripensamento dell’Ospedale come luogo di promo zione della salute, oltre che di diagnosi e cura; - quello funzionale allo sviluppo di piani e programmi locali di miglioramento della salute della popolazione: vi sono connessioni significative con il processo regionale dei Piani per la Salute e con progetti che riguardano la salute infantile e gli stili di vita adolescenziali, la formazione, la valutazione delle politiche re gionali per la salute. La Rete Toscana HPH rappresenta un fattore di spinta per la realizzazione di un progetto sociale di salute che travalica il mandato istituzio nale del sistema ospedaliero, e che costituisce anche una testimonianza di sen sibilità, interesse e impegno del management ospedaliero e del personale sani tario nel favorire la crescita delle persone e delle comunità locali; - quello generativo di nuovi contributi specifici per le politiche regionali per la salute ed anche per il movimento internazionale della promozione della salute: in particolare, l’Ospedale A. Meyer di Firenze ha proposto e coordi na, su mandato dell’Ufficio O.M.S. di Barcellona, un Working group interna zionale sul tema della promozione della salute del bambino e dell’adole scente in ospedale. Sotto il profilo delle relazioni, questo tipo di impostazione ha promosso fra l’altro: - a livello regionale, lo sviluppo di connessioni di sistema con l’Assessorato 36 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 regionale al Diritto alla Salute e con le Unità operative di Educazione alla salute delle Aziende Sanitarie Locali; - a livello nazionale, la partecipazione attiva ai momenti di coordinamento delle Reti italiane HPH ed alle Conferenze nazionali degli Ospedali per la promozione della salute; - a livello internazionale, una vasta rete di rapporti costruita attraverso l’or ganizzazione della 11° Conferenza internazionale degli Ospedali per la pro mozione della Salute (Firenze, 18-20 maggio 2003) e la presentazione di lavori scientifici nelle Conferenze internazionali. La configurazione della Rete regionale conta sull’adesione di tutte le 16 Aziende Sanitarie pubbliche della regione, con una rappresentanza di circa l’80% degli stabilimenti ospedalieri, sulla motivazione di un crescente numero di operatori ospedalieri, su una capillare rete di relazioni interna ed esterna alla Rete regionale, su un sistema di autovalutazione dello stato di avanza mento del progetto. La tipologia di attività comprende: - azioni incrementali, costituite da limitate ma percettibili azioni di promo zione della salute attivate autonomamente dai professionisti anche senza una cornice progettuale definita. Si tratta di “testimonianze” anche frammentarie di promozione della salute, quali “attenzioni” percepibili da parte dei pazienti, iniziative di tipo logistico – alberghiero o organizzativo o relazionale, singole azioni di empowerment delle persone, e così via. Il qua dro di queste azioni è molto variegato di iniziative ed esperienze che sono a volte antecedenti all’avvio del Progetto HPH stesso; - integrazioni processuali, costituite da codificazioni di “valore aggiunto” nel le fasi dei processi diagnostico-terapeutici: si tratta di iniziative spesso indi rizzate alla umanizzazione dei processi assistenziali; - “pacchetti” specifici di servizi, rappresentati da percorsi progettuali ed ope rativi completi attivati da singole Unità operative e mirati a gruppi omogenei per patologia o problematica; - pr ogetti di promozione della salute, che sviluppano interventi metodologicamente improntati al project work e quindi in grado di docu mentare i risultati prodotti. A questo livello si costituiscono team di progetto e si definiscono ruoli, impegni, modalità di comunicazione e valutazione; - interventi di ri-orientamento del setting ospedaliero, considerato come con testo globale (ambientale, organizzativo, normativo, amministrativo, relazionale) capace di ridefinire in termini distintivi l’attività dell’intera strut tura ospedaliera. Un sostegno decisivo per lo sviluppo della Rete è la formazione e in parti 37 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 colare il Laboratorio formativo allestito per elaborare una fisionomia della Rete toscana, i cui primi risultati sono incoraggianti. 2.6. L’esperienza della Rete HPH ligure ROBERTO PREDONZANI, RITA GAGNO - Dipartimento di Staff Azienda USL 1 Imperiese La Rete HPH ligure, avviata nel 1998 dall’Azienda USL 1 Imperiese, inizial mente comprendeva entro la fine del 1999 n. 4 Aziende Sanitarie e n. 4 Azien de Ospedaliere. Nel corso del 2003 si sono unite alla Rete la ASL 5 Spezzina e l’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Nel corso del 2004 ha ancora aderito l’Istituto Tumori di Genova. I principali progetti interaziendali attivati e in corso sono: - Indagine conoscitiva sull’abitudine al fumo nel personale delle aziende sanitarie: al progetto hanno partecipato 4 Aziende Sanitarie e 4 Aziende Ospedaliere. L’obiettivo è stato quello di verificare la percentuale di fuma tori nel personale, al fine di prevedere campagne preventive all’interno delle strutture sanitarie. Nel complesso, sono stati somministrati circa 5000 que stionari, e le risposte ricevute sono state 4.324, con una percentuale di fu matori nel personale del 30%. Tra il personale che ha risposto al questiona rio, si è evidenziato come il 22,7% dei medici, il 33% degli infermieri e il 19,4% del personale amministrativo sia fumatore abituale. La media di siga rette fumate giornalmente è di 14,6, mentre il 72% degli intervistati ha di chiarato di fumare mentre lavora. A seguito delle interviste effettuate, si è cercato di impostare un programma di prevenzione che preveda anche l’ac cesso facilitato del personale ai Centri Antitabacco presenti nelle aziende e di prevedere una segnaletica comune nell’ottica della creazione di Ospeda li e Strutture Sanitarie libera dal fumo. - Chi non fuma vince: nel 2003 si è avviato il primo Concorso Regionale “Uno Spot per dire Stop... Chi non fuma vince”, che ha visto la partecipazio ne di circa 15 Scuole Medie Inferiori delle Province di Imperia, Savona e Genova. Il progetto è stato supportato dal comico Andrea Foresta (Mago Forest) testimonial molto gradito dai ragazzi, nonché dalla partecipazione di una squadra di calcio genovese (Sampdoria). I ragazzi hanno prodotto uno spot di un minuto contro il fumo alla fine di un programma che ha previsto la somministrazione di un questionario (lo stesso utilizzato presso la Rete HPH veneta) alle classi partecipanti, incontri con Medici Specialisti nonché l’attivazione di un laboratorio con tutor. La giornata conclusiva si è tenuta in occasione del 31 Maggio “Giornata Mondiale senza Tabacco” presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, sia nel 2003 sia nel 2004, con la partecipazione di più di 600 ragazzi provenienti dalle varie 38 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 province liguri. I lavori dei ragazzi,valutati da una giuria di giornalisti liguri, sono stati premiati in base all’originalità e contenuto. - Ospedale senza dolore: questo progetto ha visto l’adesione di tutte le Aziende liguri. È stato attivato un gruppo interaziendale di Anestesisti che ha provvedu to alla realizzazione di un Corso accreditato ECM che si sta effettuando in cia scuna Azienda aderente al progetto. Il Corso è rivolto al personale medico, infermieristico ed ostetrico e coinvolge più di 700 discenti. Il gruppo di lavoro ha operato nei termini di una condivisione delle esperienze nell’ottica di preve dere l’elaborazione di un unico percorso didattico, che ha portato alla defini zione di un unico programma con la creazione di un CD didattico in Power Point utilizzato nelle varie sedi per la docenza. Il corso verrà ripetuto anche nel 2005, ed ha l’obiettivo di formare gli operatori alla cultura della gestione del dolore come sintomo e di fornire le basi per una corretta valutazione del sinto mo e impostazione di una corretta terapia. Diverse Aziende hanno anche pro grammato manifestazioni in occasione della Giornata del Sollievo. È ancora da ricordare come la Rete Liguria ha organizzato nel 2001 la 5° Conferenza Nazionale e abbia partecipato con un proprio stand alla Confe renza Internazionale di Firenze del 2003. In questa breve relazione, abbiamo affrontato le esperienze più significati ve, tralasciando altri progetti che sono attualmente in divenire. Possiamo peraltro affermare che l’esperienza HPH è risultata senz’altro posi tiva, in quanto ha innanzitutto sensibilizzato il personale ospedaliero al tema della promozione della salute, permettendo inoltre ai professionisti di diverse aziende di conoscersi e mettere in comune esperienze, confrontandosi su temi il più delle volte gestiti singolarmente. Si sono evidenziate come numerose ini ziative fossero in corso nelle varie Aziende, mancando però la diffusione non solo tra Aziende della stessa Regione bensì anche all’interno della stessa azien da. Non tutti i progetti attivati hanno portato a risultati o sono stati conclusi, la causa di ciò è dovuta al motivo che spesso questi progetti si aggiungono al lavoro quotidiano, pertanto non sempre è possibile trovare il tempo per poter ne perseguire gli obiettivi. È ancora da segnalare come tali iniziative siano state supportate sia logisticamente, sia finanziariamente, dall’Assessorato Regionale. 2.7. Il contesto della promozione della salute e la rete trentina HPH ENRICO NAVA1, PAOLO DE PIERI2, LORELLA MOLTENI2, ROBERTO PANELATTI2 - 1Servizio Educazione alla Salute, APSS Trento; 2Unità per la Qualità, APSS Trento Nell’organizzazione sanitaria provinciale, la promozione e l’educazione alla salute (PEAS) rappresenta una linea strategica di assoluta rilevanza. Già nel 39 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 l’assetto organizzativo aziendale, sin dal 1995 è individuata una Direzione per la Promozione e l’Educazione alla Salute con funzione di predisporre e defini re gli obiettivi nonché gestire la programmazione e il controllo di tutte le atti vità di PEAS del servizio sanitario. Inoltre, nel Piano di sviluppo strategico aziendale adottato nel gennaio del 2001, la promozione della salute, in linea con gli indirizzi della programma zione sanitaria del Trentino, rappresenta obiettivo strategico di sviluppo al l’interno della quale si collocano le attività istituzionali volte alla tutela della salute collettiva. In tale contesto politico-organizzativo, la relativamente recente nascita del la rete trentina HPH ha trovato un fertile terreno di potenziale crescita anche per la consolidata presenza di un ampio spettro di iniziative di promozione della salute, molte delle quali strettamente collegate ad attività condotte dalle strutture territoriali rivolte alla comunità ovvero a setting privilegiati quale il mondo della scuola. In coerenza con le indicazioni strategiche aziendali in tema di PEAS, già dal 2002 nella contrattazione di budget degli ospedali aderenti alla rete HPH trentina vengono riconosciuti tre specifici progetti di valenza generale verso i quali devo no essere principalmente orientale le azioni: ospedale libero dal fumo, l’approc cio precoce ai pazienti con problemi alcol correlati e la promozione della sicurez za sul lavoro in ospedale. A queste rilevanti iniziative si affianca un ricco panora ma di interventi locali orientati sia allo sviluppo di capacità di migliore gestione della malattia da parte del paziente cronico (diabete, malattie cardiovascolari, tu tela della gravidanza e del puerperio) sia alla promozione di stili di vita salutari. A tale proposito, nel corso del 2003 su tutti gli ospedali della provincia ad esclusione di quello regionale di Trento, è stata operata una ricognizione sulle iniziative sistematiche condotte a livello locale e orientate alle strategie della PEAS che ha permesso di confermare la presenza sia di attività quotidiane del personale sanitario incentrate sull’assistenza al paziente, sulla compliance alla terapia e alla conduzione di un regime di vita compatibile, sia di veri e propri progetti sviluppati da singole strutture operative ed aventi carattere di conti nuità nel tempo. Per lo sviluppo nel futuro delle attività di PEAS a livello della rete HPH trentina si impongono comunque alcune riflessioni che potrebbero orientare in modo più efficace le iniziative. Data la molteplicità di iniziative è fondamentale operare una selezione di quelle strategiche che dovrebbe avere un carattere di trasversalità nelle varie sedi ospedaliere in relazione all’impatto sociale e sanitario delle forme mor bose che si vogliono prevenire e controllare. 40 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 Il concetto di fondo della PEAS deve essere oggetto di una trasmissione ampia e trasversale a tutti gli operatori del servizio sanitario e in particolare a livello ospedaliero dove risulta importante l’integrazione tra attività clinicodiagnostica e di promozione della salute; per tale ragione risulta importante rafforzare il ruolo dei referenti HPH ospedalieri anche attraverso una forma zione mirata. È forse opportuno rivalutare il concetto di fondo HPH alla luce anche del centralità cittadino nei rapporti con il servizio sanitario inteso nella sua unitarietà; in questo senso la promozione della salute deve essere intesa in forma integrata ospedale/territorio. Infine il coinvolgimento delle strutture dipartimentali e l’inserimento della strategia di promozione della salute tra i requisiti oggetto di attenzione nell’accreditamento istituzionale potrebbero rappresentare utili opportunità di implementazione della PEAS. 2.8. La Rete HPH valdostana: dal progetto di salute al modello comunicativo GIORGIO GALLI - Coordinatore rete valdostana HPH, Responsabile URP /Ufficio Stampa Azienda USL Valle d’Aosta Sono solamente trascorsi tre anni dall’ingresso della nostra regione nella rete italiana HPH e in questo periodo, avvalendoci sia delle professionalità interne all’Azienda sia delle esperienze maturate dalle altre regioni nel campo dei progetti di salute, abbiamo promosso e realizzato numerosi programmi, alcuni originali, altri già avviati da altre regioni partner e adattati al nostro contesto. Quella della Valle d’Aosta è una realtà unica e originale, sia per la sua collo cazione geografica – da sempre crocevia con l’Europa - che per le sue dimen sioni e le caratteristiche morfologiche: 120.000 abitanti disseminati in un terri torio montuoso ricco di vallate laterali e alte quote, dove il decentramento dei servizi diventa requisito fondamentale per soddisfare i bisogni della popola zione e favorire la stanzialità. Le dimensioni contenute e l’esiguità del numero di abitanti sono condizioni favorevoli per la promozione di programmi di salute che consentono la mas sima diffusione degli stessi esercitando, nel contempo, un agevole verifica del grado di coinvolgimento dei destinatari. Ed ecco che, in alcuni casi autonomamente, in altri partecipando ai gruppi di lavoro della limitrofa rete piemontese, in questi pochi anni abbiamo svilup pato numerosi progetti, tutti in linea con le caratteristiche di un progetto HPH, ad iniziare dalla sua fattibilità e riproducibilità. In alcuni casi l’ingresso nella rete ha generato nuovo impulso a programmi già impostati e avviati (come 41 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 nel caso dell’integrazione “Ospedale-Territorio” o dell’ospedale interculturale o ancora dell’Ospedale senza dolore). In linea con la definizione di promo zione della salute, contemplata dalla Carta di Ottawa, ovvero il processo di rendere capace la persona di aumentare il controllo e migliorare la qualità della propria salute, abbiamo ideato e realizzato, su scala regionale, un pro getto incentrato sullo sport, salute e corretti stili di vita (caratterizzato dallo slogan “Chi si ferma è perduto”), giunto alla sua 2° edizione e arricchito da nuovi percorsi comunicativi. Analogamente alle altre regioni, anche in Valle d’Aosta procede incessantemente il progetto di prevenzione dal fumo e dai conseguenti danni (“Chi non fuma...vince!”), in stretta sinergia con Lega Tu mori e Sovraintendenza agli Studi, rivolgendoci in modo particolare alle fasce a rischio, ovvero la popolazione scolastica compresa in un range di età oscil lante tra i 12 e 16/17 anni. Prosegue inoltre, in raccordo con il gruppo di lavoro piemontese, il progetto sulla salute dei lavoratori, mentre è prossimo all’ingresso nella rosa dei progetti HP un programma di prevenzione, già in parte realizzato dalla struttura “Formazione Personale Infermieristico”, fina lizzato alla rilevazione, studio e proposta di soluzioni per il ben noto proble ma del peso degli zainetti trasportati dagli studenti. Al di là dell’attività progettuale, cosa sicuramente non facile, da tempo ab biamo iniziato a porci una domanda legata all’individuazione e alla definizio ne delle modalità con cui intendiamo comunicare lo stato dell’arte dei nostri programmi di salute alla popolazione. Nelle precedenti conferenze e nelle sessioni parallele tematiche, abbiamo avuto occasione di conoscere e con frontarci su ottimi progetti di salute realizzati dalle regioni afferenti alla rete, ma come li comunichiamo? Quali strumenti utilizziamo per far giungere il messaggio ai nostri destinatari? Come li promuoviamo fuori dall’ambito stret tamente ospedaliero? La Conferenza nazionale di Riva del Garda, e qui dobbiamo ringraziare la Provincia Autonoma di Trento e Carlo Favaretti, ha introdotto in modo forte il tema della comunicazione, imprescindibile per qualunque P.A. ed in modo particolare per le aziende sanitarie che da tempo, per necessità e sulla scia delle spinte normative, si trovano impegnate su questo fronte. Conosciamo tutti la rapida evoluzione che in tal senso ha caratterizzato il mondo della sanità: nel giro di un decennio si è usciti da quella autoreferenzialità che ha dominato incontrastata per lungo tempo, per arrivare alla trasparenza ammi nistrativa, alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti, alla realizzazione delle carte dei servizi, all’istituzione degli Urp, la famosa finestra di dialogo tra cittadini e P.A., oggi divenuto la struttura di comunicazione per eccellenza, a fianco degli uffici stampa – anch’essi da poco introdotti nel settore pubblico – grazie alla legge 150/2000 e alla più recente Direttiva del Ministero della Fun zione Pubblica. Ecco che allora tutta l’attività svolta da una struttura sanitaria, 42 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 con un occhio di particolare riguardo ai progetti di salute, necessita di essere portata a conoscenza del pubblico, se vogliamo coinvolgere i nostri utenti e renderli partecipi dei nostri progetti. La nostra Azienda da tempo, grazie al forte imprimatur della direzione ge nerale, sta sviluppando e promuovendo programmi di comunicazione sem pre più complessi conseguenti ad una serie di progetti innovativi, attuati da un dipartimento di comunicazione che sta prendendo forma in questi mesi, sforzandosi di utilizzare linguaggi comunicativi alternativi a quelli tradiziona li, attingendo a seconda delle necessità dalla fiction e dal mondo del cinema, dalla grafica, dall’immagine e dalla pubblicità, piuttosto che dal mondo del teatro e da quello della musica. Obiettivo: veicolare nel modo più efficace il messaggio indirizzandolo al target e al segmento di popolazione individuato. Già in questa edizione 2004 della Conferenza nazionale HPH abbiamo avu to l’opportunità di mettere a confronto non solo le nostre progettualità, ma anche le modalità con cui ogni regione cerca di trasmetterle all’esterno. Credo che da oggi in poi il tema della comunicazione ed il confronto delle nostre esperienze in tal senso, il benchmarking delle tecniche di comunicazione da tutti noi sperimentate, diventerà una costante anche nelle prossime occasioni, nel rispetto dello spirito che caratterizza il lavoro all’interno della rete. La pic cola Valle d’Aosta, proprio per le sue ridotte dimensione e la facilità di con trollare i processi, può essere in tal senso, lo dico ovviamente con molta umil tà, un interessante laboratorio per sperimentare tecniche comunicative innovative e differenziate a seconda dei contenuti e della fascia dei destinatari. “Non si può non comunicare”, questo è il fondamentale assioma della co municazione. Se la Conferenza di Riva del Garda ha oggi il merito di gettare con forza le basi di un confronto sui temi della comunicazione, oltre a quelli importanti e consolidati dello studio, della verifica dei risultati e del migliora mento continuo dei progetti di salute - soprattutto sotto il profilo scientifico -, la 9° Conferenza nazionale, che si terrà in Valle d’Aosta, proseguirà su questa strada riservando ampi spazi alla presentazione e al confronto degli strumenti comunicativi maggiormente adeguati ai nostri progetti di salute. 2.9. La Rete HPH in Friuli Venezia Giulia CRISTINA AGUZZOLI1, MARIA TERESA PADOVAN2, ADRIANA MONZANI2, DANILO SPAZZAPAN3, CLAU DIO RIEPPI4, DANIELE PITTIONI4, GIANNI CAVALLINI2 - 1Dipartimento di Prevenzione; 2Dire zione Sanitaria; 3Programmazione e Controllo; 4Direzioni Sanitarie di Ospedale Il 13 novembre 2003 a Gorizia è stato firmato alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità e Politiche Sociali, il documento per l’adesione alla rete 43 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 nazionale HPH con la partecipazione delle seguenti Aziende: Istituto di Rico vero e Cura a carattere scientifico “Burlo Garofalo” di Trieste, Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” comprensiva degli Ospedali di Gorizia e Monfalcone, Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” comprensiva degli Ospedali di Gemona e Tolmezzo, Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine, Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” comprensi va degli Ospedali di Maniago, S.Vito al Tagliamento e Spilimbergo. In tale contesto l’Ass n. 2 “Isontina”, è stata individuata quale capofila della rete. La rete regionale ha effettuato un censimento e verificato i requisiti dei numerosi progetti di Promozione della Salute in atto nelle diverse Aziende; ha promosso altresì un confronto per la condivisione di un approccio metodologico e di valutazione uniforme a livello regionale. Nel corso delle prime riunioni si è discusso sul fatto di stabilire dei criteri riconoscibili e misurabili, da rispettare nell’ambito di azioni che possono essere anche di verse. Il monitoraggio dovrebbe essere semestrale con semplici schede rias suntive. Si è deciso inoltre di avviare un percorso formativo comune per tutti i componenti dei Comitati Tecnici Aziendali al fine di uniformare le conoscenze circa i principi e i metodi della Promozione della Salute. Quale progetto unico è stato scelto “Ospedale senza dolore” su cui attivare un monitoraggio condiviso approfittando del fatto che è un progetto regionale già accettato da tutte le Aziende coinvolte. Il progetto si propone di attivare l’inserimento nella cartella clinica della rilevazione costante del dolore per cepito, protocolli condivisi di trattamento del dolore, il monitoraggio di con sumo dei farmaci. Recentemente tale percorso di confronto a livello di rete ha registrato tem poranee difficoltà in considerazione del fatto che all’interno di numerose Azien de aderenti alla rete ci sono stati rinnovi di Direzioni Generali e Sanitarie. Ciò ha frenato molto la composizione definitiva dei Comitati Tecnici Aziendali e la condivisione operativa del percorso formativo. Allo stato attuale è stata riattivata la periodicità di incontro con i nuovi interlocutori aziendali e sono oggetto di revisione alcuni punti tra cui il ruolo della rete quale soggetto nei confronti dell’Agenzia Regionale e dell’Assessorato alla Sanità, anche al fine di favorire – nell’ambito della programmazione regionale – un rafforzamento della strategia della Promozione della Salute, quale sostegno ad un reale riorientamento alla salute delle organizzazioni sanitarie. Inoltre, sono in corso nuove adesioni in regione e si è ritenuto necessario promuovere tale proces so con la produzione di materiale che riassuma brevemente le caratteristiche della rete, da usare eventualmente anche per la spinta motivazionale dei Co mitati Interni. 44 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 Conclusioni: è confermata l’assunzione da parte di ogni azienda aderente alla rete del progetto “Ospedale senza dolore”. Le Aziende hanno in corso l’individuazione di due ulteriori obiettivi che nell’ambito del confronto regionale si è convenuto devono essere specifici di ogni singola Azienda. Tali obiettivi saranno oggetto di verifica attraverso schede e sottoposti a valutazione semestrale nell’ambito di incontri di rete. 2.10. La Rete HPH della Campania: difficoltà e prospettive SARA DIAMARE - Coordinatrice Rete HPH della Campania Se fra i prerequisiti per la salute possiamo enunciare una casa, l’istruzione, la sicurezza e la giustizia sociale, un reddito, un uso sostenibile delle risorse, un ecosistema stabile, una viabilità controllata, noi, in Campania non stiamo troppo bene. La ricerca di soluzioni a questi enormi problemi può essere sollecitata da azioni sociali a favore della salute e di stili di vita che la favoriscano, con la creatività degli individui e della comunità anche per la ricerca di risorse atte a realizzare eventuali programmi di rete. Le soluzioni vanno trovate ai tavoli di contrattazione politica, ma anche capillarmente all’interno dei luoghi deputati all’erogazione delle cure, cioè nelle Aziende Ospedaliere e Sanitarie, e vanno anche al di là dei sistemi sanitari tradizionali. In Campania di creatività ne abbiamo da esportare. Ma delle reti fin’ora costituite, ci rimangono solo i buchi. Per utilizzare questo potenziale contestualizzandolo in una organizzazione di rete è necessario un profondo cambiamento culturale nel modo in cui consideriamo e, responsabilmente gestiamo il nostro ambiente, il nostro quotidiano e le nostre interrelazioni politiche e sociali. Ovvero, in primo luogo, è necessario comprendere essen zialmente la proficuità della sinergia del lavoro in rete, rispetto alla quale alcu ni oppongono un falso interesse ed una resistenza passiva. L’avvio dell’HPH in Campania è stato promosso dalla ASL Napoli 1, in par ticolare dal Direttore del Servizio Controllo Qualità dr. Alfredo Savarese, il cui Servizio ha ampiamente sostenuto questo progetto. La forza della novità HPH, ha consentito una aggregazione progressiva del l’alta Dirigenza che attualmente compone il Comitato Tecnico Centrale del l’Azienda e la costituzione di Comitati Tecnici Locali per ogni singolo Presidio Ospedaliero. L’ASL Napoli 1 è partita da una complessa organizzazione di rete intra-ASL, 45 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 2 infatti, partecipa alla rete HPH già dal 2003 con i suoi 9 Presidi Ospedalieri e 4 Presidi Sanitari Intermedi dove si erogano prestazioni in day hospital. Essa garantisce l’assistenza sanitaria nella città di Napoli ed al momento conta circa 11.250 dipendenti, di cui la maggioranza ospedalieri. Questo, in particolare, è il target su cui si è articolato il primo intervento HPH che è stato orientato all’applicazione della normativa antifumo vigente, ovvero il progetto “ASL Napoli 1 Libera dal Fumo” che partendo dagli ambien ti ospedalieri propone una cultura della salute in un territorio molto comples so e densamente popolato. I progetti HPH costituiscono, a nostro parere, una sorta di passaggio obbli gato nell’ottica di una forte volontà delle Aziende di impegnarsi in azioni che diffondano una cultura della salute nel territorio di appartenenza e aumentino la fiducia nel servizio sanitario da parte dei cittadini. Le aziende che hanno firmato l’Accordo per la costituzione della Rete della Campania e che si sono impegnate a svilupparla ed estenderla in maniera coordinata sono: L’ASL Napoli 1, l’ASL Avellino 2, l’Azienda Ospedaliera “Cotugno” di Napo li. Viene individuato quale Servizio di riferimento per il Coordinamento della Rete Regionale della Campania il Servizio Controllo di Qualità della ASL Na poli 1 e quale Responsabile del Coordinamento, la dr.ssa Sara Diamare, affian cata per la costituzione di un Centro di coordinamento dalla dr.ssa Maria Fierro per la ASL Avellino 2 e dal dr. Agostino Sasselle per l’Azienda Ospedaliera Cotugno. Il Centro di coordinamento della Rete Regionale della Campania dovrà: - organizzare la Segreteria e il Centro di documentazione della Rete Regiona le, compreso il supporto amministrativo e il coordinamento della Rete stes sa; - costituire il punto di raccordo tra la Rete Regionale della Campania, l’OMS e l’Istituto Ludwig Boltzmann; - favorire l’adesione di altre Aziende Sanitarie/Ospedaliere alla Rete HPH del la Campania. L’HPH in Campania, vuole essere l’avvio di un’operazione culturale, in col laborazione con il territorio, per una crescita della coscienza collettiva nel senso del miglioramento delle relazioni e della comunicazione, a favore della qualità della vita. 46 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 Gli ospedali per la promozione della salute nel contesto multiculturale 3.1. Gli ospedali per la promozione della salute nel contesto multiculturale: il progetto europeo Migrant-friendly hospitals ed altre iniziative della Rete HPH ANTONIO CHIARENZA - Responsabile del Centro di Coordinamento della rete HPH Emiliano-Romagnola Il fenomeno migratorio ha assunto proporzioni notevoli ed ha modificato in modo irreversibile il contesto sociale e demografico in cui i servizi sanitari si tro vano oggi ad operare. Che piaccia o no questa situazione non è destinata a modi ficarsi, le migrazioni continueranno in futuro seguendo schemi sempre più com plessi e rendendo le società sempre più differenziate. Non si può ignorare che l’Italia sta diventando una società multietnica, caratterizzata dalla compresenza di individui e gruppi che fanno riferimento ad appartenenze etniche e culturali dif ferenti e che hanno deciso di vivere stabilmente nel nostro paese. La compresenza di culture diverse, non necessariamente assimilabili ai modelli di vita e ai valori del paese ospitante richiede infatti lo sviluppo di risposte adeguate e di azioni specifiche a vario livello che coinvolgono so prattutto i servizi sociali e sanitari. I sistemi sanitari, in particolare, se vogliono migliorare la loro capacità di rispondere in modo adeguato e competente ai bisogni di un’utenza multietnica devono cominciare a modificare la loro “cul tura”, quindi il loro modo di comunicare, di organizzare e di fornire servizi e attività di cura allo scopo di garantire un accesso e un trattamento equo e di qualità per i propri pazienti e cittadini. Le disuguaglianze sul piano della salute e dell’accesso ai servizi possono essere alleviate creando dei sistemi di cura in grado di riconoscere la diversità culturale e di superare quelle barriere che possono precludere attività diagnostiche, terapeutiche e di follow-up appropriate. Questa necessità risul ta, oggi, essere particolarmente urgente per gli ospedali che rappresentano il primo punto di accesso alle cure sanitarie da parte degli immigrati. Quando i pazienti non capiscono ciò che gli operatori sanitari gli dicono e gli operatori non comprendono o sono insensibili alle differenze culturali è, in primo luo go, la qualità delle cure ad essere compromessa. Si deve accettare l’idea che l’utenza degli ospedali non è più, se mai lo è 47 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 stata, un’utenza omogenea essendo ormai caratterizzata in modo sempre cre scente da pazienti appartenenti a diversi tipi di minoranze etniche. Questa situazione pone gli ospedali davanti ad alcune priorità: - come organizzare ed erogare i propri servizi per una varietà di pazienti con differenti background etnici e culturali e che parlano lingue diverse in modo da garantire a tutti un accesso e un trattamento equo? - come rispondere in modo appropriato ai bisogni specifici di cura e di assi stenza di un’utenza multiculturale che ha differenti concezioni di salute, di percezione della malattia, di aspettative di cura, e specifici problemi di salute? Le iniziative in corso all’interno della rete HPH, la creazione di Task Force a livello nazionale ed internazionale, il progetto europeo Migrant-friendly Hospitals, si propongono di rispondere a queste priorità mediante l’implementazione e la verifica di strategie che sono tipiche della cultura degli Ospedali per la promozione della salute (HPH): - migliorare l’organizzazione generale dei servizi ospedalieri per un’utenza di tipo multiculturale mediante interventi specifici finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e rendere il setting ospedaliero “culturalmente adeguato” verso i migranti e i diversi gruppi etnici; - rafforzare il ruolo degli ospedali nella promozione della salute e la relativa conoscenza e competenza degli immigrati (health literacy) e delle minoran ze etniche mediante misure efficaci di empowerment, sia per migliorare l’ac cesso e l’utilizzo appropriato dei servizi; sia per accrescere la collaborazio ne efficace fra pazienti immigrati e il personale sanitario nella gestione delle malattie acute e croniche; sia, infine, per favorire l’adozione di stili di vita sani, utilizzando le risorse messe a disposizione dalla società d’accoglienza e combinandole coi modelli culturali delle minoranze etniche. L’obiettivo di questo intervento è di dare un contributo alla comprensione degli effetti di questi cambiamenti sui servizi sanitari allo scopo di ricavare indicazioni utili ad orientare le politiche, le strategie e le soluzioni operative in modo appropriato e competente. A questo scopo, il progetto europeo Migrant-friendly Hospitals e le Task Force, sviluppate all’interno della rete HPH, possono rappresentare opportunità e modelli concettuali ed operativi di riferimento per le organizzazioni sanitarie impegnate a rendere i servizi maggiormente rispondenti alle esigenze di un’utenza multietnica. 3.2. Ospedale interculturale: dall’esperienza alle Raccomandazioni ROSARIA AVISANI - A.O. Spedali Civili di Brescia Breve introduzione del contesto La popolazione immigrata è in continuo aumento in tutta Europa. In Italia 48 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 e, in particolare, in Lombardia la popolazione si differenzia rispetto alle altre regioni per l’alta differenziazioni della provenienza: sono più di 100 i paesi e le culture di origine degli immigrati. Dall’esperienza di alcuni ospedali lombardi che, tra i primi, hanno dovuto far fronte alle diverse problematiche connesse alle diversità di modelli culturali, si è costituito, nel 2002 “un gruppo di lavoro regionale” rappresentato - oggi - da 16 strutture ospedaliere (tra pubbliche e private)1, che ha avviato il progetto regionale. Obiettivo generale Facilitare l’accesso e l’accoglienza del cittadino immigrato ai servizi ospedalieri e la comunicazione degli stessi con gli operatori dell’ospedale, attraverso una metodologia di lavoro di rete nell’area interculturale. Obiettivi specifici 1. Predisporre una banca dati regionale sulle specifiche iniziative in atto nelle diverse strutture Regionali. 2. Identificare le aree maggiormente critiche su cui pianificare strategie di in terventi. 3. Creare una rete informativa sul territorio che consenta ai cittadini immigrati di conoscere le molteplici possibilità di accedere ai servizi sanitari regionali. 4. Creare percorsi per facilitare l’accesso agli utenti immigrati, soprattutto nel le aree sanitarie di maggiore richiesta. Target - Immigrati con e senza regolare permesso di soggiorno. - Personale aziendale dedito alla relazione con i soggetti stranieri. - Associazioni di volontariato, Onlus. - Comunità delle etnie maggiormente rappresentate nel territorio. Metodologia adottata Identificazione delle criticità e positività delle varie esperienze delle struttu re aderenti al progetto, per la realizzazione di percorsi metodologici, al fine di 1 A.O. San Carlo di Milano; A.O. I.C.P. di Milano; A.O. Ospedale L. Sacco di Milano; A.O. San Paolo di Milano; A.O Cremona; AO. Crema; A.O. Fatebenefratelli di Milano; A.O. Busto Arsizio; A.O. Spedali Civili di Brescia; A.O. Ospedale di Lodi; Istituto Clinico Humanitas di Rozzano; Istituto Clinico Mater Domini di Castellana (VA); Istituto Policlinico San Donato Milanese; IRCCS San Matteo di Pavia; Casa di Cura San Carlo di Paderno Dugnano; Casa di Cura Multimedia di Sesto S. Giovanni. 49 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 realizzare interventi informativo/educativi agli immigrati e agli operatori nelle varie strutture. Percorso operativo: azioni e risultati Anno 2002 (strutture aderenti: n. 9) - rilevazione delle azioni maggiormente significative, (mediante sommini strazione di questionario); - scambio delle esperienze tra le strutture del gruppo nonché della docu mentazione e del materiale. Anno 2003 (strutture aderenti: n. 14) Sono state individuate le aree di maggior afflusso di utenti immigrati e pre disposti i seguenti strumenti informativi: - poster multilingue con una spiegazione del triage e del significato dei colo ri relativi alle prestazioni più o meno urgenti, stampato dalla Regione e distribuito in tutte le strutture ospedaliere dotate di pronto soccorso a vari livelli; - visibilità in internet del questionario anamnestici multilinguistico di emer genza (in 29 lingue) predisposto dalla provincia di Varese ed Associazione privata; - predisposti, in italiano e condivisi dal gruppo, (pronti per la traduzione nelle 5 lingue principali e diffusione in tutte le strutture ospedaliere del territorio lombardo): - dichiarazione di nascita (area materno-infantile); - consenso informato (informazioni di carattere generale); - diritti e doveri dei cittadini (con particolare attenzione alla situazione de gli immigrati). Anno 2004 (strutture aderenti: n. 16) È emersa la necessità di predisporre un documento “Le raccomandazione per un ospedale interculturale” che contenga le esperienze delle strutture ospedaliere che hanno già avviato il progetto, suggerimenti, percorsi formativi agli operatori, documentazione per facilitare l’accoglienza degli immigrati. Il gruppo si è suddiviso in sottogruppi al fine di approfondire le seguenti tematiche per la costruzione del documento: - normativa nazionale e regionale; - formazione agli operatori; - aree tecniche: accoglienza, dimissione, integrazione ospedale-territorio; - aree cliniche: la nascita, la morte, la malattia (oncologica, infettive e croni che), le emergenze. Presentazione e valutazione dei risultati Si pensa entro l’anno di produrre il documento che verrà sottoposto ad 50 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 approvazione regionale. Questo costituirà uno strumento di base per quelle strutture ospedaliere che vogliono attivare un servizio di accoglienza agli im migrati o cogliere suggerimenti per migliore il servizio già in atto. Una volta approvato, il documento regionale verrà fatto conoscere a tutte le strutture sanitarie. La successiva divulgazione di un questionario sarà finalizzato a monitorare ed implementare le Raccomandazioni regionali “Ospedale Interculturale”. Al momento vi è una crescita di esperienze delle 16 strutture partecipanti al progetto. 3.3. Ospedale e territorio interculturale. L’esperienza del gruppo veneto MARIA CATERINA DE MARCO1, MAURIZIA BORDIN2 - 1Direzione sanitaria Presidio Ospedaliero di Treviso, Azienda ULSS n. 9; 2Servizio Educazione e Promozio ne alla salute Azienda ULSS n. 8 (Asolo) La migrazione da paesi non appartenenti all’Unione Europea è certamente uno dei fenomeni che maggiormente stanno condizionando la nostra epoca: in poco più di vent’anni l’Italia è diventata e si è consolidata come meta più o meno definitiva per un flusso di cittadini stranieri in costante aumento. A livello nazionale, alla fine del 2002 (dossier Caritas 2003), viene stimata una presenza di immigrati sulla popolazione totale pari a circa il 3%. Le regioni mag giormente interessate dal fenomeno migratorio sono la Lombardia e il Lazio: rispettivamente ospitano circa il 22% e il 18% della popolazione complessiva immigrata. Subito dopo viene il Veneto con il 10% di presenze: a livello regiona le le province di Vicenza (4,8%), Verona (4,1%) e Treviso (3,8%) sono quelle che attraggono il maggior numero di immigrati. In Veneto, le comunità di immi grati maggiormente presenti sono le seguenti: Marocco, ex Yugoslavia, Albania, Romania, Ghana, Croazia, Cina, Nigeria, Senegal, Macedonia. L’incidenza delle donne sulla presenza immigrata è attualmente pari al 4%. Oltre il 60% degli immigrati provenienti da paesi extracomunitari giunge in Italia per motivi di lavoro, circa il 26% per motivi di famiglia. L’aumento di questi, negli ultimi anni, indica come l’immigrazione stia assumendo un carat tere sempre più accentuato di insediamento stabile. La presenza di famiglie ricongiunte, inoltre, fa si che si passi da una condizio ne di tendenziale invisibilità sociale ad una relazione più intensa con il paese di accoglienza, proponendo sempre più occasioni di scambio interculturale. La popolazione immigrata soggiornante è più giovane rispetto alla popola zione autoctona e per l’80% si concentra nella fascia 0-40 anni. L’immigrato arriva generalmente nel nostro paese con un “patrimonio di salute” pressoché integro: si consideri come proprio la forza-lavoro, su cui questi gioca le possibilità di successo del proprio progetto migratorio, sia in 51 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 dissolubilmente legata all’integrità fisica; sono, poi, le complessive condizioni di vita cui l’immigrato dovrà conformarsi nel paese ospite, capaci di erodere e dilapidare, in tempi più o meno brevi, il “patrimonio di salute” iniziale. La presenza di stranieri nel territorio e il loro interagire con le istituzioni crea una serie di esigenze e di richieste da ambo le parti: per gli immigrati, inserirsi in un nuovo e complesso contesto di vita (modelli culturali, stili, re gole, percorsi), per gli operatori, garantire i servizi richiesti e il buon funzio namento dell’amministrazione di appartenenza recependo e rielaborando le trasformazioni socioculturali in atto. In tale contesto si inserisce il progetto “Ospedale e Territorio Interculturali” della regione Veneto al quale hanno aderito 5 Aziende ULSS, e diretto ai citta dini extracomunitari e alle minoranze etniche presenti sul territorio, che si rivolgono alle strutture pubbliche per i propri bisogni di salute. Come gruppo di coordinamento veneto abbiamo sin dall’inizio concordato su una questione di fondo: il sistema di cura occidentale, come tutti i sistemi organizzativi, è centrato sul proprio auto-mantenimento e dunque erige dife se e resistenze finalizzate a neutralizzare le spinte alla trasformazione. In que sto senso, la presenza di cittadini, pazienti, utenti migranti “obbliga” al cam biamento e “provoca” il sistema della salute pubblica. Perciò, tale sistema, elabora una serie di barriere strutturali che riguardano l’accesso ai servizi e l’accessibilità dei servizi: le prime (a valenza più sociale) sono prevalente mente di tipo giuridico-legale, economico, burocratico-procedurale e organizzativo; le seconde (a valenza più culturale) sono prevalentemente di tipo linguistico, comunicativo, interpretativo. In altri termini, l’incremento degli accessi ai servizi ospedalieri e territoriali da parte di cittadini immigrati com porta una serie di mutamenti e di adattamenti reciproci, anche piuttosto com plessi, tra gli stessi cittadini e gli operatori. Le differenze socioculturali e linguistiche possono produrre incomprensioni e fraintendimenti quando non vere e proprie conflittualità che impediscono agli immigrati di ricevere prestazioni e servizi efficaci e agli operatori di svol gere la loro attività in maniera organizzata, soddisfacente e proficua. Le maggiori criticità incontrate nelle diverse realtà sociosanitarie che parte cipano al coordinamento veneto sono di tipo: - normativo (difficoltà legate alla conoscenza e interpretazione della legisla zione in tema di immigrazione con particolare riferimento alle situazioni di non regolarità); - relazionale (difficoltà comunicative e di interazione nella diversità di espe rienze e riferimenti socioculturali); - organizzativo (difficoltà di individuare procedure innovative ed efficaci sia per i cittadini immigrati che per gli operatori). A fronte di tale analisi il gruppo ha individuato le finalità generali del pro 52 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 getto che consistono in: realizzare ed offrire ai cittadini extracomunitari l’ac cesso ai servizi sanitari in modo appropriato; migliorare la qualità dell’assi stenza socio-sanitaria dall’accesso nella struttura pubblica alla permanenza e al ritorno al territorio, nel rispetto delle diverse identità culturali ed ai bisogni specifici; migliorare la capacità di autotutela della salute. Gli obiettivi specifici sono così specificati: - conoscenza e definizione dei bisogni di salute della popolazione immigrata; delle reali esigenze permettendo di modulare li interventi sanitari e sociali con un approccio globale alla persona; - censimento degli enti, associazioni, organizzazioni che si occupano degli aspetti socio-sanitari dell’immigrato nell’Azienda-ULSS e nel territorio di com petenza; - istituzione di un’attività di mediazione linguistico culturale; - corsi di formazione di educazione e promozione alla salute degli operatori socio-sanitari; - costituzione di una banca dati dei servizi offerti. Le attività realizzate e le metodologie utilizzate sono: - verifica dei lavori pregressi, tratti dalla letteratura e dalla conoscenza diretta; - depliants, opuscoli e poster informativi tradotti in varie lingue; - istituzione di un’attività di mediazione culturale per facilitare l’accesso ai servizi ospedalieri; per esplicitare e chiarire le domande e i bisogni; tradurre documenti, prescrizioni, indicazioni di esami e modalità di cura; - incontri di informazione per la conoscenza della normativa di riferimento; - scheda di progetti svolti o in divenire nei riguardi della popolazione straniera; - interviste e questionari; focus group per l’analisi dei bisogni; - analisi dei bisogni, attraverso un monitoraggio dei dati inerenti i ricoveri e le patologie maggiormente significative; - analisi dei ricoveri e/o prestazioni di pronto soccorso; - utilizzo di un questionario da somministrare agli operatori socio-sanitari per affrontare la “problematica” dello straniero e del diverso; - corsi di formazione per gli operatori socio-sanitari; - individuazione di punti di riferimento per la popolazione bersaglio. Per quanto concerne i risultati, nelle Aziende ULSS aderenti al progetto si sono formati dei gruppi di lavoro aziendali, al fine di lavorare per obiettivi e metodologie comuni alle Aziende per lo sviluppo del progetto “Ospedale e Territorio Interculturali”. È stato particolarmente importante introdurre nell’ambito sanitario la figura del mediatore linguistico culturale, quale figura ponte tra l’utenza straniera e gli operatori socio-sanitari che con essa si trovano a contatto, in grado di 53 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 propiziare l’incontro tra mondi culturali differenti, ma comunicanti. La cono scenza della lingua di provenienza dei gruppi immigrati risulta questione molto importante dal momento che, quello linguistico, è il problema che di primo acchito si presenta a chi si trova a contatto con cittadini stranieri, ma le cono scenze e competenze richieste alla figura del mediatore sono anche o soprat tutto di tipo relazionale e interculturale. In diversi contesti territoriali sono stati attivati corsi di formazione per mediatori linguistico culturali rivolti per lo più, ma non necessariamente, a cittadini immigrati. All’interno del progetto, inoltre, è stato portato a termine il censimento del le organizzazioni che si occupano dei cittadini stranieri ed è stata realizzata una scheda per poter verificare quanti progetti all’interno di ciascuna Azienda sono stati messi in atto e quanti ancora sono in divenire, al fine di coordinare le attività. In particolare nell’ultimo periodo abbiamo lavorato ad un questionario per facilitare il servizio di Pronto Soccorso: sempre più spesso durante l’attività di triage, l’infermiere viene in contatto con utenti stranieri che non parlano ita liano, oppure lo parlano con molta difficoltà. Ciò ha come conseguenza che tale utenza, non essendo in grado di comprendere le nostre spiegazioni e/o assicurazioni, affronta il percorso del triage in situazione di paura ed isola mento. L’idea è di proporre un questionario anamnestico, contenente alcune domande chiuse, relative ai più frequenti sintomi, tradotte in varie lingue (albanese, arabo, cinese, francese, inglese, russo, serbo-croato, spagnolo, te desco), in modo da migliorare la comunicazione e le informazioni che vengo no fornite agli utenti stranieri che si trovano a ricevere prestazioni, talora ur genti. Dei pazienti registrati si riporteranno l’ora di registrazione al triage e di visi ta del medico, e il codice colore. Infine verrà messa a confronto la sintomatologia riportata sulla scheda di triage e la diagnosi finale di dimissione dal Pronto Soccorso. 54 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 3 Parte II Sessioni Parallele 55 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 4 56 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 4 Gli standard e le strategie del movimento HPH 4.1. Quality improvement of hospital care through self-assessment of standards and indicators for health promotion IRENA MISEVICIENE - Pro-rettore dell’Università di medicina di Kaunas, coordi natore della rete nazionale HPH della Lituania Objective The purpose of the project was: a) to develop standards and indicators for health promotion and disease prevention in hospitals and b) to develop a self-assessment tool that will support hospitals in assessing and improving the quality of health promotion activities. Methods The ALPHA programme recommendations were followed to developed standards for health promotion. Specific steps were critical literature review, proposal of first draft standards, presentation at discussion of draft, expert workshops to revise draft standards, pilot test of standards and preparation of final standards. The final set of standards was piloted in 34 hospitals in nine European countries. They address the issues of management policy; patient assessment; information and intervention; promoting a healthy workplace and continuity and cooperation. The developmental process and final standards have recently been reported in the literature [1, 2, 3]. Subsequently, a self-assessment tool was developed based on standards and indicators for health promotion. Existing performance indicator sets and the literature were reviewed and two expert workshops were held to review, select and develop the indicators for health promotion. The self-assessment tool and a complementary manual on implementation are being piloted in eleven countries. Results The review of current indicators in use in performance assessment initiatives yielded the lack of health promotion indicators and the need to further develop 57 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 4 and introduce such indicators in hospitals. Staff-related health promotion indicators exists, however, patient-related indicators are dominated by the clinical-effectiveness domain. Instead of assessing compliance with standards, indicators were developed to complement the standards for health promotion, reflecting the effect of sustained compliance with standards and hence providing a quantitative monitoring tool to improve quality of care. The following eight indicators were selected and developed: Staff awareness for managements’ health promotion policy, patients’ capacities for modifying risk factors; patients’ self-management capacities; staff short-term absenteeism; staff smoking behaviour; assessment of communication with external partners; timely information transfer to subsequent providers, and preventable emergency admissions of elderly. Descriptive sheets specify the rationale, description, numerator, denominator, data source and stratification of each indicator. A self-assessment tool was developed including measurable elements and evidence to which standards have to be assessed, and a section for reporting indicators. The tool requires developing an action plan based on the assessment of both standards compliance and level of performance on indicators. Conclusions Indicators and a self-assessment tool for health promotion in hospitals have been developed. The development process was based on a sound methodological approach and eight resulting indicators have been consented in an international expert group. A self-assessment tool was developed allowing for a comprehensive assessment of the quality of health promotion services using both standards and indicators. A complementary manual provides further support. The work provides an innovative approach towards combining qualitative and quantitative methodology on the one hand, and the possibility to align external assessment and internal continuous quality improvement on the other. Bibliography 1. GRÖNE O., JORGENSEN S. J., Health promotion in hospitals – a quality issue in health care. European Journal of Public Health [accepted for publication, October 2003]. 2. GRÖNE O., JORGENSEN S. J., Quality improvement of health promotion activities in hospitals, “HOSPITAL 5 (6)”, 2003, pp. 50-53. 3. GRÖNE O., JORGENSEN S. J., Standards for health promotion in hospitals: 58 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 4 development process, results of a pilot test and use as a self-assessment tool in European hospitals, “ISQUA Conference book and abstracts”, Dallas 2003, p. 155. 4.2. Strategies for Health Promoting Hospitals and their implementation JÜRGEN M. PELIKAN - WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and Health Care, Ludwig Boltzmann Institute for the Sociology of Health and Medi cine, Rooseveltplatz 2, A-1090 Vienna (Austria) – e-mail: [email protected] Health Promoting Hospitals (HPH) is a comprehensive vision for hospital reform which is being constantly further developed since the late 1980ies. In this sense, HPH can also be understood as a specific content for hospital quality management. In order to become useful for hospital change processes, the comprehensive vision of HPH needs to be formulated into strategies, so as every other reform concept. Based on the goals of Health Promoting Hospitals, there exists to-date a set of 18 strategies for promoting the health of hospital patients, hospital staff and the inhabitants of the hospital community by empowering the target groups for: - health promoting self-management - health promoting coproduction of health - health promoting disease management - health promoting lifestyle development and by improving health-supportive conditions by: - developing the hospital into a health-supportive setting and - contributing to developing the hospital community into a health-supportive setting. How can these strategies be implemented into hospital practice? The most comprehensive way is to develop an overall approach by integrating HPH into the hospital’s (quality) management system. The presentation will focus on: - An overview on and examples on the 18 strategies - Instruments for implementing HPH in general and specific quality manage ment 59 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 60 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 Informazione, ascolto, comunicazione 5.1. Rischio clinico: il vissuto di professionisti e cittadini FRANCESCA NOVACO, LAURA ALDROVANDI, VIOLA DAMEN - Sistema Qualità Azienda Usl di Modena, Via Scaglia est 33, 41110 Modena Premessa Da alcuni anni il Sistema Qualità dell’Azienda Usl di Modena è impegnato sul tema della sicurezza dei pazienti, intesa come riduzione degli eventi av versi e come miglioramento della qualità assistenziale. In particolare è stato avviato un sistema di gestione del rischio clinico che prevede da una parte il forte coinvolgimento di professionisti ed operatori, mediante l’utilizzo del metodo della Segnalazione Spontanea degli Eventi, e dall’altra l’ascolto della voce degli utenti, mediante l’utilizzo dei reclami e del le segnalazioni pervenute all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Queste metodologie consentono di leggere la realtà del rischio clinico per quanto riguarda il tipo di evento avverso, gli effetti che questo ha sulla salute del paziente e sull’organizzazione sanitaria, ecc... Ciò che questi sistemi non esplorano sono le ricadute degli eventi avversi o anche del rischio degli stessi sul vissuto dei pazienti e degli operatori, le mo difiche che la percezione del rischio legato ai trattamenti provoca nella rela zione tra operatore e paziente, come il problema della sicurezza è percepito dai professionisti della sanità e dai cittadini. Abbiamo dunque deciso di avviare un’indagine che ci consentisse di chiari re anche questi aspetti. Obiettivi L’obiettivo del progetto è quello di valutare la percezione di cittadini ed operatori sul tema dell’errore in medicina e della sicurezza dei pazienti. I ri sultati dell’analisi potranno essere utilizzati per: - introdurre correttivi nel sistema di gestione del rischio clinico implementa to a livello aziendale; - studiare strumenti di supporto nella gestione dell’evento avverso per gli operatori, i pazienti ed i loro familiari; - studiare strumenti di comunicazione del rischio clinico per i cittadini. 61 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 Target e metodi Sono stati somministrati questionari ed interviste rispettivamente ad opera tori sanitari e a cittadini riguardo alla percezione ed al loro vissuto in relazione all’errore in medicina ed al rischio clinico. Sono stati interpellati: - professionisti ed operatori sanitari di diverse aree specialistiche e figure pro fessionali. In particolare si sono scelti sia personale medico che infermieristico e tecnico, comunque operanti in strutture a diretto contatto con i pazienti sia a livello ospedaliero che territoriale. Si è scelto di applicare a questo target lo strumento del questionario per garantire una maggiore tranquillità e riservatezza nelle risposte; - cittadini. Si è deciso di intervistare i cittadini indipendentemente dal fatto che fossero attualmente o fossero stati utenti dei servizi dell’Azienda Usl di Modena. Sono stati comunque selezionati cittadini residenti nella Provincia di Modena e quindi potenziali utenti. Si è scelto di utilizzare lo strumento dell’intervista telefonica che risulta essere il più adeguato per cogliere gli aspetti del vissuto che rappresentano l’obiettivo dello studio. Risultati e conclusioni Le domande poste alle due categorie sono tra loro speculari e sono state elaborate partendo dall’esperienza condotta in america dalla Kaiser Family Foundation e dall’Harvard School of Public Health. Le risposte sono analizzate sia separatamente per le due categorie che me diante un raffronto tra le stesse. Una prima visione dei risultati (attualmente in fase di elaborazione) mette in luce alcuni aspetti rilevanti: - l’atteggiamento molto variabile degli operatori nei confronti dell’argomento; - le aspettative dei pazienti di trattamenti sanitari di qualità; - la volontà da parte di entrambe le categorie di migliorare la comunicazione sui rischi. Sarà necessario ora dettagliare meglio queste prime impressioni e tradurle in azioni concrete. In particolare si tratta di: - Migliorare la comunicazione tra clinici sul tema della gestione del rischio: per il raggiungimento di questo obiettivo è stata implementata un’attività di audit clinico sugli eventi avversi. - Migliorare la comunicazione a livello aziendale sul tema della gestione del rischio: per il raggiungimento di questo obiettivo è stata implementata una cospicua attività formativa per tutti i livelli dell’organizzazione aziendale. - Migliorare la comunicazione verso l’esterno sul tema della gestione del ri schio clinico: per il raggiungimento di questo obiettivo è stata attivata una pagina web dedicata a questo tema sul sito dell’Azienda Usl di Modena. 62 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 I risultati definitivi dell’indagine potranno suggerire ulteriori azioni soprat tutto orientate alla relazione tra Azienda sanitaria e cittadini e tra operatori e pazienti. 5.2. Sperimentazione gestionale verso un nuovo modello di governance: l’esperienza del nuovo ospedale di Sassuolo LORENA FRANCHINI E ALTRI AUTORI AUTORE REFERENTE: LORENA FRANCHINI, Sistema Qualità, Ausl Modena, Via Scaglia Est 33, 41100 MO - tel.: 059 2134187, fax: 059 2134180, e-mail: [email protected] Contesto e motivazioni del progetto L’attivazione del Nuovo Stabilimento Ospedaliero di Sassuolo prevista a fine 2004 rappresenta un importante cambiamento per i professionisti, per i cittadini del Distretto e per l’intera Provincia di Modena. Il Nuovo Ospe dale si caratterizza per alcuni elementi di innovazione infatti è giuridica mente una Società per azioni a capitale misto, dal punto di vista normativo è una sperimentazione gestionale basata sulla collaborazione sperimenta le tra un soggetto pubblico (Azienda Usl di Modena) e un soggetto privato (Casa di Cura Accreditata Villa Fiorita). Si prevede quindi l’adozione di un modello gestionale che deve individuare soluzioni organizzative innovative assicurando un miglior assetto dell’offerta ospedaliera ed una elevata inte grazione dei percorsi clinico-assistenziali all’interno e all’esterno con la rete dei Servizi ospedalieri e territoriali presenti nella Provincia. Obiettivi L’apertura del Nuovo Ospedale con la sua sperimentazione gestionale com porta lo sforzo di definire linee strategiche innovative per realizzare un “nuo vo modello di governo” dell’assistenza sanitaria. È necessario quindi un ap proccio sistemico per armonizzare gli obiettivi e i valori dell’organizzazione con quelli delle singole persone che la compongono e con tutti i principali stakeholders attraverso un loro coinvolgimento. La prospettiva di far conflu ire all’interno del Nuovo Ospedale risorse umane attualmente operanti presso le due strutture prefigura la necessità di sviluppare percorsi di coinvolgimento e formazione per gli operatori che permettano di raggiungere integrazione tra le èquipes, condivisione degli approcci di gestione clinico-assistenziale dei pazienti, partecipazione nella definizione delle modalità organizzative da attuare. 63 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 Target Per concretizzare la new governance progettata per l’Ospedale si è costru ito un sistema di valori, esplicitati nella Mission, che fossero rispondenti alle esigenze dei cittadini, del personale e dell’intera comunità. La centralità della persona e la sua sicurezza hanno guidato la costruzione dei percorsi clinico-assistenziali centrati sulla soluzione dei problemi di salute e integrati con al rete dei servizi socio-sanitari del territorio per garantire la continuità assistenziale. Sono state inoltre definite le proposte per la rimodulazione dell’offerta sa nitaria del territorio, all’interno della programmazione sanitaria provinciale e secondo la logica Hub & Spoke, tenendo conto dei bisogni di salute evidenziati, per alcune tipologie di prestazioni dai dati di mobilità passiva. I professionisti e gli operatori provenienti dalla struttura pubblica e da quella privata sono stati coinvolti attraverso incontri periodici, riconosciuti come “action learning” e accreditati dal sistema ECM, con il duplice obiettivo di assicurare conoscenza e integrazione reciproca e di condividere le modalità organizzative da attuare nel nuovo Ospedale. Il loro impegno si è concretizzato nella definizione delle aree di sviluppo comuni all’interno delle quali proget tare i percorsi e definire il miglioramento. L’Ospedale è parte integrante della comunità in cui è collocato, occorre quindi proporre strategie di comunicazione alle altre strutture e professionisti sanitari presenti nel territorio, ma anche e soprattutto alle istituzioni e ammi nistrazioni locali. Si è quindi operato affinché dai lavori dei gruppi emergesse ro canali preferenziali di informazione, ascolto e comunicazione, program mando momenti specifici d’incontro. Presentazione e valutazione dei risultati Il confronto fra obiettivi previsti e risultati raggiunti conferma la positività del lavoro svolto, ogni gruppo ha elaborato la propria mission, coerente con quella del nuovo Ospedale, ha proposto le aree di sviluppo e di miglioramen to sulla base di dati o altri elementi oggettivi, ha definito i principali percorsi e la relativa mappatura dei rischi, ha analizzato le principali interfacce per defi nirne i meccanismi di integrazione, ha evidenziato le necessità di comunica zione e di ascolto. Il principale indicatore è quindi costituito dal numero delle evidenze documentali con le caratteristiche sopra riportate sul numero totale dei gruppi di lavoro attivati. Conclusioni Questa esperienza è applicabile per ogni nuova struttura sanitaria che in 64 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 tenda rendere percepibile ai pazienti l’eccellenza con percorsi organizzativi agevoli e puntuali, attenzione e disponibilità nei rapporti umani, ambienti di elevato comfort, dotazioni tecnologiche avanzate, qualità ed affidabilità delle prestazioni sanitarie erogate. 5.3. Il vissuto del ricovero ospedaliero nella rielaborazione del bambino ANNA ZAPPULLA, FABRIZIO SIMONELLI, CARLO BARBURINI, DOMENICA ARONNE - U.O. Co municazione Promozione, Marketing e Formazione Ospedale Pediatrico A. Meyer di Firenze AUTORE REFERENTE: ANNA ZAPPULLA, Psicologo-Animatore di Formazione A.O. Meyer, Via Luca Giordano 13, Firenze - tel.: 055 5662441, e-mail: [email protected] Introduzione del contesto In un contesto di malattia e di ospedalizzazione, dove nell’agire degli ope ratori e delle famiglie, prevale con eccessiva frequenza, un’ottica “adultocentrica”, non raramente il bambino vive una condizione di ridotta visibilità e di ascolto. I suoi vissuti, sia durante il ricovero, sia dopo, quando rientra alla vita normale, spesso non vengono adeguatamente percepiti, valu tati e sostenuti. L’ascolto dei bambini invece ha una sua rilevanza etica e pro fessionale e come tale, dovrebbe essere sempre adeguatamente riconosciuto, perché solo attraverso l’ascolto è possibile rendere visibile il loro mondo in terno. I vissuti dei bambini dovrebbero costituire l’elemento fondamentale, o almeno uno dei principali, per ottenere indicazioni “vere”, utili o indispensa bili, per migliorare la gestione clinica del ricovero o per promuovere correttivi assistenziali, per ottenere una reale condivisione delle scelte operative, oltre che per trovare elementi utili per migliorare la qualità di vita in ospedale e realizzare una sempre più efficace promozione della salute. Ogni bambino può vivere in modo meno traumatico il ricovero ospedaliero, può essere reso consapevole che essere malati comporta un disagio, può essere educato ad affrontare meglio la malattia e ad assumere comportamenti corretti per tutelare la propria salute, può evitare paure e il portarsi dietro problemi che potrebbero pregiudicare a lungo la qualità della sua vita. Ma occorre conoscere più a fondo il vissuto del ricovero ospedaliero da parte del bambino. Obiettivi ed Attività Partendo da questi presupposti l’Ospedale Pediatrico Meyer, in collabora zione con le insegnanti della Scuola Elementare Paolieri (Impruneta), ha rac 65 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 colto una serie di elaborati scritti da alcuni bambini dal titolo “Racconto una mia esperienza in ospedale”, per indagare i vissuti e i ricordi della loro espe rienza di ricovero, fuori dal contesto ospedaliero, e interpretare quanto i bam bini hanno voluto esprimere attraverso i loro temi. Con l’esame degli elaborati non si vogliono cercare “cose nuove”, né dimo strare nuove tesi, ma solo “ascoltare” le voci dei piccoli per dare un piccolo contributo alla messa a fuoco del loro scenario emotivo e creare un’occasione di ripensamento critico delle problematiche sottese all’esperienza di malattia e di ospedalizzazione infantile. Il lavoro va nella direzione della conoscenza dei problemi, dei bisogni, delle necessità, delle emozioni, dei desideri e delle aspirazioni dei bambini che sono stati ricoverati. Elementi importanti di un’esperienza caratterizzata quasi sempre da sofferenza fisica ed emotiva, spesso da uno sconvolgimento dei rapporti familiari, dei rapporti con gli ami ci e con la scuola, e che rappresenta comunque uno strappo, piccolo o gran de, ai propri ritmi evolutivi e alla trama della vita. Bisogni, necessità, desideri, emozioni, aspirazioni delle quali è necessario facilitare sempre più l’esplicitazione, l’approfondimento, la consapevolezza, la possibilità di superamento. L’obiettivo che ci si pone riguarda quanto da questi racconti siano estrapolabili indicazioni per il miglioramento del benessere del bambino in ospedale, di rispetto dei suoi diritti, di promozione della sua salute. Gruppo target Bambini di varie età della Scuola Elementare Paolieri (Impruneta). Primi risultati Sono stati raccolti ed esaminati 63 elaborati scritti: nei loro racconti i bambi ni hanno espresso in modo innocente, con creatività, sensibilità, e un’atten zione tutta particolare il loro modo di vedere l’ospedale, ed hanno espresso bisogni, necessità, desideri e aspirazioni che si stanno al momento classifican do per una loro sistematizzazione e presentazione organica. 5.4. Carta dei servizi sanitari e sistema qualità secondo la Vision 2000 P AOLA G ORETTI 1, M ARCO B OSIO 2, E NRICO C RISTOFORI 1, A LBERTO Z OLI 3, P IETRO CALTAGIRONE4 - 1Struttura Qualità, 2Direttore Struttura Qualità, 3 Direttore Sa nitario Aziendale, 4 Direttore Generale, Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”, Regione Lombardia AUTORE REFERENTE: PAOLA GORETTI, Struttura Qualità, Accreditamento e Control 66 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 lo Strategico, A.O. “Ospedale di Lecco”, Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco tel.: 0341 489542, fax: 0341 489540, e-mail: [email protected] L’Azienda Ospedaliera di Lecco è stata una delle prime strutture sanitarie pubbliche ad intraprendere la certificazione secondo la normativa ISO, certi ficando circa il 75% dell’Azienda. L’Azienda Ospedaliera è, di fatto, un riferi mento per il territorio e per la regione, non solo per essere la struttura sanita ria più importante della provincia, ma sopratutto per le competenze dei pro fessionisti che in essa lavorano. Con l’avvento della nuova norma UNI ISO 9001 2000 l’Azienda ha struttura to il suo sistema qualità correlandolo direttamente al sistema per la gestione dell’Azienda, creando i presupposti per fare in modo che il sistema di gestio ne per la qualità e il sistema di gestione aziendale diventino lo strumento unico e integrato per il governo dell’Azienda. In questo contesto l’Azienda sta passando da un sistema di qualità fondato sulle singole U.O. certificate secon do la ISO 9001/94 nei tre presidi ospedalieri ad una certificazione unica per l’azienda (circa 1.000 posti letto e 2.700 dipendenti), strutturata sui diparti menti e sui processi. Nel dicembre del 2003 l’Azienda ha conseguito la prima fase della certificazione, con la validazione dell’intero processo di manage ment e di 4 dipartimenti sanitari dei 9 esistenti. L’obiettivo è quello di certifica re a giugno i rimanenti dipartimenti. In questo contesto la Direzione Generale ha ritenuto opportuno rivedere la Carta dei Servizi esistente, attualmente dif ferenziata per i 3 presidi ospedalieri, creandone una unica aziendale, coniu gando questa iniziativa con il processo Vision 2000. Il progetto pertanto pre vede la produzione di un’unica Carta dei servizi i cui contenuti sono desunti dal processo di certificazione, con degli standard di servizi che sono gli stessi richiesti alle varie U.O. per il conseguimento e il mantenimento della certificazione ISO. In generale gli strumenti aziendali, quali Carta dei servizi, documenti del la qualità, budget, ecc..., sono poco integrati tra di loro, con un notevole dispendio di risorse e con una difficoltà nell’individuazione degli obiettivi aziendali e dei relativi parametri di misurazione. La principale esigenza è stata quella di fornire agli operatori dell’Azienda indicazioni univoche, orien tate al miglioramento e alla trasparenza del servizio, in modo da perseguire gli obiettivi aziendali e fornire ai cittadini garanzie sulle prestazioni erogate dalle U.O. Innanzitutto è necessario un impegno rilevante della Direzione Generale che condivida il progetto e lo “sponsorizzi”. Il lavoro si deve incentrare sulla unificazione di tutti gli strumenti di gestione e di comunicazione aziendali, in modo da individuare, per esempio, azioni di miglioramento, standard ed indi catori delle singole U.O. che servano al processo di certificazione ma che, nel contempo, siano contemplate nella scheda di budget e che, con una necessa 67 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 ria selezione, siano diffusi nella carta dei servizi aziendale. Gli obiettivi gene rali da raggiungere sono: - maggiore chiarezza degli standard previsti nella Carta dei Servizi; - maggiore sicurezza del raggiungimento degli standard in quanto collegati direttamente con gli obiettivi aziendali; - aggiornamento annuale degli standard e quindi maggiore dinamicità degli stessi; - maggiori garanzie da parte del cittadino. Altri obiettivi specifici da perseguire sono: - collegare funzionalmente la Carta dei Servizi al processo di certificazione Vision 2000; - individuare standard ed indicatori delle singole U.O. che siano funzionali alle esigenze del cittadino; - rendere trasparente il percorso ai cittadini; - garantire ai cittadini il continuo perseguimento degli standard previsti nella Carta dei Servizi, in quanto parte integrante degli obiettivi aziendali. Lo stato attuale del progetto è avanzato in quanto sono stati individuati tutti gli standard delle varie strutture aziendali e sono state riprogettate le “schede di presentazione” delle strutture sanitarie, in modo da facilitare la comunica zione e permettere ai cittadini di ottenere delle informazioni corrette e funzionali rispetto ai propri bisogni. Tutto il processo della produzione della nuova Carta dei Servizi Aziendali è stato parallelo all’impostazione della certificazione aziendale, che avverrà nel mese di settembre p.v. 5.5. Le segnalazioni del cittadino: un modo di comunicare con l’azienda per un ospedale centrato sulla persona ROSANNA CERRI, FRANCO RIPA, LIA DI MARCO - ASO San Giovanni Battista Torino Introduzione I cambiamenti e le trasformazione legislative avvenute negli anni ’90 hanno portato le Aziende Sanitarie ad una maggiore attenzione nel rapporto con l’utenza. L’art. 12 del d.legisl. n. 29/93 che istituisce nella Pubblica Amministrazione gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) e la successiva direttiva del Presiden te del Consiglio dei Ministri 11/10/94, testimoniano la necessità di migliorare il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il Cittadino, mentre le disposizioni legislative sanitarie hanno sottolineato con il d.p.c.m. 09/05/95 l’importanza di questi servizi non solo per la tutela degli utenti, ma anche per il controllo sulla qualità dei servizi erogati attraverso la soddisfazione del paziente. Nello specifico la funzione informazione e comunicazione si sviluppa attra verso attività che rendono l’URP l’organismo di interfaccia con l’utente. Ma 68 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 comunicare va ben oltre il fornire informazioni; per comprendere l’efficacia dei servizi e delle prestazioni offerte occorre che l’Azienda stabilisca meccani smi di feedback sistematici con i propri portatori di interesse. Ecco che allora assume una notevole importanza l’ascolto del cittadino/utente come cliente, in grado di portare contributi sostanziali alle azioni di miglioramento. La raccolta dei reclami La raccolta dei reclami rappresenta uno strumento relativamente semplice e molto utilizzato per monitorare la soddisfazione dei pazienti; l’analisi dei reclami pone in evidenza le contraddizioni tra i bisogni del cliente, le sue aspettative, la sua domanda esplicita o ancora inespressa ed i servizi erogati. Il cittadino/utente nelle segnalazione indica le problematiche che può percepire e comprendere come non corrette: in questa logica i dati rilevati possono essere letti come eventi sentinella, come segnali. La natura sog gettiva del concetto di soddisfazione rende comunque complessa la sua lettura; nella valutazione delle prestazioni gli operatori sono maggiormen te attenti ad aspetti legati alla pratica professionale e al presidio di rischi ed errori, mentre i pazienti focalizzano maggiormente la loro attenzione su aspetti quali l’umanizzazione dei servizi, il comfort ed il comportamen to degli operatori. La gestione Negli ultimi anni l’analisi delle segnalazioni in Azienda evidenzia costan temente situazioni problematiche inerenti la “dimensione interpersonale” riguardanti in modo particolare aspetti dell’informazione e del comporta mento. Nel 2003 questa categoria rappresenta il 30% dei reclami recepiti: di questi il 8,8% si riferisce all’informazione mentre il 27,7% al comportamento degli operatori. La constatazione che le segnalazioni, per loro stessa natura, non permetto no di comprendere in modo approfondito il problema ci ha condotto, oltre all’uso dei meccanismi di gestione già ampiamente utilizzati, ad un ulteriore studio diretto ad ascoltare la voce di chi è maggiormente coinvolto nel pro cesso di cura ed assistenza. Gli operatori aziendali ed i cittadini/utenti sono stati protagonisti di specifici focus groups finalizzati ad identificare l’atteso degli utenti/clienti e le principali cause che impediscono o rendono problematica la comunicazione fra operatori e paziente e le loro aspettative. I risultati dei differenti incontri sono stati quindi confrontati per ricercare i punti comuni sui quali costruire un dialogo fra i componenti. Da questi incontri è emerso che il paziente ricoverato desidera essere ac colto come persona e non solo come caso clinico, vuole essere informato dal 69 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 medico sul percorso della sua malattia e desidera essere rassicurato dall’infer miere sulle problematiche delle prestazioni che riceve. I componenti del grup po hanno identificato come cause principali “la cultura degli operatori tecni ca che induce l’operatore a considerare il paziente come patologia”, “la ca renza di una visione antropologica”, “l’organizzazione dei reparti”, “il burnout degli operatori”. Considerazioni conclusive Successivamente agli incontri con gli operatori sanitari ed alla comparazio ne dei risultati, la cause principali saranno pesate attraverso la somministrazione di un questionario. Questo permetterà di identificare maggiormente i campi entro i quali agire, per migliorare ulteriormente gli aspetti della comunicazio ne e dell’informazione. 5.6. La progettazione partecipata come metodologia di lavoro per l’umanizzazione degli ospedali in Toscana MARCELLA FILIERI1, SERGIO ARDIS2, ANTONELLA VINCENTI2, GIUSEPPE REMEDI3 - 1Azienda USL 5 di Pisa, 2Azienda USL 2 di Lucca, 3Azienda USL 12 della Versilia AUTORE REFERENTE: MARCELLA FILIERI, Responsabile U.O. Sviluppo, Ricerca e For mazione Azienda USL 5 di Pisa, Via Zamenhof 1, 56100 Pisa – tel.: 050 954291, fax: 050 954321, e-mail: [email protected] Premessa Il lavoro per progetti e il lavoro in rete rappresentano le principali modalità operative per dare concretezza ai progetti di promozione della salute in ospedale. Anche presso la Regione Toscana operano sei gruppi di lavoro che svilup pano altrettanti progetti a valenza interaziendale: Sicurezza, Umanizzazione, Ospedale senza Fumo, Comfort/Accoglienza; Ospedale senza Dolore, Ospe dale Interculturale, ciascuno dei quali presenta diversi livelli di avanzamento. Lo sviluppo del sottoprogetto “Umanizzazione” si è dovuto confrontare quasi subito con la difficoltà di individuare denominatori comuni in grado di decli nare compiutamente i molteplici obiettivi che il termine “umanizzazione” sottende e tali da essere condivisi e quindi applicati da tutte le Aziende Sanita rie e Ospedaliere coinvolte nel progetto. Obiettivi Il tema della umanizzazione è stato oggetto di interpretazioni diverse, e 70 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 5 tutte valide, da parte dei singoli ospedali toscani che talora hanno rivolto i propri sforzi verso determinate categorie di utenti (es. il bambino in ospedale; il morente e i suoi familiari, ecc...) o verso il miglioramento di specifici percor si assistenziali (es. percorso cardiologico, oncologico, ecc...); in altri casi le aziende hanno posto l’enfasi sugli strumenti direzionali in grado di favorire l’umanizzazione (es. la formazione e la comunicazione). Di fronte ad un qua dro assai diversificato si è reso necessario individuare un metodo di lavoro in grado di elaborare una progettualità comune in tema di umanizzazione che, tenesse conto di specifiche good practices aziendali, ma che fosse in grado di rappresentare in maniera compiuta il complesso tema della umanizzazione. Si è perciò deciso di partire da un diverso punto di vista troppo spesso dimen ticato: quello dei cittadini-utenti! Target e azioni specifiche Il progetto ha coinvolto: i coordinatori HPH delle aziende toscane interessate al progetto umanizzazione attraverso riunioni di coordinamento; i professioni sti (medici, infermieri) di alcune aziende USL e ospedaliere toscane che attra verso un percorso di formazione-laboratorio hanno elaborato una proposta progettuale; i cittadini che, attraverso i propri rappresentanti, sono stati coinvol ti nella progettazione esprimendo i propri bisogni di umanizzazione. Valutazione e risultati La progettazione partecipata ha portato alla stesura di un documento con diviso dai coordinatori HPH di: Azienda USL 1 di Massa, USL 2 di Lucca; USL 4 di Prato; USL 5 di Pisa; USL 7 di Siena; USL 8 di Arezzo; USL 9 di Grosseto; USL 10 di Firenze, USL 12 della Versilia; Ospedaliera Pisana, Ospedaliera Senese) che partendo dalla centralità della dignità della persona tocca tre principali ambiti di azione da attivare: ambito culturale; ambito etico; ambito clinico. Per ciascuna azione/obiettivo sono in corso di definizione indicatori e standard concordati con i rappresentanti dei cittadini-utenti. Tale documento costituirà, una volta ultimato e approvato dalle direzioni aziendali, un impegno preciso nei confronti dei cittadini e dei loro bisogni di umanizzazione. Conclusioni Il percorso progettuale verso l’umanizzazione degli ospedali è ancora lun go, ma l’avvio condotto attraverso la progettazione partecipata dai diretti inte ressati ha aperto prospettive operative di sicuro interesse, contribuendo an che a sperimentare una diversa metodologia di lavoro. 71 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 72 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 L’Ospedale senza barriere culturali 6.1. La comunicazione transculturale PATRIZIA SIRONI1 (Responsabile Progetto Accoglienza Interculturale), SIMONETTA BIANCHI1 (Direttore Sanitario), NABIHA ARIF2 (Mediatrice Linguistico-Culturale) - 1A.O. Istituti Ospitalieri-Cremona; 2Coop. Dunia in convenzione AUTORE REFERENTE: PATRIZIA SIRONI, Responsabile Progetto Accoglienza Intercul turale, A.O. Istituti Ospitalieri - Largo Priori 1, 26100 Cremona – tel.: 0372 405409, fax: 0372 405406, e-mail: [email protected] Contesto Con riferimento alle indicazioni dell’OMS, alla l. 40/98 e successive integrazioni nonché al PSSR 2002-2004 della regione Lombardia che prevede l’individuazione di funzioni specialistiche finalizzate alle attività di mediazio ne interculturale, l’A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona, nell’ambito dell’attivi tà di promozione della salute, ha costituito il Progetto Accoglienza Interculturale per migliorare l’approccio della persona immigrata alla Struttura Sanitaria ed al contempo le capacità comunicativo-relazionali tra il personale aziendale, i pazienti immigrati ed i loro familiari. Obiettivo principale Sviluppare una capacità comunicativa efficace e culturalmente corretta tra personale aziendale e paziente immigrato, attraverso una metodologia di la voro di rete. Obiettivi specifici - Costituzione di un Servizio di Mediazione linguistico-culturale. Formalizzazione delle procedure di accesso al Servizio di Mediazione. Individuazione di un percorso formativo mirato per il personale aziendale. Diffusione di cartellonistica, materiale informativo e linee-guida multilingue. Analisi del bisogno interculturale e promozione di iniziative culturali e di ricerca. Target - Persona immigrata che si rivolge alla Struttura Ospedaliera, con particolare attenzione alla donna e al bambino. 73 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 - Familiari e gruppo etnico di riferimento. - Personale aziendale, soprattutto dedito alla cura, assistenza e front-office. Risultati Il progetto Accoglienza Interculturale, in fase di realizzazione, ha evidenziato dei risultati positivi soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento del per sonale (indicatore: misura N di persone coinvolte/ N persone conivolgibili = 83%), il grado delle capacità relazionali e di rete (indicatore: misura N valuta zione di capacità/N di interventi effettuati = 84%), il livello delle competenze linguistico-comunicative (indicatore: misura N valutazione di competenza/N di interventi effettuati = 87%), nonché la qualità globale del Servizio Ospedaliero (indicatore: misura N valutazione di qualità/ N di interventi effettuati = 86%) rilevati nell’indagine di customer satisfaction. Inoltre la presenza del Servizio di Mediazione linguistico-culturale ha favorito la gestione di situazioni com plesse e di forte impatto emozionale, in un’ottica olistica e di approccio globa le al paziente, supportando il personale aziendale e migliorando la compren sione reciproca. Conclusioni Il percorso avviato dal Progetto Accoglienza Interculturale rappresenta non soltanto una risposta alle esigenze della comunità, sempre più multietnica, ma soprattutto un orientamento alla promozione della salute secondo l’ottica dell’Ospedale Interculturale. 6.2. Come l’ospedale interculturale promuove la salute dei cittadini stranieri immigrati a Bologna GIOVANNA VITTORIA DALLARI, STEFANIA RICCI - Azienda USL di Bologna - Progetto Speciale Immigrati AUTORE REFERENTE: GIOVANNA VITTORIA DALLARI, Responsabile Progetto Speciale Immigrati, Azienda USL di Bologna, Strada Maggiore 35, 40125 Bologna - e mail: [email protected] L’Azienda USL di Bologna dal 1991 ha predisposto e sperimentato nu merosi servizi e attività per migranti regolarmente o irregolarmente pre senti nell’ambito provinciale. Dal 1999, grazie al progetto Ospedale Interculturale, si è avviato un processo complessivo di potenziamento e reengineering dei servizi territoriali ed ospedalieri, fondato sulla messa in rete delle principali Unità Operative interessate con le altre agenzie locali, 74 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 la comunità, in particolare il volontariato ed i gruppi di pazienti che di questa fanno parte. L’intero processo è stato favorito dalla creazione del “Progetto Speciale Im migrati”, Unità Operativa semplice, che ha il mandato di rilevare i bisogni, pia nificare, promuovere, programmare e coordinare gli interventi sia all’interno, che all’esterno dell’azienda, anche attraverso un percorso di condivisione di obiettivi comuni, esplicitati tra l’altro in uno specifico capitolo del Piano delle Azioni dedicato alla popolazione straniera e a rischio di esclusione sociale. Alcune azioni, metodologie e strumenti: - analisi della legge, letteratura medica e benchmarking di esperienze locali, nazionali ed internazionali; - coinvolgimento degli stakeholders della comunità in uno o più gruppi di lavoro; - numero verde (800 66 33 66) e sportello informativo, attivi due ore al gior no per 5 giorni e 4 ore al sabato mattina, che offrono a migranti e professio nisti consulenze ed informazioni telefoniche in 8 lingue sui servizi socio sanitari e sono sensori di bisogni e domanda; - corsi di formazione ed aggiornamento per mediatrici multiculturali; - menù multiculturale e corso sperimentale per dietologi e dietisti; - analisi della qualità percepita nei diversi servizi sanitari; - attività di informazione, educazione e promozione della salute dei pazienti; - corsi base di 14 ore di medicina delle migrazioni nel catalogo aziendale della formazione; - progetto “prostituzione sicura”; - progetto assistenza e sorveglianza sanitaria per cittadini indigenti italiani e stranieri con un report sulla salute di 1.200 tra cittadini stranieri, carcerati, esclusi, ecc...; - attività di cooperazione internazionale. Recentemente è stata avviata la costruzione di una pagina web, intitolata “I colori della salute”, all’interno del sito aziendale dedicata alla medicina delle migrazioni e all’ospedale interculturale, i cui obiettivi sono: 1) creare un punto di riferimento per tutti i professionisti appartenenti alle diverse istituzioni pubbliche e del Volontariato che si occupano della salu te dei migranti; 2) implementare e facilitare la diffusione di buone pratiche; 3) mettere in relazione gli enti, sia pubblici che privati, che agiscano per il miglio ramento dell’accesso dei migranti alle strutture sanitarie per cittadini migranti. In sintesi “I colori della salute” intende rendere facilmente accessibile a tutti i professionisti che operano nel settore e a tutti i cittadini interessati all’argo mento le normative, i progetti, gli indirizzi dei servizi, materiale informativo, 75 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 quando possibile tradotto e/o mediato in diverse lingue, links, ecc..., per pro muovere la salute dei migranti e scambiarsi esperienze ed informazioni. Inoltre, sulla base dei risultati del progetto “Assistenza e Sorveglianza sanitaria nelle collettività per cittadini indigenti italiani e stranieri immigrati”, che avevano evidenziato difficoltà di accesso ai servizi sanitari dei migranti, ne è stato avviato un altro, ideale continuazione del precedente: “Sperimentazione interregionale per combattere le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari” (PABO). A segui to dell’esame dei dati di ricovero e di iscrizione al SSN, si è deciso di focalizzare le attività di promozione della salute su tre diversi ambiti: materno-infantile, diagno si precoce del ca. mammario, anagrafe sanitaria e medicina di base. Le azioni fin qui realizzate o in corso di realizzazione si possono così sche matizzare: - per i pazienti: campagne di pubblicizzazione e incontri con gruppi di po polazione (chiamata con lettera personalizzata, incontri con gruppi presso le sedi di aggregazione spontanea, aziendali, ecc...), per migliorare l’acces so allo screening mammografico su chiamata, integrati con interventi di diagnosi precoce delle neoplasie della mammella; ciclo di incontri settima nali di educazione alla salute rivolti a due gruppi di donne zingare su igiene personale e alimentare, contraccezione, corretto utilizzo dei servizi sanitari, cura del bambino, educazione a comportamenti preventivi, ecc...; - per l’organizzazione e i suoi professionisti: coinvolgimento dei responsabili delle U.O. e formazione, raccolta di materiali e di esperienze diverse, riformulazione e adeguamento dei metodi di chiamata e di accoglienza (ag giunta di una mediatrice), in relazione alle caratteristiche di ciascun gruppo nazionale (filippine, maghrebine, rumene, zingare, italiane indigenti), esplicitazione, miglioramento, traduzione e pubblicizzazione delle proce dure per l’iscrizione al Sistema Sanitario; - per la cittadinanza: campagna di pubblicizzazione, anche radiofonica e pa gina “i colori della salute” del sito aziendale; - per la struttura: il centro screening verrà dotato di attrezzature e personale specifico: è prevista la costruzione di uno specifico software con le tradu zioni dei messaggi informativi, da trasmettere per il personal computer alla paziente straniera in sala d’attesa) e di mediatrici. 6.3. “Diabete per capirsi” VALERIA MANICARDI1, EZIO BOSI2, ZANICHELLI PIETRO2, BODECCHI SIMONA2 - 1Diparti mento di Medicina, Ospedale di Montecchio, Area Sud; 2Servizio di Diabe tologia, Ospedale di Guastalla e Correggio, Area Nord, AUSL di Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: VALERIA MANICARDI, Ospedale di Montecchio, Via Barilla 16, 76 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 42027 Montecchio (RE) - fax: 0522 860292 / 0522 860361-252, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto Il progetto “Diabete per capirsi” è stato ideato per affrontare il problema della comunicazione tra paziente extracomunitario affetto da Diabete Mellito ed operatori dei Servizi di Diabetologia della AUSL di Reggio Emilia. L’ostaco lo della lingua, spesso conosciuta e praticata poco (soprattutto dalle donne), si aggiunge al disagio di dover affrontare una nuova malattia, cronica, che dura tutta la vita, e che ha nel coinvolgimento del paziente, nella sua capacità di autogestirsi uno degli elementi essenziali per essere curata al meglio, e per evitare le complicanze croniche, fortemente devastanti per il paziente (Retinopatia e cecità, Nefropatia e dialisi, Cardiopatia, Piede Diabetico ed amputazioni, Neuropatia, Impotenza, ecc...). La difficoltà di comunicazione diventa quindi un ostacolo grave e spesso insuperabile, e rischia di costituire una condizione di discriminazione all’ac cesso ed al miglior utilizzo dei servizi sanitari. L’aumento della immigrazione nel nostro paese e nella nostra provincia, e la crescita esponenziale del Diabete nel mondo - definito dall’OMS la epide mia dei primi 25 anni del nuovo millennio - soprattutto nei paesi in via di sviluppo, insieme ai fattori ambientali favorenti rendono questo problema estremamente attuale oggi e nei prossimi anni. Obiettivo/i 1. Facilitare la comunicazione con i pazienti extracomunitari affetti da Diabe te Mellito, che nella provincia di Reggio Emilia, sono in continuo aumento. 2. Descrivere in modo semplice e facilmente comprensibile i principali sinto mi della malattia, la terapia, la dieta, le complicanze, i problemi connessi all’utilizzo degli strumenti per l’autocontrollo della glicemia, all’uso della insulina, delle penne, ecc... 3. Fornire le informazioni sul servizio diabetologico di riferimento, sugli orari ed i recapiti indispensabili per affrontare le urgenze. Gruppi target 1. I diabetici extracomunitari che afferiscono ai Servizi per il Diabete della Provincia di Reggio Emilia. 2. Gli operatori Medici, IP e dietiste che svolgono la loro attività presso i ser vizi per il Diabete presso l’AUSL di Reggio Emilia. 77 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 Presentazione e valutazione dei risultati Sono state prodotte 10 schede costituite da illustrazioni semplici e da un breve testo esplicativo, dedicate ai seguenti argomenti: 1. che cos’è il Diabete; 2. autocontrollo della Glicemia; 3. ipoglicemia ed iperglicemia; 4. alimentazione e Diabete; 5. i cibi da evitare e quelli da preferire; 6. l’insulina; 7. preparare e miscelare l’insulina; 8. le complicanze; 9. arterie e Diabete; 10.il Piede Diabetico; 11.una scheda di Supporto all’Anamnesi; 12.una dedicata alle informazioni sul servizio per il Diabete (“Il tuo Centro”). Le schede sono state tradotte in 11 lingue, oltre all’Italiano, inserite in un CD, accompagnate da una presentazione cartacea, e distribuite a tutti i servizi di Diabetologia italiani, oltre ad essere inserite in un sito internet dedicato al Diabete. Conclusioni Le schede costituiscono già oggi in provincia di Reggio E. ed in Italia un utile supporto per la comunicazione corretta tra paziente Diabetico extracomunitario e personale medico, IP e dietista dei servizi di Diabetologia. 6.4. Il progetto HPH “Intercultura” e l’integrazione nel territorio: l’esperienza di Arezzo ALESSANDRA PEDONE1, RINA TORRIOLI2, LUCIO COLONNA3, MONICA CALAMAI4 - Azienda Sanitaria di Arezzo AUSL 8, Coordinamento HPH 1Staff della Direzione Aziendale, Coordinamento Gruppo “Ospedale Interculturale”; 2Sez. Accoglien za, 3Coordinatore progetto aziendale HPH; 4Direttrice Sanitaria AUSL 8 AUTORE REFERENTE: ALESSANDRA PEDONE, Staff della Direzione Aziendale, AUSL 8, Via Fonte Veneziana 8, 52100 Arezzo - tel.: 0575 254106, fax: 0575 254105, e-mail: [email protected] Introduzione L’ospedale di Arezzo ha individuato l’“Ospedale Interculturale” come uno dei progetti proposti dal coordinamento regionale per l’HPH. Ne è stato affi 78 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 dato il coordinamento alla responsabile dello staff della direzione aziendale che si era precedentemente occupata di mediazione linguistico-culturale e di cooperazione decentrata. Contestualmente la Provincia di Arezzo, assessora to alle politiche sociali, particolarmente attento alle problematiche sulla im migrazione, ha promosso il progetto “Un territorio per tutti”, sostenuto dagli enti, associazioni e organismi vari, e poi finanziato nell’ambito dei bandi del FSE. Il progetto prevede interventi sulla casa, l’alfabetizzazione, il sostegno alla cultura di origine, il lavoro, i centri di informazione e la salute. A ciascun tema hanno aderito diversi soggetti e individuato un coordinatore. Per il grup po “salute” il coordinamento è stato affidato alla azienda USL e alla stessa persona che coordina i progetto HPH. È sembrato opportuno tenere unite le due esperienze e legare la programmazione dell’ospedale a quella più allar gata del territorio, prevedendo momenti comuni di scambio e lavoro tra i due gruppi. Obiettivo Sensibilizzare la comunità aretina sulla problematiche dell’immigrazione e individuare azioni all’interno dell’ospedale nel rispetto delle diverse culture, coordinate con il territorio. Gruppi Target 1. Introduzione e presenza del mediatore nel pronto soccorso, nel consultorio, alle vaccinazioni e Ser.T. 2. Lavoro sul menù ospedaliero: rappresentazione grafica, introduzione spe rimentale di cibi di altre culture e traduzione in lingua d’origine dei menù terapeutici (diabete, gestosi gravidica, ecc...). 3. Diritto all’assistenza, redazione di un opuscolo guida per il personale e per le associazioni. 4. Formazione sui temi dell’interculturalità, rivolta agli operatori ospedalieri e territoriali. 5. Formazione sul percorso nascita, rivolta agli operatori del Dipartimento materno infantile. 6. Formazione sui Piani Integrati di Salute rivolta agli operatori ospedalieri, del distretto e della prevenzione, associazioni, dipendenti dei comuni (so ciale, anagrafe, polizia municipale), scuola, sindacati, per la predisposizione di una programmazione integrata (vedi PSR 2002-2004 della Regione To scana). 7. Aggiornamento di un quaderno sulla salute degli immigrati della pro vincia di Arezzo; approfondimento di alcune aree: lavoro, materno in fantile. In collaborazione con UCODEP, organizzazione operante da 79 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 anni ad Arezzo per la cooperazione decentrata e iniziative per gli im migrati. 8. Predisposizione di un protocollo d’intesa tra azienda USL, Provincia, Regio ne per garantire continuità nell’azione nei confronti della popolazione im migrata (negli atti di programmazione, finanziamenti, ecc...). Presentazione e valutazione dei risultati 1. Progetto n. 1: riconferma con estensione delle ore, non solo Arezzo ma anche provincia; indicatore: n. ore/ n. interventi. 2. Progetto n. 2: Avviato - n. menù rappresentati / n. piatti introdotti nel menù; n. menù terapeutici tradotti. 3. Progetto n. 3: Produzione di un opuscolo guida per il personale e per le associazioni e presentazione all’interno del corso. 4. Progetto n. 4: n. corsi realizzati / n. Distretti della provincia. 5. Progetto n. 5: n. operatori del Dipartimento materno infantile coinvolti in corsi / n. operatori MI totali. 6. Progetto n. 6: n. Corsi Piani Integrati di Salute realizzati / n. Distretti; n. Progetti presentati. 7. Progetto n. 7: Realizzazione del quaderno sulla salute degli immigrati della provincia di Arezzo; aree approfondite: lavoro, materno infantile. 8. Progetto n. 8: Avvio degli incontri per il Protocollo d’intesa tra azienda USL, Provincia, Regione. Conclusioni Consapevoli del fatto che il lavoro è solo all’inizio, ci sembra tuttavia che l’approccio utilizzato e soprattutto il collegamento con il territorio, abbiano già gettato le basi per un lavoro coordinato che potrà dare risultati positivi anche nel futuro 6.5. Donne e minori di altri mondi e di altre frontiere VALENTINO LEMBO, RAFFAELLA BIONDI, ROBERTA PRANDI, MARIA CRISTINA CERATI, STEFANIA ZORZAN - Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano Problema L’afflusso massivo di utenti stranieri presso le nostra strutture ospedaliere richiede ai diversi professionisti modalità assistenziali ed approcci diversi al fine di rispondere ai loro bisogni assistenziali. 80 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 Obiettivo generale Offrire risposte adeguate alle richieste sanitarie dell’utente straniero che accede ai servizi sanitari offerti dall’Azienda Ospedaliera ICP. Obiettivi specifici - Fornire all’utente informazioni chiare in merito ai servizi offerti dalla struttura; - sviluppare una politica aziendale per garantire la libertà di culto e la tutela dei diritti dell’utenza; - informare gli utenti in merito ai loro diritti quando non comprendono o parlano un’altra lingua; - numero degli interventi dei mediatori linguistico-culturali/ numero delle ri chieste di interventi; - mettere in grado il personale di comunicare con utenti stranieri; - promuovere e garantire il diritto alla salute degli stranieri nel rispetto delle differenze culturali. Contesto La tutela della maternità e dell’infanzia sono parte integrante della missione dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento e obiettivo di in teresse del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. La sensibilità alla percezione del problema da parte degli operatori trova le sue origini nella peculiarità delle attività che istituzionalmente vengono svolte presso gli ICP: il parto, la nascita, la cura della donna, del bambino e della famiglia. La Clinica Pediatrica “De Marchi”, la Clinica Ostetrico Ginecologica “Mangiagalli” e l’Ospedale dei Bambini V. Buzzi rappresentano all’interno dell’area metropolita na milanese un punto di riferimento di fondamentale importanza per gli stranieri provenienti da paesi diversi, così come per i professionisti di altre nazioni. L’aumentata richiesta di prestazioni sanitarie da parte di utenti stranieri ha comportato da parte della nostra azienda una maggiore attenzione alle problematiche loro legate. Fin dal 1992 presso gli ICP il problema degli stranieri è stato evidenziato dal personale che, oltre a riscontrare le oggettive difficoltà da loro manifestate, ha rilevato gli ostacoli che le barriere linguistiche e culturali creavano nel regolare decorso delle attività ambulatoriali e di degenza. Ciò ha determinato la necessità di organizzare un servizio di mediazione interculturale per affrontare i problemi derivanti dalle diversità linguistiche, di tradizione, di regole etiche e morali di cui ogni straniero è portatore, favorendo in questo modo un’accoglienza più rispettosa e dignitosa ad ogni donna/mamma sfavorite dalla poca conoscenza della cultura e della lingua italiana. Diversi sono gli attori che nel corso degli anni hanno contribuito al miglio 81 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 ramento dell’accoglienza e assistenza di utenti stranieri: la Direzione Sanita ria, il Servizio Sociale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e, non da ultimo, le Associazioni di Volontariato che hanno collaborato attivamente al fine di offri re un aiuto all’integrazione sociale degli stranieri, ad evidenziare i problemi e a proporre soluzioni. Risultati Relativamente alla tutela dei diritti dell’utenza e alla garanzia della libertà di culto è stato elaborato un documento scritto che enuncia la politica e gli indi rizzi aziendali relativi a tali argomenti, garantendo contemporaneamente la sua diffusione tra il personale mediante corsi di formazione. Tutto il personale dell’A. O. ICP ha l’obbligo di rispettare, applicare e far applicare la politica aziendale e di identificare i bisogni assistenziali conse guenti al rispetto dei diritti dell’utenza al fine di soddisfarli. Il processo per identificare e rispettare i valori e le credenze viene messo in atto ad ogni rico vero/accesso di utenti ed in particolare nei riguardi degli utenti stranieri. Per quanto riguarda gli aspetti religiosi ed alimentari sono stati inseriti nel menù aziendale gli alimenti sostitutivi per diete legate a credenze religiose, è stato inoltre fornito alle caposala l’elenco dei vari Ministri di culto al fine di poter ottemperare alla maggior parte di richieste di assistenza religiosa. La coopera zione tra il servizio di Assistenza Sociale ed i Mediatori linguistico culturali ha permesso di definire i principali riti religiosi collegati alla nascita delle varie etnie al fine di informare il personale e permettere il rispetto del rito. L’Azienda ha inoltre identificato le proprie categorie protette in riferimento alla missione degli ICP. Bambini, disabili, anziani, gravide e puerpere rientra no all’interno di questa categoria. A tal fine sono state definite una serie di interventi e di norme di comportamento che il personale incaricato dell’assi stenza deve adottare (aree di ricovero dedicate, spazi per il gioco e l’allattamento, identificazione della puerpera, del neonato e del bambino tra mite bracciale, possibilità di avere la madre durante il ricovero, il partner du rante il parto, presenza di personale volontario dedicato, ecc...). Il notevole afflusso delle pazienti extracomunitarie ha reso necessari la presenza fissa negli ambulatori ostetrico-ginecologici e neonatologici del P.O. Commenda della interprete filippina, araba e cinese. Oltre a promuovere e coordinare l’attività della cooperativa Kantara, il Servizio Sociale ha fin dal 1992 ha dedi cato l’attività di una propria operatrice ai rapporti con gli utenti stranieri. L’at tività è svolta anche con la collaborazione della Commissione Visitatrici ed i volontari del Movimento per la Vita. Nel 1995 è nato uno specifico ambulato rio nel P.O. di Via Commenda al Padiglione Bergamasco che, con il neonatologo-pediatra, l’infermiera, l’assistente sociale e gli intermediatori cul 82 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 turali (filippini, arabi e cinesi), assiste nel primo mese di vita il piccolo neona to extracomunitario, costituendo il necessario tramite tra ospedale e servizi socio-sanitari territoriali. Oltre all’attività a diretto contatto con l’utenza, sono stati tradotti in varie lingue (inglese, francese, spagnolo, filippino, cinese e arabo) i questionari che le ostetriche hanno stilato allo scopo di conoscere lo stato di salute ed aiutare le puerpere extracomunitarie nelle pratiche del parto. La stessa prassi è stata seguita per l’attuazione dei disposti della Legge 194, il servizio di ane stesia e rianimazione, il servizio S.V.S ed il servizio ambulatoriale d’analisi. La traduzione della modulistica nelle principali lingue è prevista in quasi tutti i reparti della nostra Azienda. Per migliorare ulteriormente questo programma, gli ICP hanno istituito un corso di formazione per neo-assunti e volontari mirato a fornire una maggior conoscenza delle norme e della metodica della azienda. Stringere una colla borazione più proficua tra personale medico, infermieristico e volontari non può che essere un beneficio per i pazienti e le loro famiglie. Relativamente al rispetto della privacy è stata ristrutturata parzialmente la sala parto prevedendo spazi idonei per la comunicazione medico-gravida familiare così come in Pronto Soccorso Pediatrico verrà attuata una migliore distribuzione degli spazi di accoglienza dei bambini che vi accedono. Infine la politica aziendale relativa alla tutela della privacy prevede il rispetto dei bisogni di riservatezza degli utenti in occasione di ogni visita, procedura e trattamento. Il paziente può richiedere la tutela di questo diritto nei confronti del personale, di altri pazienti e di familiari. Il bisogno di privacy deve essere rispettato anche durante i momenti di comunicazione riguardanti la salute. 6.6. La Mediazione culturale al Policlinico di Modena SIMONETTA FERRETTI – Ufficio Comunicazione-accoglienza - Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena Tab. 1. Gli accessi Anno 2001 2002 2003 Degenti stranieri 3.685 3.782 4.090 83 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 Tab. 2. Le etnie più rappresentate Etnia Albanese Romania Turchia Ucraina Ghana Marocco Nigeria Tunisia Filippine 2001 334 127 97 44 414 876 236 324 127 2002 337 154 97 73 368 923 212 344 137 2003 417 203 127 104 378 845 269 363 167 L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena garantisce ai propri utenti stranieri, dal 1997, interventi di mediazione culturale. Il servizio ha subito nel 2001 una importante modifica sul piano organizzativo, determi nata dall’esternalizzazione delle prestazioni. L’ufficio Comunicazione acco glienza ha la responsabilità di pianificare e controllare il servizio erogato; la cooperativa sociale Mediazione Linguistico Culturale Integra, individuata at traverso gara pubblica, ha il compito di svolgere il servizio sulla base di quan to concordato da contratto. Il servizio è attivo 24 ore al giorno, per sette giorni e si realizza attraverso la presenza costante dei mediatori nella fascia oraria 8/ 15.30, e la loro reperibilità dalle 15.30 alle 8. Risponde alle richieste di stranie ri rappresentativi di ogni nazionalità presente sul territorio, compresi gruppi minoritari. Il servizio offre: informazione, interpretariato, mediazione, media zione telefonica, conference call, sostegno psico-sociale, controllo della posi zione amministrativa dei pazienti stranieri ricoverati, traduzioni scritte, forma zione, consulenza nell’organizzazione dei servizi, consulenza sulla gestione dei casi. Nell’anno 2003 i mediatori culturali hanno assistito circa 1.800 perso ne straniere su un totale di 4.090 pazienti stranieri transitati o ricoverati. Per favorire l’accesso dei cittadini stranieri e per accrescere il loro bagaglio informativo, nel corso dell’anno 2004 l’ufficio Comunicazione accoglienza, con la collaborazione dei mediatori, si è dedicato alla costruzione della carta dei servizi ad hoc per la popolazione straniera. La carta dei servizi è composta dalla guida al Policlinico, le carte di accoglienza dei reparti, la guida alle asso ciazioni di volontariato ed il sito internet dedicato. La guida offre informazioni utili sull’accesso, la degenza e le dimissioni dall’ospedale, elenca i reparti e i servizi presenti all’interno della struttura ed esplicita le linee guida dell’azien da. La guida al Policlinico è disponibile in cinque lingue: italiano, arabo, in glese, albanese e rumeno, le lingue più parlate dai cittadini stranieri che, ad oggi, accedono alla struttura. Alla fine del 2004 saranno disponibili in lingua anche le carte di accoglienza di alcuni reparti. Si prevede per il 10 luglio l’atti 84 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 vazione del percorso, tradotto in lingua, dedicato agli stranieri ed agli opera tori interessati a fornire informazioni www.policlinico.mo.it . Consolidato il servizio di mediazione si è valutata l’opportunità di conosce re il giudizio espresso dagli stessi fruitori. é stata avviata un indagine di customer satisfaction che prevede la somministrazione di 200 questionari che indagano sulla percezione che gli utenti hanno in merito a: prenotazione e accettazio ne, prestazioni sanitarie, prestazioni alberghiere e mediazione linguistico cul turale. I questionari sono somministrati vis a vis da una persona plurilingue scelta fra mediatori culturali che non prestano la loro opera presso la nostra Azienda. I questionari verranno elaborati dalla società Data bank con cui il Policlinico effettua normalmente tali indagini. I reparti maggiormente rappre sentati per ovvie ragioni sono: ostetricia, nido, pediatria, neonatologia, gine cologia, chirurgia pediatrica, chirurgia della mano, chirurgia d’urgenza e ma lattie infettive. È inoltre, in corso una ricerca che permetta di individuare sistemi di indagi ne qualitativi mirati ai cittadini stranieri. 85 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 6 86 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 L’Ospedale senza dolore 7.1. Diffusione progetto ospedale senza dolore dall’azienda ospedale al territorio DONATELLA GIANNUNZIO, LEONARDO GALLI, ORNELLA BARDELLI, MARISA BONVINI, SIMONETTA BIANCHI - Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona AUTORE REFERENTE: DONATELLA GIANNUNZIO, Unità Operativa di Cure Palliative Azien da Istituti Ospitalieri Cremona - fax: 0372 405330, e-mail: [email protected] Il recepimento delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 24 mag gio 2001 e la Costituzione del Comitato Ospedale senza dolore con deliberazio ne aziendale 23 agosto 2001 hanno avviato nella Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona una intensa attività per la sensibilizzazione al problema del dolore. Dopo la prima rilevazione puntuale de dolore nelle corsie del dicembre 2001 (47,4% dei pazienti ricoverati nei due presidi dell’azienda) si è proceduto ad ap profondimento di tematiche particolari e preparazioni di linee guida interne nel 2002 per passare nel 2003 al corso di formazione permanente giunto ormai alla terza edizione ed al sottoprogetto di rilevazione del dolore nelle corsie. Dopo una sperimentazione di due mesi (Marzo ed Aprile 2003) in reparti selezionati del N.A.S. (Score verbale numerico), dalla fine del 2003 si è iniziato il progetto di rilevazione del dolore come quinto segno vitale in tutte le corsie dell’Azienda. Ciò ha permesso: 1. una revisione delle grafiche di reparto da cui è poi partito un ulteriore progetto di unificazione dipartimentale delle cartelle mediche; 2. una formazione itinerante del personale infermieristico nelle sedi delle Unità Operative prendendo spunto dall’utilizzo delle nuove grafiche; 3. una formazione simile del personale medico a tener conto delle nuove segnalazioni degli infermieri a proposito dei valori riportati sulle grafiche stesse (sempre per singola Unità Operativa); 4. un approfondimento di problematiche particolari per popolazioni di pa zienti che non potessero utilizzare il N.A.S. Quest’ultimo punto ha avviato uno studio sul dolore nel bambino che ha coinvolto ovviamente anche il secondo presidio dell’Azienda impegnato in un percorso di accreditamento secondo Joint Commission dal quale pure si sono tratti elementi per perfezionare la rilevazione. Si è inoltre avviato un percorso sul dolore nell’anziano e nel paziente con deficit cognitivo che ha visto la partecipazione delle principali strutture RSA della ASL di Cremona. 87 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 Tali RSA si sono affiancate molto volentieri all’Azienda Ospedale impegnando si nella sperimentazione di scale di rilevazione apposite per il paziente demente. È previsto per il 2005 una riunione per la presentazione dello studio e della sperimentazione che verrà eseguita anche nelle corsie riabilitative dell’Ospedale. Ciò è di grande rilevanza in una ASL dove gli anziani, le patologie croniche e le patologie tumorali sono in continuo incremento. 7.2. Uso delle tecniche non farmacologiche in oncoematologia pediatrica: l’esperienza del Servizio Terapia del Dolore dell’ospedale Meyer SIMONA CAPRILLI, MARIANNA SCOLLO ABETI, CATERINA TEODORI - Servizio Terapia del dolore – A.O.U. Meyer AUTORE REFERENTE: SIMONA CAPRILLI, Servizio Terapia del dolore A.O.U. Meyer, Via L. Giordano 13, 50131 Firenze - tel.: 055 5662456, fax: 055 5662400, e mail: [email protected] Introduzione Il bambino affetto da cancro va incontro a stati di dolore, non solo provoca ti dalla patologia, ma anche da procedure invasive. Per trattare il dolore, in combinazione con i farmaci, è raccomandabile che si usino specifiche tecniche per il rilassamento psicofisico che, coinvolgendo la sfera mentale, spostano l’attenzione del bambino lontano dallo stato di pa ura ed ansia che sta vivendo così da modificare la sensazione di dolore. Target Già un bambino di tre anni è in grado di applicare la tecnica della respirazione, che prevede una serie di profondi respiri ponendo particolare attenzione all’aria che entra e che esce dai polmoni. Con la regolarizzazione del respiro si attenua la tensione fisica. Altra tecnica è il rilassamento, che consiste nel far rilasciare al bambino i muscoli del corpo. Sempre dopo i tre, quattro anni, può essere inse gnata anche la tecnica della visualizzazione, dove il bambino compirà un vero e proprio “viaggio” con l’immaginazione. Si dice al bambino, dopo la respirazione ed il rilassamento, di pensare intensamente ad un luogo o ad una situazione in cui vorrebbe trovarsi, invitandolo a concentrarsi su ciò che accade in questo posto. Il passaggio successivo consiste nell’utilizzare un’ulteriore tecnica, la desensibilizzazione. Questa tecnica è indicata dopo i dieci - undici anni e prevede la concentrazione su una precisa parte del corpo dove è localizzato il dolore in modo da abbassarne la sensibilità. Anche la distrazione può essere usata efficace mente con il bambino in età scolare e prescolare, con giocattoli, libri, videocasset 88 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 te, musica, ecc... o coinvolgendolo in conversazioni su argomenti particolarmen te graditi. Per distrarre i bambini più piccoli sono particolarmente efficaci le bolle di sapone. Tali tecniche di rilassamento possono essere utilizzate da sole o inte grate alla farmacologia sia che il paziente necessiti di un’anestesia generale, di una sedazione profonda, o di una sedazione conscia. Infatti al momento dell’in duzione di un’anestesia o sedazione, il bambino può essere coinvolto con la re spirazione e visualizzazione o con la distrazione. Lo stesso vale per il risveglio; mentre il bambino riprende conoscenza lo si invita a respirare, rilassarsi, prende re energia, spiegandogli che tutto è andato per il meglio. Presentazione risultati Sono presentate le esperienze delle psicologhe del Servizio Terapia del Do lore nell’applicazione delle tecniche non farmacologiche per il dolore cronico e da procedura nel reparto di oncoematologia all’ospedale A. Meyer di Firenze. L’esperienza ci ha mostrato che per i bambini in età prescolare sono più utili le tecniche di distrazione, soprattutto durante l’induzione dell’anestesia e durante prelievi, mentre per bambini oltre 6 anni sono applicabili tecniche di rilassamento, respirazione e visualizzazione. Inoltre nella scelta della tecnica non si può prescindere dalla valutazione del le caratteristiche di personalità del bambino; la respirazione ed il rilassamento sono più indicati per bambini con capacità di concentrazione e di autocontrollo. Invece bambini più vivaci ed estroversi sono più adatti per la distrazione. Per costruire un rapporto di fiducia con l’operatore è importante preparare il bambino spiegandogli con parole semplici in cosa consiste la procedura, in modo da attenuare ansie e paure. All’interno di questo percorso un ruolo fondamentale è rivestito dal genito re in quanto è il migliore esperto del bambino, dei suoi bisogni e desideri. Nel trattamento del dolore i genitori diventano degli alleati che contribuiscono alla scelta ed al risultato della tecnica. Infatti se adeguatamente addestrati, i genitori applicano rilassamento, distrazione, respirazione, ecc... con il pro prio figlio durante il momento di dolore. 7.3. Progetto ospedale senza dolore – ASL 21. Valutazione dei primi risultati FERDINANDO CADREGARI, ROBERTO BELLINI, GIANPIERO PATRUCCO, FRANCESCO RICAGNI Terapia del Dolore Ospedale S. Spirito, Casale M.to (Al) AUTORE REFERENTE: FERDINANDO CADREGARI, tel.: 0142 434411, e-mail: [email protected] Introduzione La promozione del benessere della persona ricoverata in ospedale trova 89 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 nel corretto trattamento del dolore un aspetto prioritario, come anche evidenziato dalle normative nazionali e regionali in tema di “Progetto Ospe dale Senza Dolore”. In questo contesto presso l’ASL 21 l’anno 2003 ha visto, dopo la costituzione del Comitato OSD, l’attivazione del progetto con la fase preliminare di indagine sul problema dolore in ospedale, la progettazione e realizzazione del percorso formativo poliennale per gli operatori sanitari e, con l’inizio del 2004, la fase di prima applicazione. A distanza di sei mesi sono state eseguite le prime valutazioni dei risultati ottenuti, con particolare riferi mento al dolore postoperatorio, indice principale di sofferenza e disagio del paziente ricoverato. Materiali e metodi È stato analizzato il decorso postoperatorio di un campione di 300 pazienti delle diverse specialità chirurgiche sottoposti ad interventi di chirurgia mag giore, trattati con protocolli analgesici postoperatori omogenei e validati se condo le linee guida SIAARTI. Il monitoraggio è stato effettuato tramite regi strazione dei dati a diversi livelli: dolore (misurazione intensità tramite scala VAS a 6 punti, incidenza di effetti collaterali, livello di sedazione, richiesta di analgesici rescue); outcome del paziente (indici di gradimento, commenti e proposte tramite autocompilazione di questionario); indicatori generali (trend consumo di farmaci analgesici nei reparti chirurgici). Risultati Nelle prime 2 ore postoperatorie il dolore è risultato ben controllato (VAS _ 2,5) nella quasi totalità dei pazienti, raggiungendo un livello ottimale (VAS _ 1) dopo 3/4 ore. La richiesta di analgesici rescue è stata registrata per 126 pazienti in 1ª giornata e per 30 pazienti in 2ª giornata. Effetti collaterali signi ficativi (nausea e vomito) sono stati riportati per 36 pazienti, correlati alla somministrazione di oppioidi maggiori. I livelli di sedazione sono risultati non rilevanti. L’analisi dei questionari compilati dai pazienti alla dimissione ha ri levato, insieme ad un elevato grado di soddisfazione anche la necessità di una corretta informazione preventiva. I dati relativi al consumo dei farmaci analgesici mostrano un trend in crescita rispetto agli anni precedenti. Conclusioni L’analisi dei risultati dello studio, oltre ai dati favorevoli che ne derivano, evidenzia anche alcuni punti di criticità che richiedono l’adozione di misure correttive. Il non completo coinvolgimento del personale sanitario richiama la necessità di un più capillare lavoro di formazione e sensibilizzazione al pro 90 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 blema dolore. L’adozione di protocolli analgesici omogenei e standard non sempre rispetta le diverse esigenze operative ed organizzative dei vari reparti chirurgici; si rende pertanto necessario elaborare protocolli clinici e terapeutici flessibili ed adattabili alle varie realtà dell’ospedale. I dati ricavati dai questio nari di gradimento rilevano l’importanza della corretta ed esauriente informa zione preventiva, da fornire al paziente all’atto dell’accoglimento in ospedale mediante opuscoli informativi dedicati e durante la degenza attraverso corret ti rapporti interpersonali con gli operatori medici ed infermieristici. I buoni risultati raggiunti, che dimostrano come sia possibile contrastare il dolore postoperatorio, e i punti deboli rilevati rappresentano comunque uno stimolo a proseguire e migliorare il lavoro. Bibliografia 1. Linee Guida per la Realizzazione per un Ospedale Senza Dolore del 24/5/01, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 29/6/01, Serie Generale n. 149. 2. SAVOIA C, AMBROSIO F., Linee guida SIAARTI per il trattamento del dolore acuto e cronico, Minerva Anestesiol. 2000, 66 (1) 9, pp. 163-171. 7.4. La formazione degli operatori nel progetto ospedale senza dolore ANDREA VENEZIANI1, ANTONIO MOLISSO2, LUISA GAROFOLINI3, BRUNELLA LIBRANDI4 - 1Me dico U.O. Anestesia e Rianimazione, 2Medico U.O. Chirurgia vascolare, 3AFD U.O. Medicina Generale, 4Referente U.O. Educazione alla Salute ASL Firenze Il progetto HPH (Health Promoting Hospitals) Ospedale Senza Dolore, cui ha aderito anche la Regione Toscana, prevede varie fasi di attuazione concor date a livello regionale. All’inizio del 2003, presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, dopo la costituzione del Comitato Ospedale Senza Dolore, è stato organizzato un corso di formazione sul trattamento del dolore in fase acuta. Stima dei fabbisogni formativi La stima dei fabbisogni formativi è avvenuta per mezzo di un questionario regionale, precedentemente distribuito al personale medico e infermieristico dell’ospedale per individuare carenze cognitive e organizzative che sono sta te alla base del progetto. Precedenti esperienze didattiche sull’argomento, rivolte unicamente agli in fermieri dell’ospedale, al di là di un interesse notevole mostrato per l’argomento trattato, avevano in seguito avuto una ricaduta d’effetti piuttosto limitata. 91 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 Rivalutazione La nuova opportunità di un corso di formazione obbligatorio nell’ambito del progetto HPH, dava sicuramente la possibilità di conferire all’iniziativa una maggiore autorevolezza e di coinvolgere tutti gli operatori sanitari, medi ci, infermieri ed ostetriche dell’ospedale. Durante la fase di progettazione iniziale la rivalutazione della precedente esperienza ha fatto emergere l’importanza della metodologia partecipativa, ovvero, i limiti di un approccio didattico centrato sull’insegnamento incon gruente con una metodologia HPH basata sul ruolo proattivo sia del soggetto assistito che dell’operatore e favorente una relazione fondata sull’ascolto che tenga conto della soggettività della persona e della sua autonomia. Per proporre un percorso formativo che tenesse conto di queste esigenze i futuri docenti hanno partecipato ad un seminario di formazione formatori “La progettazione dei percorsi formativi orientati all’HPH” ideato e condotto dalla referente dell’U.O. Educazione alla Salute con animatori di formazione dell’ASL. Nuova progettazione Il seminario, della durata di 4 giornate, ha prodotto un notevole cambia mento in tutti i partecipanti e l’esperienza si è rivelata fondamentale per la stesura secondo criteri completamente nuovi del programma del corso sul dolore. Il nuovo progetto, si è basato sul nuovo orientamento didattico ed ha individuato come obiettivi specifici: • anticipare i bisogni dei pazienti; • monitorare in modo adeguato il dolore; • garantire con la terapia ed eventuali sue correzioni un dolore con score ≤ 3; • garantire sempre condizioni di sicurezza costruendo un percorso formativo mirante a migliorare la comunicazione multidisciplinare fra gli operatori coinvolti nel trattamento del dolore. Soggetti coinvolti Destinatari del corso sono stati tutti gli infermieri e circa un terzo dei me dici afferenti all’area chirurgica (U.O. di chirurgia, sale operatorie, ostetricia, DEA) per un totale di 235 persone di cui 144 infermieri e 53 medici e 44 ostetriche. Sono state effettuate 9 edizioni di corso di due giornate ciascuna per complessive 13 ore. Il materiale didattico ha compreso una dispensa sugli argomenti trattati e successivamente un CD-ROM contenente tutto il materiale presentato, i contenuti degli elaborati realizzati dai gruppi, e i ri sultati ECM. 92 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 Programma e metodologia La metodologia utilizzata nel corso si è basata su esercitazioni a piccoli gruppi interprofessionali con cui si è dapprima definito il dolore e successivamente si è mirato a far emergere le criticità del percorso di assistenza al dolore, a scapi to delle lezioni frontali limitate ad argomenti specifici: fisiopatologia e misura del dolore, farmacologia dei farmaci antidolorifici, monitoraggio clinico postoperatorio. Le indicazioni fornite dai risultati del questionario preliminare ci hanno spinto verso un cambiamento d’orientamento dei discenti dalla centralità dell’opera tore alla centralità dell’assistito seguendo peraltro quelle che sono le più re centi indicazioni HPH. Il percorso formativo è stato realizzato con un approc cio interprofessionale basandosi sul criterio di privilegiare la centralità dell’as sistito piuttosto che dell’operatore. I singoli hanno progressivamente perso il loro atteggiamento troppo individualistico: ognuno identificava e individuava inizialmente solo le problematiche del proprio specifico professionale del percorso assistenziale multidisciplinare. Mettendo insieme e affiatando le com petenze diverse, si è aumentata la motivazione e modificato l’orientamento verso l’obiettivo comune. Risultati Il corso ha ottenuto un successo, percepito e rilevato tramite i questio nari sul gradimento e per l’ECM, superiore alle aspettative. A nostro parere ha raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva: un cambiamento di cultura e di atteggiamento verso il dolore del paziente nel rispetto della sua soggettivi tà. Grazie a una maggior sensibilizzazione al problema si è cominciato a considerare il dolore e a misurarlo come un parametro vitale in maniera più sistematica: lo testimonia il numero di rilevazioni via via crescente ese guite nei reparti per ogni paziente. È aumentato il consumo dei farmaci antidolorifici, soprattutto quello di morfina. Sulla base delle criticità emer se durante le esercitazioni di gruppo è emersa la necessità di progettare un corso per migliorare negli operatori le competenze comunicative e relazionali, che coinvolge i referenti medici e infermieristici e le caposala di ogni corsia unitamente ai componenti del Comitato Ospedale Senza Dolore dell’ospedale. 93 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 7.5. Indagine conoscitiva sull’utilizzo di farmaci analgesici nelle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della provincia autonoma di Trento MARIA GRAZIA ALLEGRETTI1, MICHELINA MONTEROSSO1, GIOVANNI MARIA GUARRERA1, PAO LO ROMITI1, DINO PEDROTTI1, BENEDETTO PARODI1, BIANCA BORTOLAMEOTTI1, FRANCA DALLAPÈ1, CRISTINA PONTALTI1, ELISABETTA FONZI2, ENRICO BALDANTONI3 - 1Comitato Ospedale senza dolore, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; 2U.O. di Farmacia, Ospedale di Trento; 3Direttore Ospedale di Trento AUTORE REFERENTE: MARIA GRAZIA ALLEGRETTI, U.O. di Farmacia, Ospedale di Trento, Largo Medaglie d’oro, 38100 Trento – tel.: 0461 903691, fax: 0461 903458, e-mail: [email protected] Introduzione L’approccio terapeutico al dolore in ambito ospedaliero è spesso trascurato rispetto ad altri sintomi ritenuti più “importanti” perché il dolore stesso viene con siderato non come una priorità di cura, bensì come un evento quasi ineluttabile e che in ogni caso è pericoloso occultare. Questo atteggiamento è fortemente in fluenzato da stereotipi culturali che bisogna cercar di modificare con una efficace azione di formazione/informazione per poter incidere sui comportamenti. Si stima che solo il 40-45% dei pazienti ospedalieri che presentano il sinto mo dolore viene trattato in modo soddisfacente, anche se la disponibilità di strumenti terapeutici efficaci consentirebbe il raggiungimento di risultati posi tivi in oltre il 90% dei casi. Nel 2001 il Ministero della Sanità ha raccolto le indicazioni della comunità scientifica ed ha emanato linee guida per la promuovere la trasformazione verso “ospedali senza dolore” con lo scopo di creare ambienti favorevoli alla modifica degli atteggiamenti e dei comportamenti dei professionisti sanitari nell’approccio al sintomo dolore. Obiettivo Nel gennaio 2003 è stato costituito nella Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (APSS) il Comitato aziendale per l’“Ospedale senza dolore” (COSD) con la finalità di promuovere nelle struttu re sanitarie l’utilizzo dei farmaci analgesici efficaci, in particolare degli oppiacei, in aderenza alle indicazioni dell’OMS e di valutarne periodicamente il consu mo, considerato indicatore di processo di buona pratica clinica. A tal fine è stata fatta un’indagine conoscitiva sui consumi dei farmaci analgesici nelle strutture ospedaliere dell’APSS che ha una popolazione resi dente di 480.000 abitanti. 94 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 Presentazione e valutazione dei risultati L’indagine sui consumi ha coinvolto le sette strutture ospedaliere dell’APSS: due ospedali cosi detti “hubs” e cinque ospedali di distretto “spokes”. Attraverso il Servizio di controllo gestione aziendale è stato possibile reperire i dati di consumo e di metterli in relazione alle giornate di degenza. Per avere dei dati che fossero confrontabili fra le varie strutture, partendo dai dati di consumo, sono state calcolate le DDD (Defined Daily Dose). La DDD è un’unità tecnica utilizzata per presentare e confrontare statistiche rela tive al consumo dei farmaci e le DDD/100pz/die che esprimono la frazione di pazienti (esposizione) che, ogni giorno, nel periodo indicato, hanno ricevuto una DDD del farmaco in oggetto consentendo in questo modo di fare un confronto diretto tra popolazioni di numerosità diversa attraverso le seguenti formule: n=g/DDD e n=(n/gd)x100 dove n corrisponde al numero di DDD, g corrisponde ai grammi di farmaco utilizzati e gd corrisponde alle giornate di degenza nel periodo considerato. Per valutare il consumo di oppiacei è stata considerata l’esposizione media agli stessi nell’area medica nella quale l’esposizione è stata di 6,32 DDD/100pz/ die nel 2003, con un aumento di 4,38 DDD/100pz/die rispetto al triennio 2000/ 2002 precedentemente analizzato. Il consumo di oppiacei nell’area chirurgica ha presentato una esposizione media agli oppiacei stessi di 3,23 DDD/100pz/die nel 2003 con un aumento di 1,39 DDD/100pz/die rispetto al triennio 2000/2002 precedentemente analiz zato. Per quanto riguarda il consumo di analgesici non oppiacei (paracetamolo, ketorolac, ketoprofene, tramadolo), l’esposizione media agli stessi nel 2003 nell’area chirurgica è stata di 4,63 DDD/100pz/die con un aumento di 0,97 DDD/100pz/die rispetto al 2002. Conclusioni L’Ospedale senza dolore presuppone un cambiamento culturale di tutti gli operatori sanitari affinché il controllo del dolore sia effettivamente garantito a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Questo cambiamento richiede un impegno costante che si realizza attraver so la collaborazione multidisciplinare fra le diverse figure professionali coin volte nella gestione del dolore, iniziando dalla loro formazione/informazio ne. I risultati finora ottenuti dimostrano che l’attività di formazione e sensibilizzazione degli operatori sanitari si sta dimostrando efficace e consen te di passare dalle dichiarazioni di principio ai fatti concreti, misurando e do cumentando i miglioramenti conseguiti. 95 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 7.6. Il progetto “Ospedale e territorio contro il dolore” della rete veneta HPH SIMONE TASSO1, MARCO VISENTIN2, RENATA FERRARI2, LEONARDO TRENTIN2 - 1 Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto ULSS n.8, Coordinatore Rete Veneta HPH; 2 U.O. Terapia del Dolore ULSS 6 Vicenza, Rete HPH del Veneto, Responsabile Regionale del Progetto Introduzione Nell’ambito della Rete HPH il corretto trattamento del dolore è considerato un intervento di primaria importanza per promuovere il benessere dei ricove rati. L’interesse per l’argomento è presente sia a livello di singoli ospedali sia a livello di coordinamento HPH ed è testimoniato dal fatto che numerosi sono gli ospedali che spontaneamente (ma talora anche con un coordinamento regionale) hanno iniziato un Progetto contro il Dolore. Inoltre vi è una sensi bilità internazionale e nazionale al problema, testimoniata dal fatto che pro prio ai Progetti sul dolore è stato dato spazio in sessioni parallele in varie Conferenze sia nazionali (Castelfranco Veneto 2002, Torino 2003, Riva del Garda 2004) che internazionali HPH (Bratislava 2002, Firenze 2003, Mosca 2004). Affrontare appropriatamente questo argomento significa mettere in moto le azioni previste dalla Carta di Ottawa, perché proprio su questo argomento è importante “cambiare una cultura” che troppo spesso affronta il dolore con un atteggiamento fatalistico, considerandolo per lo più come un fatto inelut tabile, come parte integrante ed inevitabile della malattia. Si tratta, come suggerisce la Dichiarazione di Budapest, di agire con azioni multisettoriali sul personale, sui pazienti, sulla comunità. I professionisti sanitari, ad esempio, mostrano spesso importanti carenze riguardo al dolore, al suo trattamento e non lo considerano una priorità nella pratica medica attuale: - è sempre forte la convinzione che l’unico compito della medicina sia quello di guarire le malattie; - il dolore viene considerato solo come un sintomo, che è pericoloso occultare; - se un dolore non dipende da una causa evidente, non ci si sforza di comprenderlo, ma piuttosto lo si ignora. E’ naturale che con questi presupposti sia necessario intervenire anche sulla co munità per sensibilizzarla sul problema e cambiarne credenze ed atteggiamenti. L’esperienza della Rete Veneta HPH: il Progetto “Ospedale e Territorio senza Dolore” L’esperienza HPH del Veneto è partita da questi presupposti, cercando di creare un Progetto che tenesse conto delle Linee Guida Nazionali [1] e Regio 96 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 nali [2], della esperienza maturata dai colleghi che avevano lavorato per la fase nazionale del Progetto “Ensemble contre la douleur”, dei fondamenti della promozione della salute descritti nella Carta di Ottawa e nella Dichiarazione di Budapest. Il primo passo del Progetto è stata uno studio policentrico condotto negli ospedali di 6 aziende sanitarie del Veneto (ULSS n. 1 Belluno, ULSS n. 8 Asolo, ULSS n. 16 di Padova, ULSS n. 17 Este, ULSS n. 18 Rovigo, ULSS n. 21 Legnago). Lo studio ha coinvolto complessivamente 1325 ricoverati (alcuni anche in ospedalizzazione domiciliare) ed ha avuto fondamentalmente i seguenti prin cipali obiettivi: 1. misurare la prevalenza e l’intensità del dolore che i pazienti dichiaravano di percepire; 2. misurare l’idea di dolore che, su tali pazienti, veniva registrata dagli opera tori sanitari; 3. confrontare le due misurazioni, così da valutarne il grado di concordanza; 4. valutare le conoscenze e gli atteggiamenti nei confronti del dolore da parte degli operatori sanitari (medici ed infermieri). Lo studio si è tenuto nell’ultimo trimestre del 2002 ed ha coinvolto, oltre ai suddetti pazienti anche 1.636 operatori sanitari cui sono stati somministrati altrettanti questionari sulle conoscenze e sugli atteggiamenti nei confronti del dolore. I principali risultati possono essere così riassunti: prevalenza del dolore tra i ricoverati pari a 51,5% con valore medio del dolore pari a 2,50 (deviazione standard = 3,09) utilizzando la Numerical Rating Scale (NRS), una scala che prevede 11 livelli di intensità dolorifica che vanno da 0 (assenza di dolore) a 10 (dolore massimo). Il grado di concordanza tra dolore percepito dal paziente e dolore rilevato dall’operatore è stato calcolato mediante coefficiente K di Cohen che tiene conto anche della concordanza casuale. La K di Cohen è risultata 0,3746: valo ri di questo parametro inferiori a 0,4 significano scarso grado di concordanza. I suddetti questionari sulle conoscenze e atteggiamenti riguardanti al dolo re hanno presentato una percentuale di risposte esatte pari 51,2 % con un intervallo di confidenza (95%) compreso tra 50,5 % e 51,9%. Contemporaneamente al suddetto studio policentrico si è svolta nelle aziende una azione di sensibilizzazione della comunità sull’argomento: agli ingressi degli ospedali sono stati allestiti stand dove personale appositamente istruito illustrava il Progetto ai passanti e consegnava materiale informativo. Al tempo stesso, nella maggior parte delle aziende, sono stati predisposti comunicati stampa che hanno portato alla pubblicazione di articoli sui quotidiani locali. Particolare attenzione è stata posta anche alla pubblicazione di notizie sul giornali delle ULSS. 97 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 Sono state realizzate anche azioni rivolte al personale sanitario, dato che le risposte al suddetto questionario (rivolto agli operatori sanitari) hanno evidenziato che le conoscenze/atteggiamenti del personale sulla tematica dolore sono notevolmente migliorabili. La scelta del Gruppo di Lavoro Regionale è stata la produzione di materiale formativo (set di formazione) rivolto ai formatori dei nostri ospedali. Tale set è costituito da una videocassetta e da un fascicolo formativo. L’obiettivo è stato quello di facilitare l’attività dei formatori aziendali e, al tempo stesso, di attuare una formazione che fosse, per quanto possibile, uniforme nei diversi ospedali. La videocassetta contiene due tipologie di materiale: materiale teorico (re gistrazione di lezioni powerpoint) e materiale pratico contenente alcune sce ne recitate da attori nel ruolo di medici, infermieri, pazienti, presentando i più frequenti errori compiuti dal personale sanitario nella misurazione del dolore di pazienti ospedalizzati. Le scene sono utili, perché rappresentano una sorta di role playing standar dizzato e permettono di aprire una discussione sui coretti atteggiamenti per sonale sanitario nella misurazione del dolore. Oltre alle scene errate sono recitate anche quelle corrette da presentare ai discenti alla fine della discussione. La videocassetta è corredata da un fascico lo che contiene i testi delle lezioni teoriche e i testi dei copioni recitati dagli attori insieme alle più importanti indicazioni da seguire per la corretta misura zione del dolore. Prospettive Future Al di la della esperienza Veneta è da riconoscere che numerose e valide sono le esperienze sull’argomento da parte di Ospedali della Rete HPH Italia na [3-8], presentate anche a livello internazionale [9-12]. Forse i tempi sono maturi per intraprendere se non un vero e proprio un Progetto Italiano HPH almeno azioni comuni tra le diverse Reti HPH. Bibliografia 1. Deliberazione Giunta Regionale Veneta n. 309 del 14.2.2003. Documen to di indirizzo e coordinamento alle Aziende socio-sanitarie denominato “contro il dolore”. 2. Linee Guida per la Realizzazione per un Ospedale senza Dolore del 24.5.2001, “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29/6/2001”, Serie Generale n. 149. 3. MARRI E., PETROPULACOS K., MATARAZZO T., Il Progetto Ospedale senza Dolore 98 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 7 in Emilia Romagna, “Atti 7° Conferenza Nazionale HPH”, Torino 21-22 Novembre 2003. 4. MESSERI A., MORELLO MARCHESE P., Pain-Free Hospital: Tuscany Experience, “Abstract Book 12th International Conference on HPH”, Moscow, May 26 28, 2004. 5. MESSERI A., MORELLO MARCHESE P., Progetto Ospedale senza Dolore nella Rete Toscana: stato di avanzamento ad un anno di attività, “Atti 6° Conferen za Nazionale HPH”, Castelfranco Veneto 25-26 Novembre 2002, pp. 57-58. 6. PASQUARIELLO L., MUSI M., PESENTI M. et al., Percorso Formativo “Verso un Ospedale senza Dolore” dell’Azienda USL Valle d’Aosta, “Atti 7° Conferen za Nazionale HPH”, Torino 21-22 Novembre 2003. 7. RICAGNI F., BELLINI R., CADREGARI F., Progetto Ospedale senza Dolore nella ASL 21 Piemontese di Casale Monferrato, “Atti 7° Conferenza Nazionale HPH”, Torino 21-22 Novembre 2003. 8. TASSO S., VISENTIN M., Towards a pain-free hospital, “Abstract Book 12th International Conference on HPH”, Moscow, May 26-28, 2004. 9. VISENTIN M., TASSO S., Ospedale e Territorio contro il Dolore: il Progetto delle Aziende della Rete Veneta HPH, “Atti 6° Conferenza Nazionale HPH”, Castelfranco Veneto 25-26 Novembre 2002, pp. 59-60. 10. ZUCCO F., SOTTILI S., JACQUOT L. et al., Ospedale senza Dolore: la Rete Lom barda per sviluppare e valorizzare i Progetti Aziendali, “Atti 6° Confe renza Nazionale HPH”, Castelfranco Veneto 25-26 Novembre 2002, pp. 55-57. 11. ZUCCO F., SOTTILI S., RIPAMONTI C. et al., Pain-Free Hospital: an advanced HPH Project in Regione Lombardia. “Abstract Book 11th International Conference on HPH”, Florence May 18-20, 2003, p. 61. 99 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 100 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 L’Ospedale senza fumo 8.1. Il progetto anti-tabagismo nelle reti HPH italiane attraverso l’utilizzo del questionario ENSH SIMONE TASSO - Coordinatore Rete Veneta HPH, Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto ULSS n. 8 Introduzione La Rete Europea degli Ospedali Liberi dal Fumo (European Network of Smoke Free Hospitals - ENSH) ha messo a punto un questionario per la valu tazione dei progetti anti-tabagismo in ospedale. Tale questionario è basato su domande che hanno l’obiettivo di individuare il grado di aderenza dei suddetti progetti ad un codice che gli ENSH hanno prodotto con il fine di descrivere le principali caratteristiche di un ospedale libero dal fumo. In sostanza nel questionario viene esplicitato in domande il razionale di tale codice. Le domande riguardano vari aspetti del progetto qua li ad esempio l’impegno formale della azienda per mezzo di documenti, istitu zione di un gruppo di lavoro aziendale sul tabagismo, elaborazione di pro grammi di formazione. Sono previste sia riposte dicotomiche con risposta si/ no, sia riposte di tipo quantitativo con l’attribuzione di un punteggio a ciascu na domanda: da zero (attività/azione non iniziata) a 4 (completa realizzazio ne). Inoltre, dato il carattere sperimentale del questionario è sempre prevista la riposta “non applicabile” al fine di individuare eventuali problematiche o punti poco chiari del questionario. Inoltre, è stato previsto uno spazio in chia ro per eventuali osservazioni relativamente a ciascuna domanda L’idea degli ENSH è quella di produrre uno o pochi indicatori sintetici che rappresentino la situazione dell’ospedale e facilitino i confronti. Il più sinteti co di questi indicatori è il “totale score” cioè il punteggio totale ottenuto dalla somma dei punti ottenuti in ciascuna domanda. Il questionario viene periodicamente aggiornato e la versione utilizzata nel presente studio è la versione ENSH 2004 [Ouranou, 2003]. Risultati Il questionario è stato finora somministrato a 68 ospedali delle Reti HPH Ita liane (Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria). È apparso complessivamente valido ed in linea con i principi HPH nel rap 101 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 presentare le principali caratteristiche di un progetto anti-tabagismo. Tuttavia il questionario appare migliorabile in particolare in alcune domande dove più elevata è risultata la percentuale di risposte “non applicabile” (range tra 0 e 38 %). In aggiunta, sono pervenute anche domande prive di risposta (range 0 a 15 %). Sulla modalità di attribuzione dei punteggi sono arrivate utili osserva zioni. Ad esempio, la produzione di un punteggio finale dovrebbe tenere conto della diversa importanza delle domande. Inoltre alcune osservazioni riguar dano la modalità di elaborazione dei dati. Appare poco corretto trovare medie applicandole a variabili che non hanno un andamento quantitativo lineare (es. 2 non significa doppio di 1). Per questo le elaborazioni più appropriate appaiono le distribuzioni di frequenza. Conclusioni Il questionario ENSH si è rivelato un valido strumento di auto-valutazione, utile nella discussione tra pari sull’andamento dei progetti anti-tabagismo. Al cune domande (soprattutto quelle con percentuale più alta di “non applicabile” e/o prive di risposta) possono essere migliorate, rendendole più chiare sulla base dei suggerimenti da questo studio. Attenzione deve essere posta per una corretta modalità di elaborazione dei dati. Bibliografia OURANOU A., Performance Evaluation towards a smoke free organisation, in 8th Issue Newsletter “European Network Smoke Free Hospital”, November 2003. 8.2. Grado di aderenza agli standard europei per il controllo del fumo delle Aziende Sanitarie della Lombardia MARINA BONFANTI1, LUIGI MACCHI1, VITTORIO CARCERI2 - 1Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia, 2Consulente Assessore Sanità, Regione Lombardia AUTORE REFERENTE: MARINA BONFANTI, U.O. Prevenzione, Direzione Generale Sa nità Regione Lombardia, Via Pola 9/11, 20124 Milano - tel.: 02 67653236, fax: 02 67653307, e-mail: [email protected] Contesto La costituzione nel 1998 della rete Regionale Lombarda degli Ospedali per la Promozione della salute e la successiva approvazione nel 2000 delle Linee Guida per la prevenzione del tabagismo, hanno creato le basi per una nuova attività progettuale e per una revisione delle strategie di promozione della 102 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 salute attuate all’interno delle strutture sanitarie. In questo ambito il progetto regionale “Ospedali liberi dal fumo” risponde alla logica dell’ospedale pro motore di salute, che ha l’obiettivo di proporsi come modello di riferimento nella promozione di uno stile di vita senza fumo. I dati disponibili sui comportamenti e sulle abitudini degli operatori sanitari che lavorano negli ospedali italiani, indicano che fumano più della popolazione gene rale (33,3% contro 24,2%), che hanno scarse conoscenze sul fumo, che sono consci dei danni da fumo passivo e che molti desidererebbero smettere di fumare. Il personale sanitario dell’ospedale, quindi, nel porsi come modello ed esem pio di stili di comportamento e di vita sani e positivi, rappresenta un target molto importante su cui agire, in quanto occupa un ruolo prioritario rispetto alle altre componenti del tessuto sociale: infatti, incontrando le persone in vari momenti della vita nei quali il loro bisogno di salute è prevalente, può dare risposte adeguate, di tipo terapeutico e preventivo, su un substrato più ricettivo e sensibile ad un discorso di educazione alla salute. Obiettivo Valutare il grado di aderenza agli standard europei per il controllo del fumo delle Aziende Sanitarie pubbliche e private della rete Lombarda HPH a distan za di tre anni dallo sviluppo dei primi progetti HPH- “Ospedali liberi dal fumo”. Target Aziende Sanitarie pubbliche e private della rete HPH lombarda, operatori sanitari. Risultati Il questionario ha indagato su 9 aree tematiche: 1. Impegno dei responsabili dell’azienda (mandato istituzionale). 2. Comunicazione. 3. Educazione e formazione. 4. Assistenza alla disassuefazione dal fumo. 5. Delimitazione delle zone adibite ai fumatori (controllo). 6. Cartellonistica adeguata. 7. Luogo di lavoro libero dal fumo. 8. Promozione della salute. 9. Monitoraggio. Buoni risultati si sono ottenuti per i punti 5 e 6. In linea di massima, infatti, anche se in maniera disomogenea, sono stati individuati i locali in cui vige il divieto di fumo, affissi i cartelli di divieto di fumare e nominati i funzionari 103 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 addetti alla vigilanza antifumo. Trattandosi però di un processo in continua evoluzione si auspica che, attraverso un continuo monitoraggio, le disposi zioni di legge siano sempre integralmente rispettate. Notevoli margini di miglioramento necessitano invece i punti 2, 3 e 7, in quanto le iniziative formativo/informative organizzate dalle aziende sono poco attuate: sarà, quindi, opportuno operare affinché la formazione diventi un obiettivo specifico di un progetto più ampio di promozione di uno stile di vita senza fumo. In quest’ottica, anche le iniziative correlate all’applicazione del divieto di fumare, se accompagnate da azioni educative sui danni da fumo attivo e passivo, sulla possibilità di difendersi da essi e di disassuefarsi dal fumo di tabacco, sarebbero più efficaci. Infine, migliorabile è anche il punto 1, specificatamente per la politica aziendale nei confronti della lotta al fumo e per l’identificazione di risorse economiche ed umane necessarie ad incrementare tale strategia. Conclusioni Alla luce di quanto emerso, risulta necessaria: 1) un’implementazione delle strategie aziendali sul problema “fumo” da par te dei responsabili delle Aziende Sanitarie; 2) l’attuazione di un’ampia e specifica azione di informazione/formazione degli operatori sanitari sui danni da fumo, sulle regole comportamentali e sulle normative da rispettare e da far rispettare, sulle metodologie di disassuefazione dal fumo e sulla loro messa in opera. Ovviamente, perché tali possibilità trovino pratica attuazione è necessario che aumenti: - la coscienza della priorità della lotta al tabagismo tra le attività sanitarie; - la conoscenza del proprio ruolo in tale lotta da parte di tutto il personale sanitario; - il coinvolgimento di tutti i vertici aziendali; - l’azione continuativa di stimolo da parte della Direzione Generale Sanità su tutte le aziende sanitarie. Consapevole di tutto ciò la Direzione Generale Sanità intende continuare a lavorare per dare sostegno istituzionale e per essere un riferimento pratico a chi vuole intraprendere iniziative di lotta al tabagismo nella propria azienda sanitaria. Pertanto, le attività programmate per il futuro sono: - incontri periodici di aggiornamento e scambio di informazioni con i re sponsabili antitabagismo individuati dalle Aziende; - predisposizione di un pacchetto formativo per gli operatori sanitari, ad uso delle Aziende Sanitarie; - miglioramento della comunicazione tramite aggiornamento del sito web regionale; 104 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 - implementazione dell’adesione al progetto “HPH-Ospedali senza fumo”, anche tramite azioni di tutoraggio. 8.3. Verso un ospedale libero dal fumo GIORGIO GALLI - Responsabile URP e Ufficio Stampa, Coordinatore rete HPH Regione Autonoma Valle d’Aosta, Via Guido Rey 1, 11100 AOSTA - tel.: 0165 544418, fax: 0165 544587, e-mail: [email protected] Contesto Ad iniziare dal 2002 (anno di ingresso dell’Azienda USL Valle d’Aosta nella rete nazionale HPH), anche in applicazione delle normative contro il fumo nei locali pubblici, la nostra Azienda si è attivata in materia attraverso una serie di interventi, inizialmente legati all’applicazione della norma e all’infor mazione destinata agli operatori aziendali, successivamente attinenti la sfera della prevenzione, predisponendo progetti di salute mirati. Le fasi progettuali possono essere così schematizzate: 1) febbraio 2002: predisposizione di un regolamento sul divieto di fumare in tutte le strutture sanitarie (ospedaliere, territoriali, amministrative), ap plicazione delle nuove sanzioni e individuazione dei soggetti formal mente preposti all’accertamento delle infrazioni (di cui alla legge 448/ 2001); 2) febbraio-marzo 2002: adeguamento della apposita segnaletica e affissione di cartelli di divieto in tutte le sedi sanitarie; 3) marzo 2002: incarico, affidato al Dipartimento di Prevenzione, di effettua re, tramite i propri tecnici della prevenzione, verifiche a campione del rispetto delle norme contro il fumo; 4) aprile 2002: promozione e realizzazione di incontri informativi con il per sonale dipendente riguardanti l’applicazione delle disposizioni di legge; 5) aprile 2002: apertura di un ambulatorio per la disassuefazione dal fumo nell’ambito delle attività del reparto di Pneumotisiologia, in collaborazio ne con la sezione regionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed i medici di medicina generale; 6) aprile 2002: effettuazione di una campagna di monitoraggio sul rapporto tra fumo e comportamenti in luoghi pubblici (ospedale) dove il fumo non è ammesso, attuata mediante somministrazione di un apposito questionario a dipendenti e utenti. Il questionario è stato predisposto da un gruppo di stu denti dell’Istituto Magistrale “Maria Adelaide” di Aosta; gli stessi si sono oc cupati della distribuzione del documento e dell’elaborazione dei risultati. Questi ultimo sono poi stati presentati pubblicamente in occasione di una 105 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 conferenza stampa avvenuta il 31 maggio 2002, Giornata Mondiale senza Tabacco. Anche questa iniziativa è stata realizzata in sinergia con la LILT; 7) dal 2001 ad oggi: programma di prevenzione dei danni causati dal fumo di sigaretta messo in atto presso diverse istituzioni scolastiche regionali (classi V della scuola elementare, triennio media inferiore, biennio media supe riore). L’azione di tipo informativo-formativa è attuata dallo psicologo operante presso la LILT, che opera in stretta collaborazione con la nostra Azienda. I corsi sono stati avviati nell’anno scolastico 2001-2002. Da sotto lineare un continuo aumento di richieste di intervento da parte di un nu mero sempre maggiore di scuole, il che sta a dimostrare l’interesse e la sensibilità verso il problema. Nell’anno scolastico 2003-2004 si è registrato un incremento di richieste pari al 35%; 8) anno 2003: organizzazione di n. 2 corsi per la disassuefazione dal fumo rivolti ai dipendenti aziendali, sempre in collaborazione con la LILT. Ogni corso si è articolato in 10 incontri (presenti psicologo e dietologo) + 3 incontri di follow up. 9) autunno 2003: organizzazione della mostra di poster e manifesti contro il fumo dal titolo “Immagini filtrate – Chi non fuma...vince!”, in collaborazio ne con Sovraintendenza agli Studi della Regione Valle d’Aosta; 10) 24 maggio 2004: inaugurazione della mostra “Immagini filtrate” presso la biblioteca regionale di Aosta, comprendente oltre 50 lavori prodotti da gra fici professionisti, pittori aderenti all’Associazione Artisti Valdostani, studen ti dell’Istituto d’Arte di Aosta che hanno aderito spontaneamente e gratuita mente all’iniziativa. é stato inoltre realizzato un catalogo con le riproduzioni dei lavori esposti. L’iniziativa ha coinvolto scuole e popolazione in genera le. La mostra ha carattere itinerante, tant’è che verrà riproposta nei diversi ambiti regionali in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico 2004-2005. Mostra e catalogo verranno poi messi a disposizione dei partner della rete HPH che volessero presentarla nella propria regione. 11) 31 maggio 2004: promozione della Giornata Mondiale senza Tabacco at traverso un incontro destinato agli studenti delle scuole medie inferiori per “lanciare” il progetto “Chi non fuma...Vince!”. Alla manifestazione, che si è svolta presso la sala conferenze della biblioteca regionale di Aosta, sono stati invitati gli studenti (con i rispettivi docenti) di alcune scuole medie inferiori di Aosta, destinatari “pilota” di una serie di messaggi a loro rivolti da medici, psicologi e testimonial del mondo dello sport. Il progetto di promozione della salute, in stretta collaborazione con la Sovraintendenza agli Studi, verrà attuato nell’anno scolastico 2004-2005 attraverso la pro duzione da parte delle scuole della regione di spot contro il fumo, di ma nifesti e poster, di brevi pièce teatrali. La presentazione dei lavori e la premiazione saranno oggetto della Giornata Mondiale senza Tabacco del 31 maggio 2005. 106 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 Gruppo/target Essendo passati dalla fase applicativa e informativa riguardante la norma a quella vera e propria di promozione della salute (e, più in generale, di promo zione di corretti stili di vita) i destinatari sono fondamentalmente gli studenti (scuole elementari e medie) che non hanno ancora avuto l’approccio con il tabacco. Più in generale l’azione di sensibilizzazione è rivolta a tutta la popo lazione, promuovendo i corsi per la disassuefazione dal fumo di sigaretta. Valutazione dei risultati Si intende realizzare una campagna di monitoraggio estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado, per verificare il numero degli studenti fumatori e pre disporre interventi mirati. Conclusioni Il programma di prevenzione va mantenuto nel tempo pianificando interven ti sempre più capillari nei confronti della popolazione scolastica, maggiormen te esposta al rischio di avvicinamento alla sigaretta. Va infine aggiunto che lo stesso programma va collocato all’interno di un più ampio progetto di educa zione alla salute che riguarda, in generale, un corretto stile di vita dove rientra no a pieno titolo altri programmi attivati dall’azienda: corretta alimentazione, svolgimento di attività sportiva e, per l’appunto, astensione dal fumo e dall’alcol. 8.4. “ASL NA1 Libera dal fumo”: un progetto di rete “Ospedali per la promozione della salute” HPH SARA DIAMARE1, RENATO MONTELLA2, ALFREDO SAVARESE3, ANGELO MONTEMARANO4 - 1Di rigente Psicologa Coordinatrice rete aziendale HPH – Servizio Controllo Qua lità ASL Napoli 1; 2Direttore Servizio Formazione e Aggiornamento Professio nale ASL Napoli 1; 3Direttore Servizio Controllo Qualità ASL Napoli 1; 4Diret tore Generale ASL Napoli 1 AUTORE REFERENTE: SARA DIAMARE, Servizio Controllo Qualità, ASL Napoli 1, Cen tro Direzionale Isola F9, Palazzo Esedra, 80143 Napoli – tel.: 081 2544419, fax: O81 2544418, e-mail: [email protected] Oggetto “ASL NA1 Libera dal fumo” è un intervento per l’adesione dell’ASL Napoli 1 alla Rete HPH dell’OMS. L’ASL Napoli 1, su cui si insediano 15 Presidi 107 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 Ospedalieri/Intermedi, è la più grande d’Europa. Un miglioramento della co municazione, all’interno della ASL, è risultato essere il giusto veicolo per una campagna contro la dipendenza da fumo di tabacco nel suo significato di sostituzione socio - affettiva. Obiettivi Diffondere una cultura di rispetto e sostegno reciproco, a partire dall’am biente ospedaliero; stimolare i propri operatori a divenire opinions leaders, implementando, a partire da loro stessi, comportamenti che vadano nella di rezione di corretti stili di vita rispetto al consumo di fumo di tabacco. Gruppo/i Target Operatori sanitari fumatori e non, ed a cascata per gli utenti e la comunità tutta, riguardante la dipendenza psicologica e sociale ed il consumo di fumo di tabacco, con metodiche di gruppo per stimolare processi di identificazione e di sostegno reciproco. Metodi Formazione; auto aiuto; riorientamento dei Servizi Sanitari; diffusione in formazioni; implementazione della rete con strutturazione di gruppi di lavoro interistituzionali. Valutazione/strumenti Somministrazione di questionari di apprendimento, di soddisfazione, di gestione del divieto, di misura della dipendenza da fumo di tabacco (Test di Farghestrom), della motivazione a smettere di fumare, interviste a campione, osservazioni e focus-group (a distanza di sei mesi e un anno) per verificare i cambiamenti intervenuti nell’atteggiamento degli operatori nei confronti del fumo. Domande circa le fonti dell’informazione durante colloqui di accetta zione e numero di accessi negli ambulatori antifumo valutano l’efficacia della circolazione delle informazioni. Risultati parziali - Sono state formate 50 Sentinelle Antifumo con compiti sanzionatori e infor mativi. - Sono stati attivati n. 3 Punti Informativi Antifumo. - È aumentato l’accesso agli ambulatori antifumo già presenti. 108 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 - Sono stati somministrati test e questionari per una prima mappatura epidemiologica. - Si è riorientata l’informazione per garantire l’accesso a percorsi di dissuefazione dal fumo di sigaretta. - Si è individuata la biblioteca HPH (Centro Educazione alla Salute). - L’organizzazione di rete è attiva sia a livello centrale, con la presenza uffi ciale dell’alta dirigenza in gruppi di lavoro, sia a livello Ospedaliero con la attivazione di Comitati Tecnici Locali. 109 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 8 110 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 L’empowerment dei pazienti, del personale e della comunità 9.1. Effe Elle Esse: come conciliare tempo famiglia lavoro salute ROSARIA AVISANI, ALFONSO CASTELLANI, SABINE GALLERI, NADIA GUERCÈ, M. DORIS MARCHETTI, LUCIO MASTROMATTEO, ANNARITA MONTEVERDI, SERGIO PAGHERA, PAOLO PEZZOTTI, ADALGISA PRICOCO, BENEDETTA VENTURELLI - Spedali Civili di Brescia AUTORE REFERENTE: ROSARIA AVISANI, A.O. Spedali Civili di Brescia - tel.: 030 3995959, fax: 030 3995954, e-mail: [email protected] Breve introduzione di contenuto In questi anni parliamo spesso “di complessità, di stress e di corse contro il tempo”, quali fattori sociali ed elementi incidenti sulla qualità della vita e sulla serenità di ognuno di noi, pur se con intensità e rilevanza diversi. Pur condividendo ogni aspetto di queste analisi, è oltremodo difficile agire sui fattori di stress nel settore sanitario e nella gestione delle nostre Aziende Ospedaliere. Il nostro settore vive infatti un livello di stress notoriamente e no tevolmente elevato, ma le nostre direzioni strategiche devono misurarsi con la quadratura dei budgets, la integrazione dei diversi profili professionali, il mi glioramento organizzativo e il raggiungimento degli obiettivi strategici. Il tutto cercando di migliorare la qualità di vita del singolo operatore sanitario, elemen to basilare per una migliore qualità organizzativa e di prestazione sanitaria. I punti di partenza che hanno portato l’Azienda ad un progetto in grado di conciliare Tempo Famiglia, Tempo Lavoro e Tempo Salute, sono stati: 1. l’intensità dei ritmi lavorativi; 2. la forte femminilizzazione; 3. il lavoro a turni; 4. la difficoltà alla fidelizzazione delle figure professionali; 5. il rapporto fiduciario tra Direzione Aziendale e Operatori; 6. gli effetti delle trasformazioni aziendali; 7. i problemi di natura socio economica; 8. “dall’umanizzazione alla personalizzazione dell’assistenza”. Obiettivi 1. Miglioramento del ben-essere dei cittadini dipendenti. 111 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 2. 3. 4. 5. Validazione scientifica del modello di Asilo Nido Aziendale. Miglioramento del clima organizzativo aziendale. Miglioramento del modello di cura, verso la personalizzazione dell’assistenza. Replicabilità del modello. Gruppo target Dipendenti dell’Azienda e ai loro bambini e bambini dei genitori ricoverati. Valutazione Tab. 1 Obiettivi Risultati / azioni 1. Miglioramento √ Elevato livello di gradimento del benessere dei dell’iniziativa cittadini dipendenti 2. Validazione scientifica del modello 3. Miglioramento del clima organizzativo aziendale Indicatori • Andamento del numero di bambini iscritti • La percezione della validità e della qualità del servizio a livello cittadino • Numero di adesione alla “Progettazione Partecipata” √ Costituzione del Comitato • applicazione e rispetto del Scientifico “codice etico” √ Coinvolgimento delle • la continuità dell’educatrice Università e delle famiglie di riferimento √ Ben-essere dei bambini • effetti dell’alternanza dei turni e della relazione con il gruppo dei bambini di riferimento • l’ambiente √ Coinvolgimento degli • analisi dei risultati del operatori sanitari sugli questionario sulla soddisfazione obiettivi strategici e operativi dell’utente aziendali • la permanenza presso l’azienda √ La fidelizzazione del del personale coinvolto dipendente • il livello di turn-over; rientro √ Mantenimento dalla maternità allo scadere dell’investimento sul progetto dell’istituto obbligatorio e da parte della Direzione disponibilità al rientro sui turni strategica • maggiore disponibilità alla √ Clima positivo da parte modifica del turno lavorativo; dei dipendenti nei confronti • le risorse economiche occupate dell’A.O. √ Aumento della domanda occupazionale nei confronti dell’A.O. 112 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 4. Miglioramento del modello di cura, verso la personalizzazione dell’assistenza 5. Replicabilità del modello √ Coinvolgere il territorio • il numero e la tipologia di iniziative, integrative promosse • sinergie tra diversi soggetti istituzionali e non • numero, tipologia di famiglie ed età dei non dipendenti • in merito al modello di “promozione della salute”, l’utilizzo di “momenti informativi sulla salute”, ecc. √ Fare conoscere l’esperienza • numero e tipologie di contatti; a livello nazionale • numero e tipologie di nuove √ Partecipare a convegni esperienze √ Mettere a disposizione delle • analisi dei punti di forza/di altre realtà il modello ed il debolezza delle eventuali nuove progetto esperienze sulla funzione educativa e la promozione della cultura per l’infanzia √ Sviluppare sinergie tra i diversi soggetti istituzionali √ Produrre un cambiamento culturale nell’agire dell’operatore sanitario Conclusioni Effe Elle Esse appare, in sostanza, come un ampio progetto di cambiamen to culturale che investe anche la dimensione assistenziale. Accompagnando in maniera non traumatica il passaggio in atto da una “Sanità microcosmo statale” a quella di “Sanità aziendale” e, progressivamente, a quella di “Sanità microcosmo persona”, centrata sul cittadino. 9.2. Dietoterapia in gravidanza: la consulenza nelle gestanti sovrappeso/ obese VANDA LAURO1, MAURO CONTER2, VITTORINO CALESTANI1, SIMONETTA BIANCHI1 - 1Istituti Ospitalieri di Cremona, Ospedale“Oglio Po” Reparto di Ginec. e Ostetricia, Casalmaggiore (CR); 2Ricercatore, Università di Parma AUTORE REFERENTE: VANDA LAURO, Via Guicciardini 13, 43100 Parma - tel.: 0521 961340, fax: 0375 281493, e-mail [email protected] Contesto Il sovrappeso e l’obesità sono –specie in gravidanza – un fattore di rischio per varie patologie che possono compromettere la salute della donna, con possibile riduzione/arresto della crescita del feto e prematurità. 113 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 Obiettivo Curare l’alimentazione delle gravide, sia a livello preventivo/educativo (le zioni specifiche durante i 6 Corsi di Preparazione al Parto a disposizione delle circa 550 donne che partoriscono ogni anno nel nostro Centro e Corsi di For mazione per il personale sanitario organizzati in numero di 5 dal 1998 su “Ali mentazione e Salute”), sia a livello terapeutico, nell’Ambulatorio di “Dietoterapia in Gravidanza”- operativo anch’esso dal 1998 con circa 200 con sulenze /anno- al fine minimizzare il ricorso ai farmaci durante la gestazione. Gruppi Target Gruppo Target generale: donne gravide. Gruppo Target specifico: donne gravide sovrappeso/obese - Indice di Mas sa Corporea (IMC) ≥ 25. Metodologia Raccolta l’anamnesi nutrizionale con un “Diario Alimentare/Sintoma tologico”, appositamente predisposto, nel quale la gravida registra per 7 gior ni i cibi ingeriti – specificandone le quantità – nonché i sintomi avvertiti, si analizza insieme alla paziente il “Diario” e si concordano variazioni dietetiche personalizzate. Ciò anche con l’ausilio di uno schema che rappresenta in ma niera semplificata l’elenco dei macronutrienti e dei cibi che li contengono in maggiore quantità. In caso di ricovero per le patologie più gravi (alterazioni pressorie/ preeclampsia, colestasi intraepatica) viene somministrata per alcuni giorni la “dieta dell’urgenza”: ipocalorica, iposodica e ipolipidica a base di cibi a forte presenza di amidi e di vegetali. In base poi all’evoluzione della sintomatologia e all’anamnesi si personalizza il menù. Presentazione e valutazione dei risultati Nell’esame dei “Diari”si è sempre rilevato un eccesso calorico derivante soprattutto da lipidi e da zuccheri semplici. Le indicazioni mediche miravano - oltre a suggerire una maggiore attività fisica – a ridurre tali eccessi, stimolando l’introduzione di una maggiore quan tità di vegetali, di alimenti ricchi di amidi e di pesce, con riduzione dell’uso dei condimenti grassi e salati. L’aiuto dei familiari è stato fondamentale per far sì che già al momento di fare la spesa si comprassero certi cibi anziché altri e che poi li si preparassero riducendo sia i condimenti che le porzioni troppo ricche. 114 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 L’analisi dei dati/patologie delle gravide sovrappeso/obese (147 donne) afferite al nostro Ospedale ambulatoriamente o in regime di ricovero, nonché i relativi esiti perinatali, evidenzia: - età media 30 anni (deviazione standard: 6); - variazione ponderale media a fine gravidanza rispetto al valore dichiarato di inizio gravidanza + 10,6 Kg. (DS:7; una paziente è aumentata di 34 Kg.; una è diminuita di 11 Kg., pur avendo partorito un feto di 3.400 g.). Tab. 1 IMC Inizio Gravidanza 25,0-29,9 Sovrappeso 30,0-34,9 Obesità 1 >35,0 Obesità 2 e 3 n. gravide 70 48 29 Percentuale 47,6% 32,7% 19,7% Tab. 2 Patologie più frequenti presentate dalle 147 No gravide % gravide sovrappeso/obese ipertensione/ preeclampsia 62* 42,2 problemi inerenti all’apparato digerente 27 18,4 cefalea 18 12,2 coliche biliari, colestasi intraepatica 14 9,5 iperglicemia o glicosuria 12 8,2 coliche renali 3 2,0 Edemi 32 21,8 Altro: lipotimie, tunnel carpale, cistiti recidivanti, 10 6,8 artrite psoriasica ... *di queste 26 sono state trattate anche con terapia medica, le altre 36 si sono norma lizzate con la sola Dietoterapia - Durante la loro gravidanza, 24 donne hanno fruito di 6-10 consulenze, 53 ne hanno ricevuto 3-5 e le restanti 60 una o due. - Delle 147 gravide, 48 hanno subito almeno un ricovero. Anche tra esse la patologia più frequente è stata quella legata all’ipertensione (34 su 48). I restanti ricoveri sono stati effettuati per problemi epatici, coliche renali, dia bete e iperemesi. Conclusioni Scomparsa o riduzione dei sintomi senza uso o con uso ridotto di farmaci. Nonostante oltre la metà (51,7%) di queste gravide presentasse patologie se vere (alterazioni della pressione arteriosa o del fegato), 137 (il 93,2%) hanno partorito dopo la 36° sett. di gestazione, con neonati che nel 91,8% dei casi presentavano un peso ≥ 2.500gr (peso medio dei neonati 3.280 gr, DS: 610). Visti i risultati, si ritiene importante accompagnare la gravida con problemi di peso con una consulenza personalizzata di Dietoterapia. 115 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 9.3. Il Centro di Alcologia: promozione della salute dall’ospedale al territorio TERESITA GROTTOLO, LORETTA BORTOLAMEOTTI, SANDRO CARPINETA - Centro di Alcologia, Distretto Sanitario Alto Garda e Ledro, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento AUTORE REFERENTE: SANDRO CARPINETA, Centro di Alcologia, Via Rosmini 5, 38066 Riva del Garda - tel.: 0464 582670, e-mail: Carpineta.Sandro@arc. apss.tn.it Introduzione Il CdA opera nel Distretto Alto Garda e Ledro, e si pone quale punto di riferimento per persone e famiglie con problemi alcol-correlati, attiva percorsi riabilitativi, svolge funzione di consulenza per l’ospedale e per la Commissio ne Provinciale Patenti, progetta ed attiva interventi di prevenzione, sensibilizzazione e promozione della salute nella comunità. In questo ambito il CdA ha progettato interventi, rivolti agli utenti e/o ai dipendenti dell’ospe dale e più generalmente alla comunità, che si sono concretizzati in tre progetti specifici. Questi, pur contenendo al loro interno numerosi momenti e punti di contatto, vengono qui presentati separatamente. Progetto 1: “Referenti alcologici di reparto” Obiettivi 1) aumentare la capacità e sensibilità nell’individuazione dei ricoverati che presentano Problemi Alcol Correlati; 2) aumentare nei reparti di degenza l’informazione e sensibilità degli opera tori e dei degenti per l’adozione di stili di vita sani. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’individuazione, in ogni repar to di degenza, di un Referente Alcologico di Reparto. Gruppi target Tutti i ricoverati degenti nei reparti ospedalieri ed il personale delle U.O. di degenza. Risultati Vengono continuamente monitorati 1) n. colloqui/anno effettuati in ospedale; 2) n. di persone che hanno avuto un contatto con i CdA o che sono entrati nei gruppi di riabilitazione; 3) il n. di iniziative promosse in ogni U.O.; 4) livello di gradimento e collaborazione riscontrati. 116 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 Progetto 2: “Insieme per rompere con il fumo” Obiettivo Ridurre l’abitudine al fumo di chi vive l’ospedale come operatore sanitario o come utente, in particolare favorendo la crescita e la presa di coscienza dei dipendenti attraverso una riflessione sul proprio ruolo educativo nei confron ti del cittadino ricoverato e della comunità Azioni - valutazione del fenomeno; - promozione di counselling nei confronti di dipendenti fumatori; - individuazione di un Referente per il Fumo di Reparto (R.F.R.); - adesione al progetto di tutte le U.O.; - programmazione di “Corsi di disassuefazione al fumo” per i dipendenti; - coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, degli Amministratori dei Comuni della zona e dei rappresentanti delle scuole. Gruppi Target Tutti i dipendenti di ogni U. O. e Servizi del Distretto Alto Garda e Ledro. Risultati Vengono rilevati indicatori sul n. degli ex-fumatori, sulle adesioni di U.O. al progetto, il numero di dipendenti formati come R.F.R., le iniziative da questi attuate e i livelli di gradimento. Progetto 3: “Coordinamento Alcol e Guida” Anche se questo progetto trova sul territorio la sua ragione d’essere ed il suo principale terreno di operatività, và ricordata la sua esistenza soprattutto in funzione di alcune collaborazioni con le strutture sanitarie. Il Coordinamento Alcol e Guida è nato per dare una risposta integrata ai problemi dell’alcol sulla strada. é un gruppo di lavoro composto da: 1) centro di alcologia; 2) forze dell’ordine (Polizia di Stato, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Municipali); 3) autoscuole. Il gruppo di lavoro agisce in maniera trasversale con iniziative che coinvol gono di volta in volta specifici gruppi della popolazione. Un campo specifico di interazione è quello con la sanità, sia informale che formale. 117 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 Gruppi target Genericamente tutta la popolazione. Sottoprogetti specifici vengono poi rivolti a gruppi particolari Risultati Gli indicatori utilizzati, e monitorati annualmente, riguardano il n. di pro getti ed interventi attuati ed i livelli di gradimento Conclusioni Queste esperienze, tuttora in corso, indicano con chiarezza la possibilità di sviluppare progetti ed interventi in cui sia possibile coniugare positiva mente il successo di un’iniziativa con la economica realizzazione della stes sa. Oltre a questo aspetto è opportuno sottolineare che la scelta di una modalità che poggi fortemente sulla integrazione (quindi ruoli, funzioni, competenze diverse dei soggetti interessati) e sul coinvolgimento (riscoprire le capacità dell’individuo/operatore attraverso una crescita della sua moti vazione) porta a risultati non solo evidenti e quindi misurabili, ma che met tono anche in moto “volani” positivi nel rapporto utente – operatore - co munità. 9.4. Un modello assistenziale a supporto dei bisogni globali del paziente oncologico Dott. FABRIZIO ARTIOLI1 (Direttore Unità Operativa Medicina Oncologica), Dott. KATIA CAGASSI1 (Dirigente Medico, Unità Operativa Medicina Oncologica), Dott. MARIA GRAZIA RUSSOMANNO1 (Psicologa Unità Operativa Medicina Oncologica), Dott. STEFANO CONCETTI2 (Direttore Presidio Unico), Dott. ANNE MARIE PIETRANTONIO1 (Direttore di Stabilimento), O.P.C. ANGELA RIGHI1 (Coordinatore Unità Operati va Medicina Oncologica); 1 Ospedale di Carpi, AUSL di Modena; 2AUSL di Modena AUTORE REFERENTE: DOTT.SSA ANNE MARIE PIETRANTONIO, Direttore Ospedale di Carpi, AUSL di Modena, Via Cav. Molinari 2, 41012 Carpi (MO) - tel.: 059 659402, fax: 059 659401, e-mail: [email protected] Introduzione del contesto Il reparto di Oncologia dell’Ospedale B. Ramazzini di Carpi (Azienda U.S.L. di Modena) supporta il bacino di utenza dell’Area Nord della Provincia di Modena. Con il supporto di associazioni di volontariato e di gruppi di mutuo-aiuto, il reparto di Oncologia è da tempo impegnato in iniziative di promozione della 118 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 salute in un contesto che vede tutto il personale impegnato ed orientato a supporto del paziente e della famiglia, nel difficile percorso che si profila a seguito di una diagnosi di neoplasia. Nella cura delle neoplasie, le cure mediche, pur costituendo un elemento essenziale del trattamento, non rappresentano la risposta completa ai bisogni dei pazienti. Una diagnosi di neoplasia, può comportare ripercussioni legate non solo alla necessità di far fronte allo stato di perdita della salute fisica, ma anche a fattori emozionali, di perdita del benessere psicologico e della capacità di gestire in maniera adeguata i compiti della vita quotidiana. In questo contesto il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Carpi è impe gnato ad assicurare un’offerta di prestazioni sanitarie e di servizi di supporto per la risposta al complesso dei bisogni dei pazienti che si rivolgono al repar to. Nel 2002 è stato a tal fine istituito un programma orientato al miglioramen to della qualità delle cure, basato su criteri di “centralità del paziente”. Il progetto coinvolge medici, infermieri, psicologi, volontari, familiari ed altri care givers. L’Obiettivo chiave del programma, orientato alla “centralità del paziente” è di fornire all’ammalato l’opportunità di essere personalmente coinvolto nelle decisioni che riguardano il trattamento e la cura e di orientare i medici, le infermiere, la famiglia e gli altri care givers, a considerare la persona in una dimensione olistica: di considerare cioè, non solo le sue necessità fisi che, ma anche i suoi bisogni di supporto psicologico nella gestione della malattia. Questo consente di superare una visione puramente tecnicistica della cura, riorientando l’offerta delle cure mediante programmi personalizzati in un ambiente fortemente impegnato a supportare la persona, attraverso un’atten zione costante all’esperienza soggettiva del paziente. Il progetto è stato realizzato mettendo in atto tre principali strategie: 1. Il coinvolgimento del paziente nel processo assistenziale: lo staff medico informa il paziente sulla diagnosi e coinvolge il medesimo nella scelta del la strategia terapeutica. Ciò consente al paziente di diventare un partner nell’ambito del processo di cura mediante la sua partecipazione alla defini zione delle decisioni sanitarie che lo interessano. 2. Il supporto psicologico: oltre alle ordinarie cure mediche e infermieristiche il reparto fornisce il supporto di uno psicologo e di gruppi di mutuo-aiuto che consentono al paziente e alla sua famiglia di affrontare i cambiamenti sperimentati per effetto della malattia. L’alleanza e la cooperazione tra lo staff medico, lo psicologo, i gruppi di mutuo-aiuto e l’assistenza professio nale di personale specializzato in musicoterapia, arte e joga, ha consentito a tutti gli interessati nel processo di cura di capire che “lavorare insieme”, 119 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 “comunicare”, può costituire un importante supporto nel percorso di gua rigione. 3. La valutazione della qualità del processo assistenziale: il monitoraggio pe riodico delle aspettative e della soddisfazione dei pazienti e delle famiglie sono sistematicamente utilizzati dallo staff quale feed back, per la discus sione della qualità e dei risultati delle cure fornite. Risultati A far tempo dal 2002 il programma di cura orientato al paziente oncologico ha coinvolto circa trecento ammalati e le loro famiglie ed ha consentito lo sviluppo di un piano di azione coordinato a risposta dei loro bisogni. La scelta di adottare un approccio olistico, che prende in considerazione anche la vita e i suoi significati, ha consentito alle parti interessate di svolgere il ruolo di “partecipanti attivi” nel processo di cura. 9.5. Strategie globali e pratiche riflessive: la promozione della salute degli operatori nella manipolazione dei farmaci antiblastici LIVIANA TAVANTI1-2, GIANNA ALDINUCCI1, IDA DI PAOLA1, GIULIANO GIORNI4, DONATELLA NARDI5, PAOLO GHEZZI5, GIOVANNI CINTI1, LUCIO COLONNA2, MONICA CALAMAI3 - AUSL 8 Arezzo; 1Sezione Medico Competente, 2Coordinamento HPH, 3Direttrice Sani taria AUSL 8, 4Unità Farmaci Antiblastici, 5Dipartimento Oncologico AUSL 8 AUTORE REFERENTE: LIVIANA TAVANTI, Ospedale S. Donato, AUSL 8 Arezzo, Via P. Nenni 52100 Arezzo - tel./fax: 0575-254666/67 Introduzione Nell’ambito del programma internazionale degli ospedali per la promozio ne della salute è previsto che gli stessi si attivino per promuovere, accanto ai compiti tradizionali (diagnosi, cura, riabilitazione), le condizioni affinché gli utenti e gli operatori possano implementare la tutela della propria salute an che attraverso il potenziamento delle capacità personali. Obiettivi Il presente abstract descrive il processo seguito nell’AUSL 8 al fine di mettere in atto quanto contenuto nel Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 5/8/99 sulla sicurezza e la tutela della salute degli operatori addetti alla manipo lazione dei farmaci antiblastici, in un’ottica complessiva i cui principi orientativi sono mutuati sia dal d.legisl. 626/94, sia dai programmi/metodologie dell’HPH. 120 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 Gruppi target e metodi Le strategie attivate nei confronti del personale coinvolto nella preparazio ne e manipolazione dei farmaci antiblastici, in un’ottica globale, hanno inte ressato: gli aspetti strutturali, gli aspetti organizzativi, la definizione di risorse materiali idonee. A questi va aggiunto anche lo sviluppo di comportamenti per aumentare il controllo su tematiche come quelle della corretta gestione degli antiblastici e per affrontare le decisioni inerenti la salute individuale. é infatti evidente che la piena realizzazione di quanto previsto dalle linee guida nazionali dipende anche dall’introduzione di cambiamenti che investono la competenza professionale degli operatori durante tutte le fasi del processo lavorativo che riguarda la manipolazione dei farmaci antiblastici (fasi di pre parazione, di somministrazione, di sanificazione e di smaltimento). Questi ultimi aspetti sono stati affrontati in un percorso formativo nella cui fase di progettazione, come in quella di erogazione del corso, si è cercato di privile giare modalità didattiche riflessive centrate sulle realtà in cui i soggetti vivono e lavorano. La pratica professionale è divenuta il punto di partenza del per corso di cambiamento rispetto alla problematica da affrontare. Tali modalità hanno permesso di negoziare un agire collettivo, cioè di concordare nuovi comportamenti che hanno trovano nei protocolli operativi prodotti un punto di condivisione. Valutazione dei risultati L’esperienza si configura come un processo di promozione della salute al l’interno dell’ospedale dove si sostiene la salute degli operatori sanitari attra verso l’attivazione di processi globali (strutturali, organizzativi, gestionali e formativi) per facilitare cambiamenti individuali e di gruppo rispetto ai pro blemi della gestione dei farmaci antiblastici. In particolare, la formazione orien tata ai principi della partecipazione attiva, della riflessione sulla pratica, della negoziazione e della condivisione, è divenuta lo spazio in cui gli aspetti teori ci-scientifici si sono “ricomposti/coniugati” con quelli pratici, superando così quella dicotomia che, talvolta, può accompagnare il confronto tra la teoria e la pratica e che può rendere meno incisivi i processi formativi. L’utilizzazione di protocolli operativi condivisi e la scelta dell’audit clinico come strumento di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, in rapporto agli obiet tivi individuati e negoziati, hanno rappresentato gli strumenti per la valutazio ne dei risultati attesi. Conclusioni Fra le attività di promozione della salute sviluppate dall’ospedale, è oppor 121 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 tuno che siano inseriti anche le problematiche che riguardano la sicurezza e la tutela della salute degli operatori. L’approccio metodologico e gli strumenti dell’HPH, come ad esempio l’empowerment for health, ben si coniugano con la filosofia che sta alla base del d.legisl. 626/94, configurandosi come impor tanti sinergie. é inoltre evidente che la tutela della salute degli operatori in ambito lavorativo, non può rimanere enucleata rispetto alle altre problematiche della sicurezza, ma va pensata in interazione con altre problematiche ad essa collegate come ad esempio la sicurezza degli utenti, la sicurezza nei processi diagnostici e terapeutici, le relazione interpersonali e le modalità comunicati ve. 9.6. Umanizziamo la morte encefalica SAURO FRANCESCHINI, SERGIO ARDIS, MORENO MARCUCCI, GRAZIELLA DI QUIRICO, LUCIA PULITI, MAURO GIRALDI - Azienda USL 2 Lucca AUTORE REFERENTE: GRAZIELLA DI QUIRICO, Presso Direzione Sanitaria Ospedale Campo di Marte (Lucca) - tel.: 05839701, e-mail: [email protected] Introduzione La tecnicizzazione della medicina è riuscita a modificare anche alcuni even ti della nostra vita quale il nascere ed il morire. Morire in rianimazione non ha niente a che vedere con la morte “naturale”. Le tecniche rianimatorie permet tono di salvare tante persone che altrimenti non sopravvivrebbero ma hanno come rovescio della medaglia l’aver creato un morire tecnologico che rischia di essere ancor più doloroso per i familiari di un deceduto. In alcuni casi a seguito di coma postanossico o accidente cerebrovascolare o traumatismo cranico, le funzioni cerebrali vengono completamente e definitivamente perdute e inizia quel processo del morire che oggi conoscia mo come morte encefalica. Un collegio medico accerta la morte encefalica mediante tre visite e vari esami strumentali. Il periodo di accertamento di morte varia, a seconda dell’età del deceduto, da 6 a 24 ore. La fase acuta del processo del lutto ha come fenomeno più eclatante la negazione. Si tratta di un meccanismo di difesa dell’Io messo in atto per pro teggersi dal dolore insopportabile che la perdita della persona cara genera. La morte inattesa, come quasi costantemente è la morte encefalica, rende ancora più eclatante la negazione della morte. La tecnologia che circonda il decedu to, la ventilazione meccanica, la presenza di fenomeni di vitalità organica arti ficialmente indotti con macchine e farmaci, rappresentano spunti reali che alimentano le idee deliranti della negazione. Un fattore che contribuisce a rendere disumana la morte in rianimazione 122 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 è la scarsa possibilità che viene data ai familiari di restare accanto al dece duto in morte encefalica. Lo scarso tempo disponibile per stare a contatto con il deceduto (per noi deceduto, ma vivo nella psiche dei familiari!) ali menta la negazione. Anche le fantasie di sofferenza ed il dolore da lutto anticipatorio sono aumentate dall’impossibilità di essere vicini alla perso na cara. Alla luce di quanto sopra accennato gli infermieri della rianimazione hanno deciso di realizzare un progetto per contribuire a rendere più umano per i familiari il momento della morte di un paziente in rianimazione. Obiettivo Rendere più umano il momento della morte ai familiari dei pazienti che decedono in rianimazione in morte encefalica. Target La progettazione è stata realizzata dal personale infermieristico di rianimazione che realizzerà le azioni necessarie. I destinatari finali del proget to sono i familiari delle persone decedute in morte encefalica. Azioni I degenti della nostra rianimazione sono solo adulti, pertanto il periodo di osservazione di persistenza delle condizioni neurologiche che definiscono la morte encefalica è di norma di sei ore. Durante queste sei ore devono essere eseguite le tre visite dal collegio di accertamento di morte. Durante i due in tervalli fra le tre visite gli infermieri di turno faranno sostare i familiari più prossimi al deceduto (genitori, coniuge o convivente e figli) per un tempo non inferiore a trenta minuti. In tal modo i familiari avranno avuto la possibi lità di stare con il loro caro almeno per un’ora nelle ore di accertamento di morte. Valutazione dei risultati Il personale infermieristico dovrà prendere nota per ogni deceduto dei fa miliari a cui è stato dato il permesso di sostare con il deceduto, l’ora di inizio e l’ora di fine di ogni accesso. Il risultato atteso è che il 100% dei familiari più prossimi al deceduto abbia avuto la possibilità di stare vicino alla persona cara durante il periodo di accertamento di morte, per almeno due periodi e per almeno un’ora complessiva. 123 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 Conclusioni La morte di una persona cara è ai vertici della scale di stress e sicuramente una delle esperienze più dolorose che ognuno noi può vivere. La modalità in cui si verifica la morte influisce sul decorso successivo di elaborazione del lutto da parte di chi ha perduto la persona cara. In tal modo umanizzare que sto momento della morte non è solo atto umano, ma anche sanitario, in quan to prevenzione della patologia e della cronicizzazione del lutto. 9.7. La presa in cura del paziente fragile nel Dipartimento di Medicina interna dell’Ospedale di Trento LUISA SPIANI, ADRIANA DALPONTE, ROBERTA PIFFER - Azienda Provinciale per i Servi zi Sanitari, Trento Il progetto si propone di dare un maggior orientamento all’attuale organiz zazione dell’assistenza nella direzione di una pratica basata sulla presa in ca rico dei pazienti più complessi. I modelli di presa in carico non sono ancora codificati, ma si concretizzano con una attenzione ad alcuni momenti cruciali del percorso del paziente, in particolare: - accettazione medica e infermieristica accurata con attenzione a raccogliere dati sulla situazione clinica, personale, sociale, anche attraverso l’uso di scale o griglie per valutare i livelli di criticità e quindi la necessità di una attenzione particolare; - monitoraggio quotidiano dei pazienti critici; - pianificazione della dimissione che deve iniziare prima possibile e deve coinvolgere i famigliari, può prevedere talvolta solo interventi informativi o di addestramento per continuare l’autocura fino ad attivazione di reti e servizi più complesse; - garantire a tutti i pazienti standard assistenziali accettabili (uniformando l’operato con piani standard condivisi per tipologia di pazienti) e personaliz zando l’assistenza nei casi che lo richiedono; - creare tempi e spazi concreti ma anche “mentali” di ascolto; - esperienze di follow up dopo la dimissione per consulenze al bisogno. Nelle riunioni che hanno preceduto questa fase sono stati dibattuti questi aspetti e analizzati anche nel confronto con evidenze ed esperienze di altri paesi. Dalle interviste con le caposala si è rilevato che questi processi rappresen tano delle criticità e quindi necessitano di miglioramento. 124 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 Ripensare i processi assistenziali e organizzativi in questa direzione impli ca: - una riflessione culturale diffusa e condivisa con tutti gli infermieri; - una elaborazione più procedurale (es. dell’accettazione, dimissione, piani standard,..) che dovrà essere allineata con il lavoro della Joint commission e gli obiettivi di budget; - contestualmente l’individuazione di ambiti di autonomia e responsabilizza zione, con spazi di discrezionalità e scelte nell’accompagnare il paziente nel suo percorso; - una tensione degli infermieri a differenziarsi scegliendosi un campo di ap profondimento e di specializzazione formativa (per rispondere a questa at tesa sarà necessario aiutare ciascuno a costruirsi un piano di sviluppo e di crescita specifico); - in prospettiva potrebbe emergere la necessità di individuare “integratori di processo”, per esempio un infermiere responsabilizzato nelle dimissioni o altro; - questi ruoli di integrazione e di responsabilizzazione richiederanno di ridisegnare il ruolo della caposala. 9.8. Salute, sport e stili di vita: “Chi si ferma è perduto! 2” CARLA STEFANIA RICCARDI - Direttore Generale Azienda USL Valle d’Aosta Contesto: informare la popolazione sui corretti stili di vita ed in particolare sui benefici dell’attività fisica I soggetti coinvolti sono stati: medico sportivo, dietologo, cardiologo, psi cologo, allenatore, ufficio comunicazione. Queste le azioni: a) predisposizione di 5 volumetti da distribuire alla popolazione dedicati ai benefici derivanti dalla pratica costante di attività fisica visti dagli specialisti coinvolti; b) organizzazione di 4 serate sul territorio (in corrispondenza dei 4 distretti in cui è articolata la Regione), durante le quali gli specialisti coinvolti hanno relazionato sul tema dei corretti stili di vita, ed in particolare sull’attività fisica; c) organizzazione, con la collaborazione del CONI e dell’Assessorato del Turi smo e Sport, nonché con l’intervento dell’Istituto Superiore di Sanità, della giornata nazionale dello sport, con dimostrazioni pratiche delle varie disci pline e divulgazione del messaggio inerente i corretti stili di vita. 125 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 9 Gruppo/target: tutta la popolazione. Scenari futuri 1. riproposizione del messaggio, individuando particolari categorie di perso ne su cui adeguare, nella pratica, i corretti stili di vita, in particolare l’attivi tà fisica più idonea; 2. effettuazione di una campagna di monitoraggio presso la struttura ospedaliera, finalizzata a verificare l’adozione o meno di corretti stili di vita da parte del personale sanitario; 3. verifica dei risultati e attivazione di corsi formativi-informativi destinati al personale medico-infermieristico affinché anche gli operatori sanitari di ventino protagonisti del progetto a favore degli utenti della struttura ospe daliera. 126 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 La continuità assistenziale 10.1. Integrazione Ospedale e Territorio: il progetto della Rete HPH Piemonte - Valle D’Aosta CLEMENTE PONZETTI1, MASSIMO LEPORATI1, ANGELO PENNA2, CHIARA GALOTTO3 - 1Azien da USL Valle d’Aosta; 2 Azienda Sanitaria Locale 12 Biella; 3Azienda Sanita ria Locale 5 Collegno AUTORE REFERENTE: CLEMENTE PONZETTI, Direttore Sanitario Azienda USL Valle d’Aosta, Via Guido Rey 1, Aosta - tel.: 0165 544511, e-mail: ponzetti.clemente@ uslaosta.com Introduzione Il progetto qui presentato ha preso avvio nella seconda metà del 2003, a partire dal 2004 è stato condiviso un protocollo di attuazione per il periodo 2004-2007 che viene di seguito sinteticamente descritto. Al momento attuale hanno fornito la loro definitiva adesione al progetto 18 Aziende Sanitarie del Piemonte e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, oltre che, con funzioni di supporto e coordinamento organizzativo, il CIPES Piemonte. L’esigenza espressa da queste Aziende è stata quella di costruire percorsi co muni tesi all’integrazione dell’assistenza sanitaria tra Ospedale e Territorio, condividendo le più significative esperienze sviluppate dalle varie Aziende e le evidenze offerte dalla letteratura scientifica. Il numero di Aziende e la com plessità del progetto hanno reso necessario la suddivisione del lavoro in tre sottoprogetti di seguito indicati. Obiettivo del progetto è quello di: - definire i requisiti organizzativi che possano rendere un ospedale integrato con il territorio; - fornire alle Aziende Sanitarie Regionali informazioni, esperienze e strumenti per programmare una migliore integrazione tra ospedale e territorio; - documentare, laddove possibile, attraverso indicatori le esperienze aziendali e i progetti che hanno realizzato l’integrazione e quelli che al contrario non hanno raggiunto l’obiettivo prefissato. Gruppo target Pur nella consapevolezza che i bisogni dei cittadini rappresentano il riferi mento a cui questo progetto, come gli altri della rete HPH, si ispirano, il pre 127 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 sente progetto vede, come propri destinatari intermedi, i professionisti della sanità, sia in veste di decisori sul singolo paziente (medici infermieri ecc.), sia in veste di decisori delle politiche sanitarie locali e regionali, cui verrà offerta una rassegna di esperienze, requisiti e percorsi organizzativi funzionali ad una presa in carico complessiva dei bisogni del paziente. Sono state a questo scopo definite due diverse strategie operative: 1. verranno selezionati, tra le Aziende piemontesi, progetti esemplificativi di una concreta integrazione ospedale-territorio, attraverso la documentazio ne di risultati conseguiti (attivazione di servizi, ambulatori, numeri verdi, ecc.), strumenti utilizzati (opuscoli informativi, reti di comunicazione fun zionanti ecc.) e laddove possibile di impatto sul paziente (riduzione ricove ri ripetuti, anticipazione diagnostica ecc.). Le evidenze desunte dai progetti aziendali costituiranno la base principale per la costruzione dei requisiti di un Ospedale integrato; 2. si procederà ad una revisione della letteratura sugli interventi per l’integra zione ospedale territorio a partire dalla bibliografia disponibile presso la rete internazionale HPH e di quella presente in specifiche banche dati (Cochrane Library, linee-guida, riviste di pubblicazione secondaria ecc.) nonché la collaborazione con centri di documentazione regionali e nazio nali. Sulla base delle esperienze e dei progetti realizzati dalle aziende e dei temi principali studiati in letteratura, si è deciso di suddividere il progetto in tre sottoprogetti e altrettanti gruppi di lavoro: A. Comunicazione, informazione, che ha per oggetto lo studio delle tecnolo gie dell’informazione e comunicazione per favorire l’integrazione (internet, telemedicina, numeri verdi e call center, opuscoli per i pazienti ecc.); B. Linee-guida e percorsi assistenziali, che ha per oggetto lo studio dell’utilità delle linee-guida e dei percorsi assistenziali per migliorare l’assistenza nelle patologie ad elevata esigenza di integrazione: scompenso cardiaco, diabe te, ictus, patologia ortopedica, ecc.; C. Modelli organizzativi per la dimissione: che ha per oggetto lo studio degli strumenti utili ad una corretta dimissione ospedaliera (lettera di dimissione, dimissione protetta, ADI, Lungodegenza, Unità di valutazione geriatria e ospedaliera, ruolo dei caregivers ecc.). Presentazione e valutazione dei risultati Il progetto è ormai giunto alla definitiva pianificazione e iniziale attuazio ne. Al termine del progetto si prevede di produrre un documento da diffonde re all’Assessorato regionale, alle Aziende nonché alla componente clinica ospedaliera e territoriale che documenti le esperienze realizzate e le evidenze della letteratura in tema di integrazione. 128 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 Conclusioni Il percorso avviato è ambizioso, ma l’occasione offerta dalla Rete HPH per il miglioramento della qualità dei servizi sembra aver facilitato l’adesione con vinta al progetto da parte delle singole aziende partecipanti. 10.2. Il progetto HPH della ASL n. 3 di Pistoia come strategia per lo sviluppo della promozione della salute nell’ottica della complessità MARIA JOSÉ CALDÉS PINILLA1, FABRIZIO SIMONELLI2 - 1 ASL 3 di Pistoia; 2Centro di Coordinamento della Rete HPH Toscana AUTORE REFERENTE: MARIA JOSÉ CALDÉS PINILLA, U.O. Educazione e Promozione alla Salute ASL. 3 Di Pistoia,Viale Matteotti n. 19, 51100 Pistoia L’affermarsi del nuovo paradigma della salute dopo l’enunciazione dei prin cipi della Carta di Ottawa (1986) ha reso necessario un ripensamento del ruo lo dei servizi sanitari e stimola oggi anche la ridefinizione dei profili dei pro fessionisti sanitari. La promozione della salute - come processo sociale, politico, culturale che si propone di migliorare lo stato di salute degli individui e della comunità attraverso la costruzione di capacità che consentano alle persone di esercitare i propri diritti e le proprie responsabilità nel modellare gli ambienti, gli stili di vita, le relazioni sociali- è direttamente connessa al tema della complessità. Alcuni dei principi della complessità possono allora essere utili per assu mere orientamenti coerenti con il nuovo paradigma della promozione della salute: il principio di auto-organizzazione, il principio ricorsivo, il principio dialogico e il principio ologrammatico. Muoversi nello scenario della complessità insomma significa avere consa pevolezze e strumenti di orientamento che consentano di orientare il sistema dei servizi sanitari verso nuovi orizzonti, acquisendo significati per se stessa, per i destinatari della propria azione, per la comunità di riferimento. Considerando che il progetto HPH è particolarmente complesso in quanto sviluppa promozione della salute e viene condotto in un contesto organizzativo molto articolato, dinamico e in continuo cambiamento, sembra necessario correlarlo con i principi e i criteri che la teoria della complessità sta mettendo a fuoco. In questa ottica la ASL n. 3 di Pistoia in collaborazione con il Centro di Coordinamento della Rete HPH Toscana sta elaborando alcuni indirizzi di azio ne. 129 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 10.3. Un Dipartimento per l’integrazione sociosanitaria ANNA GRAZIA GIULIANELLI - Montecatone Rehabilitation Institute S.P.A., via Montecatone 37, 40026 Imola (BO) - tel.: 0542 632811, fax: 0542 632805, e mail: [email protected] L’Ospedale di Montecatone è una struttura con 150 posti letto dedicati a pazienti con gravi cerebrolesioni (22 pl.) e a pazienti con lesione midollare (44 pl. per Acuti, 66 per Post Acuti). Può accogliere i pazienti a poca distanza temporale dall’evento lesivo gra zie agli 8 pl di Terapia intensiva e ai 10 pl. di Sub I. Ha 10 pl. di DH per controlli successivi al primo ricovero. La maggior parte dei pazienti ricoverati deve fare i conti con una disabilità inemendabile: la tempestività dei soccorsi, le conoscenze sull’intervento in emergenza, le nuove tecnologie sanitarie, i nuovi farmaci, consentono la so pravvivenza di persone destinate, fino a qualche anno fa, a soccombere al l’evento lesivo. Le gravi cerebrolesioni e le lesioni spinali cervicali sono fra le cause principali di grave disabilità acquisita. Ciò significa che le strutture ospedaliere sono chiamate a misurarsi con patologie gravissime per le quali il recupero è spesso modesto. L’ospedale di Montecatone è considerato un punto di eccellenza per la riabilitazione di pazienti che hanno compromesse funzio ni fondamentali: il movimento autonomo degli arti, nelle persone con lesione midollare, le funzioni superiori, nelle persone con grave cerebrolesione. Su perata la fase d’emergenza, comincia per il paziente ed i familiari, un percorso doloroso e difficile. Accompagnati dagli operatori, dovranno fare i conti con una situazione nuova e completamente sconosciuta che modificherà abitudi ni e stili di vita di tutto il gruppo familiare. Si tratta di un lavoro complesso che comprende aspetti sanitari, psicologici e sociali: la disabilità, da patologia, diventa una condizione di vita. é importante intervenire, fin dai primi momen ti del ricovero, con l’obbiettivo di riportare il paziente a vivere nel territorio di appartenenza: se in terapia intensiva l’holding è molto forte, già negli acuti si lavora per sostenere le espressioni di autonomia di un paziente che, nella maggior parte dei casi, ha un enorme bisogno di assistenza. In ospedale i tempi della cura e dell’assistenza sono pianificati in segmenti organizzativi ormai consolidati mentre con questi pazienti, che restano ricoverati molto a lungo, occorre prevedere opportunità ed esperienze a sostegno del percorso riabilitativo, che favoriscano la consapevolezza della condizione fisica e del recupero possibile. A Montecatone è stato istituito da pochi mesi un Dipartimento per il Reinserimento, con un Responsabile che fa capo alla Direzione Sanitaria in sieme al Responsabile del Dipartimento Riabilitativo. Il Responsabile del Dip. per il Reinserimento coordina, con un gruppo di 130 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 operatori trasversale alle professioni ed ai reparti, le azioni e gli interventi per promuovere il ritorno a casa dei pazienti ricoverati, attivando dal loro ingresso i contatti con il territorio di appartenenza. A tale scopo si sta lavorando ad una procedura che preveda una prima comunicazione con il MMG ed il Responsa bile del Distretto per segnalare il ricovero e la situazione clinica del paziente. A questa farà seguito una seconda comunicazione ed un contatto diretto con i servizi territoriali per cominciare ad affrontare i nodi di un rientro a casa: la necessità di un’assistenza particolare, la presenza di barriere architettoniche nella casa, l’individuazione degli ausili adeguati a sostegno dell’autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, la presenza di una condizione professionale da riprendere, gli studi da completare. Sono ambiti determinanti per la qualità della vita delle persone con disabilità acquisita sui quali ancora si sta lavorando molto poco, lasciando alla buona volontà degli operatori, peraltro fortemente impegnati nell’assistenza, il lavoro con il territorio. D’altro canto i servizi territo riali non sono ancora attrezzati a ricevere persone con disabilità grave. L’ospedale di Montecatone ha scelto di mettere il paziente al centro dell’in tervento: il Dipartimento per il Reinserimento è una risposta innovativa nell’organizzazione sanitaria ospedaliera e vuole essere un investimento per una sanità che fa del paziente il protagonista del suo percorso riabilitativo. 10.4. La progettazione multiprofessionale dei percorsi del paziente per la garanzia di continuità assistenziale DANILO ORLANDINI, FRANCO PRANDI, ROSANNA CARBOGNANI, CRISTINA PEDRONI, ANTONIO CARBOGNANI, GIANPAOLO GAMBARATI, ELENA CASADEI TURRONI, PIERANTONIO MAGNANI, DANIELE GOVI - Azienda USL di Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: DANILO ORLANDINI, Qualità e Accreditamento Azienda USL di Reggio Emilia, Via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia – tel.: 0522 335440, fax: 0522 335120, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto I percorsi assistenziali sono piani interdisciplinari di cura e/o assistenza pre disposti ed usati da chi eroga prestazioni sanitarie per stabilire la migliore sequenza di azioni per interventi su pazienti affetti da specifiche patologie (soprattutto croniche). In una azienda sanitaria territoriale i percorsi assisten ziali devono tenere conto di tutti le fasi della cura, che devono essere note e dichiarate, perché questo permette di conoscere meglio i bisogni dei pazienti, al fine di interiorizzarli nei servizi forniti perché le prestazioni non siano epi sodi isolati di cura ma si inseriscano in un flusso controllato dal sistema ed in linea con le esigenze e le attese dei pazienti. 131 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 Obiettivo/i Un’organizzazione governata per processi deve promuovere la gestione delle malattie mediante la definizione di percorsi assistenziali con l’obiettivo di orien tare tutte le azioni ad una visione di sistema. L’organizzazione applica i percorsi assistenziali a tutti i livelli (dall’unità operativa a specifici programmi assistenziali) con particolare riguardo alle malattie croniche, allo sviluppo di un sistema di comunicazione efficace ed alla partecipazione del paziente Gruppo/i target Gruppi multiprofessionali di pianificazione dei percorsi sono attivi in ambi to oncologico/cure palliative, cardiologico, pneumologico, diabetologico, ortopedico, ematologico, screening, ecc... I pazienti entrano in una rete di assistenza in grado di assicurare le comuni cazioni e di individuare il punto migliore a cui indirizzarli. Il sistema aziendale orienta la gestione per processi alla applicazione dei percorsi assistenziali (indicatori) e si confronta con la comunità locale con i piani di zona Presentazione e valutazione dei risultati Da alcuni anni il sistema di valutazione aziendale raccoglie anche dati sulla continuità assistenziale. (Es.: 1- Casi presi in carico dal SID nei tre giorni successivi alla dimissione, che non erano stati segnalati dai reparti di degenza; 2 - Esistenza di piani di lavoro integrati tra le aree (Cure Primarie, SERT, Dipartimento salute mentale, Sociale); I lavori di pianificazione in corso puntano all’individuazione di indicatori di processo e dove possibile di esito significativi e misurabili. Conclusioni Se l’organizzazione riesce a dotarsi di percorsi assistenziali per i temi clini co assistenziali più frequenti e/o più critici dovrebbe tenere sotto controllo il cuore del sistema produttivo ed essere in grado di migliorare a partire dall’ap plicazione dei processi (dall’operatività) e non solo dalla introduzione di nuo ve tecnologie. Gli operatori hanno l’opportunità di costruire strumenti per lavorare meglio e meno, per eliminare le variazioni non necessarie, e per conoscere tutte le azioni (non solo quelle fatte da loro), e gli esiti attesi dal sistema per il paziente. 132 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 La vera ricchezza di un percorso assistenziale è la possibilità data a tutti gli attori (paziente, famiglia e operatori) di comprendere tutte le fasi del processo (che nelle malattie croniche può durare anche molti anni) e di analizzare i cambiamenti che avvengono nel paziente e come il paziente li percepisce. È per questo che l’assistenza organizzata con i percorsi è comunque sem pre molto ben accettata da parte dei pazienti 10.5. Dimissioni protette nell’unità operativa malattie infettive ANNAMARIA GIAMPIETRI - Caposala U.O. Malattie Infettive, Dipartimento Medico 2^ Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova- Reggio Emilia, Viale Risorgimento 80, 42100 Reggio Emilia - tel.: 0522 296613, e-mail: [email protected] Nell’U.O. Malattie Infettive le problematiche del “paziente complesso” su scitano particolare interesse per la complessità della sua gestione. Dall’analisi delle schede infermieristiche 2000/03 relativamente al “grado di dipendenza” e all’età anagrafica dei pazienti ricoverati, si evince un aumento dei ricoveri per tutte le fasce di età individuate e un aumento dei pazienti autosufficienti rispetto a quelli parzialmente e totalmente dipendenti. A fronte dei dati e della difficoltà di reinserimento in sicurezza del paziente al proprio domicilio, si è quindi definito un percorso di dimissione protetta che potesse garantire la continuità assistenziale e terapeutica all’utente e fornire agli ope ratori una modalità di gestione omogenea. Lo scopo generale è quello di realizzare un collegamento operativo forma le con la rete dei servizi distrettuale che consenta al paziente ricoverato in ospedale, per il quale vi sia la necessità di utilizzo della rete dei servizi territo riali, di usufruire di un percorso unitario in continuità assistenziale. Obiettivi del progetto sono: - garantire la continuità terapeutica tra Ospedale e Struttura; - creare percorsi che rispondano meglio ai bisogni dei cittadini/utenti; - aumentare la capacità di filtro ai ricoveri impropri e conseguente riduzione dei ricoveri ospedalieri; - favorire il reinserimento nel proprio ambiente di vita del paziente dimesso al fine di diminuire il disagio del ricovero; - diminuire la spesa ospedaliera e favorire un migliore utilizzo dei posti letto. In particolare il campo di applicazione previsto è la dimissione di pazienti problematici con ulteriore degrado delle condizioni di salute rispetto all’in gresso o che presentano i seguenti problemi: - aggravamento della non autosufficienza o perdita dell’autosufficienza; - necessità riabilitative che non possono essere supportati dal nucleo familiare; 133 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 - problemi di comprensione linguistica e culturale; - pazienti senza fissa dimora o in condizione di clandestinità. Il progetto, iniziato nel 2001 è tuttora in corso. L’attività prevista consiste in: - identificazione infermieristica dei bisogni del paziente al momento del ri covero seguita da una rivalutazione medica ed infermieristica delle condi zioni del paziente in previsione della dimissione (3 giorni prima); - valutazione congiunta con la famiglia (nel caso in cui ci siano le condizioni per la dimissione) relativamente alla loro disponibilità per il livello assisten ziale che può garantire e alle ipotesi di attivare i servizi territoriali (servizio sociale, servizio domiciliare, servizio infermieristico, Sert, Simap), l’unità di valutazione geriatrica per un eventuale trasferimento in Residenza sanitaria assistita, di trasformare il ricovero ordinario in ricovero di lungodegenza, di richiedere alla direzione sanitaria il trasferimento in una struttura conven zionata; - organizzazione del rientro al domicilio da parte della caposala. Prima della dimissione, l’équipe infermieristica cura in modo dettagliato la trasmissione delle informazioni sanitarie utili per la gestione a domicilio del paziente coinvolgendo anche i familiari. L’obiettivo è anche quello di diffon dere pratiche di buona salute per vivere al meglio nel proprio ambiente di vita. Il medico, nel contempo, contatta il medico curante del paziente al fine di garantire la continuità terapeutica e per creare un contatto diretto tra ospe dale e territorio. Primi risultati I primi dati mostrano un incremento dell’adozione della procedura della dimissione protetta: nel 2001 i pazienti dimessi con tale modalità sono stati 29, nel 2002, 57 e nel 2003, 61. Gli indicatori individuati: - segnalazione di disservizi da parte dei pazienti, dei familiari e degli opera tori dei servizi coinvolti nella dimissione. Lo standard di riferimento, che è l’assenza di segnalazioni, è stato raggiunto al 100%; - gradimento degli utenti in dimissione protetta, rilevato attraverso il questio nario di soddisfazione aziendale. Lo standard di riferimento è il raggiungimento del 100% di utenti soddisfatti (utenti che hanno espresso il giudizio “Molto buono + Buono” alla valutazione complessiva) rispetto al 96,2% ottenuto nelle indagini del 2001; - n. di re-ospedalizzazione entro 3 mesi dall’ultimo ricovero in ospedale. Lo standard è una riduzione del 90% delle re-ospedalizzazioni. Nel 2001 si è registrato uno scostamento positivo del 3,1% dallo standard, mentre nel 134 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 2002 e nel 2003 si è registrato uno scostamento negativo rispettivamente del 5,8% e del 16,2%. Risultati attesi Per l’utenza: - minore ricorso all’ospedalizzazione per la risoluzione dei problemi di salute; - possibilità per il paziente complesso di vivere nel proprio ambiente di vita. Per l’organizzazione: - miglior utilizzo dei posti letto; - possibilità di incidere sul flusso dei ricoveri in modo più appropriato, più sicuro, ed economicamente più favorevole. Conclusioni L’attuazione della procedura di dimissione protetta, in tutti i casi in cui è stata applicata, ha riscontrato un alto gradimento dell’utenza e ha permesso una migliore gestione dei pazienti a complessità assistenziale alta. 10.6. L’umanizzazione del percorso assistenziale diabetico: il metodo delle “categorie assistenziali” e il rapporto con gli standard internazionali HPH MARCELLA FILIERI, SERGIO CORTOPASSI, ROBERTO CAPIFERRI, GIUSEPPE MARTINI, MAIDA PERCO, RENZO PIZ - Azienda USL 5 di Pisa AUTORE REFERENTE: MARCELLA FILIERI, Responsabile U.O. Sviluppo, Ricerca e For mazione, Azienda USL 5 di Pisa, Via Zamenhof 1, 56100 PISA – tel.: 050 954291, fax: 050 954321, e-mail: [email protected] Premessa Presso l’Azienda USL 5 di Pisa è in corso l’analisi critica di alcuni percorsi assistenziali con l’obiettivo di renderli coerenti con le strategie della rete HPH e con la definizione del PSR Toscano 2002 - 2004 che prevede un “per corso guidato del cittadino attraverso l’organizzazione sanitaria con lo scopo di mettere nella corretta relazione tutti i componenti del team, che per quel determinato problema di salute seguono specifiche linee guida con divise”. Di seguito viene descritto il metodo di lavoro ed i risultati ottenuti nell’ana lisi del percorso assistenziale del paziente diabetico. 135 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 Obiettivi del progetto Migliorare il percorso diabetico mediante l’applicazione di un metodo di lavoro che integri i contenuti professionali improntati ai principi dell’EBM con le corrette modalità organizzative e con gli aspetti relazionali ispirati ai princi pi della promozione della salute. Il metodo prevede la individuazione di indi catori di processo e di esito per il monitoraggio dei risultati. Gli indicatori dovranno contribuire a definire un “budget di percorso”. Target e azioni specifiche Il progetto è rivolto a: - i professionisti aziendali coinvolti in un percorso di formazione-laboratorio; - gli utenti del percorso diabetico in qualità di valutatori del percorso attra verso il metodo dei focus group; - i cittadini destinatari di specifiche iniziative di comunicazione, anche attra verso una rinnovata carta dei servizi. Metodo di lavoro e risultati Utilizzando la formazione del personale interessato al percorso diabetico (intraospedaliero e territoriale) come momento di “laboratorio”, i professioni sti si confrontano e descrivono le fasi attuali del percorso del paziente diabetico focalizzando per ciascuna di esse l’esistenza o meno di linee guida, protocolli, procedure, modulistica finalizzati a: 1. valutazione clinico-sociale-psicologica del paziente e dei suoi bisogni; 2. applicazione di pratiche diagnostiche e terapeutiche evidence based; 3. riduzione dei rischi clinici per il paziente; 4. informazione, educazione, partecipazione del paziente e della famiglia; 5. valutazione degli esiti clinici. Lo strumento chiave per l’analisi e l’ottimizzazione del percorso è rappre sentato da uno schema a matrice rielaborato presso l’Azienda Usl 5 a partire da una proposta dell’ISS e dall’Agenzia Sanitaria delle Marche in tema di ge stione per processi professionali e percorsi assistenziali. Tale strumento fa riferimento alle cosiddette “categorie assistenziali” alcu ne delle quali (valutazione del paziente; educazione del paziente) coincidono con alcuni standard internazionali HPH. Per ciascuno dei 5 punti di osservazione vengono individuati specifici indi catori, proposti e condivisi dai professionisti. In particolare, con riferimento ai punti 1 e 4 è in corso di sperimentazione l’individuazione e l’applicazione dei substandard e dei relativi indicatori pro 136 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 10 posti dal WHO Regional Office of Europe relativi agli standard HPH n. 2 (patient assessment) e n. 3 (patient information and intervention). Un’importante modalità di valutazione dei risultati sarà data dal confronto dei risultati di due focus group da tenersi a distanza di un anno l’uno dall’altro, ciascuno dei quali coinvolgerà 14 pazienti diabetici selezionati secondo spe cifici criteri di inclusione predisposti dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa alla quale è stata commissionata l’indagine. Conclusioni Il riorientamento dei professionisti, spesso ancora legati al proprio ruolo professionale nell’organizzazione, verso l’obiettivo di soddisfazione comples siva del cittadino è stato un compito non facile da affrontare mediante l’attivi tà formativa; tuttavia lo spirito di squadra da perseguire mediante la formazio ne, insieme con il forte sostegno della direzione aziendale costituiscono le leve irrinunciabili da utilizzare per il miglioramento dei percorsi assistenziali in generale. Nel caso del percorso diabetico il metodo adottato si è rivelato efficace per individuare le criticità attuali e per indicare la strada verso il mi glioramento. I professionisti sono attualmente impegnati in lavori di gruppo finalizzati alla l’implementazione delle linee guida, protocolli, ecc. risultati carenti in fase di analisi. Il monitoraggio nel tempo degli indicatori proposti, insieme con i risultati dei focus group consentiranno una valutazione definiti va dei risultati Il percorso assistenziale, dopo aver superato le conferenze di consenso con gli operatori interessati, entrerà nella fase di sperimentazione applicativa e produrrà due canali di comunicazione: 1. in Carta dei Servizi, all’interno degli impegni aziendali, rivolto verso i citta dini; 2. nel Foglio Accoglienza, sezione della Carta, rivolto agli utenti che entrano nel percorso. Bibliografia 1. CASATI, PANELLA, DI STANISLAO, VICHI, MOROSINI, Gestione per processi professio nali e percorsi assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Sanitaria Regionale Marche, Ministero della Salute. 2. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Self assessment tool for health promotion standard and indicators in hospitals (Draft), Copenhagen, WHO Regional Office for Europe 2004. 137 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 138 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 La promozione della salute per i bambini e gli adolescenti in ospedale 11.1. Il progetto OMS “Promozione della salute per bambini ed adolescenti in ospedale” FABRIZIO SIMONELLI, MARIA JOSÉ CALDÉS PINILLA, KATALIN MAJER, PAOLO MORELLO MAR CHESE - Centro di Coordinamento della Rete HPH Toscana, Ospedale Pediatrico A. Meyer di Firenze AUTORE REFERENTE: FABRIZIO SIMONELLI, Centro di Coordinamento della Rete HPH Toscana, Ospedale Pediatrico A. Meyer, Via Pico della Mirandola 24, 50132 Firenze – tel.: 055 5662311, fax: 055 5662940, e-mail: f.simonelli@ meyer.it Breve introduzione del contesto La salute intesa come un processo di crescita sociale e personale volto all’au to-realizzazione comincia nella prima infanzia e perdura fino alla fine della vita. Gli ospedali dovrebbero avere un ruolo sempre crescente nel promuovere una crescita sana dei bambini e adolescenti, implementando pratiche di cultura del la salute, e aiutando i bambini ed adolescenti attraverso gli episodi cruciali di sviluppo che loro attraversano. Lo sviluppo di queste capacità di vita è un ob biettivo essenziale nell’educazione della salute e nelle attività di promozione della salute, anche ospedaliere. La promozione della salute per bambini e ado lescenti in ospedale deve anche coinvolgere i loro familiari, prendendo in con siderazione non solo il bambino o l’adolescente, ma anche la loro unità familia re, inteso come una risorsa fondamentale per la loro promozione della salute. Obiettivi generali Questo progetto mira allo sviluppo e lo scambio di conoscenze, competen ze, standards e buone pratiche di promozione della salute negli ospedali pediatrici e nelle divisioni pediatriche di ospedali generali, seguendo i princi pi e i criteri dell’Health Promoting Hospitals Network, coordinato dall’Ufficio Europeo OMS di Barcellona. Obiettivi specifici - Sviluppare una cultura e pratica ospedaliera basata sul rispetto dei diritti dei bambini e adolescenti in ospedale; 139 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 - adeguare il setting ospedaliero tenendo conto dei bisogni di promozione della salute dei bambini e adolescenti; - sviluppare ricerche e studi sui bisogni di promozione della salute dei bam bini e adolescenti in ospedale; - creare una mappa di buone pratiche ospedaliere; - promuovere una nuova Comunità di Pratica e un Open Network internazionale sul tema della promozione della salute per bambini e adolescenti in ospedale; - elaborare raccomandazioni e linee-guida concernenti la promozione della salute per bambini e adolescenti in ospedale. Gruppi target - Parenti dei bambini e adolescenti ospedalizzati; bambini e adolescenti ospedalizzati con malattie acute; bambini e adolescenti ospedalizzati con malattie severe/croniche; staff ospedaliero; bambini e adolescenti visitatori. Metodologia di lavoro Per raggiungere questi obbiettivi il progetto prevede di attivare 5 infrastrut ture: 1. un Gruppo di Lavoro internazionale per lo scambio di idee, conoscenze ed esperienze su questo tema; 2. un Osservatorio sulle attività di promozione della salute per bambini e ado lescenti in ospedale, per identificare e disseminare le conoscenze e le pra tiche esemplari su questo tema; 3. una Comunità di Pratica, per promuovere la cultura della salute, il confronto scientifico e culturale, la disseminazione dei risultati, le relazioni professionali; 4. un Open Network di ospedali, istituzioni e associazioni, che acquisisca e diffonda nuovi modelli e iniziative di promozione della salute per bambini e adolescenti in ospedale; 5. un Sistema di Dialogo e Comunicazione su Internet (Website): per condivi dere le conoscenze scientifiche, per scambiare informazioni tra i partner sulle attività e i risultati; e per sostenere la Comunità di Pratica e l’Open Network. Risultati attesi 1. Elaborazione di un documento-guida, con i principi e i significati propri della Promozione della Salute per Bambini e Adolescenti in Ospedale; 2. definizione di un set di Diritti fondamentali del Bambino in Ospedale, e 140 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 3. 4. 5. 6. 7. 8. sua condivisione e diffusione negli ospedali per bambini e nelle divisioni pediatriche di ospedali generali; sviluppo di attività di ricerca sui bisogni di promozione della salute di bam bini e adolescenti in ospedale; costruzione e disseminazione di una mappa di buone pratiche europee di promozione della salute per bambini e adolescenti in ospedale; definizione di una cornice per la promozione della salute per bambini e adolescenti in ospedale basata sull’evidenza, attraverso standards e indica tori condivisi; elaborazione di raccomandazioni e linee-guida per le attività di promozio ne della salute per bambini e adolescenti in ospedale; sviluppo, attraverso tutta la Regione Europea dell’OMS, di una Comunità di Pratica, dedicata a questo tema, ed attiva nel panorama generale di pro mozione della salute; creazione di un nuovo Open Network di ospedali, università, istituzioni e associazioni, che lavori su questo tema e sviluppi relazioni di co-operazio ne sulla promozione della salute per bambini e adolescenti in ospedale coinvolgendo reti e programmi internazionali. Primi risultati - È stata preparata la versione bozza del documento-guida. È stato istituito il Gruppo di Lavoro. È stato realizzato il Sito Internet. È stata avviata l’Indagine di sfondo. Conclusioni Al momento si può constatare che il percorso progettuale è stato iniziato con un largo e qualificato coinvolgimento di partners di tutta la Regione Euro pea dell’OMS, su mandato dell’Ufficio Europeo di Barcellona. 11.2. Il Laboratorio Clinico Pedagogico per ottimizzare l’assistenza pediatrica S EBASTIANO G UARNACCIA 1, D ANIELA M ANFREDI 1, E MANUELE D’A GATA1, B ENEDETTA VENTURELLI2, ROSARIA AVISANI3, ENRICO COMBERTI4, GIOVANNA FERRETTI1, LUIGI DANIELE NOTARANGELO1, RAFFAELE SPIAZZI1 - 1Dipartimento di Pediatria, Ospedale dei Bam bini, A.O. Spedali Civili Brescia; 2Ufficio Comunicazione e Relazioni con il pubblico A.O. Spedali Civili; 3Direzione Sanitaria, A.O. Spedali Civili; 4U.S.D. Aggiornamento e Certificazione Qualità, A.O. Spedali Civili 141 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 AUTORE REFERENTE: SEBASTIANO GUARNACCIA, U.O. Laboratorio Clinico Pedagogico e Ricerca Biomedica, Ospedale dei Bambini, Clinica Pediatrica Università di Brescia, Spedali Civili, Via del Medolo 2, 25123 Brescia - Tel.: 030 3849283, fax: 030 3849284, e-mail: [email protected] Introduzione Nato all’interno dell’Ospedale dei Bambini di Brescia, il Laboratorio Clinico Pedagogico si propone di approfondire la tematica della comunicazione e dell’educazione al fine di contribuire al miglioramento dell’assistenza al bam bino ed alla sua famiglia, creando una rete di collaborazioni e sinergie tra i diversi “attori” coinvolti nel processo di educazione. In questa rete, il Labora torio diviene riferimento culturale e traino per il coinvolgimento di soggetti operanti a diverso titolo nel Servizio Sanitario e nelle Istituzioni pubbliche e private già oggi coinvolte nel progetto (la Scuola, la Farmacia, le Associazioni, le Società Scientifiche, ecc...). Obiettivi/Target - Strutturare, intorno al bambino ed alla sua famiglia, una “rete” di intervento in termini di prevenzione, terapia e di autogestione. - Configurare il Laboratorio Clinico Pedagogico come Centro di Comunica zione, Educazione e Formazione Sanitaria, che si faccia promotore di qua lità per: - l’utenza (bambino/famiglia); - l’azienda e gli operatori sanitari; - l’ambiente esterno all’ospedale, in particolare la scuola e i centri educati vi e ricreativi maggiormente frequentati dai bambini; - le altre Aziende Ospedaliere; - le Società Scientifiche; - le Istituzioni Sanitarie e Sociali (ASL, Regione, Ministero della Salute, Or dini e Collegi Professionali, Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc...). Strumenti/indicatori Le attività del Laboratorio sono orientate alla promozione e allo sviluppo del progetto educativo, principalmente attraverso: - La strutturazione, sperimentazione e diffusione di materiale educativo ca ratterizzato da una propria linea editoriale e stilistica e sarà costituito da: - Prodotti multimediali, quali cd-rom, portali web, videogiochi. - Materiale informatico educativo cartaceo: libricini con storie da colorare, schede interattive, percorsi didattici nelle scuole, ecc... 142 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 - Materiale ludico: domino, puzzle, tombola, strumentazioni mediche ripro dotte come giochi, ecc... - Un ambulatorio di educazione (Asma, Diabete, Epilessia) per bambini di Scuola Materna e Scuola Elementare, ragazzi di Scuola Media Inferiore e Superiore, e per genitori. - Iniziative di Informazione e Formazione, in collaborazione con la Forma zione Aziendale,: corsi ECM, convegni, formazione a distanza. - Indicatori di apprendimento e gradimento (questionari, griglie, giochi cognitivi). Conclusioni Il Laboratorio Clinico Pedagogico è un centro che supporta e alimenta la comunicazione, l’educazione e la formazione del bambino, della sua famiglia e di tutti gli “attori”; di conseguenza permette di migliorare la gestione della malattia in termini di autogestione, di adesione al piano terapeutico, di qualità della vita. 11.3. Un’esperienza di lavoro multidisciplinare sull’abuso e maltrattamento all’infanzia in un ospedale pediatrico FULVIA NEGRO, GEMMA ISAIA, ANNA PELOSO, ALGA BEVILACQUA, IDA BERTOTTI, ROSALINDA GEMELLO, CARLA BAIETTO, FRANCESCO ASTORINO, LUCIA CIRAMI, LAURA DE MICHELIS, CRI STINA ODDONE, SILVIA MURDOCCA - Gruppo di Lavoro su maltrattamento e abuso ai minori, Azienda O.I.R.M. S. Anna di Torino AUTORE REFERENTE: FULVIA NEGRO, O.I.R.M., Piazza Polonia 94,10126 To - tel.: 011 3135832, fax:0113135214, e-mail: [email protected] La rilevazione, la diagnosi, la presa in carico ed il trattamento dell’abuso sessuale e del maltrattamento ai minori costituiscono problemi complessi in cui si intrecciano aspetti medici, psicologici, sociali e giuridici; ciò rende indi spensabile il coinvolgimento di più figure professionali. L’esperienza clinica e l’analisi della letteratura evidenziano la necessità di costruire, tra i diversi pro fessionisti coinvolti, un linguaggio ed una modalità di intervento comuni e condivisibili. Nella nostra azienda nell’anno 2000-01, sostenuto da un proget to finanziato di Azione Positiva del Ministero del Lavoro e del Comitato Nazio nale di Pari Opportunità, si è tenuto il “Corso di formazione per operatori/ operatrici addetti/e all’assistenza di minori abusati attraverso un’organizza zione di lavoro in rete”. Il corso di tipo esperienziale-teorico aveva il fine di raggiungere una comune cultura di lavoro tra operatori di professionalità di versa e differente, attraverso un apprendimento dall’esperienza condotta in gruppo, per il riconoscimento ed il trattamento dell’abuso all’arrivo nell’istitu 143 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 zione. In seguito si è costituito, su motivazione spontanea, un Gruppo di La voro multidisciplinare (NPI, Pediatra, Psicologo, Chirurghi pediatrici, Infer mieri professionali, Assistente sociale) per il rilevamento e l’iniziale presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento su minore. “Il Gruppo di Lavoro su abuso e maltrattamento ai minori” dell’O.I.R.M. ha ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Piemonte ed istituzionalizzato come equipe multidisciplinare con compiti specifici rispetto alle equipe territoriali. Nel 2002, in base alle indicazioni emerse dall’analisi dell’attività si è reso necessario atti vare uno specifico ambulatorio cui fare riferimento con disponibilità di risorse umane e materiali. L’“Ambulatorio Dedicato”, medico ed infermiere/a dedica ti, ha lo scopo di poter dare al bambino/a con sospetto di abuso/maltratta mento l’attenzione ed il tempo necessario a raccogliere il racconto dell’ac compagnatore/bambino e soprattutto per permettere al bambino di “fidarsi” degli operatori. Il principio su cui si fonda l’”Ambulatorio Dedicato” vuole essere quello di ridare ad un bambino, che è stato violato nel corpo e nello spirito”, usando i mezzi più idonei alla sua età (linguaggio, giochi), la consi derazione come persona e la rassicurazione sul suo stato di salute fisico. Dal gennaio 2003 all’aprile 2004 sono afferiti all’ambulatorio 63 bambini (130 visi te totali), inviati dall’interno dell’ospedale (DEA, Ambulatori, reparti) e dai servizi esterni (medici di base, consultori, servizi sociali, comunità, altri ospe dali, scuole e forze dell’ordine...). La metodologia del lavoro sul modello interdisciplinare e di condivisione emotiva per un fenomeno così complesso e problematico, anche per gli operatori, che richiede per l’avvio delle cure il dispiegamento di una vera e propria task-force. 11.4. Assistenza domiciliare integrata nel bambino oncologico EDVIGE GOMBACH (Responsabile infermieristico Dipartimento chirurgico), GIULIO ANDREA ZANAZZO (Dirigente Medico U.O. Emato-Oncologia), STEFANO RUSSIAN (Dirigente Medico Direzione Sanitaria) - IRCCS Burlo Garofolo - Trieste Introduzione Il ricovero ospedaliero in assoluto determina stress, paura e sentimento di impotenza. Dal punto di vista del bambino queste sensazioni, sul piano emo zionale, sono notevolmente amplificate. Anche se molto è già stato fatto (pre senza dei genitori, camerette colorate, sala giochi, ecc...), c’è ancora qualcosa che possiamo fare? L’articolo 3 della Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale (Bioetica, 2003), enunciando il diritto a ricevere il miglior livello di cura e assistenza, specifica che il ricorso all’ospedalizzazione deve essere limitato “alle situazioni in cui 144 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 non sia possibile far fronte alle esigenze assistenziali...in altro modo” e che “ vengono favoriti day hospital e assistenza domiciliare...”. Anche il Piano Sanitario Nazionale 2002-2004 pone tra gli obiettivi quello di incrementare l’adozione di strutture socio-sanitarie alternative (quali l’ospedalizzazione a domicilio). L’unità operativa di Emato-oncologia del nostro Istituto, ha quindi avvertito l’esigenza di iniziare un percorso che porti progressivamente ad una gestione integrata del bambino con patologia oncologica nella quale il ruolo dell’assi stenza domiciliare sia centrale. Il progetto non solo risponde ad un diritto fondamentale del bambino cronicamente ammalato, ma offre altresì vantaggi al paziente/famiglia, (mi nor rischio infettivo, migliore continuità assistenziale, riduzione del costo so ciale secondario all’ospedalizzazione) nonché al Sistema Sanitario (miglior ottimizzazione delle risorse territoriali e riduzione dei costi ospedalieri). Obiettivo Creare una rete assistenziale ai soggetti d’età 0-18 anni con diagnosi di tu more maligno durante le fasi di chemioterapia antiblastica più intensa tale da garantire a domicilio: - prelievi; - gestione di presidi (CVC, sondino); - piccola chirurgia (rimozione suture, medicazioni); - monitoraggio dei parametri vitali; - supporto nutrizionale (enterale o parenterale); - proseguimento dei trattamenti antibiotici parenterali; - trattamenti chemioterapici di intensità minore; - controlli e gestione degli effetti collaterali dei farmaci; - controlli e gestione di eventuali malattie intercorrenti; - supporto psicologico e pedagogico; - educazione al self care; - terapie palliative nel terminale. Materiali e metodi Il progetto è suddiviso in fasi. Studio di fattibilità e del bacino d’utenza: è stata inviata ai Direttori generali delle 6 ASS una copia del progetto, con richiesta di indicare i referenti di dire zione sanitaria con i quali discutere gli aspetti tecnico organizzativi. Il medico e l’infermiera del Centro, responsabili del progetto, si sono recati nelle 5 ASS che hanno risposto, per illustrare il progetto ai referenti individuati. 145 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 Alla fine hanno aderito 4 ASS (per due Aziende si è stilato un Protocollo d’Intesa). Accordi Interaziendali: verificata la fattibilità del progetto, gli operatori del Centro, i responsabili del servizio infermieristico dell’ASS, un pediatria del l’ospedale territoriale e un rappresentante dei PLS di quel territorio si sono riuniti una o più volte per concordare azienda per azienda: - le competenze di ciascuna figura implicata; - la procedura di attivazione dell’assistenza domiciliare; - le linee guida comuni all’assistenza del bambino oncologico; - la modulistica da utilizzare; - il fabbisogno formativo del personale territoriale. Aggiornamento del personale sanitario territoriale: il personale infermieristico dei distretti territoriali di ogni singola ASS ha frequentato, a rotazione, per un periodo di 3 settimane per ciascun distretto, uno stage indi viduale con tutor presso il Centro per formarsi sui bisogni del bambino oncologico. A distanza di un anno dall’attivazione, si prevede di valutarne: efficacia, efficienza, soddisfazione dell’utente in termini di qualità percepita, soddisfa zione degli operatori. Risultati e commento Sono state così definite le procedure di attivazione dell’assistenza domiciliare: - Ogni nuova diagnosi viene segnalata via fax con apposita scheda dalla caposala del Centro alla caposala del distretto d’appartenenza del bambi no. S’invia anche la versione aggiornata di alcune procedure scritte (prelie vo da CVC, medicazione e sostituzione del tappo del CVC, dieta per neutropenici, norme igienico-ambientali); la stessa cs del Centro verifica telefonicamente con la collega del territorio se gli infermieri del distretto hanno partecipato alla fase di aggiornamento e concorda le date per lo svolgimento dello stage. - Il medico del Centro informa telefonicamente del nuovo caso il PLS/ MMG del bambino (in talune circostanze essi vengono informati anche dal distretto) e chiede di prescrivere l’attivazione dell’assistenza domiciliare. Nell’impossibilità di reperire il curante il responsabile me dico del distretto ha facoltà di attivare l’assistenza domiciliare in via prov visoria. - Gli infermieri del territorio ed il PLS vengono al Centro a conoscere il bam 146 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 bino e la famiglia prima della dimissione. In tale occasione vengono fornite notizie sulla diagnosi, sul programma terapeutico (di cui viene consegnato uno schema) e individuati i bisogni del bambino a domicilio. Vengono an che concordate le modalità di dimissione (date, trasporto, fornitura provvi soria di farmaci e presidi). - Nell’accordo con la ASS 3, geograficamente distante dal Centro, è previ sto invece che venga convocata nella sede del distretto una riunione di Unità di Valutazione Domiciliare (UVD) cui partecipano il medico e l’in fermiere del Centro, il PLS, il pediatra dell’ospedale territoriale, il coor dinatore medico e infermieristico del distretto, gli infermieri domiciliari del distretto, l’assistente sociale, lo psicologo. Al termine delle riunione la proposta assistenziale viene presentata alla famiglia per l’approvazio ne. Contemporaneamente alla dimissione (ricovero ordinario, Day Hospital o ambulatoriale), il Centro invia al distretto per fax o e-mail, entro le 14 del giorno precedente a quello delle procedure, l’apposita scheda di richiesta pre stazioni che riporta generalità del paziente, motivo del ricovero, data di dimissione, data del prossimo ricovero, presenza di condizioni particolari, le prestazioni richieste nelle relative date. L’assistenza domiciliare viene erogata dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 con ampia flessibilità (anche al sabato o alla domenica). Se le condizioni del bambino variano, è previsto che la comunicazione al Centro sia data dall’assi stenza domiciliare o dalla famiglia stessa. I prelievi eseguiti a domicilio vengono recapitati dal distretto al laboratorio di riferimento con la dicitura URGENTE e gli esiti vengono trasmessi direttamen te dal Laboratorio al Centro via fax entro le 13 del giorno stesso. Dopo 6 mesi dall’entrata in vigore degli accordi i protocolli prevedono una riunione collegiale ASS/Centro per valutare i risultati e correggere eventuali imperfezioni organizzative. A 15 mesi dalla firma della convenzione con l’ASS1 e a 2 da quella con l’ASS 3 i risultati ottenuti sono i seguenti. Tab. 1 ASS ASS 1 ASS 3 Pazienti eleggibili 15 1 Pazienti assistiti a domicilio 11 1 Percentuale 73,3% 100% In particolare sono stati assistiti tutti quelli con leucemia o linfoma non Hodgkin, mentre la percentuale più bassa di effettivo utilizzo della domiciliare (meno della metà dei casi) si è avuta nei linfomi di Hodgkin. 147 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 Le prestazioni più frequentemente erogate nell’ambito della convenzione sono state elencate nella Tab. 2. Tab. 2 prelievi medicazioni del cvc sostituzione tappo rilevazione parametri vitali sedute di logopedia, fisioterapia terapie parenterali (antibiotici, fattori di crescita..) altro 25 % 20 % 20 % 12 % 12 % 10 % 1% La percentuale di accessi ospedalieri risparmiati dall’assistenza domiciliare è stata del 30% circa. Per quanto riguarda gli assistiti delle altre ASS c’è stato un effetto “emulazione” che ha indotto molte famiglie a chiedere l’attivazione dell’assistenza domiciliare al di fuori di una formalizzazione interaziendale. In questi casi gli accordi sono stati presi direttamente dal Centro in via informale ed amichevole con il perso nale infermieristico del distretti e con i laboratori convenzionati, utilizzando comunque la stessa modulistica e lo stesso schema organizzativo. Queste esperienze “pilota”, vissute come gratificanti dagli operatori del ter ritorio, spingono gli stessi a premere con le proprie direzioni sanitarie per arrivare alla formalizzazione di accordi. Bibliografia BIOETICA - Rivista interdisciplinare, n. 1, marzo 2003, Editore Zadig, Milano, pp. 67-74. 11.5. “Ri-scoprirsi naturalmente”. Laboratorio multisensoriale per disabili neuropsichici Associazione Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza, - U. O. Neurop sichiatria Infantile Ospedale “G. Salesi”, DIRETTORE: CESARE CARDINALI AUTORE REFERENTE: LUIGINA CENCI, Dirig. Med. Neuropsichiatria, U.O. Neurop sichiatria Infantile, Via F. Corridoni 11, 60123 Ancona – Tel.: 071 5962504, fax: 071 5962502, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto Il progetto si configura come un vero laboratorio multisensoriale, in cui 148 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 l’approccio ludico-comunicativo permette al bambino disabile psicofisico il pieno coinvolgimento nelle esperienze educativo-riabilitative, proposte attra verso attività visive, auditive, tattili e cinestetiche. Il modello riabilitativo gruppale, che caratterizza le attività all’interno del l’Ospedale Diurno Terapeutico dell’Unità Operativa Neuropsichiatria Infanti le (U.O.NP.I) del “Salesi” è stato applicato per la realizzazione del Progetto pilota educativo-riabilitativo, rivolto al bambino con diversa abilità. Le attività svolte sono avvenute a diretto contatto con la natura, nell’Oasi Ripa Bianca di Jesi e nel Parco Urbano di Villa Colloredo di Recanati, favoren do la fruizione dell’ambiente mediante l’esercizio plurisensoriale (tatto, olfat to, vista, udito), accrescendo così la percezione e la consapevolezza del tem po come fattore dinamico, mediante la personale sperimentazione del ritmico fluire e delle modificazioni esterne ad esso connesse, attraverso il mutamento delle stagioni, pur nella stabilità dello scenario e/o il consolidamento delle esperienze nella limitrofa stanza-laboratorio all’uopo allestita. Il progetto ha fornito una opportunità pratica di sperimentare nuovi spazi e tempi, che conduce verso un processo di strutturazione ed organizzazione più integrata del proprio senso di identità nell’ambiente. Aiutare i genitori di bambini, con diverse abilità nello sviluppo neuropsichico in età scolare, ad uscire, insieme con i propri figli, dall’isolamento dell’am biente familiare ed ospedaliero per immergersi nella bellezza della natura; con il coinvolgimento immediato ed integrato di tutti i partners, secondo com petenze specifiche e culture diverse, che hanno individuato i singoli bisogni ed hanno trovato soluzioni pedagogiche condivise. Obiettivi Obiettivo del programma è stato quello di offrire e far vivere ai bambini un “ambiente speciale” in cui e attraverso cui favorire lo sviluppo della sensorialità e del contatto sociale. Innescare un processo di consapevolezza della relazione corpo/spazio/ oggetto aiutando il portatore di una disabilità psicofisica a sviluppare la per cezione dello spazio in un ambiente naturale. Migliorare, nel disabile, la consapevolezza interpersonale, la sensibilità, la comunicazione e la qualità delle relazioni. Promuovere la consapevolezza del tempo come fattore dinamico per svi luppare la percezione del tempo nella mutevolezza dello scenario: l’alternarsi del giorno con la notte, il susseguirsi delle stagioni, il passare delle ore. Gruppo/i Target - U.O.NP.I. FA.NP.I.A. e WWF delle Marche hanno ottenuto a fine 2001 un 149 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 - - - contributo dalla Regione Marche l.r.n.48/1995 per la realizzazione del pro getto; Gen. 2002/Dic. 2003: incontro con le famiglie per arruolamento dei bambi ni proposti per la partecipazione al progetto; 11 incontri tecnici di progettazione e programmazione fra l’équipe di ricerca; 40 incontri di 2 ore ciascuno con 2 gruppi di bambini (20 incontri per grup po) ad opera di due conduttori (educatori ambientali) all’interno dell’Oasi Ripa Bianca di Jesi e di Villa Colloredo di Recanati; incontri di supervisione e consulenza ai conduttori dell’esperienza; 2 incontri di analisi e valutazione dei dati raccolti e condivisione del percor so effettuato con le famiglie, gli insegnanti di sostegno e la neuropsichiatra di riferimento dell’U.O. Salesi; incontri fra l’équipe di ricerca per analizzare i dati raccolti; realizzazione di un depliant divulgativo; stesura di bozza del volume concernente l’esperienza; presentazione pubblica del volume “ri-scoprirsi naturalmente” laboratorio multisensoriale per disabili neuropsichici. Presentazione e valutazione dei risultati Far vivere al bambino disabile neuropsichico esperienze reali nella natura, per sviluppare la percezione corporea e dello spazio/tempo. Bambini ed educatori insieme per 6 mesi. 8 bambini, 7 maschi e 1 femmina, 7/14 anni, 2 gruppi, 4 bambini ciascuno con diversa disabilità neuropsichica (Ritardo Mentale, Cromosomopatia, Di sturbo Pervasivo dello Sviluppo) le famiglie dei bambini disabili coinvolti nel progetto. Conclusioni Il progetto, unico nel suo genere nella Regione Marche, si è proposto di aiutare il bambino disabile psicofisico a sviluppare la propria identità attraver so la conoscenza diretta e individuale dell’ambiente naturale e non, in uno spazio comunicativo in grado di stimolare contemporaneamente la reciproci tà e l’interazione nel piccolo gruppo. 11.6. La campagna regionale di riduzione del rischio di morte improvvisa del lattante (SIDS) in Toscana: rilevazione epidemiologica dei fattori di rischio. RAFFAELE PIUMELLI1, NICCOLÒ NASSI1, LUCA LANDINI1, ROSA GINI2, ADA MACCHIARINI3, 150 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 PAOLO MARCHESE MORELLO4 - 1Centro Regionale di riferimento per lo studio e prevenzione della SIDS, Azienda Universitaria-Ospedaliera Meyer-Firenze; 2 Agenzia Regionale di Sanità; 3Associazione genitori “Semi per la SIDS”; 4Di rettore Azienda Universitaria-Ospedaliera Meyer AUTORE REFERENTE: RAFFAELE PIUMELLI, Centro Regionale di riferimento per lo stu dio e prevenzione della SIDS, Ospedale Pediatrico Meyer, Via P. Della Mirandola 24, 50100 Firenze - tel.: 0555 662447, e-mail: [email protected] Premessa Il Centro Regionale di riferimento per lo studio e la prevenzione della SIDS è stato istituito nel 1996 presso l’Ospedale Pediatrico Anna Meyer di Firenze. La missione di tale struttura è quella di far fronte alle numerose problematiche di ordine etico, sociale e scientifico sollevate dalla SIDS. Le attività del Centro sono essenzialmente rappresentate da: - programmi di monitoraggio domiciliare dei bambini a maggior rischio di SIDS; - gestione clinica dei bambini con storia di “Eventi Apparentemente Rischio si per la Vita-Apparent Life-Threatenig Events” (ALTE); - supporto alle famiglie colpite da SIDS; - campagne per la riduzione del rischio; - attività scientifica e di ricerca. Nel 1996 è stato effettuato un primo tentativo di promuovere una campa gna di riduzione del rischio consistente nella diffusione presso i punti nascita della Toscana dell’opuscolo “Per Loro è Meglio”. Tuttavia, l’impossibilità di una valutazione della reale efficacia di suddetta campagna unita al progressivo cambiamento della composizione etnica della nostra regione, che ha aumentato di fatto il numero di persone non raggiungibili dal messaggio di riduzione del rischio, ci ha indotto a promuovere una nuova campagna preceduta dalla valutazione del grado di conoscenza dei fattori di rischio di SIDS in Toscana. Piano regionale Il piano strategico si è basato sui seguenti punti: 1) organizzazione di una Consensus Conference tra i direttori delle tre Aree Vaste Regionali, i rappresentanti dei pediatri di famiglia e dell’associazione genitori; 2) organizzazione di incontri con i responsabili dei punti nascita, dei pediatri di famiglia, dei pediatri consultoriali e delle ostetriche della regione Toscana; 3) raccolta dati sul grado di conoscenza dei fattori di rischio per SIDS prima dell’inizio della campagna; 151 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 4) distribuzione di materiale cartaceo (opuscoli, posters) e diffusione di un breve documentario informativo su emittenti regionali; 5) raccolta dati sul grado di conoscenza della SIDS dopo la campagna. Al momento attuale sono stati completati i primi 4 punti. I dati sono stati raccolti tra il 7 gennaio e il 28 febbraio 2004 tramite un questionario consegnato ai genitori di bambini di circa 3 mesi al momento della vaccinazione presso 74 centri vaccinali selezionati della Toscana, corri spondenti a circa il 25% del totale. Risultati I risultati ottenuti hanno confermato l’inefficacia della prima campagna di riduzione del rischio se si prende in considerazione il grado di conoscenza del l’opuscolo “Per Loro è Meglio” (solo il 22% degli intervistati ha dichiarato infatti di conoscere l’opuscolo). Se invece consideriamo la percentuale di bambini posti a dormire supini (55,09%) possiamo affermare che un certo livello di in formazione è stato comunque trasmesso, probabilmente grazie alle numerose attività divulgative organizzate dal Centro e culminate con l’organizzazione del la settima conferenza mondiale sulla SIDS tenutasi a Firenze nel Settembre 2002. Dai dati raccolti emerge tuttavia una percentuale ancora molto elevata di bambini posti a dormire su un fianco (38,3%), posizione che è comunque gravata da un rischio di SIDS di circa tre volte superiore a quella supina. Altro dato significativo è stato la scarsa conoscenza delle misure di riduzione del rischio di SIDS da parte dei genitori appartenenti a popoli a forte migrazione. Gli obiettivi principali della campagna regionale saranno quindi rappresentati dall’eliminazione della posizione sul fianco durante il sonno e su una maggiore penetrazione del messaggio “back to sleep” presso i popoli a forte migrazione. Contiamo di raggiungere il primo obiettivo con la trasmissione di una corretta infor mazione da parte degli operatori sanitari che, in base ai nostri dati, rappresentano il veicolo principale di informazione per i genitori e con i quali ci siamo confrontati negli incontri che hanno preceduto la campagna. Per quanto riguarda invece il superamento delle barriere linguistiche abbiamo provveduto a tradurre l’opuscolo “Per Loro è Meglio” in quattro lingue: spagnolo, inglese, arabo e cinese. L’efficacia del nostro intervento sarà valutata tramite un nuovo questionario che sarà distribuito con le medesime modalità entro la fine del corrente anno. 11.7. L’allattamento al seno: ruolo degli operatori sanitari OLGA GUARESE (C.S.), M. LUISA MADDONNI (Ost.), SIMONA STAFFIERI (Ost.), DONATEL LA GROTTOLO (I.P.) - Distretto Alto Garda e Ledro, A.P.S.S. Trento 152 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 AUTORE REFERENTE: OLGA GUARESE, U.O. Ostetricia Ginecologia Arco, e-mail: [email protected] Premesse “ Se tutti i bambini fossero allattati esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita, si stima che circa 1,5 milioni di morti infantili l’anno sarebbero evitate e la salute e lo sviluppo di milioni di altri bambini sarebbero notevolmente migliori”: per l’UNICEF e l’OMS l’allattamento esclusivo al seno è alla radice della salute e dunque promuovere l’allattamento al seno nei reparti di mater nità e nei nostri ospedali, significa sicuramente promuovere la salute del bam bino e della mamma. I benefici dell’allattamento per il bambino sono: - riduzione dell’incidenza incidenza delle malattie infettive; - riduzione del rischio di asma e allergie; - miglioramento delle capacità psico-attitudinali del bambino come confermato recentemente da uno studio in Danimarca [Vestergaard M. et al., 1999] che evidenzia la relazione tra la durata dell’allattamento e lo sviluppo del cervello; - protezione da meningite da haemophilus influenzae nei primi cinque-sei anni di vita [Silvefverdal Sa., Bodin L., Olcen P., 1999]; - a lungo termine aumento della massa ossea e quindi minor incidenza di osteoporosi in età adulta; - riduzione dei rischi dell’obesità e del soprappeso. I benefici per la mamma sono: - nell’immediato post partum diminuzione dei rischi di emorragie; - aumento dell’autostima materna e della fiducia nelle proprie capacità fisi che ed emotive [Locklin M., 1995], favorendo un’ottimale relazione madre bambino; - riduzione, a lungo termine, del rischio di tumore al seno [Furberg H. et al., 1999], di cancro alle ovaie, di fratture al femore nelle donne oltre i 65 anni che hanno allattato. Naturalmente i benefici di una coppia madre bambino in salute, si trasmet tono all’intero nucleo famigliare e poi fino al tessuto sociale. Dunque l’allattamento al seno ha dei benefici per l’intera società perché può ridurre notevolmente le spese sanitarie, è ecologico in quanto risorsa rinnovabile e naturale, non produce sprechi ed è economico. Obiettivi La nostra U.O. si pone come obiettivo quello di assicurare la riuscita dell’allattamento al seno attraverso l’adozione del protocollo UNICEF; in que sto modo tutti gli operatori sanitari forniranno alle neo mamme informazioni 153 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 uniformi sull’allattamento e sostegno adeguati; e inoltre creare una rete di supporto anche a livello territoriale mantenendo l’interazione con la struttura ospedaliera. Target Operatori sanitari. Donne in gravidanza e puerpere che si rivolgono alla nostra U.O. Strumenti - Definire un protocollo scritto e farlo conoscere a tutto il personale sanitario. Fornire a tutto il personale sanitario le competenze necessarie per attuarlo. Informare tutte le donne in gravidanza sui benefici e le tecniche per allattare. Aiutare le madri ad iniziare l’allattamento nella prima mezz’ora dopo il parto. Attuare il rooming-in, ossia sistemare i neonati in stanza della madre 24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale. - Non somministrare altri alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne su prescrizione medica. - Non usare succhiotti o tettarelle durante il periodo dell’allattamento al seno. - Favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell’allattamento al seno in modo che le madri possano rivolgersi e confrontarsi in tali gruppi. Valutazione dei risultati - Percentuale di allattamento esclusivo al seno alla dimissione delle puerpere. - Distribuzione di questionari di valutazione dell’assistenza alle neomamme. - Follow-up a distanza. Conclusioni Gli operatori sanitari sono fattori determinanti per il successo o il fallimento dell’allattamento; infatti si è visto che un adeguato supporto da parte di opera tori motivati ed adeguatamente formati, incentiva notevolmente l’allattamento materno, con tutti i benefici che ne conseguono. Bibliografia 1. CHANG-CLAUDEJ, EBY N., KIECHLE M., BASTERT G., BECHER H., Breestfeeding and breast cancer risk in young women”, British Medical Journal, 307, 1993, pp. 17-20. 2. FURBERG H. et al., Lactation And Breast Cancer Risk, “International Journal of Epidemiology”, 28, 1999, pp. 396-402. 154 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 3. IBFAN, What scientific research says, “Ibfan action park”, 12, 1998. 4. LOCKLIN M., Telling the world: low income women and their breestfeeding experiences, Jhumlact, 11(4), 1995, pp. 285-291. 5. SILVEFVERDAL SA., BODIN L., OLCEN P., Protective Effect of Breestfeeding: an Ecologic Study of Haemophilus Influenzae Meningitis and Breestfeeding in a Swedish Population, “International Journal of Epidemiology”, 28, 1999, pp. 152-156. 6. UNICEF, Breestfeeding, the foundation for a healthy future, New York, august 1999. 7. VESTERGAARD M., O BEL C., HENRIKSEN T. B., SORENSEN H. T., Duration of Breestfeeding and Developmental Milestones During The Latter Half of Infancy, “Acta Paediatrica”, 88, 1999, pp. 1327-1332. 11.8. La “narrazione” dei sentimenti degli operatori come strumento professionale nel lavoro sanitario in neonatologia e pediatria NICOLETTA VINSANI (caposala Pediatria), MARIA CLAUDIA MENOZZI (Inf. Prof. Pe diatria), A VE LUPI (caposala Neonatologia), PAOLA C RISTOFORI (Inf. Prof. Neonatologia), PIERGIUSEPPINA FAGANDINI (psicologa Dipartimento Materno In fantile) - Dipartimento Materno Infantile, direttore G. BANCHINI - Azienda Ospe daliera Arcispedale Santa Maria Nuova- Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: MARIA CLAUDIA MENOZZI, U.O. Pediatria, Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova, Viale Risorgimento 80, 42100 Reggio Emilia - e-mail: [email protected] I percorsi formativi delle professioni di cura sono finora prevalentemente improntate all’apprendimento di un sapere fondato sull’oggettività, le tecni che, l’operatività. Soggettività, sentimenti e vissuti sono ritenuti quasi sempre un ostacolo alla “professionalità” e perciò estromessi dalla formazione accreditata. Gli operatori, sprovvisti di momenti formativi sulla gestione delle emozioni loro e dei pazienti, si sono spesso “difesi” dall’affettività. I sentimenti hanno così finito per essere un “non detto” delle professioni sanitarie, anche nelle situazioni ospedaliere ad alta intensità emotiva come i reparti che ricoverano neonati, bambini e adolescenti. Taciuti o negati, nascosti o repressi, ma pur sempre presenti, i sentimenti hanno assunto forme diverse, talora manifestan dosi in modo distorto e non di rado deleterio sia per gli operatori (la nota sindrome del burn-out) sia per gli utenti. Il progetto è iniziato nel 1993 nell’U.O. di Neonatologia e nel 2000 nell’U.O. di Pediatria ed è tuttora in corso. Lo scopo principale è quello di sperimentare 155 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 e attuare un percorso formativo orientato a formare figure professionali sani tarie in grado di operare nella gestione dello stress e dei conflitti relazionali, di fornire sostegno e counselling in situazioni di gestione emotiva del dolore, dei traumi, dei lutti. Il percorso formativo ha quindi l’obiettivo di: - condurre gli operatori a considerare i sentimenti come un’opportunità e una risorsa, una ricchezza indispensabile nelle situazioni del prendersi cura soprattutto di neonati, bambini, adolescenti e delle loro famiglie; - fornire strumenti che aiutino gli operatori a riconoscere i sentimenti, propri e altrui, dare loro voce, educarli e gestirli perché non emergano disordina tamente, ma possano umanizzare la dimensione professionale. Per raggiungere tali obiettivi si è pianificato l’utilizzo di 2 strumenti metodologici qualitativi: - Focus group, che sono stati effettuati mensilmente per due anni dall’équi pe infermieristica della pediatria per la discussione dei casi più problematici ricoverati in reparto. In Neonatologia viene utilizzato dal 1993 il gruppo mensile di discussione dei casi con il personale medico ed infermieristico secondo il modello di Bion. In entrambi i percorsi è risultata sempre più chiara la funzione del gruppo come luogo di confronto e contenitore del le angosciose e talvolta conflittuali situazioni che si creavano non solo tra il personale e i genitori, ma anche all’interno del gruppo stesso degli ope ratori. Ambedue le modalità di lavoro di gruppo hanno evidenziato come il trovare il tempo internamente per fermarsi a pensare, osservare, scrive re e discutere in gruppo, svolga un’importante funzione di contenimento e modulazione del potenziale persecutorio dei vissuti emotivi che dilaga no nel lavoro quotidiano. Riflettere sull’esperienza emotiva dei piccoli e dei genitori durante la degenza ha infatti permesso di riflettere anche sui sentimenti degli infermieri e dei medici nel rapporto con i pazienti e con i colleghi. - Narrazione: l’espressione e la condivisione di sentimenti così forti, di soli to nascosti e/o negati, è possibile solo se non c’è il timore del giudizio e se, accanto alla discussione in gruppo, si riescono a trovare altre modalità di espressione (poesie, racconti, sogni, rappresentazioni teatrali, immagi ni fotografiche, disegni...). Hanno iniziato i genitori inviando lettere per raccontare la loro esperienza in reparto. Gli operatori nel loro percorso di crescita prima hanno iniziato ad osservare, hanno raccolto e condiviso i racconti dei bambini, dei genitori e degli altri famigliari e poi si sono rac contati. Attraverso la narrazione è stato possibile esprimere comunicazio ni molto più complesse rispetto a quanto viene detto “nel gruppo” e con una caratteristica di maggiore intimità, dialogo interiore fino all’uso del linguaggio poetico. “Storie” raccontate su entrambi i versanti della rela 156 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 11 zione di cura, quella degli operatori e quella degli utenti e le loro fami glie. Conclusioni La narrazione come dono della propria esperienza vissuta può diventare ambito/strumento privilegiato per “l’ascolto” dei sentimenti e permette di ri considerare l’agire professionale nei suoi profondi e complessi significati relazionali. Riteniamo in questo modo alimentare una nuova cultura dei Servizi Sanitari Ospedalieri che sappia assumere la vita emotiva nella professionalità. Questa esperienza aumenta la consapevolezza che l’ospedale non può essere solo un posto fisico per la cura, la malattia, la morte ma deve offrire anche un posto della mente e nella mente per pensare la vita, la malattia e la morte. 157 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 Parte III Poster Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 160 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Sommario dei Poster 167 169 171 173 175 176 179 183 184 186 187 189 191 192 194 196 12.1. P. ANTONIOLI, F. ANZIVINO, E. CARLINI, Piano ferrarese per l’emergenza caldo estivo 2004: un’esperienza di continui tà assistenziale 12.2 D. PROCICCHIANI, G.B. CAMURRI, R. ZOBOLI, Continuità assi stenziale e riabilitazione del paziente emiplegico 12.3. G. BORGHI, S. LOMBROSO, L. LUZZI, M. MARZEGALLI, G. POLVANI, S. SCALVINI, Ospedale e territorio: una integrazione possi bile per alcune tipologie di pazienti cardiopatici 12.4. R. CERRI, C. DEVARDO, F. RIPA, M. RAVERA, P. PANARISI, Il caregiver come risorsa per la gestione del paziente 12.5. B. VINASSA, R. VALFRÈ, P. GIULIANO, V. VOTTERO, C. GALOTTO, P. SGUAZZI, Ospedale e territorio: il nostro legame e la nostra continuità è il nostro assistito 12.6. C. PONZETTI, S. G. CALVETTO, L. IANNIZZI, E. ROVAREY, R. GRIMOD, R. DAMÉ, G. GALLI, La continuità assistenziale nella rete HPH della Valle d’Aosta: lo stato dell’arte 12.7. M. G. DE ROSA, L. BONAFEDE, A. TOSELLI, R. BONO, R. SALOMO NE, F. BORASO, Sviluppo di un sistema informativo volto al monitoraggio della dimissione protetta nella ASL 17 12.8. R. BERTAMINI, E. VALDUGA, Integrazione ospedale /territorio 12.9. F. ROCCO, F. GADDA, S. CASELLATO, V. ORTOLANI, Progetto “dimissione protetta” 12.10. A. GIGLIOBIANCO, S. CECCHELLA, Il percorso dimissioni protette tra ospedale e territorio in un distretto dell’azienda USL di Reggio Emilia – il distretto di Guastalla 12.11. G. SACCHETTI, L. SACCHI, C. GREGARI, B. FACCHETTI, I. FINZI, A. AMOROSI, Il Centro di salute e ascolto per le donne immi grate e i loro bambini: luogo di ricerca e di proposta di cambiamenti organizzativi nei servizi materno infantili 12.12. A. FORACCHIA, A. VENTURINI, Integrazione tra i servizi territo riali e ospedalieri per le donne migranti a Reggio Emilia 12.13. G. BENAGLIA, A. VENTURA, A. BERTROZZI, C. VENTURA, Informa zione e formazione interculturale nella protezione della madre e del bambino 12.14. A. FERRETTI, D. GIORGETTI, Pasti unici e pasti etnici in ospe dale 12.15. P. BORGOGNONI, P. FAGANDINI, M. RAVELLI, L. CERULLO, Attra versare confini 12.16. L. PASQUARIELLO, C. PONZETTI, M. MUSI, G. CARRARA, L. PLATI, H. ZEN, R. ORIANI, B. DAGNES, Dal percorso formativo “Ver 161 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 199 12.17. 201 12.18. 203 12.19. 205 12.20. 207 208 12.21. 12.22. 210 12.23. 210 12.24. 213 12.25. 214 12.26. 217 12.27. 219 12.28. 221 12.29 222 12.30. so un ospedale senza dolore” dell’azienda USL Valle d’Aosta alla gestione del paziente con dolore sul territorio M. PESENTI CAMPAGNONI, A. CASTIGLION, O. TORRETTA, La com prensione del dolore e della sofferenza in ospedale: un pro getto di formazione del personale mediante osservazione antropologica L. CANAVACCI, E. MENONI, A.M. ALOISI, M.G. D’AMATO, A. GRASSO, R. MARCHINI, M. GIACCHI, Assistenza e trattamento del dolore. Uno strumento di indagine su conoscenze, atteggiamenti e comportamenti di infermieri e medici A. VENEZIANI, F. PICCA, S. MIGLIORINI, I. FRATI, V. FUSARI, A. APPICCIA FUOCO, Verso la creazione di un acute pain service nell’ambi to del progetto HPH “ospedale senza dolore” L. COLONNA, C. SESTINI, M. CALAMAI, La rilevazione dei bisogni formativi in tema di dolore: analisi delle risposte a un que stionario S. SOTTILI, Ospedale senza dolore: l’esperienza continua R. MASSEI, M. CANELLA, A. CAZZANIGA, L. FERRAIOLI, A. INVERNIZZI, M. BOSIO, A. ZOLI, P. CALTAGIRONE, Il progetto ospedale senza dolore come strumento di comunicazione aziendale F. RIPA, A. DE LUCA, L. RESEGOTTI, P. ZAINA, La rete HPH Pie monte e Valle d’Aosta e “l’Ospedale senza dolore” M. MONTEROSSO, G. ALBERTINI, M.G. ALLEGRETTI, B. BORTOLAMEOTTI, D. CHIUSOLE, G.M. GUARRERA, F. DALLAPÈ, G. MENEGONI, B. PARODI, D. PEDROTTI, C. PONTALTI, P. ROMITI, E. BALDANTONI, Ruolo del comitato per l’ospedale senza dolore nel promuovere una effettiva partnership tra professionisti e pazienti L. ANGELINI, D. CRESPI, M. GALBIATI, M. G. MEZZETTI, C. RADICE, F. RIZZI, L’ospedale senza dolore: promuovere una cultura per migliorare il benessere del paziente M.T. VITALE, M.E. LA GRASSA, D. COVA, E. COFRANCESCO, Le tecni che di rilassamento nella cura del dolore: reiki e paziente oncologico anziano A. BERNASCONI, A. CAVALERI, A. GAMBA, G. GENDUSO, N. MONZANI, A. MORETTO, A. RAIMONDI, A. RUSSO, M. SALA, R. SPERANZA, L. TUCCINARDI, A.VIRTUANI, Indagine conoscitiva sulla prevalen za del dolore nei pazienti ricoverati e su atteggiamenti e conoscenze del personale sanitario F. DALLAPÈ, B. BORTOLAMEOTTI, C. PONTALTI, M.G. ALLEGRETTI, G.M. GUARRERA, G. MENEGONI, M. MONTEROSSO, B. PARODI, D. PEDROTTI, P. ROMITI, E. BALDANTONI, Ruolo del comitato per l’Ospedale senza dolore nel processo di adeguamento agli standard Joint Commission International. L’esperienza di Trento D. PEDROTTI, M. ALLEGRETTI, B. BORTOLAMEOTTI, F. DALLAPÈ, G. GUARRERA, G. MENEGONI, M. MONTEROSSO, B. PARODI, C. PONTALTI, P. ROMITI, E. BALDANTONI, Trattamento del dolore post – ope ratorio. Raccomandazioni del comitato per l’ospedale senza dolore A. SALVATERRA, E. ANESI, Emersione di una patologia sottodia gnosticata: la “sindrome delle apnee ostruttive nel sonno”; 162 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 224 12.31. 226 12.32. 228 12.33. 229 12.34. 230 12.35. 232 12.36. 233 12.37. 235 12.38. 237 12.39. 239 12.40. 240 12.41. 242 12.42. 245 12.43. 247 12.44. 249 12.45. 251 12.46. 253 12.47. problematiche di asimmetria informativa e “governance”. Esperienza di un ospedale distrettuale nel Trentino S. ZILOCCHI, G.F. MININI, N. PELI, R. AVISANI, U. A. BIANCHI, S. PECORELLI, Perineal care: un moderno programma di tutela della salute della donna E. BOTTACCHI, G. CORSO, M. PESENTI CAMPAGNONI, A. ANTICO, C.ALLEGRI, C. PONZETTI, Integrazione ospedale / territorio Prato: progetto assistenziale territorio ospedale per le ma lattie cerebrovascolari R. VEDOVELLI, P. ABELLI, A. CAJELLI, R. AQUILANI, L’ospedale che nutre bene: un progetto di qualità in riabilitazione M. COSER, R. MERLO, E. PESARESI, La visita odontoiatrica nelle scuole materne M. P RANDINI , A. M IORELLI , L’ossigeno ventiloterapia domiciliare in Provincia di Trento: un difficile equilibrio tra salute e risorse S. CAPRILLI, L. BENINI, F. MUGNAI, “Gli incontri con gli ani mali” all’Ospedale Pediatrico Meyer: valutazione della realizzabilità del progetto M. BRASI, S. CONCETTI, A. M. PIETRANTONIO, A. BARALDI, A. ANANIA, Lo Stone Center dell’Ospedale di Carpi: modello di percorso multidisciplinare centrato sulla persona per la diagnosi, trattamento e prevenzione della calcolosi urinaria N. VINSANI, T. PELLI, D. MANFREDI, La terapia del sorriso e della comunicazione E. MANICARDI, M. LINCE, M. GANASSI, Procedura per l’attiva zione di consulenza infermieristica per pazienti diabetici U.O. EDUCAZIONE ALLA SALUTE e LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CON TRO I TUMORI, Un’esperienza di teatro in ospedale “L’uomo che smise di fumare” A. ZANOBINI, Azioni di comunicazione per il sostegno al governo clinico regionale - aprile-giugno 2004 M. CORDONI, G. MICHELI, F. PRATESI, A.M. BASSO, L. CIAMPI, E. MUGNAINI, Modello di relazione-comunicazione HPH nell’ambito della prevenzione cardiovascolare M. MARCUCCI, S. ARDIS, A. MERLI, G. DI QUIRICO, L. PULITI, A. DI VITO, M. ROSSI, M. GIRALDI, Percorso formativo per i vo lontari del pronto soccorso S. ARDIS, M. MARCUCCI, A. MERLI, G. DI QUIRICO, L. PULITI, A. VINCENTI, M. DE GENNARO, M. GIRALDI, Persone a rischio di discriminazione in ospedale: aiutiamole a difendersi S. ARDIS, M. MARCUCCI, G. DI QUIRICO, L. PULITI, A. DI VITO, M. ROSSI, M. GIRALDI, Aiuto ai familiari delle persone che acce dono al Pronto soccorso A. BELFIORE, V. O. PALMIERI, G. PALASCIANO, Arte e cultura in ospedale: l’esperienza della clinica medica “Augusto Murri”, Policlinico, Bari A. CAZZANIGA, L. FERRAIOLI, A. INVERNIZZI, M. BOSIO, A. ZOLI, P. CALTAGIRONE, La prevenzione delle lesioni da decubito in ambito ospedaliero, analisi delle Best Current Evidence 163 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 254 12.48. 257 12.49. 258 12.50. 259 12.51. 261 12.52. 263 12.53. 265 12.54. 266 12.55. 268 12.56. 269 12.57. 271 12.58. 273 12.59. 275 12.60. Based ed elaborazione di un processo aziendale di preven zione A. MARIANI, E. POGGI, C. BENEDETTO, A. FILIPPI, Empowerment delle pazienti sottoposte a linfoadenectomia ascellare per neoplasia mammaria M. PARPANESI, P. SIRONI, Indagine conoscitiva sulle abitudini al fumo dei dipendenti di reparti a rischio dell’Azienda Ospedaliera di Cremona R. ALBERTAZZI, D. CANDIOLI, Verifica della qualità percepita dal l’utente in un percorso di promozione della salute relativa al trattamento riabilitativo della lombalgia A. BOLOGNANI, M. FLORIANI, S. SCARAMUZZA, Progetto “Soprai mille”. Collaborazione tra Centro Salute Mentale e Società degli Alpinisti Tridentini M. ALBERTINI, M. CHIODEGA, A. FILIPPI, A. CAZZOLLI, D. GROTTOLO, M. ROSA, B. PENASA, RAR: referente alcologico di reparto L. CARMELLINI, A. SANNICOLÒ, A. FLAIM, F. CICCARONE, V. LEONI, M. PRANDINI, Attuazione del sistema qualità: valutazione della soddisfazione dell’utente presso un servizio di fisiopatologia respiratoria- Dati preliminari A. APPICCIAFUOCO, M. MANFREDI, P. MINALE, G. ERMINI, P. CAMPI, C. MENICOCCI, C. TAZZER, A. ALESSANDRI, R. GUADAGNO, I. FRATI, D. MAZZOTTA, R. BRUNETTI, R. PREDONZANI, F. SIMONELLI, P. MORELLO MARCHESE, Progetto HPH interregionale “Allergia a scuola”: verso la realizzazione di un sito web per adolescenti V. BRUSAFERRO, F. BAZZANI, Y. KOOMEN, G. MATTEVI, F. MIORI, B. VILLOTTI e A. SALVATERRA, Ruolo dell’educazione sanitaria nel la terapia dell’asma D. COSTI, M. GARAMANTE, M. FERRARI, S. GALERO, G. ROSARIO, L. CAMORANI, Il counselling infermieristico per l’informazione terapeutica al paziente psichiatrico sugli psicofarmaci pre scritti G. GUANDALINI, N. MAZZINI, Un servizio di informazione e va lutazione degli ausili tecnici come strumento di promozio ne della salute S. CORTOPASSI, M. FILIERI, L. MORELLI, R. GUERRINI, A. D’ALESSAN DRO, I giovani del servizio civile quale risorsa nel processo di accoglienza ospedaliera A. APPICCIAFUOCO, G. RANDELLI, F. BUONO, D. BELLUCCI, A. MATUCCI, G. MARIN, M. MANFREDI, P. CAMPI, A. MARTINI, C. RUSSO, Proget to HPH “Musica in Ospedale”: per la realizzazione di una migliore accoglienza ed assistenza del paziente nel Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio – ASL 10 Firenze P. ABELLI, V. PARISI, P. LOMBARDI, P.G. MAGGI, R. VEDOVELLI, L. MAGGI, G. GHIGNI, M. ZUCCHELLA, G. CAMPO, R. AQUILANI, La pre venzione primaria della malattia cardiovascolare: eccesso di peso, alimentazione, attività fisica e lipidi ematici di una popolazione di adolescenti. 164 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 277 279 280 282 283 285 287 288 290 292 294 296 298 299 301 302 304 12.61. D. MICHELLINI, A.M. FERRARI, C. CAMPARI, Alimentarsi bene per crescere meglio: risultati finali 12.62. S. BOSI, A.M. FERRARI, S. DE FRANCO, R. BOSI, R. CAVALLI, G. AZZARONE, M. PEDRONI, C. SPAGGIARI, R. TOFFANETTI PANNELLA, O. MALVONI, Le vie del Fumo 12.63. D. MICHELLINI, A.M. FERRARI, C. CAMPARI, Alimentarsi bene per crescere meglio: comunicare come? 12.64. P.A. MILANI, S. CAMPETELLA, P.A. LOMBARDI, P.G. MAGGI, A. ZANCAN, P. ROVATI, L. SONETTI, T. BRIGADA, C. RAMPINI, F. CATA NIA, R. AQUILANI, La promozione della salute nell’anziano: riduzione del rischio di caduta 12.65. F. CARBONARO, A. MATTUZZI, G. BELLANTE, B. DE MORI, A. BERNARDI, Intervento di sensibilizzazione sulla malattia diabetica rivolto alla cittadinanza: esperienza di 6 anni 12.66. C. SPAGGIARI, S. BOSI, A. M. FERRARI, “Baby no smoke”. Pro getto sperimentale pediatri di famiglia 12.67. L. DONATI, Dal progetto “Conoscere il consultorio” 12.68. M. ANFOSSO, Progetto Vita 12.69. M.G. BAÙ, V. DONVITO, E. MAZZOLI, C. PERIS, C. PICCO, G. POP PA, Donne in ospedale: S. Anna- focus sulle pari opportu nità attraverso la sensibilizzazione 12.70. E. AGOSTI, P. GROSSO, G. GULINO, D. LEVI, T. LUBRANO, M. PAIN, C. PONZETTI, Esperienza di una ricerca/azione. La WHP in un’azienda sanitaria 12.71. F. SIMONELLI, A. ZAPPULLA, K. MAJER, M. J. CALDÉS PINILLA, C. TEODORI, La formazione come opportunità di sviluppo organizzativo della rete HPH 12.72. L. ROSSETTI, G. MAGNANI, D. MILANI, I. PO, A. M. PIETRANTONIO, C. CARAPEZZI, R. BONATTI, S. CENCETTI, Dalla esperienza di confronto con la sofferenza, alla proposta di una cultura di salute 12.73. S. ARDIS, M. MARCUCCI, A. MERLI, G. DI QUIRICO, L. PULITI, A. VINCENTI, E. GAMBOGI, D. BEVILACQUA, M.A. MALERBI, M. GIRALDI, R. GOTTARDI, Ignoranza: un terreno fertile per la discrimi nazione in sanità 12.74. R. GAGNO, Realizzazione eventi pubblici di promozione ed educazione alla salute 12.75. A. M.CIRLA, R. FAZIOLI, L. GALLI, C. MEINECKE, Esperienza di promozione della salute durante il lavoro infermieristico. Ergomotricità per la prevenzione dei disturbi muscolosche letrici 12.76. N. PULERÀ, G. MATTEELLI, A. SCOGNAMIGLIO, A. SANTOLICANDRO, Confronto tra popolazione generale e dipendenti ASL afferenti ad un centro antifumo: l’esperienza del “Centro per il trattamento e la prevenzione dei danni indotti dal fumo di tabacco” di Livorno 12.77. G. GADDOMARIA, D. COSTI, L. TAGLIABUE, Il progetto gestione del rischio nel dipartimento di salute mentale di Reggio Emilia 165 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 306 307 310 311 314 12.78. G. MORINI, D. COSTI, A. PINOTTI, M. POLETTI, La documentazione di qualità del dipartimento salute mentale come supporto alla valutazione e gestione dei rischi lavorativi 12.79. R. ROSSO, Il Sistema Qualità nell’Azienda Ospedale Università San Martino di Genova 12.80. M. C. AZZOLINA, I. M. RACITI, R. ARIONE, P. PANARISI, Paziente onco logico e continuità assistenziale 12.81. A. BRANDI, P. GIOACHIN, R. MARILLI, Linee guida aziendali sulla prevenzione delle cadute nel paziente anziano: risultati di una sperimentazione 12.82. S. CORONA, M. CASTELLETTO, La promozione della salute attraverso una campagna di comunicazione sul diabete mellito. L’esperienza dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” Pordenone. 166 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Poster 12.1. Piano ferrarese per l’emergenza caldo estivo 2004: un’esperienza di continuità assistenziale P. ANTONIOLI1, F. ANZIVINO2, E. CARLINI1 - 1Direzione Medica di Presidio, 2U.O. di Geriatria. Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, in collaborazione con: Assessorato alla Sanità e Servizi alla Persona-Comune di Ferrara, Azienda USL di Ferrara, Associazioni di Volontariato “AUSER, ARCI, ACLI, CRI” AUTORE REFERENTE: PAOLA ANTONIOLI, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Corso Giovecca 203, 44100 Ferrara - tel.: 0532 236210/288, fax: 0532 236588, e-mail: [email protected] Condizioni naturali di elevata temperatura hanno un impatto sulla salute ben più grave nelle persone anziane, in condizioni di salute precarie e con ridotte capacità individuali, familiari e sociali di fronteggiare situazioni difficili. In con siderazione delle condizioni climatiche particolarmente pesanti osservate an che nella nostra Provincia nell’estate 2003 e dei dati epidemiologici di morbilità e mortalità relativi, in particolare, al periodo giugno-agosto 2003, è stato predi sposto il Piano per l’Emergenza Caldo Estivo per coordinare tutti gli interventi socio-assistenziali per i cittadini anziani residenti nel Comune di Ferrara. Il Gruppo target di riferimento è stato identificato sulla base dei seguenti criteri: residenza nel Comune di Ferrara, età > 75 anni, essere affetti da malat tie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche, diabete, neoplasie e/o essere portatori di disabilità e/o essere in una situazione abitativa precaria e/o non avere parenti/persone di riferimento e/o non essere seguiti dai servizi territo riali sociali o sanitari. Il Piano prevede alcune tappe di sorveglianza ed intervento che possono essere così schematizzate: Fase della rilevazione del bisogno: costruzione di un sistema in grado di segnalare le persone che sono più a rischio sia per problematiche sociali che sanitarie. I canali di informazione-segnalazione possono essere vari ma, nella maggioranza dei casi, sono identificabili nei MMG, nei Centri Sociali e nel Servizio Sociale del Comune. Fase della telesorveglianza: è affidata alle Associazioni del “Volontariato” che mettono in atto un controllo periodico (uni o plurisettimanale) in cui, attraverso un questionario, valuta se insorgono possibili problemi assistenziali. 167 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Fase dell’intervento diretto: qualora nell’intervista telefonica insorgessero dubbi sulla appropriatezza delle risposte, il volontariato concorda con l’uten te, dove possibile, una visita a domicilio, secondo uno schema di valutazione standardizzato in una apposita scheda. Si possono ipotizzare alcune situazio ni tipiche: - La situazione appare tranquilla per cui si concorda di proseguire con la telesorveglianza. - Vi sono elementi di dubbio per cui si concorda un’altra visita a breve termi ne (1-2 giorni). - Si rileva una situazione diversa dal passato e preoccupante per cui si coin volge il MMG per un controllo clinico a domicilio ed eventualmente, con lui, si valuta la necessità di attivare l’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) territoriale. - Solo se la situazione fosse veramente critica si attiva l’emergenza territoria le, tramite il 118, per l’eventuale ricovero. Fase del ricovero: è la soluzione che deve essere riservata nei casi in cui la precarietà della situazione o clinica o di abbandono sociale renda non gestibile la persona a domicilio. Anche in questo caso le strategie sono differenziate e graduali: - Ricovero in Centro Diurno; - Ricovero in Casa Protetta (ricoveri di sollievo); - Ricovero in Ospedale. Ricovero in Ospedale: è stata definita una procedura per il ricovero di que sti pazienti che prevede in sostanza: - una corsia preferenziale di accesso al PS; - l’occupazione dei posti letto liberi nelle varie medicine ma con visita, in tempi stretti, dell’UVG-Ospedaliera per valutare la dimissibilità; - l’apertura di uno o due reparti chiusi nel periodo estivo che saranno dedi cati esclusivamente a tali pazienti. In ogni caso questi pazienti saranno seguiti con un programma di monitoraggio e di dimissione protetta o a domicilio o in strutture residenziali (RSA e Case Protette). Tutti gli operatori coinvolti, in particolare i soggetti deputati alla telesorveglianza e al controllo domiciliare, parteciperanno a specifici momenti formativi. Per valutare l’efficacia del sistema, sono stati posizionati negli snodi critici indicatori “di necessità”, finalizzati a cogliere i bisogni della popolazione target e l’appropriatezza della risposta fornita dal sistema. Grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti nel Piano è stato possibile realizzare un approccio sistemico di intervento e risposta ai bisogni della po polazione anziana a fronte di un problema particolarmente rilevante per le conseguenze registrate. Da sottolineare il valore aggiunto legato alla metodologia di intervento applicata. 168 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.2. Continuità assistenziale e riabilitazione del paziente emiplegico D. PROCICCHIANI, G. B. CAMURRI, R. ZOBOLI - Unità Operativa di Recupero Rieducazione Funzionale (direttore: dott. G. B. Camurri) Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: DONATELLA PROCICCHIANI, RRF Ospedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento 80, 42100 Reggio Emilia – tel.: 0522 296163, fax: 0522 296266, e-mail: [email protected] La nostra unità operativa tratta, in regime di degenza, circa 300 pazienti l’anno. Di questi, il 40% sono emiplegici per un ictus cerebrale recente. Per questi pazien ti, che sono i più gravi della nostra casistica, dalla fine degli anni ‘90, abbiamo cominciato a riflettere su come migliorare la preparazione della dimissione. Spesso la riabilitazione in regime di degenza ospedaliera dei soggetti emiplegici lavora in un setting protetto e autoreferenziale, dal quale è esclusa ogni relazione con l’esterno. Ci si accontenta che il paziente sia clinicamente stabile e recuperi alcune abilità, in particolare camminare con l’aiuto della fisioterapista. L’autonomia personale è poco curata, i rapporti con la famiglia sono occasionali, la prognosi di recupero è imprecisa e tardiva, la dimissione è decisa e comunicata in maniera affrettata, ci si dimentica degli ausili che saranno necessari a casa. Nessuno si sente responsabile della futura qualità di vita del paziente e della sua famiglia. Fino a pochi anni fa, anche se con cre scente disagio, questo era anche il nostro modo di lavorare. Tra i motivi che ci spingevano al cambiamento c’erano il malessere degli operatori e la conflittualità con la famiglia al momento della dimissione. Molto ha influito anche l’insistenza della letteratura in lingua inglese sulla necessità di cominciare a organizzare la dimissione fin dal momento dell’ingresso. Da queste sollecitazioni è iniziato, nel 2001, il nostro progetto di miglioramento della preparazione della dimissione. Il progetto si propone l’obiettivo di facilitare la dimissione discutendo in anticipo i problemi che il paziente e la famiglia avranno a casa. Gli indicatori individuati sono: - la riduzione dei tempi di degenza, - l’aumento della percentuale dei dimessi a domicilio, - la riduzione della conflittualità con le famiglie. Come riferimento di baseline utilizziamo il 2000, l’ultimo anno intero prima dell’inizio dell’azione di cambiamento. Il gruppo di pazienti target del progetto sono gli emiplegici, perché sono i più gravi, sono numerosi, restano ricoverati a lungo e consumano circa la metà delle nostre risorse. 169 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Il principale intervento organizzativo è stato la costituzione di un team interdisciplinare in cui gli operatori condividono valori e obiettivi: la restituzio ne dell’autonomia al paziente e il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile. Di conseguenza, già al momento dell’ingresso, serve una prognosi funzionale precisa sul livello di autonomia previsto alla dimissione. Per misura re obiettivi e risultati, e scambiare informazioni abbiamo adottato scale di valu tazione. Esistono riunioni periodiche del team per la preparazione di progetti e obiettivi e per la loro successiva verifica. Abbiamo posto molta enfasi sul recupero di tutte le abilità personali: camminare, lavarsi, vestirsi, andare in bagno, parla re, scrivere, uscire, riprendere i rapporti con il lavoro, la famiglia e gli amici. Coinvolgiamo le famiglie fin dall’ingresso, ascoltando le loro preoccupazioni e rispondendo alle loro domande. Per i pazienti privi di un sufficiente sostegno familiare, richiediamo, molto precocemente, la collaborazione delle assistenti sociali. La data della dimissione viene concordata con almeno due settimane di anticipo, sono prescritti gli ausili necessari a casa. Inoltre, coloro che lo deside rano vanno a casa per il weekend. Dopo la dimissione seguiamo il paziente con un trattamento ambulatoriale per alcune settimane. Nel 2000, anno di baseline per il nostro progetto, la durata della degenza si poteva considerare buona, mentre la percentuale di dimessi a domicilio era bassa. I risultati, in termini di riduzione dei tempi di degenza e aumento dei dimessi a domicilio, già visibili nel 2001, sembrano consolidarsi negli anni successivi. Tab. 1 numero pazienti età media durata degenza % dimessi a domicilio 2000 118 74,3 37,5 78,4 2001 127 72,4 33,6 83,7 2002 137 73,0 28,0 88,9 2003 144 69,8 27,3 87,3 I reclami, già pochi in precedenza, sono ora azzerati. Si prevede di attuare un’indagine qualitativa per conoscere e capire meglio le esigenze, le difficol tà, le aspettative, il punto di vista dei pazienti e dei loro familiari e il loro gradimento sull’attività svolta dal team. Lo strumento adottato sarà quello del l’intervista semistrutturata, che consente un livello di approfondimento mag giore, un rapporto diretto con l’intervistato e può fornire elementi in grado di guidare interventi futuri di miglioramento. Conclusioni: il progetto ha conseguito buoni risultati fin dai primi anni. Con la durata della degenza si sono ridotti i costi, senza riduzione dei risultati misurati dalle scale di valutazione. Constatiamo un aumento del la soddisfazione delle famiglie, e in generale un clima più sereno per i 170 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 pazienti e gli operatori. Le famiglie si sono mostrate più collaboranti del previsto e reagiscono positivamente quando si vedono ascoltate e aiuta te. Di contro, per alcuni operatori questo modo di lavorare risulta troppo impegnativo, sia da un punto di vista fisico che emozionale. Alcuni di essi, con noi all’inizio, hanno preferito chiedere il trasferimento e rinun ciare. 12.3. Ospedale e territorio: una integrazione possibile per alcune tipologie di pazienti cardiopatici G. BORGHI1, S. LOMBROSO2, L. LUZZI3, M. MARZEGALLI4, G. POLVANI5, S. SCALVINI6 1 Regione Lombardia D.G. Sanità/CEFRIEL; 2A.O. Busto Arsizio; 3Regione Lombardia D.G. Sanità; 4A.O. San Carlo Milano; 5IRCCS Fondazione Cardiologico Monzino Milano; 6IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Gussago AUTORE REFERENTE: GABRIELLA BORGHI, U.O. Programmazione Direzione Genera le Sanità Regione Lombardia, Via Pola 9/11, 20124 Milano – tel.: 02 67653325, fax: 02-67653128, e-mail: [email protected] Contesto Partendo dalla situazione epidemiologica attuale dei pazienti post acuti che presentano ampie situazioni di cronicità o necessità di riabilitazione, si è volu to sperimentare e valutare modelli assistenziali al domicilio dei pazienti, qua le valore aggiunto rispetto al ricovero in ospedale. La Regione Lombardia, basandosi su alcune iniziative presenti sul territorio, ha attivato, nel dicembre 2002, il progetto CRITERIA (Confronti fra Reti Integrate TEcnologiche per gestire a domicilio pazienti post acuti e cronici – RIcerca Applicata), che ha cofinanziato nell’ambito dei progetti di ricerca del Ministe ro della Salute. CRITERIA1 sperimenta due innovative modalità di gestione al domicilio di pa zienti cardiopatici: - Ospedalizzazione Domiciliare Riabilitativa postcardiochirurgica; - Telesorveglianza Sanitaria domiciliare. Obiettivi Elaborare due percorsi sanitari appropriati utilizzando modalità assisten 1 Si veda: http://www.sanita.regione.lombardia.it/ricerca_progetti/ministeriali/progetto_criteria.pdf 171 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 ziali alternative al ricovero ospedaliero, garantendo continuità assistenziale ai pazienti e ponendosi come alternativa valida in termini di: a) cura, con riduzione delle riammissioni o delle giornate di degenza; b) miglioramento della qualità di vita del paziente che è messo in grado di restare nel proprio ambiente sociale e di relazione; c) miglioramento della qualità dell’assistenza (grado di soddisfazione dell’utenza e degli operatori); d) risparmio di risorse, basato anche sull’utilizzo delle nuove tecnologie biomedicali e dell’informazione. Ulteriore obiettivo: valutare le tariffazioni sperimentali indicate a livello iniziale di progetto, affinché tali percorsi pos sano essere introdotti a regime. Per ognuno dei modelli di gestione è stato definito, congiuntamente dai partecipanti a CRITERIA, un protocollo clinico condiviso, ed elaborato un per corso sanitario appropriato ed in rete che utilizza anche la telemedicina. 1. Ospedalizzazione Domiciliare Riabilitativa post cardiochirurgica - per una durata di non più di 28 giorni per 200 pazienti. Gli IRCCS Cardiologico Monzino e Fondazione Maugeri seguono pazienti rispettivamente nelle aree di Milano e Brescia. Il percorso, con il supporto di un telemonitoraggio su ECG, consente di dimettere il paziente e di continuare a seguirlo verificandone i parametri funzionali dal domicilio. Al protocollo sono ammessi pazienti operati di bypass aorto-coronarico e/o di correzione di patologia valvolare che ri spondano a predefiniti criteri, quali ad esempio: profilo di rischio preoperatorio Euroscore compreso tra 0 e 10; assenza di complicanze, va lori di emoglobina maggiori o uguali a 8,5; ecc...; oltre alla presenza di un adeguato contesto abitativo e di un familiare. Al paziente, dimesso dopo 3 4 giorni dall’intervento, viene consegnato un elettrocardiografo transtelefonico monotraccia con il quale invierà un tracciato giornalmente o in caso di disturbi. Il percorso ha una durata minima di 15 giorni e massi ma di 28. Il programma riabilitativo domiciliare prevede standard minimi di servizio in termini di accessi domiciliari di medico, fisioterapista, infer miere. 2. Telesorveglianza Sanitaria Domiciliare - per una durata di sei mesi per 300 pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico. Gli IRCCS Maugeri e Monzino, nonché l’A.O. di Busto Arsizio seguono pazienti rispettivamente nelle aree di Brescia, Milano e Busto Arsizio. Il numero di pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico è in continua cresci ta nei paesi occidentali. CRITERIA propone, per questi pazienti medio gravi, un programma domiciliare basato su un telemonitoraggio attraverso ECG monotraccia e l’assistenza di personale infermieristico di riferimento. I pazienti ammessi devono avere una diagnosi di scompenso cardiaco (classi NYHA II-IV) 172 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 ed un ricovero ospedaliero nei precedenti sei mesi. Il reclutamento può avveni re sia da parte del MMG sia da parte dell’ospedale in fase di dimissione, con consenso del paziente ed accordo del MMG. Il paziente riceve un apparecchio per l’invio transtelefonico dell’ECG monotraccia che viene inviato ad Centro Ser vizi, operante 24/24 h per 365 giorni annui, che lo pone in collegamento con l’infermiera tutor e con l’equipe cardiologica ospedaliera a cui trasmette anche altre variabili fisiologiche quali peso, diuresi, temperatura, e sintomatologia. Le informazioni sul paziente sono utilizzabili in linea e sono accessibili sia all’ospedale che al MMG. Il servizio vuole ridurre le instabilizzazioni della malattia e conseguentemente le riospedalizzazioni, nonché gli accessi impro pri al Pronto Soccorso. Infine poiché la Fondazione Maugeri (www.fsm.it) e il Centro Cardiologico Monzino (www.cardiologicomonzino.it) operano con due differenti Centri Servizi (HTN e MEDICALL), il Cefriel (www.cefriel.it) svilupperà un applicativo web per rendere comuni e disponibili le informazioni di progetto. Risultati: coinvolti ad oggi circa 150 pazienti. Il Cergas (Università Bocconi) condurrà la valutazione del progetto che ci si augura possa confermare i primi dati di gradimento dei pazienti per queste modalità di cura. 12.4. Il caregiver come risorsa per la gestione del paziente R. CERRI, C. DEVARDO, F. RIPA, M. RAVERA, P. PANARISI - ASO San Giovanni Battista Torino Introduzione La riduzione delle giornate di degenza indotta dall’attenzione all’efficienza produttiva derivata processo di aziendalizzazione ha portato alla conseguen te contrazione del tempo di ricovero, ma la famiglia non sempre è preparata ed è in grado di gestire le dimissioni precoci, soprattutto per i pazienti che necessitano di proseguire le cure o di assistenza al domicilio. Nel 2003 la no stra azienda ha peraltro trasferito 274 pazienti in dimissione protetta, una strut tura aziendale dove sono ricoverate persone che per problemi sociosanitari non possono rientrare direttamente al proprio domicilio. L’attuale discrepanza fra bisogno assistenziale e risorse disponibili suggeri sce di coinvolgere maggiormente l’entourage del paziente nell’assistenza. D’al tro canto i pazienti con patologie croniche irreversibili oggi sono inseriti in un sistema di cure dove la distribuzione del lavoro, delle attività e delle responsa bilità è organizzata in sottosistemi omogenei (cure ospedaliere, cure domiciliari, cure residenziali) non sempre fra loro interagenti ed integrati. Il paziente nel suo percorso può passare da un sistema ad un altro rischian do di perdere i propri riferimenti terapeutici ed assistenziali. Il disorientamento 173 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 prodotto può portare l’utente alla richiesta di ricovero inappropriato. L’A.S.O. può contribuire allo sviluppo di un programma di gestione globale che superi la divisione settoriale esistente, contribuendo con le proprie risorse al sistema integrato di supporto assistenziale per l’utente curato nel proprio ambiente familiare; da questa considerazione è nato un progetto sperimentale. Obiettivo Gli obiettivi del progetto si concretizzano nel valorizzare il ruolo della fami glia e del caregiver nel sistema aziendale, utilizzarli come risorsa nella gestio ne del paziente con problemi cronici invalidanti, facilitare il processo di inte grazione fra ospedale e territorio. Sviluppo del progetto Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte le Strutture aziendali che maggiormente inviano i pazienti alle cure domiciliari o in RSA: Oncologia Medica, Endocrinologia Oncologica, Geriatria, Radioterapia. Il progetto si configura sul modello plan, do, check, act e si articola nei seguenti aspetti: - individuazione dei momenti assistenziali utili al training del caregiver at traverso la valutazione del percorso assistenziale dei pazienti - definizione del percorso di training del caregiver - raccolta delle procedure e dei protocolli consolidati ed utili per la forma zione del caregiver - stesura della lista di controllo per l’attuazione della fase sperimentale La sperimentazione avrà luogo a partire dal mese di luglio. Valutazione Il progetto sarà valutato attraverso: - il livello di raggiungimento degli obiettivi assistenziali previsti dai training - il grado di soddisfazione del parente e/o della figura di riferimento Considerazioni ulteriori L’impatto positivo del progetto sulle Strutture aziendali e la sua diffusione potrà ridurre le richieste improprie di ricovero per i pazienti dimessi dalle nostre strutture e le consulenze informali e formali richieste dai parenti che assistono i propri familiari al domicilio. Ma soprattutto potrà rappresentare un valore aggiunto per i pazienti e per gli stessi famigliari, che potranno global mente partecipare in modo integrato al processo di diagnosi e cura. 174 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.5. Ospedale e territorio: il nostro legame e la nostra continuità è il nostro assistito B. VINASSA, R. VALFRÈ, P. GIULIANO, V. VOTTERO, C. GALOTTO, P. SGUAZZI - Distretto 3 Orbassano (To) AUTORE REFERENTE: BARBARA VINASSA, ASL 5 Orbassano, via Papa Giovanni XXIII 9, 10043 Orbassano (To) – tel.: 011 9036460, fax: 011 9036462, e-mail: [email protected] L’esigenza di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria anche successi vamente al ricovero ospedaliero prevede l’utilizzo di appropriati modelli or ganizzativi, da utilizzare nella fase precoce di dimissione, concordati tra strut ture ospedaliere e strutture territoriali. Tali modelli si debbono basare su una corretta valutazione delle necessità assistenziali post-ricovero del paziente in dimissione da parte del personale ospedaliero e sulla messa a disposizione di idonei interventi di sostegno, con cordati con la struttura ospedaliera, da parte delle strutture territoriali. Situazione di avvio L’ASL 5 in questi ultimi anni si è adoperata per affrontare, con competenza ed efficacia, le situazioni di bisogno che si possono prefigurare e che più frequentemente rappresentano la problematicità che l’organizzazione ospedaliera in accordo e collaborazione con la realtà assistenziale territoriale deve operare a risolvere: pazienti con bisogni sanitari ospedalieri residui, pa zienti autosufficienti con bisogni sanitari NON ospedalieri, pazienti NON autosufficienti con bisogni sanitari NON ospedalieri, pazienti autosufficienti con bisogni socio-assistenziali. Obiettivo Perfezionamento delle procedure organizzative già in atto anche mediante la codificazione del programma immaginato e coinvolgimento dell’ASO S. Luigi Gonzaga in una definizione di DIMISSIONE PROTETTA. Strategie È prevista la stesura di una serie di documenti volti ad una maggiore infor mazione al paziente e famigliari dei percorsi già programmati, ad un migliora mento della trasmissione di informazione delle caratteristiche assistenziali dell’utente tra Ospedale e Territorio, ad un maggior coordinamento e condivisione rispetto al bisogno del ricoverato tra Direzione Sanitaria e Con 175 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 sorzio Socio-Assistenziale di riferimento ed anche ad una raccolta di dati circa le condizioni abitative/economiche, della convivenza del paziente al momen to del ricovero per dare la possibilità agli Operatori di meglio programmare le esigenze di dimissione. Metodologia Creazione di un tavolo di lavoro composto da gruppo progettuale HPH “DIMISSIONI PROTETTE” dell’ASL 5 e dalla Direzione Sanitaria dell’ASO S. Luigi che avrà il compito precipuo di analizzare le specifiche realtà operative e di produrre i documenti di cui sopra. Risultati Il tavolo di lavoro si è riunito tre volte ed ha messo a punto: A) Modulo Autocertificativo da somministrare al momento dell’accettazione al ricovero contenente informazioni utili alla lettura del bisogno in ordine alle modalità di dimissione (caratteristiche strutturali domicilio, conviven za, reddito). B) Opuscolo Illustrativo dei percorsi da intraprendere, a seconda del biso gno, da consegnare al momento del ricovero al paziente e/o ai famigliari. 12.6. La continuità assistenziale nella rete HPH della Valle d’Aosta: lo stato dell’arte C. PONZETTI (Direttore Sanitario); S. G. CALVETTO, L. IANNIZZI, E. ROVAREY (Diret tori di Distretto); R. GRIMOD, R. DAMÉ (Coordinatrici Territoriali delle professio ni sanitarie); G. GALLI (Responsabile Area Comunicazione e Coordinatore Regionale Rete HPH) - Azienda USL Valle d’Aosta Lo sviluppo dei rapporti tra Ospedale e Territorio nella Regione Valle d’Aosta al fine di garantire una ottimale continuità assistenziale è, storicamente, uno degli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale la cui priorità è stata affermata sia dagli ultimi due Piani Sanitari Regionali sia dai Piani di Attività Aziendali del recente quinquennio. Gli strumenti riconosciuti come fondamentali sono stati individuati nella presa in carico territoriale, la dimissione protetta, l’assistenza domiciliare, il coinvolgimento partecipativo delle componenti professionali, il coinvolgimento costante e continuo del livello regionale. La Regione Valle d’Aosta ha un’unica Azienda USL, che gestisce l’attività sia ospedaliera sia territoriale, finanziata su base budgetaria per il raggiungimento 176 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 dei livelli essenziali di assistenza e per la messa in pratica di progetti regionali; l’accordo di programma viene siglato tramite la stipula annuale del Piano Attuativo Locale (PAL) che definisce obiettivi, standard, livelli di performance e strumenti di misura. I servizi sociali vengono direttamente erogati dall’Assessorato alla Sanità/ Salute e Politiche Sociali della Regione che quindi assume anche la compo nente gestionale dei servizi resi al cittadino. Questa molteplicità di attori ha creato nel tempo alcune criticità relative principalmente alla condivisione del metodo di lavoro, la definizione delle competenze, la sovrapposizione dei ruoli in alcuni ruoli e processi. La necessità della condivisione dei percorsi ha indotto l’Azienda Sanitaria ha sviluppare una nutrita serie di progettualità che si sono concretizzate nel corso di quest’anno in merito alla dimissione protetta ed ai profili di cura con divisi. Progetto Integrazione L’integrazione tra ospedale e territorio, è una condizione indispensabile al fine di garantire la continuità delle cure a domicilio e in struttura residenziale o semiresidenziale facilitando le dimissioni precoci e riducendo i tempi di degenza. Obiettivi primari - Garantire la continuità assistenziale sanitaria e socio sanitaria in un ottica integrata al fine di ridurre i tempi di ricovero e facilitare le dimissioni pre coci. - Favorire il mantenimento dei soggetti presso il proprio domicilio attraver so lo sviluppo e la diffusione dei servizi domiciliari, in particolare in forma integrata, contrastando il ricorso alla istituzionalizzazione e con un indub bio vantaggio per la qualità della vita. - Mettere in atto una fattiva collaborazione sia in termini di coordinamento formale che di sostanziale integrazione degli interventi, tra i diversi ambiti assistenziali sanitari (ospedalieri e territoriali) ed i servizi sociali delle Re gione Valle d’Aosta. Obiettivi secondari - Migliorare e ampliare le conoscenze tra ospedaliere e territorio attraverso l’informazione e la formazione. - Condividere tra gli Enti e tra i professionisti, le procedure applicative al fine di favorire la continuità assistenziale sia in struttura residenzia 177 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 le sia a livello domiciliare (ADI), utilizzare strumenti comuni e condi visi. - Individuare gli utenti a rischio sociale attraverso l’uso di indicatori e scale di valutazione per facilitare le dimissioni. - Formulare progetti individualizzati, che coinvolgono gli operatori ospedalieri, territoriali, i degenti ed i loro famigliari già durante il ricovero per permettere l’individuazione di soluzioni idonee per garantire la conti nuità delle cure. - Facilitare la comunicazione tra i vari operatori e tra i MMG, dal territorio all’ospedale e viceversa. Progetto Profili di cura I profili di cura o percorsi diagnostico - terapeutici sono piani interdisciplinari mirati a definire la migliore sequenza di azioni (gestione integrata), nel tempo ottimale, degli interventi assistenziali, rivolti a target specifici di pazienti, cioè a quelli con particolari diagnosi o che possono richiedere procedure specifiche. La gestione integrata tra Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e la Struttura Specialistica, in tutte le situazioni cliniche, ma in particolare nel disease management di una patologia cronica, richiede pri ma di tutto una condivisione di obiettivi. Questa è possibile dopo che i vari attori del procedimento si siano confrontati in più riprese e dove si siano det tati degli obiettivi di buona pratica clinica, definiti con i criteri della EBM. Al fine di elaborare un progetto operativo la filosofia che deve spingere le varie figure professionali è fondata sulla centralità del paziente quale obietti vo dei servizi offerti e della regolazione della domanda. Il malato cronico deve potere ricevere le cure adeguate sia dallo specialista che dal MMG, dosando gli interventi dei professionisti a seconda delle necessità specifiche del decor so della malattia. Nella prima fase di applicazione della gestione integrata possono non ri dursi significativamente i costi di assistenza, ma si aumenta il valore della pre stazione sanitaria razionalizzando i comportamenti clinici con conseguente corretta distribuzione delle risorse. Nel medio - lungo termine la riduzione delle complicanze può portare ad un miglioramento della qualità della vita dei pazienti ed ad una riduzione dei costi di assistenza. Il Modello Operativo - Proposta da parte del Distretto della patologia da considerare sulla base delle evidenze epidemiologiche sui bisogni di salute analizzati nei Piani di Zona. 178 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - Inserimento della patologia e del progetto nei piani strategici dell’Assesso rato alla Sanità e della Direzione Aziendale. - Riunione convocata e condotta dal Direttore del Distretto alla presenza dei MMG distrettuali, (PLS se necessario), dell’équipe della Struttura Specialisti ca Ospedaliera di riferimento e degli eventuali Specialisti Territoriali inte ressati nosologicamente, per definire e condividere obiettivi, strumenti, tempi del progetto attraverso un contatto diretto tra i professionisti interessati. - Costituzione del gruppo di lavoro. - Analisi dei dati epidemiologici disponibili e delle procedure di presa in ca rico tradizionalmente in atto nel distretto. - Rivisitazione organizzativa del percorso assistenziale, tenuto conto della si tuazione geografica e delle risorse umane e strumentali disponibili a livello locale e a livello specialistico e dei rapporti già esistenti con il presidio ospedaliero. - Ricerca delle evidenze. - Pre-testing del profilo all’interno del gruppo di lavoro. - Testing all’interno del Distretto. - Affinamento del profilo sulla base dell’esperienza. - Invio del profilo ai medici di tutta la regione per condivisione e messa a disposizione sul sito internet aziendale della principale documentazione di letteratura. - Consensus conference aziendale per la validazione del profilo. - Approvazione da parte del Collegio di Direzione e della Commissione Paritetica Regionale con la definizione delle modalità di monitoraggio della performance del profilo. - Emanazione del Profilo da parte della Direzione Strategica Aziendale. Profili di cura elaborati (validati dalla consensus conference aziendale e in attesa di approvazione formale): - Profilo di cura per la gestione dello scompenso cardiaco - Distretto 2 di Aosta. - Profilo di cura per la gestione dell’ipertensione arteriosa - Distretto 3 di Chatillon. - Profilo di cura per la gestione del diabete mellito - Distretto 4 di Donnas. Attualmente i profili di cura sono consultabili e disponibili sul sito: www.uslaosta.com 12.7. Sviluppo di un sistema informativo volto al monitoraggio della dimissione protetta nella ASL 17 M.G. DE ROSA1, L. BONAFEDE2, A. TOSELLI3, R. BONO3, R. SALOMONE1, F. BORASO4 1 Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero; 2Servizio Assistenza Sanitaria 179 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Territoriale ASL 17, 3Servizio di Assistenza Sociale Ospedaliera, 4Direzione Sanitaria ASL 17 AUTORE REFERENTE: MARIA GRAZIA DE ROSA, Direzione Sanitaria Ospedaliera, Via Ospedali 14 Savigliano (CN) - tel./fax: 0172719117/24, e-mail: [email protected] Introduzione Dalla fine del 1999 è stato avviato un progetto di collaborazione tra la ASL 17 e il Consorzio Monviso Solidale che ha portato alla costituzione del Servi zio Sociale Ospedaliero. Le finalità del servizio sono quelle di raccogliere le problematiche dei pazienti ospedalizzati in difficoltà, di integrare l’istituzione sanitaria - ospedaliera e territoriale - con quella sociale, per il raggiungimento delle specifiche soluzioni individuate attraverso la mediazione, la semplifica zione e la realizzazione dei progetti assistenziali. Le attività prevalentemente svolte dal servizio sono di consulenza e di segretariato sociale, nonché dirette a garantire la prosecuzione dell’assistenza extraospedaliera. Ad oggi sono stati seguiti complessivamente n. 1.829 casi, circa 460casi/ anno, di cui nel 2003 circa il 65% non autosufficienti. Tale esperienza ha in dotto ad alcune riflessioni relativamente alla necessità di una più precisa defi nizione dei ruoli e delle strategie necessarie per la migliore integrazione delle risorse disponibili. A tale scopo è iniziata una collaborazione tra Direzione Sanitaria, Servizio di Assistenza Territoriale e Servizio Sociale Ospedaliero per la realizzazione di un progetto volto ad individuare le più appropriate moda lità di intervento, attraverso la valutazione ed il monitoraggio delle differenti tipologie di pazienti, dei loro problemi e delle specifiche risposte. Obiettivo e gruppo target Nella prospettiva di favorire la continuità delle cure ed il coordinamento degli interventi la nostra area di approfondimento si è rivolta in prima istanza allo sviluppo di un sistema informativo e ad una metodologia di analisi ad oggi insufficienti. Il sistema informativo è infatti necessario e preliminare per valutare la struttura, il processo e l’esito delle attività inerenti i differenti per corsi assistenziali, in particolare quello della dimissione protetta. In prima istan za è stato valutato l’esistente e analizzate le informazioni così come oggi di sponibili. Per quanto riguarda l’analisi delle attività fin qui svolte dal servizio sociale ospedaliero, si dispone di un archivio cartaceo di registrazione delle segnalazioni e degli interventi effettuati dal servizio. Tale documentazione è talvolta carente e le informazioni sono difficilmen 180 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 te sintetizzabili; pertanto a fine 2003 è stato sviluppato un registro informatizzato, tale archivio è stato strutturato in modo tale da poter disporre di informazioni complete e - mediante link con altri archivi informatizzati o cartacei - integrabili (SDO, pazienti ADI, Registri protesi ausili); ciò al fine di poter seguire il paziente dal momento della segnalazione al servizio fino al realizzazione degli specifici interventi (attivazione ADI/ADP ecc..., inserimento in strutture protette, ottenimento di protesi ausili, ottenimento sussidi ecc...). Presentazione e valutazione dei risultati Si forniscono le informazioni più significative ed inerenti il percorso assi stenziale in studio ad oggi disponibili. Tab. 1. Anni 2000-2003 ricoveri effettuati nei 3 presidi ospedalieri della ASL17 2000 n. casi Ospedale di Savigliano 12.739 Ospedale di Saluzzo 6.153 Ospedale di Fossano 3.289 Totale 22.181 2001 n. casi 12.284 6.075 3.252 21.611 2002 n. casi 11.575 4.934 2.267 18.776 2003 n. casi 9.917 4.278 1.492 15.687 Tab. 2. Anni 2000-2003 casi segnalati al Servizio Sociale Ospedaliero Ospedale di Savigliano Ospedale di Saluzzo Ospedale di Fossano Totale 2000 n. casi 155 167 73 395 2001 n. casi 169 210 79 458 2002 n. casi 172 219 85 476 2003 n. casi 173 215 112 500 Totale n. casi 669 811 349 1.829 1995 1996 1997 1998 187 242 119 119 156 156 210 210 277 464 302 544 1999 2000 2001 2002 2003 totale 226 294 327 400 396 2.072 306 532 411 705 436 763 516 916 503 899 3.236 5.308 Tab. 3. Anni 1993-2003 casi di ADI attivati 1993/94 N. casi Distretto 1 Saluzzo Distretto 2 SaviglianoFossano Totale Tab. 3. segue N. casi Distretto 1 Saluzzo Distretto 2 SaviglianoFossano Totale 181 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Come si osserva dal confronto tra le tabelle 1 e 3, a fronte di una diminuzio ne dei ricoveri ospedalieri, che nel periodo si attesta sul valore medio dell’8%, si segnala un incremento dei casi in ADI mediamente pari al 30% anno. Tuttavia dai dati in possesso al Servizio di Assistenza Territoriale si segnala una differenza nei due distretti per quanto riguarda le ADI attivate secondo modalità protetta di dimissione (22,2 versus 46,3%). Queste sono considerazioni preliminari che dovranno essere confermate dall’analisi delle informazioni che saranno disponibili con il nuovo flusso in formativo. Si riporta una breve analisi dei casi segnalati e registrati secondo le nuove modalità nel primo trimestre 2004 e per la sola sede di Saluzzo. I casi segnalati sono stati complessivamente n. 87, l’età media è 76 aa., di questi il 75% sono ricoverati in reparti di tipo medico e con una degenza media di 19 giornate a ricovero. Nel 51% i casi segnalati vivono in famiglia, nel 44% sono soli, e nel 5% sono già ospitati in comunità. I pazienti disabili o non autosufficienti costituiscono il 74% del totale. Dei casi segnalati il 37% rientra al proprio domicilio mentre dopo la fase di ricove ro il 46% dei pazienti necessita di ulteriore o definitiva ospedalizzazione in strutture protette. Conclusioni Nell’ambito delle attività volte alla integrazione ospedale territorio è impor tante evidenziare le caratteristiche della richiesta, analizzare come la compo nente sanitaria e quella sociale si coordinano nelle diverse fasi del ricovero, valutare in modo più puntuale il bisogno assistenziale residuo dei pazienti ospedalizzati, far emergere le criticità delle attuali modalità operative e monitorare eventuali interventi effettuati e/o risultati perseguiti. Il percorso da monitorare sarà dunque dall’ingresso in ospedale alla presa in carico del servizio sociale ospedaliero e dalla dimissione protetta alla presa in carico del servizio cure domiciliari. Con l’introduzione del nuovo sistema informativo sarà possibile disporre di indicatori più specifici di cui, a titolo esemplificativo, se ne riportano alcuni: Indicatori di struttura: - n. medio di interventi per operatore; - caratteristiche dell’utenza (età, sesso, caratteristiche sociali, MDC –DRG ecc...); - analisi descrittiva delle segnalazioni/interventi. Indicatori di processo: - Tipologia di segnalazioni/prestazioni (per reparto, per distretto, per MDC); - Tempo medio segnalazione - dimissione (per età, per MDC). 182 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Indicatori di esito: - richieste ADI ecc.../ADI ecc... attivate; - valutazione eventuali differenze distributive (ad esempio per distretto) Indicatori di efficienza; - Numero di giornate di ricovero risparmiate. Parallelamente alle analisi in corso saranno sviluppate specifiche azioni, inerenti in particolare la revisione delle attuali modalità di segnalazione dei casi e l’integra zione tra i servizi coinvolti. Per tali attività sarà pertanto possibile monitorarne i risultati e sviluppare, mediante la diffusione delle informazioni una maggiore con sapevolezza negli operatori sia sui reali bisogni assistenziali sia sui risultati ottenuti. 12.8. Integrazione ospedale/territorio R. BERTAMINI, E. VALDUGA - Servizio Infermieristico Territoriale Distretto Alto Garda e Ledro APSS Trento Motivazioni L’ospedale negli ultimi anni, si trova costretto sempre più spesso ad abbre viare i tempi di degenza ed a dimettere in tempi brevi utenti che hanno ancora necessità di cure mediche e/o infermieristiche. Nella pratica quotidiana, veniva rilevato dagli operatori impegnati in ambi to territoriale quanto fosse grande il disagio delle famiglie e degli utenti che, dimessi dall’ospedale tornavano al domicilio ancora bisognosi di cure ed assi stenza. Disagi legati in primo luogo ad adattare l’ambiente domestico alle nuove esigenze del paziente, alle complicazioni burocratiche necessarie per ottene re i materiali necessari, al tipo di assistenza da fornire al loro congiunto, com pito per il quale non sempre erano preparati. Lo sforzo notevole è stato quello di interfacciare organizzazioni diverse quali quella ospedaliera e quella territoriale, rilevare quali erano le difficoltà rispet to ad un intervento congiunto dell’una e dell’altra parte e progettare un inter vento integrato per proseguire a domicilio quanto iniziato in ospedale per sviluppare un modello di gestione integrata dei pazienti tra servizi territoriali e ospedalieri che consenta di fornire al paziente un livello assistenziale suffi ciente e di supportare l’ambiente familiare nella gestione di un malato che non ha più una reale necessità di proseguire il ricovero in reparti per acuti. Il progetto è stato diviso in tre fasi: - nella prima fase è stato costituito un gruppo di lavoro che ha elaborato una scheda di passaggio di informazioni dall’ospedale al territorio; - nella seconda fase c’è stato un confronto tra operatori dell’ospedale e del terri torio nel quale è stato perfezionato il progetto sul piano metodologico ed ope 183 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 rativo, valutando il gradimento della scheda da parte degli operatori, la diffu sione del suo utilizzo, l’efficacia della scheda nel passaggio di informazione; - nella terza fase è stata elaborata ed implementata una scheda che consen tisse il passaggio di informazioni dal territorio all’ospedale per quei pazien ti in carico ai Servizi Territoriali che venivano ricoverati in ospedale. Obiettivo Garantire la continuità dell’assistenza dei pazienti in dimissione dall’ospe dale, favorendo il reinserimento a domicilio attraverso un efficace lavoro inte grato tra operatori dell’area sanitaria. Gruppo a cui si riferisce il progetto Utenti in dimissione ospedaliera per i quali il ricovero non è più la risposta più idonea ma che continuano ad avere necessità di assistenza infermieristica, utenti in carico al servizio infermieristico territoriale che vengono ricoverati in ospedale, famiglie che hanno necessità di supporto infermieristico per poter seguire i loro congiunti che presentano una patologia che ne limita l’autonomia. Presentazione dei risultati L’utente viene dimesso e torna al proprio domicilio solo dopo che la fami glia, in collaborazione con il personale del territorio ha preparato un ambien te adatto, ha a disposizione farmaci e materiale sanitario necessario, la fami glia è stata opportunamente addestrata da personale sanitario per quel che riguarda l’assistenza da fornire al proprio congiunto. Conclusioni Questo progetto ha consentito di garantire la continuità dell’assistenza dei pa zienti in dimissione dall’ospedale, favorendone il reinserimento al domicilio, mi gliorandone la qualità della vita, tutto questo grazie ad un costante ed efficace lavoro di integrazione tra operatori sanitari impegnati dentro e fuori l’ospedale. 12.9. Progetto “dimissione protetta” F. ROCCO1, F. GADDA1, S. CASELLATO1, V. ORTOLANI2 - 1Unità Operativa di Urologia, IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 2Fondazione Ricerca e Tera pia in Urologia RTU - ONLUS AUTORE REFERENTE: FRANCESCO ROCCO, Dir. Unità Operativa di Urologia - IRCCS 184 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Ospedale Maggiore Policlinico di Milano Pad. Beretta EST, Via F. Sforza, 20100 Milano - tel.: 02 55034549, fax: 02 50320584, e-mail: [email protected] Introduzione Le attuali necessità di rapido turn-over nei reparti chirurgici comportano spesso una dimissione che, seppur corretta sul piano clinico, per il paziente può essere fonte di preoccupazione e angoscia legate anche alla perdita di un’assistenza continua e specialistica. La Fondazione per la Ricerca e Terapia in Urologia (RTU) - ONLUS patroci na un nuovo progetto di assistenza sul territorio in collaborazione con l’Ospe dale Maggiore Policlinico di Milano. Obiettivi - Estendere l’attenzione al malato chirurgico urologico al di fuori della strut tura ospedaliera attraverso l’attuazione del progetto “Dimissione Protetta”. - Offerta di una visita domiciliare gratuita a pazienti sottoposti a interventi chirurgici urologici con lo scopo di: - controllare che il decorso clinico a domicilio sia regolare; - rispondere ad eventuali domande o perplessità che fossero rimaste insolute o sopravvenute circa lo stato di salute o la terapia da eseguire a domicilio; - informare il Medico Curante circa la situazione clinica del paziente; - concordare con il Medico Curante le misure più opportune per la conva lescenza; - controllare e confermare il successivo programma terapeutico nelle sue diverse parti (terapia, esami di controllo, visite ambulatoriali successive). Gruppi target Medico Specialista della divisione: - partecipa all’attività clinica del reparto, conosce il paziente e ne segue il decorso post-chirurgico; - concorda con il paziente e i familiari alla dimissione la data della visita domiciliare; - visita a domicilio il paziente; - informa il Medico Curante del decorso clinico del paziente. Segreteria: - aggiorna il database pazienti; - archivia i dati sensibili dei pazienti. Paziente: - residente nell’ambito del territorio di competenza dell’ASL Milano Città; - sottoposto ad intervento chirurgico urologico di chirurgia medio-alta; 185 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - acconsente tramite consenso informato scritto e controfirmato al progetto. Risultati Tutti i pazienti a cui il progetto è stato proposto hanno accettato l’iniziativa. Il Feedback del progetto è stato valutato tramite un apposito questionario di gradimento in cui sono stati indagati: l’efficienza dell’organizzazione, la competenza degli operatori e il grado di soddisfazione del paziente. Conclusioni Dall’analisi dei questionari di gradimento si può affermare che i risultati preliminari del Progetto “Dimissione Protetta” sono molto positivi. 12.10. Il percorso dimissioni protette tra ospedale e territorio in un distretto dell’azienda USL di Reggio Emilia – il distretto di Guastalla A. GIGLIOBIANCO1, S. CECCHELLA2 - 1Direzione Sanitaria Ospedale di Guastalla, 2 Di rettore del Distretto di Guastalla. Azienda USL di Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: ANDREA GIGLIOBIANCO, Via Donatori di sangue n. 1, Guastalla (RE) - tel.: 0522 37259, fax: 0522 837288, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto La complessità del ricovero per alcuni pazienti richiede al momento della dimissione un percorso socio – sanitario che deve vedere coinvolti tutti gli attori presenti sul Territorio: il Medico di Medicina Generale, Il Servizio Infermieristico Domiciliare, l’Assistente Sociale. Obiettivo/i Garantire una continuità assistenziale al paziente dal momento del ricovero alla dimissione dall’Ospedale attraverso una comunicazione continua con il MMG, per la condivisione del percorso assistenziale. Garantire inoltre che, qualora il pazienti necessiti a domicilio di presidi e/o farmaci, la segnalazione al SID e alla Farmacia Interna sia tempestiva per assi curare la puntuale fornitura di materiali. Gruppo/i target Il Medico Ospedaliero attiva il MMG e la Farmacia Interna dell’Ospedale; la capo sala dell’Unità Operativa attiva l’Assistente Sociale ed il SID. 186 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Presentazione e valutazione dei risultati Gli indicatori che saranno utilizzati: - numero di dimissioni protette e numero di progetti attivati; - numero di segnalazione al SID e/o al MMG al di fuori dei tempi e delle modalità concordate; - fornitura di presidi o farmaci al di fuori dei tempi stabiliti sul totale delle forniture richieste. Conclusioni Il ricovero ospedaliero rappresenta, rispetto al tema della continuità delle cure, un momento critico non solo per il paziente, ma anche per i familiari. Il raccordo tra il medico di medicina generale (MMG), tutore “longitudinale” della salute del paziente e il medico ospedaliero (MO), tutore “trasversale”, rappresenta la chiave per garantire una dimissione protetta. 12.11. Il Centro di salute e ascolto per le donne immigrate e i loro bambini: luogo di ricerca e di proposta di cambiamenti organizzativi nei servizi materno infantili G. SACCHETTI1, L. SACCHI1, C. GREGARI1, B. FACCHETTI2, I. FINZI3, A. AMOROSI4 - Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano - 1Ginecologa presso il Centro di salute e ascolto per le donne immigrate e i loro bambini dell’A.O. S. Paolo; 2Laureanda in psico logia presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 3 Psicologa e psicoterapeuta della Cooperativa Crinali – Donne per un mondo nuovo; 4Coordinatore HPH A.O. S. Paolo AUTORE REFERENTE: ALESSANDRO AMOROSI, Direzione Sanitaria Azienda Ospedaliera S. Paolo, via di Rudinì 8, 20142 Milano - tel.: 02 81844490, e-mail: [email protected] Il Centro di salute e ascolto per le donne immigrate e i loro bambini, pro getto integrato tra le Aziende ospedaliere S. Paolo e S. Carlo, con la collabora zione della Cooperativa Crinali, in rete con i servizi territoriali per la famiglia è attivo dal gennaio 2000. Ha avuto dall’inizio come obiettivo principale l’ac cesso delle madri e dei bambini stranieri ai servizi ospedalieri che assistono il percorso riproduttivo delle donne e i loro bambini nel primo anno di vita. Il centro nasce con alcune caratteristiche organizzative e assistenziali diverse dai normali ambulatori d’ostetricia o di pediatria: l’accesso libero, le presta zioni non solo sanitarie ma anche psicologiche e sociali e insieme a figure professionali tradizionali, come ginecologa, ostetrica, pediatra, psicologa e 187 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 assistente sociale, ci sono le mediatrici linguistico culturali, nuova figura “ponte” tra le utenti straniere e gli operatori italiani. In quattro anni di attività il Centro ha effettuato circa 15.000 prestazioni a circa 3.500 donne e 1.000 bambini. Sono state effettuate soprattutto visite oste triche in gravidanza, ma anche visite ginecologiche, ecografie, visite e certificazioni per la legge 194, visite a neonati nel primo anno di vita, corsi di accompagnamento alla nascita, consulenze psicologiche sia individuali che di gruppo, consultazioni transculturali di gruppo, colloqui sociali. Sono stati organizzati corsi di formazione per gli operatori che approfondissero le tematiche di relazione con la diversità, la conoscenza delle tradizioni sulla gravidanza e il parto, l’educazione e le cure del bambino in altre culture, i flussi migratori e l’esperienza della migrazione. Il Centro collabora inoltre, grazie alle sue mediatrici linguistico culturali, con l’Istituto Superiore di Sani tà, nell’indagine multicentrica sull’interruzione volontaria di gravidanza e sul la conoscenza e l’utilizzo dei contraccettivi nelle donne immigrate. La metodologia è sempre stata quella del lavoro d’équipe interdisciplinare, con momenti di supervisione periodici e le mediatrici presenti in tutte le attività. Quest’anno, partendo dall’esperienza del centro, abbiamo realizzato uno studio sul momento della dimissione e del ritorno a casa della mamma stra niera con il suo bambino in collaborazione con la facoltà di Psicologia del l’Università degli Studi di Milano Bicocca. La ricerca parte dall’ipotesi che il momento delle dimissioni dopo il parto costituisca un’occasione importante, sia per offrire alle puerpere indicazioni per la gestione del bambino e di se stesse, sia per orientarle all’utilizzo delle risorse sociosanitarie disponibili in ospedale e nel territorio. Il momento delle dimissioni dopo il parto è un periodo delicato, nel quale la relazione della coppia con il bambino e con il nuovo ruolo si va impostando non senza difficoltà. L’avvio della vita a casa con il neonato è fonte d’ansie e preoccu pazioni, tanto più per le donne immigrate, prive del loro contesto di supporto culturale al ruolo materno e in difficoltà per motivi linguistici e d’identità. Lo studio ha voluto verificare se i messaggi dati in occasione delle dimissio ni post partum siano adeguati allo scopo di fornire elementi d’informazione, rassicurazione e orientamento a queste coppie. La ricerca ha utilizzato l’osservazione delle puerpere durante il periodo di degenza, e i colloqui di follow-up in coincidenza con le visite pediatriche, con l’obiettivo di trarre spunti e fornire elementi di conoscenza e riflessione rispetto al vissuto ed ai problemi della condizione di neomamma in terra stra niera. Dall’indagine è emerso che il problema principale rimane quello della com prensione linguistica. Spesso il marito agisce da interprete per la moglie in tutti gli ambiti, questo non aiuta la donna a diventare più autonoma e causa distorsioni rispetto a tematiche che da sempre appartengono all’universo bio 188 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 logico e culturale femminile. L’utilizzo sistematico della mediazione culturale anche nel reparto di neonatologia, agevolerebbe quindi il passaggio delle in formazioni e chiarirebbe il significato degli aspetti più strettamente culturali legati ai bisogni delle neomamme. Un secondo aspetto riguarda le primipare, più bisognose di chiare indicazioni relative alla cura del bambino e di sé, che le rassicurino sull’adeguatezza delle proprie competenze materne. Ciò richie de un’attenzione particolare da parte delle puericultrici (specialmente per la medicazione del cordone ombelicale ed il bagnetto) e la realizzazione di una videocassetta (tradotta in più lingue) che mostri le principali cure rivolte al bambino. Infine il sentimento di solitudine ed isolamento delle mamme stra niere, il bisogno di condivisione d’emozioni, timori, esperienze ed aspetti più pratici, suggerisce la costituzione di piccoli gruppi informativi e d’esperienze pratiche, con la presenza durante la degenza della mediatrice culturale. 12.12. Integrazione tra i servizi territoriali e ospedalieri per le donne migranti a Reggio Emilia A. FORACCHIA1, A. VENTURINI2 - 1Consultorio Familiare e CSFS Distretto di Reggio Emilia, 2U.O. Ostetricia e Ginecologia Arcispedale S. Maria Nuova (RE) AUTORE REFERENTE: ANDREA FORACCHIA - tel. 0522 332203, e-mail: andrea. [email protected] Breve introduzione del contesto Di fronte al numero sempre crescente di popolazione immigrata e al suo cambiamento qualitativo (con un aumento della componente femminile che ha raggiunto nel 2002 il 42%) è contemporaneamente aumentata la richiesta di servizi in campo sociale e sanitario. Il servizio consultoriale ha visto cambiare la sua utenza che rispetto agli inizi della attività (anni ’70) quando si rivolgeva ad una utenza prevalente mente autoctona e di livello socio-culturale medio-alto, si rivolge oggi ad una rilevante percentuale di popolazione di provenienza extra-comunitaria: que sto ha portato alla attivazione al suo interno di spazi particolarmente dedicati ad alcune fasce di popolazione che necessitano di particolare attenzione. I problemi di più frequente riscontro in un cammino di avvicinamento e di utilizzo dei servizi sono: - Lingua: la difficoltà di comunicazione ostacola la esposizione e la compren sione adeguata della storia clinica e spesso anche dei sintomi più comuni. - Cultura: nella sua accezione più ampia costituisce, con alcune popolazioni, l’ostacolo di gran lunga più difficile e non superabile con la semplice “buo na volontà reciproca”. 189 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - Difficoltà di spostamento/scarsa mobilità: il/la paziente si presenta ai servi zi sia territoriali che, soprattutto, ospedalieri in orari compatibili con le esi genze familiari. - Abitudini di vita e alimentari. - Difficoltà abitative. - Difficoltà di natura socio-economica. - Fenomeni di violenza/pressioni esterne. Mentre per alcuni di questi problemi le soluzioni sono immediatamente possibili e alcune sono già in atto (es. mediazione culturale, utilizzo di cana li di informazione multilingue, attivazione dei servizi sociali ecc...) per altre occorrono interventi di più ampia portata (es. fenomeni legati alla violenza e alla forzata “omertà”, problemi socio-economici e abitativi) in cui l’ambito sanitario può e deve costituire uno stimolo e fornire indicazioni ma in cui una reale soluzione si può trovare solo a livello di scelte economiche e po litiche. Obiettivo/i Pur nella consapevolezza dei limiti sopra accennati si individuano alcune strategie già praticabili e già attuate o in via di realizzazione da parte delle strutture territoriali e ospedaliere: - presenza istituzionalizzata del mediatore culturale nei luoghi e tempi di maggiore presenza di cittadini di diverse etnie; - istituzione di protocolli condivisi tra gli operatori e ratifica scritta delle con suetudini; - possibilità di prenotazione diretta delle visite specialistiche e degli es. stru mentali da parte delle Strutture Esterne (SE), che dispongono in quel mo mento del mediatore culturale; - esecuzione in un unico luogo e momento del più alto numero possibile di prestazioni; - individuazione di un referente interno alla struttura ospedaliera; - individuazione di metodiche di follow-up per i casi riferiti alla struttura ospedaliera e per i casi dimessi da questa; - adozione di una modulistica uguale o compatibile; - fornitura al paziente inviato dalla SE all’ospedale di indicazioni chiare e multi-lingue. Gruppo/i target Immigrati senza permesso di soggiorno e/o con grandi difficoltà di comu nicazione. 190 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Presentazione e valutazione dei risultati Considerando che il progetto è in corso d’opera verrà fatta una valutazione dei risultati durante l’autunno 2004. 12.13. Informazione e formazione interculturale nella protezione della madre e del bambino G. BENAGLIA1, A. VENTURA1, A. BERTOZZI2, C. VENTURA2, A. CHIARENZA2, A. GIGLIOBIANCO1 - 1Ospedale Civile di Guastalla; 2AUSL di Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: ALICE BERTOZZI, AUSL Reggio Emilia, Via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia – tel.: 0522 335764, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto Il progetto rappresenta una parte del più ampio progetto europeo “Migrant Friendly Hospitals”, che ha come obiettivo quello di rendere l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi ospedalieri più semplice ed equo. Si è scelto di effettuare la sperimentazione presso l’Ospedale Civile di Guastalla, in quanto è risultata essere la zona con la più alta concentrazione di immigrati della Provincia di Reggio Emilia. Sulla base di una valutazione dei bisogni, che ha evidenziato la necessità di un maggior empowerment dell’utente straniero, è stato deciso di organizzare un corso di formazione per l’area materno-infantile sulle seguenti tematiche: 1. Servizi sanitari del distretto 2. Allattamento, svezzamento e alimentazione 3. Igiene del puerperio e del bambino 4. Educazione sanitaria sulla gestione delle malattie più frequenti della ma dre e del bambino (febbre, diarrea, raffreddamento...) Obiettivo/i Formare ed informare gli utenti stranieri sui servizi offerti dagli ospedali e dal territorio e sulla gestione delle patologie di base, al fine di favorire un utilizzo più consono dei servizi. Gruppo/i target Donne straniere che abbiano partorito tra il primo luglio 2003 ed il 29 feb braio 2004. 191 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Presentazione e valutazione dei risultati L’adesione all’iniziativa è aumentata progressivamente nel corso del tempo (4 lezioni da 3 ore circa ciascuna, diluite in 5 settimane). Al termine degli incontri sono stati somministrati questionari di autovaluta zione e di gradimento su contenuti, organizzazione e materiale distribuito du rante il corso. Da una prima analisi dei dati è emersa una sostanziale soddisfazione dei partecipanti in merito ai contenuti ed alle modalità organizzative. Inoltre, molti hanno manifestato l’interesse a partecipare in futuro ad altre iniziative di que sto tipo. 12.14. Pasti unici e pasti etnici in ospedale A. FERRETTI, D. GIORGETTI - Servizio Logistico Alberghiero Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova- Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: ANNAMARIA FERRETTI, Servizio Logistico Alberghiero, viale Ri sorgimento 57, 42100 Reggio Emilia - tel.: 0522 296796, e-mail: [email protected] Dall’analisi dell’utenza afferente al nostro ospedale si evince la presenza di una molteplicità di etnie e la necessità pertanto di differenziare l’offerta di erogazione dei pasti in relazione ai diversi bisogni per favorire un migliora mento della qualità del servizio per soddisfare maggiormente gli utenti. Nell’Aprile 2004 si è dato il via ad un progetto di miglioramento della ristorazione, tuttora in corso e rivolto a tutti gli utenti ricoverati. In particolare gli obiettivi sono: - rendere più familiare la struttura sanitaria anche per la popolazione stranie ra attraverso l’utilizzo dei piatti tipici dei loro paesi (lo scopo è quello di facilitare il mantenimento delle proprie abitudini di vita); - offrire alle persone ricoverate, di qualsiasi cultura, la possibilità di scegliere all’interno del menù ospedaliero un piatto tipico delle proprie tradizioni; - introdurre nel menù ospedaliero una possibile scelta di piatti unici comple ti da un punto di vista nutrizionale; - far precedere la divulgazione del menù da informazioni alimentari rivolte all’utente degente e ai propri familiari, in modo da suggerire un nuovo modo di alimentarsi, sano, che limiti l’eccesso di proteine di origine animale e orienti verso nuovi modelli nutrizionali (lo scopo è quello di fornire mes saggi educativi forti perché provenienti da un ambiente che tradizional mente è deputato alla cura e alla prevenzione); 192 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - favorire l’integrazione fra culture diverse rispetto anche alle abitudini ali mentari. Le azioni già messe in campo sono state: - indagare sulla provenienza prevalente della popolazione straniera; - tradurre il menù ospedaliero in varie lingue (arabo, cinese, indiano ed in glese); - la possibilità da parte del degente di individuare immediatamente sul menù la presenza di pietanze che contengono carne di maiale (il piatto contenen te questo tipo di carne viene individuato perché scritto con carattere e colo re differente). Le azioni ancora da intraprendere: - incontrare i mediatori culturali (o rappresentanti) per conoscere le abitudi ni alimentari e le varie ricette; - stabilire le ipotesi di piatti tipici da preparare, il loro valore nutritivo (a ra zione), il loro inserimento in menù e la relativa frequenza, le risorse da impiegare; - indagare, anche tramite internet, sull’impiego di piatti unici nei menù di comunità (ospedali, asili, ecc...). La fattibilità delle ricette, la loro speri mentazione e la modalità di estensione nella realtà ospedaliera sarà concor data con i coordinatori di cucina; - studiare una modalità idonea per divulgare il messaggio educativonutrizionale, sia per guidare la scelta del menù da parte degli utenti, che per fornire loro quelle conoscenze utili al fine di esprimere il gradimento. Fondamentale è lo studio su come comunicare agli utenti il messaggio educativo/nutrizionale in quanto è obiettivo del servizio che tale iniziativa possa incidere sulle abitudini di vita degli utenti anche fuori dal contesto ospedaliero. Gli utenti saranno coinvolti direttamente, rendendo la presenta zione dei menù attraverso forme grafiche “appetibili” e che attirino l’attenzio ne ed anche attraverso l’apporto degli operatori che curano la distribuzione dei pasti. Altra azione di coinvolgimento capillare sarà la consegna di una lettera a tutti gli utenti, per i primi mesi di introduzione dei nuovi menù con la presentazione dell’iniziativa e l’invito a comunicare eventuali suggerimenti. La pubblicazione su mass media locali e la diffusione del ricettario dei piatti unici ed etnici all’interno dei reparti di degenza contribuirà a sensibilizzare la popolazione e i familiari in merito alle tematiche nutrizionali e a un nuovo modo di concepire l’alimentazione all’interno del nostro ospedale. Gli opera tori di cucina e quelli che curano la distribuzione, saranno formati e coinvolti nel progetto affinché il messaggio sia fatto proprio anche dalle persone ad dette al servizio. Verrà infine pianificata la raccolta dei dati relativa al gradi mento degli utenti. 193 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Gli indicatori individuati per misurare e monitorare le azioni messe in cam po nel tempo sono: - il gradimento degli utenti rilevato attraverso il questionario di soddisfazione. Lo standard di riferimento è il raggiungimento dell’80% di giudizi positivi; - n. di nuove ricette sperimentate e preparate. Lo standard è l’inserimento del piatto unico 2 volte a settimana; - la produzione di un nuovo menù con piatti unici, di un ricettario e di mes saggi educativi da diffondere. Lo standard è la produzione di 2 menù (1 invernale e 1 estivo) e di messaggi educativi plurimi. I risultati attesi sono: per l’utenza, il gradimento dei piatti proposti; per gli operatori, il gradimento dei menù cucinati; per l’organizzazione, un miglioramen to del servizio di ristorazione e la diffusione di messaggi educativi-nutrizionali. Conclusioni Riteniamo che il progetto, in un contesto multietnico come quello reggiano, sia particolarmente importante perché favorisce l’integrazione reciproca, il ri spetto e la conoscenza delle diverse culture, la personalizzazione dei bisogni del cittadino-utente anche attraverso l’educazione nutrizionale. 12.15. Attraversare confini P. BORGOGNONI (caposala ostetrica e ginecologia), P. FAGANDINI (psicologa dip. Materno Infantile) - Dipartimento Materno Infantile, direttore G. BANCHINI, M. RAVELLI (responsabile Area Qualità), L. CERULLO (ricercatrice sociale Area Quali tà) - Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova- Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: PIERGIUSEPPINA FAGANDINI, U.O. Pediatria, Dipartimento Ma terno Infantile, Viale Risorgimento 80, 42100 Reggio Emilia - tel.: 0522 296772, e-mail: [email protected] Gli stranieri residenti nella provincia di Reggio Emilia (al 31/12/01) sono 23.137, di questi 22.437 (4,8% della popolazione residente) sono di nazionalità extra UE. Rispetto al 2000 si è visto un incremento dei residenti di nazionalità extra UE pari al 18,2%. Reggio Emilia rimane la provincia della Regione Emilia Romagna con la quota maggiore di stranieri sulla popolazione residente. Le nazionalità africane continuano ad essere prevalenti nel panorama reggiano, tuttavia rispetto agli anni passati si registra un forte incremento di immigrati provenienti dall’Est-Europeo e dall’Asia. Le etnie maggiormente rappresentate sono in ordine decrescente quella Nord-Africana, Est-europea, Sud-Asiatica e Centro-Africana. 194 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 L’ospedale ha visto incrementare negli ultimi anni la sua utenza straniera, siano essi immigrati residenti che non residenti, indigenti o paganti/coperti dal SSN. La fascia di età dell’utenza straniera più rappresentata è quella che va dai “15 a 44 anni”, che nel 2002 è stata costituita da 2003 utenti. Al contrario le fasce di età meno rappresentate sono quelle che vanno dai “65 ai 74 anni” e “oltre 75 anni”. Il progetto vede coinvolti i reparti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Nido del Dipartimento Materno Infantile. Dall’analisi approfondita del contesto di partenza si evince: - un aumento della popolazione immigrata che è portatrice di esigenze, va lori, aspettative, attribuzioni di significato del tutto peculiari e diversi da quelli dell’utenza locale in quanto influenzati dalla diversa cultura; - una situazione di disagio e di difficoltà vissuta dagli operatori nell’attivi tà clinico-assistenziale quotidiana rivolta agli stranieri, dovuta sia ad evi denti problemi linguistici che ostacolano la comunicazione operatoreutente, sia alla non adeguata conoscenza dei reali bisogni degli immi grati; - una disparità sul piano della salute fra persone con background etnico e culturale diverso; - una visione dell’ospedale come primo punto di accesso dell’utenza stranie ra che non sempre compie un uso e un accesso appropriato dei servizi; - una necessità d’informazione ed educazione del paziente adeguata alle di versità culturali. Partendo da queste premesse, il progetto si propone di: - indagare il vissuto degli immigrati per conoscere e comprendere meglio le loro necessità, bisogni di cura, come vivono il ricovero e quale significato attribuiscono a tale esperienza, i loro orientamenti di valore e le categorie di pensiero che utilizzano; - indagare il vissuto degli operatori rispetto agli immigrati per conoscere i problemi che maggiormente incontrano nell’interazione con essi; ossia in dividuare gli aspetti critici, i momenti di disagio nel lavoro quotidiano su cui proporre eventuali azioni di miglioramento; - creare percorsi che rispondano adeguatamente alle diversità culturali; - promuovere la qualità dei servizi e un “setting” culturalmente competente; - fornire un’educazione ed informazioni adeguate alle diverse culture nell’area materno-infantile. La metodologia studiata prevede l’impiego di strumenti qualitativi che, pur non essendo in grado di produrre numeri sui quali fare delle valutazioni stati stiche, consentono un buon grado di approfondimento e forniscono elementi che possono guidare interventi di miglioramento. 195 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Nello specifico gli strumenti di ricerca adottati sono: - interviste semi-strutturate rivolte alla donna o alla coppia immigrata condotte con l’ausilio delle mediatrici culturali di lingua cinese ed araba e di psicologhe. L’in tervista è stato ritenuto lo strumento più idoneo in riferimento agli obiettivi prefis sati in quanto non coglie solo una valutazione ma “cosa sta dietro una valutazio ne”, “il come e il perché delle cose” (ad es. aspettative, valori, usi, bisogni ecc...); - focus group utilizzati con gli operatori sanitari (medici, infermieri, ostetri che, personale ausiliario). Il focus, è stato considerato come la tecnica più appropriata per effettuare un’esplorazione qualitativa sulle principali aree tematiche ritenute critiche e percepite come rilevanti dagli operatori nell’erogazione del servizio offerto all’utenza straniera. Da altre esperienze si rileva infatti che tale tecnica è molto utile nei casi in cui si vogliono ap profondire aspetti che riguardano l’interazione operatore/utente o aspetti legati alle emozioni e al vissuto personale da parte degli utenti. I risultati attesi sono: - un miglioramento della soddisfazione dell’utenza immigrata in momenti fondamentali della vita e della strutturazione della famiglia, quali la gravi danza, la nascita e ricoveri per malattia dei figli; - una facilitazione della comprensione e dell’interazione con lo straniero e la sua famiglia, una maggiore collaborazione fra paziente straniero e persona le sanitario e un miglioramento della qualità del servizio offerto, dei percor si ambulatoriali e di ricovero. Inoltre il progetto fornisce alla comunità un’oc casione di riflessione sui significati culturali diversi della gravidanza, della nascita e della formazione della famiglia. 12.16. Dal percorso formativo “Verso un ospedale senza dolore” dell’azienda USL Valle d’Aosta alla gestione del paziente con dolore sul territorio L. PASQUARIELLO (Resp. S.S. Terapia Antalgica), C. PONZETTI (Direttore Sanitario), M. MUSI (Dirigente U.B. Oncologia), G. CARRARA (Psicologa), L. PLATI (DDSI, Ufficio Infermieristico), H. ZEN (DDSI, Ufficio Infermieristico), R. ORIANI (Coord. Inf.), B. DAGNES (Coord. Inf.) - Comitato per l’Ospedale senza Dolore Ausl Valle d’aosta AUTORE REFERENTE: LORENZO PASQUARIELLO, Resp. Struttura Semplice di Terapia Antalgica Ospedale Regionale, Viale Ginevra 3, 11100 Aosta - tel.: 0165 543378, fax: 0165 543740, e-mail: [email protected] Contesto Le Linee Guida nazionali del progetto “Ospedale senza Dolore” (marzo 196 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 2001), invitavano le USL Italiane a costituire un Comitato ad hoc per ogni ospedale o Azienda (in breve COSD). La nostra Azienda recepiva tali indica zioni con delibera 1936 del 24/9/01. Tra i suoi primi atti il COSD ha deliberato di effettuare una indagine di prevalenza del dolore nel nostro Ospedale e per farlo si è appoggiata ad una esperienza già in corso, il progetto “Verso un Ospedale senza dolore”, pro mosso in Italia dai Dottori Visentin e Trentin di Vicenza. Dopo la rilevazione della prevalenza è stato organizzato un corso base di formazione sul dolore per tutti gli infermieri e i medici del nostro ospedale, allo scopo di realizzare, ciascuno nell’ambito del proprio servizio, dei progetti migliorativi di assistenza al paziente con dolore. Il Corso è stato accreditato ECM e finora si è svolto in due edizioni (11 punti nel 2002 e 8 nel 2003). Una terza edizione è in corso di accreditamento. Si sono così formati circa 530 infermieri e circa il 50% dei medici presenti nel nostro Ospedale (220 circa). Questo corso ha rappresentato a suo tempo una primizia in quanto in nessun Ospedale che aveva aderito alla iniziativa “Verso un Ospedale senza Dolore” si era fino ad allora realizzata la cosiddetta fase 2 (quella della formazione). Durante le prime due edizioni è stato formato un gruppo di tutor che affian casse i gruppi di miglioramento continuo della qualità che si sono formati in ogni reparto, così da essere di aiuto nella progettazione del loro intervento. Nel novembre 2003, a conclusione della prima parte dell’iter formativo, si è svolta una Giornata di Formazione Aziendale (anch’essa accreditata) durante la quale è avvenuto lo scambio di esperienze relativamente ai progetti iniziati che erano (e sono): il dolore durante la medicazione delle ulcere ischemiche, il dolore durante le manovre diagnostiche, terapeutiche e di nursing in Rianimazione, il dolore da episiotomia in corso di parto naturale, il dolore postoperatorio dopo interventi di resezione endoscopica in Urologia, il dolore da cambio di medica zione postoperatoria nel paziente neoplastico in ORL, Efficacia della terapia nel dolore in Oncologia, dolore e manovre di fisioterapia in Neurologia. Mentre questi progetti sono in fase avanzata di realizzazione, è in via di accreditamento la terza edizione del Corso che verrà allargato alle infermiere territoriali e ai fisioterapisti, essendo stata rilevata l’importanza di continuare a domicilio il pain management iniziato in ospedale. La stessa struttura delle giornate di corso è stata modificata per offrire ai partecipanti anche i risultati già ottenuti con le sessioni precedenti. Nell’ottica di interessare il maggior numero possibile di operatori, si sono svolte 2 giornate a tema anche presso la sede locale del Diploma Universitario di Infermiere per sensibilizzare anche gli allievi della Scuola che lavoreranno nel nostro Ospedale. Anche per i medici di medicina generale è in fase di accreditamento un corso ad hoc sulla gestione dei pazienti con dolore. 197 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Obiettivi Prendere coscienza e misurare il problema “dolore”. Progettare e realizzare corsi di sensibilizzazione e formazione sulla gestio ne del paziente con dolore. Avviare un percorso di miglioramento continuo della qualità nel campo “dolore”. Gruppi Target - Personale medico: - Formazione di base e avanzata - Personale infermieristico: - Formazione di base - Progettazione di interventi di miglioramento - Personale territoriale e della riabilitazione: - Formazione di base - Realizzazione di interventi di miglioramento Valutazione dei risultati - Realizzazione del percorso formativo ottobre 2002/marzo 2005: 100 medici di base; 650 II.PP.; 30 terapisti della riabilitazione. - Attivazione dei programma di miglioramento continuo della qualità: 16 reparti ospedalieri in fase avanzata di realizzazione dei loro progetti; 5 reparti in fase iniziale di progettazione. - Realizzazione di una cartella infermieristica con inserimento del parametro “dolore”. Conclusioni La realizzazione di un Progetto formativo così vasto non sarebbe stato pos sibile senza la decisiva collaborazione della Direzione Generale della Azienda USL che ha permesso ogni attività in orario di servizio. Ci auguriamo che l’im portanza dell’argomento permetta anche ad altri Ospedali di intraprendere una strada simile che riteniamo decisiva per promuovere una “cultura della salute” all’interno dei nostri Ospedali senza dimenticare l’importante peso di una gestione territoriale attenta ai bisogni reali della popolazione e pronta a supportare le terapie iniziate in ambito ospedaliero. 198 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.17. La comprensione del dolore e della sofferenza in ospedale: un progetto di formazione del personale mediante osservazione antropologica M. PESENTI CAMPAGNONI (Direttore della UB Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione), A. CASTIGLION (Responsabile Ufficio Progetti Innovativi, Dire zione Generale), O. TORRETTA (Antropologo) AUTORE REFERENTE: MASSIMO PESENTI CAMPAGNONI, Direttore della UB Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione, Ospedale regionale, Viale Ginevra 3, 11100 AOSTA - tel.: 0165 543350, e-mail: [email protected] Contesto Il dolore è più di un semplice evento neurofisiologico, è indivisibile dalla vita di ogni giorno accompagnando eventi fisiologici (gravidanza, mestrua zioni, ecc...) oltre che malattie e traumi. Non tutti i gruppi sociali e umani rispondono e comunicano ai professionisti il proprio dolore nello stesso modo, essendo la percezione del dolore influenzata da fattori sociali, culturali e psi cologici. Sinora troppo poca considerazione, rispetto ai già peraltro trascurati aspetti biologici, è stata concessa agli aspetti culturali e narrativi del problema e alle storie legate alla sofferenza. Scarsa, infatti, è la competenza del persona le a identificare e capire contestualmente, non solo in modo quantitativo, l’espe rienza della sofferenza e a distinguere i linguaggi che stanno alla base della comunicazione umana della sofferenza stessa secondo i diversi modelli etnici e culturali. L’Azienda USL VdA, consapevole di queste necessità, ha, quindi, promosso un progetto formativo, in prosecuzione del progetto iniziato nell’anno 2002 “Verso un ospedale senza dolore”, per migliorare la comprensio ne del dolore e della sofferenza utilizzando conoscenze, strumenti e tecniche specifiche della antropologia medica. Obiettivi Identificare e capire contestualmente l’esperienza della sofferenza, quindi non solo in modo quantitativo; suggerire eventuali attitudini alternative verso il fenomeno; definire e misurare la soddisfazione del paziente; concorrere allo sviluppo di modelli utili al miglioramento dei servizi sanitari e clinici esi stenti; contribuire allo sviluppo di appropriati programmi attitudinali rivolti al personale; organizzare un corso di formazione medico antropologico, utile ad accrescere le conoscenze del personale curante; produrre un manuale di antropologia medica, strumento didattico permanente utilizzabile anche dal personale rimasto escluso dalla formazione. Al termine del corso il parteci pante avrà una diversa percezione del problema sofferenza, avrà acquisito 199 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 competenze di carattere culturale del fenomeno; avrà acquisito capacità di distinguere i linguaggi che stanno alla base della comunicazione umana della sofferenza. Fasi progettuali Il progetto è articolato su 8 moduli che, sinteticamente, rappresentano le seguenti fasi: 1) Ricognizione dei bisogni formativi del personale destinatario dell’intervento attraverso l’esplorazione preliminare delle storie dei malati (gravi e/o seri), dei disabili, ecc...., e la narrativa della esperienza malattia. Più precisamen te, con la tecnica di analisi etnologica e di osservazione partecipante, un antropologo, in qualità di osservatore passivo, si immergerà nella realtà quotidiana da esaminare. Il lavoro prevede: la osservazione della interazione clinica e/o del processo riabilitativo; la comprensione della costruzione narrativa della malattia e della sofferenza come esperienza psico-sociale; la definizione dei criteri generali in grado di guidare le operazioni comuni cative di etichettatura e spiegazione della malattia, oltre che il processo di ricerca della cura e di valutazione degli approcci terapeutici antecedenti ed indipendenti dagli episodi della malattia; interviste con il personale sa nitario sul lavoro svolto; partecipazione agli incontri dello staff. Questa fase ha avuto inizio il 15 aprile u.s. 2) Effettuazione di percorso formativo pilota rivolto a medici, infermieri, fisiote rapisti e psicologi operanti nei reparti di medicina d’urgenza e accettazione, neurologia, oncologia, pediatria, servizio di terapia antalgica. Saranno trattati i seguenti argomenti: dolore e cultura, corpo, individuo e malattia, analisi dei modelli clinici (come si sa durante la loro interazione il paziente ed il medico costruiscono, nella maggior parte dei casi, realtà cliniche differenti basate sulle loro particolari percezioni culturali e sui loro modelli sanitari. Modelli che va riano oltre che socioeconomicamente anche da società a società ed etnicamente), Qualità delle comunicazioni del dolore, L’antropologia medica ed i suoi orientamenti teorici, Le origini storiche della disciplina. 3) Conclusioni e verifica finale. 4) Produzione di manuale di antropologia medica utilizzabile anche dal per sonale escluso dal presente percorso formativo. 5) Divulgazione alla popolazione dei risultati del lavoro svolto. Il progetto ha avuto inizio il 15 aprile 2004. La conclusione è prevista per il 31 marzo 2005. Risorse utilizzate Complessivamente la formazione riguarderà 32 operatori sanitari (9 medi 200 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 ci, 17 infermieri, 3 fisioterapisti, 3 psicologi) per un totale 274 ore individuali di formazione (24 ore individuali di teoria e 250 ore di stage in produzione) e 8.768 ore aziendali. Il costo previsto è pari a euro 25.473,00. Il progetto è oggetto di cofinanziamento del FSE – obiettivo 3. 12.18. Assistenza e trattamento del dolore. Uno strumento di indagine su conoscenze, atteggiamenti e comportamenti di infermieri e medici L. CANAVACCI1, E. MENONI2, A. M. ALOISI3, M. G. D’AMATO1, A. GRASSO1, R. MARCHINI2, M. GIACCHI1 - 1U.O.C. Promozione della Salute, Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica, Università di Siena; 2Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento, Università di Siena; 3Diparti mento di Fisiologia, Università di Siena AUTORE REFERENTE: MARIANO GIACCHI, U.O.C. Promozione della Salute, Diparti mento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica, Via Aldo Moro, 53100 Siena - tel.: 0577 234092, fax: 0577 234090, e-mail: [email protected] Introduzione La letteratura internazionale è concorde nell’evidenziare un atteggiamento diffuso a causa del quale il dolore (nelle sue diverse espressioni) viene quoti dianamente sottostimato e trattato inadeguatamente nelle nostre realtà sanita rie, sebbene sia oggi possibile ricorrere a presidi efficaci in tal senso. In particolare nei malati ricoverati nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, la percentuale di coloro il cui dolore è fronteggiato in maniera insoddisfacente è molto alta (40-50% dei ricoverati) e con maggiore difficoltà per quelle fasce di popolazione più vulnerabili quali bambini, anziani, malati in fase termina le, cerebropatici. A sostegno di tale atteggiamento concorrono diversi fattori: tra questi, come è stato più volte denunciato, l’opinione che il dolore sia un evento naturale che accompagna “inevitabilmente” l’iter diagnostico e terapeutico; la diffi coltà, anche culturale, ad accettare la centralità del paziente nella rilevazione dei dati relativi al dolore e nel suo trattamento; le difficoltà oggettive a co struire scale adeguate di misurazione del dolore; l’impreparazione diffusa tra gli operatori dovuta alla mancanza di una formazione di base sull’ap proccio al dolore; la mancanza di protocolli sulla terapia del dolore e sul l’uso degli analgesici. Il progetto “Ospedale senza dolore” si propone di affrontare tale situazione al fine di contrastare il dolore e le sofferenze evitabili, causate alle persone dalle malattie e dai presidi diagnostici e terapeutici adottati per curarle, per 201 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 mezzo di un radicale mutamento degli atteggiamenti e dei comportamenti che deve coinvolgere non solo il personale di assistenza ma tutti i cittadini. Il progetto Ospedali senza dolore fa esplicito riferimento a quanto deli neato nelle Linee guida per l’“Ospedale senza dolore” contenute nel docu mento messo a punto dalla Conferenza Stato-Regioni (Provvedimento 24 maggio 2001 – Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2001) ad integrazione di quan to statuito nel precedente accordo riguardante le linee guida nazionali in tema di cure palliative; costituisce inoltre specifico riferimento la Legge n. 12 dell’8 febbraio 2001 che ha riformato la normativa vigente in tema di oppioidi. Tuttavia, per essere efficacemente affrontato, il dolore deve essere conside rato nella prospettiva di un continuum olistico, di sintesi cioè rispetto ai biso gni complessivi del malato e ai percorsi assistenziali. In questo senso è appar so particolarmente utile predisporre uno strumento di maggiore potenza co noscitiva rispetto alla sola analisi dei comportamenti clinici rispetto al dolore. È stato dunque elaborato un questionario a risposte strutturate volto ad inda gare le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti di tutto il personale medico ed infermieristico in relazione ai vari aspetti caratterizzanti la terapia del dolore (clinici, psicologici ed etici). Obiettivo generale e target L’indagine conoscitiva mira ad acquisire informazioni su conoscenze, at teggiamenti e comportamenti di infermieri e medici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, dell’Azienda Usl 7 di Siena e dei medici di medicina ge nerale relativamente al trattamento dei pazienti con dolore. Obiettivi specifici - Acquisire informazioni relativamente al bisogno formativo del personale medico e infermieristico delle Aziende. - Acquisire informazioni sulla gestione di questo problema all’interno dei re parti e nel territorio. - Individuare modalità per il miglioramento e/o l’ottimizzazione di tale gestione. Risultati e conclusioni In questa fase del progetto è stato messo a punto il questionario quale stru mento di analisi delle conoscenze delle opinioni e dei comportamenti degli operatori, caratterizzato da un approccio basato sulla consapevolezza della necessità di considerare il dolore e la sua cura nei termini non solo fisiologici, ma anche psicologici, etici e relazionali, nonché dalla valutazione del lavoro 202 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 interdisciplinare e d’èquipe quale indispensabile prerequisito per una corret ta assistenza dei pazienti. In termini generali il progetto vuole portare ad un miglioramento della cono scenza dei livelli organizzativi e dei bisogni di formazione del personale sanita rio in questa materia e dunque contribuire significativamente all’avanzamento dei livelli di qualità nei percorsi assistenziali relativi dei pazienti con dolore. Un migliore controllo del dolore è infatti una precondizione essenziale af finché le persone malate possano gestire la loro sofferenza in maniera digni tosa e mettere a frutto le risorse residue per migliorare la loro qualità di vita in rapporto allo stato di salute. 12.19. Verso la creazione di un acute pain service nell’ambito del progetto HPH “ospedale senza dolore” A. VENEZIANI1, F. PICCA2, S. MIGLIORINI3, I. FRATI4, V. FUSARI4, A. APPICCIAFUOCO5 - 1Me dico U.O. Anestesia e Rianimazione, 2Infermiera Direzione Sanitaria, 3Uffi cio Infermieristico, 4Staff Amministrativo Direzione sanitaria, 5Direttore Sa nitario – Osp. Nuovo S. Giovanni di Dio ASL Firenze Introduzione L’adesione dell’Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio al progetto HPH Ospedale Senza Dolore, ha aperto nuovi scenari per l’attenzione verso il problema del dolore acuto. Il corso di formazione obbligatorio, che ha coin volto tutti gli infermieri e circa un terzo dei medici di area chirurgica e DEA, ha potuto rilevare come sia elevato l’interesse per questo argomento e la motivazione a poter cambiare radicalmente atteggiamento. Si è quindi reso opportuno mettere in pratica uno degli elementi essenziali della fase di at tuazione dell’Ospedale Senza Dolore: la misura del dolore. In analogia con un modello sviluppato dal Prof. Rawal in Svezia, la Direzione Sanitaria e Infermieristica d’intesa con l’U.O. di Anestesia e Rianimazione hanno rite nuto opportuno investire sulla creazione di una figura infermieristica addet ta al coordinamento del controllo del dolore postoperatorio nei reparti in modo da garantire per 24-48 ore post intervento chirurgico, un’analgesia ottimale per ogni paziente, definita con una scala di misurazione da un pun teggio d’intensità del dolore ≤ 3, da mantenere costante eventualmente con aggiustamenti della terapia. La figura infermieristica dedicata è un tramite tra la figura del medico anestesista che prescrive la terapia al momento della dimissione del paziente dalla sala operatoria, e l’infermiere di reparto che esegue la terapia e misura regolarmente l’entità del dolore di ogni singolo paziente. Essa ha una funzione facilitatrice nei riguardi degli altri colleghi di 203 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 corsia per ciò che concerne la messa in atto delle tecniche di misurazione del dolore e l’applicazione della terapia. Il suo compito inoltre è quello di acquisire ed elaborare i dati inerenti il controllo del dolore postoperatorio per ottimizzare la terapia anche attraverso una successiva possibile stesura di protocolli specifici. É stato previsto un suo impiego per cinque giorni alla settimana con un orario flessibile dalle 9.00 alle 16.30 in modo da poter attuare in parte un controllo dei pazienti operati il giorno precedente e in parte di quelli operati lo stesso giorno. Resoconto dell’attività Dopo un iniziale periodo di training orientativo con il supporto dei me dici dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione, dal 1 febbraio u.s. l’infermiera ha cominciato un’attività autonoma giornaliera. Inizialmente il controllo postoperatorio si è limitato agli interventi chirurgici “maggiori” e preva lentemente in reparti dove per tradizione vi è un controllo del dolore da parte del personale infermieristico già di buon livello. Successivamente si è allargato anche alle altre divisioni di chirurgia. L’organizzazione del la voro prevede la presa in carico dei pazienti in sala operatoria dove vengo no registrati la sede, il tipo di intervento e di anestesia ed il trattamento antalgico previsto. Successivamente nel postoperatorio continua l’annota zione di una serie di parametri che assicura il monitoraggio delle condi zioni del paziente e una verifica dell’efficacia dell’analgesia impostata non ché dei possibili effetti collaterali. In tal modo viene assicurato un control lo del paziente e una rilevazione del dolore che implementa quella esegui ta dagli infermieri del reparto con frequenza sempre più crescente, e che permette di apportare eventuali correttivi alla terapia e un controllo suc cessivo dell’effetto. I dati relativi al primo trimestre di attività hanno interessato 400 pazienti, e pur riconducibili ad un periodo di osservazione piuttosto breve evidenziano che: - il pain score medio rilevato dopo 3-5 ore dalla fine dell’intervento, rappre sentativo dell’efficacia dell’impostazione della terapia antalgica è stato in genere, fatte poche eccezioni di poco superiore al valore di tre; - il numero medio di volte che ogni malato è stato seguito al di là dei controlli infermieristici di reparto è compreso tra le 3 e le 4; - l’intervento dell’infermiera ha permesso in 130 casi una correzione (talvolta un semplice aggiustamento) della terapia in genere sempre coronato da successo. E’ stato acquisito dopo un iniziale utilizzo di materiale cartaceo, un compu ter palmare dedicato alla rilevazione dei dati del dolore postoperatorio. Tale sistema facilita il lavoro e abbrevia il tempo attualmente dedicato all’immis 204 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 sione dei dati permettendo inoltre una semplificazione della successiva ela borazione. Dalle impressioni generali ricavate dal contatto con i pazienti, gli infermieri di reparto, le AFD e i colleghi anestesisti, l’impatto di questa nuova figura è stato recepito in maniera del tutto positiva. Per ciò che concerne una più ap profondita valutazione dell’efficacia, questa sarà realizzata mediante un con trollo di indicatori clinici prefissati ed analizzati a scadenze prefissate concer nenti l’implementazione dell’analgesia nei vari reparti dell’ospedale e com prendente: - incremento del numero di “schede di rilevazione dolore” correttamente com pilate dal personale infermieristico; - valutazione e confronto del punteggio medio del dolore dopo 3 ore dal termine dell’intervento o dall’ammissione al PS; - numero di correzioni terapeutiche adottate per ogni singolo paziente; - punteggio medio del dolore per ogni tipologia di intervento o di patologia acuta dolorosa; - tipologia ed entità delle possibili complicanze e degli effetti collaterali rela tive all’uso di farmaci analgesici; - incremento del consumo dei farmaci per singole classi farmacologiche; - grado di soddisfazione dell’utenza espresso da questionari di gradimen to. 12.20. La rilevazione dei bisogni formativi in tema di dolore: analisi delle risposte a un questionario L. C OLONNA 1, C. S ESTINI 2, M. C ALAMAI 3 - Comitato per l’Ospedale Senza Do lore (COSD), Azienda USL 8, Arezzo - 1Coordinatore progetto HPH e COSD, 2Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, 3Direttrice Sanita ria AUSL 8 AUTORE REFERENTE: LUCIO COLONNA, Resp. Rete Aziendale di Terapia Antalgica Azienda USL 8, c/o Direzione Sanitaria, via Fonte Veneziana 8, 52100 Arezzo; tel.: 0575255652, fax: 0575-254125. Introduzione L’esigenza di trattare il dolore acuto e cronico nei reparti ospedalieri è am piamente documentata da indagini prospettiche e retrospettive, osservazionali e randomizzate, nazionali e internazionali. Gli ostacoli che si frappongono a costruire una risposta a questa esigenza sono stati individuati in numerosi fattori, fra i quali particolare rilevanza assumono, fra gli altri: - l’atteggiamento di alcuni operatori e degli stessi malati, che spesso ritengo 205 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 no che il dolore sia ineluttabilmente legato alla malattia; - difficoltà di tipo organizzativo; - modello assistenziale fondato sulla centralità della malattia, anziché sulla persona malata; - le carenze formative sul dolore, che si registrano sia nei corsi universitari e specialistici per i medici, sia in quelli per gli infermieri. La premessa di qualsiasi intervento teso a aumentare la sensibilità e la capa cità di trattamento del dolore è quella di aumentare le conoscenze specifiche fra gli operatori sanitari, in un contesto di trasformazione del processo assi stenziale da “disease centred” a “patient centred”. Obiettivo della rilevazione Individuare il bisogno formativo in materia di dolore nelle Unità Operative di area medica delle cinque Zone della Provincia di Arezzo, attraverso l’analisi delle risposte ad un questionario distribuito fra il personale infermieristico e medico. Costruire un progetto formativo che punti a riempire i vuoti culturali più evidenti. Popolazione target. Tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo assi stenziale nelle Unità Operative di Medicina Interna e Specialistiche dell’AUSL 8, pari a oltre 500 unità, come primo step da trasferire successivamente anche fra i cittadini (scuole, ospedali, forze social, ECC....) in sincronia con le Asso ciazioni del Volontariato. Metodi e risultati Il questionario, costituito da 13 domande a risposta binaria (vero/falso), conteneva affermazioni concernenti metodi di somministrazione dei far maci analgesici, conoscenze farmacologiche sugli effetti collaterali di al cune categorie di analgesici, efficacia di alcune tecniche analgesiche, rap porti con il malato e interpretazione dei suoi bisogni. Le domande erano distribuite nel questionario in modo randomizzato e veniva richiesto al l’operatore di rispondere in modo autonomo, senza conoscere le risposte dei colleghi. Le risposte ai questionari hanno evidenziato un bisogno formativo mirato in modo significativamente maggiore su: - la necessità di considerare la persona malata al centro del processo as sistenziale (circa il 20% dei medici intervistati ed oltre il 50% degli infer mieri non sono d’accordo sulla necessità di credere “sempre” al mala to); - migliorare le conoscenze sulla farmacologia e sulla conoscenza degli effet ti collaterali degli oppiacei (p. es., quasi l’80% dei medici ritiene che la 206 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 depressione respiratoria non sia la complicanza più frequente nel consu mo di oppiacei; oltre il 60% dei medici e degli infermieri intervistati pensa no che buona parte dei malati ai quali vengono somministrati oppiacei a orari fissi divengano dipendenti); - fornire agli operatori gli strumenti per la valutazione quali – quantitativa del dolore (oltre il 90% ha risposto positivamente all’affermazione se condo la quale “il dolore va misurato regolarmente come i parametri vitali”). Le risposte fornite dagli infermieri hanno mostrato una significativa correla zione fra le 5 Zone della provincia (indice di correlazione 0,86), mentre è risultata bassa la correlazione fra i medici e gli infermieri (indice di correlazio ne 0,50), manifestando in tal modo da un lato bisogni formativi almeno in parte diversi, dall’altro la necessità di un modello organizzativo basato sul confronto ed in particolare sull’audit clinico. Conclusioni I risultati del questionario hanno contribuito a evidenziare gli obiettivi di dattici del progetto formativo sulla valutazione ed il trattamento del dolore nelle U.O. Mediche dell’Azienda USL 8. Le differenze riscontrate fra il perso nale medico ed infermieristico hanno evidenziato il bisogno di un’organizza zione del lavoro fondata sul miglioramento continuo della qualità delle pre stazioni attraverso l’uso sistematico di momenti di confronto clinico. 12.21. Ospedale senza dolore: l’esperienza continua S. SOTTILI - Clinica San Carlo, Via Ospedale 21, 20137 Paderno Dugnano (MI) – tel.: 02 99038227, fax: 02 99038223, e-mail: [email protected] o [email protected] Il programma di Ospedale senza dolore” della Clinica San Carlo, iniziato nel 1999, prosegue negli anni con successivi aggiornamenti. Partito in prevalenza come programma per la gestione del dolore acuto postoperatorio, si è poi dilatato al trattamento del dolore cronico benigno per poi arrivare al trattamento del dolore da cancro. Le metodiche per il trattamento del dolore si sono nel tempo affinate e, all’uso costante da anni di terapie antidolorifiche per infusione venosa o peridurale controllate con pompe infusionali, si sono aggiunti presidi come la stimolazione elettrica peridurale e la messa a dimora di cateteri spinali, en trambi collegati a stimolatori o pompe infusionali impiantate sottocute nell’addome del Paziente. 207 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 L’attività della Clinica è poi proseguita con la istituzioni di corsi ECM per “Ospedale senza dolore” che già hanno visto tre edizioni e che richiamano operatori sanitari anche da Ospedali di Milano e hinterland. In modo partico lare l’ultimo convegno, che si svolge in due sessioni, è stato aperto a medici, infermieri, farmacisti ospedalieri e fisioterapisti. Queste ultime due categorie sono state inserite in ottemperanza al dettato delle linee guida nazionali (Il testo definitivo delle “Linee Guida” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 giugno 2001) e al manuale di applicazione di tali linee guida, già approvato da una commissione scientifica della Regione Lombardia e in atte sa di essere reso esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Regionale. Nello stesso spirito la Clinica ha organizzato un incontro sull’argomento “dolore” con il pubblico, in collaborazione con il Comune di Novate Milane se: tale incontro si è tenuto nell’aula consiliare del comune, e manifestazioni analoghe sono in programma per la fine del 2004 anche a Paderno Dugnano, sede della Clinica, e in altri comuni limitrofi. Tutto questo riflette il compito di “Ospedale che insegna la salute” che da tempo viene perseguito su varie categorie, e i cui risultati verranno valutati alla fine del 2005, con un confronto con i dati appena raccolti seguendo le indicazioni del programma nazionale “la giornata del sollievo”, che servono a confrontare dati di prevalenza del dolore in ospedale. Il programma del trattamento del dolore ha una finalità volta a coinvolgere il più possibile tutti coloro che vengono a contatto con il sintomo dolore, per combattere una battaglia comune contro un segnale corporeo che, quando non più utile, diventa rapidamente inutile e dannoso. 12.22. Il progetto ospedale senza dolore come strumento di comunica zione aziendale R. MASSEI (Direttore DEA), M. CANELLA (Dirigente medico U.O. Anestesia 1), A. CAZZANIGA (Direttore SITRA), L. FERRAIOLI (Componente SITRA), A. INVERNIZZI (In fermiere AFD, Responsabile area dip. DEA), M. BOSIO (Direttore struttura Qualità), E. CRISTOFORI (Struttura Qualità), A. ZOLI (Direttore Sanitario Aziendale), P. CALTAGIRONE (Direttore Generale) - Azienda Ospedaliera “Ospe dale di Lecco”, Regione Lombardia AUTORE REFERENTE: LAURA FERRAIOLI, SITRA, Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”, Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco - tel.: 0341 489060, fax: 0341 489093, e-mail: [email protected] Il dolore continua ad essere una dimensione cui non viene riservata ade guata attenzione, nonostante sia stato scientificamente dimostrato quanto la sua presenza sia invalidante dal punto di vista fisico, sociale e emozionale. 208 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Secondo quanto rintracciato nella letteratura corrente tutti i tipi di dolore sia acuto che cronico, in tutte le parti del modo, sono inadeguatamente trattati, il dolore potrebbe essere trattato in oltre il 90% dei pazienti affetti da cancro, ma tuttora meno del 50% riceve un adeguato trattamento, il dolore cronico è la causa più frequente di sofferenza e disabilità che seriamente influisce sulla qualità della vita, il 77% dei pazienti lamenta dolore dopo un intervento chi rurgico. Al fine di giungere a considerare il dolore fisico un segno imprescindibile nella valutazione clinica ed assistenziale della persona l’Azienda Ospedaliera di Lecco ha promosso un’indagine interna rivolta sia agli operatori che alle persone assistite, con la finalità di disegnare la dimensione epidemiologica del dolore e definire in seguito le metodologie formative, informative atte a aiutare operatori e pazienti a dare una risposta efficace ed efficiente al dolore in tutte le sue dimensioni di manifestazione. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare gli operatori sanitari del l’azienda alle problematiche del dolore acuto e cronico: riconoscimento, defi nizione, misurazione e trattamento. La definizione del percorso formativo è la diretta declinazione degli obiettivi che si perseguono attraverso la costituzio ne del Comitato Ospedale Senza Dolore. Il progetto formativo vede la crea zione di gruppi di lavoro aziendali aventi la finalità di: approfondire le diverse aree tematiche del dolore, recuperare la letteratura scientifica esistente, ela borare indagini atte a misurare la dimensione del fenomeno in ambito aziendale, definire metodi e strumenti per la rilevazione e gestione del dolo re. Gli obiettivi specifici sono quelli di acquisire conoscenze rispetto alla di mensione del dolore in ambito ospedaliero, conoscere le modalità e i criteri di rilevazione del dolore e saper utilizzare la scala di rilevazione valutazione proposta. Allo stato attuale il lavoro del Comitato si è focalizzato sulla stesura di linee guida per la gestione del dolore chirurgico post operatorio. Su tale tematica è stato effettuato un corso di formazione, strutturato in 10 edizioni, con la parte cipazione di medici ed infermieri pari all’80% dei programmati. Sono stati for mati circa 113 medici e 214 infermieri, per un totale di 327 persone. Il lavoro del Comitato continua con l’attuazione delle linee guida predisposte e con la stesura di documenti relativi ad altre due aree: la parto-analgesia e il tratta mento del dolore nelle procedure invasive. Il valore aggiunto del lavoro svolto in Azienda su questa tematica sta nella definizione univoca delle modalità di trattamento e nella messa in atto di un processo di sensibilizzazione dei pazienti. La formazione effettuata ha per messo di strutturare meglio un processo di comunicazione con il paziente finalizzato alla conoscenza preventiva del problema e alla condivisione delle modalità di trattamento. 209 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.23. La rete HPH Piemonte e Valle d’Aosta e “l’Ospedale senza dolore” F. RIPA, A. DE LUCA, L. RESEGOTTI, P. ZAINA - Rete HPH Piemonte e Valle d’Aosta Nella conferenza HPH di Torino del novembre 2003 una sessione molto articolata è stata dedicata ad un tema particolarmente attuale: l’Ospedale sen za dolore. La rete HPH Piemonte e Valle d’Aosta, prendendo spunto anche da signifi cative esperienze già sviluppate in alcune Aziende (ASL 1 Torino, ASL 4 Tori no, ASL Chivasso, ASL Casale, ASL Vercelli, ASL Valle d’Aosta, Ospedale Gradenigo Torino, ASO San Giovanni Battista Torino) ha avviato pertanto lo specifico progetto regionale, che si inserisce comunque nel contesto delle iniziative già indirizzate a livello regionale. Le Aziende che si sono trovate in un primo incontro preliminare presso l’ospedale Molinette nel mese di gennaio e negli incontri successivi hanno condiviso le reciproche esperienze, sottolineando alcune dimensioni centrali su cui impostare specifici progetti di miglioramento relativi in particolare alla “consapevolezza” del dolore da parte dei vari attori in campo, al ruolo che può rivestire in tale ambito la formazione/informazione, all’esigenza di defi nire sotto il profilo più squisitamente tecnico standard di riferimento per gli Ospedali e, più in generale, per i sistemi aziendali in una logica generale di integrazione. Tali dimensioni, peraltro, possono rappresentare altrettanti sti moli per la ricerca di specifiche azioni da sviluppare nelle Aziende. In tal senso è stato avviato una prima ipotesi di progetto il cui obiettivo è quello di ridisegnare il percorso del paziente nell’Ospedale senza dolore e nel territorio di riferimento, andando a considerare in modo specifico i momenti in cui egli si trova ad affrontare l’esperienza del dolore, per evidenziare le criticità e quindi porre in atto strumenti e metodologie di gestione in termini di comunicazione e di valutazione della percezione. Le iniziative avviate in Piemonte e Valle d’Aosta porteranno un contributo im portante nei prossimi cinque anni allo sviluppo della rete HPH anche sul tema del dolore e, in generale, sulla centralità della persona nello specifico ambito. 12.24. Ruolo del comitato per l’ospedale senza dolore nel promuovere una effettiva partnership tra professionisti e pazienti M. MONTEROSSO1, G. ALBERTINI2, M.G. ALLEGRETTI1, B. BORTOLAMEOTTI1, D. CHIUSOLE3, G. M. GUARRERA1, F. DALLAPÈ1, G. MENEGONI1, B. PARODI1, D. PEDROTTI1, C. PONTALTI1, P. ROMITI1, E. BALDANTONI3 - 1Comitato Ospedale Senza Dolore dell’Azienda Sa nitaria per i Servizi Sanitari – Trento; 2Associazione “No Pain for Children”; 3 Direzione Ospedale di Trento 210 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 AUTORE REFERENTE: MICHELA MONTEROSSO, Direzione Medica Ospedale di Trento, largo medaglie d’oro, 38100 Trento – tel.: 0461 903027, fax: 0461 903118 Introduzione Una efficace gestione del dolore nei pazienti, ricoverati in ospedale o assi stiti a domicilio, deve consentire ai professionisti di affrontare la dimensione della cura in modo integrato con quella relativa alla capacità da parte dei pa zienti e dei loro familiari di adottare comportamenti idonei per la gestione ed il controllo del sintomo dolore Questo comporta il coinvolgimento attivo e responsabile del paziente nelle cure e l’ascolto attento dei professionisti, in particolare riguardo ai soggetti con difficoltà di comunicazione (bambini, anziani, stranieri) ed al fatto che il dolore viene vissuto e di conseguenza riferito in modo diverso in relazione alla propria storia personale e alla cultura di appartenenza dei singoli. Obiettivi Descrivere il percorso seguito dal Comitato per un Ospedale Senza Dolore (COSD) della APSS nella predisposizione di linee guida locali per l’informa zione dei pazienti e dei loro familiari. L’obiettivo specifico è quello di mettere in grado i pazienti di riferire ai professionisti le proprie aspettative sul dolore, di realizzare una effettiva alle anza terapeutica per il controllo del dolore stesso attraverso la condivisione del piano di cura per la gestione del dolore, formare i professionisti sanitari ad una efficace gestione del dolore, utilizzando strumenti validati e condivisi (li nee guida e procedure) in una modalità di effettiva partnership con i pazienti. Target - Personale - formazione del personale sanitario; - conoscenza ed utilizzo di strumenti di rilevazione e monitoraggio del dolore; - informazione sulla possibilità di utilizzare mediatori culturali. - Pazienti - predisposizione di materiale informativo sulla gestione del dolore, inclu so quello audiovisivo; - indagini annuali sulla qualità percepita e la soddisfazione. - Comunità - iniziative di visibilità del Comitato (comunicazione interna ed esterna); - informazione sui risultati delle indagini di soddisfazione; - organizzazione di eventi culturali centrati sul problema del dolore. 211 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Presentazione e valutazione dei risultati Azioni sul personale. Formazione del personale sanitario: - partecipazione al master in “terapia antalgica e cure palliative dell’età pediatrica” di un medico pediatra e di un anestesista dell’area pediatrica, anche grazie alla collaborazione della associazione onlus “No Pain for Children che partecipa al COSD; - partecipazione al corso “gestione del dolore postoperatorio” frequentato da infermieri dell’area chirurgica; - partecipazione a 3 seminari organizzati dal Servizio Formazione APSS sul dolore acuto postoperatorio nel periodo 2003-2004. Sono in programma 2 seminari sul dolore cronico nel paziente oncologico; - formazione ed addestramento alla gestione del dolore postoperatorio di tutto il personale medico ed infermieristico dell’U.O. Chirurgia Pediatrica dell’Ospe dale S. Chiara tenuto dall’anestesista che ha frequentato il master sopra citato; - messa a disposizione di strumenti di facile utilizzo per la rilevazione ed il monitoraggio del dolore anche nei pazienti di età pediatrica o con difficoltà di comunicazione; - avvio negli ospedali di Trento e Rovereto di un progetto pilota che prevede l’intervento di mediatori culturali su chiamata delle unità operative nelle quali è maggiore l’afflusso degli utenti stranieri, con monitoraggio qualiquantitativo degli interventi con apposita scheda. Azioni sui pazienti: - consegna di materiale informativo per la gestione del dolore ai pazienti dell’area medica, chirurgica e materno infantile; - conduzione di due indagini annuali, con apposito questionario, sulla sod disfazione dei cittadini in occasione della “giornata nazionale del sollievo”. Nel 2004 l’indagine è stata mirata ai piccoli pazienti; - presenza presso tutte le strutture APSS del poster del Comitato “Cambia volto all’Ospedale – basta al dolore inutile”. Azioni sulla comunità: - presenza nel sito web aziendale dei documenti e delle attività del COSD; - diffusione dei risultati delle indagini di soddisfazione a mezzo media (gior nali, televisioni locali, conferenze stampa); - progettazione di incontro con associazioni di mediatori culturali per un con fronto sulla percezione e manifestazione del dolore nelle varie etnie. Conclusioni Il progetto si propone di modificare conoscenze, atteggiamenti e compor tamenti dei professionisti per metterli in grado di identificare, valutare e tratta re i diversi tipi di dolore nei pazienti assistiti negli ospedali della APSS e a 212 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 domicilio in ambito provinciale, educando i pazienti alla gestione del dolore e fornendogli strumenti conoscitivi e culturali per renderli compartecipi del pro cesso di cura che li riguarda. 12.25. L’ospedale senza dolore: promuovere una cultura per migliorare il benessere del paziente L. ANGELINI1, D. CRESPI2, M. GALBIATI3, M. G. MEZZETTI3, C. RADICE1, F. RIZZI4 - Istituto Clini co Mater Domini di Castellanza (VA) - 1Direzione Sanitaria; 2Ufficio Qualità e Formazione; 3Ufficio Comunicazione; 4Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione AUTORE REFERENTE: DEBORA CRESPI, Istituto Clinico Mater Domini, via Gerenzano 2, 21053 Castellanza (VA) - tel.: 0331 476282, fax: 0331 476204, e-mail: [email protected]. Breve introduzione del contesto L’Istituto Clinico Mater Domini è una struttura sanitaria in cui circa il 65% dei posti letto è dedicato all’attività chirurgica. Il dolore, e il dolore post-ope ratorio in particolare, rappresenta dunque un importante realtà con la quale confrontarsi per assicurare al paziente un benessere fisico ed emotivo. Il 1 agosto 2002, l’Istituto ha deciso di varare il progetto “Ospedale senza dolore”. Si tratta di una scelta volta a rendere il ricovero, ed il relativo intervento chirurgico, come un fenomeno episodico nella vita del paziente, che modifi chi il meno possibile le sue abitudini di vita. Obiettivi Il progetto si pone i seguenti obiettivi: - trattare in modo organico e continuativo il dolore (acuto, cronico, post operatorio); - prestare attenzione alla componente oggettiva e soggettiva del dolore; - adottare per ogni prestazione di accoglienza diagnostica e terapeutica tutte le strategie necessarie (farmacologiche, ambientali, alternative) per ridurre il dolore; - predisporre ulteriori modalità per aumentare il benessere del paziente. Gruppo target Sono stati individuati tre gruppi target: - Il paziente. E’ stato predisposto un opuscolo divulgativo in cui vengono illustrati i di 213 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 versi aspetti di dolore: perché si manifesta, quali sono le tipologie, come si valuta, che cos’è la terapia del dolore e in cosa consiste. - Operatori sanitari. - Gli infermieri professionali: nel corso del 2003, l’Istituto si è fatto promo tore ed organizzatore di un iter formativo con lo scopo di aggiornare il personale, non solo sugli aspetti terapeutici del dolore, ma anche su quelli psicologici e comunicativi che coinvolgono il paziente. - I medici. L’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione ha predisposto i protocolli per il trattamento del dolore post-operatorio per le attività di chirurgia generale, chirurgia vascolare, ortopedia e urologia. Successiva mente, è stata attivata un’indagine per verificare la rispondenza dei proto colli creati rispetto alla tipologia dei pazienti trattati. Si è utilizzata una scheda di misurazione del dolore che rileva il dolore percepito dal paziente. Sulla base di questi risultati, i medici delle Unità Operative coinvolte potranno così aggiornare i protocolli di trattamento del dolore in uso. Valutazione dei risultati - Dall’inizio del 2004 gli opuscoli divulgativi sono a disposizione degli utenti. - Tutto il personale è stato coinvolto nei corsi di formazione, la partecipazio ne è stata del 90% circa. - Sono stati creati quattro protocolli di trattamento per il dolore post-opera torio che potranno essere adeguati in base all’analisi delle schede di misu razione del dolore. - Le schede di rilevazione sono state distribuite a partire dal 7 gennaio 2004 fino ad aprile. Sono state quindi raccolte e analizzate, al fine di valutare i risultati emersi. Conclusioni I corsi di formazione hanno fornito nuovi strumenti per migliorare l’assi stenza e affrontare con maggior competenza e professionalità il problema del dolore percepito. Parallelamente, il paziente si è sentito coinvolto nell’iniziativa, consapevole di fornire indicazioni utili per il proprio benessere e per migliorare la qualità dell’assistenza erogata. 12.26. Le tecniche di rilassamento nella cura del dolore: reiki e paziente oncologico anziano M.T. VITALE1, M.E. LA GRASSA1, D. COVA1, E. COFRANCESCO2 - 1UOC di Onco-Geria 214 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 tria, Istituto Geriatrico “Pio Albergo Trivulzio”, Milano; 2Dip. di Scienze Me dico chirurgiche, San Donato, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Background La terapia farmacologica del dolore nel paziente anziano è molto delicata, in quanto il soggetto anziano è più sensibile ai sovradosaggi e presenta un aumentato rischio di effetti collaterali. Nell’ambito delle strategie complemen tari e di supporto nel paziente oncologico anziano, particolare interesse rive stono le tecniche di distensione e rilassamento, spesso efficaci nel lenire il dolore, innocue e gradite ai pazienti. Reiki, che ha le sue radici nel buddismo tibetano, è un antico e semplice metodo di cura tramite il tocco delle mani. Si tratta di una tecnica “dolce”, di rilassamento ed analgesia, efficace nella terapia del dolore (anche oncologico), nell’assistenza pre- e post-operatoria, durante i trattamenti chemio e radioterapici, nel malato oncologico avanzato e terminale e negli stati depres sivi in genere. Reiki viene classificato dal National Center for Complementary and Alter native Medicine (National Institute of Health) tra le terapie energetiche della “biofield medicine” o medicine del campo energetico (http://nccam.nih.gov/ health/whatiscam/index.htm). In questo specifico contesto ideologico Reiki si pone nell’ambito della medicina delle energie sottili, che ha la possibilità non solo di curare la malattia a livello fisico, ma anche di agire sugli elementi psicoenergetici della personalità, promuovendo la reintegrazione e il riallineamento del complesso corpo-mente-spirito. Come tecnica di contatto manuale (Touch Therapy), Reiki si può collocare tra le più efficaci tecniche di rilassamento e analgesia. Durante la seduta Reiki, infatti, si ottiene un rilassamento profondo con riduzione della pressione arteriosa sistolica e della tensione dei muscoli del collo, e l’aumento delle IgA salivari [J Adv Nur 2001; 33: 439]. Il rilassamento inoltre riduce i sintomi secon dari alla chemioterapia (dolore, nausea) e sostiene emotivamente il paziente oncologico in trattamento chemioterapico, riducendo l’ansia, la depressione, la confusione, il senso di rabbia e la stanchezza [Psychooncology 2001; 10: 490]. Obiettivo Scopo del presente studio è valutare se Reiki, in supporto alle terapie con venzionali, possa contribuire ad alleviare i sintomi/segni correlati alla patolo gia neoplastica nel paziente oncologico anziano e migliorare la qualità del l’assistenza. 215 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Gruppi target a) Pazienti oncologici anziani in stadio avanzato o terminale, ricoverati pres so reparti di oncologia, geriatria o hospices (progetto “Ospedale senza Do lore”); b) Personale sanitario (infermieri, fisioterapisti, caregivers, altri) (progetto “Tutela della salute e prevenzione del burn out negli operatori della salu te”). Metodi Studio pilota, prospettico, osservazionale. Arruolati 15 pazienti (11 fem mine) di età tra 62 e 87 anni, affetti da cancro in stadio avanzato e con per formance status secondo Karnofsky tra 50 (notevole assistenza) e 10 (stato terminale). Tre malati sono stati accompagnati alla morte. Cartella infermieristica informatizzata: i parametri clinici sono stati registrati a ca denza settimanale. Per ciascuno di questi è stato assegnato uno score di intensità da 0 (assenza di sintomo/segno) a 10 (massima espressione). Per ciascuna seduta sono stati registrati profondità del rilassamento e riscontro soggettivo. A fine ciclo è stato registrato l’indice di gradimento del tratta mento da parte del paziente. Risultati Sono stati eseguiti 5,7 (range 3-8) trattamenti Reiki per paziente, a cadenza bi-trisettimanale. Nella tabella 1 sono riportati gli score (valori espressi come medie). Tab. 1 basale dopo Reiki basale dopo Reiki dolore 7,1 4,1 agitazione 7,4 2,8 astenia 7,1 5,2 insonnia 6,5 3,1 dispnea depressione 5,8 5,7 3,5 2,7 nausea 6,9 3,4 vomito 5 3,8 Il rilassamento, alla fine delle sedute Reiki, era medio-profondo nel 90% dei pazienti, il riscontro soggettivo di “sentirsi meglio” nel 94%, l’indice di gradi 216 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 mento 9,5 (score da 0 a 10). Elevato il gradimento anche da parte del persona le sanitario, che si è sentito molto gratificato e motivato. Conclusioni Nel paziente anziano affetto da tumore in fase avanzata, Reiki si dimostra efficace nell’alleviare i sintomi e migliora la qualità di vita. Nel malato termi nale riduce il dolore, infonde serenità, apre alla speranza. Reiki presenta un elevatissimo indice di gradimento da parte dei pazienti. Nell’infermiere/ope ratore sanitario che tratta, Reiki sostiene la relazione, riduce l’ansia nella cura, aumenta l’empatia, sviluppa amore e compassione. L’inserimento di Reiki nella formazione professionale dell’infermiere può offrire un utile mezzo per valorizzarne la professionalità e migliorare il rapporto con il pa ziente, trasformando la ‘manipolazione’ del paziente, a volte ruvida e veloce per necessità contingenti, in una vera e propria ‘terapia di contatto’. 12.27. Indagine conoscitiva sulla prevalenza del dolore nei pazienti ri coverati e su atteggiamenti e conoscenze del personale sanitario A. BERNASCONI, A. CAVALERI, A. GAMBA, G. GENDUSO, N. MONZANI, A. MORETTO, A. RAI MONDI, A. RUSSO, M. SALA, R. SPERANZA, L. TUCCINARDI, A.VIRTUANI - A.O. S.Gerardo di Monza La A.O. S.Gerardo di Monza ha sviluppato un progetto complesso: verso un ospedale senza dolore. Una tappa significativa del progetto è rappresentata da una indagine cono scitiva su: - prevalenza e intensità del dolore nei pazienti ricoverati; - atteggiamenti e conoscenze degli operatori sanitari. Strutture interessate I presidi ospedalieri S. Gerardo (vecchio e nuovo ospedale) di Monza e Bassini di Cinisello. Tutti i reparti di degenza, ad eccezione di psichiatria e neonatologia. Pazienti Sono stati reclutati tutti i pazienti presenti in un determinato giorno, di età maggiore o uguale a 6 anni, ricoverati almeno dal giorno precedente e previo consenso informato. 217 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Personale sanitario Tutto il personale medico ed infermieristico, fisioterapisti e psicologi. Metodologia di indagine a) Rilevazione tramite questionari anonimi di: A’: presenza, intensità e tipo di dolore avvertito dal paziente A’’: dolore avvertito dal personale infermieristico sullo stesso paziente e terapia attuata B: atteggiamento e conoscenze del personale sanitario sul dolore b) Misurazione del dolore su scala NAS. Elaborazione dei dati Il rapporto, di tipo descrittivo, è stato articolato in 6 sezioni. Le prime 5 relative al questionario riferito ai pazienti (A’ e A’’) e l’ultima riguardante gli operatori sanitari (B): - tassi di risposta - caratteristiche dei pazienti - dolore percepito dal paziente - dolore riconosciuto dagli operatori sanitari - trattamento del dolore - atteggiamenti e conoscenze sul dolore Conclusioni L’indagine conoscitiva, svolta forse per la prima volta contemporaneamen te in un grande struttura ospedaliera, ha visto un lungo lavoro di preparazione e di coinvolgimento degli operatori. Solo così è stato possibile avere tassi ele vati di risposta per la rilevazione del dolore nei pazienti e per il questionario di conoscenza distribuito agli operatori sanitari. La giornata di rilevazione si è accompagnata ad una campagna informativa della cittadinanza, con stand posti all’ingresso dei presidi ospedalieri e con articoli di stampa. In entrambi i presidi circa il 50% dei pazienti non riferisce dolore. La per centuale di pazienti con dolore intenso è inferiore al 10% (9,2% S. Gerardo, 8,2% Bassini). Molto più distribuito è il dolore lieve o moderato. Così vi sono differenze nelle tre aree considerate per ospedale S. Gerardo e ospedale Bassini. La evidente discrepanza tra dolore segnalato dal paziente e dolore avvertito dagli infermieri è a volte causata da una sovrastima da parte dell’operatore sanitario. 218 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 L’approccio terapeutico prevalente conferma una attitudine persistente a dare analgesici al bisogno, piuttosto che impostare una terapia costante. L’uso di oppioidi conferma la resistenza da parte dei medici ad usare questa classe di analgesici. Infine un numero consistente di sanitari ha risposto al questionario di co noscenza personale. I questionari raccolti tra gli operatori sanitari sono stati 763. Il percento totale di risposte esatte è stato del 53,4%. Tra i 206 medici che hanno compilato il questionario vi è stata una percen tuale di risposte esatte del 63,1 %, mentre tra i 532 infermieri la percentuale positiva è stata del 50,0%. Tutti i dati ricavati dalla specifica realtà della A.O. S. Gerardo stanno ora indirizzando le successive tappe del progetto verso un ospedale senza dolo re: - corsi di aggiornamento specifici nelle unità operative, dove vi è maggior riscontro di dolore - inserimento nella cartella clinica, medica ed infermieristica, della rilevazione quotidiana del dolore tramite scala NAS - promozione dell’uso degli oppioidi. 12.28. Ruolo del comitato per l’Ospedale senza dolore nel processo di adeguamento agli standard Joint Commission International. L’esperienza di Trento F. DALLAPÈ1, B. BORTOLAMEOTTI1, C. PONTALTI1, M.G. ALLEGRETTI1, G.M. GUARRERA1, G. MENEGONI1, M. MONTEROSSO1, B. PARODI1, D. PEDROTTI1, P. ROMITI1, E. BALDANTONI2 - 1Comitato Ospedale Senza Dolore dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari, Trento; 2Direttore Ospedale di Trento AUTORE REFERENTE: FRANCA DALLAPÈ, U.O. Chirurgia Pediatrica, Ospedale di Trento, Largo Medaglie d’oro, 38100 Trento - tel.: 0461 903835, fax: 0461 903835 Introduzione La versione 2003 del modello di accreditamento secondo Joint Commission International-JCI prevede tre nuovi standard (COP 17, 18, 19) centrati sulla valutazione e la gestione del dolore. L’Ospedale S. Chiara di Trento ha iniziato nel secondo semestre del 2003 il percorso di adeguamento agli standard JCI. La Direzione di Ospedale ha chiesto la collaborazione del Comitato per l’Ospe dale senza dolore (COSD) istituito nel 2002 dal Direttore Generale della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari-APSS al fine di raccogliere ed elaborare dati 219 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 relativi alla valutazione ed al trattamento del dolore nei pazienti ricoverati, e di ottenere informazioni ed indicazioni utili per avere un approccio di sistema del problema dolore. Obiettivi Descrivere il percorso seguito dal COSD per la predisposizione di linee guida locali relative alla educazione del paziente sul dolore coerenti con gli standard JCI e le azioni per la loro applicazione. Descrivere come il COSD ha identificato gli strumenti per la rilevazione sistematica del dolore nei pazienti ricoverati e le modalità per la registrazione nella cartella clinica integrata, secondo gli standard JCI. Gruppo target Personale medico-infermieristico: - iniziative formative sulla valutazione e la gestione del dolore; - attività di consulenza allo specifico gruppo di lavoro per l’adeguamento agli standard JCI. Materiali e Metodi - ricognizione della documentazione esistente sulla informazione del paziente; - ricerca bibliografica di strumenti validati per la valutazione del dolore; - identificazione di uno strumento informativo per il paziente idoneo per l’area medica, quella chirurgica e quella pediatrica; - predisposizione di linee guida locali sulla gestione del dolore; - realizzazione degli strumenti per la raccolta dei dati relativi a valutazione, monitoraggio e gestione del dolore coerenti con gli standard JCI; - avvio di un percorso formativo indirizzato alle diverse figure professionali che intervengono nel processo di cura. Conclusioni Le azioni intraprese hanno consentito all’Ospedale di intraprendere il pro cesso di adeguamento agli standard relativi alla cura del paziente che richie dono non solo aspetti di tipo formale/documentale, ma modifiche comportamentali nella pratica quotidiana. Ciò è particolarmente significativo nell’ambito del dolore, ancora considerato spesso un fattore ineluttabilmente legato alla dimensione della malattia, e come tale spesso trascurato e non adeguatamente trattato. 220 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.29. Trattamento del dolore post – operatorio. Raccomandazioni del comitato per l’ospedale senza dolore D. PEDROTTI1, M.G. ALLEGRETTI1, B. BORTOLAMEOTTI1, F. DALLAPÈ1, G.M. GUARRERA1, G. MENEGONI1, M. MONTEROSSO1, B. PARODI1, C. PONTALTI1, P. ROMITI1, E. BALDANTONI2 - 1Comitato Ospedale Senza Dolore dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari, Trento; 2Direttore Ospedale di Trento AUTORE REFERENTE: DINO PEDROTTI, U.O. Anestesia e Rianimazione, Ospedale di Trento, largo medaglie d’oro, 38100 Trento - tel.: 0461 903298, fax: 0461 903355 Introduzione Un adeguato trattamento del dolore post-operatorio contribuisce significa tivamente al miglioramento della morbilità perioperatoria, valutata in termini di minor incidenza di complicanze postoperatorie anche ascrivibili alle tecni che di terapia antalgica, specie se invasive, di riduzione delle giornate di degenza e dei costi, in particolare nei pazienti ad alto rischio sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore. L’anestesista, per le sue peculiari conoscenze sulla fisiopatologia e terapia del dolore acuto, si trova nella condizione di poter coordinare il team responsabile del trattamento del dolore acuto, come dimostrate anche in esperienze internazionali. Obiettivi - Sviluppo da parte degli anestesisti di un adeguato piano di formazione ed addestramento per il personale ospedaliero, con identificazione di aree di intervento prioritario, in modo da prepararlo all’uso efficace e sicuro dei protocolli analgesici per un adeguato trattamento del dolore postoperatorio. Il piano di formazione continua deve includere sia gli aspetti relativi alla valutazione del dolore che, in una seconda fase, quelli relativi alla com prensione delle diverse tecniche analgesiche più sofisticate (PCA, Analgesia epidurale, altre tecniche loco-regionali); - predisposizione di strumenti di informazione rivolta ai pazienti per ottene re il massimo risultato dai trattamenti eseguiti anche cercando di fugare i preconcetti che riguardano, ad esempio, la dipendenza da oppiacei e l’ineluttabilità del dolore postoperatorio ed enfatizzare i vantaggi legati al buon trattamento postoperatorio; - utilizzo in tutti gli ospedali della APSS di linee guida di trattamento del dolore acuto postoperatorio e per la misurazione del dolore e della efficacia terapeutica. Le raccomandazioni sono state adottate dal COSD e la loro implementazione è finalizzata a far diventare la valutazione del dolore uno dei parametri di misurazione corrente alla stregua di quelli così detti “vitali” 221 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 come la frequenza cardiaca, respiratoria, la pressione arteriosa e la tempera tura corporea che sono regolarmente monitorate durante le ventiquattro ore. Gruppo target Pazienti sottoposti ad intervento di chirurgia pediatrica. Personale medico-infermieristico della unità operativa di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara. Valutazione dei risultati e conclusioni Il progetto condotto come sperimentazione pilota nella Chirurgia Pediatrica dell’ospedale S. Chiara a partire dall’estate 2003, ha avuto dei riscontri favorevoli in termini di soddisfazione del bambino e dei genitori, oltre che degli operatori sanitari e ci proponiamo di estenderlo ad altre unità operative di area chirurgica. 12.30. Emersione di una patologia sottodiagnosticata: la “sindrome delle apnee ostruttive nel sonno”; problematiche di asimmetria informativa e “governance”. Esperienza di un ospedale distrettuale nel Trentino A. SALVATERRA, E. ANESI - U.O. Pneumologia, Servizio di Fisiopatologia Respira toria Nuovo Ospedale di Arco (TN) AUTORE REFERENTE: ALESSANDRO SALVATERRA, tel.: 0464 582453, fax: 0464 882417 Introduzione Definizione di “Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno” (OSAS) nel 1976; prima terapia efficace: 1981; primo paziente trattato in Trentino: 1990. Epidemiologia: 2-4% della popolazione adulta; elevata morbilità e mortalità correlate a ipersonnia diurna, deficit cognitivo, ipertensione sistemica, iperten sione polmonare, infarto miocardico, aritmie cardiache ed elevato rischio di incidenti automobilistici e/o lavorativi; esiste una terapia efficace con un rispar mio di risorse socio-sanitarie di € 1.500/anno/paziente. La storia del Centro del Sonno inizia nel 1990, nel 1995 Riconoscimento del Modulo “Centro Disturbi respiratori nel sonno”; 1999: Certificazione di Centro del Sonno ad Indirizzo Cardiorespiratorio AIMS (Associazione Italiana Medicina del sonno). I numeri 1994: esami 50, pazienti in CPAP 15. 1997: esami 150; in CPAP 30. 222 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 2001: aumento del personale (3,3 tecnici + 1,7 medici) e dei mezzi diagnostici (2 polisonnigrafi fissi + 4 portatili) esami anno 650. Al 2003 nel Trentino: studiati 2.100 soggetti; diagnosi di OSAS: 1.050; in terapia con CPAP 440; prevalenza già diagnosticata: 0,6% (max 1,2% nel di stretto sede del Centro del Sonno). Emersione della patologia e diagnostica condizionate da: - Cultura sui disturbi del sonno: chi russa dorme bene! - Autopercezione della malattia: il paziente che russa non sa di russare. - Interdisciplinarietà: gli altri specialisti non conoscono la “nuova” malattia. - Assenza di voci di tariffario adeguate. - Sviluppo dell’attività in condizioni di iso-risorse umane. - Ubicazione periferica del Centro del Sonno: minore “visibilità”, ma maggio re possibilità di specializzazione. - Terapia dell’OSAS non farmacologica, economica, circa € 3.000/paziente/ogni 5 anni: ridotta induzione di spesa sanitaria e ridotti interessi economici correlati. Le azioni ed i risultati - Comunicazione: articoli di stampa ed interviste TV. - Iniziative di Formazione: 1 corso specifico e 7 interventi in congressi locali. - Protocolli interdisciplinari di screening, diagnosi e terapia con le U.O. di Pediatria, ORL, Neurologia e Pneumologia. - Progetto di formazione per i medici di medicina generale e gli specialisti (focalizzando il rischio cardiovascolare dell’OSAS), e per altre figure: Poli zia stradale, medicina legale, medicina del lavoro, ufficio patenti di guida (rischio di incidenti stradali e sul lavoro da sonnolenza da OSAS: il 3% dei morti per colpo di sonno, il 20% degli indicidenti stradali totali). - Innovazione nella gestione delle liste di attesa (nel 2001 i tempi di attesa erano di 9 mesi): introduzione del triage per le indagini diagnostiche: pa zienti a rischio 1 mese, a rischio intermedio 2-3, a basso rischio oltre 4 mesi; per le visite di controllo: a rischio 10 gg., a basso rischio 40 gg. - Individuazione di nuove prestazioni: calcolo di tempi e costi (controllo di gestione): Polisonnografia € 527,00; monitoraggio cardiorespiratorio € 230,00 con proposta di inserimento nel tariffario provinciale - Innovazione nei protocolli di diagnosi e terapia dell’OSAS; organizzazione completamente ambulatoriale, al posto del ricovero, dimostrandone la mag giore efficienza (risparmio di oltre € 1.200/diagnosi-paziente) e pari effica cia (compliance alla CPAP: 80% dopo 5 aa) imperniate su uno staff tecnicoinfermieristico qualificato e motivato. I punti critici attuali Rallentamento nello sviluppo dell’approccio interdisciplinare; impossibili tà a garantire il follow-up (rapporto Ospedale-territorio). 223 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Discussione L’epidemiologia, la gravità della malattia, il successo terapeutico hanno prodotto una domanda crescente evidenziata dalle liste di attesa. Sotto questo impulso l’Am ministrazione Aziendale ha risposto nel tempo adeguando le attrezzature. Nono stante 10 anni di attività ed i risultati raggiunti non si è ancora colmata la asimmetria informativa sull’OSAS fra lo specialista ed il paziente, il medico di base, la program mazione sanitaria; la possibilità di una vera governance globale dell’OSAS, che coin volga i vari specialisti, l’Ospedale ed il territorio, è frenata dal mancato recepimento dell’OSAS negli obiettivi del Piano Sanitario Provinciale e quindi dell’Azienda Sani taria e del Piano delle attività di formazione del personale. Conclusioni L’emersione dell’OSAS in Provincia di Trento è un fatto compiuto; a tutt’og gi i risultati raggiunti sovrastano i punti critici ancora da risolvere; la lunga “gestazione” di questo Centro, in assenza di politiche e strategie sanitarie spe cifiche, pone interrogativi all’organizzazione sanitaria sul come governare una emergente, nuova, domanda di salute di grande impatto epidemiologico. 12.31. Perineal care: un moderno programma di tutela della salute della donna S. ZILOCCHI, G. F. MININI, N. PELI, R. AVISANI, U. A. BIANCHI, S. PECORELLI - A.O. Spe dali Civili di Brescia AUTORE REFERENTE: ROSARIA AVISANI, A.O. Spedali Civili di Brescia - tel.: 030 3995959, fax. 030 3995954, e-mail: [email protected] Breve introduzione di contenuto L’incontinenza urinaria, il prolasso genitale e le disfunzioni ano rettali sono patologie diffuse nella popolazione femminile e inducono rilevanti problematiche non solo individuali e familiari, ma anche sociali, sanitarie, economiche e politiche. Tali patologie trovano tutte una comune origine patogenetica nella disfunzione del perineo e quindi possono in gran parte essere pervenute attraverso una adeguata cura del perineo: il Perineal Care. Presso il Dipartimento Ostetrico-Neonatologico e Ginecologico degli Spedali Civili di Brescia è in corso un programma di prevenzione perineale che ha come target la popolazione femminile dell’area bresciana. Si tratta di un arti colato programma che prevede in primo luogo la diffusione della conoscenza delle strutture pelvi-perineali e della loro funzione oltre che il riconoscimento delle condizioni che causano danno perineale e la pubblicizzazione delle 224 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 possibilità di cura del perineo. La prevenzione si basa quindi su di un inter vento educativo inteso a indurre la presa di conoscenza culturale del perineo, ma fondamentalmente è anche il riconoscimento precoce dei soggetti a ri schio e la programmazione di piani di cura riabilitativi specifici. Obiettivi Gli obiettivi perseguibili con il perineal care a breve e a lungo termine sono: a) La riduzione dell’incidenza della incontinenza urinaria e del prolasso che attual mente colpiscono una parte specifica della popolazione femminile: per l’incon tinenza urinaria si stima che ne soffrano in Italia il 7% delle donne al di sotto dei 50 anni, il 16% di quelle tra i 50-64 anni e il 17% di quelle sopra i 65 anni; b) Il miglioramento dell’autostima della donna, della sua qualità di vita e della sua sessuologia; La riduzione della chirurgia invasiva e una riduzione della spesa sanitaria: in Italia la spesa per gli assorbenti ammonta a 500 miliardi l’anno. Gruppo target L’intervento si sviluppa in diversi momenti lungo tutto il ciclo vitale, percorso biologico e riproduttivo della donna: adolescenza, prima della gravidanza, in gra vidanza, nel primo puerperio, nel puerperio secondo, ad evento ostetrico conclu so ed in menopausa, con il coinvolgimento di numerose e differenziate figure sanitarie: ostetriche, infermiere, ginecologi, puericultrici, dietiste e psicologi. Valutazione Indicatore: Misura: Numero donne (R1) che non presentano fattori di rischio perineale e segni disfunzionali _______________________________% Numero complessivo di puerpere Indicatore: Misura: Numero donne (R2) che presentano fattori di rischio perineale lievi disfunzionali _______________________________% Numero complessivo di puerpere Indicatore: Misura: Numero donne (R3) che presentano numerosi fattori di rischio perineale e importanti disfunzionali _______________________________% Numero complessivo di puerpere 225 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Conclusioni Il programma “Perineal Care” è uno strumento preventivo di largo impatto socio-sanitario ed economico. Punto di forza è la certezza dei risultati, seppure a distanza, a fronte tuttavia di notevole dispendio di energie professionali ed economiche Altro aspetto estremamente positivo è la integrazione operativa di diverse figure professionali, che devono collaborare strettamente, con di mostrata gratificazione e crescita culturale per tutti. Gli intereventi informativi, educativi, assistenziali e terapeutici hanno im pegnato e impegnano tutte le figure professionali elencate nella presentazio ne. Ogni famiglia professionale ha portato le proprie competenze ponendo al centro la donna, la sua salute e la sua qualità di vita. 12.32. Integrazione ospedale/territorio - Prato: progetto assistenziale territorio ospedale per le malattie cerebrovascolari E. BOTTACCHI1 (Direttore UB di Neurologia), G. CORSO1 (Specialista neurologo presso la UB di Neurologia), M. PESENTI CAMPAGNONI1 (Direttore della UB Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione), A. ANTICO1 (Direttore della UB di Chirur gia Vascolare), C. ALLEGRI2 (Direttore di Distretto), C. PONZETTI2 (Direttore Sanita rio Azienda USL Valle d’Aosta) - 1Ospedale Regionale di Aosta, 2Azienda USL Valle d’Aosta AUTORE REFERENTE: EDO BOTTACCHI, Viale Ginevra 3, 11100 Aosta - tel.: 0165 543610, fax: 0165 543264, e-mail: [email protected] Contesto L’ictus è la terza causa di morte e la prima di invalidità permanente nei paesi occidentali. L’età rappresenta oggi il principale fattore di rischio e di conseguenza il costan te invecchiamento della popolazione, la minore mortalità cardiovascolare ci indi cano che occorre prepararsi ad un aumento di casi di ictus nei prossimi anni. E’ necessario organizzare meglio l’assistenza in fase acuta ed effettuare con creti programmi di prevenzione. Nell’ottica della prevenzione nasce il Progetto PrATO (Progetto Assistenza Territorio Ospedale) che mira mediante l’applicazione di una carta di rischio per la malattia cerebrovascolare ad identificare in una certa fascia di popola zione le persone a rischio per inviarle ad effettuare uno screening di II° livello al fine di meglio approfondire i fattori di rischio e mettere in atto tutte quelle strategie comportamentali e terapeutiche per prevenire l’insorgere di una malattia cerebrovascolare. 226 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Obiettivi 1. Somministrare la Carta del rischio Cerebrovascolare nel Distretto n. 1 di Morgex sulla popolazione di età compresa fra 60 e 70 anni e mettere in atto idonei interventi preventivi al fine di ridurre la prevalenza degli accidenti cerebrovascolari nel quinquennio successivo. 2. Validare la metodologia per una eventuale estensione ad altre fasce di età ovvero ad altri distretti della Valle d’Aosta. 3. Promuovere l’integrazione fra Ospedale e Territorio, fra i diversi Specialisti e i Medici di Medicina Generale. Materiali e Metodi Il Progetto PrATO si applica alle persone residenti nel Distretto n. 1 di Morgex in Valle d’Aosta. La fascia di popolazione interessata è quella di età compresa tra i 60-70, è assomma a 2.400 abitanti dei 23.000 totali del Distretto. Lo screening sarà completamente gratuito, rientrando tra i “Progetti Obiet tivo” dell’USL della Valle d’Aosta. Il Progetto PrATO prevede di applicare ai probandi la “Carta del Rischio Cerebrovascolare” (CRC) allo scopo di identificare i possibili portatori di ri schio Cerebrovascolare. Molto semplice da applicare, la CRC prevede tra i suoi items: età del pazien te, pressione Sistolica, anamnesi di Cardiopatia e tabagismo. La CRC, che sarà somministrata dal Medico di Medicina Generale (MMG), determina un punteggio di “rischio” che nel caso superi il valore numerico di 1.000, considerato il limite sopra il quale esiste un reale rischio ictus, por ta alla necessità di sottoporre il probando ad una fase clinica detta di II° livello. Si stima che circa 400 dei probandi abbiano un “rischio maggiore di 1.000” e che quindi accederanno allo screening di II° livello. Questa fase, svolta dagli specialisti ospedalieri (neurologi, chirurghi vascolari, medici di Pronto Soccorso) comporta l’esecuzione di un esame clinico mirato agli aspetti vascolari, esami ematologici, ECG ed Ecocolordoppler vasi del collo. Conosciuti dal team di II° livello i risultati di questi esami clinici e strumen tali verranno definiti gli interventi sanitari necessari attraverso la formulazione di un “piano terapeutico” da inviare al medico di medicina generale. MMG che provvederà a mettere in atto tutte quelle procedure terapeutiche necessarie a correggere i problemi emersi (stile di vita, terapia farmacologica di ipertensione, dislipidemia, ecc....) ed effettuerà il follow-up nei 5 anni suc cessivi. 227 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 I MMG hanno iniziato la compilazione della CRC per i primi pazienti nel mese di giugno 2004. Le prime visite di II° livello inizieranno il 19 giugno. Il progetto terminerà nel marzo del 2005. Risultati attesi e conclusioni In Valle d’Aosta è attivo da anni un Registro Regionale dell’ictus che ci per mette di conoscere il numero di nuovi ictus anno/100.000 abitanti. L’Incidenza di primo ictus in VdA è di 240 casi anno/100.000 abitanti. Nella popolazione in esame (60-70 anni) nel distretto di Morgex sono attesi da 80 a 90 ictus nei prossimi 5 anni, e di questi l’80% si verificherà in coloro che avranno avuto un punteggio alla CRC maggiore di 1.000 secondo quanto previsto dalla letteratura [W.G.T. Coppola et al British Journal of General Practice,1995]. Considerando gli effetti preventivi di “cambiamento di stile di vita e terapia antipertensiva, ipolipemizzante e antiaggregante” ci attendiamo di veder modificata l’incidenza attesa di ictus nella popolazione studiata di una per centuale tra il 25% e 40 % con circa 30 casi di ictus evitati. E’ in programma l’estensione del progetto agli altri tre distretti della Valle d’Aosta 12.33. L’ospedale che nutre bene: un progetto di qualità in riabilitazione R. VEDOVELLI (Direzione Sanitaria), P. ABELLI (Direttore Sanitario), A. CAJELLI (Servizio Cucina), R. AQUILANI (Servizio metabolico nutrizionale) - Fondazio ne Salvatore Maugeri Istituto Scientifico di Montescano AUTORE REFERENTE: ROSA VEDOVELLI, FSM Istituto Scientifico di Montescano, via per Montescano 31 – tel.: 0385 247241, fax: 0385 61386, e-mail: [email protected] Obiettivi Attuare un sistema di programmazione della nutrizione dei degenti orienta to per patologia assecondandone nel contempo le preferenze. Metodologia La nutrizione è una terapia importante per il recupero di soggetti affetti da patologie invalidanti. Allo scopo il nostro Istituto ha ideato un progetto che si dispiega in due fasi. I° fase: ristrutturazione dell’alimentazione offerta dall’Isti tuto in modo da ottenere un alto grado di soddisfazione dei degenti (>70%), 228 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 periodicamente quantificabile. II° fase: costruzione di pacchetti di alimenta zione specifici per le tipologie di malattie del nostro Istituto, a parità di perso nale e strutture del Servizio Cucina. La presente relazione riporta i risultati della I° fase del progetto condotta in 12 mesi a periodicità trimestrale su un totale di 2.133 ricoverati, Sono riportati i risultati in percentuale. Item Quantità Qualità 90 Cottura 88 Condimento Soddisfazione relativa I piatto 92,8 90 88 89,4 81,4 II piatto 94,3 89,6 91,6 93,9 83,1 Contorni 92,6 89,2 87,4 76,9 73,1 Frutta 94,3 83 80,2 Percentuale di pazienti esprimenti soddisfazione globale per il vitto 79,4% +- 4,4% (range 73,1% -83,1%) Discussione: i risultati evidenziano la necessità di migliorare il condimento dei contorni che, pur accettabile (soddisfazione >70%), ha avuto l’effetto di ridurre il grado di soddisfazione globale che altrimenti sarebbe stato superio re all’80%. Conclusioni L’alto grado di soddisfazione dei pazienti rappresenta una premessa indi spensabile per passare alla fase successiva. 12.34. La visita odontoiatrica nelle scuole materne M. COSER, R. MERLO, E. PESARESI - Ospedale S. Lorenzo Borgo Valsugana (Tn) La prevalenza della carie nella popolazione infantile si è drasticamente ri dotta negli ultimi 30 anni: ormai acquisito l’obiettivo OMS per il 2000 (50% di bambini caries-free a 6 anni), l’Azienda Sanitaria del Trentino è concentrata sul prossimo riferimento per il 2010 (80% caries-free a 6 anni). Anche la distribuzione di questa patologia è però cambiata: dai valori piut tosto uniformi di qualche decennio fa, all’attuale 20% dei bambini di scuola elementare portatori dell’80% delle carie. Per incidere il più precocemente possibile sulla notevole predisposizione alla carie di questa piccola fetta di popolazione infantile, le igieniste dentali del nostro Ospedale hanno inserito nella tradizionale attività di animazione sulla salute orale nelle scuole materne, la visita odontoiatrica con specchiet 229 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 to e specillo per tutti i bambini, i quali hanno risposto meglio di quanto previsto. 12.35. L’ossigeno ventiloterapia domiciliare in Provincia di Trento: un difficile equilibrio tra salute e risorse M. PRANDINI, A. MIORELLI - Servizio di Fisiopatologia Respiratoria-Ospedale di Arco (TN) AUTORE REFERENTE: MARIO PRANDINI, e-mail: [email protected], tel. 0464 582415, fax: 0464 582417 Introduzione Oltre 20 anni fa è stato dimostrato che la ossigenoterapia a lungo termi ne (OLT) è l’unica terapia in grado di modificare la storia naturale dei pa zienti affetti da insufficienza respiratoria cronica secondaria a broncopatia cronica ostruttiva. Per quanto riguarda la ventiloterapia a lungo termine (VLT) studi successivi hanno dimostrato analogo risultato nei pazienti af fetti da malattie neuromuscolari ed alcune patologie toraco-polmonari. In provincia di Trento nel 1988 una deliberazione della Giunta Provinciale affidava tutte le competenze relative alla OLT (eseguita mediante concentratore o ossigeno liquido) ad un unico centro (Fisiopatologia Re spiratoria di Arco). Nel 1993 venivano affidate a tale centro tutte le compe tenze relative alla ventiloterapia domiciliare, infine una recente delibera zione attribuiva allo stesso centro tutte le competenze relative alla ossigenoterapia, mantenendo alla Medicina Generale la competenza rela tiva alla ossigeno terapia a breve termine mediante ossigeno gassoso (pe riodo massimo di prescrizione 2 mesi). Obiettivo Il governo della OLT-VLT è assai complicato: da un lato l’incremento della patologia rende necessario prescrivere la terapia ad un numero sempre mag giore di persone, dall’altro il numero delle risorse è finito. Lo scopo della no stra attività è quello di ottenere risultati terapeutici positivi, nel rispetto dell’ef ficienza e dell’economicità del servizio. Attività L’ attività per la OLT e per la VLT si articola nei seguenti punti: studio e selezione dei pazienti, consegna delle attrezzature, educazione dei pazienti e 230 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 dei familiari, istituzione di registro dei pazienti, controllo domiciliare degli stessi e delle attrezzature, controllo telemetrico di pazienti selezionati. Attual mente risultano in OLT 456 pazienti (272 liquido, 181 concentratore, 3 gasso so), 131 in VLT (dei quali 67 anche in OLT), 10 ventilati per via tracheale, i restanti per via nasale. Risultati Il costo dell’ossigeno liquido in Trentino è di 0,34 cent/litro ed il costo an nuo per tale presidio nel 2003 è stato di 962.756,04 €. I concentratori vengo no noleggiati al costo unitario di 72,3 € al mese. Il costo derivante dal noleg gio dei concentratori nel 2003 è stato di 161.176,75 €; è previsto inoltre un rimborso per la spesa relativa ai consumi di energia elettrica: 51,65 € e 64,56 € mensili rispettivamente ai pazienti che li utilizzano meno o più di 17 ore al giorno (costo minimo annuo circa 112.183 €). Per quanto riguarda i pazienti ventilati il costo varia in relazione al tipo e al modello di ventilatore, in base alla patologia: si passa dai 5.000 € dei ventilatori che vengono usati dai pa zienti che necessitano di ventilazione per meno di 15 ore al giorno, ai 29.300 € per i ventilatori necessari a pazienti totalmente dipendenti, che necessitano anche di un secondo ventilatore di riserva. Nel 2003 in provincia di Trento sono stati dimessi 41 pazienti con ventilatore, dei quali 39 con ventilatore da 5.000 € (totale 195.000 €), uno con ventilatore da 11.000 € ed uno con ventilatore da 15.200 €, per una spesa totale di 221.200 €. Non indifferente è anche il costo del materiale d’uso: 74.738,95 €, nel 2003. Per alcuni pazienti infine, viene eseguito il controllo telemetrico domiciliare: costo di circa 4.149 € nel 2003. Bisogna infine considerare il costo delle visite domiciliari: solo la spesa per il carburante dell’ automezzo risulta essere di circa 3.100 € all’anno. A questi costi si devono aggiungere quelli relativi al personale ed alla struttu ra: nel 1997 abbiamo valutato che il costo delle visite infermieristiche domiciliari era di £ 121.000 per ogni paziente (attuali 62,49 €). Di fronte a tali costi (costo totale anno 2003 circa 1.539.303 €) bisogna valutare il dato clinico: conside rando che oltre il 70% dei pazienti in OLT e circa il 90% dei ventilati non si sono più ricoverati dall’inizio della terapia e che soprattutto i pazienti total mente dipendenti da ventilatore soggiornerebbero a lungo nelle terapie in tensive condizionandone pesantemente attività e costi (il costo giornaliero per letto in UTI è superiore ai 1.000 euro), si può ritenere di aver comunque indotto un risparmio, seppure indiretto. Conclusioni Si ritiene di poter affermare che l’ossigeno ventiloterapia domiciliare a lun go termine ha consentito di ottenere risultati positivi sia per quanto riguarda 231 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 l’aspetto sanitario, sia per quanto riguarda l’aspetto economico. L’attribuzione di tale attività ad un unico centro di costo ha consentito di erogare un servizio di elevato contenuto qualitativo, con attenzione sempre rivolta al massimo rigore gestionale. 12.36. “Gli incontri con gli animali” all’Ospedale Pediatrico Meyer: valutazione della realizzabilità del progetto S. CAPRILLI, L. BENINI, F. MUGNAI - Servizio Terapia del dolore, AOU Meyer AUTORE REFERENTE: SIMONA CAPRILLI, Servizio Terapia del dolore, AOU Meyer, Via L. Giordano 13, 50131 Firenze – tel.: 055 5662456, fax: 055 5662400, e mail: [email protected] Introduzione All’ospedale pediatrico A. Meyer di Firenze è iniziato nel 2002 un progetto di inserimento di animali nei reparti come supporto a bambini ricoverati. L’ini ziativa è partita dal presupposto che gli animali possano essere un importante aiuto in situazioni di disagio, sulla base di ricerche degli ultimi anni. Il proget to “incontri con gli animali” è nato da una collaborazione tra l’AO Meyer, la Fondazione Livia Benini e l’associazione Antropozoa ONLUS e si inserisce nell’ambito del progetto “Ospedale Senza Dolore” come intervento per mi gliorare la qualità di vita del bambino in ospedale. Obiettivi Questo lavoro mira a studiare gli esiti ambientali dell’inserimento degli ani mali nell’ospedale pediatrico A. Meyer, nel senso di vedere quali siano state le reazioni da parte di genitori ed operatori sanitari e dei bambini ricoverati. Target Sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori: la partecipazione dei bambini agli incontri con gli animali, la presenza di eventuali infezioni portate dai cani, il livello di benessere e capacità di partecipazione dei bambini, il gradi mento da parte dei genitori e il gradimento da parte degli operatori sanitari. Gli strumenti utilizzati sono: analisi delle infezioni ospedaliere dal parte del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO), una scala grafica di autovalutazione (discomfort scale), tre scale comportamentali, l’analisi delle produzioni grafi che, 2 questionari autocompilati per genitori e operatori. 232 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 I risultati indicano: - che non si è rilevato aumento nella presenza di infezioni; - che la partecipazione agli incontri con gli animali nei reparti è stata mag giore delle aspettative; - che gli incontri con gli animali hanno prodotto degli effetti benefici sul bambino (miglioramento della percezione del contesto, presenza di buo ne capacità di interazione); - che i genitori sono molto favorevoli all’inserimento degli animali in ospedale; - che anche il personale sanitario è favorevole, sebbene necessiti di infor mazione circa la non pericolosità dei cani. In conclusione l’inserimento di animali nei reparti pediatrici nel nostro ospe dale appare fattibile considerata la partecipazione alle attività da parte dei pazienti ricoverati, la soddisfazione espressa da genitori e dal personale e la mancanza di eventi avversi. È stato inoltre rilevato un generale consenso da parte di genitori e del personale sanitario, nonché un generale benessere de scritto dai bambini ricoverati. 12.37. Lo Stone Center dell’Ospedale di Carpi: modello di percorso multidisciplinare centrato sulla persona per la diagnosi, trattamento e prevenzione della calcolosi urinaria M. BRASI (Direttore Unità Operativa Urologia), S. CONCETTI (Direttore Presidio Unico), A. M. PIETRANTONIO (Direttore), A. BARALDI (Direttore Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi), A. ANANIA (Dirigente Medico Direzione Sanitaria) Ospedale di Carpi, AUSL di Modena AUTORE REFERENTE: ANNE MARIE PIETRANTONIO, Direttore Ospedale di Carpi, AUSL di Modena, Via Cav. Molinari 2, 41012 Carpi (MO) - tel.: 059 659402, fax: 059 659401, e-mail: [email protected] Premessa A far tempo dal mese di ottobre del 2003, la unità operativa di Urologia dell’Ospedale B. Ramazzini di Carpi (Modena), ha istituito un percorso multidisciplinare finalizzato alla diagnosi, al trattamento, follow up e preven zione della calcolosi urinaria, definito “Stone Center”. Obiettivi Il percorso è finalizzato a realizzare i seguenti obiettivi: - ottimizzare il percorso clinico dei pazienti affetti da calcolosi inviati da Pronto 233 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Soccorso o dai Servizi Ambulatoriali, garantendo una immediata diagnosi e trattamento; - istituire un programma di follow up che prende in considerazione anche gli aspetti di prevenzione con il coinvolgimento di altre figure professionali, quali il nefrologo e il dietologo; - fornire al paziente gli strumenti per una corretta informazione circa il tratta mento e sulle modalità più idonee per prevenire le recidive. Il percorso del Paziente L’accesso allo Stone Center può avvenire secondo due modalità: 1. tramite invio dal Pronto Soccorso, in caso di colica renale; 2. dall’Ambulatorio della Calcolosi, previa indicazione del MMG, in casi sele zionati dagli urologi. Un team multiprofessionale composto da urologo, radiologo, neurologo e dietista, prende in carico il paziente secondo una logica che vede le di verse figure professionali integrate ed il paziente in posizione centrale, di core. Il percorso prevede l’esecuzione in rapida sequenza di una visita urologia ed indagini strumentali quali ecografia, radiografia e tac multidimensionale, per valutare l’urgenza del trattamento e la tipologia di intervento da adottare (litotrissia o altra metodica). All’atto della dimissione il personale di reparto provvede alle prenotazioni per le valutazioni cliniche successive: follow up urologico, visita nefrologica e dietologica. L’Opuscolo Informativo L’informazione al paziente viene fornita anche attraverso la consegna di uno specifico opuscolo che contiene la descrizione dei rischi del trattamento a cui dovrà essere sottoposto, elementi indispensabili per esprimere un con sapevole consenso, e di essere informato su come interpretare e gestire even tuali problemi clinici insorti in seguito al trattamento. L’opuscolo fornisce in formazioni circa le indicazioni e i vantaggi del trattamento della calcolosi urinaria con litotrissia o eswl (extracorporeal shock waves lithotripsy), la tec nica dell’intervento e le possibili complicanze, oltre ad un orientamento per la corretta interpretazione dei segni e sintomi che possono comparire a seguito dell’intervento. Nell’opuscolo sono contenute importanti indicazioni sui comportamenti da seguire dopo la dimissione (attività fisica, dieta, assunzione di farmaci), non ché i riferimenti per i contatti con l’unità operativa di urologia in caso di insor genza di problemi clinici. 234 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Conclusioni Il percorso realizzato nell’ambito dell’unità operativa di Urologia dell’Ospe dale di Carpi, ha consentito una ottimizzazione dell’erogazione delle presta zioni cliniche, nonché di migliorare il livello di soddisfazione dei pazienti, l’efficacia del trattamento e del percorso di cura che include la necessità di attenzione anche agli aspetti di prevenzione. L’elaborazione di un opuscolo informativo ha consentito di migliorare la compliance dei pazienti mediante gli strumenti dell’informazione e della educazione alla salute. In definitiva il percorso “orientato al paziente” ha consentito di conseguire un importante obiettivo di qualità, da individuarsi nella volontà di sostituire il concetto di “trattamento”, col concetto di “care”. 12.38. La terapia del sorriso e della comunicazione N. VINSANI (caposala Pediatria), T. PELLI (coordinatrice gruppo AVO Pedia tria), D. MANFREDI (coordinatrice gruppo Creativ-educare Pediatria) - Dipar timento Materno Infantile Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova- Reggio Emilia, direttore G. Banchini AUTORE REFERENTE: NICOLETTA VINSANI, U.O. Pediatria, Dipartimento Materno In fantile, Viale Risorgimento 80, 42100 Reggio Emilia, tel.: 0522 296243, e mail: [email protected] Dall’esperienza, dalle riflessioni e dall’analisi della letteratura si evince l’im portanza di offrire al bambino ricoverato la possibilità di continuare a giocare e a sorridere anche quando la sua vita viene sorpresa da eventi imprevisti e il suo “mondo bambino” viene sostituito dal “mondo sanitario”. Giocare per un bambino malato non è evitare esperienze difficili e dolorose ma è l’espressio ne del tentativo di attraversarle senza soccombervi, è la strada per sopravvive re alla malattia potendola pensare. L’obiettivo quindi dell’U.O. di Pediatria è quello di offrire ai bambini ricove rati un ambiente e delle opportunità che siano vicino al suo mondo attraverso l’assistenza di operatori professionalmente preparati sia dal punto di vista tec nico che psicologico ed anche con la presenza di volontari che possano con tribuire a rendere la situazione di malattia accettabile per il bambino favoren do il più possibile momenti di gioco. Le azioni messe in campo sono: - Creazione di un ambiente ospedaliero più accogliente: le pareti del corri doio sono state dipinte con murales; in corsia, poiché le stanze si trovano 235 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 sul lato destro, su ogni porta è stato disegnato un vagone di un treno da cui si affaccia il personaggio di una fiaba; all’interno di ogni stanza è stato ap peso il poster in cui si narra la fiaba del personaggio dipinto sulla porta e sulla testata di ogni lettino è stato appeso un quadretto raffigurante il perso naggio della fiaba in modo da identificare il bambino non come un n. di letto ma come un componente del racconto; le divise delle infermiere sono state colorate di rosa o di verde. - Presenza di due acquari, uno in sala giochi e l’altro nella sala d’attesa del day hospital con lo scopo di praticare in forma, ancora “rudimentale “ la pet-therapy in attesa di avere a disposizione un servizio veterinario. - Creazione di uno spazio ad hoc (sala giochi) per le attività ludiche-ricreati ve, fornita di giocattoli e piccoli arredi, donati da scuole, associazioni spor tive e privati. - Creazione, nella sala giochi, di un punto di collegamento (tramite l’utilizzo del PC) con le scuole di Reggio Emilia in modo da permettere al bambino ricoverato di comunicare con i propri compagni di classe facendolo così sentire non più “isolato” dal “suo mondo”. - Praticare l’attività di clown terapia. Dal 7 Luglio 2003 questa è praticata dall’associazione VIP nei 2 reparti piloti di Pediatria e di Recupero Rieducazione Funzionale (solo adulti). Gioco e risata sono gli strumenti del clown dottore che indossando il camice usa la fanta medicina per rendere meno traumatico il ricovero ospedaliero. Il clown dottore coinvolge l’intero reparto, medici e infermieri, contagiando tutti con l’allegria. Studi recenti hanno avvalorato che la risata influisce positivamente nei processi di guarigione e, come sostiene Patch Adams, “la gioia è una fonte inesauribile di buona salute”. I clown sono presenti in ospedale ogni sabato dalle 15 alle 18 e intrattengono i piccoli ricoverati nelle stanze di degenza e nella sala d’attesa delle visite urgenti pediatriche, i bambini che attendono di essere visitati. Per realizzare tutto il progetto è stato fondamentale stabilire una collabora zione continua con alcune associazioni di volontariato presenti nel territorio reggiano. Le associazioni AVO e Creativ-educare presenti in reparto rispettivamente dal 1992 e dal 2000, gestiscono l’attività ludica e la sala giochi del reparto intrattenendo i bambini nella sala giochi o nelle loro stanze di degenza, orga nizzano feste e spettacoli in occasione del Natale, Pasqua, carnevale, festa della mamma, oppure si occupano di sorvegliare i bambini nel caso i genitori si debbano assentare dal reparto. Per agevolare l’ingresso in reparto dei volontari, sono stati organizzati corsi di formazione tenuti dal personale sanitario e dalla psicologa della pediatria. Dal 16 Giugno 2004 è operativa, non solo in pediatria ma in tutti i reparti in cui sono ricoverati bambini o adolescenti, l’ass. Casina dei bimbi che mette a 236 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 disposizioni i propri volontari in casi di emergenza e all’occorrenza, per sostitu ire i genitori che sono impossibilitati ad accudire il proprio figlio durante il rico vero (ad es. genitori anch’essi ricoverati in ospedale o assenti perché all’estero). Conclusioni Il progetto ha evidenziato l’importanza dell’utilizzo di risorse presenti sul territorio, i volontari delle associazioni, come sinergia di forze per raggiunge re quello che è un obiettivo comune: aiutare il bambino ad affrontare al me glio il suo soggiorno in ospedale. Inoltre l’esperienza testimonia l’importanza dell’aspetto psicologico legato alla malattia, un tempo sottovalutato rispetto all’aspetto medico-terapeutico, e quindi la necessità di fornire un setting a misura di bambino e attento alle sue esigenze. 12.39. Procedura per l’attivazione di consulenza infermieristica per pa zienti diabetici E. MANICARDI, M. LINCE, M. GANASSI - Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova- Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: MARCO GANASSI, Dipartimento Area Medica 1°, Viale Risorgi mento 80, 42100 Reggio Emilia, tel.: 0522 295913, fax: 0522 295896, e mail: [email protected] L’analisi del contesto sociale dell’utenza afferente al nostro ospedale, ha evidenziato la necessità di un intervento educativo durante la degenza ordi naria al paziente diabetico trattato con insulina per la prima volta nelle varie unità operative, attraverso un intervento uniforme e coordinato rispetto alla successiva presa in carico da parte del Servizio di Diabetologia territoriale di appartenenza. La segnalazione giungeva da parte dell’Associazione Diabetici, che a sua volta raccoglieva l’esigenza dei pazienti di avere informazione, edu cazione e trattamento omogenei sia in ambito ospedaliero che dopo la dimissione. L’analisi del percorso del diabetico all’interno del nostro ospedale ha inoltre evidenziato l’assenza di una procedura comune riguardante la ge stione e la dimissione di questo tipo di malato. Obiettivo Del progetto è garantire ad ogni degente con diabete di tipo 1 di nuova diagnosi o con diabete di tipo 2 sottoposto ad una nuova terapia insulinica sicurezza nella continuità terapeutica dopo la dimissione e sino alla presa in carico da parte del centro antidiabetico di riferimento territoriale. 237 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Tutto il personale delle strutture ospedaliere di degenza ordinaria e day hospital dell’Azienda S. Maria Nuova è chiamato a segnalare la necessità di intervento educativo per pazienti diabetici degenti nelle varie Unità Operati ve all’Infermiere referente dell’Ambulatorio Diabetologico, mediante apposi to modulo di richiesta reperibile in Intranet. La consulenza, potrà essere svolta al letto del malato o presso l’ambulatorio Diabetologico. La consulenza dura dai 60 ai 90 minuti ed ha lo scopo di: a. educare il paziente diabetico ad utilizzare correttamente la siringa da insu lina e/o una penna per l’iniezione dell’ormone, fra le varie disponibili in commercio e che gli verrà consegnata. b. Educare il paziente ad adeguare l’apporto di insulina in base al riscontro glicemico preprandiale. c. Educare, ove necessario, il paziente ad eseguire correttamente il controllo della glicemia mediante striscia reattiva e lettura della medesima mediante glicemometro, che pure verrà consegnato al paziente, fra quelli che hanno vinto la gara d’appalto (se non già in possesso del paziente). d. Educare il paziente ad una corretta compilazione del diario glicemico. e. Educare al riconoscimento ed alla correzione delle ipo e delle iperglicemie. f. Fissare, ove necessario, un incontro di educazione alimentare con la Dietista. g. Verificare l’apprendimento di quanto sopra insegnato. h. Consegnare materiale illustrativo che consenta di ricordare meglio quanto insegnato e di aumentare le conoscenze. i. Consegnare un kit composto da: - Penne per insulina o siringhe in numero sufficiente a raggiungere il ser vizio di diabetologia di pertinenza territoriale secondo quanto concorda to col medesimo. - Insulina per n ciclo di terapia. - Glicemometro più strisce reattive e pungidito sempre in numero suffi ciente ad un passaggio in cura sicuro. - Diario glicemico. - Comunicazione scritta per il servizio di diabetologia che segnala quanto effettivamente appreso dal paziente. Al termine della consulenza viene consegnata al paziente una lettera di dimissione contenente le informazioni fornite al paziente e l’elenco del materiale di cui egli è stato dotato. Alla dimissione il paziente viene inoltre segnalato telefo nicamente al Servizio di Diabetologia Territoriale che lo prenderà in carico. Il progetto è iniziato il 3 maggio 2004. Gli indicatori selezionati sono: - Numero di richieste di consulenza infermieristica (rilevazione da parte dell’Am bulatorio Diabetologico, a mezzo delle copie del modulo di consulenza). - Segnalazione in registro apposito degli eventi non conformi. 238 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Conclusioni Riteniamo che il progetto presentato sia un modo razionale di garantire a tutti i diabetici ospedalizzati un’educazione essenziale ed uniforme alla ge stione della terapia insulinica e degli episodi ipoglicemici, che permetta loro di raggiungere in modo programmato e senza disagi il servizio di diabetologia di pertinenza territoriale. 12.40. Un‘esperienza di Teatro in ospedale “L’uomo che smise di fumare” U.O. EDUCAZIONE ALLA SALUTE e la LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - Azienda Sanitaria di Firenze, Ospedale S. Maria Annunziata AUTORE REFERENTE: CLAUDIA RUSSO, Dir. U.O. Educazione alla salute, via S. Salvi 12, Firenze – e-mail: [email protected] “Il 5 giugno alle ore 17,30 presso lo spazio Front office dell’ l’Ospedale S.M. Annunziata (Ponte a Niccheri) l’U.O. Educazione alla Salute dell’ASL di Firen ze, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione di Firenze, la Direzio ne Sanitaria dell’O.S.M.A., il Gruppo Teatrale delle Scuole Pie Fiorentine AGeSC - hanno presentato la commedia dal titolo “L’uomo che smise di fuma re” liberalmente tratta da un racconto di P.G. Wodehouse. Gli studenti della scuola, attori in questa occasione, parlano di temi preziosi per la salute, por tando il messaggio ai degenti, ai loro familiari e agli operatori dell’ospedale con un innovativo modello comunicativo: giovani che si fanno carico “educativo” verso gli adulti e offrono spunti di riflessione appunto con un testo teatrale.” Nel 2001 quasi il 38% degli uomini ed il 23% delle donne fumavano in Euro pa con varie differenze tra i paesi. Il consumo di tabacco tra i giovani era compreso tra il 27% ed il 30% nella regione Europa con una leggera tendenza al rialzo In Toscana fumano comunque ancora quasi mezzo milione di uomini e più di 350.000 donne, pari rispettivamente al 33% ed al 22%. Nell’insieme, la To scana ha la stessa proporzione di fumatori dell’Italia, ma il comportamento è diverso fra uomini e donne: le donne toscane infatti, al contrario degli uomini, fumano nettamente di più di quelle italiane. Anche fra i più giovani ci sono molti fumatori. Prima dei 20 anni fuma già un ragazzo ogni 5. La riflessione che sottende al progetto HPH, caratterizzato da azioni inte grate nella convinzione di costruire un network tra tutti i soggetti che possono sinergicamente impegnarsi contro il fumo, ha portato ad individuare tra gli obiettivi più specifici, la collaborazione con i “giovani” e la “scuola”. L’iniziativa fa parte delle azioni previste nel progetto HPH dell’Ospedale S. 239 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Maria Annunziata “Ospedale senza fumo”; l’idea di realizzare una rappresen tazione teatrale sul tabagismo, la voglia e la necessità di proporre materiale nuovo e più adatto, ha portato gli operatori a costruire un modello comunica tivo secondo il quale l’apprendimento è favorito dalla sollecitazione di inter rogativi piuttosto che dalla somministrazione di un prodotto preconfezionato, consapevoli che il processo educativo avviene più facilmente per elaborazio ne diretta piuttosto che attraverso l’esposizione di dati ed informazioni rigide. Molte sono le tessere del complesso innovativo modello operativo adottato: la oramai collaudata formula dell’educazione tra “pari” (durante la creazione della rappresentazione), e poi la possibilità dei giovani di rivolgere il messaggio agli adulti, e ancora il testo teatrale che si offre a svariate interpretazioni, ed aperto al dialogo ed alla riflessione, l’opportunità per i degenti dell’Ospedale di riflettere con leggerezza su un tema come quello del tabagismo e sulle sue conseguenze. Lo spunto innovativo dell’iniziativa è stato notevole, ed ha dimostrato come l’ospedale possa diventare soggetto capace di favorire la più ampia informazio ne e partecipazione della popolazione, coinvolgere e/o accogliere i soggetti che possono coprire un ruolo nell’influenzare positivamente le scelte di salute della comunità, aumentando la tendenza a prendere decisioni verso uno stile di vita libero dal fumo: MMG, personale medico ed infermieristico, insegnanti, giovani, genitori, testimoni del tessuto sociale, politico, economico e culturale. Occorre adottare politiche di intervento globali capaci di sviluppare allean ze e sinergie attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti che hanno competenze e responsabilità in ambito educativo, sanitario, politico, econo mico, del volontariato e dell’informazione. L’intento deve essere quello di pro muovere, con esempi positivi ed azioni persuasive, unitamente al rispetto della normativa vigente sul divieto del fumo, la formazione di una cultura ampia mente diffusa e condivisa del “non fumo”. 12.41. Azioni di comunicazione per il sostegno al governo clinico regionale - aprile-giugno 2004 A. ZANOBINI - Dirigente responsabile Settore Formazione, Comunicazione e Supporto al Governo Clinico Regionale – Direzione Generale Diritto alla sa lute Regione Toscana, Via Taddeo Alderotti 26/n, 50139 Firenze – tel.: 055 4383439, fax: 055 4383466, cell. 335 7107487, e-mail: a.zanobini@regione. toscana.it Breve introduzione del contesto Nel mese di Gennaio 2004 hanno preso avvio due organismi del Governo clinico regionale – Istituto Toscano Tumori e Organizzazione Toscana Tra 240 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 pianti - come sviluppo e consolidamento di strumenti e azioni programmate già da tempo previste e attuate con i Piani sanitari della Toscana. Si è inoltre voluto rafforzare il sistema già consolidato di collaborazione con le associa zioni per la donazione del sangue attraverso forme nuove di partecipazione ed invito alla “cittadinanza sociale”. Tutto in un periodo molto concentrato: da aprile a giugno 2004. Obiettivo/i Gli obiettivi che ci siamo posti con le azioni di comunicazione e le azioni collegate sul territorio sono così riassumibili: a) valorizzazione degli effetti interni sugli operatori di azioni di comunicazio ne esterne per sviluppare il senso di appartenenza e di orgoglio di squa dra; b) rafforzamento dell’identità dei sistemi di governo clinico “forte” all’interno della più ampia cornice del sistema sanitario della Toscana; c) potenziamento dell’orientamento dei cittadini su argomenti a forte impatto sociale come l’oncologia, il sistema regionale donazione-trapianto, il siste ma trasfusionale. Gruppo/i Target a) Oncologia – La Toscana ha scelto di fare del sistema oncologico regionale un Istituto mettendo in rete e rendendo disponibile e trasparente tutte le opportunità ed eccellenze in oncologia presenti nel territorio toscano. Con l’azione si è mirato inoltre a creare dei punti omogenei di prima accoglien za sul territorio attraverso il forte coinvolgimento delle aziende sanitarie e uniformando anche l’immagine e la cartellonistica. Il problema dell’oncologia è infatti spesso quello dell’orientamento e dell’informazio ne mirando a far sì che l’utente possa entrare in un percorso assistenziale senza dover andare alla ricerca di soluzioni terapeutiche segmentate e non coerenti fra loro. L’azione ha avuto anche il forte obiettivo di sviluppare il senso di appartenenza degli operatori che lavorano nella rete oncologica ora Istituto Toscano Tumori. b) Donazione-Trapianto – Come ben sappiamo un sistema efficiente di dona zione trapianto si fonda su tre pilastri: 1) eccellenza trapiantologia 2) una rete più ampia di operatori, attenta e consapevole; 3) una comunità solida le e donante. L’Azione di comunicazione, in collaborazione con le associa zioni di volontariato, ha mirato ad uscire dall’ormai superata visione moralistica dell‘”essere più buoni” nella consapevolezza che il cittadino adulto vuole ormai sapere soprattutto l’uso da parte del sistema delle pro prie azioni di solidarietà. Per questo abbiamo agito anche qui sia sull’uni 241 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 verso degli operatori con il rafforzamento dell’identità dell’Organizzazione Toscana Trapianti, sia sull’universo dei cittadini con messaggi che rafforzi no la percezione della qualità del sistema organizzativo in cui va a collo carsi il “dono”. c) Sistema trasfusionale – donazione – Si è voluto uscire anche qui da schemi ormai abusati e puntare al rafforzamento della chiave “senso civico” per una campagna sulla donazione del sangue che usa linguaggi sicuramente nuovi. In questo caso è stato forte il coinvolgimento delle associazioni dei donatori di sangue attraverso la creazione di diversi gruppi di lavoro che hanno pro dotto strumenti ed in particolare azioni verso la scuola ed i giovani. Presentazione e valutazione dei risultati Sui tre settori di intervento possiamo in sintesi trarre degli elementi di valu tazione da una parte sul numero di accessi alle accoglienze oncologiche, dal l’altra dall’incremento degli indici di donazione-trapianto e donazione san gue. Elementi di valutazione sono dati inoltre dalla numerosa partecipazione dei cittadini alle iniziative pubbliche assunte sui temi in oggetto. Conclusioni La filosofia di comunicazione adottata in questi ultimi due anni dall’Asses sorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana nelle campagne di promo zione della salute e nelle altre iniziative quali quelle qui sinteticamente de scritte ha come macro-obiettivo l’universo dei cittadini, ma punta in modo efficace a “parlare” soprattutto al microcosmo dei 50.000 operatori del servi zio sanitario della toscana che sono i primi agenti della promozione della sa lute e le prime risorse da mobilitare per agire sul patrimonio della salute. Operatori motivati e con l’orgoglio di appartenere ad un servizio sanitario di qualità sono la garanzia perché si realizzi il contenuto della headline da noi scelta: “Sistema pubblico. Cresce la salute”. 12.42. Modello di relazione-comunicazione HPH nell’ambito della prevenzione cardiovascolare M. CORDONI1, G. MICHELI1, F. PRATESI 2, A.M. BASSO2, L. CIAMPI3, E. MUGNAINI3 - 1U.O. Cardiologia Ospedale Villamarina Piombino, 2Direzione Sanitaria di Presi dio Ospedaliero Piombino - Cecina - Portoferraio, 3U.O. Educazione alla Sa lute ASL 6 Livorno AUTORE REFERENTE: MARIO CORDONI, via Muratori 3, 57025 Piombino (LI) - tel.: 360 483498, fax: 0665 67250, e-mail: [email protected] 242 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Nell’ambito del progetto internazionale HPH (Health Promoting Hospital), è stato impostato nell’Ospedale di Piombino un progetto di prevenzione se condaria della cardiopatia ischemica, con intervento strutturato sui fattori di rischio coronarico (fdr), con particolare riguardo a colesterolemia, trigliceridemia e obesità. Le diverse professionalità coinvolte, i diversi ambiti logistici in cui svolgere l’azione e la necessità di rendere i soggetti a cui è rivolto il progetto a loro volta protagonisti nella diffusione del messaggio, ha reso necessaria la crea zione di un sistema di diffusione della “cultura della salute”. Obiettivi specifici a) formazione del Personale sanitario ospedaliero e dei Medici di Medicina Generale (MMG) - destinatari indiretti del progetto - ai fini di una appro priata e omogenea informazione per gli Utenti ricoverati e gli Assistiti, sulla corretta alimentazione e adeguato stile di vita per prevenire le malattie cardiovascolari; b) coinvolgimento dei MMG per la definizione dei protocolli operativi; c) rilevazione in pazienti cardiopatici ischemici noti o soggetti con 2 o più fdr accertati - destinatari diretti del progetto - dei valori dei fdr basali, messa in atto di interventi correttivi multidisciplinari di tali fdr e controlli semestrali fino al completamento quinquennale del progetto con verifica finale dei risultati correttivi sui fdr allargata alla popolazione; d) coinvolgimento completo della locale associazione di volontariato “Amici del Cuore” costituita da pazienti cardiopatici e loro familiari. Tempi di attuazione del progetto: 5 anni, di cui – primo anno dedicato alla formazione – secondo e terzo anno arruolamento dei pazienti – quarto anno rilevazione e controllo dei fdr esaminati – quinto anno completamento delle rilevazioni e elaborazione statistica. Azioni svolte sul personale sanitario: è stato completato nel 2003 l’inter vento formativo con le finalità sopra descritte su tutto il personale sanitario dell’Ospedale Villamarina di Piombino (Medici e non Medici, tutti quelli a qualsiasi titolo a contatto con gli Utenti ricoverati) e su tutti i MMG della zona, mediante lezioni con esercitazioni e verifica valutativa finale. Con i MMG è stato anche concordato il protocollo gestionale degli Utenti destinatari diretti del progetto. Azioni svolte sulla comunità: a) 6 incontri annuali con la popolazione, a cura della locale Associazione Amici del Cuore, per approfondimento e rin forzo educativo su tematiche inerenti il progetto di prevenzione cardiovascolare 243 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 ed i fdr considerati. b) Sperimentazione del modello di rilevazione del rischio percentuale di sviluppare eventi cardio-cerebro vascolari nei prossimi 10 anni, mediante le nuove carte del rischio italiane presentate dall’Istituto Superiore di Sanità nell’aprile 2004. Tale sperimentazione, ampiamente pubblicizzata è stata svolta in un gran de Centro Commerciale toscano per 2 giorni consecutivi su centinaia di pazienti, per valutare la affidabilità e fattibilità della rilevazione e quantizzazione complessiva dei fdr sulla popolazione destinataria diretta del progetto HPH. Risultati attesi: a breve termine appropriatezza e omogeneità di informa zione fornita dal Personale sanitario ospedaliero e dai MMG sulla corretta ali mentazione per prevenire le malattie cardiovascolari a medio termine coinvolgimento al progetto dei pazienti cardiopatici ischemici o ad alto ri schio, minimo 500 a lungo termine contenimento dei fdr previsti nel progetto nei destinatari diretti. Rilevazione della ricaduta del progetto sulla popolazio ne generale, mediante una indagine a campione “consecutivo” dei valori lipemici, già eseguita nel territorio relativo all’Ospedale di Piombino negli anni 1986 e 1996. Indicatori di risultato: – numero di lezioni svolte, numero di operatori sa nitari coinvolti, questionari di valutazione di apprendimento su corretta tipologia di alimentazione – controllo basale e semestrale di colesterolemia, trigliceridemia, peso corporeo e BMI e andamento percentuale del rischio. Risultati ad oggi - formativi definitivi sul personale: 12 lezioni. Numero di persone coinvolte 462 (98,2% del totale). Apprendimento nei 20 quiz pre corso: risposte esatte 57,9%. Stessi quiz post-corso: risposte esatte 97,1%. Gra dimento (giudizio su 4 livelli, con il 4° ottimale): utilità 3,80 - efficacia 3,92 interesse 3,85. Risultati sulla comunità: partecipazione crescente della popolazione alle riunioni di informazione sanitaria rispetto al 2001 (+ 28% 2002; +34% 2003). Validazione definitiva del sistema delle carte del rischio italiane ad espressione percentuale, per poter passare alla fase successiva del progetto HPH. Il coinvolgimento di tutto il personale sanitario ospedaliero, di tutti i MMG della zona, della Associazione Amici del Cuore di Piombino, dei pazienti cardiopatici o a rischio di cardiopatia e di un numero crescente di familiari consente di valutare affermativamente i risultati fino adesso conseguiti, in quanto tutti gli interessati risultano di fatto paritariamente attori nella costru zione del sistema salute cardiovascolare locale. 244 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.43. Percorso formativo per i volontari del pronto soccorso M. MARCUCCI1, S. ARDIS1, A. MERLI2, G. DI QUIRICO1, L. PULITI1, A. DI VITO1, M. ROSSI1, M. GIRALDI1 - 1Azienda USL 2 Lucca, 2Pedagogista Clinico AUTORE REFERENTE: MORENO MARCUCCI, Ospedale Campo di Marte, Palazzina Ex ONMI, Piazza della Concordia, Lucca – fax: 0583 970114, e-mail: [email protected] Introduzione Il Pronto soccorso è un “territorio di confine” dell’ospedale e come tale è di difficile gestione. L’impegno del personale per fornire una risposta sanitaria appropriata di fronte ad una emergenza sanitaria è massima. In questo luogo gli aspetti tecnici della professione sanitaria hanno il sopravvento assoluto sugli aspetti umani di cui la sanità necessita. Per questo motivo abbiamo rea lizzato un progetto di aiuto alle persone che accedono al Pronto soccorso, attuato tramite volontari. A tal fine è stato necessario realizzare un programma di formazione rivolto ai componenti dell’Associazione dei Volontari Ospedalieri (AVO) che hanno aderito alla nostra idea. Il percorso formativo necessario doveva rispondere a due diversi ordini di necessità. In primo luogo i volontari dovevano conoscere sommariamente l’organizzazione ed il funzionamento del Pronto soccorso ed in particolare del triage. Questo è un obiettivo formativo facilmente raggiungibile. In secon do si doveva fornire una formazione di base sulle tecniche di aiuto psicologi co mirate alla possibile casistica della sala di attesa del Pronto soccorso. Le persone che sostano in sala di attesa possono avere un familiare con una pa tologia grave all’interno del Pronto soccorso ed essere quindi in ansia. Quan do la situazione è molto grave possono essere impauriti. Per alcuni questo è il luogo dove inizia il lutto per la morte di una persona cara. Quando invece la patologia per cui si trovano li è lieve, può essere molto lungo il tempo di attesa. In questi casi chi aspetta può vivere l’attesa con rabbia e diventare aggressivo verso il personale sanitario. A fornire aiuto questa gamma di emo zioni e reazioni era necessario preparare i volontari. Obiettivo Far acquisire ai volontari ospedalieri le conoscenze adeguate per fornire aiuto psicologico alle persone in sala di attesa di Pronto soccorso. Target I destinatari diretti del corso erano rappresentati dai volontari ospedalieri. 245 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Gli effetti della formazione erano destinati alle persone con sofferenza psico logica in sala di attesa. Azioni Abbiamo disegnato un percorso di formazione di 16 ore. Due ore sono state dedicate ad illustrare l’organizzazione del Pronto soccorso ed il funzio namento del triage. Altre 10 ore (due ore al mese) sono state dedicate ad affrontare i seguenti argomenti: accoglienza, relazione di aiuto, modelli di comunicazione sanitaria, comunicazione verbale, comunicazione non verba le, significato simbolico della malattia, lutto, relazione di aiuto nel lutto, colle ra, relazione di aiuto nelle reazioni aggressive. Quattro ore sono state dedica te ai role-play, rivisti e commentati in aula tramite sistema audio-video a cir cuito chiuso. Un manuale di tecnica di comunicazione (da noi prodotto per corsi di for mazione analoghi destinati ai sanitari) è stato distribuito ai volontari. Durante le lezioni abbiamo verificato che il manuale era uno strumento importante in quanto ad ogni incontro, durante i dibattiti, appariva evidente che questo ve niva studiato dai volontari. Valutazione dei risultati La valutazione dell’efficacia didattica del corso è stata provata nelle ultime quattro ore dello stesso, quando abbiamo impegnato i volontari nei role-play. Abbiamo osservato che i volontari riuscivano a mettere effettivamente in pra tica quanto appreso durante le lezioni precedenti. La capacita di ascolto è risultata eccezionalmente elevata. Anche la capacità di comunicare la com prensione empatica e l’accettazione positiva incondizionata sperimentata nel le simulazioni è stata molto elevata. L’efficacia del corso è risultata evidente anche nella pratica nella pratica. I volontari hanno affrontato con sicurezza situazioni che risultano difficili an che per i sanitari, quali il lutto o l’aggressività. In futuro potremo effettuare una ulteriore valutazione dell’efficacia com plessiva del progetto mediante gli indicatori per questo individuati. Conclusioni L’utilizzo dei volontari in compiti che non potremo svolgere come istituzio ni può aiutarci a dare qualità a quanto oggi viene fatto in ospedale. Fornire ai volontari gli strumenti per fare ciò è un nostro dovere. Non dobbiamo mai dimenticare fra gli strumenti che forniamo anche una formazione di livello adeguato al compito che affidiamo. 246 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.44. Persone a rischio di discriminazione in ospedale: aiutiamole a difendersi S. ARDIS1, M. MARCUCCI1, A. MERLI2, G. DI QUIRICO1, L. PULITI1, A. VINCENTI1, M. DE GENNARO1, M. GIRALDI1 - 1Azienda USL 2 Lucca, 2Pedagogista Clinico AUTORE REFERENTE: ANTONELLA VINCENTI, Presso U.O. Malattie Infettive, Ospedale Campo di Marte, Lucca – e-mail: [email protected] Introduzione La discriminazione rappresenta la violazione dell’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti umani e come tale costituisce atto inumano e degradante per la dignità della persona. Episodi di discriminazione ai danni di persone HIV positive si veri ficano nei nostri ospedali, soprattutto fuori dai reparti di malattie infettive che curano abitualmente le persone HIV positive, e devono essere presi in considera zione se pensiamo di umanizzare i nostri ospedali. In Italia le denunce di episodi di discriminazione subite dalle persone HIV positive sono più rare rispetto ad altri paesi, ma questo non corrisponde ad un minor numero reale di atti di discrimina zione [Fabiani B., 2002]. La paura di subire ulteriori conseguenze negative impe disce alle persone HIV positive che hanno subito una discriminazione di denun ciarla. Anche in uno studio promosso dal nostro Comitato Etico Locale abbiamo evidenziato che la maggior parte degli utenti HIV positivi del nostro ambulatorio di malattie infettive non ha fiducia nelle possibilità di tutela dei loro diritti e ritiene che denunciare una discriminazione potrebbe costituire un pericolo di danno ulteriore [Vincenti et al., in Ardis et al., 2003]. E’ necessario ricordare in premessa che la discriminazione delle persone HIV positive è considerata dall’ONU uno dei motivi principali del fallimento delle campagne di prevenzione di questa malattia [si vedano per esempio: Alto Commissariato per i Diritti dell’Uomo, Nazioni Unite E/CN. 4/1997/37 oppure A/36/56 oppure E/CN. 4/2001/80]. Nel nostro progetto di umanizzazione degli ospedali della nostra USL, su ri chiesta del Comitato Etico Locale, abbiamo inserito un progetto di prevenzione della discriminazione delle persone HIV positive. In questo ambito abbiamo realizzato varie azioni (formazione del personale, carta dei diritti e dei doveri delle persone HIV positive, creazione di un gruppo per il monitoraggio della discriminazione) e fra queste incontri con le persone a rischio di discriminazio ne per aumentare le loro possibilità di tutela in caso di discriminazione. Obiettivo Aumentare la capacità di accedere ai sistemi di tutela dei diritti per le perso ne HIV positive che subiscono discriminazione nei servizi sanitari. Prevenire la discriminazione delle persone HIV positive nei nostri ospedali. 247 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Target Il progetto è stato elaborato in collaborazione con l’associazione omoses suale “L’altro volto” di Lucca e gli iscritti di questa associazione rappresentano il primo target. Prevediamo di ripetere gli incontri anche con gli iscritti all’ANLAIDS e con gli iscritti dell’Arcigay. Azioni Il progetto prevede la realizzazione di due incontri serali con le persone a rischio di discriminazione (sieropositivi, ma anche omosessuali e transessuali) per insegnare a riconoscere la discriminazione in ambito sanitario. Nelle le zioni viene illustrato anche il funzionamento dell’ufficio di tutela presente nella nostra USL e le modalità con cui è possibile tutelare il proprio diritto a non subire episodi di discriminazione. Agli incontri partecipa personale sanitario dell’ospedale e il Coordinatore del Comitato Etico Locale. Valutazione dei risultati Far crescere la coscienza dei propri diritti e far conoscere le modalità di tutela dovrebbe far crescere il numero di segnalazioni ai nostri uffici di tutela. Tuttavia, se le altre azioni di prevenzione messe in atto funzionano, gli episodi di discrimi nazione nei nostri ospedali dovrebbero diminuire fino a sparire del tutto e quindi non si dovrebbero avere più segnalazioni di episodi di discriminazione. Quindi il risultato atteso non è l’aumento delle segnalazioni di episodi di discriminazione perché i pazienti hanno acquisito la capacità di difendersi, ma nessuna segnala zione di discriminazione perché l’ospedale è diventato più umano. Conclusioni L’ospedale come luogo o edificio non può essere definito disumano o uma no. Solo le donne e gli uomini che operano al suo interno possono umanizzarlo. Bibliografia 1) FABIANI B., Aids: poche denunce di discriminazione. Paese delle favole o paura? In Vita online, http://web.vita.it/home (inizio → medicina e salute → aids), consultato il 10/11/02. 2) VINCENTI et al., Discriminazione del paziente HIV positivo in ospedale. Stu dio su pazienti ambulatoriali, in ARDIS S. et al., Positivo scomodo, Ed. Roche, Pisa 2003. 248 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.45. Aiuto ai familiari delle persone che accedono al Pronto soccorso S. ARDIS, M. MARCUCCI, G. DI QUIRICO, L. PULITI, A. DI VITO, M. ROSSI, M. GIRALDI Azienda USL 2 Lucca AUTORE REFERENTE: SERGIO ARDIS, Via del Pozzetto 24, Pescia (PT) - cell. 335 6146737, fax. 0583 970114, e-mail: [email protected] Introduzione Noi sanitari abbiamo una buona attenzione alla sofferenza fisica, tutta via spesso trascuriamo la sofferenza psicologica o spirituale dei nostri pa zienti. Per questo cerchiamo di dare il massimo ai nostri pazienti dimenti cando che in alcuni casi in ospedale sono presenti altre persone che sof frono. I familiari dei pazienti gravi vivono con ansia, paura, tristezza quanto sta accadendo, ma anche chi aspetta a lungo per una patologia più lieve soffre questa attesa e talvolta diventa aggressivo incrementando la conflittualità tra personale sanitario e utenza. Nel nostro progetto di umanizzazione dell’ospedale abbiamo incluso azio ni rivolte alle persone in sala di attesa al Pronto soccorso. Non avendo risorse da destinare a questo progetto abbiamo richiesto la partecipazione dell’Asso ciazione Volontari Ospedalieri (AVO), già da anni presente in vari reparti del nostro ospedale. Obiettivo Il progetto ha lo scopo fornire aiuto competente alle persone che sostano in sala di attesa in Pronto soccorso. L’aiuto è rivolto sia ai pazienti sia ai fami liari che aspettano in sala di attesa. Rendere attivo un flusso informativo dalle sale di cura del Pronto soccorso verso i familiari è un ulteriore scopo del pro getto che contribuisce al primo. Target I destinatari del progetto sono rappresentati dall’utenza del pronto soccor so che beneficia dell’umanizzazione di questo settore. Target secondario del progetto sono il personale del Pronto soccorso e i volontari AVO. Azioni I volontari AVO sono stati coinvolti sin dalla fase di progettazione. E’ stato 249 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 definito un protocollo che stabilisce il ruolo dei volontari e le interazioni con il personale del Pronto Soccorso. I volontari hanno richiesto la realizzazione di un corso di formazione sia per conoscere il funzionamento del Pronto Soccorso, sia, soprattutto, per ac quisire le conoscenze psicologiche necessarie per fornire aiuto psicologico in Pronto soccorso. Il corso è stato realizzato tramite una ventina di lezione te nute da medici esperti in tecnica di comunicazione sanitaria. Prima di iniziare l’attività di aiuto in Pronto soccorso i volontari hanno in contrato il personale medico ed infermieristico per conoscersi ed abbattere i timori e le diffidenze reciproche. Durante il periodo di formazione i volontari hanno manifestato paura ad affrontare da soli questo compito. Per questo motivo è stato necessario un periodo in cui il servizio è stato svolto da due volontari contemporaneamente per turno. Nella prima fase abbiamo limitato l’attività dei volontari a due ore al giorno, dalle 10 alle 12, durante le quali si concentra un picco di elevata affluenza di pazienti. Attualmente stiamo concordando le modalità per estendere l’attività ad un altro turno di due ore al giorno. Valutazione dei risultati Come indicatori di risultato, oltre che ricorrere alla valutazione dell’impatto sul personale del Pronto soccorso, mediante questionario, ci auspicheremo una diminuzione del numero delle segnalazioni che giungono all’U.O. Comu nicazione e Marketing, designata a raccogliere le segnalazioni di disservizio da parte dei cittadini. Conclusioni Sicuramente il modo migliore di umanizzare un ospedale è garantire il ri spetto dei diritti dell’uomo in ospedale, mentre in seconda istanza potremmo dire che umanizzare è rispondere ai bisogni umani. Fornire aiuto psicologico ai familiari delle persone che accedono ai servizi di emergenza non è un com pito istituzionale di un ospedale e non rientra nel rispetto dei diritti dell’uo mo, ma sicuramente è un sistema per rendere l’ospedale più rispettoso dei bisogni dell’uomo. Il personale negli ospedali è sempre più carente ed i carichi di lavoro im pongono ritmi sempre più frenetici. Non avremmo potuto pensare di realizza re questo progetto se non avessimo avuto a disposizione una risorsa preziosa: l’operosità dei volontari. 250 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.46. Arte e cultura in ospedale: l’esperienza della clinica medica “Augusto Murri”, Policlinico, Bari A. BELFIORE, V. O. PALMIERI, G. PALASCIANO - Clinica Medica “Augusto Murri”, Azienda Ospedaliera Policlinico, Università degli Studi di Bari AUTORE REFERENTE: ANNA BELFIORE, V. S. T. D’Aquino 8/C, Bari - tel.: 080 5592961, e-mail: [email protected] Premessa Il connubio fra arte, cultura e salute ha origini remote: la malattia, alle origi ni dell’arte medica, era ritenuta un evento individuale e sociale, che richiede va l’intervento attivo dei vari “attori” che operavano nel contesto sociale del paziente. Con l’avvento della medicina scientifica, la malattia è stata sempre più “atomizzata”, separata dal contesto sociale, e trasferita in luoghi di cura, in cui l’oggetto di attenzione è diventato l’organo malato. L’“approccio sistemico” o bio-psico-sociale in medicina, pur riconoscendo al modello biomedico un’importanza fondamentale, riconsidera la malattia e la salute in termini “relazionali”, e sottolinea l’interdipendenza degli aspetti fisici, psicologici e sociali che condizionano reciprocamente l’insorgenza e lo svi luppo della patologia. L’arte e la cultura diventano, in tale prospettiva, parte integrante di un pro gramma di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza sanitaria, in quanto permettono di rivalutare la natura relazione e multisistemica della sa lute e della malattia. Obiettivi del programma culturale La Clinica Medica “Augusto Murri”, del Policlinico di Bari ha avviato un programma culturale allo scopo di: - Migliorare la qualità dell’accoglienza e degli ambienti ospedalieri, attraver so interventi di modesto impegno economico, realizzabili grazie al contri buto di generosi sostenitori (es. fioriere nei corridoi, sale di attesa gradevo li, biblioteca di reparto, pinacoteca, sala TV). - Favorire l’interazione dell’equipe ospedaliera con i pazienti e i loro visita tori. - Facilitare l’interazione fra l’ospedale e la città e favorire la democratizzazione della cultura, offrendo ai cittadini (pazienti, parenti, personale ospedaliero) la possibilità di partecipare ad eventi culturali. 251 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Programma culturale Le principali iniziative culturali promosse in clinica sono state: 1) La pinacoteca della clinica: E’ costituita da circa 100 affiches di celebri ope re di artisti del XIX e XX secolo, distribuite sulle pareti dei corridoi, delle sale di attesa, delle stanze di degenza e di ambulatorio. Oltre all’indiscutibile pregio estetico, la pinacoteca offre l’occasione, a cittadini e utenti, di sof fermarsi sulla qualità e il significato dei diversi stili pittorici rappresentati (in particolare l’impressionismo e l’espressionismo). 2) La biblioteca di reparto: è stata realizzata grazie alle continue donazioni di libri da parte di sostenitori delle iniziative culturali della clinica; in un pri mo tempo, per timore che alcuni volumi potessero essere portati via, si era provveduto a realizzare un catalogo dei libri e si era designato un respon sabile della distribuzione dei libri. Da circa un anno si è ritenuto più oppor tuno lasciare i libri a disposizione di tutti senza un particolare controllo, nell’ottica di “...meglio un libro letto che un libro rinchiuso in un armadio”. 3) I concerti in clinica: sono realizzati con frequenza bisettimanale o mensile; il medico che svolge la funzione di “responsabile culturale della clinica”, ha il compito di programmare gli eventi musicali, di mantenere i rapporti con gli artisti e le associazioni e istituzioni culturali della città (conservato rio musicale, teatri). La varietà del repertorio permette di favorire l’interes se di un pubblico molto eterogeneo per età ed interessi culturali: sono stati realizzati concerti di musica classica, di musica popolare, musica etnica, jazz; recentemente si è dato spazio anche a manifestazioni più propria mente teatrali. Il programma di ogni evento culturale viene diffuso tramite locandine che riportano il programma ed un breve curriculum degli artisti. I concerti si svolgono in un’aula immediatamente contigua al reparto di degenza; l’aula è dotata di 50 posti a sedere ed è attrezzata con una pedana su cui è collocato un pianoforte a mezza coda, acquistato grazie al contri buto benevolo di generosi sostenitori. Risultati L’impatto del programma di arte e cultura sullo stato di salute dei soggetti coinvolti (pazienti, personale sanitario, visitatori) è oggetto di una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo attraverso una serie di indicatori. Da segnalare: la richiesta di informazioni sui programmi culturali da parte di ex-degenti; la diffusione dell’iniziativa in altre U.O.; l’organizzazione di un convegno dedica to a “L’arte e la cultura negli Ospedali della Puglia”; la pianificazione di un corso per la formazione dei responsabili culturali ospedalieri; la stipula di protocolli di gemellaggio fra Ospedali e Istituzioni Culturali (biblioteche, conservatorio) per la diffusione del programma “Arte e cultura negli Ospedali”. 252 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.47. La prevenzione delle lesioni da decubito in ambito ospedaliero, analisi delle Best Current Evidence Based ed elaborazione di un processo aziendale di prevenzione A. CAZZANIGA (Direttore SITRA), L. FERRAIOLI (Componente SITRA), A. INVERNIZZI (Infermiere AFD, Responsabile area dip. DEA), M. BOSIO (Direttore struttura Qualità), A. ZOLI (Direttore Sanitario Aziendale), P. CALTAGIRONE (Direttore Generale) - Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”, Regione Lombardia AUTORE REFERENTE: LAURA FERRAIOLI, SITRA, Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”, Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco - tel. 0341 489060, fax: 0341 489093, e-mail: [email protected] La prevenzione delle lesioni cutanee da decubito rappresenta un’importan te area di attività infermieristica in ambito ospedaliero, all’interno della quale la condivisione e l’utilizzo di un protocollo di prevenzione contribuisce alla diminuzione dell’insorgenza di lesioni, nonché ad un miglioramento delle prestazioni di assistenza infermieristica. Per una buona pratica infermieristica sono necessarie conoscenze di natura scientifica derivanti da: sperimentazioni cliniche, studi sull’assistenza infermieristica, confronto con le esperienze in ternazionali; tutto ciò trova la sua massima espressione nelle linee guida. Da questo presupposto è partita la stesura di un documento che si pone quale strumento metodologico e conoscitivo al servizio di un’assistenza infermieristica evidence based. L’analisi di 4 linee guida presenti in letteratura (AISLeC – EPUAP- NICE – AWMA) ha condotto all’elaborazione di un processo di prevenzione con le finalità di: - evidenziare i contenuti dell’assistenza infermieristica; - migliorare le prestazioni infermieristiche attraverso l’utilizzo di un linguag gio comune e di una pratica standard basata su letteratura aggiornata; - ridurre l’incidenza delle lesioni cutanee da decubito; - limitare i costi attraverso l’utilizzo appropriato delle risorse e dei materiali disponibili; - individuare ed utilizzare indicatori utili alla valutazione della qualità del l’assistenza infermieristica. Accanto a queste finalità il protocollo si pone anche come strumento in grado di uniformare i comportamenti operativi degli infermieri salvaguardan do al contempo un’assistenza infermieristica personalizzata. L’Obiettivo generale è quello di implementare la rilevazione sistematica del rischio di sviluppare lesioni da decubito, definire i punti di attenzione per la pianificazione dell’assistenza infermieristica, elaborare strumenti utili per l’educazione del paziente e del care giver. Gli obiettivi specifici sono di 253 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 fornire conoscenze teoriche e pratiche inerenti l’assistenza infermieristica nella prevenzione delle lesioni da decubito alla luce delle nuove evidenze scientifiche, di definire ed implementare il processo di prevenzione e di implementare l’utilizzo sistematico della scala di Braden per la rilevazione del rischio. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo. E’ già stato elaborato il protocollo ed è stata effettuata la formazione di tutto il personale interessato. E’ stata inoltre effettuata una prima rilevazione che ha dimostrato la situazione seguente: Pazienti valutati % maschi % femmine % pz. < 70 aa % pz. a rischio % pz. con lesioni su quelli a rischio % materassi utilizzati su persone a rischio % pz. con Braden < 16 sul totale N=443 55% 45% 61% 32% 29% 35% 14% L’esperienza fino ad ora effettuata permette di sostenere come un processo articolato di formazione e sensibilizzazione del personale possa permettere di ottenere un approccio concreto al problema delle lesioni da decubito e poter mettere in atto azioni che devono essere monitorate nel tempo e sottoposte a revisione. La conoscenza del problema permette inoltre di migliorare la co municazione con il paziente e sensibilizzarlo ulteriormente rispetto alle misu re di prevenzione da attuare. 12.48. Empowerment delle pazienti sottoposte a linfoadenectomia ascellare per neoplasia mammaria A. MARIANI1, E. POGGI2, B. CUSENZA1 (Tdr Coordinatore), A. FILIPPI2 (C.S.) - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Presidio Ospedaliero di Arco; 1U.O. Medicina fisica e riabilitazione, Direttore: Dott. Roberto Albertazzi; 2U.O. Chirur gia, Direttore: Francesco Ricci AUTORE REFERENTE: ANNAMARIA MARIANI, Presidio Ospedaliero di Arco, U.O. Medi cina Fisica e Riabilitazione, Via Francesco I di Borbone 1, Arco (Tn) - e mail: [email protected] Premesse La letteratura internazionale e l’esperienza di anni di lavoro dimostrano che le pazienti operate di linfoadenectomia per neoplasia mammaria riferiscono 254 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 che nella fase iniziale post chirurgica i problemi principali che debbono af fondare sono i seguenti: - timore nell’ uso del braccio dal lato operato; - comportamento da tenere nella vita quotidiana per prevenire il linfedema; - timore di dover affrontare da sole eventuali complicanze senza sapere a chi rivolgersi. Abbiamo pertanto ritenuto utile per le pazienti sottoposte a trattamento chirurgico di mastectomia o di quadrantectomia con svuotamento linfonodale presso la chirurgia dell’Ospedale del Distretto Alto Garda e Ledro program mare un percorso terapeutico ed informativo gestito in collaborazione tra U.O. di Chirurgia e U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione con i seguenti obiettivi: - evitare i dolori e le limitazioni articolari alla spalla; - favorire una rapida ripresa delle attività quotidiane evitando che la pazien te si auto limiti nel timore di possibili conseguenze secondarie; - fornire alla paziente tutte le informazioni che le possono essere utili a pre venire la insorgenza di eventuale linfedema; - fornire recapiti e numeri telefonici dei medici di riferimento. Sintesi del programma Il programma prevede un totale automatismo nella gestione degli appunta menti e delle visite in quanto la paziente, angosciata per la diagnosi e per le procedure chirurgiche si troverebbe in difficoltà ad autogestire gli appunta menti. Il percorso clinico terapeutico prevede una visita fisiatrica pre-operatoria, direttamente prenotata dalla caposala della chirurgia, nella quale si valuta l’articolarità della spalla ed eventuali altre situazioni da tenere presenti nel trattamento post-operatorio. In tale occasione verrà anche programmato l’inizio della terapia di mobilizzazione post chirurgica da effettuare orientativamente 4-5 gg. dopo la dimissione dalla chirurgia (dimissione mediamente in terza giornata) con con trollo fisiatrico all’inizio della terapia. Eventuali proroghe di degenza o complicanze vengono segnalate a cura della caposala del reparto chirurgico. Rieducazione post operatoria: Il programma riabilitativo post operatorio si articola in 5 sedute con i se guenti obiettivi: - mobilizzazione della spalla e arto superiore; - rinforzo muscolare; 255 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - superamento del timore della paziente di riprendere le attività quotidiane; - consigli sull’uso dell’arto superiore e sulle strategie da adottare per preve nire il linfedema; - consegna alla paziente di foglio informativo con recapiti telefonici e moda lità di contatto diretto in caso di insorgenza di complicanze (è prevista in seconda fase la preparazione di volumetto con esercizi da eseguire a domi cilio e norme di comportamento). In altre esperienze anche all’interno della nostra Azienda Sanitaria è stato scelto di effettuare un trattamento di brevissima durata (da 1 a 3 gg.) con la consegna di un manuale sugli esercizi da eseguire a domicilio, questa metodi ca si è rivelata efficace in pazienti con buona capacità di autogestione, ma in alcune pazienti ha creato ulteriore motivo di ansia e difficoltà nella esecuzio ne degli esercizi a domicilio. Si è pertanto preferito fornire alla paziente solo una pagina in stile FAQ (domande frequenti) con linguaggio positivo e tranquillizzante e i recapiti telefonici cui rivolgersi in caso di dubbi o problemi. Il foglio viene consegnato direttamente alla paziente con l’indicazione di mostrarlo al proprio medico di base che pertanto viene coinvolto nella cura della paziente e nella gestione di eventuali complicanze. La rimozione dei punti di sutura è prevista in occasione della visita di con trollo chirurgica. Al termine del ciclo di trattamento viene programmata direttamente dalla Segreteria della Riabilitazione una visita di controllo ad un mese circa alla quale la paziente accederà con normale impegnativa del curante. Durante la vista verrà verificata la situazione clinica, il grado di coinvolgimento della paziente nel progetto riabilitativo e valutata la eventua le necessità di ulteriore trattamento. Risultati I parametri in fase di monitoraggio i cui risultati verranno presentati nel poster sono: - % di pazienti operate che hanno seguito il percorso clinico riabilitativo; - % di pazienti che riescono entro due settimane dall’intervento a riprendere ADL; - % di pazienti che si sono rivolte ai servizi di riferimento per complicanze insorte entro un anno dall’intervento. Prospettive future - valutazione del grado di compliance della paziente al programma di infor 256 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 mazioni e prevenzione con controlli a distanza di un mese e sei mesi dal termine della terapia; - valutazione in occasione del primo controllo del grado di soddisfazione dell’ utente sul iter del percorso clinico terapeutico. 12.49. Indagine conoscitiva sulle abitudini al fumo dei dipendenti di reparti a rischio dell’Azienda Ospedaliera di Cremona M. PARPANESI1, P. SIRONI2 - Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona; 1Presidio Ambu latoriale Territoriale, 2Unità Operativa di Neurologia AUTORE REFERENTE: MAURO PARPANESI, Presidio Ambulatoriale Territoriale, Azien da Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Trento e Trieste 15, 26100 Cremona – tel.: 0372 405853, fax: 0372 405877, e- mail: [email protected] Breve introduzione del contesto Il Piano Sanitario Nazionale 2002-2004 ha inserito la lotta al tabagismo tra gli obiettivi diretti a promuovere comportamenti e stili di vita per la salute. Oltre ad auspicare la drastica diminuzione del numero dei fumatori il Piano pone l’accento sulle necessità del rispetto della normativa esistente sul divieto di fumo. L’OMS, nel 1993, ha sancito che i servizi sanitari sono il punto cardine dell’azione per ottenere una drastica riduzione dell’abitudine al fumo. Negli ultimi decenni, importanti studi epidemiologici hanno individuato nel fumo di tabacco la principale causa evitabile di malattie e di morte nei Paesi industrializzati; nonostante ciò in molti ambulatori, ospedali e altre strutture sanitarie, si continua a tollerare il fumo degli operatori, dei pazienti e dei visitatori. Questa situazione, oltre a violare il diritto dei non fumatori a soggiornare in ambienti liberi dal fumo, rappresenta un messaggio contraddittorio e diseducativo. L’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, nell’ambito di una policy aziendale sulla promozione della salute negli ambienti sanitari secondo le indica zioni dell’OMS, ritiene prioritaria una strategia di intervento multisettoriale mirata tramite il progetto in corso attraverso la valutazione conoscitiva delle abitudini al fumo mediante la somministrazione di un questionario. Obiettivo/i - Valutare l’abitudine tabagica dei dipendenti delle U.O. di Pneumologia, Cardiologia e Ostertricia che per le loro caratteristiche intrinseche sono con siderati centrali per una corretta educazione sanitaria contro il fumo attra verso la somministrazione di un questionario; - valutare la possibilità di inserire i fumatori in un percorso di disassuefazione; - promuovere stili di vita sani all’interno dell’Ospedale. 257 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Gruppo/i Target: il progetto è rivolto ai dipendenti dei reparti di Pneumo logia, Ostetricia e Cardiologia. Presentazione e valutazione dei risultati: sono stati distribuiti 80 questio nari per circa 135 operatori sanitari. Sono stati restituiti 9 questionari. Conclusioni: è in corso l’elaborazione dei questionari. 12.50. Verifica della qualità percepita dall’utente in un percorso di promozione della salute relativa al trattamento riabilitativo della lombalgia R. ALBERTAZZI1, D. CANDIOLI2 - Fisioterapisti dell’U.O. Medicina Fisica e Riabili tazione Ospedale di Rovereto (TN), C.so Verona 4, 38068 Rovereto (TN) - tel.: 0464 453297, fax: 0464 453514; Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento - 1Direttore U.O. Medicina Fisica e Ria bilitazione Ospedale di Rovereto (TN), 2Coordinatore fisioterapista dell’ U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione Ospedale di Rovereto (TN) Motivazioni Oltre i tre quarti delle persone adulte sperimentano il mal di schiena (o lombalgia) nel corso della propria esistenza e la maggior parte in età lavorativa. Questa patologia ha un costo sociale e sanitario enorme per spese medi che e per giornate di lavoro perse. Nella maggioranza dei casi si tratta di algie comuni non correlate a cause specifiche. Fra le cause più significative riferite dagli studiosi per queste forme, vi sono le posture e i movimenti incongrui, il sovrappeso, gli stress psicologici e una forma fisica scadente. Si è evidenziata la necessità, nella pratica clinica, di favorire un “approccio attivo” per curare la persona colpita da mal di schiena nella sua globalità ricorrendo ad un coinvolgimento diretto del paziente. Da diverso tempo, nel nostro servizio, il trattamento riabilitativo della lombalgia segue un percorso particolare che prevede la partecipazione attiva dei nostri utenti ad un “corso di formazione” in cui vengono preparati per gestire autonomamente il loro problema. In pratica il trattamento, previsto in 8 lezioni, prevede tre elementi: - un software educativo computerizzato sulle cause e sulle metodologie di prevenzione della lombalgia che consente al paziente di poter interagire al fine di riuscire ad essere protagonista del proprio recupero ed apprendere i vari aspetti del problema; - una proposta terapeutica con lezione teorica e addestramento agli esercizi di auto-mantenimento nell’ottica della back school; 258 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - un fascicolo di rinforzo da consegnare al termine del percorso che serva a ricordare i concetti acquisiti e per l’auto-mantenimento a domicilio. Obiettivo Avendo standardizzato questo modo di lavoro, ci siamo posti il problema di verificare la qualità percepita dai nostri utenti. Abbiamo pensato di raggiungere l’obiettivo con la predisposizione di un questionario da far compilare ai pazienti alla fine del “corso colonna”. La raccolta dei dati e la compilazione del questionario è stata affidata ad una studentessa del D.U. di fisioterapia della scuola di Rovereto, la quale sta preparando una tesi sull’ argomento. Target Popolazione tra i 20 e i 65 aa. affetta da lombalgia semplice. Indicatori Gli indicatori scelti per il monitoraggio, concentrati in dieci domande, sono i seguenti: - valutazione dell’ aspetto organizzativo; - valutazione della professionalità degli operatori; - valutazione dell’ efficacia dell’intervento. 12.51. Progetto “Sopraimille”. Collaborazione tra Centro Salute Mentale e Società degli Alpinisti Tridentini A. BOLOGNANI1, M. FLORIANI1, S. SCARAMUZZA2 - 1Centro Salute Mentale, Distretto Sanitario “Alto Garda e Ledro”, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autonoma di Trento, 2Laureanda Corso in Tecnica della Riabilita zione Psichiatrica, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Verona AUTORE REFERENTE: MILENA FLORIANI, Centro Salute Mentale, via Capitelli 50, 38062 Arco (Tn) – tel.: 0464 582280, e-mail: [email protected] Introduzione Sulla scia di alcune esperienze, italiane ed estere, di utilizzo della montagna come scenario riabilitativo per pazienti affetti da patologie psichiatriche è sta to avviato questo progetto, nato da un formale accordo tra il Centro Salute 259 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Mentale del Distretto Alto Garda e Ledro dell’ A.P.S.S. e la Sezione di Riva del Garda della Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T.– C.A.I.). Il progetto è stato ideato, formulato ed attuato da un gruppo congiunto di operatori sanitari del CSM e di soci della SAT di Riva. Le rispettive competen ze, in ambito sanitario ed in quello legato alla frequentazione della montagna, vengono così a confrontarsi e fondersi, in un lavoro sinergico. Nella prima fase, di progettazione e preparazione, gli operatori del CSM hanno definito la “cornice riabilitativa” all’interno della quale costruire l’espe rienza, individuando gli obiettivi da raggiungere, fornendo elementi teoricopratici per facilitare la gestione del gruppo e dei singoli. Da parte loro i soci della SAT di Riva hanno messo a disposizione le loro competenze e specifiche conoscenze, guidando l’individuazione di strumenti, tecniche e proposte realizzabili “sul campo”. Nella fase attuativa gli operatori del CSM, che hanno partecipato attivamen te a tutta l’esperienza, hanno avuto la funzione di monitorare i risultati, inter venire e risolvere gli inevitabili problemi, più genericamente svolgere una essenziale funzione di tutoraggio nei confronti degli utenti. Al contempo i soci della SAT di Riva hanno presentato e gestito gli aspetti tecnici dell’inizia tiva, guidato il gruppo su un percorso esperienziale, individuato le migliori proposte in relazione alle capacità dei singoli e del gruppo. Obiettivi Stimolare l’aggregazione; favorire il contatto con realtà “esterne”, creando opportunità di socializzazione con persone ed ambienti esterni al “circuito psichiatrico”; stimolare la ripresa del contatto col proprio corpo; acquisire com petenze, anche sul piano tecnico, nel campo della manualità, dell’uso appro priato dell’attrezzatura, di dimensioni specifiche dello “ambiente natura”; di accrescere, attraverso il confronto con gli altri e con l’ambiente, la conoscenza di sé e l’autostima. Gruppo Target Nell’attuale fase (che può essere considerata sperimentale) l’iniziativa è sta ta proposta a dieci giovani utenti (età 20 – 39 anni) del Centro di Salute Men tale, individuati ed indirizzati a questa esperienza dallo psichiatra curante sul la base di una riconosciuta motivazione e nel quadro di un programma di riabilitazione più ampio. Si è tenuto particolarmente conto della composizio ne del gruppo; tutti i partecipanti al gruppo presentano una diagnosi di Di sturbo Psicotico o di Disturbo di Personalità. 260 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Presentazione risultati ottenuti Nella fase sperimentale sono state effettuate sei uscite (in rifugio, sulla neve, in parete ecc...) ognuna delle quali preceduta da un incontro “informativo” e seguita da un incontro di riflessione sull’esperienza vissuta, sui rapporti intrat tenuti, sulle proprie reazioni ecc.... Ogni uscita è stata monitorata con l’uso di una scheda personale di valuta zione allo scopo di verificare l’andamento individuale sul piano generale ed il raggiungimento di specifici obbiettivi precedentemente fissati. Alla fine di questa fase sperimentale a tutti i partecipanti (utenti, operatori e collaboratori) è stato proposto un questionario di verifica rispetto al gradi mento dell’esperienza. Conclusioni Gli elementi fondanti il progetto sono stati la sua originalità, la ricerca di una impostazione coerente sin dalle prime fasi progettuali, l’idea di creare sinergie molto forti con elementi esterni. Da una parte i risultati ottenuti sui singoli soggetti e sul gruppo nel suo insieme sono, anche se solo iniziali, molto confortanti. Dall’altra l’esperienza attuata ha permesso di ricercare nuovi linguaggi di applicazione della teoria della riabilitazione psichiatrica, attraverso l’uso di uno strumento atipico ed i cui contorni sono ancora in buona misura da delineare. La positività dei risul tati ottenuti giustifica quindi la prosecuzione dell’esperienza e, parallelamen te, un lavoro di ricerca ed individuazione di basi teoriche che portino alla creazione di tecniche più precise ed utilizzabili. 12.52. RAR: referente alcologico di reparto M. ALBERTINI, M. CHIODEGA, A. FILIPPI, A. CAZZOLLI, D. GROTTOLO, M. ROSA, B. PENASA - Distretto Alto Garda E Ledro, A.P.S.S. Trento AUTORE REFERENTE: MONICA CHIODEGA, Servizio Infermieristico Distretto Alto Garda e Ledro – e-mail: [email protected] Obiettivi Il RAR (Referente Alcologico di Reparto) è un operatore sanitario, formal mente riconosciuto dall’Azienda Sanitaria, opportunamente formato con cor si specifici per realizzare attività di counselling e di informazione a persone e famiglie con PAC (problemi alcolcorrelati) che opera all’interno dell’Unità Ope rativa. 261 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Gli obiettivi del RAR sono: 1. Individuare in ambito ospedaliero i problemi alcolcorrelati nelle persone ricoverate, indipendentemente dalla patologia che ne ha motivato l’acces so, attraverso uno screening condiviso da tutto il personale delle Unità Operative supportato da altri esami diagnostici. 2. Garantire, prima della dimissione, a tutte le persone positive allo screening per PAC o a rischio di PAC, rispettivamente un colloquio di motivazione, possibilmente con la presenza di un familiare o un colloquio breve che permetta di focalizzare il problema, dare corrette informazioni, fornire materiale informativo, indicare percorsi per facilitare il cambiamento, con invio ai programmi territoriali. 3. Incrementare nei reparti ospedalieri l’informazione, la formazione, la sensibilizzazione e la responsabilità degli operatori e dei pazienti ricovera ti sull’importanza degli stili di vita personali come determinanti del proprio benessere e del proprio star bene con gli altri. Target 1. Tutti i pazienti ricoverati nella struttura 2. Familiari delle persone con problemi alcol correlati 3. Operatori sanitari Valutazione dei risultati 1. 2. 3. 4. Numero di colloqui effettuati/n. pazienti ricoverati in ospedale; numero di arrivi al Centro di Alcologia e/o nei centri di riabilitazione (Club); numero di iniziative promosse dal gruppo RAR; monitoraggio dell’attività, ricerca e verifica attraverso incontri periodici tra gli operatori RAR ed il Centro di Alcologia, per una programmazione, valu tazione, confronto, aggiornamento e sostegno dell’attività. Conclusioni L’esperienza di questi anni ha chiaramente dimostrato che un momento “prezioso” come quello dell’ospedalizzazione (momento in cui la persona è particolarmente “debole”, dipendente ed in condizione di accettare soluzioni e proposte altrimenti negate e rifiutate), si è rivelato “sotto-utilizzato” e scarsa mente ottimizzato per l’identificazione di persone con PAC o a rischio di PAC. L’istituzione della figura del RAR, ha portato a triplicare i contatti con perso ne con PAC o a rischio di PAC ricoverate; aumentare gli ingressi nei gruppi di auto-mutuo-aiuto ed ha suscitato nuove coscienze e sensibilità fra gli opera tori sanitari. 262 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.53. Attuazione del sistema qualità: valutazione della soddisfazione dell’utente presso un servizio di fisiopatologia respiratoria- Dati preliminari L. CARMELLINI, A. SANNICOLÒ, A. FLAIM, F. CICCARONE, V. LEONI, M. PRANDINI - Ospedale Civile di Arco AUTORE REFERENTE: MARIO PRANDINI, e-mail: [email protected], tel.: 0464 582415, fax: 0464 582417 Introduzione Il concetto di “Qualità” solo da poco ha iniziato a ricevere la dovuta consi derazione nell’ambito della assistenza sanitaria, come diritto di ogni cittadino e dovere del personale sanitario. Questa considerazione deve indirizzare l’or ganizzazione alla soddisfazione dell’utente che dipende non solo dal fatto che quello che viene eseguito venga eseguito in maniera corretta, secondo le norme di buona pratica medica, ma anche da come la prestazione viene per cepita dall’utente stesso. La “Qualità” rappresenta il cardine su cui basare la visibilità e la credibilità di una organizzazione. Il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria si occupa di diverse attività: centro di riferimento provinciale per i disturbi respiratori del sonno e riferimento provinciale per l’ossigenoventiloterapia domiciliare; eroga il 90% della attività di fisiopatologia respiratoria ed il 70% di quella allergologica della provincia. Obiettivo Valutare l’impatto della nostra attività sull’utente. Abbiamo chiesto a tutti i soggetti che afferiscono al Servizio di compilare un questionario nel quale si chiede di valutare una serie di punti relativi alla attività medico infermieristica ed alla logistica. La distribuzione dei questionari è iniziata il 2 maggio u.s ed i dati che presentiamo sono relativi ai primi 260 questionari. Risultati Abbiamo raccolto il 100% dei questionari distribuiti e nessun utente si è rifiutato di compilarlo. 98 questionari riportavano solo giudizio di buono e ottimo. 162 questionari riportavano almeno 1 giudizio di sufficiente o insuffi ciente. Nessuno giudizio pessimo. Nello specifico, alla domanda 1: “come giudica la prestazione ottenuta” in 2 casi si otteneva il giudizio di insufficiente. Alla domanda 2: “come considera la prestazione rispetto alle Sue aspettati ve?” in 3 casi il giudizio era di insufficiente. 263 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 La domanda 3: “come giudica l’ accessibilità al servizio” ha evidenziato la maggiore criticità. 7 giudizi di insufficiente per quanto riguarda il punto “faci lità” di prenotazione. 32 insufficiente per quanto riguarda il punto: “segnaleti ca all’ interno dell’ ospedale.”. Anche la domanda 4 “lista d’ attesa” ha messo in luce criticità con 17 insufficiente. Le domande 5 e 6 attinenti alla accoglienza della sala d’ attesa ed al tempo trascorso nella sala d’ attesa ottenevano rispettivamente 1 insufficiente ed 3 insufficiente. La domanda 7 relativa alla disponibilità di medici e personale paramedico otteneva 3 insufficiente per quanto riguarda il personale medico e 2 insuffi ciente per il personale paramedico. La domanda 8, relativa alla privacy otteneva 4 insufficiente per quanto ri guardante l’ accettazione e 4 insufficiente per quanto attinente all’espletamento della prestazione. La domanda 9, riguardante le informazioni ricevute otteneva 6 insufficiente al punto relativo alle modalità di preparazione alla prestazione, 3 insufficiente per quanto riguarda la diagnosi, 5 insufficiente per quanto attinente la terapia, 2 insufficiente per quanto riguarda il ritiro dei referti. Discussione 2 questionari hanno dato giudizio di insufficiente per tutte le domande, mentre la maggior parte dei questionari presentava giudizi sia positivi sia ne gativi. I punti più critici sono stati quelli relativi alla domanda 3: ”come giudi ca l’ accessibilità al servizio” (39 risposte negative) e quelli relativi alla doman da 4: “lista di attesa” (17 risposte negative). Per quanto riguarda la domanda 3, al punto “facilità di prenotazione” bisogna considerare che la nostra attività non viene gestita dal CUP e quindi spesso gli utenti devono eseguire diverse telefonate prima di contattarci; per quanto attinente il punto “segnaletica all’ interno dell’ ospedale” bisogna sottolineare che l’ospedale è funzionante da solo 3 mesi e quindi non tutto è predisposto in maniera ottimale. Per quanto riguarda la “lista di attesa” bisogna considerare che i questionari sono stati distribuiti nel periodo di maggior incidenza di sintomatologia allergica da pollini e pur avendo aumentato di un terzo il numero delle sedute non siamo riusciti a contenere il periodo di attesa a meno di 40 giorni. Conclusioni La distribuzione dei questionari è risultata assai utile per comprendere qua li sono i nostri punti di debolezza sui quali operare per migliorare ed è risulta ta altresì utile per farci comprendere come sia effettivamente necessario agire per far percepire al paziente la qualità della prestazione ottenuta. 264 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.54. Progetto HPH interregionale “Allergia a scuola”: verso la realizzazione di un sito web per adolescenti A. APPICCIAFUOCO1, M. MANFREDI2, P. MINALE3, G. ERMINI4, P. CAMPI4, C. MENICOCCI2, C. TAZZER3, A. ALESSANDRI5, R. GUADAGNO5, I. FRATI5, D. MAZZOTTA6, R. BRUNETTI7, R. PREDONZANI8, F. SIMONELLI9, P. MORELLO MARCHESE10 - 1Coordinatore Progetto HPH ASL 10, 2U.O.S. Laboratorio di Immunologia e Allergologia, Nuovo Ospedale San Gio vanni di Dio ASL 10 Firenze, 3U.O. Allergologia, Dipartimento di Medicina inter na Ospedale San Martino, Genova, 4U.O.S. Allergologia ed Immunologia Clinica Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio ASL 10 Firenze, 5Management staff Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, ASL 10 Firenze, 6Management staff Ospedale S.M. Annunziata ASL 10 Firenze, 7U.O. Educazione alla salute ASL 10 Firenze, 8 Coordinatore Progetto HPH Regione Liguria, 9HPH Network Regione Toscana, A.O. Meyer-Firenze, 10Coordinatore Progetto HPH A. O. Meyer- Firenze La letteratura internazionale degli ultimi anni concorda nel rilevare un signi ficativo aumento delle malattie allergiche con conseguente sempre maggior impatto sociosanitario ed economico. Un appropriato management delle ma lattie allergiche permette di arrivare prima ad una diagnosi corretta e di evitare terapie inadeguate con indubbi vantaggi per quanto riguarda la qualità della vita e la spesa sanitaria. Programmi preventivi multidisciplinari che educano alla conoscenza della malattia e dei percorsi diagnostico-terapeutici corretti sono pertanto molto importanti. La U.O.S. Allergologia ed Immunologia Clinica e la U.O.S. Laboratorio di Immunologia ed Allergologia della ASL 10 Firenze insie me alla U.O. Allergologia dell’Azienda Ospedaliera San Martino di Genova han no elaborato un programma educazionale comune, elaborando strategie con divise e creando una alleanza tra specialisti allergologi, pediatri, educatori sanitari, insegnanti, alunni e loro genitori per migliorare la conoscenza delle malat tie allergiche e favorire lo sviluppo di una coscienza dei processi di salute. E’ stato sviluppato un Progetto cooperativo interregionale nell’ambito del Program ma HPH che coinvolge la Regione Toscana e la regione Liguria. Scopo del Progetto - Realizzare un programma educazionale per adolescenti informandoli su come identificare, prevenire e curare le malattie allergiche. - Rafforzare il legame tra Ospedale e Territorio. - Realizzare un sito Web educazionale per adolescenti sul tema dell’allergia. Metodi Partecipanti: sono stati coinvolti gli alunni delle scuole medie inferiori di 265 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Genova, Scandicci e Firenze, gli specialisti dei Servizi di Allergologia ed Immunologia Clinica e Laboratorio, gli educatori sanitari e gli insegnanti. Protocollo: è stato elaborato un protocollo educazionale in merito alle ma lattie allergiche e loro fattori di rischio che si articola in lezioni in classe, distri buzione di materiale informativo e dispense agli alunni di scuola media infe riore, proiezioni video, visite ed esperienze pratiche in laboratorio di Allergologia per il riconoscimento degli aeroallergeni. I nostri Ospedali han no aperto le porte ad alunni, insegnanti e genitori coinvolgendo attivamente i ragazzi ed aiutandoli ad elaborare loro stessi materiale educazionale in forma scritta e grafica dedicato ai loro coetanei. Risultati L’attività svolta si è concretizzata nella realizzazione di un opuscolo educazionale “Io e l’allergia” scritto dai ragazzi stessi in un linguaggio sempli ce e condivisibile da altri adolescenti e pubblicato dalla U.O. Educazione alla salute della ASL 10 Firenze, di un CD-ROM e nell’allestimento di una mostra dei disegni dei ragazzi presso i Presidi Ospedalieri. Tutto il materiale sarà inserito in un sito WEB educazionale dedicato. At tualmente il volume “Io e l’Allergia”è consultabile nel sito regionale HPH, “www.meyer.it/hph”, alla voce “documentazione- Esperienze eccellenti”. Conclusioni Il progetto che verrà esteso negli anni futuri ad altre scuole ed altre Regioni si propone come modello al fine di migliorare l’outcome di salute dei servizi sanitari e la qualità dell’assistenza nel campo delle malattie allergiche. 12.55. Ruolo dell’educazione sanitaria nella terapia dell’asma V. BRUSAFERRO, F. BAZZANI, Y. KOOMEN, G. MATTEVI, F. MIORI, B. VILLOTTI e A. SALVATERRA - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria, Ospedale Civile di Arco (TN) AUTORE REFERENTE: VITO BRUSAFERRO – e.mail: [email protected] Introduzione Nella gestione delle malattie croniche e fra queste l’asma bronchiale, vi sono diverse difficoltà da superare. Esse riguardano in particolare i rapporti del paziente con la sua malattia (conoscenza delle cause, sua evoluzione nel tem po, accettazione della malattia come malattia cronica), con la terapia (in parti 266 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 colare la conoscenza del meccanismo d’azione dei farmaci, dei loro effetti collaterali, della loro tossicità nell’assunzione cronica), il rapporto tra il pa ziente, la famiglia e l’ambiente lavorativo ed infine il rapporto tra il paziente ed il medico curante. Come già evidenziato dalla letteratura e dall’esperienza quotidiana, affron tare questi problemi significa voler migliorare la compliance del paziente nei riguardi della terapia e il suo rapporto con la malattia, al fine di ottenere un miglioramento della qualità di vita, una riduzione dei costi sociali, dei costi sanitari, dei costi economici. Obiettivo Valutare l’impatto di un programma educativo riguardo il rapporto tra pa ziente e malattia ed in particolare il rapporto tra paziente e terapia. Azioni Abbiamo somministrato un questionario a 100 pazienti con asma cronico; successivamente, guidati dai risultati raccolti, abbiamo avviato un programma di educazione sanitaria per migliorare e “correggere” le conoscenze ed i com portamenti laddove erano più carenti. In pratica un infermiere ha spiegato a tutti i pazienti l’utilità e l’uso del misuratore di picco di flusso e l’uso degli aerosolizzatori pressurizzati; i medici durante ogni visita di controllo hanno spiegato sistematicamente i concetti fondamentali della malattia asmatica (cause scatenanti, infiammazione bronchiale, iperreattività bronchiale, broncospasmo), hanno ricordato i concetti fondamentali sulla proprietà e sull’uso dei farmaci (preventivi, curativi, broncodilatatori) ed hanno richiamato poi l’attenzione sulle terapie preventive e di mantenimento che devono essere modulate attraverso i dati raccolti con monitoraggio del picco di flusso. Dati Il 32% dei pazienti era consapevole dell’utilità della misurazione ripetuta delle prove spirometriche e dell’utilità della misurazione quotidiana del picco di flusso; ancora il 32% sapeva elencare esattamente i nomi commerciali dei farmaci esclusivamente preventivi; il 33% conosceva il nome dei farmaci broncodilatatori e spiegava in maniera corretta il loro utilizzo. Dopo tre anni è stato somministrato nuovamente lo stesso questionario a 40 soggetti che avevano avuto nel tempo almeno 2 controlli/anno presso i nostri ambulatori. Per quanto riguarda le conoscenze abbiamo riscontrato un risultato notevolmente soddisfacente: il 57% è ora consapevole dell’utilità del la misurazione ripetuta delle prove spirometriche e dell’utilità della misura 267 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 zione quotidiana del picco di flusso; il 72% sa elencare esattamente i nomi commerciali dei farmaci preventivi. Per quanto riguarda la terapia, il 77% co nosce e usa correttamente i farmaci broncodilatatori. Conclusioni I risultati dimostrano l’importanza del ruolo dell’educazione sanitaria nella conoscenza e nel trattamento dell’asma bronchiale. L’apporto educativo del personale medico e tecnico-infermieristico ha infatti determinato una mag giore conoscenza della malattia e dei metodi di autovalutazione della stessa, e un miglioramento nell’utilizzo dei farmaci inalatori. 12.56. Il counselling infermieristico per l’informazione terapeutica al paziente psichiatrico sugli psicofarmaci prescritti D. COSTI, M. GARAMANTE, M. FERRARI, S. GALERO, G. ROSARIO, L. CAMORANI - Diparti mento di Salute Mentale, Azienda USL di Reggio Emilia, Via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: DORELLA COSTI - tel.: 0522 335499, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto L’informazione terapeutica al paziente psichiatrico sugli psicofarmaci pre scritti è un progetto che i centri di salute mentale (CSM) della Reggio Emilia Health Authority hanno attuato da alcuni anni nel contesto del progetto aziendale sull’educazione terapeutica. L’informazione terapeutica (informazione, decisione, supporto) è la pre scrizione di specifiche informazioni basate sull’evidenza ad uno specifico paziente, caregiver o consumatore, proprio nel momento giusto per aiu tarlo a prendere una specifica decisione o per un cambio di comportamento. Obiettivo/i - Migliorare la qualità della comunicazione relativa alle indicazioni terapeutiche con il paziente e la sua famiglia per favorire anche una miglio re qualità delle cure. - Condividere con il paziente e la sua famiglia le principali informazioni rela tive all’uso della terapia psicofarmacologica, favorire l’autonomia del pa ziente e del personale infermieristico nell’educazione all’uso dei farmaci e nell’identificazione degli effetti indesiderati. I CSM hanno promosso la diffusione di istruzioni operative riguardanti l’iden 268 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 tificazione ed il trattamento degli effetti indesiderati dei farmaci, predisposte con linguaggio non tecnico e comprensibile sulle indicazioni che richiedono l’uso del farmaco, per aiutare il paziente e la famiglia ad individuare eventuali effetti avversi, spesso transitori, e a riconoscere i segni e i sintomi che richie dono una valutazione rapida da parte del medico specialista. Sono state realizzate e distribuite agli utenti dei CSM schede informative sulle principali tipologie di psicofarmaci prescritti. Gruppo/i target Pazienti psichiatrici e relative famiglie. Presentazione e valutazione dei risultati La valutazione dell’applicazione del progetto è basata sulla predisposizione ed aggiornamento di schede informative per pazienti e familiari sugli effetti indesiderati dei farmaci, e sulla evidenza della loro diffusione. I risultati conseguiti riguardano la elaborazione di schede informative per i pa zienti e familiari relative alle diverse categorie di farmaci sulle modalità di corretta utilizzazione, sugli effetti indesiderati e sulle misure pratiche di riduzione dei disa gi; tali schede sono disponibili presso tutti i CSM e vengono consegnate, all’inizio del trattamento terapeutico e, se occorre, anche a trattamento già iniziato, durante una seduta di counseling in cui si verifica anche la comprensione del paziente. 12.57. Un servizio di informazione e valutazione degli ausili tecnici come strumento di promozione della salute G. GUANDALINI, N. MAZZINI - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento AUTORE REFERENTE: GIOVANNI GUANDALINI, Ospedale Riabilitativo Villa Rosa, Pergine (TN) – tel.: 0461 501500, fax: 0461501580, e-mail [email protected] Introduzione Nel mondo riabilitativo l’ausilio è diventato in questi ultimi anni un elemen to terapeutico sempre più importante ed essenziale per permettere la maggior autonomia possibile alle persone “diversamente abili”, per facilitare l’assistenza dei loro care-givers, per permettere una vita di qualità. D’altra parte il mondo degli ausili in quest’ultimo decennio ha avuto un enorme sviluppo; l’aumento del loro uso/consumo ha trainato un’innovazio ne tecnologica che permette di disporre di una vastissima scelta di presidi 269 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 quali: carrozzine ortopediche ad auto spinta, leggere, super leggere, personalizzate, elettroniche, a uso multiplo; sistemi di postura fabbricati con materiali sofisticati ad alto contenuto tecnologico; sistemi di domotizzazione delle abitazioni per favorire il rientro al domicilio e per attivare strategie di prevenzione della disabilità; ausili per la mobilizzazione delle persone; ausili per la prevenzione dei decubiti, ausili informatici per facilitare la comunica zione in condizioni estreme di difficoltà, ecc... Il principio di una sanità che pone al centro dei suoi interventi il paziente stesso e i suoi care-givers si è definitivamente affermato, e per quanto riguar da gli ausili si è concretizzato nella personalizzazione degli ausili stessi, nell’adattamento al singolo per la soluzione del problema posto in una prospet tiva curativa e preventiva. L’attenzione riservata alla “cronicità”, intesa non solo come malattia croni ca, ma come condizione cronica che include la disabilità come possibile stato esistenziale con pieno diritto di cittadinanza, ha comportato per il personale sanitario la necessità di acquisire competenze sul mondo degli ausili, adegua ta ai bisogni espressi dai pazienti. Obiettivo Il regolamento per le prestazioni di assistenza protesica, decreto del Mini stero della sanità n. 332, recita: “la prescrizione dei dispositivi protesici” ovve ro delle ortesi, delle protesi e degli ausili, “è redatta da un medico specialista del Ssn, competente....”, e inoltre la “prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti....”, la prima prescrizione deve comprendere “diagnosi circostanziata.... indicazione del dispositivo..., un programma terapeutico...”. Con il decreto è stato sancito il ruolo che i programmi di ausiliazione rive stono per permettere la partecipazione del soggetto con diversa abilità alla vita sociale, ma soprattutto il conteso istituzionale nel quale si collocano. L’ospedale Villa Rosa impegnato nella cura delle gravi disabilità, da alcuni anni ha attivato un’articolazione specificamente dedicata alle problematiche poste dai piani integrati di ausiliazione dei pazienti attraverso un’articolazio ne organizzativa, il servizio “Abilita”. Il servizio di informazione e valutazione degli ausili “Abilita”, si avvale di un approccio metodologico che in coerenza con il mandato istituzionale e in conformità a servizi analoghi nel territorio nazionale, è in grado di: - valutare il bisogno espresso dall’utente; - considerare la domanda esplicita o implicita del paziente e/o del suo nu cleo di curanti; - ricercare le soluzioni come parte di un progetto elaborato dall’equipe che ha in cura la persona; 270 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - coinvolgere il paziente e i suoi care-givers nella scelta, adattamento e ap prendimento all’uso oltre che nella manutenzione dei presidi. Nel servizio lavora una terapista a tempo pieno, un secondo fisioterapista per l’equivalente del 50% del tempo, e un fisiatra è il responsabile medico dell’orga nizzazione. Il servizio è alloggiato in un proprio spazio che si compone di un’area ufficio e di un’area per la valutazione dei pazienti e per i colloqui. Si compone anche di uno spazio quale piccolo deposito e mostra di ausili. La rete virtuale di servizi in internet con le diverse banche-dati consente di disporre di un’ampia possibilità illustrativa e la rete informatica aziendale consente una rapida e effi cace comunicazione con le altre articolazioni aziendali coinvolte. Gli obiettivi principali del servizio Abilita sono: - aumentare l’appropriatezza dell’ausiliazione e migliorare la soddisfazione dell’utente; - ridurre i tempi di individuazione e assegnazione degli ausili favorendo i percorsi amministrativi per le autorizzazioni; - monitorare gli “abbandoni “ dell’ausiliazione; - promuovere l’aggiornamento e coadiuvare alla formazione dei clienti interni; - offrire consulenza ad altre articolazioni provinciali per i progetti di “domotizzazione” delle abitazioni, e per favorire la partecipazione alla vita sociale dei disabili. Risultati Vengono presentati i risultati quali-quantitativi raggiunti in due anni di atti vità, 2002-2003. In prospettiva si realizzeranno strategie per favorire un adeguato riutilizzo degli ausili che sono riconsegnati all’azienda sanitaria, in collaborazione con il Distretto di Trento e Valle dei Laghi (cui fanno capo le attività di verifica di congruità sanitario-amministrativa, le procedure d’autorizzazione e di con trollo dell’erogazione degli ausili per tutto il territorio provinciale) al fine di mantenere un alto standard di prestazioni e un maggior controllo della spesa, per quanto di competenza. Un altro filone di sviluppo possibile è la consulenza on-line, un servizio di telemedicina che utilizzerebbe postazioni polifunzionali. 12.58. I giovani del servizio civile quale risorsa nel processo di accoglienza ospedaliera S. CORTOPASSI, M. FILIERI, L. MORELLI, R. GUERRINI, A. D’ALESSANDRO - Azienda USL 5 di PISA AUTORE REFERENTE: SERGIO CORTOPASSI, Responsabile U.O. Assicurazione di Quali 271 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 tà e Accreditamento Azienda USL 5 di Pisa, Via Zamenhof 1, 56100 Pisa – Tel.: 050 954207, fax: 050 954321, e-mail: [email protected] Introduzione del contesto Nel corso degli ultimi 10-15 anni si è registrato un radicale mutamento nel rapporto tra i cittadini ed i servizi, in modo particolare quelli sanitari, che, per la loro peculiare funzione ed importanza sull’incidenza della vita quotidiana, sono stati, nel settore pubblico, quelli di gran lunga più interessati al cambiamento. I cittadini che accedono in una struttura ospedaliera, si trovano spesso in un contesto la cui organizzazione e gli orari si discostano dalle abitudini della vita quotidiana. Tutto ciò è reso ancora più difficile dalle caratteristiche strut turali dell’edificio. Obiettivo Il progetto si pone l’obiettivo di fornire un’accoglienza personalizzata e l’orientamento ai cittadini e ai loro familiari che accedono ai servizi. Al fine di garantire il miglioramento dell’accoglienza, l’umanizzazione e l’in formazione ai cittadini italiani e stranieri all’interno del Presidio Ospedaliero F. Lotti di Pontedera la direzione aziendale dell’Ausl 5 di Pisa ha previsto l’in serimento dei volontari del Servizio Civile nei percorsi assistenziali. I volontari del Sevizio Civile, inoltre, collaboreranno con l’URP alla gestio ne del processo di tutela. I cittadini, infatti, possono far riferimento alla strut tura per problematiche di tipo logistico, relazionale, assistenziale che posso no intervenire durante l’utilizzo delle strutture. Il progetto si pone infine l’obiettivo di migliorare la gestione del tempo dei pazienti ricoverati attraverso iniziative educative finalizzate al miglioramento della propria salute e attraverso attività culturali e ricreative negli intervalli di tempo non occupati dalle cure. Target Il target è costituito dall’utenza che entra in contatto con la realtà ospedaliera sia per il ricovero sia per prestazioni di tipo ambulatoriale e diagnostiche con particolare riguardo per i cittadini non autosufficienti e stranieri. Con l’inserimento dei volontari del Servizio Civile tutti i cittadini inseriti nei percorsi ospedalieri saranno personalmente accolti, dotati del materiale infor mativo necessario attraverso la consegna di una cartellina di accoglienza. Per l’utenza straniera, a seguito di uno studio mirato sul tasso di ricovero dei cittadini extracomunitari, le informazioni necessarie sono state redatte in lingua inglese e albanese. 272 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 L’accoglienza è prevista anche per i familiari ed è comprensiva di aiuto per l’espletamento di pratiche burocratico-amministrative necessarie sia durante il ricovero sia al momento della dimissione. Quanto detto per facilitare il col legamento con il territorio. A tal proposito saranno coinvolte le strutture sani tarie territoriali e le strutture sociali competenti. I volontari del Servizio Civile saranno affiancati e seguiti da due Operatori Locali di Progetto dipendenti dell’Azienda USL5 che provvederanno oltre al tutoraggio anche a fornire specifica formazione teorico pratica. Presentazione e valutazione dei risultati Al momento attuale sono stati predisposti i materiali informativi, anche multilingua, ed è stata stipulato un accordo di partenariato tra l’Azienda USL 5 di Pisa e l’ARCI Valdera per l’impiego di 6 volontari del servizio civile Dalla piena realizzazione del progetto che andrà a regime nei primi mesi del 2005 quando saranno disponibili le nuove leve di volontari ci attendiamo il miglioramento della qualità percepita da parte degli utenti dei nostri servizi ospedalieri. Indagini di customer satisfaction ci consentiranno la valutazione dei risulta ti che saranno pubblicizzati nella relazione annuale di tutela e presentati alla Conferenza dei Servizi nonché utilizzati per costruire azioni di miglioramento mirate. Conclusioni L’introduzione dei volontari del Servizio Civile nella struttura ospedaliera, a nostro avviso, contribuisce ad avvicinare ulteriormente i servizi al cittadino, a sem plificare la comprensione delle informazioni fornite, ad essere elemento di stimo lo e di confronto tra i professionisti che operano all’interno dei servizi. Ulteriore ricaduta positiva del progetto consiste nel formare giovani cittadini che alla fine della loro esperienza diventano consapevoli dell’offerta sanitaria del territorio, capaci di trasmettere quanto appreso nel loro ambiente di vita. L’esperienza vis suta, inoltre, può rappresentare per il giovane volontario anche uno stimolo per indirizzare consapevolmente le eventuali e future scelte lavorative. 12.59. Progetto HPH “Musica in Ospedale”: per la realizzazione di una migliore accoglienza ed assistenza del paziente nel Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio – ASL 10 Firenze A. APPICCIAFUOCO1, G. RANDELLI2, F. BUONO3, D. BELLUCCI4, A. MATUCCI5, G. MARIN5, M. MANFREDI6, P. CAMPI6, A. MARTINI7, C. RUSSO8 - 1Coordinatore HPH Area Fio 273 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 rentina, 2Resp. Coordinamento Ospedale-Territorio, Presidente Ass. cult. Cori Ensemble3, 4Segretaria Ass. Cult. Cori Ensemble, 5Reparto di Reumatologia, 6 Reparto di Allergologia e Immunologia Clinica, 7Ostetricia Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, 8U.O. Educazione alla Salute La voce è il più antico e facile strumento a disposizione dell’uomo. La mu sica è un linguaggio dello spirito, esattamente come il pianto o il riso. Tutti possono cantare e/o provare gioia o relax ascoltando musica, perché la musi ca aiuta a sentirsi meglio. La nostra proposta è aiutare il paziente e l’operatore a sentirsi meglio con i nostri brani musicali. Scopi del progetto - Rafforzare l’idea di un Ospedale che cerca di far sentire i pazienti benvenuti durante il loro ricovero. - Aiutare i pazienti a sentirsi meno preoccupati durante la terapia. - Trasmettere la sensazione che la musica permetta una maggiore serenità che si traduce in una migliore collaborazione tra pazienti ed operatori. Metodi Il coro ha iniziato la sua cooperazione con il Nuovo Ospedale di San Gio vanni di Dio due anni fa ed ha iniziato il progetto “Musica in Ospedale” un anno fa nel Reparto di Reumatologia. All’inizio abbiamo preferito un approc cio discreto andando a cantare nel reparto due volte al mese un repertorio che, vista l’età e la tipologia dei pazienti, comprendesse canzoni della tradi zione popolare toscana o brani famosi della musica leggera, ponendo parti colare attenzione a non disturbare la privacy e a non interferire nella routine paziente/operatore. Abbiamo consegnato ai “lungo-degenti” copie del nostro repertorio affinché potessero cantare con noi la volta successiva. Successiva mente siamo passati ad una frequenza settimanale ed abbiamo partecipato ad eventi specifici organizzati dal Reparto di Reumatologia ed eseguito concerti itineranti o nell’Aula Muntoni dell’Ospedale durante giornate particolari come gli open days oppure il periodo natalizio. Al momento stiamo seguendo anche altri due nuovi progetti: - la sala di attesa del reparto di Allergologia ed Immunologia dove cantiamo ogni settimana per alleviare l’attesa dei pazienti che effettuano le prove allergologiche; - Ostetricia e Nursery, dove, sempre settimanalmente, cantiamo per mamme, papà e neonati un repertorio di Ninne Nanne durante un momento chiama to “Coccole e musica”, volto a rafforzare un’atmosfera intima e rilassata o a confortare i piccoli nelle incubatrici. 274 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Risultati I pazienti accolgono il coro con curiosità e a volte perplessità ma successi vamente con gratitudine e spesso cercano di cantare con noi anche quando le loro condizioni lo consentono poco (pensiamo soprattutto alle visite sporadi che al Reparto di Rianimazione). I pazienti gradiscono lo svolgimento del pro getto e spesso si informano su quando ritorniamo in reparto: questa è la no stra maggiore ricompensa. 12.60. La prevenzione primaria della malattia cardiovascolare: eccesso di peso, alimentazione, attività fisica e lipidi ematici di una popolazione di adolescenti P. ABELLI (Direttore Sanitario Istituto Scientifico di Montescano FSM), V. PARISI (Vicedirigente didattico Istituto L. G. Faravelli di Strabella), P. LOMBARDI (As sessore alla Cultura comune di Strabella), P.G. MAGGI (Assessore ai Servizi Sociali comune di Strabella), R. VEDOVELLI (Dirigente medico di Direzione Sa nitaria Istituto Scientifico di Montescano FSM), L. MAGGI (Vicedirigente didat tico Istituto L. G. Faravelli di Strabella), G. GHIGNI (Vicedirigente didattico Istituto L. G. Faravelli di Strabella), M. ZUCCHELLA (Vicedirigente didattico Isti tuto L. G. Faravelli di Strabella), G. CAMPO (Vicedirigente didattico Istituto L. G. Faravelli di Strabella), R. AQUILANI (Servizio Fisiopatologia MetabolicoNutrizionale Istituto Scientifico di Montescano FSM) AUTORE REFERENTE: PAOLA ABELLI, Fondazione Salvatore Maugeri Istituto Scienti fico di Montescano, via per Montescano n. 31 (PV) - tel.: 038 52471, fax: 038 561386, e-mail: [email protected] Introduzione La malattia cardiovascolare dell’adulto (infarto, ictus, arteriopatia obliteran te periferica) ha la sua base di sviluppo nell’infanzia e nell’adolescenza. Una alimentazione aterogena e una vita sedentaria in periodo adolescenziale sono fattori di rischio per la malattia cardiovascolare dell’adulto. Scopo del nostro lavoro è stato quello di quantificare nutrizione ed attività fisica di una popolazione di adolescenti. Metodologia Sono stati reclutati 199 studenti dell’Istituto Tecnico e per Geometri L.G. Faravelli di Strabella (PV), di età tra i 14 ed i 17 anni, 120 femmine e 79 maschi. Dopo la rilevazione dei dati antropometrici, ciascun adolescente ha compila 275 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 to un diario alimentare (3 giorni) ed uno di attività fisica. Sono stati eseguiti prelievi ematici per la determinazione della concentrazione dei lipidi. Risultati Tab. 1. Distribuzione in % dei pesi Peso normale Soprappeso Obesità 83,5 13,5 3 Eccesso di peso (sovrappeso+obesità) 16,5 Tab. 2. Principali caratteristiche dell’alimentazione variabili Popolazione intera KCAL KCAL/Kg peso corporeo Carboidrati (grammi) Proteine (grammi) Lipidi (grammi) Grassi totali >30% KCAL totali 71,2% Grassi saturi ≥ 10% KCAL totali 47,2% Carboidrati raffinati >12% KCAL totali 72,6% Maschi 2644±702 46±10 371±118 98±29 96±30 61,9% 50,8% 61,9% Femmine 2044±432 40±10 287±81 70±18 74±19 78,3% 44,5% 80,7% Tab. 3. Attività fisica discrezionale <1 ora/settimana Calorie consumate giornalmente per l’attività fisica nel caso in cui quest’ultima fosse > 1 ora settimanale Maschi Femmine 35,4% 55,8% 359±200 161±124 Tab. 4. Concentrazione dei lipidi ematici Variabili Colesterolo totale ≥ 200 mg/dl Col tot 171-199 mg/dl Col tot ≤ 170 mg/dl Trigliceridi ≥ 150 mg/dl Maschi 5% 30% 65% 6,6% Femmine 18% 43% 39% 3% Conclusioni Un’importante quota di adolescenti ha uno stile di vita (nutrizione, attività fisica) e tassi ematici di lipidi inadeguati per una efficace prevenzione prima ria della malattia cardiovascolare dell’adulto. 276 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.61. Alimentarsi bene per crescere meglio: risultati finali D. MICHELLINI1, A.M. FERRARI2, C. CAMPARI2 - AUSL di Reggio Emilia - 1Settore di Pediatria di comunità, 2Dipartimento di Sanità Pubblica, AUTORE REFERENTE: ANNA MARIA FERRARI, SIP di Montecchio, AUSL, via Marconi 18, Montecchio (RE) – tel.: 0522 860170, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto E’ noto che la sedentarietà, un’alimentazione troppo ricca in calorie, con un elevato apporto di grassi di origine animale e di colesterolo, sono sovente responsabili dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e metaboliche, che hanno costi personali (in termini di qualità della vita) e collettivi (intesi come spesa sanitaria e sociale) altissimi. La sensibilizzazione al problema dell’obesità in età pediatrica, spesse volte associato a scarsa attività fisica, svolge quindi un ruolo centrale e decisivo nella divulgazione di una cultura di un’alimentazione equilibrata e corretta e di adeguati stili di vita. Obiettivo/i - Favorire la conoscenza dei comportamenti alimentari e l’adozione di standard nutrizionali sani (P.S.N. 1998-2000). - Promuovere “stili di vita” idonei a favorire la buona salute. - Costruire un progetto “esportabile”, documentando tutte le fasi operative, i materiali prodotti, i risultati - Valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra citati attraverso metodi og gettivi (confronto dati epidemiologici). Gruppo/i target Nel 1999-2000 è stato proposto a 44 classi di 1° Elementare della provin cia di Reggio Emilia (812 alunni) un progetto di promozione e di educazio ne alla salute in campo alimentare svolto nell’arco dei 5 anni di scuola e articolato in modo tale che tutti “attori” dell’iniziativa (maestre, alunni e fa miglie, dietista, pedagogista, insegnanti ISEF) potessero sinergicamente col laborare. Presentazione e valutazione dei risultati Il progetto formativo è stato monitorato, tramite questionari specifici proposti in momenti diversi a genitori e alunni, al fine di valutare i risultati rag 277 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 giunti; a questa indagine epidemiologica hanno partecipato 26 classi coinvol te (campione) e 7 classi non coinvolte (controllo) nel percorso formativo. La rilevazione dei dati epidemiologici nel campione ha riguardato svariate variabili: - Valutazione auxologica (peso, altezza, eccesso ponderale secondo i percentili di Cole): l’eccesso ponderale in 1° elementare era del 72%, in 5° elementare del 70%. L’aumento dei normopesi nelle bambine è stato bilan ciato da una diminuzione nei maschi. - Dati anagrafici, breve anamnesi clinica e variabili socio-economiche della famiglia: un titolo di studio materno basso e la provenienza dalle regioni del centro-sud Italia sono associate ad un maggiore eccesso ponderale del bambino. - Attività ludiche motorie del bambino: la percentuale di bambine sedentarie è dimezzata tra l’inizio e la fine del progetto. Questa diminuzione è meno evidente nei maschi, che però dimostrano complessivamente una maggio re predisposizione all’attività ludico-motoria sin dalla 1° elementare. - Abitudini alimentari del bambino: l’apporto calorico/die è maggiore al 1° anno che al 5° (2181 vs 1902), l’introduzione di colesterolo diminuisce sen sibilmente. Un apporto calorico eccessivo caratterizza in 5° elementare il 35% del campione rispetto al 48% del controllo. - Come mi vedo, come vorrei essere (1° elementare): il bambino ha una cor retta percezione del proprio stato ponderale. - Questionario Vero/Falso/Non so sulle conoscenze nutrizionali degli alun ni: i bambini che hanno partecipato al progetto hanno una conoscenza de gli argomenti significativamente maggiore rispetto ai bambini che non han no partecipato al progetto. - Questionario Vero/Falso/Non so sulle conoscenze nutrizionali dei genitori: sia i genitori di classi aderenti al progetto che quelli di classi non aderenti dimostrano un’elevata consapevolezza e conoscenza dei temi in ambito ali mentare. Conclusioni L’eccesso ponderale è un problema multifattoriale: - Famigliarità: da intendersi non solo come componente genetica ma soprat tutto come patrimonio socio-culturale, abitudini e stili di vita della famiglia. - Attività fisica: è certamente un importante fattore di “contenimento” dell’ec cesso ponderale. - Apporto calorico e qualità della dieta: è un ovvio determinante che però nel nostro studio non sembra essere il principale. - I bambini che hanno partecipato al progetto dimostrano una conoscenza complessiva sull’alimentazione migliore. 278 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.62. Le vie del Fumo S. BOSI1, A. M. FERRARI2, S. DE FRANCO3, R. BOSI4, R. CAVALLI4, G. AZZARONE4, M. PEDRONI5, C. SPAGGIARI6, R. TOFFANETTI PANNELLA7, O. MALVONI8 - 1 Responsabile Pre venzione Lega contro i Tumori, ONLUS Sezione di Reggio Emilia; 2 Diparti mento Sanità Pubblica AUSL di Reggio Emilia; 3 Presidente Ordine dei Medici di Reggio Emilia; 4 AUSL di Reggio Emilia; 5 Medico Medicina Generale; 6 Pe diatra; 7 ASMN di Reggio Emilia; 8 IPASVI AUTORE REFERENTE: ANNA MARIA FERRARI, Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Reggio Emilia. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud Montecchio Emilia, Via Marconi 18 – tel.: 0522 860170, fax: 0522 860140, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto “Le vie del Fumo” è una rassegna didattica multimediale dedicata alla pre venzione dell’abitudine al fumo negli adolescenti che si sviluppa attraverso giochi, laboratori, mostre espositive per rispondere all’esigenza di offrire stru menti metodologici e tematici aggiornati a docenti ed operatori sanitari e per dare agli studenti (dai 13 ai 18 anni) la possibilità di affrontare il problema fumo con una modalità emotivamente coinvolgente. Obiettivo/i Offrire una possibilità di riflettere in modo originale e completo sui diversi aspetti che caratterizzano la simbologia e l’immaginario legati alla sigaretta. Nonostante, infatti, siano chiariti gli effetti nocivi che il fumo attivo e passivo provoca alla salute, smettere di fumare è una scelta estremamente impegnati va ed ambivalente. Ogni fumatore vuole abbandonare la sigaretta ma non sa decidersi a farlo. Attraverso le rassegne espositive si evidenzia quanto siano ancora forti e radicate le immagini positive che influenzano le idee e il gesto del fumare. Gruppo/i target Studenti dai 13 ai 18 anni, docenti, operatori sanitari, popolazione generale. Ai diversi gruppi target vengono proposti percorsi diversificati compren denti area informatica scientifica, laboratorio video, laboratorio informatico, laboratorio scientifico, laboratorio dell’immaginario legato al fumo, laborato rio psicologico, laboratorio del respiro. Inoltre ai docenti ed agli operatori sanitari vengono offerti “scuole senza fumo” e laboratorio metodologico. Tut ti vengono sottoposti a test di ingresso e di congedo. 279 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Presentazione e valutazione dei risultati La mostra è stata visitata da circa 8.000 persone. Sono stati elaborati questionari per valutare le conoscenze e il gradimento. Gli strumenti proposti nella mostra sono stati utilizzati nella didattica da molte scuole. Conclusioni Il bilancio della rassegna, che ha visto la collaborazione di personale esper to volontariato e istituzioni locali, è senz’altro positivo. Soddisfacente l’afflus so dei visitatori (8.000 persone). In particolare è stato centrato l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente dal punto di vista emotivo, oltre che originale e utile per appro fondimenti tematici nei suoi contenuti. E’ infatti innegabile che per affrontare in modo adeguato i problemi della prevenzione, occorre far leva sulle com ponenti che appartengono all’immaginario legato alla sigaretta, in larga parte ancora connotato positivamente, nonostante le conoscenze specifiche posse dute sulla nocività ed il danno individuale recato da certi comportamenti. Dare una forma esplicita e una voce a questo immaginario significa cominciare un processo di elaborazione più maturo del proprio vissuto rispetto al fumo e, dal punto di vista di chi si occupa di prevenzione, significa creare le sole condizioni necessarie ed efficaci per la riuscita dell’intervento. 12.63. Alimentarsi bene per crescere meglio: comunicare come? D. MICHELLINI1, A.M. FERRARI2, C. CAMPARI2 - AUSL di Reggio Emilia - 1Settore di Pediatria di comunità, 2Dipartimento di Sanità Pubblica AUTORE REFERENTE: ANNA MARIA FERRARI, SIP di Montecchio, AUSL, via Marconi 18, Montecchio (RE) - tel.: 0522 860170, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto Sempre maggiore attenzione è rivolto al problema dell’eccesso ponderale in età infantile, quale determinante di salute; è noto inoltre che stili di vita sani contribuiscono al miglioramento della qualità della vita. E’ stato proposto un progetto di educazione alimentare agli alunni della scuola elementare ritenendo la scuola la sede privilegiata per interventi di educazione e formazione; in un tale contesto, il messaggio sanitario dove va essere mediato da modalità comunicative consone al linguaggio dei bam bini. 280 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Obiettivo/i - Favorire la conoscenza dei comportamenti alimentari e l’adozione di standard nutrizionali sani (P.S.N. 1998-2000). - Promuovere “stili di vita” idonei a favorire la buona salute. - Costruire un progetto “esportabile”, documentando tutte le fasi operative, i materiali prodotti, i risultati. - Valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra citati attraverso metodi og gettivi (confronto dati epidemiologici). - Rendere i bambini e le loro famiglie protagonisti attivi. Gruppo/i target Nel 1999-2000 è stato proposto a 44 classi di 1° Elementare della pro vincia di Reggio Emilia un progetto di promozione e di educazione alla salute in campo alimentare. Il percorso didattico, svolto nell’arco dei 5 anni di scuola, ha visto la collaborazione di diversi professionisti ed enti impegnati a promuovere una corretta alimentazione associata all’attività motoria. La metodologia utilizzata prevedeva che l’acquisizione di conoscenze av venisse tramite esperienze personali: animazioni in classe con le dietiste, espe rienze sul campo, attività ludico-motoria. Presentazione e valutazione dei risultati Dalla valutazione dei questionari conoscitivi (Vero/Falso/Non so, Come mi vedo, Cosa mi piace mangiare) è emerso che gli alunni hanno una conoscen za degli argomenti significativamente maggiore rispetto a quelli che non han no partecipato al progetto. Nel corso dello svolgimento del progetto sono stati realizzati i seguenti materiali: cartelloni tematici; gioco della frutta; VHS: La colazione, Ghiro-Ghi ro, alieno alimentare, Flic e Floc, Intervento della dietista in classe; trasmissio ne televisiva: Cinque minuti di buona alimentazione; svariati CD interattivi; gioco educativo: Giocando con gusto. Conclusioni Si ritiene che le modalità comunicative adottate, che vedevano i bambini protagonisti attivi di percorsi fatti di gesti, racconti, esperienze, siano stati par ticolarmente significativi per il raggiungimento dei risultati. 281 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.64. La promozione della salute nell’anziano: riduzione del rischio di caduta P. A. MILANI (Direttore Sanitario HTC Health Tracking Center, Stradella, Pavia), S. CAMPETELLA (Servizio di Neuropsichiatria HTC), P.A. LOMBARDI (Assessore alla Cultura Comune di Stradella, Pavia), P.G. MAGGI (Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Stradella, Pavia), A. ZANCAN (Fisiatra Fondazione S. Maugeri, Pavia), P. ROVATI (Servizio di Nutrizione Clinica AO di Pavia), L. SONETTI (Terapista della Riabilitazione – HTC), T. BRIGADA (Terapista della Riabilita zione – HTC), C. RAMPINI (Terapista della Riabilitazione – HTC), F. CATANIA (Terapista della Riabilitazione – HTC), R. AQUILANI (Consulente Scientifico HTC) AUTORE REFERENTE: PIERA ADELE MILANI, HTC, Via Martiri Partigiani 33, 27049 Stradella (PV) - tel.: 0385 246861, fax: 0385 43363, e-mail: [email protected] Introduzione Le cadute rappresentano un importante evento negativo per la salute del l’anziano determinandone una minaccia per le capacità di autonomia fisica e soprattutto per la sopravvivenza. Inoltre i costi dell’ospedalizzazione e del l’eventuale assistenza post-ospedalizzazione sono elevati. Scopo del nostro intervento è stato quello di ridurre il rischio di caduta nella popolazione anziana del Comune di Stradella (PV). Metodologia: La nostra ipotesi di lavoro è che una riduzione della capacità del cammino (velocità < 84cm/sec nel o�; 74 cm/sec. nella o +) rappresenti un rischio elevato di caduta. La metodologia di intervento è stata descritta nell’abstract book edito dal 7° Congresso HPH di Torino 2003. [1] Risultati - Flusso della popolazione anziana pervenuto alla valutazione del cammino: Popolazione anziana (≥ 65 anni): n. 2.847 (=26,9% della popolazione di Stradella) � Risposte ai questionari pervenuti: n. 468 (=16,44%) (65% o +, 35% o ) Denuncianti problemi quotidiani nel camminare, lavarsi, vestirsi, svolgere mansioni fisiche n. 369 (=79%) Rientranti nei criteri di inclusione perla valutazione del cammino: n. 126 (=34,1%) Evidenziata ridotta capacità del cammino n. 46 (=12,5% della popolazione denunciante problemi) 282 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Tab. 1: Dati demografici ed antropometrici dei 46 soggetti con ridotta capacità del cammino Sesso • 37o +/9o Età (anni) 74±4,5 Peso (Kg) 68,7±14 BMI (Kg/m2) 27,9±4,5 Tab. 2: Risultati della valutazione del cammino (dati espressi come x ± D.S. con analisi statistica) Velocità del cammino (cm/sec) Metri percorsi in 6 minuti Difficoltà di respiro durante test (Scala di Borg: 0=nulla 10=max) Percezione di difficoltà durante il test (VAS 0= nulla 20= max) Prima del Dopo il ciclo ciclo terapia 73±17 95,5±17 251±74 337±74 Significatività p< 0,000 p< 0,000 2,63±2,5 1,54±1,9 n.s. 6,95±6,5 4±4,2 p< 0,02 Conclusione L’intervento dimostra l’efficacia di un ciclo di educazione al cammino e di fisioterapia per migliorarne l’efficienza, uno dei principali fattori contro il ri schio di caduta nell’anziano. Tuttavia molto rimane da attuare da parte delle autorità politico-sanitarie per ottenere un maggiore coinvolgimento della popolazione. Bibliografia 1. MILANI P. A., LOMBARDI P., MAGGI P., ZANCAN A., CAMPETELLA S., AQUILANI R., Una rete territoriale tra Centro Medico privato ed Istituzione Pubblica per la promozione della salute dei soggetti anziani. 1° fase: prevenzione della disabilità, 7° Conferenza Nazionale degli Ospedali per la Promozione della Salute, Torino 21-22 novembre 2003. 12.65. Intervento di sensibilizzazione sulla malattia diabetica rivolto alla cittadinanza: esperienza di 6 anni. F. CARBONARO, A. MATTUZZI, G. BELLANTE, B. DE MORI, A. BERNARDI - Unità Operati va di Geriatria, Ambulatorio diabetologico, Ospedale S. Maria del Carmine, Rovereto (Tn) AUTORE REFERENTE: ANNALISA MATTUZZI,GABRIELLA BELLANTE, Ambulatorio diabe tologico, Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto, TN - telefax: 0464 453398, E-mail: [email protected] 283 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Premessa Dagli studi epidemiologici è emerso che per ogni diabetico noto c’è un altro soggetto affetto da malattia diabetica (M.D.) non ancora diagnosticata. Infatti il diabete può rimanere asintomatico per molti anni pur essendo già diagnosticabile attraverso il semplice esame della glicemia. D’altra parte la mancata diagnosi di M.D. è pericolosa in quanto può condizionare lo svilup po e l’evoluzione delle complicanze micro e macro angiopatiche. Scopo Scopo del nostro intervento è stato quello di sensibilizzare la popolazione verso una precoce diagnosi di M.D. e di identificare i soggetti a rischio di diabete o già affetti da malattia asintomatica, attraverso un controllo casuale ed estemporaneo della glicemia. Metodo Nel corso degli ultimi 6 anni il team dell’Ambulatorio Diabetologico dell’Ospe dale di Rovereto, in collaborazione con la C.R.I. e l’Associazione Diabetici della Vallagarina ha effettuato delle uscite approntando uno stand in centro città. In tali occasioni sono state fornite informazioni, materiale illustrativo e un control lo estemporaneo della glicemia su sangue capillare mediante glucometro. Ai soggetti fuori range è stata offerta una consulenza diabetologica immediata e suggerito un successivo controllo glicemico di laboratorio, essendo la glicemia su sangue capillare non valida per una diagnosi. Per la diagnosi di M.D. ci siamo riferiti ai nuovi criteri della Società Italiana di Diabetologia emanati nel 2000. Risultati Nella tabella seguente sono riassunti i dati relativi a numero di uscite per anno, controlli glicemici effettuati e glicemie rilevate fuori range. Tab. 1 N. di uscite annuali N. pazienti sottoposti al test N. glicemia alterate (>110 mg/dl) % 1998 1 350 15 4,2 % 1999 1 280 8 2,8% 2000 1 200 6 3% 2001 2 295 14 4,7% 2002 3 731 53 7% 2003 3 789 62 7,8% Commento e conclusione Il successo di questa iniziativa ci ha incoraggiato a ripetere le uscite più 284 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 numerose nel corso di questi ultimi anni. Inoltre, abbiamo potuto verificare che la diagnosi di M.D. è stata formulata nello 0,5-1% dei soggetti testati per anno, attraverso le persone inviate successivamente al nostro Ambulatorio Diabetologico dal Medico di Medicina Generale, per una conferma diagnosti ca. 12.66. “Baby no smoke”. Progetto sperimentale pediatri di famiglia C. SPAGGIARI1, S. BOSI2, A.M. FERRARI3 - 1Pediatra di Famiglia, FIMP, 2Responsabi le Prevenzione Lega contro i Tumori – ONLUS Sezione di Reggio Emilia; 3Di partimento Sanità Pubblica AUSL di Reggio Emilia AUTORE REFERENTE: ANNA MARIA FERRARI, Dipartimento Sanità Pubblica AUSL di Reggio Emilia, Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud Montecchio Emilia, Via Marconi 18 – tel.: 0522 860170, fax: 0522 860140, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto Nell’ambito del progetto regionale tabagismo è iniziato nel 2003 il progetto pilota baby no smoke per i pediatri, coordinato dalla LILT di RE in collabora zione con l’AUSL di RE. Il progetto intende sensibilizzare le famiglie sui danni da esposizione al fumo attivo e passivo durante l’infanzia, offrire un rinforzo motivazionale alle mamme ed ai genitori che hanno smesso di fumare duran te il periodo della gravidanza, dare informazioni sui centri per smettere di fumare, sensibilizzare i preadolescenti sull’importanza di non cominciare a fumare. Infatti il tabagismo è la principale causa di morte prevenibile. L’abitu dine al fumo si instaura di solito in adolescenza, la gravità dei danni sollecita una prevenzione primaria che va attuata molto precocemente, tramite proget ti multidisciplinari. Dal 2001 a Reggio Emilia è iniziato il progetto “Baby no smoke” che prevedeva un intervento di counselling da parte delle ostetriche rivolto alle donne in gravidanza e ai loro partners; in questi anni il progetto ha evidenziato la necessità di una stretta collaborazione con i Pediatri per un supporto informativo e motivazionale alle famiglie nel periodo successivo alla gravidanza. Obiettivo/i Proteggere l’infanzia dall’esposizione al fumo passivo attraverso la forma zione dei pediatri di famiglia alla gestione del counselling motivazionale spe cialistico sul tema del fumo e il rinforzo motivazionale strutturato ai genitori fumatori che si sono astenuti dal fumo durante al gravidanza; sensibilizzare i preadolescenti. 285 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Gruppo/i target Pediatri di famiglia, genitori, preadolescenti. Presentazione e valutazione dei risultati Nel progetto sono previste le seguenti verifiche: rilevazione abitudine al fumo dei genitori dei nuovi nati in carico, valutazione dell’efficacia del pro gramma informativo attraverso interviste random ai genitori dei nuovi assistiti effettuate dalla LILT di Reggio Emilia, ente coordinatore del progetto, verifica di efficacia del progetto da parte dei pediatri dopo un anno sul 50% delle madri rimaste astinenti durante la gravidanza. Conclusioni Poiché l’evidenza internazionale sulla valutazione ed efficacia degli inter venti di prevenzione dell’abitudine al fumo indicano la necessità di antici pare l’introduzione dei programmi di sensibilizzazione nella fascia di età dai 5 ai 9 anni, l’inserimento dei pediatri in una rete di interventi risulta fonda mentale. Il tabagismo è la principale causa di morte prevenibile. In seguito alle campagne di disinformazione delle multinazionali del tabacco, l’opinione pubblica è stata per anni erroneamente convinta che l’inquinamento am bientale fosse più nocivo del fumo. Le sostanze presenti nel fumo di sigaret ta sono altamente tossiche. Una di queste, la nicotina, induce dipendenza, con meccanismo biochimico simile alle altre droghe. Il tabagismo è una tossicodipendenza. L’abitudine al fumo si instaura di solito in adolescenza, la gravità dei danni sollecita una prevenzione primaria che va attuata molto precocemente, tramite progetti multidisciplinari. Dal 2001 a Reggio Emilia è iniziato il progetto “Baby no smoke” che prevede un intervento di counselling da parte delle ostetriche rivolto alle donne in gravidanza e ai loro partners; in questi anni il progetto ha evidenziato la necessità di una stretta collabora zione con i Pediatri per un supporto informativo e motivazionale alle fami glie nel periodo successivo alla gravidanza. Il Pediatra di famiglia risponde alle caratteristiche del professionista sanitario che può ottenere risultati effi caci nel continuare la motivazione per i genitori dei nuovi nati e nella pre venzione del fumo in adolescenza. Con il rapporto di fiducia che si instaura con la famiglia, il Pediatra può incidere positivamente, fin dalle prime età della vita, sui fattori che influenzano l’inizio dell’abitudine tabagica, agendo in stretta collaborazione e coordinamento con le altre agenzie educative del territorio. 286 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.67. Dal progetto “Conoscere il consultorio” L. DONATI - Psicologa, Coordinatrice Consultorio di Riva del Garda (Trento) Il Consultorio di Riva del Garda, all’interno dello “Spazio Adolescenti” ha attivato nel maggio 2002 il progetto “Conoscere il Consultorio”, finalizzato ad aiutare i ragazzi a co noscere ed usufruire del Servizio. Dall’analisi dei dati, dalle considerazioni derivate dall’attività e dalla rasse gna della letteratura, si coglie la difficoltà degli adolescenti ad utilizzare i Ser vizi Sanitari in generale. Ci sembra invece importante favorire questa possibilità soprattutto per un Servizio come il nostro che può dare spazio a domande legate alla affettività, sessualità, alle consulenze ginecologiche, ostetriche, psicologiche e dell’assi stente sociale. Nel passaggio ad una maggiore autonomia complessiva pare importante aiutare i ragazzi a conoscere ed a sentirsi “legittimati” ad usufruire dei servizi, in particolare quelli sanitari. Attività spesso difficile per loro che si sentono ancora in un’area di confine tra infanzia ed età adulta. Abbiamo elaborato un progetto che è stato proposto ai ragazzi delle scuole medie superiori e dei centri educativi del nostro territorio che prevedeva di poter visitare il Consultorio, in modo che la conoscenza del servizio, della sua localizzazione, delle sue funzioni e dei suoi operatori potesse avvenire in si tuazioni più neutre sia perché realizzate con il gruppo dei pari, sia perché mediate da adulti tipo insegnanti o educatori che potessero essere meno coin volgenti rispetto ai genitori. L’organizzazione prevede una riunione con gli insegnanti e gli educatori all’inizio dell’anno scolastico in cui concordare come preparare i ragazzi al l’incontro, consegnare del materiale e costruire poi un calendario delle visite, preferibilmente relative a classi singole del secondo anno o a gruppi omoge nei. Agli insegnanti ed agli educatori viene chiesto anche di raccogliere do mande e curiosità dei ragazzi che verranno utilizzate all’interno dell’incontro. Durante la visita i ragazzi possono “familiarizzare” con la struttura e con gli operatori, conoscere le opportunità ed i servizi erogati, ed avere le prime ri sposte rispetto alle loro domande. Le scuole hanno progressivamente aderito all’iniziativa e quest’anno abbia mo avuto la “visita” di classi provenienti da tutti gli istituti superiori del nostro territorio, anche di quelli professionali con utenza prevalentemente maschile. Questo ci sembra il primo di una serie di indicatori di risultato che stiamo 287 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 analizzando e che hanno a che fare con la valutazione dei dati di frequenza e di utilizzo del servizio che abbiamo predisposto. Tab. 1: Attività “Conoscere il Consultorio” 2002 2002/2003 2003/2004 Totale n. incontri 8 8 19 37 n. insegnanti 20 15 29 64 n. alunni 64 111 208 383 12.68. Progetto Vita M. ANFOSSO - Infermiere Dirigente U.O. Attività Infermieristiche ASL 1 Impe riese Liguria “Il progetto vita” è un progetto con spirito sociale. Al “progetto vita” hanno partecipato medici e infermieri dell’ A.S.L. n. 1 Imperiese membri del Centro di Formazione I.C.R. “Riviera dei Fiori”. Tutti coloro che hanno partecipato sono Istruttori IRC BLS e BLSD, PBLS, PTC. Si vuole sottolineare quanto la preparazione professionale e didattica sia stata presa in considerazione dallo Staff aziendale al fine di poter essere a disposizione di tutti con un corso alla portata di tutti che vede come obiettivo unico il bene della persona. Supporti didattica: Strumenti: audiovisivi, cartacei, dispense, simulatori, ma nichini, defibrillatori didattici. Obiettivo Lo scopo del progetto è stato quello e a tutt’oggi in pieno svolgimento, di agire nella criticità della morte improvvisa dovuta nella maggioranza dei casi, ad un’aritmia cardiaca chiamata “fibrillazione ventricolare”, che può anche essere il primo, e purtroppo fatale, sintomo di un problema di cuore. Strutturazione Il corso è articolato in una intera giornata suddiviso nel seguente modo. Al fine di poter meglio comprendere la preparazione di coloro che frequen tano il corso stesso si procede ad un pre-test valutativo per identificare le conoscenze di ogni singolo partecipante; segue la prima parte della lezione 288 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 teorica ove vengono illustrate le tecniche di base del BLS, dopo di che si passa nei settori di simulazione didattica ove si mettono in pratica tecniche e meto diche di valutazione e azione dei vari casi clinici. A conclusione della prima parte della giornata e, una prima valutazione da parte degli istruttori, (rapporto: un istruttore ogni quattro partecipanti) si pas sa alla seconda parte della teoria rivolta alla defibrillazione e alla tecnica spe cifica. Una volta conclusa la teoria si procede nuovamente alla simulazione dei casi clinici ove il partecipante gioca un ruolo di primo piano. Nel pomeriggio quando i partecipanti hanno ritenuto di aver dissipato dubbi, perplessità e discusso delle incertezze con il gruppo dei docenti ven gono avviate le due prove valutative, quella teorica e quella pratica. La gior nata si conclude con la discussione finale e la rivalutazione delle criticità riscontrate. Si tenga presente che oltre alla formazione rivolta alla criticità cardiaca du rante il corso vengono trattate anche altre situazioni di emergenza che porta no inevitabilmente se non ad una fibrillazione ventricolare, ad un arresto cardio come le ostruzioni delle vie aeree. Infatti, tutti coloro che frequentano il corso oltre ad acquisire tecniche specifiche nella rianimazione cardio-polmonare affinano la metodologia pratica per la tecnica della disostruzione. Target Il progetto ha avuto avvio nel 2002 rivolto in prima battuta a tutto il perso nale medico, infermieristico, tecnico, ed assistenziale di tutta l’Azienda Sanita ria, sia in ambito ospedaliero che territoriale. Nel progetto sono stati inclusi anche tutti i medici di base della provincia di Imperia. Hanno partecipato al corso circa duemila dipendenti e vedrà la sua conclu sione a fine del 2004. Certamente si è già partiti con training di riverifica al fine di poter mantenere in tutti coloro che hanno frequentato il corso sempre vive le tecniche specifiche. “Ma non basta”. Come è stato detto, l’obiettivo non vuole essere solo quelli di appannaggio delle tecniche “salva vita”. Rivolte a pochi eletti, ma a tutti. La vita del prossimo si salva per la strada, nelle case, sul lavoro e non solo negli ospedali; allora meglio sarebbe dire: basta poco per far tanto. Alla luce di quanto sopra in contemporanea con il corso rivolto a personale sanitario è partito il corso rivolto a personale laico –volontari- “militi” delle pubbliche assistenze infatti oggi la provincia di Imperia consta di circa trecen to volontari abilitati dalla Commissione dell’ Emergenza per la defibrillazione. Ma non basta il corso ha preso finalmente l’ ultima e la più decisiva svolta, 289 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 ossia rivolto a tutti nei settori più disparati: nelle scuole, nel Corpo della Poli zia di Stato, nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nel Corpo dei Vigili Urbani, ma anche a coloro che non hanno nulla a che fare con l’ emergenza. Un progetto direi degno di essere citato è quello primo nella provincia in cui la IV° Superiore dell’ Istituto ITIS della città di Imperia ha frequentato tutto un corso di BLS che si è concluso con un prodotto finale didattico “video” in cui si vuole far comprendere come messaggio conclusivo che tutti possono fare molto con poco per gli altri con la formazione di dodici esecutori BLS. Certamente per la riuscita del progetto che ancora oggi è in cammino e continuerà a vivere, è da imputarsi all’ impegno incessante e continuo di tutti gli istruttori IRC medici ed infermieri che senza di loro nulla sarebbe stato possibile fare. Valutazione: Pre-test; Post-test; Attestati BLS. 12.69. Donne in ospedale: S. Anna- focus sulle pari opportunità attraverso la sensibilizzazione M. G. BAÙ, V. DONVITO, E. MAZZOLI, C. PERIS, C. PICCO, G. POPPA - OIRM S. Anna, Torino RESPONSABILE DEL PROGETTO: GRACE RABACCHI, Direttore Sanitario Presidio S. Anna ASO OIRM S. Anna Torino - C.so Spezia 60, 10126 Torino – tel.: 011 3134200, fax: 011 3134238, e-mail: [email protected] Finalità Il progetto si propone di migliorare la situazione lavorativa delle figure pro fessionali femminili, attraverso l’acquisizione di abilità specifiche e l’empowerment, al fine di garantire l’accesso a compiti e ruoli che siano stati identificati come di quasi esclusiva pertinenza maschile per l’alta critici pre sente all’interno dell’ASO OIRM- S. Anna Torino. Obiettivi Condurre una analisi retrospettiva storica e culturale, nonché attuale sui dati delle presenze femminili in aree medico- sanitarie all’interno della azien da ASO OIRM - S. Anna, che ha visto un numero crescente di medico-donna impegnate nell’ambito delle attività di assistenza al parto e del trattamento chirurgico delle patologie femminili. Identificare situazioni di emarginazione lavorativa al fine di comprendere i meccanismi di insorgenza e conseguentemente attuare soluzioni collettive (in 290 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 formazione, sensibilizzazione, monitorizzazione dei meccanismi di relazione uomo-donna). Empowerment sia “gender-oriented” che, indipendente dal genere sulla scorta di una sempre più crescente richiesta di formazione e valorizzazione delle competenze mediche. Diffusione della teleformazione e teleinformazione sulla tematica della cul tura delle Pari Opportunità. Trasferibilità della nostra esperienza. Descrizione sintetica del progetto Il progetto nasce in un contesto lavorativo ad alta specializzazione mater no-infantile: si tratta di una realtà aziendale con una componente femminile ben rappresentata che vede, analogamente ad altre realtà aziendali, una non corrispondente presenza di tipo proporzionale al salire dei livelli gerarchici. Per la specifica tipologia del settore si assiste al continuo interagire della strut tura sanitaria con utenti donne e logiche di rapporti prettamente femminili (parto, maternità) e all’aumento della presenza di donne medico coinvolte. Si propone di analizzare la realtà lavorativa di tali figure, sia passata che attuale, di aiutarle nello svolgimento dei compiti lavorativi, incrementandone l’espe rienza, e sostenendole nei percorsi di carriera meritati. Azioni Analisi delle reali attività lavorative e delle mansioni svolte dalle donne medico, azioni di sensibilizzazione e counselling sulle problematiche comu nicative delle relazioni lavoro-uomo-donna, seminari, interviste, ricorso ad esperienze innovativi di formazione. Vantaggi attesi Diffusione della cultura delle pari opportunità in un settore (area chirurgi ca) ad elevato contenuto culturale, che richiede professionalità e continuo aggiornamento a fronte di un carico lavorativo e di rischio rilevante; settore che a livello nazionale presenta una connotazione prevalentemente maschile dei ruoli. Risorse Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Linea E 1.2. 291 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Realizzazione Si realizza attraverso l’istituzione di una borsa di studio per la raccolta e la pubblicazione dei dati, la presenza di un tutor in sala operatoria, i seminari, le interviste, il report finale e un convegno conclusivo. Formazione personale La formazione tecnica del personale coinvolto si attua grazie alla presenza di un tutor esperto in tecniche chirurgiche dedicato al training direttamente in sala operatoria, rivolto alle sei donne medico nell’ambito di un corso specifi co. Utilizzo nuove tecnologie Studio pilota di fattibilità diretto ad un gruppo di sei donne per l’acquisizione di abilità tecnico-chirurgiche, che si avvale di un tutor esperto e monitoraggio in itinere dell’attività svolta. Utilizzo della rete telematica per il supporto formativo e informativo. Ruolo di controllo del Comitato Pari Opportunità aziendale che ha promosso tale iniziativa. 12.70. Esperienza di una ricerca/azione. La WHP in un’azienda sanitaria E. AGOSTI1, P. GROSSO2, G. GULINO3, D. LEVI4, T. LUBRANO5, M. PAIN6, C. PONZETTI7 1 Servizio Prevenzione e Protezione, ASL 9 Ivrea; 2Servizio Fisica Sanitaria, ASL 9 Ivrea; 3Direzione Medica Ospedaliera “Ospedali Riuniti del Canavese”, ASL 9 Ivrea; 4S.C. Ortopedia e Traumatologia, P.O. ASL 9 Ivrea; 5Servizio Me dico Competente ASL 9 Ivrea; 6Servizio Prevenzione e Protezione, ASL 9 Ivrea; 7 Direzione Aziendale, USL AOSTA AUTORE REFERENTE: ELIANA AGOSTI, Servizio Prevenzione e Protezione, ASL 9 Ivrea, Via Aldisio 2, 10015 Ivrea (TO) - tel.: 0125 414701, e-mail: [email protected] Introduzione Ogni situazione di rischio che coinvolga la collettività richiede una risposta adeguata al fine di ridurre il danno. Obiettivi La nostra ricerca-azione ha come obiettivo generale la promozione della salute nei luoghi di lavoro nell’accezione della salute, tutela e sicurezza dei lavoratori 292 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 con l’obiettivo specifico di promuovere il ruolo attivo del lavoratore nella gestione della propria salute al fine di acquisire capacità di controllo ed autogestione. Materiali e Metodi La ricerca-azione non è solo un intervento, ma è una metodologia per co noscere nell’agire e cambiare. Le indicazioni dell’ISPELS (WHP) sono state da noi applicate in maniera proporzionale alle risorse impiegate. Il metodo di ricerca utilizzato è servito per approfondire la conoscenza della nostra realtà nel suo complesso. La struttura logica in cui si evidenziano i campi d’indagine e le relative variabili analizzate comprende: Tre entità, Due relazioni e gli attributi per ciascuna entità. L’analisi riguarda 19 corsi di formazione per un totale di 395 partecipanti. Abbiamo individuato gli aspetti rilevanti della ricerca in: Tre entità: Entità A, individua tutti i lavoratori, oggetto della ricerca, cui rivolgere la promozio ne e tutela della salute; Entità B, individua gli infortuni accaduti in Azienda nell’arco temporale 1999-2000 ed è in relazione con l’entità A; Entità C indivi dua la formazione, è in relazione con A. Due relazioni: la relazione con l’en tità (A-B), è il rischio lavorativo aziendale; La relazione con l’entità (A-C) è la conoscenza soggettiva del lavoratore in tema di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli attributi rilevanti, individuati nell’entità A sono classificabili come variabili qualitative: Sesso, età, Scolarità (Diploma Inferiore, Diploma Superiore, Laurea), Ruolo/Qualifica professionale, (Infermieri, Medici, Capo sala, Tecnici, Ausiliari), Settore lavorativo d’appartenenza (U.O./Servizio). Gli attributi rilevanti individuati nell’entità B sono classificabili come variabili quantitative: numero degli infortuni occorsi negli anni 1999/2000/2001/2002 da cui si trae l’indice di frequenza, numero dei giorni di assenza determinati dall’evento infortunistico da cui si trae l’indice di gravità. Le due variabili con siderate concorrono al calcolo dell’incremento e decremento infortunistico. Gli attributi rilevanti individuati nell’entità C sono classificabili come variabili qualitative: rilevazione delle conoscenze specifiche dei lavoratori prima e dopo l’evento formativo, delle opinioni, suggerimenti, commenti e della qualità, efficacia e rilevanza del corso. Il riconoscimento e la classificazione delle in formazioni raccolte ne rappresentano il substrato su cui è stata costruita la struttura del questionario e degli items in esso contenuti. Risultati La valutazione, che ha per oggetto d’indagine l’efficacia dell’intervento, attra verso degli indicatori ci fa capire se l’azione ha prodotto i risultati e se questi sono congruenti con gli obiettivi perseguiti, inoltre, ci fornisce sia l’ampiezza del feno meno su cui si è intervenuti, sia indicazioni operative per migliorare nel futuro. 293 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Nello specifico, per i 2 ambiti di indagine - Rendimento Formativo, Grado di Sod disfazione – tutti i risultati sono espressi in una scala di graduazione. La relazione fra gli ambiti di indagine evidenzia 5 corsi in cui il vettore del campo d’azione è in equilibrio (8, 17, 21, 25). Per 6 corsi (2, 11, 14, 20, 22, 27) l’equilibrio del vettore è turbato (direzione verso la valenza negativa, espressione di una non completa soddisfazione del bisogno), per i rimanenti 8 (10,12,13,15,16,18,19,24) la direzio ne è verso la valenza positiva nel senso della soddisfazione del bisogno; entrambi esprimono l’azione dinamica - propulsiva al raggiungimento dell’obiettivo. Conclusioni Noi constatiamo una corrispondenza dei risultati osservati, nel senso di una maggiore dinamicità comportamentale nell’operatività quotidiana, rivolta alla salute e tutela del lavoratore, al fine di trovare l’adeguato equilibrio tra lo stato di necessità, attività e gratificazione. In sintesi si può dedurre che la formazione ha favorito l’empowerment, rafforzato la motivazione al cambiamento desumibile anche dall’interesse dimostrato e dalle opinioni espresse dai partecipanti ai cor si. Non solo, ma la ricerca- azione è diventata il momento di animazione sociale, di sollecitazione alla presa di coscienza del bisogno di formazione per promuo vere la salute. Infine è stato per noi un ulteriore apprendimento centrato sullo sviluppo di nuove capacità individuali e collettive, concretizzatesi in una dina mica di gruppo, tale da dare un significato costruttivo agli sforzi e alle ansie sostenute dai suoi componenti. E’ attraverso il bisogno, che la persona sviluppa un sistema di tensioni, atte a favorire la tendenza ad uscire dal proprio spazio e ambiente psicologico per crearne uno nuovo e migliore. 12.71. La formazione come opportunità di sviluppo organizzativo della rete HPH F. SIMONELLI, A. ZAPPULLA, K. MAJER, M.J. CALDÉS P., C. TEODORI - Centro di Coor dinamento della Rete HPH Toscana, Ospedale Pediatrico A. Meyer di Firen ze AUTORE REFERENTE: FABRIZIO SIMONELLI, Centro di Coordinamento della Rete HPH Toscana, Ospedale Pediatrico A. Meyer, Via Pico della Mirandola 24, 50132 Firenze – tel.: 055 5662311, fax: 055 5662940, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto La Rete HPH Toscana considera la formazione come: - una significativa opportunità di innovazione del servizio ospedaliero verso le finalità della promozione della salute; 294 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - un importante fattore di crescita culturale e scientifica del personale ospe daliero in questo senso; - un importante campo di elaborazione/confronto con altre esperienze inter nazionali; - una leva strategica fondamentale per lo sviluppo organizzativo della rete HPH; ed ha predisposto un quadro organico di attività formative indirizzato al per sonale ospedaliero, che è stato inserito nel programma biennale 2003-2004 de gli interventi formativi indirizzato al personale del SST della Regione Toscana. Le attività formative HPH si sviluppano sia a livello trasversale che di sup porto ai progetti. Tali attività rispondono alle esigenze formative rilevate du rante gli incontri di coordinamento di Rete e rispettano le indicazioni riportate dal Piano Sanitario Regionale 2002-2004, in tema di promozione della salute. Obiettivi generali Condivisione di conoscenze sulla promozione della salute; diffusione capillare della cultura della promozione della salute in ospedale; crescita e scambio di esperienze e metodologie; definizione della fisionomia concettua le della Rete HPH Toscana. Gruppo target L’intera Rete HPH Toscana, attraverso i singoli progetti formativi. Attività di formazione trasversali Laboratorio formativo per una fisionomia della Rete HPH Toscana (livello paradigmatico, livello strategico, livello progettuale): rivolto al gruppo dei coordi natori aziendali HPH, ai loro coadiutori, ai coordinatori dei progetti interaziendali HPH, e ai referenti di funzioni aziendali trasversali di rilievo per lo sviluppo HPH. Sviluppo della promozione della salute nel contesto ospedaliero: destinato agli operatori delle 16 ASL e AO coinvolti nel progetto HPH; Benchmarking progettuale in promozione della salute, rivolto agli operatori par tecipanti ai gruppi di progettazione interaziendali e agli operatori di riferimento. Attività formative specifiche, di supporto ai progetti - HPH: Ospedale senza dolore; HPH: Ospedale senza fumo; HPH: Umanizzazione; HPH: Ospedale interculturale; HPH: Sicurezza. 295 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Tutte queste iniziative formative sono rivolte agli operatori coinvolti nei progetti interaziendali. Focus: in particolare l’iniziativa Laboratorio formativo per una fisionomia della Rete HPH Toscana ha un carattere innovativo. Quest’esperienza si con fronta con il tentativo di elaborare e condividere aspetti etici, paradigmatici, strategici, e progettuali, capace di fornire una fisionomia specifica e di conno tare la crescita del progetto HPH nella Regione Toscana. L’iter formativo è stato sviluppato secondo una metodologia di autoformazione basata su fasi di brainstorming, di valutazione e selezione di contenuti condivisi e di sviluppo. Primi risultati - Avvio di interventi informativi e formativi in molti Ospedali della Rete; - per quanto riguarda il Laboratorio Formativo: - incremento della diffusione dei contenuti e metodologie HPH nel conte sto ospedaliero toscano; - attitudine crescente al confronto; - valorizzazione e promozione di iniziative legate al progetto HPH; - aumento del numero degli operatori coinvolti; - la messa a fuoco di alcuni assunti, strategie e elementi progettuali; - maggiore spinta alla pianificazione progettuale interaziendale. 12.72. Dalla esperienza di confronto con la sofferenza, alla proposta di una cultura di salute L. ROSSETTI1 (Operatore P. Coordinatore, Unità Operativa Medicina I°), G. M AGNANI2 (Servizio di Salute Mentale), D. MILANI1 (Responsabile Ufficio Infermieristico e Tecnico), I. PO1 (Ufficio Infermieristico e Tecnico), A. M. PIETRANTONIO1 (Direttore di Stabilimento), C. CARAPEZZI3 (Direttore Dipartimen to di Medicina), R. BONATTI2 (Responsabile Servizio di Salute Mentale), S. CENCETTI3 (Direttore P.O.) - 1Azienda U.S.L. di Modena, Ospedale di Carpi; 2 Azienda U.S.L. di Modena, Distretto 1 di Carpi; 3Presidio Ospedaliero, Azienda U.S.L. di Modena AUTORE DI RIFERIMENTO: LORELLA ROSSETTI, Unità Operativa di Medicina I°, Azien da U.S.L. di Modena, Ospedale di Carpi - Via Cav. Molinari 2, 41012 Carpi (MO) - tel.: 059 659309, fax: 059 659273, e-mail: [email protected] Premessa L’Ospedale di Carpi ha da tempo avviato un progetto di promozione della 296 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 salute che vede coinvolte più unità operative, finalizzato alla connotazione dei reparti ospedalieri, oltre che quali luoghi di diagnosi e trattamento, anche come luoghi di educazione alla salute, promozione della salute, con un atteggiamen to dei professionisti, medici e non medici, orientato al supporto del paziente e della famiglia, nella gestione della malattia ma anche dell’evento morte. La gestione dell’ammalato ed il supporto della famiglia, nell’ambito dell’evento morte, vede interessata in particolare l’Unità operativa di Medicina ad indirizzo Oncologico, ove quotidianamente il personale e le famiglie sono coinvolti in situazioni di forte drammaticità e sofferenza psicologica e affettiva. In questo contesto dal 1998 l’Unità Operativa di Medicina ha avviato una collaborazione con il Servizio di Salute Mentale, mediante costituzione di un gruppo tematico sull’umanizzazione della morte in ospedale. Obiettivo Il progetto è nato con l’obiettivo di migliorare la relazione interpersonale e d’aiuto nei confronti dell’ammalato terminale e della famiglia e di supportare gli operatori nella gestione di eventi a forte impatto emotivo, e di migliorare nel complesso la qualità dell’offerta assistenziale. Metodologia Il programma è stato realizzato tramite incontri ripetuti tra il personale infermieristico ed uno psichiatra che, in un’attività di gruppo, mediante l’ana lisi delle dinamiche psicologiche all’origine del disagio del personale ed un supporto metodologico, ha consentito un potenziamento delle risorse perso nali del singolo operatore, nell’ambito di un percorso che ha consentito di recuperare la consapevolezza degli aspetti di naturalità dell’evento morte, e di comprendere gli aspetti culturali, di socialità ed affettività, che connotano la parte terminale della vita. Risultati L’iniziativa ha consentito di conseguire tangibili benefici all’interno dell’équi pe in termini di sviluppo del senso di appartenenza al reparto, sviluppo della sensibilità e l’empatia nei confronti dell’ammalato e dei familiari. L’iniziativa ha trovato inoltre un suo sviluppo mediante il trasferimento dei contenuti dell’esperienza nell’ambito della comunità locale mediante una serie di conferenze che affrontano il tema della sofferenza, consentendo la condivisione con la cittadinanza di una tematica che costituisce parte integrante della cultura dell’Ospedale, consentendo una condivisione di valori ed un au mento della consapevolezza nel territorio di riferimento nel suo insieme. 297 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 12.73. Ignoranza: un terreno fertile per la discriminazione in sanità S. ARDIS1, M. MARCUCCI1, A. MERLI2, G. DI QUIRICO1, L. PULITI1, A. VINCENTI1, E. GAMBOGI1, D. BEVILACQUA1, M. A. MALERBI1, M. GIRALDI1, R. GOTTARDI3 - 1Azienda USL 2 Lucca; 2Pedagogista Clinico; 3Arcigay Pisa AUTORE REFERENTE: SERGIO ARDIS, Via del Pozzetto, 24, Pescia (PT) – tel.: 335 6146737, fax: 0583 970114, e-mail: [email protected] Introduzione Il progetto HPH di umanizzazione degli ospedali dell’Azienda USL 2 di Lucca ha realizzato un progetto di prevenzione della discriminazione delle persone HIV positive in ambito sanitario. Questo progetto, nato in collaborazione con il Comitato Etico Locale, prevede varie azioni: carta dei diritti e dei doveri delle persone HIV positive, formazione del personale, azioni dirette all’elimi nazione dei pregiudizi nella popolazione generale, azioni informative per le persone a rischio di discriminazione, ecc... Per la formazione del personale abbiamo realizzato un corso che tocca sia aspetti scientifici relativi alla patolo gia, sia aspetti tecnici dell’assistenza, sia aspetti medico-legali, sia considera zioni di ordine antropologico, psicologico, etico considerazioni sul ruolo dei media nella nascita dello stigma sociale che accompagna l’infezione da HIV. All’inizio ed alla fine del corso abbiamo somministrato ai partecipanti un que stionario. Vi presentiamo alcuni risultati del pre-test per evidenziare quanto siano scarse le conoscenze del personale sanitario su questo argomento e per poter riflettere sul fatto che la discriminazione delle persone HIV positive possa essere nata e sia cresciuta sul terreno fertile dell’ignoranza. Obiettivo Obiettivo principale dei test era di valutare l’efficacia della metodologia didattica usata. Abbiamo supposto che il basso livello di conoscenze fosse una causa di discriminazione e su questa supposizione abbiamo costruito il corso di formazione per personale sanitario. Il pre-test voleva confermare che il personale sanitario non direttamente coinvolto nella cura e nell’assistenza alle persone HIV positive non ha conoscenze adeguate sulla malattia. Target Il test è stato somministrato a personale sanitario medico, infermieristico, tecnico sanitario, ed altri laureati della sanità prima e dopo il corso di forma zione. In totale sono stati compilati 79 questionari per il pre-test e 82 per il post test. 298 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Valutazione dei risultati Il questionario somministrato prima e dopo il corso prevedeva 13 domande a risposta multipla. Al pre-test è stato dato il 51,9 delle risposte esatte, mentre al post-test è stato il 91,3 delle risposte esatte. Analizzando i dati del pre-test si è messo in evidenza che un operatore sanitario su 4 (25,3%) non sa che l’allattamento al seno dei neonati figli di madri sieropositive deve essere evita to per prevenire la malattia. I principali effetti dei farmaci antiretrovirali non sono conosciuti dai sanitari ospedalieri (38,0% delle risposte esatte possibili). Meno di un sanitario su tre sa che le persone sieropositive oggi possono rice vere un trapianto di fegato (31,6%). Un sanitario su quattro riteneva di dover visitare la persona HIV positiva usando la mascherina oppure indossando i guanti mentre solo il 73,4% aveva nozione esatta delle precauzioni universali. Solo 51,9% dei sanitari che hanno risposto al questionario sapeva che un endoscopio usato per una persona HIV positiva non necessita di precauzioni particolari ma deve essere disinfettato con le normali procedure. Sono un sa nitario su tre (29,1%) sa che la maggior parte delle persone sieropositive oggi in Italia non sa di esserlo. Quasi la metà del personale ritiene che non ci siano persone sieropositive sopra i sessanta anni (41,9% risponde no o non so). Questi dati mostrano che i sanitari che non lavorano nei reparti di malattie infettive hanno conoscenze molto scarse sull’infezione. La discriminazione delle persone HIV positive nei reparti ospedalieri può essere dovuta, fra le altre cause, anche dalla mancanza di conoscenza della malattia. La formazione rappresenta una strategia, fra le altre, per prevenire la discrimi nazione di queste persone e rendere l’ospedale più rispettoso dei diritti umani. Conclusioni Se l’HPH prevede fra i suoi obiettivi l’umanizzazione degli ospedali è per ché oggi gli ospedali, in misura variabile, sono disumani. Un ospedale può essere reso umano solo dall’umanità delle donne e degli uomini che vi lavora no dentro. Se vogliamo ospedali più umani dobbiamo scommettere ed inve stire sull’umanità di queste persone. 12.74. Realizzazione eventi pubblici di promozione ed educazione alla salute R. GAGNO - Responsabile Ufficio Educazione e Promozione della salute ASL 1 Imperiese, Regione Liguria La programmazione dell’attività di Educazione e Promozione della salute 299 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 ogni anno prevede una serie di incontri con mostre e condivisione dei lavori realizzati sia dall’Ufficio di Educazione alla Salute in collaborazione con l’Area Comunicazione URP sia durante i laboratori realizzati dalle scolaresche, que sto permette di concentrare in una unica sede e in un tempo definito l’esposi zione di tutte le attività. La funzione Educazione alla Salute è da ritenersi trasversale a tutte le strut ture interne dell’Azienda Sanitaria e la collocazione organizzativa atta a garan tire la trasversalità della funzione è quella in staff della Direzione Generale. La trasversalità della funzione Educazione alla Salute comporta la consulta zione e il coordinamento metodologico da attuarsi attraverso figure di riferi mento, di norma individuate a livello di Dipartimenti Ospedalieri e Territoria li, Distretti Sanitari o Strutture con particolare valenza strategica nel campo della Promozione della Salute. La costruzione di collaborazioni intra-aziendali e inter-settoriali nell’ottica di alleanze per la salute si rende indispensabile per favorire un’azione trasver sale su tutta l’Azienda, in modo da diffondere la maggior uniformità e omoge neità possibile degli interventi di Educazione e Promozione della Salute, sia per quanto riguarda gli aspetti metodologici che i contenuti. Al fine di garantire una ragionevole evidenza di efficacia delle attività e delle iniziative, mirante a modificare il modo di lavorare a compartimenti stagni e diffondere la cultura dell’Educazione alla Salute raccordandolo al più generale concetto di Promozione della Salute mediante una corretta comunicazione sa nitaria con tutti i settori di intervento dell’Azienda in modo armonico e paritario. Obiettivi - Favorire la collaborazione tra le Strutture Ospedaliere e Territoriali nell’otti ca del “lavorare insieme”; - motivare gli operatori sanitari alla partecipazione di programmi di preven zione e promozione della salute; - promuovere e condividere iniziative per favorire un ambiente più adatto alle esigenze di chi lo vive; - valutare il lavoro annuale con una pubblica manifestazione garantendo un confronto tra le parti coinvolte, prevedendo altresì la valutazione in itinere. Conclusioni Il Settore di Educazione e Promozione della Salute mediante il coordina mento trasversale ha voluto superare il modello statico di prevenzione a favo re di un modello dinamico caratterizzato dall’istituzione di un’organizzazione per la progettazione integrata. Si è inoltre consolidata la collaborazione tra diverse Strutture partecipanti ai progetti di educazione alla salute, mediante 300 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 l’individuazione di gruppi di lavoro e referenti di progetto, che vede il Diret tore di Dipartimento promotore del processo strategico di riorientamento che punta allo sviluppo di ambienti fisici e sociali favorevoli alla salute. In coerenza con le strategie del Ministero della Salute si è posta particolare attenzione alla promozione di Sani Stili di Vita, a favorire il Benessere dal punto di vista affettivo e sessuale, si è perseverato nella promozione di strate gie per eliminare la presenza di fumo nelle strutture. 12.75. Esperienza di promozione della salute durante il lavoro infermieristico. Ergomotricità per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici A. M. CIRLA, R. FAZIOLI, L. GALLI, C. MEINECKE - Istituti Ospitalieri di Cremona Unità di Medicina del Lavoro, U.O. Medicina Riabilitativa AUTORE REFERENTE: RAFFAELLA FAZIOLI, tel.: 0372 405433, fax: 0372 405656, e mail: [email protected] Il presente lavoro illustra un percorso formativo e applicativo di ergomotricità a favore di operatori di assistenza di un reparto di degenza medica. Si tratta per tanto di un modello sperimentale, la cui applicazione è mirata su gruppi a rischio professionale nella movimentazione di pazienti e nelle posture incongrue. L’intervento si articola in un modulo teorico-pratico ed ha la caratteristica di essere costruito sulle peculiari esigenze del contesto lavorativo, anche consi derando i risultati emersi dalla valutazione dei rischi. “Ergomotricità” è un neologismo che indica una tecnica di prevenzione che, partendo dal rischio posturale proprio di ogni mansione, individua i segmenti corporei maggior mente interessati e propone semplici esercizi mirati, ripetibili autonomamen te sul luogo di lavoro per compensare il rischio e prevenire il danno persona le. In tal modo viene promossa la salute durante l’attività lavorativa, per quan to attiene l’equilibrio muscolo-scheletrico. Si tratta pertanto di un metodo di autotrattamento sul posto di lavoro che ben si adatta alla realtà lavorativa ospedaliera. La costruzione di tale modulo teoricopratico all’interno della nostra Azienda Ospedaliera ha coinvolto diverse U.O., mediche ed amministrativo/formative (Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro, Unità Operativa di Medicina Riabilitativa, Ufficio Formazione, Qualità ed Aggiornamento, Unità Operativa di Medicina e Gastroenterologia) e si rivolge a Infermieri Professionali e ad Operatori Socio Sanitari, ossia a due figure profes sionali fra le più coinvolte nella mobilizzazione manuale dei pazienti. Il modulo contempla due fasi formative. Nella prima di circa un’ora e mezzo ci 301 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 si propone di approfondire alcune nozioni di fisiopatologia del rachide e dell’ar ticolazione scapolo-omerale, mentre nella seconda della durata di circa due ore e mezzo lo scopo è di analizzare le modalità di trasferimento di alcune tipologie di pazienti, di correggere le manovre effettuate in modo non ergonomico e di inse gnare esercizi (numericamente limitati, di semplice memorizzazione e di veloce esecuzione) di compenso muscolare come forma di autotrattamento preventivo. L’esecuzione di tali esercizi è prevista sia sul posto di lavoro sia a casa; allo scopo è stato predisposto materiale illustrativo indicante gli esercizi compensatori e gli esercizi di rilassamento da effettuare eventualmente a domicilio. Le criticità che si sono presentate sono state organizzative e di comunica zione (interne al gruppo bidisciplinare formato da Medico del Lavoro e Fisiatra/ Fisioterapista, esterne nei confronti delle altre U.O. interessate oltre che nei riguardi della Direzione Medica), di realizzazione pratica (spazi, tempi, mo dulazione oraria degli interventi, predisposizione di materiale informatico e di supporto) e di scelta metodologica (didattica formale e pratica didattica). Un primo risultato è stato quello di riuscire a far interagire diverse profes sionalità, esperienze e retroterra culturali con le esigenze organizzative e di scelta linguistico/pratica altrettanto importanti per la riuscita dell’esperienza. La valutazione dell’impatto sia di gradimento sia di apprendimento, nonché le verifiche di efficienza e di efficacia sono state predisposte mediante appositi questionari somministrati in modo sequenziale nel tempo. Questo tipo di promozione mirata può essere la base di partenza anche per una formazione pratica associata all’utilizzo di ausili minori e maggiori (sollevatori) nelle attività di mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti. 12.76. Confronto tra popolazione generale e dipendenti ASL afferenti ad un centro antifumo: l’esperienza del “Centro per il trattamento e la prevenzione dei danni indotti dal fumo di tabacco” di Livorno N. PULERÀ, G. MATTEELLI, A. SCOGNAMIGLIO, A. SANTOLICANDRO - “Centro per la Pre venzione e il Trattamento dei danni indotti da Fumo di Tabacco”- U.O. Pneumologia - Ospedale di Livorno AUTORE REFERENTE: NOLITA PULERÀ, UO. Pneumologia, Ospedale di Livorno, viale Alfieri 36 - tel 0586 223453, e-mail: [email protected] Premessa Nell’ambito del progetto HPH “Ospedale senza Fumo”, l’azienda USL6 di 302 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Livorno fornisce ai propri dipendenti (Dip.) l’opportunità di accedere al Cen tro Antifumo (CA) gratuitamente e, compatibilmente con l’esigenza della UO di appartenenza, anche in orario di lavoro. Tale disposizione è regolata da specifica deliberazione del Direttore Generale. La popolazione generale (PG), accede al servizio attraverso il pagamento di un pacchetto forfettario di € 92,96, comprendente una 1 visita (Spirometria, parametri vitali, misurazione del CO, test di Fagerstrom, counselling specifico, prescrizione della terapia farmacologica) e tutti i controlli ritenuti necessari nell’arco di 6 mesi di tratta mento. In tutti i casi i soggetti devono sostenere la spesa della terapia farmacologica. Scopo Verificare se esiste un diverso comportamento in termini di partecipazione e di successo tra Dip. e PG. Risultati Nel periodo 1/10/2000 (nascita de CA) - 31/03/2004 sono afferiti al ser vizio 1032 soggetti (PG 861, Dip. 171). Le donne Dip. sono state statistica mente più numerose (65,5 vs. 41,5% della PG). I Dip. sono risultati statisti camente: più istruiti (diploma+laurea 79,5 vs. 48,2%), meno coniugati (51,5 vs. 69,6%), più giovani (44,5±8,6 vs. 49,1 ± 11,9 anni). Per quanto riguarda le caratteristiche di fumo, i Dip hanno iniziato a fumare più tardi (17,9 vs. 16,8 anni), fumano meno sigarette (21,8 vs. 26,1 sig/die), hanno un valore di test di Fagerstrom inferiore (5,6 vs. 6,0) (differenze statisticamente si gnificative) e livelli di CO espirato al basale lievemente più bassi (21,6 vs. 22,1). Tutti i soggetti sono stati contattati telefonicamente dopo sei mesi e un anno dalla prima visita effettuata: nell’occasione veniva somministrato un questionario per la valutazione dell’astinenza, delle caratteristiche di fumo per coloro i quali erano ricaduti o non avevano cessato, e per il gra dimento del trattamento ricevuto. Al controllo a sei mesi il tasso di parteci pazione è stato del 93% nella PG e dell’ 84% nei Dip. Il controllo ad un anno ha rilevato un tasso di partecipazione dell’ 89% nella PG e dell’ 87% nei Dip. Tra coloro che hanno eseguito il controllo a 6 mesi, il 43,8% dei Dip. (femmine 40,3%; maschi 51,5%) ha riferito di essere astinente contro il 52,8% della PG (femmine 55,2%, maschi 51,1%); è da notare che mentre il tasso di successo è analogo tra i maschi delle due popolazioni, è signifi cativamente più basso tra le donne Dip. Al controllo ad un anno i tassi di successo risultano: Dip. 42,9% (maschi 39,1%; femmine 44,4%); PG 42,3% (maschi 46,1%; femmine 36,8). 303 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Conclusioni I due gruppi valutati sono risultati significativamente diversi sia in termini anagrafici (età, sesso, livello di istruzione, stato civile), che in termini di carat teristiche di fumo (inizio dell’abitudine, n. di sigarette fumate, entità della di pendenza). Per quanto riguarda la percentuale di successo al follow up, i due gruppi differiscono per il minor tasso di successo delle femmine Dip. al con trollo a sei mesi. Tuttavia il controllo a un anno non mostra differenze signifi cative tra i due gruppi, pur notandosi un comportamento inverso delle fem mine rispetto ai maschi (sono più astinenti le femmine Dip.). Quindi, nono stante le due popolazioni studiate risultino differenti per i parametri che le caratterizzano, per le modalità di accesso al Centro e per il fatto di dover so stenere o meno la spesa delle visite e del follow up, il tasso di cessazione risulta sovrapponibile dopo un anno dall’inizio del trattamento (42,3 % PG e 42,9 % Dip.). La recente indagine AIPO “Ospedali senza fumo” ha evidenziato una mag giore prevalenza di fumo nei dipendenti ospedalieri rispetto alla popolazione generale, suggerendo che il lavorare in ambiente sanitario non è un fattore protettivo nei confronti dell’abitudine al fumo; la nostra esperienza sembra dimostrare che non rappresenta neppure uno stimolo aggiuntivo alla cessa zione. 12.77. Il progetto gestione del rischio nel dipartimento di salute mentale di Reggio Emilia G. GRASSI, D. COSTI, L. TAGLIABUE AUTORE REFERENTE: GADDOMARIA GRASSI, Salute Mentale, Via Amendola 2, 42100 RE – tel.: 0522 335255/0522 335081 - e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto In letteratura è riportata la rilevanza epidemiologica degli errori sanitari e, più in generale, degli effetti iatrogeni delle cure. Esistono, in Italia, modalità definite dalle leggi nazionali e regionali di rilevazione di questi eventi: le segnalazione all’Ufficio Relazioni per il Pubbli co e al Tribunale dei Diritti del Malato (entrambe da parte dei cittadini), le segnalazioni al Servizio di Farmacovigilanza del Ministero da parte dei medi ci. E’ ampiamente documentato, tuttavia, che questi strumenti sono largamen te sottoutilizzati. Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Azienda Sanita ria (AUSL) di Reggio Emilia, che comprende Centri di Salute Mentale territo riali (Community Mental Health Centers), Residenze, Semiresidenze e un Ser 304 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 vizio di Psichiatria con posti letto nell’Ospedale Generale, si è dotato anche di altri strumenti di rilevazione di eventi indesiderati, coerentemente con le direttive aziendali e con le normative regionali. Obiettivo/i - Dotarsi di un sistema efficace di rilevazione degli eventi indesiderati nella pratica del Dipartimento di Salute Mentale. - Valutare la praticabilità, sensibilità ed efficacia di nuovi strumenti di rilevazione confrontati con quelli tradizionali. Tali obiettivi vengono perseguiti confrontando le tradizionali modalità di rilevazione di eventi indesiderati (reclami all’URP, reclami al TDM, segnalazioni al Servizio di Farmacovigilanza) con: - la rilevazione sistematica da parte degli operatori delle Non Conformità (man cata applicazione di procedure e istruzioni operative), in tutto il DSM; - rilevazione sistematica degli Eventi Sentinella (lista predefinita e specifica per ogni unità operativa di eventi potenzialmente indicativi di cattiva quali tà), in tutto il DSM; - rilevazione secondo il modello dell’Incident reporting, nell’area di degenza psichiatrica nell’Ospedale Generale). Gruppo/i target Utenti del Dipartimento di Salute Mentale di Reggio Emilia. Presentazione e valutazione dei risultati Sono stati valutati: - la capacità dello strumento di intercettare gli eventi critici (Indicatore: n. di segnalazioni per anno); - la sensibilità dello strumento (valutazione dell’entità degli eventi da parte del Nucleo Qualità e, per l’Incident Reporting di un gruppo misto unità ope rativa-staff aziendale); - l’impegno di risorse richiesto (da parte del Nucleo Qualità). Conclusioni L’utilizzazione delle vecchie e nuove modalità di rilevazione delle criticità nel Dipartimento di Salute Mentale ci ha consentito di trarre queste conclusio ni: - le modalità tradizionali intercettano pochissimi eventi potenzialmente indi cativi di cattiva qualità; 305 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - gli altri metodi registrano un numero di eventi significativamente maggiore, anche se con diverso livello di accuratezza e di impegno di risorse (le Non conformità hanno il pregio di segnalare anche eventi di tipo organizzativo ma con livello di gravità disomogeneo, il registro degli Eventi Sentinella permette una registrazione limitata ma semplice e attendibile, il modello dell’Incident reporting è più sensibile ma richiede più risorse); - l’utilizzo di un solo strumento è insufficiente per descrivere il fenomeno in oggetto; è necessario quindi dotarsi di una pluralità di strumenti di rilevazione della cattiva qualità delle cure. 12.78. La documentazione di qualità del dipartimento salute mentale come supporto alla valutazione e gestione dei rischi lavorativi G. MORINI, D. COSTI, A. PINOTTI, M. POLETTI AUTORE REFERENTE: GIOVANNI MORINI, Via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia – tel.: 0522 335236, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto La normativa europea e italiana richiedono che siano individuati tutti i rischi connessi alle attività lavorative, e che ciò venga formalizzato in un documento contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Usualmente la valutazione dei rischi è elaborata mediante l’osservazione da parte di un tecnico delle attività svolte dai lavoratori e riporta la program mazione delle misure previste per il miglioramento del livello di sicurezza. Tale programmazione si concretizza con una data di scadenza. La caratteristica dell’esperienza descritta è stata quella di sviluppare la valu tazione dei rischi per figure professionali di direzione dei servizi (Head of service), partendo dalla documentazione di qualità del Dipartimento che de scrive i prodotti erogati e le attività in esso contenute. Il programma delle misure per il miglioramento del livello di sicurezza è realizzata secondo un riesame periodico delle attività adottate. Obiettivo/i - Migliorare la sicurezza degli operatori delle strutture sanitarie. - Migliorare la valutazione dei rischi in base alle diverse figure professionali e le conseguenti misure di protezione e prevenzione. - Definizione della Tabella di classificazione delle classi di rischio. - Definizione della Tabella di corrispondenza tra rischi e misure di preven zione e protezione. 306 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 - Sviluppo delle seguenti tabelle di corrispondenza, partendo dalla descri zione della organizzazione del Dipartimento, dai suoi prodotti erogati e dal Sistema Informativo informatizzato che contabilizza le attività svolte dalle varie figure professionali: Macrostruttura aziendale � Strutture � Prodotti � Attività � Professioni � Rischi Occasionalmente si è reso necessario adattare la valutazione del rischio di alcune figure professionali che svolgono attività differenziate o con un diver so livello di rischio associato in Strutture simili. Il documento finale, pensato per il Cliente interno, contiene una tabella in cui sono riportate, per ogni Struttura considerata, le misure di prevenzione e protezione con riferimento alle figure professionali presenti, secondo il se guente schema: Strutture � Professioni � Rischi � Misure di prevenzione e protezione Gruppo/i target Operatori sanitari con funzioni di gestione dei servizi. Presentazione e valutazione dei risultati Miglioramento della valutazione e gestione dei rischi lavorativi. 12.79. Il Sistema Qualità nell’Azienda Ospedale Università San Martino di Genova R. ROSSO - Azienda Ospedale Università San Martino di Genova, tel.: 010 5555056 Introduzione La scelta strategica aziendale è stata quella di costituire una Unità Operativa complessa “L’Ufficio Qualità, Accreditamento e Relazioni con il Pubblico” che portasse allo sviluppo del Sistema Qualità Aziendale avendo competenza per le seguenti aree: Accreditamento Istituzionale, Accreditamento all’Eccellenza secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, Area della Qualità percepita, Area del Risk Management e U.R.P. 307 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Metodologia Si è costituita la Rete Aziendale per la Qualità che prevede, all’interno di tutte le U.O. la figura del Responsabile Assicurazione Qualità (R.A.Q.), e di Gruppi di Miglioramento della Qualità (G.M.Q.) composti da rappresentanti di tutte le figure che in intervengono nel processo assistenziale. L’operazione vede coinvolte circa 650 persone. Tutta la Rete Aziendale è stata formata tramite corsi ECM che hanno previ sto oltre ai concetti base della qualità, l’approccio multidisciplinare alle metodologie PDCA e l’utilizzo di strumenti di supporto. Alcuni RAQ sono stati formati in modo più approfondito attraverso corsi di formazione per “Auditor interno” e per “Valutatori dei Sistemi Qualità”, tenuti dall’organismo di Certificazione IMQ-CSQ (Istituto Marchio Qualità Certificazione Sistemi Qualità). In questo modo la struttura della rete aziendale ha cominciato a presentare un assetto di profili e competenze eterogenee e ben definite e ciò ha permesso di introdurre le Verifiche Ispettive Interne come metodo sistematico. Area Accreditamento Istituzionale Attraverso incontri mediati con lo staff centrale dell’U.O. Ufficio Qualità, Accreditamento e Relazioni con il Pubblico, ogni U.O. ha costruito un Docu mento organizzativo di reparto per ogni macroattività erogata (Degenza, Day Hospital, Day Surgery, Ambulatorio, ecc...). Si sono redatti 560 documenti di reparto che hanno determinato il ripensamento ed il riorientamento dell’organizzazione interna, consentendo a RAQ e GMQ di diventare attori organizzativi della performance clinica di reparto. Il Documento Organizzativo di reparto è così articolato: - Identificazione e rintracciabilità dell’Unità Operativa - Elenco delle prestazioni erogate - Organigramma con evidenza dei ruoli - Funzionigramma con matrice di responsabilità e sostituzioni - Organizzazione interna finalizzata alla continuità assistenziale 24h/24h - Modalità di accesso - Standard di qualità - Strumenti di verifica - Procedure utilizzate Il passo successivo è stato quello di recepire per ogni U.O. (119) dell’Azien da Linee Guida per patologia secondo criteri EBM e che le stessa fossero tra dotte in percorsi diagnostico terapeutico attraverso l’utilizzo di Flow-Chart. Il lavoro ha permesso di recepire 119 linee guida e 119 percorsi diagnostici terapeutici. 308 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Area Qualità Percepita Si sono sviluppati degli indicatori di performance attraverso “Indicatori di Processo e di esito della cura”, entrambi sono stati inseriti come obiettivi delle Unità Operative nella scheda di budget. Gli Indicatori di esito della Cura” sono stati formulati secondo la metodologia del Canadian Council on Health Services Accreditation che prevede le seguenti fasi: 1. Formulazione dell’indicatore 2. Domande chiave 3. Descrizione e tipologia 4. Scopo rationale e utilizzatori 5. Formula 6. Definizione delle variabili di base e delle modalità di rilevazione 7. Limitazioni ed esclusioni 8. Analisi dei dati 9. Riferimenti bibliografici Il lavoro ha permesso di recepire 119 indicatori. Per quanto riguarda gli indicatori di processo, sono stati utilizzati 3 stru menti: i questionari, i reclami e i Focus Group. Il Lavoro ha visto la somministrazione di 4.000 questionari che hanno indagato tutti i processi as sistenziali, l’analisi dei reclami ed i focus group hanno permesso di rilevare le criticità maggiori e quindi di poter mettere in atto azioni correttive adeguate. Area ISO 9001:2000 i risultati La strategia aziendale è stata quella di avviare il processo di accreditamento all’eccellenza secondo la Norma UNI EN ISO 9001: 2000 nelle diagnostiche trasversali e nei Servizi di supporto – Servizio di Anatomia, Istologia, Citologia Patologica e Citogenetica; Radiologia Cattedra “R”; Laboratorio di Analisi Cen trale; Servizio di Nutrizione e Dietetica Clinica – per estendere il dominio alle Degenze e alle Unità Strategiche – Neurologia e Centro Ictus; Servizio di Pre venzione e Protezione; Ufficio Qualità, Accreditamento e Relazioni con il Pub blico; Affari Generali e Legali; Formazione e Aggiornamento. Sono attualmente in via di Certificazione le seguenti U.O.: Nefrologia e Dia lisi, Neonatologia, Malattie Infettive Adulti, Clinica Urologia, Chirurgia Gene rale e Trapianti d’Organo. Area Risk Management Il progetto avviato all’interno di 2 Unità Operative, prevede un approccio metodologico basato sulla mappatura sia del rischio clinico che farmacologico, 309 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 attraverso l’analisi e la scomposizione dei processi arrivando alla costruzione di una Master List o elenco dei possibili errori/guasti riferiti alla singola se quenza del processo individuata. Il progetto, attualmente in fase iniziale, vedrà l’utilizzo sia della tecnica dell’Incident Reporting, attraverso la somministrazione al personale delle U.O. pilota, di una scheda di segnalazione dei “possibili errori”, sia della tecnica dell’HFMEA o “analisi dei modi di guasto/errore e dei loro effetti” proposto dalla JCAHO, privilegiando l’analisi prospettica dei processi considerati più rischiosi, e identificandone le potenziali vulnerabilità. Conclusioni Il modello implementato ha favorito l’instaurarsi di un “Clima Organizzativo” molto favorevole allo sviluppo della “Cultura del NOI e del Sentirsi Parte”, parte attiva delle decisioni dei processi di crescita dell’organizzazione, in una pro spettiva di enpowerment che dia validi contributi ai processi decisionali al fine di un continuo miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria erogata. 12.80. Paziente oncologico e continuità assistenziale M. C. AZZOLINA, I. M. RACITI, R. ARIONE, P. PANARISI - ASO San Giovanni Battista di Torino Per soddisfare le esigenze di una tipologia particolare di paziente, quale quello oncologico l’ASO San Giovanni Battista di Torino ha progettato e rea lizzato il Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino (C.O.E.S.). Il COES è una struttura .che ospita 60 posti letto di day hospital (30 posti letto di Ematologia e 30 di Oncologia), 18 ambulatori per le visite di diverse patologie neoplastiche (Ematologia, Oncologia Medica e Chirurgica), un Ser vizio Farmaceutico per la preparazione centralizzata dei farmaci antiblastici, un’ Area dedicata allo sviluppo di terapie innovative inclusi trapianti emopoietici autologhi ed allogenici. Il C.O.E.S. è anche la sede del Centro di Prevenzione Oncologica (C.P.O.) e del Coordinamento della Rete Oncologica della Regione Piemonte; rappresenta dunque a livello oncologico, il “ponte” ideale tra la nostra Azienda e le Strutture territoriali. Per la peculiarità dei pazienti trattati, sin dalla fase della progettazione si è volta particolare attenzione alla umanizzazione della Struttura ed alla centralità del paziente. Sono state a tal fine realizzate ampie sale di attesa, nelle quali è possibile svolgere varie attività: per esempio: isola delle chiacchiere, dei giochi enigmistci, della spiritualità, della lettura e dell’espressività. 310 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Il “Centro Accoglienza e Servizi” (C.A.S.) si occupa di: informare circa le modalità di accesso ai Servizi/Reparti di riferimento; gestire i rapporti con Centro accoglienza e servizi delle altre sedi regionali di Polo e aggiornare il sistema informativo Intranet ed Internet;attivare il Gruppo Interdisciplinare Cure (G.I.C.) per una valutazione collegiale; accogliere l’utente; costruire per il singolo utente uno specifico percorso assistenziale E’ operativo un Centro accoglienza composto da un Infermiere Professio nale (con funzione di gestione e coordinamento), quattro operatori addetti all’accoglienza, sette operatori addetti al trasporto. È altresì attiva apposita Commissione Medico – infermieristica coordinata dalla Direzione Sanitaria, che si occupa dei problemi logistici più frequenti tramite: - riunioni mensili con il Direttore del Dipartimento di Oncologia ed i Diretto ri delle Strutture Complesse afferenti al C.O.E.S.; - riunioni bimensili, per la gestione delle criticità di carattere operativo con personale medico, infermieristico e amministrativo, referenti di Day Hospital e Ambulatori. I pazienti hanno dimostrato notevole apprezzamento per tali iniziative: ciò è stato desunto dagli appositi questionari, somministrati sistematicamente ai pazienti afferenti al C.O.E.S.. Lodevole è l’attività svolta dalle associazioni di volontariato, dimostrata sia attraverso la destinazione di fondi per l’acquisto di giochi da tavolo e l’abbonamento a varie riviste sia tramite il costante sup porto psicologico agli utenti. 12.81. Linee guida aziendali sulla prevenzione delle cadute nel paziente anziano: risultati di una sperimentazione A. BRANDI1, P. GIOACHIN2, R. MARILLI2 - 1 Dirigente dell’Assistenza Infermieristica, 2 Collaboratore professionale sanitario - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi AUTORE REFERENTE: ANGELA BRANDI, Direzione Sanitaria, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; tel.: 0554 279692, fax: 0554 279080, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto L’indagine che viene presentata rientra nell’ambito di un progetto iniziato nel 2002, volto alla predisposizione e implementazione di linee guida aziendali per la prevenzione delle cadute del paziente anziano in ambito ospedaliero. 311 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 La sperimentazione, che rappresenta una fase del progetto, è stata realizzata per verificare se le linee guida e gli strumenti di monitoraggio in essa inseriti, elaborati attraverso la revisione sistematica della letteratura scientifica, siano effettivamente applicabili nella pratica clinica. Sulla base dei risultati della sperimentazione le linee guida saranno modificate per renderle strumenti di orientamento per gli operatori e per i pazienti stessi nella promozione della loro sicurezza e strumenti di miglioramento della qualità per l’organizzazione. Obiettivo/i Lo studio aveva l’obiettivo di conoscere il fenomeno caduta in tutti i suoi aspetti analizzandolo in un contesto ospedaliero, ci si è proposti di dare una risposta alle seguenti domande: a. Qual è l’incidenza del fenomeno caduta nell’ospedale? b. Quali sono le caratteristiche dei pazienti a rischio di caduta? c. Quali sono i fattori di rischio ambientali e di struttura che aumentano il rischio di caduta? d. Quali sono le misure che possono essere adottate per prevenire la caduta? e. Quanto è specifica e sensibile la scala Morse? Gruppo/i Target L’implementazione del progetto, al termine della sperimentazione, preve de il coinvolgimento di: - pazienti ricoverati, in particolare gli anziani individuati come a rischio e loro famiglie; - operatori dell’A.O.U.C. appartenenti ai ruoli sanitario, tecnico e ammini strativo che svolgono attività di assistenza, cura e supporto all’assistenza, nonché attività che contribuiscono alla sicurezza/comfort ambientale dei pazienti ricoverati; - persone afferenti agli ambulatori rispetto alle quali sarà particolarmente evidenziato l’aspetto preventivo-educativo. Presentazione e valutazione dei risultati La fase di sperimentazione ha avuto luogo dal 21/10/02 al 21/04/03: il me todo adottato è stato quello osservazionale prospettico. I pazienti ammessi nelle unità operative, sede dello studio, sono stati sottoposti a screening attraverso la somministrazione della scheda Morse per iden tificare il paziente a rischio di caduta. Ogni evento caduta esperito dai pazienti è stato monitorizzato dall’infer miere rilevatore presente al momento in cui si è verificato. 312 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 Le schede di monitoraggio degli arredi e presidi e della struttura sono state compilate dal personale in servizio una volta all’inizio della sperimentazione, poi ogni tre mesi. Osservazioni I dati emersi dallo studio non consentono al momento di dare una risposta definitiva ai quesiti oggetto della sperimentazione, ai quali sarà forse possibi le rispondere dopo un monitoraggio dell‘evento caduta sull’universo dei pa zienti ricoverati in azienda per il periodo di un anno. Tuttavia questi risultati aiutano a rivedere alcune raccomandazioni delle linee guida: - la popolazione target ha un’età > ai 70 anni, e presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: diagnosi di malattie neurologiche, cerebrovascolari, cardiovascolari, stato mentale alterato, deambulante autonomamente e con aiuto; - i fattori ambientali e lo stato della struttura sembrano influire sull’aumento di probabilità di caduta solo come fattori secondari alle sopra descritte con dizioni del paziente. In presenza di queste condizioni una buona illumina zione, specialmente notturna, letti disarticolati e corrimano nei percorsi più usati dai pazienti possono aiutare nella prevenzione; - dai dati emersi dalla valutazione della scheda Morse, si può affermare che la scala è abbastanza predittiva per quanto riguarda l’individuazione dei pazienti che non cadranno, ma lo è molto meno per l’individuazione dei soggetti con alta probabilità di caduta; - la percentuale di caduti nei reparti soggetti alla sperimentazione è aumen tata passando da una percentuale dello 0,5% (dato emerso con l’indagine retrospettiva) ad una percentuale dell’1,2 %. Questo dato conferma l’ipotesi formulata dal gruppo, di una sottostima del fenomeno nelle indagine pre cedente e dimostra come l’assenza di un sistema di monitoraggio sistemati co, porti a un errata interpretazione della qualità offerta dai servizi. Si ritie ne tuttavia di dover dare una lettura positiva di questo dato , in quanto dimostra che una maggiore educazione ed una maggiore responsa bilizzazione del personale porta a un cambiamento culturale in virtù del quale l’evento caduta è stato percepito non come un errore da nasconde re, ma come un evento da monitorare, per conoscerne la dinamica e poter lo più facilmente prevenire. Conclusioni Malgrado alcune difficoltà incontrate, si ritiene che la documentazione ela borata possa essere ritenuta un valido strumento per il miglioramento della 313 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 qualità dell’assistenza e un esempio di percorso metodologico da seguire per altre aree tematiche ritenute rilevanti ai fini della promozione della Best Practice, sia a livello assistenziale che organizzativo. Ma soprattutto, al di là degli specifici risultati ottenuti, il progetto ha contri buito a realizzarne altri: nei reparti soggetti alla sperimentazione ha consenti to di coinvolgere tutti gli operatori in un processo qualitativo di mantenimen to, miglioramento dell’assistenza, e di rafforzare gradualmente in loro una cultura della promozione della salute. 12.82. La promozione della salute attraverso una campagna di comunicazione sul diabete mellito. L’esperienza dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” - Pordenone. S. CORONA1, M. CASTELLETTO2 - Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occi dentale”, 1Responsabile Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, 2 Responsabile S.O.C. “Area della Medicina Legale e Gestione attività sanitarie” AUTORE REFERENTE: SILVANA CORONA, Via Vecchia Ceramica, 1, 33170 Pordenone tel.: 0434 369988, fax: 0434 523011, e-mail: [email protected] Breve introduzione del contesto Il diabete mellito è una delle patologie più diffuse nei Paesi Occidentali, può associarsi all’obesità e costituisce un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, renali, del sistema nervoso periferico, della vista, ecc.. é stato riconosciuto come “malattia sociale” per il fatto di costituire un proble ma di sanità pubblica in quanto, da un lato, comporta un elevato carico socia le e assistenziale, mentre, d’altro canto, esiste una molteplicità di interventi sanitari in grado di prevenirne le complicanze e di migliorare la qualità della vita delle persone colpite. Nel Friuli Venezia Giulia si stima che vi siano oltre 38.000 diabetici (con un tasso di prevalenza del 3,43 ogni cento per abitanti, superiore alla media na zionale di 3,02 per cento), e in provincia di Pordenone i diabetici sono oltre 9.000 (3,2 ogni cento abitanti). L’assistenza ai diabetici residenti sul territorio provinciale è fornita, in parti colare, da cinque servizi diabetologici: tre fanno capo all’Azienda Sanitaria e due all’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone. I bisogni e le aspettative delle persone diabetiche sono fortemente rappre sentate sul territorio dalle Associazioni di Volontariato, in particolare dall’As sociazione Famiglie Diabetici della provincia di Pordenone, che ha promosso e sostenuto finanziariamente la realizzazione di una vasta campagna di comu nicazione sul diabete. Questa iniziativa si è realizzata mediante la collabora 314 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 zione, attivata dall’Azienda Sanitaria, con l’Azienda Ospedaliera e con i medi ci di medicina generale. In particolare, si è costituito un gruppo di lavoro interaziendale, coordinato dall’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, che ha coinvolto vari servizi e al quale hanno preso parte diverse figure professionali (diabetologo, dietista, nutrizionista, medico legale, farmacista, medico di me dicina generale) per un totale di 15 componenti. Obiettivi La realizzazione della campagna di comunicazione intendeva perseguire principalmente i seguenti obiettivi: - accrescere l’informazione sulle problematiche sanitarie connesse a una delle patologie più diffuse nei Paesi Occidentali; - aumentare la consapevolezza nelle persone affette dal diabete sulle possi bili complicanze e sulle modalità per impedire o rallentare le complicanze stesse; - favorire un utilizzo più diffuso e più regolare dell’esecuzione di un esame laboratoristico (emoglobina glicata), particolarmente utile per monitorare l’andamento della glicemia in un arco temporale dei due – tre mesi antece denti l’esecuzione dell’esame; - promuovere stili di vita sani, in particolare dal punto di vista dell’alimenta zione e dell’attività fisica; - migliorare l’accessibilità ai servizi diabetologici presenti sul territorio pro vinciale; - rafforzare la tutela dei diabetici negli ambienti scolastici; - fornire riferimenti certi in tema di esenzione per prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche e per il rilascio/rinnovo della patente di gui da. Gruppi Target Il gruppo di lavoro ha individuato, nella provincia di Pordenone, tre princi pali categorie di destinatari: - la popolazione in generale; - le persone affette da diabete; - i familiari delle persone affette da diabete. Presentazione e valutazione dei risultati Come strumenti informativi sono stati prodotti dieci opuscoli ad argomento diversificato su questa patologia e sui riflessi che questa comporta nella vita di tutti giorni. La serie inizia con informazioni generali sul diabete e prosegue 315 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 con indicazioni dettagliate sulle modalità di autocontrollo, sulle possibili complicanze, sulle modalità di accesso ai cinque servizi diabetologici della Provincia. Fornisce, poi, indicazioni per un corretto stile alimentare, norme comportamentali per soccorrere con efficacia i diabetici nell’ambiente scola stico, indicazioni per il rilascio e rinnovo della patente di guida e si chiude con precisazioni per sapersi meglio destreggiare nel difficile mondo delle esen zioni per prestazioni specialistiche e farmaci. Per raggiungere efficacemente, in tutto l’ambito provinciale, i diversi destinatari individuati, sono stati stampati oltre 60.000 opuscoli e sono stati selezionati canali interni ed esterni diversificati per la distribuzione degli stes si. I canali interni erano rappresentati dai servizi diabetologici, dagli Uffici sanitari, dalla Commissione Medica Locale per le patenti di guida, dalle articolazioni degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico delle due Aziende Sanitarie e dagli spazi di maggiore aggregazione dell’utenza (sale di attesa, sportelli, ecc.). I canali esterni erano rappresentati dagli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta (n. 260), dalle farmacie (n. 81), dalle Associazioni di categoria (n. 3) e dalle Scuole (n. 80). Come indicatore più significativo, ma anche di più immediato e agevole riscontro per misurare l’efficacia della campagna informativa, è stato indivi duata la variazione dell’esecuzione di una certa tipologia di esame (emoglobina glicata) nell’ultimo quadrimestre del 2002 in rapporto all’ultimo quadrimestre dell’anno precedente (2001). Tab. 1 Riferimento temporale 9-12 / 2001 9-12 / 2002 % 1-4 / 2003 % Prestazioni (emoglobina glicata) 6.545 6.881 + 5,1 6.875 + 5,0 Utenti 5.650 6.057 +7,2 6.000 +6,2 L’analisi dei dati ha evidenziato un aumento del 5% delle richieste di esecu zione dell’emoglobina glicata e questa percentuale si è mantenuta costante anche nel primo quadrimestre dell’anno successivo (2003), mentre il numero di assistiti che hanno fatto ricorso a tale esame è percentualmente aumentato in misura ancora maggiore. Questi persistenti incrementi portano a ritenere che la campagna informativa abbia trovato larga diffusione e pronta applica zione, col risultato di determinare sia un più diffuso ricorso all’esame della glicemia glicata (aumento significativo del numero degli assistiti che hanno effettuato l’esame), sia una razionalizzazione del numero degli accertamenti eseguiti (incremento dell’esame in misura percentualmente minore di quello degli assistiti). Questo incremento è da ritenersi particolarmente significativo e utile nella gestione della malattia diabetica, in quanto tale esame, consente di conoscere meglio l’andamento della glicemia in un lasso di tempo medio – lungo. Ciò consente, non solo di stare meglio, ma anche di ridurre la probabi 316 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19 CAPITOLO 12 lità di complicanze legate al diabete, tanto quelle acute (chetoacidosi e coma, coma iperosmolare e ipoglicemico), quanto quelle croniche (neuropatia, retinopatia, nefropatia, malattia vascolare) che, tra l’altro, costituiscono il fat tore più rilevante nel determinare il peso della malattia. L’iniziativa ha permesso anche alle Aziende di raggiungere ulteriori risultati importanti, come l’omogeneizzazione delle procedure di presa in carico delle persone diabetiche all’interno dei vari Servizi Diabetologici; il rafforzamento della logica di lavoro di rete interaziendale; un generale miglioramento del l’immagine; il consolidamento del rapporto con le Associazioni di Volontariato, che hanno dimostrato di gradire la disponibilità ad ascoltare le loro istanze e proposte e a trasformarle in progetti condivisi. Conclusioni L’aumento del numero complessivo dell’esame (emoglobina glicata) rileva to nell’ultimo quadrimestre del 2002 in rapporto all’ultimo quadrimestre del l’anno precedente (2001) e, ancor più, l’incremento persino maggiore degli assistiti che hanno praticato tale esame inducono a pensare che la campagna informativa abbia incontrato il grande interesse degli assistiti e abbia sortito un importante risultato: una maggiore informazione e consapevolezza sugli effetti della patologia e, auspicabilmente, l’acquisizione di un maggiore impe gno nel ricercare stili di vita corretti, tali da favorire il controllo degli effetti della patologia e, in ultima analisi, un miglioramento della qualità di vita. Da ultimo, anche se i dati meriterebbero un maggiore dettaglio di appro fondimento, al momento non disponibile, sembrerebbe di poter cogliere che la campagna informativa abbia conseguito non solo un incremento del nume ro percentuale di accertamenti di emoglobina glicata eseguiti, ma anche una razionalizzazione del numero degli accertamenti stessi. L’iniziativa, infine, può essere considerata anche un positivo connubio di risorse tra il settore pubblico e il terzo settore rappresentato dalle Associazioni di Volontariato: l’uno per aver messo in campo la professionalità e l’altro per aver messo a disposizione le risorse finanziarie e per aver dato voce ai biso gni dei diabetici; insieme per promuovere la salute e rafforzare la tutela della centralità del cittadino. 317 Provincia Autonoma di Trento - Documenti per la salute n. 19
Scarica